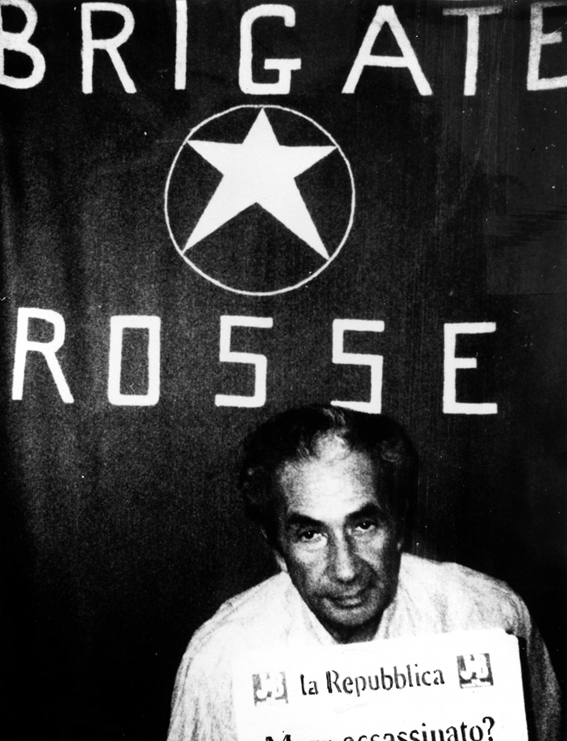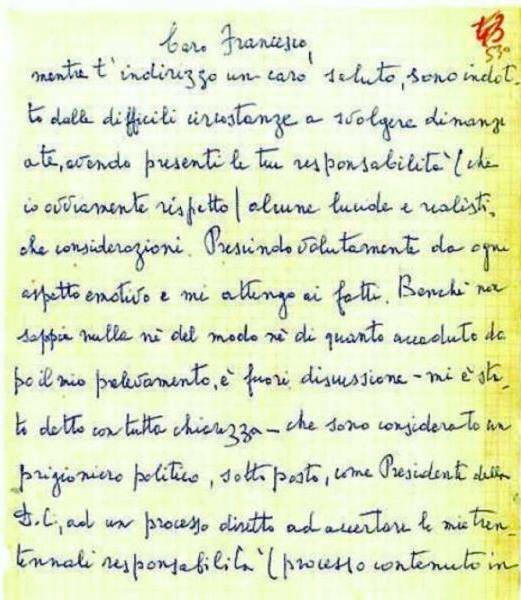Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI

 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
PARLIAMO
DI ALDO MORO
di antonio giangrande
DI ANTONIO
GIANGRANDE


Da Cinquantamila.corriere.it

Da Corriereobjects.it

Da Wikimedia.org

Da Rai.tv

Da Il SecoloXIX.it

Da Rai.tv
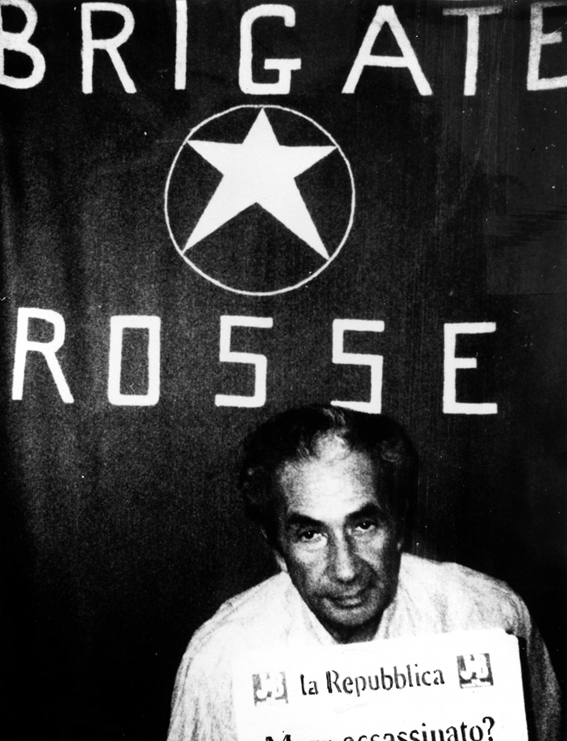
Da Giornalettismo.com

Da Blitzquotidiano.it

Da i.res.24o.it
L’AFFAIRE
MORO.
QUELLO CHE SI
DICE E QUELLO CHE SI TACE.
LA MAFIA TI UCCIDE, TI
AFFAMA, TI CONDANNA
IL POTERE TI INTIMA:
SUBISCI E TACI
LE MAFIE TI ROVINANO LA
VITA.
QUESTA ITALIA TI
DISTRUGGE LA SPERANZA
UNA VITA DI RITORSIONI,
MA ORGOGLIOSO DI ESSERE DIVERSO
Antonio Giangrande, scrittore,
accademico senza cattedra universitaria di Sociologia Storica, giornalista ed
avvocato non abilitato.
“L'Italia
tenuta al guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e
massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere.
La “Politica”
deve essere legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza
d’interessi, invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono
meritarlo il rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto
tra cittadini e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è
cogenza di legge, vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno
“Stato di Diritto” degrada in anarchia. In questo caso è palese la
responsabilità politica ed istituzionale per incapacità o per collusione. Così
come è palese la responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per
codardia o emulazione."
Di Antonio
Giangrande
TIRANNIDE
indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto
alla esecuzion delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle,
impedirle, sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E
quindi, o questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o
legittimo; buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza
effettiva, che basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è
tirannide; ogni popolo, che lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
Ogni tema trattato
sinteticamente in quest'opera è oggetto di approfondimento analitico in un
saggio dedicato.
SOMMARIO
UNA BALLATA
PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE SIAMO.
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande). L’AVETRANA CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
INTRODUZIONE.
LE STORIE DEI 5 UOMINI
UCCISI DALLE BRIGATE ROSSE.
IL MEMORIALE DI MORO.
1978 L’ANNO DEI TRE PAPI.
ALTRO CHE CONTRO IL
COMPROMESSO STORICO. CI VOLEVANO DEINDUSTRIALIZZARE.
ALTRO CHE CONTRO IL
COMPROMESSO STORICO. CI VOLEVANO SOVIETIZZARE. IL TERRORISMO
COMUNISTA-ISLAMISTA.
QUELL'ESKIMO IN REDAZIONE.
I 55 GIORNI DI MORO CHE
CAMBIARONO LA STORIA D’ITALIA.
LA LETTERA CHE UCCISE MORO.
QUELLO CHE TORNA...
TUTTO QUELLO CHE NON TORNA.
QUELLO CHE NON DICONO.
ALBERTO FRANCESCHINI E LA
VERITA' ACCETTABILE.
LA VERITA’ DICIBILE.
IL SEGRETO…
ALDO MORO ED I SALTIMBANCHI
DELLA DIETROLOGIA.
CONTINUIAMO A RICORDARE
(CIO’ CHE SI CERCA DI SCORDARE).
DOPO ALDO MORO. IN QUESTO
MONDO DI LADRI.
PRIMA DI ALDO MORO. "PADRI
DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA
NOSTRA ROVINA.
ALDO MORO. PALADINO DELLE
MASSE.
COMMISSIONE MORO: SULLA
VICENDA OPACITA' ED OMISSIONI.
ALDO MORO ED IL SIGNORAGGIO
BANCARIO.
16 MARZO 1978. QUEL GIORNO
DA CANI.
ALDO MORO....
IL CASO MORO.
ALDO MORO, LA GENUINITA’
DELLE LETTERE E LA TRATTATIVA.
LETTERE DI MORO DALLA
"PRIGIONE DEL POPOLO".
ALDO MORO E LO SPARTITISMO.
L’ITALIA DELLE TRATTATIVE.
UN COMPROMESSO NON STORICO.
ALDO MORO. LA STORIA VA RISCRITTA.
COME MORI' MORO?
CHI VOLLE LA MORTE DI MORO?
SEQUESTRO
MORO TRA MONTANELLI E SCIASCIA.
SEQUESTRO
MORO: I SEGRETI.
SEQUESTRO
MORO: LE COMMISSIONI D’INCHIESTA.
RILETTURA CRITICA DELLA
STORIA DELLE BRIGATE ROSSE E DEL RAPIMENTO DI ALDO MORO.
BRIGATE ROSSE E RISCRIZIONE
DELLA STORIA: LE VERITA' NEGATE.
MAI DIRE DEPISTAGGIO…
RAPIMENTO DI ALDO MORO. LA
POLIZIA SAPEVA E NULLA HA FATTO.
ALDO MORO ED IL
COMPLOTTISMO.
ALDO MORO TRA BUFALE E
DEPISTAGGI.
IL COMPLOTTO
INTERNAZIONALE.
SEQUESTRO
MORO: LA PISTA DELLA ‘NDRANGHETA.
IL SEQUESTRO
MORO E LA CAMORRA.
IL SEQUESTRO
MORO E COSA NOSTRA.
IL SEQUESTRO MORO E LA MASSONERIA.
IL SEQUESTRO MORO ED I SERVIZI SEGRETI ITALIANI.
IL SEQUESTRO MORO E GLI STATI UNITI.
IL SEQUESTRO MORO E
L’UNIONE SOVIETICA.
PARLA ELEONORA CHIAVARELLI
IN MORO.
PARLA AGNESE MORO.
PARLA GIOVANNI MORO.
PARLA MARIA FIDA MORO.
ALDO MORO: FU VERA GLORIA?
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA PER
UNA MEMORIA CONDIVISA.
APUZZO E FALCETTA: STRAGE
DI ALCAMO: NON FU GLADIO (NEMMENO GULOTTA).
GLI SCHELETRI DELLA DC.
FRANCESCO COSSIGA.
FILMOGRAFIA SUL CASO MORO.
PIAZZA DELLE CINQUE LUNE: STORIA O FINZIONE?
UNA BALLATA PER L’ITALIA
(di Antonio Giangrande)
Sono un italiano vero e me ne
vanto,
ma quest’Italia mica mi piace
tanto.
Tra i nostri avi abbiamo
condottieri, poeti, santi, navigatori,
oggi per gli altri siamo solo
una massa di ladri e di truffatori.
Hanno ragione, è colpa dei
contemporanei e dei loro governanti,
incapaci, incompetenti,
mediocri e pure tanto arroganti.
Li si vota non perché sono o
sanno, ma solo perché questi danno,
per ciò ci governa chi causa
sempre e solo tanto malanno.
Noi lì a lamentarci sempre e
ad imprecare,
ma poi siamo lì ogni volta gli
stessi a rivotare.
Sono un italiano vero e me ne
vanto,
ma quest’Italia mica mi piace
tanto.
Codardia e collusione sono le
vere ragioni,
invece siamo lì a
differenziarci tra le regioni.
A litigare sempre tra terroni,
po’ lentoni e barbari padani,
ma le invasioni barbariche non
sono di tempi lontani?
Vili a guardare la pagliuzza
altrui e non la trave nei propri occhi,
a lottar contro i più deboli e
non contro i potenti che fanno pastrocchi.
Italiopoli, noi abbiamo tanto
da vergognarci e non abbiamo più niente,
glissiamo, censuriamo,
omertiamo e da quell’orecchio non ci si sente.
Sono un italiano vero e me ne
vanto,
ma quest’Italia mica mi piace
tanto.
Simulano la lotta a quella che
chiamano mafia per diceria,
ma le vere mafie sono le
lobbies, le caste e la massoneria.
Nei tribunali vince il più
forte e non chi ha la ragione dimostrata,
così come abbiamo l’usura e i
fallimenti truccati in una giustizia prostrata.
La polizia a picchiare, gli
innocenti in anguste carceri ed i criminali fuori in libertà,
che razza di giustizia è
questa se non solo pura viltà.
Abbiamo concorsi pubblici
truccati dai legulei con tanta malizia,
così come abbiamo abusi sui
più deboli e molta ingiustizia.
Sono un italiano vero e me ne
vanto,
ma quest’Italia mica mi piace
tanto.
Abbiamo l’insicurezza per le
strade e la corruzione e l’incompetenza tra le istituzioni
e gli sprechi per accontentare
tutti quelli che si vendono alle elezioni.
La costosa Pubblica
Amministrazione è una palla ai piedi,
che produce solo disservizi
anche se non ci credi.
Nonostante siamo alla fame e
non abbiamo più niente,
c’è il fisco e l’erario che
ci spreme e sull’evasione mente.
Abbiamo la cultura e
l’istruzione in mano ai baroni con i loro figli negli ospedali,
e poi ci ritroviamo ad essere
vittime di malasanità, ma solo se senza natali.
Sono un italiano vero e me ne
vanto,
ma quest’Italia mica mi piace
tanto.
Siamo senza lavoro e senza
prospettive di futuro,
e le Raccomandazioni ci
rendono ogni tentativo duro.
Clientelismi, favoritismi,
nepotismi, familismi osteggiano capacità,
ma la nostra classe dirigente
è lì tutta intera da buttà.
Abbiamo anche lo sport che è
tutto truccato,
non solo, ma spesso si scopre
pure dopato.
E’ tutto truccato fin anche
l’ambiente, gli animali e le risorse agro alimentari
ed i media e la stampa che
fanno? Censurano o pubblicizzano solo i marchettari.
Sono un italiano vero e me ne
vanto,
ma quest’Italia mica mi piace
tanto.
Gli ordini professionali di
istituzione fascista ad imperare e l’accesso a limitare,
con la nuova Costituzione
catto-comunista la loro abolizione si sta da decenni a divagare.
Ce lo chiede l’Europa e tutti
i giovani per poter lavorare,
ma le caste e le lobbies in
Parlamento sono lì per sé ed i loro figli a legiferare.
Questa è l’Italia che c’è, ma
non la voglio, e con cipiglio,
eppure tutti si lamentano
senza batter ciglio.
Che cazzo di Italia è questa
con tanta pazienza,
non è la figlia del
rinascimento, del risorgimento, della resistenza!!!
Sono un italiano vero e me ne
vanto,
ma quest’Italia mica mi piace
tanto.
Questa è un’Italia figlia di
spot e di soap opera da vedere in una stanza,
un’Italia che produce veline e
merita di languire senza speranza.
Un’Italia governata da vetusti
e scaltri alchimisti
e raccontata sui giornali e
nei tg da veri illusionisti.
Sono un italiano vero e me ne
vanto,
ma se tanti fossero cazzuti
come me, mi piacerebbe tanto.
Non ad usar spranghe ed a chi
governa romper la testa,
ma nelle urne con la matita a
rovinargli la festa.
Sono un italiano vero e me ne
vanto,
ma quest’Italia mica mi piace
tanto.
Rivoglio l’Italia
all’avanguardia con condottieri, santi, poeti e navigatori,
voglio un’Italia governata da
liberi, veri ed emancipati sapienti dottori.
Che si possa gridare al mondo:
sono un italiano e me ne vanto!!
Ed agli altri dire: per
arrivare a noi c’è da pedalare, ma pedalare tanto!!
Antonio Giangrande
(scritta l’11 agosto 2012)
Il Poema di Avetrana di
Antonio Giangrande
Avetrana mia, qua sono nato e
che possiamo fare,
non ti sopporto, ma senza di
te non posso stare.
Potevo nascere in Francia od
in Germania, qualunque sia,
però potevo nascere in Africa
od in Albania.
Siamo italiani, della
provincia tarantina,
siamo sì pugliesi, ma della
penisola salentina.
Il paese è piccolo e la gente
sta sempre a criticare,
quello che dicono al vicino è
vero o lo stanno ad inventare.
Qua sei qualcuno solo se hai
denari, non se vali con la mente,
i parenti, poi, sono viscidi
come il serpente.
Le donne e gli uomini sono
belli o carini,
ma ci sposiamo sempre nei
paesi più vicini.
Abbiamo il castello e pure il
Torrione,
come abbiamo la Giostra del
Rione,
per far capire che abbiamo
origini lontane,
non come i barbari delle terre
padane.
Abbiamo le grotte e sotto la
piazza il trappeto,
le fontane dell’acqua e le
cantine con il vino e con l’aceto.
Abbiamo il municipio dove da
padre in figlio sempre i soliti stanno a comandare,
il comune dove per sentirsi
importanti tutti ci vogliono andare.
Il comune intitolato alla
Santo, che era la dottoressa mia,
di fronte alla sala gialla,
chiamata Caduti di Nassiriya.
Tempo di elezioni pecore e
porci si mettono in lista,
per fregare i bianchi, i neri
e i rossi, stanno tutti in pista.
Mettono i manifesti con le
foto per le vie e per la piazza,
per farsi votare dagli amici e
da tutta la razza.
Però qua votano se tu dai,
e non perché se tu sai.
Abbiamo la caserma con i
carabinieri e non gli voglio male,
ma qua pure i marescialli si
sentono generale.
Abbiamo le scuole elementari e
medie. Cosa li abbiamo a fare,
se continui a studiare, o te
ne vai da qua o ti fai raccomandare.
Parlare con i contadini
ignoranti non conviene, sia mai,
questi sanno più della laurea
che hai.
Su ogni argomento è sempre
negazione,
tu hai torto, perché l’ha
detto la televisione.
Solo noi abbiamo l’avvocato
più giovane d’Italia,
per i paesani, invece, è
peggio dell’asino che raglia.
Se i diamanti ai porci
vorresti dare,
quelli li rifiutano e alle
fave vorrebbero mirare.
Abbiamo la piazza con il
giardinetto,
dove si parla di politica
nera, bianca e rossa.
Abbiamo la piazza con
l’orologio erto,
dove si parla di calcio, per
spararla grossa.
Abbiamo la piazza della via
per mare,
dove i giornalisti ci stanno a
denigrare.
Abbiamo le chiese dove sembra
siamo amati,
e dove rimettiamo tutti i
peccati.
Per una volta alla domenica
che andiamo alla messa dal prete,
da cattivi tutto d’un tratto
diventiamo buoni come le monete.
Abbiamo San Biagio, con la
fiera, la cupeta e i taralli,
come abbiamo Sant’Antonio con
i cavalli.
Di San Biagio e Sant’Antonio
dopo i falò per le strade cosa mi resta,
se ci ricordiamo di loro solo
per la festa.
Non ci scordiamo poi della
processione per la Madonna e Cristo morto, pure che sia,
come neanche ci dobbiamo
dimenticare di San Giuseppe con la Tria.
Abbiamo gli oratori dove
portiamo i figli senza prebende,
li lasciamo agli altri, perché
abbiamo da fare altri faccende.
Per fare sport abbiamo il
campo sportivo e il palazzetto,
mentre io da bambino giocavo
giù alle cave senza tetto.
Abbiamo le vigne e gli ulivi,
il grano, i fichi e i fichi d’india con aculei tesi,
abbiamo la zucchina, i
cummarazzi e i pomodori appesi.
Abbiamo pure il commercio e le
fabbriche per lavorare,
i padroni pagano poco, ma
basta per campare.
Abbiamo la spiaggia a quattro
passi, tanto è vicina,
con Specchiarica e la
Colimena, il Bacino e la Salina.
I barbari padani ci chiamano
terroni mantenuti,
mica l’hanno pagato loro il
sole e il mare, questi cornuti??
Io so quanto è amaro il loro
pane o la michetta,
sono cattivi pure con la loro
famiglia stretta.
Abbiamo il cimitero dove tutti
ci dobbiamo andare,
lì ci sono i fratelli e le
sorelle, le madri e i padri da ricordare.
Quelli che ci hanno lasciato
Avetrana, così come è stata,
e noi la dobbiamo lasciare
meglio di come l’abbiamo trovata.
Nessuno è profeta nella sua
patria, neanche io,
ma se sono nato qua, sono
contento e ringrazio Dio.
Anche se qua si sentono alti
pure i nani,
che se non arrivano alla
ragione con la bocca, la cercano con le mani.
Qua so chi sono e quanto gli
altri valgono,
a chi mi vuole male, neanche
li penso,
pure che loro mi assalgono,
io guardo avanti e li incenso.
Potevo nascere tra la nebbia
della padania o tra il deserto,
sì, ma li mi incazzo e poi non
mi diverto.
Avetrana mia, finchè vivo ti
faccio sempre onore,
anche se i miei paesani non
hanno sapore.
Il denaro, il divertimento e
la panza,
per loro la mente non ha
usanza.
Ti lascio questo poema come un
quadro o una fotografia tra le mani,
per ricordarci sempre che oggi
stiamo, però non domani.
Dobbiamo capire: siamo niente
e siamo tutti di passaggio,
Avetrana resta per sempre e
non ti dà aggio.
Se non lasci opere che
restano,
tutti di te si scordano.
Per gli altri paesi questo che
dico non è diverso,
il tempo passa, nulla cambia
ed è tutto tempo perso.
La Ballata ti l'Aitrana di
Antonio Giangrande
Aitrana mia, quà già natu e ce
ma ffà,
no ti pozzu vetè, ma senza ti
te no pozzu stà.
Putia nasciri in Francia o in
Germania, comu sia,
però putia nasciri puru in
africa o in Albania.
Simu italiani, ti la provincia
tarantina,
simu sì pugliesi, ma ti la
penisula salentina.
Lu paisi iè piccinnu e li
cristiani sempri sciotucunu,
quiddu ca ticunu all’icinu iè
veru o si l’unventunu.
Qua sinti quarche tunu sulu ci
tieni, noni ci sinti,
Li parienti puè so viscidi
comu li serpienti.
Li femmini e li masculi so
belli o carini,
ma ni spusamu sempri alli
paisi chiù icini.
Tinimu lu castellu e puru lu
Torrioni,
comu tinumu la giostra ti li
rioni,
pi fa capii ca tinimu
l’origini luntani,
no cumu li barbari ti li
padani.
Tinimu li grotti e sotta la
chiazza lu trappitu,
li funtani ti l’acqua e li
cantini ti lu mieru e di l’acitu.
Tinimu lu municipiu donca fili
filori sempri li soliti cumannunu,
lu Comuni donca cu si sentunu
impurtanti tutti oluni bannu.
Lu comuni ‘ntitolato alla
Santu, ca era dottori mia,
ti fronti alla sala gialla,
chiamata Catuti ti Nassiria.
Tiempu ti votazioni pecuri e
puerci si mettunu in lista,
pi fottiri li bianchi, li neri
e li rossi, stannu tutti in pista.
Basta ca mettunu li manifesti
cu li fotu pi li vii e pi la chiazza,
cu si fannu utà ti li amici e
di tutta la razza.
Però quà votunu ci tu tai,
e no piccè puru ca tu sai.
Tinumu la caserma cu li
carabinieri e no li oiu mali,
ma qua puru li marescialli si
sentunu generali.
Tinimu li scoli elementari e
medi. Ce li tinimu a fà,
ci continui a studià, o ti ni
ai ti quà o ta ffà raccumandà.
Cu parli cu li villani no
cunvieni,
quisti sapunu chiù ti la
lauria ca tieni.
Sobbra all’argumentu ti ticunu
ca iè noni,
tu tieni tuertu, piccè le
ditto la televisioni.
Sulu nui tinimu l’avvocatu
chiù giovini t’Italia,
pi li paisani, inveci, iè
peggiu ti lu ciucciu ca raia.
Ci li diamanti alli puerci
tai,
quiddi li scanzunu e mirunu
alli fai.
Tinumu la chiazza cu lu
giardinettu,
do si parla ti pulitica nera,
bianca e rossa.
Tinimu la chiazza cu
l’orologio iertu,
do si parla ti palloni, cu la
sparamu grossa.
Tinimu la chiazza ti la strata
ti mari,
donca ni sputtanunu li
giornalisti amari.
Tinimu li chiesi donca pari
simu amati,
e donca rimittimu tutti li
piccati.
Pi na sciuta a la tumenica
alla messa do li papi,
di cattivi tuttu ti paru
divintamu bueni comu li rapi.
Tinumu San Biagiu, cu la
fiera, la cupeta e li taraddi,
comu tinimu Sant’Antoni cu li
cavaddi.
Ti San Biagiu e Sant’Antoni
toppu li falò pi li strati c’è mi resta,
ci ni ricurdamo ti loru sulu
ti la festa.
No nni scurdamu puè ti li
prucissioni pi la Matonna e Cristu muertu, comu sia,
comu mancu ni ma scurdà ti San
Giseppu cu la Tria.
Tinimu l’oratori do si portunu
li fili,
li facimu batà a lautri, piccè
tinimu a fà autri pili.
Pi fari sport tinimu lu campu
sportivu e lu palazzettu,
mentri ti vanioni iu sciucava
sotto li cavi senza tettu.
Tinimu li vigni e l’aulivi, lu
cranu, li fichi e li ficalinni,
tinimu la cucuzza, li
cummarazzi e li pummitori ca ti li pinni.
Tinimu puru lu cummerciu e
l’industri pi fatiari,
li patruni paiunu picca, ma
basta pi campari.
Tinumu la spiaggia a quattru
passi tantu iè bicina,
cu Spicchiarica e la Culimena,
lu Bacinu e la Salina.
Li barbari padani ni chiamunu
terruni mantinuti,
ce lonnu paiatu loro lu soli e
lu mari, sti curnuti??
Sacciu iù quantu iè amaru lu
pani loru,
so cattivi puru cu li frati e
li soru.
Tinimu lu cimitero donca tutti
ma sciri,
ddà stannu li frati e li soru,
li mammi e li siri.
Quiddi ca nonnu lassatu
laitrana, comu la ma truata,
e nui la ma lassa alli fili
meiu ti lu tata.
Nisciunu iè prufeta in patria
sua, mancu iù,
ma ci già natu qua, so
cuntentu, anzi ti chiù.
Puru ca quà si sentunu ierti
puru li nani,
ca ci no arriunu alla ragioni
culla occa, arriunu culli mani.
Qua sacciu ci sontu e quantu
l’autri valunu,
a cinca mi oli mali mancu li
penzu,
puru ca loru olunu mi calunu,
iu passu a nanzi e li leu ti
mienzu.
Putia nasciri tra la nebbia di
li padani o tra lu disertu,
sì, ma ddà mi incazzu e puè
non mi divertu.
Aitrana mia, finchè campu ti
fazzu sempri onori,
puru ca li paisani mia pi me
no tennu sapori.
Li sordi, lu divertimentu e la
panza,
pi loro la menti no teni
usanza.
Ti lassu sta cantata comu nu
quatru o na fotografia ti moni,
cu ni ricurdamu sempri ca mo
stamu, però crai noni.
Ma ccapì: simu nisciunu e
tutti ti passaggiu,
l’aitrana resta pi sempri e no
ti tai aggiu.
Ci no lassi operi ca restunu,
tutti ti te si ni scordunu.
Pi l’autri paisi puè qustu ca
ticu no iè diversu,
lu tiempu passa, nienti cangia
e iè tuttu tiempu persu.
Testi scritti il 24
aprile 2011, dì di Pasqua.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
Antonio Giangrande,
orgoglioso di essere diverso.
Se si è omologati (uguali)
o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi
nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
In un mondo caposotto
(sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli
ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono
l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I
nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Dove si sentono alti anche
i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi
fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.
Il difetto degli
intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio
degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di
avere già le risposte.
Un popolo di “coglioni”
sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.
Un chierico medievale si
imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo
sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti
creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra
caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed
illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di
altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare,
dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso,
dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo
sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace
e disposto ad ascoltarci.
E’ comodo definirsi scrittori
da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale.
Da sempre diffido di chi,
vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti
giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del difensore
civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro, per poter
metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi
batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di
rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son
bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di
soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e mai parlano di
libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione umana nefasta
si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli
animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta
che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito
preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli
permettiamo di farle.
Parlare nei miei libri del
caso singolo del semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di
mitomania, pazzia o calunnia, oltre che ne disinteresse. Invece parlo di loro,
delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso
dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto
divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere
altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di
loro stessi e se ne fottono degli altri.
Alle sentenze irrevocabili di
proscioglimento del Tribunale di Taranto a carico del dr Antonio Giangrande, già
di competenza della dr.ssa Rita Romano, giudice di Taranto poi ricusata perché
denunciata, si aggiunge il verbale di udienza dell’11 dicembre 2015 della causa
n. 987/09 (1832/07 RGNR) del Tribunale di Potenza, competente su fatti attinenti
i magistrati di Taranto, con il quale si dispone la perfezione della fattispecie
estintiva del processo per remissione della querela nei confronti del dr Antonio
Giangrande da parte del dr. Alessio Coccioli, già Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto, poi trasferito alla Direzione
Distrettuale Antimafia di Lecce. Remissione della querela volontaria, libera e
non condizionata da alcun atto risarcitorio.
Il Dr Antonio Giangrande era
inputato per il reato previsto e punito dall’art. 595 3° comma c.p.
“perchè inviando una missiva a sua firma alla testata
giornalistica La Gazzetta del Sud Africa e pubblicata sui siti internet
lagazzettadelsudafrica.net, malagiustizia.eu, e
associazionecontrotuttelemafie.org, offendeva l’onore ed il decoro del dr.
Alessio Coccioli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Taranto, riportando in detto su scritto la seguente frase: “…il PM Alessio
Coccioli, inopportunamente delegando i carabinieri di Manduria, quali PG, ha
reso lecito tale modus operandi (non rilasciare attestato di ricezione da parte
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Manduria ndr), motivandolo dal fatto che
non è dannoso per il denunciante. Invece in denuncia si è fatto notare che tale
usanza di recepimento degli atti, prettamente manduriana, può nascondere
alterazioni procedurali in ambito concorsuale e certamente abusi a danno dei
cittadini. Lo stesso PM Alessio Coccioli, inopportunamente delegando i
carabinieri di Manduria, quali PG, per la colleganza con il comandante dei
Vigili Urbani di Manduria, ha ritenuto le propalazioni del Giangrande, circa il
concorso per Comandante dei Vigili Urbani, ritenuto truccato (perché il medesimo
aveva partecipato e vinto in un concorso da egli stesso indetto e regolato in
qualità di comandante pro tempore e dirigente dell’ufficio del personale), sono
frutto di sue convinzioni non supportate da riscontri di natura obbiettiva e
facendo conseguire tali riferimenti, al predetto dr. Coccioli, ad altre
notazioni, contenute nello stesso scritto, nelle quali si denunciavano
insabbiamenti, o poche richieste di archiviazioni strumentali attribuite ai
magistrati della Procura della Repubblica di Taranto”.
Il Processo di Potenza, come i
processi tenuti a Taranto, sono attinenti a reati di opinione. Lo stesso dr.
Alessio Coccioli, una volta trasferito a Lecce, ha ritenuto che le opinioni
espresse dal Dr Antonio Giangrande riguardo la Giustizia a Taranto non potessero
continuare ad essere perseguite.
Ultimo atto. Esame di Avvocato
2015. A Lecce uno su quattro ce l’ha fatta. Sono partiti in 1.108: la prova
scritta è stata passata da 275 praticanti. Preso atto.....
All'attenzione dell'avv.
Francesco De Jaco. Illustre avv. Francesco De Jaco, in qualità di Presidente
della Commissione di Esame di Avvocato 2014-2015, chi le scrive è il dr Antonio
Giangrande. E’ quel signore, attempato per i suoi 52 anni e ormai fuori luogo in
mezzo ai giovani candidati, che in sede di esame le chiese, inopinatamente ed
invano, Tutela. Tutela, non raccomandazione. Così come nel 2002 fu fatto
inutilmente con l’avv. Luigi Rella, presidente di commissione e degli avvocati
di Lecce. Tutela perché quel signore il suo futuro lo ha sprecato nel suo
passato. Ostinatamente nel voler diventare avvocato ha perso le migliori
occasioni che la vita possa dare. Aspettava come tutti che una abilitazione,
alla mediocrità come è l’esame forense truccato, potesse, prima o poi, premiare
anche lui. Pecori e porci sì, lui no! Quel signore ha aspettato ben 17 anni per,
finalmente, dire basta. Gridare allo scandalo per un esame di Stato irregolare
non si può. Gridare al complotto contro la persona…e chi gli crede. Eppure a
Lecce c’è qualcuno che dice: “quello lì, l’avvocato non lo deve fare”. Qualcuno
che da 17 anni, infastidito dal mio legittimo operato anche contro i magistrati,
ha i tentacoli tanto lunghi da arrivare ovunque per potermi nuocere. Chi afferma
ciò è colui il quale dimostra con i fatti nei suoi libri, ciò che, agli
ignoranti o a chi è in mala fede, pare frutto di mitomania o pazzia. Guardi, la
sua presidenza, in sede di scritto, è stata la migliore tra le 17 da me
conosciute. Purtroppo, però, in quel di Brescia quel che si temeva si è
confermato. Brescia, dove, addirittura, l’ex Ministro Mariastella Gelmini chiese
scampo, rifugiandosi a Reggio Calabria per poter diventare avvocato. Il mio
risultato delle prove fa sì che chiuda la fase della mia vita di aspirazione
forense in bruttezza. 18, 18, 20. Mai risultato fu più nefasto e, credo,
immeritato e punitivo. Sicuro, però, che tale giudizio non è solo farina del
sacco della Commissione di esame di Brescia. Lo zampino di qualche leccese c’è!
Avvocato… o magistrato… o entrambi…: chissà? Non la tedio oltre. Ho tentato di
trovare Tutela, non l’ho trovata. Forse chiedevo troppo. Marcire in carcere da
innocente o pagare fio in termini professionali, credo che convenga la seconda
ipotesi. Questo è quel che pago nel mettermi contro i poteri forti
istituzionali, che io chiamo mafiosi. Avvocato, grazie per il tempo che mi ha
dedicato. Le tolgo il disturbo e, nel caso l’importasse, non si meravigli, se,
in occasione di incontri pubblici, se e quando ci saranno, la priverò del mio
saluto. Con ossequi.
Avetrana lì 26 giugno 2015. Dr
Antonio Giangrande, scrittore per necessità.
INTRODUZIONE.
Il “caso Moro”, Sciascia,
Mattarella e la Sicilia,
scrive il 22 giugno 2018 su "La Repubblica" Simona Zecchi, Giornalista e
scrittrice. Scriveva Leonardo Sciascia sul Corriere della Sera nel 1982: «Si è
parlato - e molti che non ne hanno parlato ci hanno creduto - della 'geometrica'
perfezione di certe operazioni delle Brigate Rosse: e si è poi visto di che
pasta sono fatti i brigatisti e come la loro efficienza venisse dall'altrui
inefficienza. Arriveremo alla stessa constatazione - almeno lo spero - anche con
la mafia». Già altrove lo scrittore siciliano era ricorso a rappresentare le due
forze - terrorismo e mafia - come motrici entrambe degli omicidi Mattarella
(Piersanti, ammazzato il 6 gennaio 1980) e Reina (Michele, ammazzato il 9 marzo
1979). Scriveva in particolare il 7 gennaio del 1980 sempre sul Corriere: «Io
sono stato tra i pochissimi a credere che Michele Reina, segretario provinciale
della Democrazia Cristiana, fosse stato assassinato da terroristi. Terroristi
magari un pò sui generis, come qui ogni cosa; ma terroristi. [...] Oggi di
fronte all'assassinio del presidente della Regione Mattarella, quella mia
ipotesi, che quasi mi ero convinto ad abbandonare, mi pare che torni a essere
valida.» Giovanni Falcone, infatti, titolare della prima istruttoria
sull'omicidio di Piersanti Mattarella aveva sin da subito indirizzato le
indagini verso una pista nera per ciò che riguardava gli assassini materiali di
cui chiese l'arresto nel 1986. Quella istruttoria culminò in una requisitoria
depositata nel 1991 che poi non ebbe conferme giudiziarie ma che proprio
recentemente ha di nuovo fatto capolino. Mattarella ha rappresentato in terra
siciliana, per ciò che riguarda il compromesso storico fra PCI e DC, quello che
Aldo Moro (con un percorso iniziato nel 1969 attraverso una sua "strategia
dell'attenzione" verso il partito comunista italiano) è stato a livello
nazionale, con tutte le specificità e le differenze che certo li
caratterizzavano e che caratterizzavano le "due terre": la Sicilia spesso per
anni un mondo a parte, e il resto d'Italia. Una differenza che anche si
inserisce nella questione del compromesso in sé a livello nazionale. Chi si è
opposto a logiche criminali come Mattarella e Reina si era anche opposto a un
sistema di potere più complesso e ampio. Nel caso di Mattarella parliamo
-secondo quanto emerse allora e permane come sospetto per il momento oggi - di
terrorismo nero oltre all'intervento di Cosa Nostra. Per quanto riguarda il
sequestro e l'omicidio di Aldo Moro - strage degli agenti annessa-, l'evento
spartiacque per gli equilibri nazionali indicativi per Moro di un cambiamento
nel Paese al quale dare inizio, si è trattato di terrorismo rosso. Il colore
politico, è ormai giunto il momento di dichiararlo con coraggio, cambia soltanto
in funzione di dinamiche ma non di resa, di risultati. Cambiare approccio per
ricostruire i cinquantacinque giorni del Caso Moro nella inchiesta da me
condotta e culminata nel libro, "La Criminalità servente nel Caso Moro" ha
significato certo attraversare quaranta anni di storia politico-criminale e di
contesti politici nazionali e internazionali, ma non da ultimo ha inoltre
significato raccogliere i fatti che conducevano verso quel filone, esaminarli in
controluce ed esporli tutti in fila come se posti su un tavolo immaginario
(anche se in realtà fisicamente è avvenuto proprio così), certo verificandoli.
Lavorare su temi così complessi non può prescindere dall'analisi dei fatti e dei
contesti insieme. Concentrarsi soltanto su uno dei due fattori rende il quadro
intero sbilanciato nelle sue tinte. Così, la tavolozza che mano a mano ne è
emersa non lasciava scampo: i vertici della criminalità organizzata e delle
consorterie che la costituivano in quegli anni (attenzione non pedine o anche
soltanto boss qualunque seppure di rilievo) hanno influito e operato nel Caso
Moro, moltissimo. Non soltanto per ciò che riguarda le presenze di uomini della
'ndrangheta accertate o ancora da accertare sul luogo della strage, Via Fani,
dove alle 9.02 del mattino la raffica di fuoco incrociato è partita, ma anche
per quanto riguarda la gestione del sequestro fino alla consegna di Moro morto
in Via Caetani, riverso nell'abitacolo di una Renault 4 rossa, e per le
connivenze tra frange della lotta armata allineate alle BR e la criminalità
organizzata e comune. A parte, poi, va considerato l'aspetto forse più noto al
grande pubblico: il ruolo di alcune organizzazioni criminali nel tentativo di
liberazione dell'onorevole Moro. Aspetto questo che ricostruito da me
interamente dall'inizio, compiendo tabula rasa su quanto scritto e raccolto sino
a quale momento da altri, ha anche fatto emergere dettagli e aneddoti rilevanti
e nuovi per la comprensione dell'Affaire tutto. L'insieme di questa distesa di
elementi conducevano tutti in Calabria: la 'ndrangheta, cresciuta nel corso
degli anni all'ombra dei riflettori di una Cosa Nostra più 'spettacolare',
infatti, rappresenta secondo quanto da me ricostruito la costante del Caso Moro
e insieme la costante di altri eventi tragici che, come le ultime inchieste
della Procura di Reggio Calabria certificano, ha attraversato questo Paese. Una
costante operante quasi sempre con Cosa Nostra ma non necessariamente. Durante
il corso delle indagini che la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso
stava svolgendo, ho seguito dunque un mio percorso investigativo parallelo
supportato ovviamente dalla ricerca incessante e dallo studio degli atti passati
e nuovi che come già svolto per un'altra inchiesta, quella sulla morte di Pier
Paolo Pasolini, mi ha poi portato a sviscerare elementi inediti e anche alla
ricostruzione di un contesto mai considerato prima in modo unitario. Fino a
giungere agli anni della trattativa Stato-mafia così come la conosciamo, quella
il cui processo di Palermo è da poco culminato a un primo grado di condanne e ad
alcune assoluzioni (parziali o totali). Il cuore di questo libro-inchiesta è
costituito da due punti principali: da un lato la spiegazione del "mistero" del
falso comunicato del lago della Duchessa, legato alla scoperta del covo di Via
Gradoli il 18 aprile del 1978 nel bel mezzo del sequestro, e l'emersione di una
nuova prigione in cui Aldo Moro è stato di passaggio durante la sua prigionia:
un covo non lontano dal lago stesso nella Sabina fra il Lazio e l'Umbria, luogo
legato a sua volta sia a elementi della lotta armata sia alla criminalità;
dall'altro, lo sviluppo delle inchieste del generale Dalla Chiesa e il giudice
Vittorio Occorsio sulle morti dei quali pesa l'ombra sia della mafia sia del
terrorismo: entrambi, infatti, stavano indagando su una struttura riservata
composta da parti della massoneria, della criminalità organizzata, consorterie
politiche e della magistratura, e di elementi del terrorismo di destra e di
sinistra. Nel libro, tra le altre cose inedite, viene per la prima volta
pubblicato l'estratto di un verbale sconosciuto alle cronache e alle
ricostruzioni sin qui svolte, un verbale che porta proprio la firma del
Generale. Intorno a questi due punti cardinali della inchiesta vengono da me
sviluppati ulteriori fatti e risvolti a essi collegati. La "geometrica potenza"
invocata da Sciascia, espressione usata in un articolo sequestrato a Franco
Piperno leader di Potere Operaio, e operativo presso l'Università della
Calabria, si dispiega tutta qui. Attraverso un metodo giornalistico che
definisco "della piramide rovesciata" arrivo dunque al cuore del Caso Moro
cercando di consegnare un pezzo di verità mancante di questo segreto usurato
della Repubblica. Con le "prove" che un giornalista umilmente può portare. Il
libro: “La criminalità servente nel Caso Moro”, La Nave di Teseo
Il Pantheon dei capri
espiatori.
La storia politica dell’Italia repubblicana raccontata attraverso l’odio per il
singolo, scrive Francesco Damato il 17 Aprile 2018 su "Il Dubbio". L’articolo di
Angela Azzaro in difesa del Pd, e del suo ex segretario, diventato la sentina di
tutti i mali della politica e persino della società italiana dopo i risultati
elettorali del 4 marzo, mi ha fatto tornare alla mente un po’ di capri espiatori
nella storia più che settantennale ormai della Repubblica. Tutto sommato, Matteo
Renzi può sentirsi in buona compagnia, pur con tutti gli errori che ha
sicuramente compiuti, compreso quello che personalmente gli ho più volte
rimproverato di avere negato il Pantheon della sinistra riformista italiana a
Bettino Craxi. Di cui pure, volente o nolente, lui ha ripercorso alcune tappe
nell’azione di partito e di governo, persino quelle delle reazioni più scomposte
e indegne dei suoi avversari, che ne hanno sognato l’arresto, sprovvisto com’era
prima dell’elezione a senatore di Scandicci, di quel poco che è rimasto della
vecchia immunità parlamentare. O lo hanno più semplicemente scambiato per un
aspirante tiranno, come fece appunto con Craxi nel 1983 l’allora segretario del
Pci Enrico Berlinguer. Che pure Renzi è tornato anche di recente a preferire al
leader socialista nella galleria della sinistra.
Nel 1953 il ruolo del capro
espiatorio toccò addirittura al protagonista della ricostruzione post- bellica
del Paese: Alcide De Gasperi. Al quale non fu rimproverata, per quanto neppure
scattata nelle elezioni di quell’anno, una legge chiamata “truffa” perché
contemplava un premio di maggioranza in Parlamento per chi avesse raccolto il 50
per cento più uno dei voti. Roba da ridere rispetto ai premi adottati o tentati
durante la cosiddetta seconda Repubblica. Il povero De Gasperi subì l’onta della
sfiducia parlamentare ad un governo appena formato, l’ottavo della sua storia
personale, e si ritirò fra le montagne del suo Trentino per morirvi praticamente
di crepacuore. E ciò mentre il suo successore alla guida della Dc, l’allora
giovane Amintore Fanfani, si vantava di essere stato da lui stesso aiutato a
subentrargli. «Una fantasia», soleva commentare a labbra strette Giulio
Andreotti, che di De Gasperi era stato il braccio destro.
Toccò poi al medesimo Fanfani
diventare il capro espiatorio di una rivolta di partito che lo estromise
contemporaneamente da segretario, da presidente del Consiglio e da ministro
degli Esteri. Furono utilizzati contro di lui persino alcuni incidenti
ferroviari per dargli del menagramo. E appendergli in fotografia al collo un
corno, come fece in una copertina un settimanale allora in voga – Il Borghese –
fondato da Leo Longanesi.
Aldo Moro, succeduto a Fanfani
come segretario della Dc nel 1959 e poi anche come presidente del Consiglio alla
testa, nel 1963, del primo governo “organico” di centrosinistra, con tanto di
trattino, divenne nel 1968 il capro espiatorio del mancato successo elettorale
dell’unificazione socialista. Che pure lui aveva cercato di favorire, fra le
proteste della maggiore corrente della Dc, quella dei “dorotei”, sponsorizzando
nel 1964 l’elezione del suo ministro degli Esteri Giuseppe Saragat al Quirinale.
Dove peraltro qualche mese prima il democristiano Antonio Segni era stato colto
da ictus in un alterco proprio con Saragat. Fu proprio la mancanza dell’appoggio
di Saragat, nell’estate del 1968, a determinare l’allontanamento di Moro da
Palazzo Chigi. «Non lasciatemi morire con Moro», si lasciò supplicare
quell’estate Pietro Nenni, che ne era stato il vice al vertice del governo.
Estromesso dalla presidenza del Consiglio per convergenza di interessi e
risentimenti democristiani e socialisti, Moro divenne il bersaglio persino del
coltissimo ed ecumenico Giovanni Spadolini. Che da direttore del Corriere della
Sera ne contestò in un fondo domenicale il voto espresso nella competente
commissione della Camera a favore di un emendamento comunista alla riforma degli
esami di Stato, approvato per garantire la promozione dello studente in caso di
parità di giudizi. In quel voto Spadolini vide addirittura tracce o indizi
della Repubblica conciliare, anticipatrice di quello che sarebbe poi diventato
con Berlinguer il progetto del “compromesso storico”. Ricordo ancora lo
sconforto confidatomi da Moro per essere stato frainteso da un professore
universitario dimentico – mi disse l’ex presidente del Consiglio – che anche un
imputato va assolto a parità di voti. Debbo dire che poi Moro, quando gli capitò
da presidente del Consiglio, in un bicolore Dc- Pri con Ugo La Malfa, di far
nominare Spadolini ministro gli ‘ regalò’ – mi disse – il Ministero dei Beni
Culturali fornendogli con un decreto legge il portafogli di cui quel dicastero
non disponeva ancora. Dopo tre anni Moro, nel frattempo detronizzato di nuovo da
Palazzo Chigi, sarebbe stato sequestrato e ucciso dalle brigate rosse. Il capro
espiatorio anche di quella vicenda, e non solo di un presunto deterioramento dei
rapporti fra società civile e politica avvertito dal Pci nei risultati stentati
di un referendum contro la legge che disciplinava il finanziamento pubblico dei
partiti, fu Giovanni Leone. Il quale fu costretto dalla mattina alla sera a
dimettersi da presidente della Repubblica, quando mancavano solo sei mesi alla
scadenza del mandato quirinalizio.
Così il povero Leone pagò
pure, o soprattutto, la colpa di essersi messo di traverso alla linea della
fermezza adottata dal governo di fronte al sequestro del presidente della Dc. Di
cui invece il capo dello Stato aveva voluto tentare uno scambio predisponendo la
grazia per Paola Besuschio, compresa nell’elenco dei tredici detenuti che i
terroristi avevano chiesto di liberare per restituire vivo l’ostaggio.
Il turno successivo di capro
espiatorio toccò ad Arnaldo Forlani, dimessosi da presidente del Consiglio nel
1981 per le liste della loggia massonica P2 di Licio Gelli, in cui c’era anche
il nome di un prefetto che era il suo capo di Gabinetto. Poi Forlani dovette
difendersi in una causa alla Corte dei Conti per i danni subiti dai massoni, e
risarcibili dallo Stato, a causa della diffusione delle liste, per quanto
avvenuta d’intesa tra il governo e la competente autorità giudiziaria. Una
vicenda tutta italiana per confusione, caccia alle streghe e quant’altro.
Decisamente più drammatica fu,
come capro espiatorio, la sorte di Bettino Craxi, perseguito con «una durezza
senza uguali», certificata dopo anni con lettera dell’allora capo dello Stato
Giorgio Napolitano alla vedova, per il finanziamento illegale della politica, e
reati connessi. Come se Craxi non avesse ereditato ma inventato lui quel
fenomeno, per giunta coperto nel 1989 con un’amnistia che aveva consentito a un
bel po’ di politici di farla franca.
Giulio Andreotti divenne
invece negli stessi anni il capro espiatorio delle carenze nella lotta alla
mafia, per quanto il suo ultimo governo avesse trattenuto con un decreto legge
di controversa costituzionalità un bel po’ di mafiosi che avevano maturato il
diritto di uscire dal carcere. E avesse arruolato al Ministero della Giustizia,
proprio per la lotta alla mafia, un campione come il giudice Giovanni Falcone,
eliminato per questo dai criminali con la strage di Capaci. Processato, in
sovrappiù, ed assolto anche per il delitto Peccorelli, il sette volte presidente
del Consiglio, nonché senatore a vita di nomina quirinalizia avendo «illustrato
la Patria – secondo la formula dell’articolo 59 della Costituzione – per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario», si è
portata nella tomba l’onta, ancora rimproveratagli ogni volta che gli capita dal
pubblico accusatore Gian Carlo Caselli, di una prescrizione del reato di
associazione a delinquere, prima che diventasse concorso esterno in associazione
mafiosa. Da cui in ogni modo Andreotti fu assolto, per ammissione anche di
Caselli.
Passati dalla prima alla
seconda Repubblica, ci siamo dovuti accontentare, sempre nel campo politico, di
capri espiatori, diciamo così, più alla buona. Come il povero Achille Occhetto,
sostanzialmente deposto nel 1994 da Massimo D’Alema al vertice dell’ex Pci per
la sorprendente e strepitosa vittoria elettorale conseguita sulla sinistra
dall’esordiente Silvio Berlusconi. E poi lo stesso Berlusconi per le sue
abitudini di vita non da seminario, o per i suoi affari, analoghi a quelli di
tutti gli altri imprenditori della sua stazza finanziaria, o persino per le
speculazioni subite dai titoli del debito pubblico italiano nell’estate del
2011, quando irruppe sulla scena il loden austero di Mario Monti.
Il ruolo di capro espiatorio è
inoltre toccato a D’Alema per essere subentrato nel 1998 a Romano Prodi senza
passare per gli elettori con le elezioni anticipate, e per una certa spocchia
rimproveratagli a volte a ragione ma a volte anche a torto.
Il povero Fausto Bertinotti, a
dispetto delle buone maniere che tutti gli riconoscono, è stato buttato dal mio
amico Giampaolo Pansa tra le fiamme come ‘ il parolaio rosso’ per non aver
voluto a suo tempo sostenere i governi Prodi oltre le loro materiali capacità di
resistenza politica.
Walter Veltroni divenne nel
2009 il capro espiatorio di alcuni rovesci locali del Pd da lui stesso fondato
due anni prima, scampando al torto più consistente e per lui dannoso di essersi
apparentato a livello nazionale nelle elezioni del 2008 con Antonio Di Pietro,
subendone la linea. Matteo Renzi chiude, per ora, la lista per le rottamazioni
sbagliate, o per quelle incompiute. E per sopravvivere fisicamente alle sue
dimissioni da segretario del Pd dopo la sconfitta del 4 marzo. Già, perché la
sua stessa presenza fisica sembra infastidire i vecchi e nuovi avversari
politici. E’ incredibile ma vero in questo Paese che continua a chiamarsi
Italia.
Con una fuga di notizie
infilzarono Craxi.
25 anni fa la congiura che lo escluse da palazzo Chigi, scrive Francesco Damato
il 10 giugno 2017 su "Il Dubbio". Dopo la strage di Capaci e l’elezione in 48
ore di Oscar Luigi Scalfaro al Quirinale, dove per quindici votazioni avevano
inutilmente tentato di arrivare, con candidature formali o sotterranee, Arnaldo
Forlani, Giulio Andreotti e persino il presidente uscente e dimissionario
Francesco Cossiga, nulla fu più uguale sul piano politico. Terminato di comporre
il suo staff al Quirinale il 4 giugno con la nomina del generale Paolo
Scaramucci a consigliere militare, Scalfaro predispose le consultazioni per la
formazione del nuovo governo: quello di esordio della legislatura nata con le
elezioni del 5 e 6 aprile. Ma la prima sfilata delle delegazioni dei partiti
davanti al capo dello Stato terminò il 10 giugno senza altro risultato che la
constatazione di un clima politico irrespirabile, con veti e controveti
all’interno e all’esterno della maggioranza uscente composta da democristiani,
socialisti, socialdemocratici e liberali. Era una maggioranza peraltro troppo
risicata per fronteggiare una difficile situazione economica e un’ancora più
difficile situazione politica nel contesto delle indagini giudiziarie in corso a
Milano su Tangentopoli. Scalfaro non riuscì a venirne a capo neppure
moltiplicando le sue preghiere alla Madonna di Lourdes, dove peraltro si era
proposto prima della imprevista elezione a capo dello Stato di recarsi in
pellegrinaggio. Si scusò della rinuncia esortando gli organizzatori del viaggio
a pregare anche perché lui venisse illuminato. In attesa di un secondo giro di
consultazioni formali, il presidente della Repubblica vide o sentì privatamente
un’infinità di amici, fra i quali i ministri uscenti dell’Interno e della
Giustizia: il democristiano Enzo Scotti e il socialista Claudio Martelli,
invitati insieme al Quirinale formalmente per discutere di un provvedimento in
gestazione per intensificare la lotta alla mafia dopo la strage di Capaci. Ma il
discorso scivolò subito sul tema della formazione del governo. Vuoi su
sollecitazione di Scalfaro, come poi avrebbe raccontato Martelli, vuoi di
iniziativa dei due ministri, il capo dello Stato ricavò l’impressione, a torto o
a ragione, che fossero entrambi convinti di potere insieme tentare la formazione
di un governo di decantazione, scambiandosi i ruoli di presidente e vice
presidente, capace di guadagnarsi se non l’appoggio, almeno la benevola
opposizione del Pds- ex Pci guidato da Achille Occhetto. Informato, non si è mai
ben capito se dallo stesso Scalfaro, col quale aveva allora eccellenti rapporti,
tanto da averne sostenuto con la solita baldanza l’elezione prima a presidente
della Camera e poi a capo dello Stato, Marco Pannella confidò la cosa a Bettino
Craxi. Che – convinto di avere ancora buone carte da giocare per tornare a
Palazzo Chigi, da dove riteneva di essere stato allontanato malamente da Ciriaco
De Mita nel 1987, con la storia di una staffetta con Andreotti prima promessa
per l’ultimo anno della legislatura e poi negata – a sentire Pannella cadde
dalle nuvole. Ma di brutto, perché se la prese subito con Martelli, essendo
ancora convinto che Scalfaro gli fosse leale, come lo era stato al Ministero
dell’Interno nei quattro anni di governo da lui presieduto: tanto leale non solo
da avere rifiutato di prestarsi a fare il governo elettorale offertogli da De
Mita, come ho già ricordato qui, ma anche da avere cercato e trovato una decina
d’anni prima negli archivi del Viminale un documento da tutti negato in
precedenza, ma utile alla difesa dei socialisti finiti sotto processo a Milano
per gli attacchi ai pubblici ministeri che avevano indagato per l’assassinio di
Walter Tobagi. Era un’informativa dei servizi segreti che nel 1980 aveva
inutilmente segnalato il pericolo di un imminente agguato mortale delle brigate
rosse al famoso giornalista del Corriere della Sera, peraltro amico personale
del leader socialista. Notizia di quell’informativa era stata data personalmente
a Craxi all’indomani dell’uccisione del povero Walter dal generale dei
Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa. Craxi girò la confidenza di Pannella
sull’incontro di Scotti e Martelli con Scalfaro al segretario della Dc Arnaldo
Forlani, facendo cadere dalle nuvole pure lui. Ed entrambi si ripromisero di
punire, diciamo così, i due giovani aspiranti alla guida del nuovo governo o non
confermandoli ai loro posti o lasciandoli proprio fuori. Ma né l’uno né l’altro
ebbero poi la voglia di raccontare come fossero veramente andate le cose, dopo
molti anni, ai magistrati di Palermo che li interrogarono sulle presunte
trattative fra lo Stato e la mafia della stagione stragista. Essi diedero agli
inquirenti l’impressione di essere stati sacrificati perché contrari a quelle
trattative, contribuendo così all’impianto accusatorio del processo contro
mafiosi, generali e uomini politici ancora in corso a Palermo. Ma da cui è stato
già assolto, avendo scelto il rito abbreviato, l’ex ministro democristiano
Calogero Mannino, che pure era stato accusato di essere stato addirittura il
promotore della trattativa per scongiurare una minaccia della mafia alla sua
vita. Non ci fu tuttavia soltanto l’incidente o l’equivoco della coppia Scotti-
Martelli durante le consultazioni informali di Scalfaro per la formazione del
nuovo governo. Ci fu anche, fra l’altro, una rovinosa fuga di notizie sui
documenti pervenuti dalla Procura di Milano alla Camera, e assegnati subito alla
giunta delle cosiddette autorizzazioni a procedere per Tangentopoli sul conto
degli ex sindaci di Milano Paolo Pillitteri e Carlo Tognoli, entrambi
socialisti. Il “verde”, ed ex direttore del Manifesto, Mauro Paissan fu
indicato, a torto o a ragione, come fonte di quella fuga con interpretazioni
troppo estensive di alcune parti dei fascicoli, da cui avrebbe ricavato, come
esponente dell’apposita giunta di Montecitorio, l’impressione di un
coinvolgimento anche di Craxi nelle indagini chiamate Mani pulite. Ricordo
ancora nitidamente quella giornata in cui le agenzie avevano inondato le
redazioni dei giornali di lanci a dir poco allarmanti sulla posizione
giudiziaria del segretario socialista ancora in corsa per il ritorno a Palazzo
Chigi. Nelle prime ore del pomeriggio, tornando a piedi da casa alla redazione
del Giorno, di cui ero direttore, incrociai per caso in Piazza della Scala
Antonio Di Pietro, il magistrato ormai simbolo di quell’inchiesta che stava
demolendo la cosiddetta prima Repubblica. Allontanata la scorta con un cenno di
mano, “Tonino” mi disse che nelle carte partite da Milano per la Camera non
c’erano elementi contro Craxi, di cui lui parlava volgendo lo sguardo verso la
Galleria, cioè verso gli uffici milanesi del segretario del Psi. E mi
preannunciò un comunicato della Procura, che in effetti fu diffuso dopo qualche
ora per precisare che nulla risultava “allo stato” delle indagini contro Craxi.
Il quale tuttavia il giorno dopo si trovò su tutte le prime pagine dei giornali
ugualmente come uno ormai compromesso nell’inchiesta. Non ricordo se l’ho già
riferito ai lettori del Dubbio in altre circostanze riferendo del biennio
“terribile” 1992- 93, ma il clima nei giornali, ormai di tutte le tendenze, era
tale che la sera di quel giorno mi telefonò l’amico Ugo Intini, portavoce di
Craxi, per chiedermi come avessi deciso di uscire con la prima pagina del
Giorno. Alla confidenza che sarei uscito col titolo sul comunicato di smentita
diffuso dalla Procura, che ai miei occhi costituiva l’unica notizia certa della
giornata rispetto a tutte le voci col condizionale diffuse dalle agenzie, Ugo mi
chiese se poteva consigliare al comune amico Roberto Villetti, direttore
dell’Avanti, di chiamarmi. Cosa che Villetti fece subito, ma non per
consultarsi, come si aspettava il povero Intini, bensì per dissentire fermamente
dal modo garantista in cui avevo deciso di titolare. Rimasi francamente di
stucco. Neppure Scalfaro al Quirinale dovette rimanere convinto del comunicato
della Procura milanese se volle parlarne direttamente col capo Francesco Saverio
Borrelli, peraltro figlio di un suo vecchio collega ed amico. L’impressione che
ne ricavò l’uomo del Colle fu di paura di mandare a Palazzo Chigi un “amico” –
quale ancora egli considerava il suo ex presidente del Consiglio – destinato
prima o dopo ad essere davvero coinvolto nelle indagini, come avvenne a fine
anno con i primi avvisi di garanzia, e poi anche con richieste di arresto. Lo
stesso Craxi mi raccontò di essersi sentito dire da Scalfaro all’incirca così:
“Tu sai quanto ti stimi e ti voglia bene, ma è opportuno, anche nel tuo
interesse, che tu faccia un passo indietro in questo momento. Dimmi tu stesso il
nome di un socialista al quale io possa dare l’incarico”. E il 10 giugno, nel
secondo ed ultimo giro di consultazioni, Craxi maturò la decisione del doloroso
passo indietro. Che annunciò personalmente all’uscita dall’ufficio del capo
dello Stato dicendo di avergli indicato “in un ordine non solo alfabetico”
Giuliano Amato, già ministro con De Mita e suo sottosegretario a Palazzo Chigi,
Gianni De Michelis e Claudio Martelli. La delegazione della Democrazia
Cristiana, ricevuta per ultima, non ebbe così neppure la possibilità di proporre
Craxi, contro la cui destinazione si erano già espressi nel partito alcuni
esponenti, fra i quali De Mita, convinti che Palazzo Chigi spettasse ancora alla
Dc, nonostante il ritorno di un democristiano al Quirinale dopo il movimentato
settennato di Cossiga. Pertanto fu Amato l’uomo al quale Scalfaro diede
l’incarico, che fu espletato con una certa difficoltà, avendo impiegato il nuovo
presidente del Consiglio una decina di giorni, sino al 28 giugno, per la
definizione del programma e soprattutto della lista. Dove Scotti risultò
spostato dal Viminale alla Farnesina, che formalmente era una promozione, da lui
però rifiutata perché Forlani aveva deciso di sperimentare dentro la Dc la
incompatibilità fra le cariche di ministro e di deputato o senatore. Scotti
reclamò inutilmente una deroga per conservare il mandato parlamentare, che alla
fine preferì alla guida della diplomazia italiana. Martelli invece entrò nella
lista all’ultimo momento, dopo essere andato da Craxi, su suggerimento dello
stesso Amato, per chiedergli di essere confermato al Ministero della Giustizia,
come poi mi avrebbe raccontato lo stesso Craxi, per portare a termine il lavoro
svolto col povero Giovanni Falcone, suo prezioso collaboratore sino alla morte –
e che morte – come direttore degli affari penali del dicastero di via Arenula. E
Craxi acconsentì, parendogli – mi disse – “una richiesta umanamente
ragionevole”, lungi forse dall’immaginare che Martelli fosse destinato pure lui
dopo qualche mese ad essere investito da Tangentopoli e costretto alle
dimissioni. Comunque, Martelli fu l’ultimo ministro e il primo governo di Amato
l’ultimo sul quale il leader socialista riuscì a dire la sua, perché di fatto in
quel mese di giugno di 25 anni fa al falconicidio col sangue, preceduto
dall’ostracismo in vita praticatogli da tanti colleghi, seguì il craxicidio
senza sangue. I rapporti di Craxi con Scalfaro rimasero buoni ancora per poco.
Col procedere delle indagini e del linciaggio politico da cui pochi lo difesero,
neppure quando subì il famoso lancio di monetine e insulti davanti all’albergo
romano dove abitava, e donde usciva per andare ad una trasmissione televisiva
dopo essere scampato a scrutinio segreto ad alcune, le più gravi, delle
autorizzazioni a procedere chieste contro di lui dalla magistratura, il leader
socialista si fece del presidente della Repubblica l’idea da lui stesso espressa
in una serie di litografie raffiguranti falsi “extraterrestri”: finti
inconsapevoli del finanziamento generalmente illegale della politica e delle
forzature con le quali la magistratura aveva deciso di trattarlo. Oltre a
Scalfaro, furono definiti extraterrestri anche Achille Occhetto, Eugenio
Scalfari, Giorgio Napolitano e l’ormai compianto Giovanni Spadolini, la cui foto
fu sostituita con un manifesto bianco listato a lutto. Craxi stesso mi raccontò
nel suo rifugio di Hammamet di avere scritto più volte al presidente della
Repubblica, anche come presidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
contro gli eccessi che stavano compiendo i magistrati, ma di non avere mai
ricevuto una risposta, né diretta né indiretta. Il Quirinale non lo considerò
più degno di riconoscimento alcuno. Ci vollero del resto la morte di Craxi e
l’arrivo sul colle più alto di Roma di Giorgio Napolitano perché un presidente
della Repubblica parlasse di lui riconoscendone il servizio politico reso al
Paese e lamentando, fra le solite proteste dei manettari in servizio permanente
effettivo, irriducibili anche di fronte alla morte, “la severità senza uguali”
con cui era stato trattato dalla magistratura. Proprio alla magistratura,
vantando di averne fatto parte, Scalfaro nel suo discorso di insediamento,
pronunciato il 28 maggio a Montecitorio, davanti alle Camere in seduta congiunta
con la partecipazione dei delegati regionali, aveva chiesto “energia, serenità e
perseveranza” parlando della “questione morale”. Di energia e perseveranza
sicuramente i magistrati si dimostrarono capaci nei mesi e negli anni
successivi. Di serenità, francamente, un po’ meno, nella sostanziale e
incresciosa disattenzione proprio di chi l’aveva reclamata insediandosi al
vertice dello Stato sull’onda peraltro di una strage neppure citata per luogo e
per nomi nel discorso alle Camere, essendosi Scalfaro limitato a parlare di una
“criminalità aggressiva e sanguinaria”, forse aiutata anche da qualche mano
straniera. Di cui nessuno, a dire il vero, aveva avuto sentore a Capaci e
dintorni.
È Stato contro la mafia.
Chi era per
la linea dura. Il caso di Scotti e Martelli, scrive Francesco Bechis su
Formiche.net il 22 aprile 2018. Dalle rogatorie dei pm del processo
"Stato-Mafia" emerge un volto (buono) della politica che nessuno vuole
raccontare: il caso degli ex ministri Vincenzo Scotti e Claudio Martelli. La
politica esce malconcia, ma non distrutta, dalla sentenza della Corte d’Assise
di Palermo sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, in cui vertici dello
istituzioni e delle forze armate si sarebbero ritrovati a scendere a patti con
Cosa Nostra per porre fine alla stagione stragista del 1992-1993. Una sentenza
di primo grado, che dunque lascia intatta la presunzione di innocenza degli
imputati: è bene ricordarlo a chi, preso dall’euforia, ha dato per chiusa la
fase processuale apertasi nel 2013. Se è giusto sottolineare l’impatto
dirompente che la sentenza letta venerdì pomeriggio dal presidente della corte
Alfredo Montalto avrà sullo scenario politico italiano, è altrettanto doveroso
ricordare che non tutta la politica di quegli anni è finita sul banco degli
imputati. Oltre all’ex ministro Nicola Mancino, assolto dall’accusa di falsa
testimonianza perché “il fatto non sussiste”, la chiusura della prima fase del
processo lascia integra, fra le altre, la figura di due uomini di Stato
protagonisti di quella stagione politica che a più riprese sono stati sentiti
dai magistrati in questi anni: l’ex ministro dell’Interno democristiano Vincenzo
Scotti e l’ex ministro della Giustizia socialista Claudio Martelli. E in
particolare gli atti, le dichiarazioni e le vicende politiche dell’attuale
presidente della Link Campus sono state usate come supporto delle tesi
accusatorie, confermando la totale estraneità di Scotti e Martelli ai fatti al
vaglio dei pubblici ministeri. La lunga requisitoria dei pm ha fatto ampio
ricorso alla vicenda pubblica di Scotti, che fu a capo del Viminale dall’ottobre
del 1990 al giugno del 1992. Significativi a riguardo alcuni stralci tratti
dall’esposizione degli elementi accusatori da parte del pm Roberto Tartaglia il
14 dicembre del 2017 e del pm Nino Di Matteo il 15 dicembre e l’11 gennaio 2018.
Secondo l’accusa tre sono i passaggi che provano la ferrea volontà dell' “asse
Scotti-Martelli” nella lotta senza compromessi contro la mafia. Il primo
consiste nel “cambio di passo” impresso da Scotti alla politica di contrasto
alla criminalità organizzata una volta ottenuto l’incarico agli Interni. Spiega
Tartaglia il 14/12: “Cosa Nostra vede in questi tre soggetti e in questi tre
poli (Scotti, Martelli, Falcone), l’emblema, l’immagine del cambiamento
dell’azione politica […]”. Un cambio di passo che prese forma in una serie di
iniziative concrete. Decisivo, ha spiegato Tartaglia, fu il decreto legge n. 60
del 1 marzo 1991 che delegava all’ “interpretazione autentica” del governo il
calcolo della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Un intervento che
rimise in carcere 43 imputati mafiosi del maxi-processo che meno di un mese
prima erano stati liberati dopo una condanna di primo grado e che il pm nella
requisitoria definisce “un segnale devastante per le aspettative di Cosa
Nostra”. Rilevanti nella lotta alla mafia furono due riforme giudiziarie
introdotte dall’allora guardasigilli: la regola della turnazione nei ricorsi di
mafia in deroga del principio di competenza per materia, e infine
l’introduzione, il 15 gennaio del 1993, del 41-bis, il regime carcerario duro
per i mafiosi la cui paternità ancora oggi Martelli rivendica con orgoglio. Poi
il secondo passaggio della requisitoria che sottolinea la linea di fermezza del
ministro Scotti con il crimine organizzato: si tratta delle sue prese di
posizione pubbliche durante il mandato, dove non mancò mai di mettere al
corrente l’opinione pubblica e gli organi dello Stato di un piano “sovversivo”
di Cosa Nostra. Riecheggiano ancora oggi le dure parole del titolare del
Viminale, a pochi giorni dall’omicidio di Salvo Lima, in un’audizione
parlamentare del 17 marzo 1992: “Oggi, dopo questo omicidio, siamo in presenza
di un fenomeno che non mira a distruggere le istituzioni ma a piegarne gli
apparati ai propri fini, a condizionarli”. Preoccupazioni ribadite il 20 marzo
successivo davanti alla commissione Affari Costituzionali del Senato:
“Nascondere ai cittadini che siamo di fronte ad un tentativo di
destabilizzazione delle istituzioni da parte della criminalità organizzata è un
errore gravissimo. Io ritengo che ai cittadini vada detta la verità e non
edulcorata, la verità: io me ne assumo tutta la responsabilità”. L’allora
premier Giulio Andreotti definì “una patacca” l’allarmismo del suo ministro,
scatenando involontariamente un polverone mediatico che non fu privo di
strumentalizzazioni. A dare ulteriore conferma della rettitudine dell’operato di
Scotti e Martelli, secondo i pm del processo sulla “trattativa”, ci sarebbe
infine la tesi del “golpe bianco”. Nella requisitoria dello scorso 11 gennaio il
pm Nino Di Matteo sostiene che la “prima condizione essenziale nel 1992 per
portare avanti la linea del dialogo con la mafia era quella di cacciare Scotti
dalla titolarità del Viminale”. L’avvicendamento del ministro dell’Interno con
Nicola Mancino nel giugno 1992, che portò Scotti alla guida della Farnesina (su
indicazione del presidente della Dc Ciriaco De Mita) mentre Giuliano
Amato entrava a Palazzo Chigi, fu letto da molti come un promoveatur ut
amoveatur. Anche l’uscita di Martelli dal Ministero della Giustizia nel febbraio
del 1993 attirò gli stessi sospetti. Di Matteo è sicuro che non si è trattato di
due semplici avvicendamenti: il pm palermitano l’11 gennaio ha affermato che è
stata messa in atto piuttosto una strategia per “liberarsi di chi della
contrapposta linea del rigore e delle intransigenza aveva fatto la sua bandiera
e lo aveva dimostrato con i fatti”. Chiamato a parlare davanti alla Corte
d’Assise di Palermo, Martelli in questi anni ha confermato la tesi della
“rimozione forzata” del 1993, dovuta soprattutto, a suo parere, all’introduzione
del 41-bis. Scotti invece ha preferito una linea di maggior riserbo, pur avendo
manifestato davanti ai giudici le sue perplessità su quel cambio di vertice al
Viminale.
«Il teorema è stato
smontato, chiedo scusa per il silenzio.
A 86 anni posso dare consigli ma avrei bisogno di orecchie pronte ad ascoltare»:
Nicola Mancino riabbraccia Avellino, scrive Luigi Salvati il 24 aprile 2018 su
"Orticalab.it". «Il teorema è stato smontato, chiedo scusa per il silenzio. A 86
anni posso dare consigli ma avrei bisogno di orecchie pronte ad ascoltare»:
Nicola Mancino riabbraccia Avellino. L’ex Ministro degli Interni parla dopo la
sentenza sulla trattativa Stato-mafia che lo ha visto scagionato dall’accusa di
falsa testimonianza: «Diventare all’improvviso protagonista delle cronache
giudiziarie è stato un colpo duro inferto nei confronti ma io ho sempre
rispettato lo Stato e ho sempre ritenuto che lo Stato non può scendere a
trattative con la mafia, la camorra o la malavita organizzata. Mi sono piegato
nel silenzio provando sempre ad onorare le mie origini. Se vi ho fatto nascere
il sospetto che io potessi non essere un uomo della legge, vi chiedo scusa». Su
una possibile candidatura per la Città: «Avellino ha bisogno di una classe
dirigente nuova che si innamori del ruolo». «Questa sentenza recita che il fatto
non sussiste. Il “fatto” ha un’origine che è l’inchiesta e un “non sussiste” che
è la sentenza. Ma se non sussiste vuol dire che non sussiste nelle radici. Per
quel che mi riguarda ho sempre rispettato lo Stato e ho sempre ritenuto che lo
Stato non può scendere a trattative con la mafia, la camorra o la malavita
organizzata. Mi sono difeso a fronte di un pregiudizio e ho giurato di aver
onorato l’Italia. Finalmente il teorema è venuto meno»: emozionato ma non
commosso, l’ex Ministro dell’Interno Nicola Mancino parla dopo la sentenza sulla
trattativa Stato-mafia che lo ha visto scagionato dall’accusa di falsa
testimonianza. Ad attendere, al Circolo della stampa, ci sono tanti amici di
vecchia data, tante persone che hanno condiviso con lui un lungo percorso
politico e tanti esponenti della società civile. Tutti presenti e in religioso
silenzio ad ascoltare il monologo dell’ex Vicepresidente del Consiglio superiore
della magistratura che si arriva a piedi, sereno in volto, sorridente come non
lo si vedeva da troppo tempo. «Non è facile parlare sia pure dopo una sentenza
favorevole che ha mobilitato dirigenti, amici, responsabili della politica,
persone appartenenti al mondo della cultura e dell’università - ha esordito
Mancino - ma dovevo e devo delle spiegazioni oltre a dover ricordare alcuni
passaggi di una storia che mi ha messo in un angolo. Dal 2008 si è sviluppato un
teorema nei miei confronti forse perché avevo accettato di diventare Ministro
dell’Interno, carica importante ma che io non avevo richiesto. Sono stato al
centro di una spiacevole vicenda e la ragione di questa conferenza è anche
quella di chiedere scusa alla comunità. Diventare all’improvviso protagonista
delle cronache giudiziarie è stato un colpo duro inferto nei confronti di una
persona che ha risposto ad indirizzi di carattere politico e all’assunzione di
responsabilità». In piena tangentopoli, Mancino spiega che non si sarebbe mai
sognato di fare pressioni per ottenere la carica occupata in precedenza da
Vincenzo Scotti poi diventato Ministro degli esteri e di aver accettato per
«determinazione e senso dello Stato, quello per cui mi sono adoperato per
combattere una presenza malavitosa tanto in Sicilia quanto in tutto il
territorio italiano. Mi insediai pochi mesi dopo la strage di Capaci che vide la
morte del giudice Falcone e pochi giorni prima della strage di Via D’Amelio che
vide la morte del giudice Borsellino che io, come ho detto in tribunale, non
conoscevo personalmente, ma non ho mai escluso di avergli potuto stringere la
mano. Sono stato protagonista involontario di tanti libri che parlavano di una
mia reticenza nel voler ammettere di essere amico del giudice Borsellino
nonostante a conferma della mia tesi ci sia anche una sentenza che avrebbe
potuto tranquillamente chiudere il caso». E invece no, il teorema nato per
contestare la legittimità della sua nomina a ministro dell’Interno è andato
avanti. «Doveva avere il suo percorso - ha continuato Mancino - ma io ho sempre
protestato contro il teorema, rimasto tale anche dopo la richiesta di rinvio a
giudizio. Difendere il mio onore tuttavia era un diritto-dovere nei confronti
della gente che mi aveva votato perché credeva che la potessi rappresentare. Non
ho mai saputo nulla della trattativa e l’ho affermato sotto giuramento anche di
fronte alla corte che mi ha giudicato. Tra un po’ ricorre il 40esimo
anniversario della morte di Aldo Moro di cui ero molto amico e ricordo che fui
uno di quelli a dire che con le brigate rosse non ci poteva essere alcuna forma
di trattativa, figuriamoci se io potevo accettare che si trattasse con la
criminalità organizzata». Sono tanti i bocconi amari che l’ex Ministro ha dovuto
digerire: «i cinque anni di dibattimento, oltre a tutto quello che c’è stato
prima, l’essere mischiato a personaggi malavitosi come Totò Riina o Bernardo
Provenzano. Tra le altre cose Riina ebbe anche a dire che io ero un “nemico
della mafia” ma non fu creduto. Io so solo di aver fatto sempre il mio dovere,
di aver onorato il ruolo e di aver sempre considerato la norma un obbligo di
accettazione da parte dei cittadini». L’unico passaggio in cui Mancino ha avuto
un momento di titubanza è quando ha ammesso di avere paura di lasciare la vita
terrena prima che venisse emessa la sentenza: «E’ morto Scalfaro, è morto
Ciampi, sono morti altri. Pensavo che non avessero il coraggio di andare a
sentenza. E invece c’è stata. Per mio carattere mi sono messo in un angolo con
una preoccupazione: in caso di sentenza non favorevole cosa avrebbero pensato di
me le persone che mi conoscono. Mi sono piegato nel silenzio provando sempre ad
onorare le mie origini. Se vi ho fatto nascere il sospetto che io potessi non
essere un uomo della legge, vi chiedo scusa. Ma io ho rispettato lo Stato perché
lo Stato non può scendere a trattative. Deve essere limpido perbene. La sentenza
è stata letta con grande senso di equilibrio. Non mi sono rallegrato ma mi sono
compiaciuto. C’è un giudice anche a Palermo e vorrei che questo giudice fosse
presente in tutta Italia. Abbiamo bisogno di giustizia». Prima degli abbracci e
delle strette di mano, c’è stato il tempo per rivolgere una domanda all’ex
ministro sul futuro della città. «Ottantasei anni sono ottantasei anni - ha
concluso - posso dare suggerimenti ma Avellino ha bisogno di una classe
dirigente nuova che si innamori del ruolo. Ci sono troppi improvvisatori. Dai
consiglieri comunali, ai regionali, ai parlamentari sono troppi quelli che
ritengono di essere leader. Mi chiedo, che fine hanno fatto i circoli? La classe
dirigente deve avere il coraggio di ascoltare, di dialogare. A mancare non è il
politico in sé ma la politica e il politico preparato. Non mi avventuro in
esperienze che non posso affrontare. Ringrazio la fortuna e Dio per essere
ancora qui e guardo avanti».
Piperno: «Si poteva salvare
Moro. Gotor? Scrive balle»,
scrive Paolo Persichetti il 26 Aprile 2018 su "Il Dubbio". Intervista a Franco
Piperno, professore di fisica e fondatore di Potere Operaio. Il sequestro Moro
poteva concludersi senza la morte dell’ostaggio? Franco Piperno ribadisce che
era possibile. Tutto ruota attorno ai giorni concitati d’inizio maggio ‘ 78,
dopo la telefonata di Mario Moretti (leader delle Br) del 30 aprile alla
famiglia dello statista democristiano e il comunicato Br nel quale figurava quel
gerundio – «eseguendo la sentenza» – che di fatto rimandava l’esecuzione.
L’iniziativa socialista aveva aperto un canale di comunicazione ed ai brigatisti
era stato detto che il 7 maggio Fanfani avrebbe fatto un’importante
dichiarazione di apertura. Perché tacque? Il suo silenzio fu la conseguenza di
una interferenza del Pci, che, forte dei suoi voti indispensabili per l’elezione
del nuovo Presidente della Repubblica, aveva validi argomenti per condizionare
le decisioni del Presidente del Senato, uno dei pretendenti più quotati? Durante
le trattative per la formazione del nuovo governo, Fanfani aveva cercato di
scavalcare a sinistra Moro proponendo un governo d’emergenza con la
partecipazione diretta dei comunisti. Ne scrive sui suoi Diari un infastidito
Andreotti e lo testimonia l’ambasciatore Usa Gardner, allarmatissimo ma poi
rassicurato dall’opzione ben più moderata di Moro che tenne fuori dal governo i
tre ministri tecnici indicati dal Pci, rompendo gli accordi presi da Zaccagnini,
pronto a dimettersi, e dallo stesso Andreotti. Franco Piperno giocò un ruolo
chiave attorno a quell’abbozzo di trattativa che però non riuscì a conseguire il
suo scopo. Una lacerazione della «linea della fermezza» che ancora oggi disturba
la storiografia ispirata a quelle posizioni e che a distanza di quarant’anni non
rinuncia a lanciare i propri strali dietrologici, calunniando i protagonisti di
quella complicata vicenda. Sul Fatto Quotidiano del 6 e del 20 aprile Miguel
Gotor ha tirato in ballo nella intricata vicenda di via Gradoli la
responsabilità di Franco Piperno, figura di spicco del ’ 68, tra i fondatori di
Potere operaio, coinvolto nei processi 7 aprile e Metropoli. Secondo l’ex
parlamentare, già membro della Commissione Moro, dietro la messa in scena della
seduta spiritica che si tenne il 2 aprile 1978 a Zappolino, piccola frazione
distante una trentina di chilometri da Bologna, nella casa di campagna del
professor Clò, presenti Romano Prodi ed altri docenti universitari, che negli
anni successivi saranno destinati ad incarichi di governo, ci sarebbe stata la
“soffiata” di «un esponente di prestigio dell’area dell’eversione». Piperno
avrebbe fornito il suggerimento al futuro ministro del Tesoro, Beniamino
Andreatta, secondo alcune voci mai confermate presente anch’egli alla seduta
spiritica, approfittando del fatto che fosse fondatore e rettore dell’Unical,
l’università della Calabria, dove Piperno stesso era docente di fisica. In via
Gradoli, situata nella zona Nord di Roma, il 18 aprile 1978 i Vigili del fuoco,
chiamati per una perdita d’acqua, scoprirono una importante base delle Brigate
rosse, affittata nel dicembre 1975 all’ingegner Borghi, alias Mario Moretti. La
preziosa informazione – lascia intendere Gotor – sarebbe pervenuta all’ex
esponente di Potop dalla proprietaria dell’appartamento di via Gradoli: i due si
sarebbero conosciuti alla fine degli anni ‘ 60 per via della comune
frequentazione del Cnen, il centro di ricerca nucleare di Frascati. Gotor,
sostenitore della tesi che il danno d’acqua non fosse casuale, solleva ulteriori
sospetti, ipotizzando che «un brigatista dissidente, un esponente dell’area
dell’autonomia collaborativo con lo Stato o un agente dell’antiterrorismo» possa
essere entrato nell’appartamento la mattina del 18 aprile, dopo l’uscita di
Balzerani e Moretti che quella sera non sarebbe dovuto rientrare, con
l’obiettivo di provare a recuperare gli scritti di Moro, sperando fossero
nell’appartamento e poi provocare il danno d’acqua che fece cadere la base.
Tuttavia nel corso della fantomatica seduta spiritica emerse un’indicazione
molto diversa dalla strada dove qualche settimana dopo venne rinvenuta la base
brigatista. Nell’appunto manoscritto, subito girato al capo della polizia
Parlato, redatto da Luigi Zanda, collaboratore del ministro dell’Interno
Cossiga, che il 5 aprile ricevette la segnalazione da Umberto Cavina, addetto
stampa di Benigno Zaccagnini, a suo volta informato il giorno precedente da
Romano Prodi di passaggio a Roma, è annotato: « Caro dottore, ecco le
indicazioni di cui s’è detto: Via Monreale 28, scala D, int. 1, piano terreno,
Milano; lungo la statale 74, nel piccolo tratto in provincia di Viterbo, in
località Gradoli, casa isolata con cantina». Per giustificare questa
incongruenza, Gotor inventa la categoria del “depistaggio a fini informativi”,
attribuendo a Piperno una sofisticata strategia che mescolando vero e falso
avrebbe mirato a « provocare il fallimento dell’azione Moro senza far arrestare
Moretti, che era un avversario politico con una diversa prospettiva
rivoluzionaria, non un nemico da tradire », per facilitare la riuscita della
soluzione negoziata del sequestro nei giorni in cui il vertice socialista si era
attivato in questa direzione.
Abbiamo chiesto a Franco
Piperno come ci si sente ad essere raffigurato nei panni di una sorta di
Cagliostro, burattinaio che tira le fila di un gioco spregiudicato.
«Penso
che sia la personalità irrisolta di Gotor ad assegnarmi un ruolo del genere; non
a caso dagli scrittori di libri polizieschi il Nostro viene ritenuto uno storico
mentre secondo gli storici siamo in presenza di un romanziere. In ogni caso, ad
essere sincero, non posso certo dire che sia il prof. Gotor ad avermi calunniato
di più. Ben prima dei suoi articoli sul Fatto Quotidiano, sul finire degli anni
‘ 70 mi hanno fatto decisamente di peggio, sono stato accusato, dalla Procura di
Padova e poi da quella di Roma, oltre che del delitto Moro, di ben 20 omicidi e
15 rapine; e, per non farmi mancare niente, ci si mise anche la giornalista
americana Clara Sterling: in un suo libro sull’Italia di quegli anni scrisse che
la Cia aveva accertato come io fossi un agente segreto comunista, educato alla
guerriglia a Praga, frequentando i corsi tenuti nella capitale cecoslovacca
direttamente dal Kgb».
Una spia dell’Est? Proprio
tu che conoscevi i dirigenti del Kor, il Comitato di difesa degli operai
polacchi?
«Già,
li incontrai tutti insieme nel dicembre del 1978: Jacek Kuron, Adam Michnik e
gli altri. Non a caso ci fu poi chi per compensare provò a dire che lavoravo per
la Cia perché ero riparato in Canada».
Ma non ti era stato
rifiutato l’ingresso quando su invito del Mit di Cambridge ti eri recato negli
Usa?
«Fu
quella la ragione per cui poi mi ritrovai nel Quebec, in Canada, tra i
pellerossa».
Quindi smentisci di aver
mai parlato con Andreatta?
«Faccio
molta fatica a prendere sul serio ricostruzioni del genere. Sono arrivato
all’università di Cosenza solo all’inizio del 1975, In precedenza ero docente al
Politecnico di Milano. All’epoca il rettore dell’Unical era Cesare Roda,
Andreatta aveva l’asciato l’università calabrese l’anno precedente; e nel 1976
venne eletto per la prima volta in Parlamento. Non ho mai avuto occasione di
conoscerlo. Mi par di capire che Gotor non si sia per nulla informato prima di
scrivere».
E via Gradoli? Una vecchia
nota di Ansoino Andreassi, funzionario dell’Ucigos, del 6 luglio 1979 riferiva,
non sulla base di documenti amministrativi accertati ma di voci provenienti da
fonti riservate, originate dal Sismi e dalla questura di Genova, che avresti
conosciuto fin dal 1969, al Cnen della Casaccia, Luciana Bozzi, proprietaria
dell’appartamento di via Gradoli. Per tenere in piedi le sue congetture, in
barba all’Ucigos, Gotor sposta addirittura la Bozzi a Frascati mentre
l’informativa della polizia la colloca alla Casaccia, oltretutto il contratto fu
stipulato da Moretti col marito della Bozzi, anch’egli coproprietario.
«Infatti,
ho fatto la mia tesi e poi la specializzazione in fisica della fusione nucleare
al Cnen di Frascati, non ho mai frequentato la Casaccia e il nome di Luciana
Bozzi non mi dice assolutamente nulla».
La seconda commissione
Moro, presieduta da Giuseppe Fioroni, allude ad un tuo ruolo di supervisore del
sequestro. Un suo consulente, il colonnello dei carabinieri Massimo Giraudo,
afferma che la mattina del 16 marzo dalle finestre dell’abitazione della signora
Birgit Kraatz, descritta come un’esponente del gruppo sovversivo tedesco «2
giugno», in via dei Massimi 91, avresti osservato i movimenti del commando
brigatista verificando che tutto procedesse come previsto: il parcheggio delle
vetture nel garage della palazzina dello Ior e il trasbordo di Moro nell’attico.
Siamo al delirio?
«Anche
oltre! Birgit Kraatz era una giornalista assolutamente ben introdotta nei
circoli della stampa e del mondo politico romano. L’ho conosciuta nei primi anni
‘ 70 in occasione di una intervista sul movimento studentesco romano rilasciata
per Der Spiegel, il giornale di cui in quegli anni era corrispondente. Niente
più lontano dalla intelligenza e dalla sensibilità della signora Kraatz il ruolo
di sorvegliante delle prestazioni dei brigatisti. In effetti aver tirato in
ballo il nome della signora Kraatz appare l’ennesimo incredibile infortunio di
questa commissione. Non solo è iscritta alla Spd dal ‘ 74, e di fatto ha curato
i rapporti della socialdemocrazia tedesca con la sinistra italiana, in modo
particolare col Pci, intervistando nel 1976 lo stesso Berlinguer (è citata
persino nella biografia scritta da Chiara Valentini), ma è stata corrispondente
per più di trent’anni oltre che di Der Spiegel, dello Stern e ZDF, ha scritto un
libro intervista con Willy Brandt, pubblicato da Editori riuniti».
C’è un episodio molto
importante che smentisce alla radice quanto afferma Gotor: poche settimane dopo
la morte di Moro hai incontrato Mario Moretti. Perché?
«La
richiesta era venuta dalle Br; l’incontro, come ho riferito alla Commissione
presieduta dall’on. Pellegrino, si svolse in un appartamento del quartiere Prati».
In commissione Stragi ad
una precisa domanda dicesti che ad aprire la porta era stato un maggiordomo.
L’episodio suggestionò molto la fantasia dei commissari: il Presidente
Pellegrino vi intravide la presenza di «inquietanti zone di contiguità» che
negli anni successivi hanno alimentato la pubblicistica cospirazionista.
«Il
maggiordomo con i guanti era un modo metaforico per sottolineare la qualità
alto- borghese dell’appartamento».
Insomma li hai presi in
giro e loro ci hanno creduto. Cosa volevano sapere le Br?
«Moretti
ed i suoi avevano chiesto d’incontrarmi con urgenza per ricostruire l’insuccesso
della trattativa ma anche per chiarire se ci fosse stata una nostra influenza
esterna sui loro militanti provenienti da Potop. Volevano capire se la vicenda
della trattativa fosse stata una nostra costruzione per orientare il sequestro.
Nonostante queste premesse la discussione si concentrò subito sul silenzio di
Fanfani. Volevano capire perché il presidente del Senato non parlò il 7 maggio
smentendo l’impegno preso. Lì mi resi conto di quanto le Brigate rosse avessero
preso sul serio quei segnali di apertura e capii che il sequestro avrebbe potuto
avere un esito diverso se solo ci fosse stata quella dichiarazione annunciata».
Come sei finito in questa
storia?
«In
realtà all’inizio furono Scialoia e Mieli a contattarmi per conto di Livio
Zanetti, che conoscevo perché l’Espresso da lui diretto aveva seguito tutto il ‘
68. Zanetti mi fece capire che c’era una forte insistenza dei socialisti per
aprire una trattativa. Fu lui a mettermi in contatto con Signorile, vice
segretario del Psi che si muoveva per conto di Craxi. Il segretario non voleva
esporsi direttamente, lo incontrai personalmente solo alcune settimane dopo la
morte di Moro. Inizialmente ero restio a farmi coinvolgere malgrado fossi
assolutamente consapevole che l’eventuale uccisione di Moro avrebbe provocato
una repressione tragicamente liberticida per tutti i movimenti antagonisti di
quegli anni. Per altro, il mio trasferimento in Calabria mi aveva allontanato
dalla militanza politica; oltre ad insegnare, dirigevo un dipartimento
universitario sicché mi restava poco o nessun tempo per l’attività politica
extra- accademica. Poi, a metà aprile accadde qualcosa destinata a mutare non
solo il mio umore ma la mia vita stessa: Fiora Pirri Ardizzone, allora mia
moglie, venne arrestata ed accusata di aver partecipato al rapimento di Moro in
via Fani ed all’uccisione degli uomini della scorta. Un testimone aveva
scambiato il suo volto con quello di una donna del commando, quando in realtà
quella mattina Fiora partecipava ad una assemblea universitaria a Cosenza. Di
conseguenza riorganizzai da cima a fondo la mia agenda, rimandai l’impegno di
“visiting professor” assunto con il Mit di Boston e mi lasciai afferrare dal
dramma che, per altro, l’intero nostro Paese stava vivendo. Cosi, una settimana
dopo quell’arresto, mi recai a Roma per incontrare Zanetti e poi Signorile. A
maggio il direttore dell’Espresso mi chiese un articolo sulla trattativa che
ebbe un destino singolare: apparso il giorno del ritrovamento del cadavere di
Moro in via Caetani, dopo 5 ore fu ritirato dalle edicole e inviato al macero.
Nel dicembre del 1978 ripresi e sviluppai quel testo che uscì su Pre-print col
titolo «Dal terrorismo alla guerriglia»».
Quello che riprendeva il
verso di Yeats, «coniugare insieme la terribile bellezza del 12 marzo del ‘ 77
per le strade di Roma con la geometrica potenza dispiegata in via Fani»?
«Sì,
nel testo ragionavo cercando di spiegare perché era meglio liberare Moro. Al
tempo stesso tentavo di aprire un discorso sulla lotta armata legandola al
carattere insurrezionale della manifestazione del 12 marzo. Quel giorno ero di
passaggio in città perché dovevo raggiungere la fiera di Lipsia, allora nella
Ddr, dove avevo un appuntamento con degli armeni per acquistare un computer
necessario al Dipartimento di Fisica che allora dirigevo. Per inciso la
“macchina socialistica” costava all’epoca un decimo della sua analoga
“capitalistica”, ma occupava uno spazio venti volte maggiore – insomma fu un
viaggio inutile, salvo il fatto che per caso mi offrì l’occasione, nel
pomeriggio di quel fatale giorno di marzo, di partecipare ad un vero e proprio
tentativo insurrezionale. Nel centro storico di Roma, tutti i negozi e perfino i
bar erano chiusi: per le strade ed i vicoli si svolgevano durissimi scontri tra
manifestanti e gendarmi, scontri nei quali gli abitanti, per esempio quelli di
Campo de Fiori, fraternizzavamo attivamente con i dimostranti. Ricordo un
fruttivendolo che aveva riaperto il suo negozio per dare rifugio ai feriti; così
come un’armeria su Lungotevere presa d’assalto e saccheggiata dalla folla in
tumulto. Prima di quel pomeriggio di marzo, nei miei non brevi anni di
militanza, non avevo mai partecipato o anche solo assistito ad una esperienza di
ribellione sociale, per dir così, allo stato nascente. Da qui l’immagine sulla
«terribile bellezza» che riprendeva gli scontri della Pasqua irlandese del 1916».
Secondo te perché Fanfani
non parlò?
«Ritengo
che ci fu un intervento molto forte del Pci, una pressione che fece venir meno
l’impegno preso. Io penso che Fanfani avesse informato il Pci del suo intento.
Non poteva fare diversamente anche per il ruolo istituzionale che rivestiva.
Signorile non aveva parlato solo con Craxi ma anche con altri politici. Di
sicuro ne era al corrente il Presidente della Repubblica Leone, il suo addetto
militare, ovviamente i vertici socialisti e del partito democristiano. Lo
sapevano in troppi perché la cosa non fosse circolata e pervenuta al Pci».
In effetti il 2 di maggio
Berlinguer aveva visto Craxi e Balzamo. Durante l’incontro i socialisti
spiegarono che un modo possibile per salvare la vita di Moro sarebbe stato, per
esempio, la scarcerazione anche di un solo detenuto politico con problemi di
salute ed in regime di carcerazione preventiva. Berlinguer era radicalmente
contrario a qualsiasi concessione favorevole ai brigatisti; piuttosto si
mostrava, come un commissario della polizia politica, interessato ad avere
informazioni sui canali di cui si avvalevano i socialisti e che li rendevano
sicuri di una possibile liberazione dell’ostaggio. In ogni caso, bisogna pur
dire che il tentativo dei socialisti, nel quale fosti coinvolto e travolto, non
riuscì e vinse il partito della «fermezza repubblicana», quello che aveva
rimosso ogni autocritica e si mostrava disposto a sacrificare la vita di Moro.
In un primo momento Fanfani si era mostrato disponibile ad intervenire
pubblicamente: Signorile lo aveva incontrato per la sua posizione critica
rispetto alla linea della fermezza ed aveva ricevuto rassicurazioni. Alle Br
giunse questa informazione: «Fanfani ha una disponibilità ad ascoltare le
richieste delle Br purché queste non comportino inaccettabili violazioni della
legalità». Ad esempio: alleggerire le condizioni carcerarie, al limite della
tortura, alle quali erano sottoposti migliaia di detenuti politici. La domenica
invece parlò Bartolomei, credo ad Arezzo, dove pronunciò un bla bla
incomprensibile e inaccettabile a livello di senso comune. Noi che eravamo della
partita riuscimmo a percepire nelle sfumature di una frase, un esile messaggio.
Ma non era questo il segnale atteso. Per i brigatisti che si aspettavano una
dichiarazione chiara e netta quel discorso suonò come un rifiuto. Signorile ha
raccontato che davanti a lui Fanfani aveva dato istruzioni telefoniche a
Bartolomei su cosa dire mentre si era riservato di prendere la parola nella
riunione di Direzione prevista il 9 maggio. Ma alla fine non disse nulla neanche
in quella sede, basta leggere i suoi diari. La notizia del ritrovamento del
corpo di Moro in via Caetani arrivò dopo il suo intervento.
«Risulta
anche a me. Credo che questo repentino cambio di atteggiamento riassuma il nodo
politico della vicenda: Fanfani fece un passo indietro su pressione del Pci».
LE STORIE DEI 5 UOMINI
UCCISI DALLE BRIGATE ROSSE.
La Peugeot 403 «famigliare»
di Aldo Moro ritrovata a Roma.
Pubblicato venerdì, 3 maggio 2019 da Giosuè Boetto Cohen su Corriere.it.
Improvvisamente l’annuncio: un medico pugliese, Attilio Cesarano, ha scoperto in
un capannone a Roma una vecchia Peugeot giardinetta. E’ di un bel blu mare, ha
le targhe e i documenti originali. E’ intestata ad Aldo Moro e alla moglie
Eleonora. Dall’archivio della Associated Press sbuca anche una «telefoto» che li
ritrae a bordo: è il 20 aprile 1970, giorno delle nozze d’argento. Al volante
c’è la signora. Così inizia la seconda vita della Peugeot 403 «familiale»
acquistata il 23 gennaio 1960 - come recita il libretto di circolazione - dall’
«Onorevole Moro, residente a Bari in corso Vittorio Emanuele 20 barra A». Non è
la Fiat 130 blu tallonata da una Alfetta, crivellate di colpi e trasformate in
una icona del Ventesimo secolo. E nemmeno quella Renault 4 rossa, con il
bagagliaio tragicamente aperto. Questa è un’auto privatissima, a otto posti, per
portare a spasso una famiglia di sei persone e – magari – una governante. Quando
andò in concessionaria per prenotarla Moro era deputato, segretario della DC, da
poco ex ministro della Pubblica Istruzione e quasi pronto per diventare
presidente del Consiglio. Decise per una delle rare 403 importate in Italia,
così semplice e fuori moda da non dare proprio nell’occhio. Per questo era stata
scelta. Marito e moglie d’accordo, ci si potrebbe scommettere. La memoria corre
alla amata «Noretta» delle lettere dalla prigione. La donna minuta, austera, che
sembrava sola contro tutti. Quella che riusciva a dire «mi scusi» se, al
telefono, parlava sopra la voce al brigatista. La stessa che chiuse, senza
appello, i funerali agli uomini dello Stato. E forse anche al Papa. E’ proprio
lei, Eleonora, la vera padrona dell’auto. Moro praticamente non guidava. Lo
ricordano in tanti e lo dice quella foto, bellissima, che racchiude lo spirito
della 403. Alla guida una donna tranquilla, sorridente. E il trasportato che
ammicca dall’altro sedile, con l’aria mite, un po’ altrove, con cui l’uomo della
strada lo ricordava. La 403 blu visse molte primavere, con le sue tre file di
sedili piene di giovani Moro e di amici, cugini, chissà. Viaggiò tra Roma e le
Puglie nelle vacanze. Ma era anche la macchina per andare a fare la spesa al
quartiere Prati. Poi venne la notte immane. Chissà se Noretta aveva ancora la
forza di guidare, dopo quel 1978? Forse il volante passò alle figlie minori, che
ancora vivevano in casa. O all’unico maschio, Giovanni, patentato da poco, ma
che facilmente ambiva a qualcosa di diverso. Così la 403 cominciò a dormire
sonni sempre più lunghi, posteggiata in un capannone a Monteverde, non troppo
lontano da casa. Settimane di oblio che divennero mesi, quando da casa si
allontanò lei, perché nessuno dei Moro abitava più là. Nel capannone si
caricavano sacchi di calce e cemento, e la polvere cadde sull’azzurro mare delle
fiancate, rese ciechi i vetri, spense le cromature. I nidi di rondine sulle
capriate non aiutarono, mamma topo fece il nido dietro il cruscotto, i suoi
piccoli impararono a rosicchiare sui pomelli del cruscotto. Il capomastro ogni
tanto le dava una pulita, gonfiava le gomme, provava a far girare il motore.
Quasi come se la signora Moro dovesse tornare l’indomani a riprendersela. Ma
nessuno venne. I Moro si erano dimenticati della loro 403. Così un giorno, dopo
l’ennesimo colpo di straccio su un sporco che sembrava indomabile, il custode
decise che era ora di smetterla. Che andassero tutti alla malora. Chiuse
bofonchiando il portone abbandonò l’auto al suo destino. Dopo una decina d’anni
il deposito fu venduto e il nuovo proprietario vi trovò dentro quel mucchio di
polvere con le ruote. Nessuno, mai, era venuto a cercarla, perché da qualche
parte, lontano, in silenzio, la forte Noretta si era spenta anche
lei. All’inizio del 2018 il magazzino cambiò di nuovo proprietario. E prima di
traslocare, il vecchio parlò col suo medico di fiducia, Attilio Cesarano,
procidano d’origine, pugliese di adozione, conterraneo di Moro. «Perché non la
prende lei, dotto’? Mandarla alla monnezza, sarebbe un peccato».
Dai delitti delle Br alle
trame della P2: la storia italiana negli archivi del tribunale di Milano.
Nell'ufficio corpi di reato sono custoditi i volantini delle Br, i nastri con le
telefonate minatorie a Giorgio Ambrosoli, la bici del terrorista Alunni e
tantissimi documenti legati alle inchieste sugli anni di Piombo. Massimo Pisa il
07 luglio 2019 su La Repubblica. Il pacco 51186 è alto e largo come una risma di
carta. E quella contiene, grosso modo. Volantini, appena più di un migliaio:
"nr. 320 rinvenuti in data 25.4.78 alle ore 7,00 in piazza S.Babila; nr. 188 in
Piazza Beccaria...". Così usava allora, con le rivendicazioni degli omicidi
delle Brigate Rosse lasciate a mazzi in vari punti della città. Per dimostrare,
anche in questo modo, che loro - i brigatisti - la città la controllavano e si
muovevano come volevano. In quel mattino di martedì, con Milano e l'Italia
appese da quaranta giorni alle sorti di Aldo Moro, l'omicidio del maresciallo
Francesco Di Cataldo della Penitenziaria di San Vittore era già vecchio di
cinque giorni, già dimenticato. Quei deliri con la stella a cinque punte lo
additavano come "torturatore" della colonna Walter Alasia. Non era vero, lo
sapevano soprattutto i detenuti. Digos, carabinieri e vigili raccolsero quei
1.025 fogli. Divennero un unico corpo di reato da conservare fino al processo.
Divennero questo pacco ancora annodato con lo spago e sigillato a piombo, con
l'elenco del contenuto battuto a macchina in puro "poliziottese", che dorme da
quarantun'anni con migliaia di altri reperti nella stanza quattro di uno dei
corridoi dell'Ufficio corpi di reato del tribunale. Due scaffali enormi, sono
quelli su cui sono appoggiati i reperti degli Anni di piombo. I pezzi
superstiti. Quelli non ancora reclamati da nessuno, non restituiti agli aventi
diritto, non ancora consegnati a un museo, a una fondazione, alla storia.
Giacciono, affidati alle metodiche cure del magistrato Alfredo Nosenzo, del
funzionario Giannino Talarico e della mezza dozzina di impiegati chiamati a
gestire enormi spazi e volumi di oggetti per contro del presidente del
tribunale, Roberto Bichi. Questo pezzettino di archivio è quello storicamente
più prezioso. Di qui si dice che sia transitato per anni l'originale della
scheda di affiliazione di Silvio Berlusconi alla Loggia P2. Qui, di certo, di
quell'intreccio infernale di massoneria, poteri deviati e criminalità che
marchiò la storia d'Italia, sono custodite le voci. Reperto 56979: "una cassetta
con nastro registrato della prima e della seconda telefonata minatoria a Enrico
Cuccia il 28/ 3/ 1980; una cassetta con nastro registrato della telefonata
minatoria a Giorgio Ambrosoli il 9/1/1979". L'ombra di Michele Sindona e di quel
milieu atlantico e cattolico, che travolgerà la vita dell'eroe borghese e
sfiorerà quella del gran capo di Mediobanca. Busta 55129: altre due telefonate
di avvertimento a Cuccia e Ambrosoli, e una piantina di Milano sequestrata a
William J. Aricò, il killer mafioso dell'avvocato milanese assoldato da Sindona.
Plico 54746: agenda, rubrica e corrispondenza sequestrate alla Giole di
Castiglion Fibocchi, la fabbrica di camicie di Licio Gelli che di quelle trame
era il sommo tessitore. Pacchi numero 57055 e 57061, con le firme in calce dei
giudici istruttori Giuliano Turone e Gherardo Colombo: foto e negativi portati
via da Villa Wanda, sempre in quel fatidico 17 marzo 1981, il giorno in cui i
vertici dello Stato compromessi con grembiuli e compassi cominciarono a tremare.
E ancora, dagli armadi e dai registri originali del tribunale, catalogati a
penna e con quelle antiche etichette battute a piombo, riaffiorano documenti
bancari, schede, biglietti: fonti di prova che entrarono in quei processi e da
allora sono in attesa di destinazione. Ma almeno, adesso, hanno un loro posto.
"Per decenni - spiegano all'Ufficio - in questi corridoi e nelle stanze ogni
scaffale era stracolmo di materiale lasciato lì senza nessun criterio. In alcuni
ambienti non si poteva nemmeno entrare". L'idea, spiega Nosenzo, è "di ragionare
tra qualche mese con Archivi e fondazioni pubbliche per capire cosa fare di
questo materiale". Ritroverebbero una casa le videocassette di Mistero Buffo e
delle altre rappresentazioni teatrali di Dario Fo trasmesse in tv, che qualche
zelante ufficiale periodicamente registrava in caso di futura denuncia.
Ritroverebbe un suo spazio la Legnano nera col cestello e "col freno posteriore
rotto" (ricorda il cartellino) portata via il 13 settembre 1978 dal covo di via
Negroli di " Massimo Turicchia", nome di Corrado Alunni, ex fondatore delle Br e
ideatore delle Formazioni Comuniste Combattenti. Sarebbero visibili ai feticisti
del genere le macchine da scrivere e i ciclostile portati via dalle varie basi
del terrorismo rosso. Le valigie con gli striscioni originali che venivano
appese nelle fabbriche dai fiancheggiatori: alla Breda, alla Pirelli, alla
Magneti Marelli. Il 759 volantini con la rivendicazione del sequestro del
generale statunitense Lee Dozier, ritrovate nel 1982 in un appartamento di via
Verga. I nastri dei sequestratori di Renzo Sandrucci, le telefonate dei killer
di Prima Linea. Passato remoto, vicinissimo, ancora inciso nella carne della
città.
Sequestro Moro:
le storie dei cinque uomini uccisi dalle Brigate Rosse.
Poliziotti e carabinieri con storie simili. Cinque ritratti nell’Italia ai tempi
bui del terrorismo, scrive Giovanni Belfiori il 16 marzo 2019 su Democratica.
Ci sono vittime di serie A, di serie B e anche di serie C. Quel 16 marzo 1978 i
cinque uomini della scorta di Aldo Moro furono massacrati in via Fani senza
pietà dai terroristi delle Brigate Rosse, ma nelle commemorazioni, nei ricordi
del rapimento dello statista democristiano, rischiano di passare inosservati,
quasi fossero una nota a margine. Gli stessi terroristi, oggi liberi di parlare,
di rilasciare interviste dalle loro case, non fanno menzione di quei cinque
uomini trucidati, come se si fosse trattato non di esseri umani, ma di oggetti
da eliminare sul percorso della ‘rivoluzione’. Claudio Magris, in un editoriale
sul 40esimo anniversario agguato di via Fani intitolato significativamente “Le
vittime di terza categoria”, scriveva: «I tre poliziotti e i due carabinieri
scannati, e come loro innumerevoli uomini e donne senza nome bestialmente
massacrati, non trovano posto nella mente, nel cuore, nella memoria, quasi non
fossero uomini come chi ha un nome o un ruolo un po` più noti. Ogni tanto si
ricordano quegli agenti ma assai flebilmente; ad esempio non ho sentito alcuna
loro menzione in una delle recenti trasmissioni televisive su quegli eventi.
Restano vittime di terza classe».
Agguato di via Fani:
gli uomini della scorta di Aldo Moro. La scorta armata, composta da cinque
agenti dei famigerati Corpi Speciali, è stata completamente annientata (Dal
comunicato n. 1 delle Brigate Rosse, 18 marzo 1978)
Chi sono, dunque, i
cinque “famigerati”, uccisi dal commando delle Brigate Rosseche in via Fani a
Roma, aveva rapito Aldo Moro? Chi ricorda il Pasolini della poesia sui fatti di
Valle Giulia, rammenta, con una interpretazione assai parziale, soltanto i versi
in cui il poeta dichiara di ‘simpatizzare’ coi poliziotti. Ma poco più avanti,
nella stessa lirica, c’è una descrizione forte, quasi icastica e sensoriale di
quegli uomini in divisa: “E poi, guardateli come li vestono: come pagliacci, con
quella stoffa ruvida che puzza di rancio, fureria e popolo”.
Rancio, fureria e
popolo: sono loro. Il più ‘vecchio’ degli uomini di scorta ha 52 anni, il più
giovane 24: nessuno torna a casa, quel mattino di quarant’anni fa. Uno viene da
una famiglia contadina della Campania: il fratello lavorava nei campi quando
apprende dalla radiolina la notizia dell’attentato, un altro vive in caserma (lo
stipendio di un agente non consentiva molto di più) e aspetta di essere promosso
prima di sposarsi, un altro ancora era migrato dalle campagne molisane. Non sono
solo “divise”, sono uomini che hanno famiglia, figli, genitori, fratelli. Fanno
un lavoro difficile e hanno una paga da fame. Sono loro i figli del popolo,
uccisi ‘in nome del popolo’ da assassini che di popolare non hanno nulla.
La scorta di Aldo
Moro. Poliziotti e carabinieri della scorta di Moro: uomini con storie simili,
un magro reddito familiare e spesso la miseria, la volontà di trovare un lavoro,
la necessità di emigrare, la divisa indossata con l’orgoglio di chi serve lo
Stato. E poi i figli, la vita quotidiana fra turni massacrati di lavoro e la
voglia di stare in famiglia. Cinque storie dell’Italia ai tempi bui del
terrorismo, cinque storie di uomini normali ammazzati in nome della
‘rivoluzione’. E oggi i ricordi di chi è rimasto: le moglie, i figli, i
genitori. Uno di loro, Giovanni Ricci, ha avuto la determinazione di incontrare
«chi mi aveva fatto del male». Nel 2012 guarda negli occhi Morucci, Bonisoli,
Faranda. Lo ha raccontato al giornalista di Repubblica Tv Concetto Vecchio. Ha
detto: non odio più da quanto li ho visti. Che cosa ha visto Giovanni Ricci? Ha
visto persone normali, davanti a lui, altri esseri umani. Persone normali: il
male non ha un cartellino di riconoscimento, la “banalità del male” del resto è
la cosa che, come essere umani, più ci spaventa e ci sconcerta. Perché avete
voluto fare questo? ha chiesto Giovanni Ricci agli assassini del padre.
Oreste Leonardi, 52
anni: il “nemico del popolo” che difese Moro col suo corpo. Il maresciallo dei
Carabinieri Oreste Leonardi era nato nel 1926 a Torino. Mentre frequenta il
ginnasio, rimane orfano del padre che muore in guerra. Dopo aver terminato gli
studi, si arruola nell’Arma. Lavora in diverse sedi, poi è inviato a Viterbo
come istruttore alla Scuola Sabotatori del Centro Militare di Paracadutismo. A
una festa di carnevale conosce una ragazza, Ileana Lattanzi che sposa dopo
neanche un anno di fidanzamento. Nel 1963 è chiamato a far parte della scorta di
Aldo Moro. Leonardi, detto Judo, era il caposcorta e come tale quasi un’ombra di
Moro, la sua guardia del corpo più fedele. Quel 16 marzo 1978 si trova nel
sedile anteriore della macchina del presidente, vicino a Domenico Ricci. È
Leonardi a compiere il tentativo estremo di proteggere Moro con il proprio
corpo. Lo ammazzano a 52 anni. Con la la moglie, lascia anche due figli Sandro e
Cinzia di 17 e 18 anni. Ha raccontato Ileana una decina di anni fa: «La nostra
disperazione è derivata anche dal fatto che durante tutti questi anni ci siamo
trovati soli. Lo Stato non ci ha messo a disposizione psicologi, come
si usa fare adesso».
Domenico Ricci, 44
anni: il “nemico del popolo” che salutò il suo bambino. A 44 anni è
assassinato Domenico Ricci, appuntato dei carabinieri. Era marchigiano, nato a
San Paolo di Jesi, in provincia di Ancona, nel 1934. Ottimo motociclista, entra
a far parte della scorta di Moro alla fine degli anni Cinquanta. Diviene il suo
autista di fiducia e quel 16 marzo 1978 si trova al posto di guida della Fiat
130 su cui viaggiava il presidente della DC. Gli contano sette proiettili
sparati alla testa. A casa lascia la moglie Maria e due bambini. Uno di loro si
chiama Giovanni ed ha 11 anni quando assassinano suo padre. Anni fa dichiarò al
Corriere della Sera: «Non vorrei che fossero solo i brigatisti a scrivere la
storia. Perché mio padre era un carabiniere, ma dentro la divisa c’era un uomo
che la sera prima di essere ammazzato ha salutato il suo bambino, cioè io, con
una carezza e un complimento per la prima partita di calcio giocata coi compagni
di scuola». In una recente intervista a Repubblica Tv ha detto: «Non dico mai
che si è sacrificato né che è un eroe. Non si è sacrificato, perché l’adorava
quel lavoro, era tutta la sua vita. Mio papà è un eroe del quotidiano, così come
tanti suoi colleghi, ma così come tante di quelle persone che si alzano la
mattina alle 4 per andare a lavorare in un panificio o nelle fabbriche».
Francesco Zizzi, 30
anni: il “nemico del popolo” che progettava le nozze. Quel 16 marzo Francesco
Zizzi è al suo primo giorno di scorta al servizio dell’onorevole Moro. Lui, nato
a Fasano, in provincia di Brindisi, nel 1948, era entrato in Polizia nel 1972.
Quattro anni dopo aveva vinto il concorso per la scuola allievi sottufficiali di
Nettuno. All’epoca Francesco vive, come molti altri poliziotti giovani, nella
caserma Cimarra, di via Panisperna. Dopo aver ottenuto i gradi di vice
brigadiere, inizia a progettare le nozze con la fidanzata Valeria.
Si trova
nell’Alfetta bianca che precede la macchina di Moro, seduto al posto del
passeggero. I brigatisti gli sparano, ma non muore subito. Il cuore si fermerà
all’ospedale Gemelli di Roma. Aveva trent’anni e una grande passione: amava
cantare e si esibiva con la chitarra. La sorella Adriana, al sito di
informazione locale Osservatoriooggi.it racconta che quel 16 marzo era «un
giorno qualunque per me. Ero un’insegnante ma quel giorno non ero andata a
scuola. Stavo svolgendo normali mansioni domestiche quando venne a trovarmi mio
suocero che mi spinse ad accendere la tv in quanto raccontava di un grave evento
accaduto a Roma. Appresi la notizia così, dalla tv, in modo brusco e con
un’aspirapolvere in mano. E poi la nostra vita è cambiata». Anni fa aveva detto:
««Non piango mai per la morte di mio fratello in presenza di altri e a maggior
ragione con mia figlia. Lei voleva sapere, e capire. Le ho raccontato ma in
maniera pacifica senza disturbare la sua coscienza. La mia è stata già
abbastanza disturbata».
Raffaele Iozzino, 25
anni: il “nemico del popolo” emigrato per lavoro. L’unico che riesce ad uscire
dall’auto, tentando la difesa, è la guardia Raffaele Iozzino. I terroristi lo
finiscono a terra sparandogli in fronte. Non aveva ancora compiuto i 25 anni.
Raffaele era nato in provincia di Napoli, a Casola, nel 1953, in una modesta
famiglia contadina. Raffaele per lavorare deve emigrare. Nel 1971 si arruola
nella Pubblica Sicurezza, frequenta la scuola della Polizia di Alessandria e
viene poi aggregato al Viminale e comandato alla scorta di Aldo Moro. «Lui per
non metterci preoccupazione, non ci diceva nulla dei pericoli – ha raccontato il
fratello Ciro al Corriere Tv – io ero tra i campi ad aiutare mio padre avevo la
radiolina accesa quando, purtroppo, interruppero le trasmissioni per dare la
notizia del sequestro».
Giulio Rivera, 23
anni: il “nemico del popolo” figlio di contadini. Il più giovane è il poliziotto
Giulio Rivera. Giulio guida la macchina che precede quella di Moro. I brigatisti
lo crivellano con otto colpi di pistola. Era nato nel 1954 a Guglionesi, in
Molise, in provincia di Campobasso. I genitori e i fratelli lavorano la terra.
La sorella Carmela: «Se solo chiudo gli occhi e lo rivedo in quella bara…non è
piacevole. A casa non ho una sua foto in divisa: non riesco a sopportarlo».
IL MEMORIALE DI MORO.
Gianni Barbacetto per
il “Fatto quotidiano” il 25 novembre 2019. "Uno scandalo veramente senza fine".
È il caso Moro, secondo Sergio Flamigni, ex senatore e infaticabile ricercatore
che da anni indaga sulla P2 , sul terrorismo italiano, sul sequestro del
presidente della Dc. Il suo ultimo lavoro, Rapporto sul caso Moro (Kaos
edizioni), presenta il suo contributo ai lavori della seconda Commissione
parlamentare d' inchiesta sul sequestro di Aldo Moro (2014-2017). Ma rende
pubblica anche una denuncia secca per come il presidente della Commissione, il
Pd Giuseppe Fioroni (preferito al più esperto Miguel Gotor), ha condotto i
lavori. "In modo autocratico e disordinato", "abusando della secretazione",
lavorando "quasi solo attorno all'agguato di via Fani, senza affrontare il nodo
del 18 aprile, ossia la scoperta del covo di via Gradoli e il falso comunicato
del Lago della Duchessa". Risultato finale: "Mantenere il delitto Moro un enigma
irrisolto". Eppure alcuni elementi raccolti dalla Commissione sono riusciti a
confermare "che la verità di Stato sul delitto Moro - confezionata dalla Dc di
Francesco Cossiga insieme agli ex Br Valerio Morucci e Mario Moretti e avallata
dalla magistratura romana - è una colossale menzogna". Flamigni segnala "tre
dati di fatto che sbugiardano quella versione dall' inizio (strage di via Fani)
alla fine (uccisione di Moro)".
Il primo dato accertato è che
subito dopo la strage di via Fani, la mattina del 16 marzo 1978, i terroristi
delle Brigate rosse si sono rifugiati con l'ostaggio in uno stabile di via
Massimi 91 di proprietà dello Ior (la banca del Vaticano), su cui non è mai
stato fatto alcun approfondimento. Non ci sono stati - come raccontato "dalla
menzognera versione di Stato" - trasbordi del rapito in piazza Madonna del
Cenacolo; non c' è stata una tappa successiva nel sotterraneo del grande
magazzino Standa dei Colli portuensi; e non c' è stato l' approdo finale nel
covo-prigione di via Montalcini.
Il secondo dato accertato
dalla Commissione è che "sono una sequela di menzogne" anche il luogo e le
modalità dell'uccisione del presidente della Dc raccontate dai brigatisti.
Secondo la loro versione, Aldo Moro sarebbe stato ammazzato nel box auto di via
Montalcini, nel baule della Renault rossa, con 11 colpi sparati alle 6-7 del
mattino. Con successivo trasporto del cadavere per alcuni chilometri, da via
Montalcini fino in via Caetani, al centro di Roma. Falso, secondo Flamigni: "Le
vecchie e le nuove perizie hanno definito improbabile il luogo, ben diverse le
modalità, e falso l' orario del delitto indicato dalla versione brigatista
avallata dalla magistratura romana".
Il terzo dato di fatto è che
la "verità ufficiale" sulla prigionia e sull' uccisione di Moro in via
Montalcini (quella del "memoriale Morucci") è stata confezionata in carcere dal
brigatista dissociato Valerio Morucci con la regia del Sisde, il servizio
segreto del Viminale, con "la fattiva collaborazione della Dc cossighiana". "Il
sequestro del presidente della Dc è rimasto un delitto senza verità", scrive
Flamigni. "Infatti a distanza di più di quarant' anni non c' è alcuna certezza
sul luogo (o i luoghi) dove Moro fu tenuto segregato per quasi due mesi, né si
sa chi, come e perché lo abbia ucciso". Secondo Flamigni, "è certo che alla
strage di via Fani partecipò un tiratore scelto". Ne parla anche uno dei
testimoni oculari, il benzinaio Pietro Lalli, pratico di armi: raccontò di "aver
visto sparare un esperto e conoscitore dell'arma in quanto con la destra la
impugnava, e [teneva] la sinistra guantata sopra la canna in modo che questa non
si impennasse".
Per scoprire gli eventuali
professionisti in via Fani, "la Commissione avrebbe dovuto occuparsi dell' aereo
libico, diretto a Ginevra, che nel tardo pomeriggio del 15 marzo 1978 (vigilia
della strage di via Fani) atterrò invece a Fiumicino con quattro persone a
bordo, e che ripartì l' indomani mattina alle ore 10,05 (un' ora dopo la strage)
alla volta di Parigi. Un volo fortemente sospetto di avere trasportato uno o più
killer di una particolare struttura di addestramento e supporto per
organizzazioni terroristiche formata a Tripoli (Libia) dagli americani Edwin P.
Wilson e Frank Terpil, entrambi ex agenti della Cia". Flamigni segnala come
"episodica eccezione" al "quarantennale disastro giudiziario relativo al delitto
Moro" il lavoro del procuratore generale di Roma Luigi Ciampoli, che avocò un'
indagine della Procura guidata da Giuseppe Pignatone. La requisitoria di
Ciampoli dell' 11 novembre 2014 "ha confutato la versione di Stato del duo
Morucci-Moretti sulla dinamica dell' agguato e della strage. E non ha mancato di
menzionare la 'protratta inerzia' del pubblico ministero romano che lo aveva
indotto a esercitare il potere di avocazione". La "protratta inerzia" ha
riguardato anche la figura e il ruolo dell' americano Steve Pieczenik (insediato
al Viminale per conto del Dipartimento di Stato Usa durante il sequestro Moro).
Venne mandato a Roma da Washington - secondo Ciampoli - per quella che era una
vera e propria operazione di "guerra psicologica" con tre obiettivi: garantire
l' uccisione dell' ostaggio; recuperare le registrazioni degli interrogatori e
degli scritti di Moro; ottenere il silenzio dei terroristi. Ciampoli ha riferito
anche di aver indagato sulla presenza in via Fani di due uomini dei servizi
segreti, a bordo di una moto Honda, al comando del colonnello Camillo Guglielmi.
E si è detto convinto che "in via Fani vi fosse la presenza anche di servizi
segreti di altri Paesi interessati, se non a determinare un processo di
destabilizzazione dello Stato italiano, quantomeno a creare del caos". È stata
secretata l'audizione in seduta segreta del 29 luglio 2015 di Luca Palamara,
sostituto procuratore a Roma e membro del Consiglio superiore della
magistratura: riguardava l' interrogatorio di Pieczenik svolto per rogatoria da
Palamara il 27 maggio 2014. "Da allora", commenta Flamigni, "la posizione
giudiziaria di Steve Pieczenik si è inabissata, col suo carico di segretezza,
nel porto delle nebbie".
Maria Antonietta Calabrò per
il “Fatto quotidiano” il 26 novembre 2019.
La STASI, il potente servizio
segreto della defunta Repubblica democratica tedesca, in un appunto dell' 8
giugno 1978, pubblico dal 2014, metteva in evidenza le somiglianze dell'intera
azione brigatista con la notissima vicenda del rapimento dell' industriale
Hanns-Martin Schleyer, compiuta dalla RAF (Rote Armeee Fraktion) alla fine del
1977, e segnalava una possibile "prigione del popolo" vicina al luogo del
sequestro, via Fani.
La STASI era particolarmente
ben informata visto che, secondo il suo leggendario capo Markus Wolf, la RAF
(che oggi sappiamo essere stata presente con almeno due terroristi sulla scena
di via Fani), era nelle sue mani. Se oggi questa "prigione" - la prima e più
importante - è stata "scoperta", si deve ai lavori parlamentari della scorsa
legislatura. Era in via Massimi 91. Ne parlo in più capitoli del libro che ho
scritto a quattro mani con Giuseppe Fioroni, Moro, il caso non è chiuso, la cui
seconda edizione è stata pubblicata in occasione del trentesimo anniversario
della caduta del Muro di Berlino. I riscontri sono stati trovati negli atti
desecretati a partire dal 2014, e hanno portato a individuare questa prigione in
un miniappartamento ricavato nell'attico della palazzina B di via Massimi 91, di
proprietà allora dello IOR , la cosiddetta banca vaticana. Un attico che ha un'
altra caratteristica: era allora sicuramente l' appartamento più alto di Roma.
Quindi vista libera, nessun occhio indiscreto e la possibilità per Moro di poter
stare all'aria aperta e di muoversi (tanto che il suo tono muscolare era buono e
quindi incompatibile con una lunga detenzione su una brandina in via
Montalcini). Oggi sappiamo che una "fonte riservata", già il giorno successivo
al sequestro, il 17 marzo 1978, aveva avvertito il comandante della GdF Raffaele
Giudice, che "le 128 dei brigatisti sarebbero state parcheggiate in un box o
garage nelle immediate vicinanze di via Licinio Calvo", presso una base situata
a un piano elevato, con accesso dal garage mediante ascensore, una tipologia di
edilizia residenziale signorile e moderna. Grazie alla collaborazione del
Comando della GdF, sono stati acquisiti dalla Commissione Moro, presieduta da
Fioroni, tutti i documenti che riguardavano la localizzazione di questo
covo-prigione. Le palazzine erano gestite dal padre di don Antonio (che le Br
scelsero come interlocutore e mediatore con la famiglia Moro), Luigi Mennini,
all' epoca ai vertici dello IOR . Gli accertamenti sviluppati dalla Commissione
Moro 2, a partire dal 2015 hanno dimostrato che mai, dal 1978 a oggi, era stato
svolto un serio lavoro investigativo sui condomini di via Massimi 91. Un
miniappartamento nell' attico della Palazzina B Nel complesso di via Massimi 91,
tra il 1977 e il 1978, furono fatte modifiche che sono state oggetto di recenti
approfondimenti. Nell' attico della Palazzina B fu realizzata una camera
compartimentata, costruita sul terrazzo e appoggiata a uno dei muri perimetrali.
Situata nella zona di servizio, la stanza poteva ospitare un eventuale soggetto
temporaneamente custodito nella "cameretta" con gli spazi e i servizi di un vero
e proprio miniappartamento. E ciò combacia con quanto descritto in un appunto
del 28 settembre 1979 dal generale Grassini (Sisde), in cui fa riferimento a un'
intercettazione ambientale di una conversazione tra detenuti, "uno dei quali di
alto livello terroristico": "Non gli hanno mai messo le mani addosso", "Non gli
è stato torto un capello"; Moro otteneva tutto ciò di cui "aveva bisogno, si
lavava anche quattro volte al giorno, si faceva la doccia, mangiava bene, se
voleva scrivere scriveva []". Si torna sempre sul luogo del delitto Le indagini
compiute tra il 2014 e il 2017 hanno consentito di identificare per la prima
volta due persone, allora conviventi in via Massimi 91, hanno esplicitamente
ammesso di aver ospitato per alcune settimane, nell' autunno 1978, Prospero
Gallinari il carceriere di Moro in un'abitazione sita in quello stesso
condominio. Non è un caso se Gallinari entrò in quella abitazione in un periodo
in cui la caduta della base di via Monte Nevoso a Milano e di altri covi
brigatisti dovette indurre a cercare sistemazioni più sicure per il carceriere
di Moro. All’interno del complesso di via Massimi 91, oltre quella degli alti
prelati vaticani (tra cui Marcinkus) , la Commissione Moro 2 ha riscontrato
altre presenze. Vi abitava la giornalista tedesca Birgit Kraatz, corrispondente
in Italia dei periodici tedeschi Der Spiegel e Stern, a quel tempo legata a
Franco Piperno, il leader di Autonomia Operaia. Nella palazzina c' era poi la
sede operativa di una società statunitense, la Tumpane Company (TumCo), con sede
legale negli Stati Uniti e domicilio fiscale proprio in via Massimi 91. Ha
cessato le proprie attività nel 1982, ma dal 1969 forniva assistenza alla
presenza Nato e statunitense in Turchia, ed esercitava anche attività di
intelligence per l'organismo informativo militare statunitense. Vivevano o
lavoravano in via Massimi 91 anche diversi personaggi legati alla finanza e ai
traffici tra Italia, Libia e Medio Oriente. Come Omar Yahia che mise in contatto
con il Sismi la fonte Damiano, particolarmente informata sulle dinamiche
terroristiche palestinesi. Il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro, quindi non
appaiono come una vicenda puramente interna all' eversione di sinistra, ma
acquisiscono una rilevante dimensione internazionale, che i brigatisti hanno
sempre negato. Roma a quei tempi, come Berlino, era occidentale per tre quarti e
orientale per un quarto. Era in via Massimi 91 il Checkpoint Charlie della
capitale italiana? Tutti gli atti e la documentazione raccolti dalla Commissione
Moro 2 sono stati desecretati a eccezione degli atti prodotti dai magistrati o
dagli ufficiali di Polizia giudiziaria consulenti della Commissione che hanno
esplicitamente chiesto di mantenere la documentazione segreta, in quanto si
tratta di indagini ancora in corso di approfondimento. Infatti "il caso non è
chiuso".
Aldo Moro: “Il giorno di
Piazza Fontana il Pci mi consigliò di non tornare a Roma”.
Mentre si avvicina il cinquantenario della strage milanese, ecco quel che nel
1978 il leader Dc rivelava nel memoriale consegnato alle Brigate Rosse. Maurizio
Tortorella il 20 novembre 2019 su Panorama. Manca meno di un mese al
cupo anniversario della strage di Piazza Fontana, con i suoi 17 poveri morti
causati dai candelotti di gelignite piazzati dai neonazisti di Ordine Nuovo il
12 dicembre 1969. Mentre stanno per partire celebrazioni e manifestazioni per il
cinquantenario della prima grande strage italiana, va ricordato un particolare
importante, ma del tutto ignorato dalle cronache di questi ultimi anni. E cioè
che anche Aldo Moro, che nel 1969 è ministro degli Esteri del governo Rumor, e
quel 12 dicembre si trova a Parigi, scrive di piazza Fontana. E si convince
presto che sia una strage “nera”. Moro lo dichiara con estrema chiarezza nel
memoriale che affida alle Brigate Rosse durante la sua prigionia del
marzo-maggio 1978: “Personalmente ed intuitivamente”, annota il presidente del
Consiglio, poche settimane prima di essere ucciso dai suoi carcerieri, “io non
ebbi mai dubbi e continuai a ritenere (…) che questi e altri fatti che si
andavano sgranando fossero di chiara matrice di destra e avessero l’obiettivo di
scatenare un’offensiva di terrore indiscriminato (…) allo scopo di bloccare
certi sviluppi politici che si erano fatti evidenti a partire dall’autunno caldo
e di ricondurre le cose, attraverso il morso della paura, a una gestione
moderata del potere”. Poco più in là, sempre nel suo memoriale, Moro offre alle
Br una rivelazione interessante, che dimostra come già nel dicembre 1969 gli
stessi potenti apparati d’intelligence del Partito comunista italiano avessero
presente il rischio di una svolta autoritaria collegata alla bomba di Milano.
Moro scrive che “Tullio Ancora, un alto funzionario della Camera dei Deputati e
da tempo mio normale organo d'informazione e di collegamento con il Partito
comunista, mi telefonò in ambasciata a Parigi, per dirmi con qualche
circonlocuzione che non ci si vedeva chiaro e che i suoi amici (cioè proprio i
comunisti) consigliavano qualche accorgimento sull'ora di partenza, sul
percorso, sull'arrivo e sul trasferimento di ritorno. (…) Io ritenni, poiché ne
avevo la possibilità, di adottare le consigliate precauzioni e rientrai a Roma
non privo di apprensione”. Moro, comunque, ha una certezza: esistono centrali
dell’intelligence straniera che hanno interferito nella strage. Nel memoriale,
il prigioniero indica i due regimi di destra che nel 1969 sono al potere in
Spagna e Grecia, poi aggiunge una frase sibillina: “Ci si può domandare” scrive
“se gli appoggi venivano solo da quella parte o se altri servizi segreti del
mondo occidentale vi fossero comunque implicati”. È una lettura interessante,
che non andrebbe sottovalutata. Di certo, va conosciuta.
Storia d'Italia. Il
memoriale che finalmente ci restituisce il vero Aldo Moro.
Il documento, scritto a mano dal prigioniero durante il sequestro nel 1978, da
sempre considerato la chiave dei cinquantacinque giorni più oscuri della
Repubblica, approda a una nuova edizione critica. Che riconsegna allo Statista
ucciso il suo tempo e la sua scrittura. Marco Damilano il 15 novembre 2019 su
L'Espresso. La scrittura e il tempo. Erano queste le uniche armi, fragili, su
cui poteva contare l’uomo di Stato spogliato del suo potere, diventato
prigioniero, «nel cuore del terrore», come lo immaginò Italo Calvino, nelle mani
dei suoi carcerieri e delle forze esterne al covo che si muovevano per
condizionare gli esiti del sequestro di cui sapeva, lui soltanto, decifrare i
fili invisibili. Scrivere per prendere tempo, come in una favola antica, e
prendere tempo per scrivere, come in una lenta caduta in cui si sono
avvinghiati, una volta per tutte, in un solo destino, la storia della Repubblica
e il dramma di una persona. «Saper leggere il libro del mondo, con parole
cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, i
segreti che fanno paura», è il testo di una canzone di Fabrizio De André, che
viene in mente recuperando oggi, finalmente ricomposte con rigore scientifico,
con dedizione e con umanità, le parole di Aldo Moro nel memoriale consegnato
alle Brigate rosse più di quarant’anni fa, durante i 55 giorni del sequestro,
dal 16 marzo 1978, il giorno del rapimento a Roma in via Mario Fani e della
strage dei cinque agenti della scorta, al 9 maggio, quando il cadavere del
presidente della Democrazia cristiana fu ritrovato nel bagagliaio di una Renault
rossa in via Michelangelo Caetani. Il cosiddetto Memoriale di Moro fu scoperto
in forma dattiloscritta e parziale nell’ottobre 1978, in un covo delle Br a
Milano, in via Montenevoso, e poi, dodici anni dopo, nel 1990, rispuntò da
un’intercapedine dello stesso appartamento in forma autografa e fotocopiata,
dando il via a una serie infinita di congetture. È considerato una delle chiavi
possibili dei misteri del caso Moro, i «segreti che fanno paura», quelli che il
prigioniero minacciava di svelare, quelli legati al possesso del manoscritto
originale che nel corso dei decenni avrebbe giustificato altre guerre di potere
e il sospetto di altri morti e altro sangue. Oggi, a distanza di più di
quarant’anni, il Memoriale viene pubblicato dalla direzione generale Archivi del
ministero dei Beni culturali e dall’archivio di Stato di Roma in una nuova
edizione critica, grazie al lavoro di cinque anni di un gruppo di studiosi,
coordinati da Michele Di Sivo, vicedirettore dell’Archivio di Stato di Roma,
esperto di fonti giudiziarie: gli storici Francesco Biscione e Miguel Gotor e
l’ex senatore Sergio Flamigni, che in passato del memoriale hanno curato
edizioni e pubblicazioni, Ilaria Moroni, direttrice dell’archivio Flamigni che
conserva le carte personali dell’uomo politico, la grafologa Antonella Padova,
l’archivista Stefano Twardzik. La storia, la filologia, la freddezza
dell’analisi per un testo rovente consentono il passaggio fondamentale,
definitivo, per la comprensione di quanto accadde nel 1978, nella vicenda
spartiacque della nostra storia.
La conclusione in cui Moro
immagina vicina la sua liberazione. «Il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro
ruotano attorno a una sola azione dell’ostaggio: il suo scrivere», afferma Di
Sivo nell’introduzione. Le lettere, pensate dall’ostaggio per comunicare con
l’esterno, utilizzate dai terroristi come arma di pressione, rese pubbliche o
tenute segrete ovvero mai consegnate. E il Memoriale, fino ad ora considerato
come il testo con cui Moro rispondeva alle domande dei suoi carcerieri, nel
grottesco “processo del popolo” annunciato dalle Br nei loro comunicati: i 239
fogli ritrovati in fotocopia in via Montenevoso nel 1990, parte di un corpus di
documenti più ampio, 420 fogli tra lettere e biglietti mai consegnati.
Ricostruire il testo, in fotocopie rovinate e per di più mutilate dai prelievi
della polizia scientifica, tondini conservati in bustine, come coriandoli.
Ricostruire le modalità di stesura del prigioniero e le condizioni in cui Moro
scriveva. «Ricostruire l’elaborazione da cui le scritture di Moro furono
originate e il loro disporsi nel tempo, riconoscere il testo più prossimo alle
intenzioni di un autore inquisito e condizionato da pieno dominio e da totale
cattività, accostarsi alla tortuosa morfologia di questa fonte sono stati i
nostri obiettivi», spiega Di Sivo. La grafologa Antonella Padova rivela che nel
1970 Moro si era rivolto a un medico psico-grafologo, Tonino Bellato, per
risolvere un problema pratico, solo in apparenza banale: i suoi più stretti
collaboratori non riuscivano a decifrare la sua scrittura, un impaccio non da
poco perché Moro usava buttare giù a mano i discorsi e gli articoli, per poi
arrivare alla stesura definitiva dopo una serie infinita di correzioni,
integrazioni, cancellature, ricopiature. Tra i testi presi a paragone c’è
l’intervista che il nostro Guido Quaranta gli fece nell’agosto 1972 per
Panorama, dove la grafia ordinatissima di Quaranta convive sullo stesso foglio
con l’appunto del leader politico: «Ho raggruppato le domande, collegando quelle
affini. I numeri a margine sono quelli delle mie risposte, che seguono, mi pare,
un ordine logico. Ho messo “no” per le domande cui non intendo rispondere.
L’intervista è già lunghissima». Una notazione preziosa perché per gli studiosi
fu lo stesso metodo utilizzato da Moro per rispondere ai suoi carcerieri.
Raggruppare, ricopiare, riscrivere. Un lavoro meticoloso che ora consente di
dare una risposta finale alla questione dell’autenticità degli scritti e della
possibilità che Moro fosse stato drogato o costretto a scrivere messaggi non
suoi. Paragonati (in modo emozionante) con l’ultima nota a mano da uomo libero,
la firma del libretto del professore universitario con l’argomento della lezione
(15 marzo 1978: La recidiva. All’agguato di via Fani mancavano meno di
ventiquattr’ore, le caselle delle lezioni numero 41 e 42 del professor Moro
docente di Istituzioni di diritto e procedura penale resteranno per sempre
vuote), i fogli dalla prigionia portano a osservazioni molto lontane da quelle
della grafologa Giulia Conte Micheli che giudicò la grafia di Moro «abulica,
passiva, inerte», segno di «uno stato depressivo di angoscia interiore». Moro
per primo aveva intuito di essere finito in una trappola nella trappola: se la
sua scrittura fosse apparsa nervosa lo avrebbero fatto passare per un pazzo
incapace di ragionare, se troppo ordinata come il diligente copista di testi
scritti da altri. Protestava nelle sue lettere con i suoi compagni di partito:
«Scrivo con il mio stile, per brutto che sia, ho la mia solita calligrafia. Ma
sono, si dice, un altro e non merito di essere preso sul serio». E ancora: «Moro
insomma non è Moro... Per qualcuno la ragione di dubbio è nella calligrafia,
incerta, tremolante, con un’oscillante tenuta delle righe. Il rilievo è
ridicolo, se non provocatorio. Pensa qualcuno che io mi trovi in un comodo e
attrezzato ufficio ministeriale o di partito? Io sono, sia ben chiaro un
prigioniero politico ed accetto senza la minima riserva, senza né pensiero, né
un gesto di impazienza la mia condizione. Pretendere però in queste circostanze
grafie cristalline e ordinate e magari lo sforzo di una copiatura, significa
essere fuori della realtà delle cose». «Lo studio dei comportamenti grafomotori
consente di restituire ad Aldo Moro non solo l’autografia ma anche la paternità
dell’impianto generale» del Memoriale, arrivano a dire gli studiosi. Sono di
Moro i brani, le correzioni, l’ordine delle domande e delle risposte. Sua
l’organizzazione interna del discorso. Sua, e non dei carcerieri, la struttura
del Memoriale. Ricostruita la cronologia del testo si arriva ad altre due
conclusioni decisive. La prima: i rinvii interni al testo trovano la loro
sistemazione, come un enigma che si scioglie. E l’attività grafomotoria del
prigioniero evidenzia il cambiamento del piano d’appoggio su cui scrivere,
orizzontale nei primi testi, e dunque il mutamento logistico delle condizione di
scrittura nella seconda fase del sequestro. Il testo del Memoriale appare ora
nella sua integrità, anche con correzioni notevoli. «Lei sbaglia da sempre e
sbaglierà sempre perché costituzionalmente chiamato all’errore. E l’errore è, in
fondo, senza cattiveria», sembrava aver scritto Moro del capo doroteo Flaminio
Piccoli, suo avversario interno nella Dc. Ma ora la frase diventa: «E l’errore
è, in fondo, sempre cattiveria». Che non è la stessa cosa. Il Memoriale consente
di penetrare nella scrittura di Moro, nella sua materialità. Le penne
utilizzate, la pressione sulla carta, la povera carta straccia di cui sono
rimaste le fotocopie che odorano di ciano. Entrare nel covo delle Br. E ancora
di più, entrare nell’interiorità, nello stato d’animo di Moro. L’ottimismo e il
pessimismo, le salite, le discese, il precipitare delle speranze, il senso di
morte e l’attesa della liberazione che è evidente in una pagina drammatica: «Il
periodo, abbastanza lungo, che ho passato come prigioniero politico delle
Brigate Rosse, è stato naturalmente duro, com’è nella natura delle cose, e come
tale educativo». In quelle stesse righe Moro spiega di aver avuto il tempo di
valutare «gli avvenimenti, spesso così tumultuosi della vita politica e
sociale», il loro ritmo, il loro ordine. «Motivi critici, diffusi ed
inquietanti, che per un istante avevano attraversato la mente, si
ripresentavano, nelle nuove circostanze, con una efficacia di persuasione di
gran lunga maggiore che per il passato. Ne derivava un’inquietudine difficile da
placare e si faceva avanti la spinta ad un riesame globale e sereno della
propria esperienza, oltre che umana, sociale e politica». Si può così rileggere
di seguito il testo del Memoriale carico di rimandi, come le uniche pagine
diffuse durante i 55 giorni del sequestro, quelle relative al ruolo di Paolo
Emilio Taviani, l’ex ministro democristiano che nel 1978 aveva un ruolo
secondario ma che invece da ministro della Difesa, nel 1956, aveva fondato la
struttura Stay-behind Gladio per operazione di difesa e anti-guerriglia in caso
di invasione sovietica, ma di questo si venne a sapere soltanto all’inizio degli
anni Novanta, proprio mentre il memoriale di Moro riemergeva dall’intercapedine
di via Montenevoso, resistente come il muro di Berlino. E trovare in quel
memoriale la spiegazione dell’ordine politico che sarebbe arrivato negli anni
successivi, in un’epoca distante dalla sua. Quell’uomo che scriveva in
condizioni di prigionia, a rischio della vita, aveva visto molte cose del
futuro. La fine della rappresentanza dei partiti e l’emergere di
un’organizzazione leggera, nella politica interna e internazionale.
L’impossibilità dei partiti ad auto-riformarsi che avrebbe portato a scaricare
la colpa dell’impasse sulle istituzioni e sulla Costituzione: «Ogni volta che
c’è una difficoltà politica obiettiva, sembra sbucare lo strumento elettorale
che dovrebbe permettere di superarla... in generale si può dire che si tratta di
false soluzioni di reali problemi politici e che è opportuno non farsi mai delle
illusioni. Non si accomodano con strumenti artificiosi situazioni obiettivamente
contorte». Intuiva «il nerbo della nuova economia, assunto come condizione di
efficienza, l’imprenditorialità privata ed anche pubblica con opportuna
divisione del lavoro», la riduzione dell’Europa a «dimensione regionale» operata
dagli Stati Uniti. Sfogliava le sorti future della stampa italiana che
«costituisce un enorme problema sia per quanto riguarda il suo ordinamento e
sviluppo, sia per quanto riguarda la sua indipendenza... Il Paese è così
dominato da cinque o sei testate. Questi giorni hanno dimostrato come sia facile
chiudere il mercato delle opinioni. Non solo non troverai opinioni, ma neppure
notizie. Forse è questo un aspetto particolare di una crisi economica, che non
può non essere anche una crisi editoriale. Infatti su 20-25 seri giornali è
difficile bloccare; su 5 o 6 sì...». Guardava l’evoluzione futura della società
italiana che avrebbe cambiato la politica: «Per chi abbia visto “Forza Italia”,
fa impressione il linguaggio, a dir poco, estremamente spregiudicato, che i
democristiani usano al Congresso tra un applauso e l’altro all’On. Zaccagnini.
Sono modi di dire e di fare che un tempo sarebbero apparsi inconcepibili. Oggi
sono accettati e mettono in moto una sovrastruttura politica che
presumibilmente, poiché le cose non nascono a caso, corrisponde all’esigenza di
una parte almeno della società italiana di oggi». In quella scena del film di
Roberto Faenza che Moro aveva visto al cinema (fu ritirato dalle sale il giorno
del suo sequestro), un montaggio di immagini e sonori in cui i notabili di
governo uscivano a pezzi, i delegati del congresso democristiano venivano alle
mani, si affrontavano come nemici che non avevano più nulla in comune, si
scambiavano i vaffa pur essendo dello stesso partito. Era già l’immagine del
tutti contro tutti, nel cambiamento del linguaggio il prigioniero Moro una
mutazione, un’esigenza della società italiana. E lo scrisse nel covo delle
Brigate rosse, come una premonizione, non potendo sapere che sarebbe nato un
partito chiamato Forza Italia e un altro originato da un vaffa-day, entrambi
tutt’altro che estranei a quella spregiudicatezza, a quell’esigenza della
società italiana, perché «le cose non nascono a caso». Inoltrarsi in quelle
pagine, come ha fatto l’attore Fabrizio Gifuni che lo ha portato a teatro
ritrovandone gli echi di Pasolini e di Gadda, attraversare il memoriale di Moro
e della Repubblica significa provare a comporre con pietà le parole del
condannato a morte e ridare vita a chi le ha scritte con disperazione e con
fiducia, perché la scrittura è sempre un atto di apertura, e soprattutto
continuare a compiere un passo essenziale per capire l’Italia di oggi. Strappare
Moro dal caso Moro e restituirgli il suo onore politico e la sua dignità umana
perché, come conclude Michele Di Sivo, «quella rappresentazione, così
ricostruita, sembra dirigere il lettore verso una vertigine: il Memoriale di
Moro si squaderna come l’ultimo atto della storia che si rivela».
40 anni fa il ritrovamento
del "memoriale Moro".
Il 18 ottobre 1978 veniva diffuso il contenuto dei dattiloscritti. Duro attacco
alla Dc di Andreotti, all'eversione, alla corruzione. Con temi attualissimi come
le pressioni dell'Europa e la Libia, scrive Edoardo Frittoli il 18 ottobre 2018
su "Panorama".
Milano: Via Monte Nevoso, 8
(Lambrate). Mattina del 1 ottobre 1978. Tutto era cominciato dall'irruzione da
parte dei Carabinieri di Carlo Alberto Dalla Chiesa nel covo milanese delle
Brigate Rosse in via Monte Nevoso, 8 nello storico quartiere milanese di
Lambrate. In una borsa di pelle marrone vengono ritrovati 60 fogli. Oltre ad
alcune lettere scritte da Moro e mai recapitate, ci sono 49 pagine che
contengono le risposte del prigioniero alle domande delle Brigate Rosse, parte
del cosiddetto Memoriale Moro. Esattamente 40 anni fa il contenuto degli scritti
fu divulgato, fatto che ebbe un importante impatto nell'opinione pubblica in
particolare modo per il ruolo della Democrazia Cristiana nei trent'anni della
storia dell'Italia Repubblicana.
Nel memoriale, il cui
contenuto fu sviluppato durante gli interrogatori delle Br nei 55 giorni di
prigionia, toccando molti degli aspetti controversi ed oscuri: dagli attacchi
eversivi alle istituzioni democratiche, alla corruzione politica, agli scandali
economici e finanziari. Aldo Moro fece molti ed illustri nomi, in gran parte
compagni di partito come Andreotti, Piccoli, Donat Cattin, Galloni, Forlani.
Italcasse. L'Istituto di
Credito delle Casse di Risparmio era un organo di secondo livello con il compito
di investire la liquidità in eccesso delle Casse di Risparmio italiane.
Nel 1977 fu interessato da un'ispezione da parte di Bankitalia che mise allo
scoperto lo scandalo: Moro indica in Andreotti il cuore della malversazione,
finalizzata al finanziamento illecito della Dc tramite favori a imprenditori
"amici" come Gaetano Caltagirone (che fu in quel periodo nominato ai vertici
dell'ente da Andreotti) e Nino Rovelli (Sir). Sui fondi neri al partito dello
scudo crociato indagherà anche il giornalista Mino Pecorelli, assassinato nel
1979. Lo scandalo Italcasse vide coinvolti anche Domenico Balducci (membro della
Banda della Magliana) e boss mafiosi come Pippo Calò.
Giulio Andreotti. "Un regista
con tanti esecutori di ordini". Così, dalla "prigione del popolo", Aldo Moro
descriveva l'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Come nel caso
Italcasse, il prigioniero delle Br lo chiamava in causa per fatti ancora più
gravi, che avevano segnato con il sangue la storia italiana degli anni della
"strategia della tensione". Con sentito dolore Aldo Moro dipingeva il leader
democristiano come un freddo calcolatore, con una smodata sete di potere, al
quale veniva attribuito un ruolo centrale nella destabilizzazione eversiva. Tra
le righe del memoriale dedicate al "divo Giulio" il Presidente democristiano
palesava la propria quarantennale diffidenza nei confronti di Andreotti, ben
descritta nell'analisi della carriera politica di quest'ultimo. Moro lo accusava
di avere sempre cercato il suo appoggio alla ricerca di investiture e cariche
nel partito, per poi averlo lasciato come vittima sacrificale nelle mani delle
Brigate Rosse per i propri personali sogni di gloria. Moro dipingeva Giulio
Andreotti come un uomo privo di sentimenti, con la pretesa di identificarsi
vanamente con la figura di Alcide de Gasperi, di cui fu il delfino. Lo accusava
persino di aver abbracciato il Maresciallo Rodolfo Graziani nei primi anni del
dopoguerra, segno di contiguità al defunto regime fascista. La grande colpa di
Andreotti sarebbe stata quella di avere alimentato la divisione
politico-ideologica dell'Italia uscita dalla guerra civile, provocando
una frattura mai sanata dopo l'esclusione dei partiti frontisti dagli incarichi
di governo e la formazione dell'esecutivo con i liberali. Nello scritto riferito
all'allora Primo Ministro, Moro faceva riferimento all'amicizia pericolosa
tra Andreotti e Michele Sindona e metteva in guardia Berlinguer da colui che
avrebbe mandato a morte l'alleato ideatore della "strategia dell'attenzione"
verso il Pci.
La trattativa con le Brigate
Rosse. Aldo Moro, nell'affrontare il tema della trattativa con i terroristi,
premette di essere lucido e in pieno possesso delle proprie facoltà
intellettuali al momento della stesura. La sua è una denuncia integrale della
posizione di "fermezza" assunta da Dc e Pci durante i giorni della sua
prigionia. Da giurista, Moro affermava che il principio di legalità di una
democrazia non può basarsi sul sacrificio di vittime innocenti. Secondo il
prigioniero, la Democrazia Cristiana avrebbe abbracciato incondizionatamente la
linea della fermezza per trarne vantaggio, emergendo come pilastro della
legalità dopo la crisi politica ed elettorale che aveva colpito il partito negli
anni delle rivendicazioni sociali dal 1968 fino al successo comunista del 1976.
L'eversione in Italia. Aldo
Moro si concentra principalmente su tre fatti di eccezionale gravità, che i
brigatisti avevano descritto nei comunicati come sommersi da una montagna di
"omissis": il tentativo di golpe organizzato dal Generale dei
Carabinieri Giovanni De Lorenzo nel 1964 (noto anche come "piano solo"); la
strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e il golpe Borghese del 1970. Sul
caso De Lorenzo, Moro faceva i nomi di chi nella Democrazia Cristiana era al
corrente del piano eversivo, sostenendo la posizione del Generale come pedina e
di fatto scagionandolo. Il motivo della sua difesa sarebbe da ricercare nella
lunga collaborazione tra Moro e De Lorenzo, in particolare nel ruolo di difesa
dell'ordine pubblico che il generale garantì in occasione della grave situazione
di tensione sociale nata dopo i fatti di Genova del 1960 supportando Moro
nell'azione di sfiducia al governo Tambroni ed aprendo di fatto la via alla
lunga esperienza politica del centro-sinistra. Su Piazza Fontana lo statista
democristiano affermava la propria originaria diffidenza sulla piega che presero
le indagini all'indomani dei fatti, la cosiddetta "pista rossa" che vide
coinvolti Pinelli e Valpreda. Moro traeva questa conclusione partendo dal fatto
che gli inquirenti fossero tutti uomini politicamente orientati a destra, che
non avrebbero potuto prendere altre direzioni se non indagare negli ambienti
anarchici. Sul golpe Borghese infine, il redattore del memoriale ne sottolinea
la pericolosità e la reale minaccia che il tentativo rappresentò nel 1970, tesi
supportata dal fatto che il colpo di stato sarebbe stato avvallato da una parte
significativa dei vertici dell'Esercito e del Ministero degli Interni.
La questione palestinese,
l'ingerenza dell'Europa nella politica italiana, il mancato appoggio della Dc a
Paolo VI. Una parte delle pagine dattiloscritte e corrette a penna da Moro
riguardava la questione palestinese, con particolare riferimento al cosiddetto
"lodo Moro", ossia il patto di non-belligeranza con i terroristi del FPLP di Abu
Nidal raggiunto dal leader Dc per tramite dell'uomo del Sid a Beirut, Colonnello
Stefano Giovannone. L'accordo, nel quale era stato coinvolto anche Vito Miceli,
prevedeva lo scambio di prigionieri delle organizzazioni terroristiche
palestinesi in cambio della salvaguardia del territorio italiano da attentati.
Moro aveva incluso l'esempio del lodo per dimostrare che gli stessi soggetti che
allora negavano la trattativa ai fini della sua liberazione, all'epoca
accettarono senza dubbi lo scambio. Il capitolo Europa viene affrontato partendo
da un fatto che aveva interessato i rapporti tra la Comunità Europea e la
politica italiana, risalente al 1964. Il francese Robert Marjolin era all'epoca
vice-presidente della CEE e incontrò a Roma Aldo Moro assieme ai ministri del
governo che lo statista pugliese allora presiedeva. Dal vertice emerse un
atteggiamento fortemente critico, se non aggressivo nei confronti della politica
economica italiana, che Moro difendeva. Marjolin invocava senza mezzi
termini una sorta di austerity ante-litteram che ebbe l'effetto di spaccare gli
equilibri del centro-sinistra al governo e vanificare la speranza in un prestito
europeo per tamponare gli effetti della crisi economica iniziata al termine del
"boom". L'azione fu vista da molti esponenti politici come una decisa e brutale
ingerenza di Bruxelles negli affari italiani. Aldo Moro affrontava quindi uno
dei temi principali del fallimento della trattativa per il suo rilascio,
il mancato appoggio all'iniziativa umanitaria di Papa Paolo VI (amico personale
del prigioniero) in cui anche in questo caso ci sarebbe stata una volontà di
isolamento dell'idea della negoziazione da parte degli esponenti Dc influenti in
Vaticano, che avrebbero fatto leva sui vertici della Santa Sede (in particolare
Monsignor Clemente Riva) affinché anche il Vaticano abbracciasse la linea della
fermezza.
Lo scandalo Lockheed. Secondo
Moro fu il successo del Pci alle politiche del 1976 (quelle del famoso
"sorpasso") a rompere l'egemonia di trent'anni di potere democristiano, nel
quale si sarebbe collocato lo scandalo della commessa militare segnata dalle
tangenti per la fornitura degli aerei da trasporto Lockheed C-130. Lo stesso
Moro fu sospettato fino alla vigilia della strage di via Fani di essere il
personaggio-chiave del sistema delle tangenti (il famoso Antelope Cobbler).
Anche in questo caso l'analisi di Moro si rivelerà anticipatrice, dichiarando
nelle pagine del memoriale che la faccenda Lockheed (che porterà alle dimissioni
del Presidente della Repubblica Giovanni Leone) sarebbe stata solamente la punta
dell'iceberg di un sistema di corruzione diffuso e radicato. Tangentopoli gli
darà ragione.
Pagine mancanti: i Servizi
Segreti italiani in Libia e i rapporti Andreotti-Miceli. Non mancano, nel
memoriale, i riferimenti ai rapporti Italia-Libia. O meglio non mancavano, dal
momento che la parte che riguardava il ruolo degli 007 italiani in Libia
risultò mancante anche dopo il ritrovamento della seconda parte del memoriale
nel 1990. Nei dattiloscritti del 1978 si notavano palesi omissioni e mancati
rimandi alle domande formulate dai carcerieri a riguardo. E' la maggiore e forse
più rilevante omissione che riguarda entrambe le versioni ritrovate nel 1978 e
nel 1990. L'unica traccia rimasta sull'argomento è un passaggio in cui Aldo Moro
loda l'operato dei Servizi italiani attivi durante il regime di Gheddafi. Tutto
faceva pensare ad una sottrazione volontaria della parte riguardante l'operato
del Sid, che comprendeva anche una parte su Giulio Andreotti e i suoi rapporti
conflittuali con il Generale Vito Miceli. La parte del memoriale mai ritrovata
conteneva forse i segreti del caso Moro. Forse gli stessi di cui era a
conoscenza Mino Pecorelli, direttore di O.P. assassinato pochi mesi dopo
l'irruzione nel covo di via Monte Nevoso, il 20 marzo 1979. Esattamente un anno
dopo i giorni del calvario di Aldo Moro.
IL MEMORIALE DI MORO: DI
VERITÀ SI MUORE. CON LE MANIPOLAZIONI, GLI OCCULTAMENTI E I RICATTI SI
SOPRAVVIVE E SI PUÒ PROSPERARE,
scrive Benedetta Tobagi per "la Repubblica" il 5 maggio 2011. Nella "prigione
del popolo", Aldo Moro fu interrogato dalle Brigate Rosse che volevano
estorcergli i segreti di trent´anni di potere democristiano. In piena guerra
fredda, nella palude della corruzione diffusa che sarebbe esplosa con
Tangentopoli, il terrore di ciò che Moro avrebbe potuto dire fece tremare il
governo e allertò i servizi segreti di 16 paesi: il lato più destabilizzante del
sequestro Moro risiedette proprio in questo risvolto spionistico-informativo. I
terroristi non pubblicarono mai gli interrogatori, adducendo motivazioni
contraddittorie e insoddisfacenti; gli originali sono spariti. Di quella "verità
rivoluzionaria" possediamo solo qualche centinaio di fogli: il cosiddetto
"memoriale", in parte rielaborazione degli interrogatori, in parte memoria
difensiva e testamento spirituale denso di durissimi giudizi politici. I
Carabinieri lo ritrovarono nel covo milanese di via Montenevoso con tempi e modi
rocamboleschi: un primo mazzo di dattiloscritti anonimi nell´ottobre ´78 (un
formato "neutro" che consentì al governo di pubblicarli negando che fossero
parola di Moro); una versione più ampia nel ´90, caduto il Muro, esploso lo
scandalo Gladio (cui lo statista alludeva), con fotocopie dei manoscritti
autografi di Moro che ne attestano l´autenticità. Stava dietro un tramezzo di
cartongesso che alimentò infinite dietrologie su chi e perché l´avesse nascosto.
Nel Memoriale della Repubblica (Einaudi, pagg. 624, euro 25) lo storico Miguel
Gotor affronta con successo una sfida ambiziosa: a partire dall´analisi
microstorica dell´odissea di queste carte, vagliando una mole immensa di
documenti, testimonianze e atti processuali, ci racconta l´Italia degli anni
Settanta e l´anatomia nascosta del potere italiano, un mosaico di spinte
eterogenee e contraddittorie nel quadro di pesanti vincoli internazionali.
Allergico alla retorica dei misteri, Gotor completa lo studio analitico del caso
Moro inaugurato con l´edizione commentata delle Lettere dalla prigionia,
portando elementi nuovi in un quadro di più ampio respiro. Intrecciando tenui ma
incontestabili tracce documentali, con uso rigoroso del paradigma indiziario,
deduce l´esistenza di un´operazione "Montenevoso-bis", mai verbalizzata. Dietro
l´occultamento delle fotocopie autografe, l´ombra della cordata di Carabinieri
infiltrata dalla P2 e un doppio terminale di riferimento, Andreotti sul piano
istituzionale, Gelli su quello informale. Le operazioni di disinformazione a
mezzo stampa che, attraverso la figura ambigua dell´ex Carabiniere Demetrio
Perrelli, hanno voluto addossare al defunto Dalla Chiesa l´occultamento dei
manoscritti, sono occasione per un´analisi delle tecniche manipolatore della P2.
Le fughe di notizie e la gestione mediatica dei contenuti del memoriale dal ´78
in poi sono geroglifici attraverso cui indagare l´abbraccio soffocante tra
stampa e potere; si ricostruisce il ruolo ambiguo svolto dal giornalista Mario
Scialoja (ex giornalista dell'Espresso, oggi collabora al sito del settimanale
trattando di vela, NDR), che aveva accesso a informazioni di prima mano dal
partito armato. Il proliferare di versioni contraddittorie, fittizie ma
verosimili, attorno a operazioni delicate come la scoperta e le perquisizioni di
via Montenevoso, consente allo storico di sollevare il velo su alcune tecniche
spregiudicate utilizzate dall´antiterrorismo in Italia. Contro la retorica che
li ha ridotti a monumenti, le figure di Dalla Chiesa e di Moro giganteggiano,
umane e chiaroscurali: emblemi dei dilemmi tragici e dei compromessi
necessariamente posti dall´esercizio del potere, che in loro non fu mai
disgiunto da una visione alta - della politica, dello Stato, dell´Arma. Sono
sconfitti, scavalcati da due lati: dalla spregiudicatezza andreottiana, l´uso
strumentale del potere che mira innanzitutto alla propria conservazione, e dalle
spinte antipolitiche con pretese di purezza: virus trionfanti nel corpo del
potere italiano. Con la libertà di giudizio di chi negli anni Settanta è nato,
Gotor dedica pagine taglienti al cinismo e alle reticenze di quanti si mossero
nella vasta area di contiguità con il terrorismo, che lambiva salotti, giornali,
università. Dentro le Br, l´intelligenza del filologo Fenzi e del criminologo
Senzani si profila nella gestione oculata di passaggi cruciali del sequestro:
con forte afflato civile, lo storico non limita le responsabilità al cerchio
delle risultanze processuali. Non solo Gladio: Gotor ripercorre il memoriale
sopravvissuto, di cui leggiamo ampi stralci, argomenta perché certi passaggi
fossero "pericolosi" prima del ´90 e ci resistuisce lo sguardo di Moro
sull´Italia del suo tempo (è in preparazione un´edizione completa e annotata di
tutti gli scritti della prigionia). Setacciando testimonianze dei "lettori
precoci" del memoriale, morti ammazzati come Pecorelli o sopravviventi come gli
ex brigatisti, desume l´esistenza di un "un-memoriale", un testo originario più
ampio e ipotizza alcuni dei temi censurati: il golpe Borghese, la fuga del
nazista Kappler, il cosiddetto "lodo Moro" che regolava i conflitti tra
palestinesi e israeliani in Italia. Il crudo ammonimento evangelico agli
ipocriti posto in esergo addita un percorso di lettura nella meditazione sul
rapporto tra verità e potere. Il controllo dell´informazione resta il più
formidabile ed elusivo strumento di dominio: una partita feroce giocata tra
propaganda e segreto, utilizzando sofisticate mescolanze di vero, falso e
verosimile. Di verità si muore, come Pecorelli e Dalla Chiesa. Grazie al
combinato di manipolazione, occultamento e mercati ricattatori si può
sopravvivere, vivere, financo prosperare, provano le diverse ma convergenti
strategie di Brigate Rosse, Andreotti, Gelli. Il ragionare metodico dello
storico che riconosce la realtà brutale della politica senza cedere al cinismo,
chino a ricomporre i frammenti per sottrarre il potere urticante della verità
alla fisiologica usura del tempo, è un vaccino - non solo un´autopsia - al corpo
infetto del potere. Raccoglie la sfida di cui Moro prigioniero aggrappato alla
propria scrittura fu l´incarnazione più tragica: l´intelligenza degli
avvenimenti resta, ancora, "punto irriducibile di contestazione e di
alternativa".
SCIALOJA CONTRO
"REPUBBLICA": "MAI STATO AMBIGUO NELLA CRONACA SULLE BR".
Lettera di Mario Scialoja a "la Repubblica" dell'5 maggio 2011. Leggo
nell'articolo di Benedetta Tobagi su libro di Miguel Gotor Il memoriale della
Repubblica che l'autore «ricostruisce il ruolo ambiguo del giornalista Mario
Scialoja che aveva accesso a informazioni di prima mano dal partito armato». Ho
scorso il libro e constatato che l'autore, bontà sua, mi cita in ben 44 pagine.
Non capisco quale ambiguità possa venir attribuita a un cronista che ha sempre
pubblicato sull'Espresso tutte le notizie di cui veniva in possesso. Cosa mai
messa in discussione. Quanto ai miei «sin troppo informati articoli», come li
definisce Gotor, ribadisco quanto ho sempre detto ai magistrati che mi hanno
sentito nel corso degli anni e in Commissione Stragi: nessuna informazione mi è
venuta attraverso un contatto diretto con l'area Br. Bensì tramite persone
(Piperno, Scalzone ...) che potevano ricevere notizie dall'interno del gruppo
armato. Sarebbe lunghissimo controbattere a tutte le ipotesi e connessioni
fantasiose avanzate dall'autore. Solo un esempio. Gotor, parlando dell'incontro
a Roma nel luglio '78 tra Piperno e Moretti «avvenuto in una casa alto borghese
situata nei dintorni di piazza Cavour», osserva una «curiosa coincidenza
topografica». Sostiene che io nel '78 abitavo dalle parti di piazza Cavour e che
quindi la casa della «clamorosa riunione» potesse essere proprio la mia. Il che
spiegherebbe, secondo lui, il mio essere tanto informato, ecc. Purtroppo, nel
'78 (e fino al 1980) abitavo a via San Valentino 18. Tutt'altra zona di Roma.
LE DUE BOMBE DI ETTORE
BERNABEI: "LE LETTERE DALLA PRIGIONIA NON SONO SCRITTE DA MORO. IO CREDO AI
SOLERTI 007 CHE HANNO UBICATO IL SUO BARBARO OMICIDIO TRA LE MURA DI PALAZZO
CAETANI".
Dall'intervista di Malcom Pagani a Ettore Bernabei per "l'Espresso".
La dietrologia comunque non le
dispiace.
"Spesso converge con la
verità. Pensi al povero Aldo Moro".
Lei Moro lo conosceva bene.
"Benissimo. Lui e la sua
calligrafia. Le lettere dalla prigionia, ad esempio, non sono scritte dalla sua
mano. Se si vuole intuire qualcosa della recente parabola italiana, bisogna
partire dal sogno energetico di Enrico Mattei".
Perché proprio Mattei?
"Il suo progetto,
l'autosufficienza a basso costo per l\'Italia, irritò le grandi potenze.
Disturbavamo. Da allora, il progetto di destabilizzazione del Paese non conobbe
soste. Lo sapevano in Vaticano e ne tenevano conto in Piazza del Gesù".
Tra il tramonto dei Sessanta e
i Settanta l\'Italia fu scossa da tragedie. Anni di caos.
"Stragi, bombe, terrorismo. I
brigatisti rossi erano omuncoli di rara modestia. Mai avrebbero potuto sostenere
lo sforzo economico e ideologico della loro mattanza".
Quindi?
"Erano eterodiretti. Qualcuno
ha calcolato che l\'operazione costò in termini economici tra covi, armi e
coperture, più della guerra del Vietnam".
Se le dico lobby cosa le viene
in mente?
"Il clan dei sardi è stato, in
Italia, l'unico vero gruppo di potere degli ultimi 50 anni. Politica,
massoneria, matrimoni in chiesa, parentele, trasversalità. Berlinguer,
Siglienti, Segni, Cossiga. Ricorda le picconate?"
Certo.
"Chi le scriveva per lui,
sapeva quali messaggi trasmettere. Tra le righe, si sostenevano cose enormi, ma
non c'era un solo passaggio che lo avrebbe potuto trascinare all'impeachment. Il
Cossiga scosso dal caso Moro e messo a terra dalla vicenda Donat Cattin-Prima
Linea, seppe poi adeguatamente risorgere".
Divenne presidente della
Repubblica.
"All'unanimità. Dovrebbe far
riflettere".
Aldo Moro, la profezia
sulle Br e il leader Dc: “Il Presidente deve morire”.
Il “piano b” - Nel ’69 l’articolo del “Bagaglino”: “Dio lo salvi”. Il leader Dc
isolato anche per i dubbi di Berlinguer. Il 16 marzo in via Fani era tutto
pronto, scrive Miguel Gotor il 16 marzo 2018 su "Il Fatto Quotidiano". Il 16
marzo di quarant’anni fa, le Brigate rosse rapirono in via Fani Aldo Moro e
sterminarono la scorta composta da Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico
Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Quella mattina passarono a prenderlo e
se lo portarono via come se si fossero dati un appuntamento. Nelle ultime due
settimane Moro si era esposto troppo, fino a rimanere isolato. Nel corso del
discorso ai gruppi Dc del 28 febbraio 1978 aveva forzato il passo per
raggiungere l’obiettivo di includere i comunisti nella maggioranza di governo,
per la prima volta dal 1947. Un coraggioso atto di imprudenza, forse l’unico
e l’ultimo della sua vita politica, in ragione dell’addensamento, in quegli
ultimi mesi, delle resistenze del contesto internazionale della Guerra fredda e
della vischiosità del fronte interno e degli apparati. Uno strappo che aveva
fatto sì che Moro diventasse l’unico personale garante di quell’accordo, mentre
nelle stesse ore Enrico Berlinguer diventava sempre più dubbioso e
recalcitrante. Il colpo, secco e feroce, venne da sinistra, dagli esponenti del
“partito armato”, ma avrebbe potuto arrivare da destra, dai cosiddetti
“strateghi della strategia della tensione” e il risultato non sarebbe cambiato.
Per persuadersi di questo meccanismo basterebbe prendere sul serio un articolo
premonitore di Pier Francesco Pingitore che uscì nel 1969 sul Bagaglino
intitolato “Dio salvi il presidente” in cui venivano descritti, con satirico e
informatissimo puntiglio, il percorso che Moro faceva ogni mattina, le sue
abitudini, il numero dei poliziotti di scorta, le qualità delle armi da usare
per colpirlo, il punto esatto dove sarebbe stato agevole ucciderlo (presso
la Chiesa di Santa Chiara secondo il “piano a” e proprio in via Fani secondo il
“piano b”). Un articolo minacciosamente premuroso (talora la satira serve a
veicolare le veline dei servizi e avvertimenti serissimi) che iniziava ponendosi
questa domanda: “Quindici uomini vegliano sulla vita dell’onorevole Moro. Ma
sarebbero sufficienti a difenderlo contro un Oswald italiano?”, oppure dal
pugnale del fanatico cattolico che uccise nel 1589 il re di Francia Enrico III,
il cui omicidio era ricordato in posizione enfatica alla fine dell’articolo,
sottolineando come fosse protetto da ben 45 uomini di scorta e non solo 15 come
Moro. In realtà l’operazione ordita dalle Brigate rosse nove anni dopo l’uscita
di questo scritto si sarebbe rivelata più raffinata: non un semplice regicidio,
come quelli avvenuti più volte nella storia, a partire da Giulio Cesare, ma il
suo sequestro e, poi, l’uccisione. L’eccezionalità della vicenda Moro è tutta
qui: è il rapimento di un sovrano che si conclude con la sua morte, non un
assassinio e basta. Un sequestro di persona che sarebbe equivalso al sequestro
di uno Stato a partire dal suo capo (e capo dello Stato in senso proprio Moro lo
sarebbe diventato se avesse vissuto ancora qualche mese) dei suoi segreti, delle
sue informazioni sulla sicurezza nazionale ed estera. Un rapimento funzionale a
distruggerne l’integrità morale, civile e politica, a massacrarne l’immagine in
modo che quel disegno di tessitura e di conciliazione non potesse avere
continuatori. In tanti avevano l’interesse, sia tra le eterne fazioni delle
contrade nostrane sia tra le nazioni amiche, che l’Italia rimanesse lacerata e
in balia degli eventi perché negli ultimi trent’anni quel Paese si era
eccessivamente allargato, perdendo la guerra ma vincendo la pace, e perciò
facendosi troppi nemici. Soltanto nel marzo 1990 si conobbero i nomi di nove
partecipanti all’agguato, canonizzati nel memoriale del brigatista
dissociato Valerio Morucci, redatto nel 1986 e inviato riservatamente all’allora
presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. In base a questo documento, su
cui ancora oggi si fonda la verità giudiziaria sull’agguato di via Fani, quel
giorno entrarono in azione Franco Bonisoli, arrestato nell’ottobre
1978, Prospero Gallinari, Raffaele Fiore e Valerio Morucci, catturati nel
1979, Bruno Seghetti, imprigionato nel 1980, Mario Moretti, carcerato nel
1981, Barbara Balzerani, arrestata nel 1985, Alvaro Lojacono, catturato nel
1988, ma poi espatriato in Svizzera, e Alessio Casimirri, tuttora latitante
in Nicaragua. In un’intervista dell’ottobre 1993, Morucci si ricordò anche
di Rita Algranati, moglie di Casimirri, arrestata nel 2004. I brigatisti
portarono via due delle cinque borse di Moro e, nella concitazione dell’azione,
bisogna riconoscere che seppero scegliere con chirurgica precisione: presero
infatti la borsa con le medicine e quella, secondo la testimonianza della
moglie, con i “documenti riservatissimi”. L’agguato di via Fani accelerò la
formazione del nuovo governo Andreotti e lo stesso giorno i sindacati
proclamarono lo sciopero generale. Nelle principali città si tennero
manifestazioni in cui le bandiere rosse del Pci e quelle bianche della Dc si
confusero con i vessilli dei sindacati. Nella tarda mattinata gli esponenti
di Autonomia operaia e del movimento studentesco tennero un’assemblea presso
l’Università di Roma: esaltazione, euforia, eccitazione, ammirazione,
smarrimento, paura, dubbio e attesa composero l’ampia e contraddittoria gamma
sentimentale di questo vasto schieramento giovanile. Un’atmosfera tesa e
sfuggente che il trascorrere degli anni e i balsami della memoria e del
reducismo avrebbero contribuito a offuscare, fra una serie di inevitabili
rimozioni, ambiguità e reticenze generazionali: chi aveva sparato a via Fani non
era un marziano, ma un compagno di banco o magari il ricordo del primo bacio. Il
giornale Lotta Continua l’indomani intitolò: “Respingiamo il ricatto: né con lo
Stato, né con le Br”, facendo riferimento al clima di quest’assemblea. Uno
slogan che, se vogliamo dirla tutta, coglieva lo spirito del tempo non soltanto
fra quelle fasce studentesche, ma fra ampi strati del mondo operaio e della
piccola e media borghesia italiana in cui diffusi umori giustizialisti e
antiparlamentari lasciavano mormorare: poveri uomini della scorta, certo, ma
Moro era un politico di “Palazzo” e dunque…A quarant’anni dalla strage di via
Fani, il numero di quanti vi parteciparono è incompleto, ma viene da chiedersi
se questo oggi sia un dato storico rilevante e non l’ovvietà che caratterizza
ogni omicidio politico. Da alcune testimonianze oculari è possibile dedurre che
furono presenti all’agguato perlomeno altri due individui, i quali agirono a
bordo di una moto Honda, anche se i brigatisti hanno sempre smentito questa
presenza, che li costringerebbe ad ammettere le relazioni intercorrenti tra le
Br e le altre componenti del cosiddetto “partito armato”. Vale a dire la miriade
di sigle, che spuntavano come funghi, composte in buona parte da una minoranza
di ex militanti di Potere Operaio e di Lotta continua, i quali, dopo lo
scioglimento delle due organizzazioni, invece di ritornare a casa o alle libere
professioni dei padri, avevano preferito, sull’onda di ritorno del movimento del
1977, impugnare le pistole e imboccare la strada della lotta armata. E che dire
poi di un confronto con il sequestro del magistrato Mario Sossi, realizzato
dalle Brigate rosse nel 1974: allora non fu necessario eliminare la scorta, e
sappiamo che vennero impiegati almeno 18 uomini, contro i dieci di via Fani. Un
altro dato di fatto induce a ritenere che i numeri non tornano: nelle ore
successive al sequestro le Brigate rosse fecero beffardamente ritrovare ben tre
macchine utilizzate nell’agguato tutte in una stesso posto, la piccola
via Licinio Calvo, un’operazione logistica che, oltre a una spiegazione
ragionevole ancora mancante, deve avere richiesto la collaborazione di una
manovalanza più numerosa. Anche la dinamica dell’agguato, quella restituita
dalle testimonianze dei protagonisti e dalle non meno scivolose perizie
balistiche, suggerisce la presenza di altre persone ancora non identificate.
Un’azione non semplice perché si trattò di colpire i bersagli in modo selettivo,
ossia uccidendo i due occupanti della vettura di Moro, ma lasciando incolume
l’ostaggio da prelevare, colui che, secondo un testimone oculare, avrebbe urlato
(e si fa fatica a immaginare Moro urlare) “mi lascino andare, cosa vogliono da
me”. Sull’agguato di via Fani si stese prontamente la coltre ideologica della
“geometrica potenza di fuoco” di un osservatore interessato come Franco Piperno,
ma in realtà le perizie e le stesse testimonianze dei brigatisti dicono altro.
In effetti, l’aspetto più paradossale di tutta la storia è proprio questo:
tutti, nessuno escluso, hanno raccontato che le loro armi si incepparono nel
corso dell’azione. Del resto, la seconda perizia ha stabilito come l’armamento
utilizzato dai brigatisti fosse per oltre un terzo composto da veri e propri
“residuati bellici” come ammesso dallo stesso Moretti. L’intervento di un
tiratore scelto – per gli esegeti della Commissione Moro, un quinto sparatore da
destra non ancora identificato che avrebbe giustiziato con un colpo di grazia il
maresciallo Leonardi – potrebbe spiegare perché i brigatisti del gruppo di fuoco
scelsero di indossare delle divise di aviere, rendendosi in questo modo più
facilmente individuabili così da evitare di essere colpiti dal fuoco amico di un
possibile tiro incrociato. L’ultima commissione Moro ha accertato la presenza di
due macchine dalla posizione sospetta: un’Austin così malamente collocata da
impedire alla vettura della scorta di Moro di svincolarsi (un particolare notato
dallo stesso Morucci nel suo memoriale) e una Mini Cooper parcheggiata davanti
alle fioriere dove si nascose il gruppo di fuoco. Le tardive ricerche sui loro
proprietari hanno rivelato in entrambi casi dei profili biografici gravitanti
nell’area dei servizi segreti nazionali. Un dato di fatto, ma anche le
coincidenze possono esserlo. Le ultime testimonianze avvistarono Moro e i suoi
rapitori in piazza Madonna del Cenacolo. Secondo la versione diffusa a rate dai
brigatisti (peraltro gravida di evidenti contraddizioni logiche e pratiche)
sarebbe stato portato in via Montalcini, nel quartiere della Magliana, da dove
non si sarebbe mai mosso nel corso dei 55 giorni più bui della storia della
Repubblica. Grazie all’attività della Commissione Moro oggi sappiamo che
Gallinari, nell’autunno 1978, trovò rifugio in via Massimi, a poche centinaia di
metri da via Fani e da via Licinio Calvo, dove vennero rilasciate le macchine
del sequestro. Evidentemente in quello stabile di proprietà dello Ior, abitato
da alti prelati, diplomatici, giornalisti, agenti e società di copertura di
servizi segreti mediorientali e statunitensi, Gallinari dovette sentirsi
sufficientemente al sicuro. Oppure, più banalmente (perché questa al fondo,
fatta salva l’eccezionalità della vittima, è una storia banale se si pensa che
la maggioranza dei sequestri termina con la morte dell’ostaggio), gli assassini
ritornano sempre sul luogo del delitto.
Aldo Moro, le Br e la
“strategia delle lettere” per beffare lo Stato, scrive Miguel Gotor il 30
marzo 2018 su "Il Fatto Quotidiano". Come uno sparo nel buio: così risuonarono,
dopo tredici interminabili giorni di silenzio, le prime tre lettere di Aldo
Moro recapitate dalle Brigate rosse il 29 marzo 1978. La prima era indirizzata
alla moglie Eleonora, la seconda al ministro degli Interni Francesco Cossiga e
la terza a Nicola Rana, capo della segreteria politica di Moro. Nella tarda
serata, i brigatisti fecero ritrovare un comunicato, cui allegarono la fotocopia
della lettera a Cossiga (solo quella) che pervenne contemporaneamente alle
redazioni di alcuni giornali di Roma, Milano, Genova e Torino, dando così prova
di un imponente coordinamento e dispiegamento di forze che rivelava una
logistica e una organizzazione ramificate a livello nazionale. Queste tre
lettere sono importanti, anzi decisive, per diversi motivi in quanto
costituirono il momento genetico della complessa “operazione Moro” e, come una
prima cellula cancerogena, ne preannunciarono lo svolgimento futuro e l’esito
finale. Sul piano della “propaganda armata” e della battaglia comunicativa
determinarono i successivi orientamenti dell’opinione pubblica italiana
concorrendo a formare l’immagine del prigioniero che occupò lo spazio mediatico
in quei 55 giorni. I sequestratori dispiegarono una micidiale strategia
differenziata dei recapiti che divenne parte integrante della loro azione
terroristica. In un primo momento inviarono le tre lettere in originale a Rana
così da potere saggiare il comportamento dei destinatari, ma subito dopo
stabilirono di divulgarne una sola (quella a Cossiga), decidendo così loro
quanto doveva restare segreto e quanto essere offerto in pasto all’opinione
pubblica. In questo modo, costrinsero da subito il governo all’inseguimento e i
famigliari del rapito ad acconciarsi ai tempi e ai modi della loro strategia
comunicativa. In secondo luogo, sul piano della lotta politica visibile, le due
lettere a Cossiga e a Rana (che vanno lette insieme come un’unica missiva)
innescarono la dimensione spionistico-informativa del sequestro. Il prigioniero,
infatti, spiegava che era in gioco la ragione di Stato, che si trovava “sotto un
dominio pieno ed incontrollato”, che era sottoposto a un “processo popolare” e
che poteva “essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere
sgradevole e pericolosa in determinate situazioni”. In terzo luogo, con queste
due lettere i brigatisti lasciarono che Moro indossasse direttamente i panni del
capo del fronte della trattativa così da potere loro conservare uno spazio di
autonomia e di libertà di manovra e di smentita. L’ostaggio, infatti, propose un
esplicito scambio di prigionieri a condizione però che la trattativa rimanesse
segreta. Bisognava quindi limitarsi a informare il capo dello Stato Giovanni
Leone, il presidente del consiglio Giulio Andreotti “e pochi qualificati capi
politici” che è facile immaginare rispondessero alle figure di Enrico
Berlinguer, Bettino Craxi, Ugo La Malfa e forse Amintore Fanfani. Inoltre Moro
indicava con chiarezza a chi rivolgersi per favorire il negoziato, ossia
alla Santa Sede, essendo ben consapevole di come quel sentiero
extra-territoriale avesse per secoli svolto un delicato ruolo di intermediazione
tra i governanti della penisola e di compensazione dei conflitti fazionari.
Infine, il comportamento adottato dai sequestratori con queste due missive
mostra oggi come allora che i brigatisti in realtà erano ben interessati ad
avviare una trattativa segreta che a parole negavano perché “nulla doveva essere
nascosto al popolo”. Non si tratta di illazioni, ma di una semplice analisi
delle loro effettive azioni, tutte efficaci e razionali. I brigatisti, infatti,
dopo avere consegnato riservatamente le due lettere e avere garantito al
prigioniero che il loro contenuto non sarebbe stato reso pubblico decisero di
divulgare quella indirizzata a Cossiga. Oggi sappiamo che contemporaneamente
fecero credere al prigioniero che non erano state loro a violare i patti, ma il
ministro dell’Interno cui Moro rivolse una seconda lettera di rimprovero,
scritta intorno al 4-5 aprile, che si guardarono bene dal recapitare, ritrovata
soltanto nell’ottobre 1978 come dattiloscritto e in fotocopia autografa
addirittura nell’ottobre 1990. In questo modo i brigatisti nel loro comunicato
serale non persero l’occasione per farsi beffe di Moro, di Cossiga e della Dc e
di conquistare punti davanti all’opinione pubblica italiana sostenendo che
“le manovre occulte sono la normalità per la mafia democristiana”. Allo stesso
tempo, però, vollero tutelare la riservatezza della seconda missiva, quella
indirizzata a Rana, il cui contenuto rimase segreto per loro scelta. Il
contenuto di questa lettera era sostanzialmente identico a quello della missiva
a Cossiga ma con una preziosa novità: Moro, infatti, individuava nella
portineria dell’abitazione privata del suo collaboratore il luogo da utilizzare
per far pervenire dei messaggi riservati dall’esterno all’interno della prigione
e viceversa e invitava Cossiga a difendere la segretezza di questo canale di
ritorno. Così facendo i brigatisti dimostravano all’antiterrorismo e agli uomini
politici più avveduti che proprio quella era la preziosa informazione che essi
volevano salvaguardare per futuri ed eventuali utilizzi. Che insomma, un conto
erano le parole dette al popolo, un altro le loro effettive intenzioni che
spietatamente avrebbero perseguito. Non a caso, tre giorni dopo il recapito di
questa missiva rimasta segreta iniziò la vera partita, giocata mediante una
serie interminabile di finte e controfinte, che avrebbe previsto l’avvio di un
doppio e intrecciato canale, riservato (primo livello, con l’“iniziativa”
socialista/Franco Piperno) e segreto (secondo livello, con il “negoziato”
Vaticano) e che avrebbe coinvolto proprio la Santa Sede nella persona di Paolo
VI e la famiglia pontificia lungo l’esile ma tagliante filo della ragion di
Stato. Una dottrina di matrice cattolica, realistica, serissima e feroce, che
già Benedetto Croce aveva definito “un Dio ascoso”: dunque non stupisce che
avrebbe coinvolto persino lo spirito di Giorgio La Pira, che sarebbe stato
interrogato nel corso di una seduta spiritica il 2 aprile 1978 e di seguito
certamente invocato da Moro in una lettera d’addio non recapitata con un
enigmatico “spero mi aiuti in altro modo”, di cui però parleremo la prossima
volta. E già, in altro modo.
Un gigante timido in quel
bel miracolo che fu la prima repubblica.
È morto a 92 anni Giovanni Galloni, dimenticato, uno dei protagonisti della
politica italiana, scrive Piero Sansonetti il 25 Aprile 2018, su "Il Dubbio".
È morto l’altroieri, a 92 anni, Giovanni Galloni. Ieri non ho trovato traccia di
questa notizia sulle prime pagine dei giornali. E neanche sulle homepage dei
siti, che pubblicavano altre notizie e ci informavano anche della morte di altre
persone, ma non di Galloni. Un personaggio, evidentemente, considerato come una
figura minore dai giornalisti e dagli intellettuali. Un politico puro (oltre che
un giurista) sobrio, poco conosciuto in Tv, riservato, percettore di vitalizio.
Diciamo pure un uomo trascurabile. Casta, casta…No, non è solo una questione di
nostalgia. È un fatto indiscutibile: lo spirito pubblico in questi anni ha
subito un fortissimo decadimento, e l’annientamento della politica e il
disprezzo per l’immaginario che la politica suscitava, sono stati probabilmente
due delle cause di questa deriva. Chi era Giovanni Galloni ve lo racconta
Francesco Damato nell’articolo che pubblichiamo qui accanto. Damato lo ha
conosciuto molto bene. Io l’ho conosciuto poco, sul piano personale, ma ricordo
benissimo del ruolo decisivo che ebbe Galloni nella politica italiana,
soprattutto nella stagione della solidarietà nazionale, cioè negli anni del
grande riformismo che trasformò questo paese e lo fece approdare alla modernità.
Galloni era uno dei cervelli pensanti più rigorosi e lungimiranti di quella
macchina politica che fece vivere la prima repubblica, e portò l’Italia a grandi
successi, nonostante l’asprezza della lotta e del clima politico di quegli anni,
e le grandi difficoltà dell’economia. Allora il ceto politico era molto ampio e
variegato. C’erano i burocrati, c’erano gli organizzatori, c’erano quelli capaci
di aggregare il consenso, i clientelari, i combattenti, e poi c’erano anche i
cervelli, gli strateghi, gli intellettuali. Un vero leader politico doveva
essere in grado di coprire diversi questi ruoli. E comunque gli si chiedeva di
essere un intellettuale. I leader politici erano molto colti. Come Moro,
Amendola, Ingrao, Lombardi, La Malfa, Fanfani. Tutti loro erano leader nel senso
pieno, organizzatori, creatori di consenso, oratori, pensatori. Galloni era
soprattutto un pensatore, che agiva in gruppo, ma credo che senza la sua
capacità di pensiero, ma anche la sua prudenza e le sue doti di mediatore, la
solidarietà nazionale sarebbe stata impossibile. Berlinguer e Moro la
disegnarono, ma Galloni fu decisivo nel gestirla e nel trasformarla in una
stagione di grande riformismo. Anche dopo la morte di Moro e durante la fragile
segreteria Zaccagnini. Vi dicevo che un pochino l’ho conosciuto anche
personalmente. E’ stato nel 1968. Andavo a scuola dai preti a piazza di Spagna,
e a scuola con me c’era il figlio di Galloni, Nino, che oggi è un economista
noto. Allora, insieme, organizziamo le (piccole e un po’ clandestine) proteste
politiche. Ai preti non piacevano. Una volta ci sorpresero a distribuire
volantini fuori dal portone e ci rifilano 15 giorni di sospensione. Allora,
insieme ad altri compagni di scuola un po’ rivoltosi, ci riunimmo a casa di
Nino, per prendere delle contromisure. Stavamo chiusi lì, a discutere in una
nuvola di fumo, quando si aprì la porta ed entrò l’onorevole Galloni, con un
libro in mano, sorridente. Ci lesse qualche riga di questo libro ed erano righe
che spiegavano quanto fosse velleitaria la battaglia che noi stavamo conducendo.
Poi alzò lo sguardo verso di noi e citò l’autore di quelle righe, scandendo bene
le tre parole: Vladimir – Ilic – Lenin. Sorrise di nuovo e andò via. Votò
inutilmente per Moro, mentre gran parte dei suoi colleghi di corrente votò per
Leone, il cui figliolo Mauro d’altronde era già o sarebbe diventato presto – non
ricordo più bene consigliere nazionale della Dc proprio per la sinistra di Base.
“Hanno fatto – mi confidò Galloni parlando degli amici di corrente – un torto
ingiusto a Moro e un cattivo servizio a Leone, condannandolo a gestire una fase
politica pericolosa”. Il centrosinistra infatti si interruppe. La Dc sostituì i
socialisti con i liberali di Giovanni Malagodi al governo e si incamminò verso
quel referendum sul divorzio che, gestito proprio da Fanfani alla segreteria del
partito nel 1974, avrebbe compromesso duramente la lunga primazia politica dello
scudo crociato. Ma di Leone il povero Galloni era destinato ad occuparsi
drammaticamente nella primavera del 1978, dopo la tragica fine di Moro, che già
l’aveva tormentato partecipando come vice segretario della Dc alla gestione
della cosiddetta linea della fermezza. Una linea dove Moro, dalla prigione delle
brigate rosse, stentava a credere davvero che fosse sinceramente attestato
l’amico Galloni, di cui faceva ricorrentemente il nome nelle lettere ai
democristiani incitandoli a salvargli la vita, anche a costo di trattare con i
terroristi che lo avevano sequestrato sterminandone la scorta. Alla fine di Moro
seguì quella anticipata del settennato presidenziale di Leone. Ebbene, toccò
proprio a Galloni andare al Quirinale, mandatovi dal segretario del partito
Benigno Zaccagnini, per chiedere al capo dello Stato il “sacrificio” delle
dimissioni, reclamate con una paradossale simmetria dai radicali di Marco
Pannella e dal Pci di Enrico Berlinguer continuava a scrivere e a pubblicare,
facendoci lo sconto sui prezzi di copertina: saggi della consueta lucidità.
Giovanni non riuscì mai a dimenticare, in particolare, il rude trattamento
riservatogli dall’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga, quando
lui ne era il vice al vertice del Consiglio Superiore della Magistratura.
Cossiga arrivò nel 1991 a ritirargli pubblicamente quasi tutte le deleghe,
restituitegli poi dal successore Oscar Luigi Scalfaro. La contesa, chiamiamola
così, era scoppiata attorno al diritto nuovamente rivendicato da Cossiga, dopo
un episodio analogo verificatosi col precedente Consiglio Superiore, ai tempi
del governo Craxi, di dire l’ultima parola sugli ordini del giorno dell’organo
di autogoverno della magistratura. La cui presidenza è affidata dalla
Costituzione al capo dello Stato. I rapporti tra la magistratura e il Quirinale
erano tesissimi. Si arrivò alla proclamazione di uno sciopero nei tribunali
contro il presidente della Repubblica, cui si rifiutò di aderire a Milano, con
tanto di cartello appeso alla porta del suo ufficio, il sostituito procuratore
Antonio Di Pietro. Che Cossiga naturalmente volle poi conoscere personalmente,
instaurando con lui rapporti altrettanto naturalmente destinati poi a rompersi.
Ma la vice- presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura fu dolorosa
per Galloni anche dopo la presidenza di Cossiga, in particolare quando le
inchieste giudiziarie sul finanziamento illegale della politica travolsero i
partiti di governo e l’intera cosiddetta prima Repubblica. Galloni era sommerso
dalle proteste di vecchi amici di partito e non, che volevano da lui interventi
risolutivi contro questo.
GALLONI. QUANDO SINISTRA
ERA ANCHE LA DC,
scrive il 25 aprile 2018 Roberto Di Giovan Paolo su "Ildomaniditalia.eu". Le
biografie di un’epoca in cui mancano non solo le ideologie ma spesso anche
ideali, ci raccontano solo la sequela degli incarichi ma Galloni non fu certo
una “seconda fila”. Sin da ragazzo. Giovanni Galloni, al di là delle biografie
ufficiali, dell’ex ministro della pubblica istruzione (il successore della
eterna Falcucci e il predecessore dell’attuale presidente della repubblica,
Sergio Mattarella), è stato molto di più di una figura di spicco della
Democrazia Cristiana, perché forse come pochi cattolici in politica ha saputo
essere un ideologo, rispettato culturalmente e talvolta bistrattato
politicamente anche dai suoi amici, nonostante abbia certamente vissuto una vita
politica di primissimo piano, in cui oltre all’incarico di ministro è stato sei
volte parlamentare, visegretario e vicepresidente dc e direttore de Il popolo.
In un versante di mondo – quello cattolico – troppo spesso dominato dalla
retorica dei valori e dal pragmatismo incombente delle scelte quotidiane –
specie dopo la vittoria del 1948 che proiettò la Dc saldamente al governo –
Giovanni Galloni ha mantenuto viva una battaglia ideale e un confronto
ideologico che, con scritti, discorsi ed azioni politiche ha avuto pochi eguali,
forse soli Guido Bodrato, Luigi Granelli e Carlo Donat Cattin, della sua
generazione. Galloni è stato il collante e il riferimento ideologico di più di
una generazione Dc, perché aveva cominciato presto a far politica, staffetta
partigiana in Emilia Romagna, a Bologna dove la sua famiglia si era trasferita
dalla Sicilia. Era stato, direi “naturalmente” tra i giovani che poi avevano
seguito l’impegno politico di Giuseppe Dossetti, al punto di essere tra coloro
presenti al secondo incontro di Rossena, nel 1951 quando il leader di minoranza
della Dc annunciò l’addio alla politica e le dimissioni da vicesegretario dc e
da deputato della Repubblica. Di quel dibattito (con Dossetti stesso poco,
perché egli non voleva discutere un arretramento della sua scelta e fu
categorico, ma di e con altri parecchio “forte” e che si è conosciuto solo nel
tempo con una certa reticenza dei protagonisti, Giovanni Galloni fu testimone
certo e ne scrisse in riviste (come Iniziativa Democratica e poi più in là in
Appunti, ma anche in molti libri, ultimo quello su “Dossetti Profeta”), o forse
si dovrebbe dire, che lo visse sulla sua pelle, sempre, in tutti i lunghi anni
della sua vita politica. Quel dibattito verteva sulla condizione del
cattolicesimo democratico nel nostro Paese e sulla ferrea presa di De Gasperi
sulla Dc. Dossetti in sostanza diceva che le premesse della Resistenza per un
cambio sociale nel Paese erano rimaste deluse ed i cattolici avevano grandi
colpe in ciò (Nicola Pistelli anni dopo parlò di “rachitismo politico” dei
cattolici italiani) e dunque nelle condizioni date De Gasperi rispondeva al
massimo di progresso politico possibile per un movimento che non poteva andare
oltre le sue radici. Giuseppe Dossetti, che con la sua corrente dopo lo sforzo
fortissimo dei “professorini” per la nascita della Costituzione aveva contestato
le modalità dell’Alleanza atlantica, aveva richiesto una riforma agraria
complessiva e piani generali per il lavoro e per la casa (le “attese della
povera gente” di La Pira) e cosa si ritrovava ora? Un partito baluardo contro il
comunismo conservatore socialmente e che senza de Gasperi avrebbe ripiombato
l’Italia nel conservatorismo politico ante Costituzione. Dunque, addio alla
politica, almeno per lui. In attesa che il mondo cattolico evolva per cambiare
poi la rappresentanza politica dei cattolici (e infatti prende i voti monacali…)
Ma per chi resta? Tra cui Giovanni Galloni e tanti altri? Dossetti elabora la
teoria dei “due piani”: chi vuole faccia formazione politica per accelerare il
cambio di condizione culturale dei cattolici e del Paese; chi invece vuol
continuare in politica sappia che dovrà rafforzare De Gasperi, anche se non lo
ama, perché è l’unico argine al rischio di conservatorismo politico. Nel dire
questo Dossetti si rivolge esplicitamente a Galloni e agli altri dei gruppi
giovanili. E da lì prende le mosse il lavoro politico interno alla Dc di
Giovanni Galloni. Il quale resiste due anni ma poi a Belgirate nel 1953 con
altri, tra cui Marcora su tutti, dà vita alla corrente di “sinistra di Base”, la
prima corrente di sinistra dc che punta decisamente sul cambio strutturale dello
Stato (riforme strutturali, riforme istituzionali, confronto politico con tutti)
e non solo sul miglioramento delle condizioni sociali o di mero eco delle
battaglie sindacali. La sinistra di Base è stata la casa di Giovanni Galloni per
tutta la sua vita. Una casa di famiglia, da cui ha polemizzato con Fanfani,
uscito dalla corrente dossettiana convinto che solo il controllo pieno del
partito portasse al controllo del governo, e in cui ha incontrato dall’inizio il
brillante operaio Italsider Luigi Granelli (poi parlamentare e ministro), e gli
studenti della Cattolica, Ciriaco De Mita e Riccardo Misasi, la corrente di cui
è stato l’“anello romano” per Giovanni Marcora. Moro? Certo Aldo Moro era tra le
amicizie più care ma il leader barese era restio al lavoro organizzato di una
corrente a suo modo “scientifica” come la “sinistra di Base”. Rimasero
l’amicizia e la consonanza “dossettiana” tutta la vita, fino al momento del
comune concepimento della solidarietà nazionale e della tragedia del rapimento e
dell’uccisione di Moro, ma non sempre si trovarono a fare il congresso Dc
assieme, perché le tattiche di Moro e dei basisti spesso divergevano, anche per
i numeri oggettivamente diversi. Giovanni Galloni fu l’ideologo di Marcora e
della Base per l’apertura prima ai socialisti e poi al confronto con il Pci (qui
assieme a Moro, certamente) e fu, assieme a Bodrato, colui che mise assieme
tutte le anime delle sinistre dc per vincere il congresso con Zaccagnini nel
1975 e da allora il massimo esponente di un confronto istituzionale per le
riforme con il Pci. Non era certo l’uomo delle clientele… eletto sei volte in
parlamento, spesso con grande sforzo dei giovani e dei suoi amici fedeli,
capolista al comune di Roma e appositamente non votato da tutte le altre
correnti della riprovevole dc romana dei dorotei o degli andreottiani sia di
rito Evangelisti che Sbardella. Galloni era mite ma non le mandava a dire…
quando Cossiga presidente decise di improvvisarsi “picconatore”, lui nel
frattempo divenuto vicepresidente del Csm, parlò di politica e di responsabilità
e Cossiga-caso unico nella Repubblica – gli ritirò delle deleghe che gli furono
restituite solo dal successore, Scalfaro. È stato un docente universitario
valente ma soprattutto il riferimento di chiunque volesse fare un dibattito o
una sessione di formazione politica. A qualunque partito, corrente, sindacato,
associazione o qualsivoglia comunità appartenesse. Per discutere partiva da ogni
dove ed arrivava ogni dove. Molti lo ricordano al volante della sua Fiat 127 con
cui, per la verità metteva allarme in figli ed amici cari perché
dell’intellettuale aveva tutte le caratteristiche, compresa una certa leggerezza
per le cose di tutti i giorni. Che, francamente lo faceva apprezzare ancor di
più.
Trattativa Stato mafia,
anomalo riferimento a Berlusconi nella sentenza,
scrive il 21 aprile 2018 Affari Italiani. "Marcello Dell'Utri è colpevole del
reato ascrittogli limitatamente alle condotte contestate come commesse nei
confronti del Governo presieduto da Silvio Berlusconi": così i giudici della
corte d'assise, nel dispositivo della sentenza del processo sulla trattativa
Stato-mafia, "circoscrivono" la responsabilità penale di Marcello Dell'Utri.
L'ex senatore di Forza Italia, imputato di minaccia a Corpo politico dello
Stato, è stato condannato a 12 anni. Un dispositivo ritenuto dagli addetti ai
lavori "anomalo" perchè la corte non si limita a un riferimento temporale "dopo
il '93", ma fa espressamente riferimento a Berlusconi. Anomalia ancora più
evidente se si ritiene che per gli altri imputati, i vertici del Ros, condannati
per lo stesso reato nel lasso temporale precedente al '93 la formula cambia. E
manca completamente il riferimento specifico al premier in carica all'epoca. E
tra i politici di Forza Italia c'è chi grida alla sentenza politica,
sottolineando la vicinanza tra il pm Di Matteo e il M5s.
Altro che patti con la
mafia, ecco tutti i boss messi in galera dai governi Berlusconi.
L'assurda sentenza di Palermo non dice che il centrodestra ha raggiunto i
maggiori risultati sul campo. Scovati i latitanti più pericolosi, scrive Luca
Fazzo, Domenica 22/04/2018, su "Il Giornale". Una casupola bianca e un po’
malconcia in una masseria sulle colline di Montagna dei Cavalli, fuori Corleone:
un braccio che si allunga per ritirare un pacco di biancheria lasciato da poco
lì fuori. «Via, entriamo», dice la radio dei trenta poliziotti arrivati fin
lassù, nel silenzio del martedì di aprile. Finisce così, dopo quarantatré anni,
la latitanza di Bernardo Provenzano, Binnu u’ Tratturi. Era l’11 aprile 2006. Da
tredici anni, dalla cattura di Totò Riina, Binnu era il numero uno di Cosa
Nostra, il latitante più importante d’Italia. Bisogna ripartire da quel
fotogramma, dal braccio che si sporge, per capire quanto stia in piedi la teoria
di un governo Berlusconi addomesticato ai voleri di Cosa Nostra, come sostengono
trionfanti i pm di Palermo dopo la indiscutibile vittoria ottenuta nel processo
per la presunta trattativa Stato- Mafia. Bisogna partire da quella foto,
guardare le date, ragionare. Provenzano viene arrestato nella fase finale della
XIV legislatura. Ministro dell’Interno è Beppe Pisanu, capo del governo è Silvio
Berlusconi: cioè l’uomo politico che secondo la tesi della Procura di Palermo,
fatta propria dalla sentenza di ieri, avrebbe ricevuto «una serie di richieste
finalizzate ad ottenere benefici di varia natura per gli aderenti a Cosa
Nostra». Una trattativa in tre fasi, l’ultima - secondo i pm - gestita in prima
persona da Provenzano medesimo. Che però viene catturato e sepolto in un carcere
di massima sicurezza. Ne uscirà solo dieci anni dopo, ormai demente, per andare
a morire in una stanza d’ospedale. Cosa era accaduto tra il 1993 della presunta
trattativa e l’arresto di Provenzano? Si potrebbe ipotizzare che gli accordi di
non belligeranza tra Stato e mafia avessero dispiegato un qualche effetto,
almeno nella prima fase. Macché. Berlusconi va a Palazzo Chigi la prima volta il
10 maggio 1994, ci resta fino al 17 gennaio successivo; ministro dell’Interno è
Roberto Maroni. Una manciata di mesi: ma nello stesso periodo finiscono in
galera quasi cento latitanti per reati di mafia, criminali inseguiti da anni da
mandati di cattura. Sono camorristi, ’ndranghetisti, ma il prezzo più alto lo
paga Cosa Nostra, anche nelle sue propaggini internazionali: il 20 luglio 1994 a
Long Island viene catturato dallo Sco, Paolo Lo Duca, latitante dal 1990, l’uomo
di raccordo tra Cosa Nostra, i clan americani e il cartello di Medellin, un
personaggio chiave nell’economia mafiosa. Tre mesi dopo a Palermo la Mobile
arresta Francesco Inzerillo, cugino del boss ammazzato dai Corleonesi nel 1980,
e interfaccia in Sicilia dei Gambino di New York. A novembre in Canada viene
individuato e preso Salvatore Ferraro, successore di «Piddu» Madonia alla testa
di Cosa Nostra a Caltanissetta. Si azzannano i tentacoli della Piovra
oltreconfine. Berlusconi torna al governo nel 2001, al Viminale vanno prima
Scajola e poi Pisanu. E la musica non cambia. La «Lista dei Trenta», l’elenco
dei latitanti più pericolosi, deve venire aggiornata di continuo, perché uno
dopo l’altro i boss cadono nella rete. Il 16 aprile 2002 a Roccapalumba tocca a
Antonino Giuffrè: è il sanguinario braccio destro di Provenzano, in fuga da nove
anni, condannato a otto ergastoli. Appena arrestato si pente e comincia ad
accusare Marcello Dell’Utri e Forza Italia. L’anno dopo, a luglio, finiscono le
latitanze anche di Salvatore Rinella e Salvatore Sciarabba: sono gli uomini che
proteggono Provenzano. Il cerchio intorno a «Binnu» si sta stringendo. Saranno
questi, i «benefici di varia natura» di cui parla la Procura di Palermo? Ad
aprile 2006 tocca a Provenzano. Due settimane più tardi si vota, il centrodestra
lascia Palazzo Chigi. Ci torna due anni dopo, l’8 maggio 2008. Premier è di
nuovo Berlusconi, ministro degli Interni di nuovo Bobo Maroni. E la musica
riprende. È il periodo d’oro della caccia ai boss, quello in cui Maroni a conti
fatti potrà vantare l’arresto di 6.754 mafiosi, compresi ventotto della «Lista
dei Trenta». Vengono smantellati santuari della criminalità organizzata in tutto
il Mezzogiorno. La ’ndrangheta, che nel 2004 aveva visto la fine della
interminabile latitanza di Giuseppe Morabito, «Peppe Tiradrittu» tra il 2008 e
il 2009 vede finire in cella imprendibili di lungo corso come Francesco e
Antonio Pelle; il 10 dicembre 2008 termina la fuga di Giuseppe De Stefano, «il
top della ’ndrangheta» nelle parole del procuratore Giuseppe Pignatone. Il 17
novembre 2010 catturano nella sua Casal di Principe il superboss della camorra
Antonio Iovine: «Abbiamo preso un re nel suo regno», commenta il procuratore
antimafia Piero Grasso. «Questa è l’antimafia dei fatti», dice Maroni. Ma è in
Sicilia, nella terra dove il progetto della trattativa avrebbe preso forma e
sostanza, che l’assedio alla criminalità mafiosa continua con i risultati
maggiori. Matteo Messina Denaro non si trova, ma - come all’epoca di Provenzano
polizia e carabinieri fanno terra bruciata intorno al padrino in fuga. A
settembre 2009 viene catturato Domenico Raccuglia, il collaboratore che gestisce
la latitanza di Messina Denaro. A dicembre nello stesso giorno vengono presi a
Palermo il giovane boss rampante Giovanni Nicchi e a Milano Gaetano «Tanino»
Fidanzati, 78 anni, uno dei primi uomini d’onore a sbarcare al nord. Nel giugno
successivo prendono Giuseppe Falsone, il capo di Cosa Nostra ad Agrigento: vive
sotto falso nome a Marsiglia, la città dove Provenzano era riuscito a farsi
operare alla prostata durante la latitanza. E poi centinaia di arresti solo
apparentemente minori, esponenti di seconda fila dei clan e anche semplici
gregari: che però costituiscono l’ossatura dei clan, la pianta organica senza la
quale il potere dei boss diventa una scatola vuota. Sono risultati imponenti,
figli del lavoro oscuro e tenace delle forze dell’ordine. E di una volontà
politica.
40 anni fa: poteri occulti
e lunga scia di sangue,
scrive il 16 marzo 1978 Valter Vecellio su “la Voce dell'isola". Al terrorismo
tutto l’Italia paga un pesantissimo tributo: in 20 anni almeno 428 morti, 14
mila atti di violenza politica. Cosa resta di quegli anni? È materia di amara
riflessione per tutti. Di certo i terroristi sparano, uccidono, vengono usati da
poteri occulti e settori deviati dello Stato. Qualcuno magari pensava davvero di
colpire al cuore l’odiato potere. Ma qui non è più cronaca; diventa storia. 16
marzo di 40 anni fa: è il giorno in cui le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro e
uccidono i cinque uomini della scorta. Moro è il protagonista di una politica
scomoda, impasto di prudenza e di audacia: 55 giorni dopo lo uccidono. Uno
scempio di umanità che segna l’apice del terrorismo rosso, ma anche l’inizio
della sua irreversibile crisi. Al terrorismo l’Italia paga un pesantissimo
tributo: in 20 anni almeno 428 morti, oltre 1.000 feriti, almeno 14 mila gli
atti di violenza politica.
Come inizio prendiamo il 12
dicembre 1969, la strage di piazza Fontana a Milano: una bomba collocata nella
Banca Nazionale dell’Agricoltura,17 morti. Il paese precipita in un buio periodo
di violenza. Una follia di cui sono vittime forze dell’ordine, magistrati,
politici, sindacalisti, cittadini comuni. Ne ricordiamo alcuni episodi.
Il commissario Calabresi: per la magistratura vittima di un gruppo di fuoco di
Lotta Continua; il rogo di Primavalle: aderenti a Potere Operaio incendiano la
casa di un dirigente missino, tra le fiamme muoiono i due figli di 22 e 8 anni.
Poi le stragi fasciste, nel 1974 a Brescia, piazza della Loggia, e al treno
Italicus; in quell’anno le Brigate Rosse rapiscono il giudice Mario Sossi.
Virgilio Mattei, 22 anni,
figlio di Mario Mattei, segretario locale del Movimento Sociale Italiano, ucciso
nel rogo di Primavalle (Roma) insieme al fratellino di 8, da aderenti a Potere
Operaio il 16 aprile 1973.
Virgilio Mattei, 22 anni,
figlio di Mario Mattei, segretario locale del Movimento Sociale Italiano, ucciso
nel rogo di Primavalle (Roma) insieme al fratellino di 8, da aderenti a Potere
Operaio il 16 aprile 1973.
Ogni giorno un agguato, un
delitto. Tra le prime vittime due magistrati, Francesco Coco, assassinato dalle
Brigate Rosse; Vittorio Occorsio, ucciso dai fascisti di Ordine Nuovo; sempre le
Brigate Rosse uccidono il vicedirettore della Stampa, Carlo Casalegno. Il
culmine con l’assassinio di Moro. Poi, come se qualcuno abbia detto: basta.
Inizia la parabola discendente, non meno sanguinosa: le Brigate Rosse uccidono
tra gli altri Guido Rossa, Emilio Alessandrini, Valerio Verbano, Mario Amato. E
secondo la magistratura porta la firma della destra estrema la strage alla
stazione di Bologna del 2 agosto 1980: 85 morti, oltre 200 feriti.
La strage alla stazione di
Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti, oltre 200 feriti: per la magistratura la
firma è della destra estrema.
1980, strage di Bologna. Cosa
resta di quegli anni? E’ materia di amara riflessione per tutti. Di certo i
terroristi sparano, uccidono, vengono usati da centri di potere occulti e
settori deviati dello Stato. Qualcuno di loro magari pensava davvero di colpire
al cuore l’odiato potere. Ma qui non è più cronaca; diventa storia.
La storia, dunque. Quel 16
marzo a via Fani, questa forse è una delle poche cose sicure, si scrive una
delle pagine più buie e tragiche della nostra storia recente. Le Brigate Rosse
pensano di colpire mortalmente il cuore dello Stato. Indubbiamente si blocca una
politica sgradita sia a Est che a Ovest, che mette in discussione equilibri
nazionali e internazionali raggiunti quarant’anni prima. Il muro di Berlino era
ancora ben solido. Al tempo stesso, uccidendo Moro le Brigate Rosse segnano
anche l’inizio della loro fine. Prima, erano le Brigate Rosse cosiddette
“storiche”: quelle dei Renato Curcio, delle Mare Cagol, degli Alberto
Franceschini. Ingozzati di nozionismo marxisticheggiante mal digerito, il mito
di una Resistenza ora e sempre salvifica e purificatrice. Prima semplici,
simbolici, sequestri come quello, nel 1973, di Ettore Amerio, capo del personale
della FIAT Mirafiori. Poi, un anno dopo, a Padova la svolta: quando uccidono due
militanti del Movimento Sociale. Poi, ecco le Brigate Rosse di Mario Moretti,
con solidi e anche sordidi contatti con l’Est europeo, movimenti palestinesi
estremisti, ambienti inquinati da servizi segreti di ogni tipo. Su Moretti da
sempre gravano sospetti mai del tutto fugati, da parte dei suoi stessi compagni.
È lui che gestisce in prima persona l’affaire Moro. Ancora oggi ci si interroga
su chi lo abbia ispirato, sui “suggeritori” occulti. C’è anche un “dopo”
Moretti, che possiamo identificare con Giovanni Senzani. E’ l’ideologo
terrorista che gestisce il rapimento di Ciro Cirillo, che vede coinvolti in una
oscura trattativa gli immancabili servizi segreti e la camorra di Raffaele
Cutolo; lo stesso anno in cui, a Verona, viene rapito il generale americano
James Lee Dozier, liberato da un blitz dei NOCS. Sono gli anni del declino delle
Brigate Rosse. Un declino, lungo, doloroso, scandito sempre da rapimenti,
attentati, sangue, morti; ma ormai è evidente che non servono più a nessuno. Il
delitto Moro è uno spartiacque anche per loro: il sogno di colpire al cuore il
Potere dello Stato si è rivelato solo un incubo, cementato da inganni e
stupidità.
Caso Moro. I brigatisti
rossi? Figli dell’Italia dell’odio antifascista e resistenziale,
scrive il 19 marzo 2018 Mario Bozzi su Barbadillo e Secolo d’Italia. Il
quarantesimo anniversario del massacro di Via Fani, con il sequestro di Aldo
Moro, leader della Dc, da parte delle Brigate Rosse, ha confermato, oggi come
ieri, un oggettivo ritardo culturale nell’interpretazione delle cause della
stagione del terrorismo. A leggere certe ricostruzioni si ha quasi l’impressione
che gli autori del massacro della scorta e del rapimento fossero venuti da un
altro pianeta e non fossero invece i figli legittimi dell’Italia dell’epoca, di
ben chiare ascendenze storiche e ideologiche. Al di là dei “misteri insoluti”,
su cui ci si è soffermati nelle diverse ricostruzioni offerte in questi giorni
(il numero dei partecipanti all’azione, il luogo della prigionia, i
“depistaggi”, il ruolo di soggetti stranieri, ecc…) esistono alcuni fattori
“certi” che erano alla base del sequestro Moro e dell’esperienza terroristica
del decennio settanta.
Ascendenze e connivenze
culturali. A legittimare ideologicamente l’operato dei terroristi era la visione
dello Stato-nemico, prodotto dell’antagonismo di classe e strumento di
sfruttamento della classe oppressa (Lenin), ed il nuovo radicalismo
marxista-leninista, frutto delle esperienze guerrigliere in America Latina e nel
Vietnam. La “visione” era in fondo simile a quella dei Partiti Comunisti
“legalitari” (l’instaurazione della “dittatura del proletariato”), diversa la
strada per raggiungere il potere. A difendere questo quadro d’assieme è il
sostanziale asservimento della cultura italiana alla logica egemonica di stampo
gramsciano, ma fatta propria da Togliatti. Riviste, case editrici, università
sono state il “brodo di coltura” di questa doppia verità: in apparenza
pluralista ed aperta al dialogo, in realtà alimentata dalle aspettative
rivoluzionarie di stampo marxista-leninista: “I filosofi hanno soltanto
‘interpretato’ variamente il mondo, ora si tratta di ‘trasformarlo’” (Marx). “Il
terrorismo è una forma di azione militare che può essere utilmente applicata o
addirittura rivelarsi essenziale in certi momenti della battaglia” (Lenin).
La continuità antifascista.
L’appello mitico alla Resistenza non è solo dettato dal cosiddetto “pericolo
stragista”, quanto soprattutto dall’idea di una rivoluzione antifascista
incompiuta e di un suo ulteriore sviluppo sulla strada della liberazione
socialista dallo sfruttamento e dall’ oppressione capitalista, fino al passaggio
– segnalato da Alberto Franceschini, cofondatore, con Renato Curcio, delle
Brigate Rosse – delle armi usate durante la Resistenza ai “nuovi partigiani”: un
passaggio reale e simbolico, che, durante gli Anni Cinquanta-Sessanta, era
stato ideologicamente rappresentato – all’interno del Partito Comunista – da
Pietro Secchia, vicesegretario del partito dal 1948 al 1958, e poi da Pietro
Longo, segretario dal 1964 al 1972, il quale, ancora nel 1970, arriva a
scrivere (su “l’Unità”) di una “nuova Resistenza”, in grado di realizzare nel
nostro paese “ … una nuova decisiva avanzata democratica, liberandolo da ogni
subordinazione all’imperialismo americano, dalla arretratezza e dalla miseria”.
L’ambiguità politica. Sia la
Dc che il Partito Comunista hanno giocato per anni sulla politica degli “opposti
estremisti”, dei “compagni che sbagliano”, delle “sedicenti Brigate Rosse”,
favorendo così la crescita del terrorismo armato, che non a caso – secondo una
coerente logica “antifascista” – aveva iniziato colpendo un sindacalista della
Cisnal (Bruno Labate, sequestrato il 12 febbraio 1973, a Torino e sottoposto ad
un “processo proletario”) e due militanti missini (Graziano Giralucci e
Giuseppe Mazzola, uccisi durante l’ assalto delle Br alla sede del Msi di Padova
nel giugno 1974). C’è una complicità (morale) e una sottovalutazione (politica)
dietro l’emergere delle Brigate Rosse, che chiamano in causa la principale forza
di governo dell’epoca ed il maggiore partito comunista dell’occidente. Ad
unirli non c’era solo la strategia del “compromesso storico” quanto l’idea di un
possibile abbraccio tra cattolicesimo e marxismo, ben analizzato da Augusto Del
Noce, il quale all’epoca denunciava il cosiddetto “progressismo cristiano”,
autentica quinta colonna nel campo cattolico e moderato, culturalmente disarmato
e quindi pronto a qualsiasi compromesso. Il “trauma” provocato dal sequestro di
Moro (1978) e poi dall’assassinio (1979) dell’operaio comunista Guido Rossa da
parte delle Br, obbligherà sia la Dc che il Pci a superare la fase
dell’ambiguità politica per cogliere i tratti reali del fenomeno terroristico
nel nostro paese. Ma fu certamente una presa d’atto tardiva, visti i grandi
costi umani degli “anni di piombo”. Su un manifesto, che all’epoca fece
scalpore, diffuso dal Fronte della Gioventù, c’era scritto “Moro: chi semina
vento raccoglie tempesta”. Dopo quarant’anni – al di là di ogni retorica
rievocazione – anche da lì bisogna partire per cogliere il senso di quella
stagione, pervasa dall’odio ideologico e dalla tempesta che ne seguì e che
travolse tutta l’Italia, con la sua lunga striscia di sangue. Per fissarne le
responsabilità reali. Per non dimenticare.
Primavalle, il rogo e i
depistaggi. Così la sinistra perse l’innocenza.
I due figli del «fascista Mattei» furono uccisi una seconda volta dalla campagna
di veleni e dall’indifferenza con cui l’omicidio fu trattato da un vasto fronte
politico, scrive Pierluigi Battista il 17 aprile 2018 su "Il Corriere della
Sera". Oggi Stefano Mattei, arso vivo in un delitto politico che si consumò la
notte del 16 aprile 1973, avrebbe 55 anni. Suo fratello Virgilio, invece, ne
avrebbe 67. Morirono tutti e due nell’incendio che, appiccato da un manipolo di
delinquenti politici, stava divorando la piccola casa popolare in cui vivevano
con tutta la famiglia. Una fotografia scattata quella notte di esattamente
quarantacinque anni fa, dalla strada ritrae Virgilio carbonizzato dalle ustioni,
che cerca inutilmente di gettarsi dalla finestra. Nella foto non si vede invece
il piccolo Stefano, che in quel momento se ne sta avvinghiato alle gambe del
fratello grande che non era riuscito a salvarlo. Due morti vittime dell’odio
politico. Due vittime dell’indifferenza con cui la cultura democratica e
progressista aveva reagito all’assassinio così orrendo che aveva colpito dei
ragazzi colpevoli solo di essere figli di un fascista.
I responsabili. La vicenda
giudiziaria è stata lunga, complessa, ma ormai nessuno più dubita dell’identità
dei responsabili. Achille Lollo, Manlio Grillo e Marino Clavo, militanti di
Potere Operaio, sono stati condannati come esecutori materiali di quel delitto.
Sono riparati all’estero anche grazie all’aiuto di una sinistra che, come Dario
Fo e Franca Rame, è stata talmente trascinata dall’odio ideologico contraffatto
con le parole dell’antifascismo da considerare veniale la morte di un bambino e
di un ragazzo nel rogo di Primavalle, il luogo dove la giovane sinistra uscita
dal Sessantotto perse la sua innocenza. La casa dove abitavano i fratelli
Mattei, era un appartamento a Primavalle di appena 40 metri quadri, al terzo
piano della Scala D, lotto 15, in uno dei più famosi quartieri proletari di
Roma. Ci abitavano in otto in quella casa di 40 metri quadri del «fascista
Mattei», che poi era Mario Mattei, segretario della sezione «Giarabub» del
Movimento Sociale Italiano: i genitori e sei figli, Stefano, Virgilio,
Giampaolo, Antonella, Lucia e Silvia.
L’incendio. Quella notte
terribile, mentre tutta la famiglia dormiva, gli assassini si misero in fretta a
cospargere di benzina il pianerottolo al terzo piano, davanti alla porta e a far
filtrare il combustibile con un piano inclinato, lasciare l’innesco e scappare.
Probabile che quel gesto criminale volesse essere un irresponsabile gesto
dimostrativo, i rampolli della borghesia di sinistra romana forse non avevano
nemmeno idea di cosa fosse una casa di appena 40 metri quadri abitata da otto
persone. Fatto sta che l’innesco esplose, la benzina prese fuoco e in un
battibaleno bruciò l’intero appartamento del «fascista Mattei», i mobili, i
letti, l’armadio, i vestiti, persino i pigiami dei bambini. Mario e la moglie
spaccarono i vetri delle finestre e aiutarono i ragazzi a buttarsi nel vuoto. Ce
la fecero tutti, sia pur con ustioni e fratture. Tranne due: Virgilio, 22 anni,
che si era attardato per salvare il fratellino, e appunto Stefano, 10 anni,
bruciato vivo in quello che passerà alla storia come il «rogo di Primavalle».
Disinformazione. Ma l’Italia
non rimase sgomenta e interdetta per la fine così orribile di un bambino, il
figlio di un fascista non meritevole di pietà e cordoglio sincero. Cominciò
invece una campagna di disinformazione e di depistaggio, partita dall’estrema
sinistra ma appoggiata dagli organi tradizionali della stampa e della
televisione, per cancellare la vera matrice politica di quel misfatto. Stefano e
Virgilio furono uccisi una seconda volta da titoli oltraggiosi e insensati che
servivano a colpevolizzare le vittime e a scagionare politicamente e
materialmente i responsabili del delitto. Si urlò al «regolamento dei conti tra
i neri», si delirava di una «faida tra fascisti», si farneticava di una
«provocazione fascista che arriva al punto di uccidere i propri figli»: ma a
queste farneticazioni vollero credere in tanti, purtroppo non solo
nell’estremismo di sinistra, ma anche negli ambienti rispettabili
dell’establishment antifascista. Si faceva pure dell’ironia sulla fiamma
«assassina» che sarebbe stata una «fiamma tricolore», come il simbolo del Msi in
cui militava il «fascista Mattei». Partirono i cortei con gli slogan per «Lollo
libero». Il padre di uno dei tre indagati venne raggiunto da una lettera aperta
scritta da alcuni dei più accreditati esponenti della sinistra in cui si
suggeriva il blasfemo paragone tra il carcere in cui era rinchiuso il figlio e
un campo di concentramento nazista.
Odio ideologico. Per questa
velenosa campagna di disinformazione, di odio ideologico, di disprezzo per le
vittime, di cinica indifferenza per la morte di un bambino bruciato vivo nessuno
ha chiesto veramente scusa. E in quella assurda campagna di
autoinnocentizzazione insincera davvero una parte della sinistra ha perduto la
sua innocenza morale e politica. Sono passati quarantacinque anni e quella
vicenda terribile è quasi dimenticata, derubricata a uno dei tanti episodi di
cieca violenza politica degli anni Settanta. Ma fu molto peggio. E a distanza di
tanto tempo facciamo ancora fatica a rendercene conto.
1969 – 1978: la politica
estera di Aldo Moro ai tempi del terrorismo internazionale,
scrive Enrico Malgarotto il 12 aprile 2018 su "socialnews.it". “L’Unione
Sovietica mira ad indebolire l’Europa occidentale con una manovra per linee
esterne, tentando di separare politicamente da essa il Medio Oriente e l’Africa
del Nord. In questo stato di cose si rafforzano i segni di un progressivo
disimpegno degli Stati Uniti dall’Europa. E’ umano che il popolo americano
cominci ad essere stanco di vedere schierati alla difesa dell’Europa occidentale
i figli di coloro che la liberarono. Ciò pone, tuttavia, problemi di sicurezza
interna e anche di obiettivo politico che noi europei dobbiamo prepararci ad
affrontare al più presto.” Questo appunto inedito di Aldo Moro risalente
al marzo del 1970 è stato ritrovato nell’archivio di Stato dall’ Avvocato e
scrittore Valerio Cutonilli, autore, insieme al Giudice Rosario Priore, di un
interessante libro sulla strage di Bologna e sui rapporti tra lo Stato
italiano e le organizzazioni terroristiche palestinesi. La nota, ignorata per
oltre 40 anni, si rivela particolarmente significativa se si esamina il contesto
in cui è stata vergata e, più ancora, se si comprende la lucida analisi che
connota la visione dello Statista sugli equilibri geopolitici dei decenni
successivi e sulla stabilità interna di un’Italia ancora provata dalla strage
alla Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre
1969 e che si preparava ad affrontare un importante vertice con la Germania, a
sostegno della Ostpolitik per l’apertura con i paesi dell’Est.
Tale visione, da qualcuno
definita “eretica”, si rivelerà profetica alla luce degli avvenimenti degli anni
seguenti. L’allora Ministro degli Esteri Moro, autore di questa annotazione,
sapeva bene quale fosse la situazione internazionale tra la fine degli
anni sessanta ed il decennio successivo. Gli Stati Uniti erano impegnati nella
guerra del Vietnam con ingenti forze militari e risorse. Questa concentrazione
di fondi ed energie verso il sud est asiatico aveva portato l’Amministrazione
statunitense a rivedere le proprie priorità a svantaggio della tradizionale
centralità dell’Europa nella propria pianificazione. Sebbene questo spostamento
verso l’estremo oriente della politica estera di Washington fosse stato oggetto
di appositi negoziati con la controparte sovietica, i fatti successivi hanno
dimostrato che il Cremlino ha approfittato di questa situazione per agire contro
l’Europa occidentale ed i suoi alleati. Questo processo sarebbe avvenuto non
attraverso un conflitto frontale con la NATO, ma ricorrendo ad una guerra non
convenzionale attuata da organizzazioni terroristiche supportate dai Servizi
segreti del blocco orientale.
Verso il Lodo Moro: il
terrorismo palestinese. In quegli anni faceva la sua comparsa in Europa
il fenomeno terroristico dei gruppi palestinesi. L’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP), il Fronte Popolare per la Liberazione della
Palestina (FPLP) e Settembre Nero sono i nomi delle maggiori formazioni operanti
in quegli anni, sebbene la galassia delle unità terroristiche arabe fosse molto
più vasta. Sono molti i fatti salienti, tra il 1969 e il 1973, che hanno visto
come epicentro l’aeroporto di Roma – Fiumicino e che avrebbero portato il nostro
Paese ad imboccare la strada dell’accordo con questi gruppi, ad iniziare dal
dirottamento su Damasco di un aereo della TWA in volo da Los Angeles a Tel
Aviv (con scalo a Roma) compiuto il 29 agosto 1969 dalla più famosa terrorista
dell’organizzazione palestinese, Leila Khaled, cui è seguito l’attentato del 16
giugno 1972 messo in atto con un mangianastri imbottito di tritolo dotato di un
timer regalato da due giovani arabi a delle ragazze israeliane conosciute poco
prima. Nonostante la deflagrazione dell’ordigno nella stiva durante il
volo, l’aereo, non avendo riportato danni, atterrava a Tel Aviv. Il 4 aprile
1974 a Ostia, fuori Roma, due membri dell’organizzazione palestinese venivano
fermati e arrestati per detenzione di alcuni missili Strela di costruzione
sovietica – facilmente trasportabili – da usare contro un aereo della compagnia
di bandiera israeliana El Al durante le fasi di decollo o atterraggio. Il 17
dicembre 1973 a Fiumicino, cinque terroristi lanciavano delle bombe incendiarie
all’interno di un aereo della statunitense Pan Am uccidendo trenta passeggeri
tra cui quattro italiani. Il gruppo terroristico, poi, prendeva possesso di un
velivolo della Lufthansa (la compagnia di bandiera tedesca) costringendo il
pilota a decollare. Dopo aver fatto scalo per il rifornimento di carburante
ad Atene, il velivolo veniva fatto atterrare a Kuwait City dove, una volta
liberati gli ostaggi, le Autorità provvedevano ad arrestare i
terroristi, rilasciati, in seguito e posti a disposizione dell’organizzazione
terroristica palestinese. Anche i siti industriali sono stati oggetto di
attentati da parte di tali organizzazioni arabe come occorso il 3 agosto del
1972 all’oleodotto di Trieste (in concomitanza con un simile attacco avvenuto in
quegli anni in Olanda).
Il Lodo Moro. Di fronte
alla portata degli attentati i Paesi europei decisero di entrare in contatto con
le formazioni per stringere speciali accordi affinché il proprio territorio
fosse escluso da ulteriori attacchi. L’Italia, presumibilmente nel 1972/1973,
attraverso il Ministero degli Affari Esteri, allora retto da Aldo Moro,
stringeva un patto – passato alla storia come il Lodo Moro – che concedeva piena
libertà alle organizzazioni palestinesi di muoversi nel nostro territorio e ad
utilizzarlo come base logistica per azioni in tutta Europa. La controparte
avrebbe assicurato che in Italia non ci sarebbero stati altri attentati, ad
esclusione delle sedi e dei siti americani ed israeliani presenti nel territorio
della penisola. Probabilmente l’autore materiale dell’accordo e’ stato il
Servizio segreto italiano: prima il SID, il Servizio informazioni Difesa (organo
d’intelligence italiano dal 1965 al 1977) e poi il SISMI – Servizio Informazioni
Sicurezza Militare (a partire dal 1978) nella figura del Colonnello Stefano
Giovannone, responsabile del centro del Servizio a Beirut, in Libano. L’agente
infatti per tutto il periodo di durata del Lodo, aveva provveduto a mantenere i
contatti tra Roma e il Medio Oriente sia con le organizzazioni terroristiche sia
con gli altri Paesi, in particolare Giordania e Libano, che mal
tolleravano la massiccia presenza di organizzazioni palestinesi nel proprio
territorio. L’assenza di azioni terroristiche in Italia suggerisce che nel corso
degli anni settanta l’accordo tra le parti sia stato sostanzialmente rispettato.
Come hanno dimostrato diversi eventi, i terroristi scoperti e arrestati in
procinto di progettare attentati nel nostro Paese sono stati liberati e
riportati alle loro basi palestinesi anche attraverso la Libia di Mu’ammar
Gheddafi, da sempre Padre Protettore di tali organizzazioni, cui forniva campi
di addestramento e significativo supporto.
Da Ortona a Bologna: la
violazione del Lodo. Nel novembre del 1979 ad Ortona, piccola cittadina
abruzzese, i Carabinieri sequestrarono dei missili Strela (lo stesso modello
usato dai due arabi a Ostia nel 1974) ad alcuni rappresentanti romani
di Autonomia Operaia, movimento della sinistra extraparlamentare e
rivoluzionaria in aperta opposizione al Partito Comunista Italiano di quel
periodo. Indagando sulla provenienza delle armi, le Autorità Giudiziarie
arrestavano a Bologna Abu Anzeh Saleh, ufficialmente studente fuori corso presso
l’Ateneo ma, in verità, membro, in qualità di responsabile della rete logistica
in Italia, del gruppo terroristico FPLP e della formazione
tedesca Separat di Carlos lo Sciacallo, nome di battaglia di Ilich Ramirez
Sanchez, famoso rivoluzionario venezuelano marxista – leninista e filo arabo,
autore, con i suoi gruppi, di numerosi attentati in tutta Europa. Fin da subito
le poche persone a conoscenza dell’accordo stretto da Moro si rendevano conto
che l’arresto di Saleh avrebbe potuto essere considerato dalle formazioni
palestinesi come una violazione del Lodo, con le inevitabili conseguenze che ciò
avrebbe comportato. Attraverso le informazioni raccolte dal Colonnello
Giovannone, cominciavano ad arrivare a Roma i primi segnali d’allarme circa la
volontà di compiere un’azione punitiva nei confronti dell’Italia da
parte dell’ala più oltranzista dell’organizzazione palestinese. Col passare dei
mesi, con la condanna di Saleh, dal Medio Oriente giungeva la notizia
che l’eventuale attacco contro il nostro Paese sarebbe avvenuto per mano
di elementi esterni al FPLP. Il 2 agosto 1980 una bomba nascosta dentro una
valigia nella sala d’aspetto della stazione di Bologna esplodeva
causando ottanta vittime e il ferimento di circa duecento persone. Per circa
trent’anni o più si è voluto associare questa strage alla matrice
neofascista nell’ambito della strategia della tensione, tuttavia altri punti di
vista, ancorché controversi ed in parte smentiti, porterebbero a puntare il dito
contro quel Carlos a capo del gruppo Separat di cui anche lo stesso Saleh faceva
parte.
La spinta dall’est del
terrorismo europeo. Le formazioni eversive di estrema sinistra presenti in tutta
Europa negli anni settanta e ottanta erano le francesi Action Directe, le
tedesche RAF o Rote Armee Fraktion – conosciute anche come Banda Baader –
Meinhof dal nome dei due capi storici – e le italiane Brigate Rosse. Questo
sistema eversivo europeo occidentale, in coordinamento con quello medio
orientale, nella sua fase più matura, era gestito dall’Unione Sovietica. I
Servizi segreti di Mosca, quelli cecoslovacchi (Stb) e della Germania
orientale (Stasi e Hva) hanno contribuito a supportare il terrorismo rosso di
quegli anni. Fin dai primo dopoguerra, la Cecoslovacchia si è sempre
dimostrata in prima linea per quanto riguarda le attività clandestine comuniste
in occidente. Per approfondire quest’ultimo aspetto è necessario far riferimento
a diverse fonti tra cui l’archivio Mitrochin, (il voluminoso dossier sui
documenti top secret del kgb che l’ex archivista del Servizio sovietico Vasilij
Nikitič Mitrochin ha portato in occidente nei primi anni novanta contribuendo a
svelare la fitta rete di legami tra il blocco orientale e l’occidente durante la
guerra fredda) ed il libro di Antonio Selvatici “Chi spiava i terroristi? KGB,
STASI – BR, RAF. I documenti negli archivi dei servizi segreti dell’Europa
<<comunista>>” Ed. Pendragon, 2010, i quali trattano in modo approfondito le
dinamiche con cui gli organi di intelligence d’oltrecortina aiutavano i
terroristi. I campi erano stati creati dal Kgb nel 1953 per addestrare anche il
personale dell’apparato militare clandestino in seno al PCI, composto
soprattutto da ex Partigiani comunisti fuggiti dall’Italia in quanto colpevoli,
durante la guerra, di crimini e per questo motivo ricercati dalle Autorità, alle
attività di sabotaggio, guerriglia, intercettazione, all’uso delle armi
interrate dal Kgb nel nostro Paese (che si aggiungevano a quelle utilizzate
dalle formazioni rosse durante l’ultimo biennio della Seconda Guerra
Mondiale e mai restituite agli alleati alla fine del conflitto) e alle
comunicazioni radio cifrate. Karlovy Vary è il nome della località nell’ex
Cecoslovacchia in cui sorgeva il campo d’addestramento gestito, a differenza di
quello che si potrebbe pensare, non dai Servizi segreti di Praga ma
dal Gru, l’organo di intelligence militare di Mosca. La presenza degli 007
sovietici in questi campi potrebbe confermare la tesi secondo cui la stagione
degli attentati degli anni settanta e ottanta non fosse solo una manovra
politica ma una vera e propria guerra contro l’occidente, combattuta
con strumenti ben lontani dal concetto tradizionale di conflitto. Nel 1974, dopo
l’arresto, da parte dei Carabinieri di Renato Curcio e Alberto Franceschini,
esponenti di spicco delle BR ma completamente slegati ed autonomi dalle trame
politiche di Mosca e Praga, il Servizio segreto cecoslovacco incrementò la
propria presenza a fianco del movimento eversivo. I vertici del PCI erano a
conoscenza di questi legami “pericolosi” tra est e ovest al punto che il
segretario del partito Enrico Berlinguer inviava, nel 1975,
una delegazione a Praga guidata da Salvatore Cacciapuoti, in qualità di
responsabile agli affari internazionali del PC, per conoscere quanti e chi
fossero gli italiani addestrati in Cecoslovacchia. Dalle Autorità slave
solo silenzio (probabilmente dovuto alla volontà di non trattare l’argomento con
elementi esterni o perché, come effettivamente è stato, i Servizi cecoslovacchi
non avevano alcuna autorità su questi campi) e una vaga promessa di inviare a
Roma una relazione in merito. L’invio della delegazione è dovuto al fatto che
il PCI, soprattutto a partire dal 1974, cominciava a considerare la questione
terrorismo rosso con molta preoccupazione, soprattutto perché era a conoscenza
che elementi interni al partito continuavano a collaborare alle attività
clandestine comuniste d’oltrecortina e che l’unica soluzione per contribuire a
fermare l’ondata eversiva che stava colpendo l’Italia (e forse anche per
scongiurare eventuali situazioni di imbarazzo politico) era collaborare con le
Forze dell’Ordine, in particolare con la Sezione antiterrorismo dei Carabinieri
guidati dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.
Contatti tra le Brigate Rosse
e l’FPLP. Le Brigate Rosse godevano anche del supporto delle formazioni
palestinesi, le quali mettevano a disposizione dei terroristi italiani i campi
di addestramento del Libano, Yemen, Siria e Iraq mentre, come in una sorta di
scambio, le BR custodivano le armi che i terroristi arabi portavano in
Italia per colpire gli obiettivi israeliani e statunitensi presenti nel nostro
Paese. Questi contatti erano avvenuti durante gli anni settanta proprio quando,
come già detto, i Servizi segreti italiani stringevano con il Fronte Popolare di
Liberazione delle Palestina (FPLP) di George Habbash il Lodo Moro. Come
riportato dalla Stampa, citando le carte della Commissione parlamentare
d’Inchiesta sul caso Moro, già a partire dal 1976 i Vertici del FPLP
cominciavano una rivoluzione all’interno delle varie sigle arabe a causa delle
diverse vedute circa la richiesta di Mosca di por fine ai dirottamenti aerei e
cominciavano a diffidare delle BR. Inoltre i vertici arabi volevano mantenere, a
tutti i costi, la parola data al Governo Italiano attraverso il Lodo
risparmiando la penisola da ogni tipo di attacco. Il già citato Colonnello
Giovannone, il capo centro del SID/SISMI in Libano, veniva informato dal suo
omologo palestinese circa i piani eversivi delle BR in Italia.
L’ultima nota inviata a Roma dall’Ufficiale del Servizio risaliva al 18 febbraio
1978 e diceva:”[…] Mio abituale interlocutore rappresentante Habbash, incontrato
stamattina, ha vivamente consigliatomi non allontanarmi da Beirut, in
considerazione eventualità di dovermi urgentemente contattare per informazioni
riguardanti operazione terroristica di notevole portata programmata
asseritamente da terroristi europei che potrebbe coinvolgere nostro Paese se
dovesse essere definito progetto congiunto discusso giorni scorsi in Europa da
rappresentanti organizzazione estremista. Alle mie reiterate insistenze per
avere maggiori dettagli, interlocutore ha assicuratomi che opererà in attuazione
confermati impegni miranti escludere nostro Paese da piani terroristi del
genere, soggiungendo che mi fornirà soltanto se necessario, elementi per
eventuale adozione adeguate misure da parte delle nostre Autorità.” A distanza
di circa un mese dalla ricezione di questo telegramma da parte del governo
italiano, l’Onorevole Aldo Moro veniva rapito dalle Brigate Rosse. Con la morte
dello statista si concludeva quello che può essere definito “Il decennio di Aldo
Moro”, iniziato nel 1969 in qualità di Ministro degli Esteri e terminato
nel 1978 da presidente della Democrazia Cristiana con il suo assassinio.
Lettere inedite dei
familiari di Moro a Sciascia: sono conservate in Fondazione ad Agrigento.
Ma la famiglia dell’ex presidente del Consiglio ucciso dalle Br non ha
autorizzato la lettura pubblica, scrive Alan David Scifo il 17 aprile 2018 su
"Il Corriere della Sera". Da quasi trent’anni quelle lettere sono lì: la busta
strappata e l’indirizzo della casa di Leonardo Sciascia, che intanto scriveva il
suo “Affaire Moro” avanzando numerosi dubbi sul ruolo dello Stato e della
politica durante i giorni del rapimento di Aldo Moro, segretario Dc, ucciso in
seguito dalle Brigate Rosse. Dall’altra parte c’era la moglie di Aldo Moro che
si rivolgeva allo scrittore nei giorni successivi all’uccisione del leader della
Democrazia Cristiana e sua figlia che scriveva altre missive all’autore,
fortemente impegnato in politica e personaggio con un ruolo di rilievo nella
società del tempo. Quelle lettere, consegnate insieme ad altre 14mila alla
Fondazione Sciascia di Racalmuto, oggi sono rimaste conservate e poco si conosce
sul contenuto, nonostante una lettura potrebbe probabilmente portare più
chiarezza in uno dei casi più bui della storia italiana. Quello che si sa è che,
mentre le lettere della moglie di Aldo Moro, Eleonora Chiavarelli, hanno un
contenuto esiguo, quelle della figlia, Maria Fida, sarebbero molto più lunghe e
si rivolgerebbero allo scrittore ponendo delle domande e dei quesiti, per dei
dubbi che Maria Fida Moro voleva fugare. Sono proprio queste tre lettere quelle
impossibili da leggere a causa della mancata autorizzazione data dalla diretta
interessata, e che rimarranno in questo stato se la negazione continuerà. Questo
accade per un fatto semplice: le lettere infatti, pur essendo state donate dagli
eredi di Sciascia alla Fondazione voluta proprio dallo scrittore qualche anno
prima della sua morte, non sono di proprietà della stessa, ma della famiglia. Se
questa ha comunque dato l’autorizzazione alla lettura, la legge impone che anche
dall’altro lato ci sia il nulla osta per poter leggere e pubblicare, cosa che
non è mai avvenuta. Quelle lettere però potrebbero essere importanti ai fini
della ricostruzione della vita del presidente del Consiglio ucciso il 9 maggio
del 1978. Così come si scoprì che erano importanti, ma solo diversi anni dopo la
sua morte, le missive che Enzo Tortora, presentatore al centro di un clamoroso
caso di malagiustizia, inviava dal carcere a Leonardo Sciascia. Oggi quelle
lettere sono in un caveau, mentre l’unica bibliotecaria a 15 ore settimanali
continua il suo non facile lavoro di inventario, volto a collegare le lettere
esistenti, per un archivio ancora fermo alla lettera C nonostante un lavoro che
dura da più di 30 anni. Mentre quelle decine di migliaia di lettere giacciono
all’interno delle stanze della grande Fondazione costruita nell’ex centrale
Enel, la Regione taglia i fondi e addirittura gli addetti ai lavori non riescono
a pagare neanche le bollette della luce e in alcuni casi sono costretti a dover
spegnere i riscaldamenti a giorni alterni al fine di rientrare nel budget
annuale. Oltre a quelle dei familiari di Moro, che sono rimaste inedite, a
creare scalpore è il fatto che altre lettere oggi sono sconosciute ai più solo
per l’assenza di un lavoro mirato che cerchi di ricostruire la genesi degli
autori, al fine di chiedere l’autorizzazione per la pubblicazione di missive che
da sole potrebbero dare un quadro più chiaro degli anni che vanno dal Settanta
ai Novanta, forse i più bui della storia italiana. Tutti infatti, come il boss
Giuseppe Sirchia (lui dal carcere) scrivevano a Sciascia, consci della sua
influenza nella società di quegli anni. Anni di misteri, di uccisioni, di mafia
e di strani suicidi.
1978 L’ANNO DEI TRE PAPI.
1978, l'anno dei tre papi.
Quarant'anni fa, in 53 giorni, si succedono tre pontefici alla guida della
Chiesa cambiandone il volto e aprendola al mondo sulle spinte innovatrici del
Concilio Vaticano II e avviandola verso il terzo Millennio, scrive Orazio La
Rocca il 10 agosto 2018 su Panorama. Tre papi in un solo anno, precisamente in
71 giorni. È quanto la Chiesa cattolica vive nel 1978, quando al suo vertice la
Navicella di Pietro colpita al cuore per ben due volte nel breve giro di 53
giorni—con le morti di Paolo VI (Giovanni Battista Montini) del 6 agosto e
di Giovanni Paolo I (Albino Luciani) la notte del 28 settembre—, sembra
traballare paurosamente sotto i colpi di un destino avverso che, per di più,
vede ascendere al Soglio un papa non italiano, il polacco Giovanni Paolo II,
dopo oltre 4 secoli e mezzo, con tutte le incognite legate ad una “novità” a cui
onestamente nessuno era preparato. Vicende storiche di cui ricorre il
quarantennale iniziato con la celebrazione della scomparsa di Montini definito
da papa Francesco nell’omelia alla Messa di suffragio “il Papa della modernità”.
Il 1978, dunque, passa alla storia come l’anno in cui tre pontefici tra gioie e
dolori, sorprese e interrogativi cambiano il volto della Chiesa aprendola al
mondo sulle spinte innovatrici del Concilio Vaticano II ed avviandola verso il
terzo Millennio. Succede quando dopo la morte di Paolo VI vengono eletti il 26
agosto Giovanni Paolo I (Albino Luciani) che muore dopo 33 giorni, e il 16
ottobre Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla), il primo papa di un Paese dell’Est a
regime comunista. Un anno — il
1978 — in
cui la Chiesa, pur colpita da uno shock tremendo trova la forza di rialzarsi e
riprendere il cammino attraverso giorni contrassegnati anche da momenti
altrettanto drammatici e dolorosi come l’esplosione del terrorismo culminato col
sequestro di Aldo Moro e l’assassinio della sua scorta del 16 marzo e
l’uccisione dello stesso Moro il 9 maggio, lo stesso giorno in cui la mafia
ammazza a Palermo il giornalista Peppino Impastato, uno dei tanti martiri di
Cosa Nostra caduti solo per aver fatto il proprio dovere di denunziare il male
con la scrittura.
I TRE PAPI DEL 1978, UN ANNO
DI TRAGEDIE. Dodici mesi archiviati col prezzo più alto pagato al terrorismo
rosso e nero, iniziato il 7 gennaio con la strage di Acca Larentia a Roma con
l’uccisione di tre giovani missini da parte di militanti armati comunisti, ma
che anche a livello internazionale vengono macchiati di sangue con l’invasione
del Libano dell’esercito israeliano il 14 marzo, una delle tante guerre nella
martoriata Terra Santa che ancora oggi non riesce a trovare pace e felice
convivenza tra le popolazioni dell’intera area. Un anno che in Italia anche a
livello politico si vivono momenti di altissima tensione con le dimissioni del
presidente della Repubblica Giovanni Leone, travolto dallo scandalo Lockheed da
cui poi uscirà assolto, e sostituito per la prima volta da un partigiano, il
socialista Sandro Pertini, che da non credente allaccerà una fraterna amicizia
con papa Wojtyla, contribuendo entrambi, ciascuno secondo le proprie competenze,
alla ricostruzione (morale, sociale e politica) del Paese.
SHOCK SALUTARE PER LA CHIESA.
Appare del tutto naturale, quindi, parlare del 1978 come l’anno in cui la
Chiesa, malgrado la non felice cornice in cui il Paese è costretto a vivere,
viene colpita da un salutare choc che anche 40 anni dopo continua a suscitare
interesse, domande, curiosità, voglia di capire come ho tentato di mettere a
fuoco nel libro “L’Anno dei Tre papi” (Edizioni S.Paolo). Un momento epocale per
la cattolicità e per il mondo intero su cui ancora c’è tanto da scoprire e da
capire, anche se è indiscutibile che l’opera riformatrice di Montini, Luciani e
Wojtyla—benché diversi per carattere, cultura, stili, origini familiari,
sensibilità pastorali—, parte dalla stessa base ispiratrice nel Concilio
Vaticano II. Tre papi-padri che, con i loro sguardi, con i loro sentimenti, con
la loro passione pastorale in momenti difficili per la Chiesa e per la società
intera, ci hanno trasmesso l’importanza di “essere sempre in cammino…” e la
consapevolezza “di aver bisogno di incontrare sempre nuovamente il Signore sulla
nostra strada…”, ricorda il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.
Sentimenti che non a caso nel anni successivi animeranno l’opera pastorale
di Benedetto XVI e di papa Francesco, pur di fronte ad attacchi, critiche e
resistenze che, dentro e fuori le Sacre Mura, hanno tentato (con Ratzinger) e
stanno tentando (con Bergoglio) di frenare la ventata riformatrice conciliare
per aprire la Chiesa al mondo contemporaneo nel rispetto della Tradizione
evangelica.
Paolo VI, il Papa che non
riuscì a salvare l'amico Aldo Moro.
Gli sforzi del Papa per salvare Moro, amico di lunga data. La sua lettera alle
BR, l'idea di un riscatto in denaro, la Caritas, i cappellani carcerari, e alla
fine la sconfitta, scrive Edoardo Frittoli il 18 ottobre 2018 su "Panorama".
Il 9 maggio 1978 Giovanni Battista Montini, Papa Paolo VI, cadde in ginocchio
nella cappella privata raccogliendosi nel dolore e nella preghiera. Aveva appena
ricevuto la notizia del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro nel portabagagli
della Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani. I suoi sforzi, esplicitati
durante le omelie lungo i 55 interminabili giorni della prigionia
e sintetizzati nella lettera indirizzata ai brigatisti, si erano rivelati vani.
Salvare la vita ad un amico.
Paolo VI non era riuscito a salvare la vita ad uno statista massima espressione
della politica cattolica italiana ma non soltanto: aveva perso, quel pomeriggio
di 40 anni fa, un amico sincero. I due si conoscevano infatti da lungo tempo,
sin dalla militanza comune nella FUCI (Federazione Universitaria Cattolica
Italiana) di cui proprio Montini era stato tra i fondatori. Il futuro Papa aveva
chiamato proprio Moro a dirigere la Federazione negli anni difficilissimi della
guerra, che costituirono un passo fondamentale nella formazione politica dello
statista barese e di molti altri futuri leader della Dc. Partecipare dunque alla
tragedia di una persona che Montini considerava di famiglia fu un durissimo
colpo anche per la già compromessa salute del Pontefice che si spegnerà appena
tre mesi più tardi, il 6 agosto 1978. L'intervento mediatore del Pontefice della
provincia di Brescia da poco canonizzato fu duplice: da una parte
gli appelli per la liberazione dell'ostaggio ripetuti in diverse occasioni
pubbliche ed attraverso i media; dall'altra un'azione individuale che si
sviluppò nell'arco temporale compreso tra gli ultimi due comunicati delle
Brigate Rosse, tra il 24 aprile e il 5 maggio. Tre giorni prima del ritrovamento
del comunicato n°8 (quello che conteneva la richiesta di scambio con i
brigatisti in carcere) Giovanni Battista Montini scrisse una lettera ai
carcerieri di Moro, che diventerà oggetto di una lunga controversia per le
ipotesi di manipolazione dei contenuti che si sono succedute negli anni. Nella
missiva il Pontefice chiedeva la liberazione dell'ostaggio "senza condizioni".
La lettera di Paolo VI ai
carcerieri di Aldo Moro. La ricezione della lettera, che pareva aver omologato
l'atteggiamento del Vaticano alla linea della "fermezza" espressa dai partiti
politici con l'eccezione del Psi (in primis La Dc di Andreotti) gettò Moro
nello sconforto e nell'angoscia. In realtà nella prima stesura il Papa avrebbe
scritto "senza condizioni imbarazzanti" (dove l'aggettivo indicherebbe più che
altro l'imbarazzo come sinonimo di paralisi nelle trattative "ufficiali")
lasciando quindi intendere l'intenzione del Pontefice di intervenire come
soggetto di una negoziazione diretta con le BR. Sulla correzione fatta
all'ultimo minuto del testo della lettera si sono succedute numerose
interpretazioni e ipotesi. Alcune di queste chiamano in causa l'allora
Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, che avrebbe pilotato per mezzo
di Agostino Casaroli (futuro Segretario di Stato Vaticano) la correzione del
testo nella versione definitiva, tesi che sarà ripresa nel film di Marco
Bellocchio sul rapimento Moro, "Buongiorno Notte". Il primo ad indicare la
possibilità di un intervento di Andreotti fu Corrado Guerzoni, Segretario
personale di Moro. La sua idea sarà smentita da successive testimonianze come
quella del Segretario particolare di Paolo VI Monsignor Pasquale Macchi. Proprio
il segretario sarà uno dei primi a confermare l'intenzione di Papa Paolo VI di
volersi sostituire come ostaggio in cambio della liberazione di Aldo Moro. A
supportare le voci sul tentativo estremo di Montini furono i pregressi che
videro il Pontefice spendersi più volte in azioni simili. Si ricordano gli
interventi accorati e determinati durante il rapimento di Mario Sossi tra
l'aprile ed il maggio 1974. Nello stesso mese si offrì ai terroristi palestinesi
in cambio dei 105 bambini sequestrati in una scuola elementare israeliana;
nel 1977 offrì la sua persona in cambio degli ostaggi del volo Lufthansa
181sequestrati dai Palestinesi a Mogadiscio. La lettera di Giovanni Battista
Montini ai carcerieri di Moro e le intenzioni del Vaticano di intervenire come
intermediario nella trattativa per la liberazione dell'ostaggio furono
considerate dalle Brigate Rosse come un'opportunità di ottenere quel
riconoscimento politico che lo Stato italiano, con l'affermarsi della strategia
della fermezza, negava.
Paolo VI e la ricerca della
trattativa diretta con le Brigate Rosse. Attraverso il Vaticano, in quei due
drammatici mesi del 1978, presero forma diverse iniziative alternative alla
trattativa tra lo Stato e le Brigate Rosse. E' nota l'iniziativa del Vescovo di
Ivrea Luigi Bettazzi che, in costante contatto con i familiari di Aldo Moro,
avrebbe organizzato la raccolta del riscatto pronto ad essere versato ai
carcerieri in cambio della vita del prigioniero. Sempre da ambienti religiosi
partì l'iniziativa di far passare la trattativa attraverso le carceri dove erano
detenuti i brigatisti. Se ne occupò l'Ispettore generale dei cappellani
carcerari Don Cesare Curioni, che avrebbe secondo alcune fonti ricevuto
l'incarico direttamente da Paolo VI di prendere contatto con i membri delle BR,
(in particolare modo alle Carceri Nuove di Torino) con l'obiettivo di
raggiungere i carcerieri di Moro che chiedevano la liberazione dei detenuti
politici. Durante gli ultimi giorni della prigionia di Moro si mosse anche
la Caritas, nell'intento di convogliare il rapimento sul piano umanitario. Era
il 18 aprile 1978, giorno della scoperta del covo di via Gradoli e del falso
comunicato n.7, quando sui giornali comparve la dichiarazione di intervento
dell'organizzazione umanitaria cattolica. L'iniziativa della Caritas fu affidata
a Monsignor Georg Hussler, invitato all'azione dal Vaticano, mentre la Dc si
manteneva a riguardo su posizioni neutrali perché non venisse identificata
l'azione umanitaria con quella politica, che si era stabilizzata sull'idea di
una fermezza senza compromessi con le Brigate Rosse.
I Socialisti bussano alla
porta del Vaticano. Nei giorni del sequestro Moro cercarono di mettersi in
contatto con Paolo VI e la Santa Sede anche i Socialisti, sin dall'inizio
favorevoli alla trattativa con i terroristi rossi. Lo fecero per suggerimento di
Padre David Maria Turoldo, mentre l'iniziativa fu portata avanti
dall'ambasciatore del Psi presso la santa Sede, il Senatore Gennaro Acquaviva.
Questi si mise in contatto con monsignor Clemente Riva, Vescovo ausiliario di
Roma. I colloqui tra i due non ebbero esito, in quanto Riva riferì tra le righe
che anche il Vaticano, pur mantenendo viva la possibilità di un'iniziativa
diretta del Santo Padre, si sarebbe assestato sulla linea della fermezza. Anche
ai Socialisti, riferì Acquaviva, fu indicata l'esistenza di una forte somma
raccolta per pagare un ipotetico riscatto. Il 5 maggio è recapitata l'ultima
lettera di Aldo Moro alla famiglia, quella che contiene le durissime accuse alla
Democrazia Cristiana per il comportamento intransigente che portò il Presidente
del partito di fronte alla morte. Lo scritto, testamento dell'amore di Moro per
i membri della sua famiglia e per gli amici più cari, si conclude con una nota
amara nei confronti di un amico di lunga data, Papa Montini. Le ultime righe
della lettera recitano così: "il Papa ha fatto pochino. Forse ne avrà scrupolo".
Così come Aldo Moro si sentirà abbandonato da tutti nelle ultime ore passate
nella "prigione del popolo", Giovanni Battista Montini sarà affranto da queste
ultime parole rivolte a lui dall'amico di sempre, che non riuscì a salvare
nonostante gli sforzi compiuti.
Dio, Dio Mio: perchè mi hai
abbandonato? 13 maggio 1978. Il tema della solitudine e della sconfitta
ritornerà nel discorso di Paolo VI in occasione della Messa in ricordo di Aldo
Moro, che rifiutò i funerali di Stato. Il Pontefice usò le parole del Salmo 22,
in cui Gesù sulla croce si sente abbandonato dal Padre. L'omelia del Papa si
apriva il 13 maggio 1978 con queste parole: E chi può ascoltare il nostro
lamento, se non ancora Tu, o Dio della vita e della morte? Tu non hai esaudito
la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo Uomo buono, mite,
saggio, innocente ed amico; ma Tu, o Signore, non hai abbandonato il suo spirito
immortale, segnato dalla Fede nel Cristo, che è la risurrezione e la vita. Per
lui, per lui. Signore, ascoltaci!
Come Paolo VI cercò di
salvare Aldo Moro e di convincere Andreotti.
In due messaggi mai pubblicati e anticipati da Panorama, la famiglia dello
statista in mano alle Br chiedeva al Papa di fare pressioni sul premier di
allora, scrive Orazio La Rocca il 24 aprile 2018 su "Panorama". Il caso Moro
visto dal Vaticano. Se ne parla, per la prima volta, con la pubblicazione di
documenti inediti usciti dagli archivi della Santa Sede nel libro Non doveva
morire. Come Paolo VI cercò di salvare Moro (Edizioni San Paolo), ora in
libreria. L'autore del volume, Riccardo Ferrigato, rivela tra l'altro il giallo
che si consumò Oltretevere intorno alla famosa lettera di Paolo VI "agli uomini
delle Brigate Rosse", dove in una prima stesura il pontefice chiedeva il
rilascio di Moro "senza condizioni imbarazzanti". Nella versione finale, invece,
Papa Montini parla, di "rilascio senza condizioni". Non solo. Ferrigato porta
alla luce anche le pressioni su Paolo VI da parte della famiglia Moro, che non
si fidava più dei politici. Sono testimoniate da due messaggi riservati del 31
marzo e del 5 aprile 1978 - Panorama li anticipa nell'altra pagina - fatti
arrivare al Pontefice tramite il vescovo Antonio M. Travia. Vi si "ringrazia" il
Papa e gli si chiede interventi più "concreti", mettendolo in guardia
dalla indisponibilità di Giulio Andreotti e del governo a non avviare trattative
con le Br. Non sarà stato un caso che il 21 aprile Montini si rivolge
pubblicamente "agli uomini delle Br", mentre in segreto ha già fatto preparare
15 miliardi di lire - confezionati con fascette di una banca israeliana - per
pagare il riscatto del presidente della Dc, come rivelerà alla Commissione
parlamentare Moro don Fabio Fabbri, segretario di don Cesare Curioni,
l'ispettore dei cappellani militari incaricato dal Papa di trovare un canale con
i terroristi.
Nella prefazione del libro di
Ferrigato, monsignor Leonardo Sapienza, Reggente della Prefettura della Casa
Pontificia, accenna poi a un eventuale, straordinario sacrificio: la
disponibilità di Paolo VI a offrirsi come ostaggio alle Br in cambio di Moro.
D'altra parte, nell'ottobre 1977, papa Montini aveva offerto analoga
disponibilità per favorire la liberazione di ostaggi, dopo una spettacolare
azione della banda terroristica tedesca Baader-Meinhof.
31 marzo 1978. Padre Santo, la
Sig.ra Eleonora Moro ha chiamato a colloquio la Sig.na Civran, Vice Presidente
Centrale del Movimento Laureati di A.C., e l’ha pregata di far pervenire a
Vostra Santità, nella maniera più riservata e più diretta, un suo appello. La
Sig.na Civran si è consigliata a tal fine con Romolo Pietrobelli e con Padre di
Rovasenda. Essi hanno convenuto di affidare a me tale incarico, che pertanto
questa mattina mi è stato confidato personalmente e oralmente dal Padre di
Rovasenda. Il pensiero della Sig.ra Moro può essere espresso, nella sostanza,
come appresso. La famiglia Moro è profondamente grata al Santo Padre per
l’affettuosa e ripetutamente dichiarata partecipazione al dramma del suo
congiunto e suo. Ritiene che la lettera indirizzata da Aldo Moro al Ministro
Cossiga sia autentica, almeno materialmente. È convinta comunque che sia
autentico l’appello in esso contenuto di fare qualcosa per la sua liberazione,
cioè di non irrigidirsi nel rifiuto di trattarla e particolarmente che le
trattative siano mosse dalla Santa Sede. La Sig.ra Moro oserebbe chiedere al
Santo Padre di chiamare l’On. Andreotti per indurlo personalmente ad accettare
la via della trattativa. (La Sig.ra Moro teme che l’On. Andreotti possa essere
incline verso un disinteressamento del Governo alla vicenda. Le dà motivo di
coltivare tale timore il fatto che l’On. Andreotti sia l’unica personalità
politica di rilievo che non si è recato a farle visita). La Sig.ra Moro
chiederebbe che, dopo tale passo, la Santa Sede direttamente, se possibile, o
per tramite di una organizzazione internazionale, per esempio la Croce Rossa,
prendesse contatto con le Brigate Rosse al fine di avviare l’inizio di una
qualche trattativa. Padre Santo, mi perdoni e mi benedica. Umilissimo e
devotissimo figlio Antonio M. Travia
5 aprile 1978. La Sig. Moro
desidera che giunga al Santo Padre l’espressione della profonda gratitudine sua
e dei suoi figliuoli per il nobilissimo appello rivolto domenica scorsa ai
rapitori per la liberazione del marito. Nello stesso tempo desidera
manifestarGli l’angoscia e lo scoramento suo e dei suoi famigliari per la
posizione di assoluta intransigenza assunta dai Partiti e dal Governo. Si rende
conto in qualche modo che la Dc non può assumere posizione diversa, ma ritiene
che così non debba fare il Governo [...] pertanto che sia fatta autorevole
pressione su l’On. Andreotti. Ritiene che lo scambio con un personaggio non di
rilievo delle Brigate Rosse sarebbe accettato da quest’ultime. Assicura che non
le è pervenuto alcun messaggio dal marito, nonostante le supposizioni avanzate
dalla stampa. La Sig.ra Moro ripone solo nella preghiera e nella iniziativa del
Santo Padre tutta la sua speranza. Antonio M. Travia
(Articolo pubblicato sul n° 18
di Starbene in edicola dal 19 aprile 2018 con il titolo "Per salvare Moro il
Papa convinca Andreotti").
La lettera di Paolo VI ad
Aldo Moro venne “ritoccata”: ecco la prima versione,
scrivono il 3 maggio 2018 Emanuele Cascapera e Roberta Benvenuto su "Michele
Santoro". Un documento inedito, riportato alla luce dopo 40 anni. E’ la prima
versione in bozza della famosa lettera scritta di proprio pugno da Papa Paolo
VI agli “uomini delle brigate rosse” per chiedere la liberazione di Aldo Moro.
Un testo limato e bilanciato parola dopo parola, in cui tratti di penna e
correzioni svelano come si sia passati dalla prima versione a quella definitiva,
resa poi pubblica. E forse oggi, alla luce delle nuove rivelazioni, si può dire
che quelle modifiche furono il sottile tentativo di non svelare le carte in una
partita importantissima e delicata, che puntava alla liberazione di Moro. “Io
non vi conosco, e non ho modo d’avere alcun contatto con voi. Per questo vi
scrivo pubblicamente, profittando del margine di tempo, che rimane alla scadenza
della minaccia di morte, che voi avete annunciata contro di lui, Uomo buono ed
onesto, che nessuno può incolpare di qualsiasi reato”, scriveva il papa il 21
aprile 1978. Ma soprattutto si tratta della lettera con la quale il Pontefice
chiedeva ai brigatisti il rilascio di Aldo Moro “Semplicemente, senza
condizioni”. Quel “Senza condizioni”, che negli anni ha lasciato spazio a
molteplici interpretazioni, è appunto il frutto di alcune, misurate modifiche
che hanno poi portato alla formulazione definitiva della lettera consegnata per
sempre alla Storia. Ma cosa aveva scritto, di suo pugno, Paolo VI? Quali sono
state le modifiche apportate alla prima stesura? E su suggerimento di chi? A
documentare la bozza della lettera scritta dal Pontefice in persona è Riccardo
Ferrigato, ricercatore e scrittore classe 1986, autore del volume “Non doveva
morire. Come Paolo VI cercò di salvare Aldo Moro” (Edizioni San Paolo). La prima
versione della lettera, infatti, conteneva l’invito a liberare l’ostaggio
“Semplicemente, senza alcuna imbarazzante condizione”, diventato poi
“Semplicemente, senza condizioni”. Una variazione significativa che, secondo il
ricercatore, aveva l’obiettivo di tenere celato il tentativo di trattativa che
lo stesso Papa aveva cercato di avviare per riuscire a liberare e salvare Aldo
Moro, ma che quel riferimento a condizioni “imbarazzanti” poteva mettere a
rischio. Un testo importante, quello di Ferrigato, che contiene anche altri
documenti inediti, tra cui due lettere a Paolo VI dove, tramite un
intermediario, la moglie di Aldo Moro chiede direttamente aiuto al Pontefice
dimostrando di non avere piena fiducia nel Governo e un documento della
Segreteria Vaticana che mette in luce i violenti dissidi tra gli uomini più
vicini al Papa.
ALTRO CHE CONTRO IL
COMPROMESSO STORICO. CI VOLEVANO DEINDUSTRIALIZZARE.
CHI COMANDA IL MONDO.
Quelli che decidono tutto:
nomi, cognomi, club, confraternite e…scrive
Alberto Di Pisa su "Sicilia Informazioni" l'8 novembre 2017. Spesso sulla
stampa, nei media, nei talk show, in numerosi libri, si parla di poteri forti.
Ma a cosa ci si riferisce con tale espressione? Tale espressione sta ad indicare
un ristretto numero di persone che, in piena autonomia, gestisce i capitali e la
finanza del mondo. In questi casi il pensiero va alle grandi dinastie dei
banchieri come i Rothschild, J.P. Morgan, i Rockfeller o ancora la
famiglia Hahn-Elkann e la famiglia Worms, la famiglia Thyssen, la famiglia Kahn,
la famiglia Goldschmidt, le famiglie Fitzgerald e Kennedy, le famiglie Agnelli –
Caracciolo e molte altre. Si tratta di poteri per lo più sconosciuti all’uomo
comune ma che agiscono in silenzio ed hanno una notevole influenza sulle
decisioni dei governi ufficiali. Scrive Marco Pizzuti nel suo libro “Rivoluzione
non autorizzata” con riguardo a siffatti poteri: “Il loro braccio esecutivo”
clandestino per eccellenza è la massoneria, un’organizzazione praticamente
sconosciuta alla popolazione, che da secoli occupa tutti i palazzi del potere.
Non è quindi una mera coincidenza se ritroviamo i suoi membri tra i principali
leader di ogni grande capovolgimento storico”. Negli ultimi decenni
la massoneria è stata affiancata da altri organismi, creati dalla èlite
finanziaria, tra i quali vanno menzionati il club Bilderberg, la Commissione
Trilaterale, il CFR, la Round Table e il club di Roma. Scrive ancora Marco
Pizzuti nel succitato libro: “Tutti questi nuovi organismi cooperano con la
massoneria, per accelerare il processo di globalizzazione nel rispettivo campo
di competenza e ambito territoriale” Al fine di realizzare tale obiettivo i
suddetti organi invitano nei loro club gli esponenti di maggiore spicco delle
varie categorie sociali: industriali, banchieri, politici, scrittori,
giornalisti, militari. Nel settore bancario internazionale particolarmente
rilevante è, ad esempio, il ruolo svolto in passato e fino ad oggi
dalla famiglia Rothschild, proprietaria di un impero bancario che, secondo le
stime degli esperti controllerebbe più di 350 miliardi di dollari. Tra i
componenti della famiglia, un ruolo primario ricopre Jacob Rothschild il quale,
oltre a gestire i beni di famiglia, gestisce anche i beni di oltre 10 mila
azionisti. Lo stesso ha intrattenuto rapporti con i più importanti uomini di
governo e della politica internazionale quali i presidenti degli Stati Uniti
Ronald Reagan e Bill Clinton e l’ex primo ministro inglese Margaret
Thatcher. Nel 2002 organizzò l’European Economic Round Table al quale
intervennero ospiti di prestigio quali Nicky Oppenheimer, Warren Buffet,
importante imprenditore ed economista statunitense, considerato il più grande
valueinvestor di sempre (nel 2003 definì i derivati come armi finanziarie di
distruzione di massa), Arnold Schwarzenegger, attore, politico, imprenditore e
produttore cinematografico, James Wolfensohn, economista e banchiere australiano
naturalizzato statunitense. Non inferiore a quella degli Rothschild è certamente
la potenza finanziaria della famiglia Rokfeller il cui più prestigioso esponente
è stato David Rockfeller uno dei fondatori del gruppo Bilderberg e della
Commissione Trilaterale. Nel 2012 Rockfeller e Rothschild, due delle più grandi
famiglie di banchieri, si riunirono. La “RIT Capital Partners” di Jacob
Rothschild acquistò una quota del “Financial Services di Rockfeller. Si trattò
di un accordo storico a seguito del quale la RIT Capital Partners divenne socio
del gruppo Rockfellere con il 37% di capitale. Il potere finanziario dei
Rothschild è presente anche in Italia dove il gruppo Rothschild ha condotto
l’acquisizione di Armani Exchange da parte di Armani Group, e ha avuto il ruolo
di advisor per Cassa Depositi e Prestiti e Fintecna sulla privatizzazione di
Fincantieri attraverso un’IPO di 390 milioni, e per l’acquisizione del 40% di
Ansaldo Energia da parte di Shanghai Electric per ben 400 milioni di euro, e
dalla creazione di due joint venture e dalla fusione da 24 miliardi di euro tra
Atlantia e Gemina. Dovendo parlare di poteri forti non si può non parlare del
gruppo Bilderberg del quale, come si è detto, uno dei fondatori fu David
Rockfeller su iniziativa del quale nel maggio del 1954 fu organizzato il primo
incontro. Il gruppo nacque con lo scopo di favorire, in un forum annuale, il
dialogo tra l’Europa e il Nord America. Alle riunioni sono invitati a
partecipare circa 120-150 leader politici, esponenti qualificati dell’industria,
della finanza, del mondo accademico e dei media. L’incontro è un forum di
discussioni informali sui trend e le principali problematiche che affliggono il
mondo. Gli incontri sono caratterizzati da segretezza dato che non possono
essere rivelate all’esterno le informazioni ricevute né l’identità o la
appartenenza di chi ha fornito le informazioni. Non vi è alcun programma
dettagliato, non vengono proposte delle risoluzioni, non viene espresso alcun
voto e non viene esternata alcuna dichiarazione politica. E’ stata proprio la
natura segreta dell’evento e del contenuto delle discussioni svolte all’interno
del forum che intorno al gruppo Bilderberg ha fatto sorgere teorie complottiste,
a mio avviso, non del tutto infondate. Sul presupposto che è impensabile
ritenere che nel contesto di un mondo globalizzato qualsiasi questione, sia in
Europa che nel Nord America possa essere affrontata in modo unilaterale, nel
corso degli anni, gli incontri annuali hanno avuto ad oggetto una vasta gamma di
argomenti spaziando dal commercio, ai posti di lavoro, alla politica monetaria
per gli investimenti alla sicurezza e alle dinamiche politiche internazionali.
Nel club Bilderberg vi sono stati e vi sono anche italiani. Si possono
ricordare Franco Bernabè, banchiere e dirigente pubblico, già amministratore
delegato dell’ENI e successivamente di Telecom Italia, fondatore di FB Group,
holding di partecipazioni e management company di un gruppo attivo nel settore
della consulenza strategica dell’ITC e delle energie rinnovabili e investito di
numerosi altri incarichi di prestigio tra cui quello, dal 2011 al 2013 di
Presidente della GSMA, organizzazione internazionale che riunisce gli operatori
di telefonia mobile eancora membro dell’European Roundtable of industrialist e
dell’International Council di JP Morgan. Si possono poi ricordare come facenti
parte del club Bilderberg gli italiani Claudio Costamagna e John Elkann, il
primo banchiere e dal luglio 2015 presidente della Cassa Depositi e Prestiti
oltre che Presidente di FSI SGR Spa, società costituita dalla riorganizzazione
del Fondo strategico italiano Spa-FSI di cui è statoa sua volta presidente e il
secondo presidente della Fiat Chrysler Automobiles oltre che presidente ed
amministratore delegato della Exor N.V. una società di investimento controllata
dalla famiglia Agnelli. Sembra facciano parte del club anche la nota giornalista
della rete televisiva “La 7” Lilli Gruber nonché Carlo Ratti, architetto ed
ingegnere, docente presso il Massachuttes Institute Technology di Boston. In
passato, ci sono stati anche tanti altri membri italiani nella Bilderberg. Tra i
quali spicca il nome dell’ex premier Mario Monti, un vero e proprio habitué
della Bilderberg. Poi spiccano i nomi di Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli,
Renato Ruggiero, Barbara Spinelli, Marco Tronchetti Provera, Mario Draghi,
Alessandro Profumo, Monica Maggioni, presidente della RAI e molti altri ancora.
Per avere un’idea del potere che gestisce il gruppo Bilderberg basta pensare che
tutti coloro che ne fanno parte possiedono più della metà del patrimonio
mondiale, il che induce ad avanzare qualche dubbio sul fatto che la finalità di
questo club e dei relativi incontri sia quella di “aumentare i dialoghi tra
Nord-America ed Europa e che i partecipanti si incontrino per tre giorni
all’anno soltanto per trascorrere un piacevole weekend o per perseguire finalità
benefiche. Così come si è indotti a ritenere che ogni qualvolta questo enorme
potere finanziario e non solo, venga messo in pericolo, il club reagisca con
azioni non sempre ortodosse per usare un eufemismo. E non è un caso se ogni
familiare di David Rockfeller è o direttore della CIA o ambasciatore all’ONU o
segretario di Stato o ricopre incarichi di vertice nel settore della sanità. Lo
stesso David Rockfeller è stato d’altra parte, dal 2000, presidente ed
amministratore delegato di JP Morgan, la banca che certamente costituisce uno
dei poteri forti di cui parliamo. Il gruppo Bilderberg raccoglie i potenti della
terra, leader politici ed economici precursori della globalizzazione, di diversi
paesi come, può constatarsi ad esempio avuto riguardo alla riunione che nel
2002, in un clima di segretezza e tra rigide misure di sicurezza, ebbe luogo a
Chantilly in Virginia. Ebbene, a tali lavori parteciparono, tra gli altri, l’ex
segretario di Stato americano Henry Kissinger, e l’ex direttore generale del
Tesoro, Mario Draghi, oggi presidente della BCE. Più di recente, nel 2012 ha
avuto luogo a Roma, una riunione del gruppo Bilderberg alla quale era presente
Mario Monti, allora Presidente del Consiglio, che illustrò agli intervenuti gli
sforzi dell’Italia per rimettere i conti in ordine. Presenti tra gli altri gli
allora ministri Francesco Profumo, Paola Severino ed Elsa Fornero. Presenti
erano anche importanti esponenti del mondo finanziario quali Ignazio Visco
(Bankitalia), Alberto Nagel (Mediobanca), Rodolfo de Benedetti (CIR), Mauro
Moretti (FS), Enrico Cucchiani (Intesa), Fulvio Conti (Enel), Etienne Davignon
(già commissario europeo per il mercato interno). Presenti anche esponenti del
mondo del giornalismo come Lilli Gruber. A presiedere il gruppo vi era Henry De
Castries, pdg di Axa, società di assicurazioni. Numerose furono le contestazioni
e le critiche allora formulate in occasione del suddetto incontro sia da parte
della sinistra che della destra. In particolare affermò Francesco Storace che
“partecipare al Bilderberg è peggio che essere della P2, è commettere
tradimento”. Per quanto riguarda la partecipazione del Presidente del Consiglio
Mario Monti, Palazzo Chigi fece sapere che Monti aveva accettato l’invito per
poter parlare delle misure adottate dall’Italia per combattere la crisi e che
“le polemiche sono fuor di luogo”. Monti ha ricoperto anche cariche nella
Commissione Trilaterale, nella Università Bocconi, di cui era presidente, e in
Goldman Sachs, incarichi abbandonati all’atto della sua nomina a presidente del
Consiglio. Peraltro è stato sostenuto, non senza fondamento, che il forum del
gruppo Bilderberg altro non è che un consesso dei poteri forti che decide le
sorti del mondo, fuori dai meccanismi democratici. Di Contro Etienne Davignon
nel negare questa caratteristica del gruppo Bilderberg ha affermato: “Se fossimo
la cupola segreta che comanda il mondo dovremmo vergognarci come cani” Certo
Davignon convince meno quando afferma che le 130 personalità che si incontrano
ogni anno sono importanti quanto la cena sociale di un Cral di ferrovieri. Del
club fanno parte e vi vengono invitate soltanto personalità di rilievo del mondo
economico, finanziario, politico, dei media. Significativo è quanto verificatosi
in occasione della riunione tenutasi nel 2011 a Saint Moritz e alla quale erano
presenti tra gli altri Henry Kissinger, David Rockfeller, Paolo Scaroni,
banchieri internazionali, imprenditori greci e spagnoli. In tale occasione,
l’allora eurodeputato della Lega Nord, Mario Borghezio, si presentò al bureau
per chiedere di partecipare ai lavori ma venne malamente allontanato. Dichiarò
allora all’ANSA: “Ci hanno letteralmente preso a spintoni. Mi hanno anche dato
un colpo al naso che ora è sanguinante. Un comportamento che smaschera la reale
natura di questa consorteria: è una società segreta e non un gruppo che si
riunisce in modo riservato”. Sembra che questi incontri, ai quali più volte
Gianni Agnelli aveva partecipato gli piacessero meno di quelli dell’altro grande
circolo di potenti, la Trilaterale fondata nel 1972 dal suo grande amico David
Rockfeller. La natura del gruppo Bilderberg e le sue finalità sono molto
discusse e le critiche nei confronti di tale gruppo provengono sia dalla
sinistra che dalla destra. Comune ad entrambe è la convinzione che ci si trovi
in presenza di una organizzazione globale che vuole dominare il mondo. Per la
sinistra si tratterebbe di un organismo composto da capitalisti e finanzieri che
ordiscono trame politiche ed economiche mentre per la destra si tratterebbe di
una elite che intenderebbe imporre i propri disegni, tipo euro, in un mondo
antidemocratico. Al di là di enfatizzazioni, non vi è dubbio che il Bilderberg è
un gruppo di capitalisti che difendono il capitalismo. Nel corso degli incontri
i partecipanti affrontano non solo temi politici, di economia o di finanza ma
probabilmente discutono di affari e magari ne fanno e talvolta favoriscono
qualche nomina rilevante. Forse non è una coincidenza il fatto che, dopo la
partecipazione di Herman Van Rompuy ad una cena organizzata dal gruppo a
Bruxelles, questi, poco tempo dopo divenne presidente del Consiglio europeo. Van
Rompuy, appena eletto presidente del Consiglio UE, si dimostrò favorevole ad un
prelievo sulle transazioni finanziarie, una specie di Tobintax. Lo stesso, prima
della sua nomina aveva spiegato questo suo orientamento ai potenti politici,
banchieri e uomini d’affari del riservato gruppo Bilderberg in un incontro
avvenuto nel castello di Valduchesse, nelle vicinanze di Bruxelles, in occasione
della cena di cui sopra. Ma negli incontri si parla anche di vicende
internazionali. Così, in occasione della riunione tenutasi a Saint Moritz, si
parlò molto di Grecia, di dollaro, di Libia e del conflitto interno all’Opec tra
sauditi e iraniani sul prezzo del barile di greggio. Se forse è eccessivo
affermare che il gruppo Bilderberg costituisce una organizzazione globale che
vuole dominare il mondo tuttavia tale ipotesi non è del tutto priva di un
qualche fondamento. Ma vi è chi va oltre e ritiene la implicazione del club
Bilderberg anche in vicende tragiche che hanno attraversato il nostro Paese.
Così l’ex magistrato Ferdinando Imposimato, nel suo libro “La Repubblica delle
stragi impunite” e in una intervista rilasciata in occasione della presentazione
del libro sostiene che: “La stagione delle stragi non serviva a destabilizzare
lo Stato, serviva ad impedire la dinamica politica nel senso di portare gli
equilibri politici da destra verso la sinistra.” E continua: “Hanno fatto tutto
questo non per fare un colpo di Stato ma per rafforzare il potere,
destabilizzare l’ordine pubblico per stabilizzare il potere politico”. E
spingendosi oltre afferma, facendo riferimento ad un documento rinvenuto tra gli
atti della indagine condotta dal giudice Alessandrini sulla strage di Bologna e
riportato nel libro, che il gruppo Bilderberg sarebbe responsabile della
strategia della tensione e quindi anche delle stragi. “Il Bilderberg-afferma-
governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo
sviluppo democratico di queste democrazie”. Si è sostenuto poi da Carlo
Freccero, ma anche nei media e in varie pubblicazioni, tra cui Micro Mega, che
Casaleggio & C sarebbero legati al gruppo Bilderberg e con una tesi alquanto
azzardata, ma forse non priva del tutto di fondamento, anche se sfornita di
prove certe, sostiene che i poteri forti “si sarebbero costruiti una gestibile
opposizione interna attraverso Casaleggio, Grillo e quindi il movimento Cinque
Stelle”. Ciò sarebbe avvalorato dal fatto che del gruppo Bilderberg, sempre
secondo Freccero, farebbe parte il giornalista Enrico Sasson, socio di
Casaleggio, manager legato all’Aspen Institute e quindi al gruppo Bilderberg.
L’Aspen Institute , che sorge a Roma in Piazza Navona, è una filiale locale
europea dell’Aspen e una ramificazione italiana dell’internazionale Club
Bildenberg e la cui finalità è l’internazionalizzazione della leadership
imprenditoriale. Enrico Sasson, in una lettera indirizzata al Corriere della
Sera, pur ammettendo di essere socio di minoranza nella Casaleggio associati,
precisava di non rappresentare alcun potere forte, di non conoscere Beppe
Grillo, mai incontrato, di non avere mai partecipato alla gestione del suo blog
in seno alla Casaleggio Associati, di non avere mai avuto niente a che fare con
il movimento Cinque Stelle. Affermava essere calunniose e diffamatorie le teorie
del complotto apparse in blog e in siti di diversa connotazione e che era una
informazione distorta e malata quella che, anche in articoli e servizi
televisivi, sosteneva il teorema dei poteri forti dediti ad infiltrare il
Movimento. Se la tesi di Carlo Freccero fosse fondata, ciò significherebbe che
il potere avrebbe deciso lui stesso di gestire l’opposizione. In altri termini,
se dietro il Bilderberg vi fosse la Casaleggio, ciò significherebbe che il
potere avrebbe deciso di infiltrare l’opposizione. Molto legata al gruppo
Bilderberg è la Commissione Trilaterale all’interno della quale sono presenti
più di 200 personalità eminenti (uomini politici, diplomatici, industriali,
finanzieri, universitari, giornalisti) provenienti da Europa, America, e
Giappone. Anche la Trilaterale fu fondata, qualche anno dopo la Bilderberg, da
David Rockfeller, presidente della Chase Manhattan Bank di New York e altri
dirigenti tra cui Henry Kissinger e pare anche da Gianni Agnelli anche se , per
quanto riguarda quest’ultimo, non vi sono documenti che lo provino. Mario Monti
ne fu presidente dal 2010 al 2011. Nel 2016, dopo oltre 33 anni, la Commissione
Trilaterale si è riunita a Roma; in tale occasione gli Italiani che vi hanno
partecipato sono stati oltre 20 tra cui Mario Monti, John Elkan, Mario
Tronchetti Provera e la presidente della RAI Monica Maggioni. Riunioni della
Commissione sono state tenute a Tokio, Washington, Parigi, Kioto e come si è
detto in Italia. In occasione di una riunione avvenuta a Parigi nel dicembre del
1975 ed avente ad oggetto la gestione delle risorse mondiali, alla domanda su
chi finanziasse l’attività della commissione, il direttore della stessa Zbigniew
Brzezinky rispondeva : “Cittadini privati e qualche governo con contributi di
minore importanza”. In occasione dell’incontro di Parigi si parlò sulla stampa
di “un nuovo ordine mondiale”, affermazione non del tutto campata in aria se si
considera che a tale riunione intervennero e fecero un discorso l’allora primo
ministro Jacques Chirac e l’ex governatore della Banca d’Italia Guido Carli.
Gianni Agnelli, intervenendo, nel 1984 alla riunione della Commissione
Trilaterale a Washington, sottolineò il ruolo dei vertici economici dei “sette
grandi”, cioè i sette paesi più industrializzati.
Chi comanda, come e perché,
dalle Logge all’Opus Dei, finanza e…scrive
Alberto Di Pisa su "Sicilia Informazioni" l'11 novembre 2017. Alla riunione
della Trilaterale che ebbe luogo a Roma nell’aprile del 2016 parteciparono
uomini di governo, ministri imprenditori, i massimi esponenti della classe
dirigente mondiale del Nord America, Europa ed Asia. Tra i partecipanti vi
furono l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, Jean Claude Trichet, ex
presidente della BCE, Monica Maggioni, presidente della RAI. Presenti anche
Andrea Guerra, ex AD di Luxottica, molto amico di Renzi, Maria Elena Boschi,
allora ministro delle riforme che una settimana prima della Trilaterale, in una
intervista aveva dichiarato: “Ci attaccano proprio perché non siamo schiavi dei
poteri forti, non siamo il terminale di niente e di nessuno. Questo non piace a
molti” Affermazione quanto meno strana se si considera che svolse un intervento
in un meeting in cui erano presenti i poteri più forti del pianeta. Per dare una
idea del vero e proprio grumo di potere presente alla riunione della Trilaterale
di Roma basta considerare che tra gli invitati vi erano persone come Michael
Bloomberg, miliardario, ex sindaco di New York, Jurghen Fitchen, della
DeutschBank, Gerald Corrigan, vice presidente della Federal Reserve oggi a
Goldman Sachs, Eric Schmidt, presidente di Google, Marta Dassau Finmeccanica,
Herman Van Rompuy ex presidente del Consiglio europeo, oltre che David
Rockfeller, fondatore della Trilaterale. Gianfelice Rocca, presidente
dell’Assolombarda, intervistato da un giornalista della “Gabbia”, al termine
della riunione dichiarava: “Io credo che questo governo abbia il sostegno di
gran parte dell’establishement”. Secondo indiscrezioni trapelate dalla riunione,
nell’incontro si sarebbe parlato anche del destino affatto roseo dell’Italia: la
Trilaterale non immaginava un bel futuro per il nostro paese. Alla riunione si è
parlato anche di privatizzazioni e di tagli alla spesa, il che significa la
svendita del patrimonio pubblico dell’Italia, cioè la svendita delle aziende
pubbliche. Ma al meeting si è parlato anche di immigrazione e, fatto strano, a
presiedere l’incontro era Peter Satermann, direttore non esecutivo di Goldman
Sachs, rappresentante generale dell’Onu per le migrazioni e componente del
Bilderberg. Come mai e perché uno degli uomini più importanti della finanza
internazionale si occupava di immigrazione? La risposta è semplice: lo scopo
della Trilaterale è quello di favorire l’immigrazione di massa dal sud del mondo
verso l’Europa in maniera da consentire alle multinazionali di avvalersi di una
ingente massa di lavoratori sottopagati. Ciò è avvalorato dal fatto che, sempre
secondo indiscrezioni, tutti i membri della Trilaterale concordarono sul fatto
che i giornali parlassero dei vantaggi dell’immigrazione. Tutto ciò evidenzia la
preminenza del potere economico –finanziario sulla politica che finisce con
l’eseguire il diktat di questa elite di potere e come il fine del Bilderberg,
della Trilaterale e di altri organismi simili, sia quello di togliere sovranità
agli Stati e di creare un nuovo ordine mondiale. Desta impressione oggi leggere
la relazione che, nel 1984, a conclusione della riunione della Trilaterale di
Washington, fu predisposta dall’ex consigliere americano per la sicurezza
Zbgniew Brzezinsky, dal segretario del partito socialdemocratico David Owen e
dall’ex ministro degli esteri giapponese Saburo Okita, per conto della
Commissione Trilaterale, relazione nella quale vengono indicati quelli che
sarebbero stati i quattro pericoli per il mondo. Sembra quasi che i redattori
del rapporto avessero previsto, con estrema precisione, e con 33 anni di
anticipo, quello a cui oggi, nel 2017 assistiamo. Secondo quanto si legge nella
suddetta relazione 4 erano i pericoli che , negli anni successivi avrebbero
minacciato il mondo e l’umanità: Un significativo peggioramento della
collaborazione economica e politica tra gli Stati , una crescente
disoccupazione; un abbassamento del tenore di vita e una minore democrazia. Una
escalation dei conflitti regionali, sempre meno contenibili sul piano
internazionale e latori di rischi crescenti di confronto tra est ed ovest.
Grossi sconvolgimenti sociali in ampie zone d’Africa e forse dell’America
latina; fenomeni di carestie di grandi dimensioni che potrebbero sfociare, in
massicce emigrazioni, in caos e violenza, riducendo in questo modo le
prospettive di democrazia ed offrendo maggiori opportunità agli estremisti di
destra e di sinistra di impadronirsi del potere. L’ultimo dei grossi pericoli
che oggi incombono sull’umanità intera e sul pianeta è costituito dal rischio di
una guerra nucleare. Afferma il rapporto della Trilaterale: “La guerra nucleare,
con le sue capacità di provocare morti e distruzioni illimitate, costituisce una
catastrofe dalla quale il globo potrebbe non essere in grado di riprendersi”. Il
pensiero, leggendo queste parole, non può non andare al conflitto tra il premier
nordcoreano e il presidente Trump che oggi rischia l’esplosione di un conflitto
nucleare. Più che di previsioni viene da pensare ad un programma che nel 1984
qualcuno si proponeva di attuare negli anni successivi. Ma forse si tratta di
una idea eccessiva. Ma come soleva dire Andreotti a pensare male si fa peccato
ma spesso si indovina. Per quanto riguarda le reali finalità del gruppo
Bilderberg, gli studiosi di questa materia scrivono a proposito dei promotori
Bernardo de Lippe, ufficiale olandese, ex ufficiale delle SS e Joseph Retinger,
politico polacco e massone : “La loro ambizione era quella di costruire una
Europa Unita per arrivare ad una profonda alleanza con gli Stati Uniti e quindi
dar vita a un nuovo Ordine Mondiale, dove potenti organizzazioni sopranazionali
avrebbero garantito più stabilità rispetto ai singoli governi nazionali…” Al di
là delle teorie complottiste, non vi è dubbio che costituisce un dato
difficilmente smentibile il fatto che ci si trovi in presenza di un intreccio
tra politica, finanza e in particolare banche in cui un gruppo ristretto di
persone, a partire dal 1954 e una sola volta all’anno, si riunisce per decidere,
nella massima segretezza il futuro politico ed economico dell’umanità. “Le
Monde” intravede nelle biografie di Mario Draghi, Mario Monti e Luca Papademos
la prova dei disegni nascosti maturati “nei piani alti della banca d’affari
Goldman Sachs”. Ed è legittimo nutrire dei sospetti sul conflitto di interessi
di cui hanno dato prova i banchieri che, come Corrado Passera sono diventati
ministri nel governo Monti. E non bisogna dimenticare che la caduta di Silvio
Berlusconi fu determinata e voluta dai poteri forti che teleguidarono lo spread.
L’influenza poi del gruppo Bilderberg sulla politica internazionale, secondo
quanto scrive sulla “Repubblica “Giuliano Balestreri, sarebbe comprovata dalla
lettera che Richard Perle, membro del comitato direttivo del gruppo Bilderberg e
teorico del neoconservatorismo americano, scrisse a Bill Clinton per chiedere la
rimozione di Saddam Hussein. Di tale gruppo direttivo, oltre che Henry Kissinger
e Edmond de Rotschild, hanno fatto parte anche 12 italiani tra cui il presidente
di Telecom Italia, Franco Bernabè. Si è anche sostenuto che le riunioni del
Bilderberg fossero anche finalizzate ad ascoltare quelli che sarebbero stati
futuri presidenti e premier, anche degli USA. Così, sarebbero stati ascoltati,
Tony Blair, Hillary Clinton, e lo stesso Barak Obama. Quest’ultimo si dice fosse
presente con Hillary nel 2008, quando Bilderberg avrebbe negoziato un accordo
per passare la mano attendendo le elezioni del 2016. Al meeting, avrebbero
partecipato un paio di volte Mario Monti (nel 2011 e 2013), Enrico Letta (nel
2012). Non sarebbe estranea a Bilderberg la formazione del governo Monti. Non si
ha notizia di una partecipazione di Renzi. Sembrerebbe quindi che per governare
in Italia e nel mondo bisogna essere graditi ai poteri forti. Non può poi non
suscitare dubbi, sul ruolo del Bilderberg nelle vicende internazionali, quanto
scritto dal giornalista inglese, Tony Gosling, in un giornale di Bristol,
secondo cui nel meeting del Bilderberg, nel 2002, si era parlato di invasione
dell’Irak da parte degli USA, ben prima che ciò accadesse. Per comprendere
l’importanza del Gruppo Bilderberg, della Trilaterale e degli altri organismi
simili e il peso che in ambito internazionale queste elite rivestono, basta
avere riguardo all’oggetto delle discussioni che hanno luogo all’interno di
questi gruppi in occasione delle periodiche riunioni anche se il contenuto delle
relazioni e degli interventi è mantenuto rigorosamente segreto. I temi trattati
infatti, riguardano spesso i rapporti tra Europa e Stati Uniti, l’economia e in
particolare la gestione della crisi economica mondiale, l’euro, l’inflazione, il
protezionismo, la globalizzazione, il petrolio, il mercato delle armi,
l’immigrazione. Essendo però segreto il contenuto delle relazioni, non è dato
conoscere le decisioni adottate dal gruppo riguardo tali problematiche; i
partecipanti agli incontri sarebbero però tenuti a mettere in pratica quanto
deciso. L’interrogativo che spesso si pone è quali siano i rapporti tra la
massoneria e gli altri poteri forti anche se deve riconoscersi che le inchieste
che hanno riguardato la massoneria e il potere politico finanziario nazionale e
internazionale, quasi sempre non hanno portato a nulla. E’ appena il caso di
ricordare come l’inchiesta sulla P2 si concluse, dopo tanto clamore, in un nulla
di fatto. Va tuttavia detto che quando si parla di massoneria bisogna tenere
presente che ci si trova in presenza di due diversi livelli: un livello
ufficiale ispirato a temi quali la libertà, l’eguaglianza la tolleranza
religiosa e un secondo livello segreto caratterizzato dalla presenza di comitati
di affari e di rapporti con la criminalità organizzata, mafia, camorra
‘Ndrangheta, servizi segreti deviati e terrorismo stragista. In altri termini ci
si trova in presenza di due mondi paralleli. Ma, come sostenuto da taluno,
esiste un rapporto tra la massoneria e i poteri forti di cui abbiamo parlato e
se esiste a quale dei due livelli fa riferimento? Una risposta interessante ci
viene da Giuliano De Bernardo, ex Gran Maestro della principale “obbedienza”
italiana, il Grande Oriente d’Italia, dal 1990 al 1993, quindi ai vertici della
massoneria, che abbandonò riferendo quello che pensava realmente. Ha dichiarato
De Bernardo: “Dietro Gelli, (che rappresentava il livello oscuro della
massoneria ndr), c’erano gli ambienti americani. Gelli è un prodotto degli
americani”. De Bernardo parla anche del sequestro di Aldo Moro che aveva perso
la fiducia degli americani che lo consideravano “un cavallo di Troia, “un ponte
che avrebbe consentito ai comunisti di arrivare al potere. Quindi gli americani
si trovarono senza rappresentanti autorevoli e affidabili in un Paese chiave
dello scacchiere internazionale. E in piena guerra fredda”. Ed aggiunge: “Sono
anni convulsi, nei quali il confronto tra il mondo atlantico e il blocco
comunista è durissimo: anni di riarmo nucleare, di servizi segreti attivissimi,
di spie, di omicidi politici. Tutto appare lecito in quel momento. La
prospettiva di un sorpasso elettorale da parte dei comunisti, così come
l’ipotesi di un compromesso storico tra Dc e PCI, terrorizza gli ambienti
atlantici”. Il dipartimento di Stato americano e la CIA si convinsero allora di
avere a che fare con una situazione di emergenza in Italia. Gli americani
ritennero, e qualcuno glielo suggerì che, in Italia, Gelli, l’esponente della
più potente loggia massonica mai esistita, era l’uomo adatto ad arginare il
pericolo comunista. Non vi è dubbio quindi che vi fosse un ben preciso interesse
degli americani ad impedire a Moro di realizzare il suo progetto di un
compromesso storico tra DC e PCI. Continua De Bernardo sostenendo che
allorquando divenne Gran Maestro, LinoSalvini, Sindona, Calvi e Gelli accrebbero
il loro potere “fatto di alta finanza, controllo dei media (come il gruppo
Rizzoli-Corriere della Sera), corruzione politica ed uso dei servizi segreti” e
istaurarono collusioni pericolose. Ma De Bernardo parla anche dei rapporti con
la criminalità organizzata e della mafia infiltrata nella famosa Loggia
Garibaldi in cui confluivano esponenti dell’area grigia tra massoneria e
malavita. Dice De Bernardo ; “Ricordo che una volta, quando andai in visita a
quella loggia pensai di avere intorno a me tutti i capi di Cosa Nostra in
America”. La potente massoneria americana d’altra parte era legata fin dai tempi
della Seconda guerra mondiale ai servizi segreti e in rapporti organici con
ambienti siciliani. E’ d’altronde un fatto noto che lo sbarco degli alleati in
Sicilia fu preparato dalla massoneria siciliana insieme a elementi della mafia
americana. Io credo che si può dare per acclarata l’esistenza di rapporti non
sempre leciti tra massoneria e potere politico- finanziario nazionale e
internazionale nonché di una contiguità tra il livello oscuro della massoneria e
le realtà criminali presenti nel nostro Paese. Così, per quanto riguarda La P2,
numerose sentenze hanno accertato come Gelli godesse di un potere enorme ed
avesse creato una rete di potere caratterizzata da favoritismi, finanziamenti
concessi ai privati dalle banche vicine alla P2, da rapporti anche con poteri
criminali, e come avesse un ruolo rilevante nel favorire le nomine anche di
personaggi delle istituzioni; ma se aveva il potere di fare nominare una
determinata persona, aveva anche il potere di asservirla a sé. E’ appena il caso
di ricordare come Gelli raggiunse l’apice del proprio potere con l’appoggio di
banchieri iscritti alla P2 quali Michele Sindona e Roberto Calvi. Va poi
ricordato, a proposito degli intrecci tra massoneria e servizi segreti, come
Gelli dal 1941 al 1945 sembra sia stato al servizio del Counter Intelligence
Corp, cioè il controspionaggio militare americano. E che il potere di Gelli
permanesse immutato anche dopo le indagini aperte sulla P2, a seguito della
scoperta della lista degli iscritti, è testimoniato da una lettera inviata da
Gelli al gran Maestro del Grande Oriente, nella quale lo stesso si dichiara
certo dell’esito favorevole dell’indagine. (Non è un mistero per alcuno-scrive
Gelli- che queste conclusioni saranno interamente assolutorie). E in effetti le
indagini, non concluse dal Procuratore di Palmi Agostino Cordova, vennero
trasferite per competenza alla Procura di Roma dove il procedimento, dopo essere
rimasto fermo per circa sei anni, nel dicembre del 2002 venne archiviato dal
giudice Augusta Iannini. Sempre De Bernardo evidenzia come il trasferimento
della inchiesta Cordova alla Procura di Roma coincise con la pax mafiosa seguita
all’assassinio di Falcone e Borsellino del 1992, anno in cui ebbe inizio
l’inchiesta di Cordova. Analogie inquietanti. Lo stesso Cossiga, in una
intervista, affermò che la P2 era stata una creazione degli americani, una
“operazione “Filoamericana e atlantica…la P2 era perciò un baluardo
anticomunista, un caposaldo di un certo tipo di politica estera e di pensiero”.
Se le sentenze hanno escluso che la P2 cospirasse contro lo Stato, tuttavia “le
ragioni atlantiche” che secondo la P2 dovevano cambiare l’Italia, erano
certamente illegali. Si può parlare di poteri forti o poteri occulti anche a
proposito dell’Opus Dei? Indubbiamente l’Opus Dei e la massoneria presentano una
caratteristica comune che è quella della riservatezza interna. Dichiarò, in
proposito, l’ex Gran Maestro Di Bernardo, in una intervista del 23 marzo 1991:
“Se si parla di potere occulto, volendo fare riferimento alla massoneria,
bisognerebbe considerare anche l’Opus Dei, che svolge una attività
particolarmente occulta”. Ed ancora, in una intervista rilasciata a Giovanni
Bianconi del “Corriere della Sera” Di Bernardo non lesina critiche all’Opus Dei.
Afferma infatti: “Forse che quello non è un potere occulto? La massoneria
(quella ufficiale, n.d.r.) cerca sempre di far conoscere le proprie finalità, si
muove sempre sulla strada della trasparenza. Non mi risulta che l’Opus Dei abbia
fatto qualcosa di simile. Eppure esiste e si muove ai limiti della riservatezza.
Dobbiamo pensare che in Italia esistano due pesi e due misure?” Quanto fin qui
scritto porta a ritenere che un gruppo ristretto di persone detiene ed orienta
la politica finanziaria e internazionale e che con i suoi meccanismi di
globalizzazione impone, in maniera sempre più incisiva, il proprio potere alle
masse. Possiamo dire che una ristretta elite, l’uno per cento dell’umanità
comanda sul restante 99% definendone il destino e in alcuni casi persino la
sopravvivenza. Ma ciò che è più grave è che tale uno per cento detiene il
proprio potere in “regime di democrazia rappresentativa”, favorito dalla
legislazione e addirittura con il consenso popolare! E ciò è stato possibile,
come scrive Rosario Castello nel libro “L’invisibile identità del potere
nascosto”, grazie alla finanza mondiale con l’arma della globalizzazione e della
moneta privata. E’ pertanto fondato ritenere che durante gli incontri che
periodicamente hanno luogo tra i partecipanti del Bilderberg, della Trilaterale
e degli altri organismi simili, vengano prese dalla classe dirigente globale, al
riparo della privacy armata e della segretezza, le decisioni più rilevanti per
il futuro dell’umanità su politica, economia e questioni militari, decisioni che
sono e rimangono top secret.” Noi ci illudiamo di essere liberi ma l’illusione
viene meno nel momento in cui i nostri diritti entrano in conflitto con quelli
che sono gli interessi dei poteri forti e ci rendiamo conto di chi comanda
realmente in questa società. Si assiste oggi ad un appiattimento dei partiti
politici, delle istituzioni e degli organi di informazione che noi crediamo
liberi e indipendenti ma che mai si porranno, salve rare eccezioni, in contrasto
con tali poteri. In realtà sono le elite finanziarie di cui ho parlato che in
ambito politico, finanziario, economico e dell’informazione, stabiliscono al
nostro posto quali sono i limiti di conoscenza e di libertà oltre i quali non è
consentito andare. Woodrow Wilson, nel 1913 eletto Presidente degli Stati Uniti,
dopo la approvazione del “Federal Reserveact (la legge costitutiva della Federal
ReserveBank) e la sua promulgazione da parte dello stesso Wilson, anni dopo
dichiarò: “Sono uno degli uomini più infelici. Io ho inconsapevolmente rovinato
il mio paese, una grande nazione industriale è ora controllata dal suo sistema
creditizio. Non siamo più un governo della libera opinione, non più il governo
degli ideali e del voto della maggioranza, ma il governo dell’opinione e della
coercizione di un piccolo gruppo di personaggi dominanti”. Considerazione che
anche oggi non può non essere condivisa.
Mattei, Kennedy, Moro:
quando la mafia decideva i destini del mondo,
scrive Alberto Di Pisa su "Sicilia Informazioni" il 24 ottobre 2017. Il
Presidente degli Stai Uniti Donald Trump ha annunciato su Twitter la sua
intenzione di divulgare i documenti, a lungo coperti dal segreto di Stato,
sull’assassinio di J.F. Kennedy avvenuto a Dallas, nel Texas, il 22 novembre
1963. Sia la Commissione Warren che indagò sull’omicidio del Presidente degli
Stati Uniti sia la stessa famiglia Kennedy, avevano optato per l’apposizione del
segreto di Stato sui documenti riguardanti l’assassinio. Si trattò di una scelta
infelice dato che tale decisione non fece altro che rafforzare le tesi degli
scettici e dei complottisti. In realtà, nel corso degli anni, sono stati
desecretati più del 90% dei documenti soprattutto a seguito del film JFK di
Oliver Stone. I rimanenti documenti avrebbero dovuto essere desecretati nel
2017, come previsto nel “President Jhon F. Kennedy Assassination Records
Collectio Act, intenzione che sembra avere, in questi giorni, manifestato il
Presidente Trump. Avverso tale intenzione di Trump è stata tuttavia avanzata, da
ambienti della Casa Bianca e in particolare dalla CIA la preoccupazione che la
pubblicazione dei file più recenti potrebbe mettere in pericolo le operazioni di
intelligence. In una dichiarazione giurata, Jefferson Morley, giornalista del
Washington post ed esperto di servizi segreti, ha dichiarato che la CIA dispone
di circa 1100 documenti riguardanti l’assassinio di Kennedy che dovrebbero esser
mantenuti segreti fino al 2017, documenti che non sono mai stati visti dal
Congresso degli Stati Uniti. E’ fondato ritenere che vi siano pressioni da parte
delle Agenzie federali, CIA ed FBI, per convincere il Presidente Trump a
mantenere ancora il segreto sui rimanenti documenti e ciò al fine di evitare di
mettere in pericolo i segreti nazionali, relativi ad inchieste collegate che
potrebbero divenire di pubblico dominio. Se Il Presidente Trump dovesse cedere
alle pressioni dei suddetti organismi, rimarranno negli archivi dei documenti
che potrebbero portare alla luce oscure e dubbie attività della CIA come quelle,
ad esempio, relative ai programmi di assassinio di leader stranieri. Tra i
documenti ancora secretati vi sono ad esempio quelli relativi ad Edward Hunt
l’agente della Cia che partecipò allo sbarco fallito nella Baia dei Porci a Cuba
nel 1961 e che divenne famoso nello scandalo del Watergate che costrinse alle
dimissioni il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon nel 1974. Quello di
Kennedy non è stato il primo omicidio di un presidente degli Stati Uniti. Prima
di lui vennero assassinati Abram Lincoln, ucciso il 14 aprile 1865, James
Garfield, ucciso il 2 luglio del 1881, William McKinley ucciso il 6 settembre
1901. E ciò senza contare i numerosi attentati falliti. L’assassinio di
Kennedy, avvenuto a Dallas il 22 novembre del 1963, fu un evento determinante
nella storia degli Stati Uniti per l’impatto che ebbe sulla nazione e sulla
politica del Paese. Per l’omicidio venne arrestato Lee Oswald a sua volta ucciso
da Jack Ruby che morì a sua volta in carcere di cancro. Numerose sono state le
ipotesi sull’uccisione di Kennedy: un complotto di cubani, della mafia, della
stessa CIA. La Commissione parlamentare Warren, istituita per indagare
sull’assassinio del presidente degli Stati Uniti, chiuse frettolosamente
l’inchiesta archiviando il caso come omicidio ad opera di un fanatico e cioè:
Lee Oswald. Sulla morte di Kennedy quindi esiste una verità ufficiale, quella
della commissione Warren, istituita il 29 novembre 1963 dal Presidente Lyndon B.
Johnson che concluse che Lee Oswald fu il solo esecutore materiale
dell’omicidio. Le conclusioni della Commissione furono molto contestate e furono
formulate molte ipotesi cospirazioniste. Soprattutto dei dubbi, peraltro non
privi di un certo fondamento, sorsero sul fatto che soltanto Oswald possa essere
stato l’esecutore materiale. Oswald infatti avrebbe sparato tre o quattro colpi
a tempo di record – 6,75 secondi – un tempo ritenuto da coloro che contestarono
le risultanze della commissione Warren, troppo breve. Un documentario, andato in
onda sul canale televisivo CBS, dimostrò che in realtà si trattava di un tempo
più che ragionevole per un tiratore scelto (qualità che non risulta avesse Lee
Oswald) dato che, undici tiratori, messi alla prova, avevano esploso tre colpi
in un tempo medio di 5,6 secondi. Tuttavia, alcuni testimoni affermarono
concordemente di avere udito un quarto colpo che sarebbe stato sparato da una
collinetta adiacente e quindi non soltanto dal deposito di libri da cui avrebbe
sparato Oswald. Il che indurrebbe a ritenere la partecipazione all’assassinio di
più persone. Cinque autorevoli storici americani, docenti universitari, hanno
pubblicato dei libri nei quali hanno ricostruito l’omicidio di Kennedy. Di essi,
quattro hanno sostenuto che Kennedy fu vittima di un complotto e che Oswald non
agì da solo e uno ritiene che l’omicidio potrebbe essere avvenuto con il
coinvolgimento di alcuni ufficiali dell’intelligence americana. David Kaiser,
del Naval War College e Michael Kurt, poi, quest’ultimo della Luisiana
University, sono concordi nel ritenere che a tirare i fili di tutta la vicenda
sia stata la CIA. Fletcher Prouty, capo delle operazioni speciali del Pentagono
dal 1960 al 1964 ed ufficiale di collegamento con la CIA, in una intervista
rilasciata il 19 marzo del 1992 all’ “Unità”, sostenne che Kennedy venne ucciso
in seguito ad una vera e propria cospirazione politica affermando che si trattò
di un colpo di Stato in piena regola e che Lee Oswald non era colpevole.
L’assassinio, eseguito militarmente con grande professionalità e coperture da
“una anonima assassini”, sarebbe stato programmato e realizzato per la tutela
degli affari e degli interessi di un strettissima elite di personaggi che da
secoli si tramandano il governo del pianeta, interessi che venivano minacciati
da Kennedy divenuto incontrollabile e pericoloso. Non soltanto l’uccisione di
Kennedy ma tanti altri delitti sarebbero quindi stati eseguiti nell’ottica del
dominio del mondo e delle risorse e a tal proposito Fletcher ricorda la guerra
del petrolio e il cartello del petrolio nel mondo ed aggiunge: “Il Presidente
degli Stati Uniti fu ucciso nello stesso piano strategico in cui fu eliminato
l’anno precedente, Enrico Mattei. Lei ha presente che cosa rappresenta il potere
di controllo sulle fonti energetiche? Si tratta del governo mondiale: Mattei
come Kennedy e poi come Aldo Moro, sono stati uccisi da mani diverse ma per lo
stesso motivo: non si adattavano a discipline superiori. E tanti altri sono
stati uccisi come loro”. In altri termini una ristretta elite avrebbe il dominio
della gran parte del continente. Ci si troverebbe in presenza di un governo
segreto costituito da pochi gruppi di potere che regolano la fame, l’energia, le
guerre e che non esitano a ricorrere al crimine ogni qualvolta vedono minacciati
i loro affari e i loro interessi. Realizzati i delitti si sono occultate e si
continuano a d occultare le prove. Ciò ad esempio è avvenuto più volte in
America (ma anche in Italia) nel caso Nixon, nel caso dei bombardamenti segreti
in Laos e Cambogia, in Iran, in Nicaragua, con i Contras, con gli ostaggi in
Iran e dopo Kennedy con l’uccisione di Martin Luther King e Bob Kennedy. Ma tra
coloro che improntarono la loro attività a un forte impegno democratico si
possono ancora ricordare Allende, Palme, e Moro. Nell’assassinio di Kennedy non
possono trascurarsi alcune strane coincidenze che sembrerebbero avvalorare,
nell’omicidio del Presidente americano, un connubio tra politica e strutture
criminali quali mafia e massoneria. Ma probabilmente si tratta soltanto di
coincidenze che tuttavia qualche dubbio lo suscitano. Il giorno dell’assassinio
infatti a Dallas, sulla autovettura in cui si trovavano John Kennedy e la First
Lady, vi era il governatore del Texas John Connally, un nome che, curiosamente
compare nei verbali delle varie inchieste italiane sulla Loggia massonica P2.
Connally, fervente anticomunista e in seguito ministro del Tesoro sotto
l’amministrazione Nixon, era infatti amico e sodale del venerabile Licio Gelli
come scrive l’ex giudice Imposimato nel libro “La Repubblica delle stragi
impunite”. E non può non evidenziarsi e lasciare perplessi come negli omicidi di
Kennedy e di Aldo Moro si trovino gli stessi personaggi legati alla mafia e alla
massoneria come appunto il governatore del Texas Jhon Connally e il suo braccio
destro Philip Guarino. E a proposito di quest’ultimo, Luigi Cipriani, nel suo
intervento in aula del 2 agosto 1990, in occasione dell’anniversario della
strage di Bologna, evidenziò come Guarino, che negli Stati Uniti aveva diretto
il comitato elettorale di Regan e di Bush, fosse stato grande amico di Sindona e
dirigente della Franklin Bank che Sindona aveva acquistato negli Stati Uniti.
Matteo Lecs poi, un massone inquisito per la strage di Bologna, ha parlato dei
rapporti di Philip Guarino con Gelli e delle riunioni che venivano tenute a
Livorno alle quali partecipava un ufficiale della base americana diCamp Derby e
nel corso delle quali si discuteva delle operazioni che Gelli e la P2
conducevano in quel periodo. Il Lecs dichiarò anche che gli elenchi veri della
P2 sono depositati in codice presso il Pentagono. In un messaggio inviato agli
americani, John Kennedy sembra quasi tracciare il profilo di quel coacervo di
interessi che poco tempo dopo decreterà la sua morte. Disse infatti Kennedy in
quella occasione: “La parola segretezza è ripugnante in una società libera e noi
abbiamo avuto storicamente come persone un senso innato di avversione alle
società segrete, ai giuramenti segreti e alle procedure segrete. Per questo si
oppone a noi, in tutto il mondo, una cospirazione monolitica e spietata fondata
principalmente sull’uso di mezzi sotterranei per espandere la propria sfera di
influenza. Sull’infiltrazione anziché l’intrusione. Sulla sovversione anziché
sulle elezioni. Sull’intimidazione anziché sulla libera scelta. E’ un sistema
che ha coscritto vaste risorse umane e materiali per la costruzione di una fitta
rete, una macchina altamente efficiente che combina operazioni militari,
diplomatiche, di intelligence, economiche, scientifiche e politiche. La
preparazione di queste operazioni viene nascosta, non resa pubblica. I loro
errori sepolti, non sottolineati. Gli oppositori sono messi a tacere, non
elogiati. Il costo di queste operazioni non viene messo in discussione; nessun
segreto viene rivelato. E’ per questo che il legislatore ateniese Solone decretò
che il rifiuto di una vertenza, di un dibattito pubblico, costituiva un reato
per ogni cittadino. Sto chiedendo il vostro aiuto nell’arduo compito di
informare ed allertare il popolo americano, fiducioso che con il vostro aiuto
l’uomo potrà essere quello per cui è nato: libero e indipendente”. In fondo lo
stesso concetto avevano espresso lo statista inglese Benjamin Dislaeli e il
Presidente Franklin Delano Roosevelt. Disse infatti il primo: “Il mondo è
governato da personaggi molto diversi da quelli che immaginano coloro che non si
trovano dietro le scene”. E in maniera più incisiva disse il secondo: “La verità
su questo tema è che elementi della finanza sono proprietari del governo nei
suoi cardini principali dai giorni di Andrew Jackson”. Si riuscirà mai a sapere
la verità su Dallas? Io credo di no poiché, per quello che ne sappiamo oggi, non
vi sarebbe nulla di scritto e documentato che proverebbe, nell’assassinio di
Kennedy, un complotto di quelli che oggi si suole definire “poteri forti”. Uno
spiraglio tuttavia sembra potersi aprire se, come annunciato dal presidente
Trump, saranno definitivamente e completamente aperti gli archivi che contengono
i documenti sull’assassinio di Kennedy, fino ad oggi coperti dal segreto di
Stato. Soltanto in tal modo, io credo, si potrà riprendere in mano il controllo
della democrazia eliminando la parola “segretezza” che, come affermò Kennedy, è
una parola ripugnante in una società libera.
Via Fani, 16 marzo del
1978. I segreti inesplorati sul caso Moro,
scrive Alberto Di Pisa su "Sicilia Informazioni" l'11 marzo 2018. Sono passati
quaranta anni da quando il 16 marzo del 1978, Aldo Moro, mentre si stava recando
alla Camera dei deputati per la presentazione del nuovo governo, fu vittima di
un agguato effettuato da un commando delle Brigate rosse che, con una vera e
propria azione militare, uccisero i cinque uomini della scorta e sequestrarono
il presedente della Democrazia cristiana. Il sequestro si concluse dopo 55
giorni di prigionia nel covo di via Montalcini, con l’uccisione di Moro, fatto
trovare all’interno di una Renault rossa, il 9 maggio a Roma in via Caetani, una
via che si trova tra la sede della allora Democrazia cristiana e via delle
Botteghe Oscure, la sede nazionale del Partito comunista italiano. Oggi, tutto,
per ciò che riguarda questo grave fatto, sembra essere stato chiarito. In realtà
molti sono i punti oscuri che ancora permangono e che non sono stati,
volutamente o no, sufficientemente approfonditi. Così dicasi per ciò che
riguarda il possibile coinvolgimento della P2 e dei servizi segreti, dell’URSS e
degli Stati Uniti o di Israele Ed ancora non si è sufficientemente approfondita
la vicenda del falso comunicato n. 7 e la scoperta del covo di via Gradoli. O
ancora il ritrovamento, nell’ottobre del 1990, in un appartamento in via
Montenovoso a Milano, appartamento occupato dalle BR e già allora attentamente
perquisito, di documenti relativi alla prigionia di Aldo Moro. Per ciò che
riguarda il possibile coinvolgimento degli Stati Uniti e dell’URSS, si può
affermare che sia gli uni che gli altri potrebbero essere stati mandanti del
sequestro. Non vi è dubbio infatti come il progetto di apertura del governo al
PCI di Berlinguer, che come è noto era uno dei più convinti sostenitori
dell’Eurocomunismo, fu mal visto dagli Stai Uniti che temevano un siffatto
programma: se attuato, avrebbe cambiato gli equilibri di potere sia nazionali
che internazionali. Ma anche dalla stessa URSS, una siffatta apertura poteva
essere non gradita dato che tale evenienza avrebbe dimostrato, come è stato
osservato, che un partito comunista era in grado di andare al potere in maniera
democratica e di sfuggire così alla dipendenza dal PCUS di Mosca. Sin dagli anni
70 vi era sempre stata, negli USA una forte contrarietà sia da parte della
amministrazione repubblicana con Nixon e Ford sia da parte di quella democratica
con Carter (presidente dal 1977 al 1981, nel periodo in cui si verifica il
sequestro e l’uccisione di Moro), alla politica perseguita da Moro che mirava a
fare partecipare i comunisti al governo. Un segnale ben preciso si ebbe infatti
nel settembre del 1974, allorquando Moro, allora Ministro degli esteri, si recò
negli Stati Uniti. In questa occasione infatti vi fu un confronto molto duro tra
l’allora segretario di Stato Henry Kissinger e Moro il quale voleva convincere
Kissinger che data l’ascesa elettorale del partito comunista, un modo per
fermare tale ascesa era proprio quello di fare partecipare i comunisti alla
responsabilità di governo e che in pratica si trattava soltanto non di una
alleanza di governo vera e propria ma di un accordo provvisorio per trovare una
soluzione alla crisi economica. Kissinger, in questa occasione, per nulla
convinto dalle affermazioni di Moro, minacciò che se l’Italia avesse perseguito
tale strategia avrebbe tagliato gli aiuti economici di cui l’Italia in quel
momento aveva particolare bisogno. Naturalmente ciò non significa affermare che
l’ordine di sequestrare ed uccidere Moro sia venuto da Kissinger o da chi per
lui, ma bisogna comprendere i meccanismi che stanno alla base di quasi tutti i
delitti eccellenti. Non c è in altri termini nessun politico che direttamente
dica ad altri di commettere un determinato delitto. Basta infatti che il potere
politico lanci un messaggio quale ad esempio. “I comunisti stanno per
impossessarsi del potere; la situazione è grave”. Questo messaggio viene
recepito da un livello inferiore che non ha nessun contatto con il livello
superiore ma che si rende conto della preoccupazione di quest’ultimo e trasmette
il messaggio ad un livello successivo che comprende cosa fare ed esegue. Se,
come si è detto, gli Stati Uniti erano fortemente contrari all’ipotesi che il
partito comunista potesse andare al governo e che pertanto avrebbero fatto
qualsiasi cosa per impedire tale evenienza, è semplicistico pensare che le
Brigate rosse abbiano fatto tutto da sole e di loro iniziativa. Esse, come è
stato osservato, gestirono un appalto e solo se si ritiene fondata questa tesi,
si può comprendere ciò che avvenne durante i 55 giorni in cui Moro fu
prigioniero delle Brigate Rosse. Significativa in proposito è la circostanza che
la decisione di uccidere Moro viene presa proprio nel momento in cui la DC,
attraverso l’allora presidente del Senato Fanfani, si apre alla trattativa.
Rafforza ancora l’ipotesi di un coinvolgimento degli Stati Uniti nel sequestro
Moro, quanto dichiarato nel 2005 da Giovanni Galloni, ex vicesegretario della
democrazia cristiana secondo cui Moro gli disse di essere conoscenza del fatto
che sia i servizi americani che quelli israeliani, avevano degli infiltrati
nelle BR e che nessun aiuto davano ai servizi italiani per l’individuazione dei
covi di tale organizzazione. Nella seduta del 22 luglio 1998, dinanzi alla
Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia, lo stesso
Galloni dichiarò come per gli americani impedire l’entrata dei comunisti al
governo era una questione strategica di vita o di morte dato che se si fosse
verificata una siffatta evenienza temevano di perdere le basi militari che gli
Usa avevano sul territorio italiano in una posizione idonea a fare fronte ad una
eventuale invasione dell’Europa da parte dei Sovietici. Dichiarò in particolare
Galloni: «Quindi, l’entrata dei comunisti in Italia nel Governo o nella
maggioranza era una questione strategica, di vita o di morte, “life or death”
come dissero, per gli Stati Uniti d’America, perché se fossero arrivati i
comunisti al Governo in Italia sicuramente loro sarebbero stati cacciati da
quelle basi e questo non lo potevano permettere a nessun costo. Qui si
verificavano le divisioni tra colombe e falchi. I falchi affermavano in modo
minaccioso che questo non lo avrebbero mai permesso, costi quel che costi, per
cui vedevo dietro questa affermazione colpi di Stato, insurrezioni e cose del
genere. » (Dichiarazioni di Giovanni Galloni, Commissione parlamentare
d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi, 39ª seduta, 22 luglio 1998.) Emanuele Macaluso,
in un articolo pubblicato il 26.09.1982 sull’Unità scrisse: “Caso Moro. Noi
siamo tra coloro che non hanno mai creduto che a rapire ed uccidere il
presidente della Dc siano state solo le Brigate rosse che organizzarono l’infame
impresa. Abbiamo sempre pensato che gli autonomi obiettivi politici delle Br
coincidessero con quelli di potenti gruppi politico-affaristici, nazionali ed
internazionali che temevano una svolta politica in Italia”. Ma che Moro fosse
inviso agli Stati Uniti a causa della sua politica di avvicinamento al partito
comunista, emerge anche dalle dichiarazioni rese dalla moglie di Moro in
occasione del primo processo al nucleo storico delle BR. La vedova di Moro
dichiarò che fin dal 1974 il marito era stato oggetto da parte di esponenti
politici degli USA, tra cui il segretario di Stato Henry Kissinger, di moniti e
di avvertimenti sulla pericolosità di qualsiasi legame con il PCI. Riferì in
particolare che nel marzo del 1976 il marito ricevette un avvertimento esplicito
da parte di un personaggio americano che, avvicinatolo, lo aveva apostrofato
duramente. L’episodio fu riferito dalla vedova Moro dinanzi alla Commissione di
inchiesta in questi termini: “: «È una delle pochissime volte in cui mio marito
mi ha riferito con precisione che cosa gli avevano detto, senza svelarmi il nome
della persona. […] Adesso provo a ripeterla come la ricordo: ‘Onorevole (detto
in altra lingua, naturalmente), lei deve smettere di perseguire il suo piano
politico per portare tutte le forze del suo Paese a collaborare direttamente.
Qui, o lei smette di fare questa cosa, o lei la pagherà cara. Veda lei come la
vuole intendere’». Un altro aspetto, forse non sufficientemente approfondito è
quello relativo ad una macchina tipografica che collegherebbe il delitto Moro a
Gladio, organizzazione quest’ultima che altro non era se non una propaggine
della Cia. La stampatrice infatti, usata dalle BR per redigere i comunicati
emessi durante i 55 giorni del sequestro del presidente della DC, venne portata
nella tipografia brigatista di via Pio Foà a Roma da Mario Moretti nel 1977.
Ebbene tale macchina tipografica proveniva ufficialmente, come sostenuto in un
servizio del 1990 dell’ “Espresso” da un reparto unità speciali dell’esercito,
sigla RUS. Secondo quanto dichiarato dal generale Gerardo Serravalle alla
Commissione stragi, il RUS era “una proiezione del centro addestramento
guastatori, il Cag di Alghero” Lo stesso Serravalle, che fu a capo di Gladio dal
settembre 1971 al luglio del 1974, precisò che il “RUS” era un settore
supersegreto, “sempre compartimentato da tutti”. Dichiarazioni in contrasto con
quanto invece affermato a suo tempo, dall’ex capo del SISMI, Giuseppe Santovito,
dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro. In relazione
alla rivelazione dell’Espresso, il senatore Sergio Flamigni, componente della
Commissione Moro ed autore del libro “La tela del ragno” sul sequestro Moro ebbe
a dichiarare: “E’ una informazione di grande valore, che consente di rileggere
in una nuova luce tutta la storia della “stampatrice” usata durante il sequestro
del leader democristiano”. Alla Commissione Moro, Flamigni ed altri commissari
cercarono di approfondire la questione nel corso delle audizioni dei dirigenti
dei servizi ed emerse che l’ufficio “RUS” era uno dei compartimenti segreti di
Gladio, che altri non era, come si è detto, che una propaggine della Cia; il che
ci riporta ancora una volta a un possibile coinvolgimento degli USA nel
sequestro Moro. Non vi è dubbio pertanto che ci si trovò in presenza di una
circostanza che sembrava avallare i sospetti di collegamento tra brigatisti e
servizi deviati. Non risulta che le indagini sul punto che indurrebbero a
ritenere un collegamento tra le BR e Gladio e quindi la CIA siano state
approfondite al fine di chiarire o comunque smentire un siffatto rapporto.
Nell’ambito di una inchiesta aperta dal PM De Ficchy nel 1992 sul caso Moro si
indagò anche sul ruolo che avrebbe svolto l’ex colonnello del Sismi, Camillo
Guglielmi, ufficiale che, come venne accertato, si trovava nei pressi di via
Fani, al momento in cui ebbe luogo l’agguato delle BR. Il Guglielmi inoltre
sembra che fosse l’uomo incaricato dai servizi segreti di tenere i rapporti con
esponenti della criminalità. La presenza dl Guglielmi in via Fani non era stata
segnalata agli inquirenti e venne alla luce casualmente a seguito della
rivelazione di un ex carabiniere che poi fu costretto a ritrattare. Interrogato
nel 1991, Gugliemi ammise che si trovava in via Fani a suo dire perché invitato
a pranzo da un collega e che assistette al rapimento di Moro. Affermò di essere
stato invitato dal colonnello Armando D’Ambrosio che effettivamente abitava nei
pressi di via Fani. Questi dichiarò che Guglielmi si era presentato a casa sua
poco dopo le nove ma negò di averlo invitato a pranzo aggiungendo che si era
intrattenuto con lui solo qualche minuto perché, sempre a dire del Guglielmi,
egli doveva tornare in strada in quanto “doveva essere accaduto qualcosa”.
Lasciando l’abitazione del collega, circostanza inverosimile, Guglielmi disse di
non essersi accorto che all’incrocio con via Fani c’era stata una strage e di
avere appreso che era stato sequestrato Moro soltanto quando era rientrato a
casa. La versione fornita dal Guglielmi, come emerso nell’ambito dell’inchiesta
condotta dal P.M. De Ficchy, fu smentita dall’ex agente del Sismi Ravasio il
quale, parlando di Guglielmi, disse che la mattina del sequestro Moro, l’alto
ufficiale si era precipitato in via Fani dopo avere ricevuto una telefonata di
Musumeci, ai vertici del Sismi, che lo aveva invitato a recarsi subito in via
Fani avendo appreso da un infiltrato delle BR, il cui nome di copertura era
“Franco” che in via Fani sarebbe successo qualcosa di grosso e che forse
avrebbero rapito Moro. Guglielmi, recatosi in via Fani sostenne successivamente
di non aver potuto intervenire. Lo stesso, come scrive la giornalista Rita Di
Giovacchino ne “Il libro nero della Prima Repubblica” avrebbe confidato a
Ravasio di essere andato in via Fani a cose fatte e di essere rimasto sconvolto:
“Ero lì’, c’erano tutti quei corpi a terra e non ho potuto fare niente”. Una
strana circostanza è quella che per anni i servizi segreti fecero circolare la
notizia che Gugliemi era morto. La figura e il ruolo di quest’ultimo, mai
chiariti, riconducono verosimilmente a un coinvolgimento nel sequestro Moro dei
servizi segreti e ,considerati i rapporti che Guglielmi teneva con la
criminalità, a un interessamento della criminalità e in particolare della mafia,
della ‘ndrangheta e della banda della Magliana, contattati per la liberazione di
Moro, Il pentito Marino Mannoia ha riferito che negli ultimi giorni della
prigionia di Moro circolava una specie di parola d’ordine : “Lasciate perdere le
iniziative per trovare Moro, qualcuno ha già deciso che deve essere ucciso”. Un
elemento che rafforza la convinzione che il sequestro Moro non fu gestito
esclusivamente dalle Brigate Rosse, così come ritenuto in sede processuale, è
dato dal famoso comunicato numero 7, quello con cui i brigatisti annunciarono
l’esecuzione di Moro indicando in un laghetto ghiacciato in provincia di Roma il
luogo in cui era stato abbandonato il cadavere del presidente della DC. Ebbene,
tutti i cinque processi del caso Moro hanno accertato che fu Antonio Giuseppe
Chicchiarelli, un falsario legato alla banda della Magliana, a redigere il
suddetto comunicato (il c.d. comunicato del lago della Duchessa) e che la stessa
macchina da scrivere veniva usata nello stesso periodo di tempo dai brigatisti e
da un soggetto esponente della criminalità romana e dei servizi segreti. Ciò
venne confermato dalla testimonianza dell’ex capo dell’Ucigos, dr.Fariello il
quale, sentito il 7 novembre 1980 dalla Commissione parlamentare di indagine sul
delitto Moro, allorquando gli fu mostrato il comunicato n. 7 affermò: “…era
autentico, lo do per scontato…io mi baso sui miei collaboratori, i quali a suo
tempo hanno riconosciuto che la battuta e la testina erano le stesse (di quelle
usate per gli altri comunicati brigatisti n.d.r.)
Moro, 40 anni senza verità.
Chi era Martin Woodrow Brown?
Scrive Alberto Di Pisa su "Sicilia Informazioni" il 14 marzo 2018. La figura di
Chicchiarelli non venne approfondita nel corso dei processi sul sequestro e
l’uccisione di Moro, cosa che sarebbe stata opportuna se si considera che lo
stesso aveva collegamenti oltre che con la criminalità (Cosa Nostra e banda
della Magliana), con estremisti di destra e di sinistra, la loggia P2, l’Opus
Dei e i servizi segreti. Secondo il confidente del Sisde e dei carabinieri
Luciano Dal Bello, soprannominato Gheddafi, Chicchiarelli era un esponente delle
BR. Ed ancora il 14 aprile 1979 fu fatto ritrovare “casualmente” in un taxi a
Roma un borsello con materiale vario riguardante il sequestro e l’omicidio Moro,
l’omicidio Pecorelli e il depistaggio del lago della Duchessa, borsello che
risultò appartenere al Chicchiarelli il quale però venne sostanzialmente
lasciato ai margini del processo Moro anche quando vennero rinvenuti due
spezzoni di foto scattate, quasi sicuramente da Chicchiarelli, all’interno del
covo dove era tenuto prigioniero Moro. Il ruolo rivestito dal Chicchiarelli
nella vicenda Moro e i motivi che lo spinsero a redigere il falso comunicato non
sono mai stati accertati e chiariti. Un dato però è certo e cioè che questi era
certamente a conoscenza dei retroscena della vicenda Moro. Il 28 settembre 1984
Chicchiarelli venne ucciso in un agguato a Roma. Il possibile coinvolgimento
della CIA nel sequestro Moro emergerebbe dalla vicenda che vide protagonista
Aldo Semerari, direttore dell’Istituto di criminologia dell’università di Roma,
docente di psichiatria forense, più volte inquisito per terrorismo nero.
Nell’estate del 1978 pervenne, indirizzata personalmente al Semerari, una
lettera che lo stesso aprì e lesse insieme al suo collega Antonio Mottola. La
lettera che era a firma di tale “Mister Brown” diceva che il sequestro e la
morte di Moro erano riconducibili a “un complotto della CIA”. La lettera venne
inviata al generale dei carabinieri Ferrara, ma non risulta che sul contenuto
della stessa siano state effettuate particolari indagini. Nel luglio del 1981
Mottola venne assassinato dopo essere stato prelevato presso la propria
abitazione da tre uomini. Aldo Semerari scomparve il 25 marzo del 1982: il suo
cadavere decapitato sarà ritrovato all’interno di una fiat 128, parcheggiata in
viale Elena, a pochi metri dal municipio di Ottaviano. Una circostanza strana si
verifica il 14 giugno1986 allorquando un cittadino inglese, tale Martin Woodrow
Brown muore mentre viene trasportato in ospedale a Pisa. Nella sua borsa vengono
rinvenuti degli articoli in tedesco e in italiano che riguardano la camorra e le
BR tedesche e italiane. Ma circostanza interessante è che nella borsa vi è anche
una lettera inviata da Semerari a un funzionario della Criminalpol nella quale
lo stesso annotava alcune sue valutazioni sulle Brigate Rosse. Ma chi era
Woudrow Brown? Era una spia, un mitomane un criminologo? Tra il materiale
ritrovato nella borsa vi è anche un ritaglio di giornale dal quale risultava che
Brown era stato fermato dalla Polizia di Dallas in occasione dell’assassinio di
Kennedy, nel 1963. Si trovava a breve distanza dal luogo in cui si era trovata a
transitare la macchina di Kennedy. Per gli inquirenti Brown era un mitomane con
una passione per le indagini e nessun collegamento aveva con ambienti della
criminalità e del terrorismo. Resta comunque il fatto, non spiegato, di come lo
stesso fosse in possesso di una lettera di Semerari indirizzata alla Criminalpol
e sulla cui autenticità gli inquirenti avanzarono qualche dubbio pur non
escludendola. La verità giudiziaria nei vari processi Moro si basò quasi
esclusivamente sulla ricostruzione della vicenda che ne fece il brigatista
Valerio Morucci nel suo c.d. memoriale, redatto in carcere con la collaborazione
del giornalista democristiano Remigio Cavedon. Si è sempre ritenuto, sulla base
della ricostruzione della vicenda effettuata dall’ex brigatista, che nel
sequestro e nell’assassinio di Moro tutto fosse chiaro. Il memoriale fu visto
con favore dalla DC e fu avallato dall’ex capo delle BR Mario Moretti nonché da
una parte della magistratura. In realtà come osserva l’ex senatore Sergio
Flamigni nel libro “Patto di omertà” il memoriale è un documento pieno di
omissioni, di reticenze, di bugie, di vuoti e di ambiguità “che racconta una
verità ufficiale menzognera dall’inizio (la strage di via Fani) alla fine (la
prigionia e l’uccisione di Moro”. In questo libro Sergio Flamigni, non solo
ritiene del tutto inattendibile il memoriale ma afferma che lo stesso sarebbe il
frutto di un” patto di omertà” stipulato dagli ex terroristi con settori
politici, statali ed istituzionali. In altri termini il memoriale avrebbe avuto
come finalità quella di impedire una ricostruzione completa e veritiera del
sequestro e dell’omicidio del presidente della DC presentando delle lacune
gravissime e dei quesiti ancora oggi privi di risposta. Nel memoriale si
sostiene che la strage e i 55 giorni della prigionia di Moro vennero eseguiti e
gestiti soltanto dalle BR senza l’intervento di complicità esterne, di manovre o
trattative occulte. In realtà come si è visto rimangono ancora alcuni aspetti
oscuri della vicenda che non furono adeguatamente scandagliati e che possono
così riassumersi: nessuno raccolse mai i numerosi avvertimenti che indicavano
che proprio quella mattina Moro sarebbe stato rapito. Le linee telefoniche di
buona parte di Roma restarono fuori uso durante il periodo del rapimento. Il
colonnello dei servizi segreti Guglielmi era presente al rapimento fornendo
versioni contrastanti e smentite della sua presenza in via Fani la mattina del
16 marzo 1978. A distanza di 39 anni dall’agguato vennero fuori alcune foto
scattate sul luogo della strage e poi scomparse. Si tratta di 11 fotografie
scattate da un ottico di via Stresa, Gennaro Gualerzi il cui esercizio si
affacciava a metà della stradina che si snoda sull’incrocio-scena della
sparatoria. Della esistenza di queste foto vi è traccia in un rapporto del
Nucleo Operativo dei Carabinieri (allegato agli atti della prima Commissione
Moro (voll. 30-39). Circa il numero di queste foto si rileva una correzione a
mano che lo porta a 16 ma quelle effettive sono solo 11. Tra queste foto vi è
l’immagine di Giustino De Vuono, un ex legionario vicino all’estremismo politico
che nel 1975 partecipò insieme ad elementi di Autonomia operaia al sequestro
dell’ing. Carlo Saronio. Il De Vuono venne riconosciuto da un testimone tale
Rodolfo Valentino. Si ipotizzò che il De Vuono, presente sul luogo dell’agguato,
non avesse partecipato all’azione di sequestro ma si trovasse sul posto con il
ruolo di supervisore. La domanda che ci si pone è perché queste foto sparirono
dagli atti per 39 anni? Nessuna spiegazione plausibile è stata data del fatto
che la stampante utilizzata per la redazione dei comunicati delle BR proveniva
da un ufficio riservato dei servizi segreti. Non tutti i componenti il gruppo di
fuoco dell’agguato sono stati identificati. Alcune delle borse che Moro portava
sempre con sé, non furono prelevate dal commando brigatista. Però scomparvero
ugualmente, e non se ne seppe più nulla. Non è stato accertato da chi
Chicchirelli, componente della banda della Magliana, ricevette l’incarico di
redigere il falso comunicato della Duchessa nel quale, come si è detto, si
diceva che il cadavere di Moro era stato sepolto in tale lago. Chicchiarelli,
che venne ucciso a Roma nel 1984, era in effetti in contatto con le BR e quasi
sicuramente si era recato nel covo in cui era tenuto prigioniero Moro. La banda
della Magliana, alla quale Chicchiarelli apparteneva, era legata al terrorismo
nero, alla mafia, a Giusva Fioravanti, all’aristocrazia nera romana, a Flavio
Carboni, a Francesco Pazienza e a Pippo Calò. Nessuna indagine risulta essere
stata effettuata al fine di accertare quale fosse il nesso tra questi personaggi
e le Brigate Rosse e il ruolo dagli stessi avuto nella vicenda Moro. Da quanto
fin qui, sia pure sinteticamente detto, si intuisce nella vicenda del sequestro
e della uccisione di Moro, un intreccio perverso, ancora oggi oscuro, tra varie
componenti, quali servizi di sicurezza anche stranieri, criminalità comune ed
organizzata, massoneria, interessi transnazionali. E non è senza significato il
fatto che il comitato costituito presso il ministero dell’Interno per seguire la
vicenda del sequestro Moro era quasi completamente costituito da esponenti
piduisti che con l’assassinio di Moro verosimilmente perseguivano gli interessi
delle suddette componenti. In ogni caso la vicenda Moro non potrà mai essere
compresa a fondo se non verrà vista avuto riguardo al contesto internazionale in
cui maturò il delitto: una dimensione senza cui esso è condannato a restare
inintelligibile.
Il caso Moro e gli
infiltrati dei servizi nelle brigate rosse,
scrive il 4 giugno 2018 Piccole Note su Il Giornale. Difficile dire cose nuove
sul caso Moro, la tragedia che ha cambiato l’Italia nel profondo e che
resta snodo centrale della storia del nostro Paese, anche recente (è nota
l’assidua frequentazione del presidente del consiglio italiano Matteo Renzi con
Michael Ledeen, uomo della Nato la cui storia personale è legata anche a quei
giorni). Tante interpretazioni di quell’oscura vicenda, tanti interrogativi,
tante spiegazioni o rivelazioni che spesso vanno a intorbidire ancora di più le
acque. A dire qualcosa di nuovo è stato Giovanni Galloni, figura di primo piano
della democrazia cristiana, in una intervista a una televisione poco
nota, Attivo-tv, tempo fa. Nel suo intervento, l’esponente della Dc, ricordando
quei giorni, spiega: «Io non posso dimenticare il discorso che ebbi con Moro
poche settimane prima del suo rapimento. Discutevamo con Moro delle Br, delle
difficoltà di trovare i covi delle Br, e Moro mi disse: “La mia preoccupazione è
questa: che io ho per certo la notizia che i servizi segreti sia americani che
israeliani hanno degli infiltrati all’interno nelle Br, però non siamo stati
avvertiti di questo, perché se fossimo stati avvertiti i covi li avremmo
trovati». Un ricordo postumo, che giustifica così: «Me ne sono ricordato proprio
per le difficoltà che nei 55 giorni della prigionia di Moro noi avemmo con i
nostri servizi segreti a metterci in contatto con i servizi segreti americani
per ritrovare la prigione di Moro, che non fu mai ritrovata». Mentre invece,
ragiona ancora Galloni, quanto le Brigate rosse rapirono il generale
americano James Lee Dozier (1981) «la prigione fu ritrovata nel giro di quindici
giorni». Possibile che da questi infiltrati all’interno delle Brigate rosse non
arrivò alcuna indicazione? A questa domanda, posta dall’intervistatore, Galloni
risponde che forse qualche informazione, in effetti, era trapelata. E rammenta
come il giornalista Carmine Pecorelli, del cui assassinio «fu accusato
ingiustamente Andreotti», doveva aver saputo qualcosa. Così Galloni: «Pecorelli
tre giorni prima del rapimento di Moro scrisse una notizia un po’ ambigua sulla
sua agenzia, dicendo: “il 15 di marzosi verificherà un nuovo fatto gravissimo in
Italia in cui saranno implicate personalità di grande rilievo”. Lo disse tre
giorni prima […]. In realtà poi sapemmo che la cattura di Moro doveva avvenire
il giorno prima [Moro fu rapito il 16 marzo ndr.], quindi aveva imbroccato
decisamente tutto». Tanto che, è l’ipotesi di Galloni, il direttore
dell’Osservatore politico (Op) sarebbe stato ucciso proprio perché, a un certo
punto, avrebbe minacciato «di rivelare da dove aveva attinto quelle notizie. E
fu fatto fuori scientificamente, in maniera molto adeguata, probabilmente da
servizi». Il mistero che ancora aleggia su quell’oscura vicenda è dovuto anche
alla reticenza dei brigatisti. Le loro dichiarazioni, infatti, non sono state
«convincenti», secondo quanto riferito a Galloni dai magistrati che in diverse
inchieste e gradi di giudizio hanno cercato di far luce sul caso Moro. Ancora
Galloni: «Le brigate rosse interrogate oggi ci dicono che hanno già detto tutto
[…] Non è così. Probabilmente qualche cosa ci hanno taciuto; anche loro hanno
voluto coprire certe situazioni, certe realtà. Questo è l’interrogativo che
nasce». Un interrogativo che investe anche i servizi segreti italiani, meglio i
servizi «cosiddetti deviati», che poi deviati non furono secondo Galloni.
Semplicemente si trattava di funzionari che «in buona fede, ritenevano che,
stante la stretta alleanza che avevamo con l’America, su alcune questioni
delicate dovevano rispondere prima ai loro colleghi americani della Cia che non
al governo italiano».
Lo rivela l'ex
vicesegretario DC, Giovanni Galloni. Moro sapeva che le "Br" erano infiltrate da
Cia e Mossad,
scrive il 13 luglio 2015 Pmli. Prendendo spunto dal caso dell'imam egiziano
rapito da spie americane nel nostro Paese, in un'intervista trasmessa il 4
luglio scorso dal programma di approfondimento quotidiano "Next" di Rainews24,
l'ex vicepresidente della DC Giovanni Galloni ha rivelato nuovi particolari sul
rapimento di Aldo Moro che confermano l'ipotesi non nuova di un ruolo occulto
della Cia e del Mossad in quella vicenda. "Non posso dimenticare - ha dichiarato
Galloni - un discorso con Moro poche settimane prima del suo rapimento: si
discuteva delle BR, delle difficoltà di trovare i covi. E Moro mi disse: 'La mia
preoccupazione è questa: che io so per certa la notizia che i servizi segreti
sia americani che israeliani hanno infiltrati nelle BR ma noi non siamo stati
avvertiti di questo, sennò i covi li avremmo trovati"'. L'ex vicepresidente del
CSM ha aggiunto di essersene ricordato proprio ora "perché nei 55 giorni di
prigionia di Moro avemmo grandi difficoltà a metterci in contatto con i servizi
americani, difficoltà che non incontrammo poi durante il rapimento del generale
Dozier". Il generale americano della Nato J. L. Dozier fu rapito dalle "BR" a
Verona il 17 dicembre 1981 e liberato senza colpo ferire con un blitz delle
forze speciali dei Nocs il 28 gennaio 1982. Il modo rapido e apparentemente
"brillante" con cui fu risolto il caso destò subito forti sospetti sulla
possibilità che i rapitori fossero infiltrati dai servizi segreti americani, se
non addirittura che la "liberazione" dell'ostaggio fosse stata in qualche modo
concordata con i rapitori. Galloni conferma questi sospetti, rivelando una sorta
di politica a doppio binario da parte dei servizi segreti Usa nei due casi:
collaborativa nel caso di Dozier, per nulla collaborativa nel caso del rapimento
di Moro. In effetti Galloni aveva già rivelato qualcosa di simile qualche anno
fa, il 22 luglio 1998 davanti alla Commissione parlamentare sulle stragi, quando
riferì che Moro gli aveva detto: "La cosa che mi preoccupa è che credo che i
Servizi segreti americani e israeliani abbiano elementi sulle Brigate rosse che
ci sarebbero utili per le nostre indagini, ma non ce li hanno detti". Secondo
questa prima dichiarazione Moro avrebbe lamentato solo una mancanza di
informazioni da parte dei servizi Usa e israeliani, mentre ora Galloni precisa
che il presidente della DC era "certo" che essi avessero degli infiltrati nelle
"BR" e che di questo non tenessero informate le autorità italiane.
Il vero obiettivo del
rapimento Moro. La differenza è sostanziale, e tale da dare corpo all'ipotesi,
già avanzata da alcune fonti e suffragata da diversi elementi mai chiariti
finora, della presenza di spie della Cia e del Mossad dietro le quinte del
rapimento di Moro. In particolare le rivelazioni di Galloni confermano in pieno
quello che noi abbiamo sempre denunciato e sostenuto fin dall'inizio della
vicenda di Moro, e cioè che il suo rapimento, detenzione e assassinio furono
pianificati ed eterodiretti, tramite l'infiltrazione della Cia e del Mossad
nelle sedicenti "Brigate rosse", da parte del governo Usa per impedire che si
realizzasse il disegno di Moro di pilotare l'ingresso del PCI in un governo di
"unità nazionale" insieme alla DC. A conferma di ciò Galloni aggiunge
nell'intervista altri particolari significativi, come l'osservazione che "tutti
i magistrati che hanno lavorato sul rapimento Moro hanno detto che le
dichiarazioni delle BR non sono state del tutto convincenti. I brigatisti
interrogati ci dicono di aver raccontato tutto ma sappiamo che non è così.
Qualcosa ci hanno taciuto, resta da capire che cosa hanno voluto coprire. E
l'interrogativo nasce in relazione anche ai servizi segreti deviati italiani,
che rispondevano prima ai colleghi americani della Cia che ai loro superiori". E
come l'impressione riportata dai suoi numerosi viaggi negli Usa effettuati tra
il 1978 e il 1984, dove "venni a sapere - confida l'ex vicepresidente della DC e
del CSM - che la Cia era estremamente preoccupata per l'Italia, per il fatto che
se i comunisti arrivavano al governo loro non avrebbero potuto mettere certe
basi in Italia: una questione di vita o di morte, per loro, rispetto alla quale
qualunque atto sarebbe stato giustificabile". Che gli americani avessero
informazioni di prima mano sul rapimento di Moro, tali che se avessero voluto
avrebbero potuto portare all'individuazione della prigione di Moro di via
Montalcini, per Galloni è dimostrato anche dallo strano preannuncio del
rapimento dello statista democristiano, fatto tre giorni prima in forma criptica
dal giornalista Mino Pecorelli, legato ai servizi italiani "deviati" e alla Cia,
sul suo foglio scandalistico "OP". "L'assassinio di Pecorelli - aggiunge
l'intervistato - potrebbe essere stato determinato dalle cose che il giornalista
era in grado di rivelare". Le rivelazioni di Galloni sul coinvolgimento dei
servizi segreti americani nella vicenda Moro sono suffragate anche da una
testimonianza del giornalista de "l'Unità" Luigi Cancrini, che in un articolo
sul suddetto quotidiano del 7 luglio riporta le confidenze che gli furono fatte
nel 1990 in punto di morte dal professor Franco Ferracuti, docente di psicologia
giuridica all'università della Sapienza, uomo legato ai servizi segreti e alla
P2 e facente parte della commissione del ministero degli Interni istituita da
Cossiga al tempo del sequestro di Moro: il professore gli rivelò che le riunioni
della commissione che coordinava al massimo livello le azioni di tutte le forze
dell'ordine erano "non solo frequentate ma sostanzialmente dirette da due
funzionari della Cia".
Reazioni sprezzanti. Malgrado
tutto ciò le dichiarazioni di Galloni a Rainews24 sono state praticamente
ignorate tanto dalla destra neofascista quanto dalla "sinistra" borghese, ormai
perfettamente convergenti nel negare qualsiasi interpretazione "dietrologica"
del rapimento e dell'uccisione di Moro, attribuendoli esclusivamente
all'ideologia "rivoluzionaria" aberrante dei sedicenti "brigatisti rossi". C'è
da segnalare tuttavia gli interventi di due "parti in causa", e cioè i senatori
neofascisti Francesco Cossiga e Paolo Guzzanti. Il primo, con una lunga lettera
a "l'Unità" del 7 luglio, in cui ridicolizza "i ricordi sinistri di Galloni",
sostenendo che al tempo del rapimento Moro mai quest'ultimo, pur essendo a
stretto contatto con lui come suo referente per la DC, gli prospettò l'ipotesi
di un'infiltrazione della Cia e del Mossad nelle "BR". Il secondo, che è anche
presidente della Commissione Mitrokin, con un fondo su "Il Giornale" della
famiglia di Berlusconi di cui è anche il vicedirettore, in cui rigetta le
rivelazioni di Galloni quali frutto di una falsa tesi diffusa allora dal Kgb
sovietico, che a suo dire sarebbe invece il vero servizio segreto infiltrato
nelle "BR" e che ordinò e diresse per loro tramite il rapimento e l'assassinio
di Moro. Per quanto riguarda Cossiga c'è da dire che ammesso dica il vero (cosa
che nel suo caso c'è sempre da dubitare), non ci sarebbe comunque da
meravigliarsi che Galloni non gli avesse riferito le preoccupazioni di Moro,
specie se essendo depositario delle confidenze dello statista DC fosse stato già
allora a conoscenza del ruolo di Cossiga come capo di Gladio, e quindi referente
diretto dei servizi segreti americani. Quanto alla tesi di Guzzanti, pur non
escludendo del tutto che anche il Kgb possa aver avuto contatti e infiltrati
nelle "BR", cosiccome analoghi interessi alla Cia e al Mossad nel far fallire il
"compromesso storico", da qui a scambiarne il ruolo con gli americani nel caso
Moro ce ne corre. Basti pensare alla vicenda del rapimento dell'imam egiziano e
a come la Cia si muove in tutta libertà nel nostro Paese e con la piena
collaborazione dei servizi segreti italiani, suoi stretti alleati dal 1945 in
poi, per capire chi tra i due - Cia o Kgb - abbia potuto più facilmente attuare
e gestire un'operazione politico-militare così complessa come il rapimento e
l'uccisione di Moro. E in ogni caso, ammesso che a rapire Moro fosse stato un
servizio segreto avversario della Cia, possibile che questa, che opera in Italia
come in casa sua, non ne sapesse nulla e non fosse in grado di scovare la
prigione del sequestrato? Si provi a immaginare un'operazione altrettanto
spettacolare e clamorosa, attuata dalla Cia in un paese dell'allora blocco
socialimperialista sovietico, condotta per 55 giorni sotto il naso del Kgb,
senza che questo riuscisse a capirci nulla. Quantomeno irreale! Resta da capire
perché Galloni si è deciso solo ora, dopo quasi trent'anni, a rivelare
l'importante confidenza di Moro, quando tutto è stato abbuiato e nessuno, né a
destra né a "sinistra", ha più interesse a fare luce sui veri burattinai, in
Italia e all'estero, che hanno tirato le fila del suo rapimento e sul disegno
politico che lo ha ispirato: che è quello piduista della seconda repubblica
neofascista, presidenzialista e federalista di Gelli, Craxi e Berlusconi, ma che
oggi sta bene anche alla "sinistra" borghese composta da rinnegati, falsi
comunisti, riformisti e democristiani. Il fatto è che anche Galloni, come
appartenente a tale "sinistra", ha coperto questo disegno è stato complice, ed è
per questo che le sue rivelazioni finiscono per essere reticenti e tardive e
cadere oggi sostanzialmente nel vuoto. Mentre se fatte a suo tempo avrebbero
avuto ben altro peso ed effetto sulla situazione politica.
CASO MORO: GALLONI RISPONDE
A PASCALINO,
scrive il 9 dicembre 1993 Adnkronos. Il Consiglio Superiore della Magistratura
non può interrogare l'ex Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma,
Pietro Pascalino, sulle rivelazioni di Francesco Cossiga in merito al caso Moro,
dal momento che il magistrato è andato in pensione. In ogni caso, al termine
dell'ispezione promossa dal ministro Conso, il Csm sicuramente si pronuncerà
sull'accaduto. E' quanto si legge in una lettera inviata dal Vicepresidente del
Csm, Giovanni Galloni, a Pietro Pascalino. ''Ho preso cognizione -scrive
Galloni- della sua lettera aperta nella quale esprime il comprensibile disagio
in lei provocato dalle dichiarazioni dell'onorevole Cossiga sulla collaborazione
di magistrati per la formazione di un piano diretto a comprimere la libertà
personale dell'onorevole Moro nel caso in cui fortunatamente fosse stato
liberato dalla sua prigionia''. ''Per quanto fui a conoscenza della dolorosa
vicenda -prosegue Galloni- nei 55 giorni di ansiosa attesa e di speranza della
restituzione di Moro vivo non posso che confermare la sua categorica smentita.
Tuttavia per ragioni insuperabili di forma e di sostanza che lei ben conosce non
possiamo come Csm aprire un'indagine promossa o sollecitata da un magistrato
che, pur sentendosi a ragione parte ancora in senso morale dell'ordine
giudiziario servito con ben 40 anni spesi con intelligenza e con grande senso di
equità al servizio della giustizia, non fa piu' parte solo materialmente
dell'ordine soggetto al governo del Csm''.
Giovanni Galloni è morto/
“Il cervello più lucido della Dc”: amico di Moro, ex ministro e vicepresidente
Csm. È morto
Giovanni Galloni, ex ministro e storico esponente della Dc: "il cervello più
lucido della Democrazia Cristiana". Amico di Moro e Andreotti, ex vicepresidente
del Csm: la sua eredità, scrive il 23 aprile 2018 Niccolò Magnani su "Il
Sussidiario". Era definito negli ambienti della politica come “il cervello più
lucido della Dc”: è morto nella sua abitazione di Roma nord Giovanni Galloni,
storico rappresentante della Democrazia Cristiana, più volte ministro e anche
vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). Un addio
importante nel mondo della Prima Repubblica, un esponente di rilievo che fece
spesso da “tramite” per le varie anime interne della “Balena Bianca” da
Andreotti e Moro, profondo uomo di cultura e di fede è stato ed è ancora per
tutti gli “eredi” della Dc uno dei maggiori ispiratori. Nei due libri scritti
“Trent’anni con Aldo Moro” e “Giuseppe Dossetti profeta del nostro tempo”
Galloni ha saputo raccontare le due anime della Democrazia Cristiana, ovvero la
sacralità della Dottrina sociale della Chiesa e insieme il rispetto e il valore
della Carta Costituzionale di cui lui fu un grande “estimatore”. «Certamente
vengono da lì i valori e le regole di cui abbiamo bisogno per vincere non
soltanto la corruzione ma anche la più estesa malattia politica che sta mettendo
a dura prova l’Italia», disse di quel libro Beppe Pisanu in una intervista sul
Corriere della Sera. Fu tra i fondatori della corrente di sinistra della
Democrazia cristiana, tra i migliori amici di Aldo Moro e più volte ministro
dell’Istruzione sia nei governi Goria (dal 1987 al 1988) che nell’esecutivo De
Mita (1988-1989); per 4 anni poi fu anche il vicepresidente e membro del Csm,
oltre che in epoca più recente (era il 2009) fu tra i fondatori del Movimento
Sinistra cristiana-Laici per la giustizia. Nel ricordare più volte l’amico
ucciso nel celebre sequestro delle Brigate Rosse, Galloni amava ripetere che
«Moro in un discorso una settimana prima del rapimento mi disse che “La mia
preoccupazione è questa: che io so per certa la notizia che i servizi segreti
sia americani che israeliani hanno infiltrati nelle Br ma noi non siamo stati
avvertiti di questo, sennò i covi li avremmo trovati”». Nelle sue lezioni di
politica e giurisprudenza, Galloni ripeteva spesso che finita l’epoca dei
partiti ideologici (Pci, Dc, Psi ecc) bisognava assolutamente tornare alla
cultura politica della Carta Costituzionale o ci saremmo arresi allo stallo e al
caos politico. Galloni lascia una famiglia che lo adorava, in particolare modo i
due figli Nino (noto e stimato economista) e Matteo, un sacerdote che a Firenze
ha fondato anni fa la comunità Amore e Libertà per accogliere bambini poveri,
malati e sotto disagio inviati dai Centri Sociali.
Nino Galloni: Come ci hanno
deindustrializzato,
scrive il 29 luglio 2013 "Inchiesta On Line". Per il Dossier L’Europa verso la
catastrofe? pubblichiamo una intervista di Claudio Messora de Il fatto
quotidiano a Nino Galloni, economista, ex direttore del Ministero del Lavoro.
Nino Galloni è figlio di Giovanni Galloni amico e stretto collaboratore di Aldo
Moro.
MESSORA: Nino, buongiorno.
GALLONI: Buongiorno!
MESSORA: Benvenuto
su byoblu.com, a queste interviste volute dalla rete. Io ero rimasto molto
colpito dalla tua affermazione in un convegno che ripresi e misi su Youtube,
intitolando il video “Il funzionario oscuro che fece paura a Kohl”. Nel tuo
racconto del processo con il quale siamo entrati nell’euro, tratteggiavi questa
decisione assunta dalla politica italiana di un vero e proprio progetto di
deindustrializzazione del nostro paese. E mi sono sempre chiesto: ma perché mai,
alla fine, la politica avrebbe dovuto decidere questo strangolamento, questo
inaridimento, la morte del nostro tessuto produttivo? Ho cercato, via via, delle
risposte nel tempo, ma oggi che sei qua forse queste risposte ce le puoi dare
tu. È un processo, quello di deindustrializzazione, che parte da molto lontano.
Riesci a farci una carrellata di eventi e poi arriviamo al focus?
GALLONI: Credo che la data
dalla quale dobbiamo necessariamente partire sia il 1947, quando al Trattato di
Parigi De Gasperi cede una parte della nostra sovranità, ma in cambio ottiene il
riassetto di certi equilibri. La componente socialcomunista esce dal governo, ma
manterrà una grande influenza nel campo creditizio e questo, vedremo, sarà un
fattore decisivo una trentina di anni dopo.
MESSORA: gli Stati Uniti hanno
avuto un bel ruolo in questa decisione.
GALLONI: Gli Stati Uniti hanno
avuto un bel ruolo perché chiaramente gli aiuti del Piano Marshall erano
condizionati all’uscita dei comunisti dal governo. In realtà Togliatti,
giustamente, si lamentava del fatto che ci fosse questo ricatto, ma era
perfettamente consapevole di doverlo fare di uscire dal governo, anche perché
tutto sommato alla Russia stalinista non faceva comodo un Partito Comunista al
governo, come poi trent’anni dopo non farà scomodo il rapimento e l’omicidio di
Aldo Moro, che tutto sommato era stato additato come interessato a fare
avvicinare i comunisti all’area di governo, cosa che poi potrebbe essere
sfatata.
Ma torniamo all’industria.
Quindi nel 1947 la produzione industriale, per non parlare della produzione
agricola italiana, è a livelli del 1938. Il paese è semidistrutto. Tuttavia
inizia una ricostruzione. Ad un certo punto di questa ricostruzione, in cui
hanno un ruolo le industrie energetiche, quindi Mattei, ma si comincia a
sviluppare in modo sorprendente anche il nucleare, ci si trova già negli anni
’60 nel miracolo. Cioè piccole industrie, grandi industrie, industrie a
partecipazione statale, soprattutto, e anche cooperative, trainano l’Italia in
una situazione completamente diversa. Negli anni ’70 scopriamo che abbiamo
superato l’Inghilterra, scopriamo che ci stiamo avvicinando alla Francia,
scopriamo che possiamo, dal punto di vista manifatturiero, andare a dar fastidio
alla Germania. Nel ’71 si sgancia la moneta dall’oro e questo rende teoricamente
tutto più facile: gli aumenti salariali anche in termini reali, la spartizione
dei guadagni di produttività che va in parte ai lavoratori e quindi aumentano i
consumi, aumentano le vendite, aumenta il valore delle imprese. Questo è un
concetto fondamentale che oggi è stato completamente dimenticato. Oggi la
consapevolezza e l’orizzonte delle imprese – e di questo ha grave responsabilità
la Confindustria – è ridotto all’immediato, al profitto annuale. Le imprese
dovrebbero traguardare obiettivi di crescita del valore delle imprese stesse, in
modo di contrattare poi con le banche tassi di interesse buoni e invece manca
completamente questa consapevolezza.
MESSORA: Negli anni ’70
eravamo all’apice.
GALLONI: All’apice. Diciamo
che forse l’anno di maggior crescita è proprio il ’78, che è l’anno, non a caso,
del rapimento di Moro.
MESSORA: Cioè noi stavamo
raggiungendo e superando le altre economie avanzate.
GALLONI: C’erano stati altri
segnali gravissimi di attacco al sistema italiano, come appunto l’omicidio di
Mattei, ordinato perché aveva pestato i piedi alle “Sette Sorelle” in Medio
Oriente, trovando una formula che ci aveva dato una posizione nel Mediterraneo
veramente ragguardevole dal punto di vista della politica estera. E non ci
dimentichiamo che Moro era amico degli arabi moderati, quindi aveva contro
Israele e aveva contro gli arabi estremisti. Poi abbiamo visto che aveva contro
la Russia, che non voleva un avvicinamento del Partito Comunista Italiano al
governo e anzi mal sopportava l’importanza in Europa di questo grande partito, e
gli americani che temevano – questa è la versione non dico ufficiale, ma su cui
concordano molti osservatori, che dobbiamo (va citato in questo caso) alla
ricostruzione di mio padre, che era principale collaboratore di Moro a quei
tempi – che l’avvicinamento del Partito Comunista all’area di governo, secondo
i loro centri studi, i loro servizi, avrebbe potuto vanificare il principale
piano strategico di difesa dell’Occidente nei confronti della Russia sovietica,
che aveva una supremazia evidente di terra. Quindi un’avanzata dei carri armati
sovietici attraverso la Germania orientale, poteva essere fermata prima che i
carri arrivassero nella Germania occidentale solo con degli ordigni atomici
tattici che erano necessariamente e solo piazzabili e piazzati nel Nord-Est
dell’Italia. Quindi se non si poteva fermare con armi atomiche nucleari tattiche
l’avanzata dell’esercito sovietico verso occidente, l’Europa era persa e quindi
gli americani se ne sarebbero dovuti andare dall’Europa, conseguentemente dal
Mediterraneo che – teniamolo sempre presente – è l’ombelico del mondo. Ma questo
è un quadro teorico.
MESSORA: Spieghiamolo bene.
Cosa c’entra Moro in questo quadro? Cosa c’entra Moro con le bombe nucleari?
GALLONI: c’entra! Perché se
Moro faceva riavvicinare i comunisti al governo, si pensava che i comunisti
avrebbero posto un veto all’uso di ordigni nucleari, anche nel caso di
un’avanzata dei carri armati sovietici verso occidente. Ma erano scenari che gli
americani fanno continuamente, non è detto che le politiche si debbano ispirare
a quello. Però c’è un fatto di cui ci sono testimonianze certe, anche della
famiglia di Moro: Kissinger gliel’aveva giurata, aveva minacciato Moro di morte
poco tempo prima, Moro lo aveva riferito alla famiglia e la famiglia aveva detto
“ritirati dalla politica”, cosa che poi lui non aveva fatto, ma non si sa poi
che cosa avesse in mente di fare dopo quel fatidico marzo 1978.
MESSORA: Quindi le Brigate
Rosse in realtà avevano avuto un ruolo…
GALLONI: Dobbiamo distinguere
le prime Brigate Rosse, per capirci quelle di Curcio, che erano un fenomeno
promanante dall’incontro tra l’estremismo, un certo tipo di estremismo
marxista-leninista, che bene o male aveva un legame col Partito Comunista, anche
se lontano, e forze che tutto sommato, partigiani ed ex partigiani che avevano
conservato le armi, anche perché si sapeva che dall’altra parte c’era la
minaccia; tutti gli anni ’70, e forse anche prima, sono stati vissuti con l’idea
che potesse esserci un golpe di destra, quindi partigiani ed ex partigiani
avevano conservato armi, soprattutto nel nord. Quindi una certa continuità col
terrorismo si può anche vedere. Le seconde Brigate Rosse, quelle che – per
capirci – rapirono Moro, eccetera, invece sono fortemente collegate con i
servizi, con deviazioni dei servizi, con i servizi americani, israeliani; ci
sono evidenze ormai incontrovertibili su questa lettura. Torniamo all’industria.
Il problema qual è? Il problema è che in pratica il gioco è: quanto e come ci
avviciniamo all’Europa, quanto e come sviluppiamo l’economia italiana, che già
appunto era arrivata a livelli, come abbiamo detto, di eccellenza. Allora ci
sono due strategie, fondamentalmente. C’è la strategia più moderata che vuole
l’Europa e che faceva capo anche a Moro, ma che faceva capo anche a Paolo Baffi,
governatore della Banca d’Italia, e ad altri personaggi del mondo economico e
finanziario italiano, e poi invece emerge una posizione più estremista, pro
Europa, che praticamente fa propria l’idea che si debba combattere la classe
politica corrotta e clientelare e tutte le sue espressioni facenti capo
fondamentalmente alla Democrazia Cristiana e ai suoi partiti alleati, compreso
il Partito Socialista, e che per questo si debbano anche cedere porzioni di
sovranità, e si comincia con la sovranità monetaria.
MESSORA: Ma chi si faceva
propugnatore di questa tesi?
GALLONI: Intanto era cambiata
la dirigenza della Banca d’Italia ed era passata la linea, diciamo, più
estremista sull’Europa, facente capo a Carlo Azeglio Ciampi. Poi la sinistra
democristiana era divisa tra la sinistra sociale, che faceva capo a
Donat-Cattin, che era su posizioni euromoderate, e la sinistra politica, che
faceva capo a De Mita e soprattutto a Beniamino Andreatta, che invece era su
posizioni euroestremiste e giustificavano questa rinuncia alla sovranità
monetaria, cioè alla possibilità dello Stato di fare investimenti pubblici
produttivi, per impedire alla classe politica stessa, corrotta e clientelare, di
avere potere. Quindi per sottrarre potere alla classe politica, si cominciò a
rinunciare alla sovranità monetaria, quindi agli investimenti pubblici. Quindi
la classe politica poi si trovò ad occuparsi solo di nomine, di poltrone,
eccetera, perché non c’era più da discutere gli investimenti pubblici che ormai
dovevano minimizzarsi. Degli investimenti pubblici la componente più importante
era sicuramente quella riguardante le partecipazioni statali, l’energia, i
trasporti e via dicendo, dove l’Italia stava primeggiando a livello mondiale.
MESSORA: Mario Monti era molto
vicino a De Mita, quindi potremmo dire che già da allora era un euroestremista.
GALLONI: Di Monti mi ricordo
la posizione sulla scala mobile, che era stata considerata interessante da
Donat-Cattin, però poi, per il resto, era sicuramente un rappresentante della
scuola monetarista, non era un keynesiano. I keynesiani si stavano abbandonando.
Anche Andreatta, pur essendo stato un keynesiano, era entrato in quella che noi
chiamiamo “la corrente neo-keynesiana”, li chiamiamo anche “keynesiani
bastardi”, di cui il maggior rappresentante era il premio Nobel Modigliani, i
quali proponevano appunto questo passaggio rispetto alla moneta che impedisse
alla classe politica di decidere investimenti in infrastrutture per lo sviluppo
industriale, per lo sviluppo del paese. Ecco, questo è stato un errore cruciale
che ha determinato poi l’esplosione dei tassi di interesse e quindi del debito
pubblico, ma soprattutto l’accorciamento di orizzonte delle imprese industriali
che assumevano sempre di meno perché dovevano valutare il profitto immediato e
non potevano stare a fare grandi progetti industriali. Quindi quello che accadde
per gli investimenti pubblici, accadde anche per gli investimenti privati, a
causa degli alti tassi di interesse. Io negli anni ’80 feci una ricerca che
dimostrava che i 50 gruppi più importanti pubblici e i 50 gruppi più importanti
privati facevano la stessa politica, cioè investivano la metà dei loro profitti
non in attività produttive ma nell’acquisto di titoli di Stato, per la semplice
ragione che i titoli di Stato italiani rendevano tantissimo e quindi si
guadagnava di più facendo investimenti finanziari invece che facendo
investimenti produttivi. Questo è stato l’inizio della nostra
deindustrializzazione. Il passaggio successivo però è molto più grave e riguarda
appunto il periodo che va dalla fine degli anni ’80 all’inizio delle
privatizzazioni.
MESSORA: Ci arriviamo. Ci
spieghi però, a noi che non siamo economisti, come si lega questa nuova politica
monetarista con l’esplosione dei tassi di interesse? Questo passaggio tecnico ce
lo spieghi un po’?
GALLONI: Fino al 1981 la Banca
d’Italia, se un’emissione di obbligazioni pubbliche che servivano per ottenere
moneta da parte dello Stato non veniva completamente coperta, comprava lei il
restante, quindi era la compratrice di ultima istanza, come diceva il mio
maestro Federico Caffè. Questo faceva sì che se l’emissione avveniva a un tasso
di interesse basso, mettiamo del 3%, e una parte non veniva comprata proprio
perché il rendimento era basso, la Banca d’Italia comprava quello che avanzava e
quindi emetteva moneta. Con il divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia, era data
alla Banca d’Italia la facoltà di non essere obbligata… Sembra un po’ un gioco
di parole però, in fondo, lo stesso divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia, di cui
stiamo parlando, non è che obbligava la Banca d’Italia a non comprare titoli, le
dava la facoltà di non farlo e la pratica, voluta da Carlo Azeglio Ciampi, fu di
applicare questo divorzio in modo letterale. Per la cronaca, ricordo che
l’Inghilterra aveva le stesse regole, perché noi copiammo quelle, ma non le
praticava. Cioè la Banca d’Inghilterra, quando serviva, stampava sterline a
gogò, mentre la Banca d’Italia si irrigidì su quella facoltà che le era stata
riconosciuta attraverso una semplice lettera del Ministro del Tesoro Beniamino
Andreatta, e quindi la parte di emissione obbligazionaria che non veniva
coperta, causava un aumento del tasso di interesse finché non si piazzava questo
residuo, ma poi questo tasso di interesse andava ad essere applicato su tutta
l’emissione della mattinata. Quindi in questo modo c’è stata una rincorsa dei
tassi di interesse verso l’alto. In effetti io feci un appunto e ci fu una
discussione col Ministro del Tesoro, in cui dimostrai oltre ogni ragionevole
dubbio, applicando semplicissimi tassi di capitalizzazione – come sanno tutti
gli economisti – che il debito pubblico sarebbe raddoppiato e avrebbe superato
il Pil. Addirittura mi dissero che il debito pubblico non poteva superare il
Pil, se no il sistema saltava, al che io gli feci presente che non era così,
perché il debito è uno stock e il Pil è un flusso. Ma avevano deciso una cosa e
non volevano più cambiarla, non accettavano né le critiche di Federico Caffè né
quelle di Paolo Leon, figuriamoci le mie! Per cui poi litigammo e io andai via
da quella amministrazione. E siamo a metà degli anni ’80. Il peggio deve ancora
arrivare.
MESSORA: Lo scopo era soltanto
quello nobile di sottrarre alla politica la gestione dei soldi e quindi andare
verso un’Europa che avrebbe potuto salvarli in qualche maniera, o c’era anche
sotto una strategia che poi avrebbe portato al nostro processo non solo di
deindustrializzazione ma anche di privatizzazione? Qual è stata la road map
successiva?
GALLONI: Nel mio ultimo libro
“Chi ha tradito l’economia italiana”, infatti, affronto questo problema e
identifico due tipi di personaggi, cioè quelli che in buona fede volevano fare i
salvatori della patria, come hai ricordato tu, ma anche quelli che traguardavano
nella possibilità di una svendita delle partecipazioni statali, nelle
privatizzazioni – allora si chiamavano dismissioni – la possibilità di fare
immensi profitti, come fu. Quindi c’è stata anche una parte di questa
componente, diciamo così, anti-statalista, anti-italiana, anti-sviluppista, che
ha fatto affari strepitosi e su cui qualcuno, infatti, ha proposto una
commissione di indagine parlamentare.
MESSORA: arriviamo quindi, con
questo ragionamento, all’inizio degli anni ’90.
GALLONI: Sì. Diciamo che c’è
il passaggio successivo. È prima dell’inizio degli anni ’90, perché all’inizio
degli anni ’90 avviene il crollo del sistema monetario europeo, perché non era
sostenibile per la semplice ragione che produceva tassi di interesse più alti
per i paesi deboli, che quindi si indebolivano di più, e tassi di interesse più
bassi per i paesi forti, che quindi si rafforzavano di più. Ad un certo punto il
sistema è saltato, ma era prevedibile. Ma noi ci dobbiamo rapportare,
raccontando gli eventi, al tempo in cui accadevano, perché col senno del poi
siamo tutti bravi. Nell’89 è emerso, qualcuno aveva detto – lì entra in gioco
l’oscuro funzionario, probabilmente-, l’apice della classe politica italiana,
che tutto sommato faceva capo in quel momento a Giulio Andreotti, capisce che
bisogna trovare una strada un po’ diversa, perché se no si compromettono gli
interessi nazionali. Tra le altre cose, quindi, mi manda un biglietto, mi scrive
Giulio Andreotti e mi dice “caro dottore, vuole collaborare con noi per cambiare
l’economia di questo paese?”. Al che io entusiasticamente aderisco. Per farla
breve io mi trovo al vertice del Ministero del Bilancio, che era il ministero
cruciale, alla fine dell’estate del 1989. Quindi in quel momento Andreotti era
più vicino alle posizioni americane e più lontano dalle posizioni europeistiche
estreme. Passano poche settimane, perché dalla fine di agosto dell’89, quando io
ho ripreso servizio al mio ex ministero, fino a quando praticamente vengo di
nuovo estromesso, che è novembre, passano due mesi praticamente. In questi due
mesi io metto mano, e si sa in giro che io sto mettendo mano, ci fu anche un mio
incontro molto in tensione con Mario Monti alla Bocconi. Io stavo appunto col
mio Ministro e ci fu questo scontro piuttosto forte sul problema della moneta e
del debito pubblico; avevamo posizioni completamente diverse.
MESSORA: La tua qual era?
GALLONI: La mia era che
praticamente si dovesse operare per abbassare i tassi di interesse in qualunque
modo e dimostrai appunto che la Banca d’Inghilterra aveva lo stesso regime
nostro, cioè il divorzio, ma non lo praticava, quindi quando serviva al paese
stampava sterline. Questo era il problema.
MESSORA: E la sua?
GALLONI: La sua, che si
dovesse andare avanti su una politica di forte europeizzazione e quindi si
dovesse continuare con questo forte debito pubblico. Dopo questo incontro alla
Bocconi in effetti si scatena l’inferno, perché arrivano pressioni dalla Banca
d’Italia, dalla Fondazione Agnelli, dalla Confindustria e vengo a sapere che
persino un certo Helmut Kohl aveva telefonato al Ministro del Tesoro Guido Carli
per dire “c’è qualcuno che rema contro il nostro progetto”, adesso le parole le
ho ricostruite in base a delle testimonianze dirette, però vengono fatte
pressioni sul mio Ministro affinché io venga messo da parte, cosa che avviene
nel giro di un pomeriggio, nel senso che io ottengo dal Ministro la verità, mi
rivela la verità, la scriviamo su un pezzo di carta perché lui temeva ci fossero
dei microfoni, gli faccio vedere questo pezzetto di carta, dico “ci sono state
pressioni anche dalla Germania sul Ministro Carli perché io smetta di fare
quello che stiamo facendo?” e lui mi fece di sì con la testa. Per cui ho
mantenuto rispetto per questa persona, però me ne sono andato. Che cosa era
successo? Che fino all’estate del 1989 Andreotti era contrario alla
riunificazione tedesca e questo fatto impediva qualunque progresso, ovviamente,
perché la Germania voleva fare la riunificazione.
MESSORA: e ci fu quella famosa
battuta.
GALLONI: sì, sì. Infatti in
quei tempi ad Andreotti chiesero “ma lei ce l’ha tanto con la Germania?”, dice
“no, io amo la Germania. Anzi, la amo talmente tanto che mi piace che ce ne
siano addirittura due!”. Questa era la frase. Passano appunto pochi mesi e
invece la Germania, pur di ottenere la riunificazione, si mette d’accordo con la
Francia per rinunciare al marco, che era quello che faceva paura alla Francia.
Però perché questo accordo tra Kohl e Mitterand regga, occorre
deindustrializzare l’Italia e indebolire l’Italia. Perché se no che fanno? Si
passa a una moneta unica e l’Italia poi…
MESSORA: che stava fiorendo.
GALLONI: stava già perdendo
colpi l’industria italiana, da vari punti di vista, però era una situazione
ancora di dominio del panorama manifatturiero internazionale. Eravamo la quarta
potenza che esportava. Voglio dire, eravamo qualcosa di grosso dal punto di
vista industriale e manifatturiero. Bastavano alcuni interventi, bisognava
riprendere degli investimenti pubblici e cose del genere. Dopodiché, ovviamente,
si entra nella stagione delle privatizzazioni spinte, negli anni ’90, in cui
praticamente quasi scompare la nostra industria a partecipazione statale.
MESSORA: Quindi decidono la
deindustrializzazione. Dopodiché c’è qualcuno che si attiva.
GALLONI: Sì. La
deindustrializzazione significa che non si fanno più politiche industriali. Non
ci dimentichiamo che poi c’è stato un periodo in cui Bersani era Ministro
dell’Industria, in cui, diciamolo, teorizzò che non servivano le strategie
industriali. Adesso sta dicendo il contrario, ma poteva pensarci pure prima. Per
dirne una. Non si fanno politiche per le infrastrutture. Questo è importante,
perché è un paese che è molto lungo, quindi è costoso trasportare le merci da
sud a nord, mentre il nord è già in Europa dal punto di vista geografico e
infrastrutturale, il centro e il sud sono lontani, quindi potenziare le
infrastrutture sarebbe stato strategico.
Poi, alla fine degli anni ’90,
si introduce la banca universale, quindi la possibilità per la banca di
occuparsi di meno del credito all’economia e di occuparsi di più di andare a
fare attività finanziarie e speculative che poi avrebbero prodotto solo dei
disastri, come sappiamo.
MESSORA: La fine del
Glass-Steagall Act.
GALLONI: Sì, esatto. Poi la
mancanza di strategie efficaci della stessa FIAT, dell’industria privata.
Ripeto, in quegli anni la Confindustria era solo presa dall’idea di introdurre
forme di flessibilizzazione sempre più forti – che poi avrebbero prodotto la
precarizzazione – aumentare i profitti, quindi una visione poco profonda di
quello che è lo sviluppo industriale, quindi perdita di valore delle imprese,
perché le imprese guadagnano di valore se hanno prospettive di profitto che
dipendono dalle prospettive di vendita. Questo è l’ABC. Se invece difendono il
profitto oggi perché devono realizzare e devono portare ai proprietari una certa
redditività ma poi, voglio dire, compromettono il futuro di un’azienda, questa
perde di valore.
MESSORA: Si narra di questo
incontro sul Britannia. Qual è stato il ruolo anche dell’Inghilterra, secondo
te?
GALLONI: L’Inghilterra non è
che avesse un interesse diretto all’indebolimento dell’Italia nel Mediterraneo,
ma ha una strategia complessiva in Africa e in Medio Oriente, che ha sempre teso
ad aumentare i conflitti, il disordine, e c’è la componente che fa capo alla
corona, di cui sono espressione anche alcuni movimenti ambientalisti, che poi si
debba puntare a una riduzione drastica della popolazione del pianeta; quindi è
contraria ad ogni politica che invece favorisca lo sviluppo così come lo
intendiamo comunemente.
MESSORA: Quindi è vero che sul
Britannia si presero delle decisioni?
GALLONI: Qui dobbiamo capirci.
Allora, Bilderberg, Britannia, il Gruppo dei 30, dei 10, gli Illuminati di
Baviera, sono tutte cose vere. Gente che si riunisce, come certi club massonici,
e decidono delle cose. Ma non è che le decidono perché veramente le possono
decidere, è perché non trovano resistenza da parte degli Stati. L’obiettivo è
quello di togliere di mezzo gli Stati nazionali allo scopo di poter aumentare il
potere di tutto ciò che è sovranazionale, multinazionale e internazionale in
questo senso. Dopodiché è ovvio che se gli Stati sono stati indeboliti o
addirittura nei governi ci sono rappresentanti di questi gruppi, che siano il
Britannia, il Bilderberg, gli Illuminati di Baviera, eccetera, negli Stati Uniti
d’America c’era la Confraternita dei Teschi, di cui facevano parte padre e
figlio Bush, che sono diventati presidenti degli Stati Uniti. E’ chiaro che dopo
questa gente risponde a questi gruppi che li hanno, bene o male, agevolati nelle
loro ascese.
MESSORA: Quindi alla fine
decidono.
GALLONI: Ma perché dall’altra
parte è mancata, da parte dei cittadini e degli Stati, una seria resistenza.
Quindi praticamente questi dominano la scena.
MESSORA: Quindi non è colpa di
questi ma è colpa di chi non si oppone abbastanza.
GALLONI: Questi si riuniscono,
decidono delle cose, però rimangono lì. Ci sono sempre stati i circoli dei
notabili che hanno deciso delle cose. Mica è detto che siano riusciti sempre a
farle!
MESSORA: Però in questo caso
ci sono riusciti.
GALLONI: In questo caso ci
sono riusciti perché non hanno trovato resistenza.
MESSORA: Quindi è colpa
nostra.
GALLONI: Beh, sì, un po’ sì,
secondo me.
MESSORA: L’ignavia del
cittadino che non rivendica il potere.
GALLONI: Sì. Ad esempio l’idea
montiana che l’aumento della base monetaria produca inflazione è stato ciò che
ha consentito di attrarre anche i sindacati in un’area di consenso per quelle
riforme sbagliate che si sono fatte a partire dal 1981, quando invece si è
dimostrato, anche in tempi recenti, che l’emissione e l’autorizzazione di mezzi
monetari per migliaia, decine di migliaia di dollari e di euro non ha prodotto
l’iper inflazione. Quindi evidentemente è qualcos’altro che genera l’inflazione,
non è la quantità di moneta. La quantità di moneta può influire sui tassi di
interesse attraverso le tensioni della domanda di essa, ma non è che influiscano
direttamente sull’inflazione. Certo, paradossalmente potrebbe essere il
contrario: se la moneta è poca e i tassi di interesse aumentano, quelli hanno
effetti sui livelli dell’inflazione.
MESSORA: Quindi l’ignoranza
degli attori sociali è stata o anche un certo tornaconto?
GALLONI: Una cosa non esclude
l’altra. Diciamo che quelli che volevano avere un certo tornaconto facevano leva
sull’ignoranza dei fatti monetari, dei partiti, dei sindacati, della classe
dirigente e anche una certa scomparsa della scuola keynesiana dovuta a vari
fattori anche oscuri.
MESSORA: Quindi
privatizzazioni. Anni ’90. Cosa succede poi?
GALLONI: Dopo gli anni ’90 la
situazione praticamente comincia a precipitare quando inizia questa crisi, che è
il 2001. Quando gli operatori di borsa si accorgono che anche i titoli che
avevano tirato fino a quel punto, e-commerce, e-economy, prodotti avanzati,
eccetera, non danno più rendimenti crescenti, allora cominciano a svendere e
comincia la speculazione al ribasso. In quelle condizioni le banche, che avevano
preso grandi impegni coi sottoscrittori dei loro titoli, perché erano diventate,
come ho ricordato prima, universali, per garantire questi rendimenti fanno
operazioni di derivazione. Le operazioni di derivazione sono tipo catene di
Sant’Antonio: tu acquisisci denaro per dare i rendimenti e quindi posticipi la
possibilità di dare i rendimenti agli ultimi che ti hanno affidato delle somme.
Questa cosa, si è fatta nel giro di due o tre mesi, perché dopo c’era la
ripresa, era sempre stata fatta dalle banche, è un’operazione tecnica, diciamo
così. Quindi di tre mesi in tre mesi si diceva che arrivava la ripresa. Centri
studi, economisti, osservatori, studiosi, ricercatori, tutti sui loro libri
paga, prevedevano di lì a tre mesi, di lì a sei mesi, la ripresa. Non si sa
perché. Perché le politiche economiche volute per esempio da Bush, tipo la
riduzione delle tasse, erano chiaramente politiche che non avrebbero risolto il
problema della crescita. Poi tutte queste guerre americane, speculazioni,
vanificavano la potenza di un dollaro che se fosse stato destinato a
investimenti produttivi, alla ricerca, alle infrastrutture, eccetera,
probabilmente avrebbe creato una situazione accettabile. Invece non si faceva
niente di tutto questo, non si avviavano gli investimenti produttivi pubblici,
perché i privati non investono se non c’è prospettiva di profitto; come avviene
in borsa così avviene nell’economia reale. Quindi siamo andati avanti anni e
anni con queste operazioni di derivazione, emissione di altri titoli tossici.
Finché si è scoperto, intorno al 2007, che il sistema bancario era saltato, nel
senso che nessuna banca prestava liquidità all’altra, sapendo che l’altra faceva
le stesse cose che faceva lei stessa, cioè speculazioni in perdita. La massa dei
valori persi dalle banche sui mercati finanziari superava, per la prima volta,
la massa di quello che le famiglie, le imprese e la stessa economia criminale
mettevano dentro il sistema bancario. Di qui la crisi di liquidità che deriva da
questo, cioè che le perdite superavano i depositi e i conti correnti. A questo
punto è intervenuta la FED e ha cominciato a finanziare le banche, anche
europee, nelle loro esigenze di liquidità. La FED ha emesso, dal 2008 al 2011,
17 mila miliardi di dollari, cioè più del Pil americano, più di tutto il debito
pubblico americano, ha autorizzato o immesso mezzi monetari in qualche modo e
poi ha chiesto all’Europa di fare altrettanto. L’Europa alla fine del 2011 ha
offerto qualche resistenza e poi, anche con la gestione di Mario Draghi, ha
fatto il “quantitative easing”, cioè dare moneta illimitatamente per consentire
alle banche di non soffrire di questa crisi di liquidità derivante dalle perdite
che superano nettamente le entrate. Ovviamente l’economia è sempre più in crisi,
quindi i depositi che seguono gli investimenti produttivi sono sempre di meno e
le perdite, invece, sono sempre di più. Allora il problema qual è? Perché
continua questo sistema? Questo sistema continua per due ragioni. La prima è che
chi è ai vertici delle banche, e lo abbiamo visto anche al Monte dei Paschi,
guadagna sulle perdite. Perché non guadagna su quello che sono le performance,
come sarebbe logico, ma guadagna sul numero delle operazioni finanziarie che si
compiono, attraverso algoritmi matematici, sono tantissime nell’unità di tempo.
Quindi questa gente si porta a casa i 50, i 60 milioni di dollari e di euro,
scompare nei paradisi fiscali e poi le banche possono andare a ramengo. Non
vanno a ramengo perché poi le banche centrali, che sono controllate dalle stesse
banche che dovrebbero andare a ramengo, le riforniscono di liquidità.
MESSORA: Non solo le banche
centrali, anche i governi.
GALLONI: Sì, ma sono le banche
centrali che autorizzano i mezzi monetari.
MESSORA: Ma i Monti bond? Chi
ce li ha messi i soldi?
GALLONI: Sì, però i debiti
pubblici sono bruscolini. Nel caso delle perdite delle banche stiamo parlando di
decine di trilioni di dollari e di euro.
MESSORA: Sì, questo non lo
discuto. Però quello che abbiamo dato di Monti bond, alla fine si sarebbe
risparmiata forse l’IMU agli italiani. Per cui sulle singole famiglie questo
discorso ha valore.
GALLONI: sì, sicuramente sulle
singole famiglie. Certo, avremmo potuto risparmiarci l’IMU invece che darli al
Monte dei Paschi. Però è una piccola cosa rispetto ai 3-4 quadrilioni di titoli
tossici che oggi sono in giro per il mondo. Sono tremila, quattromila trilioni.
Un trilione sono mille miliardi. Quindi stiamo parlando di grandezze
stratosferiche. Siccome le perdite si aggirano sul 10%, mediamente, che è quello
che ovviamente questi titoli non rendono, avremmo bisogno a regime non di
qualche decina di trilioni, come hanno dato oggi le banche centrali alle banche,
ma praticamente dai 300 ai 400 trilioni di dollari. Cioè in pratica stiamo
parlando di 6 volte il Pil mondiale. Sono cose spaventose.
MESSORA: Quindi come se ne
esce adesso?
GALLONI: Se ne esce con un
accordo tra gli Stati, Cina, India, Stati Uniti d’America, possibilmente Europa
e qualcun altro, che congelano tutta questa massa, la garantiscono, la
trasformano invece in mezzi monetari che servano per lo sviluppo. Quindi a quel
punto poi il problema diventerebbe la capacità di progettare infrastrutture,
voli su Marte, acchiappare gli asteroidi per farne delle miniere, voglio dire,
se ci vogliamo allargare. Se ci sono queste capacità progettuali, industriali,
produttive, forze disoccupate, eccetera, noi ne usciamo. Diversamente la teoria
ci porta a pensare che potrà esserci una grande botta iperinflattiva che
cancellerà tutti i debiti.
MESSORA: Traduci per i non
capenti.
GALLONI: Allora, dai debiti si
esce in vari modi. Primo, perché si hanno dei redditi che consentono di ripagare
in qualche modo i debiti, e questa è la via maestra, quindi non ci si dovrebbe
mai indebitare per somme che si sa che non si possono ripagare attraverso i
nostri redditi; e questa sarebbe la regola numero uno. Quindi il debito non è un
male, il debito è un bene se tu hai il reddito (nel caso degli Stati il Pil)
sufficiente per poi fronteggiare la situazione. C’è la remissione del debito,
che è una possibilità anche parziale che io ho sollevato in una mia ricerca
sulle banche italiane anni fa, quando ci fu la crisi del 2007-2008, che tutto
sommato agevolerebbe anche le banche e ci metterebbe tutti in condizione di
avere fondamentalmente, per 8 anni, un 5% in più di reddito, riducendo del 40% i
crediti delle banche; questa è un’altra possibilità. E poi c’è l’inflazione che
praticamente, se non ci sono indicizzazioni, si mangia il debito, perché
decresce il valore della moneta e conseguentemente decresce l’importanza del
debito. Queste sono le strade che si possono aprire a livello operativo nei
confronti della gestione del debito.
MESSORA: A livello nazionale?
Per esempio andrebbe bene per l’Italia o parli a livello europeo?
GALLONI: A livello nazionale
c’è appunto chi parla di varie misure riguardanti il debito pubblico. In realtà
la cosa migliore sarebbe riprendere il percorso della crescita e quindi
minimizzare l’importanza del debito rispetto alla ricchezza nazionale. Non ci
dimentichiamo che le ricchezze pubbliche e private in Italia sono 10 volte il
Pil, quindi ovviamente ce n’è, non è che non riusciremmo a ripagare il debito.
Però il debito non è che si deve ripagare, come credono alcuni, il debito sta
lì. L’importante è ridurre i tassi di interesse e che i tassi di interesse siano
più bassi dei tassi di crescita, allora non è un problema. Questo è il modo sano
di affrontare il tema del debito pubblico. Diversamente può succedere, come è
successo in Grecia, che per 300 miseri miliardi di euro poi se ne perdano a
livello europeo 3.000 nelle borse. Allora ci si interroga: ma questa gente si
rende conto che agisce non solo contro la Grecia ma anche contro gli altri
popoli e paesi europei? Ma chi comanda effettivamente in questa Europa si rende
conto? Oppure vogliono obiettivi di questo tipo per poi raggiungere una sorta di
asservimento dei popoli, di perdita ulteriore di sovranità degli Stati per
obiettivi poi fondamentalmente, come è stato in Italia con le privatizzazioni,
di depredazione, di conquista di guadagni senza lavoro?
MESSORA: Adesso c’è un altro
ciclo di privatizzazioni. Sembra che ci stiamo avvicinando a quello.
GALLONI: Il problema delle
privatizzazioni è anche quello dei prezzi di vendita. Perché se ovviamente, come
è successo negli anni ’90, ci si aggirava intorno ai valori di magazzino, voi
capite di che truffa stiamo parlando. È chiaro che se poi i prezzi di vendita
fossero troppo alti, nessuno comprerebbe. Bisogna trovare una via di mezzo. Ma
in realtà bisognerebbe cercare di ragionare sulle capacità strategiche e sul
mantenimento di poli pubblici di eccellenza che servissero per rilanciare la
ricerca, il campo dell’acquisizione delle migliori tecnologie per il trattamento
dei rifiuti, che per esempio in Italia avrebbe delle prospettive enormi. Non ci
dimentichiamo che in Italia siamo depositari di due brevetti fondamentali, uno è
dell’Italgas e l’altro dell’Ansaldo, per produrre degli apparati relativamente
piccoli che consentono al chiuso, quindi senza emissioni, di trasformare i
rifiuti in energia elettrica e in altri sottoprodotti utili per l’agricoltura e
per l’edilizia.
MESSORA: E dove stiamo andando
in Europa, in questo momento?
GALLONI: Io avevo identificato
una spaccatura di impostazione, anche al momento in cui Monti era diventato
Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le posizioni americane e le posizioni
europee. In Europa si diceva “lacrime e sangue. Prima il risanamento dei conti
pubblici e poi lo sviluppo”. Questa strada si sa che è impossibile, perché tu
non puoi fare il pareggio di bilancio o perseguire obiettivi ancora più
ambiziosi se non c’è la ripresa. In condizioni di ripresa è facile ridurre la
spesa pubblica, ma in condizioni recessive ridurre la spesa pubblica significa
far aumentare la recessione con conseguenze sulle entrate e sulle uscite.
MESSORA: ma è possibile,
secondo te, che questi non lo sanno?
GALLONI: Ma bisogna vedere
quali sono i loro obiettivi.
MESSORA: Quali sono?
GALLONI: E che ne so quali
sono i loro obiettivi?
MESSORA: Si possono
immaginare?
GALLONI: Sono obiettivi anche
di asservimento dei popoli, chiaramente. Mentre la posizione americana era una
posizione di sviluppo, cercando di non peggiorare i conti pubblici, che già è
una versione possibilista. Ma non è la concezione né di Monti né della Merkel né
del polo europeo, chiaramente. Quindi al momento le uniche speranze sono quelle
di una politica nuova che reintroduca la Glass-Steagall, che riproponga la
sovranità monetaria a livello europeo o se no si torni alle valute nazionali o
al limite alla doppia circolazione, che sarebbe assolutamente sostenibile.
MESSORA: Valuta nazionale più
euro?
GALLONI: Sì. Terza cosa da
fare è un gestione diversa dei debiti pubblici, tranquillizzante, perché ci sono
tanti altri modi per gestire i debiti pubblici. In parte qualcosa, addirittura,
è stato anticipato da Draghi che è intervenuto sul mercato secondario
raffreddando gli spread. Quindi praticamente forse Draghi ha fatto una
retromarcia rispetto alle decisioni dell’inizio degli anni ’80 dei cosiddetti
divorzi tra governi e banche centrali. Poi in Italia dobbiamo assolutamente
riposizionare la pubblica amministrazione. Oggi è piazzata in modo di creare
un’alleanza tra irregolari e criminali. Questo ci porta a una sconfitta. La
pubblica amministrazione si deve piazzare in un altro modo, si deve piazzare tra
gli irregolari e i criminali. I criminali li deve trattare come meritano, con
gli irregolari, invece, deve avere tutto un altro atteggiamento, cioè deve
essere la stessa pubblica amministrazione che deve realizzare gli adempimenti
previsti dalle normative e quando c’è scontro, perché spesso c’è scontro tra
norma e diritto, tra norma e buonsenso, tra norma ed equità, il funzionario
pubblico deve essere messo in condizioni di scegliere il diritto, l’equità e il
buonsenso e vedere di tutelarsi rispetto alla arida applicazione della norma. Se
non si fa questo non si va da nessuna parte. E poi, quello che è forse più
importante e che riassume un po’ tutto, dobbiamo acquisire quelle strepitose
tecnologie oggi a disposizione dell’umanità, che rimetteranno in gioco tutti gli
equilibri geopolitici a livello internazionale e a livello locale, ma che sono
la nostra più grande speranza per l’ambiente e per lo sviluppo, per esempio
tutte le tecnologie di trasformazione e di trattamento dei rifiuti solidi
urbani. Ci sono, ripeto, delle tecnologie, alcune sono già applicate, ad esempio
a Berlino si stanno applicando. Tu vai a conferire i tuoi rifiuti e ti danno dei
soldi, poi ricevi energia gratis, non inquini, non ci sono i cassonetti per
strada, non ci sono i mezzi comunali o municipali che intralciano il traffico
per trasportare l’immondizia, non ci sono cattivi odori, non ci sono emissioni
nocive. Questo è fondamentale. L’azzeramento delle emissioni genotossiche e la
limitazione di quelle tossiche nell’ambito dei parametri internazionali.
MESSORA: Facciamo un
ragionamento sullo scenario geopolitico globale. Spiegaci come si bilanciano gli
interessi degli Stati Uniti e quelli dell’Europa con quelli della Cina, se
questi Stati Uniti d’Europa convengono oppure no agli Stati Uniti, se c’è una
pressione, secondo te, da parte loro e in che modo la Cina può influire in
questo processo, se è un influsso positivo o negativo. Lanciamoci in queste
speculazioni.
GALLONI: Diciamo che dopo
Kennedy gli Stati Uniti sono sempre più risultati preda dei britannici. È lì che
c’è un nodo fondamentale da sciogliere. Peraltro gli Stati Uniti hanno
drammaticamente cercato, in determinate situazioni regionali, come può essere la
più importante il Mediterraneo, dei partner adeguati. L’Italia questa partita
non se l’è saputa giocare dopo la caduta del muro di Berlino, per le ragioni che
dicevamo all’inizio. La Cina si sta avvicinando agli Stati Uniti d’America sotto
certi profili, ma è ancora lontanissima sotto altri profili. Non dobbiamo
neanche sopravvalutare certi comparti manifatturieri, che se anche fossero
totalmente ceduti alla Cina e all’India – ma c’è anche il Brasile, c’è anche il
Sud Africa, ci sono tante altre realtà emergenti nel pianeta – non sarebbe un
dramma. Il problema è che noi abbiamo un futuro, ad esempio nei nostri rapporti
con la Cina, se capiamo che non dobbiamo andare lì in Cina per fare un business
qualunque, ma se capiamo che cedendo anche parti delle nostre produzioni
industriali e manifatturiere, otteniamo però una maggiore penetrazione rispetto
ai nostri prodotti di qualità, di eccellenza, perché non ci dimentichiamo che
stiamo confrontando un mercato di 60 milioni di persone con un mercato che è 20
volte più grande. Quindi è chiaro che se noi rinunciamo a qualche cosa, ma
riusciamo anche ad esportare un po’, quel po’ moltiplicato per la domanda che in
questo momento sta crescendo, ci dà tutto un altro risultato. Però della Cina
parlerei da un altro punto di vista. All’ultimo congresso del Partito Comunista
Cinese è stato deciso un grande cambiamento di rotta, cioè di puntare di più
sulla crescita della domanda interna e di meno sulle esportazioni. Questo
potrebbe essere l’inizio della fine della cosiddetta globalizzazione. Non ci
dimentichiamo che la globalizzazione è il sistema che premia il produttore
peggiore, quello che paga di meno il lavoro, quello che fa lavorare i bambini,
quello che non rispetta l’ambiente, quello che non rispetta la salute. Questa è
la causa principale delle crisi che stiamo vivendo: che invece di premiare il
produttore migliore, abbiamo premiato il produttore peggiore. Questo ha
danneggiato le industrie europee e soprattutto l’industria italiana,
chiaramente. E non solo l’industria, anche l’agricoltura.
MESSORA: Perché si demanda la
questione della tutela dei diritti oltre il confine, dove non c’è un controllo.
GALLONI: Si deve rimettere in
piedi l’economia, nel senso che deve avere tutta la sua importanza l’economia
reale. L’economia reale deve avere una finanza che la aiuta. Poi se c’è un’altra
finanza che va a fare disastri da qualche altra parte, che non influiscano
sull’economia reale, sulla vita dei cittadini. Questo deve essere il primo punto
che corrisponde alla reintroduzione della legge Glass-Steagall in pratica. Per
questo possono essere utili le doppie e le triple circolazioni monetarie, le
monete complementari e addirittura la reintroduzione di monete nazionali, pure
in presenza di una moneta internazionale.
MESSORA: Ma per scontrarsi o
per far fronte alla Cina è necessario avere gli Stati Uniti d’Europa o basta
anche il piccolo guscio di noce italiano, come alcuni dicono?
GALLONI: Io non penso che ci
si debba scontrare o frenare la Cina. Bisogna avere delle strategie industriali,
e non solo industriali, in grado di difendere i nostri interessi, i nostri
valori, i nostri principi, le nostre vocazioni. Dopodiché ci si confronta con i
cinesi e si vede quali sono le sinergie che possono essere messe in campo. Si
deve fare un discorso di carattere strategico, secondo me.
MESSORA: Ma la politica di
Nino Galloni quale sarebbe? Uscire dall’euro e recuperare sovranità monetaria o
puntare sul “più Europa”?
GALLONI: A me interessa che ci
siano spese in disavanzo, perché se c’è crisi, se c’è disoccupazione è un
crimine puntare al pareggio di bilancio. Ovviamente se gli Stati hanno pareggio
di bilancio, è possibile che l’Europa faccia gli investimenti in disavanzo, e
allora mi sta benissimo l’euro.
MESSORA: Cosa che non c’è.
GALLONI: Cosa che non c’è, ma
è il terzo passaggio che potrebbe essere favorito dalla gestione Draghi. Io non
lo escludo. Perché chi immaginava che avrebbero dato mezzi monetari
illimitatamente alle banche? Chi immaginava che sarebbero intervenuti per
raffreddare gli spread acquistando i titoli pubblici sui mercati? Adesso il
terzo e ultimo passaggio è quello di accettare di autorizzare mezzi monetari per
la ripresa, per lo sviluppo, per gli investimenti produttivi. L’importante però
è che questo non avvenga in una logica di quantitative easing. Cioè la politica
monetaria sbagliata può impedire lo sviluppo, ma la politica monetaria giusta
non produce lo sviluppo. Cioè la moneta è una condizione necessaria, ma non
sufficiente dello sviluppo. Quindi non basta approntare mezzi monetari a gogò e
allora si acchiappa lo sviluppo. Questa è una visione di tipo liberista
riguardante le emissioni monetarie. In realtà bisogna fare dei progetti di
infrastrutture, di ricerca, di ripresa industriale, di salvaguardia della salute
e degli interessi dei cittadini e soprattutto dell’ambiente, e sulla base di
queste grandi strategie approntare i mezzi monetari che certamente non sarebbero
scarsi. Quindi se io dovessi ripetere i miei punti fondamentali, immediati: una
legge che ripristini la netta separazione tra i soggetti che fanno speculazioni
finanziarie sui mercati internazionali dai soggetti che devono fare credito
all’economia. Perché la prima cosa è il credito, la più grande componente della
moneta, il 94% della moneta è credito. Poi il discorso della sovranità
monetaria, come ho detto prima. O gli Stati o l’Unione Europea devono fare spese
in disavanzo per acchiappare la ripresa. Una diversa gestione dei debiti
pubblici, che è possibile, un diverso posizionamento della pubblica
amministrazione, perché il cittadino deve vedere un amico nello Stato, nella
pubblica amministrazione, quindi fermare anche questo progetto di polizia
europea senza controlli che potrebbe compiere qualunque azione senza dover
rispondere a nessuna autorità.
MESSORA: Eurogendorf con base
in Italia a Vicenza.
GALLONI: Quinto: acquisizione
di tutte quelle grandi tecnologie che oggi sono a disposizione dell’umanità per
migliorare veramente le condizioni di vita di tutti.
MESSORA: L’ultima domanda.
Tedeschi cattivi? Amici o buoni?
GALLONI: I tedeschi sono
posizionati nella storia e nella geografia in modo di doversi in qualche modo
espandere. Se devono assumere una posizione di leader, devono anche accettare di
rivedere le proprie politiche estere. Quindi un paese che voglia essere leader,
come sono stati gli Stati Uniti d’America, importano più di quello che
esportano. Se i tedeschi non accettano di importare più di quello che esportano,
non possono neanche pretendere di essere leader.
ALTRO CHE CONTRO IL
COMPROMESSO STORICO. CI VOLEVANO SOVIETIZZARE. IL TERRORISMO
COMUNISTA-ISLAMISTA.
Da Ansa il 28 aprile 2019.-
"Potevo salvare Moro, fui fermato". Così il super boss della camorra, Raffaele
Cutolo, in carcere da anni, in un verbale inedito di un interrogatorio del 2016
di cui riferisce oggi in esclusiva Il Mattino. "Aiutai - spiega Cutolo -
l'assessore Cirillo (rapito e successivamente rilasciato dalle Br, ndr), potevo
fare lo stesso con lo statista. Ma i politici mi dissero di non intromettermi".
Nel '78 Cutolo era latitante e si sarebbe fatto avanti per cercare, sostiene
lui, di salvare Moro. "Per Ciro Cirillo si mossero tutti, per Aldo Moro nessuno,
per lui i politici mi dissero di fermarmi, che a loro Moro non interessava". Le
dichiarazioni di Cutolo risalgono al 25 ottobre del 2016, come risposte alle
domande del pm Ida Teresi e del capo della Dda, Giuseppe Borrelli.
Paolo Guzzanti, quando era
presidente della Commissione Mitrokin, fu a un passo dalle prove che il
terrorismo rosso aveva contatti con i Paesi dell'Est. Ma poi tutto fu
insabbiato,
scrive Paolo Guzzanti, Martedì 09/04/2019 su Il Giornale. «Venga a Budapest e
troverà tutte le risposte che cerca» mi aveva scritto nell'estate del 2005 il
procuratore generale di Budapest per posta diplomatica. E mi dette un assaggio:
il terrorista venezuelano Ilich Ramirez Sanchez, detto Carlos lo Sciacallo - mi
disse - fu trapiantato dal Kgb sovietico a Budapest negli anni Ottanta e gli
ungheresi furono costretti a sopportarlo mentre scorrazzava per la città con i
suoi pistoleros, protetto dalla Stasi tedesca. Quando Carlos andava in missione
terroristica in Europa occidentale, mi spiegò ancora il magistrato, gli
ungheresi furono autorizzati a fotografare i documenti che si trovavano nelle
abitazioni della banda: «Dovevamo consegnare tutto, ma abbiamo fatto le copie:
venga a Budapest e saprà tutto sui rapporti fra terrorismo e Kgb». La
Commissione bicamerale Mitrokhin di cui ero Presidente stava per chiudere i
battenti avendo ultimato i suoi compiti ma, insieme al deputato Enzo Fragalà
(uno squisito dandy e intellettuale palermitano) riuscimmo a vincere le
resistenze delle sinistre e ottenere una rogatoria internazionale. Ci
presentammo dunque a Budapest dove la Commissione fu ricevuta in un palazzo di
stile sovietico-babilonese. Aleggiava ancora l'odore inconfondibile dei Paesi
comunisti: varechina e scarpe vecchie, the perfect mix. Fummo accolti
sontuosamente con tè, pasticcini, discorsi e grandi applausi per la ritrovata
democrazia. Poi il procuratore si schiarì la voce e ci presentò un giovane
maggiore in uniforme dal nome impronunciabile il quale issò sul tavolo una
grande valigia di cuoio verde dagli angoli lisi. La aprì e mostrò il contenuto:
pacchi di fogli ingialliti, contenitori di dossier a soffietto con la costa
cartonata e disse: «Qui troverete tutto: nomi e cognomi, foto, date e recapiti
degli uomini delle Brigate Rosse eterodirette dalla Stasi e dal Kgb e tutto ciò
che abbiamo raccolto in questi anni». Mi sembrava di sognare. Chiesi: «Anche ciò
che riguarda il rapimento e la morte di Moro?». Certo, disse. Tutto. Troppo
bello per essere vero. Infatti, ecco la postilla avvelenata: «Purtroppo non
siamo liberi di consegnarvi questo materiale senza il permesso di quelli del
piano di sopra». E chi sono quelli del piano di sopra? «Noi abbiamo un trattato
con la Federazione Russa come ogni Paese dell'ex Patto di Varsavia e non siamo
proprietari dei documenti di quell'epoca. Ma entro una settimana spediremo tutto
per valigia diplomatica». La fine è nota. Non arrivò nulla perché gli amici del
piano di sopra dissero di no. Andai a protestare col un certo generale Ollo,
l'uomo del collegamento con i Paesi della Nato, e quello allargò le braccia. Non
possiamo farci nulla. Fine dell'illusione. Il tesoro restò sepolto. Pochi mesi
dopo finì la legislatura e dunque anche la Commissione Mitrokhin. Non vorrei
sembrare patetico con questo ricordo. Vorrei invece pronunciare un atto
d'accusa. Non contro i russi o gli ungheresi, ma contro coloro che in Italia
ebbero le informazioni che ho appena riferito (atti ufficiali di una rogatoria
internazionale) che una Commissione del Parlamento raccolse con le stesse
funzioni di un magistrato. Invece, tutti zitti. Come mai, pur avendo la notizia
del tesoro contenente i legami del terrorismo italiano con i servizi segreti
dell'Est, comprese le coperture di fiancheggiatori, esecutori e complici di
delitti come la cattura, interrogatorio ed esecuzione di Aldo Moro, nessuno
delle varie Commissioni e processi Moro Ter, Quater, Quinque e così via, abbia
fatto un salto sulla sedia gridando che si doveva a tutti i costi recuperare il
materiale di Budapest? Soltanto l'onorevole Enzo Fragalà, anima di quella
rogatoria, insorse contro gli insabbiatori ma fu barbaramente assassinato a
bastonate sotto la porta del suo studio il 23 febbraio 2010. A questi ed altri
eventi ho pensato leggendo gli eccellenti interventi ieri e l'altro ieri sul
Giornale sul tema del terrorismo dopo il caso Battisti firmati da Alessandro
Gnocchi e del mio ex consulente Gianni Donno, storico ed accademico. E vedo che
ancora una volta si torna sulla segretezza di alcuni documenti e all'invocazione
al governo affinché imponga di aprire la gabbia in cui la colomba della verità è
imprigionata. Questo nobile impulso può essere, se preso da solo, alquanto
fuorviante perché l'esperienza di investigatore storico mi suggerisce che la
«ciccia» sia altrove che non in un armadio blindato. Ogni Commissione
parlamentare ha infatti diritto di ottenere documenti, non importa quanto
riservati, segreti o segretissimi, da tutte le agenzie ed enti dello Stato come
magistratura, servizi segreti, polizie e carabinieri. Questi enti, a norma di
legge, consegnano documenti su cui è scritto riservato, segreto o segretissimo e
restano proprietari di questa classifica («classified» è la parola inglese per
segretato). Il Parlamento è autorizzato a leggere, ma non a riprodurre. Un
consulente di Commissione può apprendere ma non può svelare l'originale. Io ho
personalmente letto centinaia di documenti segretissimi (e come me ogni
commissario) e posso garantire che dentro c'è soltanto burocrazia. Direte:
dunque sarebbe tutto pulito? No, al contrario. Tutto è molto più sporco di
quanto si immagini. Solo che il marcio è nascosto molto meglio. Un solo esempio:
la mia Commissione deve moltissimo a un servitore dello Stato, militare e
galantuomo (che non nomino per non arrecargli ulteriori danni) il quale ci
spiegò a tutti e quaranta senatori e deputati che un documento si nasconde
dandogli un nome diverso o cambiando la sua collocazione. Per la mia esperienza,
i documenti ci sono, basta cercarli e i famosi «misteri italiani» sono tutti
risolvibili. Ho trovato un documento della Stasi tedesca (il servizio segreto
della DDR) che apparteneva a un magistrato illustre, ma era illeggibile per le
righe nere della censura. Dandomi da fare ottenni lo stesso documento da una
fonte diversa e appresi così che proprio il terrorista Ilich Ramirez Sanchez
detto Carlos lo Sciacallo, dava conto ai suoi referenti tedeschi e russi di
essere l'attentatore del cosiddetto «treno di Natale» del 1983, per cui furono
condannati dei neofascisti. Qualcuno ha forse fiatato? Nulla. Quando con la
Commissione andammo a Parigi per un'altra rogatoria presso la Procura, non
soltanto scoprii che il parquet dei magistrati inquirenti d'Oltralpe funziona,
ma feci amicizia con il «Giovanni Falcone francese», ovvero Jean-Louis
Bruguière, colui che ha stroncato le attività di Carlos e dei suoi affiliati
terroristi arabi, il quale mi disse: «So da un ufficiale del Kgb che l'attentato
al Papa del 13 maggio 1981 fu organizzato dal servizio segreto militare Gru
sovietico che aveva assoluto bisogno di garantirsi lo spazio di manovra di una
Polonia sgombra dal Papa e da Solidarnosc». Con Fragalà organizzammo e facemmo
votare una analisi medico legale computerizzata delle foto dell'attentato in
piazza San Pietro e scoprimmo attraverso i periti che l'uomo che era accanto ad
Ali Agca mentre sparava al Papa era il signor Antonov, cioè il capo del servizio
segreto bulgaro e referente delle forze armate sovietiche. Le sinistre della
Commissione, profondamente irritate, chiesero un secondo expertise di loro
scelta, che però confermò senza esitazione il primo e fu questa la svolta e
anche l'inizio della fine della più delicata e maltrattata inchiesta che il
Parlamento abbia avviato e poi con poco coraggio seppellito. L'accesso ai
documenti è dunque molto importante e va sostenuto, ma senza nutrire illusioni
superflue sulla localizzazione del tesoro. Il tesoro, vi assicuro, è in genere
altrove.
Così fu bloccato da Est il
"compromesso storico". Il piano di staccare il Pci da Mosca scatenò il Kgb Anche
Orbán dovrebbe riaprire gli archivi...,
scrive Paolo Guzzanti, Mercoledì 10/04/2019, su Il Giornale. Intanto, sono grato
anch'io al ministro Salvini per i suoi propositi e, visto che è amico del
premier ungherese Viktor Orbán, mi permetto di suggerirgli di chiedere a quel
leader di recuperare la promessa valigia di cuoio verde e farmela recapitare o
almeno invitarmi a Budapest per esaminarla. Sarebbe l'ora che l'Italia
reclamasse ciò che fa parte della sua storia. In questo articolo vorrei
spiegare, specialmente a chi è più giovane e non sa, per quale motivo il dossier
Mitrokhin che tutti i Paesi occidentali ricevettero dagli inglesi, soltanto in
Italia diventò una vicenda furiosa e scalmanata, conclusa da un bel po' di
morti, sfuggiti all'attenzione dei giornalisti eroici. Il fatto: quando gli
inglesi annunciarono per via diplomatica negli anni Novanta di voler distribuire
ai Paesi alleati le schede di loro interesse redatte dal maggiore Vasilij
Mitrokhin, in Italia e soltanto in Italia successe il finimondo in casa
comunista, divisa verticalmente fra l'ala americana (Giorgio Napolitano era da
tempo uno stimato amico di Henry Kissinger) e quella pro-sovietica capeggiata da
Armando Cossutta. Il comunismo sovietico era già crollato e avevano proposto nel
2000 una commissione parlamentare d'inchiesta che non andò in porto, io fui
eletto nel 2001 in Senato come giornalista esperto dei fatti e l'anno
successivo, varata faticosamente la legge, fui dichiarato presidente eletto da
un lividissimo Giulio Andreotti che mi fu contro da subito e per sempre. Il
terrorismo rosso (e in parte nero) era già finito da oltre dieci anni e il
presidente emerito Francesco Cossiga era già andato in pellegrinaggio nelle
carceri per visitare i brigatisti e certificarli come «bravi ragazzi che avevano
un po' esagerato» o anche «boys scout della rivoluzione». Quando ero un
redattore del quotidiano socialista Avanti!, negli anni Sessanta, fui
personalmente avvicinato da uomini del Kgb un po' troppo entusiasti dei miei
articoli, anche perché i sovietici preferivano reclutare fra socialisti e
democristiani per non esporre gli iscritti al Pci. Quando interrogammo nella
commissione Mitrokhin l'ex capo della Rezidentura sovietica a Roma, Leonid
Kolosov, quello raccontò un sacco di balle, ma era certamente sincero quando
disse che davanti alla sua porta «c'era la fila» degli informatori che odiavano
l'America e volevano collaborare con i russi. Ma sui reali informatori e agenti
di influenza non indagò nessuno perché era considerata un'attività poco
amichevole nei confronti del Pci il cui segretario, Enrico Berlinguer, aveva del
resto fallito nel tentativo di sottrarre il suo partito ai finanziamenti di
Mosca (vedi L'Oro di Mosca del nostro Valerio Riva). Berlinguer aveva tentato di
installare una nuova ideologia: quella del comunista geneticamente ariano del
bene che guarda più a Santa Maria Goretti che a Lenin. Il Kgb sosteneva allora
anche gli estremisti di destra e qualsiasi gruppo eversivo in Europa. Pochi si
sono presi la briga di leggere un testo fondamentale: A Cardboard Castle? An
Inside Story of the Warsaw Pact 1955-1991. Il grosso tomo, 720 pagine, contiene
tutti i verbali delle riunioni del Patto di Varsavia (l'anti-Nato del blocco
sovietico) da cui si può vedere come, fino al 1991, l'Est progettasse ogni anno
una nuova invasione dell'Europa occidentale anche con atomiche tattiche
sull'Italia, col pretesto di reagire preventivamente a un imminente attacco
della Nato. Il progetto era politico oltre che militare: l'Europa tecnologica
sarebbe stata resa irrecuperabile agli Stati uniti con una guerra lampo che
sigillava porti e aeroporti e sarebbe stata aggregata al sistema sovietico, come
spiegò Vladimir Bukowskij in EURSS. Unione europea delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche nel 2007 quando a suo parere il progetto politico era ancora in
svolgimento. Questo piano aveva bisogno di una continua pressione terroristica
in Occidente (Francia e Italia con la banda Carlos e i suoi agenti interni, la
Frazione Armata Rossa in Germania, l'appoggio all'Ira irlandese e all'Eta basca,
per azioni di infiltrazione). In Italia il progetto del Compromesso storico era
stata benedetto dalla Cia americana (vedi Maurizio Molinari L'Italia vista dalla
Cia con i documenti originali) con la garanzia di Aldo Moro nelle vesti di
Presidente della Repubblica (si dovette estromettere con una falsa campagna
mediatica l'innocente presidente Giovanni Leone sulla base di documenti
americani fatti apparire ad hoc) e il senso strategico era di distaccare per
sempre il Pci dall'Unione Sovietica e portarlo al governo dopo aver scatenato la
famosa operazione «Clean Hands» (Mani Pulite) che avrebbe decapitato la corrotta
Prima repubblica per far posto ai comunisti italiani. Tutto ciò è narrato per
filo e per segno con tutti i documenti in The Italian Guillotine: Operation
Clean Hands and the Overthrow of Italy's First Repubblic scritto in inglese da
Stanton H. Burnett e Luca Mantovani, un libro che, curiosamente, nessun editore
italiano ha avuto il fegato di pubblicare. La reazione sovietica non si fece
aspettare: dopo un primo tentativo fallito di uccidere Berlinguer mandato da
Cossutta a visitare la Bulgaria, con la consolidata tattica del camion che sbuca
all'improvviso (morì l'autista di Berlinguer il quale rimase lievemente ferito e
fu subito fatto riportare in Italia dai corpi speciali, mandati da Cossiga). Poi
arrivò la strage di Via Fani, dove tutti furono uccisi da una sola arma e un
solo killer e la neutralizzazione del garante del Compromesso destinato al
Quirinale. L'operazione era politicamente ovvia. Attendiamo da Orbàn le carte.
Il Compromesso storico fallì, il Pci tornò ad elemosinare la sua paghetta al
Cremlino anche se l'operazione mani pulite portò realmente alla ghigliottina la
prima Repubblica e certamente Achille Occhetto, leader del rinominato partito
comunista, avrebbe vinto con la sua Gioiosa macchina da guerra se l'imprenditore
Silvio Berlusconi non si fosse messo di traverso costruendo il bipolarismo
impossibile e battendo il vecchio piano degli anni Settanta. Ciò accadde dopo la
fine della Guerra fredda, ma l'apparato di sostegno a tutte le forme di
terrorismo in funzione tattica era rimasto funzionante. Il mea culpa dello
scrittore francese Daniel Pennac, ipocrita e conformista anche se avverte
rossore sulle guance, è esemplare. Quando nel 1999 a dieci anni dalla caduta del
Muro di Berlino, per iniziativa di Berlusconi, organizzammo un grande convegno
internazionale di cui fui il chairman, conobbi un uomo dagli enormi baffi
rossicci furibondo e aggressivo. Era Lech Walesa, l'elettricista cattolico che
aveva organizzato, insieme al papa polacco Karol Wojtyla, il sindacato
Solidarnosc che aveva conquistato le piazze polacche, occupato il Paese e
paralizzato le manovre militari sovietiche. Walesa parlava soltanto polacco e
una ragazza mesta e gentile traduceva con sbalorditiva rapidità: «Che diavolo vi
è venuto in mentre di celebrare la caduta del Muro di Berlino decisa da
Gorbaciov? Siamo noi, i polacchi, che abbiamo fatto cadere il sistema, noi del
Paese da cui doveva partire la guerra, noi destinati al sacrificio, noi polacchi
che ci siamo ribellati e abbiamo vinto. Altro che muro! altro che Berlino!».
Aveva perfettamente ragione. Il Muro venne giù quando Gorbaciov lo decise
d'accordo con il presidente Reagan che pronunciò lo storico invito: «Mister
Gorbaciov, tear down this wall!». La nostra storia, quella della contiguità
culturale e militare fra terroristi alla Cesare Battisti e sistema sovietico è
però ancora tutta da raccontare e da rivelare, almeno per le nuove generazioni
che si affacciano al mondo fresche e pulite e che chiedono il sacrosanto
rispetto della verità.
La legittimità delle
Crociate, un atto di difesa,
scrive Massimo Viglione il 23 novembre 2015. Dal VII all’XI secolo l’Islam ha
sistematicamente attaccato e invaso manu militari gran parte delle terre di
quello che era l’Impero Romano d’Occidente (premendo nel contempo senza sosta
alle porte di quello d’Oriente), conquistando gran parte del Medio Oriente,
l’Africa del Nord, la Penisola Iberica, tentando di varcare i Pirenei, poi
occupando la Sicilia, la Sardegna e la Corsica, risalendo con scorrerie fino a
Lione e poi in Svizzera e alle Alpi, ponendo delle enclave fisse vicino Roma (le
basiliche di San Pietro e San Paolo e l’abbazia di Montecassino furono
distrutte), ma soprattutto terrorizzando per secoli le popolazioni cristiane
mediterranee, specialmente quelle italiane. Quattro secoli di invasioni militari
(massacri di uomini, deportazioni di donne negli harem, conversione forzata dei
bambini) e razzie, di cui nessuno mai potrà fare il calcolo non tanto dei danni
materiali, quanto del numero dei massacrati e del dolore immenso causato a
intere generazioni di cristiani, senza che questi potessero in alcun modo
contrattaccare. Gli stessi pellegrini che andavano in Terra Santa venivano
spesso massacrati, specie a partire dall’XI secolo, con l’arrivo del dominio dei
turchi selgiuchidi. Tutto quanto detto deve essere tenuto presente prima di
emettere qualsivoglia giudizio storico e morale sulla crociate: non si può
infatti presentare i crociati come una “banda di matti fanatici” e ladri che
calò improvvisamente in Palestina per rubare tutto a tutti e uccidere i poveri
musulmani indifesi. Ciò è solo ridicolo, evidentemente sostenuto da chi non
cerca la verità storica ma è mosso solo dal suo odio anticristiano (o dalla sua
simpatia filoislamica). Come sempre ufficialmente dichiarato dalla Chiesa
tramite la voce dei Papi e dai teorici del movimento crociato (fra questi, san
Bernardo di Chiaravalle) e dai teologi medievali (fra gli altri, san Tommaso
d’Aquino e anche santa Caterina da Siena), lo scopo e la legittimità delle
crociate risiedono nei seguenti princìpi fondamentali:
Il diritto/dovere assoluto
della Cristianità a rientrare in possesso dei Luoghi Santi;
La difesa dei pellegrini (e a
tal fine nacquero gli Ordini monastico-cavallereschi);
La legittima difesa dai
secolari assalti della Jahad islamica.
Come si può notare, tutti e
tre i princìpi indicati si fondano pienamente sul diritto naturale: quello del
recupero della legittima proprietà privata lesa, quella della difesa del più
debole dalla violenza ingiustificata, quello della legittima difesa da un nemico
ingiustamente invasore. È interessante notare a riguardo che le fonti islamiche
sulle crociate, pur accusando i crociati di atti barbarici e stragisti di ogni
genere, mai mettono però idealmente in dubbio il loro diritto alla riconquista
dei Luoghi della Redenzione di Cristo. Da conquistatori, essi sanno che il
diritto del più forte, su cui essi si fondano, prevede anche il contrattacco. A
questi tre princìpi poi, santa Caterina da Siena ne aggiunge un altro: il
doveroso tentativo di conversione degli infedeli alla vera Fede, per la loro
salvezza eterna, bene supremo di ogni uomo. Per necessaria completezza, occorre
tener presente poi che il movimento crociato non si esaurì nell’ambito dei due
secoli (1096-1291) in cui avvennero la conquista e la perdita della Terra Santa
da parte cristiana (crociate tradizionali); infatti, a partire dal XIV secolo, e
fino agli inizi del XVIII, con l’avanzata inarrestabile dei turchi ottomani, di
crociate se ne dovettero fare in continuazione; questa volta però non per
riprendere i Luoghi Santi, ma per difendere l’Europa stessa (l’Impero Romano
d’Oriente cadde in mano islamica nel 1453) dalla conquista musulmana. I soli
nomi di Cipro, Malta, Lepanto, Vienna (ancora nel 1683) ci dicono quale immane
tragedia per secoli si è consumata anche dopo le stesse crociate “tradizionali”
e ci testimoniano un fatto incontrovertibile e di importanza capitale: per
quattro secoli prima e per altri quattro secoli dopo le crociate “tradizionali”,
il mondo cristiano è stato messo sotto attacco militare dall’Islam (prima arabo,
poi turco), subendo quella che può definirsi la più grande e lunga guerra
d’assalto mai condotta nella storia, in obbedienza ai dettami della Jihad
(Guerra Santa) voluta e iniziata da Maometto stesso. Mille anni di guerre. Per
questo, occorre essere sereni, preparati e giusti nei giudizi. Le crociate
furono insomma anzitutto guerre di legittima difesa e di riconquista di quanto
illegittimamente preso da un nemico invasore. Pertanto, ebbero piena legittimità
storica e ideale (ciò non giustifica, ovviamente, tutte le violenze gratuite
commesse da parte cristiana nel corso dei secoli). Ancor più ciò è valido a
partire dal XIV secolo, quando l’unico scopo del movimento crociato divenne la
difesa della Cristianità intera aggredita dai turchi.
Con la Rivoluzione Francese
abbiamo diviso lo Stato dalla Chiesa e questi ci vogliono imporre un nuovo tipo
di regime teocratico ideologico?
Israele-Gaza: tutti i falsi
miti da sfatare.
Dall'onnipotenza del Mossad alla lobby ebraica e all'idea di "Due
popoli due Stati". La complessità del conflitto israelo-palestinese negli anni
ha generato una serie di convinzioni che non si basano sui fatti. Il dizionario
del conflitto dalla A alla Z, scrivono Anna Mazzone e Paolo Papi su "Panorama".
Israele ha avvertito i palestinesi della Striscia di Gaza di abbandonare le loro
abitazioni. La pseudo-tregua è durata un batter di ciglia. I razzi di Hamas
continuano a piovere in Israele e lo Stato ebraico ha ripreso i bombardamenti su
Gaza e si prepara (forse) a un'operazione terrestre. Compresso tra i suoi
falchi, Netanyahu sembra non avere chiara la rotta da seguire e intanto il
numero dei morti aumenta di ora in ora. Si parla di più di 200 persone, tutti
palestinesi e 1 israeliano. Il conflitto israelo-palestinese affonda la sua
storia nella notte dei tempi. Difficile districarsi nelle fitte trame degli
eventi, dei passi fatti in avanti e di quelli (tanti) fatti indietro. E,
soprattutto, difficile non ascoltare le sirene dei "falsi miti". Idee
preconcette, spesso frutto di propaganda da una parte e dall'altra, che a forza
di essere ripetute sono diventate realtà. Abbiamo provato a smontarli uno per
uno.
Il mito dei Paesi arabi
"fratelli". Non è vero, contrariamente a quanto sostiene la vulgata corrente,
che i palestinesi siano vittime esclusivamente delle rappresaglie israeliane. I
Paesi arabi che confinano con Israele, Gaza e Cisgiordania sono stati,
nonostante la retorica antisionista dei governi arabi strumentalmente usata in
chiave interna, tra i più feroci nemici degli oltre 5 milioni di profughi
palestinesi della diaspora, considerati - ovunque siano stati ospitati - come
dei paria senza diritti, degli inguaribili attaccabrighe da confinare in campi
sovraffollati, senza servizi né diritti e controllati a vista dalle onnipotenti
polizie locali. Dalla Giordania - dove durante il settembre nero del 1970 la
polizia giordana lanciò una sanguinosa operazione contro i gruppi palestinesi
nei campi - al Libano - dove i 500 mila profughi che vivono nei campi sono
considerati tuttora senza diritti politici e sociali - fino al Kuwait - dove i
lavoratori palestinesi furono espulsi durante la prima guerra del Golfo per il
sostegno che l’Olp ricevette dal regime di Saddam - non c’è Paese arabo che - al
di là delle magniloquenti dichiarazioni di solidarietà ai fratelli palestinesi
- abbia mai offerto un concreto aiuto ai palestinesi fuggiti dalle loro case.
Sempre in Giordania (e anche in Libano) un palestinese non può studiare Legge o
Medicina e non può essere proprietario di un immobile. Se questi sono
"fratelli", allora forse è il caso di parlare di "parenti serpenti".
Il mito dei negoziati. Non è
vero, o meglio: è estremamente improbabile, visto anche il disimpegno americano
- che una soluzione al conflitto israelo-palestinese possa essere frutto di un
negoziato tra i leader dei due campi, come dimostrano i fallimenti di tutti gli
accordi di pace degli anni '90 e 2000. È assai più probabile che le tendenze
demografiche di lungo periodo dei due gruppi etnici possano mutare,
irrimediabilmente, nei prossimi decenni, la natura politica dello Stato di
Israele. E questo per una ragione molto semplice: se guardiamo alle proiezioni
statistiche scopriamo che al momento in Terra Santa vivono 6.1 milioni di ebrei
e 5.8 milioni di arabi. La demografia dice che gli arabi fanno molti più figli
degli ebrei. E' inevitabile pensare che nel giro dei prossimi dieci anni,
qualora non si riuscisse a raggiungere una soluzione "Due popoli due Stati",
Israele potrebbe perdere progressivamente il suo carattere di Stato ebraico.
Insomma, quello che non si riesce a raggiungere da più di mezzo secolo al tavolo
dei negoziati, potrebbe realizzarlo la Natura.
Il mito degli insediamenti
congelati. Nonostante il governo israeliano abbia più volte dichiarato
l'intenzione di congelare i nuovi piani di insediamento nella West Bank, questo
non è accaduto. L'ultimo esempio è molto recente. Ai primi di giugno di
quest'anno l'esecutivo israeliano ha annunciato uno stop nella costruzione di
nuove abitazioni in Cisgiordania. In realtà, però, su un piano che prevedeva
1.800 nuovi insediamenti ne sono state costruite 381. Forte la pressione da
parte di cinque Paesi dell'Unione europea affinché Israele congelasse i suoi
piani sui nuovi insediamenti. Ma il governo Netanyahu ha fatto sapere che lo
stop è arrivato per motivi "tecnici" e non in seguito alle pressioni europee.
Il mito della
lobby ebraica. E' sicuramente il mito più gettonato. Quello dell'esistenza di
una lobby ebraica in grado di influenzare qualsiasi avvenimento
socio-economico-politico nel mondo è il cavallo di battaglia dell'esercito dei
complottisti. Il mito della lobby "giudaica" affonda le sue radici
nell'antisemitismo e, come tutti i miti, si fonda su idee fantasiose ripetute a
oltranza, nei secoli dei secoli, fino a diventare - almeno per alcuni - delle
verità inviolabili. E' il mito che ha gettato le fondamenta dello sterminio
nazista e che ha motivato nei secoli l'odio nei confronti degli ebrei, accusati
- dopo la Seconda guerra mondiale - di fare "marketing dell'Olocausto" per poter
mantenere una situazione di potere nel mondo. In realtà, basterebbe una sola
domanda per smontare il mito della lobby ebraica: perché - se la lobby esiste
sul serio - Israele non riesce a modificare l'immagine che passa sulla maggior
parte dei media nel mondo e che assegna allo Stato ebraico la maglia nera del
carnefice a fronte di una Palestina presentata largamente come vittima
indiscussa? Il vecchio adagio che la verità sta nel mezzo in realtà vale sia
per Israele che per la Palestina, ed è troppo semplice e superficiale credere
che esista una struttura monolitica e unica come la potente lobby ebraica, in
grado di modificare i destini del mondo.
Il mito di "Due popoli, due
Stati". La soluzione "Due popoli due Stati" è l'idea di creare uno Stato
palestinese indipendente, che possa esistere "assieme" a Israele. Negli anni è
diventata una sorta di "mito", perché sarebbe sicuramente la soluzione migliore
per risolvere un conflitto così complesso, ma è pur vero che al momento le parti
in causa sono troppo distanti. La creazione di creare uno Stato binazionale non
ottiene ugualmente supporto e i sondaggi dimostrano che sia gli israeliani che i
palestinesi preferirebbero la "mitica" soluzione "Due popoli due Stati". E
allora perché questa soluzione non viene raggiunta? La risposta affonda le sue
radici in anni e anni di conflitto israelo-palestinese per la terra, la
legittimazione, il potere. Un tema molto sentito dai palestinesi è il controllo
delle frontiere e la libertà di movimento. Movimento che Israele restringe e
controlla ai check-point e all'ingresso della città di Gerusalemme. E' molto
difficile negoziare una soluzione "Due popoli due Stati" se non ci si riesce a
mettere d'accordo sui confini come punto di partenza. Un ulteriore motivo di
conflitto è la disputa sul controllo di Gerusalemme, casa di molti siti sacri
per gli ebrei, ma anche per i palestinesi (e i cristiani). C'è poi la questione
degli insediamenti israeliani nella West Bank, che fa parte dei territori
palestinesi. L'espansione degli insediamenti israeliani nella West Bank è vista
da molti come il principale ostacolo alla costruzione di una pace stabile e
duratura. Infine c'è Hamas, l'organizzazione terroristica che controlla Gaza,
che non vuole l'esistenza di Israele e si batte per cancellare lo Stato ebraico
dalla mappa mediorientale. Di fronte a queste considerazioni, è evidente come la
soluzione "Due popoli due Stati", pur essendo la migliore da praticare, è anche
un falso mito da sfatare. Almeno finché le parti non muoveranno passi in una
direzione diversa da quella presa finora.
Il mito dell'estremismo
"solo" arabo. Per chi crede che nel conflitto israelo-palestinese il
"terrorismo" si esprima solo sul fronte islamico, questo è un altro mito da
sfatare. In Terra Santa gli estremisti sono anche ebrei e rappresentano un serio
problema per il governo israeliano. Ultra ortodossi, gli estremisti ebraici si
sono spesso distinti per attacchi di gruppo a donne. Come nel caso della ragazza
presa a sassate a Beit Shemesh (nei pressi di Gerusalemme) perché stava
attaccando dei poster della lotteria nazionale per le strade del villaggio. In
occasione della recente visita di Papa Francesco in Terra Santa, le autorità
israeliane hanno vietato a cinque noti estremisti di mettere piede nella città
di Gerusalemme. Considerano lo Stato israeliano "un nemico" e attaccano con
bombe e attentati, esattamente come gli omologhi della controparte palestinese.
Un nome su tutti è quello di Yigal Amir, il terrorista ultranazionalista che nel
1995 ha ucciso Yitzhak Rabin, perché non accettava l'iniziativa di pace sposata
dal premier israeliano e la sua firma sugli accordi di Oslo.
Il mito dell'onnipotenza del
Mossad. I servizi segreti israeliani vengono spesso portati a esempio di
infallibilità, ma non è così. Anche perché è umanamente impossibile. Tuttavia,
il mito dell'onnipotenza del Mossad è uno delle fondamenta su cui si articola il
mito della lobby ebraica, e pertanto resiste tenacemente nel tempo. Eppure, i
flop del Mossad (e dello Shin Bet, l'intelligence israeliana per gli affari
interni) sono sotto gli occhi di tutti. Cominciano nell'ottobre del 1973, quando
Aman, i servizi militari israeliani, giudica "Poco probabile" lo scoppio di una
guerra con i Paesi arabi, Qualche giorno dopo l'esercito sirio-egiziano attacca
Israele, cogliendo il Paese del tutto impreparato. Il capo di Aman fu costretto
a dimettersi. Poco prima, a luglio dello stesso anno, gli agenti del Mossad
danno la caccia ai leader di Settembre Nero, l'organizzazione terroristica
islamica responsabile dell'uccisione di 11 atleti israeliani ai Giochi olimpici
di Monaco del '72. Gli 007 israeliani credono di avere individuato Hassan Salamé
(uno dei leader) in Norvegia. Lo colpiscono, ma poi scoprono di avere ucciso per
sbaglio un cameriere di origine marocchina. In tempi più recenti, a gennaio del
2010 in un hotel di Dubai viene ucciso Mahmoud al Mabhouh, uno dei comandanti di
Hamas. Le foto dei killer (agenti del Mossad) fanno il giro del mondo con i loro
passaporti, su operazione della polizia locale. Infine, a giugno 2011 i siti
dell'IDF, di Shin Bet e del Mossad vengono violati da un gruppo di hackers di
Anonymous, che minaccia un attacco cibernetico contro Israele. Per due ore i
siti non sono accessibili.
Violenti scontri a Gaza: 16
palestinesi uccisi dall'esercito israeliano. Oltre mille feriti.
L'Autorità nazionale
palestinese (Anp) ha chiesto l'intervento della comunità internazionale dopo la
violentissima battaglia al confine con la Striscia dove ha preso il via la
“Grande marcia del ritorno” che commemora gli scontri del marzo 1976. La
mobilitazione durerà fino al 15 maggio, giorno della Nakba. Fonti diplomatiche:
all'Onu riunione d'urgenza a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza, scrive il
30 marzo 2018 "La Repubblica". Sedici morti e più di mille feriti nella
Striscia, secondo il ministero della Sanità. Tra le vittime, la più giovane ha
16 anni. È il bilancio, ancora provvisorio secondo fonti mediche di Gaza, degli
scontri tra palestinesi e forze della sicurezza israeliane scoppiati al confine
tra il sud della Striscia e Israele, dove ha preso il via la “Grande marcia del
ritorno” convocata da Hamas nell'anniversario dell'esproprio delle terre arabe
per creare lo Stato di Israele nel 1948. Da fonti diplomatiche si apprende che
il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, su richiesta del Kuwait, terrà una riunione
d'urgenza sui tragici eventi di Gaza. La stessa fonte, coperta da anonimato, ha
precisato che la riunione avverrà a porte chiuse a partire dalle 18.30 ora
locale (le 00.30 in Italia). La Grande Marcia si è aperta nella Giornata della
Terra che ricorda l'esproprio da parte del governo israeliano di terre di
proprietà araba in Galilea, il 30 marzo 1976. Le proteste dureranno fino al 15
maggio, anniversario della fondazione di Israele, per i palestinesi "Nakba", la
"catastrofe", come la chiamano, perché molti furono costretti ad abbandonare per
sempre case e villaggi.
L'esercito ha aperto il fuoco
in più occasioni con colpi di artiglieria, munizioni vere e proiettili di gomma
vicino alla barriera di sicurezza davanti a cui hanno manifestato 17 mila
palestinesi. Dalla folla sono stati lanciati sassi e bottiglie molotov verso i
militari. Di primo mattino il colpo di artiglieria di un carro armato aveva
ucciso Omar Samour, un agricoltore palestinese di 27 anni che era entrato nella
fascia di sicurezza istituita dalle forze armate israeliane. Testimoni hanno
raccontato che si trovava su terreni vicini alla frontiera e un portavoce
dell'esercito ha spiegato l'episodio parlando di "due sospetti che si sono
avvicinati alla barriera di sicurezza nel sud della Striscia di Gaza e hanno
cominciato a comportarsi in maniera strana", e i carri armati hanno sparato
contro di loro". Successivamente è stato ucciso con un colpo allo stomaco un
25enne a est di Jabaliya, nel nord del territorio costiero e altri due (fra cui
un 38enne) in punti diversi della frontiera. La maggior parte dei feriti sono
stati colpiti da proiettili di gomma e gas lacrimogeni.
L'Autorità nazionale
palestinese (Anp) ha chiesto l'intervento della comunità internazionale. Yusef
al Mahmoud, portavoce dell'Anp a Ramallah, ha chiesto "un intervento
internazionale immediato e urgente per fermare lo spargimento del sangue del
nostro popolo palestinese da parte delle forze di occupazione israeliane".
L'esercito israeliano ha precisato di aver preso di mira "i principali
istigatori" delle proteste violente e ha ribadito che non verrà permesso a
nessuno di violare la sovranità di Israele superando la barriera di sicurezza e
per questo ha anche schierato un centinaio di tiratori scelti. Secondo il
generale israeliano Eyal Zamir, l'esercito è intervenuto perché ha "identificato
alcuni terroristi che cercano di condurre attacchi, camuffandosi da
manifestanti". Zamir ha chiesto ai residenti palestinesi di stare lontano dal
confine e ha accusato Hamas di essere responsabile degli scontri in corso. Le
manifestazioni sono partite da sei punti dell'arido confine tra Gaza e Israele,
lungo una cinquantina di chilometri: in particolare Rafah e Khan Younis nel sud,
el-Bureij e Gaza City al centro, Jabalya nel nord. Il leader di Hamas, Ismail
Haniyeh, ha arringato la folla assicurando che "è l'inizio del ritorno di tutti
i palestinesi". Fonti dell'esercito di Tel Aviv hanno descritto gli scontri:
"Fanno rotolare pneumatici incendiati e lanciano pietre verso la barriera di
sicurezza, i soldati israeliani ricorrono a mezzi antisommossa e sparano in
direzione dei principali responsabili e hanno imposto una zona militare chiusa
attorno alla Striscia di Gaza, una zona dove ogni attività necessita di
autorizzazione".
L'esercito israeliano ha detto
che una ragazzina palestinese di 7 anni è stata "mandata verso Israele per
superare la barriera difensiva". "Quando i soldati hanno realizzato che era una
ragazzina - ha continuato l'esercito - l'hanno presa e si sono assicurati che
tornasse in sicurezza dai genitori". Secondo l'esercito - citato dai media - la
ragazzina è stata inviata da Hamas che "cinicamente usa le donne e i bambini, li
manda verso la frontiera e mette in pericolo le loro vite". La protesta, che
secondo gli organizzatori sarebbe dovuta essere pacifica, ha l'obiettivo di
realizzare il "diritto al ritorno", la richiesta palestinese che i discendenti
dei rifugiati privati delle case nel 1948 possano ritornare alle proprietà della
loro famiglia nei territori che attualmente appartengono a Israele. Sono giorni
che Israele fa intendere che avrebbe usato le maniere forti. Il ministro della
Difesa, Avigdor Liberman, aveva avvertito che qualsiasi palestinese si fosse
avvicinato a una barriera di sicurezza avrebbe messo a repentaglio la propria
vita. Secondo i media israeliani, Liberman da stamane si trova presso il
quartier generale dell'esercito per monitorare la situazione. L'esercito ha
dichiarato la zona "area militare interdetta". Scontri sono in corso anche in
Cisgiordania, nelle zone di Ramallah e di Hebron. Secondo il quotidiano
israeliano Haaretz la mobilitazione chiamata da Hamas è anche un modo per sviare
l'attenzione dal pantano politico all'interno della Striscia: dove dopo la
guerra del 2014 le infrastrutture sono in rovina e la gestione delle necessità
quotidiane è sempre più complicato. "Condanniamo in modo forte l'uso
sproporzionato della forza da parte di Israele contro i palestinesi durante le
proteste pacifiche di oggi a Gaza", ha detto il ministro degli Esteri della
Turchia. "È necessario che Israele ponga fine rapidamente all'uso della forza,
che innalzerebbe ulteriormente le tensioni nella regione", afferma Ankara,
lanciando un invito "alla comunità internazionale a rispettare la sua
responsabilità di convincere Israele ad abbandonare il suo atteggiamento
ostile".
Israele spara sulla marcia
palestinese: 15 morti a Gaza.
Striscia di Gaza. Uomini, donne e bambini per il ritorno e il Giorno della
terra: i cecchini israeliani aprono il fuoco su 20mila persone al confine. Oltre
mille i feriti, scrive Michele Giorgio il 30.3.2018 su "Il Manifesto". Manifesto
Il video che gira su twitter mostra un ragazzo mentre corre ad aiutare un amico
con in mano un vecchio pneumatico da dare alle fiamme. Ad certo punto il
ragazzo, avrà forse 14 anni, cade, colpito da un tiro di precisione partito
dalle postazioni israeliane. Poi ci diranno che è stato “solo” ferito. Una
sorte ben peggiore è toccata ad altri 15 palestinesi di Gaza rimasti uccisi
ieri in quello che non si può che definire il tiro al piccione praticato per
ore dai cecchini dell’esercito israeliano. Una strage. I feriti sono stati un
migliaio (1.500 anche 1.800 secondo altre fonti): centinaia intossicati dai gas
lacrimogeni, gli altri sono stati colpiti da proiettili veri o ricoperti di
gomma. È stato il bilancio di vittime a Gaza più alto in una sola giornata
dall’offensiva israeliana “Margine Protettivo” del 2014. Gli ospedali già in
ginocchio da mesi hanno dovuto affrontare questa nuova emergenza con pochi
mezzi a disposizione. Hanno dovuto lanciare un appello a donare il sangue
perché quello disponibile non bastava ad aiutare i tanti colpiti alle gambe,
all’addome, al torace. «I nostri ospedali da mesi non hanno più alcuni farmaci
importanti, lavorano in condizioni molto precarie e oggi (ieri) stanno
lavorando in una doppia emergenza, quella ordinaria e quella causata dal fuoco
israeliano sul confine», ci diceva Aziz Kahlout, un giornalista.
Gli ordini dei comandi
militari israeliani e del ministro della difesa Avigdor Lieberman erano
tassativi: aprire il fuoco con munizioni vere su chiunque si fosse spinto fino
a pochi metri dalle barriere di confine. E così è andata. Per giorni le
autorità di governo e i vertici delle forze armate hanno descritto la Grande
Marcia del Ritorno come un piano del movimento islamico Hamas per invadere le
comunità ebraiche e i kibbutz a ridosso della Striscia di Gaza e per occupare
porzioni del sud di Israele. Per questo erano stati fatti affluire intorno a
Gaza rinforzi di truppe, carri armati, blindati, pezzi di artiglieria e un
centinaio di tiratori scelti.
Pur considerando il ruolo da
protagonista svolto da Hamas, che sicuramente ieri ha dimostrato la sua
capacità di mobilitare la popolazione, la Grande Marcia del Ritorno non è stata
solo una idea del movimento islamista. Tutte le formazioni politiche
palestinesi vi hanno preso parte, laiche, di sinistra e religiose. Anche Fatah,
il partito del presidente dell’Anp Abu Mazen che ieri ha proclamato il lutto
nazionale. E in ogni caso lungo il confine sono andati 20mila di civili
disarmati, famiglie intere, giovani, anziani, bambini e non dei guerriglieri
ben addestrati. Senza dubbio alcune centinaia si sono spinti fin sotto i
reticolati, vicino alle torrette militari, ma erano dei civili, spesso solo dei
ragazzi. Israele ha denunciato lanci di pietre e di molotov, ha parlato di
«manifestazioni di massa volte a coprire attacchi terroristici» ma l’unico
attacco armato vero e proprio è stato quello – ripreso anche in un video
diffuso dall’esercito – di due militanti del Jihad giunti sulle barriere di
confine dove hanno sparato contro le postazioni israeliane prima di essere
uccisi da una cannonata.
La Grande Marcia del Ritorno
sulla fascia orientale di Gaza e in Cisgiordania è coincisa con il “Yom
al-Ard”, il “Giorno della Terra”. Ogni 30 marzo i palestinesi ricordano le sei
vittime del fuoco della polizia contro i manifestanti che in Galilea si
opponevano all’esproprio di altre terre arabe per costruire comunità ebraiche
nel nord di Israele. I suoi promotori, che hanno preparato cinque campi di
tende lungo il confine tra Gaza e Israele – simili a quelle in cui vivono i
profughi di guerra -, intendono portarla avanti nelle prossime settimane, fino
al 15 maggio quando Israele celebrerà i suoi 70 anni e i palestinesi
commemoreranno la Nakba, la catastrofe della perdita della terra e dell’esilio
per centinaia di migliaia di profughi. Naturalmente l’obiettivo è anche quello
di dire con forza che la gente di Gaza non sopporta più il blocco attuato da
Israele ed Egitto e vuole vivere libera. Asmaa al Katari, una studentessa
universitaria, ha spiegato ieri di aver partecipato alla marcia e che si unirà
alle prossime proteste «perché la vita è difficile a Gaza e non abbiamo nulla
da perdere». Ghanem Abdelal, 50 anni, spera che la protesta «porterà a una
svolta, a un miglioramento della nostra vita a Gaza».
Per Israele invece la Marcia è
solo un piano di Hamas per compiere atti di terrorismo. La risposta perciò è
stata durissima. Il primo a morire è stato, ieri all’alba, un contadino che,
andando nel suo campo, si era avvicinato troppo al confine. Poi la mattanza:
due-tre, poi sei-sette, 10-12 morti. A fine giornata 15. E il bilancio
purtroppo potrebbe salire. Alcuni dei feriti sono gravissimi.
Si rischia la Pasqua di
rappresaglia. In Israele si rischia una Pasqua di rappresaglia,
scrive Fiamma Nirenstein, Sabato 31/03/2018 su "Il Giornale". C'è confusione sui
numeri ma non sul significato della «Marcia del ritorno», come l'ha chiamata
Hamas. 15 morti, 1.400 feriti e 20mila dimostranti sul confine di Israele con
Gaza, in una manifestazione organizzata per essere solo la prima in direzione di
una mobilitazione di massa che dovrebbe avere il suo apice il 15 di maggio,
giorno della Nakba palestinese, il «disastro», festa dell'indipendenza di
Israele, che coinciderà anche con il passaggio dell'ambasciata americana a
Gerusalemme. Un'escalation continua di eccitazione mentre cresceva l'incitamento
ha visto per ben quattro volte unità di giovani armati di molotov, bombe a mano
e coltelli, infiltrati dentro il confine. Un esempio limitato di quello che
Hamas vorrebbe riprodurre su scala di massa, ovvero l'invasione di Israele, come
nei loro discorsi ieri hanno ripetuto i leader massimi Ismail Hanyie e Yehyia
Sinwar. Non a caso nei giorni della preparazione si sono svolte esercitazioni
militari con lanci di razzi e incendi di finti carri armati, pretesi rapimenti e
uccisioni che hanno persino fatto scattare i sistemi antimissile spedendo gli
israeliani nei rifugi. Il messaggio di Hamas era chiaro: marciate, noi vi
copriamo con le armi. Ma le intenzioni terroriste sono state incartate dentro lo
scudo delle manifestazioni di massa e l'uso della popolazione civile, inclusi
donne e bambini, è stato esaltato al massimo. Molti commentatori sottolineano
che se Hamas decide di marciare, non ci sia molta scelta. E una marcia di civili
risulta indiscutibile presso l'opinione pubblica occidentale, ma il messaggio
sottinteso è stato spezzare il confine sovrano di Israele con la pressione della
folla civile, utilizzare le strette regole di combattimento dell'esercito
israeliano che mentre lo stato maggiore si arrovellava, si è trovato nel
consueto dilemma delle guerre asimmetriche: tu usi soldati in divisa e il nemico
soldati in abiti civili, donne, bambini, talora palesemente utilizzati come
provocazione. L'esercito ha confermato che una piccola di sette anni per fortuna
è stata individuata in tempo prima di venire travolta negli scontri. E in serata
Israele ha bombardato con cannonate e raid aerei tre siti di Hamas a Gaza in
risposta a un tentativo di attacco armato contro soldati. La protesta di Hamas -
che arriva alla vigilia della festa di Pesach, la Pasqua ebraica - ha vari
scopi: il primo è legato alla situazione interna di Gaza. L'uso militarista dei
fondi internazionali e il blocco conseguente del progresso produttivo ha reso la
vita della gente miserabile e i confini restano chiusi. È colpa della minaccia
che l'ingresso da Gaza di uomini comandati da un'entità terrorista, comporta per
chiunque, israeliani o egiziani. Hamas con la marcia incrementa la sua
concorrenza mortale con l'Anp di Abu Mazen, cui ha cercato di uccidere pochi
giorni fa il primo ministro Rami Hamdallah; minacciata di taglio di fondi urla
più forte che può contro Israele, cosa su cui la folla araba, anche quella dei
Paesi oggi vicini a Israele come l'Arabia Saudita e l'Egitto, la sostiene. Il
titolo «Marcia del ritorno» significa che non può esserci nessun accordo sul
fondamento di qualsiasi accordo di pace, ovvero sulla rinuncia all'ingresso
distruttivo nello Stato ebraico dei milioni di nipoti dei profughi del '48,
quando una parte dei palestinesi fu cacciata e una parte se ne andò
volontariamente certa di tornare sulla punta della baionetta araba. Israele ha
cercato invano di evitare che alle manifestazioni si facessero dei morti. Ma
nessuno Stato sovrano accetterebbe da parte di migliaia di dimostranti guidati
da un'organizzazione che si dedica solo alla sua morte una effrazione di
confini. Hamas userà i nuovi shahid (povera gente) per propagandare la sua sete
di morte in nome di Allah e contro Israele. Certo questo non crea in Israele
maggiore fiducia verso una pace futura.
Il silenzio assordante sul
massacro dei curdi,
scrive Marco Rovelli il 29 marzo 2018 su Left. Fin dove arriva l’estensione
dell’impunità? Fin dove ci si può spingere nel massacro e nel disprezzo del
diritto? Fin dove si può farlo nella più totale indifferenza della comunità
internazionale e dei media? Erdogan ci sta mostrando sul campo che questi
confini sono assai estensibili. Quella porzione di Medio Oriente che dopo la
dissoluzione dell’Impero ottomano prese il nome di Siria, e che adesso si è
dissolta a sua volta, è il luogo ideale per riplasmare i confini di ciò che è
lecito. Ed è lecito tutto ciò che si può fare, come nello stato di natura di
Hobbes e Spinoza. In quello stato di natura non esiste alcuno Stato civile:
l’assoluta libertà di massacro di Erdogan, allora, ci mostra che non è
collassata solo la sovranità statale siriana, ma pure qualsiasi simulacro di
comunità internazionale. Erdogan ha di fatto invaso la Siria, e tutto accade
come nulla fosse: perché, dal punto di vista di una comunità internazionale, che
non esiste in quanto comunità normata da un diritto, nulla è, in effetti.
Erdogan massacra i curdi, tanto combattenti quanto civili, e, ancora, nulla è. I
curdi del resto sono da cent’anni l’assoluto rimosso del Medio Oriente, vittima
silenziosa delle strategie delle sovranità statali. Negli ultimi quindici anni i
curdi hanno provato a mettere in discussione il principio della sovranità dello
Stato-nazione, attraverso la teoria del confederalismo democratico: e così
adesso, quel Leviatano si abbatte su di loro, in forma di vendetta, lacerando
ancora le carni di quel popolo ribelle. Mentre il sacrificio si compie, il mondo
resta ammutolito. Ma non perché sgomento dalla terribile entità di quel
massacro. Piuttosto, perché nulla sa, e, se sa qualcosa, preferisce non farne
parola. Così appaiono del tutto naturali le immagini di Erdogan in visita in
Italia senza che nessuno dei nostri governanti abbia osato far cenno dei suoi
crimini. Un’infamia inemendabile. E allora, sia gratitudine a chi è penetrato
nei cancelli della fabbrica Agusta, il luogo primo della nostra complicità nel
massacro in corso. È con i nostri elicotteri Agusta Westland che il massacro
viene compiuto. Le pale degli elicotteri fanno un rumore tale, e le bombe
sganciate, che il silenzio dei media e dei governanti si fa sempre più
assordante. Fanno bene al cuore le immagini della partecipazione alle
manifestazioni per Afrin, certo: ma è sempre troppo poco quel che possiamo fare,
perché il silenzio del discorso pubblico ci sopravanza. Ciò, ovviamente, non ci
esime dal continuare a fare. Bisogna ricordare, senza posa, a fronte
dell’obsolescenza programmata del discorso pubblico, dove i morti scompaiono
dalla scena più velocemente di una qualsiasi canzone pop, di qualsiasi
tormentone estivo, come si getta un bene di consumo qualsiasi nell’immondizia.
Ricordiamo, invece. Ricordiamoci di Alan Kurdi, quel bambino curdo finito morto
riverso sulla spiaggia, che il mondo ha guardato in faccia per un istante,
commuovendosi come sempre per interposta persona, per poi assistere il giorno
dopo a un nuovo spettacolo che cancella quello del giorno precedente.
Ricordiamolo, che migliaia di piccoli Alan Kurdi sono uccisi, o costretti a un
esodo immane, dalle nostre bombe. E ricordiamo che Erdogan sta provando a
uccidere la speranza più luminosa di un Medio Oriente da troppo tempo disperato,
la speranza costruita giorno dopo giorno da un movimento curdo che tenta di
ridare forma e contenuti e pratiche nuovi a una parola da noi usurata e consunta
e abusata: democrazia. Ricordiamolo, che è perché i curdi del Rojava
sperimentano una democrazia radicale, che sono massacrati.
MIGRAZIONI O INVASIONI?
Di Claudio
Mutti 1 dicembre 2016. La storiografia italiana e francese è solita applicare la
definizione di “invasioni barbariche” a quel vasto fenomeno di spostamenti a
catena che si verificò tra l’Asia e l’Europa a partire dal IV secolo d. C.,
portando popolazioni eterogenee a stabilirsi in sedi diverse da quelle
originarie, spesso sui territori appartenenti o appartenuti all’Impero romano.
Gli storici tedeschi e ungheresi, per ragioni facilmente comprensibili, hanno
preferito far uso di termini più neutri e anodini,
quali Völkerwanderung e népvándorlás (“migrazione di popoli”). L’odierna
penetrazione di masse umane originarie dell’Asia e dell’Africa entro i confini
europei è a volte paragonata al fenomeno che ebbe luogo nel Tardoantico e
nell’Alto Medioevo; ed anche i termini “migrazione” e “invasione”, quando
vengono applicati al caso attuale, riflettono prospettive e percezioni alquanto
diverse.
“Migrazione”, infatti, è il
termine con cui viene comunemente indicato lo spostamento che individui,
famiglie o gruppi più o meno numerosi intraprendono con l’intenzione di
stabilirsi in una nuova sede, in maniera provvisoria o definitiva. La teoria
geopolitica è solita distinguere i movimenti migratori, rispetto alla volontà
dei migranti, in volontari e coatti. Si parla di migrazione volontaria quando
gl’individui decidono liberamente di andare a stabilirsi in un luogo in cui
sperano di migliorare la loro condizione economica. Invece, una migrazione viene
considerata coatta quando i migranti trasferiscono altrove la loro residenza per
effetto di una costrizione esercitata dal potere politico (ad esempio, nel caso
in cui siano vittime di una deportazione); il movimento migratorio è considerato
coatto anche quando viene intrapreso allo scopo di evitare il coinvolgimento in
eventi bellici o in catastrofi naturali. Alle due suddette varianti della
tipologia migratoria è possibile aggiungerne una terza: quella che in uno studio
recente Kelly M. Greenhill (già assistente del senatore John Kerry e consulente
del Pentagono) definisce come coercive engineered migration, ossia “migrazione
coatta progettata”. Le migrazioni “create ad arte” (engineered) sono, secondo la
definizione fornita dalla studiosa stessa, “movimenti di popolazione
transfrontalieri che vengono deliberatamente creati o manipolati al fine di
estorcere concessioni politiche, militari e/o economiche ad uno o più Stati
presi di mira”.
Le migrazioni coatte
progettate vengono a loro volta distinte in espropriatrici, esportatrici,
militarizzate. “Le migrazioni progettate espropriatrici – scrive la Greenhill –
sono quelle il cui obiettivo principale consiste nell’appropriazione del
territorio o della proprietà di un altro gruppo o gruppi, oppure
nell’eliminazione di tale gruppo o gruppi in quanto minacciano il dominio
etnopolitico o economico di coloro che progettano l’(e)migrazione; rientra in
questo caso ciò che è comunemente noto come pulizia etnica”.
Si parla invece di “invasione”
allorché un gruppo militare o anche un gruppo di civili penetra in un
territorio, vi si diffonde e lo occupa, sottraendolo, tutto o in parte, al
controllo ed alla sovranità della popolazione autoctona. Non è dunque necessario
che un’invasione, per essere tale, venga portata a termine con le armi; anzi,
un’invasione può avvenire in modo pacifico, se a stanziarsi su un determinato
territorio e a modificarne l’omogeneità etnica o culturale sono masse umane
disarmate ma numericamente consistenti.
Vi sono infatti casi nei quali
un fenomeno immigratorio si configura come un’invasione vera e propria.
L’immigrazione di massa possiede allora l’efficacia di un’arma di distruzione di
massa. Esempi storici in tal senso non mancano: si pensi all’immigrazione che ha
praticamente cancellato dal territorio degli attuali Stati Uniti d’America la
presenza della popolazione autoctona o a quella che ha trasformato la Palestina
nell’odierno “Stato d’Israele”. Da parte sua, Kelly M. Greenhill individua circa
una cinquantina di casi di migrazioni architettate o comunque eterodirette ed
utilizzate, tutti casi verificatisi dopo che nel 1951 entrò in vigore la
Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati.
Perciò l’invasione migratoria
attualmente diretta verso l’Europa, se si vuole riproporre un termine usato
dalla studiosa statunitense, è “un’arma di guerra” (a weapon of war), che
rientra nel novero delle armi non convenzionali impiegate nella cosiddetta
“guerra asimmetrica”. Come il terrorismo, la manipolazione dei mezzi di
comunicazione, la pirateria informatica, le turbative dei mercati azionari, così
anche i flussi migratori che investono l’Italia e la regione balcanica – flussi
sollecitati, attirati, agevolati ed importati – costituiscono un’arma non
convenzionale utilizzata per destabilizzare l’Europa. È dunque in corso qualcosa
che, a detta di Samar Sen, ambasciatore dell’India all’ONU, assomiglia molto ad
una guerra. “Se aggredire un Paese straniero – argomenta il diplomatico –
significa colpire la sua struttura sociale, danneggiarne l’economia,
costringerlo a rinunciare a porzioni del suo territorio per accogliere profughi
(refugees), qual è la differenza tra questo tipo di aggressione e il tipo più
classico, che si ha quando viene dichiarata una guerra?” Il medesimo concetto è
stato espresso nel corso di una conferenza sul conflitto in Cossovo tenuta l’11
dicembre 2000 alla Brandeis University: “La natura della guerra è cambiata –
ebbe a dire Martha Minow, della Harvard Law School –; ora la guerra sono i
profughi (refugees)”.
Gli strateghi di questa
guerra sui generis agiscono allo scoperto. Uno di loro, il famigerato
speculatore statunitense George Soros, il 20 settembre 2016 ha apertamente
rivendicato dalle colonne di “The Wall Street Journal” il proprio ruolo di
finanziatore dell’invasione. “Ho deciso – ha dichiarato – di stanziare 500
milioni di dollari per investimenti destinati in modo specifico ai bisogni di
migranti, rifugiati e centri d’accoglienza. Investirò in nuove imprese, società
già esistenti, iniziative di impatto sociale fondate dai migranti e rifugiati
stessi. Anche se il mio impegno principale consiste nell’aiutare migranti e
rifugiati che arrivano in Europa, cercherò progetti di investimento che
avvantaggino i migranti in tutto il mondo”.
Come furono inventati i
palestinesi,
scrive di Robert Spencer il 19 agosto 2018 su l’Informale. Nel 1948, il nascente
Stato di Israele sconfisse gli eserciti di Egitto, Iraq, Siria, Transgiordania,
Libano, Arabia Saudita e Yemen che volevano distruggerlo completamente. Il jihad
contro Israele proseguì, ma lo Stato ebraico tenne duro, sconfiggendo ancora
Egitto, Iraq, Siria, Giordania e Libano nella guerra dei Sei Giorni nel 1967 e
l’Egitto e la Siria ancora una volta nella guerra dello Yom Kippur del 1973.
Nell’ottenere queste vittorie contro enormi difficoltà, Israele riscosse
l’ammirazione del mondo libero, vittorie che comportarono l’attuazione più
audace e su più ampia scala nella storia islamica del detto di Maometto: “La
guerra è inganno”. Per distruggere l’impressione che il piccolo Stato ebraico
stesse fronteggiando ingenti nemici arabi musulmani e che stesse prevalendo su
di loro, il KGB sovietico (il Comitato sovietico per la sicurezza dello Stato)
inventò un popolo ancora più piccolo, i “palestinesi”, minacciato da una ben
funzionante e spietata macchina da guerra israeliana. Nel 134 d.C., i Romani
avevano espulso gli ebrei dalla Giudea dopo la rivolta di Bar Kokhba e
ribattezzarono la regione Palestina, un nome tratto dalla Bibbia, il nome degli
antichi nemici degli Israeliti, i Filistei. Ma il termine palestinese era sempre
stato riferito a una regione e non a un popolo o a una etnia. Negli anni
Sessanta, tuttavia, il KGB e il nipote di Hajj Amin al-Husseini, Yasser Arafat,
crearono tanto questo presunto popolo oppresso quanto lo strumento della sua
libertà, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP). Ion Mihai
Pacepa, già vicedirettore del servizio di spionaggio della Romania comunista
durante la Guerra Fredda, in seguito rivelò che “l’OLP era stata una invenzione
del KGB, che aveva un debole per le organizzazioni di ‘liberazione’. C’era
l’Esercito di liberazione nazionale della Bolivia, creato dal KGB nel 1964 con
l’aiuto di Ernesto ‘Che’ Guevara (…) inoltre, il KGB creò il Fronte democratico
per la liberazione della Palestina, che perpetrò numerosi attacchi dinamitardi.
(…) Nel 1964, il primo Consiglio dell’OLP, composto da 422 rappresentanti
palestinesi scelti con cura dal KGB, approvò la Carta nazionale palestinese – un
documento che era stato redatto a Mosca. Anche il Patto nazionale palestinese e
la Costituzione palestinese nacquero a Mosca, con l’aiuto di Ahmed Shuqairy, un
influente agente del KGB che divenne il primo presidente dell’OLP”. Affinché
Arafat potesse dirigere l’OLP avrebbe dovuto essere un palestinese. Pacepa
spiegò che “egli era un borghese egiziano trasformato in un devoto marxista
dall’intelligence estera del KGB. Il KGB lo aveva formato nella sua scuola per
operazioni speciali a Balashikha, cittadina a est di Mosca, e a metà degli anni
Sessanta decise di prepararlo come futuro leader dell’OLP. Innanzitutto, il KGB
distrusse i documenti ufficiali che certificavano la nascita di Arafat al Cairo,
rimpiazzandoli con documenti falsi che lo facevano figurare nato a Gerusalemme
e, pertanto, palestinese di nascita”. Arafat potrebbe essere stato marxista,
almeno all’inizio, ma lui e i suoi referenti sovietici fecero un uso copioso
dell’antisemitismo islamico. Il capo del KGB, Yuri Andropov, osservò che “il
mondo islamico era una piastra di Petri in cui potevamo coltivare un ceppo
virulento di odio antiamericano e antisraeliano, cresciuto dal batterio del
pensiero marxista-leninista. L’antisemitismo islamico ha radici profonde… .
Dovevamo solo continuare a ripetere i nostri argomenti – che gli Stati Uniti e
Israele erano ‘paesi fascisti, imperial-sionisti’ finanziati da ricchi ebrei.
L’Islam era ossessionato dall’idea di evitare l’occupazione del suo territorio
da parte degli infedeli ed era assolutamente ricettivo al ritratto da noi fatto
del Congresso americano come un rapace organismo sionista volto a trasformare il
mondo in un feudo ebraico”. Il membro del Comitato esecutivo dell’OLP, Zahir
Muhsein, spiegò in modo più esaustivo la strategia in una intervista del 1977 al
quotidiano olandese Trouw: Il popolo palestinese non esiste. La creazione di uno
stato palestinese è solo un mezzo per continuare la nostra lotta contro lo stato
di Israele per la nostra unità araba. In realtà, oggi non c’è alcuna differenza
fra giordani, palestinesi, siriani e libanesi. Solo per ragioni politiche e
strategiche parliamo oggi dell’esistenza di un popolo palestinese, dal momento
che gli interessi nazionali arabi esigono che noi postuliamo l’esistenza di un
distinto “popolo palestinese” che si opponga al sionismo. Per ragioni
strategiche, la Giordania, che è uno stato sovrano con confini definiti, non può
avanzare pretese su Haifa e Jaffa mentre, come palestinese, posso indubbiamente
rivendicare Haifa, Jaffa, Bee-Sheva e Gerusalemme. Tuttavia, nel momento in cui
rivendicheremo il nostro diritto a tutta la Palestina, non aspetteremo neppure
un minuto a unire Palestina e Giordania. Una volta che era stato creato il
popolo, il loro desiderio di pace poteva essere facilmente inventato. Il
dittatore romeno Nicolae Ceausescu insegnò ad Arafat come suonare l’Occidente
come un violino. Pacepa raccontò: “Nel marzo del 1978 condussi in gran segreto
Arafat a Bucarest per le istruzioni finali su come comportarsi a Washington.
‘Devi solo far finta di rompere con il terrorismo e riconoscere Israele, ancora,
e ancora e ancora’, disse Ceausescu ad Arafat. (…) Ceausescu era euforico
all’idea che Arafat e lui potessero riuscire ad accaparrarsi un Premio Nobel per
la pace con la loro farsa del ramoscello d’ulivo. (…) Ceausescu non riuscì a
ottenere il suo Premio Nobel per la pace. Ma nel 1994 Arafat lo ricevette,
proprio perché continuò a interpretare alla perfezione il ruolo che gli avevano
affidato. Aveva trasformato la sua OLP terrorista in un governo in esilio
(l’Autorità palestinese), fingendo sempre di porre fine al terrorismo
palestinese, pur continuando ad alimentarlo. Due anni dopo la firma degli
accordi di Oslo, il numero degli israeliani uccisi dai terroristi palestinesi
era aumentato del 73 per cento”. Questa strategia ha continuato a funzionare
alla perfezione, attraverso i “processi di pace” negoziati dagli Stati Uniti,
dagli accordi di Camp David del 1978 alla presidenza di Barack Obama e oltre,
senza posa. Le autorità occidentali non sembrano mai riflettere sul perché siano
tutti falliti così tanti tentativi di raggiungere una pace negoziata tra Israele
e i “palestinesi”, la cui esistenza storica oramai tutti danno per scontata. La
risposta, ovviamente, sta nella dottrina islamica del jihad. “Cacciateli da dove
vi hanno cacciato” è un ordine che non contiene alcuna mitigazione e che non
accetta nessuno.
Nota: Questo è un estratto
esclusivo dal nuovo libro di Robert Spencer, The History of Jihad From Muhammad
to ISIS. Tutte le citazioni sono contenute nel libro. Traduzione in italiano di
Angelita La Spada
Terrorismo islamista.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Il terrorismo islamista o, meno
correttamente, islamico è una forma di terrorismo religioso praticato da diversi
gruppi di fondamentalisti musulmani per raggiungere vari obiettivi politici in
nome della loro religione. Eccezione fatta per alcune sporadiche manifestazioni
di antica militanza oltranzista religiosa condotta con metodi sanguinari
dalla setta degli assassini(specialmente in Persia e negli ex-dominî
fatimidi quali Egitto e Siria), il fenomeno ha assunto dimensione globalmente
rilevante solo nel secondo dopoguerra, in particolare a seguito
dell'irrisolta questione palestinese[senza fonte], varie organizzazioni della
cui resistenza hanno fatto ricorso a strumenti quali attentati dinamitardi,
rapimenti, dirottamenti aerei, omicidi e attentati suicidi. L'anelito verso
l'instaurazione di un nuovo ordine sociale ancorato ai valori dalla propria fede
per fronteggiare le sfide del presente, al pari di un certo qual spirito
apocalittico, è un topos ricorrente da tempo immemorabile in numerose religioni.
Tale concezione, parlando di Islam, affonda le proprie radici fin dalle origini
di questa religione. Già fin da dopo il 750, in effetti, con la fine
del califfato omayyade, si attendeva da parte di nostalgici sostenitori della
dinastia abbattuta dagli Abbasidi l'epifania di un non meglio precisato Sufyāni,
appartenente cioè al deposto casato omayyade del ramo sufyanide, che avrebbe
riportato per volere divino la Umma alla sua purezza originaria. Analogamente,
nel 1258, la presa di Baghdadda parte dei Mongoli e la conseguente distruzione
del califfato abbaside fu ricollegata dal giurista e teologo hanbalita del XIV
secolo Ibn Taymiyya all'allontanamento della comunità dei credenti dalla pretesa
«retta via» della prima Umma musulmana. Al giorno d'oggi le azioni poste in
essere da tali gruppi rappresentano, secondo la loro ideologia, un tentativo di
ricreare una società perfetta — ancorché utopistica— in quanto asseritamente
modellata secondo i dettami del Corano e, di conseguenza, priva di quelle
ingiustizie sociali, politiche ed economiche attribuite dall'ecumene islamica ai
regimi secolarizzati (munāfiqūn, «ipocriti» e proni al mondo occidentale,
definito kāfir, «infedele») i cui governanti sarebbero di fatto asserviti
al Cristianesimo e al sionismo e, quindi, pervicacemente ostili all'Islam più
"puro". Non manca, peraltro, chi considera le organizzazioni terroristiche di
matrice islamica l'ala estrema di una «religione politica», adottando una
terminologia analoga a quella utilizzata per definire il nazismo. Vi furono in
passato gruppi, configurati come sette religiose, che contestarono alla
maggioranza dei credenti musulmani o agli ulema, il cosiddetto clero islamico,
l'allontanamento dal retto insegnamento di Maometto, che essi cercarono di
contrastare con un loro distacco fisico o simbolico dalla società, come fece la
setta dei kharigiti (arabo kharaa, «coloro che vanno fuori») ove non fosse
possibile il ricorso a una «doverosa» violenza, come fu il caso della setta
degli Assassini. Nei cosiddetti versetti della spada della Sura IX del Corano,
cosiddetta "della conversione", è scritto: «Quando poi saran trascorsi i mesi
sacri, uccidete gli idolatri dovunque li troviate, prendeteli, circondateli,
appostateli, ovunque in imboscate. Se poi si convertono e compiono la Preghiera
e pagano la Dècima, lasciateli andare, poiché Dio è indulgente, clemente.»
(Cor., IX:5) « Combattete coloro che non credono in Dio e nel Giorno Estremo, e
che non ritengono illecito quel che Dio e il Suo Messaggero han dichiarato
illecito, e coloro fra quelli cui fu data la Scrittura, che non s'attengono alla
Religione della Verità. Combatteteli finché non paghino il tributo, uno per uno,
umiliati.» (Cor., IX:29) I summenzionati passi sono stati oggetto di
interpretazioni non univoche: da una parte alcuni studiosi hanno interpretato i
questi passaggi coranici come giustificazione per l'uccisione su larga scala
degli infedeli, mentre vi è chi non è d'accordo con tale visione, privilegiando
una lettura non orientata alla violenza, ispirata piuttosto alla tolleranza,
così come invocato nella sura II:256: « Non vi sia costrizione nella Fede: la
retta via ben si distingue dall'errore, e chi rifiuta āġūt e crede in Dio s'è
afferrato all'impugnatura saldissima che mai si può spezzare, e Dio ascolta e
conosce.» (Cor., II:256). Tra le varie ipotesi formulate per spiegare l'origine
del terrorismo islamista moderno figurano la rivoluzione iraniana, il ritiro
sovietico dall'Afghanistan e la rivitalizzazione della religione a livello
globale post-guerra fredda: «Mentre è impossibile stabilire in maniera
definitiva quando fu usato per la prima volta, le radici di quello che oggi
chiamiamo "terrorismo" affondano in un passato di 2000 anni fa. Inoltre il
terrorismo odierno ha in qualche maniera chiuso il cerchio, con molti dei suoi
praticanti attuali spinti da convinzioni religiose – cosa che guidò molti dei
predecessori originari.» Nel 1979 la rivoluzione islamica in Iran spazzò via
lo shah Mohammad Reza Pahlavi, con tutte le forze d'opposizione riunite attorno
all'ayatollah Khomeini. Il nuovo governo instaurò la shari'a nel Paese e col
tempo iniziò a finanziare anche movimenti politici tra cui Hezbollah in Libano,
successivamente classificato come terroristico in vari Paesi del mondo, compresi
quelli arabi come la Giordania, l'Arabia Saudita e l'Egitto di Mubarak; i citati
condannarono le azioni di Hezbollah, mentre Siria e Iran si dichiarano
favorevoli alle azioni dell'organizzazione. L'Unione europea rifiutò
inizialmente di qualificare Hezbollah come organizzazione terroristica, ma il 10
marzo 2005 il Parlamento europeo adottò una risoluzione non vincolante che di
fatto accusa Hezbollah di aver condotto «attività terroriste»; gli Stati Uniti
esercitarono pressioni sull'Unione per fare includere il movimento nella lista
delle organizzazioni terroristiche[18]; il Consiglio d'Europa accusò poi Imad
Mughiyah di essere membro di Hezbollah e di attività terroristica. Il primo
movimento che teorizzò l'uso della lotta per ripristinare lo stile di vita
ortodosso dei primi credenti (salaf al-aliīn, «i pii antenati», da cui il
termine salafita), fu quello dei Fratelli Musulmani. Il movimento, fondato
in Egitto nel 1928 a opera di Hasan al-Banna, si diffuse rapidamente
in Siria, Giordania e Sudan, e, alla fine degli anni quaranta, esso contava
circa 500 000 adepti, con la volontà di affrancare il mondo islamico dalla sua
sudditanza, psicologica e politica, nei confronti dell'Occidente non-musulmano,
anche se ancora il salafismo non aveva l'accezione attualmente in uso e
collegata al rigido fondamentalismo. Le metodologie di organizzazione del
movimento ricalcarono quelle di ideologia marxista che si andavano affermando
dopo la fine della seconda guerra mondiale nei Paesi arabi, in corso di
affrancamento dai regimi coloniali, con un emiro al posto della segreteria
generale e la shura al posto del «comitato centrale» dei gruppi marxisti, e
nelle università spesso i gruppi studenteschi islamisti contendevano il
predominio intellettuale a quelli marxisti, più allineati ai governi esistenti.
I Fratelli Musulmani, organizzati secondo una rigida struttura gerarchica,
divennero così il primo vero movimento di massa neo-islamico e, all'inizio
degli anni cinquanta, sull'onda della guerra in Palestina, esso arrivò a
raccogliere circa due milioni di aderenti. Nelle prime fasi della guerra
afghano-sovietica le varie centinaia di arabi che si erano trasferite
a Peshāwar, in Pakistan, occuparono solo ruoli di supporto, compreso Ayman
al-Zawāhirī che effettuò varie missioni umanitarie con la Mezzaluna Rossa, ma a
un certo punto iniziarono a crearsi i presupposti per un diverso tipo di
impegno. ʿAbd
Allāh al-ʿAzzām era
un predicatore nato in Palestina, trasferitosi in Arabia Saudita e poi in
Pakistan, i cui sermoni avevano influenzato anche il pensiero di bin Laden e che
aveva istituito un'organizzazione denominata Maktab al-Khidamat (MAK),
finalizzata alla gestione dell'afflusso di volontari e fondi in loco per il
sostegno ai mujaheddin[23]; quando i due si incontrarono a Peshāwar, al-ʿAzzām
iniziò a teorizzare una lotta come obbligo morale per tutti i musulmani, come
nel suo libro Ultime Volontà del 1986; in Difendere la terra dei musulmani è il
dovere più importante di ognuno, al-ʿAzzām
afferma che: « Questo dovere non si concluderà con la vittoria in Afghanistan;
il jihad resterà un obbligo personale finché ogni altra terra appartenuta ai
musulmani non ci sarà restituita così che l'Islam torni a regnare; davanti a noi
si aprono la Palestina, Bukhara, il Libano, il Ciad, l'Eritrea, la Somalia,
le Filippine, la Birmania, lo Yemen del Sud, Tashkente l'Andalusia.» Nei testi
di al-ʿAzzām
viene ripetutamente citato il martirio come mezzo per ottenere le ricompense
nell'altra vita quali «l'assoluzione da tutti i peccati, settantadue bellissime
vergini, e il permesso di portare con sé settanta membri della propria
famiglia»; comunque sugli obiettivi da perseguire emersero contrasti tra
al-Zawhāhirī e al-Azzām, che portarono quest'ultimo a essere dapprima fatto
bersaglio di un attentato fallito e poi ucciso da tre mine. Una radicale
trasformazione del terrorismo islamico si è avuta con l'emergere di nuovi Stati
con grandi disponibilità finanziarie come l'Arabia Saudita e gli emirati del
Golfo Persico, caratterizzati anche da forme di governo che si influenzano
reciprocamente con gli ambienti "clericali" islamici e con le dottrine legate a
correnti di pensiero integraliste come il wahhabismo. Questi Stati hanno
indirettamente finanziato (foss'anche inconsapevolmente), attraverso donazioni
da parte di istituzioni caritatevoli, gruppi più o meno legati al terrorismo, e
lo stesso si può dire di facoltosi esponenti del mondo privato di questa stessa
area. Non esiste un automatismo tra donazione e finanziamento al terrorismo, ma
parte dei soldi destinati ad opere assistenziali è stata usata per gestire
istituzioni di accoglienza in aree come il Pakistan, dalla quale gli stranieri
provenienti dal Golfo Persico, dalle Filippine o da altri paesi con una
popolazione almeno in parte islamica sono stati smistati presso i campi di
addestramento situati in Afghanistan o nell'area di confine tra i due paesi; qui
è stata fatta una ulteriore selezione tra i candidati, destinandone alcuni a
corsi specifici di uso degli esplosivi e demolizione o gestione degli ostaggi.
La pratica era comune nel periodo dal 1990 al 2001 e assolutamente trasversale
tra le varie sigle del terrorismo islamista. Tra i nomi più noti dei terroristi
addestrati in questi campi figura ʿAbd
al-Rasūl Sayyāf, cui è dedicato il gruppo terroristico filippino Abū Sayyāf. In
altri casi dei fondi sono stati usati per finanziare direttamente spedizioni di
armi, come ad esempio dall'Alto Commissariato saudita per i rifugiati
all'Alleanza Nazionale Somala di Mohammed Farrah Aidid, in cui armi e munizioni
provenienti da Sudan e Iraq sarebbero stati trasportati dai sauditi, insieme a
beni di necessità, nascoste nei doppi fondi di container fino ai magazzini della
SNA a Mogadiscio.
Questioni aperte e dibattute
rimangono:
se le motivazioni dei
terroristi o supposti tali siano di auto-difesa o espansionistiche, di
autodeterminazione popolare o di supremazia islamica;
se gli obiettivi dei
terroristi o supposti tali siano non di tipo militaristico;
se l'Islam perdoni o
giustifichi, e in quali casi, il terrorismo;
se alcuni attentati vadano
compresi nel terrorismo islamista o se siano da considerare semplici atti di
terrorismo attuati da musulmani;
quanto appoggio abbiano nel
mondo musulmano e, in caso, per quale tipo di terrorismo islamista propendano;
se il conflitto
arabo-israeliano sia la radice del terrorismo islamista o ne sia solo una
concausa.
Il modo nel quale il
terrorismo viene combattuto dagli Stati Uniti d'America, sua principale
controparte, non è da tutti ritenuto efficace; tra i dubbiosi un ex giudice
francese, Jean-Louis Bruguiere, che ritiene venga raccolto un eccesso di
informazioni, ma poi non venga analizzato, ed un altro ostacolo è la scarsità di
coordinamento tra le troppe agenzie federali statunitensi. Lo stesso giudice ha
peraltro evidenziato come organizzazioni ufficialmente umanitarie come la Insani
Yardim Vakfi abbiano avuto almeno in passato legami con al-Qaida. Sebbene Stati
Uniti e Israele siano gli obiettivi più spesso colpiti dal terrorismo islamista,
molti attentati sono avvenuti in altri Paesi e contro altri obiettivi: a metà
degli anni novanta nel mirino dei terroristi c'era la Francia, come strascico
della guerra civile algerina; la Russia ha subito molti attentati terroristici
per il suo coinvolgimento nella seconda guerra cecena e nel 1997 il governo
cinese fu il principale artefice dell'Organizzazione per la cooperazione di
Shanghai voluta anche per combattere i movimenti islamici in Asia centrale. Tra
il 2005 e 2007 l'Iraq fu il luogo dove si concentrò maggiormente l'attività
terroristica: solo nel 2005 oltre 8 000 iracheni morirono a causa di attentati.
Non tutti gli attentati elaborati da organizzazioni terroristiche islamiste
ebbero successo; tra i fallimenti figura il progetto Bojinka (una esplosione
simultanea in volo di undici aerei di linea), attacco con missili terra-aria a
un aereo di linea israeliano con 260 persone a bordo al decollo da Nairobi il 28
novembre 2002; contemporaneamente a quest'ultimo, tuttavia, un attentato con una
jeep imbottita di esplosivo contro un albergo frequentato da turisti israeliani,
con tredici morti e decine di feriti. Solo parzialmente riuscito era stato,
quasi dieci anni prima, l'attentato al World Trade Center del 1993, in quanto
l'obiettivo era l'implosione delle Torri gemelle tramite cariche di esplosivo
collocate in un parcheggio sotterraneo; ciononostante vi furono sei morti.
L'ideatore e realizzatore del piano, Ramzi Yusuf, non cercò la morte
nell'esplosione, a dimostrazione che non tutte le espressioni di terrorismo
islamista cercano il martirio dell'esecutore, fatto salvo l'obiettivo comune di
colpire l'Occidente. Secondo i dati elaborati dal centro nazionale per
l'antiterrorismo statunitense, l'estremismo islamico tra il 2004 e i primi mesi
del 2005 si rese responsabile di circa il 57% delle vittime e del 61% dei
ferimenti per terrorismo, considerando solo i casi in cui la matrice è chiara.
Gli atti terroristici dell'estremismo islamico includono dirottamenti di
aerei, decapitazioni, rapimenti, assassinii, autobombe, attentati suicidi e,
occasionalmente, stupri. L'attività dei terroristi islamisti è spesso indicata
come jihad ("sforzo, "impegno", qui inteso però in senso bellico), ma questa
espressione non intende necessariamente una azione violenta. Le minacce, incluse
quelle di morte, sono spesso emesse come fatwa, (sentenze legali islamiche su
fattispecie giuridiche del tutto astratte). Obiettivi e vittime includono sia
musulmani che non musulmani. I musulmani sono normalmente minacciati con
il takfir (condanna di "miscredenza" grave, emessa contro un musulmano o un
gruppo che si definisca islamico, tale da rendere teoricamente lecito "versarne
il sangue"). Questa è una condanna a morte implicita perché, secondo
gli hadith del Profeta, nell'Islam la punizione degli apostati è la morte.
Secondo il Rapporto sul terrorismo internazionale di matrice jihadista della
Fondazione ICSA presentato alla Camera dei deputati italiana il 28 novembre
2013, negli ultimi 5 anni vi sono state in Europa 14.470 vittime di attentati
terroristici di matrice islamica, con 153 morti compresi gli attentati nel 2015
in Francia, ed in Italia si riscontra un aumento della cyber-jihad, cioè
l'attività terroristica programmata od effettuata via web. La galassia
terrorista si articola in molte organizzazioni, in alcuni casi direttamente
sponsorizzate da servizi segreti nazionali, come il caso della
deviata Inter-Services Intelligence pakistana che ha sostenuto
i Talebani in Afghanistan e sostiene tuttora Lashkar-e Taiba nella sua campagna
di destabilizzazione del Kashmir indiano e negli attacchi all'India. In alcuni
casi sono direttamente gli stati a supportare militarmente, spiritualmente e
finanziariamente le organizzazioni, come nel caso dell'Iran verso Hezbollah;
stime ritengono che il sostegno duri da 25 anni e che vi siano stati
trasferimenti di valuta e materiale dell'ordine dei 100 milioni di dollari
annui, anche se la provenienza è di una fonte non terza come il Mossad, il tutto
finalizzato anche ad espandere la propria influenza regionale. Le organizzazioni
evolvono col tempo, o spariscono a beneficio di nuovi gruppi sotto la pressione
degli stati e delle forze di polizia; un esempio è il Gruppo Salafita per la
Predicazione e il Combattimento che ha raccolto l'eredità e il ruolo del Gruppo
Islamico Armato (GIA) in Algeria e nella zona del Sahel, espandendosi nel
Mali dove sotto il nome di Al-Qa'ida nel Maghreb islamico (AQMI) ha fomentato la
guerra civile e la secessione del nord del paese, dimostrando di poter
perseguire obiettivi politico-militari di ampio respiro rispetto all'esecuzione
di attentati e alla propaganda[45]; il cambio di nome evidenzia inoltre la
volontà di sottolineare l'affiliazione ad Al-Qāʿida
o quanto meno una contiguità di metodi ed obiettivi. I soldi che finanziano
l'operatività di queste organizzazioni provengono da varie fonti come donazioni
di privati, ma anche e soprattutto vendita di armi o di droga come nel caso
dell'AQMI[45]. Un'altra fonte, anche se indiretta, è la pirateria navale, come
nel caso della pirateria somala dalla quale l'organizzazione Al Shabab ha
preteso percentuali dell'ordine del 20% dei riscatti ai pirati, e non
ricevendoli ha proceduto ad "arrestare" alcuni tra loro. Al-Gama'at
al-Islamiyya è una organizzazione egiziana che si è resa responsabile
del massacro di Luxor e di una intensa campagna terroristica, anche se nel 2003
aveva dichiarato di abbandonare la lotta armata. In realtà vi sono stati
massicci rilasci di suoi membri dopo i 25 anni dalla morte di Sadat, che avrebbe
dovuto essere un segno di confidenza del governo egiziano dell'epoca sulla
riduzione della minaccia[48]. L'organizzazione ha come leader religioso ʿUmar
ʿAbd
al-Ramāned affonda le sue origini nei Fratelli Musulmani, una cui frangia
denominata Al-Jihād o Tanīm al-Jihād (Organizzazione del Jihād) fu costituita
nel 1980 ed è elencata dalle Nazioni Unite tra le entità appartenenti o
associate ad al-Qāʿida.;
l'organizzazione è responsabile dell'assassinio di Anwar el-Sadat nel 1981.
Tuttavia un leader della Jamāʿa, Mohammad
Hasan Khalil al-Hakim (Muhammad al-ukayma), disse anche che non tutti i membri
della Jamāʿa erano
ancora propensi all'uso della violenza e che alcuni rappresentanti della Jamāʿa avevano
negato di essersi uniti ad al-Qāʿida[51].
Lo Shaykh ʿAbd
al-Akhir ammād, ex leader della Jamāʿa dichiarò
ad al-Jazeera: "Se [alcun]i fratelli ... hanno raggiunto [al-Qāʿida],
ciò è la loro personale scelta e io non credo che la maggioranza dei membri
di al-Jamāʿa
al-Islāmiyya condividano la medesima opinione"[52]. In realtà al-Qāʿida
non è una organizzazione rigida, e spesso ha concesso l'uso del proprio nome, in
una specie di franchising del terrore a gruppi che rappresentavano interessi
locali particolari, pur nell'ambito del fattore comune dato dalla fede islamica
e dalla lotta contro gli infedeli. Altra organizzazione molto importante ed
attiva nel sud-est asiatico è il già citato gruppo Abu
Sayyaf (letteralmente padre di Sayyaf). Il nome deriva dal fatto che il suo
fondatore diede il nome di Sayyaf a suo figlio; questo nome però è ispirato al
predicatore wahhabita afghano Sayyaf, che nel 1981 fondò una fazione, Ittehad
e-Islam, che venne scelta come interlocutore dal servizio segreto pakistano ISI
e godeva di finanziamenti e supporti religiosi sauditi[53]. Sayyaf in origine si
chiamava Ghulam Rasud (servo o schiavo del Profeta) in Abd al-Rab al-Rasud
(servo di Dio e del Profeta), poiché la venerazione di un essere umano, sia pure
il Profeta, implicata dal primo nome era inaccettabile dai fedeli di stretta
osservanza wahhabita; con i fondi arabi venne creata intorno al 1984 una città,
nota comeSayyaffabad (letteralmente città di Sayyaf) che ospitava un campo
profughi ma anche magazzini di armi e materiale bellico, strutture di
addestramento, moschee e madrasse, nei pressi della città di Pabbi, ad est
di Peshawar. Un'altra organizzazione relativamente recente è Boko Haram, attiva
in Nigeria dove sta tentando di scatenare una guerra civile di matrice religiosa
tra la componente cristiana e quella musulmana di questa repubblica federale.
Al-Qaida è una rete mondiale panislamica di
terroristi sunniti neo-neo-hanbaliti, capeggiata da Ayman al-Zawahiri, diventata
famosa in particolare per gli attentati dell'11 settembre 2001 contro gli Stati
Uniti. Attualmente sembra sia presente in più di 60 Paesi. Il suo obiettivo
dichiarato è l'utilizzo del jihad per difendere l'Islam dal Sionismo,
dal Cristianesimo, dall'Occidente secolarizzato e dai governi musulmani
filo-occidentali o "moderati", quali quello dell'Arabia Saudita che è visto come
insufficientemente islamico e troppo legato agli USA. Formata nel periodo
successivo l'invasione sovietica dell'Afghanistan, nei tardi anni ottanta da Bin
Laden e Muhammad Atef, al-Qāʿida
rivendica il legittimo uso delle armi e della violenza contro l'Occidente e il
potere militare degli Stati Uniti d'America e di ogni Stato che sia alleato con
essi[58]. Dalla sua formazione, al-Qāʿida
ha compiuto numerosi attacchi terroristici in Africa, Vicino Oriente, Europa,
e Asia. Sebbene un tempo fosse sostenuta dai Talebani, gli Stati Uniti
d'America e il governo britannico non considerano i Talebani un'organizzazione
terroristica. Fath al-Islam è un gruppo islamista operante fuori dal
campo-profughi di Nahr al-Bared, nel settentrione del Libano. Fu costituito nel
novembre 2006 da militanti che ruppero col gruppo filo-siriano di Fath-Intifada,
a sua volta un gruppo scissionista di al-Fatḥ, e guidato da un militante
clandestino palestinese chiamato Shaker al-Absi. Gli appartenenti del gruppo
sono stati genericamente descritti dai media come militanti jihadisti, e il
gruppo stesso è stato descritto come un movimento terrorista ispiratosi
ad al-Qa'ida. Il suo fine ufficiale è quello di portare tutti i campi-profughi
palestinesi sotto l'imperio della Shari'a e i suoi obiettivi prioritari sono la
lotta contro Israele e gli Stati Uniti d'America[60]. Le autorità libanesi hanno
accusato l'organizzazione di essere coinvolta nell'attentato dinamitardo del 13
febbraio 2007 contro due minibus, nel quale hanno trovato la morte tre persone,
mentre 20 altre sono rimaste ferite, nella libanese Ain Alaq, con quattro
attentatori identificati e rei confessi dell'attentato. Hamas, ("scossa" o
"zelo" in arabo, ma acronimo di Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, "Movimento di
Resistenza Islamica"), cominciò a propugnare attacchi contro obiettivi militari
e civili israeliani[64] all'inizio della Prima Intifada nel 1987. Come
organizzazione che si ispira esplicitamente alla Fratellanza Musulmana per la
Palestina, la sua leadership è assicurata da «…intellettuali della pia classe
media […] da rispettabili chierici devoti alla religione islamica, da dottori,
chimici, ingegneri e insegnanti». Lo Statuto di Hamas del 1988 esorta alla
distruzione di Israele sebbene i suoi portavoce non ricordino sempre in modo
così esplicito questo fine strategico. La sua «ala militare» rivendica sempre la
responsabilità degli attentati perpetrati contro lo Stato d'Israele. Hamas è
stata anche accusata di sabotaggio del processo di pace israelo-palestinese,
avviato con gli ormai falliti Accordi di Oslo, grazie al lancio di operazioni
armate contro i civili israeliani anche nel corso delle elezioni, al fine di
esasperare l'animo dei cittadini dello Stato ebraico e indurli a eleggere
candidati collocati su posizioni sempre più estremistiche, al fine di rendere
impraticabile un avvicinamento delle posizioni fra i contendenti. Ad esempio,
«…una serie di attacchi suicidi spettacolari condotti da palestinesi e che
portarono alla morte di 63 israeliani, condussero direttamente alla vittoria
elettorale di Benjamin Netanyahu e del partito Likud il 29 maggio 1996». Hamas
giustifica tali attacchi come necessari nel combattere l'occupazione militare
israeliana dei territori palestinesi occupati e come risposta agli attacchi
condotti da Israele contro obiettivi palestinesi. Il movimento serve anche da
collettore di fondi, usati tra l'altro per fini di assistenza caritatevole dei
rifugiati palestinesi. Hamas è stata definita come "gruppo terroristico"
dall'Unione europea, dal Canada, dagli Stati Uniti d'America, da Israele,
dalla Commissione ONU per i diritti umanie da Human Rights Watch. Gli oppositori
di tale definizione oppongono la supposta non legittimità dello Stato di Israele
in ragione delle modalità che portarono all'autoproclamazione d'indipendenza nel
1948. Hezbollah è un partito politico sciita libanese, dotato di sue proprie
milizie armate e di un articolato programma mirante allo sviluppo sociale delle
aree libanesi (di quelle meridionali in particolare) e di strutture in grado di
portarlo a effettiva realizzazione. Jaljalat (in arabo: «Tuono dirompente») è un
gruppo islamico salafita armato operante nella Striscia di Gaza che ha preso
ispirazione da al-Qāʿida.
Nato nel 2007 mentre Hamas conquistava il potere, Jaljalat raccoglie fuoriusciti
di Hamas ed ex militanti di un altro gruppo vicino ad al-Qāʿida,
l'Esercito dell'Islam. Nel settembre 2009, l'organizzazione rivelò di aver
cercato di assassinare il precedente presidente statunitense Jimmy Carter ed il
Quartetto del Medio Oriente inviato da Tony Blair. Una nuova sigla che si è
affacciata sulla scena mondiale è lo Stato Islamico, (IS), proclamatosi
indipendente il 29 giugno 2014 ma in precedenza conosciuto anche come Stato
Islamico dell'Iraq e al-Sham, comunemente tradotto come Stato Islamico dell'Iraq
e della Siria (ISIS) oppure Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL). La
sua origine è legata alla Jamā'at al-Tawīd wa l-jihād, al-Qāʿida
in Iraq e Mujāhidīn del Consiglio della Shura (attivo dal 1999 al 2006), fondato
dal salafita e takfirista giordano Abu Mus'ab al-Zarqawi. La sua storia si è
incrociata con quella del siriano Fronte al-Nusra, che crebbe rapidamente
diventando una forza combattente sostenuta dall'opposizione siriana. Il
gruppo gihadista, attivo in Siria e in Iraq, ha come leader nel 2014 Abu Bakr
al-Baghdadi, che ha unilateralmente proclamato la rinascita del califfato nei
territori caduti sotto il suo controllo. Peculiarità dello Stato Islamico è
quella di riunire in una sola entità le caratteristiche dell'esercito, delle
modalità terroristiche, della fisicità del territorio in cui risiede e della
struttura statale. Lo Stato Islamico ha anche coniato una sua moneta, seppure
non riconosciuta a livello internazionale: il Dinaro dello Stato Islamico.
SEGRETI DI STATO/ Dal Lodo
Moro alle stragi, i silenzi di un testimone scomodo.
E' tornata d'attualità la vicenda del cosiddetto lodo Moro. "La Stampa" ha
intervistato Bassam Abu Sharif, ma i conti non tornano. Molte le reticenze. E
non solo sue, scrive Salvatore Sechi il 5 luglio 2017 su "Il Sussidiario". E'
tornata d'attualità la vicenda del cosiddetto lodo Moro. Il termine indica lo
scambio (una sorta di informale patto di non belligeranza) tra Aldo Moro, per
conto del governo italiano, e il Fronte Popolare per la Liberazione della
Palestina, un'organizzazione del terrorismo palestinese affiliata all'Olp. Il
Fplp risulta legatissimo all'Unione sovietica, alla primula rossa del terrorismo
Carlos, alle Cellule rivoluzionarie tedesche di Thomas Kram. Attraverso il
responsabile per l'informazione, Bassam Abu Sharif (più tardi stretto
collaboratore di Arafat), il Fronte intrattiene ottimi rapporti con il col.
Stefano Giovannone, uomo di assoluta fiducia di Moro sulle questioni e i
rapporti mediorientali. E con la sua collaborazione invia in Italia il giordano
Abu Saleh Anzeh. Sarà sempre Giovannone a proteggere Abu Saleh (un finto
studente nelle università di Perugia e Bologna) anche dai tentativi della
questura del capoluogo emiliano e in generale del ministero dell'Interno di
rimandarlo in Giordania, per antisemitismo e odio rissoso verso Israele. Come
capo-centro del Sismi, da Beirut nel 1972-1981, e in quanto collegato a Moro,
Giovannone ha l'incarico di vigilare sulla sicurezza delle nostre rappresentanze
diplomatiche in Medio oriente. Acquisisce una conoscenza preziosa e ineguagliata
dei problemi e dei dirigenti politici del Medio oriente. Morto nel 1985, dopo un
calvario giudiziario in cui è stato lasciato solo dai suoi referenti politici,
ai minuziosi contatti con i palestinesi di Giovannone si debbono i sette anni di
pace di cui l'Italia ha potuto godere dal 1973 all'80. Da quanto emerge da
diversi documenti dell'intelligence, il nostro governo gioca la carta della
diplomazia parallela. Condivide l'obiettivo di dare ai palestinesi uno Stato e
riconosce un vero e proprio salvacondotto per i terroristi (o estremisti arabi
che li si voglia chiamare), cioè il diritto a lottare per conseguirlo anche col
trasporto di armi sul nostro territorio. In cambio, il Fronte si impegna a non
compiere azioni di guerra o di rappresaglia anti-israeliana all'interno delle
nostre frontiere, oltre a fornire — pare — una moral suasion sui paesi arabi per
la fornitura (e il prezzo) del petrolio. L'intesa si rompe nell'inverno del
1979-1980. Abu Saleh Anzeh (legatissimo ad Habbash), insieme a Daniele Pifano e
ad altri tre rappresentanti romani di Autonomia vengono fermati e arrestati il 7
novembre 1979 a Ortona e condannati dai tribunali di Chieti e di Ortona, il 25
gennaio 1980, a sette anni di carcere per il trasporto di alcuni missili Sam 7
Strela di fabbricazione sovietica. Sono solo in transito da noi, ma la loro
destinazione è di essere usati contro un nostro alleato, Israele. I paesi arabi
reagiscono con una forte minaccia. Se Abu Saleh Anzeh non verrà immediatamente
liberato (il che avverrà il 17 giugno 1981 per decorrenza dei termini di
custodia), ci saranno pesanti ritorsioni contro la popolazione civile
(Giovannone parla di una città o di un aeroporto). Questo è il messaggio che i
nostri servizi (Ucigos e Sismi) recepiscono e diffondono. Nel giro di qualche
semestre si avrà l'abbattimento nel mare di Ustica di un aereo Dc9 dell'Itavia
(con la morte di 81 persone) e l'attentato alla stazione centrale di Bologna con
200 feriti e 84 morti. Il 2 settembre a Beirut scompaiono due giornalisti, Italo
Toni e Graziella De Palo, che il Fplp avrebbe dovuto proteggere. Forse i due
giornalisti hanno appurato troppo sui responsabili della strage di Bologna? C'è
un collegamento tra i due episodi? A chiarire il clima di quel periodo la
Commissione parlamentare d'inchiesta su Moro ha di recente chiamato uno dei
dirigenti del Fplp, amico di Giovannone, Bassam Abu Sharif. La Stampa lo ha
fatto intervistare da Francesca Paci. In realtà la sua testimonianza, che sia
Fioroni sia la giornalista non hanno pensato minimamente di contestare, è poco
affidabile e reticente. Vediamolo da vicino. Sharif ignora la differenza, sul
piano giuridico, tra la promessa di un impegno e un "lodo". Il Fronte avrebbe
concesso solo la prima, e l'Italia si sarebbe obbligata a fornire un aiuto
umanitario che per la verità era in corso da anni. La mediazione svolta da
Giovannone non può essere scambiata per una responsabilità istituzionale per la
quale il colonnello dei carabinieri non aveva la veste né le deleghe. Sharif
dice di avere contato circa un migliaio di italiani che frequentarono i corsi di
addestramento militare e ideologico, e ricorda l'opzione del Fronte per il
sindacato. Ma non è in grado di fare i nomi di nessuno. Non spende una parola su
Rita Porena, una giornalista e ricercatrice del ministero degli Esteri che era
legata a Giovannone, ma anche a lui e al responsabile dei servizi segreti di Al
Fatah, Abu Iyad. Per la verità, è incomprensibile, se è ancora in vita, la
mancata testimonianza di costei. Avventata mi pare la negazione di ogni rapporto
tra il Fplp e le Brigate rosse. E' vero che inizialmente ci furono delle
resistenze, ma le testimonianze raccolte dal giudice Mastelloni, insieme alle
memorie di Mario Moretti, presso il Tribunale di Venezia mostrano che fu
stabilita una collaborazione sul traffico delle armi. Suscitano ulteriori dubbi
e riserve sull'affidabilità di Sharif la sua dichiarazione di non sapere nulla
di quanto avvenne a Ortona, come della strage di Ustica e di quella di Bologna.
Eppure Abu Saleh Anzeh, cioè una persona molto vicina ad Habbash e a Giovannone,
è direttamente o indirettamente presente in tutte queste vicende. Sulla crisi
dei missili del novembre 1979, quando il lodo Moro si ruppe, il silenzio di
Sharif è solo reticenza. Trovo molto strano e preoccupante che il senatore
Fioroni e i suoi collaboratori di centro-sinistra e di centro-destra non abbiano
voluto contestare le affermazioni di questo alto dirigente del Fplp. Per quale
ragione l'hanno invitato in Commissione se non avevano nulla da chiedergli?
1969 – 1978: la politica
estera di Aldo Moro ai tempi del terrorismo internazionale,
scrive Enrico Malgarotto il 12 aprile 2018 su "socialnews.it". “L’Unione
Sovietica mira ad indebolire l’Europa occidentale con una manovra per linee
esterne, tentando di separare politicamente da essa il Medio Oriente e l’Africa
del Nord. In questo stato di cose si rafforzano i segni di un progressivo
disimpegno degli Stati Uniti dall’Europa. E’ umano che il popolo americano
cominci ad essere stanco di vedere schierati alla difesa dell’Europa occidentale
i figli di coloro che la liberarono. Ciò pone, tuttavia, problemi di sicurezza
interna e anche di obiettivo politico che noi europei dobbiamo prepararci ad
affrontare al più presto.” Questo appunto inedito di Aldo Moro risalente
al marzo del 1970 è stato ritrovato nell’archivio di Stato dall’ Avvocato e
scrittore Valerio Cutonilli, autore, insieme al Giudice Rosario Priore, di un
interessante libro sulla strage di Bologna e sui rapporti tra lo Stato
italiano e le organizzazioni terroristiche palestinesi. La nota, ignorata per
oltre 40 anni, si rivela particolarmente significativa se si esamina il contesto
in cui è stata vergata e, più ancora, se si comprende la lucida analisi che
connota la visione dello Statista sugli equilibri geopolitici dei decenni
successivi e sulla stabilità interna di un’Italia ancora provata dalla strage
alla Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre
1969 e che si preparava ad affrontare un importante vertice con la Germania, a
sostegno della Ostpolitik per l’apertura con i paesi dell’Est.
Tale visione, da qualcuno
definita “eretica”, si rivelerà profetica alla luce degli avvenimenti degli anni
seguenti. L’allora Ministro degli Esteri Moro, autore di questa annotazione,
sapeva bene quale fosse la situazione internazionale tra la fine degli
anni sessanta ed il decennio successivo. Gli Stati Uniti erano impegnati nella
guerra del Vietnam con ingenti forze militari e risorse. Questa concentrazione
di fondi ed energie verso il sud est asiatico aveva portato l’Amministrazione
statunitense a rivedere le proprie priorità a svantaggio della tradizionale
centralità dell’Europa nella propria pianificazione. Sebbene questo spostamento
verso l’estremo oriente della politica estera di Washington fosse stato oggetto
di appositi negoziati con la controparte sovietica, i fatti successivi hanno
dimostrato che il Cremlino ha approfittato di questa situazione per agire contro
l’Europa occidentale ed i suoi alleati. Questo processo sarebbe avvenuto non
attraverso un conflitto frontale con la NATO, ma ricorrendo ad una guerra non
convenzionale attuata da organizzazioni terroristiche supportate dai Servizi
segreti del blocco orientale.
Verso il Lodo Moro: il
terrorismo palestinese. In quegli anni faceva la sua comparsa in Europa
il fenomeno terroristico dei gruppi palestinesi. L’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP), il Fronte Popolare per la Liberazione della
Palestina (FPLP) e Settembre Nero sono i nomi delle maggiori formazioni operanti
in quegli anni, sebbene la galassia delle unità terroristiche arabe fosse molto
più vasta. Sono molti i fatti salienti, tra il 1969 e il 1973, che hanno visto
come epicentro l’aeroporto di Roma – Fiumicino e che avrebbero portato il nostro
Paese ad imboccare la strada dell’accordo con questi gruppi, ad iniziare dal
dirottamento su Damasco di un aereo della TWA in volo da Los Angeles a Tel
Aviv (con scalo a Roma) compiuto il 29 agosto 1969 dalla più famosa terrorista
dell’organizzazione palestinese, Leila Khaled, cui è seguito l’attentato del 16
giugno 1972 messo in atto con un mangianastri imbottito di tritolo dotato di un
timer regalato da due giovani arabi a delle ragazze israeliane conosciute poco
prima. Nonostante la deflagrazione dell’ordigno nella stiva durante il
volo, l’aereo, non avendo riportato danni, atterrava a Tel Aviv. Il 4 aprile
1974 a Ostia, fuori Roma, due membri dell’organizzazione palestinese venivano
fermati e arrestati per detenzione di alcuni missili Strela di costruzione
sovietica – facilmente trasportabili – da usare contro un aereo della compagnia
di bandiera israeliana El Al durante le fasi di decollo o atterraggio. Il 17
dicembre 1973 a Fiumicino, cinque terroristi lanciavano delle bombe incendiarie
all’interno di un aereo della statunitense Pan Am uccidendo trenta passeggeri
tra cui quattro italiani. Il gruppo terroristico, poi, prendeva possesso di un
velivolo della Lufthansa (la compagnia di bandiera tedesca) costringendo il
pilota a decollare. Dopo aver fatto scalo per il rifornimento di carburante
ad Atene, il velivolo veniva fatto atterrare a Kuwait City dove, una volta
liberati gli ostaggi, le Autorità provvedevano ad arrestare i
terroristi, rilasciati, in seguito e posti a disposizione dell’organizzazione
terroristica palestinese. Anche i siti industriali sono stati oggetto di
attentati da parte di tali organizzazioni arabe come occorso il 3 agosto del
1972 all’oleodotto di Trieste (in concomitanza con un simile attacco avvenuto in
quegli anni in Olanda).
Il Lodo Moro. Di fronte
alla portata degli attentati i Paesi europei decisero di entrare in contatto con
le formazioni per stringere speciali accordi affinché il proprio territorio
fosse escluso da ulteriori attacchi. L’Italia, presumibilmente nel 1972/1973,
attraverso il Ministero degli Affari Esteri, allora retto da Aldo Moro,
stringeva un patto – passato alla storia come il Lodo Moro – che concedeva piena
libertà alle organizzazioni palestinesi di muoversi nel nostro territorio e ad
utilizzarlo come base logistica per azioni in tutta Europa. La controparte
avrebbe assicurato che in Italia non ci sarebbero stati altri attentati, ad
esclusione delle sedi e dei siti americani ed israeliani presenti nel territorio
della penisola. Probabilmente l’autore materiale dell’accordo e’ stato il
Servizio segreto italiano: prima il SID, il Servizio informazioni Difesa (organo
d’intelligence italiano dal 1965 al 1977) e poi il SISMI – Servizio Informazioni
Sicurezza Militare (a partire dal 1978) nella figura del Colonnello Stefano
Giovannone, responsabile del centro del Servizio a Beirut, in Libano. L’agente
infatti per tutto il periodo di durata del Lodo, aveva provveduto a mantenere i
contatti tra Roma e il Medio Oriente sia con le organizzazioni terroristiche sia
con gli altri Paesi, in particolare Giordania e Libano, che mal
tolleravano la massiccia presenza di organizzazioni palestinesi nel proprio
territorio. L’assenza di azioni terroristiche in Italia suggerisce che nel corso
degli anni settanta l’accordo tra le parti sia stato sostanzialmente rispettato.
Come hanno dimostrato diversi eventi, i terroristi scoperti e arrestati in
procinto di progettare attentati nel nostro Paese sono stati liberati e
riportati alle loro basi palestinesi anche attraverso la Libia di Mu’ammar
Gheddafi, da sempre Padre Protettore di tali organizzazioni, cui forniva campi
di addestramento e significativo supporto.
Da Ortona a Bologna: la
violazione del Lodo. Nel novembre del 1979 ad Ortona, piccola cittadina
abruzzese, i Carabinieri sequestrarono dei missili Strela (lo stesso modello
usato dai due arabi a Ostia nel 1974) ad alcuni rappresentanti romani
di Autonomia Operaia, movimento della sinistra extraparlamentare e
rivoluzionaria in aperta opposizione al Partito Comunista Italiano di quel
periodo. Indagando sulla provenienza delle armi, le Autorità Giudiziarie
arrestavano a Bologna Abu Anzeh Saleh, ufficialmente studente fuori corso presso
l’Ateneo ma, in verità, membro, in qualità di responsabile della rete logistica
in Italia, del gruppo terroristico FPLP e della formazione
tedesca Separat di Carlos lo Sciacallo, nome di battaglia di Ilich Ramirez
Sanchez, famoso rivoluzionario venezuelano marxista – leninista e filo arabo,
autore, con i suoi gruppi, di numerosi attentati in tutta Europa. Fin da subito
le poche persone a conoscenza dell’accordo stretto da Moro si rendevano conto
che l’arresto di Saleh avrebbe potuto essere considerato dalle formazioni
palestinesi come una violazione del Lodo, con le inevitabili conseguenze che ciò
avrebbe comportato. Attraverso le informazioni raccolte dal Colonnello
Giovannone, cominciavano ad arrivare a Roma i primi segnali d’allarme circa la
volontà di compiere un’azione punitiva nei confronti dell’Italia da
parte dell’ala più oltranzista dell’organizzazione palestinese. Col passare dei
mesi, con la condanna di Saleh, dal Medio Oriente giungeva la notizia
che l’eventuale attacco contro il nostro Paese sarebbe avvenuto per mano
di elementi esterni al FPLP. Il 2 agosto 1980 una bomba nascosta dentro una
valigia nella sala d’aspetto della stazione di Bologna esplodeva
causando ottanta vittime e il ferimento di circa duecento persone. Per circa
trent’anni o più si è voluto associare questa strage alla matrice
neofascista nell’ambito della strategia della tensione, tuttavia altri punti di
vista, ancorché controversi ed in parte smentiti, porterebbero a puntare il dito
contro quel Carlos a capo del gruppo Separat di cui anche lo stesso Saleh faceva
parte.
La spinta dall’est del
terrorismo europeo. Le formazioni eversive di estrema sinistra presenti in tutta
Europa negli anni settanta e ottanta erano le francesi Action Directe, le
tedesche RAF o Rote Armee Fraktion – conosciute anche come Banda Baader –
Meinhof dal nome dei due capi storici – e le italiane Brigate Rosse. Questo
sistema eversivo europeo occidentale, in coordinamento con quello medio
orientale, nella sua fase più matura, era gestito dall’Unione Sovietica. I
Servizi segreti di Mosca, quelli cecoslovacchi (Stb) e della Germania
orientale (Stasi e Hva) hanno contribuito a supportare il terrorismo rosso di
quegli anni. Fin dai primo dopoguerra, la Cecoslovacchia si è sempre
dimostrata in prima linea per quanto riguarda le attività clandestine comuniste
in occidente. Per approfondire quest’ultimo aspetto è necessario far riferimento
a diverse fonti tra cui l’archivio Mitrochin, (il voluminoso dossier sui
documenti top secret del kgb che l’ex archivista del Servizio sovietico Vasilij
Nikitič Mitrochin ha portato in occidente nei primi anni novanta contribuendo a
svelare la fitta rete di legami tra il blocco orientale e l’occidente durante la
guerra fredda) ed il libro di Antonio Selvatici “Chi spiava i terroristi? KGB,
STASI – BR, RAF. I documenti negli archivi dei servizi segreti dell’Europa
<<comunista>>” Ed. Pendragon, 2010, i quali trattano in modo approfondito le
dinamiche con cui gli organi di intelligence d’oltrecortina aiutavano i
terroristi. I campi erano stati creati dal Kgb nel 1953 per addestrare anche il
personale dell’apparato militare clandestino in seno al PCI, composto
soprattutto da ex Partigiani comunisti fuggiti dall’Italia in quanto colpevoli,
durante la guerra, di crimini e per questo motivo ricercati dalle Autorità, alle
attività di sabotaggio, guerriglia, intercettazione, all’uso delle armi
interrate dal Kgb nel nostro Paese (che si aggiungevano a quelle utilizzate
dalle formazioni rosse durante l’ultimo biennio della Seconda Guerra
Mondiale e mai restituite agli alleati alla fine del conflitto) e alle
comunicazioni radio cifrate. Karlovy Vary è il nome della località nell’ex
Cecoslovacchia in cui sorgeva il campo d’addestramento gestito, a differenza di
quello che si potrebbe pensare, non dai Servizi segreti di Praga ma
dal Gru, l’organo di intelligence militare di Mosca. La presenza degli 007
sovietici in questi campi potrebbe confermare la tesi secondo cui la stagione
degli attentati degli anni settanta e ottanta non fosse solo una manovra
politica ma una vera e propria guerra contro l’occidente, combattuta
con strumenti ben lontani dal concetto tradizionale di conflitto. Nel 1974, dopo
l’arresto, da parte dei Carabinieri di Renato Curcio e Alberto Franceschini,
esponenti di spicco delle BR ma completamente slegati ed autonomi dalle trame
politiche di Mosca e Praga, il Servizio segreto cecoslovacco incrementò la
propria presenza a fianco del movimento eversivo. I vertici del PCI erano a
conoscenza di questi legami “pericolosi” tra est e ovest al punto che il
segretario del partito Enrico Berlinguer inviava, nel 1975,
una delegazione a Praga guidata da Salvatore Cacciapuoti, in qualità di
responsabile agli affari internazionali del PC, per conoscere quanti e chi
fossero gli italiani addestrati in Cecoslovacchia. Dalle Autorità slave
solo silenzio (probabilmente dovuto alla volontà di non trattare l’argomento con
elementi esterni o perché, come effettivamente è stato, i Servizi cecoslovacchi
non avevano alcuna autorità su questi campi) e una vaga promessa di inviare a
Roma una relazione in merito. L’invio della delegazione è dovuto al fatto che
il PCI, soprattutto a partire dal 1974, cominciava a considerare la questione
terrorismo rosso con molta preoccupazione, soprattutto perché era a conoscenza
che elementi interni al partito continuavano a collaborare alle attività
clandestine comuniste d’oltrecortina e che l’unica soluzione per contribuire a
fermare l’ondata eversiva che stava colpendo l’Italia (e forse anche per
scongiurare eventuali situazioni di imbarazzo politico) era collaborare con le
Forze dell’Ordine, in particolare con la Sezione antiterrorismo dei Carabinieri
guidati dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.
Contatti tra le Brigate Rosse
e l’FPLP. Le Brigate Rosse godevano anche del supporto delle formazioni
palestinesi, le quali mettevano a disposizione dei terroristi italiani i campi
di addestramento del Libano, Yemen, Siria e Iraq mentre, come in una sorta di
scambio, le BR custodivano le armi che i terroristi arabi portavano in
Italia per colpire gli obiettivi israeliani e statunitensi presenti nel nostro
Paese. Questi contatti erano avvenuti durante gli anni settanta proprio quando,
come già detto, i Servizi segreti italiani stringevano con il Fronte Popolare di
Liberazione delle Palestina (FPLP) di George Habbash il Lodo Moro. Come
riportato dalla Stampa, citando le carte della Commissione parlamentare
d’Inchiesta sul caso Moro, già a partire dal 1976 i Vertici del FPLP
cominciavano una rivoluzione all’interno delle varie sigle arabe a causa delle
diverse vedute circa la richiesta di Mosca di por fine ai dirottamenti aerei e
cominciavano a diffidare delle BR. Inoltre i vertici arabi volevano mantenere, a
tutti i costi, la parola data al Governo Italiano attraverso il Lodo
risparmiando la penisola da ogni tipo di attacco. Il già citato Colonnello
Giovannone, il capo centro del SID/SISMI in Libano, veniva informato dal suo
omologo palestinese circa i piani eversivi delle BR in Italia.
L’ultima nota inviata a Roma dall’Ufficiale del Servizio risaliva al 18 febbraio
1978 e diceva:”[…] Mio abituale interlocutore rappresentante Habbash, incontrato
stamattina, ha vivamente consigliatomi non allontanarmi da Beirut, in
considerazione eventualità di dovermi urgentemente contattare per informazioni
riguardanti operazione terroristica di notevole portata programmata
asseritamente da terroristi europei che potrebbe coinvolgere nostro Paese se
dovesse essere definito progetto congiunto discusso giorni scorsi in Europa da
rappresentanti organizzazione estremista. Alle mie reiterate insistenze per
avere maggiori dettagli, interlocutore ha assicuratomi che opererà in attuazione
confermati impegni miranti escludere nostro Paese da piani terroristi del
genere, soggiungendo che mi fornirà soltanto se necessario, elementi per
eventuale adozione adeguate misure da parte delle nostre Autorità.” A distanza
di circa un mese dalla ricezione di questo telegramma da parte del governo
italiano, l’Onorevole Aldo Moro veniva rapito dalle Brigate Rosse. Con la morte
dello statista si concludeva quello che può essere definito “Il decennio di Aldo
Moro”, iniziato nel 1969 in qualità di Ministro degli Esteri e terminato
nel 1978 da presidente della Democrazia Cristiana con il suo assassinio.
Strage di Ustica, il
testimone che riscrive la storia d'Italia: "Era guerra, ho visto tutto",
scrive il 20
Dicembre 2017 “Libero Quotidiano”. Si riaccende lo scontro politico, dopo le
novità arrivate dagli Usa, sul caso Ustica, con la nuova testimonianza su quanto
avvenne il 27 giugno del 1980, la notte in cui il Dc9 Itavia, in volo da Bologna
a Palermo, con a bordo 81 persone, sparì dai radar, finendo in mare. Le parole
di Rian Sandlin, l’ex marinaio della portaerei Saratoga, che al
giornalista Andrea Purgatori racconta di un conflitto aereo, nel Mediterraneo,
tra caccia americani e libici, rilanciano, di fatto, l’ipotesi di un incidente
di guerra che coinvolse il volo civile italiano. Parole che - in attesa di un
interessamento della Procura di Roma - riaprono il dibattito tra chi sostiene la
tesi della bomba a bordo e chi pensa che a colpire l’aereo sia stato un missile,
forse alleato. Per Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione Parenti delle
Vittime della strage di Ustica "il fatto che due Mig libici fossero stati
abbattuti la notte di Ustica lo avevano già detto altri, ma sentirlo dire da un
signore che stava sulla Saratoga, che finora gli Usa ci avevano detto stesse in
rada, è una novità importante". "È chiaro che ci sono cose non dette su Ustica,
ma il problema non è la verità, perché loro, al governo, sanno qual è la verità,
il problema è che non vogliono raccontarla", aggiunge Paolo Bolognesi,
presidente dell’Associazione 2 agosto: "Pensavano con la direttiva Renzi di
tacitare la richiesta di verità, ma non hanno fatto il loro dovere fino in
fondo, ora basta, diano le carte vere". Di cosa "vergognosa" e di "bufala
gigantesca", parla invece il senatore di Idea, Carlo Giovanardi. "Sono falsità -
sottolinea - già smentite da sentenze penali passate in giudicato che dicono che
non c’è stata alcuna battaglia aerea, nessun missile, nessun aereo in volo".
Giovanardi, non dà alcun credito alle ultime novità: "Ci sono 4mila pagine di
perizie internazionali che dicono dov’era la bomba, quando è esplosa e tutti i
dettagli - spiega il senatore di Idea - dall’altra, invece, abbiamo 27 versioni
diverse" che accusano "gli Usa, i francesi, i libici". "Ho letto cose
terrificanti in Commissione Moro - ricorda il senatore che è membro
dell’organismo che indaga sulla morte del leader Dc - sui palestinesi che
preparavano un terribile attentato, i documenti sono ancora segretati e
Gentiloni, che abbiamo chiesto venisse a riferire, non ci risponde". "Per
arrivare a chiarire rendiamo pubbliche quelle carte, in particolare il carteggio
del biennio ’79-’80 dei nostri servizi da Beirut che parla delle minacce di
rappresaglia da parte dei palestinesi, dopo lo stop al Lodo Moro", conclude il
senatore di Idea.
Giovanni Lindo Ferretti e
la stage di Bologna: furono o no i fascisti?,
scrive il 2/08/2017 Chiara Comini. Avvenne il 2 agosto del 1980 alle 10.25
l’esplosione, causata da una bomba, che provocò la morte di 85 persone e 200 i
feriti. Oggi, dopo 37 anni dalla strage, Giovanni Lindo Ferretti lancia una
provocazione. Ferretti, noto per essere stato il cantate del gruppo
musicale CCCP Fedeli alla linea, nato nell’Emilia degli anni Ottanta, in un
intervista rilasciata a Repubblica dichiara: “Non concordo con il pensiero della
maggioranza dei bolognesi, non credo che l’attentato del 2 agosto sia opera di
fascisti italiani. Mi dispiace non essere in sintonia con la mia città, quella
in cui ho vissuto di più. Quando è successo il 2 agosto io ero ancora un
bolognese di adozione, ma io non ci ho mai creduto”. Continua affermando: “In
quel momento i palestinesi avevano dei problemi con lo Stato italiano e il fatto
che non siano state fatte indagini su tre o quattro personaggi in quei giorni a
Bologna mi convince oltremisura. Se almeno si fossero fatte le indagini…”.
Secondo Ferretti sarebbe più plausibile la pista, allora archiviata, definita
“Lodo Moro”, o “Lodo Palestinese”: il patto tra servizi segreti italiani e la
dirigenza palestinese per evitare attentati in Italia. Solo negli ultimi anni si
sono iniziate a scoprire le carte, ammettendo l’effettiva esistenza
dell’accordo, allora considerato una tesi complottista. Un documento segreto,
emerso anni fa grazie a Enzo Raisi, datato 17/02/1978 e pubblicato nel 2015
dal Quotidiano nazionale, prova l’esistenza del Lodo Moro. Raisi il 2 agosto
1980 era nei pressi della stazione, in procinto di partire per il servizio
militare. Da quel giorno si è assiduamente dedicato alla ricerca della verità.
La sua convinzione è che la strage sia stata opera dei palestinesi in combutta
con Carlos, un terrorista internazionale famoso anche con il nome di
“Sciacallo”. Non è da sottovalutare che tra la fine del 1979 e l’inizio del
1980, fosse stato arrestato e condannato il responsabile del Fronte per la
liberazione della Palestina in Italia. Nel libro “Ustica storia e
controstoria”, scritto dall’on. Eugenio Baresi, possiamo leggere: “Fra il sette
e otto novembre 1979, in un casuale controllo – ricorda Baresi – vengono
sequestrati missili antiaerei a membri dell’Autonomia romana e ad un
palestinese, Abu Anzeh Saleh, […], rappresentante in Italia del Fronte per la
liberazione della Palestina (FPLP). La Procura di Chieti con assoluta e inusuale
velocità perviene ad un’immediata condanna il 25 gennaio del 1980. Il
responsabile del FPLP in Italia, arrestato e condannato, è residente da anni a
Bologna”. La strage della stazione di Bologna, pertanto, si collocherebbe in uno
scenario intrecciato di fatti avvenuti in quegli anni che la collegherebbero
dall’omicidio di Aldo moro e all’aereo di Ustica, che Baresi considera un
“avvertimento non capito”. L’ordigno a Bologna sarebbe stato il secondo
avvertimento. Ferretti conclude la sua dichiarazione a La Repubblica dicendo:
“Tutte le persone che conosco e a cui voglio bene non lo vogliono nemmeno
sentire. Questa città si è fatta un punto di onore nel rivendicare una necessità
di antifascismo militante 50 anni dopo l’epopea fascista e ha avuto un’occasione
meravigliosa”. Resta il fatto che questa ipotesi, dopo quasi quarant’anni dalla
tragedia, grazie a documenti allora secretati, ha iniziato a prendere sempre più
forma.
C’è una pista araba per la
strage alla stazione di Bologna?
Scrive Paolo Delgado il 2
Agosto 2017 su "Il Dubbio". Trentasette anni dopo la bomba alla stazione di
Bologna, cioè la più sanguinosa strage nella storia d’Italia, oggi si
ripeteranno puntualissime le polemiche che accompagnano da sempre la
commemorazione. Stavolta nel mirino ci sarà la stessa procura di Bologna,
fortemente criticata per aver archiviato l’inchiesta sui mandanti della strage.
E’ opportuno ricordare che, secondo una sentenza definitiva ma giudicata quasi
ovunque non credibile, non sono ancora stati individuati né i mandanti, né il
movente, né gli esecutori materiali della strage. Ci sono tre condannati,
Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, ma come “anelli
intermedi”: quelli che avrebbero organizzato, su mandato non si sa di chi,
l’attentato poi realizzato non si sa da chi per non si sa quali ragioni. Si può
scommettere che nella polemica sui mandanti non una parola verrà dedicata alla
denuncia che il quotidiano romano Il Tempo porta avanti, inascoltato, da una
settimana. Il direttore Gian Marco Chiocci ha rivelato che esistono delle note
dell’allora capo dei servizi segreti in Medio Oriente Stefano Giovannone,
capocentro Sismi a Beirut e già uomo di fiducia di Aldo Moro. Le informative,
ancora secretate dal Copasir, potrebbero secondo Chiocci gettare una luce tutta
diversa sulla strage e sui suoi mandanti. Le note di Giovannone sono state
visionate dai parlamentari della commissione Moro, ma senza il permesso di
fotocopiarle né di diffonderne i contenuti. Prima di entrare nel merito degli
appunti del vero ideatore del famoso Lodo Moro, quello che consentiva alle
organizzazioni palestinesi di usare di fatto l’Italia come base in cambio
dell’impegno a non colpire obiettivi italiani ( a meno che, segnalava però
Cossiga, non avessero rapporti con Israele: il che, secondo l’ex presidente
picconatore, escludeva dall’accordo gli ebrei), bisogna chiarire perché quelle
note sono importanti e fino a che punto costituiscono un elemento valido per
l’individuazione della verità sulla strage del 2 agosto 1980. A rendere
particolarmente interessante quel documento è prima di tutto proprio il fatto
che siano note di pugno di Giovannone. Non si trattava infatti di un agente
dell’Intelligence come tanti: “Stefano d’Arabia”, com’era soprannominato, era
senza dubbio la persona che nello Stato italiano conosceva meglio, più a fondo e
più da vicino le organizzazioni palestinesi, nei confronti delle quali provava
una assoluta simpatia. Il secondo elemento d’interesse è la stessa scelta di
mantenere il segreto su quelle note del 1979- 80 a destare curiosità e sospetti:
cosa giustifica, a quasi quarant’anni di distanza, tanta prudenza? Allo stesso
tempo va chiarito che gli appunti di Giovannone non indicano affatto con
certezza una responsabilità palestinese nella strage. In compenso confermano al
di là di ogni dubbio che le indagini trascurarono deliberatamente una pista e
scelsero, non sulla base di elementi concreti ma al contrario ignorando i soli
elementi concreti a disposizione, di seguire solo quella neofascista.
L’antefatto è noto ma conviene riassumerlo. Nella notte tra il 7 e l’8 novembre
tre autonomi romani del collettivo di via dei Volsci furono arrestati a Ortona
mentre trasportavano per conto dei palestinesi due lanciamissili Sam- 7 Strela
di fabbricazione sovietica. Giovannone si mobilitò immediatamente, poche ore
dopo l’arresto, per cercare invano di risolvere l’incidente, evidentemente molto
preoccupato per qualcosa, anzi per qualcuno, che non potevano certo essere i tre
autonomi. Si trattava infatti Abu Anzeh Saleh, ufficialmente studente a Bologna,
in realtà responsabile militare del Fronte popolare per la Liberazione della
Palestina in Europa. Saleh, che aveva chiesto ai tre autonomi di occuparsi del
trasporto, senza chiarire di cosa si trattasse, fu arrestato pochi giorni dopo.
Qualche settimana fa l’allora dirigente dell’Fplp Abu Sharif, nel corso
dell’audizione di fronte alla Commissione Moro, ha rivelato che proprio Saleh
era il dirigente palestinese a cui lo Stato italiano si era rivolto, dopo il
sequestro di Moro, chiedendo un intervento dell’Olp a favore della liberazione
dell’ostaggio. I rapporti stretti tra Giovannone e Saleh sono confermati
dall’interessamento del potente colonnello perché al palestinese, espulso nel ‘
74, fosse consentito il ritorno e il soggiorno in Italia. La preoccupazione di
Giovannone era comprensibile e fondata. Sin dal ‘ 73 era in vigore l’accordo con
il Fronte, come con altre organizzazioni palestinesi, che avrebbe dovuto mettere
Saleh al riparo da ogni rischio d’arresto. Il colonnello aveva capito al volo
che, con tre autonomi italiani di mezzo e nel clima dell’epoca, ottenere la
scarcerazione del palestinese sarebbe stato molto difficile. Era ben consapevole
di quanta irritazione ciò avrebbe comportato nei vertici dell’Fplp, allora
fortemente influenzato dalla Libia, e quanto fosse di conseguenza alto il
rischio di una reazione violenta. Pochi giorni dopo gli arresti, Giovannone
accenna, nelle informative ancora secretate, a una lettera inviata al premier
italiano Cossiga da Arafat, evidentemente preoccupatissimo per i sospetti di
collusione tra palestinesi e terrorismo italiano. Nella lettera, mai consegnata
a Cossiga per l’intervento del responsabile dell’Olp in Italia Nemer Hammad,
Arafat attribuiva alla Libia ogni responsabilità per il trasporto dei
lanciamissili. In dicembre Giovannone accenna per la prima volta a una divisione
tra falchi e colombe ai vertici dell’Fplp e del conseguente rischio di dure
rappresaglie ove l’Italia non mantenesse i propri impegni con il Fronte. In
concreto, senza la liberazione di Saleh e la restituzione dei lanciamissili. Il
colonnello torna a registrare la possibilità di rappresaglie e di iniziative
punitive nei confronti dell’Italia nei primi mesi del 1980, dopo che il 25
gennaio tutti gli imputati erano stati condannati in primo grado a sette anni.
In aprile Giovannone riporta le preoccupazioni dello stesso leader dell’Fplp
George Habbash, che si dice pressato dall’ala estremista del Fronte favorevole
alla rappresaglia. Nella stessa occasione il responsabile dei servizi segreti
italiani in Medio Oriente specifica che l’eventuale attentato sarebbe
commissionato a un’organizzazione esterna all’Olp, quella di Carlos con il
quale, aggiunge Giovannone, l’area dura dell’Fplp ha appena preso contatti.
L’esecuzione, prosegue la nota, sarebbe probabilmente affidata a elementi
europei, per non ostacolare il lavoro diplomatico in vista del riconoscimento
dell’Olp da parte dell’Italia. In maggio Giovannone cita apertamente un
ultimatum, con scadenza il 16 maggio, dopo il quale la maggioranza sia dei
vertici che della base del Fronte è favorevole a riprendere la piena libertà
d’azione in Italia, se nel frattempo non ci sarà stata la liberazione di Saleh.
Il colonnello afferma anche che, secondo le sue fonti, a premere per un’azione
violenta è la Libia, principale sostegno del Fronte ma che, in ogni caso, nulla
succederà prima della fine di maggio. La fase più pericolosa è invece
considerata l’avvio del processo d’appello, il 2 luglio. Nelle settimane
seguenti il governo italiano fa sapere di essere pronto a prendere in
considerazione la condizione di Saleh, ma non quella dei tre autonomi italiani,
e di essere disponibile a indennizzare i palestinesi per i due lanciamissili
sequestrati. Il 29 maggio però la Corte d’Appello dell’Aquila respinge la
richiesta di scarcerazione di Saleh e le fonti di Giovannone alludono a due
possibili ritorsioni: un dirottamento aereo oppure l’occupazione di
un’ambasciata. Ma è lo stesso capocentro del Sismi, in giugno, a sottolineare
che gli siano stati segnalati obiettivi falsi allo scopo di coprire quelli e a
ipotizzare un attentato “suggerito” dalla Libia all’Fplp ma non rivendicato per
evitare di creare problemi all’Olp. L’ultimo appunto è di fine giugno.
Giovannone dice di essere stato informato sulla scelta del Fronte di riprendere
a muoversi in piena libertà, cioè senza più offrire le garanzie previste dal
Lodo Moro e afferma di aspettarsi «reazioni particolarmente gravi» se l’appello
non rovescerà la sentenza di condanna. Il processo però viene subito rinviato
fino a ottobre. Le comunicazioni di Giovannone si fermano qui, ma l’11 luglio il
direttore dell’Ucigos prefetto Gaspare De Francisci mette in allarme con una
nota riservata il direttore del Sisde Giulio Grassini in merito a possibili
ritorsioni da parte dell’Fplp. Né l’informativa di Giovannone né i molti altri
elementi che potrebbero indicare una pista libicopalestinese per la strage sono
tali da permettere di arrivare a conclusioni credibili, come troppo spesso ha
cercato di fare negli ultimi anni uno stuolo di investigatori dilettanti. Ma il
punto non è sostituirsi agli inquirenti. È, più semplicemente, chiedersi perché,
che, con elementi simili a disposizione, gli investigatori abbiano deciso, sin
dalle prime ore dopo l’attentato, di seguire tutt’altra pista.
Quegli ipocriti perbenisti
dell’Lgbt. Demonizzano D&G, ma restano in silenzio sui gay uccisi dall’Is,
scrive Giulio Meotti il 16 Marzo 2015 su “Il Foglio”. Nulla hanno mai detto
sugli omosessuali palestinesi, tutti fuggiti in Israele per non finire spellati
vivi sotto il regime di Arafat e Abu Mazen, per non parlare di Hamas. Non
soltanto il mondo Lgbt si è voltato dall’altra parte, ma ha pure accettato,
senza soprassalto di dignità, accecato com’è, che il Gay Pride di Madrid
boicottasse gli omosessuali israeliani. Nulla, ma proprio nulla, l’Lgbt ha detto
negli anni Novanta mentre in Algeria i fondamentalisti islamici annunciavano
come avrebbero risolto la questione gay: “Nella lotta contro il male abbiamo il
dovere di eliminare gli omosessuali e le donne depravate”. Nulla o quasi ha
detto contro Mahmoud Ahmadinejad, il presidente iraniano che qualche anno fa,
oltre alle camere a gas, negò l’esistenza di gay nella Repubblica islamica? Va
da sé che adesso i capi Lgbt stiano in silenzio, mentre lo Stato islamico getta
dai palazzi di Siria e Iraq i reprobi omosessuali, bendati, uno dopo l’altro,
per un “peccato” da mondare con la morte, e le pietre della folla. Non uno
striscione, non un appello, non una campagna che provenga dal mondo della
militanza gay. Due giorni fa, il più noto editorialista australiano, Andrew
Bolt, si è chiesto perché non c’erano barche contro l’Is alla fiera di Sydney
dell’orgoglio gay friendly. Non una barca su centocinquanta. Opinionisti gay
spesso accusano gli “islamofobi” di voler dividere mondo islamico e omosessuali.
Come ha fatto Chris Stedman su Salon: “Stop trying to split gays and Muslims”.
In questi giorni
invece si sono tutti scatenati – a cominciare da Elton John, e poi via via altre
celebrities – contro Dolce e Gabbana, il due fondatori della casa di moda
italiana, rei di credere alla famiglia tradizionale e che i figli non si
fabbricano in provetta. “Filthy”, lercio, osceno, schifoso, è l’aggettivo più
usato su twitter contro i due stilisti italiani da parte della comunità gay nel
mondo, che adesso annuncia il boicottaggio. La rappresaglia economica ha già
funzionato contro Barilla e Mozilla, i cui capi erano stati accusati di
“omofobia” e poi costretti a umilianti scuse pubbliche. E la rappresaglia
funzionerebbe se volessero davvero attirare l’attenzione del mondo su quei
regimi arabo-islamici dove gli omosessuali sono davvero discriminati, altro che
in occidente. Eppure ipocrisia e silenzio annebbiano l’Lgbt. Mai una volta che
denuncino i versetti della Sunna, che assieme al Corano compone la legge
islamica, e in cui degli omosessuali si dice: “Quando un uomo cavalca un altro
uomo, il trono di Dio trema. Uccidete l’uomo che lo fa e quello che se lo fa
fare”. Qualche giorno fa il settimanale inglese Spectator ha sintetizzato
l’indulgenza Lgbt: “Perché la battaglia per i diritti gay si ferma ai confini
dell’islam”. Non è che il diritto alla vita di un gay è meno importante del
diritto di Elton John ad avere un bambino? Non è che sputare contro Dolce e
Gabbana renda perfino, in termini di probità morale, mentre denunciare i
fanatici islamici può costare la testa e allora è meglio glissare? Perbenisti.
QUELL'ESKIMO IN REDAZIONE.
Anni di piombo: i
giornalisti e le Brigate Rosse,
scrive "Cultura.biografieonline.it".
I giornalisti nel mirino delle
Br. A partire dal 1977 anche i giornalisti entrano nel mirino dei terroristi
rossi (Brigate Rosse). Tra il primo e il 3 giugno, tre direttori vengono
gambizzati a Genova, Milano e Roma. Si tratta di Vittorio Bruno de “Il Secolo
XIX”, Indro Montanelli de “Il Giornale” e Emilio Rossi del “Tg1”. Lo scopo è
quello di intimorire il mondo giornalistico. Nei mesi di luglio e settembre
vengono feriti altri giornalisti e a novembre i brigatisti alzano il tiro
sparando a Carlo Casalegno, vice direttore de “La Stampa”, che muore dopo
tredici giorni.
L’agguato di Carlo Casalegno.
È il 16 novembre del 1977 quando Carlo Casalegno viene ferito dalle Brigate
Rosse a Torino. Colpito con quattro pallottole alla testa, rimane vivo per 13
giorni ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Le Molinette. Muore il
29 novembre, dopo vari giorni di agonia. Casalegno Aveva ricevuto minacce, una
bomba era arrivata al giornale, da alcuni giorni era scortato. Quel giorno un
improvviso mal di denti lo costringe ad andare dal dentista: è senza scorta.
Quando arriva a casa, ad attenderlo nell’androne trova gli assassini, che gli
sparano a bruciapelo.
1980, la Brigata 28 marzo:
ancora attentati. Il terrorismo si scatena di nuovo contro i giornalisti nel
1980. La Brigata 28 marzo, gruppo terroristico di estrema sinistra, ferisce a
Milano Guido Passalacqua inviato di “Repubblica”. A maggio uccide Walter Tobagi,
giovane inviato del “Corriere della Sera”. È un delitto feroce e assurdo che
desta sospetti perché il volantino di rivendicazione appare scritto da persone
che hanno una buona conoscenza del mondo del giornalismo milanese. Per i
socialisti i mandanti vanno cercati in via Solferino, sede del Corriere. I
processi contro Marco Barbone e i suoi compagni dimostrano l’infondatezza di
questi sospetti.
Il delitto di Walter Tobagi. È
il 28 maggio 1980 quando, poco prima delle 11, il giornalista esce di casa e si
reca verso via Salaino, dove ha lasciato l’auto in un garage. Viene affiancato
da due giovani armati: sparano, Tobagi cade a terra, vicino al marciapiede. Si
saprà poi che all’agguato partecipano sei giovani: Marco Barbone, Paolo
Morandini, Mario Marano, Francesco Giordano, Daniele Laus e Manfredi De Stefano.
A sparare il colpo mortale è Marco Barbone.
Chi è Marco Barbone. All’epoca
dei fatti Barbone ha 22 anni. E’ esponente della Milano “bene”, leader
dell’organizzazione terroristica di estrema sinistra, chiamata “Brigata 28
marzo”. Nata a Milano nel maggio del 1980 con lo scopo di lottare e contrastare
il mondo dei media, in particolare i giornalisti della carta stampata.
Il sequestro Aldo Moro. I
problemi più complessi sorgono dall’evento cruciale: il sequestro di Aldo Moro,
presidente della Democrazia Cristiana. La notizia del sequestro e del massacro
della scorta viene diffusa la mattina del 16 marzo 1978 dalla radio, dalla
televisione e dalle edizioni straordinarie di molti quotidiani. Nel corso della
prigionia, i servizi segreti non riescono a trovare Moro. Nasce il dibattito, in
Italia, tra chi sostiene la necessità di trattare con le Brigate Rosse e chi, al
contrario, rifiuta ogni compromesso. Così lo Stato non tratta: il 9 maggio del
1978 il cadavere del presidente della Dc viene ritrovato all’interno di una
Renault 4, a Roma, in via Michelangelo Caetani.
1980: Le Br sfidano i
giornali. Alla fine del 1980 le Br sfidano direttamente i giornali. Per
rilasciare il magistrato Giovanni D’Urso chiedono che vengano pubblicati i
proclami dei loro compagni incarcerati a Trani e a decidere se accettare o meno
devono essere i giornali. La maggior parte delle testate respinge il ricatto,
mentre pubblicano i proclami “Il Messaggero”, “Il Secolo XIX”, “L’Avanti!”, “Il
Manifesto” e “Lotta continua”. Il “Corriere della Sera” decide di adottare il
“completo silenzio stampa” e quindi di non dare neppure notizie riguardanti
il terrorismo. Gli altri quotidiani del gruppo devono adottare la stessa linea.
Nel 1982, subito dopo la pubblicazione dei documenti brigatisti e la chiusura
del supercarcere dell’Asinara, i terroristi rilasciano il magistrato.
Così i giornalisti chiusero
gli occhi sulle Brigate rosse.
Negli anni '70 i quotidiani ignorarono i terroristi. Per preconcetto ideologico,
scrive Michele Brambilla, Martedì 17/07/2018, su "Il Giornale". Il Giorno,
quotidiano di proprietà pubblica, il 23 febbraio del 1975 sentì il dovere di
dare ai suoi lettori la chiave di lettura di un fenomeno che stava diventando
sempre più inquietante: le Brigate Rosse. Per farlo, impegnò una delle sue firme
più prestigiose: quella di Giorgio Bocca. L'articolo, a pagina 5, aveva un
titolo che non lasciava spazio a equivoci: «L'eterna favola delle Brigate
Rosse». «A me queste Brigate Rosse», scriveva Bocca, «fanno un curioso effetto,
di favola per bambini scemi o insonnoliti; e quando i magistrati e gli ufficiali
dei Cc e i prefetti ricominciano a narrarla, mi viene come un'ondata di
tenerezza, perché la favola è vecchia, sgangherata, puerile, ma viene raccontata
con tanta buona volontà che proprio non si sa come contraddirla». Purtroppo,
quella delle Br non era una favola. Non interessava solo i bambini scemi o
insonnoliti. Non faceva per nulla tenerezza e, soprattutto, non era una storia
«vecchia, sgangherata, puerile». Nel momento in cui Bocca scriveva quel pezzo,
le Br avevano già compiuto una serie di azioni delle quali gli italiani erano
venuti a conoscenza non leggendo libri di fiabe, ma la cronaca nera dei
giornali. La prima impresa brigatista risaliva addirittura a cinque anni prima:
il 17 settembre 1970 era stato incendiato il garage di un dirigente della Sit
Siemens di Milano. Una cosa da ridere, in confronto alla vera guerriglia
rivoluzionaria. Ma da quel momento era cominciata una paurosa escalation. Il 3
marzo del 1972, sempre a Milano, era stato rapito il dirigente della Siemens
Idalgo Macchiarini; il 12 febbraio del '73 altro sequestro: a Torino, del
sindacalista della Cisnal Bruno Labate; il 10 dicembre 1973 ancora un rapimento,
quello a Torino di Ettore Amerio, capo del personale del settore auto della
Fiat. A conferma che di un'escalation si trattava, e quindi che i bersagli delle
Br erano sempre più importanti e difficili da colpire, il 18 aprile del 1974 era
stato sequestrato a Genova, e poi a lungo tenuto prigioniero e «processato», il
sostituto procuratore della Repubblica Mario Sossi, un magistrato cattolico
osservante, considerato dalla sinistra un duro, un intransigente, un
conservatore. Insomma, un reazionario. E a conferma che, nel momento in cui
veniva pubblicato il pezzo di Bocca, le Brigate Rosse avevano già fatto capire
di non scherzare, il 17 giugno '74 c'era stato il duplice omicidio, a Padova, di
due aderenti al Movimento Sociale Italiano: Giuseppe Mazzola e Graziano
Giralucci. E il 16 ottobre dello stesso anno 1974, a Robbiano di Mediglia, il
maresciallo dei carabinieri Felice Maritano era rimasto ucciso in uno scontro a
fuoco con dei brigatisti. Nel frattempo (9 settembre '74) erano stati arrestati
a Pinerolo due capi storici delle Br, Renato Curcio e Alberto Franceschini. Il
20 febbraio '75, cioè tre giorni prima dell'apparizione sul Giorno dell'«eterna
favola delle Brigate Rosse», un commando di questa formazione che secondo alcuni
non esisteva neppure era riuscito a far evadere Renato Curcio dal carcere di
Casale Monferrato. Com'era dunque possibile che, nonostante tre omicidi, quattro
sequestri e un'evasione, Giorgio Bocca scrivesse in quei termini delle Brigate
Rosse? C'erano fatti che non potevano essere ignorati. Ma la risposta è
contenuta nello stesso articolo «L'eterna favola delle Brigate Rosse». Giorgio
Bocca spiegava che le prove raccolte su questi tupamaros italiani erano talmente
ridicole da non poter essere prese sul serio: «Questi brigatisti rossi», si
legge in quell'articolo, «hanno un loro cupio dissolvi, vogliono essere
incriminati a ogni costo, conservano i loro covi, le prove di accusa come dei
cimeli, come dei musei. Sull'auto di Curcio, al momento dell'arresto, vengono
trovati dei documenti, delle cartine; in un covo, intatto, c'è, si dice, la
cella in legno in cui era prigioniero Sossi... E, naturalmente, bandiere con
stelle a punte irregolari». (...)
Giorgio Bocca faceva notare,
sempre in quell'articolo, che ai magistrati e alla polizia aveva «fatto
parecchie pubbliche domande sulle incongruenze, quasi divertenti, di questi
guerriglieri, senza ricevere né sdegnate smentite né spiegazioni convincenti». E
allora, che cos'erano queste Br? «Una cosa è certa», scriveva Bocca, «le vigilie
elettorali hanno per queste Brigate Rosse un effetto da flauto magico, due o tre
note e saltano fuori nello stesso modo rocambolesco in cui sono scomparse». Il
pezzo, come un processo, finiva con un verdetto: «Questa storia è penosa al
punto da dimostrare il falso, il marcio che ci sta dietro: perché nessun
militante di sinistra si comporterebbe, per libera scelta, in modo da rovesciare
tanto ridicolo sulla sinistra». Questo si leggeva, nel 1975, su un giornale
considerato «borghese». Anni dopo, Giorgio Bocca fece pubblica autocritica,
ammettendo di «non aver capito niente» del terrorismo rosso. Ma va detto che sia
lui personalmente, sia Il Giorno non erano certo eccezioni nel panorama della
stampa italiana. Erano anzi la regola. Da quando le bombe, gli omicidi, gli
attentati, gli scontri di piazza avevano avvelenato la politica e non solo la
politica del Paese, i mass media erano entrati in un tunnel.
Giugno 1977: la campagna Br
contro i giornalisti e il black out su Montanelli, scrive il 2 giugno 2018 Ugo
Maria Tassinari.
1 giugno 1977 Genova. Vittorio
Bruno, vice direttore del Secolo XIX di Genova viene ferito alle gambe da un
giovane armato di pistola. L’attentato avviene vicino all’ingresso della
tipografia. Le Br rivendicano l’attentato con un volantino in cui dichiarano
guerra a tutta la stampa.
2 giugno 1977 Milano. Indro
Montanelli, direttore del Giornale Nuovo, viene colpito alle gambe da un uomo
armato di pistola con silenziatore. L ‘attentatore e un suo complice raggiungono
una macchina che li attendeva e fuggono. L’attentato è rivendicato con una
telefonata al Corriere d’Informazione dal “gruppo Walter Alasia” delle Br.
3 giugno 1977 Roma. Emilio
Rossi, direttore del TG l, viene colpito da due giovani, un uomo ed una donna
armati di pistola. L ‘attentato avviene in via Teulada a pochi metri dalla sede
Rai di Roma. I due giovani dopo aver sparato si allontanano a piedi con un terzo
complice. L’attentato è rivendicato con un volantino fatto pervenire all’ANSA e
al Messaggero dalle Br. Nel volantino Rossi viene definito “direttore del più
grande giornale di regime”. Così, in rapida successione, si dispiega la campagna
brigatista contro la “stampa di regime”, con gli attacchi eseguite da tre delle
principali colonne della Br. Mancano soltanto i torinesi. A perenne vergogna,
invece, della stessa stampa la vergognosa scelta di “oscurare” il fatto che una
delle vittime era il più noto e prestigioso giornalista italiano, Indro
Montanelli, all’epoca protagonista di una “scissione da destra” del Corriere
della Sera per fondare il Giornale, organo di battaglia anticomunista ben prima
che divenisse proprietà di Berlusconi. Non solo il Corriere della Sera (in
basso), che aveva dirette ragioni di bottega, ma anche numerosi altri
quotidiani. Tra questi la Stampa (a sinistra) che il 3 giugno fa (del tutto
volontariamente) un clamoroso “errore”, titolando in prima pagina sul ferimento
di due direttori (Bruno e Montanelli) sull’articolo da Milano sulla
gambizzazione del secondo, mentre il primo è stato ferito l’1 e in pagina c’è un
altro articolo sugli sviluppi delle indagini. Viola così una regola ferrea: non
si titola su elementi che non sono presenti nell’articolo. Fedele al suo
personaggio di feroce anticomunista (all’epoca) non farà la mattina per poi
avviare un dialogo umano con il leader delle Br che gli aveva sparato alle
gambe, Franco Bonisoli.
Ugo Tognazzi è il Capo delle
BR, scrive il 13 maggio 2011 Pier Luca Santoro su mediahub.it. "Il Male" è stata
una rivista satirica di grande successo in Italia. Edita tra il 1978 ed il 1982
con cadenza settimanale è stata diretta anche da Vincenzo Sparagna poi
co-fondatore di Frigidaire. Uno dei motivi di successo della pubblicazione si
legava al filone di falsificare le prime pagine dei principali quotidiani
italiani. Il paginone centrale, mascherato da un qualsiasi quotidiano nazionale,
diventava la prima pagina del Male, dalla finta prima di Repubblica che
annunciava a caratteri cubitali "Lo stato si è estinto" al Corriere dello Sport"
che riportava l'annullamento dei mondiali del '78, passando per l'annuncio
dell'avvenuta invasione aliena del Corsera. E' ancora molto vivo nella mia mente
il ricordo di come mi divertissi all'epoca, mentre andavo al liceo in autobus,
ad esibire le diverse versioni per poi spiare di nascosto le facce, le reazioni
degli altri passeggeri. Come noto, erano quelli, anche, "anni bui", un periodo
difficile della storia della nostra nazione caratterizzato dal fenomeno del
terrorismo. Una delle versioni che ebbe maggior successo fu l'annuncio, in tre
versioni diverse che riproducevano la prima pagina del Giorno, della Stampa e di
Paese Sera, dell'arresto di Ugo Tognazzi identificato come il capo delle Brigate
Rosse.
Dall'eskimo al burqa (in
redazione).
Così il buio della ragione contraddistingue i nostri intellettuali e la nostra
cultura, scrive Nicola Porro Domenica 27/03/2016, su "Il Giornale". C'è un libro
che le nuove generazioni, specialmente, dovrebbero leggere. Per la verità è
consigliabile anche a quella fascia di ex giovani nati agli inizi degli anni
'70, dunque troppo giovani per sapere cosa stesse succedendo accanto a loro.
Scritto nel '91, per le edizioni Ares, da Michele Brambilla, si intitola
L'eskimo in redazione. Varrebbe la pena leggerlo per due ordini di motivi. Uno
contingente: anche oggi siamo immersi in un pensiero unico sul fenomeno del
terrorismo islamista. Chi pensa che accoglienza e integrazione siano due balle,
viene trattato come un paria. E infine c'è una ragione più storica: occorre
conoscere il livello di cialtronaggine che ha caratterizzato la nostra classe
giornalistica e culturale nel ventennio del terrorismo. Che poi sono gli stessi
che si sono fatti establishment spiegando alle nuove generazioni quali errori
non fare, proprio loro che ne hanno commessi una caterva. D'altronde era la
generazione che inventò lo slogan giornalistico più ridicolo del secolo: i fatti
separati dalle opinioni. Brambilla ci racconta bene come le cronache erano per
lo più ideologiche, altro che opinioni. Quello di Brambilla è il racconto di un
orrore a cui solo pochi si seppero sottrarre: Montanelli, Pansa, Casalegno,
Tobagi. È l'orrore per cui nei giornalisti degli anni '70 l'ideologia veniva
prima della cronaca. L'orrore per cui campagne di stampa hanno armato la mano
che ha ucciso il commissario Calabresi. L'orrore orwelliano del pensiero unico
per cui i manifesti della gente per bene erano firmati da Eco e da Fo, da
Scalfari e da Mieli. L'orrore per cui, nonostante tutte le evidenze, giornalisti
come Bocca, Sechi (pensate un po', ancora considerato un mito del giornalismo),
Galli e mille altri ci hanno raccontato per anni che le Brigate Rosse erano
sedicenti, e che piuttosto era in corso una strategia della tensione sotto la
regia della destra. L'orrore della signora Cederna (quanto continua a essere
celebrata...), la quale nel '72 aveva il coraggio di scrivere sull'Espresso: «Ho
capito da sola in questi anni come è scomodo essere in una minoranza
specialmente quando si ha ragione». E aggiungeva che Feltrinelli era stato
ucciso chissà da chi e non, come si seppe qualche anno dopo (ma tutti lo
sapevano anche allora), da un incidente sul lavoro, piazzando un ordigno su quel
traliccio. E la sua supposta minoranza era piuttosto la maggioranza degli
intellettuali dell'epoca. Brambilla fa un lavoro grandioso: mette in fila questa
galleria degli orrori, fa nomi e cognomi, cita date e giornali e mette in
evidenza questo impasto di conformismo e di vigliacca omologazione. Merita un
posto d'onore nella nostra Biblioteca liberale, anche se non si tratta di un
saggio economico, non affronta questioni filosofiche, ma meglio dei primi e dei
secondi racconta il buio della ragione che ha contraddistinto i nostri
intellettuali e la nostra cultura.
L’eskimo in redazione, i
bei giornali di una volta,
scrive il 6 marzo 2016 Stefano Olivari su "L'Indiscreto.info". La fusione
Repubblica-Stampa-Secolo-eccetera già definita e quella Corriere della Sera-Sole
24 Ore scenario credibile hanno già scatenato i rimpianti per il presunto bel
giornalismo di una volta, quello che mai si sarebbe conformato al pensiero
unico. Leggendo a distanza di oltre quarto di secolo L’Eskimo in redazione –
Quando le Brigate Rosse erano ‘sedicenti’ viene qualche dubbio, perché Michele
Brambilla già nel 1990 ebbe il merito di analizzare gli anni di piombo, non
ancora storicizzati perché molti dei suoi protagonisti erano ancora in pista,
dal punto di vista di chi li avrebbe dovuti raccontare ai lettori. I
giornalisti, insomma. Un libro che suo tempo generò fortissime polemiche, dovute
alla cattiva coscienza di una stampa che aveva sottovalutato i pericoli del
terrorismo rosso continuando a sostenere la tesi che si trattasse di operazioni
portate avanti da fascisti mascherati, al soldo della CIA o di indefinibili
poteri forti. Brambilla, attuale direttore della Gazzetta di Parma, si muove su
più fronti. Il primo è proprio quello della paternità dei crimini, anche quando
chi li aveva commessi li rivendicava con orgoglio e la sua storia politica era
evidente. Così per anni, fino a quasi il sequestro Moro, le Brigate Rosse quando
venivano nominate erano accompagnate nell’articolo dall’aggettivo ‘sedicenti’.
Le sedicenti Brigate Rosse, così come sedicenti erano altri gruppi della stessa
area, altro non sarebbero stati che gruppi di destra diretti astutamente dalle
forze della reazione: questo si leggeva sul Corriere della Sera e su altri
grandi giornali nazionali, con la ovvia eccezione del Giornale che nel
1974 Indro Montanelli fondò proprio per sfuggire al pensiero unico e perché non
si riconosceva più nel Corriere di Piero Ottone. Il secondo fronte su cui si
muove Brambilla è quello del doppiopesismo. L’attentato rivendicato dal
neofascista è indubbiamente opera sua, quello del brigatista una manovra per
influire sul voto popolare ed impedire l’arrivo del PCI al governo. Questi della
maggioranza silenziosa e della CIA però avevano sbagliato i calcoli, visto che
alle Politiche del 1976 il partito allora guidato da Enrico Berlinguer toccò il
suo massimo storico superando il 34% dei voti. Il doppiopesismo si applica anche
alle vittime: quella di destra è uno che in qualche modo se l’è cercata (esempio
classico Sergio Ramelli, iscritto al Fronte della Gioventù ma non certo un
attivista) mentre quello di sinistra è la vittima di uno Stato reazionario. E
qui si arriva ai tanti uomini dello Stato maltrattati anche dai giornali
cosiddetti borghesi, quelli con lettori che istintivamente avevano più fiducia
nel prefetto Mazza che in Sofri. Il caso Calabresi è da manuale, con una
campagna di odio senza precedenti che non fu soltanto di Lotta Continua (tra i
tanti firmatari del documento dell’Espresso in cui veniva definito ‘commissario
torturatore’ svettavano Eco, Fellini, Bobbio, Guttuso, Scalfari, Bocca,
Moravia…) e che terminò con l’assassinio di Calabresi, ma anche i magistrati
capaci di mantenere equilibrio (fra questi Gerardo D’Ambrosio) venivano
giudicati con sospetto perché facevano il gioco del ‘nemico’. Brambilla mette
insieme verità giudiziarie, semplice logica e articoli dell’epoca, in un
affresco che sarebbe esilarante se non fosse popolato di morti e di violenza
ideologica. Non classificabile il Corriere della Sera che non comprò la foto più
famosa degli anni di piombo (quella scattata in via De Amicis, a Milano, durante
gli scontri in cui fu ucciso il vicebrigadiere Antonio Custra) e che non mise il
nome di Montanelli (non ancora icona anti-berlusconiana) nel titolo
dell’articolo sulla sua gambizzazione, imbarazzanti le tante ipotesi fatte sulle
morti di Pasolini e Feltrinelli (con la scomparsa del ‘Se la sono cercata’), di
assoluto culto gli articoli che mettevano in relazione la strage dei Graneris
(storia con cui Vespa oggi farebbe 1.200 puntate di Porta a Porta), assimilabile
per certi versi alla vicenda di Pietro Maso, con una vendetta contro partigiani
comunisti. Solo in pochi, non a caso i più grandi (su tutti Bocca), seppero poi
fare autocritica, ma in generale davanti all’evidenza dei fatti si preferì la
notizia asettica o il silenzio. Insomma, nemmeno editori diversi possono fare
più di tanto contro il pensiero unico, che a prescindere dalla realtà ha già i
suoi buoni e i suoi cattivi. La forza di questo libro, per niente datato
nonostante abbia ormai più di 25 anni, è proprio questa: il pensiero unico non è
una tavola di leggi imposte da un grande vecchio, ma un conformismo a cui quasi
tutti si adeguano per pigrizia e soprattutto convenienza. L’abbiamo visto
applicato al terrorismo di sinistra come all’europeismo, al liberismo come
all’immigrazione, a seconda dei periodi, con una ‘linea’ a cui la maggioranza si
adegua perdendo ogni capacità critica e svegliandosi troppo tardi. Ma qui già
stiamo andando sui massimi sistemi, dimenticando una questione mai davvero
analizzata: l’intolleranza quasi genetica della sinistra (e non parliamo di
terrorismo o violenza fisica) nei confronti di chi la pensa diversamente, che
non si esprime con la spranga ma in maniere molto più sottili e durature.
Quell’eskimo in redazione
che fa ancora vergognare.
Esclusiva intervista a Michele Brambilla: il mea culpa mancato
dei giornalisti italiani sugli anni di piombo, scrive il 13 giugno 2018 Frediano
Finucci su "Informazionesenzafiltro.it". Il mea culpa è una pratica a cui i
giornalisti italiani sono da sempre poco avvezzi. Non tiriamo in ballo la legge
sulla Stampa e l’obbligo della rettifica per chi è oggetto di notizie false o
imprecise: chi l’ha vissuto sulla propria pelle sa quanto sia difficile – se non
impossibile – ottenere la pubblicazione di una rettifica, su di un giornale o un
notiziario, con la stessa evidenza della notizia da rettificare. Figuriamoci poi
sul Web. Sull’argomento “mea culpa e stampa” esiste però un caso editoriale sul
quale da decenni, nel mondo del giornalismo italiano, si discute di malavoglia e
sottovoce, come si fa nelle famiglie per il caso di un parente che ha dato
scandalo e delle cui malefatte tutti sono al corrente. Protagonista è il
giornalista Michele Brambilla, attuale direttore della Gazzetta di Parma, per
decenni inviato del Corriere della Sera e de La Stampa, già vicedirettore de Il
Giornale e di Libero. Brambilla nel 1990 ha scritto un libro molto
documentato, L’eskimo in redazione, nel quale dimostra come la quasi la totalità
della stampa italiana negli anni ’70 abbia fatto di tutto per negare l’esistenza
delle Brigate Rosse e per dare la colpa a elementi neofascisti di gravissimi
fatti di cronaca nera che in realtà non avevano alcuna connotazione politica.
Una tesi semplice ma dirompente che torna d’attualità oggi, nel quarantennale
dall’assassinio di Aldo Moro.
Dopo l’uscita del tuo libro
quanti giornalisti hanno fatto mea culpa per avere negato l’esistenza delle BR?
«Alcuni,
anche se non subito. Giorgio Bocca fu uno dei primi a farlo, e in tempi non
sospetti, quando scusarsi non era di moda. Nel corso degli anni Paolo Mieli ed
Eugenio Scalfari hanno riconosciuto di avere sbagliato: qua mi riferisco a una
delle nefandezze legate a quegli anni, vale a dire l’incitamento della stampa
all’odio verso il commissario di polizia Luigi Calabresi con il famoso documento
pubblicato sull’Espresso nel giugno 1971, dove più di 800 esponenti del mondo
culturale e giornalistico accusavano il commissario della morte dell’anarchico
Giuseppe Pinelli. Nel complesso però sono stati pochi quelli che hanno fatto
pubblica ammenda. Uno dei primi fu certamente Giampaolo Pansa che, pur essendo
di sinistra, tra l’altro non aveva di che pentirsi avendo sempre fatto un tipo
di giornalismo corretto. Il mondo che non si è mai pentito è quello che ad
esempio gravitava intorno a Dario Fo, che continuava a sostenere che Calabresi
era un poco di buono».
Chi non ha fatto mea culpa,
secondo te, non l’ha fatto per quale motivo?
«Direi
essenzialmente per orgoglio e ideologia. Nel primo caso perché se per un essere
umano è difficile dire “ho sbagliato”, lo è di più per un giornalista. Nel
secondo caso, ovvero l’ideologia, perché negare l’esistenza di un terrorismo
rosso ancora oggi vuol dire affermare che la Sinistra era (ed è) esente dal
peccato originale della violenza, perché sta sempre dalla parte degli ultimi e
dei poveri. Non si vuole ammettere insomma la possibilità che anche da sinistra
possa venire violenza, il che storicamente è successo – e non solo in Italia,
intendiamoci. Per questo ancora oggi quando si parla delle BR c’è sempre dietro
un complotto, delle macchinazioni del potere: si sostiene che le bombe furono
solo fasciste, che non furono i brigatisti a rapire Moro, anzi: furono
manovrati. Ma per queste affermazioni non ci sono prove».
Qual è stato il mea culpa
più sincero da parte di un collega?
«Difficile
dirlo ma per farti capire il clima – e non solo di allora – che persiste nella
categoria, ti racconto un episodio. Nel 2012 scrivevo per La Stampa e fui
inviato in un cinema romano a vedere l’anteprima per i giornalisti del film di
Marco Tullio Giordana Romanzo di una strage, sulla bomba di piazza Fontana e i
fatti che ne seguirono. Valerio Mastandrea interpretava il commissario
Calabresi, dipinto come una figura positiva, un giovane poliziotto schiacciato
da vicende più grandi di lui, rispettoso degli indagati durante gli
interrogatori; soprattutto – come emerge dalla verità storica – si precisava che
il commissario non si trovava nella stanza della Questura di Milano dalla cui
finestra l’anarchico Pinelli volò giù, morendo. Al termine della proiezione,
quando si riaccesero le luci, in sala calò il gelo: nessuno dei giornalisti
applaudì e dai commenti si capiva che i presenti si aspettavano da un regista
apertamente di sinistra come Giordana tutto meno che la riabilitazione di
Calabresi. Andai subito a parlare con Giordana riferendogli delle perplessità
dei colleghi e lui rispose: “quando ero militante di sinistra fui arrestato e
interrogato da Calabresi il quale fu di una correttezza esemplare, un poliziotto
che si sforzava di capire le rimostranze di una generazione”. Morale: Per i
giornalisti italiani a partire dagli anni ’70 Calabresi fu un capro espiatorio,
e quando una categoria fa una scelta del genere poi è difficile tornare indietro».
C’è stato qualche collega
che dopo aver letto il libro ti ha detto in privato che avevi ragione, ma poi
non ha fatto scuse pubbliche?
«Ti
rispondo ancora una volta con un episodio. Il mio libro è stato pubblicato da
quattro editori e ha avuto una quindicina di ristampe. Quando uscì, nel 1990,
lavoravo al Corriere della Sera, e con l’eccezione de La Repubblica L’eskimo in
redazione fu recensito da tutti i giornali italiani. Allora al Corriere il
direttore era Ugo Stille e tra i vicedirettori c’era un gentiluomo piemontese
che si chiamava Tino Neirotti, che mi disse: “hai fatto un libro bellissimo, ora
dico ai colleghi della Cultura di scrivere una recensione”. Nessun giornalista
però si dichiarò disposto a farlo: nessuno voleva “sporcarsi le mani”. Allora
Neirotti mi disse: “Michele, scrivi tu una scheda di sessanta righe sul tuo
libro, non firmarla e a lato mettiamo un pezzo di Giuliano Zincone che secondo
me qualche riflessione sul tema la fa volentieri”. Ebbene, una volta scritta la
scheda, da sessanta righe previste diventò una segnalazione di una riga e mezzo
con accanto il pezzo di Zincone che mi stroncava. Questo per dirti che persino
un vicedirettore non era riuscito non dico a far pubblicare un’autocritica, ma
nemmeno a garantire una parità di dibattito. E questo, credimi, lo dico con
dolore profondo, perché il Corriere è un pezzo della mia vita».
In occasione del
quarantennale della morte di Moro la stampa italiana ha affrontato anche il tema
della negazione delle BR da parte dei giornali di cui parli nel libro?
«Alcuni
l’hanno fatto: Ernesto Galli della Loggia sul Corriere, demolendo la
riproposizione del cosiddetto “mistero del caso Moro”, e anche sul Post di Luca
Sofri sono apparsi articoli che smontavano le tesi complottistiche sull’eccidio
di via Fani. Nonostante questo ancora oggi si vuol far credere che non ci sia
stato un terrorismo di sinistra. Proviamo a riflettere: i “bombaroli” neri degli
anni ’70, quelli davvero coperti da alcuni elementi dei Servizi segreti
italiani, sono stati fatti scappare all’estero o messi in condizione di essere
assolti nei processi. I rapitori di Moro hanno passato 20/30 anni in galera: se
davvero fossero stati collaboratori di Servizi italiani o esteri questi li
avrebbero fatti scappare, assolti o al limite uccisi. Che interesse avrebbero i
brigatisti a negare ancora oggi di essere stati manovrati?»
Dopo gli anni del
terrorismo, a tuo parere, ci sono stati nella stampa italiana episodi di
conformismo estremo, di miopia giornalistica analoghi a quelli che racconti nel
libro?
«Si.
Uno è stato la prima fase di Mani Pulite che ho seguito sin dall’arresto di
Mario Chiesa. Di nuovo: non credo che dietro lo scoppio di Tangentopoli ci sia
stato un complotto di chissà chi. Tutto nacque dalla grande abilità di Antonio
di Pietro – forse più bravo come poliziotto che come magistrato – a trovare le
prove della corruzione dei politici. Allora montò un’indignazione popolare verso
i politici corrotti, e all’inizio fu giusto per la stampa italiana appoggiare le
inchieste; dopodiché la cosa sfuggì di mano ai giornalisti. Subito le procure di
tutt’Italia cominciarono ad arrestare politici e imprenditori senza avere però
le competenze di Di Pietro, e la grande stampa peccò di conformismo appoggiando
sempre e comunque i magistrati. Fu allora che nacque l’idea generale che i
politici sono tutti corrotti e nel nostro Paese lo sono più che in altri. Il “fa
tutto schifo” e il “tutti sono colpevoli” non li ha inventati Beppe Grillo, ma
proprio i “giornaloni” verso i quali il comico si accanisce. I pochi che non si
accodavano al conformismo verso i magistrati – ad esempio Giuliano Ferrara o
Filippo Facci – venivano accusati di essere complici dei ladri. C’è però una
grande differenza tra il conformismo totale della stampa negli anni di piombo e
quello di Mani Pulite. Nel primo caso – con l’eccezione de Il Giornale di
Montanelli – tutti i quotidiani erano concordi nell’esprimere dei dubbi sulla
reale esistenza delle Brigate Rosse, che non a caso definivano “sedicenti”; nel
caso di Tangentopoli il conformismo si spezzò dopo un paio d’anni quando venne
indagato Silvio Berlusconi: allora i giornali e l’opinione pubblica si divisero
tra chi lo difendeva a spada tratta e chi invece appoggiava i giudici di Milano.
Ora, Berlusconi ha avuto sicuramente dalla sua buona parte dei media di cui è
proprietario, ma anche i cronisti di Mani Pulite di allora (molti dei quali
hanno fatto autocritica) riconoscono che fu eccessivamente demonizzato, tant’è
che oggi nei suoi confronti è in corso, come dire, una sorta di riabilitazione».
L’ESKIMO IN REDAZIONE DI
BRAMBILLA. UN IMPORTANTE LIBRO SUL CONFORMISMO.
Scrive il 20/11/2015 Stefania Miccolis su "Lamescolanza.com". È difficile
essere obiettivi con il libro “L’Eskimo in redazione” di Michele Brambilla. È
difficile tenere un distacco adeguato per dare una valutazione a favore o
contro, drugstore there soprattutto se si è affetti da una sorta di pregiudizio
dovuto a una formazione culturale ben precisa. Ma il libro è certamente di alto
interesse e porta a una riflessione profonda, e senza dubbio fa comprendere
meglio il clima di quegli anni di piombo, capitolo buio della storia italiana.
All’epoca della sua uscita nel 1990 (ristampato varie volte e nel 2010 da ed.
Ares), fu recensito da molti quotidiani tranne che dal Corriere della Sera dove
Brambilla lavorava, luogo in cui i tanti giornalisti indossavano un Eskimo per
coprire i loro cachemire. Fu oggetto di discussione, un testo scomodo per tutta
una élite culturale di sinistra. Il titolo del libro che fa riferimento a una
canzone di Francesco Guccini diviene un nuovo modo di dire per indicare i “tempi
in cui il giornalismo era allineato su posizioni più gruppettare che di
sinistra”. Il lavoro di Brambilla si basa su una ricerca accurata, fatta in
particolare negli archivi del Corriere della Sera, una carrellata o miscellanea
di articoli di giornalisti di prestigio dell’epoca, quelli che Indro Montanelli
indica come “l’intellighenzia (inutile aggiungere “di sinistra”: quella di
destra non è riconosciuta come intellighenzia)”. Ma questo, tiene a
sottolineare lo stesso autore, “lungi dall’essere un libro contro la sinistra, è
un libro di denuncia di uno dei vizi mai morti della nostra categoria: il
conformismo”: la sinistra negli anni ’70 è la vincente di turno, e sua è
l’egemonia culturale. È un “libro-documento” come scrive Indro Montanelli nella
prefazione, dove “c’è tutto quello che bisogna sapere” ed è “scritto a futura
memoria, nella speranza che la memoria serva a qualcosa”. Vengono raccontati gli
anni di piombo, e analizzati alcuni dei casi importanti delle Brigate Rosse. Ne
esce un quadro ideologizzato e fazioso: le Brigate Rosse erano le “sedicenti
Brigate Rosse”, a detta dei molti giornali borghesi che “per anni hanno fatto
intendere agli italiani che quelle formazioni non erano rosse, e quindi erano
nere, o peggio ancora al servizio delle istituzioni. Ma il loro programma era
quello di aumentare la tensione al punto di scatenare una reazione dei
conservatori che avrebbe convinto tutta la sinistra a scendere nelle strade e
nelle piazze per dar vita alla guerra civile e instaurare un nuovo regime,
marxista”. “Le Brigate Rosse hanno sempre rivendicato le proprie azioni e la
propria appartenenza alla sinistra rivoluzionaria”. Si diceva fossero “fascisti
mascherati”, e che “di rosso avessero solo il nome” (Sandro Pertini); Biagi,
Bocca e molti altri avevano sottovalutato la gravità del loro potere
rivoluzionario. Si prendeva in considerazione la “strategia della tensione” che
serviva a spostare a destra l’equilibrio politico italiano, mentre “la teoria
degli opposti estremismi”, ovvero l’esistenza di due terrorismi, uno rosso e uno
nero, era solo un alibi per le forze conservatrici. Un vero coro conformista,
solo pochi si distinguevano fra cui Pansa, Tobagi e Montanelli, che si
attenevano ai fatti e senza incriminare nessuno aspettavano le sentenze, e
comunque condannavano qualsiasi tipo di terrorismo, a destra e a sinistra.
Brambilla fa coincidere l’inizio della violenza politica in Italia con la morte,
rimasta impunita, il 19 novembre 1969 dell’agente di polizia Annarumma, (questo
fu “l’esordio degli scontri di piazza e della guerriglia”), nello scontro a
Milano fra estremisti di sinistra e forza pubblica. Nessuno voleva dare la colpa
agli estremisti. Poi venne il 12 dicembre del 1970 e il prefetto di Milano Mazza
scrisse un rapporto al Ministero degli Interni in cui segnalò la violenza rossa
e la violenza nera e per questo non fu mai perdonato dalla sinistra e da allora
Mazza venne considerato un ottuso conservatore reazionario. Ecco poi dunque il
caso di Giangiacomo Feltrinelli morto perché gli era scoppiata in mano una
carica di dinamite per fare saltare un traliccio e provocare il black-out in una
zona di Milano. Ma tutti scrissero che Feltrinelli “Il guerrigliero dei Navigli”
o “il rivoluzionario dorato” era stato ucciso, che vi era “Il sospetto di una
spaventosa messa in scena” che fosse “un delitto”. Solo Montanelli e pochi altri
ebbero il coraggio di andare contro a una stampa preconcetta, quella della
“verità in tasca” che ingannava i lettori. Montanelli nel 1972 diceva che non
c’era nulla da obiettare se fossero ipotesi di una messa in scena e di un
delitto, ma “ciò che rifiutiamo è il tentativo di spacciarla come una certezza
già acquisita”; “in questa orgia di bombe e incalzare di attentati, in questo
macabro carnevale di cadaveri e nella irresponsabile speculazione che si cerca
di farne strumentalizzandoli a scopi di parte, l’unica speranza riposa proprio
nella pubblica opinione, nella saldezza dei suoi nervi, nell’equilibrio del suo
giudizio […] la esortiamo a non credere, per ora, a nessuno”. Altro caso
analizzato, il delitto Calabresi, ucciso nel 1972 da due colpi di pistola, “e,
ancor prima, da una campagna diffamatoria forse senza precedenti in Italia” dopo
la morte nel 1969 di Giuseppe Pinelli. E così venne chiamato il “commissario
finestra”. Accusato della morte di Pinelli, diversi furono gli appelli e le
lettere aperte, e le adesioni degli uomini di cultura “una delle prove più
evidenti del conformismo di allora”. L’autore espone un documento firmato da
filosofi, intellettuali, registi cinematografici, storici, giornalisti e
pubblicato sull’Espresso il 13 giugno del 1971, in cui Calabresi veniva definito
un “commissario torturatore” e il “responsabile della fine di Pinelli”. Questo
fa comprendere quanto la cultura italiana, scrive Brambilla, fosse
monopolizzata. E neanche dopo la sua morte Calabresi fu lasciato in pace. Sofri
riconobbe durante il processo che vi fu una campagna diffamatoria sul giornale
di lotta continua sul commissario: “una specie di gusto inerte, diciamo,
dell’insulto, del linciaggio, della minaccia, si è impadronito di noi, e non
solo di noi”. Indro Montanelli fu “fra i giornalisti che non seguirono l’onda” e
lo difese: “Calabresi pagò con la vita la campagna di opinione che lo dipingeva
come un brutale torturatore al servizio dei golpisti. Ma nemmeno il suo
assassinio turbò i sonni dei suoi accusatori. L’unica loro preoccupazione fu di
risolvere in chiave nera anche quel delitto”. Una forte disputa la ebbe con
Camilla Cederna; fra i due botta e risposta sui giornali, per Montanelli la
Cederna era colpevole di prendere sempre “posizioni preconcette”. Poi ancora si
parla dell’attentato a Indro Montanelli “Uno dei clamorosi casi di censura
politica attuata dai giornali italiani. “Quando le Br mi spararono alle gambe –
dice Montanelli -, i grandi quotidiani non misero neppure il mio nome nel
titolo” (tranne Scalfari e Bocca). Infine Brambilla non lascia in disparte
neanche il caso di Pier Paolo Pasolini, nulla a che vedere con terrorismo o
estremismo, ma “l’appiccicare un’etichetta politica, ovviamente di stampo
reazionario, anche a ciò che di politico non aveva alcunché, rientrava nella
logica di quegli anni, la logica delle sedicenti Brigate Rosse e delle
provocazioni del potere”. Un delitto che poi con l’intervento di Oriana Fallaci,
che mai rivelò le sue fonti, diventò delitto politico, addirittura paragonabile
al caso di Feltrinelli. Solo la morte di Moro scosse le coscienze, anche se non
tutti furono capaci di autocritica. Certo è che alcuni giornalisti riconobbero
di avere sottovalutato la violenza delle Brigate Rosse. Per Bocca – La
Repubblica, febbraio 1979 – “in quegli anni dal 69 al 72 l’informazione fu
travolta da uno spirito fazioso e dalla rivelazione, per molti di noi
traumatizzante del “terrorismo di Stato”. “In quegli anni noi cronisti non
capimmo niente della sinistra armata”, “perché non si volle dire e capire sin
dagli inizi che le Brigate Rosse erano una cosa seria? Noi conosciamo i nostri
errori.” E così Walter Tobagi nel 1979 sul Corriere della Sera “…i germi del
partito armato c’erano, ed erano espliciti. Solo i pregiudizi ideologici
impedivano di rendersene conto”. Montanelli, nella sua acuta, concisa
prefazione, ritiene che Brambilla abbia compilato una preziosa “comparsa per il
cosiddetto Tribunale della storia”, tribunale del quale non ha molta fiducia, ma
certamente chi vorrà ricostruire gli anni di piombo non potrà fare a meno di
questo libro.
Ne ammazza più la penna che
le BR. «Io
non credo che le Brigate Rosse fossero molto lusingate dalla partecipazione,
dalla loro parte, degli intellettuali - non credo. Erano gli intellettuali che
volevano mettersi – casomai - al sicuro. Gli intellettuali italiani, si ricordi,
per nove decimi stanno dalla parte di chi picchia. Mai dalla parte di chi le
busca! È sempre stato così» (Indro Montanelli ad Alain Elkann), scrive Valerio
Alberto Menga il 26 novembre 2015 su "L'Intellettualedissidente.it". La
Repubblica ha dato notizia dell’avvenuto passaggio di direzione del quotidiano
da Ezio Mauro a Mario Calabresi. È però noto che tra le firme illustri del
sopracitato giornale vi era quella di Adriano Sofri, ritenuto il mandante
dell’omicidio del Commissario Luigi Calabresi, padre del neodirettore di Rep. Le
due firme avrebbero potuto convivere con ovvie difficoltà. Così Adriano Sofri si
è dovuto ritirare. E la cosa ha suscitato molto scalpore. Spieghiamo il perché,
ripercorrendo la Storia recente. Milano, 12 dicembre 1969. Ore 16:37. Sette
chili di tritolo esplodono all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura
sita in Piazza Fontana. 16 morti e 87 feriti. La polizia imbocca subito la pista
anarchica. Dopo alcune indagini e interrogazioni ai tassisti che quel giorno
hanno portato sul luogo dell’attentato, spunta fuori il nome dell’anarchico
Pietro Valpreda, noto per essere un ballerino con inclinazioni “bombarole”, ma
solo a parole. Poi, la notte successiva alla strage, si interroga Giuseppe
Pinelli, anarchico anche lui. Verrà portato in questura per una serie di lunghi
ed estenuanti interrogatori. Tre giorni dopo l’attentato, il 15 dicembre del
1969, Pinelli precipita dal quarto piano dell’aula dell’interrogatorio e si
schianta al suolo. Arriverà già morto all’ospedale Fatebenefratelli. Questa è
una vicenda a tinte fosche, dai mille risvolti. Sono gli anni della Guerra
Fredda. L’Italia ha paura di divenire una repubblica sovietica da una parte, e
dall’altra di ritornare alla dittatura nera. Con Piazza Fontana ebbero inizio i
tristemente noti “Anni di piombo” e con essi la teoria della “Strategia della
tensione”. Una teoria secondo cui uomini di stato, servizi segreti, terroristi
rossi e neri avrebbero stretto un patto scellerato, portando la Repubblica
Italiana alla sua ora più buia. L’obiettivo supposto? Condizionare l’opinione
pubblica italiana, spaventata da una serie di attentati ben orchestrati,
affinché la colpa ricadesse sugli “opposti estremi” e i voti confluissero verso
il più rassicurante centro democristiano. In seguito alla strana morte
dell’anarchico Pinelli il movimento extraparlamentare Lotta Continua indicava il
commissario Luigi Calabresi come il responsabile, oltre che esecutore materiale,
della morte di Pinelli, avvenuta probabilmente (sempre secondo LC) per un colpo
di karate ben assestato. Il 10 giugno 1971 il settimanale L’Espresso pubblicò
una lettera aperta sul caso in questione. In questa lettera si formulavano una
serie di accuse a persone che avrebbero condizionato il processo in favore del
commissario Calabresi, avvalendosi della “indegna copertura concessagli dalla
Procura della Repubblica”, dando per scontata l’uccisione di Pinelli per mano o
responsabilità diretta del commissario Calabresi. La lettera era “rivolta ai
commissari torturatori, ai magistrati persecutori, ai giudici indegni” e si
chiedeva (leggesi pretendeva) l’allontanamento di costoro dai loro uffici, in
quanto si rifiutava di “riconoscere in loro qualsiasi rappresentanza della
legge, dello Stato, dei cittadini”. La lettera, partendo da 10 firme iniziali,
arrivò, al momento della pubblicazione, al numero di ben 757 personalità di
spicco della società italiana, comprendendo la quasi totalità
dell’intellighenzia della Sinistra di allora e di oggi, ma non solo. Tra questi
nomi si ricordano, in ordine sparso, quelli di: Norberto Bobbio, Umberto Eco,
Dario Fo, Franca Rame, Margherita Hack, Giorgio Bocca, Eugenio Scalfari, Inge
Feltrinelli, gli Editori Laterza, Giulio Einaudi, Federico Fellini, Paolo Mieli,
Tinto Brass, Luigi Comencini, i fratelli Taviani, Bernardo Bertolucci, Pier
Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, Folco Quilici, Carlo Levi, Alberto Moravia,
Dacia Maraini, Alberto Bevilacqua, Primo Levi, Giancarlo Pajetta, Furio Colombo,
Camilla Cederna, Tiziano Terzani, Toni Negri e i fratelli Carlo e Vittorio Ripa
di Meana. (Qui l’elenco completo dei firmatari. Vedere per credere). Il Premio
Nobel Dario Fo, in seguito alla firma, ebbe pure la brillante idea di portare in
scena lo spettacolo Morte accidentale di un anarchico. In tale spettacolo
Calabresi era soprannominato “il Commissario Cavalcioni” a causa della strana
usanza da lui praticata nei confronti degli interrogati, messi, appunto, a
cavalcioni di una finestra, per poi, ovviamente, farli cadere giù. Nella lunga
video-intervista che tenne Alain Elkann con Indro Montanelli negli anni Novanta
per la Storia d’Italia, il buon vecchio Indro, ebbe a dire di Calabresi quanto
segue: “Se c’era un funzionario corretto e che veniva portato ad esempio da
tutti i suoi colleghi questi era Calabresi”. E poi ricordò un piccolo dettaglio:
“Calabresi non era in questura nel momento in cui avvenne il fattaccio”. Ma
erano anni in cui il vento del conformismo tirava a sinistra e la verità veniva
dettata dagli dei del proletariato armato. Quella lettera risuonò come una vera
e propria condanna a morte. Tant’è che un anno dopo la sua pubblicazione, Luigi
Calabresi verrà freddato dai sicari di Lotta Continua. Giustizia proletaria fu
fatta. Era il 17 maggio del 1972. Solo pochi giornalisti italiani non si unirono
al coro. Tra loro Giampaolo Pansa (unitosi oggi ad un altro coro), Massimo Fini
e il già citato Indro Montanelli. Il caro Indro, a causa della sua dissidenza
nei confronti della linea editoriale filobrigatista che il Corriere della
Sera pareva aver assunto in quegli anni, lasciò, nauseato, la redazione del
giornale ritirando la sua penna. Il 2 giugno 1977, Montanelli fu “gambizzato” da
parte delle Brigate Rosse. Ne uscì vivo, con qualche ferita alle gambe. Non si
saprà mai chi fu il mandante. Si mormorò però che, come in altri casi analoghi,
in qualche salotto-bene della sinistra di allora si brindò all’evento. Sofri, ha
ricordato Montanelli, scrisse una lettera alla vedova Calabresi in cui negava di
esser stato il mandante dei sicari di suo marito. Si assumeva però, in
quell’occasione, la responsabilità per aver contribuito a creare l’atmosfera che
condusse all’assassinio del marito. E di ciò le chiese perdono. Venti anni dopo
l’omicidio Calabresi, L’Europeo mandò un redattore ad intervistare i firmatari
dell’appello di Lotta Continua per rendergliene conto: dissero di non
ricordarsene più. Montanelli, nell’intervista con Elkann, ebbe a dire: «Nessuno
di loro ha fatto atto di contrizione. Gli unici che lo hanno fatto sono stati
quelli che si trovano in galera». Quando si dice: “ne ammazza più la penna”…
Oggi, Giampiero Muhgini, insieme a Fulvio Abbate, ha ricordato i fatti narrati
alla telecamera di Teledurriti. E bisogna rendergliene atto, dato che Mughini
stesso fu uno dei giovani esaltati di Lotta Continua. Ma la sua firma, a quella
dannata lettera, non comparve. Per chi avesse l’interesse e il coraggio di
ripercorrere quegli anni e quelle vicende, può trovare tutto nel saggio di
Michele Brambilla L’eskimo in redazione. Quando le Brigate Rosse erano
“sedicenti”.
Quei giornali che negavano
le Br. ll
nuovo libro del conduttore di Matrix, giornalista liberale, contro i concreti
pericoli del pensiero unico, scrive Nicola Porro il 9 Ottobre 2016 su "La
Gazzettadiparma.it". C’è un libro che le nuove generazioni, specialmente,
dovrebbero leggere. Per la verità è consigliabile anche a quella fascia di ex
giovani nati agli inizi degli anni settanta, dunque troppo giovani per sapere
cosa stesse succedendo in Italia nei loro primi anni di vita. Scritto nel 1991
da Michele Brambilla, si intitola «L’eskimo in redazione». Varrebbe la pena
leggerlo per due ordini di motivi. Il primo è contingente: anche oggi siamo in
una situazione paragonabile, immersi in un pensiero unico sul fenomeno del
terrorismo islamista. Chi pensa che accoglienza e integrazione siano due
etichette vuote, chi ritiene che il fenomeno non derivi da presunte colpe
dell’Occidente, chi denuncia la violenza fondamentale di certe interpretazioni,
molto diffuse, del Corano, viene trattato come un paria. C’è poi una ragione più
storica: occorre conoscere bene il livello di cialtroneria che ha caratterizzato
la nostra classe giornalistica e culturale nel ventennio del terrorismo. Uno dei
più delicati della nostra breve stagione repubblicana. Che poi sono gli stessi
intellettuali che si sono «fatti» establishment spiegando alle nuove generazioni
quali errori non fare, proprio loro che ne hanno commessi un’infinità.
Criticavano il presunto «regime» di allora per trovare un posto al sole e,
quando ci sono riusciti, hanno messo in opera esattamente il medesimo modello di
controllo degli spazi culturali che criticavano negli anni settanta. D’altronde
era la generazione che inventò lo slogan giornalistico, alla luce di ciò che
avvenne, più ridicolo del secolo: «i fatti separati dalle opinioni». Brambilla
ci racconta bene come le cronache erano per lo più ideologiche, altro che
opinioni. Sentite cosa scriveva l’inventore del fortunato slogan, Lamberto
Sechi, del «Giornale» di Montanelli: «Quando ‘il Giornale’ finanziato da Cefis
commemora, nel settimo anniversario della morte di Giovanni Guareschi, un uomo
che ha dedicato la maggior parte della sua vita alla denigrazione
dell’antifascismo e della repubblica, qualsiasi fascista ha diritto di sentirsi,
nonché giustificato, riverito, degno di un medaglione su uno di molti (ormai
quasi tutti) giornali di regime». Insomma «il Giornale» non poteva e non doveva,
secondo l’autorevole opinione dell’inventore dei fatti separati dalle opinioni
(regola a cui si sarebbero dovuti attenere tutti i giornalisti a eccezione
dell’inventore della stessa), commemorare nell’anniversario della morte il padre
di Don Camillo e Peppone, uno degli autori più amati dagli italiani. Come scrive
il Nostro, bastava questa commemorazione «per essere ritenuti non solo dei
fascisti, ma addirittura dei complici morali dei bombaroli che sterminavano
innocenti sui treni». Il racconto di Brambilla è il racconto di un orrore a cui
solo pochi si seppero sottrarre: Montanelli, Pansa, Casalegno, Tobagi. È
l’orrore, come detto, per il quale nei giornalisti degli anni settanta
l’ideologia veniva prima della cronaca. L’orrore per il quale le campagne di
stampa hanno armato la mano che ha ucciso il commissario Calabresi. Camilla
Cederna (bisognerà dire una volta che non merita neanche un centesimo della
correttezza e della fama di cui ancora gode) disse che Calabresi aveva
interrogato l’anarchico Pinelli «per 77 ore ininterrotte». Totalmente falso.
«Lotta continua» e «l’Unità» si inventarono che Calabresi era un agente della
Cia. Totalmente falso. Fu «Lotta continua» a scrivere: «Luigi Calabresi deve
rispondere pubblicamente del suo delitto contro il proletariato. E il
proletariato ha già emesso la sua sentenza: Calabresi è responsabile
dell’assassinio di Pinelli e Calabresi dovrà pagarla cara». E ancora: «Sappiamo
che l’eliminazione di un poliziotto non libererà gli sfruttati, ma è questo
sicuramente un momento e una tappa fondamentale dell’assalto del proletariato
allo stato assassino». E quando Calabresi sporse querela 44 redazioni di riviste
politiche e culturali (tra cui alcune cattoliche) sottoscrissero un documento di
solidarietà a «Lotta continua». Brambilla racconta l’orrore orwelliano del
pensiero unico per cui i manifesti della gente per bene erano firmati da Eco e
da Fo, da Scalfari e da Mieli. Manifesti in cui si scriveva: «Combattere un
giorno con le armi in pugno contro lo stato fino alla liberazione dai padroni e
dallo sfruttamento». E pensare che tanti di quelli che all’epoca firmarono oggi
sono i padroni. L’orrore per il quale, nonostante tutte le evidenze, giornalisti
come Bocca, Sechi (pensate un po’, ancora considerato un mito del giornalismo),
Galli e mille altri ci hanno raccontato per anni che le Brigate rosse erano
sedicenti, e che piuttosto era in corso una strategia della tensione sotto la
regia della destra. L’orrore della signora Cederna (quanto continua a essere
celebrata) che nel 1972 aveva il coraggio di scrivere sull’«Espresso»: «Ho
capito da sola in questi anni come è scomodo essere in una minoranza
specialmente quando si ha ragione». Poco più giù diceva che Feltrinelli era
stato ucciso chissà da chi e non, come si seppe qualche anno dopo (ma tutti
sapevano anche allora), per un incidente sul lavoro, piazzando un ordigno su
quel traliccio. E la sua supposta minoranza era, piuttosto, la maggioranza degli
intellettuali dell’epoca. Brambilla fa un lavoro grandioso: mette in fila questa
galleria degli orrori, fa nomi e cognomi, cita date e giornali e mette in
evidenza questo impasto di conformismo e di vigliacca omologazione. Merita un
posto d’onore in questa nostra Biblioteca liberale, anche se non si tratta di un
saggio economico, non affronta questioni filosofiche, ma meglio dei primi e dei
secondi racconta il buio della ragione che ha contraddistinto i nostri
intellettuali e la nostra cultura. Il fenomeno non era confinato certamente alla
sola Italia. I paesi anglosassoni hanno però poi saputo combattere contro questo
piatto e ormai canuto conformismo culturale. Oggi la cultura del dubbio, il
punto di vista dell’individuo contro quello della massa, il privilegio del
pensiero contro il gusto della moda restano merce rara. Negli anni settanta gli
intellettuali, che bene descrive Brambilla, erano affascinati dalla rivoluzione
e disgustati dalla cosiddetta maggioranza silenziosa. Avevano clamorosamente
ingannato e oggi le giovani generazioni e quelle di mezzo pendono dalle labbra
di questi vecchi tromboni che hanno sbagliato tutto e dai quali si attendono uno
strapuntino o almeno un decente assegno consegnato a margine di uno dei tanti
ridicoli premi giornalistici da strapaese che i vecchi arnesi controllano con
efficacia.
Le Brigate Rosse e i
quotidiani francesi dal caso Sossi alla tragedia Moro,
scrive Eleonora Marzi.
Riassunto. Le Brigate Rosse
sono state un fenomeno sociale e politico controverso che ha creato una frattura
nella società italiana e nel mondo politico degli anni Settanta. Il presente
articolo si propone di analizzare le pubblicazioni che il quotidiano Le
Monde diede del fenomeno in due momenti cruciali: la nascita delle Brigate Rosse
come soggetto mediatico con il rapimento del giudice Mario Sossi nel 1974, e il
suo gesto più eclatante, il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro nel 1978. Così,
attraverso un’analisi dei pezzi di giornalismo di quel periodo è possibile
prefigurare lo scenario di comprensione e il messaggio che conseguentemente
venne trasmesso al paese.
Indice
1. Il sequestro Sossi o
«l’operazione girasole»
1.1 Il dato storico: il
sequestro
1.2 Le particolarità del Caso
Sossi e il percorso identificativo delle BR
2. I quotidiani e le Brigate
Rosse: un nuovo e misterioso soggetto politico si affaccia sulla scena mediatica
2.1 Le Monde e gli
«sconosciuti armati»
3. Il caso Moro o
«l’operazione Fritz»: l’apice delle Brigate Rosse
3.1 Il dato storico: tra via
Fani e via Caetani
3.2 L’analisi di Le Monde: chi
sono le Brigate Rosse?
Testo integrale. Le Brigate
Rosse sono state un fenomeno sociale e politico controverso che ha spaccato la
società italiana e il mondo politico degli anni Settanta. Ancora oggi è un caso
che continua a dividere il mondo degli studiosi, anche a causa delle discordanti
testimonianze dei protagonisti: si tratta infatti di un soggetto scivoloso, la
cui ricostruzione storica presenta numerose zone d’ombra. Uno dei principali
ostacoli alla carenza di esattezza storica consiste nella mancata
metabolizzazione del fenomeno da parte degli italiani. É perciò interessante
fornire un punto di vista altro, esterno, alla cui prospettiva storica si unisce
l’analisi testuale dei pezzi di giornalismo in un epoca nella quale i fatti
quotidiani erano la principale fonte di informazione – internet non esisteva – e
la neo-arrivata televisione si posizionava ancora in una zona di consumo di
nicchia. Si è scelto dunque di analizzare, attraverso le pagine del
quotidiano Le Monde, due momenti storici precisi, la nascita “mediatica” delle
Brigate Rosse – resa possibile dal rapimento del magistrato Mario Sossi, e il
loro atto più eclatante, il rapimento e l’uccisione dell’onorevole Aldo Moro. La
metodologia impiegata per condurre questo lavoro unisce in un discorso che si
vuole pluridisciplinare la storia e la cultura italiana ad una forma di critica
giornalistica che si concentra sia sui contenuti che sulla loro presentazione
formale. Prima di affrontare il discorso sulla comunicazione si rende necessario
compiere un breve excursus al fine di presentare utili elementi storici per una
migliore comprensione.
1. Il sequestro Sossi o
«l’operazione girasole».
1.1 Il dato storico: il
sequestro. Il 18 aprile 1974, il sostituto procuratore della Repubblica di
Genova, il dottor Mario Sossi viene rapito da un commando armato, facente parte
del gruppo di lotta marxista-leninista delle Brigate Rosse. La condizione per la
liberazione del rapito è la scarcerazione e il successivo espatrio dei
componenti della «XXII Ottobre», un gruppo di attivisti di sinistra i cui membri
sono stati precedentemente condannati per diversi atti criminosi1. In realtà la
tattica del sequestro si inscrive in una più ampia strategia volta ad indebolire
lo Stato: le BR sono infatti convinte che in Italia vi siano le condizioni per
una rivoluzione che però non si concretizzano per la mancanza di una guida
rivoluzionaria e per il “tradimento” del Partito Comunista Italiano, oramai
integrato nelle istituzioni. I brigatisti intendono perciò colpire con la lotta
armata “l’ordine borghese”, così da mostrarne la debolezza, risvegliare la
coscienza rivoluzionaria delle masse e porre le basi di una sollevazione. Le BR
con il sequestro Sossi, anche detta «l’operazione girasole» decidono e attuano
ciò che verrà descritto come «l’attacco al cuore dello Stato»; se
precedentemente infatti si erano limitate ad azioni di propaganda “pacifica” con
quest’azione compiono un passaggio ulteriore iniziando un percorso che sfocerà,
come vedremo, nel drammatico epilogo del rapimento e della morte di Aldo Moro.
Intendono dunque compiere un salto di qualità, adeguandosi al corso degli eventi
che, a loro giudizio, costringe ad alzare il tiro rispetto alla precedente fase
della propaganda armata. Da un opuscolo interno al movimento risalente al 1974
si legge: […] Perché se è vero che la crisi di regime e la nascita di una
controrivoluzione agguerrita e organizzata sono il prodotto di anni di dure
lotte operaie e popolari, è ancora più vero che per vincere il movimento di
massa deve oggi superare la fase spontanea e organizzarsi sul terreno strategico
della lotta contro il potere. E la Classe Operaia si conquisterà il potere solo
con la lotta armata. Il procuratore Mario Sossi sarà detenuto per la durata di
35 giorni. Lungo questo arco di tempo l’opinione pubblica e le istituzioni, si
divideranno su due linee contrapposte: l’una di intransigenza, la «linea della
fermezza» (incarnata dal governo, dalla Democrazia Cristiana e dal Partito
Comunista Italiano) l’altra d’apertura alla trattativa da parte di associazioni
come «magistratura democratica». Le trattative per la scarcerazione sembrano
concretizzarsi, ma il procuratore della Repubblica Francesco Coco si oppone al
provvedimento; sebbene le richieste non vengano esaudite le BR rilasciano
comunque Sossi in buone condizioni di salute. Il loro scopo, ovvero mostrare
come lo Stato non sia in grado di proteggere i cittadini, è stato raggiunto.
Hanno rapito e detenuto per 35 giorni un sostituto procuratore della repubblica,
lo hanno interrogato, ed hanno confermato la loro analisi dello e sullo stato
“borghese-canaglia”: nutrito da politiche farraginose, dedito alla pratica del
sotterfugio e succube del capitalismo. Inoltre l’opinione pubblica, tacitamente
e velatamente, le percepisce come un gruppo criminale “cavalleresco” per aver
rilasciato il detenuto nonostante il mancato accordo.
1.2 Le particolarità del Caso
Sossi e il percorso identificativo delle BR. L’importanza del caso Sossi, nella
logica delle BR, è specialmente di natura propagandistica. Innanzitutto le BR si
presentano all’opinione pubblica in modo organizzato, introducono il proprio
programma, la propria ideologia e iniziano massicciamente quell’azione di
chiamata alla lotta armata indirizzata alla classe proletaria. I terroristi
sanno perfettamente che la loro richiesta è troppo alta per essere soddisfatta.
Ciò che davvero gli interessa è la presentazione di loro stessi al paese,
l’accertamento della veridicità delle loro tesi riguardo il tessuto politico, la
risposta sociale alle loro azioni e la verifica della strategia mediatica che
rappresenterà un punto cardine dei loro futuri attacchi. Il mezzo del
“comunicato”, che troverà larghissimo impiego durante il sequestro Moro, inizia
qui il suo percorso come strumento informativo e propagandistico per eccellenza,
in grado di unire con un comune filo la stampa, il potere istituzionale e
l’opinione pubblica in un gioco di specchi estremamente complesso. Il governo,
il popolo e la comunicazione: il triangolo perfetto lungo il quale le BR
giocheranno la loro partita al fine di istaurare ciò che definiscono lo «Stato
proletario».
2. I quotidiani e le Brigate
Rosse: un nuovo e misterioso soggetto politico si affaccia sulla scena
mediatica. 8Come per un meccanismo di specchi riflessi, all’esordio delle BR
sulla scena mediatica, lo sforzo maggiore dei quotidiani è diretto ad inquadrare
e comprendere questo “nuovo” soggetto. Il tempo impiegato dai giornali a
focalizzare il fenomeno, a definirne le dimensioni e a comprenderne le
conseguenze fu determinante per il tipo di informazione che venne veicolata.
Sulla scena nazionale ed internazionale si affaccia un nuovo protagonista:
presenta tratti clandestini, usa le armi per portare a termine azioni criminali
a fini politici e informa delle proprie rivendicazioni e dei propri programmi
ideologici sia la classe governativa che l’opinione pubblica utilizzando dei
“comunicati”. Non si tratta dunque di comuni malavitosi, ma di un gruppo che ha
fini e scopi ben precisi che per i contemporanei risulta estremamente difficile
chiarire. Al momento della loro comparsa sulle pagine dei quotidiani riguardo le
BR si ipotizza tutto l’ipotizzabile. Il nome del gruppo armato è
sistematicamente riportato tra virgolette, ad indicare un dubbio generico
rispetto le reali origini e le motivazioni che muovono i combattenti. Ed è
proprio questo clima di smarrimento a dare adito alle più fantasiose ipotesi con
interrogativi che sui giornali francesi si accavallano in merito al colore
politico dell’organizzazione, alla composizione e alla strutturazione del gruppo
stesso. Come si vedrà nel corso dell’articolo il tema della reale identità delle
Brigate Rosse sarà ampiamente indagato dai quotidiani, rappresentando in questo
modo uno dei fulcri d’interesse del discorso mediatico e inoltre il punto
d’incontro delle differenti interpretazioni provenienti dai vari Stati d’Europa.
2.1 Le Monde e gli
«sconosciuti armati». Le Monde informa del sequestro Sossi nell’edizione del 20
aprile con un pezzo di Jacques Nobécourt in terzo taglio dal titolo: «Il
sostituto procuratore di Genova è stato rapito da sconosciuti armati». La
notizia è pubblicata due giorni dopo del fatto, elemento normale in epoca non
ancora digitale, sebbene dia anche la misura di una attenzione di grado medio
verso la notizia. É significativo come essi vengano definiti come degli
“sconosciuti” anche se l’articolo si interroga sulla natura dell’organizzazione,
pur non inoltrandosi in supposizioni caotiche; si limita a riportare il fatto
certo. Nell’introduzione del pezzo la notizia è riportata con stupore: L’evento
più spettacolare è il rapimento a Genova, giovedì alle nove, del sostituto
procuratore della Repubblica, Mario Sossi, un uomo di quarant’anni che è uno dei
giovani magistrati italiani più controversi degli ultimi anni. Il cronista,
proseguendo il racconto del sequestro, riferisce: Mario Sossi rientrava a casa
in autobus e davanti il suo domicilio alcuni uomini tra i venticinque e i
trent’anni, secondo i testimoni, vestiti elegantemente e senza alcuna maschera,
lo hanno costretto, minacciandolo con un’arma, a salire su un furgone. Il
particolare dell’aspetto dei rapitori, eleganti e a viso aperto, deve aver
colpito gli osservatori dell’epoca, ed è un elemento che colora di mistero
l’identità del gruppo. Le Monde mostra cautela quando nell’individuazione del
gruppo terrorista modifica lo status di «sconosciuti» precedentemente attribuito
alle BR: «In alcuni comunicati trovati in una cabina telefonica, le “brigate
rosse” rivendicano la responsabilità dell’operazione». L’atteggiamento è cauto,
ben riscontrabile attraverso l’utilizzo delle virgolette che mantengono il
soggetto terrorista in un campo di indefinitezza. Tuttavia il comunicato viene
preso in considerazione, seppure non assunto a prova di certezza: Il
ritrovamento dei comunicati non prova assolutamente che le «brigate rosse»
esistano realmente, né che si tratti di un’organizzazione di estrema sinistra.
Tuttavia, la personalità del magistrato tende a far credere che l’operazione è
stata condotta da estremisti di sinistra. L’atteggiamento cauto porta Le Monde a
non assumere posizioni nette in mancanza di dettagli. Gli unici elementi che
potrebbero concorrere all’individuazione dell’identità sono di natura storica:
Lo stesso modus operandi era stato utilizzato in dicembre in occasione del
rapimento di uno dei capi del personale della Fiat a Torino. Questi era stato
rilasciato dopo qualche giorno e i suoi rapitori, che si dichiaravano ugualmente
appartenenti alle «brigate rosse», facevano apparentemente parte di un gruppo
isolato, senza alcun legame con altre organizzazioni politiche. Le Monde si
posiziona su una linea corretta nel non attribuire legami con altre
organizzazioni politiche: in termini generali, alla data del rapimento, ogni
interrogativo è aperto, l’orientamento politico del gruppo armato resta non
definito così come la loro ideologia, e gli scopi che si prefiggono attraverso
le loro azioni. Nel corso del sequestro l’attenzione del quotidiano sarà
fortemente polarizzata sul comportamento tenuto dalla magistratura e sugli
effetti che il ricatto delle Brigate rosse ha sulle relazioni tra questa e il
governo. Il tema dell’identità delle BR non viene affrontato nella sua totalità,
contentandosi di qualche definizione qua e là e più spesso di citazioni
provenienti dalla stampa italiana. É questo il caso dell’edizione del 25 aprile,
quando a seguito di un messaggio dell’ostaggio, viene sospesa dalla procura di
Genova l’indagine su quest’ultimo. Il quotidiano riporta la reazione de La
Stampa: La Stampa esprime un sentimento generalmente diffuso affermando che «il
blocco dell’inchiesta non può non apparire come un gesto di abdicazione dello
Stato». […] Ciò suscita sgomento, provoca un sentimento di sfiducia nei
confronti del potere e della capacità di resistenza delle istituzioni davanti a
tali fenomeni. Era permesso ai magistrati genovesi, direttamente implicati, di
inclinarsi davanti alla sfida terrorista?. Il quotidiano si ferma alla
definizione di “sfida terrorista” ma i moventi e le ideologie che vi si celano
restano ignoti, come viene sottolineato in seguito: «Gli inquirenti sembrano
convinti che il giudice sia detenuto a Genova, ma la natura delle “brigate
rosse” resta misteriosa». Nell’articolo del 22 maggio «La sorte del giudice
Mario Sossi non è stata svelata dai suoi rapitori» è riportato il punto di vista
de l’Unità «L’Unità, organo del P.C.I. denuncia il fallimento di tutte le
inchieste fatte per «smascherare e punire» le Brigate rosse e richiede che la
«democrazia italiana si difenda da tutti gli attacchi e, in primo luogo, contro
dei tali gesti criminali». Le linee utilizzate per definire i brigatisti si
orientano intorno ad una definizione di criminalità, a volte di terrorismo, ma
senza alcun riferimento al quadro ideologico che muove le loro azioni. Sulle
reazioni provocate all’interno del potere giudiziario di cui tratta l’articolo
del 14 maggio «Il caso Sossi accentua i dissensi all’interno della
magistratura» il quotidiano tuttavia definisce una caratteristica brigatista
quando scrive: […] si tratta della credibilità de la magistratura, e in
particolar modo del ministero pubblico. Su questo punto, le Brigate rosse –
qualunque sia il loro orientamento politico – hanno ottenuto una vittoria
portando Mario Sossi, nelle sue lettere successive, a rinnegare il rigore delle
sue proprie requisitorie e gettando dunque il dubbio su ciò che ispirava la sua
interpretazione della legge. Si noti come l’orientamento politico delle Brigate
Rosse resti incerto e come ingenerale si proceda a stenti e per piccoli passi
alla definizione della loro identità. Un momento di sblocco può considerarsi
postumo alla liberazione di Sossi in cui Le Monde giunge alle seguenti
conclusioni: «Sossi è in buona salute; è dimagrito di cinque chili, ma la sua
detenzione sembra essersi svolta in discrete condizioni. Poteva leggere i
giornali e non ha mai avuto la sensazione che la sua vita potesse essere in
pericolo». Si tratta di criminali cortesi, elemento ugualmente rintracciabile
quando in cronista riporta le condizioni della liberazione del giudice: […] dopo
aver fatto un viaggio in un furgoncino ed essersi svegliato dopo un lungo sonno
provocato da una bevanda che gli era stata somministrata, Sossi si trovava in un
luogo sconosciuto. Degli occhiali da sole nascondevano i suoi occhi bendati e
aveva su di se un biglietto di prima classe per il tragitto Milano-Genova. […]
Senza difficoltà il magistrato ha preso un taxi, si è recato alla stazione, è
salito su treno ed è rientrato nella propria città. Il quotidiano scrive che i
suoi rapitori hanno provveduto a fornirgli un biglietto di prima classe per il
treno che gli avrebbe permesso di rientrare a casa: non si tratta di riflessioni
esplicite, ma esse lasciano comunque trasparire un atteggiamento di stupore
riguardo la condotta cavalleresca delle Brigate Rosse. Si consideri a questo
proposito che le richieste del gruppo armato non erano state soddisfatte, o
almeno lo erano state per una minima parte. É seguendo questo ragionamento
che Le Monde si pone un interrogativo che trascende la mera cronaca: Per quale
ragione le Brigate Rosse lo hanno liberato? Negli ultimi giorni, la situazione
era sfociata in un’impasse totale, e ugualmente l’esecuzione del magistrato
avrebbe avuto come solo effetto quello di provocare una reazione molto forte,
che i rapitori certamente non si augurano. Si noti come vi sia la certezza che
essi non siano sanguinari né crudeli. Le Monde prosegue nella sua ricerca:
Durante la notte, l’ottavo comunicato delle Brigate rosse è stato trasmesso
al Corriere della Sera per spiegare le ragioni della liberazione di Mario Sossi.
La prima riguarda la decisione della corte d’appello di Genova che ha deciso di
accordare la libertà provvisoria all’ottavo condannato del processo del 22
ottobre. La seconda motivazione apportata dalle Brigate rosse riguarda la
volontà di «combattere fino alla fine». La conclusione del comunicato è la
seguente: «Il significato strategico della nostra scelta è più chiaro che mai:
la classe operaria prende il potere unicamente attraverso la lotta armata». Le
Monde – a differenza di altri quotidiani, come ad esempio Le Figaro – non
riporta la totalità del comunicato ma si limita a pubblicare singole frasi
direttamente provenienti dal documento brigatista, commentando e deducendo. Lo
scopo dei brigatisti, secondo Le Monde, è la strategia di lotta armata per il
proletariato. Si tratta comunque di una consapevolezza ancora embrionale, con le
zone d’ombra che prevalgono sulle conoscenze acquisite. Il ritratto dei
terroristi è dunque qualcosa che resta nel vago, si comprende che la loro
matrice è politica, si immagina un’appartenenza allo schieramento di sinistra ma
molti sono i punti che rimangono in sospeso. In generale l’informazione è ben
coperta con una presenza di 35 articoli su venti giorni; non vi sono mai prime
pagine e gli articoli vengono presentati interamente nella sezione della cronaca
internazionale. Questo elemento relativo alla posizione della notizia – che in
analisi giornalistica risulta particolarmente indicativo dell’importanza che
essa ha per l’opinione pubblica – sembra abbastanza naturale trattandosi
effettivamente di cronaca estera: essa cambierà radicalmente durante il caso
Moro – 55 giorni di detenzione – durante il quale la prima pagina sarà
appannaggio della cronaca italiana. Siamo nel 1974, le BR si affacciano sul
panorama politico italiano, gruppo terroristico che in quanto tale si serve
della comunicazione in modo massiccio e importante. L’estremo della loro
attività culminerà quattro anni dopo, nel 1978, allorché l’inasprirsi della
lotta politica e sociale e più in generale un cambiamento del livello di
tensione nella lotta armata porterà il gruppo a compiere un atto estremo: il
rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, l’allora presidente della Democrazia
Cristiana. Anche in questo caso sarà necessario partire dal dato storico al fine
di comprendere al meglio il trattamento che la stampa diede del caso.
3. Il caso Moro o
«l’operazione Fritz»: l’apice delle Brigate Rosse.
3.1 Il dato storico: tra via
Fani e via Caetani. La mattina del 16 marzo 1978 l’onorevole Aldo Moro,
presidente del consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, si sta recando in
Parlamento per assistere al voto di fiducia del IV governo Andreotti, formatosi
l’11 marzo 1978. L’esecutivo – risultato di una tela tessuta congiuntamente da
Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, segretario nazionale del Partito Comunista
Italiano – è la sublime espressione delle convergenze parallele, e consiste in
un governo monocolore con l’appoggio esterno dei comunisti, oltre che dei
socialisti, dei repubblicani e dei socialdemocratici, entrato nella storia della
Repubblica come compromesso storico25. Il ragionamento che porta alla necessità
di creare un governo di solidarietà nazionale deriva dall’analisi dello stato di
salute della società italiana, solcata dal disagio economico e dalla
recrudescenza sociale. Quella stessa mattina del 16 marzo tra le 9.00 e le 9.15
in via Mario Fani a Roma un commando delle Brigate Rosse rapisce l’onorevole
Aldo Moro e a colpi di mitragliatrice fa strage della sua scorta, composta da
cinque uomini; l’azione è rapida e precisa, l’ostaggio non viene ferito ma
caricato di una FIAT 125 e fatto sparire nel nulla. Ha inizio ciò che i
terroristi preparavano da mesi: l’operazione Fritz. Il paese è sotto shock e la
mobilitazione militare immediata con il dispiegamento di 6000 uomini delle forze
dell’ordine lanciate in una massiccia caccia all’uomo. Perché le BR compiono un
tale gesto? Moro appare ai loro occhi uno dei massimi responsabili delle
ingiustizie e dei crimini commessi da quello che chiamano lo Stato Imperialista
delle multinazionali, in qualità di protagonista della politica italiana da
circa un ventennio. Per accertare le sue colpe nei confronti della classe
proletaria, come capo e come rappresentante della DC, lo rinchiuderanno in una
“prigione del popolo” sottoponendolo ad un processo ad opera del “tribunale del
popolo”. Attraverso un’approfondita analisi dei loro documenti si possono
rintracciare due tipologie di conseguenze che essi auspicavano; la prima era di
natura strategica e in linea con l’attività propugnata fino a quel momento: la
destabilizzazione dello Stato. La seconda era di natura ideologica: essi
volevano ricevere lo status di interlocutori, anche se loro malgrado. Dichiara
Moretti: Avremmo liberato Moro e si sarebbero spostati gli equilibri politici:
chi, Pci o altri, avesse preso atto della nostra esistenza, avrebbe tentato un
nostro recupero, un rientro, avrebbe fatto politica e rafforzato la sua
contrattualità. Per avere un quadro generale del caso Moro occorre inoltre
analizzare brevemente quali furono le posizioni incarnate ufficialmente dalle
istituzioni. Fin dal principio infatti erano emersi due fronti: quello della
fermezza, che niente avrebbe concesso ai terroristi, di cui facevano parte il
PCI e la Democrazia Cristiana, e quello della trattativa, disposto a scendere a
compromessi per il costo di una vita umana che comprendeva il Partito Socialista
Italiano e il Vaticano. Ma quali furono le reazioni del fulcro di tale vicenda,
del prigioniero Moro? Egli scrisse una grande quantità di materiale tra cui
lettere, testamenti, promemoria e biglietti. Redasse 87 lettere, 27 furono
recapitate di cui 16 destinate ad alte personalità politiche ed istituzionali.
In questi scritti – mappatura della distribuzione del potere all’epoca – si
trova tutto il tentativo di Moro di portare il suo partito ed il paese verso il
fronte della trattativa. Salvarsi così la vita, «impedendo non in ultima analisi
una frattura irreparabile nell’ethos della democrazia italiana». Purtroppo
queste dichiarazioni scatenarono delle reazioni degli uomini di partito, i quali
negarono alle parole di Moro prigioniero ogni validità etica e morale,
ipotizzando uno stato psichico non attendibile. Le Brigate Rosse comunicano con
l’esterno attraverso dei comunicati nei quali informano dello stato di salute di
Moro e delle loro richieste. Il ritmo dei comunicati cadenza tutto il sequestro;
si è arrivati al n° 6 quando il 15 aprile giunge una risoluzione che appare
irremovibile «Aldo Moro è colpevole e viene perciò condannato a morte». Il
subbuglio negli ambienti politici è massimo, l’opinione pubblica è sconcertata;
il quotidiano italiano Il Messaggero riceve una telefonata che annuncia il luogo
per il ritrovamento del comunicato n° 7. Secondo quest’ultimo, Moro sarebbe
stato ucciso e il suo cadavere si troverebbe nei fondali del lago Duchessa,
nella regione limitrofa a Roma. Vengono dispiegate migliaia di forze dell’ordine
e sommozzatori ma dopo ore di ricerche del cadavere non v’è nessuna traccia. Si
tratta di un comunicato falso, opera del magistrato Claudio Vitalone, scritto al
fine di informare i terroristi che i servizi segreti erano in grado non solo di
controllare le loro mosse, ma anche di occupare e manipolare i loro stessi
canali mediatici. Il 20 aprile le BR fanno pervenire alla redazione
di La Repubblica il vero comunicato n° 7 a cui è allegata una foto di Moro con
in mano il quotidiano, ad indicare che egli è vivo, e all’interno del quale i
brigatisti esplicitano il vero oggetto per salvare la vita di Moro: i tredici
brigatisti detenuti e sotto processo nel tribunale di Torino. Va aggiunto al
dato storico che contemporaneamente al periodo di detenzione dell’onorevole
Moro, si sta svolgendo a Torino il processo contro i capi storici delle BR, tra
cui vi sono Renato Curcio e Alberto Franceschini. I fili che da qui si dipanano
sono incrociati, perché i brigatisti incarcerati rivendicano la responsabilità
del rapimento Moro, creando notevoli problemi giuridici, e simmetricamente nella
seconda parte del sequestro la richiesta dei brigatisti in libertà sarà di
scarcerare quelli in prigione. La risposta ufficiale del governo è del 28
aprile, quando Andreotti in televisione comunica con fermezza il rifiuto delle
istituzioni democratiche alla trattativa con i terroristi. Nonostante un ultimo
appello della famiglia Moro il Governo mantiene la propria linea. Arriva il 5
maggio l’ultimo comunicato n° 9 dove si legge «Concludiamo […] la battaglia
iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato».
Il 9 maggio 1978 sarà un giorno che cambierà per sempre il corso della storia
italiana: in via Mario Caetani, a Roma vicino alle sedi della DC in Piazza del
Gesù e del PCI in via delle Botteghe Oscure, viene ritrovato il cadavere
dell’onorevole Aldo Moro, crivellato da undici colpi di mitragliatore nel
bagagliaio di una Renault 4 rossa. Il paese sprofonda all’istante in uno stato
di shock, le reazioni internazionali irradiano stupore misto ad orrore. La
democrazia italiana non ha ceduto ai terroristi, ma lo ha fatto sacrificando la
vita di un uomo30. Si svolgono dunque il 10 maggio i funerali privati a Torrita
Tiberina; tre giorni più tardi piazza di San Giovanni in Laterano sarà invasa da
una folla di comuni cittadini e presieduta da tutti gli uomini di potere per il
rito funebre di Aldo Moro, senza salma e senza la presenza della famiglia.
3.2 L’analisi di Le Monde: chi
sono le Brigate Rosse? La distribuzione della notizia sulle pagine di Le
Monde risulta di primo impatto: su 55 giorni di sequestro 45 sono coperti dalla
notizia sull’Italia, di cui 17 prime pagine. Rispetto alla copertura del caso
Sossi la percentuale aumenta notevolmente, indice questo di un maggiore
interesse verso la vicenda ma anche di una diversa portata del suo significato,
non perché diverso il valore della vita dell’uomo in questione, ma perché con
Moro entrano in gioco una serie di elementi che investono la totalità delle
istituzioni del Paese e inoltre l’identità delle BR è, ad oggi, abbastanza
chiara da poter far temere il peggio. La notizia del rapimento di Moro viene
data in prima pagina, come articolo di testa in primo taglio. Le Monde rispetto
ad altri quotidiani è piuttosto avaro di immagini; Le Figaro e Libération ad
esempio pubblicheranno la foto che fece il giro dei quotidiani di tutto il
mondo, quella del cadavere di Moro crivellato di colpi nel bagagliaio della
Renault 4 in Via Fani mentre Le Monde si “limiterà” in questo caso a pubblicare
un pezzo di solo testo, occupando però la quasi-totalità della prima pagina
dell’edizione del 10 maggio 1978. Durante tutto il sequestro Moro, dal 16 marzo
al 9 maggio 1978, le Brigate rosse stabilirono un contatto con il mondo
attraverso i comunicati. In questo tipo di azioni il mezzo risulta fondamentale:
il terrorismo si alimenta del rimbalzo dell’informazione spesso trattata in modo
iperbolico e finzionale. Negli anni Settanta, in un’epoca non ancora
multimediale, lo strumento cartaceo assume tutta la sua importanza e il mezzo
attraverso il quale esso viene diffuso – la redazione giornalistica – si trova
nell’occhio del ciclone della nostra analisi. I comunicati delle Brigate rosse
seguivano un preciso iter: venivano nascosti dai “postini” Valerio Morucci e
Adriana Faranda in luoghi pubblici, come cabine del telefono o cassonetti
dell’immondizia, successivamente una telefonata informava uno o più redazioni di
quotidiani sul luogo del ritrovamento. I comunicati, che spesso allegavano le
lettere dello stesso Moro, in sostanza informavano governo e opinione pubblica
sul corso del processo da parte del tribunale del popolo a cui il prigioniero
era sottoposto e illustravano attraverso le analisi brigatiste quali fossero gli
obiettivi che le stesse si propugnavano nell’ambito del loro progetto
rivoluzionario. Il ritmo dei comunicati cadenza tutto il sequestro e di
conseguenza tutta la produzione giornalistica che ad ogni ritrovamento, oltre a
darne il fatto di cronaca forniva anche una serie di approfondimenti e
riflessioni sulla vicenda e sui suoi protagonisti. Per seguire la linea che
avevamo tracciato all’inizio dell’articolo ci concentreremo sulla questione
dell’identità delle BR, elemento che, accanto ovviamente alla cronaca dei fatti,
richiama l’attenzione ei giornalisti e degli osservatori. Due sono i fattori che
concorrono alla discussione sulla loro identità quale si possono rintracciare le
sfumature sfogliando le pagine dei quotidiani. Uno è il lungo calvario dei 55
giorni di sequestro che porta ad un progressivo aumento della percezione della
crudeltà dei brigatisti, il secondo è l’apparente sdoppiamento dei terroristi
presenti come carcerieri di Moro e contemporaneamente come “incarcerati” a
Torino durante il processo al loro «primo gruppo». Questo apparente sdoppiamento
dei terroristi crea una sorta di illusione ottica che spinge ad interrogarsi tra
l’eventualità dell’esistenza di diverse brigate rosse o piuttosto un’evoluzione
in corso all’interno dei quadri del movimento terrorista. Nel 1978 la stampa
francese ha le idee abbastanza chiare su chi siano i brigatisti. Si conoscono il
loro orientamento politico, la loro modalità d’azione, si conoscono i loro fini
e scopi. Ma con il rapimento Moro, le BR realizzano un’azione spettacolare, di
cui nessuno le avrebbe mai ritenute capaci. Vi sono dunque dei nuovi elementi
che la stampa, l’opinione pubblica e la classe politica non hanno l’abitudine ad
affiancare alle BR: ad esempio la scoperta di un’impressionante competenza nelle
armi, elemento risultato dalla perfezione criminale dell’attentato, che farà
nascere l’ipotesi di trovarsi di fronte a dei killer professionisti.
Immediatamente Le Monde mostra un’approfondita conoscenza delle Brigate Rosse.
All’indomani del rapimento di Moro, il quotidiano dà alle stampe un articolo
monografico sulle BR altamente informativo: vi sono riferimenti ai processi in
corso e l’individuazione di Curcio come capo dell’organizzazione è immediata. Le
BR sono « un mouvement d’extrême gauche, partisan de l’action violente »31. Esse
sono precisamente inquadrate e rapidamente viene compresa la loro pericolosità,
più velocemente rispetto ad altri quotidiani, come ad esempio Le
Figaro o Libération. Dalla penna di Robert Solé, alla data del 1 aprile
scaturisce un’efficacie riassunto della situazione in Italia: Gli italiani sono
alle prese con un nemico imprendibile in tutti i sensi. È riuscito a scappare
alla più formidabile caccia all’uomo che questo paese – così poco poliziesco –
ha mai conosciuto dopo la fine della guerra. D’altra parte, i suoi reali
obiettivi sfuggono a tutti colo che vi riflettono con attenzione. Le brigate
rosse sono, effettivamente, completamente scollegate dalla realtà. Esse invocano
un «popolo» che le ignora, si identificano con un «proletariato» che le rigetta.
Ma si mostrano anche estremamente efficaci sia nella strategia delle armi che in
quella della tensione…una «follia lucida» si dice a Roma. Il riconoscimento
della pericolosità delle BR è un tema al quale Le Monde dedica parecchio spazio,
ovviamente specificando che ammettere la loro forza non significa né
legittimarle tantomeno assolverle. Se Le Figaro ha in un primo momento definito
la loro sceneggiatura come «banale», Le Monde non sottovaluta mai il
loro potere, fino ad interrogarsi se esse siano «Les maîtres du jeu»: Nelle
incertezze e nella confusione italiana si impone un dato evidente: le Brigate
rosse stanno riuscendo, ben oltre le loro aspettative, nella loro impresa. Di
fronte allo Stato, questo «contro-Stato selvaggio» di qualche fuorilegge ha
raggiunto i propri obiettivi. Il suo nemico si discredita e si sgretola ogni
giorno di più. Il dibattito di ordine «umanitario» per salvare la vita di Aldo
Moro […] è in fondo un notevole successo del terrorismo. I ritratti delle BR
forniti da Solé e Franceschini con i loro articoli hanno la precisione e
l’esattezza di una biografia storica. Viene ripercorsa più volte nei particolari
la storia del gruppo terrorista, si informa sul loro scopo iniziale di
«costruire un’avanguardia proletaria armata per favorire il potere
rivoluzionario delle classi oppresse che lottano contro il sistema»34.
Indicativo è il titolo dell’articolo: «Delle brigate d’un rosso sospetto». I
particolari seguono, viene ripercorsa la loro “carriera” riportando la svolta
del ’74 con il relativo rapimento del giudice Sossi e la scalata verso l’attacco
al cuore dello Stato. Rispetto ad altri quotidiani Le Monde cerca di scendere in
profondità lasciandosi prendere dalla tesi, molto inflazionata in quel periodo,
di una possibile influenza sul gruppo terroristico delle azioni di CIA o del
KGB; nell’articolo dall’indicativo titolo «Manipolati? E da chi?» Le Monde porta
un’ipotesi, palesa un’esitazione alla quale Solé adduce due argomentazioni: esse
compiono delle azioni per la cui riuscita si necessita di precise informazioni,
e spesso le loro azioni sortiscono l’effetto contrario a quello desiderato. Le
BR mostrano certo le contraddizioni del regime ma «[…] le masse non seguono
affatto la loro “avanguardia”». Le Monde prosegue: Molti uomini politici ne
deducono che queste Brigate di un rosso sospetto sono contemporaneamente
supportate e manipolate. E aggiungono: da servizi segreti stranieri […] Nelle
conversazioni, oltre all’inevitabile CIA, si citano volentieri alcuni paesi
dell’Est, come la Cecoslovacchia...Si tratta di un dubbio legittimo che Le
Monde lascia in sospeso, siglando l’articolo con un sibillino «[…] resta ancora
da provarlo». L’analisi scende nel particolare delle reazioni dell’opinione
pubblica, dove, il ricorso alla violenza riduce gli spazi di simpatia diffusi
soprattutto negli ambienti di estrema sinistra. Il quotidiano scrive: Invece di
minare l’ultra-revisionismo di Berlinguer, le loro azioni spingono senza sosta
il partito comunista verso il potere. Le istituzioni sono senza dubbio
screditate, appaiono certamente alcune contraddizioni dello Stato, ma le masse
non seguono affatto la loro [delle Brigate Rosse] «avanguardia»: al contrario si
mobilitano contro la violenza […]. Le Brigate Rosse sperano forse di attaccare
il forte potere di Roma provocando delle reazioni a catena fino al sollevamento
popolare? Nulla di tutto ciò si è ancora verificato […] ogni volta che un corpo
è crivellato da pallottole, i terroristi si allontanano un po’ di più dalla
popolazione. Le Monde coglie il moto di base della reazione dell’opinione
pubblica, che a prescindere dall’oggetto della contestazione reagisce togliendo
supporto alla causa perché perpetrata con la violenza. Il 24 marzo l’ex sindaco
della città di Torino, democristiano, Domenico Piantone subisce un attentato.
L’evento conduce Le Monde verso un disarmante interrogativo: «Esistono diverse
Brigate rosse?». La vittima viene ferita, non si comprende se lo scopo degli
attentatori è stato raggiunto o se essi avrebbero voluto ucciderlo. Ciò porta
Robert Solé a scrivere: «Questa nuova sparatoria pone varie questioni. Si tratta
di un ritorno alla strategia precedente che puntava delle personalità
d’importanza secondaria e consisteva, una volta su due, a intimidire senza
uccidere?». Secondo i responsabili della DC, il fine degli attentatori era però
quello di uccidere. Le Monde conclude dunque: Sono dunque di un tutt’altro
livello «tecnico» rispetto a chi ha massacrato la scorta armata di Aldo Moro
senza ferire, apparentemente, il presidente della DC. Anche se i due attentati
rientrano all’interno della medesima strategia della «guerra civile
anti-imperialista», nella quale si arrivare a domandarsi se non esistano diverse
«Brigate rosse». La rabbia con la quale i dirigenti «storici»
dell’organizzazione, sotto processo a Torino, rivendicano ogni attentato, la
loro caparbia nel dimostrare ad ogni costo l’unità delle Brigate rosse, sono
sospette. L’interrogativo che si pone Le Monde è analogo a quello di Le Figaro,
le spiegazioni offerte però, differiscono. Per Le Monde l’ipotesi di una doppia
esistenza potrebbe essere legata ad una differente competenza e padronanza della
tattica criminale, da un lato killer professionisti che polverizzano una scorta,
dall’altro goffi tiratori che gambizzano piuttosto che uccidere. Giungiamo
all’epilogo del sequestro e Le Monde annuncia la notizia contenendo il suo
stupore e spiazzamento rispetto all’atroce gesto compiuto dalle BR. Questo è
ovviamente condannato, ma avendo il quotidiano inquadrato con più precisione la
pericolosità dell’argomentazione non mostra eccessivo stupore davanti il
crimine. Le Monde a mezzo di un editoriale del direttore Jacques Fauvet dal
titolo particolarmente emblematico «Illegittima demenza »44 si indigna
addirittura verso coloro che sono stati presi alla sprovvista dal crimine.
«L’assassinio di Aldo Moro ha sorpreso soltanto gli ingenui e gli ottimisti
impenitenti: l’Italia non ha vissuto per cinquantaquattro giorni un qualunque
scherzo di studenti, ma un dramma sanguinario proveniente dal fanatismo più
assoluto »45. Il direttore del giornale sottolinea l’evidenza dell’agguato di
via Fani, che a suo avviso avrebbe mostrato sufficientemente la pericolosità del
gruppo armato. L’epilogo del caso non deve far dimenticare che i commandos delle
Brigate rosse avevano ucciso a sangue freddo le cinque guardie del corpo del
presidente della Democrazia Cristiana per impossessarsi dell’ostaggio: fin
dall’inizio avevano palesato il loro istinto di morte: lo hanno confermato anche
durante la detenzione di Aldo Moro aggiungendo altre vittime al loro sinistro
quadro di caccia. La loro crudeltà era dunque qualcosa di chiaro fin
dall’inizio. Quando Fauvet parla nel suo articolo di illegittima demenza si
riferisce ad uno stato che, seppure fuori dalle forme di pensiero delle persone
“usuali”, non può essere scusato neanche attraverso la disperazione. Si
riferisce alla diabolica sceneggiatura montata dalle BR che mostra «[...] non il
prodotto dell’immaginazione di qualche giovane perduto, deluso, alla ricerca di
un ideale, ma delle menti profondamente perversi, dei maniaci della politica
allo stato peggiore »47. Anche Le Monde, rintraccia i segni di una logica altra,
una logica sanguinaria. In un articolo di Robert Escarpit, egli individua il
loro modus operandi ispirato in «Un culto perverso della personalità »48. Il
cronista motiva: «Rapendo, torturando, massacrando degli individui o giocandoci
come degli ostaggi, hanno rivelato la loro vera natura nella misura in cui
pensavano influenzare in questo modo il destino dei popoli». Le Monde cerca di
scendere nei meandri della buia e oscura logica che spinge i terroristi a
compiere crimini efferati, e se durante il caso Moro, articoli sullo stesso tema
presentavano un tono meno drammatico, ora a disastro avvenuto prendono tinte più
fosche, più accese. L’importante, per Le Monde è scongiurare quella tendenza a
considerare i brigatisti come degli ingenui, degli insoddisfatti, dei disperati:
questo atteggiamento equivarrebbe a sottovalutare la loro vera forza, ossia non
solo quella di essere gente senza scrupoli, ma di avere un piano ben preciso e
soprattutto motivato anche se la legittimazione gli viene da loro stessi.
Escarpit prosegue nella sua analisi: «Tutte le azioni, anche le più orribili,
mostrano una profonda coerenza che esclude le improvvisazioni del cieco
fanatismo». Giunge per Le Monde la condanna circa gli effetti nulli della
campagna delle Brigate Rosse. Con il loro operato, afferma Escarpit, esse non
giungeranno ai cambiamenti da loro auspicati: «[…] nessuno è indispensabile, e
qualunque sia l’importanza politica della loro vittima, questi assassini che non
rischiano neanche la pena di morte vogliono ignorare ciò che ogni terrorista sa:
quando un uomo cade, un altro uomo esce dall’ombra e lo rimpiazza».
Per citare l'articolo.
Eleonora Marzi, «Le Brigate Rosse e i quotidiani francesi dal caso Sossi alla
tragedia Moro», 3/05/2017, su “Revues.univ-tlse2.fr”
I 55 GIORNI DI MORO CHE
CAMBIARONO LA STORIA D’ITALIA.
Sequestro Moro: perché le
prime ricerche fallirono.
Tra riforma dei Servizi, trasferimento di uomini-chiave e mancato coordinamento
passarono i primi 15 giorni. Tra gli errori anche quello di un supercomputer del
Viminale, scrive Edoardo Frittoli il 13 aprile 2018 su "Panorama". Il rapimento
di Aldo Moro aveva colto i Servizi Segreti italiani mentre si trovavano in
una terra di nessuno: una fase transitoria e di completa trasformazione. La
sensazione che la risposta delle Autorità all'azione brigatista
fosse inefficace montò rapidamente in Italia già una decina di giorni dopo la
strage di via Fani. Ma ciò che lascia maggiormente perplessi rileggendo le
cronache di 40 anni fa è che tutto quello che fu costruito per combattere il
terrorismo in quasi un decennio di strategia della tensione era stato
decisamente indebolito in quella cruciale primavera del 1978. Il motivo della
transizione era dovuto alla riforma dei Servizi, che prevedeva un vero e proprio
smantellamento degli organismi precedenti e la formazione dell'UCIGOS (Ufficio
Centrale per le Investigazioni Generali e per le Operazioni Speciali).
La situazione dei Servizi
Segreti. Poco prima del rapimento di Moro diversi funzionari chiave
dell'ex Sisde erano stati trasferiti ad altri incarichi. Si trattava di
dirigenti molto attivi nell'antiterrorismo sin dalla strage di Piazza Fontana.
Uno di loro, Guglielmo Carlucci (ex vicecapo del Sisde) si trovava in Questura a
Milano la sera della morte di Pinelli. Si diceva sapesse ogni
dettaglio sull'organico delle Br, tuttavia allo scioglimento del Servizio era
stato assegnato alla Criminalpol. Il 10 gennaio 1978 era stato trucidato a
Torino proprio dai brigatisti rossi il Maresciallo Rosario Berardi, uno dei
massimi esperti dell'eversione terrorista, mentre il suo collaboratore più
stretto Giorgio Criscuolo era stato inviato in un commissariato di provincia,
proprio come il suo collega toscano Giuseppe Joele. Nel 1974, anno del rapimento
di Mario Sossi era stato istituito proprio per l'emergenza
terrorismo l'SdS (voluto dallo stesso Cossiga) con funzioni soprattutto
operative, mentre il nuovo Ucigos avrebbe avuto funzione squisitamente
informativa, quindi meno "sul campo". Da questo sostanziale caos nella storia
dei Servizi Segreti partirono le prime ricerche della prigione di Moro,
coordinate da un Consiglio di Sicurezza permanente con sede al Viminale e
presieduto dal Ministro Cossiga.
Cervelli umani. Cossiga e il
Consiglio di Sicurezza. Si trattava nella pratica un centro di raccolta delle
informazioni convogliate da tutti gli organi di Pubblica Sicurezza, che si
riuniva due volte al giorno. Ne facevano parte anche politici come il
democristiano Nicola Lettieri (Sottosegretario agli Interni) e il compagno di
partito Francesco Mazzola, nuovo in tale ruolo in quanto nominato il giorno
stesso della strage di via Fani. Oltre al capo del Sisde prossimo alla riforma,
nel consiglio sedeva anche il Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla
Chiesa, che aveva allora l'incarico di responsabile della sicurezza nelle
carceri italiane. Il nuovo Ucigos era rappresentato da un uomo di fiducia di
Cossiga, Antonio Fariello. Sedevano al tavolo infine i comandanti di Polizia,
Carabinieri e Guardia di Finanza.
Fuori, il caos. Il numero del
Viminale, l'ondata di perquisizioni a vuoto. Mentre si susseguivano
i briefing del Consiglio del Viminale, Roma era nel panico. Si parlava
continuamente di possibili attentati ai Ministeri, vi erano continui allarmi
Nato nelle caserme, si temeva ancora il colpo di Stato. E quel che sembrava
peggio era che, con il passare dei giorni, l'iniziale solidarietà degli italiani
uniti nella difesa della democrazia stesse cedendo il passo alla rassegnazione e
ancor peggio alla sfiducia nelle Forze dell'Ordine. Cossiga si era ispirato
ai tedeschi nell'organizzazione delle ricerche e nella strategia di intervento.
Questo perché nel 1977 si era consumato un rapimento che in pratica era
la fotocopia di via Fani. I terroristi rossi della RAF avevano sequestrato il
capo della Confindustria della Germania Ovest Hanns-Martin Schleyer utilizzando
la tecnica del "cancelletto" dopo aver neutralizzato la scorta dell'industriale
tedesco, azione replicata esattamente dalle Br in via Fani. Il Viminale prese
contatti anche con uno psicologo che aveva partecipato alle operazioni di
ricerca di Schleyer, Wolfgang Salewski, e istituì una linea telefonica per la
raccolta di segnalazioni anonime (lo 06/4756989). Il numero fu tempestato di
chiamate spesso di mitomani, medium, veggenti e parapsicologi. Con il passare
del tempo la linea squillò sempre meno, così come si stese gradualmente il
silenzio sulla localizzazione della prigione di Moro. Ma il peggio agli occhi
dei cittadini lo offrirono le sortite isteriche delle Forze dell'Ordine. La
prima e forse la più grottesca fu l'arresto la sera stessa del 16 aprile 1978 di
un funzionario di banca tesserato Dc, Franco Moreno, accusato di essere un
fiancheggiatore delle Br. Passò kafkianamente quattro giorni recluso a Regina
Coeli con l'accusa di "omicidio plurimo e sequestro di persona" prima di essere
rilasciato immediatamente al primo interrogatorio. Nei giorni successivi al
rapimento del segretario Dc, Roma fu un fischiare continuo di sirene che
uscivano giorno e notte dai commissariati coordinati dalla Questura di Roma San
Vitale, che si erano concentrate nei primi giorni di ricerche nella zona
di Monte Mario, nei pressi dell'abitazione della famiglia Moro. In totale
le perquisizioni fino al 3 aprile 1978 saranno ben 233, i fermi 129 e 42gli
arresti, tutti senza esito. Molti degli obiettivi indicati dagli inquirenti
erano palesemente fuori bersaglio: il nervosismo e la fretta avevano portato
la Questura a fare irruzione persino nella libreria alternativa di Roma
"L'Uscita" (letteralmente devastata) e nelle sedi delle radio libere. Non andò
meglio ai Carabinieri in mancanza di coordinamento con la Polizia di Stato
nonostante l'impiego di uomini che negli anni precedenti e sotto la guida
di Dalla Chiesa avevano portato all'arresto di Curcio e Franceschini.
Cervelli artificiali: gli
errori del supercomputer della Questura. Se le menti umane brancolavano nel
buio, non andò diversamente per l'intelligenza artificiale, vale a dire quella
del supercomputer installato negli uffici di PS di Castro Pretorio e fortemente
voluto da Cossiga. Il primordiale cervellone elettronico avrebbe dovuto
incrociare i dati di 10 milioni di schede personali raccolte dai vari organi di
Polizia. Fu un flop clamoroso, perché il computer indicò come responso finale 20
possibili autori del rapimento Moro. L'errore fu subito chiaro in quanto molti
dei terroristi presunti si trovavano già in carcere (e in molti casi per reati
comuni), uno compariva due volte con due nomi e due foto diverse. La tensione
crescente per l'impasse nelle ricerche generò screzi tra il Viminale e le Forze
dell'ordine da questo coordinate, con accuse reciproche di ritardi
nell'organizzazione dei posti di blocco a cui si replicava con la mancata
coordinazione strategica e con la carenza cronica di uomini e mezzi. I sindacati
delle Forze dell'Ordine avevano denunciato all'indomani di via Fani il proprio
malessere per la carenza di almeno 13.000 agenti. Quelli in servizio si
sentivano allo sbaraglio, avevano la sensazione di rispondere ad ordini
inefficaci e talvolta contradditori. Mancavano armi e munizioni e la sicurezza
non era garantita, come aveva dimostrato la mancata dotazione alla scorta di
Moro di auto blindate e giubbotti antiproiettile. In questo
momento difficile Francesco Cossiga si chiuse nel riserbo più assoluto, cosa che
fece irritare non poco l'opinione pubblica a cui fece eco Sandro Pertini, che
più volte aveva punzecchiato il Ministro degli Interni per l'inefficienza
strutturale dei Servizi e delle Forze dell'Ordine.
I militari intervengono.
Inefficienza di un Esercito di soldati di leva. L'ultima decisione presa
dal Viminale nei primi 15 giorni di prigionia di Moro fu quella di coinvolgere
l'Esercito. Non andò meglio, nonostante Cossiga avesse dovuto trattare per due
giorni con i vertici della Difesa. I militari italiani non avevano un piano di
intervento antiterrorismo aggiornato, essendosi fermati alle ultime disposizioni
operative risalenti al golpe Borghese del 1970.
Erano stati ai margini durante
gli anni della strategia della tensione. Il ritardo si palesò immediatamente
anche perchè l'Esercito Italiano era ancora pressochè totalmente formato
da militari in servizio di leva, che furono richiamati in numero di 1,200 per
l'operazione dal nome altisonante di "Cintura di Ferro". Uscirono dalle caserme
romane i mezzi e gli uomini dei Granatieri di Sardegna, i Bersaglieri e gli
Artificieri da Civitavecchia mentre l'unico corpo speciale era rappresentato da
un nucleo di Incursori di Marina trasferiti da La Spezia. I soldati di leva
furono portati nelle strade ad istituire posti di blocco con vecchi fucili
Beretta mod.59 (il Fal) e vetusti Garand tra le lamentele degli ufficiali di
carriera che potevano misurare con mano tutta l'inadeguatezza degli organici
dell'Esercito. Una situazione ben diversa da quella tedesca a cui si era
ispirato il Ministero degli Interni, e lo si era capito dall'azione delle
squadre speciali GSG-9, le teste di cuoio entrate in azione a Mogadiscio per la
liberazione degli 86 ostaggi del volo Lufthansa dirottato dai terroristi come
appendice del tragico rapimento Schleyer.
Il silenzio di Cossiga. Tra le
maglie dei posti di blocco e dei rastrellamenti senza coordinamento, le Br
furono in grado di lasciare impunite il comunicato n.2 nelle principali città
italiane. Parole di sfida dei carcerieri di Aldo Moro che di lì a poco avrebbero
fatto recapitare anche una lettera indirizzata a Cossiga. Parole siglate con la
stella a cinque punte a cui si era contrapposto il cupo silenzio del Ministro,
uomo normalmente incline alle esternazioni.
Sequestro Moro e BR:
"Panorama" e il numero speciale dopo via Fani.
Come il settimanale ha analizzato i fatti dopo il rapimento. Parlano Pertini e i
think tank americani. Si rilegge la storia dell'escalation delle Br, scrive
Edoardo Frittoli il 30 marzo 2018 su "Panorama". Il numero speciale
di Panorama esce nelle edicole il 21 marzo 1978, a 5 giorni dalla strage di via
Fani. Il direttore è Lamberto Sechi, firma l'editoriale Giuliano Amato.
Le "voci della strada" il
giorno della Strage di via Fani. Stefano Benni, che nello 1978 curava la rubrica
"opinioni per la Tv" su Panorama, fa rivivere ai lettori i momenti che
accompagnarono uno dei giorni più drammatici della vita della Repubblica
Italiana. Voci dal mercato, drappelli nei bar davanti alle televisioni poco dopo
la prima diffusione della notizia da parte di radio e televisione. Benni ci
lascia la testimonianza delle voci, delle imprecazioni, delle provocazioni e in
generale dello sgomento e del terrore che il rapimento di Aldo Moro, (che molti
ormai consideravano il prossimo Presidente della Repubblica) aveva pervaso gli
Italiani. Squillano i telefoni delle radio "libere": le voci gracchiano notizie
false tipo "è vero che hanno ucciso i figli di Moro"? ma anche "Giustizia
proletaria è fatta". Alle 10 la Rai manda le prime immagini che Benni guarda in
un bar dove il silenzio e l'emozione sono rotte dalle parole di un anziano:
"Quando hanno sparato a Togliatti non c'erano tutte queste cose qui…". Fuori dal
bar un uomo dice di essere spaventato perché abita sopra una sezione del Pci. Un
altro vuole andare a casa a vedere "la Tv Svizzera, per sapere la verità". La
diffusione della notizia, quarant'anni prima di Twitter, avviene con ogni mezzo.
Anche un sorpasso tra camionisti può funzionare, come raccontato da un
trasportatore dell'ortomercato. Quindi al brusio continuo si sovrappone il
gracchio di un altoparlante di una macchina del Pci che invita alla
mobilitazione immediata dei cittadini, nel nome della solidarietà nazionale.
Mentre passano le drammatiche immagini dell'Alfetta della scorta di Moro
crivellata di colpi, c'è lo spazio anche per qualche frase cinica per
esorcizzare la paura: "scommettiamo che stasera in tv salta anche Scommettiamo".
Allora è davvero "la fine del mondo" è la risposta.
Parla Pertini. Tutto nasce da
una frase pronunciata da Ugo La Malfa poco dopo la strage di via Fani: "siamo in
guerra". E la guerra era proprio ciò che le Br volevano che lo Stato
riconoscesse, argomento chiave del primo comunicato dal rapimento Moro. Il
leader repubblicano è spinto dall'angoscia quando comincia a parlare di
Tribunali Speciali, pena di morte, stato di emergenza nazionale. Gli
risponderà Sandro Pertini, che aveva conosciuto le carceri del ventennio e le
leggi speciali di Mussolini, intervistato da Panorama. Il futuro Presidente
della Repubblica e ex Presidente della Camera è naturalmente molto ferrato
sull'argomento: Più che di "guerra", come paventava La Malfa, Pertini parla una
di guerriglia brigatista descrivendo l'azione intrapresa dai terroristi. E sa
bene per esperienza che la guerriglia può far male, molto male. Era quella unica
forma di lotta possibile che il partigiano Pertini combattè fino al 1945,
sconfiggendo alla fine lo Stato fascista. Da uomo delle istituzioni democratiche
se la prende con i Servizi segreti italiani, a suo avviso inefficienti nel
prevenire l'agguato e il rapimento del Presidente Dc. Il futuro Capo dello Stato
dichiara la propria convinzione che dietro all'azione vi sia una mente
antidemocratica, che vorrebbe far tornare indietro di 50 anni l'Italia. Nel 1972
ebbe a scontrarsi con Francesco Cossiga proprio sull'argomento. Il tono si fa
quindi duro quando Pertini esprime la convinzione che la centrale del terrorismo
sia all'estero, in qualche punto nevralgico parte di una rete internazionale.
Per questo "bacchetta" Cossiga, allora Ministro degli Interni per l'inefficienza
nelle ricerche del covo dove Moro è nascosto. E' pessimista, ma non abbattuto il
leader socialista: ancora una volta il suo sguardo volge indietro al delitto
Matteotti, quando "il delitto vinse come arma politica". Ma nel marzo 1978, dice
Pertini, la situazione è molto diversa. Nessuno si era ritirato sull'Aventino.
Lo sciopero di massa seguito alla strage di via Fani era un segnale della
presenza del Paese, da non sottovalutare e da non abbandonare a sé stessa. La
responsabilità della fiducia al governo Andreotti (pur con tutte le lacune che
Pertini tiene a sottolineare) significa una risposta forte dello Stato contro le
armi delle Br. Che a Pertini rievocano molti fantasmi del passato.
Il punto di vista di Botteghe
Oscure. E' affidata alla parola del deputato milanese Giovanni Cervetti (1933)
la reazione del Partito Comunista Italiano alla strage di via Fani. Cervetti è
membro della Segreteria Nazionale del partito dal 1975 dopo essere stato
segretario della Federazione milanese del Pci. La sede nazionale del partito
di Botteghe Oscure è tra le organizzazioni che per prime si muovono nelle
immediate circostanze del rapimento di Moro costato la vita ai 5 uomini della
scorta, facendo scattare l'"operazione periferia" cioè l'ordine di mobilitazione
dei consigli di fabbrica attraverso una rete di circa 150 sedi decentrate tra
Provincia e Regione. Il punto di vista dei comunisti emerge immediatamente e si
può sintetizzare dalle parole di Cervetti come l'esito di un'azione delle forze
reazionarie internazionali nella scia inaugurata nel 1969 con la strage di
Piazza Fontana e proseguita nella "strategia della tensione". Il colpo di
acceleratore dell'azione terroristica nel caso del rapimento Moro, secondo i
dirigenti del Pci, sarebbe stato causato proprio dalla crescita elettorale
inaugurata dalle politiche del 1976 e proseguita nell'avvicinamento alla Dc
voluto e promosso dallo stesso Presidente democristiano. Nessun intervento
esterno da parte di Mosca, che non avrebbe avuto motivo di colpire le
istituzioni italiane nel momento di massimo favore di un partito membro
dell'Internazionale comunista. Dall'intervista non emerge immediatamente la
futura linea della fermezza che caratterizzerà la posizione del Pci di Enrico
Berlinguer lungo i 55 drammatici giorni della prigionia di Moro. A poche ore dal
rapimento le parole di Cervetti riecheggiano ancora un linguaggio "sinistrese":
il ruolo primario del Pci di fronte all'attacco al cuore dello Stato avrebbe
dovuto essere quello di organizzare "un grande contatto di massa del partito
alimentando costantemente la discussione sulle radici e le azioni del
terrorismo".
Visto dagli Stati Uniti. La
parola ai think tank americani della Rand Corporation di Los Angeles: risponde
alle domande di "Panorama" Brian Jenkins, uno dei massimi esperti di terrorismo
internazionale. Sull'addestramento militare del commando di via Fani Jenkins
allontana subito ogni ipotesi di coinvolgimento dei Servizi delle due grandi
potenze della Guerra Fredda. Nè CIA nè KGB, forse i Palestinesi. Anche perché ci
sarebbe il precedente dei terroristi tedeschi del gruppo Baader Meinhof (poi
RAF) addestrati dai Palestinesi e autori dell'attacco al villaggio olimpico di
Monaco di Baviera nel 1972. Gli esperti americani non escludono neppure la
possibilità di un intervento dei Nordcoreani nell'appoggio logistico alle
operazioni dei terroristi rossi in Europa. Se Jenkins e Robert Kupperman
(esperto di terrorismo e consigliere dell'Us Arms Control and Disarmament
Strategy) si dicono convinti del non coinvolgimento dei Servizi Segreti
americani nel caso Moro, altrettanto ritengono per quanto riguarda una ipotetica
azione del Kgb, condivisa da parte dell'opinione pubblica di destra in Italia,
in funzione di contrasto all'"eurocomunismo" del Pci di Berlinguer. Secondo gli
studiosi californiani l'Italia del 1978 sarebbe stata molto lontana dal Cile di
Allende di 5 anni prima: quindi niente implicazioni delle grandi potenze. E in
chiusura di intervista una dichiarazione non poco inquietante, se letta 40 anni
dopo e se inquadrata nelle primissime ore che seguirono il rapimento di una
delle figure più importanti della politica italiana del dopoguerra. "D'altra
parte- dichiarava Michael Ledeen (consigliere di Kissinger) è difficile
ipotizzare che atti come l'operazione Moro possano provocare svolte determinanti
nella politica italiana". Ma per ammissione stessa degli esperti americani, le
Brigate rosse erano state attentamente studiate negli ultimi mesi come uno dei
53 gruppi terroristici da prendere in seria considerazione, anche per i suoi
possibili legami internazionali. Ma solamente con altre organizzazioni
terroristiche internazionali: impermeabili ai Servizi occidentali.
Un legame con i "compagni"
tedeschi? Quando Moro viene rapito, le Brigate rosse sono già entrate in
una seconda fase organizzativa, quella successiva a Curcio e Franceschini già in
carcere dal settembre 1974, rappresentata dalla leadership strategica di Mario
Moretti. La prova dell'esistenza di legami con i terroristi
tedeschi della Baader-Meinhof era emersa alla scoperta del covo di Robbiano di
Mediglia (a pochi chilometri a Est di Milano) il 15 ottobre 1974 in seguito allo
scontro a fuoco che costò la vita al Maresciallo dei Carabinieri Felice
Maritano. In un opuscolo in tedesco appariva la foto di Pietro Bertolazzi, uno
dei capi storici delle Br. Segno che qualcosa stava cambiando nelle relazioni
dei terroristi rossi, e che la diffidenza dovuta alla prima impostazione
leninista e operaista dei vecchi capi stava cedendo il passo ad una idea di
internazionale del terrorismo che avrebbe prediletto l'azione di piccoli nuclei
di guerriglieri al posto della grande sollevazione delle masse proletarie. Le
azioni dei "Tupamaros" italiani furono forse lette in una chiave sbagliata,
specie nel caso dell'azione più importante dopo via Fani, il rapimento del
Procuratore Generale Mario Sossi. L'azione terminata con il rilascio
dell'ostaggio dopo un "processo" non sarebbe tanto servito ad ottenere il
rilascio dei terroristi del gruppo XXII ottobre, bensì a testare la reazione
degli organi dello Stato prima di sferrare il "colpo al cuore" del 16 marzo
1978. Pochi giorni dopo Sossi i brigasti alzavano il tiro e uccidevano per la
prima volta due militanti nella sede del Msi di Padova, provando in questo caso
l'efficacia delle armi. Secondo il pm Emilio Alessandrini, che morirà nel 1979
sotto il piombo di Prima Linea, le Br della seconda generazione erano molto
pericolose perché dotate di una rete capillare di "irregolari" ben coperti e
difficilmente individuabili in grado di colpire rapidamente dappertutto. In
questo nuovo corso, la Raf (Rote Armee Fraktion) tedesca era indubbiamente il
modello di riferimento. Tornando al manuale ritrovato a Robbiano di Mediglia, si
nota come diversi contenuti si ritrovino poi nel comunicato n.1 seguito di due
giorni al rapimento di Aldo Moro: la centralità della Dc come obiettivo da
colpire e l'analisi della storia dei partito da De Gasperi in poi. Esiste tra le
righe dell'opuscolo il riferimento all'internazionalismo della lotta armata
contro quella che i brigatisti considerano allo stesso modo un'organizzazione di
potere transnazionale: Lo Stato Imperialista delle Multinazionali (SIM) citato
poi continuamente nei comunicati redatti nel corso dei 55 giorni del sequestro
Moro. Qualcuno parla di legami con le frange più oscure del terrorismo
arabo-palestinese in un momento di grave tensione del Medio Oriente. Qualcuno
invece, come l'avvocato esperto di terrorismo Giannino Guiso, parla addirittura
di preparazione sotterranea alla terza guerra mondiale.
Banda Baader-Meinhof. Le
idee, le bombe, i suicidi, “sospetti”. Nel 1968 in Germania si forma il gruppo
terroristico Raf. E scoppia l’autunno caldo,
scrive Paolo Delgado l'8 Aprile 2018 su "Il Dubbio". Li chiamavano “Banda
Baader- Meinhof” e i media tedeschi li definivano comunemente “anarchici”, oltre
che naturalmente “terroristi”. In realtà il nome che si erano dati era Raf, Rote
Armee Fraktion, Frazione dell’armata rossa, ed erano comunisti con forte
venatura terzomondista. Per sconfiggerli, lo Stato varò leggi eccezionali
infinitamente più dure di quelle adoperate in Italia contro le Br. Calpestò ogni
diritto, umano e civile. Fu il momento più tragico della storia della Germania
ovest nel dopoguerra: “l’autunno tedesco”. Bettina Rohl, figlia di Ulrike
Meinhof, una delle più famose esponenti del gruppo, ha segnalato in una recente
intervista quanto, secondo lei, la separazione dei genitori sia stata
determinante nella scelta estrema di sua madre. Materiale sufficiente per
consentire qualche titolo a effetto sul terrorismo tedesco derivato dalle
sofferenze private di Ulrike, giornalista molto nota negli anni 60. In realtà
neppure Bettina Rohl accenna una tesi così balzana. Si limita ad affermare che
il “tradimento” di suo padre Klaus Rohl, direttore della rivista radicale
tedesca Konkret, la stessa dove aveva a lungo lavorato Ulrike, avesse fatto
vacillare l’equilibrio mentale della madre, spingendola nelle braccia
dell’Armata rossa. È anche questa una forzatura. Iscritta al Partito comunista
illegale sin dal 1959, poi redattrice di punta dell’infiammata Konkret, Ulrike
Menhoif era sempre stata schierata su posizioni molto estreme. E’ possibile che
l’abbandono da parte di Rohl abbia pesato sulla sua decisione, ma certamente fu
più determinate la situazione che si era creata in Germania ovest alla fine
degli anni 60. Lo stesso clima incandescente che aveva portato alla nascita
della Raf, gruppo armato longevo il cui scioglimento fu annunciato solo nel
1998, con numerosi attentati spettacolari all’attivo e un bilancio di sangue
pesante: 33 vittime, oltre 200 feriti. Più una sfilza impressionante di suicidi,
su molti dei quali non hanno mai smesso di aleggiare sospetti di omicidio
camuffato, tra cui quello della stessa Ulrike Meinhof. Il ‘ 68 tedesco inizia in
realtà il 2 giugno 1967. Quel giorno, nel corso delle manifestazioni contro la
visita dello Scià di Persia, uno studente di 27 anni, Benno Ohnesorg fu ucciso
da un poliziotto a Berlino. La situazione era già tesa di per sé. Per la prima
volta era al governo una Grosse Koalition e i già esigui spazi d’opposizione,
con il partito comunista fuori legge, si erano definitiva- mente chiusi. Il capo
del governo, Kurt Georg Kiesinger, aveva avuto in tasca la tessera nazista fino
al 1945. Ex nazisti di spicco erano disseminati un po’ ovunque nella pubblica
amministrazione. L’assassinio di Ohnesorg suscitò tra i giovani una reazione
fortissima, che si tradusse nella nascita di un diffuso movimento rivoluzionario
che coniugava spesso confusamente marxismo, terzomondismo e suggestioni
controculturali. Dal quel terreno sarebbero presto nati i gruppi armati, come la
stessa Raf, le Cellule rivoluzionarie, il Movimento 2 Giugno di Bommi Bauman,
che prendeva il nome proprio dalla data dell’uccisione di Ohnesorg. Il 2 aprile
1968 quattro studenti, tra cui Andreas Baader e Gudrun Ensslin, diedero fuoco
alla sede di due grandi magazzini a Francoforte per protesta contro la guerra in
Vietnam. Meno di dieci giorni dopo il leader della Sds, guida del movimento
studentesco, Rudi Dutschke fu ferito gravemente da un neofascista dopo una
campagna martellante contro il movimento e contro Dutschke personalmente dei
giornali del gruppo Springer. La Germania prese fuoco. Le manifestazioni furono
violentissime, costellate da attacchi ai giornali di Springer. Gli attentatori
di Francoforte furono condannati a tre anni, con pena temporaneamente sospesa
nel giugno 1969. Cinque mesi dopo, in novembre, fu spiccato un nuovo ordine di
arresto ma a quel punto tre di loro, tra cui Baader e Ensslin erano già riparati
in Francia, ospiti del giornalista amico di Castro e di Guevara Regis Debray.
Baader fu catturato nell’aprile 1970: meno di un mese dopo fu fatto evadere
grazie all’aiuto di Ulrike Meinhof. Il ruolo della giornalista, che aveva
chiesto un’intervista per far sì che il leader della Raf venisse spostato dal
carcere permettendo l’evasione, avrebbe dovuto restare ignoto. Ma
nell’imprevisto scontro a fuoco ci scappò un ferito grave e la giornalista
decise di seguire Baader e la Ensslin in clandestinità. La Raf propriamente
detta nacque allora. Il gruppo si trasferì in Libano, fu addestrato all’uso
delle armi nei campi del Fronte popolare della Palestina. Strinse legami
fortissimi con i palestinesi e probabilmente anche con qualche servizio segreto
dell’est. Scelse il nome e il simbolo, pare commissionato da Baader a un grafico
pubblicitario debitamente pagato: la stella rossa col mitra sovraimpresso e il
nome del gruppo. Iniziarono le rapine e gli attentati, molti segnati
dall’antimperialismo ma molti anche contro le propietà di Springer. La Raf
diventò il pericolo pubblico numero 1 in Germania, oggetto di una caccia
all’uomo di proporzioni inaudite che si concluse con l’arresto di tutti i
dirigenti nel giugno 1972. Una nuova generazione di militanti riempì però i
vuoti lasciati dagli arresti e iniziò allora la fase più tragica della storia
tedesca nel dopoguerra. I detenuti furono rinchusi nel carcere di massima
sicurezza di Stammheim, un inferno lastricato di isolamento assoluto, luci
sempre accese, controlli permanenti. Nel 1974 Holger Meins proclamò uno sciopero
della fame per protesta e ne morì. Nel 1976 morì anche la Meinhof: un altro
suicidio. In occasione dell’inizio del processo ai capi della Raf, nell’aprile
1977, il gruppo uccise il pubblico ministero, Siegfried Buback, con l’autista e
la guardia del corpo. In luglio fu colpito a morte il banchiere Hans Jurgen
Ponto. Il 5 settembre fu sequestrato a Colonia il presidente della Confindustria
tedesca, in un attacco che fece da modello al sequestro Moro. I quattro uomini
della scorta furono uccisi. La Raf chiese il rilascio dei detenuti, lo Stato
prese tempo pur avendo già deciso di non trattare. In ottobre l’Fplp si unì
all’operazione con uno spettacolare dirottamento aereo. Per il rilascio degli
ostaggi avanzò le stesse richieste dei rapitori di Schleyer, aggiungendo alla
lista due detenuti palestinesi. Le teste di cuoio tedesche attaccarono l’aereo
in sosta a Mogadiscio uccidendo quasi tutti i sequestratori. La stessa notte
Baader, la Ensslin a Jan- Carl Raspe si suicidarono a Stammheim. Sulla loro
morte, come su quella di Ulrike Meinhof non è mai stata fatta davvero chiarezza.
Schleyer fu ucciso il giorno dopo. L’autunno tedesco durò ancora a lungo.
Sequestro Moro: tutti i
comunicati delle Br nei 55 giorni di prigionia.
L'analisi degli obiettivi e
del linguaggio dei rapitori. Le lettere di Moro durante la drammatica trattativa
tra le Br e lo Stato prima della tragica fine, scrive Edoardo Frittoli il 21
marzo 2018 su "Panorama". Tra Largo Arenula e Largo di Torre Argentina c'è un
sottopasso pedonale. Sul tetto di una macchinetta automatica per le fototessere
c'è una busta arancione. Dentro l'involucro, il primo comunicato delle Brigate
Rosse viene ritrovato da un giornalista de "Il Messaggero" dopo una telefonata
in redazione da parte dei rapitori. Si apre così la storia dei 9 comunicati (di
cui uno falso) divulgati dai brigatisti durante i 55 giorni di prigionia del
Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Di seguito, la sintesi e
l'analisi dei messaggi inseriti nel contesto dei 55 giorni del sequestro.
COMUNICATO n.1 - Aldo Moro
nella "prigione del popolo". E' il primo messaggio fatto pervenire ai media due
giorni dopo la strage di via Fani. Viene ritrovato sabato 18 marzo 1978.
Allegato al messaggio nella busta trovata sopra la macchina per fototessere c'è
la polaroid che diventerà l'icona dei 55 giorni del sequestro di Aldo Moro. Il
Presidente DC è ritratto in maniche di camicia, in apparenti buone condizioni
fisiche. Dietro di lui un fondale con la stella a cinque punte su cui campeggia
la scritta "Brigate Rosse". Il lessico del primo messaggio dei brigasti presenta
già una serie di caratteristiche che ricorreranno nei comunicati successivi: la
contrapposizione tra il "noi", che evoca anche una supposta unità del fronte
terrorista ed il "loro", identificato come il nemico del proletariato (regime
democristiano, Stato imperialista delle multinazionali, partiti dell'arco
costituzionale ecc.). L'impressione è quella che i redattori dei messaggi
vogliano arrivare subito all'obiettivo della propria legittimazione e ad
un riconoscimento da parte dello Stato come interlocutori ufficiali e
rappresentanti della giustizia nei confronti di un non meglio descritto
"proletariato". Proprio questa volontà emerge fin dalle prime battute, dove si
dichiara la detenzione del "prigioniero" (e non "ostaggio") in uno stato di
detenzione carceraria, la famigerata "Prigione del popolo". Si nota subito
l'enfasi posta dai brigatisti riguardo il successo dell'azione in via Fani, con
l'eliminazione fisica non di una scorta regolare bensì degli appartenenti a non
ben definiti "famigerati Corpi Speciali". Di seguito le Br analizzano
il curriculum politico di Aldo Moro, che definiscono erede diretto
dell'anticomunismo di Alcide De Gasperi, principale promotore
dell'allontanamento di quel PCI erede della lotta partigiana dalla compagine del
Governo e di conseguenza artefice della mancata rivoluzione proletaria che
avrebbe dovuto seguire la fine della guerra. Nella seconda parte del primo
comunicato le Brigate Rosse passano all'incitamento e alla ricerca dell'appoggio
dei "compagni" tramite l'eco attesa dai media nazionali e internazionali. Si
definisce il nemico da combattere, lo Stato Imperialista delle Multinazionali
(una sorta di anticipazione delle future critiche alla globalizzazione) un
organo sovranazionale rappresentato in Italia dalla Democrazia Cristiana, dai
Servizi e dai partiti politici (non escluso il Pci, perchè siamo al culmine
della fase di avvicinamento all'area di governo nota come "compromesso storico".
Quindi il primo messaggio non è tanto rivolto allo Stato, bensì
ai simpatizzanti e fiancheggiatori non organici alle Br, come in una sorta di
dimostrazione dell'effettivo potere dei terroristi nell'azione militare pronta a
colpire direttamente il "cuore dello Stato". Il comunicato si chiude infatti con
l'uso di termini militari atti a dimostrare che vi sia in corso una guerra (come
ad esempio l'espressione "stanare dai covi democristiani gli agenti
controrivoluzionari" piuttosto che il "non concedere tregua" (notare che "Senza
Tregua" era il titolo di un testo fondamentale sulla guerriglia partigiana
scritto dal gappista Giovanni Pesce e considerato una guida negli ambienti del
terrorismo come dimostrò la storia di Giangiacomo Feltrinelli). La parte finale
è spezzettata in una serie di slogan, altra caratteristica ricorrente dei
messaggi durante la detenzione di Aldo Moro.
COMUNICATO n.2
- L'"Internazionale del terrore" letta dai terroristi. Questa volta, come a
confermare la volontà dei rapitori di coinvolgere il più possibile i mass media
e di raccoglierne la più larga eco possibile, i volantini vengono fatti trovare
a Torino, Roma, Milano e Genova in seguito a telefonate alle redazioni locali
dell'Ansa, delle radio e di alcuni quotidiani. E' il 25 marzo 1978. Moro ha
trascorso la Pasqua nella "prigione del popolo". Sono passati 8 giorni dal primo
comunicato e la reazione dello Stato al rapimento e alla strage degli agenti di
scorta aveva portato alla fiducia immediata all'esecutivo guidato da Giulio
Andreotti, che aveva già reso nota la linea della "fermezza" nel rifiutare ogni
tipo di trattativa con i rapitori. L'incipit del messaggio dattiloscritto
riguarda un prolisso elenco delle responsabilità di Aldo Moro nell'esercizio
delle sue numerose cariche istituzionali dagli anni '50 in poi. Si fa accenno a
passaggi fondamentali e oscuri nella storia della Repubblica, sopra tutti il
"Piano Solo" e lo scandalo del Sifar del Generale De Lorenzo (1964). I rapitori
dichiarano che tutti questi ultimi saranno i punti chiave dell'interrogatorio al
prigioniero Moro e che le risposte saranno divulgate pubblicamente, cosa che non
avverrà mai. Il comunicato, diviso anche in questo caso in due parti distinte,
affronta quindi la definizione del nemico sovranazionale, quel fantomatico Stato
Imperialista retto manu militari da organizzazioni identificate come
"Internazionale del Terrore". Stati Uniti e Israele sarebbero i centri
nevralgici della controrivoluzione e della repressione della lotta comunista e
proletaria (contro gli irlandesi dell'IRA, i Palestinesi, I tedeschi della Raf,
i Tupamaros). Importante il riferimento all'autonomia delle BR messa in dubbio
dai giornali nella prima settimana della prigionia di Moro. Lo scritto si chiude
con un riferimento non privo di interrogativi: si rende onore ai due
giovanissimi "compagni" milanesi Fausto Tinelli e Lorenzo "Iaio" Iannucci,
assassinati il 18 marzo 1978. Nonostante gli organi di informazione e gli
inquirenti credessero fermamente nella pista dello spaccio di droga, le Br
escludono anche il possibile movente politico indicando chiaramente il duplice
omicidio quale opera di "sicari del regime", come fossero stati a conoscenza di
qualche elemento oscuro nella vicenda.
COMUNICATO n.3 - La lettera a
Cossiga. L'attacco al Pci di Berlinguer. La sera del 29 marzo 1978 si ripete la
pratica usata per il recapito del comunicato precedente, fatto ritrovare nelle
stesse città dopo le telefonate alle redazioni. Allegata al messaggio delle Br
viene ritrovata una lettera scritta da Aldo Moro a Francesco Cossiga (Ministro
degli Interni). L'autenticità delle parole del Presidente della Dc è
subito messa in dubbio, poiché suona come un testo dettato dai carcerieri al
fine di alzare il tono della trattativa con lo Stato. Ormai il Governo ed i
rappresentanti dei partiti hanno definito la propria linea, con la Dc, il Pc e
l'Msi per la fermezza, alla quale si contrapponeva la voce dei Socialisti di
Craxi e dei Socialdemocratici aperti alla trattativa per avere salva la vita di
Moro. La minaccia di rendere pubbliche le missive del prigioniero che avrebbero
potuto contenere elementi compromettenti nei confronti della politica italiana
fu una sorta di boomerang per Moretti e i suoi, che trovarono inefficaci e
sminuite le armi costituite dalle parole di Moro da parte dei destinatari del
comunicato. La risposta della controparte, rappresentata dalla posizione di
assoluta intransigenza di Giulio Andreotti, costrinse i carcerieri a dichiarare
che il "prigioniero" collaborasse fattivamente e stesse
svelando segreti inquietanti. L'attacco è poi diretto al Partito Comunista
Italiano accusato di tradimento del proletariato per la sua opera di "spionaggio
e delazione" nel fabbriche. I toni contro Berlinguer sono durissimi: è il capo
di un partito di traditori e spie asservito al potere Dc, alla quale in quei
mesi i comunisti si sarebbero avvicinati. Il testo qui rispecchia l'origine
vetero marxista del linguaggio originario delle Brigate Rosse sin dalla
fondazione nel 1970.
COMUNICATO n.4 - Moro
abbandonato, lettera a Zaccagnini - Le Br sulla difensiva. Squilla il telefono
alla redazione milanese del quotidiano "La Repubblica". Una voce anonima
annuncia la pubblicazione del quarto comunicato dopo il rapimento Moro. E' il 4
aprile del 1978. Anche in questo caso assieme al volantino viene ritrovata
una lettera del prigioniero al Segretario della Dc Benigno Zaccagnini. Nello
scritto autografo al compagno di partito Moro si sarebbe lamentato della linea
intransigente espressa dai Comunisti, sentiti come traditori degli accordi del
"compromesso storico". In un passo del manoscritto emerge una contraddizione con
il primo comunicato riguardo la sicurezza della scorta e l'inadeguatezza i mezzi
a disposizione di quest'ultima al momento dell'agguato di via Fani. Una
situazione ben diversa da quella descritta dai terroristi che si erano pregiati
di aver eliminato un nucleo di teste di cuoio armate di tutto punto. Il
comunicato va subito sulla difensiva: Moro è stato lasciato solo dalle
istituzioni, e lo scritto a Cossiga divulgato con il comunicato n.3 sarebbe
stato autenticamente redatto dal prigioniero, nonostante i giornali e le tv lo
considerassero un messaggio sotto dettatura. Segue un testo contorto e scritto
in un linguaggio esortativo sulle intenzioni programmatiche nel passaggio
dall'azione clandestina alla vera e propria guerra del proletariato contro lo
Stato Imperialista delle Multinazionali con una serie di passaggi strategici che
ricalcano in qualche modo le azioni (non ben declinate nella realtà
socio-economica italiana del 1978) dei primi nuclei comunisti organizzati alle
origini della Rivoluzione di Ottobre.
COMUNICATO n.5 - Stralcio del
"processo" a Moro, attacco a Paolo Emilio Taviani e al Pci di Berlinguer. E' un
giorno di primavera ai Giardini Pubblici di Palestro, nel cuore di Milano. In un
cestino dei rifiuti viene ritrovato il quinto comunicato dal giorno del
sequestro di Aldo Moro. E' il 10 aprile 1978. Questa volta, insieme al consueto
volantino con la stella a cinque punte è presente una parte delle risposte di
Moro alle domande del "Tribunale del popolo". E' uno dei passaggi
più inquietanti dei 55 giorni di prigionia, in quanto l'attacco è rivolto
a Paolo Emilio Taviani, chiamato con spregio dai brigasti "teppista di Stato".
Colpisce il fatto che proprio Taviani fosse stato in quei giorni uno dei più
convinti sostenitori della fermezza contro ogni trattativa. Il politico Dc è
chiamato in causa come tessitore di trame con i Servizi, la CIA, le altre
cariche dello Stato in una rete segreta che ricorda da vicino la descrizione
dell'organizzazione "Gladio". Le Brigate Rosse riprendono il discorso di Moro
con una dimostrazione di forza che parte proprio da Taviani e dalle origini del
terrorismo in Italia: il gruppo XXII ottobre di Genova (omicidio Floris, 1971).
Le parole che seguono sono un elenco dell'azione delle Br della colonna genovese
contro la "cricca democristiana" duramente colpita con l'uccisione del
giudice Francesco Coco l'8 giugno 1976, il rapimento del magistrato Mario
Sossi il 18 maggio 1974 ed altre azioni andate a segno come i ferimento del
dirigente Ansaldo Carlo Castellano (17 novembre 1977). Sembra ancora un passo
di difesa, quello compiuto dai redattori del comunicato numero 5: la trattativa
sta andando in stallo, la risposta dello Stato è ancora stabile sul rifiuto. E'
necessario per i sequestratori ribadire ancora una volta l'azione del
fantomatico "partito armato dei proletari" in contrasto all'azione "repressiva"
dello Stato, alla quale parteciperebbero attivamente Berlinguer ed il P "C" I,
con le virgolette sulla "C" al fine di sottolineare il tradimento dell'ideale
comunista.
COMUNICATO n.6 - L'imputato
Moro è condannato a morte dal "popolo"- il distacco dalla realtà delle Br.
Ancora una volta una telefonata a "Repubblica" anticipa il ritrovamento di un
comunicato. Stavolta a Roma, ancora in un cestino dei rifiuti in via
dell'Annunciata. E' il 15 aprile 1978 e sono passati appena cinque giorni dal
comunicato ritrovato a Milano. L'attacco del comunicato sembrerebbe ad una prima
lettura indicare il fallimento degli obiettivi del processo a Moro, il quale
secondo i brigatisti non avrebbe aggiunto nulla di nuovo alla storia del potere
democristiano dal dopoguerra. E' il comunicato che preannuncia la sentenza di
morte per l'imputato del "Tribunale del popolo". Nelle parole dei brigatisti
irrompe un linguaggio che per la prima volta utilizza una terminologia molto
vicina a quella della mafia. I capi della Dc sono descritti infatti come "boss",
appartenenti ad una "cosca" di politici. L'analisi delle Br di Moretti su 30
anni di Stato Imperialista sostenuto dalla Dc esce dai binari della realtà. La
descrizione dell'oppressione di stato nei confronti delle avanguardie comuniste
evoca direttamente la storia del nazismo: arresti di massa, rastrellamenti,
torture, campi di concentramento per i "compagni combattenti". Non c'è più alcun
riferimento a fatti precisi come nel caso del comunicato precedente (citazione
dell'esperienza delle Br a Genova).
COMUNICATO n. 7 (FALSO) - Il
cadavere di Aldo Moro sul fondale del lago della Duchessa. Viene trovato la
mattina del 18 aprile 1978 a Roma in piazza Belli, a pochi passi dal Ministero
di Grazia e Giustizia. Non è un documento originale, ma una copia battuto
utilizzando una macchina da scrivere diversa dalla precedente. Importantissima
la data del 18 aprile, che coincide con il ritrovamento del covo romano delle Br
in via Gradoli 96, occupato da Mario Moretti e Barbara Balzerani ai vertici
della colonna romana dell'organizzazione terroristica e autori della strage di
via Fani. Inizialmente identificato come autentico dagli esperti, in realtà
differisce dagli altri comunicati per molti aspetti, a partire da quello
sintattico lessicale, ai contenuti, all'italiano incerto che lo allontanava dai
messaggi ritrovati sino ad allora. Era inoltre molto più breve degli altri e non
conteneva i soliti slogan conclusivi. Il messaggio
annunciava l'avvenuta esecuzione del Presidente della Dc e l'occultamento
del cadavere nei fondali "limacciosi" del lago della Duchessa, uno specchio
d'acqua a 1,800 metri di quota tra Lazio ed Abruzzo. Naturalmente i sommozzatori
giunti sul posto non trovarono altro che ghiaccio e neppure l'ombra del corpo di
Aldo Moro, che era ancora in vita. Il comunicato del lago della Duchessa fu
realizzato dal falsario Paolo Cucchiarelli, collegato alla banda della Magliana.
COMUNICATO n.7- Moro è vivo,
tutta la colpa è di Andreotti. L'ultimo scambio possibile. Il vero
comunicato n.7 delle Brigate Rosse fu trovato due giorni dopo quello fasullo.
Era stato lasciato a Roma in via dei Maroniti nella solita busta arancione.
Nell'involucro c'è la seconda foto di Aldo Moro, quella che i brigatisti
usarono per dimostrare immediatamente l'esistenza in vita del prigioniero,
ritratto mentre tiene in mano una copia del quotidiano "La Repubblica" datata 19
aprile. Il linguaggio torna quello dei veri comunicati divulgati
precedentemente. Il cuore del messaggio sono le pesantissime accuse al
Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, che sarebbe stato l'autore del falso
comunicato, di anni di trame con i Servizi deviati e addirittura della bomba in
Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 come atto primo della "strategia della
tensione". L'opinione delle Br a riguardo lascia un interrogativo riguardo alla
decisione di colpire Aldo Moro piuttosto che Andreotti. Dopo il consueto delirio
sulla risposta delle forze proletarie armate, giunge l'ultimatum di 48 ore allo
Stato: la vita di Moro in cambio della libertà dei brigatisti incarcerati. O la
sentenza del "popolo" sarà eseguita nonostante gli appelli giunti alle Br da
parte del Papa Paolo VI, della Caritas, delle organizzazioni umanitarie
internazionali.
COMUNICATO n.8- Funesti
presagi di un condannato a morte, la lista dei brigatisti per lo scambio. Il
penultimo comunicato delle Br, ritrovato il 24 aprile 1978, giunge in un momento
particolarmente drammatico dei 55 giorni del sequestro dello statista Dc. Due
giorni prima il Papa Paolo VI aveva rivolto un appello ai brigatisti letto
ambiguamente, poiché il pontefice implorava la liberazione dell'ostaggio "senza
condizioni", escludendo quindi ogni forma di scambio o trattativa con i
rapitori. La fermezza del governo Andreotti procedeva parallelamente all'isteria
generale e allo spiraglio letto dai sostenitori della trattativa capeggiati
da Bettino Craxi. Il clima di chiusura alle richieste delle Br gettò Aldo Moro
(che soffriva da tempo di una forma depressiva) nello sconforto, che si può
leggere in una seconda lettera a Zaccagnini nella quale il prigioniero accusa la
condotta dei democristiani annunciando un cupo avvenire per la politica italiana
che avrebbe pagato caro il prezzo del suo sacrificio. Il comunicato contiene i
nomi dei brigatisti di cui i rapitori richiedono la liberazione in cambio di
Moro. Sono in tutto tredici (Tra cui Franceschini e Curcio, oltre al delinquente
comune Sante Notarnicola e altri detenuti).
COMUNICATO n.9 - La trattativa
è fallita. Il Tribunale del popolo ha emesso la sentenza di morte per colpa
della Dc e del Pci. L'ultimo messaggio delle Brigate Rosse precede di soli
quattro giorni l'esecuzione di Aldo Moro. Il ritrovamento avviene intorno alle
16,30 del 5 maggio 1978 e a Torino viene lasciato in un luogo macabramente
evocativo: nei pressi di Corso Regina Margherita e via Valdocco. E' il "Rondò
della Forca" dove fino all'800 venivano impiccati i condannati a morte. Passano
ben 10 giorni dall'ultimo messaggio in cui si moltiplicano gli appelli
umanitari, si riaccende la flebile speranza di salvare la vita di Aldo Moro. In
questo lasso di tempo il prigioniero moltiplica i suoi appelli per la
trattativa, includendo anche politici al di fuori del suo partito come Pietro
Ingrao e naturalmente Bettino Craxi. Il comunicato n.9 giunge alle redazioni
come una doccia fredda. Il linguaggio dei terroristi si fa greve nello scaricare
la responsabilità di un processo (deciso e svolto solo ed esclusivamente dalle
Br) sulla Democrazia Cristiana e addirittura su Luciano Lama e Enrico
Berlinguer. Tornano i temi ossessivi del nazismo, dei lager, delle SS e la
descrizione delirante di sistematici "rastrellamenti nei quartieri proletari"
perpetrati dalle Forze dell'Ordine. I rapitori di Moro, dopo aver annunciato
ufficialmente la fine del processo e l'imminente esecuzione dell'imputato, si
aggrappano alla consolazione di una presunta vittoria sullo Stato Imperialista,
che non sarebbe riuscito ad individuare il carcere del Presidente Dc in
quasi due mesi di sequestro. La postilla che segue la firma in calce al
messaggio dichiara la volontà di diramare gli atti del processo del "Tribunale
del popolo" ad un fantomatico "Movimento rivoluzionario". L'intenzione non avrà
naturalmente alcun seguito. Quello che accadrà quattro giorni dopo sarà
proprio l'esecuzione di Aldo Moro. Era il 9 maggio 1978. Per l'Italia la morte
del Presidente Dc significherà la fine di un percorso che cambierà la storia
della vita politica nazionale: la morte, contemporanea a quella del suo massimo
esponente, dell'idea di "compromesso storico" tra la Dc e il Pci.
Perché Aldo Moro è il
Kennedy italiano. I tanti dubbi sulla strage di via Fani e la gestione del
sequestro, nel 1978. Le rivelazioni della figlia sulla mancata presenza dello
statista sul treno Italicus. I nuovi interrogativi sollevati dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta. «La storia del delitto Moro è un impasto di mezze
verità, bugie, depistaggi, manovre». Parola di un giornalista che ci ha
costruito un libro di successo, uscito dopo 36 anni dalla prima stesura, scrive
Antonio Ferrari il 12 marzo 2018 su "Il Corriere della Sera”. Tra gli uomini
migliori che ho conosciuto e frequentato, uno si staglia decisamente. Non era un
filosofo, non un sofisticato intellettuale, ma un limpido servitore dello Stato:
Sandro Pertini. Se non ci fossero stati il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro
(rispettivamente il 16 marzo e il 9 maggio 1978, ndr.), probabilmente Pertini
non sarebbe mai diventato presidente della Repubblica. Quando esplose
fragorosamente lo scandalo della loggia massonica P2, centrale eversiva e
criminale, per fortuna l’Italia era guidata da un grandissimo patriota, che
seppe lenire anche le gravi ferite subite dal nostro amato Corriere della Sera,
inquinato dalle pedine di Lucio Gelli. Pertini impose e ottenne la nomina di un
direttore verticale come lui, e con lo stesso aspro carattere, Alberto
Cavallari. Il presidente ripeteva: «Ai giovani non servono sermoni. Hanno
bisogno di esempi di onestà, di coerenza, di altruismo». Sante parole, valide
sempre, oggi come nel passato e sicuramente nel futuro.
Il frigorifero dei silenzi.
Quando la mia azienda mi chiamò, dopo la pubblicazione della vergognosa lista
dei piduisti, ero un giovane inviato speciale sotto scorta. L’anno prima,
infatti, era stato ammazzato dai terroristi il collega Walter Tobagi, ed era
necessario garantire la sicurezza a chi, come chi scrive, si occupava di
terrorismo. L’azienda mi chiese di aiutare il Corriere a salvarsi l’anima,
imponendo l’esempio delle figure non compromesse con Gelli. Mi convocò e chiese,
anzi mi impose di scrivere un libro. Non ero pronto per un saggio. Optai per un
romanzo, dove avrei raccontato i retroscena del sequestro e dell’assassinio di
un uomo politico. Non avrei fatto il nome, ma tutti avrebbero capito. Non vi
furono obiezioni. Firmai il contratto, ottenni l’anticipo, ma il mio libro finì
nel frigorifero dei silenzi, della paura e dell’imbarazzo.
Trentasei anni dopo. Per 36
anni — ripeto, trentasei anni — non uscì. È uscito adesso perché sono un
ostinato, un «guastafeste della memoria», come mi ha definito l’Ambasciatore
Sergio Romano, che del Corriere è una della firme più illustri. Il romanzo,
titolo Il Segreto, edito da @chiarelettere, è composto dal 60 per cento di
verità comprovata, dal 20 per cento di fantasia, e dal restante 20 per cento di
quella «zona grigia» che sempre accompagna le storie epocali. Per esempio:
sappiamo davvero tutto sull’assassinio del presidente degli Stati Uniti John
Kennedy a 55 anni di distanza? Sappiamo davvero tutto dell’11 settembre 2001 con
l’attacco all’America? Pensate allora che sia possibile sapere tutto del nostro
«11 settembre», cioè del sequestro e dell’assassinio di Moro? Pia illusione.
Le verità ufficiali. La
rassicurante costruzione che ci è stata offerta per far quadrare il cerchio
delle responsabilità, e cioè il ruolo esclusivo delle Brigate rosse, formazione
appartenente all’album di famiglia della sinistra (ma solo all’inizio) non mi ha
mai convinto. Allora non sapevamo tante cose e forse avevamo bisogno di parziali
«certezze». La paura, infatti, può produrre danni gravi. Sapevo che il
mio Segreto aveva toccato corde intoccabili, come il ruolo dei servizi segreti e
forse di quella stessa P2 che aveva infangato il mio Corriere. Mi hanno
ovviamente accusato d’essere il dietrologo che non sono mai stato. Non amo le
appartenenze, le ideologie, i partiti. Cerco di pensare con la mia testa. Certo,
se dietrologo vuol dire rifiutare le veline e diffidare delle presunte verità
ufficiali, allora mi riconosco nel ruolo.
La Commissione d’inchiesta.
Nella mia seconda vita, dopo aver seguito il terrorismo, sono andato all’estero,
seguendo le vicende internazionali con identica passione, e impegnato soltanto a
rendere più forte il Corriere e a cercare di far vedere i «sorci verdi» alla
concorrenza. Però la vicenda del Segreto mi rodeva. E quando ho deciso di
affidarmi al più bravo agente letterario italiano, Marco Vigevani, ho trovato
finalmente la strada giusta. La gara è stata vinta da @chiarelettere, e siamo
ormai alla sesta edizione. Ma non è solo questo che mi soddisfa. Sono i
risultati dell’ultima Commissione parlamentare d’inchiesta sul sequestro e
sull’assassinio di Moro a tendermi la mano, dimostrando 36 anni dopo che alcune
intuizioni non erano soltanto fantasie «dietrologiche», come speravano gli
smemorati o i sabotatori della memoria.
Cosa è affiorato. La
Commissione ha fatto affiorare: gli ambigui ruoli di Mario Moretti e Valerio
Morucci; le ambiguità del ministro dell’Interno e futuro capo dello Stato
Francesco Cossiga. Il quale non soltanto era convinto che Moro non fosse stato
ucciso dalla BR, ma disse che conosceva il nome dell’assassino: non un
brigatista ma un affiliato ad un’organizzazione criminale; le inascoltate
dichiarazioni di testimoni preziosi come il palestinese Bassam Abu Sharif,
esponente del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, convinto che
in via Fani abbiano agito gli americani; il ruolo di un brigatista lasciato
espatriare e mai arrestato, Alessio Casimirri, figlio di un dipendente del
Vaticano; le iniziative del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Cosa sappiamo. È ormai
assodato che: 1) In via Fani c’erano «anche le Brigate rosse»; 2) in via Fani
erano presenti agenti di almeno quattro servizi segreti; 3) in via Fani c’erano
uomini della ‘ndrangheta e della Banda della Magliana; 4) almeno un corpo dello
Stato sapeva che in via Gradoli c’era un covo delle BR (con all’interno Mario
Moretti e Barbara Balzerani, armati fino ai denti), ma non fecero nulla per
scoprirlo. Il collega Andrea Purgatori, già grande firma del Corriere della
Sera e ora straordinaria punta professionale de La7, ha condotto un’inchiesta
televisiva esemplare sul caso Moro, scoprendo senza alcun timore carte e
sospetti che dovevano restare segreti. Tanto di cappello davvero. Perché la
storia del delitto Moro è un impasto di mezze verità, bugie, depistaggi,
manovre.
Il ricordo degli studenti.
Anch’io, riprendendo le vicende ai quegli anni drammatici per il nostro Paese,
ho potuto mettere a punto fatti e retroscena che 36 anni fa ignoravo. Per
esempio, la figura morale di Aldo Moro. Ho parlato con i suoi studenti, con i
suoi colleghi universitari, con chi lo ha ben conosciuto. L’ammirazione è
intatta. Le lezioni del professore pugliese, grande visionario della Democrazia
Cristiana, cominciavano tutte con una frase: «Prima di tutto la persona», con
l’invito a «rispettare le idee di tutti». Moro si battè come un leone per far
approvare la legge sull’istruzione obbligatoria fino alla terza media. Era
convinto che la democrazia si sarebbe consolidata soltanto diffondendo la
cultura.
Quell’agosto del ‘74. Alla
destra tutto questo non piaceva. Nel ‘63, negli anni di De Lorenzo e del piano
Solo, si prevedeva la soppressione di Moro e il confino in Sardegna degli altri
leader democratici. Il leader della Dc era sempre nel mirino. Per ragioni
internazionali (il compromesso storico che non piaceva né agli Stati Uniti né
all’Unione Sovietica) e per ragioni di politica interna. È passata quasi sotto
silenzio, nel 2004, un’intervista di rilasciata da Maria Fida Moro a Giorno,
Carlino, Nazione, al Gazzettino di Venezia e al Venerdì di Repubblica, in cui la
figlia dello statista raccontava quanto gli confidò suo padre. Il 4 agosto del
1974, Moro salì sul treno Roma-Monaco per raggiungere la famiglia in vacanza nel
Trentino. All’ultimo momento fu invitato a scendere da due funzionari della
Farnesina, perché c’erano documenti importanti da firmare. Di malavoglia, Moro
scese e decise di partire poi in auto. Poche ore dopo quel treno (l’Italicus)
saltò in aria a San Benedetto val di Sambro: 12 morti e decine di feriti. Una
coincidenza? Forse. Oppure un segnale minaccioso inviato all’uomo politico che,
due giorni prima di morire, a chi prevedeva che sarebbe diventato presidente
della Repubblica, rispose: «No, mi faranno fare la fine di John Kennedy».
La Lega e i 5S come Dc e
Pci nel ‘76: è ora di “un compromesso storico”,
scrive Francesco Damato il 7 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Nessuno aveva i numeri
per governare e Moro trovò la soluzione. Nella storia ormai più che
settantennale della Repubblica c’è un solo precedente di risultato elettorale
neutro come quello di domenica scorsa. Esso risale al 1976, quando nel
Parlamento eletto con un sistema integralmente proporzionale nessuno dei due
partiti più votati – la Dc di Benigno Zaccagnini e Aldo Moro e il Pci di Enrico
Berlinguer, dichiaratamente alternativi nella campagna elettorale – aveva i
numeri per governare l’uno contro l’altro insieme con alleati disponibili e/ o
sufficienti all’avventura. Che si trattasse di un’avventura era dimostrato da
una situazione economica gravissima e da un ordine pubblico minacciato da un
terrorismo di matrice non più soltanto nera ma anche rossa, affacciatosi sulla
scena nel 1974 col sequestro del giudice Mario Sossi. La soluzione della crisi
fu trovata da quel mago della mediazione che era Moro adottando, ma in una forma
ridotta e contingente, il famoso ‘ compromesso storico’ proposto in una
prospettiva più ampia alla Dc da Berlinguer. Il quale aveva temuto che anche in
Italia una svolta marcatamente di sinistra finisse come in Cile. Dove i militari
sostenuti dagli americani avevano soppresso nel sangue la democrazia. Ai
colleghi di partito insofferenti e desiderosi di altre elezioni, anticipate come
quelle appena svoltesi, Moro espose la parabola, diciamo così, dei due vincitori
usciti dalle urne: la Dc e il Pci. Troppi per governare con i vecchi schemi di
maggioranza e opposizione, capaci solo di paralizzarsi a vicenda. Occorreva
quindi una stagione di decantazione o tregua, chiamata poi di ‘ solidarietà
nazionale’, in cui entrambi i vincitori dovevano aiutarsi a vicenda a passare la
nuttata, dicono a Napoli. E nacque il governo monocolore democristiano di Giulio
Andreotti sostenuto in modo determinante dai comunisti: prima con l’astensione,
poi con la vera e propria fiducia negoziata nella lunga crisi che precedette il
tragico sequestro di Moro. Sta per ricorrerne il quarantesimo anniversario.
Diversamente dal 1976, questa volta si è votato con un sistema elettorale misto:
prevalentemente proporzionale, con una quota maggioritaria modesta ma
sufficiente a produrre un effetto opposto a quello perseguito dai cultori del
metodo maggioritario. Si è prodotta non più governabilità, parola quasi magica
dei costituzionalisti anti- proporzionalisti, ma meno governabilità. I due
vincitori di domenica scorsa, destinati nella parabola morotea a garantire una
tregua obbligata dopo un risultato neutro, sono il candidato grillino a Palazzo
Chigi, che ha preso tanti voti da farne indigestione, e la coalizione di
centrodestra, anch’essa molto votata ma non tanto da disporre della maggioranza
assoluta dei seggi parlamentari, al pari del movimento delle 5 stelle.
All’interno del centrodestra si è tuttavia verificato il sorpasso della Lega di
Matteo Salvini sulla Forza Italia di Silvio Berlusconi, o del proconsole
potenziale a Palazzo Chigi indicato dallo stesso Berlusconi alla vigilia del
voto in Antonio Tajani, suo ex portavoce e attuale presidente del Parlamento
Europeo. I due vincitori del 4 marzo si chiamano pertanto Di Maio e Salvini, col
partito o la coalizione che hanno, rispettivamente, alle spalle. Coalizione,
quella di cui Salvini ha conquistato la guida, che proprio per questa novità
potrebbe però trovare ancora più difficilmente in Parlamento i voti che le sono
mancati nelle urne per conquistare la maggioranza assoluta dei seggi. E ciò
anche se il forzista Renato Brunetta, capogruppo uscente alla Camera, ha
immaginato davanti ai microfoni nella notte dello spoglio elettorale una lunga
fila di aspiranti al ruolo di responsabili, pronti cioè a saltare sul carro di
un governo Salvini. Se il segretario della Lega dovesse pertanto rassegnarsi
alla rinuncia ad un incarico presidenziale conferitogli dal presidente della
Repubblica, come ha già reclamato, per mancanza dei numeri necessari alla
fiducia, egli si ritroverebbe a maggior ragione da solo a rivendicare e a
condividere con Di Maio la vittoria elettorale. E insieme rientrerebbero nello
schema moroteo dei due vincitori costretti dal loro stesso ruolo ad accordarsi.
Che è poi la cosa alla quale Renzi li ha praticamente e perfidamente sfidati
collocando il suo malmesso Pd all’opposizione per rimanere fedele all’impegno
elettorale di non accordarsi con gli ‘ estremisti’ dei campi avversi. Sembrerà
un paradosso al simpatico Sergio Staino, espostosi sul Dubbio a favore di
un’intesa fra i grillini e il Pd, forse preferito da Di Maio per le condizioni
di debolezza in cui lo stesso Pd si trova dopo le elezioni, ma la posizione
assunta da Renzi appare più in linea di altre con lo schema moroteo del 1976. Lo
stesso Renzi si sorprenderà a sentirsi dare del moroteo, o quasi. E i suoi
avversari di sinistra saranno letteralmente scandalizzati, al pari di Sergio
Mattarella e dei suoi collaboratori al Quirinale, per il culto che hanno di
Moro, ma così stanno le cose stando al precedente del 1976. Così è se vi pare,
avrebbe detto Luigi Pirandello.
Aldo Moro, quei 55 giorni
che cambiarono l'Italia,
scrive Davide Gianluca Bianchi il 6 aprile 2008 su "L’Occidentale". Quando Moro
fu rapito facevo la Quinta elementare e, nonostante questo ne ho un ricordo
piuttosto nitido, soprattutto delle emozioni che quel grande fatto politico
determinò nel nostro paese. L’episodio che più mi colpì allora, e che non
raramente mi ritorna alla mente ancora oggi, è di carattere personale, ma
significativo: la mattina del 16 marzo, mentre mi trovavo a scuola,
improvvisamente si spalanca la porta ed una signora del personale non docente,
trafelata, dice poche parole con evidente emozione: “Hanno rapito Moro”. La
maestra di allora, non estranea alla Sinistra extraparlamentare, scoppia in una
risata sarcastica, che lascia esterefatta la signora e anche qualche ragazzino
che, pur senza afferrare tutti gli elementi della vicenda, non capisce cosa ci
sia da ridere della morte di cinque uomini alle dipendenze dello Stato (che
secondo Pasolini erano più proletari dei contestatori universitari). Era l’area
della “contiguità”, come si diceva allora, della condivisione politica di un
progetto che intendeva attaccare il “cuore dello Stato”, era la scelta della
complicità fattiva da parte di alcuni, l’ambiguità.
MORO: I 55 GIORNI CHE
CAMBIARONO L'ITALIA,
scritto da Ferdinando Imposimato e Ulderico Pesce. Scheda artistica: “Non
l’hanno ucciso solo le Brigate Rosse, Moro e i ragazzi della scorta furono
uccisi anche dallo Stato.” Questa frase è il fulcro dell’azione scenica ed è
documentata dalle indagini del giudice Ferdinando Imposimato, titolare dei primi
processi sul caso Moro, che nello spettacolo compare in video interagendo con il
protagonista e rivelando verità terribili che sono rimaste nascoste per
quarant’anni. Il titolo dello spettacolo è “moro” con la “m” minuscola a voler
sottolineare che nel cognome del grande statista c’è la radice del verbo
“morire”. Come se la “morte” di Aldo Moro fosse stata “scritta”, fosse cioè
necessaria per bloccare il dialogo con i socialcomunisti assecondando i desideri
dei conservatori statunitensi e dei grandi petrolieri americani in Italia
rappresentati da Giulio Andreotti e Francesco Cossiga che, dopo la morte di
Moro, ebbero una folgorante carriera e condannarono l’Italia alla “sudditanza”
agli USA. Moro sente che uomini di primo piano del suo stesso partito
“assecondano” la sua morte trincerati dietro “la ragion di Stato” e lo scrive in
una delle ultime lettere che fanno da leit motive dello spettacolo: “Il mio
sangue ricadrà su di voi, sul partito, sul Paese. Chiedo che ai miei funerali
non partecipino né Autorità dello Stato, né uomini di partito. Chiedo di essere
seguito dai pochi che mi hanno voluto veramente bene e sono degni di
accompagnarmi con la loro preghiera e con il loro amore”.
IL RACCONTO SCENICO. Il
racconto scenico parte dai fatti del 16 marzo 1978 quando fu rapito Aldo Moro e
furono uccisi gli uomini della scorta: Raffaele Iozzino, Francesco Zizzi,
Domenico Ricci, Giulio Rivera e Oreste Leonardi. Raffaele Iozzino, unico membro
della scorta che prima di morire riuscì a sparare due colpi di pistola contro i
terroristi, era di Casola di Napoli e proveniva da una famiglia di contadini.
Raffaele, alla Cresima, aveva avuto in regalo dal fratello Ciro un orologio con
il cinturino in metallo. Ciro, quella mattina del 16 marzo era a casa e
casualmente, grazie al vecchio televisore Mivar, vide l’immagine di un lenzuolo
bianco che copriva un corpo morto. Spuntava da sotto al lenzuolo soltanto il
braccio con l’orologio della Cresima. Questa è l’immagine emblematica che
ricorre più volte nelle video proiezioni, questa immagine è la radice prima del
dolore di Ciro, protagonista dello spettacolo. Questo dolore diventa rabbia, e
questa rabbia lo spinge a rintracciare il giudice Imposimato titolare del
processo al quale chiede di sapere la verità. Sarà il rapporto tra Ciro e il
giudice, strutturato su questo forte desiderio di verità, a rendere chiaro al
pubblico che la morte di Moro e dei giovani membri della scorta furono è
“assecondata” dai più alti esponenti dello Stato italiano con la collaborazione
dei Servizi segreti americani. Nello spettacolo assume una funzione altrettanto
importante l’incontro e l’amicizia tra Ciro Iozzino e Adriana, la sorella del
poliziotto Francesco Zizzi, altro membro della scorta di Moro, proveniente da
Fasano in provincia di Brindisi, che quella mattina del 16 marzo era al suo
primo giorno di lavoro sostituendo la guardia titolare che la sera prima,
“stranamente”, era stata mandata in ferie. Francesco, diventato da poco
poliziotto, aveva una grande passione per la chitarra e cantava le canzoni di
Domenico Modugno, pugliese come lui e come lo stesso Aldo Moro che, in macchina,
quella mattina, affrontava gli ultimi giorni della sua vita, ascoltando Zizzi
che cantava “La Lontananza” di Modugno. L’ingenuità e la leggerezza dei membri
della scorta irrobustiscono la disperata determinazione di Ciro Iozzino nella
ricerca della verità. Questa ricerca lo porterà di fronte a molte “stranezze”
portate avanti da statisti come Giulio Andreotti e Francesco Cossiga. Tra le
“stranezze” scoperte e denunciate da Ciro Iozzino nello spettacolo ne ricordiamo
alcune: in genere un’ora dopo il rapimento di una persona le indagini venivano
assegnate, come stabilito dal Codice di procedura penale, al giudice istruttore
che a Roma, il giorno in cui avvenne la strage, era Ferdinando Imposimato.
Invece le indagini, trasgredendo il Codice, rimangono nelle mani della Procura
della Repubblica di Roma che le affida al giudice Imposimato solo il 18 maggio
1978 quando Aldo Moro è già stato ucciso da nove giorni. Le “stranezze”
denunciate nello spettacolo continuano. Il 31 gennaio del 1978, circa due mesi
prima del rapimento Moro, nasce l’UCIGOS, un organismo di polizia speciale che
va a lavorare alle dipendenze del Ministro dell’Interno che all’epoca era
Francesco Cossiga. La famiglia di Iozzino non si spiega come mai nasca una
squadra speciale di polizia investigativa senza l’autonomia che la Costituzione
gli affida perché alle strette dipendenze di un ministero. Qualche mese prima
della strage di via Fani accade una cosa ancora più inspiegabile, viene
smantellato l’Ispettorato antiterrorismo diretto da Santillo che aveva raggiunto
risultati eccellenti contro i terroristi e contro la Loggia Massonica P2. Fatto
fuori Santillo e la sua “squadra”, a indagare sul terrorismo, prima del
rapimento di Moro, rimaneva solo l’UCIGOS, che era alle strette dipendenze del
ministro Cossiga. Chi aveva interessi a cancellare la squadra antiterrorismo di
Santillo per fondare una polizia alle strette dipendenze di Cossiga? –si chiede
Ciro Iozzino. Altra terribile verità scoperta da Ciro e denunciata nello
spettacolo è quella secondo la quale uomini dell’UCIGOS ad agosto del 1978 erano
già stati in via Montalcini n. 8, la prigione di Moro e che il quadro generale
dei fatti fosse chiaro a pezzi dello Stato già allora. La denuncia finale che
Ciro Iozzino fa nello spettacolo, e che allontana ogni dubbio sulla
partecipazione dello Stato alla condanna a morte di Moro, suffragata da
documenti, riguarda le rivelazioni di Pieczenik, un esperto di terrorismo
mandato segretamente in Italia dal governo USA per la gestione del caso Moro.
Pieczenik fa delle rivelazioni di cui è in possesso il giudice Imposimato e che
riportiamo in parte, che diventano un momento importante dello spettacolo e, nel
contempo, la rivelazione finale della verità sui mandanti dell’assassinio di
Moro: “Quando Moro ha fatto capire attraverso le sue lettere che era sul punto
di rivelare dei segreti di Stato e di fare i nomi di coloro che quei segreti
detenevano, in quel momento mi sono girato verso Cossiga dicendogli che ci
trovavamo a un bivio: se Moro potesse continuare a vivere o dovesse morire con
le sue rivelazioni. La decisione di far uccidere Moro non è stata una decisione
presa alla leggera. La decisione finale è stata di Cossiga, e presumo anche di
Andreotti: Moro doveva morire.”
Note di regia. “Un altro
spettacolo su Moro? Non se ne può più.” -direte. Avete ragione. Più che di
spettacoli sul caso Moro c’è la necessità di sapere la verità sulla sua morte.
Questo nostro lavoro vuole prima di tutto contribuire alla scoperta della verità
e alla sua divulgazione. E’ un pò altezzoso il fine ma le scoperte del giudice
Ferdinando Imposimato, titolare dei primi processi sul caso Moro, fino
all’assassinio del fratello Franco, vanno verso la costruzione di una chiara
verità: “Moro doveva morire”, era utile bloccare la sua apertura alla sinistra.
Le nuove rivelazioni del giudice Imposimato rappresentano la base contenutistica
del testo dove però le scoperte del giudice, sono intrecciate con la vita di
Iozzino e Zizzi, due membri della scorta. Raffaele Iozzino era il poliziotto che
riuscì a sparare due colpi contro i terroristi. Francesco Zizzi, era poliziotto
ma soprattutto grande chitarrista e cantante di piano bar. Era al suo primo
giorno di lavoro avendo sostituito, proprio quella mattina, la guardia titolare
che aveva presentato un certificato medico. Nelle parole e nelle azioni di Ciro
Iozzino, fratello di Raffaele, protagonista dello spettacolo, abbiamo voluto
descrivere le ansie e la disperazione di un ragazzo del sud a cui “distruggono”
la famiglia. Con la figura della mamma di Raffaele, continuamente evocata,
abbiamo voluto far parlare la disperazione di una mamma che non riesce a darsi
pace, una mamma che vede il figlio partire per servire lo Stato e che rimane ad
aspettare la verità da più di trent’anni. Nello stesso tempo crediamo che questo
lavoro contribuisca ad informare sulle “colpe” di Francesco Cossiga e Giulio
Andreotti che “non hanno voluto salvare Moro”.
Gustavo Selva, Eugenio
Marcucci: Aldo Moro. Quei terribili 55 giorni. Introduzione di Simona
Colarizi, Collana: Problemi Aperti 2003, pp 446, Rubbettino Editore, Storia
d'Italia. La cronaca del "caso Moro" così come gli italiani la vissero fra il 16
marzo e il 17 ottobre del 1978. Di quelle giornate il racconto conserva tutta la
drammaticità e le emozioni provate da chi, come Selva e Marcucci, seguirono la
vicenda momento per momento. Gustavo Selva, all'epoca direttore del GR2,
commentò, con una serie di "editoriali", i passaggi più significativi che sono
rimasti impressi nella memoria di tutti ma che i giovani non conoscono. Al testo
è aggiunta una documentazione di particolare interesse: per la prima volta
vengono raccolte tutte le lettere, anche quelle mai recapitate ai destinatari,
che Aldo Moro scrisse dalla "prigione del popolo", dove le Brigate rosse lo
segregarono per 55 giorni; il "memoriale" dettato dallo statista democristiano;
l'ultimo discorso del 28 febbraio 1978 che Aldo Moro pronunciò davanti ai gruppi
parlamentari della DC e che fu determinante per la formazione del Governo
Andreotti appoggiato dal Partito Comunista.
Aldo Moro, i 55 giorni più
lunghi della Repubblica.
Lo statista democristiano fu rapito il 16 marzo 1978 e ucciso dalle Brigate
Rosse il 9 maggio, scrive il 9 maggio 2017 "Ansa". Il 16 marzo 1978, poco dopo
le 9, un commando delle Brigate Rosse entra in azione in via Fani, a Roma:
blocca le auto del presidente Dc Aldo Moro, uccide i 5 uomini di scorta e
portano via Moro su una Fiat 132 blu. Poco dopo rivendicano l'azione con una
telefonata all' Ansa. Il sequestro terminerà 55 giorni dopo, il 9 maggio, con
l'uccisione dello statista. Ecco le tappe drammatiche di quei giorni.
- 16 marzo: poco dopo le 9 un
commando delle Brigate Rosse entra in azione a via Fani, a Roma. In pochi
minuti, dopo aver bloccato con un tamponamento le auto del presidente Dc
Aldo Moro, le Br uccidono i 5 uomini di scorta e portano via Moro su una Fiat
132 blu. Poco dopo rivendicano l'azione con una telefonata all' Ansa. Cgil, Cisl
e Uil proclamano lo sciopero generale. In serata il governo Andreotti, il primo
con il voto favorevole del Pci, ottiene la fiducia alla Camera e al Senato.
- 18 marzo: Arriva il
'Comunicato n.1' delle Br, che contiene la foto di Moro e annuncia l'inizio del
processo.
- 19 marzo: Papa Paolo VI
lancia il suo primo appello per Moro.
- 20 marzo: al processo di
Torino, il 'nucleo storico' delle Br rivendica la responsabilità politica del
rapimento.
- 21 marzo: Il governo approva
il decreto antiterrorismo.
- 25 marzo: Le Br fanno
trovare il Comunicato n.2.
- 29 marzo: Arriva il
''comunicato n. 3'' con la lettera al ministro dell'Interno Cossiga in cui Moro
dice di trovarsi ''sotto un dominio pieno e incontrollato dei terroristi'' e
accenna alla possibilità di uno scambio. Moro non voleva renderla pubblica, ma i
brigatisti scrivono di averla resa nota perchè ''nulla deve essere nascosto al
popolo''. Recapitate anche altre lettere indirizzate alla moglie e a Nicola
Rana.
- 4 aprile: Arriva il
'Comunicato n. 4', con una lettera al segretario della Dc Benigno Zaccagnini.
- 7 aprile: Il ''Giorno''
pubblica una lettera di Eleonora Moro al marito. La famiglia tiene un linea del
tutto autonoma rispetto alla ''fermezza'' del governo. - 10 aprile: Le Br
recapitano il comunicato n.5 e una lettera di Moro a Taviani, che contiene forti
critiche.
- 15 aprile: Il 'Comunicato
n.6' annuncia la fine del processo popolare e la condanna a morte di Aldo Moro.
- 17 aprile: Appello del
segretario dell'Onu Waldheim.
- 18 aprile: Grazie ad
un'infiltrazione d'acqua, polizia e carabinieri scoprono il covo di via Gradoli
96. I brigatisti (Moretti e Balzerani) sono però assenti. A Roma viene trovato
un sedicente 'comunicato n.7' in cui si annuncia l'avvenuta esecuzione di Moro e
l'abbandono del corpo nel Lago della Duchessa. Il comunicato, falso in modo
evidente, è ritenuto autentico e per giorni il corpo di Moro sarà cercato, con
un grande schieramento di forze, in un lago di montagna, tra le province di
Rieti e L'Aquila, ghiacciato da mesi.
- 20 aprile: Le Br fanno
trovare il vero 'Comunicato n.7', a cui è allegata una foto di Moro con un
giornale del 19 aprile.
- 21 aprile: La direzione Psi
è favorevole alla trattativa.
- 22 aprile: Messaggio di
Paolo VI agli ''Uomini delle Brigate rosse'' perchè liberino Moro ''senza
condizioni''.
- 24 aprile: Il Comunicato n.8
delle Br chiede in cambio di Moro la liberazione di 13 Br detenuti, tra cui
Renato Curcio. Zaccagnini riceve un'altra lettera di Moro, che chiede funerali
senza uomini di Stato e politici.
- 29 aprile: E' il giorno
delle lettere. Messaggi di Moro sono recapitati a Leone, Fanfani, Ingrao, Craxi,
Pennacchini, Dell' Andro, Piccoli, Andreotti, Misasi e Tullio Ancora.
- 30 aprile: Moretti telefona
a casa Moro e dice che solo un intervento di Zaccagnini, ''immediato e
chiarificatore'' puo' salvare la vita del presidente Dc.
- 2 maggio: Craxi indica i
nomi di due terroristi ai quali si potrebbe concedere la grazia per motivi di
salute.
- 5 maggio: Andreotti ripete
il 'no alle trattative'. Il 'Comunicato n. 9' annuncia: ''Concludiamo la
battaglia cominciata il 16 marzo, eseguendo la sentenza''. Lettera di Moro alla
moglie: ''Ora, improvvisamente, quando si profilava qualche esile speranza,
giunge incomprensibilmente l'ordine di esecuzione''.
- 9 maggio: Verso le 13,30, in
via Caetani (vicino alle sedi di Dc e Pci), dopo una telefonata di Morucci
avvenuta poco prima delle 13, la polizia trova il cadavere di Moro nel
portabagagli di una Renault 4 rossa. Era in corso la direzione Dc, dove sembra
che Fanfani stesse per fare un discorso aperto alla trattativa. Moro sarebbe
stato ucciso la mattina presto nel garage di via Montalcini, il covo usato dai
brigatisti come ''prigione del popolo''.
Moro: Da via Fani a via
Caetani, mappa di un sequestro.
Tra le strade di Roma che raccontano covi e misteri a 40 anni dall'agguato,
scrive Massimo Nesticò il 12 marzo 2018 su "Ansa”. Da via Fani a Via Caetani.
Passando per via Montalcini. Senza trascurare via Gradoli. Con una puntata
'fuori porta', tra Palidoro e Palo Laziale, sul litorale. I misteri del caso
Moro si riflettono plasticamente sulla toponomastica di una città - Roma - che
tra il 16 marzo ed il 9 maggio del 1978 era presidiata dalle forze dell'ordine,
con posti di blocco ovunque. Ma nessun controllo si rivelò utile e le vie della
Capitale si trasformarono in un labirinto senza uscita. Quarant'anni dopo, per
ciascuna delle 'stazioni' lungo cui si è dipanata la via crucis dello statista
democristiano restano aperti gli interrogativi su cosa sia davvero successo. Una
coltre di nebbia favorita dalla rigida compartimentazione con cui si muovevano
le Brigate Rosse, oltre che da reticenze e depistaggi messi in atto da diversi
soggetti.
VIA FANI - Inizia tutto in via
Fani, angolo con via Stresa, la mattina del 16 marzo, intorno alle 9. Quartiere
Camilluccia, quadrante nord della città. Un commando di terroristi (ma c'erano
solo loro? E quanti in realtà?) apre il fuoco sulla scorta del presidente della
Dc, Aldo Moro (partito dalla sua casa in via del Forte Trionfale 79 per andare
alla Camera a votare la fiducia al quarto governo Andreotti), uccidendo i cinque
agenti: Oreste Leonardi e Domenico Ricci a bordo della Fiat 130 di Moro;
Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi sull'altra vettura. Moro viene
prelevato e sistemato a bordo di una Fiat 132 blu che riparte a tutta velocità
verso via Trionfale, preceduta e seguita da altre due auto dei componenti del
commando. Secondo le ricostruzioni fornite successivamente dai brigatisti, le
tre auto vengono abbandonate tutte insieme nella vicina via Licinio Calvo.
VIA MONTALCINI - Quartiere
Portuense. Al numero 8, interno 1, di questa via della Magliana, secondo quanto
emerso dai processi, sarebbe stato tenuto sotto sequestro per 55 giorni il
presidente della Dc. La prigione del popolo è in un territorio all'epoca
capillarmente controllato dalla banda della Magliana che, a sua volta, ha legami
solidi con apparati dello Stato deviati. Alcuni esponenti del gruppo criminale -
da Danilo Abbruciati ad Antonio Mancini - abitano a pochi passi dal numero 8 di
via Montalcini. L'appartamento è intestato alla brigatista Anna Laura Braghetti,
la cosiddetta 'vivandiera'. Dentro ci sono anche Prospero Gallinari e Germano
Maccari. Per gli 'interrogatori' arriva Mario Moretti, che parte da un altro
luogo simbolo: via Gradoli 96. Tanti i dubbi sul covo: c'è chi ipotizza che lo
statista sia stato prigioniero in altre zone. Addirittura sul litorale, in una
zona più appartata e tranquilla rispetto a Roma, tra Focene e Palidoro, come
indicherebbero i sedimenti trovati sugli indumenti del politico.
VIA GRADOLI - In questa
traversa della Cassia, zona Nord, in una palazzina al numero 96, c'è Mario
Moretti, sotto l'alias 'ingegner Borghi', con la compagna Barbara Balzerani. La
Polizia, in occasione dei controlli fatti due giorni dopo la strage di via Fani,
va in via Gradoli, come in altre strade del quartiere, ma non in
quell'appartamento. Il 'covo di Stato' (nella definizione di Sergio Flamigni)
viene scoperto solo il 18 aprile 1978, in seguito ad una perdita d'acqua
segnalata dall'inquilina del piano di sotto. Si apprenderà poi che nella
palazzina ci sono ben 24 case di società immobiliari intestate a fiduciari del
Sisde. Altra stranezza: nel settembre del '79 il funzionario del Viminale
Vincenzo Parisi compra un appartamento al numero 75, stesso stabile dove
Moretti, prima e durante il sequestro, disponeva di un box auto. Tra l'81 e l'85
Parisi - nel frattempo diventato vicedirettore e poi direttore del Sisde -
prosegue con gli acquisti al numero 75 ed anche al 96. Parisi diventa poi capo
della polizia.
VIA CAETANI - Il sequestro si
chiude con l'ultimo atto, questa volta al centro di Roma: in via Caetani -
dietro Botteghe Oscure, sede del Pci e poco distante da piazza del Gesù, sede
della Dc - dove la mattina del 9 maggio viene fatta trovare una Renault 4
amaranto con il cadavere del politico nel portabagagli. Tanti i dubbi sollevati
da chi ritiene improbabile che i brigatisti quella mattina abbiano attraversato
tutta la città per arrivare da via Montalcini al centro storico, con
quell'ingombrante carico. C'è chi ipotizza che il prigioniero si trovava in
realtà in un covo nei dintorni di via Caetani. L'informato Mino Pecorelli scrive
il 17 ottobre 1978: "Il ministro di Polizia (Cossiga, ndr.) sapeva tutto, sapeva
persino dove era tenuto prigioniero: dalle parti del ghetto". Altra suggestione:
via Caetani costeggia due palazzi storici, Palazzo Caetani e Palazzo Antici
Mattei. In quest'ultimo il Sismi fa degli accertamenti dopo via Fani
identificando il direttore d'orchestra russo, naturalizzato italiano, Igor
Markevitch e la moglie, Topazia Caetani. Markevitch venne poi indicato come
possibile intermediario nella trattativa per liberare Moro e, da alcuni,
addirittura come colui che condusse gli interrogatori sul politico.
Successivamente, il Sisde installerà un ufficio nella piccola via alle porte del
ghetto. L'ennesimo enigma di una storia ancora oscura, come una strada non
illuminata.
Nella cella di Aldo Moro
oggi dormono due bambine.
Dall’appartamento di via Montalcini al covo di via Gradoli, ecco cosa resta,
scrive Giovanni Bianconi il 10 marzo 2018 su "Il Corriere della Sera". Nella
stanza dove fu recluso Aldo Moro, ostaggio delle Brigate rosse dal 16 marzo al 9
maggio 1978, ora dormono due bambine di 7 e 4 anni. È la camera da letto e dei
giochi delle figlie della famiglia che abita in via Camillo Montalcini 8, piano
1 interno 1. La «prigione del popolo» allestita dai terroristi in una ordinata
palazzina piccolo-borghese alla periferia sud di Roma non ha più nulla di ciò
che fu quarant’anni fa, quando in quell’appartamento di oltre cento metri
quadrati, completo di giardino, cantina e garage dove avvenne l’esecuzione
dell’ostaggio, abitavano i militanti delle Br Anna Laura Braghetti, Prospero
Gallinari e Germano Maccari, con Mario Moretti che andava e veniva per
interrogare il prigioniero. La cella di Moro era nascosta dietro un muro
improvvisato che copriva un’intercapedine larga poco più di un metro e lunga
quattro. Anche fuori l’ambiente è cambiato. Nello spazio verde sull’altro lato
della strada, all’epoca abbandonato, oggi c’è un bel parco attrezzato,
all’ingresso il capolinea degli autobus. Sui muri campeggiano un paio di
graffiti illeggibili e una scritta neofascista contro Laura Boldrini.
Nient’altro che evochi i contrasti politici di oggi, e tantomeno quelli del
1978, quando in questo luogo cambiò la storia d’Italia. La casa dove Moro fu
segregato fu acquistata nel 1977 dalla Braghetti, non ancora entrata in
clandestinità, che restò ad abitarci per qualche tempo dopo la conclusione del
sequestro e lo smantellamento della prigione. Sul parquet, a terra, rimase il
segno della parete rimossa. Nel ’79 la brigatista vendette l’appartamento alla
stessa cifra a cui l’aveva comprato, 50 milioni di lire, e l’acquistò il
capofamiglia del quarto piano, per la suocera. Ignaro di tutto. Finché un giorno
bussarono gli investigatori, la signora mostrò il contratto d’acquisto dove
compariva il nuovo indirizzo della Braghetti, che fu arrestata poco dopo. Poi si
scoprì che quel covo era stato il carcere di Moro, e il segno sul parquet rimase
lì a ricordarlo finché nel 2008 — dopo la morte della signora e l’ingresso di
una nipote — i lavori di ristrutturazione tolsero ogni traccia. Non prima di un
contatto con la famiglia Moro: «Voi avrete sempre il diritto di venire in questo
luogo, ogni volta che vorrete». Un esempio di memoria privata che va oltre il
tempo trascorso e la mutazione dei luoghi. L’anno scorso sono tornati qui i
carabinieri del Ris, che in garage hanno fatto nuovi rilievi e prove di sparo
per verificare la versione brigatista dell’omicidio, portando in via Montalcini
una Renault 4 uguale a quella in cui fu riconsegnato il cadavere dell’ostaggio.
Conclusione: «Si ritiene che non siano emersi elementi oggettivi tali da
sconfessare un’azione di fuoco nel box in questione contro Aldo Moro». Diciotto
chilometri più a nord, dall’altra parte della città, una sbarra a comando regola
l’accesso in via Gradoli, una traversa della Cassia, dove c’era la base br
abitata da Mario Moretti. «Certamente il luogo più enigmatico», scrive l’autore
televisivo Roberto Fagiolo nel suo recentissimo Topografia del caso
Moro (Nutrimenti editore). Il 18 aprile, un mese dopo la strage di via Fani,
un’infiltrazione d’acqua dal secondo piano della palazzina B, interno 11,
provocò l’irruzione dei vigili del fuoco: saltarono fuori armi e documenti delle
Br, ma il sedicente ingegnere Mario Borghi, che l’aveva affittata tre anni
prima, riuscì a farla franca insieme all’altra inquilina, la brigatista Barbara
Balzerani. Poi si scoprì che già all’indomani del sequestro, il 18 marzo, la
polizia aveva controllato l’edificio, all’interno 11 nessuno aprì e gli agenti
se ne andarono; nonostante la signora di fronte sostenesse di aver sentito
trasmettere nottetempo messaggi con l’alfabeto Morse (mai confermati). Seguirono
la segnalazione su «Gradoli» giunta da una seduta spiritica, che portò gli
investigatori in un paese del viterbese ma non nella via omonima, e la
successiva scoperta di appartamenti in zona nella disponibilità dei servizi
segreti. Ancora oggi, dice un inquilino che all’epoca non era nato, molte case
sono intestate a società, «e chissà chi c’è dietro». Sul cancello gli annunci di
vendite e affitti sono scoloriti dal tempo, l’appartamento delle Br è vuoto.
Fino a dicembre era abitato da un anziano signore morto in solitudine,
l’amministratore è alla ricerca degli eredi. Nessuno degli attuali inquilini era
qui quarant’anni fa. Il portiere — un cingalese arrivato nel 1999 — ha sentito
parlare di Moro e delle Br solo dopo tanto tempo, in occasione di un altro caso
di cronaca dai risvolti politici emerso dal sottoscala del palazzo: gli incontri
della transessuale Natalie, frequentata dall’allora presidente della Regione
Lazio. Era il 2009, e per interrompere il viavai di giornalisti, curiosi e
clienti fu montata la sbarra che oggi protegge la tranquillità degli abitanti e
i segreti veri o presunti di quarant’anni fa. Da qui Mario Moretti portava i
testi dei comunicati brigatisti nella tipografia di via Pio Foà 31, quartiere
Monteverde. La polizia la individuò negli ultimi giorni del sequestro, ma
l’irruzione avvenne dopo il 9 maggio. Tra macchine da scrivere e stampatrici
c’era pure una fotocopiatrice dismessa dal ministero della Difesa, particolare
che ha alimentato ulteriori sospetti. Oggi dietro la stessa saracinesca lavora
un tappezziere che ha acquistato il locale nel 1994. Delle Br ha avuto i
racconti del barbiere che lavorava nel negozio accanto, dove si appostavano i
poliziotti durante i pedinamenti; ora il barbiere è in pensione, al suo posto
c’è un parrucchiere per signore. Di fronte abitava il leader comunista Giancarlo
Pajetta insieme alla giornalista Miriam Mafai, morta nel 2012, da cui ha preso
il nome della Fondazione che ha sede nello stesso, anonimo palazzo. Di fianco,
lungo la rampa che porta ai garage, un materasso sull’asfalto e un paio di
coperte, accanto a un fornelletto e due pentole sporche, sono il ricovero di un
senzatetto; quarant’anni fa sarebbe stato un testimone utile per
l’antiterrorismo, oggi lo è di una nuova emergenza. A breve distanza, meno di
cinque chilometri, un’altra base brigatista che ha avuto grande importanza
durante il sequestro Moro: via Gabriello Chiabrera 76, alle spalle della
basilica di San Paolo. Era il rifugio dei «postini» delle Br Valerio Morucci e
Adriana Faranda. Da qui, la mattina del 16 marzo, Morucci e Franco Bonisoli
uscirono per andare a sparare in via Fani contro gli uomini della scorta, mentre
la Faranda rimase ad ascoltare i messaggi radio di polizia e carabinieri. Qui,
la sera dell’8 maggio, Moretti e compagni decisero le modalità d’azione della
mattina seguente: l’esecuzione di Moro e il trasporto del cadavere nel centro di
Roma, dove in via Caetani un brigatista aveva parcheggiato la sua macchina per
tenere il posto alla Renault 4 rossa. Anche in via Chiabrera, dove in fondo alla
strada c’era un bar frequentato dai banditi della Magliana, nessuno s’era
accorto di nulla all’epoca; ma nessuno sa niente nemmeno adesso.
Nell’appartamento al primo piano affittato dalle Br abitano tre studentesse
ignare di tutto. Che non mostrano alcuna curiosità per le Brigate rosse né per
la storia di Aldo Moro. «Vabbè, ma noi che c’entriamo?», si schermisce quella
che apre la porta. Pronta a richiuderla: «Arrivederci». La memoria può
aspettare.
Aldo Moro, il buio oltre
via Fani. Indagine sui retroscena del sequestro.
Il 16 marzo in edicola con il «Corriere» un saggio di Giovanni Bianconi sulla
tragedia del leader democristiano. Qui pubblichiamo una sintesi della nuova
introduzione, scrive Giovanni Bianconi il 14 marzo 2018 su "Il Corriere della
Sera". Il testo che segue è una sintesi della nuova introduzione scritta da
Giovanni Bianconi per la riedizione del suo libro «Eseguendo la sentenza», in
edicola il 16 marzo con il «Corriere della Sera» in collaborazione con Giulio
Einaudi editore. Sono passati quarant’anni, e più che in altre occasioni le
celebrazioni per l’anniversario del sequestro di Aldo Moro e la strage della sua
scorta — i carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci, insieme ai poliziotti
Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi — assumono un significato
particolare. Non solo perché è una ricorrenza «a cifra tonda» e dunque
considerata più evocativa, ma per l’atmosfera in cui cade. È l’inizio di una
nuova legislatura, caratterizzata da incognite e fermenti che, in tutt’altre
condizioni, ricorda quella del 1978, quando il presidente della Democrazia
cristiana cercava soluzioni a una situazione politica ugualmente ingarbugliata.
E individuò una difficile via d’uscita che apriva nuove prospettive. La
«solidarietà nazionale», che per un biennio aveva tenuto in vita il governo
monocolore Dc grazie all’astensione degli altri partiti, si trasformò in «unità
nazionale», con il voto favorevole di tutti gli alleati, comunisti compresi. Era
la prima volta, dal 1947. Ma la mattina del 16 marzo 1978, quando il Parlamento
doveva sancire questa svolta storica, le Brigate rosse tolsero dalla scena il
protagonista principale della trama, e la via d’uscita si trasformò in un vicolo
cieco. Destinato ad esaurirsi in pochi mesi, dopo l’omicidio di Moro, con una
retromarcia che riportò le maggioranze di governo su percorsi più tradizionali.
Rispetto ad allora tutto è cambiato, ma la politica italiana è sempre alla
ricerca di qualche via d’uscita. Non ci sono più i partiti di allora e —
soprattutto — non ci sono più le formazioni armate che condizionarono in maniera
decisiva quel lungo tratto di strada, dalle Br in giù; e prima ancora le sigle
neofasciste che con le bombe e le coperture degli apparati statali avevano
alimentato la «strategia della tensione». Ciò nonostante la violenza politica,
seppure con forme e prospettive nemmeno paragonabili, resta un fantasma sempre
pronto ad agitarsi e ad agitare i contrasti che viviamo. Oggi non solo l’Italia,
ma le società occidentali in genere sono chiamate a misurarsi con altre forme di
terrorismo che quarant’anni fa non erano contemplate, seppure già covassero
sotto i conflitti dell’epoca, in Medio Oriente e non solo. Rievocare i
drammatici cinquantacinque giorni della primavera 1978 può servire a conoscere
meglio la storia di ieri e quello che siamo diventati, fino ad oggi. In questo
libro pubblicato nel 2008, a trent’anni dai fatti, ho cercato di ricostruire
l’intera vicenda vista da tre angolazioni differenti, tutte essenziali: i
brigatisti che sferrarono l’attacco, con il loro carico di ideologia e di morte;
lo Stato che lo subì, nelle sue diverse articolazioni: la magistratura e le
forze dell’ordine, il governo, i partiti e la Dc in primo luogo; Moro e la sua
famiglia che inizialmente, in qualità di vittime, erano al fianco delle
istituzioni ma da un certo momento in poi, quando l’ostaggio cominciò a scrivere
le sue lettere dalla «prigione del popolo», divennero a loro volta antagonisti
dello Stato e della «linea della fermezza» ufficialmente adottata. Ho cercato di
scavare tra tanti episodi più o meno conosciuti, che si sono susseguiti e spesso
accavallati in quei due mesi frenetici e drammatici, per portare alla luce
sensazioni personali, stati d’animo, speranze, delusioni, ragioni e torti dei
diversi protagonisti, per provare a meglio comprendere la storia più grande
attraverso piccoli frammenti. Dalla prima edizione sono trascorsi altri dieci
anni, ma la sostanza del racconto che si potrebbe fare oggi non è dissimile da
quella di allora. Le ulteriori indagini di magistratura e commissione
parlamentare d’inchiesta non hanno cambiato il quadro complessivo. Il mosaico
che si può intravedere mettendo insieme le tessere dei tre punti di vista, resta
sostanzialmente lo stesso. Con le ombre, i chiaroscuri, i rilievi e i vuoti che
pure ci sono, ma non impediscono di vedere il disegno che s’è realizzato:
un’azione politico-criminale, di stampo rivoluzionario, lanciata all’assalto di
un sistema che per resistere all’urto ha scelto di sacrificare un suo illustre
rappresentante finito «sotto processo» per conto di tutti gli altri, e
condannato a morte. Schierandosi contro gli assassini che avevano trucidato la
scorta e avrebbero ucciso il prigioniero, ma anche contro un uomo che fino
all’ultimo ha cercato di salvare la propria vita e una certa idea dello Stato e
delle istituzioni. Inutilmente.
Delitto Moro: l’identikit
di "Defilato", un imprendibile delle Brigate Rosse.
A Firenze c'è un uomo, in
libertà, che era "il contatto sporco" dei fiancheggiatori delle Br che gestivano
gli interrogatori del presidente della Dc, scrive Giorgio Sturlese Tosi il 15
marzo 2018 su Panorama. Quarant’anni dopo il sequestro Moro c’è ancora chi, tra
quei terroristi che progettarono il più eclatante attacco allo Stato, è sfuggito
agli arresti. Qualcuno che conosce molti segreti delle Brigate rosse, dagli anni
’70 ai giorni nostri. Il suo nome in codice è il “Defilato”, l’uomo che unisce
via Fani agli ultimi attentati brigatisti di Nadia Desdemona Lioce; il giovane
militante che accompagnava il braccio destro di Barbara Balzerani, componente
del commando che sequestrò Moro, nei suoi soggiorni fiorentini e ha poi permesso
di organizzare il gruppo di Nadia Lioce. Passando come testimone, se non
protagonista, dei delitti brigatisti degli anni ’80. L'antiterrorismo continua a
dargli la caccia perché ha ancora le chiavi di accesso a molti segreti delle
vecchie e delle nuove Brigate Rosse, dai covi agli arsenali, ai nomi dei
brigatisti ancora in libertà. A svelare la sua esistenza agli investigatori è
stata la brigatista Nadia Desdemona Lioce, la primula rossa che aveva ucciso
Massimo D’Antona e Marco Biagi e che fu catturata il 2 marzo 2003 a Castiglion
Fiorentino dopo lo scontro a fuoco sul treno in cui persero la vita il
sovrintendete di Polizia Emanuele Petri e il terrorista Mario Galesi. O meglio,
sono stati i computer e i floppy disk scoperti, nove mesi dopo quella
sparatoria, nel covo brigatista in via Montecuccoli, a Roma. Quell’archivio
digitale conteneva 183.690 files, protetti da numerose password. Violate grazie
anche alla collaborazione dell’Fbi statunitense. Dalla lettura di quei
documenti gli investigatori scoprirono che il Defilato era l’unico che –
scrivevano le stesse Br nei loro documenti interni - "conosceva i meccanismi per
entrare in contatto con la sede centrale, le modalità di ripresa del rapporto
con l’Istanza Centrale cioè la parte residua dei militanti di quel collettivo”.
Cioè di quei compagni che parteciparono alle azioni degli anni ’80. Quel nome in
codice ha destato l’interesse dello Sceti (Servizio contrasto estremismo e
terrorismo interno), l’ex Ucigos. E soprattutto della Digos fiorentina, che ben
conosceva la storia dei movimenti eversivi toscani. Furono così ripescate le
indagini condotte sull’omicidio, nel 1987, dell’ex sindaco Lando Conti.
Rileggendo quegli atti, in questura hanno ritenuto di poter retrodatare la
militanza nella lotta armata della Lioce fino a quegli anni. La brigatista, che
oggi sconta la sua pena al 41bis nel penitenziario dell’Aquila, unica detenuta
“politica” in regime di carcere duro, nel 1978, da Foggia, si trasferisce a Pisa
e già scrive lettere d’amore immaginando il suo futuro dietro le sbarre.
Frequenta ambienti
antagonisti, viaggia tra Mosca e il Nicaragua e, quando le Br toscane uccidono
Lando Conti, viene perquisita dalla Digos. Conti venne ucciso con la stessa
mitraglietta Skorpion impiegata negli omicidi di due militanti del Msi, a Roma,
nel 1978; del professor Ezio Tarantelli, sempre a Roma nel 1985, e del senatore
democristiano Roberto Ruffilli, nel 1988, Forlì. Quella mitraglietta, marchio di
fabbrica Br, non è mai stata ritrovata. E le sentenze hanno accertato che non
tutti i responsabili di quegli omicidi sono stati individuati e condannati. Tra
i loro fiancheggiatori c’erano certamente militanti dei Nuclei comunisti
combattenti, organizzazione guidata da Nadia Lioce che progettava la
ricostruzione delle nuove Brigate Rosse. Ancora oggi il dossier della Digos
sulla Lioce sta a portata di mano, accanto all’ufficio di Gabinetto, al secondo
piano della questura di via Zara, a Firenze. A parte la beffarda logica
alfabetica che lo posiziona accanto a quello del terrorista nero Mario Tuti, il
fascicolo della Lioce si distingue per i colori: poche pagine bianche,
relativamente recenti, e quelle ormai gialle e fragili delle antiche indagini
sul Comitato rivoluzionario toscano, l’organizzazione che, in riva d’Arno, diede
ospitalità alla Direzione Strategica delle Brigate Rosse che, proprio da
Firenze, nel 1978, gestì il sequestro, gli interrogatori e l’assassinio di Aldo
Moro. Tra quelle carte vecchie e nuove c’è una corposa relazione che la Digos ha
inviato alla procura della Repubblica di Firenze nel 2006. Panorama ha potuto
leggere quelle carte dove, per la prima volta, si traccia il profilo politico e
criminale del Defilato, fino ad ipotizzare quattro nomi di personaggi tuttora a
piede libero, depositari di segreti protetti per decenni. Trentotto pagine con
le quali gli investigatori, riassumendo piste investigative dimenticate o
inedite, ricostruiscono una matrice fiorentina, ma anche pisana e del litorale
tirrenico, dell’organizzazione eversiva più sanguinaria della nostra storia.
Panorama ha consultato gli atti processuali e i vecchi atti di indagine citati
nella relazione riservata. Una rilettura che, dopo decenni, dimostra che, grazie
a quei nomi, è possibile riannodare il filo dei misteri che ancora avvolgono gli
assassinii commessi da brigatisti vecchi e nuovi. Fino a suggerire un’inedita
chiave di lettura della metamorfosi del brigatismo italiano: che cioè se Curcio,
partendo da Trento, fondò le Brigate Rosse, il loro sanguinario cammino fu
portato avanti soprattutto da ex militanti di Lotta Continua, fondata a Pisa da
Adriano Sofri. I nomi contenuti nella relazione inviata alla procura di Firenze,
che però non riuscì ad emettere capi d’accusa circostanziati, riportano ai covi
toscani dove si riunivano Mario Moretti e compagni. E al magma di
fiancheggiatori che da Pisa e della costa tirrenica predisposero i preparativi
per il sequestro Moro. Sul cruscotto della Renault 4 dove fu recuperato il corpo
dello statista, infatti, era esposto il tagliando assicurativo rubato proprio a
Pisa nel 1976 dal Comitato rivoluzionario toscano. Proprio da quel gruppo di
militanti (Paolo Baschieri, Dante Cianci - altro foggiano emigrato a Pisa come
la Lioce -, e Giampaolo Barbi), fermati a Firenze, nel dicembre 1978, con varie
armi comprate con lo stesso porto d’armi utilizzato per acquistare un fucile
pompa marca Ithaca trovato nel covo di via Gradoli il 18 aprile 1978. Oltre alle
chiavi di uno dei covi fiorentini dove si riunivano, nei giorni del sequestro
Moro, Moretti e la Balzerani.
D’altronde Barbara Balzerani a
Firenze aveva stretto rapporti con i componenti della brigata Catabiani, attiva
dalla costa al capoluogo toscano, con frequenti incursioni a Milano e Roma, poi
confluita nel Comitato rivoluzionario toscano.
Il Defilato fa parte di quel
gruppo ma riesce a sfuggire agli arresti. Poi, negli anni ’80, sempre
accompagnandosi alla Balzerani - che dal carcere rivendica l’omicidio Moro -
contribuisce a riformare le Brigate Rosse. Partecipa quindi all’organizzazione
degli ultimi omicidi firmati dalla stella a cinque punte (Ezio Tarantelli, Lando
Conti e Roberto Ruffilli) e per qualche anno, appunto, si defila. Fino ad essere
riattivato, nel 1997, dalla Lioce, che ben conosceva. Ma chi è il Defilato? Gli
esperti dell’antiterrorismo hanno redatto una lista di quattro nomi; tutti
personaggi ben noti ai più anziani tra i poliziotti fiorentini. Mentre a Roma
gli analisti sperano che le nuove tecnologie possano estrarre un’identità certa
dalle prove dormienti repertate sugli omicidi D’Antona e Biagi. Capelli e altri
reperti biologici che quindici anni fa non fornirono un profilo genetico
completo, che i nuovi strumenti acquistati dalla Polizia scientifica potrebbero
ricostruire. Panorama ha rintracciato quei quattro sospettati. Sono nati tra il
1962 il 1965. Uno di loro è di origini straniere, un altro gestisce un bar, uno
è un sindacalista e un altro partecipa alle iniziative dell’Associazione
nazionale partigiani. Tutti e quattro sono ancora attivi nell’ultrasinistra.
Tutti hanno frequentato o frequentano il Centro popolare autogestito Firenze
Sud, come faceva Mario Galesi e, prima di lui, alcuni dei brigatisti degli anni
’80. Lo stesso centro sociale fiorentino dove Barbara Balzerani, oggi libera,
proprio nella ricorrenza del sequestro Moro, “per fuggire ai fasti del
quarantennale”, ha annunciato la presentazione del suo ultimo libro. Alla
riunione, tra vecchi compagni e giovani antagonisti che forse nemmeno sanno chi
era Aldo Moro, potrebbe esserci anche il Defilato. (Una versione più breve di
questo articolo è stata pubblicata sul numero di Panorama in edicola il 15 marzo
2018, in un servizio ampio dedicato ai 40 anni dal rapimento e l'omicidio di
Aldo Moro).
Rapimento Moro: 40 anni fa
la strage di via Fani.
Il 16 marzo 1978 un commando delle Br rapiva il Presidente della Dc Aldo Moro
uccidendo tutti gli uomini della scorta. Italia sotto shock, scrive Edoardo
Frittoli il 14 marzo 2018 su "Panorama". Nel 40° anniversario della Strage di
via Fani dove fu rapito il Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e
dove furono trucidati i 5 componenti della sua scorta, ripercorriamo con le
immagini la cronaca di quel giorno che cambiò la storia dell'Italia
repubblicana.
Roma, via del Forte Trionfale.
Ore 8,45 di giovedì 16 marzo 1978: il giorno del "compromesso storico".
L'Alfetta bianca della scorta del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo
Moro attende con il motore acceso fuori dal civico 79. Il politico pugliese (62
anni e 5 mandati da Presidente del Consiglio alle spalle) era atteso alla Camera
dei Deputati per votare la fiducia al quarto governo Andreotti a cui per la
prima volta avrebbero partecipato i deputati del Partito Comunista Italiano di
Enrico Berlinguer. Il clima del Paese in quel marzo del 1978 era molto teso,
segnato profondamente dalla lunga scia di delitti da parte delle organizzazioni
terroristiche che caratterizzarono gli anni di piombo. Le Brigate Rosse avevano
alzato il tiro fin dal secondo arresto del leader Renato Curcio nel 1976 e,
sotto la guida organizzativa di Mario Moretti, avevano assassinato a Genova il
Procuratore Generale Francesco Coco e gli uomini della scorta. Oltre ai morti
nelle forze dell'ordine dovuti a diversi scontri a fuoco con i brigatisti, gli
uomini di Moretti facenti parte della "colonna romana" compirono la prima azione
nella Capitale, ferendo il 12 febbraio 1977 Valerio Traversi, membro del
Ministero di Grazia e Giustizia. L'attacco al "cuore dello Stato" era
cominciato. Poco dopo, a Torino, sarà la volta dell'assassinio del presidente
dell'Ordine degli Avvocati Fulvio Croce. A Milano, pochi giorni dopo sarà
gambizzato Indro Montanelli, così come altri giornalisti di diverse testate e
orientamenti politici. Il 16 novembre fu ferito Carlo Casalegno, che morirà dopo
13 giorni di agonia. Proprio l'emergenza generata dall'attività dei terroristi
aveva portato ai cosiddetti "governi di unità nazionale" nei quali era maturata
l'idea del compromesso storico tra DC e PCI, osteggiato dal dissenso interno di
parte dei rappresentanti dei due partiti e dagli Stati Uniti, che avevano già
ammonito Moro sulla ferma intenzione di Washington di interrompere gli aiuti
americani in caso di coinvolgimento dei Comunisti nel Governo italiano. Nei
giorni precedenti il 16 marzo, inoltre, Aldo Moro era stato
fatto bersaglio della campagna scandalistica legata al processo
sullo scandalo Lockheed, secondo le cui indiscrezioni il mediatore politico
delle tangenti per le forniture militari, in codice "Antelope Cobbler", sarebbe
stato proprio il Presidente DC. Pochi minuti dopo l'arrivo della scorta, Moro
prendeva posto sul sedile posteriore della Fiat 130 blu ministeriale e la
colonna si muoveva rapidamente verso Montecitorio.
Via Fani angolo via Stresa.
Ore 9:00. La strage. All'incrocio tra le due vie del quartiere Trionfale, la
storia italiana sarà segnata da uno dei fatti più sconvolgenti dal dopoguerra.
All'improvviso la vettura di Moro tamponava una Fiat 128 familiare di colore
bianco con targa falsa del Corpo Diplomatico (CD 19707), che aveva tagliato la
strada alle due auto in viaggio verso la destinazione. In una manciata di
secondi il commando terrorista sbucato dai cespugli di fronte al bar "Olivetti"
fa fuoco sull'Alfetta della scorta, uccidendo sul colpo gli agenti Giulio Rivera
e Raffaele Iozzino, l'unico riuscito a scendere dall'auto durante l'assalto. Il
Vicebrigadiere Francesco Zizzi giaceva ferito gravemente dai proiettili delle
BR, l'unico rimasto in vita oltre a Moro. All'interno dell'auto di Aldo Moro
giaceva il corpo dell'autista, L'appuntato dei Carabinieri Domenico Ricci. Sul
sedile anteriore del passeggero della 130 il corpo del maresciallo dei CC Oreste
Leonardi, responsabile della scorta. Di dietro, il posto vuoto occupato
dall'Onorevole Aldo Moro. La prima volante della Polizia di Stato giungeva sul
posto pochi minuti dopo l'agguato, intorno alle 9:05 proveniente dal
Commissariato Monte Mario, distante circa 2 km. da via Fani. Gli agenti
allontanavano a fatica la folla, chiedendo l'intervento delle ambulanze. Le
pattuglie giunte per prime in via Fani diramavano la segnalazione di ricercare
un'altra Fiat 128 bianca targata Roma M53995, una Fiat 132 blu (Roma P79560) e
una moto Honda di colore scuro. I poliziotti riportano quanto riferito dai
testimoni, che avrebbero visto i membri del commando indossare divise
da "marinai o da agenti di PS". Alle 9:20 fu informato il Ministro
dell'Interno Francesco Cossiga.
Ore 9:25 GR2 Edizione
Straordinaria. Quando giungono gli uomini della Digos, nelle case degli Italiani
le trasmissioni radiofoniche della mattina sono interrotte dalla sigla
dell'edizione straordinaria del GR2: la voce del giornalista Cesare Palandri,
rotta dall'emozione, diffonde la notizia del rapimento di Aldo Moro e della
strage degli agenti di scorta. Nel frattempo sul luogo della strage la Digos
inizia a raccogliere prove ed indizi, faticando per la pressione della massa di
cittadini attorno alla scena. Nella Fiat 130 vengono rinvenute due borse e
documenti dell'Onorevole Moro, le armi cariche della scorta e la radio
dell'Alfetta con il ricevitore appoggiato sul pianale, come fosse stata
pronta all'uso. A poca distanza gli uomini delle Forze dell'Ordine rinvengono a
fianco della 128 una borsa e, a poca distanza, un caricatore con 22 colpi e
un cappello dell'Alitalia.
Ore 9:45 I posti di blocco, le
telefonate all'Ansa, la seduta a Palazzo Chigi. Tre quarti d'ora dopo l'agguato
i posti di blocco delle Forze dell'Ordine sono completati. Nel frattempo era
stata ritrovata la Fiat 132 usata dai terroristi per la fuga e abbandonata
in via Licinio Calvo, ad appena 2 km. da via Fani. Dall'aeroporto militare di
Pratica di Mare si alzavano in volo due elicotteri. Alle 10:00, esattamente
un'ora dopo la strage, i brigatisti rivendicavano l'attentato alle sedi
dell'Ansa di Milano e Roma, usando la famosa espressione "attacco al cuore dello
Stato". Il Ministro dell'Interno Francesco Cossiga convocava allora
il supervertice interforze al quale prendono parte il Ministro della
Giustizia Bonifacio, quello delle Finanze Malfatti (a capo della GdF) e della
Difesa Ruffini. Con loro i capi delle tre Armi, della Polizia e dei Carabinieri,
il Questore di Roma e i comandanti dei Servizi Segreti. Alle 10:20 si riunisce
anche il Governo con le rappresentanze dei Partiti. Lo sgomento e la
concitazione inducono il Presidente della Camera Sandro Pertini ad invitare i
rappresentanti delle forze politiche italiane a votare immediatamente la fiducia
al Governo di solidarietà nazionale guidato da Giulio Andreotti. Quando anche i
telegiornali nazionali danno la notizia del rapimento e della strage della
scorta, dal Policlinico Gemelli giunge la notizia del decesso dell'unico
sopravvissuto all'agguato, il Vicebrigadiere Francesco Zizzi, ricoverato con tre
colpi di arma da fuoco in pieno torace.
Primo pomeriggio del 16 marzo
1978: l'Italia si ferma. Mentre gli inquirenti ascoltavano le prime concitate
testimonianze dei cittadini che avevano assistito all'agguato, in tutta Italia
i lavoratori delle aziende pubbliche e private si fermavano.
I sindacati pronunciavano lo sciopero generale e nelle piazze della principali
città italiane affluivano spontaneamente centinaia di migliaia di persone in
solidarietà alle istituzioni democratiche. Non mancò qualche episodio isolato
di giubilo alla notizia, limitato tuttavia a qualche elemento tra le componenti
di estrema sinistra degli studenti e di alcuni esponenti della sinistra
extraparlamentare che vedevano la soluzione nell'allargamento della lotta
armata. Ma nella pressoché totalità, gli Italiani erano attoniti e spaventati:
l'azione terroristica era arrivata all'obiettivo in una manciata di secondi,
portando con sè l'angoscia sulla sorte di Aldo Moro e lo sgomento per la morte
violenta degli uomini della scorta.
Cala la sera sul giorno più
lungo: inizia la notte della Repubblica. Al calare della luce del sole il buio
della sera dell'attentato al cuore dello Stato è interrotto dalla luce tremola
dei milioni di apparecchi televisivi sintonizzati sui canali della Rai che
trasmettono le immagini della strage. Il Consiglio dei Ministri con i
rappresentanti dei partiti vota la fiducia all'esecutivo alle
20:45. Roma è blindata da una rete di posti di blocco intrecciata da 2.000
agenti, che attendono ulteriori rinforzi da altre città. Mentre l'Italia fatica
a prendere sonno al termine di quel giorno drammatico, nessuna traccia del
Presidente della Democrazia Cristiana e del commando dei rapitori. Iniziavano
i 55 giorni di detenzione del "prigioniero" Aldo Moro in un appartamento di
proprietà della brigatista Anna Laura Braghetti al primo piano di via
Montalcini, 8 nel quartiere Portuense. La "prigione del popolo" dove, dietro ad
una parete costruita appositamente, fu rinchiuso e processato il Presidente
della DC nella sua cella di 4 metri per 1. Oppure in altri luoghi di detenzione,
come sostenuto in tempi recenti da diversi studiosi del caso Moro: forse in una
villa sul litorale romano, forse in un appartamento di proprietà dello Ior a
pochi passi da via Caetani, dove la storia del rapimento ebbe il suo tragico
epilogo.
Sequestro Moro, Bodrato:
«Quel 16 marzo tememmo che fosse iniziata l’insurrezione»,
scrive Carlo Fusi il 14 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Guido Bodrato, che all’epoca
era il numero due della Dc, guidata da Zaccagnini, e che ebbe un ruolo decisivo
in tutti i drammatici 55 giorni del rapimento. Guido Bodrato, Dc, classe 1933:
il 27 marzo prossimo compirà 85 anni. A metà degli anni ‘ 70, assieme a Corrado
Belci, Luigi Granelli e Giovanni Galloni, ha fatto parte della “banda dei 4”,
termine mutuato dalla Rivoluzione culturale avviata da Mao Tsedong e poi
rovesciata come struttura di potere popolare. Meno enfaticamente, la banda
scudocrociata identificava i migliori cervelli in circolazione che stazionavano
all’ombra di Aldo Moro. In quel livido marzo di quarant’anni fa, Bodrado
festeggiò il suo compleanno più amaro: undici giorni prima la Brigate Rosse
avevano rapito l’allora presidente della Dc sterminando la sua scorta. Quattro
decenni hanno inevitabilmente cambiato la prospettiva di quell’atto terroristico
che segnò l’apogeo dell’attacco “al cuore dello Stato”. Ma Bodrato conserva il
sentimento e la memoria di una cesura che fu allo stesso tempo, politica,
storica, culturale e personale. Stroncò la vita di Moro, immerse l’Italia negli
Anni di piombo, pose una pietra tombale sulla stagione del dialogo volta a
realizzare la cosiddetta “democrazia compiuta”, quella dell’alternanza:
finissima tessitura politica morotea, strappata e rimasta incompiuta per come
era stata concepita nella mente del suo creatore. «E’ passato tanto tempo, sono
state dette e scritte moltissime cose», sussurra Bodrato riandando a quesi
terribili 55 giorni di prigionia che poi portarono al martirio di Moro. «Quando
ci comunicarono la notizia, stavamo entrando in Parlamento per il voto di
fiducia al governo Andreotti. Fu un colpo durissimo».
Ma lei quale fu la prima cosa
che pensò: hanno vinto i terroristi oppure c’è la vita di un amico in pericolo
mortale?
«Fu impossibile selezionare
sentimenti così netti in quel momento. Pensai alla scorta che era stata
distrutta, assieme ad altri amici ci domandavamo se Moro era morto
nell’attentato oppure no. Fu un miscuglio di emozioni: grandi e tremende tutte».
E magari la principale era
l’angoscia per quanto stava avvenendo e i pericoli che dischiudeva…
«Per forza. Però vede, le
voglio dire una cosa. A quarant’anni di distanza, molti si rifanno al rapimento
di Moro come se quell’atto segnasse l’inizio dell’incubo terrorista. Non è così.
Da tempo infatti nella realtà italiana incubava la degenerazione della violenza
politica, dalla piazza all’omicidio politico. Le cose erano già accadute, i
morti c’erano già stati. Il rapimento Moro rappresentò un salto di qualità e
costrinse tutti ad interrogarsi sul suo significato, sulla sua valenza».
Cosa accadde in quei primi
momenti?
«Ci riunimmo subito tutti a
palazzo Chigi per valutare la situazione, decidere cosa fare e come reagire. Si
sovrapponeva il fatto che stavamo per votare la fiducia al governo».
Ecco, appunto: la fiducia al
governo. Non aveste subito la percezione che fosse quello l’obiettivo politico
delle Br: sabotare l’intesa Dc- Pci?
«Guardi, a questa distanza
temporale c’è il rischio di mischiare le valutazioni fatte allora a caldo con
quelle successive. Certamente la prima cosa che cercammo di capire era cosa
significava il rapimento: se fosse un atto chiuso in sè oppure il segnale
d’avvio di una strategia di tipo insurrezionale. Adesso, a tanti anni di
distanza, è possibile mettere in ordine le cose, allora non era così».
Davvero pensaste che l’Italia
poteva diventare terra rivoluzionaria?
«Ma non era forse questo
l’obbiettivo dei terroristi? Nella strategia delle Br c’era la convinzione di
essere l’avanguardia di una rivoluzione che doveva nascere da una insurrezione.
Cosa dovevamo fare? Tra le proteste dei Radicali e dell’estrema sinistra,
optammo per un dibattito di fiducia molto veloce. Ma c’era da affrontare
un’emergenza nazionale».
Era l’attacco al cuore dello
Stato…
«Così si è detto dopo. In quel
momento c’era il rapimento di Moro: anche lui stava arrivando a Montecitorio per
la fiducia. Tutti sapevano che si trattava di una discussione dall’esito assai
incerto. La mia interpretazione – che ho raccolto in un libro scritto assieme a
Belci e credo sia l’unica testimonianza di parte democristiana – è che il
rapimento di Moro ha avuto come effetto quello di indurre il pci a votare una
fiducia che probabilmente non avrebbe votato. L’intenzione brigatista era
stroncare la politica di incontro tra Dc e Pci e nel tempo medio l’obiettivo fu
raggiunto. Ma nell’immediato, creando appunto un’emergenza terroristica,
l’effetto fu di spingere le principali forze politiche ad unirsi per
fronteggiare quel tipo di pericolo, tralasciando di affrontare qualunque altra
questione politica e sociale. E’ una contraddizione, qualche volta dimenticata.
Ma ci sono testimonianze dirette che la confermano. I comunisti si aspettavano
alcuni cambiamenti nella compagine governativa che invece non ci furono. Senza
il rapimento Moro non avrebbero votato a favore del governo. Ricordiamo tutta la
polemica interna al Pci se stare oppure no in mezzo al guado, se stare dentro o
fuori della maggioranza».
A quarant’anni di distanza,
lei conferma la scelta della fermezza, del no alla trattativa? Oppure bisognava
agire diversamente?
«Un tema che non si è mai
posto. Si trattava di salvare la vita di Moro e anche di respingere la
possibilità di un riconoscimento politico alle Br. Io non ho mai dimenticato che
prima del rapimento c’erano già stati dei morti; che gli attentati c’erano e poi
sono proseguiti; non posso dimenticare l’assassinio di Ruffilli seppur avvenuto
successivamente; non posso dimenticare gli amici colpiti dai terroristi a
Genova, a Milano a Torino. Colpiti perché democristiani. Guardi, chi insiste
sulla trattativa ignora la realtà delle cose. Io non posso farlo. Sicuramente lo
Stato era impreparato; sicuramente c’era chi approvava l’azione delle Br.
Ricordo che Liberazione fece un inserto su quella vicenda che io ho conservato.
Una parte della popolazione italiana appoggiava le Br. Gli studenti della mia
città giustificavano il rapimento di Moro perché era l’Uomo del Regime che si
era arricchito sulle sciagure del Paese; così come a destra c’erano persone che
sostenevano che Moro se l’era voluta. Il Paese era tutt’altro che unito. La Dc
cercò una soluzione ma a patto che non apparisse come un riconoscimento
all’azione del terrorismo brigatista perché questo non avrebbe fatto altro che
allargare il bacino della violenza senza peraltro salvare la vita di Moro. Le
ricostruzioni in base alle quali la fermezza per il Pci era il riconoscimento
del senso dello Stato e per la Dc il tradimento del senso dell’amicizia non mi
appartengono».
C’era anche una parte del
Paese che era agostica: nè con lo Stato né con le Br…
«Come dice lei: era agnostica.
Guardi una parte dell’Italia così c’è sempre stata. C’era ieri e c’è anche oggi.
Chi possiede un minimo di conoscenza della cultura politica di Moro sa che di
questi sentimenti del profondo dell’Italia lui era assolutamente consapevole.
Era maestro ed è rimasto insuperato in quel tipo di analisi. Chi si considera
moroteo sa benissimo che le cose non sono mai del tutto limpide, che ci sono
sempre zone d’ombra e aree di compromissione nell’opinione pubblica».
E’ senso comune sostenere che
dopo l’uccisione di Moro l’Italia non fu più la stessa. Che quei 55 giorni
segnarono una cesura. Secondo lei cosa davvero cambiò nel profondo con
l’uccisione del presidente della Dc?
«Siamo tutti d’accordo che è
stato così, anche se poi ognuno declina quella consapevolezza in modo diverso.
Certo, dopo l’uccisione di Moro non è finita la Storia: le nuove generazioni che
non hanno vissuto quella tragedia non capiscono nemmeno il problema se è posto
così. Per quel che era un processo avviato verso quella che si definiva una
democrazia compiuta, per quello che era il sottilissimo filo che legava Moro e
Berlinguer, certamente la sua barbara uccisione ha troncato quel filo, ha
azzerato quel processo. C’è stata una profondissima svolta nella vita politica
del Paese, penso nessuno possa negarlo. Naturalmente non è finita la politica.
Chi non condivideva quel disegno non si è sentito affatto messo fuori gioco: al
contrario. E’ una innegabile constatazione: una certa politica è stata colpita
al cuore. Una politica che in larga parte si fondava sulla possibilità di
costruirla, di interpretarla, di darle un’anima da parte di Aldo Moro. Lui ne
era il garante e sapeva di esserlo. Non si può dire che morto lui è finita la
storia democratica italiana: sicuramente però ha perso il regista di una partita
politica fondamentale».
E adesso Bodrato, cosa rimane?
Che Italia c’è del dopo Moro?
«L’Italia è cambiata molto, e
molto è cambiato il mondo. La politica fa fatica a interpretare la realtà. Per
esempio: il mondo digitale che ci circonda la mia generazione non lì’ha
conosciuto e fa fatica ad adeguarvisi. Ma non c’è dubbio che ha una influenza
decisiva nel disegnare la realtà che viviamo e la politica fatica a
interpretarla. Non ci sono più le grandi fabbriche, è scomparsa o quasi la
classe operaia. Ancora nel 1978 gli scioperi si decidevano davanti ai cancelli
di Mirafiori: ora Mirafiori non c’è più. Sono in atto mutamenti profondi. Se la
politica li affrontasse con lo sguardo lungo, considerando il dialogo – ecco il
punto – una forza della politica e non espressione della sua debolezza, se lo
facesse senza posizioni dogmatiche, e Moro era tutto fuorché un dogmatico,
allora probabilmente ne verrebbe un vantaggio per tutti. Si è persa la capacità
di legare una visione più generale – per Moro direi anche culturale e religiosa
– della vita con la politica».
Cioè si è persa la capacità di
pensare la politica come uno strumento per governare la società?
«Sì, dice bene: governare. Ma
stiamo attenti. Oggi governare significa conquistare il potere ed esercitarlo
fino in fondo e senza limiti. Per Moro non era assolutamente così. Le Br lo
consideravano l’espressione dello Stato delle Multinazionali, ed invece è noto
che Moro era tutt’altro. Io non mi considero assolutamente un interprete del suo
pensiero, però dico questo. Manca Moro come persona, ovviamente, anche se oggi
sarebbe centenario. Manca in particolare la sua capacità di riflessione, manca
vorrei dire il Moro “montiniano”. Moro ha rappresentato l’espressione più
compiuta di una generazione che considerava la politica non mera conquista del
potere. Era un politico laico e non leninista, nel senso che la dimensione
cattolica serviva ad esaltare la sua laicità e non a soffocarla, dunque era
soprattutto laico liberale. Si è persa quella dimensione della vita democratica
che in lui era vivissima. Oggi c’è il rischio che votare non significhi più
affermare la democrazia bensì addirittura uscirne. Anche in Turchia e in Russia
si vota: ma è un voto plebiscitario. Abbiamo perso la capacità di riflettere
sulle radici più profonde della democrazia, che si esprime, è vero, nel voto ma
può anche finire per avere un significato opposto. Ebbene la capacità di Moro
era di arrivare al fondo delle cose, di capire il senso degli accadimenti senza
lasciarsi trascinare dalla dimensione del momento. Amava approfondire, insomma.
Oggi chi lo fa?».
In morte di Aldo Moro,
scrive il 14 marzo Piccole Note su "Il giornale". Tante e diverse in questi
giorni le rivisitazioni del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro. Sono passati
quarant’anni dal suo assassinio ed è atto dovuto. Purtroppo sono tutte più o
meno stucchevoli. Con questo articolo iniziamo una serie di riflessioni sulla
vicenda. Per cenni, come si può scrivere di queste cose. Un premessa d’obbligo è
sulle ricostruzioni. Di tanto in tanto spuntano nuovi covi dei brigatisti, nuovi
particolari su quanto accaduto in via Fani e altrove in quei terribili giorni.
Di ricostruzioni. Si tratta di
particolari importanti, ma secondari. Tutti sanno che Moro non è stato nel covo
che ci hanno detto i brigatisti. Semplicemente non avrebbe potuto stare in
quello sgabuzzino senza deperire, né poteva avere sabbia nei risvolti dei
pantaloni e tanto altro. Come tutti sanno che Moro era stato salvato dai suoi
compagni di partito, come scritto da Pecorelli (e altri). Liberato, Aldo Moro
non è stato ucciso nel bagagliaio, come da narrativa ufficiale. È stato ucciso
in macchina durante il trasferimento in auto, mentre era seduto sul sedile
posteriore, come ricostruito in maniera definitiva da Paolo Cucchiarelli in
“Morte di un Presidente”, uno dei pochi libri sull’omicidio Moro che val la pena
leggere perché supportato da documenti d’epoca più che sorprendenti. Uno di
questi, tanto per citare, è la foto del bagagliaio della Renault 4 dove fu
trovato il corpo di Aldo Moro. Una foto successiva, del bagagliaio vuoto, mostra
come la macchia di sangue sul tappetino non si trovasse nella zona dove stava
poggiato il busto dello statista, quello martoriato dai colpi, ma sotto le
gambe, che colpi non avevano ricevuto. Insomma, come indica anche la posa del
tutto innaturale del corpo, Moro fu ucciso e poi stipato nel bagagliaio: il
corpo che andava irrigidendosi fu costretto a forza nello spazio angusto del
ripostiglio. Ma chi vuole può leggere il libro citato che, come detto, è uno dei
pochi che dice qualcosa di interessante sul tema.
Aldo Moro e il compromesso
storico. Ma interrogarsi su queste cose, anche se utile e prezioso, non
esaurisce un tema molto più vasto, sul quale non vengono poste domande. Oggi
possiamo fare un primo cenno su questo livello. Una narrativa consolidata spiega
che il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro fu un attacco al cuore dello Stato.
Lo Stato avrebbe vacillato, certo, ma si sarebbe poi ripreso e avrebbe
contrattaccato riuscendo a debellare il nemico. Nulla di più falso: l’omicidio
Moro fu un omicidio politico perfettamente riuscito. Moro, Andreotti,
Berlinguer, Rodano e Paolo VI (nei modi e nelle forme con le quali un Papa può
accompagnare un processo politico) avevano immaginato un cambiamento epocale.
Tale era il compromesso storico, il più grande disegno politico del Dopoguerra.
Che aveva prospettiva globale e non solo italiana. Una prospettiva che avrebbe
fatto del Pci italiano, ormai scollegato da Mosca, il punto di riferimento della
sinistra d’Occidente. E avrebbe così indotto l’Unione sovietica a intraprendere
un cammino di riforme ben prima dell’era Gorbacev. Con Moro quella prospettiva
fu uccisa. Un omicidio politico perfettamente riuscito, appunto.
Il rapimento dell’onorevole
Moro, la morte dei 5 agenti di scorta, i 55 giorni del sequestro e il tragico
epilogo: I dubbi sulle verità svelate, i segreti mai rivelati e i timori di
rivelazioni devastanti. A 40 anni dalla strage di via Fani, il docuweb di
Giovanni Bianconi e Antonio Ferrari sui retroscena del sequestro. Giovanni
Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, è in edicola dal 16 marzo con il
libro «Eseguendo la sentenza», in vendita con il «Corriere della Sera» in
collaborazione con Giulio Einaudi editore. Antonio Ferrari, ex inviato ed ora
editorialista del Corriere della Sera, è in libreria dal 14 settembre con il
Segreto (edizione Chiarelettere), romanzo che racconta un’altra verità sul
delitto Moro: un’opera di fantasia che vale come un’inchiesta.
Sequestro Moro, cosa ci
faceva il boss in via Fani?
Una foto può riaprire il caso. Sparito e poi riapparso, lo scatto che ritrae un
capo della ’ndrangheta potrebbe dare un volto a uno dei colpevoli dell'eccidio,
impunito dopo 40 anni, scrive Paolo Biondani il 15 marzo 2018 su "L'Espresso".
Il mistero di una foto. Scattata in via Fani il 16 marzo 1978, poco dopo il
sequestro di Aldo Moro e l’eccidio della scorta. Un’immagine scomparsa dal
palazzo di giustizia di Roma. E ritrovata in copia a Perugia. Una foto che
potrebbe dare un volto e un nome a uno dei colpevoli che da 40 anni restano
impuniti. E riscrivere uno dei capitoli più tragici della nostra storia. Perché
l’uomo della foto non è uno dei brigatisti già identificati e condannati:
assomiglia terribilmente a un mafioso della ’ndrangheta. Un boss di alto rango,
che scambiava favori sporchi con un militare dei servizi segreti. Una foto
collegata ad altri misteri: la presenza in via Fani di due sconosciuti, in moto,
armati di almeno un mitra che ha sparato. E il recente ritrovamento in Calabria
di due mitragliette skorpion, che i boss più potenti della ’ndrangheta
collegavano proprio al caso Moro. Tutto parte dalla storia della moto, che è
confermata anche dagli studiosi più scettici. Vladimiro Satta è uno storico che
ha firmato vari saggi per smontare «i falsi misteri del caso Moro». Sentito
dall’ultima commissione parlamentare d’inchiesta, ha riconfermato la sua
conclusione: «Moro è stato sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse di Mario
Moretti, che non erano etero-dirette». Le tante dietrologie di questi anni, ha
aggiunto però lo studioso, hanno distolto l’attenzione dall’unico vero mistero,
che «merita di essere approfondito»: la «questione della moto Honda». Di cosa si
tratti lo ha spiegato ai parlamentari il pm romano Antonio Marini: «Un cittadino
mio omonimo, Alessandro Marini, che nel momento dell’agguato si trovava sul suo
motorino all’incrocio di via Fani, ha visto passare una moto Honda di grossa
cilindrata, da cui sono stati esplosi alcuni colpi contro di lui». Il magistrato
romano sottolinea che la presenza della moto in via Fani «non è un’ipotesi, ma
un fatto accertato con sentenza definitiva: «i brigatisti sono stati condannati
in tutti i gradi di giudizio anche per il tentato omicidio di Alessandro
Marini». In concorso con gli ignoti motociclisti. La «moto Honda di colore blu»
è stata vista da altri tre testimoni oculari, sempre accanto a due soli
brigatisti (poi condannati). Un teste ha notato anche «il calcio di un mitra».
Il killer che ha sparato, «quello seduto dietro», impugnava «una mitraglietta di
piccole dimensioni» ed era «coperto da un passamontagna scuro». Per cui avrebbe
potuto tornare senza problemi a godersi la scena in via Fani. I brigatisti del
commando hanno sempre smentito la presenza di qualsiasi moto, rivendicando di
aver fatto «tutto da soli». Sul caso Moro però i terroristi rossi, dissociati
compresi, hanno offerto nel tempo solo verità parziali, aggiustate dopo la
scoperta e le successive condanne di altri complici, come Alessio Casimirri o il
carceriere Germano Maccari. Le prime indagini sulla moto, quindi, seguono
l’ipotesi più logica: altri due brigatisti ancora ignoti. Ma la pista rossa
porta solo a due ex autonomi, riconosciuti totalmente estranei al caso Moro. Il
primo a parlare di complici esterni è un super pentito della ’ndrangheta,
Saverio Morabito, arrestato in Lombardia nei primi anni ’90. Le sue confessioni
hanno permesso al pm milanese Alberto Nobili e alla Direzione investigativa
antimafia di ottenere più di cento condanne nel maxi-processo Nord-Sud.
Morabito, giudicato nelle sentenza «di assoluta attendibilità», rivela che un
mafioso importante, Antonio Nirta, nato a San Luca l’8 luglio 1946, negli anni
’70 aveva legami inconfessabili con un carabiniere di origine calabrese,
Francesco Delfino, poi diventato generale dei servizi. Il pentito ne parla con
paura e aggiunge che il suo capo, Domenico Papalia, gli rivelò che «Nirta fu uno
degli esecutori materiali del sequestro Moro»: un segreto di mafia confermatogli
anche dal boss Francesco Sergi. Il pm Nobili trasmette il verbale al collega
Marini, che riapre l’indagine sui due in moto. E riascolta una telefonata
intercettata durante il sequestro Moro. Un nastro del 1978, ma tenuto segreto
fino al 1982. Un parlamentare calabrese della Dc, Benito Cazora, impegnato come
tanti a cercare il covo brigatista, spiega al segretario di Moro che la
’ndrangheta può aiutare, ma vuole qualcosa in cambio: «Quelli giù, dalla
Calabria» chiedono di «far sparire una foto del 16 marzo, presa lì sul posto»,
perché si vede «uno di loro... un personaggio noto a loro». L’inchiesta accerta
che la profezia calabrese si è avverata. Un fotografo, Gherardo Nucci, ha
scattato numerose foto in via Fani subito dopo l’agguato. Il rullino risulta
consegnato all’allora pm romano Luciano Infelisi, ma non si trova più: è
sparito. A recuperare alcune copie di quelle foto, anni dopo, sono i magistrati
di Perugia che indagano sull’omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Visto che
«i calabresi di giù» parlavano di un’immagine pubblicata, le verifiche si
concentrano su una foto apparsa su un quotidiano del 17 marzo. È lo scatto
riprodotto in queste pagine. In via Fani, davanti al bar Olivetti e ai corpi
delle vittime, c’è un uomo che fuma una sigaretta. Giacomo Lauro, un altro
grande pentito calabrese, vede la foto e conferma: «È Antonio Nirta». La
somiglianza è riscontrata anche da una perizia dei carabinieri del Racis. Per
fare un confronto, L’Espresso ha recuperato due foto segnaletiche di Nirta del
1968 e del 1975. Tra il boss e l’uomo di via Fani coincidono tutti i dettagli
visibili: capigliatura, forma del naso, orecchio, occhi, sopracciglia... Se non
è lui, è un sosia.
La pista della ’ndrangheta è
accreditata anche dall’ex procuratore di Reggio Calabria, Federico Cafiero De
Raho, e dal suo aggiunto Giuseppe Lombardo. Sentiti dalla commissione il 28
settembre scorso, i due magistrati premettono che la famiglia Nirta “la
maggiore” fa parte di «un livello altissimo della ’ndrangheta», una cupola
segreta con referenti nell’economia, politica e servizi. E in questo quadro
inseriscono i legami tra Antonio Nirta e il generale Delfino. I procuratori
calabresi aggiungono che un armiere importante della ’ndrangheta, quando si è
pentito, ha fatto ritrovare un arsenale micidiale, con due armi speciali. Due
«mitragliette tipo skorpion» che un boss potentissimo gli diede da «custodire
con particolare cura e attenzione, perché sono simili a quelle usate per Moro».
Dicendo «simili», sottolineano i pm, il pentito e il suo boss non parlano delle
armi usate dai brigatisti, ma le collegano comunque al caso Moro. I due in moto,
secondo i testimoni, non erano del commando: facevano da copertura esterna ai
terroristi. A tutt’oggi solo un ex brigatista, Raimondo Etro, ha parlato della
moto. Etro non era in via Fani, ma dopo l’agguato ha ricevuto le armi in
custodia da Alessio Casimirri. Mentre gliele consegnava, proprio Casimirri gli
parlò di «due in moto», non previsti da altri brigatisti, tanto da definirli
«due cretini». Al processo Moro, quando si scoprì un viaggio di Mario Moretti a
Reggio Calabria, altri brigatisti reagirono con stupore. Oltre al capo delle Br,
chi potrebbe conoscere questi segreti è Casimirri, che però non è mai stato
arrestato ed è latitante dal 1982 in Nicaragua. La commissione Moro ha
recuperato un documento del 1982 da cui risulta che fu fermato dai carabinieri,
ma incredibilmente rilasciato. Lo stesso Etro, che era suo amico e scappò con
lui, oggi sospetta una fuga favorita dai servizi. Antonio Nirta, intervistato
dall’autore di questo articolo durante un processo, non ha mai ammesso nulla, ma
ha risposto con una frase allusiva: «Cosa volete da noi? In Italia comandano gli
americani». Delfino, che dopo il caso Moro lavorò alla Nato e poi a New York,
era soprannominato «l’americano». Purtroppo il generale è morto il 2 settembre
2014, portando con sé tutti i suoi segreti.
Sequestro Moro, le Br hanno
sempre mentito.
A quarant’anni di distanza dal rapimento sono ancora troppe le
zone d’ombra. Che mettono seriamente in dubbio la versione "ufficiale" delle
Brigate Rosse, scrive Federico Marconi il 15 marzo 2018 su "L'Espresso". A
quarant’anni da quei 55 giorni che hanno sconvolto l’Italia, il Caso Moro rimane
ancora avvolto nel mistero. Non sono bastati cinque processi, sette commissioni
parlamentari, decine di inchieste giornalistiche e opere storiografiche, per
elaborare una ricostruzione del rapimento, del sequestro e della morte del
presidente della Democrazia Cristiana, che faccia definitiva chiarezza. Sono
ancora molti coloro che, nonostante siano tacciati di complottismo e
dietrologia, continuano a mettere in dubbio l’asse portante della “verità
ufficiale”: la versione dei fatti fornita dalle Brigate Rosse. O meglio, le
versioni dei fatti. I brigatisti, infatti, nel corso degli anni hanno deciso di
collaborare con gli inquirenti, pentendosi o dissociandosi, e godendo così di
forti benefici carcerari. Ma le loro ricostruzioni sono state sempre parziali e
spesso in contrasto. Basti pensare alle due testimonianze più celebri: quella
di Valerio Morucci, sul cui memoriale si fonda gran parte della verità
processuale, e quella del regista dell’“attacco al cuore dello Stato”,
l’irriducibile Mario Moretti.
Sono molti i punti che non
combaciano tra le ricostruzioni dei due Br, ma anche tra queste e le
testimonianze di chi ha assistito all’agguato. Morucci ha scritto che i
brigatisti presenti in via Fani erano solamente nove, numero confermato anche da
Moretti. Il capo delle Br ha poi sempre dichiarato di essere stato l’unica
persona all’interno della Fiat 128 bianca che blocca la scorta di Moro e di
esservi rimasto fino alla fine della sparatoria. Ma i presenti al momento della
strage hanno testimoniato di aver visto due persone scendere da quella macchina
e sparare verso l’auto della scorta di Moro. Se così fosse il numero dei
presenti in via Fani non sarebbe quello indicato dai brigatisti. Nel corso degli
anni, il numero dei componenti del commando ha subito continue modifiche: si è
passati dai sette condannati nei primi processi, ai nove indicati da Morucci,
agli undici individuati tra anni ’80 e ’90. Senza considerare i due uomini, di
cui ancora non si è scoperta l’identità, che hanno sparato verso un testimone,
Antonio Marini, mentre erano a bordo di una moto Honda al seguito del convoglio
brigatista. Allo stesso tempo è cambiato anche il numero dei carcerieri del
presidente Dc. Nel 1993, Moretti ha svelato la presenza di un quarto uomo in via
Montalcini, oltre lui, Barbara Balzerani e Prospero Gallinari, che avrebbe
partecipato all’omicidio Moro: il suo nome è Germano Maccari e viene subito
arrestato e condannato a 30 anni. Perché smascherarlo quindici anni dopo la
morte del politico pugliese? Tante contraddizioni rimangono poi su molti altri
aspetti: sul percorso fatto dai brigatisti in fuga da via Fani, sulle modalità
con cui sono state abbandonate le auto utilizzate, sul luogo in cui Moro è stato
tenuto prigioniero, e persino sulla dinamica dell’assassinio del presidente Dc.
Nel 2017, questa è stata oggetto di una perizia dei Ris, incaricati dalla
Commissione Moro che ha lavorato nell’ultima legislatura, e che ha messo nero su
bianco che no, lo statista non è stato ucciso coricato nel portabagagli come
hanno sempre dichiarato i brigatisti, ma era seduto e avrebbe guardato il suo
assassino negli occhi. A quarant’anni di distanza quindi sono ancora molte le
zone d’ombra, e viene spontaneo chiedersi se le Br non abbiano sempre mentito.
Hanno voluto coprire qualche compagno sfuggito alla giustizia? O hanno celato la
presenza di complici non appartenenti alle Brigate Rosse?
Ritrovare Moro: a 40 anni
dal sequestro l'Italia è di nuovo in un momento cruciale.
I quarant’anni del suo rapimento coincidono con le elezioni del 4 marzo 2018 e
con l’apertura di una fase politica molto delicata, come quella di allora. Nuove
elezioni che sembrano chiudere una fase di lungo periodo, quello che cominciò
dopo la morte del leader della Dc, scrive Marco Damilano il 15 marzo 2018 su
"L'Espresso". Immagini dell'archivio Aldo Moro conservate nel centro
documentazione Sergio Flamigni. Moro tra i militari, Moro tra la gente, Moro in
auto scoperta, Moro con le bacchette che mangia giapponese. Affacciato da un
balcone sopra la scritta “Viva Moro”, inchinato, reclinato, omaggiato da
politici locali, vescovi, ambasciatori, insegnanti, imprenditori, poveracci.
Scorro per ore e ore, sul computer, sugli album, sui ritagli, le foto di Aldo
Moro, dopo aver letto la sua corrispondenza riservata con Eugenio Scalfari,
Indro Montanelli, Alberto Ronchey, Vittorio Gorresio. Nel suo archivio
personale, conservato nel centro di documentazione di Oriolo Romano che porta il
nome dell’ex senatore del Pci Sergio Flamigni, sono raccolte quindicimila
immagini: diapositive, fotogrammi, gli scatti ufficiali in bianco e nero degli
anni Cinquanta e le polaroid a colori sbiaditi degli anni Settanta, le foto
comparse sulla stampa italiana e internazionale del Presidente, ritagliate,
incollate e conservate. Mucchietti di carta, con le graffette colorate e ora
arrugginite. In una scatola che contiene articoli ingialliti c’è un biglietto
del sarto Randolfo Conti, via Duilio 7, nel quartiere romano di Prati, con la
fattura per un abito e fodera due petti con gilet, costo 15 mila lire, datata 11
giugno 1955. Quando Moro giura da ministro della Giustizia, il 6 luglio, deve
ancora compiere quarant’anni. L’immagine pubblica esisteva già anche in una
stagione in cui pensavamo non ci fosse. Moro si ripete, si replica, sempre
uguale, sempre identico a se stesso, sempre rigorosamente vestito di scuro e in
giacca e cravatta, così, per quindicimila volte, e sempre diverso,
impercettibilmente in movimento, come lo era quella politica, la sua politica.
Messe tutte insieme, in ottomila giorni di quei 23 anni fanno in media quasi due
foto al giorno, sono il film di un uomo totalmente dedito alla politica, al
governo, al potere, ma anche della vita collettiva degli italiani, di trent’anni
di progresso, di benessere, di sviluppo, di protagonismo nel mondo, e poi di
improvvisa cupezza e depressione. Quando il grigio era il colore dominante si
intuiva una febbrile vitalità, verso gli anni Settanta le tinte si fanno
plumbee. Di tutti questi momenti Moro era stato il garante, lui a tenere in
equilibrio la crescita economica e la maturazione democratica che l’Italia non
aveva mai avuto. Fino ai due ultimi scatti, quarant’anni fa, i due dei 55 giorni
del rapimento nel covo delle Brigate rosse, dopo la strage di via Mario Fani del
16 marzo 1978 con l’omicidio dei cinque agenti della scorta: Oreste Leonardi,
Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi. Lo ricordano
tutti, in camicia, anche i più giovani che non c’erano. In pochi, invece,
ricordano oggi chi era Aldo Moro, la sua politica, il suo progetto, il suo
metodo. I quarant’anni del suo rapimento coincidono con le elezioni del 4 marzo
2018 e con l’apertura di una fase politica molto delicata, come quella di
allora. Nuove elezioni che sembrano chiudere una fase di lungo periodo, quello
che cominciò dopo la morte di Moro. La fine della Repubblica dei partiti,
rappresentativi della società in ogni sua piega, e l’emergere di leader e
movimenti che si sono proposti di rappresentarsi da soli, seguendo il «moto
indipendente delle cose» di cui aveva parlato Moro nel 1975. Dopo Moro è finito
il suo partito, la Democrazia cristiana. Dopo Moro è finito il Pci. Il
segretario Enrico Berlinguer morì nel 1984, ma tutto era terminato la mattina
del 16 marzo 1978, con la violenta estromissione dalla scena del presidente
democristiano che aveva strappato a Berlinguer qualcosa di più importante di un
partner privilegiato: l’alleato indispensabile, insostituibile. Dopo Moro è
finito anche Bettino Craxi. Moro era il potere fragile, Craxi il potere forte.
Moro aveva capito che il potere si stava disgregando. Craxi, invece, pensava che
solo il potere valesse, la conquista delle posizioni, lo sfondamento nelle linee
avversarie, a qualunque costo, con qualsiasi mezzo. Furono sconfitti entrambi.
Nessuno può dire cosa sarebbe successo se Moro non fosse stato rapito quella
mattina di marzo, mentre andava a votare la fiducia al governo Andreotti. I
segnali non erano positivi e la decisione del Pci di entrare in maggioranza per
la prima volta dall’inizio della guerra fredda nel 1947 era messa a dura prova.
Nell’intervista pubblicata postuma da Eugenio Scalfari nell’ottobre 1978, una
rielaborazione di un colloquio che si era svolto nello studio di via Savoia il
18 febbraio, un mese prima del sequestro, il presidente della Dc sembrava
ipotizzare una coabitazione al governo, una grande coalizione all’italiana.
Finita la fase dell’emergenza, sarebbe cominciata quella dell’alternanza: «Se
continua così, questa società si sfascia, le tensioni sociali, non risolte
politicamente, prendono la strada della rivolta anarchica, della disgregazione.
Se questo avviene, noi continueremo a governare da soli, ma governeremo lo
sfascio del paese. E affonderemo con esso». Corrado Guerzoni, il portavoce di
Moro, ha testimoniato che alla fine del colloquio il Presidente fece un gesto
inatteso, strinse con la mano un braccio di Scalfari. Nell’ultimo discorso ai
parlamentari democristiani, il 28 febbraio 1978, sedici giorni prima del
rapimento, Moro aveva invitato i suoi amici di partito a guardare fuori dal
Palazzo, nel cuore dell’emergenza italiana, «l’emergenza reale che è nella
nostra società»: «C’è la crisi dell’ordine democratico, crisi latente, con
alcune punte acute. Il dato serpeggiante del rifiuto dell’autorità, il rifiuto
del vincolo, la deformazione della libertà che non sa accettare né vincoli né
solidarietà. Immaginate cosa accadrebbe in Italia, in questo momento storico, se
fosse condotta fino in fondo la logica della opposizione, da chiunque essa fosse
condotta, da noi o da altri, se questo Paese dalla passionalità intensa e dalle
strutture fragili, fosse messo ogni giorno alla prova di una opposizione
condotta fino in fondo...». E aveva concluso: «Se non avessimo saputo cambiare
la nostra posizione quando era venuto il momento di farlo, noi non avremmo
tenuto, malgrado tutto, per più di trent’anni la gestione della vita del Paese.
È la nostra flessibilità, più che il nostro potere, che ha salvato fin qui la
democrazia italiana...». Nel quarantesimo anniversario del rapimento, in un
nuovo momento di passaggio, nell’Italia «dalla passionalità intensa e dalle
strutture fragili» di nuovo in bilico, in questi giorni di crisi che come
quarant’anni fa richiedono più flessibilità che esercizio cieco del potere. In
tutto l’Occidente le innovazioni non sono più governate dalla politica, la
politica è apparenza di potere ma non sostanza. La politica non è più sfida di
cambiamento dell’esistente, ma appiattimento sull’istante. La politica non
coltiva più la speranza, ma la paura e la rabbia dei cittadini. Genera
frustrazione negli elettori, promette quello che non riesce più a dare e prova a
guadagnare consenso sulla frustrazione che ha generato. Per questo Moro va
ritrovato, come scriveva Leonardo Sciascia nella prima pagina del suo libro
dedicato al sequestro: «un tempo da ritrovare». Moro va strappato dal caso Moro,
l’immagine del prigioniero cui è stato consegnato dai terroristi. Lo Stato non
riuscì a farlo ma noi possiamo oggi liberarlo e riconsegnato alla politica,
all’Italia di oggi di cui aveva capito molto, quasi tutto. Il leader che per la
politica era vissuto e infine morto e che nella politica, tuttavia, non aveva
mai esaurito la sua persona. «La verità, cari amici, è più grande di qualsiasi
tornaconto», scrisse Moro in una delle sue ultime lettere disperate dal covo
delle Br al deputato dc Riccardo Misasi. «Datemi da una parte milioni di voti e
toglietemi dall’altra parte un atomo di verità, ed io sarò comunque perdente. Lo
so che le elezioni pesano in relazione alla limpidità ed obiettività dei giudizi
che il politico è chiamato a formulare. Ma la verità è la verità». Negli ultimi
giorni della sua vita, in maniche di camicia, con un foglio di carta a quadretti
e una penna come sola arma a disposizione per farsi sentire, con la coscienza
come unica voce da ascoltare, Aldo Moro aveva concluso che tutto si racchiudeva
in questo, un atomo di verità. Ciò che manca oggi a una politica che si
percepisce come onnipotente, forte di consensi e successi, che si auto-celebra
per i milioni di voti raccolti, ma che non possiede un atomo di verità sul Paese
e su se stessa. E dunque è destinata a essere perdente, sempre.
"Quel giorno rappresenta
l'11 settembre italiano".
Damilano: «Capimmo cos'è la paura, l'ansia di un attacco imprevedibile riuscito
nei dettagli», scrive Massimo Malpica, Venerdì 16/03/2018, su "Il Giornale". Un
libro per ricordare quei giorni, ma anche per «liberare» Aldo Moro. Questo il
senso di Un atomo di verità - Aldo Moro e la fine della politica in Italia, di
Marco Damilano, direttore dell'Espresso, che racconta a 40 anni dai fatti il
sequestro, la prigionia e la morte dello statista democristiano, ma che vuole
anche ricordare quello che Moro ci ha lasciato, e recuperarlo alla memoria
comune. «Penso che Moro vada liberato dalla prigione delle Br in cui è stato
confinato da 40 anni», spiega l'autore, che quel giorno di marzo del 1978 era
solo un bambino, e che passò con il minibus della scuola proprio a
quell'incrocio, in via Fani, pochi minuti prima dell'agguato e dell'uccisione
degli uomini della scorta di Moro. Anche la portata emotiva dell'evento trova
spazio nel libro, visto che quel 16 marzo è per Damilano «l'11 settembre
italiano», da un lato per l'enormità di un gesto come il rapimento dell'uomo
«architrave del sistema politico italiano», e dall'altro appunto per le
sensazioni che quell'evento ha impresso in ognuno di noi, e che sono rimaste
sedimentate nella memoria, sia personale che collettiva, da allora: «Quel giorno
- scrive il direttore dell'Espresso - abbiamo conosciuto cos'è la paura, l'ansia
di un attacco imprevedibile e riuscito fin nei dettagli». Ma l'altro spunto di
questo libro, Damilano l'ha trovato nel «liberare» Moro, raccontandone gli
aspetti umani e la visione politica, e non solo l'immagine di un prigioniero,
stanco, immortalato davanti allo stendardo delle Brigate Rosse. «A via Mario
Fani - scrive Damilano - è finita in Italia la politica come leva privilegiata
del cambiamento, e oggi la politica invece non coltiva speranze ma cavalca
paure». E se è un caso che un libro che celebra un anniversario si ritrovi a
uscire proprio dopo le elezioni, non lo è di certo il parallelo che l'autore fa
da quella che era la politica in quell'«anno di mezzo» tra 1968 e 1989, tra
contestazione e caduta del muro di Berlino. Per Damilano di quel 1978 c'è poco
da invidiare se non un elemento: la politica dei partiti che, allora, si poneva
l'obiettivo di rappresentare la società. In questo mille miglia lontana da
quella attuale. Di fronte alla frattura profonda tra classe politica ed
elettori, tra sentimenti anticasta e frustrazione di fronte al proliferare di
promesse prima delle urne, suona ancora più profetica la frase scritta da Moro
al deputato Dc Riccardo Misasi: «Datemi un milione di voti e toglietemi un atomo
di verità e io sarò perdente».
Quelle cinque vittime
dimenticate.
I carcerieri di Moro non erano, in quel momento, soltanto i suoi rapitori, con i
quali eventualmente trattare. Erano già anche gli assassini degli agenti, scrive
Claudio Magris il 15 marzo 2018 su "Il Corriere della Sera". Quarant’anni dopo
il rapimento e la morte di Aldo Moro si torna pure a discutere sulla tragica
scelta tra salvarlo, cedendo ai rapitori, oppure difendere la legge e lo Stato,
ossia l’intera comunità civile, sacrificando la vita di un uomo, lasciandolo
morire per mano dei suoi criminali carcerieri. Salvare ad ogni costo una vita
umana — cosa cui del resto, in generale, non si bada sempre molto, non solo in
guerra, ma anche sul posto di lavoro — o difendere con fermezza la legalità,
difesa anch’essa talora trascurata o esercitata chiudendo un occhio.
Oblio ripugnante. C’è un
elemento rivoltante che colpisce in questa certo drammatica scelta tra fermezza
e pietà, legge generale garante di ogni convivenza e caso individuale, anche al
di là delle oscure manovre politiche celate dietro quell’incertezza. I
carcerieri di Moro non erano, in quel momento, soltanto i suoi rapitori, con i
quali eventualmente trattare. Erano già anche gli assassini dei cinque agenti
della sua scorta, ammazzati come cani e subito dimenticati quasi non fossero
esseri umani. Moro era certo politicamente e socialmente più «importante», così
come pure tra le vittime dell’Isis e anche di Auschwitz ci sono personalità più
e meno pubblicamente «importanti», ma non perciò il loro assassinio può essere
preso sottogamba. Questo oblio, inconsciamente insensibile e indifferente al
valore di ogni vita umana, è ripugnante.
Le lettere di Moro. Trattare
con i terroristi significava cancellare l’assassinio di cinque persone, quasi
non fosse avvenuto o fosse irrilevante. Nemmeno nelle lettere di Moro si fa
menzione di loro, morti per difenderlo, ma ovviamente erano i carcerieri a
decidere cosa potesse e dovesse venir detto o no in quelle lettere. Proprio per
questo esse non potevano e non dovevano essere prese in considerazione, così
come un matrimonio non è valido se il sì viene pronunciato con una pistola
puntata alla schiena. Non a caso in quei giorni Sandro Pertini dichiarò che, se
eventualmente egli fosse stato rapito, da quel momento qualsiasi sua parola
detta o scritta avrebbe dovuto essere ignorata e cestinata.
Memoria. Persone diverse,
tempre diverse. Anche diversi sentimenti di umanità. I tre poliziotti e i due
carabinieri scannati, e come loro innumerevoli uomini e donne senza nome
bestialmente massacrati, non trovano posto nella mente, nel cuore, nella
memoria, quasi non fossero uomini come chi ha un nome o un ruolo un po’ più
noti. Ogni tanto si ricordano quegli agenti ma assai flebilmente; ad esempio non
ho sentito alcuna loro menzione in una delle recenti trasmissioni televisive su
quegli eventi. Restano vittime di terza classe.
Panettoni. Qualche tempo dopo
l’assassinio di Moro, una sua strettissima congiunta inviò, a Natale, dei
panettoni ai suoi uccisori. Le chiesi pubblicamente, sul Corriere, se si era
ricordata di mandarne pure alle vedove dei poliziotti assassinati, anche
considerando che, per chi vive con la pensione vedovile di un agente di pubblica
sicurezza, un panettone, oltre ad essere un segno di affetto, può essere anche
un piccolo aiuto per il pranzo di Natale. Non ci aveva pensato.
Moro, figlio agente Ricci il
15 marzo 2018: «Basta "scorte di", ricordiamo i nomi di chi difese uomini e
democrazia». "Si è parlato di una guerra ma in una guerra sai chi è il nemico.
Lì era sparare vigliaccamente alle spalle. In via Fani furono esplosi 93 colpi:
91 dei brigatisti, 2 dall'eroico Raffaele Iozzino". Così Giovanni Ricci, figlio
di Domenico Ricci, uno dei cinque uomini della scorta uccisi 40 anni fa in via
Fani, con Iozzino, Oreste Leonardi, Francesco Zicci e Giulio Rivera. "Non è più
tempo di schiacciare tanti uomini sotto diciture anonime come la 'scorta di'
Moro, Falcone e Borsellino - ha detto Ricci all'inaugurazione dei giardini in
memoria delle cinque martiri di quell'agguato -. Da oggi spero che anche i
ragazzi delle scuole possano leggere non una semplice riga ma i nomi di chi ci
garantisce la libertà democratica di cui godiamo".
Via Fani 40 anni dopo: Moro
e la strage nel ricordo dei residenti.
Siamo tornati sul luogo
dell'agguato di quel drammatico 16 marzo 1978. E nella memoria di chi ci vive,
sembra sia passato un giorno, scrivono Giulia Pozzi e Valentina Barresi il 16
Marzo 2018 su "La Voce di New York". Per le strade della Balduina, il quartiere
di Roma sconvolto da un evento che avrebbe cambiato per sempre la storia
d'Italia. “Un’angoscia! Abbiamo sentito i rumori, ma nessuno ebbe il coraggio di
muoversi. Poi andammo a prendere i figli a scuola”, racconta una vicina di casa
del leader Dc. Mentre una residente in via Fani ricorda “una persona appostata
in mezzo alle piante” le sere prima dell'agguato. Tornare in via Fani,
all’angolo con via Stresa, 40 anni dopo. A Roma è una mattinata plumbea, l’aria
è carica di umidità, e i colori di quella via passata drammaticamente alla
storia sono appiattiti sulle sfumature del grigio. Fino a qualche ora prima
dell’inaugurazione del nuovo monumento, il marciapiede in prossimità
dell’incrocio, dove alle 9.02 del 16 marzo 1978 la Fiat 130 che trasportava Aldo
Moro venne bloccata da una 128 bianca guidata dal capo delle Brigate Rosse Mario
Moretti, era reso inaccessibile dalle transenne che delimitavano un cantiere.
Oggi, alla cerimonia, in presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, è
stato scoperto il nuovo memoriale. Per anni, però, il ricordo del rapimento del
presidente della Democrazia Cristiana e dell’uccisione dei cinque uomini della
sua scorta è stato affidato a una lapide quasi anonima appesa al muro,
momentaneamente rimossa con l’inizio dei nuovi lavori. Una volta rimontata, a
fine febbraio, è stata barbaramente imbrattata con svastiche e la scritta “a
morte le guardie”. Proprio lì, dove, 40 anni prima, a trovare la morte furono il
maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi e i poliziotti Domenico Ricci,
Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi. Eppure, anche a distanza di
quattro decenni, il tempo, in via Fani, pare essersi fermato. Gli imponenti
palazzi che sorgevano ai lati della strada ci sono ancora, qualcuno
riammodernato nel corso del tempo; c’è ancora quella strada un po’ in salita che
conduce fino a via Trionfale, nei pressi della via dove Moro abitava; c’è ancora
la chiesa del quartiere che il leader della Dc frequentava non solo la domenica.
Certo: qualcosa è anche cambiato. Come il bar Olivetti, un tempo “crocevia di
criminali” – come riconobbe già la Commissione Moro presieduta da Beppe Fioroni
-, che fu smantellato subito dopo l’agguato. Oggi al civico 109, dove sorgeva,
soltanto appartamenti residenziali, e di fianco un ristorante, “La Camilluccia”.
Il proprietario del locale – che negli anni ha cambiato gestione – ricorda bene
tutte le cerimonie che di 16 marzo in 16 marzo si susseguono e a cui può
facilmente assistere dalla grande vetrata della sala da pranzo che dà proprio
sull’incrocio tra via Fani e via Stresa. “Quest’anno hanno fatto la lapide
nuova”, osserva. “Dopo 40 anni finalmente si sono decisi: prima era attaccata al
muro, era una cosa… bruttina”, spiega. E, indignato, prosegue: “Quando la
stavano facendo, hanno fatto pure uno scempio, con scritto ‘A morte le
guardie’…”. Sarà forse per le tante immagini della strage passate davanti ai
nostri occhi, anno dopo anno; o sarà perché ancora oggi Aldo Moro resta presente
“come un fantasma” – così osservò il figlio – sulla scena politica italiana, che
camminando in via Fani è così semplice fare un tuffo nel passato. Un’altra delle
ragioni, probabilmente, è anche che tanti, troppi dubbi sono rimasti aperti
nella ricostruzione di quei 55 giorni, tra i più drammatici della storia
d’Italia.
GLI INTERROGATIVI ANCORA
APERTI. Moro si stava recando in Parlamento – alle 10 lo attendeva il voto di
fiducia al quarto governo Andreotti, appoggiato anche dal Partito Comunista –
quando il rapimento andò in scena. Più tardi, avrebbe dovuto presiedere la
discussione di 10 tesi di laurea alla Sapienza di Roma. Nulla di tutto ciò
accadde. Ma quello che esattamente avvenne, ancora oggi, non si sa ricostruirlo.
Quante persone furono coinvolte in quell’azione giustamente definita “militare”?
Perché – come sostennero i brigatisti – venne trasbordato due volte in luoghi
affollati (prima, in piazza della Madonna del Cenacolo, su un furgone 850 Fiat
guidato da Mario Moretti, poi, in un parcheggio sotterraneo in via Newton, Ami 8
familiare di Laura Braghetti)? Che ne è di quella moto Honda cavalcata da due
passeggeri, rapidamente passata in via Fani a pochi secondi dall’agguato, e
dalla quale, secondo alcuni testimoni, addirittura partirono dei colpi? Cosa ci
faceva un colonnello del Sismi in via Fani? E ancora, che fine hanno fatto le
altre 3 delle cinque borse di Aldo Moro? E fu davvero tenuto in prigionia solo
in via Montalcini o, dubbio avvalorato dall’ultima Commissione di inchiesta,
anche in via Massimi, dove sorgevano i palazzi dello Ior? Che dire, poi, di
quella “seduta spiritica”, avvenuta il 2 aprile 1978, nella casa di campagna di
Alberto Clò a Zappolino, a cui assistette anche Romano Prodi, dove uscì il nome
della località “Gradoli” come luogo di prigionia di Moro? Tutte domande
drammaticamente aperte, anche dopo che sei commissioni d’inchiesta, cinque
processi e tanti tentativi di ricostruzione di quei 55 giorni tra via Fani e via
Caetani, dove il corpo di Moro fu poi ritrovato.
LA MEMORIA VIVA DEI RESIDENTI.
Domande che riecheggiano anche tra la gente che ancora oggi abita quel
quartiere: non è difficile trovare persone che già vivevano lì, in quei palazzi,
il 16 marzo 1978. E per molti di loro, i ricordi di quei momenti – quei momenti
in cui si seppe che qualcosa di grave, gravissimo stava avvenendo – sono
pressoché indelebili. La signora Caterina è una degli inquilini del civico 109
di via Fani che all’epoca ospitava il famigerato bar Olivetti, quello della
saracinesca mezza abbassata sulla scena del crimine la mattina del 16 marzo e
che pure per 38 anni venne dichiarato completamente chiuso quel giorno. Bar
frequentato da personaggi quantomeno “sinistri”, commenta un residente, e che le
indagini hanno portato a identificare quale centrale operativa per l’innesco
dell’agguato a Moro e agli agenti della sua scorta. Nel rievocare quei giorni,
la signora Caterina annota degli strani movimenti tutt’intorno: “All’epoca
uscivo tutte le sere perché avevo un bassotto: ecco, la cosa che ben ricordo è
che per diverse sere vidi una persona che stava ferma proprio lì davanti al
palazzo, appostata in mezzo alle piante – racconta – Poi la mattina del
sequestro non vidi nulla, perché ero a lavoro. Naturalmente dopo perquisirono la
casa e tutta la zona”. E sulle celebrazioni per il quarantennale aggiunge: “E’
chiaro che adesso stiano ricordando tanto questo evento, non soltanto perché
ricorrono i quarant’anni, ma penso che abbia più un significato politico, perché
si vede che allora dal punto di vista politico… beh, diciamo che c’era un po’ di
confusione”. Ci sono poi le vicine di casa del presidente della Dc, due signore
che abitavano nella stessa strada di Aldo Moro, alla Balduina, in via Cortina
d’Ampezzo: oggi percorrono una traversa di via Fani con il carrellino della
spesa al seguito e, a dispetto dei 40 anni trascorsi, di quel 16 marzo hanno un
ricordo nitido, impresso a fuoco nella memoria. “Un’angoscia! Te lo ricordi?”,
chiede Mirella all’amica, che annuisce col capo: “Abbiamo sentito proprio i
rumori. È un ricordo netto – sottolinea – anche se non abbiamo visto niente,
perché nessuno aveva il coraggio di muoversi. Poi siamo andate a prendere subito
i figli a scuola, perché dicevano che bisognava andarli a prendere”.
“Soprattutto in noi c’era una rabbia! – esclama invece Anna, che scandisce bene
ogni parola nel racconto delle emozioni provate in quegli attimi e nei giorni
immediatamente successivi all’eccidio di via Fani – Una rabbia per questo ‘coso
inutile’, proprio una cosa balorda. I giorni dopo sono stati molto molto brutti,
venivano nelle case, ispezionavano… E’ un ricordo chiarissimo. Noi c’eravamo!”
Riferendosi a Moro racconta: “Lo vedevamo sempre. Abitava proprio vicino a noi e
la mattina presto lo vedevamo andare a messa, a Santa Chiara. Sapete cosa mi ha
fatto un po’ impressione ieri sera alla tv? – confessa – Vedere le interviste ai
brigatisti! Perché dare voce a questi soggetti che sono pure tutti liberi?”.
Mentre si allontanano insieme, Mirella aggiunge: “E’ stata una morte proprio
cattiva, perché era un uomo di grande stile”. C’è poi chi pur non essendo stato
testimone diretto o indiretto, descrive l’atmosfera dei giorni che seguirono il
rapimento di Aldo Moro: “Ricordo lo stato di guerra – dice il signor Carlo –
ricordo posti di blocco ovunque, anche se fatti malissimo. Mia moglie stessa se
ne andava in giro insieme ai bambini con un bagagliaio immenso, ma nessuno l’ha
mai fermata – sorride. “Ricordo i cecchini appostati mentre imboccavo
l’autostrada per Civitavecchia. È stato un periodo buio certo, ma ormai sono
passati quarant’anni, appartiene al passato”. Risalendo via Fani e imboccando
poi sulla sinistra via Trionfale, dopo una manciata di minuti si arriva in un
altro luogo chiave del caso Moro, via Massimi 91. Un complesso di palazzine di
lusso, nel 1978 di proprietà della banca vaticana, lo Ior, al cui interno gli
investigatori della Commissione Moro hanno individuato un covo delle Brigate
rosse e dove, verosimilmente, venne organizzata la vera prigione dello statista
della Democrazia Cristiana. “L’ho vissuto quel periodo, eccome! – racconta il
signor Paolo – So’ venuti pure a casa mia e di mi’ moglie a fa’ i controlli. Il
complesso adesso è tutto rifatto – spiega – Solo un palazzo è rimasto originale.
Dopo che lo Ior l’ha venduto, qui sono passati mafiosi, ‘ndranghetisti e pure
strozzini”. Di movimenti strani, però, dice di non averne mai registrati in quei
55 giorni che vanno da via Fani al ritrovamento del cadavere di Moro in via
Caetani. E con una scrollata di spalle si congeda. “Tutti banditi e ladri, la
storia d’Italia si fonda su questo!”.
Quarant’anni fa i
terroristi rapivano Moro: apice e declino delle Brigate Rosse.
Il presidente Dc verrà ucciso 55 giorni dopo: uno scempio di umanità che segna
il culmine del terrorismo rosso, ma anche l'inizio della sua irreversibile
crisi, scrive Sciascianamente Valter Vecellio il 16 Marzo 2018 su "La Voce di
New York". Al terrorismo tutto l’Italia paga un pesantissimo tributo: in 20 anni
almeno 428 morti, 14 mila atti di violenza politica. Cosa resta di quegli anni?
E’ materia di amara riflessione per tutti. Di certo i terroristi sparano,
uccidono, vengono usati da poteri occulti e settori deviati dello Stato.
Qualcuno magari pensava davvero di colpire al cuore l’odiato potere. Ma qui non
è più cronaca; diventa storia.
16 marzo di 40 anni fa: è il
giorno in cui le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro e uccidono i cinque uomini
della scorta. Moro è il protagonista di una politica scomoda, impasto di
prudenza e di audacia: 55 giorni dopo lo uccidono. Uno scempio di umanità che
segna l’apice del terrorismo rosso, ma anche l’inizio della sua irreversibile
crisi. Al terrorismo l’Italia paga un pesantissimo tributo: in 20 anni almeno
428 morti, oltre 1.000 feriti, almeno 14 mila gli atti di violenza politica.
Come inizio prendiamo il 12 dicembre 1969, la strage di piazza Fontana a Milano:
una bomba collocata nella Banca Nazionale dell’Agricoltura,17 morti. Il paese
precipita in un buio periodo di violenza. Una follia di cui sono vittime forze
dell’ordine, magistrati, politici, sindacalisti, cittadini comuni. Ne ricordiamo
alcuni episodi. Il commissario Calabresi: per la magistratura vittima di un
gruppo di fuoco di Lotta Continua; il rogo di Primavalle: aderenti a Potere
Operaio incendiano la casa di un dirigente missino, tra le fiamme muoiono i due
figli di 22 e 8 anni. Poi le stragi fasciste, nel 1974 a Brescia, piazza della
Loggia, e al treno Italicus; in quell’anno le Brigate Rosse rapiscono il giudice
Mario Sossi. Ogni giorno un agguato, un delitto. Tra le prime vittime due
magistrati, Francesco Coco, assassinato dalle Brigate Rosse; Vittorio Occorsio,
ucciso dai fascisti di Ordine Nuovo; sempre le Brigate Rosse uccidono il
vicedirettore della Stampa, Carlo Casalegno. Il culmine con l’assassinio di
Moro. Poi, come se qualcuno abbia detto: basta. Inizia la parabola discendente,
non meno sanguinosa: le Brigate Rosse uccidono tra gli altri Guido Rossa, Emilio
Alessandrini, Valerio Verbano, Mario Amato. E secondo la magistratura porta la
firma della destra estrema la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980:
85 morti, oltre 200 feriti. Cosa resta di quegli anni? E’ materia di amara
riflessione per tutti. Di certo i terroristi sparano, uccidono, vengono usati
da centri di potere occulti e settori deviati dello Stato. Qualcuno di loro
magari pensava davvero di colpire al cuore l’odiato potere. Ma qui non è più
cronaca; diventa storia. La storia, dunque. Quel 16 marzo a via Fani, questa
forse è una delle poche cose sicure, si scrive una delle pagine più buie e
tragiche della nostra storia recente. Le Brigate Rosse pensano di colpire
mortalmente il cuore dello Stato. Indubbiamente si blocca una politica sgradita
sia a Est che a Ovest, che mette in discussione equilibri nazionali e
internazionali raggiunti quarant’anni prima. Il muro di Berlino era ancora ben
solido. Al tempo stesso, uccidendo Moro le Brigate Rosse segnano anche l’inizio
della loro fine. Prima, erano le Brigate Rosse cosiddette “storiche”: quelle dei
Renato Curcio, delle Mare Cagol, degli Alberto Franceschini. Ingozzati di
nozionismo marxisticheggiante mal digerito, il mito di una Resistenza ora e
sempre salvifica e purificatrice. Prima semplici, simbolici, sequestri come
quello, nel 1973, di Ettore Amerio, capo del personale della FIAT Mirafiori.
Poi, un anno dopo, a Padova la svolta: quando uccidono due militanti del
Movimento Sociale. Poi, ecco le Brigate Rosse di Mario Moretti, con solidi e
anche sordidi contatti con l’Est europeo, movimenti palestinesi estremisti,
ambienti inquinati da servizi segreti di ogni tipo. Su Moretti da sempre gravano
sospetti mai del tutto fugati, da parte dei suoi stessi compagni. E’ lui che
gestisce in prima persona l’affaire Moro. Ancora oggi ci si interroga su chi lo
abbia ispirato, sui “suggeritori” occulti. C’è anche un “dopo” Moretti, che
possiamo identificare con Giovanni Senzani. E’ l’ideologo terrorista che
gestisce il rapimento di Ciro Cirillo, che vede coinvolti in una oscura
trattativa gli immancabili servizi segreti e la camorra di Raffaele Cutolo; lo
stesso anno in cui, a Verona, viene rapito il generale americano James Lee
Dozier, liberato da un blitz dei NOCS. Sono gli anni del declino delle Brigate
Rosse. Un declino, lungo, doloroso, scandito sempre da rapimenti, attentati,
sangue, morti; ma ormai è evidente che non servono più a nessuno. Il delitto
Moro è uno spartiacque anche per loro: il sogno di colpire al cuore il Potere
dello Stato si è rivelato solo un incubo, cementato da inganni e stupidità.
E alla fine Vittorio
Emiliani strappò D’Urso alle Br,
scrive Giuseppe Loteta il 31 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". Nel 1980 le Br
sequestrarono il magistrato Giovanni D’Urso. Il Messaggero fu al centro della
vicenda capeggiando il fronte umanitario, grazie al quale si salvò una vita. La
sera del 12 dicembre del 1980 un cronista del Messaggero riceve una telefonata:
“Qui Br. Abbiamo prelevato il magistrato Giovanni D’Urso. Chiediamo la
soppressione del carcere dell’Asinara. Segue comunicato”. In quel tempo lavoravo
nel giornale romano. Il direttore era Vittorio Emiliani. Immediatamente si
riformarono gli schieramenti politici che avevano caratterizzato la vicenda di
Moro: il “fronte della fermezza” e il “fronte della trattativa”. Il primo era
costituito dai comunisti, dai repubblicani e dai missini, più tiepidi e divisi
al loro interno i democristiani. Il secondo, dai radicali e dai socialisti. Ma
questa volta furono i giornali a giocare un ruolo di primo piano, perché le Br
chiesero la pubblicazione dei loro comunicati. Pubblicare o no? Salvare D’Urso o
lasciare che l’uccidessero? Erano passati due anni e mezzo dall’assassinio di
Aldo Moro quando l’Italia fu scossa da un caso che presentava molte analogie con
le circostanze che erano costate la vita allo statista democristiano e che, come
nei giorni del caso Moro, divise profondamente il mondo politico italiano. Il 12
dicembre del 1980 le Brigate rosse rapirono il magistrato Giovanni D’Urso,
direttore dell’ufficio III della Direzione generale degli istituti di
prevenzione e pena del ministero di Grazia e Giustizia. A differenza di quanto
era accaduto a Moro, D’Urso non fu ucciso. Il 15 gennaio del 1981, dopo più di
un mese dal rapimento, fu liberato. Ma cosa accadde in quel mese? Quale partita
fu giocata sulla pelle del magistrato? E quali erano le forze in campo? Andiamo
con ordine. La sera del 12 dicembre un cronista de Il Messaggero riceve un
insolita telefonata: “Qui Br. Abbiamo prelevato il magistrato Giovanni D’Urso.
Chiediamo la soppressione del carcere dell’Asinara. Segue comunicato”. In quel
tempo lavoravo nel giornale romano. Il direttore era Vittorio Emiliani, che
aveva formato una bella equipe nominando condirettore l’ex bravissimo
capocronista, Silvano Rizza, vicedirettore Felice La Rocca, che conosceva Il
Messaggero come le sue tasche, e redattore capo Pino Geraci, che aveva ricoperto
lo stesso incarico al Giornale di Sicilia. La squadra, insieme con tutta la
redazione, fu all’altezza della situazione, in quelle ore e nei giorni
successivi. Di D’Urso, fu appurato, non c’era traccia. E il giornale del 13
dicembre uscì con un titolo di prima pagina a sette colonne che annunciava il
rapimento del magistrato ad opera delle Brigate rosse. Nello stesso giorno le Br
si fecero vive con l’annunciato comunicato, diffuso insieme con una fotografia
del giudice. Vi si leggeva che D’Urso, “aguzzino di migliaia di proletari”, “è
in un carcere del popolo e verrà sottoposto con un processo al giudizio del
proletariato”. Il documento si chiudeva con un imperativo: “CHIUDERE L’ASINARA”,
il carcere di massima sicurezza che sorgeva sull’omonima isola sarda e che era
adibito alla reclusione di brigatisti. Immediatamente si riformarono gli
schieramenti politici che avevano caratterizzato la vicenda di Moro, fino alla
sua morte: il “fronte della fermezza” e il “fronte della trattativa”. Il primo
era costituito dai comunisti, dai repubblicani e dai missini, più tiepidi e
divisi al loro interno i democristiani. Il secondo, dai radicali e dai
socialisti. Ma questa volta sono i giornali a giocare un ruolo di primo piano,
soprattutto nella seconda fase della vicenda. Gli intransigenti si fanno sentire
subito, il 14 dicembre. Il comunista Ugo Pecchioli, il più autorevole dirigente
del Pci dopo Berlinguer, afferma: “Ogni cedimento ai ricatti sarebbe
inaccettabile”. Gli fa eco il repubblicano Leo Valiani: “È necessario rispondere
con la stessa fermezza con cui si rispose al sequestro Moro”. Il 15 dicembre i
brigatisti ripropongono in un secondo comunicato la richiesta di una chiusura
immediata dell’Asinara, aggiungendo che D’Urso “sta bene e risponde
all’interrogatorio”. Il giorno dopo, in Parlamento, i radicali sono i primi a
schierarsi sul fronte umanitario. Franco De Cataldo: “Qualsiasi tentativo deve
essere fatto per salvare la vita di D’Urso”. E Marco Boato: “Chiudere il carcere
dell’Asinara e rivedere tutto il regime delle carceri speciali è una
rivendicazione sacrosanta che dobbiamo portare avanti autonomamente, con forza”.
Per la verità, la chiusura del carcere di massima sicurezza era stata già
programmata, ma l’attuazione era stata rinviata a tempo indeterminato. Seguono
dieci giorni di incertezza. Il governo, presieduto da Arnaldo Forlani, è diviso,
con una maggioranza di possibilisti, dal ministro di Grazia e Giustizia, Adolfo
Sarti, al ministro dell’Interno, Virginio Rognoni. Ed è Rognoni ad affermare, a
chiusura del dibattito parlamentare sul rapimento: “Il governo non lascerà nulla
d’intentato, nei limiti delle possibilità, per raggiungere l’obiettivo, oggi
primario, della restituzione del giudice D’Urso alla sua famiglia”. Si delinea
anche tra i giornali la divisione tra intransigenti e trattativisti. Il
direttore de Il Messaggero decide di tenere una linea “laicamente possibilista”
per “non ripetere il caso Moro”. Radio radicale dedica molte ore alla vicenda
del giudice. I brigatisti, il 18 e il 23 dicembre, informano con due comunicati
che “l’interrogatorio del prigioniero D’Urso prosegue”. E continuano a
richiedere l’immediata chiusura dell’Asinara. Il giorno di Natale i socialisti
rompono ogni indugio. Il segretario del Psi, Bettino Craxi, fa diffondere un
comunicato della direzione del partito, nel quale si afferma che la chiusura
dell’Asinara coincide con un “adempimento giustificato e da più parti
richiesto”. Il giorno dopo il ministro Sarti annuncia lo sgombero del carcere, A
questo punto è ragionevole supporre che le Br, soddisfatta la loro richiesta,
rilascino D’Urso. Ma, all’improvviso si apre, con una rivolta carceraria e con
una tragedia, la seconda fase della vicenda. Il 28 dicembre, domenica, nel
carcere di Trani, dopo l’ora d’aria, il brigatista Seghetti aggredisce il capo
delle guardie e lo sequestra. Una settantina di detenuti cattura le altre
guardie e si asserraglia nella sezione speciale del carcere. Ma dura poco. Nel
pomeriggio del giorno successivo entrano in azione i gruppi d’intervento
speciale dei carabinieri. Scendono dagli elicotteri, impiegano bombe al magnesio
e armi da fuoco, domano in breve tempo la rivolta. Non ci sono vittime,
ventisette feriti tra i rivoltosi. Tre giorni dopo, alle 18,30 il generale
Enrico Galvaligi ritorna a casa. Il generale è il vice comandante del
coordinamento dei servizi di sicurezza per gli istituti di prevenzione e pena.
In quei giorni ha avuto parecchio da fare. È lui, infatti, che ha diretto da
Roma l’operazione di repressione della rivolta di Trani. Ora sta per raggiungere
moglie e figli e festeggiare insieme con loro l’arrivo del nuovo anno. Non ha
scorta. E, nell’androne di casa, trova due brigatisti travestiti da fattorini
postali. Dicono di volergli consegnare un pacco, ma uno dei due impugna
rapidamente una pistola e gliela scarica addosso. Il generale non ha scampo.
L’assassinio di Galvaligi è la reazione vendicativa delle Br all’operazione
guidata dal generale. Ma non è la sola. Il 29 dicembre, lo stesso giorno del
blitz dei carabinieri, i brigatisti alzano la posta con un ultimatum. I nostri
comunicati, affermano, “devono essere pubblicati immediatamente e
integralmente”. E ancora: “Se quanto sopra verrà disatteso, agiremo di
conseguenza”. Il 4 gennaio sono più espliciti. Da un lato annunciano la condanna
a morte del magistrato. Dall’altro affermano che “l’opportunità di eseguirla o
di sospenderla deve essere valutata politicamente”. E che “per decidere se
eseguire o sospendere l’esecuzione di D’Urso i comunicati dovranno essere
trasmessi dai vostri strumenti televisivi, letti sui maggiori quotidiani
italiani”. Ma di quali comunicati si tratta? Di una serie di fogli che i
brigatisti detenuti hanno consegnato ai deputati radicali durante una loro
visita al carcere. Sono scritti da Renato Curcio e contengono le abituali
farneticanti accuse allo Stato imperialista e la rivendicazione delle lotte
“proletarie” delle Brigate rosse. A questo punto la parola passa ai giornali.
Sono loro, non il governo, gli interlocutori dei brigatisti. Che fare? Il
Tempo diretto da Gianni Letta e Il Corriere della Sera, diretto da Franco Di
Bella, annunciano il silenzio stampa su tutte le notizie che riguardano il
terrorismo e chiedono agli altri giornali di fare altrettanto. Il Messaggero si
oppone nettamente. Avrebbe continuato a dare tutte le informazioni sul
terrorismo. Ma neanche gli altri giornali raccolgono l’invito, neppure La
Repubblica, pur schierata da Eugenio Scalfari sul fronte della fermezza. Restava
l’interrogativo: pubblicare o no i comunicati dei brigatisti? “Non pubblicare” è
la linea dura del Corriere della Sera, di
Repubblica, della Stampa, del Tempo, dell’Unità, di Paese Sera, dell’Avvenire,
del Mattino, del Resto del Carlino, del Giornale, seguiti da una serie di
giornali minori; una linea ancora una volta sostenuta con ferrea decisione dai
comunisti, dai repubblicani, dai missini e dagli ambienti più conservatori del
mondo cattolico. L’Espresso è contrario alla pubblicazione, ma non rinuncia agli
scoop. Così, lo stesso giorno dell’omicidio Galvaligi, il 31 dicembre, viene
arrestato il giornalista del settimanale, Mario Scialoja, che aveva ricevuto dal
brigatista Giovanni Senzani (e pubblicato) il resoconto dell’interrogatorio di
D’Urso da parte delle Br. Al Messaggero la vicenda è seguita dalla direzione e
dal corpo redazionale con viva partecipazione. Il giornale romano è laico e
garantista, è stato protagonista di battaglie libertarie, a cominciare da quella
per il divorzio. Non può restare insensibile alla sorte di D’Urso. L’assemblea
di redazione si riunisce in permanenza e la maggioranza dei sostenitori della
pubblicazione si scontra con una minoranza di contrari. La direzione, malgrado
il parere avverso della proprietà, si attesta su una linea “marcatamente
aperturista, possibilista”. E pubblica un’intervista a Leonardo Sciascia, nella
quale lo scrittore siciliano sostiene che “il cittadino ha il diritto di essere
informato, anzi a formarsi un’opinione, su qualsiasi argomento”. Il 10 gennaio,
Sciascia lancia un appello ai giornali, sottoscritto da settanta giornalisti e
personalità in vista, invitandoli alla pubblicazione dei documenti delle Br. I
primi nomi in calce all’appello sono quelli di Elena Moro, Stella Tobagi e
Andrea Casalegno. E due giorni dopo, con un secondo appello, rivolge ai
direttori dei giornali italiani lo stesso invito, nominandoli uno ad uno. Il
Corriere della Sera, con il quale Sciascia aveva un contratto di collaborazione,
non dà notizia dell’intervista e non pubblica gli appelli. Altri giornali non
contrari alla pubblicazione sono l’Avanti, il Secolo XIX, Lotta continua, Il
manifesto. Giuliano Zincone dirige il genovese Il lavoro, del gruppo Rizzoli. È
possibilista, ma non lo sono i vertici del gruppo. Non lo è Angelo Rizzoli, non
lo è Bruno Tassan Din, direttore generale di Rcs, non lo è Franco Di Bella,
direttore de Il Corriere della Sera. I nomi di tutti e tre compariranno, dopo
qualche tempo, negli elenchi degli iscritti alla loggia massonica P2, guidata da
Licio Gelli. Ed è Leonardo Iorio, direttore editoriale del Corriere, a
ingiungere a Zincone, in nome del gruppo, di non pubblicare i documenti delle
Br. La risposta è: “Se lo riterrò opportuno pubblicherò e subito dopo mi
dimetterò dalla direzione del Lavoro. Il Giorno si impegna alla pubblicazione
dei documenti dopo la liberazione di D’Urso. Il direttore
della Nazione, Gianfranco Piazzesi, vorrebbe pubblicare, ma ne è impedito dal
proprietario del gruppo che comprende anche il giornale fiorentino, Attilio
Monti, anche lui, si saprà dopo, negli elenchi della P2. L’attività dei radicali
è frenetica. Il 12 gennaio cedono la loro tribuna politica televisiva a una
figlia di D’Urso, Lorena (oggi giornalista a Radio radicale), che lancia un
appello alle Br e ai direttori dei giornali. La ragazza legge anche un brano dei
documenti. Ha le lacrime agli occhi quando nel corso della lettura deve dare del
“boia” al padre. E non passa giorno che Radio radicale, Pannella e altri
esponenti del partito non intervengano sul caso. L’ultimo messaggio dei
brigatisti è del 10 gennaio. Non lascia spazio a interpretazioni: “Se entro 48
ore non leggeremo integralmente sui maggiori quotidiani italiani i comunicati,
daremo senz’altro corso all’esecuzione della sentenza a cui D’Urso è stato
condannato”. A questo punto bisogna decidere. Il possibilismo e la non
contrarietà non bastano più. L’onere della decisione spetta soprattutto
al Messaggero, il più diffuso tra i giornali che puntano alla liberazione del
magistrato. L’assemblea di redazione è sempre più infuocata. Assistono ai suoi
lavori la moglie di D’Urso, Franca, e le due figlie. Non sembrano esserci spazi
di mediazione tra la maggioranza favorevole alla pubblicazione e la minoranza
contraria. Si sta per arrivare a una votazione che avrebbe spaccato in due il
giornale, quando arriva in assemblea il direttore, Emiliani. “La nostra linea
umanitaria è nota”, dice, “non condividiamo nulla di quei comunicati deliranti,
ma siamo disposti a pubblicarli soltanto per ragioni squisitamente umanitarie.
Vi scongiuro di non giungere a un voto che creerebbe fratture gravi tra di noi.
La responsabilità del giornale è mia e la rivendico pienamente, nel bene e nel
male”. Non si vota. La decisione è presa. E confermata da un corsivo indirizzato
alle brigate rosse che Emiliani scrive l’indomani sulla prima pagina del
giornale. Indirettamente, i brigatisti fanno sapere che accettano la
pubblicazione “per ragioni umanitarie”. Il 14 gennaio Il Messaggero pubblica
integralmente i comunicati delle Br. Contemporaneamente pubblicano l’Avanti, il
Secolo XIX, Lotta continua, Il Manifesto e Notizie radicali. Pubblica anche Il
Lavoro e Zincone si dimette dalla direzione. Ritorna al Corriere della Sera, ma
dopo poco tempo lascerà anche questo giornale. Il Messaggero accompagna la
pubblicazione con un editoriale che puntualizza: “È una decisione soltanto
umanitaria, non politica”. Nello stesso 14 gennaio Leonardo Sciascia pubblica un
terzo appello, rivolgendosi direttamente ai brigatisti. La mattina del 15
gennaio D’Urso viene ritrovato al Portico di Ottavia, a Roma, incatenato in
un’auto, occhi e bocca coperti da cerotti, ma vivo. L’incubo è cessato. Non si è
ripetuta la tragica conclusione del caso Moro. I sostenitori della “fermezza”
sono stati sconfitti. Sconfitti i comunisti e la loro visione leninista dello
Stato. Sconfitta l’intransigenza di stampo risorgimentale dei repubblicani.
Sconfitti i missini, i piduisti di Gelli e quanti auspicavano, con la morte di
D’Urso, la fine del governo quadripartito di Forlani e una virata a destra
dell’asse governativo. Una vita umana è stata salvata. Due giorni dopo Sciascia
viene al Messaggero, accolto da un applauso. Si congratula con Emiliani per la
linea umanitaria tenuta in tutta la vicenda e s’impegna a collaborare al
giornale. Il francese Le Monde pubblica una vignetta che mostra D’Urso in
viaggio verso la libertà su un aereo del Messaggero.
Aldo Moro. Faccia a faccia
tra la figlia e l'ex brigatista,
scrive Antonio Maria Mira venerdì 16 marzo 2018 su Avvenire. 16 marzo 1978: in
via Mario Fani a Roma si scrive una delle pagine più buie della nostra storia,
la parte più tragica della «notte della Repubblica». In un agguato le Brigate
Rosse sequestrano Aldo Moro uccidendo i 5 uomini della sua scorta. Il rapimento
si concluderà drammaticamente dopo 55 giorni di prigionia con l’uccisione
dell’allora presidente della Democrazia Cristiana. Oggi il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla cerimonia commemorativa in via Fani,
durante la quale il sindaco di Roma Virginia Raggi scoprirà una lapide in
memoria degli agenti trucidati, alla presenza di una rappresentanza dei loro
familiari. Prevista anche la visita di una delegazione del Pd. Nel pomeriggio
presso L’Altro Spazio di via Tiburno si svolge l’evento 'Via Fani 16 marzo
1978', durante il quale viene presentato il cortometraggio 'Valeria' di Matteo
Pizziconi e Valerio Schiavilla, che racconta la storia, vera o verosimile, della
fidanzata di Francesco Zizzi, uno dei poliziotti uccisi. In programma anche la
mostra fotografica I particolari della cronaca dello stesso Pizziconi e un
incontro con Gero Grassi, membro della commissione parlamentare su Moro.
Agnese e Adriana. La vittima e
il carnefice. Eppure quando le vedi, le senti, è la prima ad apparire la più
forte. Come quando Agnese Moro accarezza Adriana Faranda, quasi per sostenerla,
per sostenere parole difficili. La figlia del presidente della Dc, rapito dalle
Brigate rosse quaranta anni fa e l’ex brigatista fianco a fianco. L’occasione è
un incontro nella chiesa romana di San Gregorio al Celio, per raccontare
l’esperienza del gruppo sulla giustizia riparativa, promosso da padre Guido
Bertagna, del quale Agnese e Adriana fanno parte, assieme ad altre vittime e
altri ex esponenti della lotta armata. Si parla del loro incontro, del loro
dialogo. Ma il dramma di quei 55 giorni del 1978 emerge continuamente. Agnese
ricorda «l’uccisione di cinque brave persone che proteggevano mio padre, il suo
rapimento, un lungo periodo di angoscia, di disumanità non solo in coloro che
avevano commesso questi atti ma anche in coloro che avrebbero dovuto aiutare mio
padre ad uscire da quella situazione. E poi la sua morte e tutto quello che è
seguito. Alla fine c’è una grande assenza, una persona per te cara,
indispensabile, che non c’è più». Anche Adriana ricorda. «Quando è stato ucciso
il papà di Agnese, mi sono sentita responsabile in pieno di quella morte ma ero
assolutamente contraria al fatto che venisse ucciso e l’ho vissuta come una
delle cose più atroci che stavano avvenendo». Poi il carcere e un percorso per
un’altra forma di giustizia. «Per me Agnese era il suo avvocato di parte civile
che voleva dimostrare che io ero la persona più orribile che fosse mai nata
sulla terra. Non potevo in quel momento e in nessun modo arrivare ad Agnese, era
assolutamente impossibile perchè dovevo solo difendermi e cercare di affermare
la dignità di un percorso che avevo scelto. Quando poi alla fine riconquisti la
libertà, ti rendi conto che quella del carcere è una forma di giustizia ma
incompleta. A me non bastava. Quello che sentivo come dovere e anche come
desiderio era affrontare fino in fondo il problema della giustizia ritrovando le
persone che erano state colpite, andando a cercare l’altro che avevamo negato».
È lo stesso cammino di Agnese cominciato proprio 40 anni fa. «La mia vita è
rimasta bloccata tra il 16 marzo e il 9 maggio 1978, sei sempre lì. E non perché
te lo ricordi, ma perché ogni giorno risuccede. E questa dittatura del passato
ti isola perché pensi che nessuno ti potrebbe mai capire. Hai dentro un urlo che
non riesce a uscire, ti soffoca. Alla fine tutto fa sì che i morti abbiano più
spazio dei vivi, di quelli che stanno intorno a te, di quelli che ami. E ti
accorgi drammaticamente che il male non rimane lì. Va avanti finchè qualcuno non
lo fermerà, perché crea altre situazioni di sofferenza. E tutto si accompagna a
sentimenti di rancore, di rabbia, anche di senso di colpa perché mio padre non è
stato abbattuto un giorno uscendo di casa. È stato lì tanti giorni e io non sono
riuscita a salvarlo. E assieme c’è un desiderio di giustizia». Che non sono gli
anni di carcere. «Non si sta meglio. È un’illusione. Potevano dargli 100mila
anni di carcere e non si sarebbe risolto il problema perché tu hai bisogno di
avere una giustizia che riguardi anche le ferite che hai ricevuto. E che non
sono facilissime da curare». E allora, Agnese, la giustizia sta provando a
costruirla proprio insieme ai responsabili della morte del padre. «Sono stati
una sorpresa perché nella mia mente loro sono dei mostri senza cuore, senza
pietà. E lo sono anche stati». Ma, aggiunge, «le persone non rimangono uguali,
non è che se tu hai fatto delle cose orrende poi per sempre dovrai essere una
persona orrenda. Dentro queste persone c’è qualcosa di diverso da quello che io
pensavo». In particolare scoprire «un dolore infinitamente peggiore del mio,
perché è quello di chi l’ha fatta grossa e non può rimediare. E che li fa essere
totalmente disarmati nei nostri confronti. Per me Adriana è l’emblema della
persona disarmata (le sorride e l’accarezza, ndr) perché io avrei potuto fare o
dire qualsiasi cosa e l’avrebbe accettata, non perché sono delle pecore ma
perché sono disarmate di fronte a me. E imparare a disarmarsi è stata per me la
grande lezione di questo stare insieme. Ho imparato da loro che se tu vuoi
ascoltare qualcuno e poi parlare ti devi disarmare da pregiudizi e rabbia». E
Adriana conferma, piegata sul microfono e dai ricordi. «Io sono sempre disarmata
rispetto a qualunque parola, al tocco di Agnese che nel momento in cui sembra
spaccarti in due il cuore costruisce un ponte, ti tende sempre la mano. Questa è
una delle cose più importanti che ho vissuto in questo percorso estremamente
duro in cui ci siamo messi a nudo gli uni nei confronti degli altri». Con una
certezza. «Che quelle cose che venivano dette con forza nei momenti di maggiore
emotività e dolore non erano per tagliarti fuori ma per stimolare una maggiore
profondità, intensità, autenticità dell’incontro che stavamo vivendo». In
«un’atmosfera di quotidianità, come se fosse naturale che persone vittime di
tragedie così irreparabili potessero convivere lavando i piatti insieme a chi
aveva prodotto questo disastro». E così, sottolinea Agnese, «il passato arretra
e viene sostituito da un presente che è fatto dai loro volti, delle nostre
discussioni e tu sei più libero. Così quel male che ti ha portato via qualcuno,
e di cui delle persone sono state interpreti ma che esiste a prescindere da
loro, non ha l’ultima parola perché le loro vite sono ritornate delle vite buone
perché c’è la possibilità di ricostruire. Per me è l’unica forma di vera
giustizia: tu male che hai preso mio padre in maniera così terribile, non
vincerai per sempre perché oggi siamo qui insieme, siamo amici, ci occupiamo gli
uni degli altri e questo guarirà qualcosa». Un’esperienza che Adriana cala nel
presente. «Se siamo riusciti a dialogare noi, può riuscirci chiunque e può
riuscirci prima che sia necessario perché altrimenti ci ritroveremo con altre
espressioni di violenza che non saranno paragonabili a quelle dei nostri anni,
ma potranno assumere altri volti». Ma, avverte Agnese, «bisogna recuperare nella
vita quotidiana, nella politica, la fiducia nella forza della parola. Noi non
abbiamo fatto altro che accettare di stare seduti in una stanza e parlarci,
anche dirci cose odiose. Le parole cambiano le vite, cambiano le persone».
L’ex br Balzerani sui morti
di via Fani: «La vittima è un mestiere».
La componente della colonna
terroristica che rapì Moro e uccise la scorta è intervenuta a Firenze. Le sue
parole ancora una volta suonano come uno schiaffo ai familiari di chi venne
ucciso, scrive Claudio Del Frate il 17 marzo 2018 su "Il Corriere della Sera".
Barbara Balzerani, l’ex componente della colonna romana delle Br condannata per
l’omicidio di Aldo Moro e la strage di via Fani non recede e rivendica il suo
diritto a parlare a 40 anni dai tragici fatti che sconvolsero l’Italia. Lo ha
fatto da Firenze dopo la sera del 16 marzo, proprio in coincidenza del
quarantennale dell’eccidio della scorta del segretario Dc era stata invitata in
un centro sociale a presentare il suo libro dal titolo «l’ho sempre saputo» (che
non parla di terrorismo). «C’è una figura, la vittima, che è diventato un
mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola
- ha detto la componente della batteria che prese parte al rapimento di Aldo
Moro -. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non
ce l’hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te» aggiunto
Balzerani sfidando il cinismo e pronunciando parole destinate a innescare dure
polemiche sull’eredità degli anni di piombo.
Il centro sociale: «Pura
coincidenza». Inizialmente, alla presentazione del libro a Firenze erano
intervenuta solo una settantina di persone e l’ex terrorista aveva evitato di
parlare dell’anniversario della strage. «Anche se nessuno ci potrà credere, in
realtà davvero nessuno aveva pensato a questa coincidenza, ma quando è stato
fissato l’appuntamento non ci siamo tirati indietro» aveva affermato Edoardo
Todaro, sindacalista dei Cobas, introducendo l’iniziativa con Silvia De
Bernardinis, autrice della prefazione: «Probabilmente i mezzi di informazione,
vista la scarsezza di notizie da dare, dovevano `crearne´ una». Poi, a incontro
concluso Barbara Balzerani ha pronunciato le frasi destinate a rinfocolare la
polemica.
La replica di Maria Fida Moro.
Già lo scorso gennaio l’ex brigatista aveva pronunciato frasi che erano suonate
come uno schiaffo ai familiari delle vittime di via Fani e di Aldo Moro. «Che
palle, sta per arrivare il quarantennale della strage, qualcuno vuole
ospitarmi?» aveva detto colei che era stata condannata per omicidio e sequestro
di persona. Dopo un lungo silenzio proprio pochi giorni fa le aveva replicato
Maria Fida Moro, figlia dello statista assassinato, attraverso un video
pubblicato su Youtube. «Io ho il diritto di dire “che palle il quarantennale,
non tu» aveva detto Maria Fida rivolgendosi all’ex terrorista.
Cinismo-shock dell'ex br
Balzerani: "Vittima è diventato un mestiere...". Polemica a Firenze, rabbia di
Fida Moro.
Presenta un suo libro in un centro sociale. Parla di "spauracchio del 16 marzo".
Molti rappresentanti cittadini: "Episodio inaccettabile". La figlia dello
statista: "Voi avete trasformato in mestiere una morte ingiusta" . Il presidente
dell'Associazione vittime del terrorismo: "Un consiglio? Questi signori
cercassero di farsi dimenticare", scrivono Gerardo Adinolfi e Laura Montanari il
17 marzo 2018 su "La Repubblica". "C’è una figura, la vittima, che è diventato
un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della
parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non
ce l’hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te". Così
l'ex brigatista Barbara Balzerani - della colonna romana delle Br e componente
del gruppo che ha preso parte al rapimento di Aldo Moro - ha commentato
l'anniversario di quel 16 marzo 1978, ieri sera al centro sociale Cpa di
Firenze, alla fine della presentazione del suo libro "L'ho sempre saputo".
L'incontro era stato fissato il giorno stesso dell'anniversario della strage di
via Fani e questo ha suscitato non poche polemiche e proteste da parte di
parlamentari del centrosinistra e della destra fiorentina. Lei ha risposto con
quelle parole sulle vittime a chi ricordava l'intervento del capo della polizia
Franco Gabrielli che aveva sostenuto che "vedere i brigatisti in tv era un
oltraggio ai morti". Non si è fatta attendere la risposta di Maria Fida Moro,
figlia dell'ex statista della Dc: "Prendo atto della sua inconsulta
dichiarazione. Avrei immaginato che avrebbe risposto con il silenzio che è
d'oro. Negli ultimi quaranta anni mentre io mi arrampicavo sugli specchi per
mantenere mio figlio, voi ve la siete "goduta" senza fatica, senza dolore e
senza merito" - dice Fida Moro - ciò detto aggiungo che io sono quella del
perdono nei vostri confronti, che mi è costato un baule di parolacce e minacce
di morte (compresa la carta igienica sporca inviata per posta). Altri -
sottolinea - hanno trasformato in mestiere ed in una lucrosa fonte di reddito il
nostro dolore. Detesto anche solo l'idea del mestiere di vittima, che ho sempre
rifiutato. Sono andata in giro gratis attraverso l'Italia per portare un
messaggio di pace amorevole, nonostante. Se c'è qualcuno che ha trasformato in
mestiere una morte totalmente ingiusta siete voi, portati in palma di mano, da
gente vile e meschina". Oltretutto, nelle settimane precedenti, la stessa
Balzerani aveva scritto (il 9 gennaio) un post su Facebook poi cancellato in cui
si leggeva: "Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40ennale?". Il
riferimento all'anniversario di Moro è parso evidente e qualche giorno fa, la
figlia dell'esponente Dc, Maria Fida Moro, ha caricato un video su Youtube in
cui ha risposto a distanza: "Che palle il quarantennale lo dico io che non l'ho
provocato e che l'ho subito e che ho il titolo per dirlo. Perché il
quarantennale mi dà dolore. Ma la signora Balzerani non può dirlo perché lei è
tra coloro che l'hanno provocato". La ex terrorista, nel parlare delle vittime
durante la presentazione del libro a Firenze, ha anche spiegato con un parallelo
agghiacciante che "non è che se vai a finire sotto un'auto sei una vittima della
strada per tutta la vita, lo sei nel tempo che ti aggiustano il femore...".
L'invito del Cpa a Barbara Balzerani aveva sollevato molte polemiche e proteste
fin dalla vigilia: "E' inaccettabile che una ex brigatista non pentita possa
dare lezioni sugli anni più drammatici e bui della democrazia" ha detto
l'onorevole Gabriele Toccafondi (di Civica Popolare eletto nel centrosinistra),
mentre Jacopo Cellai e Mario Tenerani (Forza Italia) e Francesco Torselli
(Fratelli d'Italia) hanno parlato di "memoria infangata delle vittime di una
strage che segnò per sempre la storia della nostra Repubblica". Sulle parole
della ex Br è intervenuto anche il presidente della Regione Enrico Rossi: "Non
provo rancore nei confronti di chi partecipò al rapimento Moro, il tempo passa,
ma non sono loro i protagonisti dei commenti e del ricordo. Capisco che hanno
espiato e che hanno diritto a dire la loro. Ma ci sono molte cose su cui
esprimersi: sulla vicenda Moro loro possono solo dire di avere sbagliato e
chiedere scusa agli italiani”. Per il sindaco di Firenze Dario Nardella invece
"le parole dell'ex brigatista Balzerani sono un insulto meschino ad Aldo Moro e
a tutte le vittime del terrorismo. Quanto da lei affermato è un oltraggio alla
memoria di coloro che hanno perso la vita in una strage che ha segnato e
cambiato la storia del nostro Paese. Firenze, che ha perso un sindaco, Lando
Conti, per mano terrorista - conclude Nardella -, si schiera dalla parte di chi
ha perso la vita in nome dei valori istituzionali che i brigatisti volevano
sovvertire". E comunque in una saletta affollata uno degli organizzatori aveva
spiegato che l'invito per il 16 marzo era soltanto una coincidenza: "Ma abbiamo
pensato di non tirarci comunque indietro", aggiungendo che non si sarebbe
parlato di via Fani. Così non è stato, non c'è stato un minimo contradditorio,
nessuno che dalla platea abbia sollevato obiezioni alle parole
dell'ex-terrorista che ha argomentato di una "decontestualizzazione di quella
mattina" di 40 anni fa e di una "guerriglia comunista condotta contro le
principali forze politiche che avevano fatto blocco". Di via Fani si è parlato,
eccome. Ma alle parole dell'ex-compagna di Mario Moretti (con cui ha condiviso
anche la "gestione" della prigionia di Moro nel covo di via Gradoli) nessuno ha
sollevato una qualsiasi obiezione. Dura, invece, la reazione dell'Associazione
vittime del terrorismo, il cui presidente Roberto Della Rocca, fu gambizzato
dalle Br nel 1980 a Genova: "La vittima non è mestiere ma una calamità che
capita a persone e familiari. E dura tutta la vita, perché le ferite morali non
si rimarginano - ha detto Della Rocca - questi signori se hanno da dire qualcosa
si presentino davanti ai giudici e diano brandelli di verità, anche se la
giustizia noi non la possiamo ormai più pretendere". Della Rocca continua: "Ci
farebbe piacere che invece che esporsi cercassero di farsi dimenticare". Sulla
stessa linea Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell'Associazione tra i
familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili: "Quello delle
vittime non è un mestiere, lo è invece quello di chi ha fatto parte di gruppi
terroristici eversivi e oggi cerca di imporsi alle nuove generazioni con
insegnamenti".
Il tour indisturbato della
terrorista. Gira l'Italia per rivendicare il proprio passato. E nessuno dice
nulla,
scrive Luca Fazzo, Lunedì 19/03/2018 su "Il Giornale". Hanno evidentemente la
manica larga, i capi della azienda di informatica che ha assunto Barbara
Balzerani, già membro della direzione strategica delle Brigate Rosse: cui,
invece di timbrare il cartellino, concedono di impiegare il tempo scrivendo
libri e girando l'Italia per presentazioni, convegni e dibattiti. Contenti loro,
si potrebbe dire. Peccato che i tour della Balzerani si trasformino in una sorta
di campagna revisionistica della stagione del terrore, in cui l'unico vero torto
che viene ammesso dalle Br è quello di non avere vinto la loro guerra. Più delle
inossidabili certezze della Balzerani, fa effetto il fascino che le sue
rivendicazioni esercitano non solo sui vecchi compagni di ideali, ma anche su
una galassia che va dal mondo antagonista a settori della sinistra parlamentare,
del sindacalismo di base e persino delle istituzioni. Non una banda di fanatici
ma degli Icaro caduti in volo: così la Balzerani e i suoi compagni si presentano
e vengono applauditi. Il D-Day, il giorno in cui la sanguinosa utopia brigatista
viene ufficialmente sdoganata, è il 19 gennaio 2013, quando si celebrano i
funerali di Prospero Gallinari, fondatore delle Br: a salutare a pugno chiuso la
bara ci sono i quadri storici, con in testa Renato Curcio e la Balzerani: ma
anche centri sociali, comitati no Tav, persino il coordinatore di Rifondazione
Comunista Alberto Ferrigno e il segretario nazionale Claudio Grassi, già
senatore. Pugni chiusi, inni partigiani, un clima da «formidabili quegli anni».
«Non sarò mai né un ex brigatista né una dissociata», dice pochi giorni dopo la
Balzerani. È una rivendicazione tetragona della giustezza delle ragioni
brigatiste che non impedisce a settori importanti della sinistra di flirtare con
l'ex ergastolana. A venire sedotta è anche una figlia della più celebre vittima
delle Br, Maria Fida Moro: che nel 2007 incontra a lungo la Balzerani, e ne esce
dando il suo decisivo via libera alla scarcerazione della brigatista. La quale
oggi la ringrazia con la battuta brutale a margine di un incontro a Firenze,
«quello di vittima ormai è un mestiere». A fare la fila per ospitare la
Balzerani sono soprattutto i centri sociali dell'ala antagonista: le ultime
esternazioni di «Compagna Luna» (suo soprannome e titolo della sua
autobiografia) hanno avuto per teatro il Cpa di Firenze. Nel 2009 era toccato al
«Corto Circuito» di Roma, il cui sgombero, dopo ventitré anni di occupazione
abusiva, verrà poi stigmatizzato dai leader di Sinistra Italiana: come se la
rivendicazione dell'esperienza brigatista non fosse sufficiente a tirare una
riga nel dibattito a sinistra, non bastasse a separare ragioni e torti, e anche
i crimini delle Br dovessero venire ammessi nell'album di famiglia della gauche.
Qua e là per l'Italia - da Ruvo di Puglia a Carpineto Romano a Aiello Calabro -
sindaci in stato confusionale si candidano a ospitare e patrocinare le
presentazioni-comizio della Balzerani. Ma i veri plebisciti «compagna Luna» li
riscuote sui social network, di cui è alacre frequentatrice. E dove anche le
ultime polemiche che l'hanno investita per la battutaccia sul «mestiere di
vittima» vedono scendere in campo al suo fianco valanghe di supporter: «Hai
avuto il coraggio di agire insieme agli altri compagni per una trasformazione in
senso socialista della società e osato sfidare frontalmente il capitalismo!». E
roba di questo genere.
La sceneggiatura del caso
Moro. Tra
Todo Modo di Sciascia e influenze bibliche. Il rapimento del leader Dc riletto
da uno scrittore millennial come fosse un film, scrive Raffaele Alberto Ventura
il 17 Marzo 2018 su "Il Foglio". Quando nel 1978 il segretario della Democrazia
Cristiana Aldo Moro venne rapito e assassinato dalle Brigate Rosse, lo scrittore
Leonardo Sciascia dovette ammettere che i fatti presentavano spiacevoli analogie
con il contenuto del suo romanzo Todo modo, pubblicato nel 1974 e adattato al
cinema nel 1976. Il libro fornisce una descrizione grottesca dei torbidi
meccanismi di potere che regolavano la vita politica italiana della Prima
Repubblica e alla fine racconta l’uccisione rituale di un personaggio
riconoscibile come caricatura di Aldo Moro. Nel romanzo il segretario della DC
paga per le colpe di un intero sistema politico: proprio come accadrà nella
realtà, ovvero come sosterrà lui stesso nelle sue lettere dalla prigionia e come
rivendicheranno i rapitori nei loro comunicati. Tutto sarà trovato esatto più
tardi. Immaginando quella morte e poi raccontandola, Sciascia aveva per caso,
involontariamente, designato (ovvero disegnato) la vittima? Lo scrittore
siciliano era riuscito nel suo romanzo a trasfigurare la complessa situazione
politica italiana in un’allegoria potente e grottesca. Era riuscito a fornire,
in forma di finzione, una chiave di lettura della realtà. E così aveva in un
certo senso disegnato la mappa che le Brigate Rosse avrebbero usato per muoversi
nello spazio tra la strategia rivoluzionaria e la la tattica terroristica. In
questo senso Todo modo non è una profezia innocente che anticipa la realtà, ma
un evento che la produce, un tassello fondamentale della storia delle
rappresentazioni che portarono a quel mistero tremendo che è la "Passione" di
Aldo Moro. Durante il rapimento, un mese prima dell’omicidio, il 23 marzo,
Sciascia aveva espresso su Radio Radicale il suo stato d’animo: "Oggi posso dire
che non mi rimangio nemmeno una virgola di Todo Modo. Come uomo, come cittadino,
di fronte al caso Moro sento lo sgomento e la pena di qualsiasi persona che
abbia sentimento e ragione. Ma come autore di Todo Modo, rivedo nella realtà
come una specie di proiezione delle cose immaginate. Questo mi ha fatto da
remora nell’intervenire, come scrittore, anche per un senso di preoccupazione e
di smarrimento nel vedere le cose immaginate verificarsi…" Sciascia esitava tra
la tentazione di rallegrarsi per la sua illuminata profezia e il timore
d’influenzare (ancora) gli eventi. Faceva sicuramente bene perché il 9 maggio,
dopo una prigionia di 55 giorni, Aldo Moro venne infine ucciso. Proprio come nel
romanzo. Ovviamente non esiste nessuna prova, nessuna testimonianza che
le Brigate Rosse si siano ispirate a Todo modo; e nello stesso tempo è
improbabile che non lo conoscessero, perlomeno nella sua versione
cinematografica. La pellicola di Elio Petri, liberamente tratta dal romanzo, è
persino più potente del romanzo. C’è, soprattutto, quella tremenda somiglianza
tra Aldo Moro e Gian Maria Volonté, che si era impegnato a riprodurre in maniera
caricaturale tutti i tic dell’onorevole DC, presentandolo nella finzione come
quel viscido burattinaio e aspirante agnello sacrificale che le Brigate Rosse
presenteranno nei loro comunicati. Fu quindi nel buio di una sala di cinema che
si è deciso di condannare a morte il presidente della Democrazia Cristiana? Il
regista dovette difendersi dall’accusa di essere in qualche modo un mandante
morale dell’omicidio — o il mandante simbolico — dichiarando che “Todo modo non
era certo un invito a uccidere Moro” e che “No, il film non era terroristico”.
Quella sala buia ci riporta alla mente le grotte preistoriche dove gli uomini
decretavano la morte dei bisonti, e dove oggi talvolta si condannano a morte gli
esseri umani. Non fu certo l’ultima volta che un artista ha dovuto difendersi
dall’accusa di avere influenzato la realtà. Nel 1981, John Hinckley Jr. tentò di
assassinare il presidente americano Ronald Reagan per imitare le gesta del
protagonista del film Taxi Driver (1976) e fare colpo sull’attrice Jodie Foster.
Lo scrittore Michel Houellebecq, il cui romanzo sull’Islam è uscito in Francia
proprio nel giorno degli attentati al settimanale Charlie Hebdo all’inizio del
2015 e quindi non ha potuto in alcun modo influenzare i fatti, è stato comunque
accusato dalla stampa di avere contribuito a provocare i terroristi. Qualche
mese dopo, intervistato dalla televisione francese a proposito della sua
responsabilità di scrittore, Houellebecq ha risposto semplicemente: "Non me lo
spiego, ma nella pratica è terrificante: lascia credere che effettivamente ci
sia una divinità che crea delle coincidenze tra gli eventi e che sono stato
chiamato a ciò che chiamiamo un destino… Non mi sento responsabile: mi sento
manipolato da una divinità malefica. È piuttosto sgradevole". Anche Aldo Moro e
i brigatisti parvero presto essere manipolati da una divinità che assomigliava
stranamente al Dio cristiano. Tutto il caso Moro, il grande trauma della Prima
Repubblica, presenta curiose contaminazioni tra realtà e finzione. Ci sono,
ovviamente, le innumerevoli versioni dei fatti, i depistaggi, le sedute
spiritiche, i falsi comunicati. Ci sono le innumerevoli congetture sugli autori
— americani? russi? marziani? — della sceneggiatura che i brigatisti sembrano
seguire senza nemmeno capirla. Ma c’è innanzitutto il modo in cui i protagonisti
della vicenda hanno iniziato a immedesimarsi nei personaggi di altre storie. E
principalmente nel Nuovo Testamento, come dei padri pellegrini alla conquista di
un nuovo territorio. I primi martiri del cristianesimo vivevano e morivano come
il Nazareno, utilizzando i racconti che erano stati tramandati come vere e
proprie “sceneggiature” da attualizzare. Nei secoli non c’è re o santo cristiano
che non abbia preteso di orientare la sua condotta sull’esempio di Gesù Cristo,
imitando il Figlio come il Figlio imitava il padre. Alla fine di un secolo che
sembrava essersi lasciato alle spalle ogni teologia politica, Aldo Moro si trovò
a interpretare di nuovo quel ruolo antichissimo. La Pasqua 1978 cadde un 26
Marzo, in pieno durante la prigionia di Aldo Moro. Questa coincidenza temporale,
che si ripete ogni anno con differente precisione, negli ultimi quarant’anni ha
ispirato continue commemorazioni incrociate della Passione di Cristo e di quella
del segretario DC. Il giornalista televisivo Bruno Vespa poteva dunque nel 2008
dedicare una puntata del suo programma, nella notte tra Giovedì e Venerdì Santo,
ai “55 giorni di Passione” di Moro così contribuendo alla reductio ad
Christum che lo stesso presidente democristiano aveva suggerito nelle sue ultime
lettere. Si tratta di un corpus strano e affascinante, in bilico tra autenticità
e apocrifia, che possiamo leggere nell’edizione curata da Miguel Gotor per
Einaudi proprio nel 2008, per il trentennale. Scritte sotto il controllo e
l’influenza dei carcerieri, ispirate dalle informazioni filtrate che giungevano
a Moro e poi nuovamente filtrate prima di giungere ai loro lettori, rese
pubbliche secondo modi e tempi differenti da differenti destinatari, queste
lettere non hanno uno ma tanti autori. Ognuno di questi co-autori manipola la
realtà in modo diverso per produrre un effetto diverso. La formazione di questo
corpus è un vero proprio thriller che Gotor, di formazione specialista del
Cinquecento e del Seicento, ha sviluppato qualche anno più tardi in un volume
corposo, Il memoriale della Repubblica. Attraverso la storia di questi scritti,
prodotti su commissione dei carcerieri e sottoposti a vari livelli di censura,
poi scomparsi e riapparsi a singhiozzo in versioni diverse, lo storico prova a
fornirci nientemeno che una “anatomia del potere italiano”. E denuncia una
rimozione della quale questi scritti sono stati oggetto, una volontà di
dimenticare la testimonianza di Aldo Moro da parte dell’intera generazione di
coloro che, per eterogenesi dei fini, inconsapevolmente si accordarono per
propiziare — vedi Sciascia — e lasciar compiere il suo sacrificio. Gotor confuta
piuttosto facilmente il luogo comune secondo cui tra le Brigate Rosse e la
sinistra extraparlamentare della fine degli anni Settanta non ci fossero punti
di contatto, e arriva a suggerire una responsabilità del vertice di Potere
Operaio non certo nella pianificazione del rapimento, ma nella formazione del
contesto ideologico e nella formulazione dei quesiti che sarebbero stati rivolti
al rapito, e complessivamente nella costruzione dell’ingranaggio mortale nel
quale finì il corpo di Moro. Il corpus delle lettere dalla sua prigionia ha una
dimensione martiriale che evoca gli epistolari tragici di Paolo di Tarso o di
Ignazio di Antiochia oltre che l’antica letteratura apocalittica
giudaico-cristiana. Come disse Giovanni Moro, figlio di Aldo, “le lettere devono
essere lette anche sotto il genere letterario della profezia”. E proprio come
questi testi antichissimi, anche le lettere di Moro ci giungono in forma
apocrifa, o meglio come risultato di una contorta sovrapposizione al termine
della quale si trova un autore impossibile, un discorso del quale viene
misconosciuta l’originalità. Tuttavia, il risultato ha una misteriosa coerenza
che realizza una sacra sceneggiatura; un “sacro mistero” proiettato
nell’immaginario collettivo, sulla superficie della Storia. In un paio di
occasioni Aldo Moro descrive la propria prigionia come un “Calvario”. Quando
capisce che i suoi compagni di Partito intendono abbandonarlo in nome della
Ragion di Stato, il prigioniero si sente abbandonato come Gesù sulla croce. E
finisce per scrivere testualmente le parole “Il mio sangue ricadrà su di loro”
come maledizione lanciata al Sinedrio democristiano. Il Partito sembra
rispondere con le parole di Caifa: “È meglio che un uomo solo muoia per il
popolo”. Se prendiamo alla lettera questa lettura cristologica, ne dobbiamo
concludere che le Brigate Rosse non sono altro che gli esecutori materiali di un
delitto “moralmente” commissionato dallo Stato. Evidentemente questa narrazione
non è neutra e serve uno scopo, ma quale? Secondo Sciascia, è questo il dubbio
che Moro tenta di produrre nei brigatisti: ovvero di essere delle semplici
pedine, inconsapevoli strumenti di un progetto democristiano e forse americano.
La sua insistenza sulla necessità di una trattativa non era rivolta allo Stato
ma innanzitutto ai suoi carcerieri, i quali avrebbero dovuto convincersi che
paradossalmente la sua morte facesse comodo allo Stato. Nello stesso tempo, ciò
che forse Moro non capiva, questa versione dei fatti assolve i brigatisti ed è
spesso servita ad attenuare le loro colpe: hanno dovuto uccidere Moro perché
nessuno dei loro tentativi di trattativa è andato a buon porto. Quando i
combattenti comunisti eseguiranno la sentenza potranno “lavarsene le mani” come
Ponzio Pilato perché Moro morituro aveva dirottato la colpa su altri. Ma in cosa
consiste precisamente questa maledizione, reiterata di continuo nelle lettere e
continuamente tenuta implicita – questa maledizione che distruggerà e farà
collassare la Democrazia Cristiana, chiamando altro sangue? Come doveva
realizzarsi la catastrofica profezia, e come si è realizzata? Tutto il discorso
della prigionia di Aldo Moro tiene nel conflitto tra Legalità e Necessità,
ovvero tra il Diritto e la Politica. Abdicando al proprio potere di sospendere
la Legalità sulla base di una Necessità politica, morale e umanitaria, la
Democrazia Cristiana stava semplicemente rinunciando alla propria anima
cristiana, riducendosi ad una grigia idolatria procedurale, incapace di
esercitare la Sovranità (e perciò l’Eccezione) in nome di un bene più alto. In
questo senso vanno i continui appelli alla Santa Sede, che avrebbe dovuto
spingere lo Stato ad una rottura dell’ordinamento giuridico in materia di
sequestri. Aldo Moro sperava dunque in un miracolo, ma non un miracolo
impossibile che infrangesse le leggi della fisica, ma nel miracolo possibile
della politica. Rifuggendo la soluzione politica, ovvero la soluzione cristiana,
Moro profetizzò, la D.C. avrebbe perso l’anima. E perché lo fece? Lemà
sabactàni? Scrive Sciascia: "Da un secolo, da più che un secolo, [lo Stato
Italiano] convive con la mafia siciliana, con la camorra napoletana, col
banditismo sardo. Da trent’anni coltiva la corruzione e l’incompetenza, disperde
il denaro pubblico in fiumi e rivoli d’impunite malversazioni e frodi. Da dieci
tranquillamente accetta quella che De Gaulle chiamò – al momento di farla finire
– “la ricreazione”: scuole occupate e devastate, violenza dei giovani tra loro e
verso gli insegnanti. Ma ora, di fronte a Moro prigioniero delle Brigate Rosse,
lo Stato Italiano si leva forte e solenne. Chi osa dubitare della sua forza,
della sua solennità?" Infine c’è l’ultima analogia cristologica: la coincidenza
simbolico-istituzionale tra vittima e carnefice. L’archetipo del sacrificio del
Re, o del suo rappresentante, il figlio prediletto, è pienamente rispettato.
Aldo Moro viene lasciato morire dal partito di cui è presidente, e in qualità di
presidente paga. Un ultimo paradosso: è la propria morte, il più alto crimine
che Moro paga con la propria morte.
Moro, parla l'avvocato Li
Gotti: "Non si fece mai vincere e non è mai stato zitto".
Il legale che ha rappresentato i familiari dell'appuntato Domenico Ricci e del
maresciallo Oreste Leonardi, due degli uomini della scorta che morirono in via
Fani. "Sulla prigionia di Moro c'è un documento inedito del 1979 con una
intercettazione della conversazione fra due detenuti, di cui uno di alto livello
terroristico, avvenuta in un carcere di massima sicurezza", scrive il 17 marzo
2018 "La Repubblica". "Durante la sua prigionia nelle mani delle Brigate Rosse,
Aldo Moro si è comportato con estrema dignità davanti ai suoi carcerieri, non si
è fatto vincere, non si è fatto prendere dal panico, non è stato zitto". A
riferirlo è l'avvocato Luigi Li Gotti estrapolando parte "di quanto è contenuto
in un documento inedito del 1979 in cui è trascritta una intercettazione
ambientale della conversazione fra due detenuti di cui uno di alto livello
terroristico avvenuta in un carcere di massima sicurezza". Il legale ha
rappresentato i familiari dell'appuntato Domenico Ricci e del maresciallo Oreste
Leonardi, uomini della scorta di Moro assassinati dalle Br nell'agguato di via
Fani del 16 marzo 1978, cui seguì il sequestro dello statista e poi la sua
uccisione. Intervistato dalla AdnKronos, sostiene che sui giorni del sequestro e
sul trattamento subito da Moro durante la prigionia questo "documento inedito
mai diffuso" potrebbe "fare luce su altri misteri" legati al sequestro e
all'uccisione del presidente della Dc. Secondo Li Gotti, che è stato
sottosegretario alla Giustizia nel secondo governo Prodi, non esisterebbe però
"solo il documento di trascrizione dell'intercettazione ma, come dice,
"esisterebbe il nastro della registrazione di questa intercettazione" che
potrebbe essere ancora custodito in qualche cassetto "del ministero
dell'Interno". "Nel processo Moro quater -racconta il legale- arrivarono dalla
Presidenza del Consiglio tantissimi documenti, casse di documenti che mi andai a
guardare e trovai, fra questi, che nel 1979 erano stati trasmessi alle varie
autorità documenti particolari che riguardavano la trascrizione della
conversazione fra due detenuti". "Appresi, e apprendemmo, quando vidi questa
documentazione, che l'autorità giudiziaria - sostiene ancora Li Gotti - avuta
cognizione di tale documentazione la restituì al mittente dicendo che,
trattandosi di persone ignote - gli intercettati -, non potevano fare ingresso
nel processo, essere cioè messi come elemento di prova. Per cui si disse di
individuare i nomi degli intercettati e poi di rimandare il documento completo".
Ma, chiarisce Li Gotti, "da quel momento non arrivò più nulla e solo nel 1990
venne fuori questo carteggio e presi conoscenza di questa trascrizione che
riguardava il sequestro ed il trattamento che aveva Moro durante la prigionia".
Oltre a dichiarare che, in base a quanto letto nel documento, "nella sua
prigionia Aldo Moro fu trattato bene, non è mai stato torturato fisicamente, non
gli sono mai state messe le mani addosso", Li Gotti sostiene che dal documento
risulterebbe che "Moro abbia meditato a lungo, anche un'ora, prima di rispondere
alle domande del suo interrogatorio".
E dopo Moro iniziò il
riformismo rosso,
scrive Piero Sansonetti il 17 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Il
sequestro di Aldo Moro, la sua uccisione, e poi nove mesi nei quali il palazzo
spostò il paese a sinistra. Uscii di casa verso le nove e comprai i giornali.
Repubblica aveva un titolo molto grande che diceva che Aldo Moro era Antelope
Cobbler, nome in codice del politico italiano che aveva preso le tangenti della
Lockheed. Clamoroso: perché il caso Lockheed fu il più grande scandalo del
dopoguerra prima di Tangentopoli, e perché quel giorno si presentava alla Camera
il primo governo di unità nazionale, cioè con comunisti e dc in maggioranza, e
Moro era il regista, l’artefice, il padre di quel governo. Moro Antelope
Cobbler? Una bomba. Arrivai a Montecitorio in autobus una ventina di minuti più
tardi. Per me era la prima volta a Montecitorio: non c’ero mai entrato. Una
settimana prima del 16 marzo, il direttore mi aveva nominato cronista
parlamentare e mi aveva detto che iniziavo con la presentazione del nuovo
governo. Lavoravo all’Unità, il giornale del Pci. Davanti all’ingresso della
Camera però non trovai il mio collega Frasca Polara, che mi aveva dato
appuntamento alle 9 e un quarto. Chissà come mai. Lui era precisissimo, non
scordava mai niente. Invece vidi Massimo D’Alema, che era il segretario dei
giovani comunisti ed era venuto a Montecitorio per accompagnare in macchina suo
padre, vecchio deputato comunista. D’Alema mi venne incontro e mi disse che
avevano rapito Moro e sterminato la sua scorta. Me lo disse con quella sua aria
di sempre, apparentemente calmissima, fredda, ma in realtà drammatica, teatrale.
Rapito Moro? Una cosa incredibile, pazzesca. Ero sveglio solo da un paio d’ore
ed avevo saputo prima che Moro rischiava di essere travolto da una valanga
giudiziaria, che ragionevolmente avrebbe travolto anche il governo, e poi che
Mo- ro era prigioniero delle Brigate Rosse, le quali gli avevano ammazzato i
cinque uomini di scorta, e ora avrebbero chiesto allo Stato di trattare. Cinque
minuti dopo entrai alla Camera, andai nel Transatlantico, che non sapevo neppure
come fosse fatto, ero un po’ spaesato: vidi comparire i volti che fino a quel
momento avevo visto solo nelle foto dei giornali, oppure sui libri di storia:
Pietro Nenni, Ferruccio Parri, Luigi Longo, Francesco de Martino, e poi
Amendola, Berlinguer, Riccardo Lombardi, Ugo La Malfa. Ho ancora impressa nella
memoria la faccia rugosa di Benigno Zaccagnini, che veniva verso l’aula da uno
dei due corridoi laterali, e piangeva, piangeva. Ancora oggi, se penso a
Zaccagnini mi viene subito in mente quella immagine. Così come, se penso a Ugo
La Malfa, rivedo la scena di lui che strilla “pena di morte, pena di morte!”.
Pensai che fosse impazzito. Fu una giornata incredibile nella politica italiana.
Per me, giovinetto che vedeva il palazzo per la prima volta, addirittura
sconvolgente. Finii di lavorare alle quattro di mattina, quando il Senato votò
la fiducia e io dettai qualche riga di “ribattuta” al giornale. Allora i
quotidiani chiudevano tardissimo, quasi all’alba. Tornai a casa molto incerto.
Non impaurito, perché i ragazzi di 26 anni non si impauriscono facilmente. Però
se qualcuno mi avesse chiesto: «secondo te cosa succederà, ora, in Italia?»,
avrei risposto: boh. L’altro giorno Guido Bodrato, che in quei giorni era il
giovane numero 2 della Democrazia Cristiana, ha raccontato al Dubbio che loro
temettero che fosse iniziata l’insurrezione. Beh, il clima era quello. Cosa
successe in realtà? Nei giorni scorsi abbiamo parlato molto del sequestro, dei
risvolti drammatici, della condotta dei partiti, dei misteri veri o presunti.
Non aggiungo altro. Vorrei solo accennare a cosa successe in termini politici
reali, perché, di solito, nessuno, quando ragiona sul nostro passato politico,
si sofferma su quei mesi – più o meno nove – dal sequestro Moro alla fine
dell’anno. Io credo che furono i mesi del riformismo rosso. Non trovo un altro
modo per definirlo. In nessun altro periodo della sua storia l’Italia
repubblicana ha visto realizzarsi un numero così grande di riforme politiche e
sociali, di tipo socialdemocratico, molto profonde e che cambiarono il volto del
paese e del suo popolo. Il 1978, oltre ad essere l’anno del sequestro Moro, è
l’anno del riformismo. E si potrebbe persino azzardare l’ipotesi che i due
avvenimenti non furono slegati Prima vi presento un breve elenco di quello che
successe, nel Parlamento italiano, tra il 9 maggio – cioè il giorno
dell’esecuzione di Moro – e la fine dell’anno. Poi proviamo a ragionarci un
attimo, senza paraocchi e senza formule. Dunque, nello stesso mese di maggio nel
quale fu trovato il cadavere dello statista democristiano, lasciato dalle Br nel
centro di Roma in un luogo equidistante tra le sedi della Dc e del Pci (via
Caetani) si svolse alla Camera, e poi in forma più blanda al Senato, la
battaglia dell’aborto. I partiti laici e di sinistra avevano presentato una
legge che legalizzava e regolamentava l’aborto. Si opponevano la Dc, per ragioni
religiose, il Msi di Almirante e – per ragioni opposte – anche i radicali che
non avrebbero voluto regole e quindi preferivano la semplice depenalizzazione,
da ottenere tramite referendum. Alla Camera il provvedimento passò dopo alcuni
giorni di ostruzionismo radicale. Al Senato si andò al voto con grande
incertezza. I partiti laici disponevano di 160 voti, più quattro senatori a
vita. Gli oppositori, guidati dalla Dc, di 153 voti più 3 senatori a vita. Si
votò il 18 maggio, appena 9 giorni dopo l’assassinio di Moro. Si temevano
defezioni in un campo e nell’altro. I senatori a vita dc non si presentarono,
tranne Fanfani che però si astenne in quanto presidente del Senato. C’erano una
decina di assenti, più o meno nella stessa misura tra le due parti. Il voto era
segreto. Il risultato era in bilico. Vinsero i laici, 160 a 148. E Giulio
Andreotti, capo del governo monocolore Dc, firmò la legge che introduce l’aborto
in Italia. Con grande furia del Vaticano. La settimana dopo il Parlamento
approvò quella che fu chiamata la legge- Basaglia. Franco Basaglia era un grande
psichiatra e un teorico della de- istituzionalizzazione. La legge- Basaglia,
ispirata al suo pensiero, chiudeva i manicomi. E introduceva l’idea che la
malattia mentale non è qualcosa da reprimere ma da assistere e curare. L’Italia
fu il primo paese al mondo a dotarsi di una legge simile, fece da apripista. In
luglio, il giorno nove, Sandro Pertini, uno dei capi della Resistenza, diventa
il primo presidente della Repubblica socialista nel nostro paese. Rompe
l’eternità della Dc. La sua elezione è il primo successo politico di Craxi,
segretario da poco, anche se in realtà Craxi gli avrebbe preferito Antonio
Giolitti. Pertini, appena insediato, pronuncia un discorso trascinante.
Entusiasma la sinistra. Grida: «Riempite i granai e svuotate gli arsenali». Due
settimane dopo la sua elezione, il Parlamento approva un’altra riforma molto
forte. Si chiama equo canone. In pratica limita fortemente il diritto di
proprietà sulle abitazioni. Stabilisce che l’affitto delle case non è a libero
mercato ma è a prezzi fissi (molto bassi) stabiliti dallo Stato. E’ una riforma
che non funzionerà, ma che è in tutta evidenza una riforma di tipo socialista.
Prima di dicembre vengono riformati i patti agrari e viene modificato anche il
diritto di famiglia. In dicembre arriva a conclusione la grandiosa riforma
sanitaria, che assomiglia molto a quella che Obama riuscirà ad imporre agli
Stati Uniti quasi mezzo secolo più tardi. Afferma il principio del diritto
assoluto alla salute e alle cure gratuite. Stabilisce un criterio che è il più
avanzato in tutto il mondo occidentale. L’Italia sarà poi imitata da quasi tutti
i paesi europei. Beh, se qualcuno è in grado di trovare nella storia d’Italia
nove mesi più rossi di questi vince un premio. Non lo vincerà nessuno. Le
domande che mi pare giusto porre, sono le seguenti.
Prima: questo blocco di
riforme profondissime e così veloci era nei piani originari del governo
Andreotti ed era nella mente di Moro?
Seconda: quali furono le forze
che permisero questa quasi rivoluzione?
Terza: L’impeto dell’attacco
terroristico frenò o no la spinta riformista?
Io credo che Moro e
Berlinguer, quando siglarono l’accordo che portò alla nascita del governo
(guidato, come abbiamo detto, da Giulio Andreotti, cioè da un esponente moderato
della destra Dc) non avessero in mente un piano di riforme così radicali e
strutturali. La verità è che il Pci si trovò in quei mesi, dopo l’uscita di
scena del capo della Dc, in una posizione incredibilmente forte, che non si
aspettava, e che gli permise di spingere a tavoletta sul programma. Poi il Pci
pagò pesantemente, in termini elettorali, i suoi successi, ma di questo ne
parliamo tra qualche riga. E la verità è anche che le Brigate Rosse, e insieme
il movimento giovanile rivoluzionario, che era molto forte, soprattutto in
piazza, e molto di rottura – e che nel 1977 aveva messo a soqquadro l’Italia –
non provocarono nessun contraccolpo di tipo reazionario, anzi, spinsero tutti i
partiti a sinistra – anche la Dc esercitando quasi una forza di attrazione, non
ideale, ma molto concreta. Il Palazzo si convinse che per combattere il
terrorismo bisognava usare un mix: mano libera (e mano dura) alla magistratura,
e riforme sociali che rendessero meno evidenti e meno forti le ingiustizie che
rappresentavano il carburante “di massa” per la lotta armata. Le Brigate rosse,
forse a loro insaputa, esercitarono un ruolo, più o meno, di “riformismo
armato”. La sterzata a destra, in Italia, arrivò molto più tardi. All’inizio
degli anni ottanta. Ma non dipese né dalle Br, né da fattori di politica
interna, né tantomeno dal Pci o dalla Dc. Dipese dalla congiuntura
internazionale, dalla vittoria della signora Thatcher in Gran Bretagna e poi del
vulcanico Reagan negli Stati Uniti. Ma allora perché il Pci, che ebbe una
funzione di guida in questa stagione “rossa”, poi perse le elezioni e iniziò il
declino? Forse la risposta sta proprio in quell’inciso che abbiamo fatto qualche
riga sopra. Il doppio binario: da una parte riforme sociali, dall’altra stretta
autoritaria sul piano dello Stato di diritto e delega alla magistratura. La
storia dello strapotere della magistratura in Italia inizia in quei giorni. E
probabilmente è proprio la convinzione che si possa sacrificare la libertà e il
diritto in cambio di riforme sociali – e cioè la tara storica, in varie e molto
diverse gradazioni, del movimento comunista – la ragione della sconfitta dei
comunisti. Il Pci ebbe un’occasione riformista grandiosa, ma seppe sfruttarla
solo in parte: seppe riformare l’Italia ma non seppe riformare se stesso. Perciò
iniziò la discesa.
«Liberate Moro, senza
condizioni». Così cambiò la lettera di Paolo VI ai brigatisti. La prima bozza
scritta dal Papa e le successive modifiche. Il suggeritore ignoto,
scrive Giovanni Bianconi il 14 aprile 2018 su "Il Corriere della Sera". La
famosa e controversa frase contenuta nella lettera di Paolo VI agli «uomini
delle Brigate rosse», in cui chiedeva loro di liberare Aldo Moro «semplicemente,
senza condizioni», fu scritta dopo la correzione di una precedente versione.
Cancellando due parole e modificandone un’altra. Nella prima stesura il Papa
vergò di suo pugno un’altra formulazione; più ambigua e suscettibile di
interpretazioni che potevano rimandare a trattative in corso, o a contropartite
accettabili per lo Stato. E forse proprio per questo venne cambiata.
Rivolgendosi ai terroristi che, dopo la strage di via Fani, da 36 giorni
tenevano prigioniero il presidente della Democrazia cristiana, il Pontefice
aveva chiesto inizialmente di rilasciarlo «semplicemente, senza alcuna
imbarazzante condizione». Ma poi la terza e quarta parola di questa frase
(alcuna e imbarazzante) furono escluse con un tratto di penna anonimo, e un
puntino sull’ultima lettera di «condizione» trasformò il sostantivo da singolare
a plurale.
Trattativa segreta. Venne così
fuori l’espressione definitiva, più generica e più drastica, che pure tante
discussioni e illazioni ha provocato in quarant’anni: «senza condizioni». La
scoperta è contenuta in un libro di Riccardo Ferrigato (nato otto anni dopo
l’omicidio Moro) che sta per essere pubblicato dalla casa editrice San Paolo:
«Non doveva morire. Come Paolo VI cercò di salvare Aldo Moro». Un lavoro
prezioso, costruito su alcuni documenti inediti rimasti finora custoditi negli
archivi vaticani. Come la «brutta copia» della lettera del Papa (che contiene
altre significative correzioni) su cui Ferrigato si interroga: chi suggerì
quelle modifiche, e perché? Secondo il giovane studioso, l’eliminazione di ogni
riferimento a improponibili «condizioni imbarazzanti» doveva servire, nelle
intenzioni del Papa, a mantenere segreta la trattativa con i brigatisti che lui
stesso aveva provato ad attivare attraverso il cappellano delle carceri,
monsignor Cesare Curioni. Una volta pubblicizzata la lettera, infatti, tutti si
sarebbero chiesti quali fossero le richieste non imbarazzanti che, nella mente
di Paolo VI, potevano essere prese in considerazione per ottenere la liberazione
di Moro. Facendo così emergere il proprio ruolo, anche solo auspicato, di
mediatore tra i brigatisti e lo Stato.
La visita ad Andreotti. Ma
ammesso che questo fosse il motivo della correzione, resta ignoto il
suggeritore. Per quanto se ne sa, la sera del 21 aprile 1978 alla stesura della
missiva parteciparono, oltre al Papa e al suo segretario don Pasquale Macchi
(sua la calligrafia delle correzioni), don Curioni (interpellato
telefonicamente) e monsignor Agostino Casaroli, futuro Segretario di Stato. Il
quale, subito dopo l’arrivo della lettera di Moro al Papa con la preghiera di
aiuto, la portò al presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Che a sua volta
gli spiegò, affinché li riferisse al Pontefice, «i limiti che i nostri doveri ci
impongono», sostenendo che lo scambio dei prigionieri preteso dai brigatisti era
«inaccettabile» per il governo. Dunque, quando decise di rivolgersi ai
carcerieri di Moro, Paolo VI aveva ben presente la ferma posizione del governo,
e di certo non sarebbe stato utile mettersi in contrapposizione. Così come fu
ritenuto conveniente cambiare alcune espressioni che potevano essere lette come
un atteggiamento troppo disponibile del Papa verso i terroristi; e viceversa
altre troppo dure nei loro confronti. Ecco allora che laddove era scritto «oso
rivolgermi a voi» resta un meno deferente «mi rivolgo a voi»; in un successivo
passaggio sparisce la formula «ardisco scrivere» e scompare un «vi supplico»,
considerato di troppo. Per contro, i brigatisti da «terribili» avversari di Moro
diventano solo «implacabili»; e il «vile ardimento» con il quale commettono
ferimenti e omicidi scompare nella stesura definitiva.
Scontro tra cardinali. Le
altre modifiche testimoniano la lunga e sofferta elaborazione della lettera —
rimasta senza esito — scritta dal Papa anche per andare incontro alle richieste
della famiglia dell’ostaggio. Nel libro di Ferrigato vengono per la prima volta
resi noti altri documenti vaticani che svelano come il cardinale vicario di Roma
Ugo Poletti riferì a Paolo VI i timori della signora Moro rispetto allo «stato
di remissività» della Dc nei confronti di un governo «controllato e forse
manovrato dal partito comunista», e di conseguenza schiacciato su un
atteggiamento di immobile intransigenza che avrebbe inesorabilmente portato alla
morte dell’ostaggio. La famiglia spingeva perché la Santa Sede premesse su
Andreotti in senso contrario, ma non tutti nei palazzi apostolici erano
d’accordo. Lo si evince da un appunto del 2 maggio del cardinale Segretario di
Stato Jean Villot, molto critico nei confronti di Poletti, accusato di voler
interferire sulla linea del governo per conto dei familiari di Moro. Alla fine
il Papa in persona scrive che «occorre avvertire il card. Poletti: non videtur
expedire (non sembra opportuno, ndr), e avvertire L’Osservatore Romano, come
indicato», e cioè che non bisognava prendere posizione a favore dello scambio di
prigionieri. Con una postilla: «Ciò non vieta che si continui a vedere se vi sia
qualche altra via per la soluzione del dolorosissimo caso». Ma non se ne
trovarono.
Sequestro Moro: il cadavere
nella Renault 4 rossa.
Il 9 maggio 1978 il corpo di Aldo Moro fu ritrovato nel bagagliaio dell'auto
parcheggiata in via Caetani a pochi metri dalle sedi del Pci e della Dc. Un
fatto che sconvolse la storia dell'Italia repubblicana, scrive Edoardo Frittoli
l'8 maggio 2018 su "Panorama". Due settimane di flebile speranza, poi la fine
drammatica della storia del rapimento di Aldo Moro si consuma alle ore 13,15 di
mercoledì 9 maggio 1978 in via Caetani, una strada del centro di Roma posta
simbolicamente a metà strada tra via delle Botteghe Oscure (sede del Pci) e
piazza del Gesù (sede della Dc). Il corpo del Presidente della Democrazia
Cristiana è nascosto nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, crivellato da 11
colpi esplosi da una mitraglietta Skorpion. Alla diffusione della notizia
l'Italia, come era accaduto 55 giorni prima in occasione della strage di via
Fani dove ebbe inizio la drammatica storia del rapimento Moro, scese in piazza a
difesa delle istituzioni democratiche.
I giorni precedenti
l'assassinio. Gli episodi del del falso comunicato n.7, ritenuto attendibile dal
supervertice del Ministero dell'Interno, e il nodo del 18 aprile con il
ritrovamento "casuale" del covo Br di via Gradoli che non aveva portato alla
cattura dei suoi occupanti, avevano gettato molte ombre sull'operato degli
uomini di Francesco Cossiga, il quale aveva irritato buona parte del mondo
politico e dell'opinione pubblica con il suo ostinato silenzio di fronte al
precipitare della situazione. Dall'altra parte l'attività delle Brigate
Rosse non si era fermata al rapimento dello statista Dc, ma era proseguita con
la volontà di mantenere alta la tensione e di alzare la posta della trattativa.
Le ultime vittime del piombo brigatista erano tutte legate alla gestione del
sistema carcerario italiano. Già nel comunicato n.8 i carcerieri di Moro
avevano chiesto il rilascio dei brigatisti rinchiusi nelle carceri di massima
sicurezza paragonate dai rapitori ai lager nazisti, gestiti da Agenti carcerari
che nel messaggio del 24 aprile le Br non esitavano a definire "le mai
dimenticate SS". Tra le parole grottesche del comunicato si possono inquadrare
i due delitti compiuti a Roma e Milano nelle circostanze del sequestro Moro. Il
primo in ordine cronologico avviene nella Capitale un mese prima di via Fani, il
14 febbraio 1978. La vittima è Riccardo Palma, all'epoca direttore dell'Ufficio
VIII della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, responsabile
dell'edilizia carceraria. Fu freddato da 14 colpi di mitraglietta dalla "colonna
romana" responsabile poco più tardi della strage di via Fani. A Milano è
freddato dalle Br "Walter Alasia" il Maresciallo maggiore degli Agenti di
Custodia (oggi Polizia Penitenziaria) Francesco di Cataldo. Siamo nel pieno del
sequestro Moro, è il 20 aprile 1978.
Gli ultimi messaggi delle Br.
Gli ultimi comunicati, dai quali emergeva chiaramente l'oggetto dell'ultima
possibilità di trattativa, fu causa anche della spaccatura che si consumerà
definitivamente all'interno delle forze politiche parlamentari con Craxi e parte
dei Socialisti con i Radicali di Pannella favorevoli al dialogo, a cui si
contrapponeva la linea della fermezza promossa soprattutto dalla Dc di Giulio
Andreotti e dal Pci di Berlinguer. In particolare nel comunicato n.8 veniva
esplicitato l'attacco non solo al regime carcerario di massima sicurezza, ma
anche ai magistrati e ai Carabinieri di Carlo Alberto Dalla Chiesa. La
possibilità di trattare alla pari con lo Stato offriva ai rapitori di Moro la
possibilità di sfruttare e alimentare la situazione
esplosiva delle carceri italiane, da anni in attesa di riforma, come serbatoio
di consensi alla lotta armata.
La famiglia Moro e le ultime
speranze. Durante il silenzio che passò fino all'ultimo comunicato, anche
la famiglia di Moro si mosse in silenzio, distante dalla strategia ufficiale del
Viminale. Il tentativo estremo di trattativa dei familiari dello statista barese
si era consumato nei giorni immediatamente precedenti l'ultimo drammatico
messaggio delle Br, il numero 9. Da quel momento parve impossibile a tutti
(Craxi compreso) poter trovare ancora qualche barlume di speranza seppur
flebile. Si attendeva nervosamente la mossa successiva dei brigatisti:
presumibilmente l'ultima, dato che ai vertici dei partiti dell'arco
costituzionale si cominciava a parlare di "dopo Moro". L'iniziativa privata di
un tentativo di contatto tra la famiglia Moro e i suoi carcerieri avvenne per
intercessione dei Vescovo di Ivrea Luigi Bettazzi il quale si sarebbe offerto
come prigioniero in cambio del Presidente Dc, procurando contemporaneamente la
disponibilità di 10 miliardi di lire per un'eventuale richiesta di riscatto in
denaro.
"Cara Norina, mi hanno detto
che tra poco mi uccideranno". L'ultima lettera di Aldo Moro alla famiglia. Il
comunicato n.9 spense le speranze di tutti. Era il 5 maggio 1978.
Solamente quattro giorni separavano il messaggio dal ritrovamento del corpo
dello statista rapito il 16 marzo. Furono ore convulse, durante le quali si
susseguirono rassegnazione, smarrimento, rabbia, illusioni. VI furono
perfino estremi tentativi di liberare terroristi in carcere con un colpo di
mano, come quello studiato dall'uomo di fiducia dei Moro Sereno Freato,
segretario particolare del Presidente della Dc. Nei giorni immediatamente
precedenti la morte del leader democristiano cercò di organizzare il
trasferimento di 7 detenuti delle Br nel carcere di Novara, dal quale sarebbe
poi dovuta scattare l'operazione di evasione. Per il mancato appoggio finale al
piano, il progetto finì con un nulla di fatto. Il 5 maggio 1978 è anche il
giorno in cui fu recapitata alla famiglia l'ultima drammatica lettera di Aldo
Moro indirizzata alla moglie Eleonora. Nell'epilogo della fitta corrispondenza
intrattenuta da moro durante i 55 giorni di prigionia (aveva scritto in tutto 39
lettere, di cui 25 recapitate) il Presidente Dc rivolgeva durissime accuse ai
colleghi di partito. Ecco le parole di Moro dell'ultima lettera in cui le
pesanti accuse al partito emergono stridenti dal commovente commiato ai suoi
cari. "Vorrei restasse ben chiara la piena responsabilità della D.C. con il suo
assurdo ed incredibile comportamento. Essa va detto con fermezza così come si
deve rifiutare eventuale medaglia che si suole dare in questo caso. E’ poi vero
che moltissimi amici (ma non ne so i nomi) o ingannati dall’idea che il parlare
mi danneggiasse o preoccupati delle loro personali posizioni, non si sono mossi
come avrebbero dovuto. Cento sole firme raccolte avrebbero costretto a
trattare".
La passione di Moro è
terminata. Una trattativa che, come è noto, non si svolgerà mai. Sarà la voce
fredda di Valerio Morucci a interrompere bruscamente tutte le speranze di aver
salva la vita di Aldo Moro. Alle 13 circa giunge la telefonata delle Br. A
rispondere è Francesco Tritto, assistente universitario di Aldo Moro. Il corpo
senza vita di Moro si trova in una Renault 4 rossa rubata e parcheggiata in via
Caetani, di cui Morucci fornisce l'inizio della targa "Roma N5". Sono circa
le 14.00 quando la Polizia arriva sul posto insieme agli Artificieri per il
sospetto che nella vettura possa esserci un ordigno. Quando il bagagliaio della
Renault viene forzato tutti i dubbi vengono purtroppo fugati. Aldo Moro giaceva
sopra ad una coperta di tela cerata, con la testa appoggiata al passaruota
sinistro. Così l'Artificiere Vitantonio Raso svelò agli occhi del mondo la
terribile e innegabile realtà. Il corpo ormai irrigidito di Aldo Moro indossava
gli stessi abiti del 16 marzo, giorno del rapimento. Nei risvolti dei pantaloni
e sui calzini gli inquirenti troveranno tracce di sabbia e alcuni forasacchi, le
piccole spighe tipiche della vegetazione litorale del Lazio ed alcuni residui
bituminosi che alimenteranno i dubbi sulla reale localizzazione della "prigione
del popolo". Mentre i referti avrebbero indicato una possibile detenzione di
Moro sulle coste del litorale romano, negli atti degli interrogatori successivi
alla cattura i brigatisti della "colonna romana" avrebbero dichiarato che la
sabbia e i residui vegetali sarebbero stati appositamente raccolti e sparsi sul
corpo dell'Onorevole Moro ai fini del depistaggio. Tuttavia le deposizioni
appariranno lacunose ed in molti casi incongruenti, alimentando le teorie sul il
mistero della prigionia dello statista proseguite fino ai giorni nostri.
La condanna di Moro,
l'Assoluzione divina. L'ultima scena della tragedia dei 55 giorni del sequestro
Moro si chiude con il primo compagno di partito ad aver visto il corpo del
Presidente della Dc, Guido Gonella. Pochi minuti dopo sarà la volta di Francesco
Cossiga, che aveva guidato il Viminale durante i giorni della prigionia del
leader democristiano. La folla si accalca, ci sono anche piccoli scontri con il
cordone di Polizia. Mentre gli Artificieri sono ancora intorno alla Renault 4,
si avvicina un vecchio sacerdote arrivato dalla chiesa di piazza del Gesù. Sono
le 14,45 del 9 maggio 1978 quando il prete fa il segno della croce sulla fronte
terrea di Moro, ancora adagiato nel bagagliaio: è l'Assoluzione divina per un
uomo dalla fede incrollabile, che lasciava la vita terrena conclusa con la
feroce condanna di un "tribunale del popolo".
Sequestro Moro: il nodo del
18 aprile.
La scoperta del covo romano di via Gradoli, (presagita anche da una seduta
spiritica) e il falso comunicato del Lago della Duchessa. Un punto di svolta
verso l'esito tragico del caso Moro, scrive Edoardo Frittoli il 18 aprile 2018
su "Panorama". La giornata del 18 aprile 1978 è considerata uno spartiacque
durante i 55 della prigionia di Aldo Moro per tre fatti accaduti quello stesso
giorno: il ritrovamento del falso comunicato n.7 a firma delle Brigate Rosse,
della scoperta del covo di via Gradoli, 96 a Roma e per l'intervento delle Forze
dell'ordine presso il Lago della Duchessa, dove il falso volantino avrebbe
indicato la presenza del cadavere del Presidente della Democrazia Cristiana
rapito il 16 marzo precedente in via Fani.
Le Brigate Rosse alzano il
tiro. Durante il primo mese di prigionia dello statista barese, era emerso
quanto inadeguati fossero stati le indagini e i conseguenti interventi di
Polizia e Carabinieri nelle ricerche della prigione di Moro. Le Brigate Rosse
avevano fatto ritrovare il 6° comunicato in cui si dichiarava per la prima volta
la "condanna a morte" per il prigioniero. Era il 15 aprile 1978. Un colpo di
acceleratore dei rapitori a fronte di uno Stato che brancolava nel buio e tra le
pesanti polemiche da parte di molti esponenti politici nei confronti della
gestione della crisi da parte del Ministro dell'Interno Francesco Cossiga.
Le Brigate Rosse gettano
l'amo: il falso comunicato del Lago della Duchessa. Ma il peggio doveva ancora
venire: a soli tre giorni dal ritrovamento dell'ultimo comunicato viene trovato
in piazza Belli a Roma un altro messaggio a firma BR. Fatto singolare, perché i
precedenti messaggi erano stati recapitati a distanza di circa una settimana
l'uno dall'altro. Fu dato per autentico dagli esperti, ma in realtà il volantino
si presentava ben diverso da tutti i precedenti. Era stato consegnato soltanto a
Roma, e non nelle principali città d'Italia tramite le redazioni dei quotidiani;
il foglio era fotocopiato (e non ciclostilato come gli
altri) di formato inferiore. I caratteri e la sintassi erano totalmente
differenti, il testo era breve e scarno: non vi erano proclami ideologici
scritti in un italiano più che corretto, bensì poche e macabre parole sul
presunto "suicidio" di Moro, il cui cadavere sarebbe stato gettato nel fondale
"limaccioso" del Lago della Duchessa, uno specchio d'acqua a oltre 1,800 metri
di quota al confine tra Lazio e Abruzzo. Il comunicato scatena il putiferio al
Viminale, Cossiga è uno dei più convinti dell'autenticità del messaggio. Parte
così la spedizione al lago montano, allora ricoperto da uno spesso strato di
ghiaccio che gli artificieri fanno saltare con il tritolo. Saranno i
sommozzatori che, dopo l'immersione nelle acque gelide del laghetto
confermeranno la falsità delle dichiarazioni contenute nel comunicato. Nessuna
traccia del cadavere di Aldo Moro, soltanto gli effetti di una trappola alla
quale le istituzioni avevano abboccato in toto. Invece di aver visto affiorare
il corpo di Moro, emerse la cruda verità: a cinque settimane dal rapimento,
le indagini erano più o meno al punto di partenza. Nonostante ciò, Cossiga
pronunciò solo poche e inconcludenti parole dopo i fatti cruciali di quel
giorno. Il secondo colpo di scena di quel martedì 18 aprile 1978 fu la scoperta
"casuale" del covo delle Brigate Rosse di via Gradoli, 96 a Roma. Fu un
allagamento dovuto al rubinetto di una doccia lasciato aperto ad attirare
l'attenzione su un anonimo appartamento della zona Cassia. I Vigili del Fuoco,
dopo aver sfondato la porta, trovarono nei locali allagati un arsenale e una
quantità notevole di documenti quasi fossero stati appositamente messi in
mostra. Nessuno degli occupanti di quell'appartamento era presente e nessuno fu
in seguito individuato o arrestato. Lo spiegamento di forze accorse sul posto fu
enorme, cosa che con tutta probabilità mise in allarme gli occupanti che non vi
fecero più ritorno. La casa, un trilocale di modeste dimensioni in un palazzo
piccolo borghese, era stato affittato all'Ingegner Mario Borghi, alias Mario
Moretti. Il capo delle Br della colonna romana aveva abitato l'appartamento
assieme alla compagna Barbara Balzerani. Entrambi erano stati parte attiva nel
sequestro di via Fani. Nessuno di loro sarà rintracciato dopo l'irruzione
spettacolare delle Forze dell'Ordine. Fatto ancora più inquietante emerso già
due settimane prima del ritrovamento del falso comunicato n.7 e diffusasi come
voce di corridoio negli ambienti parlamentari della Dc, fu la notizia
della seduta spiritica svoltasi la sera del 3 aprile nella casa di campagna di
Zappolino (Bologna) di proprietà di Alberto Clò, allora professore universitario
e in seguito ministro dell'Industria nel governo Dini. Con lui anche erano altre
due figure di primissimo piano della politica italiana dei decenni
successivi: Romano Prodi e Mario Baldassarri. Il gruppo, all'epoca parte del
corpo accademico dell'università di Bologna, decise di evocare gli spiriti di
due padri della Democrazia Cristiana perché rivelassero la posizione della
prigione di Aldo Moro: Giorgio La Pira e Don Luigi Sturzo. Il piattino, girando
vorticosamente, compose la parola Gradoli, che fu intesa come nome di un piccolo
comune in provincia di Viterbo e non come il toponimo della via di Roma, che
neppure fu preso in considerazione. Giunta alle orecchie degli inquirenti, la
risposta degli spiriti si tradusse in una retata nel piccolo centro,
naturalmente senza esito e con gran pubblicità e dispiegamento di quelle forze
di Polizia già messe a dura prova dai giorni di frenesia isterica che seguirono
il rapimento del Presidente Dc. Un altro passo falso del Viminale, che fece
crescere il sentimento di sfiducia degli Italiani e l'acuirsi della tensione tra
le forze politiche. Il nodo del 18 aprile fece sì che la frattura tra
i favorevoli alla trattativa e i fautori della linea intransigente divenisse
ancora più netta. Ad aggravare il momento contribuì decisamente la sempre più
netta sensazione di un prossimo sacrificio di Aldo Moro. A suggellare quel cupo
presentimento contribuirà il comunicato n. 7 (quello vero) ritrovato il 20
aprile 1978 in una busta arancione in via dei Maroniti. Allegata, la seconda
foto di Moro: quella in cui il prigioniero è fotografato con il numero de La
Repubblica del 19 aprile. Per la prima volta i rapitori impongono un ultimatum
di 48 ore e lo scambio con i brigasti in carcere per la vita di Moro.
I giorni dell'angoscia: Le Br
continuano a colpire. I giorni che seguiranno saranno carichi di angoscia: sulle
pagine di periodici e quotidiani si parlò apertamente di un possibile colpo di
Stato da parte della destra con lo scopo di "ristabilire l'ordine", sullo stile
di quello dei Colonnelli in Grecia. Altre voci paventarono un rafforzamento dei
brigatisti dopo i fatti del 18 aprile. Questi ultimi ebbero una conferma il 20
aprile 1978quando a Milano le Brigate Rosse del colonna Walter Alasia colpiscono
a morte e in pieno giorno Francesco di Cataldo, Maresciallo Maggiore capo degli
Agenti di Custodia del Carcere di San Vittore, rivendicando poco dopo l'omicidio
di un "torturatore e assassino dei compagni in carcere". In realtà Di Cataldo si
era sempre distinto per la propria umanità, riconosciuta dagli omaggi successivi
alla sua morte da parte di molti detenuti di san Vittore. Nonostante le
molte minacce di morte ricevute non gli fu mai assegnata una scorta, rendendolo
un obiettivo "facile". Proprio come era avvenuto nel caso di Aldo Moro e dei
cinque agenti della sua scorta, privi dei mezzi adeguati per proteggersi dai
nemici del progresso delle istituzioni democratiche italiane.
Il rapimento e l'uccisione
di Moro "Quei 55 giorni che cambiarono la nostra storia".
Dal 9 marzo, ogni venerdì su “Repubblica”, Ezio Mauro racconta a quarant’anni
dai fatti “Cronache di un sequestro”, con ricostruzioni e interviste, scrive
Marco Bracconi il 6 marzo 2018 su "la Repubblica". "E' stato l'11 settembre
dell'Italia. L'istante lungo 55 giorni che ha dirottato il cammino verso una
democrazia finalmente compiuta. Perché con la morte di Moro, ben prima di Mani
Pulite e della caduta del Muro di Berlino, finisce la Prima Repubblica". Dopo
la Rivoluzione d'Ottobrela nuova inchiesta multimediale di Ezio Mauro Aldo Moro
- Cronache di un sequestro (dieci articoli e due interviste su Repubblica dal 9
marzo al 9 maggio, una webserie in dieci episodi su Repubblica.it e un
documentario dal titolo Il condannato in onda su Rai3 il 16 marzo) entra nel
vivo di una pagina decisiva della nostra storia, che "a differenza della
rivoluzione russa non è ancora storia, anzi pesa sulla carne viva del Paese". Il
sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, appunto, narrati attraverso la rilettura
del corpus di materiali che a quarant'anni da quella tragedia abbiamo a
disposizione: le carte processuali, i comunicati dei brigatisti, le lettere
inviate dal presidente della Dc dalla cella di un covo che ancora oggi non
sappiamo con certezza se sia stato l'unico. Ma anche la mappa dei luoghi di
quella Roma plumbea e frenetica, la via Fani del rapimento e della strage, la
prigione di via Montalcini, il piazzale davanti alla chiesa di Santa Chiara dove
il brigatista Franco Bonisoli vide per la prima volta la scorta dell'uomo
politico. "Sono luoghi che sembrano parlare ancora di quanto avvenne. Ogni
mattina passo davanti a quella chiesa e mi è impossibile non andare col pensiero
alla primavera del 1978 e a quell'Italia sfiancata da un decennio terribile che
inizia con la strage di piazza Fontana e finirà con la bomba alla stazione di
Bologna. Ecco, esattamente come ho fatto per l'Ottobre, provo a raccontare quei
giorni nella loro complessità, con uno sguardo da cronista". Un cronista che si
emoziona, quarant'anni dopo, sfiorando con i polpastrelli i fori lasciati dai
proiettili sulle automobili dove viaggiavano Moro e gli uomini che lo
proteggevano, oppure scorrendo gli originali scritti a mano delle lettere che
"il prigioniero" inviava tramite i suoi carcerieri al mondo esterno. La
famiglia, il partito, il papa, e una calligrafia "che con il passare del tempo,
mentre le possibilità di uscire vivo da quella cella si confermano sempre più
esigue, si fa rapida, nervosa". Perché la cronaca del sequestro e
dell'assassinio di Aldo Moro, per Ezio Mauro, non è la storia di un
"prigioniero" ma quella di un "condannato", perché storia di una macchina
implacabile che si mise in moto non con un capo d'accusa ma con un verdetto poi
impossibile da disattendere. "Se c'è una chiave di lettura in questo lavoro è
appunto nell'idea di una condanna connaturata all'atto stesso del sequestro, che
di per sé è già un punto di non ritorno.
Nello schema brigatista la
Democrazia Cristiana è uno dei referenti dello Stato Imperialista delle
Multinazionali, il famigerato Sim dei comunicati; Moro è il presidente della Dc
e l'imputazione, se così possiamo chiamarla, è troppo totalizzante per non
contenere in sé anche la sentenza". Quello che accadrà dopo, allora, sarà
l'impossibile tentativo dello statista di sfuggire a un destino già deciso, nel
contesto lunare di un processo "proletario" dove l'"imputato" e i suoi
accusatori parlano un linguaggio reciprocamente incomprensibile: "Le Br
chiedevano nomi e cognomi, lui argomentava spiegando processi politici e intanto
cercando di scovare i punti deboli dei terroristi". L'anello della rete da
smagliare, insomma, il buco dove infilarsi per ritrovare la libertà, la vita,
l'amato nipotino accarezzato in una delle sue lettere più commoventi. Sull'altro
versante, le parole indirizzate al partito, nelle quali ancora oggi risuona il
terribile dilemma che separa la ragione di Stato e la pietas umana. "In quei
pochi metri quadrati Moro gioca contemporaneamente due partite. Una con i
terroristi e un'altra con la Dc. Era abituato a influenzare i processi politici
e ha tentato di farlo, per come poteva. Ma tutto ciò avveniva in un contesto
dove gli stessi brigatisti, con un macabro paradosso, si erano "condannati a
condannarlo"". Non c'era scampo, dunque. La sola soluzione possibile sarebbe
stata - se gli apparati dello Stato fossero stati più efficienti e meno
inquinati - trovare il covo e liberarlo. "Resto convinto che la fermezza nel non
trattare con i terroristi sia stata la scelta giusta", dice Ezio Mauro, pure se,
da tanti punti di vista, suonano come un monito a rischiarare ogni ombra le
parole di Giovanni Moro: "Mio padre - dice Giovanni - resta presente sulla scena
pubblica come un fantasma, in senso concreto e non metaforico. In fondo i
fantasmi cosa sono? Morti che ritornano a ricordare dei doveri nei loro
confronti che non sono stati compiuti". Per riannodare tutti i fili Mauro ha
così riascoltato le voci degli inquirenti, di chi era personalmente vicino al
presidente Dc, dei protagonisti politici che all'epoca svolsero un ruolo. E
anche quelle degli uomini e delle donne che si "condannarono a condannare": da
Morucci a Bonisoli, dalla Faranda alla Braghetti. Ne esce un quadro che è
assieme una ricostruzione dell'Italia di quegli anni di piombo, di quella
società civile, politica e sindacale che si dimostrò all'altezza di una sfida
mortale, e il ritratto di un uomo e di un uomo di Stato. Il cui destino fu
segnato "fin da quella prima foto simbolo, occhi fissi sul proprio carceriere,
la stella a cinque punte dietro le spalle leggermente ricurve. Ecco, nella
violenza di quella immagine, nel sopruso intrinseco a quello scatto che ritrae
un uomo in cattività, è lì che sta racchiusa simbolicamente l'intera tragedia".
Che non è stata tragedia definitiva della democrazia, ricorda Mauro, "perché
questa storia ci ha detto con chiarezza che la democrazia era più forte". Ma è
la stessa storia, conclude, che ci consegna un messaggio senza tempo e che tutti
ci riguarda. "Perché la democrazia non è mai scontata. Ha bisogno di buona
manutenzione. E ne ha bisogno sempre".
CRONACHE DI UN SEQUESTRO.
A quarant’anni dal rapimento e dall’omicidio di Aldo Moro da parte delle Brigate
Rosse ripercorriamo i 55 giorni che sconvolsero il nostro Paese e la democrazia.
Una webserie in dieci puntate in cui Ezio Mauro incontra i protagonisti di
quella drammatica vicenda e ne analizza tutti gli aspetti e i nodi ancora
irrisolti. Tanti extra: interviste, documenti originali, audio, video, foto,
mappe. Un viaggio nell’Italia del 1978. Guerre Stellari, Portobello,
l’austerity, il terrorismo. L’Italia del caso Moro, scrive "La Repubblica". La
sera del 15 marzo Aldo Moro rimane fino alle 22 nel suo ufficio di via Savoia, a
Roma. Discute con i suoi collaboratori Nicola Rana e Corrado Guerzoni. Siamo a
un passo dal compimento del suo disegno politico: il nuovo governo Andreotti,
monocolore Dc, riceverà l’appoggio esterno del Partito comunista. E’ la prima
volta dal 1947. Ma non è detto che l’intesa regga, il giorno seguente, alla
prova del voto di fiducia in aula. Tutto intorno, il Paese è inquieto. Tante
sigle terroristiche, tanti omicidi politici. E l’austerity, l’inflazione (nel
‘78 è al 12,1%), la crisi economica internazionale. Il tasso di disoccupazione è
del 6,6% (era del 6,4 nel 1977, sarà del 6,9 nel 1979). Un litro di latte costa
quasi 400 lire, il pane 523 lire al Kg, un chilo di pasta 600 lire. Al cinema,
dove un biglietto costa tra le 1000 e le 2500 lire, gli italiani vedono
fantascienza e film d’autore. E in tv spopolano Raffaella Carrà ed Enzo Tortora.
Cronache Di Un Sequestro. I
55 giorni di Moro.
La mattina del 16 marzo 1978 il presidente della Dc esce di casa.
Alla Camera sta per giurare il primo governo con l’appoggio del Partito
comunista. È il suo capolavoro politico. Quella stessa mattina un commando delle
Brigate Rosse lo sta aspettando. Così incominciano i 55 giorni più lunghi della
nostra storia, scrive EZIO MAURO l'8 marzo 2018 su "La Repubblica".
Vento freddo di marzo quel
giovedì mattina, il 16, cinque minuti prima delle nove, in via del Forte
Trionfale a Roma. Sette gradi, umidità 72 per cento. Le due auto erano già in
formazione, l'una dietro l'altra coi motori spenti nel piccolo ingresso del
numero 79. Oggi il cancello rinchiude la normalità a mattonelle rosse di un
condominio borghese, anche se allora - quarant'anni fa - nel cass...
Giovanni Moro: “È mio padre
il fantasma di questa Italia senza pace”.
"In quei 55 giorni lo Stato decise di non decidere: né trattò con i terroristi
né tentò di prenderli. Bisognava seguire una delle due strade" di EZIO MAURO 12
marzo 2018. Giovanni Moro, 59 anni, sociologo. Lei è figlio dello statista
sequestrato e ucciso con gli uomini della scorta dalle Brigate Rosse, ma è anche
un intellettuale, ha studiato quegli anni su cui ha scritto un libro che ci
restituisce il contesto di quell'attacco al cuore dello Stato. Per lei dunque il
caso Moro è insieme un dramma privato e una tragedia pubblica.
Adriana Faranda: “L’ultimo
giorno di Aldo Moro iniziò la fine di noi brigatisti”.
Parla l'ex Br, condannata a trent'anni per il rapimento e l'uccisione dello
statista: “Siamo tutti responsabili. Abbiamo accettato l’idea che si potesse
uccidere e l’uso politico della violenza” di EZIO MAURO 13 marzo 2018. Adriana
Faranda, lei ha 67 anni è entrata nelle Br a 24, è stata condannata a trent'anni
per il rapimento Moro e l'uccisione dei cinque uomini della scorta. Quarant'anni
dopo che giudizio dà di quei 55 giorni? "Che sono stati una vera e propria
tragedia. Noi sequestrando Moro lo abbiamo praticamente condotto in un vicolo
che alla fine si è rivelato cieco, in nome della ragion di Stato e di una
presunta ragione rivoluzionaria.
“Il Condannato - Cronaca di
un sequestro”,
il film di Ezio Mauro su una tragedia repubblicana. di FILIPPO CECCARELLI 13
marzo 2018. Rivisti in questo tempo confuso, i colori degli anni '70 sono
pesanti, sgranati e paiono addirittura più irreali degli stessi eventi che pure
allora certissimamente non solo ebbero luogo, ma condizionarono i successivi
quarant'anni. LEGGI I 55 giorni di Moro di Ezio Mauro Il rosso carico del sangue
sparso in strada e quello metallico della Renault4 di Moro; il blu quasi azzurro
del pennarello usato nelle lettere dal "carcere"; il bianco abbacinante delle
grottesche...
Via Fani ore 9.05, tutto è
già finito: l’agguato a Moro.
È il 16 marzo 1978. I brigatisti si sono svegliati presto, hanno fatto colazione
e hanno ripassato il piano. È un'operazione militare "perfetta": il presidente
della Dc e la scorta finiscono in trappola. Cadono cinque agenti. Sull'asfalto,
93 bossoli e un paio di baffi finti. In tre minuti l'Italia piomba nell'incubo.
E in quarant'anni di misteri di EZIO MAURO 15 marzo 2018. Alle sette del mattino
Valerio Morucci e Franco Bonisoli avevano fatto colazione nell'"ufficio", come
le Br chiamavano le due stanze e cucina di via Chiabrera, covo dell'ultima
notte. Poi avevano indossato le divise azzurre da aviere che Adriana Faranda
aveva comperato da quindici giorni per 42 mila lire da Cardia, un negozio
specializzato in via Firenze 57. Mentre Raffaele Fiore si calava in testa il
berretto blu con la visiera uscendo in maglione e camicia bianca dalla ca...
Queste ore tristissime.
Di Moro nessuna traccia. Messaggi delle Brigate Rosse preannunciano l’invio di
una foto del rapito. Il governo darà più poteri alla polizia per interrogatori,
fermi e perquisizioni di EUGENIO SCALFARI 16 marzo 2018. 18 marzo 1978
Quarantotto angosciose e tristissime ore sono passate dal massacro di Monte
Mario e dal rapimento di Aldo Moro, durante le quali l’analisi delle conseguenze
politiche di quel fatto ha ceduto il campo all’emozione, agli appelli alla
concordia nazionale, alla necessità di una ferma reazione nei confronti degli
eversori d’ogni risma, calibro e specie. Ma la politica, dopo un sia pur breve
intervallo spunta di nuovo e chiede il suo spazio. E spunta s...
L’Amaca di Michele Serra
(17/03/2018). Dalle rievocazioni del caso Moro si esce con la netta sensazione
che quei tempi fossero peggiori di questi. Più violenti, e si sapeva; ma
soprattutto più tenebrosi, con una democrazia più fragile, e poteri maligni che
la torcevano ai loro scopi. Dell’orrenda P2, consorteria di nuovi mestatori e di
vecchi fascisti, ci si è dimenticati troppo in fretta. Si stava peggio quando si
stava peggio. Alla luce di quelle stragi nere favorite da traditori stipendiati
d...
Stato, parenti e povera
gente intorno alle vittime delle Br
di GIAMPAOLO PANSA 17 marzo
2018. 19 Marzo 1978 ROMA - Ed eccoci all'ultima scena della strage di via
Fani. Dinanzi all'altare nella basilica patriarcale di San Lorenzo al Verano, lo
schieramento è il seguente. A destra la bara del capo-scorta di Moro, il
maresciallo Leonardi (sette pallottole). Poi il vice-brigadiere Zizzi (tre
pallottole). L'appuntato Ricci (sette pallottole). La guardia Rivera (almeno
sette pallottole). Infine la guardia Jozzino (cinque pallottole). Raffaele
Jozzino era il…
Controlli casa per casa,
identificato il negozio che ha venduto le divise ai terroristi.
Setacciato il quartiere della strage. Ritrovata un'altra auto adoperata dal
commando. L'utile collaborazione dei testimoni ha consentito di tracciare gli
identi-kit di due terroristi. Oggi i funerali delle cinque vittime di GIORGIO
BATTISTINI 18 marzo 2018. 18 marzo 1978 ROMA - Sul rapimento Moro e sulla
strage dei cinque agenti di scorta, la notizia del giorno è che mancano notizie
ufficiali. La questura tace e rinvia al Viminale, il Ministero degli Interni
tace e rinvia ogni notizia alla questura. Dunque i casi sono due: o gli
inquirenti pe rora brancolano nel buio, affidandosi alla massa di segnalazioni
che il comprensibile clima di "caccia al terrorista" ha favorito, oppure sanno
già molto ma preferiscono far...
Moro è vivo, ecco la foto.
Le Brigate Rosse lo vogliono processare.
Il documento fotografico e il proclama trovati da un redattore del "Messaggero".
Non si chiede la liberazione dei brigatisti di Torino. Imponenti funerali ai
cinque agenti assassinati dal commando delle Br. A Torino, dove domani riprende
il processo a Curcio, ordine di cattura contro una giovane accusata
dell'omicidio del maresciallo Berardi di GIORGIO BATTISTINI 19 marzo 2018. 19
marzo 1978 ROMA. E' vivo. I terroristi hanno rotto l'angoscia del silenzio,
hanno inviato una foto di Aldo Moro a un giornale romano, "il Messaggero". Per
la prima volta, ufficialmente, le Brigate Rosse hanno rivendicato l'agguato, il
massacro, il rapimento del leader democristiano. Nessuna richiesta, per ora,
nessuna contropartita. I terroristi si sono serviti dell'ostaggio e del clima di
tensione nel Paese per dare la massima diffusione a un ennesimo proclama....
Rapimento Moro: “È nelle
nostre mani” urla Curcio dietro le sbarre.
Al processo di Torino contro
le Br, accanito scontro verbale tra il pubblico ministero e i brigatisti che
volevano leggere un comunicato. Gli imputati ripetono le loro minacce: "Il
processo si farà a tutto lo Stato e sarà molto serio". Un incidente procedurale
per il divieto d'ingresso ai foto-operatori, poi revocato. Oggi lo scoglio
dell'autodifesa di GUIDO PASSALACQUA 21 marzo 2018. 21 marzo 1978 TORINO. Il
processo alle Br si muove faticosamente attraverso formalità procedurali,
interferenze del potere esecutivo nei confronti di quello giudiziario, scatti di
nervi del pubblico ministero e blandizie diplomatiche del presidente della Corte
Giudo Barbato. Oggi, quinta udienza di questa terza tornata, tutti si
aspettavano di sentire la rivendicazione del rapimento Moro, chissà, forse una
proposta di scambio. Sulla Olivetti portatile di Curcio i brigatisti h...
Silenzio stampa sul
“processo” a Moro? La Dc chiede cautela a giornali e Rai.
Un problema scottante che il
vertice democristiano sta ora discutendo di GIAMPAOLO PANSA 21 marzo 2018. 21
marzo 1978 Roma - Le due del pomeriggio sono suonate da un pezzo e alla fine,
dopo tanto aspettare, ecco Zaccagnini che esce dal suo ufficio, al secondo piano
di piazza del Gesù. Lo precede la moglie, silenziosa. Anche lui tace e si avvia
rapido all'ascensore. Gli chiedo: ci sono novità? Zac non risponde, preme il
pulsante e rimane lì in attesa, con la faccia quasi schiacciata contro il muro.
Ripeto la domanda e Zac seguita a tacere, il volto sempre più vi...
Sequestro Moro, Torino è
una città divisa tra paura e reazione.
Chi sono i cittadini
protagonisti della mobilitazione contro il terrorismo. Il racconto di Giorgio
Bocca dalle cronache di Repubblica del '78 nei tragici giorni del rapimento e
del processo alle Brigate Rosse in città di GIORGIO BOCCA 22 marzo 2018. 22
Marzo 1978 TORINO - La paura si dice è una consigliera e la paura a Torino c'è:
paura del terrorismo, ma anche di tutto ciò che al terrorismo può appendersi. La
sera del rapimento di Moro, quartieri "fuorilegge" come la Falchera e le
Vallette, si sono messi da soli in stato di assedio, di coprifuoco, porte e
persiane chiuse, per paura di tutto e di tutti, di quelli che rubano e di quelli
che scappano, paura di un prossimo infido e vi...
Il “prigioniero” Moro forse
è già lontano da Roma.
Le ricerche si spostano sul litorale laziale e nell'Italia centrale di GIORGIO
BATTISTINI 22 marzo 2018. 22 marzo 1978 Roma - "Non abbiamo quasi niente in
mano. Molte notizie io stesso le apprendo dalla stampa, non solo dai rapporti di
polizia". Sono parole di Giovanni De Matteso, procuratore capo della Repubblica
a Roma, il massimo magistrato che conduce le indagini sull'affare-Moro. Del
rapimento al sesto giorno dall'agguato di vita Fani ancora non si sa. Dal giorno
del sequestro le uniche notizie "ufficiali" sono state il volantino delle Br,
l'annuncio...
Sequestro Moro: l'attacco
al cuore dello Stato.
"Ho capito chi siete", dice il presidente della Dc alle Brigate
Rosse. Si trova ormai in via Montalcini, al buio, nel covo mascherato da
appartamento borghese dei suoi rapitori, che lo fotografano vestito da
prigioniero. Anche il Paese inizia a capire. A Montecitorio, si decide di
accelerare il voto di fiducia al nuovo governo Andreotti di EZIO MAURO 22 marzo
2018. "Presidente, ha capito chi siamo"? Aldo Moro è in piedi, bendato, nello
studio del "covo" di via Montalcini, mascherato da appartamento borghese di una
giovane coppia senza figli. Anna Laura Braghetti, la padrona di casa, dopo aver
visto in televisione la scena insanguinata di via Fani era scesa in strada
quando vide arrivare la sua automobile - una "Citroen Ami" familiare - guidata
da Mario Moretti e le aprì la porta del garage. Poi salì di...
Il caso di coscienza che
turba i giornalisti italiani
di EUGENIO SCALFARI 22 marzo
2018. 22 marzo 1978 I guasti morali e politici che il terrorismo e la violenza
armata possono produrre vanno molto al di là dei fatti specifici e a mano a mano
che passano le ore ciascuno li va misurando sulla propria esperienza quotidiana.
Nascono irrefrenabili fenomeni imitativi: in una società di massa, nella quale
operano mezzi di comunicazione di massa, questo pericolo è sempre latente.
Purtroppo esso non si scongiura sognando un'impossibile regressione verso...
Sciascia: “Quella tragica
foto di Moro...”
di ALBERTO STABILE 23 marzo 2018. 23 marzo 1978 Palermo - Del suo silenzio
dopo il rapimento di Aldo Moro s'è detto che "fa rumore" e ne è nata una
polemica. Chiediamo a Leonardo Sciascia di darcene l'interpretazione autentica.
"Innanzitutto, questo mio silenzio durava da un po'. Io ho scritto il contesto e
ho scritto Todo Modo. Quando mi sono presentato candidato al consiglio comunale
nella lista del partito comunista ho detto che non mi sarei rimangiato una
virgola del...
Moro nelle mani delle Br,
le misure eccezionali.
Da oggi in poi la polizia può fermare qualsiasi cittadino e
trattenendo per 24 ore, interrogare i fermati senza la presenza di magistrati o
avvocati, effettuare intercettazioni telefoniche praticamente fuori dal
controllo dei magistrati e senza limiti di tempo. Che si può volere di più? Di
STEFANO RODOTÀ 23 marzo 2018. 23 marzo 1978 Credo che sia utile dire, subito e
con chiarezza, che le misure legislative sull’ordine pubblico approvate dal
Consiglio dei ministri hanno certamente carattere eccezionale, per il loro
contenuto e per il modo in cui sono state prese. Bisogna dirlo per diversi
motivi. Primo: proprio nelle situazioni di emergenza è indispensabile ritrovare
l’onestà di chiamare le cose con il loro nome, senza velare la realtà dietro
giri di frase. S...
Quando Moro tornerà.
Granelli parla dello stato del partito. Prima intervista a un leader Dc sette
giorni dopo il rapimento di FAUSTO DE LUCA 24 marzo 2018. 24 marzo 1978 ROMA -
La Dc in attesa di Moro, la Dc che può anche perdere tragicamente il suo leader,
il problema eventuale di una successione personale e politica: temi difficili,
angosciosi, ma che pur bisogna affrontare. Ne parliamo con Luigi Granelli,
membro della direzione dc, personalità assai vicina a Moro da diversi anni,
intelligenza per molti versi congeniale a quella del "prigioniero" delle Brigate
rosse. E' la prima intervista di un dirige...
I giorni del sequestro
Moro: bandiere rosse, bandiere bianche
di ENZO FORCELLA 24
marzo 2018. 24 MARZO 1978 Uno Stato moderno, è risaputo, non si può più
reggere sulla sola forza bruta. E in uno Stato democratico, che fonda la sua
legittimazione sul suffragio universale, il consenso è molto più importante
della forza, è il pilastro essenziale. Il consenso, a sua volta, comporta che
sia organizzato. È ingenuo sperare, come ritengono alcuni giovani teorici della
nuova sinistra, che nel futuro, quando lo Stato socialista si…
Sequestro Moro: un nappista
ha parlato, adesso si cercano i covi
di GIORGIO BATTISTINI 25 marzo
2018. 25 Marzo 1978 Il "giallo" politico del rapimento di Aldo Moro riserva le
prime notizie sicure. E' accertato: due brigatisti sono rimasti feriti nel corso
della sparatoria che ha fulminato i cinque uomini della scorta del presidente
dc. L'ha chiarito la perizia ematologica, consegnata ieri dagli esperti che ha
stabilito l'appartenenza, a persone diverse delle macchie di sangue trovate
sulle auto abbandonate. Non è possibile stabilire se le ferite sono prod...
Nuovo agguato Br a Torino.
Ferito a
rivoltellate in pieno centro l'ex sindaco democristiano. Giovanni Picco
affrontato da due killer mentre rincasa alle 13.05: gli sparano 13 colpi di
pistola e lo feriscono alle gambe e a una spalla - l'attentato rivendicato con
la consueta telefonata all'Ansa - il racconto del ferito di SALVATORE TROPEA 25
marzo 2018. 25 marzo 1978 Il terrorismo ha rivolto nuovamente le sue armi
contro Torino. A quindici giorni dall'assassinio del maresciallo Rosario Berardi
e a nove dei tragici fatti di Roma, le Brigate Rosse hanno preso di mira
Giovanni Pico, ex sindaco democristiano, e oggi consigliere regionale. Un
commando gli ha teso un agguato sotto casa, ferendolo in più parti del corpo.
Subito dopo, con una telefonata all'Ansa, le Br hanno rivendicato la paternità
dell'attentato....
Radiografia politica del
documento di
SANDRO VIOLA 26 marzo 2018. 26 MARZO 1978 L'elenco dei capi d'accusa di cui
Aldo Moro "dovrà rendere conto al Tribunale del popolo", è completo. Esso può
essere riassunto in questa frase del comunicato delle Br: "La sua presenza (di
Moro), a volte palese, a volte strisciante, negli organi di direzione del
regime". Segue il dettaglio, la lista degli incarichi di governo e di partito
che l'"imputato" ha ricoperto dal '55 ad oggi. Il processo…
Le Br hanno cominciato il
“processo” contro Moro
di Ezio Mauro 26 marzo 2018. 26-27 marzo 1978 Dopo sei giorni
di silenzio, le Brigate rosse si sono rifatte vive infestando l'Italia di copie
dello stesso "comunicato numero 2". La prima è stata trovata in una cabina di
Torino. La segnalazione telefonica è giunta alla "Gazzetta del popolo" poco dopo
le 16. Un altro volantino è stato fatto pervenire, quasi contemporaneamente,
all'Ansa. Poi, con la scadenza fissa di mezz'ora, è stata la volta di Ro...
Sequestro Moro, non era
questo il processo voluto da Pasolini
di GIORGIO GALLI 28 marzo 2018. 28 Marzo 1978 E' già stato rilevato che il
secondo messaggio delle Brigate Rosse, riecheggia alcuni temi che sono stati
propri dell'estrema sinistra italiana, dallo stalinismo degli anni '50 alle
formulazioni del '68. Si può aggiungere che l'iniziativa specifica del
cosiddetto "processo" al massimo leader della Dc riprenda un argomento che era
stato dell'ultimo Pasolini. Questi non era congeniale al Pci stalinista (che lo
aveva espulso) e ave...
Come risponde il Pci al
comunicato delle Br, intervista con Emanuele Macaluso
di Ezio Mauro 28 marzo 2018.
"Solo gli avventurieri o degli sprovveduti possono pensare che sia possibile in
Italia la via della rivoluzione attraverso il terrorismo". "Anche negli stessi
gruppi di giovani che dissentono dal Pci c'è stato un netto rifiuto della
violenza". "Banco di prova della nuova maggioranza sarà pure la risposta ai
problemi del paese". 28 Marzo 1978 Di Giorgio Rossi ROMA - Senatore Macaluso,
lei fa parte della direzione del Pci. E' d'accordo con la definizione che da
molti è stata data del messaggio numero due dei brigatisti e cioè che si tratta
di un'accozzaglia di argomenti più o meno deliranti? "Non c'è dubbio che questo
documento, a parte il delirio, in effetti usi argomenti fra i più
contraddittori. Da un canto esalta il terrorismo e la violenza…
La sanguinosa scalata a un
paradiso disabitato
di UMBERTO ECO 29 marzo 2018. 29 marzo 1978 L'attesa spasmodica di un nuovo
comunicato delle Br e le concitate discussioni su come ci si sarebbe comportati
in quel caso hanno portato la stampa a reagire in modo contraddittorio. C'è
stato chi non ha riportato il comunicato, ma non ha potuto evitare di
pubblicizzarlo con titoli a piena pagina; chi l'ha riportato, ma in caratteri
così piccoli da privilegiare solo i lettori con dieci decimi di vista
(discriminazione accettabile). Quanto al contenu...
Nelle Br la preoccupazione
di rompere l’isolamento
di Ezio Mauro 29 marzo 2018. 29 Marzo 1978 ROMA - Le indagini sul
rapimento Moro sono praticamente ferme al punto in cui erano la sera successiva
al sequestro, tredici giorni fa. Tracce della "colonna" delle Br che agì in via
Mario Fani (alcuni elementi della quale terrebbero ora in detenzione il
presidente della Dc) non ce ne sono. Sul piano strettamente operativo, quindi,
bisogna ammettere che in questa prima, lunga fase le Br sono riuscite a
contenere la pressione delle forze di polizia, e a sventar...
“Moro nel carcere del
popolo” di
Ezio Mauro 29 marzo 2018. Il presidente della Democrazia cristiana passa la
prima notte in cella. I brigatisti, reduci dalla strage di Via Fani siedono in
cucina. Uno di loro batte a macchina parole come "gerarca", "imperialista",
"processo". È il comunicato numero uno. Che si abbatte su un Paese in cui
qualcuno incomincia a dire "né con lo Stato né con le Br". "E' stato un macello.
Noi stiamo tutti bene, ma è stato un macello". Valerio Morucci è appena
rientrato nell'"ufficio" di via Chiabrera, dall'agguato di via Fani, dopo aver
lasciato l'ostaggio sull'auto guidata da Moretti verso la "base", perché nessun
brigatista oltre ai quattro carcerieri deve conoscere il luogo della prigione.
La televisione mostra la scena fissa del massacro, l'"Alfetta" dell...
Sequestro Moro, quelle
parole non sono le sue,
di Ezio Mauro 30 marzo 2018. 30 Marzo 1978 Se la lettera a Cossiga, diffusa dai
brigatisti, è stata veramente scritta da Aldo Moro, come ritengono gli
inquirenti, essa acuisce ancora i sentimenti di angoscia e preoccupazione sulla
sorte del presidente della Dc. Se il fatto di aver scritto la lettera testimonia
che Moro è vivo, lo stile e il contenuto del messaggio fanno ritenere che Aldo
Moro sia soggetto a pressioni di natura tale che la parola tortura, sia pure
intesa come condizionamento psicologico o...
La grafia di Moro durante
il sequestro,
scrive Evi Crotti, Sabato 05/05/2018, su "Il Giornale". Fui incaricata
dall’allora ministro degli interni Cossiga di analizzare gli scritti pervenuti
dopo il sequestro di Aldo Moro e di confrontarli con quelli precedenti il
rapimento.
PRIMA DEL SEQUESTRO.
Dall’analisi della grafia dell’onorevole Aldo Moro prima del sequestro emerge un
gesto veloce, con degli stiracchiamenti nelle lettere che indicano impazienza e
sveltezza di mente e d’azione. Il pensiero era profondo ma vissuto più
interiormente che non espresso all’esterno. La firma, con le iniziali molto
grandi, mette in risalto quanto per Moro fosse importante la scalata sociale,
mantenendo sempre un’eleganza composta che si rifletteva in un comportamento
controllato e raffinato.
DURANTE I 55 GIORNI DI
PRIGIONIA. Innanzi tutto, occorre dire ai tempi del sequestro ho eseguito una
perizia grafotecnica per dimostrare che, nonostante le differenze apparenti tra
le due scritture, si trattava della stessa persona: identici alcuni gesti
fuggitivi (vedi forma delle “g”), uguale il legamento dinamico tra alcune
lettere (vedi legamenti con gesto orario) e sovrapponibili alcune parole (vedi
“del”). Aldo Moro aveva corretto il suo modo di scrivere per rendesi leggibile a
tutti, cosa che prima non gli interessava. Nelle lettere che Aldo Moro scrive
dalla prigionia emerge una maggiore chiarezza e una lentezza che non faceva
parte del suo patrimonio grafico, espressione della necessità di poter
comunicare in modo comprensibile col mondo esterno. Anche la firma, più
contenuta, conferma la sensazione di costrizione che lo statista stava vivendo.
ULTIMO SCRITTO PRIMA DI ESSERE
UCCISO. Si nota immediatamente come la grafia torna ad essere quella precedente
il sequestro, anche se si rileva un gesto meno tonico, uno spazio sul foglio mal
occupato e la comparsa di un “riccio” prolungato orizzontalmente a fine parola
(vedi “abbraccio” e “grazie”) quasi cercasse di dire al mondo: “Tutto è
compiuto, non c’è più nulla da fare”. Non a caso conclude il suo messaggio con
la frase: “Vedi che non si può fare previsioni?”
Moro scrive a Cossiga
di Ezio
Mauro 30 marzo 2018. In un messaggio chiaramente estorto il leader dc chiede al
governo di trattare con le Brigate rosse. ROMA - Le Brigate rosse hanno
recapitato il Comunicato n. 3. È un volantino di due cartelle, accompagnato da
una lettera manoscritta di Aldo Moro, indirizzata al ministro degli Interni,
Francesco Cossiga. Erano le 21 e 10: quando sono squillati contemporaneamente i
telefoni dell'Ansa e della Gazzetta del Popolo a Torino, del Secolo XIX e del
Corriere della Sera a Milano. I brigatisti hanno comunicato i luoghi in cui si
trovavano i messaggi. A Roma, il comunicato delle Br è ...
Sequestro Moro: senza pietà
e senza giustizia
di Ezio Mauro 31 marzo 2018. 31 marzo 1978 La fantasia degli italiani si sta
esercitando in queste ore su un dilemma: Moro ha scritto la lettera a Cossiga in
"piena coscienza" o costretto? In questa seconda ipotesi quali sono i mezzi di
coercizione usati dai suoi carcerieri? Le tesi sono molteplici. Nel nostro
numero di ieri abbiamo messo in rilievo alcune frasi della lettera che sembrano
non appartenere al linguaggio del leader democristiano: oggi diamo conto di
altre autorevoli interpretazioni, propense in...
Sequestro Moro, la lettera
doveva restare segreta
di SANDRO VIOLA 31 marzo 2018. 31 marzo 1978 Quando i familiari di Aldo Moro
hanno avuto tra le mani, mercoledì sera, la lettera scritta dal loro congiunto a
Francesco Cossiga, per prima cosa hanno tirato un respiro di sollievo.
Guardavano e riguardavano la calligrafia, si soffermavano sulla forma di certe
lettere, studiavano la lunghezza e l'inclinazione delle righe. E a poco a poco
l'ansia con cui si erano gettati sulla lettera si stemperava, e al suo posto
emergeva, come s'è detto, un senso d...
Caso Moro, che cosa possono
chiedere i terroristi
di SANDRO VIOLA 1 aprile 2018. 1 aprile 1978 ROMA – Dopo l’arrivo delle due
lettere di Moro (una alla famiglia – questa è l’ultima notizia -, l’altra a
Cossiga), il quadro va perdendo una parte delle ombre che lo velavano. E ora è
più leggibile, nel senso che durante le ultime quarantott’ore si è delineato un
traliccio di posizioni e di «intenzioni»: le posizioni e le «intenzioni» delle
Brigate rosse da un alto, quelle del governo e d...
Sequestro Moro,
ventiquattr’ore terribili e alla fine i capi Dc hanno scelto la fermezza
di GIAMPAOLO PANSA 1 aprile 2018. 1 aprile 1978 ROMA - Le venticinque righe
senza titolo e senza firma pubblicate dal Popolo per rendere esplicito il
rifiuto della Dc a trattare con i terroristi, sono il documento più drammatico
fra i tanti prodotti dal partito di maggioranza in questi ultimi trent'anni. Fra
quali tormenti è nato? E per quali ragioni la Dc, pur sapendo in gioco la vita
di Moro, ha deciso di «ribadire con meditata convinzione che non è possibile
accettare il ricatto posto in e...
Sequestro Moro, l’Europa
guarda senza capire
di BERNARDO VALLI 2 aprile 2018. 2 aprile 1978 PARIGI- L’anno scorso il
sequestro del tedesco Schleyer, poi assassinato dalla «Rote Armee Fraktion»
accese molto più passioni e polemiche nell’Europa occidentale. Nel dramma
germanico alcuni intravidero «l’ombra di Weimar», la possibilità di una reazione
autoritaria alla psicosi del disordine provocata dai terroristi. I fantasmi
della storia riaffiorano nelle redazioni dei giornali e negli studi degli
intellettuali. Uno ...
Sequestro Moro, ora si
aspetta la nuova mossa
di GIAMPAOLO PANSA 2 aprile 2018. 2 aprile 1978 ROMA – Che cosa raccontare sul
«caso Moro» dopo diciassette giorni di buio? Talvolta il nostro mestiere ci
obbliga a semplificazioni crudeli e impone di spogliare un dramma come questo di
tutto il suo carico di sofferenze per tentar di capire a quale punto siamo. E
allora immaginiamo una scacchiera. Su di un lato c’è il prigioniero con la banda
terroristica che lo ha rapito, che lo nasconde, che lo distrugge con lentezza
feroce. Sull’altro,...
Andreotti risponde in
Parlamento sul caso Moro
di GIORGIO ROSSI 4 aprile 2018. 4 aprile 1978 ROMA - Oggi a
Montecitorio si svolge la discussione sulla strage di via Fani e il rapimento
Moro. Sarà Andreotti a rispondere alle 25 interrogazioni che sono state rivolte
da diverse parti politiche a lui stesso, al ministro Cossiga e ad altri membri
del governo. Le interrogazioni riguardano un po' tutti gli elementi della
drammatica vicenda: dalla ricostruzione ufficiale del sanguinoso agguato alle
deficienze delle misure protettive, dalle lacune delle indagini ai...
Strategia del silenzio in
Vaticano ma confermato l'impegno a trattare
di LUIGI ACCATTOLI 4 aprile 2018. 4 aprile 1978 CITTÀ DEL VATICANO – Le fonti
vaticane non aggiungo nulla all’appello lanciato domenica da Paolo VI agli
«ignoti autori del terrificante disegno», perché diano «libertà al prigioniero».
L’«Osservatore Romano» di ieri riporta con grande evidenza l’appello del Papa,
ma non aggiunge alcun commento. Del resto le parole che Paolo VI ha pronunciato
dalla finestra del suo studio, rivolto alla consueta ...
Sequestro Moro, il
Parlamento risponde no al nuovo ricatto contro lo Stato
di FAUSTO DE LUCA 5 aprile 2018. 5 aprile 1978 ROMA - Avevo in tasca la
lettera dei brigatisti, a Montecitorio, qualche minuto prima di Cossiga. Il
Transatlantico era deserto, tutti i deputati in aula ad ascoltare il dibattito
sulle dichiarazioni di Andreotti. L'intesa con il direttore era precisa:
aspettare il via di Cossiga per diffondere il testo. Ho pregato un commesso
della Camera di avvertire Zaccagnini e Piccoli che era arrivato un importante
messaggio di Moro. Passa il comunista Lucio Libertini, gli chied...
Moro chiede aiuto
di Ezio Mauro 5
aprile 2018. Le Br costringono il leader dc a proporre uno scambio con i
terroristi in carcere. 5 aprile 1978 Mentre Giulio Andreotti parlava alla
Camera sulla vicenda di Aldo Moro, alle 17.30 è arrivato alla redazione milanese
de "La Repubblica" un nuovo messaggio delle Brigate rosse, comprendente, come
quelli precedentemente inviati, una premessa dell'organizzazione terroristica,
una lettera del leader democristiano e un commento dei brigatisti. La Malfa
porta in aula la drammatica lettera. Il Parlamento non modifica la sua linea: no
al ricatto delle Brig...
Processo al prigioniero
Aldo Moro di
Ezio Mauro 5 aprile 2018. Nella cella dove la luce non si spegne mai, il leader
della Dc diventa un imputato senza difesa. Le Br lo interrogano perché sveli i
segreti italiani e dell’“imperialismo internazionale”. È questo, nella mente dei
terroristi, il vero nucleo dell’operazione. Ma alle loro domande ideologiche
ricevono risposte politiche che non sono in grado di comprendere. Gli hanno
tolto la benda, ma è ancora come se fosse al buio. Nella cella la luce non si
spegne mai, giorno e notte, e da stasera i carcerieri lasciano socchiusa anche
la porta, quando la casa dorme. Si sono accorti che non possono tenere
l'impianto di aerazione acceso la notte, fa troppo rumore, ma senza l'aria che
arriva dal tubo la prigione non può restare chiusa. Gallinari è il responsabile
della "base", tocca a lui risolvere il problema. Si infila i...
Sequestro Moro, il giorno
più lungo a piazza del Gesù
di LUCIO CARACCIOLO 6 aprile
2018. 6 aprile 1978 ROMA - E' stato un misterioso personaggio, giunto a Piazza
del Gesù pochi minuti dopo mezzogiorno, a consegnare nelle mani di Zaccagnini il
testo originale della drammatica lettera di Moro. Accanto al segretario sedevano
in quel momento i sette leaders democristiani chiamati personalmente in causa da
Moro nel suo ultimo messaggio: Andreotti, Cossiga, Fanfani, i vicesegretari
Galloni e Gaspari, i capi-gruppo al Parlamento Piccoli e Bartolomei. Fra i
destinatar...
Per salvare Moro la
famiglia cerca un contatto con le Br
di Ezio Mauro 6 aprile 2018.
Ipotesi di una trattativa in Svizzera. Il Vaticano avrebbe scelto il territorio
elvetico come la sede più adatta per avviare il negoziato. Governo e Dc
smentiscono tuttavia ogni volontà di trattare con le Br. 6 Aprile 1978 ROMA -
Il Viminale, e se non il Viminale una parte della Dc, gli amici di Moro, la
famiglia hanno stabilito un contatto con le Br? La risposta è, almeno per il
momento, no. Allo stato delle cose non è neppure certo che Moro sia vivo, né
quando - esattamente quale giorno - abbia scritto la lettera a Zaccagnini
recapitata dalle Br martedì sera. Ma questo buio impenetrabile, quest'incertezza
non tolgono che sul versante governo Dc-famig...
"Crediamo sia ancora
possibile riabbracciarlo"
di Ezio Mauro 7 aprile 2018. 7 aprile 1978 MILANO - Eleonora Moro ha inviato una
lettera al direttore del " Il Giorno": "Roma 6 aprile. Gentile Direttore, in
questa situazione che non ci consente alcun contatto, mi avvalgo della cortesia
del suo giornale, sul quale mio marito ha tante volte scritto, per rivolgermi a
lui, se mia sarà possibile che egli ne sia informato, e rassicurarlo che tutti i
componenti della famiglia sono uniti e in salute. Noi, purtroppo, non abbiamo
alcun segno che conforti ...
Contrasto tra la Dc e la
famiglia Moro
di SANDRO VIOLA 7 aprile 2018. 7 aprile 1978 ROMA - Un colloquio
dai toni tesi e commossi, poi duri, infine drammatici. È questo che è venuto
fuori mercoledì (attorno alle tredici e trenta) dall’incontro tra Benigno
Zaccagnini e la famiglia di Aldo Moro, quando il segretario della Dc – finito il
vertice dei capi del partito a piazza del Gesù – è andato da Eleonora Moro e dai
suoi figli a riferire che la Democrazia cristiana è ferma nel rifiuto di ogni
trattativa...
La moglie di Moro aspetta
la risposta dei brigatisti
di SANDRO VIOLA 8 aprile 2018. 8 aprile 1978 ROMA – Era parso,
sulle prime, uno dei tanti elementi della straordinaria vicenda che il paese
vive da tre settimane: ma poi il dissidio tra la famiglia di Aldo Moro e la Dc è
andato man mano crescendo, quindi si è drammatizzato, ed ora è una sorta di
romanzo nel romanzo. Il primo scontro di una delle «grandi famiglie»
democristiane con il partito, una discussione acre e violenta che a tratti, in
questi ultimi due giorni, ha avuto le form...
Il caso Italia al vertice
europeo di
BARBARA SPINELLI 8 aprile 2018. 8 aprile 1978 COPENAGHEN – E’ un singolare
vertice europeo, quello che si è aperto oggi pomeriggio al palazzo
Christiansborg di Copenaghen: c’è un po’ meno pessimismo che in altre occasioni
analoghe; tutti i campi di stato e di governo convocati per il summit appaiono
in qualche modo consapevoli che l’ora delle decisioni è arrivata e che i
classici rinvii non sarebbero più giustificabili di fronte a un’opinione
pubblica europea...
La voce di Moro detta
l’ultimatum delle Br
di GIORGIO BATTISTINI 9 aprile 2018. 9 aprile 1978 ROMA – Nuovo messaggio di
Aldo Moro. È contenuto in un nastro registrato, con la sua voce. Il tono è
drammatico, ultimativo; quasi l’appello disperato di chi sa di avere i giorni
contati. L’ha annunciato una telefonata, l’ennesima segnalazione beffarda d’un
terrorista, verso le 18, al centralino della questura di Roma. «C’è un messaggio
di Moro, l’ultimo», ha detto la voce prima di indicare il luogo. No...
Nel bunker della Dc si
decide sul futuro del partito
di EUGENIO SCALFARI 9 aprile 2018. 9 aprile 1978 ROMA - Lo stato maggiore di
piazza del Gesù è compatto attorno al suo segretario, Benigno Zaccagnini. Nel
"bunker" del secondo piano del vecchio palazzo Bolognetti, dove fino al 16 marzo
batteva il cuore del potere democristiano, siedono praticamente in permanenza i
capi del partito per fronteggiare le crescenti onde della crisi provocata dal
rapimento di Moro: insieme a Zac, sempre più scavato nel volto, e sofferente
nell'animo, Galloni, Pic...
Che cosa ha scritto Moro
di MAURO BENE 10 aprile 2018. 10 aprile 1978 Una lettera di tre cartelle
manoscritte, un atto d’accusa contro il partito che l’ha abbandonato, che
rifiuta qualsiasi trattativa con i brigatisti: è l’ultimo messaggio di Moro.
Queste le anticipazioni giunte ieri notte. Una notte drammatica, costellata di
silenzi angosciosi, di caute ammissioni, di riunioni d’emergenza. È diffusa la
sensazione, anzi la quasi certezza, che si stanno vivendo le ore decisive della
tragedia-Moro. A sera si ...
Le 24 ore più difficili dal
giorno del rapimento
di Ezio Mauro 10 aprile 2018. 10 aprile 1978 Le ultime ventiquattr’ore sono
state le più convulse del caso Moro, dopo l’eccidio e il rapimento del 16 marzo.
Anche se il testo dell’ultima lettera inviata dal leader dc alla famiglia e
intercettata dalla polizia il pomeriggio di sabato continua a restare
rigorosamente segreto, c’è in tutti la sensazione che una svolta decisiva sia
ormai prossima. Non si spiegherebbe altrimenti l’intrecciarsi d’una serie di
fatti e di compor...
Sequestro Moro, una voce
stravolta dal “carcere del popolo”
di SANDRO VIOLA 11 aprile 2018. 11 aprile 1978 ROMA - Quel che il mondo
democristiano aveva più temuto in queste pesanti settimane, si è ormai
verificato. Dal chiuso del "carcere del popolo" con parole insieme vaghe e
lucide, con una curiosa petulanza, Aldo Moro (o più esattamente lo Aldo Moro
prigioniero, da venticinque giorni, delle Br) ha cominciato a attaccare uomini,
correnti, fasi politiche della Dc. Il "processo" annunciato dalle Brigate Rosse
va dunque avanti, e ieri sera...
L’interrogatorio di Moro
di Ezio Mauro 11 aprile 2018. 11 aprile 1978 MILANO - La telefonata che
preannunciava il quinto comunicato delle Brigate rosse dopo il rapimento
dell'onorevole Moro è arrivata al centralino della nostra redazione milanese
poco dopo le 17.30.Ilvolantino era nascosto in una busta delle nettezza urbana
c'era una busta arancione con dieci fogli: otto di fotocopia del testo scritto a
mano da Aldo Moro, e due di dattiloscritti con la stella a cinque punte. Altri
comunicati sono arrivati a poca distanza di tempo...
Tre i messaggi segreti
inviati da Moro alla famiglia
di FRANCO COPPOLA 12 aprile 2018. 12 aprile 1978 ROMA - Le lettere segrete
scritte da Moro alla famiglia sarebbero tre. La prima, scritta per rassicurare i
congiunti delle sue condizioni di salute, venne recapitata mercoledì 29 marzo,
contemporaneamente ai messaggi a Cossiga e al segretario particolare Nicola
Rana. La seconda, quella della cui esistenza si è saputo solo ieri, sarebbe
stata fatta arrivare in via del Forte Trionfale prima che la moglie di Moro,
venerdì mattina, facesse pubbli...
Catturato un brigatista a
Torino. Un agente lo ha ferito prima di cadere assassinato di
GUIDO PASSALACQUA 12 aprile 2018. 12 aprile 1978 TORINO - L'uomo è disteso sul
marciapiede del Lungodora Napoli. La faccia larga, da meridionale, è terrea. Il
vestito grigio, fatto in serie, è inzuppato di sangue. Sotto la giacca
sbottonata, la camicia azzurra di popeline, è bucata dai colpi di pistola. Sono
le nove di mattina, è lì da un'ora e mezza. Vicino alla mano destra, rigata di
sangue, c'è una 7,65 d'ordinanza con il caricatore vuoto. Sulla sini...
Le lettere di Aldo Moro
di Ezio
Mauro 12 aprile 2018. Dalla sua cella dove non può né camminare né vedere il
sole il presidente della Dc capisce che ha un solo modo per salvarsi: usare la
sua mente politica per una trattativa verso il mondo esterno. E per farlo ha un
unico strumento: la scrittura. Così, dopo aver rassicurato la “mia carissima
Noretta”, invia messaggi ai politici, agli amici, al partito perché “Iddio vi
illumini”. Ma quelle che dovevano restare missive segrete vengono usate dalle Br
per “smascherare la mafia democristiana”. E un dubbio si insinua nel Paese: può
un uomo prigioniero che lotta per la vita non perdere la lucidità? Non aveva mai
fatto ginnastica, solo qualche passeggiata mattutina con il maresciallo Leonardi
al fianco, davanti allo Stadio dei Marmi al Foro Italico, quando aveva tempo tra
la messa e il partito. O la domenica sul lungomare al sole, se andava a
Terracina nella bella stagione. Adesso vorrebbe muoversi, camminare, sforzare un
po’ il fisico, bloccato in quella gabbia rettangolare senza finestre e senza
notizie, con la porta appena socchiusa sul mistero della casa, ma sbarrata su...
“Contro le Br”: il
sindacato scende in campo.
"Di fronte ai terroristi che hanno dichiarato guerra al sistema democratico Non
sono tollerabili giustificazioni di alcun genere". "Aberrante lo slogan Né con
lo Stato, né con le Br". Esaminati anche i rapporti con il governo, la politica
salariale e le polemiche interne di VITTORIA SIVO 13 aprile 2018. 13 aprile 1978
Roma - "Di fronte ai terroristi che hanno dichiarato guerra allo Stato
democratico non sono tollerabili giustificazionismi di alcun genere.
All'aberrante slogan "né con lo Stato né con le Brigate rosse" dobbiamo opporre
l'affermazione che la difesa delle istituzioni e il rinnovamento dello Stato
nato dalla Resistenza sono due termini dello stesso problema e capisaldi della
nostra strategia politica". La risposta del...
Il Pg Pascalino avoca
l’inchiesta sul rapimento di Moro
di GIORGIO BATTISTINI 13
aprile 2018. 13 aprile 1978 Roma - Il Procuratore generale della Repubblica di
Roma Pietro Pascalino ha chiesto "in visione" tutti gli atti dell'inchiesta sul
rapimento di Aldo Moro e il massacro della sua scorta. In pratica è l'avocazione
dell'intero procedimento al massimo livello giudiziario. Sui motivi della
decisione trapelata nel pomeriggio di ieri si possono fare varie ipotesi. Non
ultima quella dell'estrema modestia dei risultati conseguiti fino a questo m...
Come si vive nel carcere
delle Br di
GUIDO PASSALACQUA 14 aprile 2018. 14 aprile 1978 TORINO - E' la mattina di
lunedì 10 dicembre 1973 quando il cavalier Ettore Amerio, direttore del
personale Fiat del gruppo auto, viene sequestrato da un commando delle Br. I
brigatisti lo terranno in una "prigione del popolo" per otto giorni. E' il primo
lungo e estenuante braccio di ferro tra le Brigate rosse e lo Stato.
Oggi, alla diciannovesima udienza del processone alle Br, il cavaliere Ame...
Per Moro non si tratta,
tutti d’accordo nella Dc
di GIAMPAOLO PANSA 14 aprile 2018. 14 aprile 1978 Roma - La Dc tiene, non si fa
ricattare dall'offensiva della paura messa in atto dalle Brigate Rosse e ripete:
con i terroristi non si tratta. Lo ha detto ieri in direzione Zaccagnini, il
primo bersaglio umano di questa battaglia di logoramento che dura ormai da
ventinove giorni ed è condotta a colpi di messaggi, di foto, di lettere
pubbliche e segrete, di "verbali" del "processo" a Moro. Il segretario
democristiano ha parlato con sofferenza ma ...
“Torino è una città malata”
di SALVATORE TROPEA 15 aprile 2018. 15 aprile 1978 TORINO - Una rivista
americana ha descritto la Torino amministrata dalla giunta socialcomunista come
una città nella quale "sequestri, bombe, omicidi e rapine a marno armata
abbondano, e il semplice vandalismo, spesso commesso da bande di bambini sotto i
dodici anni è dilagante". "Nelle strade di Torino, il terrore" titola il
quotidiano francese "France Soir". E' dunque questa la città che si presenta agi
occhi dei...
Pintor, “Lo stato, la vita
di Moro e le colombe”
di GIAMPAOLO PANSA 15 aprile 2018. 15 aprile1978 ROMA -Trattare
o non trattare con le Brigate rosse? Cedere ai terroristi non comporta il
pericolo di far saltare quel tanto di sistema democratico che siamo riusciti a
tenere in piedi? E quanti vogliono trattare, ossia le "colombe", non rischiano
di diventare, loro malgrado, dei "falchi"? La storia cominciata il 16 marzo
ripropone ogni giorno domande sempre più aspre. E allora andiamo a sentire che
cosa risponde, dopo le prime polemiche, una...
Moro condannato a morte
di Ezio Mauro 16 aprile 2018. Le Br annunciano: «il processo è finito». Nessuna
rivelazione sull’interrogatorio. 16 aprile 1978 "Aldo Moro è colpevole e
pertanto viene condannato a morte". A trenta giorni dal sequestro e dalla strage
di via Fani, le Brigate Rosse hanno concluso il "processo" al leader dc e questa
è la loro "sentenza". I terroristi l'hanno diffusa con il solito sistema: un
comunicato (il numero 6, datato 15 aprile), spedito ieri sera, fra le 20 e le
20.30, alla redazione milanese della "Repubblica" e ad altri giornali. È ...
Sequestro Moro, la spietata
sentenza delle Br
di Ezio Mauro 16 aprile 2018. A un mese dal rapimento di Moro si profila una
tragica conclusione. Ecco il testo del comunicato n. 6 delle Brigate rosse che è
stato annunciato alla nostra redazione milanese ed a quella di altri giornali.
Il messaggio si trovava in un cestino di rifiuti, in via dell’Annunciata, a
cinquanta metri dalla Questura centrale di Milano. 16 aprile 1978
"L'interrogatorio al prigioniero Aldo Moro è terminato. Rivedere trenta anni di
regime democristiano, ripercorrere passo passo le vicende che hanno scandito lo
svolgersi della controrivoluzione imperialista nel nostro paese, riesaminare i
vari momenti delle trame di potere, da quelle "pacifiche" a quelle più
sanguinarie, con cui la borghesia ha tessuto la sua offensiva contro il
movimento proletario, individuare attraverso le risposte di Moro ...
Sequestro Moro, un prezzo
che lo Stato non deve pagare
di Ezio Mauro 18 aprile 2018.
18 aprile 1978 Di fronte alla crudeltà della "condanna a morte" di Aldo Moro, la
famiglia e la Dc hanno deciso di far intervenire le organizzazioni
internazionali che per statuto si prendono cura dei prigionieri, del loro
trattamento, della loro sorte: anzitutto "Amnesty International" e poi - se sarà
necessario - la "Caritas" vaticana e la Croce Rossa Internazionale. Questa nuova
linea di condotta pone due problemi: 1) Sarà sufficiente a ...
Ultimo S.O.S. per Moro.
La richiesta è partita dalla famiglia in accordo con la Democrazia cristiana. Da
Londra Amnesty International si rivolge alle Br per discutere la liberazione del
leader rapito di BARBARA SPINELLI 18 aprile 2018. 18 aprile 1978 LONDRA -
L'organizzazione "Amnesty International", nota per la sua strenua difesa dei
prigionieri politici in tutto il mondo, ha lanciato oggi pomeriggio un pressante
appello perché la vita di Moro sia risparmiata. In un comunicato diramato alle
18 ora italiana dalla segreteria generale che ha sede a Londra, l'organizzazione
"offre i suoi buoni uffici" per la salvezza del leader Dc, condannato a morte
sabato scorso dalle brigate rosse, e si...
Moro assassinato? Vane le
ricerche di elicotteri e sommozzatori.
Non si esclude l’ipotesi di una falsa pista di PAOLO GUZZANTI 19 aprile 2018. 19
aprile 1978 RIETI. Prima delle 19 le ricerche del corpo di Aldo Moro al lago
della Duchessa sono state sospese. Le prime ricognizioni non hanno dato alcun
risultato. È forte il sospetto che il contenuto del settimo messaggio delle
brigate rosse sia falso. Se fosse invece vero, e il corpo del presidente della
Democrazia Cristiana si trovasse realmente sepolto nelle gelide acque del
laghetto si dovrebbe accettare una delle seguenti ipotesi: Aldo Moro è morto da
diversi giorni...
Sequestro Moro, tragico 18
aprile a piazza del Gesù
di GIAMPAOLO PANSA 19 aprile 2018. 19 aprile 1978 Roma - Doveva arrivare, questo
18 aprile a piazza del Gesù, ma nessuno lo immaginava così carico d'angoscia,
così straziato fra notizie vere e notizie incerte, così' crudele nell'alternarsi
dei messaggi di morte e dei lampi di speranza. La prima telefonata alle 10.30, è
di Lettieri, sottosegretario all'Interno: c'è l'ultimo comunicato delle Brigate
Rosse, Moro è stato assassinato. Zaccagnini ascolta con ...
Aldo Moro: parola d’ordine
“fermezza”. Il no alla trattativa con le Brigate rosse trova concordi la
Democrazia cristiana e il Partito comunista. "Garantire l'ordine democratico" è
sin da subito la risposta di Enrico Berlinguer all'azione dei terroristi di EZIO
MAURO 19 aprile 2018. A un certo punto il registratore Philips gira a vuoto, da
solo, nessuno trascrive più le cassette, Maccari e Gallinari posano la penna, è
inutile. Non si riesce a fare un uso politico della voce di Moro: eccola che
esce dalla cella e arriva nello studio, pacata, lenta nelle grandi curve del
discorso, solitaria perché nessuno vede il prigioniero durante l'interrogatorio,
solo Mario Moretti attraverso quei due fori per gli occhi dentro il cappuccio di
tela. Quando gli ...
Nel lago della Duchessa non
c’è traccia del corpo di Moro
di PAOLO GUZZANTI 20 aprile 2018. 20 aprile 1978 LA DUCHESSA - Giornata densa di
tante novità tranne quella più tristemente attesa: il ritrovamento del cadavere
di Aldo Moro. Si parte sempre dalla stessa ipotesi di lavoro, finché da Roma è
data per buona. E cioè che il comunicato numero 7 delle Br sia autentico. Poiché
il Viminale - fino a questo momento - ha ribadito queste valutazioni, pur
ammettendo che la macchina da scrivere e il dattilografo delle Br sono cambiati,
le ricerch...
Aldo Moro, è morto o è
vivo? Nuovi
appelli per una trattativa con i terroristi di GIORGIO ROSSI 20 aprile 2018. 20
aprile 1978 L'ultima drammatica lettera di Moro alla moglie, con le accuse a
Zaccagnini, al partito, agli amici, al Vaticano ("Che fa Zaccagnini? Che fa la
Democrazia cristiana? Che cosa fa il cardinale Poletti?") e di cui riferiamo in
altra parte del giornale, è probabilmente al centro dell'ultimo, clamoroso
episodio dell'angosciosa vicenda: un solenne appello della presidenza della
Conferenza episcopale in favore dell'apertura di trattative con i brigat...
Sequestro Moro: sacrificare
un uomo o perdere lo Stato
di Ezio Mauro 21 aprile 2018. 21 aprile 1978 Sapevamo tutti, fin dall’inizio
di questa orribile vicenda, che sarebbe arrivato il momento dell’ultimatum.
C’era un’alternativa: che Moro rivelasse infami segreti e crimini di Stato. Se
lo avesse fatto – o perché quei crimini di Stato esistono oppure inventandoli
pur d’aver salva la vita – i terroristi l’avrebbero certamente rilasciato,
essendo la sua presenza da vivo assai più ingombrante che il suo cadaver...
Aldo Moro, Craxi si schiera
per la trattativa.
Lo scambio dei prigionieri è tecnicamente impossibile. Ma possono esserci altre
vie d’uscita, e quelle vie bisogna esplorarle. Richiamato ad esempio il
comportamento del governo tedesco di GIAMPAOLO PANSA 21 aprile 2018. 21 aprile
1978 ROMA - Non si può abbandonare Moro nelle mani delle Brigate rosse e farlo
ammazzare. Bisogna cercare una soluzione. Una volta raggiunta la certezza che
Moro è vivo, occorre individuare un canale con i terroristi e cominciare a
vedere che cosa vogliono. Se chiedono cose ragionevoli si può trattare con loro.
Lo scandalo dei prigionieri è tecnicamente impossibile e va escluso. Ma possono
esserci altre vie d'uscita e quelle vie debbono essere esplo...
Amato: «Non trattare per
Aldo Moro fu una scelta poco comprensibile».
L’ex premier: per salvare la
vita di un cittadino lo Stato può negoziare con chicchessia, ma lì c’era un
ostacolo in più, e cioè la questione del riconoscimento politico che si sarebbe
garantito ai terroristi. Intervista di Giovanni Bianconi del 8 maggio 2018 su
"Il Corriere della Sera". La notizia l’apprese dalla televisione: «Mi trovavo a
casa, e un giovane Bruno Vespa annunciò che l’uomo trovato morto nella Renault 4
rossa era Aldo Moro. Una conclusione terribile, che cinquantacinque giorni prima
non avemmo la lucidità nemmeno di immaginare». Era il 9 maggio 1978.
Cinquantacinque giorni prima, il 16 marzo, Giuliano Amato — oggi giudice
costituzionale dopo essere stato più volte ministro e presidente del Consiglio,
all’epoca direttore del Dipartimento di studi giuridici della facoltà di Scienze
politiche, alla Sapienza — era andato all’università dov’erano in programma gli
esami di laurea; di alcune tesi era relatore Aldo Moro, professore di Diritto
penale: «Appena arrivarono le prime informazioni, prima di un incidente e poi
del rapimento, dicemmo ai suoi studenti che le loro discussioni erano rinviate a
quando Moro fosse tornato. Ma non lo vedemmo mai più».
Lei all’epoca militava nel Psi
guidato da Bettino Craxi, che da un certo momento tentò la strada della
trattativa con i brigatisti, per provare a far tornare Moro a casa. Cosa ricorda
di quei giorni?
«Fui interpellato una sola
volta da Craxi, insieme a Gino Giugno e Giuliano Vassalli. Ci chiese indicazioni
sulla legittimità del negoziato, e io sostenni che per salvare la vita di un
proprio cittadino lo Stato può negoziare con chicchessia. Ma lì c’era un
ostacolo in più, e cioè la questione del riconoscimento politico che si sarebbe
garantito ai terroristi, dando loro una patente di autorità e politicità quasi
pari a quella dello Stato. Ricordo quell’incontro a quattro, noi tre e Craxi, ma
poi il segretario non ci convocò più, e i tentativi proseguirono con il solo
Vassalli».
Lei dunque era favorevole a
una trattativa con i brigatisti?
«Allora, da estraneo qual ero
alla vicenda, la vivevo pieno di dubbi. Ma ciò che più mi colpì fu il motivo per
cui le istituzioni del tempo, rappresentate in particolare dalla Dc e dal Pci,
decisero per la fermezza. A me sembrava che a richiederla fosse non la
“statualità”, ma la debolezza che essi stessi sentivano nel nostro Stato. Uno
Stato forte avrebbe reagito diversamente, trattando anche con il diavolo, salvo
andare ad arrestarlo un attimo dopo. Basti guardare quello che ha sempre fatto e
continua a fare Israele, anche con una controparte come Hamas, che considera
terrorista; non si sente intaccato da uno scambio di prigionieri, se serve a
salvare la vita di propri cittadini».
Era quello che cercava di
spiegare Moro nelle lettere dalla «prigione del popolo».
«Certo, e non fu ascoltato.
Allora c’è da chiedersi perché lo Stato si sentiva così debole. In quei giorni
si avvertiva una sensazione di grande inadeguatezza, una situazione nella quale
ciascuno si muoveva per conto proprio, con il presidente della Repubblica pronto
a concedere la grazia a una brigatista che non si era macchiata di reati di
sangue e altri che fecero di tutto per dissuaderlo. Non c’era unità d’intenti».
Tranne che nel ritenere
inattendibile e troppo condizionato dai suoi carcerieri il Moro che lanciava
appelli dalla prigionia. Lei che cosa pensò di quegli scritti?
«Non ho mai ritenuto che non
fossero autentici, e capisco il risentimento della famiglia nei confronti di chi
invece sostenne di non poter riconoscere Moro in quelle lettere. Probabilmente
era una posizione necessaria a mantenere la linea della fermezza, che per il Pci
poteva avere una ragione: forse quei “compagni che sbagliavano” avevano
assonanze anche in casa sua, e qualunque interlocuzione con loro poteva ridurre
le barriere immunitarie. Ma la Dc non aveva lo stesso problema, e dunque è meno
comprensibile. Ripeto: non trattare può essere un’eccezione, non la regola. Del
resto abbiamo esempi di trattative condotte per conto dello Stato italiano sia
prima che dopo Moro: da Sossi a Cirillo, e con gli stessi terroristi
palestinesi».
Quando conobbe Moro?
«Lo conobbi prima da politico
che da professore, quando fu presidente del Consiglio nei governi di
centrosinistra, dal 1963 al 1968. Io collaboravo col ministro del Bilancio
socialista, e c’erano contrasti sulla ripartizione di poteri e competenze con il
Tesoro tenuto dai democristiani; ricordo riunioni interminabili nelle quali Moro
non imponeva soluzioni, ma portava gli altri a discutere e confrontarsi fino a
convergere su quella che lui riteneva più congrua. Non era mai una sua
decisione, lui si limitava a prendere atto del punto d’incontro e solo allora
diceva: “Vedo che abbiamo concluso”. Era come se costringesse gli altri al
dialogo per ottenere il risultato voluto».
Fu la sua caratteristica
principale?
«Questa lo era senz’altro, ma
io penso che Moro debba essere ricordato nei libri di storia sull’Italia
unitaria non tanto per i suoi metodi o perché l’hanno ucciso, bensì come uno dei
pochi statisti che hanno colto e affrontato il mal sottile dell’Italia unita: la
parzialità del consenso sociale che costituisce la base delle nostre
istituzioni. Lui capì che era troppo esigua, e che bisognava allargarla per
rendere meno fragile lo Stato. Un primo passo era stato compiuto con
l’integrazione dei cattolici nelle istituzioni, di cui lui era parte, poi
proseguì con l’apertura prima al Psi e poi al Pci, con la cosiddetta terza fase.
Non per qualche alchimia politica o per imporre matrimoni innaturali, ma per la
sostanziale necessità di integrare i ceti sociali rappresentati da quei partiti.
Era un modo, anzi il modo per rafforzare lo Stato debole».
Quello che non ebbe la forza
di trattare con i brigatisti?
«Esattamente: lo Stato debole
che non è riuscito a salvare Aldo Moro».
Ore contate per Moro,
scrive Venerdì 11/05/2018 L’Adige. Dissero a Moro che lo avrebbero ucciso perché
gli uomini, anzi di «amici» del suo partito non avevano voluto trattare lo
scambio: tredici prigionieri legati alle Br, e alcuni di loro erano banditi
politicizzati in carcere, liberi e trasferiti magari in Libia per Aldo Moro
vivo. Gheddafi, il presidente della Libia, aveva convocato l’ambasciatore
d’Italia a Tripoli e nell’incontro, ripreso dalla televisione, aveva dichiarato
la propria condanna al terrorismo delle Br e la sua disponibilità ad ogni
intervento, utile a salvare la vita dell’ostaggio. Si era detto disposto ad
accogliere in Cirenaica le persone indicate dai brigatisti. Anche Castro si era
dichiarato pronto ad accogliere a Cuba i brigatisti. Poi si era saputo che gli
americani non avrebbero gradito la presenza di terroristi rossi italiani
nell’isola della rivoluzione. Il capo delle Brigate Rosse Mario Moretti aveva
già telefonato alla famiglia Moro spiegando con tono molto cortese che solo un
intervento «immediato e chiarificatore» del leader della Dc Zaccagnini avrebbe
impedito l’uccisione dell’ostaggio. C’era stato un colloquio decisamente
drammatico tra Benigno Zaccagnini e i familiari del presidente rapito, quando il
segretario della Dc, finito il vertice dei capi del partito a piazza del Gesù –
un incontro tesissimo e duro – era andato da Eleonora Moro e dai suoi figli a
riferire che la Democrazia Cristiana era ferma nel rifiuto di ogni trattativa
con i terroristi. Ecco il momento della rottura totale tra la famiglia del
leader da una parte e dall’altra il governo sostenuto dalla maggioranza del
partito. Si parlò persino del funerale: la famiglia Moro disse di non volere
quelli di Stato né la presenza di uomini della politica e nel partito, da tempo
chiamato «balena bianca». Dal canto suo, Bettino Craxi leader del Partito
Socialista aveva indicato a Zaccagnini i nomi di due detenuti che potevano
essere graziati. La brigatista Paola Besuschio che a Trento, nella facoltà di
Sociologia, aveva conosciuto Renato Curcio e Margherita Cagol e ferita in uno
scontro a fuoco, era stata ricoverata nell’ospedale Santa Chiara e il nappista
Alberto Buonoconto. Era in corso la campana elettorale per le amministrative, ma
i comizi erano semideserti e forse cominciò in quei giorni del maggio di
quarant’anni fa, il crescente distacco degli italiani dai partiti tradizionali.
Gli uomini della politica – le donne erano numericamente una insignificante
minoranza – non capirono l’andazzo e nella Dc l’atteggiamento della famiglia
che, ovviamente, non voleva accettare il dettato di Zaccagnini, venne
considerato una «mina vagante» mentre nel quadro della vicenda si radicò la
convinzione che i familiari e gli amici di Moro – fra di loro Amintore Fanfani –
avevano stabilito un contatto con i terroristi. Si capiva che il sequestro non
poteva durare altro tempo; il giornale «la Repubblica» pubblica un articolo a
tutta pagina dal titolo «Ultimo sos per Moro» e l’appello di Amnesty
International scrivendo che «a Piazza del Gesù si ha la certezza che si stanno
vivendo le ore decisive della tragedia Moro». Le notizie filtrano con difficoltà
anche se i massimi esponenti del partito siedono in continua riunione alla quale
partecipa anche Willy De Luca, all’epoca di massimo dirigente della Rai.
L’antico palazzo Bolognetti, sede della Dc, è diventato un bunker presidiato dai
Bersaglieri che imbracciano i mitragliatori. Ricordava Flaminio Piccoli che
l’aria era «d’angoscia» e dopo quella parola si chiudeva nel silenzio. Insieme a
Zaccagnini c’erano Galloni, De Mita, Andreotti, Cossiga, personaggi che nel
corso degli anni si erano variamente disputati il potere e talvolta i loro
dissidi si erano trasformati in scontri violenti e in alcune occasioni
addirittura furibondi. Come scriveva Eugenio Scalfari aggiungendo: «Siedono
l’uno accanto all’altro, accumunati dalla cattiva sorte; le vecchie correnti,
tante volte date per morte sulla carta, sono state cancellate da un gigantesco
colpo di spugna, perché questa volta la crisi è veramente tremenda, non consente
lussi, divagazioni, margini, giochi personali». Scrive ancora «la Repubblica»
quel titolo da brivido: «Ore contate per Moro». Anni davvero decisivi quelli dal
1969 al 1978, dalla strage di Piazza Fontana a quella di via Fani. Il Paese era
infestato dal terrorismo mentre viveva la prima grande recessione dopo gli anni
del boom; il Pci rischiava il sorpasso della Dc e il segretario comunista Enrico
Berlinguer sosteneva di sentirsi più sicuro sotto l’ombrello della Nato. Anche
il 18 aprile del 1948 Palmiro Togliatti non se la prese troppo per la sconfitta
del suo partito. Anche lui si sentiva più tranquillo sotto l’ombrello americano
che all’ombra dei baffoni di Stalin. Intanto nel covo, i brigatisti preparavano
il sesto omicidio. Poi qualcuno di loro disse che non voleva la morte di Moro.
Boniver: «Ci linciarono
perchè Craxi provò a salvare Moro».
Margherita Boniver racconta i giorni di prigionia di Aldo Moro, vissuti dalla
sede del Psi, scrive il 10 Maggio 2018 "Il Dubbio". «Aldo Moro fu l’unico
cittadino italiano per il quale lo Stato non trattò la liberazione. Noi
socialisti fummo gli unici a mettere in campo un tentativo concreto per cercare
di salvarlo e lo Stato ha molte colpe in questa tragedia». Margherita Boniver,
presidente della fondazione Craxi e membro del Psi all’epoca del sequestro Moro,
ricostruisce i lunghi giorni del sequestro e l’affanno di Bettino Craxi nel
cercare una strada di dialogo tra Istituzioni e brigatisti.
Lei parlò con Bettino Craxi
durante il sequestro Moro?
«Sì,
perchè Craxi mi chiese di coinvolgere Amnesty International nel disperato
tentativo di salvare la vita di Moro. All’epoca, infatti, ero presidente della
sezione italiana dell’associazione, che avevo costituito nel 1973. Per farlo, mi
recai più volte a Londra per parlare con l’allora segretario generale, Martin
Ennals: Amnesty International si occupava di “prigionieri di coscienza” e
prigionieri politici ma la sezione italiana per Statuto non avrebbe potuto
occuparsi di casi italiani. Questa era la regola, per mantenere integra
l’apartiticità e l’imparzialità di un’associazione molto rigorosa e molto
attiva. Ennals non solo conosceva Moro, ma valutò la situazione talmente
drammatica da decidere di diramare un fortissimo appello rivolto ai terroristi,
affinchè liberassero senza condizioni e incolume lo statista».
Solo il segretario
socialista le chiese di operare questa intermediazione?
«Non
solo. Su questo argomento venni contattata diverse volte anche da Amintore
Fanfani, l’unico democristiano che si mosse con determinazione per la
liberazione, seppur tardivamente».
Ricorda il clima politico
in Italia di quei 55 giorni?
«Furono
giorni terribili e di contrapposizioni feroci. Da una parte c’era il cosiddetto
“partito della fermezza” capitanato dal Pci, da buona parte della Dc,
profondamente lacerata al suo interno e succube oltre che protagonista di
quell’immane tragedia, nonchè dai giornali, con in prima linea la Repubblica di
Eugenio Scalfari, che tutti i giorni tuonava contro ogni ipotesi, anche la più
legale, di cedimento nei confronti dei terroristi. Dall’altra c’eravamo noi
socialisti, insieme agli altri partiti laici minori: Bettino Craxi aveva
costruito tutta un’azione politica per la liberazione di Moro, nominando un
comitato di celebri costituzionalisti e avvocati, presieduto dal professor
Giuliano Vassalli, leggendario giurista che aveva organizzato la fuga di Sandro
Pertini dal carcere nel 1944».
Quanto era concreta
l’ipotesi elaborata da questo comitato?
«Il
comitato di Craxi aveva imbastito un tentativo di scambio di prigionieri coi
terroristi, individuando anche i possibili detenuti da liberare. Si trattava di
due brigatisti, entrambi mai coinvolti in fatti di sangue e uno dei quali era
gravemente malato. Questa era la base di un ipotetico scambio, ma quella che
oggi si chiamerebbe trattativa divenne impossibile a causa di un clima infame,
costruito in particolare intorno al mio partito. Fummo definiti i capifila del
cedimento e traditori della ragion di Stato, con attacchi feroci da parte della
stampa, quasi tutta allineata sulla linea della fermezza di Scalfari. Al
contrario, io credo che l’azione purtroppo inutile che fu coraggiosamente
costruita dal Psi di Bettino Craxi rappresenti una delle pagine più belle della
tradizione del Partito Socialista».
Il Psi era tutto schierato
con Craxi?
«Sì,
il partito era unanime dietro i tentativi del segretario, che visse quei giorni
praticamente chiuso in una sorta di bunker, circondato dai giuristi, alla
ricerca frenetica di una via d’uscita per lo statista democristiano. Dopo
l’omicidio, Craxi fu l’unico politico ad essere invitato ai funerali privati di
Moro voluti dalla famiglia, che era stata fortemente critica con lo Stato e la
Dc. Ricordo che la vedova Moro gli fece anche dono della famosa auto blindata
che era stata tardivamente consegnata alla famiglia giorni dopo il sequestro di
via Fani».
A distanza di anni, lei
crede che Moro si sarebbe potuto salvare?
«Il
dubbio rimane, sicuramente l’azione svolta da Craxi e dal Psi aveva costruito
un’ipotesi di scambio che avrebbe forse potuto risolvere la situazione.
Quarant’anni dopo la sua morte, ciò che risulta incredibile è che Moro fu
l’unico cittadino italiano sacrificato senza trattative. In anni successivi,
sono innumerevoli i casi di cittadini italiani sequestrati da terroristi in
molte parti del mondo per i quali i governi italiani hanno immediatamente aperto
il fronte della trattativa coi terroristi, per salvare la vita dei loro
concittadini sequestrati. Furono trattative più o meno segrete o palesi e io
stessa, decenni dopo il 1978, ho partecipato con funzioni diplomatiche e
politiche a missioni di liberazione di ostaggi che avevano alla base una robusta
trattativa da parte degli organi dello Stato».
Quella del 1978, però, era
un’Italia diversa?
«Certamente,
e anche di un’interpretazione diversa di ciò che erano le Br, in particolare da
parte del Pci: una frangia estremista e inaccettabile che nasceva alla sua
sinistra e che doveva essere assolutamente sgominata».
Lei crede che per la morte
di Moro anche le istituzioni di allora siano in parte colpevoli?
«C’è
stata sicuramente responsabilità da parte dello Stato. Penso ai pasticci nelle
ricerche, ai depistaggi e ai tanti misteri, ma ricordo soprattutto le incertezze
eclatanti nell’azione dei nostri servizi e delle forze di polizia. C’è stato un
evidente fallimento investigativo, ma la responsabilità ricade anche su quel
fronte della fermezza, assolutamente incomprensibile nell’ottica di oggi».
Cosa resta, oggi, di questa
pagina così atroce della nostra storia recente?
«La
Dc dell’epoca riuscì a chiudere quella stagione del terrore senza promulgare
leggi di emergenza, che avrebbero potuto ledere i diritti costituzionali dei
cittadini in nome dell’antiterrorismo. Ci volle un decennio, ma fu una lezione
bella seppur tardiva da parte del nostro Paese».
Sequestro Moro: la Dc di
fronte alla scelta più difficile della sua storia
di GIORGIO ROSSI 21 aprile 2018. 21 aprile 1978 ROMA - Terrà la Dc? Questo
interrogativo ha avuto una prima risposta positiva nell'editoriale pubblicato
oggi da "Il Popolo". Ma di più finora non si è saputo. All'una e mezzo di notte
lo stato maggiore del partito era ancora riunito a Piazza del Gesù. C'erano
tutti, con Zaccagnini e Andreotti: Galloni e Gaspari, Bartolomei e Piccoli,
Fanfani, Forlani, Cossiga, De Mita, Donat Cattin ed Emilio Colombo. La riunione
era iniziata ...
Aldo Moro: il prezzo è
politico, chi deve pagarlo? Di Ezio Mauro 22 aprile 2018. 22 aprile 1978 Le ore
passano in fretta ma la politica è lenta. Perciò la giornata di ieri si è
consumata in riunioni, appelli, comunicati, raccolta di firme, mentre le
lancette dell'orologio portano verso quel fatale appuntamento fissato
nell'ultimatum delle Br: oggi, sabato 22 aprile ore 15. Il governo si è riunito
ed ha deciso provvedimenti di ordinaria amministrazione. Sul caso Moro, nulla,
almeno ufficialmente. Ufficiosamente si sa che il governo ha...
Ecco la lettera segreta di
Moro a Zaccagnini
di Ezio Mauro 22 aprile 2018. 22 aprile 1978 Ieri sera è pervenuto alla nostra
redazione un plico contenente il testo autografo dell’ultima lettera di Moro a
Zaccagnini. È un documento agghiacciante nel quale il conflitto tra il
«personale» e il «politico» esplode con impensata intensità. Lo pubblichiamo
integralmente affinché l’opinione pubblica giudichi con informata coscienza gli
aspetti essenziali del dramma che il paese intero sta vivendo....
Dio perdona ma Cesare
castiga di
EUGENIO SCALFARI 23 aprile 2018. 23 aprile 1978 Raramente, nel suo pur lungo
pontificato, Paolo VI aveva saputo trovare accenti così alti come quelli che
abbiamo letto nella sua lettera alle Brigate rosse. Gli accenti del Buon Pastore
alla ricerca della pecora smarrita sul monte, dove le pecore smarrite in questo
caso sono due: la vittima in pericolo di vita e i carnefici che stanno perdendo
nella ferocia la vita dello spirito. E com’è giusto per il Buon Pastore, la sua
sollecitudine di cristiano…
È la Caritas il canale
della speranza
di LUIGI ACCATTOLI 23 aprile 2018. 23 aprile 1978 CITTÀ DEL
VATICANO – «Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse: restituite alla
libertà, alla sua famiglia, alla vita civile l’onorevole Aldo Moro». Così inizia
l’appello diretto, personale e autografo rivolto da Paolo VI alle Brigate rosse
e consegnato ai giornalisti cinque ore prima della scadenza dell’ultimatum. Si
tratta dell’interpellanza più diretta ed esplicita che sia stata rivolta, da
qualsiasi...
La loro ferocia, la nostra
fermezza di
Ezio Mauro 25 aprile 2018. 25 aprile 1978 A questo si doveva arrivare e lo
sapevamo tutti fin dal principio, perché quale altra richiesta avrebbero potuto
fare i terroristi se non quella di scambiare gli «ostaggi»? E quale altra hanno
mai fatto, in Italia come in Germania e altrove, tutte le volte che casi
analoghi si sono verificati? Nello scambio tutto è contenuto: la parità
contrattuale tra lo stato e la banda armata, il sovvertimento della legge, la
frustrazione degli apparati g...
Perché vogliono ucciderlo
di SANDRO VIOLA 25 aprile 2018. 25 aprile 1978 ROMA. Sembra una terribile
partita di poker, una partita con poste altissime: la vita d'un uomo, la
stabilità d'un sistema politico. Ed ora col comunicato numero 8, le Brigate
rosse hanno fatto il rilancio più pauroso. La vita di Moro contro la liberazione
di tredici "prigionieri comunisti", altrimenti "trarremo immediatamente le
debite conseguenze ed eseguiremo la sentenza a cui Aldo Moro è stato
condannato". Nel pronu...
Ma chi scrive quelle
lettere? Di
FAUSTO DE LUCA 26 aprile 2018. 26 aprile 1978 ROMA. Perché Il Popolo, giornale
ufficiale della Dc, ha pubblicato l'ultima lettera di Aldo Moro, quella
recapitata al quotidiano Vita, e senza dubbio la più dura e minacciosa nei
confronti del gruppo dirigente democristiano? In prima pagina il giornale della
Dc scrive che la lettera è stata "imposta, dettata o estorta", a Moro. In terza
pagina, come avvertenza sul testo della lettera, è scritto che essa viene
pubblicata "per un...
Sequestro Moro: il destino
in uno scatto
di Ezio Mauro 26 aprile 2018. Arriva con il comunicato numero 7, quello vero, la
seconda fotografia che diventa il simbolo di una tragedia italiana. Lo statista
prigioniero ha lo sguardo provato e intenso, la camicia spiegazzata, tiene in
mano una copia di "Repubblica" del 19 aprile mentre guarda il suo carceriere. È
la prova che il leader democristiano è ancora vivo. Ma la trattativa per
liberarlo è ferma. Nonostante gli appelli del segretario dell'Onu Kurt Waldheim
e di papa Paolo VI, che "prega in ginocchio" i terroristi. Nell'"ufficio", come
i brigatisti chiamavano il covo di via Chiabrera, c'era soltanto un vecchio
ciclostile. Quando Moretti consegnava ai due "postini" un comunicato con la
stella a cinque punte, o una lettera del prigioniero, bisognava pensare alle
fotocopie, e quasi sempre Adriana Faranda e Valerio Morucci usavano un chiosco
pubblico a due passi dalla facoltà di Architettura, dove potevano fare da soli,
uno di guardia, una alla macchina per le copie. Poi,...
Craxi propone la grazia per
tre terroristi.
l Segretario democristiano si reca dal collega socialista per sondarne le reali
intenzioni. Poi raduna il vertice a Piazza del Gesù, e alla fine viene
riconfermata la linea della fermezza. Solidarietà alla Dc di Romita e Biasini di
MIRIAM MAFAI 27 aprile 2018. 27 aprile 1978 ROMA. In questa orrenda partita di
poker la cui posta è, assieme la vita di Moro, la credibilità dello Stato
democratico, si è verificato ieri un fatto nuovo. Zaccagnini ha voluto "vedere"
le carte di Craxi, che da venerdì scorso, polemico con le prese di posizione
della Dc e degli altri partiti della maggioranza, insiste nell'affermare che
esistono margini e possibilità di trattativa non ancora esplorati. Lo ripeteva
ieri matt...
L’appello di Waldheim.
Contestato da La Malfa e dal Pci
di SANDRO VIOLA 27 aprile 2018. 27 aprile 1978 ROMA. Due interrogativi pesano da
ieri sull'ultimo sviluppo del "caso Moro" e cioè l'appello di Kurt Waldheim "ai
membri delle Brigate Rosse". Il primo riguarda la sostanza del messaggio, la
possibilità o meno che esso implichi un "riconoscimento" politico-diplomatico
del gruppo terrorista. Il secondo verte sul come e quando il Segretario generale
dell'Onu ha preso l'iniziativa: si è trattato d'una decisio...
Nella Dc tutti uniti sulla
linea Zaccagnini
di MIRIAM MAFAI 28 aprile 2018. 28 aprile 1978 Un comunicato emesso ieri sera a
Piazza del Gesù ha smentito le voci di contrasti e differenziazioni all'interno
del gruppo dirigente della dc e che sembravano avere avuto conferma per una
improvvisa visita di Fanfani a Zaccagnini. "I componenti della direzione del
partito sentiti dal segretario" afferma il comunicato "hanno espresso pieno
consenso alla linea assunta e all'operato della delegazione". La posizione della
Dc resta quindi immuta...
Ecco il piano Craxi. "Per
Salvare la vita di Moro lo Stato deve essere clemente"
di FAUSTO DE LUCA 28 aprile
2018. 28 aprile 1976 Roma - "Non mi spiego di sicuro" dichiara Bettino Craxi.
"Non bastano certo i titoli di alcuni giornali a farmi cambiare idea". Il
segretario socialista è nel suo studio alla direzione del Psi in via del Corso.
Sul tavolo un mare di carte: mentre le consulta, parla a scatti, con accento
polemico. "Chi ha detto che io chiedo la grazia per tre terroristi? E' falso. Io
non ho fatto nessuna proposta specifica. La linea della direzione, decisa a...
Sequestro Moro, Andreotti
sdrammatizza
di CORRADO AUGIAS 29 aprile 2018. 29 aprile 1978 Il rifiuto del governo di
trattare con le Brigate Rosse deve essere considerato definitivo. Dopo le voci
anche autorevoli ma non ufficiali che s'erano levate nei giorni scorsi, questo
atteggiamento di fermezza è stato confermato ieri sera, nel corso di
un'intervista televisiva in diretta, da presidente del Consiglio. Con il suo
intervento Andreotti ha ufficialmente rotto un silenzio che in pratica durava
dal 16 marzo. Riservatezza eccezionale per le nostre abit...
Sequesto Moro: perché
tacciono le Brigate Rosse
di SANDRO VIOLA 29 aprile 2018. 29 aprile 1978 Le Brigate Rosse
tacciono da cinque lunghi giorni, e a questo punto bisogna tentare di
comprendere che cosa c'è (quali motivazioni, calcoli tattici o difficoltà del
gruppo terrorista) dietro il ritardo del comunicato numero 9. Le ipotesi
elaborate dal vertice degli inquirenti sono quattro. Elenchiamole in ordine
sparso, e poi vedremo qual è la loro attendibilità. La prima ipotesi è che
all'interno della "colonna" (o della ...
Sequesto Moro, Craxi: “Deve
restare vivo e il Psi lo salverà”
di PAOLO GUZZANTI 30 aprile 2018. 30 aprile 1978 Bettino Craxi esce dalla
riunione con gli esperti che si occupano del caso Moro. Lo raggiungiamo per
strada. Ha un impermeabile bianco molto maltrattato, una camicia bianca quasi
estiva. Passeggiamo su e giù per piazza Augusto Imperatore. Sta andando a
preparare il discorso che pronuncerà oggi a Madrid al convegno di riunificazione
socialista. In serata sarà di ritorno a Roma. Onorevole Craxi, la lettera di
Moro la chiama direttamente in causa. Lei a qu...
Il sequestro Moro e il
partito della famiglia
di EUGENIO SCALFARI 30 aprile 2018. 30 aprile 1978 Le lettere di Moro dal
carcere possono avere molti fini e prestarsi a molti usi, ma dopo l’ultima
pubblicata ieri dal “Messaggero” una cosa è certa: la vita del leader dc, almeno
per ora, non corre rischi sicché, da questo punto di vista, possiamo tirare un
respiro di sollievo. Quando i suoi carcerieri emisero il comunicato con la
condanna a morte e poi ribadirono, pochi giorni dopo, che l’esecuzione sarebbe
stata immediata se il governo ...
Aldo Moro: quelle grida dal
fondo della prigione
di Ezio Mauro 3 maggio 2018. 3 maggio 1978 Qualcuno, con una rozzezza morale e
politica sulla quale non c 'è bisogno di spender parole, cerca di riversare su
coloro che difendono una linea di fermezza di fronte ai terroristi, la
responsabilità dei loro assassinii. Sarebbe come dire che è colpa degli
aggrediti il delitto perpetrato dagli aggressori. Vale la pena di polemizzare
con chi stravolge la realtà fino a questo punto? L'ultima serie di lettere di
Aldo Moro, arrivate tutt...
Aldo Moro, battaglia sul
piano Craxi.
Andreotti e Berlinguer ribadiscono la fermezza, la Dc incerta si
rimette al governo. Le proposte del segretario del Psi riguardano la concessione
della grazia o della libertà provvisoria ad alcuni detenuti delle Br e dei Nap.
Sono state messe a punto dopo un lungo colloquio con Sereno Freato, portavoce
della famiglia Moro. Ma Pci, Pri e Psdi hanno ribadito che non può essere fatta
alcuna concessione ai brigatisti di MIRIAM MAFAI 3 maggio 2018. 3 maggio 1978 In
quattro ore di riunione, dalle sette e mezzo di ieri sera fino a quasi
mezzanotte, si sono affrontate, al secondo piano di Piazza del Gesù, la
delegazione socialista e quella della Democrazia Cristiana. I socialisti erano
capeggiati da Craxi, la camicia aperta sul collo, un fascicoletto di carte in
mano con dentro i nomi dei terroristi per i quali si suggerisce la grazia. I
democristiani erano capeggiati da Zaccagnini sulla cui faccia si fanno di giorno
in giorno…
Eseguendo la sentenza.
Le Br
capiscono che non otterranno il riconoscimento politico che volevano. E che dopo
55 giorni l'unica via di uscita sembra essere quella prevista sin dall'inizio.
L'Esecutivo decide di "giustiziare" il prigioniero e invia un comunicato con un
verbo in sospeso. Ma anche l'ultima trattativa naufraga. Nella sua cella, lo
statista scrive le ultime lettere alla famiglia e lascia un amaro testamento:
"Questo bagno di sangue non andrà bene né per Andreotti, né per la Dc, né per il
Paese, ciascuno porterà la sua responsabilità". L'ultimo atto di una tragedia
italiana sta per compiersi di EZIO MAURO 3 maggio 2018. La porta della cella è
chiusa da 35 giorni, e oggi l’uomo incappucciato non si presenta davanti al
prigioniero per interrogarlo, dargli qualche scampolo di notizia sulle reazioni
esterne al sequestro, leggere le lettere che lui ha scritto di notte. Mario
Moretti è partito in treno per una riunione dell’Esecutivo Br, l’ultima, quella
decisiva. Si incontra con Bonisoli, Azzolini, Micaletto, valutano gli ultimi
segnali che arrivano dalla Dc e dal governo, lui rac...
Sequestro Moro, Andreotti
non cede di
FAUSTO DE LUCA 4 maggio 2018. 4 maggio 1978 La vicenda Moro passa dai partiti al
governo, e dal governo passa al Parlamento. Si ritorna nell'ambito delle
istituzioni. Finisce la finzione delle Camere che discutono di tutto tranne che
dell'argomento che occupa la mente e il cuore degli italiani. E si va forse
verso una ricomposizione, almeno formale, della maggioranza nata il giorno
stesso del rapimento di Moro e divisa adesso da aspre polemiche. La delegazione
dc, che ha deciso d'investire il governo di una...
Sequestro Moro: governo e
Dc ripetono il no
di MIRIAM MAFAI 4 maggio 2018. 4 maggio 1978 C'è stato un momento d'incertezza
di vero e proprio, sbandamento nella delegazione democristiana, quando martedì
sera, si è incontrata con quella socialista? A Piazza del Gesù lo negano: "La
nostra posizione è rimasta sempre immutata. Non potevamo far nostra la proposta
di Craxi di concedere la grazia ad alcuni terroristi, ma non potevamo nemmeno
pregiudizialmente rifiutarci di assecondarla. Si tratta comunque di atti di
governo...
Cossiga apre in Tv la
campagna elettorale.
“Caso Moro” al centro delle elezioni di Ezio Mauro 5 maggio 2018.
ROMA - Un Cossiga calmo, padrone di sé, ha fatto ieri sera la sua prima
apparizione in Tv dall'inizio della vicenda del sequestro Moro. Il ministro
degli Interni apriva una serie di trasmissioni dedicate dalla Rai-Tv alle
elezioni amministrative del 14 maggio: non proprio un turno di "Tribuna
elettorale", ma comunque trasmissioni con cui il governo e i partiti politici
introdurranno i telespettatori ai temi della prova elettorale. L'attesa era
evidentemente centrata sulle dichiarazioni che Cossiga avrebbe potuto fare sul
"caso Moro". Ma è stata un'attesa subito delusa dall'intervistatore Jader
Jacobelli, che aprendo la trasmissione ha precisato che avrebbe rivolto al
ministro degli Interni domande tecniche (distribuzione dell'elettorato,
comunicazione dei risultati), e non politiche. E tuttavia, rispondendo
all'ultima delle domande ("Lei crede", aveva chiesto Jacobelli, "che la vicenda
Moro influirà sui risultati elettorali?"), Francesco Cossiga ha lasciato
trapelare indirettamente l'intenzione di fermezza con cui il governo guarda alla
sfida delle Br. "Non sono in grado di valutare", ha infatti risposto,
"l'influenza che avranno sugli elettori l'eccidio di via Fani e il sequestro
dell'on. Moro, il rivelarsi del terrorismo, i giudizi che il paese dà sulle sue
origini, sul suo impianto e sui modi con cui viene combattuto. Ma resta che di
fronte a questo che è certo l'attacco più grave e subdolo portato alla pace
civile, il paese ha risposto con grande dignità e fermezza dimostrando come la
vita sociale resista all'insidia dell'eversione. Penso quindi che sia per
l'afflusso, sia per la qualità del voto, le elezioni costituiranno una risposta
ferma al tentativo di rompere la legalità repubblicana, e suoneranno come una
condanna del tentativo eversivo". In parte politica, in parte anch'essa legata
alla vicenda del sequestro Moro, era stata anche la risposta precedente, dopo
che Jacobelli aveva chiesto se il ministero degli Interni ha previsto misure di
sicurezza particolari per il turno elettorale. "Saranno prese", ha detto
Cossiga, "le identiche misure che sono state adottate in questi trent'anni di
elezioni libere e civili. D'altra parte vediamo che la campagna elettorale si
sta svolgendo con grande compostezza, a dimostrazione del senso di
responsabilità con cui le forze politiche vivono questo momento particolare".
Una risposta che conferma, dunque, il rifiuto del governo di adottare leggi o
misure speciali per fronteggiare l'emergenza della minaccia terrorista. Cossiga
aveva prima precisato che le elezioni del 14 maggio avviano una serie di
consultazioni elettorali che si svolgeranno tra maggio e giugno. Le
amministrative il 14, il 28 le comunali in alcune zone della Sicilia. L'11
giugno i referendum (o tutti e cinque, o quelli che resteranno dopo le nuove
leggi che si stanno preparando in Parlamento), e il 25 le elezioni regionali del
Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta. Ma, certo, il test più
significativo (perché viene dopo l'accordo della nuova maggioranza e dopo il
"caso Moro") è quello del 14 maggio, che interessa 4 milioni di elettori, il
dieci per cento dell'intero elettorato, un "campione" - come ha detto Cossiga -
"grosso modo valido" per rilevare gli umori politici del paese.
“Tanti morti per troppa
debolezza e ci accusano d’essere prussiani…”
di GIAMPAOLO PANSA 5 maggio 2018. 5 maggio 1978 ROMA - "Non posso sapere come si
concluderà questa storia terribile - dice La Malfa - Credo, però, di poter dire
che il paese sta superando bene la prova. Adesso tocca a noi, tocca alla classe
politica dimostrare di avere l'energia sufficiente per utilizzare la forza che i
cittadini certamente hanno. Io non sono di quelli che dicono: ogni paese ha la
classe politica che si merita. Il nostro paese è migliore della sua classe
politica. E quello che ...
L’assassinio di Moro
preannunciato dalle Br. "Concludiamo la battaglia eseguendo la sentenza"
di Ezio Mauro 6
maggio 2018. 6 maggio 1978 La folle logica delle Br sembra purtroppo esser
arrivata alla sua tragica conclusione. Il testo del comunicato numero 9, oltre
all'annuncio che la condanna a morte di Moro è "in corso di esecuzione",
contiene un appello all'insurrezione vera e propria: "...Estendere l'attività di
combattimento, concentrare l'attacco armato contro i centri vitali dello Stato
imperialista... questo bisogna fare per fermare gli assassini capeggiati da ...
Un'ultima ambiguità per
acuire il dramma
di SANDRO VIOLA 6 maggio 2018. 6 maggio 1978 Roma - Il dramma è dunque giunto
"alla sua conclusione"? È quel che affermano i terroristi della stessa a cinque
punte, la banda "Brigate Rosse", nel comunicato n. 9 giunto ieri pomeriggio alla
redazione milanese di "Repubblica": "Concludiamo la battaglia iniziata il 16
marzo, eseguendo la sentenza cui Aldo Moro è stato condannato". Così ora,
cinquantuno giorni dopo l'avvio di questa vicenda paurosa (cert...
Il “comunicato n. 9” dei
terroristi: “Concludiamo la battaglia eseguendo la sentenza”
di Ezio Mauro 6 maggio 2018. 6 maggio 1978 "Compagni la battaglia iniziata il 16
marzo con la cattura di Aldo Moro è arrivata alla sua conclusione". Così si apre
il comunicato numero 9 delle Brigate rosse fatto avere ieri pomeriggio (undici
giorni dopo il numero 8) alla nostra redazione di Milano, avvolto in una pagina
del "Corriere mercantile". Il comunicato annuncia che avendo registrato " il
chiaro rifiuto della Dc, del governo e dei complici che lo so...
Ma il piano eversivo è
fallito di
EUGENIO SCALFARI 7 maggio 2018. 7 maggio 1978 Mentre aspettiamo con angosciosa
incertezza di saperne di più sulla vera sorte che i terroristi hanno riservato
ad Aldo Moro, converrà riflettere sugli esiti che le loro fosche imprese hanno
conseguito e sui mutamenti psicologici, politici e funzionali che hanno
provocato nel paese. Il loro primo obbiettivo - che probabilmente speravano di
realizzare lo stesso giorno del rapimento di Moro - fu di suscitare un
soprassalto reazionario nel governo e nella mag...
Zaccagnini tra la sua gente
nel primo comizio
di NATALIA ASPESI 7 maggio 2018. 7 maggio 1978 NOVARA - "Il nostro è un vessillo
bianco che non conosce la violenza. Se qualche macchia di sangue lo ha
arrossato, è sangue non dei nostri avversari, ma dei nostri martiri". Benigno
Zaccagnini grida queste parole quasi con violenza, nel piccolo teatro
Faraggiana, stipato di gente, di bandiere e di striscioni. È il suo primo
discorso in pubblico dal giorno della strage di via Fani e del rapimento di Aldo
Moro: il segretario della Dc…
Sequestro Moro: lo sfogo di
Fanfani, incitamento o siluro?
Di Ezio Mauro 8 maggio 2018. 9
maggio 1978 Dopo aver conservato il silenzio per molte settimane (e quali
settimane!) il senatore Fanfani ha gettato il suo sasso nello stagno politico ed
ha rotto l'unanimismo vigente nella Dc dal 16 marzo in poi. Ha attaccato il
governo accusandolo d'inefficienza e di immobilismo e non ha neppure risparmiato
critiche - sia pure caute e velate - alla gestione del partito. Se si tiene
conto della delicatezza della situazione e dell'indiscussa autorevolezza del
presidente del S...
A casa Moro è forse
arrivato un segnale di speranza.
Qualcosa si muove anche nel
partito di SANDRO VIOLA 8 maggio 2018. 9 maggio 1978 I familiari di Moro hanno
ricevuto lunedì' mattina un "segnale" che ha fatto loro comprendere che il
presidente della dc è vivo? Questa voce circola insistente. In ogni caso, sia da
venerdì' scorso (giorno in cui erano arrivati il comunicato delle Br e
l'"ultima" lettera di Moro) l'atteggiamento della famiglia e degli amici appare,
se non proprio ottimistico, certo più dinamico che disperato: come se a via del
For...
Aldo Moro: l’ultimo viaggio
nel buio.
Via Caetani: una strada di Roma poco distante dalla sede del Pci e della Dc,
che proprio questa mattina ha riunito la direzione con l'ormai unico ordine del
giorno: la sorte del presidente del partito. Il cui corpo è qui, nel bagagliaio
di una Renault 4 rossa parcheggiata tra il civico 32 e il 33. La scelta del
luogo in cui si conclude la tragedia politica italiana è l'ultimo messaggio
simbolico. Da quell'automobile si scatenano i demoni di un terrorismo avviatosi
verso l'autodistruzione, di una classe dirigente stremata e di un Paese che si
vede riflesso nel cadavere di una vittima sacrificale di EZIO MAURO 8 maggio
2018. Un uomo col cane è l'unico inconsapevole testimone che vede spuntare in
via Montalcini la "R4" rossa appena uscita dal "covo", poco dopo le 7 del
mattino. È targata Roma N56786, l'hanno rubata a marzo, hanno cambiato la targa,
pochi giorni fa l'hanno scelta per l'ultima missione. La guida Mario Moretti,
Germano Maccari è al suo fianco. Non sanno che nel bagagliaio, sotto la coperta,
Moro sta ancora agonizzando, incosciente.
L’assassinio di Moro.
Il cadavere ritrovato in un’auto a pochi metri dalle sedi della Dc e del Pci. Il
paese reagisce compatto alla sfida delle Br di EUGENIO SCALFARI 9 maggio 2018.
10 maggio 1978 Il primo atto della tragedia si è concluso nel modo più atroce:
un cadavere crivellato di proiettili, avvolto in un fagotto di coperte,
abbandonato sul sedile d'un'auto a pochi metri dalle sedi della Democrazia
cristiana e del Partito comunista. In questo modo dopo 55 giorni d'attesa e
d'agonia, le Br hanno restituito il corpo di Aldo Moro. L'emozione di queste ore
è immensa ed a rendere il dramma ancora più cupo c'è...
Aldo Moro, undici colpi al
cuore.
L’hanno ammazzato con una raffica di mitra forse 24 ore prima del ritrovamento
di MIRIAM MAFAI 9 maggio 2018. 10 maggio 1978 Questo fagotto gettato dietro il
sedile posteriore della Renault color amaranto parcheggiata in via Caetani è il
corpo di Aldo Moro. È un fagotto informe, avvolto in una coperta di lana color
cammello, con un bordo di raso, una coperta come ce ne sono in tutte le nostre
case. Il sedile è leggermente inclinato verso l'avanti. La macchina ha gli
sportelli aperti. A pochi metri ci sono il ministro Cossiga, i sottosegretari
Darida e Lettieri, il procurato...
LA LETTERA CHE UCCISE MORO.

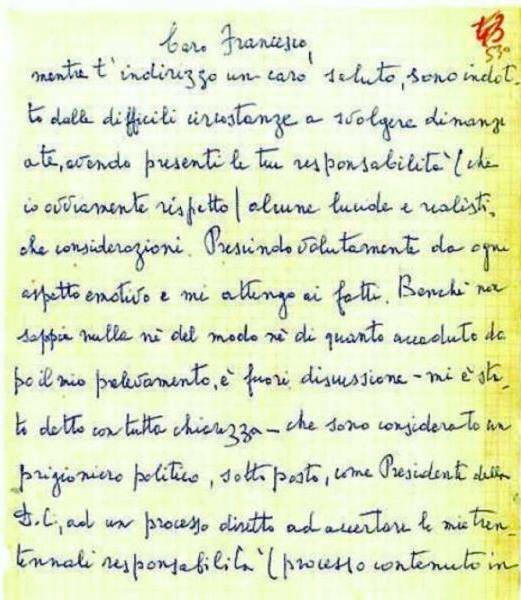
Da Issuu.com
La lettera che uccise Moro.
Lo statista democristiano scrisse a Cossiga. Le Br resero tutto pubblico. Fu
l’inizio della fine, scrive Paolo Delgado il 29 Marzo 2018 su "Il Dubbio". In un
certo senso quello che comunemente definiamo il caso Moro cominciò davvero il 29
marzo 1978, 13 giorni dopo la strage di via Fani e il sequestro della scorta.
Erano state due settimane quasi silenziose, scandite solo dal primo comunicato
delle Brigate rosse, con la rivendicazione dell’attacco e da un secondo
comunicato, diffuso il 25 marzo, nel quale l’organizzazione armata spiegava
perché avesse scelto proprio quell’obiettivo, ricapitolando la carriera del
leader democristiano, sottolineando la sua probabile imminente elezione a
presidente della Repubblica e insistendo sul ruolo strategico di quella carica
istituzionale nella costruzione dello Stato Imperialista. In qui 13 giorni
veniva dato per certo, anzi per scontato che nella sanguinosa partita che si
stava giocando sarebbero stati in campo solo due protagonisti: le Brigate Rosse,
dalle quali ci si aspettava sin dal primo momento la richiesta di uno scambio di
prigionieri e lo Stato, blindatosi dietro la linea detta "della fermezza" ancor
prima che venissero avanzate richieste o ipotizzate trattative. Al sequestrato
spettava il ruolo muto della vittima, l’oggetto inanimato per il quale si
sarebbe certo chiesto un riscatto. I giornali lo dipingevano a priori come eroe
e come martire. Quel 29 marzo cambiò tutto. Il prigioniero entrò in campo
direttamente. Prese la parola. Provò a tessere la trama che avrebbe potuto
salvargli la vita facendo ciò che sapeva fare meglio e che faceva da sempre:
facendo politica. Scrisse una lettera meditata e calibrata in ogni singola
parola e in ogni segno di punteggiatura. La fece recapitare al suo segretario
particolare, Nicola Rana, perché la consegnasse al ministro degli Interni
Cossiga raccomandando la massima discrezione: «La mia idea e speranza è che
questo filo, che cerco di allacciare, resti segreto il più a lungo possibile,
fuori da pericolose polemiche». Nella lettera a Cossiga il prigioniero di via
Montalcini chiariva di essere «sotto un dominio pieno e incontrollato»,
escludendo così la possibilità di attivare rapporti con potenze straniere per
risolvere la situazione. Specificava di essere ‘ processato’ per accuse che in
realtà riguardavano l’intero gruppo dirigente della Dc. Ma soprattutto metteva
sul piatto della bilancia la minaccia di rivelare segreti tali da mettere in
pericolo la sicurezza dello Stato. Moro non adoperò in quell’occasione giri di
parole: «Entra in gioco, al di là di ogni considerazione umanitaria, che pure
non si può ignorare, la ragione di Stato… Sono in questo stato avendo tutte le
conoscenze e sensibilità che derivano dalla lunga esperienza, con il rischio di
essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e
pericolosa in determinate situazioni». Moro aveva probabilmente scelto di
rivolgersi al ministro Cossiga, invece che al premier Andreotti o al segretario
della Dc Zaccagnini, perché del primo non si fidava e del secondo conosceva la
debolezza e perché sapeva che Cossiga era in quel momento la figura chiave anche
nei rapporti con il Pci. Forse sperava anche nei rapporti personali tra
l’inquilino del Viminale e il cugino segretario del Pci. In ogni caso Cossiga,
slegato dai tipici giochi di corrente democristiani e con un ben noto senso
dello Stato, era la figura che più di ogni altra avrebbe potuto in quel momento
alterare gli equilibri a sfavore della ‘ fermezza’. Data la personalità di
Cossiga, la leva utile poteva essere solo l’interesse superiore dello Stato. Si
trattava di rovesciare la logica alla base della fermezza dimostrando che il
senso dello Stato consigliava di salvare l’ostaggio a tutti i costi e non di
sacrificarlo. Perché la strategia messa a punto da Moro avesse successo, era
necessaria la segretezza. In caso contrario le «pericolose polemiche», in
concreto il fuoco incrociato dei media e dei partiti più ostili a ogni ipotesi
di trattativa, avrebbe gelato il germoglio prima che avesse il tempo,
necessariamente lungo, di sbocciare. L’argomentazione scelta per spostare
Cossiga, una volta resa pubblica, sarebbe suonata come minaccia ricattatoria e
avrebbe reso ancora più difficile sgretolare il muro della fermezza. Senza
avvertire il prigioniero, le Br decisero invece di rendere nota la lettera. «Ha
chiesto di scrivere una lettera segreta (le manovre occulte sono la normalità
per la mafia democristiana)… Gli è stato concesso ma siccome niente deve essere
nascosto al popolo ed è questo il nostro costume la rendiamo pubblica»,
spiegarono i brigatisti nel comunicato n. 3. Fu un errore clamoroso. E’ noto che
Moro reagì con disappunto e delusione, probabilmente con disperazione, certo
sentendosi tradito. Da parte delle Br fu uno sbaglio tremendo, dettato
probabilmente dallo stesso errore di valutazione che le aveva spinte a
sequestrare Moro senza neppure chiedersi come sarebbe stato poi politicamente
un’operazione così deflagrante: la convinzione che, avendo in mano il capo del
fronte nemico, lo Stato non avrebbe potuto in nessun caso fare a meno di
trattare. Le conseguenze di quello sbaglio condizionarono da quel momento in poi
tutto, e forse determinarono l’esito della vicenda. I giornali e la politica
reagirono esattamente come aveva previsto Moro. Una raffica di titoli e
dichiarazioni che ripetevano tutti la stessa affermazione: quello non è il vero
Aldo Moro. Un coro unanime: «Messaggio chiaramente estorto», «Testo autografo ma
stile diverso da quello dello statista». «Una lettera estorta a Moro», «Moro
dice di scrivere costretto dalle Br». Moro non aveva e non doveva avere diritto
di parola e di intervento nella partita che aveva per posta in gioco la sua
pelle. Non lo si poteva prendere in considerazione perché le sue parole erano ‘
estorte’ e quando non fu più possibile attaccarsi a questo appiglio si passò a
proclamarlo matto. Per lo Stato moro era morto il 16 marzo e le cose non sono
cambiate. Dopo quarant’anni sull’Aldo Moro dei 55 giorni resta calata una cappa
di piombo.
QUELLO CHE TORNA...
Tutti i falsi misteri del
caso Moro.
Sono passati quarant’anni dall’uccisione del presidente della DC e si continua a
parlare di teorie del complotto: ma di “misteri” in realtà ce ne sono
pochissimi, scrive Davide Maria De Luca su "Ilpost.it" mercoledì 9 maggio 2018.
A 40 anni dalla morte di Aldo Moro, la verità sul suo sequestro e sul suo
omicidio è stata largamente accertata. Il presidente della Democrazia Cristiana
fu rapito dalle Brigate Rosse, un’organizzazione terroristica di estrema
sinistra che voleva innescare una rivoluzione comunista. Fu tenuto prigioniero
per 55 giorni in un appartamento in via Montalcini, a Roma. Il governo rifiutò
qualsiasi ipotesi di trattativa con le BR e fu sostenuto nella sua scelta dalla
maggioranza dei partiti, dei sindacati e dei grandi quotidiani. Quando le
richieste dei sequestratori non furono esaudite, i brigatisti Mario Moretti e
Germano Maccari uccisero Aldo Moro con undici colpi di arma da fuoco. Il corpo
del presidente della DC venne ritrovato alle 13 del 9 maggio 1978 nel bagagliaio
di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani, a pochi passi dalla sede del
suo partito. Eppure, secondo una credenza largamente condivisa, non è questo
quello che accadde nei 55 giorni del sequestro: la cosiddetta “verità ufficiale”
sarebbe come minimo incompleta e al peggio profondamente lacunosa. Le BR non
avrebbero agito da sole e i “reali mandanti” del delitto non sarebbero ancora
stati scoperti. Come ha scritto il giornalista Andrea Colombo nell’edizione
aggiornata del suo libro Un affare di stato, «il rapimento Moro nasconde trame
imperscrutabili che coinvolgono praticamente tutti gli attori in campo sul
teatro italiano e mondiale: la CIA, la Stasi, i servizi segreti cecoslovacchi,
il Mossad, la P2, i servizi italiani deviati, Gladio, lo IOR vaticano, un
misterioso servizio supersegreto detto “anello”, la mafia, la ‘ndrangheta, la
banda della Magliana e i palestinesi». Nei 40 anni trascorsi dal sequestro,
dietrologi e teorici del complotto hanno percorso ogni sorta di pista o traccia,
l’una in contraddizione con l’altra, uniti soltanto dalla certezza che la verità
di quella vicenda sia ancora in larga parte celata. Ma come scrisse venticinque
anni fa il giornalista Giorgio Bocca, «bisogna ignorare tutto delle BR per
andare avanti con simili assurde supposizioni». Nella stragrande maggioranza dei
casi, infatti, le dietrologie poggiano su falsi misteri, frutto di mancanza di
approfondimento sui documenti dell’epoca, di racconti fantasiosi di testimoni
inaffidabili o della volontà di vedere a tutti i costi qualcosa di strano in
situazioni altrimenti normali. Dopo 40 anni di indagini è importante provare a
smentire alcuni dei falsi misteri che si sono dimostrati più difficili da
debellare.
La misteriosa doccia di via
Gradoli.
Nessun elemento del caso Moro ha attirato dietrologie come il covo
dell’organizzatore del sequestro, il brigatista Mario Moretti, situato in via
Gradoli. E nulla di ciò che accadde in quella strada nell’estrema periferia
settentrionale di Roma ha prodotto tanti interrogativi come la fortunosa
scoperta del covo, avvenuta il 18 aprile, un mese dall’inizio del sequestro,
quando per un allagamento in bagno iniziò a far filtrare acqua nell’appartamento
sottostante. I vicini chiamarono i vigili del fuoco che fecero irruzione e non
faticarono a capire dov’erano finiti: armi, munizioni e materiale delle BR erano
sparsi ovunque. I brigatisti raccontarono che la compagna di Moretti, Barbara
Balzerani, era molto distratta e aveva dimenticato aperto il rubinetto della
doccia. Una fessura nelle mattonelle del muro avrebbe fatto colare l’acqua fin
al piano di sotto causando la scoperta del covo. Ma secondo la versione di
questa storia che ancora oggi è più diffusa, l’allagamento non era il frutto di
una casualità e la distrazione di Balzerani fu solo un’invenzione per coprire la
verità: l’allagamento e quindi la scoperta del covo sarebbero stati organizzati
appositamente dagli stessi brigatisti. La prova di questo complotto sarebbe il
bizzarro stratagemma che secondo molte ricostruzioni avrebbe causato
l’allagamento: una scopa era stata messa di traverso alla vasca da bagno, il
manico della doccia agganciato al bastone e il getto puntato contro una fessura
tra le mattonelle che coprivano il muro. È certamente possibile che un
terrorista dimentichi una doccia aperta, ma non che metta insieme per caso una
costruzione così complessa. Decine di giornalisti, magistrati e scrittori si
sono interrogati su questo dettaglio: perché le BR decisero di far scoprire il
loro covo usando questo complicato trucco? Che messaggio volevano comunicare? E
a chi? Secondo alcuni, le BR sapevano di essere sorvegliate dai servizi segreti
e facendo ritrovare il covo di via Gradoli vollero comunicare che se ne erano
accorti. La conseguenza sarebbe che tra le BR e i servizi segreti c’era un
qualche tipo di accordo segreto che suggerisce la presenza di ancor più oscuri e
inconfessabili misteri. Altri ancora, invece, non si spingono a sostenere
complesse teorie, ma indicano lo stratagemma come uno dei molti misteri ancora
insoluti del caso Moro. Tutte queste teorie hanno un problema in comune: la
storia della scopa e della doccia è falsa. A scoprirlo è stato Vladimiro Satta,
archivista del Senato e per 13 anni assistente della Commissione di indagine
parlamentare sulle stragi, una delle cinque commissioni che si sono occupate del
caso Moro. La scoperta di Satta risale ai primi anni Duemila, quando stava
raccogliendo materiale per quello che sarebbe diventato il suo primo libro sul
caso Moro. Mentre consultava gli atti della prima Commissione Moro (che operò
dal 1980 al 1983) si imbatté nelle fotografie originali scattate dai poliziotti
che la mattina del 18 aprile entrarono nel covo di via Gradoli. Guardandole, ha
raccontato Satta al Post: «Mi meravigliai. Fino ad allora, avevo preso per buona
la tesi secondo cui la scoperta del covo di via Gradoli era stata provocata ad
arte», ma le fotografie del bagno non mostravano affatto lo stratagemma della
scopa e della doccia: «Il telefono della doccia era al suo posto, attaccato al
gancio sul muro, mentre la scopa era da un’altra parte!». Satta a quel punto
controllò anche gli altri documenti disponibili su quella giornata ed ebbe una
seconda sorpresa: nessuno citava scope o docce sistemate in maniera inusuale, né
i vigili del fuoco nei loro primi rapporti, né la polizia nei suoi. Il dettaglio
non compariva nemmeno nei resoconti dei quotidiani pubblicati nei giorni
successivi. L’unico riferimento allo stratagemma si trova in una frase ambigua,
pronunciata dal maresciallo dei vigili del fuoco Giuseppe Leonardi nel corso di
un interrogatorio da parte di un giudice avvenuto mesi dopo la perquisizione.
«Abbiamo trovato il rubinetto della doccia aperto con getto forte», raccontò
Leonardi. «Esso era appoggiato ad una scopa che si trovava nell’interno delle
vasca». La frase è molto strana: sembra difficile che il “rubinetto” della
doccia, cioè la parte con le manopole che serve a regolare il flusso d’acqua,
possa essere “poggiata” su una scopa, visto che solitamente è un elemento fisso
e attaccato al muro. Semmai la scopa può essere poggiata al rubinetto, come
infatti sembrerebbe essere nelle fotografie. Per anni, però, alle parole di
Leonardi è stata data un’altra interpretazione: “rubinetto” è stato letto come
sinonimo di “soffione”, cioè la parte dalla doccia dalla quale esce l’acqua. In
questa ricostruzione, quindi, il “soffione” è appoggiato al manico di scopa,
dando origine alla bizzarra creazione così spesso raccontata. Ma per dare
credito a questa teoria bisogna ignorare tutta la parte successiva della
testimonianza di Leonardi, quella in cui spiega che il “soffione” della doccia
si trovava nell’esatta posizione mostrata dalle foto scoperte da Satta, e cioè
agganciato nella sua posizione normale. E bisogna ignorare anche le fotografie e
le testimonianze del giorno della perquisizione, in cui nessuno notò alcunché di
strano nel bagno dell’appartamento. Quando ritrovò le fotografie, Satta si stupì
che nessuno le avesse notate fino a quel momento. «Se dunque per circa 20 anni
tanti scrupolosi osservatori non si sono accorti che agli atti c’erano foto,
documenti e dichiarazioni testimoniali che demolivano l’ipotesi di un
allagamento intenzionale», ha raccontato al Post, «a maggior ragione si
concederà che è ben possibile che la mattina del 18 aprile Barbara Balzerani non
si sia accorta di avere lasciato un rubinetto aperto».
Altri misteri di via
Gradoli.
Quello dell’allagamento è soltanto uno dei molti “misteri” che circondano il
covo di Mario Moretti. Satta se ne è occupato nei tre dettagliati volumi che ha
dedicato a sfatare i falsi misteri del caso Moro. Oggi racconta di sentirsi come
un fact-checker, un giornalista specializzato nello scovare le notizie false.
Restando a via Gradoli, la più citata tra le notizie false in circolazione, dopo
quella della doccia, è probabilmente la perquisizione del 18 marzo 1978, quando
due giorni dopo il sequestro un gruppo di poliziotti arrivò proprio davanti
all’interno dove abitavano Moretti e Balzerani, bussò alla porta con l’intento
di perquisire l’abitazione e, non ricevendo risposta, se ne andò. Come mai gli
agenti arrivarono a un passo da un importantissimo covo delle BR e all’ultimo
istante decisero di non sfondare la porta? Secondo i dietrologi è un indizio del
fatto che qualche forza oscura non voleva che il covo venisse scoperto. In
realtà, come ha dimostrato Satta, sulla perquisizione del 18 marzo abbiamo tutte
le informazioni che uno storico potrebbe desiderare: i rapporti scritti degli
agenti che vi presero parte, le loro testimonianze, quelle dei loro superiori e
quelle degli abitanti del palazzo che furono interrogati quel giorno. La prima
cosa da chiarire è che quella del 18 marzo non era una perquisizione mirata e
nessuno pensava di trovare qualcosa di specifico in via Gradoli. Era una delle
migliaia di perquisizioni che si fecero a Roma e in tutta Italia nei giorni dopo
il sequestro. Soltanto nella zona di via Gradoli, in quei giorni furono visitati
dalla polizia 30-40 palazzi. Per quanto riguarda il mancato sfondamento della
porta, la spiegazione del mistero è abbastanza semplice ed è stata riferita
dagli stessi agenti che svolsero la perquisizione. È vero che all’epoca l’ordine
era sfondare le porte in caso di mancata risposta da parte degli occupanti, ma
questa disposizione non venne mai realmente messa in pratica. Sfondare una porta
significava dover lasciare un agente a presidiare l’appartamento fino al ritorno
degli occupanti (e rimborsare il danno, in caso non si fosse trovato nulla).
L’allora questore di Roma spiegò che «se fossero stati aperti tutti gli
appartamenti degli assenti, non si sarebbero avuti uomini sufficienti per
poterli piantonare e difendere dai ladri». Un’altra notizia falsa che si sente
spesso circolare su via Gradoli è quella in cui si parla di misteriosi
appartamenti dei servizi segreti situati proprio nel palazzo che ospitava
Moretti e Balzerani (secondo alcuni sarebbe stato addirittura il covo di Moretti
ad essere di proprietà dei servizi, il che ovviamente è falso). In realtà la
storia è profondamente diversa: nel 1979 e poi nel 1986, cioè dopo il sequestro
Moro, il prefetto Vincenzo Parisi (che sarebbe divenuto vicedirettore del SISDE
nel 1980) acquistò alcuni appartamenti nella via e li intestò alle figlie. Uno
degli appartamenti del palazzo di Moretti, inoltre, era di prorietà di una
società, la Gradoli Spa, che a sua volta era di proprietà di un’altra società
immobiliare, la Fidrev, con cui il ministero dell’Interno aveva avuto rapporti.
Ma la Fidrev non era una società del ministero: era una società che alcuni
funzionari del ministero avevano utilizzato e di cui si fidavano. Non esiste
alcuna prova di collaborazioni tra il ministero e la Fidrev o la Gradoli Spa per
quel che riguarda via Gradoli. In altre parole, all’epoca del sequestro in via
Gradoli non c’era alcuna base dei servizi segreti. E anche ci fosse stata, non è
chiaro che vantaggio avrebbero avuto le BR o i servizi segreti a mettere vicine
le proprie basi. Ad aggiungere altri misteri ancora ci hanno pensato negli anni
parecchi personaggi, spesso già condannati per reati di mafia, che con dieci e a
volte venti anni di ritardo hanno sostenuto che all’epoca conoscevano
perfettamente l’ubicazione del covo di via Gradoli e di averne informato i loro
confidenti negli organi di polizia. Nessuno di loro, però, ha mai fornito prove
delle sue affermazioni né sono stati trovati ulteriori riscontri.
I superkiller di via Fani.
Oltre a via
Gradoli e ai suoi misteri, i dietrologi hanno appuntato le loro attenzioni su un
altro episodio: l’agguato di via Fani, quello in cui il 16 marzo del 1978 venne
rapito Aldo Moro e furono uccisi i cinque uomini della sua scorta. Secondo i
dietrologi, le BR non avrebbero mai potuto avere la capacità militare di
neutralizzare la scorta senza ferire Moro. Per questa ragione viene ipotizzata
la presenza in via Fani di un “super killer”, inviato – a seconda della versione
– dal KGB, dalla CIA o dai servizi segreti italiani. Sarebbe stato lui, con la
sua elevata conoscenza delle armi, a garantire il successo di un’operazione così
complicata. In realtà, queste obiezioni sembrano tutte provenire da persone che
hanno una scarsissima competenza militare. Come hanno dimostrato le perizie, i
brigatisti spararono a distanza estremamente ravvicinata e in alcuni casi erano
così vicini alle auto della scorta da poterle toccare. A quella distanza è
praticamente impossibile sbagliare, come raccontarono gli stessi brigatisti.
Moro, inoltre, si trovava da solo sui sedili posteriori dell’auto di testa ed
era quindi molto difficile colpirlo mentre si prendevano di mira gli agenti a un
metro o poco più di distanza. I consulenti interpellati nel corso dei processi e
dei lavori delle Commissioni conclusero che la preparazione tecnico-militare di
chi aveva compiuto l’agguato «si può definire di livello medio, acquisibile con
normali e non troppo frequenti esercitazioni».
Altri sequestri.
Spesso gli stessi dietrologi fanno un passo indietro rispetto all’analisi delle
minuzie delle indagini e del comportamento dei brigatisti. Il problema,
sostengono alcuni, è a monte: qualcosa non torna nel modo in cui il governo
avrebbe gestito il sequestro Moro al suo livello più alto. Sarebbe questa
eccezionalità nello svolgimento del sequestro a giustificare le analisi dei
dettagli più apparentemente irrilevanti alla ricerca di incongruenze nella
versione ufficiale della storia. Ma per sapere se davvero il rapimento di Moro
fu “sui generis” bisognerebbe confrontarlo con altri rapimenti simili avvenuti
nello stesso periodo. Ed è proprio questo l’esercizio compiuto da Satta nel suo
volume del 2006, Il caso Moro e i suoi falsi misteri. Passando in rassegna i
sequestri che avvennero in quegli anni in Italia e all’estero, Satta ha
dimostrato che in realtà nella gestione di quello di Moro non ci fu nulla di
particolarmente strano. Secondo i dietrologi il problema è che la “linea della
fermezza”, cioè la decisione del governo di non trattare con le BR, fu un
elemento anomalo e inusuale del caso Moro. La ritrosia del governo a trattare,
quindi, non può che essere giustificata dal fatto che “qualcuno” voleva Moro
morto. In realtà un’identica “linea della fermezza” era stata adottata già
quattro anni prima, quando le BR avevano sequestrato il magistrato Mario Sossi.
Come Moro, anche Sossi scrisse delle lettere dalla sua prigionia in cui
esprimeva la sua sfiducia negli investigatori e, sostanzialmente, chiedeva di
accettare le richieste dei brigatisti. Il governo respinse ogni possibilità di
accordo e quando sembrò che la magistratura fosse pronta a cedere al ricatto,
liberando alcuni brigatisti detenuti, il ministro dell’Interno fece circondare
il carcere dalla polizia per evitare qualsiasi scarcerazione. La “linea della
fermezza” non era all’epoca un’esclusiva italiana. Quando, nel 1977, il gruppo
terrorista di estrema sinistra RAF rapì il capo degli industriali tedeschi
Hanns-Martin Schleyer in un’operazione del tutto simile a via Fani (ulteriore
dimostrazione che per rapire qualcuno non servono super killer dei servizi
segreti), il governo tedesco rifiutò ogni trattativa e Schleyer fu ucciso dai
suoi rapitori. Certo, in Italia ci furono eccezioni. In molti sottolineano che
tre anni dopo il sequestro Moro, nel 1981, il rapimento dell’assessore della
Campania Ciro Cirillo finì con la liberazione dell’ostaggio in seguito al
pagamento di un riscatto. Ma in realtà anche durante il sequestro Cirillo il
governo adottò la linea della fermezza, almeno in pubblico. L’assessore fu
liberato perché le BR accettarono in segreto il pagamento di un riscatto. Un
tentativo simile era stato fatto anche durante il sequestro Moro, quando il
Vaticano raccolse con la tacita approvazione del governo un miliardo e mezzo di
lire per riscattare Moro. All’epoca, però, le BR preferirono rifiutarsi di
trattare, poiché quel che gli interessava non era il denaro ma un riconoscimento
politico.
Storie assurde e
improbabili.
La cosa che colpisce, studiando il caso Moro, è che nel corso
degli anni non hanno ricevuto credito soltanto teorie superficialmente credili o
almeno plausibili. La stampa, ma anche giudici e membri delle Commissioni di
indagini, si sono occupati a lungo anche di storie così assurde che farebbero
sorridere se non riguardassero una vicenda così tragica. Una delle più
grottesche è quella di Antonino Arconte, pregiudicato per calunnia e traffico di
stupefacenti, che sostiene di aver fatto parte di una misteriosa organizzazione
segreta che tra le sue altre rocambolesche attività si occupò anche del
sequestro Moro. Arconte, in particolare, sostiene che i servizi segreti
sapessero in anticipo del sequestro Moro. La ragione per cui ha fatto questa
affermazione così grave ha avuto una grande risonanza sui media, e ha ricevuto
considerazione persino dalla famiglia Moro: per questo merita di essere racconta
per esteso. Nei primi anni Duemila, cioè dopo 25 anni di silenzio, Arconte
iniziò a sostenere che alcune settimane prima del sequestro Moro i servizi
segreti gli affidarono un messaggio sigillato da consegnare al capo
dell’intelligence italiana in Libano. Arconte decise di raggiungere il Libano in
nave: non è chiaro perché visto che già all’epoca era molto più comodo farlo in
aereo. Quando arrivò a destinazione il suo contatto dei servizi segreti, il
tenente colonnello Mario Ferraro, lo raggiunse nella sua cabina e, davanti a
lui, iniziò a leggere il messaggio. Nel mezzo della lettura però ebbe
un’improvvisa esigenza fisiologica e, ha raccontato Arconte in uno dei suoi
libri, «dovette correre al gabinetto». Per ingannare il tempo, Arconte tirò
fuori da una custodia una cinepresa che aveva acquistato da poco e che aveva
casualmente con sé. Racconta che provò lo zoom riprendendo varie parti della
stanza e inquadrando tra gli altri i fogli lasciati sulla scrivania dal
colonnello Ferraro. Quando il colonnello tornò, Arconte aveva già rimesso la
cinepresa al suo posto. Soltanto molti anni dopo, sviluppando casualmente quei
rullini, Arconte si sarebbe accorto di aver accidentalmente ripreso il contenuto
del messaggio: era una richiesta ai servizi segreti di stanza in Libano di
prendere contatti con i terroristi palestinesi in modo da aprire attraverso di
loro una trattativa con le BR per liberare Aldo Moro. Ma questo,
incredibilmente, veniva richiesto due settimane prima dell’effettivo rapimento
di Aldo Moro. La storia di Arconte è stata ovviamente smentita. Il ministero
della Difesa ha negato l’esistenza della struttura segreta di cui Arconte
sostiene di far parte, così come quelli che avrebbero dovuto essere i suoi
colleghi smentiscono di averlo mai conosciuto. Persino la descrizione fisica che
Arconte dà del colonnello Ferraro è sbagliata. Nonostante questo, per molti
Arconte resta un portatore di verità indicibili. Ancora più strana è la storia
dell’ex carabiniere ed ex agente dei servizi segreti Pierluigi Ravasio, un altro
dei sostenitori della teoria secondo cui le forze dell’ordine sapevano in
anticipo del sequestro Moro. A dicembre del 1990, con più di dieci anni di
ritardo sui fatti, Ravasio raccontò che all’epoca del sequestro lavorava in un
gruppo segreto di investigatori agli ordini del colonnello Camillo Guglielmi
(secondo Ravasio, il colonnello era morto da poco: una coincidenza
provvidenziale, visto che non avrebbe potuto smentire il suo racconto). Il
gruppo di investigatori, raccontò Ravasio, aveva scoperto che il rapimento di
Moro era stato organizzato dalla Banda della Magliana e che, in cambio del
servizio reso, i soliti “poteri occulti” avrebbero garantito copertura politica
e giudiziaria ai criminali. Ma l’investigazione di Ravasio e dei suoi colleghi
venne bloccata «per ordine di Cossiga e Andreotti» e i documenti e rapporti
prodotti furono bruciati. Poco dopo le sue dichiarazioni, Ravasio fu convocato
dai magistrati per fornire spiegazioni e si rimangiò tutto, forse perché
conosceva la differenza tra il parlare alla stampa e parlare con un magistrato o
forse perché nel frattempo aveva scoperto che il colonnello Guglielmi, in
realtà, non era morto. Non tutti i misteri del caso Moro sono così sciocchi e
superficiali e nella vicenda esistono ancora dettagli non del tutto chiariti.
Per esempio non è ancora sicuro quanti fossero davvero i brigatisti che
parteciparono alla strage di via Fani, mentre la loro rete di appoggi e
complicità non è ancora emersa completamente. Non conosciamo tutti i dettagli la
della storia del falso comunicato del lago della Duchessa, né sappiamo come e
perché Romano Prodi venne a sapere nel corso di una “seduta spiritica” che il
rapimento di Aldo Moro aveva qualcosa a che fare con la parola “Gradoli”. È
molto difficile però che uno di questi elementi possa sconvolgere completamente
la storiografia del caso Moro, che si basa oramai su una mole di testimonianze e
documenti che hanno pochi rivali nella storia giudiziaria del nostro paese.
Una malattia italiana.
“Antelope Cobbler? Semplicissimo, è Aldo Moro presidente della DC”. Così
titolava a pagina tre il quotidiano Repubblica la mattina del 16 marzo 1978, il
giorno del rapimento di Aldo Moro. Antelope Cobbler era il nome in codice di un
politico italiano che nel 1968 aveva ricevuto tangenti dalla società produttrice
di aerei Lockheed nel corso di quello che all’epoca era il più grave scandalo di
corruzione nella storia italiana. Quando alle dieci di mattina uscì l’edizione
straordinaria del quotidiano con la notizia del rapimento di Moro e del massacro
della scorta, l’articolo era sparito e non se ne seppe più niente.
Successivamente Moro fu dichiarato del tutto estraneo alla vicenda. In altre
parole, ancora prima che iniziassero i 55 giorni della sua prigionia, Moro era
già al centro di misteri che non hanno retto alla prova di un’attenta analisi.
Nei quarant’anni successivi le indagini si sono moltiplicate e l’intera vicenda
è stata sottoposta a uno scrutinio metodico che non ha tralasciato alcuna pista,
per quanto ridicola e improbabile potesse sembrare. Del caso Moro si sono
occupati direttamente o indirettamente dieci processi, cinque Commissioni
parlamentari, decine di libri e centinaia di inchieste giornalistiche. È facile
argomentare che nessun singolo episodio della storia italiana abbia mai attirato
così tanta attenzione. È probabile che il minuzioso approfondimento svolto abbia
pochi eguali in tutto il continente. Eppure la maggior parte dell’opinione
pubblica continua a non essere soddisfatta. C’è sempre un’altra pista meritevole
di approfondimento, una fonte non adeguatamente interrogata, un documento
misteriosamente sparito. Ancora nel dicembre del 2017 la Commissione Moro-2
scriveva in una delle sue relazioni «nonostante i tanti anni trascorsi dai
tragici avvenimenti [permane] una mancanza di verità rispetto a aspetti
importanti della vicenda». Come però rilevano Satta e l’ex deputato del PD e
membro della Commissione Fabio Lavagno nel loro libro Moro, l’inchiesta senza
finale, la Commissione non è riuscita a trovare una singola prova o documento
che possa testimoniare queste gravi “mancanze di verità”. Rimane quindi insoluto
quello che forse è il mistero principale dell’intero caso Moro: perché la storia
del suo rapimento si è trasformata in un’apparentemente inesauribile fonte di
dietrologie. Storici e intellettuali ci hanno spesso visto qualcosa di legato in
maniera peculiare alla società e alla cultura del nostro paese. All’inizio del
loro volume, Satta e Lavagno citano una frase dell’intellettuale tedesco Hans
Magnus Enzensberger: «L’Italia era preparata a credere a tutto ciò che accusava
le classi dirigenti». Enzensberger si riferiva alle teorie del complotto che
circondavano l’omicidio Montesi, un caso di cronaca degli anni Cinquanta nel
quale si cercò sistematicamente di coinvolgere una serie di importanti
personaggi della politica e dell’industria. Un’abitudine, quella di essere
disposti a credere a qualsiasi accusa nei confronti delle classi dirigenti, che
si è riproposta spesso anche in seguito. «All’indomani della strage di Piazza
Fontana del 1969», ha raccontato Satta al Post, «si diffuse molto presto l’idea
che si trattasse di una “strage di Stato”». Le indagini però hanno dimostrato
che l’attacco, come altre stragi, fu compiuto dalla destra eversiva. Secondo
Satta: «L’atteggiamento segnalato dall’intellettuale tedesco è ricorrente e, a
mio parere, deriva da un pregiudizio negativo di molti italiani nei confronti
dello Stato». La cosiddetta “trattativa Stato-mafia”sembra essere un’altra
vicenda in cui dietrologie ed interpretazioni estensive delle sentenze della
magistratura sono state dettate dal fatto che molti sono pronti a credere che lo
Stato sia stato capace di compiere ogni sorta di crimine. Ma questa sfiducia non
sembra estendersi al solo Stato: sono proprio l’Italia e gli italiani a non
essere presi sul serio. Sembra questa infatti l’unica spiegazione alle numerose
teorie che senza tirare in mezzo lo Stato italiano attribuiscono ai terroristi
oscuri mandati stranieri, super killer sovietici o aiuti da parte del terrorismo
internazionale. Già nei primi giorni del sequestro questa tendenza era oramai
evidente. Come scrisse il 18 marzo il giornalista Alberto Ronchey: «La stessa
efficienza spietata dei terroristi sarebbe prova che dietro c’è una mano
straniera. Sono efficienti, dunque sono stranieri o diretti da stranieri. A
questo è giunta la pubblica alienazione». Da parte sua, il capo del sequestro
Mario Moretti commentò le teorie del complotto dicendo al giornalista Giorgio
Bocca: «L’Italia ufficiale non si è mai rassegnata ad ammettere che l’azione era
stata progettata e fatta da quattro operaiacci». Quarant’anni dopo quei fatti
non ci sono più dubbi che furono proprio quei “quattro operaiacci” a rapire e
uccidere Moro. Scegliere di non trattare con i terroristi fu una discutibile ma
legittima decisione politica, che all’epoca era comune anche ad altri paesi, non
un metodo per portare alla morte Moro e gli oscuri segreti di cui era custode.
La fermezza fu una scelta difficile perché portò alla morte di un uomo
innocente, ma fu presa in nome di un bene superiore: la resistenza dello Stato
al ricatto dei terroristi.
I falsi “misteri” del
sequestro Moro,
scrive Davide Steccanella l'11 maggio 2018 su "Articolo21". L’ultimo in ordine
di tempo a sbizzarrirsi è tale Ugo Mattei che firma oggi sul Fatto Quotidiano un
articolo dal titolo “Due dubbi, una spiegazione” dove si ipotizza che Moro non
sarebbe stato sequestrato in Via Fani e che sarebbe stato trattenuto nella base
BR di Via Gradoli e non già nell’appartamento di Via Montalcini. Ultimo, perché
in questi giorni siamo stati inondati di una marea di ricostruzioni
“dietrologiche” del sequestro Moro finalizzate a ribadire che “dietro” alle
Brigate rosse ci sarebbe stato necessariamente qualcun altro che l’avrebbe fatta
franca. Ovviamente, non potendo neppure l’ennesima Commissione (SIC!) dare un
nome a quel “qualcun altro”, si punta come sempre sugli asseriti “misteri” che
inquinerebbero la ricostruzione fatta ai tempi da chi quel delitto ebbe invece
effettivamente a commetterlo. E questo nonostante siano stati pubblicati in
questi anni numerosi libri (vd. gli scritti di Satta, Armeni, Clementi,
Persichetti ecc), che hanno puntualmente smentito, fino al più minuscolo
dettaglio, la ridda del falsi misteri che tuttora vengono fatti passare per
verità acquisite ma non importa. L’ondata italica della dietrologia è talmente
forte da spazzare tutto quel che trova d’ostacolo sul proprio cammino. Molto in
breve, e rimandando per l’approfondimento ai testi sopra citati, vediamo quali
sarebbero, secondo la vulgata, i principali misteri, e perché sono dei
giganteschi “falsi”.
1) La scelta del giorno 16
marzo sarebbe stata imposta dai nemici del compromesso storico perché quel
giorno era previsto il voto di fiducia al monocolore Andreotti. Prima balla. Il
sequestro di un alto esponente DC (individuato inizialmente nella terna
Andreotti, Fanfani e Moro) era stato progettato da anni, tanto che ai primi
pedinamenti romani partecipò anche Franceschini arrestato l’8 settembre 1974,
come ci racconta lui stesso nel libro Mara Renato ed io, prima di trasformarsi
nel più accanito dietrologo. Una volta individuato Moro per ragioni logistiche,
era l’unico dei tre che non abitava in centro, il sequestro fu pianificato per
processare lo Stato in risposta al processo al nucleo storico delle Brigate
rosse che il 9 marzo era ripreso a Torino. E’ ulteriore balla che Moro avesse
chiesto l’auto blindata perché temeva attentati da chi non voleva il compromesso
storico ipotizzato da Berlinguer (ancora nel 1973 con i due articoli su
Rinascita all’indomani del golpe cileno), perché Moro non voleva affatto
“governare insieme al PCI”, ma voleva “sdoganarlo” come partito dell’arco
democratico vista la situazione particolare delle piazze italiane nel 1977.
2) In Via Fani ci sarebbero
stati anche altri soggetti non identificati oltre ai dieci brigatisti processati
e condannati, visto che qualcuno da una moto sparò al parabrezza del teste
Marini. Seconda balla. Il libro di Armeni, Questi fantasmi, smentisce con
l’ausilio di foto e documenti d’archivio la testimonianza (falsa) di Marini,
dimostrando che il suo parabrezza era già stato danneggiato prima di quel 16
marzo. Non occorrevano peraltro tiratori speciali, nè particolari esperti
d’addestramento militare, per colpire a brevissima distanza delle persone
intrappolate in un’auto e in ogni caso l’intera azione del 16 marzo, copiata da
quella di qualche mese prima delle RAF tedesche per il sequestro Schleyler, è
stata recentemente riprodotta e simulata su incarico dell’ultima Commissione,
con tanto di mezzi laser, e ha confermato la validità della ricostruzione dei
brigatisti.
3) Il luogo ove Moro fu tenuto
prigioniero non sarebbe stato quello di Via Montalcini. Terza balla. Il tragitto
da via Fani con l’ostaggio, puntualmente ricostruito con le due tappe intermedie
per consentire i due cambi di auto e il trasferimento in una cassa di legno, e
riscontrato in ogni minimo dettaglio dagli inquirenti, conduceva esattamente in
quella zona, dove solo Moretti e Gallinari, tra i 10 brigatisti presenti in via
Fani, conoscevano l’ubicazione dell’appartamento. L’appartamento infatti fu
individuato dagli inquirenti solo 4 anni dopo grazie al pentimento di Savasta
(neppure il grande pentito Peci sapeva dove fosse), il quale, arrestato in
occasione della liberazione del generale Dozier, anche se pure lui non conosceva
l’indirizzo, riferì che Moro era stato tenuto in una casa acquistata l’anno
prima da Laura Braghetti (arrestata nel 1980), e così fu possibile risalire
all’atto del 1977. Giunti in quell’appartamento, gli inquirenti rinvennero le
tracce dell’intercapedine interna in cui fu ricavata la cella di Moro e che era
stata smantellata 4 anni prima al termine del sequestro.
4) L’appartamento romano di
Via Gradoli, dove durante il sequestro soggiornavano Moretti e Balzerani, era
stato indicato ai carabinieri da Prodi ma i carabinieri furono mandati in un
paese del viterbese. Quarta balla. L’appunto consegnato da Prodi, evidente
frutto di una “soffiata” dato che la seduta spiritica era una scemenza,
riportava effettivamente la parola Gradoli ma aggiunta alle parole Viterbo e
Cascina indicata su un punto della strada nazionale che porta al paese di
Gradoli, quindi è del tutto logico che si sia andati a cercare Moro lì, e non in
una via di Roma.
5) Sempre l’appartamento di
Via Gradoli, che fu la prima base romana affittata ancora nel 1975 dalle BR, fu
fatto scoprire ad aprile dai brigatisti perché era stata lasciata a bella posta
una doccia aperta della vasca su un manico di scopa appoggiato alla fessura del
muro del bagno. Quinta balla, come chiunque può leggere sul rapporto redatto dai
vigli del fuoco che ai tempi ebbero a fare l’intervento per la perdita d’acqua
segnalata dalla vicina, come ha recentemente confermato uno di loro al
giornalista Purgatori nel recente documentario di La 7, e peraltro
quell’appartamento aveva già manifestato difetti segnalati tempo addietro
all’amministratore. I brigatisti vennero a sapere della scoperta solo perché il
TG mandò in onda il servizio e quindi evitarono di farvi ritorno. In ogni caso
Moro non era mai stato in via Gradoli, e quindi anche il fatto, emerso al
processo, secondo cui pochi giorni dopo il sequestro i carabinieri avrebbero
controllato quello stabile senza abbattere la porta dell’appartamento dopo avere
vanamente suonato il campanello, non avrebbe comunque consentito la liberazione
dell’ostaggio.
6) Il falso comunicato numero
7, che secondo alcuni sarebbe stata la prova generale da parte dello Stato per
verificare l’impatto sull’opinione pubblica in caso di uccisione di Moro e che
indusse le ricerche sul lago ghiacciato della duchessa, fu fatto con diversa
macchina da scrivere rispetto a quella usata dalle BR da un noto falsario
romano, che non aveva nulla a che vedere con le Brigate rosse.
7) Il rinvenimento il 9 maggio
della Renault rossa in via Caetani sarebbe avvenuto prima dell’orario ufficiale.
Ennesima balla perché l’artificiere che a distanza di anni ha raccontato questa
storia, Vitantonio Raso, è stato incriminato nel 2014 per calunnia dalla Procura
di Roma, stesso reato per il quale l’anno prima era stato incriminato l’ex
brigadiere GDF Giovanni Ladu per altro depistaggio.
8) Il mancato rinvenimento del
1978 nella base milanese di via Monte Nevoso di materiale riguardante il
sequestro Moro, emerso nel 1990 dietro un calorifero, è dipeso dal fatto che i
carabinieri non aprirono quel portello celato e del resto che mancasse qualcosa
all’appello era stato segnalato dagli stessi brigatisti ad un processo, quando
Maria Brioschi disse che in quella base c’era anche parecchio denaro (che
qualcuno evidentemente si intascò).
9) La mancata indicazione
iniziale agli inquirenti del terzo uomo di via Montalcini dipese dalla scelta,
da parte di chi era già stato arrestato di preservare dalla galera Germano
Maccari che fino al 1993 non era stato individuato come il possibile autore di
quella firma di tale ing. Altobelli che compariva sul contratto di luce e gas.
Ritenere che la mancata indicazione di un compagno dimostri che si sia voluta
celare anche la partecipazione di apparati deviati dello stato è follia.
Va infine segnalato che: tutti
i brigatisti hanno sempre escluso qualsiasi interferenza esterna, ivi compresi
quelli che in seguito hanno deciso di dissociarsi, eccezion fatta che per
Franceschini, ai tempi del sequestro Moro in galera da 4 anni, e che per sua
stessa ammissione apprese la notizia del carcere di Torino, ancora oggi, dopo
quasi 40 anni, l’organizzatore “manovrato” di quel sequestro, Mario Moretti,
rientra tutte le sere nel carcere di Opera. Sarebbe questa la ricompensa per
avere coperto i “poteri forti”? il fatto che “dietro” gli esecutori di quel
sequestro non ci fossero misteriosi poteri occulti lo scrisse chiaramente e
subito lo stesso Aldo Moro a Cossiga: “Mi trovo sotto un dominio pieno e
incontrollato”. Detto questo, sono assolutamente certo che chi ancora dopo 40
anni non si rassegna all’assenza di gialli e complotti sarà del tutto
disinteressato anche a leggere quel che ho scritto, ma mi pareva comunque giusto
farlo.
“L'indicibile verità” sul
caso Moro.
Lo schema è sempre lo stesso: le acquisizioni processuali e l’indagine storica
porterebbero a una soluzione che però non coincide con le peggiori supposizioni.
Dunque la soluzione è apparente, se non falsa, scrive Massimo Bordin il 10
Maggio 2018 su "Il Foglio". A conferma di quello che qui si poteva leggere sul
quarantennale dell’omicidio di Aldo Moro, sempre ieri, sul Tempo, è apparsa una
intervista a Giuseppe Fioroni, presidente della ennesima commissione
parlamentare sulla vicenda. L’intervista è servita al presidente Fioroni anche
per annunciare l’imminente uscita di un libro, a sua firma insieme a quella
della giornalista Maria Antonietta Calabrò, che fa il punto sulle acquisizioni
della commissione. Il titolo è singolare: “Moro, il caso non è chiuso. La verità
non detta”. La verità si trova dunque nelle pagine del libro? La risposta di
Fioroni è complessa. Da un lato, il presidente dell’ennesima – ma non ultima,
visto che il caso non è chiuso – commissione, sostiene che essa ha comunque
messo un punto fermo nella storia perché le sue relazioni sono state approvate
all’unanimità. Dall’altro Fioroni parla di verità indicibili che non sono ancora
state svelate. Si può in questa sede trascurare il possibile allargamento
dell’antica contraddizione fra verità storica e verità giudiziaria a un nuovo
tipo di verità, quella parlamentare. Conviene soffermarsi sull’uso particolare
dell’aggettivo “indicibile” a proposito del quale il procuratore generale
palermitano Roberto Maria Scarpinato dovrebbe cominciare a pretendere royalties,
visto che ne è l’inventore. Lo schema in effetti è sempre lo stesso. Le
acquisizioni processuali e l’indagine storica porterebbero pianamente a una
soluzione che però non coincide con le peggiori supposizioni. Dunque la
soluzione è apparente, se non falsa. E’ lo schema palermitano sulle stragi e
sulla trattativa. Abbiamo imparato che funziona. Al di là dei fatti.
Il filo rosso tra la
commissione Moro e la Trattativa. Le nuove rivelazioni di Paolo Persichetti a
Franco Piperno aprono nuovi scenari sul rapimento del democristiano. Con un
finale sorprendente, scrive Massimo Bordin il 28 Aprile 2018 su "Il Foglio".
L’intervista di Paolo Persichetti a Franco Piperno pubblicata due giorni fa dal
Dubbio getta un ulteriore fascio di luce sulla qualità dei lavori della ennesima
commissione sul caso Moro. Gli onorevoli indagatori hanno a lungo fissato la
loro attenzione su un palazzo di Via dei Massimi, una tranquilla strada del
quartiere Balduina dove i brigatisti hanno abbandonato due auto utilizzate
nell’attacco di via Fani. Nel palazzo poteva esserci una sede Br, questa la
tesi. Siccome il palazzo dispone anche di un ampio terrazzo condominiale alla
sua sommità e di un garage, qualcuno ha ipotizzato che Moro sia stato trasferito
in elicottero. Ora l’intervista citata aggiunge un ulteriore particolare. Agli
atti della commissione risulta un rapporto investigativo che parla della
frequentazione di quel palazzo da parte di Franco Piperno che andava a trovare
una giornalista tedesca dello Spiegel che vi abitava. Nel rapporto si ipotizza
che il 16 marzo Piperno, non si sa se munito di cannocchiale, abbia seguito dal
balcone di casa della giornalista l’agguato di Via Fani. La fonte citata è il
portiere dello stabile. Anche gli onorevoli indagatori hanno esitato a
valorizzare il rapporto investigativo. Se si compulsano gli atti della
commissione Fioroni si trovano i nomi di chi ha investigato sul palazzo di Via
dei Massimi e sulla giornalista tedesca. Si tratta del colonnello dei
carabinieri Massimo Giraudo e del sostituto procuratore della Procura nazionale
antimafia, distaccato alla commissione Moro, Gianfranco Donadio. Investigatori
che si ritrovano valorizzati dall’accusa nel processo Trattativa. Il mondo è
piccolo.
Il caso Moro, antichi dubbi
e zero prove.
Un articolo sull’eccidio di Via Fani pubblicato dal Fatto e firmato dal
professore Ugo Mattei riapre la tesi cospirazionista, scrive Massimo Bordin il
12 Maggio 2018 su "Il Foglio". A tutto c’è un limite, si usa dire, quando il
limite viene superato. Più che di una prescrizione si tratta di una petizione di
principio, come tale destinata a restare lettera morta. Per quanto il limite si
sposti in avanti, accade che venga sistematicamente superato. Un po’ il
contrario del paradosso di Achille e la tartaruga. Viene da pensarlo
leggendo l’articolo sull’eccidio di Via Fani pubblicato ieri dal Fatto e firmato
dal professore Ugo Mattei. Il professore per la verità mette subito le mani
avanti, scontando in anticipo una prevista accusa di cospirazionismo ma non
resiste alla tentazione di esplicitare un suo antico dubbio su come andarono
davvero le cose. L’unica precauzione è un consulto preventivo, come racconta,
con suo figlio, esperto di videogame. Le due domande da cui si parte sono
antiche, coeve ai fatti. Come mai Moro non fu colpito? Perché nelle sue lettere
non parlò mai della strage della sua scorta? Il professore ha sempre pensato a
una risposta e ieri l’ha finalmente svelata. Moro fu rapito prima, mentre era a
messa, da ignoti personaggi che, simulando una emergenza, l’avrebbero convinto a
uscire da una porta secondaria. E la scorta? Ripartì senza Moro per poi cadere
nell’imboscata, definita dal professore una “messinscena”, anche se i morti non
si sono rialzati da terra. E Moro? Moro venne portato in Via Gradoli, dove
viveva Moretti, poi sospettato, aggiunge maliziosamente il professore, come
infiltrato da alcuni brigatisti, senza però mai prove. Come nessuna prova esiste
che Moro sia stato tenuto a via Gradoli. Anche perché, pure volendo, non c’era
proprio spazio. Non è vero che a tutto c’è un limite.
TUTTO QUELLO CHE NON TORNA.
Caso Moro, Francesco
Pazienza e il suo Lodo: “Negli anni ’80 accordo con l’Olp.
Gli aprivamo le porte del Vaticano”. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto una
indiscrezione sulla testimonianza di Francesco Pazienza, ex agente segreto e
faccendiere di grosso calibro, ascoltato come persona informata dei fatti dalla
procura generale di Roma che ha aperto una nuova indagine sull’agguato di via
Fani, scrive Stefania Limiti il 14 giugno 2018 su "Il Fatto Quotidiano". Bocche
cucite alla Procura generale di Roma dove è aperta una indagine sul caso Moro,
in particolare sull’agguato di via Fani e sulla passeggiata mattutina del
colonnello Camillo Guglielmi, ufficiale dei carabinieri e addestratore
di Gladio, che si trovò in quel luogo preciso proprio mentre il commando
brigatista scatenava l’inferno contro l’auto del presidente Dc e la sua scorta.
Una parte dell’inchiesta riguarda traffici di armi e l’ombra di Stay Behind.
Ilfattoquotidiano.it ha raccolto una indiscrezione sulla testimonianza
di Francesco Pazienza, ex agente segreto e faccendiere di grosso calibro,
condannato per i depistaggi sulla strage di Bologna e per il crack del Banco
Ambrosiano, ascoltato come persona informata dei fatti. Pazienza è recentemente
salito alla ribalta delle cronache del processo bolognese per la strage del 2
agosto 1980 con un attacco frontale contro il generale Mario Mori. Una
testimonianza, quella del faccendiere, che va oltre il caso Moro e che svela
l’esistenza di un accordo, già battezzato Lodo Pazienza, che proseguì agli anni
anni ‘80. La strategia di Aldo Moro nell’area del Mediterraneo e del suo Lodo,
cioè l’accordo in base al quale l’Italia garantiva l’incolumità dei guerriglieri
palestinesi in cambio dell’impegno a non usare mai il nostro territorio
per azioni armate. Uno scambio con il quale il presidente Dc, che voleva ad ogni
costo uno Stato palestinese indipendente, tendeva a ritagliare per l’Italia un
posto di primo piano nell’area del Mare nostrum. Tornando a Pazienza, è noto che
alla fine degli anni ‘70 e nel decennio successivo è stato protagonista
indiretto (nel senso che non apparteneva a nessuna istituzione dello Stato ma
agiva come se fosse lo Stato) dell’intelligence italiana, consulente del
piduista capo del Sismi Giuseppe Santovito, e portatore dei suoi legami con
personalità di spicco del mondo arabo e con quello dell’Oltretevere, oltre che
di uomini dell’amministrazione americana. Aveva buoni contatti anche con il
colonnello Stefano Giovannone, dominus dei nostri Servizi in Medioriente: una
solida base di relazioni che gli permise di intavolare nuove trattative tra il
gennaio e il marzo del 1981 con la direzione dell’Olp – come ha raccontato ai
magistrati delegati della Procura generale di Roma – ottenendo la prosecuzione
dei vecchi patti ma con una variante: voi lasciate fuori il nostro territorio
dagli attacchi armati e noi vi apriamo le porte del Vaticano. Al tavolo ci sono
Pazienza per conto dei Servizi italiani, Ibrahim Ayad, sacerdote del Patriarcato
latino di Gerusalemme che fu tra i vecchi consiglieri del presidente
palestinese Yasser Arafat, ed emissari del cardinale Achille Silvestrini. Il
dialogo va avanti qualche mese, con la soddisfazione di tutte le parti in causa,
e portò alla prima visita di Arafat in Vaticano risale al 15 settembre 1982.
Tanto bastò a far esplodere l’ira di Israele contro la Chiesa cattolica: Menahem
Begin, allora primo ministro, accusò il Papa di aver stretto “una mano sporca
dio sangue di bambini ebrei innocenti”. Esponenti della Procura generale,
interpellati, si trincerano dietro un no comment: “Stiamo lavorando”, dicono.
Le tante verità mancanti
del caso Moro e le complicità internazionali svelate da Calabrò,
scrive Roberto Arditti il 13/06/2018 su "Formiche". Maria Antonietta Calabrò,
coautrice del libro "Moro, il caso non è chiuso", spiega come la ricostruzione
ufficiale sul rapimento e sull'omicidio del presidente Dc non regga. E sul
perché moltissimo di questa vicenda sta negli equilibri internazionali. Il
rapimento e l’uccisione di Aldo Moro sono innanzitutto una tragica e monumentale
vicenda di intrecci internazionali, drammaticamente emblematica dei fragili
equilibri del secondo dopoguerra. Maria Antonietta Calabrò ha scritto
con Giuseppe Fioroni un libro solido e assai utile (Moro, il caso non è
chiuso, Lindau), facendo leva sull’immensa mole di documenti che l’apposita
commissione parlamentare ha trovato nella legislatura appena conclusa. Non si
tratta solo di storia, ma di stringente attualità, poiché le dinamiche
internazionali sono tutt’oggi lì da osservare e i nostri tempi sono decisamente
figli di quelli. L’Italia agisce nel contesto che c’è, oggi come allora. Moro
governava e faceva politica, ben consapevole dei limiti (e dei rischi
dell’esercizio).
Questo libro ha il pregio
di mettere tutto in fila, con grande chiarezza ed assoluta onestà intellettuale.
L’intera vicenda Moro mostra una immensa attività internazionale attorno a
quella storia. Come possiamo riassumere questo scenario?
«In
modo semplice, nel senso che i nuovi documenti desecretati a partire dal 2014,
lavorati e studiati dalla Commissione Moro2, dimostrano che nel corso del
sequestro (e poi anche negli anni successivi) si muovono per recuperare i
documenti di Moro tutti i servizi segreti rilevanti ai fini della collocazione
internazionale del nostro Paese. L’Italia è in Occidente e fa parte della Nato,
però ha i suoi rapporti con l’est e con la Russia, così come li aveva al tempo
con l’Unione Sovietica. Moro si è trovato in mezzo a uno scacchiere molto
composito e non è riuscito a gestirne tutti gli aspetti. Questo ha creato
probabilmente i presupposti del sequestro, attribuibile alle azioni di Br e Raf
tedesche collegate alle frange più estreme del terrorismo palestinese e poi
l’esito tragico del sequestro stesso».
Noi oggi possiamo dire
quindi che le ragioni della morte di Aldo Moro vanno cercate più fuori che
dentro l’Italia?
«Si
è creato un gioco di specchi per cui alla fine quelli che sembravano gli amici,
cioè le frange estreme palestinesi con cui l’Italia stava trattando per la
liberazione di Aldo Moro, hanno condotto alla morte del prigioniero. D’altra
parte è agghiacciante considerare che il lodo Moro, cioè l’accordo fatto dai
nostri servizi segreti con i palestinesi per mettere al riparo il Paese da
attentati terroristici è servito a tutti tranne che ad Aldo Moro. Cioè a Aldo
Moro che è stato rapito nonostante il lodo Moro ed è morto nonostante il lodo
Moro».
Ha senso parlare di uno
Stato nello Stato, o, per dirla all’inglese, di un Deep State?
«Si
che ha senso. Ve n’è traccia evidente nelle centinaia di documenti agli atti
della Commissione Moro 2 che abbiamo esaminato nel libro. Cioè oltre allo Stato
espressione delle elezioni, dei vari leader politici, dei rapporti tra i
partiti, (penso al ruolo di Craxi durante i 55 giorni e poi naturalmente alla Dc
e al Pci) ne esiste uno più profondo che gestisce anche la collocazione
internazionale dell’Italia con i relativi accordi. Il tema forse più drammatico
evidenziato nel libro è che il generale Dalla Chiesa scrive al ministro
dell’Interno, già nel gennaio 1979, esprimendo tutto il suo allarme per il fatto
che le Brigate Rosse a un certo punto iniziano a parlare di una struttura
segreta della Nato, cioè Gladio. In effetti dal ministero della Difesa, durante
il sequestro Moro, sono scomparsi documenti riguardanti i piani top secret della
rete Nato Stay Behind in Europa, ed essi sono arrivati In mano alle Brigate
Rosse e, con altissima probabilità, furono ritrovati nel loro covo di via
Fracchia a Genova dai carabinieri dal Generale Dalla Chiesa».
Veniamo al rapimento di
Aldo Moro. Cosa non torna nella versione ufficiale di quella maledetta giornata?
«Due
elementi essenziali. Il primo. Dalla scena dell’agguato di via Fani scompaiono
due terroristi della Raf. Questo ormai si può dire con certezza. Sono due
persone a bordo di una moto tra cui una donna con lo chignon: ne parlano
testimoni oculari mai ascoltati nelle istruttorie giudiziarie. Può sembrare
pazzesco, poiché già allora si sapeva dei collegamenti tra le Br e Raf. Allora
perché tanta cura nel non citare i terroristi tedeschi? Però nessuno parla di
quei due, men che meno la versione ufficiale dei brigatisti consegnata nel 1990
a Cossiga. Il motivo è nel contesto internazionale del sequestro. Perché la Raf
vuol dire Germania Est e vuol dire Stasi, cioè i servizi segreti gestiti
da Markus Wolf. Non a caso le Br chiamano il sequestro “operazione Fritz”: un
chiaro riferimento ad un contesto internazionale, altro che il ciuffo bianco nei
capelli di Moro. Il secondo elemento è che le autovetture che si allontanano
dalla scena di via Fani vengano ritrovate in via Licinio Calvo nell’arco di tre
giorni. Cioè la 132 di Moro e le due 128 usate dai terroristi per fuggire da Via
Fani vengono lasciate in quella via in sequenza, non nello stesso momento.
Quindi c’è in zona un luogo “sicuro” che le ha custodite. Con altissima
probabilità è il garage di via Massimi 91, forse anche la prigione di Aldo Moro,
almeno per i primi dieci giorni. Ma forse anche per maggiore tempo. Lo stabile
di via Massimi 91 aveva una proprietà molto particolare, cioè lo Ior, la banca
vaticana».
E per quanto riguarda i 55
giorni di prigionia qual è l’elemento più importante che non torna?
«Un
uomo tenuto prigioniero per cinquantacinque giorni in una striscia di stanza di
un metro per tre (com’era la prigione del popolo “ufficiale” di via Montalcini
8) senza la possibilità di lavarsi, di muoversi, di avere uno spazio idoneo per
scrivere tutto quello che ha scritto Moro. Un uomo ridotto a passare tutta la
giornata steso su una brandina non presenta il tono muscolare di Aldo Moro
evidenziato dall’autopsia. L’uomo che arriva sul tavolo dell’obitorio è un uomo
che ha potuto muoversi, camminare, sedersi a un tavolo. Un prigioniero detenuto
così, soprattutto, non può avere la lucidità per interloquire indirettamente con
il colonnello Giovannone come si dimostra nel libro, non può gestire la
complessa trattativa che lo riguarda, dentro e fuori la Dc. Per questo la
commissione Moro2 ha puntato il suo faro sul complesso di via Massimi 91, dove
sull’attico della palazzina B era stato ricavato un vero e proprio mini
appartamento. Un luogo su cui una fonte altamente qualificata della Guardia di
Finanza aveva richiamato l’attenzione già dai primi giorni del sequestro. Io
l’ho chiamato il checkpoint Charlie di Roma. Quell’edificio è la linea di
confine di quegli anni tormentati. Arriviamo all’esecuzione del presidente della
Dc. Anche qui la versione ufficiale non regge. I carabinieri hanno dimostrato
che Moro non può essere stato ucciso nel garage di via Montalcini: quel garage è
un box troppo piccolo per essere stato la scena del delitto. I primi colpi lo
raggiungono quando lui è seduto probabilmente fuori della Renault Rossa e vede
perfettamente chi gli sta sparando con la Scorpion. Poi, già ferito gravemente,
Moro viene messo nel bagagliaio e nuovamente raggiunto da diversi colpi,
l’ultimo dei quali è della pistola Walther calibro nove, cioè quella pistola che
sarà recuperata dai carabinieri di Dalla Chiesa a Roma nel 1980 dopo che venne
smantellato il covo di via Fracchia. Uno strano destino quello di quest’arma,
che è sempre rimasta un po’ sullo sfondo del delitto (secondo i brigatisti non
avrebbe mai sparlato perché si inceppò) tanto che solo dal 2016 sappiamo dai
riscontri del Ris dei carabinieri che è una delle due armi che ha ucciso Moro».
L’omicidio del generale
Dalla Chiesa è secondo te collegato al caso Moro?
«Questo
hanno sostenuto diversi testimoni, come la signora Setti Carraro al processo di
Palermo. Poi c’è l’assassinio di Carmine Pecorelli, che era molto informato
sull’andamento del sequestro e soprattutto sul recupero delle carte. Già, perché
è proprio Pecorelli che aiuta Dalla Chiesa a ritrovare i documenti di Aldo Moro
nel carcere di Cuneo. Poi rimangono molti interrogativi sulla morte del generale
Galvaligi ed anche su quella del falsario della Banda della Magliana Antonio
Chichiarelli, che compie due grandi furti, alla banca Brink’s Securmark e a
Villa Abalmelek. Il primo gli porta nelle tasche 35 miliardi delle vecchie lire,
ma probabilmente anche molti documenti, facendo parte la banca della galassia
Sindona. Il secondo nell’abitazione dell’ambasciatore russo, dove vengono
trafugati quadri di un certo valore, ma che probabilmente non erano il primario
oggetto di interesse. Pochi mesi dopo quei furti Chichiarelli muore».
"MORO, IL CASO NON E'
CHIUSO".
Moro ha guardato negli occhi chi gli sparava ed è morto dopo un'agonia molto
lenta. Il box di via Montalcini una scatola troppo piccola per essere il luogo
del delitto, scrive il 9 maggio 2018 su "Huffingtonpost.it" Maria Antonietta
Calabrò. Oggi, 40 anni fa, veniva ucciso Aldo Moro. Dove? Come è stato ucciso?
Chi lo ha ucciso? Quando è stato ucciso? Contrariamente a quanto si possa
pensare l'assassinio di Moro è un delitto non ancora definitivamente risolto.
Alla luce dei risultati delle nuove tecniche d'indagine scientifica è un vero e
proprio cold case. Una riscrittura della scena e delle modalità del delitto è
ormai necessaria dopo le molte novità emerse grazie alle nuove indagini affidate
al RIS (Reparto di investigazioni scientifiche) dei Carabinieri dalla
Commissione parlamentare d'inchiesta Moro-2, presieduta da Giuseppe Fioroni, che
ha chiuso i suoi lavori il 28 febbraio 2018. Esse colmano un clamoroso vuoto di
investigazione: sono accertamenti che nessun inquirente aveva mai ritenuto di
effettuare prima del maggio 2017. Soprattutto, il delitto - così come è stato
ricostruito su basi scientifiche a quarant'anni dai fatti - acquista i connotati
di un assassinio feroce, veramente efferato. I brigatisti hanno sempre affermato
che Moro morì sul colpo. Questo non è assolutamente vero. Sul bavero sinistro
della giacca di Moro il RIS ha trovato quella che è stata definita dal suo
Comandante, una "particolarità": lì c'è tutt'oggi traccia di un rigurgito di
saliva, che la vittima ha espettorato ancora vivo. Già, secondo l'autopsia,
eseguita il 9 maggio 1978, Moro sarebbe morto almeno quindici minuti dopo che
gli hanno sparato. Alle 19 di sera del 9 maggio 1978 quando inizia l'esame
necroscopico il rigor mortis non è ancora completo, il che vuol dire che, sia
pur in modo molto approssimativo, non sono passate 12 ore dal decesso. Ma "un
morto parla, se lo si lascia parlare", ebbe a dichiarare pochi giorni dopo
l'assassinio un alto funzionario di Polizia, e il RIS, a seguito dei suoi
ulteriori approfondimenti, è giunto alla conclusione che la morte è sopraggiunta
sicuramente dopo un'agonia molto lenta. La narrativa della morte sul colpo non è
solo un modo, diciamo così, per "ammorbidire" il delitto, con una bugia che
potrebbe sembrare pietosa. Essa è servita a celare la verità su come siano
andati realmente i fatti. I primi tre colpi colpiscono Moro a bruciapelo,
vengono sparati contro una vittima vigile, a volto scoperto, non bendata né
tanto meno avvolta dalla famosa coperta che coprì il cadavere nel bagagliaio
della Renault 4. Moro dunque guarda in faccia i suoi assassini. Guarda negli
occhi chi gli sta sparando. Muore per emorragia interna, avendo perso quasi un
litro di sangue (900 cl). Sangue di cui c'è una grossa chiazza sul pianale del
bagagliaio della Renault rossa, insieme ai liquidi organici rilasciati al
momento della morte. Anche chi spara guarda Moro negli occhi, e la vittima alza
la mano sinistra per difendersi istintivamente dalla mitraglietta. Soprattutto,
oggi sappiamo che - quando inizia ad essere colpito - Moro non è disteso dentro
il cofano della famosa Renault Rossa in cui fu trovato cadavere in via Caetani,
perché - ormai è un fatto certo - i colpi arrivano non dall'alto verso il basso,
come sarebbe avvenuto in quel caso, ma al contrario dal basso verso l'alto.
Tanto da far pensare che l'esecuzione possa addirittura essere cominciata quando
la vittima era in piedi. Un'esecuzione barbara e imprecisa che contrasta con "la
geometrica potenza" dispiegata al momento del rapimento in via Fani, nel corso
del quale Moro rimase praticamente illeso, dopo una sparatoria in cui sono stati
esplosi 93 colpi.
Un'altra, insomma, è la mano
che uccide. I dubbi dei magistrati. Le nuove attività di indagine della
Commissione parlamentare Moro 2 - i cui risultati insieme al Presidente Fioroni
ho raccolto in un libro - che sarà presentato domani al Salone del Libro di
Torino - hanno preso le mosse dai dubbi espressi già dalla sentenza di primo
grado del cosiddetto processo Moro-quinquies, l'ultimo in ordine di tempo dei
processi penali istruiti dalla magistratura romana per la strage di via Fani
Fani e l'assassinio di Moro. Proprio quella sentenza del 16 luglio 1996 - a
proposito della verosimiglianza o meno del racconto del trasporto di Moro dalla
prigione nella cesta e dell'esecuzione nel garage - affermava: "Non si comprende
come i brigatisti abbiano accettato un simile e gratuito rischio, quando
avrebbero potuto facilmente evitarlo, ad esempio uccidendo l'on. Moro nella sua
stessa prigione e trasportandolo poi da morto; e incredibile sembra il fatto che
si sia programmata l'esplosione di una serie di colpi, quanti risultano dalle
perizie, in un box che si apriva nel garage comune agli abitanti dello stabile,
essendo noto che anche i colpi delle armi silenziate producono rumori
apprezzabili, che potevano essere facilmente percepiti da persone che si
trovassero a passare, così come furono distintamente percepiti dalla Braghetti".
Sul luogo presunto del delitto - il garage di via Montalcini 8 - gli uomini del
RIS hanno ripetuto gli spari, hanno fatto misurazioni, registrato rumori,
scattato foto ed effettuato filmati video. E si è accertato che l'auto che è
stata la prima bara di Aldo Moro, poteva solo con difficoltà entrare nel box di
via Montalcini così come esso era nel 1978 (prima dei lavori di ampliamento e di
rifacimento cui è stato sottoposto) per consentire l'esecuzione della condanna.
La Renault rossa non poteva entrarci con il portellone posteriore aperto. O
meglio, per entrarci doveva sporgere all'esterno di parecchio, e diventare
visibile per qualunque condomino avesse avuto la necessità di uscire usando la
propria vettura (comunque un rischio elevato, anche se l'orario indicato dai
brigatisti, le 6.30 del mattino, fosse corretto). E in effetti un'inquilina del
quinto piano sosterrà - già ai primi di luglio del 1978 - di aver visto Anna
Laura Braghetti nel garage e una Renault rossa parcheggiata. Ma "qualche giorno
prima" del 9 maggio testimonierà ai magistrati. Per non parlare del rumore che i
colpi (anche silenziati) produrrebbero, se sparati in una palazzina come quella
di via Montalcini, una palazzina di cortina, con grandi finestre a vetri e muri
di modesto spessore, ben diverse da quelle del centro storico della capitale,
dove i muri perimetrali sono di pietra piena (non di mattoni forati) e possono
essere spessi anche oltre un metro. Un condominio posto per di più in una strada
che costituisce uno degli accessi a una grande aerea verde, Villa Bonelli, in
primavera rifugio di stormi di uccelli, che sicuramente si sarebbero spaventati
all'udire molteplici colpi. Sulla base delle attività compiute dal RIS in
relazione alla ricostruzione della dinamica del delitto, essa, oggi, può essere
così riassunta.
Moro eretto, fuori dalla
Renault, a sparare inizia la Skorpion. L'ipotesi ritenuta scientificamente più
probabile è che in un primo momento la vittima sia stata colpita anteriormente
al torace sinistro da almeno tre colpi sparati a bruciapelo con la mitraglietta
Skorpion. L'inclinazione di tali traiettorie è pressoché ortogonale alla
superficie del corpo e la postura della vittima è, verosimilmente, con il busto
eretto e seduta, come dimostrato dalle colature di sangue sulla maglietta intima
unitamente alle proiezioni e colature di fluido biologico sui pantaloni. E'
probabile che, proprio in quel momento, la vittima sia stata ferita anche al
pollice della mano sinistra, protesa in avanti in un istintivo gesto di
autodifesa, e che il medesimo proiettile abbia poi proseguito la sua traiettoria
raggiungendo il torace anteriormente. Tale fase iniziale della dinamica del
delitto potrebbe essere avvenuta anche ipotizzando Aldo Moro seduto sul pianale
del portabagagli della Renault 4, sopra la coperta, con il busto eretto e le
spalle rivolte verso l'interno dell'abitacolo. Non si può tuttavia escludere
che la vittima fosse seduta con il busto eretto in qualsiasi altro ambiente,
compreso il sedile posteriore dell'auto. E - come ipotesi "in maniera residuale"
- che fosse in piedi. Il colonnello Ripani, comandante del RIS, ha espresso - in
un'audizione davanti alla Commissione Moro2 - la sua opinione di esperto, e cioè
che i primi colpi abbiano raggiunto la vittima, seduta, probabilmente fuori
dall'auto. Quest'ultima ipotesi giustificherebbe, sul piano logico, il
ritrovamento durante l'ispezione cadaverica del 1978 di fazzoletti di carta -
che per non sono più ormai tra i reperti, finiti chissà dove - inseriti tra la
camicia e il gilet. Infatti essi potrebbero aver avuto lo scopo di tamponare le
prime ferite al torace, durante il trasporto della vittima dal luogo dei primi
colpi fin dentro il vano portabagagli. Inoltre, secondo i risultati degli
accertamenti del RIS riferiti dal colonnello Luigi Ripani, "contrariamente a
quanto riportato in atti", Moro è stato colpito da dodici proiettili: otto
calibro 7,65 estratti dal cadavere durante l'autopsia; due calibro 7,65,
ritrovati tra la maglia intima e la camicia; due fuoriusciti dal corpo,
perforando la giacca e la coperta (dei quali uno solo repertato, sul pianale del
portabagagli, il calibro 9).
Dodici colpi. Dodici colpi
dunque, e non undici come dichiarato dai brigatisti, visto che altrimenti esiste
una assoluta discrepanza tra i fori di ingresso e i proiettili usciti o
ritenuti. Se ne deduce che il dodicesimo colpo potrebbe trovarsi ancora nel
corpo di Moro. Lo si sarebbe potuto accertare subito, semplicemente con un esame
radiografico che al tempo del delitto fu realizzato, ma che - non si sa perché -
non risulta più agli atti. I reperti balistici rinvenuti sulla scena del crimine
e dopo l'autopsia del 1978 sono questi: 9 bossoli e 11 proiettili. Mancano 3
bossoli e un proiettile. Secondo la ricostruzione del RIS, Moro già colpito, ma
ancora vivo, viene spostato, disteso in posizione supina nel vano portabagagli,
sopra la coperta stesa sul pianale della Renault, con il capo contro la parte
sinistra dell'auto. Il tenente colonnello Paolo Fratini, ascoltato in
Commissione Moro-2, ha osservato che parte della coperta doveva trovarsi sotto
il corpo, mentre l'altra non poteva ricoprirlo completamente, altrimenti sarebbe
stata perforata dai proiettili. C'è un altro importante dettaglio. Durante lo
spostamento di Moro ancora vivo dentro il bagagliaio cadono evidenti macchie di
sangue, ancora oggi visibili sul paraurti della Renault 4. E questo, insieme
all'uso dei fazzoletti di carta, avvalora l'ipotesi che i primi colpi siano
stati sparati fuori dall'auto. Magari vicino, ma fuori dall'auto. La pistola
semiautomatica Walther quindi avrebbe sparato non all'inizio dell'azione come ha
raccontato Germano Maccari, il cosiddetto quarto uomo di via Montalcini,
(secondo il quale quella pistola si inceppò e lui allora passò la Skorpion a
Mario Moretti), ma presumibilmente alla fine.
E' la Walther PPK che "firma"
il delitto? Nel corso dell'autopsia è stata riscontrata una forma a stampo di
una corona circolare sul gilet di Moro, verosimilmente riferibile alla pressione
esercitata dalla parte superiore di un silenziatore sull'indumento, all'atto
dello sparo di un colpo a bruciapelo. Ma quale silenziatore? Il colonnello
Ripani ha specificato che l'unico silenziatore presente tra i reperti è uno
realizzato in modo artigianale per la Skorpion, ma il punto è che esso non
corrisponde al segno lasciato sugli indumenti di Moro da un colpo sparato a
contatto con quel silenziatore montato. Confrontando la forma circolare con
quella del silenziatore artigianale applicato alla Skorpion, non c'è
compatibilità sia per le dimensioni del diametro, sia per la presenza di nastro
isolante sporgente dalla parte superiore. Infatti quest'ultimo, in una ipotetica
azione di pressione sull'indumento, avrebbe impedito la formazione "a stampo" di
una corona circolare ben definita come quella osservata sul gilet della vittima.
Di qui, due ipotesi possibili secondo il RIS: "O un silenziatore era montato
anche sulla Walther al momento in cui tale pistola ha sparato il proiettile
calibro 9 corto oppure la Skorpion ha sparato con un ulteriore silenziatore". Al
riguardo va ricordato inoltre che gli accertamenti balistici comparativi non
hanno consentito di stabilire se i proiettili calibro 7,65 trovati nella Renault
4 rossa siano stati sparati con o senza il silenziatore montato sulla Skorpion.
In ogni caso l'abbondanza di residui dello sparo sugli indumenti di Aldo Moro
indica un'estrema vicinanza della vittima all'arma o alle armi durante l'azione
di fuoco. E' stato accertato che, impugnando la Skorpion in modo tale da
orientare la bocchetta di espulsione verso destra con un angolo di 45 gradi, i
bossoli esplosi vengono espulsi con una traiettoria parabolica di oltre 4 metri
e ciò potrebbe giustificare il ritrovamento di almeno cinque di essi nella parte
anteriore dell'abitacolo, senza che si debba necessariamente ipotizzare che la
sparatoria sia avvenuta all'interno dell'auto. Il RIS, infatti, ritiene meno
probabile l'ipotesi alternativa secondo la quale in un primo momento la vittima
è stata colpita al torace quando era seduta all'interno della Renault 4, mentre
lo sparatore (plausibilmente) occupava la posizione del passeggero anteriore.
Riassumendo. Moro è seduto su una sedia, accanto alla Renault 4, o forse
addirittura in un altro ambiente, guarda negli occhi chi gli spara. Il fuoco
parte con tre colpi di Skorpion 7,65. La vittima si accascia. Viene spostata,
sistemata nel portabagagli dell'auto ed è lì che vengono esplosi gli altri nove
colpi (con Moro vivo e sempre a volto scoperto). Alla fine dell'azione omicida,
Moro è ancora colpito a bruciapelo dalla Walther calibro 9 corto, anche
denominata PPK, un'arma prodotta nel secondo dopoguerra nell'Europa dell'Est,
come variante "corta" della più nota P38, in dotazione all'esercito tedesco
durante la seconda guerra mondiale.
Il cuore di Moro, non viene
raggiunto da nessun proiettile. I proiettili 9 e 7,65 sono di piccolo calibro. I
colpi non sono di per sé mortali, causano ferite che tuttavia, anche se
multiple, provocano una morte molto lenta. Si può arrivare ad ipotizzare fino a
40 minuti di agonia. Chi ha compiuto un omicidio così crudele non può non
ricordarlo con precisione. Non si può non ricordare con esattezza un evento così
drammatico. Chi ha sparato non può dimenticare. E invece contrariamente a quanto
ci si potrebbe attendere, i racconti del capo delle Br Mario Moretti, di Maccari
e Prospero Gallinari (il carceriere di Moro), sull'esecuzione dell'omicidio sono
imprecisi e contraddittori. Dei tre solo Moretti è ancora in vita. Maccari è
morto a 48 anni, nella sua cella del carcere di Rebibbia, a fine agosto 2001. Il
sabato precedente aveva incontrato i familiari, raccontando loro di un imminente
permesso premio. Gallinari è morto il 14 gennaio del 2013 nel garage di casa sua
a Reggio Emilia, dove da anni era agli arresti domiciliari visto che Moretti nel
1993 lo aveva discolpato dall'assassinio. Al termine, la vittima è stata
sistemata a forza nel vano portabagagli con le gambe flesse all'indietro e anche
facendole compiere una rotazione antioraria del busto. E' in questa posizione
che il rigor mortis "fissa" il cadavere di Moro, quando arriva all'Istituto di
medicina legale. Nel giugno 1980, nel covo romano di via Silvani venne ritrovata
anche una pistola Walther calibro 9. Oggi sappiamo che quella pistola era
proprio la PPK usata per uccidere Moro. Solo nel 2016, il proiettile e il
bossolo calibro 9 trovati tra i reperti della Renault 4 rossa, abbandonata in
via Caetani, sono stati oggetto di confronto con l'arma di via Silvani, da parte
del RIS. Dagli accertamenti comparativi è risultata "una identità balistica",
tra proiettile, bossolo e arma: quindi il proiettile calibro 9 è stato esploso
proprio da quell'arma. Il covo di via Silvani fu individuato dai Carabinieri,
dopo le operazioni in Piemonte, scaturite dalla collaborazione di Patrizio Peci,
e l'irruzione nel covo in via Fracchia, a Genova, nel corso della quale morirono
quattro brigatisti, tra i quali il capo militare della "colonna" , e braccio
destro di Mario Moretti, Riccardo Dura.
Il box, una scatola troppo
piccola. Proprio alla luce degli accertamenti condotti sulla dinamica
dell'omicidio, sui colpi sparati e in quale sequenza, la Commissione Moro 2 ha
richiesto di disporre di elementi di valutazione sulla reale praticabilità
dell'omicidio di Moro nel garage di via Montalcini 8, secondo le dichiarazioni
dei brigatisti. Il 4 maggio 2017 il RIS ha svolto delle prove d'ingombro di una
Renault 4 nel box-garage di via Montalcini 8, e ha effettuato delle vere prove
di sparo con le armi usate per l'esecuzione dell'omicidio (la pistola
semiautomatica Walther calibro 9 corto e la mitraglietta Skorpion calibro 7,65
con relativo silenziatore), per verificare anche l'effettivo fragore
dell'esplosione dei colpi. Per prima cosa il RIS ha verificato che il box nel
corso del tempo ha subito importanti modifiche strutturali volte al suo
ampliamento. E in secondo luogo, che nel 1978 la sua porta di ingresso non era a
serranda come adesso, ma basculante. In base alle prove compiute, reali
(collocando fisicamente una Renault 4 all'interno del box) e virtuali
(elaborando i dati acquisiti con il Laser Scanner 3D), sono state formulate
diverse conclusioni possibili. Se la porta basculante che esisteva nel 1978
fosse stata chiusa completamente, anche posizionando la Renault 4 in retromarcia
fino a far toccare con la sua parte anteriore la parte interna della basculante,
sarebbe risultato pressoché impossibile aprire/chiudere il portellone dell'auto,
senza evitare che quest'ultimo urtasse sulla parete di fondo (a prescindere dal
modo più o meno obliquo, con cui poteva esser parcheggiata in retromarcia l'auto
nel box). Se invece la Renault 4 fosse stata parcheggiata in retromarcia nel box
con il portellone posteriore già aperto, allora la porta basculante (dopo tale
manovra) si sarebbe potuta chiudere completamente. Tuttavia, in tale caso, lo
spazio di manovra dietro la Renault 4 sarebbe stato di poco superiore a 0,40 m.
E cioè chi ha sparato avrebbe avuto a disposizione meno di mezzo metro per
compiere l'esecuzione. Inoltre anche in questa ipotesi il portellone del cofano
avrebbe urtato comunque la parete di fondo del box. Se invece la Renault 4 fosse
stata parcheggiata nel box in retromarcia, a una distanza dalla parete di fondo
superiore a 0,51 m, allora molto probabilmente (si legge nella perizia) "la sua
parte anteriore sarebbe sporta oltre l'ingresso del box", e la porta basculante
non si sarebbe potuta chiudere del tutto. E' solo in questa seconda ipotesi che
il portellone posteriore si sarebbe potuto chiudere/aprire liberamente (cioè
senza urtare sulla parete di fondo del box). Anche sul lato lungo del box lo
spazio residuo non sarebbe stato molto ampio. Se la Renault 4 fosse stata
parcheggiata in retromarcia accostandola al lato destro, lo spazio disponibile
sull'altro lato sarebbe stato compreso all'incirca tra 1 m e 1,6 m. Se viceversa
fosse stata parcheggiata in retromarcia accostandola al lato sinistro, lo spazio
residuo su quello a destra poteva variare tra 1 e 1,5 m all'incirca. Quindi 50
centimetri al massimo di distanza dalla parete di fondo (con la porta basculante
aperta) e circa un metro e mezzo di spazio sul lato lungo del box. Secondo i RIS
e la Commissione d'inchiesta Moro 2, anche se "alcune delle ipotesi formulate
sono astrattamente compatibili con l'esecuzione dell'omicidio nel box [di via
Montalcini], nel complesso si rafforzano i dubbi che sul piano logico, si
evidenziano rispetto alla praticabilità, in quel luogo, dell'azione
omicidiaria".
Prove di sparo del RIS con la
porta aperta per motivi di sicurezza. Il RIS ha anche condotto test reali di
sparo con entrambe le armi usate per uccidere Moro, utilizzando il
munizionamento del campionario di laboratorio.
Ma il fatto più importante è
che, per garantire la sicurezza degli uomini del RIS, si è reso necessario
esplodere i colpi d'arma da fuoco a una distanza dal retro della Renault 4 tale
che tutta la sua parte anteriore sporgeva dal box. Cioè la saracinesca di
chiusura, presente attualmente è dovuta rimanere completamente sollevata nel
corso di tutti i test di sparo, consentendo così la propagazione delle onde
sonore nello stabile. Dopo la sperimentazione effettuata il 4 maggio 2017 in via
Montalcini a Roma, si può quindi concludere che "non si può in modo assoluto
escludere - anche alla luce degli esami balistici - un'azione di fuoco nel box
in questione contro Aldo Moro, anche se essa appare poco probabile sul piano dei
rischi" cui avrebbe esposto il commando e della richiesta rapidità di azione, a
motivo dell'esiguità degli spazi. Il rischio non solo di essere sentiti e
scoperti, ma anche quello non trascurabile di mettere in pericolo l'incolumità
di chi doveva sparare, come dimostra il fatto che il RIS non ha potuto
effettuare i test con la porta del box chiusa per ragioni di sicurezza, volendo
garantire cioè l'incolumità dei suoi operatori dai colpi di rimbalzo. La
necessità di tenere la porta saracinesca aperta - nonostante l'uso del
silenziatore - ha fatto avvertire, durante l'esperimento dei RIS, il rumore
delle espulsioni, come era facile prevedere, "soprattutto nei locali più vicini,
cioè quelli dell'androne e lo spazio esterno, e cioè i luoghi dove che, su un è
maggiormente ipotizzabile il rischio di passaggio di inquilini", anche
nell'orario indicato dai brigatisti, le 6.30 del mattino, in cui non sono pochi
quelli che già escono da casa per arrivare in tempo sul posto di lavoro.
Via Montalcini, la prigione
"ufficiale" (ed unica) di Moro. L'appartamento di via Montalcini venne a
definirsi come "prigione ufficiale" di Moro, attraverso un complesso processo
testimoniale che si sviluppò almeno per tutti gli anni '80 (il primo sopralluogo
di Valerio Morucci e Adriana Faranda con i magistrati romani Rosario Priore e
Ferdinando Imposimato avvenne il 17 giugno 1985). Il covo di via Montalcini
divenne così una delle architravi del "perimetro" della "verità accettabile" e
dicibile sul caso Moro prima della caduta del Muro di Berlino. Una "verità" che
però ha lasciato aperti molti interrogativi, sui quali si è sviluppato il lavoro
- che non è stato concluso a causa dell'interruzione anticipata della XVII
legislatura - della Commissione Moro-2. L'opinione pubblica non sa che,
contrariamente a quanto si possa pensare, la sua individuazione emerse
progressivamente e con una certa lentezza, fino a essere "consacrata" nella
sentenza della Corte d'Assise al processo Moro-ter, le cui motivazioni furono
depositate il 12 ottobre 1988. Più di dieci anni dopo il sequestro. La sentenza
riconosceva che "è una verità processuale quella che lo statista sia stato
tenuto in cattività nell'appartamento di via Montalcini n. 8". Ma per
l'identificazione i giudici hanno operato su un piano logico-deduttivo. Si
trattava, come si legge nella stessa motivazione della sentenza, "di una
ricostruzione ex post, sia pure sillogistica, ed è in fondo la ricostruzione che
fanno Savasta, Libera, Morucci e Faranda anche attraverso notizie indirette e
fatti oggetto di rivelazioni da parte della stessa Braghetti e di altri. Il
sillogismo è il seguente: Gallinari e Braghetti convivono dal 1977. Gallinari e
una donna gestiscono la "prigione del popolo" dove è custodito Moro ed il primo
esegue anche la condanna a morte dello statista. Ergo, la casa dove è tenuto in
cattività Moro è l 'appartamento di via Montalcini, preso in locazione per
l'Organizzazione dalla Braghetti, estremamente compartimentato a tutti gli altri
brigatisti che ne vengono a conoscenza soltanto dopo la scoperta". Lo stesso
Morucci ha dichiarato di non essere stato mai in via Montalcini durante il
sequestro Moro.
Aldo Moro fu davvero rapito
in via Fani?
Scrive l'11 maggio 2018 Rita Di Giovacchino, Giornalista e scrittrice, su "Il
Fatto Quotidiano". Aldo Moro fu davvero rapito in via Fani? Prendo spunto da una
lettera pubblicata oggi da Il Fatto Quotidiano per rispondere all’interrogativo
posto da Ugo Mattei. Primo, basilare interrogativo dei tanti che ancora
avvolgono i misteri sulla fine del presidente della Democrazia cristiana. Il
professore pone “due quesiti e un dubbio”. Come mai Moro non è stato ucciso o
perlomeno ferito dalla gragnuola di colpi sparati in via Fani contro la Fiat
130, come gli è stato possibile uscire illeso da quel volume di fuoco che è
costato la vita ai suoi cinque agenti di scorta? E come mai, pur essendo legato
da grande amicizia e affetto agli uomini che quotidianamente proteggevano la sua
vita, nelle tante lettere pubbliche e private che ha scritto nei 55 giorni della
sua prigionia, non parla mai del loro sacrificio cui pure avrebbe assistito
prima di essere prelevato e portato via? La logica deduzione di Mattei è che
Moro non era in via Fani e non è mai salito sulla 130 crivellata dai colpi, più
semplicemente è stato rapito “prima”, fatto salire su un’altra vettura da
“qualcuno” che lo aveva avvisato del pericolo imminente. Aggiungo, quel qualcuno
che doveva avere il volto rassicurante di un uomo delle istituzioni.
Diversamente da quanto afferma il professore la questione è stata posta più
volte nel corso delle indagini, pur essendo talmente imbarazzante per le
soluzioni che sottendeva da non essere mai stata troppo divulgata. Sono quesiti
e dubbi che ho coltivato anche io, come cronista presente in via Fani il 16
marzo 1978 e negli approfondimenti successivi da me fatti in articoli e libri,
senza arrivare ad alcuna certezza e tuttavia collezionando vari tasselli che ora
cercherò di mettere in fila. Qualora fosse esatta l’ipotesi di Mattei, il “vero”
rapimento di Aldo Moro non può che essere avvenuto nella chiesa di Santa Chiara
dove attorno alle 8 quella mattina il presidente si era recato prima di
dirigersi a Montecitorio per affrontare la prova più importante della sua vita
politica: il varo di un governo con l’appoggio esterno del Pci che dava vita a
quel “compromesso storico” che era stato (negli ultimi tempi) il suo obiettivo
primario. La testimonianza (da me raccolta quel giorno) di una signora che –
affacciata alla finestra della sua casa in via Fani – si disse convinta di aver
visto Moro scendere dalla Fiat 130 mi impedisce di accettare in toto tale
ipotesi, anche se non l’ho mai scartata del tutto ben sapendo quanto poco siano
attendibili le testimonianze di persone che si trovano ad assistere ad eventi
tanto devastanti. Ma nella chiesa di Santa Chiara qualcosa di molto importante
quel giorno è successo, ne sono certa. Lo prova il fatto che il caposcorta – il
maresciallo Oreste Lonardi – decise di imboccare proprio il percorso che
conduceva in via Fani, che pure non era il più logico e neppure il più rapido
per arrivare in centro, cadendo nel tranello di passare proprio dove
l’agguato era stato preparato nei giorni precedenti e dove erano già ad
attendere Moro una ventina o più di killer tra cui “anche”
alcuni brigatisti, come ha scritto di recente
la commissione di Giuseppe Fioroni nella relazione finale. Quel “anche” basta a
far capire il ruolo subalterno dei terroristi delle Brigate rosse rispetto ad
altre entità presenti sul posto. Ma ciò conferma anche che quel “qualcuno” – che
potrebbe aver prelevato Moro nella chiesa di Santa Chiara e/o aver ordinato al
maresciallo Lonardi di passare in via Fani – non poteva che essere un
suo diretto superiore, ben conosciuto dal responsabile della scorta di Moro che
non avrebbe mai consegnato il presidente a chi si fosse presentato con un
semplice distintivo e neppure avrebbe mutato il percorso che come sempre
decideva all’ultimo momento senza neppure anticiparlo ai suoi uomini. Ho molto
elucubrato su quale argomento possa essere stato usato per convincere Lonardi e
alla fine mi sono convinta che possa essere stato l’allarme lanciato da Radio
Città futura pochi minuti prima con cui si annunciava la possibilità che Moro
potesse essere rapito, spacciato dal “qualcuno” come conferma di voci raccolte
in ambienti estremisti. Quel poco che sappiamo è che in via Fani c’era il
colonnello Camillo Guglielmi, responsabile dei reparti di sbarco e assalto
di Capo Marrargiu. Sappiamo anche che con tutta probabilità Lonardi era stato
addestrato nella base sarda degli apparati Gladiodella Nato come altri
sottufficiali destinati alla protezione di alte personalità politiche. Nessuna
conferma ufficiale, soltanto dubbi e deduzioni. Il colonnello Guglielmi è morto
prima della conclusione del primo processo. Una dipartita salutata con un gran
funerale che ebbe molta risonanza, quasi a sottolineare l’estraneità
dell’ufficiale agli eventi cui aveva accidentalmente assistito nonché la
definitiva chiusura di una vicenda processuale oltremodo imbarazzante...A questi
tasselli ne va aggiunto un ultimo che lungi dal chiarire la scena
criminis del rapimento Moro allunga nuove, gravissime ombre. L’ultima perizia
balistica sull’uccisione dei cinque agenti di scorta ordinata dalla commissione
Fioroni sancisce che a tutti fu inflitto il colpo di grazia, quasi a scongiurare
la loro sopravvivenza. Che interesse potevano avere i brigatisti rossi a un
simile ulteriore massacro? Gli agenti erano tutti o morti o gravemente feriti,
non più in grado di reagire aprendo il fuoco contro di loro. Il successivo
dubbio è che quel “qualcuno” dovesse eliminare il rischio della sopravvivenza di
un testimone in grado di raccontare cosa era davvero accaduto nella chiesa di
Santa Chiara.
Caso Moro: la domanda più
assordante,
scrive Giovedì 03/05/2018 "Ladige.it". Dalla “prigione del popolo”, la lettera
di Moro a Benigno Zaccagnini, lo “Zac – Zac” delle folle democristiane di quasi
mezzo secolo fa, è la sintesi di una tragedia che si sta compiendo. “Siamo quasi
all’ora zero: mancano più secondi che minuti, siamo al momento dell’eccidio”.
Oggi sembra impossibile che fra il marzo e il maggio del 1978, nell’Italia del
benessere dove quasi ogni famiglia aveva l’automobile, quasi tutte il
frigorifero, il telefono, la lavatrice, ovviamente il televisore anche se
comperato a rate, si era costretti a vivere nella sciagurata morsa del
terrorismo politico crescita a dismisura dopo la strage di Piazza Fontana del
dicembre del 1969. L’arcitaliano Giorgio Bocca aveva scritto, raccontando la
guerra partigiana “la pietà è morta”; Moro scrisse: “Dev’essere chiaro che,
politicamente, il tema non è quello della pietà umana, pur così suggestiva, ma
dello scambio di alcuni prigionieri di guerra, o guerriglia come si vuole, come
si pratica dove si fa la guerra, dove si scambia non solo per obiettive ragioni
umanitarie, ma per la salvezza della vita umana innocente”. E ancora: “In questo
modo si reintroduce la pena di morte che un Paese civile come il nostro ha
escluso sin dal Beccaria ed espunto nel dopoguerra dal codice penale come primo
segno di autentica democratizzazione”. Poi il grido di dolore: “Zaccagnini, sei
eletto dal Congresso. Nessuno ti può sindacare. La tua parola è decisiva. Non
essere incerto, pencolante, acquiescente. Sii coraggioso e puro come nella tua
giovinezza”. All’indomani della strage di via Fani quasi tutti i direttori dei
giornali invocando la mobilitazione dell’Esercito e sull’onda delle
dichiarazioni del giornalista e senatore Mario Tedeschi del Movimento Sociale
Italiano che chiedeva il ripristino della pena di morte appellandosi al codice
militare, avevano accarezzato, se non invocato, quella tragica scelta, relegata
il primo gennaio del 1948 nella soffitta della storia nazionale, per i
brigatisti assassini. Solo Gianni Faustini, direttore del giornale “Alto Adige”,
aveva scritto un fondo di grande equilibrio: “Le parole sono vane ma il più
grave episodio di guerra civile dalla Liberazione ad oggi richiede che
sentimenti e ragionamenti si affidino pur sempre alla parola, alla possibilità
di dialogo”. Era appena arrivato, attraverso un documento di 25 righe senza
titolo e senza firma pubblicato dal “Popolo”, l’organo ufficiale della
Democrazia Cristiana, il rifiuto della Dc a trattare con i terroristi. Era
quello il documento più drammatico tra i tanti prodotti dal partito dal giorno
della sua fondazione: pur essendo in gioco la vita di Moro si era stabilito che
non era possibile accettare il ricatto delle Brigate Rosse. Un dilemma politico
e un dramma personale; Zaccagnini era da sempre amico di Moro e anche i più
giovani – e fra di loro il giornalista e parlamentare trentino Luciano Azzolini
– erano legati al presidente rapito da un fortissimo sentimento di stima,
rispetto, amicizia. Aveva tentato di rompere il fronte del no Bettino Craxi, il
segretario del Psi, il leader nascente della politica italiana. Aveva deciso di
cercare un’alternativa proponendo a Zaccagnini l’ipotesi di graziare tre
terroristi non condannati per reati di sangue e di eliminare le carceri speciali
pur di riavere Moro vivo. È fra la fine di aprile e i primi giorni di maggio che
diventa intenso il tentativo socialista di arrivare ad una mediazione. Lanfranco
Pace a Franco Piperno, già militanti di Potere operaio, si incontrano più volte
con due brigatisti, Adriana Faranda e Valerio Morucci, “postini” delle Br, cioè
quei personaggi che, ricevuti gli scritti di Moro e i messaggi delle Br, li
collocavano nei punti prestabiliti e poi telefonavano ai giornali per farli
trovare. Molti anni dopo il senatore Giorgio Postal, che agli inizi degli anni
Sessanta era stato segretario della Dc trentina, scriverà sul giornale l’Adige:
“C’è un interrogativo che, quando penso al caso Moro, mi turba profondamente. E’
noto oggi che il Psi di Craxi e Claudio Signorile tentò di salvare la vita di
Moro anche attraverso i massimi esponenti Autonomia operaia” appunto Piperno e
Pace. “Ed è altrettanto noto che questi due ebbero, durante il periodo del
sequestro, un certo numero di contatti e di colloqui con Morucci e Faranda.
Ebbene non è terribile pensare che una semplice segnalazione agli organi di
sicurezza avrebbe potuto portare all’individuazione di Morucci o di Faranda e,
forse, alla scoperta del covo dove Moro era tenuto prigioniero”? È la domanda
più assordante su alcuni misteri, invero molti presunti, che aleggiano su quei
55 giorni. Di certo solo Postal focalizza l’attenzione sugli incontri fra
Piperno e Pace con Morucci e Faranda. Forse i due “postini” non sono mai entrati
nell’appartamento dove era rinchiuso Moro. Ma qualcuno che era in quella casa
incontrò uno o l’altro dei fiancheggiatori per consegnare lettere e documenti:
sarebbe bastato un contatto e, forse, Moro poteva essere salvato.
Tutto quel che non torna
del rapimento di Aldo Moro.
16 marzo 1978 – 9 maggio 1978.
Quaranta anni fa sembra concludersi uno degli episodi più tragici nella storia
della Repubblica. Viaggio in tre puntate nelle molte zone oscure di uno degli
episodi più tragici della storia italiana. Il caso Moro. Ecco tutto quello che
non torna nelle ricostruzioni ufficiali. Errori, omissioni. E bugie, scrive Luca
Longo il 30 Aprile 2018 su "L’Inkiesta". Tragico non per il numero di morti: gli
eventi di quegli anni ci hanno rapidamente portato a confrontarci con stragi a
due cifre come gli 85 caduti per la bomba fascista di Bologna. Tragico perché
quegli eventi fecero fallire il tentativo di avviare il Paese verso una vera
democrazia dove due forze contrapposte potessero liberamente confrontarsi ed
ambire a guidare l’Italia sulla base dei risultati delle urne e non del trattato
di Yalta. Se avesse avuto successo il tentativo di quegli anni – Moro lo
chiamava “democrazia operante”, Berlinguer “compromesso storico” - entrambi i
maggiori partiti di allora avrebbero subito una evoluzione ideologica che li
avrebbe portati oltre i vincoli delle rispettive alleanze (e dipendenze) dalle
due superpotenze mondiali. L’Italia avrebbe rotto unilateralmente il trattato di
Yalta, che prevedeva l’obbligo di mantenerla ancorata al di qua della cortina di
ferro a prescindere dai risultati dalla volontà popolare. Il Paese sarebbe
veramente passato dalla Prima Repubblica ad una seconda fase: chiamiamola
Repubblica 2.0 per non confonderla con la Seconda Repubblica - niente altro che
l’agonia della Prima. Per questo la regia, la conduzione e i depistaggi del caso
Moro non sono stati mai portati alla luce nella loro interezza, nonostante sei
processi, innumerevoli libri ed interviste dei protagonisti e una marea di
sedute delle Commissioni Parlamentari sul caso Moro e sulle stragi degli anni di
piombo. Forse proprio per questo, tanto gli ex brigatisti quanto molti membri
delle Istituzioni si affannano da 40 anni a ripetere in coro che “sul caso Moro
non c’è più nulla da scoprire.” Proviamo a elencare quello che, però, ancora non
torna. Riavvolgiamo di 40 anni il nastro della Storia e organizziamo gli
interrogativi in ordine cronologico. Torniamo indietro al 1978.
Il soggetto. I
brigatisti diranno che scelgono di rapire Moro semplicemente perché Andreotti è
troppo protetto. Circostanza smentita dallo stesso Andreotti che in quegli anni,
tutte le mattine, molto presto e sempre alla stessa ora, va a messa da solo e a
piedi passeggiando per il centro di Roma semideserto.
Il momento. I
brigatisti sosterranno che è un caso che Moro sia rapito proprio mentre si reca
alla Camera per dare la fiducia al quarto governo Andreotti sostenuto da una
complessa maggioranza appoggiata per la prima volta anche dal PCI. Ma non è
verosimile che l’appostamento in Via Fani si sia ripetuto più di una volta. Ad
esempio perché soltanto la notte precedente 16 marzo le BR squarciarono tutte e
quattro le gomme del Ford Transit del fioraio ambulante Antonio Spiriticchio. In
questo modo, solo in quel preciso giorno gli impediscono di piazzarsi – come fa
tutte le mattine – in via Fani proprio in prossimità dello stop all’incrocio con
Via Stresa.
Il modo. La
moglie del maresciallo Oreste Leonardi testimonierà che Moro va a passeggiare
quasi tutte le mattine allo Stadio dei Marmi accompagnato dal solo caposcorta.
E’ quindi inutile fermare due auto a tutta velocità e con cinque militari a
bordo quando è più semplice prelevarlo nel parco semideserto vincendo la
resistenza del solo Leonardi. Per non parlare dei molti fine settimana trascorsi
da Moro nella casa di Terracina, spesso trascorsi a passeggio sul lungomare.
La vettura blindata. Agli
atti si trovano numerose richieste del caposcorta e di Moro per la concessione
di una vettura blindata. L’ultima commissione stragi il 6 dicembre 2017
ammetterà che sarebbe bastata un’auto blindata, In effetti, il 18 febbraio il
colonnello Stefano Giovannone riferisce che il suo “abituale interlocutore
Habbash” rappresentante del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina,
gli ha parlato di una operazione terroristica di notevole portata che sta per
scattare in Italia. La segnalazione da Beirut con intestazione “Ufficio R,
reparto D, 1626 segreto”, “fonte 2000” è agli atti.
Spinella troppo tardi. Il
capo della DIGOS Domenico Spinella, contattato da Nicola Rana, collaboratore di
Moro, la sera del 15 marzo si reca dal Presidente DC per concordare
l’istituzione di un servizio di vigilanza presso lo studio di via Savoia.
Spinella decide anche di attivare il servizio il 17 marzo. Ma la sua relazione
al Questore di Roma (“relazione post-datata” la definirà il presidente della
Commissione Moro, Sergio Fioroni) arriverà solo undici mesi dopo: il 22 febbraio
1979. Spinella questa volta arriva troppo tardi, ma il giorno dopo arriverà
troppo presto e in un episodio precedente non arriva per niente. Ne parliamo fra
poco.
Radio Città Futura. Renzo
Rossellini, direttore di Radio Città Futura parla ai microfoni del sequestro di
Aldo Moro circa tre quarti d’ora prima del rapimento: ma la magistratura viene
informata della trasmissione solo il 27 settembre 1978, quando lo rivela
Famiglia Cristiana. Il vice questore Umberto Improta conosce personalmente
Rossellini: lo stesso Vittorio Fabrizio, allora funzionario della DIGOS,
riferirà alla Commissione che c’era da tempo un “rapporto privilegiato”. Radio
Città Futura e Radio Onda Rossa - le seguitissime emittenti del movimento
antagonista romano – in quel periodo sono sistematicamente ascoltate da una
struttura di monitoraggio informale della Polizia. Secondo la testimonianza del
funzionario Riccardo Infelisi, cugino del magistrato, sentito della Commissione,
lo stesso questore De Francesco è estremamente sensibile all’ascolto delle
Radio. Ma proprio quella frase di Rossellini … scappò. Per Vittorio Fabrizio, è
impossibile che non sia stata ascoltata e non sia “stata portata subito a
conoscenza del dirigente dell’ufficio politico”. Cioè di Domenico Spinella, di
cui riparleremo ancora più oltre.
La direzione di fuoco. I
terroristi diranno sempre che il gruppo di fuoco sbuca da dietro le siepi del
Bar Olivetti attaccando le due auto del presidente DC dal loro fianco sinistro
all’incrocio fra via Fani e via Stresa. Ma l’agente Raffaele Iozzino esce
dall’auto sul lato destro e viene ucciso da sei colpi provenienti sempre dal
lato destro della strada.
I vestiti da personale di
volo Alitalia. Dalle
siepi del bar Olivetti sbucano quattro uomini vestiti con finte uniformi
Alitalia. La maggior parte delle ricostruzioni frettolose parla di uniformi da
avieri, il personale di terra dell’Aeronautica Militare, che sono ben diverse. I
travestiti sono i brigatisti Morucci, Fiore, Gallinari e Bonisioli. Sono loro ad
aprire il fuoco con mitragliatrici e pistole. Le uniformi vengono viste da
diversi testimoni e uno dei terroristi perde pure il berretto e lasciandolo a
terra. Perché scegliere uniformi così appariscenti che li renderanno facilmente
identificabili se qualcosa andrà storto? Una spiegazione ragionevole è che non
tutti i terroristi si conoscano e abbiano scelto quelle uniformi proprio per non
spararsi addosso.
L’aviere biondo. Armida
Chamoun, residente in Via Gradoli 96 - dove si scoprirà il covo BR -
testimonierà al magistrato Antonia Giammaria che in quell’appartamento in quei
giorni c’è anche un uomo biondo "con gli occhi di ghiaccio". Il 16 marzo lo vede
uscire vestito da aviere. Nessuno dei BR arrestati ha i capelli biondi e gli
occhi azzurri. In via Gradoli verrà ritrovato l'elenco con gli acquisti fatti
per ottenere i vestiti Alitalia. In testa all'appunto una intestazione: "Fritz".
Anna Laura Braghetti sosterrà che “Fritz” era il nome in codice con cui
identificavano Moro stesso.
Ne manca uno. Moretti
affermerà di essere stato solo sulla 128 che taglia la strada alle auto di Moro,
ma il testimone Alessandro Marini dichiara alla Polizia poche ore dopo di aver
visto un secondo uomo scendere dal sedile del passeggero della 128 e fare fuoco
sulla 130 di Moro da destra, cioè dalla parte opposta rispetto al gruppo di
fuoco “ufficiale”.
I bossoli sul lato
sbagliato della strada. I
bossoli vengono raccolti anche sul Iato destro della strada, vicino alla 128 e
tra questa e l’incrocio.
Morucci non convince.
Nel 1987, al processo Moro ter, Morucci dice: "Poiché si erano inceppati i due
mitra che dovevano sparare, usarono la pistola e probabilmente uno di questi
girò intorno alla macchina portandosi quasi all'angolo con via Stresa" e
sparando dal lato destro contro l'agente lozzino. Questa versione è ancora meno
convincente. Sembra poco credibile che qualcuno aggiri l'AIfetta della scorta
mentre è in pieno svolgimento l'azione per annientare i cinque militari correndo
il rischio di incappare in una pallottola del proprio commando.
Le risultanze della perizia
balistica. I
periti incaricati, Jadevito, Ugolini e Lopez, nella perizia depositata il 19
gennaio 1979 scriveranno che le traiettorie dei proiettili dimostrano che a fare
fuoco dalla parte dell’incrocio sono due killer, uno uscito dal lato sinistro ed
uno da quello destro della 128 usata per bloccare le auto del presidente.
I Brigatisti negano. Tutti
i brigatisti arrestati, soprattutto Moretti e Morucci, diranno più volte che non
c’è nessuno sparatore sulla parte destra di Via Fani perché riceverebbe addosso
i colpi dei quattro brigatisti che sparano dal lato sinistro dove si trova il
Bar Olivetti. Ma il maresciallo Leonardi, sul sedile del passeggero anteriore
della 130 di testa, si gira a sinistra per cercare di fare abbassare Moro e
viene colpito più volte sul fianco destro. Dal lato dove non si troverebbe
nessuno degli assassini.
Il gruppo di fuoco. Secondo
le ricostruzioni e sulla base delle testimonianze confermate più volte dagli
stessi protagonisti, partecipano all’agguato solo nove persone, di cui solo
cinque fanno fuoco. Rita Algranati, piazzata all’inizio di Via Fani, solleva un
mazzo di fiori per dare il segnale dell’arrivo del corteo e scappa su un
ciclomotore uscendo di scena. Sull’incrocio con Via Stresa c’è Barbara Balzerani
vestita da poliziotto con in mano una paletta per bloccare le auto in arrivo.
Moretti ha accostato la Fiat 128 con targa diplomatica al marciapiede 200 metri
prima dell’incrocio, sempre in Via Fani e prima di Via Sangemini. Quando vede il
segnale nello specchietto esce di scatto, si pone davanti al corteo e inchioda
davanti all’incrocio tagliando la strada alla Fiat 130 con a bordo il
presidente. Morucci e Fiore mirano a questa con colpi singoli facendo attenzione
a non colpire Moro. Intanto Gallinari e Bonisioli spararono a raffica sulla
Alfetta di scorta che la segue. E quando i mitragliatori si inceppano, i due
brigatisti tirarono fuori le pistole. Moretti esce dalla 128 e fa fuoco sulla
130. Intanto, alcuni passi indietro lungo Via Fani, Alessio Casimirri e Alvaro
Lojacono escono da una 128 bianca restano pronti a intervenire. Barbara
Balzerani si trova in Via Stresa su una 128 blu, sull’altro lato di via Stresa
c’è Bruno Seghetti su una Fiat 132 blu.
I proiettili. In
via Fani vengono rinvenuti gli 89 bossoli dei brigatisti e i 2 esplosi in
risposta dall’agente Iozzino, vengono uccisi tutti i membri della scorta ma
Moro, al centro della strage, rimane illeso. Si scoprirà che le munizioni – con
un trattamento superficiale protettivo e senza matricola – provengono da un
arsenale militare come quelli in dotazione a Gladio: i “depositi Nasco”.
Le armi. In
quei tre minuti - secondo la perizia effettuata nei giorni successivi - sparano
sei armi: una pistola Smith&Wesson calibro 9, che esplode 8 colpi; una pistola
Beretta M51 o M52, 4 colpi; una pistola-mitra FNA-B 1943, 22 colpi; una
pistola-mitra Sten oppure FNA-B 1943, 49 colpi; una pistola mitra TZ-45, 5
colpi; una pistola-mitra Beretta M12 che spara solo 3 colpi.
Le armi (bis). La
seconda perizia verrà condotta nel 1993 dagli ingegneri Domenico Salza e Pietro
Benedetti e si rende necessaria perché nei giorni successivi l’agguato sarà
rinvenuto piantato nel bagagliaio dell’Alfetta di scorta uno strano proiettile
calibro 9 corto incompatibile con tutte le armi ipotizzate nella prima perizia.
Si scopre che quei 49 colpi non vengono da uno ma da due mitra FNA-B 43. La
seconda perizia esclude anche la presenza di una settima arma perché stabilirà
che il proiettile 9 corto identificato in seguito viene esploso da una delle
armi poi sequestrate - erroneamente caricata - che si inceppa al momento dello
sparo del proiettile sbagliato. Questa nuova versione stabilisce che il primo
mitra FNA-B spara 19 proiettili; il secondo FNA-B, 15; la Beretta M12, 1
proiettile; il TZ-45, 5; la Smith&Wesson, 5; la Beretta M51 o M52 solo 2. Il
problema non è tanto la suddivisione dei colpi fra armi compatibili fra loro:
comunque ricalcoliamo i bossoli ed i proiettili cercando di assegnarli alle
varie armi, il conto proprio non torna.
Il caricatore del mitra
FNA-B. Non è
chiaro chi impugna il mitra FNA-B che spara 49 colpi. L’arma risalente alla
seconda guerra mondiale può sparare 400 colpi al minuto ed è in teoria possibile
che un esperto riesca a tirare tutti quei colpi prendendo la mira in direzioni
diverse – su più agenti distribuiti su due auto – in poco più di una decina di
secondi. C’è un problema. I suoi caricatori possono contenere 10, 20, 30 o 40
colpi, quindi per spararne 49 occorre un cambio di caricatore in piena azione.
Di questa possibile sostituzione non parla nessuno dei brigatisti, ne’ dei
testimoni.
Il killer professionista. 26
anni dopo, in un’intervista, il fondatore delle BR Alberto Franceschini dirà:
“un’operazione di grande portata come quella del sequestro Moro non la fai se
non hai qualcuno alle spalle che ti protegge. Ai miei tempi, noi militarmente
eravamo impreparati. Io conosco quelli che hanno portato a compimento
l’operazione: gli unici ad avere un minimo addestramento potevano essere Morucci
e Moretti. Ma secondo me c’era una situazione generale di protezione, un
contesto di cui erano consapevoli solo uno o due dell’intero commando”. E
ancora: “Nel sequestro Moro furono utilizzate tecniche che non avevano nulla a
che fare col nostro tipo di azione.”
I proiettili vaganti. L’Ing.
Benedetti nel 2003 confermerà che per i 91 bossoli complessivamente recuperati,
vengono ritrovate solo 68 pallottole. I colpi di un’arma automatica a canna
lunga viaggiano a 380 m/s, ipotizzando che rimbalzino su un’auto o sulla strada,
dopo il primo urto possono ancora volare lontano. In teoria, qualcuno dei colpi
potrebbe essere finito disperso, ma la maggior parte dovrebbero trovarsi nelle
vetture, nei corpi, sul muro di fronte al bar o nell’asfalto. Tutta l’area è
stata setacciata più volte, ma sono sparite per sempre un quarto delle
pallottole esplose in Via Fani.
Il colonnello Guglielmi. In
Via Stresa all’incrocio con Via Fani - a pochi metri dall’agguato - si trova il
colonnello Guglielmi del SISMI – la VII divisione che controlla Gladio – alle
dirette dipendenze del generale Musmeci (P2, implicato per vari depistaggi e poi
condannato per quello della Strage di Bologna). Giustifica la sua presenza in
quel posto esatto “perché stavo andando a pranzo da un amico”. Erano passate da
poco le nove di mattina.
Il Bar Olivetti. Nel
2015 alcuni testimoni dichiareranno che il bar non è affatto chiuso quel giorno,
come invece hanno assunto tutte le indagini nel corso dei 37 anni successivi.
Alcuni testi giurano di aver preso il caffè o di aver usato il telefono proprio
nella mattina del 16. La possibilità che il bar sia aperto al pubblico il 16
marzo - nonostante fosse giuridicamente in liquidazione - introduce altri dubbi
sulla dinamica dell'agguato descritta dai brigatisti. Questi sosterranno di aver
atteso l'arrivo delle auto di Moro nascosti dietro le fioriere prospicienti il
bar. Ma le fioriere possono offrire un riparo poco efficace a più persone
destinate ad aspettare per un lasso di tempo non trascurabile, tanto più se
vestite da personale Alitalia, con borse contenenti diverse armi e – soprattutto
– avendo alle spalle le vetrine di un bar affollato. In tutte le immagini
scattate da media e forze dell’ordine dopo l’attentato, il Bar Olivetti ha le
saracinesche abbassate.
Olivetti e i Servizi. Tullio
Olivetti, proprietario del bar, è già noto alla magistratura. Accusato di
traffico internazionale di armi, rapporti con la criminalità organizzata, con la
mafia e riciclaggio di 8 milioni di marchi tedeschi, è l’unico a uscire pulito
da tutte le indagini. La Commissione Moro scrive "che la sua posizione
sembrerebbe essere stata 'preservata' dagli inquirenti e che egli possa avere
agito per conto di apparati istituzionali ovvero avere prestato collaborazione".
Nella relazione si aggiunge che la sua posizione “impone ulteriori accertamenti
sull’ipotesi che fosse un appartenente o un collaboratore di ancora non meglio
definiti ambienti istituzionali; sarebbe, infatti, circostanza di assoluto
rilievo verificare un’eventuale relazione tra i Servizi di sicurezza o forze
dell’ordine e Tullio Olivetti, titolare del bar di via Fani, 109.”
La Morris nel posto giusto. Proprio
all’incrocio, a soli sei metri dallo stop e a ben 80 cm dal marciapiede destro,
è parcheggiata una Austin Morris targata RM T 50354. Proprio l’ingombro prodotto
da quell’auto ha bloccato la manovra di svincolo più volte tentata da Ricci alla
guida della 130 di Moro. Morucci riconoscerà al processo che “la presenza
casuale della Morris fu fatale”. La Morris è stata acquistata un mese prima
dalla società immobiliare Poggio delle Rose con sede a Roma in Piazza della
Libertà, 10; lo stabile nel quale si trova l’Immobiliare Gradoli spa,
proprietaria di alcuni appartamenti di Via Gradoli, 96 e gestita da fiduciari
del Servizio Segreto civile. La presenza “casuale” della Morris risulta decisiva
anche per coprire chi spara da destra almeno due raffiche dirette contro
l’Alfetta e quindi dalla parte opposta al gruppo di fuoco principale. Non
risulta sia mai stata analizzata nei processi.
La moto Honda. L’ingegner
Alessandro Marini – che è fermo all’incrocio a pochi metri dall’agguato e
accorre verso le auto - viene fermato da due giovani su una moto Honda blu. Il
passeggero gli scarica addosso un piccolo mitra. Marini si salva perché cadde a
terra mentre arrivava la raffica. Tre testimoni confermano le sue parole.
L’ingegnere segnala l’episodio solo pochi minuti dopo la strage consegnando lo
stesso caricatore caduto al passeggero della moto. A terra, quindi, rimangono
anche i bossoli dell’ottava arma a fare fuoco in via Fani, dopo le sei
“ufficiali” e quella di Iozzino. Questa non sarà mai identificata e il
caricatore non è mai stato confrontato con i mitra successivamente trovati nei
vari covi. Non è chiaro se la mitragliata su Marini abbia realmente rotto il
parabrezza del ciclomotore su cui si trovava l’ingegnere.
Un’altra moto. La
Commissione Moro nel 2015 ascolterà due testimoni oculari, mai sentiti in
precedenza. Giovanni De Chiara abita in via Fani 106 e vede allontanarsi a
sinistra, su via Stresa, una motocicletta con a bordo due persone, delle quali
una ha appena sparato verso qualcuno. Eleonora Guglielmo - allora “ragazza alla
pari” presso l’abitazione di De Chiara – sente grida “achtung, achtung” e vede
una motocicletta di grossa cilindrata che parte, seguendo un’auto sulla quale
era stato spinto a forza un uomo, dirigendosi da via Fani in direzione opposta
verso via Stresa. La motocicletta ha a bordo due persone; il passeggero ha
capelli scuri, con una pettinatura a chignon e un boccolo che scende, per questo
la Guglielmo ritiene che sia una donna.
Alessio Casimirri e i due
sulla Honda. Mentre
all’incrocio si scatena la sparatoria, il tratto precedente di Via Fani è
presidiato dai brigatisti Casimirri e Lojacono. Si trovano, quindi, proprio nei
pressi della misteriosa Honda. Casimirri dopo l’agguato porta le armi a Raimondo
Etro perché le nasconda e le custodisca. A tutt’oggi solo Etro, fra tutti gli ex
BR, ha ammesso la presenza della moto. Mentre consegnava le armi, proprio
Casimirri gli parla di «due in moto», non previsti, e li definisce «due
cretini». Oltre al capo delle Br, chi potrebbe conoscere il segreto della moto è
Casimirri, che però non sarà mai stato arrestato ed è latitante dal 1982 in
Nicaragua. La commissione Moro recupererà un documento del 1982 da cui risulta
che viene fermato dai carabinieri, ma stranamente rilasciato. Lo stesso Etro,
che è suo amico e scapperà con lui, sospetterà sempre una fuga favorita dai
servizi.
Anche Lojacono la farà
franca. Nel
processo Moro quater la giustizia italiana condannerà Lojacono all'ergastolo in
contumacia per aver bloccato via Fani con Casimirri, intrappolando le auto di
Moro (sentenza confermata nel 1997). Ma Lojacono, di madre svizzera, prende la
residenza in Canton Ticino perché il diritto svizzero non prevede estradizione
per i propri cittadini. I due brigatisti di copertura di Via Fani sono gli unici
due brigatisti noti a non aver scontato nemmeno un giorno di carcere per i sei
omicidi della vicenda Moro ma gli unici che, insieme all’irriducibile Moretti,
potrebbero dirci qualcosa della Honda.
L’ispettore Rossi. Nel
2012 l’ex ispettore Enrico Rossi della DIGOS racconterà di una lettera anonima
ricevuta nel 2009 da un quotidiano. Lo scrivente dirà di essere il passeggero
della moto e di aver dato disposizione di spedire quella lettera sei mesi dopo
la sua imminente morte per cancro. Sosterrà di essere stato alle dipendenze del
colonnello Guglielmi insieme all’altro agente ai comandi della moto “proveniente
da Torino”. Rossi dichiarerà di essere riuscito a identificare entrambi sulla
base degli elementi concreti forniti dall’anonimo. “Sono riuscito a rintracciare
nel 2011 gli uomini sulla Honda ma mi fermarono. E non sono riuscito ad
interrogare quello che era alla guida”.
Le minacce telefoniche. Marini
si trasferirà all’estero in seguito alle minacce di morte che gli arrivano a
partire dalla sera stessa dell’agguato. Poco probabile che i brigatisti riescano
ad individuare il numero di telefono di casa del testimone scomodo dopo solo
poche ore e mentre sono impegnati a coprire la fuga e a occultare il
prigioniero.
La ‘ndrangheta calabrese. Il
primo a parlare di complici esterni è un super pentito della ’ndrangheta,
Saverio Morabito, arrestato in Lombardia nei primi anni ’90. Le sue confessioni
hanno permesso al PM milanese Alberto Nobili e alla Direzione investigativa
antimafia di ottenere più di cento condanne nel maxi-processo “Nord-Sud”.
Morabito, giudicato nelle sentenze «di assoluta attendibilità», rivelerà che un
mafioso importante, Antonio Nirta, negli anni ’70 aveva legami inconfessabili
con un carabiniere di origine calabrese, Francesco Delfino, poi diventato
generale dei Servizi. Il pentito ne parlerà con paura e aggiungerà che il suo
capo, Domenico Papalia, gli avrebbe rivelato che «Nirta fu uno degli esecutori
materiali del sequestro Moro»: un segreto di mafia confermatogli anche dal boss
Francesco Sergi.
Il trasferimento. Secondo
una testimone, dopo la tempesta di fuoco, il trasferimento di Moro sull’auto dei
brigatisti avviene con calma surreale. Gherardo Nucci, giornalista ASCA, fa a
tempo ad affacciarsi sulla terrazza al 109 di Via Fani (sopra il Bar Olivetti)
rientrare per prendere la macchina fotografica, uscire di nuovo e scattare
dodici foto della scena.
Le foto di Nucci. Il
rullino viene consegnato alla magistratura dalla moglie del giornalista. Non se
ne troverà più traccia.
La ‘ndrangheta rimette
tutto a posto.
Nonostante si tratti di terrorismo politico di sinistra, e non di un fatto di
mafia, la ndrangheta calabrese è molto interessata alle foto scattate da Nucci.
Ecco uno stralcio delle intercettazioni telefoniche effettuate sul telefono di
Sereno Freato in contatto con l'On. Benito Cazora, incaricato dalla DC di tenere
i rapporti con la malavita calabrese per cercare di avere notizie sulla prigione
di Moro. Cazora: Un'altra questione, non so se posso dirtelo. - Freato: Si, si,
capiamo. - Cazora: Mi servono le foto del 16, del 16 Marzo. - Freato: Quelle del
posto, lì? - Cazora: Si, perchè loro... [nastro parzialmente
cancellato]...perché uno stia proprio lì, mi è stato comunicato da giù. -
Freato: E' che non ci sono... ah, le foto di quelli, dei nove - Cazora: No, no!
Dalla Calabria mi hanno telefonato per avvertire che in una foto preso sul posto
quella mattina lì, si individua un personaggio... noto a loro. - Freato: Capito.
E' un po’ un problema adesso. - Cazora: Per questo ieri sera ti avevo
telefonato. Come si può fare? - Freato: Bisogna richiedere un momento, sentire.
- Cazora: Dire al ministro. - Freato: Saran tante! – Detto, fatto. Foto sparite.
La ‘ndrangheta può stare tranquilla.
Le foto di Gualerzi. A
metà di via Stresa e a 50 metri dall’incrocio con Via Fani, si affaccia il
negozio dell’ottico Gennaro Gualerzi. Questi vede sfrecciargli davanti una 128
scura con a bordo persone che si stanno togliendo la giacca, sente delle grida,
prende al volo una macchina fotografica ed esce di corsa scattando 11 fotografie
entro le 09:15. L’esistenza delle foto è indicata per la prima volta in un
rapporto del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Via Trionfale agli atti della
Prima Commissione Moro. È un sommario del verbale rilasciato la mattina del 16
marzo dall’ottico (il nome indicato è sbagliato: “Gualersi”). Sono riportate 11
foto ma vengono corrette a penna in 16. Queste spariscono subito dopo la
consegna ai Carabinieri e vengono ritrovate solo nel maggio 2017.
Il mafioso. Tra
le foto di Gualerzi compare Giustino De Vuono lo "scotennato". Il volto su
questa immagine inedita sembra perdersi tra la folla ma di seguito si può vedere
il suo ingrandimento a confronto con le poche immagini ufficiali che lo
riguardano, inclusa quella che lo raffigura su alcuni documenti del Paraguay nei
quali compare il riferimento all'accusa per i reati di sequestro e omicidio
della scorta di Moro.
Un altro mafioso. In
un’altra foto di Gualerzi spunta - proprio davanti al Bar Olivetti - un altro
noto mafioso: Antonio Nitra, detto “due nasi”.
Altri rullini scomparsi.
La lista dei rullini scomparsi è inarrestabile: solo il 21 gennaio 2016 il
Messaggero pubblica una foto inedita scovata fra i faldoni del processo per
l’omicidio Pecorelli. Si parla anche di alcune foto a loro volta sparite dagli
uffici della Procura che ritraggono parte del commando proprio durante l’azione,
ma non è chiaro chi le abbia scattate o se siano mai esistite. Altri rullini
vengono poi rinvenuti da una abitante della zona nel proprio giardino e da
questa consegnate a un agente in borghese. C’è la testimonianza ma non se ne ha
più traccia. Il giornalista Diego Cimara riferisce alla Commissione Moro
dell’esistenza di altri rullini, poi scomparsi, ma anche su questo non ci sono
altri elementi. Infine un’altra serie – inutile dirlo, scomparsa - di cui
Antonio Ianni ha parlato alla stessa Commissione. Ianni è il primo fotografo
arrivato sul posto. Scatta tre rullini quando i corpi non sono ancora stati
coperti. La sera stessa, Ianni rientrando a casa trova la sua abitazione
sottosopra, ma i rullini sono al sicuro: li aveva subito portati alla sede ANSA
di Roma, dove lavora. Nei giorni successivi i rullini e alcune delle foto
sviluppate da questi vengono trafugate direttamente dall’archivio fotografico
dell’agenzia.
Spinella troppo presto. L’allarme
viene diramato dalla questura di Roma alle ore 09:02. Ma Emidio Biancone,
autista del capo della DIGOS Domenico Spinella, ha dichiarato in tre
interrogatori separati che a quell’ora stava già correndo sul luogo dell’agguato
con la Alfasud targata S88162 e Spinella a bordo. L’auto esce dalla Questura di
Roma “poco dopo le 08:30”. Prima dell’allarme generale … ma quasi mezz’ora prima
dell’agguato.
Le due borse. Eleonora
Moro confermerà che suo marito non si separa mai da cinque borse: una con
documenti riservati, una con medicinali e oggetti personali, tre con ritagli di
giornale, libri, tesi di laurea dei suoi studenti. Nell’auto crivellata di colpi
vengono ritrovate solo le ultime tre. Ma i testimoni non notano i terroristi
trasferire anche le due borse “sensibili” insieme a Moro. Inoltre, quando
Eleonora viene portata sul luogo dell’agguato, lei stessa mostra ai carabinieri
che il lago di sangue che aveva inzuppato tutti i tappetini aveva risparmiato
proprio due zone dove evidentemente erano appoggiate le due borse. Sparite,
quindi, quando il sangue si era già rappreso e i brigatisti erano già lontani.
Ancora le borse. Bonisoli
e Morucci si contraddiranno e dal confronto delle loro dichiarazioni non
risulterà chiaro se e chi prelevi le due borse mancanti. Né spiegano con che
criterio scelgono proprio le due borse giuste. La confusione è notevole se si
pensa che dopo l’agguato vengono ritrovate nella 130 solo due delle tre borse
abbandonate. La terza borsa scompare per sei giorni e poi viene fortuitamente
ritrovata durante una nuova perquisizione nel bagagliaio della 130, dove prima
nessuno l’aveva notata. In conclusione, due borse vengono subito ritrovate fra i
sedili della 130, una sei giorni dopo nel bagagliaio e proprio le due con
documenti riservati e oggetti personali scompaiono per sempre.
La pattuglia. Caricato
Moro, i terroristi riescono a dileguarsi grazie ad un’altra sorprendente
coincidenza: una volante della polizia staziona come ogni mattina in Via Bitossi
per proteggere il giudice Walter Celentano. Proprio qui stanno arrivando le auto
dei brigatisti in fuga; ma qualche istante prima, un allarme del Centro
Operativo Telecomunicazioni) fa muovere la pattuglia.
Via Bitossi. Proprio
accanto alla pattuglia in via Bitossi (è lunga in tutto 150 m) è parcheggiato il
furgone Fiat 850T grigio chiaro (in alcune versioni è blu) con la cassa di legno
pronta ad accogliere e nascondere Moro durante il trasferimento. I brigatisti
lasciano il furgone nella via dove si trova la volante perché è a solo 2 km di
strada dal punto dell’agguato. Ma avrebbero potuto scegliere molti altri luoghi
più discreti. Il furgone non verrà ritrovato.
L’appunto. Tra
i reperti sequestrati a Morucci dopo il suo arresto verrà scoperto un appunto
recante il numero di telefono del commissario capo Antonio Esposito (P2), in
servizio proprio la mattina del rapimento. Non c’è alcuna prova che sia stato
Esposito a far togliere di mezzo la pattuglia in Via Bitossi.
La catena. Dopo
aver prelevato Moro, i brigatisti fuggono sulla Fiat 132 blu guidata da Bruno
Seghetti, che da Via Stresa è tornata in retromarcia su Via Fani per prelevare
Moro trascinato da Raffale Fiore. Nascosto l’ostaggio con una coperta, anche
Moretti scende dalla 128 dell’agguato e sale sulla 132 che parte subito in
direzione di Via Trionfale. La Fiat 128 bianca di Casimirri e Lojacono, su cui
sale anche Gallinari, la segue a ruota. Morucci preleva le borse dalla 132 e
sale sulla 128 blu parcheggiata indietro lungo via Fani e su cui sono già saliti
Balzerani e Bonisoli, poi segue le prime due a circa 50 m di distanza. La 128
blu deve aprire il corteo ma si ritrova in coda, supera le altre due ma viene
bloccata in una curva stretta e ritorna in coda. Il commando ha pianificato di
imboccare Via Casale De Bustis, una strada privata bloccata da una sbarra. Qui
si fermano, e dalla 132 scende un brigatista con un tronchese per tagliare la
catena, sollevare la sbarra e risalire in auto. Operazione poco credibile perché
il tronchese dovrebbe essere pronto sulla 128 che avrebbe dovuto mantenersi in
testa e perché la rottura della catena potrebbe richiamare l’attenzione. Inoltre
il corteo potrebbe essere inseguito ed avere solo pochi secondi di vantaggio. Il
superamento della sbarra richiede certamente molti preziosi secondi.
Il cambio. Secondo
gli esecutori, il commando brigatista preleva un gruppo di nuovi mezzi in Via
Bitossi ma tutte le auto usate vengono portate in Piazza Madonna del Cenacolo.
In mezzo alla piazza Moro viene trasferito e chiuso in una cassa nel furgone
Fiat 850T guidato da Moretti che parte seguito da una Dyane azzurra al cui
volante è Morucci. I due mezzi scompaiono. Per portare a termine il sequestro
del più importante uomo politico italiano - e fronteggiare eventuali posti di
blocco - le BR diranno di aver usato solo un furgone e una utilitaria. Ma ad
esempio per rapire Vittorio Vallarino Gancia nella tranquilla strada fra Canelli
e Alessandria, le stesse Br ne avevano usate tre.
Via Licinio Calvo. La
Fiat 132 blu, la Fiat 128 blu e la Fiat 128 bianca usate nella prima parte della
fuga vengono portate tutte e tre a quasi un km dalla Piazza, in via Licinio
Calvo, quindi abbandonate. Il problema è che vengono lasciate in tre momenti
diversi: la 132 viene abbandonata al civico 1 alle 09:23, due testimoni vedono
allontanarsene un uomo e una donna (se è vero, non è mai stata identificata:
Barbara Balzerani era sulla 128 blu). L’auto viene identificata dalle forze
dell’ordine a meno di mezz’ora dal rapimento. Alle 04:10 della notte fra il 16
ed il 17 marzo, la 128 bianca viene identificata sulla stessa via all’altezza
del civico 23. Solo alle 21:00 del il 19 marzo viene individuata, sul lato
sinistro all’altezza dei civici 23 e 25, la Fiat 128 blu, a pochi metri dal
luogo in cui era stata trovata la 128 bianca due giorni prima. Le immagini del
servizio RAI di Piero Badaloni dopo il ritrovamento della prima 128, dimostrano
che l’altra 128 il 18 marzo non c’era ancora. E i verbali di Polizia dichiarano
che tutte le auto in sosta nella via sono state ispezionate dopo ciascuno dei
tre separati ritrovamenti.
Problemi di parcheggio. Via
Licinio Calvo termina con una scalinata che, attraverso via Prisciano, la
collega a Piazza Medaglie D’Oro dove si trovano le fermate di numerosi autobus.
Per questo, molti romani parcheggiano abitualmente proprio in Via Calvo per
prendere l’autobus. Trovare tre parcheggi liberi alle 9:30 di un giovedì
mattina, in una strada sempre affollata – come mostrano anche le immagini della
Polizia dopo i tre ritrovamenti - è un bel colpo di fortuna. Oppure, se
realmente le auto giungono più o meno contemporaneamente come sosterranno i
brigatisti, ad attenderle ci dovrebbero essere altrettante auto con altrettanti
complici pronti a cedere il posto alle macchine dell’agguato. Del resto, il
problema della mancata individuazione di fiancheggiatori, impiegati a guardia di
auto e parcheggi, rimane un aspetto non chiarito di tutta la vicenda.
Fuga solitaria. Secondo
i brigatisti, il furgone prosegue da solo con Moro nella cassa, a bordo Moretti,
Morucci e Seghetti. E’ l’unica volta in cui brigatisti rossi in fuga con un
ostaggio dopo un’azione rimangono solo in tre e su un singolo mezzo. Circostanza
che impedirebbe loro di forzare posti di blocco o gestire eventuali problemi.
Dalla Banda della Magliana
alla seduta spiritica: tutto quello che non torna nella detenzione di Aldo Moro.
Viaggio in tre puntate nelle molte zone oscure di uno degli episodi più tragici
della storia italiana. Il caso Moro. Ecco tutto quello che non torna nelle
ricostruzioni ufficiali. Errori, omissioni. E bugie, scrive Luca Longo il 2
maggio 2018 su "L’Inkiesta".
Un altro luogo affollato. La
cassa di Moro viene scaricata dal Fiat 850T e caricata su una Citroën Ami nel
parcheggio sotterraneo della Standa di Via Colli Portuensi dove li aspetta
Gallinari. Moretti e Gallinari diranno che ripartono sulla Citroën familiare per
portare da soli la cassa di Moro nel covo di Via Montalcini mentre gli altri si
disperdono. Il parcheggio di un supermercato attorno alle 10 di mattina è scelto
proprio per trasferire una grossa e pesante cassa, col rischio che Moro gridi
chiedendo aiuto capendo di trovarsi in un luogo affollato.
Via Montalcini, 8. Appartamento
al piano terra, interno 1, 100 mq completo di giardino, garage e cantina di
proprietà dei coniugi Altobelli: in realtà Anna Laura Braghetti (che lo acquista
l’anno precedente con 50 milioni in contanti consegnati da Moretti) e Germano
Maccari. Secondo tutti i brigatisti, Aldo Moro viene rinchiuso ininterrottamente
dal 16 marzo al 9 maggio 1978 in un cubicolo 2,80 m per 1 m separato dallo
studio con una parete insonorizzata e accessibile da una libreria che ruota su
un cardine. Alla fine del sequestro le BR smantelleranno la parete ma Braghetti
continuerà a vivere lì per ancora un anno, quando - convinta di essere seguita
dalla Polizia - scapperà lasciando alla zia l’incarico di vendere “ma senza fare
sconti”. La zia riesce a rivendere l’appartamento ancora per 50 milioni. Unico
caso noto di un covo terrorista che non viene abbandonato ma rimane in uso per
un altro anno e poi rivenduto per rientrare nelle spese.
Prigionia. Moretti
sosterrà che Moro “scriveva sulle ginocchia su dei cuscini”. Per le pulizie
personali “Quando occorre gli vengono portati dei catini”. “Non ha mai
camminato. Si alza, si sgranchisce le gambe, ma non si è mai mosso da lì
dentro”. L’autopsia accerterà l’assoluta assenza di atrofizzazione degli arti
inferiori e che il corpo di Moro è in una condizione di igiene assoluta, che mal
si concilia con l’affermazione di Moretti circa i catini che gli sarebbero stati
concessi per le sue pulizie personali. Il Sisde, nel luglio 1979, con
registrazione ambientale di una conversazione tra due brigatisti detenuti nel
carcere dell’Asinara, ascolterà che Moro ottiene “tutto quello che (sic) aveva
bisogno: si lavava anche quattro volte al giorno, si faceva la doccia, mangiava
bene, se voleva scrivere scriveva […], è stato trattato come un signore”.
Giovanni Ladu. Bersagliere
di leva, nel 2008 e poi nel 2012 dichiarerà di essere stato, insieme a altri
nove militari in borghese, piazzato in un appartamento adiacente all’Interno 1
per presidiare una stazione di controllo e prendere nota di chi entra e esce
dall’appartamento di fronte. Curioso che si affidi una missione così delicata ad
un soldato di leva. Ladu si giustifica dicendo di essere stato un membro di
Gladio e prosegue dicendo che il 7 maggio arriverà l’ordine di smobilitare.
Verrà indagato per calunnia dalla Procura di Roma.
E l’altra prigione? Una
perizia sul leader democristiano dimostrerà che è stato tenuto prigioniero in
almeno due posti diversi. È uno studio sui reperti sabbiosi rinvenuti sugli
indumenti di Moro e sulle ruote della Renault rossa dove sarà trovato il corpo.
Moretti sosterrà che sono collocati a bella posta nei vestiti e nelle scarpe
dello statista allo scopo di depistare le indagini. Appare poco credibile che in
pieno sequestro, con una città assediata e centinaia di posti di blocco, la
Faranda e la Balzerani vadano a raccogliere sulle spiagge del litorale laziale
“sabbia, catrame, parti di piante da mettere sui vestiti e sotto le scarpe” del
sequestrato per precostituire un depistaggio che acquisterà validità solo dopo
il ritrovamento del cadavere.
I vicini di casa. La
banda della Magliana è come il prezzemolo: compare in tutte le vicende criminali
ma anche in tutti i depistaggi. Lasciando da parte le congetture, è innegabile
che numerosi esponenti abitino proprio nei pressi della prigione di Moro: Danilo
Abbruciati con altri due malavitosi in via Fuggetta 59 (a 120 m dalla prigione;
Danilo Sbarra e Francesco Picciotto, uomo di Pippo Calò, in via Domenico
Luparelli 82, a 130 m (ma a 50 m se si passa dall’ingresso secondario); in via
di Vigna Due Torri, 135 (a 150 m) abita Ernesto Diotallevi, compare di Calò. In
via Montalcini 1 sorge villa Bonelli, appartenente a Danilo Sbarra, di cui Pippo
Calò si serve per riciclare il denaro proveniente da attività mafiose. Se
davvero le BR tengono prigioniero Moro in un luogo sotto il controllo fisico
della banda della Magliana, ci si chiede se Moretti, Gallinari e la Braghetti
ignorino di essere letteralmente circondati dai capi della banda o conoscono
questa circostanza e hanno scelto quel posto proprio perché sanno di poter
contare su una benevola protezione?
La seduta spiritica. Questo
rimane il mistero più famoso: nell’ultimo quarto di secolo è stato continuamente
rilanciato solo per tirare fango addosso a uno dei dodici protagonisti. Secondo
i professori bolognesi, il 2 aprile del ’78 a casa Clò il piattino indicò un
mare di lettere senza significato e anche parole di senso compiuto, come Bolsena
e Viterbo, poi uscì anche Gradoli. La Commissione Moro, acquisita la
testimonianza di tutti i partecipanti, ha concluso che è abbastanza surreale la
tesi che questo sia stato un modo per segnalare il covo di Via Gradoli
preferendolo a un messaggio anonimo perché quest’ultimo si sarebbe perso fra le
migliaia ricevuti in quei giorni dagli inquirenti. Se ambienti dell’Autonomia
bolognese o altri simpatizzanti delle BR fossero venuti a conoscenza del covo,
non avrebbero avuto alcun motivo per segnalarlo collaborando con le Istituzioni.
La loro posizione era riassunta nel famoso slogan “Né con lo stato, né con le
BR.” E se anche avessero avuto un po’ di senso civico, piuttosto che questa
messinscena sarebbe stato più furbo recapitare un messaggio anonimo con
circostanze precise a persone in grado di segnalarlo ai vertici del governo o
della magistratura.
Via Gradoli 96, interno 11,
secondo piano. È
lì che abitano nella primavera del 1978, Mario Moretti e Barbara Balzerani.
Proprio in quel palazzo diversi appartamenti erano di proprietà dei servizi
segreti, intestati a società di copertura ed occupati da personaggi vicini ai
servizi, alle forze dell’ordine e a informatori di polizia e carabinieri. Ma
tutta la zona vede una alta densità di appartenenti ai servizi. Ad esempio al
numero 89 - proprio di fronte al 96 - prima e durante il sequestro Moro abita il
sottufficiale dei carabinieri Arcangelo Montani. E’ un agente del Sismi,
proviene da Porto San Giorgio (quindi è un compaesano di Mario Moretti). Il
regista del sequestro Moro ha trovato un posto ideale per la sua base.
La dirimpettaia. Lucia
Mokbel è l’inquilina della porta accanto all’interno 11: l’appartamento numero
9, dove alloggia col convivente Gianni Diana, impiegato da un commercialista
amministratore di immobili in cui figurano anche società in mano ai servizi
segreti. Mokbel, di origine egiziana, figlia di un diplomatico legato ai Servizi
del suo Paese e conoscente del commissario Elio Cioppa, riferirà alla polizia di
strani ticchettii notturni, tipo alfabeto morse (che la Mokbel conosce),
provenienti dall'appartamento brigatista.
La perquisizione. Secondo
il giudice Luciano Infelisi, immediatamente dopo il sequestro le perquisizioni
per individuare la prigione di Moro si concentrano su tutti i miniappartamenti
ed i residence della zona. Anche Via Gradoli, 96 viene passata al setaccio solo
due giorni dopo, ma all’interno 11 non risponde nessuno e gli agenti se ne
vanno. «Non mi fu dato l’ordine di perquisire le case — riferirà in aula il
sottufficiale Merola — Era solo un’operazione di controllo durante la quale
furono identificati numerosi inquilini, mentre molti appartamenti furono trovati
al momento senza abitanti e quindi, non avendo l’autorizzazione di forzare le
porte, li lasciammo stare, limitandoci a chiedere informazioni ai vicini.
L’interno 11 fu uno degli appartamenti in cui non trovammo alcuno. Una signora
che abitava sullo stesso piano ci disse che lì viveva una persona distinta,
forse un rappresentante, che usciva la mattina e tornava la sera tardi». Ma
Lucia Mokbel - la signora in questione - aggiunge di aver dato il biglietto
proprio ai poliziotti, perché lo consegnassero a Elio Cioppa (poi risultato
iscritto alla P2). Quel biglietto non è mai stato ritrovato.
Gradoli (Viterbo). Fra
le decine di migliaia di perquisizioni in tutta Italia, il 6 aprile viene
effettuato anche un controllo mirato in alcune case coloniche nel comune di
Gradoli (Viterbo), vicino al lago di Bolsena. L'operazione viene compiuta su
segnalazione alla Direzione generale di Polizia tramite il Gabinetto del
Ministro dell'Interno. Il biglietto autografo del 5 aprile, trasmesso al Capo
della Polizia dal dottor Luigi Zanda Loi, capo ufficio stampa del Ministro
Cossiga, contiene non parole smozzicate riferite da un piattino paranormale ma
due precise indicazioni: "Casa Giovoni - Via Monreale, 11 - scala D int. 1 piano
terreno - Milano" e "lungo la statale 74, nel piccolo tratto in provincia di
Viterbo, in località Gradoli, casa isolata con cantina". Le perquisizioni non
daranno alcun frutto.
Il falso comunicato numero
7. Le BR
durante il sequestro fanno trovare 9 comunicati. Il 18 aprile, proprio il
trentennale delle prime elezioni politiche che consegnarono il Paese alla DC, in
Piazza Indipendenza compare il presunto comunicato numero 7. Realizzato dal
falsario Antonio Chichiarelli, della Banda della Magliana, neofascista e
confidente dei Servizi segreti, il falso sostiene che Moro è stato ucciso e
buttato nel Lago della Duchessa, fra Lazio e Abruzzo, dove viene cercato per due
giorni dai sommozzatori anche se la superficie è completamente ghiacciata.
Le BR interpretano il
comunicato taroccato come un falso di Stato e un rifiuto a trattare uno scambio
di Moro coi brigatisti in carcere.
La doccia. Sempre
il 18 aprile, le forze dell'ordine scoprono il covo di via Gradoli, 96. Questo
avviene solo per una perdita d'acqua segnalata ai vigili del fuoco. È provocata
da un rubinetto della doccia lasciato aperto, appoggiato su una scopa e con la
cornetta rivolta verso un muro. Mario Moretti dirà di averne avuta notizia dai
giornali, che la riportano subito. Perciò non vi fa ritorno e sfugge alla
cattura. La polizia, durante la perquisizione, trova anche la targa originale
della 128 bianca usata per il tamponamento di via Fani. Un souvenir.
Le lettere. Moro
scrive 86 lettere durante la prigionia. Sono state esaminate per 40 anni.
Leonardo Sciascia per primo ipotizzerà che nascoste nelle parole di Moro ci
siano indicazioni su dove si trova. «Io sono qui in discreta salute» del 27
marzo, dove indica alla moglie di essere a Roma. «mi trovo sotto un dominio
pieno ed incontrollato, sottoposto ad un processo popolare che può essere
opportunamente graduato» inviata a Cossiga, in cui - col senno di poi - sembra
specificare che si trova in un piano basso sotto un condominio affollato ma mai
controllato che potrebbe essere opportunamente perquisito, e in cui, sempre
rivolto a Cossiga, avverte: «che sono in questo stato avendo tutte le conoscenze
e sensibilità che derivano dalla lunga esperienza, con il rischio di essere
chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e
pericolosa in determinate situazioni.» A buon intenditor…
Via Gradoli 96, interno 11,
secondo piano.
È lì che abitano nella primavera del 1978, Mario Moretti e
Barbara Balzerani. Proprio in quel palazzo diversi appartamenti erano di
proprietà dei servizi segreti, intestati a società di copertura ed occupati da
personaggi vicini ai servizi, alle forze dell’ordine e a informatori di polizia
e carabinieri. Ma tutta la zona vede una alta densità di appartenenti ai
servizi.
Gli interrogatori.
Ogni giorno Moretti esce da Via Gradoli per andare alla prigione e interrogare
Moro. Gli interrogatori vengono registrati e poi sbobinati. Le bobine originali,
secondo i brigatisti, vengono distrutte insieme agli originali degli scritti del
prigioniero “perché non importanti”. Il presidente DC parla dell'organizzazione
Gladio, del Piano Solo (il tentato colpo di Stato del Generale De Lorenzo, capo
dei Carabinieri, nel 1964), della connivenza di parte della DC e dello Stato
nella strategia della tensione, ma anche dello scandalo Italcasse e Caltagirone.
Sono esattamente le rivelazioni che le BR cercano e che nei primi comunicati
promettono di rendere pubbliche. Ma non manterranno mai la parola e sostengono
di aver preferito distruggere tutto “perché non importante”.
I comitati di crisi. Il
Ministro dell'Interno Francesco Cossiga nomina già il 16 marzo il «comitato
tecnico-politico-operativo», presieduto dallo stesso Cossiga e - in sua vece -
dal sottosegretario Nicola Lettieri, di cui fanno parte i comandanti di polizia,
carabinieri e guardia di finanza, oltre ai direttori del SISMI e del SISDE, al
segretario generale del CESIS, al direttore dell'UCIGOS e al questore di Roma.
Nomina anche il «comitato informazione», di cui fanno parte i responsabili dei
vari servizi: CESIS, SISDE, SISMI e SIOS.
Viene creato anche un terzo
comitato, non ufficiale, denominato «comitato di esperti».
Della sua esistenza si saprà solo nel 1981, quando Cossiga stesso ne rivelerà
l'esistenza alla Commissione Moro, senza indicarne le attività e le decisioni.
Di questo organismo fanno parte, tra gli altri: Steve Pieczenik (funzionario
della sezione antiterrorismo del Dipartimento di Stato americano), il
criminologo Franco Ferracuti, Stefano Silvestri, Vincenzo Cappelletti (direttore
generale dell'Istituto per l'Enciclopedia italiana) e Giulia Conte Micheli. Si
avranno le prove che la maggior parte dei membri dei tre comitati sia iscritta
alla Loggia P2 di Licio Gelli. Di Pieczenik riparleremo dopo.
Moretti, gioventù di un
brigatista particolare.
Mario Moretti è il regista del rapimento Moro: partecipa al rapimento, agli
interrogatori, all’eliminazione del presidente DC. Una figura particolare. I
suoi studi giovanili vengono finanziati da una benestante famiglia nobile
fascista, Camillo e Anna Casati Stampa di Soncino. Il 30 agosto 1970 Camillo
ucciderà Anna e il suo amante, Massimo Minorenti, poi si toglierà la vita. La
loro villa, ereditata dalla figlia Anna Maria, verrà poi venduta per 250 milioni
(parliamo di 3500 mq, inclusa una pinacoteca con opere del ‘400 e del ‘500, una
biblioteca con 10.000 volumi antichi, un parco immenso, scuderie e piscine)
grazie alla decisiva intermediazione del pro-tutore della ricca ereditiera
ancora minorenne: l’avvocato Cesare Previti. L’acquirente e “utilizzatore
finale” di Villa San Martino è Silvio Berlusconi, ma questa è un’altra storia,
torniamo a Moretti. Verrà assunto alla Sit-Siemens nel 1968 grazie ad una
lettera di raccomandazione di Anna Casati. Lì conosce Corrado Alunni, Paola
Besuschio, Giuliano Isa, futuro zoccolo duro delle Brigate Rosse, l’ala
militarista osteggiata da Curcio e Franceschini, contrari alla lotta armata.
Moretti il 30 giugno 1971, partecipa con Renato Curcio ad una rapina per
autofinanziarsi a Pergine di Valsugana. E’ la sua prima azione all’interno delle
Brigate Rosse, è sicuro di sé, pronto a tutto. Durante il fallito rapimento del
politico democristiano Massimo De Carolis, le forze dell’ordine decapitano
l’intera classe dirigente delle Br, ma proprio lui riesce a fuggire. Però
all’interno del covo che avrebbe dovuto accogliere De Carolis, polizia e
carabinieri trovano in una scatola di scarpe le fotografie di Curcio e altri
scatti compromettenti. Quella scatola l’ha dimenticata Moretti, che pure
assicura i compagni di averla bruciata. E inizia una latitanza obbligata. Nel
1974 vengono arrestati a Pinerolo Curcio e Franceschini, durante un incontro con
Silvano Girotto, detto Frate Mitra, infiltrato dai carabinieri. Un incontro al
quale avrebbe dovuto partecipare anche Mario Moretti, opportunamente avvertito
da una telefonata anonima che gli permette di sfuggire all’arresto. La
telefonata arriva ben quattro giorni prima, ma nel frattempo Moretti “non
riesce” ad avvisare Curcio e Franceschini.
Moretti, la scalata di un
brigatista particolare.
Curcio e Franceschini sono fuori dai giochi e le BR virano
decisamente verso la linea dura: lotta armata contro lo Stato. In uno scontro a
fuoco con i carabinieri durante il rapimento dell’industriale Vittorio Vallarino
Gancia muore Mara Cagol, mentre Giorgio Semeria rimane gravemente ferito.
Semeria dal carcere riuscirà a scrivere a Curcio per avvertirlo che Moretti è
una spia e che Mara Cagol è stata ammazzata quando era già ammanettata e in
ginocchio. Moretti è ormai il capo indiscusso delle Brigate Rosse, si
trasferisce a Roma e si prepara a gestire la stagione di piombo che culminerà
con il rapimento Moro.
Curcio intanto evade dal
carcere di Casale Monferrato con una fuga rocambolesca e incontra i nuovi
vertici delle BR. Moretti insiste per soggiornare nell’appartamento di Curcio,
di cui non conosce ancora l’indirizzo. Solo due giorni dopo, la polizia fa
irruzione nell’abitazione del vecchio leader, arrestandolo nuovamente. Confiderà
in seguito Curcio a Franceschini “Sono convinto che Moretti sia una spia”.
Moretti, la fine di un
brigatista particolare.
Il pluriricercato Moretti negli anni successivi va più volte in
Francia per incontrare compagni latitanti. Rivelerà questa circostanza durante
il processo provocando lo stupore degli altri brigatisti coimputati che non ne
sapevano nulla. Ne riparleremo più avanti alla voce Hyperion. Durante il
sequestro Moro, viaggia ripetutamente tra Roma e Firenze, sfuggendo a qualsiasi
controllo. Il 4 aprile 1981, dopo oltre dieci anni di latitanza, la primula
rossa verrà arrestata e condannata a sei ergastoli. Dopo soli 16 anni, nel
luglio del 1997, otterrà la semilibertà. Moretti non si è mai pentito, né si è
mai dissociato e non ha collaborato con gli inquirenti.
Viaggio in tre puntate nelle
molte zone oscure di uno degli episodi più tragici della storia italiana. Il
caso Moro. Ecco tutto quello che non torna nelle ricostruzioni ufficiali.
Errori, omissioni. E bugie, scrive Luca Longo il 5 maggio 2018 su "L’Inkiesta".
Via Caetani. Le
BR telefonano al professor Tritto il 9 maggio alle 12:30 per indicare dove si
trova il corpo di Moro. Negli interrogatori successivi diranno di aver lasciato
la Renault 4 rossa col cadavere fra le 7:00 e le 8:00 della mattina. L’autopsia
rivela che la morte si colloca tra le 9:00 e le 10:00 della mattina stessa. Non
si capisce perché attendere oltre quattro ore tra l’abbandono dell’auto e la
telefonata. Alcune testimonianze diranno di aver notato la Renault parcheggiata
solo a partire dalle 12:30 e non prima.
Informatori e infiltrati. La
Commissione Moro ha più volte constato che le BR sono state oggetto di un
attento e prolungato monitoraggio da parte degli apparati di sicurezza. Lo
confermano, fra le tante prove, la lettera scritta da Duccio Berio nel 1972 al
suocero Alberto Malagugini in cui riferisce dei contatti con un appartenente al
SID che gli propose di infiltrarsi nelle BR; la vicenda dell’infiltrato Silvano
Girotto che nel 1974 fece scattare la trappola per Curcio e Franceschini;
l’audizione del giudice Pietro Calogero, che conferma “resoconti periodici di
informatori infiltrati” nelle Brigate Rosse e in altre formazioni
dell’estremismo di sinistra. Anche se è ragionevole pensare che, dopo la cattura
dei vertici delle BR grazie a Girotto, i brigatisti abbiano rafforzato le
cautele per evitare ulteriori infiltrazioni, non può non sorprendere che il
flusso informativo si sia inaridito proprio nella fase precedente il sequestro
di Aldo Moro.
Via Montenevoso, Milano.
Il 1 ottobre 1978 i carabinieri di Carlo Alberto Dalla Chiesa pedinano il
brigatista Lauro Azzolini e trovano il covo di Via Monte Nevoso e vi scoprono
alcune pagine del memoriale con le trascrizioni degli interrogatori. Il covo
viene perquisito per cinque giorni e vi vengono posti i sigilli. Il Senatore
Sergio Flamigni, parlando in carcere con Azzolini e Bonisoli, viene a sapere che
nel covo avrebbe dovuto trovarsi la trascrizione completa degli interrogatori.
Nel 1986 e nel 1988 Flamigni chiede al magistrato competente Ferdinando Pomarici
di riaprire il covo e cercare meglio, ma viene rassicurato sul fatto che il covo
è stato “scarnificato”.
Un’altra manina. Le
carte di Moro ritrovate durante il blitz a Via Montenovoso vengono prelevate e
fotocopiate prima della verbalizzazione da parte della Magistratura e poi
riportate nel covo, per essere consegnate la sera stessa al generale dalla
Chiesa. La seconda sezione civile della Corte d’Appello del Tribunale di Milano,
ha stabilito che il colonnello Umberto Bonaventura del SISDE entra nel covo
durante la perquisizione e porta via le carte, restituendole dopo qualche ora,
visibilmente assottigliate.
Di nuovo in via
Montenevoso. Il
9 ottobre 1990 il proprietario dell’appartamento incarica un muratore di
ristrutturarlo. Si scopre che i sigilli posti nel 1978 sono stati rotti. Il
muratore toglie sotto una finestra quattro chiodi e un pannello di cartongesso e
scopre uno vano contenente un mitra Tokarev avvolto in un giornale del 1978, 60
milioni in contanti, pistole, detonatori e 229 pagine fotocopiate del memoriale
Moro. Ma mancano ancora diverse pagine, fino ad ora mai ritrovate.
Carmine Pecorelli. Il
fondatore dell’agenzia di stampa OP-Osservatore Politico, diventata rivista
settimanale proprio nel marzo del 1978, deve la sua fama (e la sua morte) alle
sibilline “profezie” che pubblica. Queste sono frutto di notizie provenienti
dalla sua rete di contatti nella politica, nella loggia P2 (di cui fa parte),
nei vertici dei Carabinieri e nei servizi segreti.
OP prima. Il
15 marzo, il giorno prima del sequestro, pubblica un articolo che - citando le
Idi di marzo e collegandole con il giuramento del governo Andreotti - fa
riferimento a un nuovo Bruto.
OP durante. Durante
il sequestro è il primo a dichiarare la falsità del Comunicato n. 7. Rivela che
all’interno delle BR ci sono due fazioni, i trattativisti e quelli che vogliono
uccidere il Presidente DC ad ogni costo, che “gli autori della strage sono dei
professionisti addestrati in scuole di guerra del massimo livello” e non sono
gli stessi che tengono prigioniero Moro. E’ il primo a notare che in Via Gradoli
tutte le prove che si tratta di un covo sono in bella vista per essere sicuri
che non possano sfuggire anche al pompiere più distratto. Altri bersagli
privilegiati di Pecorelli sono Giulio Andreotti, di cui descrive ad esempio i
rapporti con cosa nostra, l’imprenditore Nino Rovelli o l’agente del SID Mario
Giannettini, o il tentativo di corruzione proposto dal braccio destro di
Andreotti, Franco Evangelisti, per convincere lo stesso Pecorelli a tacere (30
milioni di lire, prestati da Caltagirone).
OP dopo. Dopo
il sequestro, Pecorelli scrive che il "generale Amen" (il generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa) avrebbe informato il ministro dell'Interno Francesco Cossiga
dell'ubicazione del covo in cui era prigioniero. Ma Cossiga non avrebbe "potuto"
far nulla poiché obbligato verso qualcuno o qualcosa. Il generale Amen, sostenne
Pecorelli nel 1978, sarà ucciso (profezia poi avveratasi nel 1982) proprio a
causa dalle lettere di Moro. Pecorelli pubblica su OP anche alcuni documenti
inediti sul sequestro, comprese tre lettere inviate alla famiglia e dimostra di
conoscere l’esistenza del Memoriale mesi prima della prima parte del suo
ritrovamento. Ha evidentemente scoperto alcune verità scottanti, tanto che
profetizza anche il suo stesso assassinio. Anche questa profezia si avvera il 20
marzo 1979, esattamente un anno dopo il rapimento Moro e la prima uscita di OP.
Ma esattamente il giorno stesso in cui Sandro Pertini avvalla la nascita del
quinto governo Andreotti. Il pentito Buscetta dichiarerà che è stato ucciso
dalla Mafia con la manovalanza della Banda della Magliana per “fare un favore ad
Andreotti”, preoccupato per certe informazioni sul caso Moro.
Hyperion. Il
primo a parlare di una centrale eversiva a Parigi è Giulio Andreotti su “Il
Mondo” nel 1974: «Sono tutt’ora convinto che una centrale fondamentale, che
dirige l’attività dei sequestri politici per finanziare i piani d’eversione e
che coordina lo sviluppo terroristico su scala anche europea, si trova a
Parigi». Proprio in quell’anno si sfalda il gruppo estremista guidato da Duccio
Berio, Vanni Mulinaris, Corrado Simioni, Renato Curcio, Alberto Franceschini e
Mario Moretti allo scopo di «contribuire alla crescita politica delle masse e
alla trasformazione dello scontro in lotta sociale generalizzata». Gli ultimi
tre entrano a fare parte delle Brigate Rosse, mentre i primi tre si spostano
proprio a Parigi (la Francia riconosce facilmente lo status di rifugiato
politico) e danno vita alla scuola di lingue Hyperion (in Quai de la Tournelle,
27). Alberto Franceschini in Commissione Stragi riferirà che i tre fondatori di
Hyperion erano in disaccordo con l'impostazione dei leader storici delle BR
guidati da Curcio e Franceschini. Questi consideravano troppo violento il gruppo
originale della scuola parigina (soprannominato "Superclan", ovvero
"superclandestino"). I vertici di Hyperion avrebbero mantenuto un legame
speciale, invece, con Moretti che faceva parte del Superclan. Questo legame si
rafforza proprio dopo l’8 settembre 1974, giorno della cattura dei capi
brigatisti Curcio e Franceschini. A quel punto, l’oltranzista Moretti rimane
l'unico tra i capi storici brigatisti in libertà. Durante i 55 giorni, Hyperion
di Parigi era strettamente collegata con una scuola francese di lingue con sede
a Roma in piazza Campitelli, a 150 metri da via Caetani, la via dove sarà
rinvenuto il 9 maggio 1978 il corpo di Moro. Il mese precedente il sequestro
Moro, Hyperion aveva aperto a Roma un ufficio di rappresentanza in via Nicotera
26 (nello stesso stabile dove si trovano alcune società coperte del SISMI); lo
stesso ufficio viene chiuso subito dopo il sequestro.
Corrado Simioni.
L’ambiguo fondatore
di Hyperion non gode della fiducia di molti estremisti per una serie di
comportamenti ambigui culminati proprio con l’arresto di Curcio e Franceschini.
Simioni, dopo essere stato espulso da PSI nel 1965 per “condotta immorale”, si
trasferisce a Monaco di Baviera ma nel 1967 ritorna a Milano dove lavora per la
Mondadori, ma anche per l’USIS (United States Information Service), diretta
emanazione della CIA. La sede romana dell’USIS si trova al numero 32 di via
Caetani, quasi di fronte al punto in cui sarà parcheggiata la Renault rossa con
il corpo di Moro. Fra le varie ambiguità che portano il nucleo storico e
moderato delle BR a dubitare di Simoni c’è il fatto che nel settembre 1970
fornisce a Maria Elena Angeloni e Giorgio Christou Tsikouris esplosivo e timer
per compiere un attentato all’ambasciata USA di Atene. L’ordigno esplode
anzitempo e i due muoiono. L’esplosivo e il timer dell’attentato di Atene sono
identici a quelli che nel 1972 uccidono Giangiacomo Feltrinelli, proprio mentre
sta piazzando un ordigno su un traliccio dell’Enel nelle campagne di Segrate.
Giovanni Pellegrino, presidente della Commissione Stragi per 7 anni, scrive che
Hyperion in realtà era il punto d'incontro tra i servizi segreti delle nazioni
contrapposte nella Guerra Fredda, necessario nella logica di conservazione degli
equilibri derivanti dagli accordi di Yalta. Hyperion quindi sarebbe stato un
mezzo per azioni comuni contro eventuali sconvolgimenti dell'ordine stabilito a
Yalta. Proprio la politica di apertura al PCI attuata da Moro, poteva
considerarsi una minaccia degli stessi equilibri politici consolidatisi fino a
quel momento.
Steve Pieczenik. Dopo
via Fani Cossiga si fa affiancare da un esperto statunitense: Steve Pieczenik,
assistente del Sottosegretario di Stato e Capo dell'Ufficio gestione del
terrorismo internazionale del Dipartimento di Stato USA. Ventotto anni dopo,
Pieczenik rivela di aver deciso di creare il falso comunicato n. 7, e di aver
spinto le Brigate Rosse a uccidere Moro, con lo scopo di delegittimarle, quando
ormai era chiaro che i vertici del governo non volevano fosse liberato. Il ruolo
giocato nel sequestro e nell’omicidio, Pieczenik lo descrive benissimo da solo
durante una intervista del 2006: «Capii subito quali erano le volontà degli
attori in campo: la destra voleva la morte di Aldo Moro, le Brigate rosse lo
volevano vivo, mentre il Partito Comunista, data la sua posizione di fermezza
politica, non desiderava trattare. Francesco Cossiga, da parte sua, lo voleva
sano e salvo, ma molte forze all'interno del paese avevano programmi nettamente
diversi, il che creava un disturbo, un'interferenza molto forte nelle decisioni
prese ai massimi vertici. [...] Bisognava evitare che i comunisti di Berlinguer
entrassero nel governo e, contemporaneamente, porre fine alla capacità di
nuocere delle forze reazionarie e antidemocratiche di destra. Allo stesso tempo
era auspicabile che la famiglia Moro non avviasse una trattativa parallela,
scongiurando il rischio che Moro venisse liberato prima del dovuto. Ma mi resi
conto che, portando la mia strategia alle sue estreme conseguenze, mantenendo
cioè Moro in vita il più a lungo possibile, questa volta forse avrei dovuto
sacrificare l'ostaggio per la stabilità dell'Italia»… «Mi rincresce per la morte
di Aldo Moro; chiedo perdono alla sua famiglia e sono dispiaciuto per lui, credo
che saremmo andati d'accordo, ma abbiamo dovuto strumentalizzare le Brigate
rosse per farlo uccidere.»
Conclusioni
(?) In conclusione, non ho
nuove risposte da proporre, o nuove originali tesi da discutere. Questo è solo
un breve elenco delle principali lacune e contraddizioni che ancora lasciano
nell’ombra quello che è veramente successo in quei 55 giorni che ex brigatisti e
Istituzioni dichiarano completamente chiariti. Da Via Fani in poi, nella
migliore tradizione italiana, i depistaggi ad opera di chi voleva nascondere la
verità si sono mescolati inestricabilmente agli errori in buona fede, alla
cialtroneria di apparati dello Stato, alle invenzioni di persone malate di
protagonismo, alle fantasiose teorie dei complottisti per partito preso, pronti
a giurare che sotto qualsiasi vicenda oscura ci sia lo zampino degli eterni
cattivi del ‘900: i servizi segreti - deviati o stranieri - la P2, la mafia, la
banda della Magliana e, naturalmente, Cossiga e Andreotti. Il guaio è che questo
fu il momento cruciale che avrebbe potuto portare l’Italia a camminare sulle
proprie gambe affrancandosi dai blocchi contrapposti della guerra fredda. Il
cammino che avrebbe portato i cittadini a scegliere ogni volta tra due proposte
politiche alternative ma entrambe fondate sull’identità nazionale, sul rispetto
reciproco, sugli stessi valori e sui principi della Costituzione. Troppi avevano
interesse a mandare fuori strada chi stava compiendo quel cammino, e fra questi
è provato che ci furono anche gli eterni cattivi del ‘900: i servizi segreti -
deviati e stranieri - la P2, la mafia, la banda della Magliana e, naturalmente,
Cossiga e Andreotti.
QUELLO CHE NON DICONO.
Quando Aldo Moro salvò
l’Italia, storia del luglio ’60.
Fabrizio Cicchitto su Il
Riformista il 21 Luglio 2020. Il luglio 1960 si è sviluppato come è stato
descritto da Claudio Petruccioli e da Fausto Bertinotti. Si sarebbe però risolto
in una tragedia peggiore (ci furono comunque manifestanti uccisi dalla polizia
in varie città) se non ci fosse stato uno sbocco politico, quello offerto dal
Psi con il centro-sinistra. Ciò è sottolineato nella ricostruzione di
Petruccioli e in parte anche in quella di Bertinotti. Quello che non ricordano è
che quello sbocco alle origini fu costruito non d’intesa, ma contro una parte
cospicua del Pci e contro quella parte del Psi che poi ottusamente fece nel 1964
la scissione del Psiup, sulla quale torneremo. In quella vicenda un’autentica
stranezza fu il comportamento assai contraddittorio del presidente della
Repubblica Giovanni Gronchi. Il vero artefice dell’elezione di Giovanni Gronchi
contro il gruppo dirigente democristiano fu Pietro Nenni, che si mosse molto
abilmente per aggiungere un tassello nella costruzione del centro-sinistra. Lo
fece con una complessa manovra parlamentare che vide combinare insieme i voti di
tutta la sinistra (Pci e Psi) e di una larga parte del centro-destra (destra
democristiana antifanfaniana e missini). Tambroni era un uomo di Gronchi che gli
diede l’incarico proprio nella logica di preparare il centro-sinistra. A loro
volta sul terreno del gioco tattico e della manovra, la destra democristiana e
quella missina non sbagliarono un colpo e ad un certo punto Tambroni, che era un
mediocre avvocato di provincia, sfuggì sia alla gestione di Gronchi sia al
controllo del gruppo dirigente democristiano che non voleva certo trovarsi in
mezzo al decollo di una guerra civile. Ma Tambroni era stato per anni ministro
degli Interni e in quel mondo opaco c’erano forze che in nome
dell’anticomunismo, ideale che poi nel 1964 si tradusse in antisocialismo assai
pratico, erano pronte. Tambroni sfuggì a tutti, non solo al suo originario
sponsor Giovanni Gronchi, ma anche al gruppo dirigente democristiano. Sarebbero
stati guai serissimi, con tutti quei morti per le strade ma anche con quella
mobilitazione della polizia, se Moro non fosse stato in grado di proporre una
soluzione di tregua che si fondava sul fatto che per il futuro era possibile una
soluzione politica organica di stampo riformista, che era quella del
centro-sinistra. Quello sbocco politico non ci sarebbe stato se a suo tempo,
cioè dai tempi del rapporto segreto di Kruscev e specialmente dell’occupazione
sovietica dell’Ungheria, da un lato Pietro Nenni non avesse rotto con il Pci e
ricostruito l’autonomia politica e culturale del Psi e dall’altro lato Riccardo
Lombardi, su questo totalmente concorde con Nenni, non avesse costruito, insieme
ad Antonio Giolitti, agli amici de Il Mondo e a Ugo La Malfa i punti
programmatici dell’eventuale intesa con la Dc, che aveva come punti chiave la
nazionalizzazione dell’energia elettrica, la riforma urbanistica, la riforma
della federconsorzi, la riforma della scuola. L’autonomia socialista fu
riconquistata non d’intesa, ma contro larga parte del Pci e anche contro un bel
pezzo di Psi che non a caso al Congresso di Venezia del Psi nel 1957 impallinò
Nenni nell’elezione del Comitato centrale. Fortunatamente prima del luglio del
1960 c’era stato il Congresso del Psi nel 1959 vinto da Nenni per cui lo sbocco
politico dal 1960 in poi era possibile, altrimenti l’esplosione del movimento
del luglio del ’60 si sarebbe trovato in un tragico cul de sac. Certamente di
fronte all’autentica provocazione di un monocolore democristiano con l’appoggio
determinante del Msi, ma specialmente all’autentica provocazione costituita
dalla convocazione a Genova del Congresso del Msi, nella città ligure si scatenò
di tutto: quel pezzo di resistenza partigiana, molto forte in Liguria, che si
sentiva “tradita” dalle vicende successive al 1945, i “camalli del porto”, forti
nuclei di classe operaia, un’inattesa ribellione giovanile, anche vaste aree di
ceto medio intellettuale: tutto ciò – espresso poi in modo icastico dal comizio
di Pertini e dalla battuta di Riccardo Lombardi («non c’è il rischio di guerra
civile, la guerra civile c’è già») – fece capire al gruppo dirigente
democristiano che la coppia Gronchi-Tambroni aveva provocato una situazione
pericolosissima per tutti da cui bisognava uscire. Ma se il Psi non fosse stato
quello affermatosi (grazie a Nenni, a Riccardo Lombardi, a Fernando Santi e a
molti altri) dai Congressi di Venezia e Napoli, ma fosse rimasto quello del
1955, lo sbocco politico non ci sarebbe stato, la situazione si sarebbe
presentata senza via d’uscita e l’avventurismo di Tambroni e di tutto un mondo
che stava alle sue spalle avrebbe potuto fare anche in presenza di quel
movimento danni devastanti. Per capirci, già nel 1955 nel suo Congresso di
Torino il Psi aveva parlato di “dialogo con i cattolici”, ma lo aveva fatto
mantenendo in piedi il frontismo col Pci e anche lo stalinismo ideologico con
effetti politici molto scarsi. Quindi quando si esaminano vicende assai
complesse come quelle imperniate sul luglio 1960 bisogna porre in essere quella
che Palmiro Togliatti ha chiamato «l’analisi differenziata»: un metodo di
analisi che, però, a suo tempo egli ha adottato in modo assai discontinuo, assai
serio quando lo ha applicato ai fascisti («il corso sugli avversari», Lezioni
sul fascismo), del tutto reticente o addirittura inconsistente quando si è
occupato dell’Unione Sovietica. Ma questa ricostruzione deve riguardare non solo
ciò che avvenne prima del 1960, ma anche ciò che avvenne dopo, perché la
sinistra ha commesso gravissimi errori non solo dopo il 1989, ne ha commessi di
gravissimi anche prima. A proposito del centro-sinistra, Bertinotti parla sia
delle sue importanti realizzazioni, sia della sua involuzione moderata e del suo
fallimento nell’obiettivo di trasformazione della società. A nostro avviso
comunque in centro-sinistra per un verso ha salvato la democrazia nel nostro
paese, per altro verso ha contribuito a modernizzarlo, per un altro verso ancora
è stato segnato da un’involuzione moderata. Esso è stato certamente pieno di
contraddizioni e per molti aspetti gli anni ’64-’68 non sono stati brillanti,
anche se riforme assai importanti furono fatte nella fase Rumor-De Martino, ma,
messi nel conto tutti gli errori del gruppo dirigente socialista nelle sue
molteplici articolazioni (Nenni, De Martino, Mancini, Lombardi, Giolitti),
dobbiamo anche parlare degli incredibili errori (mi riferisco al Pci) e di
qualcosa di molto peggio (mi riferisco al gruppo dirigente del Psiup) posto in
essere dai suoi critici e oppositori di sinistra. Rispetto al centro-sinistra
all’inizio Togliatti fece una perfetta analisi differenziata: «il
centro-sinistra è un nuovo e più avanzato terreno di lotta, il suo sbocco può
essere di stampo riformista o risolversi in un’involuzione moderata». Come in
tante altre cose (la Fiat, il ’68, il sindacato) Amendola, a nostro avviso, sul
centro-sinistra assunse una posizione giusta: egli partiva dal giudizio di
Togliatti per dislocare il Pc in uno stretto rapporto con il Psi, La Malfa, con
il sindacalismo cattolico. Invece per Ingrao il centro-sinistra era
un’operazione di modernizzazione neocapitalista dell’Italia, le sue riforme
erano tutte intrinseche al sistema, per cui la contestazione del Pci doveva
essere globale. L’analisi di Ingrao era del tutto ideologica e astratta anche
per cogliere la dialettica e le contraddizioni reali del centro-sinistra. In
questo quadro Ingrao fu del tutto favorevole alla scissione del Psiup. Nella
sostanza, poi, quasi tutto il Pci, tranne Amendola, nel corso di quegli anni si
spostò sulla linea della contestazione frontale del centro-sinistra nel timore
che, se fosse decollato il suo riformismo, il Psi avrebbe potuto modificare a
suo vantaggio i rapporti di forza nella sinistra italiana. Così, quando ancora
la partita era del tutto aperta sulla caratterizzazione riformista o moderata
del centro-sinistra, la sinistra del Psi (quella di Valori e Vecchietti, ma
anche di Basso e Foa) fece la scissione e fondò il Psiup nel 1964. Anche a tanti
anni di distanza non posso fare a meno di rilevare che si trattò o di un atto di
totale ottusità politica o di criminalità politica pura. Per definirla basta
ricordare chi la finanziò: il Kgb e l’Eni di Cefis su sollecitazione di Antonio
Segni allora in ottimi rapporti personali con Lelio Basso. È evidente che il Kgb
lo fece per indebolire il Psi e aiutare il Pci. Quanto a Segni e a Basso chi
vide giusto fu certamente il primo. Allora Segni, oltre che presidente della
Repubblica, era anche il leader dei dorotei e quindi collocato oltre gli
orientamenti della corrente della Dc moderata (tant’è che poco dopo, di fronte
al piano Solo, anche Scelba gli disse di non essere per niente d’accordo con
lui). Giustamente Segni, attraverso la scissione, voleva indebolire i socialisti
e smontare il centro-sinistra riformista. Non
sorprendono Valori e Vecchietti, legati al Pcus più dello stesso Pci, sorprende
invece Lelio Basso che ai tempi del Psi staliniano fu addirittura perseguitato
dagli sgherri morandiani (l’ha raccontato lui stesso nelle sue memorie, dicendo
che solo Pertini, Lombardi e Santi lo salutavano e che dovette a Pajetta e ad
Amendola se non fu espulso dal Psi, ma comunque escluso dalla Direzione e dal
Comitato Centrale lo fu: stiamo parlando di un uomo della storia e dalla storia
di Lelio Basso). Probabilmente Lelio Basso era troppo suggestionato dalla storia
della Rivoluzione russa: pensava di viaggiare verso la rivoluzione sul treno
blindato dell’esercito tedesco e invece, in quella circostanza, fu utilizzato
dal leader della destra democristiana per indebolire gli odiati riformisti
(Nenni e Lombardi). Come si vede, se si adotta davvero non solo per un pezzo il
metodo togliattiano dell’analisi differenziata si scopre che la storia italiana
non sopporta proprio nessuno schema prefabbricato e neanche la mitologia.
Che abbaglio tirare in
ballo Moro…Marco
Follini il 10 gennaio 2020 su Il Dubbio. Moro lanciò una sfida e rivendicò una
politica. Non chiese complicità. Quella volta, in difesa di Luigi Gui
sull’affare Lockheed, Moro scrisse inizialmente un testo anodino, tutto in punta
di diritto, senza concessioni di sorta alla controversia politica del tempo. Fu
il suo portavoce, Corrado Guerzoni, che era un consigliere discreto e influente,
a convincerlo a dare uno spessore assai più politico e assai più controverso
alle sue parole. Così andò, e il giorno dopo, viste le reazioni di mezzo mondo,
Moro ebbe il dubbio di avere reagito in modo troppo forte. Punto e a capo. Ora,
però, converrebbe evitare che l’eco di quelle parole lontane riempisse il vuoto
della nostra attualità politica. Infatti, si può liberamente decidere di
affidare Salvini alle cure della magistratura, oppure fargli da scudo in nome di
una immunità parlamentare che ha le sue ragioni. Liberamente, appunto. Magari
senza confondere gli anni Settanta con i nostri giorni, e il fu presidente della
Dc con il leader della Lega. Moro lanciò una sfida e rivendicò una politica. Non
chiese complicità. Mentre oggi sembra piuttosto che la ricerca della complicità
venga prima del ritrovamento della politica. Questione di tempi, e di uomini.
Basterebbe non mescolarli per avere riguardo degli uni e degli altri.
Gli anni del Male: quando
eravamo democristiani.
Fulvio Abbate de Il Riformista l'8 Novembre 2019. Nella romana
cornice di marmo già littorio dell’ex GIL, in largo Ascianghi, a ridosso del non
meno rinomato cinema “Nuovo Sacher”, angolo estremo di Trastevere comprensivo di
piazzola destinata al parcheggio, luogo di rissa per gli irriducibili spettatori
ritardatari di Nanni Moretti, nei giorni scorsi, nella luce incerta di ciò
che Pasolini chiamava “Dopostoria”, si è svolto un significativo e decisamente
crudele incontro dedicato all’eredità del più fantasmagorico settimanale di
satira che l’ormai malconcio Stivale abbia mai conosciuto, Il Male,
l’indimenticato. Un dibattito a compendio di una mirabile mostra che testimonia,
tra gigantografie di leggendarie “false” prime pagine, disegni e manufatti
originali, la ricostruzione del locale della stessa redazione, memorabilia e
ogni altro feticcio della satira passata ormai agli alberi pizzuti della
repubblica, un momento di assoluta vitalità nella battaglia delle idee e del
necessario sarcasmo da contrapporre alle bassezze altrove dominanti
dell’informazione. I protagonisti? Da Vincino a Pino Zac, e ancora Angese,
Giuliano, Cinzia Leone, Angelo Pasquini, Sergio Saviane in veste di
“fiancheggiatore”, Riccardo Mannelli, Vauro, Jacopo Fo, Alain Denis, Roberto
Perini, Mario Canale, Vincenzo Sparagna, Jiga Melik, Piero Lo Sardo, Giovanna
Caronia, i disegnatori Tamburini e Liberatore, e lo stesso Andrea Pazienza, già
allora alle prese con il suo Pertini, fino a Carlo Zaccagnini, figlio di
Benigno, in arte, per pudore familiare, Carlo Cagni. Questi i volti contenuti
nell’ideale quadreria-albo d’oro dell’avventura che adesso si rinnovella
nell’omaggio intitolato Gli anni del Male 1978-1982. A fronteggiare ogni tavola
illustrata del sarcasmo trascorso, sotto bassorilievi che ancora adesso
innalzano la gloria italica fin dai giorni delle sanzioni, quando Mario
Appellius ebbe modo di coniare l’epiteto “Dio stramaledica gli Inglesi!”, ecco
ora, irresistibile, indomabile, Paolo Cirino Pomicino, pronto a far rivista di
sé tra disegni e ancora tavole; a seguirlo, Beppe Attene, ex direttore
dell’Istituto Luce (e già questa, contemplato il luogo già caro al Ventennio,
appare come metafora), distintivo massonico fieramente portato all’occhiello; il
non meno eponimo Duca Conte radicale Roberto Cicciomessere; Sergio Staino, volto
e postura da antico senatore romano, da attesa dei barbari, così come ne
prefigurano l’implacabile arrivo i versi di Kavafis; l’esperto di cose disegnate
Luca Raffaelli a moderare l’intera matassa, a contestualizzare fatti, azioni ed
espedienti perfino drammaturgici orditi, sempre allora, dalla comitiva del Male,
infine Filippo Ceccarelli, romano profondo, collezionista di spigolature, uomo
saggio e di mondo, pronto a mettere anche lui ordine nell’ordito di un’avventura
editoriale che oggi appare antica e insieme struggente per vitalità, per
irritualità, per volontà anarco-situazionista, per ascesa editoriale e infine
tracollo e rovina, così nel clima trascorso del compromesso storico in attesa
del rapimento e dell’assassinio di Aldo Moro da parte delle ottuse Brigate
Rosse… Perfino per irriproducibilità. Evocando la falsa prima pagina che
annunciava lo scioglimento della Dc Cicciomessere auspica il ritorno del Male
che presto «si contrapponga a La Bestia di Salvini». Attene, nostalgia canaglia
del Garofano, ricorda invece che «i socialisti avevano più senso dell’umorismo
di tutti gli altri». Viene addirittura evocata, come possibile Belfagor dell’evo
politico trapassato, la “signorina” Enea, leggendaria segretaria di Andreotti,
la si rammenta “in ciabatte” negli uffici di piazza San Lorenzo in Lucina.
Andreotti, diversamente dai comunisti, era tuttavia tra coloro che richiedevano
le vignette agli autori, così da metterle tra i trofei, accanto alle foto con i
capi di Stato. Altre facce e faccine della cosiddetta prima repubblica si
ritrovano intanto chiamate in causa, e così affiancate alle attuali per uno
spareggio impietoso. Staino, dal suo ideale trono, evoca il Don Basilio,
giornale anticlericale post-bellico che visse poche stagioni, Staino, con faccia
da Bobo ormai in pensione, racconta ancora di quando, militante nel più oscuro
partito marxista-leninista che la nostra penisola extraparlamentare abbia mai
conosciuto, il P.c.d’I., stretta osservanza filocinese e addirittura
filoalbanese al tempo di Enver Hoxha, reduce da un dibattito politico, ospite, a
Treviso, di una “compagna”, chiese a quest’ultima se avesse, per caso, una
copia, metti, di Tex Willer, delizie di lettura cui dedicarsi prima di andare a
letto, e la infame militante irreprensibile, denunciò la gravità della richiesta
al comitato centrale dell’organizzazione. Sfilano gli invitati davanti alla
prima pagina di “Paese Sera” che annuncia Tognazzi essere il capo delle Br, il
“grande vecchio” per l’amarezza dell’ex socio Vianello che tuttavia concede: «È
pazzo, ma lo perdono». Sfila Stefano Disegni davanti ai falsi gialli Mondadori
che insinuano una “tisana assassina” per la dipartita di Papa Luciani. Solleva
il capo Luca Sossella ascoltando il racconto della rabbia dei repubblicani per
il modo in cui il giornale titolò la scomparsa di Ugo La Malfa: «In fondo era
solo una tartaruga». Durante il funerale, i militanti dell’Edera bruciarono
addirittura le copie del Male davanti alla bara del leader. Paolo Cirino
Pomicino, ’O Ministro, monotipo, pezzo unico, a fronte di una richiesta
esplicita degli astanti, non si sottrae dal mettersi in posa, lui, andreottiano,
proconsole di quest’ultimo nella Campania Felix, eccolo ora accanto al busto di
Andreotti, lo stesso che il collettivo del Male si apprestava a piazzare lassù
al Pincio, accanto ai simulacri dei padri nobili della storia nazionale,
l’irruzione della polizia, capitanata dal commissario Pompò, consentì il
sequestro immediato del manufatto marmoreo. Ne seguì perfino una sventagliata di
denunce, nella rete cadde anche Roberto Benigni, lì in veste di “madrina” della
cerimonia. Quarant’anni dopo, davanti al busto ritrovato, custodito nel
frattempo in casa di Vincino, c’è, sorridente, inaffondabile, magistrale, Paolo
Cirino Pomicino, qualcuno, poco prima, auspicava la possibilità che “rinasca la
Dc”, lui, l’ex ministro del bilancio, già antologizzato ne Il divo di Paolo
Sorrentino, nell’immensa interpretazione di Carlo Buccirosso, è lieto anche di
mostrarsi accanto alle altre false prime pagine de l’Unità e di Paese Sera.
“Basta con la Dc!” e “La Dc abbandona!”, fa intanto eco la seconda. Sogni
infranti. C’era una volta la satira, c’è ancora Cirino Pomicino.
Caso Lockheed, 1977: Moro a
difesa di Gui.
Redazione de Il Riformista il 13 Dicembre 2019. 9 marzo del 1977, il
caso Lokheed (una storia di tangenti sull’acquisto di aeroplani americani)
arriva alla Camera. Si tratta di decidere se processare due ex ministri: Luigi
Gui, dc, e Mario Tanassi, Psdi. Aldo Moro, giusto un anno prima del suo
rapimento, interviene con un discorso formidabile, di impronta davvero
garantista, a difesa di Gui, soprattutto, ma anche di Tanassi. Rivendica
l’autonomia e l’unicità della politica e il valore dell’impegno politico e dei
partiti. Grida: «Non ci faremo processare nelle piazze». Però va in minoranza. I
più duri contro di lui sono i comunisti e i radicali. Tanassi e Gui sono
rinviati a giudizio davanti alla Corte Costituzionale. Che assolverà Gui e
condannerà a 2 anni e 4 mesi di carcere Tanassi.
·
I Nemici di Aldo Moro.
Caso Moro, non
dimentichiamo cosa (non) fece Berlinguer.
Fabrizio Cicchitto su Il
Riformista il 30 Giugno 2020. Sul Corriere della Sera del 20 giugno è comparsa
un’intervista di Walter Veltroni a Claudio Signorile sul tentativo socialista di
salvare Moro facendo compiere allo Stato “atti autonomi” che mettessero le Br in
una condizione di difficoltà politica nell’eseguire la condanna a morte che esse
avevano proclamato. L’intervista è molto bella per merito di entrambi,
dell’intervistatore e dell’intervistato, e rompe un singolare silenzio dei media
che aveva circondato l’azione socialista sulla trattativa. In seguito al valore
positivo dell’intervista, interloquiamo con alcune affermazioni fatte da
Signorile. Il dato di fondo che Signorile e Veltroni non affrontano è il
seguente: Aldo Moro non era uno dei tanti dirigenti della Dc. Aldo Moro, dopo De
Gasperi, è stato il più significativo esponente della Dc che ha guidato quel
partito a fare unitariamente le sue due scelte politiche più importanti dopo
quella centrista, cioè prima il centro-sinistra e poi la strategia
dell’attenzione nei confronti del Pci con i governi Andreotti di unità
nazionale. A un leader politico di quella caratura è stato riservato dallo
Stato, dal governo, dagli apparati un trattamento inusitato: prima, ma, cosa
ancor più grave, anche dopo l’uccisione di Moro, non c’è stato governo italiano
che non abbia “trattato” in caso di rapimenti. Anche dopo Moro infatti, fino ai
giorni nostri, lo Stato italiano ha sempre “trattato” spesso pagando riscatti.
Addirittura, per preservare l’Italia da futuri atti terroristici, abbiamo
liberato terroristi palestinesi che già avevano fatto azioni sul nostro
territorio. Quello che provocò “la pazzia” di Moro durante la sua prigionia è
stata la lucida consapevolezza che nel suo caso questo criterio non veniva
seguito, anzi veniva rovesciato. Non a caso più volte nelle sue lettere egli
chiese che venisse richiamato in Italia il colonnello Giovannone che aveva in
diverse occasioni messo in atto l’opzione trattativista e che aveva rapporti con
tutti i gruppi palestinesi che, insieme ai servizi cecoslovacchi (ricordiamo la
battuta di Pertini), avevano rapporti con i brigatisti anche perché li
rifornivano di armi. Moro, poi, non poteva sapere che dopo il suo assassinio
questa linea della trattativa sarebbe stata interamente ripristinata in primo
luogo dalla Dc, come dimostrò tutto quello che ha fatto per salvare Cirillo, un
assessore regionale campano che faceva parte del sistema di potere di Antonio
Gava. Sul piano internazionale, poi, molti Stati non seguono una linea rigida,
ma sono molto pragmatici, come la Germania e Israele, a seconda delle
circostanze e degli interlocutori. I più ipocriti sono tuttora gli Stati Uniti:
negano in linea di principio come Stato qualunque trattativa e pagamento di
riscatto, poi aggirano questi proclami attraverso le assicurazioni private e i
contractor. Ma come mai a Moro, e solo a lui, è stato riservato questo
trattamento? Sia Veltroni che Signorile tendono a evitare il nodo: fondamentale
fu l’atteggiamento del Pci. Berlinguer e Pecchioli furono molto chiari in primo
luogo con Andreotti presidente del Consiglio e
con Zaccagnini e Galloni, segretario e vicesegretario della Dc: al primo accenno
di trattativa il governo sarebbe saltato. Quindi Andreotti non ebbe
l’atteggiamento notarile che Signorile gli attribuisce: no, Andreotti fu attivo
nell’impedire o bloccare sul nascere ogni ipotesi di trattativa. Giustamente
Veltroni ricorda che egli intervenne anche per infilare due parole nell’appello
che Paolo VI rivolse ai brigatisti e che sostanzialmente lo vanificò: le due
parole furono «senza condizioni». Invece Paolo VI, che dai tempi della Fuci
negli anni ’30 aveva con Aldo Moro un rapporto profondissimo, fece di tutto per
salvarlo e, disperato, morì qualche mese dopo. Quindi Andreotti remò contro
raccogliendo in modo totale l’ultimatum di Berlinguer-Pecchioli (un autentico
tandem in quella vicenda), mentre Cossiga, ha ragione Signorile, si mosse
tenendo conto della posizione americana di cui, giorno per giorno, si faceva
latore al ministero dell’Interno quell’inquietante professor Steve
Pieczenik, ingaggiato come “esperto”: ma era un esperto o un
controllore/supervisore forse dello stesso tipo di quello o di quelli che,
sull’altro versante, diede ordini decisivi a Moretti? Come ricorda Signorile
anche tutto il contesto internazionale era contro Moro, non per ragioni
personali (è noto che a Kissinger Moro stava proprio antipatico), ma per il tipo
di operazioni che egli stava portando avanti: l’ingresso del Pci nell’area di
governo in un paese come l’Italia che allora (non è il caso attuale) rivestiva
una grande importanza sia in Europa sia nel Mediterraneo. È agli atti la
presenza alle lezioni di Moro di un singolare studente di nome Sokolov che
attirò l’attenzione dello stesso Moro e del caposcorta Leonardi. Perché anche
questo avvenne: Moro e Leonardi prima dell’attacco erano molto inquieti perché
avvertirono pedinamenti e altro. Ma non ottennero (da Andreotti e da Cossiga)
un’auto blindata mentre non possiamo non dire che la scorta era tecnicamente e
quantitativamente inadeguata. Non a caso l’idea originaria dei brigatisti era
quella di rapire Andreotti, ma dalle loro “inchieste” ricavarono il giudizio che
il presidente del Consiglio era “blindato” e che invece il presidente della Dc
era vulnerabile. La dottrina della fermezza impostata da Berlinguer-Pecchioli si
tradusse nella prassi della sciatteria e dell’inerzia. Clamoroso il caso
Gradoli. Prodi aveva avuto dal suo “piattino” (che probabilmente era il
corrispettivo dell’autonomia bolognese di Piperno e di Pace) la “dritta” giusta:
se le forze dell’ordine fossero allora arrivate a via Gradoli comunque il
rapimento di Moro sarebbe finito molto prima, visto che lì alloggiavano Moretti
e la Balzarani e di tanto in tanto passava anche la Faranda. Comunque, è chiaro
che, dal lancio del documento apocrifo del lago della Duchessa, scesero in campo
altri soggetti che interloquivano per loro conto con le Br. Ciò detto, sarei più
cauto di Signorile nella descrizione dei rapporti di forza all’interno del Psi
che allora erano molto bilanciati: nessuno, né Craxi né Signorile, aveva in
tasca una maggioranza certa. Direi piuttosto che a influenzare molto la
situazione interna del Psi sia stato il comportamento del Pci e quello che poi,
nel 1980, accadde nella Dc. Pesò molto lo schematismo e il settarismo di
Berlinguer. Non vorrei scandalizzare Veltroni, ma a mio avviso, paradossalmente,
vista la linea politica che Berlinguer portava avanti nei confronti della Dc e
del mondo cattolico, proprio lui avrebbe dovuto sostenere la linea scelta da
Craxi per salvare Moro. Nel momento di maggiore difficoltà della Dc, Berlinguer
avrebbe dovuto darle una sponda, non metterle il coltello alla gola come invece
fece e come teorizzò nelle sue lettere Tatò. Berlinguer avrebbe dovuto anche
fare i conti con un dato elementare: tutta la sua strategia si fondava sulla
persona di Moro. Senza Moro, nella Dc non andava avanti nulla, a maggior ragione
in una Dc prima costretta a rinchiudersi nella linea della fermezza, poi
scioccata dall’uccisione del suo leader. Lo stesso schematismo fu adottato dal
Pci nei confronti del Psi a partire dal comportamento sull’incarico di formare
il governo dato a Craxi da Pertini nel 1979. Personalmente ho il ricordo nitido
di un incontro che con Signorile avemmo con Barca e Chiaromonte: «proprio perché
la Dc si sta esprimendo contro il tentativo di Craxi è auspicabile una vostra
apertura che avrebbe l’effetto di migliorare i rapporti fra il PSI e il PCI».
Non cavammo un ragno dal buco anche perché Berlinguer su Craxi e su tutti noi
aveva gli stessi garbati giudizi espressi da Tatò nei suoi appunti. In effetti
proprio Berlinguer scelse di piegare la Dc ad una totale subalternità (ma la Dc
non era Galloni) e di marcare il suo giudizio sul Psi guidato da Craxi (una
banda di avventurieri della politica). In questo modo Berlinguer diede un
contributo decisivo alla determinazione della fase politica successiva, quella
del pentapartito e della rottura fra il Psi e il Pc.
Beppe Pisanu: «Per salvare
Moro Zaccagnini incontrò Craxi. Come poterono le Br passare inosservate?»
Walter Veltroni il 2 luglio 2020 su Il Corriere della Sera. L’ex dc: «Uno Stato
democratico più forte avrebbe accettato la trattativa e poi affrontato le Br».
Signorile: «Convinsi Fanfani ad aprire alle Br per salvare Moro. Poi accadde
qualcosa». L’onorevole Beppe Pisanu è stato, nel 1978, capo della segreteria
politica di Benigno Zaccagnini. È quindi un testimone privilegiato di quei mesi
di travaglio e dolore vissuti a Piazza del Gesù.
Che ricordo hai dei giorni del
rapimento Moro?
«Li ho vissuti come un’unica
interminabile giornata scandita da paure, incertezze, tribolazioni e qualche
barlume di speranza».
Zaccagnini come attraversò
quel periodo?
«Lo visse drammaticamente
perché lacerato: da un lato il desiderio di salvare la vita del suo più grande
amico, leader politico del suo partito e dall’altro l’esigenza di salvaguardare
lo Stato e di rispondere adeguatamente alla sfida sanguinosa delle Brigate
rosse. Un fenomeno che oggi forse abbiamo inquadrato dopo tanti anni di analisi
e ricerche, ma che allora sembrava militarmente organizzato e capace di portare
i suoi attacchi in tutta Italia, persino durante i cinquantacinque giorni. Era
una forza sconosciuta, che aveva consensi evidenti nelle fabbriche, nel mondo
della cultura, nei giornali...».
Il tuo 16 marzo? Dove eri,
come sapesti la notizia?
«Stavo uscendo di casa per
andare alla Camera, quando mi raggiunse la telefonata di una mia segretaria che
mi diceva confusamente di una aggressione a Moro, che era stato sequestrato, che
c’erano dei morti e di andare subito a Palazzo Chigi dove mi attendeva
Zaccagnini. La voce era talmente alterata che mi apparve uno scherzo di cattivo
gusto, mi sembrava quasi che la segretaria ridesse, invece stava piangendo».
Perché le Br scelsero il 16
marzo?
«Io credo perché eravamo alla
consacrazione parlamentare del progetto politico di Aldo Moro ed Enrico
Berlinguer».
Tu credevi in quel progetto?
«Sì, ci credevo profondamente.
Va ricordato che avevamo, col Pci, approcci diversi. Io ovviamente condividevo
quello moroteo, la solidarietà nazionale. Berlinguer sottolineava invece
l’importanza del compromesso storico come l’esito della riflessione sulla
vicenda cilena di Allende, ed esplicitava un richiamo chiarissimo al primo
storico compromesso, che era quello della Costituzione. E quel compromesso aveva
affascinato Moro. Lui parlava della Costituente con una nostalgia da innamorato.
Ricordava i confronti appassionanti, specialmente sui primi tre articoli, tra
Dossetti, lui, La Pira da un lato e dall’altro Togliatti, Marchesi, Lelio Basso,
Nilde Iotti. E lo ricordava come un periodo politicamente felice, di grandi
architetti che diedero vita, nonostante la durezza estrema dei conflitti
politici del tempo, alla bellissima Costituzione italiana».
Hai mai avuto la sensazione
che ci fosse la reale possibilità che Moro fosse liberato?
«Più che la sensazione, la
speranza. E il momento almeno per me più positivo, fu la lettera di Paolo VI
agli uomini delle Brigate rosse. Mi illusi che, avendo ottenuto
un’interlocuzione così alta, i brigatisti potessero considerare raggiunti gli
scopi politico propagandistici della loro impresa e quindi desistere dall’andare
oltre. Però al di fuori di quel momento, no, non ci fu mai nulla di così
convincente da far sperare nella sua liberazione».
La prospettiva di Moro e
quella di Berlinguer non piacevano né agli americani, né ai sovietici...
«Questo era un dato
consolidato. Del resto Berlinguer e Moro avevano ricevuto entrambi pressioni
veementi, persino minacce. L’uno da Mosca e l’altro da Washington e da almeno
altre due capitali dell’alleanza atlantica. Quella operazione politica faceva
saltare a gambe all’aria la logica di Yalta, che aveva retto fino ad allora gli
equilibri mondiali. E quindi c’erano interessi fortissimi contro questa
operazione: dal punto di vista di Mosca avrebbe accreditato l’eurocomunismo, o
meglio l’idea berlingueriana del socialismo nella libertà, affrancando
definitivamente da Mosca il più grande partito comunista dell’occidente mentre
da parte americana si intravedeva il rischio che i comunisti si avvicinassero
pericolosamente ai centri di decisione della Nato».
E da questo punto di vista il
lago della Duchessa che segnale era?
«Sulle prime al lago della
Duchessa ci credemmo un po’ tutti perché era ritenuto un esito possibile. Almeno
noi a piazza del Gesù, altri non so».
E poi?
«E poi si scoprì che era un
bluff, ma qui parliamo del senno di poi. Io sto cercando di parlare di quei
momenti col senno di allora».
Però poi apparve abbastanza
rapidamente che era una manovra...
«Era un’operazione
orchestrata. È stata rivendicata come un espediente per stanare le Brigate
rosse. Ma è lecito dubitare delle intenzioni e dell’efficacia».
Che impressione ti fa che il
comitato che indagava attorno a Cossiga fosse composto per la stragrande
maggioranza da iscritti alla P2 e che in quei giorni si aggirasse questo
singolare consulente americano che sembrava avere a cuore solo il desiderio di
vedere Moro morto?
«La scoperta successiva di
questi due elementi a me ha provocato grande inquietudine, sapevo dell’ostilità
diffusa che c’era in certi ambienti nei confronti della segreteria Zaccagnini e
di Moro. Moro ci aveva trasmesso la percezione chiara che nel Paese c’era una
destra profonda, annidata negli angoli bui della società e delle istituzioni,
contraria ad ogni forma di rinnovamento e pronta ad intervenire con ogni mezzo.
Cossiga era un amico di Moro e non aveva nulla da spartire con quel mondo.
Certamente fece degli errori e fu lui il primo a riconoscerli quando si dimise
da ministro dell’Interno e assumendosi la responsabilità politica di errori e
limiti non suoi come quelli degli apparati di sicurezza. Ma da qui a gettare
ombre sulla sua rettitudine, ne corre. E ben lo seppero i grandi elettori che,
sette anni dopo, lo elessero presidente della Repubblica alla prima votazione».
Le lettere di Moro, fin
dall’inizio, vengono fatte passare come totalmente estorte. Invece a leggerle
c’è tutto il filo del modo di ragionare, della visione del mondo di Moro. Perché
fu fatta questa operazione di cordone, di muro attorno a quelle lettere?
«Parlando sempre col senno di
allora, noi avemmo la sensazione che fosse in corso un’azione subdola volta a
screditare l’immagine morale e politica di Aldo Moro. Poi la rilettura critica
fatta in sedi storiografiche degne di rispetto ha dimostrato che questa
operazione le Brigate rosse la fecero veramente, mentendo ripetutamente a Moro e
revisionando anche i testi. Questa era allora la nostra preoccupazione. Ma oggi
penso che tra i disorientamenti di quei giorni, questo sia stato uno dei più
dolorosi. Perché in realtà Moro, a parte i condizionamenti delle Brigate rosse,
stava facendo vivere esattamente le idee che aveva sempre sostenuto sul primato
della persona umana e sul suo irrinunziabile valore».
C’è una frase nelle lettere di
Moro che mi ha molto colpito. In una delle lettere non consegnate e poi
ritrovate a Monte Nevoso, ad un certo punto lui dice, te la cito testualmente:
«Spero che l’ottimo Giacovazzo si sia inteso con Giunchi». E chi sono Giacovazzo
e Giunchi? Erano i due medici che lui si era portato in America e che lo
curarono dopo che lui ebbe quel drammatico incontro con Kissinger. Quindi è come
se lui stesse dicendo alla moglie che quella era una chiave. È
un’interpretazione corretta la mia?
«Non so se è corretta, però è
degna di ascolto. I due non si intendevano. Kissinger manifestava rudemente
l’insofferenza per Moro. E Moro lo considerava un maleducato. E per uno come
lui, che era sempre sorvegliato e gentile, a me suona come un giudizio
severissimo».
Lui ti raccontò mai
quell’incontro?
«No. Però ne ho sentito
parlare dai suoi stretti collaboratori. Corrado Guerzoni ha lasciato
testimonianze scritte inequivocabili. Furono incontri duri, dai quali Moro uscì
provato, soprattutto quello del G7 di Santo Domingo quando non solo gli
americani, ma gli europei, soprattutto i tedeschi, gli fecero capire chiaramente
che, con la solidarietà nazionale, sarebbe venuto meno il sostegno dell’Europa
all’economia italiana. Il Paese era in gravissime difficoltà: il Pil a meno 4,
l’inflazione che marciava verso il 20%, le strade insanguinate dal terrorismo.
Gli fecero capire che gli aiuti sarebbero arrivati solo se lui avesse desistito
dal progetto politico che stava coltivando. E Moro fu talmente impressionato che
esortò i suoi collaboratori a far sapere che stava pensando seriamente di
lasciare la politica».
Tu credi alla versione delle
Br sull’assassinio di Moro in quel garage di via Montalcini?
«Io credo molto poco a tutto
quello che hanno detto i brigatisti rossi. Ho sempre avuto, e ho ancora,
l’impressione che abbiano concordato tra di loro una versione comune dell’intera
vicenda tacendo più spesso e altre volte mentendo, ma dopo aver concordato
silenzi e menzogne anche con loro referenti esterni».
Che quindi esistevano?
«Mi sovviene qui la mia
esperienza politica complessiva. Come fa un fenomeno come quello delle Brigate
rosse a passare inosservato agli occhi di Servizi segreti oculatissimi e
presenti in Italia massicciamente fin dagli inizi della guerra fredda? Non ho
nessun elemento concreto per accampare sospetti, penso però che non sia casuale
il fatto che terroristi italiani potessero tranquillamente viaggiare da Roma a
Parigi, da Parigi al Nordafrica e dal Nordafrica magari in Nicaragua. E che dire
di quell’opaca dottrina Mitterrand che consentì a pluriassassini di passare
tranquillamente per esuli politici in Francia? Come si fa ad ignorare tutte
queste cose? Ripeto io non ho nessun elemento, ma proprio nessuno, per
affermare, tanto per essere espliciti, che le Brigate rosse siano state pilotate
dall’estero, però mi sembra molto difficile che non avessero collegamenti
esterni. E mi spiego perfettamente il fatto che di questo si siano guardati bene
dal parlare».
Moretti chiama casa Moro pochi
giorni prima dell’assassinio e dice che per evitarlo è necessaria una posizione
chiarificatrice di Zaccagnini. Quale fu la su reazione?
«Non si capiva in che cosa
doveva consistere la posizione chiarificatrice, c’era molta vaghezza. Quando il
Partito Socialista ruppe il fronte della fermezza emerse l’idea che era
possibile una qualche forma di trattativa con le Brigate rosse. Quello che
ricordo bene è che il 26 aprile Zaccagnini, nonostante i pareri dei capigruppo
dc Piccoli e Bartolomei e di altri amici, decise di andare lui da Craxi per
chiedergli che cosa esattamente si potesse proporre. Fu piuttosto deluso: Craxi
ipotizzò solo la possibilità di concedere la grazia a tre terroristi che non si
fossero macchiati le mani di sangue. Questo passo di Zaccagnini suscitò anche
critiche da altre parti politiche, dal Partito repubblicano al Partito
comunista, che temettero un’intesa tra Craxi e Zaccagnini. Era un tempo di
sospetti politici che avvelenavano la ricerca di una soluzione: mentre Pci e Pri
temevano una convergenza tra Dc e Psi in casa socialista si temeva invece che
l’intesa sulla linea della fermezza tra Zaccagnini e Berlinguer potesse
stringersi come una morsa politica sul Partito socialista italiano. Ci furono
istanze umanitarie ed esigenze politiche che si intrecciarono ovviamente,
talvolta però anche con giochi di più modesta portata».
Come si muoveva in questo
labirinto un galantuomo come Zaccagnini?
«In questo intreccio di
istanze politiche e umanitarie Zaccagnini tenne una linea rigorosa nel senso che
umanamente pensò non bisognasse lasciare nulla di intentato — uso un’espressione
che lui dettò a me personalmente — per restituire Aldo Moro alla famiglia e al
suo partito. E al tempo stesso si attenne lealmente alle intese che si
raggiunsero sulla linea della fermezza nella convinzione politica profonda che
non ci fosse alternativa a questa linea. Siamo chiari: l’apertura di una qualche
trattativa da parte della Dc avrebbe provocato la caduta immediata del governo e
il probabile collasso delle istituzioni già fortemente debilitate. Lasciami
aggiungere col senno di poi che uno stato democratico più forte e con una più
solida maggioranza parlamentare forse avrebbe accettato la trattativa per la
liberazione di Moro e poi avrebbe regolato a suo modo i conti con le Br».
È vero che Leone era
disponibile a firmare?
«Per quel che mi risulta al
ministero di Grazia e Giustizia si stava studiando il modo di formulare una
proposta di grazia senza che ci fosse la richiesta. Si ipotizzava infatti un
gesto unilaterale dello Stato, non conseguente ad una trattativa. Si cercò anche
di individuare dei brigatisti detenuti che fossero in cattive condizioni di
salute. Ed è vero che Leone disse “Ho la penna in mano”».
E la Dc era d’accordo su
questo?
«Si lavorò a questa ipotesi ma
non fu mai definita perché si percepiva che in tutto questo gran parlare di
possibilità di salvezza di Moro, non c’era nulla di concreto. C’erano le
sollecitazioni che arrivavano dalle Br e poi le notizie che di rimbalzo
giungevano dal Partito Socialista che sembrava avere una sua linea di
comunicazione con i brigatisti. Abbiamo appreso dopo che faceva capo a Pace e
Piperno. Solo fumi, niente che ci potesse far immaginare a quale gesto avrebbe
corrisposto davvero la liberazione di Moro».
Quella di Signorile
sull’intenzione di Fanfani di prendere posizione nella riunione della direzione
dc del 9 maggio è una ricostruzione che ti convince?
«Non ne sapevo nulla allora e
non vorrei far polemiche adesso. Non so cosa Fanfani avrebbe detto in Direzione.
La riunione si fece, ma purtroppo fu interrotta perché arrivò la notizia. Arrivò
a me. Mi chiamarono al telefono e mi comunicarono che avevano trovato la Renault
rossa a via Caetani. Rientrai subito nella sala della Direzione e balbettai
qualcosa all’orecchio di Zaccagnini. (A questo punto Pisanu si ferma, commosso).
Lui si alzò, pronunziò poche parole. Si fece silenzio e la riunione finì. Sono
comunque certo che se Fanfani avesse indicato una via praticabile Zaccagnini lo
avrebbe assecondato. Di questo ho la certezza morale».
Voi sapevate che Fanfani stava
per fare un discorso di questo tipo?
«No, io almeno non lo sapevo.
Può darsi lo sapesse Zaccagnini però negli anni successivi non me ne ha mai
parlato. Per la verità era diventato difficilissimo parlare di quelle vicende
tra di noi, perché la ferita faceva male davvero. In molti rimanemmo feriti, ma
Zaccagnini fu ferito a morte».
Perché la sinistra Dc perde il
Congresso dell’80?
«Essenzialmente perché non
c’era più Moro. Noi morotei eravamo esattamente l’8,5 per cento della Dc, la
corrente più piccola del Partito. Ma Moro era l’equilibratore supremo della vita
interna della Democrazia cristiana. Con la sua morte noi zaccagniniani e anche
le altre sinistre interne perdemmo la guida vera. La segreteria Zaccagnini era
stata una geniale invenzione di Moro, con l’accordo di Fanfani. E tutta
l’esperienza di Zaccagnini, fino a via Caetani, fu ispirata dal pensiero di
Moro. Zaccagnini era il capo del popolo democristiano, Moro era il leader più
prestigioso e aveva già lasciato segni indelebili lungo i primi trent’anni della
storia repubblicana. Dalla costituente alla ricostruzione, dal centrismo al
centrosinistra e infine alla solidarietà nazionale, Moro fu sempre, all’interno
della Dc e nei rapporti con gli altri partiti, l’uomo del dialogo e del
confronto. Ma innanzitutto fu un cattolico di profonda fede con un senso alto
della laicità della politica e dello Stato. Era stato capace di far evolvere,
Dio solo sa con quali resistenze, la politica italiana verso la prospettiva di
una democrazia dell’alternanza. Per questo ha pagato. Nessuno può dimenticarlo».
È vero che nel 2006, quando il
risultato delle elezioni era incerto, fosti sollecitato, come ministro
dell’Interno, a dichiararle non valide?
«Diciamo che ci furono
chiacchiere molto confuse da parte di gente che non sapeva che il ministro
dell’Interno non aveva alcun potere per interferire sulle procedure elettorali,
perché i risultati delle elezioni si proclamano soltanto nelle apposite sezioni
delle Corti d’Appello. Non a caso il nostro ordinamento affida alla magistratura
e non al ministero dell’Interno la gestione dei processi elettorali. Ci
mancherebbe altro, se fosse così saremmo in una dittatura».
Ti chiedo infine di ricordare
un momento vissuto con Zaccagnini.
«Un giorno gli chiesi perché
mai nel testo di un discorso che doveva di lì a poco pronunciare avesse
cancellato per tre volte la parola disoccupazione e l’avesse sostituita con la
parola disoccupati. Mi rispose: “Perché disoccupazione evoca astrattamente una
questione sociale, mentre disoccupati evoca un padre di famiglia che una sera
torna a casa e dice a moglie e figli “ ho perso il posto di lavoro, da domani
dobbiamo stringere la cinghia, finché non ne trovo un altro”. Era l’umanità
della politica. Era Zaccagnini».
Claudio Signorile:
«Convinsi Fanfani ad aprire alle Br per salvare Moro. Poi accadde qualcosa».
Walter
Veltroni il 20 giugno 2020 su Il Corriere della Sera. La ricostruzione dell’ex
socialista: «Cossiga mi chiamò nel suo ufficio e poco dopo fu informato del
ritrovamento del corpo. Mi sono chiesto perché io fossi lì, dei sospetti li ho».
Claudio Signorile era, nel tempo del rapimento Moro, vicesegretario del Psi. È
stato tra i più impegnati nella ricerca di una soluzione politica che salvasse
la vita del presidente della Dc. Per questo incontrò più volte esponenti
dell’autonomia romana. Qui racconta la sua convinzione, maturata negli anni.
Qualcuno ha accelerato la fine di Moro perché consapevole che la mattina del 9
maggio, alla direzione Dc, Amintore Fanfani avrebbe fatto quell’apertura che le
Br, in una telefonata di Moretti alla famiglia Moro, avevano richiesto come
condizione per non eseguire l’assassinio dello statista. Signorile aveva
convinto nei giorni precedenti Fanfani ed altri esponenti Dc a fare un passo.
Con lui torniamo a quelle ore. «Quella che avevamo concordato non sarebbe stata
una posizione isolata di Fanfani. Altri, come Donat Cattin, Bisaglia, Emo Danesi
mi avevano garantito che avrebbero sostenuto quella linea. Ciò avrebbe prodotto
una modifica degli orientamenti precedenti e avrebbe messo le Br in una
condizione di difficoltà. E insieme un segno di attenzione per quello che
stavano facendo i socialisti. Sarebbe stata una riunione importante, molto
importante».
Chi avrebbe potuto sostenere
la linea di Fanfani?
«I dorotei non erano amici di
Moro, però Bisaglia era amico di un rapporto con i socialisti: in politica si
intrecciano le convergenze più complesse. Un comportamento ispirato ad una
preoccupazione umanitaria corrispondeva anche, in quel momento, ad una logica
politica».
L’impressione che tu avesti
dai colloqui con Piperno e Pace fu che questa posizione di Fanfani sarebbe stata
sufficiente?
«In quel momento ero convinto
di sì. Perché ti dico in quel momento? Perché in questi anni mi sono convinto
che Piperno pensasse di sapere delle cose che probabilmente non sapeva. Cosa
voglio dire? Che forse il tavolo sul quale si stavano giocando le carte era
cambiato. Ecco perché io insisto molto sugli ultimi giorni del rapimento. Dopo
il lago della Duchessa io comincio ad avere non dei dubbi sulla buona fede di
Piperno che si comportò correttamente, ma sulla reale capacità di orientamento
delle decisioni da parte del gruppo cosiddetto politico. Per questo è sbagliato,
nel ricostruire le cose, affidare tutto al rapporto nostro con Piperno e Pace.
Perché molto probabilmente già allora si era stabilito un intreccio fra il
sistema dei Servizi e la realtà del brigatismo».
Stai dicendo una cosa
importante...
«Faccio una riflessione:
nell’estremismo italiano, all’inizio, noi abbiamo due componenti: il braccio
armato delle Brigate rosse al cui interno c’è anche una dialettica e poi
Autonomia operaia, Potere operaio, cioè le formazioni politiche. Ad un certo
punto, prima del rapimento Moro, avviene una rottura. Autonomia operaia, Potere
operaio o comunque il gruppo che si forma, di cui Piperno è uno dei portatori,
ha una visione, un obiettivo politico, eversivo ma politico, mentre il braccio
armato, le Br, coloro che scelgono la lotta armata, hanno bisogno di un alleato
che sia in condizioni di dare loro armi e denaro. È quasi fatale, è una verità
storica. Non mi metto neanche a discuterne, è fatale».
Quali Servizi?
«Lo dico per l’esperienza
diretta di quegli anni. L’Italia era nel cuore di un sistema di Servizi che l’un
l’altro si controllavano, si intersecavano, si combattevano. Ma era un sistema.
L’Italia è troppo importante strategicamente. Lo è per il suo essere un Paese
Nato, per la sua collocazione nel Mediterraneo, per la presenza di un partito
comunista al trenta per cento. Io credo che già nel momento dell’organizzazione
del rapimento ci sia stata una forma di sostegno, o di aiuto. Tutta la vicenda
dei cinquantacinque giorni va letta con un doppio riferimento: i brigatisti che
direttamente, fisicamente, compiono l’operazione — anche con una dialettica
interna tra la componente più politica e quella militare — e le forze
internazionali intenzionate ad assicurare una determinata evoluzione di quel
passaggio storico. Quando avviene il depistaggio della Duchessa è chiaro che
quel Sistema sta dando un segnale. È il segnale che è cambiata la gestione. L’ho
pensato e poi mi è stato confermato. Un cambio di gestione. Da quel momento
tutto scivola rapidamente verso l’assassinio».
E tu cosa fai?
«Cosa potevo fare? Vado
avanti. Ho convinto Fanfani a fare il passo. Pensavo, forse ingenuamente, che
avessimo, comunque, a che fare con un soggetto politico. Le Br avevano chiesto
esplicitamente un gesto chiarificatore della Dc e quello si stava per
determinare. Loro potevano anche pensare che comunque l’obiettivo fosse stato
raggiunto. Dare un colpo alla solidarietà nazionale, ricevere una legittimazione
e delegittimare Moro che, anche libero, sarebbe stato politicamente finito. Ma
questo era un atteggiamento politico, invece scattarono altre logiche e altri
interessi. In quelle ore pensavo ancora che una posizione della Dc, dopo la
telefonata di Moretti a casa Moro, non poteva essere ignorata. Bisognava
stringere i tempi. Io continuo a ritenere di essere stato intercettato, quando
chiamai Craxi dal telefonino della macchina per raccontargli dell’incontro con
Fanfani. Tutti noi eravamo seguiti e ascoltati. Forse, sapere che la Dc si stava
muovendo, ha spinto chi lo voleva morto a stringere i tempi. È il grande quesito
che mi porto dentro. Dopodiché qualcuno ha sparato».
Che idea ti sei fatto sulle
ricostruzioni dell’assassinio in via Montalcini?
«Te lo dico onestamente,
qualsiasi ricostruzione io abbia visto fino adesso non riesce ad essere
convincente. La ricostruzione fatta dai brigatisti non convince, non è
palesemente vera, risulta da tante cose. Ci può essere stato un intervento
terzo».
Craxi ad un certo punto dice
«È venuto qualcuno da fuori»...
«Un intervento terzo. Se sono
vere le cose che ti sto dicendo, perché no? Si ha a che fare con figure tipo
Moretti che sono assolutamente subalterne, borderline, forse anche più di
borderline. È una situazione in cui i Servizi, diversi, conflittuali ma
guardiani dell’equilibrio di Yalta, convergono nella volontà che la vicenda si
concluda con la morte di Moro, considerato l’artefice della politica di
solidarietà nazionale che nessuno dei due blocchi poteva accettare. Anche se,
per esempio tra gli americani, esistevano due posizioni diverse, allora. Più
contrario il Dipartimento di Stato, più favorevole, sembra incredibile, la Cia.
Io ero andato negli Stati Uniti ad ottobre del ’77. Cerco lì di spiegare le
cose: ripeto a tutti una frase apparentemente banale: “Il Partito Comunista
Italiano, con Berlinguer, ha preso una posizione importante sulla Nato. Ed è il
più grande partito comunista dell’occidente? È un bene o un male che questo
avvenga?”. Loro ammettono: “Un bene”. Allora di cosa stiamo parlando?».
Perché secondo te tutti,
compreso Maccari in punto di morte, sono rimasti su quella posizione? Cioè
perché non c’è mai stata una smagliatura?
«Ti faccio una domanda: perché
avrebbero dovuto? Con una smagliatura si riapre tutto. Senza quella smagliatura
si chiude tutto. Io preferisco morire non lasciando strascichi dietro di me.
Messa così si capisce meglio. Tutto si è chiuso, come una porta blindata. Oggi
chi vuole la verità?».
Perché la polizia non ha
seguito Piperno e Pace che evidentemente, dopo i colloqui con voi, riferivano a
qualcuno il contenuto?
«Perché aveva avuto
indicazione di non farlo».
Da Cossiga?
«Da chi poteva dargli queste
indicazioni. Non lo so, quindi non mi permetto di fare illazioni. Certamente è
incredibile che, sapendo che noi avevamo questi incontri, in quei giorni nessuno
abbia predisposto pedinamenti... Eravamo sotto uno stretto controllo. Pensa che
allora ci davano una pistola per difenderci...».
Rino Formica mi ha detto che
«non è vero che non avessimo avvertito, Cossiga e Leone erano informati».
«Leone sì, con Cossiga non
avevo un rapporto allora. Non gli parlai mai di queste cose perché non mi fidavo
di lui. Leone, per aver dimostrato disponibilità a cercare strade per la
liberazione di Moro, ha pagato un prezzo altissimo».
Parlami di Cossiga e Andreotti
in questa vicenda. Andreotti sembra sempre defilato...
«È garante dello statu quo,
non è defilato. Se si creano le condizioni per la liberazione di Moro lui non le
ostacola, ma non fa niente per produrle».
Mette mano all’appello di
Paolo VI per chiudere ogni spiraglio...
«Lui è presidente del
Consiglio di un governo che non può andare in Parlamento perché non ha
maggioranza parlamentare. Andreotti era leale verso gli alleati. In tutta la
vicenda non fa nulla in favore di una soluzione. Non facilita, non ostacola. La
posizione di Cossiga è diversa. Più che allievo di Moro, lui mi sembrava allievo
di se stesso. Cossiga ha sempre avuto un rapporto con i Servizi. Forse era
naturale che fosse così. Ma in quel periodo avviene un radicale mutamento degli
assetti dei Servizi. È un fatto storico che gran parte dei vertici furono
inquinati dalla P2. E non ho mai capito l’uso di quel consulente americano che
ha sempre dichiarato esplicitamente di avere come unico obiettivo quello di
assicurarsi che Moro non uscisse vivo dalla prigione Br. Cossiga in quel periodo
sta costruendo il suo futuro politico. Se Andreotti è il garante dello statu
quo, Cossiga è il garante del divenire, di quello che si sta preparando».
La morte di Moro è stato un
demone che non lo ha mai lasciato, c’era in lui un dolore autentico...
«Era Presidente della
Repubblica. Parlando una volta del 1978 mi capita di dire: “Poi bisogna andare a
guardare in quelli che sono i santuari, perché esistono”. La mattina dopo arriva
una telefonata del capo dello Stato. “Ti voglio dire subito che questa
telefonata è intercettata”. Ho risposto: “Francesco è tuo diritto farlo, fallo,
cosa c’è?”. “Volevo dirti che queste cose che tu hai detto non corrispondono a
verità”. Ho replicato: “Guarda che tu non c’entri, non c’è nessun riferimento a
te”. Insomma mi fa capire che lui allora avrebbe potuto tirare fuori delle altre
intercettazioni del periodo dei nostri tentativi. Allora io chiudo: “Non pensavo
a te, non ho nessuna intenzione di fare reati di lesa maestà nei confronti del
Presidente. Quindi finiamola qui”. C’erano delle cose sulle quali lui era
reattivo in maniera impressionante. C’è una circostanza che non finisce di
turbarmi. Quando mi chiama da lui la mattina dell’assassinio, prima del momento
in cui viene trovato Moro, perché lo fa? Io allora ho pensato che volesse
commentare ciò che stava per accadere nella Dc quella mattina. Vado lì, ma lui
non fa nessun cenno a questa cosa. Allora penso: forse lui ha la notizia che
l’hanno liberato o lo stanno liberando. Se no perché mi ha chiamato? Fa in
maniera che io sia lì quando si apprende di Via Caetani. Nel suo ufficio c’era
una cicalina collegata con il Prefetto e il capo della Polizia. “È stata
individuata un’automobile, andiamo a vedere”. Un attimo di silenzio e poi: ”È la
nota personalità”. Cossiga diventa bianco, dice: “Mi devo dimettere”. “Devi
farlo”, gli dico. Ci abbracciamo, me ne vado. Perché mi ha fatto andare lì
quella mattina? Me lo chiedo ancora oggi».
Tu che spiegazione ti sei
dato?
«Non me la sono voluta dare.
Però il pensiero peggiore è che lui consapevole che la vicenda si stava
concludendo volesse un testimone inattaccabile in grado di dare conto della sua
sorpresa e del suo sgomento. Devo pensare questo. Non ne ho mai parlato, non ho
mai aperto polemiche su questo. Ma Cossiga, in quel tempo, guardava “oltre”».
Quando Craxi parla del grande
vecchio a chi si riferisce?
«Non a una persona, a un
sistema. È il destino disgraziato di questo Paese di frontiera attraversato
dagli interessi pesanti della Guerra fredda. Eravamo in piena Seconda Guerra
fredda, alla fine degli anni Settanta. C’è Ustica due anni dopo, e gli
euromissili...».
Cosa morì, politicamente, con
l’uccisione di Moro?
«C’è stata sempre confusione
su questo. La solidarietà nazionale non finisce subito dopo il 9 maggio. Resiste
due anni. Perché Berlinguer, che non era un estremista irresponsabile, voleva
chiudere il percorso iniziato in quella legislatura. Nel Psi il fatto che io
avessi la maggioranza poteva scongiurare l’idea di un governo senza il Pci,
suggestione che pure si faceva strada. Berlinguer voleva essere il leader del
Pci che completava la legittimazione del suo partito, che apriva la strada alla
praticabilità di quella democrazia dell’alternanza che era la sola formula
possibile per la governabilità italiana. Non l’alternativa, non la semplice
solidarietà nazionale, ma uno schema nel quale Dc e sinistra — che avrebbe
regolato all’interno il tema dei rapporti di forza tra socialisti e comunisti —
potevano tornare a competere. Un disegno lucido. Era quello di Moro, “la terza
fase”. Per questo la storia del rapimento è finita in quel modo. Quel progetto,
utile per la democrazia italiana, era incompatibile con gli equilibri della
Seconda Guerra fredda».
E la Dc?
«Dc e Pci vanno alle elezioni,
nel 1979, pensando che ne uscisse un risultato non dissimile da quello del 1976
e questo consentisse di continuare quel processo politico. Ma non fu così.
Persero voti ambedue. A quel punto Berlinguer comincia a cambiare rotta ma,
soprattutto, comincia a cambiare rotta Craxi. Io ho ancora la maggioranza nel
partito, De Michelis non ha ancora fatto il passaggio con gli autonomisti. Dopo
le elezioni c’è l’incarico a Craxi, il primo incarico. L’idea era Craxi
presidente con la maggioranza di Moro. Io mi faccio il giro del mondo, visti i
precedenti, per convincere. C’è il sì di tutti, meno della Dc. Il Pci non si
oppone, forse pensando che la cosa sarebbe morta per l’opposizione
democristiana. Nel 1980 il congresso della Dc si apre con la maggioranza di
Moro. Nel senso che la relazione di Zaccagnini parla di emergenza senza
alternative: voleva dire governo di solidarietà nazionale. La maggioranza sulla
carta c’è: Zaccagnini, Andreotti, e i dorotei che portano a casa il segretario
del partito, Piccoli. Galloni, che era vicesegretario uscente, convince invece i
suoi ad andare da Zaccagnini per dire che la sinistra dopo la morte di Moro non
poteva accettare un segretario che non fosse della sinistra, cioè lui. Si
sfascia così la maggioranza. I dorotei capiscono l’aria, prendono armi e bagagli
e fanno l’accordo con Donat Cattin e con Forlani. La stupidità fu non aver
capito, cosa che a me era chiara, che i dorotei erano il punto di
interlocuzione. Se il congresso della Dc si fosse chiuso come si era aperto,
cioè con la maggioranza Andreotti, Zaccagnini, dorotei, probabilmente parleremmo
di un’altra storia nazionale. Poi la domanda vera è: avrebbe retto la Dc senza
un leader forte? Fatto sta che nasce, senza il Pci e con l’appoggio esterno del
Psi, un governo Cossiga. Il garante dell’avvenire».
In una puntata della
bellissima trasmissione di Zavoli «Notte della Repubblica» tu, parlando delle
riunioni di quei giorni con la Dc, dici: «Mi fermo perché dovrei raccontare
episodi imbarazzanti».
«In quell’incontro tra le due
delegazioni, Zaccagnini non aprì bocca, disse solo a Craxi: “Vuoi bere qualcosa?
Portate due bottiglie d’acqua”. Tutto qui, in una riunione di sette ore. Disse
solo questo perché parlava sempre Galloni. Lui non profferì parola. Era una
riunione inutile, nella quale loro si tenevano accuratamente lontani dal
problema».
Come interpretasti il loro
atteggiamento?
«Non potevano far nulla perché
avevano, come priorità, il rapporto col Pci come rapporto dominante. Non
rendendosi conto, così dicevo a Bisaglia, “che se i socialisti dicono di no, voi
non potete fare niente con il Partito comunista, neanche andare a prendere un
caffè. Senza il Psi non potete avere un rapporto con il Pci”».
Faccio a te, in conclusione,
la stessa domanda che ho rivolto a Hollande. Il socialismo, egemone in Europa
negli anni Novanta, è stato consumato dagli scenari del nuovo millennio?
«No, assolutamente. Abbiamo
vissuto una lunga stagione di globalizzazione economica finanziaria in cui
il mainstream culturale è stato il neoliberismo. Siamo stati tutti, in qualche
modo, vittime o comunque partecipi di questo. Siamo entrati ora in una
globalizzazione della sopravvivenza nella quale è il socialismo quasi
necessariamente il punto di riferimento culturale ideologico. Quello che è morto
è il socialismo classista, antagonista, autoreferenziale. Quello che sta
crescendo è invece un socialismo umanitario, comunitario. È la globalizzazione
per la sopravvivenza e non per il puro profitto. La globalizzazione comunitaria
sul piano sanitario, sociale, ambientale. Un mondo nuovo».
La Cia non si fidava di Dc
e Psi e puntò su Berlinguer.
Paolo Guzzanti su Il
Riformista il 22 Novembre 2019. Ieri abbiamo raccontato come gli Stati Uniti e
gli alleati occidentali fossero inclini a portare i comunisti italiani al
governo durante gli anni del Compromesso storico (fallito per la soppressione
del contraente e garante Aldo Moro) per due ragioni solide. La prima era
incoraggiare lo strappo del Pci da Mosca, iniziato da Enrico Berlinguer con la
scelta dell’ombrello della Nato e il riconoscimento della fine della “spinta
propulsiva della Rivoluzione d’ottobre”, ma poi rimasto senza una vera
conclusione, ciò che impediva agli alleati occidentali di condividere i segreti
militari. La seconda era il desiderio di liberarsi di democristiani e socialisti
che si erano rivelati infidi o addirittura nemici. Per questo era cominciata una
marcia di avvicinamento fra il Dipartimento di Stato e la stessa Central
Intelligence Agency, verso il Pci. La nota amicizia e reciproca stima
fra Giorgio Napolitano ed Henry Kissinger non sono casuali. E credo che quando
Giuliano Ferrara dice di aver lavorato per la Cia, intenda dire di avere aderito
a questo progetto, anche se bisognerebbe chiederlo a lui. Nel Partito dunque si
era formata e consolidata una forte corrente filoamericana duramente contrastata
da quella filosovietica di Armando Cossutta. Ciò che interessava agli
Occidentali non era affatto – come sosteneva la propaganda ispirata dall’Urss –
imporre governi golpisti, reazionari, padronali e nemici dei sindacati, ma
semmai il contrario: la Cia ha sempre perseguito una linea dura antisovietica,
ma per quanto possibile riformista e anche apertamente di sinistra purché
schierata contro l’Urss. Al Dipartimento di Stato americano interessava aver la
certezza che il personale di governo in Italia non andasse a spifferare ai russi
segreti di natura militare e strategica. Ciò che invece era accaduto in alcuni
casi con il personale specialmente democristiano. Le informazioni che sto
cercando di ordinare hanno le loro fonti in alcuni testi fondamentali, ascoltati
negli anni della mia presidenza della Commissione bicamerale d’Inchiesta sulle
influenze sovietiche in Italia, nel lavoro che ho svolto in quanto appartenente,
per molti anni, alla delegazione parlamentare italiana presso la Nato. D’altra
parte, il racconto che sto per fare non contiene alcun segreto ma solo molto
buon senso e può essere facilmente verificato e confermato con ricerche
accessibili. Cominciamo da Michail Gorbaciov. Chi era costui? Era il pupillo, il
prescelto e selezionato dall’uomo più intelligente, anche spietato, ma molto ben
informato dirigente che l’Unione Sovietica abbia avuto. Stiamo parlando di Yuri
Andropov, che fu prima il sovrano direttore del KGB per ben quindici anni, dal
1967 al 1982, anno in cui successe a Leonid Breznev, l’uomo immobile dalle
enormi sopracciglia. Andropov vide che la partita fra Urss e Stati Uniti con i
loro alleati, era in prospettiva una partita persa. E allevò, come suo
successore e uomo di fiducia, Gorbaciov, che aveva un appeal di tipo occidentale
per vivacità intellettuale, età e anche per avere una moglie elegante come
Raissa che poteva fare bella figura sulla scena internazionale. Poi le cose si
svolsero in maniera convulsa e imprevista perché Andropov morì prematuramente il
9 febbraio 1984, troppo presto per consolidare la successione del suo candidato
Gorbaciov, sicché le vecchie cariatidi del Cremlino insediarono il più
immobilista della loro cerchia, Konstantin Cernienko. Gorbaciov fu costretto a
saltare un turno e aspettare la morte di costui per salire sul podio più alto
del governo sovietico. Per comprendere la natura della politica militare di
quella fase, che riguardò direttamente la politica italiana per la vicenda dei
cosiddetti Euromissili, occorre fare un passo indietro, piuttosto lungo. Bisogna
cioè risalire all’inizio della Guerra Fredda, quando i Paesi occidentali si
erano riuniti nell’Alleanza Atlantica della Nato e quelli dell’Est, sotto
stretto comando sovietico, nel Patto di Varsavia da cui si sfilò soltanto la
Romania di Ceausescu, che pagò con la vita il suo sgarro in epoca gorbacioviana.
Esiste un libro che si chiama A Cardboard Castle? – An inside story of the
Warsaw Pact 1955-1991, che nessun editore italiano ha trovato conveniente
tradurre e pubblicare. Questo testo, certificato dai documenti originali, lo si
può acquistare via Internet e vale quel che costa. Il volume contiene, insieme a
due eccellenti saggi, tutti i verbali di tutte le riunioni del Patto di
Varsavia, dalla prima – 1955 – all’ultima – 1991 – seduta. Se si ha la pazienza
di leggere, si scopre che ogni riunione ripete con alcune varianti, lo stesso
schema: le potenze occidentali attaccano proditoriamente il blocco dell’Est che,
dopo aver fermato l’aggressione, prontamente contrattacca penetrando nell’Europa
occidentale con operazioni velocissime e brutali, e uso di un buon numero di
armi atomiche tattiche (cioè relativamente piccole ma capaci di polverizzare una
città) per sigillare le coste atlantiche e rendere uno sbarco americano
impossibile. Per questo il Patto di Varsavia aveva bisogno di missili “a medio
raggio” (cioè non in grado di attraversare l’Atlantico e colpire gli Stati
Uniti) ma capaci di mettere a tacere le difese europee. Qualcuno si chiederà a
quale scopo l’Urss e i suoi satelliti avrebbero compiuto una tale azione. Sia
Gorbaciov che Eltsin hanno fornito la spiegazione, ben illustrata anche
dall’intellettuale dissidente russo residente a Londra Vladimir Bukowski, mio
caro amico scomparso da poco, che scrisse un magistrale Urss, come l’Unione
Sovietica voleva inghiottire l’Europa dopo essere stato internato proprio da
Yuri Andropov in un lager in cui i prigionieri venivano mantenuti in stato di
sonnolenza perenne. In breve, il programma che Andropov tentò disperatamente di
spingere e che poi fallì, prevedeva una conquista fulminea dell’Europa
occidentale, Italia compresa naturalmente, in cui sarebbero stati instaurati dei
governi fantoccio ma con finte coalizioni precotte con ecologisti, finti
socialdemocratici, non troppi comunisti per dare una parvenza “democratica”. I
missili SS20 a testata multipla furono installati dai russi nei Balcani e in
Italia si scatenò un inferno politico contro l’installazione di missili Cruise e
Pershing 2 in Sicilia, capaci di contrastare tali armi. L’installazione cominciò
nel 1983 e in Italia, come nei principali Paesi europei, le sinistre e i
movimenti pacifisti dimostrarono duramente contro questi missili di risposta.
Nella lotta politica che si svolse in Parlamento e sulla stampa, oltre che nelle
piazze, il Pci dopo alcuni contorcimenti e qualche dissenso interno, si schierò
sulla linea gradita all’Unione Sovietica. Questo causò una frattura molto
profonda anche nell’Italian Desk di Washington, dove gli americani avevano
sperato a lungo che il Partito comunista italiano seguisse l’indicazione di
Berlinguer, che nel frattempo era scomparso, secondo cui ci si sentiva più
protetti sotto l’ombrello della Nato. Ma anche con questa frattura, peraltro
prevista realisticamente, non furono annullati i rapporti speciali tra la
frazione filoamericana del Partito comunista e Washington.
Dagospia il 28 maggio 2020.
(estratti dal libro “Moro, il caso, non è chiuso”, LINDAU , 2019, di
M.Antonietta Calabrò e Giuseppe Fioroni). La strage di via Fracchia, a Genova,
che si svolse in piena notte il 28 marzo del 1980, rappresenta una delle
vicende più complesse della storia delle Brigate Rosse e delle azioni che le
contrastarono, lasciando molti interrogativi sul reale svolgimento
dell’irruzione, divenuto poi un evento cui si riferì simbolicamente la lotta
armata, con la costituzione di un gruppo milanese denominato appunto «XXVIII
marzo». Fu la Brigata “XXVIII marzo” che uccise l’inviato del «Corriere della
Sera», Walter Tobagi, proprio a due mesi dall’irruzione di Genova da parte degli
uomini del generale Dalla Chiesa, il 28 maggio 1980. Domani, vent’anni fa. Il
«Corriere della Sera», il 2 aprile 1980, negli articoli che illustravano
l’irruzione in via Fracchia segnala che sarebbe stata trovata nel covo br una
cartellina con un appunto «materiale da decentrare sotto terra». I giornalisti
presenti erano Antonio Ferrari inviato a Genova dal direttore Franco Di Bella
insieme a Giancarlo Pertegato e Tobagi, appunto, cattolico, socialista, vicino
al segretario Bettino Craxi, che ebbe un ruolo nella «trattativa» milanese del
segretario del Psi Bettino Craxi, durante il sequestro Moro, emersa solo negli
ultimi anni grazie alle indagini della Commissione Moro2 che ha chiuso i
battenti nel dicembre 2018. Facendo emergere tanti fatti e circostanze che
illuminano gli ultimi anni della vita di Tobagi, e forse, anche della sua morte.
Perchè la conoscenza di quegli anni è molto progredita, portando alla luce fatti
sorprendenti. Lo dobbiamo alla memoria di Walter, un grande giornalista.
L’impegno di Walter Tobagi per
salvare Moro. Umberto Giovine, iscritto al Psi sin da ragazzo, militando nella
Federazione milanese, aveva avuto incarichi nell’ambito dell’Internazionale
socialista ed era divenuto direttore di «Critica Sociale» alla fine degli anni
’60, ha dichiarato alla Commissione d’inchiesta Moro2 che: l’input per cercare
d’intervenire nella vicenda Moro per salvare la vita del sequestrato avvenne
qualche giorno dopo il sequestro, a Torino, durante il congresso del Psi. “Ebbi
modo di parlare con Walter Tobagi che conoscevo da molti anni e mi disse che
secondo lui avrei potuto e dovuto fare qualcosa attraverso «Critica Sociale»
visto che lui personalmente, data la sua posizione al «Corriere della Sera» non
poteva agire”. Questa attività milanese era speculare ad un’attività con le
medesime finalità e medesimi contenuti, una vera trattativa, che era stata
avviata a Roma dal segretario Craxi. “Craxi - continua Giovine - in ogni caso
poteva contare sull’appoggio e il contributo del generale Dalla Chiesa che era
responsabile nazionale delle carceri di massima sicurezza e che in tale veste
poteva muoversi anche in modo indipendente e senza specifiche autorizzazioni del
Governo. In quelle settimane non ebbi incontri personali con Craxi ma solo
colloqui telefonici protetti in quanto lo chiamavo nel ristorante dove andava a
pranzo o a cena”.
Il “tesoro” di Genova: tutte
le carte di Moro. Massimo Caprara scriverà più volte, in date diverse: «Disse a
caldo (dopo l’irruzione nel covo brigatista di via Fracchia, NdA) l’allora
procuratore della Repubblica di Genova, Antonio Squadrito: “La verità è che
abbiamo trovato un tesoro. Un arsenale di armi… Soprattutto una trentina di
cartelle scritte meticolosamente da Aldo Moro alla Dc, al Paese”». I due
articoli sono stati pubblicati anni dopo la barbara uccisione di Tobagi, nel
numero 1 di «Pagina», del 25 febbraio 1982, e nel periodico «Illustrazione
Italiana», n. 32, luglio 1986. La rivelazione di Caprara, ex segretario di
Palmiro Togliatti, è precisa e circostanziata. Ma di quelle trenta cartelle
«meticolosamente scritte da Aldo Moro», indicate dal magistrato che nel 1980 era
al vertice della Procura del capoluogo ligure, non è stata trovata alcuna
traccia agli atti del processo. I lavori della Commissione Moro 2 sono partiti
da qui. La quantità e l’importanza del materiale sequestrato in via Fracchia si
desumono esaminando il verbale di perquisizione e sequestro (acquisito agli atti
della Commissione) che reca un impressionante elenco di 753 reperti, che
certamente dal punto di vista investigativo poteva essere considerato un
«tesoro». Tenuto conto degli interrogativi che sono nati dai parziali
ritrovamenti documentali avvenuti nel covo di via Monte Nevoso a Milano (nel
1978 e nel 1990) , la citata esternazione di Squadrito, è apparsa meritevole di
serio approfondimento, anche alla luce delle indicazioni sul ruolo che la
colonna genovese guidata da Riccardo Dura ha giocato, secondo la Commissione,
nel sequestro Moro. Solo agli inizi degli Anni Duemila, sono cominciati ad
emergere nuovi fatti. Nell’articolo intitolato “Via Fracchia, ricordi
indelebili. Quella donna in giardino, l’uomo con il piccone, pubblicato venerdì
13 febbraio 2004, firmato da Simone Traverso sul Corriere Mercantile, storico
quotidiano della città della Lanterna, vengono riportati i ricordi raccolti
dalla «gente del civico 12», tra cui quello di «un uomo misterioso, forse
Riccardo Dura , che scavava con un piccone nell’erba alta delle aiuole».
Testimonianza questa che descrive una caratteristica peculiare del covo: la
presenza anche di un giardino di pertinenza, a cui si accedeva dalla cucina e
dalla sala da pranzo, e che conduceva alla parte posteriore dell’edificio. «Un
giardino che, incredibilmente – annota la Commissione Moro 2 – non trova
esplicita menzione negli atti processuali, né viene evidenziato nella
ricostruzione della planimetria dell’appartamento». Che sia stato effettuato uno
scavo nel giardino pertinenziale è stato confermato ai consulenti della
Commissione Moro 2 da Filippo Maffeo, intervenuto sul posto in qualità di
pubblico ministero di turno. Il magistrato ha indicato con certezza il
particolare che in giardino il terreno appariva smosso da poco tempo, precisando
le rilevanti dimensioni dello scavo, corrispondente, a suo avviso, al volume di
tre valigie di media grandezza. Uno scavo immediato e verosimilmente mirato non
poteva che scaturire dalla disponibilità di indicazioni precise.
Quell’operazione dovette durare ore ed ore e terminare, appunto, prima
dell’arrivo del magistrato di turno. Anche lo scavo di un’ampia buca nel
giardino del covo non fu riferito negli atti giudiziari del 1980, ma è stato
esplicitamente rievocato solo il 15 marzo 2017 nel corso delle dichiarazioni a
Palazzo San Macuto dal pm Maffeo.
L’agente tedesco nella
palazzina di Tobagi, le carte “segrete” di Moro. Umberto Giovine (che ha
illustrato da qualche anno il ruolo di Tobagi nella trattativa per Moro) ha
anche parlato della opaca vicenda di Volker Weingraber (alias Karl Heinz
Goldmann), un agente tedesco occidentale che operò in Italia durante il
sequestro Moro.
6 informative del Sisde che lo
riguardavano sono state desecretate dall’AISE (l’attuale servizio segreto
estero) nel giugno 2017. In particolare, dagli atti del nostro servizio segreto
– solo ora resi noti – risulta che Weingraber giunse a Milano nel febbraio 1978
e che si mise in contatto con diverse persone, tra cui il terrorista Oreste
Strano e un gruppo che preparava il sequestro di un imprenditore svizzero.
L’informativa del 6 novembre 1978 precisava inoltre che «la fonte infiltrata ha
avuto contatti con Aldo Bonomi il quale gli avrebbe confermato di essere in
grado di procurare armi e documenti falsi per sviluppare attività eversive». La
fonte – continua la citazione – «ritiene che Bonomi sia un provocatore e un
confidente della Polizia. Sarebbe stato isolato dalle Br perché ha sempre
evitato di assumersi compiti rischiosi nell’ambito dell’organizzazione». Ma «la
fonte infiltrata» – come risulta da un’altra lettera desecretata del 2
novembre 1990 inviata dall’ammiraglio Martini, capo del Sismi, al capo della
Polizia, prefetto Vincenzo Parisi oggi desecretata – altri non era che proprio
Weingraber, il quale lavorava in un’operazione congiunta del Sismi e dei servizi
segreti tedesco e svizzero. Risulta inoltre che Weingraber – come confermato dal
colonnello Giorgio Parisi al giudice Priore il 28 settembre 1990 – entrò in
contatto, tramite Strano (che aveva una compagna tedesca), anche con Nadia
Mantovani, cioè la persona che aveva avuto l’incarico di battere a macchina il
Memoriale Moro, e che prima del suo arresto, a Novara frequentava una radio di
sinistra extraparlamentare collegata alla Rote Armee Fraktion. Va pure segnalato
che Weingraber alloggiò a partire dal 1978 in Italia nello stesso palazzo dove
abitava Tobagi, ucciso il 28 maggio 1980. Ma poi fu lo stesso Strano a
denunciare Weingraber pubblicamente come un infiltrato, dopo che al valico del
Brennero vennero sequestrati a quattro cittadini tedeschi 800 fogli di
documenti: ciò accadde poche settimane prima della seconda scoperta di materiale
proveniente dal sequestro Moro nel covo di via Monte Nevoso 8, a Milano, nel
novembre 1990”. Moro per sempre, dunque. Il caso non è chiuso!
Aldo Moro e la pietas di
Sciascia, medicina contro stalinisti e forcaioli.
Filippo La Porta su Il
Riformista il 12 Maggio 2020. Il 9 maggio del 1978 veniva trovato il corpo senza
vita di Moro nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, abbandonata in via Caetani,
a conclusione di 55 giorni di prigionia da parte delle Brigate Rosse: uno degli
episodi cruciali e più drammatici della storia della nostra Repubblica.
Riparliamo di Moro prendendo spunto da un interessante articolo di un blog e da
un libro utile e accurato. Nel blog Minima & Moralia Virginia Fattori si occupa
di uno dei testi più belli di Leonardo Sciascia, L’affaire Moro, scritto nei
giorni del sequestro. Dal punto di vista letterario si tratta di un felice
ibrido tra pamphlet, diario in pubblico, reportage, meditazione morale. Un
esempio unico di filologia morale, scritto con una lingua riflessiva e
acuminata, memore del Manzoni della Colonna infame, dell’esprit volterriano e
della prosa labirintica di Borges. Com’è noto Sciascia fu uno dei pochi a
difendere la autenticità delle lettere di Moro dal carcere (ben 97), insieme ai
familiari, sfidando gli anatemi di Scalfari e Amendola, o la linea ufficiale dei
capi democristiani. Certo lettere “condizionate” (dal contesto), ma moralmente e
intellettualmente autentiche. A ben vedere tutti i personaggi di Sciascia si
progettano come uomini in rivolta, dal capitano Bellodi del Giorno della civetta
all’avvocato Di Blasi del (meraviglioso) Consiglio d’Egitto, dall’ispettore
Rogas del Contesto fino allo stesso Moro in carcere, e tutti verranno ammazzati.
In rivolta contro che? Contro il potere, che proprio sulla morte – limite oscuro
dell’esistenza – costruisce il suo spaventevole edificio di bugie e soprusi.
Fattori osserva che Sofri, benché schierato dalla parte di quel libro, definisce
Sciascia e Moro intellettuali meridionali, dunque disincantati, «poco fiduciosi
nell’agire umano contro l’immanenza della realtà». Poi chiosa: eppure «chi
potrebbe negare ad Aldo Moro l’assoluta fiducia nel riformismo della sua In
Amare il nostro tempo. Appunti sul giovane Moro (Domani d’Italia) Lucio
D’Ubaldo, ex senatore della Margherita e nella Dc vicino ai morotei,
ricostruisce il pensiero dello statista a partire dalla formazione giovanile, a
metà degli anni ‘40: originalità nella lettura della società italiana, tensione
costante tra utopia e realismo, riformulazione personale di certi apporti
(l’“umanesimo integrale” di Maritain diventa “cristianesimo umano”) e di
categorie nate in ambiti diversi (il “postfascismo di Carlo Rosselli”, fondatore
del movimento “Giustizia e Libertà”, come radicale riforma, morale e politica,
della società italiana), e soprattutto l’idea che la politica “non deve essere
una tecnica arida del potere, ma un omaggio reso quotidianamente alla verità e
alla bellezza della vita” (enunciata nel 1977, tuttavia impregnata della
formazione giovanile di Moro). D’Ubaldo rivela la sua genuina vocazione di
storico delle idee, totalmente a suo agio con la ricostruzione della filosofia
cattolica che ispira gli orientamenti politici (ad esempio il ruolo di Del
Noce e Rodano), ma anche con opere letterarie (sorprendentemente Il giovane
Holden di Salinger), con Pasolini, con la teoria critica della società dei
francofortesi e dell’epigono Marcuse. Indispensabile la meticolosa ricostruzione
dell’atteggiamento dei cattolici e della Dc verso il ‘68, la comprensione delle
sue istanze più radicali, il riferimento a un convegno delle Acli del 1967, con
la critica della società opulenta che vi fu espressa. Ma non bisogna occultare
la vera natura del libro di D’Ubaldo, il suo essere una proposta politica
“militante” per l’oggi, un tentativo di rilancio del centrismo, a partire dal
crollo della Dc dovuto a immobilismo e perdita di motivazioni ideali, e dal
rifluire dei cattolici nell’“universo fluttuante della società civile”, tra
volontariato e assistenza. E il centro si rilancia a partire da Moro (al di
fuori di qualsiasi mitologia), dal suo appello (nel 1944) alla sensibilità di
ogni cattolico, che “non può sopportare di convivere con l’ingiustizia”.
Concludo sull’Affaire Moro di Sciascia (purtroppo non citato da D’Ubaldo). Un
libro non solo letterariamente sperimentale (virtuosistico montaggio d’autore di
materiali giornalistici) ma a suo modo “religioso”, intriso di pietas e
conoscenza dell’animo umano, che volle denunciare lo “stalinismo” delle Brigate
Rosse e anche del “partito della fermezza” e insieme difendere la dignità offesa
di Moro. Sciascia volle mettersi dalla parte di Moro, e poi di Enzo Tortora,
dalla parte degli inermi e degli indifesi, di chi ha paura e viene calunniato,
in nome della parte di infermità e debolezza che è cristianamente in ogni essere
umano.
ALDO MORO, L’ASSASSINIO 42
ANNI FA. “Ma la verità deve ancora venire a galla”.
Davide Giancristofaro Alberti
su Il Sussidiario il 9.05.2020. Aldo Moro venne ucciso oggi 42 anni fa: era il 9
maggio del 1978 e il suo corpo venne ritrovato in una Renault 4 in via Caetani a
Roma. Quattro decadi di misteri, silenzi e omissioni. Il 9 maggio di 42 anni fa,
era il 1978, veniva ucciso Aldo Moro, ex numero uno della Dc. Sono passati più
di quattro decadi da quella giornata, considerata fra le pagine più buie della
storia della Repubblica, ma la verità non è ancora venuta a galla in toto. Molti
sono infatti quelli convinti che vi siano ancora diversi aspetti della vicenda
da chiarire, a cominciare da Roberto Della Rocca (all’epoca dei fatti, direttore
del personale di Fincantieri, oggi numero uno dell’Aiviter, l’Associazione
italiana vittime del terrorismo), ferito in un agguato dalle Brigate Rosse due
anni dopo la morte di Moro: «La morte di Aldo Moro – le sue parole riportate
oggi dall’edizione online de La Stampa – fu uno spartiacque terribile per la
lotta al terrorismo. La verità ancora non è dietro l’angolo e sinceramente non
so se ci arriveremo mai: è passato troppo tempo, ci sono state cose che sembrano
inverosimili. Ma dobbiamo capire, sapere se sia stato un fenomeno endogeno,
esclusivamente italiano, o se non sia stato anche un qualcosa che veniva da
fuori, in termini di possibili mandanti». (aggiornamento di Davide
Giancristofaro)
ALDO MORO, 42 ANNI FA
L’ASSASSINIO, IL SEQUESTRO, LA PRIGIONIA DI 55 GG, L’UCCISIONE. Esattamente
oggi, 9 maggio, 42 anni fa, era il 1978, moriva Aldo Moro, segretario
della Democrazia Cristiana. Venne rapito dalle Brigate Rosse poi ucciso, e il
suo corpo venne ritrovato all’interno di una Renault 4 posteggiata in via
Caetani a Roma. Fu una delle pagine di cronaca nera più toccanti e segnanti
della storia moderna dell’Italia, con Moro che venne assassinato da un commando
che l’aveva sequestrato in via Fani, dopo aver sterminato a colpi di mitra la
sua scorta. Il sequestro era avvenuto 55 giorni prima, quasi due mesi di
prigionia durante i quali l’allora leader della Dc, il partito numero uno in
Italia, fu sottoposto ad una sorta di processo, perchè “colpevole”, stando ai
brigatisti, di voler “unire” Dc e Pci. Nonostante trattative varie, alla fine
non si riuscì ad ottenere la liberazione di Moro, e le Brigate Rosse decisero
quindi di giustiziare l’onorevole, provocando una crisi politica senza
precedenti. Per ricordare Moro, in Italia è stata istituita una giornata
speciale dal 2008, in cui vengono appunto ricordate le vittime del terrorismo.
ALDO MORO, IL MESSAGGIO DI
MATTARELLA: “BARBARIE BRIGATISTA GIUNSE ALL’APICE”. «Il 9 maggio è il giorno in
cui Aldo Moro venne ucciso – la nota di oggi del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, nel Giorno della memoria per le vittime del
terrorismo – la barbarie brigatista giunse allora all’apice dell’aggressione
allo Stato democratico. Lo straziante supplizio a cui Moro venne sottoposto
resterà una ferita insanabile nella nostra storia democratica. Respinta la
minaccia terroristica – ha aggiunto il Capo dello Stato – oggi ancor più
sentiamo il dovere di liberare Moro e ogni altra vittima da un ricordo
esclusivamente legato alle azioni criminali dei loro assassini». Raffaele
Iozzino, fratello di uno degli agenti della scorta di Moro assassinati, ha
invece commentato in maniera polemica: «Sono stati scritti libri, si è parlato
tanto, eppure la verità è così lontana – afferma all’agenzia Adnkronos – il
giorno della sua morte e quello del ritrovamento del corpo di Moro sono gli
unici due giorni in cui ci chiamano. Mi piacerebbe che le Istituzioni si
ricordassero di noi familiari, non che ci riservassero un canale preferenziale,
per carità. All’epoca siamo stati aiutati, oggi ho ancora due ragazzi a casa che
con questa crisi non lavorano. Spero si aggiustino le cose, per tutti i ragazzi
che qui rischiano di finire in mano alla malavita». Questa mattina, come si
evince dal video che trovate più in basso, i Corazzieri dei carabinieri, con
rigorosa mascherina, hanno posto una corona di fiori della Presidenza della
Repubblica in via Caetani.
ALDO MORO. E la lettera a
Craxi che svela il disegno perverso dell’ideologia italiana.
Gianluigi Da Rold su Il
Sussidiario il 09.05.2020. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato in via Caetani il
cadavere di Aldo Moro. La posizione di Craxi non fu strumentale, quella della
Dc, sì. La vicenda del delitto Moro, di cui oggi, 9 maggio 2020, ricorre il
42esimo anniversario del tragico epilogo, dell’esecuzione e del ritrovamento del
cadavere, rappresenta sempre, nel ricordo che è stato fatto dalla maggioranza
della cosiddetta “intelligencija” e dei “detective politicizzati per caso”, uno
degli aspetti più perversi di quella che si può definire “ideologia italiana”.
Commissioni di inchiesta di durata interminabile e conclusioni tutte
approssimative e spesso mescolate ad altre realtà. Deposizioni surreali su
presunti “pendolini” che lasciano esterrefatti. Quindi i processi e le
rivelazioni improvvise, promosse subito a “verità storiche”, dettagli ripescati
qua e là, ma mai, ripetiamo mai, un quadro sufficientemente chiaro e complessivo
della ricostruzione dettagliata, delle cause, della ragione autentica, del
perché di tutta quella tragedia italiana. Non è ancora ben chiaro, dopo tutti
questi anni, in quanti parteciparono all’azione del rapimento e della strage
della scorta di Moro il 16 marzo 1978 in via Mario Fani, e neppure chi veramente
sparò al leader della Dc, prima che fosse ritrovato sulla Renault rossa in via
Caetani il 9 maggio dopo 55 giorni, è stato identificato con sicurezza. Lasciamo
poi perdere “le voci e le certezze” sull’appartamento-covo di via Montalcini, lo
scambio piuttosto ambiguo tra via Gradoli a Roma e Gradoli paese, con
l’escursione di forze dello Stato sul Lago della Duchessa. In questi 42 anni,
accanto ai volumi editi, ai discorsi, ai ricordi “volgari” (quello della statua
a Maglie dedicata al leader democristiano con l’Unità sotto il braccio, come se
fosse un simpatizzante comunista), ci sono state le tesi depistanti confezionate
in modo grossolano, quelle ideologiche appena più falsamente raffinate, quelle
opportuniste, quelle dettate solo dalle mistificazioni cocciute e ripetute.
Tutto questo, in fondo, è il nocciolo vero, appunto, dell’“ideologia italiana”:
rimuovere, manipolare, improvvisare, creare dietrologie e tenersi sempre lontani
dalla verità. Sembrerà paradossale, ma un passo avanti si è fatto con
l’ammissione che furono le Brigate rosse a rapire e uccidere Aldo Moro. Per
anni, infatti, famosi giornalisti hanno scritto su giornali importanti le
“cosiddette Brigate rosse”, alludendo a manovre di servizi segreti, più o meno
deviati. Più avanti, e ancora adesso, si fa una distinzione tra le prime Brigate
rosse, quelle “pure” di Renato Curcio, Mara Cagol e Alberto Franceschini, da
quelle, “meno pure” e magari “infiltrate”, di Mario Moretti, Prospero Gallinari,
Adriana Faranda e Valerio Morucci. In realtà, come ha scritto nel trentesimo
anniversario del delitto Moro su Critica sociale uno storico come Ugo Finetti,
le due principali mistificazioni sarebbero queste: da un lato Moro sarebbe stato
ucciso dalla Cia su istigazione di Henry Kissinger per evitare che portasse i
comunisti nel cuore della Nato; dall’altro il leader Dc “sarebbe stato soppresso
dal Kgb per evitare che destabilizzasse il sistema di potere dell’Urss portando
al governo l’euro-comunista Berlinguer”. Sono due tesi senza fondamento, di
comodo e di opportunismo politico da basso livello, formulate senza tenere conto
della realtà. Nel 1978 Kissinger non aveva alcun potere, dopo la caduta di Nixon
e il Watergate; alla Casa Bianca ci stava il democratico Jimmy Carter e il nuovo
segretario di Stato era Cyrus Vance. Il Cremlino di Breznev era in tutte altre
faccende affaccendato: con i problemi che aveva in casa sfoderava il suo aspetto
imperiale, mettendosi all’offensiva in Africa e in Asia. Quanto ai rapporti tra
Berlinguer e l’Unione Sovietica, dopo alcune distinzioni anche tollerate, nel
1977, in occasione del 60esimo anniversario della Rivoluzione d’Ottobre
l’eurocomunismo era in crisi e stava letteralmente evaporando. A Mosca, il
segretario comunista francese Georges Marchais non andò; allo spagnolo Santiago
Carrillo non venne concessa la parola; Enrico Berlinguer parlò invece per 6
minuti e 32 secondi, per dire che intendeva difendere “tutte le libertà
personali e collettive, civili e religiose”. Dichiarazioni che nemmeno i
sovietici potevano permettersi di contestare. Non ci sono più polemiche nel
discorso di Berlinguer, ma un riavvicinamento sancito dall’onore che gli
tributano i dirigenti sovietici con la successiva pubblicazione del suo
intervento sulla Pravda. Due anni dopo, nel novembre del 1979, Berlinguer
parlerà in pieno comitato centrale dell’attualità delle lezioni del leninismo e
griderà furente a Giorgio Amendola “Non capisci nulla di marxismo–leninismo”. Ma
se dal contesto internazionale si passava a quello italiano, la realtà era
ancora più concitata. Moro aveva risposto duramente ai comunisti nel 1977, in
occasione dello scandalo Lockheed: “Non ci faremo processare da voi nelle
piazze”. Poi a novembre, il repubblicano Ugo La Malfa apre una crisi e invoca
l’ingresso del Pci nella maggioranza di un nuovo governo. Moro trova una
situazione di compromesso con un accordo con Craxi: un governo monocolore
democristiano, con i comunisti in maggioranza, ma senza i “tecnici” che il Pci
richiede e che provocano reazioni sia in Berlinguer che in Pajetta. Lo sfondo
politico che porta al governo del 16 marzo 1978 è questo, ma viene sempre
dimenticato, smarrito, confuso, Potenza dell’“ideologia italiana”, che in quel
momento a tutti i livelli è innamorata del catto–comunismo. Capitano spesso
queste sbandate a chi si è dimenticato persino il nome del capo della
Resistenza. Chissà se i nostri valenti insegnanti di storia e i nostri studenti
conoscono la figura di Alfredo Pizzoni, mai onorato in tutti i 25 aprile?
Recentemente un “guitto” italo–bulgaro parlava in televisione di un’Italia
liberata dal nazifascismo per la grande tenuta dell’Urss di Stalin contro
Hitler, dimenticandosi ovviamente della V e dell’VIII armata anglo–americana che
risalivano l’Italia e pagavano pure la diaria ai partigiani dopo i patti di Roma
del novembre 1944 (Harold Macmillan, Diari di guerra 1943–1945, il Mulino). Ma
la potenza della disinformazione dell’ideologia italiana è travolgente. Quando
il 16 marzo 1978 Moro è “nella prigione del popolo”, scompare dalla terza pagina
di Repubblica questo titolo: “Antelope Cobbler? Semplicissimo è Aldo Moro
segretario della Dc”. Migliaia di copie del quotidiano progressista vengono
mandate al macero, ma qualcuno ne mantiene copie per un ricordo indelebile della
vergogna. Nella stessa mattinata Ugo Pecchioli, uomo del Pci che si è sempre
occupato dei rapporti (anche della rete di radio clandestine) con l’Urss, si
presenta nella sede della Dc e sentenzia: “Per noi è morto”. Traduzione: nessuna
trattativa. Dal “carcere del popolo” Moro comincia a scrivere lettere che
invocano una trattativa e poi lancia accuse ben precise. La risposta degli
intellettuali di matrice cattolica compare con una lettera e un lungo elenco di
firme e spiega: “Moro non è responsabile di quello che scrive”. Praticamente
viene abbandonato e visto come una specie di pazzoide. Una vergogna infame. A
questo punto la politica italiana si spacca. Bettino Craxi, il leader del Psi,
suggerisce una trattativa. Si unisce a questa iniziativa anche Marco Pannella.
Naturalmente la proposta di Craxi è vista come una manovra per rompere l’asse
catto–comunista e guadagnare consensi, sparigliare un inevitabile processo di
unità nazionale tra Pci e Dc. È un’altra mistificazione oscena. Moro ha scritto
51 lettere. Nella dodicesima, inviata il 12 aprile a Craxi, e recapitata nella
sede del Psi in via del Corso a Roma, Moro è disperato: “Caro Craxi, poiché ho
colto, pur tra le notizie frammentare che mi pervengono, una forte sensibilità
umanitaria del tuo partito in questa dolorosa vicenda, sono qui a scongiurarti
di continuare e anzi di accentuare la tua importante iniziativa”. Moro implora
una trattativa. Scrive ancora: “Ogni ora che passa potrebbe renderla vana. E
allora ti scongiuro di fare in ogni sede opportuna tutto il possibile nell’unica
direzione giusta, che non è quella della declamazione”. Più avanti spiega:
“Anche la Dc sembra non capire. Ti sarei grato se glielo spiegassi subito. Non
c’è un minuto da perdere”. Quando Craxi legge queste parole su un foglietto di
quaderno a quadretti non trattiene le lacrime e ricomincia la sua battaglia. Ma
contro di lui c’è il blocco del “fronte delle fermezza”, costituito dai maggiori
partiti e da quelli laici, ma soprattutto dalla grande stampa. Si contendono il
primato del “fronte della fermezza” il Corriere della Sera, che in quel momento
era mantenuto e più o meno al servizio dal “maestro venerabile” Licio Gelli, e
la rampante Repubblica dell’ex fascista Eugenio Scalfari, poi diventato
azionista, forse radicale, quindi socialista e infine filo–berlingueriano. Un
uomo di coerenza! Nella visione di Craxi non c’era un calcolo politico di
smarcamento, ma soprattutto di un principio della nostra Costituzione, che non è
“la più bella del mondo”, ma è almeno figlia del compromesso di Yalta. Fu
proprio il giovane giurista Aldo Moro, ai tempi della Costituente, a difendere
il principio che le persone vengono prima dello Stato, che la ragione di Stato
non si baratta con una vita umana. Quello Stato del 1978 che alla fine si
arrese all’esecuzione di Moro da parte delle Br senza trattare per non
riconoscerle formalmente, venne ben descritto nel libro di Leonardo
Sciascia L’affaire Moro, dove il grande scrittore paragonava quello Stato a una
sorta di moribondo che sta in un letto di ospedale e all’improvviso impettisce,
scende in strada e minaccia sfracelli, andando inevitabilmente verso il disastro
annunciato.
PS: Chi scrive questo articolo
non cambia idea da 42 anni. E ancora oggi è fiero di aver ritirato la firma
dal Corriere per un anno, proprio per come era stato descritto il caso Moro.
Quello che accadde si può vedere da un comunicato Ansa dell’epoca.
Servizi di sicurezza, a che
servono se non ci sono problemi specifici incombenti?
Frank Cimini de Il Riformista
il 19 Marzo 2020. La preoccupazione maggiore dei nostri apparati di sicurezza
sembra rivolta a una lettura diversa dei cosiddetti anni di piombo rispetto alla
storiografia ufficiale che rischia di trovare consensi “nell’uditorio
giovanile”. Usano proprio questo termine gli apparati nella loro relazione
annuale al Parlamento presentata nei giorni scorsi con un po’ di ritardo e che è
passata inosservata sui giornali soprattutto perché mancavano indicazioni su
pericoli specifici incombenti. Ma è meglio lasciare direttamente la parola
ai “servizi” prima di spiegare la ragione di queste povere righe. «L’attività di
costante monitoraggio informativo assicurata dal comparto intelligence ha
rilevato in linea di continuità con gli ultimi anni il proseguire dell’impegno
divulgativo specie attraverso la testimonianza di militanti storici e detenuti
“irriducibili”, volto a tramandare la memoria degli “anni di piombo” e
dell’esperienza delle organizzazioni combattenti. La propaganda si è in
particolare rivolta in un’ottica di proselitismo a un uditorio giovanile con un
occhio di riguardo alla composita area dell’antagonismo di sinistra sulla cui
sensibilità risulta tarata una lettura trasversale in chiave rivoluzionaria
dell’antifascismo dell‘antimilitarismo e dell’antiimperialismo nonché delle
questioni correlate al disagio sociale dall’emergenza abitativa a quella
migratoria passando per le criticità del mondo del lavoro». Bisogna ricordare
che nel nostro paese esistono apparati costosissimi e spropositati rispetto alla
bisogna dal momento che ormai da molto tempo quel po’ di conflitti sociali in
essere non sembra in grado di costituire “un pericolo per la democrazia”. Ma di
queste strutture e soprattutto dei loro costi appare pressoché impossibile
parlare nel senso di suscitare un dibattito pubblico sui mezzi di informazione.
Vige una sorta di segreto di stato di fatto che nessuno è disposto dentro il
circuito istituzionale a mettere in discussione. Gli apparati al fine di
giustificare sia loro esistenza sia il privilegio di disporre di quantità molto
rilevanti di fondi scriverebbero qualsiasi cosa e sanno benissimo che il solo
evocare il tentativo di rivoluzione, il più serio nel cuore
del capitalismo occidentale, fallito quarant’anni fa li mette al riparo da
qualsiasi osservazione critica. Succede tanto per fare un esempio che il
raggruppamento speciale dei carabinieri arrivi a chiedere di investire
l’attività del mitico Ris di Parma per rilevare il Dna di un gruppetto di
ventenni responsabile di uno striscione pro-palestinesi davanti alla sede
del Corriere della Sera. Nel caso specifico pare che la procura di Milano non
abbia dato seguito all’iniziativa. E parliamo della procura che di recente ha in
pratica azzerato le lotte per la casa con misure cautelari e reati associativi
per un collettivo dì militanti pur specificando che il tutto non aveva scopo di
lucro. Da tempo siamo in presenza di una repressione di tipo preventivo che ha
il compito di ammazzare nella culla eventuali azioni “sovversive”. Di questo
quadro si giocano i nostri apparati di sicurezza dove chi ne fa parte teme di
veder finire la vita nella bambagia e di essere “mandato a lavorare”. Ma si
tratta di rischi puramente teorici sia perché la politica è debole incapace di
prendere decisioni forti sia perché gli uffici inquirenti le procure anche
quando non danno seguito agli input degli apparati (con i quali dovrebbero avere
nulla a che fare ma tutti sanno che non è così) però ne coprono le gesta perché
tra poteri come dicono a Napoli “si apparano”. In tempi di spending review non
sarebbe male avviare una discussione seria in merito. Ma ricordiamo che siamo
nel paese in cui a quarant’anni dai fatti sono andati con il laser in via Fani
per stabilire se a sparare alla scorta di Moro erano state solo le Br.
L’esperimento portò a concludere che sì solo le Br. E tutto si chiuse con 18
righe sul Sole 24 ore. Quanti soldi nell’occasione buttati dal balcone?
Impossibile saperlo dalla commissione parlamentare e dalla procura generale di
Roma. Ma si sa che il procuratore generale di Roma poi è diventato il pg della
Cassazione. Insomma se la cantano e se la suonano. Tutto in famiglia.
Scoop dei dietrologi:
risolto il caso Moro, è stato ucciso da un barista.
Frank Cimini de Il Riformista
il 25 Febbraio 2020. Abbiamo a che fare con le dietrologie incrociate sulle
quali disserta frequentemente il Manette Daily alias Cappio Quotidiano.
«Bologna, strage crocevia di due storie criminali» è il titolo dell’ultimo
articolo sul tema. Le due storie legate tra loro dalla chiusura indagine
sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980 sono il crac del Banco Ambrosiano e il
sequestro Moro. E con pezze di appoggio da far tremare i polsi e accapponare la
pelle: «Sia i soldi mancanti della bancarotta dell’Ambrosiano sia il
brigatista Alessio Casimirri che non ha scontato un giorno di carcere negli
stessi anni trovarono il loro “paradiso sicuro” in Nicaragua». Un paese del
quale il figlio di Licio Gelli (condannato sia per il crac sia per il
depistaggio sulla strage) è da anni ambasciatore prima in Uruguay e poi in
Canada. E solo oggi sappiamo, è la tesi del Fatto, perché esiste un documento
desecretato dal governo nel 2014, che Tullio Olivetti, proprietario
dell’insolito caffè di via Fani a lungo copertura di un grosso traffico di armi
con mafia terrorismo interno e internazionale, era presente nel capoluogo
emiliano il giorno della strage della stazione, ma non fu mai interrogato. Da
sempre i dietrologi di mezzo mondo favoleggiano di questo famoso bar Olivetti
raccontando che ci andavano i mafiosi a far colazione perché aveva i migliori
maritozzi della capitale. “L’insolito caffè di via Fani”, comunque, la mattina
del 16 marzo del 1978, come è stato infinitamente accertato, era chiuso… Ma i
cultori del mistero legato al bar Olivetti non demordono. Sul caso Moro tutto
vale, anche la panna dei maritozzi. Se l’informazione si è ridotta a questo non
può meravigliare che chiedendo ai liceali di adesso chi mise la bomba in piazza
Fontana arrivi la risposta inevitabile a sto punto: le Brigate Rosse. E ormai le
Br sarebbero responsabili anche della strage di Bologna e pure della bancarotta
dell’Ambrosiano. Alla confusione sul tema hanno dato un rilevante contributo le
commissioni parlamentari di inchiesta sul caso Moro che tra l’altro ascoltarono,
dandogli dignità di oracolo, Raimondo Etro “pentito” e dietrologo acquisito,
balzato recentemente agli onori della cronaca perché cacciato dallo studio tv
di Giletti. Un paese che rifiuta di fare i conti con il tentativo di rivoluzione
fallito a cavallo degli anni 70 e 80 non può che continuare a dare spazio a una
dietrologia troppo interessata a nascondere la verità e di cui la sinistra
appare più responsabile di altre fazioni politiche. Insomma a sinistra non hanno
ancora digerito che in pieno sequestro Moro, Rossana Rossanda gridò in faccia al
Pci che le Brigate Rosse erano comuniste con due famosi articoli sull’album di
famiglia. E oggi a sinistra si sollazzano leggendo il Manette Daily.
Il libro di Antonietta
Calabrò e Giuseppe Fioroni. Trovare Moro si poteva, ma nessuno lo cercò.
Fabrizio Cicchitto de Il Riformista il— 29 Novembre 2019. La seconda edizione
del libro di Maria Antonietta Calabrò, nota giornalista, e di Giuseppe Fioroni,
presidente della seconda commissione Moro Il caso non è chiuso. La verità non
detta aggiunge altri interrogativi assai inquietanti ad una vicenda, quella del
rapimento e dell’assassinio di Aldo Moro e della sua scorta, che ha segnato
l’inizio della crisi della Dc e della Prima Repubblica. «Il mio sangue ricadrà
su di voi» scrisse Moro in una delle sue ultime lettere rivolgendosi al gruppo
dirigente della Dc. Partiamo, però, dalle origini della vicenda. Subito dopo il
rapimento fu netta la sensazione che il gruppo dirigente del Pci, guidato con
mano ferrea da Enrico Berlinguer, riteneva che ormai Moro era un uomo morto. Di
rimbalzo, del tutto simile era l’orientamento del gruppo dirigente della Dc (il
presidente del Consiglio Andreotti, il ministro degli Interni Cossiga, il
segretario formale della Dc Zaccagnini, il segretario sostanziale l’onorevole
Galloni). Berlinguer riteneva che le Brigate Rosse con molteplici legami
internazionali, dai palestinesi ai cecoslovacchi, si muovevano non solo contro
il compromesso storico, ma contro la strategia di fondo del Pci. Di conseguenza,
non bisognava in alcun modo trattare con essi dando la sensazione di un qualche
riconoscimento del “partito armato”. Berlinguer notificò subito alla Dc che il
Pci avrebbe fatto cadere il governo al primo accenno di trattativa. Andreotti,
Cossiga, Zaccagnini, Galloni, Gava per i dorotei, si uniformarono a questa
scelta per due ragioni: salvare il governo e mantenere in piedi la politica di
unità nazionale. Tutto ciò però si tradusse in modo paradossale per ciò che
riguardava le indagini e la ricerca del luogo dove Moro era tenuto prigioniero,
cioè nell’inerzia. In effetti, né fu fatta la trattativa né furono sviluppate
indagini serie e reali, specie dopo le prime e polemiche lettere di Moro. Poi,
sui tempi lunghi, dopo quasi due mesi, le Br dovevano chiudere una partita che
durava già da troppo e l’unico modo era quello di consegnare Moro cadavere anche
perché le Br non gradivano esser messe di fronte a mosse politiche che la
complicavano sul piano politico e mediatico. Non a caso fecero trovare il
cadavere di Moro a via Caetani quando seppero che alla direzione della Dc
Fanfani avrebbe “aperto” sulla trattativa. Ben diversa sarebbe stata la partita
se le Br si fossero trovate subito di fronte ad un’iniziativa dello Stato sulla
trattativa. Ma lo Stato non agiva in modo incisivo e aggressivo neanche sul
terreno delle indagini. Anzi da quel punto di vista avvennero cose incredibili:
clamoroso fu l’errore commesso quando Prodi diede l’indicazione di Via Gradoli.
Nessuno, anche a distanza di tempo, ha chiesto a Prodi di rivelare quale fu la
fonte autentica che gli fece quella rivelazione perché non è credibile la storia
della seduta spiritica. Comunque sia se le forze dell’ordine si fossero recate
in via Gradoli, il caso Moro avrebbe avuto una svolta dopo pochi giorni: a via
Gradoli c’era il covo segreto di Moretti e della Balzarani. Invece le forze
dell’ordine ai recarono a Gradoli, un paese del viterbese. Ora, c’è un limite al
grottesco anche perché esiste lo stradario. Evidentemente non lo si voleva
trovare e di fronte ad una “mossa” esterna imprevista quale fu la rivelazione di
Prodi gli apparati e chi li guidava non esitarono ad andare incontro ad una
figura ridicola per altro non sottolineata da una stampa succube di un potere
che andava dalla Dc al Pci. La seconda vicenda inesplicabile riguardò quello che
accadde quando Craxi e il Psi si dichiararono a favore della trattativa. Non è
questa l’occasione per riaprire il dibattito politico su quella iniziativa ma
invece è interessante ricostruire ciò che accadde e ciò che non accadde. Bettino
Craxi incaricò Claudio Signorile e Antonio Landolfi di prendere tutti i contatti
possibili per accertare se le Br erano disponibili o meno ad una trattativa e a
quali condizioni. Signorile e Landolfi fecero la cosa più ovvia di questo mondo:
presero contatto con Lanfranco Pace e Franco Piperno, due personalità che
provenivano da Potere Operaio e che erano borderline con il mondo
dell’estremismo armato. Fecero subito centro: Pace e Piperno stabilirono il
contatto con Valerio Morucci e la Faranda che erano i postini delle Br. Orbene,
dei servizi degni di questo nome, avrebbero dovuto seguire da tempo, dall’inizio
della vicenda, Pace e Piperno, e a maggior ragione avrebbero dovuto farlo da
quando essi furono interpellati da Landolfi e Signorile che tenevano informato
il governo di tutti i loro passi. Terza stranezza: quando Morucci e la Faranda
ruppero con le Br perché erano contrari all’assassinio di Moro essi si
rifugiarono a casa di Giuliana Conforto che era la figlia del decano degli
agenti del Kgb in Italia, Giorgio Conforto che fu presente anche al momento del
loro arresto, ma che fu subito “dimenticato”? Altra domanda: perché Giorgio
Conforto si fece trovare lì, dove erano anche la scorpion e altre armi? Detto
tutto ciò, per mettere ulteriormente in chiaro quello che avvenne nella realtà,
bisogna ricordare che invece, in occasione del rapimento del generale Dozier da
parte delle Br, gli apparati dello Stato (polizia carabinieri servizi) divennero
dei fulmini di guerra. Anche se ciò è stato sempre negato allora fu usata anche
la tortura: i brigatisti catturati dissero subito dove era Dozier, i Nocs
intervennero e, senza spargimento di sangue, liberarono Dozier e arrestarono i
rapitori: una operazione da manuale. Calabrò e Fioroni mettono in evidenza il
retroterra di ciò che abbiamo descritto nelle sue manifestazioni più visibili.
Questo retroterra era il cosiddetto lodo Moro che, a onor del vero, avrebbe
dovuto essere chiamato “lodo Moro e Andreotti”. Dopo che l’Italia era stata
colpita alcune volte da attentati, gli apparati italiani, con un dovuto consenso
politico (appunto “lodo Moro e Andreotti”) fecero una intesa con le
organizzazioni palestinesi (sia l’Olp di Yasser Arafat, sia il Fplp di George
Habash) secondo la quale essi avevano libertà di transito (di uomini e armi) sul
nostro territorio, ma non avrebbero più fatto attentati. Si è trattata di una
sorta di patto con il Diavolo che era gestito dal colonnello Giovannone (il cui
intervento non a caso fu invocato da Aldo Moro in una sua lettera). Le Br, però,
avevano diretti rapporti con queste organizzazioni che le rifornivano di armi e,
stando ad una battuta di Berlinguer a Sciascia, poi da lui smentita, anche coi
servizi cecoslovacchi. Di conseguenza il lodo Moro-Andreotti evitò che i
palestinesi continuassero a fare attentati sul nostro territorio ma non evitò
che essi rifornissero di armi anche le Br che per parte loro sparavano a uomini
politici, a magistrati, a esponenti delle forze dell’ordine, a imprenditori, a
professori universitari. Cioè, indirettamente, per un tragico paradosso “il lodo
Moro” consenti ai brigatisti di attrezzarsi per determinare il “caso Moro”. Le
cose non si fermano qui. Stando a quello che è riportato nel libro di Calabrò e
di Fioroni il giudice Armati, in una testimonianza resa davanti alla
Commissione, ritenne assai probabile che il colonnello Giovannone rivelò a
George Habash che i giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni si stavano
recando a Beirut (1980) per indagare sul traffico d’armi fra l’Italia e il
Libano. Da allora De Palo e Toni sono scomparsi. Secondo Armati, Giovannone
avvertì Habash che la De Palo e Toni andavano a Beirut a rompere le scatole e
Habash ne trasse le conseguenze. D’altra parte ricordiamo le proteste e le
minacce dei dirigenti palestinesi quando per caso Daniele Pifano e alcuni
militanti del Fplp furono arrestati perché su un’auto trasportavano addirittura
un missile. Giovannone paventò ritorsioni. Non parliamo poi di tutti gli
interrogativi ancora aperti sulla strage di Bologna che potrebbe essere stata
determinata dall’esplosione fortuita di ordigni che venivano trasportati in una
valigia avendo altra destinazione. Tanti sono gli interrogativi ancora aperti,
tra cui quello assolutamente banale sul perché Moro non avesse una macchina
blindata: non dimentichiamo che in un primo momento i brigatisti avevano scelto
Andreotti come obiettivo, ma poi avevano desistito perché troppo protetto. Altro
interrogativo è costituito dal fatto che dopo l’uccisione di Moro e le polemiche
sviluppate dalla famiglia Moro. Ci fu una sorta di anticipazione di Mani
pulite e Sereno Freato, l’uomo che si occupava dei finanziamenti della corrente
morotea, fu colpito sul piano giudiziario e demonizzato. Lo stesso che avvenne
a Baffi e a Sarcinelli quando non ottemperarono alle richieste di Andreotti e di
Evangelisti per aiutare Sindona. Da tutto ciò emerge che la storia italiana
dagli anni Cinquanta in poi è piena di interrogativi ai quali è difficile dare
risposta perché quello che è avvenuto “sotto il tavolo” è stato talora più
decisivo di quanto non è avvenuto “sopra il tavolo”, cioè alla luce del sole.
Oggi solo gli scemi possono pensare che le cose vanno diversamente, solo che c’è
una ulteriore modernizzazione tecnologica grazie all’uso del trojan e all’uso
politico di internet attraverso il quale Putin sta smontando le democrazie
occidentali.
Aldo Moro, il più lucido e
il più autonomo Perciò «doveva morire»,
scrive il 16 Marzo 2018 Giuseppe De Tommaso su "La Gazzetta del Mezzogiorno".
C’è chi dice che il delitto Moro (1978) stia all’Italia come il delitto Kennedy
(1963) sta all’America. C’è chi dice che il delitto Moro stia all’Italia
repubblicana come il delitto Matteotti (1924) sta all’Italia fascio-monarchica.
Può essere. Tutti e tre i delitti sopra indicati hanno cambiato il corso della
storia. Tutti e tre i delitti presentano zone d’ombra mai illuminate. Tutti e
tre i delitti costituiscono i misteri più indecifrabili dell’ultimo secolo.
Tutti e tre i delitti non hanno mandanti identificati per nome e cognome. Gli
indiziati dell’uccisione di Dallas vanno dai boss mafiosi ai capi della
rivoluzione cubana, dalla nomenklatura del Cremlino agli ultrà dei servizi
segreti Usa. I sospettati dell’agguato mortale al deputato socialista vanno dal
Duce alla monarchia (tesi quest’ultima della famiglia Matteotti), dai fascisti
più irriducibili ai trafficanti di petrolio smascherati dalla vittima designata.
Ecco. I complici sospettati della strage di via Fani e del successivo tragico
epilogo in via Caetani sono ancora più numerosi, tanto che ad abbozzarne
l’elenco si rischierebbe di dimenticarne qualcuno. Si può solo dire che la morte
di Aldo Moro (1916-1978) faceva comodo pressoché a tutti, dentro e fuori
l’Italia. Faceva comodo alle superpotenze internazionali, ciascuna delle quali
considerava lo statista italiano in quota al nemico. Faceva comodo alle
minipotenze nazionali, spaventate dal grado di autonomia e indipendenza del
leader democristiano. Faceva comodo a poteri occulti e a poteri palesi, chi per
una ragione chi per un’altra. Che la vita di Moro ai vertici delle istituzioni
italiane non sarebbe stata una passeggiata, lo s’intuì sùbito, già prima che il
Nostro s’insediasse a Palazzo Chigi sul finire del 1963, alla guida del primo
vero governo di centrosinistra. L’ala conservatrice della Chiesta gli è ostile
in modo plateale. L’arcivescovo di Genova, il cardinale Giuseppe Siri
(1906-1989), invia a Moro lettere pesanti e ultimatum raggelanti. Si rischia il
corto circuito tra Chiesa cattolica e Democrazia Cristiana. Provvede Giovanni
XXIII (1881-1963) a disinnescare la miccia. Anche il neocancelliere tedesco
Ludwig Erhard (1897-1977), artefice del miracolo economico teutonico, non va per
il sottile. Alla vigilia dell’accordo di governo con i socialisti in Italia,
Erhard chiama Moro e gli sottopone una proposta indecente: la rinuncia al
centrosinistra in cambio di un grande programma di industrializzazione del Sud
Italia finanziato dalla Germania. Moro ascolta quel do ut des osceno e
scambista, e replica senza esitazioni: «Caro Cancelliere, non abbiamo ancora
rinunciato ad essere italiani». Sta tutta qui, in questa frase, la cifra
dell’uomo ucciso dalle Brigate Rosse. Solo dalle Brigate Rosse? Le conclusioni
delle indagini promosse dall’ultima commissione Moro, sollevano dubbi
inquietanti e aprono scenari agghiaccianti. Emerge un puzzle di colpe e
responsabilità che pure un giallista del calibro di John Le Carrè avrebbe
difficoltà a mettere assieme. Non a caso i primi a intuire la complessità del
delitto Moro sono i letterati, i romanzieri, più che gli investigatori e gli
inquirenti. Lo scrittore Alberto Moravia (1907-1990), riecheggiando Pier Paolo
Pasolini (1922-1975), scrive nei giorni successivi al ritrovamento del cadavere:
«Lui doveva morire». Elias Canetti (1905-1994), in seguito citato spesso da
Leonardo Sciascia (1921-1989), aggiunge sentenzioso: «Qualcuno doveva morire al
momento giusto». La verità è che Moro non è difeso da nessuno, o quasi, nelle
sue sfide impossibili. L’ondata di gelo nei suoi confronti proviene da lontano.
La sinistra-sinistra lo scambia per un incantatore di serpenti e, come tale, lo
ritiene più insidioso di un cacciatore acclarato. La destra vede in lui il
cavallo di Troia del comunismo, come se Moro non avesse scritto mai nulla
sull’incompatibilità tra filosofia collettivistica e pensiero cristiano. I
riformisti lo giudicano un conservatore o, nell’accezione più velenosa, il più
grande anestesista del secolo. I conservatori lo descrivono arrendevole e troppo
incline al compromesso. L’America diffida di lui. L’Unione Sovietica lo segue
con sospetto. La verità è che Moro è Moro. Uno che guida i processi politici,
anziché subirli. Uno che guarda all’interesse del Paese, anziché ai calcoli del
retrobottega. Uno che, nonostante la flemma mediatica, possiede una
determinazione che tutt’al più sconfina nella pazienza (e viceversa). Ma di
sicuro non è un pavido. Per informazioni rivolgersi ai protagonisti e agli
studiosi dell’esperienza di governo tra Dc e Psi: vi racconteranno di un Moro
tutt’altro che pieghevole. Agli alleati socialisti Amintore Fanfani (1908-1999)
concede molto di più. Il Moro più autentico è il Moro studioso, è il Moro delle
Lezioni di filosofia del Diritto. Quello è il Moro stratega. Il Moro politico è
il Moro realista, che tiene conto della realtà così com’è e non di come si
vorrebbe che fosse. Ma il Moro empirista tende sempre ad avvicinarsi, con le
dovute accortezze, al Moro teorico. Moro non è un criptobolscevico, né è un
agente segreto al servizio della Casa Bianca o di Sua Maestà Britannica. Moro
apre al Pci perché ritiene che in un momento così drammatico, per il Paese, in
piena bagarre terroristica e con l’inflazione a due cifre, non ci si può
consentire il lusso di una spaccatura lacerante del tessuto sociale. Il suo
traguardo, l’obiettivo di Moro, è la democrazia dell’alternanza, non la
democrazia dell’inciucio. La Grande Coalizione è l’eccezione, non la regola, in
una democrazia. Ma la Grande Coalizione non va confusa con la cultura della
resa. E poi, il compromesso è nel Dna di ogni democrazia. Nessuna democrazia può
vivere senza compromessi. Purtroppo, la coincidentia oppositorum, che in questo
caso non sarebbe Dio, secondo la concezione filosofica del neoplatonico Nicola
Cusano (1401-1464), bensì la convergenza fra gli interessi ostili, ha fatto in
modo che la potenza militare delle Brigate Rosse prendesse di mira il più
indifeso, il meno colpevole di tutti (Leonardo Sciascia), fra i capi della Prima
Repubblica. Marco Damilano, nel giro - leggete il suo bel libro Un atomo di
verità - tra i luoghi di Moro, dimostra che la politica-politica, in Italia, è
morta con la fine dello statista di Maglie. Difficile dargli torto. Soprattutto
oggi che all’Italia sempre più ingovernabile manca una guida, un faro come Aldo
Moro, che sta al Belpaese come Virgilio sta a Dante Alighieri (1265-1321) nel
viaggio attraverso due (Inferno e Purgatorio) dei tre regni dell’Oltretomba.
Caso Moro e il “Processo
alla DC”: il “motivo” (di molti) di una strage (di pochi).
Il “Processo alla DC” e la “Fermezza”: la “confusione delle lingue” fu radice
dell’antidemocrazia, scrive Fuori dal Coro Fabio Cammalleri il 15 Marzo 2018 su
"La Voce di New York". Il "Processo alla DC" avviato con via Fani può essere
considerato il "motivo" di quella strage. Non a caso, proprio la parola
"processo" fu evocata, da Moro, nel suo discorso in difesa del ministro Luigi
Gui, quando censurò chiunque volesse fare un processo politico e morale "nelle
piazze". Poi, quel processo andò in scena in via Fani, e nel modo più efferato.
Ci sono molti modi di guardare, oggi, al “Processo alla DC”, voluto dalle
Brigate Rosse. Avviato con la Strage di Via Fani, il sequestro di Aldo Moro, e
di cui, in questi giorni, ricorre il quarantennale. A parte certa superstizione
pseudostoriografica, inappagata evocatrice di “verità nascoste”, il modo più
diffuso, e più longevo, è stato quello che potremmo chiamare della “alterità”.
L’unico capace di serissime propagazioni: noi, gli italiani, una cosa; loro, i
brigatisti, un’altra. E tuttavia, Sciascia, già in quei giorni, aveva ammonito:
“E diciamola francamente: non fosse stato per quei cinque morti, per quei cinque
che “si guadagnavano il pane”, facendo scorta all’onorevole Moro, l’opinione
sarebbe stata univoca: ma per tutt’altro verso. E’ terribile, lo so: ma va
detto. Per capire” (Lettera di Sciascia a Luigi Compagnone, su La Stampa, marzo
1978). Ogni azione, anche la più efferata e, anzi, proprio la più efferata,
dunque, ha un motivo. E il motivo, ciò che muove, essendo sentimento del reale,
può accomunare: talvolta, più di quanto piaccia ammettere. Come si presenta un
motivo, come riconoscerlo? Dalle parole in cui si incarna. Strage e sequestro,
furono l’azione; “Il Processo”, il motivo. L’una, di pochi, l’altro, di molti.
Di quanti? Di molti. Di moltissimi. Le parola “Processo”, come “motivo”, anche
delle BR, sembra quasi vaticinata dallo stesso Moro: in un famoso discorso
parlamentare: non a caso, diffusamente rievocato proprio in relazione ai “55
giorni”. Fu il discorso tenuto in difesa del ministro Luigi Gui, per la vicenda
Lockeed, nel marzo 1977. Si era levato contro “chiunque voglia fare un processo
morale e politico…nelle piazze. Parlando, e solennemente, in nome di una radice
umana, personale: “Intorno al rifiuto dell’accusa che, in noi, tutti e tutto sia
da condannare, noi facciamo quadrato davvero”. E aggiungendo: “Quello che non
accettiamo è che la nostra esperienza complessiva sia bollata con marchio
d’infamia”. Ma se ne era registrata una resa unicamente partitica, di
consorteria potente, che rivendica di essere al di sopra della legge: “E’ un
discorso di estrema arroganza”, scrisse Camilla Cederna: sciorinando una
moltitudinaria e presuntuosa sciatteria di giornata, sul volto di un uomo che
interpretava una profonda complessità storico-politica (“Giovanni Leone”,
Feltrinelli: curiosamente, questo volume, scritto ovviamente in precedenza, andò
in libreria negli stessi giorni di Via Fani). E’ noto che quella massificata
parola-motivo, “Processo alla DC”, era stata pure avallata da una complessa
anima di artista e di letterato, che l’assunse anzi, tre anni prima, come Opera
propria: Pasolini. Un’ingombrantissima continuità, questa: fra “Il Processo” di
Pasolini, che anche Sciascia aveva voluto fosse suo, e quello delle B.R. Per
attenuare, per spiegare il conflitto di coscienza, il proprio e quello
collettivo, sorto il 16 marzo (aveva già detto, a Le Nouvelle Observateur, nel
Giugno 1978: “la sua morte ci mette tutti sotto accusa”), Sciascia, proprio in
apertura del suo “L’affaire Moro” (finito di scrivere nell’Agosto
1978), richiama ancora una locuzione di Pasolini: “il meno implicato”. Moro, il
“meno implicato” con quella che venne detta “la stagione delle stragi”. Con gli
“altri” D.C. Eppure, ugualmente ritenuto (come da molti italiani) in una
“enigmatica correlazione” con costoro. Quale, l’enigma? Proprio la radice umana:
quella che nei momenti “estremi”, prevale su ogni altro profilo. A quella radice
Moro si era richiamato in difesa di Gui. Alla stessa radice si aggrapperà
durante il suo rapimento. Ciò che, ai suoi occhi, rende “estremo” il momento è
la pretesa, in Parlamento come nella Prigione del Popolo, di essere eliminati,
in quanto uomini che agiscono politicamente: e dunque, per Moro, in quanto
“cristiani”. Non un enigma, allora, stringe Moro alla D.C., ma il suo essere
cristiano: nella famiglia e nella dimensione personalistica. E che sempre in lui
prevalse sull’astratta istituzione, sull’astratta legalità, come esplicitamente
scrive a Cossiga il 29 Marzo, dalla “Prigione del Popolo”. Qualche anno dopo,
Micromega e affini, perpetuando la “sintonia con gli umori del popolo” già
espressa da Cederna, tradurranno quella dimensione personalistica con “familismo
amorale”. Durante il sequestro, ad un certo punto, Moro definisce il suo
annunciato eccidio “strage di Stato”. Con la “Fermezza”, scrive alla moglie, “si
avalla il peggior rigore comunista, ed al servizio dell’unicità del comunismo.
E’ incredibile a quale punto sia giunta la confusione delle lingue”. “La linea
della fermezza” è ideata dal P.C.I.: “il nuovo inquilino del potere”, secondo
un’altra feconda immagine di Pasolini (riferita a Berlinguer e meno ricordata di
quella sul “Processo”, o del suo “Io so”) che, in questo modo, inventa uno
Stato: ma è un’invenzione sterilizzante. Questo Nuovo Stato, questa
nuova-vecchia idea, si insinua nella D.C., snaturandola, e rendendola colpevole
del suo stesso snaturamento: la “confusione delle lingue”, che abbandona la
difesa della vita umana in favore dell’astrattezza legalistica. La Ragion di
questo Stato, sorta nella impietosa durezza, diverrà “statolatria”. E stabile
ragione del nuovo Potere: il Potere inquisitorio. Il potere inquisitorio, però,
una volta istituito, è insaziabile. Sciascia coglie le inquietudini suscitate
dalla “fermezza”: sebbene sparute, in ogni tempo. E avverte che, opporre
violenza di Stato a violenza contro lo Stato, è una strada senza sbocco: si può
fare, ma solo “fino a quando, come rimedio, come salvezza, e salutata come
salvezza da un popolo stanco e nauseato, non interverrà la fine della libertà”
(La Sicilia, Agosto 1978). E’ la sua ragionata prefigurazione di Tangentopoli, e
dei suoi inevitabili frutti politici di massa. Il seguito, lo vedremo.
Sequestro Moro: tutte le
fake news del “Memoriale” di Morucci, il brigatista elegante poi al soldo dei
servizi. Per
molti anni è stata la verità ufficiale, ma oggi sappiamo che su diversi punti il
documento firmato dall'ex responsabile logistico del gruppo armato confondono le
acque: sul covo-prigione, sui componenti del commando, sulle auto impiegate.
Negli anni successivi, i rapporti con il Sisde. Sullo sfondo, una trattativa
parallela e oscura, scrive Stefania Limiti il 16 marzo 2018 su "Il Fatto
Quotidiano". Valerio Morucci si presentò al suo primo incontro con i capi
brigatisti, in viale Zara a Milano, a bordo di una Mini Cooper gialla con tetto
nero e una ragazza bionda. Era molto elegante: giacca blu con bottoni d’oro,
camicia di seta, cravatta, occhiali Ray-Ban. Chiese di entrare nelle Br, ma
l’incontro non andò bene perché “sembrava un fascistello sanbabilino”, ha poi
scritto Alberto Franceschini che, insieme a Mario Moretti, era arrivato su una
Fiat 850 grigio sbiadito e un enorme portabagagli sul tetto. Le cose andarono
come è noto: Morucci divenne responsabile logistico delle Brigate rosse e uno
degli uomini-chiave dell’operazione Moro che lo ha rivelato alle cronache come
il brigatista della mediazione, il “buono” che vuole salvare l’ostaggio, contro
il duro e spietato Moretti. La faccenda è un po’ più complessa dello schema che
si è impresso nell’immaginario collettivo. Del resto, tutto il caso Moro è
diventato un luogo simbolico dove gli eventi sono più rappresentati che
raccontati nella loro essenzialità – anche il figlio di Moro, Giovanni, in
genere schivo, dice a Ezio Mauro che “la questione non è affatto chiusa, non amo
le spy story, ma è ammissione comune che ci siano zone d’ombra, questioni non
chiarite, contraddizioni e spiegazioni non ragionevoli”. Perciò la ricerca
storico-giudiziaria non è affatto chiusa e due inchieste sono in corso alla
Procura di Roma e alla Procura generale. Dopo 40 anni, in effetti, siamo qui a
ripercorrere gli eventi, ma ciò che è stampato nelle nostre menti è in gran
parte una sceneggiatura, non la verità. Il regista dell’opera di aggiustamento
del racconto è stato, nel fronte brigatista, proprio lui, Valerio Morucci che ha
sbattuto sul tavolo della grande mediazione il suo Memoriale: 285 pagine – di
cui solo 110 dedicate ai particolari del caso Moro – nelle quali l’informazione
che convince di più, forse, è il costo complessivo a carico delle Br di tutta
l’operazione: 700mila lire, un dato che appare sottolineare il minimalismo e
l’approccio militante della sua preparazione. Il Memoriale sembra risolvere il
quesito principe, quello della prigione di Moro: in realtà, il brigatista
ammette di essere all’oscuro della questione perché non ha mai saputo nulla in
modo diretto, per via della rigida compartimentazione, anche se impone la
cancellazione di alternative: “Escludo in modo assoluto che Moro sia stato
tenuto prigioniero in via Gradoli o nella base di Velletri… o fosse stato
portato in luogo coperto da immunità diplomatica o in qualche sede di partito o
in qualsiasi altro luogo che fosse estraneo all’organizzazione”. O sa o non sa,
in ogni caso la sua versione sulla prigione di via Montalcini diventa verità
processuale e poi, diremmo, luogo comune. Sul numero dei partecipanti
alla strage di via Fani Morucci nel 1984, data d’inizio della lunga stesura del
testo, sostiene che il commando era composto da nove persone, ma nel 1997 ne
aggiungerà una decima, Rita Algranati, che prima «aveva dimenticato». Sostiene
poi che il commando sparò solo da sinistra, mentre sappiamo, perché ce lo
conferma la perizia richiesta dal presidente del processo Moro-quater, che
diversi colpi partirono anche dal lato destro della strada. Il particolare è
cruciale ma la questione si chiude lì. Morucci descrive poi il percorso fatto
dalle auto del commando da via Fani in poi: non dice che fine fanno la Dyane
guidata da lui con a bordo Bruno Seghetti e l’autofurgone 850 sul quale viene
fatto salire Moro in Piazza Madonna del Cenacolo, dove avviene il primo
trasbordo dell’ostaggio. Tutte le altre auto della fuga, dice, vengono riportate
e abbandonate in una stessa strada, via Licinio Calvo: che bisogno c’era di
riportarle tutte lì? Come se l’assassino tornasse sul luogo del delitto. In
realtà, oggi, grazie al lavoro della Commissione Moro 2, è anche noto che le
auto della fuga vennero ritrovate a distanza di giorni l’una dalle altre ed è
stato anche accertato che la 132 sulla quale venne fatto salire Moro in via Fani
fu ritrovata tra le 9,15 3 le 9,23: non è possibile che quell’auto abbia portato
l’ostaggio fino a Piazza Madonna del Cenacolo. Sostiene sempre Morucci che il
furgone con l’ostaggio va poi verso il parcheggio della Standa di Viale
Portuense. Qui il racconto non si incrocia mai con quello degli altri: Moretti
dice che alla Standa c’erano Laura Braghetti e Prospero Gallinari; Morucci dice
che quest’ultimo si era subito allontanato da via Fani per recarsi verso la
prigione; il guazzabuglio assume i contorni di un imbroglio se si considera che
Braghetti comincia il suo libro proprio dicendo di essere rimasta a casa ad
aspettare il ritorno dei suoi compagni e dell’ostaggio. Insomma, il Memoriale,
che ha avuto il ‘visto’ del libro intervista di Mario Moretti, è approssimativo
e arrangiato, natura descritta in una indimenticabile risposta che Morucci diede
alla domanda dell’onorevole Luciano Violante nel 1983, durante una audizione
della prima Commissione Moro: “Nella strage di via Fani sono stati impegnati più
di dodici brigatisti?”. “Secondo me sì, ma non eccessivamente di più”. Oggi sono
stabiliti (Terza Relazione Commissione Moro 2) “l’incongruenza delle
ricostruzioni di Morucci su punti non secondari” e il dato che diversi soggetti
parteciparono alla costruzione della verità giudiziaria offerta da quel testo:
al tavolo c’erano il Sisde, il servizio segreto civile, uomini politici e delle
istituzioni, in particolare Remigio Cavedon, personaggio autorevole della Dc,
vicedirettore de Il Popolo, e i buoni servigi di una suora tuttofare, Teresilla,
un po’ spia e un po’ religiosa, molto legata a Francesco Cossiga e Oscar Luigi
Scalfaro. Morucci più che testimone ha una più ampia e opaca funzione di
consulente di una trattativa che venne sempre nascosta all’opinione pubblica. Il
brigatista “buono”, che aveva nel portafogli l’indirizzo e il telefono
dell’Università Pro Deo diretta dal religioso nonché agente della Cia padre
Felix Morlion, dialoga con i Servizi segreti, fornisce loro note critiche su
diverse questioni e si pone come punto di riferimento della politica carceraria.
Tra il 1986 e il 1987 il rapporto Morucci/Sisde è “continuativo” e il suo
parziale disconoscimento della paternità del Memoriale – ha detto di ricordare
di averne scritto una parte – appare in effetti verosimile perché le
caratteristiche formali e compositive del testo fanno scrivere alla Commissione
Moro 2 che si tratta di “un elaborato interno agli apparati di sicurezza”. Il
Memoriale ha stabilito la purezza rivoluzionaria dell’azione di via Fani e la
responsabilità unica del gruppo brigatista. Perché la Democrazia cristiana si è
seduta al tavolo della trattativa? Perché doveva autoassolversi dall’accusa più
grave: non aver salvato l’uomo che rappresentava la sua storia e, in quel
momento, il suo futuro. La stabilizzazione di una verità parziale è stata
funzionale alla chiusura di una stagione. Operazione riuscita fino a oggi ma a
caro prezzo: quello di sacrificare la piena comprensione del caso Moro e la
consapevolezza delle forze che hanno interferito durante i 55 giorni,
determinandone il loro esito tragico.
“Aldo Moro, i terroristi
parte di un gioco più grande di loro”. Così le potenze Nato volevano
sbarazzarsene. Prima delle Br.
Nel libro di Giovanni Fasanella, "Il Puzzle Moro", l'analisi di documenti
inglesi e americano oggi desecretati. Raccontano che non erano le Brigate rosse
le sole nemiche del presidente della Dc sequestrato il 16 marzo 1978 e ucciso 55
giorni dopo. Usa, Uk, Francia e Germania erano preoccupate dal rischio di un Pci
al governo e dalla sua apertura verso il mondo arabo. Nei vertici al massimo
livello l'ipotesi di intervenire anche con "metodi per noi ripugnanti", scrive
"Il Fatto Quotidiano" il 16 marzo 2018. Non è questione di dietrologia e
complotti. Sono i documenti a parlare. E i documenti mostrano che non erano solo
le Brigate rosse a vedere in Aldo Moro un nemico. E’ il filo conduttore del
libro di Giovanni Fasanella Il puzzle Moro (Chiarelettere, 368 pagine, 17,60
euro), basato su testimonianze e documenti inglesi e americani oggi desecretati.
Negli anni Sessanta e Settanta Londra, Washington, Parigi e Berlino temono
innanzitutto che in Italia il Partito comunista italiano più forte d’Europa
possa andare al potere, sia pur legittimamente attraverso il voto, sconfiggendo
una Dc minata da scandali e clientele. E neppure gradiscono le aperture del
nostro Paese verso il mondo arabo, Libia e Palestina incluse. Moro era il volto
che meglio incarnava questi pericoli, come dimostra il brano tratto dal libro
che pubblichiamo di seguito per gentile concessione di Chiarelettere. Questo non
significa che le potenze straniere siano state partecipi del sequestro e
dell’assassinio del presidente della Democrazia cristiana, avvenuti quarant’anni
fa a Roma. Ma, scrive Fasanella, i brigatisti sono rimasti ancora oggi “convinti
di essere stati il motore esclusivo di avvenimenti che sono invece più grandi di
loro”, pur non ammettere il loro ruolo da “utili idioti”. Lasciati fare, in quei
55 giorni, in nome di altri interessi. E se l’ultima commissione parlamentare
d’inchiesta ha concluso che quella accumulata finora dai processi è solo “la
verità dicibile”, i documenti desecretati illuminano quella indicibile: “Ciò che
non si poteva dire”, scrive ancora l’autore, “era che l’assassinio di Moro fu un
vero e proprio atto di guerra contro l’Italia anche da parte di Stati amici e
alleati, un attacco alla sovranità di una nazione e alle sue libertà politiche
portato da interessi stranieri con la complicità di quinte colonne interne”.
Ecco un estratto dal libro. Il «direttorio politico» dei «Quattro», nato su
iniziativa americana per decidere che fare per risolvere una volta per tutte il
caso italiano, si riunì la prima volta a Helsinki il 31 luglio 1975. Subito dopo
le elezioni amministrative che, in giugno, avevano decretato un clamoroso
successo del Pci e una secca sconfitta della Dc, travolta da scandali a
ripetizione. Nella capitale finlandese era in corso la conferenza sulla
sicurezza europea. E in quell’occasione, i rappresentanti di Usa, Gran
Bretagna, Francia e Germania approfittarono di una pausa per appartarsi e
discutere lontani da occhi indiscreti. Si videro a pranzo nella sede
dell’ambasciata inglese. Ma senza alcun risultato utile. Tutti erano d’accordo
sui rischi che avrebbe corso l’Alleanza atlantica nel caso in cui il Pci si
fosse avvicinato al governo. Tutti pensavano che si dovesse fare qualcosa. Ma
quando cominciarono a esaminare le varie opzioni, la discussione si arenò.
Prevalse un atteggiamento di prudenza fra gli europei, ancora molto «sensibili
riguardo alla macchia di un’ingerenza così vicino a casa», come emerge dai
documenti americani pubblicati dalla storica Lucrezia Cominelli. Così, l’unica
decisione presa fu quella di tornare a incontrarsi un paio di mesi dopo, a New
York. L’appuntamento negli Usa fu fissato per il 5 settembre 1975. E anche
quella volta i «Quattro» si videro nella sede diplomatica britannica. C’erano,
oltre a Kissinger, i ministri degli Esteri inglese, James Callaghan, francese,
Jean Sauvagnargues, e tedesco, Hans-Dietrich Genscher. In quel secondo incontro,
le rispettive posizioni cominciarono a delinearsi con più chiarezza. Il padrone
di casa, Callaghan, prospettò un quadro drammatico della situazione.
L’intera Europa meridionale rischiava di finire sotto l’influenza comunista,
disse. Ma non per colpa dell’Urss, che «non sembra avere tutta questa fretta di
aggiudicarsi altri costosi clienti», si affrettò a precisare. Anzi, secondo lui
il Cremlino avrebbe accettato «una dottrina Brežnev rovesciata», in base alla
quale l’Alleanza atlantica era autorizzata a intervenire con la mano pesante in
un paese a rischio del proprio campo; così come il Patto di Varsavia aveva fatto
in Cecoslovacchia in base al principio della «sovranità limitata» teorizzato da
Leonid Brežnev per i satelliti dell’Urss. In ogni caso, per il ministro degli
Esteri inglese, era necessario escogitare qualcosa che fosse «a metà strada fra
metodi per noi ripugnanti e la necessità di scoraggiare l’influenza sovietica».
Insomma, anche se dal Cremlino non arrivavano incoraggiamenti al Pci, un
intervento era comunque necessario per frenare eventuali, future tentazioni. Per
Callaghan la situazione italiana era tale da non giustificare ulteriori
esitazioni. Durante l’estate aveva incontrato Rumor (trasferitosi alla Farnesina
dopo che Moro ne aveva preso il posto a Palazzo Chigi) e dal colloquio ne era
uscito con l’impressione che non ci fosse niente, fra i metodi democratici, che
potesse «fermare la presa del potere da parte dei comunisti». E allora, come
impedirlo? Il ministro britannico non si sbilanciò. Probabilmente voleva che
fossero gli altri a scoprirsi, per capire fino a che punto fossero disposti a
spingersi. Sul tavolo, una delle opzioni per bloccare l’avanzata comunista era
costringere la Dc a rinnovare la propria classe dirigente, troppo chiacchierata
per la sua disinvolta gestione del potere. Ma Kissinger non nutriva molte
speranze in proposito: «Mi sento bloccato, non ho alcuna idea brillante per
riformare la Dc» disse. «Ci vorrebbe un partito che spazzasse via tutta la
spazzatura» commentò Callaghan con un moto di sconforto. Una radicale riforma
morale della Democrazia cristiana, ai «Quattro» doveva sembrare un’impresa
davvero titanica, che richiedeva troppo tempo. Ma il tempo a disposizione si
stava paurosamente consumando. E quell’opzione, benché auspicabile, non era
certo la più efficace per una situazione che si era trasformata ormai in
un’emergenza internazionale. (…) L’ultima delle tre riunioni, quella del gennaio
1976, si tenne nel quartier generale della Nato, a Bruxelles. C’erano tutti i
ministri degli Esteri, tranne il tedesco Genscher, che questa volta inviò a
rappresentarlo un funzionario, Günther van Well. Il clima era ancora più cupo.
Il Psi di Francesco De Martino, con una mossa a sorpresa, aveva appena provocato
la crisi di governo, e Moro si era dimesso. La decisione socialista, in effetti,
aveva complicato ancora di più le cose. De Martino si sentiva schiacciato nella
morsa del dialogo a distanza tra Moro e Berlinguer. Non era più disposto ad
accettare che, a sinistra, fosse solo il suo partito a pagare il prezzo
elettorale per una politica economica di sacrifici. La rabbia dei ceti più
deboli si stava scaricando sul Psi che, pur non avendo propri ministri nel
governo Moro, lo aveva comunque appoggiato dall’esterno. Insomma, De Martino non
intendeva più dissanguarsi a vantaggio del Pci, che continuava a guadagnare
consensi nell’opinione pubblica. Perciò fece sapere che non avrebbe più fatto
parte di una maggioranza se anche i comunisti non si fossero assunti delle
responsabilità dirette. La sua decisione gettò tutti nel panico. E fu giudicata
intempestiva anche da Berlinguer. Il quale, ben conscio dei condizionamenti
internazionali e dei rischi che correva l’Italia, aveva tarato la sua strategia
su tempi molto più lunghi, quindi non fremeva certo dal desiderio di vedere i
comunisti nel governo. Né Moro, d’altra parte, ce li voleva. Ma De Martino era
irremovibile. E l’Italia stava andando a passi veloci verso elezioni anticipate.
Al tavolo dei «Quattro», a Bruxelles, ora si stava materializzando lo scenario
più drammatico che potessero immaginare: quello di una disfatta della Dc e, per
la prima volta nella storia repubblicana, il sorpasso comunista, pronosticato
ormai da tutti gli osservatori. Se il Pci fosse diventato il primo partito
italiano, sarebbe stato impossibile escluderlo dal governo senza ricorrere a una
soluzione alla cilena. Di qui il senso di impotenza e di frustrazione, come
riferisce Lucrezia Cominelli. (…) A Kissinger non interessava quanto Berlinguer
fosse autonomo da Mosca, ma soltanto il grado di pericolosità della sua politica
per Usa e Urss. Quanto agli inglesi, la preoccupazione principale, molto ben
mimetizzata dietro la loro continua, sistematica esasperazione della minaccia
comunista, era che la scena politica italiana continuasse a essere dominata
dalla figura di Aldo Moro. E lo fecero capire ancora più chiaramente alla
vigilia delle elezioni italiane. I «Quattro» stavano valutando la possibilità di
un nuovo vertice segreto. Prevaleva l’idea di tenerlo subito dopo il voto. Ma
per Callaghan sarebbe stato troppo tardi. Disse al cancelliere tedesco Schmidt:
«Se vogliamo cercare di avere una qualche influenza dovremmo farlo prima. In
caso contrario avremmo il vecchio Moro seduto e mezzo addormentato per tutto il
tempo come un primo ministro con la spina dorsale spezzata e i comunisti che
hanno ottenuto un grande successo». Ecco perché, fra i «Quattro», la Gran
Bretagna spingeva con più forza. Voleva che gli alleati l’aiutassero
a sbarazzarsi di Moro. (da Il Puzzle Moro, di Giovanni Fasanella, Chiarelettere)
Aldo Moro e le Brigate
Rosse, la verità 40 anni dopo. Cosa diceva Cossiga: "La colpa di tutto fu di
Berlinguer e Pci",
scrive il 16 Marzo 2018 Renato Farina su "Libero Quotidiano".
Quaranta anni fa, come oggi, veniva sequestrato Aldo Moro e sterminata la sua
scorta in via Mario Fani a Roma. Da quel giorno del 1978, quando si evocano
questi fatti, inevitabile ecco sentir pronunciare il nome di Francesco Cossiga.
Di solito per associarlo a dei sospetti. L'ultimo a farlo, in ordine di tempo, è
stato Giovanni Moro, figlio minore dello statista. In una intervista
a Repubblica rilancia l'accusa: «Perché lo Stato non fece nulla per
salvarlo?... Andreotti era il capo del governo, il responsabile politico ... E
Cossiga? In qualsiasi paese, un ministro dell'Interno a cui fosse capitata una
disgrazia del genere, sarebbe finito a coltivare rose... lui invece divenne due
volte presidente del Consiglio e una volta capo dello Stato». Ho potuto
ascoltare (e registrare) per ore - nel luglio del 2008 - il presidente emerito
della Repubblica esprimersi su quelle vicende e sul peso che si è portato
dietro. Era amico intimo dello statista poi assassinato il 9 maggio. Ho
trascritto le parti essenziali della sua testimonianza nel libro Cossiga mi ha
detto (Marsilio). Una cosa mi colpisce. La domanda che allora si pose con me
Cossiga, ed era la prima volta, a proposito delle ripetute accuse contro di lui
e Andreotti dei Moro, è stata: «Perché hanno sempre accusato noi due, e
mai Enrico Berlinguer ed il Pci, che in nessun modo si adoperarono per salvare
Aldo?». Qui, credo possa essere utile trascrivere alcune pagine da quelle
"confessioni", certificate da registrazioni già messe a disposizione della
magistratura.
Dice Cossiga: "Lo scorso 4
luglio 2008, la festa dell'Indipendenza, mentre all'ambasciata americana
partecipavo al ricevimento, era verso sera, una ragazza mi si avvicina.
«Senatore Cossiga». Non sapevo chi fosse, non la conoscevo, forse un tratto del
volto però, qualcosa di familiare e amico «Sono la nipote di Aldo ed Eleonora
Moro, sono la figlia di Agnese». Se ne andò subito via. Mi ricordo qualcosa, un
sorriso, non so, devo averle dato la mano, non ricordo bene. Dopo trent' anni
dalla morte di Aldo Moro è la prima volta che qualcuno della sua famiglia si
rivolge a me parlandomi, chiamandomi per nome. L' ho sentito come una carezza
dall' aldilà. Forse Aldo comincia a capirmi. Io ero e sono diverso da lui. Molto
più piccolo di lui. Profetizzò che per molto tempo avrei patito di quella mia
scelta. Ha ragione, e ne soffro ancora, è la mia croce. Ma ho imparato a
distinguere tra rimorso psicologico e rimorso morale. Quello morale non l'ho. ()
La coscienza mi ha imposto quelle scelte. E io le ritengo tuttora giuste. Lui
vede, sa. Avevamo una diversa concezione dello Stato. Per me era essenziale, per
lui alla fine lo Stato non esisteva. Esistono gli uomini, lo Stato no".
LE LETTERE. Le sue lettere -
l'ho capito dopo - sono oneste e coraggiose, non ha cambiato idea per salvarsi
la vita. Rispecchiano perfettamente la sua concezione della Democrazia
cristiana. Non è mai stato liberale, Aldo Moro. Lo ricordo da vivo. Non mi ha
abbracciato in alcuna occasione per tutto il tempo in cui sono stato a lui
vicino. Andreotti una volta, per sbaglio, lo fece. Aldo Moro mai. Eppure mi ha
voluto bene. Per questo so che mai ha pensato a un mio calcolo, a una
cattiveria. Ha addebitato tutto a una mia concezione dello Stato che lui
riteneva sbagliata e che mi avrebbe certo fatto correggere solo se avesse potuto
parlarmi a quattr' occhi. Non ha pensato mai un istante che fossi sleale o gli
mancassi d' affetto, ma attribuì la mia scelta alla fragilità. A qualcosa che
non c' entrava né con la ragione né con i sentimenti, bensì con il mio essere
prigioniero di Andreotti, ma soprattutto di Berlinguer. Mi fermo un attimo e lo
vedo. È prigioniero, in condizioni di cattività. Ha davanti a sé sin dal primo
momento la prospettiva dell'ultima ora per mano violenta. Eppure egli ha una
tale indipendenza di coscienza, come uno Spartaco che ha le catene ai piedi ma
la testa libera, da vedere in me un povero suo figlio traviato non moralmente ma
da un altro tipo di prigionia, più sottile e più forte.
IL WHISKY. Ci chiamavamo per
nome, mi faceva sedere e mi offriva whisky. Uno dei ricordi che mi torna spesso
alla mente è di lui nel suo studio privato di via Savoia a Roma. Io che entro, è
tarda sera, mi siedo, e mi domanda: «Francesco cosa posso offrirti?». Rispondo:
«Aldo, un dito di whisky». E lui costernato: «Francesco, mi spiace, non ce
l'ho». Il giorno dopo senza che lo chiedessi mi porse contento il bicchiere. Mi
raccontò poi il suo fido collaboratore Nicola Rana che la mattina stessa era
arrivato con un involto di giornali, e c'era, avvoltolata dentro, la bottiglia.
Svolse i fogli e disse: «Tenetela per Francesco, è per lui». Non credetti all'
autenticità delle sue lettere, lui non credette all' autenticità delle mie
disposizioni, non si capacitava potessi pensare in piena coscienza che le
lettere non fossero davvero sue. Ora lui sa che le mie convinzioni erano
autentiche e io che le sue lo furono altrettanto. Ci divideva proprio il
giudizio sulle cose. La gerarchia delle cose importanti. ()
GLI ASSASSINI. Sono sempre
stato considerato da tutti i Moro, per ogni istante di questi trent' anni dal 9
maggio 1978, come l'assassino del loro marito, padre, nonno. L'ho condannato a
morte, è vero. L'ho fatto in piena coscienza. Le mie convinzioni, di me
cattolico liberale, che crede nello Stato e nelle ragioni dello Stato per il
bene comune, hanno prevalso. L'ho condannato a morte, insieme con Andreotti,
Zaccagnini e Berlinguer. Io non sono l'assassino però! Lo furono le Brigate
Rosse. Devo dirla questa banale verità. Ci si dimentica sempre di questo: che
gli assassini sono i brigatisti. E che tra coloro che hanno deciso la condanna a
morte c' è, e in una posizione decisiva, di intransigenza estrema, Enrico
Berlinguer con il suo Partito comunista. Perché gli assassini di Moro, secondo i
suoi familiari, siamo io, Zaccagnini e Andreotti? Perché essi non hanno mai
detto una parola contro i comunisti? Hai mai sentito uno della famiglia Moro
dire che la linea della fermezza era voluta innanzitutto da Berlinguer e dai
suoi? La mia risposta è: perché i comunisti fanno ancora paura. Perché facciano
ancora paura non me lo spiego. Oppure hanno questa magia per cui qualunque cosa
facciano non sono giudicabili, quasi fossero superuomini. Nel suo ultimo libro,
quel matto di Giovanni Moro indica queste persone come gli assassini del padre:
Paolo VI, Andreotti, io e Zaccagnini. Ancora una volta Berlinguer lo lascia
fuori. Nessuno della famiglia l' ha mai lontanamente indicato anche solo come
appena appena responsabile. O i comunisti sanno su di loro cose per cui li
minacciano oppure la realtà è metafisica e fanno paura in sé. Se non ci sono
altri pasticci che non so, basterebbe leggessero in mia compagnia, una sera,
quanto ha scritto di me Aldo. Nel verbale del processo cui è stato sottoposto
dalle Br, Aldo mi dedica un capitolo. È la risposta a un interrogatorio. () «Di
derivazione sarda e imparentato con Berlinguer, ha la sua base elettorale e
psicologica in Sardegna, dove spesso vivono i familiari. Conosce naturalmente a
Roma ai più alti livelli, ma non è, come Andreotti, un romano e non ne ha
oltretutto la mentalità. Se dovessi esporre con una certa riservatezza il mio
pensiero, direi che in questa vicenda mi è parso fuori di posto, come
ipnotizzato. Da chi? Da Berlinguer o da Andreotti? Se posso avanzare una
ipotesi, era ipnotizzato da Berlinguer piuttosto che da Andreotti con il quale
lega a prezzo di qualche difficoltà ()».
LO SCAMBIO. Supponeva fossi
plagiato, di più, "ipnotizzato" da Enrico Berlinguer. Me lo lasciò intendere
anche in una lettera scrittami tra il 5 e l'8 aprile dal carcere delle Brigate
Rosse. C' è questa frase: «Se mai potessi parlarti, ti spiegherei meglio e ti
persuaderei. Ti chiedo di avere fiducia». Non l'ho avuta, questa fiducia in lui.
In quel momento ero ancora convinto fosse non lui ma un altro a scrivere con la
sua testa e le sue mani. Ma non mi avrebbe convinto egualmente. Quando ripenso a
quella frase, aggiungo sempre «Francesco». E sento la sua voce. «Se mai potessi
parlarti, Francesco». Ma non mi avrebbe convinto. Sullo scambio di prigionieri
in quel momento no. Lo Stato si sarebbe liquefatto moralmente. Sarebbe finito il
compromesso storico per mano delle Brigate Rosse, ottenendo così la loro massima
vittoria. Renato Farina
Renato Farina. Cossiga mi
ha detto. Il testamento politico di un protagonista della storia italiana del
Novecento.
Marsilio Editori, pagg.240, Euro 18,00. Da Archivio storico.
IL LIBRO – “Cossiga era il
massimo esperto del globo sulle questioni relative all'intelligence e agli 007
di ogni Paese. Subito dopo l'11 settembre si mise in contatto con Feltri. Gli
disse che Berlusconi stava per scegliere dei vertici del Sismi e del Sisde
disastrosi. Occorreva forzare la mano. Era disposto Feltri a ospitare dei suoi
testi? Feltri disse di sì e affidò a me l'opera di trasformare un meraviglioso
enigmatico testo in qualcosa di masticabile per i lettori. Era d'accordo
Cossiga? Di più: entusiasta. Lavorammo insieme, e uscì un articolo in cui Franco
Mauri (lui!) fucilava come traditori gli altri candidati e promuoveva a pieni
voti e con la garanzia di salvezza per l'Italia i generali Nicolò Pollari per il
Sismi e Mario Mori per il Sisde. Cossiga mi invitò a brindare: la nostra
accoppiata aveva vinto per il bene dell'Italia. Questa storia portò bene
all'Italia, meno bene a me. Ma mi regalò un'amicizia cementata nella pugna
(ironia, ma neanche tanto). Da allora ci sentimmo quasi tutti i giorni,
scrivemmo insieme, registrammo materiale per un libro biografico traslocando a
Lugano o in Toscana per settimane intere. Il libro è mio e le parole sono sue.
Sono quelle che ho udito da lui, quelle delle carte da lui tirate fuori dai
cassetti.” (Renato Farina)
DAL TESTO – “Io sono un
cattolico liberale. Ma resto convinto che il latino è la lingua della Chiesa. Mi
fa specie che il beato Pio IX, preparandosi a scappare a Gaeta, abbia avuto il
tempo prima della fuga di confermare sette condanne a morte. Ma la Chiesa così
un po' mi piacerebbe. Se si accendesse qualche rogo, si piazzasse di nuovo la
ruota, si riaprissero le segrete del Vaticano, qualche cardinale progressista
smembrato... “In piazza Duomo, smembrato, cioè prese, con corde e ganci, testa,
braccia e gambe, davanti alla gente che tripudia e salmodia... e poi francescani
e domenicani oranti e un gesuita che gli dice: «Ringrazia Iddio perché con
questa morte ti salvi dai tuoi peccati». Coppie di cavalli, crac, per terra, in
piazza Duomo, e le campane che suonano. Che goduria anche solo l'immaginarlo. A
un pazzo sarà concessa questa licenza cattogiustizialista. O no? “Di questa
intransigenza fino alle tenaglie contro gli eretici, so che non mi pentirò
neanche in punto di morte. Mi consola Bruce Marshall. Racconta: prima di andare
all'assalto nella Prima guerra mondiale, dove poi morirà, un ufficiale
scavezzacollo va a confessarsi di tutte le donne avute. Crede che il pentimento
consista nel rinnegare che ha avuto momenti piacevoli. Ma non può farlo, sarebbe
una menzogna. Allora il prete gli chiede: «Figliuolo, ti penti di non
pentirti?». «Certo.» «Allora io ti assolvo dai tuoi peccati» e muore. Ecco
vorrei morire così.”
L’AUTORE – Renato
Farina (Desio, 1954), giornalista, scrittore. Fra il 1987 e il 1999 riveste il
ruolo di mediatore diplomatico informale di alto profilo in vari contesti
geopolitici. Nel luglio del 2000 fonda con Vittorio Feltri il quotidiano
«Libero» dalle cui pagine, nel 2001, collabora con Francesco Cossiga alla
campagna che porterà il generale Nicolò Pollari alla guida
dell'intelligence italiana. Accusato di favoreggiamento dei generali Pollari e
Mancini per la vicenda del sequestro di Abu Omar, nel 2006 è radiato dall'Ordine
dei giornalisti, e direttori come Feltri e Sallusti che hanno ospitato i suoi
articoli sono stati inseguiti da provvedimenti di sospensione. Contro queste
sentenze intende appellarsi alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo.
Dal 2008, eletto nelle file del Pdl, è deputato e consigliere politico dei
ministri Gelmini e Frattini.
INDICE DELL’OPERA - Premessa.
La storia di un libro - Cossiga mi ha detto - Verrà la morte, e io la bacerò -
Interludio I. A Lugano, parlando di sesso e pm - Foto di gruppo a Sassari con
maestra e cuginetti - Interludio II. A Cortona Gatto Mammone colpisce ancora -
Gli amori e la sposa perduta - Interludio III. A Roma, Telecom e altre spiate -
Perché un bravo ragazzo come me prese in mano due bombe - Papi, latino e
champagne - Francesco, ti sei confessato per l'omicidio di Moro? - Le valige
delle stragi: palestinesi e americane - Confesso, sono il capo dei gladiatori -
Falcone, Mani Pulite, Abu Omar. Tre storie parallele - Mescolanze e aforismi di
politica e di cultura - Commiato di un pazzo in attesa di cielo – Cronologia -
Indice dei nomi
Ecco la Mani Pulite che
nessuno racconta: gli indagati di Di Pietro intercettati da tre anni.
Renato Farina racconta in un libro: "Antonio Di Pietro ha ammesso di aver
incastrato Chiesa con le intercettazioni. E su diversi blog hanno usato questa
sua autodenuncia per sostenerne l’utilità. Ma non furono mai esibite in nessun
processo, e se ci furono erano illegali", scrive Stefano Zurlo, Martedì
12/07/2011, su "Il Giornale". La prosa è sempre vivacissima, come nello stile
che i lettori del Giornale conoscono bene. Renato Farina, per lunghi anni
vicedirettore del quotidiano di via Negri e poi di Libero, torna indietro nel
tempo, fino agli anni cruciali di Mani pulite e del Pool. E ci consegna
aneddoti, giudizi, ritratti, episodi inediti sul confine scivoloso fra la
politica e la giustizia. Ce n’è per tutti, anche perché Farina sfrutta una guida
d’eccezione: lo scomparso presidente Francesco Cossiga. «Cossiga mi ha detto»:
questo è il titolo del libro in uscita da Marsilio. Un testo è che è un rotolare
di sorprese. E un susseguirsi di dettagli che lasciano a bocca aperta. Anche se
non sempre Farina svela le sue fonti: «Qui rivelo un episodio inedito». E il
giornalista, oggi deputato del Pdl, allunga il passo: «Durante un
interrogatorio, per far vedere con chi aveva a che fare, Primo Greganti, il
mitico Compagno G, picchiò Di Pietro». Possibile? Farina incalza: «Gli balzò
addosso. Proprio come facevano alcuni impavidi partigiani con gli ufficiali
della Gestapo. Quelli - è la chiusa ironica - però venivano fucilati. Greganti
è, per sua fortuna, tornato fra noi». Non c’è il tempo per controllare la
notizia: Farina è già oltre. E sparge dubbi sull’incipit della Rivoluzione
giudiziaria. Domanda: chi diede a Di Pietro il combustibile per far girare la
macchina degli arresti? «In realtà - è la risposta - quando presero con i soldi
nel cesso il Mario Chiesa alla Baggina di Milano, febbraio ’92, erano già tre
anni che lavoravano con le intercettazioni». Addirittura? Tre anni? «Antonio Di
Pietro - prosegue Farina - ha ammesso di aver incastrato Chiesa con le
intercettazioni. E su diversi blog hanno usato questa sua autodenuncia per
sostenerne l’utilità. Ma non furono mai esibite in nessun processo, e se ci
furono erano illegali. Mi domando: grazie a chi furono effettuate? C’entrano i
servizi segreti deviati? O magari gli americani? I quali vedevano male sia Craxi
sia Andreotti per le loro posizioni filoarabe e avevano anche dei riflessi di
vendetta per Sigonella». Certi argomenti sono tabù. E restano, come dire, nel
backstage delle grandi inchieste: Farina ha una scrittura partigiana e non ha
paura di esporsi, di offrire il fianco alle critiche, di prendere posizioni
eretiche, da iconoclasta. Del resto in un’altra vita, parallela a quella in
redazione, Renato è stato l’agente Betulla e questa sua consuetudine con i
Servizi segreti gli è costata cara. Molto cara. Un patteggiamento nell’inchiesta
sul sequestro di Abu Omar e la radiazione dall’Ordine dei giornalisti, annullata
solo pochi giorni fa dalla Cassazione. Lui spariglia, cita e dissacra
appoggiandosi alle intuizioni e alle narrazioni di quel monumento nazionale
chiamato Cossiga. Che il 7 gennaio 2004 gli scrive una letterina pepata a
proposito di Francesco Saverio Borrelli: «Anni fa, l’allora procuratore Borrelli
mi chiamò al mattino presto nella mia abitazione: più che chiedere mi intimò per
telefono di smentire che egli - come in un’intervista avevo riferito - fosse
socialista, dicendo anzi che era di famiglia monarchica... Avendo egli
insistito, io allora gli dissi -come effettivamente feci - che avrei eseguito,
ma non mi chiedesse di smentire in futuro quel che io sapevo con certezza e
cognizione dei fatti e cioè che la sua nomina a Procuratore era avvenuta con
l’opposizione della Dc e su pressione del Partito socialista, guidato da Bettino
Craxi».
Farina, un libro bufala.
L'ex agente Betulla, oggi parlamentare Pdl, ha appena sfornato un volume
intitolato "Cossiga mi ha detto". Ma Cossiga non gli ha detto niente, avendo
interrotto ogni rapporto con lui due anni prima di morire. E non voleva saperne
più nulla. Colloquio con Pasquale Chessa di Malcom Pagani del 22 luglio 2011 su
“L’Espresso". Francesco Cossiga "ha smesso di parlare alcuni mesi prima di
decidere di smettere di vivere. Ma quando interruppe ogni rapporto con Renato
Farina era lucido e stava ancora bene". In una casa di mezzo tra le oscurità di
Regina Coeli e le luminose ombre dell'Accademia dei Lincei, in faccia a una
piccola collezione di antichi libri sardi, Pasquale Chessa, giornalista,
storico, biografo di Cossiga, riflette sulle ultime incredibili picconate
postume. Tirate brutali, analisi perfide, giudizi pesanti su protagonisti
dell'attualità e della politica, ricostruzioni insinuanti fatte scivolare in un
volume intervista ("Cossiga mi ha detto") appena pubblicato da Marsilio. Lo
firma, con tutto quel che ne consegue, Renato Farina. Dentro balla una
narrazione che l'ex presidente non avrebbe voluto vedere pubblicata. Provò a
bloccarla. Come raccontano le sue carte lasciate all'attenzione della famiglia e
alla cura scientifica di Pasquale Chessa. "L'operazione di Farina è sospetta.
Come mai non ha fatto uscire il libro, già pronto, con Cossiga ancora in vita?".
Perché Chessa?
"Sapeva che sarebbe scoppiato
un inferno. Cossiga già nel 2008, quasi due anni prima dell'aggravarsi della sua
salute, aveva spedito una lettera di rinuncia all'editore di Farina, all'epoca
Piemme, restituendo i 12.500 euro dell'anticipo e diffidando dal mandare in
stampa alcunché. Chiuse ogni contatto, da un giorno all'altro, come ferocemente
gli capitava".
Farina fa coincidere il
rifiuto di Cossiga con l'avanzare della malattia.
"Mente. Sapendolo. Profitta
delle parole di un uomo che non può più smentirlo. Cossiga era capace di
stabilire con i suoi intervistatori uno speciale rapporto di fiducia. Sapeva
come forzare i toni e persino i fatti per fare notizia, ma sapeva anche di poter
contare sulla loro complicità professionale, sul controllo del racconto,
sull'esattezza di date e nomi e sul senso generale. Gli premeva fosse il suo.
Ecco la falsificazione operata da Farina. Lasciando le parole di Cossiga nude e
crude, ne altera il senso. Spostando in avanti le date suggerisce che fu la
malattia a impedire la revisione del testo. Non è così. Fu una scelta ragionata
e consapevole".
Farina si arrese?
"Insistette con la famiglia.
Con garbo, Giuseppe Cossiga, il figlio, ricostruisce i tempi confermando la
scelta del padre. Non pubblicare il libro. Ma Farina avanza, nonostante dai
documenti e dalla lettera emerga come il presidente "avesse deciso di ritirare
ogni suo contributo di appoggio al progetto"".
Cossiga lasciò Farina al suo
destino.
"Mi parve il segno che, da
qualche parte, il fango fosse tracimato. Farina potrà anche esibire stralci di
conversazione, ma non c'è bisogno di scomodare gli psicanalisti per sapere che
le parole non sempre rispondono alla verità".
Farina e Cossiga si
conoscevano. Quando si rafforzò il rapporto?
"Il contatto ravvicinato fu
stabilito quando Cossiga, sotto pseudonimo, iniziò a scrivere per "Libero" su
richiesta di Feltri. La vanità del potere lo portava a fidarsi. Era curioso e
possedeva un'innata capacità di mimesi. Colpiva la competenza culturale con cui
maneggiava materie così diverse tra loro. Se incontrava un musulmano si faceva
imam, se discuteva con un prete diventava teologo, se si trovava di fronte a una
spia, si trasformava nel capo delle spie".
E Farina lo era a tutti gli
effetti?
"Me lo disse lui stesso,
all'hotel Senato di Milano, in coincidenza con la scoperta dei media del suo
doppio ruolo. Giornalista e agente Betulla. È la tesi che sostiene nel libro:
"Sono entrato nei servizi su ordine del presidente per favorire l'ascesa del
generale Pollari". Mi sembrò una chiamata di correo".
La turbò?
"Non capivo perché ne parlasse
a me, ma vissi la rivelazione come una potenziale minaccia nei confronti di
Cossiga. Non avevo particolari motivi per amare Farina. Diverse culture, diverse
frequentazioni. Per dire: nella mia infanzia sono stato scout. Mi è rimasta una
sottile idiosincrasia per un certo sentore di sagrestia. Le mani sudate, il
parlare obliquo, la cantilena lamentosa. Mi interessava però il suo punto di
vista ultracattolico".
Apprezzato anche da altri?
"Godeva di grande credito
culturale, fino al punto di essere massimo consulente di una trasmissione
simbolo del centrosinistra come l'Infedele di Gad Lerner. Infedele appunto:
quando si scoprì che Farina era una vera e propria spia, furono in molti a
rimanerci male. E allora perché mi chiedo, ha deciso di mettere in piazza le
registrazioni di Cossiga?".
Si è fatto un'idea?
"Il suo libro serve a un solo
scopo. Dimostrare che il suo burattinaio è Cossiga e non Pio Pompa (ndr l'agente
che smistava informative e collezionava dossier)".
Come finì l'incontro all'Hotel
Senato?
"Arrivò Cossiga e iniziò ad
apostrofare Farina da lontano, a gran voce: "Renato diglielo che sei un eroe,
che hai servito la patria, che sei andato da Milosevic su mandato di Lamberto
Dini. Devi recarti alla Procura della Repubblica, raccontare tutto". Mi sembrò
inutilmente enfatico ma poi capii. Era un modo, tipicamente cossighiano, di
parare il colpo in anticipo. Se all'orizzonte apparivano difficoltà, Cossiga
dava il meglio di sé. E infatti, attenzione alle date: la guerra in Serbia è del
1999, il ministro degli Esteri era Lamberto Dini, il presidente del Consiglio
D'Alema. Pollari viene nominato capo del Sismi a fine 2001".
Anche sullo spionaggio Cossiga
nutriva una certa competenza.
"Di carattere legislativo e
istituzionale. Nell'età democristiana, che è una categoria più significativa di
quella di Prima Repubblica, rappresentava l'uomo di Stato molto più che il
quadro di partito. E il segreto è qualcosa che ha a che vedere col potere dello
Stato. Per questo, non senza malizia, gli piaceva citare Bobbio".
Tutto qui?
"Se capitava in un tavolo in
cui nel raccontare i risvolti più indicibili della quotidianità politica si era
andati oltre, concludeva, dopo uno dei suoi rari silenzi con un motto affilato e
definitivo: "Se non aveste stupidi preconcetti morali, sareste delle ottime
spie".
Farina non li aveva?
"Certamente no. Cossiga diceva
sempre: "Quello ha i cassetti pieni". Dava un grande valore alla funzione
istituzionale dei servizi segreti. E quando ne parlavamo irrideva ogni mio
dubbio, per così dire etico, democratico. Ma fissava un limite alle azioni
segrete: dovevano rimanere tali. Allora mi toccava giocare sul tasto
dell'ironia, ricordando che Farina veniva intercettato dal pm Spataro proprio
nel momento in cui Pio Pompa gli dava istruzioni per cercare di carpire notizie
riservate con la scusa di un'innocente intervista".
Accadde davvero?
"Andò ad intervistarlo mentre
Spataro e Pomarici intercettavano lui il suo suggeritore, conoscendo in anticipo
il contenuto di ciò che gli avrebbero chiesto. Come in un racconto di Simenon,
quando il lettore ne sa di più della spia. E chi è andato per suonare, esce
suonato" (ride).
La diverte?
"Con Cossiga allora mi piaceva
immaginare la faccia di Feltri e di Sallusti, scoperto che gli scoop di Farina
erano farina del sacco di Pompa. Se uno non è in grado di fare la spia, facevo
cadere distrattamente provocando il presidente, sarebbe meglio scegliesse
un'altra direzione".
Dove cigola tragicamente il
libro di Farina?
"Ci sono nomi inventati, date
confuse, dialetti sardi straziati. A Farina si può perdonare tutto, ma
Saltabranca no! Il nome dello storico direttore antifascista della Nuova
Sardegna nel dopoguerra, è Arnaldo Satta Branca. Ecco: gli errori di Farina
funzionano come lapsus. Rivelano un'approssimazione in cui nuota un disprezzo
per la sostanza delle cose".
Esempi?
"Cossiga amava citare un
piccolo testo del grande scrittore americano William Styron, il famoso autore
della "Scelta di Sophie". Un libello luminoso sulle nebbie della depressione:
"Un'oscurità trasparente". Nella trascrizione di Farina Styron diventa Jostein
Gaarder, autore di un volume divulgativo intitolato "Il mondo di Sofia". Andiamo
al succo: Farina non ha capito la citazione. E ha inventato aiutandosi con
Wikipedia. Tutto vero quindi. Ma tutto falso".
Sembra arrabbiato?
"Ai tempi di Zeus, Cossiga
l'avrebbe fulminato".
Non lo avrebbe fatto per
l'amicizia che mi ha sempre dimostrato. Farina: Cossiga non mi ha certamente
usato per diffondere falsità post mortem su Moro,
scrive Renato Farina su ItaliaOggi Numero 224 pag. 8 del 21/09/2011. L'articolo
che Italia Oggi di martedì 20 ha pubblicato sul mio libro «Cossiga mi ha detto»
è importante: spezza l'omertà che lo ha finora circondato, entrando nel merito
dei contenuti, che in alcune pagine sono tremendi, e talvolta profetici. Sulla
profezia ne cito una sola: è incredibile come, nel luglio del 2008, Cossiga
vedesse in Maroni il pericolo prossimo per il governo Berlusconi insieme ad
indagini «di Milano e di Napoli». Ma le profezie, anche quelle azzeccate, non
possono essergli imputate come menzogne, al massimo sono indovinate o no (e lui
ci azzecca), invece il racconto di fatti dei quali è stato testimone diretto,
sì. E Italia Oggi lo fa. Piero Laporta, autore dell'accusa, è studioso di fatti
di terrorismo tra i più preparati, ed è uomo retto, incapace di annacquare il
suo vino per opportunismi vari. A partire dalle sue convinzioni forti, direi
marmoree, giudica che Cossiga abbia riferito bugie sul caso Moro (Laporta ci
vede la mano sovietica e una qualche complicità omissiva di Cossiga),
sull'assassinio di Giorgiana Masi nonché sul patto tra Moro e i palestinesi (per
il presidente emerito equivaleva a una immunità sul territorio italiano per i
fedayn; per Laporta solo a un sostegno politico). Su tutte queste vicende io non
voglio né posso mettermi a fare da arbitro tra i due, come un perito del
Tribunale della Storia: non ho la patente. Di alcune cose sono però certo, e
queste riguardano la sfera più intima che ci sia, quella dell'amicizia. Sulla
base di questa sicurezza affettiva, e percependo il dolore intenso, fisico e
insieme come una strozza all'anima, che Cossiga mi trasmetteva parlandomi di
Moro, posso dire che non mi ha ingannato, né usato per diffondere post-mortem
delle falsità. Per questo ritengo che il vino dell'amico Laporta sia, a
proposito dei sentimenti di Cossiga, invecchiato male e diventato dopo tanti
anni aceto. Cossiga è un uomo che ha stracciato la tessera di giornalista quando
fui radiato (ora la sentenza è stata annullata definitivamente dalla
Cassazione). Mi fece chiamare dai suoi carabinieri di scorta poco prima di
morire (non parlava più al telefono) per ringraziarmi dei miei messaggi e per
domandare il nome di mia moglie. Sono prove (e le sento come carezze di un padre
moribondo) del fatto che non mi ha usato come un pupazzo tonto... Perché allora,
a un certo punto, improvvisamente, dopo aver lodato il libro, Cossiga si è
chiuso nel silenzio? Ipotesi ne ho, nessuna però che c'entri con l'inganno.
Approfitto dello spazio concessomi per riferire ai tuoi lettori di un'altra
recensione che mi è stata dedicata da Pasquale Chessa sull'Espresso. Dice, in
forma di intervista, che questo libro è una bufala ed io ho agito come burattino
di Pio Pompa. Bum! Mi ha colpito un fatto. Cossiga, poco prima di morire, mi ha
spedito due scatole con i ritagli degli insulti che gli ha dedicato il kombinat
debenedettiano di Repubblica-Espresso per anni e anni. E dire che - lo rivela
sempre Cossiga nel mio libro (fatto di 27 ore di conversazioni registrate) - il
presidente alla Casa Bianca difese per amor di patria l'Olivetti dell'ingegner
De Benedetti dall'accusa gravissima di essere fornitrice di tecnologia sensibile
all'Urss. Cosa – ritiene Cossiga – invece vera e documentabile. Interessante che
Chessa (biografo di Cossiga e candidato alla custodia del suo archivio) si allei
ora all'Espresso. Ancora più tragica e interessante la menzogna di Chessa
ospitata dall'Espresso, secondo cui Cossiga avrebbe «deciso» di morire. La
storia della morte di Cossiga la racconto nel mio libro, inconfutabile, ed è
diversa, molto diversa. Sulla verità rivelata da Cossiga sul caso Abu Omar, mi
aspetto un altro vostro articolo.
«Sul caso Moro hanno
mentito tutti».
Il 16 marzo di quarant’anni fa veniva rapito il segretario della Democrazia
Cristiana. Antonio Ferrari, storico giornalista del “Corriere”, ne ha scritto un
libro nell’81, che vede la luce solo oggi. Un romanzo che mette in fila tutte le
incongruenze della pagina più nera della nostra repubblica, scrive Francesco
Cancellato il 16 Marzo 2018 su “L’Inkiesta”. «Aldo Moro? Voleva emancipare
l’Italia dall’abbraccio soffocante degli americani. Così come Berlinguer voleva
emancipare il Pci dall’abbraccio soffocante di Mosca. Per questo il leader della
Dc è stato rapito e ucciso». Antonio Ferrari non è l’ultimo dei cospirazionisti.
Settant’anni, storica penna del Corriere, di cui è stato a lungo inviato in
Medio Oriente, il 16 marzo del 1978, era un giovane cronista che si occupava di
terrorismo e di lotta armata. Tre anni dopo quel giorno, il giorno in cui fu
rapito Moro - poi ucciso 55 giorni dopo - il suo giornale gli chiese di
scriverne un libro. Un romanzo, scelse lui, «60% verità, 20% finzione e 20% zona
grigia», avvertendo però «che tante cose che scriverò non vi piaceranno».
Risultato? Rizzoli non pubblicò mai “Il Segreto”, che ha visto la luce solo lo
scorso anno per Chiarelettere, intatto nel testo, con la sola aggiunta di una
postfazione, in cui Ferrari racconta la genesi turbolenta del libro: «Il
giornale mi chiese di scrivere di Moro per lavarsi la coscienza dopo lo scandalo
P2 che per il Corriere fu devastante: tutti, dal presidente all’amministratore
delegato, sino al direttore a non so quanti giornalisti facevano parte di una
loggia di criminali».
Un attimo, Ferrari: che
c’entra la P2 col rapimento di Aldo Moro?
«Sono
sempre più convinto che avesse ragione Tina Anselmi: per capire il caso moro
bisogna partire dalla P2.
Perché?
«La
P2 era un’organizzazione che voleva creare un sovrastato che doveva controllare
tutto, eventualmente creare le precondizioni per un colpo di Stato».
Come mai tutta questa
smania di fare un colpo di Stato in Italia?
«Dobbiamo
fare un salto indietro al 1964, in questo caso, quando va in crisi il primo
governo di centrosinistra guidato proprio da Aldo Moro. È in quel contesto che
il generale Giovanni de Lorenzo, comandante dell’Arma dei Carabinieri, decide di
elaborare un piano per prendere il potere, si dice con la complicità del
presidente della Repubblica Antonio Segni».
Ancora: perché?
«Perché
Moro aveva uno scopo che non piaceva alla destra del suo partito, e nemmeno ad
americani e britannici. Noi siamo stati governati per cinquant’anni dallo stesso
partito. È una condizione quasi unica al mondo, nei paesi democratici. Moro
voleva si sfidassero una grande forza di sinistra progressista e una forza di
destra moderata, o quantomeno allargare l’area di governo ai comunisti, che
allora avevano superato il 30% dei consensi».
E questo non piaceva agli
americani?
«No,
e nemmeno ai russi. Jimmy Carter, molti anni dopo, mi disse che loro avevano
avuto molto a cuore il caso Moro. Ma negli Usa c’era chi non ci voleva liberi
dell’abbraccio molto ingombrante di Usa e Gran Bretagna sul nostro Paese.
L’Italia era Paese di frontiera tra blocco Nato e comunismo».
Non avevano tutti i torti,
però. Noi avevamo un partito comunista, non socialista, che fino a Berlinguer,
almeno, prendeva ordini da Mosca...
«Però
con Berlinguer si stava staccando dall’Unione Sovietica. E per Moro andava
favorito questo distacco del Pci da Mosca, così come voleva emancipare la
Democrazia Cristiana da Washington. Ma così come c’era un pezzo del Pci che non
voleva mollare Mosca, c’era un pezzo di Democrazia Cristiana - e di
establishment del Paese - che non voleva un’Italia emancipata. Il piano Solo, il
tentato golpe del 1964, fu il primo tentativo eversivo per andare contro al
disegno di Moro, approfittando della crisi del suo primo governo di
centrosinistra. Il presidente Segni arrivò addirittura a consultare il generale
De Lorenzo, capo dei golpisti, per la formazione di un nuovo governo. Siamo
stati a un passo dalla dittatura militare: già allora il piano era quello di
deportare in Sardegna 270 tra politici e dirigenti statali. E di uccidere Moro».
Addirittura ucciderlo?
«Fu
Mino Pecorelli a denunciarlo, tre anni dopo, in un articolo apparso su “Il nuovo
mondo d’oggi”. A ucciderlo avrebbe dovuto essere il tenente colonnello dei
paracadutisti Roberto Podestà».
Insomma, Moro è
sopravvissuto per quattordici anni, prima di morire davvero per Mano delle
Brigate Rosse…
«Non
solo. Secondo la figlia Maria Fidia era il padre era il vero obiettivo
dell’attentato all’Italicus del 1975. Salito proprio su quel treno sul treno
alla stazione Termini per raggiungere la famiglia in villeggiatura in Trentino
venne fatto scendere da alcuni funzionari del Ministero, suoi collaboratori, a
causa di alcune carte che avrebbe dovuto firmare».
Ma come mai questo
accanimento contro un politico solo?
«Andreotti,
in un’intervista ha rivelato che nel 1974, Moro subì una vera e propria
aggressione da Henry Kissinger, con minacce pesantissime. Moro era un problema
anche per la sua politica filo araba in Medio Oriente, che proseguiva l’azione
del suo grande amico Enrico Mattei. Una politica che non piaceva alle sette
sorelle del petrolio, all’America e pure al Regno Unito, che aveva interessi in
Iraq e in generale in tutto il mondo arabo».
Andreotti. Il sequestro
Moro avvenne il giorno del giuramento del suo governo. Che ruolo ebbe, secondo
lei, il presidente del consiglio in carica nella gestione di quei 55 giorni?
«Quando
ho scritto il libro, trentasette anni fa, pensavo che Andreotti fosse l’anima
nera di tutta la vicenda. Sbagliavo. Il personaggio più ambiguo di tutti, nel
caso Moro, è stato Francesco Cossiga, allora ministro dell’interno. La moglie di
Moro ha raccontato che non l’ha mai più cercata dopo la morte di suo marito,
nonostante fossero amici. Diciamo che l’ambiguità di Cossiga rafforza la tesi
dell’eterodirezione della vicenda Moro».
Non è ambigua anche la
posizione di Berlinguer? Perché il segretario del Pci si schierò per la linea
della fermezza, contro ogni trattativa per salvare Moro?
«Berlinguer
era per la linea della fermezza e faceva bene. Era convinto che non sarebbe mai
stato liberato. E che legittimare le Brigate Rosse sarebbe stato pericoloso. Io
credo avesse ragione lui, e che avesse ragione Sciascia. Sciascia dice che Moro
era favorevole a prendere tempo, non a trattare. La linea della trattativa di
Craxi è un atto di generosità e furbizia politica di Craxi, che capisce che deve
smarcarsi da tutti, per dar corpo alle sue ambizioni. Ma Craxi, peraltro, era
amico del fondatore di Hyperion, Corrado Simoni».
Hyperion, ecco. Secondo
molti è la chiave che spiega l’eterodirezione del rapimento di Moro…
«È
una strana scuola di lingue fondata da brigatisti a Parigi, piena zeppa di spie.
L’ex brigatista Enrico Franceschini la definisce “una specie di Parlamento degli
007”. Questa scuola nasce uno o due anni prima del sequestro, sembra creata
apposta. Man mano che si avvicinano i giorni del sequestro Moro, compaiono tante
piccole Hyperion a Roma, Milano, Como, Parigi, Londra. E chi nelle Br teneva i
rapporti con Hyperion, andando su e giù da Roma a Parigi è quello che molti
ritengono essere l’infiltrato della Brigate Rosse, Mario Moretti. L’uomo che
prelevò Moro, quello che lo interrogò, quello che si dice abbia ucciso».
Cosa le fa pensare che
Moretti fosse infiltrato?
«Tante
cose. Innanzitutto, che le Br erano piene di infiltrati. Franceschini dice che
quando hanno scelto di abbracciare la lotta armata, nelle Br c’erano da uno a
tre infiltrati. E che a un certo punto erano più gli infiltrati dei brigatisti».
Però dice anche che
definire Moretti una spia fosse riduttivo…
«Non
nega. Dice che è riduttivo. Faccio un esempio: nel 1990 Andreotti scoperchiò la
storia di Gladio un'organizzazione paramilitare clandestina italiana organizzata
dalla Nato e dalla Cia. Di quell’organizzazione, Moro parlò nel suo memoriale
dalla prigionia, denunciandone l’esistenza. Perché le Br non rivelarono mai,
durante la prigionia, quelle pagine del memoriale? Sarebbe stato uno scandalo
clamoroso. A domanda precisa di un giudice, Moretti disse che avevano
sottovalutato quella rivelazione».
Parliamo anche della seduta
spiritica dei sette professori, cui partecipò anche Romano Prodi. Quella in cui
uscì il nome di Gradoli….
«Sul
caso Moro hanno mentito tutti, dal primo all’ultimo. Quei professori si dice
organizzarono la seduta spiritica per far emergere un nome che, si dice,
Beniamino Andreatta aveva ascoltato all’università di Cosenza da Franco Piperno,
capo di Autonomia Operaia, amico dei brigatisti Valerio Morucci e Adriana
Faranda, e, al pari di Andreatta, professore nell’università calabrese.
Comunque, esce questo nome, Gradoli, e le forze dell’ordine vanno a cercare Moro
in una località con quel nome. La vedova Moro, a quel punto, va da Cossiga,
chiedendogli se esistesse una via Gradoli a Roma. Cossiga la liquida sbrigativo,
dice che non risulta dalle Pagine Gialle. Il problema è che via Gradoli a Roma
non solo esiste, ma è pure in una zona in cui i servizi avevano un mare di
appartamenti. Strano che il ministro degli interni non lo sapesse. Comunque in
via Gradoli, al numero 96, c’era veramente un covo delle Br, uno dei più
importanti, e in quel covo ci stavano, guarda caso, Mario Moretti e Barbara
Balzarani».
È la vicenda più
paradossale del caso Moro, quella di Gradoli?
«No,
c’è pure quella del lago della Duchessa. Nello stesso giorno in cui fu scoperto
il covo di via Gradoli, siamo ad aprile, un falso comunicato delle Brigate Rosse
dice di cercare il cadavere di Moro in questo lago. Si dice che a realizzare
quel comunicato fu il falsario d'arte Tony Chichiarelli, legato alla Banda della
Magliana. Io sono convinto che quella storia fu inventata dai servizi segreti,
con un obiettivo: convincere le Brigate Rosse a fare in fretta ad ammazzare
Moro, che per loro era già morto».
Lei fra l’altro dice nel
libro che Moro non fu materialmente ammazzato dalle Brigate Rosse. Cos’è? Il 60%
di verità, il 20% di finzione o il 20% di zona grigia?
«Io
continuo a pensare che il presidente della Democrazia Cristiana sia stato
liberato e ucciso successivamente. La maggioranza delle Brigate rosse voleva
liberare Moro, una minoranza, i brigatisti vicini a Hyperion, no. Sono convinto
di questo e diversi magistrati me l’hanno confermato».
La verità su Aldo Moro: in
via Fani, con le Br, malavitosi e servizi segreti.
Quarant'anni dopo: intervista a Gero Grassi, membro della seconda Commissione
parlamentare d'inchiesta su rapimento e morte dello statista Dc, scrive
Valentina Barresi su "La Voce di New York" il 15 Marzo 2018. Gero Grassi: “Il
caso Moro è un intrigo internazionale con la partecipazione di Cia, Mossad, Kgb,
servizi segreti inglesi e francesi. Chi in senso attivo, chi in senso omissivo,
ha partecipato. In tutto questo ci sono anche responsabilità di pezzi della
magistratura italiana, delle forze dell’ordine e della cupola maggiore che è la
P2". La fine di un uomo, l’annientamento di uno statista e della sua visione:
sono trascorsi 40 anni dalla strage di via Fani, da quella mattina del 16 marzo
1978 in cui il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, venne rapito, e
i cinque uomini della sua scorta uccisi, fino al ritrovamento del suo cadavere,
avvenuto il 9 maggio in via Caetani a Roma. Per troppo tempo la verità ufficiale
ha sostenuto che la mano principale dietro al rapimento e alla morte del fautore
del “compromesso storico” fosse quella delle Brigate Rosse. Buona parte del
dramma che paralizzò l’Italia e che si consumò in quei 55 giorni che separano
via Fani da via Caetani rimane tuttora avvolto nell’ombra. Un caso contenuto in
ben 8 processi Moro, quattro commissioni terrorismo e stragi, due commissioni
Moro, una commissione Mitrokhin e una commissione P2, che però non sono bastati
a far piena luce su una delle pagine più grigie e inquietanti del Belpaese. Un
tassello alla volta, la seconda Commissione d’inchiesta su Aldo Moro è riuscita
però a fare emergere elementi nuovi, smontando pezzo per pezzo la versione
conosciuta negli ultimi quarant’anni. Ad animarne il lavoro, in prima
linea, Gero Grassi, vicepresidente del gruppo Pd della Camera, autore del
libro “Aldo Moro: le verità negate”. Verità che Grassi non ha mai smesso di
cercare in tutti questi anni, che passano per depistaggi, cospirazioni, morti
sospette e menzogne, parte di un intrigo internazionale capace di tenere assieme
tutti i poteri forti – politica, massoneria, servizi segreti, chiesa,
criminalità organizzata – presenze costanti che si intersecano e si celano
dietro ai più grandi misteri irrisolti della storia italiana recente.
Onorevole Grassi, quali sono
le sostanziali novità e discrepanze che emergono dal vostro lavoro rispetto alla
precedente Commissione Moro?
“Anzitutto, la certezza che in
via Fani con le Brigate Rosse, e sottolineo con le Brigate Rosse, ci fossero
soggetti terzi della malavita romana, della Banda della Magliana e i servizi
segreti italiani e stranieri. Poi, la certezza che il Bar Olivetti non fosse
chiuso al momento della strage, come si è scritto invece per 38 anni, ma fu
l’epicentro del rapimento Moro, la centrale operativa, frequentata da
brigatisti, Nar, uomini della ‘ndrangheta, Frank Coppola (mafia-siculo
americana), Tano Badalamenti (mafia siciliana), e Camillo Guglielmi, vice
comandante generale di Gladio. Le altre due grandi novità riguardano poi la
prigione di Aldo Moro e la sua morte. Prigione che non dovrebbe essere quella di
via Montalcini, ma in via Massimi 91 (alla Balduina, poco distante da via Fani,
ndr.) dove peraltro è stato ospitato il brigatista Prospero Gallinari e dove
aveva sede il palazzo dello Ior, in un complesso che godeva dunque della
extraterritorialità. E poi la ricostruzione della morte di Moro che, così come i
brigatisti Germano Maccari e Mario Moretti la descrivono, per il numero dei
proiettili, per i proiettili silenziati, per il tempo, per il luogo, oggi non
regge rispetto alle ultime prove. Loro dicono che è morto sul colpo e invece
Moro è morto dopo 30 minuti di agonia. Loro parlano di 8-9 colpi e i colpi
invece sono 12. Loro dicono che Moro era steso nella Renault e noi riteniamo che
Moro fosse appoggiato alla Renault, che stesse fuori dalla vettura. Tutto questo
ci induce a dire che in via Fani c’erano anche le Brigate Rosse, e che sul luogo
della morte invece mancavano le Brigate Rosse. Anche perché ci sono due
testimoni: don Fabio Fabbri, assistente del cappellano don Curioni, che descrive
l’omicida senza però fare il nome. E poi c’è un professore che addirittura fa il
nome. E c’è Cossiga che in un’intervista televisiva dice: ‘Io ho conosciuto chi
ha rapito e custodito Moro, non ho conosciuto chi l’ha ucciso’, e aggiunge: “E’
morto poco tempo fa”. Lui ha conosciuto tutti i brigatisti. Mettendo a confronto
l’intervista con la rilevazione sulla morte di Moro viene fuori che questa
persona potrebbe essere Giustino De Vuono, ‘ndranghetista calabrese”.
Qual è la portata del ruolo
della ‘ndrangheta e della mafia nel caso Moro?
“La ‘ndrangheta frequentava il
bar Olivetti, riciclava armi giocattolo che poi diventano armi che sparavano. Ci
sono delle intercettazioni telefoniche del tempo rispetto alle quali il
procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e procuratore nazionale
antimafia ha evidenziato in commissione che la ‘ndrangheta seguiva il caso Moro
e partecipava – non sappiamo in che misura – alla vicenda. Ci sono ad esempio i
viaggi sospettissimi, nei 55 giorni, di Moretti in Calabria e in Sicilia. La
‘ndrangheta, come la mafia e la camorra entrano nel caso Moro. Certamente non
sono stati loro a organizzare il rapimento”.
A oggi quali sono le
responsabilità accertate dietro al rapimento e all’uccisione del presidente?
“Il caso Moro è un intrigo
internazionale che vede la partecipazione di Cia, Mossad, Kgb, servizi segreti
inglesi e francesi. Chi in senso attivo, chi in senso omissivo, ha partecipato
alla vicenda del rapimento e dell’omicidio. In tutto questo ci sono anche
responsabilità di pezzi della magistratura italiana, pezzi delle forze
dell’ordine, mentre la cupola maggiore è la P2, che poi è il governo di tutti
questi fenomeni criminali”.
Sono trascorsi quarant’anni e
dalla scena mancano, tra i tanti, due personaggi chiave, su cui permangono ombre
e interrogativi: uno è l’allora ministro degli interni Francesco Cossiga, di cui
si sostenne una responsabilità morale dell’omicidio Moro, l’altro è il
presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Quale il ruolo di entrambi, quali le
colpe?
“Cossiga riunisce un comitato
di emergenza formato da 40 piduisti (comitato dal quale, sosterrà Steve
Pieczenik, funzionario della sezione antiterrorismo del Dipartimento di Stato
americano, avvennero fughe di notizie, ndr.). Potrebbe fare delle cose che non
fa per cercare Moro, lui spera che lo salvino. Non è stato lui ad ucciderlo,
come pure Cossiga stesso dice, però certamente non ha fatto nulla per evitare
che lo uccidessero. E in questo ha agito in perfetta intesa con un altro
parlamentare, con il quale costituiva una coppia di fatto, l’onorevole Ugo
Pecchioli, del Partito comunista italiano. Quanto a Giulio Andreotti, lui era il
presidente del Consiglio e dagli atti risulta che il suo governo non si è
impegnato per la liberazione di Aldo Moro. Ha fatto “confusione”, per così
dire. Andreotti ha le sue responsabilità. La vicenda Moro è stata gestita da
Cossiga d’intesa con Andreotti e con Pecchioli dall’altro lato”.
Sul caso Moro sono decine i
nodi irrisolti. Tra i tanti, quello relativo al brigatista Alessio Casimirri,
oggi libero in Nicaragua…
“Casimirri fu arrestato dai
carabinieri, individuato in via della Conciliazione a Roma su segnalazione del
dottor Cherubini, padre del cantante Jovanotti e amico del padre di Casimirri
che era cittadino vaticano. Ma poco dopo l’arresto venne inspiegabilmente
rilasciato. La cosa più grave è che lo Stato italiano non ha mai chiesto la sua
estradizione, se non attraverso il ministro degli Esteri Gentiloni quando in
commissione l’abbiamo domandata nel 2016. Dal 1981 al 2016 nessuno l’aveva mai
fatto”.
Alla luce del lavoro svolto e
dei punti chiave sollevati dalle vostre indagini, lei pensa che un nuovo governo
potrebbe dare impulso alla ricerca della verità?
“D’impulso non credo che ci
sarà più un’altra Commissione Moro. Innanzitutto perché il mio partito non mi ha
ricandidato. Se dopo 500 manifestazioni, non mi ricandida significa che non
crede alla possibilità di continuare. Quindi non credo proprio che quelli che
arriveranno possano impegnarsi a trovare i pezzi mancanti sul caso Moro”.
Come si collocano gli Stati
Uniti in questo intrigo internazionale che lei ha tratteggiato?
“E’ emblematica la frase che
Henry Kissinger rivolse ad Aldo Moro il 25 settembre del 1974: ‘Presidente, lei
deve smettere di perseguire sul piano politico per portare tutte le forze del
suo Paese a collaborare direttamente. O la smette, o la pagherà cara’. Questo fu
l’avvertimento ufficiale. Gli Stati Uniti non volevano né l’Europa dei popoli,
che era l’obiettivo di Moro, né la democrazia compiuta in Italia. Ovviamente
anche per gli Stati Uniti non si può generalizzare. Parliamo di Henry Kissinger,
del quale noi abbiamo chiesto la rogatoria internazionale ma che non ci è stata
concessa”.
Nella sua ricostruzione dei
fatti e della figura di Aldo Moro lei ha anche accostato il presidente della Dc
a John Fitzgerald Kennedy…
“Per la storia Kennedy e Moro
sono le uniche due persone che hanno battuto moneta non passando per le banche
centrali: Kennedy per i due dollari nel 1961 non passò dalla Federal Reserve, e
Moro per le 500 lire del 1966 non passò dalla Banca d’Italia. Ricordo poi un
episodio, quello del 14 marzo 1978, due giorni prima del rapimento: Moro era
all’università a Roma e il suo assistente, Francesco Tritto, gli disse:
“Presidente, si ricorda che dopodomani ci sarà la sua ultima seduta di laurea?”.
“Perché l’ultima?”, gli chiese Moro. “Perché lei a giorni sarà eletto presidente
della Repubblica”. E Moro rispose: “La ringrazio, lei è affettuoso ma ingenuo.
Io non farò mai il presidente della Repubblica. Mi faranno fare la stessa fine
di John Fitzgerald Kennedy, ucciso a Dallas il 22 novembre del 1963”.
La trattativa dimenticata
tentata da Craxi,
scrive Francesco Forte, Lunedì 19/03/2018, su "Il Giornale". Nel dibattito
sull'eccidio di via Fani e sulla uccisione di Moro, dominato da intellettuali di
sinistra fermi ai loro stereotipi, s'è dimenticata la trattativa per Moro,
condotta da Craxi, dall'hotel Raphael. Il Psi il giorno prima della sua
uccisione aveva approvato lo scambio umanitario. La Dc il giorno della fine di
Moro si riunì per deliberare se associarsi al Psi o sceglier la linea della
fermezza del Pci, gradita a Mosca. Il ministro dell'Interno ombra del Pci,
Pecchioli, legato a Mosca aveva detto «per noi Moro è praticamente morto. Non si
tratta con le Br, perché non possono esser riconosciute come soggetto politico».
Moro sosteneva una linea catto-comunista d'alleanza col Pci, che somigliava a
quella dei comunisti del dissenso di Praga, soppressa dai carri armati
sovietici. Il compromesso storico di Berlinguer, sponsorizzato da Andreotti e
altri Dc comportava apertura all'Unione Sovietica in cambio dell'austerità, con
un modello neo corporativo con le contro parti industriali. A Craxi e a me suo
consigliere non piaceva la linea di Berlinguer, l'opposto del socialismo
liberale craxiano e del mio liberal socialismo né quella di Moro, che comportava
un nuovo comunitarismo cattolico dirigista. Ma a Craxi, che nel suo burbero
decisionismo era in realtà un buono, l'idea di sacrificare Moro alla ragion di
stato in contrasto col socialismo umanitario pareva mostruosa. Ma aveva bisogno
di convincersi che salvare Moro con una trattativa non era una concessione
all'obbiettivo di metter in difficoltà i comunisti e a un buonismo contrario
alla legalità. Nelle lettere che Moro indirizzava ai democristiani, li implorava
di non compiere «il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio
di legalità». Craxi si rivolse a me, per documentarsi sulle teorie sul tema. Io
gli diedi il libro del filosofo Giuliano Pontara «Se il fine giustifica i mezzi»
basato sul principio «prima l'uomo, poi lo Stato», che giustificava la
trattativa. E ne scrissi su Critica sociale aggiungendo la teoria
dell'escalation per cui il sangue chiama sangue. Nella trattativa con gli
emissari delle Brigate rosse, che mandavano messaggi al Raphael, che il ministro
dell'Interno Cossiga lasciava passare, Moro veniva scambiato con una terrorista
definita malata terminale. Oltre a una parte delle Br, che cinicamente voleva un
riconoscimento come nuova sinistra, era per lo scambio Lotta Continua, che non
voleva più uccidere. Moro aveva scritto ai fautori della fermezza «Il mio sangue
ricadrà su di voi». Il comando Br gli sparò. Il compromesso storico cadde. Ma ci
fu anche un'altra ragione per la sua fine. Il Pci non voleva votare lo Sme,
padre della moneta unica europea. Il Psi di Craxi optò per l'astensione. Esso fu
approvato e iniziò l'era Psi-Dc degli anni '80.
Caro Prodi, ora devi dirci
chi ti ha detto “Gradoli”,
scrive Fabrizio Cicchitto il 16 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Quarant’anni di
misteri sul rapimento e la morte di Aldo Moro. Sull’Affaire Moro pongo una serie
di interrogativi. Ho fatto l’errore di non partecipare alla Commissione
presieduta da Fioroni per cui è possibile che la cosa mi sia sfuggita, ma non mi
risulta che abbia invitato il presidente Prodi a riferire. Nessuna persona può
ancora credere che fu una seduta spiritica quella che diede il nome di Gradoli:
a tanti anni di distanza Prodi potrebbe dire chi gli diede quell’indicazione.
Caso Moro: il gelido Andreotti, l’irresoluto Zaccagnini, il colto Galloni
Leonardo Sciascia fu profetico due volte: in Todo modo anticipò che l’Italia
sarebbe stata teatro di assassini politici, in L’Affare Moro affermò che
l’assassinio di Moro sarebbe stato l’inizio della decerebralizzazione della Dc
che infatti si srotolò in modo inesorabile nel corso degli anni 80 per cui il
partito arrivò del tutto impreparato al crollo del comunismo russo e di quello
dell’Europa dell’Est. Andreotti, Forlani, Fanfani, i dorotei, lo stesso De Mita
tramutarono le loro correnti in gruppi di potere che risucchiarono in questa
involuzione anche Bettino Craxi che nel 1991 non ebbe il coraggio politico di
provocare elezioni anticipate e così espose sé stesso, i partiti laici, il
centro- destra della Dc all’attacco del circo mediatico- giudiziario che
risparmiò la sinistra Dc e che fu utilizzato dal Pds di Occhetto e di D’Alema.
L’unico leader della Dc che in qualche modo intuì che il crollo del comunismo
avrebbe creato enormi problemi anche alla Dc fu Francesco Cossiga, che da un
certo momento in poi si difese svolgendo in prima persona il ruolo di
contestatore del suo partito originario con il quale entrò in rotta di
collisione. Aldo Moro – il cui retroterra culturale era di grande spessore,
risaliva alla Fuci (l’organizzazione degli universitari cattolici), ai rapporti
con Monsignor Montini, alle riflessioni filosofiche di Maritain e a quelle
politico - giuridiche di Giuseppe Dossetti e che svolse un ruolo di rilievo già
nell’assemblea Costituente – combinò insieme il realismo politico, la sapienza
tattica, lo sforzo di analisi della società italiana fino alla sua ricerca sul ’
68 e la contestazione giovanile. In ogni caso la sua convinzione di fondo era
che la politica è per larga parte mediazione. Non a caso quando nel 1959 i
dorotei disarcionarono Fanfani da presidente del Consiglio e da segretario della
Dc essi elessero come segretario Aldo Moro per evitare che l’operazione
apparisse una pura e semplice operazione di potere. Così Moro fu il protagonista
di entrambe le “aperture” sul terreno delle alleanze operate dalla Dc, il
centro- sinistra con il Psi e l’unità nazionale con il Pci: in entrambe le
occasioni tracciò le prospettive culturali e programmatiche dell’operazione, ma
lavorò sempre con grande attenzione per salvaguardare gli aspetti fondamentali
del sistema di potere della Dc. Fu contro un uomo di questo rilievo che le Br
sferrarono il loro colpo e non sbagliarono certo il bersaglio: come scrisse lo
stesso Moro in una delle sue drammatiche lettere, il suo sangue si riversò
proprio sul gruppo dirigente del partito che non fece nulla per salvarlo. Come è
noto il primo bersaglio preso in considerazione dai brigatisti fu Giulio
Andreotti, ma lo trovarono così “blindato” che rinunciarono. Perché Moro non era
altrettanto “blindato” e aveva una scorta numerosa ma non dotata nemmeno di una
macchina blindata? Perché nelle settimane precedenti al sequestro, Moro e il suo
caposcorta Leonardi furono assai inquieti, misero sotto osservazione un giovane
russo che d’improvviso aveva iniziato a frequentare le sue lezioni
all’Università e che poi si volatilizzò tornando nel suo paese, e perché non
furono prese misure più adeguate?
Questo è il primo
interrogativo da porsi. Ciò detto è inutile tergiversare: qualche ora dopo che
Moro era stato rapito e la sua scorta massacrata il gruppo dirigente del Pci al
completo, il gelido Andreotti, l’irresoluto Zaccagnini, il coltissimo Giovanni
Galloni lo diedero per morto e si attestarono tutti sulla linea della più
assoluta fermezza. Ma la teoria della fermezza coprì una prassi fondata
sull’inerzia. Questa inerzia è tanto più evidente se si fa il paragone con
quello che fu fatto successivamente per liberare il generale Dozier: con il
permesso del governo si ricorse alla tortura e tramite stringenti interrogatori
fu indentificato il covo, e i Nocs intervennero senza spargimenti di sangue.
Nulla di tutto ciò avvenne durante la detenzione di Moro. Però quello che non si
aspettavano il gruppo dirigente del Pci, il gelido Andreotti, il ministro degli
Interni Cossiga, i dirigenti morotei della Dc era che Moro rompesse il silenzio
e cercasse disperatamente di salvarsi inviando lettere di straordinaria forza
politica e morale. Fu di fronte all’appello sconvolgente contenuto in quelle
lettere che Craxi decise di muoversi e di rompere l’omertà del ceto politico
dell’arco costituzionale. Craxi consultò uno per uno tutti i dirigenti del Psi
per conoscere il loro parere: tutti dissero di sì all’iniziativa per salvare
Moro, tranne Pietro Nenni che avanzò qualche riserva. Così Craxi lanciò un primo
messaggio. Ancora mi vengono i brividi nella schiena quando Craxi mi chiamò
nella sua stanza e mi fece leggere la prima lettera di Moro che ringraziava i
socialisti: il nostro colloquio fu breve e quando ci alzammo in piedi Bettino mi
abbracciò e in preda ad una fortissima emozione mi disse: «Noi non siamo
comunisti, faremo di tutto per salvarlo». Ma Bettino era un gigante della
politica: dopo di lui ho conosciuto molti nani, qualche ballerina, un autentico
mascalzone che prima ha fatto il magistrato e poi è sceso in politica, quindi un
altro personaggio fuori dal comune come Berlusconi. Ciò detto pongo una serie di
interrogativi senza risposta. Ho fatto l’errore di non partecipare alla
Commissione presieduta da Fioroni per cui è possibile che la cosa mi sia
sfuggita, ma non mi risulta che essa abbia mai invitato il presidente Prodi a
riferire. Nessuna persona di buon senso può ancora credere che fu una seduta
spiritica quella che diede il nome esattissimo di Gradoli: a tanti anni di
distanza Prodi potrebbe finalmente dire chi gli diede quell’indicazione. La cosa
più incredibile però fu l’uso, o meglio il non uso di quella indicazione che
avrebbe consentito di intervenire fin dall’inizio su un covo di straordinaria
importanza. Invece tutto l’apparato poliziesco si precipitò in un paesino del
viterbese: idiozia o volontà di guardare da un’altra parte?
Secondo interrogativo. Quando
Claudio Signorile e Antonio Landolfi si mossero su mandato di Craxi per trovare
un aggancio che arrivasse fino ai brigatisti, fecero la cosa più ovvia: si
rivolsero a due personaggi “borderline” fra il mondo dell’autonomia e quello
brigatista quali Franco Piperno e Lanfranco Pace. La mossa si rivelò giusta
tant’è che attraverso di essi fu stabilito un contatto indiretto con Morucci e
con la Faranda. Ma dei servizi segreti degni di questo nome non avrebbero dovuto
da subito controllare Pace e Piperno per la stessa ragione per cui Landolfi e
Signorile li cercarono? Terzo interrogativo determinato da un colloquio con
Misasi, uno degli esponenti della sinistra di base della Dc più seri e
intelligenti, molto amico di Ciriaco De Mita. «Io», mi disse Misasi, «mi
convinsi che bisognava che la Dc prendesse un’iniziativa per liberare Moro: tu
mi conosci, non è che andai a dirlo ai quattro venti. Ne parlai con tre dei
massimi dirigenti della Dc per cui ti puoi immaginare quale fu la mia sorpresa e
la mia angoscia quando Moro inviò una lettera nella quale mi chiedeva di
convocare il Consiglio nazionale della Dc ed esporre lì le mie convinzioni». Una
parte dell’interrogativo che deriva da questo ricordo dell’onorevole Misasi è di
facile soluzione: probabilmente uno dei dirigenti della Dc interpellati da
Misasi parlò con la famiglia di Moro. Evidentemente, però, esisteva un canale
finora non emerso fra la famiglia e i brigatisti.
Ultima questione: mi sembra
evidente che la direzione delle Br temesse di essere posta di fronte ad una
iniziativa ufficiale e pubblica che avanzasse una proposta (per esempio la
liberazione della Besuschio) volta ad avere come contropartita la salvezza di
Moro. I brigatisti non volevano essere posti di fronte a una iniziativa politica
(quelle investigative- militari non ci furono) che li avrebbe messi in
difficoltà e divisi. La controprova di ciò è che essi uccisero Moro prima che,
alla direzione della Dc, Fanfani ponesse il problema dell’iniziativa da parte
della Dc per salvare il suo presidente. Ma essi sapevano in anticipo quello che
Claudio Signorile mi disse in gran segreto e cioè che Fanfani avrebbe parlato in
modo chiaro e netto in direzione dopo i pasticci combinati da Bartolomei
(fanfaniano, presidente dei senatori Dc). Un’ultima osservazione di merito: può
essere un caso ma Morucci e la Faranda furono arrestati a casa di Giuliana
Conforto che era figlia di Giorgio Conforto (nome in codice Dario) che era da
molti anni la principale spia del Kgb in Italia, che fu presente all’arresto e
fu fatto sgusciare via.
Un’impressione finale sul
piano politico. Il gruppo dirigente del Pci fu monolitico nel considerare Moro
morto fin dall’inizio. La loro chiusura a testuggine derivò dal fatto che essi
ritenevano che le Br, autonome o pilotate, erano un gruppo che operava in primo
luogo contro il Pci e la strategia del compromesso storico usando materiale
ideologico e operativo tratto dall’album di famiglia, di cui parlò Rossana
Rossanda. Nella Dc chi non ebbe mai un’esitazione furono Andreotti e Cossiga. Il
primo fu gelido e disumano nel corso di tutta la vicenda: il problema per lui
era solo quello di salvare il suo governo. Cossiga fu dominato dalla ragion di
stato, ma almeno lo fece parlando, confrontandosi con molti, combinando
pasticci, talora disperandosi. Rispetto a tutto ciò Bettino Craxi espresse
un’alternativa in primo luogo culturale e ideale e si affermò come un grande
leader, capace di andare controcorrente.
ALBERTO FRANCESCHINI E LA
VERITA' ACCETTABILE.
Bari, bufera sul convegno
con fondatore delle Br: «Via patrocinio Puglia».
L'incontro, previsto il 14
marzo, è incentrato sulla figura di Aldo Moro, con la partecipazione di Alberto
Franceschini, fondatore delle Br, scrive il 09 Marzo 2019 La Gazzetta del
Mezzogiorno. Un incontro sulla figura di Aldo Moro, con la partecipazione di
Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse, fa esplodere la polemica a
Bari. «È vero che il diritto di parola non deve essere negato a nessuno perché è
quello che eleva il nostro stato di esseri umani. Ma è anche vero che non può
essere dato in questa maniera a chi è stato uno degli artefici di quello che è
il periodo più buio della nostra Italia, soprattutto se ci saranno dei ragazzi
di fronte a lui», il messaggio di protesta di Potito Perruggini, nipote di
Giuseppe Ciotta, brigadiere di polizia ucciso nel 1977 da Prima Linea. Al
convegno, promosso dal consiglio regionale della Puglia, è in programma giovedì
14 marzo, parteciperanno anche il presidente del consiglio, Mario Loizzo, e Gero
Grassi, componente della commissione d’inchiesta Moro 2». In chiusura
dell’incontro la discussa intervista all’ex capo delle Br. «Cosa aspetta la
regione Puglia a ricordare invece i nomi e i volti di tutti quei pugliesi che
sono stati uccisi dai killer degli anni di piombo? - si chiede Perruggini,
presidente anche di «Anni di piombo», osservatorio nazionale per la verità
storica -. Chiedo anche come cittadino italiano che le istituzioni che ci
rappresentano monitorino queste situazioni e le blocchino sul nascere così come
fece il ministro Salvini tempestivamente a febbraio scorso a Settimo Milanese».
Intanto scoppia la polemica politica. «Come può un’istituzione promuovere un
convegno in memoria di una vittima e invitare anche il fondatore
dell’associazione criminale che l’ha ucciso?», si domanda il capogruppo di FI al
Consiglio regionale, Nino Marmo, che chiede conto al presidente del Consiglio
regionale della Puglia, Mario Loizzo, «di questa notizia incresciosa, odiosa e
inaccettabile» e chiede che Loizzo "tolga il patrocinio del Consiglio
regionale». «Si tratta - accusa Marmo - di uno scempio irrispettoso dei
familiari di Moro e dei familiari delle tante vittime delle barbarie
brigatiste». Per Marcello Gemmato, deputato di FdI, «è inopportuno, fuori luogo
e disdicevole, che in un convegno di commemorazione di Aldo Moro, vi sia
Franceschini. Altrettanto disdicevole che a patrocinare l’evento vi sia la
massima istituzione regionale». "Invito il presidente del Consiglio - dice - a
ritirare immediatamente il patrocinino dando così un tardivo contributo di
gratitudine e di verità». All’incontro, oltre al presidente del consiglio
Loizzo, è annunciata la partecipazione di Gero Grassi, componente della
commissione d’inchiesta Moro 2.
Dal “Corriere della Sera” del
10 marzo 2019. A febbraio la presentazione di un libro sulle Br a Settimo
Milanese fu annullata fra le polemiche. Stavolta Alberto Franceschini, tra i
fondatori delle Brigate Rosse, parteciperà all' incontro promosso dal Consiglio
regionale della Puglia su Aldo Moro. Le proteste di Potito Perruggini, nipote
del brigadiere Giuseppe Ciotta ucciso nel '77 da Prima Linea, non hanno fatto
cambiare idea agli organizzatori. Il convegno di giovedì, promosso in
collaborazione col Miur, prevede la partecipazione di docenti delle superiori e
circa 400 studenti. Tra i relatori ci saranno anche il presidente del Consiglio
Mario Loizzo (Pd) e l'ex parlamentare Gero Grassi, componente della commissione
d' inchiesta «Moro 2». In chiusura è in programma una intervista all' ex Br.
«Cosa aspetta la regione Puglia a ricordare tutti i pugliesi che sono stati
uccisi dai killer degli anni di piombo?» chiede Perruggini. Dalla Regione vanno
avanti: «Capisco il dolore delle vittime del terrorismo - dice Loizzo -, domani
le ricorderemo in una mostra fotografica, ma Franceschini ha pagato il suo
debito scontando 18 anni e non ha mai ucciso. Incontrarlo vuole essere la
testimonianza di un periodo buio e un messaggio alle nuove generazioni, perché
costruiscano il futuro senza violenza».
Polemica convegno Moro a
Bari, Grassi: «Franceschini, ex brigatista, viene a chiedere scusa».
Così Gero Grassi, ex presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
caso Moro: «Franceschini non ha mai ucciso nessuno», scrive l'11 Marzo 2019 La
Gazzetta del Mezzogiorno. «Alberto Franceschini, brigatista che non ha mai
ucciso nessuno, viene a dire 'scusate, abbiamo sbagliato, non copiateci'». Così
Gero Grassi, ex presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso
Moro, risponde alle polemiche dei giorni scorsi sulla partecipazione dell’ex
brigatista ad uno degli eventi organizzati dal Consiglio regionale della Puglia
per ricordare lo statista pugliese, in programma il prossimo 14 marzo. Grassi ne
ha parlato con i giornalisti a margine della inaugurazione della mostra dedicata
ad Aldo Moro nella nuova sede del Consiglio regionale. «Non c'è un incontro del
14, c'è un progetto 'Moro educatore' - precisa Grassi - nel quale per due anni
magistrati, procuratori nazionali antimafia, professori universitari spiegano ai
docenti di Puglia che cos'è il caso Moro. Una di queste puntate è con Alberto
Franceschini, uno che dice che in via Fani non c'erano solo le Brigate rosse,
dice che le Brigate rosse sono state utilizzate da servizi segreti italiani e
stranieri per uccidere Moro, quindi credo che sia una voce autorevole in un
campo nel quale noi abbiamo bisogno di recuperare la verità». «Rispetto alla
conclusione della commissione di inchiesta, nessuno si indigna - continua Grassi
- che esiste un filmato che ci dice chi ha rubato la borsa di moro in via Fani.
Quel filmato dice che la borsa l’ha presa un ufficiale dei carabinieri, che era
scortato da due generali dell’Esercito». «Credo - conclude - che l’indignazione
del Paese debba essere di gran lunga superiore rispetto a polemiche
strumentali». «Voglio un incontro ma deve essere prima di tutto un confronto
dove dicano le verità ai familiari delle vittime e a chi ha indagato e vissuto
quegli anni sulla propria pelle. Sono pronto a guardare negli occhi non solo
Franceschini ma addirittura Enrico Galmozzi, il killer di mio zio, perché finora
comunque non ho mai visto nessuno andare a chiedere perdono davanti a una delle
tombe delle persone da loro brutalmente uccise». Così Potito Perruggini, nipote
di Giuseppe Ciotta, poliziotto ucciso nel 1977 da Prima Linea, risponde a Gero
Grassi che è intervenuto sulla polemica nata in seguito all’invito di Alberto
Franceschini, tra i fondatori delle Br, ad un convegno su Aldo Moro a
Bari. «Domani è l’anniversario dell’omicidio Ciotta - continua -, aspetto Enrico
Galmozzi al cimitero di Ascoli Satriano dove mio zio riposa da 42 anni».
Perruggini si dice poi disposto ad "incatenarsi per non consentire l’accesso al
teatro dove di terrà l’evento», giovedì prossimo.
LA MOSTRA - In 84 pannelli
allestiti nell’agorà della nuova sede del Consiglio regionale della Puglia è
raccontata la cronaca dei 55 giorni di prigionia di Aldo Moro e quello che ne
seguì. L’esposizione dal titolo «Aldo Moro: per ricordare», con una pagina del
Corriere della Sera e gli altri 83 pannelli che riproducono le pagine ingiallite
della Gazzetta del Mezzogiorno di quei giorni, sarà aperta fino alla prima
decade di maggio. Alla cerimonia di inaugurazione della mostra hanno partecipato
circa 300 studenti di sei scuole superiori della provincia di Bari. «A distanza
di quarant'anni, il sacrificio di Moro, coi suoi terrificanti segreti non ancora
svelati, ci ha consentito di leggere negli occhi degli studenti l'incredulità e
lo sgomento di chi viene a conoscenza, per la prima volta, di quel periodo
tragico» ha detto il presidente del Consiglio regionale pugliese, Mario Loizzo.
Per Gero Grassi, ex presidente
della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro, lo statista pugliese
rappresenta un "patrimonio dell’umanità che il Consiglio regionale della Puglia
sta riattualizzando ed esportando nel mondo scolastico, in quello associativo,
in quello delle biblioteche, in Puglia e in Italia». Il direttore della Gazzetta
del Mezzogiorno Giuseppe De Tomaso, ha ricordato come la figura di Moro abbia
«inciso non soltanto sulla storia del Paese, della Dc e del Sud ma anche della
Gazzetta del Mezzogiorno, perché in un’altra circostanza in cui il giornale si
trovava a vivere un momento molto difficile, Moro riuscì a trovare una
soluzione», auspicando che «la lezione di Moro serva di aiuto morale ma anche
come formula per uscire dalle secche societarie in cui ci troviamo oggi». Per il
direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Cammalleri, «la verità è
libertà e per questo cerchiamo di diffondere tra gli studenti la conoscenza di
quegli eventi». La cerimonia si è conclusa con la consegna di premi, su
iniziativa dell’Associazione Consiglieri regionali, a sei componenti del
Consiglio regionale della prima legislatura costituente (1970-75) e a tutti i
presidenti di Giunte e Consigli regionali, dall’istituzione alla nona
legislatura. È stato ricordato anche il poliziotto Francesco Zizzi di Fasano,
agente della scorta di Moro, ucciso in via Fani, il 16 marzo 1978.
M5S: PATROCINIO CONSIGLIO
INOPPORTUNO - I consiglieri regionali pugliesi del M5S annunciano una
interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore Nunziante sul ruolo di
Gero Grassi nelle iniziative dedicate ad Aldo Moro e ritengono «inopportuno» il
patrocinio del Consiglio regionale ad un evento con l’ex brigatista Alberto
Franceschini. «Siamo assolutamente favorevoli a tutte le iniziative per
ricordare Aldo Moro - dicono in una nota i consiglieri regionali pentastellati -
ma ci chiediamo se sia opportuno affidare tutti i progetti del Consiglio
Regionale dedicati allo statista, a Gero Grassi (ex presidente della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul caso Moro, ndr), dopo che Maria Fida Moro lo ha
diffidato dal 'parlare pubblicamente, in modo inopportuno e blasfemo, della
terribile agonia e della mortè di suo padre». "Ci chiediamo come mai a
iniziative così importanti - continuano - non prenda parte anche Maria Fida
Moro, che più volte ha chiesto di essere ricevuta dal Presidente Emiliano, senza
ricevere alcuna risposta. Così come ci sembra quantomeno inopportuno che il
Consiglio dia il patrocinio ad un incontro con la partecipazione di Alberto
Franceschini, il fondatore delle Brigate Rosse, organizzato per il 14 marzo
nell’ambito del progetto 'Moro: Educatorè». Il M5S pugliese evidenzia, inoltre
che «il link con la locandina dell’evento è stato cancellato dal sito del
Consiglio regionale ma di certo questo non basta. Se il presidente Loizzo è
convinto della bontà dell’incontro che senso ha farlo sparire dal sito?».
COMUNE DI TERLIZZI DISERTA
- Il Comune di Terlizzi non ha partecipato questa mattina alla cerimonia di
inaugurazione della mostra «Aldo Moro: per ricordare», annunciando che non
prenderà parte anche ai prossimi eventi dedicati allo statista pugliese
organizzati dal Consiglio regionale. «Una forma di dissenso - è spiegato in una
nota - legata alla scelta, sempre da parte del Consiglio regionale pugliese, di
promuovere altri due eventi dedicati alla figura di Aldo Moro che si terranno il
prossimo 14 marzo, entrambi con la presenza di Alberto Franceschini, fondatore
delle Brigate Rosse». «I grandi uomini del nostro tempo si ricordano attraverso
lo studio della storia e il racconto delle loro azioni, - dice il sindaco, Ninni
Gemmato - non certo facendo salire sul palco e facendo entrare in un’aula di
scuola personaggi discutibili fautori di una stagione di terrore che seminò
sangue nel nostro Paese». «Chiedo a tutte le autorità istituzionali regionali -
dice il sindaco - di rivedere l’organizzazione di questi eventi per non
offendere la memoria delle vittime delle Brigate Rosse e il dolore delle loro
famiglie».
La Regione Puglia sceglie
le Brigate Rosse per celebrare Aldo Moro.
Il co-fondatore delle Br, Alberto Franceschini, chiamato a parlare della storia
brigatista agli studenti in occasione delle commemorazioni per la strage di via
Fani, scrive Giuseppe D. Vernaleone, Lunedì 11/03/2019, su Il Giornale.
Le Brigate rosse un esempio? Assolutamente no ma per il consiglio regionale
pugliese è più utile la parola di uno dei fondatori del terrorismo anziché far
ascoltare chi ha patito la violenza rossa o chi l’ha combattuta. L’aggravante è
costituita anche dalla composizione della platea che il 14 udirà il mea
culpa del brigatista: centinaia di studenti. Cosa diversa se venisse a
relazionare "del fallimento umano e politico delle Br" al cospetto di profondi
conoscitori, quali storici-giornalisti od investigatori, con capacità di
conoscenze già acquisite al fine di valutare ulteriormente quelle pagine oscure
in cui la battaglia politica si trasformò in orribile violenza criminale. Invece
no e per il Consiglio Regionale pugliese, per l'Ufficio scolastico regionale,
per l'Istituto per la storia dell'antifascismo e della storia del Risorgimento e
per la Società Italiana per le Scienze Umani e Sociali un buon maestro e buon
educatore, per coloro che saranno i futuri gruppi dirigenti di questo Paese, è
colui che ha scontato di 18 anni di carcere per esser stato uno dei protagonisti
della organizzazione che fece, dell’azione omicida, un metodo di lotta. Per l’ex
componente della commissione di inchiesta sul Caso Moro di Montecitorio, l’ex
deputato pd Gero Grassi il tutto appare plausibile per il sol fatto che Alberto
Franceschini, si legge in un comunicato inviato a fine gennaio dal Consiglio
Regionale, venga a parlare del "fallimento umano e politico delle Br... e verrà
a dire agli studenti: abbiamo sbagliato". Insorgono le opposizioni ed in primis
il presidente del gruppo regionale di Forza Italia, Nino Marmo: "Come può
un'istituzione promuovere un convegno in memoria di una vittima e invitare anche
il fondatore dell'associazione criminale che l'ha ucciso?". Non è il solo a
sollevare un interrogativo simile, della stessa idea tutti gli esponenti
dell'opposizione a Michele Emiliano da Fratelli d'Italia alla Lega, pur nel
silenzio delle altre forze che governano, da centrosinistra, la Regione di
origine del leader dc ucciso assieme alla sua scorta. Alla base
dell’indignazione non la libertà di parola per chi si è pentito della propria
storia collaborando anche con la giustizia ma l'esempio che questo possa
rappresentare su una platea non abbastanza informata sul clima degli anni
Settanta. Cosa penserebbero i familiari degli agenti di scorta, e dello
stesso Aldo Moro, ad ascoltare una lezione di politica terroristico/giudiziaria
da parte di chi fu uno dei principali ideologi dell’organizzazione criminale di
tanti omicidi? La Puglia chiede di togliere il patrocino da parte
dell’Istituzione ed evitare che Franceschini venga visto, dalle scolaresche,
come un simbolo di pentimento dopo anni di violenze. Titolo dell’incontro: "Moro
educatore. Le Brigate rosse e il loro fallimento storico sociale e politicò" ma
a Bari scelgono come educatore colui che, secondo Potito Perruggini, presidente
dell’Associazione Anni di Piombo e nipote di Giuseppe Ciotta brigadiere di
Polizia ucciso nel 1977, hanno una responsabilità diretta di tante violenze. Per
Perruggini la Regione Puglia avrebbe fatto meglio a "ricordare nomi e volti di
tutti quei pugliesi che sono stati uccisi dai killer degli anni di piombo. Il
fallimento del terrorismo è di qualcosa che nasce già deviato e malvagio. Questo
messaggio non può essere oscurato dalla parola “fallimento” che potrebbe
implicare anche il negativo esito di qualcosa che nasce da giusti ideali e da
uomini giusti. Infatti anche lo stesso Napolitano nel 2007 esortò a non renderli
protagonisti rischiando di dare falsi insegnamenti storici soprattutto ai
giovani". Ma in Puglia il pentimento di qualcosa di errato lascia intendere che
le originarie motivazioni ideali possano essere considerate positivamente se a
relazionare non siano studiosi degli eventi ma i promotori delle azioni
rivoluzionarie poi sfociate in criminali omicidi.
L'inconfessabile verità sul
delitto Moro nascosta dietro Mani Pulite e Cinquestelle.
La regia di quel delitto? La
stessa che tiene in pugno l'Italia da 40 anni, scrive Paolo Guzzanti, Mercoledì
09/05/2018, su "Il Giornale". Quarant'anni fa come oggi eravamo tutti in via
Caetani, a metà strada fra piazza del Gesù sede della Democrazia Cristiana e le
Botteghe Oscure allora sede faraonica del Partito comunista. Il cadavere
smagrito nell'angoscia di Aldo Moro era nel bagagliaio della famosa Renault
rossa. Aveva il pollice fracassato da uno dei colpi sparati, nel tentativo
disperato di coprirsi il volto. I carnefici non ebbero nemmeno la pietà di
coprirgli il volto prima di tirare il grilletto. Moro fu assassinato per
impedire che il Partito comunista si sganciasse dall'Unione Sovietica, come
tutto l'Occidente sperava. Per impedire questo risultato avevano già tentato di
far fuori il segretario comunista Enrico Berlinguer in Bulgaria investendolo con
un camion che uccise il suo autista. Moro fu catturato, spremuto e liquidato
secondo un copione che poi tutti si sono dati da fare per insabbiare per far
credere che un gruppo di sconsiderati boyscout comunisti le sedicenti Brigate
rosse lo avesse catturato per fargli un processo del popolo. Una contraffazione
ridicola, ma buona da dare a bere alle folle, allora come oggi. La storia di
quel delitto è la storia di mille insabbiamenti. Francesco Cossiga che era stato
il braccio destro di Aldo Moro e poi uno dei fautori del sacrificio umano sotto
l'etichetta del «partito della fermezza» - a cose fatte andò a visitare tutti i
brigatisti in galera con cui strinse un accordo: sarebbero stati rimessi tutti
in libertà, purché tenessero la bocca chiusa. Quando io andai, come presidente
di una Commissione bicamerale d'inchiesta e sotto copertura diplomatica a
Budapest nel 2005 per un incontro formale con la Procura ungherese, fu mostrata
a me e agli altri membri della commissione una grande valigia di cuoio verde con
tutti i documenti che certificavano l'arruolamento dei principali brigatisti
rossi nei servizi segreti sovietici e della Stasi tedesca. Al momento della
consegna di quei documenti che ci erano stati promessi in pompa magna,
intervenne il veto diplomatico russo. Ma per me, per noi, bastava e avanzava.
Moro aveva accettato di svolgere il ruolo di garante dell'ingresso dei comunisti
in area democratica, purché tagliassero il loro legame con Mosca. Per questo
sarebbe dovuto diventare presidente della Repubblica e per questo una
terrificante campagna di stampa aveva costretto alle dimissioni l'innocente
presidente Giovanni Leone trascinato nel fango dalle falsificazioni della
potente centrale che guidava l'operazione. Alla potente centrale si opponeva
l'altra potente centrale che alla fine vinse, liquidando il garante. La
liquidazione di Moro mandò all'aria il progetto. E questa è la storia negata e
insabbiata. L'operazione che avevano preparato gli americani vedi L'Italia vista
dalla Cia di Paolo Mastrolilli e Maurizio Molinari, con tutti i documenti
originali del corteggiamento americano al Partito comunista guidato da Enrico
Berlinguer consisteva allora nel tentativo di far fuori una parte della Dc
sgradita. Operazione che riuscì perfettamente qualche anno più tardi con
l'eliminazione programmata di tutta la classe politica democratica italiana con
l'operazione Clean Hands, Mani Pulite come ben documentato in The Italian
Guillotine di Luca Mantovani e Stanton H. Burnett, libro mai tradotto in Italia,
per eloquente prudenza. Queste circostanze sono note e stampate ma mantenute
accuratamente nell'ombra affinché il comune sentire della pancia italiana non
avesse a soffrirne. Ma meritano di essere ricordate perché oggi, sotto
l'inesistente vessillo della inesistente Terza Repubblica, è in atto una nuova
purga della classe politica italiana, stavolta sotto forma di liquidazione del
nucleo liberale e moderato rappresentato da Forza Italia e dal suo leader Silvio
Berlusconi. L'intransigenza razzista mostrata da Luigi Di Maio nel rifiutarsi di
prender atto dell'esistenza politica di Berlusconi e del suo partito non è una
capricciosa impuntatura, ma l'esecuzione dei desiderata di una grande lobby
internazionale che sta dietro i danti causa del Movimento Cinque Stelle. La
storia della contraffazione italiana continua, il grande giornalismo dei divi
della comunicazione democratica tace e incassa dividendi di notorietà a costo
zero, mentre agli italiani viene risparmiato oggi come quaranta anni fa il
disturbo di sapere, di discutere, di dubitare. Moro da vivo era stato odiato dai
comunisti che lo avevano sempre deriso e attaccato, ma che oggi lo santificano
come se fosse un loro martire. Moro era odiato da Eugenio Scalfari, così come
Giovanni Falcone era odiato dai comunisti e degradato da vivo, ma poi assunto
nell'Olimpo dei martiri resi innocui. Quanto a Moro, sapeva che si stava
stringendo il cappio al suo collo e che quel cappio era stato preparato da ben
altri che non i quattro mascalzoncelli sanguinari dei brigatisti «duri e puri».
Nulla era duro, nulla era ed è puro. La democrazia repubblicana è da decenni
sotto attacco, fragile, infetta e sempre sotto tutela. La macabra sorpresa nella
Renault rossa di via Caetani quaranta anni fa rappresentò l'apice della viltà e
della malvagità, ma il delitto più grave è che malgrado le decine di migliaia di
pagine e di udienze, agli italiani è stato propinato, allora come oggi, un
pappone imbottito di sonnifero ed edulcoranti, affinché non pensassero troppo. È
la vecchia tecnica dei signori tedeschi durante il feudalesimo, che sceglievano
personalmente la moglie per i loro contadini e, affinché non avessero a
faticare, gliela davano già gravida. Oggi l'antico delitto seguita a perpetrarsi
ogni giorno e ad ogni anniversario attraverso la manipolazione e la
disinformazione sorvegliata e gestita da molti finti eroi. Moro è morto e anche
la verità ha fatto la stessa fine, mentre maturano nuovi accurati delitti
politici, complice il populismo allevato in batteria come i polli e spacciato
come ruspante.
Il rapimento e la morte di
Aldo Moro. Moro, 40 anni dopo. Possiamo provare a capire?
Scrive Piero Sansonetti l'8
Maggio 2018 su "Il Dubbio". Domani è il quarantesimo anniversario dell’uccisione
di Aldo Moro. Fu abbattuto a colpi di mitraglietta la mattina del 9 maggio del
1978 da Mario Moretti e forse da un altro esponente delle Br. Aveva 61 anni. Il
patibolo fu il portabagagli di una Renault 4 di colore rosso. La R4 è
un’utilitaria francese, piccola ma con una struttura da station wagon, che in
quegli anni era molto diffusa. L’esecuzione avvenne la mattina presto nel garage
della palazzina di via Montalcini, a Monteverde, dove Moro era stato tenuto
prigioniero per 55 giorni. Spararono con il silenziatore. Poi Moretti chiuse il
portellone posteriore e si mise alla guida della Renault; al suo fianco era
seduto Germano Maccari, un altro dei carcerieri di Moro (morto d’infarto una
decina di anni fa). Guidò fino a piazza Venezia, dove incrociò un’altra auto,
una Simca 1000 guidata da un terzo brigatista, probabilmente Bruno Seghetti. Sul
sedile a fianco al guidatore c’era Valerio Morucci. La Simca fece da staffetta
fino a via Caetani dove lo stesso Seghetti aveva parcheggiato, le sera prima,
un’altra automobile. Seghetti scese dalla Simca, salì a bordo dell’auto
parcheggiata e se ne andò. Moretti parcheggiò la Renault 4 al posto rimasto
vuoto, poi salì sulla Simca, ancora in moto, e sparì anche lui. Alle 12 e 30,
Valerio Morucci, da un telefono pubblico vicino alla stazione Termini, chiamò il
professor Francesco Tritto e lo avvertì che il cadavere di Moro stava in via
Caetani. Gli disse che doveva informare la famiglia, la signora Eleonora, doveva
dirle che Moro era morto e il cadavere era in via Caetani. Tritto era
spaventatissimo, cercò di sottrarsi. Ma non c’era niente da fare. Allora chiamò
la polizia Dopo dieci minuti la polizia circondò la Renault 4. Arrivò il
ministro dell’Interno, Cossiga, arrivò Ugo Pecchioli (una specie di ministro
ombra del Pci) arrivarono i vertici dei servizi segreti (tra i quali il generale
Mori). Si aprì il portellone del portabagagli e Moro stava lì, rannicchiato,
senza vita da qualche ora. Non era morto sul colpo, perché nessuno proiettili
aveva colpito il cuore. Perse conoscenza, dopo la prima raffica, e morì per le
emorragie, dopo più o meno un quarto d’ora. Via Caetani è un luogo simbolico.
Perché è esattamente equidistante da Botteghe Oscure e da piazza del Gesù.
Botteghe Oscure era la sede del Pci, Piazza del Gesù la sede della Dc. Le
Brigate Rosse volevano dire quello: abbiamo ucciso il capo del compromesso
storico, dell’operazione- regime, dell’alleanza tra Dc e Pci. Moro era stato un
uomo politico grandioso. In tutte le fasi della sua carriera. Era stato un
moderato, un progressista, un doroteo, uno degli artefici del centrosinistra,
l’uomo dell’apertura ai giovani nel ‘ 68, e infine, insieme a Berlinguer, aveva
guidato l’operazione politica più difficile: l’ingresso dei comunisti in
maggioranza in un grande paese europeo. Quest’ultima operazione gli costò la
vita. Mario Moretti fu catturato nel 1981, Da allora è detenuto. Ha scontato,
sin qui, 37 anni di prigione. Ora è in regime di semilibertà, ma è sempre
detenuto. Qualche anno fa tenne un incontro con gli studenti milanesi, in un
corso organizzato dalla Provincia e condotto dal giornalista Enrico Fedocci. E
poi scrisse a Fedocci la lettera che pubblichiamo qui a fianco e che fino ad
oggi non era stata resa pubblica. Ognuno può leggere la lettera e commentare
come vuole. A me ha colpito – in positivo e in negativo – la serenità del
giudizio di Moretti. Lui dice: Le Brigate Rosse sono un pezzo molto complesso
della storia italiana, e sono una specie di specchio, per tutti. Soprattutto per
chi ha vissuto quegli anni. Io capisco perfettamente la posizione di un
protagonista – anzi del leader – di una formazione che ha praticato la lotta
armata, o se preferite il terrorismo, e che oggi vuole collocare nella Storia e
non solo nella storia giudiziaria, quella esperienza che è stata tragica per
tutti. Non solo, ma io credo che noi dovremmo, quarant’anni dopo, trovare la
forza e la lucidità per esaminare effettivamente in modo freddo quelle vicende,
cercando di capirne il senso, le motivazioni, gli effetti, le conseguenze, senza
spirito di rivalsa, senza ossessioni complottiste. Non ci fu nessun complotto,
fu un fenomeno molto più complesso. La generazione del baby boom (cioè quella
nata tra il 1945 e il 1955) in quasi tutto l’occidente è stata protagonista di
fenomeni, più o meno marginali, di lotta armata. Non solo nei paesi dove
regnavano regimi autoritari di destra, come la Spagna, o dove esplodevano
questioni nazionali antiche (Irlanda) ma anche nei grandi paesi della
democrazia, come gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, e l’Italia. In Italia
il fenomeno fu più clamoroso, e più vasto, perché si accompagnò con una rivolta
giovanile e sociale amplissima, che coinvolse una parte molto consistente, e la
più attiva, di quella generazione. A me sembra che quasi mezzo secolo dopo
quegli avvenimenti sarebbe ragionevole, anche da parte della politica, avviare
una riconsiderazione serena su quello che successe in quel decennio. Cosa osta?
Due elementi. Uno, è evidente, è il giustizialismo, che tende a trasformare in
revanche e in vicenda giudiziaria tutti i fenomeni violenti e illegali. Senza se
e ma. L’altro elemento però è la reticenza dei protagonisti. Non la reticenza
giudiziaria, per carità: non credo ci sia più niente da scoprire sul terrorismo
rosso, casomai bisognerebbe scoprire tante cose legate al terrorismo nero e a
quello di Stato (le stragi, gli attentati) ma questo è un altro discorso. La
reticenza che i protagonisti della lotta armata dovrebbero superare è quella
umana. Voglio dire che è difficile discutere con delle persone che quarant’anni
dopo non hanno la forza per condannare alcune loro azioni. E’ chiaro che
fucilare Moro è stato un gesto incomprensibile e inumano, che non può essere
spiegato da nessuna strategia politica perché è in contrasto con qualunque
strategia politica. Ora è molto ragionevole discutere di quante responsabilità
per la sua morte ricadano sulle spalle di quel pezzo di società politica che
rifiutò la trattativa. Benissimo. Ma come si fa a farlo se prima non si mettono
dei punti fermi sulla colpa degli esecutori? Da Moretti e dagli altri capi delle
Br è questo che ci si aspetta. La volontà di “esporsi” ad una discussione a
tutto campo. Che può avvenire solo se loro compiono un passo di chiarezza. Che
non ha niente a che fare con la legislazione sui pentiti, con i benefici di
legge, con gli sconti di pena. Ha a che fare solo con la politica. Così come
solo con la politica ha a che fare l’ipotesi della cosiddetta soluzione politica
della questione lotta- armata. Attualmente – ce lo ha svelato ieri Milena
Gabanelli – ci sono una cinquantina di ex della lotta armata ancora in carcere.
Forse un provvedimento di amnistia non sarebbe irragionevole. E sicuramente ci
aiuterebbe ad aprire una discussione vera sulla lotta armata.
Moro, il fallimento della
Grosse Koalition all'italiana e l'inizio della fine del terrorismo.
Sono passati 40 anni dal rapimento dello statista democristiano, che
voleva condurre il paese verso il bipolarismo, rispettando le alleanze
occidentali, scrive "Il Foglio" il 16 Marzo 2018. A quarant’anni dal rapimento
di Aldo Moro e dall’eccidio della sua scorta, preludio all’assassinio del
presidente della Democrazia cristiana, 55 giorni dopo, è ancora difficile
elaborare una visione storicamente compiuta di quella vicenda che segnò
indelebilmente la vita della democrazia italiana. Nelle versioni giornalistiche
ancora si fatica a rintracciare una lettura convincente dei due fenomeni – i
governi di compromesso storico e l’apice dell’offensiva terroristica – che
caratterizzarono quella fase cruciale. L’assassinio di Moro condusse al
fallimento dell’idea di una maggioranza stabile con il Partito comunista e avviò
al contempo la lenta ma inesorabile reazione dello stato che portò
all’eliminazione del terrorismo rosso. Oggi Moro viene per lo più descritto come
il tessitore di una prospettiva di alleanza tra Dc e Pci, ma in realtà il suo
disegno era quello – di fronte a un esito elettorale con due vincitori, ambedue
però privi della possibilità di agglutinare una maggioranza autosufficiente – di
promuovere una transizione che permettesse di arrivare a un confronto bipolare
in condizioni di sicurezza per la democrazia interna e per il sistema di
alleanze occidentali. Si trascura spesso il contesto internazionale, segnato
dalla diffidenza, espressa da un esplicito altolà pronunciato dal cancelliere
tedesco Helmut Schmidt nei confronti di quel disegno, audace e comunque non
politicamente infondato. Chi ne tiene conto, peraltro, inclina a teorie
complottistiche che descrivono la Brigate rosse come mandatarie di non meglio
identificati interessi stranieri. In realtà una delle ragioni che spinsero la Dc
ad accettare la lettura morotea del compromesso era la convinzione che
l’associazione del Pci alla maggioranza avrebbe ridotto le potenzialità del
terrorismo: l’assassinio di Moro fu la dimostrazione di quanto errato fosse
questo calcolo e spinse, nel giro di un anno e mezzo ad abbandonare quella
politica. Vista in una prospettiva più ampia, la vicenda della “Grosse
Koalition” all’italiana si dimostrò un generoso fallimento. Da lì in poi i due
protagonisti, la Dc e il Pci, vivono processi degenerativi: la prima costretta a
cedere la guida del governo prima a Giovanni Spadolini e poi a Bettino Craxi, il
secondo a una ritirata nel ridotto moralistico dell’isolamento politico. Fu
l’aggressione terroristica, la pressione internazionale o una debolezza
intrinseca a provocare quel fallimento? A questa domanda è difficile rispondere,
ma probabilmente uno degli elementi decisivi fu il carattere statico e
paralizzante del compromesso a condannarlo. Mentre la società e l’economia
cercavano nuove strade, dalle telecomunicazioni private ai fondi di investimento
alle agenzie di collocamento non pubbliche, il compromesso era basato su una
difesa a oltranza dei monopoli pubblici ormai obsoleti. Il suo obiettivo era
stringere la società e l’economia in vincoli ancora più stretti, come dimostra
l’unica riforma rilevante di quella fase, l’equo canone. Con Moro si avvia alla
conclusione una fase che era stata caratterizzata dall’onnipotenza dei partiti,
che aveva creato le strutture di intervento pubblico nell’economia, dalla
proprietà statale delle grandi banche e dal ruolo invasivo delle partecipazioni
statali (ereditate dal fascismo), alle illusioni di programmazione dello
sviluppo del meridione affidate alla Cassa del Mezzogiorno. Quei giorni tragici
non segnarono l’avvio di una nuova fase della Repubblica, ma la fine, o almeno
l’inizio della fine, di quella precedente.
Terrorismo, dove sono oggi
i brigatisti del sequestro Moro,
scrivono Giovanni Bianconi e Milena Gabanelli il 9 maggio 2018 su "Il Corriere
della Sera". Sono passati 40 anni esatti da quella telefonata «parlo a nome
delle Brigate Rosse, deve comunicare alla famiglia che il corpo dell’on Aldo
Moro si trova in Via Caetani, che è la seconda traversa a destra di Via delle
Botteghe Oscure, dentro ad una Renault 4 rossa». I 14 brigatisti coinvolti nel
sequestro furono nel tempo tutti arrestati e processati. Dove sono oggi?
Rita Algranati.
Aveva segnalato al
commando con un mazzo di fiori l’arrivo dell’auto con Moro in via Fani. Fuggita
in Nicaragua, poi in Algeria, estradata nel 2004, sta scontando l’ergastolo ma è
ammessa ai benefici esterni.
Barbara Balzerani.
Partecipò al
sequestro. Condannata all’ergastolo, ha ottenuto la liberazione condizionale.
Anna Laura Braghetti e
Germano Maccari.
Anna Laura Braghetti durante il sequestro era l’intestataria e l’inquilina
dell’appartamento dove è stato sequestrato Moro in Montalcini a Roma, insieme a
Germano Maccari. Lei è stata condannata all’ergastolo e oggi è in libertà
condizionale, lui è morto nel carcere di Rebibbia mentre scontava una pena a 23
anni di reclusione.
Alessio Casimirri e Alvaro
Lojacono.
Alessio Casimirri presidiava la parte alta di via Fani insieme a Alvaro
Lojacono: Casimiri è fuggito in Nicaragua, dove gestisce un ristorante. Lojacono
in Svizzera, che non ha mai concesso la sua estradizione in Italia.
Raimondo Etro.
Fu il custode delle armi usate nella strage. Condannato a 24 anni e 6 mesi, poi
ridotti a 20. Si è pentito e ha collaborato con i magistrati, oggi è in libertà.
Adriana Faranda.
È stata la «postina» del sequestro Moro, arrestata nel 1979. In carcere si
dissocia dalla lotta armata ed è tornata in libertà dopo 15 anni di carcere.
Quelli che spararono alla
scorta: Bonisoli, Fiore, Morucci, Gallinari.
Franco Bonisoli, Raffaele
Fiore, Valerio Morucci, Prospero Gallinari, spararono sulla scorta di Moro in
via Fani. Bonisoli in carcere si è dissociato dalla lotta armata, ha ottenuto i
benefici di legge e oggi è libero. Raffaele Fiore fu condannato all’ergastolo,
ha ottenuto la liberazione condizionale. Valerio Morucci fu condannato a 30
anni, dopo la dissociazione dalla lotta armata. Scarcerato nel 1994, oggi è in
libertà. Prospero Gallinari, Condannato all’ergastolo ha avuto la pena sospesa
per motivi di salute. Deceduto nel 2013.
Mario Moretti.
La mente del sequestro. Era alla guida dell’auto che ha bloccato il convoglio di
Moro e della scorta, e ha condotto gli interrogatori nella «prigione del
popolo». Si è dichiarato esecutore materiale dell’omicidio di Moro. Condannato a
6 ergastoli, oggi è in semilibertà e la sera rientra in carcere.
Bruno Seghetti.
Era alla guida dell’auto con la quale Moro venne portato via dopo l’agguato.
Condannato all’ergastolo, ha ottenuto prima la semilibertà, revocata per un
periodo, e oggi è in libertà condizionale.
Il caso Lioce e i sepolti
vivi del 41 bis: quando il carcere è inumano.
La feroce brigatista è sottoposta a un regime di isolamento psicologico. E ora
torna a processo perché ha protestato. Anche per le vedove D'Antona e Biagi, sue
vittime, è troppo, scrive Giorgio Sturlese Tosi il 2 maggio 2018 su "Panorama".
Torna alla sbarra Nadia Desdemona Lioce, l'irriducibile brigatista rossa
condannata per gli omicidi dei giuslavoristi Massimo D'Antona e Marco Biagi e
del sovrintendente di Polizia Emanuele Petri. Ma stavolta la lotta armata non
c'entra. La Lioce è accusata di turbamento della quiete carceraria, perché "con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante schiamazzi o
rumori, provocati sbattendo ripetutamente una bottiglia di plastica contro le
inferriate della propria cella, disturbava le occupazioni o il riposo delle
persone detenute nel reparto 41 bis della casa circondariale di L'Aquila", dove
la Lioce, unica detenuta "politica" assieme a quattro mafiose, è rinchiusa, in
isolamento, dal 2006.
Perché la Lioce protesta dal
carcere. La Lioce, mai pentita né dissociata, non ha perso l'animo ribelle né
l'occasione per protestare. Le sue contestazioni contro le presunte
vessazioni di cui sarebbe vittima le sono costate oltre settanta provvedimenti
disciplinari. Che non sono serviti a mitigare la sua condotta. Per mesi, ogni
mattina, per trenta minuti, la Lioce ha messo in atto una delle tipiche forme di
protesta esercitate nelle carceri: la "battitura". Da qui la denuncia e il
processo al tribunale dell'Aquila, seguito con turbolenta partecipazione da
numerosi antagonisti. Dal dibattimento però, oltre alle sue intemperanze, stanno
emergendo gli episodi che hanno portato l'ex leader delle Br Pcc (Brigate rosse
- Partito comunista combattente) ad armarsi di bottiglietta e portare avanti la
sua ultima battaglia. A cominciare dal divieto di tenere in cella più di tre
libri per volta e di non poterne acquistare liberamente, nemmeno da biblioteche
convenzionate, o di riceverne dall'esterno. Una limitazione motivata dal fatto
che l'amministrazione penitenziaria non ha il personale sufficiente per
verificare che ogni pagina di un testo, per esempio Guerra e pace, sia stata
scritta da Tolstoj e non da un rivoluzionario che possa aver inserito messaggi
segreti.
Un isolamento psicologico che
le impedisce di parlare a lungo. Altro tema oggetto di discussione è quello
della socialità, il tempo cioè che ogni detenuto può trascorrere in compagnia.
Il regolamento del 41 bis prevede che si possa godere delle due ore d'aria in
compagnia di una sola detenuta, sempre la stessa, scelta dall'istituto. Ma
quella assegnata alla Lioce è da tempo malata e non esce dalla cella. Così la
brigatista, per oltre un anno, ha trascorso il tempo riservato alla socialità in
rigorosa solitudine. E siccome ha diritto a un'ora di colloquio al mese con i
familiari e, in caso di bisogno, a due ore al mese con i propri avvocati, è
emerso che in un anno solare ha potuto dialogare con qualcuno soltanto
per quindici ore in totale. Questa situazione le ha provocato uno stato
di isolamento psicologico che le impedisce di poter discorrere normalmente più
di qualche minuto quando riceve la visita della madre o della sorella. Altro
motivo di attrito sono le frequenti perquisizioni della sua cella, per poter
effettuare le quali gli agenti di polizia penitenziaria hanno dovuto
sequestrarle la mole di documenti, lettere e giornali che la Lioce aveva
raccolto e ordinato per mesi. Arrivando a portarle via anche un laccetto porta
occhiali ottenuto da una striscia di stoffa non previsto dal regolamento.
Panorama ha provato a chiedere direttamente alla Lioce quali fossero le
condizioni della sua detenzione, ma la direzione del carcere non le ha
consegnato la lettera con le nostre domande "perché le condizioni detentive dei
soggetti in 41 bis possono essere valutate tramite atti ufficiali". E questo
nonostante il nuovo regolamento sul 41 bis emanato dal ministero della Giustizia
lo scorso ottobre sancisca che "al detenuto è consentito inoltrare e ricevere la
corrispondenza a mezzo posta", sia pure dopo il visto della censura. D'altra
parte sembra che, soprattutto per ragioni organizzative, molti articoli del
nuovo regolamento siano ancora ben lungi dall'essere applicati, come per esempio
quelli che concernono il numero di libri, riviste e quotidiani che si possono
acquistare. Alla Lioce sarebbe insomma impedito di leggere, studiare, scrivere e
persino parlare. Molte associazioni che si occupano di carceri e carcerati
parlano di violazioni dei diritti umani e di "tortura psicofisica".
Le vedove D'Antona e Biagi
contro l'inumanità del carcere. Ma uno Stato democratico che ha saputo
sconfiggere il terrorismo può permettersi di esporsi a queste accuse? Olga Di
Serio, la mattina del 20 maggio 1999, aveva appena salutato il marito, il
professor Massimo D'Antona, consulente del ministro del Lavoro Antonio Bassolino
nel governo D'Alema, quando, in via Salaria, a Roma, il commando della Lioce
glielo ha ucciso scaricandogli addosso un intero caricatore di pistola.
La vedova D'Antona conosce
bene le strutture carcerarie per averle visitate da parlamentare. E, pur
preferendo non intervenire sul caso specifico di Nadia Lioce, riconosce che "in
molte carceri ci sono situazioni di difficoltà e tanti aspetti dovrebbero essere
migliorati, perché tra quello che è possibile e quello che sarebbe giusto c'è
una grossa differenza". E "sarebbe auspicabile che le carceri fossero in grado
di adempiere a quello che è il loro compito, e cioè la rieducazione e il
reinserimento del detenuto". La professoressa Marina Orlandi, vedova di Marco
Biagi, accademico e consulente dei ministeri del Lavoro e del Welfare, ucciso a
Bologna dalle Br Pcc mentre rincasava in bici la sera del 19 marzo 2002, ascolta
con attenzione le circostanze che hanno portato a un nuovo processo la
brigatista. E ritiene "che la Lioce abbia il diritto di poter leggere i libri
che desidera. Basta un po' di fantasia per ovviare alle difficoltà burocratiche,
ad esempio facendo arrivare in cella i libri da biblioteche sempre diverse e
distanti geograficamente". Anche l'impossibilità per la Lioce di parlare con una
detenuta perché questa è malata appare un problema risolvibile. "Si tratta di
diritti umani che sono previsti anche per chi è in regime di 41 bis" ci dice la
vedova Biagi "e bisogna fare in modo che sia possibile esercitarli; se c'è una
legge deve essere rispettata e non si può rendere ancora più restrittivo il
regime del carcere duro. A volte basta il buon senso e un po' di elasticità".
(Articolo pubblicato sul n° 19 di Panorama in edicola dal 26 aprile 2018 con il
titolo "Dei relitti e delle pene").
Alberto Franceschini, uno
dei fondatori delle Brigate Rosse: «Sul sequestro Moro c’è una verità
accettabile: ci sono cose che non possono venir dette».
Alberto Franceschini, oggi 71 anni, ripercorre le tappe del sequestro Moro 40
anni dopo il rapimento e l’uccisione del leader democristiano. - Antonio Ferrari
/Corriere TV 17 aprile 2018. Metà aprile di 40 anni fa. Il presidente della
Democrazia Cristiana Aldo Moro è da un mese prigioniero delle Brigate Rosse, che
il 16 marzo lo hanno rapito, dopo aver ammazzato cinque uomini armati: la scorta
e l’autista del leader politico, in via Fani, a Roma. Mentre tutti cercano (a
parole) Moro, si stanno per realizzare, in poche ore, due episodi inquietanti:
il falso comunicato brigatista, con l’annuncio che il cadavere del leader è in
fondo al lago della Duchessa (nell’entroterra), e l’indicazione casuale del covo
di via Gradoli che, come si scoprirà, era la base dei brigatisti più pericolosi,
Mario Moretti e Barbara Balzerani. Quarant’ anni sono passati, e abbiamo voluto
ripercorrere la storia delle Brigate Rosse intervistando uno dei due fondatori
del gruppo terroristico: Alberto Franceschini, reggiano, che oggi ha quasi 71
anni, e che appartiene alla squadra di coloro che si ritenevano custodi
dell’eredità dei comunisti duri e puri. L’altro fondatore delle BR è infatti il
cattolico di ultrasinistra Renato Curcio. Le due componenti si incontrarono in
un hotel ligure di Chiavari, e decisero di definire il programma. L’hotel si
chiama Stella Maris, e da quel nome nacque l’idea del simbolo con la stella a
cinque punte, le ultime due allungate. Alberto Franceschini, che non ha mai
ucciso nessuno, ha accettato di raccontare la storia e soprattutto gli errori
mostruosi e le nefandezze del gruppo terrorista, da cui si è dissociato. Ha
pagato il suo conto con la giustizia, e ora dice che sulla vicenda Moro, che
seguì dal carcere, si è cercata «una verità accettabile», perché vi erano cose
che non potevano essere dette. Il fondatore in realtà è l’unico che parla
dicendo cose concrete, mentre gli altri (tutti, compreso Curcio) o tacciono o
raccontano soltanto parte della verità confessabile, condendola di silenzi,
forse frutto di patteggiamenti, e di menzogne. Ecco perchè questo documento
audio-video, di cui trasmettiamo la prima di tre puntate, è importante. E’ stata
l’ossatura originaria dei lavori della seconda Commissione parlamentare
d’inchiesta sul delitto Moro, costretta a chiudere nel dicembre scorso per la
fine della legislatura. La Commissione ha concluso con una sentenza lapidaria:
«In via Fani c’erano anche le Brigate Rosse». Terribile sentenza!
Alberto Franceschini, uno
dei fondatori delle Brigate Rosse: «L’interrogatorio di Moro? Non credo l’abbia
fatto Moretti (che si credeva Lenin).
E incontrammo il Mossad». Alberto Franceschini, oggi 71 anni, ripercorre le
tappe del sequestro Moro 40 anni dopo il rapimento e l’uccisione del presidente
della Dc. «La lotta armata», riconosce oggi, «fu un errore gravissimo».
CorriereTV 28 aprile 2018. Mancano pochi giorni al feroce epilogo di una delle
più grandi tragedie italiane, che si consumò 40anni fa, con la strage di via
Fani (16 marzo) e con l’assassinio di Aldo Moro (9 maggio). Il cofondatore delle
Brigate rosse Alberto Franceschini, apertamente dissociato e oggi lontano anni
luce dall’organizzazione terroristica, ripercorre, anche in questa seconda
puntata dell’intervista al Corriere della Sera, le tappe di una storia di errori
e di orrore (qui trovate la prima puntata). Sono passati alcuni giorni
dall’anniversario di due eventi che moltiplicarono l’angoscia diffusa in Italia
e nel mondo: il falso comunicato del Lago della Duchessa, compilato dai servizi
segreti, con l’annuncio della morte di Moro, affondato nelle viscere del
profondo specchio d’acqua nel cuore del nostro Paese. Fu il primo segnale, per
dimostrare che a quel punto l’ostaggio doveva morire. E poi la scoperta, tragica
e assieme ridicola, del covo di via Gradoli, dove due capi delle BR,
indisturbati, avevano ordito la trama assassina. Franceschini, come è noto, era
in prigione, arrestato anni prima assieme al gruppo originario delle BR. E ora
ripercorre i tanti punti oscuri di questa storia esemplare di fatti, porcherie,
deviazioni, manipolazioni e silenzi, forse risultato di irriferibili scambi
sottobanco, Mario Moretti, il capo militare delle BR, è — a suo avviso — un capo
per modo di dire. Lo è nominalmente, ma di lui, delle sue ardite giravolte, dei
suoi continui viaggi in Francia, per tanto tempo si è saputo quasi niente.
L’uomo che si credeva Lenin, vittima di un ego smisurato, culturalmente non
certo in grado di tenere testa ad Aldo Moro, probabilmente è soltanto il postino
delle domande compilate da altri, nella cosiddetta prigione del popolo. Forse il
suggeritore era il professor Giovanni Senzani, autore di numerose nefandezze
terroristiche, che la Commissione parlamentare sul sequestro e l’assassinio di
Moro ha individuato come collegato ai nostri servizi segreti. Senza
tentennamenti, Alberto Franceschini denuncia il ruolo della scuola parigina
«Hyperion» e del suo conduttore Corrado Simioni. Poi attacca le manovre
francesi, i sospetti di quelle inglesi, e la certezza —sono le sue parole — che
«le BR hanno avuto rapporti con il Mossad, il servizio segreto israeliano».
Circostanza non nuova, se ne parlò anche ai tempi di Carlo Fioroni. In sostanza,
mentre nessuno sapeva ufficialmente dove si trovassero, il Mossad raggiunse le
BR in tutte le fasi delle loro scorribande terroristiche. Patrizio Peci, il
pentito più noto, ne parlò a lungo con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Franceschini conferma e aggiunge: «Non ci chiesero di uccidere, ma di fare ciò
che volevamo. Offrivano armi e assistenza. Il loro obiettivo dichiarato era
destabilizzare l’Italia».
Alberto Franceschini,
co-fondatore Br: «Perché sono diventato brigatista: volevamo la guerra allo
Stato. Un
fallimento reale». A 40 anni dall’uccisione dello statista democristiano Aldo
Moro da parte delle Brigate Rosse, le parole e il pentimento di uno dei
fondatori dell’organizzazione terroristica, scrive Antonio Ferrari l'8 maggio
2018 su "Il Corriere della Sera". Siamo all’epilogo della tragedia che ha
vissuto l’Italia con il sequestro e l’assassinio del presidente della DC Aldo
Moro, tragedia che si concluse il 9 maggio di 40 anni fa quando il cadavere fu
restituito in via Caetani, a Roma, in una simbolica metà strada tra la sede
della Democrazia Cristiana e quella del Partito Comunista, quasi a dimostrare
simbolicamente le responsabilità di entrambi. Quaranta anni dopo il mistero dei
misteri - e cioè chi ha pianificato, organizzato, gestito e concluso il crimine
più odioso della storia della Repubblica, che per noi equivale a quello che per
gli americani è stato l’11 Settembre 2001 -, è ancora un fitto enigma e forse lo
rimarrà per sempre. Personalmente mi colpiscono le conclusioni della seconda
Commissione Parlamentare sul caso Moro, che in qualche misura confermano le
intuizioni del mio libro «Il Segreto». I parlamentari hanno detto che «in via
Fani c’erano anche le Brigate Rosse», lasciando intendere che altre forze
partecipavano all’operazione, e il vicepresidente del Pd e in sostanza della
Commissione, Gero Grassi, ha dichiarato: «Non abbiamo una completa ricostruzione
di quanto accaduto. Sappiamo però che tutto quello che ci avevano raccontato non
sta in piedi, non è vero». Tanto basta per spiegare che la verità venduta per 40
anni è un opportuno calmante per placare l’opinione pubblica turbata da quella
tragedia. Sapremo mai la verità? Credo proprio di no. Lo sostiene con
convinzione l’Ambasciatore Sergio Romano, illustre editorialista del Corriere, e
ritengo abbia pienamente ragione. Tutto ciò che ha circondato il caso Moro
sembra opaco, o meglio melmoso, inquinato da sospetti e manipolazioni. Si
conclude, con la terza puntata sul Corriere Tv, l’intervista ad Alberto
Franceschini, cofondatore delle Brigate rosse, dissociato dall’organizzazione e
tuttora alla ricerca di colmare i tanti buchi neri della storia del terrorismo
italiano. «Fare luce» è il suo mantra. Ecco perché si domanda il perché del
silenzio di Renato Curcio, che con lui fu protagonista della prima stagione
delle BR, quando I terroristi non uccidevano ancora; ed ecco perché ammette con
onestà la catena di errori commessi. «Con la lotta armata abbiamo favorito
quelli che volevamo combattere». Franceschini confessa le ubriacature dei miti e
della propaganda. «Ci convincevamo, studiando Lenin, che non ci fosse poi grande
differenza tra la democrazia e la dittatura. Errore mortale, che abbiamo pagato
sulla nostra pelle». Sono passati 40 anni dal delitto Moro. Ma oggi uno
spiraglio di luce s’intravede. Luce assai fioca, però meglio del buio totale. E
di questo bisogna ringraziare la Commissione Parlamentare, che ha dovuto
chiudere i lavoro con la fine della legislatura nello scorso dicembre. Le
conclusioni, approvate dal Parlamento, confermano la distanza tra verità
giudiziaria e verità storica. Ma confermano soprattutto che è stato fatto troppo
poco per avvicinarsi davvero alla verità giudiziaria. Chissà! Forse ne sapremo
qualche frammento in più fra 10 anni, per il cinquantenario.
INTERVISTA VIDEO A UNO DEI
DUE FONDATORI DELLE BRIGATE ROSSE.
Alberto Franceschini, uno dei
fondatori delle Brigate Rosse: «Sul sequestro Moro c’è una verità accettabile:
ci sono cose che non possono venir dette». Alberto Franceschini, oggi 71 anni,
ripercorre le tappe del sequestro Moro 40 anni dopo il rapimento e l’uccisione
del leader democristiano, scrive Antonio Ferrari il 17 aprile 2018 su "Il
Corriere della Sera". Metà aprile di 40 anni fa. Il presidente della Democrazia
Cristiana Aldo Moro è da un mese prigioniero delle Brigate Rosse, che il 16
marzo lo hanno rapito, dopo aver ammazzato cinque uomini armati: la scorta e
l’autista del leader politico, in via Fani, a Roma. Mentre tutti cercano (a
parole) Moro, si stanno per realizzare, in poche ore, due episodi inquietanti:
il falso comunicato brigatista, con l’annuncio che il cadavere del leader è in
fondo al lago della Duchessa (nell’entroterra), e l’indicazione casuale del covo
di via Gradoli che, come si scoprirà, era la base dei brigatisti più pericolosi,
Mario Moretti e Barbara Balzerani. Quarant’ anni sono passati, e abbiamo voluto
ripercorrere la storia delle Brigate Rosse intervistando uno dei due fondatori
del gruppo terroristico: Alberto Franceschini, reggiano, che oggi ha quasi 71
anni, e che appartiene alla squadra di coloro che si ritenevano custodi
dell’eredità dei comunisti duri e puri. L’altro fondatore delle BR è infatti il
cattolico di ultrasinistra Renato Curcio. Le due componenti si incontrarono in
un hotel ligure di Chiavari, e decisero di definire il programma. L’hotel si
chiama Stella Maris, e da quel nome nacque l’idea del simbolo con la stella a
cinque punte, le ultime due allungate. Alberto Franceschini, che non ha mai
ucciso nessuno, ha accettato di raccontare la storia e soprattutto gli errori
mostruosi e le nefandezze del gruppo terrorista, da cui si è dissociato. Ha
pagato il suo conto con la giustizia, e ora dice che sulla vicenda Moro, che
seguì dal carcere, si è cercata «una verità accettabile», perché vi erano cose
che non potevano essere dette. Il fondatore in realtà è l’unico che parla
dicendo cose concrete, mentre gli altri (tutti, compreso Curcio) o tacciono o
raccontano soltanto parte della verità confessabile, condendola di silenzi,
forse frutto di patteggiamenti, e di menzogne. Ecco perchè questo documento
audio-video, di cui trasmettiamo la prima di tre puntate, è importante. E’ stata
l’ossatura originaria dei lavori della seconda Commissione parlamentare
d’inchiesta sul delitto Moro, costretta a chiudere nel dicembre scorso per la
fine della legislatura. La Commissione ha concluso con una sentenza lapidaria:
«In via Fani c’erano anche le Brigate Rosse». Terribile sentenza!
Antonio Ferrari: Esattamente
quarant’anni fa c’è stata la strage di via Fani con il sequestro del presidente
della Democrazia Cristiana Aldo Moro e l’assassinio di 5 uomini armati: tre di
scorta e due autisti. Lei era in prigione come cofondatore delle Brigate Rosse.
Quale è stata la vostra reazione?
Alberto Franceschini: Noi
l’abbiamo appresa, ora non mi ricordo, la mattina, verso le nove, dieci, nove e
un quarto.
Antonio Ferrari: Quindi
subito?
Alberto Franceschini: Subito.
Da una radiolina che…perché nonostante, appunto, il carcere, potevamo avere
delle piccole radioline per ascoltare. Appunto, arrivò all’improvviso questa
notizia del sequestro e l’uccisione degli uomini della scorta e di Moro
sequestrato. Immediatamente, la reazione prima fu quella di quasi incredulità.
Cioè, come dire, ma forse è sbagliata, non è vero. Poi, invece, poi ci siamo
resi conto che era vera. Verissimo. Che era successo davvero questo fatto. E la
prima sensazione, appunto, fu di gelo. Cioè, nessuno di noi eravamo in tre in
cella insieme e ci guardavamo e non dicevamo nulla.
Antonio Ferrari: Gelo vuol
dire che avevate paura che lo Stato reagisse con voi?
Alberto Franceschini: avevamo
paura anche, sì avevamo certamente anche questa paura, perché, ad esempio, in
Germania rispetto ai membri della Raf che erano in carcere furono uccisi. Almeno
così fu la versione ufficiale. E quindi noi temevamo che in qualche modo ci
sarebbe stata una ritorsione nei nostri confronti. Anche perché La Malfa,
allora, aveva fatto su il fondo de “Il Corriere della Sera” un fondo dove
sosteneva che se appunto Moro veniva ucciso. Comunque se erano stati uccisi
della scorta dovevano…noi dovevamo pagare un prezzo.
Antonio Ferrari: Come si
ritiene, Franceschini, un pentito, un dissociato, uno che comprende che avete
fatto dei tragici errori, o no?
Alberto Franceschini: Vede,
potrei riconoscermi in tutti e quattro, vedendo il valore che possono avere le
singole affermazioni. Però dico la...indubbiamente, dal punto di vista
giuridico, mi riconos…sono un dissociato. Questo è…che vuol dire che facevo
parte di una associazione dalla quale mi sono separato. Dalle Brigate Rosse la
separazione, ecc.
Antonio Ferrari: Voi odiavate,
voi combattevate, persino, la nostra democrazia. Combattevate il nostro Stato.
Però mi dica questo. In fondo lo Stato democraticamente si è comportato in
maniera corretta con voi, con l’organizzazione della quale lei è cofondatore.
Però non credo che l’organizzazione con quelli che stavano fuori lei non ha mai
ucciso nessuno e questo lo so e questo va detto. Beh non avete agito di
conseguenza. Voi avete ucciso. Voi, l’organizzazione ha ucciso, mentre voi avete
pagato il vostro prezzo ma nessuno di voi vi ha toccato. Avete sbagliato ad
attaccare la democrazia? Lo dica chiaro e tondo. La prego, anche in confronto
dei giovani che l’ascoltano.
Alberto Franceschini: Intanto,
non per giustificare, ma bisogna tornare un attimo al contesto di quegli anni.
Dove c’era uno slogan determinante, che valeva per tutti, che era quello che lo
Stato si abbatte e non si cambia. Questo era lo slogan che dovevamo anche…nei
cortei. Quindi il discorso che facevamo allora, non solo come BR, ma era un
discorso più generale di quello che fu il movimento che nasce dal ’68 in avanti,
ecc., era esattamente quest’idea precisa: che bisognava organizzarci che dallo
Stato, in quanto Stato democratico, non ci sarebbe stato nessun cambiamento
importante delle cose, quindi bisognava attrezzarci per distruggerlo.
Antonio Ferrari: Francescini,
però, sostenere che lo Stato va abbattuto, è stato, credo, un gravissimo errore
e che avete pagato anche caro, o no?
Alberto Franceschini: Certo.
Per me è una contraddizione che rivivo dentro e che mi sono vissuto dentro e che
mi vivo ancora dentro. E’ proprio questa, cioè…le Brigate Rosse hanno ammazzato
l’ostaggio che loro tenevano in galera…avevano arrestato, diciamo così. Moro e
lo hanno ammazzato. Noi eravamo stati arrestati da questo Stato. Eravamo in
galera...no…però nessuno ci ha mai ammazzato. Quindi da questo punto di vista io
vivevo questa contraddizione. Fuori di dubbio che lo Stato…lo Stato democratico
si era dimostrato più generoso, ma anche più corretto dal punto di vista
politico, di quanto non lo eravamo noi.
Antonio Ferrari: Franceschi,
lei ha partecipato al sequestro del giudice Mario Sossi a Genova e Mario Sossi,
che a Genova era un personaggio molto discusso, che, però, era un magistrato di
questo Stato. L’avete tenuto prigioniero per parecchi giorni e poi lei lo ha
salvato. Perché una parte delle Brigate Rosse voleva ammazzarlo e lei disse di
no. Ecco chi era che lo voleva ammazzare e perché lei disse di no?
Alberto Franceschini: In
realtà la discussione all’interno nostro fu molto complicata. Perché da una
parte noi avevamo detto che: o liberavano…venivano liberati alcuni compagni in
galera da anni, oppure noi avremmo ammazzato Sossi. Quindi questa forma di
ricatto. Quindi se uno la doveva ragionare dal punto di vista formale,
doveva…diceva che abbiamo detto che lo uccidiamo se non liberano i compagni, se
non liberano i compagni, noi ovviamente lo uccideremo. Questa era l’impostazione
all’interno del dibattito nostro. Però, ovviamente, era complicata la cosa. Non
era sempl…almeno per me personalmente c’era anche un fattore emotivo di
ammazzare…di uccidere una persona che tu avevi tenuto…gli avevi dato da
mangiare, lo avevi quasi allevato per trentacinque giorni. Quindi non era così
facile togliere la vita…
Antonio Ferrari: Ma chi vuole
ammazzarlo davvero, chi voleva…
Alberto Franceschini: Quello
che dicevo prima. Una parte dell’organizzazione era dell’idea del fatto che
fosse fondamentale mantenere una coerenza da un punto di vista rivoluzionario.
Che poi quello, credo in qualche modo, si sia riverificato nel sequestro Moro.
Antonio Ferrari: E’ vero che
quello che premeva di più per abbattere Mario Sossi, ammazzarlo fosse un certo
Francesco Marra, che non era neanche uno dei vostri, ma era un infiltrato?
Alberto Franceschini: Sì. Lui
era uno di quelli che dicevano che andava ammazzato.
Antonio Ferrari: E chi era
questo Marra?
Alberto Franceschini: Ma…era
un pescivendolo milanese. Era un compagno…che ritenevamo immediatamente un
compagno che era entrato nell’organizzazione e poi, invece, anni e anni dopo
scoprimmo che era…scoprii io che era un uomo degli affari riservati.
Antonio Ferrari: …e quindi dei
Servizi Segreti. Franceschini, lei è l’unico, per quanto mi risulti che ha
accettato di parlare. Che parla francamente senza nascondere nulla. Come mai i
suoi compagni, anche quelli, diciamo della prima fase, quelli del nucleo storico
che hanno pagato tutti un prezzo molto pesante, giusto secondo me, a questa
società, come mai non vogliono parlare e come mai anche loro raccontano bugie?
Alberto Franceschini: Mah…c’è,
potemmo dire, una verità accettabile, oppure una verità di regime. Su tutte ste
vicende, soprattutto in particolare sul sequestro Moro ci sono stati una serie
di movimenti, diciamo così, dal punto di vista sia giudiziario, sia dal punto di
vista politico, per chiudere la partita in un certo modo. Perché, chiaramente, è
talmente deflagrante il sequestro e l’uccisione, poi, di Moro, che in qualche
modo, appunto, uno Stato democratico fa fatica ad accettare.
Antonio Ferrari: Sì certo,
però, voglio dire, con Moro si ripropone una chiave nuova esattamente come
quello che era successo con Sossi e cioè, c’erano alcuni che avrebbero voluto
chiuderla subito e lei ha detto, credo alla Commissione Parlamentare sul caso
Moro, lei ha detto in fondo noi non l’abbiamo ucciso, cioè noi…quelli che
stavano fuori, che avevano in mano Aldo Moro, non l’avevano ucciso subito,
perché il problema non era creare una vittima…era smontare psicologicamente una
persona, un uomo. Ma questo lo volevano le Brigate Rosse, secondo lei, o lo
volevano i Servizi Segreti? La Commissione stessa dice: “in via Fani c’erano,
anche, le Brigate Rosse”. Mi sembra una dichiarazione pesante.
Alberto Franceschini: Sì, la
dichiarazione è pesante perché è un’affermazione che arriva da una struttura
istituzionale come la Commissione. Ci sono alcune cose che vengono…che
vengono…che possono essere dette, quindi accettabili, ed altre cose che non
possono essere accettabili, quindi non vengono e non possono venir dette.
Antonio Ferrari: Non so…c’è un
ministro che aveva detto: “abbiamo sul tavolo determinate cose che tutti posso
più o meno sapere. Poi abbiamo altre sotto il tavolo che è bene non si sappiano
mai. Che cos’è che non si deve sapere mai Franceschini? Qual è il grande
segreto? L’eterodirezione delle Brigate Rosse, cioè le Brigate Rosse che
prendevano ordini da fuori come mi sembra che lei stia sospettando, oppure c’è
qualcos’altro? Complicità all’interno dello Stato? O cose di questo genere? Lei
in sintesi come la vede?
Alberto Franceschini: La vedo
che, certamente, ci sono state una serie, forse, di complicità o forse di mosse
giocate sulla scacchiera, diciamo, dei sequestri, di tutte le sue conseguenze.
Indubbiamente c’era chi spingeva affinchè l’ipotesi dell’uccisione fosse
realizzata o comunque si opponeva alla liberazione per varie motivazioni. Altre
situazioni, invece, che, in qualche modo, cercavano di salvare Moro. Per esempio
tutta la sinistra democristiana, gli amici di Moro che però, la stessa parte…
un’altra parte, per questo il gioco è complesso, un’altra parte della DC,
ovviamente, non voleva che questa parte, la sinistra democristiana, raggiungesse
l’obbiettivo: la liberazione di Moro. Per cui ci sono state certamente una serie
di interventi. Per esempio la…da cui sono documentati, come un americano
“Pisnick”, che lui stesso dichiara, un anno fa, poco tempo fa, ha dichiarato che
era stato mandato dagli Stati Uniti, richiesto da Cossiga, allora Ministro degli
Interni, e il suo compito era che Moro fosse ucciso o che Moro non doveva
salvarsi.
Antonio Ferrari: Ma secondo
lei, Franceschini, Moro era condannato a morte nel momento in cui viene rapito
oppure viene deciso dopo di condannarlo a morte?
Alberto Franceschini: Io ho il
sospetto che era condannato a morte sin dall’inizio, che difficilmente
sarebbe…avrebbe dovuto salvarsi, anche se lui ha fatto di tutto…è stato un abile
politico nel difendersi, nel cercare di salvarsi. E’ stato bravissimo da questo
punto di vista. Però non poteva purtroppo vincere la partita perché c’erano
forze ben più importanti che…
Antonio Ferrari: Italiani o
internazionali?
Alberto Franceschini: Italiani
e internazionali, che non tanto si ponevano…volevano eliminare Moro, anche
questo, ma volevano soprattutto eliminare Moro, non tanto…non semplicemente
fisicamente, ma come progetto politico. Ciò che andava distrutto, in qualche
modo, era l’impianto generale di Moro. Quindi bisognava distruggere la persona
di Moro. Se Moro fosse uscito vivo dalla situazione, lui sarebbe stato un
problema: sia per quelli che lo volevano morto, sia per quelli che, invece, lo
volevano vivo.
Antonio Ferrari:
Lei...facciamo un’ipotesi per fortuna realistica. Immaginiamo che lei fosse
ancora, durante il caso Moro, il responsabile politico delle Brigate Rosse, lei
cosa avrebbe fatto: lo avrebbe liberato o lo avrebbe ucciso, avrebbe accettato
di ucciderlo, lei che non ha mai ucciso nessuno?
Alberto Franceschini: Se devo
dire una follia pura, lo avrei proprio portato in Parlamento. Cioè l’avrei
portato nei pressi…con tutti i brigatisti dietro, di modo che la partita si
chiude e vediamo di trovare una soluzione politica in tutte le vicende del
terrorismo di quegli anni.
Antonio Ferrari: Un sogno…
Alberto Franceschini: Sì, un
assoluto sogno…
Antonio Ferrari: Quindi come
Brigate Rosse avete fallito.
Alberto Franceschini:
Assolutamente. Certo gli obbiettivi che noi avevamo come punto di partenza si
sono dimostrati assolutamente sbagliati!
INTERVISTA AD ALBERTO
FRANCESCHINI, CO-FONDATORE E CAPO STORICO DELLE BRIGATE ROSSE
di giovedì 27 settembre 2007 di Massimiliano Vitelli su "Les Enfants Terribles"
e postato da René Querin.
Prima domanda, semplice. Chi è
Alberto Franceschini oggi?
La domanda è semplice, la
risposta è difficile. Alberto Franceschini oggi spero sia una persona normale.
Ecco, diciamo che la mia più grande ambizione oggi è essere una persona normale.
Si sente un po’ un miracolato?
Una persona a cui la vita ha dato una seconda possibilità?
Si. Diciamo che può essere
paradossale dire che mi sento fortunato. Però è così, nel senso che avrei
potuto, in quegli anni, subire ferite gravissime, morire. In realtà ne sono
uscito tutto sommato abbastanza integro quindi, certamente, posso dire di si.
Le Brigate Rosse nascono da
un’ideologia. Questa ideologia, con il tempo, quanto ha influito con la scelta
del passaggio alla lotta armata?
L’ideologia delle Brigate
Rosse ha una sua storia. L’ho scritto anche in diverse occasioni, il discorso
della resistenza tradita, la storia del filo rosso. Nel libro Mara Renato ed
io questo discorso viene sviluppato in maniera abbastanza esauriente. Posso dire
che questo tipo di cultura, che viene dalla resistenza, dalla lotta armata
contro il fascismo ed il nazismo, per certi aspetti si pensava non dovesse
terminare come in effetti è terminata. Probabilmente non si sarebbe trasformata
in attività pratica se non ci fosse stata la rottura storica rappresentata dal
sessantotto/sessantanove. Quegli anni erano anni che hanno rimesso in
discussione qualunque cosa.
L’utopia, quindi il
raggiungimento di un obiettivo considerato personalmente giusto, può travalicare
i mezzi per raggiungerlo? Il fine giustifica i mezzi? O almeno, per voi li
giustificava?
All’epoca si, per noi li
giustificava. Il fine giustificava i mezzi. Adesso sono assolutamente convinto
invece che i mezzi sono i fini. Non puoi separare una certa finalità da un certo
mezzo. Se tu pensi che il mondo, il mondo del futuro deve essere un posto di
pace non puoi tentare di realizzarlo usando strumenti di guerra.
Quindi la sua opinione adesso
è maturata in maniera diversa?
Si, assolutamente.
Il suo salto nella
clandestinità e nella lotta armata possono avere avuto, in parte, una spinta dal
conflitto generazionale? Suo padre avrebbe preferito che lei restasse nel P.C.
per combatterlo dall’interno…
Si. Certamente c’è stato anche
un conflitto generazionale che però è un conflitto caratteristico di quegli
anni. Una delle chiavi di lettura del sessantotto è anche questo. La rivolta dei
figli contro i padri.
Suo nonno era di un’idea più
vicina alla sua, c’è stato il famoso salto di generazione?
Esatto. Ma quella credo sia
una caratteristica dello sviluppo umano…
Avete mai pensato, durante gli
anni di piombo, che stavate facendo qualcosa che era più grande di voi?
Si. Questa è la sensazione che
abbiamo avuto da un certo momento in poi. Soprattutto dal sequestro
del magistrato Sossi. Lì ci siamo resi conto che, da come reagivano i giornali,
da tutta una serie di elementi, da come si era mosso lo Stato nei nostri
confronti, eravamo diventati un soggetto importante, pesante. Questo
personalmente mi produceva dei problemi. Perché, potrà apparire anche strano
ora, l’inizio per noi è stato abbastanza ludico, uso questa parola. Un inizio
dove non ci sono fatti di sangue…
Poi gli eventi hanno preso un
po’ la mano sulle vostre azioni/intenzioni?
Si, in un certo senso. Ad un
certo punto gli eventi ti trascinano…come un sasso.
C’era più in voi un senso di
gratificazione, quello di riuscire a muovere degli elementi così importanti, o
più un senso di timore, la paura di stare andando “oltre”?
Beh… l’elemento di
gratificazione era forte perché altrimenti avremmo lasciato stare subito. Ad
esempio, durante il sequestro del magistrato Sossi la televisione parlava non
tanto di noi come persone ma dei fatti che noi compivamo. Chiaramente questo
tipo di dimensione è indubbio che ci gratificasse, nel senso che ci faceva
ritenere allo stesso livello, alla stessa altezza, di chi comandava il Paese.
Eravamo il “contro potere”.
Quando le capita adesso di
sentir parlare delle B.R. cosa pensa? Quali sono i suoi sentimenti?
In realtà il mio sentire è
contraddittorio. Da una parte c’è certamente un tentativo di allontanarmi ma,
contemporaneamente, dall’altra mi sento anche una grande responsabilità sulle
spalle. Una responsabilità a cui non mi posso sottrarre.
C’è qualcosa nelle ultime B.R.
che riprende un po’ le vostre idee?
Per quello che ho visto
leggendo dai giornali, perché le informazioni sono tutte mediate dai giornali,
io non ci vedo molto di simile, quasi nulla. Anche perché il mondo è talmente
cambiato negli ultimi 30/40 anni che veramente non ha nessun senso rifarsi ad
una esperienza così vecchia, ormai datata, come la nostra.
E nelle B.R. degli omicidi
Biagi e D’Antona?
Assolutamente no. Dal punto di
vista politico c’è una distanza abissale rispetto al nostro modo di agire.
Tutti questi “no” portano
dritti ad una domanda. Si sente un po’ defraudato, essendone stato l’ideatore,
di quel simbolo e di quel nome?
In parte si. Infatti,
scherzando, tante volte dico che se noi, io e Renato (Curcio), avessimo
depositato il marchio a questo punto saremmo ricchissimi. Seriamente, invece, il
vero problema è che ora viene usato in un modo totalmente diverso da quello che
noi, all’epoca, credevamo giusto.
Sequestro Moro. Lo Stato cosa
avrebbe dovuto ammettere o concedere per farvi ritenere soddisfatti e salvare la
vita di Aldo Moro?
Questa è una domanda a cui non
è semplice rispondere. È il punto centrale di tutta la gestione del sequestro.
Probabilmente se lo Stato avesse liberato qualcuno,… qualcuno che era malato,
non posso oggi garantire che questo avrebbe potuto salvare Moro, ma certamente
avrebbe messo in grave difficoltà chi gestiva il caso. Era questa infatti,
secondo me, l’unica possibilità che avrebbe potuto salvare la vita di Aldo Moro.
Cosa ha pensato quando ha
saputo della notizia della sua uccisione?
Ce l’aspettavamo. Visto da una
parte l’atteggiamento dei due grandi partiti politici dell’epoca, D.C. e P.C.,
di chiusura netta e dall’altra l’incapacità dei nostri compagni fuori di rompere
questo muro così potente che si era creato. Era inevitabile che si giungesse
purtroppo a quell’evento.
Secondo lei è uscita tutta la
verità o ci sono ancora delle zone d’ombra?
Di zone d’ombra ce ne sono
tantissime. Sono state fatte diverse commissioni parlamentari, ed anche in
queste, ci sono zone d’ombra. Appaiono delle inadempienze dello Stato che sono
gravissime ed è impossibile accettare che ci fosse uno Stato così inefficiente.
Questo porta a pensare che più che di inefficienza dello Stato, c’era
un’inefficienza “voluta” e come tale, di fatto, una complicità.
Il caso Moro gestito da Mario
Moretti. Nel vostro arresto, suo e di Renato Curcio, la posizione di Moretti è
un po’ al limite…
Si. C’è questa ambiguità del
suo comportamento che può essere giustificato, non necessariamente con una
volontà di non aiutarci scappare, a sottrarci all’arresto, ma con una sua
sostanziale incapacità in certe situazioni.
Poi però Moretti diventa il
capo delle Brigate Rosse…
Si. Certo, la cosa fa un po’
pensare. Ci sono tutta una serie di arresti, che avvengono nel giro di un anno e
mezzo, l’uccisione di Mara, il secondo arresto di Renato, che di fatto portano a
far si che le Brigate Rosse finiscano nelle mani di Moretti che, di fatto, è il
personaggio più importante rimasto fuori. Oltretutto lui da questi arresti si
salva spesso per il rotto della cuffia, da ricostruzioni fatte dai carabinieri e
da lui stesso. Quindi resta il dubbio che, in qualche modo, qualcuno lo abbia
favorito. Indipendentemente poi dal fatto che lui ne fosse a consapevole o meno.
All’epoca, com’erano i vostri
rapporti con le altre organizzazioni europee di estrema sinistra, in particolare
la Raf di Baader e della Meinhof?
Con la Baader-Meinhof i nostri
rapporti si interrompono nel 1972 quando vengono arrestati. Noi, i rapporti più
stretti con i movimenti tedeschi, almeno fino al mio arresto, li tenevamo con un
gruppo di Berlino, un gruppo che attuò il sequestro di un dirigente
democristiano tedesco, Lorenz. Era un gruppo meno militarista di quanto fosse la
Raf. Più simile a noi.
In quegli anni, in Italia, da
una parte c’eravate voi, dall’altra c’erano i N.A.R., Valerio Fioravanti. Qual
era la vostra idea sulle posizioni “al di la del fiume”?
Noi ritenevamo che la destra
fosse strettamente legata a doppio filo a settori dello Stato, del potere. Il
famoso discorso della strategia del colpo di Stato. In particolare questi
gruppi, Ordine Nero, Ordine Nuovo, erano assolutamente funzionali a questo
progetto. Al progetto delle forze armate in particolare che cercavano una
soluzione, come si diceva allora, alla greca o alla cilena della crisi italiana.
Questa, mi sembra, fosse la funzione di questi gruppi.
Quindi non avete mai pensato
all’estrema destra, come ad un possibile alleato contro lo Stato?
Assolutamente no. Proprio
perché la pensavamo come complice dello Stato.
Attualità. Come ha vissuto il
cambiamento del nome del P.C.? Da P.C. a P.D.S. a D.S. ed a breve, Partito
Democratico. Vede un po’ il compimento della teoria berlingueriana?
Certamente. Era indubbio che i
partiti comunisti con la crisi dell’Unione Sovietica, con il crollo del muro di
Berlino, implodessero. Diciamo che l’intelligenza politica di Berlinguer e dei
comunisti italiani è stata quella di prevederlo, di capire che il mondo
cosiddetto orientale era in crisi fortissima e quindi di cercare in qualche modo
di costruirsi un’alternativa. Per cui quando c’è stato il crollo del muro di
Berlino all’interno del Partito Comunista c’era già un gruppo dirigente che
cercava nuove strade.
Com’erano i rapporti tra B.R.
e P.C.?
Era un rapporto conflittuale
perché una parte del P.C., minoritaria, in qualche modo ci era vicina mentre la
parte maggioritaria, quella che noi chiamavamo berlingueriana, non voleva
modificare più di tanto lo Stato. Quello Stato.e le sue regole democratiche gli
andavano bene.
Per chiudere, come si sente
oggi nei confronti della lotta armata?
Assolutamente estraneo. Mi
sembra poi che chi pensa di fare la lotta armata oggi sia così fuori dal
mondo…Viviamo in un’epoca talmente diversa che, di quell’esperienza, di quegli
anni nostri, si può parlare solo in termini di ricordi storici.
C’è qualcosa che
invidia Alberto Franceschini oggi all’Alberto Franceschini degli inizi?
Beh… posso invidiare il fatto
che allora avevo 20 anni oggi ne ho 60. Ma, tutto sommato, come si diceva
all’inizio mi ritengo fortunato e quindi... non ho niente da invidiare.
E l’Alberto Franceschini di 20
anni invidierebbe qualcosa a quello di oggi?
Non lo so. Tante volte mi sono
posto le domande: “Se il 68 fosse venuto un anno o due dopo? Se io fossi nato
leggermente prima? Sarebbe bastato forse un anno prima…Probabilmente mi sarei
laureato, avrei fatto l’ingegnere, me ne sarei andato in giro per il
mondo…Probabilmente avrei fatto tutta un’altra vita.
Caso Moro, l'ex br
Franceschini: "Moretti una spia? Riduttivo, si sentiva Lenin".
Il fondatore br alla Commissione Moro: "Hyperion 'parlamento' degli 007
internazionali". "Dalla Chiesa fu fermato a un passo dalla sconfitta dei
brigatisti". "All'Asinara temevamo di essere uccisi". Fioroni: "Strano il salto
di capacità militare e culturale dopo il suo arresto", scrive Alberto Custodero
il 27 ottobre 2016 su “La Repubblica”. "Spia? Una definizione troppo riduttiva
per Mario Moretti. Io sono convinto che abbia giocato le sue carte in un certo
modo, c'è un livello psicologico da tenere presente, lui crede di essere Lenin,
lui era per alcuni compromessi su cui io non ero d'accordo". In tre ore di
audizione, Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse che fece
poi autocritica, autore, tra l'altro, del libro "Mara, Renato e io" di Franco
Giustolisi e Pier Vittorio Buffa (in carcere all'Asinara durante il caso Moro),
parla così dell'ex tecnico della Sit-Siemens a capo delle Br che hanno gestito
il sequestro dello statista democristiano. La sua audizione lascia agli atti
della Commissione parlamentare d'inchiesta Moro presieduta da Giuseppe
Fioroni nuovi dubbi su Hyperion, la scuola di lingue francese fondata
da Simioni, Berio e Mulinaris, dopo la rottura con le Br, nella prima metà degli
anni '70. Franceschini avverte: "I dietrologismi non mi interessano, io faccio
una critica politica a Moretti, deve ancora giustificare il fatto che ha
distrutto un'ipotesi politica, in base a una linea politica sballata". "Senza
copertura dei servizi esteri si regge la storia dei 55 giorni?", gli chiedono i
parlamentari della Commissione. "Sono pensieri che ho, ma è importante la
riflessione politica della nostra esperienza", risponde. L'ipotesi che ci
fossero altri personaggi, rispetto a quelli conosciuti e processati, a gestire
l'operazione militare di via Fani e, soprattutto, l'interrogatorio di Aldo Moro,
durante i 55 giorni resta forte. Franceschini, in particolare, ricorda come
seppe dal generale Inzerilli, uomo di Gladio, del "ruolo chiave che
svolgeva Hyperion, (scuola fondata da brigatisti fuoriusciti a Parigi, nel
'77, ndr) una specie di parlamento degli 007, che poneva ai palestinesi le
regole dei servizi internazionali, dai francesi ai tedeschi". Poi un riferimento
al Mossad: "Gli israeliani ci cercarono chiedendoci cosa ci servisse, 'a noi
interessa che voi ci siate, non vogliamo indicare obiettivi, ci dissero. Ma noi
rifiutammo". "I servizi potrebbero aver condizionato il supercla - sottolinea il
fondatore delle Br -. Noi nel '76 siamo finiti, a seguito delle operazioni del
generale Dalla Chiesa. Ma va rilevato come proprio a Dalla Chiesa" a un passo
dalla sconfitta definitiva del brigatismo "gli tolgono il gruppo speciale. Nel
giugno del '76 viene sciolto quel gruppo che teneva insieme magistratura,
intelligence e carabinieri e dava fastidio a tanta gente". "Dal '76 al '78-79
non avviene un arresto. Poi Dalla Chiesa viene richiamato in servizio da
Rognoni, da ottobre del '78 e in due mesi riarresta un sacco di gente. Il
generale non 'chiuse gli infiltrati nel periodo in cui era stato estromesso,
evidentemente", dice ancora Franceschini. Parlando del fondatore di Hyperion,
Corrado Simioni, Franceschini dice che "era personaggio interessante
intellettualmente, uno degli esponenti di punta del Psi a Milano, espulso per
indegnità morale, amico di Craxi. Per anni a Monaco di Baviera a lavorare a
radio libertà, con noi parlava in latino". "Nel '68 aveva fondato comitati di
base del giornalismo, girava il movimento proponendo di fare un quotidiano del
movimento - ricorda Franceschini - facendo capire che i soldi li aveva. Loro
erano borghesi, rampolli della borghesia di destra e sinistra, noi venivamo
dalle fabbriche, invece". Franceschini ricorda ancora come "alcuni di loro
giravano con tesserini delle questure locali e se venivano fermati non avevano
problemi". Il fondatore delle Br dice poi che loro sapevano "degli strani
rapporti di Corrado, lui diceva per esempio che aveva soldi in banca nella
Grecia dei colonnelli, per fare la rivoluzione dovete fare compromessi, ci
diceva". "Nel novembre del '70 ci fu la rottura con noi - aggiunge Franceschini
- lui e altri scomparvero" creando una rete, la Dip, diffusione italiana
periodici, che si occupava di giornali della polizia. "Dopo la rottura con lui
andarono Ivan Maletti, Prospero Gallinari e tanti altri". Franceschini ricorda
che dopo la morte di Feltrinelli "rimaniamo come gattini ciechi, perché lui
gestiva i rapporti con l'esterno. Ci saltarono le relazioni, mentre i rapporti
ora li coltivavano Simioni e gli altri di Hyperion". E si torna a Moretti, che
inizialmente andò con Simioni: "Lui e Corrado avevano rapporto anche
conflittuale, ma Simioni lo stimava capace, penso fosse un suo uomo". Altro
episodio oscuro l'arresto di Curcio e Franceschini l'8 settembre del '74. "Il
giovedì arrivò una telefonata che avvertiva dell'imminente arresto di Curcio,
organizzato per domenica. Levati avverte Moretti, che da giovedì a domenica, non
avverte della soffiata, bastava piazzarsi lì vicino e fermare la nostra macchina
- sottolinea Franceschini - E lui non l'ha fatto". Franceschini poi parla di
Valerio Morucci e di Giovanni Senzani. Per il primo, che disse che sapeva come
Franceschini lo volesse morto dice: "A Nuoro abbiamo fatto insieme la rivolta in
carcere, se volevamo ucciderlo era l'occasione e non l'abbiamo fatto. Sa che le
ha fatto sporche e teme sempre vendette, rispetto alla verità le sue
affermazioni sono sempre molto 'complesse'". Loro cattura, con Faranda nel '79,
una autoconsegna? "Morucci fuggì con 80 milioni delle br romane, lui temeva per
la sua vita, nessuno di noi ha mai rubato".
"Altro personaggio
interessante è Senzani - dice parlando del criminologo forlivese - che per me
era un perfetto sconosciuto, viene 'immesso nelle Br, sono personaggi che fanno
riferimento a certe reti". Sulla vicenda della trattativa per la liberazione di
Moro, Franceschini spiega come "noi eravamo per la trattativa, Renato
(Curcio, ndr) per tenersi fuori, ma sapevamo che se ammazzavano Moro avrebbero
ucciso anche noi in carcere, per questo ruotavamo in cella con Curcio, poiché
per noi era il primo che avrebbe fatto quella fine". Franceschini ricorda come
fu lo stesso Ugo la Malfa a dichiarare che 'se Moro moriva, sarebbe giusto fare
come i tedeschi Stammheim (con alcuni dei capi della Raf, trovati sucidati in
carcere, il giorno dopo l'assassinio del presidente degli industriali tedeschi
Hanns-Martin Schleyer, ndr). "Noi volevamo la chiusura dell'Asinara, come punto
di partenza per trattare la liberazione. Volevamo lo stesso schema del sequestro
Sossi, che per noi era stata una vittoria politica", spiega Franceschini a San
Macuto. Sulla dinamica di Via Fani restano i dubbi: "Per fare operazione Sossi,
che era senza scorta e viaggiava da solo, impiegammo 18 compagni. A via Fani
erano in nove, come dice Morucci, di cui 4 sparatori, affrontarono una scorta
che non credo fosse incapace di difendere Moro. Allora ci si domanda come hanno
fatto? I compagni mi dissero 'l'abbiamo fatta noi, addestrandoci nel cortile di
casa, diceva Gallinari". Il commento di Fioroni. "Sottolineo il richiamo di
Franceschini a non semplificare la complessità del fenomeno eversivo di cui fu
fondatore - ha commentato il presidente della Commissione, Fioroni - ma ad
osservarlo all’interno del contesto geo-politico che ne ha influenzato le
scelte. Inoltre, trovo utili le riflessioni sull’utilizzo degli infiltrati e sul
ruolo del gruppo Hyperion, come l’analisi sulla rapida trasformazione del gruppo
brigatista che, nel volgere di pochi anni, dal '74, anno dell’arresto di
Franceschini, al ’78, acquisisce una sorprendente capacità militare ed anche
culturale, se si pensa agli interrogatori cui fu sottoposto Aldo Moro.
Franceschini ci fa capire esplicitamente che le persone che aveva conosciuto
durante la sua militanza, in sostanza, non avevano quei livelli di operatività”.
I dubbi di Grassi. "Di estremo
interesse - sottolinea Gero Grassi, componente della Commissione - il racconto
della nascita del gruppo brigatista e il passaggio oscuro alla gestione
morettiana. Resta una domanda che certamente non può essere rivolta a lui:
perchè gli toccò scontare 18 anni di galera, 21 a Renato Curcio? Erano accusati
di banda armata, non avevano reati di sangue. I brigatisti condannati come
responsabili dell'uccisione di Aldo Moro e della strage di via Fani se la sono
cavata con molto meno". Il parere dello storico. "Non mi sembra che Franceschini
faccia rivelazioni inedite - è il parere dello storico Federico Imperato, autore
di due libri su Aldo Moro, ricercatore in Storia delle Relazioni e delle
Organizzazioni Internazionali - Di Hyperion, Franceschini aveva già parlato in
una audizione in Commissione stragi, nel 1999. Hyperion era ufficialmente una
scuola di lingue a Parigi, in realtà un centro di collegamento tra gruppi del
terrorismo internazionale, ritenuta in contatto anche con i servizi segreti.
Hyperion fu fondata nel 1970 da tre esponenti della sinistra extraparlamentare
italiana: Corrado Simioni, Vanni Mulinaris e Duccio Berio. I tre ebbero un ruolo
agli albori della storia delle Br. Parteciparono, infatti, nel 1969, ad un
convegno del Collettivo Politico Metropolitano, che decise il passaggio alla
lotta armata e la nascita ufficiale delle Brigate Rosse. Secondo Franceschini,
Simioni, Mulinaris e Berio, staccatisi dalle Br, fondarono prima il Superclan,
di cui avrebbero fatto parte Mario Moretti e Prospero Gallinari, e poi, nel
1970, in Francia, l'Hyperion. Secondo Franceschini, ancora, il padre di Berio
era un famoso medico milanese, legato ai servizi israeliani. "Il nome di Simioni
fatto da Craxi". "Corrado Simioni - spiega Imperato - è un personaggio
interessante. Il suo nome viene fatto per la prima volta da Craxi a
Montecitorio, forse nel 1980: "Non cercate i terroristi sulla luna, guardatevi
intorno, magari tra i vostri compagni di scuola". E ancora: "Quando si parla del
"Grande Vecchio" bisognerebbe riandare indietro con la memoria, pensare a quei
personaggi che avevano cominciato a far politica con noi e che poi
improvvisamente sono scomparsi". Simioni, infatti, aveva militato, negli anni
Cinquanta e Sessanta, nel Psi, faceva parte della corrente autonomista, ed era
in stretti rapporti di collaborazione con Craxi e Silvano Larini. Poi viene
espulso dal Psi, nel 1965; si trasferisce a Monaco di Baviera, dove collabora
con Radio Free Europe. Quindi il ritorno in Italia e l'impegno nella sinistra
extraparlamentare di cui ho già detto. In quegli ambienti, tuttavia, inizia
presto a farsi la fama di doppiogiochista. Secondo Lotta Continua è un
confidente della polizia, mentre in una scheda ritrovata nell'archivio segreto
di Avanguardia operaia si legge: 'Entra tra i primi in clandestinità anche se
all'epoca non ha alcun mandato di cattura a suo carico (...) era un pezzo grosso
a livello di Curcio. Espulso come poliziotto, probabilmente è del Sid. Secondo
Dalla Chiesa 'È un'intelligenza a monte delle Brigate Rosse'".
"Senzani gestì la regia del
sequestro". "Anche Giovanni Senzani è un personaggio interessante - continua
Imperato - . Criminologo, docente dell'Università di Firenze. Secondo Giovanni
Pellegrino sarebbe stato lui, da Firenze, a gestire la regia politica dei 55
giorni del rapimento Moro. Pellegrino cita anche documenti che confermerebbero i
legami tra Senzani e apparati di sicurezza italiani e stranieri. In particolare,
un documento, anonimo, quindi inutilizzabile nel corso delle indagini,
consegnato dal generale Lee Winter al giornalista Ennio Remondino, secondo cui
la stazione di Roma (della Cia, ndr) ha dato assicurazione al Sops (Special
Operation Planning Staff) che il nuovo collegamento con Parigi, Giovanni
Senzani, è sotto contratto. Probabilmente a lui si riferisce Morucci, in
Commissione Stragi, quando accenna agli irregolari: Bisogna chiedersi se c'era
un anfitrione o no, chi era il padrone di casa, chi era l'irregolare, chi
batteva a macchina i comunicati del comitato esecutivo, che poi erano
distribuiti in tutta Italia, sul caso Moro. Certo, ritengo che siano cose che
non cambino radicalmente la questione, ma penso che andrebbero dette".
I misteri infiniti delle
Br. Davanti
alla Commissione d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro il
fondatore delle Brigate Rosse, Alberto Franceschini, parla della scuola di
lingue Hyperion di Parigi, del rapporto tra gruppo storico e morettiani e delle
figure di Valerio Morucci e Giovanni Senzani, scrive Salvatore Ventruto il 23
febbraio 2017 su "Lintellettualedissidente.it". Quando un componente
della Commissione d’inchiesta sul caso Moro gli chiede quale sia stato il motivo
che nel 1972 portò le Brigate Rosse a respingere la richiesta di adesione di
Valerio Morucci, a quei tempi esponente di spicco di Potere Operaio, Alberto
Franceschini non lascia molto spazio alla fantasia: “C’erano vari motivi. Il
primo è che a me e altri Morucci non piaceva. Il secondo è che Morucci faceva
traffico di armi tra la Svizzera e l’Italia, armi che poi distribuiva al
movimento. Fu scoperto, insieme a un altro o ad altre due persone. Sta di fatto
che uno o due di loro si fecero sei mesi di galera, Morucci sì e no venti giorni
e uscì”.
E’ un Franceschini
collaborativo quello che un paio di settimane fa si è approcciato di nuovo con i
commissari, dopo l’audizione dello scorso 27 ottobre. Ancora una volta ha
evidenziato come le BR, per lui che le aveva fondate, fossero finite già nel
1976, quando il capo incontrastato era Mario Moretti. Cresciuto in una famiglia
comunista, con il padre e il nonno protagonisti della Resistenza antifascista,
Franceschini ha sempre sostenuto nei suoi libri, interviste e incontri che la
militanza brigatista fosse per lui il naturale seguito della lotta partigiana.
Arrestato nel 1974 a Pinerolo mentre era in macchina con Renato Curcio, altro
esponente di spicco del gruppo storico brigatista, Franceschini ha rappresentato
tra la fine degli anni novanta e gli inizi del nuovo secolo colui che più di
ogni altro ha affrontato alcuni elementi poco chiari o del tutto sconosciuti
del brigatismo italiano e del sequestro Moro.
Alberto Franceschini,
fondatore delle Brigate Rosse assieme a Renato Curcio. Viene arrestato nel 1974
a Pinerolo. In alcuni suoi libri, ad esempio “Che cosa sono le BR”, affronta e
approfondisce alcuni elementi ancora oscuri sulla nascita delle BR e il
sequestro Moro. Recentemente alla domanda se esistesse o meno un piano di messa
in sicurezza delle Brigate Rosse ha risposto: “Mi verrebbe da dire l’Hyperion”.
Il “ragazzo dell’appartamento”, ha fatto dimenticare ai commissari i mi avvalgo
della facoltà di non rispondere e i non gradisco che avevano caratterizzato,
qualche settimana prima, la testimonianza di Valerio Morucci, ex leader della
colonna romana delle BR, protagonista dell’azione militare che portò la mattina
del 16 marzo 1978 al rapimento di Moro in via Fani. Personaggio particolare
Morucci, da maneggiare con estrema cura. Prima responsabile del servizio
d’ordine di Potere Operaio, poi brigatista dal 1976. Partecipò all’agguato di
via Fani, ma fu, secondo le ricostruzioni ufficiali, contrario assieme ad
Adriana Faranda, sua compagna, all’esecuzione di Aldo Moro, incarnando quell’ala
“trattativista” che sarebbe diventata interlocutrice degli “autonomi” Lanfranco
Pace e Franco Piperno nell’ambito dei ripetuti tentativi messi in atto dal
Partito Socialista per salvare il Presidente della DC. Sul suo famoso
“Memoriale” di 300 pagine, poi clamorosamente sconfessato dalle ultime indagini
e da più approfonditi riscontri, si è basata per anni la ricostruzione
dettagliata dell’operazione militare che portò al rapimento di Moro e
all’uccisione della sua scorta. Rimane ancora un mistero la telefonata che
Morucci fece la mattina del 9 maggio 1978 alle ore 12.15 a Francesco Tritto,
stretto collaboratore di Moro, per annunciare la morte del Presidente della
DC. Ancor più alla luce di quanto è stato riscontrato dall’attuale commissione
d’inchiesta e cioè che Francesco Cossiga, allora Ministro dell’Interno,
ricevette già alle ore 11 la telefonata del Prefetto di Roma che annunciava la
morte di Moro. Perché Morucci telefona un’ora e quindici minuti dopo il
Prefetto? Quella telefonata può essere considerata come un depistaggio che
sancisce l’inizio della collaborazione di Morucci con lo Stato, al punto da far
redigere a quest’ultimo un falso memoriale sull’agguato di via Fani?
Quando Morucci, dopo la morte
di Moro, esce assieme alla Faranda dalle BR, decide di portarsi via tutte le
armi che aveva portato all’interno del gruppo: mitra, munizioni, pistole
rinvenute il 29 maggio 1979, giorno del loro arresto, nell’appartamento di Viale
Giulio Cesare, 47. In quell’appartamento viene trovato anche un elenco di 90
brigatisti e anarchici. Alla domanda del Presidente Fioroni se i due volessero
vendere l’elenco “per fare la stessa fine di Casimirri” (ultimo grande latitante
dell’operazione Moro, da 30 anni in Nicaragua), Franceschini dice: “può essere,
anche se non conosco esattamente gli atti”. Comincia nel 1982 al Foro Italico il
processo per l’assassinio di Aldo Moro e della sua scorta. Nella foto, due dei
maggiori imputati, Valerio Morucci e Adriana Faranda. “Solo a Giovanni Senzani –
continua Franceschini – ritrovarono un elenco di nomi all’interno di un panino
mentre era detenuto nel carcere di Rebibbia. Quel panino e quell’elenco furono
intercettati e molti compagni furono arrestati”- aggiunge, precisando come anche
Senzani, leader del comitato rivoluzionario toscano delle BR, sia stato per lui
una figura difficile da capire. Senzani fu oggetto di un dossier da parte della
Commissione Stragi presieduta negli anni ‘90 dal Senatore Giovanni Pellegrino in
cui si precisava che la sua figura “potrebbe aver avuto un coinvolgimento pieno
e determinante nella vicenda Moro, non solo attraverso l’organizzazione a
Firenze delle riunioni del comitato esecutivo delle BR durante i 55 giorni del
rapimento, ma anche svolgendo, grazie alla sua statura intellettuale e alla
grande esperienza politica e giuridica, il ruolo di grande inquisitore nel corso
delle controverse fasi del processo al quale venne sottoposto lo stesso Moro”.
Giovanni Senzani. Negli anni
’70 insegna all’Università di Firenze ed è consulente del Ministero della
Giustizia. Contemporaneamente fa parte della direzione strategica delle Brigate
Rosse. Dopo 23 anni di carcere non si è mai pentito. Dopo aver confermato che
“l’attenzione sulle Brigate Rosse da parte dello Stato è sin dalla nascita”,
Franceschini ha parlato anche di Corrado Simioni e del ruolo ambiguo di
Hyperion, la scuola di lingue fondata a Parigi nel 1976 dallo stesso Simioni,
Duccio Berio e Vanni Mulinaris. Nel 1970 i tre si “staccarono” dal gruppo
originario di Sinistra Proletaria, che poco dopo avrebbe dato vita alle Brigate
Rosse, e formarono il Superclan. Quando i commissari gli chiedono di fare
un’analisi storica della figura ambigua di Simioni e della scuola parigina,
capace di aprire due sedi di rappresentanza a Roma nelle settimane del sequestro
Moro e rivelatasi successivamente una centrale del terrorismo internazionale
infiltrata dai servizi segreti di tutto il mondo, Franceschini è come se
ammettesse la “sconfitta” del gruppo storico. “Se devo fare una riflessione
onesta e sincera – dice – è che noi abbiamo sbagliato tutto e loro hanno capito
tutto. Chi andò a Parigi, chi stabilì certe relazioni, certi rapporti aveva
capito una serie di cose”. All’Hyperion e ai personaggi che le ruotavano
attorno, che secondo Franceschini “operarono a livello geopolitico alto,
utilizzando i residui della politica bassa”, sono legati gran parte dei misteri
ancora irrisolti della galassia brigatista. Fu il giudice istruttore del
Tribunale di Venezia Carlo Mastelloni ad azzardare per primo, nel 1984,
l’ipotesi che l’Hyperion avesse avuto un ruolo di mediazione nelle forniture di
armi che l’Olp garantì ai brigatisti. Oggi, dopo più di trent’anni, i rapporti
tra le BR e le organizzazioni palestinesi tornano sotto la lente d’ingrandimento
del caso Moro, grazie a una lettera che il 21 giugno 1978 il colonnello Stefano
Giovannone scrisse da Beirut. Nella missiva, l’ex ufficiale del Sismi, di stanza
in Libano, riferiva della possibile consegna, da parte delle Brigate Rosse, al
leader palestinese George Habbash di una parte dei verbali degli interrogatori
subiti dal Presidente DC durante la prigionia, al fine di ristabilire il
rapporto di collaborazione interrotto da due anni. Un documento, quindi, che
farebbe presagire relazioni tra le Brigate Rosse e palestinesi anche prima
dell’operazione Moro, diversamente da quanto dichiarato in più occasioni da
Mario Moretti.
“L’ipotesi che io mi sono
sempre fatto è che certamente i cosiddetti brigatisti, morettiani o non
morettiani, avevano dei rapporti con i palestinesi”. Franceschini torna poi sui
contatti tra lui e Curcio, in carcere, e i “compagni” che pianificarono e
gestirono l’operazione Moro. “Io e Renato dal 1976 in avanti siamo molto critici
con quelli fuori perché secondo noi avevano abbandonato il terreno del movimento
dicendo che bisognava prendere le armi. Ricordo che ciò che ci fece infuriare di
più fu il ritrovamento degli interrogatori di Moro nelle carte di via Monte
Nevoso perché i compagni fuori ci avevano sempre detto che lui non aveva mai
detto niente, nonostante nei primi giorni avessero affermato invece che stava
parlando e che tutto andava bene”. Rapporti che secondo Franceschini si chiusero
definitivamente dal giorno della scoperta del covo di via Gradoli e del
depistaggio del Lago della Duchessa. “Da lì cambia radicalmente la posizione di
quelli fuori che fanno sapere a noi dentro che non potevano tirarci più fuori”,
dice Franceschini. A dimostrazione, forse, che gli interessi estranei al
movimento brigatista avevano ormai preso il sopravvento nella vicenda.
Il carabiniere e il
brigatista. I ricordi del generale Mori e dell'ex brigatista Franceschini, per
una volta d'accordo: "Quella stagione è ormai finita",
scrive Gianluca Ferraris il 23 settembre 2014 su "Panorama". Verso la fine di
quella che poteva sembrare una chiacchierata tra due combattenti su meteo e
acciacchi, una bottiglietta d’acqua cade a terra con un tonfo rumoroso.
Trascorre forse mezzo secondo di pupille allargate e teste roteanti da parte di
pubblico e malcelati bodyguard destati dal loro pomeriggio di sorveglianza
discreta, finché uno dei due signori, che si chiama Mario Mori, prorompe
serafico: «Tranquilli, non è mica una bomba». E il suo dirimpettaio, che si
chiama Alberto Franceschini, abbozza: «Non è più stagione». Sorridono, senza
concedersi alla risata, e tornano a guardarsi negli occhi. È la prima volta che
lo fanno da 40 anni esatti. Era l’8 settembre 1974 quando Mori, allora capitano
agli ordini del Nucleo speciale antiterrorismo dei carabinieri comandato dal
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, pianificò l’operazione che portò
all’arresto di Franceschini, cofondatore delle Brigate rosse. Dopo, i due non si
sono mai più rivisti né parlati. Lo hanno fatto venerdì 12 settembre alla
biblioteca civica di Verona, durante uno degli incontri della quattro giorni di
«Panorama d’Italia» (vedere anche a pag. 96). Moderati da Giovanni Fasanella,
l’unico giornalista a potersi vantare di essere stato coautore di entrambi, Mori
e Franceschini (Stato e antistato) hanno rievocato quei giorni in cui «guerra
civile», per l’Italia, non era una frase scritta sui libri di scuola ma qualcosa
che si respirava ogni giorno, lasciandoti lo stomaco pesante come un blocco di
ghisa e la testa carica di domande, alcune delle quali ancora oggi senza
risposta. A cominciare dalla prima: quel «c’era qualcuno dietro le Br?» che ha
alimentato centinaia di libri, documentari e dibattiti. «Non c’era nessuno
dietro di noi, almeno fino a quando io ho fatto parte dell’organizzazione» dice
Franceschini, col tono rassegnato di chi ha già parato il colpo mille volte. Poi
però concede al pubblico un anelito complottista: «Di certo le nostre azioni
facevano comodo a qualcuno. In quegli anni erano in molti a vedere con favore
un’escalation di violenza in Italia».
Il grande vecchio. Pochi
attimi e si plana sui classici: il «Grande vecchio», il Mossad israeliano, i
servizi segreti deviati, la destra extraparlamentare, la criminalità comune. «Ci
sono state senza dubbio connivenze, omissioni e cointeressenze ma non complicità
o coperture, né da parte di pezzi dello Stato né da fantomatiche piste estere»
puntualizza Mori. Il riferimento è a un altro pallino dell’ex brigatista, il
cosiddetto Superclan: una sorta di Spectre ospitata dalla scuola Hyperion di
Parigi, che riuniva vecchi fascisti, ex guerriglieri, intellettuali di sinistra
e protohacker, tutti capaci, secondo i retroscenisti, di orchestrare tanto lo
stragismo nero quanto il terrorismo rosso con l’obiettivo di smantellare
l’Italia. «Abbiamo investigato a lungo su Parigi» dice l’ex generale dei
carabinieri «ma abbiamo sempre avuto l’impressione che quel gruppo non
c’entrasse. Certo, attorno alla Francia si muovevano personaggi equivoci e
fuggiaschi di ogni colore, ma li abbiamo sempre stanati tutti. Molti anni dopo,
quando ero a capo del Sisde, avevo un aereo pronto per prelevare Cesare
Battisti, e restai a lungo in attesa di un via libera politico all’arresto che
non arrivò mai. Se avessi avuto la possibilità di decapitare il vertice delle Br
in un’epoca in cui ci era concessa molta più libertà, vi pare che mi sarei
lasciato pregare?». Franceschini non sembra convinto: «Ci sono un sacco di cose
che non ci avete mai spiegato, come il blitz nel quale morì Mara (Cagol,
compagna di Renato Curcio, uccisa nel 1975 in uno scontro a fuoco, ndr) e
l’agguato di via Fani» osserva. «Abbiamo chiesto ai tuoi compagni che c’erano di
chiarircele, ma non hanno mai cambiato versione. I dubbi, però, talvolta sono
rimasti anche a me» replica Mori.
Toni bassi. Tra i due reduci i
toni non si alzano mai. Non è un impasto di Pietà l’è morta e di La mia
generazione ha perso, ma semplice rispetto, cresciuto dal tempo e da
consapevolezze come quella che arriva a metà serata: «Forse la nostra nascita e
la nostra azione erano necessarie» dice Franceschini; «Forse anche le nostre.
Come se avessimo bisogno di esistere l’uno per l’altro» ribatte Mori. Che di
quegli anni ricorda i continui cambi di direzione investigativa, la fatica,
l’idea di avere a che fare con un nemico nuovo che andasse affrontato con armi
nuove: «Volete che ve lo dica in una parola? Eravamo incazzati. Davamo la caccia
a un gruppo di persone di cui non sapevamo nulla, se non che erano simpatiche a
molti, mentre la politica esitava a schierarsi con noi». Non fa sconti alla
coscienza, invece, Franceschini, che pur essendosi dissociato nel 1983 dei suoi
primi, caotici anni di clandestinità rievoca «la frenesia, la necessità che
sentivamo dentro di sovvertire un certo ordine, la convinzione che studenti e
operai, soprattutto i secondi, sarebbero stati dalla nostra parte. Io sono nato
a Reggio Emilia, vivevo nel mito negativo della Resistenza tradita. L’idea di
rifare la rivoluzione per me aveva un suo fondamento politico».
Br e vecchi partigiani.
Proprio alla Resistenza è legato uno dei ricordi più cari di Franceschini.
«Andai a trovare un vecchio partigiano riparato in Cecoslovacchia. Mi disse: “So
che partirai. Vorrei venire con te ma ormai sono vecchio. Una cosa, però, te la
voglio dare”». La cosa era una pistola Luger, rubata a un ufficiale delle SS
ucciso sull’Appennino. Ricomparirà, stretta nel pugno di Franceschini, nella
Polaroid brigatista che ritrae Michele Mincuzzi, capo dell’ufficio del personale
dell’Alfa, vittima di un sequestro lampo nel 1973. Era la fase della propaganda
armata, i morti arrivarono solo a partire dall’anno successivo, ma era come se
fossero stati messi in conto da sempre. «Un giorno, sarà stato il luglio del
1974, Moretti disse: “Siamo così carichi di odio che le nostre pistole sparano
da sole”. Curcio gli rispose: “Sì, però per il momento ci spariamo sui piedi.
Abbiamo bisogno di lui”». Lui era Silvano Girotto, detto «Frate Mitra», un ex
guerrigliero ingaggiato come istruttore militare che si rivelò il primo
infiltrato di Dalla Chiesa ai piani alti delle Br.
Dalla Chiesa, il ricordo.
Proprio sulla figura del generale, ucciso dalla mafia nel 1982, si sofferma a
lungo Mori. «Carlo era un uomo dalle straordinarie intuizioni investigative»
racconta Mori. «Il nostro metodo, mantenuto anche in seguito nella caccia ai
boss mafiosi latitanti, si potrebbe sintetizzare con il motto “Meglio un pollaio
domani che una gallina oggi”». Che poi altro non è che la sublimazione dello
sbirro vecchia scuola, ancora più fondamentale quando si ha a che fare con
gruppi ermetici: pedinamenti, suole consumate, riscontri. Si parte da una
traccia sottile e si arriva chissà dove, chissà quando: «La colonna romana delle
Br la stroncammo seguendo alcuni militanti di Potere operaio. Erano solo
simpatizzanti, ma un giorno li fotografammo sulla spiaggia di Ostia con
Barbara Balzerani: per noi era una sconosciuta, ma dagli ingrandimenti risultò
avere una pistola nella borsetta. Potevamo prenderla subito, invece continuammo
a seguirla; così finimmo per arrestare 34 persone». Alla fine chi voleva portare
l’attacco al cuore dello Stato e chi in quegli anni lo Stato rappresentava e
proteggeva, si stringono la mano. Senza eccessivo calore, ma sempre con
rispetto. «Penso che avremmo potuto continuare a chiacchierare per altre due
ore» dice Mori. «Anche di più» commenta Franceschini.
Brigate rosse. Il grottesco
incontro tra Moretti, Franceschini e Morucci, scrive Spazio 70 il 5 ottobre
2016.
– Valerio Morucci, romano
classe 1949, studente universitario, fanatico di armi e capo della struttura
militare di Potere operaio, prova a entrare nelle Brigate rosse fin dai
primissimi anni Settanta: a vagliare la richiesta di Morucci, Alberto
Franceschini e Mario Moretti. I tre si incontrano a Milano nel 1971.
– Alberto
Franceschini: «Stavamo riorganizzando le Br dopo la prima ondata di arresti
e Valerio Morucci ci aveva fatto sapere più volte che voleva parlarci. Era il
capo del servizio militare di Potere operaio e lo conoscevamo di nome anche
perché era considerato un esperto di armi. Lo incontrammo io e Moretti a Milano,
in viale Sarca. Arrivò in Mini-minor, una giacca blu con i bottoni d’oro,
camicia di seta, cravatta, occhiali Ray-ban: sembrava un fascistello
sanbabilino. Parlò soprattutto lui, e di armi: voleva farci vedere che le
conosceva bene, che uno come lui sarebbe stato indispensabile per la nostra
organizzazione. Ci chiese di entrare nelle Br, ma nessuno di noi fu d’accordo
nell’accogliere Valerio. La nostra diffidenza per quelli di Potere operaio era
congenita. Li consideravamo dei mezzi aristocratici che volevano giocare alla
rivoluzione. Mi fu sufficiente raccontare ai compagni come si era presentato
all’appuntamento con noi perché la richiesta di Valerio venisse respinta. Si
decise soltanto di continuare a tenere con lui il rapporto che già avevamo, di
tipo esclusivamente logistico, e di cui venne incaricato Moretti, l’unico che
aveva cercato di difendere, sia pur timidamente, la causa di Morucci».
– Valerio Morucci: «Mi diedero
appuntamento in viale Zara. Io andai su a Milano con la mia Mini Cooper gialla e
nera e con la bionda, per approfittare del viaggio. Già da subito vedo
che Moretti e Franceschini mi guardano storto. Io infatti indosso il mio blazer
e una camicia azzurra incravattata sotto un bel cappotto blu. Inoltre mi ero
presentato con un macchina e una bionda piuttosto appariscenti. Mi guardano come
se fossi stato un libertino gaudente appena uscito da un night dopo essermi
strafatto di troie e cocaina. Quello con gli occhialetti, Franceschini, mostra
il sorrisetto storto del bambino sadico che dà pizzicotti alla sorella. Le
labbra di Moretti superano a fatica la smorfia di ripugnanza e supponenza con
cui sembra essere nato. Mi dicono: “Da Roma hanno detto che puoi procurarci
delle armi”. “Sì”, dico io sorridente, “che vi serve?”. “Tutto: mitra, pistole,
munizioni…”.”Ci proverò”, faccio io, “ma se vi servono urgenti bisognerà
prenderle al prezzo che si trova”».
– Morucci su Moretti: «Ogni
tanto, tra il serio e il faceto, gli scappava di dire che era il capo e che
lasciava impronte dappertutto perché i giornali all’epoca non lo nominavano mai
e temeva che la polizia volesse giocarlo come spia. Alcuni come Moretti
interpretavano il riposo del guerriero come avere una donna in ogni città e
anche più di una all’occorrenza. Mi assoggettai anche io alla sicurezza e ai
vantaggi delle regole».
– Ancora Morucci: «Comprai
una moto Norton Commando con cui scorazzavo per la città come un pazzo. Mi
compravo bei vestiti e ogni sera mangiavo al ristorante. Allora con le donne ero
una bestia. Ma con lei mi ero messo per ripicca, per toglierla da sotto al naso
a quelli del gruppo che pensavano più alla fica che alla rivoluzione».
– Morucci, Faranda e i
ristoranti: «Nei giorni tra l’appello di Paolo VI e la diffusione del comunicato
numero 8, che è del 24 aprile 1978, si presentò Lanfranco Pace in uno dei
ristoranti in cui io e Faranda eravamo soliti pranzare da anni, quello sito in
via dei Genovesi o via dei Salumi, dietro piazza in Piscinula. Si tratta di un
ristorante siciliano con le pareti riccamente addobbate con oggetti provenienti
dalla Sicilia. Il Pace ci disse che da alcuni giorni girava per ristoranti da
noi frequentati abitualmente per rintracciarci e chiederci se effettivamente
le Brigate rosse, dopo i comunicati n.6 e n.7, avessero intenzione di
uccidere Moro. Pace conosceva quel ristorante perché prima del periodo in cui
ebbe contatti con le Br – tra l’autunno del 1977 e i primi giorni del 1978 –
egli lo aveva saltuariamente frequentato assieme a noi».
– Morucci aveva raccontato al
magistrato che con la Faranda impiegavano intere giornate per cercare il luogo
più adatto dove lasciare i comunicati delle Br o le lettere di Moro, tentando di
far credere di avere adottato tutte le possibili precauzioni, fino a ricorrere a
metodi quasi scientifici, per impedire di essere individuati e pedinati dalla
forze dell’ordine. Adesso invece sostiene che due dei brigatisti più ricercati
d’Italia, come lui e Faranda, andavano a pranzo in ristoranti che frequentavano
da anni, assieme ad altri militanti dell’estrema sinistra, col risultato di
essere facilmente rintracciati da un ex militante delle Br che meno di un mese
prima era stato fermato dalla Polizia.
– Alfredo Bonavita: «Per
quanto concerne la nascita della colonna romana, anche a Roma c’era fin dal 1971
un nucleo di compagni vicini alle Br che militavano nell’area di Potere operaio.
Ricordo che si parlava della zona di Cinecittà, ove erano avvenute azioni contro
i fascisti. Alcuni compagni di Roma andavano a Milano e tenevano i contatti
con Franceschini e a volte anche con Curcio. Si trattava di compagni di
quartiere, non inseriti in alcuna realtà di fabbrica o di scuola. Da noi erano
considerati un poco come barboni, anche perché facevano dei furti per
sopravvivere. Una volta rubarono la testa di una mummia o di una statua che poi
rivendettero per meno di 200 mila lire. Un’altra volta rubarono, sempre a Roma,
una collezione di francobolli. Questo primo tentativo di costituire un nucleo Br
a Roma fallì nella primavera del 1972, quando a Milano e a Torino decidemmo il
passaggio alla clandestinità. Tale decisione fu determinata da una serie di
elementi di carattere politico-organizzativo, a partire dalla riflessione sugli
arresti dei primi di maggio 1972, determinati sia dalle indagini di polizia e
magistratura sia dalle rivelazioni fatte da Marco Pisetta dopo il suo arresto. A
seguito delle rivelazioni si accelerò il processo di clandestinizzazione degli
uomini e delle strutture. Tale scelta non fu condivisa da molti compagni romani
che si staccarono dalla organizzazione».
– Anna Laura
Braghetti: «Esiste un racconto molto significativo sul primo incontro fra i
milanesi e i romani. La leggenda vuole che tramite intermediari fosse stato
fissato un abboccamento fra Morucci, Franceschini e Moretti. Franceschini e
Mario arrivarono su una vecchia Fiat, con addosso scarpacce pesanti e orridi
cappotti sformati. Valerio invece era smagliante: una bella macchinetta,
occhiali neri alla moda, giacca blu doppiopetto, stivali. Immagino si siano
guardati e si siano fatti reciprocamente schifo. I brigatisti avevano fatto
della sobrietà nordica e dello stile di vita operaio un dogma e tenevano una
minuziosa contabilità ritenendo di avere rapinato le banche in nome e per conto
del proletariato. Ma Valerio non vedeva francamente la ragione di tanto
moralismo e veniva pur sempre da un’area politica – quella della Autonomia
operaia – che negli anni successivi avrebbe prodotto dirigenti capaci di dire ai
ragazzi: “Guai se trovo uno di voi cretini che distrugge un’automobile di lusso.
Le belle macchine si rubano, e poi ci si fa tutti un giro”. Giorgio Bocca, nel
suo bellissimo libro ‘Noi terroristi’ fa raccontare a Morucci quel meeting:
“Quando li ho conosciuti nel 71 erano tipi tristissimi e anonimi, mimetizzati
sul fondo di grigiore di una città operaia, sempre atteggiati ai modi che loro
pensavano consoni a dei rivoluzionari professionisti. Io ero arrivato
all’appuntamento su una Mini cooper gialla con tetto nero e con una ragazza
bionda. Loro vennero all’appuntamento con una 850 grigio sbiadito e un enorme
portabagagli sul tetto. Franceschini con gli occhiali, senza baffi, ingobbito
come sempre, cinereo in faccia e nei vestiti. Moretti un po’ più aitante, con
indosso un assurdo tre-quarti spigato grigio e marrone, con le spighe enormi”. I
tre quindi non si piacquero e le Br non si mossero dal Nord finché non decisero
che era ora di andarsi a cercare il cuore dello Stato. E lo Stato significava
Roma».
– Alberto Franceschini sui
compagni romani: «Erano faciloni e chiacchieroni. Le regole di
compartimentazione con loro erano inutili. Ogni tanto ti arrivavano a casa con
la testa di una statua rubata in una chiesa per chiederti di piazzarla presso un
antiquario di Milano. Quello di rubare pezzi di statue era il loro modo
preferito di finanziarsi. A me i rapporti con loro lasciavano un cattivo sapore
di borbonesco e di sottoproletariato. Ripetevo in continuazione che una forza
rivoluzionaria non può vivere alla maniera dei tombaroli, che i soldi bisognava
andarseli a prendere nelle banche. Mi guardavano con quella loro aria sempre
stanca e tranquilla, per poi rispondermi invariabilmente: ‘Hai ragione,
compagno, ma intanto vedi di piazzare questa zucchetta».
Sequestro Moro, intervista
al brigatista Alberto Franceschini: "Sbagliammo".
I viaggi a Parigi di Moretti. Le avance del Mossad. I "nemici" della trattativa.
Il fondatore delle Brigate rosse ripercorre una delle stagioni più controverse
della storia italiana. La Balzerani? "Farebbe meglio a tacere". E ai giovani di
oggi dice: "Non fate come noi", scrive Raffaella Fanelli l'11 maggio 2018 su
"Panorama". "Le Brigate Rosse hanno sbagliato, mi sembra talmente chiaro. E ai
ragazzi che oggi si chiedono il perché di tanta violenza, che cercano una
spiegazione a episodi così gravi come il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro,
dico di fare cose diverse da quelle che ho fatto io, e persone come me,
all’epoca". Alberto Franceschini, co-fondatore e, insieme a Renato Curcio, capo
storico delle Brigate Rosse, confessa che la lotta armata fu un errore. Che i
brigatisti "sbagliarono". Lo ammette senza reticenze. A dispetto di chi ancora
si aggrappa a un passato di sangue, di chi, come Barbara Balzerani o Raffaele
Fiore, continua a provocare e a mentire trincerandosi dietro al falso memoriale
Morucci-Faranda. "Le persone fanno fatica a cambiare rispetto alle loro ragioni
di vita. È difficile per questi ex compagni dichiarare di aver sbagliato. Anche
se dovrebbe essere da persone intelligenti ammettere un errore palese come il
nostro". Errore, sbaglio. Franceschini lo ripete, con una voce ferma che ha la
stessa aria di calma determinazione che porta in volto. Lo incontriamo a Milano,
in un giardino pubblico chiuso tra i palazzi di piazza Wagner. Gli chiedo di
Barbara Balzerani, che non contenta del clamore suscitato da un suo post ironico
sull’anniversario del sequestro Moro ("Chi mi ospita oltre confine per i fasti
del 40ennale?"), ha rincarato la dose con una battutaccia sul "mestiere di
vittima" che ha suscitato l’indignazione dei familiari delle vittime, e non
solo. "Farebbe bene a tacere", taglia corto Franceschini, uomo spigoloso e
riservato. Qui parla di quello ha visto e di quello che ha capito e sentito nei
suoi anni di carcere.
Quindi adesso condanna la
lotta armata?
"Sì, assolutamente.
Fiore, membro del commando che
rapì Moro e uccise la scorta, disse che in via Fani c’erano persone che non
conosceva... che erano altri a gestire.
"L’ho incontrato in carcere.
Nel periodo in cui negava addirittura di aver partecipato all’agguato. Fu
Patrizio Peci a tirarlo in ballo. Che al sequestro Moro abbiano partecipato
altre persone è ormai assodato... Valerio Morucci e Mario Moretti avevano
rapporti con 'altri'. Rapporti mai chiariti".
Durante i 55 giorni di
prigionia, Moro fu sottoposto a lunghi interrogatori da parte di Moretti. Chi
preparò quelle domande?
"Moretti non aveva grandi doti
di analisi politica e di scrittura. Andava spesso a Parigi, anche durante il
sequestro Moro. Non è escluso che l’interrogatorio sia stato preparato altrove.
Moretti e Morucci hanno avuto un ruolo determinante nella vicenda Moro. Tra loro
c’è stato un accordo sulle cose da dire. Non so se l’accordo c’è stato anche
sulle cose da non dire".
Ha mai incontrato Francesco
Delfino (generale dei carabinieri e ufficiale del Sismi) o Alessio Casimirri
(l’unico brigatista del commando di via Fani che è ancora latitante, vive in
Nicaragua)?
"No".
Le Brigate rosse hanno mai
avuto contatti con i servizi segreti italiani o stranieri?
"I servizi segreti israeliani
ci hanno cercato nel ‘74. Ci furono due o tre incontri ma rifiutammo di avere
rapporti stretti con loro, volevamo conservare la nostra autonomia. Ci avrebbero
dato soldi e informazioni importanti. Ma abbiamo rifiutato. È probabile che
abbiano cercato un nuovo aggancio dopo il mio arresto e quello di Renato
(Curcio, ndr)".
Cosa avrebbe dovuto fare lo
Stato per salvare Moro?
"Liberare almeno una persona.
In questo modo avrebbero messo in difficoltà i brigatisti... tanto che hanno
fatto di tutto per non liberare nessuno".
Bettino Craxi indicò a Benigno
Zaccagnini i nomi di due detenuti da graziare, la brigatista Paola Besuschio e
il nappista Alberto Buonoconto. Fu Giulio Andreotti a bocciare qualsiasi ipotesi
di mediazione. Le Br avrebbero potuto sequestrare anche Andreotti... Perché
presero Moro?
"Qualcun altro voleva Moro
morto. Aldo Moro era pericoloso per una serie di soggetti... Il famoso lodo Moro
dava fastidio a certe forze internazionali di destra. Per loro e anche per gli
americani, Moro era pericoloso. E per eliminarlo si sono mosse una serie di
pedine".
Cioè lei crede che le Br da
lei fondate siano state strumentalizzate?
"Certo. C’era qualcuno dietro,
a muovere le fila... La nostra storia è durata 20 anni, e ha avuto una serie di
relazioni a livello europeo, impossibile che non sia stata monitorata da nostri
Servizi e dai Servizi segreti europei. Il nostro gruppo era quello più radicato
socialmente e ci sono state operazioni diverse e di diverso tipo da parte di
soggetti, diciamo così, extra istituzionali".
Cosa intende per
"operazioni"?
"Contatti".
Per impedire l’omicidio di
Moro sarebbe bastato liberare un detenuto. Anche lei era in carcere in quel
periodo...
"Ero detenuto a Torino.
Dall’esterno mi arrivarono dei messaggi attraverso gli avvocati e da altre
persone che erano in contatto con i compagni fuori. Noi eravamo per la
trattativa. E ci aspettavamo anche una vendetta. Pensavamo che se avessero
ammazzato Moro avrebbero ucciso anche noi in carcere. Lo ritenevamo molto
probabile. C’erano già state le uccisioni dei compagni della Raf in Germania, in
carcere a Stammheim (alcuni capi della Raf si suicidarono il giorno dopo
l’assassinio del presidente degli industriali tedeschi Hanns-Martin Schleyer in
circostanze non del tutto chiare, ndr) e Ugo La Malfa lo diceva espressamente:
con Moro morto lo Stato avrebbe dovuto restituire cadaveri".
Perché le verità di Moro su
Gladio, sui finanziamenti della Cia alla Dc non furono rese pubbliche dai
brigatisti?
"Hanno raccontato una loro
verità di comodo, accettano di passare per ignoranti, di aver visto ma di non
aver capito il valore di quelle dichiarazioni. Davanti ai magistrati si sono
definiti dei cretini... ed è assurdo pensare che un evento tragico di tale
portata che ha segnato la storia mondiale, e non solo di questo Paese, fosse in
mano a dei cretini". (Articolo pubblicato sul n° 20 di Panorama, in edicola dal
3 maggio 2018 con il titolo "Eravamo nel torto e ci hanno anche manovrato").
Mario Moretti: «Le Br sono
uno specchio per tutti».
La lettera dell’ex leader delle Br al giornalista Enrico Fedocci, scrive il 10
Maggio 2018 "Il Dubbio". Tempo fa Mario Moretti, che negli anni 70 fu il leader
delle Brigate Rosse, è stato invitato a parlare agli studenti di un corso tenuto
dal giornalista Enrico Fedocci. Successivamente gli studenti hanno scritto dei
commenti sull’incontro. I commenti sono stati mostrati a Moretti, che ha
risposto inviando questa lettera a Enrico Fedocci che viene resa nota solo oggi.
Ciao Enrico, grazie per avermi fatto leggere quello che i ragazzi del corso
hanno scritto sull’incontro. Molto interessante. In un modo o nell’altro la
vicenda delle BR è di quelle che fungono da specchio a chi le guarda. A volte
uno specchio sociale, altre più semplicemente riflettono il modo individuale con
cui ci si pone di fronte ai grandi eventi, alla riflessione sulla vita, la
morte, i valori fondanti la propria esistenza. Si interroga me e la risposta che
viene colta è soltanto quella più vicina al sentire consolidato di chi ha posto
la domanda. Ti faccio un esempio, non è domanda e risposta ma il più innocuo
degli argomenti e il più scivoloso per chi scrive, la descrizione del
personaggio: qualcuno mi descrive come uno che “ ha un sorriso aperto e l’aria
di chi ne ha passate tante nella vita“, un altro “ volto tirato, scavato dalle
rughe… racconta senza tradire la minima emozione”, o al contrario “ la voce si
incrina, gli occhi si fanno lucidi e lo restano per buona parte della
conversazione“, per un altro “…con un sorriso piuttosto commosso, gli tremano le
mani, suda visibilmente, deglutisce come avesse un nodo alla gola“, ancora “ ha
l’aspetto del professore qualunque”, “un uomo consunto”, “abbigliamento semplice
e atteggiamento cordiale e disponibile”, e così via. È chiaro che Moretti è un
po’ tutte queste cose messe insieme, ma volevo sottolineare che, se guardando la
medesima persona ognuno può “vedere” cose così contrastanti (e si ripeterà ancor
più per ogni argomento della conversazione), Moretti è soltanto un pretesto, un
accidente in una vicenda, quella delle Brigate Rosse, che rimanda a qualcosa di
inestricabile dal proprio essere sociale: se si parla delle BR chiunque ci mette
di suo, sempre, non importa quanto egli sia lontano per età o per indole da
quella vicenda. Peccato che se ne parli così poco e malamente. Se ti capita
ringrazia i tuoi allievi da parte mia, tutti, anche quelli che pensano come un
carabiniere, parlano come un carabiniere e fortunatamente, non avendo
l’equilibrio di un carabiniere, non sono armati come un carabiniere. Se hai
difficoltà con la duplicazione della registrazione filmata io posso esserti
d’aiuto, sono un informatico non dimenticarlo. Aspetto di sentirti e grazie di
nuovo MARIO MORETTI
LA VERITA’ DICIBILE.
GERO GRASSI: IO ESCLUSO PER
IL LAVORO SU ALDO MORO,
scrive Antonio Procacci il 4 febbraio 2018. L'on. Gero Grassi non è stato
ricandidato dal Pd alle elezioni del 4 marzo. Antonio Procacci lo ha
intervistato per la puntata de "Il Graffio" (Telenorba) proprio dedicata alle
liste elettorali (2 febbraio 2018).
Gero Grassi fuori dai
giochi per il “Caso Moro”. Io non ci sto!
Scrive Nico il 29 gennaio 2018 su Baratta su "La Gazzetta Meridionale". «Non ci
sto a questa ennesima carognata di Renzi. L'esclusione di Gero Grassi delle
liste parlamentari è l'ennesimo attentato alla democrazia che lavora per la
verità, legalità e giustizia Se il “Caso Moro” ha colpito ancora, e lo ha fatto,
vuol dire che la Seconda Commissione parlamentare d’Inchiesta” sul predetto caso
ha lavorato più che bene, scoperchiando quel vaso di Pandora che si vuol tenere
saldamente chiuso. Sono fiero di Gero, di essere suo amico, e orgoglioso, col
mio lavoro di giornalista, per aver contribuito a ricercare, scrivere, informare
e comunicare, verità di Stato nascoste al Popolo Italiano, un tempo Sovrano.
Gero è forte e perseverante e ritornerà». Con questo post, che ho pubblicato sul
mio profilo di Facebook, di Twitter e Google +, ho voluto esternare tutta la mia
disapprovazione per la non candidatura di dell’On. Gero Grassi alla XVIII
Legislatura che il 4 marzo prossimo vedrà eleggere i nuovi parlamentari. Chiedo
scusa se il presente è scritto in prima persona, come se fosse un editoriale,
che non lo è, ma contro ogni forma deontologica giornalistica ritengo che ogni
tanto si debba valicare quel confine che spesso fa sembrare impersonale un
articolo. Gero Grassi purtroppo è fuori da tutti i giochi. «Da parte loro
slealtà e scorrettezza» l’amaro e comprensibile commento che l’amico Gero ha
fornito alla stampa. «La presentazione delle liste per le politiche del 4 marzo
2018 pone fine alla mia presenza in Parlamento dopo 3 legislature» ha proseguito
Grassi nella sua spiegazione, ad un torto grande quanto un tradimento, non solo
politico, bensì umano e verso chi in tutti questi anni lo ha seguito nella sua
indefessa e certosina ricerca della verità sulla morte del Presidente Aldo Moro.
È l’amaro epilogo di un lavoro svolto quotidianamente a beneficio della verità,
di quella legalità e giustizia che soprattutto le scolaresche hanno voluto
testimoniare invitando Gero nei loro istituti per conoscere i particolari del
Caso Moro e soprattutto chi era il Pres. Aldo Moro e cosa aveva fatto. Con circa
500 incontri tenuti in tutta Italia (e che stanno ancora continuando, Parlamento
sciolto), Gero Grassi ha fatto conoscere il lavoro svolto dalla Commissione,
presieduta dall’On. Fioroni, aprendo incartamenti, mostrando foto e video, tutte
testimonianze ora accessibili sulla pagina web di Grassi. Infatti chi volesse
approfondire l’attività della Commissione parlamentare sul Caso Moro può
visitare il web sitewww.gerograssi.it, dove troverà documenti interessanti e
inediti. Ma non solo: Gero nei suoi incontri ha raccontato aneddoti inediti e
confidenze avute dalla famiglia Moro, grazie alla fiducia conferita dai
familiari del Pres. Moro, in primis la figlia Maria Fida. Difatti l'archivio sul
caso Moro è passato dalla famiglia, per loro volontà, a Gero Grassi che
attraverso tutte le interrogazioni della Seconda Commissione parlamentare sul
caso sono a disposizione online. La mancata ricandidatura di Gero pare essere
l’ennesimo prezzo, molto caro, che, chiunque si avvicina alla torbida verità di
un caso che invece dovrebbe essere limpidamente detto, deve pagare sulla propria
pelle. Ricordo a tutti che questa non ricandidatura fa il paio con un’altra,
inseguito descritta, che molti o se lo sono dimenticato o non vogliono
ricordarlo. Avvicinarsi a una verità celata dallo stesso Stato è sempre stato
pericoloso. Nel mio piccolo, da giornalista, ho seguito quotidianamente il
lavoro svolto dalla Commissione, grazie anche al contatto diretto con Gero, che
lo ringrazio pubblicamente. Un lavoro che intuitivamente era a un passo dalla
verità, che attendeva la certificazione della stessa Commissione per pubblicare
altre verità, non solo quelle approvate a fine anno 2017 dalla Camera dei
Deputati per fine naturale della XVII Legislatura. Verità che sono state
pubblicate e che il sottoscritto più volte ha riportato in tanti articoli,
incontrando attriti di ogni tipo, anche di editori e direttori di giornali, web
e cartacei, indegni del loro ruolo, e a volte subendo anche da altri soggetti
"inviti", meschini e intimidatori, a farmi i fatti miei. Ciò denota palesemente
cosa stava accadendo scoperchiando quel vaso di Pandora, che oggi sbugiarda la
menzognera scelta del “capo partito PD” per l’uscita forzata di Gero Grassi
dalle scene politiche parlamentari. 2250 documenti acquisiti e 440 operazioni
investigative della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Caso Moro non sono
bruscolini. Come non lo sono le molteplici foto, video, bibliografie e
pubblicazioni varie, oggi preziosamente custodite dall’On. Gero Grassi e messe
pubblicamente a disposizione sul suo sito web. Ma la verità, quella buia di uno
Stato che non vuol far sapere, fa tremare i polsi finanche a chi li oggi li ha
ammanettati. Quando si parla di Brigatisti Rossi pentiti che ritrattano le loro
deposizioni per poi infangare altri, depistando inquirenti a caccia di ulteriori
prove, o di una brigatista rispondente al nome di Faranda Adriana che parla di
“Gero Grassi ossessionato”, quando si rendono pubbliche liste, come quella
trovata a viale Giulio Cesare il 29 maggio del 1979, contenenti molti nomi di
brigatisti, oltre 90, quando la reticenza diventa mezzo d’oblio come ha fatto il
brigatista Valerio Morucci, quando Maria Fida Moro, primogenita del Pres. Aldo
Moro, svela sulle “intrusioni” del “Movimento Febbraio 74” subite in casa
durante i 55 giorni del sequestro di suo padre, quando si parla di agenti dei
servizi deviati e di “Gladio”, di interferenze della Banda della Magliana, di
poliziotti e carabinieri intimoriti ed alcuni pagati per mentire, quando si
nomina Paul Casimir Marcinkus e lo IOR con tanto di documenti alla mano, di
Servizi Segreti Italiani, anche deviati, quando si nominano massoni e logge come
la P2, quando si dice che nel complotto sul rapimento del Presidente Aldo Moro
quel giorno in Via Fani a Roma erano presenti, oltre agli italiani, anche agenti
della CIA, del KGB e del Mossad, quando di svela chi davvero ha fisicamente
ucciso Moro, vuol dire che la verità è a un passo. E Gero lo ha detto, ed io
l’ho scritto, come del resto hanno fatto alcuni miei colleghi. Tanto per far
comprendere a tutti voi quanto si era vicini alla “vera verità” sul Caso Moro,
basterebbe leggere le carte presenti sul sito predetto: è pubblico e Gero, ed io
e chi lo ha seguito, sostenuto, ascoltato, incoraggiato, lo sa e lo dirà sempre.
A corroborare questa “vera verità” basterebbe anche ascoltare l’intervista che
Gero Grassi ha rilasciato a Tele Sveva nel programma “Spazio Città”: ecco il
titolo del video che immortala questa “vera verità”, SPAZIO CITTÀ - Intervista
all'onorevole Gero Grassi (14-12-2017), cliccando sopra potrete vederla e
ascoltarla. Vi riporto un stralcio della “vera verità” detta dall’On. Gero
Grassi: «In via Fani non c'erano solo le Brigate Rosse. C'erano uomini dei
Servizi Segreti stranieri e italiani. C'erano i tedeschi. Al complotto Moro
hanno partecipato la CIA, il KGB, il Mossad, una grande partecipazione della P2
che è stata determinante. Ciò che dico è tutto provato nei documenti della
Commissione cui faccio parte. La novità è lo IOR di Marcinkus, che sta tutto
dentro il Caso Moro. La prima prigione di Moro, cosa inaudita, nuovissima come
notizia, è in via Massimi 91 a Roma, palazzine dello IOR, gestite da Marcinkus.
La cosa altrettanto strana è che nelle palazzine dello IOR vivevano dei
brigatisti, uomini della finanza palestinese, uomini di una società americana di
copertura della CIA. Chi ha ucciso Moro non era un brigatista, era un uomo della
'Ndrangheta calabrese, defunto prima della fine degli anni '90, sepolto in
Calabria, stava in carcere quando morì, e quindi questo dimostra che le Brigate
rosse sono state comprimarie nel rapimento Moro, come ha detto Abu Bassam Sharif
in Commissione, che era il braccio destro di Arafat, quando ha detto che le
Brigate Rosse dopo Francheschini, Curcio e Cadol, erano state infiltrate dalla
CIA e dai Servizi Segreti». Provate a dirle voi queste cose, e a scriverle come
me, e poi ditemi se i polsi non vi tremano. Ecco, queste “vere verità”, come ha
ben detto l’amico Gero sono state le cause della sua esclusione a questa tornata
elettorale «Io escluso. Il Caso Moro colpisce ancora» lo sfogo di Gero, che
accosta questo sua uscita a quella precedente che vide il Sen. Vittorio Cervone
non ricandidato dall’allora DC perché proponente della Prima Commissione
parlamentare sul Caso Moro che operò dal 1979 al 1983. Un caso? No! Un’amara
verità, allorquando davanti al tavolo della Commissione finiscono nomi e sigle
eccellenti. Per chi crede che Gero si fermerà, sbaglia. Lui continuerà nella sua
opera per la “vera verità”. Certo non lo farà da parlamentare, ma le giovani
coscienze possono essere edotte ed educate con incontri, conferenze, seminari,
tavoli maieutici scolastici e universitari. Per chi invece crede che tre
legislature son tante ed è ora di riposarsi, lo conforto rispondendo che per
Gero Grassi la politica non è un lavoro bensì una passione, perciò non lo stanca
se la si fa per ridare verità. L’Italia va avanti anche senza di lui ma
azzoppata in una parte che la rende stabile, verità, legalità, giustizia. Del
resto siamo in democrazia e rispetto chi non vorrebbe più Gero in
Transatlantico, ma non lo condivido, e per certe persone che preferiscono
“pulirsi” la faccia adulando il binomio Renzi-Emiliano per le scelte partitiche
per gli attuali candidati, lo aborro. Non è questione di legislature, ma di
portare avanti un lavoro che avrebbe ridato vita a ciò che altri hanno ucciso e
condannato all’oblio. Così facendo si rimanda nella tomba il Pres. Aldo Moro. Il
16 marzo del 2018 ricadrà l’anniversario, il quarantesimo, della strage di via
Fani e perciò, poi, dell’omicidio del Pres. Aldo Moro. Già ci sono contestazioni
in essere e sempre da chi vuol celare la verità, da parte di chi vorrebbe una
democrazia propria, rendendola incompiuta richiudendo il “Caso Moro”. Almeno in
quest’occasione non permettiamo a costoro di oscurare le giovani menti. Gero ci
sarà e poi ritornerà, certo che ritornerà in quel Parlamento, Renzi o senza
Renzi, che di questo passo terminerà di essere il capo di un partito, non un
segretario. Mi congedo con un pensiero che lo stesso Gero Grassi ha voluto
esternare sul suo profilo social, citando Brecht: "Prima di tutto vennero a
prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a
prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi erano antipatici. Poi vennero a
prendere gli omosessuali e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi
vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me, e non c'era rimasto nessuno a protestare."
Bertolt Brecht.
Grassi, tour elettorale col
santino di Moro,
scrive il 13 aprile 2017 Francesco Greco su "Il Giornale di Puglia". Si può
“usare” un cadavere eccellente per disboscare la giungla della politica
post-ideologica e “liquida” per avere una candidatura, anzi, una ricandidatura,
nel tentativo di dare smalto a una carriera da mediano, avara di soddisfazioni?
Si può andare in tour elettorale come i Rolling Stones a Cuba annunciando
addirittura “la verità” sulle tante ombre del caso-Moro, e poi risolvere il
tutto con una sagra della banalità (e delle vanità) da copia e incolla,
sfondando porte aperte, ripetendo cose note come da bambini mandavamo a memoria
“T’amo pio bove” e “La donzelletta vien dalla campagna”? E’ etico usare un corpo
citazione della “Pietà” di Michelangelo, quello dello statista della Dc rapito a
Roma dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 e assassinato il 9 maggio? L’eredita
di Moro è ingombrante e tentare di accreditarsela segno di supponenza. Ognuno si
dà la visibilità che vuole e la tattica più efficace quando va in cerca di
consensi, di un posto al sole, ma è l’impresa che sta compiendo il parlamentare
pugliese Gero Grassi, Pd (già Margherita, moroteo d’annata) componente della
commissione del caso-Moro, da un angolo all’altro dell’Apulia, da Vieste
(Foggia) a Vignacastrisi (Lecce), e altre date inzeppano l’agenda: lo spettacolo
è ambito da retroscenisti e complottisti nel paese dove a pensar male fai
peccato ma quasi sempre c’azzecchi. “Non sarò ricandidato…”, sospira Grassi alla
fine della performance fumando l’ennesima sigaretta dopo una lezioncina di due
ore, tradendo freudianamente la ragione della fatica. Ma dai toni da campagna
elettorale (mancano solo i “santini”) tutti avevano capito: rivelatore anche uno
schizzo di veleno su Maurizio Gasparri che gli siede accanto in una commissione
di cui “Il Fatto quotidiano” il 6 maggio 20’16 ha scritto che è “sommersa dalle
bufale”. Un uomo così audace, sprezzante del pericolo, capace di andare a
mezzanotte a Ostia Lido, il luogo dove la notte dei Morti del 1975 fu ucciso
Pier Paolo Pasolini, dopo aver avvisato il figlio, per incontrare un
caporedattore della Rai che dopo 40 anni si ricorda qualcosa sul bar “Olivetti”
di via Fani, è segno che rincorre i mitomani. Tutti i luoghi comuni ripercorsi,
i depistaggi sovrapposti, con gli attori (molti defunti) che recitano più parti
in commedia: servitori dello Stato la mattina, nei servizi, ovviamente deviati,
la sera. Ma la narrazione di Grassi si rivela tuttavia densa di omissis. Non una
parola sui due della motocicletta sul luogo del rapimento il 16 marzo. Chi erano
e cosa facevano? Non un cenno alla borsa di Moro “ravanata” chissà da chi e
mostrata a “Il fatto” (Rai1) da Enzo Biagi. Non su chi può aver indotto chi era
arrivato sul pianerottolo del covo di via Gradoli a fare retromarcia. Anzi,
Grassi ha messo una “taglia” di 500 euro per cercare le Pagine Gialle di quegli
anni, come se una via potesse essere inghiottita dal buco nero. Non un
riferimento al “partito della fermezza”, Dc-Pci, guarda caso i partiti che
avrebbero dovuto governare se lo statista di Maglie (ma qualcuno dice che è nato
a Galatina) quel mattino fosse riuscito a giungere in Parlamento. Nulla sulla
stessa Dc che tre anni dopo (aprile 1981) non è più inflessibile e va a trattare
con la camorra per liberare Ciro Cirillo, politico dc. Doppia morale un sacco
italian-style. E se quello di Moro fu un assassinio politico come aveva intuito
Leonardo Sciascia, il canovaccio dipinto da Grassi, al contrario, tiene i
politici sullo sfondo, li accredita quasi di folklore, calcando invece la mano
su potenze straniere, i soliti servizi deviati, la P2 (ma anche Moro era
massone) e le mafie, che probabilmente sono state esecutrici di volontà
politiche maturate all’ombra dei palazzi e dello Stato. Se ci fosse stato un
minimo di dibattito, e non un comizio a manetta, alla “così è se vi pare”,
avremmo voluto chiedergli se ci sono ancora in vita politici che ebbero un
qualche ruolo in una tragedia che ha segnato e condizionato la storia patria e
che, all’italiana, offrì snodi farseschi (la seduta spiritica del 3 aprile):
politici alla Prodi che chiedono lumi a un piattino (Othelma ancora era un
garzoncello) su un tavolino a tre gambe sono buoni per i b-movie di Alvaro
Vitali, Renzo Montagnani ed Edwige Fenech alle grandi manovre. In cambio
dobbiamo credere, per fede, che le Br di Alberto Franceschini non hanno mai
ucciso nessuno: sottinteso, gli assassini sono venuti dopo, con gli infiltrati.
Che i governi sinora non hanno mai chiesto al Nicaragua l’estradizione di
Alessio Casimirri, cittadino nicaraguense. E che la povera Emanuela Orlandi,
sparita a 15 anni, “era incinta, non è stata rapita, e mi fermo qui…”. Qualcuno
parlò di pedofilia oltretevere. Il padre, commesso alla Santa Sede, è morto nel
2004 a 74 anni credendo al rapimento, come ci crede ancora il fratello Pietro,
ormai 50enne. Caro Grassi, stia sereno, continui a distribuire “santini” e la
ricandidatura arriverà: ormai non è come in prima repubblica, le liste sono
zeppe di società civile. Viviamo nella società dello spettacolo, dei talent, che
ha leggi ferree, quasi scientifiche, ma non è con lo show che si arriva a una
qualche verità sul coacervo di interessi coagenti che portarono all’omicidio di
Moro. Ma serve a farsi mettere nel listino in posizione utile.
Gero Grassi “rompe le
palle” sul caso Moro,
scrive Nicola Teofilo Giovedì 25 Gennaio su "Turi Web". L’onorevole ospite a
Turi, insultato sulla pagina Facebook perché ha dimostrato la verità. Il
convegno su Aldo Moro tenutosi sabato scorso a "Mamma Rosa" a Turi, coincide
nella settimana delle polemiche scatenate dal post scioccante della ex
terrorista delle Brigate Rosse, Barbara Balzarani. “Chi mi ospita oltreconfine
per i fasti del 40ennale?” ha scritto la Primula Rossa, ironizzando sul
quarantennale che ricorre dal sequestro di Aldo Moro e dall’eccidio della sua
scorta, il 16 marzo del 1978 in Via Fani. Lei partecipò a quella strage
bloccando il traffico con una paletta della polizia. Ma non fu l’unica dei
protagonisti noti di quell’attentato. Perché – insiste Gero Grassi – "le Br non
agirono da sole". Per questo, a margine di quel post, l’on. Grassi (componente
della Commissione d’Inchiesta sul caso Moro) è stato insultato, accusato di
“rompere le palle” sul caso Moro. Grassi è stato ospite sabato scorso al
convegno di Turi. Sono intervenuti: il sindaco Coppi, Nicola De Grisantis
(presidente Centro Studi ‘Aldo Moro’), Vitangelo Scisci (presidente Centro Studi
di Storia e Cultura di Turi), Pierangelo Antonio Pugliese (presidente del Lions
Club Turi ‘Matteo Pugliese’) e tra il pubblico l’immancabile Simeone Maggiolini,
grande amico di Moro. “Nel novembre del 2014 – dichiara Grassi – il Procuratore
alla Repubblica di Roma Ciampoli ha scritto che è ormai certo che in Via Fani,
insieme alle Brigate Rosse, vi fossero elementi dei servizi segreti deviati
dello Stato, uomini della mafia romana (Banda della Magliana) e uomini dei
servizi segreti europei che avevano interesse per lo meno a creare caos in
Italia. Oltre a questo è emerso che in via Fani vi erano almeno due persone che
parlavano in tedesco, è stato, infatti, più volte ripetuto il termine
“Achtung””. Ma non è tutto. Sono state rilevate “incongruenze anche a riguardo
dell’esecuzione materiale del sequestro. I brigatisti hanno più volte affermato
che si sarebbe sparato solo da sinistra. La Commissione ha accertato che si è
sparato anche da destra. Tutto ciò ci induce a ritenere che in via Fani vi
fossero “anche” le Brigate Rosse”.
GERO GRASSI: “ALDO MORO: LA
VERITA’ NEGATA”,
scrive Vito De Leo su "Corato Live" giovedì 25 gennaio 2018. Dopo
oltre 500 interessantissime conferenze tenute in molteplici città italiane sul
tema “Chi e perché ha ucciso Aldo Moro”, a partire dal 1 novembre 2014
(Terlizzi), effettuate nel suo ruolo di vicepresidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, istituita su
sua proposta, con la legge n. 82 del 31 maggio 2014, nel mese di gennaio 2018,
l’amico on. le Gero Grassi, ha pubblicato cinquemila copie del suo ultimo libro
intitolato “ALDO MORO: LA VERITA’ NEGATA” edito dal Centro Stampa di Terlizzi.
Essendo stato uno dei tantissimi amici destinatari di questa importantissima
pubblicazione, nella mia veste di referente del Centro Studi Politici “Aldo
Moro” di Corato, non posso esimermi dall’esprimere pubblicamente la mia
gratitudine e l’ammirazione per questo tenace, instancabile professionista della
ricerca della verità effettuata anche nel suo ruolo di vicepresidente della
Commissione parlamentare di inchiesta presieduta dall’on. Giuseppe Fioroni, che
ha relazionato sull’attività svolta dalla Commissione nella seduta del 6
dicembre 2017. “In questo, come in altri ambiti, - si legge nella relazione
della Commissione trasmessa alla presidente della Camera dei deputati Laura
Boldrini e al presidente del Senato Pietro Grasso – la Commissione ha potuto
compiere passi avanti in quanto ha potuto acquisire un’ingente documentazione e
ha potuto individuare fonti dimenticate o occultate, che sono state lette alla
luce delle audizioni e delle attività d’indagine delegate ai collaboratori e
alle forze di polizia”. Il libro di 233 pagine ha le prefazioni di Maria Fida
Moro – primogenita di Aldo Moro, Giuseppe Fioroni – presidente Commissione
Moro 2, Alberto Franceschini – fondatore delle Brigate rosse, Ettore Rosato –
presidente Gruppo PD Camera Deputati. Per farne comprendere il vario, utile e
importante contenuto sulla tragica vicenda, ritengo di fare cosa utile riportare
l’ultimo capitolo del libro. “E’ quasi finita. Scrivo queste ultime righe del
libro il giorno di Natale 2017. Dopodomani il libro va in stampa. Ripercorro con
la mente quattro anni di lunghissimo e duro lavoro in tutta Italia, ma anche i
quaranta anni che intercorrono dal 16 marzo 1978 ad oggi. Tanti sacrifici, tante
rinunce, tante emozioni, tanto lavoro. 500 manifestazioni sul tema "Chi e
perché ha ucciso Aldo Moro", dappertutto in Italia. Accolto sempre benissimo da
amici del Partito Democratico, ma anche da tanti sindaci di altro schieramento e
da uomini e donne in rappresentanza di associazioni culturali. Nelle piccole e
grandi città. Senza il Gruppo del Partito Democratico alla Camera nulla sarebbe
stato possibile. Alla fiducia avuta ho risposto dando quattro anni della mia
vita. Ogni giorno. Stupendo il ricordo delle tante scuole visitate e dei
tantissimi giovani che mantengono un rapporto epistolare con me su Aldo Moro.
Grazie ai tantissimi Dirigenti Scolastici e ai tanti professori che hanno
studiato, approfondito e parlato di Aldo Moro. Sono la dimostrazione di una
scuola, quella italiana, che è migliore di come viene rappresentata, in alcuni
casi, dagli stessi operatori. La scuola che affronta il dramma Moro è una
scuola che guarda al futuro e che non ha paura della verità. Grazie alle
migliaia di cittadini che mi hanno ascoltato con una partecipazione emotiva
impressionante. Rivedo Aldo Moro quando ero bambino. Lui frequentava le piazze
di Puglia da Presidente del Consiglio. Un Uomo buono. Quando lo uccidono, Moro
ha poco meno di 62 anni. Il prossimo aprile io ne avrò 60. Tantissimi rispetto
al bambino che conosce Moro il 24 aprile 1963 a Terlizzi. Non avrei mai pensato
di sedere sui banchi che lui frequenta alla Camera dei Deputati dal 1946 al
1978. Mai avrei immaginato, come lui, di essere Vicepresidente di un Gruppo
Parlamentare. Piccole responsabilità le mie, rispetto alle grandissime sue.
Giustamente. Sono felice di esserci stato. La XVII legislatura è finita. Così
come finirono la XV e la XVI che mi videro Parlamentare della Repubblica. Un
grandissimo onore per me. Non so cosa mi riserva il futuro. Il mio ultimo
intervento alla Camera lo ricorderò sempre, come il primo. Sono intervenuto in
rappresentanza del Gruppo PD, il 13 dicembre 2017, per la dichiarazione di voto
sull’approvazione della Terza Relazione Moro, votata dal Parlamento
all’unanimità, con un solo astenuto. Mai avrei immaginato, in un Parlamento
diviso su tutto, tale coralità. Evidentemente, quando vuole, la classe politica
sa dare il meglio di sé. Come il Paese. Voglio ringraziare tutti coloro i quali
mi hanno aiutato ed anche quelli che mi hanno ostacolato. Ai primi il grazie per
la collaborazione, ai secondi il grazie perché hanno rafforzato in me la
convinzione che bisognava rincorrere la verità. Renato Dell’Andro, il giorno in
cui sostengo l’esame di Diritto Penale all’Università di Bari, mi dice: “Aldo
Moro non morirà mai. Nella vita e nella morte è stato un Maestro. Moro si è
distinto per la centralità che ha sempre dato ad ogni persona”. Rino Formica,
più volte Ministro socialista, barese, il 29 gennaio 1992, scrive: “Il mistero
della cattura, della prigionia e della morte di Aldo Moro è il grande buco nero
della storia repubblicana. Gli archivi da aprire sono numerosi, le sincere
confessioni forse non sono mai cominciate, ma ciò che si consolida è la
convinzione che subito maturò in noi: il sequestro Moro fu possibile perché
l’ordine internazionale difendeva disperatamente equilibri sempre più precari
avvalendosi di forze e apparati nazionali ossequiosi e marci. Se questa
tragedia, purtroppo, rivive con l’uso abile e spregiudicato di veri o falsi
annunci è perché tanti hanno avuto paura di andare sino in fondo”. L’obiettivo
della verità sulla strage dei cinque uomini della scorta ed il rapimento di
Aldo Moro in via Fani resta attuale, come attuale è la verità sulla morte di
Moro. La Commissione Moro-2 ha dato un grandissimo contributo facendo emergere
novità sinora sconosciute. Chi non vuole ammetterlo, commette un grave errore
ed è poco trasparente, se non in malafede. Io sono felice di aver parlato di
Moro in ogni parte d’Italia. Il mio omaggio ad uno statista e ai cinque uomini
della scorta, barbaramente assassinati: Oreste Leonardi, Domenico Ricci,
Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Forse oggi possono riposare
in pace. Sono lieto di aver contribuito a tutto questo e di aver donato il
massimo dell’impegno. Per Aldo Moro, il Paese, la verità e la giustizia ne è
valsa la pena. E’ stato bello. Grazie a tutti”. Vito De Leo.
Caso Moro e omicidio Dalla
Chiesa, spunta un boss di Taranto,
scrive il 23 gennaio 2018 su "La Ringhiera" Michele Tursi. E’ un intreccio fitto
e inestricabile. Verità ufficiali, verità paralelle, verità nascoste. Omissioni
e depistaggi. Dopo quarant’anni il caso Moro è ancora in cima ai misteri della
Repubblica italiana. Il buio e le nebbie sono stati in parte rischiarati e oggi
c’è una relazione approvata dal Parlamento che, come dice l’on. Gero Grassi, ci
consegna il 90 per cento della verità su una vicenda che tutti gli italiani
dovrebbero conoscere in cui ci sono state “anche le Brigate Rosse”. Serata ad
alta tensione quella proposta dalla Bcc San Marzano di San Giuseppe, con il
patrocinio del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo, svoltasi nella sala conferenze dell’Università, nella città
vecchia di Taranto. Protagonisti sono Antonio Ferrari, giornalista del Corriere
della Sera, autore del libro “Il Segreto” (ChiareLettere) che propone una
versione romanzata del caso Moro e l’on. Gero Grassi (Pd), componente della
Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul rapimento e sul delitto di Aldo Moro.
Un viaggio nelle trame che hanno segnato la storia d’Italia in cui compare anche
un malavitoso della provincia di Taranto. Si tratta di Alberto Lorusso di
Montemesola (di cui abbiamo già scritto), detenuto con Totò Riina nel carcere di
Opera a Milano. A lui il “capo dei capi” affida una confidenza sull’omicidio del
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: “Ci hanno chiesto un favore. Lo abbiamo
ucciso per fottergli le carte di Moro”. L’on. Grassi ricostruisce l’intreccio
tra le colonne dell’ex caserma Rossarol, citando a memoria date, nomi e frasi.
485 incontri e 170 audizioni ne fanno uno tra i massimi esperti di un delitto
intorno al quale nel 1978 convergono interessi nazionali ed internazionali. Una
scacchiera su cui si muovono la Cia, il Kgb, il Mossad, la loggia P2, la
camorra, la ‘ndrangheta e la mafia. Un caso su cui ancora oggi, dice Ferrari “ci
sono troppe cose che non quadrano”. Un mistero su cui molti vorrebbero
definitivamente stendere una coltre di silenzio perchè, come ammonisce il
giornalista del Corsera “la memoria dà molto fastidio”.
Dalla cella di Totò Riina i
segreti di un traffico di droga tra Taranto e Varese,
scrive il 16 novembre 2017 "La Ringhiera". A settembre era riuscito a sfuggire
alla cattura dileguandosi tra le campagne intorno alla propria abitazione a
Villa Castelli (Brindisi). Aveva poi lasciato l’Italia rifugiandosi in
Romania. Da qui, grazie all’appoggio di alcuni complici, era rimpatriato
utilizzando documenti falsi, travestimenti e parrucche. Infine aveva trovato
rifugio a Erchie, ospite di Emanuele Valentino Fazzi, 34 anni, personaggio noto
alle forze dell’ordine. Ma il ritorno in Italia è costato caro a Giancarlo
Matichecchia, 48 anni, nato a Cosenza, ma residente in provincia di Taranto. I
due sono stati bloccati ad Erchie a bordo di una Fiat Punto in uso a Fazzi.
Matichecchia si preparava a lasciare nuovamente il territorio nazionale per
raggiungere la Germania. Nell’auto i carabinieri del Ros (reparto operativo
speciale) hanno rinvenuto apparati telefonici dedicati, documenti falsi, uno
scanner e denaro in contanti. Per entrambi sono scattate le manette. Fazzi dovrà
rispondere di favoreggiamento personale, Matichecchia di associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi
da fuoco. Nei suoi confronti pendeva, infatti, un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della
Direzione distrettuale antimafia. Entrambi sono rinchiusi nella casa
circondariale di Brindisi. A settembre, quando Matichecchia scappò, erano stati
arrestati Pierluigi Cafforio, 38 anni, di Grottaglie (Taranto) e Salvatore
Margherita, 49 anni di Taranto. L’operazione fu eseguita dai carabinieri del ROS
coadiuvati dai comandi provinciali di Taranto e Varese ed era scaturita da
un’indagine condotta nei confronti di alcuni esponenti del clan Lorusso,
operante nel comprensorio di Grottaglie, ritenuti responsabili di traffico di
sostanze stupefacenti. L’inchiesta è partita da un’attività delegata al Ros
dalla Procura di Caltanissetta a seguito del coinvolgimento di Alberto Lorusso,
esponente di rilievo dell’omonimo sodalizio, nelle minacce rivolte dai vertici
di cosa nostra ai magistrati della Procura di Palermo Antonino Di Matteo e
Francesco Del Bene. Nel 2013 la Procura nissena aveva delegato il Ros allo
svolgimento di indagini su Lorusso che in quel periodo era detenuto insieme a
Totò Riina nel carcere di Milano-Opera. L’attenzione degli investigatori era
concentrata sull’effettiva disponibilità di un “arsenale militare” di cui
avevano parlato Lorusso e il boss mafioso. Lorusso, infatti, in più occasioni
aveva ricevuto le confidenze di Riina inerenti i propositi di vendetta nutriti
da quest’ultimo nei confronti dei responsabili dei disagi connessi al regime del
carcere duro cui era sottoposto. Lorusso avrebbe ascoltato anche le
considerazioni riguardanti gli auspicati attentati al pm Di Matteo a seguito
delle iniziative giudiziarie che avevano fatto scaturire il processo ai soggetti
coinvolti nella “trattativa”. Le attività investigative avevano preso il via con
il monitoraggio del nucleo familiare e dei soggetti vicini a Lorusso, tra i
quali Matichecchia e Margherita, quest’ultimo residente in provincia di Varese,
sul conto dei quali aveva già riferito, alla fine degli anni ’90, il
collaboratore di giustizia Ciro Carriere. Gli sviluppi dell’indagine hanno
permesso di accertare il coinvolgimento degli indagati nel traffico di sostanze
stupefacenti gestito da Matichecchia che vantava un consolidato rapporto con
esponenti della ‘ndrangheta di Rosarno (Reggio Calabria). In particolare,
venivano documentati diversi incontri, a Grottaglie, con esponenti criminali
reggini per pianificare l’importazione di sostanze stupefacenti da
commercializzare nelle provincie di Taranto e Varese. Le indagini hanno permesso
di individuare nelle rapine ai portavalori ad agli istituti di credito, un’altra
delle fonti illecite di guadagno degli indagati.
Moro: Fioroni, se protetto
altra piega,
scrive il 12 dicembre 2017, "Ansa". "Emerge con chiarezza che la storia avrebbe
preso una piega ben diversa se Aldo Moro fosse stato protetto". Lo afferma in
Aula, a Montecitorio, Giuseppe Fioroni, presidente della Commissione
parlamentare di indagine sul rapimento e la morte di Moro, presentando la terza
relazione dell'organismo parlamentare. Fioroni conferma quanto ha potuto
chiarire la Commissione, riferendosi alle segnalazioni fatte prima del sequestro
da fonti palestinesi, arrivate in Italia e lasciate senza seguito. Fioroni ha
ricordato come la vicenda "vada vista nell'analisi del contesto mediterraneo, in
particolare nella connessione con i rapporti Italia-Medio-Oriente".
Aldo Moro, a premere il
grilletto fu uno ‘ndranghetista calabrese.
Questi gli esiti del lavoro svolto dalla commissione parlamentare. Brigate rosse
ma non solo, per il rapimento e l'assassinio dello statista pugliese, scrive il
14 dicembre 2017 "Noi Notizie". Giustino Di Buono, calabrese ‘ndranghetista. Fu
lui a premere il grilletto e ad ammazzare Aldo Moro. Queste le conclusioni alle
quali giunge la commissione parlamentare presieduta dal parlamentare pugliese
Gero Grassi. Quasi in chiusura della legislatura, presentati gli esiti del
lavoro di quella commissione che, è detto con chiarezza dai commissari, porta a
dire: non solo brigate rosse. Magistratura che omise, una trattativa fra pezzi
dello Stato e criminalità negli anni Ottanta, un affaire ben più ampio della
stella a cinque punte.
La strage di via Fani e la
caccia alla ‘ndrangheta e ai servizi segreti. La commissione Moro è finita nel
nulla, senza scoprire complotti.
E alla fine i Ris e il Dna
confermano quel che sappiamo sul sequestro Moro. Non c'è singolo passaggio dei
"55 giorni" che non sia stato rivisitato, nel quadro di un'ottica dietrologica e
complottista: la commissione ha perlustrato una quantità enorme di piste e
ipotesi. Alla resa dei conti, però, tutte le ipotesi investigative scandagliate
non hanno prodotto risultati tali da consentire una sintesi coerente. E così la
Commissione non trarrà conclusioni, scrive Ugo Maria Tassinari, giornalista e
studioso, su "Notizie tiscali" il 14 dicembre 2017. Ancora una volta, una
commissione parlamentare d’inchiesta che si è occupata della vicenda Moro
finisce i suoi lavori senza giungere a conclusioni. Stamattina, in una
conferenza stampa, il presidente Fioroni presenterà il terzo report provvisorio,
un volumone di quasi 300 pagine che documenta un lavoro imponente ma impotente.
Era già successo sedici anni fa con quella presieduta dal senatore Pellegrino.
In quel caso, però, la bozza di relazione proposta dal parlamentare diessino
lasciò traccia, orientando saggistica e cronaca giornalistica sul terrorismo
italiano verso una maggiore attenzione al contesto internazionale e ai giochi
politici e militari delle potenze, più o meno grandi, attive nello scacchiere
mediterraneo.
La I Commissione e Leonardo
Sciascia. Solo la prima Commissione Moro c’è riuscita, nonostante la chiusura
anticipata di un anno della legislatura, nel 1983. Anzi mise capo a due
relazioni conclusive contrapposte, una di maggioranza approvata da Dc, Pci,
repubblicani e socialdemocratici, l'altra, opera prevalente di Leonardo
Sciascia, votata da uno schieramento trasversale che andava dal Msi ai
socialisti, cioè le forze che per distinte ragioni dissentivano dalle posizioni
e dalla ricostruzione storica di quello che era stato il "partito della
fermezza", l'ampia coalizione che rifiutò ogni trattativa con le Brigate rosse
durante il sequestro di Aldo Moro.
Tante le piste finite nel
nulla. Molte e roboanti le anticipazioni su clamorose svolte investigative
annunciate dal presidente Fioroni e dal più attivo dei commissari, Gero Grassi,
che si è impegnato in un faticosissimo e meritorio tour in decine di scuole per
raccontare a migliaia di studenti una pagina a loro spesso ignota della recente
storia italiana. Non c'è singolo passaggio dei "55 giorni" che non sia stato
rivisitato, nel quadro di un'ottica dietrologica e complottista: dal numero dei
brigatisti attivi a via Fani alle "presenze inquinanti" sulla scena del
rapimento ('ndranghetisti, uomini dei servizi segreti, terroristi tedeschi,
motociclisti di supporto), dalle prigioni di Moro alla visita di un sacerdote
nel covo, dalle influenze internazionali alle modalità dell'omicidio del leader
dc, la commissione ha perlustrato una quantità enorme di piste e ipotesi. Alla
resa dei conti, però, tutte le tracce investigative scandagliate non hanno
prodotto risultati tali da consentire una sintesi coerente. In molto casi sono
stati inviati gli atti alla magistratura romana delegandole il compito di fare
chiarezza e tirare le somme. Un'ammissione di resa per una commissione
d’inchiesta dotata di poteri giudiziari.
Le nuove tecnologie confermano
le sentenze. Gli accertamenti svolti applicando nuove tecnologie hanno
confermato nella sostanza le conclusioni processuali. Non risulta traccia del
Dna di Aldo Moro nel covo di via Gradoli, dove abitavano i capi delle Br, Mario
Moretti e Barbara Balzerani. L'analisi balistica con tecnica tridimensionale non
smentisce la ricostruzione dei brigatisti sulla dinamica della sparatoria di via
Fani. Anche la fase drammatica dell'esecuzione del presidente della Dc,
confutata da un agguerrito pool di cultori del "mistero Moro", ha retto alla
verifica dei Ris: le prove di ingombro, di sparo e acustiche hanno confermato la
compatibilità sostanziale del racconto brigatista. Moro è colpito da una raffica
appena si siede nel pianale posteriore della R4 poi si accascia, seguono altre
due raffiche e il colpo di pistola. A sparare sono stati in due, con il "quarto
uomo" Germano Maccari che subentra a Mario Moretti, emotivamente scosso. Una
dinamica che ha qualche evidente contraddizione e che difficilmente potrà essere
chiarita in futuro, visto che il primo brigatista, reo confesso, è morto da
tempo e il secondo si è sempre rifiutato di fornire precisazioni sui
particolari.
Quelle strane presenze in Via
Fani. In qualche caso sono stati gli stessi supertestimoni a venire meno:
l'ingegnere Marini, presente sulla scena del rapimento, dopo aver alimentato un
appassionato dibattito sulla presenza di una moto Honda a supporto del commando
brigatista, alla fine, ha ammesso che nessuno aveva sparato contro il suo
parabrezza ma che questo si era rotto nei giorni precedenti il 16 marzo. E
questa, paradossalmente, è una delle poche smentite delle sentenze passate in
giudicato: perché tra le condanne per reati "minori" dei brigatisti presenti a
via Fani c'è anche il tentato omicidio dello stesso Marini. Della testimonianza
di tale Nirta, nipote di un boss nella 'ndrangheta e identificato tra i presenti
sulla scena del crimine in un giovane riccioluto assai somigliante a Ninetto
Davoli, la Commissione ha deciso di fare a meno così come di altre tracce
investigative sui collegamenti tra Brigate rosse e terrorismo internazionale.
Tracce e materiali che sicuramente arricchiranno il dibattito e le inchieste
giornalistiche nei prossimi mesi.
Commissione Moro, approvata
dopo 40 anni la relazione che riscrive la verità sull'omicidio dello statista
della Dc. Il
documento spiega che il presidente della Dc avrebbe avuto la possibilità di
rimanere in vita: sarebbe bastata una macchina blindata e una scorta, scrive il
13/12/2017 Maria Antonietta Calabrò, Giornalista dell'Huffingtonpost.it. Tutto
quello che abbiamo saputo fin qui (e sono passati quasi quarant'anni anni) del
rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, è da riscrivere. Anzi, in gran parte è
stato già riscritto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da
Giuseppe Fioroni. La terza e ultima Relazione, approvata il 6 dicembre e
depositata per l'approvazione dell'Aula alla Camera, oggi, spiega come e perché
Moro non è stato ucciso sul pianale della Renault 4 rossa parcheggiata nel
garage di Via Montalcini 8. In base alle nuove perizie espletate dal Ris dei
Carabinieri, quell'auto non avrebbe potuto neppure avere il cofano aperto, tanto
ristretto era il box dove secondo la versione dei brigatisti sarebbe stata
eseguita la condanna a morte dello statista. Il documento spiega che veramente
il presidente della Dc avrebbe avuto la possibilità di rimanere in vita perché
la segnalazione di un possibile attentato, giunta a Roma dalle fonti palestinesi
del colonnello Giovannone, un mese prima del sequestro, era assolutamente
attendibile. A evitare la tragedia sarebbe bastata una macchina blindata e una
scorta.
Gallinari latitante nella
palazzina dello Ior. La Relazione spiega ancora che Moro ebbe la possibilità di
ricevere la visita di un prete e di confessarsi. Dimostra che in un modo o
nell'altro uomini del mondo vaticano sono stati centrali nella vicenda. A
cominciare dall'individuazione, nella zona della Balduina, in via Massimi 91, di
una palazzina, di proprietà Ior, la cosiddetta banca vaticana, (posseduta
attraverso la società Prato Verde srl, e gestita da Luigi Mennini), abitata (o
frequentata) da cardinali (Vagnozzi e Ottaviani), prelati e dallo stesso
presidente dello Ior, Paul Marcinkus. Dove aveva sede una società americana che
lavorava per la Nato, e vivevano in affitto esponenti tedeschi dell'Autonomia,
finanzieri libici e due persone contigue alle Brigate rosse. "Complesso edilizio
che, anche alla luce della posizione, potrebbe essere stato utilizzato - si
legge nel documento - per spostare Aldo Moro dalle auto utilizzate in via Fani a
quelle con cui fu successivamente trasferito oppure potrebbe aver addirittura
svolto la funzione di prigione dello statista". La Relazione, grazie a nuovi
testimoni, dimostra addirittura che Prospero Gallinari (il carceriere di Moro) e
le armi usate dalle Br a via Fani, sono stati nascosti per alcuni mesi,
nell'autunno 1978, nello stesso stabile di Via Massimi 91, in cui si ipotizza
essere stato il covo-prigione.
Una narrativa confezionata a
tavolino. Ma soprattutto la Commissione ha accertato - grazie alla
declassificazione di una grande quantità di atti dei servizi segreti e delle
forze dell'ordine seguita alla cosiddetta "direttiva Renzi", - che la
"narrativa" ufficiale sul sequestro e la morte di Moro, contenuta nel cosiddetto
memoriale Morucci-Faranda, altro non è che una "versione ufficiale e di Stato"
del caso Moro, preparata a tavolino molti anni prima che essa approdasse sul
tavolo di Francesco Cossiga. L'unica verità "dicibile" per chiudere l'epoca del
terrorismo. Una verità di comodo messa a punto da magistrati (Imposimato, Priore
citati con nome e cognome), esponenti delle forze dell'ordine e naturalmente dai
brigatisti. Valerio Morucci divenne addirittura consulente del Sisde, come si
chiamava allora il servizio segreto interno.
Echi di Guerra fredda: una
società americana e il Kgb. La stessa vicenda del suo arresto e di quello di
Giuliana Faranda in casa di Giuliana Conforto (figlia "del più importante agente
del Kgb in Italia", come l'ha definito il professor Christopher Andrew nel suo
libro "L'Archivio Microchip"), "è stata oggetto di una completa rilettura, che
ha consentito di mettere finalmente alcuni punti fermi sulla scoperta del
rifugio di Viale Giulio Cesare 47, ma anche di evidenziare uno scenario più
complesso, che chiama in causa la possibilità che l'arresto di Morucci e Faranda
sia stato negoziato". "Alla luce delle indagini compiute, comunque, scrive
Fioroni, il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro non appaiono affatto come una
pagina puramente interna dell'eversione di sinistra, ma acquisiscono una
rilevante dimensione internazionale". Ancora: "Al di là dell'accertamento
materiale dei nomi e dei ruoli dei brigatisti impegnati nell'azione di fuoco di
via Fani e poi nel sequestro e nell'omicidio di Moro, emerge infatti un più
vasto tessuto di forze che, a seconda dei casi, operarono per una conclusione
felice o tragica del sequestro, talora interagendo direttamente con i
brigatisti, più spesso condizionando la dinamica degli eventi, anche grazie alla
presenza di molteplici aree grigie, permeabili alle influenze più diverse". Al
riguardo Fioroni parla di "martirio laico" di Moro. Un martirio avvenuto ai
tempi della Guerra fredda.
Il figlio del capitano
Corelli. Un capitolo particolare è dedicato alle "protezioni" che hanno messo al
sicuro la latitanza di uno dei brigatisti presenti in via Fani, Alessio
Casimirri. La primula rossa delle Br, tuttora latitante, prima di giungere in
Nicaragua, riuscì più volte, in maniera rocambolesca, a sfuggire alla cattura.
Per l'ex brigatista, di cui anche nei mesi scorsi è stata sollecitata
l'estradizione, ci fu però un momento in cui mancò veramente un nulla ad
ammanettarlo. A riconoscerlo, proprio nei dintorni di San Pietro, fu il padre di
Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, uno dei più noti cantautori italiani.
"Mario Cherubini, che era un gendarme vaticano - ha raccontato il vicepresidente
della Commissione Vero Grassi - riconobbe Casimirri, già latitante, per strada e
corse a denunciarlo, ma non si riuscì a fermarlo". Negli scorsi giorni proprio
il cantante aveva raccontato a Vanity Fair di quando la famiglia Casimirri, a
metà degli anni '70, invitava i Cherubini nella casa di campagna a Monterotondo,
ricordando come lui, bambino, restava affascinato dai racconti che Luciano e
Ermanzia Casimirri facevano del figlio, già ai tempi provetto sub e pescatore
subacqueo, fino al giorno in cui lo stesso Alessio gli mostrò i suoi trofei di
pesca. Il padre di Casimirri, Luciano è a sua volta un personaggio leggendario.
Responsabile della Sala stampa vaticana sotto tre papi - Pio XII, Giovanni XXIII
e Paolo VI -, dunque per circa trent'anni, è stato un ufficiale italiano durante
la Seconda Guerra Mondiale sopravvissuto all'eccidio della Divisione Aqui a
Cefalonia, e secondo le parole del suo stesso figlio, alla sua figura si è
ispirato il romanzo dello scrittore britannico Louis De Bernières "Il mandolino
del capitano Corelli", e l'omonimo film interpretato da Nicholas Cage e Penelope
Cruz.
L’ultimo latitante del caso
Moro. Il mistero dell’arresto fantasma.
Trovato dalla commissione
parlamentare d’inchiesta un documento nell’archivio dei carabinieri. L’ex br
Alessio Casimirri è rifugiato in Nicaragua dal 1983, scrive il 18 ottobre 2017
"Il Corriere della Sera". La vita avventurosa dell’ex brigatista rosso Alessio
Casimirri — uno dei dieci componenti del commando che rapì Aldo Moro in via
Fani, 1l 16 marzo 1978, oggi sessantaseienne cittadino nicaraguense — s’è
dipanata tra i giardini vaticani dove giocava da bambino, la lotta armata
praticata negli anni Settanta e il rifugio centro-americano dove vive dal 1983.
Mai passato da una prigione; unico tra i sequestratori del presidente della
Democrazia cristiana ad aver evitato l’arresto. Una inafferrabile «primula
rossa», intorno alla quale si sono costruite ipotesi più o meno fondate, e
persino leggende. Alimentate prima dall’essere figlio e nipote di alti
funzionari della Santa Sede, con tanto di prima comunione ricevuta dalle mani di
Paolo VI, e poi dalle presunte protezioni garantite dal governo sandinista in
Nicaragua.
Nome già noto. Oggi però,
dagli archivi del Comando provinciale dei carabinieri di Roma, spunta un
documento che rappresenta un mistero autentico, e ripropone gli interrogativi
sull’ex terrorista ancora uccel di bosco. È un cartellino fotodattiloscopico
utilizzato per identificare le persone, saltato fuori dalle ricerche ordinate
dall’ultima commissione parlamentare d’inchiesta sul sequestro e l’omicidio
Moro. La data dell’avvenuto accertamento è il 4 maggio 1982, quando a carico di
Casimirri pendevano due mandati di cattura per associazione sovversiva e
partecipazione a banda armata, accusa debitamente annotata sul cartellino. E
alla voce «motivo del segnalamento» il compilatore tuttora anonimo (c’è una
firma illeggibile) scrisse «arresto». Ufficio segnalatore: una serie di
abbreviazioni che stanno a significare «Reparto operativo carabinieri Roma».
Logica vorrebbe che per Alessio Casimirri — un nome all’epoca già iscritto sulla
rubrica delle frontiere, come persona da fermare in caso di tentativo di
espatrio — quel giorno si fossero aperte le porte del carcere. Invece così non è
stato. Non risulta che l’allora militante delle Br dal nome di battaglia
«Camillo» (altro particolare segnalato sul cartellino) abbia mai messo piede in
una cella. Perché? Com’è possibile che un ricercato venga fermato e
fotosegnalato, ma poi liberato?
Dubbi e anomalie.
Dell’operazione non c’è traccia in nessun altro documento giudiziario, e alla
data del 4 maggio ’82 non si hanno notizie del suo fermo né di altri terroristi.
Un arresto fantasma, insomma; certificato da un documento apparentemente
autentico, senza che si sia mai realmente verificato. L’apparenza
dell’autenticità deriva dal fatto che il cartellino è di quelli effettivamente
in uso, nel 1982, alle forze di polizia, ma nella compilazione ci sono alcune
anomalie. La più evidente sta nella foto: non è di quelle normalmente scattate
negli uffici investigativi, su tre lati (di fronte, fianco destro e fianco
sinistro, accanto al misuratore di centimetri che stabilisce l’altezza) bensì è
un’unica fototessera, trovata probabilmente a casa di Casimirri durante una
perquisizione (senza esito, lui non c’era) effettuata durante i giorni del
sequestro Moro, il 3 aprile ’78. Perché? L’indicazione del falso nome «Camillo»
è di provenienza ignota, e le dieci impronte digitali delle due mani impresse su
entrambe i lati non si sa di chi siano: per procedere a un confronto la
commissione Moro ha chiesto alle autorità nicaraguensi, tramite canali
diplomatici, il recupero di quelle autentiche, ma la risposta (chissà quanto
credibile) è che non le hanno. Nello spazio riservato alla firma della persona
segnalata, il carabiniere compilatore scrisse «si rifiuta», e dunque non c’è
nemmeno la possibilità di perizie calligrafiche.
La lettera di Fioroni. Tutto
questo alimenta il mistero: si trattò di un’operazione interrotta (dopo il fermo
qualcuno intervenne per lasciare andare Casimirri), di cui qualche zelante
militare volle comunque dare atto lasciando una traccia rimasta sepolta in un
archivio per 35 anni? Oppure è un falso costruito apposta? Ma da chi, quando e
con quali finalità? Sono domande che autorizzano a riproporre i molti enigmi
maturati intorno all’ultimo latitante del «caso Moro»; compreso quello, rimasto
senza riscontri, a cui accennò l’ex pubblico ministero Antonio Marini alla
commissione stragi nel 1995, quando riferì la voce secondo cui l’ex br sarebbe
stato un informatore di un ex capitano dei carabinieri (poi identificato nel
generale Antonio Delfino, morto nel 2014) che l’avrebbe passato al Sismi, il
servizio segreto militare. Teorie mai verificate, che tornano d’attualità con la
prova dell’arresto fantasma.
Per adesso il presidente della
commissione Moro, Giuseppe Fioroni, si è limitato a scrivere una lettera al
presidente del Consiglio Gentiloni, e ai ministri Alfano, Minniti e Orlando, per
sottoporre nuovamente al governo la necessità di «promuovere l’estradizione del
latitante Alessio Casimirri». Fioroni ricostruisce la sua carriera di estremista
e brigatista, avanza «ampi dubbi sulle protezioni di cui egli poté eventualmente
godere», e cita il mistero del fermo per sostenere che «poté sottrarsi alla
giustizia grazie al concorso di una rete di complicità che la Commissione sta
cercando di ricostruire».
Caso Moro, spunta un
documento sul brigatista Casimirri: “Fu arrestato in Italia nel 1982. Ora
estradizione”.
Dopo il caso Battisti, Fioroni scrive al presidente del Consiglio e chiede
stesso impegno per estradizione dell'ex primula nera del brigatismo rosso. “La
latitanza è una offesa alle vittime e alla giustizia”, scrive Stefania Limiti il
18 ottobre 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Dalla grande nebulosa del caso Moro,
qui e là, viene sempre fuori qualcosa di inedito. La Commissione parlamentare
d’inchiesta ha scoperto che Alessio Casimirri, la primula nera del brigatismo
rosso, fu arrestato nel maggio del 1982 e nessuno lo aveva mai saputo. Significa
che rimase in Italia più a lungo di quanto non si supponesse fino ad ora, ed
anche che le ricerche furono fatte proprio male, e poi anche che potè contare su
una rete di complicità importante. Dalle recenti indagini è inoltre emerso che
diversi documenti e un’agendina telefonica che gli vennero sequestrati il 3
aprile 1978, durante una perquisizione disposta nell’ambito delle indagini sul
rapimento Moro, non sono mai stati oggetto di indagine. Giuseppe Fioroni,
presidente dell’organismo parlamentare, lo ha reso noto oggi diffondendo una sua
lettera al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ai ministri Minniti,
Orlando e Alfano, nella quale chiede al Governo lo stesso impegno profuso per
mettere all’angolo Cesare Battisti, l’ex militante dei Pac riparato in Brasile,
anche per ottenere risultati dalle autorità di Managua. Casimirri, infatti, vive
in Nicaragua da molti anni e di quel Paese è cittadino a tutti gli effetti,
motivo che rende l’iter burocratico assai complicato – l’Italia chiese invano
per la prima volta la sua estradizione nel settembre del 1988. Fioroni scrive
cautamente che le modalità con cui Casimirri lasciò l’Italia non sono mai state
chiarite: in realtà, si è scritto molto in questi anni e autorevoli osservatori
hanno sostenuto che scappò con comodo grazie ad un regolare passaporto falso
messogli a disposizione dai servizi segreti. Scappò in Francia con un compagno
brigatista, Raimondo Etro, ma questi ne perse le tracce per una settimana. Poi
lo rivide pronto alla partenza per l’oltreoceano, Etro rimase in Francia ed ebbe
altra sorte. Figlio di un funzionario dello Stato Vaticano, Casimirri fu un
dirigente di spiccò della colonna brigatista romana costituita attorno al
76-77 e che fu centrale dell’Operazione Frezza, il rapimento e il sequestro di
Aldo Moro. Alessio è componente del commando di Via Fani, dove viene preso il
presidente della Democrazia cristiana, miracolosamente o misteriosamente illeso,
e trucidati tutti gli agenti della sua scorta. Oltre all’ergastolo per il caso
Moro, pendono sulla sua testa anche altre pesanti condanne per l’omicidio dei
magistrati Palma e Tartaglione e degli agenti di Polizia Mea e Ollanu, colpiti
durante l’assalto di Piazza Nicosia alla sede della D.C. Secondo Fioroni “Lo
sforzo di ricerca della verità sulla vicenda Moro non può prescindere da un
ulteriore tentativo di porre termine a una latitanza che è offensiva per le
vittime e per la giustizia”. Ma c’è anche un altro piano di interesse: la fuga
di Casimirri, e la tenuta della sua latitanza, infatti, sono sempre state
oggetto di riflessione per gli straordinari contatti che le hanno consentite e
che gettano una lunga ombra non solo sulla sua figura ma anche sul delitto Moro
i cui misteri ruotano intorno alla esistenza e alla natura delle interferenze di
soggetti e forze estranei al mondo brigatista o criminale. Come
ilfattoquotidiano.it scrisse tre anni fa, nel 2006 Casimirri è uscito indenne da
un tentativo di esfiltrazione organizzato già nei minimi dettagli ma sospeso da
non si sa quale scala gerarchica e, in precedenza, nel ’98, fallì nel tentativo
di ascoltarlo anche il magistrato milanese Meroni, che cercava riscontri ad
alcune testimonianze che collegavano Valerio Morucci all’omicidio Calabresi.
Insomma, è una latitanza che pesa più di altre, se è possibile una gerarchia:
sono in tutto 34, secondo i dati del ministero della Giustizia, i ricercati
all’estero per fatti di terrorismo nazionale. Paradosso della nostra strana
storia: non c’è il nome del neofascista Delfo Zorzi perché nessun tribunale
riuscì ad incastrarlo.
Biografia di Alessio Casimirri
di Giorgio Dell'Arti.
Roma 1951. Terrorista.
L’ultimo brigatista latitante del commando che rapì Aldo Moro. Dopo essere stato
a Cuba e in Libia, dall’83 vive in Nicaragua.
Figlio di Luciano Casimirri,
capo dell’ufficio stampa e portavoce di tre pontefici, Pio XII, Giovanni XXIII e
Paolo VI. «Fu Paolo VI in persona a celebrare la sua prima comunione. Chissà se
avrebbe mai potuto immaginare che quel bambino sarebbe poi diventato uno dei
rapitori di Aldo Moro... Per il quale il papa rivolse agli uomini delle Brigate
Rosse un accorato appello per ottenerne la liberazione (Aldo Grandi) [L’ultimo
brigatista, Rizzoli 2007].
«A parlare di Casimirri come
componente del commando di via Fani furono Valerio Morucci e Adriana Faranda: i
due br dissidenti decisero di dissociarsi con un documento in cui per la prima
volta indicavano solo con le sigle i nomi di 2 terroristi mai comparsi prima,
cioè A.C. (Alessio Casimirri) e A.L. (Alvaro Loiacono). Ha avuto rapporti
proficui con i servizi segreti. Con quelli dell’Est, a suo tempo, tra l’81 e
l’82, essendo fuggito in Centroamerica dall’Italia passando per Parigi e poi
Mosca. Si favoleggia anche di una sosta a Cuba prima di essere fraternamente
accolto dal rivoluzionario Daniel Ortega a Managua. Ma l’ex terrorista ha
stretto un qualche accordo anche con i nostri servizi. Era il 1993 quando due
agenti del Sisde, Mario Fabbri e Carlo Parolisi, lo contattarono nel suo
ristorante “Magica Roma”, locale alla moda nel centro della capitale
nicaraguense. Il risultato si vide qualche mese dopo: quando la magistratura
romana poté impiantare il cosiddetto Moro quinquies, il quinto processo sul
delitto Moro, a carico di due soli imputati. Si chiamavano Germano Maccari e
Raimondo Etro. I nomi li aveva fatti Casimirri» (Sta).
La versione di Grandi sostiene
che il lignaggio ne avrebbe facilitato la fuga: «Nel giugno 1987, sul tavolo di
un dirigente del Sisde, Riccardo Malpica, arrivò un appunto riservato: “Fonte
confidenziale solitamente attendibile ha riferito che i brigatisti latitanti
Casimirri Alessio e Algranati Rita si troverebbero presso una missione cattolica
dell’Africa centrale. Il loro espatrio sarebbe stato favorito dall’intervento di
un soggetto che opera in Vaticano, probabilmente legato da vincoli di parentela
al Casimirri”» (Aldo Grandi, cit.).
«Ha avuto rapporti proficui
con i servizi segreti. Con quelli dell’Est, a suo tempo, tra l’81 e l’82,
essendo fuggito in Centroamerica dall’Italia passando per Parigi e poi Mosca. Si
favoleggia anche di una sosta a Cuba prima di essere fraternamente accolto dal
rivoluzionario Daniel Ortega a Managua. Ma l’ex terrorista ha stretto un qualche
accordo anche con i nostri servizi. Era il 1993 quando due agenti del Sisde,
Mario Fabbri e Carlo Parolisi, lo contattarono nel suo ristorante “Magica Roma”,
locale alla moda nel centro della capitale nicaraguense. Il risultato si vide
qualche mese dopo: quando la magistratura romana poté impiantare il cosiddetto
Moro quinquies, il quinto processo sul delitto Moro, a carico di due soli
imputati. Si chiamavano Germano Maccari e Raimondo Etro. I nomi li aveva fatti
Casimirri» (Sta).
Condannato all’ergastolo
(estradizione non concessa). Oltre al rapimento Moro, prese parte, il 10 ottobre
1978, anche all’omicidio del magistrato Girolamo Tartaglione. «Per questo su di
lui pendono sei ergastoli (mai un giorno di galera), emessi nel processo
Moro-ter. Prima di darsi alla latitanza fece parte del servizio d’ordine di
Autonomia operaia e gestì insieme alla moglie un’armeria vicino piazza San
Giovanni di Dio, a Roma. Adesso fa il ristoratore, sospeso tra il suo locale
storico a Managua, La Cueva del Buzo, e le battute di caccia subacquea a San
Juan Del Sur, dove ha aperto il suo secondo ristorante, il Doña Ines» (Andrea
Colombari, Rafhael Zanotti) [Sta 8/3/2010].
Già sposato con Rita Algranati
(vedi), in Nicaragua ha sposato, senza divorziare dalla Algranati, una Raquel
García da cui ha avuto due figli.
Casimirri, Br “protetto”.
Ma il padre di Jovanotti stava per catturarlo…,
scrive Robert Perdicchi martedì 12 dicembre 2017 su "Il Secolo d’Italia".
Coperto, protetto, aiutato a scappare. Solo adesso, grazie al lavoro della
Commissione d’Inchiesta sull’uccisione di Aldo Moro, emerge il ruolo degli
apparati segreti dello Stato, presumibilmente legati alla sinistra, che
favorirono la fuga di Alessio Casimirri, Brigatista rosso, figlio del capo
ufficio stampa del Vaticano ai tempi di Paolo VI, sempre sfuggito alla cattura.
Il presidente Fioroni, nel suo intervento in Aula, durante la presentazione
della relazione della commissione Moro, si è soffermato a lungo “sulla latitanza
di Casimirri, che indisturbato vive tuttora in Nicaragua”. “Di lui abbiamo
trovato una foto segnaletica e più volte venne segnalato, vivendo però, fino al
luglio dell”83, in Italia”, sottolinea Fioroni. “Casimirri riuscì poi ad
espatriare con un passaporto grossolanamente contraffatto – ricorda il
presidente della Commissione –. Poi ci fu un fallimentare tentavo nel ’93 per
arrivare all’estradizione”. “A salvarlo – conclude Fioroni – non sono stati solo
i rapporti con i sandinisti, ma anche coperture di cui ha goduto in Italia”. La
primula rossa delle Br, Alessio Casimirri, prima della latitanza in Nicaragua,
riuscì più volte, in maniera rocambolesca, a sfuggire alla cattura. Per l’ex
brigatista, figlio di un notabile vaticano, ci fu però un momento in cui mancò
veramente un nulla ad ammanettarlo. A riconoscerlo, proprio nei dintorni di San
Pietro, fu il padre di Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, uno dei più noti
cantautori italiani. “Mario Cherubini, che era un gendarme vaticano – racconta
all’AdnKronos, Gero Grassi – riconobbe Casimirri, già latitante, per strada e
corse a denunciarlo, ma non si riuscì a fermarlo”. Negli scorsi giorni proprio
il cantante aveva raccontato di quando la famiglia Casimirri, a metà degli anni
’70, invitava i Cherubini nella casa di campagna a Monterotondo, ricordando come
lui, bambino, restava affascinato dai racconti che Luciano e Ermanzia Casimirri
facevano del figlio, ai tempi provetto sub e pescatore subacqueo, fino al giorno
in cui lo stesso Alessio gli mostrò i suoi trofei di pesca.
Jovanotti: "Quando il mio
amico diventò brigatista".
Jovanotti in esclusiva su Vanity Fair racconta la sua infanzia in
concomitanza con l'uscita del suo nuovo album, scrive Luisa De Montis, Mercoledì
08/11/2017, su "Il Giornale". Un'intervista senza filtri che anticipa l'uscita
del nuovo album Oh, vita!, che uscirà il primo dicembre. L'amico nelle brigate
rosse. "In Vaticano mio padre aveva un collega, un suo
superiore, Luciano Casimirri. Nei fine settimana, con una moglie dal nome
indimenticabile, Ermanzia, ci invitava nella casa di campagna di Monterotondo,
io avevo otto-dieci anni e loro ci raccontavano con ammirazione del
figlio Alessio". E ancora: "Era molto più adulto di me e, a detta dei suoi, era
un sub provetto. Io me l’immaginavo subito come una specie di Jacques Costeau e
fantasticavo su questo lupo di mare (…). Una di quelle domeniche Alessio si
manifestò e mi portò nella sua stanza per mostrarmi pesci bellissimi di ogni
dimensione, tutti catturati e catalogati da lui, tra cui spiccava la foto di una
micidiale murena": spiega il cantante a Vanity Fair. Peccato che quel ragazzo
poi intraprese strade tortuose e criminose: "Venni a sapere, anni dopo, che era
entrato a far parte delle Brigate Rosse partecipando al rapimento di Aldo Moro e
al massacro della sua scorta in Via Fani per poi scappare in Nicaragua" ammette
Jovanotti. Un dettaglio della sua infanzia mai rivelato prima.
Jovanotti, retroscena
sull’assassinio di Aldo Moro: “Che amara scoperta…”. A tre settimane da "Oh,
vai", torna a raccontarsi Jovanotti. E svela un inedito retroscena
sull'infanzia, scrive Manuel Magarini l'8 novembre 2017 su "Ultimenews.net".
L’Italia, si sa, pullula di grandi artisti. Alcuni ribelli, altri un po’
spocchiosi. In pochi emanano però un intenso calore umano come Jovanotti.
Perché, al di là dell’indiscutibile estro, ciò che lo denota è una “normalità”
quasi insolita nel suo ambiente. Ed anche per questo fan e addetti ai lavori lo
ricoprono d’affetto. In fremente attesa per “Oh, vita!”, il quattordicesimo
album – negli store tra tre settimane – di Lorenzo Cherubini, che a Vanity Fair
svela il suo coloratissimo mondo interiore.
Jovanotti: l’ingresso nella
musica. “Il mio ingresso nella vita sociale risale all’estate del 1982 –
racconta Jovanotti -. Quella del Mondiale vinto dall’Italia. L’estate più
importante di sempre, quella in cui scoprii la musica. Iniziai a mettere dischi
in radio e poi in una discoteca di Cortona. La mia prima paga da dj, 5.000 lire,
me la ricordo ancora”. Una stagione memorabile “perché coincise con l’esatto
momento in cui capii cosa volessi fare nella vita. Senza neanche l’ombra di un
dubbio. Fu un istante di illuminazione totale, quasi mistica”.
Jovanotti: come sbarcava il
lunario. Jovanotti conobbe di lì a poco il primo mentore: “Mio fratello Umberto
– lo ringrazierò per sempre – aveva un amico che faceva un programma di dediche
a Radio Foxes. Mi portò con lui, entrai in questo studiolo, con le scatole di
uova alle pareti per insonorizzare la stanza in maniera rudimentale e pensai:
“Cazzo, ma questo è il posto più bello del mondo”. Poco tempo dopo mi ritrovai
in onda. Dalle 14 alle 16, a titolo gratuito. All’epoca la radio era un
passatempo e non c’era uno di noi che venisse pagato”. Ma i soldi “si
trovavano”. Con quali lavori? “Il cameriere alle sagre, e lì si prendevan le
mance che era un piacere e il barista nel bar di mio zio. Poi lo sverniciatore”.
Jovanotti: triste ricordo. Nel
corso della chiacchierata c’è anche spazio per un retroscena inedito. E
doloroso. “In Vaticano, dove lavorò per mezzo secolo, mio padre aveva un
collega, un suo superiore, Luciano Casimirri – ricorda Jovanotti -. Nei fine
settimana, con una moglie dal nome indimenticabile, Ermanzia, ci invitava nella
casa di campagna di Monterotondo, io avevo 8 o 10 anni e loro ci raccontavano
con ammirazione del figlio Alessio. Era molto più adulto di me e, a detta dei
suoi, era un sub provetto. Io me l’immaginavo subito come una specie di Jacques
Cousteau e fantasticavo su questo lupo di mare con il fucile in mano e il
cappellino rosso calato sulla testa. Una di quelle domeniche Alessio si
manifestò e mi portò nella sua stanza per mostrarmi pesci bellissimi di ogni
dimensione, tutti catturati e catalogati da lui, tra cui spiccava la foto di una
micidiale murena. Venni a sapere, anni dopo, che era entrato a far parte delle
Brigate Rosse partecipando al rapimento di Aldo Moro e al massacro della sua
scorta in via Fani, per poi scappare in Nicaragua. Non ci possiamo fare mai
un’idea definita su niente e nessuno. Ci si immerge e non si sa mai cosa si può
incontrare, le murene per esempio, attraenti e pericolosissime”.
Caso Moro, parla l’ex Br
che fu sospettato di essere il passeggero della moto in via Fani.
Raimondo Etro uscì ben presto da quell'ipotesi investigativa. Arrestato nel '94
eseguì alcuni sopralluoghi alla Chiesa di Santa Chiara frequentata dal
presidente Dc. Racconta: "Alessio Casimirri (uno degli autisti delle Br presenti
in via Fani, ndr) mi disse che era successo qualcosa di imprevisto che potrebbe
riguardare una moto e chi la guidava", scrive Stefania Limiti (autrice del libro
Doppio livello, edito da Chiarelettere) su "Il Fatto Quotidiano il 23 marzo
2014. All’inizio si sospettò che proprio lui, Raimondo Etro, l’uomo delle
Brigate rosse finito il carcere nel 1994, fosse uno dei passeggeri della moto
Honda notata il 16 marzo del 1978 in via Fani dall’ingegner Alessandro Marini
durante il sequestro del presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro. La
stessa moto su cui ora s’ipotizza ci fossero due uomini dei servizi segreti per
proteggere l’azione dei brigatisti. Il particolare, tutto da confermare, viene
raccontato da un ex agente dell’antiterrorismo di Torino che svela l’esistenza
di una lettera scritta da uno dei due motociclisti. Etro, intanto, uscì subito
da quella storia. Non era lui l’uomo sulla Honda. Però, oggi, ricorda un
passaggio del suo vecchio interrogatorio che alla luce dei nuovi scenari diventa
altrettanto clamoroso. “Alessio Casimirri (uno degli autisti delle Br presenti
in via Fani, ndr) mi disse che era successo qualcosa di imprevisto (durante
l’attentato) che potrebbe riguardare una moto e chi la guidava”. Il ruolo di
Etro nell’affare Moro fu chiarito dopo il suo arresto. All’epoca aveva 37 anni.
Prospero Gallinari gli chiese, infatti, di fare un accurato sopralluogo nella
chiesa di Santa Chiara, dove Aldo Moro era solito andare a pregare la mattina
presto: svolse con cura il suo lavoro, andando ogni giorno in chiesa e facendosi
passare con il parroco per un ragazzo in cerca di sé stesso. Fece una cartina
millimetrica del luogo ma alla fine non se ne fece nulla perché, spiegò durante
il processo Moro Quinques, “non sarebbe stato facile immobilizzare la scorta di
Moro fuori dalla Chiesa”. Questi gli iniziali propositi brigatisti. Il ruolo di
Etro finì lì. Si era anche pensato di organizzare un avvistamento via radio
dell’auto di Moro: Raimondo avrebbe dovuto dare il segnale ma le prove non
andarono bene e non se ne fece nulla. Tuttavia conobbe durante quei tentativi il
capo brigatista Mario Moretti e Barbara Balzerani: si incontravano in via Stresa
per provare e riprovare. Iniziato al gioco dell’eversione da Alessio Casimirri e
Rita Algranati, i suoi compagni lo ritenevano comunque uno con i nervi fragili.
Durante l’attentato al giudice Palma, nel febbraio del ’78, non riesce a premere
il grilletto: nel commando c’è Gallinari che porta a termine l’agguato.
Impossibile, perciò, dargli altro lavoro nell’Operazione Frezza, come le Br
chiamarono il progetto di rapire Aldo Moro. Fu avvisato dal suo amico Casimirri,
due giorni prima del 16 marzo, che stava per compiersi l’azione del secolo. Oggi
Raimondo Etro è un uomo che porta i segni delle sue scelte. Le novità sul caso
Moro, le stringenti rivelazioni di un ufficiale di polizia sull’identità dei due
uomini sulla Honda, agenti legati al colonnello del Sismi Camillo Guglielmi (che
ha sempre ammesso la sua presenza a via Fani la mattina del 16 marzo) lo
colpiscono come un fulmine e ammette di essere sconvolto. “Se fosse vero – dice
– tutto sarebbe da riscrivere”. Ricorda che nel 1996 ebbe i primi barlumi di
consapevolezza che la vicenda che lo vide protagonista era troppo grande per
poter essere stata gestita tutta dai suoi compagni ma, allo stesso tempo, Etro
si è sempre rifiutato di pensare che esistesse una doppia mano nella vicenda che
segnò la storia delle Brigate rosse e del paese. Continua: “Se fosse confermata
questa nuova versione, significa che in via Fani c’era anche lo Stato. Ma molti
di noi non ne sapevano niente. E non ne abbiamo mai saputo niente dopo. Anche
se”. Cosa? “Non ho mai capito come Alessio Casimirri e Rita Algrani riuscirono a
scappare in Nicaragua: erano insieme in Francia, Antonio Savasta stava
collaborando e dovevamo cercare riparo. Per una settimana sparirono e poi vengo
a sapere che sono fuggiti in America Latina. E poi ancora: perché Casimirri è
ancora libero e Rita Algranati, che lasciò il Nicaragua alla volta dell’Algeria,
fu poi ‘venduta’ e catturata durante il governo Berlusconi (l’operazione fu
condotta dal colonnello Mario Mori che ottenne un accordo di cooperazione con
l’Egitto per arrestare l’ex moglie di Casimirri, ndr). Sarà forse perché il
padre di Casimirri era molto amico del generale Santovito? Certamente non
quadrano molte cose, la sua latitanza fa davvero pensare a quella assicurata
a Delfo Zorzi”. Perché sceglieste proprio Aldo Moro? “Gallinari disse che era
l’uomo sopra le parti, che non era un capo corrente e che per lui la Dc avrebbe
trattato. Un capo corrente lo avrebbero lasciato a se stesso. Negli anni mi sono
reso conto che in realtà era l’uomo più in conflitto con gli Stati Uniti mentre
noi aveva di lui l’idea ben altra idea. Sbagliammo”, chiosa Etro che non vuole
aggiungere altre riflessioni e chiede tempo. Stefania Limiti (autrice del libro
Doppio livello, edito da Chiarelettere)
Da chi si finge morto a chi
apre un ristorante. Ecco chi sono i 34 assassini ancora in libertà.
Di molti si sa dove
sono ma non si riesce a portarli a casa. Con qualche eccezione, scrive Stefano
Zurlo, Domenica 15/10/2017 su "Il Giornale". É la lista ufficiale dei fuggitivi.
Quella che circola negli uffici dell'Interpol. Trentaquattro nomi di ricercati
che col tempo sono diventati imprendibili: quasi tutti terroristi rossi legati
alla Spoon River degli anni Settanta e Ottanta. Qualcuno probabilmente è morto,
di altri si sono perse le tracce, ma molti sono, teoricamente, a portata di
mano. Si sa dove abitano ma non si riesce a riportarli in Italia anche se sono
passati decenni da quei delitti e da quelle pagine di sangue. É il caso appunto
di Cesare Battisti, inseguito, come ha raccontato al Giornale il sottosegretario
Cosimo Ferri, dal lontano 2003: prima in Francia, dove aveva provato a stanarlo
l'allora Guardasigilli Roberto Castelli, e ora in Brasile. In Francia risiede
anche Giorgio Pietrostefani, dirigente di Lotta continua, ritenuto con Adriano
Sofri il mandante dell'assassinio del commissario Luigi Calabresi, avvenuto a
Milano il 17 maggio 1972, il prologo degli anni di piombo. Gli ex brigatisti e i
reduci delle altre formazioni della galassia terroristica hanno trovato rifugio
e protezione un po' ovunque, aiutati qualche volta dal passaporto di un altro
Paese o da un matrimonio all'altro capo del mondo. Cosi alcuni nomi, pesi
massimi della storia dell'eversione, sono diventati bersagli virtuali. Si sa
benissimo che, a parte improbabili colpi di scena, non verranno più acciuffati
anche se sulle spalle hanno una condanna che non va mai in prescrizione:
l'ergastolo. É la situazione in cui si trovano Alvaro Lojacono e Alessio
Casimirri, due membri del commando che il 16 marzo 1978 in via Fani a Roma rapi
Aldo Moro e sterminò la sua scorta. Lojacono è diventato cittadino svizzero per
via della madre ed è inavvicinabile; stesso discorso per Casimirri che si è
sposato in Nicaragua, ha ottenuto la cittadinanza, oggi ha un ristorante a
Managua. In Sudamerica, più precisamente in Perù, erano arrivati ormai molti
anni fa Oscar Tagliaferri e Maurizio Baldasseroni, protagonisti di uno degli
episodi più feroci e, se possibile, insensati, di quell'interminabile mattanza:
la strage di via Adige a Milano, il 1 dicembre 1978. Tre morti, ammazzati a
fucilate. Un massacro compiuto non in nome dell'ideologia, ma dettato da futili
motivi, tanto che i due furono buttati fuori da Prima linea cui avevano chiesto
invano una copertura e la rivendicazione del gesto, ma aiutati ad espatriare.
Ora,a distanza di tanto tempo, Baldasseroni è stato dichiarato morto,
Tagliaferri è invece sempre presente negli archivi dell'Interpol e
dell'intelligence. É invece considerato un irriducibile Claudio Lavazza, il cui
percorso coincide per un tratto con quello di Cesare Battisti. I due vengono
condannati al carcere a vita per i quattro omicidi compiuti dai Pac, i Proletari
armati per il comunismo, una meteora nella storia dell'eversione. Poi però
prendono strade diverse: Battisti comincia la partita al gatto e al topo con la
giustizia italiana, Lavazza entra nell'orbita dell'anarchia e viene arrestato in
Spagna nel 1996 dopo una rapina ad una banca. Ventuno anni dopo è ancora in
prigione e dalla sua cella lancia proclami contro il Fies, l'equivalente
spagnolo del 41 bis. Ma il destino di Lavazza è segnato: conclusa la detenzione
in Spagna, lo attendono le carceri italiane e quelle francesi con condanne
severissime e un fine pena lontanissimo sul calendario. Gli anni di piombo non
passano mai.
I misteri infiniti delle
Br. Davanti
alla Commissione d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro il
fondatore delle Brigate Rosse, Alberto Franceschini, parla della scuola di
lingue Hyperion di Parigi, del rapporto tra gruppo storico e morettiani e delle
figure di Valerio Morucci e Giovanni Senzani, scrive Salvatore Ventruto il 23
febbraio 2017 "L'Intellettuale Dissidente". Quando un componente
della Commissione d’inchiesta sul caso Moro gli chiede quale sia stato il motivo
che nel 1972 portò le Brigate Rosse a respingere la richiesta di adesione di
Valerio Morucci, a quei tempi esponente di spicco di Potere Operaio, Alberto
Franceschini non lascia molto spazio alla fantasia: “C’erano vari motivi. Il
primo è che a me e altri Morucci non piaceva. Il secondo è che Morucci faceva
traffico di armi tra la Svizzera e l’Italia, armi che poi distribuiva al
movimento. Fu scoperto, insieme a un altro o ad altre due persone. Sta di fatto
che uno o due di loro si fecero sei mesi di galera, Morucci sì e no venti giorni
e uscì”. E’ un Franceschini collaborativo quello che un paio di settimane fa si
è approcciato di nuovo con i commissari, dopo l’audizione dello scorso 27
ottobre. Ancora una volta ha evidenziato come le BR, per lui che le aveva
fondate, fossero finite già nel 1976, quando il capo incontrastato era Mario
Moretti. Cresciuto in una famiglia comunista, con il padre e il nonno
protagonisti della Resistenza antifascista, Franceschini ha sempre sostenuto nei
suoi libri, interviste e incontri che la militanza brigatista fosse per lui il
naturale seguito della lotta partigiana. Arrestato nel 1974 a Pinerolo mentre
era in macchina con Renato Curcio, altro esponente di spicco del gruppo storico
brigatista, Franceschini ha rappresentato tra la fine degli anni novanta e gli
inizi del nuovo secolo colui che più di ogni altro ha affrontato alcuni elementi
poco chiari o del tutto sconosciuti del brigatismo italiano e del sequestro
Moro. Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse assieme a Renato
Curcio. Viene arrestato nel 1974 a Pinerolo. In alcuni suoi libri, ad esempio
“Che cosa sono le BR”, affronta e approfondisce alcuni elementi ancora oscuri
sulla nascita delle BR e il sequestro Moro. Recentemente alla domanda se
esistesse o meno un piano di messa in sicurezza delle Brigate Rosse ha risposto:
“Mi verrebbe da dire l’Hyperion”. Il “ragazzo dell’appartamento”, ha fatto
dimenticare ai commissari i mi avvalgo della facoltà di non rispondere e i non
gradisco che avevano caratterizzato, qualche settimana prima, la testimonianza
di Valerio Morucci, ex leader della colonna romana delle BR, protagonista
dell’azione militare che portò la mattina del 16 marzo 1978 al rapimento di Moro
in via Fani. Personaggio particolare Morucci, da maneggiare con estrema cura.
Prima responsabile del servizio d’ordine di Potere Operaio, poi brigatista dal
1976. Partecipò all’agguato di via Fani, ma fu, secondo le ricostruzioni
ufficiali, contrario assieme ad Adriana Faranda, sua compagna, all’esecuzione di
Aldo Moro, incarnando quell’ala “trattativista” che sarebbe diventata
interlocutrice degli “autonomi” Lanfranco Pace e Franco Piperno nell’ambito dei
ripetuti tentativi messi in atto dal Partito Socialista per salvare il
Presidente della DC. Sul suo famoso “Memoriale” di 300 pagine, poi
clamorosamente sconfessato dalle ultime indagini e da più approfonditi
riscontri, si è basata per anni la ricostruzione dettagliata dell’operazione
militare che portò al rapimento di Moro e all’uccisione della sua scorta.
Rimane ancora un mistero la telefonata che Morucci fece la mattina del 9 maggio
1978 alle ore 12.15 a Francesco Tritto, stretto collaboratore di Moro,
per annunciare la morte del Presidente della DC. Ancor più alla luce di quanto è
stato riscontrato dall’attuale commissione d’inchiesta e cioè che Francesco
Cossiga, allora Ministro dell’Interno, ricevette già alle ore 11 la telefonata
del Prefetto di Roma che annunciava la morte di Moro. Perché Morucci telefona
un’ora e quindici minuti dopo il Prefetto? Quella telefonata può essere
considerata come un depistaggio che sancisce l’inizio della collaborazione di
Morucci con lo Stato, al punto da far redigere a quest’ultimo un falso memoriale
sull’agguato di via Fani? Quando Morucci, dopo la morte di Moro, esce assieme
alla Faranda dalle BR, decide di portarsi via tutte le armi che aveva portato
all’interno del gruppo: mitra, munizioni, pistole rinvenute il 29 maggio 1979,
giorno del loro arresto, nell’appartamento di Viale Giulio Cesare, 47. In
quell’appartamento viene trovato anche un elenco di 90 brigatisti e anarchici.
Alla domanda del Presidente Fioroni se i due volessero vendere l’elenco “per
fare la stessa fine di Casimirri” (ultimo grande latitante dell’operazione Moro,
da 30 anni in Nicaragua), Franceschini dice: “può essere anche se non conosco
esattamente gli atti”.
Comincia nel 1982 al Foro
Italico il processo per l’assassinio di Aldo Moro e della sua scorta. Nella
foto, due dei maggiori imputati, Valerio Morucci e Adriana Faranda. “Solo
a Giovanni Senzani – continua Franceschini – ritrovarono un elenco di nomi
all’interno di un panino mentre era detenuto nel carcere di Rebibbia. Quel
panino e quell’elenco furono intercettati e molti compagni furono arrestati” -
aggiunge, precisando come anche Senzani, leader del comitato rivoluzionario
toscano delle BR, sia stato per lui una figura difficile da capire. Senzani fu
oggetto di un dossier da parte della Commissione Stragi presieduta negli anni
‘90 dal Senatore Giovanni Pellegrino in cui si precisava che la sua figura
“potrebbe aver avuto un coinvolgimento pieno e determinante nella vicenda Moro,
non solo attraverso l’organizzazione a Firenze delle riunioni del comitato
esecutivo delle BR durante i 55 giorni del rapimento, ma anche svolgendo, grazie
alla sua statura intellettuale e alla grande esperienza politica e giuridica, il
ruolo di grande inquisitore nel corso delle controverse fasi del processo al
quale venne sottoposto lo stesso Moro”.
Giovanni Senzani. Negli anni
’70 insegna all’Università di Firenze ed è consulente del Ministero della
Giustizia. Contemporaneamente fa parte della direzione strategica delle Brigate
Rosse. Dopo 23 anni di carcere non si è mai pentito. Dopo aver confermato che
“l’attenzione sulle Brigate Rosse da parte dello Stato è sin dalla nascita”,
Franceschini ha parlato anche di Corrado Simioni e del ruolo ambiguo di
Hyperion, la scuola di lingue fondata a Parigi nel 1976 dallo stesso Simioni,
Duccio Berio e Vanni Mulinaris. Nel 1970 i tre si “staccarono” dal gruppo
originario di Sinistra Proletaria, che poco dopo avrebbe dato vita alle Brigate
Rosse, e formarono il Superclan. Quando i commissari gli chiedono di fare
un’analisi storica della figura ambigua di Simioni e della scuola parigina,
capace di aprire due sedi di rappresentanza a Roma nelle settimane del sequestro
Moro e rivelatasi successivamente una centrale del terrorismo internazionale
infiltrata dai servizi segreti di tutto il mondo, Franceschini è come se
ammettesse la “sconfitta” del gruppo storico. “Se devo fare una riflessione
onesta e sincera – dice – è che noi abbiamo sbagliato tutto e loro hanno capito
tutto. Chi andò a Parigi, chi stabilì certe relazioni, certi rapporti aveva
capito una serie di cose”. All’Hyperion e ai personaggi che le ruotavano
attorno, che secondo Franceschini “operarono a livello geopolitico alto,
utilizzando i residui della politica bassa”, sono legati gran parte dei misteri
ancora irrisolti della galassia brigatista. Fu il giudice istruttore del
Tribunale di Venezia Carlo Mastelloni ad azzardare per primo, nel 1984,
l’ipotesi che l’Hyperion avesse avuto un ruolo di mediazione nelle forniture di
armi che l’Olp garantì ai brigatisti. Oggi, dopo più di trent’anni, i rapporti
tra le BR e le organizzazioni palestinesi tornano sotto la lente d’ingrandimento
del caso Moro, grazie a una lettera che il 21 giugno 1978 il colonnello Stefano
Giovannone scrisse da Beirut. Nella missiva, l’ex ufficiale del Sismi, di stanza
in Libano, riferiva della possibile consegna, da parte delle Brigate Rosse, al
leader palestinese George Habbash di una parte dei verbali degli interrogatori
subiti dal Presidente DC durante la prigionia, al fine di ristabilire il
rapporto di collaborazione interrotto da due anni. Un documento, quindi, che
farebbe presagire relazioni tra le Brigate Rosse e palestinesi anche prima
dell’operazione Moro, diversamente da quanto dichiarato in più occasioni da
Mario Moretti. “L’ipotesi che io mi sono sempre fatto è che certamente i
cosiddetti brigatisti, morettiani o non morettiani, avevano dei rapporti con i
palestinesi”. Franceschini torna poi sui contatti tra lui e Curcio, in carcere,
e i “compagni” che pianificarono e gestirono l’operazione Moro. “Io e Renato dal
1976 in avanti siamo molto critici con quelli fuori perché secondo noi avevano
abbandonato il terreno del movimento dicendo che bisognava prendere le armi.
Ricordo che ciò che ci fece infuriare di più fu il ritrovamento degli
interrogatori di Moro nelle carte di via Monte Nevoso perché i compagni fuori ci
avevano sempre detto che lui non aveva mai detto niente, nonostante nei primi
giorni avessero affermato invece che stava parlando e che tutto andava bene”.
Rapporti che secondo Franceschini si chiusero definitivamente dal giorno
della scoperta del covo di via Gradoli e del depistaggio del Lago della
Duchessa. “Da lì cambia radicalmente la posizione di quelli fuori che fanno
sapere a noi dentro che non potevano tirarci più fuori”, dice Franceschini. A
dimostrazione, forse, che gli interessi estranei al movimento brigatista avevano
ormai preso il sopravvento nella vicenda.
CASO MORO, 40 ANNI DI
INDAGINI ED UNA VERITÀ “DICIBILE”.
Commissione Moro: “Ciò che abbiamo saputo finora è una verità dicibile: servì a
chiudere la stagione del terrorismo”. La commissione d'inchiesta presieduta dal
deputato Pd è alla terza relazione. E stabilisce un punto fermo: intorno alla
figura dell'ex brigatista Morucci è stata creata una "operazione di
sdoganamento" di una versione dei fatti falsa: "Fu quasi una trattativa". Una
verità "di comodo" alla quale hanno contribuito diversi soggetti, secondo la
commissione: dai giudici Imposimato e Priore al Sisde fino a politici e
religiosi come suor Teresilla, "in quota Cossiga", scrive Stefania Limiti su "Il
Fatto Quotidiano" il 12 dicembre 2017. Caso Moro. Quaranta anni di indagini
fatte male e veri e propri depistaggi. Ma arrivata alla terza relazione la
commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro fornisce ora un punto fermo:
quel che abbiamo saputo fino ad ora del rapimento, dell’omicidio e delle
indagini del presidente della Democrazia Cristiana è frutto di una “verità
dicibile”, come la definisce il presidente della commissione Giuseppe Fioroni.
Una verità “dicibile”, di comodo, alla quale hanno contribuito i soggetti “che
operarono attorno al percorso dissociativo di Valerio Morucci: i giudici
istruttori Imposimato e Priore, il Sisde, alcune figure di rilievo della
politica e delle istituzioni, suor Teresilla Barillà”, la religiosa mandata
da Francesco Cossiga nelle carceri più come spia che per dare conforto ai
detenuti. La terza relazione della commissione Moro è oggi in calendario in Aula
alla Camera. Non è quella conclusiva, anche se non è certo se si arriverà a una
sintesi anche perché le attività d’indagine possono proseguire fino allo
scioglimento della legislatura, peraltro sempre più prossimo. Dopo 164 sedute
plenarie in 4 anni il materiale raccolto è molto. In parte è ancora sotto
segreto perché consegnato alla Procura di Roma che ha un fascicolo aperto, altro
alla Procura generale della Capitale che segue alcuni specifici filoni
soprattutto sulla strage di via Fani. La verità “dicibile”, dunque, come pagina
inversa rispetto alle “verità indicibili” cui ha spesso fatto riferimento
procuratore alla corte d’Appello di Palermo Roberto Scarpinato. Si legge nella
relazione che lo spazio di dialogo tra Morucci e le istituzioni “di per sé non
implica che le dichiarazioni processuali di Morucci siano viziate. È
però innegabile che, con il concorso di forze diverse, si venne a creare una
posizione processuale particolarmente garantita, nella quale il ruolo
testimoniale scoloriva in una più ampia e opaca funzione consulenziale del
Morucci, quasi realizzando concretamente una trattativa che veniva pubblicamente
negata”. Nel caso Moro, dunque, secondo la relazione della commissione, attorno
alla figura di Morucci, ex brigatista responsabile logistico delle Brigate
Rosse, è stata creata una grande operazione di sdoganamento di una versione dei
fatti falsa. Dall’agguato di via Fani alla prigione di via Montalcini,
dalla dinamica della fuga ai contatti con il mondo politico esterno alla
prigione, la circolazione degli scritti di Moro e la loro misteriosa scomparsa,
tutto è stato raccontato secondo una modalità concordata, lungo un processo di
“stabilizzazione della verità parziale, funzionale a una operazione di chiusura
della stagione del terrorismo che ne espungesse gli aspetti più controversi,
dalle responsabilità politiche e istituzionali al ruolo di quell’ampio partito
armato, ben radicato nell’estremismo politico, di cui le Br costituirono una
delle espressioni più significative del terrorismo”. Parole che trovano
dettaglio nelle molte pagine della relazione che spiegano passo dopo passo
la costruzione del Memoriale Moro e un suggello nelle attività di consulenza
avviate da Morucci con l’intelligence: già nel 1984 il direttore del
Sisde Vincenzo Parisi trasmetteva al Cecis (l’organo di coordinamento dei
Servizi) una lettera (12 aprile ’84) nella quale Morucci esponeva il “personale
programma di politica carceraria, finalizzato ad un uso del carcere in funzione
“controemergenziale” e a una ricerca di ‘soluzione politica’”. L’anno
successivo, nel 1985, sempre il Sisde considerava Morucci “una fonte da
cautelare in assoluto”. Tra il 1986 e il 1987 il rapporto Morucci-Sisde appare
continuativo e presenta diversi aspetti di tipi consulenziale, anche in una fase
in cui Morucci rendeva dichiarazioni nei processi Metropoli e Moro-ter,
fortemente segnati dalla sua collaborazione. Certo è che nel luglio 1988 una
copia del “Memoriale” identica a quella che sarà resa nota nel 1990 era già
stata acquisita dal Sisde, tanto da poter affermare che quel documento, su cui
sono stati imbastiti processi e scritti libri, più che un Memoriale sia
piuttosto un dossier dei servizi, servito sul piatto d’argento ad una classe
politica e giudiziaria impegnata principalmente a conservare il proprio ruolo.
Già in sede di pubblicistica il Memoriale era stato buttato giù dal piedistallo,
ora c’è molto materiale che dimostra puntualmente la grande operazione di
imbrigliamento della verità. E non è poco, insieme a tanto altro: a proposito di
depistaggi, lo stabile di via Massimi 91, quello nel quale avviene con quasi
certezza lo scambio delle auto usate dai brigatisti, è l’unico della zona
“sensibile” di via via Fani che non fu perquisito: forse per un milieu
abbastanza elevato di cui facevano parte cardinali e prelati, “come il
cardinal Egidio Vagnozzi, già delegato apostolico negli Stati Uniti e, dal 1968,
Presidente della Prefettura per gli affari economici della Santa Sede, e il
cardinal Alfredo Ottaviani. Risulta inoltre, da alcune testimonianze, un’assidua
frequentazione del complesso da parte di monsignor Paul Marcinkus. Alcune
testimonianze indicano anche una frequentazione dei prelati in questioni da
parte di Moro e dell’onorevole Piccoli”. All’interno del complesso si
riscontrano tuttavia anche presenze di altro genere, che potrebbero aver avuto
una funzione specifica in relazione al sequestro Moro. Lì abitava la giornalista
tedesca Birgit Kraatz, già attiva nel movimento estremista “Due giugno” e
compagna di Franco Piperno. Secondo la testimonianza di più condomini Piperno
frequentava quell’abitazione e, secondo una testimonianza che l’interessato ha
dichiarato di aver appreso dal portiere dello stabile, lo stesso Piperno avrebbe
da lì osservato i movimenti di Moro e della scorta. Oltre ad una serie di
personaggi legati alla finanza e a traffici tra Italia, Libia e Medio Oriente va
sottolineata la presenza di una società statunitense, la Tumco, compagnia
americana che nel 1969 forniva assistenza alla presenza Nato e Usa in Turchia e
attività di intelligence a beneficio dell’organo informativo militare
statunitense la cui sede era in edificio di Via Veneto a Roma, noto come The
Annexe, “l’annesso”, l’edificio supplementare. ra le altre presenze
significative nel complesso c’è poi quella di Omar Yahia(1931-2003), finanziere
libico, legato all’intelligence libica e statunitense, il cui ruolo è ampiamente
trattato nella sentenza-ordinanza “Abu Ayad”. Di certo lì, in via Massimi 91,
nell’autunno del ’78 per diverse settimane venne ospitato Prospero Gallinari:
riservati i nomi dei suoi due ospiti per tutelare le indagini ancora in corso.
Ma è nebbia, dunque, sulla prigione di Moro, mentre si infittisce il materiale
che offre spunti di indagine e di ricostruzione letteraria – nuovi elementi
sulle protezioni di Alessio Casimirri, una confessione in punto di morte del
maresciallo Angelo Incandela sulle carte trovate dal generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa, una inedita dichiarazione del pentito Michele Galati sul sacerdote
che andò nella prigione a confessare Moro. Forse con più ordine metodologico si
poteva ottenere di più, ma c’è tanto per riflettere e discutere. Chissà se la
politica se ne occuperà.
Aldo Moro, il testimone mai
ascoltato svela nuovi dettagli sull'omicidio.
Il film “Mario Mori un’Italia a testa alta” a 40 anni dalla morte di Aldo Moro,
scrive Patrizio J. Macci, Mercoledì, 6 dicembre 2017, su "Affari Italiani". Ugo
Pecchioli “ministro degli interni” dell’allora Pci insieme a Francesco Cossiga
gestì l’apertura della Renault 4 nel quale fu ritrovato il corpo di Aldo Moro la
mattina del 9 maggio 1978. Lo racconta per la prima volta in una lunga
intervista il Generale dei Carabinieri Mario Mori. La dinamica degli eventi che
seguì al ritrovamento del corpo di Aldo Moro, leader della Democrazia Cristiana
ucciso dalle Brigate Rosse, in via Michelangelo Caetani nel cuore del centro
storico romano a poche centinaia di metri dalle sedi della Dc e del Pci è dunque
ancora incerta e tutta da scrivere. I fatti. Mori il 16 marzo del 1978, il
giorno del sequestro di Aldo Moro, venne nominato comandante della Sezione
Anticrimine del Reparto Operativo di Roma, cominciando un lungo periodo che lo
vedrà protagonista nella lotta al Terrorismo. Con queste testuali parole
ricostruisce per la prima volta quei momenti: “Cossiga era vestito di grigio,
Pecchioli mantenne un atteggiamento freddo, fu lui a gestire operativamente
l’apertura della portiera e la vicenda connessa alla Renault 4. Pecchioli
(“ministro dell’interno del PCI”) era lì insieme a Cossiga, poi quando Cossiga
capì che quel cadavere era quello di Aldo Moro si allontanò. Fece qualche passo,
andò a finire sugli scalini di Palazzo Antici. Si appoggiò al muro e cominciò a
piangere. Pecchioli rimase freddo, impassibile, assunse la direzione delle
operazioni da uomo delle istituzioni come ritengo e ritenevo che fosse”.
Nell’intervista rilasciata a Giovanni Negri non vi è nessuna indicazione precisa
che possa mettere in discussione la scansione temporale di quella mattinata
“infernale”: l’ora esatta in cui accadono gli eventi raccontati dal Generale
rimane indefinita. Mori non è mai stato ascoltato dalle commissioni istituite
nel corso degli anni per cercare di sbrogliare la matassa del Caso Moro. Perché
questa amnesia? Frugando tra le migliaia di pagine del Caso prodotte dalle varie
commissioni negli anni, non c’è traccia di questa ricostruzione dei fatti.
Cossiga divenuto poi presidente della Repubblica (dopo i cinquantacinque giorni
che fecero tremare la Repubblica si mostrò al pubblico con i capelli
improvvisamente divenuti bianchi) è morto, così come il senatore Pecchioli
scomparso all’inizio degli Anni Novanta. Ma una commissione d’inchiesta è ancora
attiva e sta alacremente svolgendo un lavoro d’indagine sotto la guida del
Senatore Beppe Fioroni, democristiano come lo è stato Aldo Moro, e terminerà i
suoi lavori con questa legislatura. Mori è dunque uno degli ultimi testimoni
viventi del Caso, uno dei pochi che potrebbe gettare una nuova luce sul puzzle
di un delitto del quale ancora troppe sono le tessere mancanti. Il film
“Generale Mori. Un’Italia a testa alta” del regista Ambrogio Crespi Prodotto
dalla Index Production dedicato alla ricostruzione della vita di Mori che nel
film viene definito uno degli “uomini più potenti d’Italia”, nel quale è
contenuta la rivelazione, è stato presentato nella Biblioteca della Camera dei
Deputati e uscirà nelle sale a gennaio.
Caso Moro, quella zampata
sovietica dietro il sequestro,
scrive Elisa Calessi il 13 Dicembre 2017 su "Libero Quotidiano". La verità sul
rapimento e sulla morte di Aldo Moro va riscritta. Da cima a fondo. È questa la
conclusione a cui arriva l'immane lavoro fatto dalla commissione di inchiesta
parlamentare presieduta da Beppe Fioroni e che proprio ieri ha presentato la
relazione finale in Parlamento: 700mila pagine di documentazione, riassunte in
un testo finale che accende i riflettori su diversi aspetti finora non emersi.
Primo: il ruolo dell'Unione sovietica, in particolare di un suo agente, noto ai
Servizi italiani. Secondo: i rapporti con l'Olp. Terzo: la casa dello Ior dove
visse Prospero Gallinari, uno dei carcerieri di Aldo Moro. E ancora: la
latitanza di Alessio Casimirri in Nicaragua, il ruolo di ambienti criminali o
border-line, l'azione di Bettino Craxi e di ambienti milanesi nel tentativo di
salvare la vita dello statista democristiano. Sono questi, per sommi i casi, gli
«elementi nuovi» emersi nel lavoro della commissione. Novità che, come ha
precisato Fioroni, «sono state immediatamente trasmesse alla procura di Roma».
Non è detto, quindi, che non ci siano sviluppi imprevisti, come la riapertura
dell'inchiesta. Intanto la commissione, grazie non solo alle migliaia di
audizioni fatte, ma anche alla possibilità di acquisire documenti finora coperti
dal segreto, offre una prima verità sui 55 giorni di quel 1978. Diversa da
quella finora data per certa. Il primo elemento riguarda la casa dove Valerio
Morucci e Adriana Faranda, due dei brigatisti che organizzarono rapimento e
sequestro, furono arrestati il 29 maggio 1979. Finora si era sempre detto che
l'arresto avvenne grazie ai gestori di un concessionario che vendeva auto, da
cui Faranda comprò due vetture. Invece ci fu un altro canale, attivato dalla
Digos. E aveva a che fare con il proprietario di quella casa. L' appartamento di
via Giulio Cesare, dove furono trovati Morucci e Faranda, era di proprietà di
Giuliana Conforto, figlia di Giorgio, agente dell'Unione sovietica, uomo del
Kgb, ma anche confidente degli 007 italiani. Sarebbe stato lui a «negoziare» con
i Servizi italiani l'arresto dei due brigatisti per salvare la figlia, che
infatti ebbe un trattamento piuttosto morbido. Il suo ruolo è accennato in una
nota del Sismi che però, misteriosamente, viene tenuta nascosta ai magistrati
che allora indagano sulla vicenda. Altra novità inquietante è che Moro poteva
essere salvato. «Una semplice lettura combinata dei documenti programmatici
delle Brigate rosse e delle informative che provenivano dal Medio Oriente», si
legge nella relazione, «avrebbe consentito di individuare una specifica
necessità di tutelare la persona dell'onorevole Moro». Viene riscritta la
dinamica dell'attentato in via Fani. C' è poi il ruolo dello Ior, la cosiddetta
Banca Vaticana: era di proprietà dell'Istituto, infatti, il «complesso» che
«ospitò nella seconda metà del 1978 Prospero Gallinari e che era caratterizzato
dalla presenza di prelati, società Usa, esponenti tedeschi dell'autonomia,
finanzieri libici e di due persone contigue alle Brigate rosse». Quella casa
potrebbe essere stata utilizzata «per spostare Aldo Moro dalle auto utilizzate
in via Fani a quelle con cui fu successivamente trasferito oppure potrebbe aver
addirittura svolto la funzione di prigione dello statista». Altro elemento che
emerge «con chiarezza» è che non c' è stata una «regia unica» nella vicenda
Moro. In conclusione, il rapimento e l'omicidio dello statista democristiano non
sono solo opera di quattro brigatisti, non è un affare solo interno alla
sinistra, «ma acquisiscono una rilevante dimensione internazionale».
Via Fani, come fu occultato
il filo rosso delle munizioni che dal Medio Oriente portava alle Br.
Nell’ultima relazione della commissione d’inchiesta su Moro si ricostruiscono
molti rapporti tra terroristi rossi e gruppi palestinesi, scrive Francesco
Grignetti il 13/12/2017 su "La Stampa". I proiettili che furono usati dai
brigatisti rossi per sterminare la scorta di Aldo Moro venivano dall’estero. Più
esattamente dal Medio Oriente. Erano stati fabbricati dalla ditta Fiocchi di
Lecco, presumibilmente prima del 1973, ed erano destinati all’esportazione. Si
trattava di una partita di munizioni per armi da guerra destinate all’Egitto, ma
che probabilmente prese un’altra strada, forse qualche gruppo palestinese di
fede marxista, e che rientrò in Italia per finire negli arsenali delle Br.
Quanto a una pistola mitragliatrice Beretta M12 utilizzata nell’eccidio,
successivamente sequestrata a un brigatista, si scoprì che faceva parte di una
partita di armi destinata all’Arabia Saudita. La storia delle armi e delle
pallottole di via Fani è una delle tante scoperte che la Commissione
parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di Aldo Moro ha affidato alla sua ultima
relazione, ora a disposizione del Parlamento e dell’opinione
pubblica. Importante scoperta. Che si trattasse di munizioni «egiziane», i
giornali lo avevano scritto subito. Viene citato un articolo de La Stampa a
firma di Vincenzo Tessandori, del 13 agosto 1978 («Caso Moro. Torna la pista del
Cairo. Identificato un “br” di via Gradoli»). Lo scriveva anche la povera
Graziella De Palo (inghiottita assieme a Italo Toni dal Libano dilaniato dalla
guerra civile) su «L’Astrolabio» il 14 giugno. Ma questa era una pista che
evidentemente qualcuno riteneva pericolosa e da smontare. Così capitò che i
periti del primo processo Moro sostennero semplicemente che quello stock di
munizioni non faceva parte delle dotazioni standard, ma lasciavano aperta la
possibilità che fossero dotazioni delle forze speciali. Gli investigatori della
Digos di Roma, successivamente, annusarono che in ambienti giornalistici e
politici si vociferava che «dagli esami compiuti dai periti su alcuni bossoli
rinvenuti in questa via Fani, risulterebbe che le munizioni usate provengono da
un deposito dell’Italia settentrionale le cui chiavi sono in possesso di sole
sei persone». In tutta evidenza ci si indirizzava verso i nostri 007. E magari
s’alludeva alla Gladio, che era ancora un segreto gelosamente custodito.
Puntualmente la notizia finì sui giornali e nelle interrogazioni parlamentari.
Ne nacque un caso. Diventò una «vulgata» infrangibile. Da quel momento in poi fu
abbastanza ovvio interrogarsi se dietro la strage non vi fosse l’eterodirezione
dei nostri 007 (ma quantomeno pasticcioni, se lasciavano tracce così evidenti).
Ci dice ora la commissione presieduta dall’onorevole Giuseppe Fioroni, Pd: «Tali
armi e munizioni potrebbero essere state esportate in Medio Oriente in virtù di
traffici la cui segretezza era da tutelare a ogni costo, sia perché fondati su
accordi politici internazionali sconosciuti all’opinione pubblica sia perché
coinvolgevano specifiche responsabilità». Sarebbero stati gli stessi 007 a
indirizzare i sospetti su di loro per nascondere le tracce del Lodo Moro?
L’avrebbero fatto per tutelare comunque e dovunque i palestinesi, rapporto che
era fondamentale per molteplici scopi? C’è poi una questione subordinata. I
brigatisti di via Fani si nascosero dietro le fioriere di un bar. Il bar
Olivetti. Il titolare di quel bar si è scoperto solo ora che era al centro di
mille traffici sospetti, a metà strada tra ’ndrangheta calabrese e clan
libanesi. Era suo socio un tal Luigi Guardigli, molto vicino alla sinistra
extraparlamentare, dedito all’import–export di armi, «a suo dire autorizzate»
verso diversi paesi del Nord Africa e del Medio Oriente quali, in particolare,
Egitto, Arabia Saudita, Libano ed Algeria. Su Olivetti e Guardigli non si è mai
indagato in relazione alla strage. «La necessità di tutelare la riservatezza di
questi traffici potrebbe spiegare il lungo oblio sul bar Olivetti e sulla figura
del suo titolare. Accendere i riflettori su questo locale avrebbe infatti fatto
riemergere una vicenda di traffico di armi, che coinvolgeva soggetti
appartenenti alla ’ndrangheta e partite di armi assemblabili, che, secondo
quanto riferito anche dal generale Cornacchia in audizione presso la
Commissione, erano utilizzabili sia dalla criminalità organizzata che dalle
Brigate rosse».
IL SEGRETO…
"Il segreto"
di Antonio Ferrari, Editore: Chiarelettere. Descrizione. Un thriller travolgente
che ha anticipato verità che 35 anni fa non potevano essere dette e che ora,
finalmente, sono emerse grazie alle commissioni d’indagine e a nuove
testimonianze. Le avventure dell’agente segreto americano Ron J. Stewart, tra
Praga, Parigi, Berlino... È il 1978. L’Italia si trova al centro del più grosso
complotto internazionale del dopoguerra. Il romanzo che nessun editore ha voluto
pubblicare e che dopo 35 anni vede finalmente la luce! Dopo aver indagato sulle
Br ed essere stato minacciato più volte e scortato, l’autore, inviato del
“Corriere della Sera”, amico di Walter Tobagi, ai tempi della scoperta della P2
fu incaricato dalla direzione del giornale di scrivere un romanzo-verità su
quegli anni. Ferrari lo scrisse raccontando quello che sapeva ma non poteva
essere detto. Fu così che nessuno glielo pubblicò e non solo: ci fu anche chi si
adoperò in tutti i modi perché il libro rimanesse segreto. Il segreto: “Quando
si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta La verità è sempre
illuminante Ci aiuta a essere coraggiosi” (Aldo Moro) Marzo 1978: l’Italia si
trova al centro di uno dei più grossi complotti internazionali del dopoguerra Il
romanzo sul rapimento Moro che per 35 anni nessuno ha voluto pubblicare Troppo
vero e troppo imbarazzante Per tutti | Tutto ha inizio al “Marriott hotel” di
Washington Nessuno dei convocati sa qual è veramente la posta in gioco e il
ruolo che ciascuno di loro avrà nel più grosso complotto internazionale degli
ultimi decenni Non lo sa nemmeno Ron J Stewart, agente segreto americano, pronto
a tutto, una vita segnata da missioni impossibili Ma questa che sta per essergli
affidata è la più mefitica e delicata in assoluto In gioco c’è il futuro
politico dell’Italia e i rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica Fermare
l’entrata al governo del PCI usando qualsiasi mezzo, anche le Brigate rosse:
questo l’obiettivo Tra Praga, Parigi, la Berlino attraversata dal Muro, Milano,
Genova, in accordo con altri agenti segreti dell’Est e dell’Ovest, al di fuori
dei canali ufficiali, Stewart dovrà infiltrarsi e aiutare i terroristi nella
loro azione eversiva e destabilizzante.
Un caso editoriale. Il
romanzo-verità sull’Italia dei giorni del rapimento Moro, per anni tenuto
nascosto. Tutto ha inizio al “Marriott hotel” di Washington. Nessuno dei
convocati sa qual è veramente la posta in gioco e il ruolo che ciascuno di loro
avrà nel più grosso complotto internazionale degli ultimi decenni. Non lo sa
nemmeno Ron J. Stewart, agente segreto americano, pronto a tutto, una vita
segnata da missioni impossibili. Ma questa che sta per essergli affidata è la
più mefitica e delicata in assoluto. In gioco c’è il futuro politico dell’Italia
e i rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Fermare l’entrata al governo
del PCI usando qualsiasi mezzo, anche le Brigate rosse: questo l’obiettivo. Tra
Praga, Parigi, la Berlino attraversata dal Muro, Milano, Genova, in accordo con
altri agenti segreti dell’Est e dell’Ovest, al di fuori dei canali ufficiali,
Stewart dovrà infiltrarsi e aiutare i terroristi nella loro azione eversiva e
destabilizzante. A farne le spese, l’uomo politico italiano più famoso. Un
agente segreto francese, scoprendo la trama che si stava tessendo, cercherà
invano di salvare il leader democristiano. Invano, perché “lui” doveva morire.
Commissionato a Ferrari con non poche pressioni dal “Corriere della Sera”
devastato dallo scandalo P2, tenuto nel cassetto per anni, questo romanzo
avvincente e coraggioso anticipava quanto poi in parte confermato da nuove
testimonianze e dalle commissioni d’indagine sul delitto Moro. Un vero caso
editoriale. “Tanti ‘dettagli’ che sembravano indimostrabili e figli della
dietrologia – sostiene oggi l’autore – purtroppo o per fortuna si sono
dimostrati veri. Fu davvero un orrendo complotto, che oggi non fa più paura
raccontare, o forse ne fa molta meno”.
Br, la fabbrica del
complotto non riposa mai,
scrive Paolo Delgado il 22 Settembre 2017 su "Il Dubbio". E anche sul caso Moro
spuntano i Servizi segreti. Valerio Morucci un uomo del Sisde? L’inquietante
domanda arriva da Giuseppe Fioroni, il presidente della commissione bicamerale
che riindaga sulla strage di via Fani. La nuova ondata di interrogativi
partorita dalla commissione non si discosta dalla tante che si sono susseguite.
Valerio Morucci un uomo del Sisde? Ma non era Mario Moretti il fellone al soldo
non si sa di chi ma in questi casi i servizi “deviati” si sa che c’entrano
sempre? I due, lo sa chiunque abbia anche solo sfiorato il caso Moro, erano in
conflitto frontale. Vorrà dire che dietro il fattaccio che seppellì la vera
prima Repubblica si davano da fare non uno ma due pupari impegnati in cinica
tenzone sulla pelle del presidente della Dc? Il dubbio, l’inquietante domanda,
la vertigine che deriva giocoforza da questo proliferare di ipotesi
contraddittorie spunta quando il presidente della commissione bicamerale che ri-
indaga sulla strage di via Fani, 16 marzo 1978, e sui successivi 55 giorni
chiede ad Adriana Faranda, all’epoca del sequestro compagna di Morucci, se è al
corrente della collaborazione del medesimo “Pecos”, come soprannominato un
tempo, col Sisde nel 1990, quando i due ex Br non facevano peraltro più coppia
fissa da un bel po’. Faranda cade dalle nuvole. Balbetta qualcosa come un
classico «Non so.. Non credo… Sarà stata una consulenza». In realtà nel mistero
numero centomila di misterioso non c’è nulla. Uscito da poco di galera,
riciclatosi da esperto d’armi in tecnico informatico, squattrinato, Morucci
cercava lavoro a destra e manca, bussava a ogni porta inclusa quella del Sisde,
col quale aveva avuto inevitabili contatti negli anni della collaborazione, sia
pure in veste di dissociato e non di pentito, con investigatori e inquirenti. La
nuova ondata di interrogativi partorita dalla nuova commissione Moro non si
discosta dalla tante che si sono susseguite nel corso dei decenni. Monta ipotesi
e dicerie promuovendole a fatti. Scarta a priori l’eventualità della pura
coincidenza. Trasforma il sospetto in indizio. Uno sguardo ai più scottanti tra
i neo- misteri aiuta a capire. E’ tornata in auge l’idea che dietro alla strage
di via Fani ci sia la ‘ ndrangheta, che va da sé avrebbe comunque lavorato in
conto terzi. La prova è una foto nella quale, tra la folla addensata nella via
dopo il massacro, compare un uomo che potrebbe somigliare al nipote omonimo di
un boss calabrese: Antonio Nirta. Forse si tratta davvero di lui, forse no. Le
risultanze dicono che «non si può escludere» ma alcuni militanti romani dicono
invece di aver riconosciuto un compagno del Movimento di allora. Quand’anche si
trattasse davvero del Nirta junior in questione, la presenza nella folla sarebbe
magari un po’ poco per concludere che le ‘ ndrine avevano pianificato e magari
anche eseguito la mattanza. Niente da fare: dietro il sequestro c’è “l’ombra
della ‘ ndrangheta”, e chi ne dubita o è tonto o cospira a propria volta. E’
inoltre data per appurato, anche in seguito all’audizione di uno dei leader del
Fronte popolare per la liberazione della Palestina, Abu Sharif, che il capo dei
servizi segreti in Medio Oriente nonché uomo di fiducia di Moro Stefano
Giovannone, si trasferì a Roma, si adoperò come poteva, coinvolse i vertici
dell’Olp che volentieri collaborarono. In realtà Sharif ha detto che quella
collaborazione non ci fu e né fu chiesta, pur assicurando, parola sua, che le Br
erano infiltratissime dagli americani. Ma che Giovannone si sia dato da fare è
comunque certo, anche perché era stato lo stesso Moro a chiedere il suo
intervento, nella prima lettera dal carcere. E’ probabile che qualcosa i
palestinesi abbiano davvero provato a fare, nonostante le assicurazioni in senso
opposto di Sharif. Perché il fatto dovrebbe suscitare scalpore però resta in
effetti misterioso, fatto salvo il particolare dei rapporti tra Olp e Br che in
effetti l’Olp per primo ha tutto l’interesse a negare per sin troppo ovvi
motivi. La cosa ha una sua rilevanza, che però con la morte di Aldo Moro non
c’azzecca. Più diretto sarebbe stato l’intervento di non meglio identificati
“tedeschi”, eventualità suffragata soprattutto dal fatto che una testimone
avrebbe sentito gridare in via Fani “Achtung, Achtung”. Sembra una barzelletta.
Non lo è. Ma sulla credibilità dei testimoni capitati in mezzo a una sparatoria
velocissima e comprensibilmente frastornati è d’uopo ricordare che per decenni
interi castelli di ipotesi azzardate sono state costruite sulle dichiarazioni
del superteste Alessandro Marini, quello sul quale avrebbero aperto il fuoco i
due sconosciuti sull’ormai famigerata Honda crivellando il parabrezza. Solo
l’anno scorso un giovane ricercatore ha rintracciato le foto scattate in via
Fani dopo l’agguato. Il parabrezza di Marini è intatto. Il caso estremo è quello
del Bar Olivetti, proprio di fronte al luogo dell’attacco in via Fani. Il 16
marzo 1978 era chiuso da un bel po’. Capita però che qualcuno si ricordi di
averci preso il caffè proprio quella mattina. La commissione ipotizza che il bar
fosse aperto, con ciò stabilendo che per oltre 35 anni le indagini erano state
affidate all’ispettore Clouseau (cfr. La pantera rosa). Essendo piuttosto facile
certificare che il locale era effettivamente chiuso, sorge il dubbio che però
all’interno ci fosse qualcuno, evidentemente appostato dietro le saracinesche
calate, e chissà perché l’idea balzana debba apparire più realistica che non uno
scherzo della memoria di quanti, sempre dopo 35 anni e oltre, si sono ritrovati
in bocca il sapore del caffè degustato quel giorno. Naturalmente il gioco
perverso ma gustosissimo delle coincidenza non si ferma qui. Il proprietario del
bar, Tullio Olivetti, era infatti stato coinvolto in una storiaccia di traffico
d’armi, uscendone però pulito. Il che sembrerebbe significare che non c’entrava
niente, ma solo per gli ingenuotti. Rivela invece le alte coperture di cui il
reprobo potrebbe aver goduto, a ulteriore conferma della trama fitta dietro il
sequestro. Del resto, ciliegina sulla torta, Olivetti era a Bologna il 2 agosto
1980, giorno della strage. Gatta ci cova e “tutto si tiene”, secondo il motto
che orienta gli incubi dei paranoici ovunque nel mondo.
“IL SEGRETO” DI ANTONIO
FERRARI CON LE SOLITE DIETROLOGIE SUL RAPIMENTO MORO,
scrive Pasquale Hamel il 23 settembre 2017. Leggere le pagine de “Il segreto” di
Antonio Ferrari edito dalla “Chiarelettere” è un rituffarsi negli intrighi e nel
complottismo che ha segnato un passaggio fondamentale della storia nazionale,
quello che vede l’ultima stagione dei partiti che avevano dominato la scena
italiana dal secondo dopoguerra in poi e il lento ma inarrestabile sgretolarsi
dell’impero sovietico con la conseguenza della fine dell’equilibrio bipolare che
aveva fino ad allora governato il mondo. Attraverso l’artificio letterario, un
corposo romanzo che non ha nulla da invidiare ai tanti spy story americani,
l’autore ricostruisce, a suo modo, la drammatica vicenda del rapimento e del
successivo assassinio dell’on. Aldo Moro, uno degli storici protagonisti della
storia politica del nostro Paese noto, soprattutto, per la grande capacità di
tessere trame politiche, di elaborare formule nuove, di sfiancare i propri
avversari con un paziente e certosino lavoro di mediazione. Antonio Ferrari,
giornalista e gran conoscitore delle vicende internazionali ma altrettanto
informato sul terrorismo italiano, raccontando la sua storia romanzata sposa,
senza mezzi termini, la tesi del complotto teso ad eliminare l’uomo del
“compromesso storico”. Moro, “l’importante uomo politico italiano” nel mirino
dei complottisti, viene individuato come l’obiettivo da eliminare per bloccare
alcuni processi allora in atto che spingevano al superamento dei tradizionale
equilibri politici del Paese. La strategia di Moro infatti, condivisa dal suo
interlocutore, il segretario del partito comunista italiano Enrico Berlinguer,
significava la rottura del compromesso che era stato raggiunto a Yalta con la
divisione delle aree di influenza. Un fatto che preoccupava i protagonisti di
quel difficile compromesso. Ma il disegno politico di Moro non poteva non
preoccupare chi aveva puntato sulla strategia terroristica nel velleitario
obiettivo di rianimare lo spirito rivoluzionario delle masse negli ultimi tempi
molto decaduto. Eliminare Moro, l’uomo degli “equilibri più avanzati” sembrava
dunque la strada giusta da percorrere per fermare i processi in atto e, magari,
far tornare indietro l’orologio della storia. Tutto chiaro, tutto semplice, si
potrebbe dire “il complotto è servito!” parafrasando il titolo di una nota
trasmissione televisiva. Tralasciando la parte letteraria del libro, apprezzata
e apprezzabile visto che la scrittura di Ferrari, con la sua grande abilità a
ricostruire la cornice ambientale in cui si svolgono i fatti, è capace di legare
il lettore dalla prima all’ultima pagina alla stregua del migliore Dan Brown,
resta la riflessione sulla vicenda raccontata. Certo, luci ed ombre si sono
addensate su quella triste vicenda ma sono più fatti casuali che, e non solo a
nostro avviso, soltanto la vocazione alla dietrologia, sport nazionale italiano,
è riuscita a cucire insieme facendone un emblematico e scandaloso caso politico.
Vero è infatti che, le strategie, di Moro non piacevano agli americani e che
soprattutto non piacevano ai sovietici e ai regimi dei loro satelliti, vero è
che molte perplessità e perfino ostilità si manifestavano nel partito
democristiano, ma da questo ad affermare, come ad esempio fa ad esempio qualche
sacerdote del complottismo, che Moro sia stato sacrificato dai suoi compagni di
partito, da un Giulio Andreotti o da un Francesco Cossiga per citare i più noti,
ce ne vuole. Per convincersi che “l’affaire Moro” è stata una creazione
intellettuale alimentata da speculazioni politiche, basta infatti leggere un
testo di uno storico serio come Massimo Mastrogregori, il quale ha dedicato alla
biografia del presidente della Dc un corposo volume, per rendersi conto che
forse è il tempo di uscire dalle fantastorie e restituire all’intelligenza
collettiva la verità su quelle vicende anche a rischio di scontentare qualcuno.
Mastrogregori, con estrema puntualità evidenzia i pregi e i difetti del
cosiddetto statista, ne esamina la storia politica fino al tragico evento che
chiude la sua vita terrena, per concludere che “l’idea di un Moro demiurgo della
politica italiana, abile regista eliminato col sequestro e l’assassinio dopo per
deviare sviluppi politici ben definiti e avviati, ancorché molto diffusa, non è
per niente realistica.” Ed allora, concludendo, l’invito è di leggere il libro
apprezzando le qualità letterarie del suo autore ma guardandosi bene di ricavare
da quelle pagine una verità che va oltre la realtà.
Caso Moro, «Il mio romanzo
in libreria 35 anni dopo essere stato scritto»,
scrive il 22 settembre 2017 "Il Corriere TV". Antonio Ferrari, modenese, è al
«Corriere della Sera» dal 1973. È stato inviato speciale e ora è editorialista.
Negli anni Settanta e Ottanta si è occupato di terrorismo nero e rosso. Il 14
settembre 2017 è uscito per Chiarelettere il romanzo «Il segreto», dedicato al
caso Moro. Ferrari lo scrisse nel 1981, ma la pubblicazione fu sospesa. In
questo video ripercorre i misteri del sequestro e dell’uccisione del leader
democristiano e la vicenda editoriale de «Il segreto». Il 26 settembre alle 18
il libro sarà presentato in un incontro organizzato dalla Fondazione Corriere
della Sera nella Sala Buzzati del «Corriere».
Caso Moro, il romanzo
segreto. Antonio Ferrari lo scrisse nel 1981, ma la pubblicazione fu sospesa.
Il 14
settembre uscirà per Chiarelettere: un’opera di fantasia che vale come
un’inchiesta. - Il lettore capirà tutto. Ve la sentite? Un brano dalla
postfazione di Antonio Ferrari. Perché il libro ha aspettato 35 anni prima di
uscire: la postfazione di Antonio Ferrari, scrive Francesco Cevasco il 10
settembre 2017 su "Il Corriere della Sera". Antonio Ferrari, modenese, è al
«Corriere della Sera» dal 1973. È stato inviato speciale e ora è editorialista.
Negli anni Settanta e Ottanta si è occupato di terrorismo nero e rosso.
«Un rompiscatole della
memoria». L’intrigante definizione è dell’ambasciatore Sergio Romano. E si
attaglia perfettamente ad Antonio Ferrari, l’autore di Il segreto, questo libro
ostinato e contrario in cui l’editorialista del «Corriere della Sera» racconta
la verità sul delitto Moro. Ostinato, dicevamo non a caso. Perché questo libro
per trentacinque anni è rimasto sepolto nei labirinti delle case editrici. E nei
labirinti che «il potere» ha abilmente costruito per nascondere tutto ciò che è
scomodo. Contrario, dicevamo non a vanvera. Perché questo libro racconta una
verità che è contraria a quella che ci hanno voluto raccontare, per decenni,
quasi per una quarantina d’anni.
La verità cercata è quella sul
caso Moro, sul delitto Moro. Bene, Aldo Moro «tira dentro», anche soltanto con
l’astensione, pure «i comunisti» nella maggioranza di governo. Correva l’anno
1978. Insopportabile. Per i padroni del mondo occidentale d’allora, per i
custodi degli accordi di Yalta e anche per i rivoluzionari delle Brigate rosse.
Per i primi c’era il pericolo del vento dell’Est, una sorta di pacifica ma pur
sempre «invasione rossa». Per i secondi il pericolo che venisse incrinato
l’equilibrio su cui si fondava il potere dei protagonisti della guerra fredda.
Per i terzi il pericolo che il «compromesso storico» sfaldasse definitivamente,
in Italia, lo spirito rivoluzionario che, nella classe operaia, tirava ancora
qualche asfittico respiro. Fatto sta che Moro viene eliminato. Ma prima di
essere eliminato dal gioco della politica e dalla sua stessa vita passano
cinquantacinque giorni. Di prigionia, di trattative, di ricatti, di imbrogli, di
febbrili lavori — puliti e, soprattutto, sporchi, di tanti servizi segreti di
tanti Paesi del mondo — fino al sospiro di sollievo che accompagna la sua morte.
Contenti i sostenitori della fermezza della Stato italiano. Contenti gli
americani (una parte) che tramavano affinché la verginità dell’Italia non
venisse violata dai comunisti. Contenti i francesi che «in queste cose bisogna
aver prudenza». Contenti gli israeliani che «noi osserviamo tutto ma lasciamo
fare». Contenti quelli della Cecoslovacchia e di qualche altro satellite
sovietico che «i conti tornano: certe cose non si possono cambiare
superficialmente». Tutti contenti. E Aldo Moro è, inutilmente, morto. Anche il
Papa di allora, Paolo VI, che non era certo una tempra di rivoluzionario, ha
lottato contro una morte ingiusta. Il suo appello agli «Uomini delle Brigate
rosse» è rimasto inascoltato. Moro è morto. Doveva morire. Ecco il libro di
Ferrari. Perché e chi? Perché uccidere Moro? E chi c’è dietro quell’orrendo
complotto? C’era una volta un albergo di Washington, il Marriott. Lì si
trovarono, una sera, un grappolo di personaggi ambigui. Non tutti sapevano
perché erano lì. Ma a reggere i fili che avrebbero mosso le marionette c’era il
dottor Alfred Greninger (questo è un nome di fantasia). Jimmy Carter era
presidente degli Usa. Ma a mister Greninger e alla sua Organizzazione quel
presidente, «un venditore di noccioline», non piaceva proprio. Quelli del suo
entourage (di Carter) che si occupavano di politica estera non avevano chiuso la
porta in faccia a quel miserabile di Moro. Avevano detto un mezzo ok ai
comunisti: nel governo no ma nella maggioranza... A Greninger, e alla sua
Organizzazione, non bastava, bisognava fare in modo che «liberali, radicali e
tutto quel marciume intellettuale che qui, in America, ascoltano tanto fossero
zittiti. E i comunisti italiani? Dei pazzi intrattabili. Credono che si possano
inquinare gli equilibri del mondo con teorie ridicole. Che cos’è il
marxismo-leninismo libertario? Oppure il neocapitalismo comunista?».
Zittire, cancellare,
sopprimere, con tutti i mezzi possibili. E il complotto parte annodandosi ad
altri interessi che, comunque, portano sempre allo stesso obbiettivo. I
personaggi del libro di Ferrari hanno (quasi) tutti un nome di fantasia. Ma,
come ammette anche l’autore, è molto facile smascherarli. A cominciare da Ron J.
Stewart che corrisponde a Ronald Stark agente di «un» servizio segreto americano
che frequentò l’Italia ed entrò in contatto con i vertici delle Brigate rosse. È
facile identificare Valerio Morucci e seguire le sue mosse di rigoroso capo
dell’organizzazione che però celano inquietanti ambiguità. Come rivedere nel
personaggio di Giusto Semprini uno di quei giovani disillusi del Pci e illusi
dalle Br che credevano veramente in una possibile e giusta rivoluzione finché...
O imbattersi in magistrati e poliziotti per bene che ci hanno rimesso la vita o
la carriera. E in intellettuali contorti come Toni Negri. E in circoli culturali
e politici (Kyrie nel libro, Hyperion nella realtà) che diventarono crogiuolo di
esperienze diverse: convegni contro la repressione ma anche luogo d’incontro di
spie di tutto il mondo, palestra del pensiero rivoluzionario ma anche zona
franca per allestire complotti politici. La ricostruzione del sequestro e del
delitto Moro si sposta da Roma a Milano: giusto quanto basta per dire che questo
libro è un romanzo e non un’inchiesta. Che poi romanzo, questo libro, lo è
davvero. Una lunga storia dove la suspense non cede mai. Fino alle ultime otto
righe, quando il lettore sperava di aver trovato un po’ di quiete, di aver
appagato almeno in parte i suoi sentimenti di giustizia e invece...
La storia di come nasce Il
segreto è un romanzo nel romanzo. La racconta bene Ferrari nella postfazione.
C’è da sapere che l’autore, prima di essere inviato e poi editorialista di
politica estera, negli anni Settanta e primi Ottanta si è occupato di terrorismo
rosso e nero, due anni ha vissuto con la scorta. Si presume che certe vicende le
conoscesse bene quando nel 1981, seduto alla scrivania che fu di Dino Buzzati,
ricevette una telefonata dal sopravvissuto manager, Salvatore Di Paola, allo
scandalo P2 che s’era abbattuto sul «Corriere». Più o meno gli disse: tu che sei
persona per bene scrivi un libro, in questo momento può essere utile far vedere
ai lettori che, nonostante tutto, siamo puliti. Per farla breve, Ferrari scrisse
il suo libro, questo di cui stiamo parlando. Per farla breve, quando lo consegnò
cominciò un gioco a nascondino tra i responsabili della casa editrice: rinvii e
rinvii spesso immotivati. Per farla lunga, sono passati trentacinque anni da
allora. In tutti questi anni Ferrari ha ricevuto minacce, più o meno esplicite,
che in qualche modo si ricollegavano alle cose che sapeva e che aveva avuto il
coraggio di scrivere e il coraggio di volerle pubblicare. Bene, ora la storia è
finita. Il libro è stampato. Quell’Araba Fenice che è la commissione
parlamentare sul delitto Moro, che ogni tanto risorge com’è successo da poco,
oggi ha fatto proprie alcune tesi di Ferrari. E, forse, Il segreto è un po’ meno
segreto.
«Il segreto» di Antonio
Ferrari sul caso Moro: la postfazione. Perché il romanzo è uscito trentacinque
anni dopo essere stato scritto,
scrive Antonio Ferrari il 22 settembre 2017 su "Il Corriere della Sera". La
telefonata arrivò a metà pomeriggio di una calda giornata di inizio luglio del
1981. «Ciao Ferrari, sono Salvatore Di Paola. Ti spiace fare un salto nel mio
ufficio? Ti devo parlare con urgenza.» Guardai, sorpreso, i miei due colleghi
inviati, Nicola D’Amico e Fabio Felicetti. Insieme condividevamo l’onore di
occupare l’ufficio che fu di Dino Buzzati, al pianterreno del «Corriere della
Sera», in via Solferino, dove forse nacque un suo capolavoro, Il deserto dei
Tartari. Libro straordinario e fenomenale metafora sui tempi lunghi e le attese
infinite che logoravano la nostra impazienza e condizionavano – noi pensavamo –
la vita e la salute del giornale. «Chissà cosa vorrà l’azienda. Vado e poi vi
racconto.» Salutai i colleghi, mi infilai la giacca estiva e salii le scale. Di
Paola, con il quale ero da tempo in confidenza, era un dirigente curioso, che
amava il «Corriere» e non pensava soltanto ai lauti compensi della pletora di
super manager dei nostri giorni. Era il numero tre del gruppo editoriale, ma
praticamente era rimasto il più alto in grado, visto che l’editore, Angelo
Rizzoli, e il direttore generale, Bruno Tassan Din, erano stati di fatto
esautorati dopo l’esplosione dello scandalo P2. Mi aspettava sulla porta del suo
ufficio. «Vieni, Antonio, siediti. Devo dirti subito una cosa: siamo nella
merda.» Lo disse senza preamboli, con brutale franchezza, strappandomi un
sorriso di piena condivisione. «Lo scandalo della P2 è devastante. Abbiamo
bisogno di dare alla gente, ai nostri lettori, inequivocabili segnali di
pulizia. Tu hai coraggio, ti occupi di terrorismo. Hai rischiato la pelle. Vivi
con la scorta. Ecco, dovresti scrivere un saggio su questi anni devastanti». A
volte, forse per temporanea pigrizia mentale, vengo travolto dal desiderio di
rifiutare sempre e comunque, anche se caratterialmente sono l’esatto contrario.
«No, Salvatore. Non me la sento. Non sono pronto. È una responsabilità che va
oltre le mie forze». «Antonio, se ho pensato di chiamarti è perché so quanto ami
e quanto sei legato al nostro “Corriere della Sera”. Il “Corriere”, adesso, ha
bisogno di te... Non cercare scuse. Fatti venire un’idea». Per prendere tempo,
risposi: «Ci penso qualche giorno». Di Paola, determinatissimo: «Qualche giorno?
Non hai capito. Tu andrai a firmare il contratto in Rizzoli domattina. Scrivi
quello che vuoi». Alla fine, lo so, la fantasia e il gusto del rischio mi hanno
sempre soccorso. Anzi, quando mi lanciano il guanto della sfida, non riesco a
sottrarmi. Guardai Salvatore Di Paola. «Quello che posso fare è un romanzo, dove
racconterei tutto ciò che non ho potuto scrivere perché non ne ho le prove
assolute». «Perfetto. Non voglio neppure conoscere i dettagli». «Fermati,
Salvatore. Mi devi ascoltare. Racconterò alcuni segreti che si nascondono dietro
l’assassinio di un leader politico. Immagini già chi è. Non farò nomi, neppure
di lui. Altererò i tempi, il luogo della strage, le decisioni delle Brigate
rosse. Non è pura fantasia: intreccerò alcune confidenze che ho ricevuto da
amici magistrati, preziose notizie ignorate dai giornali e indiscrezioni davvero
piccanti, con una trama parallela. Ti avviso che chi leggerà capirà tutto. Te la
senti? Ve la sentite? Sei sicuro?». «Te l’ho detto e te lo ripeto. Carta bianca.
Ti prendo l’appuntamento per domattina». Credo che qualsiasi autore sarebbe
stato felice di tanta generosità e di tanta fiducia. Impiegai mezz’ora per
illustrare il progetto al dirigente della Rizzoli Libri, che si chiamava Piero
Gelli (un caso di imbarazzante e sofferta omonimia). Firmai il contratto, che
prevedeva la consegna del testo entro sei mesi. Tre giorni dopo ricevetti
l’anticipo e cominciai a lavorare per rispettare i tempi. Sei mesi più tardi:
consegna del libro e un sudario di silenzio. Silenzio di tomba dalla casa
editrice. Nessuno chiamava. Sergio Pautasso, il responsabile della narrativa,
taceva. Quando parlavo con il suo ufficio, rispondevano che si stava valutando.
Ma valutando cosa? Eppure continuavo a essere ingenuamente ottimista. Alla fine
quel romanzo, che ha più di trentacinque anni, non è mai stato pubblicato, come
avevano previsto gli amici ai quali l’avevo fatto leggere. Persone di cui mi
fidavo, e che erano state generose: alcune di informazioni davvero scottanti,
altre di preziosi consigli. «Antonio – mi dissero –, ci vogliono molto coraggio,
una dose smisurata di anticonformismo e la determinazione di colpire i vari
poteri per pubblicare questo libro». Eccomi qui, trentacinque anni dopo, con i
capelli bianchi ma l’intatto desiderio di condividere con i lettori (in primo
luogo i giovani, che di quegli anni sanno poco o niente, ma anche i
«diversamente giovani», che invece ricordano quasi tutto) una storia che oggi
non fa più scandalo, come la nuova Commissione Moro, voluta da Matteo Renzi, sta
ricostruendo tra mille difficoltà. La storia che non si poteva scrivere, oggi, è
persino meno traumatica di quanto sta emergendo dai lavori della commissione
parlamentare. Il delitto Moro fu una grande porcheria internazionale.
Devo fare un passo indietro.
Anzi ne devo fare due. Il primo passo riporta all’aprile del 1979, quando il
direttore del «Corriere della Sera», Franco Di Bella, mi chiese di partire
subito per Padova, dove mi avrebbero poi raggiunto i colleghi Giancarlo
Pertegato e Walter Tobagi. C’era stata una serie di clamorosi arresti nel mondo
dell’Autonomia operaia organizzata, a cominciare dalla quasi totalità dei
docenti della facoltà di Scienze politiche, a partire dal barone Toni Negri.
Erano stati scoperti legami con le Brigate rosse, e si sospettavano
responsabilità dirette per il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro, avvenuto
l’anno prima. Il 28 aprile, a oltre venti giorni dalla retata, il sostituto
procuratore della Repubblica Pietro Calogero mi ricevette, assieme ad altri
colleghi. Fece il punto sull’inchiesta. Spiegò le connessioni che erano state
scoperte a Parigi, presso l’istituto di ricerca Hyperion. Ci confidò che i
servizi segreti francesi avevano collaborato fruttuosamente all’indagine, anche
se avevano fatto sapere che la collaborazione doveva ritenersi sospesa, perché
gravemente compromessa. Calogero mi guardò dritto negli occhi: «Ferrari,
purtroppo il suo giornale, il “Corriere della Sera”, ci ha tradito». Mi sembrava
un’accusa infamante, incomprensibile e profondamente ingiusta. Ma prima che
potessi esternare la mia reazione di corrierista doc, il giudice precisò: «Non
lei, Ferrari, naturalmente. Ha letto la prima pagina del “Corriere” di quattro
giorni fa? La rilegga, e ricordi quanto le ho detto». Rammentavo il titolo,
clamoroso, Secondo i servizi segreti era a Parigi il quartier generale delle
Brigate rosse, e l’articolo. Ricordavo che la rivelazione dell’«uomo dei
servizi» era stata raccolta da un collega che stimavo e stimo. Mi chiesi, in
pochi secondi, che cosa avrei fatto io se avessi avuto quella notizia, quello
scoop. «Capisco il suo turbamento» mi disse Calogero. «Apprezzo sempre il lavoro
di voi giornalisti. Ma sappiate che anche voi potete essere strumenti
inconsapevoli di giochi orrendi. Se foste “consapevoli”, sarebbe davvero una
tragedia per la libertà di questo paese». Quella conversazione si sedimentò
nella mia mente, ed è logico che, da quel giorno, cercai di ragionare molto più
attentamente su tutto ciò che accadeva, anche su dettagli che parevano
marginali. Per esempio fui molto colpito da una notizia. La scarcerazione e la
scomparsa di un ricco americano, che era stato arrestato a Bologna per traffico
di droga nel 1975, e che era tornato misteriosamente in libertà. In carcere si
era infiltrato nelle Br e, come poi si seppe, era un uomo legato alla Cia. Si
chiamava Ronald Hadley Stark. Anni dopo, nel 1985, venni a sapere anche che
Stark era morto nelle Antille, in circostanze davvero particolari.
È chiaro che molte fiaccole si
erano accese nella mia mente. All’inizio del 1981, un collega de «L’Espresso»
che stimavo moltissimo, Franco Giustolisi, compagno di tante missioni
giornalistiche in giro per l’Italia, rientrando a Milano da Padova mi fece una
strana confidenza. «Hai fegato, Antonio. Ma attento. Tu scrivi spesso che la
loggia P2 si staglia dietro molte storie di terrorismo. Ho sentito che il tuo
giornale non ne è estraneo». Ricordo che reagii con insofferenza. «Anche tu,
Franco! Ce l’avete proprio tutti con il “Corriere”. Non crederò mai a una cosa
del genere.» Giustolisi mi sorrise, enigmatico. Cambiammo discorso. La sera del
20 maggio 1981 ero al giornale. Credo che aspettassi due amici della redazione
per un pokerino notturno. Chiacchieravamo di calcio quando, in sala Albertini,
entrò un fattorino. Aveva in mano un telex. Il capo del servizio politico
sbiancò. «L’elenco! Arriva l’elenco della P2.» Pokerino svanito. Tutti in fila
davanti al telex, mentre la macchina vomitava, con il suo ritmo scandito da ogni
lettera. Quasi mille nomi. Eravamo diventati tutti guardoni. «Hai visto chi
c’è?» «Incredibile.» La lista era come una frustata. Non so quanti possano
immaginare che cosa abbia voluto dire, per un amante del «Corriere», scoprire
che i vertici del suo giornale erano dentro. Quasi tutti. Fu chiamato a casa il
direttore, che arrivò trafelato. Vide l’elenco. Quattro parole: «Bene, si
pubblichi tutto». Al centralino del «Corriere» fioccavano telefonate notturne,
nervosissime. Chi compilò quella pagina, che aveva un titolo imbarazzato, La
presunta lista della Loggia P2, fece molto più degli straordinari. Molti
volevano smentire subito: chi sdegnosamente, chi con rabbia, chi si affidava al
giudizio della gente, chi minacciava querele. Ricordo due cose di quella notte
di tregenda. La fatica dei colleghi della redazione per inserire le smentite,
che suonavano ridicole, talvolta patetiche, talora grottesche. Poi l’autentica
fitta di dolore per colleghi professionisti, compreso un giovanissimo talento
che consideravo quasi un allievo, i quali erano andati a inginocchiarsi davanti
a quel brutto ceffo di Licio Gelli. Un lercio burattinaio con disegni
delinquenziali e golpisti, in Italia come in Argentina, in Uruguay e altrove.
Non mi aveva sconvolto la presenza nella lista dei politici, dei generali, di
tutti i capi dei servizi segreti, di alcuni magistrati. L’intero codazzo
istituzionale di questo bellissimo ma slabbrato paese, abitato da troppi
camerieri del potere. Lo davo per scontato. Fui fulminato dalla presenza del
cantante Claudio Villa (sì, caro Reuccio, la vanità e la piaggeria fanno brutti
scherzi!) e da quella del grande imitatore Alighiero Noschese, che conoscevo
personalmente. Povero Alighiero, forse Gelli lo aveva utilizzato per telefonate
ricattatorie. L’artista – dissero – non resse alla vergogna e si tolse la vita.
Magari era vero che soffrisse di depressione. Avendo poi seguito, a Torino,
numerose udienze del processo alle Br, e avendo ammirato l’equilibrio del
presidente della corte d’assise Guido Barbaro, un educato garantista che era il
beniamino di noi inviati speciali, rimasi raggelato nel vedere anche il suo nome
nella lista della P2. In quei momenti, mentre si spiegavano carriere fulminanti,
tessevamo collegamenti inquietanti. Quella notte non dormii. Meno di due mesi
più tardi, quando fui chiamato da Salvatore Di Paola, ero ancora sotto choc,
anche se nella vita ci si abitua a tutto. Il mio «Corriere» ferito era come una
pugnalata alla schiena di ciascuno di noi.
Anni dopo, quando un collega
tentò di far pubblicare sul nostro magazine un’intervista a Licio Gelli, mi
consultai con il supervisore del settimanale, il mio migliore amico Francesco
Cevasco, collega bravo e limpidissimo, che già aveva deciso di impedirne la
pubblicazione senza consultare nessuno. In quanto delegato sindacale degli
inviati speciali, convocai un’assemblea. «Se esce l’intervista, cari colleghi,
propongo uno sciopero immediato, senza trattative e senza compromessi. A muso
duro.» Ferruccio de Bortoli, all’epoca capo dell’Economia, si mise la giacca e,
passando davanti all’ufficio di direzione, disse: «Se esce l’intervista, il
giornale ve lo fate da soli». Il direttore Paolo Mieli fu d’accordo con noi.
L’intervista non fu pubblicata. Ma torniamo al libro. Il tempo passava e la
Rizzoli non mi dava notizie. Si erano lamentati per la lunghezza del testo.
Pautasso compiva salti mortali (o quasi) per spiegarmi che c’erano «cose che non
andavano». Scuse pietose. Cambiò il direttore della divisione libri. Arrivò
Valerio Riva, ruvido galantuomo. Mi fece una telefonata di fuoco: «Cazzo! La
scuola di Parigi. Perché non esce questo libro?». Mi venne da ridere: «Non
chiederlo a me». Riva si impegnò, ma poco dopo fu allontanato. Arrivò Oreste Del
Buono, che mi disse chiaramente: «Non ce la sentiamo. Mi spiace». Decisi di
ritirare il mio Il Segreto. Chiesi solo l’ultima rata dell’anticipo. Una causa?
Al «Corriere della Sera» e alla casa editrice Rizzoli non l’avrei mai fatta.
Provai allora con altri editori. Devo però essere sincero. Da una parte mi
urtava questa tremebonda cortina da prima Repubblica, dove certe libertà non
erano previste; dall’altra comprendevo le resistenze, e in qualche caso le
condividevo. In realtà, con questo romanzo, ero andato – per quei tempi – ben
oltre i binari della mia autonomia e del mio ruolo professionale. Ero
insofferente ed ero giunto a una conclusione: non volete il libro? Me ne farò
una ragione.
Cominciai la mia seconda vita
professionale: inviato speciale all’estero. Due episodi. Ero stato incaricato di
partire, ancora una volta, per Parigi. Dovevo raccontare la vita da esuli dei
ricercati italiani per terrorismo. Il mio direttore, Piero Ostellino,
presuntuoso ma schietto e sicuramente per bene, mi disse: «Lo so, lo so che
Negri non ti ama. Dice che sei una specie di carabiniere». Risposi con una
battuta: «Be’, direttore, quanto onore! Meglio somigliare a un carabiniere che a
Toni Negri». Tornato a casa, mi consultai con la mia compagna di allora, Agnes
Spaak. Reagì con istinto protettivo: «Non mi piace, Antonio. Torna subito al
giornale». E mi suggerì: «Chiedi al direttore cosa volesse dire. Insomma da dove
veniva quella battuta». Tornai da Ostellino. Mi spiegò che era arrivata una
lettera di Toni Negri dalla Francia. Era indirizzata a «Fabio Barbieri,
caporedattore del “Corriere della Sera”». Informazione assolutamente inesatta.
Sbagliata, falsa, anche se in realtà il collega de «il mattino di Padova» e poi
inviato de «la Repubblica» era stato in corsa per essere assunto nel nostro
«Corriere», e qualche giornale vi aveva accennato. Un membro della segreteria di
redazione, Inigo Scarpa, aveva privilegiato la carica e non il nome del
destinatario e aveva aperto la lettera. Ostellino mi spiegò che era formalmente
un «corpo di reato». Arrivava da un ricercato, anzi da un condannato a
trent’anni di prigione. L’azienda, mi disse, «l’ha fatta consegnare al
magistrato».
Domandai: «Che cosa si dice
nella lettera?».
Ostellino mi rispose:
«Fanfaronate. Alla fine Negri si rivolge a Barbieri per chiedergli in sostanza
di non utilizzarti su questi argomenti, in nome dell’antica amicizia». Barbieri
era stato infatti in Potere operaio, proprio come il professore padovano.
«Direttore, quando è arrivata
la lettera?».
«Mi sembra un mese fa».
«E tu non mi hai informato?».
«Ma no, Antonio. Non c’erano
minacce dirette a te».
«Piero, mi hai esposto al
rischio di finire stritolato da qualche fogliaccio calunniatore...».
«Secondo me esageri».
«Al punto che domani andrò
anch’io dallo stesso magistrato. Farò una dichiarazione a futura memoria.» Così
feci, e chiesi che fosse messa agli atti.
Chi non ha vissuto l’atmosfera
di quegli anni velenosi non può immaginare, neppur lontanamente, come si viveva
e come vivevano coloro che seguivano per il proprio giornale le vicende del
terrorismo. C’erano le minacce, le tensioni, le paure personali e i timori
familiari, le calunnie esplicite e quelle fabbricate con le allusioni. Nel 1980
il mio collega Walter Tobagi, che con me raccontava i mali del nostro paese, era
stato ucciso da un commando di praticanti terroristi, dopo essere stato sepolto
di insinuazioni. Potete quindi immaginare quanto fosse delicata una lettera di
un personaggio come Toni Negri, magari ripresa e commentata dai fogli che
raccoglievano pettegolezzi e spazzatura. Forse amplificata da coloro – non
sapete quanti! – che allora erano estremisti dell’ultrasinistra e poi sono
entrati con le fanfare nelle stanze del potere. Soprattutto di destra. Ero
turbato e sconcertato dalla gravità di quell’episodio. Due giorni dopo partii
per Parigi. Incontrai Oreste Scalzone e altri espatriati sfuggiti alla giustizia
italiana. Nessuno di loro amava Negri. Una sera rientrai in albergo, al
Montalembert, e il portiere mi consegnò un pacco. Dentro, una pila di fotocopie
e un bigliettino anonimo in francese. Lessi: «Sappiamo la disavventura che ha
avuto con il suo libro Il Segreto. Vogliamo farle sapere che cosa sta per
pubblicare la Rizzoli. Titolo: Il treno di Finlandia, autore: Toni Negri. Trova
qui le fotocopie del testo». Ero allibito e, direi, scandalizzato. Ne scrissi
tranquillamente in un paio di articoli, contando sul fatto che nessuno sarebbe
intervenuto per chiedermene ragione. Ostellino è sempre stato un vero liberale.
Ovviamente, svelato il segreto, scoppiò un piccolo scandalo in casa editrice, e
il libro di Negri fu scartato. Uscì, in grave ritardo rispetto ai tempi
previsti, con un piccolo editore. Mi capitò, molti anni dopo, di incontrare
Fabio Barbieri a Davos per il World Economic Forum. Stavamo cenando con i
colleghi al ristorante Morosani. Si parlava di amicizia. Dissi: «Fabio, tu sei
mio amico da anni, ma con me non ti sei comportato da amico. So che sei stato
contattato dal nostro direttore generale di allora, Luigi
Guastamacchia». Rispose: «Sì, è vero. Ci conosciamo e frequentiamo da tempo. Lo
incontrai, mi parlò della lettera di Negri e mi chiese notizie e valutazioni sul
tuo conto». Lo incalzai. «E tu, amico mio, non mi dicesti nulla? Vergognati.» I
colleghi presenti nel ristorante di Davos impallidirono. Il nostro Danilo Taino,
eccellente giornalista, grande corrispondente, analista e soprattutto uomo
verticale, tornando in albergo mi prese sottobraccio e disse: «Antonio, quel che
ho sentito è davvero sconvolgente». Fabio, senza riferirsi direttamente a
quell’episodio, si mostrava pentito e dispiaciuto. Qualche tempo prima di morire
(era malato e lo avevo saputo), venne a Gerusalemme con la moglie. Gli stetti
vicino in questo suo pellegrinaggio in Terrasanta.
Questo è il passato. Oggi,
come vedete, Il Segreto è uscito. L’ho riletto tre volte, per riprendere
confidenza con una vicenda che ha segnato la mia vita. L’ostinazione ha vinto.
«Guastafeste della memoria» mi ha definito con amicizia e simpatia
l’ambasciatore Sergio Romano. Ne sono fiero. Ma c’è di più. Finirà che dovrò
ringraziare chi, trentacinque anni fa, rifiutò di pubblicarlo. Oggi il mio
romanzo quasi combacia con la realtà.
Antonio Ferrari: “Ecco il
romanzo-verità sul caso Moro che 35 anni fa nessuno volle pubblicare”,
scrive Antonio Sanfrancesco il 17.09.2017. Antonio Ferrari, a lungo inviato del
“Corriere della Sera”, lo scrisse nel 1981, ma qualcuno ne impedì la
pubblicazione perché, spiega, "metteva in discussione quello che si doveva
credere". Ora esce per Chiarelettere. Ed è destinato a far discutere.
L'intervista a tutto campo al grande giornalista, che ai giovani aspiranti tali
consiglia di "crederci. Questo resta il mestiere più bello del mondo. Se cerchi
soldi, meglio lasciar perdere. Se cerchi le emozioni, allora devi insistere..."
Questa è la storia di un libro che doveva uscire trentacinque anni fa, ma
qualcuno lo impedì. È la storia, ancora senza finale, del mistero dei misteri
d’Italia: il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro. È la storia di un
romanzo-inchiesta, Il Segreto, scritto da un cronista di razza, Antonio Ferrari,
per trent’anni inviato speciale del Corriere della Sera, che ama sentire l’odore
delle cose, vedere di persona e sa coniugare quello che ha visto con il
ragionamento e l’analisi. Negli anni Settanta e Ottanta Ferrari si è occupato di
terrorismo rosso e nero, dello scandalo della P2, che travolse anche
il Corriere, e per due anni ha avuto pure la scorta. Poi, dal 1982, da inviato
in Medio Oriente, ha intervistato i principali leader dell’area: Arafat, Sharon,
il presidente libico Gheddafi, l’ex re di Giordania Hussein e l’attuale
Abdullah, il presidente siriano Bashar el Assad e l’egiziano Mubarak. Fino alla
principessa Rania di Giordania di cui è amico personale. Ha raccontato la guerra
in Libano, che l’ha particolarmente segnato, tanto da conservare un cimelio che,
rivela, “porto sempre sul cuore”. L’intervista si svolge al Rigolo, il
ristorante a due passi da via Solferino, storico ritrovo dei giornalisti
del Corriere come ricorda Ferrari con aria compiaciuta. È un attimo. Poi
l’espressione del volto si fa di nuovo seria ed emerge l’istinto
dell’intervistatore: “Ha letto la postfazione? Non le sono venuti i
brividi?”. Il Segreto, pubblicato da Chiarelettere, si legge tutto d’un fiato,
ha il ritmo incalzante di un thriller ma vale un’inchiesta.
Non rischia di alimentare
la dietrologia sul caso Moro?
“Io non sono un fanatico della
dietrologia, ma non mi sono mai accontentato delle veline e delle dichiarazioni
ufficiali. Sono abituato, grazie al più grande direttore che ho avuto, Piero
Ottone, ad andare e cercare di scavare anche l’impossibile pur di tentare di
scrostare le bugie attorno alla verità. Non sono un ingenuo, so che arrivare
alla verità pura è una chimera. Eliminare le bugie, però, è un primo passo verso
la verità”.
Nel romanzo, Aldo Moro
viene liberato dai brigatisti e ucciso subito dopo. È questa la verità?
“Io continuo a pensare che il
presidente della Democrazia Cristiana sia stato liberato e ucciso
successivamente. Due mesi, dal rapimento al ritrovamento del cadavere, sono
tanti. La maggioranza delle Brigate rosse voleva liberare Moro, una minoranza,
inquinata dalla scuola francese Hyperion (Kyrie nel libro, ndr) no. Sono
convinto di questo e alcuni magistrati me l’hanno confermato”.
Perché Moro doveva morire?
“Il leader democristiano,
insieme ad Enrico Berlinguer, stava lottando per far uscire l’Italia da
un’impasse politica e istituzionale. Due uomini diversi, un cattolico e un
comunista, entrambi concentrati sul progetto di rompere il ‘fattore K’ e tirare
dentro nella maggioranza di governo anche il Partito comunista italiano. Un
progetto che faceva paura a molti”.
A chi?
“In America c’era il
presidente Jimmy Carter e in Russia Leonid Breznev. L’accordo tra Moro e
Berlinguer metteva in crisi gli uni e gli altri: gli americani perché vedevano
un partito comunista entrare nell’area di governo e i russi perché un partito
comunista si permetteva di entrare in una maggioranza di governo sia pure con la
formula dell’astensione. In tutti i Paesi ci sono sempre poteri paralleli agli
Stati che si muovono e tramano nell’ombra. Nel caso Moro ci fu una convergenza
tra questi poteri”.
A muovere i fili di questa
trama, nel romanzo, è il dottor Alfred Greninger.
“Un personaggio di fantasia.
Nella realtà, esponente di un’organizzazione nazionalista e intransigente
americana che aveva l’equivalente in Russia. Anche l’Italia giocò una partita
poco limpida. La mia impressione è che non sia stato fatto tutto il possibile
per liberare Moro. Cossiga (all’epoca ministro dell’Interno, ndr) giocò un ruolo
ambiguo”.
Poi c’è Ron J. Stewart, un
agente segreto americano facilmente identificabile…
“È Ronald Stark, un americano
infiltrato che entrò in contatto con i vertici delle Brigate Rosse. Poi si
scoprì che morì in circostanze poco chiare nelle Antille. Fu una cosa tacitata
dai giornali e ancora oggi mi chiedo perché”.
Chi voleva che il suo libro
non fosse pubblicato?
“Molti, perché metteva in
discussione quello che si doveva credere, cioè che le Br erano pure e rosse, che
non c’erano possibilità d’infiltrazioni e che tutto il resto era dietrologia
spicciola di serie B. Quello che ho raccontato nella postfazione è tutto vero.
Il Corriere, tramite il manager Salvatore Di Paola, sopravvissuto allo scandalo
P2, voleva che scrivessi un saggio. Proposi di raccontare in chiave romanzata
quello che non ho mai potuto provare. Credevo che fosse il momento di denunciare
tutto. Mi sbagliavo. Forse ero presuntuoso. Però i giochi di potere erano molto
forti e quegli erano difficili. Ricevevo continuamente minacce, più o meno
velate. Il libro nacque così. Dopo averlo scritto, cominciò un calvario di
rimpalli, rinvii, ‘vediamo, stiamo valutando’. Alla fine capii che la Rizzoli
non l’avrebbe mai pubblicato”.
Se fosse uscito prima
sarebbe
stato un riacquisto di credibilità per il Corriere che usciva con le ossa rotte
dallo scandalo della loggia P2?
“Ci ho pensato più volte. Mi
sono risposto di sì, però forse è la mia presunzione. Certo, ho avuto coraggio a
dire, da dentro, che alcune cose le avevo capite e non ero uno sciocco. Proprio
in questo ristorante ebbi un incontro con una grande regista
tedesca, Margarethe von Trotta, la quale mi chiese se il giornale mi avesse mai
condizionato. Le dissi di no. Lei voleva fare un film e propose di far
interpretare il mio ruolo da Gian Maria Volontè. La ringraziai ma le dissi di
non poter accusare nessuno, neanche il direttore Franco Di Bella che non mi ha
mai censurato un pezzo quando scrivevo della P2 nonostante lui stesso fosse tra
gli iscritti”.
La verità sul caso Moro
oggi fa meno paura?
“Forse sì perché la mia è una
verità romanzata ma che si raccorda con le ultime scoperte della seconda
Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro voluta da Renzi che su
questo, va detto, ha avuto un grande coraggio nel voler tirar fuori le porcherie
di regime”.
Nella sua carriera ha
seguito il terrorismo, ha
vissuto sotto scorta per alcuni anni, poi è andato in Medio
Oriente a raccontare la guerra. Che differenza c’è?
“Enorme. Io non ho mai avuto
paura in Medio Oriente ma l’ho avuta, e tanta, in Italia. Il terrorismo era
cieco, poteva colpirti senza darti alcun segnale. La guerra è palese, tu sai che
ogni giorno corri il pericolo di morire. Sul cuore porto sempre questo (lo
estrae dalla tasca del gilet, ndr): è un frammento del Corano dove si riconosce
la verginità di Maria. Me lo regalò il mio autista Sami. Un giorno a Beirut a
metà degli anni Ottanta mi ha salvato da un sequestro perché avevo visto e
fotografato cose che non avrei dovuto vedere e fotografare. C’era appena stata
una strage di palestinesi uccisi dagli sciiti a Shatila. La religione non è
violenza, porta sempre un messaggio di pace, lo dico da laico”.
Lei crede?
“Non lo so. Il cuore dice sì,
la ragione dice no. Sento però che c’è qualcosa che mi guida e mi aiuta. Che sia
il caso, lo Spirito, Dio, non lo so. Aver vissuto a lungo a Gerusalemme mi ha
molto colpito e cambiato. Nel 1999, alla vigilia del Giubileo, feci un reportage
sulle orme di Gesù Cristo”.
Che giudizio ne ha tratto?
“Non so se è il figlio di Dio.
Era un profugo, veniva da Nazareth, considerata dai dottori della Legge di
Gerusalemme la feccia come i luoghi d’origine dei profughi di oggi. Gesù era un
rivoluzionario e anche un gran rompiballe: caccia i mercanti dal Tempio, predica
contro i dottori della Legge. Un po’ come papa Francesco oggi, mi arrabbio molto
quando lo attaccano”.
L’ha conosciuto?
“L’anno scorso ad Assisi. Il
mio sogno è passare una giornata con lui e poi raccontarla in un libro”.
Che consigli vorrebbe dare
ai giovani che si affacciano a questa professione?
“Crederci. Questo resta il
mestiere più bello del mondo. Se cerchi soldi, meglio lasciar perdere. Se cerchi
le emozioni, allora devi insistere. Noi siamo collezionisti di emozioni, questa
è la nostra forza. Quando non riesco a dormire la sera penso a tutto quello che
mi ha regalato questo mestiere: ho incontrato le persone più incredibili, ho
vissuto le situazioni più strane, ho visto gente piangere e ridere, ho
conosciuto leader e gente comune, poveri e ricchi, re e regine. Però ciascuno mi
ha lasciato qualcosa, nel bene e nel male. Questo lo ritengo un dono che mi è
stato fatto. Sono molto grato. Quest’anno ho guardato Sanremo e mi sono
innamorato della canzone di Fiorella Mannoia. Sì, davvero la vita è perfetta. Le
sono grato, anche se alla fine, tra gioie e sofferenze, il conto è pari. Ho
avuto un’infanzia disperata, ho vissuto la tragedia di restare orfano di padre a
9 anni. Poi mi sono rialzato e sono andato avanti”.
Il suo prossimo libro?
“Un romanzo su Auschwitz e
sulla controversa figura del prete slovacco Josef Tiso, che voleva vendere gli
ebrei ai nazisti e fu fermato da Pio XII”.
ALDO MORO ED I SALTIMBANCHI
DELLA DIETROLOGIA.
L'ultima su Moro: «A via
Fani c'era la ndrangheta».
Scrive Paolo Delgado il 15 luglio 2016 su "Il Dubbio". Sul rapimento del
presidente democristiano si sono accumulati misteri, sempre presunti, fantasie,
sempre sbrigliate, rivelazioni clamorose, sempre inconsistenti, decine di
volumi, quasi sempre sconfinanti nel delirio…«Possiamo affermare con ragionevole
certezza che il 16 marzo del 1978 in via Fani cera l’esponente della ndrangheta
Antonio Nirta». Parola di Beppe Fioroni, presidente della commissione
d’inchiesta bicamerale che indaga per la millesima volta sul rapimento e
l’assassinio di Aldo Moro. La butta lì come se nulla fosse, anche se a prenderla
sul serio la fragorosa "ragionevole certezza" rovescerebbe come un guanto
vecchio la storia italiana recente. Gli stessi media, solitamente pronti a
saltellare come cani di Pavlov di fronte alle "rivelazioni clamorose", procedono
stavolta con i piedi di piombo. Come si dice in gergo, "la danno bassa".
Consapevoli, persino loro, di quanto poco misteriosi si siano rivelati, alla
prova di uno sguardo meno superficiale, i misteri del caso Moro. Stavolta la
montatura è più vistosa del solito. La certezza di Fioroni si basa sull’analisi
fatta dai Ris di una foto scattata in via Fani non durante la mattanza ma
un’oretta più tardi. Hanno concluso che tra il boss della ndrangheta e uno dei
curiosi accorsi sul luogo della strage «cè unanalogia sufficiente a far dire, in
termini tecnici, che c’è assenza di elementi di netta dissomiglianza». Sarà
sufficiente per considerare accertata la presenza del banditone in via Fani, non
solo a strage perpetrata ma anche un’ora prima, col mitra fumante in mano?
Fioroni però non si accontenta. E bulimico. Un bandito non basta, sospetta la
presenza di un secondo uomo delle ‘ndrine, Giustino De Vuono: «C’è una perizia
analoga sul volto di un altro personaggio legato alla malavita e che comparve
tra le foto segnaletiche dei possibili terroristi il giorno dopo il 16 marzo».
Roba forte. I nomi di Nirta e De Vuono non sono una novità per il manipolo di
perversi che da decenni si aggira nel labirinto dei falsi misteri del caso Moro.
Nirta era stato indicato già nel 1993 dal boss della ndrangheta Saverio Morabito
come infiltrato nelle Br dal generale dei carabinieri Delfino. Si rivelò una
fandonia e difficilmente le cose cambieranno sulla base della "non netta
dissomiglianza". Il caso di De Vuono è più interessante. Nella saga fantasy del
sequestro Moro incarna infatti una leggenda longeva, pietra angolare delle
costruzioni più azzardate. Un testimone, Pietro Lalli, dichiarò di aver notato
nel corso dell’attacco un brigatista molto più esperto degli altri. Mitragliava
a raffica, saltava all’indietro per allargare il raggio di tiro, solo dalla sua
arma sarebbero usciti 49 dei 91 proiettili sparati dai brigatisti. E chi era,
Pecos Bill? Probabilmente sì, essendo appunto questo il soprannome di Valerio
Morucci nel Movimento romano, in virtù della sua dimestichezza con le armi. In
un saggio appena pubblicato dalla casa editrice "Les Flaneurs", Cronaca di un
delitto politico, il giovane ricercatore Nicola Lofoco si è preso la briga di
confrontare il testo della deposizione di Lalli con la ricostruzione fatta dallo
stesso Morucci, dimostrando che i racconti coincidono e che i movimenti di
"Pecos" corrispondono a quelli registrati da Lalli. Quanto alla massa di colpi
sparati da un solo mitra, Lofoco fa notare che per la verità raggiunsero tutti
una sola vittima, l’agente Iozzino, oppure andarono a vuoto. Superkiller sì, ma
fino a un certo punto. La commissione presieduta Fioroni è la seconda a
occuparsi esclusivamente del fattaccio, dopo quella istituita nel 1979 che
esaurì il mandato nel 1983. I 55 giorni del 1978 sono però stati centrali nella
lunghissima attività della commissione Stragi, dal 1988 al 2001. Se ne è poi
occupata la commissione d’inchiesta sulla P2 e anche, più di striscio, quella
sul dossier Mitrokhin. Tra una cosa e l’altra, trattasi dunque della quinta
indagine parlamentare sulla strage di via Fani. Tante commissioni quanto i
processi propriamente detti. Nel frattempo si sono accumulati misteri, sempre
presunti, fantasie, sempre sbrigliate, rivelazioni clamorose, sempre
inconsistenti, decine di volumi, quasi sempre sconfinanti nel delirio. Questa
montagna di ipotesi confuse, farraginose e contraddittorie, basate sul criterio
del "mi sa tanto" e poi supportate da elementi concreti che dire tirati per i
capelli è niente, ha di fatto sostituito nell’immaginario la realtà storica.
L’ultima ondata di misteri, che vede sulla schiumosa cresta la commissione
parlamentare, appare a occhio nudo anche più sgangherata delle precedenti. Hanno
trovato credito sui media testimonianze meno credibili dell’invasione Ufo, come
quella secondo cui Cossiga in persona si sarebbe aggirato intorno alla Renault
col corpo non ancor scoperto di Moro in via Caetani, la mattina del 9 maggio
1978, o come quella che raccontava di nuclei speciali pronti a irrompere nella
"prigione del popolo" di via Montalcini e fermati in extremis da un telefonata.
La stessa commissione, impavida, ha sostenuto che il bar Olivetti, dietro le cui
siepi erano appostati i 4 br travestiti da avieri, non fosse chiuso da tempo
come universalmente sostenuto ma aperto e che in via Fani fossero assiepati ben
20 brigatisti, che tanto valeva andarsi a prendere il povero Moro in corteo.
Anche una pseudoscienza infima come la dietrologia ha un apogeo e una mesta
decadenza. La prima ondata misteriologica rispondeva a un logica politica:
assolvere il Pci dal fallimento storico dell’unità nazionale, cancellarne
l’imbarazzante presenza nell’album di famiglia del terrorismo rosso, coprire le
responsabilità dirette dello stesso Pci nella scelta di sacrificare l’ostaggio
pur di non trattare con un’organizzazione "concorrente". La seconda ondata,
negli anni 90, mirava a rovesciare le accuse con una narrazione uguale e
contraria, nella quale al posto degli americani cerano, nei panni dei
burattinai, i russi. Quest’ultima messe di scoperte ancor più farneticanti
dimostra che la dietrologia sul caso Moro è ormai un territorio franco a
disposizione di chiunque: politici in cerca d’autore, autori in cerca di
editore, picchiatelli in cerca di un pubblico da perseguitare con le proprie
paranoie.
Il caso Moro, la
dietrologia e quel sospetto di Giovanni Leone,
scrive Francesco Damato il 9 Aprile 2017 su "Il Dubbio". A 39 anni di distanza
dalla tragica fine di Aldo Moro, il lavoro della Commissione bilaterale
riaccende il dibattito sul sequestro e l’uccisione dell’esponente Dc. A 39 anni
ormai di distanza dalla tragica fine di Aldo Moro, e dopo una lunga serie di
inchieste giudiziarie e parlamentari, per non parlare dei numerosi e inutili
tentativi compiuti in ogni sede di fare uscire i responsabili superstiti di
quell’operazione condotta con “geometrica potenza” contro “il cuore dello Stato”
dalla sin troppo sfacciata reticenza delle loro deposizioni, e persino
memoriali, capisco la diffidenza dell’ottimo Paolo Delgado. Che ha avvertito o
temuto la presenza dei soliti “saltimbanchi della dietrologia” nella
ricostruzione che del sequestro e dell’uccisione di Moro sta facendo la
commissione bicamerale presieduta dall’ex ministro Giuseppe Fioroni, del Pd. Le
relazioni sui primi due anni di lavoro sono già state approvate all’unanimità –
cosa non frequente nelle commissioni d’inchiesta parlamentare – a dimostrazione
del clima unitario in cui si è lavorato, pur in un contesto politico generale di
tutt’altro segno. E nella previsione, oltre che auspicio, di una relazione
conclusiva largamente condivisa alla fine della legislatura, ordinaria o
anticipata che sia destinata a rivelarsi. Fra i nuovi temi sollevati dalla
commissione Fioroni, rispetto alle precedenti indagini, Delgado ha trovato
curioso e – temo – irrilevante quello del bar d’angolo fra via Fani e via
Stresa, dietro le cui fioriere si nascosero i brigatisti rossi travestiti da
avieri, con le loro armi, in attesa che arrivasse l’auto blu che portava Moro
dalla sua vicina abitazione di via di Forte Trionfale a Montecitorio, preceduta
da una vettura più piccola della scorta. Che, costretta apposta ad una brusca
frenata, fu tamponata dalla macchina contro la quale i terroristi spararono
uccidendo gli agenti che sedevano davanti e risparmiando il presidente della Dc
per sequestrarlo, prelevandolo a forza dai sedili posteriori. ‘ Lasciatemi
stare’, furono le uniche parole uscitegli dalla bocca. Quel bar molto spazioso,
che gli agenti di scorta di Moro avevano frequentato per un po’ fino a che non
si insospettirono di qualcosa e smisero di andarvi, esortando la figlia di Moro,
Maria Fida, che lo frequentava anche lei, a starsene lontana, la mattina del
sequestro – il 16 marzo – doveva essere chiuso. E non per turno o altro. Era
stato chiuso da un bel po’ per fallimento della società proprietaria. Un socio
della quale risultò poi coinvolto in un oscuro e inquietante traffico d’armi e
di moneta, oggetto di una indagine giudiziaria dalla gestione a dir poco
bizzarra. Ebbene, quel bar la mattina del 16 marzo fu trovato aperto da cronisti
e operatori televisivi accorsi sul posto della tragedia. E che vi si rifugiarono
per fare le loro telefonate di lavoro. Così anche altri, fra i quali un uomo
alto che parlava tedesco. Tedesco come la lingua usata durante l’eccidio della
scorta di Moro da uno sconosciuto – forse lo stesso – che correva per la strada
gridando ai passanti di fermarsi e di stare attenti. Tedesco come la montagna di
marchi cambiati dal socio del bar fallito per una partita forse di armi. Tedesca
come una terrorista catturata dopo qualche tempo in Germania e trovata in
possesso di una carta d’identità italiana falsificata, risultata poi proveniente
da una partita trafugata in un comune del Comasco: la stessa dei documenti
ancora intonsi trovati il mese dopo il sequestro di Moro nel covo brigatista di
via Gradoli, una traversa della via Cassia. Un covo che la colonna romana delle
brigate rosse aveva messo a disposizione di Mario Moretti, mandato nella
Capitale dalla direzione strategica ad organizzare e condurre l’operazione
contro il presidente della Dc.
Si tratta dello stesso covo
nella cui palazzina fu curiosamente eseguito un sopralluogo infruttuoso della
Polizia pochi giorni dopo il sequestro di Moro. Si arrivò alla sua scoperta dopo
un mese per un allagamento dalla casualità assai sospetta, dopo che il nome
Gradoli, raccolto da Romano Prodi in una incredibile seduta spiritica vicino a
Bologna, era stato scambiato dalla Polizia per l’omonima località del Reatino,
con relativo, inutile dispiego di forze e perdita di tempo. C’era insomma
qualcuno dall’altra parte della barricata che voleva mandare al posto giusto,
per catturare Moretti, forze dell’ordine che non riuscivano invece ad arrivarci.
Quel qualcuno, forse provvisto delle chiavi, fu alla fine costretto a ricorrere
ad una doccia da lasciare aperta. Ma ormai era troppo tardi per beccare il capo
dell’operazione. Si riuscì solo a far prendere documenti, come quelle carte
d’identità rubate, da cui sperare di dare nuovi e utili impulsi alle indagini.
Ma torniamo a quel maledetto
bar d’angolo fra via Fani e via Stresa. Siamo proprio sicuri di poter liquidare
come ininfluente, occasionale, dietrologica della peggiore specie, la questione
del perché e del come quella maledetta mattina fosse stato ad un certo punto
aperto? Dopo le altre circostanze che ho ricordato prendendole dalla prima
relazione della commissione Fioroni, non me la sento di fare spallucce. Spero
altresì di trovare nella relazione finale qualche risposta non ad mio
interrogativo capriccioso, ma alla domanda che angosciò il povero Giovanni Leone
sino alla morte. E che ebbi la ventura di raccogliere dalla sua viva voce in una
intervista per Il Foglio nel ventesimo anniversario del sequestro di Moro, che
so finita tra le carte esaminate dalla commissione Fioroni. Leone, nella sua
casa alle Rughe, sulla Cassia, mi raccontò alla presenza della moglie che il 9
maggio 1978 aveva dato appuntamento al Quirinale verso mezzogiorno al ministro
della Giustizia Francesco Paolo Bonifacio, suo ex allievo, per firmare di
propria iniziativa, senza che l’interessata glielo avesse chiesto, e quindi in
deroga alla legge allora in vigore, la grazia a Paola Besuschio, condannata in
via definitiva per reati di terrorismo, ma non di sangue. Presente nell’elenco
dei 13 prigionieri con i quali le brigate rosse avevano chiesto di scambiare il
povero Moro, la Besuschio era stata scelta dall’allora presidente della
Repubblica, d’intesa col giurista e amico Giuliano Vassalli e con l’ex capo di
Gabinetto di Moro, il consigliere di Stato Giuseppe Manzari, a causa delle sue
cattive condizioni di salute. L’unica copertura che Leone, consapevole di
forzare la linea della cosiddetta fermezza adottata dal governo e dalla
maggioranza di solidarietà nazionale, estesa sino al Pci di Enrico Berlinguer,
si era premurato di chiedere era quella dell’amico di partito e presidente del
Senato Amintore Fanfani. Che proprio quella mattina aveva appena preso la parola
alla direzione della Dc per affidarsi alle autonome valutazioni del capo dello
Stato quando fu interrotto, drammaticamente zittito dall’annuncio del
ritrovamento del cadavere di Moro. Che i terroristi avevano preferito ammazzare
di prima mattina, piuttosto che dividersi nella valutazione della grazia alla
sola Besuschio. Per dirla in parole povere, Leone morì nel sospetto che in
quella disgraziata vicenda, costatagli probabilmente anche il posto con quelle
dimissioni reclamate e ottenute sei mesi prima della scadenza del mandato con
altre motivazioni di opportunità politica e persino morale, di cui si sarebbero
tutti scusati troppo tardi, fosse stato un infiltrato di troppo: o uno infedele
dei servizi segreti nelle brigate rosse o uno, purtroppo fedelissimo, delle
brigate rosse nei servizi segreti. Che peraltro in quel momento stavano
attraversando una difficile transizione per una riforma appena intervenuta.
Il caso Moro e gli strani
affari di Lucia Mokbel.
Nel ’78 abitava in via Gradoli, accanto al covo Br. La Mokbel al
primo processo sullo statista Dc raccontò la storia di un bigliettino, poi
sparito, in cui lei sostenne di aver sentito alle tre di notte il ticchettio di
una trasmissione in Morse provenire dall'appartamento adiacente, il nascondiglio
brigatista, scrive Giovanna Vitale il 29 marzo 2012 su “La Repubblica”. È una
vecchia conoscenza della cronaca nera, Lucia Mokbel. Iscritta nel registro degli
indagati insieme al marito per gli strani affari sul Punto verde qualità del
Parco Feronia, deve la sua notorietà non solo alla parentela con Gennaro suo
fratello, l'imprenditore dell'estrema destra romana finito in carcere
nell'ambito dell'inchiesta "Broker". Per uno strano gioco del destino, la
signora dagli ingombranti legami, di sangue e d'amicizia, è stata infatti una
delle protagoniste (involontarie?) del mistero di via Gradoli, il covo delle Br
dove il leader della Dc Aldo Moro fu imprigionato dopo il sanguinoso agguato di
via Fani. Era lì, nel condominio al civico 96, che nella primavera del 1978
Lucia Mockbel abitava con il compagno: interno 11, secondo piano. Proprio
affianco ai sequestratori, in affitto all'interno 9: era lei l'inquilina della
porta accanto, dove in quei giorni alloggiavano i brigatisti Mauro Moretti e
Barbara Balzerani. Lucia allora viveva con Gianni Diana, impiegato da un
commercialista che amministrava immobili, tra cui alcune società in mano ai
servizi segreti. Gli stessi servizi che in via Gradoli avevano appartamenti
intestati a società di copertura. La Mokbel al primo processo Moro raccontò la
storia di un bigliettino, poi sparito, in cui lei sostenne di aver sentito alle
tre di notte il ticchettio di una trasmissione in Morse provenire
dall'appartamento adiacente, il covo delle Br. Un biglietto consegnato agli
agenti di polizia che il 18 marzo effettuarono un sopralluogo, su precisa
segnalazione, e indirizzato al commissario Elio Cioppa (poi risultato iscritto
alla P2). "Non mi fu dato l'ordine di perquisire le case - riferì in aula il
brigadiere Merola - Era solo un'operazione di controllo durante la quale furono
identificati numerosi inquilini, mentre molti appartamenti furono trovati al
momento senza abitanti e quindi, non avendo l'autorizzazione di forzare le
porte, li lasciammo stare, limitandoci a chiedere informazioni ai vicini.
L'interno 11 fu uno degli appartamenti in cui non trovammo alcuno. Una signora
che abitava sullo stesso piano ci disse che lì viveva una persona distinta,
forse un rappresentante, che usciva la mattina e tornava la sera tardi". Ma
Lucia Mokbel - la signora in questione - spiegò al processo di aver dato ai
poliziotti un biglietto in cui scrisse di aver sentito la sera prima segnali in
Morse venire dall'appartamento accanto. Ma di quel biglietto non s'è mai trovata
traccia.
CONTINUIAMO A RICORDARE
(CIO’ CHE SI CERCA DI SCORDARE).
Il giustizialismo, caro
Scalfari, ha avvelenato la tua Repubblica,
scrive Francesco Damato il 26 gennaio 2018 su "Il Dubbio". Riflessioni dopo lo
scontro tra Scalfari e De Benedetti. Al debutto di Repubblica nelle edicole, il
14 gennaio del 1976, Indro Montanelli ci esortò, al Giornale che in edicola ci
stava già da più di un anno e mezzo, a non temerne la concorrenza. Eppure il
quotidiano fondato da Eugenio Scalfari aveva assunto il nome di una giovane
testata portoghese socialista distintasi per anticomunismo. Che era anche la
cifra, per quanto non proprio di sinistra, del giornale fatto nascere da
Montanelli dopo essere uscito dal Corriere della Sera, diretto da Piero Ottone.
Le preoccupazioni più forti per la concorrenza che ci poteva fare Scalfari
venivano da Enzo Bettiza, ma erano condivise anche da Cesare Zappulli,
Gianfranco Piazzesi, Renzo Trionfera, Danilo Granchi e alcuni collaboratori
esterni, fra i quali lo storico Rosario Romeo. “Tranquilli, Scalfari non ci
procurerà danni. Ne procurerà solo a Paese Sera e all’Unità, dove non a caso ha
pescato di più per mettere su la sua redazione”, ci disse Montanelli. E così in
effetti avvenne perché Repubblica, a dispetto del modello portoghese
attribuitogli all’esordio, si rivolse ben presto ad un pubblico che già votava o
era tentato di votare per il Pci guidato da Enrico Berlinguer. Cui Scalfari si
rivolgeva con spirito per niente di antitesi, ma di dialogo, di incoraggiamento
sulla strada evolutiva che quel partito aveva imboccato ma stentava a percorrere
con la velocità da lui desiderata. Il pur fulminante avvio del nuovo giornale,
per quanti danni avesse subito apportato a Paese sera e all’Unità, come
Montanelli aveva previsto, stentò poi a tenere botta nelle edicole con ricavi
proporzionati alle sue spese. Gli diede una grossa mano involontariamente Aldo
Moro, durante il cui sequestro, fra il 16 marzo e il 9 maggio del 1978, quando
anche lo statista democristiano fu ucciso dalle brigate rosse, come la scorta 55
giorni prima, Repubblica guidò vistosamente la linea della fermezza, ancor
meglio del governo monocolore dc di Giulio Andreotti sostenuto esternamente dai
comunisti. Ne fummo condizionati anche noi al Giornale, dove non ero il solo –
vi assicuro – a chiedermi se valesse la pena lasciare uccidere Moro non tanto
per difendere, come si diceva, la saldezza dello Stato, quanto per garantire la
sopravvivenza di una maggioranza – quella di “solidarietà nazionale”- cui i
comunisti non potevano comprensibilmente lasciare spazi di manovra in quella
tragedia. Essi avrebbero perduto diversamente la credibilità di forza di
governo, visto che i terroristi rossi appartenevano a quello che Rossana
Rossanda, allora cinquantaquattrenne, aveva impietosamente definito “album di
famiglia” sul Manifesto. Ma non fu solo nella drammatica vicenda di Moro che
al Giornale fummo condizionati dalla concorrenza e dalla cultura di Scalfari e
della sua Repubblica. Ne ebbi una prova personale e clamorosa cinque anni dopo,
nel 1983, quando abbandonai Montanelli per il rifiuto opposto alla pubblicazione
di un editoriale che avevo scritto per difendere il segretario socialista
Bettino Craxi dalle accuse di prepotenza e di lottizzazione. Che gli erano state
rivolte da comunisti e sinistra democristiana per alcuni avvicendamenti ai
vertici dell’Eni. La lottizzazione, come poi si sarebbe accertato anche col
finanziamento irregolare della politica, non era – e non è tuttora – un fenomeno
addebitabile a un solo partito e relativo leader. Ebbene, quando discutemmo al
telefono di quell’editoriale bloccato sulla sua scrivania, e forse anche già
cestinato, Montanelli mi disse, fra l’altro: “Franceschino, non possiamo
lasciare a Scalfari l’esclusiva delle critiche per lottizzazione a Bettino”.
Anche lui chiamava per nome Craxi, ma gli davano fastidio il carattere e un po’
anche la concorrenza elettorale che il segretario socialista faceva pure a
quella Dc per la quale il direttore del Giornale da anni invitava i lettori a
votare “turandosi il naso”, pur di non farla sorpassare dal Pci. Successivamente
alla nostra separazione professionale, quando dirigevo Il Giorno, non mi
sorprese più di tanto vedere il mio ex Giornale appiattito sulla Procura di
Milano, come Repubblica, in quel grande e demolitorio processo ai partiti di
governo – ma solo ad essi – della cosiddetta prima Repubblica: quella vera, non
di carta. Che infatti crollò impietosamente, con la collaborazione – debbo anche
dire – delle vittime. Le quali, anziché difendersi collettivamente, come tentò
di fare Craxi per conto di tutti in un discorso alla Camera che nessuno dei suoi
avversari osò interrompere, si divisero fra loro, ed anche al proprio interno.
Ciascuno cercò di salvarsi per proprio conto, ai danni magari del vicino di
banco, nello stesso gruppo parlamentare. Più che una guerra, come piacque
dipingerla a certi magistrati che si erano assunti il compito della
rigenerazione o rifondazione della politica, fu una tonnara. Il giustizialismo,
preferito ad un garantismo scambiato sbrigativamente per complicità col
malaffare, divenne una malattia infettiva, anche nel campo mediatico.
Repubblica lo cavalcò con astuzia ed efficacia superiori ad ogni altro giornale,
dandogli con l’autorevolezza dei suoi collaboratori esterni quasi una dignità
etica e culturale, elevandolo dall’opportunismo politico dei partiti che lo
usavano per liberarsi degli avversari. E lo fece con una potenza di fuoco
enorme, che portò il quotidiano di Scalfari in testa alle graduatorie nelle
edicole, senza alcuna discontinuità tra l’epilogo della prima Repubblica, sempre
quella vera e non di carta, e tutto l’accidentato corso della seconda. Ci fu una
sola, vistosa eccezione, che io ricordi bene. Essa risale al 2012, quando
Scalfari, ormai soltanto fondatore ma pur sempre anima del suo giornale,
spiazzando mezza redazione, forse anche il direttore Ezio Mauro, e un bel nugolo
di autorevoli collaboratori, a cominciare dal presidente emerito della Corte
Costituzionale Gustavo Zagrebelsky, prese le difese dell’allora capo dello Stato
Giorgio Napolitano in uno scontro durissimo con la Procura di Palermo. Gli
inquirenti siciliani avevano intercettato “incidentalmente” il capo dello Stato
al telefono con l’indagato Nicola Mancino, già ministro democristiano
dell’Interno, presidente del Senato e suo vice al Consiglio Superiore della
Magistratura. Essi si ostinarono a conservarne le registrazioni, anziché
distruggerle, come reclamavano al Quirinale. Dove si facevano giustamente forti
anche del fatto che gli stessi magistrati d’accusa avevano definito quelle
intercettazioni ininfluenti ai fini delle indagini e del relativo processo –
tuttora incredibilmente in corso – sulle presunte trattative fra lo Stato e la
mafia nella stagione delle stragi del 1992- 93. Ebbene, è stato proprio il
giustizialismo, a mio modesto avviso, ad avvelenare anche i pozzi
di Repubblica, sino a determinare il rovinoso scontro consumatosi fra Carlo De
Benedetti e il suo ormai ex giornale, ma anche fra Carlo De Benedetti e i figli
ai quali egli ne ha ceduto la proprietà, a cominciare naturalmente da Marco, che
presiede la società editrice. Il quale ha rilasciato una lunga intervista
a Repubblica per difenderla dalle critiche del padre ed esprimere tutto il suo
comprensibile imbarazzo, pur evitando di addentrarsi nella ricerca delle ragioni
dell’accaduto, o prendendosela solo col forte temperamento del genitore. Cui
egli ha tuttavia assicurato che ne corrisponde un altro altrettanto forte, che è
naturalmente il suo. Il che penso abbia rasserenato a tal punto Scalfari da
avergli fatto riprendere, sia pure di lunedì, anziché di domenica questa volta,
il suo abituale e impegnativo appuntamento con i lettori. Lo stesso Scalfari, in
una intervista anche da lui rilasciata a Repubblica per difendersi da
un’imbarazzante aggressione verbale dell’ex amico e sodale consumatasi in sua
assenza nel salotto televisivo di Lilli Gruber, ha espresso la sensazione che
possano avere contribuito a condizionare gli umori di Carlo De Benedetti le
polemiche appena riesplose contro i pur modesti, relativamente, guadagni di 600
mila euro realizzati tre anni fa acquistando titoli delle banche popolari. Di
cui l’editore aveva appena saputo l’imminente riforma dall’allora presidente del
Consiglio Matteo Renzi dopo una colazione a Palazzo Chigi, nel frettoloso saluto
di commiato sulla porta dell’ascensore, presente quindi il commesso di turno. La
consistenza relativa – ripeto di quei guadagni in borsa, dove De Benedetti
movimentava centinaia di milioni di euro, e gli accertamenti eseguiti dopo la
trasmissione della pratica dalla Consob hanno indotto più di un anno e mezzo fa
la Procura di Roma a chiedere al giudice competente, e tuttora silente,
l’archiviazione del fascicolo, peraltro ridotto a carico soltanto dell’operatore
incaricato dell’investimento dal finanziere. Carlo De Benedetti si aspettava –
secondo me giustamente – una difesa da parte di Repubblica. Che invece ha voluto
prendere le distanze con un breve editoriale dettato dall’esigenza, dichiarata,
di non esporre il giornale al sospetto o all’accusa dei lettori di “conflitto
d’interessi”. E il presidente ora soltanto onorario della società editrice – pur
avendo già liquidato con poche battute la faccenda dei 600 mila euro e parlando
più in generale di Repubblica e di una sua presunta perdita d’identità nel già
citato salotto ospitale di Lilli Gruber – si è doluto del mancato “coraggio” del
giornale ora diretto da Mario Calabresi. Che egli ha un po’ paragonato al don
Abbondio dei celebri Promessi Sposi manzoniani.
2017. L’ANNO DELLA
GIUSTIZIA CALPESTATA E DELLA MEMORIA TRADITA,
scrive il 30 dicembre 2017 Andrea Cinquegrani su "la Voce delle Voci". 2017,
l’anno in cui la giustizia muore. E l’Italia perde sempre più memoria. L’anno
dei buchi neri sempre più neri, dei misteri di Stato che pesano come
insopportabili macigni, delle vittime senza lo straccio di una giustizia, uccise
due volte, dei familiari oltraggiati nelle loro richieste regolarmente senza
risposta. Come diceva spesso il grande Olivero Beha, “un Paese senza più memoria
non è più un Paese”. E la nostra memoria resta affidata, di tanto in tanto, al
blaterare di un Presidente dell’Ovvio, di un capo dello Stato ectoplasma che,
alle rituali scadenze, chiede di far luce sulla strage di Ustica o su quella di
Bologna. Mattarella, ma ci faccia il piacere. L’anno che ci lasciamo alle spalle
ha il volto segnato dal dolore di Luciana Riccardi, la madre di Ilaria
Alpi, trucidata 23 anni fa in Somalia con Miran Hrovatin. E il volto truce del
procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone che mesi ebbe la faccia di bronzo di
suggerire alla signora Alpi, “mi dica lei chi devo interrogare”. Un’atroce presa
in giro per quella madre coraggio e per la memoria della figlia. Roma in questo
modo torna ad essere quel porto delle nebbie che è sempre stato: la procura
arriva a chiedere l’archiviazione del caso Alpi dopo che una sentenza a Perugia
ha messo nero su bianco un chiaro “depistaggio”: basta ora andare a prendere
mandanti e assassini, un gioco quasi da ragazzi dopo quella illuminante sentenza
perugina. Invece niente, il buio più totale. L’inerzia più assoluta. Il
depistaggio è entrato, come un cancro, nei processi Borsellino, siamo arrivati
al quater – incredibile ma vero – e nessuno osa far pagare il conto a quei
magistrati con tanto di nomi, cognomi e indirizzi, i quali hanno inventato a
tavolino il pentito Scarantino per depistare meglio ed evitare che luce venisse
fatta su quel chiaro omicidio di Stato, come fu anche quello di via Capaci.
Perchè quei due magistrati “dovevano morire”. Come “Doveva morire” Aldo Moro,
secondo il profetico libro scritto da Ferdinando Imposimato e Sandro
Provvisionato: e adesso la commissione d’inchiesta, presieduta dall’ex Dc Beppe
Fioroni, chiude i battenti senza aver prodotto neanche l’ombra di un topolino.
Come del resto capita, storicamente, a tutte le commissioni parlamentari
d’inchiesta, autentiche sceneggiate e prese per i fondelli dei cittadini. Il
porto delle nuove nebbie, la procura di Roma, produce altri aborti. Come la
manifesta non volontà di far luce sul caso di Emanuela Orlandi, proprio quando –
come per Ilaria Alpi – ci sarebbero tutti gli elementi giusti per arrivare ad
una conclusione. E’ venuto infatti alla luce, un paio di mesi fa, che Emanuela
aveva alloggiato a Londra, in un collegio femminile, per circa un anno: e le
spese vennero sostenute dal Vaticano. Che quindi sapeva ed era perfettamente a
conoscenza delle trame. Perchè mai, ora, la procura di Roma non vede, non parla,
non sente, non alza un dito e non fa il becco di un’indagine? Stesso copione per
il giallo Pasolini. Esattamente un anno fa il legale della famiglia presenta
delle inoppugnabili prove del DNA, che attestano come sulla scena del crimine ci
fosse almeno un altro ‘protagonista’, un Ignoto 2 (e forse anche un Ignoto 3).
Mentre appare ormai chiaro anche ai non vedenti che il motivo di
quell’assassinio di Stato aveva una matrice ben precisa: i buchi neri dell’Eni,
quel Petrolio bollente che avrebbe rischiato di mandare in tilt la nomenklatura
di allora. E la procura di Roma, oggi, a oltre un anno di distanza da quelle
prove schiaccianti, resta solo a guardare. Come sta a guardare, da quasi un anno
e mezzo, la procura di Napoli, che ha un fascicolo aperto (sic) sul caso
di Marco Pantani, al quale la camorra sottrasse il Giro d’Italia 1999,
comprandolo a suon di minacce e corruzioni, facendo alterare il suo campione di
sangue. La Direzione distrettuale antimafia partenopea da agosto 2016 dovrebbe
far luce e, invece, fino ad oggi non ha prodotto neanche lo straccio di un
documento: eppure le verbalizzazioni di parecchi pentiti sono lì, sul tavolo
delle prove, a sostenere che quel Giro d’Italia venne taroccato. Cosa si
aspetta, l’intervento di San Gennaro? Da un suicidio-omicidio all’altro il passo
è breve, ed eccoci a Siena. Dove la Procura per ben due volte, nonostante la
mole di prove dica esattamente il contrario, ha chiesto l’archiviazione per la
morte di David Rossi, il responsabile per la comunicazione del Monte dei Paschi
di Siena volato giù dal quarto piano di palazzo Salimbeni. Solo il coraggio
della moglie di David e della famiglia fa sperare ancora in qualcosa. Per le
toghe di casa nostra, invece, tutto chiaro: suicidio. Per saperne di più,
leggete l’illuminante “Morte dei Paschi”, appena uscito in libreria e firmato
da Elio Lannutti e Franco Fracassi. Anche per capire come i Bankster uccidono i
risparmiatori. Calpestata quest’anno, ancora una volta, la memoria delle vittime
di Ustica: mandanti mai. Ora spunta un marinaio della Navy a stelle strisce,
smemorato per quarant’anni. E magistrati sempre sotto coperta, a non vedere ed
esaminare neanche un documento choc filmato e firmato Canal Plus di mesi fa, che
ricostruisce quell’atroce scenario di guerra, con una portaerei francese
(Foche o Clemanceau) protagonista. Perchè nessuno indaga, pur con una pista così
precisa? I soliti misteri della (non) giustizia di casa nostra. L’anno che
arriva potrà portare ad una sentenza-sentenza, autentica, in grado di far
giustizia dopo oltre vent’anni per la strage del sangue infetto? C’è solo da
sperarlo. Il processo, cominciato a Napoli nella primavera 2016, è andato avanti
per tutto quest’anno, e il verdetto dovrebbe essere pronunciato tra febbraio e
marzo 2018. Un strage di cui nessuno osa parlare, i media regolarmente tacciono
(solo il Fattoha scritto alcuni articoli): una strage da 5 mila vittime e passa.
Nessuno vuol disturbare lorsignori, i pezzi da novanta di Big Pharma, i vertici
delle aziende che lavorano e commerciano sangue, come da noi il gruppo Marcucci,
storico oligopolista nel settore fin dai tempi di Sua Sanità De Lorenzo e oggi
ancor più in sella per l’amicizia di ferro tra uno dei rampolli di
casa Marcucci, il senatore Andrea, col suo capo, l’ex premier Matteo Renzi. Con
una magistratura così assonnata, sarebbe il caso di poter contare su un
giornalismo che faccia il suo dovere, un vero giornalismo d’inchiesta, capace di
svelare trame e connection, soprattutto sul versante degli storici – e
sempreverdi – rapporti fra mafie, politica e imprese. Invece che succede? Il
vero problema sono le Fake News! Si guarda la pagliuzza in rete e non la trave
di un giornalismo carta e tivvù ormai omologato, cloroformizzato, genuflesso
davanti al Potere. Per una serie di motivi, non ultimo quello della via
giudiziaria alla normalizzazione dei media: le querele inventate di sana pianta,
le citazioni milionarie utilizzate al solo scopo di intimidire – come un
revolver puntato alla tempia – quel raro giornalista che voglia ancora fare il
suo mestiere. Spesso un free lance. Ma chissenefrega. Lotta alle Fake news è il
nuovo cavallo di battaglia in casa Pd, che ha da tempo ormai mandato in soffitta
la libertà di stampa e il diritto dei cittadini ad essere informati. Ciliegina
sulla torta, vera strenna natalizia, ora, la nuova normativa sulle
intercettazioni e soprattutto sulla loro divulgazione: un vero, nuovo bavaglio
come neanche Berlusconi si sarebbe mai sognato. Vero è che le intercettazioni,
per i giornalisti, devono rappresentare uno strumento in più a corredo di
inchieste che si basino su una corposa acquisizione di dati, notizie, documenti
e informazioni. Ma non è possibile, come succede adesso, sotto il vigile sguardo
del guardasigilli Andrea Orlando, che intende la lotta alle mafie come un
esercizio da scout, mettere una simile pietra tombale sull’uso delle
intercettazioni nei media. Chi decide cosa sia rilevante o meno? Cosa vuol dire
mai che sono riproducibili solo alcuni ‘brani essenziali’? E via di questo
passo, tanto per seppellire una volta per tutte quei pochi brandelli della
libera informazione. Era proprio uno scout, il Venerabile Licio Gelli…
P.S. Il nostro abbraccio più
forte va a due amici dei quali sentiamo una tremenda mancanza, Oliviero Beha e
Sandro Provvisionato. Non solo due penne rare nel panorama del giornalismo
italiano, ma due uomini di raro coraggio, capaci di lottare nella giungla
dell’informazione sempre con la schiena dritta e con rara intelligenza. Ciao.
1978, l'anno degli
assassinii eccellenti e dei diritti civili.
L'omicidio di Aldo Moro, l'elezione di Sandro Pertini. La canzone di Lucio Dalla
"Caro amico ti scrivo" e i referendum radicali. Anniversario di un momento
storico per il nostro Paese, scrive Filippo Ceccarelli l'11 gennaio 2018 su
"L'Espresso". Nel gran torneo degli anniversari ad alto impatto, il 1978 si
affaccia senza dubbio come il più enigmatico e ingombrante. In bilico fra
estreme collocazioni di comodo, gli anni di piombo e il riflusso, via Fani e
febbre del sabato sera, fu un reattore di cambiamenti, un confine attraversato
col cuore in gola e al dunque un momento destinato a segnare di sé un tortuoso
prima, un tempestoso durante e un misterioso poi. Perché troppo in definitiva
accadde in quei 12 mesi. Assassini eccellenti, conquiste civili come l'aborto e
la legge anti-manicomi, sperimentazioni sociali, culturali e artistica all'ombra
di un'inflazione che rasentava il 20 per cento: e poi i referendum, le
dimissioni di Leone e l'ascesa di Pertini, la morte di due papi e l'inizio
glorioso del pontificato di Wojtyla. E tuttavia, proprio la potenza di tutti
questi eventi ottenebra il giudizio storico e il senso ultimo di quel periodo,
facendo anzi di quell'anno un unicum che sfugge a celebrazioni di circostanza.
Tutto questo per dire, si spera con maggiore semplicità, che forse conviene
prenderla un po' di lato. E ricordare per esempio che un giorno imprecisato di
quel 1978, in uno studio di registrazione dentro il castello di Carimate,
Brianza, Lucio Dalla diede vita e forma definitiva a una canzone che comincia:
“Caro amico ti scrivo”. E che non a caso da 40 anni, regolarmente, viene
ripropinata agli italiani come una specie di augurio - quando per certi versi lo
è davvero e per altri dice il contrario. Ora, è difficile dire di che cosa
esattamente parli, oltretutto in forma epistolare, il brano in questione,
incompreso o frainteso che sia. Ma certo come nessun altro “l'anno che verrà” è
figlio di quel tempo, così come con la stessa stralunata e fiduciosa malinconia
anticipa ciò che l'Italia sarebbe diventata. C'è un po' tutto, comunque, lì
dentro: il terrorismo, la paura, il dissolversi dei vincoli collettivi, le nuove
libertà individuali, dal sesso all'autoconsapevolezza, poi la solitudine, la
religione che mutava i suoi riferimenti, la pietà e il suo contrario, fino al
trionfo della manipolazione e della tecnologia del far credere. Lo stesso Dalla,
come tanti artisti-rabdomanti, ne ha parlato nel corso degli anni in modo
problematico definendola via via una canzone “importante”, “coraggiosa”,
“disperata”, pur sforzandosi di farla risultare “ottimista”. Nelle teche Rai si
trova un documento radiofonico in cui, rispondendo a una 24enne Serena Dandini,
come fonte di quel brano indicava l'Italia di allora, “una terribile società di
fuoco, però anche affascinante. Si stanno muovendo le cose – insisteva a caldo -
quelle di oggi e le cose che verranno”. “Meno botti del solito a mezzanotte –
annota nel suo diario l'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti alla
data del primo gennaio 1978 – Sono grato ai silenziosi perché il mio anno si
inizia con un mal di testa di prima classe”. Non gliene mancavano certo le
ragioni. Più che aperta, ormai, la questione del Pci è incandescente. Non esiste
più maggioranza, ma sui comunisti al governo la risposta americana è un pubblico
e risolutissimo No (si saprà poi che in sede Nato è previsto anche un “Coup
d'Etat or other subversive action”). Il 9 di febbraio il vecchio Nenni, patrono
del socialismo italiano, compie 87 anni: “Solita pioggia di telegrammi” scrive
anche lui nel diario: “Ma io mi sento sempre in debito con la società”. Non
senza fatica, ma con energica spregiudicatezza il suo pupillo Craxi cerca di
farsi largo nel Psi. Alleatosi a sorpresa con i furbi coetanei lombardiani, al
congresso di Torino sostituisce falce martello sole e libro con un garofano e
rottama in via definitiva i vecchi De Martino e Mancini. Nella Dc, ancora una
volta, Moro prende tempo e tesse la tela districandosi fra gli impedimenti della
Guerra fredda con l'obiettivo di portare l'intero scudo crociato all'accordo con
Berlinguer, che anche umanamente stima (un giorno, per caso, l'ha visto giocare
a palla con i figli al Foro Italico, ha fermato l'auto e l'ha voluto salutare).
Classica figura di leader completo, ideologo stratega e tattico, complessa
personalità superba e insieme umile, nel dirigersi nell'auletta dei Gruppi a
Montecitorio, dove sta per pronunciare il suo ultimo discorso, probabilmente il
più straordinario esempio di oratoria della Prima Repubblica, con la testa
inclinata un rassegnato sorriso: “Eh – così saluta a voce bassa i giornalisti -
andiamo un po' a sentire...”.
“Si esce poco la sera, perfino
quando è festa...” Su quanto poi accadde – a lui e all'Italia - si sa già troppo
e troppo poco ancora, come capita spesso dopo un rituale di passaggio, allorché
il trauma si tira appresso una congerie di indizi, segni, simboli, presagi,
coincidenze, slittamenti, equivoci e code di paglia con opportune puntate nei
santuari di varie consorterie e qualche sosta nella psichiatria, nella
grafologia e nell'enigmistica – mancando solo la fantascienza, per quanto nel
covo br di via Gradoli siano stati trovati diversi numeri di Urania. “Quando non
si vede bene cosa c'è 'davanti' – disse Norberto Bobbio rivolgendosi al ministro
dell'Interno di allora, Cossiga – viene spontaneo chiedersi cosa c'è 'dietro'”.
Così da 40 anni un intero paese si sente autorizzato a lasciarsi variamente
influenzare da suggestioni per lo più occulte, quando non proprio occultistiche
se solo si pensa alla seduta spiritica di Zappolino, alla chiromante del fumetto
di Metropolis, ai veggenti consultati dalle forze dell'ordine o ai ciechi che la
sera prima del rapimento vengono a sapere da sconosciuti ciò che sarebbe
accaduto l'indomani. Con il che, di tutte le definizioni del caso Moro, la
migliore rimane forse quella di un pensatore visionario come Guy Debord:
“Un'opera mitologica a grandi macchinari scenici, in cui degli eroi terroristi a
trasformazioni multiple sono volpi per prendere in trappola la preda, leoni per
non temere nulla da nessuno per tutto il tempo che la tengono in custodia, e
pecore per non trarre da questo colpo assolutamente niente che possa nuocere al
regime che ostentano di sfidare”.
“C'è chi ha messo dei sacchi
di sabbia vicino alla finestra...” Dopo 54 giorni la botta e la paura si
sentono. Strilla la copertina di Time: “The caos in Italy”. Per scaricare paura
e tensione si cerca un capro espiatorio: eletto male, vissuto come macchietta e
per via di alcune frequentazioni sfiorato dall'affare Lochkeed, Giovanni Leone è
una vittima perfetta. “E senza grandi disturbi qualcuno se ne andrà”: il
risultati dei referendum (fermo di polizia e finanziamento pubblico ai partiti)
accelerano la sua cacciata dal Quirinale, che avviene di notte, dopo una penosa
apparizione in tv, sotto una pioggia scrosciante. Insieme con Marco Pannella,
che pochi giorni prima s'è piazzato per 24 interminabili minuti con un bavaglio
davanti alle telecamere di Tribuna politica, il nuovo e arzillissimo inquilino
del Colle, Sandro Pertini, nemico del protocollo e amico dei colpi di teatro,
accende ufficialmente i riflettori della politica spettacolo. Nel 1978 esce
anche il primo numero di un iperbolico strumento di contraffazione satirica, Il
Male. Intanto la Repubblica prende il via, e con breve scandalo Il Corriere
della Sera mette l'amore e le corna in prima pagina. Nanni Moretti si presenta
al pubblico con “Ecce Bombo”. Dalla rivoluzione alla ristorazione, Mauro
Rostagnò apre “Macondo”. Nel frattempo l'eroina invade il mercato, a scapito di
un'intera, sempre più disillusa generazione. Scorrono, a 40 anni di distanza,
scampoli, spezzoni e lacerti di ricordi non sai bene se più sintomatici o
irrilevanti: “L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va”. La
“terza via” di Berlinguer. I “sacrifici” di nuovo richiesti da Lama. L'allarme
di Cesare Romiti sull'11-12 per cento di operai che nei giorni in cui c'è la
partita non vengono al lavoro. L'ascesa nel Palazzo di Licio Gelli: editoria,
petrolio, partiti e forze armate. Sempre in quell'anno il Censis calcola che
l'economia sommersa assorbe dai 4 ai 7 milioni di persone, tra il 15 e il 20 per
cento delle attività in Italia.
“Ma la televisione ha detto
che il nuovo anno...”. E già, non poteva mancare: proprio nei giorni del
sequestro Moro nei sotterranei dell'hotel Jolly di Milano 2 il giovane
costruttore Silvio Berlusconi dà il via a TeleMilano 58, embrione di Canale5 e
della tv commerciale (chiuso il bilancio con una perdita di 300 milioni). “Ogni
Cristo scenderà dalla croce...”. Muore Paolo VI e poi qualche settimana dopo
rimuore anche il suo mansueto successore Giovanni Paolo I. Appunto di Andreotti:
“Cadono anche i proverbi, tipo: 'A ogni morte di Papa'”. Entra in scena dalla
Polonia un pontefice empatico ed atletico. “Se sbaglio – azzarda affacciandosi
appena eletto - mi corrigerete”. Non accadrà così spesso. E di nuovo, sulle note
lievi del fado e l'inconfondibile voce di Lucio Dalla, la memoria oscilla fra il
troppo e il nulla. “Caro amico, ti scrivo...”. Documento storico, messaggio
civile, preghiera e magari anche profezia.
1978, quell’anno cupo,
triste e luttuoso che vide nascere il nostro mondo,
scrive Paolo Delgado il 9 gennaio 2018. Dal caso Moro all’elezione di Wojtyla.
Il 1968, anno incendiario e luminoso, ricco di rabbia e di speranza e dunque di
rivolta, lo ricordiamo tutti. Celebrarlo è già da un pezzo liturgia. Del 1978,
anno mesto e luttuoso, parliamo invece poco, e quasi solo in virtù di quel
sequestro durato 55 giorni che condizionò in effetti la sorte della Repubblica
italiana come nulla sino a quel momento e che è circondato ormai da tante di
quelle favole e leggende e ridicoli sospetti da essere quasi avulso dalla
storia: pane per i denti degli studiosi della piscopatologia di massa. Invece il
mondo in cui viviamo è nato proprio il quel grigio e triste 1978, quando gli
italiani combattevano con un’inflazione ben oltre il 20% e già da un paio d’anni
erano abituati a usare bizzarri “miniassegni” emessi dalle banche al posto degli
spicci, quando era lecito confondere il vento islamico che per la prima volta
soffiava impetuoso in Medio Oriente con una promessa di riscatto, quando i
lavoratori italiani scoprivano con un certo smarrimento che le loro
rappresentanze sindacali e quelle politiche erano pronte a far pagare proprio a
loro i prezzi della crisi, in quella svolta storica che fu definita allora
“dell’Eur”, mentre quelli inglesi neppure immaginavano che un ciclone di
proporzioni mai viste in precedenza, l’uragano Maggie, stesse per abbattersi
sulle loro teste e sulle loro tasche per poi dilagare in tutto il mondo. Da noi,
in Italia, non servivano doti profetiche per indovinare che sarebbe stato un
anno difficile. Bastava ascoltare il discorso di fine anno del presidente
Giovanni Leone, già assediato per un presunto e inesistente coinvolgimento nello
scandalo Lockheed, per capire che la febbre era altissima. Come si fa a
equivocare quando il capo dello Stato, che sarebbe di lì a poco stato costretto
alle dimissioni da una campagna stampa tanto infondata quanto violenta, conclude
il suo messaggio augurale affermando: «Non vi ho detto parole serene come avrei
sperato e anzi in esse avrete trovato motivi di preoccupazione?» Forse il cupo
pessimismo di Leone era anche un riflesso dei guai nei quali stava annegando.
Dovette lasciare il Quirinale con sei mesi d’anticipo e al suo posto, in luglio,
arrivò Sandro Pertini. Ma Leone aveva anche parecchi motivi oggettivi per
stappare lo chamapagne senza troppi sorrisi. Le tensioni sociali erano oltre
l’allarme rosso e le barricate dell’anno precedente a Roma, Milano e Bologna
promettevano sfracelli. Il Palazzo era fragile come mai prima, con un governo
tenuto in piedi solo dalla benevola astensione del partitone d’opposizione, il
Pci di Enrico Berlinguer. Un numero non esiguo di giovani militanti cresciuti
nel decennio rosso avevano deciso di passare “dalle armi della critica alla
critica delle armi” e parecchi altri si apprestavano a farlo arruolandosi nelle
Brigate Rosse, in Prima Linea o nella pletora di sigle minori che fiorivano
ovunque. Il polso della situazione non perse tempo nel notificarsi. Scelse
l’esecuzione di due militanti del Msi di fronte alla sezione romana Acca
Larentia, la sera del 7 gennaio. Poche ore dopo una terza vittima: circostanze
misteriose ufficialmente ma che la polizia spari sui militanti che protestano è
certo. Però a denunciare i carabinieri nonostante il veto missino, della
migliaia circa di neofascisti presenti ci va solo una ragazza: Francesca Mambro.
Per i ragazzini di estrema destra Acca Larentia è una specie di “perdita
dell’innocenza” come quella che aveva colpito i coetanei di sinistra quasi 10
anni prima in piazza Fontana. I Nar, destinati a diventare negli anni seguenti
la più temuta banda armata di destra, nascono davvero in quella tragica serata e
pochi giorni dopo cercano vendetta sbagliando bersaglio. Uccidono un poveraccio
che la strage di Acca Larentia non c’entrava niente, Roberto Scialabba. Nemmeno
due mesi dopo anche i Nar avranno la loro prima vittima, Franco Anselmi, colpito
alle spalle dopo una rapina in un’armeria dal proprietario della stessa. Il
crepitio delle pallottole, nonostante il terrorismo fornisca un prezioso terreno
comune ai partiti della solidarietà nazionale, dunque essenzialmente a Dc e Pci,
non basta a coprire gli scricchiolii dell’alleanza che permette al governo
Andreotti di esistere nonostante difetti della maggioranza parlamentare. Al Pci
la formula della “non sfiducia” non basta più. Il partito e la Cgil hanno
accettato con la svolta dell’Eur di farsi carico, a spese del salario, del
risanamento. In cambio promettono ai lavoratori aumenti dell’occupazione che
però latitano. Il sostegno al governo e alle sue politiche economiche diventano
ogni giorno meno comprensibili. Berlinguer deve portare a casa qualche risultato
e reclama l’ingresso a pieno titolo nella maggioranza, modifiche sostanziali sia
nella composizione che nelle politiche del governo. Ma convincere la Dc è
impresa quasi impossibile. Aldo Moro, presidente del partito, ci riesce ma a
prezzo carissimo: nessuna delle richieste del Pci verrà accettata. Nel governo
resteranno i ministri messi all’indice dal bottegone e nessuno dei “tecnici
d’area” indicato dai comunisti ne farà parte. Quando il nuovo governo è alla
vigilia del decollo, i malumori dei leader comunisti tengono banco e occupano
paginate sui giornali. C’è persino chi mette in dubbio il voto di fiducia, come
il battagliero Giancarlo Pajetta. E’ una classica sceneggiata. Il sì del Pci è
già certo. Dovrebbe arrivare dopo un serrato dibattito parlamentare, a partire
dalla mattina del 16 marzo. Invece per una volta la tragedia vera, quella che
costa sangue e cadaveri, incrocia la messa in scena di Montcitorio. Poco prima
dell’inizio del dibattito in aula le Br attaccano, sterminano la scorta di Moro,
rapiscono il presidente della Dc. Il Parlamento, sotto shock, vota la fiducia in
quattro e quattr’otto. Il presidente della Camera, il leader della sinistra del
Pci Pietro Ingrao, farà in modo che di fatto non torni più a riunirsi sino al
termine del lunghissimo dramma. Durò 55 giorni, costellati dalle lettere sempre
più disperate del prigioniero, dai comunicati più gelidi di quanto non fossero
in realtà gli estensori dei sequestratori, dalle richieste sempre più stridule
di fermezza da parte di un composito fronte che preferiva Moro morto a qualsiasi
gesto potesse anche solo sembrare debole, dalla fellonia degli amici dell’ex
potentissimo che non esitarono a rinnegarlo e a dichiararlo pazzo per evitare
che le sue missive fossero prese sul serio, dal dolore composto e lancinante
della famiglia, il solo elemento in quei giorni che ricordasse l’esistenza di
sentimenti e logiche diverse dal gelido interesse politico che dominava invece
tutti gli altri attori in campo. Il nove maggio il cadavere di Aldo Moro fu
fatto ritrovare dalle Br in via Caetani a Roma, una strada vicina sia alla sede
nazionale del Pci che a quella della Dc. Per le Br, anche se allora nessuno
poteva immaginarlo, quello fu l’inizio della fine. Lo fu anche per la prima
Repubblica. Il lungo ponte tra l’uccisione di Moro e tangentopoli fu in realtà
qualcosa di sostanzialmente diverso dal trentennio precedente: un triumvirato
che governava senza più progetto politico, con un Pci messo una volta per tutte
alle corde. Quanto ai “programmi” il governo sostenuto ormai attivamente dai
comunisti concesse qualcosa di importante sul fronte dei diritti civili in quel
1978, prima che la maggioranza si sfasciasse nel gennaio dell’anno seguente. In
maggio vennero approvate prima la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi,
poi la legge sull’aborto. Quelle leggi resero l’Italia un Paese certamente più
civile ma non bastarono a compensare la crisi di consensi che colpì il Pci in
seguito alle politiche economiche di fatto anti- operaie dei governo di
solidarietà nazionale. Nelle elezioni della primavera 1979 il Pci perse due
milioni di voti e non si riprese mai più dal colpo. E’ appena il caso di notare
che quell’esito era stato pianificato e previsto sia da Andreotti che dallo
stesso Moro. Entrambi lo illustrarono all’ambasciatore americano Gardner,
cercando di spiegargli perché il coinvolgimento del Pci nell’area di governo si
sarebbe rivelato devastante per il Pci stesso. Forse l’uomo che soffrì di più
per l’esito della tragedia Moro, dopo i familiari del leader Dc, fu Giovanni
Battista Montini, da 15 anni pontefice: Paolo VI. Il papa aveva raccolto,
d’accordo con Andreotti, una cifra enorme da offrire alla Br in cambio della
vita di Aldo Moro, a cui era legatissimo. Gli toccò pronunciare la frase che
sapeva essere una condanna a morte per il suo amico, «Liberatelo semplicemente,
senza condizioni». Non si riprese dal colpo e seguì il presidente della Dc nella
tomba dopo meno di tre mesi, il 6 agosto. Il successore, Albino Luciani, fu
eletto abbastanza rapidamente e a sorpresa. Prese il nome di Giovanni Paolo I,
stupì il mondo con uno stile all’epoca inusuale e dichiarando che «Dio è papà ma
più ancora è madre». Trapassò dopo appena 33 giorni di pontificato, suscitando
inevitabili sospetti su una fine così improvvisa. Il quotidiano Lotta
continua, beffardo, uscì con uno dei suoi titoli migliori: «E’ rimorto il papa».
In ottobre il conclave scelse come nuovo pontefice Karol Wojtyla, cardinale
polacco, che assunse il nome di Giovanni Paolo II. Era il primo papa non
italiano dai tempi di Adriano VI, dunque dal 1523. Ma per rintracciare una sorta
di albero genealogico di Wojtyla si sarebbe dovuto guardare a un altro papa del
XVI secolo: Giulio II, il papa guerriero. Giovanni Paolo II non era un politico
abile nei giochi di curia, non era un intellettuale raffinato come Paolo VI e
non era neppure un porporato con radici nel popolo come Giovanni XXIII. Era un
combattente, un generale che prendeva sul serio la propria missione: sconfiggere
il comunismo. Ci riuscì e nel crollo del Muro, 11 anni dopo l’ascesa al soglio
di Pietro, pesò persino più degli altri due comandanti di quella crociata:
Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Anche se sul momento nessuno poteva saperlo,
quel Muro, simbolo della Guerra fredda e della divisione del mondo in blocchi a
modo loro ordinati, avreva cominciato a sgretolarsi con la fumata bianca che nel
pomeriggio del 16 ottobre annunciò l’esito del secondo Conclave riunito nel
1978. Wojtyla non era l’unico leader religioso capace di indossare la corazza,
in quel sottovalutato 1978. In quello stesso autunno l’ayatollah Ruholla
Khomeini, massima autorità dell’Islam sciita, sfidò dal suo esilio parigino lo
scià Reza Pahlevi. Un composito fronte che vedeva i Mullah a fianco dei fedayin
del popolo comunisti e delle stesse élites liberali iraniane riempì le piazze di
Teheran e dell’intero Paese. Alla fine del 1978 la partita non era ancora finita
ma l’esito era già evidente. Pahlevi si sarebbe dimesso il 16 gennaio del ‘ 79
ma l’illusione di poter conciliare conflitto sociale, democratizzazione e
Repubblica islamica durò pochissimo. In dicembre, così come se nulla fosse,
nacque anche l’Unione europea. Non si chiamava ancora così, ma lo Sme, il
Sistema monetario europeo, ne era il consapevole presupposto, non un passo
qualsiasi ma quello decisivo. Sarebbe stato proprio lo Sme a provocare quella
rottura tra Dc e Pci per evitare la quale era stato sacrificato Aldo Moro. A
bersagliare con lucida preveggenza l’Europa della moneta fu Giorgio Napolitano,
nell’aula di Montecitorio. Peccato che quel discorso lo abbia poi dimenticato, o
le sue posizioni sulla Ue sarebbero state nel XXI secolo ben diverse.
Moro, Tortora, Craxi:
quando l’Italia andò in overdose da “Emergenza”.
Con loro si racconta una sola storia, cominciata nel 1978 e proseguita fino al
2018. Il sequel però è ignoto, scrive Fuori dal Coro Fabio Cammalleri su
"Lavocedinewyork.com" il 9 gennaio 2018. Storie parallele di Ragioni umane
contro Ragioni di Stato. Ma quale “Stato”? La “fermezza” fu oscura e velenosa
fecondazione; perché ne gemmarono “Le Emergenze Permanenti”: fu il loro
fondamento teorico. E ciascuna di queste “Emergenze”, avrebbe avuto un duplice
alimento: da un lato, un rinnegamento; dall’altro, un travisamento. “Io ci sarò
ancora come un punto irriducibile di contestazione e alternativa”. E’ la prima
parte di una famosissima frase, scritta da Aldo Moro, mentre era sequestrato
dalle Brigate Rosse. Si rivolgeva a Benigno Zaccagnini, Segretario del suo
partito, in una lettera del 24 Aprile 1978; in realtà, suo tramite, si rivolgeva
all’Italia intera. Alle generazioni passate, a quelle presenti e, soprattutto, a
quelle future. Alcune parole si stagliano sulle altre: “ancora”, che tradisce
una terribile previsione sulla sua possibile sorte; “irriducibile”, che
segue “contestazione”: a confermare, quasi da una dimensione già eterna, la
lucidità di quella cupezza; e ad incarnare, in sua difesa, una superiore
opposizione al mediocre corso delle cose: nel nome di un’autentica ragione
umana, negata da una pretesa Ragion di Stato. Ma quella frase si completava in
una seconda parte, dove previsione, opposizione e difesa trovavano uno scopo, la
loro sintesi: “per impedire che della D.C. si faccia quel che se ne fa oggi”.
Ora, proviamo a sostituire idealmente quell’autore e quell’anno: Aldo Moro,
1978; con un altro nome e un altro anno; e a immaginare uno spazio bianco, al
posto della sigla “D.C.”. Enzo Tortora, 1983, Bettino Craxi, 2000; e, dove c’è
il bianco, leggiamo “libertà”, in un caso, “Repubblica Italiana”, nell’altro. Ed
ecco il risultato: “Io ci sarò ancora come un punto irriducibile di
contestazione e alternativa, per impedire che della libertà (1) / della
Repubblica italiana (2), si faccia quel che se ne fa oggi”. Cosa avrebbero in
comune queste frasi parallele? Intanto, si può subito notare che le due
interpolazioni, “della libertà”, per Tortora, “della Repubblica Italiana”, per
Craxi, in realtà, si possono leggere come se fossero una: “della libertà della
Repubblica Italiana”: con la libertà di uno che è tale, solo se è libertà di
tutti, e viceversa. Le frasi parallele, in primo luogo, hanno in comune di
essere intessute alla morte. Due sono gli anni di morte, si potrebbe osservare:
quello di Moro, e quello di Craxi; ma Tortora? Il 1983 fu l’anno del suo
arresto, non della sua morte; “mi è scoppiata dentro una bomba al cobalto”,
così, nella prima lettera dal carcere di Regina Coeli, il 17 giugno 1983.
Perciò, poiché le bombe uccidono, anche per Tortora, quello fu un anno di morte.
E la visione della morte, sappiamo, può elevare a visioni vastissime,
profondissime. Poi, questi tre uomini, ebbero in comune la coartazione:
ingiusta, impietosa, meticolosa; non una coartazione qualsiasi; ma una ricreata
da una perturbazione ideologica. Prima delle BR, era stata seminata e sparsa,
dai meno giovani, sul capo dei più giovani, quella perturbazione; dopo, da
questi, a loro volta cresciuti, fu posta in attesa di riscuotere il frutto di
promesse catastrofiche, di livide speranze. Occorreva però uno strumento adatto
alla meta, e schiere organizzate: pretoriani che sapessero maneggiarlo. Prima
e dopo di Moro, “Il processo alla DC” è stato un miraggio diffuso, sapientemente
coltivato. Da ceti manovrieri: forti di penna e di rango e, per lunga e
risalente tradizione, democraticamente irresponsabili. Si badi: “Il Processo”,
non la critica, non l’opposizione; perchè l’unica opposizione era il Processo;
ogni altra, solo complicità. Moro aveva capito: e sui rapporti fra magistratura
e parlamentari e, in genere, la “politica”, aveva le idee piuttosto chiare. Un
anno prima di essere altrimenti “processato”, il 10 marzo del 1977, si presentò
in Parlamento: dove si discuteva di presunte tangenti in seno al c.d.
scandalo Lockeed, e della messa in stato d’accusa di due ex Ministri della
Difesa, il democristiano Luigi Gui ed il socialdemocratico Mario Tanassi.
Disse: “…noi vi diciamo che non ci faremo processare nelle piazze”. Ma fu una
difesa impotente. La semina era stata capillare: e il raccolto stava crescendo.
Quella parola, così, “Processo”, non più però mosso ad un solo Soggetto, ma,
escogitato come un Assoluto Politico, divenne lo strumento con cui la
perturbazione ideologica assunse la “Coartazione” come la “Categoria Nuova”
della vita comunitaria in Italia: gradatamente, “progressivamente”, ma
ineluttabilmente. Resa il punto di confluenza dei benpensanti e delle plebi,
affratellati dall’invidia, dalla frustrazione, dallo stordimento inebriante di
una furia iconoclasta. Le squadracce delatorie (strumento dello strumento),
pertanto, poterono celebrare il loro emblematico battesimo: su un uomo “famoso”,
“liberale”, “antipatico”, quanto “inerme”, e in verità anche gentile; poi, così
rodate, dilagarono sui “Grandi Colpevoli” (non tre, quattro, cinque, contro
cinquecento, come avrebbero fatto, poco dopo, al Pool di Palermo: ma decine e
decine contro uno, come avvenne prima e sarebbe avvenuto dopo; questa
sproporzione le rende “squadracce delatorie”, e non “fonti di prova
dichiarative”). Ragioni umane, contro Ragioni di Stato. Ma quale “Stato”? La
“fermezza” fu oscura e velenosa fecondazione; perchè ne gemmarono “Le Emergenze
Permanenti”: fu il loro fondamento teorico. E ciascuna di queste “Emergenze”,
avrebbe avuto un duplice alimento: da un lato, un rinnegamento; dall’altro, un
travisamento. Dal rinnegamento, metodologico e finalistico, dell’Antimafia di
Falcone e Borsellino, sorse “l’Antimafia di mestiere”. Dal travisamento di un
equilibrato redde rationem sul finanziamento irregolare dei partiti, sorse “il
manipulitismo”: cioè, l’Anticorruzione carrieristica, liquidatoria: nata a
conteggiare colpe altrui fra nascoste scatole di scarpe, finita a conteggiare
appartamenti fra microfoni per una volta accesi. Quindici anni dopo, Craxi,
sulla scia di quel Moro già impotente, e in un contesto “maturo” per un più
sistematico “cambio di passo”, avrebbe parlato di “processi sommari”. A Craxi
liquidato, fu emanato, fine del 1995, l’Editto Borrelliano, tuttora moralmente
vigente: “Se si creano situazioni di emergenza nelle quali diviene
indispensabile comprimere i diritti individuali, per ripristinare l’ordinamento
giuridico, allora, nell’interesse comune, sono favorevole alle restrizioni di
diritti individuali”. Fra Moro e Craxi, Tortora potè affermare: “Sto pensando di
chiedere il cambio di cittadinanza, questo Paese non è più il mio”. Rimase, e
ne morì. Ma, anche grazie a lui, l’Idea della libertà, vive. Ma per quanto?
Accuse sui contatti con la
mafia, Le Monde si scusa con Berlusconi.
Rettifica a due articoli degli scorsi anni anche su Fininvest, scrive il 10
gennaio 2018 "Il Corriere della Sera". Il quotidiano parigino Le Monde ha
pubblicato una rettifica in merito a quanto aveva scritto su Silvio Berlusconi e
sulla Fininvest in relazione a presunti contatti con la criminalità organizzata.
La rettifica si riferisce a due articoli, del 4 agosto 2015 e del 10 luglio
2017, rispettivamente intitolati «Quando Berlusconi viene a patti con la Piovra»
e «Quando Berlusconi trattava con Cosa nostra». Lo rende noto la Fininvest nel
prendere atto della rettifica che martedì è comparsa non soltanto sull’edizione
cartacea del quotidiano ma anche sul sito lemonde.fr. «Nella precisazione - si
legge nella nota - si riconosce che in Italia sono stati avviati diversi
procedimenti penali per verificare se Berlusconi e il suo gruppo Fininvest
avessero utilizzato capitali di provenienza mafiosa, ma dopo approfondite
indagini, finalizzate soprattutto ad analizzare le dichiarazioni dei pentiti e i
flussi finanziari di Fininvest, questi procedimenti hanno portato a
provvedimenti di non luogo a procedere o di assoluzione. In queste sentenze
definitive, riconosce Le Monde nella rettifica, non c’è alcuna prova che
Fininvest e Silvio Berlusconi abbiano potuto beneficiare di somme di origine
mafiosa, o che si siano dedicati a riciclare tali somme». «Passo dopo passo i
vecchi detrattori del presidente Silvio Berlusconi fanno marcia indietro, con
tanto di pubbliche scuse, e la verità viene lentamente ripristinata dopo anni di
insulti, di assurde accuse e di fantasiose ricostruzioni che di giornalistico
avevano, a dire il vero, ben poco. Dopo l’Economist tocca a Le Monde cospargersi
il capo di cenere e rettificare due articoli scritti nel 2015 e nel 2017 nei
quali il nome del nostro leader veniva infangato e accostato a organizzazioni
criminali del nostro Paese». Così Renato Brunetta, presidente dei deputati di
Forza Italia.
Le Monde: infondate le
nostre accuse a Berlusconi.
Il quotidiano francese ammette: sentenze definitive dimostrano che Fininvest e
Berlusconi non hanno beneficiato di soldi di origine mafiosa, scrive il 9
gennaio 2018 Panorama. Non c’è soltanto la brusca retromarcia di Bill Emmott,
l’ex direttore del settimanale Economist che nel 2001 fu autore di una famosa
copertina intitolata "Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy" (Perché
Berlusconi è inadatto a governare l’Italia), e venerdì scorso, al contrario, ha
scritto un articolo per dichiarare al mondo che il Cavaliere è "uno statista"
nonché il solo possibile "salvatore d'Italia" contro il populismo dilagante.
Adesso anche Le Monde ha deciso di regalare un notevole assist al fondatore di
Forza Italia. Perché proprio oggi si conclude con una clamorosa ammissione
d’errore una dura campagna giornalistica condotta dal quotidiano francese nei
confronti di Berlusconi e della Fininvest. In particolare, il 4 agosto 2015 e il
10 luglio 2017, Le Monde aveva pubblicato due articoli intitolati,
rispettivamente, "Quando Berlusconi scende a patti con la Piovra" e "Quando
Berlusconi patteggiava con Cosa nostra". Entrambi gli articoli erano firmati dal
giornalista Daniel Psenny—il reporter che da due anni viene celebrato in Francia
come un eroe per essere stato ferito durante l’attacco terroristico al teatro
Bataclan—e presentavano ai lettori di Le Monde un documentario trasmesso su
France 3, dedicato al tema "Berlusconi e la mafia, scandali all’italiana". Nel
primo articolo, Psenny scriveva che "numerosi testimoni, magistrati, pentiti di
mafia e collaboratori di Berlusconi raccontano come e perché l’ascesa
dell’imprenditore non avrebbe potuto realizzarsi senza l’appoggio di Cosa
nostra"; il giornalista aggiungeva che "i suoi legami con la mafia siciliana
sono stati stabiliti con certezza dai numerosi giudici incaricati di indagare
sui suoi affari". Nel secondo articolo, Le Monde confermava l’infamante accusa:
scriveva che "i soldi sporchi aleggiano su tutto il percorso di Berlusconi" e
che "le inchieste giudiziarie hanno mostrato che gli enormi investimenti nel
complesso immobiliare Milano 2, realizzato alla fine degli anni Settanta nella
periferia milanese, sono stati realizzati grazie al denaro nero della mafia". In
realtà, se pure Berlusconi nella sua Odissea giudiziaria è stato più volte
indagato per accuse di quel tipo, innescate dalle controverse dichiarazioni di
pentiti di mafia poco credibili, è falso che sia mai stato condannato. Al
contrario, il Cavaliere è stato sempre pienamente assolto, se non prosciolto già
in istruttoria. Oggi, in una rettifica pubblicata sia sulla versione cartacea
sia sul suo sito internet (lemonde.fr), Le Monde riconosce l’errore e ammette
che le sue accuse erano del tutto infondate: "In Italia" scrive il quotidiano,
"sono stati effettivamente avviati diversi procedimenti penali per verificare se
Berlusconi e il suo gruppo Fininvest avessero utilizzato dei capitali di
provenienza mafiosa. Ma dopo approfondite indagini, finalizzate soprattutto ad
analizzare le dichiarazioni dei pentiti e i flussi finanziari di Fininvest,
questi procedimenti si sono chiusi con provvedimenti di non luogo a procedere o
di assoluzione". "In queste sentenze definitive", conclude il testo pubblicato
oggi da Le Monde, si riconosce che "non c’è alcuna prova che Fininvest e Silvio
Berlusconi abbiano potuto beneficiare di somme di origine mafiosa, o che si
siano dedicati a riciclare tali somme". Insomma, considerando il dietro-front di
Emmott, in pochi giorni il Cavaliere ottiene un clamoroso 2 a 0. Il risultato è
un vero tonico per la campagna elettorale del leader di Forza Italia: tanto più
che la seconda vittoria arriva da un quotidiano–simbolo della sinistra europea.
Roma: successo per la prima
nazionale del docufilm “Generale Mori. Un’Italia a testa alta”,
scrive Sonja Tambaro l'8 gennaio 2018 su "Agorà24". “Generale Mori. Un’Italia a
testa alta” non è solo un docufilm che narra la storia degli ultimi 50 anni del
nostro Paese raccontata dallo stesso Mario Mori. E’ la trilogia del
regista Ambrogio Crespi che nella scelta dei suoi tre documentari sulla
giustizia ha saputo captare storie incredibili, partendo da quella di Enzo
Tortora per poi approdare al Festival di Venezia con la vita degli ergastolani
ostativi in “Spes Contra Spem liberi dentro” lanciando un forte e chiaro
messaggio contro la mafia. Prima di approdare allo schermo, visto l’appuntamento
fissato per il prossimo 16 Marzo su Rete4, lo scorso 21 Dicembre 2017 a Roma al
Capranichetta è stata presentata la sua ultima opera prodotta da Index
Production. A moderare la prima nazionale il direttore de Il Tempo Gian Marco
Chiocci che ha condotto una lunga intervista al Generale. Una sala gremita di
autorità dell’Arma dei Carabinieri, di magistrati e giudici, esponenti della
politica e del Governo come Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia e
cittadini che hanno voluto assistere alla proiezione del film con la presenza
del Generale, del regista e del Colonnello Giuseppe De Donno, uomo di fiducia di
Mori e autore insieme a Crespi della pellicola. Tanti i momenti storici
ripercorsi. Dalle Brigate Rosse alla mafia di Riina, da Falcone e Borsellino al
Generale Dalla Chiesa, passando per il Ros e i servizi segreti. 70 minuti che
scorrono rapidamente senza mai abbassare la suspence della storia. Luci e giochi
di telecamere, immagini storiche che si sovrappongono a quelle girate dal
regista. Prima e dopo che scatenano sentimenti ed emozioni. Un Mori senza veli,
che al termine del film risponde a tutte le domande che Chiocci gli pone. Il
Generale Mori, nonostante le vicende giudiziarie che ancora lo vedono coinvolto,
ricorda la buona magistratura. Uomini al servizio della giustizia che svolgono
egregiamente il loro lavoro, partendo dal procuratore di Nola Paolo Mancuso e
dal pubblico Ministero del tribunale di Roma Giancarlo Capaldo protagonisti del
film, ma anche il Procuratore aggiunto del Tribunale di Milano Ilda Boccassini,
definita dallo stesso Mario Mori “un’eccellenza della magistratura italiana”, il
sostituto procuratore di Milano Sergio Spadaro ed altri. D’altronde un uomo come
lui che ha combattuto la vera mafia ed il terrorismo non può che essere stimato
ed apprezzato dalla buona giustizia. Ma come dice il direttore Gian Marco
Chiocci, se Mori fosse stato ammazzato dalla mafia oggi sarebbe stato un eroe.
Il film che ridà l’onore
al generale Mori.
Sarà proiettato oggi a Roma il documentario sulla sua carriera. Una vita a
combattere boss e terroristi, ripagato dallo Stato con il fango, scrive Luca
Rocca il 22 Dicembre 2017 su "Il Tempo". Mentre al processo sulla fantomatica
"trattativa" Stato-mafia va in scena una requisitoria che descrive come
l’artefice di tutti i mali, ieri alle 16, alla Sala Capranichetta dell’Hotel
Nazionale (Piazza di Monte Citorio 131), c'è stata la proiezione della prima
nazionale del docufilm di Ambrogio Crespi «Generale Mori. Un’Italia a testa
alta», prodotto da Index Production e scritto dal colonnello Giuseppe De Donno,
a lungo collaboratore di Mori, che si è avvalso della collaborazione di
Giovanni Negri, presidente de "La Marianna" e già segretario del Partito
Radicale. Un appuntamento organizzato in collaborazione con Il Tempo e che ha
visto la partecipazione di centinaia di persone, fra cui lo stesso Mori, il
regista Crespi, il colonnello De Donno e il nostro direttore Gian Marco Chiocci.
Si tratta di un docufilm di ottima fattura, che ripercorre la carriera di Mori,
i suoi successi e i suoi momenti bui, superati anche grazie a una rara tenacia.
Dalla morte del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa (che ammirava Mori) al
sequestro e l’uccisione di Aldo Moro; dalla strage di Capaci a quella di via
D’Amelio, fino alla cattura di Totò Riina e alla lotta contro il terrorismo
(anche se Mori, lo si potrà vedere nel docufilm, parla sempre del rispetto,
ricambiato, dovuto ai terroristi), la camorra e la ’ndrangheta. Una proiezione,
dunque, che smentisce seccamente quanto sostenuto da alcuni magistrati sul conto
di Mori (ci sono anche gli elogi all’ex Generale da parte dei procuratori con
cui ha lavorato). Perché Mori, che i suoi uomini chiamavano "Comandante Unico",
non è "l’uomo nero" che ha protetto Riina e Bernardo Provenzano, non è
l’ufficiale che ha "trattato" con la mafia, non è il militare che ha
"indirizzato" gli obiettivi dei corleonesi, come si va sostenendo in questo
giorni nell’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo. Invece di premiarlo, Mori, di
elogiarlo, di imparare da lui, lo hanno massacrato. Lo hanno portato sul banco
degli imputa- ti come colui che, in nome della fantomatica "trattativa", avrebbe
consentito ai sodali di Riina di svuotare il covo del capomafia dopo il suo
arresto avvenuto il 15 gennaio 1993; eppure lo hanno assolto (la procura di
Palermo non presentò nemmeno ricorso); lo hanno processato, di nuovo, come
l’uomo che, sempre in nome della mai provata "trattativa", avrebbe protetto la
latitanza di Provenzano, rimanendo inerte di fronte alla possibilità concreta di
catturarlo; e anche in questo caso lo hanno assolto in primo grado, appello e
Cassazione; lo stanno processando ancora, dopo tutte le assoluzioni, come
l’autore materiale del presunto patto fra Co- sa nostra e pezzi delle
Istituzioni, arrivando a dire (lo ha fatto il pm Di Matteo qualche giorno fa)
che Mori avrebbe persino "confessato" di aver portato avanti una "trattativa"
con don Vito Ciancimino. Eppure, sono state le stesse sentenze ad escluderlo,
dando a quella parola, "trattativa", utilizzata da Mori di fronte ai giudici, un
senso che nulla ha a che fare con quello inteso dai pm palermitani. Lo scopo di
Mori, nessuno ormai lo può più negare, se non qualche pm palermitano, era quello
di sempre: fare di tutto per consegnare alla giustizia i boss di Cosa nostra,
anche attraverso i suoi contatti con Vito Ciancimino. E invece no! All’uomo del
docu-film, l’uomo che ha lavorato con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
l’uomo che ha assestato colpi fatali alla mafia e che ha dato la caccia ai
terroristi, gli hanno voluto appioppare, ad ogni costo, l’etichetta di
"trattativista"; come se fosse un traditore di Stato e non uno degli "eroi" che
allo Stato ha dedicato quasi tutta la sua vita. Qualche giorno fa Il Tempo ha
chiesto a De Donno chi fosse Mori, e la risposta non poteva che essere questa:
«Mori è una persona a cui questo paese deve tanto. Degli anni trascorsi con lui
ho un ricordo bellissimo, perché sono stati anni in cui abbiamo lavorato con
persone straordinarie come Falcone e Borsellino. Mori è il comandante che tutti
vorrebbero avere, per la sua umanità e perché, essendo stato anche lui un
operativo, sa che significa lavorare senza poter contare sull’appoggio dei
superiori». La verità, dicono, è destinata al trionfo, e finora, nei vari
tribunali dove Mori si è difeso, è andata così. Di certo c’è che il docufilm
proiettato ieri ci racconta, anche attraverso le sue parole, stimolate dalle
domande di Giovanni Negri, l’unico Mori esistente, quello a cui non piace essere
definito "eroe" ma che facciamo fatica a non definire tale.
MARIO MORI E IL DOCUFILM
CHE SI FA BEFFE DELL’INCHIESTA SULLA TRATTATIVA,
scrive Rocco Schiavone il 29 dicembre 2017 su “L’Opinione". Ci sono inchieste
che non entrano nell’immaginario collettivo se non di chi ha tentato di farci
una carriera politica sopra. Quella sulla fantomatica trattativa tra Stato e
mafia è sicuramente una di esse. Per questo è arrivato come il cacio sui
maccheroni un docufilm di Ambrogio Crespi per la “Index production” sulla figura
del generale per anni a capo del Ros dei carabinieri, Mario Mori. L’uomo che ha
catturato Totò Riina e che prima ancora aveva collaborato nella lotta al
terrorismo con il compianto generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Generale Mori
- Un’Italia a testa alta” (prodotto anche da Giovanni Negri, che intervista Mori
nel docufilm, e da “Il Tempo” diretto da Gianmarco Chiocci) è la classica
testimonianza sottovoce di un eroe dello stato massacrato da calunnie a carriera
finita. Destino condiviso, peraltro, con il colonnello Giuseppe De Donno. Altro
“io narrante” del docufilm insieme allo stesso Mori. De Donno in effetti fu per
anni a fianco di Mori, compreso il momento della cattura di Riina poi effettuata
materialmente da Sergio De Caprio. Al secolo il capitano Ultimo, altro
perseguitato della allegra comitiva dell’eroico Ros dei primi tempi. Il
documentario di Crespi contiene anche una chicca. De Donno racconta infatti un
particolare quasi smarrito nella pubblicistica conformista dei professionisti
editoriali che fan parte del partito di coloro che vogliono credere per dogma in
questa ‘trattativa’: “Riina quando fu arrestato aveva con se tutti i documenti e
i pizzini in una busta e noi li sequestrammo e in seguito portarono a molti
arresti”. Qualcuno però si ostina a scrivere che nella casa di via Bernini a
Palermo ci fosse stata una cassaforte e altri documenti trafugati. Ma c’è
un’altra “rivelazione” che De Donno fa nel film: quella di via Bernini a Palermo
era la casa in cui erano ospitati temporaneamente i familiari di Riina, non il
suo covo. E lui fu preso lì, con la cooperazione attiva del pentito Balduccio Di
Maggio nel servizio di appostamento, solo perché si era recato in visita. Mentre
il covo da cui sarebbero spariti chissà quali carte ancora deve essere
semplicemente individuato. Tutta una storia da riscrivere, dunque, che il
docufilm affronta senza intenti polemici. Facendo parlare i protagonisti
dell’epoca e non i quaquaraquà odierni. Altra storia su cui si sofferma il
racconto di Mori è il famoso rapporto del Ros dei carabinieri su “mafia e
appalti”: la Procura di Palermo non gli diede mai troppo peso, né ai tempi di
Giovanni Falcone né dopo la sua uccisione. Invece il magistrato eroe dietro cui
si nascondono oggi tutti i carrieristi editoriali e in toga lo riteneva centrale
e così pure il suo amico Paolo Borsellino. La morale da trarre? Mori, come prima
di lui il suo maestro Carlo Alberto Dalla Chiesa, avevano capito sin troppo bene
come si potesse battere la mafia. Che in effetti, almeno nel versante Cosa
Nostra, fu battuta. Ironia della sorte il colpo di grazia ai boss ci fu proprio
sotto il Governo Berlusconi due. Quanto a Dalla Chiesa e Mori, avendo capito
troppo furono eliminati: il primo con il piombo, il secondo con la calunnia.
Scrive il
21.02.2017 Gianfranco La Grassa su “Conflitti e strategie". La morte di Pasquale
Squitieri (cui rivolgo ancora un ricordo reverente) mi ha smosso pure un altro
ricordo: una sua intervista a Malcolm Pagani (per il “Fatto quotidiano”, 17
settembre 2016, da me citata pochi giorni dopo in “Conflitti e strategie”), di
cui riporto un pezzo, che m’ha intrigato perché confermava quello che sto
dicendo da anni (direi da sempre in merito ad un certo evento): A dire la verità
odio, rancore e povertà c’erano anche ieri. E lo dice a me? All’epoca in cui
rapirono Aldo Moro, l’odio era nelle strade. Mario Cecchi Gori incaricò me e
Nanni Balestrini di lavorare sul caso e nella ricerca della verità, io e Nanni
ci spingemmo molto in là. Ero amico di Giovanni Leone, il Presidente della
Repubblica. Il 10 maggio del ’78, il giorno dopo il ritrovamento di Moro nella
R4 in Via Caetani, Leone mi convocò al Quirinale. Era stravolto: “Avevo firmato
la grazia per alcuni brigatisti in cambio della libertà di Moro. Me l’hanno
strappato di mano due persone. I nomi non te li dico. Fai il cinematografo, hai
i figli, non voglio farti rischiare”. Raccontò questa vicenda già in Registi
d’Italia di Barbara Palombelli. Ha mai saputo chi fossero le due persone in
questione? "Uno era Benigno Zaccagnini e l’altra Enrico Berlinguer. Fermarono la
Grazia concessa da Leone. Come mi disse il Presidente: “non sono persone
pericolose, ma pericolosissime”. Immaginare due fautori del compromesso storico
nel ruolo di aguzzini suona improbabile. "La pensi come vuole, l’ho sentito con
le mie orecchie. Moro vivo non lo voleva nessuno. Erano tutti d’accordo. Gli
americani decidevano, i politici di casa nostra eseguivano. i brigatisti fecero
il lavoro sporco. L’organizzazione era infiltrata a ogni livello ed eterodiretta
dai servizi segreti di mezza Europa. Leone fu reticente. Voleva proteggermi:
“Maestro-gli dissi, le sembra che ne abbia bisogno?”. Allora mi rivelò disse i
nomi dei due che gli strapparono la Grazia dalle mani: “Zaccagnini e
Berlinguer”. Attendo smentite. Non arriveranno. La Democrazia Cristiana ha
sempre ucciso i proprio figli. Come Crono, se li è mangiati uno dopo l’altro".
Da anni (ma tanti, tanti)
ripeto che Moro fu magari ucciso materialmente dalle BR, ma se ciò accadde esse
di fatto agirono come semplice “mano d’opera”. Dietro c’erano certi ambienti
americani, da me definiti “di riserva” perché di fatto, mentre quelli
“ufficiali” seguono una data linea politica, questi preparano eventuali
cambiamenti se diventano necessari. Facciamo un esempio: tra il 1967 e il 1974
gli Stati Uniti appoggiarono apertamente i Colonnelli in Grecia. Tuttavia, i
suddetti ambienti “di riserva”, come minimo a partire dal ’70-’71, tennero
rapporti con chi avrebbe poi sostituito quel regime (che non dava sufficienti
garanzie di stabilità), cioè Karamanlis (di “destra”), ma anche con la
“sinistra” rappresentata dal PC dell’interno (eurocomunista e ormai lontano
dall’URSS). Il partito leader degli eurocomunisti era il PCI (ormai in mano alla
frazione berlingueriana, anche se il loro leader diventerà Segretario nel 1972,
ma già da vicesegretario nel ’69 aveva il controllo dell’apparato, con
l’appoggio della frazione “ingraiana” e perfino la simpatia dei “manifestaioli”,
buttati fuori in quell’anno o nel ‘70). Sempre dal ’69 o ‘70, il PCI aveva
iniziato discreti contatti con gli Stati Uniti, detto meglio con i suddetti
“ambienti di riserva”. Nel settembre del ’73 ci fu l’incidente di Berlinguer a
Sofia, che era con tutta probabilità un attentato. Mi permetto di sostenere che
non si intendeva uccidere il Segretario piciista italiano; si voleva solo
avvertirlo che le sue mene con gli USA erano note e che non si spingesse troppo
oltre. La maggioranza del PCI non se ne diede per intesa e continuò nei suoi
intrighi con gli americani; è ciò che non capisce il giornalista intervistatore
di Squitieri. Leggete la sciocchezza che dice: è difficile pensare come aguzzini
due fra i principali promotori del “compromesso storico”. Invece, proprio quel
compromesso non era affatto un evento di esclusivo interesse nazionale; era una
“carta d’imbarco” dei sedicenti comunisti italiani per i rapporti con
l’oltreatlantico, processo in cui bisognava procedere con i piedi di piombo. Nel
PCI, infatti, esistevano ancora importanti porzioni filosovietiche. Il
“compromesso storico” non doveva perciò far entrare il partito nel governo; solo
qualche passo per iniziare il “giusto rodaggio”. Perché bisognava che non si
avvicinasse troppo alla conoscenza di quel po’ che il nostro governo DC-PSI
sapeva della NATO e di ciò che questa faceva. Il “rodaggio” del PCI
berlingueriano si ebbe ad es. con i fatti del Cile nel settembre 1973.
Berlinguer scrisse tre articoli su “Rinascita”, in cui sostenne che i comunisti
dovevano pur sempre tenere conto che l’Italia faceva parte del “sistema
atlantico” ed era quindi essenziale non preoccupare i “padroni” di quel sistema
(non si espresse così, ma il senso era questo). Allende sarebbe stato troppo
imprudente; si tenga conto che fu invece molto incerto e “timido” (anche in tema
di semplice riforma agraria), sollevando l’opposizione netta della sinistra
“radicale” (il MIR). Nel giugno del 1976, in un’intervista a Pansa sul
“Corriere”, Berlinguer compie un altro passo di quel “rodaggio”, dichiarando che
era necessario accettare l’ombrello della NATO. Si accettava cioè quella
“protezione” che era rivolta, in modo aggressivo, contro l’URSS.
Successivamente, i piciisti (figlietti di Berlinguer) sostennero che, in base a
documenti trovati in archivi sovietici, quella dichiarazione era conosciuta e
anche approvata in URSS. Il che potrebbe corrispondere, ma solo in parte, a
verità; nel senso che va riscritta pure la storia di quel paese durante il
periodo della “cristallizzazione” brezneviana. E’ indubbio che quest’ultima fu
dovuta alla presenza – pur dopo la defenestrazione di Krusciov (1964) in seguito
alla mal condotta azione dei missili a Cuba (ottobre ’62) con l’iniziale accordo
di Kennedy, poi saltato per intervento di dati settori USA – di due linee in
contrasto, da cui poi infine emerse la vincitrice (1985) che mise alla
segreteria Gorbaciov e condusse l’Unione Sovietica (con il “campo socialista”)
allo sfacelo (1989 “crollo del muro” e agosto ’91 fine dell’URSS). Tornando in
Italia negli anni ’70, il “compromesso storico” trovò ampie garanzie nella
“sinistra” diccì (di cui era personaggio decisivo proprio Zaccagnini e poi De
Mita, Andreatta, ecc.). Andreotti volle fare come al solito il “troppo furbo” e
si mise “in mezzo”, cercando di garantire che il “compromesso” si facesse, ma
senza procurare troppi danni alla DC; perché vi erano già brutti sospetti circa
le reali intenzioni degli americani in merito a quella parte di PCI che si stava
spostando verso di loro. Nessuno poteva predire – e all’epoca nemmeno lo
pensavano gli “ambienti di riserva” USA – quello che sarebbe accaduto con
l’avvento di Gorbaciov e la dissoluzione del “socialismo”. Tuttavia, la DC era
divisa. Fanfani non era d’accordo circa i rapporti tra PCI e ambienti USA; in
questo appoggiato dall’esterno dal socialista Craxi, che si rese almeno in buona
parte conto del pericolo incombente anche per il suo partito. Moro era
decisamente contrario, ma non lo disse apertamente (anzi piuttosto finse il
contrario, in sede “pubblica”), sapendo che i contatti del PCI non erano con
nuclei dirigenti americani di poco conto. Egli fu, inoltre, messo in difficoltà
dall’andamento delle vicende cilene, che comportarono la sua sostanziale rottura
con Eduardo Frei. Questi fu presidente del Cile prima di Allende, con ottimi
rapporti appunto con Moro, da cui nacquero iniziative in comune, fra cui una non
irrilevante “agenzia stampa”, che ebbe piuttosto fortuna in seguito come tale;
ma che all’inizio forse non era una semplice agenzia stampa. Frei a quel tempo
non era troppo legato agli Usa, anzi si permetteva “aneliti” di autonomia. Dai
rapporti amichevoli tra lui e Moro nacquero buone occasioni di fruttuosi affari
per l’imprenditoria italiana. E non vi era solo la questione economica, ma anche
quella politica, una certa qual influenza di settori italiani in Sud America
(dove di nostri emigrati italiani, di varie successive generazioni, ce ne sono
molti). Non credo che gli Usa fossero del tutto contenti di simili rapporti,
anche se certo non erano molto preoccupati di un minimo di penetrazione italiana
nel loro “giardino di casa”. Con la vittoria di Allende nel 1970, Frei ebbe un
forte “ripensamento”, si avvicinò in modo deciso agli ambienti americani; e
proprio a quelli che andarono organizzando il successivo colpo di Stato di
Pinochet. Fu un avvertimento per Moro; bisognava riconsiderare molte cose e non
irritare troppo quegli ambienti statunitensi, che erano in definitiva in sella
nel loro paese e premevano, in Italia, per il “compromesso storico”, un evento
in grado di favorire l’ulteriore allontanamento dell’eurocomunismo dall’URSS,
con qualche indebolimento dei settori dirigenziali sovietici che si opponevano
all’ascesa di quelli poi emersi con Gorbaciov. Gli articoli di Berlinguer sul
colpo di Stato in Cile pubblicati in “Rinascita” e soprattutto, dopo qualche
anno (1976), l’intervista in cui accettava esplicitamente la funzione della
NATO, non potevano non allarmare Moro. Non che potesse immaginare quel che
accadde a 15 anni dalla sua morte; tuttavia, intuì che vi erano pericoli di una
diminuzione dell’importanza attribuita dagli Stati Uniti alla DC. Immagino che
anche l’altro “grande” di tale partito, Andreotti, se ne rese conto; tuttavia,
credé di potersi comportare come al suo solito, con i suoi maneggi compromissori
e “tutto facenti”; questa volta si trattava però di un “ossetto” duro da
rosicchiare. Bene, si arriva così al 1978 e al finalmente realizzato passo
decisivo per gli accordi tra PCI – sempre la parte che sappiamo, ormai
nettamente maggioritaria anche per la mania dei suoi avversari di manovrare
sotto sotto, senza mai appellarsi “alla base” chiarendo bene i motivi del
dissenso e il cambio di campo che si approssimava – e gli ambienti statunitensi.
Un importante dirigente piciista è invitato e si prepara al ben noto viaggio
“culturale” negli USA. Moro è viepiù preoccupato ma, mi sbaglierò, tiene stretti
alcuni documenti che possono intralciare le manovre in atto. Intendiamoci: non
perché vi sia una qualsiasi minaccia di divulgarli (non lo si fa mai, in genere
documenti di quel tipo sono dannosi anche per il prestigio di chi li possiede e
che ha anche lui magari compiuto manovre sotterranee da non rivelare), ma
servono pur sempre da deterrente perché possono comportare ricatti vari,
minaccia di rivelarli ai nemici che ogni dirigente di partito ha perfino nello
stesso suo gruppo d’appartenenza o in quelli di opposizione a quest’ultimo, ecc.
Se simili documenti ci sono stati, non furono depositati né nella propria casa
né al Ministero; meglio portarseli dietro, non separarsene. Solo che non era
previsto l’attentato in via Fani e il rapimento, avvenuto pochi giorni prima che
iniziasse quel bel viaggio “culturale” del piciista importante e per importanti
contatti negli Usa (direi quelli decisivi). Della borsa, dove comunque dei
documenti vi erano, non si è saputo gran che. Le “valorose” BR non mi sembra
abbiano mai detto con chiarezza cosa vi fosse. Alcuni documenti furono ritrovati
in seguito, se ben ricordo, ma non certo quelli veramente rilevanti. Nemmeno
esisteranno più ormai. E comunque, non ha poi grande rilevanza sapere cosa vi
fosse o meno. Resta il fatto che durante la prigionia di Moro, si mossero per
salvarlo Fanfani e Craxi; PCI e sinistra DC erano per non trattare con i
“delinquenti”, perché ciò avrebbe indebolito la fiducia dei cittadini nello
Stato. Un esponente dei diccì di sinistra fece una seduta spiritica, in cui un
“fantasma” rivelò un nome “fatale”: Gradoli. Questo poteva essere magari un
segnale alle BR che dovevano sbrigarsi a liberarsi di Moro per evitare “grane”.
Ma chi voleva invece salvarlo riuscì a dirottare le ricerche sul borgo antico
con quel nome. Per inciso, dico di essere convintissimo che si sapeva bene dove
si trovava Moro, ma qualsiasi tentativo improprio e affrettato di liberarlo
l’avrebbe invece perduto, accelerando l’esecuzione. Insomma, la solita pantomima
disgustosa dei “poteri costituiti”, in specie quando questi sono dipendenti e
servi di un paese straniero (gli USA). E gli “ambienti” prevalenti in tale paese
avevano deciso per gli accordi segreti con un partito che avrebbe avuto in
seguito la sua rilevanza. Il “compromesso storico” era stato ormai realizzato;
chi faceva finta d’essere d’accordo su tutto, ma aveva potere sufficiente (e
informazioni) per frapporre intralci vari, era certo fastidioso. Tuttavia, debbo
dire che non mi sembra egualmente fossero riunite tutte le condizioni per volere
la soppressione violenta di Moro. Non credo avesse modo di infastidire troppo
gli “ambienti” USA. Ci deve essere stato qualcosa d’altro – e forse di più
intrinseco agli intrighi svolti specificamente in ambito italiano – che resta un
punto interrogativo. Forse vi era modo, se Moro fosse uscito vivo
dall’accadimento, di creare scompiglio nel PCI e mettere i bastoni fra le ruote
di chi lo aveva ormai in mano e conduceva il gioco del progressivo
riconoscimento (e “riconoscenza”) da parte americana. Concludiamo in ogni caso
con una notazione molto evidente, ma solo per chi sa fare 2+2=4 (è facile no? Ma
il popolo spesso non lo sa fare). Quindici anni dopo il “delitto Moro”, crollati
il “socialismo reale” e l’URSS, venuto allo scoperto il falso (da ormai
vent’anni e oltre) PCI, che aveva anche mutato il suo nome per essere ancora più
esplicito nel suo cambio di campo a favore degli USA, si ha la liquidazione
giudiziaria – favorita e spinta anche da oltre atlantico (con un magistrato, di
cui si è anche un po’ discusso il come era entrato in Magistratura, che sembrava
avere addentellati e “conoscenze” nei Servizi di quel paese) – della prima
Repubblica. E, guarda caso, chi viene salvato dalla “bufera”? Il “fu PCI” (ormai
totalmente in mano ai “figliastri” berlingueriani) e la sinistra DC. La povera
Tiziana Parenti (magistrato addetto alle indagini sugli “affari” del PCI) viene
impedita a compiere il suo lavoro e, mi sembra, anche rimossa infine. Il
miliardo di Gardini, seguito fino al piano IV delle Botteghe Oscure (quello
della Direzione del partito, almeno quando io vi andai nei primi anni ’70,
spingendomi fino a trovare “qualcuno” al piano V, quello della segreteria), è
infine dato per “disperso” e anche in quel caso l’indagine si arena. Ma insomma,
era pur tuttavia arrivato al PCI; interessava solo la persona specifica? In
definitiva, con la prima Repubblica finisce anche gran parte della DC e il PSI
di Craxi, quelli che volevano salvare Moro; vengono “graziati”, anzi salgono
sugli “altari”, i “fu piciisti” (quelli della parte maggioritaria, gli altri
sono ormai in gran parte usciti per “rifondare” l’“irrifondabile”) e la
“sinistra” DC, cioè quelli che volevano Moro “non più tanto adatto” a opporsi a
ciò cui nessuno doveva più opporsi: il “compromesso storico”, come primo passo
di accettazione del “fu partito filosovietico” nel campo atlantico, in attesa di
vedere come utilizzarlo in seguito, cosa che fu subito chiara dopo il crollo
dell’URSS. Dicevo prima: 2+2=4. E dopo un quarto di secolo ancora non si compie
un’operazione tanto semplice. Che qualcuno si opponga al chiarimento? Anche per
capire chi si può opporre aiuta sempre la precedente semplicissima operazioncina
aritmetica. E i liquidatori di Moro – o meglio i loro successori – sono ancora
qui a devastare questo povero paese nostro. Chi si deciderà a toglierli di mezzo
come accadde a Moro? Non però con un assassinio mascherato da “azione
rivoluzionaria”; con autentici processi, anche se spesso indiziari, e condanne
esemplari.
UN GIORNO LEONE MI DISSE:
«BERLINGUER E ZACCAGNINI VOGLIONO LA MORTE DI MORO».
Intervista a Pasquale Squitieri. Il suo ultimo film, proprio come la curva che
da settimane lo costringe all’immobilità, non si vede: “Si intitola L’ultimo
Adamo, l’ho girato l’anno scorso e sto cercando qualcuno che lo distribuisca.
Non ci sono ancora riuscito. Una cosa di una gravità insopportabile”. Fuori
carreggiata, ai margini, Pasquale Squitieri è finito spesso. Il recente
incidente stradale: “Evidentemente dormivo” gli ha lasciato in dote una gamba
rotta e l’onorario di un dentista: “Ho sempre pagato tutti i debiti, pagherò
anche questo”. Settantasei anni, un tumore ai polmoni: “Si può avere un
portacenere?”, molti respiri anomali in una parabola che lo ha visto avvocato,
impiegato, regista e senatore della Repubblica. Da qualche settimana, per una
condanna definitiva figlia dei tempi in cui lavorava al Banco di Napoli,
Squitieri non gode più del vitalizio destinato agli ex parlamentari. 2381 euro
che Montecitorio gli ha tolto d’imperio: “Per un assegno di 25.000 lire. Lo feci
incassare a un cliente nel ’65, era scoperto e 15 anni più tardi venni
processato e arrestato per peculato”. Senza pensione da politico per caso e
senza rimpianto, Squitieri non riconosce alla vicenda una luce letteraria: “Non
c’è niente di kafkiano, non diamo a quest’elemosina un significato eccessivo.
Per 40 anni ho vissuto senza vitalizio, non riceverlo più non mi spaventa”. Ma
la racconta, dice, perché “quando la sfiga si presenta, riderle in faccia è il
minimo che si possa pretendere da un uomo di spirito”.
Ritrovarsi più povero la
rende allegro?
«Mi
permette di ricordare: un lusso. La storia dell’assegno parte da lontano. Nel
1979 girai Razza Selvaggia, un film terribile sulla condizione dei meridionali a
Torino. Volevo girare dentro alla Fiat e andai da Montezemolo con un finto
copione in cui magnificavo la fabbrica di Agnelli. Ottenuti i permessi, mostrai
che inferno fosse, cosa succedeva quando un operaio si faceva male e tante altre
belle cose».
Corretto.
«Cosa
vuole? Senza azzardo non ho mai saputo stare. Agnelli me la giurò. Assoldò un
paio di investigatori privati, fece raccogliere un po’ di fango ad Aversa,
avvertì chi di dovere e la vicenda dell’assegno uscì fuori. Stavo partendo per
il Festival di Mosca nell’80 e sull’aereo mi si avvicinarono un paio di
poliziotti: “Squitieri, ci risultano problemi con il suo passaporto, ci segua in
Questura e la riportiamo qui in tempo utile per partire”. Era una balla. Mi
trascinarono a Rebibbia. Cinque mesi di galera. Mi graziò Pertini».
Di Agnelli ha mai più avuto
notizie?
«Tutto
poteva immaginare, il signor Agnelli, ma non che sarei diventato senatore. Lo
acchiappai in Senato. Lo chiusi in una stanza. “Secondo te il coltello in tasca
ce l’ho o no?”.»
Vi davate del tu?
«I
senatori si danno sempre del tu: “Secondo te la lama in tasca ce l’ho o no”
gridavo. “Ti apro in due come un maiale”. Agnelli era sconvolto. Balbettava: “Ma
che c’entra?”, cercava possibili vie di uscita. A un tratto, il terrore gli
suggerì un pensiero intelligente e mi spiazzò».
Cosa disse?
«“Sei
andato da Montezemolo e lo hai ingannato. Se giochi sporco non puoi aspettarti
che gli altri giochino pulito”. Prima che mi potessi complimentare per la
prontezza, arrivarono alle spalle di Agnelli e lo portarono via. È stato il mio
peggior nemico, ma anche il più divertente».
Ne ha avuti molti?
«Ho
sparato, picchiato e insultato, ma l’ho fatto sempre per difendere qualcuno e
mai me stesso. Se vedo la mia vita in controluce e alla mia età iniziare a
osservarla è quasi un obbligo, noto che tutti gli eventi negativi che mi hanno
sfiorato erano slanci mascherati di generosità. Sono arrivato a 77 anni
sbattendo porte in faccia agli arroganti. E sono orgoglioso di averlo fatto. Una
volta, in Rai, rovesciai il tavolo addosso al direttore di Rai Tre. Si chiamava
Giuseppe Rossini».
Perché gli rovesciò il
tavolo addosso?
«Curavo
una serie di ritratti monografici e avevo scelto Leopoldo Mastelloni. Rossini mi
telefonò allarmato: “Vieni in Rai, abbiamo un problema”. Lo raggiunsi: “Qual è
il problema?”. “Il problema è che Mastelloni è frocio”. Non ci vidi più. Gli
scaricai addosso portapenne e foto di famiglia: “Anche Rock Hudson è frocio,
stronzo”.»
Sempre avuto un brutto
carattere, lei.
«Ho
sempre avuto carattere, una cosa diversa. I miei colleghi l’hanno perso da un
pezzo. Non si guardano intorno, non indagano, non si incazzano. Tutti a fare i
film su Leopardi, sul Boccaccio o sull’eterno due camere e cucina in cui i
familiari litigano tra loro. La poetica del tinello. Il cinema italiano non
risorge. È spento. Non illumina più. Speravo che gli ultimi reduci fossero
feroci. E invece è tutta una melassa, una predichetta, un monituccio piccolo
borghese».
Il suo ultimo film, diceva,
non si è visto.
«Forse
non si vedrà mai, ma non importa. Mi interrogavo sull’intelligenza artificiale.
Sulla rivoluzione tecnologica. Su un mondo che tra 10 anni avrà il 34 per cento
di robotizzazione in più. Sull’estinzione del genere umano. Gli scienziati hanno
avvertito: “Guardate che qui finisce male, ci saranno presto 2 miliardi di
affamati in guerra tra loro”. Non c’è un solo intellettuale italiano che
affronti temi simili. È pazzesco, ma che siano sordi al tema in fondo è anche
normale».
Sa perché? Ce lo dica.
«Perché
gli intellettuali italiani sono morti. Prenda Nanni Moretti. Una volta dissi che
dei suoi film ci saremmo ricordati solo le battute. Adesso neanche quelle. Uno
che comincia con Ecce Bombo e finisce con Mia madre si presenta da sé. “Dai
Nanni, reagisci” vorrei dirgli: “Sei stato grande”.»
Ci ricordiamo di una sua
dichiarazione: “Ho sempre pensato a Moretti come a un regista di estrema
destra”.
«Chi?
Nanni? Ma certo. Che c’entra la sinistra con Moretti? Ma stiamo scherzando? Nel
mondo sinistra e destra hanno rappresentato categorie severe, durissime e
spietate. In Italia destra e sinistra non sono mai esistite. Sono state due
cialtronate. Due slogan. Due abiti da indossare a seconda delle convenienze e
delle circostanze. Qui da noi abbiamo scambiato per fascisti, liberali e
repubblicani e per comunisti, i rivoluzionari da salotto. Se penso a uno di
destra penso a De Gaulle e un De Gaulle in Italia non lo vedo».
Lei è sempre stato
considerato di destra?
«Sono
un narratore. Mentre preparavo Claretta sono andato a frugare nelle fascisterie
e mi sono sentito fascistissimo. Quando ho studiato i fratelli Cervi,
comunistissimo. Il problema non sono io che devo essere libero per sentirmi
vivo, il problema sono gli altri. Sono le etichette. I conformismi. La
riflessione piatta, banale, apodittica».
In Italia si riflette male
secondo lei?
«Se
discuti in modo critico di certi aspetti positivi del ventennio mussoliniano, ti
lapidano. Se provi a ricordare la figura di Craxi, ti sputano. Siamo tutti morti
con Bettino. Craxi, per quanto carognone, contadino o arraffone, era tra quelli
che avevano capito che le casse erano vuote e la festa conclusa. E non ce lo
diceva mai. Atteggiamento adorabile. Finito il sabba socialista è finita la
politica».
Qualcuno potrebbe eccepire
e dirle che sbaglia.
«E
io me ne strafotto. Ogni politico compie dei delitti, certamente. Ma a volte i
delitti sono necessari, cambiano il volto del mondo. Pensi a quel che cazzo ha
fatto Napoleone e mi dica se sinceramente possiamo considerarlo alla stregua di
un filantropo. Non lo era, ma era un grande condottiero. I cattivi servono,
anche e soprattutto alla coscienza di tutti quelli che recitano da buoni per
contratto».
Lei è stato giovane in anni
pieni di cattivi maestri.
«Erano
anni difficili, infinitamente più interessanti dei contemporanei. Oggi, a
iniziare dagli ideali, non abbiamo più un cazzo. Solo povertà, odio e rancore».
Ma odio, rancore e povertà
c’erano anche ieri.
«E
lo dice a me? All’epoca in cui rapirono Aldo Moro, l’odio era nelle strade.
Mario Cecchi Gori incaricò me e Nanni Balestrini di lavorare sul caso e nella
ricerca della verità, io e Nanni ci spingemmo molto in là. Ero amico di Giovanni
Leone, il presidente della Repubblica. Il 10 maggio del ’78, il giorno dopo il
ritrovamento di Moro nella R4 in Via Caetani, Leone mi convocò al Quirinale. Era
stravolto: “Avevo firmato la grazia per alcuni brigatisti in cambio della
libertà di Moro. Me l’hanno strappato di mano due persone. I nomi non te li
dico. Fai il cinematografo, hai i figli, non voglio farti rischiare”.»
Raccontò questa vicenda già
in Registi d’Italia di Barbara Palombelli. Ha mai saputo chi fossero le due
persone in questione?
«Uno
era Benigno Zaccagnini e l’altro Enrico Berlinguer. Fermarono la Grazia concessa
da Leone. Come mi disse il Presidente: “Non sono persone pericolose, ma
pericolosissime”.»
Immaginare due fautori del
compromesso storico nel ruolo di aguzzini suona improbabile.
«La
pensi come vuole, l’ho sentito con le mie orecchie. Moro vivo non lo voleva
nessuno. Erano tutti d’accordo. Gli americani decidevano, i politici di casa
nostra eseguivano, i brigatisti fecero il lavoro sporco. L’organizzazione era
infiltrata a ogni livello ed eterodiretta dai servizi segreti di mezza Europa.
Leone fu reticente. Voleva proteggermi: “Maestro – gli dissi – le sembra che ne
abbia bisogno?”. Allora mi rivelò i nomi dei due che gli strapparono la Grazia
dalle mani: “Zaccagnini e Berlinguer”. Attendo smentite. Non arriveranno. La
Democrazia Cristiana ha sempre ucciso i propri figli. Come Crono, se li è
mangiati uno dopo l’altro».
Oggi chi somiglia a Crono?
«Angela
Merkel. Con lei siamo nei guai. Si parla solo di austerity, mai di ripresa. In
certe questioni il riverbero psicologico è tutto e noi ancor prima di essere
poveri, siamo depressi. Scoraggiati. Convinti che non esista altra via d’uscita
che non sia pagare i debiti fino a morire. Si può essere straccioni illudendosi
di essere signori o si può essere ugualmente straccioni intonando la litania del
sacrificio e delle cambiali da estinguere. Filosoficamente, ho sempre preferito
la prima opzione».
Non è quella scelta da
Merkel.
«Viviamo
nel sogno infantile della cancelliera tedesca, ma sarebbe meglio dire
nell’incubo. Siamo i suoi burattini, i suoi bambolotti, i poveracci che devono
ubbidire a questa bambina nazista».
Non le pare di esagerare?
«Mai
un’opinione vera, un punto di vista, una frase vitale. Merkel è il niente».
Ora sta preparando un film
su Vincenzo Gemito, grande scultore napoletano dell’800. Non ha pensato a un
film sulla crisi contemporanea?
«Ci
ho provato. Proprio ora, in questo scomposto sputare sulla Grecia, avrei voluto
fare un film su Omero. Un Omero che passa tra carri armati, guerre e carestie
recitando l’Iliade da solo. Non mi hanno dato una lira: “Che vuoi fare tu?
Omero?” Si sono messi a ridere».
Chi le manca oggi?
«Gente
come Ugo Pirro. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, avrei trascorso con Ugo
mesi e anni, me lo sarei sposato».
Si è invece accompagnato
per molti anni con Claudia Cardinale.
«Ci
conoscemmo mentre preparavo I Guappi. Franco Cristaldi mi convocò alla Vides. Me
la voleva imporre ad ogni costo e io non volevo saperne: un po’ perché gli
attori famosi mi disturbavano, un po’ perché arrivava con la raccomandazione.
Proposi di farle un provino e Cristaldi mi guardò come se avessi bestemmiato la
Madonna: “Se proviniamo Cardinale, si rivolta Roma”. Non si rivoltò nessuno.
Neanche lei. Quando andammo a vedere il risultato, lei si appollaiò dietro di
me: “Mi ha ripreso male, Squitieri. Sembro grassa”. Mi girai di scatto: “Lei non
sembra grassa, signora cara. Lei è grassa”. Non conoscevo ancora la sua
determinazione. Si mise a dieta. Perse cinque chili in due giorni».
Poco dopo scappò con lei.
«Claudia
era esasperata dal rapporto con Cristaldi e dal solito giretto. Si sentiva in
gabbia. Lui che era tutt’altro che un santo, la manteneva versandole un cachet
mensile. Se l’era comprata. Sfuggirgli equivaleva a conquistare libertà».
I vostri amici di allora?
«Mario
Monicelli lo vedevamo spesso. Quando iniziò la storia con Claudia, Monicelli
pensò che tutto il cinema italiano bigotto ci avrebbe abbandonati. Veniva la
sera a casa a tirarci un po’ su. Complimentoso. Eccessivamente premuroso. Gli
dicevo: “Mario, guarda che non abbiamo nessun bisogno di tutta questa allegria,
siamo tranquilli, sereni. Mangiamo e poi andiamo a letto, non devi
preoccuparti”. E lui, di rimando: “Lo faccio per amicizia, non c’è nulla di più
importante dell’amicizia”. La realtà era diversa. In realtà Claudia se la
volevano scopare tutti».
Anche Monicelli?
«Eeehhh,
certo, certo. C’era chi c’era riuscito e chi no. Non l’ho mai saputo e non mi ha
mai interessato. Sicuramente qualcuno me l’ha tirata. Avevo veramente tolto la
fidanzata agli italiani. Ancora oggi, se ho un incidente come quello che ho
avuto poco tempo fa, mi riesce impossibile non ricondurlo alle maledizioni di
allora. Determinati influssi restano nell’aria».
Qualcuno raccontava che tra
lei e Cardinale finisse spesso a schiaffi e che lei del manifesto machista
“cazzo e cazzotto” fosse strenuo sostenitore.
«Qualche
volta siamo finiti a fare a botte, ma era inevitabile. Ci lasciavamo, ci
riprendevamo, l’ho amata molto come oggi amo Ottavia Fusco che ha 27 anni in
meno di me. Due donne colte, eleganti, straordinarie».
È straordinaria anche la
vecchiaia?
«Non
ci crederà, ma è così vera, polverosa e piena di fuochi improvvisi che non
potevo aspettarmi di meglio».
Pensa mai alla morte?
«Ci
penso e le parlo. Da tanti anni. Cos’è la morte se non un momento bellissimo
della vita e un incontro tra un me che va via e un me che rimane? Lasciarselo
scappare sarebbe un delitto. Non li ho mai compiuti. Non ho mai ucciso nessuno,
io». Malcom Pagani, il Fatto Quotidiano 2/8/2015
Cinema in lutto: è morto
Pasquale Squitieri, l’anarcofascista,
scrive Priscilla Del Ninno sabato 18 febbraio 2017, su "Il Secolo d'Italia".
Alla fine si è arreso alla malattia. Al dolore. Alla morte: si è spento questa
mattina a Roma, all’Ospedale Villa San Pietro, circondato dai suoi affetti
familiari, il regista Pasquale Squitieri. A dare notizia del decesso il fratello
Nicola, la seconda moglie Ottavia Fusco, la figlia Claudia. Aveva 78 anni: la
maggior parte dei quali passati a muoversi “contro”. Addio a Pasquale Squitieri,
un uomo contro. Controccorente. Contro gli stereotipi. Contro la corruzione e il
malcostume. Contro l’inciucio e, soprattutto, sempre contro la banalità e la
superficialità imperanti in questo anni per lui troppo vuoti e edonistici
persino per essere raccontati dalla macchina da presa. Un uomo rigorosamente
contro, Pasquale Squitieri, che della lotta al conformismo più bieco e sterile
ha sempre fatto una regola di vita da applicare sul set e fuori dal set, nel
privato come nell’impegno civico dimostrato sublimato nei suoi film, sviscerato
nelle sue apparizioni (e esternazioni) pubbliche. Un uomo, insomma, che
difficilmente avrebbe potuto non lasciare un segno in chi lo ha conosciuto, in
chi con lui ha lavorato, in chi con lui ha condiviso anche il semplice spazio di
una conversazione. Un uomo a cui hanno sempre invidiato l’amore e la lunga
relazione con Claudia Cardinale, sua compagna di vita negli Anni Settanta e
partner di tanti successi cinematografici. Un personaggio pubblico a cui in
molti non hanno perdonato la sua scelta di campo a destra – esplicitata con
l’elezione al Senato nel 1994 nelle liste di Alleanza Nazionale – e coronato sul
grande schermo grazie a Claretta, il film ispirato e dedicato all’amante del
Duce, da lui stesso definita «una donna innamorata del mito, morta per
coerenza». Un regista che ammiccava al nazional popolare dall’alto del suo
essere – come lui stesso si era definito – un «anarcofascista». Regista scomodo
e rigorosamente disorganico, anti-politically correct già in epoca non sospetta,
era nato a Napoli il 27 novembre del 1938 e aveva cominciato a farsi strada nel
mondo della settima arte già sul finire degli anni Sessanta: e quando nel
Belpaese ancora si era ebbri dei postumi del boom economico e ancora si
ancheggiava con il twist – e mentre ci si preparava, prima, e si affrontavano
poi, allo sconvolgimento e agli esiti della guerra civile che avrebbe
imperversato negli anni di piombo – Squitieri sfidava stereotipi cinefili e
luoghi comuni del sociale dirigendo pellicole del calibro di Django sfida
Sartana (firmandosi William Redford), Camorra, Il prefetto di
ferro e Corleone, solo per citare alcuni dei suoi più rinomati successi di
pubblico e di critica. E allora, dalla mafia alla droga, dal terrorismo alle
cosiddette “morti bianche”, fino all’immigrazione, è su questi temi –
controversi e difficili, di sicuro assai poco seducenti dal punto di vista
spettacolare – che il regista ha sfidato comune sentire e convinzioni ataviche,
e sempre con quel suo approccio artigianale al cinema e all’immaginario
collettivo che il grande schermo evoca e omaggia. Poliedrico, mai banale, il suo
sguardo cinematografico ha strizzato l’occhio all’epopea degli spaghetti
western come al kolossal storico, senza dimenticare i temi da sempre cari al
sociale. Non solo: Squitieri è stato molto spesso anche sceneggiatore dei propri
film, che scriveva e dirigeva, molti dei quali interpretati dalla prima moglie
Claudia Cardinale – (nel 2013 aveva sposato l’attrice Ottavia Fusco) – con uno
stile registico duro e diretto, che ha sempre rispecchiato il suo carattere
ruvido di uomo amante della provocazione e di un certo estremismo
retorico. Anche per questo, allora, la fama di Squitieri è dovuta soprattutto ai
suoi film storico-politici, l’ultimo dei quali, Li chiamarono… briganti!, datato
1999 e incentrato sul brigantaggio postunitario, e che il regista sapeva, già in
fase di sceneggiatura, destinato a sollevare non poche reazioni. Ma lui era
tosto, un duro. Anzi, come ricordato in queste ore anche dallo scrittore,
giornalista e storico Giordano Bruno Guerri – che da Squitieri è stato diretto
in Stupor Mundi, un lungometraggio del 1998, tratto dal poema drammatico Ager
sanguinis di Aurelio Pes – «era durissimo, sul set come nella vita»…
DOPO ALDO MORO. IN QUESTO
MONDO DI LADRI.
In Questo Mondo Di Ladri di
Antonello Venditti.
Eh, in questo mondo di ladri
C' ancora un gruppo di amici
Che non si arrendono mai.
Eh, in questo mondo di santi
Il nostro cuore rapito
Da mille profeti e da quattro
cantanti.
Noi, noi stiamo bene tra noi
E ci fidiamo di noi.
In questo mondo di ladri,
In questo mondo di eroi,
Non siamo molto importanti
Ma puoi venire con noi.
Eh, in questo mondo di debiti
Viviamo solo di scandali
E ci sposiamo le vergini.
Eh, e disprezziamo i politici,
E ci arrabbiamo, preghiamo,
gridiamo,
Piangiamo e poi leggiamo gli
oroscopi.
Voi, vi divertite con noi
E vi rubate tra voi.
In questo mondo di ladri,
In questo mondo di eroi,
Voi siete molto importanti
Ma questa festa per noi.
Eh, ma questo mondo di santi
Se il nostro cuore rapito
Da mille profeti e da quattro
cantanti.
Noi, noi stiamo bene tra noi
E ci fidiamo di noi.
In questo mondo... in questo
mondo di ladri...
In questo mondo... in questo
mondo di ladri...
In questo mondo... in questo
mondo di ladri...
Mamma l’italiani, canzone del
2010 di Après La Class
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li ca
nei secoli dei secoli girando
per il mondo
nella pizzeria con il Vesuvio
come sfondo
non viene dalla Cina non è
neppure americano
se vedi uno spaccone è
solamente un italiano
l'italiano fuori si distingue
dalla massa
sporco di farina o di sangue
di carcassa
passa incontrollato lui
conosce tutti
fa la bella faccia fa e poi la
mette in culo a tutti
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li ca
a suon di mandolino nascondeva
illegalmente
whisky e sigarette chiaramente
per la mente
oggi è un po' cambiato ma è
sempre lo stesso
non smercia sigarette ma
giochetti per il sesso
l'italiano è sempre stato un
popolo emigrato
che guardava avanti con la
mente nel passato
chi non lo capiva lui lo
rispiegava
chi gli andava contro è
saltato pure in a...
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li ca
l'Italia agli italiani e alla
sua gente
è lo stile che fa la
differenza chiaramente
genialità questa è la regola
con le idee che hanno cambiato
tutto il corso della storia
l'Italia e la sua nomina e un
alta carica
un eredità scomoda
oggi la visione italica è che
viaggiamo tatuati con la firma
della mafia
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no
questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora
di cambiare aria
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no
questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora
di cambiare aria
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li ca
vacanze di piacere per giovani
settantenni
all'anagrafe italiani ma in
Brasile diciottenni
pagano pesante ragazze
intraprendenti
se questa compagnia viene
presa con i denti
l'italiano è sempre stato un
popolo emigrato
che guardava avanti con la
mente nel passato
chi non lo capiva lui lo
rispiegava
chi gli andava contro è
saltato pure in a...
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li ca
spara la famiglia del pentito
che ha cantato
lui che viene stipendiato il
27 dallo Stato
nominato e condannato nel suo
nome hanno sparato
e ricontare le sue anime non
si può più
risponde la famiglia del
pentito che ha cantato
difendendosi compare tutti
giorni più incazzato
sarà guerra tra famiglie
sangue e rabbia tra le griglie
con la fama come foglie che ti
tradirà
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no
questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora
di cambiare aria
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no
questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora
di cambiare aria
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma
l'italiani mancu li cani mancu li ca
ITALIANI. LA CASTA DEI
"COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO BISIO.
In molti mi hanno scritto
chiedendomi il testo del mio monologo effettuato durante il Festival di Sanremo
2013 il 16 Febbraio scorso. Beh, eccolo. Inoltre alcuni di voi, sull'onda del
contenuto di quel monologo hanno creato una pagina facebook "Quelli che domenica
voteranno con un salmone". Come vedete, l'ho fatto anch'io...
Sono un italiano. Che
emozione... E che paura essere su questo palcoscenico... Per me è la prima
volta. Bello però. Si sta bene… Il problema ora è che cosa dire. Su questo palco
è stato fatto e detto davvero di tutto. E il contrario di tutto. Gorbaciov ha
parlato di perestroika, di libertà, di democrazia… Cutugno ha rimpianto l’Unione
Sovietica. Gorbaciov ha parlato di pace… e Cutugno ha cantato con l’Armata
Rossa… Belen ha fatto vedere la sua farfallina (io potrei farvi vedere il mio
biscione, ma non mi sembra un’ottima idea… è un tatuaggio che ho sulla caviglia,
dopo tanti anni a Mediaset è il minimo…) Ma soprattutto Benigni, vi ricordate
quando è entrato con un cavallo bianco imbracciando il tricolore? Ecco, la
rovina per me è stato proprio Benigni. Lo dico con una sana invidia. Benigni ha
alzato troppo il livello. La Costituzione, l'Inno di Mameli, la Divina
Commedia... Mettetevi nei panni di uno come me. Che è cresciuto leggendo
Topolino... Però, se ci pensate bene, anche Topolino, a modo suo, è un classico.
Con la sua complessità, il suo spessore psicologico, le sue contraddizioni…
Prendete Nonna Papera, che animale è? ... chi ha detto una nonna? Non fate gli
spiritosi anche voi, è una papera. Ma è una papera che dà da mangiare alle
galline. Tiene le mucche nella stalla... Mentre invece Clarabella, che anche lei
è una mucca, non sta nella stalla, sta in una casa con il divano e le tendine. E
soprattutto sta con Orazio, che è un cavallo. Poi si lamentano che non hanno
figli... Avete presente Orazio, che fa il bipede, l’antropomorfo, però ha il
giogo, il morso, il paraocchi. Il paraocchi va bene perché Clarabella è un
cesso, ma il morso?!? Ah, forse quando di notte arriva Clarabella con i tacchi a
spillo, la guêpiere, la frusta: "Fai il Cavallo! Fai il cavallo!" nelle loro
notti sadomaso… una delle cinquanta sfumature di biada. E Qui Quo Qua. Che
parlano in coro. Si dividono una frase in tre, tipo: "ehi ragazzi attenti che
arriva Paperino/ e/ ci porta tutti a Disneyland", oppure: "ehi ragazzi cosa ne
direste di andare tutti/ a/ pescare del pesce che ce lo mangiamo fritto che ci
piace tanto..." ecco, già da queste frasi, pur banali se volete, si può evincere
come a Quo toccassero sempre le preposizioni semplici, le congiunzioni, a volte
solo la virgola: "ehi ragazzi attenti che andando in mezzo al bosco/, /
rischiamo di trovare le vipere col veleno che ci fanno del male" inoltre Quo ha
sempre avuto un problema di ubicazione, di orientamento... non ha mai saputo
dove fosse. Tu chiedi a Qui: "dove sei?" "sono qui!" ... Chiedi a Qua "dove
sei?", e lui: "sono qua!" tu prova a chiederlo a Quo. Cosa ti dice? "sono Quo?"
Cosa vuol dire? Insomma Quo è sempre stato il più sfigato dei tre, il più
insulso: non riusciva né a iniziare né a finire una frase, non era né qui, né
qua... Mario Monti. Mari o Monti? Città o campagna? Carne o Pesce? Lo so. So che
siamo in piena par condicio e non si può parlare di politica. Ma sento alcuni di
voi delusi dirsi: ma come, fra sette giorni ci sono le elezioni. E questo qui ci
parla di mucche e galline... Altri che invece penseranno: basta politica! Io non
voglio nascondermi dietro a un dito, anche perché non ne ho nessuno abbastanza
grosso… decidete voi, volendo posso andare avanti per altri venti minuti a
parlare di fumetti, oppure posso dirvi cosa penso io della situazione politica…
Ve lo dico? Io penso che finché ci sono LORO, non riusciremo mai a cambiare
questo paese. Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Non mantengono le promesse.
Sono incompetenti, bugiardi, inaffidabili. Credono di avere tutti diritti e
nessun dovere. Danno sempre la colpa agli altri… A CASA! Tutti a casa!!! (A
parte che quando dici tutti a casa devi stare attento, specificare: a casa di
chi? No perché non vorrei che venissero tutti a casa mia) Vedo facce
spaventate... soprattutto nelle prime file... Lo so, non devo parlare dei
politici, ho firmato fior di contratti, ci sono le penali... Ma chi ha detto che
parlo dei politici? Cosa ve l'ha fatto pensare? Ah, quando ho detto
incompetenti, bugiardi, inaffidabili? Ma siete davvero maliziosi... No, non
parlavo dei politici. Anche perché, scusate, i politici sono in tutto poche
centinaia di persone... cosa volete che cambi, anche se davvero se ne tornassero
tutti a casa (casa loro, ribadisco)? Poco. No, quando dicevo che devono andare
tutti a casa, io non stavo parlando degli eletti. Io stavo parlando degli
elettori... stavo parlando di NOI. Degli italiani. Perché, a fare bene i conti,
la storia ci inchioda: siamo noi i mandanti. Siamo noi che li abbiamo votati. E
se li guardate bene, i politici, ma proprio bene bene bene... è davvero
impressionante come ci assomigliano: I politici italiani… sono Italiani!
Precisi, sputati. Magari, ecco, con qualche accentuazione caricaturale. Come le
maschere della commedia dell'arte, che sono un po' esagerate, rispetto al
modello originale. Ma che ricalcano perfettamente il popolo che rappresentano.
C'è l'imbroglione affarista, tradito dalla sua ingordigia “Aò, e nnamose a
magnà!... A robbin, ‘ndo stai?”; C'è il servitore di due padroni: "orbo da
n'orecia, sordo de n'ocio"… qualche volta anche di tre. Certi cambiano casacca
con la velocità dei razzi… C'è il riccone arrogante...”Guadagno spendo pago
pretendo” C'è la pulzella che cerca di maritarsi a tutti i costi con il riccone,
convinta di avere avuto un'idea originale e che ci rimane male quando scopre che
sono almeno un centinaio le ragazze che hanno avuto la sua stessa identica
idea... C'è il professore dell'università che sa tutto lui e lo spiega agli
altri col suo latino/inglese perfetto: "tananai mingheina buscaret!" Cos’ha
detto? “Choosy firewall spending review” Ah, ecco, ora finalmente ho capito… C'è
quello iracondo, manesco, pronto a menar le mani ad ogni dibattito... “culattoni
raccomandati” Insomma, c'è tutto il campionario di quello che NOI siamo, a
partire dai nostri difetti, tipo l'INCOERENZA. Come quelli che vanno al family
day... ma ci vanno con le loro due famiglie... per forza poi che c'è un sacco di
gente.... E se solo li guardi un po' esterrefatto, ti dicono: "Perché mi guardi
così? Io sono cattolico, ma a modo mio”. A modo tuo? Guarda, forse non te
l'hanno spiegato, ma non si può essere cattolico a modo proprio... Se sei
cattolico non basta che Gesù ti sia simpatico, capisci? Non è un tuo amico,
Gesù. Se sei cattolico devi credere che Gesù sia il figlio di Dio incarnato
nella vergine Maria. Se sei cattolico devi andare in chiesa tutte le domeniche,
confessare tutti i tuoi peccati, fare la penitenza. Devi fare anche le novene,
digiunare al venerdì... ti abbuono giusto il cilicio e le ginocchia sui ceci.
Divorziare: VIETATISSIMO! Hai sposato un farabutto, o una stronza? Capita.
Pazienza. Peggio per te. Se divorzi sono casini… E il discorso sulla coerenza
non vale solo per i cattolici... Sei fascista? Devi invadere l’Abissinia!
Condire tutto con l'olio di ricino, girare con il fez in testa, non devi mai
passare da via Matteotti, anche solo per pudore! Devi dire che Mussolini, a
parte le leggi razziali, ha fatto anche delle cose buone! Sei comunista? Prima
di tutto devi mangiare i bambini, altro che slow food. Poi devi andare a Berlino
a tirare su di nuovo il Muro, mattone su mattone! Uguale a prima! Devi guardare
solo film della Corea… del nord ovviamente. Devi vestirti con la casacca grigia,
tutti uguali come Mao! …mica puoi essere comunista e poi andare a comprarti la
felpa da Abercrumbie Sei moderato? Devi esserlo fino in fondo! Né grasso né
magro, né alto né basso, né buono né cattivo... Né…Da quando ti alzi la mattina
a quando vai a letto la sera devi essere una mediocrissima, inutilissima,
noiosissima via di mezzo! Questo per quanto riguarda la coerenza. Ma vogliamo
parlare dell'ONESTÀ? Ho visto negozianti che si lamentano del governo ladro e
non rilasciano mai lo scontrino, Ho visto fabbriche di scontrini fiscali non
fare gli scontrini dicendo che hanno finito la carta, Ho visto ciechi che
accompagnano al lavoro la moglie in macchina, Ho visto sordi che protestano coi
vicini per la musica troppo alta, Ho visto persone che si lamentano
dell’immigrazione e affittano in nero ai gialli… e a volte anche in giallo ai
neri!, Ho visto quelli che danno la colpa allo stato. Sempre: se cade un
meteorite, se perdono al superenalotto, se la moglie li tradisce, se un piccione
gli caga in testa, se scivolano in casa dopo aver messo la cera: cosa fa lo
stato? Eh? Cosa fa?... Cosa c’entra lo stato. Metti meno cera, idiota! Lo sapete
che nell'inchiesta sulla 'ndrangheta in Lombardia è venuto fuori che c'erano
elettori, centinaia di elettori, che vendevano il proprio voto per cinquanta
euro? Vendere il voto, in democrazia, è come vendere l'anima. E l'anima si vende
a prezzo carissimo, avete presente Faust? Va beh che era tedesco, e i tedeschi
la mettono giù sempre durissima, ma lui l'anima l'ha venduta in cambio
dell'IMMORTALITA'! Capito? Non cinquanta euro. Se il diavolo gli offriva
cinquanta euro, Faust gli cagava in testa. La verità è che ci sono troppi
impresentabili, tra gli elettori. Mica poche decine, come tra i candidati… è
vero, sembrano molti di più, ma perché sono sempre in televisione a sparar
cazzate, la televisione per loro è come il bar per noi... "Ragazzi, offro un
altro giro di spritz" "E io offro un milione di posti di lavoro" e giù a ridere.
"E io rimborso l'imu!” “e io abolisco l'ici!" “Guarda che non c'è più da un
pezzo l'ici" "Allora abolisco l'iva... E anche l'Emy, Evy e Ely!" "E chi sono?
"Le nipotine di Paperina! "Ma va là, beviti un altro grappino e tasi mona!..."
Vedi, saranno anche impresentabili ma per lo meno li conosci, nome e cognome, e
puoi anche prenderli in giro. Invece gli elettori sono protetti dall’anonimato…
alle urne vanno milioni di elettori impresentabili, e nessuno sa chi sono!
Sapete quale potrebbe essere l’unica soluzione possibile? Sostituire
l'elettorato italiano. Al completo. Pensate, per esempio, se incaricassimo di
votare al nostro posto l'elettorato danese, o quello norvegese. Lo prendiamo a
noleggio. Meglio, lo ospitiamo alla pari... Au pair. Carlo, ma chi è quel
signore biondo che dorme a casa tua da due giorni? “Oh, è il mio elettore
norvegese alla pari, domenica vota e poi riparte subito... C'è anche la
moglie”... E per chi votano, scusa? "Mi ha detto che è indeciso tra Aspelünd
Gründblomma e Pysslygar". Ma quelli sono i nomi dell'Ikea!, che tra l’altro è
svedese… "Ma no, si assomigliano… però ora che mi ci fai pensare, effettivamente
ho visto nel suo depliant elettorale che i simboli dei loro partiti sono un
armadio, una lampada, un comodino. Mah. E tu poi, in cambio cosa fai, vai a
votare per le loro elezioni? In Norvegia? "Ah, questo non lo so. Non so se mi
vogliono. Mi hanno detto che prima devo fare un corso. Imparare a non
parcheggiare in doppia fila. A non telefonare parlando ad alta voce in treno. A
pagare le tasse fino all'ultimo centesimo. Poi, forse, mi fanno votare." Si, va
beh, qualche difficoltà logistica la vedo: organizzare tutti quei pullman,
trovare da dormire per tutti... Ma pensate che liberazione, la sera dei
risultati, scoprire che il nostro nuovo premier è un signore o una signora
dall'aria normalissima, che dice cose normalissime, e che va in televisione al
massimo un paio di volte all'anno.
(Lancio di batteria e poi,
sull’aria de “L’italiano”)
Lasciatemi votare
con un salmone in mano
vi salverò il paese
io sono un norvegese…
Le persone perbene non
riescono a fare carriera all’interno della pubblica amministrazione.
Un giudizio lapidario che viene dal presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione Raffaele Cantone, scrive “Blitz Quotidiano” il 28 ottobre 2015.
Un giudizio appena mitigato dai due minuti di spiegazione dell’affermazione:
Cantone spiega che, a volte, questo avviene anche per colpe dei diretti
interessati. “Spesso le persone perbene all’interno della pubblica
amministrazione sono quelle che hanno meno possibilità di fare – dice Cantone –
Spesso fanno meno carriera. Spesso sono meno responsabilizzati perché
considerati per bene”. Secondo Cantone è ora di recuperare parole che non si
usano nel nostro mondo del lavoro. Una è la parola “controllo”. E il presidente
dell’anticorruzione si riferisce a chi osserva i colleghi timbrare il cartellino
e poi lasciare il posto di lavoro senza denunciare nulla. Quello che serve,
secondo Cantone, è una “riscossa interna” e un recupero non imposto dall’alto di
moralità e cultura dello Stato, il terzo settore e di conseguenza il nostro
Paese si salveranno dalla mala gestione della cosa pubblica.
Commenti disabilitati su
Cantone: “Non sono tutti fannulloni ma nella Pubblica amministrazione, le
persone perbene hanno meno possibilità”,
scrive Antonio Menna il 28 ottobre 2015 su “Italia Ora”. “Non sono tutti
fannulloni nella Pubblica amministrazione. Meno che mai sono tutti corrotti. Ma
è vero che le persone perbene sono quelli che vengono meno coinvolti nelle
scelte, meno responsabilizzati. Sono quelli che hanno meno possibilità di fare
carriera”. Lo dice chiaro e tondo, Raffaele Cantone, magistrato anticamorra, e
presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Lo dice nel corso di una
intervista pubblica al Sermig di Torino e il segmento sulla corruzione nella
pubblica amministrazione (rilanciato da un video del Corriere della Sera) è
quello che impressiona di più. Quante volte lo abbiamo pensato che essere onesti
è una penalizzazione? Chi è onesto non va lontano. “A volte, però”, chiarisce
Cantone, “anche per sue responsabilità. Dobbiamo trovare il coraggio di
ripristinare alcune parole che nel nostro lessico si sono dimenticate: la parola
controllo, per esempio. Se il mio amico, vicino di stanza, usa il badge per
coprire i colleghi che magari sono in vacanza, devo stare zitto? Perché devo
stare zitto? Queste apparenti distrazioni sono complicità. La società dei
piccoli favori, magari banali, magari che non portano necessariamente alla
corruzione, ci abitua all’idea che ci sia uno spazio dove tutto si può
comprare.” “Il problema – conclude Cantone – non è solo la disonestà ma, a
volte, anche non capire con chi parlare. Ci sono cento centri di costo solo
nella città di Roma, cento uffici che fanno appalti e spesa. Come li controlli?
La deresponsabilizzazione la fa da padrona, ed è essa stessa una delle ragioni
che giustifica la corruzione.”
In Italia si fa carriera solo se si è ricattabili,
scrive il 5 giugno 2015 Claudio Rossi su "L'Uomo qualunque".
“Il nostro Paese sta sprofondando nel conformismo (…) siamo usciti da una
consultazione elettorale che ha dato il risultato a tutti noto, ma la cosa che
colpisce è questo saltare sul carro del vincitore. Tacito diceva che una delle
abitudini degli italiani è di ruere in servitium: pensate che immagine potente,
correre ad asservirsi al carro del vincitore. Noi tutti conosciamo persone
appartenenti al partito che ha vinto le elezioni che hanno opinioni diverse
rispetto ai vertici di questo partito. Ora non si tratta affatto di prendere
posizioni che distruggono l’unità del partito, ma di manifestare liberamente le
proprie opinioni senza incorrere nell’anatema dei vertici di questo partito (…)
Queste persone, dopo il risultato elettorale, hanno tirato i remi in barca e le
idee che avevano prima, oggi non le professano più. Danno prova di conformismo.
(…) La nostra rappresentanza politica è quella che è (…) La diffusione della
corruzione è diventata il vero humus della nostra vita politica, è diventata una
sorta di costituzione materiale. Qualcuno, il cui nome faccio solo in privato,
ha detto che nel nostro Paese si fa carriera in politica, nel mondo della
finanza e dell’impresa, solo se si è ricattabili (…) Questo meccanismo della
costituzione materiale, basato sulla corruzione, si fonda su uno scambio, un
sistema in cui i deboli, cioè quelli che hanno bisogno di lavoro e
protezione, gli umili della società, promettono fedeltà ai potenti in cambio di
protezione. È un meccanismo omnipervasivo che raggiunge il culmine nei casi
della criminalità organizzata mafiosa, ma che possiamo constatare nella nostra
vita quotidiana (…) Questo meccanismo funziona nelle società diseguali, in cui
c’è qualcuno che conta e che può, e qualcuno che non può e per avere qualcosa
deve vendere la sua fedeltà, l’unica cosa che può dare in cambio (…) Quando
Marco Travaglio racconta dei casi di pregiudicati o galeotti che ottengono 40
mila preferenze non è perché gli elettori sono stupidi: sanno perfettamente
quello che fanno, ma devono restituire fedeltà. Facciamoci un esame di coscienza
e chiediamoci se anche noi non ne siamo invischiati in qualche misura. (…)
Questo meccanismo fedeltà-protezione si basa sulla violazione della legge. Se
vivessimo in un Paese in cui i diritti venissero garantiti come diritti e non
come favori, saremmo un paese di uomini e donne liberi. Ecco libertà e onestà.
Ecco perché dobbiamo chiedere che i diritti siano garantiti dal diritto, e non
serva prostituirsi per ottenere un diritto, ottenendolo come favore. Veniamo
all’autocoscienza: siamo sicuri di essere immuni dalla tentazione di entrare in
questo circolo? (…) Qualche tempo fa mi ha telefonato un collega di Sassari che
mi ha detto: “C’è una commissione a Cagliari che deve attribuire un posto di
ricercatore e i candidati sono tutti raccomandati tranne mia figlia. Sono venuto
a sapere che in commissione c’è un professore di Libertà e Giustizia…”. Io ero
molto in difficoltà, ma capite la capacità diffusiva di questo sistema di
corruzione, perché lì si trattava di ristabilire la par condicio tra candidati.
Questo per dire quanto sia difficile sgretolare questo meccanismo, che si basa
sulla violazione della legge. Siamo sicuri di esserne immuni? Ad esempio,
immaginate di avere un figlio con una grave malattia e che debba sottoporsi a un
esame clinico, ma per ottenere una Tac deve aspettare sei mesi. Se conosceste il
primario del reparto, vi asterreste dal chiedergli il favore di far passare
vostro figlio davanti a un altro? Io per mia fortuna non mi sono mai trovato in
questa condizione, ma se mi ci trovassi? È piccola, ma è corruzione, perché se
la cartella clinica di vostro figlio viene messa in cima alla pila, qualcuno che
avrebbe avuto diritto viene posposto. Questo discorso si ricollega al problema
del buon funzionamento della Pubblica amministrazione: se i servizi
funzionassero bene non servirebbe adottare meccanismi di questo genere. Viviamo
in un Paese che non affronta il problema della disonestà e onestà in termini
morali. (…) Se non ci risolleviamo da questo, avremo un Paese sempre più
clientelarizzato, dove i talenti non emergeranno perché emergeranno i
raccomandati, e questo disgusterà sempre di più i nostri figli e nipoti che
vogliono fare ma trovano le porte sbarrate da chi ha gli appoggi migliori. È una
questione di sopravvivenza e di rinascita civile del nostro Paese. Ora,
continuiamo a farci questo esame di coscienza: non siamo forse noi, in qualche
misura, conniventi con questo sistema? Quante volte abbiamo visto vicino a noi
accadere cose che rientrano in questo meccanismo e abbiamo taciuto? Qualche
tempo fa, si sono aperti un trentina di procedimenti penali a carico di colleghi
universitari per manipolazione dei concorsi universitari (…) Noi non sapevamo,
noi non conoscevamo i singoli episodi (…) e per di più non siamo stati parte
attiva del meccanismo, ma dobbiamo riconoscere che abbiamo taciuto, dobbiamo
riconoscere la nostra correità. Proposta: Libertà
e Giustizia è una associazione policentrica che si basa su circoli, che
sono associazioni nella associazione, radicati sul territorio e collegati alla
vita politica. Non sarebbe il caso che i circoli si attrezzassero per monitorare
questi episodi, avendo come alleati la stampa libera e la magistratura autonoma?
Potrebbe essere questa una nuova sfida per Libertà e Giustizia, controllare la
diffusione di questa piovra che ci invischia tutti, cominciando dal basso,
perché dall’alto non ci verrà nulla di buono, perché in alto si procede con quel
meccanismo che dobbiamo combattere.”
Gustavo Zagrebelsky.
“I cittadini silenziosi possono essere dei perfetti sudditi per
un governo autoritario, ma sono un disastro per una democrazia”.
Robert Alan Dahl
Il volume più letto dai
politici? Un manuale per ottenere l'immunità.
Alle
Biblioteca delle Nazioni Unite non hanno più nemmeno una copia. Spiega i vari
tipi di immunità e chi può usufruire, scrive Gabriele Bertocchi Venerdì,
08/01/2016, su “Il Giornale”. Non è un semplice libro, è il libro che ogni
politico dovrebbe leggere. E infatti è cosi, tutto lo vogliono. È diventato il
libro più richiesto alla biblioteca delle Nazioni Unite. Vi starete chiedendo
che volume è: magari se è un'opera di letteratura classica, oppure un trattato
sulla politica internazionale. Nessuno di questi, si chiama "Immunità di capi e
funzionari di Stato per crimini internazionali", è uno scritto da Ramona
Pedretti, ex studentessa dell’Università di Lucerna. È una tesi di dottorato,
un vademecum che spiega e illustra che tipo di immunità esistono per tali
soggetti. "Più che un libro è una star" commenta Maria Montagna sulle
pagine de La Stampa, una delle addette alla gestione banca dati di Dag
Hammarskjold Library, libreria dedicata al'ex segretario generale, alle Nazioni
Unite. "È senza dubbio il libro più richiesto del 2015, anche più di classici
della letteratura Onu o grandi dossier" continua l'addetta. Il successo lo
si deve anche a Twitter, infatti la Dag Hammarskjold Library ha pubblicato il
"primato" del libro, creando così un vero e proprio cult da leggere. Ma
all'interno cosa si può imparare, come scrive la Pedretti, autrice del volume,
si può scoprire che esistono due dtipi di immunità: quella ratione personae che
mette i capi di stato al riparo dalla giurisdizione penale straniera, e quella ratione
materiae che protegge atti ufficiali e funzionari che agiscono per conto
dello Stato dal giudizio di tribunali di altri Paesi. La Montagna spiega che "ora
però la platea di lettori si è allargata vista la pubblicità dei social", ma
prima era perlopiù composta da funzionari degli uffici legali e storici Onu,
interessati in particolare alle conclusioni tratte da Pedretti. La tesi è che
capi o alti esponenti di Stato in carica non possono essere perseguiti da corti
straniere, al contrario degli ex. E intanto, come si legge su La Stampa, arriva
la conferma da parte della libreria: "Mi spiace, al momento non abbiamo
neanche una copia disponibile".
Va a ruba all’Onu il libro
che insegna ai leader come avere l’immunità.
Esaurito in biblioteca.
Tesi di laurea. Il pamphlet è stato scritto da Ramona Pedretti ex studentessa
dell’Università di Lucerna, scrive Francesco Semprini su “La Stampa” l’8 gennaio
2016. Basta entrare nella biblioteca delle Nazioni Unite e menzionare il nome
del libro per capire che non stiamo parlando di un volume qualunque. Maria
Montagna, una delle addette alla gestione della banca data di Dag Hammarskjold
Library - la libreria dedicata all’ex segretario generale - guarda la collega
Ariel Lebowitz e sorride. «Più che un libro è una star - dice - aspetti qui,
controlliamo subito». L’opera in questione è «Immunità di capi e funzionari di
Stato per crimini internazionali», un pamphlet scritto da Ramona Pedretti, ex
studentessa oriunda dell’Università di Lucerna. È una tesi di dottorato, un
vademecum per capire che tipo di immunità esistono per tali soggetti. Ne
esistono due, come spiega Pedretti nel suo scritto, quella ratione personae che
mette i capi di stato al riparo dalla giurisdizione penale straniera, e quella
ratione materiae che protegge atti ufficiali e funzionari che agiscono per conto
dello Stato dal giudizio di tribunali di altri Paesi. «È senza dubbio il libro
più richiesto del 2015, anche più di classici della letteratura Onu o grandi
dossier», dice Maria. Twitter ha fatto il resto, visto che Dag Hammarskjold
Library ha rilanciato sul social network il «primato» del libro moltiplicandone
notorietà e richieste. Ma chi lo chiede in prestito? All’inizio erano
soprattutto funzionari degli uffici legali e storici Onu, interessati in
particolare alle conclusioni tratte da Pedretti. La tesi dell’autrice è che capi
o alti esponenti di Stato in carica non possono essere perseguiti da corti
straniere, al contrario degli ex. È questo il principio ad esempio che ha
portato all’arresto di Adolph Eichmann da parte di Israele e Augusto Pinochet
dalla Spagna. «Ora però la platea di lettori si è allargata vista la pubblicità
dei social», chiosa Maria. E arriva la conferma: «Mi spiace, al momento non
abbiamo neanche una copia disponibile».
Fondazioni, i soldi
nascosti dei politici.
Finanziamenti milionari anonimi. Intrecci con banchieri,
costruttori e petrolieri. Società fantasma. Da Renzi a Gasparri, da Alfano ad
Alemanno, ecco cosa c'è nei conti delle fondazioni, scrivono Paolo Biondani,
Lorenzo Bagnoli e Gianluca De Feo il 7 gennaio 2016 su “L’Espresso”.
Finanziamenti milionari ma anonimi. Un intreccio tra ministri, petrolieri,
banchieri e imprenditori. Con una lunga inchiesta nel numero in edicola
“L'Espresso” ha esaminato i documenti ufficiali delle fondazioni che fanno capo
ai leader politici, da Renzi a Gasparri, da Alfano a Quagliarello, tutte
dominate dall'assenza di trasparenza. Nel consiglio direttivo di Open, il
pensatoio-cassaforte del premier, siedono l’amico che ne è presidente Alberto
Bianchi, ora consigliere dell’Enel, il sottosegretario Luca Lotti, il braccio
destro Marco Carrai e il ministro Maria Elena Boschi. Il sito pubblica centinaia
di nomi di finanziatori, ma omette «i dati delle persone fisiche che non lo
hanno autorizzato esplicitamente». Il patrimonio iniziale di 20 mila euro,
stanziato dai fondatori, si è moltiplicato di 140 volte con i contributi
successivi: in totale, 2 milioni e 803 mila euro. Sul sito compaiono solo tre
sostenitori sopra quota centomila: il finanziere Davide Serra (175), il defunto
imprenditore Guido Ghisolfi (125) e la British American Tobacco (100 mila).
Molto inferiori le somme versate da politici come Lotti (9.600), Boschi (8.800)
o il nuovo manager della Rai, Antonio Campo Dell’Orto (solo 250 euro). Ma un
terzo dei finanziatori sono anonimi per un importo di 934 mila euro. Ad Angelino
Alfano invece fa oggi capo la storica fondazione intitolata ad Alcide De
Gasperi, che ha «espresso il suo dissenso» alla richiesta ufficiale della
prefettura di far esaminare i bilanci: per una fondazione presieduta dal
ministro dell’Interno, la trasparenza non esiste. Nell’attuale direttivo
compaiono anche Fouad Makhzoumi, l’uomo più ricco del Libano, titolare del
colosso del gas Future Pipes Industries. Tra gli italiani, Vito Bonsignore, l’ex
politico che dopo una condanna per tangenti è diventato un ricco uomo d’affari;
il banchiere Giovanni Bazoli, il marchese Alvise Di Canossa, il manager Carlo
Secchi, l’ex dc Giuseppe Zamberletti, l’ex presidente della Compagnia delle
Opere Raffaello Vignali, l’avvocato Sergio Gemma e il professor Mauro Ronco. Ma
tutti i contributi alla causa di Alfano sono top secret. Invece la fondazione
Magna Carta è stata costituita dal suo presidente, Gaetano Quagliariello, da un
altro politico, Giuseppe Calderisi, e da un banchiere di Arezzo, Giuseppe
Morbidelli, ora numero uno della Cassa di risparmio di Firenze. Gli altri
fondatori sono tre società: l’assicurazione Sai-Fondiaria, impersonata da Fausto
Rapisarda che rappresenta Jonella Ligresti; la Erg Petroli dei fratelli Garrone;
e la cooperativa Nuova Editoriale di Enrico Luca Biagiotti, uomo d’affari legato
a Denis Verdini. Il capitale iniziale di 300 mila euro è stato interamente
«versato dalle tre società in quote uguali». I politici non ci hanno messo un
soldo, ma la dirigono insieme ai finanziatori. Nel 2013 i Ligresti escono dal
consiglio, dove intanto è entrata Gina Nieri, manager di Mediaset. L’ultimo
verbale (giugno 2015) riconferma l’attrazione verso le assicurazioni, con il
manager Fabio Cerchiai, e il petrolio, con Garrone e il nuovo consigliere
Gianmarco Moratti. La fondazione pubblica i bilanci, ma non rivela chi l’ha
sostenuta: in soli due anni, un milione di finanziamenti anonimi. La Nuova
Italia di Gianni Alemanno invece non esiste più. “L’Espresso” ha scoperto che il
23 novembre scorso la prefettura di Roma ne ha decretato lo scioglimento: «la
fondazione nell’ultimo anno non ha svolto alcuna attività», tanto che «le
raccomandate inviate dalla prefettura alla sede legale e all’indirizzo del
presidente sono tornate al mittente con la dicitura sconosciuto». Ai tempi d’oro
della destra romana sembrava un ascensore per il potere: dei 13 soci promotori,
tutti legati all’ex Msi o An, almeno nove hanno ottenuto incarichi dal ministero
dell’agricoltura o dal comune capitolino. All’inizio Gianni Alemanno e sua
moglie Isabella Rauti figurano solo nel listone dei 449 «aderenti» chiamati a
versare «contributi in denaro». I primi soci sborsano il capitale iniziale di
250 mila euro. Tra gli iscritti compaiono tutti i fedelissimi poi indagati o
arrestati, come Franco Panzironi, segretario e gestore, Riccardo Mancini,
Fabrizio Testa, Franco Fiorito e altri. La “Fondazione della libertà per il bene
comune” è stata creata dal senatore ed ex ministro Altero Matteoli assieme ad
altre dieci persone, tra cui politici di destra come Guglielmo Rositani (ex
parlamentare e consigliere Rai), Eugenio Minasso, Marco Martinelli e Marcello De
Angelis. A procurare i primi 120 mila euro, però, sono anche soci in teoria
estranei alla politica, come l’ex consigliere dell’Anas Giovan Battista Papello
(15 mila), il professor Roberto Serrentino (10 mila) e l'imprenditore, Erasmo
Cinque, che versa 20 mila euro come Matteoli. La fondazione, gestita dal
tesoriere Papello, pubblica i bilanci: tra il 2010 e il 2011, in particolare,
dichiara di aver incassato 374 mila euro dai «soci fondatori», altri 124 mila di
«contributi liberali» e solo duemila dalle proprie attività (convegni e
pubblicazioni). Gli atti della prefettura però non spiegano quali benefattori li
abbiano versati. Espressione di Massimo D'Alema, ItalianiEuropei nel 1999 è
stata una delle prime fondazioni. I fondatori sono l'ex premier Giuliano Amato,
il costruttore romano Alfio Marchini, il presidente della Lega Cooperative,
Ivano Barberini, e il finanziere esperto in derivati Leonello Clementi. Il
capitale iniziale è di un miliardo di lire (517 mila euro), quasi totalmente
versati da aziende o uomini d’affari: 600 milioni di lire da varie associazioni
di cooperative rosse, 50 ciascuno da multinazionali come Abb ed Ericsson, la
Pirelli di Tronchetti Provera, l’industriale farmaceutico Claudio Cavazza, oltre
che da Marchini (50) e Clementi (55). ItalianiEuropei deposita regolari bilanci
e ha autorizzato la prefettura di Roma a mostrarli. L’ultimo è del 2013. Gli
atti identificano solo i finanziatori iniziali del 1998. A quei 517 mila euro,
però, se ne sono aggiunti altri 649 mila sborsati da «nuovi soci», non
precisati. Nei bilanci inoltre compare una diversa categoria di «contributi alle
attività» o «per l’esercizio»: in totale in sei anni i finanziamenti ammontano a
un milione e 912 mila euro. Italia Protagonista nasce nel 2010 per volontà di
due leader della destra: Maurizio Gasparri, presidente, e Ignazio La Russa,
vicepresidente. Tra i fondatori, che versano 7 mila euro ciascuno, c’è un
ristretto gruppo di politici e collaboratori, ma anche un manager, Antonio
Giordano. Dopo la fine di An, però, La Russa e i suoi uomini escono e la
fondazione resta un feudo dell’ex ministro Gasparri. Come direttore compare un
missionario della confraternita che s’ispira al beato La Salle, Amilcare
Boccuccia, e come vice un suo confratello spagnolo. Tra i soci viene ammesso
anche Alvaro Rodriguez Echeverria, esperto e uditore del sinodo 2012 in
Vaticano, nonché fratello dell’ex presidente del Costarica. L’ultimo bilancio
riguarda il 2013, quando il capitale, dai 100 mila euro iniziali, è ormai salito
a 231 mila. Le donazioni di quell’anno, 56 mila euro, non sono bastate a coprire
le spese, con perdite finali per 63 mila, però in banca ci sono 156 mila euro di
liquidità. Ma sui nomi dei benefattori, zero informazioni. «Quello che è
assolutamente inaccettabile è l’assenza di una regolamentazione che quanto meno
adegui le fondazioni alle regole dei partiti politici», dichiara
Raffaele Cantone a “l'Espresso” :
«Fermo restando che la riforma Letta sulla pubblicità ai partiti si è rivelata
inadeguata, perché il sistema delle verifiche è assolutamente ridicolo, ma
almeno ha introdotto un meccanismo di controllo. Sulle fondazioni invece c’è
totale anarchia: non si possono conoscere entrate e uscite, non c’é trasparenza
sui finanziatori».
«Non si possono conoscere
entrate e uscite, non c’é trasparenza sui finanziatori. I conti delle fondazioni
possono essere fatti in modo semplicistico e semplificato, senza rendere noto
come arrivano i soldi e come vengono spesi», scrive Gianluca De Feo il 7 gennaio
2016 su "L'Espresso". «È una situazione che ha raggiunto i limiti
dell’indecenza». Un anno fa Raffaele Cantone fu il primo a lanciare l’allarme
sui fondi opachi trasferiti alla politica attraverso le fondazioni. Con
un’intervista a “l’Espresso” il presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione sottolineò il problema della carenza di controlli. Negli ultimi
mesi le indagini hanno poi evidenziato altri sospetti sui soldi passati
attraverso questi canali per finanziare l’attività dei partiti.
Raffaele Cantone, ma da allora è cambiato qualcosa?
«Non è cambiato nulla. Ma
questo più che un finanziamento ai partiti è un modo di sovvenzionare gruppi
interni ai partiti, quelle che un tempo si chiamavano correnti. Nel tempo le
correnti si sono organizzate in realtà di tipo associativo: questa scelta
potrebbe essere positiva, perché in qualche modo dà una struttura evidente alle
correnti. Quello che è assolutamente inaccettabile è l’assenza di una
regolamentazione che quanto meno adegui le fondazioni alle regole dei partiti
politici. Fermo restando che la riforma Letta sulla pubblicità ai partiti si è
rivelata inadeguata, perché il sistema delle verifiche è assolutamente ridicolo,
ma almeno ha introdotto un meccanismo di controllo. Sulle fondazioni invece c’è
totale anarchia. Viene previsto solo il controllo formale e generico delle
prefetture, che non hanno capacità di incidere sui bilanci: non si possono
conoscere entrate e uscite, non c’é trasparenza sui finanziatori. I conti delle
fondazioni possono essere fatti in modo semplicistico e semplificato, senza
rendere noto come arrivano i soldi e come vengono spesi».
Molte di queste fondazioni politiche sono semplici associazioni,
che non depositano neppure una minima documentazione.
«Bisogna tenere presente che
nel nostro Paese per ragioni culturali queste realtà sono state un momento
significativo della libertà di associazione. Nel diritto civile sono previste le
associazioni non riconosciute, tutelate perché si tutela la libertà di
associazione, che devono avere una loro possibilità di operare. Il problema è
che in questi casi viene a mancare persino quel minimo di controllo esercitato
dalle prefetture: sono in tutto uguali a una bocciofila. Non ci sono né regole,
né rischi legali quando vengono usate per incassare finanziamenti sospetti:
possono solo incorrere in verifiche fiscali della Guardia di Finanza se emergono
pagamenti in nero. È una carenza normativa che si fa sentire e più volte il
Parlamento ha espresso esigenza di intervenire. Sono stati presentati diversi
disegni di legge, alcuni dei quali validi, ma non sono mai andati in
discussione».
Negli organi che gestiscono le fondazioni politiche c’è poi una
diffusa commistione tra centinaia di imprenditori e di politici. È una
confusione che può alimentare i conflitti di interesse?
«In sé non è un aspetto
deleterio. Che ci sia un legame nelle attività delle fondazioni tra chi svolge
politica attiva e chi si occupa di attività economiche, imprenditoriali e
professionali, non è un dato atipico delle moderne democrazie. Anzi, avviene in
tutte le democrazie occidentali. Il problema è che i potenziali conflitti di
interesse possono essere contrastati o attenuati solo attraverso meccanismi di
trasparenza. Se l’imprenditore Tizio finanzia la fondazione del politico Caio e
questo dato è noto, come avviene ad esempio negli Usa, questo sterilizza il
conflitto d’interessi perché quando si discuterà di provvedimenti che riguardano
l’imprenditore Tizio, direttamente o indirettamente, tutti potranno rendersi
conto dei legami. Quello che è grave è l’assenza di pubblicità nel modo in cui
le due situazioni si interfacciano all’interno delle fondazioni».
Alfano nasconde i soldi
perfino ai suoi prefetti.
La
Fondazione presieduta dal ministro non pubblica l'elenco dei finanziatori. E il
dg Rai è sponsor di Renzi, scrive
Paolo Bracalini Sabato,
09/01/2016, su “Il Giornale”.
Un investimento da appena 250 euro che ne rende ogni anno 650mila (di
stipendio), un posto di assoluto comando nella tv pubblica e prima ancora il Cda
di Poste italiane. In epoca di rendimenti bassi o negativi, l'investimento di
Antonio Campo Dall'Orto è da manuale di finanza. Il nuovo direttore generale
della Rai ha donato 250 euro alla Fondazione Open, la cassaforte renziana,
entrando così nel cerchio ristretto degli amici dell'ex sindaco di Firenze, che
poi da premier ha ricambiato quelli che aveva creduto in lui nominandoli nelle
partecipate pubbliche. Dall'Orto è uno dei molti finanziatori «in chiaro» della
fondazione guidata da Maria Elena Boschi, Luca Lotti e Marco Carrai. I donatori,
cioè, che hanno dato il consenso alla pubblicazione dei propri nomi nell'elenco
dei finanziatori del think tank legato a Renzi.Ma c'è una zona grigia. Sui
2.803.953,49 euro raccolti dalla Open, infatti, quasi un terzo (913mila euro)
arriva da ignoti sostenitori del renzismo che preferiscono restare anonimi. E
nemmeno tirando in ballo le prefetture, che per legge vigilano (poco) su enti di
diritto privato come le fondazioni, si riesce a sapere di più. Il test lo ha
fatto l'Espresso, contattando via mail sette prefetti di altrettanti città
italiane (da Roma a Napoli) dove hanno sede le associazioni politiche
espressione di qualche leader o presunto tale. Ma anche l'intervento dello
Stato, nella figura del prefetto, non sembra illuminare granché di quella zona
d'ombra che nasconde le modalità di finanziamento delle fondazioni. Il paradosso
è che persino quella che fa capo ad Angelino Alfano, ministro dell'Interno e
dunque riferimento istituzionale dei prefetti, «esprime dissenso» alla richiesta
di fornire bilanci e informazioni sulla Fondazione De Gasperi, presieduta
appunto dal leader di Ncd e capo del Viminale. L'unico patrimonio tracciabile
risale all'eredità della vecchia Dc, 400 milioni di lire, passati alla
fondazione intitolata al grande statista democristiano. Il resto dei
finanziatori si può solo immaginare guardando i membri del consiglio di
amministrazione (Bazoli di Intesa San Paolo, il miliardario libanese Makhzoumi
Fouad...), visto che la fondazione del ministro non si rende trasparente ai
prefetti. E donatori ne servono, visto che anche il 5 per mille per
l'associazione di Alfano è andato molto male: l'ultima volta solo 59
contribuenti hanno espresso la preferenza nella dichiarazioni dei redditi, per
complessivi 6.700 euro. Spiccioli. Di fondazioni politiche ce n'è un centinaio,
ma le più importanti (e ricche) sono una ventina. Ricevono fondi ministeriali,
accedono al 5 per mille, hanno sgravi fiscali, a differenza dei partiti possono
ricevere donazioni da aziende pubbliche - munifici colossi come Eni,
Finmeccanica, Poste - e non devono rendere pubblici i bilanci. Tanti vantaggi
che ne spiegano la proliferazione. Una di quelle storiche è ItalianiEuropei di
Massimo D'Alema. Quando nasce, nel 1999, viene innaffiata di soldi da
cooperative rosse, grosse multinazionali, colossi della farmaceutica. La
fondazione dell'ex premier Ds ha autorizzato la prefettura a rendere pubblici i
suoi bilanci. Dai quali, però, non si ricavano le informazioni complete sui
finanziatori. In totale dai rendiconti fino al 2013 risultano quasi 2 milioni di
euro di donazioni, registrate genericamente come «contributi all'attività» da
«nuovi soci». Ma quali siano i loro nomi non è dato saperlo.
Figuraccia italiana nella visita a Riad: rissa per il Rolex regalato a Renzi &
C. I 50 membri della delegazione si sono azzuffati per i regali offerti dalla
famiglia reale. Il premier li fa sequestrare ma a Palazzo Chigi non sono ancora
arrivati,
scrive
TGCOM il 9 gennaio 2016.
Monta la polemica per il viaggio diplomatico e commerciale compiuto da Matteo
Renzi e una delegazione politico-economica in Arabia Saudita l'8 novembre 2015.
E non c'entrano gli appalti
miliardari o
la crisi internazionale con l'Iran a causa delle esecuzioni capitali compiute da
Riad. Il problema sono i Rolex, i regali che i ricchi sauditi avevano preparato
per alcuni membri della delegazione italiana ma che alla fine tutti avrebbero
preteso. Stando alle indiscrezioni di stampa questi Rolex non è chiaro che fine
abbiano fatto. E' il Fatto Quotidiano a ricostruire la vicenda: i 50 ospiti
arrivati da Roma (tra cui vertici di aziende statali e non come Finmeccanica,
Impregilo e Salini) sono a cena con la famiglia reale. Arrivano gli omaggi
preparati dagli sceicchi, pacchettini con nomi e cognomi, in italiano e arabo.
C'è il pacchettino di serie A, con il Rolex svizzero, e quello, diciamo, di
serie B con un cronografo prodotto a Dubai che vale "solo" 4mila euro. Il
fattaccio avviene quando un furbetto della delegazione italiana scambia il suo
cronografo arabo col pacchetto luccicante svizzero. Il "proprietario" del Rolex
se ne accorge e scoppia una quasi rissa. Tutti vogliono il Rolex, i reali
sauditi sarebbero anche pronti a cambiare tutti i regali pur di non vedersi di
fronte questa scena da mercato del pesce. Ma interviene la security di Renzi che
sequestra tutti i pacchetti. Ora,
denuncia il Fatto Quotidiano, di questi orologi si è persa traccia. Va ricordato
che il governo di Mario Monti varò una norma che impedisce ai dipendenti
pubblici di accettare omaggi del valore superiore a 150 euro. I Rolex e gli
altri cadeau avrebbero dovuto essere depositati nella stanza dei regali al terzo
piano di Palazzo Chigi. Ma qui non si trovano. Interpellata
sul caso, Ilva Saponara, padrona del cerimoniale di Palazzo Chigi, non risponde,
dice di avere la febbre e di non ricordare nemmeno il contenuto dei doni offerti
dai sauditi. Anche l’ambasciatore Armando Varricchio, consigliere per l'estero
di Renzi, non parla ma annuisce di fronte alla ricostruzione del caso. Non dice
che fine hanno fatto i Rolex ma rassicura: "I doni di rappresentanza ricevuti
dalla delegazione istituzionale italiana, in occasione della recente visita
italiana in Arabia Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del
Consiglio, secondo quello che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi
casi, dello scambio dei doni se ne occupa il personale della presidenza del
Consiglio e non le cariche istituzionali". Se ne deduce che qualcuno ancora non
ha restituito il Rolex in questione. E chissà se mai lo farà.
Governo in visita in Arabia
Saudita. La missione finisce in rissa per i Rolex in regalo.
Durante la trasferta a Ryad dello scorso novembre, i delegati italiani si sono
accapigliati per dei cronografi da migliaia di euro, un omaggio dei sovrani
sauditi. Per questo la delegazione del premier li ha sequestrati. Nota di
Palazzo Chigi: "Sono nella nostra disponibilità", scrive Carlo Tecce l'8 gennaio
2016 su "Il Fatto Quotidiano". Parapiglia tra dirigenti del governo in viaggio
con Matteo Renziper i Rolex elargiti dagli amici di Ryad. Questo racconto,
descritto da testimoni oculari, proviene dall’Arabia Saudita. È una grossa
figuraccia internazionale per l’Italia. È ormai la notte tra domenica 8 e lunedì
9 novembre. Il palazzo reale di Ryad è una fonte di luce che illumina la
Capitale saudita ficcata nel deserto. La delegazione italiana, che accompagna
Matteo Renzi in visita ai signori del petrolio, è sfiancata dal fuso orario e
dal tasso d’umidità. La comitiva di governo è nei corridoi immensi con piante e
tende vistose, atmosfera ovattata, marmi e dipinti. Gli italiani vanno a
dormire. Così il cerimoniale di Palazzo Chigi, depositario degli elenchi e dei
protocolli di una trasferta di Stato, prima del riposo tenta di alleviare le
fatiche con l’inusuale distribuzione dei regali. Quelli che gli oltre 50 ospiti
di Roma – ci sono anche i vertici di alcune aziende statali (Finmeccanica) e
private (Salini Impregilo) – hanno adocchiato sui banchetti del salone per la
cena con la famiglia al trono: deliziose confezioni col fiocco, cognome scritto
in italiano e pure in arabo. Gli illustri dipendenti profanano la direttiva di
Mario Monti: gli impiegati pubblici di qualsiasi grado devono rifiutare
gli omaggi che superano il valore di 150 euro oppure consegnarli subito agli
uffici di competenza. Qui non si tratta di centinaia, ma di migliaia di euro.
Perché i sovrani sauditi preparano per gli italiani dei pacchetti con orologi
preziosi: avveniristici cronografi prodotti aDubai, con il prezzo che oscilla
dai 3.000 ai 4.000 euro e Rolex robusti, per polsi atletici, che sforano decine
di migliaia di euro, almeno un paio. A Renzi sarà recapitato anche un cassettone
imballato, trascinato con il carrello dagli inservienti. Il cerimoniale sta per
conferire i regali. Il momento è di gioia. Ma un furbastro lo rovina. Desidera
il Rolex. Scambia la sua scatoletta con il pacchiano cronografo con quella
dell’ambito orologio svizzero e provoca un diverbio che rimbomba nella residenza
di re Salman. Tutti reclamano il Rolex. Per sedare la rissa interviene la scorta
di Renzi: sequestra gli orologi e li custodisce fino al ritorno a Roma. La
compagine diplomatica, guidata dall’ambasciatore Armando Varricchio, inorridisce
di fronte a una scena da mercato di provincia per il chiasso che interrompe il
sonno dei sauditi. Anche perché i generosi arabi sono disposti a reperire presto
altri Rolex pur di calmare gli italiani. Non sarà un pezzo d’oro a sfaldare i
rapporti tra Ryad e Roma: ballano miliardi di euro di appalti, mica affinità
morali. Nonostante le decapitazioni di Capodanno, tra cui quella dell’imam
sciita che scatena la furia dell’Iran, per gli italiani Ryad resta una meta
esotica per laute commesse. E che sarà mai una vagonata di Rolex? Il guaio è che
degli orologi, almeno durante le vacanze natalizie, non c’era più traccia a
Palazzo Chigi. Non c’erano nella stanza dei regali al terzo piano. Chi avrà
infranto la regola Monti e chi l’avrà rispettata? E Renzi ce l’ha o non ce l’ha,
il Rolex? La dottoressa Ilva Sapora, la padrona del cerimoniale di Palazzo
Chigi, non rammenta il contenuto dei doni. Ha la febbre e poca forza per
rovistare nella memoria. Varricchio ascolta le domande e la ricostruzione dei
fatti di Ryad: annuisce, non replica. Varricchio è il consigliere per l’estero
di Renzi, nonché il prossimo ambasciatore italiano a Washington. Allora merita
un secondo contatto al telefono. Non svela il destino del Rolex che ha ricevuto,
ma si dimostra comprensivo: “I cittadini devono sapere. Queste vicende meritano
la massima attenzione. Le arriverà una nota di Palazzo Chigi. Che la voce sia
univoca”. Ecco la voce del governo, che non smentisce niente, che non assolve la
Sapora, ma precisa i ruoli: “I doni di rappresentanza ricevuti dalla delegazione
istituzionale italiana, in occasione della recente visita italiana in Arabia
Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, secondo quello
che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi casi, dello scambio dei
doni se ne occupa il personale della presidenza del Consiglio e non le cariche
istituzionali”. Il racconto non finisce. Cos’è accaduto dopo la notte di Ryad?
Chi non voleva restituire o non ha ancora restituito i Rolex? Da
Il Fatto Quotidiano di venerdì 8 gennaio 2016.
Renzi, Caporale vs Fiano
(Pd): “Ci fu rissa tra dirigenti per Rolex regalati dai sauditi”. “Scena
ignominiosa, ma per me non c’è notizia”,
continua "Il Fatto Quotidiano
tv". Polemica vivace tra Antonello Caporale, inviato de Il Fatto Quotidiano, e
il deputato Pd Emanuele Fiano, durante Omnibus, su La7. Lo scontro è
innescato dall’articolo di Carlo Tecce, pubblicato sul numero odierno del Fatto,
circa il parapiglia esploso nello scorso novembre tra i dirigenti del governo in
viaggio con Matteo Renzi in Arabia Saudita: la rissa tra i dirigenti governativi
della folta delegazione italiana è stata scatenata dalla generosa elargizione di
circa 50 Rolex di varia fattura ad opera del re saudita. Come spiega Caporale
nella trasmissione, nella hall dell’hotel di Ryad alcuni dirigenti italiani si
sono ribellati perché avevano ricevuto l’orologio meno lussuoso, peraltro in
barba alla legge Monti che impone di rifiutare doni oltre i 150
euro. Successivamente la scorta di Renzi ha dovuto sequestrare gli orologi,
tutti prodotti a Dubai e dal valore oscillante tra3mila e 4mila euro. Caporale
commenta: “Temo che la mediocrità del gruppo dirigente e di coloro che
dovrebbero guidare l’Occidente a risolvere questa crisi internazionale sia tale
che anche i dettagli illustrino il pessimismo generale. E questo episodio è un
dettaglio significativo”. Il giornalista definisce il caso dei Rolex d’oro
donati dagli ‘amici di Ryad’ un dettaglio di costume non certo folkloristico:
“E’ indicatore della nostra ambiguità che ovviamente non è solo italiana, e
simboleggia la debolezza dell’Occidente. Che non riesce non solo a porre un’idea
generale cu come far fronte a una guerra così asimmetrica, pericolosa, atipica,
difficile da condurre, ma nemmeno a misurare le forze per far fronte a cose più
banali”. Insorge Fiano, che ribadisce di aver letto l’articolo de Il Fatto
Quotidiano ‘parola per parola': “Qui c’è un grande titolo, ma di notizie certe
non c’è nulla”. “E’ notizia certa che i Rolex siano stati dati”, replica
Caporale. “L’unica fonte che viene citata” – obietta il parlamentare Pd – “è un
consigliere diplomatico di Palazzo Chigi”. “C’è la nota di Palazzo Chigi alla
fine dell’articolo” – ribatte la firma de Il Fatto – “lo legga tutto”. Ma il
deputato Pd, pur definendo “ignominiosa” la rissa descritta nell’articolo di
Tecce, ripete che non c’è notizia, né la nota di Palazzo. In realtà, la versione
del governo c’è e non smentisce nulla, ma precisa i ruoli: “I doni di
rappresentanza ricevuti dalla delegazione istituzionale italiana, in occasione
della recente visita italiana in Arabia Saudita, sono nella disponibilità della
Presidenza del Consiglio, secondo quello che prevedono le norme. Come sempre
avviene in questi casi, dello scambio dei doni se ne occupa il personale della
presidenza del Consiglio e non le cariche istituzionali”.
SOCIETÀ INCIVILE E
RINCOGLIONITA.
Scrive Mario
Vito Torosantucci su
“L’Oservatore d’Italia” il 23/12/2015. Caro italiano, tu non esisti più, e se
esisti, è soltanto una tua convinzione personale, che ti porterà ad essere
sempre più un insignificante burattino. A volte, sembra di sognare, e poi,
quando ti svegli, sei invaso da una strana sensazione di disagio psicofisico che
ti fa star male. Ti guardi intorno, e non riesci bene a realizzare se stai
veramente nel tuo mondo, in quel mondo dove sei cresciuto, dove hai vissuto
momenti indelebili, dove hai imparato dei valori sani della vita, dove si
parlava con il prossimo, si discuteva anche animatamente, ci si divertiva e
avevamo lo stimolo per ridere, essere ottimisti e credere nel futuro. Giri lo
sguardo, sperando di vivere soltanto un brutto sogno, immerso nei pensieri più
deprimenti e pessimisti, cercando di convincerti, che quello che vedi non è la
tua realtà, e che si dissolverà nell’aria come una nuvola passeggera,
dileguandosi, spinta da una folata di vento piena di positività. Quante
illusioni! Basta uscire da casa, e ti accorgi subito, che la realtà è
un’altra, rievocando la torre di Babele, ti immergi istantaneamente in un caos
totale, di ignoranza, maleducazione, cattiveria, inciviltà, aggravata
dall’invasione di popoli non per loro colpa, retrogradi, nel quale si ha
l’impressione, non di iniziare un nuovo giorno con un certo ottimismo, bensì,
con la consapevolezza di andare in guerra, usando un eufemismo appropriato.
Salutare il prossimo, è un’opzione remota, del passato, non più di moda, anche
se si abita nello stesso palazzo, o occupanti dello stesso parcheggio, però, in
compenso ci si guarda in cagnesco, pronti a far esplodere la propria ira al
primo indizio negativo. Il menefreghismo, che regna nella maggioranza della
gente, oltre naturalmente, una forte dose di maleducazione, induce ad aggravare
lo stato di degrado generale che notiamo per le strade. L’ impegno gravoso, per
esempio, di pigiare con il piede il cassonetto, per gettare i rifiuti, spinge il
cittadino comune, a lasciare il sacchetto per terra, oppure bisognerebbe
allargare i fori per la plastica, perché, sempre il cittadino comune, non può
perdere tempo a gettare le bottiglie singolarmente, cosicchè è costretto ad
incastrare l’intero involucro delle sue bottiglie, lasciando il suo lavoro al
prossimo imbecille, che se non vuole accollarsi il lavoro superfluo altrui,
lascia il tutto tranquillamente per terra. Camminare sui marciapiedi, è
diventato difficile, e per una mamma che spinge il carrozzino, l’impresa è
ancora più ardua, perché non c’è lo spazio necessario. Infatti fra escrementi di
cani, foglie cadute dagli alberi, particolarmente abbondanti in questo periodo,
cespugli che crescono a vista d’occhio, e, dulcis in fundo, le auto parcheggiate
con le ruote sui marciapiedi, la gimcana con il complementare pericolo, è
d’obbligo per i poveri pedoni. Guai a reclamare con qualcuno, perché il minimo
che può capitare è di finire in ospedale, e spesso si è offesi ed umiliati e si
è costretti ad andare via, covando dentro di sé quella rabbia, che pian piano ci
mangerà il fegato. Osservare le regole nel nostro amabile paese, è diventato un
rischio, infatti se per esempio, in auto rispetti i limiti di velocità, fra
l’altro, non si sa con quale criteri siano stati stabiliti, puoi essere
tamponato e susseguentemente malmenato da chi ti è venuto addosso, per intralcio
nel traffico, oppure decidi di accelerare, e così ti prendi una bella multa, per
avere superato il limite di velocità. E’ soltanto una questione di scelte
soggettive. Discutere con il prossimo, specialmente se è un extracomunitario, è
pericolosissimo, perché le armi da taglio abbondano, se non si tira fuori anche
qualche pistola, ma le forze dell’ordine, da capire, per una questione di
privacy, non possono fermarli e perquisirli, perché li offenderebbero. Gloria ai
giudici, che per spirito di giustizia, puniscono i cittadini onesti, che
vogliono per forza difendersi, quando capita di essere aggrediti in casa
propria, malmenati, e derubati dei propri sacrifici. Onore ai politici, che
invece di cambiare un’innumerevole quantità di leggi sbagliate, cosa che
potrebbero fare in pochi minuti, si dedicano costantemente ai propri ed
esclusivi interessi. Caro italiano, tu non esisti più, e se esisti, è soltanto
una tua convinzione personale, che ti porterà ad essere sempre più un
insignificante burattino. Una cosa è vera, e bisogna ammetterla; che noi
cittadini, abbiamo un fisico veramente bestiale, come diceva una famosa canzone,
perché sopravvivere in un mondo inquinato nei generi alimentari, prodotti in
campagne che spesso custodiscono scorie chimiche altamente pericolose,
medicinali, che dopo tanto tempo usati, si scopre che sono fortemente tossici, è
la prova che siamo fatti di ferro. Certo! Qualche volta il ferro si fonde, e,
molti sene vanno, ma che importa, il problema si risolve con migliaia di nuovi
profughi che continuamente arrivano. In questo caos, la società moderna ha
trovato il rimedio. Meglio fare come le tre scimmiette, non vedo, non sento, non
parlo, così ci si racchiude in noi stessi, ed il mezzo per farlo è il
telefonino. Grandissima invenzione, che ci consente di telefonare, ma ci regala
altre cose molto più importanti, quella di estraniarci da tutto ciò che ci
circonda, ci fa messaggiare, ci fa fare centinaia di giochini, rendendoci la
vita più piacevole, anche se qualche volta, distrattamente si va a sbattere
contro qualche palo della luce, oppure addosso alle persone, che non riescono a
sparire all’istante. Sui mezzi pubblici il novanta per cento dei passeggeri è
assorto nel mondo del proprio cellulare, per la gioia degli scippatori, che al
contrario sono molto attenti al prossimo. Conclusione, chi ha una certa età in
Italia, oggigiorno, si sente un pesce fuor d’acqua, grazie a questa società
incivile e rincoglionita.
E’ TUTTA QUESTIONE DI
COSCIENZA.
A’ Cuscienza di Antonio de
Curtis-Totò
La coscienza
Volevo sapere che cos'è questa
coscienza
che spesso ho sentito
nominare.
Voglio esserne a conoscenza,
spiegatemi, che cosa
significa.
Ho chiesto ad un professore
dell'università
il quale mi ha detto: Figlio
mio, questa parola si usava, si,
ma tanto tempo fa.
Ora la coscienza si è
disintegrata,
pochi sono rimasti quelli, che
a questa parola erano attaccati,
vivendo con onore e dignità.
Adesso c'è l'assegno a vuoto,
il peculato, la cambiale, queste cose qua.
Ladri, ce ne sono molti di
tutti i tipi, il piccolo, il grande,
il gigante, quelli che sanno
rubare.
Chi li denuncia a questi ?!?
Chi si immischia in questa faccenda ?!?
Sono pezzi grossi, chi te lo
fa fare.
L'olio lo fanno con il sapone
di piazza, il burro fa rimettere,
la pasta, il pane, la carne,
cose da pazzi, Si è aumentata la mortalità.
Le medicine poi, hanno
ubriacato anche quelle,
se solo compri uno sciroppo,
sei fortunato se continui a vivere.
E che vi posso dire di certe
famiglie, che la pelle fanno accapponare,
mariti, mamme, sorelle, figlie
fatemi stare zitto, non fatemi parlare.
Perciò questo maestro di
scuola mi ha detto, questa conoscenza (della coscienza)
perchè la vuoi fare, nessuno
la usa più questa parola,
adesso arrivi tu e la vuoi
ripristinare.
Insomma tu vuoi andare contro
corrente, ma questa pensata chi te l'ha fatta fare,
la gente di adesso solo così è
contenta, senza coscienza,
vuole stentare a vivere. (Vol
tirà a campà)
PRIMA DI ALDO MORO. "PADRI
DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA
NOSTRA ROVINA.
Lettera da Crispi a Garibaldi
- Caprera. Torino, 3 febbraio 1863.
Mio Generale!
Giunto da Palermo, dove stetti poco men che un
mese, credo mio dovere dirvi qualche cosa della povera isola che voi chiamaste a
libertà e che i vostri successori ricacciarono in una servitù peggiore di prima.
Dal nuovo regime quella popolazione nulla ha
ottenuto di che potesse esser lieta. Nissuna giustizia, nissuna sicurezza
personale, l'ipocrisia della libertà sotto un governo, il quale non ha
d'italiano che appena il nome. Ho visitate le carceri e le ho trovate piene
zeppe d'individui i quali ignorano il motivo per il quale sono prigionieri. Che
dirvi del loro trattamento? Dormono sul pavimento, senza lume la notte, sudici,
nutriti pessimamente, privi d'ogni conforto morale, senza una voce che li
consigli e li educhi onde fosser rilevati dalla colpa.
La popolazione in massa detesta il governo
d'Italia, che al paragone trova più tristo del Borbonico. Grande fortuna che non
siamo travolti in quell'odio noi, che fummo causa prima del mutato regime! Essa
ritien voi martire, noi tutti vittime della tirannide la quale viene da Torino e
quindi ci fa grazia della involontaria colpa. Se i consiglieri della Corona non
mutano regime, la Sicilia andrà incontro ad una catastrofe.
E' difficile misurarne le conseguenze, ma esse
potrebbero essere fatali alla patria nostra. L'opera nostra dovrebbe mirare ad
evitare cotesta catastrofe, affinchè non si sfasci il nucleo delle provincie
unite che al presente formano il regno di Italia. Con le forze di questo regno e
coi mezzi ch'esso ci offre, noi potremmo compiere la redenzione della penisola e
occupar Roma. Sciolto cotesto nucleo, è rimandata ad un lontano avvenire la
costituzione d'Italia. Della vostra salute,
alla quale tutti c'interessiamo, ho buone notizie, che spero sempre migliori. Di
Palermo tutti vi salutano come vi amano.
Abbiatevi i complimenti di mia moglie e voi continuatemi il vostro affetto e
credetemi. Vostro ora
e sempre. F. Crispi.
La verità è
rivoluzionaria. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono
incommensurabili. Non credo di aver fatto del male. Nonostante ciò, non rifarei
oggi la via dell'Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate,
essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio. Giuseppe
Garibaldi (da una lettera scritta ad Adelaide Cairoli, 1868)
Cronologia
moderna delle azioni massoniche e mafiose.
27 marzo 1848 -
Nasce la Repubblica Siciliana. La Sicilia ritorna ad essere indipendente,
Ruggero Settimo è capo del governo, ritorna a sventolare l'antica bandiera
siciliana. Gli inglesi hanno numerosi interessi nell'Isola e consigliano al
Piemonte di annettersi la Sicilia. I Savoia preparano una spedizione da affidare
a Garibaldi. Cavour si oppone perchè considera quest'ultimo un avventuriero
senza scrupoli (ricordano impietositi i biografi che Garibaldi ladro di cavalli,
nell' America del sud, venne arrestato e gli venne tagliato l'orecchio destro.
Sarà, suo malgrado, capellone a vita per nascondere la mutilazione) [Secondo
altre fonti l’orecchio gli sarebbe stato staccato con un morso da una ragazza
che aveva cercato di violentare all’epoca della sua carriera di pirata,
stupratore, assassino in America Latina, NdT]. Il nome di Garibaldi, viene
abbinato altresì al traffico di schiavi dall'Africa all'America. Rifornito di
denaro inglese da i Savoia, Garibaldi parte per la Sicilia.
11 maggio 1860 -
Con la protezione delle navi inglesi Intrepid e H.M.S. Argus, Garibaldi sbarca a
Marsala. Scrive il memorialista garibaldino Giuseppe Bandi: I mille vengono
accolti dai marsalesi come cani in chiesa! La prima azione mafiosa è contro la
cassa comunale di Marsala. Il tesoriere dei mille, Ippolito Nievo lamenta che si
trovarono pochi spiccioli di rame. I siciliani allora erano meno fessi! E'
interessante la nota di Garibaldi sull'arruolamento: "Francesco Crispi arruola
chiunque: ladri, assassini, e criminali di ogni sorta".
15 maggio 1860 -
Battaglia di Calatafimi. Passata alla storia come una grande battaglia, fu
invece una modesta scaramuccia, si contarono 127 morti e 111 furono messi fuori
combattimento. I Borbone con minor perdite disertano il campo. Con un esercito
di 25.000 uomini e notevole artiglieria, i Borbone inviano contro Garibaldi
soltanto 2.500 uomini. E' degno di nota che il generale borbonico Landi, fu
comprato dagli inglesi con titoli di credito falsi e che l'esercito borbonico
ebbe l'ordine di non combattere. Le vittorie di Garibaldi sono tutte una
montatura.
27 maggio 1860 -
Garibaldi entra a Palermo da vincitore!....Ateo, massone, mangiapreti, celebra
con fasto la festa di santa Rosalia.
30 maggio 1860 -
Garibaldi dà carta bianca alle bande garibaldine; i villaggi sono saccheggiati
ed incendiati; i garibaldini uccidevano anche per un grappolo d'uva. Nino Bixio
uccide un contadino reo di aver preso le scarpe ad un cadavere. Per incutere
timore, le bande garibaldine, torturano e fucilano gli eroici siciliani.
31 maggio 1860 -
Il popolo catanese scaccia per sempre i Borbone. In quell'occasione brillò, per
un atto di impavido coraggio, la siciliana Giuseppina Bolognani di Barcellona
Pozzo di Gotto (ME). Issò sopra un carro un cannone strappato ai borbonici e
attese la carica avversaria; al momento opportuno, l'avversario a due passi,
diede fuoco alle polveri; il nemico, decimato, si diede alla fuga disordinata.
Si guadagnò il soprannome Peppa 'a cannunera (Peppa la cannoniera) e la medaglia
di bronzo al valor militare.
2 giugno 1860 -
Con un decreto, Garibaldi assegna le terre demaniali ai contadini; molti
abboccano alla promessa. Intanto nell'Isola divampava impetuosa la rivoluzione
che vedeva ancora una volta il Popolo Siciliano vittorioso. Fu lo stesso popolo
che unito e compatto costrinse i borbonici alla ritirata verso Milazzo.
17 luglio 1860 -
Battaglia di Milazzo. Il governo piemontese invia il Generale Medici con 21.000
uomini bene armati a bordo di 34 navi. La montatura garibaldina ha fine. I
contadini siciliani si ribellano, vogliono la terra promessagli. Garibaldi,
rivelandosi servo degli inglesi e degli agrari, invia loro Nino Bixio.
10 agosto 1860 -
Da un bordello di Corleone, Nino Bixio ordina il massacro di stampo mafioso di
Bronte. Vengono fucilati l'avvocato Nicolò Lombardo e tre contadini, tra i quali
un minorato! L'Italia mostra il suo vero volto.
21 ottobre 1860
- Plebiscito di annessione della Sicilia al Piemonte. I voti si depositano in
due urne: una per il "Sì" e l'altra per il "No". Intimorendo, come abitudine
mafiosa, ruffiani, sbirri e garibaldini controllano come si vota. Su una
popolazione di 2.400.000 abitanti, votarono solo 432.720 cittadini (il 18%). Si
ebbero 432.053 "Sì" e 667 "No". Giuseppe Mazzini e Massimo D'Azeglio furono
disgustati dalla modalità del plebiscito. Lo stesso ministro Eliot, ambasciatore
inglese a Napoli, dovette scrivere testualmente nel rapporto al suo Governo che:
"Moltissimi vogliono l'autonomia, nessuno l'annessione; ma i pochi che votano
sono costretti a votare per questa". E un altro ministro inglese, Lord John
Russel, mandò un dispaccio a Londra, cosí concepito: "I voti del suffragio in
questi regni non hanno il minimo valore".
1861 - L'Italia
impone enormi tasse e l'obbligo del servizio militare, ma per chi ha soldi e
paga, niente soldato. Intanto i militari italiani, da mafiosi, compiono atrocità
e massacri in tutta l'Isola. Il sarto Antonio Cappello, sordomuto, viene
torturato a morte perchè ritenuto un simulatore, il suo aguzzino, il colonnello
medico Restelli, riceverà la croce dei "S.S. Maurizio e Lazzaro". Napoleone III
scrive a Vittorio Emanuele: "I Borbone non commisero in cento anni, gli orrori e
gli errori che hanno commesso gli agenti di Sua Maestà in un anno”.
1863 - Primi
moti rivoluzionari antitaliani di pura marca indipendentista. Il governo
piemontese instaura il primo stato d'assedio. Viene inviato Bolis per massacrare
i patrioti siciliani. Si prepara un'altra azione mafiosa contro i Siciliani.
8 maggio 1863 -
Lord Henry Lennox denuncia alla camera dei Lords le infamie italiane e ricorda
che non Garibaldi ma l'Inghilterra ha fatto l'unità d'Italia.
15 agosto 1863 -
Secondo stato d'assedio. Si instaura il terrore. I Siciliani si rifiutano di
indossare la divisa italiana; fu una vera caccia all'uomo, le famiglie dei
renitenti furono torturate, fucilate e molti furono bruciati vivi. Guidava
l'operazione criminale e mafiosa il piemontese Generale Giuseppe Govone. (Nella
pacifica cittadina di Alba, in piazza Savona, nell'aprile 2004 è stato
inaugurato un monumento equestre a questo assassino. Ignoriamo per quali
meriti.)
1866 - In
Sicilia muoiono 52.990 persone a causa del colera. Ancora oggi, per tradizione
orale, c'è la certezza che a spargervi il colera nell'Isola siano state persone
legate al Governo italiano. Intanto tra tumulti, persecuzioni, stati d'assedio,
terrore, colera ecc. la Sicilia veniva continuamente depredata e avvilita; il
Governo italiano vendette perfino i beni demaniali ed ecclesiastici siciliani
per un valore di 250 milioni di lire. Furono, nel frattempo, svuotate le casse
della regione. Il settentrione diventava sempre più ricco, la Sicilia sempre più
povera.
1868 - Giuseppe
Garibaldi scrive ad Adelaide Cairoli:"Non rifarei la via del Sud, temendo di
essere preso a sassate!". Nessuna delle promesse che aveva fatto al Sud (come
quella del suo decreto emesso in Sicilia il 2 giugno 1860, che assegnava le
terre comunali ai contadini combattenti), era stata mantenuta.
1871 - Il
Governo, con un patto scellerato, fortifica la mafia con l'effettiva connivenza
della polizia. Il coraggioso magistrato Diego Tajani dimostrò e smascherò questa
alleanza tra mafia e polizia di stato e spiccò un mandato di cattura contro il
questore di Palermo Giuseppe Albanese e mise sotto inchiesta il prefetto, l'ex
garibaldino Gen. Medici. Ma il Governo italiano, con fare mafioso si schiera
contro il magistrato costringendolo a dimettersi.
1892 - Si
formano i "Fasci dei Lavoratori Siciliani". L'organizzazione era pacifica ed
aveva gli ideali del popolo, risolvere i problemi siciliani. Chiedeva,
l'organizzazione dei Fasci la partizione delle terre demaniali o incolte, la
diminuzione dei tassi di consumo regionale ecc.
4 gennaio 1894 -
La risposta mafiosa dello stato italiano non si fa attendere: STATO D'ASSEDIO.
Francesco Crispi, (definito da me traditore dei siciliani a perenne vergogna dei
riberesi) presidente del Consiglio, manda in Sicilia 40.000 soldati al comando
del criminale Generale Morra di Lavriano, per distruggere l'avanzata impetuosa
dei Fasci contadini. All'eroe della resistenza catanese Giuseppe De Felice
vengono inflitti 18 anni di carcere; fu poi amnistiato nel 1896, ricevendo
accoglienze trionfali nell'Isola.
Note di "Sciacca
Borbonica": Sono molti i paesi del mondo che dedicano vie, piazze e strade a
lestofanti e assassini. Ma pochi di questi paesi hanno fatto di un pirata
macellaio addirittura il proprio eroe nazionale. Il 27 luglio 1995 il
giornale spagnolo "El Pais", giustamente indignato per l’apologia di Garibaldi
fatta dall’allora presidente Scalfaro (quello che si prendeva 100 milioni al
mese in nero dal SISDE, senza che nessuno muovesse un dito) nel corso di una
visita in Spagna, così gli rispose a pag. 6: “Il presidente d'Italia è stato
nostro illustre visitante...... Disgraziatamente, in un momento della sua
visita, il presidente italiano si è riferito alla presenza di Garibaldi nel Rio
della Plata, in un momento molto speciale della storia delle nazioni di questa
parte del mondo. E, senza animo di riaprire vecchie polemiche e aspre
discussioni, diciamo al dott. Scalfaro che il suo compatriota [Garibaldi] non ha
lottato per la libertà di queste nazioni come egli afferma. Piuttosto il
contrario". Il 13 settembre 1860, mentre l'unificazione italiana era in pieno
svolgimento, il giornale torinese Piemonte riportava il seguente articolo.
(1): «Le imprese di Garibaldi nelle Due Sicilie parvero sin da allora così
strane che i suoi ammiratori ebbero a chiamarle prodigiose. Un pugno di giovani
guidati da un audacissimo generale sconfigge eserciti, piglia d'assalto le città
in poche settimane, si fa padrone di un reame di nove milioni di abitanti. E ciò
senza navigli e senz'armi... Altro che Veni, Vedi, Vici! Non c'è Cesare che
tenga al cospetto di Garibaldi. I miracoli però non li ha fatti lui ma li fecero
nell'ordine: 1°)-L'oro con il quale gli inglesi comprarono quasi tutti i
generali borbonici e col quale assoldarono 20.000 mercenari ungheresi e slavi e
pagarono il soldo ad altri 20.000 tra carabinieri e bersaglieri, opportunamente
congedati dall'esercito sardo-piemontese e mandati come "turisti" nel Sud, altro
che i 1000 scalcinati eroi...... 2°)-il generale Nunziante ed altri tra
ufficiali dell'esercito e della marina che, con infinito disonore, disertarono
la loro bandiera per correre sotto quella del nemico eccovi servito un piccolo
elenco di traditori al soldo degli anglo-piemontesi, oltre al
Nunziante: Generale Landi, Generale Cataldo, Generale Lanza, Generale Ghio,
Comandante Acton, Comandante Cossovich,ed altri ancora; 3°)-i miracoli li ha
fatti il Conte di Siracusa con la sua onorevolissima lettera al nipote Francesco
II° (lettera pubblicata in un post a parte); 4°)-li ha fatti la Guardia
Nazionale che, secondo il solito, voltò le armi contro il re che gliele avea
date poche ore prima; 5°)-)li ha fatti il Gabinetto di Liborio Romano il quale,
dopo aver genuflesso fino al giorno di ieri appié del trono di Francesco II, si
prostra ai piedi di Garibaldi; 6°)- La quasi totalità della nobiltà siciliana.
Beh, Con questi miracoli ancor io sarei capace di far la conquista, non dico
della Sicilia e del Reame di Napoli, ma dell'universo mondo. Dunque non state a
contare le prodezze di Sua Maestà Garibaldi I. Egli non è che il comodino della
rivoluzione. Le società segrete (la massoneria) che hanno le loro reti in tutto
il paese delle Due Sicilie, hanno di lunga mano preparato ogni cosa per la
rivoluzione. E quando fu tutto apparecchiato si chiamò Garibaldi ad eseguire i
piani [...]. Se non era Garibaldi sarebbe stato Mazzini, Kossuth, Orsini o Lucio
della Venaria: faceva lo stesso. Appiccare il fuoco ad una mina anche un bimbo
può farlo. Di fatto vedete che dappertutto dove giunge Garibaldi la rivoluzione
è organizzata issofatto, i proclami sono belli e fatti, anzi stampati. In questo
modo credo che Garibaldi può tranquillamente fare il giro del mondo a piantare
le bandiere tricolori del Piemonte. Dopo Napoli Roma, dopo Roma Venezia, dopo
Venezia la Dalmazia, dopo la Dalmazia l'Austria, caduta l'Austria il mondo è di
Garibaldi, cioé del Piemonte! Oh che cuccagna! Torino capitale dell'Europa, anzi
dell'orbe terracqueo. Ed i torinesi padroni del mondo!». Dai Savoia agli
Agnelli, da una famiglia di vampiri ad un altra.....per il Sud sempre lo stesso
destino.......dar loro anche l'ultima goccia di sangue. Comunque la Giustizia
Divina arriva sempre........i savoia son finiti nella merda e nel ludibrio, gli
Agnelli nella tomba e nella droga che certamente sarà il mezzo con quale ci
libereremo di questa gente maledetta.
Gli eurobond che fecero
l'Unità d'Italia quando il Regno di Napoli era come la Germania,
scrive
Giuseppe Chiellino il
30 giugno 2012 su “Il Sole 24 Ore”. Il vertice europeo di fine giugno ha
cancellato gli eurobond dall'agenda. Almeno per ora. Angela Merkel è stata
drastica: «Mai finchè sarò viva» aveva detto in pubblico qualche giorno prima.
Chissà se la cancelliera tedesca aveva avuto il tempo di leggere lo studio di
Stéphanie Collet, storica della finanza della Université Libre de Bruxelles che
è andata a spulciare negli archivi delle Borse di Parigi e Anversa per studiare
l'unico precedente assimilabile agli Eurobond: l'unificazione del debito sovrano
dei sette stati che 150 anni orsono, su iniziativa del Piemonte e sotto tutela
di Francia e Inghilterra, costituirono il Regno d'Italia. Nella storia dello
stato moderno è l'esperienza storicamente più vicina al faticosissimo tentativo
di dare maggiore consistenza politica all'Unione europea, anche attraverso
l'integrazione delle politiche economiche e fiscali, compresi debiti sovrani dei
17 paesi dell'euro. Un precedente prezioso, secondo la Collet, per cercare di
capire – mutatis mutandis - come potrebbero comportarsi i mercati finanziari di
fronte all'unificazione del debito pubblico dei paesi della zona euro. «Come
l'Italia di allora, l'Europa oggi è fatta da stati eterogenei, con economie di
dimensioni e condizioni diverse, che parlano lingue diverse e hanno sistemi di
imposizione fiscale separati» ricorda la studiosa. Grazie al fatto che anche
dopo l'unificazione i titoli del Regno d'Italia conservarono fino al 1876
l'indicazione della loro origine (per esempio, ad Anversa le emissioni del Regno
delle Due Sicilie erano indicate come "Italy-Neapolitean") la Collet è riuscita
a ricostruire le serie storiche dei prezzi settimanali tra il 1847 e il 1873. Un
lavoro certosino di raccolta manuale dei dati dagli archivi e dai database
originali per capire come si sono mosse le quotazioni, prima e dopo l'unità,
politica ed economica. 25 emissioni suddivise in quattro gruppi: Regno di
Piemonte e Sardegna, Lombardo-Veneto, Due Sicilie e Stato Pontificio. La prima
cosa che balza agli occhi è lo spread (anche allora!) tra i rendimenti dei
diversi gruppi di bond prima e dopo l'Unità. Quelli del Regno delle Due Sicilie
(che erano un quarto del totale) prima del 1861 pagavano i tassi più bassi:
4,3%, 140 punti base in meno delle emissioni papali e di quelle piemontesi (che
rappresentavano rispettivamente il 29% e il 44% del debito unitario dopo la
conversione) e 160 in meno rispetto a quelle Lombardo-Venete (che però erano
solo il 2%). Insomma, a voler utilizzare le categorie di oggi, il Regno di
Napoli economicamente era per l'Italia quello che oggi la Germania è per
l'Eurozona. «Come il Regno di Napoli prima dell'integrazione del debito sovrano,
la Germania di oggi è l'economia più forte dell'eurozona e beneficia del costo
del debito più basso in assoluto» scrive Collet. Considerazioni, queste, che
faranno storcere il naso a molti, ma sicuramente non di parte. Del resto, come
ricorda Collet, Napoli era di gran lunga la città più importante del neonato
Regno d'Italia. E le regioni del Sud avevano una discreta struttura industriale,
un'agricoltura fiorente sia pure basata sul latifondismo, e importanti porti
commerciali. Subito dopo il 1861, però, lo scettiscismo dei mercati nel processo
unitario italiano impose un "risk premium" comune a tutti i bond degli stati
preunitari, anche a quelli che fino a quel momento avevano goduto di maggiore
fiducia e dunque di rendimenti più bassi. Proprio quello che oggi la Germania
teme possa avvenire con gli eurobond: l'anno successivo, infatti, i rendimenti
dei titoli convertiti in "Regno d'Italia" si allinearono ben al di sopra dei
tassi precedenti, al 6,9%. Per gli "Italy – Neapolitean" 260 punti base in più
che diventarono 460 nel 1870, per poi cominciare a ripiegare dopo il 1871,
quando cioè l'annessione di Venezia e di Roma e il trasferimento della capitale
nella città del papato convinsero gli investitori, e non solo, che l'Unità era
ormai irreversibile. L"Italia" non era più una mera "espressione geografica",
come l'aveva definita Metternich nel 1847, ma dopo tre guerre d'indipendenza e
più di vent'anni di manovre diplomatiche era diventata uno stato unitario.
«L'integrazione dei debiti sovrani era stato uno strumento per portare avanti
l'integrazione politica, come sarebbe oggi per l'Europa» afferma Collet, ma nota
anche che «un aumento del premio di rischio aggraverebbe la crisi del debito che
sta vivendo l'Europa piuttosto che risolverla. Significherebbe che, se fossero
introdotti gli eurobond, la Germania perderebbe il suo rating elevato». Questo
portava Collet a definire, già nei mesi scorsi, «remote» le speranze di vedere
nel breve termine un mercato integrato dei titoli di debito dell'eurozona. Nel
lungo termine, invece, i risultati della ricerca sul caso italiano dimostrano
che «nel tempo i rendimenti dei titoli diminuirono». Alla luce di questo, oggi
la domanda è: quanto tempo ci vorrà perché anche l'Europa sia considerata come
un blocco unico e in grado di dotarsi di un vero e proprio piano di salvataggio
per l'euro? Per l'Italia ci volle all'incirca un decennio. Considerato che
quella italiana fu un'annessione anche militare e quella europea è
un'integrazione consensuale, e che i mercati dei capitali si muovono a ritmi
diversi rispetto alla seconda metà dell'800, anche Collet concorda che un
aumento del costo del debito nel breve termine sarebbe un prezzo che potremmo
permetterci di pagare se avessimo la certezza di avere, tra qualche anno,
un'Europa più unita. Ma questa certezza nessuna ricerca, per quanto accurata,
potrà mai darla. Serve, forse, la capacità di andare oltre il breve periodo, di
guardare un po' più lontano rispetto alla prossima scadenza elettorale,
superando la "veduta corta" che per Tommaso Padoa Schioppa è stata «la radice»
della crisi.
Gli italiani? Sono fascisti
dentro. Il
nuovo libro di Tommaso Cerno in uscita in questi giorni, racconta come la
mentalità del Ventennio sia ancora oggi diffusa nella politica, nella società,
nella cultura del nostro Paese, scrive Tommaso Cerno il 20 novembre 2015 su
“L’Espresso”.
Pubblichiamo l’introduzione del libro di Tommaso Cerno, “A noi”, in libreria dal
20 novembre (Rizzoli, pp. 310, € 19). Si dice che un bambino nasca con la
camicia, quando viene alla luce avvolto nel sacco amniotico. Quel sacco sembra
un abito, cucito addosso durante i nove mesi dentro il ventre di mamma. E noi di
chi siamo figli? L’Italia in cui viviamo, l’Italia del nostro Ventennio, quello
che chiamiamo l’epoca di Berlusconi e Renzi, è nata con la camicia? Proviamo ad
azzardare un’ipotesi: l’Italia è nata con la camicia nera. Proprio così,
fasciata nel sacco amniotico del fascismo, da cui cerca a fatica di liberarsi da
settant’anni, senza riuscirci davvero. Nel dopoguerra la retorica antifascista
può avere dato l’impressione di un taglio netto con i vent’anni precedenti, ma
come il “politicamente corretto” non cancella il razzismo, non ridà la vista a
un cieco chiamandolo non vedente, l’affermazione di essere antifascista, per
quanto eticamente giustificabile, non basta a cancellare ciò che del fascismo è
dentro di noi. Dentro di noi perché italiano come noi, forse più di noi. In
tutto il corso della sua storia, il fascismo fu senza dubbio un fenomeno
rivoluzionario, giovanile, si direbbe oggi “rottamatore”. Mussolini contribuì a
ringiovanire l’Italia, a partire dalla sua classe politica, così come consentì
per la prima volta nella storia del nostro Paese ai ceti medi di entrare nelle
stanze del potere. Questo significa che ebbe un legame con il Paese molto più
radicato, profondo, osmotico di quanto si pensi. Un legame possibile solo quando
c’è un collante. E questo collante viene proprio dall’essenza dell’italiano,
dalle radici del nostro modo di essere, dal nostro rapporto con il potere, da
ciò che non muta sulla nostra penisola al di là del regime o del governo, più o
meno democratico, che ci capita di eleggere o di contestare. Impegnati come
siamo a ripeterci che il fascismo è finito, oppure che si manifesta solo nei
simboli esplicitamente esibiti del regime, dentro i partiti dell’ultradestra
xenofoba, che alzano le croci celtiche nelle manifestazioni, non ci rendiamo
conto di una cosa: quei militanti postfascisti sono riconoscibili prima ancora
che espongano il proprio pensiero, mentre il fascismo del Ventennio fu un grande
movimento di massa. Se ci ostiniamo a cercare il fascismo lì dove è fin troppo
facile trovarlo, non facciamo altro che insistere nel non vedere. E perché lo
facciamo? Perché abbiamo paura di ritrovarlo dove non ce lo aspettiamo più, nel
nostro modo di essere quotidiano, nei nostri difetti di Paese, nel nostro
sistema politico e sociale. Annidato là dove sempre è stato, nell’angolo buio
della Repubblica che preferisce puntare i fari altrove, dove sa che fascismo non
se ne vedrà. Riflettiamo su un fenomeno mediatico di questi ultimi settant’anni.
Ancora oggi se accendiamo il televisore e ci sintonizziamo su un dibattito
politico, sentiamo spesso ripetere come un ritornello: «Siete fascisti!». Si
ascolta così tante volte, da essere assaliti dalla curiosità di capire perché.
Un giorno il fascista in questione è Matteo Renzi, tacciato di metodi spicci da
destra e da sinistra, addirittura da una parte del suo stesso partito, il
Partito Democratico; il giorno appresso, invece, ci si riferisce a Silvio
Berlusconi, accusato di avere addormentato il Paese come un nuovo Duce, di
averlo assopito in una sorta di Ventennio che potremmo definire, piuttosto che
regime dal volto umano, regime dal mezzobusto umano, trattandosi di un’anestesia
televisiva pressoché totale. Questa anestesia, però, ha generato la propaganda
di governo, come tutti i regimi democratici e non, ma ha generato anche i suoi
anticorpi: l’antiberlusconismo militante. Un terzo giorno l’epiteto di fascista
è attribuito alle epurazioni del Movimento 5 Stelle e a Beppe Grillo, accusato
di essere l’uomo solo che decide per tutti, quando il tal deputato è espulso dal
gruppo parlamentare perché “ribelle” alla linea ufficiale. Fino a Matteo
Salvini, il leader leghista dell’era post-bossiana, il quale, abbandonato il
divino Po e la sacra ampolla, si fa crescere la barba e si reinventa una specie
di marcia su Roma per allargare il consenso, ormai troppo stringato, del suo
Nord. La morale è che, almeno a parole, qui siamo tutti fascisti, destra e
sinistra, alti e bassi, belli e brutti. Saremo anche il Paese delle
generalizzazioni, ma c’è davvero da chiedersi cosa stia capitando a noi
italiani. Perché, all’improvviso, ci accusiamo l’un l’altro di fascismo? Perché
dopo la fine del regime, dopo l’epopea della Resistenza, dopo sette decenni di
democrazia quella parola torna sulle labbra di tutti noi, usata con sufficienza,
con disinvoltura? Forse perché il 1945, la data che mette fine ai regimi
fascista e nazista in Europa, non è una data che l’Italia abbia davvero
digerito. Certo sul piano ufficiale, nei proclami, nelle affermazioni di
principio, così come nella retorica di Stato, il fascismo è morto e sepolto,
giace sotto strati e strati di antidoto costituzionale, democratico,
parlamentare. Eppure, nella vita di tutti i giorni, nel profondo degli italiani,
la censura del modus vivendi mussoliniano non corrisponde affatto a una cesura,
perché molti atteggiamenti del regime - che già provenivano dal passato - si
sono conservati, pur con i naturali ammodernamenti, nel futuro: pensiamo ad
esempio all’Italia bigotta e bacchettona che fa e non dice, al maschilismo
diffuso in tutte le fasce sociali. Pensiamo alla distanza fra regole scritte e
regole davvero applicate. Pensiamo all’usanza politica del dossier,
all’insabbiamento dei misteri di Stato, alla corruzione come sistema di governo,
all’utilizzo dell’informazione come macchina per controllare l’opinione pubblica
prima ancora che per informarla, alle regole non scritte delle gerarchie
comuniste del dopoguerra, dove il valore della “fedeltà coniugale” garantiva la
scalata ai vertici del Pci (Partito Comunista Italiano) proprio come del Pnf
(Partito Nazionale Fascista). Per arrivare, infine, all’uomo forte, al
leaderismo craxiano, berlusconiano, renziano, incarnazioni del bisogno primario
di un capo. Sono solo coincidenze? No, siamo nati davvero con la camicia nera.
C’è un filo conduttore che unisce il fascismo “a noi”, proprio come era il
saluto ai tempi del Duce. A noi del fascismo è giunto più di quello che vogliamo
ammettere. Un’eredità che arriva dritta nell’epoca di Silvio Berlusconi e Matteo
Renzi. Un’eredità che non si manifesta nell’esibizione di simboli e bandiere, ma
nei piccoli gesti, nei modi di pensare, nelle abitudini malate del nostro Paese
che non mutano con i governi. Abitudini che ritroviamo nel fascismo di Benito
Mussolini, nei risvolti del regime e del carattere del Duce che facevano del
fascismo e del suo capo, prima ancora che una dittatura e un dittatore, un
modello d’Italia e di italiano, simili nei difetti al popolo. Difetti che non
sono scomparsi, sono solo mutati di sembianza. E che ritroviamo ancora oggi. Se
sappiamo dove andare a cercarli.
ALDO MORO. PALADINO DELLE
MASSE.
L'Aldo Moro di Mosse?
Paladino delle "masse".
Ampio consenso per formare governi forti e attenzione alle
istanze provenienti dal basso. Nell'intervista-saggio dello storico statunitense
le idee del leader della Dc, scrive Francesco Perfetti, Venerdì 29/04/2016, su
"Il Giornale". A un anno, o giù di lì, dalla tragica uccisione di Aldo Moro lo
storico statunitense George L. Mosse, all'epoca già ben conosciuto per i suoi
studi sulla «nazionalizzazione delle masse» e sulla fenomenologia del
totalitarismo contemporaneo, tentò un'interpretazione del pensiero e della
politica dello statista italiano. Lo fece in un'articolata intervista ad Alfonso
Alfonsi pubblicata originariamente come introduzione a un volume che, curato
dalla Fondazione Aldo Moro, intendeva proporre un'ampia silloge di scritti
dell'esponente democristiano, comprese alcune lettere dalla prigionia. Mosse era
stato scelto sia perché considerato estraneo al dibattito politico italiano sia
perché i suoi lavori erano centrati sul problema della partecipazione delle
masse alla vita politica. L'intervento dello storico americano suscitò
interesse, ma anche polemiche giunte soprattutto da esponenti democristiani e da
studiosi che rimproveravano a Mosse il fatto di non conoscere a fondo la
dinamica e le caratteristiche della politica italiana. Presto dimenticato,
proprio nell'anno del centenario della nascita dello statista torna in libreria
come testo autonomo (George Mosse, Intervista su Aldo Moro, a cura di Alfonso
Alfonsi, Rubbettino, pagg. XVIII-124, euro 14) arricchito da una bella
prefazione di Renato Moro su Mosse e da un'accurata nota critica di Donatello
Aramini. È uno studio importante. Lo è nel quadro della produzione storiografica
di Mosse perché costituisce un tentativo di applicare i risultati della sua
ricerca sulla società di massa a un periodo storico e a una situazione politica
diversi da quelli da lui frequentati. E lo è, soprattutto, per lo sforzo di
leggere e interpretare la politica di Moro in un contesto non più soltanto
nazionale, ma in una dimensione comparativa che finisce per collegarla
all'evoluzione politico-sociale europea e, in particolare, ai fenomeni di
trasformazione e crisi della democrazia parlamentare su cui, a partire già dagli
anni '50, si era sviluppata un'ampia letteratura di taglio prevalentemente
politologico. Secondo Mosse la politica di Moro assume un significato di
interesse generale proprio per il fatto di essere collegata a quella crisi del
sistema di governo parlamentare propria dei Paesi occidentali e di porsi come un
tentativo di risposta alle sfide della società di massa. In quest'ottica,
l'essenza della politica sviluppata da Moro si sarebbe risolta in un tentativo
di allargamento della «base del sistema di governo parlamentare per cercare di
prendere in considerazione la natura della moderna politica di massa». Lo
statista democristiano avrebbe finito per diventare, così, il sostenitore di un
progetto volto a trasformare il suo stesso partito, la Dc, in una realtà più
dinamica e, soprattutto, laica e svincolata dai legami stretti con la Chiesa che
ne irrigidivano la struttura e la rendevano inadeguata a percepire i mutamenti
di una società di massa in continua evoluzione. Insomma, la posizione di Moro
sarebbe stata, se non estranea, conflittuale rispetto al suo partito. Lo
statista, secondo Mosse, aveva una concezione dello Stato «come un processo,
come un qualcosa continuamente in fieri, un organismo sensibile ai mutamenti» il
cui unico punto fermo era il principio del governo rappresentativo: una
concezione, in qualche misura, relativistica su cui pesavano le preoccupazioni
per la stabilità di un sistema politico che non riusciva a integrare appieno le
masse e a generare il consenso necessario per garantire un governo forte ed
efficiente oltre che sensibile alle istanze politiche e sociali provenienti dal
basso. In questo quadro, la coalizione di centrosinistra, prima, e il
compromesso storico, poi, avrebbero dovuto rappresentare, per Moro, dopo
l'esaurimento del processo di ricostruzione postbellica del Paese, l'inizio di
una nuova fase politica in cui, sono parole di Mosse, «l'accento fosse posto
sull'integrazione dinamica dei gruppi che erano rimasti fuori dal processo
politico» oltre che «sulla estensione della ristretta area di consenso che si
era stabilita subito dopo la guerra». Il progetto di Moro sarebbe stato sempre
quello di cercare d'inserire «nell'attività governativa quei gruppi che ne erano
rimasti fino ad allora esclusi, attribuendo loro maggiori responsabilità»: i
socialisti, in primo luogo, ma anche, in un secondo tempo, i comunisti. Il
tutto, ovviamente, nel presupposto che il sistema di democrazia parlamentare non
venisse messo in discussione e risultasse, anzi, rafforzato da questa operazione
che avrebbe dovuto ampliare l'area del consenso evitando il pericolo, per un
verso, di derive golliste e, per altro verso, di slittamenti verso ipotesi di
tipo autoritario o totalitario. L'assassinio del leader democristiano da parte
delle Brigate Rosse avrebbe avuto come risultato finale non già quello di
«ritardare» l'attuazione del disegno di Moro, quanto «quello di far irrigidire a
tal punto il quadro politico da far crollare in pochissimo tempo tutte le
prospettive» della «mediazione» morotea. Pieno di suggestioni stimolanti, il
saggio di Mosse, a una lettura non condizionata dall'emotività del momento in
cui fu scritto, rivela tuttavia alcuni limiti intrinseci dovuti sia all'uso di
categorie storiografiche e politologiche troppo generalizzanti, sia alla mancata
e diretta conoscenza della particolarità della dinamica e delle caratteristiche
della storia politica italiana, per molti aspetti assai diversa da quella delle
altre democrazie occidentali. Esso pone l'accento sulla coerenza del pensiero di
Moro come sviluppo di una linea speculativa che, con l'«umanesimo integrale» di
Jacques Maritain e il «personalismo comunitario» di Emmanuel Mounier, si
proietta verso un preciso ideale di società cristiana. Ma, ciò facendo, mette in
ombra uno dei lati più caratteristici della personalità di Moro, quel suo
«pragmatismo» che era all'origine di una prassi politica fondata sulla
«mediazione» e sul tentativo di esorcizzare o minimizzare le differenze
ideologiche. Il saggio, infine, non riesce a dar conto del fatto che, al di là e
al di sopra della concezione che Moro poteva averne, l'esperimento del
centrosinistra in Italia maturò per una serie di circostanze, anche
internazionali, che si svilupparono a partire dalla seconda metà degli anni '50:
l'elezione di Giovanni Gronchi, la teorizzazione del «neoatlantismo», la
repressione della rivolta di Budapest con le sue devastanti conseguenze nel
comunismo occidentale, l'ascesa al soglio pontificio di Giovanni XXIII, la
presidenza di John Fitzgerald Kennedy e l'elaborazione da parte
dell'amministrazione americana di un progetto che intendeva utilizzare l'Italia
come «laboratorio politico».
Nell’aula dell’ultimo
discorso di Moro,
scrive Francesco Damato il 2 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Il ricordo: nella sala
della conferenza di fine anno, il dirigente Dc parlò prima del rapimento. Seduto
nell’auletta dei gruppi parlamentari della Camera per seguire la conferenza
stampa di fine anno del presidente del Consiglio, più sentivo Paolo Gentiloni,
più guardavo le pareti, più sollevavo gli occhi verso il soffitto, meno riuscivo
a sottrarmi al ricordo del povero Aldo Moro. Mi chiederete, a distanza di più di
38 anni dalla sua tragica morte che cosa c’entri Moro con Gentiloni e col suo
incontro con i giornalisti, fresco di nomina a presidente del Consiglio.
C’entrava e c’entra, forse all’insaputa dello stesso Gentiloni, che all’epoca
della vicenda che sto per raccontarvi aveva meno di 24 anni e non immaginava di
certo il tipo di carriera politica che lo aspettava, impegnato com’era allora a
contestare da extraparlamentare sia la maggioranza sia l’opposizione. Seduto
nell’auletta dei gruppi parlamentari della Camera per seguire la conferenza
stampa di fine anno del presidente del Consiglio, più sentivo Paolo Gentiloni,
più guardavo le pareti, più sollevavo gli occhi verso il soffitto, meno riuscivo
a sottrarmi al ricordo del povero Aldo Moro. Mi chiederete, a distanza di più di
38 anni dalla sua tragica morte che cosa c’entri Moro con Gentiloni e col suo
incontro con i giornalisti, fresco di nomina a presidente del Consiglio.
C’entrava e c’entra, forse all’insaputa dello stesso Gentiloni, che all’epoca
della vicenda che sto per raccontarvi aveva meno di 24 anni e non immaginava di
certo il tipo di carriera politica che lo aspettava, impegnato com’era allora a
contestare da extraparlamentare sia la maggioranza sia l’opposizione. Fu proprio
in quell’auletta dove il presidente del Consiglio ha avuto il battesimo del
“fuoco” con le domande dei giornalisti smaniosi di spiazzarlo, e di misurarne
maliziosamente le distanze dal predecessore e grande assente, Matteo Renzi; fu
proprio in quell’auletta, dicevo, che il 28 febbraio del 1978 Moro pronunciò il
suo ultimo discorso. Egli aveva compiuto da pochi mesi 61 anni, guidato 6
governi, la Dc per 4 anni, e collezionato tre Ministeri di prestigio come gli
Esteri, la Pubblica Istruzione e la Giustizia, destinato infine, secondo tutte,
ma proprio tutte le previsioni, a diventare alla fine di quell’anno presidente
della Repubblica, alla scadenza ordinaria del mandato di Giovanni Leone. Eppure
Moro quel giorno era inconsapevolmente arrivato al capolinea politico. Dopo soli
16 giorni sarebbe stato rapito. Nessuno più, dopo quel discorso, avrebbe più
sentito dal vivo la sua voce, eccetto quegli sciagurati brigatisi che si
arrogarono addirittura il diritto di processarlo nel loro covo. E infine di
condannarlo a morte. L’auletta dei gruppi parlamentari della Camera non aveva
allora le luci e i decori di oggi. Era dignitosa ma austera, direi sobria se
questo aggettivo non fosse stato rovinato qualche anno fa con l’abuso che se ne
fece per commentare abbigliamento, portamento e quant’altro di Mario Monti, per
quanto avvolto in due mandati non da poco: presidente del Consiglio e senatore a
vita, entrambi conferitigli a pochi giorni o addirittura ore di distanza
dall’allora capo dello Stato Giorgio Napolitano. Moro la sera di quel 28
febbraio non stava bene. Oreste Leonardi, il giovanile e fedele maresciallo dei
Carabinieri che ne comandava la scorta, e lo seguiva ovunque portandosi appresso
una borsa in cui custodiva anche le punture che all’occorrenza sapeva fargli se
ne avesse avuto bisogno per il cosiddetto “mal bronzino” che l’affliggeva, mi
disse che quella volta “il presidente” aveva qualche linea di febbre, non
essendo riuscito a smaltire una fastidiosa influenza. A quell’appuntamento con i
parlamentari democristiani tuttavia egli non aveva voluto mancare perché solo
lui – gli avevano detto il segretario della Dc Benigno Zaccagnini e il
presidente del Consiglio Giulio Andreotti – avrebbe saputo rimuovere gli ultimi
ostacoli alla chiusura della lunga crisi apertasi alla fine del 1977 per la
richiesta dei comunisti di apparire ancora più chiaramente, e non solo di essere
decisivi nella partecipazione alla maggioranza di governo. Il Pci di Enrico
Berlinguer aveva sino ad allora sostenuto dall’esterno con l’astensione, o “non
sfiducia”, il governo monocolore democristiano di Andreotti formatosi dopo le
elezioni politiche anticipate del 1976, provocate dall’allora segretario
socialista Francesco De Martino con l’annuncio che il Psi non sarebbe più
tornato a collaborare con la Dc senza l’appoggio dei comunisti. A Palazzo Chigi
c’era in quel momento proprio Moro, a capo di un governo “bicolore” Dc- Pri, con
Ugo La Malfa vice presidente del Consiglio. Quell’annuncio era costato carissimo
ai socialisti, usciti dalle urne con il minimo storico. Incapaci numericamente
di fare a meno gli uni degli altri per governare un Paese alle prese con una
drammatica crisi economica e finanziaria e con il terrorismo, democristiani e
comunisti avevano concordato una tregua assumendo la linea della cosiddetta
solidarietà nazionale, variante del “compromesso storico” teorizzato ancor prima
da Berlinguer per scongiurare che l’Italia facesse la fine del Cile col generale
Pinochet. Dopo più di un anno di astensione, con i sindacati in agitazione per
la politica dei sacrifici praticata da un governo cui però non partecipavano, i
comunisti avevano posto il problema di un chiarimento programmatico e di quadro
politico. Scartata l’ipotesi, che pure non sarebbe dispiaciuta ad Andreotti, e
forse neppure a Zaccagnini, dell’ingresso nel governo di due indipendenti di
sinistra eletti nelle liste del Pci, Moro condusse personalmente con Berlinguer
una trattativa sul programma che consentisse ai comunisti di votare la fiducia.
Neppure questa prudenza tuttavia era riuscita a placare le insofferenze e le
paure nella Dc, sia a destra sia a sinistra: a destra con le resistenze di
uomini come Mariotto Segni e Oscar Luigi Scalfaro, pur destinato dopo 12 anni ad
essere eletto al Quirinale anche dai comunisti; a sinistra con Carlo Donat-
Cattin. Costoro avrebbero preferito un altro turno di elezioni anticipate. Moro
pazientemente spiegò quella sera agli uni e agli altri, nell’auletta – ripeto –
dei gruppi parlamentari della Camera, che le elezioni sarebbero state di nobile
ma inutile “testimonianza”. Ne sarebbero usciti rafforzati entrambi i partiti
maggiori, ma a spese dei minori, di cui invece essi avrebbero avuto bisogno per
fare una maggioranza di governo che li rendesse anche in Parlamento alternativi
com’erano in campagna elettorale. Il passaggio più decisivo di quel discorso,
per convincere i refrattari alla nuova e più stringente intesa col Pci, fu
paradossalmente un inciso riguardante il Psi, passato dopo le elezioni del 1976
dalle mani del vecchio De Martino a quelle del giovane Bettino Craxi. Che aveva
avviato, rispetto al predecessore, un’inversione di rotta all’insegna
dell’autonomia, di cui però occorreva sapientemente attendere i tempi non
rapidi. Era chiaro che Moro, peraltro convinto, come ho già accennato, di poter
arrivare alla fine dell’anno in quel crocevia che era ed è tuttora il Quirinale,
aspettasse il ritorno dei socialisti al centrosinistra da lui stesso realizzato
in forma organica per la prima volta, con un governo a partecipazione diretta,
nel lontano 1963. Ma questo il presidente della Dc non poteva auspicarlo e
teorizzarlo con troppa evidenza, con qualcosa di più di un inciso allusivo,
perché sapeva che avrebbe in tal caso ferito l’orgoglio del Pci. Di cui lui
invece aveva profondo rispetto, tanto che una volta, facendo uno strappo al suo
garbo usuale, mandò quasi a quel paese, alla mia presenza, un amico che parlava
della necessità di “stanare” i comunisti sul versante ormai non più
internazionale, essendosi Berlinguer spinto a dichiararsi garantito pure lui
sotto “l’ombrello della Nato”, ma sindacale. Moro lasciò quella sera, quasi
notte, l’auletta dei gruppi parlamentari della Camera sfinito, ma soddisfatto di
avere compiuto la sua missione di persuasione. In quella mano che mi tese,
uscendo scortato dal solito Leonardi per raggiungere l’auto e tornarsene a casa,
sentii più abbandono che forza. Un abbandono che ancora mi angoscia quando lo
ricordo. Quella d’altronde fu anche per me l’ultima volta che lo vidi. Mi sono
sempre chiesto, e torno ancora a chiedermi oggi, perché non sia stata dedicata
alla memoria di Moro quell’auletta, anziché la sala al piano nobile del Palazzo
di Montecitorio che porta il suo nome ma dove temo c’egli non avesse mai messo
piede. Non vi dico la delusione che provai quando, finito lo sfarzoso restauro
di quell’auletta ed espressa la mia delusione per l’occasione mancata di
dedicargliela, mi accorsi che l’alto funzionario della Camera con cui parlavo
non sapesse neppure che lì Moro aveva pronunciato il suo ultimo discorso.
La storia compromettente
del "compromesso storico".
Quarant'anni fa Enrico Berlinguer rilanciò l'idea (che fu di
Togliatti nel dopoguerra) della collaborazione fra Pci e Dc. Ma il flirt durò
poco. E indebolì entrambi i partiti, scrive Francesco Perfetti, Venerdì
27/09/2013, su "Il Giornale". La proposta di un «compromesso storico» fra
cattolici e comunisti la lanciò l'allora segretario del Pci Enrico Berlinguer
tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 1973 dalle pagine di Rinascita,
la rivista ideologica del partito fondata da Palmiro Togliatti, in tre articoli
pubblicati con il titolo generale Riflessioni sull'Italia dopo i fatti del Cile.
Nel Paese latino-americano si era appena consumato il colpo di Stato del
generale Pinochet contro Salvador Allende: era stata interrotta traumaticamente
la «via cilena al comunismo». Divenuto segretario del Pci nel marzo 1972 dopo
esserne stato vice-segretario, Berlinguer si era formato ed era cresciuto
politicamente all'ombra di Togliatti e durante la lunga segreteria di Luigi
Longo si era rafforzata la sua autorevolezza. Aveva portato avanti la linea del
«dissenso» dall'Urss dopo l'invasione della Cecoslovacchia del 1968, ma al tempo
stesso aveva negato la possibilità di un abbandono dell'internazionalismo e di
una posizione di rottura nei confronti dell'Unione Sovietica. I fatti cileni
suggerirono a Berlinguer una proposta politico-strategica che egli rese nota
attraverso quegli articoli senza che fosse prima discussa dagli organismi
dirigenti del partito. Ciò anche se in maggio sulla rivista Il Contemporaneo,
supplemento mensile di Rinascita, era apparso un ampio dibattito sulla
«questione democristiana», in cui Alessandro Natta aveva accennato alla
necessità di una intesa fra socialisti, comunisti e cattolici e Gerardo
Chiaromonte aveva osservato che sarebbe stato difficile per i comunisti
governare anche ottenendo la maggioranza assoluta dei voti a causa della
estensione e della influenza delle forze avversarie. Ciò non toglie, peraltro,
che la paternità dell'idea del compromesso storico, così come venne presentata,
sia senza dubbio attribuibile a Berlinguer. Il caso cileno offriva una lezione
importante. Dimostrava che l'unità delle sinistre, da sola, non era sufficiente
a garantire la governabilità e che bisognava puntare alla collaborazione fra
tutte le forze popolari, partito comunista e democrazia cristiana in primis, e
quindi a un sistema di alleanze sociali che coinvolgesse ceti diversi. Al fondo,
c'era la convinzione che solo così sarebbe stato possibile sbloccare il sistema
politico italiano che, di fatto, anche per la sua collocazione internazionale,
non consentiva una alternanza. La formulazione della proposta era chiara: «la
gravità dei problemi del paese, le minacce sempre incombenti di avventure
reazionarie, e la necessità di aprire finalmente alla nazione una sicura via di
sviluppo economico, di rinnovamento sociale e di progresso democratico rendono
sempre più urgente e maturo che si giunga a quello che può essere definito il
nuovo grande compromesso storico tra le forze che raccolgono e rappresentano la
grande maggioranza del popolo italiano». In altre parole, Berlinguer metteva in
soffitta l'idea della «alternativa di sinistra» e la sostituiva con quella di
una «alternativa democratica» che avrebbe consentito riforme radicali evitando
il pericolo di derive reazionarie. La proposta poteva sembrare una novità. E
come tale alimentò il dibattito politico. Ma non era così. Il filosofo cattolico
Augusto Del Noce osservò che essa era «condizionata interamente dalla linea
gramsciana» tanto che, riferita al pensiero di Gramsci, si configurava come
«offerta» frutto della «constatazione della maturità storica per il passaggio
dell'Italia al comunismo e per il transito dalla vecchia alla nuova Chiesa».
D'altro canto lo stesso Berlinguer precisò che l'offerta di compromesso storico
non era una «apertura di credito alla Dc», ma doveva intendersi come
«sollecitazione continua» per una trasformazione radicale della stessa Dc che ne
valorizzasse la «componente popolare» a scapito delle «tendenze conservatrici e
reazionarie». A ben vedere, il discorso di Berlinguer riprendeva, con altre
parole e in un contesto diverso, il progetto che, all'indomani del secondo
conflitto mondiale, Palmiro Togliatti aveva sintetizzato nella celebre
espressione «democrazia progressiva» fondata sulla collaborazione fra le «grandi
forze popolari», ovvero comunisti, socialisti e cattolici. Esisteva, per dirlo
con Del Noce, una «continuità Gramsci-Togliatti-Berlinguer e delle formule della
via nazionale e democratica e dell'accordo dei partiti di massa». Nella visione
berlingueriana il compromesso storico avrebbe dovuto rappresentare lo strumento
per «sbloccare» il sistema politico italiano che - in virtù della tacita ma
accettata conventio ad excludendum nei confronti del Pci per i suoi legami con
Mosca e per la sua monolitica struttura interna di tipo leninista - precludeva
ai comunisti l'ingresso nelle stanze del potere. Le opposizioni, più che le
perplessità, furono numerose sia all'interno del Pci, dove molti pensavano
ancora all'ipotesi della trasformazione del Paese in una «democrazia popolare»,
sia all'interno della Dc, del Psi e dei partiti laici minori, preoccupati, non a
torto, che il compromesso storico si risolvesse nell'incontro fra due «religioni
secolari». Comunque sia, alla prova dei fatti il compromesso storico non si
realizzò. Gli anni fra il 1974 e il 1978 furono, sì, quelli della grande
avanzata elettorale del Pci e del suo ingresso nell'area di potere con
l'appoggio esterno al governo monocolore di «solidarietà nazionale» di
Andreotti. Ma, al tempo stesso, furono anni - particolarmente difficili anche
per l'offensiva del «partito armato» delle Brigate Rosse - che mostrarono come
la «strategia dell'attenzione» nei confronti del Pci teorizzata da Aldo Moro
fosse sostanzialmente velleitaria. Alla fine proprio il rapimento e l'assassinio
di Moro chiusero traumaticamente la strada al compromesso storico. E aprirono
una nuova stagione della politica italiana dominata dalla figura di Bettino
Craxi e destinata a sua volta a esaurirsi con la fine ingloriosa della prima
repubblica sotto i colpi di maglio della «rivoluzione giudiziaria» di
Tangentopoli.
COMMISSIONE MORO: SULLA
VICENDA OPACITA' ED OMISSIONI.
Gli 007 del Parlamento
lavorano 5 ore al mese.
Le commissioni d'inchiesta: tante e inutili. Volevano indagare pure su Fiat e
Pasolini, scrive Domenico Di Sanzo, Giovedì 21/09/2017, su "Il Giornale".
Indagare, in Parlamento, non stanca affatto. I James Bond di Montecitorio e
Palazzo Madama infatti fanno proprio la pacchia. Secondo i dati diffusi da un
report pubblicato dal sito Openpolis, le 15 commissioni di inchiesta
parlamentare in Camera e Senato lavorano, in media, cinque ore al mese. Non un
minuto di più. Circa 2000 ore di lavoro per 1871 sedute. Il tutto va sommato
alle spese elefantiache per il mantenimento di questi carrozzoni: 852 mila euro
sprecati da Montecitorio e 751 mila da Palazzo Madama. Così lo strumento che,
secondo l'articolo 82 della Costituzione, doveva servire a «disporre inchieste
su materie di pubblico interesse» è diventato un bengodi per onorevoli senza
poltrona oppure lo specchietto per le allodole di parlamentari in cerca di
ribalta mediatica. E oltre a essere inutili sono anche tante, 15 tra Camera e
Senato, sulle materie più disparate. A Montecitorio si indaga sugli «effetti
dell'utilizzo dell'uranio impoverito», su «contraffazione, pirateria commerciale
e commercio abusivo», «digitalizzazione e innovazione della Pubblica
Amministrazione», «condizioni di trattenimento dei migranti», «morte del
militare Emanuele Scieri» e «condizioni di sicurezza e stato di degrado delle
città e delle loro periferie». Il totale alla Camera fa 6. Le 5 commissioni del
Senato invece sono su «infortuni sul lavoro», «intimidazioni nei confronti degli
amministratori locali», «disastro del traghetto Moby Prince», «ricostruzione
della città de L'Aquila dopo il terremoto del 2009» e, dulcis in fundo, c'è il
«femminicidio e ogni forma di violenza di genere». Il quadretto è completato
dalle quattro commissioni bicamerali che si occupano di «fenomeno delle mafie»,
«ciclo dei rifiuti», «rapimento e morte di Aldo Moro», «sistema bancario e
finanziario». Due di queste non si sono riunite nemmeno una volta, quella sul
terremoto de L'Aquila e la bicamerale sul sistema economico e finanziario. Ma le
inchieste non bastano mai. Sono ferme nel pantano dei lavori parlamentari oltre
130 proposte di indagine. E c'è n'è un po' per tutti i gusti. Il grillino
Claudio Cominardi vuole approfondire la questione degli sgravi statali di cui ha
beneficiato la Fiat a partire dal secondo dopoguerra. Fabio Rampelli di Fratelli
d'Italia è concentrato sulla «violenza politica dal 1970 al 1989». L'ex M5s
Fabio Campanella, poi passato a Mdp, pensa sia importante spendere altri soldi
pubblici per un'inchiesta parlamentare sui fatti del G8 di Genova. Gli
appassionati di storia si sbizzariscono con proposte sulla morte di Pasolini, la
tragedia di Ustica e la scomparsa di Emanuela Orlandi. Tra le idee più curiose,
c'è sicuramente la commissione d'inchiesta sul maltrattamento degli animali.
Imbattibile il dem Roberto Giachetti che vuole investigare sul «giuoco del
calcio». Ma tutto ha un prezzo. Facendo i calcoli, ogni presidente di
commissione intasca circa 1200 euro al mese oltre allo stipendio. Più benefit e
rimborsi anche per vicepresidenti e segretari. Indagare conviene.
Fioroni shock: «Morucci era
del Sisde, ho le carte…».
La rivelazione sull’ex brigatista durante un’udienza della commissione Moro,
scrive Greta Marchesi il 21 Settembre 2017 su "Il Dubbio". Il brigatista Valerio
Morucci era del Sisde. «Ho le carte dei servizi che dimostrano la sua
collaborazione nel 1990», ha detto il presidente della Commissione Moro,
Giuseppe Fioroni. I fatti emergono dalla terza audizione di Adriana Faranda,
anche lei ex brigatista pentita ed ex compagna di Morucci, durante la quale
Fioroni l’ha incalzata: «Il Sisde, con cui Valerio Morucci collaborava a quel
tempo, gli chiese cosa pensasse del ritrovamento in via Montenevoso delle
fotocopie del memoriale Moro, nel 1990». Lei non ha nascosto lo stupore:
«Valerio collaborava con il Sisde? È una cosa che detta così mi lascia sgomenta.
Forse gli avranno chiesto una consulenza». E, alla domanda se i servizi segreti
ebbero contatti anche con lei, la brigatista ha risposto in modo ambiguo:
«Imposimato mi fece incontrare due funzionari del Sisde, ma io rifiutai di
proseguire il rapporto. Uno di loro mi disse che aveva fatto perquisire casa
mia». Fioroni, in seguito, torna sul tema: «Morucci, parlando in qualità di
collaboratore del Sisde, si disse non sicuro che Gallinari avesse distrutto gli
originali delle lettere e dei documenti di Moro, Morucci non vedeva ragione per
distruggere quelle carte». «Anche io mi sono sempre chiesta perché si dovessero
distruggere gli originali dei documenti di Moro», ha risposto Faranda,
sottolineando però di non sapere se ci fossero carte a Genova. Durante
l’audizione, Faranda ha anche parlato dei rapporti con il nucleo storico delle
Br: «La divisione delle Br in una prima e in una seconda fase è arbitraria e
scorretta. Noi ci muovevamo soprattutto in funzione delle indicazioni dei capi
storici detenuti a Torino. Durante il processo di Torino, il nucleo storico si
rifiutò di riconoscersi come un gruppo di imputati. Loro sostennero di essere
prigionieri politici e invitarono i giudici a nominare loro un avvocato
difensore e l’invito a chi stava fuori era quello di portare l’attacco al cuore
dello Stato. Quando furono uccisi Coco e l’avvocato Croce, i comunicati di
rivendicazione di chi era in carcere è significativo – ricorda l’ex postina del
caso Moro – perché si dice che quell’azione non è una rappresaglia e si parla
dei due poliziotti di scorta al giudice come di mercenari uccisi giustamente»,
tutte «indicazioni precise per chi stava fuori – ha concluso Faranda, ricordando
come Franceschini stesso abbia rivendicato di aver scritto oltre l’ 80% della
risoluzione strategica delle brigate rosse: quindi loro non subivano le
decisioni di chi era fuori. Nella risoluzione strategica c’era già tutto, c’era
anche Moro dentro». E ancora, «Franceschini ha rivendicato di avere scritto in
carcere il 75- 80% della risoluzione strategica. Solo il 20% è stato scritto
fuori. Franceschini disse solo che non era d’accordo sull’impostazione che era
stata data al sequestro Moro: per lui non era un processo alla Dc, la
discussione fondamentale doveva essere sul compromesso storico. Questo l’ho
sentito anche da Gallinari: il compromesso storico era la riprova dell’abilità
politica di Moro di imbrigliare il conflitto sociale, ad esempio come avvenne
con l’inglobamento del Psi nel centrosinistra». Faranda ha anche confermato di
aver ricevuto 36 lettere di Moro. Era però l’esecutivo delle Br, tra cui
Moretti, Bonisoli, Azzolini, Micaletto, che decideva che cosa doveva uscire
all’esterno e cosa no. E sugli originali del memoriale Moro ha aggiunto: «Mi
sono sempre chiesta perchè distruggere gli originali. Mi sembra improbabile che
fosse rimasta solo una copia a via Montenevoso».
Caso Moro. Valerio Morucci,
uomo dei servizi.
Ora lo scopre Fioroni, la Voce lo scrisse 7 anni fa, scrive il 21 settembre
2017 Andrea Cinquegrani su "La Voce delle Voci". Scoppia la bomba. Il
brigatista Valerio Morucci faceva parte dei Servizi segreti. La maxi notizia
viene fuori nel corso di una delle audizioni della commissione parlamentare sul
caso Moro, e a darla è il presidente, Giuseppe Fioroni, il quale annuncia: “Nel
1990 Valerio Morucci era un collaboratore del Sisde”. Peccato che quella bomba
sia un tric trac, o poco di più. Da molti anni ormai era a nota a non pochi la
militanza doppia di Morucci, Bierre e Servizi. Esattamente sette anni fa, in
un’inchiesta titolata “Brigate Rossonere” e uscita ad ottobre 2010,
la Voce dettagliava i rapporti di Morucci con i Servizi ed in particolare con un
pezzo da novanta, Mario Mori. Giuseppe Fioroni. Ma ricostruiamo i fatti, a
partire dall’ultima audizione davanti alla commissione Moro. A deporre c’è un
personaggio storico delle Bierre, Adriana Faranda. Arrestata nel 1979, uscì dal
carcere 15 anni dopo, nel 1994, da dissociata.
Ecco un fresco report di Rai
News 24, datato 20 settembre, e scarsamente attenzionato dai media: Corsera e
Repubblica, tanto per citare due autorevoli testate, non ne parlano. “Nel 1990 –
esordisce la notizia – il brigatista Valerio Morucci era un collaboratore del
Sisde. Lo rende noto il Presidente della Commissione Moro, Giuseppe Fioroni, che
sostiene di avere le carte del Sisde che comprovano questa tesi. Fioroni,
durante la terza audizione di Adriana Faranda, brigatista ed ex compagna di
Morucci, afferma: "Al tempo del secondo ritrovamento di via Montenevoso, il
Centro Sisde trasmise il 3 novembre 1990 alla direzione dei servizi del Sisde
una serie di valutazioni di Valerio Morucci che all’epoca collaborava col
servizio. Morucci collaborava col Sisde e il 3 novembre 1990 trasmisero una
serie di valutazioni di Morucci sulla vicenda di Montenevoso". Continua il
report: “Faranda si limita a replicare: Detta così mi sgomenta. Fioroni insiste:
Questo c’è scritto nelle carte. Se vuole gliele trasmetto. Faranda: Sarà stato
che qualcuno gli ha chiesto una consulenza. Non mi pongo la domanda…. Qualche
minuto dopo Fioroni torna sull’argomento. Scrivendo Morucci in qualità di
collaboratore, consulente, persona informata sui fatti con il Sisde…. Faranda
ribatte: Non ne ho la minima idea. Ecco ancora un passaggio riportato da Rai
News 24: “Ad un parlamentare che afferma la tesi secondo cui anche il difensore
di Faranda, l’avvocato Tommaso Mancini, fosse legato ai servizi segreti, l’ex
brigatista risponde: Allora rinuncio…. Ad un parlamentare che subito dopo
sostiene la tesi secondo la quale Adriana Franda, da ricercata, mise la testa in
una macchina della polizia, l’ex terrorista risponde: No, assolutamente. Mi
sento circondata… Posso dire che l’avvocato fu scelto da mia madre, disperata e
convinta che fossi innocente. Chiese consiglio a mio padre, che era a sua volta
avvocato. Mia madre non era dei servizi. E poi, ancora: “’Io e Morucci – spiega
Faranda – avevano come avvocato difensore Tommaso Mancini. Cambiai difensore
dopo l’arresto di Maccari, perchè io confermai che Maccari era il quarto uomo e
qui scattò l’incompatibilità perchè Mancini era anche il legale di Maccari”.
Sono alcuni dei passaggi della terza verbalizzazione. Di non poco valore,
comunque. Faranda, infatti, cade dalle nuvole quando sente parlare del suo ex
compagno doppio, nella vita e nella politica, come di qualcuno vicino ai
servizi: un collaboratore, un consulente o che?
Peccato che la storia sia nota
da molto tempo. La Voce realizzò nel 2010 un’inchiesta che partiva da un
periodico d’area fascista ed ispirato dall’allora sindaco di Roma Gianni
Alemanno, Theorema, per arrivare a un formidabile tandem che operava in quella
struttura redazionale, del resto vissuta pochi mesi: l’ex super capo dei
Servizi, Mario Mori, fianco a fianco con uno dei collaboratori di punta, Valerio
Morucci. Incredibile ma vero. E come ciliegina sulla torta anche un ordinovista
di peso, Loris Facchinetti. Per la serie: attacco a tre punte, Bierre a
sinistra, Ordine Nuovo a destra per la regia dei Servizi! La quadratura del
cerchio. Osserva un avvocato romano: “E’ la riprova che le Brigate rosse erano
eterodirette e sono state infiltrate fin dall’inizio. Del resto era la terapia
storicamente consigliata da uno che di terrorismo e servizi se ne intendeva
bene, come Francesco Cossiga: la prima cosa da fare è infiltrarsi”. Conferma un
collega partenopeo: “Il caso Moro ma anche il caso Cirillo sono la prova del
super ruolo giocato dai Servizi. Anche in quel caso il regista del rapimento,
sul fronte brigatista, fu l’ideologo Senzani, che aveva buoni rapporti con i
servizi segreti”. E poi la sintesi di entrambi: “in moltissime vicende Brigate
rosse da un lato, camorra e mafia dall’altro, sono state la manovalanza dei
Servizi, che hanno affidato loro gli affari sporchi da sbrigare. Tant’è che
restano a volto regolarmente coperto i mandanti di quasi tutte le stragi, dove
sono stati assicurati alle galere in alcuni casi gli esecutori, mai i mandanti,
i colletti bianchi che agiscono sempre dietro le quinte e sui quali mai si alza
il velo”. Tornando a Morucci, nella sua story a quanto pare fanno capolino non
solo i servizi di casa nostra, ma anche quelli israeliani. Ecco cosa nel 2010
scrisse la Voce, riferendo il commento di un docente dell’università di Trento:
“Anche Renato Curcio ne parlava. Parlava di richieste di incontri da parte
del Mossad. Sarebbero avvenuti a Roma, presso fermate di autobus. Ci sarebbe
stato, fra gli altri, anche Morucci”.
Torniamo a quel Theorema.
Spunta appunto nel 2010, quando Alemanno – per fornire un supporto ideologico
alla sua giunta – pensa bene di dar vita a questo laboratorio di intelligenze
(sic) per raccogliere il meglio soprattutto a destra ma anche a sinistra.
Direttore del comitato scientifico viene nominato sul campo il generale Mario
Mori, cui fa compagnia, all’interno dello stesso comitato, un suo storico
collaboratore, il colonnello Giuseppe De Donno, che lo ha affiancato in svariate
avventure non sempre gloriose. Manca all’appello solo il capitano Ultimo, che in
quei mesi però affiancava lo stesso Mori come supervisore per la sicurezza a
Roma, incarica assegnato ai due proprio dal sindaco Gianni Alemanno. E oggi
Fratelli d’Italia pensa a Sergio De Caprio-Ultimo come asso nella manica per le
prossime politiche, dopo averlo già votato per la presidenza della Repubblica
nella competition con Sergio Mattarella! In seno alla redazione di Theorema, il
responsabile per la politica estera è stato Loris Facchinetti, un pedigree da
non poco: missino, Ordine Nuovo, massone, tanto per non farsi mancare niente. Ma
l’uomo di punta nel team griffato Mori era proprio lui: Valerio Morucci. Il
telefonista del caso Moro, il compagno di Adriana Faranda. Che però oggi,
immacolata come una mammola, cade dalle nuvole.
LE INEDITE CONTIGUITA’ TRA
BARBE FINTE, EX BIERRE E NAZI,
scriveva nel Gennaio 2011 Andrea Cinquegrani su "La Voce delle Voci". Roma. 5
ottobre 2010. Nel cuore chic della capitale, via in Lucina 17, presso la sede
della Fondazione Nuova Italia viene presentato il quarto numero di un
trimestrale, Theorema. A presiedere la Fondazione c’è nientemeno che il primo
cittadino della capitale, Gianni Alemanno, mentre nel folto consiglio di
amministrazione fa capolino anche la gentile consorte, Isabella Rauti (figlia di
Pino Rauti, fresco di assoluzione “tombale” nell’ennesimo processo per la strage
di piazza della Loggia a Brescia). E’ articolata in aree di “studio”, Nuova
Italia: Sergio Gallo alla giustizia, Francesca Romana Fragale e Giovanni
Monastra per agricoltura e ambiente, Claudio Gaudino allo sviluppo economico,
Costantino Lauria per Sicurezza dello Stato e del cittadino, alle Politiche
internazionali Loris Facchinetti. Un nome, una storia, quella di Facchinetti.
Ecco come viene dipinto nell’archivio della Fondazione (una che serve davvero ad
uno scopo sociale) Cipriani: «Ex missino passato a Ordine nuovo, massone del
gruppo dell’ex generale fascista Ghinazzi, facente parte della redazione del
periodico L’incontro delle genti con Elvio Sciubba, Facchinetti (con tutto il
gruppo di Europa Civiltà composto da Serpieri, Tacchi, Orlandini, Borghese) sin
dal 1969 aveva stretti rapporti con Miceli. Facchinetti era inoltre in contatto
con la P2 perchè vi era transitato ed era in contatto con elementi della
Magliana, Egidio Giuliani e Paolo Aleandri». Per aver qualche ulteriore
ragguaglio basta scorrere le pagine web de Il Faro Magazine che alla voce “Loris
Facchinetti, il più grande italiano vivente”, infila un chilometrico curriculum
che va da una dozzina di sigle “umanitarie” sparse in mezzo mondo, fino alla
carica (nel passato) di assessore alle politiche sociali del comune di
Battipaglia, e alla presidenza del comitato consultivo della Fondazione Caschi
Bianchi Europa ai cui vertici siedono l’argentino Octavio Frigerio e per
l’Europa il nostrano Antonio Volpe. Insomma, un ottimo biglietto da visita,
quello con le onoreficenze di Facchinetti, per la Fondazione promossa dal
sindaco di Roma, con fini - evidentemente - altrettanto umanitari. Un
Facchinetti davvero iperattivo, visto che pochi giorni dopo la presentazione
della rivista di casa, ha promosso per l’8 novembre un convegno dal titolo
“Esiliato, rifugiato, migrante. Temi dell’esilio e itinerari dall’Est”, svoltosi
presso la Sala del Caminetto di Nuova Italia. E passiamo alla creatura
trimestrale, Theorema. Viene edita da una sigla veronese, Noema (con una sede
secondaria a Roma, in via XX Settembre), direttore editoriale Nicola Peppe,
responsabile Salvatore Santangelo. Il comitato scientifico è coordinato da
Alfredo Mantici e composto da Luigi Cardona, Giuseppe De Donno, Nicola Pedde e
Sabatino Stornelli. A presiederlo, Mario Mori. Due nomi, quelli di Mori e Di
Donno, che riportano dritti dritti ai Servizi segreti di casa nostra, ai vertici
del Ros. Due nomi e un destino in comune: assolti (ma con una motivazione che -
se letta con attenzione - suona come una condanna che più forte non si può) nel
processo palermitano per la mancata perquisizione del covo di Totò Riina (venne
lasciato incredibilmente senza controllo per due settimane, trovato addirittura
ritinteggiato e ovviamente privo della cassaforte in cui con ogni probabilità
era contenuta la lista da 3000 nomi “eccellenti” pro mafia: «se ne cadeva tutta
l’Italia se lo trovavano», dichiarò la collaboratrice di giustizia Giusy
Vitale); ma oggi sotto processo, sempre a Palermo, per la mancata cattura di
Bernardo Provenzano.
Proseguiamo con l’organigramma
di Theorema. Il coordinamento redazionale è affidato a Carlo Andrea Cardona e
Rocco Bellantone. Fra i collaboratori ecco alcune firme: Floriana Barone,
Emanuela Del Re, Marta Fresolone, Marco Giaconi, Maria Rita Gismondo, Franz
Gustincich, Francesco La Licata, Giorgio Mantici, Luca Mantovani, Valerio
Morucci, Carlo Panella, Vittorfranco Pisano. Valerio Morucci? Possibile mai? Il
brigatista del caso Moro? Gomito a gomito con l’ex vertice del Ros Mori?
Rammentiamo, anche stavolta, qualche pezzo di storia. Morucci, fra i
protagonisti del rapimento-eccidio di via Fani, è stato condannato a più
ergastoli; poi, però, ha pensato bene di “dissociarsi”, facile percorso per una
fortissima riduzione di pena, tanto che è uscito di galera addirittura nel 1994.
Commenta lo scrittore Domenico Geluardi: «Mi ha lasciato di stucco leggere un
articolo di Morucci su Theorema, una rivista che si occupa di sicurezza,
geopolitica e intelligence. Il titolo è “Quando l’illecito diventa lecito” ed il
terrorismo non c’entra in alcun modo. L’ex brigatista parla della situazione
socio politica italiana, una vera analisi con tanto di attacco finale alla
“inconsistenza del Pil”. Nelle poche righe che presentano l’autore si legge che
“ha partecipato, tra l’altro, al sequestro di Aldo Moro, al cui epilogo si è
inutilmente opposto”. Piccola omissione: ha partecipato alla strage di via Fani,
ha sparato. Questo non è solo un dettaglio». Continua Geluardi: «leggo con
sgomento che il comitato scientifico è presieduta da Mario Mori e composto da
figure di primo piano delle Forze Armate e dei Servizi e anche dal collaboratore
storico del generale Mori, Giuseppe De Donno. Proprio il Mori che ha combattuto
il terrorismo al fianco del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Mori che ha
dichiarato che “uccidere un carabiniere è un reato che più di altri non può
restare impunito”. In via Fani il 16 marzo 1978 hanno perso la vita i
carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci». E, sconsolato, conclude: «Chissà
cosa prova l’ex direttore del Sisde a presiedere il comitato scientifico di una
rivista di intelligence che pubblica le analisi politiche di Valerio Morucci. E
cosa prova il sindaco Alemanno, che ha chiesto di non dimenticare le vittime
degli anni di piombo». E che - guarda caso - ha nominato proprio il generale
Mori e l’altro braccio destro nelle sue performances siciliane (soprattutto il
mancato controllo del covo di Riina), Sergio Di Caprio (al secolo il capitano
Ultimo, immortalato nel serial da Raul Bova) come responsabili della sicurezza
per il comune di Roma, incarichi lautamente retribuiti. E ora Alemanno è alle
prese con l’inchiesta della procura sulla mega Parentopoli in Campidoglio...
Sempre a proposito di Morucci, non mancano altri tasselli del passato
brigatista. Che conducono ad altri Servizi. Stavolta di marca israeliana.
Ricostruiscono all’università di Trento: «Anche Renato Curcio ne parlava,
richieste di incontri da parte del Mossad. Sarebbero avvenuti a Roma, presso
fermate di autobus. Ci sarebbe stato, fra gli altri, anche Morucci. Ma a quanto
pare non avrebbero portato poi a risultati concreti o a rapporti di qualche
tipo».
Non solo Servizi di casa
nostra, Mossad oppure Kgb nella bierre story. A quanto pare la “genesi” del
movimento (o comunque di una sua significativa costola) è avvenuta con la
benedizione dei vertici Usa. Osserva lo “storico” dei servizi segreti,
consulente di numerose procure e autore di diversi libri sul tema, Giuseppe De
Lutiis: «Non dimentichiamo un tassello fondamentale che si chiama Hyperion, la
cellula creata dalla Cia e della quale facevano parte alcuni brigatisti della
prima ora come Corrado Simioni, Giovanni Mulinaris e Duccio Berio». I tre,
infatti, fanno parte del nucleo originario delle Br, denominato “Collettivo
politico metropolitano”, in cui militarono anche Moretti e Prospero Gallinari.
La stella di Hyperion - una sorta di super cupola transnazionale in cui
confluiscono interessi politici e finanziari d’ogni risma - comincia a splendere
in Normandia, in una mega villa nei pressi di Rouen, «la villa dai tre anelli
concentrici», sottolinea De Lutiis. «I cerchi, gli anelli - descrive un altro
esperto che preferisce l’anonimato - sono una chiara simbologia che torna ancora
oggi più attuale che mai, in tempi di super lobbies che valicano i confini
nazionali e disegnano i destini del pianeta: e la prossima cyber war scatenata
dal caso Assange sta lì a dimostrarlo. Trilateral e Bilderberg, del resto, non
sono realtà metafisiche ma, purtroppo, ben concrete e determinanti...». Quella
storia, comunque, finì con destini separati. I tre (Berio, Mulinaris e Simioni),
dal ‘75 in poi si trasferiscono in Francia, mentre Moretti e Gallinari si
dedicarono ai destini bierre in Italia. Ma sarà mai finito il condizionamento
degli Anelli targati Cia su tante storie & misteri di casa nostra?
IN PRINCIPIO FU CIRILLO.
Torna in libertà Giovanni Senzani, l’ex criminologo brigatista che ebbe un ruolo
centrale nel sequestro dell’assessore democristiano della Campania Ciro Cirillo:
uno dei misteri italiani, con l’ombra dei Servizi, scriveva nel Gennaio 2011
Cristiano Mais su "La Voce delle Voci". Ex Terroristi, neri e rossi, nazi d’un
tempo, eversori d’ogni razza e tacca, oggi tutti rapiti da una comune passione
per editoria, stampe & culture? Più di un segnale ci porta in questa direzione.
E allora avviamoci in questo impervio cammino tra svastiche e falcimartello: ma
soprattutto, sovente, con un comune denominatore che si chiama Servizi Segreti.
Zitto zitto, senza rulli di tamburo è tornato libero come un fringuello l’ex
numero uno delle Brigate Rosse (in condominio con Mario Moretti per alcuni
anni), Giovanni Senzani. L’evento trapela solo a ottobre scorso, «perchè lui
vuole mantenere una posizione riservata», commenta il suo legale, Bonifacio
Giudiceandrea che del resto aggiunge: «non ha mai concesso interviste, non s’è
mai voluto confondere con gli altri ex pentiti, ha sempre mantenuto un dignitoso
silenzio».
Criminologo di belle speranze,
studi a Berkeley, prime pubblicazioni con Jaca Book (editrice filo Comunione e
Liberazione) un bel giorno scopre la lotta armate, ispirato anche dal cognato,
Enrico Fenzi. Co-protagonista nel caso Moro (regia morettiana), è l’indiscusso
numero uno nel sequestro e, soprattutto, nella “trattativa” per la liberazione
del potente assessore dc della Regione Campania, il gavianeo di ferro Ciro
Cirillo (nello stesso periodo l’assassinio di altri due dc, Pino Amato e
Raffaele Delcogliano). E’ lui, Senzani, in quel 1982, il vero trait d’union tra
Br, vertici Dc, camorra e Servizi segreti. Sarà proprio il carcere di Ascoli
Piceno, dove è detenuto il capo della Nco Raffaele Cutolo, la meta preferita per
gli “incontri”: un vero via vai di delinquenti organizzati, camorristi,
brigatisti con la chicca di alcuni pezzi da novanta dello scudocrociato. Sono di
allora le voci, sempre più ricorrenti, di «stretti legami di Senzani con pezzi
deviati dei servizi segreti». Con l’uomo ovunque, il faccendiere Francesco
Pazienza? Con il generale Giuseppe Santovito, piduista e mesi dopo morto in
circostanze misteriose? Con uno degli 007 più “esperti”, ossia Adalberto Titta?
Cirillo, dopo un paio di mesi, verrà “regolarmente” liberato (al contrario di
Aldo Moro che “Doveva morire”, come documentano carte alla mano Ferdinando
Imposimato e Sandro Provvisionato nell’omonimo best seller per Chiarelettere),
previo pagamento di un riscatto dall’importo mai chiarito (fra i 2 e i 5
miliardi di vecchie lire), frutto di una colletta tra aficionados della Dc
(costruttori impegnati nel dopo terremoto), e transitato in buona parte via Stet
(a quel tempo numero uno il piduista Michele Principe) attraverso pubblicità
canalizzata tramite compiacenti media vicini alla balena bianca. Scriveva la
Voce ad aprile 1989 in una delle tante inchieste dedicate al caso Cirillo: «Il
maresciallo Francesco Sanapo del Sismi ha riferito che il tenente colonnello
Giuseppe Belmonte gli confidò che la somma complessivamente raccolta era di 3
miliardi, provenienti in parti uguali dalla Dc e da un’operazione fatta da
Giuseppe Santovito. Soltanto la metà era stata data ai br; l’altra era stata
divisa tra Pietro Musumeci, Santovito, il ministro della Difesa e il
“segretario” di Santovito, Pazienza». Un brutto anno, per Giovanni Senzani, quel
1982, perchè viene arrestato per l’omicidio di Roberto Peci, fratello del br
Patrizio (considerato un traditore) e massacrato con undici revolverate. E c’è
chi non dimentica un particolare non da poco: proprio nei giorni del sequestro
Peci, Senzani sarebbe stato visto in compagnia di “un personaggio dei Servizi”
alla stazione di San Benedetto del Tronto; un altro incontro, poi, si sarebbe
verificato ad Ancona con uno dei vertici dei servizi, Musumeci, piduista, anche
lui “impegnato” nel caso Moro e dentro quel “comitato di sicurezza”
eccezionalmente varato dall’allora ministro degli Interni Francesco Cossiga e
composto da 11 piduisti su 12. La sentenza a carico di Senzani per l’omicidio
Peci? Ergastolo. Trascorso, però, in modo “particolare”. La condanna arriva
nell’87, e dura solo 12 anni, perchè nel 1999 ottiene già la semilibertà: di
notte in galera a Firenze, di giorno a lavorare in una libreria. Già, quella
passione. La sua palestra? La Edizioni della Battaglia (tanto per non cambiare),
che per fortuna si trova proprio di fronte alla sede del comando regionale dei
carabinieri, legione Toscana.
Torniamo al capo delle Br, la
mente del sequestro Moro, Mario Moretti. Di lui, del sequestro, ma soprattutto
del quartier generale-covo di via Gradoli, la Voce ha ampiamente scritto in
un’inchiesta dello scorso settembre. Documentando civico per civico, immobile
per immobile, le proprietà (passaggi di mano compresi) e le “storie” mattonare.
Che spesso e volentieri portano a prestanome o a sigle riconducibili ai Servizi
segreti. Sottolineano oggi i promotori di un battagliero comitato di inquilini:
«Ma si vuol far luce una buona volta su queste proprietà? Su dove realmente
viviamo? Sul ruolo dei servizi segreti? Sulle storie di trans e coca che hanno
reso la zona pressochè invivibile e quotidianamente pericolosa?». Sempre a
proposito del sequestro Moro: ma può mai essere un maledetto caso del destino -
o cos’altro - che ha indotto le Br di Moretti a trovare il covo dove nascondere
Moro nel posto più infestato di uomini dei Servizi? Ai confini della realtà...
«Non ai confini, ma dentro certa fisiologia dei Servizi - osserva un esperto -
ricordiamo solo un paio di casi: un immobile vis a vis con la autobomba
destinata a Maurizio Costanzo era intestato a uomini dei Servizi segreti. E come
dimenticare la storia di Castel Utveggio, con un intero maniero acquartierato
sulla collina che dominava la scena di via D’Amelio a Palermo, dove era
tranquillamente ubicata una società dei Servizi?».
Moro, Saronio e l’ex Br De
Vuono: la commissione d’inchiesta non fa luce,
scrive giovedì 21 settembre 2017 "Il Secolo d’Italia”. Un giallo antico sta per
essere risolto? Giustino De Vuono, l’ex Br e ‘ndranghetista, il cui nome più
volte è stato accostato al caso Moro è morto nel ’94, mentre il giallo della
foto scattata a via Fani, il 16 marzo del ’78, dove qualcuno ha sostenuto di
riconoscere il volto dello stesso De Vuono, non potrà essere risolto così
facilmente. È quanto rendo noto il Presidente dellaCommissione parlamentare
d’inchiesta sull’assassinio di Aldo Moro, Giuseppe Fioroni, a proposito della
figura di Giustino De Vuono, condannato per diversi delitti tra cui l’assassinio
dell’ingegner Carlo Saronio – rapito e ucciso da estremisti di sinistra – e
chiamato in causa come possibile assassino di Moro da alcuni quotidiani
all’indomani del 9 maggio 1978, quando venne pubblicata anche la sua foto
segnaletica. “Tramite l’arma dei carabinieri – spiega Fioroni – è stato
possibile stabilire con certezza la sua data di morte e il luogo di sepoltura.
De Vuono, ristretto nel carcere di Carinola dal 16 marzo 1991, venne ricoverato
il 1° novembre del 1994 nell’ospedale di Caserta, già operato di aneurisma
fissurato, e lì morì il 13 novembre dello stesso anno”. Secondo quanto acquisito
dalla Commissione Moro “la salma di De Vuono venne poi tumulata nella tomba di
famiglia presso il cimitero di Scigliano, dopo che una regolare autorizzazione
del magistrato ne consentì lo spostamento”. “Per quanto riguarda, invece, la
foto rinvenuta negli archivi del Messaggero, dove sembra intravvedersi il suo
volto in via Fani il giorno della strage, il Ris ha chiarito che non è possibile
eseguire utili comparazioni con quelle segnaletiche perché mancano alcuni
parametri essenziali per un eventuale accertamento”, ha concluso il presidente
dell’organismo parlamentare.
Gero Grassi e la verità sul
Caso Moro.
Aldo Moro, intervista del Tg Norba del 2 agosto 2017 a Gero Grassi sulle novità
dell’inchiesta. La Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro sospende
i lavori per la pausa estiva. Ecco le novità emerse nel corso di questo anno
fitto di audizioni. A parlarcene l’onorevole Gero Grassi, membro della
commissione. In Via Fani a Roma il 16 marzo di 38 anni fa, quando Aldo Moro fu
Rapito, erano presenti le Brigate Rosse, oltre ai Servizi stranieri ed italiani
ed alcuni membri della banda della Magliana. Al momento della sua uccisione, a
maggio dello stesso anno, i brigatisti, quasi certamente, non c’erano. Queste
alcune novità sul caso Moro emerse dal lavoro svolto negli ultimi mesi dalla
Commissione Parlamentare d’Inchiesta che si sta occupando da circa tre anni per
chiarire il rapimento e la morte dello statista pugliese della democrazia
cristiana. Oltre 120 audizioni ed interrogatori dai quali sono emersi
interrogazioni importanti come spiegato da Gero Grassi, membro della
Commissione. “Tra questi quella del capo dell’OPA Abusharif è stata
determinante, ma altrettanto determinante è stata quella di Alberto
Franceschini, che è stato uno dei capi delle Brigate Rosse. Ma anche alcuni
Magistrati e Funzionari di polizia hanno rotto il velo di omertà ed omissione
che c’era intorno al caso Moro”. Ma chi ha sparato? Moro fu ucciso con 12 colpi
intorno al cuore che non colpirono il cuore. “C’è un’indagine in corso, credo
che per fine anno questo quadro si possa definire con un nome ed un cognome
preciso. Sono emerse anche altre valutazioni preoccupanti, quali? La permanenza
in case di insospettabili di alcuni brigatisti dopo l’omicidio Moro:
insospettabili particolari”.
Segue l’intervista di Selene
Di Giovine su Studio9tv del 13 febbraio 2017. Lucera, grazie al Rotary Club, ha
ospitato l’On. Gero Grassi, promotore della legge istitutiva della Commissione
d'inchiesta sulla strage di Via Fani e sull'Omicidio di Aldo Moro. Grassi è'
anche membro della suddetta commissione e, da circa due anni, gira l'Italia per
parlare di Aldo Moro e svelare la verità sul rapimento e l'omicidio. Sono
passati quasi quarant’anni da quel 16 Marzo '78 – giorno del rapimento di Moro –
e dal 9 Maggio '78 – giorno dell'omicidio e ritrovamento del cadavere del
Presidente DC -. E se, per l'opinione pubblica non sono ancora chiari mandanti e
mandatari, per l’Onorevole è doveroso rendere giustizia ad un Uomo e consegnare
ai cittadini un'Italia più civile, più democratica, più libera, più sicura. Il
caso Moro è contenuto in due milioni di pagine che derivano da: otto processi,
quattro Commissioni Terrorismo e Stragi, due Commissioni Moro e una Commissione
P2. Volere fortemente l'istituzionalizzazione di una nuova Commissione, dopo
aver letto tutti i documenti sopracitati, è propedeutico alla verità giacché,
sino ad oggi, la verità non è stata raccontata. Molto, oggi, lo stiamo
scoprendo. Quello che racconto non è il pensiero di Gero Grassi ma tutte le
parole, citate, sono testuali della magistratura e delle commissioni.
Una storia cupa, che ha visto
protagonisti più parti e più interessi e con più vicende.
Gero Grassi e la verità sul
Caso Moro. Lucera, grazie al Rotary Club, ha ospitato l’On. Gero Grassi,
promotore della legge istitutiva della Commissione d'inchiesta sulla strage di
Via Fani e sull'Omicidio di Aldo Moro. Grassi è' anche membro della suddetta
commissione e, da circa due anni, gira l'Italia per parlare di Aldo Moro e
svelare la verità sul rapimento e l'omicidio. Sono passati quasi quarant’anni da
quel 16 Marzo '78 – giorno del rapimento di Moro – e dal 9 Maggio '78 – giorno
dell'omicidio e ritrovamento del cadavere del Presidente DC -. E se, per
l'opinione pubblica non sono ancora chiari mandanti e mandatari, per l’Onorevole
è doveroso rendere giustizia ad un Uomo e consegnare ai cittadini un'Italia più
civile, più democratica, più libera, più sicura. Il caso Moro è contenuto in due
milioni di pagine che derivano da: otto processi, quattro Commissioni Terrorismo
e Stragi, due Commissioni Moro e una Commissione P2. Volere fortemente
l'istituzionalizzazione di una nuova Commissione, dopo aver letto tutti i
documenti sopracitati, è propedeutico alla verità giacché, sino ad oggi, la
verità non è stata raccontata. Molto, oggi, lo stiamo scoprendo. Quello che
racconto non è il pensiero di Gero Grassi ma tutte le parole, citate, sono
testuali della magistratura e delle commissioni. Una storia cupa, che ha visto
protagonisti più parti e più interessi e con più vicende.
“L’opinione pubblica deve
andarla a cercare la verità. L’opinione pubblica accanto a San Remo deve
studiare la Storia, come stanno facendo le scuole. Cosa c’è di esaltante in
tutto questo: cancelliamo tutta la verità che conoscevamo e riprendiamo daccapo.
Anche le Brigate rosse hanno fatto il rapimento di Aldi Moro, che significa: che
insieme alle Brigate Rosse c’era la Mafia, la Camorra, la ‘Ndrangheta, la Banda
della Magliana. C’erano servizi segreti stranieri, CIA e KGB, e pezzi di servizi
segreti italiani. C’era anche un pezzo di Vaticano, lo Ior. Hanno fatto una
riunione ed hanno deciso di rapire Moro? No! Ma ci sono state le convergenze
parallele dell’Ovest, Usa; e dell’Est, Urss, fermi a Jalta per bloccare l’idea
di Moro che era la democrazia compiuta in Italia e l’Europa dei popoli”.
Perché 55 giorni di rapimento
per poi uccidere Aldo Moro?
“Innanzi tutto perchè le
Brigate Rosse erano divise sull’opportunità di ucciderlo o di rilasciarlo. E
poi, come lei può immaginare, se lo avessero ucciso in via Fani tutto il clamore
che c’è stato non ci sarebbe stato. I 55 giorni sono serviti anche per farsi
pubblicità. Usiamo un termine improprio. E per tenere in scacco l’Italia. Lei è
giovane, ma in quei 55 giorni il paese fu bloccato in tutti i sensi”.
Sicuramente, appunto, dietro
il caso Moro c’è l’interesse internazionale di, come diceva lei di Usa-Urss, ma
qual era l’importanza di questo Compromesso Storico?
“Guardi, Moro non voleva
questo Compromesso Storico. Il termine Compromesso Storico è di Berlinguer. Moro
voleva il confronto con i comunisti e la democratizzazione del Partito
Comunista. A tutto questo si opponevano sia gli Stati Uniti che non volevano i
comunisti al Governo, sia l’Unione Sovietica, che non voleva i comunisti al
Governo, se no, come avrebbe fatto a giustificare i carri armati di Budapest, di
Praga e di Varsavia. Quel mondo era cristallizzato ed era fermo a Jalta. Tutto
quello che andava oltre Jalta era sgradito e malvisto. Ecco perché Moro è stato
rapito ed ucciso.
1974, Washington DC. Kissinger
- Segretario di Stato Americano – riferendosi a moro dice: “Onorevole Lei deve
smetterla di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo
paese a collaborare. O la smette di fare queste cose o la pagherà cara. Veda Lei
come vuole intenderla”.
1976, Roma Termini. Alle 19,58
Aldo Moro sale sul treno Roma-Monaco. E' diretto a Predazzo per ricongiungersi
con la famiglia per trascorrere le ferie con la famiglia. Il treno parte alle
20.05. Alle 20.03, due agenti dei nostri servizi segreti fanno scendere Moro da
quel treno adducendo la scusa che deve, ancora, firmare documentazione
importante. Quel treno, per chi non avesse compreso, è l'Italicus che salta in
aria nella galleria San Benedetto Val di Sambro. La magistratura su quel treno
accerta tre cose: non ci sono colpevoli fisici ma la strage ha una matrice
neo-fascista; la polvere pirica utilizzata per la strage dell'Italicus è la
stessa di Piazza Fontana, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Piazza della Loggia,
Stazione di Bologna; la polvere pirica non è a disposizioni degli italiani ma di
una struttura internazionale che si chiama Gladio.
1975/76/77 – OP, giornale
diretto da Mino Pecorelli, in prima pagina intotola “Moro...bondo”, “E' solo
Moro il ministro che deve morire?”, “Con l'omicidio di Aldo Moro scomparirà la
presunzione berlingueriana di portare i comunisti al governo.”
Novembre 1977 – Moro scrive al
collega parlamentare Rosati “Berlinguer ha i suoi peggiori nemici in Unione
Sovietica. Io, in gran parte della Germania e negli Stati Uniti d'America.
Sempre nello stesso mese ed anno, nella totale assenza della popolazione Italia
e di chi avrebbe dovuto intervenire, a Roma, dopo la gambizzazione di Publio
Fiori, sui muri italiani appare una scritta impietosa “Oggi Fiori, domani Moro
”. Nessuno interviene.
Febbraio 1978 – I servizi
segreti francesi avvisano i nostri servizi che nel mese di Marzo l'onorevole
Moro sarebbe stato rapito. Nei nostri archivi, questo fatto, non risulta. Lo
scopriranno Imposimato e Priore solo nel 1982.
2 Marzo 1978 – Il ministero
della Difesa a Roma. Partono cinque passaporti falsi insieme con un documento.
Chi trasporta questo materiale è G-71, un gladiatore che s'imbarca sulla
motonave Jumbo M a La Spezia. La direzione è Beirut. Cosa dice il documento?
Prendere contatti immediati con i gruppi del terrorismo mediorientale per la
liberazione di Aldo Moro. Carta intestata del Ministero della Difesa. Firma
Ammiraglio Remo Malusardi, capo della X Divisione Gladio. Il destinatario?
Colonnello Stefano Giovannone, capo dei nostri servizi a Beirut. Il documento
viene ricevuto da G 243, capitano dei carabinieri Mario Ferrario. Questi
dovrebbe leggere il documento e distruggerlo. Il documento viene letto ma non
distrutto. Dopo qualche giorno, Ferrario, viene suicidato nella propria casa. Il
capitano, infatti, si impicca al porta asciugamani del bagno, posizionato a 1,20
di altezza e la perizia dimostra, tuttavia, che il porta asciugamani non avrebbe
retto il peso. I primi ad arrivare a casa sua sono agenti dei servizi che
puliscono la casa di ogni prova. Questa vicenda si interseca con altre due
vicende drammatiche che, sino ad oggi, erano coperte dal segreto di stato:
nell'Agosto del 1980 due venticinquenni, giornalisti italiani, scompaiono a
Beirut. I due giornalisti avevano scoperto che in un campo di addestramento
dell'OLP si addestrano i Brigatisti e che gli addestratori, di OLP e Brigatisti,
sono uomini italiani di Gladio; i vertici dei nostri servizi, tra cui i generali
P2, vengono arrestati per aver favorito commercio di armi ed intascato ingenti
guadagni tra le BR e l'OLP.
16 Marzo 1978 – L'operazione
dei brigatisti, per rapire Moro, è chiamata Operazione Fritz, parola tedesca per
indicare il ciuffo bianco. Moro si dirige in Chiesa per pregare. Quando esce,
Moro sale sulla Fiat 132 diretta alla Camera dei Deputati, ma la scorta per
raggiungere il luogo arriva in via Fani percorrendo quindi un giro molto più
lungo. Perché questa decisone? Il Ministero degli Interni non ha mai dato, in 36
anni, la striscia delle telefonate che la macchina della polizia ha ricevuto in
quella mezz’ora. L’operazione di via Fani dura 3 minuti. Rita Algranati, giovane
brigatista alza un mazzo di fiori per segnalare agli altri brigatisti l’arrivo
dell’auto del Presidente DC. Alberto Franceschini, membro delle BR, ha sostenuto
che senza la copertura della CIA, del KGB, del Mossad, loro non avrebbero potuto
né rapire né tenere nascosto Moro a Roma per 55 giorni. Chi ha ucciso la scorta
era persona conosciuta da quest'ultimi. L'uccisione è stata una esecuzione.
Il caso Moro presenta una
moltitudine di attori, principali e non. Vi sono presenti attori che agiscono
con atti omissivi, altri con atti attivi. Alcuni interessati alla morte di Moro
per destabilizzare il paese, altri interessati alle carte di Moro. Materialmente
l'operazione è stata portata a compimento dai brigatisti ma questi sono stati
accompagnati da soggetti terzi, statali e non. E' difficile individuare una
persona ma è senz'altro vero che possiamo ricercare, trovare, impugnare una
corresponsabilità.
Perché Moro? Gli Stati Uniti,
come si evince, non volevano che si attuasse la teoria del confronto con il PCI.
La Russia non voleva che il PCI si avvicinasse all'area di Governo altrimenti il
PCI avrebbe dimostrato che si poteva andare al governo senza l'ausilio dei carri
armati. Giacché i comunisti sovietici, nel resto del mondo, erano andati al
potere solo con l'ausilio di forze militari, questa anomalia
berlingueriana/italiana avrebbe anticipato la caduta del Muro di Berlino.
Perché sequestrarlo per 55
giorni se poi l'hanno ucciso? L'uccisione è ancora un mistero. I brigatisti, nel
raccontare la loro verità, commettono una serie di errori ed omissioni che non
combaciano. Le BR sostengono di aver ucciso Moro nel cofano della Renault ma è
materialmente impossibile che l'abbiano ucciso là. Dove l'hanno ucciso? I
brigatisti dicono in Via Montalcini. Non è vero. E' stato ucciso nei pressi di
Via Caetani. Quanti colpi sparati? I brigatisti non sanno dirlo. In realtà sono
11, 2 silenziati e 9 normali. Loro sostengono che Moro sia morto sul colpo e
questo non è vero. L'autopsia ha dimostrato che l'agonia è durata minimo un
quarto d'ora. Perché mentono? Perché anche nell'omicidio i brigatisti coprono
soggetti terzi non ancora individuati. D'altronde Curcio e Franceschini
sostengono che Mario Moretti sia una spia dei servizi segreti. Non
dimentichiamoci che alcuni brigatisti, oggi, sostengono che alcuni dei
brigatisti erano infiltrati dei servizi e si fanno i nomi di Moretti, Senzani e
Maccari. I dati di oggi ci dicono che anche nell'omicidio i brigatisti non erano
soli. Tante zone d'ombra e d'abisso, ancora, ci sono su un fatto nel quale
dentro ci sono i servizi segreti, nazionali ed internazionali, la Mafia, la
Camorra, la 'Ndrangheta, la Magliana, pezzi delle istituzioni. Selene Di Giovine
9 maggio 1978, verità e
menzogne sull’uccisione di Aldo Moro,
scrive Francesco Damato il 9 maggio 2017 su "Formiche.net". Per quanto
l’attualità politica sia ben altra, quasi all’indomani di due fatti – l’elezione
di Emmanuel Macron a presidente della Repubblica di Francia e il ritorno
di Matteo Renzi alla segreteria del primo partito d’Italia – che potrebbero
finire per intrecciarsi e riservarci sorprese, vedremo se più amare o più dolci,
secondo i gusti naturalmente; e mentre Sergio Mattarella riceve all’estero da
Roma notizie che lo incoraggiano forse a sperare che sia la volta buona perché
si proceda finalmente in Parlamento a varare quella riforma o riformetta
elettorale da lui ritenuta necessaria per affrontare una eventuale crisi di
governo con tutti i poteri conferitigli dalla Costituzione, compreso quello di
sciogliere anticipatamente le Camere, già troppo consumate di loro, e rimandare
gli italiani alle urne; per quanto, dicevo, ci siano tante cose a bollire nella
pentola dell’attualità politica, non riesco a togliermi dalla testa un ennesimo,
triste anniversario. Sono oggi trascorsi ben 39 anni dal 9 maggio del 1978,
quando una banda di sciagurati delle brigate rosse – al minuscolo, per favore,
come raccomandava la buonanima di Sandro Pertini per non confonderle con quelle
omonime da lui conosciute durante la Resistenza, con la maiuscola naturalmente –
uccise Aldo Moro, che era allora il regolo della politica italiana, dopo una
prigionia di 55 giorni, cominciata col sequestro e la strage della sua scorta a
poche centinaia di metri da casa, a Roma. Un omicidio, quello di Moro,
dichiaratamente compiuto dagli assassini sparandogli nel bagagliaio di un’auto
chiusa in un box della palazzina dove era stato nascosto. Un’auto poi guidata
per mezza città, sfidando controlli e incidenti, per essere posteggiata
provocatoriamente a due passi dalle sedi dei due partiti -la Dc e il Pci- che
avevano impedito di trattare il rilascio dell’ostaggio liberando tredici
detenuti per reati di terrorismo definiti “prigionieri politici” dai banditi.
Era peraltro anche il giorno di una importante riunione della direzione
nazionale della Dc, attesa da Giovanni Leone per firmare, come vedremo,
materialmente una grazia nel tentativo disperato di fermare gli assassini.
Già divisasi nella decisione
di chiudere il sequestro nella stessa maniera tragica in cui l’avevano
cominciato, cioè versando sangue innocente, l’infausta “direzione strategica”
delle brigate rosse ordinò l’esecuzione della “sentenza di morte” in tempo per
impedire che l’allora presidente della Repubblica, Leone appunto, forse anche
per questo costretto poi a dimettersi dai sostenitori della linea della fermezza
sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, firmasse un provvedimento di
clemenza predisposto per Paola Besuschio. Ch’egli aveva scelto in assoluta
autonomia e con criteri umanitari, per le sue precarie condizioni di salute, fra
i 13 detenuti di cui i terroristi avevano reclamato la liberazione. Così i
brigatisti, informati con una tempestività che avrebbe angosciato il povero
Leone sino alla morte, nel 2001, si risparmiarono il fastidio, chiamiamolo così,
di tornare a dividersi nella valutazione se la grazia alla sola Besuschio
potesse essere considerata sufficiente a segnare una loro vittoria nella sfida
lanciata allo Stato la mattina del sequestro del presidente della Dc. Che il 16
marzo del 1978 stava recandosi alla Camera per la presentazione del quarto
governo del suo collega di partito Giulio Andreotti, appena costituito per
disporre della fiducia del Pci guidato da Enrico Berlinguer. E ciò dopo una
lunga e difficile trattativa politica condotta per la Dc proprio da Moro. Grazie
alla cui capacità di persuasione e di realismo Berlinguer aveva rinunciato al
proposito di fare nominare ministri due indipendenti di sinistra eletti nelle
liste del Pci, accontentandosi di passare dall’astensione nei riguardi dello
stesso governo alla fiducia negoziandone solo l’aggiornamento del programma.
Tutto questo era evidentemente bastato e avanzato alle brigate rosse, e a quanti
le controllavano o usavano, a considerare sia Moro che Berlinguer, tenuti di
mira da tempo, dei traditori della sinistra e complici del demenziale Stato
imperialistico mondiale contro il quale si sentivano impegnati a combattere. E
non potendo attentare a Berlinguer, anche perché a quello potevano provvedere
direttamente a Mosca e dintorni, come si era già tentato di fare nel 1973 in
Bulgaria, attentarono a Moro. Che andava in giro per Roma su un’auto blindata
per modo di dire e con una scorta -pace all’anima di tutti i componenti- troppo
metodica nei percorsi e soprattutto abituata a mettere nel bagagliaio delle auto
di servizio, anziché imbracciarli sistematicamente, i mitra in dotazione.
La notte della Repubblica,
come fu chiamata per diverse e tutte fondate ragioni la stagione del sequestro
di Aldo Moro, si è purtroppo infittita, anziché schiarirsi, col passare degli
anni. Ogni volta che si è cercato di venirne a capo con indagini giudiziarie e
parlamentari, al di là della cattura e della condanna degli autori del
sequestro, il buio si è infittito, anziché diradarsi. I misteri sono aumentati,
anziché ridursi. E i racconti fatti, con deposizioni giudiziarie, memoriali,
interviste e quant’altro dai terroristi condannati, nessuno dei quali più in
carcere, si sono rivelati sempre più reticenti. Direi, odiosamente reticenti,
evidentemente motivati con la necessità di coprire responsabilità e complicità a
dir poco inquietanti, capaci di compromettere ancora più di quanto già non sia
accaduto il mito ideale e rivoluzionario, sia pure fallito, delle brigate rosse:
sempre al minuscolo, vi raccomando. L’ultima menzogna, che infittisce la notte
della Repubblica, l’ha appena scoperta la commissione parlamentare d’inchiesta
sulla vicenda Moro presieduta dall’ex ministro Giuseppe Fioroni con una
rilevazione tecnica che incredibilmente nessun inquirente aveva mai ritenuto di
effettuare. Si è accertato, in particolare, che l’auto nel cui bagagliaio i
brigatisti uccisero Moro, lasciandone tracce di sangue e altro, non poteva
materialmente entrare nel box per consentire loro quell’operazione di morte.
Doveva sporgervi di parecchio, e finire a vista di qualunque avesse avuto la
ventura di uscire dalla palazzina a quell’ora usando la propria vettura, perché
i Mario Moretti e compagni a bagagliaio aperto potessero passarsi l’arma e
sparare a turno contro l’ostaggio, come hanno raccontato. A questo punto è
diventato possibile sospettare, o risospettare, tutto: anche che Moro non fosse
stato ucciso in quel maledetto box di via Montalcini, né trattenuto in quella
palazzina. E chissà dove, allora. E chissà con quali e quante complicità. E
chissà con quanti mascalzoni sfuggiti alle loro responsabilità, e magari ancora
in grado di nuocere, almeno alla verità.
Il caso Moro spiega a cosa
dovrebbe servire una commissione parlamentare.
Contro i doppioni di indagini giudiziarie, scrive Massimo Bordin il 12 Luglio
2017 su “Il Foglio”. "Lo consideravamo l’apice del sistema di potere. Pensavamo
che lo stato avrebbe fatto carte false per riaverlo. Sbagliammo completamente
valutazione. Fino alla fine sperammo che Moro con le sue lettere fosse in grado
di muovere qualcosa all’interno della Dc”. Così ieri Adriana Faranda sentita
dalla ennesima Commissione sul caso Moro ha descritto la gestione, anche se il
termine è a dir poco inadeguato, del rapimento Moro da parte delle Br. Coincide
con l’analisi, mirabilmente sintetica, messa nero su bianco in un libro di
qualche anno fa da Aldo Giannuli: “Fecero una strage per rapire Aldo Moro e dopo
pochi giorni dal sequestro si accorsero che non sapevano che farsene”. Una
commissione parlamentare, piuttosto che doppioni di indagini giudiziarie,
dovrebbe occuparsi del senso politico del terrorismo italiano per come
rappresentato nelle elaborazioni, nelle azioni e nelle riflessioni successive
dei suoi militanti. Sarebbe una indagine forse di qualche utilità e non sarebbe
attività impropria, visto che il ruolo di una commissione parlamentare è per
l’appunto un ruolo politico. Bisognerebbe partire proprio dalle parole di
Faranda citate più sopra. Ma si sa che gli onorevoli indagatori sono interessati
a ben altro e anche questa occasione andrà sprecata.
Caso Moro, Adriana Faranda in
commissione: “La lista dei 90 nomi? Morucci non ne sapeva nulla”. L'esponente
delle Brigate Rosse dice la sua sull'elenco di 90 persone, nomi in codice ed
indirizzi di brigatisti noti (tra cui quello di Moretti) e di persone contigue
all’area sovversiva, ritrovato nell’appartamento che ospitava lei e Valerio
Morucci. E smonta la ricostruzione di chi indaga, scrive Stefania Limiti l'11
luglio 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Perentorio, aggressivo e sfrontato Valerio
Morucci: “Presidente, non gradisco” disse a più riprese rivolto a Beppe Fioroni.
Calma e disponibile lei, Adriana Faranda, ex compagna di Morucci e soprattutto –
come lui – componente della colonna romana delle Brigate Rosse che rapirono e
uccisero il presidente della Dc, Aldo Moro. Furono entrambi condannati a
trent’anni, ma lei fu la promotrice del movimento della dissociazione, grazie
alla quale beneficiò di uno sconto di pena: ora è un’apprezzata fotografa.
L’audizione alla commissione Moro della “signora delle Br” era attesa da tempo.
In due ore ha ricostruito diversi passaggi. Le Brigate Rosse, per esempio, non
volevano uccidere Moro, ma l’esecutivo brigatista decise che non si poteva fare
altro in “assenza di segnali”, anche se il mondo intero si era mosso per
implorare la liberazione del presidente della Dc: da Papa Paolo VI a Fidel
Castro, da Arafat al segretario generale dell’Onu fino alla Democrazia
Cristiana che avrebbe annunciato l’abbandono del fronte della fermezza la
mattina del 9 maggio, il giorno dell’assassinio. Racconta la Faranda:
“Con Lanfranco Pace (mediatore nei contatti con i socialisti, ndr) più che una
trattativa fu un dialogo, visto che nessuno di noi poteva decidere. Ci vedevamo
nei luoghi pubblici: come ci trovava lui, potevano trovarci anche le forze
dell’ordine”. La domanda non va posta alla Faranda, dunque, ma certamente non ci
fu un’azione investigativa degna di questo nome: i due postini delle Br, lei e
Morucci, giravano la città e frequentavano i locali di sempre, mentre Claudio
Signorile, alto esponente socialista, aveva informato il comandante dei
carabinieri dei contatti in corso. Insomma, fa notare il presidente della
commissione Beppe Fioroni, “non vi hanno voluto prendere”. Continua l’ex
brigatista: “Eravamo ragazzi sprovveduti, mediamente intelligenti che avevano
fatto una cosa di cui non avevano capito le conseguenze”. Insomma: “Speravamo
che Moro fosse in grado di rompere il fronte della fermezza”. La Faranda – senza
tradire emozioni, composta, disponibile – tiene a dare l’idea di un gruppo di
ingenui che giocavano alla rivoluzione. E forse per molti era davvero così.
Fioroni fa la domanda che forse lei più di tutte si aspetta e alla quale si è
più preparata: “Che ci dice della lista di nomi, quell’elenco di circa 90
persone, nomi in codice ed indirizzi di brigatisti noti (tra cui quello di
Moretti) e di persone contigue all’area sovversiva, ritrovato nell’appartamento
che ospitava lei e Valerio Morucci?”. Quando Fioroni fece la stesse domanda a
Morucci questi vacillò, si capì perfettamente che era un colpo basso, negò che
quei fogli fossero suoi, disse addirittura di non conoscerne l’esistenza anche
se erano allegati, come corpi di reato, all’ordinanza del suo arresto. La
Faranda, invece, coglie al volo: “Sì, presidente gliela spiego io! Avessi
buttato quella lista allora, per non sentire queste domande oggi! Si trattata di
un elenco ritrovato in un commissariato da alcuni compagni che lo diedero a me,
Valerio non ne sapeva proprio niente!”. Risolto il nodo. Morucci disse di non
aver mai visto quella lista e che forse era nell’appartamento di Giuliana
Conforto, che ospitava lui e la Faranda, e nel quale furono arrestati il 29
maggio del 1979, ma non era sua. Morucci si era innervosito molto, tanto da
arrivare a rispondere a Fioroni, a più riprese, con “Non gradisco questa
domanda”. Oggi la Faranda vanifica la fonte di prova di una possibile trattativa
intavolata per la loro resa in cambio dei loro compagni, scenario dato per certo
da fonti della commissione Moro, nel quale avrebbe coinvolto Umberto Federico
D’Amato, capo dei servizi segreti interni dal 1961 al 1974.
Un patteggiamento che sarebbe stato gestito dalla Squadra Mobile di Roma e
avrebbe portato alla verità “taroccata” del Memoriale, firmato da Morucci e
Faranda, che consentì al primo di essere presto libero, attivo interlocutore
anche di uomini delle istituzioni: ha lavorato per esempio per la G Risk,
società di intelligence e sicurezza amministrata dall’ex capo del Ros Mario
Mori, come rivelarono tempo fa Emiliano Liuzzie Marco Lillo sul Fatto. Sarà in
grado ora la Commissione parlamentare di tornare alla carica? Vedremo, se fino
ad ora non era chiaro, la partita è aperta, e diversi sono i giocatori in campo.
Ex magistrato genovese:
«Sparite le carte di Aldo Moro trovate in via Fracchia»,
scrive il 19 giugno 2017 "Il Secolo XIX". Dove sono finite le “carte di Aldo
Moro” ritrovate nel covo di via Fracchia a Genova? L’interrogativo torna di
attualità perché oggi la commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di
via Fani e l’omicidio di Aldo Moro ha ascoltato il magistrato Luigi Carli, che
all’epoca (28 marzo 1980) lavorava in procura a Genova: «Oggi abbiamo ascoltato
l’ex magistrato della Procura di Genova Luigi Carli che ha dato importanti
informazioni sulla nota e tragica vicenda del covo di via Fracchia dove i
quattro terroristi che stavano all’interno furono freddati dai Carabinieri del
generale dalla Chiesa», dichiara il deputato del Pd Gero Grassi, componente
della commissione. «Carli ha detto che sentì parlare durante un incontro con i
procuratori di Torino Maddalena, Laudi, Caselli e con il pm romano Priore
delle "carte di Moro" trovate nel covo durante l’irruzione e che, tuttavia, di
quelle carte nulla finì nei fascicoli di indagine». Aggiunge Grassi: «Le
affermazioni di Carli andranno riscontrate, dunque l’indagine prosegue ma
ricordo che l’allora procuratore di Genova, Antonio Squadrito, a proposito della
strage di via Fracchia disse in una intervista a Massimo Caprara nel febbraio
1982: “La verita´ è che abbiamo trovato un tesoro. Un arsenale di
armi...Soprattutto una trentina di cartelle scritte meticolosamente da Aldo Moro
alla Dc, al paese”. La deposizione di Carli appare perciò per il momento assai
significativa». «Non mi risulta niente di niente di quel che viene attribuito al
dott. Luigi Carli a seguito di dichiarazioni che egli avrebbe reso alla
Commissione parlamentare Moro. Del resto, è fuori di ogni logica che la
magistratura torinese possa aver `deciso l’irruzione nel covo Br di via
Fracchia´ o possa essersene in qualche altro modo occupata. E ciò per la
semplice ragione che la collaborazione di Patrizio Peci coi magistrati di Torino
ebbe inizio soltanto il 1 aprile 1980. Prima di allora egli (in veste di
semplice `confidente´ dei carabinieri e non ancora di "collaboratore di
giustizia"), nel pieno rispetto della legge aveva avuto rapporti esclusivamente
con il Nucleo speciale Antiterrorismo diretto dal Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa. Sono autorizzato dal collega Marcello Maddalena a precisare
(confermandolo a mia volta) che di Patrizio Peci in pratica egli non ebbe mai ad
occuparsi. Mi è invece impossibile aggiungere anche la smentita di Maurizio
Laudi (altro magistrato torinese che Carli avrebbe menzionato), essendo Laudi,
com’è noto, deceduto da tempo».
Il figlio di Roberto
Rossellini: "Le Brigate Rosse provarono ad uccidermi. Aldo Moro e mio padre
erano amici".
"A Rebibbia Maccari mi disse che mi aveva dovuto pedinare per 2
mesi perché incaricato di farmi un attentato", scrive di Guido Ruotolo il 10
luglio 2017. Parlando con un vecchio amico, Renzo Rossellini, figlio del grande
regista Roberto, con cui condivisi, negli anni Settanta la nascita di Radio
città futura (Rcf), una radio militante della sinistra che fu anche al centro di
un attacco terroristico dei NAR di Francesca Mambro e Valerio Fioravanti,
riaffiora un episodio che non è mai stato svelato. Le Brigate rosse volevano
uccidere Renzo Rossellini.
Renzo Rossellini, come lo
venisti a sapere?
"Creai RCF anche per
contrastare lo sbandamento di tanti compagni verso la lotta armata. Speravo che
dandogli voce preferissero parlare che sparare e, con altri compagni ci siamo
convinti che le BR fossero infiltrate dai Servizi Deviati, e rientrassero ancora
dentro lo schema della Stategia della Tensione".
E perché le Br avrebbero
dovuto ucciderti?
"Anni dopo, per avere
informazioni sulla carcerazione di Aldo Moro chiesi un permesso per andare alla
biblioteca del carcere romano di Rebibbia, che sapevo essere gestita da un
collettivo di cui faceva parte Germano Maccari che era stato un carceriere, il
quarto uomo, di Aldo Moro. A Rebibbia Maccari mi disse che mi aveva dovuto
pedinare per 2 mesi perché incaricato di farmi un attentato. Ma siccome vide che
mi toccavo frequentemente la vita capì che c'era qualcosa di strano e scoprì che
ero armato".
Un militante della sinistra
rivoluzionaria armato? Un paraterrorista? O armato per legittima difesa?
"In effetti la Digos della
questura di Roma, dopo 2 attentati dei NAR a Radio città futura, mi diede un
porto d'armi. Io portavo una pistola non in una fondina ma nella cinta ed avevo
paura che mi scivolasse via. Maccari mi raccontò che fatta la relazione alla
colonna romana delle BR, scoperto che ero armato, desistettero dall'attentato".
Come è possibile? le br che
in pochi minuti assaltarono l'auto e la scorta armata di Aldo Moro, uccidendo
tutti i poliziotti, desistettero perché tu eri armato?
"Maccari mi disse una frase
che ricordo molto bene: "Prima che un poliziotto reagiva noi l'avevamo già
colpito, ma un compagno armato poteva farci del male. E noi non volevamo
rischiare”. Dopo quell'incontro con Maccari partii subito per gli Stati Uniti,
quando tornai seppi che Maccari era morto in carcere".
Di cosa ti accusavano le
Brigate Rosse?
"Non era un mistero che
ritenessi le Br infiltrate dai Servizi e legate al blocco dei Paesi dell'Est.
Ricordo che un compagno palestinese mi raccontò che nel campo di addestramento
di Karlovy Vary, creato dal KGB, nella Repubblica Ceca, aveva conosciuto
compagni delle BR che si stavano preparando per azioni terroristiche urbane. Mi
raccontò anche che il campo di Karlovy Vary era attrezzato come un teatro di
posa cinematografico e che dei tecnici ricostruivano esterni ed interni simili
al teato dell'azione terroristica. Il sapere che le BR si addestrassero in un
campo militare del KGB mi fece fare molte domande e provai a dare risposte?".
Già in una intervista al
Fatto, l'anno scorso, hai sollevato il tema della infiltrazione delle Br.
"Per la verità l'ho sollevata
svariate volte alla Commissione parlamentare che ha indagato sul sequestro e la
morte di Aldo Moro. Ancora oggi ne sono convinto nonostante che a quarant'anni
dai fatti nessun pentito o dissociato, nessuna indagine della Procura di Roma
abbia accertato appunto i rapporti tra le Brigate rosse e le entità straniere. I
servizi segreti russi e cechi".
In quegli anni hai
conosciuto Aldo Moro, a casa di tuo padre...
"Ho conosciuto Aldo Moro a
casa di mio padre. Erano amici. Quando mio padre morì il 3 giugno 1977 Aldo Moro
venne al suo funerale e per farmi le condoglianze si volle appartare con me e
parlarmi di mio padre e del suo lavoro, riconoscendogli il merito di avere, con
"Roma Città aperta", contribuito a dare nel mondo un'immagine diversa
dell'Italia. E che con due martiri antifascisti, un partigiano comunista ed un
parroco prefirigurava il compromesso storico".
Quarantacinque minuti prima
di via Fani una ascoltatrice di Rcf disse di averti sentito anticipare che quel
giorno sarebbe accaduto un evento eclatante. In una intervista dell'ottobre del
1978 a un quotidiano francese confermasti questa tua analisi quella mattina.
Fosti preveggente o qualcuno ti informò prima?
"Io aprivo la Radio ogni
mattina con una rassegna stampa, i compagni non si svegliavano o non erano così
disciplinati da farlo. Quel 18 marzo 1978 si votava in Parlamento un governo con
l'astensione del PCI, di fatto nella maggioranza. La mia analisi rifletteva il
fatto che le BR erano state sempre presenti in campagne elettorali od altri
eventi politici con loro azioni terroristiche e dissi che ci saremmo potuti
aspettare un'azione tertoristica. Non nominai mai Aldo Moro ma un'ascoltatrice
disse di avermi sentito dire "Oggi le BR rapiranno Aldo Moro". Da qui l'equivoco
per il quale sono stato ascoltato da tutte le commissioni Moro. RCF era
registrata 24 ore su 24 dal Viminale e dalla Digos e nella registrazione non
nomino mai Aldo Moro".
Moro, la Renault 4 e quel
garage di via Montalcini: il racconto brigatista non torna.
La Commissione d'inchiesta e i Ris nel garage dove, secondo la versione delle
Br, uccisero il leader Dc il 9 maggio del 1978 a Roma, scrive Roberta Benvenuto
il 4 maggio 2017 su "Globalist.it". Trentanove anni dopo, la presunta scena del
crimine politico più misterioso d'Italia torna a rivivere. È via Montalcini 9. E
la dinamica da ricostruire è quella dell'uccisione di Aldo Moro il 9 maggio del
1978. Gli spari, la Renault 4 (rossa, come l'originale), le stesse due armi, la
mitraglietta Skorpion e la pistola Ppk. Trentanove anni dopo il Ris torna nel
garage dove i brigatisti Moretti e Maccari dissero di aver ucciso Aldo Moro.
Sulle modalità dell'uccisione si sa che chi ha ammazzato il leader Dc promotore
del compromesso storico lo guardò negli occhi. Ma, trentanove anni dopo, sono
ancora tanti i punti che non tornano. Il sopralluogo. Ad arrivare per primo
nella via della periferia sud-est di Roma, zona Magliana, il comandante Luigi
Ripani, l'uomo che guida le operazioni dei carabinieri che stanno ricostruendo
le scene del crimine più noto delle Br, quello che Sciascia da subito definì
Affaire Moro, dalla strage di via Fani al tragico epilogo, con l'omicidio
dell'uomo del compromesso storico nel box dell'appartamento-prigione del primo
piano. Ripani è arrivato con sottobraccio il libro Il prigioniero di Anna Laura
Braghetti, uno dei quattro carcerieri di Moro, oltre i due che si sono
autoaccusati degli spari, c'era infatti Prospero Gallinari, rimasto in casa
quella drammatica mattina, che cambiò la storia della Repubblica.
Due domande. Obiettivo
(dichiarato) degli investigatori, quello di verificare il racconto di quei
momenti. Due le domande principali che la Commissione Moro del presidente
Fioroni ha posto: la prima è se è possibile che gli spari, alcuni in sequenza e
altri unici, alcuni silenziati e altri no, possano essere passati inosservati,
non ascoltati da nessuno, 39 anni fa. La seconda e se quella R4, poi ritrovata a
via Caetani, entrasse in quel piccolo box, permettendo in spazi angusti di far
sdraiare Moro nel portabagagli, lasciando lo spazio necessario per sparare a chi
aveva il compito di uccidere il presidente, mentre l'auto era con il muso
rivolto all'uscita, con mezza saracinesca aperta. Attesa per perizia dei
carabinieri che verificherà il racconto dei terroristi. Domande a cui il Ris
cercherà di rispondere con le sue perizie, che arriveranno a breve. Nel
frattempo i tanti politici della Commissione presente, i carabinieri e gli
abitanti del condominio, fanno le loro ipotesi. Per alcuni il rumore degli spari
è assordante: "impossibile che non si siano sentiti" e quindi qualcosa non
torna, per altri, che si sono posizionati nei pianerottoli soprastanti invece
"da lì non si sentiva nulla". Alla fine, sono passate oltre quattro ore, e gli
uomini del Ris hanno smontato le apparecchiature portate. Le nuove tecnologie,
gli apparati elettronici, i misuratori del rumore delle armi e poi la R4,
prestata da un comune cittadino, lasciano in corteo il garage. Il 'nuovo'
proprietario del box, chiude la saracinesca. "È una storia di quasi 40 anni fa,
la casa la comprò mia suocera, ora ci vive mia figlia, ma noi nel garage non
abbiamo mai toccato nulla, è rimasto così com'era...". "Il sopralluogo è stato
di grande impatto emotivo - racconta Gero Grassi, componente della commissione
parlamentare d'inchiesta- anche perché le prove sono state realizzate portando
dentro il box una R4 identica a quella usata nel '78 dai brigatisti. La prima
forte sensazione che si ha arrivando in via Montalcini è che la presunta
prigione del popolo (le Br sostengono che in quel palazzo all'interno 1 è stato
tenuto Moro per 55 giorni) sarebbe stata collocata in un luogo assai esposto e
pieno di insidie: l'appartamento affaccia sulla strada, contiguo quasi con
l'esterno e alle finestre si arriva da una grande veranda. Quanto al box dove
sarebbe stata parcheggiata l'auto: non si chiude la saracinesca perché l'auto
non entra interamente se ha il cofano aperto. Quindi tutte le operazioni
sarebbero state fatte con la porta basculante aperta. Poi non c'è abbastanza
spazio per far entrare nell'abitacolo una cesta: mentre le Br sostengono che
così hanno portato il presidente Moro all'interno del bagagliaio dove poi è
stato ritrovato. Ancora: gli spazi ristretti impongono allo sparatore di essere
a dieci centimetri dal volto di Moro. Infine, i colpi sparati dagli uomini del
RIS, a noi che eravamo senza protezione acustica, hanno dato l'impressione che
scoppiasse una bomba: possibile che nessuno degli abitanti del palazzo sentì
rumore quella mattina del 9 maggio?
Aldo Moro, l’ultima perizia
e la ricostruzione che potrebbe riaprire il caso,
scrive il 10 maggio 2017 su “Il Corriere della Sera”. Com’è stato ucciso il
presidente della Dc Aldo Moro? La perizia di 108 pagine depositata pochi giorni
fa dal Ris alla commissione Moro potrebbe riaprire il caso. Gli investigatori
segnalano infatti «incongruenze logiche», cioè tracce di spari dove «non
avrebbero dovuto esserci». Nel maggio del 1978 sangue del tipo A1MN, compatibile
con la sequenza genetica di Aldo Moro (il test del Dna non c’era ancora), fu
raccolto dai medici legali sul tettuccio della Renaut 4 all’altezza del sedile
posteriore sinistro e sul lato interno del finestrino posteriore sinistro, oltre
che nel bagagliaio dell’auto dove - secondo le sentenze, il racconto dei
brigatisti e i periti medico legali e balistici - si consumò la sequenza
dell’assassinio del presidente della DC.
Omicidio Moro, nuove tracce
di spari e sangue nella R4: la perizia del Ris riapre il caso,
scrive Laura Larcan Domenica 7 Maggio 2017 “Il Messaggero”. Ad Aldo Moro fu
sparato solo mentre era reclinato nel portabagagli della Renault 4 dopo che le
Br gli avevano steso una coperta sopra? E perchè allora ci sono altre tracce di
sangue di Moro in altre parti della macchina? La storia potrebbe essere
riscritta. Una nuova «incongruenza logica» riapre, infatti, il caso sulla
modalità di omicidio del presidente della Dc Aldo Moro (era il 9 maggio del
1978) dopo la lunga prigionia di 55 giorni da parte delle Brigate Rosse. Il caso
è legato a tracce di sparo e di sangue dove «non dovrebbero esserci». La notizia
è di oggi. Il Ris di Roma, nella perizia di 108 pagine depositata pochi giorni
fa in Commissione Moro, segnala la presenza "incongruente" di tracce di sparo
(GRS) dove non dovrebbero esserci e cioè sull'aletta parasole di destra della
Renault 4 e sul “cielo” della R4, quasi al centro dell'automobile. Due presenze,
cioè, che riaprono il capitolo delle modalità dell'uccisone di Aldo Moro. Perché
la perizia parla di «incongruenza logica»? Facciamo un passo indietro
nell'indagine. Nel maggio del 1978 sangue di tipo "A1MN", del tutto compatibile
con la sequenza genetica di Aldo Moro (all'epoca non c'era ancora l'esame del
DNA), fu raccolto dai medici legali sul tettuccio della R4, all'altezza del
sedile posteriore sinistro, e sul lato interno del finestrino posteriore
sinistro, oltre che nel bagagliaio dell'auto dove si consumò tutta la sequenza
dell'omicidio, secondo le sentenze, il racconto delle Br e gli stessi periti
medico legali e balistici dell'epoca. Oggi, dunque, il Ris di Roma, evidenzia
una ulteriore incongruenza logica. A ricordare alla Commissione Moro il primo
elemento, cioè il sangue di Moro dentro la R4, sono state alcune lettere
scritte dai periti Alberto Bellocco e Gianluca Bordin che hanno collaborato per
la parte scientifica alla ricostruzione dell'omicidio di Moro nell'inchiesta
"Morte di un Presidente" e le relative perizie (140 e 7 pagine) sono agli atti
della Commissione Moro dal giugno del 2016. Nei giorni scorsi il Ris di Roma ha
consegnato alla Commissione Moro la sua perizia (108 pagine) segnalando
sul tettuccio la presenza di vernice (l'unica traccia che ha potuto analizzare)
e al contempo la scomparsa di almeno due delle tre macchioline rossastre che per
conformazione, struttura e valutazione, seconda la tecnica BPA, erano di sangue.
Al momento dei rilievi congiunti Ris-Polizia scientifica - come mostra
la comparazione tra le foto del 9 maggio 1978 e quelle dell'11 novembre 2015 -
alcune delle macchioline che i medici indicarono come sangue di Moro non c'erano
più. Questa doppia presenza rende molto problematico sostenere che Moro sia
stato ucciso solo stando racchiuso nel portabagagli dopo che le Br gli avevano
steso sopra una coperta. Infatti la stessa non è bucata nella parte superiore e,
soprattutto, Moro offre al suo assassinio, collocato secondo la vulgata in
piedi fuori dal portellone, solo la parte destra del corpo mentre la sequenza di
sparo è concentrata in una area ristretta dell'emitorace sinistro.
Commissione Moro:
annunciati nuovi, clamorosi sviluppi.
La seconda relazione del gruppo parlamentare d'inchiesta smonta tutte le
precedenti certezze su rapimento e uccisione dello statista Dc, scrive Giorgio
Sturlese Tosi il 23 dicembre 2016 su "Panorama". Dimenticate tutto quello che
cinque processi ci hanno raccontato sulla strage di via Fani e sul rapimento e
l’assassinio di Aldo Moro. La seconda relazione della Commissione parlamentare
d’inchiesta, in 197 pagine, smonta ogni certezza, restituisce dignità alle più
inverosimili tesi complottiste e annuncia, per l’anno nuovo, sviluppi clamorosi.
Le novità.
Le presunte novità
cominciano proprio dall’agguato del mattino del 16 marzo 1978, per il quale
l’onorevole Gero Grassi, tra i più attivi membri della Commissione, titola il
suo intervento: “In via Fani ci sono anche le Brigate Rosse”. E aggiunge:
“Stiamo riscrivendo la storia di Aldo Moro e quindi la storia d’Italia; chi dice
che sulla vicenda Moro si sa tutto dice delle plateali bugie”. I brigatisti
rimasero feriti e avevano una base dove si curarono. La Commissione – spiega il
presidente Beppe Fioroni – si dice certa di aver individuato nei pressi di via
Fani un nuovo covo, una base logistica che ha permesso il trasbordo del
presidente della Dc subito dopo il sequestro e il ricovero dei brigatisti feriti
durante l’assalto (circostanza dedotta dalle tracce di sangue repertate su tre
delle auto usate dai Br nel blitz). Di più. Questo covo, “una base di copertura
medica”, localizzato in una palazzina di via Massimi, era di proprietà dello
Ior, la banca vaticana, e vi abitavano terroristi palestinesi, elementi di
Autonomia Operaia e una appartenente alle Br (“atti trasmessi alla procura di
Roma e coperti dal segreto istruttorio”). Per la Commissione, inoltre, l’agguato
non avrebbe potuto aver luogo se il bar Olivetti, situato in posizione
strategica, quel giorno fosse stato aperto. Il presidente Fioroni sottolinea che
quel bar era di proprietà di un pregiudicato ben noto alle forze di polizia,
Tullio Olivetti, ed era al centro di un traffico di armi con il Medio Oriente e
con la ‘ndrangheta. Quanto basta, alla Commissione, per sospettare presenze
eterogenee sul luogo dell’assalto.
I palestinesi e l'allarme
inascoltato.
Nella relazione si torna sulla già nota vicenda del presunto
allarme lanciato da un nostro agente segreto di stanza in Libano per confermare
i collegamenti tra Brigate Rosse e i movimenti palestinesi. In particolare si
racconta che il colonnello Stefano Giovannone, allora capocentro del Sismi a
Beirut, il 17 febbraio 1978, inviò una nota su una possibile azione terroristica
segnalatagli da George Habash, leader del Fronte Popolare di Liberazione della
Palestina (Fplp). Lo stesso Giovannone sarebbe poi partito per Roma, a sequestro
avvenuto, per esplorare un canale palestinese di trattative con le Br. “I
palestinesi - deduce Fioroni - divennero protagonisti di una trattativa
finalizzata alla liberazione di Moro”. E infine, ancora Giovannone, rivelò che
le Br avrebbero inviato a George Habash copia delle dichiarazioni rese da Moro
nel corso degli interrogatori. Esisterebbe dunque un verbale dell’interrogatorio
a cui fu sottoposto lo statista nella “prigione del popolo”, donata da Mario
Moretti ai palestinesi – secondo la Commissione – per farsi perdonare di non
aver ascoltato l’appello di Yasser Arafat a liberare Aldo Moro e il fallimento
della trattativa.
Il superclan e la Raf.
La
Commissione torna poi a concentrarsi sulla scuola di lingue di Parigi Hyperion,
definita - non è ben chiaro su quali nuove e certi elementi – la centrale del
terrorismo internazionale che seguì da vicino, inviando un suo emissario a Roma
nei giorni del sequestro, la vicenda Moro. I collegamenti porterebbero fino alla
Raf, la Rote Armee Fraktion, tanto che gli onorevoli si accingono a chiedere una
rogatoria in Germania.
La relazione è solo
“intermedia”, ne seguirà una conclusiva alla scadenza della legislatura, se ce
ne sarà il tempo. Qualunque sia l’esito del lavoro dei parlamentari che
orgogliosamente rivendicano di aver fatto luce “su ampie zone di opacità,
inefficienze operative, omissioni nelle versioni rilasciate dai brigatisti,
investigatori e uomini politici che hanno impedito a lungo l’accertamento di
aspetti centrali della vicenda”, l’unica certezza è che, su Aldo Moro, questa
sarà l’ultima commissione parlamentare d’inchiesta.
L’ultimo segreto del
sequestro Moro “Le Br inviarono le carte ai palestinesi”.
La Commissione d’inchiesta: “L’Olp si offrì di mediare, ma il governo disse no”,
scrive Fabio Martini il 22/12/2016 su “La Stampa”. Dai cassetti segreti di una
storia infinita come il caso Moro, ora affiora una nuova vicenda che conferma il
rapporto privilegiato e oscuro intrecciato dallo Stato italiano con i movimenti
palestinesi, nella stagione in cui questi praticavano attività terroristiche:
nell’aprile 1978 - quindici giorni prima che il prigioniero Aldo Moro venisse
ucciso dalle Br - dunque nel momento di massima crisi dello Stato repubblicano -
i Servizi italiani attivarono un canale riservatissimo con i palestinesi per
sondare una trattativa. Obiettivo: la liberazione del presidente
democristiano. Ma quella trattativa - pur promettente - naufragò: anche perché
si capì che sarebbe stato scandaloso, se si fosse scoperto quel canale
privilegiato con movimenti che uccidevano da anni cittadini occidentali e che
rifornivano di armi proprio le Br, che in quei giorni tenevano prigioniero Aldo
Moro. In altre parole quella trattativa segretissima non decollò anche perché
avrebbe rischiato di determinare un formidabile corto circuito, accendendo i
riflettori sulle ambiguità dello Stato italiano che già da anni aveva stretto un
patto top-secret con i palestinesi: a loro la possibilità di far passare fiumi
d’armi nel nostro Paese e in cambio l’Italia sarebbe stata risparmiata da azioni
terroristiche. La vicenda della trattativa parallela è stata ricostruita dalla
Commissione Moro che, oramai da due anni con spirito pragmatico, sta scavando e
acquisendo molti nuovi elementi fattuali, ma «evitando il rischio di una
storiografia parlamentare», come dice il presidente e relatore della Commissione
di inchiesta Giuseppe Fioroni, già ministro della Pubblica istruzione
nell’ultimo governo Prodi. Storia senza fine quella del rapimento di Aldo Moro:
dopo 38 anni, dopo cinque processi, dopo diverse inchieste parlamentari, più si
scava, più aumentano le scoperte spiazzanti, capaci di riscrivere interi
capitoli di una delle storie più misteriose della Repubblica. La trattativa con
i palestinesi è stata ricostruita grazie alla scoperta di documenti, in alcuni
casi rimasti secretati per decenni: il 17 febbraio 1978, il colonnello Stefano
Giovannone, capocentro Sismi a Beirut, invia un messaggio ai superiori di Roma
su una possibile azione terroristica in Italia, come segnalatogli da ambienti
vicini al leader palestinese George Habbash. Allarme sottovalutato. Il 16 marzo
Moro viene rapito e a fine aprile si apre lo spiraglio per una trattativa. Il 23
Moro, nelle mani delle Br, spedisce una lettera, nella quale consiglia di far
richiamare Giovannone a Roma, cosa che si concretizza immediatamente.
L’«ambasciatore» dell’Olp a Roma Hammad chiede un incontro urgentissimo al
ministro dell’Interno Cossiga, ma la trattativa si blocca di colpo. Per diverse
ragioni. Compresa la spaccatura nelle Br sulla sorte di Moro, che il 9 maggio
viene ucciso. Ma per avere un’idea dei rapporti tra le Br e i movimenti
palestinesi, interessante anche la scoperta di un messaggio di Giovannone del
giugno 1978 che da Beirut segnalava: «Le Br avrebbero fatto pervenire in questi
giorni personalmente ad Habbash copia di dichiarazioni rese dall’onorevole Moro
nel corso di interrogatori subiti». Commenta il presidente Fioroni: «Tale
notizia, se verificata, confermerebbe ciò che da tempo si sospetta, ovvero un
uso politico e spionistico delle carte e delle dichiarazioni di Moro». Un altro
fronte sul quale la Commissione ha scoperto una clamorosa anomalia riguarda la
cattura di Valerio Morucci e Adriana Faranda, due brigatisti dell’ala
trattativista, in quei giorni fatidici in contatto con il mondo politico ed
intellettuale che si mosse per liberare Moro. Ambienti che negli anni successivi
hanno aiutato ad avvalorare la veridicità del «Memoriale Morucci», diventato
«vulgata» per tanti libri sul caso Moro. Secondo quella «vulgata brigatista» le
modalità dell’arresto dei due furono molto aspre. Una versione contestata da
anni da chi ipotizza una «resa» concordata, una sorta di scambio che -
attraverso il Memoriale - avrebbe consentito di mettere una pietra tombale sulle
tante ambiguità che connotarono il rapporto tra Br e Stato. Ebbene, la
Commissione ha scoperto l’esistenza di due diversi verbali in occasione
dell’irruzione del 29 maggio 1979. Due documenti contrapposti. Nel verbale di
perquisizione, redatto a caldo, si racconta che i due non opposero alcuna
resistenza e anzi, secondo l’ispettore Nervalli, «sembrava che i due si stessero
costituendo». Mentre nella relazione inviata l’indomani alla magistratura si
riporta la descrizione di un’irruzione «fulminea» che avrebbe preso di sorpresa
i due brigatisti, bloccati nell’atto di prendere le loro armi per abbozzare una
resistenza. Originale anche il destino della padrona di casa: Giuliana Conforto,
figlia di uno dei principali agenti del Kgb in Italia, all’inizio pesantemente
imputata, uscì dai processi perché fu accettata la tesi di una sua
inconsapevolezza sull’identità di Morucci e Faranda.
Omicidio Moro, la relazione
della commissione di inchiesta: forse in uno stabile dello Ior la prigione
dell'ex leader Dc,
scrive su L'Huffington Post Di Maria Antonietta Calabrò il
21/12/2016. Per ora è un’ipotesi investigativa, ma piuttosto corposa, non più
solo un’ipotesi di lavoro, e di conseguenza, la dinamica del rapimento e
dell’uccisione di Aldo Moro sembrano sempre più da riscrivere. Due palazzine
dello IOR di via Massimi 91, alla Balduina (una zona residenziale a nord ovest
della Capitale, ndr), potrebbero essere state usate almeno per i primi dieci
giorni del sequestro, come base logistica o addirittura come “prigione del
popolo” per la detenzione dello statista democristiano. La Commissione
parlamentare d’inchiesta presieduta da Giuseppe Fioroni ha inviato atti e
testimonianze frutto di un anno di accertamenti alla Procura e alla Procura
generale di Roma e sono in corso nuove indagini. Perché ai tempi del sequestro
delle BR i controlli delle forze dell’ordine in quella zona si fermarono proprio
davanti al complesso residenziale costruito dalla cosiddetta banca vaticana tra
il 1965 e il 1970 e di cui l’Istituto per le opere di religione è rimasto
proprietario fino a dieci anni fa (2006), quando il comprensorio finì nella
maxivendita degli immobili IOR per cui gli amministratori sono stati messi sotto
inchiesta per peculato dal Procuratore vaticano. “La Commissione ha indagato con
particolare impegno sulla tematica della presenza di un possibile covo
brigatista nell’area della Balduina”, si legge nella seconda Relazione della
Commissione approvata nella serata di martedì 20 dicembre e illustrata in una
conferenza stampa a palazzo San Macuto. Si tratta di uno sviluppo clamoroso che
segue quanto già esposto nella Relazione 2015 relativamente alla dinamica
dell’agguato di via Fani e dell’abbandono di un’auto dei brigatisti, la 128 blu
targata Roma L55580, in via Licinio Calvo, dove venne ritrovata mezzora dopo la
mezzanotte del sabato successivo al rapimento, il 19 marzo 1978. Il fatto che
tutte e tre le auto servite per la fuga furono lasciate in tre diversi momenti,
a distanza di tempo l’una dall’altra, in una zona limitrofa a via Fani, già
dall’inizio venne considerata dagli investigatori segno evidente di grande
padronanza del territorio di cui diedero prova le BR. Polizia, Carabinieri e
Guardia di Finanza effettuarono ricerche nella zona (fra via Bitossi, via
Licinio Calvo, via Alfredo Serranti e via Massimi) per individuare il “garage
compiacente” che poteva aver ospitato innanzitutto la 128 bianca e la 128 blu.
Ma non emerse nulla perché le perquisizioni si fermarono davanti all’ampio
comprensorio di via Massimi 91, che pur non godendo dell’extraterritorialità in
senso giuridico, venne risparmiato: fu trattato con riguardo, quasi fosse
impensabile andare a guardare là dentro, tra gli affittuari della banca
vaticana. La Commissione Fioroni (che ha i poteri d’indagine dell’autorità
giudiziaria), riprendendo gli accertamenti sin dall’inizio, ha svolto
autonomamente i suoi riscontri, sia acquisendo documenti sia con l’acquisizione
di molte testimonianze e adesso nelle pagine della nuova Relazione “tra i
principali filoni di indagine sviluppati e le prime risultanze “vengono messi
sotto i riflettori i due stabili dello IOR. Con un’avvertenza importante: “Con
tutti i limiti di ciò che allo stato dell’inchiesta può essere reso pubblico”.
“È stato in tal modo possibile dare sostanza ad un’ipotesi, da tempo sostenuta
da varie fonti, sulla presenza di una base brigatista non lontana da via Fani”,
afferma la Commissione d’inchiesta. Continua la Relazione: “Le due palazzine in
questione, di proprietà dello IOR, registrano una serie di presenze
significativamente legate all’area politico-ideologica in cui è maturato il
sequestro dell’onorevole Moro, tra le quali quella di un soggetto straniero, la
cui presenza è confermata da più testimoni; quella di un esponente
dell’Autonomia operaia romana anche nel periodo del sequestro Moro; quella di
almeno un militante regolare delle Brigate Rosse, con disponibilità di regolare
accesso in periodo successivo al sequestro”. “Tali presenze - aggiunge il
documento - risultano peraltro insediate, con modalità che sono in corso di
accertamento, in una realtà profondamente diversa in quanto il condominio era
abitato, in ragione della sua proprietà, oltre che da privati, da prelati ed era
sede di società estere”. Quest’ultima notazione aggiunge giallo al giallo. Il
comprensorio di via Massimi 91 è costituito, si diceva, da due palazzine, la A e
la B, con molti garage che hanno accesso diretto ai vari piani, grazie ad
ascensori, e un grande spazio verde con giardini e alberi ad alto fusto. La
palazzina che si ipotizza possa essere quella utilizzata dalle BR è la B. Non
solo per nascondere le auto, visto che già nel novembre del 1978 in una
relazione del Commissariato Monte Mario al Questore di Roma si scrisse di “un
garage attraverso il quale i rapitori dell’On. Moro lo avrebbero condotto nel
luogo di prigionia”. L’appartamento-covo si sarebbe trovato all’ultimo piano,
sovrastato da un terrazzo che costituisce il punto più alto di tutti gli edifici
della Capitale. Dopo la vendita del 2006 gli appartamenti sono stati totalmente
ristrutturati e completamente riorganizzati negli spazi interni.
Caso Moro, “covo Br in
palazzina dello Ior: forse una delle prigioni del presidente Dc”.
Gli investigatori della Commissione d'inchiesta hanno individuato uno stabile in
zona Balduina, proprio vicino via Mario Fani. Pubblicata la seconda relazione:
trattativa aperta grazie all’Olp di Yasser Arafat, con l’intermediazione del
famoso colonnello Giovannone, ma ai primi di maggio qualcuno la fa saltare,
scrive Stefania Limiti il 21 dicembre 2016 su "Il Fatto Quotidiano". Occhi
puntati su via Massimi, zona Balduina, proprio vicino via Mario Fani. Lì c’è una
elegante palazzina, nel ’78 proprietà dello Ior, la Banca vaticana, dove gli
investigatori della Commissione Moro hanno individuato un covo delle Br e dove
assai probabilmente fu organizzata la prigione di Moro. E’ su quest’ultima
ipotesi che si allungano le ricerche. Le novità più ‘pesanti’, da quel che si
apprende, non sono state pubblicate nella II Relazione sull’attività della
Commissione d’inchiesta: tutta roba che resta secretata per tutelare il lavoro
istruttorio ma che è già sul tavolo della Procura di Roma. I punti di partenza
delle indagini sono stati tre: una nota della Guardia di Finanza che
nell’immediatezza dei fatti parlava di una sede ‘extraterritoriale’, vicina al
luogo dell’agguato, come possibile punto di primo riparo; alcuni accertamenti
compiuti a suo tempo dalla polizia anche in seguito alla pubblicazione di un
noto articolo di Pietro Di Donato pubblicato sul numero di dicembre 1978 della
rivista statunitense Penthouse, nel quale venivano forniti precisi e inediti
particolari; la ricostruzione delle modalità con cui sono state abbandonate le
auto usate per l’agguato: i brigatisti le hanno parcheggiate tutte lì, in via
Licinio Calvo, tornando su luogo del delitto, ma non dopo pochi minuti, come
vuole la loro versione, ma in varie tappe nelle successive 48 ore. L’ipotesi è
che in realtà furono subito messe dentro un garage nel covo di via Licinio Calvo
e gradualmente riportate e abbandonate in strada. Anche la 132 su cui venne
fatto salire Moro fu lasciata lì qualche istante successivo alla fine
dell’operazione (tra le 9,15 3 le 9,23 per l’esattezza).
La ricostruzione contrattata della verità tra Br e una parte della Dc (Cossiga)
non regge: gli investigatori della Commissione sono andati ad ascoltare uno ad
uno tutti gli ex abitanti della distinta palazzina scoprendo che alcuni
personaggi legati agli ambienti dell’eversione frequentavano quel luogo, anche
durante i 55 giorni del sequestro. Tra le accertate e significative presenze:
una persona straniera, un esponente dell’Autonomia operaia romana e, dopo la
fine del sequestro Moro, un militante regolare delle Brigate rosse. Tre persone
‘insediate’ in una realtà tipicamente “borghese”, dove era alta la presenza di
società estere (pare con interessanti attività) e di prelati. Lo studio della
zona, e del tratto di strada percorsa per arrivare nel garage della palazzina,
permette anche di spiegare uno dei tanti dettagli rimasti da allora in sospeso:
cioè le infiorescenze ritrovate sulla Fiat 132 sulla quale era stato fatto
salite l’ostaggio. La novità è dunque importante. Il presidente Fioroni promette
di arrivare a stabilire un punto fermo con le indagini in corso che si
protrarranno fino alla fine della legislatura – dunque potrebbero anche avere
vita assai breve. Di grande interesse anche il filone che ricostruisce, in modo
solido, l’esistenza di una trattativa aperta grazie all’Olp di Yasser Arafat,
con l’intermediazione del famoso colonnello Giovannone, giunto a Roma intorno al
13 aprile, dato fino ad oggi non noto: l’esito sembrava felice, Francesco
Cossiga, ministro dell’Interno ne era al corrente. Trattativa alla quale sembra
partecipare anche lo stesso prigioniero – Leonardo Sciascia lo scrisse già
nell’ottobre ‘78, aveva qualificate fonti o una sua suggestione? Moro, infatti,
proprio in quei giorni scrive due lettere nelle quali si sofferma sullo scambio
di prigionieri e sollecita l’attivazione di Giovannone. Siamo arrivati ai primi
di maggio: ma qualcuno fa saltare il tavolo e chiude ogni possibilità di
restituire Moro vivo. Tanti i filoni aperti: il doppio livello dell’arresto di
Morucci e Faranda – il ritrovamento di due diversi verbali della perquisizione
dell’appartamento di viale Giulio Cesare dimostra che si consegnarono quel 29
maggio del 1979, giorno in cui è stata avviata la collaborazione con alcuni
esponenti politici per concordare una verità ‘sostenibile’; la conservazione da
parte della ’ndrangheta di un’arma usata in via Fani – sono in corso attività
di comparazione balistica sui reperti di via Fani e di via Caetani, promosse
dalla Procura di Roma, nell’ambito del coordinamento tra la Commissione, la
Procura della Repubblica di Roma e quella di Reggio Calabria; il ferimento di
una o più persone del commando, mai ammesso dai brigatisti. Serrato l’impegno,
in particolare del senatore Federico Fornaro, nelle ricerche su Hyperion, la
scuola di lingua o “camera di compensazione tra i servizi segreti più importanti
della Guerra fredda”, secondo quanto ha riferito l’ex capo di Glazio
Inzerilli ad Alberto Franceschini (e da quest’ultimo riferito in audizione lo
scorso novembre). Si devono a Carlo Mastelloni gli approfondimenti del passato
che la Commissione sta ampliando: in Italia l’attività di Hyperion è
riconducibile al gruppo del Super Clan (nati da una scissione dalle Br) e a un
personaggio di grande calibro, Corrado Simioni. Il gruppo poteva contare sulla
disponibilità di “centri studi” e appartamenti: a Milano, Genova Nervi, Venezia
e di una attività commerciale – di cui si ha un riscontro certo negli anni
1977-1979 – nell’ambito della Dip (Diffusione Italiana Periodici), promozione e
vendita delle riviste “Ordine Pubblico”, “Nuova Polizia – Riforma dello Stato”,
“Notiziario Finanze e Tesoro” e altre. “Chi ancora sostiene che sul caso Moro si
sa tutto – conclude il componente della Commissione Gero Grassi – dice una
plateale bugia, coprendo sue o altrui responsabilità”.
Cosa (non) si sa
dell’omicidio di Aldo Moro. Il rapporto della commissione Fioroni,
scrive Stefano Vespa su "formiche.net" il 22/12/2016. Ci sarà ancora parecchio
da scavare e usciranno ancora importanti novità dal lavoro della commissione
d’inchiesta sul sequestro e l’omicidio di Aldo Moro. La seconda relazione,
presentata il 21 dicembre dal presidente della commissione, Giuseppe Fioroni
(Pd), sintetizza un anno di lavoro con 100 mila documenti acquisiti e conferma
che quella vicenda si è svolta in modo molto diverso da come l’abbiamo
conosciuta. Un covo non individuato, le tracce di sangue riconducibili ai
brigatisti, la sottovalutazione dell’allarme che arrivò dal Medio Oriente, il
fondamentale ruolo dei palestinesi nella trattativa, il traffico d’armi e
l’oscura figura del titolare del bar Olivetti in via Fani sono alcuni dei
passaggi più importanti ricostruiti nella relazione e che andranno approfonditi
nei prossimi mesi: la commissione è prorogata fino alla fine della legislatura,
ma sarebbe davvero opportuno che potesse proseguire anche in quella successiva.
Il covo alla Balduina. Sembra ormai certo che al quartiere Balduina di Roma, a
pochissima distanza da via Fani, ci fosse un covo che forse fu la prima prigione
di Moro. Si parlò subito di palazzine che potrebbero essere appartenute allo
Ior, la banca del Vaticano, perché si è sempre cercato un garage dove le auto
brigatiste si sarebbero subito dirette. Le indagini dell’epoca non portarono a
niente, anche se l’ennesimo indizio è giunto dall’audizione del 29 giugno di
Mario Fabbri, all’epoca del sequestro in servizio all’ufficio politico della
Questura e dal novembre successivo al Sisde. Fabbri effettuò i primi rilievi
sulla Fiat 132 ritrovata in via Licinio Calvo e nella quale c’era una coperta.
Un cane inviato subito dalla Questura l’annusò ma, ha detto Fabbri, “non fece
più di venti metri” fermandosi all’altezza delle scale che portano verso viale
delle Medaglie d’oro. In quelle palazzine sembra abbiano abitato soggetti legati
in qualche modo al sequestro, tra cui una persona vicina alla Raf, un’altra
dell’Autonomia romana e (dopo il sequestro) un brigatista. E’ evidente che
dimostrare la presenza di quel covo farebbe di per sé riscrivere la storia del
rapimento. I brigatisti feriti. Riesaminando gli atti dell’epoca, la commissione
d’inchiesta ha avuto la prova che in tre auto Fiat usate in via Fani furono
riscontrate tracce di sangue. Dunque, almeno un brigatista rimase ferito: non si
sa come né i br l’hanno mai rivelato. Nella relazione, viene specificato che “è
in corso un’attività volta alla attribuzione dei profili genetici che sono stati
isolati da mozziconi di sigaretta che erano stati sequestrati all’interno della
Fiat 128 familiare con targa CD, utilizzata dagli attentatori per arrestare la
marcia dell’auto che ospitava l’onorevole Aldo Moro”. Uno dei profili è del
proprietario del mezzo, ovviamente estraneo ai fatti. Altri quattro profili (due
riconducibili a uomini e due a donne) sono stati estrapolati dai reperti del
covo di via Gradoli. Alcuni degli interessati rifiutano però di sottoporsi agli
esami: nella relazione si legge che “i brigatisti individuati e, in caso di
latitanti o deceduti, i loro prossimi congiunti sono stati tutti rintracciati;
alcuni hanno prestato il loro consenso a sottoporsi al prelievo”. L’allarme
sottovalutato e il ruolo dell’Olp. Un’altra conferma riguarda il famoso
messaggio inviato dal colonnello Stefano Giovannone, capo centro Sismi di Beirut
e “uomo” di Moro: il 17 febbraio 1978 scrisse di una “operazione terroristica di
notevole portata programmata asseritamente da terroristi europei, che potrebbe
coinvolgere il nostro Paese”. La sua era una fonte palestinese dell’Fplp. Il
lavoro della commissione ha confermato che l’allarme fu sottovalutato e di
fatto, è scritto nella relazione, “oggetto di una trasmissione prevalentemente
burocratica ai centri locali”. Il 17 marzo Giovannone riferì che “George
Habbash, contattato stanotte da Arafat… sin dalle prime ore di stamattina ha
attivato i suoi elementi in Europa Occidentale per avere notizie [sul
rapimento]”. Lo stesso Yasser Arafat cercò di un contatto qualificato,
soprattutto tramite esponenti della Raf tedesca, per giungere a dialogare con le
Br. La commissione ha rintracciato i documenti datati 24, 25 e 28 aprile dai
quali emergono forti aspettative su un esito positivo del sequestro, periodo nel
quale Giovannone era rientrato a Roma, come risulta da una conversazione del 13
aprile 1978 con Nicola Rana al quale diceva di essere nella Capitale e a
disposizione. Mesi di trattative. In quelle settimane l’ottimismo cresceva,
tanto che Nemer Hammad, il rappresentate dell’Olp a Roma, il 28 aprile aveva
chiesto un incontro con il ministro dell’Interno, Francesco Cossiga, “per
rappresentare la disponibilità e l’interesse della dirigenza Olp a una forma di
collaborazione permanente tra i servizi di sicurezza palestinesi e quelli
italiani”. All’improvviso all’inizio di maggio la trattativa si interrompe e si
arriverà all’omicidio: la commissione presieduta da Fioroni ipotizza una rottura
tra l’ala di Potere operario, vicina ai palestinesi, e quella vicina a Mario
Moretti che deteneva Moro, anche se successivamente Moretti avrebbe tentato di
riallacciare i rapporti con l’Olp perché il colonnello Giovannone, in un
messaggio del 22 giugno, riferì che “le Brigate rosse italiane avrebbero fatto
pervenire in questi giorni personalmente a George Habbash, leader del Fplp,
copia di dichiarazioni rese da Onorevole Moro nel corso interrogatori subiti”.
Com’è noto, parallelamente il Psi aveva avviato una propria trattativa tesa alla
liberazione di Moro e nella relazione vengono riferiti due elementi di
cui Formiche.net ha scritto il 23 novembre: Bettino Craxi ebbe tre lettere di
Moro prima che fossero rese pubbliche e Claudio Signorile fu convocato da
Cossiga la mattina dell’omicidio, quasi dovesse essere “testimone”. L’ex
direttore di Critica sociale, Umberto Giovine, ha infatti detto alla commissione
che toccava a lui ritirare quelle lettere in una libreria per consegnarle a
Craxi, rivelando un canale finora sconosciuto. Signorile, invece, fu convocato
alle 9 dall’allora ministro dell’Interno che alle 11 ricevette la notizia del
ritrovamento del cadavere: all’inizio Cossiga gli apparve ottimista sulla
possibile liberazione, ma secondo Signorile “l’impressione che ebbi allora fu
che ero stato chiamato lì per assistere alla telefonata. Perché mi chiami? E
perché chiami me? Perché sono la persona più esposta sul versante…” della
trattativa. Nell’audizione il presidente Fioroni ipotizzò anche che Cossiga
sapesse della morte fin dalle 7: va ricordato che Valerio Morucci telefonò a
Sereno Freato alle 12.15 e che la notizia venne diffusa dall’Ansa solo alle
13.59. La grazia e l’esecuzione. Tra i tanti aspetti da sviluppare, la
commissione Moro farà accertamenti “sulla vicenda della grazia che il Presidente
della Repubblica, Giovanni Leone, avrebbe inteso concedere a Paola Besuschio e
alla visita di un ufficiale dei Carabinieri nell’ospedale dove la brigatista si
trovava ricoverata in stato di detenzione al fine di chiederle di sottoscrivere
la domanda di grazia” e per verificare le modalità e l’orario dell’uccisione di
Moro: lo scopo è capire se l’omicidio fu affrettato per evitare ogni trattativa
e se il gruppo di fuoco fu diverso da quello conosciuto. Bisogna ricordare,
infatti, che il giornalista Paolo Cucchiarelli, nel libro “Morte di un
Presidente”, con due perizie realizzate ad hoc demolisce le “verità” balistiche
e che il 4 febbraio la commissione ascoltò monsignor Fabio Fabbri, stretto
collaboratore di monsignor Cesare Curioni, ispettore generale dei cappellani
carcerari nel 1978 e una delle persone che più si impegnò per la liberazione di
Moro. Monsignor Fabbri ha raccontato di aver avuto per primo le foto
dell’autopsia di Moro e che monsignor Curioni quando le vide disse: “So chi l’ha
ucciso”, riferendosi a una rosa di sei fori di proiettile che non toccavano il
muscolo cardiaco. Si riferiva alla tecnica di un giovane che aveva conosciuto
nel carcere minorile Beccaria e che era un killer professionista, Giustino De
Vuono. Bar e traffico d’armi. Ulteriori approfondimenti, infine, riguarderanno
la storia del bar Olivetti in via Fani e sul suo titolare, Tullio Olivetti. Il
bar era stato chiuso per uno “strano” fallimento qualche mese prima del
sequestro e durante i lavori della commissione è stato detto chiaramente che con
un bar aperto a pochi metri quell’azione sarebbe stata impossibile. Su Olivetti
sono emerse prove di favoritismi da parte degli investigatori dell’epoca. La
commissione scrive nella relazione che “non è stato ancora chiarito in maniera
definitiva il significato di tali omissioni investigative. Tuttavia, occorre
rilevare che la vicenda fa emergere un possibile intreccio tra il caso Moro e
una corrente di traffico d’armi che coinvolgeva sia la criminalità organizzata
che l’area mediorientale e sul quale occorre compiere ulteriori e – si auspica –
definitivi approfondimenti”. Molto si dovrà capire, infine, sulla scuola
Hypérion a Parigi (che potrebbe essere stata un coordinamento tra organizzazioni
terroristiche europee e Flp) e sul vero ruolo di Giorgio Conforto, agente del
Kgb (e forse anche di Cia e Sismi), che avrebbe di proposito fatto arrestare
Valerio Morucci e Adriana Faranda a casa di sua figlia Giuliana in via Giulio
Cesare. I lavori della commissione Moro sembrano disegnare la sceneggiatura di
una spy story, invece è un pezzo fondamentale della storia d’Italia che ancora
non conosciamo davvero.
L’ultimo latitante del caso
Moro. Il mistero dell’arresto fantasma.
Trovato dalla commissione parlamentare d’inchiesta un documento nell’archivio
dei carabinieri. L’ex br Alessio Casimirri è rifugiato in Nicaragua dal 1983,
scrive il 18 ottobre 2017 "Il Corriere della Sera". La vita avventurosa dell’ex
brigatista rosso Alessio Casimirri — uno dei dieci componenti del commando che
rapì Aldo Moro in via Fani, 1l 16 marzo 1978, oggi sessantaseienne cittadino
nicaraguense — s’è dipanata tra i giardini vaticani dove giocava da bambino, la
lotta armata praticata negli anni Settanta e il rifugio centro-americano dove
vive dal 1983. Mai passato da una prigione; unico tra i sequestratori del
presidente della Democrazia cristiana ad aver evitato l’arresto. Una
inafferrabile «primula rossa», intorno alla quale si sono costruite ipotesi più
o meno fondate, e persino leggende. Alimentate prima dall’essere figlio e nipote
di alti funzionari della Santa Sede, con tanto di prima comunione ricevuta dalle
mani di Paolo VI, e poi dalle presunte protezioni garantite dal governo
sandinista in Nicaragua.
Nome già noto. Oggi però,
dagli archivi del Comando provinciale dei carabinieri di Roma, spunta un
documento che rappresenta un mistero autentico, e ripropone gli interrogativi
sull’ex terrorista ancora uccel di bosco. È un cartellino fotodattiloscopico
utilizzato per identificare le persone, saltato fuori dalle ricerche ordinate
dall’ultima commissione parlamentare d’inchiesta sul sequestro e l’omicidio
Moro. La data dell’avvenuto accertamento è il 4 maggio 1982, quando a carico di
Casimirri pendevano due mandati di cattura per associazione sovversiva e
partecipazione a banda armata, accusa debitamente annotata sul cartellino. E
alla voce «motivo del segnalamento» il compilatore tuttora anonimo (c’è una
firma illeggibile) scrisse «arresto». Ufficio segnalatore: una serie di
abbreviazioni che stanno a significare «Reparto operativo carabinieri Roma».
Logica vorrebbe che per Alessio Casimirri — un nome all’epoca già iscritto sulla
rubrica delle frontiere, come persona da fermare in caso di tentativo di
espatrio — quel giorno si fossero aperte le porte del carcere. Invece così non è
stato. Non risulta che l’allora militante delle Br dal nome di battaglia
«Camillo» (altro particolare segnalato sul cartellino) abbia mai messo piede in
una cella. Perché? Com’è possibile che un ricercato venga fermato e
fotosegnalato, ma poi liberato?
Dubbi e anomalie.
Dell’operazione non c’è traccia in nessun altro documento giudiziario, e alla
data del 4 maggio ’82 non si hanno notizie del suo fermo né di altri terroristi.
Un arresto fantasma, insomma; certificato da un documento apparentemente
autentico, senza che si sia mai realmente verificato. L’apparenza
dell’autenticità deriva dal fatto che il cartellino è di quelli effettivamente
in uso, nel 1982, alle forze di polizia, ma nella compilazione ci sono alcune
anomalie. La più evidente sta nella foto: non è di quelle normalmente scattate
negli uffici investigativi, su tre lati (di fronte, fianco destro e fianco
sinistro, accanto al misuratore di centimetri che stabilisce l’altezza) bensì è
un’unica fototessera, trovata probabilmente a casa di Casimirri durante una
perquisizione (senza esito, lui non c’era) effettuata durante i giorni del
sequestro Moro, il 3 aprile ’78. Perché? L’indicazione del falso nome «Camillo»
è di provenienza ignota, e le dieci impronte digitali delle due mani impresse su
entrambe i lati non si sa di chi siano: per procedere a un confronto la
commissione Moro ha chiesto alle autorità nicaraguensi, tramite canali
diplomatici, il recupero di quelle autentiche, ma la risposta (chissà quanto
credibile) è che non le hanno. Nello spazio riservato alla firma della persona
segnalata, il carabiniere compilatore scrisse «si rifiuta», e dunque non c’è
nemmeno la possibilità di perizie calligrafiche.
La lettera di Fioroni. Tutto
questo alimenta il mistero: si trattò di un’operazione interrotta (dopo il fermo
qualcuno intervenne per lasciare andare Casimirri), di cui qualche zelante
militare volle comunque dare atto lasciando una traccia rimasta sepolta in un
archivio per 35 anni? Oppure è un falso costruito apposta? Ma da chi, quando e
con quali finalità? Sono domande che autorizzano a riproporre i molti enigmi
maturati intorno all’ultimo latitante del «caso Moro»; compreso quello, rimasto
senza riscontri, a cui accennò l’ex pubblico ministero Antonio Marini alla
commissione stragi nel 1995, quando riferì la voce secondo cui l’ex br sarebbe
stato un informatore di un ex capitano dei carabinieri (poi identificato nel
generale Antonio Delfino, morto nel 2014) che l’avrebbe passato al Sismi, il
servizio segreto militare. Teorie mai verificate, che tornano d’attualità con la
prova dell’arresto fantasma.
Per adesso il presidente della
commissione Moro, Giuseppe Fioroni, si è limitato a scrivere una lettera al
presidente del Consiglio Gentiloni, e ai ministri Alfano, Minniti e Orlando, per
sottoporre nuovamente al governo la necessità di «promuovere l’estradizione del
latitante Alessio Casimirri». Fioroni ricostruisce la sua carriera di estremista
e brigatista, avanza «ampi dubbi sulle protezioni di cui egli poté eventualmente
godere», e cita il mistero del fermo per sostenere che «poté sottrarsi alla
giustizia grazie al concorso di una rete di complicità che la Commissione sta
cercando di ricostruire».
Caso Moro, spunta un
documento sul brigatista Casimirri: “Fu arrestato in Italia nel 1982. Ora
estradizione”.
Dopo il caso Battisti, Fioroni scrive al presidente del Consiglio e chiede
stesso impegno per estradizione dell'ex primula nera del brigatismo rosso. “La
latitanza è una offesa alle vittime e alla giustizia”, scrive Stefania Limiti il
18 ottobre 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Dalla grande nebulosa del caso Moro,
qui e là, viene sempre fuori qualcosa di inedito. La Commissione parlamentare
d’inchiesta ha scoperto che Alessio Casimirri, la primula nera del brigatismo
rosso, fu arrestato nel maggio del 1982 e nessuno lo aveva mai saputo. Significa
che rimase in Italia più a lungo di quanto non si supponesse fino ad ora, ed
anche che le ricerche furono fatte proprio male, e poi anche che potè contare su
una rete di complicità importante. Dalle recenti indagini è inoltre emerso che
diversi documenti e un’agendina telefonica che gli vennero sequestrati il 3
aprile 1978, durante una perquisizione disposta nell’ambito delle indagini sul
rapimento Moro, non sono mai stati oggetto di indagine. Giuseppe Fioroni,
presidente dell’organismo parlamentare, lo ha reso noto oggi diffondendo una sua
lettera al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ai ministri Minniti,
Orlando e Alfano, nella quale chiede al Governo lo stesso impegno profuso per
mettere all’angolo Cesare Battisti, l’ex militante dei Pac riparato in Brasile,
anche per ottenere risultati dalle autorità di Managua. Casimirri, infatti, vive
in Nicaragua da molti anni e di quel Paese è cittadino a tutti gli effetti,
motivo che rende l’iter burocratico assai complicato – l’Italia chiese invano
per la prima volta la sua estradizione nel settembre del 1988. Fioroni scrive
cautamente che le modalità con cui Casimirri lasciò l’Italia non sono mai state
chiarite: in realtà, si è scritto molto in questi anni e autorevoli osservatori
hanno sostenuto che scappò con comodo grazie ad un regolare passaporto falso
messogli a disposizione dai servizi segreti. Scappò in Francia con un compagno
brigatista, Raimondo Etro, ma questi ne perse le tracce per una settimana. Poi
lo rivide pronto alla partenza per l’oltreoceano, Etro rimase in Francia ed ebbe
altra sorte. Figlio di un funzionario dello Stato Vaticano, Casimirri fu un
dirigente di spiccò della colonna brigatista romana costituita attorno al
76-77 e che fu centrale dell’Operazione Frezza, il rapimento e il sequestro di
Aldo Moro. Alessio è componente del commando di Via Fani, dove viene preso il
presidente della Democrazia cristiana, miracolosamente o misteriosamente illeso,
e trucidati tutti gli agenti della sua scorta. Oltre all’ergastolo per il caso
Moro, pendono sulla sua testa anche altre pesanti condanne per l’omicidio dei
magistrati Palma e Tartaglione e degli agenti di Polizia Mea e Ollanu, colpiti
durante l’assalto di Piazza Nicosia alla sede della D.C. Secondo Fioroni “Lo
sforzo di ricerca della verità sulla vicenda Moro non può prescindere da un
ulteriore tentativo di porre termine a una latitanza che è offensiva per le
vittime e per la giustizia”. Ma c’è anche un altro piano di interesse: la fuga
di Casimirri, e la tenuta della sua latitanza, infatti, sono sempre state
oggetto di riflessione per gli straordinari contatti che le hanno consentite e
che gettano una lunga ombra non solo sulla sua figura ma anche sul delitto Moro
i cui misteri ruotano intorno alla esistenza e alla natura delle interferenze di
soggetti e forze estranei al mondo brigatista o criminale. Come
ilfattoquotidiano.it scrisse tre anni fa, nel 2006 Casimirri è uscito indenne da
un tentativo di esfiltrazione organizzato già nei minimi dettagli ma sospeso da
non si sa quale scala gerarchica e, in precedenza, nel ’98, fallì nel tentativo
di ascoltarlo anche il magistrato milanese Meroni, che cercava riscontri ad
alcune testimonianze che collegavano Valerio Morucci all’omicidio Calabresi.
Insomma, è una latitanza che pesa più di altre, se è possibile una gerarchia:
sono in tutto 34, secondo i dati del ministero della Giustizia, i ricercati
all’estero per fatti di terrorismo nazionale. Paradosso della nostra strana
storia: non c’è il nome del neofascista Delfo Zorzi perché nessun tribunale
riuscì ad incastrarlo.
Caso Moro, “stop dei
servizi a cattura del Br Casimirri latitante in Nicaragua”.
Nel '98 ci provò il magistrato milanese Meroni, per trovare riscontri a
collegamenti tra Br e omicidio Calabresi. Nel 2006 toccò all'ufficiale del Sisde
Cataldi. Il primo, rivelano oggi fonti investigative, fu bloccato da un
intervento delle autorità del Nicaragua, il secondo da ordini superiori, scrive
Stefania Limiti il 14 giugno 2014 su "Il Fatto Quotidiano". Tra i buchi neri
del caso Moro c’è anche la latitanza di Alessio Casimirri, ex brigatista del
commando di via Fani. Una circostanza rivelata nel cosiddetto ‘memoriale’
sull’agguato a Moro di un altro ex membro delle br, Valerio Morucci. La fuga
protetta di Casimirri, che partì per il Nicaragua dalla Francia con un
passaporto secondo molti fornito dai servizi segreti, ha retto il passaggio del
tempo. In particolare, rivelano oggi fonti investigative, almeno un paio di
tentativi di incursione da parte di due uomini delle istituzioni, un magistrato
e un alto ufficiale del Carabinieri, entrambi bloccati prima che le loro azioni
potessero avere un seguito. Il primo caso riguardò l’allora pubblico ministero
di Milano Massimo Meroni, un magistrato che aveva svolto indagini molto accurate
sull’omicidio del commissario Luigi Calabresi (17 maggio ’72). Per questo finì
sul suo tavolo il fascicolo aperto dalla procura di Roma sulla base delle
dichiarazioni di un ex brigatista, Raimondo Etro, il quale riferì ai magistrati
della capitale (7 marzo ’98) e poi a quelli milanesi (31 marzo e il 3 giugno
’98) alcune confidenze raccolte nel periodo del sequestro dell’onorevole Aldo
Moro proprio dalla nostra primula rossa. Alessio Casimirri avrebbe detto ad Etro
che nell’omicidio Calabresi era coinvolto Valerio Morucci, all’epoca della sua
militanza nel movimento di Potere Operaio, di cui era stato fin dagli inizi
degli anni ’70 un elemento di spicco, tanto da entrare nel 1972 a fare parte del
Direttivo Centrale Romano. L’origine politica di Morucci, legata a un gruppo che
aveva molti punti di contatto con Lotta continua (di cui esponenti sono stati
giudicati responsabili dell’omicidio Calabresi), pur nella diversità di visione
nel modo di condurre la lotta di classe, aveva suscitato interesse negli
investigatori. Meroni oggi ricorda Etro come una persona attendibile, che non
aveva nessun interesse collaterale nel raccontare quella confidenza del tutto
spontanea. Per questo gli sembrava importante andare a sentire la fonte
principale e per farlo non aveva che un modo: andare in Nicaragua. Tra l’altro
ben prima di Etro, anche una brigatista pentita, Emilia Libera, aveva detto (2
aprile 1982) le stesse cose su Morucci e i suoi possibili legami con il caso
Calabresi, aggiungendo che all’epoca questa era la voce che circolava
nelle Brigate Rosse. Meroni si attivò immediatamente: chiese alle autorità
giudiziarie nicaraguensi di poter interrogare Casimirri. Tutto sembrava pronto,
ma la sera prima della partenza una telefonata dell’ambasciata italiana a
Managua bloccò Meroni: “Non parta dottore, non se ne fa niente, sono state
revocate tutte le autorizzazioni in seguito a un ricorso dell’interessato”. La
questione si chiudeva con una porta sbattuta in faccia a un magistrato dello
Stato italiano, senza che questo provocasse clamore in Italia. Meroni dopo una
serie di tentativi si trovò costretto ad archiviare il procedimento (20 luglio
2000). Se il fallimento del viaggio del magistrato milanese è imputabile alle
protezioni nicaraguensi accordate a Casimirri – “sicuramente quel paese lo
protegge molto”, dice oggi Meroni che non si sbilancia sulle responsabilità
italiane – la faccenda dell’operazione tentata per riportarlo a casa è bene
diversa. Tra il 2005 e il 2006, dopo la cattura di Rita Algranati, ex moglie di
Casimirri, Enrico Cataldi, un ufficiale puntiglioso e attento, allora direttore
della divisione terrorismo interno del Sisde, pensò che si potesse orchestrare
la stessa identica azione per riportare in Italia il latitante numero uno delle
Br. Algranati, la ragazza con il mazzo di fiori (il segnale secondo Morucci
dell’imminente passaggio della macchina di Moro via Fani) aveva lasciato il
Nicaragua e si era stabilita con il suo nuovo marito, Maurizio Falessi,
in Algeria. Il Ros di Mario Mori mise su la trappola, probabilmente realizzata
all’interno di uno scambio di favori tra intelligence. Mori riuscì a ottenere
che Algranati e Falessi lasciassero il paese che li ospitava, pare che qualcuno
li indusse a credere che gli algerini erano pronti a ‘venderli’. Di passaggio
in Egitto la fuga dei due fu interrotta all’aeroporto del Cairo, il 14 gennaio
del 2004, dagli uomini della Digos di Roma in collaborazione con Ucigos e Sisde.
Gli investigatori romani spiegarono che alla loro cattura, “oltre a un enorme
lavoro di intelligence della polizia italiana con il servizio interno civile, si
è arrivati anche grazie a uno scambio di informazioni tra i servizi italiani e
quelli del nord Africa, che hanno consentito alle forze di polizia di mettere in
atto i giusti dispositivi investigativi”. Algranati e Falessi furono subito
espulsi, ricondotti in Italia e arrestati. Il generale Cataldi, che oggi
mantiene un assoluto riserbo e rifiuta ogni commento, pensò di attuare la stessa
strategia per acciuffare Casimirri: avrebbe trovato il modo di indurlo a
lasciare momentaneamente il Nicaragua per bloccarlo in un paese terzo, il Costa
Rica, dove l’ex brigatista si recava per motivi di lavoro, d’accordo con le
autorità locali. Cataldi è un ufficiale noto nell’ambiente per l’estrema
meticolosità e per la tenacia nel raggiungere i suoi obiettivi. Era sicuro di
riuscire anche in quella occasione. Erano già stati comperati i biglietti aerei
dall’agenzia del Servizio – che li rimborsò al momento dell’annullamento. Fu
bloccato, dicono oggi diverse fonti investigative, non dalle autorità di Managua
ma dagli alti vertici del Servizio interno che gli dissero di stare fermo, di
occuparsi d’altro, che quella operazione non si doveva fare. Le ombre attorno
alla figura di Casimirri sono sempre state tante, ma il tempo pare che lavori
per ingrandirle: c’è solo da sperare che la nuova Commissione parlamentare
d’inchiesta sul caso Moro abbia voglia e possibilità di raccontarci qualche
pezzo di verità, compresa la faccenda delle protezioni accordate all’ex
brigatista e ai segreti che, evidentemente, custodisce.
ALDO MORO ED IL SIGNORAGGIO
BANCARIO.
Aldo Moro, Signoraggio
Bancario e le strane coincidenze,
scrive il 15 agosto 2013 "Sporchibanchieri". Cosa accomuna diversi politici che
si sono battuti per la Sovranità Monetaria? In questo articolo analizzeremo le
inquietanti coincidenze relative in particolar modo a tre esponenti politici
che, poco dopo aver promosso leggi a favore della sovranità monetaria dei
rispettivi Paesi, hanno poi fatto un brutta fine. Stiamo parlando di Abraham
Lincoln, John Fitzgerald Kennedy e Aldo Moro. Il problema di fondo è quello
dell’emissione sovrana di moneta, ben noto per chi si occupa di Signoraggio
Bancario. Abbiamo in parte toccato questo tema i due precedenti
articoli: Signoraggio Bancario: perché il debito è inestinguibile? e Auriti, il
valore indotto e la proprietà della moneta. Le banche centrali di moltissimi
Paesi, spacciate come istituti pubblici, ma in realtà Società per Azioni private
possedute generalmente da famiglie di banchieri senza scrupoli, hanno da sempre
utilizzato qualsiasi mezzo per occultare la loro vera natura e nascondere
l’inganno agli occhi della popolazione.
Cerchiamo di riassumere
brevemente i fatti.
Il presidente Lincoln nel
1862, ebbe un incontro privato con un amico di vecchia data, il colonnello
Edmund Dick Taylor che suggerì di stampare biglietti di Stato a corso legale per
fronteggiare le spese della Guerra Civile Americana scoppiata l’anno precedente.
Questa idea scaturì anche a causa degli interessi usurai (dal 24 al 36 per
cento) pretesi dai banchieri internazionali nell’eventualità di un prestito
all’Unione. Lincoln ovviamente non accettò le condizioni poiché non voleva
trascinare il proprio Paese nel baratro del debito. Così, nonostante forti
opposizioni, il 25 febbraio 1862 firmò il First Legal Tender Act che autorizzava
l’emissione dei biglietti di Stato, conosciuti in seguito come greenbacks, nome
derivato dall’uso di inchiostri verdi per distinguerli dalle altre banconote. Il
14 aprile 1865, durante uno spettacolo teatrale al Ford’s Theatre, John Wilkes
Booth (attore che aveva più volte recitato proprio in quello stesso teatro)
spara un colpo alla testa del presidente Lincoln. I lati oscuri della vicenda
resteranno numerosi: l’assenza della guardia del corpo del presidente, impegnata
a bersi qualche drink ed il mistero del killer, ufficialmente scovato e ucciso
una decina di giorni dopo, anche se nel corso degli anni molti ricercatori hanno
sostenuto che Booth fosse riuscito a scappare.
Facciamo un salto di un
secolo. John Fitzgerald Kennedy, il 4 giugno 1963, firma l’Ordine Esecutivo
11110, un decreto presidenziale che di fatto toglieva alla Federal Reserve Bank
(la banca centrale presente negli Stati Uniti) il potere di stampare denaro,
restituendolo al Dipartimento del Tesoro, come sancito nella Costituzione
americana. Il governo USA tornava in possesso della propria sovranità monetaria
grazie ad una legge esplicita che lo autorizzava a «emettere certificati
d’argento a fronte di ogni lingotto di argento e dollari d’argento della
Tesoreria». Praticamente gli Stati Uniti si riprendevano il diritto di stampare
moneta, collegando l’emissione di banconote alle riserve d’argento della
Tesoreria, senza la necessità di chiedere prestiti ad interessi alla Federal
Reserve: biglietti a corso legale sgravati dal debito all’atto di emissione.
L’unica differenza visibile sulle nuove banconote rispetto alle precedenti era
la dicitura: quelle successive all’ordine esecutivo di Kennedy riportavano
“Biglietto degli Stati Uniti” (United States Note), le altre “Biglietto della
Federal Reserve” (Federal Reserve Note).
Guarda caso pochi mesi dopo,
il 22 novembre 1963, il presidente Kennedy verrà ucciso a Dallas. Dopo più di
quarant’anni i punti oscuri di questo omicidio rimangono senza una plausibile e
convincente spiegazione ufficiale. Al contrario, risultano ormai palesi le
incongruenze, i depistaggi e le manomissioni relative alla vicenda. Come in
altri casi anologhi, i poteri forti hanno manovrato nell’ombra per far passare
l’idea che il tutto fosse riconducibile ad un mitomane, un povero pazzo isolato
che aveva agito da solo (in questo caso Lee Harvey Oswald). Questo perché, per
definizione, un’eventuale azione premeditata da più persone costituirebbe un
complotto. Il che starebbe a significare l’esistenza di strategie occulte che
meriterebbero un’attenzione profonda da parte del pubblico. Ed è ovvio che i
criminali complottisti abbiano tutto l’interesse nel mantenere un basso profilo
e non essere scoperti. Stranamente anche lo squilibrato, l’utile idiota
dell’omicidio Kennedy, verrà a sua volta messo a tacere per sempre prima ancora
di poter rivelare qualche informazione compromettente, ucciso in pubblico da
Jack Leon Ruby (nato Jacob Leon Rubenstein), apparentemente senza un valido
movente, appena un paio di giorni dopo l’assassinio del presidente USA. Il bello
è che “Sparky” Jack Ruby riuscì ad eliminare lo scomodo testimone davanti alla
centrale di polizia di Dallas, proprio mentre Oswald veniva scortato da un
gruppo di poliziotti al vicino carcere statale. Inutile dire che pure Ruby
morirà poco dopo, ufficialmente per un’embolia polmonare, il 3 gennaio 1967,
dopo aver scampato una sentenza di morte dettata dal tribunale il 14 marzo 1964.
Sia Oswald che Ruby avevano dichiarato più volte di essere stati incastrati.
Facciamo notare, fra parentesi, che pure la data della morte di Kennedy presenta
una particolare coincidenza: cade esattamente cinquantatré anni dopo l’incontro
(all’epoca segreto) tenuto sull’isola di Jekill (Jekill Island) fra un gruppetto
di banchieri che stavano sviluppando il progetto che avrebbe portato a
costituire proprio la Federal Reserve. Un fatto che potrebbe apparire casuale
per chi è a digiuno di esoterismo, rituali e la logica relativa a gruppi
massonici e paramassonici. Invitiamo perciò i nostri lettori ad approfondire la
questione con studi e ricerche. Prossimamente pubblicheremo una serie di
articoli al riguardo.
Veniamo al caso Moro. Negli
anni sessanta lo statista della Democrazia Cristiana decise di finanziare la
spesa pubblica italiana attraverso l’emissione di cartamoneta di Statosgravata
da debiti, in tagli da 500 lire, ossia con un “biglietto di Stato a corso
legale”. Con i DPR 20-06-1966 e 20-10-1967 del presidente Giuseppe Saragat venne
regolamentata la prima emissione, la serie “Aretusa” (Legge 31-05-1966), mentre
il presidente Giovanni Leone regolarizzò con il DPR 14-02-1974, la serie
“Mercurio” (DM 2 aprile 1979), le famose banconote da 500 lire conosciute come
“Mercurio alato”. Già all’epoca la sovranità monetaria dell’Italia era limitata:
allo Stato era concesso (chiedetevi, fra l’altro, da chi fosse “elargita” questa
concessione) solamente il diritto di conio delle monete attraverso la Zecca,
mentre le banconote venivano aquistate dal Fondo Monetario Internazionale. Un
po’ come accade oggi, dove ai singoli Paesi europei spetta il diritto di coniare
gli euro di metallo ma non le banconote, che vengono emesse dalla Banca Centrale
Europea. Per questo quando nel 2002 Giulio Tremonti, all’epoca ministro
dell’Economia, propose di sostituire le monete da uno e due euro, Wim
Duisenberg, primo governatore della BCE, rispose con un avvertimento: «Spero che
Mr. Tremonti si renda conto che se tale banconota dovesse essere introdotta,
egli perderebbe il diritto di signoraggio che si accompagna ad essa. Dunque se
egli, come ministro dell’Economia, ne sarebbe contento non lo so». Fra
parentesi ci sarebbe anche da indagare sulla strana morte di Duisenberg,
avvenuta il 31 luglio 2005, nemmeno due giorni dopo le sentenze di rinvio a
giudizio pronunciate a Milano contro le filiali Deutsche Bank, UBS, Morgan
Stanley e Citygroup partite dai procuratori che stavano indagando sul crac
Parmalat. Ricordiamo che il banchiere olandese era stato eletto primo presidente
della Banca Centrale Europea proprio grazie all’appoggio del colosso bancario
tedesco. Coincidentemente, nelle stesse ore, precipitava dalla finestra del suo
appartamento di New York Arthur Zankel, ex membro del consiglio di Citybank. Ma
forse stiamo divagando troppo, torniamo alle 500 lire cartacee emesse dai
governi Moro. Lo statista, per ovviare ai limiti imposti di cui sopra, utilizzò
un brillante stratagemma. Dopo aver autorizzato il conio delle 500 lire di
metallo, fece una deroga che permetteva, contemporaneamente, l’emissione della
versione cartacea, che poteva in questo modo essere stampata ugualmente
dalla Zecca di Stato. Il 16 marzo 1978 Aldo Moro venne rapito e ucciso il 9
maggio dello stesso anno. Casualmente, in seguito al tragico avvenimento,
l’Italia smise di emettere biglietti di Stato. Come per gli omicidi di Lincoln e
Kennedy, anche in questo caso i punti oscuri sono numerosissimi. Uno dei fattori
comuni è il ruolo dei servizi segreti. La versione ufficiale che additava la
responsabilità alle fantomatiche Brigate Rosse non hai mai convinto le persone
minimamente informate sui fatti. La strategia della tensione era chiaramente
funzionale alla volontà di destabilizzare l’Italia, obiettivo confermato e
dichiarato anche nell’Operazione Chaos e nell’Operazione Condor in America
latina (fra i tanti misteri dei Servizi, mai sentito parlare dell’ufficio K?).
Più volte è stata avanzata l’ipotesi dei tre livelli delle BR: base
ideologizzata utilizzata come manovalanza, alcuni capicolonna eterodiretti come
Mario Moretti ed il centro studi Hyperion di Parigi, una scuola di lingue usata
come copertura per uno degli avamposti della CIA in Europa, il corrispettivo
francese della Gladio italiana, il tutto parte della rete NATO “Stay Behind”. I
dubbi su Moretti (capo effettivo delle Brigate Rosse durante il sequestro Moro)
circa il suo ruolo di infiltrato, spia e doppiogiochista dei servizi segreti
sono stati sollevati più volte dagli stessi brigatisti, ad esempio Alberto
Franceschini, Renato Curcio, Giorgio Semeria e Valerio Morucci o da personaggi
come il senatore Sergio Flamigni, che definì il capo brigatista “la sfinge”.
Addirittura vennero fatti degli accertamenti da parte di alcuni esponenti delle
BR su questo losco individuo, prima del sequestro dello statista, ma non ne
venne fuori nulla e così Moretti rimase ai vertici dell’organizzazione.
È ormai risaputa la presenza
del colonnello del Sismi Camillo Guglielmi in via Stresa la mattina dell’agguato
e del rapimento di Moro avvenuto in via Fani, a soli duecento metri di distanza.
Cosa ci facesse da quelle parti non è mai stato chiarito. E nemmeno un’altra
delle miriadi di coincidenze: nello stesso palazzo in via Gradoli 96 dove viveva
Moretti al tempo del sequestro c’erano almeno 24 appartamenti intestati a
società immobiliari fra i quali amministratori figuravano membri dei servizi
segreti. Al secondo piano dello stabile viveva un’informatrice della polizia,
mentre al n° 98 della solita via abitava un compaesano di Moretti, agente
segreto militare ed ex ufficiale dei carabinieri. Qualche anno fa nel libro Nous
avons tué Aldo Moro di Emmanuel Amara pubblicato da Patrick Robin Editions
(uscito in Italia con il titolo Abbiamo ucciso Aldo Moro. Dopo trent’anni un
protagonista esce dall’ombra edito da Cooper e curato da Nicola Biondo), Steve
Pieczenik, assistente del sottosegretario Usa nel 1978, psichiatra, specialista
in “gestioni di crisi”, esperto di terrorismo, mandato in missione da Washington
su “invito” di Francesco Cossiga durante i cinquantacinque giorni del sequestro,
ha rivelato: «Ho messo in atto la manipolazione strategica che ha portato alla
morte di Aldo Moro al fine di stabilizzare la situazione dell’Italia. I
brigatisti avrebbero potuto cercare di condizionarmi dicendo “o soddisfate le
nostre richieste e lo uccidiamo”. Ma la mia strategia era “No, non è così che
funziona, sono io a decidere che dovete ucciderlo a vostre spese”. Mi aspettavo
che si rendessero conto dell’errore che stavano commettendo e che liberassero
Moro, mossa che avrebbe fatto fallire il mio piano. Fino alla fine ho avuto
paura che liberassero Moro. E questa sarebbe stata una grossa vittoria per
loro». Pieczenik non solo ha ammesso di aver intavolato una falsa trattativa con
i brigatisti, ma dice spudoratamente che uno degli obiettivi fu quello di
costringere le Brigate Rosse ad uccidere Moro: «La mia ricetta per deviare la
decisione delle BR era di gestire un rapporto di forza crescente e di illusione
di negoziazione. Per ottenere i nostri risultati avevo preso psicologicamente la
gestione di tutti i Comitati (del Viminale n.d.r.) dicendo a tutti che ero
l’unico che non aveva tradito Moro per il semplice fatto di non averlo mai
conosciuto». Il colpo di grazia venne inferto quando risultò evidente che Moro
fosse ormai disperato e si decise di attuare il piano della Duchessa, un falso
comunicato da attribuire alle Brigate Rosse: «I brigatisti non si aspettavano di
trovarsi di fronte ad un altro terrorista che li utilizzava e li manipolava
psicologicamente con lo scopo di prenderli in trappola. Avrebbero potuto venirne
fuori facilmente, ma erano stati ingannati. Ormai non potevano fare altro che
uccidere Moro. Questo il grande dramma di questa storia. Avrebbero potuto
sfuggire alla trappola, e speravo che non se ne rendessero conto, liberando Aldo
Moro. Se lo avessero liberato avrebbero vinto, Moro si sarebbe salvato,
Andreotti sarebbe stato neutralizzato e i comunisti avrebbero potuto concludere
un accordo politico con i democristiani. Uno scenario che avrebbe soddisfatto
quasi tutti. Era una trappola modestissima, che sarebbe fallita nel momento
stesso in cui avessero liberato Moro». Secondo le parole di Pieczenik Cossiga
era d’accordo con praticamente la maggior parte delle scelte proposte: «Moro, in
quel momento, era disperato e avrebbe sicuramente fatto delle rivelazioni
piuttosto importanti ai suoi carcerieri su uomini politici come Andreotti. È in
quell’istante preciso che io e Cossiga ci siamo detti che bisognava cominciare a
far scattare la trappola tesa alle BR. Abbandonare Moro e fare in modo che
morisse con le sue rivelazioni. Per giunta i carabinieri e i servizi di
sicurezza non lo trovavano o non volevano trovarlo». Gli obiettivi raggiunti con
questa strategia furono molteplici: venne eliminato Moro, le BR furono messe a
tacere e fu possibile entrare in possesso del vero memoriale e delle
registrazioni dell’interrogatorio dello statista italiano. Quello dell’esponente
della Democrazia Cristiana è stato un sacrificio umano, come dichiarato
apertamente da Pieczenik: «Mai l’espressione “ragion di Stato” ha avuto più
senso come durante il rapimento di Aldo Moro in Italia». E come ogni rituale, la
scena del delitto era carica di simbologia esoterica, evidente soprattutto per
gli iniziati. Il discorso merita un articolo a parte, che verrà pubblicato
prossimamente. La cosa meno esoterica fu la seduta spiritica alla quale
partecipò Romano Prodi, dove venne fuori la parola “Gradoli”, il nome della via
in cui era situato il covo dei sequestratori di Moro. Quella stessa via nella
quale erano presenti immobili di proprietà dei servizi segreti. Ovviamente la
seduta spiritica fu un escamotage per tenere sotto copertura la fonte della
soffiata che comunque venne deliberatamente ignorata. Venne sviata l’attenzione
su Gradoli in provincia di Viterbo, arrivando addirittura ad affermare che non
esistesse nessuna via a Roma con quel nome. Va anche tenuto presente che
all’epoca del sequestro i massimi dirigenti dei Servizi erano appartenenti alla
Loggia P2. Senza considerare che alcuni anni prima, durante la visita negli
Stati Uniti dello statista italiano nel settembre 1974, Henry Kissinger lo
minacciò pesantemente, come riferito dal portavoce di Moro, Corrado Guerzoni,
davanti ai giudici. Per non parlare della testimonianza della moglie
dell’esponente della DC, che dichiarò alla commissione parlamentare a proposito
delle evidenti minacce fatte al marito da parte della delegazione americana:
«Lei deve smettere di perseguire il suo piano politico di portare tutte le forze
del suo paese a collaborare direttamente. Qui, o lei smette di fare questa cosa,
o lei la pagherà cara, veda lei come la vuole intendere». Un’altra delle
numerose coincidenze fu la morte di Pier Paolo Pasolini che, guarda caso, aveva
espresso pubblicamente le sue perplessità, avanzando ipotesi e connessioni tra
“stragi di Stato”, poteri forti, servizi segreti internazionali, politici,
petrolieri e banchieri. Già nel 1975 aveva fatto notare che la “Strategia della
Tensione” era cominciata il 12 dicembre 1969 proprio con l’attacco alle sedi di
tre banche: la Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, la
Banca Commerciale Italiana, anch’essa a Milano (dove per fortuna la bomba rimase
inesplosa) e la Banca Nazionale del Lavoro in via Veneto a Roma. La Banca
Nazionale dell’Agricoltura, che aveva cominciato ad emettere le 500 lire
cartacee poco prima di questi tragici eventi, casualmente interruppe l’emissione
dei biglietti di Stato a corso legale dopo gli attentati. Guardatevi il video
della relazione di Marco Saba sul tema di Signoraggio Bancario e stragi di
Stato. Sentite cosa dice a proposito dei libri Il bilancio dello Stato – Un
istituto in trasformazione – Franco Angeli / La finanza pubblica (1977) di
Giuliano Passalacqua e del Libro bianco del Ministero del Tesoro (1969): «A
proposito dei buoni ordinari del tesoro, il grado di liquidità dei BOT può
essere uguale a quello della base monetaria se la Banca d’Italia li acquista
senza limiti ad un prezzo uguale a quello di emissione». In poche parole la
Banca d’Italia (quando era un po’ più statale di ora) poteva comprare
illimitatamente BOT alla pari, senza dover pagare interessi; praticamente come
se lo Stato italiano si fosse stampato la propria moneta. Come riferisce Marco
Saba, la cosa importante da notare è che questa era la pratica che
effettivamente esisteva in Italia fino al 1969, anno della strage di piazza
Fontana e delle bombe nelle banche. Senza considerare il discorso sui residui
passivi.
Altro tema interessante è
quello sulle guerre, le quali hanno quasi sempre a che vedere con il ricatto ed
il potere bancario nei confronti dei Paesi che hanno le banche nazionalizzate ed
una gestione della moneta a livello statale. Saba pone l’esempio della
rivoluzione iraniana che cominciò quando Khomeini fece due leggi contro
l’usura e nazionalizzò le banche. Chissà perché chi si occupa di denunciare e
contrastare le attività criminose di banchieri senza scrupoli generalmente non
fa una bella fine. Per esempio Federico Caffè, scomparso alle prime luci
dell’alba dalla sua casa a Roma, dove viveva con il fratello Alfonso, il 15
aprile nel 1987 (coincidentemente lo stesso giorno della morte del presidente
Abraham Lincoln). Un paio di anni prima, il 27 marzo 1985, il suo allievo Ezio
Tarantelli venne ucciso nel parcheggio dell’Università La Sapienza, attentato
poi rivendicato dalle fantomatiche Brigate Rosse per la costruzione del Partito
Comunista Combattente. Sia ben inteso, sono tutte coincidenze.
16 MARZO 1978. QUEL GIORNO
DA CANI.
Caccia ai rapitori di Moro
Interi quartieri perquisiti,
scrive "Il Tempo" il 10/07/2014. Ieri alle 9,15 un «commando» di dodici
terroristi ha sequestrato il presidente della DC. Aldo Moro e la sua scorta sono
caduti nell’imboscata sofistica e feroce delle Brigate rosse ieri mattina,
qualche minuto dopo le nove. All’angolo tra via Mario Fani e via Stesa, nei
quartieri collinari a nord-ovest di Roma, lo aspettavano dodici brigatisti,
undici uomini e una ragazza. I cinque uomini di scorta al presidente della DC
sono stati liquidati da tre serie successive di raffiche di mitra. In pochi
secondi, in due auto crivellate di colpi e sull’asfalto, c’erano i corpi dei
carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci e dei poliziotti Raffaele Iozzino e
Giulio Rivera; il vice brigadiere di PS Francesco Zizzi, portato in fin di vita
al Policlinico Gemelli, è morto tre ore dopo. Subito dopo l’atroce pioggia di
proiettili, Aldo Moro, rimasto quasi certamente incolume, è stato abbrancato da
quattro brigatisti e portato via con un’auto scura, probabilmente una «128».
Meno di un’ora dopo le Brigate rosse hanno rivendicato l’azione con una
telefonata alla sede ANSA di Roma: «Questa mattina abbiamo sequestrato il
presidente della DC Aldo Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, "teste di
cuoio" di Cossiga. Seguirà un comunicato. Firmato Brigate rosse». Una seconda
telefonata dallo stesso contenuto in cui Moro viene definito «servo dello Stato»
è arrivata all’ANSA di Torino. Nessuno dei messaggi accennava a richieste di
«riscatto», che saranno presumibilmente affidate al comunicato promesso. Ecco le
sequenze della azione. Verso le otto e mezzo, come ogni mattina, Aldo Moro esce
di casa, in via del Forte Trionfale2. Al portone lo aspetta una «130» blu (Roma
L59812) guidata dall’appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, quarantaquattro
anni, di Staffolo nell’Anconetano. Accanto all’appuntato siede il «fedelissimo»
del presidente democristiano, il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, 52
anni, di Ceres in provincia di Torino. Moro prende posto sul sedile dietro a
sinistra, secondo un’abitudine consolidata negli anni. Attorno a lui gli oggetti
abituali di ogni trasferimento da casa al centro: una «mazzetta» di una
cinquantina di giornali sul sedile di destra, che Moro comincia a sfogliare; una
valigetta ventiquattr’ore e una borsa di cuoio sul pavimento, sempre a destra;
un soprabito grigio e un impermeabile sul piano del lunotto, accanto a due
cappelli, uno invernale ed uno estivo. Dietro alla «130» si avvia «l’Alfetta» di
scorta della polizia (Roma S93393). Al volante c’è la guardia Raffaele Iozzino,
25 anni, napoletano di Casola; al suo fianco il capo equipaggio, il vice
brigadiere Francesco Zizzi, 30 anni, di Brindisi; dietro siede l’altra guardia,
Giulio Rivera, 24 anni, molisano di Guglionesi. Le due auto in corteo partono
verso via Trionfale, girano a sinistra verso il centro ma dopo poche centinaia
di metri sono già ferme, in piazza di Monte Gaudio. E’ una sosta abituale: Moro
scende dalla «130» e infila il portone della chiesa di San Francesco a Monte
Mario. E’ la chiesa parrocchiale e il presidente della DC è puntuale ogni
mattina alla Messa e alla comunione. Alle 9, quando la Messa finisce, Moro
riprende posto sulla «130». Le due auto scattano verso il centro ma, anzichè
proseguire lungo via Trionfale, secondo il percorso più diretto, svoltano a
sinistra in via Mario Fani, una strada in leggera discesa che porta a via Stresa
e di lì alla Camilluccia, altra grossa arteria da cui è raggiungibile il centro.
Si tratta di uno dei cinque o sei itinerari alternativi che Moro e la scorta
cambiano giorno dopo giorno senza un preciso criterio di rotazione per rendere
più ardui attentati e agguati di terroristi. E qui si inserisce una domanda,
forse cruciale per l’indagine: i brigatisti sapevano con certezza che il piccolo
corteo di Moro avrebbe scelto via Mario Fani, oppure hanno giocato d’azzardo?
C’è un particolare di straordinario interesse che sembra avallare la prima tesi.
Eccolo: ogni giorno, di buon mattino, all’angolo tra via Fani e via Stresa,
proprio nel punto in cui tra qualche momento i killers del commando BR
scaricheranno i mitra addosso alle due auto, un fioraio ambulante, Antonio
Spiriticchio, posteggia il suo furgone «Ford Transit» pieno di tulipani e
mimose. Ieri mattina lo Spiriticchio, che abita con la moglie portiera in via
Angelo Brunetti 42, ha trovato il suo «Ford» con le gomme squarciate e ha dovuto
rinunciare alla giornata di lavoro. Torniamo ai «fotogrammi» della vicenda che
adesso vanno girati al rallentatore, così da poter ricomporre con la maggior
precisione possibile gli istanti del minuto di fuoco e di morte che ha sconvolto
questo angolo di Roma in una mattinata di quasi primavera. L’auto di Moro e
quella della scorta sfilano a velocità sostenuta lungo le palazzine eleganti e
gli alberi in fiore di via Mario Fani. Davanti scende una «128 familiare» bianca
(è targata CD 19707) con un uomo a bordo. Il sedile posteriore è ribaltato, così
da allargare il piano carico. La «128» tallonata dalla «130» e dall’«Alfetta» si
avvicina veloce allo stop sull’incrocio tra via Fani e via Stresa; poi
«inchioda» repentinamente. E siamo già in piena imboscata. Un inferno. Domenico
Ricci, l’autista della «130» di Moro, è svelto a scansare l’ostacolo che
d’improvviso gli chiude la strada: sterza lievemente a destra e frena, così che
l’auto blu si arresta un po’ obliquamente col muso a pochi centimetri dalla coda
della «128». Alle spalle l’«Alfetta» non è così pronta e tampona leggermente la
«130». C’è un attimo di incertezza e la sorpresa ha ragione sulla prontezza di
riflessi. Attorno si scatena l’inferno. A fianco delle tre auto, incolonnate
allo stop, sorgono quattro brigatisti vestiti con divise approssimativamente da
aviatore civile: azzurre con berretti gallonati. I testimoni racconteranno di
averli notati già da un po’, fermi sui marciapiedi di fronte al bar Olivetti,
che è chiuso da qualche mese. Sparano in tre, con i mitra (da terra verranno
raccolti ottanta bossoli calibro nove), e le serie di raffiche sono tre, in
successione serrata. Il fuoco è preciso e annientante. Le due auto, a cose
fatte, sono crivellate di fori e tutti i finestrini laterali sono in frantumi,
tranne quello posteriore sinistro della «130», giusto in corrispondenza della
testa di Moro che siede, come sempre, un po’ accasciato. Domenico Ricci e Oreste
Leonardi si accasciano uno contro l’altro: il primo ha tre fori di proiettile
solo sulla guancia sinistra. Nella seconda auto Giulio Rivera muore al volante,
mentre Francesco Zizzi al suo fianco assorbe una raffica che gli lede polmoni e
diaframma, gli spappola fegato e reni. Morirà tre ore dopo all’ospedale, al
termine di un inutile intervento chirurgico. L’unico che può tentare di reagire
è «il ragazzino» del gruppo, Raffaele Iozzino, che è sul sedile posteriore.
Balza dall’«Alfetta», estrae la pistola e spara tre colpi cercando di coprirsi
dietro la vettura. Uno dei brigatisti fa qualche passo indietro e gli fa piovere
addosso un’ennesima raffica. Anche Iozzino muore, colpito alla testa, e la
pistola gli cade di mano. (...) A pochi metri di distanza, mentre torna il
silenzio e il sangue di Giulio Rivera comincia ad allungarsi sull’asfalto, i
quattro brigatisti in divisa azzurra si avventano sulla «130» e afferrano Aldo
Moro, due per le gambe e due per le braccia. (...)
Via Fani, quella mattina di
un giorno da cani,
scrive Lanfranco Caminiti il 5 settembre 2016 su “Il Dubbio”. Sono le 9.00 e
qualche minuto. Nella strada residenziale il traffico è scarso; la giornata è
serena, ma la temperatura ancora pungente. E poi si scatena l'inferno. Il 16
marzo 1978, qualche minuto prima delle 9.00 del mattino, l'onorevole Aldo Moro,
presidente della Democrazia cristiana, esce dal portone numero 79 di via del
Forte Trionfale a Roma. Sono ad attenderlo la 130 blu di rappresentanza, su cui
sale Moro, e un'Alfetta bianca con la scorta. Il presidente deve prima recarsi
al Centro Studi della Dc e poi, alle 10.00, alla Camera dei Deputati; qui
l'onorevole Andreotti presenterà il nuovo governo, entrato in carica l'11 marzo,
un monocolore democristiano, che sarà il primo sorretto anche dai voti
comunisti, di cui l'onorevole Moro è stato accorto e paziente artefice. Sono le
9.00 e qualche minuto. Nella strada residenziale di via Fani, alla Camilluccia,
il traffico è scarso; la giornata è serena, ma la temperatura ancora pungente.
Quattro uomini, che indossano impermeabili e berretti dell'Alitalia e portano
delle borse, sono fermi nei pressi del bar Olivetti, che ha cessato da tempo
ogni attività, all'incrocio tra via Fani e via Stresa. Qui, ogni mattina
staziona il furgone del signor Antonio Spiriticchio, che vende i suoi fiori, ma
nella notte ne sono state squarciate le ruote, e così non c'è. Una Fiat 128
giunge veloce e rapidamente si ferma allo stop dell'incrocio. I quattro uomini
fermi al bar superano il marciapiede imbracciando ciascuno un mitra, si
avvicinano alle auto e aprono il fuoco. La 130 blu è imprigionata tra la 128
davanti e l'Alfetta dietro, a sua volta bloccata da un'altra auto sopraggiunta e
messasi di traverso. Disperatamente l'autista della 130 blu cerca di manovrare
per guadagnare un varco, ma un ulteriore impedimento è una Mini Minor lì
parcheggiata casualmente. Il crepitare delle armi è infernale. I cinque uomini
della scorta vengono uccisi; uno di essi, ancora in vita, morirà poco dopo
all'ospedale. Il presidente della Dc è prelevato dal sedile posteriore della 130
blu e trasbordato su un'altra auto. Vengono prese anche le borse che aveva con
sé. I componenti del commando salgono sulle proprie auto e si danno alla fuga.
L'azione è durata solo pochi minuti. La notizia si diffonde immediatamente: i
residenti della zona telefonano alla polizia, che rapidamente invia pattuglie
sul posto. Presto in via Fani sorvolata da elicotteri si ritroverà una piccola
folla di autorità, poliziotti, carabinieri, magistrati, giornalisti, fotografi e
curiosi. Sull'asfalto, un cappello da pilota e un caricatore di mitra. I fogli
dei quotidiani che Moro leggeva in auto - e quel giorno lo accostavano di nuovo
al caso Lockheed - vanno a coprire il corpo senza vita di un agente della
scorta. I giornali radio e quelli televisivi interrompono i programmi e danno le
informazioni in una ridda di voci non verificate sulle armi e le auto usate, sul
numero e la nazionalità dei componenti del commando, sui testimoni del fatto.
Qualcuno evoca il sequestro Schleyer operato dalla Raf tedesca nel settembre
dell'anno precedente. I quotidiani preparano le edizioni straordinarie.
Sorpresa, incredulità e sgomento sono le parole più ricorrenti, ma sono anche le
emozioni che attraversano il paese da un capo all'altro. Intanto, sul luogo è
presto arrivata Eleonora Moro, moglie del presidente democristiano. Rientra dopo
poco a casa, dove riceve la visita del cardinale Poletti, vicario di Roma. Il
Papa, che conosce personalmente Aldo Moro e la moglie, è stato prontamente
avvisato degli accadimenti. Telefonate delle Brigate rosse che rivendicano
l'agguato e preannunciano ulteriori messaggi giungono alle redazioni Ansa di
diverse città. Alla Camera la seduta prevista è spostata dal presidente Pietro
Ingrao dopo un accordo con i capigruppo parlamentari. Il Parlamento è agitato:
dichiarazioni di questo o quel personaggio segnano la necessità di prendere atto
di uno «stato di guerra», contribuendo ad alimentare un senso generale di
incertezza e di confusione. A Palazzo Chigi convergeranno presto, per una
riunione, segretari dei partiti, esponenti politici e, per i tre sindacati,
Lama, Macario e Benvenuto. Il segretario del Partito comunista, Berlinguer,
accompagnato da Natta e Pajetta, arriva con una decisione adottata d'impeto:
«impedire qualsiasi trattativa». Il paese si ferma. Mentre partono dalle
centrali operative delle forze di polizia le prime impacciate disposizioni su
piani di ricerca e blocchi di controllo, migliaia di lavoratori escono dai posti
di lavoro. Unendosi ad altri cittadini, sciamano per le piazze principali di
tutte le città d'Italia, anticipando la proclamazione dello sciopero generale
intanto indetto dai sindacati. Fabbriche, uffici e scuole si chiudono. Molte
saracinesche di negozi si abbassano in segno di paura o di lutto. C'è rabbia e
senso di impotenza. Ma si registrano, insieme a una diffusa pietà per gli agenti
della scorta, anche parole di indifferenza: il potere democristiano non è stato
mai molto amato. Le manifestazioni saranno mute, con qualche sventolio di
bandiere rosse e bianche, ma segnate soprattutto dall'angoscia, da un bisogno
popolare di presenza, dal disorientamento. Le voci accorate di sindacalisti e
oratori ufficiali chiamano dai palchi alla «difesa del Paese contro il ricatto
del terrorismo», alla mobilitazione, alla «vigilanza e a isolare chi sta a
guardare o, peggio, solidarizza con questi criminali». Alle 11.00 circa si
riunisce il Consiglio dei ministri: Andreotti comunica che il dibattito alla
Camera sulla fiducia al governo sarà necessariamente breve, decisione con cui si
sono già dichiarati d'accordo i partiti. Dopo una rapida valutazione dei fatti,
si decide di adottare le prime misure di coordinamento delle attività di
polizia. Il ministro degli Interni, Cossiga, convoca per le 11.30 al Viminale i
titolari dei dicasteri della Difesa, delle Finanze, di Grazia e Giustizia, i
vertici delle Forze Armate e dei Servizi di Sicurezza per dare vita a un
Comitato tecnico-operativo che si riconvocherà nel tardo pomeriggio, incaricato
di tracciare le linee di ricerca e la gestione dei dati informativi delle
investigazioni. Cossiga deciderà anche la costituzione di un gruppo di
consulenti, in diretto rapporto soltanto con lui, che possa supportare le
indagini con analisi e valutazioni. In serata, il Viminale distribuirà alla
stampa le foto dei terroristi latitanti e ricercati. L'elenco, diffuso anche
attraverso la televisione, contiene numerose inesattezze ma anche precise
indicazioni. Viene inoltre trasmesso un numero di telefono a cui chiunque può
fornire informazioni coperte da segretezza. Poco dopo mezzogiorno, Andreotti
legge alla Camera una dichiarazione programmatica che ripeterà più tardi di
fronte al Senato: il governo, con il suo programma, ottiene rapidamente la
fiducia. In serata, il presidente del Consiglio apparirà alla televisione
parlando di fermezza e difesa dello Stato. Nel pomeriggio, il procuratore capo
della Repubblica di Roma, De Matteo, che in mattinata ha partecipato al vertice
al Viminale, convoca i sostituti procuratori e assume la direzione delle
indagini, assicurando un lavoro collaborativo. I primi sopralluoghi sono stati
compiuti dal sostituto di turno, Infelisi. Interrogato dai giornalisti, De
Matteo dichiara che c'è la possibilità di applicare uno «stato di pericolo
pubblico». La direzione democristiana riunita in permanenza, tramite il suo
segretario Zaccagnini, definisce l'agguato di via Fani «un attacco alla nuova
maggioranza». È la stessa conclusione - trasmessa alla stampa - a cui sono
giunti i comunisti. Da tutto il mondo cominciano ad arrivare messaggi di
solidarietà e dichiarazioni di sostegno. Da americani, tedeschi e inglesi
arrivano anche offerte di collaborazione tecnico-logistica. Aldo Moro è a via
Montalcini, prigioniero delle Br. Il Tribunale del Popolo gli comunica l'inizio
del processo nei suoi confronti.
ALDO MORO....
Aldo Moro
1916 – 1978 da “La Storia
Siamo Noi”. Aldo Moro nasce a Maglie, in provincia di Lecce, il 23 settembre
1916. Si iscrive a Giurisprudenza nell'Università di Bari, e, dopo la laurea,
inizia la carriera accademica. Nel 1939 pubblica il suo primo libro, che è
dedicato alla capacità giuridica penale. In quegli anni matura anche l'impegno
politico nella FUCI: la federazione degli universitari cattolici di cui è
presidente dal 1939 al 1943. Dal 1945 al 1946 dirige il Movimento Laureati
dell'Azione Cattolica. Nel 1946 è eletto all'Assemblea Costituente come
rappresentante della DC di cui è uno dei fondatori. Poco dopo entra a far parte
della Commissione dei Settantacinque che ha il compito di redigere il testo
costituzionale. Nelle elezioni dell'aprile 1948 viene eletto alla Camera e fino
al 1959 ricopre alcuni fra gli incarichi governativi più importanti: nel quinto
governo De Gasperi è nominato sottosegretario agli esteri. Nel 1955, con il
primo governo Segni, è ministro di Grazia e Giustizia. Due anni dopo, è ministro
della Pubblica Istruzione nel governo Zoli. È a lui che si deve l'introduzione
dell'educazione civica come materia d'insegnamento nelle scuole elementari e
medie. Lavora alla costruzione del centro sinistra dalla fine degli anni
Cinquanta. È d'accordo con Fanfani. Comprende che la stagione del centrismo è
terminata, e che occorre spostare a sinistra la politica del governo per dare al
paese le riforme di cui ha bisogno. Ma è una strada difficile. Deve superare le
resistenze interne al suo partito e quelle del PSI che, fino allora, ha
sostenuto una politica di collaborazione con il PCI. Il 1959 è l'anno della
svolta. Al VII congresso della DC ottiene la segreteria del partito: è il
risultato di un compromesso fra le correnti democristiane. Nello scontro fra
Fanfani e la destra del partito, che si oppone all'apertura verso i socialisti,
Moro riesce ad imporre una linea che esclude l'appoggio parlamentare dei partiti
di destra per ogni futuro governo e che equivale a sostenere l'ipotesi del
centro sinistra. Nel 1963 è presidente del Consiglio di un governo che vede la
partecipazione dei socialisti. Un'esperienza politica che ha termine nel 1968.
Gli elettori puniscono i partiti del centro sinistra e determinano, di fatto, la
crisi di quella stagione. Dal 1970 al 1974 Moro è ministro degli esteri. Nel
1974 costituisce il suo quarto governo, ma l'anno successivo una novità
importante cambia il quadro politico italiano. Alle elezioni amministrative del
1975 il PCI ottiene un grande consenso, e riporta al centro del dibattito
politico la strategia che Moro sostiene da tempo: coinvolgere il PCI nella
compagine governativa per dare una nuova spinta riformista al paese. Dal luglio
del 1976 al marzo 1978 l'Italia conosce la stagione della solidarietà nazionale.
La guida democristiana del governo è sostenuta dall'esterno da tutti i partiti
dell'arco costituzionale che si astengono. Votano contro il MSI, i radicali e
democrazia proletaria. Il 16 marzo del 1978 un commando delle Brigate Rosse
rapisce Moro che dal luglio del 1976 è presidente della DC. Vengono uccisi tutti
gli uomini della scorta. Moro si sta recando in Parlamento dove avrebbe votato
la fiducia al primo governo con il sostegno dei comunisti. Durante i giorni
della prigionia, i servizi segreti di tutto il mondo non riescono a trovare
Moro. In Italia si apre un dibattito drammatico fra coloro che sostengo la
necessità di trattare con le BR e coloro che, invece, rifiutano di scendere a
compromessi. Lo Stato non tratta e il 9 maggio 1978 il cadavere del presidente
della DC viene ritrovato dentro il bagagliaio di una Renault 4 a Roma, in via
Michelangelo Caetani. È uno degli episodi più drammatici dell'intera storia
dell'Italia repubblicana.
Aldo Moro
Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. «Per quanto si sia turbati, bisogna guardare al nucleo
essenziale di verità, al modo di essere della nostra società, che preannuncia
soprattutto una nuova persona più ricca di vita e più consapevole dei propri
diritti. Governare significa fare tante singole cose importanti ed attese, ma
nel profondo vuol dire promuovere una nuova condizione umana» (Aldo Moro,
Relazione al XII Congresso della Democrazia Cristiana, Roma, 9 giugno 1973).
Incarichi Istituzionali:
Presidente del Consiglio dei
Ministri: 4 dicembre 1963 - 24 giugno 1968.
Presidente del Consiglio dei
Ministri: 23 novembre 1974 - 29 luglio 1976.
Ministro degli Affari Esteri:
5 agosto 1969 - 29 luglio 1972; 7 luglio 1973 - 23 novembre 1974.
Ministro della Pubblica
Istruzione: 19 maggio 1957 - 15 febbraio 1959.
Ministro della Giustizia: 6
luglio 1955 - 19 maggio 1957.
Presidente del Consiglio
Nazionale della Democrazia Cristiana: 1976 - 1978.
Segretario Nazionale della
Democrazia Cristiana: 1959 - 1964.
Incarichi parlamentari:
Segretario della Commissione
Speciale per l'esame del disegno di legge sulle nuove formule di giuramento dal
10 dicembre 1946 al 31 gennaio 1948.
Commissione per la
Costituzione dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948.
1ª
Sottocommissione dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948.
Comitato di Redazione dal 19
luglio 1946 al 31 gennaio 1948.
Commissione Parlamentare per
la vigilanza sulle radiodiffusioni dal 7 luglio 1947 al 31 gennaio 1948.
Componente della Giunta per il
Regolamento dall'8 maggio 1948 al 27 maggio 1948, dal 6 agosto 1951 al 24 giugno
1953 e dal 26 giugno 1953 al 6 luglio 1955.
Componente della 2ª
Commissione (Affari Esterni) dall'11 giugno 1948 al 24 giugno 1953 e dal 1°
luglio 1953 al 6 luglio 1955.
Componente della 6ª
Commissione (Istruzione e Belle Arti) dal 29 gennaio 1950 al 24 giugno 1953 e
dal 1° luglio 1953 al 6 luglio 1955.
Componente della Commissione
Speciale per l'esame dei provvedimenti relativi alla Corte Costituzionale (n.
469 e 1292) dal 25 settembre 1952 al 18 dicembre 1952.
Componente della Giunta per i
trattati di commercio e la legislazione doganale dal 27 luglio 1951 al 1° luglio
1952.
Componente della 1ª
Commissione (Affari Costituzionali) dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1962.
Componente della 4ª
Commissione (Giustizia) dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1959, dal 1° luglio 1962
al 15 maggio 1963 e dal 1º luglio 1963 al 4 dicembre 1963.
Componente della 8ª
Commissione (Istruzione e Belle Arti) dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972.
Componente della 3ª
Commissione (Affari Esteri) dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976 e dal 5 luglio
1976 al 9 maggio 1978.
Presidente della 3a Commissione
(Affari Esteri) dall'11 luglio 1972 al 7 luglio 1973.
Aldo Romeo Luigi Moro (Maglie, 23
settembre 1916 – Roma, 9
maggio 1978)
è stato un politico,
accademico e
giurista italiano,
cinque volte Presidente
del Consiglio dei ministri, Segretario politico e presidente del consiglio
nazionale della Democrazia
Cristiana. Fu rapito il 16 marzo 1978 e
ucciso il 9 maggio successivo da alcuni terroristi
delle Brigate
Rosse. Nacque a Maglie,
in provincia
di Lecce, da genitori originari di Gemini,
frazione di Ugento.
Conseguì la Maturità
Classica al
Liceo "Archita" di Taranto.
Si iscrisse presso l'Università di Bari alla
Facoltà di Giurisprudenza,
dove prese la laurea,
sotto la guida del prof. Biagio
Petrocelli, con una tesi su "La capacità
giuridica penale".
In seguito, nel 1939,
pubblicò la tesi e ottenne la docenza in filosofia del diritto e di politica
coloniale alla stessa università nel 1941.
L'anno successivo svilupperà la sua seconda opera La
subiettivazione della norma penale e
otterrà così la cattedra di professore di diritto penale. Durante gli anni
universitari partecipò ai Littoriali
della cultura e dell'arte. Nel 1935 entrò
a far parte della Federazione
Universitaria Cattolica Italiana di
Bari, segnalandosi ben presto anche a livello nazionale. Nel luglio 1939 venne
scelto, su consiglio di Giovanni
Battista Montini, di cui, proprio in quegli anni, divenne amico, come presidente
dell'Associazione. Mantenne l'incarico sino al 1942,
quando fu chiamato alle armi, prima come ufficiale di fanteria,
poi come commissario nell'aeronautica. Gli successe Giulio
Andreotti, sino ad allora direttore della rivista Azione
Fucina. Dopo
qualche anno di carriera accademica, fondò nel 1943 a Bari,
con alcuni amici, il periodico La
Rassegna che
uscì fino al 1945.
Nel luglio dello stesso anno prese parte ai lavori che portarono alla redazione
del Codice
di Camaldoli. Nel 1945 sposò Eleonora Chiavarelli (1915–2010), con la quale ebbe
quattro figli: Maria
Fida (1946),
Anna (1949), Agnese (1952), e Giovanni (1958). Nei primi anni cinquanta fu
nominato professore ordinario di diritto
penale presso
l'Università di Bari. Nel 1963 ottenne
il trasferimento all'Università di Roma, in qualità di titolare della cattedra di
Istituzioni di Diritto e Procedura penale presso la Facoltà di Scienze
politiche. Tra il 1943 e il 1945 Aldo Moro aveva cominciato a interessarsi di
politica, in un primo tempo mostrò particolare attenzione alla componente
socialdemocratica del partito
socialista, successivamente però il suo forte credo cattolico lo spinse verso il
costituendo movimento democristiano.
Nella DC mostrò subito la sua tendenza democratico-sociale, aderendo alla
componente dossettiana.
Nel 1945 divenne direttore della rivista Studium e
fu eletto presidente del Movimento Laureati dell'Azione
Cattolica. Nel 1946 divenne vicepresidente della Democrazia Cristiana e fu
eletto all'Assemblea Costituente, dove entrò a far parte della Commissione che
si occupò di redigere il testo costituzionale.
Eletto deputato al Parlamento nelle
elezioni del 1948,
fu nominato sottosegretario agli esteri nel gabinetto De
Gasperi (23
maggio 1948 -
27 gennaio 1950).
Nel 1953 fu
rieletto alla Camera,
ove fu eletto presidente
del gruppo parlamentare democristiano.
Nel 1955 fu
ministro di Grazia e Giustizia nel governo
Segni I e
l'anno dopo risultò
tra i primi eletti nel consiglio nazionale del partito durante il VI congresso
nazionale della DC. Ministro della Pubblica Istruzione nei due anni successivi
(governi Zoli e Fanfani),
introdusse lo studio dell'educazione
civica nelle
scuole. Nel marzo 1959,
in conseguenza delle dimissioni di Fanfani da segretario del partito, e dopo la
spaccatura della corrente maggioritaria nel partito, "Iniziativa Democratica",
Aldo Moro venne eletto nuovo segretario della Democrazia Cristiana. Guidò
il VII congresso nazionale, che si svolse a Firenze dal 23 al 28 ottobre 1959.
Nel dicembre 1963 (IV
Legislatura, 1963 - 1968)
divenne, a soli 47 anni, presidente del Consiglio. Formò il suo primo governo
con una coalizione inedita: DC, PSI, PSDI e PRI;
fu il primo governo del centro-sinistra.
La coalizione resse fino alle elezioni del 1968. Il governo
Moro III (23
febbraio 1966 -
5 giugno 1968)
batté il record di durata (833 giorni) e rimase uno dei più longevi della
Repubblica. Dopo le elezioni venne costituito un governo
balneare in
attesa del congresso DC, previsto per l'autunno. Al congresso Moro passò
all'opposizione interna al partito. Dal 1969 al 1974 (V
e VI Legislatura), assunse l'incarico di Ministro
degli affari esteri. Dopo la caduta del V governo Rumor, riprese la guida di
palazzo Chigi, dove rimase fino alle elezioni anticipate del 1976.
Nel 1975 il
suo governo conclude il Trattato
di Osimo, con cui si sanciva l'appartenenza della Zona B del Territorio
Libero di Trieste alla
Jugoslavia. Nel 1976 fu eletto Presidente del Consiglio Nazionale del partito.
Aldo Moro «era un cattolico osservante e praticante e la sua fede in Dio si
rispecchiava nella sua vita politica». Era considerato un mediatore tenace e
particolarmente abile nella gestione e nel coordinamento politico delle numerose
"correnti" che agivano e si suddividevano il potere all'interno della
Democrazia Cristiana. All'inizio degli anni sessanta Moro fu un convinto
assertore della necessità di un'alleanza tra il suo partito e il Partito
Socialista Italiano, per creare un governo di centro-sinistra.
Nel congresso democristiano di Napoli del 1962 riuscì
a portare su questa posizione l'intero gruppo dirigente del partito. La stessa
cosa avvenne all'inizio del 1978 (poco
prima del rapimento), quando riuscì a convincere la DC della necessità di un
"governo di solidarietà nazionale", con la presenza del PCI nella
maggioranza parlamentare. La sua intenzione dominante era di allargare la base
del sistema di governo, ossia il vertice del potere esecutivo avrebbe dovuto
rappresentare un numero più ampio di partiti e di elettori. Questo sarebbe stato
possibile solo con un gioco di alleanze aventi come fulcro la DC, seguendo così
una linea politica secondo il principio di democrazia consociativa. Secondo
Sandro Fontana, Moro nella sua attività politica si trovava nella difficoltà di
conciliare la missione cristiana e popolare della Democrazia Cristiana con i
valori di tendenza laica e liberale della società italiana. Il “miracolo
economico”, che aveva portato l'Italia rurale a diventare in pochi decenni una
delle grandi potenze industriali mondiali, comportò anche un cambiamento
sociale, con il risveglio delle masse richiedenti una presenza attiva nella vita
del paese. Moro, quando affermava che “di crescita si può anche morire”,
esprimeva un suo giudizio sui rischi di una società in rapida crescita. Il
risveglio delle masse aveva favorito nuove e più forti fasce sociali (tra cui i
giovani, le donne e i lavoratori) che avevano bisogno di integrazione (anche
economica con precise riforme) all'interno del processo politico. Le masse
popolari, secondo alcuni, tendevano a esprimere in forma “emotiva e mitologica”
il loro bisogno di una partecipazione diretta alla gestione del potere. Secondo
altri, più semplicemente, le masse popolari italiane erano e sono – per ragioni
storiche, politico-culturali e di fragilità del ceto intellettuale – propense a
inclinare verso una destra autoritaria. In questo quadro variegato e in
evoluzione, la missione che Moro avrebbe ascritto alla Democrazia Cristiana fu
di recuperare le classi popolari dal fascismo e traghettarle nel sistema
democratico. Per questo motivo, Moro si sarebbe ritrovato nella situazione di
dover “armonizzare” realtà apparentemente inconciliabili tra loro. Questo
fattore era un fondamentale presupposto per la nascita di gruppi
terroristici che, visti sotto quest'ottica, sarebbero il frutto
dell'estremizzazione della partecipazione attiva ed extraparlamentare alla
politica del paese da parte di una piccola frazione della popolazione in cui
componenti emozionali e mitologiche si mescolerebbero provocando quasi sempre
“situazioni drammatiche”. Dall'altro lato c'era il desiderio di far sopravvivere
il sistema politico, che a questo scopo aveva bisogno sia di regole precise, sia
di scendere continuamente a compromessi alla ricerca di una forma di tolleranza
civile. Sandro Fontana così riepiloga i dilemmi di Moro: «Come conciliare
l'estrema mobilità delle trasformazioni sociali con la continuità delle
strutture rappresentative? Come integrare nello Stato masse sempre più estese di
cittadini senza cedere a seduzioni autoritarie? Come crescere senza morire?»
Nell'opinione di Moro la soluzione a tali quesiti non poteva non essere
raggiunta che con un compromesso politico, ampliando l'esperienza dell’
“'apertura a sinistra” della DC nei confronti del PSI di Pietro
Nenni, avvenuta all'inizio degli anni sessanta. Ma la situazione era diversa:
fin dal 1956 (rivoluzione ungherese) il PSI si era dichiaratamente staccato dal
PCI intraprendendo una strada autonoma. Negli anni
settanta e
soprattutto dopo le elezioni
del 1976, Moro concepì l'esigenza di dar vita a governi di "solidarietà
nazionale", con una base parlamentare più ampia comprendente anche il PCI. Ciò
rese Moro oggetto di aspre contestazioni: i critici lo accusarono di volersi
rendere artefice di un secondo “compromesso storico”, più clamoroso di quello
con Nenni, in quanto prevedeva una collaborazione di governo con il Partito
Comunista di Enrico
Berlinguer, che ancora faceva parte della sfera d'influenza sovietica,
cosa confutata da recenti studi di filosofia politica, in particolare quelli di
Danilo Campanella, esperto di filosofia
politica morotea, secondo cui la strategia di Moro era quella di un
"logoramento" del partito comunista per arrivare all'unità nazionale. Berlinguer
anticipò le eventuali preclusioni ai suoi danni prendendo pubblicamente le
distanze da Mosca e
rivendicando la capacità del PCI di muoversi autonomamente sullo scacchiere
politico italiano. Aldo Moro fu uno dei leader politici che maggiormente
prestarono attenzione alle affermazioni di Berlinguer, che con lo «strappo da
Mosca» si sarebbe reso accettabile a una parte degli elettori della Democrazia
Cristiana. Il segretario nazionale del Partito
Comunista Italiano aveva
proposto un accordo di solidarietà politica fra i comunisti e cattolici, in un
momento di profonda crisi sociale e politica in Italia: la conseguenza fu un
intenso confronto parlamentare tra i due schieramenti, che fece parlare di
"centralità del Parlamento". All'inizio del 1978 Moro, allora presidente della
Democrazia Cristiana, fu l'esponente politico più importante che ritenne
possibile un governo di "solidarietà nazionale", che includesse anche il PCI
nella maggioranza, sia pure senza una presenza di ministri comunisti nel
governo, in una prima fase. Tale soluzione presentava rischi sul piano della
politica internazionale, in quanto non trovava il consenso delle grandi superpotenze mondiali:
Disaccordo degli Usa:
l'ingresso al governo di persone che avevano stretti contatti con il partito
comunista sovietico avrebbe consentito loro di venire a conoscenza, in piena guerra
fredda, di piani militari e di postazioni strategiche supersegrete della Nato.
Inoltre, una partecipazione comunista in un paese d'influenza americana sarebbe
stata una sconfitta culturale degli Usa nei confronti del resto del mondo, e
soprattutto dell'Urss;
Disaccordo dell'Urss:
la partecipazione al governo del PCI sarebbe stata interpretabile come una forma
di emancipazione del partito dal controllo sovietico e di avvicinamento autonomo
agli USA.
Le divergenze sul piano
internazionale Moro le aveva già constatate sulla propria pelle nel periodo
direttamente antecedente il sequestro: la sua difesa di Rumor
nella discussione parlamentare sullo Scandalo
Lockheed fu
da taluno spiegata con un suo personale coinvolgimento nel sistema di tangenti versate
dall'impresa aerospaziale americana Lockheed in cambio dell'acquisto di aerei da
trasporto militari C-130. Secondo alcuni giornali dell'epoca Moro era il
fantomatico Antelope
Cobbler, destinatario delle bustarelle. L'accusa, che avrebbe avuto lo scopo di
fare fuori politicamente Moro e far naufragare i suoi progetti politici, venne
ridimensionata con l'assoluzione di Moro del 3 marzo 1978, tredici giorni prima
dell'agguato in via Fani. Il 7 marzo 1977 cominciò
in Parlamento il dibattito sullo scandalo
Lockheed. Marco
Pannella, tra i primi a parlare, sostenne la tesi che il responsabile delle
tangenti non fosse il governo ma il Presidente della Repubblica in persona, Giovanni
Leone. Ugo
La Malfa si
schierò dalla sua parte chiedendo le dimissioni del Presidente. Il 9 marzo prese
la parola Moro. Il presidente DC difese il suo partito dall'accusa di aver posto
in essere un «regime» e difese i ministri Luigi
Gui (democristiano)
e Mario
Tanassi (PSDI),
che erano al centro dell'inchiesta. Poi replicò all'intervento di Domenico
Pinto, deputato di Democrazia
Proletaria, che aveva detto che la corruzione della DC era provata dallo
scandalo Lockheed; per questo i democristiani sarebbero stati processati nelle
piazze: «Nel Paese vi sono molte opposizioni (…); e quell'opposizione, colleghi
della Democrazia Cristiana, sarà molto più intransigente, sarà molto più
radicale quando i processi non si faranno più in un'aula come questa, ma si
faranno nelle piazze, e nelle piazze vi saranno le condanne». Moro replicò:
«Onorevoli colleghi che ci avete preannunciato il processo nelle piazze, vi
diciamo che noi non ci faremo processare». In seguito la frase si prestò a
diverse interpretazioni politiche. La vicenda giudiziaria si concluderà nel 1979 con
l'assoluzione di Gui e la condanna di Tanassi. Il 16 marzo 1978, giorno della
presentazione del nuovo governo, il quarto guidato
da Giulio
Andreotti, la Fiat
130 che
trasportava Moro, dalla sua abitazione nel quartiere Trionfale zona Monte
Mario di Roma alla
Camera dei deputati, fu intercettata da un commando delle Brigate
Rosse all'incrocio
tra via Mario Fani e via Stresa. Gli uomini delle BR uccisero,
in pochi secondi, i cinque uomini della scorta (Domenico
Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi) e
sequestrarono il presidente della Democrazia
Cristiana. Dopo una prigionia di 55 giorni nel covo di via Montalcini le
Brigate Rosse decisero di concludere il sequestro uccidendo Moro: lo misero
dentro il portabagagli di un'automobile Renault 4 rossa, rubata il 2 marzo 1978
a un imprenditore (Filippo Bartoli) nel quartiere Prati, due settimane prima
dell'eccidio di via Fani e
gli dissero di coprirsi con una coperta dicendo che avevano intenzione di
trasportarlo in un altro luogo. Dopo che Moro fu coperto, gli spararono dieci cartucce uccidendolo.
Il corpo di Aldo Moro fu ritrovato nella stessa auto il 9 maggio a Roma in via
Caetani emblematicamente
vicina sia a piazza
del Gesù (dov'era
la sede nazionale della Democrazia
Cristiana), sia a via
delle Botteghe Oscure (dove
era la sede nazionale del Partito
Comunista Italiano). Fu sepolto nel comune di Torrita
Tiberina, piccolo paese della provincia romana dove lo statista amava
soggiornare. Aveva 61 anni. Papa Paolo VI il
successivo 13 maggio officiò una solenne commemorazione funebre pubblica per la
scomparsa di Aldo Moro, amico di sempre e suo alleato, a cui parteciparono le
personalità politiche italiane e che venne trasmessa in televisione. Questa
cerimonia funebre venne celebrata senza il corpo dello statista per esplicito
volere della famiglia, che non vi partecipò, ritenendo che lo stato italiano
poco o nulla avesse fatto per salvare la vita di Moro, rifiutando il funerale
di stato e
scegliendo di svolgere le esequie dello statista in forma privata. Rinchiuso
dalle Brigate
Rosse nella
"prigione del popolo", Aldo Moro scrisse moltissime lettere, indirizzate
perlopiù ai familiari e alla dirigenza della Democrazia Cristiana, più
precisamente a Benigno
Zaccagnini, a Francesco Cossiga, a Giulio
Andreotti, a Riccardo
Misasi e
ad altri; oltre che al capo socialista Bettino
Craxi, l'unico esponente di governo che abbia sostenuto la necessità di trattare
per salvare la vita di Moro. Le lettere, che degli esami grafologici hanno
attribuito come scrittura al politico,
sono sicuramente di Moro, anche se ragioni tattiche (ascrivibili alla cosiddetta
"linea della fermezza" e alla necessità di chiudere ogni spiraglio alla
trattativa) spinsero buona parte dell'allora dirigenza politica (soprattutto DC)
ad allinearsi e a metterne in dubbio l'autenticità, a sostenere che non fossero
state pensate da Moro o fossero addirittura dettate dalle Brigate Rosse. Il
parere dei familiari, dei migliori studiosi e infine di chiunque abbia letto le
lettere integralmente, è concorde nel riconoscere pienamente Moro in quegli
scritti. Trentotto di queste lettere vennero pubblicate, con una introduzione
attribuita a Bettino
Craxi, nel pamphlet Lettere
dal Patibolo dalla
rivista Critica
Sociale. Il
settimanale Panorama,
nel numero del 19 maggio 1980 in
un articolo dal titolo Perché
rubano tanto?,
aveva sollevato il caso delle fattorie
del senese amministrate dal consigliere di Aldo Moro, Sereno
Freato. La polemica fu poi ripresa da Giorgio
Pisanò sul
settimanale Candido.
Il 4 maggio 2007,
il Parlamento ha votato e approvato una legge con il quale si istituisce il 9
maggio il "Giorno della memoria" in ricordo di Aldo Moro e di tutte le vittime
del terrorismo. Tra aprile e maggio 2007 è
stata presentata presso l'Istituto San Giuseppe delle suore Orsoline a Terracina e
presso la sede dell'associazione Forche Caudine a Roma, presente la figlia
Agnese, una raccolta ragionata dei suoi scritti giornalistici, curata da Antonello
Di Mario e Tullio
Pironti editore.
Nella notte tra l'8 e il 9 giugno 2007,
giorni della visita del presidente
degli Stati Uniti d'America George
W. Bush in
Italia, la lapide di via Fani che ricorda il rapimento di Aldo Moro e le cinque
persone della scorta uccise è stata imbrattata con la scritta "Bush uguale a
Moro". Il giorno della domenica
delle Palme del 2008,
16 marzo, a trenta anni dal suo rapimento, il vescovo
di Caserta Raffaele
Nogaro nell'omelia pasquale
ha chiesto l'avvio di un processo di beatificazione per Aldo Moro: "uomo di
infinita misericordia, che perdonò tutti". Il 20 settembre 2012 il
presidente del tribunale diocesano di Roma dà il via libera all'inchiesta sulla
beatificazione di Aldo Moro dopo il nulla osta concesso dal vicario del Papa,
cardinal Agostino
Vallini, che ha indicato lo statista «servo di Dio». È stato nominato
postulatore per la causa di beatificazione dello statista il dottor Nicola
Giampaolo di Rutigliano.
Nel giorno del 30º anniversario della sua morte, l'Università degli Studi di
Bari, di cui Moro fu studente e docente, ha deliberato di intitolarsi allo
statista, la decisione ha avuto il consenso e apprezzamento della figlia Agnese
Moro. Ad Aldo Moro è dedicato il ponte omonimo di Taranto conosciuto anche come Ponte
Punta Penna Pizzone. Ormai i termini di secretazione sono scaduti, e lentamente
vengono pubblicati alcuni documenti realizzati durante la sua attività politica.
Nell'ottobre 2014 è
stata costituita la commissione d'inchiesta parlamentare, alla cui presidenza si
è insediato Giuseppe
Fioroni. Il pensiero moroteo è stato scandagliato negli ultimi anni alla ricerca
di una traccia che possa teorizzare un piano teoretico di Moro. Ricercatori,
collaboratori, filosofi si sono impegnati, non soltanto in ambito storiografico,
a decifrare la vasta memoria di scritti e discorsi, opere, articoli e
pubblicazioni dello statista. Giovanni
Galloni racconta nel suo Trent'anni
con Moro
l'esperienza politica e personale con lo statista all'interno della DC e della
politica italiana. Il libro non è parco di aneddoti, teorie e considerazioni
personali dell'ex ministro della Pubblica istruzione. Angelo Schillaci, nel suo
lavoro Persona
ed esperienza giuridica nel pensiero di Aldo Moro individua
le radici di una filosofia del diritto all'interno del pensiero di Moro, che
afferisce ad autori quali Mounier e Maritain.
In particolare Schillaci sottolinea il concetto di subiettivazione della norma
penale nella teoria giuridica morotea in cui il soggetto di reato è in
primis titolare
di un diritto innato, appunto soggettivo, al quale il legislatore deve
sottostare; ne derivano temi come la pena di morte, l'ergastolo e la
rieducazione dell'ergastolano in
cui Aldo Moro s'impegnerà durante la sua attività politica. La filosofia
politica di Aldo Moro verrà trattata da Danilo Campanella che, dopo un'attenta
ricerca del retroterra biografico e del diritto, individuerà in Aldo Moro un
vero e proprio filosofo della politica.
Lo
statista non s'impegnò in una commistione di filosofie precedenti, né criticò
teorie politiche, ma cercò di dare risposte nuove ai problemi della politica
all'interno della filosofia, come illustrato durante l'Inaugurazione nazionale
delle presentazioni Aldo Moro, in
cui il filosofo ha trattato il ruolo del cittadino nella democrazia, una nuova
concezione di Stato, il ruolo della Resistenza come nuovo, vero Risorgimento,
l'alternanza tra cattolicesimo e socialismo,
il pluralismo, una nuova e innovativa concezione di laicità (polo pubblico e
polo privato che Moro trasla dalla giurisprudenza), il pluralismo, la comunità
sociale e le prospettive europee negli Stati Uniti d'Europa,
la
politica reale e quella ideologica.
Aldo Moro si occupò, assieme
di politica attiva, anche di filosofia, principalmente filosofia del diritto e
filosofia politica.
OPERE DI ALDO MORO.
La capacità giuridica
penale,
Padova, CEDAM, 1939.
La subiettivazione della
norma penale,
Bari, Macrì, 1942.
Lo stato. Corso di lezioni
di filosofia del diritto tenute presso l'Università di Bari nell'anno accademico
1942-43, raccolte a cura e per uso degli studenti,
Padova, CEDAM, 1943.
Il diritto. Corso di
lezioni di filosofia del diritto tenute presso la R. Università di Bari
nell'anno accademico 1944-45, raccolte a cura e per uso degli studenti,
Bari, L.U.C.E., 1945.
L'antigiuridicità penale,
Palermo, Priulla, 1947.
Appunti sull'esperienza
giuridica. Lo stato. Lezioni di filosofia del diritto tenute presso l'università
di Bari nell'anno accademico 1946-1947,
Bari, L.U.C.E., 1947.
Unità e pluralità di reati.
Principi,
Padova, CEDAM, 1951; 1954.
La parità della scuola,
in Libertà e parità della scuola non statale nella Costituzione, Roma,
Fidae, 1957.
Pensiero politico di Luigi
Sturzo,
Napoli, Ediz. Politica popolare, 1959.
Relazione al VII Congresso
nazionale della Democrazia cristiana. Firenze, 23-28 ottobre 1959,
Roma, DC Spes, 1960.
La Democrazia cristiana per
il governo del paese e lo sviluppo democratico nella società italiana,
Roma, Cinque lune, 1961.
Le funzioni sociali dello
Stato, in Funzioni
e ordinamento dello Stato moderno, Roma, Studium, 1961.
Per garantire e sviluppare
la democrazia in Italia. Relazione dell'on. Moro al Consiglio nazionale della
D.C., Roma,
DC Spes, 1961.
La continuità della
politica di sviluppo democratico promossa in Italia dalla Democrazia cristiana,
Roma, DC Spes, 1962.
Discorsi elettorali.
Elezioni amministrative 10 giugno 1962,
Roma, Cinque lune, 1962.
Il discorso al Consiglio
nazionale. Roma 3-4-5 luglio 1962,
Roma, DC Spes, 1962.
La Democrazia cristiana per
la donna nella famiglia e nella società,
Roma, DC Spes, 1963.
La professione forza
coesiva della società,
in Cristianesimo e democrazia, Roma, Civitas, 1964.
Dichiarazioni
programmatiche di governo. Dicembre 1963,
Roma, Spes centrale, 1964.
La linea Moro,
Livorno, Il telegrafo, 1964.
Luigi Sturzo: una vita per
la libertà e la democrazia,
in Il movimento politico dei Cattolici, Roma, Civitas, 1969.
Una politica per i tempi
nuovi, Roma,
Agenzia Progetto, 1969.
Per la società italiana e
la comunità internazionale,
Roma, Agenzia Progetto, 1971.
Prima e dopo il 7 maggio,
Roma, Agenzia Progetto, 1972.
Per una iniziativa politica
della Democrazia cristiana,
Roma, Agenzia Progetto, 1973.
Il diritto. Lezioni di
filosofia del diritto tenute presso l'Università di Bari: 1944-1945,
Bari, Cacucci, 1978.
Il diritto, 1944-1945.
Lezioni di filosofia del diritto tenute presso l'Università di Bari; Lo
Stato, 1946-1947. Appunti sull'esperienza giuridica, Bari, Cacucci, 1978.
Discorsi politici,
Roma, Cinque lune, 1978.
Nella società che cambia.
Discorsi della prima seconda e terza fase,
Roma, EBE, 1978.
L'intelligenza e gli
avvenimenti. Testi 1959-1978,
Milano, Garzanti, 1979.
Scritti e discorsi,
6 voll., Roma, Cinque lune, 1982-1990.
Al di là della politica e
altri scritti. Studium, 1942-1952,
Roma, Studium, 1982.
Moro. I giorni del tormento,
Roma, Cinque lune, 1982.
Italia nell'evoluzione dei
rapporti internazionali. Discorsi, interventi, dichiarazioni e articoli
recuperati e interpretati da Giovanni Di Capua,
Roma-Brescia, EBE-Moretto, 1986.
Aldo Moro. Il potere della
parola (1943-1978),
Roma, EBE, 1988.
Dichiaro aperta la fiera
del Levante.... I discorsi da Presidente del Consiglio alle edizioni del 1964,
1965, 1966, 1967, 1975 della Campionaria barese,
Bari, Safra, 1991.
Il memoriale di Aldo Moro
rinvenuto in via Monte Nevoso a Milano,
Roma, Coletti, 1993.
Lettere. 16 marzo-9 maggio
1978, San
Bellino, Nova Cultura, 1995.
Lettere dal patibolo,
Milano, Giornalisti editori, 1995.
Discorsi parlamentari.
1947-1977, 2
voll., Roma, Camera dei Deputati, 1996.
Il mio sangue ricadrà su di
loro. Gli scritti di Aldo Moro prigioniero delle Br,
Milano, Kaos, 1997.
Moro: lettere dal carcere
delle Brigate Rosse. 9 maggio '78 - 9 maggio '98,
Roma, L'Editrice Romana, 1998.
Pietro Nenni, Aldo Moro.
Carteggio 1960-1978,
Firenze, La Nuova Italia, 1998.
Ultimi scritti. 16 marzo-9
maggio 1978,
Casale Monferrato, Piemme, 1998.
La democrazia incompiuta.
Attori e questioni della politica italiana, 1943-1978,
Roma, Editori Riuniti, 1999.
55 giorni di piombo. Le
lettere dal carcere di Aldo Moro, i ricordi di Francesco Cossiga, Claudio
Martelli, Agnese Moro, Eugenio Scalfari,
Roma, Elleu Multimedia, 2000.
55 giorni. Aldo Moro-voci e
carte dalla prigione,
Roma, Nuova iniziativa editoriale, 2003.
Lezioni di istituzioni di
diritto e procedura penale. Tenute nella Facoltà di scienze politiche
dell'Università degli studi di Roma,
con DVD audio, Bari, Cacucci, 2005.
Lo Stato, il diritto,
Bari, Cacucci, 2006.
Lettere dalla prigionia,
Torino, Einaudi, 2008.
La democrazia incompiuta,
Milano, RCS Quotidiani, 2011.
Libertà e giustizia
sociale. Per un'autonomia della persona umana (13 marzo 1947),
in I valori costituzionali del riformismo cristiano, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2011.
L'Italia di Donat-Cattin.
Gli anni caldi della prima Repubblica nel carteggio inedito con Moro...
(1960-1991),
Venezia, Marsilio, 2011.
"Siate indipendenti. Non
guardate al domani ma al dopo domani". Le lettere di Aldo Moro dalla prigionia
alla storia,
Roma, Direzione Generale per gli Archivi-Archivio di Stato di Roma, 2013.
OPERE SU ALDO MORO.
Cinema.
Todo modo:
film di Elio Petri, 1976, nel quale il personaggio del presidente, interpretato
da Gian Maria Volonté, è palesemente ispirato ad Aldo Moro. Il film è tratto
dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia.
Il caso Moro:
film di Giuseppe Ferrara, 1986. Il protagonista è nuovamente Gian Maria Volonté.
L'anno del terrore:
film di John Frankenheimer, 1991. Tratto dal romanzo Year of The Gun di
Michael Mewshaw; il personaggio dello statista compare brevemente in alcune
scene ed è interpretato da Aldo Mengolini.
Piazza delle Cinque Lune:
film di Renzo Martinelli, 2003. Il vero Moro appare in immagini di repertorio.
Quello finto è interpretato da un caratterista mai in primo piano. Il film è
dedicato all'allora ventisettenne nipote Luca Bonini Moro, che compare sui
titoli di coda in veste di cantautore, interpretando il brano Maledetti voi;
sullo sfondo del ragazzo (figlio di Maria Fida Moro e spesso affettuosamente
citato nelle lettere dello statista durante la prigionia), alcune fotografie di
lui a due anni col nonno nei giorni immediatamente precedenti il sequestro.
Buongiorno, notte:
film di Marco Bellocchio, 2003. Moro è interpretato da Roberto Herlitzka.
Nel cuore dello Stato:
film documentario di Alberto Castiglione, scritto con Fabrizio Scibilia,
presentato a Palermo il 18 marzo 2008.
Se sarà luce sarà
bellissimo - Moro: Un'altra storia:
film di Aurelio Grimaldi, (2004, uscito nel 2009); Moro è interpretato da Roshan
Seth.
Il divo:
film di Paolo Sorrentino, 2008. Lo statista è interpretato da Paolo Graziosi.
Romanzo di una strage:
film di Marco Tullio Giordana, 2012. Lo statista è interpretato da Fabrizio
Gifuni.
Musica.
La canzone E Berta filava di Rino
Gaetano è, per molti un riferimento ad Aldo Moro e alla sua politica di apertura
verso il PCI, che era in realtà totale, seppur Moro non lo dicesse in pubblico.
Alla base di ciò ci sono le parole che lo stesso Rino Gaetano disse nel 1977 nel
concerto a San Cassiano, dove citò proprio Moro, dedicandogli la canzone.
Io se fossi Dio di Giorgio
Gaber (1980): la canzone, della durata di 14 minuti, esprime un giudizio
negativo su Aldo Moro. Fu pubblicata dalla F1 Team su disco da 12 pollici inciso
solo da un lato, per il rifiuto della Carosello. La canzone era stata scritta
nel 1978, dopo l'uccisione di Aldo Moro, ma fu pubblicata due anni dopo perché
evidentemente le case discografiche temevano ripercussioni legali.
Teatro.
L'ira del sole, un 9 di
maggio (1998)
di Maria Fida Moro e Antonio Maria Di Fresco, regia di Antonio Raffaele Addamo.
Con Maria Fida Moro e Luca Bonini Moro. Teatro Biondo Stabile di Palermo.
Aldo Moro – Una tragedia
italiana (2007)
di Corrado Augias e Vladimiro Polchi, regia di Giorgio Ferrara. Con Paolo
Bonacelli (Aldo Moro) e Lorenzo Amato (il narratore). Teatro Stabile della
Sardegna, Teatro Eliseo di Roma.
Corpo di stato – Il delitto
Moro: una generazione divisa (1998)
di Marco Baliani, regia di Maria Maglietta. Con Marco Baliani. Casa degli
Alfieri – Trickster Teatro.
Se ci fosse luce – i
misteri del caso Moro (2007)
scritto, diretto e interpretato da Giancarlo Loffarelli. Con Emiliano
Campoli, Marina Eianti, Giancarlo Loffarelli, Luigina Ricci, Elisa
Ruotolo, Maurizio Tartaglione. Compagnia "Le colonne".
Roma, Via Caetani, 55º
giorno (2008)
scritto e interpretato da Lucilla Falcone – Associazione Culturale "La Buona
Creanza".
ALDO MORTO - Tragedia (2012)
di Daniele Timpano, regia di Daniele Timpano. Con Daniele Timpano. Amnesia
vivace, Area 06, Cité internationales des Arts - Résidence d'artistes di Parigi.
Letteratura.
Amici e nemici
di Giampaolo
Spinato, pubblicato nel 2004 da Fazi, è un romanzo, il primo, interamente
ispirato ai 55 giorni del sequestro e all'uccisione di Aldo Moro, il cui
rapimento si immagina parallelo a quello di uno dei componenti del commando
brigatista di via Fani.
Televisione.
Assolvenza Aldo Moro (Blob
Speciale) antologia
di filmati ed estratti dagli archivi Rai (servizi tratti dai TG, pubblicità,
frammenti di film, programmi vari) risalenti al periodo del rapimento dello
statista. Fu realizzata dalla redazione di Blob nel 1998 in occasione del
ventennale dei noti avvenimenti. Fu trasmessa su Rai 3 dal 9 marzo al 16
maggio per cinque giorni a settimana
(lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato); ogni puntata durava circa una
dozzina di minuti e precedeva l'inizio di Blob.
Aldo Moro - Il Presidente: fiction
televisiva in due puntate, prodotta dalla TaoDue di Piero Valsecchi, diretta
da Gianluca Maria Tavarelli e interpretata da Michele Placido, in onda su Canale
5 il 9 e 11 maggio 2008 in occasione del trentennale dalla morte dello statista.
Alcuni filmati di repertorio
dell'omicidio di Aldo Moro compaiono all'inizio del primo episodio della seconda
stagione della serie televisiva inglese "Utopia".
Bibliografia.
Giovanni Acquaviva, Un
italiano diverso: Aldo Moro, 1968.
Gianni Baget Bozzo, Il
partito cristiano e l'apertura a sinistra: la DC di Fanfani e di Moro 1954-1962.
Gianni Baget Bozzo, Democrazia
cristiana, Moro, «partito americano», in Argomenti radicali, n. 10, 1978.
Gianni Baget Bozzo e Giovanni
Tassani, Aldo Moro: il politico nella crisi, 1983.
Danila Barbara, Raffaele
Marino, La Lezione, Aula XI, Curcio, 2008.
Roberto Bartali, Giuseppe De
Lutiis, Sergio Flamigni, Ilaria Moroni e Lorenzo Ruggiero, Il sequestro di
verità. I buchi neri del delitto Moro, 2008.
Danilo Campanella, Aldo
Moro, politica, filosofia, pensiero, Edizioni Paoline, Milano, 2014.
Romano Bianco e Manlio
Castronuovo, Via Fani ore 9.02. 34 testimoni oculari raccontano l'agguato ad
Aldo Moro, 2010.
Giovanni Bianconi, Eseguendo
la sentenza. 2007.
Francesco Biscione, Il
delitto Moro: strategie di un assassinio politico, 1998.
Carlo Bo, Aldo Moro.
Delitto d'abbandono, 1988.
Giorgio Bocca e Silvia
Giacomoni, Moro: una tragedia italiana, 1978.
Silvio Bonfigli e Jacopo Sce, Il
delitto infinito. Ultime notizie sul sequestro Moro.
Anna Laura Braghetti e Paola
Tavella, Il prigioniero, 1998.
Manlio Castronuovo, Vuoto a
perdere, 2007.
Marco Clementi, La pazzia
di Aldo Moro, 2001.
Aniello Coppola, Moro,
1976.
Eugenio Cutolo, Aldo Moro:
La vita, l'opera, l'eredità, 1980.
Augusto D'Angelo, Moro – I
vescovi e l'apertura a sinistra, 2005.
Giuseppe De Lutiis, Perché
Aldo Moro, 1988.
Giovanni Di Capua, Aldo
Moro: il potere della parola (1943-1978), 1988.
Antonello Di Mario, L'attualità
politica di Aldo Moro negli scritti giornalistici dal 1937 al 1978, 2007.
Roberto Ducci I Capintesta,
1982.
Giovanni Fasanella, Giuseppe
Rocca Il misterioso intermediario – Igor Markevic e il caso Moro, 2003.
Sergio Flamigni, La tela
del ragno. Il delitto Moro, 1988.
Sergio Flamigni, Il mio
sangue ricadrà su di loro. Gli scritti di Moro prigioniero delle BR.
Sergio Flamigni, Convergenze
parallele.
Sergio Flamigni, Il covo di
stato. Via Gradoli 96 e il delitto Moro.
Guido Formigoni, Aldo Moro.
L'intelligenza applicata alla mediazione politica, 1997.
Antonio Ghirelli e Franco
Angeli, Moro tra Nenni e Craxi. Cronaca di un dialogo tra il 1959 e il 1978,
1991.
Agostino Giovagnoli, Il
caso Moro – Una tragedia repubblicana, Il Mulino, 2005.
Ferdinando Imposimato, Sandro
Provvisionato, Doveva morire. Chi ha ucciso Aldo Moro. Il racconto di un
giudice, 2008.
Andrea Ligorio, Il caos
Moro, 2008.
Robert Katz, I giorni
dell'ira, 1986 (libro da cui è tratto il film di G. Ferrara Il caso Moro).
Daniele Luttazzi, Stanotte
e per sempre, racconto grottesco su Andreotti e il caso Moro.
Giovanni Maddamma, Aldo
Moro – Omicidio Misterioso, 2008.
Salvatore Martino, Aldo
Moro - Il seme amaro della speranza, 2012.
Ivo Mej, Moro rapito!,
2008.
Mario Moretti, Rossana
Rossanda, Carla Mosca, Brigate Rosse. Una storia italiana, 2002.
Agnese Moro, Un uomo così,
2003.
Carlo Alfredo Moro, Storia
di un delitto annunciato, 1998.
Giovanni Moro, Anni
Settanta, 2007.
Maria Fida Moro, La
nebulosa del caso Moro, 2004.
Renato Moro, Aldo Moro
negli anni della FUCI, 2008.
Roberto Pantanelli, Ammazzate
Moro, 1987.
Paolo Parisi, Il sequestro
Moro, 2006.
Demetrio Piccini, Aldo Moro -
una vittima dei poteri forti, 2013.
Roberto Ruffilli, Vicenda
Moro e sistema politico, ne Il Mulino, 4, luglio-agosto 1978,
pp. 668-fine.
Vladimiro Satta, Odissea
nel caso Moro, 2003.
Vladimiro Satta, Il caso
Moro e i suoi falsi misteri, 2006.
Salvatore Savoia, Aldo
Moro. L'iniqua ed ingrata sentenza della D.C...., 2006.
Leonardo Sciascia, L'affaire
Moro, 1994.
Leonardo Sciascia, Todo
modo, 1974.
Giampaolo Spinato, Amici e
nemici, Fazi, 2004.
Webster Tarpley et al., Chi
ha ucciso Aldo Moro?, studio commissionato da Giuseppe Zamberletti, 1978.
Vittorio Vettori, Diario
apocrifo di Aldo Moro prigioniero, 1982.
Antonio Volpi, La macchina
rossa, 2008.
IL CASO MORO.
In questo capitolo, tra le
altre cose, vi sono inserite le lettere inviate da Aldo Moro per sostenere la
sua liberazione. Si deve notare l’estrema differenza in termini di dignità
rispetto alla morte tenute dallo statista con l’atteggiamento tenuto da Fabrizio
Quattrocchi, un semplice cittadino. E quanto l’ideologia modifichi la percezione
della realtà rispetto ai comportamenti umani.
Bufera dopo il post del
portavoce di Gabellone, la Sinistra chiede la rimozione.
La polemica, nata sul web prosegue a colpi di comunicati stampa. Dopo il post
delle scorse ore del portavoce del presidente della provincia di Lecce Antonio
Gabellone ne chiedono la rimozione dall'incarico il gruppo “Salento bene
comune”, Abaterusso e Carlo Salvemini. Gabellone non risponde, per
l'interessato: mera strumentalizzazione, scrive “TeleRama il
18 novembre 2015.
Continua a far discutere il post su Facebook scritto dal portavoce del
presidente della Provincia Cosimo Carulli sulla morte di Valeria Solesin, negli
attacchi terroristici a Parigi. “Non
portava la kefiah, non agitava bandiere della pace, dunque sarà dimenticata in
fretta.
– si
legge – Solo una ragazza normale e studiosa,
figuriamoci se la feccia della nostra società le riconoscerà qualche onore. Sta
circolando tra le agenzie di stampa la notizia sulla morte di una nostra
connazionale. Valeria, studentessa modello alla Sorbona di Parigi per mano di
bastardi senza scrupoli; ma certamente non farà nessun effetto ai nostri tanti
connazionali caproni comunisti vestiti del loro finto egualitarismo con il
portafoglio pieno e del loro dialogo del niente con gente come loro, puzzolente
e stragista, brigatista e violenta quanto loro. Scenderanno in campo per le
varie Vanessa e Greta, le cooperanti in gita di piacere in Siria (piacere in
tutti i sensi….), per la Sgrena a cui bastò un rapimento per un seggio in
Parlamento e non per i Quattrocchi morti per l’Italia. Insomma, restano quelli
che sono: il tumore maligno dell’Italia”.
L'ideologia contro
Quattrocchi: "I killer non erano terroristi". La Corte d'Assise riconsidera le
motivazioni dell'esecuzione del contractor in Irak. Come se le uniche vite
preziose fossero quelle della Sgrena o delle due Simone, scrive Gian Micalessin
su “Il Giornale”. Incredibile e raccapricciante. Non vi sono altri aggettivi per
definire le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Roma che manda
assolti due degli assassini di Fabrizio Quattrocchi, la guardia privata rapita
in Irak assieme a Salvatore Stefio, Maurizio Agliana e Umberto Cupertino che il
14 aprile 2004 davanti agli aguzzini pronti a freddarlo con un colpo alla nuca
urlò «Vi faccio vedere come muore un italiano». Quell'atto di coraggio e di
dignità gli valsero una medaglia d'oro al valor civile che il presidente della
Repubblica Azeglio Ciampi così motivò: «Vittima di un brutale atto terroristico
rivolto contro l'Italia, con eccezionale coraggio ed esemplare amor di Patria,
affrontava la barbara esecuzione, tenendo alto il prestigio e l'onore del suo
Paese». Ma gli atti di un Presidente della Repubblica non valgono nulla.
Motivando la sentenza che lascia impuniti Ahmed Hillal Qubeidi e Hamid Hillal
Qubeidi, due responsabili del rapimento catturati durante la liberazione di
Stefio, Agliana e Cupertino, i giudici spiegano che l'identità dei due non è
comprovata, il loro collegamento con gruppi eversivi non è evidente e - dulcis
in fundo - l'esecuzione non è un atto di terrorismo. Insomma i due imputati,
catturati mentre facevano la guardia a Stefio, Agliana e Cupertino, passavano di
lì per caso e non sono stati identificati con precisione neppure durante gli
anni trascorsi nella galera irachena di Abu Ghraib. I nostri giudici
evidentemente la sanno più lunga degli inquirenti americani e iracheni che
interrogarono i due imputati vagliandone generalità e responsabilità. Verrebbe
da chiedersi come, ma porsi domande troppo complesse non serve. Dietro questa
sentenza e le sue motivazioni non c'è il codice penale, ma l'ideologia. La
stessa ideologia formulata dal giudice Clementina Forleo che nel gennaio 2005
assolse dall'accusa di terrorismo il marocchino Mohammed Daki e i tunisini Alì
Toumi e Maher Bouyahia pronti a trasformarsi in kamikaze islamici in Irak. Nella
motivazione del caso Quattrocchi quell'ideologia raggiunge la perfezione. Pur di
mandare liberi due assassini i giudici arrivano a mettere in dubbio che
l'uccisione di un eroe italiano decorato con la medaglia d'oro sia un atto
terroristico. E per convincerci scrivono che «non è chiaro se quell'azione
potesse avere un'efficacia così destabilizzante da poter disarticolare la stessa
struttura essenziale dello stato democratico». Una motivazione sufficiente a far
assolvere anche gli assassini di Moro visto che neppure quell'atto bastò a
disarticolare lo stato italiano. Ma i magistrati superano se stessi quando
tentano di convincerci che il collegamento dei due sospettati con i gruppi
eversivi non è provato. L'assassinio di Quattrocchi viene deciso, come tutti
sanno, per far capire al nostro governo che solo accettando il ritiro dall'Irak
verrà garantita la salvezza degli altri rapiti. Ma evidentemente ricattare
l'Italia uccidendo un suo cittadino e tenendone prigionieri altri tre per 58
giorni non è un atto sufficientemente eversivo. E a far giudicare eversori e
terroristi gli assassini di Quattrocchi non basta neanche l'ammissione di uno
degli aguzzini che racconta all'ostaggio Cupertino di aver partecipato
all'attentato di Nassirya costato la vita a 19 italiani. Quelle per i magistrati
sono semplici vanterie. Ma non stupiamoci troppo. Il problema anche qui non è la
giustizia, bensì l'ideologia. In Italia, persino nelle aule giudiziarie,
qualcuno continua a ritenere che le uniche vite preziose siano quelle di chi la
pensa come lui. Soprattutto se quelli come lui sono «umanitari» di sinistra come
le due Simone o giornaliste «democratiche» come Giuliana Sgrena. Le vite di chi
non la pensa allo stesso modo invece valgono poco o nulla. Per questo uccidere
l'eroe Fabrizio Quattrocchi non è reato.
Ostaggi «buoni» e «cattivi».
Scontro tra destra e sinistra, scrive Paolo Conti su “Il Corriere della Sera”
Possono esistere «buoni» e «cattivi», giudicati a seconda della necessità
polemica da destra e da sinistra, persino tra gli italiani rapiti dai terroristi
iracheni? Ora nelle loro mani, e sul video di Al Jazira, c'è Enzo Baldoni. Ma
proviamo a fare un passo indietro, a tornare ad aprile, quando gli ostaggi si
chiamavano Salvatore Stefio, Maurizio Agliana e Umberto Cupertino, quando
Fabrizio Quattrocchi venne trucidato dalle Falangi di Maometto. Sui giornali
della sinistra campeggiarono per intere settimane le stesse parole chiave:
«mercenari», «vigilantes». Il manifesto parlò di «privatizzazioni da
combattimento», l'Unità di «Mestiere della guerra». Scoppiò una durissima
polemica quando Vauro, il giorno dopo l'assassinio di Fabrizio Quattrocchi,
nella sua vignetta del giorno sul manifesto mostrò un dollaro penzolante da un
pennone e sotto il titolo «morire per denaro» commentò con la battuta:
«Banconote a mezz'asta». Liberazione insistette sulla tesi della collaborazione
dei quattro italiani con i servizi segreti e irrise Piero Fassino che parlò di
uccisione di un «civile inerme» («Viene da dire: ma di che cosa stanno
parlando?»). Quando il centrodestra definì «eroico» il famoso ultimo momento di
vita di Quattrocchi («ti faccio vedere come muore un italiano») ancora il
manifesto titolò immediatamente «Eroi di scorta». Ora il rito in parte si
ripete, specularmente opposto. La provocazione ieri è venuta da Libero: grande
foto del pacifista Baldoni sotto il titolo «Vacanze intelligenti» e giù, nel
sommario: «Aveva detto: "cerco ferie col brivido". E' stato accontentato». In
perfetta linea con la titolazione il commento di Renato Farina. Si chiede come
mai sia così rilassato nel video di Al Jazira: «Perché dovrebbero fargli del
male? E' un giocherellone della rivoluzione... Dopo le ferie intelligenti,
cominciamo a fare quelle sconvolgenti». Poi, più in là: «Signori di Al Qaeda,
proprio dal vostro punto di vista, non vale la pena di ammazzarlo.
Restituitecelo, farà in futuro altri danni all'Occidente come testimonial della
crudeltà capitalistica». Quanto a Il giornale, è stato l'unico quotidiano a
relegare la notizia in centro pagina, ben al di sotto di due inchieste. Commenta
Franco Debenedetti, senatore ds: «Credo sia giusto cercare una logica nelle
azioni di qualcuno, comprendere il senso delle scelte per esempio nel caso di un
rapimento perché tutto questo può contribuire alla liberazione di un ostaggio.
Ma i commenti così diversi propongono davvero una gran bella gara...» Qual è il
suo giudizio su questo contrasto? «Ricordo che ai tempi dei tre rapiti, questo
insistere sul loro ruolo di "mercenari" suggeriva quasi l'idea che si fossero
andati a cercare una simile sorte. Un modo per esorcizzare il problema, di
allontanarlo, come se il lavoro di vigilante non fosse onorevole come tanti
altri, e anzi spesso indispensabile nella complessa ricostruzione dell'Iraq. E
magari fosse meno nobile di un'occupazione intellettuale come quella del
reporter». E quanto invece alla reazione di Libero? «Sinceramente mi sembra solo
e soltanto agghiacciante. Comunque sia, insisto, mi pare davvero una bella
gara...». Concorda Marcello Veneziani, intellettuale apprezzato dalla destra:
«La figura di Quattrocchi combaciava con una mentalità che aveva caro il senso
dell'onore e l'amor patrio. Invece Baldoni coltiva, lo abbiamo letto, valori
dichiaratamente pacifisti. Motivazioni diverse, lontane, che hanno spinto le
"tifoserie" a schierarsi da una parte e dall'altra, visto che in questa faccenda
sembra contare ancora una labile appartenenza ideologica». E allora, Veneziani?
«Allora sono state eccessive entrambe le reazioni. Voglio dire che sulla
motivazione che spinge qualcuno a una scelta ci possono essere divisioni,
diversità di vedute. Ma sulla vicenda in sé no: sono di rigore in ogni caso
attenzione, rispetto, solidarietà...».
Aldo Moro contro il
fascismo nel ’43: ha ucciso la patria, la ricostruiremo.
Pubblicato lunedì, 06 maggio 2019 da Aldo Moro su Corriere.it. L’intervento qui
pubblicato risale all’autunno del 1943. Aldo Moro lo pronunciò a Radio Bari,
allora unica voce dell’Italia libera, quando aveva 27 anni. «Abbiamo ritrovato
nove discorsi inediti, che si trovano presso il centro di documentazione creato
da Sergio Flamigni a Oriolo Romano, dove sono conservate le carte personali di
Moro, mentre quelle politiche, che erano nel suo studio, sono depositate
all’Archivio centrale dello Stato», dichiara al «Corriere» Renato Moro, storico
dell’Università Roma Tre, nipote dello statista e presidente del comitato
scientifico incaricato di curare l’Edizione nazionale delle sue opere. Il
professore inquadra storicamente i testi: «Aldo Moro, all’epoca libero docente,
venne colto dall’8 settembre mentre stava partendo per prendere servizio a Roma
come ufficiale dell’aeronautica. Invece rimase a Bari e fu aggregato all’ufficio
stampa del governo del Regno del Sud. Già attivo nella vita pubblica, ex
presidente degli universitari cattolici della Fuci, prese a scrivere e
pronunciare discorsi radiofonici». (Antonio Carioti) Radio Fascio ha impostato
di recente il problema dei traditori. L’elenco dei miserabili che hanno
partecipato al tradimento — così sconsolatamente confessa — è lungo,
lunghissimo. Purtroppo vi sono — continua — traditori di grosso calibro, i quali
costituiscono un gruppo non eccessivamente numeroso e accanto ad essi una fila
interminabile di personaggi minori. Aldo Moro (Maglie, Lecce, 1916) in una foto
del 1941Coloro che non credono più, e si rifiutano in conseguenza di obbedire e
di combattere, son dunque ormai tra gli italiani, per riconoscimento esplicito
della pattuglia di punta del rinascente partito, schiera e lunghissima schiera.
Fino a ieri, si può dire, non si sentiva altro che di fedeltà incondizionata e
di adesioni definitive, sicché lo sparuto drappello dei dissenzienti sembrava
davvero fosse nascosto abilmente nei famosi e certo angusti angolini. Oggi si
riconosce che le cose stavano ben diversamente e che i dissensi — chiamateli
tradimenti, se volete — erano seri e vasti, anzi veramente totalitari. Per
provenire le due valutazioni radicalmente diverse dalla stessa fonte, bisogna
riconoscere che vi fu errore e, noi penseremmo, errore in mala fede
nell’apprezzamento ottimistico che fu fatto allora dell’opinione del popolo
italiano. Vero è che non vi fu mai un’Italia fascista e filo tedesca, come gli
avvenimenti del 25 luglio e successivi hanno dimostrato. Vero è che oggi non
esiste un’Italia fascista e filo-tedesca, la quale si riduce ad una carta
cattiva giocata nel pessimo gioco del dittatore nazista. Il fascismo non ha,
come non ebbe mai, per sé né i vecchi né i giovani né i giovanissimi; ma se mai
sparute minoranze disinteressate. Bisogna onestamente riconoscere che la crisi,
per dirla con frase mussoliniana, non è nel sistema ma del sistema che il
fascismo fu nella storia d’Italia. Tutte le convulsioni che la sparuta schiera
di questi tristi reintegratori del passato determini, per favorire la Germania,
è veramente tradimento perpetrato ai danni dell’Italia. Ed è triste constatare
la cieca pervicacia con la quale si dà opera a continuare una politica rovinosa
ed a preparare la più inumana di tutte le guerre civili, quella cioè che
contrappone l’uno all’altro i cittadini di una stessa Patria, i quali non
divide, più forte della solidarietà nazionale, un diverso ideale, ma soltanto la
prepotenza di un oppressore straniero cui tiene bordone un oppressore
domestico. Tutto ciò è molto triste certamente. E noi non possiamo pensare senza
disperazione al sangue italiano che sarà forse versato ancora vanamente, contro
la verità, contro la libertà, contro la vita. Ma vogliamo superare
l’indignazione e il dolore che ci prendono, per dire ancora una parola serena ai
fascisti d’Italia, se ancora ve ne sono. Noi non vogliamo porre ora in
discussione la loro buona fede, ma domandiamo soltanto che facciano uno sforzo
per capire che al disopra di una particolare intuizione della Patria c’è la
Patria stessa nella sua verità, nella sua storia, nel suo avvenire, quale
risulta dal pensiero e dall’amore di tutti i suoi figli; per capire che la
Patria è patrimonio di tutti e che è delittuoso piegarla alla propria
particolare visione. Proprio perché la Patria è cosa di tutti, al fascismo fu
dato di porsi tra le forze politiche del Paese, per far valere il suo programma
accanto agli altri. La storia si fa di questi scontri e incontri,
incessantemente. La Patria è certo il nostro io, ma non il piccolo io angusto,
che si chiude ad ogni considerazione, ad ogni rispetto, ad ogni amore degli
altri, ma l’io che si fa, energico e pieghevole, memore di sé ed attento alla
vita di tutti, incontro agli altri, e afferma e nega, cede e s’impunta, sicché
nel vasto gioco delle azioni di tutti sorga, in libertà e come frutto di
libertà, il volto storico della Patria. La tirannia comincia là dove il piccolo
io, rotto ogni vincolo di fraternità e di rispetto, dimentico di quella sublime
umiltà che fa l’individuo uomo, la sua particolare visione eleva ad universale,
senza il vaglio di una critica che consacri questo passaggio; il proprio
particolare amore proponga orgogliosamente come l’amore di tutti. Allora la
Patria è morta; quella sua grandezza augusta, che è nell’accogliere ogni voce,
ogni palpito, ogni gioia, ogni sofferenza dei suoi figli, è spenta, terribile
furto ai danni del proprio fratello è questo. Di più, impadronirsi della Patria
di tutti, farne una piccola povera cosa di noi, è fatalmente condannarsi a
perderla a nostra volta. Non si può negare ed affermare insieme. Non si può dire
Patria, senza dire «tutti». Dove gli altri siano stati dimenticati, dove si sia,
fingendone l’adesione o comprimendone la reazione, fatto a meno di loro, la
Patria è veramente finita. Di questa fine, triste come l’oscurarsi dei valori
che danno alla vita bellezza e dignità, potrebbero gli altri, i dimenticati e
oppressi, chiedere conto ai dimentichi ed agli oppressori. Ma qui non si tratta
di questo. Si tratta della Patria che ritorna, valore il quale, benché
compresso, non può morire. Si tratta dell’Italia, la quale chiede di non essere
ancora negata nella sua anima universale, di essere tutti, di accogliere in sé
anche i figli che hanno sbagliato, anche quelli che hanno fatto intenzionalmente
il male. L’Italia ha troppo sofferto di questa divisione fatale, per la quale
non bastava essere italiani per essere italiani, perché non sia pronta a
dimenticare; ha troppo perduto di energie, di vivezza, di sapere, di moralità,
di bontà, perché respinga ora qualsivoglia energia data con lealtà per l’opera
di ricostruzione. Ma non può essa permettere che coloro i quali proposero
l’esclusivismo angusto tornino a chiamarsi italiani, senza aver riconosciuto il
loro errore e la loro colpa, senza un’anima nuova, senza aver ritrovato il
rispetto per tutti. Tanto meno può permettere che il solco fatale che ha diviso
e divide ancora la storia d’Italia sia tolto, senza che essa sia assicurata per
l’avvenire da un ritorno in forza di ideologie e prassi politiche, le quali,
abusando della libertà, operino contro la libertà. Essa chiede che le voci di
tutti gli italiani tornino a farsi sentire compostamente, che nessuna sia fatta
tacere e nessuna pretenda di levarsi con prepotenza al disopra delle altre.
Perché soltanto in questo equilibrio, in questo rispetto, in questa reale
libertà si forma quella volontà solidale dei singoli riuniti in unità di popolo
che fa la storia. Contro i vecchi e nuovi tentativi di dittatura, quelli scaltri
e quelli candidi, contro tutte le esagerazioni e le unilateralità, l’Italia
chiede l’umiltà di tutti, la coscienza della propria particolarità, il bisogno e
l’attesa della integrazione, un grande rispetto per le cose che sono più grandi
di noi. E ciò l’Italia attende e domanda non con debole voce come per cosa che
si possa dare o negare a proprio piacimento, ma con voce imperiosa, seppure
amorevole. È un dovere di patriottismo, è una esigenza squisitamente umana che
ciascuno prenda con disciplina, la quale non esclude l’iniziativa e la
responsabilità, il proprio posto di lavoro e dia opera in esso, dimenticando per
un momento il triste passato, a costruire un avvenire più degno.
Istituita dal ministero dei
Beni culturali nel 2016, l’Edizione nazionale delle opere di Aldo Moro è diretta
da un comitato scientifico presieduto da Renato Moro, di cui fanno parte molti
illustri studiosi: tra gli altri Giuliano Amato, Piero Craveri, Ugo De Siervo,
Guido Formigoni, Francesco Malgeri, Alberto Melloni, Leopoldo Nuti, Paolo
Pombeni, Francesco Traniello, Giuseppe Vacca. Il progetto presenta
caratteristiche molto innovative, poiché gli scritti dello statista pugliese
saranno posti interamente su piattaforma digitale, quindi risulteranno
liberamente leggibili e scaricabili. Grazie alla collaborazione con la casa
editrice il Mulino, l’edizione sarà interrogabile in modo selettivo per
effettuare ricerche. E verrà utilizzato anche un software originale di analisi
del discorso, sperimentato dall’Istituto storico italo-germanico di Trento e dal
gruppo Digital Humanities della Fondazione Bruno Kessler (sempre di Trento):
attraverso questo dispositivo saranno possibili ricerche testuali
particolarmente sofisticate. L’Edizione nazionale sarà divisa in due sezioni:
una con gli scritti e discorsi di carattere politico, religioso e giornalistico
(quattro volumi, tre dei quali divisi in due tomi, per un totale di sette),
l’altra con le opere di argomento giuridico (quattro volumi). In settembre
uscirà il primo volume degli scritti e discorsi, a cura di Tomino Crociata e
Paolo Trionfini, che copre il periodo 1932-1946, fino all’elezione di Moro alla
Costituente.
·
Aldo Moro e la Tangentopoli ante litteram.
Mani pulite, 1993: Craxi
contro la fine della politica.
Redazione de Il Riformista il
13 Dicembre 2019. 29 aprile 1993. L’inchiesta “Mani Pulite”, quella di Di
Pietro, è iniziata circa un anno prima. Sta travolgendo tutti i partiti, in
particolare il Psi. Bettino Craxi, che fino a un mese prima era stato il
segretario del partito, si alza alla Camera e pronuncia un discorso che
diventerà celeberrimo a difesa dell’autonomia della politica e di denuncia della
corruzione del sistema. Dice che il finanziamento dei partiti, tutti lo sanno, è
in gran parte illecito, e aggiunge: «Non credo che ci sia nessuno in quest’aula,
responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e
pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo: presto o tardi i
fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro». Nessuno si alza.
Caso Lockheed, 1977: Moro a
difesa di Gui. Redazione de Il Riformista il 13 Dicembre 2019. 9 marzo del 1977,
il caso Lokheed (una storia di tangenti sull’acquisto di aeroplani americani)
arriva alla Camera. Si tratta di decidere se processare due ex ministri: Luigi
Gui, dc, e Mario Tanassi, Psdi. Aldo Moro, giusto un anno prima del suo
rapimento, interviene con un discorso formidabile, di impronta davvero
garantista, a difesa di Gui, soprattutto, ma anche di Tanassi. Rivendica
l’autonomia e l’unicità della politica e il valore dell’impegno politico e dei
partiti. Grida: «Non ci faremo processare nelle piazze». Però va in minoranza. I
più duri contro di lui sono i comunisti e i radicali. Tanassi e Gui sono
rinviati a giudizio davanti alla Corte Costituzionale. Che assolverà Gui e
condannerà a 2 anni e 4 mesi di carcere Tanassi.
Caso Lockheed, 1978: Leone
si dimette.
Redazione de Il Riformista il 13 Dicembre 2019. 15 giugno del 1978. Aldo
Moro è stato ucciso poco più di un mese prima. Al governo c’è Andreotti,
sostenuto dai comunisti. La sera, alle 20, compare in Tv il presidente della
Repubblica Giovanni Leone, napoletano, 70 anni, e annuncia le sue dimissioni. Il
motivo? Una feroce campagna di stampa contro di lui, alimentata dai servizi
segreti, con vari dossier, e da alcuni partiti politici di opposizione. Leone
non ha nessuna colpa. Il suo coinvolgimento nel caso Lockhe è da escludere.
L’Espresso lo massacra. Lui non ne può più, lascia. Perché lascia? Leone è uno
degli ultimi statisti, uno di quelli che hanno fatto grande l’Italia. Sa
sacrificarsi e si sacrifica.
Così Moro avvertì i
giudici: «Noi Dc non ci lasceremo processare nelle piazze!».
Lo scontro tra politica e
magistratura iniziò ufficialmente nel marzo del ’77 con l’affare Lockheed,
scrive Paolo Delgado il 31 gennaio 2019 su Il Dubbio". C’era una volta, in
un’Italia lontana lontana, tanto lontana da somigliare a una fiaba o a una
leggenda, un primato della politica sulla magistratura tanto assoluto e
incontrastato da autorizzare seri e fondati dubbi sull’effettiva divisione dei
poteri sancita dalla Costituzione. La politica era di fatto intoccabile. Il
potere togato si arrestava di fronte alla soglia del Palazzo. Non è che di
scandali non ce ne fossero. Ma le richieste di autorizzazione a procedere
sbattevano regolarmente contro il voto contrario del Parlamento. Nella
legislatura 1963- 68, ad esempio, su 75 richieste di autorizzazione a procedere
ne furono accolte 5. Nella successiva, 1968- 72, le richieste furono 69 e le
autorizzazioni 4. Il boom di richieste da parte della magistratura fu tuttavia
nella legislatura successiva, 1972- 76, indice chiaro di un rapporto di
subalternità della magistratura che i togati iniziavano a sopportare sempre
meno. Le richieste furono ben 159, di cui solo 40 accolte. Se si dovessero
indicare un anno e una vicenda precisa per datare l’inizio, ancora molto in
sordina, di un braccio di ferro che prosegue a tutt’oggi bisognerebbe risalire
al 1965 e alla vicenda che coinvolse il senatore democristiano ed ex ministro
delle Finanze Giuseppe Trabucchi. Era accusato di aver permesso a una società
guidata da un altro notabile democristiano ed ex sottosegretario, Carmine De
Martino, di acquistare illegalmente partite di tabacco messicano per poi
rivenderle in patria con un guadagno netto di un miliardo e 200 milioni di lire
dell’epoca, cifra di tutto rispetto e anche qualcosina in più. Il tutto,
ovviamente, in cambio di generosa tangente. Trabucchi ammise ma si difese
impugnando l’interesse di partito: «Era solo un finanziamento illecito per la Dc».
La commissione, nel giugno 1965, respinse la richiesta. Il mese dopo le camere
riunite furono chiamate a votare per una decisione definitiva. Servivano 476
voti per accogliere la richiesta della Procura di Roma. Ne arrivarono 461.
Trabucchi se la cavò alla grande. Prima che si ripetesse un braccio di ferro di
dimensioni anche maggiori passarono quasi 10 anni. Nel febbraio 1974 i segretari
amministrativi di tutti e quattro i partiti di governo, Dc, Psi, Psdi e Pri,
furono indagati con l’accusa di aver incassato tangenti dall’Enel in cambio di
scelte politiche contro le centrali nucleari. Lo scandalo fu enorme e coinvolse
numerosi ex ministri. Il governo Rumor in carica si dimise. Per rientrare in
maggioranza il leader repubblicano Ugo La Malfa impose una legge che
regolamentasse il finanziamento dei partiti. Varata a spron battuto, in soli 16
giorni e con l’approvazione di tutto il parlamento a eccezione del Pli, sulla
base di una proposta firmata da uno dei principali leader Dc, Flaminio Piccoli.
La legge non servì a fermare il finanziamento illecito ma derubricò i reati per
i quali erano indagati segretari a amministrativi e tesorieri. Restava lo
spinoso caso degli ex ministri e i nomi in ballo erano davvero pesanti. La
commissione parlamentare incaricata di vagliare i casi affrancò subito i dc
Andreotti e Ferrari Aggradi perché i reati erano prescritti. Decise
l’archiviazione per il dc Bosco e il Psdi Preti, ma ordinò di aprire
un’inchiesta a carico di altri due ex ministri, Ferri del Psdi e Valsecchi, Dc.
L’inchiesta si concluse cinque anni dopo con il proscioglimento. Il grande
scandalo degli anni ‘ 70 fu tuttavia il cosiddetto "affare Lochkeed". Una
tangentona di 61 milioni di vecchie lire, pagata secondo gli inquirenti dalla
società americana per favorire l’acquisto da parte del governo italiano di 14
aerei Hercules 130. Erano coinvolti due ex ministri della Difesa, Luigi Gui, Dc,
e Mario Tanassi, Psdi, e un ex premier, Mariano Rumor, Dc. Nel marzo 1977 il
Parlamento votò, in seduta comune, la messa in stato d’accusa dei primi due
mentre salvò Rumor. In quell’occasione Aldo Moro pronunciò un discorso destinato
a essere ricordato ancora oggi: «La Dc fa quadrato intorno ai propri uomini. Non
ci lasceremo processare nelle piazze». In effeti il processo si svolse, secondo
le regole di allora per i ministri, direttamente di fronte alla Corte
costituzionale, con unico grado di giudizio. Nel 1979 Gui fu assolto, Tanassi
condannato. Nel 1989 una riforma costituzionale modificò i criteri dei processi
contro ministri ed ex ministri, affidandoli alla magistratura ordinaria e con
procedura altrettanto ordinaria. Mai accusato, mai processato, mai condannato, a
pagare più di tutti fu il presidente della Repubblica Giovanni Leone. Indicato
da una forsennata campagna giustizialista come coinvolto nello scandalo fu
costretto alle dimissioni. La sua innocenza fu acclarata solo anni dopo. Quando
si rovesciano i rapporti di forza che almeno in apparenza restano identici per
tutti gli anni ‘ 80? In apparenza il punto di rottura è Tangentopoli, quando le
inchieste di mani pulite spazzarono letteralmente via un intero ceto politi- co
e spianarono la prima Repubblica. In realtà i rapporti di forza avevano iniziato
a subìre una modifica profonda già da prima. La magistratura si affranca dalla
soggezione alla politica non con Tangentopoli ma con la lotta al terrorismo.
All’epoca, tra la fine degli anni ‘ 70 e i primi anni ‘ 80, era abbastanza
comunque sentir dibattere di ‘ delega alla magistratura’ del contrasto al
terrorismo. Quella delega fu in realtà totale e appena tra le righe lo si
percepisce nella memoria di due tra i magistrati che di quella fase furono
protagonisti assoluti, Gian Carlo Caselli e Armando Spataro: «Nel 1978, però, in
particolare nel periodo post- Moro, la situazione registrò un’evoluzione
positiva grazie all’iniziativa autonoma di Pubblici Ministeri e Giudici
Istruttori, che diedero vita ad un coordinamento spontaneo tra gli uffici
giudiziari ed alla creazione di gruppi specializzati nel settore del terrorismo.
Il sistema di legge non prevedeva allora alcuna norma in tema di coordinamento:
anzi conosceva barriere formali che ostacolavano lo scambio di notizie.
Ciononostante, a partire dalla metà del 1978, quei magistrati, superando ogni
logica formalistica ed ogni possibile diversità di estrazione culturale,
cominciarono ad incontrarsi spontaneamente, con periodicità molto ravvicinata ed
in modo riservato». Nella stessa fase la magistratura irruppe di fatto anche
nella sfera di competenza del potere legislativo: alcune delle principali leggi
anti- terrorismo, incluse quelle squisitamente politiche come la legge sulla
dissociazione furono dettate norma per norma dalla magistratura.
Tangentopoli intervenne su
equilibri già radicalmente alterati. Il risultato del referendum del 1987 sulla
responsabilità civile dei magistrati è non a caso l’unico nella storia italiana
a essere stato completamente disatteso, a conferma del peso enorme che il potere
togato aveva acquisito nel decennio precedente, a fronte di un progressivo ma
inesorabile indebolirsi del potere politico colpito da una crisi di
legittimazione all’epoca senza precedenti. Tangentopoli chiuse il conto e siglò
l’affermazione di un equilibrio opposto a quello che aveva segnato la prima
Repubblica, con un primato assoluto del potere togato. La seconda Repubblica è
stata segnata dall’inizio alla fine dal confronto e a volte dal conflitto aperto
tra un potere tanto più saldo perché legittimato dal sostegno dell’opinione
pubblica, quello della magistratura, e un potere debole e sempre sotto scacco,
infragilito dalla scarsa legittimazione popolare, quello della politica
derubricata ormai a casta. Quando, nel 1994, il primo governo Berlusconi tentò
di frenare le procure con quello che è passato alla storia come "decreto salva-
ladri", i quattro giudici del pool milanese Mani pulite si limitarono a
presentarsi in tv spogliandosi per protesta delle toghe e bastò per suscitare
una tale ondata di proteste da costringere il governo a una sgangherata
retromarcia. Pochi anni dopo, nel 1998, il solo tentativo serio e approfondito
di riformare la Costituzione, la bicamerale presieduta da Massimo D’Alema, fu
condannato al fallimento, come ha più volte confessato il relatore Cesare Salvi
allora dirigente dei Ds, dall’opposizione del potere togato a qualsiasi
revisione delle norme sulla magistratura. Quella delle "toghe rosse" è una
leggenda che, diffusa dalla destra, ha avuto ampio corso negli anni della
Seconda Repubblica ma che è in realtà destituita di fondamento. Se a confliggere
con la magistratura è stato in quei decenni quasi esclusivamente il centrodestra
è perché la controparte ha sempre evitato di contraddire, se non
superficialmente e di sfuggita, le toghe. Ma la stessa destra, nonostante i
fragorosi pronunciamenti del leader Berlusconi, ha sempre evitato di sfidare la
magistratura se non quando non era possibile evitarlo, cioè quando ci andavano
di mezzo la sua sorte o quella delle sue aziende. Il Movimento 5 Stelle nasce
dalla stessa temperie culturale, sociale e politica che ha accompagnato e in
buona misura determinato il prevalere della magistratura sulla politica: una
crisi di legittimazione popolare della politica accompagnata nella delega
assegnata dal basso alle toghe come unico freno alla corruzione dei politici.
Per il Movimento fondato da Grillo la magistratura è sempre stata la bussola. In
teoria il successo elettorale dei pentastellati avrebbe dovuto quindi siglare il
trionfo finale del potere in toga nel lunghissimo duello con il potere che siede
in Parlamento. La pratica si sta rivelando subito e si rivelerà diversa. Per sua
stessa natura il "governo del cambiamento" deve almeno provare ad affermarsi
come governo forte, sovvertendo così quel rapporto tra un potere politico debole
e un potere della magistratura forte che data ormai dalla fine degli anni ‘ 80
del secolo scorso. L’incidente sull’autorizzazione a procedere contro il
ministro Salvini è solo il primo di una lista che sarà probabilmente lunga.
Vi ricordate quel cavallo
di razza?
Scrive Piero Sansonetti il 5 settembre 2016 su "Il Dubbio". In una sola figura
riuniva le qualità degli altri grandi statisti del dopo-fascismo da De Gasperi a
Togliatti, da Nenni a Berlinguer, da Craxi a Fanfani. In questo mese di
settembre si compiono i cent'anni dalla nascita di uno dei più grandi statisti
italiani del novecento. Aldo Moro era nato a Maglie, cittadina vicino a Lecce,
il 23 settembre del 1916. Sapete tutti come e quando è morto: nel portabagagli
di una piccola Renault rossa, il 9 maggio del 1978, abbattuto a colpi di
mitraglietta dai capi delle Brigate Rosse - la più importante e potente
organizzazione terroristica italiana, che fu attiva, più o meno, tra il 1972 e
il 1986 - i quali lo avevano rapito 55 giorni prima durante una spettacolare e
sanguinosissima azione in via Fani, a Roma, nella zona di Monte Mario. Aldo
Moro, rispetto agli altri grandi statisti del dopo-fascismo (De Gasperi,
Togliatti, Nenni, Berlinguer, Craxi, Fanfani) ha qualche cosa di più: la
"completezza". Fu uno straordinario uomo di azione e di governo, un grandissimo
dirigente di partito, e soprattutto fu un pensatore, e cioè appartenne a quella
"razza" di leader politici che oggi - non solo in Italia, probabilmente - sembra
del tutto scomparsa. Moro fu l'unico che possedeva tutte quelle doti insieme.
L'Italia gli deve moltissimo. Più che agli altri: Moro seppe tenere insieme
tutte le anime della politica italiana (cosa che non era riuscita a Togliatti e
a De Gasperi); Moro seppe garantire laicità al paese, seppure in un periodo
dominato dalla potenza, anche morale, del Vaticano; Moro fu un baluardo per la
difesa (e lo sviluppo) dello stato di diritto; Moro fu un riformatore
eccezionale, e si deve a lui, ai suoi governi, alla sua iniziativa politica,
alla sua intuizione, alla sua capacità di orientare il proprio partito - e
persino la Chiesa - l'enorme mole di riforme sociali che nel quindicennio che va
dal 1963 al 1978 cambiarono completamente il volto dell'Italia, i rapporti tra
le classi, aumentarono il potere dei lavoratori riducendo la potenza della
finanza e del capitale, diedero un impulso straordinario alla conquista di nuovi
diritti individuali e collettivi, e imposero un fortissimo sviluppo al welfare,
riducendo le diseguaglianze sociali. Gli anni successivi alla morte di Moro -
certo, anche per una congiuntura internazionale - sono quelli che segnano una
costante, lenta, e inesorabile marcia indietro sulla strada dei diritti, del
diritto, del pluralismo e dell'equità sociale. In questo mese di settembre, Il
Dubbio dedicherà ogni giorno uno spazio al ricordo di Aldo Moro. Lo faremo
ospitando interventi, analisi, ricordi, opinioni, ma soprattutto lo faremo
ripubblicando una selezione delle lettere che Moro scrisse dalla prigione delle
Brigate Rosse, e che furono ignorate dal "Palazzo" della politica e dei
giornali, con un atteggiamento fortissimamente ingiusto e di clamorosa sordità
politica e intellettuale: quelle lettere esprimevano forse il punto più alto del
pensiero e dell'umanità di Aldo Moro che poi, a guardar bene, era esattamente il
punto più alto del pensiero e dell'umanità - e del sentire comune - di tutto il
vastissimo mondo politico italiano - fatto di partiti, di sindacati, di
associazioni popolari, di consigli di fabbrica, di movimenti studenteschi e
giovanili, di organizzazioni religiose - che era la spina dorsale del paese, e
che dopo la scomparsa di Moro si disperse. Moro ha una biografia molto ricca.
Giovanissimo fu uno studioso appassionato del diritto e un dirigente di primo
piano della gioventù universitaria cattolica (la Fuci) che era una delle poche
associazioni non vietate dal fascismo, ma sicuramente in posizione di dissenso
forte verso il regime. Moro era un figlioccio del segretario di Stato Vaticano e
futuro papa Giovan Battista Montini. E da quell'esperienza iniziò la sua
travolgente carriera politica. Che lo portò, a trent'anni, a far parte della
Costituente e della commissione ristretta che scrisse la Costituzione, poi a
ricoprire molte volte la carica di ministro (della scuola, della giustizia,
degli esteri...) e infine ad assumere la carica di primo ministro nei primi
governi organici di centrosinistra (dal 1963 al 1968), cioè dei primi governi
riformisti dell'Italia repubblicana. Fu anche segretario della Dc, fu di nuovo
premier a metà degli anni '70, e poi fu presidente del partito (col suo amico
Zaccagnini segretario) quando maturò la scelta della "solidarietà nazionale" e
della formazione di quel governo basato sulla alleanza tra Dc e Pci che in un
anno e mezzo (subito dopo la morte di Moro) varò riforme clamorose, come la
riforma sanitaria, quella psichiatrica, i patti agrari, l'aborto, l'equo canone.
È Moro che convinse il suo partito, che recalcitrava, a scegliere la via
dell'alleanza con il Pci e delle riforme. Lo fece col discorso di Benevento,
nell'inverno del 1978, e cioè come uno degli ultimi prima del rapimento, che
avvenne proprio nel giorno nel quale il governo di solidarietà nazionale si
insediava. L'anno prima aveva pronunciato alla Camera un intervento memorabile,
in difesa del ministro Gui, che era accusato di aver preso tangenti nell'affare
Lockheed (acquisto di aerei per l'esercito italiano da una azienda
statunitense). Quel discorso andrebbe riletto alla Camera e al Senato ogni volta
che si discute e si vota sull'autorizzazione all'arresto di un parlamentare.
Perché conteneva, in forma molto alta, tutte le argomentazioni del moderno
garantismo, metteva in guardia la politica dall'inseguire le pulsioni
dell'opinione pubblica (che invece va rispettata, informata e orientata) e
descriveva con grande lucidità la necessità che la politica rivendicasse il
proprio ruolo e anche la propria discrezionalità e la delicatezza dei propri
compiti, senza abdicare ad altri poteri e senza sacrificare il diritto ai
calcoli della tattica o dell'interesse. Moro - in un clima di grandissima
tensione - concluse così il suo discorso: " Per tutte queste ragioni, onorevoli
colleghi che ci avete preannunciato il processo sulle piazze, vi diciamo che noi
non ci faremo processare! ". Era la sera del 9 marzo 1977. Un anno e una
settimana più tardi Moro fu rapito e processato dalle Br. Si difese, accusò,
spiegò, continuò ad essere un leader politico e un pensatore fino a un minuto
prima che la mitraglia lo uccidesse, a 61 anni, nel pieno della sua vigorìa
intellettuale. A noi sembra che la grandiosità di Moro stia nelle lettere dalla
prigione delle Br. E per ricordare la sua figura, da oggi, iniziamo un lavoro
editoriale che durerà un mese intero e che parte proprio da quella maledetta
giornata, il 16 marzo del 1978, che forse è stata la giornata più tragica della
Repubblica, e anche quella che ha pesato più di ogni altra sul suo destino.
Due o tre cose che so di
Moro... Il ricordo di un cronista,
scrive Francesco Damato il 14 set 2016 su "Il Dubbio". Nel novembre 1977,
rivolto al Pci disse: «Quello che voi siete, noi abbiamo contribuito a farvi
essere e quello che noi siamo, voi avete contribuito a farci essere». Non
ricordo bene se fu nel 1966 o nel 1967. Ma quando il vice capo ufficio stampa
Gastone Favero mi accompagnò nell'ufficio di Aldo Moro, a Palazzo Chigi, per
farci scambiare gli auguri di Natale e Capodanno, mi feci dell'allora presidente
del Consiglio, per quanto fosse stato il primo a formare un governo "organico"
di centro sinistra, con la partecipazione diretta dei socialisti, l'idea di un
uomo non moderato ma moderatissimo. Un uomo che non avrei mai potuto immaginare
fosse destinato a diventare in pochissimi anni, esattamente nel 1968, l'uomo
della Dc più a sinistra. Più ancora delle stesse correnti di sinistra dello
scudo crociato. Che erano due: una chiamata "Base", capeggiata al Nord da
Giovanni Marcora, "Albertino" per gli amici, al centro da Giovanni Galloni e al
sud da Ciriaco De Mita, e l'altra chiamata "Forze Nuove", guidata con polso
fermissimo dall'ex sindacalista Carlo Donat-Cattin. Una era la sinistra
politica, che si distingueva per le alleanze che perseguiva all'esterno della
Dc. L'altra era la sinistra sociale, che si caratterizzava per le leggi che
perseguiva. Delle due, quella che sarebbe andata più d'accordo con Moro sarebbe
stata la seconda, "Forze Nuove", a tal punto che il suo leader, tentato dopo il
1968, l'anno della contestazione giovanile, di uscire dalla Dc, ne fu trattenuto
solo da Moro. Quando fu rovesciato dalla guida del governo, dopo le elezioni
politiche del 1968, gli amici di corrente di Moro usarono come argomento contro
di lui non più la presunta arrendevolezza ai socialisti ma il rifiuto di
costoro, usciti delusi dalle urne due anni dopo l'unificazione con i
socialdemocratici, di continuare a collaborare con lui. «Non fatemi morire con
Moro», disse Pietro Nenni, che gli era stato per quattro anni a Palazzo Chigi
vice presidente del Consiglio. Per recuperare l'alleanza col Psi, Rumor offrì
disinvoltamente tutto ciò che a Moro non era stato permesso di concedere: un
centro-sinistra "più incisivo e coraggioso", non più "delimitato a sinistra",
quindi aperto ai contributi dell'opposizione comunista, un'inchiesta sui servizi
segreti sospettati di avere tentato un colpo di Stato quattro anni prima, la
pensione sociale ai meno abbienti e l'avvio di una legge per lo statuto dei
diritti dei lavoratori. A quel punto, da moderatissimo come lo avevo lasciato
quel giorno nel suo ufficio di presidente del Consiglio, Moro cominciò ad essere
diverso. Con la complicità del capo della scorta, gli feci la posta sulla
spiaggia di Terracina, dove Moro arrivava vestitissimo sotto l'ombrellone ogni
mattina, e cercai di sondarne gli umori in vista del Consiglio Nazionale della
Dc che avrebbe dovuto ratificare in autunno la formazione del primo governo
"balneare" di Giovanni Leone, formato in attesa che i socialisti decidessero di
accettare le offerte di programmi e di posti di Rumor per un successivo
Gabinetto di coalizione. L'uomo, prudentissimo, non si lasciò scappare una
parola. E io, di ritorno a Roma, mi unii agli altri colleghi, che neppure si
erano scomodati ad andare a Terracina, a scrivere pezzi per interpretare il
silenzio di Moro. Pensate che tempi. Meno prudente che con me, il povero Moro fu
purtroppo, dopo qualche settimana, con Francesco Cossiga. Che gli fu mandato da
Paolo Emilio Taviani, leader di una correntina chiamata "dei pontieri", a
sondare l'ex presidente del Consiglio. A Cossiga, che dopo meno di dieci anni -
pensate anche questo - sarebbe stato il ministro dell'Interno nominato dallo
stesso Moro nel suo penultimo governo e chiamato poi a gestirne il tragico
sequestro, l'ex presidente del Consiglio rivelò che sarebbe uscito dalla
corrente dorotea e ne avrebbe messa su una tutta sua. Taviani disinvoltamente
avvertì Rumor della cosa e si offrì a sostituire Moro nella maggioranza di
partito. D'accordo anche con i "basisti" e con Amintore Fanfani, l'altro
"cavallo di razza" della Dc, come diceva Carlo Donat-Cattin, i dorotei misero
Moro nell'angolo, cioè in minoranza. Ma a Moro bastarono due paroline -
"strategia dell'attenzione" verso l'opposizione comunista, sull'onda delle
contestazioni di quel 1968, che fu anche l'anno dell'invasione sovietica della
Cecoslovacchia, da cui il Pci, diversamente dai fatti ungheresi del 1956, ebbe
la forza di dissentire - per spiazzare i suoi avversari e riaprire tutti i
giochi, interni ed esterni alla Dc. Per i dorotei non ci fu più pace. E neppure
per i socialisti, che si sentirono scavalcati. Scambiato per uno di loro, capace
cioè di tutto per conservare un posto o guadagnarne un altro, gli avversari
interni di partito e i giornali fiancheggiatori accusarono Moro di corteggiare i
comunisti per ottenerne l'appoggio, alla fine del 1971, nell'elezione
parlamentare del successore di Giuseppe Saragat al Quirinale. Di un'intesa fra
Dc e Pci si parlava allora come della "Repubblica conciliare", come la chiamò
l'allora direttore del Corriere della Sera Giovanni Spadolini, che poi sarebbe
diventato un grande estimatore di Moro. Ma allora apparve rivoluzionario anche
un voto da lui espresso nella competente commissione della Camera a favore di
una proposta comunista di equiparare ad una promozione, negli esami di Stato, la
parità di voti. «Ma questo - mi disse, sconsolato - è un elementare principio
applicato già nel codice penale». Quando si arrivò al momento delle candidature
al Quirinale la Dc mise in corsa Fanfani, che si era astutamente piazzato in una
postazione privilegiata di partenza come la Presidenza del Senato. Ma Fanfani,
per quanto ostinato a rimanere in gara anche dopo numerose votazioni a vuoto,
dovette alla fine rinunciare. E il segretario ancora fanfaniano della Dc,
Arnaldo Forlani, si presentò ai gruppi parlamentari per sostenere la legittimità
di una candidatura, a quel punto, di Moro, «già segretario del partito, già
presidente del Consiglio e ora ministro degli Esteri per considerarlo ben in
grado di fare il presidente della Repubblica». «Traditore», gli gridò un
fanfaniano all'uscita dalla sala, dove si era però deciso di non votare subito
per il cambio di cavallo. All'indomani mattina i "grandi elettori" della Dc
furono chiamati a scegliere, a scrutinio naturalmente segreto, tra Moro e
Giovanni Leone, proposto quest'ultimo dai dorotei e fanfaniani con
l'assicurazione che avrebbero votato per lui anche socialdemocratici,
repubblicani e liberali. I socialisti avevano invece candidato Pietro Nenni. La
candidatura di Leone, presidente della Camera e defilato nel panorama
correntizio della Dc, nacque in una notte per evitare che i comunisti
risultassero decisivi nell'elezione di Moro. Eppure Giorgio Amendola aveva
raccontato ai giornalisti a Montecitorio: «Tutti sono venuti a chiederci i voti,
a cominciare da Fanfani, fuorchè l'unico al quale li daremmo: Moro». Che infatti
se ne stette sulle sue, chiuso nell'ufficio del funzionario di Montecitorio
Tullio Ancora, del quale dicevamo tutti nella Stampa Parlamentare che a furia di
frequentare Moro ne avesse preso un ciuffo bianco fra i capelli, sulla fronte.
Inutilmente l'amico Carlo Donat-Cattin lo incitava a farsi votare senza essere
il candidato della Dc perché «per fare i figli bisogna fottere». Per farvi
capire che idea avesse invece Moro dei rapporti con il proprio partito, voglio
raccontarvi la mattina in cui doveva svolgersi una nuova votazione nell'aula di
Montecitorio su Leone, la vigilia di Natale. Io andai a prendere a casa, con la
mia macchina, un amico deputato moroteo, Nicola Lettieri. Che, prendendo un
caffè con me, mi raccontò di non avere votato il giorno prima per Leone, non
condividendo la logica con la quale era stato scelto, peraltro prevalendo nei
gruppi parlamentari con meno di cinque voti di scarto su Moro, e non lo avrebbe
votato neppure quel giorno. Come se ci stesse ascoltando da casa sua, peraltro
non molto distante da noi, che eravamo vicino a Ponte Milvio, mentre lui abitava
vicino alla sovrastante Camilluccia, arrivò a Lettieri una telefonata da Moro in
persona, analoga ad altre -poi seppi - fatte ad amici tentati dalla dissidenza.
«Si vota Leone e basta», intimò il ministro degli Esteri. In effetti Leone
quella mattina fu eletto, ma a stento. E i missini si vantarono di essere stati
determinanti con i loro voti favorevoli. Annuncio che fu creduto e deplorato dal
moroteo Benigno Zaccagnini con una dichiarazione contro la quale Leone protestò
con una lettera inviata al giornale ufficiale del partito, Il Popolo. Fu proprio
Moro sei anni dopo, quando cominciò una campagna scandalistica contro Leone,
destinata a farlo dimettere sei mesi prima della scadenza del mandato, a
prendere le difese del capo dello Stato. Le dimissioni sopraggiunsero, su
richiesta del Pci e della Dc, solo dopo la tragica morte di Moro, per mano delle
Brigate rosse. Che lo sequestrarono il 16 marzo 1978, fra il sangue della scorta
a poca distanza da casa, mentre si recava a Montecitorio per la presentazione
del governo monocolore democristiano di Giulio Andreotti, sul cui programma egli
aveva condotto, come presidente del suo partito, le trattative con Enrico
Berlinguer per ottenere il voto di fiducia dei comunisti. Erano gli anni della
cosiddetta "solidarietà nazionale", cominciati nel 1976 con l'astensione o "non
sfiducia" del Pci a quello stesso governo. Ad Aldo Moro, una volta rapito, Leone
fu uno dei pochi a tendere davvero la mano raccogliendone gli appelli alla
salvezza, a dispetto della linea della fermezza adottata dal governo e dalla
maggioranza con la sola eccezione dei socialisti di Bettino Craxi. Fu proprio
Leone, in particolare, a predisporre la grazia per Paola Besuschio, che era
nella lista dei 13 detenuti con i quali i terroristi avevano reclamato lo
scambio con l'ostaggio. E fu Amintore Fanfani, l'altro "cavallo di razza" della
Dc, antagonista di Moro in tanti passaggi della storia del partito, l'unico ad
offrire una copertura politica a Leone con un discorso alla direzione dello
scudo crociato che aveva appena cominciato a pronunciare, la mattina del 9
maggio, quando arrivò la notizia del tragico epilogo del sequestro. I
terroristi, informati con sospetta e "inquietante" tempestività, come vent'anni
dopo l'ormai ex presidente della Repubblica mi dichiarò in una intervista per Il
Foglio, precedettero Leone e Fanfani ammazzando Moro nel bagagliaio di un'auto
custodita nella palazzina di via Montalcini dove l'ostaggio era stato rinchiuso
e "processato", e poi parcheggiata in via Caetani, prescelta perché a mezza
strada fra le sedi nazionali della Dc e del Pci. Con Moro - che il 18 novembre
1977 a Benevento aveva descritto i rapporti fra comunisti e democristiani
dicendo: «Quello che voi siete, noi abbiamo contribuito a farvi essere e quello
che noi siamo voi avete contribuito a farci essere» - la Repubblica perse la sua
anima. Mai un delitto fu così diabolicamente centrato per attentare alla
democrazia.
La sua audace lentezza, la
paurosa frenesia dell'oggi,
scrive Marco Follini il 9 set 2016 su "Il Dubbio". Davanti al successo di
Zaccagnini osservò sconsolato: «Non è che io sia vecchio, ma lui è il nuovo». A
Moro si devono le grandi svolte della politica italiana: dal centrosinistra alla
solidarietà nazionale. L'onorevole Moro era un uomo d'altri tempi. Non solo nel
senso, ovvio, che apparteneva a un'altra epoca politica. Ma anche, e
soprattutto, nel senso che aveva una sua idea, antica e radicata, cauta e
prudente, pensosa, mai affrettata, dello scorrere del tempo politico. Quando
Craxi, appena eletto segretario del Psi, lo andò a trovare la prima volta nello
studio di via Savoia per raccontargli il suo progetto, lui commentò con i suoi
intimi che aveva detto cose interessanti ma per le quali ci sarebbe voluto
«molto, molto tempo». E quando Lima un giorno gli confidò che voleva aderire
alla sua corrente, gli rispose sornione: «C'è tempo». Che era un modo di
sottrarsi all'imbarazzo, certo. Ma era anche un modo di intendere la politica.
Ironizzava sulle riforme, segnalando che occorreva sempre stare in guardia dai
guasti che una eccessiva frenesia innovativa era destinata a produrre. E
considerava la fretta come indice di avventatezza e superficialità. Un giorno
gli raccontarono che Andreotti aveva "scritto" per l'editore Laterza il
libro-intervista su De Gasperi intrattenendo il giornalista co-autore per tre,
quattro ore un pomeriggio a Palazzi Chigi. Se ne mostrò scandalizzato, come se
quel poco tempo dedicato all'argomento fosse quasi un affronto alla memoria del
padre nobile dei democristiani. Aveva preso il suo primo aereo che era già
presidente del Consiglio. Era morta la mamma di Saragat, capo dello Stato, e non
avrebbe fatto in tempo a raggiungere Torino con i mezzi che solitamente
prediligeva. Il suo ritmo era quello delle sue camminate: lente e pensose.
Impiegava ore e ore a scrivere puntigliosamente i suoi discorsi, con una grafia
quasi incomprensibile, ma con una cura certosina per i dettagli, le sfumature,
l'aggettivazione. Diffidava delle mode. Chiamava "il fratturato" l'abito
spezzato, segno della sua poca approvazione. E quando il suo portavoce, Corrado
Guerzoni, un giorno si presentò nel suo ufficio con un maglione dolce vita sotto
un impeccabile vestito grigio, commentò con ironia che i figli avrebbero
sicuramente apprezzato un papà così moderno e al passo coi tempi. Come dire: la
prossima volta indossi la cravatta. Quando sul finire degli anni Settanta una
larga parte della gioventù democristiana prese ad inneggiare con un tifo da
stadio al segretario Zaccagnini, Moro - che pure lo aveva fatto eleggere -
osservò un po' sconsolato: non è che io sia vecchio, ma lui è il nuovo. Capiva
di essere bersaglio del nuovismo del tempo e metteva a verbale il suo
scetticismo, se non anche la sua disapprovazione. Era un uomo severo, gentile ma
privo di compiacenze. Un giorno al congresso della Dc barese l'onorevole
Matarrese, appena eletto deputato, reclamò tre posti per la sua corrente negli
organi provinciali del partito. Moro lo prese da parte e offrendogli un posto,
uno solo, gli disse: le cose si fanno con calma, come insegna la Chiesa. Prima
si è parroci in una chiesetta, poi si trova una parrocchia più grande, poi si
diventa vescovi, poi forse cardinali e poi forse addirittura Papi. Ma sempre un
passo alla volta. Al congresso di Napoli, quando c'era da convincere la Dc
dell'apertura a sinistra - correva l'anno 1962 - parlò per sette ore. La
trascrizione integrale della sua relazione si compone di 124 mila caratteri. Non
proprio il dono della sintesi, anche se mancava ancora mezzo secolo all'avvento
di twitter. Quando un giornalista gli chiese se poteva disporre di una sintesi
del suo intervento gli fece sapere che la sintesi più appropriata era la
pubblicazione del testo integrale. Una battuta al limite dell'arroganza, se
vogliamo. Che però rifletteva anche il suo perfezionismo politico e letterario.
Moro odiava la fretta. Non perché fosse pigro, tantomeno svogliato. Ma perché
secondo lui ogni passaggio della politica richiedeva la sua maturazione.
Conosceva il suo paese, conosceva il suo partito. Ne scrutava le paure, le
fragilità, gli sbandamenti. Si cimentava con un'Italia attraversata da "passioni
forti" e presidiata da "strutture deboli". E proprio il conflitto tra la forza
delle passioni e la debolezza degli argini che avrebbero dovuto contenerle e
indirizzarle verso uno sbocco era il suo cruccio. E insieme la ragione di quel
suo procedere apparentemente incerto e tortuoso. Soffriva l'attivismo di altri
capi democristiani. Il dinamismo di Fanfani, per cui pure provava rispetto.
L'inquietudine di Piccoli. L'assertività di Taviani. Le ansie dei più giovani
cultori di una modernizzazione a cui credeva poco. La sua attualità stava per
così dire nella fatica quasi estenuante con cui faceva maturare le svolte. Ma
quei percorsi avevano appunto bisogno di fare appello a tecniche fin troppo
raffinate e a modalità improntate a un'infinita, pedagogica pazienza. Era questo
il suo ruolo, e questa la sua vocazione. Quando condusse la Dc all'approdo della
solidarietà nazionale impiegò ore ed ore a "confessare" i singoli deputati. Li
incontrò ad uno ad uno, li ascoltò diligentemente, li convinse dedicando a
ognuno di loro un tempo inusitatamente lungo. Un tempo che strideva con le
gerarchie dell'epoca, e forse anche con l'intimo giudizio che Moro dava di molti
di loro. Nella sua pedagogia politica l'ascolto valeva più dello sforzo di
convinzione, non dirò della propaganda. Interrogava i suoi interlocutori con una
pazienza infinita, e anche con una viva curiosità. A distanza di anni ho cercato
di ricordare alcuni dei nostri colloqui, e mi sono accorto che avevo parlato più
io di lui. Era complicato, elaborato, niente affatto alla moda -neppure secondo
i canoni, non proprio fulminei, dei suoi tempi. Eppure arrivava a destinazione.
Era tutt'altro che ondivago. Infatti, le grandi svolte della politica italiana,
dal centrosinistra alla solidarietà nazionale, maturarono tutte sotto la sua
accorta regia. E perfino i grandi movimenti di contestazione giovanile trovarono
proprio in quel notabile apparentemente così attempato il loro interlocutore più
attento, disponibile e costruttivo. Insomma, il passo lento e calibrato di Moro
portava sempre da qualche parte. Forse sarà il caso di farlo presente ai
giovanotti trafelati che governano a passo di carica la più recente politica del
nostro paese.
Aldo Moro, lo stratega
pensoso.
Così lo vedevano gli Usa: l’inedito. A cent’anni dalla nascita dello statista,
il libro di Guido Formigoni (il Mulino). Fu inviso a molti, ma il suo assassinio
aprì un vuoto ancora non colmato, scrive Andrea Ricciardi il 5 settembre 2016 su
“Il Corriere della Sera”. La «Repubblica dei partiti» sembra lontana in questo
tempo di politica personalizzata. Il suo sistema, così partitocratico, appare
poco trasparente, bizantino nel formarsi e scomporsi di maggioranze, disattento
alla governabilità e alla spesa pubblica pur di ammortizzare le difficoltà
politiche. È un modo di far politica caduto in discredito con Mani pulite, che
ne ha rivelato gli aspetti di corruzione (peraltro poi non estirpata). Eppure
questa è la storia, attraverso cui l’Italia si è trasformata profondamente in
quasi mezzo secolo. Le masse italiane, tradizionalmente spettatrici, entrarono
allora in politica con larga partecipazione. Hanno votato e discusso di politica
con passione. Non è facile, però, raccontare questa storia proprio per la sua
complessità. I primi anni sono caratterizzati da Alcide De Gasperi, presidente
del Consiglio dal 1945 (l’ultimo del Regno) al 1953. L’origine della Repubblica
coincide con l’età di De Gasperi. Ma poi? La storia successiva appare
complicata. Ha per protagonista un collettivo dai molti volti: la Democrazia
cristiana, che Agostino Giovagnoli ha definito «il partito italiano» o della
nazione. Guido Formigoni, con Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, che esce
l’8 settembre per il Mulino, mostra come il politico pugliese ebbe, lungo gli
anni, una grande capacità di sintesi e guida nel variegato gruppo dirigente
democristiano. Dopo la sua uccisione da parte dalle Brigate rosse nel maggio
1978, non ancora sessantaduenne, la Dc non è stata più la stessa. Eppure Moro,
per molti, ha incarnato i difetti del partito: far politica lontano dalla gente.
Formigoni riporta come l’immagine dello statista sia stata anche quella
«dell’involuto e oscuro custode degli arcani del potere, del pigro e levantino
insabbiatore di ogni processo innovativo». Più chiaro, seppur criticato, fu
l’attivismo politico di Amintore Fanfani. Moro è stato tuttavia uno degli attori
più incisivi del cambiamento della società italiana.
Guido Formigoni, «Aldo
Moro. Lo statista e il suo dramma
(il Mulino, pp. 486, euro 28), scrive "Il Corriere della Sera" il 7 settembre
2016. La sua biografia è quella dell’ingresso di tanti giovani nella vita
politica dopo la guerra. Moro era nato cento anni fa, il 23 settembre 1916, a
Maglie in Puglia, figlio d’insegnanti elementari. La sua vicenda è ripercorsa da
Formigoni in modo documentato e attento. Attraverso l’associazionismo religioso,
entrò nel nuovo scenario politico apertosi con la fine del fascismo. Un tratto
pensoso lo contraddistinse fin da giovane. Del resto il rapporto tra cultura,
ideologia e politica era allora rilevante per parecchi partiti del dopoguerra.
In Moro non c’era la passione per una politique d’abord, nonostante la sua
accortezza politica. È stato un intellettuale, un giurista, un attento
osservatore della realtà italiana. Accentuò questo carattere negli ultimi dieci
anni di fronte alle spinte del Sessantotto e alle domande di cambiamento. Pure
negli scritti dal carcere delle Br, emerge il suo carattere pensoso. Eppure
Formigoni, a ragione, registra l’«odio diffuso» di cui era oggetto, ricordando
che, alla notizia del rapimento, il cardinal Giuseppe Siri, fiero avversario
dell’apertura morotea ai socialisti prima e, poi, ai comunisti, disse: «Ha avuto
quello che si meritava per aver trafficato con i comunisti». Una personalità di
segno diverso, Altiero Spinelli, l’avrebbe giudicato «un animo da coniglio» nel
carcere bierrista. Il segretario di Stato americano Henry Kissinger lo
considerava tortuoso e cedevole verso i comunisti. In realtà, Moro ha segnato
con coraggio e visione la storia d’Italia della seconda metà del
Novecento: presidente del Consiglio per sette anni e in cinque governi; ministro
degli Esteri per cinque anni (per due anni sottosegretario nello stesso
dicastero); segretario della Dc per quattro anni. Oltre a lui, l’altro «cavallo
di razza» della Dc (per usare l’espressione di Carlo Donat Cattin) fu Fanfani,
di qualche anno più anziano, politico dal carattere più perentorio e fattivo.
Moro è stato però il grande stratega: dal superamento del centrismo con
l’apertura ai socialisti alla «solidarietà nazionale» (l’apertura ai comunisti).
Scevro da protagonismi (tanto che, quando fu rapito, occupava il posto modesto
di presidente del Consiglio nazionale Dc), amava più la persuasione che il
leaderismo. Si esprimeva con discorsi complessi e articolati, talvolta ermetici,
che invitavano a pensare e creavano consenso. A Moro e Fanfani si deve la
decisione di portare la politica in Rai con Tribuna elettorale, facendo parlare
e interrogare i leader dei partiti. Per Moro, la Dc era l’asse centrale della
politica italiana: «Sento — dice nel 1959 — l’insostituibile funzione del
partito come filtro delle esigenze complesse della vita politica, economica e
sociale del Paese… la vedo come manifestazione efficace di opinioni, come
strumento di educazione e guida del popolo italiano». Secondo lui la democrazia
non avrebbe tenuto senza i partiti e la Dc. Non bastava la gestione del potere:
occorreva sintonizzarsi con gli sviluppi della società senza avventurismi, ma
anche senza paura del futuro. Era preoccupato, negli ultimi anni, che il partito
si avvitasse su di sé. Formigoni ricostruisce l’azione di Moro nel partito e al
governo. Disegna quasi un’«anatomia del potere italiano» (per usare
l’espressione di Miguel Gotor), ricostruendo le dinamiche della classe
dirigente: un gioco complesso, intreccio di fattori politici e personali, in cui
si vede un ruolo tutt’altro che grigio del Quirinale di Gronchi, di Segni e di
Saragat. Si delineano minacce golpiste, azioni terroristiche, reti oscure,
vicende internazionali condizionanti, interventi della Chiesa... Moro si muove,
accorto e determinato, facendo sintesi tra spinte differenti. È allo stesso
tempo realista e di visione: «La gente pensa che abbiamo un’autorità immensa,
che possiamo fare e disfare tutto…», confida a Eugenio Scalfari. E aggiunge: «Il
lavoro di sintesi è ancora più faticoso e incerto». Perché Aldo Moro fu preso
dalle Brigate Rosse? Si trattava del bersaglio più facile, secondo Francesco
Cossiga. Era però anche il cardine e il simbolo del sistema che, tra difficoltà,
stava entrando nella «terza fase» della democrazia italiana. Nell’ultimo
capitolo della biografia di Formigoni, dedicato ai 55 giorni di prigionia,
emerge che «lo Stato italiano non ha fatto nel suo complesso quanto sarebbe
stato possibile per salvare Moro con la via maestra dell’efficienza delle forze
dell’ordine». La classe dirigente fu attonita, bloccata, quasi incapace di
maneggiare le leve del potere a fronte delle Br, violente e inconsistenti
politicamente. Mancò una sintesi. Paolo VI, ormai anziano (morì tre mesi dopo)
non vi riuscì in quel turbinoso momento. Non era proprio il suo compito, ma non
trovò interlocutori politici. Eppure Montini era stato l’artefice della Dc e del
consenso cattolico alla democrazia: l’«unico papa democristiano» — lo definì
Emile Poulat. In quel maggio 1978, «un po’ della Democrazia cristiana se n’è
andata» — scrisse il prigioniero delle Br. La Dc non fu più la stessa. L’assetto
politico si sarebbe consumato negli anni Ottanta. Lo si poteva prolungare un
po’, ma una rottura era avvenuta in profondità alla fine degli anni Settanta e
sarebbe emersa. Così la Dc e anche il sistema sono implosi. Il vuoto aperto
dalla morte di Moro mostra il suo ruolo decisivo negli anni precedenti, più di
quanto si credeva.
Aldo Moro visto dagli
americani: filo-occidentale di sinistra.
Il messaggio inedito inviato nel 1974 dall’ambasciatore americano in Italia,
tratto dal libro «Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma» di Guido Formigoni (il
Mulino). Dal libro «Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma» di Guido Formigoni
(il Mulino, pagine 486, e 28, in libreria dall’8 settembre) pubblichiamo un
brano da un messaggio inedito tratto dagli Archivi nazionali degli Stati Uniti
(Nara). Fu inviato il 29 novembre 1974 dall’ambasciatore americano in Italia,
John Volpe, al segretario di Stato Henry Kissinger all’indomani della formazione
del quarto governo Moro. Dal nostro punto di vista, dobbiamo trattare con un
primo ministro che è diventato negli ultimi cinque anni il simbolo e l’immagine
stessa della sinistra democratica cristiana. Egli è l’unico membro dell’ala
sinistra della Dc con una statura sufficiente da godere del rispetto di tutti i
partiti democratici come uno statista che può essere scelto per la leadership
del governo. Io penso che le sue credenziali filo-occidentali sono valide ancora
oggi come sempre, ma il Moro della politica interna è in qualche modo alla
sinistra del Moro statista internazionale. Egli è spinto a sinistra dalla sua
stessa natura piuttosto fatalistica e dalla sua lungamente coltivata antipatia
per Fanfani, che ora sta ben alla destra di Moro. Con Fanfani pronto a
sostituirlo, Moro farà ogni sforzo per evitare problemi o scontri con i
socialisti. Una rottura definitiva con i socialisti significherebbe la fine
della formula di centro-sinistra con cui Moro è storicamente associato, e che
egli ha definito «irreversibile». Ci si può attendere che egli paghi il prezzo
di un accordo o di una deriva, come necessari per tenere assieme il suo governo
quanto a lungo sarà possibile. Io inclino a pensare che il quarto governo Moro
non durerà molto. Fazioni importanti della Dc e addirittura esponenti del
governo predicono solo pochi mesi, e in effetti i sindacati e i socialisti sono
già irrequieti e insoddisfatti. Sarei però negligente a non ricordare, comunque,
che quando Moro ha buone ragioni per star saldo, come spiegato sopra, la sua
ingegnosità e tenacia sono fenomenali. Non è per coincidenza che Moro ha guidato
il governo italiano per un periodo di tempo più lungo di qualsiasi primo
ministro dopo De Gasperi.
«Mi trovo sotto un dominio
pieno e incontrollato»,
scrive Lanfranco Caminiti il 6 settembre 2016 su "Il Dubbio". «Caro Francesco...
in verità siamo tutti noi del gruppo dirigente che siamo chiamati in causa ed è
il nostro operato collettivo che è sotto accusa e di cui devo rispondere».
A Eleonora Moro. Pasqua 1978
"Mia carissima Noretta, Desidero farti giungere nel giorno di Pasqua, a te ed a
tutti, gli auguri più fervidi ed affettuosi con tanta tenerezza per la famiglia
ed il piccolo in particolare. Ricordami ad Anna che avrei dovuto vedere oggi.
Prego Agnese di farti compagnia la notte. Io discretamente, bene alimentato ed
assistito con premura. Vi benedico, invio tante cose care a tutti e un forte
abbraccio. Aldo"
A Francesco Cossiga. "Caro
Francesco, mentre t'indirizzo un caro saluto, sono indotto dalle difficili
circostanze a svolgere dinanzi a te, avendo presenti le tue responsabilità (che
io ovviamente rispetto) alcune lucide e realistiche considerazioni. Prescindo
volutamente da ogni aspetto emotivo e mi attengo ai fatti. Benché non sappia
nulla né del modo né di quanto accaduto dopo il mio prelevamento, è fuori
discussione - mi è stato detto con tutta chiarezza - che sono considerato un
prigioniero politico, sottoposto, come Presidente della D. C., ad un processo
diretto ad accertare le mie trentennali responsabilità (processo contenuto in
termini politici, ma che diventa sempre più stringente). In tali circostanze ti
scrivo in modo molto riservato, perché tu e gli amici con alla testa il
Presidente del Consiglio (informato ovviamente il Presidente della Repubblica)
possiate riflettere opportunamente sul da farsi, per evitare guai peggiori.
Pensare quindi fino in fondo, prima che si crei una situazione emotiva e
irrazionale. Devo pensare che il grave addebito che mi viene fatto, si rivolge a
me in quanto esponente qualificato della DC nel suo insieme nella gestione della
sua linea politica. In verità siamo tutti noi del gruppo dirigente che siamo
chiamati in causa ed è il nostro operato collettivo che è sotto accusa e di cui
devo rispondere. Nella circostanza sopra descritta entra in gioco, al di là di
ogni considerazione umanitaria che pure non si può ignorare, la ragione di
Stato. Soprattutto questa ragione di Stato nel caso mio significa, riprendendo
lo spunto accennato innanzi sulla mia attuale condizione, che io mi trovo sotto
un dominio pieno ed incontrollato, sottoposto ad un processo popolare che può
essere opportunamente graduato, che sono in questo stato avendo tutte le
conoscenze e sensibilità che derivano dalla lunga esperienza, con il rischio di
essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e
pericolosa in determinate situazioni.
Inoltre la dottrina per la
quale il rapimento non deve recare vantaggi, discutibile già nei casi comuni,
dove il danno del rapito è estremamente probabile, non regge in circostanze
politiche, dove si provocano danni sicuri e incalcolabili non solo alla persona,
ma allo Stato. Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di
legalità, mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a
salvarli, è inammissibile. Tutti gli Stati del mondo si sono regolati in modo
positivo, salvo Israele e la Germania, ma non per il caso Lorenz. E non si dica
che lo Stato perde la faccia, perché non ha saputo o potuto impedire il
rapimento di un'alta personalità che significa qualcosa nella vita dello Stato.
Ritornando un momento indietro sul comportamento degli Stati, ricorderò gli
scambi tra Breznev e Pinochet, i molteplici scambi di spie, l'espulsione dei
dissidenti dal territorio sovietico. Capisco che un fatto di questo genere,
quando si delinea, pesi, ma si deve anche guardare lucidamente al peggio che può
venire. Queste sono le alterne vicende di una guerriglia, che bisogna valutare
con freddezza, bloccando l'emotività e riflettendo sui fatti politici. Penso che
un preventivo passo della S. Sede (o anche di altri? di chi?) potrebbe essere
utile. Converrà che tenga d'intesa con il Presidente del Consiglio
riservatissimi contatti con pochi qualificati capi politici, convincendo gli
eventuali riluttanti. Un atteggiamento di ostilità sarebbe una astrattezza ed un
errore. Che Iddio vi illumini per il meglio, evitando che siate impantanati in
un doloroso episodio, dal quale potrebbero dipendere molte cose. I più
affettuosi saluti. Aldo Moro"
È il 29 marzo 1978. Nicola
Rana, da anni segretario particolare di Moro, riceve, nello studio di via Savoia
del presidente democristiano, una telefonata delle Br, che gli indica dove
trovare una busta: a piazza Sant'Andrea della Valle, nell'intercapedine tra il
muro e un'edicola di giornali. Rana la recupera e si reca da Eleonora Moro. La
busta contiene tre lettere di Moro. La prima, indirizzata a Rana, in cui lo
prega di preservare la segretezza e la sicurezza dello studio di via Savoia come
canale di comunicazione. La seconda, alla moglie. La terza, la più lunga,
indirizzata a Cossiga, a cui Rana la consegna nel primo pomeriggio. Moro deve
avervi ragionato su durante la Settimana Santa. È domenica di Pasqua, 26 marzo.
Sono passati dieci giorni dal rapimento. Ha letto ritagli di giornali con le
dichiarazioni dei partiti, di esponenti del governo, dei sindacati. Suppone che
si sia aperta una caccia all'uomo per rintracciare il luogo dov'è tenuto
prigioniero, ma non crede che questa sia la strada per la quale poter tornare
libero. Vuole far rendere conto gli altri della condizione a cui è sottoposto,
il «dominio», il «processo». «Siamo tutti noi a essere chiamati in causa»,
scrive Moro. Lo si deve considerare un prigioniero politico e trovare il modo di
tirarlo fuori da lì. Fa riferimento a precedenti comportamenti di Stato come il
caso Lorenz (leader dei democristiani di Berlino sequestrato il 27 febbraio del
1975 e rilasciato l'1 marzo in cambio della liberazione di cinque anarchici) e
gli scambi di spie tra paesi ostili. Indica nella Santa Sede un possibile
interlocutore, un mediatore attivo. Cossiga riceve la lettera convinto - come
gli scrive Moro - che abbia un carattere privato. Da lì a poco, invece, le Br
faranno rinvenire in quattro città copie della lettera e il comunicato n. 3. La
scelta di rendere pubblico quanto a Moro era stato garantito come privato sarà
motivata dicendo: «Ha chiesto di scrivere una lettera segreta (le manovre
occulte sono la normalità per la mafia democristiana) al governo ed in
particolare al capo degli sbirri Cossiga. Gli è stato concesso, ma siccome
niente deve essere nascosto al popolo ed è questo il nostro costume la rendiamo
pubblica». Questa decisione non è stata presa senza obiezioni interne. Il
comunicato, che si rivolge al Movimento rivoluzionario, proclama che renderà
noti i risultati dell'interrogatorio di Moro, a cui il prigioniero - si dice -
sta collaborando. A sera finalmente il Comitato tecnico-operativo sarà informato
dell'ultimo comunicato brigatista e delle lettere di Moro, compresa quella al
ministro degli Interni di cui nessuno era al corrente. Cossiga, intanto, si
consulta con Andreotti per decidere insieme l'atteggiamento da assumere. Il
gruppo dei più stretti collaboratori di Moro - Rana, Freato e Guerzoni - prepara
un articolo per il quotidiano «Il Popolo», in cui si mostra una certa
disponibilità ad ascoltare i suggerimenti contenuti nella lettera del presidente
democristiano. Ma la pubblicazione dell'articolo viene bloccata dai vertici del
partito. Immediatamente dopo aver ricevuto la lettera del marito, Eleonora Moro,
seguendone le indicazioni, si è messa in contatto con il Vaticano per
sollecitarne la mediazione. Si apre a Torino il 41° Congresso socialista. Non è
in discussione la leadership di Craxi, rafforzata dal patto con Signorile,
quanto la collocazione che il partito intende assumere riguardo alla maggioranza
governativa. È anche il banco di prova della nuova classe dirigente socialista,
quella generazione di quarantenni che si è stretta attorno a Craxi. Il discorso
introduttivo del segretario è atteso anche per i suoi imprescindibili
riferimenti al sequestro Moro.
«Sono un prigioniero
politico, il partito deve liberarmi»,
scrive Lanfranco Caminiti il 8 settembre 2016 su "Il Dubbio". È il 4 aprile,
inizia il dibattito alla Camera, il presidente del Consiglio Andreotti espone le
linee del governo e ribadisce che «non si può patteggiare nulla con gente che ha
le mani grondanti di sangue». «Caro Zaccagnini, scrivo a te, intendendo
rivolgermi a Piccoli, Bartolomei, Galloni, Gaspari, Fanfani, Andreotti e Cossiga
ai quali tutti vorrai leggere la lettera e con i quali tutti vorrai assumere le
responsabilità, che sono ad un tempo individuali e collettive. Parlo
innanzitutto della D. C. alla quale si rivolgono accuse che riguardano tutti, ma
che io sono chiamato a pagare con conseguenze che non è difficile immaginare.
Certo nelle decisioni sono in gioco altri partiti; ma un così tremendo problema
di coscienza riguarda innanzitutto la D. C., la quale deve muoversi, qualunque
cosa dicano, o dicano nell'immediato, gli altri. Parlo innanzitutto del Partito
Comunista, il quale, pur nella opportunità di affermare esigenze di fermezza,
non può dimenticare che il mio drammatico prelevamento è avvenuto mentre si
andava alla Camera per la consacrazione del Governo che m'ero tanto adoperato a
costituire. È peraltro doveroso che, nel delineare la disgraziata situazione, io
ricordi la mia estrema, reiterata e motivata riluttanza ad assumere la carica di
Presidente che tu mi offrivi e che ora mi strappa alla famiglia, mentre essa ha
il più grande bisogno di me. Moralmente sei tu ad essere al mio posto, dove
materialmente sono io. Ed infine è doveroso aggiungere, in questo momento
supremo, che se la scorta non fosse stata, per ragioni amministrative, del tutto
al disotto delle esigenze della situazione, io forse non sarei qui. Questo è
tutto il passato. Il presente è che io sono sottoposto ad un difficile processo
politico del quale sono prevedibili sviluppi e conseguenze. Sono un prigioniero
politico che la vostra brusca decisione di chiudere un qualsiasi discorso
relativo ad altre persone parimenti detenute, pone in una situazione
insostenibile. Il tempo corre veloce e non ce n'è purtroppo abbastanza. Ogni
momento potrebbe essere troppo tardi. Si discute qui, non in astratto diritto
(benché vi siano le norme sullo stato di necessità), ma sul piano
dell'opportunità umana e politica, se non sia possibile dare con realismo alla
mia questione l'unica soluzione positiva possibile, prospettando la liberazione
di prigionieri di ambo le parti, attenuando la tensione nel contesto proprio di
un fenomeno politico. Tener duro può apparire più appropriato, ma una qualche
concessione è non solo equa, ma anche politicamente utile. Come ho ricordato in
questo modo civile si comportano moltissimi Stati. Se altri non ha il coraggio
di farlo, lo faccia la D. C. che, nella sua sensibilità ha il pregio di
indovinare come muoversi nelle situazioni più difficili. Se così non sarà,
l'avrete voluto e, lo dico senza animosità, le inevitabili conseguenze
ricadranno sul partito e sulle persone. Poi comincerà un altro ciclo più
terribile e parimenti senza sbocco. Tengo a precisare di dire queste cose in
piena lucidità senza avere subìto alcuna coercizione della persona; tanta
lucidità almeno, quanta può averne chi è da quindici giorni in una situazione
eccezionale, che non può avere nessuno che lo consoli, che sa che cosa lo
aspetti. Ed in verità mi sento anche un po' abbandonato da voi. Del resto queste
idee già espressi a Taviani per il caso Sossi ed a Gui a proposito di una
contestata legge contro i rapimenti. Fatto il mio dovere d'informare e
richiamare, mi raccolgo con Iddio, i miei cari e me stesso. Se non avessi una
famiglia così bisognosa di me, sarebbe un po' diverso. Ma così ci vuole davvero
coraggio per pagare per tutta la D. C. avendo dato sempre con generosità. Che
Iddio v'illumini e lo faccia presto, com'è necessario. Affettuosi saluti Aldo
Moro». È il 4 aprile. Il 31 marzo, il «Popolo» e «l'Unità» avevano titolato:
«Nessuna trattativa, nessun cedimento al ricatto». È questo il senso consonante
di due articoli che definiscono, rispettivamente, la posizione democristiana e
comunista. Entrambe disconoscono l'autenticità della scrittura di Moro,
attribuendola allo stato di costrizione che subisce. Uno stuolo di criptologi,
grafologi, farmacologi analizzano le parole di Moro per dimostrare come sia
sottoposto a stupefacenti o a tortura. Il 2 aprile, Paolo VI si affaccia, a
mezzogiorno, a piazza San Pietro e, pur sottolineando l'assenza di «alcun
particolare indizio sullo stato di fatto», rivolge un appello ai rapitori di
Moro perché lo rilascino. Intanto si è concluso il Congresso socialista. Nella
relazione conclusiva di Craxi c'è un pregnante riferimento al caso Moro, in cui
il segretario socialista sembra prendere le distanze dalle posizioni più
intransigenti. «È in gioco una vita umana - dice - e non dovrebbe essere
lasciato cadere nessun margine ragionevole di trattativa». Il 3 aprile, i
segretari dei partiti di maggioranza si riuniscono per la seconda volta: la
prima era stata immediatamente dopo il sequestro e aveva registrato un fronte
compatto per la fermezza. Adesso, in previsione del dibattito parlamentare
dell'indomani, sembra necessario verificare la maggioranza. Cossiga relaziona
sullo stato delle indagini. È minuzioso e dettagliato ma, evidentemente, non ha
alcun conforto di risultati. Berlinguer insiste sulla necessità che il governo
esprima con estrema chiarezza il rifiuto di ogni trattativa; in caso contrario
teme le reazioni delle forze dell'ordine. Zaccagnini attenua i toni: è d'accordo
sulla fermezza, ma non esclude ogni azione legale volta a salvare Moro. È Craxi,
reduce dal Congresso di partito, a discordare dagli altri. Prima dell'incontro,
ha rilasciato una breve intervista al giornale radio, in cui dichiara la
necessità di esplorare tutte le strade per liberare il presidente democristiano.
È il 4 aprile. Inizia, nel pomeriggio, il dibattito alla Camera. In mattinata,
nella riunione dei capigruppo, si è concordato di fissare dei limiti di tempo
per le interrogazioni. È Andreotti che espone le linee del governo. Ribadisce
che «non si può patteggiare con gente che ha le mani grondanti di sangue».
Ragguaglia sulla lettera inviata da Moro a Cossiga e la dichiara - con il
conforto degli esperti - «moralmente a lui non ascrivibile». Dopo di lui si
ascoltano gli interventi di Natta, per i comunisti, e di Piccoli, per i
democristiani. Natta proclama il dovere del parlamento e delle forze
democratiche di provvedere alla difesa più ferma e rigorosa dei princìpi, delle
leggi e degli istituti dello Stato democratico. Piccoli ripete il rifiuto di
avviare trattative, una scelta che la Dc avrebbe fatto anche se fosse stato un
partito d'opposizione. È a questo punto che viene comunicato a Cossiga, a
Zaccagnini, ad Andreotti, a Berlinguer e ad altri che è giunta un'altra lettera
di Moro. Le Br hanno telefonato, nel pomeriggio, a Milano, Genova, Torino e
Roma, alle redazioni di alcuni giornali per avvertire di aver lasciato dei
plichi. Dentro, ci sono il comunicato n. 4 delle Br, la Risoluzione strategica
del febbraio '78 e una lettera di Moro a Zaccagnini, scritta presumibilmente
qualche giorno prima - «da quindici giorni in una situazione eccezionale». Il
comunicato delle Br, dopo aver affermato che il processo a Moro è il processo a
trent'anni di regime democristiano, sottolinea che «la posizione sullo scambio
non è la nostra». Moro, nella lettera, fa riferimento al caso di Mario Sossi, il
magistrato sequestrato dalle Brigate rosse a Genova nell'aprile 1974 e liberato
dopo trentacinque giorni di prigionia, dopo aver chiesto la scarcerazione di un
gruppo di militanti politici. «Il processo ad Aldo Moro andrà regolarmente
avanti», scrivono adesso le Br. In nottata, a piazza del Gesù, riunione del
vertice democristiano. Zaccagnini è il più provato e la direzione Dc sembra
riunirsi attorno a lui per impedire ogni sgretolamento della linea adottata.
Lanfranco Caminiti
«Non creda la Dc di avere
chiuso il suo problema liquidandomi»,
scrive Lanfranco Caminiti il 14 set 2016 su "Il Dubbio". «Chiedo che ai miei
funerali non partecipino né Autorità dello Stato, né uomini di partito. Chiedo
di essere seguito dai pochi che mi hanno veramente voluto bene e sono degni
perciò di accompagnarmi con la loro preghiera e con il loro amore». "Caro
Zaccagnini, ancora una volta, come qualche giorno fa m'indirizzo a te con animo
profondamente commosso per la crescente drammaticità della situazione. Siamo
quasi all'ora zero: mancano più secondi che minuti. Siamo al momento
dell'eccidio. Naturalmente mi rivolgo a te, ma intendo parlare individualmente a
tutti i componenti della Direzione (più o meno allargata) cui spettano
costituzionalmente le decisioni, e che decisioni! del partito. Intendo
rivolgermi ancora alla immensa folla dei militanti che per anni ed anni mi hanno
ascoltato, mi hanno capito, mi hanno considerato l'accorto divinatore delle
funzioni avvenire della Democrazia Cristiana. Quanti dialoghi, in anni ed anni,
con la folla dei militanti. Quanti dialoghi, in anni ed anni, con gli amici
della Direzione del Partito o dei Gruppi parlamentari. Anche negli ultimi
difficili mesi quante volte abbiamo parlato pacatamente tra noi, tra tutti noi,
chiamandoci per nome, tutti investiti di una stessa indeclinabile
responsabilità. Si sapeva, senza patti di sangue, senza inopinati segreti
notturni che cosa voleva ciascuno di noi nella sua responsabilità. Ora di questa
vicenda, la più grande e gravida di conseguenze che abbia investito da anni la
D. C., non sappiamo nulla o quasi. Non conosciamo la posizione del Segretario né
del Presidente del Consiglio; vaghe indiscrezioni dell'On. Bodrato con accenti
di generico carattere umanitario. Nessuna notizia sul contenuto; sulle
intelligenti sottigliezze di Granelli, sulle robuste argomentazioni di Misasi
(quanto contavo su di esse), sulla precisa sintesi politica dei Presidenti dei
Gruppi e specie dell'On. Piccoli. Mi sono detto: la situazione non è matura e ci
converrà aspettare. È prudenza tradizionale della D. C. Ed ho atteso fiducioso
come sempre, immaginando quello che Gui, Misasi, Granelli, Gava, Gonella
(l'umanista dell'Osservatore) ed altri avrebbero detto nella vera riunione, dopo
questa prima interlocutoria. Vorrei rilevare incidentalmente che la competenza è
certo del Governo, ma che esso ha il suo fondamento insostituibile nella D. C.
che dà e ritira la fiducia, come in circostanze così drammatiche sarebbe
giustificato. È dunque alla D. C. che bisogna guardare. Ed invece, dicevo,
niente. Sedute notturne, angosce, insofferenza, richiami alle ragioni del
Partito e dello Stato. Viene una proposta unitaria nobilissima, ma che elude
purtroppo il problema politico reale. Invece dev'essere chiaro che politicamente
il tema non è quello della pietà umana, pur così suggestiva, ma dello scambio di
alcuni prigionieri di guerra (guerra o guerriglia come si vuole), come si
pratica là dove si fa la guerra, come si pratica in paesi altamente civili
(quasi la universalità), dove si scambia non solo per obiettive ragioni
umanitarie, ma per la salvezza della vita umana innocente. Perché in Italia un
altro codice? Per la forza comunista entrata in campo e che dovrà fare i conti
con tutti questi problemi anche in confronto della più umana posizione
socialista? Vorrei ora fermarmi un momento sulla comparazione dei beni di cui si
tratta: uno recuperabile, sia pure a caro prezzo, la libertà; l'altro, in nessun
modo recuperabile, la vita. Con quale senso di giustizia, con quale pauroso
arretramento sulla stessa legge del taglione, lo Stato, con la sua inerzia, con
il suo cinismo, con la sua mancanza di senso storico consente che per una
libertà che s'intenda negare si accetti e si dia come scontata la più grave ed
irreparabile pena di morte? Questo è un punto essenziale che avevo immaginato
Misasi sviluppasse con la sua intelligenza ed eloquenza. In questo modo si
reintroduce la pena di morte che un Paese civile come il nostro ha escluso sin
dal Beccaria ed espunto nel dopoguerra dal codice come primo segno di autentica
democratizzazione. Con la sua inerzia, con il suo tener dietro, in nome della
ragion di Stato, l'organizzazione statale condanna a morte e senza troppo
pensarci su, perché c'è uno stato di detenzione preminente da difendere. È una
cosa enorme. Ci vuole un atto di coraggio senza condizionamenti di alcuno.
Zaccagnini, sei eletto dal congresso. Nessuno ti può sindacare. La tua parola è
decisiva. Non essere incerto, pencolante, acquiescente. Sii coraggioso e puro
come nella tua giovinezza. E poi, detto questo, io ripeto che non accetto
l'iniqua ed ingrata sentenza della D. C. Ripeto: non assolverò e non
giustificherò nessuno. Nessuna ragione politica e morale mi potranno spingere a
farlo. Con il mio è il grido della mia famiglia ferita a morte, che spero possa
dire autonomamente la sua parola. Non creda la D. C. di avere chiuso il suo
problema, liquidando Moro. Io ci sarò ancora come un punto irriducibile di
contestazione e di alternativa, per impedire che della D. C. si faccia quello
che se ne fa oggi. Per questa ragione, per una evidente incompatibilità, chiedo
che ai miei funerali non partecipino né Autorità dello Stato, né uomini di
partito. Chiedo di essere seguito dai pochi che mi hanno veramente voluto bene e
sono degni perciò di accompagnarmi con la loro preghiera e con il loro amore.
Cordiali saluti. Aldo Moro. P. S. Diffido a non prendere decisioni fuori dagli
organi competenti di partito". Le Brigate rosse fanno ritrovare il comunicato n.
8. Insieme c'è una lettera di Moro al segretario democristiano Zaccagnini. Moro
sembra abbastanza informato delle posizioni di esponenti del suo partito. Fa, ad
esempio, riferimento alle cose dette da Granelli, della Direzione nazionale, o
da Gonella, autorevole democristiano, membro dell'Assemblea costituente, in quei
giorni fra i più strenui difensori della fermezza. Le Br, nel comunicato,
considerano dilatorie e oscure le risposte della Dc a quanto finora da loro
richiesto ed esplicitato ora con maggiore chiarezza. È la Democrazia cristiana
il loro unico interlocutore: «La Dc e il suo governo hanno la possibilità di
ottenere la sospensione della sentenza del Tribunale del Popolo e il rilascio di
Aldo Moro solo liberando i prigionieri comunisti». Segue un elenco di tredici
detenuti, dal «nucleo storico» dei Nap e della XXII Ottobre a «proletari
prigionieri» politicizzatisi in carcere. «Se così non sarà, trarremmo
immediatamente le debite conseguenze ed eseguiremo la sentenza a cui Aldo Moro è
stato condannato». A mezzogiorno circa il testo del comunicato è sui tavoli di
tutte le segreterie di partito. A piazza del Gesù si decide di non tenere alcun
incontro. Nessuna riunione. Anche i socialisti sembrano perentori di fronte alle
richieste del comunicato Br. Quattro righe secche arrivano dalla segreteria
socialista di via del Corso: «La Direzione ha già espresso la sua opinione
contraria a uno scambio di prigionieri». Il presidente della Caritas
Internationalis, che i brigatisti non considerano attendibile interlocutore a
meno di un formale incarico a trattare da parte della Dc, e a cui lo stesso Moro
fa cenno nella sua lettera («proposta nobilissima») dichiara: «Il papa nel suo
appello agli uomini delle Br ha semplicemente chiesto la liberazione di Moro
senza condizioni. Noi siamo sulla stessa linea». I comunisti non rilasciano
alcuna dichiarazione ufficiale. Il partito è impegnato nella preparazione della
ricorrenza del 25 aprile. A Palazzo Chigi riunione del Comitato
Interministeriale per la Sicurezza, a conclusione del quale il governo dichiara
che «le richieste di scambio erano e sono inaccettabili? la valutazione del
governo è conforme a quella espressa dal Parlamento». Proprio alla Camera, il
presidente Ingrao aveva tolto la parola a Pannella che avrebbe voluto discutere
del comunicato brigatista. Monsignor Casaroli telefona ad Andreotti,
chiedendogli di inviargli per iscritto le considerazioni da lui svolte sui
limiti necessari all'azione del Papa rispetto allo Stato. A casa della famiglia
Moro sono convenuti tutti i collaboratori del presidente Dc, che continuano a
fare la spola tra piazza del Gesù e via del Forte Trionfale. Si discute se fare
una dichiarazione ulteriore dopo l'arrivo del comunicato n. 8 e della lettera di
Moro, ma si decide di aspettare. Freato e Rana, collaboratori di Moro, vanno a
Palazzo Chigi, dove invano tenteranno di parlare con Andreotti. Eleonora Moro,
dopo la dichiarazione del presidente della Caritas, si fa accompagnare in
automobile alla sede della Dc. A tarda sera, convergono nuovamente tutti a via
del Forte Trionfale. Lanfranco Caminiti
«Il mio sangue ricadrà su
di loro»,
scrive Lanfranco Caminiti il 9 set 2016 su "Il Dubbio". La lettera di Aldo Moro
dalla prigionia alla moglie Eleonora dell'8 aprile 1978 - «La faccia è salva, ma
domani gli onesti piangeranno per il crimine compiuto e soprattutto i
democristiani». "Mia carissima Noretta, anche se il contenuto della tua lettera
al Giorno non recasse motivi di speranza (né io pensavo che li avrebbe recati),
essa mi ha fatto un bene immenso, dandomi conferma nel mio dolore di un amore
che resta fermo in tutti voi e mi accompagna e mi accompagnerà per il mio
Calvario. A tutti dunque il ringraziamento più vivo, il bacio più sentito,
l'amore più grande. Mi dispiace, mia carissima, di essermi trovato a darti
questa aggiunta d'impegno e di sofferenza. Ma credo che anche tu, benché
sfiduciata, non mi avresti perdonato di non averti chiesto una cosa che è forse
un inutile atto di amore, ma è un atto di amore. Ed ora, pur in questi limiti,
dovrei darti qualche indicazione per quanto riguarda il tuo tenero compito. È
bene avere l'assistenza discreta di Rana e Guerzoni. Mi pare che siano rimasti
taciti i gruppi parlamentari, ed in essi i migliori amici, forse intimiditi dal
timore di rompere un fronte di autorità e di rigore. Ed invece bisogna avere il
coraggio di rompere questa unanimità fittizia, come tante volte è accaduto.
Quello che è stupefacente è che in pochi minuti il Governo abbia creduto di
valutare il significato e le implicazioni di un fatto di tanto rilievo ed abbia
elaborato in gran fretta e con superficialità una linea dura che non ha più
scalfito: si trattava in fondo di uno scambio di prigionieri come si pratica in
tutte le guerre (e questa in fondo lo è) con la esclusione dei prigionieri
liberati dal territorio nazionale. Applicare le norme del diritto comune non ha
senso. E poi questo rigore proprio in un Paese scombinato come l'Italia. La
faccia è salva, ma domani gli onesti piangeranno per il crimine compiuto e
soprattutto i democristiani. Ora mi pare che manchi specie la voce dei miei
amici. Converrebbe chiamare Cervone, Rosati, Dell'Andro e gli altri che Rana
conosce ed incitarli ad una dissociazione, ad una rottura dell'unità. È l'unica
cosa che i nostri capi temono. Del resto non si curano di niente. La
dissociazione dovrebbe essere pacata e ferma insieme. Essi non si rendono conto
quanti guai verranno dopo e che questo è il meglio, il minor male almeno. Tutto
questo andrebbe fatto presto, perché i tempi stringono. Degli incontri che
riuscirai ad avere, se riuscirai, sarà bene dare notizia con qualche
dichiarazione. Occorre del pubblico oltre che del privato. Su questo fatti
guidare da Guerzoni. Nel risvolto del Giorno ho visto con dolore ripreso dal
solito Zizola un riferimento dell'Osservatore Romano (Levi). In sostanza: no al
ricatto. Con ciò la S. Sede, espressa da questo Sig. Levi, e modificando
precedenti posizioni, smentisce tutta la sua tradizione umanitaria e condanna
oggi me, domani donne e bambini a cadere vittime per non consentire il ricatto.
È una cosa orribile, indegna della S. Sede. L'espulsione dallo Stato è praticata
in tanti casi, anche nell'Unione Sovietica, e non si vede perché qui dovrebbe
essere sostituita dalle stragi di Stato. Non so se Poletti può rettificare
questa enormità in contraddizione con altri modi di comportarsi della S. Sede.
Con queste tesi si avvalla il peggior rigore comunista ed a servizio
dell'unicità del comunismo. È incredibile a quale punto sia giunta la confusione
delle lingue. Naturalmente non posso non sottolineare la cattiveria di tutti i
democristiani che mi hanno voluto nolente ad una carica, che, se necessaria al
Partito, doveva essermi salvata accettando anche lo scambio dei prigionieri.
Sono convinto che sarebbe stata la cosa più saggia. Resta, pur in questo momento
supremo, la mia profonda amarezza personale. Non si è trovato nessuno che si
dissociasse? Bisognerebbe dire a Giovanni che significa attività politica.
Nessuno si è pentito di avermi spinto a questo passo che io chiaramente non
volevo? E Zaccagnini? Come può rimanere tranquillo al suo posto? E Cossiga che
non ha saputo immaginare nessuna difesa? Il mio sangue ricadrà su di loro. Ma
non è di questo che voglio parlare; ma di voi che amo e amerò sempre, della
gratitudine che vi debbo, della gioia indicibile che mi avete dato nella vita,
del piccolo che amavo guardare e cercherò di guardare fino all'ultimo. Avessi
almeno le vostre mani, le vostre foto, i vostri baci. I democratici cristiani (e
Levi dell'Osservatore) mi tolgono anche questo. Che male può venire da tutto
questo male? Ti abbraccio, ti stringo, carissima Noretta e tu fai lo stesso con
tutti e con il medesimo animo. Davvero Anna si è fatta vedere? Che Iddio la
benedica. Vi abbraccio. Aldo". Moro scrive il 7 aprile, dopo aver letto la
lettera della moglie Eleonora, pubblicata dal "Giorno". Scriveva Nora: «Tutti i
componenti della famiglia sono uniti e in salute. (...) Vorremmo sapesse che
gli siamo vicini (...), che, avendo nonostante tutto fiducia negli uomini,
crediamo sia ancora possibile, dopo tanto dolore, riabbracciarlo». Il giorno
dopo, "Il Popolo", quotidiano democristiano, ripubblica la lettera di Eleonora
Moro, con un commento in cui si dice che «a parte la rigorosa salvaguardia delle
prerogative dello Stato repubblicano, nessuna possibilità di restituire l'on.
Moro innanzitutto ai suoi cari può restare inesplorata». Anche Zaccagnini in un
intervento a "Tribuna Politica" di qualche giorno fa - era dal 16 marzo che non
appariva in pubblico - lascia filtrare la contraddittorietà dei suoi sentimenti.
Accenna al «dramma che stiamo vivendo, che sto vivendo» e allo sforzo di
«restituire al partito, e soprattutto alla famiglia, il nostro carissimo amico
Aldo Moro». Craxi si incontra con Cossiga e Galloni e li mette a parte dei suoi
tentativi, attraverso l'avvocato Guiso, di capire quali spazi reali di
intermediazione esistano. L'avvocato Guiso ha incontrato i brigatisti detenuti a
Torino, per il processo ai capi storici, secondo i quali è necessaria una
«risposta politica a quanto Moro sollecita». È l'8 aprile. Nel pomeriggio,
migliaia di donne partecipano alla manifestazione di Roma per l'aborto. Nelle
stesse ore le Br contattano il prof. Tritto, persona vicina ad Aldo Moro, perché
ritiri una busta - dentro c'è la lettera scritta da Moro alla moglie - ma la
telefonata è intercettata dalla polizia, che si precipita sul posto indicato -
piazza Augusto Imperatore - e sequestra tutto. Fotocopie della lettera di Moro
alla moglie gireranno presto nel Palazzo. Tritto viene fermato e interrogato a
lungo. Il tentativo di lasciare libere le comunicazioni tra Moro e la famiglia è
quindi negato. Le Br trovano immediatamente un altro canale. È padre Antonello
Mennini. Moro ha ormai scelto il terreno del dibattito pubblico, insiste anzi
per dare massima visibilità alle questioni che pone. Sollecita la moglie a
contattare il senatore Vittorio Cervone, il deputato Elio Rosati, l'allora
sottosegretario alla Giustizia Renato Dell'Andro, che erano tutti della corrente
"Amici di Moro". Come lo è anche Guerzoni, suo portavoce e giornalista Rai. Ma,
leggendo il "Giorno", è rimasto colpito da un articolo di Giancarlo Zizola,
vaticanista del quotidiano, che commentava l'opinione di don Virgilio Levi,
vicedirettore de "L'Osservatore Romano", dal titolo "L'ora della verità". L'on.
Taviani, a cui Moro aveva fatto riferimento nella sua lettera a Zaccagnini,
smentisce di aver mai discusso con il presidente democristiano del caso Sossi e
della necessità di essere flessibili di fronte a vicende del genere. L'on. Gui
invece conferma le parole di Moro.
«Carissima Noretta, sono
intatto e lucido ma non c'è tempo»,
scrive Lanfranco Caminiti l'8 set 2016 su "Il Dubbio". Al Senato vengono
discusse le norme antiterrorismo approvate per decreto. I socialisti sono
notevolmente critici e chiedono la «temporaneità» del provvedimento. Moro scrive
il suo testamento. "Mia Carissima Noretta, questi fogli che ti accludo sono
tutti, a loro modo, importanti e li dovrai leggere perciò con la dovuta
attenzione. Ma è questo quello più urgente ed importante, perché riguarda la mia
condizione che va facendosi sempre più precaria e difficile per l'irrigidimento
totale delle forze politiche ad un qualche inizio di discorso su scambi di
prigionieri politici, tra i quali sono anch'io. Non so se tu hai visto bene i
miei due messaggi (altrimenti li puoi chiedere subito a Guerzoni). È da quelli
che bisogna partire, per mettere in moto un movimento umanitario, oggi nelle
Camere assolutamente assente malgrado le loro tradizioni. Solo Saragat ed un po'
i socialisti hanno avuto qualche debole cenno a motivi umanitari. Degli altri
nessuno ed in ispecie la D. C. cui avevo scritto nella persona di Zaccagnini e
di altri esponenti: ricordando tra l'altro a Zaccagnini che egli mi volle (per i
suoi comodi) a questo odiato incarico, sottraendomi alle cure del piccolo che
presentivo di non dovere abbandonare. Son giunto a dirgli che egli moralmente
avrebbe dovuto essere al mio posto. La risposta è stata il nulla. Ora si tratta
di vedere che cosa ancora con la tua energia, in pubblico ed in privato, puoi
fare, perché se questo blocco non comincia a sgretolarsi un poco, ne va della
mia vita. E cioè di voi tutti, carissimi, e dell'amato piccolo. Sarebbe per me
una tragedia morire, abbandonandolo. Si può fare qualche cosa presso: Partiti
(specie D. C., la più debole e cattiva), i movimenti femminili e giovanili, i
movimenti culturali e religiosi. Bisogna vedere varie persone, specie Leone,
Zaccagnini, Galloni, Piccoli, Bartolomei, Fanfani, Andreotti (vorrà poco
impegnarsi) e Cossiga. Si può dire ad Ancora di lavorare con Berlinguer: i
comunisti sono stati durissimi, essendo essi in ballo la prima volta come
partito di governo. Il Vaticano va ancora sollecitato anche per le diverse
correnti interne, si deve chiedere che insista sul governo italiano. Tempi di
Pio XII che contendeva ai Tedeschi il giovane Prof. Vassalli, condannato a
morte. Si dovrà ritentare. E poi vedi tu nelle direzioni possibili con il meglio
di te. È un estremo tentativo. Tieni presente che nella maggior parte degli
Stati, quando vi sono ostaggi, si cede alla necessità e si adottano criteri
umanitari. Questi prigionieri scambiati vanno all'estero e quindi si realizza
una certa distensione. Che giova tenerli qui se non per un'astratta ragione di
giustizia, con seguiti penosi per tutti e senza che la sicurezza dello Stato sia
migliorata? Ma vedi tu se puoi coinvolgere rapidamente. La mia pena è Luca. Lo
amo e lo temo senza di me. Sarà il dolore più grande. Forse non si deve essere,
neppur poco felici. Ti abbraccio forte. Aldo". La lettera porta la data di
intestazione del 7 aprile, ma viene recapitata il 6. Moro è al corrente del
dibattito alla Camera e delle posizione espresse dai partiti - con evidenza, ha
modo di leggere ritagli dei quotidiani che gli passano i brigatisti. Non sa
invece - aveva chiesto che fossero riservate, ma i brigatisti le hanno inviate
ai giornali perché «niente deve essere nascosto al popolo» - che le sue lettere
a Cossiga e Zaccagnini sono ormai di dominio pubblico. Chiede alla moglie di
prenderne visione attraverso Corrado Guerzoni - suo portavoce e stretto
collaboratore - ma Eleonora, come tutti d'altronde, sa già benissimo cosa vi era
scritto. Moro comincia a rendersi conto dell'irrigidimento delle posizioni.
Cerca spazi di manovra. Dei fogli cui accenna alla moglie, benché lui stesso
consideri rilevante soprattutto la lettera, non c'è traccia. Oltre che i capi
del suo partito, suggerisce di contattare i comunisti e Berlinguer attraverso
Tullio Ancora, funzionario della Camera dei deputati, che era stato il tramite
della sua tessitura per il sostegno del Pci al nuovo governo di Andreotti. E di
ricordare al Vaticano, nei contatti da coltivare, come papa Pio XII fosse stato
capace di salvare Giuliano Vassalli, deputato socialista, professore
universitario e amico di Moro, quando da giovane membro della Resistenza era
stato catturato dai nazisti, detenuto e torturato a via Tasso. Il suo pensiero e
il suo rammarico - che ricorrerà spesso nelle lettere - è al piccolo nipote
Luca. Eleonora Moro decide di rispondere al marito attraverso un quotidiano,
forse il modo più sicuro per informarlo e per iniziare pubblicamente la sua
battaglia per salvarlo. Miriam Mafai su Repubblica analizza le reazioni operaie
al terrorismo in una città come Genova, che definisce «laboratorio per le Br».
Dopo aver registrato le risposte stereotipate di dirigenti provinciali e
sindacali di sinistra, racconta di un malessere diffuso tra gli operai e
soprattutto tra i portuali, ma anche di un'estesa indifferenza borghese. Non c'è
simpatia per le Br, ma neanche tanto affetto per lo Stato e la Dc. Giancarlo
Quaranta, leader del movimento Febbraio '74, - un'organizzazione della sinistra
giovanile cattolica che si propone di costruire «dal basso» un rapporto con i
comunisti e in cui milita Giovanni, il figlio di Moro - incontra Enrico
Berlinguer a Botteghe Oscure. Gli chiede di essere meno intransigente verso
un'ipotesi di trattativa, ma il segretario comunista è inflessibile. «Non
trattare è il modo migliore per salvare la vita di Moro», dirà. Intanto, il 5
aprile, sulla base della curiosa notizia della seduta medianica di Bologna è
stato ordinato di perquisire la località Gradoli, in provincia di Viterbo. Il 2
aprile un gruppo di amici bolognesi, stimati professori universitari legati da
parentele incrociate, riunito in una villa di campagna, per gioco aveva dato
inizio a una seduta medianica per la ricerca di Moro. Viene fuori, tra le altre,
la parola «Gradoli» che, sola, incuriosisce i presenti. È il professor Romano
Prodi, con numerosi conoscenti a Roma, a incaricarsi di trasmettere questa
curiosità. Così, viene effettuato un rastrellamento della zona. Nessun
riscontro. Non viene in mente che «Gradoli» possa essere un'indicazione stradale
e non geografica. Durissima intervista di Luciano Lama a Repubblica: «Quelli che
abbracciano la teoria "né con lo Stato né con le Br" non possono far parte della
Federazione sindacale unitaria; o se ne vanno o debbono essere messi fuori». Al
Senato vengono discusse le norme antiterrorismo approvate per decreto, che dovrà
essere ratificato dai due rami del Parlamento entro sessanta giorni. I
socialisti sembrano notevolmente critici e chiedono la «temporaneità» del
provvedimento. Moro scrive il suo testamento.
«Credetemi, non c'è più un
minuto da perdere»,
scrive Lanfranco Caminiti il 16 settembre 2016 su "Il Dubbio". Il 28 aprile il
presidente del Consiglio Andreotti pone il sigillo definitivo al rifiuto di
trattare con le Br. «Chi ha responsabilità di governo giura di rispettare e far
rispettare le leggi, questo è un limite che nessuno di noi ha il diritto di
valicare».
A Flaminio Piccoli: "Caro
Piccoli, mi rivolgo a te con la fiducia e l'affetto che sai. Sei tu ora, punto
di riferimento. E vedo il segno della tua presenza nel fatto che sia stato sin
qui evitato il peggio, la chiusura indiscriminata. Guardando agli aspetti
umanitari, che sono essenziali e valgono per tutti i Paesi, bisogna rapidamente
approfondire questa breccia. Andare avanti, cioè, nel concreto, senza illudersi
che invocazioni umanitarie possano avere il minimo effetto. Non dividete sul
sangue la D. C., non illudetevi di risolvere così i problemi del paese, date
fiducia, ora che si manifesta intero, all'umanitarismo socialista, anche se vi
fosse la sfida della crisi, la cui composizione del resto è stata così
faticosamente accettata. La crisi, per questo motivo che lascia allo scoperto i
comunisti, non ci sarebbe o almeno sarebbe risolvibile. Non lasciate allo
scoperto i vecchi amici che hanno dato fino all'ultimo. Sarebbe un fatto
obbrobrioso e immorale. Sarebbe un eroismo su basi fragilissime. Scusa queste
considerazioni che, soprattutto per la famiglia dovevo fare, ed abbiti i più
cordiali saluti. Aldo Moro".
A Riccardo Misasi: "Carissimo
Riccardo, un grande abbraccio e due parole per dirti che mi attendo, con
l'eloquenza ed il vigore che ti sono propri, una tua efficace battaglia a difesa
della vita, a difesa dei diritti umani, contro una gretta ragion di Stato. Tu
sai che gli argomenti del rigore, in certe situazioni politiche, non servono a
nulla. Si tratta di ben altro che dovremmo sforzarci di capire. Se prendi di
petto i legalisti, vincerai ancora una volta. Non illudetevi di invocazioni
umanitarie. Vorrei poi dirti che, se dovesse passarsi, come ci si augura, ad una
fase ulteriore, la tua autorità ed esperienza di Presidente della Commissione
Giustizia, dovrebbero essere, oltre che per le cose in generale che interessano,
preziose per alcuni temi specifici che tu certo intuisci. Grazie e tanti
affettuosi saluti. Aldo Moro".
A Tullio Ancora: "Caro Tullio,
un caro ricordo ed un caloroso abbraccio. Senza perdersi in tante cose
importanti, ma ovvie, concentrati in questo. Ricevo come premio dai comunisti
dopo la lunga marcia la condanna a morte. Non commento. Quel che dico, e che tu
dovresti sviluppare di urgenza e con il garbo che non ti manca, è che si può
ancora capire (ma male) un atteggiamento duro del PCI, ma non si capirebbe certo
che esso fosse legato al quadro politico generale la cui definizione è stata
così faticosamente raggiunta e che ora dovrebbe essere ridisegnato. Dicano, se
credono, che la loro è una posizione dura e intransigente e poi la lascino lì
come termine di riferimento. È tutto, ma è da fare e persuadere presto.
Affettuosamente. Aldo Moro".
A Giulio Andreotti: "Caro
Presidente, so bene che ormai il problema, nelle sue massime componenti, è nelle
tue mani e tu ne porti altissima responsabilità. Non sto a descriverti la mia
condizione e le mie prospettive. Posso solo dirti la mia certezza che questa
nuova fase politica, se comincia con un bagno di sangue e specie in
contraddizione con un chiaro orientamento umanitario dei socialisti, non è
apportatrice di bene né per il Paese né per il Governo. La lacerazione ne
resterà insanabile. Nessuna unità nella sequela delle azioni e reazioni sarà più
ricomponibile. Con ciò vorrei invitarti a realizzare quel che si ha da fare nel
poco tempo disponibile. Contare su un logoramento psicologico, perché son certo
che tu, nella tua intelligenza, lo escludi, sarebbe un drammatico errore. Quando
ho concorso alla tua designazione e l'ho tenuta malgrado alcune opposizioni,
speravo di darti un aiuto sostanzioso, onesto e sincero. Quel che posso fare,
nelle presenti circostanze, è di beneaugurare al tuo sforzo e seguirlo con
simpatia sulla base di una decisione che esprima il tuo spirito umanitario, il
tuo animo fraterno, il tuo rispetto per la mia disgraziata famiglia. Quanto ai
timori di crisi, a parte la significativa posizione socialista cui non manca di
guardare la D. C., è difficile pensare che il PCI voglia disperdere quello che
ha raccolto con tante forzature. Che Iddio ti illumini e ti benedica e ti faccia
tramite dell'unica cosa che conti per me, non la carriera cioè, ma la famiglia.
Grazie e cordialmente tuo Aldo Moro".
A Bettino Craxi: "Caro Craxi,
poiché ho colto, pur tra le notizie frammentarie che mi pervengono, una forte
sensibilità umanitaria del tuo Partito in questa dolorosa vicenda, sono qui a
scongiurarti di continuare ed anzi accentuare la tua importante iniziativa. È da
mettere in chiaro che non si tratta di inviti rivolti agli altri a compiere atti
di umanità, inviti del tutto inutili, ma di dar luogo con la dovuta urgenza ad
una seria ed equilibrata trattativa per lo scambio di prigionieri politici. Ho
l'impressione che questo o non si sia capito o si abbia l'aria di non capirlo.
La realtà è però questa, urgente, con un respiro minimo. Ogni ora che passa
potrebbe renderla vana ed allora io ti scongiuro di fare in ogni sede opportuna
tutto il possibile sull'unica direzione giusta che non è quella della
declamazione. Anche la D. C. sembra non capire. Ti sarei grato se glielo
spiegassi anche tu con l'urgenza che si richiede. Credi, non c'è un minuto da
perdere. E io spero che o al San Rafael o al Partito questo mio scritto ti
trovi. Mi pare tutto un po' assurdo, ma quello che conta non è spiegare, ma, se
si può fare qualcosa, di farlo. Grazie infinite ed affettuosi saluti Aldo Moro".
Il 25 aprile, trentatreesimo
anniversario della Liberazione, sindacati, Pci e Dc si sono impegnati in una
mobilitazione straordinaria. Dappertutto i comizi intrecciano l'anniversario
della Liberazione alla lotta contro il terrorismo. A Roma, alla manifestazione
indetta dal movimento e da Autonomia, ci sono state violentissime cariche della
polizia. Il segretario dell'Onu, Waldheim, interviene con un nuovo appello via
satellite, in cui chiede il rilascio di Moro: «Tale atto di pietà sarà ricevuto
con un senso di sollievo da tutto il mondo». Un portavoce delle Nazioni Unite
precisa che l'iniziativa di Waldheim è a titolo personale. Il 26 aprile
Zaccagnini si incontra con Craxi per capire quali siano in concreto le possibili
iniziative a cui il segretario socialista fa riferimento. Le indicazioni di
Craxi vertono sul riesame della situazione delle «carceri speciali» e su
provvedimenti di grazia a favore di alcuni detenuti brigatisti, per le loro
condizioni di salute. Dopo aver visto Craxi, Zaccagnini consulta telefonicamente
altri leader Dc ed esponenti della maggioranza. In serata, dopo una riunione a
piazza del Gesù, Piccoli dichiara: «La nostra linea rimane immutata». Il
vicesegretario socialista Signorile è intervistato dalla «Repubblica»: «Con
questo allucinante attendere la notizia dell'assassinio di Moro, con questo
immobilismo, non abbiamo sfruttato le "due linee" che chiaramente esistono
all'interno delle Br». Signorile, che nell'intervista ritorna sulla possibilità
di iniziative, ha incontrato Piperno e Pace, entrambi ex leader di Potere
Operaio, i quali hanno insistito sulla necessità di dare presto segnali di
concreta disponibilità. Fanfani fa visita a Eleonora Moro; un colloquio di circa
mezz'ora. Intanto si registrano reazioni durissime all'appello di Waldheim.
Viene considerato una sorta di «ufficializzazione» delle Br. Steve Pieczenik,
che ha fatto parte del gruppo di esperti del ministro degli Interni, rilascia
una dichiarazione dagli Stati Uniti, dove è tornato da poco: «Poiché l'obiettivo
evidente dei terroristi era ed è destabilizzare lo Stato italiano, è stato
estremamente importante rispondere facendo chiaramente comprendere che se
l'onorevole Moro è una figura essenziale della democrazia italiana, tuttavia
nessuno è indispensabile». Verso la Croce Rossa si era intanto mosso Cottafavi,
diplomatico e amico di Moro, da lui stesso sollecitato. Per il governo,
Andreotti fa sapere di essere decisamente contrario: l'intervento della Croce
Rossa significherebbe un «riconoscimento internazionale di parti belligeranti».
Il 28 aprile, a sera, conferenza stampa televisiva del presidente del Consiglio.
È il sigillo definitivo al rifiuto del governo a trattare con le Br. «Chi ha
responsabilità di governo giura di rispettare e far rispettare le leggi, questo
è un limite che nessuno di noi ha il diritto di valicare». Andreotti ha
aggiunto: «Lo Stato è qualcosa che sta al di sopra di noi». Lanfranco Caminiti
«Dite la verità: in Italia
lo scambio di prigionieri c'è sempre stato»,
scrive Lanfranco Caminiti il 16 set 2016 su "Il Dubbio". Le lettere di Aldo Moro
a Renato Dell'Andro ed Erminio Pennacchini.
"Carissimo Renato, in questo
momento così difficile, pur immaginando che tu abbia fatto tutto quello che la
coscienza e l'affetto ti suggerivano, desidero aggiungere delle brevi
considerazioni. Ne ho fatto cenno a Piccoli e a Pennacchini ed ora lo rifaccio a
te, che immagino con gli amici direttamente e discretamente presenti nei
dibattiti che si susseguono. La prima riguarda quella che può sembrare una
stranezza e non è e cioè lo scambio dei prigionieri politici. Invece essa è
avvenuta ripetutamente all'estero, ma anche in Italia. Tu forse già conosci
direttamente le vicende dei palestinesi all'epoca più oscura della guerra. Lo
scopo di stornare grave danno minacciato alle persone, ove essa fosse perdurata.
Nello spirito si fece ricorso allo stato di necessità. Il caso è analogo al
nostro, anche se la minaccia, in quel caso, pur serissima, era meno definita.
Non si può parlare di novità né di anomalia. La situazione era quella che è oggi
e conviene saperlo per non stupirsi. Io non penso che si debba fare, per ora,
una dichiarazione ufficiale, ma solo parlarne di qua e di là, intensamente però.
Ho scritto a Piccoli e a Pennacchini che è buon testimone. A parte tutte le
invenzioni che voi saprete fare, è utile mostrare una riserva che conduca, in
caso di esito negativo, al coagularsi di voti contrari come furono minacciati da
De Carolis e altri, Andreotti che (con il Pci) guida la linea dura, deve sapere
che corre gravi rischi. Valorizzare poi l'umanitarismo socialista, più
congeniale alla Dc e che ha sempre goduto, e specie in questa legislatura,
maggiori simpatie. Forza, Renato, crea, fai, impegnati con la consueta
accortezza. Te ne sarò tanto grato. Ti abbraccio. Aldo Moro."
"Carissimo Pennacchini, ho
avuto sempre grande stima di te, per tutto, ma soprattutto per la cristallina
onestà. È quindi naturale che in un momento drammatico mi rivolga a te per un
aiuto prezioso che consiste semplicemente nel dire la verità. Dirla, per ora,
ben chiara agli amici parlamentari ed a qualche portavoce qualificato
dell'opinione pubblica. Si vedrà poi se ufficializzarla. Si tratta della nota
vicenda dei palestinesi che ci angustiò per tanti anni e che tu, con il mio
modesto concorso, riuscisti a disinnescare. L'analogia, anzi l'eguaglianza con
il mio doloroso caso, sono evidenti. Semmai in quelle circostanze la minaccia
alla vita dei terzi estranei era meno evidente, meno avanzata. Ma il fatto c'era
e ad esso si è provveduto secondo le norme dello Stato di necessità, gestite con
somma delicatezza. Di fronte alla situazione di oggi non si può dire perciò che
essa sia del tutto nuova. Ha precedenti numerosi in Italia e fuori d'Italia ed
ha, del resto, evidenti ragioni che sono insite nell'ordinamento giuridico e
nella coscienza sociale del Paese. Del resto è chiaro che ai prigionieri
politici dell'altra parte viene assegnato un soggiorno obbligato in Stato Terzo.
Ecco, la tua obiettiva ed informata testimonianza, data ampiamente e con la
massima urgenza, dovrebbe togliere alla soluzione prospettata quel certo
carattere di anomalia che taluno tende ad attribuire ad essa. È un intermezzo di
guerra o guerriglia che sia, da valutare nel suo significato. Lascio alla tua
prudenza di stabilire quali altri protagonisti evocare. Vorrei che comunque
Giovannoni fosse su piazza. Ma importante è che tu sia lì, non a fare circolo,
ma a parlare serenamente secondo verità. Tra l'altro ricordi quando l'allarme ci
giunse in Belgio? Grazie per quanto dirai e farai secondo verità. La famiglia ed
io, in tanta parte, dipendiamo da te, dalla tua onestà e pacatezza.
Affettuosamente, Aldo Moro."
Moro ritorna sulla questione
dei palestinesi. Il riferimento è a una sorta di accordo segreto con l'Olp,
l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, guidata da Arafat, per
evitare che sul territorio italiano vi fossero atti di terrorismo. Vi furono
diversi episodi, ma forse il più importante accadde durante la guerra dello Yom
Kippur tra Egitto e Israele nel 1973. Due dei cinque palestinesi arrestati a
Ostia mentre preparavano a Fiumicino un attentato a un aereo delle linee
israeliane furono scarcerati e mandati in Libia. Il deputato
democristiano Erminio Pennacchini era dal dicembre 1977 presidente del Comitato
parlamentare di controllo sui servizi segreti, il cui vicepresidente era il
comunista Pecchioli.Renato Dell'Andro era stato sottosegretario al ministero di
Grazia e Giustizia con presidente del Consiglio Moro. Il colonnello Giovannone
era un ufficiale del Sismi, il Servizio segreto militare, responsabile per il
Medio Oriente. Moro era stato ministro degli Esteri dal 1969 al 1974, e in
questa veste aveva compiuto numerosi viaggi all'estero, in particolare nell'area
del Mediterraneo. Intanto, le lettere inviate da Moro nei giorni precedenti
hanno creato agitazione a piazza del Gesù; vari leader arrivano per incontrarsi
nello studio di Zaccagnini. Il Consiglio nazionale della Democrazia cristiana si
terrà tra una decina di giorni, non prima. È l'unica decisione. C'è inoltre da
preparare la campagna per le elezioni amministrative che si terranno tra due
settimane e coinvolgeranno almeno quattro milioni di elettori. Ai giornalisti
che lo aspettano, Andreotti, uscendo, dice: «Noi passiamo ogni sera solitamente
da Zaccagnini per vedere se ci sono novità e oggi non ce ne sono». «Non ci sono
elementi tali da spingere il Pci a convocare delle riunioni e a prendere nuove
decisioni dette e ribadite nelle precedenti», questa la dichiarazione
proveniente da Botteghe Oscure. Qui, Berlinguer ha incontratoTullio Ancora,
incaricato da Moro in una sua lettera, a cui ha ribadito le posizioni di
intransigente fermezza. D'altronde i comunisti sono impegnatissimi nella seduta
fiume in commissione Giustizia, presieduta da Misasi, per proseguire rapidamente
l'esame della nuova normativa sull'ordine pubblico, contro cui radicali e
missini applicano l'ostruzionismo. Il 30 aprile, Giuliano Vassalli, che guida il
gruppo di giuristi incaricato da Craxi, consegna al Quirinale al presidente
Leone il «documento di lavoro» socialista che specifica le linee generali su cui
lo Stato può autonomamente intervenire. Per le carceri speciali si suggerisce di
togliere i vetri blindati dai colloqui, di intensificare le ore di visita per i
familiari e di aumentare le ore d'aria per i detenuti. In riferimento alla
concessione della grazia o della libertà provvisoria per alcuni terroristi, che
non sono colpevoli di gravissimi reati, Vassalli ha con sé un elenco di nomi.
L'attenzione si circoscrive attorno ai nomi di Paola Besuschio, militante Br
della prima ora, e Alberto Buonoconto, napoletano dei Nap. Entrambi non godono
di buona salute. Nella direzione di colonna romana delle Br le perplessità di
Morucci e Faranda hanno preso consistenza. Moretti telefona a casa Moro. La
telefonata è lunga quindi rischiosa; oltre che «un puro scrupolo», suona come un
estremo tentativo di trovare una soluzione. La famiglia si sta battendo come può
per la trattativa, soprattutto con i democristiani. Moretti insiste: «Finora
avete fatto soltanto cose che non servono assolutamente a niente? quindi
chiediamo solo questo: che sia possibile l'intervento di Zaccagnini, immediato e
chiarificatore». Eleonora Moro e il figlio Giovanni si mettono immediatamente in
contatto con Zaccagnini, con Leone e riprendono il giro delle loro relazioni.
Rigoroso riserbo del Vaticano sulla vicenda Moro, soprattutto dopo la delusione
del presidente democristiano per quell'appello del Papa a liberarlo «senza
condizioni». Paolo VI oggi ha invitato tutti a tenere viva la speranza e a
invocare la Vergine.
Quella volta che Craxi mi
abbracciò e disse: «Lo dobbiamo salvare»,
scrive Fabrizio Cicchitto il 16 set 2016 su "Il Dubbio". Nell'iniziativa del
leader socialista c'era una visione garantista e la tutela del singolo individuo
anche di fronte alla ragion di Stato. Infatti solo nei confronti di Moro si
rifiutò la trattativa. La storia politica e personale di Aldo Moro è segnata da
elementi molto contraddittori, ma la contraddittorietà è nella storia politica
dell'Italia che è stata segnata dalla coesistenza di un vasto e forte
establishment istituzionale, politico, economico con tendenze eversive arrivate
fino alla pratica di un terrorismo del tutto ideologico. Aldo Moro - che con
Dossetti, La Pira, Fanfani fece parte di quella comunità politica che nella Dc
degli anni 40 più si impegnò nella stesura della Costituzione repubblicana - si
formò negli anni 30 nella Fuci, che aveva la supervisione di Mons. Montini. A
sua volta Fanfani si formò all'Università del Sacro Cuore. Infatti, negli anni
del fascismo, la Chiesa seguì una linea assai articolata. Per un verso realizzò
con Mussolini un compromesso, che diede largo spazio alle tendenze
clerico-fasciste, ma il Concordato del 1929 fu assai utile a entrambe le parti.
Nel contempo nella Fuci e nell'associazionismo cattolico veniva fatta maturare
una classe dirigente potenzialmente alternativa o sostitutiva. La formazione di
Aldo Moro fu giuridica ed etico-politica. Quella di Fanfani fu invece di
carattere economico e combinò insieme la dottrina corporativa fascista e le
nuove teorie provenienti dagli Usa (il cosiddetto volontarismo americano) che
costituivano il retroterra culturale del New Deal. Ma nei confronti del New Deal
l'attenzione di alcuni settori del fascismo fu più rilevante di quanto non si
racconti. Alle origini a guidare la "comunità del porcellino" c'era Giuseppe
Dossetti che però era portatore di una linea di "unità nazionale", di apertura
al Pci, non solo del tutto contraddittoria con quella degasperiana, ma anche con
la divisione internazionale del mondo e con gli orientamenti di Pio XII.
Dossetti ne prese atto e si ritirò dalla politica puntando sui tempi lunghi: lo
ritroveremo al Concilio Vaticano II come consigliere teologico del Card.
Lercaro. Nella Dc degli anni Sessanta-Settanta si affermarono Fanfani, Moro, i
dorotei, Giulio Andreotti. I due "cavalli di razza", per usare una battuta di
Carlo Donat Cattin, furono appunto Fanfani e Moro. Fanfani, dopo De Gasperi, fu
il più grande uomo di governo che la Dc abbia avuto: egli è stato un autentico
riformista, tant'è che il suo monocolore appoggiato dai socialisti fu il governo
più riformatore della fase del centro-sinistra. Se Fanfani fu il più grande uomo
di governo della Dc, fu però il suo peggior segretario, nel senso che non aveva
il senso della mediazione né all'interno, né all'esterno del partito, per cui
andò incontro a due scacchi, quello che portò alla sua defenestrazione da
segretario e alla sua sostituzione proprio con Aldo Moro in seguito alla
"congiura dei dorotei" (Rumor, Colombo, Bisaglia, Piccoli) e poi alla sconfitta
nel referendum sul divorzio. A sua volta Aldo Moro è stato di gran lunga il più
grande segretario della Dc, ma il peggiore fra i suoi presidenti del Consiglio.
Aldo Moro come segretario della Dc portò il suo partito, in entrambi i casi
assai riluttante, all'apertura nei confronti del Psi e poi nei confronti del
Pci, un'apertura che in entrambi i casi conservò l'egemonia della Dc tant'è che
prima il Psi di Nenni, poi il Pci di Berlinguer ne uscirono con le ossa rotte.
Per piegare Nenni e il Psi all'accettazione di una politica moderata, poco
riformista, il gruppo dirigente della Dc, nel 1964, non esitò ad usare anche "il
tintinnio delle sciabole" posto in essere da Antonio Segni, presidente della
Repubblica, e dal gen. De Lorenzo. Moro, però, fallì come presidente del
Consiglio: il governo Moro-Nenni durò dal 1964 al 1968 e segnò il
ridimensionamento dell'originario riformismo del centro-sinistra e fu preso
d'infilata e di sorpresa dal '68. A causa di questo immobilismo fallì
l'unificazione socialista e il Psi andò incontro ad una dura sconfitta politica.
Paradossalmente successivamente nella Dc proprio Aldo Moro fu il leader che in
modo culturalmente sofisticato aprì una riflessione sul '68, sui "giovani" e
sulle novità della società italiana. Poi di fronte ai risultati elettorali del
1976 nei quali al Pci non riuscì il sorpasso ma ottenne un grande risultato
(34,37%), la Dc si consolidò (con il 38,71%) mentre il Psi fu ridotto al 9,64%,
Moro elaborò la teoria dei "due vincitori" e la conseguente linea dell'unità
nazionale, nella quale, però, il Pci era ammesso o all'astensione e poi nella
maggioranza, non al governo. Nel contempo Moro non accettò nessuna delle
preclusioni del Pci sulla presenza al governo di questo o quell'esponente
democristiano. Il paradosso fu che nel giorno fatidico in cui Moro fu rapito, il
Pci, su spinta di Alessandro Natta, stava per decidere di astenersi sul governo
Andreotti rifiutando di entrare in maggioranza proprio perché molto contrariato
dalla composizione dell'esecutivo. Però di fronte alla situazione di emergenza
determinata dal rapimento di Moro e dall'uccisione della sua scorta, Berlinguer
tagliò corto e decise per il voto favorevole al governo. Sia la dottrina
berlingueriana del compromesso storico, sia la politica morotea dell'unità
nazionale di Aldo Moro non venivano visti favorevolmente né dagli Usa né
dall'Urss, perché entrambe queste strategie erano contraddittorie con la
rigidità e con il rigore della divisione del mondo in due blocchi. Far
discendere da ciò la conseguenza che il rapimento Moro fu un'operazione di
carattere internazionale - secondo alcuni di matrice Cia, secondo altri di
matrice Kgb con coinvolgimenti mafiosi o della 'ndrangheta - a mio avviso è una
ricostruzione forzata volta a giustificare l'estrema debolezza dello Stato
italiano di allora. Per di più tuttora componenti post-democristiane e
post-comuniste non vogliono accettare che lo Stato italiano fu allora messo in
scacco da un terrorismo fondamentalmente autoctono, derivante da un filone del
Pci. Il filone di Secchia, della volante rossa, di quei partigiani comunisti che
continuarono a sparare dopo il 25 aprile, almeno fino al 1947, e che furono
bloccati e messi fuorigioco da Togliatti, d'intesa con il Pcus: furono bloccati
ma riuscirono ad avere degli eredi. Che poi sia la Cia, sia il Kgb, di fronte
all'iniziativa delle Br per una fase abbiano girato la testa dall'altra parte,
ciò è possibile, ma non provato. Certamente le Br una connessione internazionale
l'avevano, ed era con alcuni nuclei palestinesi, i quali a loro volta in ultima
analisi avevano rapporti con il Kgb, ma le Br il Italia agirono in proprio.
Comunque di fronte al rapimento di Moro l'unico partito che nell'immediato reagì
in modo rapido e incisivo fu il Pci che, sapendo bene che tutta la linea delle
Br era volta a far saltare la sua strategia di fondo nelle fabbriche, nella
società e poi nello Stato adottò la linea durissima del rifiuto totale di ogni
trattativa. A sua volta, con la messa fuorigioco di Moro la Dc era totalmente
decerebralizzata, non aveva più un leader: Zaccagnini era così sconvolto che
politicamente non esistette più. A quel punto la linea del Pci fu fatta propria
da Andreotti per salvare il suo governo, da Cossiga, ministro degli Interni, per
una sua scelta ideologica (salvare lo Stato a tutti i costi), da Giovanni
Galloni (per salvare la politica di unità nazionale e il rapporto fra la Dc e il
Pci). Di conseguenza tutto era pronto perché Moro fosse santificato e
sacrificato come un martire in continuità con i caduti della Resistenza: allora
gli assassini erano le Brigate nere, adesso le Brigate rosse. Tutto sarebbe
funzionato alla perfezione se Moro si fosse sacrificato. Invece ciò non avvenne
e fra la stupefazione generale né Moro né la sua famiglia stettero al gioco.
Moro non accettò il ruolo di martire che il Pci e Andreotti-Cossiga-Galloni gli
avevano assegnato, anzi volle far di tutto per salvare la sua vita e cominciò ad
inviare le sue terribili, sconvolgenti lettere, scritte da una personalità che
era stata la quintessenza del sistema che adesso contestava alla radice perché
proprio quel sistema lo voleva morto in nome di sé stesso e della ragion di
Stato. Fu a quel punto che scattò l'azione politica e culturale di Bettino
Craxi. La scelta di Craxi per la trattativa avvenne per ragioni insieme
politiche e ideali. La ragione politica fu certamente quella di riconquistare
una spazio politico per un Psi che era stato annullato dall'intesa ferrea fra
Moro-Andreotti-Evangelisti-Berlinguer-Pecchioli-Di Giulio. Ma nell'iniziativa di
Craxi c'era anche ben altro, c'era una visione garantista e la tutela del
singolo individuo anche di fronte alla ragion di Stato. Infatti solo nei
confronti di Moro lo Stato italiano rifiutò la trattativa. Sia prima che dopo
l'Italia ha sempre trattato. Allora la Repubblica fu sul piano giornalistico la
"punta di lancia" più efficace per la fermezza e contro la trattativa ma
successivamente, alcuni anni dopo, quando un suo giornalista fu rapito anche la
Repubblica sostenne la teoria (e la conseguente prassi) dello scambio. Craxi
reagì a tutto ciò, recuperando tutto un filone garantista contro lo Stato etico.
Non ci fu un mero calcolo politico, Craxi si impegnò in quella linea proprio
come persona. Ricordo ancora un episodio: quando Craxi rese pubblica la
posizione favorevole alla trattativa del Psi, Moro gli inviò una lettera che per
alcune ore rimase segreta. Allora Craxi chiamò uno per uno gli esponenti del
gruppo dirigente socialista e separatamente a ognuno di essi fece leggere quel
testo. Fui chiamato anch'io: eravamo soli nella sua stanza, Craxi e il
sottoscritto; Bettino mi passò la lettera senza una parola, io la lessi, e ci
guardammo negli occhi. Allora Craxi mi disse «andiamo avanti, faremo di tutto
per salvargli la vita, noi non siamo come i comunisti», si alzò in piedi, mi
abbracciò e si commosse. Su suo mandato Landolfi e Signorile si misero in
movimento negli ambienti contigui alle Br. Le Brigate rosse si spaccarono
(Morucci e la Faranda ritennero che Moro vivo sarebbe stato dirompente per il
sistema) ma i marxisti-leninisti Moretti e Gallinari andarono avanti nella loro
linea omicida. L'ultimo Moro, quindi, come risulta dalle sue lettere, si ribellò
perché si sentì abbandonato e tradito proprio dalle forze politiche e dai
personaggi che aveva privilegiato nell'ultima fase della sua attività, cioè da
Andreotti, dall'area di sinistra della Dc e dal Pci berlingueriano. Moro è un
personaggio di grande spessore personale, culturale, politico e morale. A mio
avviso la sua morte ha decerebralizzato la Dc e conseguentemente anche tutto il
sistema politico della prima repubblica. A questo proposito basta un esempio
finale. Quando tanti anni dopo esplose Tangentopoli, Bettino Craxi prese la
parola alla Camera facendo i conti con le ragioni e le caratteristiche del
finanziamento irregolare della politica affermando che Tangentopoli era un
sistema che coinvolgeva tutto e tutti, imprese e partiti. La Dc di Andreotti, di
De Mita, di Gava, dello stesso Forlani non disse una parola, ritenendo che
isolando Craxi e consegnando i socialisti "ad bestias", cioè al circo
mediatico-giudiziario, a sua volta essa si sarebbe salvata: un calcolo mediocre
che segnò il suicidio della Dc. Ben altra fu anni prima, di fronte al caso
Lockheed (che fu il primo dei molti tentativi posti in essere da un settore
della magistratura e da una parte del Pci di distruggere i partiti moderati e
riformisti) la risposta di Aldo Moro. Egli si alzò alla Camera e con grande
determinazione disse «Non ci faremo processare nelle piazze». Ma fra Moro e
Fanfani (appunto i due cavalli di razza) e gli epigoni c'era un abisso. Non a
caso, appunto, nel '92-'94 la DC si lasciò massacrare senza combattere.
«Ma l'unica gioia che cerco
è ritrovare la mia cara famiglia»,
scrive Lanfranco Caminiti il 21 settembre 2016 su "Il Dubbio". Le lettere di
Aldo Moro a Giovanni Leone, Amintore Fanfani e Pietro Ingrao. Pietro Ingrao con
Giovanni Leone e Giulio Andreotti durante la messa funebre per la morte di Aldo
Moro il 13 maggio 1978.
"A Giovanni Leone, Presidente
della Repubblica Italiana. Faccio vivo appello, con profonda deferenza, al tuo
alto senso di umanità e di giustizia, affinché, d'accordo con il Governo, voglia
rendere possibile una equa e umanitaria trattativa per scambio di prigionieri
politici, la quale mi consenta di essere restituito alla famiglia, che ha grave
e urgente bisogno di me. Le tante forme di solidarietà sperimentate,
t'indirizzino per la strada giusta. Ti ringrazio profondamente e ti saluto con
viva cordialità. Aldo Moro".
"A Amintore Fanfani, Onorevole
Presidente del Senato, in questo momento estremamente difficile, ritengo mio
diritto e dovere, come membro del Parlamento italiano, di rivolgermi a Lei che
ne è, insieme con il Presidente della Camera, il supremo custode. Lo faccio
nello spirito di tanti anni di colleganza parlamentare, per scongiurarla di
adoperarsi, nei modi più opportuni, affinché sia avviata, con le adeguate
garanzie, un'equa trattativa umanitaria, che consenta di procedere ad uno
scambio di prigionieri politici ed a me di tornare in seno alla famiglia che ha
grave ed urgente bisogno di me. Lo spirito umanitario che anima il Parlamento
ebbe già a manifestarsi in sede di Costituente, alla quale anche in questo campo
ebbi a dare il mio contributo, e si è fatto visibile con l'abolizione della pena
di morte ed in molteplici leggi ed iniziative. D'altra parte non sfuggono alle
Assemblee né i problemi di sicurezza, che però possono essere adeguatamente
risolti, né la complessità del problema politico per il quale non sarebbero
sufficienti scelte semplici e riduttive. Al di là di questa problematica io
affido a Lei, signor Presidente, con fiducia ed affetto la mia persona, nella
speranza che tanti anni di stima, amicizia e collaborazione mi valgano un aiuto
decisivo, che ricostituisca il Plenum del Parlamento e che mi dia l'unica gioia
che cerco, il ricongiungimento con la mia amata famiglia. Con i più sinceri e
vivi ringraziamenti, voglia gradire i miei più deferenti saluti. Suo Aldo Moro".
"A Pietro Ingrao. Onorevole
Presidente della Camera, in questo momento estremamente difficile, ritengo mio
diritto e dovere, come membro del Parlamento italiano, di rivolgermi a Lei che
ne è, insieme con il Presidente del Senato, il supremo custode. Lo faccio nello
spirito di tanti anni di colleganza parlamentare, per scongiurarla di
adoperarsi, nei modi più opportuni, affinché sia avviata con le adeguate
garanzie, un'equa trattativa umanitaria, che consenta di procedere ad uno
scambio di prigionieri politici ed a me di tornare in seno alla famiglia che ha
grave ed urgente bisogno di me. Lo spirito umanitario che anima il Parlamento
ebbe già a manifestarsi in sede di Costituente, alla quale anche in questo campo
ebbi a dare il mio contributo, e si è fatto visibile con l'abolizione della pena
di morte ed in molteplici leggi ed iniziative. D'altra parte non sfuggono alle
Assemblee né i problemi di sicurezza, che possono però essere adeguatamente
risolti, né la complessità del problema politico per il quale non sarebbero
sufficienti scelte semplici e riduttive. Al di là di questa problematica io
affido a Lei, Signor Presidente, con fiducia ed affetto la mia persona, nella
speranza che tanti anni di stima, amicizia e collaborazione mi valgano un aiuto
decisivo che ricostituisca il Plenum del Parlamento e che mi dia l'unica gioia
che cerco, il ricongiungimento con la mia amata famiglia. Con i più sinceri e
vivi ringraziamenti, voglia gradire i miei più deferenti saluti. Suo Aldo Moro".
Grandi manifestazioni
sindacali per la ricorrenza del Primo Maggio, festa del lavoro. In tutti i
comizi la vicenda Moro assume centralità. Zaccagnini incontra Craxi in mattinata
e si riconvocano per l'indomani. Nel pomeriggio si reca a Botteghe Oscure per
vedere Berlinguer, che alla fine dell'incontro, dice: «Non vedo perché la
posizione della maggioranza e del governo dovrebbe venire modificata rispetto
all'ultimatum delle Br». Infine, il segretario democristiano convoca la
delegazione Dc nel suo studio, chiedendo anche la presenza di Andreotti. Intanto
Berlinguer e Natta vanno da Andreotti, a cui dicono di temere iniziative
destabilizzanti per il governo. Craxi, dopo aver visto Freato, tiene una
riunione con gli avvocati del suo comitato di giuristi. Considerando
impercorribile la richiesta brigatista del rilascio di tredici detenuti, crede
che «riducendo il numero acquista importanza la qualità». Questa «qualità» la
intravede in Paola Besuschio, detenuta brigatista che peraltro figura
nell'elenco del comunicato n. 8 delle Br. Le sue condizioni di salute la
configurano come «un caso veramente umanitario». Il 2 maggio, di mattina presto,
Craxi vede Andreotti al quale espone le sue proposte, che si concentrano sulla
liberazione della Besuschio. Teme sia la possibilità che Moro venga ucciso
presto sia un'eventuale reazione di vendetta. Propone di evitare qualsiasi
dibattito parlamentare e, più che mai, una votazione sulla trattativa. Considera
necessario evitare un gran clamore sulla stampa. A Craxi, Andreotti obietta che
la Besuschio ha altre condanne e chiede quale elemento di certezza vi sia in
merito al fatto che graziando lei le Br rilascino Moro. Poi, Craxi incontra
Berlinguer nel palazzo dove hanno sede i gruppi parlamentari. L'incontro è
gelido, e si rileva dalle dichiarazioni alla stampa di entrambi i leader: «Ci
siamo scambiati le nostre opinioni. Penso che ci incontreremo ancora. Quando?
Non lo so», dice Berlinguer. Anche Craxi è molto secco: «Non desidero fare
dichiarazioni. Dico soltanto che ci siamo scambiati delle opinioni». Berlinguer
telefona ad Andreotti. Nel tardo pomeriggio, a piazza del Gesù, l'incontro tra
la delegazione socialista e il vertice democristiano durerà fin quasi
mezzanotte. Zaccagnini ha intanto consultato socialdemocratici e repubblicani;
gli uni e gli altri hanno definito vaghe e approssimative le proposte
socialiste. Craxi illustra quella che continua a definire «una ipotesi in via
umanitaria», evitando ogni considerazione sulla trattativa. Ma la delegazione
democristiana respinge ogni possibilità al riguardo. Il 3 maggio, a piazza
Barberini, a Roma, Moretti, Balzerani e Seghetti si incontrano con Morucci e
Faranda. È un incontro pericoloso dal punto di vista della clandestinità e delle
regole di sicurezza, ma il dissenso dei due per un esito mortale del sequestro
Moro è consistente. Oltre ai ragionamenti politici, spendono una riluttanza a
eliminare un prigioniero, un argomento questo che non deve suonare del tutto
estraneo a chi con Moro sta condividendo minimi gesti di vita quotidiana. Ma
Moretti e gli altri sembrano determinati. Non solo l'esecutivo ha già deciso, ma
tutte le colonne sono state interpellate e il responso è univoco: il Tribunale
del Popolo ha stabilito una condanna. Il 4 maggio, l'Unità titola "Una via non
praticabile" un articolo in cui si criticano duramente le iniziative socialiste,
considerate dannose sotto il profilo giuridico e politico. Ogni ipotesi viene
valutata e respinta. L'articolo conclude chiedendosi se così non «si finisca col
recare grave nocumento sia alla causa del rigore costituzionale sia a quella
stessa della vita di Moro». Nella stessa prima pagina, un fondo, I santuari,
argomenta ancora la scelta della fermezza, ma soprattutto si chiede perché le
indagini non compiano passi avanti e si fermino quando «sulla loro strada
incontrano oscuri quanto protetti santuari forse ben più potenti
dell'organizzazione terrorista». La Dc comunica che il 9 maggio si terrà la
direzione del partito per convocare il Consiglio nazionale.
«Muoio, perché così ha
deciso il mio partito»,
scrive Lanfranco Caminiti il 22 settembre 2016 su "Il Dubbio". La lettera
disperata di Aldo Moro alla Democrazia Cristiana.
"Al Partito della Democrazia
Cristiana. Dopo la mia lettera comparsa in risposta ad alcune ambigue,
disorganiche, ma sostanzialmente negative posizioni della DC sul mio caso, non è
accaduto niente. Non che non ci fosse materia da discutere. Ce n'era tanta.
Mancava invece al Partito, al suo segretario, ai suoi esponenti il coraggio
civile di aprire un dibattito sul tema proposto che è quello della salvezza
della mia vita e delle condizioni per conseguirla in un quadro equilibrato. È
vero: io sono prigioniero e non sono in uno stato d'animo lieto. Ma non ho
subito nessuna coercizione, non sono drogato, scrivo con il mio stile per brutto
che sia, ho la mia solita calligrafia. Ma sono, si dice, un altro e non merito
di essere preso sul serio. Allora ai miei argomenti neppure si risponde. E se io
faccio l'onesta domanda che si riunisca la direzione o altro organo
costituzionale del partito, perché sono in gioco la vita di un uomo e la sorte
della sua famiglia, si continua invece in degradanti conciliaboli, che
significano paura del dibattito, paura della verità, paura di firmare col
proprio nome una condanna a morte. E devo dire che mi ha profondamente
rattristato (non avrei creduto possibile) il fatto che alcuni amici da Mons.
Zama, all'avv. Veronese, a G. B. Scaglia ed altri, senza né conoscere, né
immaginare la mia sofferenza, non disgiunta da lucidità e libertà di spirito,
abbiano dubitato dell'autenticità di quello che andavo sostenendo, come se io
scrivessi su dettatura delle Brigate Rosse. Perché questo avallo alla pretesa
mia non autenticità? Ma tra le Brigate Rosse e me non c'è la minima comunanza di
vedute. E non fa certo identità di vedute la circostanza che io abbia sostenuto
sin dall'inizio (e, come ho dimostrato, molti anni fa) che ritenevo accettabile,
come avviene in guerra, uno scambio di prigionieri politici. E tanto più quando,
non scambiando, taluno resta in grave sofferenza, ma vivo, l'altro viene ucciso.
In concreto lo scambio giova (ed è un punto che umilmente mi permetto sottoporre
al S. Padre) non solo a chi è dall'altra parte, ma anche a chi rischia
l'uccisione, alla parte non combattente, in sostanza all'uomo comune come me. Da
che cosa si può dedurre che lo Stato va in rovina, se, una volta tanto, un
innocente sopravvive e, a compenso, altra persona va, invece che in prigione, in
esilio? Il discorso è tutto qui. Su questa posizione, che condanna a morte tutti
i prigionieri delle Brigate Rosse (ed è prevedibile ce ne siano) è arroccato il
Governo, è arroccata caparbiamente la DC, sono arroccati in generale i partiti
con qualche riserva del Partito Socialista, riserva che è augurabile sia
chiarita d'urgenza e positivamente, dato che non c'è tempo da perdere. In una
situazione di questo genere, i socialisti potrebbero avere una funzione
decisiva. Ma quando? Guai, Caro Craxi, se una tua iniziativa fallisse. Vorrei
ora tornare un momento indietro con questo ragionamento che fila come filavano i
miei ragionamenti di un tempo. Bisogna pur ridire a questi ostinati immobilisti
della DC che in moltissimi casi scambi sono stati fatti in passato, ovunque, per
salvaguardare ostaggi, per salvare vittime innocenti. Ma è tempo di aggiungere
che, senza che almeno la DC lo ignorasse, anche la libertà (con l'espatrio) in
un numero discreto di casi è stata concessa a palestinesi, per parare la grave
minaccia di ritorsioni e rappresaglie capaci di arrecare danno rilevante alla
comunità. E, si noti, si trattava di minacce serie, temibili, ma non aventi il
grado d'immanenza di quelle che oggi ci occupano. Ma allora il principio era
stato accettato. La necessità di fare uno strappo alla regola della legalità
formale (in cambio c'era l'esilio) era stata riconosciuta. Ci sono testimonianze
ineccepibili, che permetterebbero di dire una parola chiarificatrice. E sia ben
chiaro che, provvedendo in tal modo, come la necessità comportava, non si
intendeva certo mancare di riguardo ai paesi amici interessati, i quali infatti
continuarono sempre nei loro amichevoli e fiduciosi rapporti. Tutte queste cose
dove e da chi sono state dette in seno alla DC? È nella DC dove non si
affrontano con coraggio i problemi. E, nel caso che mi riguarda, è la mia
condanna a morte, sostanzialmente avvallata dalla DC, la quale arroccata sui
suoi discutibili principi, nulla fa per evitare che un uomo, chiunque egli sia,
ma poi un suo esponente di prestigio, un militante fedele, sia condotto a morte.
Un uomo che aveva chiuso la sua carriera con la sincera rinuncia a presiedere il
governo, ed è stato letteralmente strappato da Zaccagnini (e dai suoi amici
tanto abilmente calcolatori) dal suo posto di pura riflessione e di studio, per
assumere l'equivoca veste di Presidente del Partito, per il quale non esisteva
un adeguato ufficio nel contesto di Piazza del Gesù. Sono più volte che chiedo a
Zaccagnini di collocarsi lui idealmente al posto ch'egli mi ha obbligato ad
occupare. Ma egli si limita a dare assicurazioni al Presidente del Consiglio che
tutto sarà fatto come egli desidera. E che dire dell'On. Piccoli, il quale ha
dichiarato, secondo quanto leggo da qualche parte, che se io mi trovassi al suo
posto (per così dire libero, comodo, a Piazza, ad esempio, del Gesù), direi le
cose che egli dice e non quelle che dico stando qui. Se la situazione non fosse
(e mi limito nel dire) così difficile, così drammatica quale essa è, vorrei ben
vedere che cosa direbbe al mio posto l'On. Piccoli. Per parte mia ho detto e
documentato che le cose che dico oggi le ho dette in passato in condizioni del
tutto oggettive. È possibile che non vi sia una riunione statutaria e formale,
quale che ne sia l'esito? Possibile che non vi siano dei coraggiosi che la
chiedono, come io la chiedo con piena lucidità di mente? Centinaia di
parlamentari volevano votare contro il Governo. Ed ora nessuno si pone un
problema di coscienza? E ciò con la comoda scusa che io sono un prigioniero. Si
deprecano i lager, ma come si tratta, civilmente, un prigioniero, che ha solo un
vincolo esterno, ma l'intelletto lucido? Chiedo a Craxi, se questo è giusto.
Chiedo al mio partito, ai tanti fedelissimi delle ore liete, se questo è
ammissibile. Se altre riunioni formali non le si vuol fare, ebbene io ho il
potere di convocare per data conveniente e urgente il Consiglio Nazionale avendo
per oggetto il tema circa i modi per rimuovere gli impedimenti del suo
Presidente. Così stabilendo, delego a presiederlo l'On. Riccardo Misasi. È noto
che i gravissimi problemi della mia famiglia sono la ragione fondamentale della
mia lotta contro la morte. In tanti anni e in tante vicende i desideri sono
caduti e lo spirito si è purificato. E, pur con le mie tante colpe, credo di
aver vissuto con generosità nascoste e delicate intenzioni. Muoio, se così
deciderà il mio partito, nella pienezza della mia fede cristiana e nell'amore
immenso per una famiglia esemplare che io adoro e spero di vigilare dall'alto
dei cieli. Proprio ieri ho letto la tenera lettera di amore di mia moglie, dei
miei figli, dell'amatissimo nipotino, dell'altro che non vedrò. La pietà di chi
mi recava la lettera ha escluso i contorni che dicevano la mia condanna, se non
avverrà il miracolo del ritorno della DC a se stessa e la sua assunzione di
responsabilità. Ma questo bagno di sangue non andrà bene né per Zaccagnini, né
per Andreotti, né per la DC, né per il paese. Ciascuno porterà la sua
responsabilità. Io non desidero intorno a me, lo ripeto, gli uomini del potere.
Voglio vicino a me coloro che mi hanno amato davvero e continueranno ad amarmi e
pregare per me. Se tutto questo è deciso, sia fatta la volontà di Dio. Ma nessun
responsabile si nasconda dietro l'adempimento di un presunto dovere. Le cose
saranno chiare, saranno chiare presto. ALDO MORO".
Monsignor Zama era vescovo di
Sorrento; l'avvocato Veronese, amico di vecchia data di Moro, era stato alla
guida delle Acli; il deputato democristiano Scaglia era stato nel 1968 ministro
dell'Istruzione. Con altri, avevano sottoscritto e pubblicato una lettera in cui
si affermava che «l'Aldo Moro che conosciamo non è presente nelle lettere a
Zaccagnini». È a loro che fa riferimento Moro, nella sua lettera al partito, a
proposito di chi ne mette in dubbio l'autenticità. È il 5 maggio. A Genova,
Milano, Torino e Roma viene fatto ritrovare il comunicato n. 9 delle Br: «La
battaglia iniziata il 16 marzo è arrivata alla sua conclusione». Il comunicato è
durissimo. La Dc viene indicata come responsabile del rifiuto della loro
proposta di scambio, mentre le iniziative dei socialisti vengono irrise come
«fumo negli occhi». Il nocciolo vero è la questione della liberazione dei
tredici detenuti. «Concludiamo quindi eseguendo la sentenza cui Aldo Moro è
stato condannato». È a quel gerundio che si aggrappano le opinioni di politici,
osservatori e giornalisti. Poco prima dell'arrivo del comunicato era finita la
riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza, con una dichiarazione
finale di non accettabilità delle proposte socialiste di atti di clemenza verso
alcuni detenuti e di modifica di alcune norme vigenti nelle carceri speciali. La
riunione, in realtà, oltre a fare il punto su indagini e iniziative, ha il senso
della prima valutazione strategica sul dopo-Moro. Il governo ritiene ormai
superata ogni possibilità «umanitaria» e, verificato il fronte maggioritario di
convergenza con comunisti e repubblicani, si prepara a gestire l'emergenza.
Immediate le riunioni dei partiti dopo l'arrivo del comunicato n. 9. A piazza
del Gesù sui volti di Zaccagnini e degli altri leader si legge la sensazione
dell'epilogo. È la stessa impressione che riporta Tatò, capo ufficio stampa e
uomo di fiducia di Berlinguer, venuto qui da Botteghe Oscure, dove ritorna.
Piccoli comunque dice che «il comunicato non ci appare completamente
conclusivo». Questa sospensione, questa attesa emergono dalla nota che viene
affidata al «Popolo», per essere pubblicata l'indomani: «Al di là del tono
ultimativo, questo comunicato non permette una valutazione conclusiva per ciò
che riguarda la vita di Aldo Moro». Claudio Vitalone, sostituto della procura
generale della Repubblica di Roma, incontra a Palazzo di Giustizia Daniele
Pifano, uno dei leader di via dei Volsci, collettivo dell'area di Autonomia
operaia. Interpellato in merito alla vicenda Moro, Pifano insiste per l'urgenza
di un intervento diretto del governo verso la liberazione di un detenuto e verso
il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri. Non ha alcun elemento
di certezza che l'iniziativa consenta automaticamente la liberazione di Moro, ma
è convinto che possa rappresentare qualcosa che smuova l'inerzia ineluttabile
degli eventi. È il 6 maggio. Eleonora Moro telefona a Fanfani. Ha già sentito il
presidente Leone che le ha garantito di stare «con la penna in mano» pronto a
firmare un provvedimento di grazia, purché il governo, tramite il ministro di
Grazia e Giustizia, gliene faccia richiesta. Tutto sembra avviarsi a
conclusione. Ormai pare esaurita la possibilità di muoversi all'interno delle
contraddizioni democristiane. Resta Fanfani. Il presidente del Senato si reca a
via del Forte Trionfale e assicura alla signora Moro che avrebbe preso delle
iniziative. Craxi non si rimprovera nulla. In un certo senso, l'attacco di cui è
fatto oggetto nell'ultimo comunicato Br rilegittima i suoi tentativi in termini
istituzionali. Non crede e con lui buona parte del partito che si sia arrivati
all'epilogo. Incontra Lanfranco Pace, ex leader di Potere Operaio, per un ultimo
tentativo. Questa volta ha bisogno di sapere con certezza che Moro sia vivo e
che un suo messaggio giunga a destinazione. A Lanfranco Pace affida la frase
«misura per misura»: se la si leggerà in una prossima comunicazione delle Br o
in un biglietto autografo di Moro, ci sarà ancora spazio per la trattativa. Pace
non può dare alcuna garanzia in merito, ma cercherà di riuscirci. Il socialista
Giuliano Vassalli, intanto, con la collaborazione di alcuni funzionari del
ministero di Grazia e Giustizia, ha fatto disporre il trasferimento in ospedale
di Alberto Buonoconto, uno dei detenuti su cui si è appuntata la valutazione di
un'alternativa alla liberazione dei tredici detenuti richiesti dalle Br.
Buonoconto, militante dei Nap, è affetto da gravi problemi motori e depressivi.
Fanfani è impegnato in provincia di Arezzo per la campagna elettorale. In un suo
comizio dirà che «apprezza lo spirito umanitario del recente atteggiamento del
Psi». Si inerpica anche su alcune considerazioni rispetto al quadro politico
della maggioranza e alla necessità di distinguere un'opposizione. È certo un
segnale debolissimo. Ma per gli esperti di linguaggio democristiano, Fanfani si
prepara a dar battaglia.
«Lascio in modo
irrevocabile la Dc»,
scrive Lanfranco Caminiti il 23 settembre 2016 su "Il Dubbio". La lettera di
Aldo Moro a Benigno Zaccagnini. "Caro Zaccagnini, ecco, sono qui per comunicarti
la decisione cui sono pervenuto nel corso di questa lunga e drammatica
esperienza ed è di lasciare in modo irrevocabile la Democrazia Cristiana. Sono
conseguentemente dimissionario dalle cariche di membro e presidente del
Consiglio Nazionale e di componente la Direzione Centrale del Partito. Escludo
ovviamente candidature di qualsiasi genere nel futuro. Sono deciso a chiedere al
Presidente della Camera, appena potrò, di trasferirmi dal Gruppo Parlamentare
della D. C. al Gruppo Misto. È naturale che aggiunga qualche parola di
spiegazione. Anzi le parole dovrebbero essere molte, data la complessità della
materia, ma io mi sforzerò di ridurle al minimo, cominciando, com'è ovvio, dalle
più semplici. Non avendo mai pensato, anche per la feroce avversione di tutti i
miei familiari, alla Presidenza della Repubblica, avevo immaginato all'inizio di
legislatura di completare quella in corso come un vecchio al quale qualche volta
si chiedono dei consigli e con il quale si ama fare un commento sulle cose, che
l'età ed il personale disinteresse rendono, forse, obiettivo. Come più volte ti
ho detto, fosti tu a deviare questo corso delle cose, mentre furono ancora tuoi
amici che fecero riserve, sempre nell'illusione che io dovessi dare ancora
qualche cosa al Partito, non appena si accennò ad una presidenza di Assemblea,
per concludere in tal modo la mia attività politica. Così mi sono trovato in un
posto difficile e ambiguo, che dava all'esterno la sensazione di un predominio
(inesistente) della D. C. ed all'interno creava imbarazzi, gelosie, equivoci,
timori. Essendoci lasciati in ottima intesa la sera del martedì, già pochi
giorni dopo, qui dove sono, avevo la sensazione di avervi in qualche modo
liberato e che io costituissi un peso per voi non per il fatto di non esserci,
ma piuttosto per il fatto di esserci. E questo per ragioni obiettive, perché non
c'è posto, accanto al Segretario Politico eletto dal Congresso, per un
Presidente del Partito che abbia rispetto di sé e delle cose. E se il vostro
profondo pensiero coincideva con quello che io avevo fatto valere, perché non
accontentarci tutti in una volta? Aggiungerò poi (e questo va al di là della
Presidenza del Consiglio Nazionale di cui abbiamo parlato sin qui) che io non ho
compreso e non ho approvato la vostra dura decisione, di non dar luogo a nessuna
trattativa umanitaria, anche limitata, nella situazione che si era venuta a
creare. L'ho detto cento volte e lo dirò ancora, perché non scrivo sotto
dettatura delle Brigate Rosse, che, anche se la lotta è estremamente dura, non
vengono meno mai, specie per un cristiano, quelle ragioni di rispetto delle
vittime innocenti ed anche, in alcuni casi, di antiche sofferenze, le quali,
opportunamente bilanciate e con il presidio di garanzie appropriate, possono
condurre appunto a soluzioni umane. Voi invece siete stati non umani, ma ferrei,
non attenti e prudenti, ma ciechi. Con l'idea di far valere una durissima legge,
dalla quale vi illudete di ottenere il miracoloso riassetto del Paese, ne avete
decisa fulmineamente l'applicazione, non ne avete pesato i pro e i contro,
l'avete tenuta ferma contro ogni ragionevole obiezione, vi siete differenziati,
voi cristiani, dalla maggior parte dei paesi del mondo, vi siete probabilmente
illusi che l'impresa sia più facile, meno politica, di quanto voi immaginate,
con il vostro irridente silenzio avete offeso la mia persona, e la mia famiglia,
con l'assoluta mancanza di decisioni legali degli organi di Partito avete
menomato la democrazia che è la nostra legge, irregimentando in modo osceno la
D. C., per farla incapace di dissenso, avete rotto con la tradizione più alta
della quale potessimo andar fieri. In una parola, l'ordine brutale partito
chissà da chi, ma eseguito con stupefacente uniformità dai Gruppi della D. C.,
ha rotto la solidarietà tra noi. In questa (cosa grossa, ricca di implicazioni)
io non posso assolutamente riconoscermi, rifiuto questo costume, questa
disciplina, ne pavento le conseguenze e concludo, semplicemente, che non sono
più democratico cristiano. Essendo scontata in ogni caso dal momento del mio
rapimento (e della vostra mistica inerzia) il mio abbandono della Direzione e
del Consiglio Nazionale, restava, se il vostro comportamento fosse stato diverso
e più costruttivo, la possibilità della mia permanenza senza alcun incarico
nella famiglia democratica cristiana e che è stata mia per trentatré anni. Oggi
questo è impossibile, perché mi avete messo in una condizione impossibile. E
perciò il mio ritiro da semplice socio della D. C. è altrettanto serio, rigido
ed irrevocabile quanto lo è il mio abbandono dalle cariche nelle quali avevamo
creduto di poter lavorare insieme. Tutto questo è finito, è assolutamente
finito. Ed ora che posso parlare, senza che nessuno pensi ad una pretesa di
successione, a parte il mio durissimo giudizio sul Presidente del Consiglio e su
tutti coloro che hanno gestito in modo assolutamente irresponsabile questa
crisi, c'è, per dovere di sincerità ed antica appannata amicizia, la valutazione
su di te, come, per così dire, il più fragile Segretario che abbia avuto la D.
C., incapace di guidare con senso di responsabilità il partito e di farsi
indietro quando si diventa consapevoli, al di là della propaganda, di questa
incapacità. Guidare e non essere guidato è il compito del Segretario del più
grande partito italiano. Giunti a questo punto, i motivi di dissenso, che non ci
faranno incontrare più, sono evidentemente molti. Tu non penserai che possa
trattarsi solo del modo chiuso e retrivo che ha caratterizzato il vostro
comportamento in questa vicenda, nella quale vi sembrerà di avere conseguito
chissà quale straordinario successo. Questa è una spia, la punta dell'iceberg,
ma il resto è sotto. Ho riflettuto molto in queste settimane. Si riflette
guardando facce nuove. La verità è che parliamo di rinnovamento e non rinnoviamo
niente. La verità è che ci illudiamo di essere originali e creativi e non lo
siamo. La verità è che pensiamo di fare evolvere la situazione con nuove
alleanze, ma siamo sempre là con il nostro vecchio modo di essere e di fare,
nell'illusione che, cambiati gli altri, l'insieme cambi e cambi anche il Paese,
come esso certamente chiede di cambiare. Ebbene, caro Segretario, non è così.
Perché qualche cosa cambi, dobbiamo cambiare anche noi. E, a parte il fatto che
davvero altri (socialisti ieri, comunisti oggi) siano in grado di realizzare una
svolta in accordo con noi il che possiamo augurarci e sperare la D. C. è ancora
una così gran parte del Paese, che nulla può cambiare, se anch'essa non cambia.
E per cambiare non intendo la moralizzazione, l'apertura del Partito, nuovi e
più aperti indirizzi politici. Si tratta di capire ciò che agita nel profondo la
nostra società, la rende inquieta, indocile, irrazionale, apparentemente
indominabile. Una società che non accetti di adattarsi a strategie altrui, ma ne
voglia una propria in un limpido disegno di giustizia, di eguaglianza, di
indipendenza, di autentico servizio dell'uomo. Ecco tutto. Benché sia
pessimista, io mi auguro che facciate più di quanto osi sperare. Non era questa
la conclusione cui avevo pensato né l'addio immaginato per te ed i colleghi. Ma
le cose sono così poco nelle nostre mani, specie se esse sono troppo deboli o
troppo forti. Che Iddio ti aiuti ed aiuti il Paese. Cordialmente. ALDO MORO". Il
7 maggio, Joseph Califano, uno dei più stretti collaboratori del presidente
americano Carter, incontra Andreotti manifestandogli «l'ammirazione del governo
degli Stati Uniti per l'atteggiamento di fermezza sulla questione Moro».
Zaccagnini, reduce da due comizi a Novara e Pavia, ritorna a Roma. Durante i
suoi interventi il segretario democristiano è parso attraversato da commozione
autentica. Ha spiegato: «Noi della Dc abbiamo dato una testimonianza sofferta
tra il sentimento che ci spingerebbe a compiere certi atti e il senso dello
Stato». La delegazione Dc, pur impegnata nella campagna elettorale, ha deciso di
non lasciare sguarnita la sede centrale. Tutti i leader vi rientrano. Anche
Berlinguer tiene un comizio, a Viterbo. La lotta all'estremismo e l'impegno a
mantenere salda questa maggioranza sono i temi centrali della sua
argomentazione. Fortemente polemico contro ogni ipotesi di trattativa con la
«banda di assassini delle Br», Berlinguer motiva la sua intransigenza: «Ogni
patteggiamento significherebbe un'offesa ai caduti delle forze dell'ordine, alle
altre vittime, alle loro famiglie ogni cedimento renderebbe impossibile chiedere
alle forze dell'ordine di continuare a compiere il loro dovere». Il segretario
comunista ha rivendicato al suo partito di aver guidato il fronte della
fermezza. Craxi rilascia una dichiarazione: «I socialisti non possono associarsi
al trionfalismo dei salvatori della Repubblica. La morte di Moro sarebbe una
sconfitta». Il procuratore di Roma, Pascalino, rilascia una dichiarazione in cui
sostiene che «anche a chi non fa parte delle Br, ma ne condivide l'ideologia, ad
esempio l'attentato alle istituzioni democratiche, possono essere contestati i
reati di cospirazione politica e di banda armata». Si tratta, a suo avviso, di
colpire l'area di consenso all'eversione. L'8 maggio, i legali di Alberto
Buonoconto, detenuto dei Nap con gravi problemi di salute, presentano richiesta
di libertà provvisoria per il loro assistito. Qualcuno dal ministero di Grazia e
Giustizia sollecita il presidente della corte di Appello di Napoli a prendere
rapidamente in esame la questione. Di questa iniziativa, riconducibile alle
pressioni della famiglia Moro sui socialisti, sul ministro della Giustizia, sul
presidente Leone, e finora quasi sottaciuta, vengono presto a conoscenza
Zaccagnini, Cossiga e Andreotti. Per loro si tratta ora di capire quali
intenzioni reali abbia Fanfani, da sempre decisamente contrario alla maggioranza
attuale. Il presidente del Senato si è ormai deciso a utilizzare l'incontro
dell'indomani a piazza del Gesù per esprimere compiutamente il suo punto di
vista. Facendo leva su una critica di inefficienza al ministro degli Interni,
circoscriverà la sua proposta: provvedimento di grazia firmato da Leone. In
serata, Craxi e Fanfani si incontrano. Un asse politico sulla trattativa sembra
adesso delinearsi e prendere consistenza. Giovanni Spadolini, per i
repubblicani, scrive un articolo di critica contro la decisione del governo di
far ispezionare le carceri di massima sicurezza ad Amnesty International. È
contrario anche alla convocazione del Consiglio nazionale della Dc («richiesta
contenuta in una delle lettere attribuite all'on. Moro»). Aldo Moro esprime ai
brigatisti che lo detengono il desiderio che la moglie sia la prima a essere
informata della sua morte, da loro e non da altri. Una Renault 4 rossa, rubata
giorni addietro, viene portata nel box del garage di via Montalcini,
l'appartamento che è stata la prigione di Moro per tutti i giorni del sequestro.
L'addio alla dolcissima
Noretta. Poi nove colpi al cuore,
scrive Lanfranco Caminiti il 24 settembre 2016 su "Il Dubbio". "A Eleonora Moro.
Tutto sia calmo. Le sole reazioni polemiche contro la Dc. Luca no al funerale.
Mia dolcissima Noretta, dopo un momento di esilissimo ottimismo, dovuto forse ad
un mio equivoco circa quel che mi si veniva dicendo, siamo ormai, credo, al
momento conclusivo. Non mi pare il caso di discutere della cosa in sé e
dell'incredibilità di una sanzione che cade sulla mia mitezza e la mia
moderazione. Certo ho sbagliato, a fin di bene, nel definire l'indirizzo della
mia vita. Ma ormai non si può cambiare. Resta solo di riconoscere che tu avevi
ragione. Si può solo dire che forse saremmo stati in altro modo puniti, noi e i
nostri piccoli. Vorrei restasse ben chiara la piena responsabilità della D. C.
con il suo assurdo ed incredibile comportamento. Essa va detta con fermezza così
come si deve rifiutare eventuale medaglia che si suole dare in questo caso. È
poi vero che moltissimi amici (ma non ne so i nomi) o ingannati dall'idea che il
parlare mi danneggiasse o preoccupati delle loro personali posizioni, non si
sono mossi come avrebbero dovuto. Cento sole firme raccolte avrebbero costretto
a trattare. E questo è tutto per il passato. Per il futuro c'è in questo momento
una tenerezza infinita per voi, il ricordo di tutti e di ciascuno, un amore
grande grande carico di ricordi apparentemente insignificanti e in realtà
preziosi. Uniti nel mio ricordo vivete insieme. Mi parrà di essere tra voi. Per
carità, vivete in una unica casa, anche Emma se è possibile e fate ricorso ai
buoni e cari amici, che ringrazierai tanto, per le vostre esigenze. Bacia e
carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A
ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia
dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore.
Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto ed a te e tutti un
caldissimo abbraccio pegno di un amore eterno. Vorrei capire, con i miei piccoli
occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo.
Amore mio, sentimi sempre con te e tienimi stretto. Bacia e carezza Fida, Demi,
Luca (tanto tanto Luca), Anna, Mario, il piccolo non nato, Agnes, e Giovanni.
Sono tanto grato per quello che hanno fatto. Tutto è inutile, quando non si
vuole aprire la porta. Il Papa ha fatto pochino: forse ne avrà scrupolo..."
"A Eleonora Moro. Ora,
improvvisamente, quando si profilava qualche esile speranza, giunge
incomprensibilmente l'ordine di esecuzione. Noretta dolcissima, sono nelle mani
di Dio e tue. Prega per me, ricordami soavemente. Carezza i piccoli dolcissimi,
tutti. Che Iddio vi aiuti tutti. Un bacio di amore a tutti. ALDO".
È il 9 maggio 1978. Sui
quotidiani l'attenzione è tutta rivolta alla riunione della direzione
democristiana, prevista in mattinata, e, in particolare, a quello che si presume
possa dire Fanfani. «I riflettori sono puntati su piazza del Gesù» scrive il
«Corriere della Sera». I legali di Alberto Buonoconto, detenuto dei Nap con
gravi problemi di salute, hanno presentato richiesta di libertà provvisoria per
il loro assistito. Qualcuno dal ministero di Grazia e Giustizia ha sollecitato
il presidente della corte di Appello di Napoli a prendere rapidamente in esame
la questione. Di questa iniziativa, riconducibile alle pressioni della famiglia
Moro sui socialisti, sul ministro della Giustizia, sul presidente Leone, e
finora quasi sottaciuta, vengono presto a conoscenza Zaccagnini, Cossiga e
Andreotti. Per loro si tratta ora di capire quali intenzioni reali abbia
Fanfani, da sempre decisamente contrario alla maggioranza attuale. Fanfani, per
parte sua, si è schierato più apertamente «nel rispetto della Costituzione e
delle leggi in difesa della vita e della libertà di Aldo Moro». Il presidente
del Senato si è ormai deciso a utilizzare l'incontro di oggi a piazza del Gesù
per esprimere compiutamente il suo punto di vista. Facendo leva su una critica
di inefficienza al ministro degli Interni, circoscriverà la sua proposta:
provvedimento di grazia firmato da Leone. Ieri, in serata, Craxi e Fanfani si
sono incontrati. Un asse politico sulla trattativa sembra adesso delinearsi e
prendere consistenza. Ma la situazione sembra comunque blindata. Zaccagnini è
tornato dal giro elettorale più convinto che mai di avere scelto la strada
giusta. Piccoli è al suo fianco. Galloni nega ogni possibilità di trattativa.
Granelli e Cossiga ripetono che sarà fatto tutto il possibile per salvare Moro,
ma «senza aprire la via a cedimenti». Anche «la Repubblica» titola su Fanfani e
si interroga «sui riflessi che probabilmente ci saranno nella direzione
democristiana». Tuttavia, continua il quotidiano di Scalfari, «non pare che la
sortita fanfaniana possa modificare gli equilibri attuali». «l'Unità» riporta
tutte le dichiarazioni di esponenti democristiani che si addensano attorno la
frase «la posizione della Dc rimane precisa e continua». Il quotidiano comunista
dà risalto alle parole di Manca, esponente socialista, critico verso la
segreteria di Craxi, e a quelle di La Malfa che ribadiscono l'esigenza di
fermezza. I brigatisti Moretti e Gallinari riconsegnano a Moro i suoi vestiti e
i suoi oggetti personali. Il presidente democristiano ha indossato finora una
tuta da ginnastica. Nell'appartamento di via Montalcini sono presenti anche la
Braghetti, che ha preparato i pasti del prigioniero, e Maccari, che figurava
come proprietario. Durante i lunghi giorni del sequestro, Moro è dimagrito. Gli
viene detto di prepararsi perché bisogna andare. Scendono nel box del garage. È
buio. Qualcuno di loro controlla le scale perché non arrivi nessuno
all'improvviso. Moro viene fatto sdraiare nel bagagliaio posteriore della
Renault4 rossa. Si rannicchia, lo spazio è angusto. Si sparano nove colpi
ravvicinati al cuore. La sentenza è stata eseguita. L'automobile inizia il suo
percorso verso via Caetani. Morucci è alla stazione Termini. La piazza è
gremita, come sempre. È mezzogiorno. Tocca a lui telefonare per avvisare la
famiglia su dove ritrovare il corpo. Moro aveva espresso il desiderio che la
moglie fosse la prima a essere informata della sua morte. Morucci chiama uno dei
contatti che ha già utilizzato per recapitare le lettere. È un assistente
universitario di Moro. «Pronto? È il professor Franco Tritto?». «Chi parla?».
«Brigate rosse».
Leone mi raccontò perché
non riuscì a salvare Moro,
scrive Francesco Damato il 24 settembre 2016 su "Il Dubbio". Molto si è scritto
e si è detto, o si è più semplicemente insinuato, su cosa consistesse quello
spiraglio avvertito da Aldo Moro negli ultimi giorni di vita, nel covo
brigatista in cui era rinchiuso, scrivendo alla moglie per rivelarle che tutto
si era improvvisamente chiuso. Come in effetti si chiuse perché il 9 maggio del
1978, di prima mattina, egli fu ucciso dai suoi aguzzini nel bagagliaio di
un'auto poi parcheggiata in via Caetani, a poca distanza dalle sedi nazionali
del Pci e della Dc, ma soprattutto della Dc. La cui direzione nazionale era
stata convocata proprio per quella mattina per una discussione importante. Alla
quale il presidente del Senato Amintore Fanfani si era impegnato con Bettino
Craxi, in un incontro organizzato nell'abitazione di Ettore Bernabei, a
pronunciare un discorso che fornisse una copertura politica all'allora capo
dello Stato Giovanni Leone. Che era pronto a concedere la grazia a Paola
Besuschio, compresa fra i tredici "prigionieri", cioè detenuti per reati di
terrorismo, con cui le brigate rosse avevano chiesto di scambiare il loro
ostaggio. Mi convinsi che fosse proprio la grazia alla Besuschio quello
spiraglio avvertito da Moro quando nel 1998, intervistando per Il Foglio proprio
Leone in occasione del ventesimo anniversario del sequestro dello statista
democristiano, mi sentii raccontare la storia di quell'atto di clemenza e ne
raccolsi gli atroci dubbi rimastigli nel cuore, oltre che nella mente, per la
gestione di quel maledetto affare. Dubbi mai manifestati prima perché poche
settimane dopo la morte di Moro il povero Leone fu costretto dai due maggiori
partiti a dimettersi con ragioni o pretesti vari ch'egli avvertì, forse non a
torto, come intimidazioni. Sarebbero arrivate solo molti anni dopo le scuse dei
radicali per la campagna scandalistica contro Leone alimentata da un libro di
Camilla Cederna, poi condannata in tribunale, e cavalcata dal pur garantista
partito di Marco Pannella. Molti anni dopo sarebbe arrivata anche la
riabilitazione di Leone, per fortuna quando lui era ancora vivo, da parte dei
comunisti. Che nel 1978, convincendo anche la Dc, avevano reclamato la fine
anticipata, sia pure di soli sei mesi, del mandato del presidente della
Repubblica come "segnale" di svolta morale nel Paese dopo un referendum
abrogativo del finanziamento pubblico in cui i partiti avevano rasentato la
sconfitta cominciando a sentirsi poco popolari. Le umane resistenze di Leone a
quella defenestrazione, comunicatagli dal comunista ed amico Gerardo Chiaromonte
con "la morte nel cuore", erano state inutili. Si era addirittura arrivati al
rifiuto dell'Ansa, su imput del governo, di pubblicare una circostanziata
autodifesa del presidente dalle accuse infamanti che gli erano state rivolte in
una campagna di stampa che non si era arrestata, forse non a caso, come vedremo,
durante i 55 terribili giorni del sequestro di Moro.
L'ottimo Lanfranco Caminiti ha
già ricordato, commentando le lettere scritte da Moro ai presidenti della
Repubblica e delle Camere, passaggi importanti dell'affare Besuschio, che mi
hanno fatto tornare alla mente quel giorno in cui, dietro appuntamento, andai a
trovare Leone nella sua casa alle Rughe. Lo trovai alle prese con un grosso
fascicolo, nel quale aveva messo le pagine del suo diario, o qualcosa di simile,
riguardanti proprio i giorni del sequestro di Moro. Ci sentiva poco, il povero
Leone, e la nostra conversazione fu aiutata più volte dalla moglie Vittoria, che
alla fine dell'incontro, accompagnandomi all'uscita, mi chiese la disponibilità
ad aiutare i figli a mettere in ordine le carte del marito. Io ebbi il torto,
che non mi sono mai perdonato, di far cadere l'offerta. Quelle carte sono
comunque finite e conservate, spero integre rispetto all'impressione che ne ebbi
quel giorno, negli archivi del Senato. Comunque gran parte del racconto
dell'affare Besuschio fattomi da Leone comparve nell'intervista al Foglio, della
quale - una volta pubblicata - egli volle gentilmente ringraziarmi definendola
"formidabile". E che risulta fra i documenti sui quali ha lavorato e lavora
tuttora l'ultima commissione parlamentare d'inchiesta, in ordine di tempo, sulla
vicenda Moro. Commissione presieduta dall'ex ministro della Pubblica Istruzione
Giuseppe Fioroni. Se ne trova traccia anche nella relazione sul primo anno di
lavoro dei commissari. Leone cominciò rivelandomi che già poche ore dopo il
sequestro di Moro, viste le note di agenzia e i comunicati che anticipavano la
cosiddetta linea della fermezza concordata fra la Dc e il Pci, e fatta propria
dal governo, egli convocò al Quirinale il segretario democristiano Benigno
Zaccagnini. Col quale non si parlava dal giorno della propria elezione a
presidente della Repubblica, alla fine del 1971, quando lo stesso Zaccagnini,
non ancora alla guida del partito, si era pubblicamente doluto del concorso
determinante dei missini alla sua ascesa al Quirinale, credendo alla loro
versione piuttosto che alle smentite opposte dal capo dello Stato in una lettera
al direttore del quotidiano ufficiale dello scudo crociato. Leone disse
francamente a Zaccagnini di non condividere la linea della fermezza, convinto
che la difesa della vita di Moro dovesse prevalere su tutto. L'ospite ne prese
atto ma non cambiò idea. Da allora curiosamente Leone si sentì isolato. Ogni
tanto gli telefonavano il presidente del Consiglio Giulio Andreotti e il
ministro dell'Interno Francesco Cossiga per assicurargli che si stesse facendo
tutto il possibile per liberare Moro. I servizi segreti smisero di mandargli le
segnalazioni quotidiane, e naturalmente riservatissime, inoltrate al governo.
Dopo il comunicato col quale le brigate rosse avevano reclamato lo scambio di
Moro con 13 detenuti per reati di terrorismo, Leone fu contattato dall'amico
avvocato Giuliano Vassalli, socialista, e dal consigliere di Stato Giuseppe
Manzari, amico e già capo di Gabinetto di Moro alla Presidenza del Consiglio dal
1963 al 1968. Con loro e con l'allora ministro della Giustizia Francesco Paolo
Bonifacio, già giudice e presidente della Corte Costituzionale, Leone spulciò
una per una le posizioni dei 13 detenuti indicati dalle brigate rosse. Le
spulciò con la perizia di avvocato e di giurista, ai cui testi generazioni di
studenti hanno attinto nei loro corsi di laurea. L'attenzione alla fine si fermò
sulla Besuschio, condannata in via definitiva per reati di terrorismo ma non di
sangue e ammalata. Era l'unica, secondo lui, nelle condizioni giuridiche e umane
di essere graziata con un provvedimento utile anche a cercare di smuovere i
terroristi dalla loro intransigenza con quell'elenco così lungo e provocatorio
per lo scambio. E si decise di avviare le procedure.
Chiesi a quel punto a Leone -
sapendo anche di una testimonianza resa da Bonifacio alla prima commissione
parlamentare d'inchiesta sulla vicenda Moro in cui aveva escluso che fosse stato
predisposto un provvedimento di grazia per la Besuschio - se davvero il ministro
della Giustizia fosse d'accordo, vista la posizione di Andreotti e del governo
contro ogni cedimento alla linea della fermezza. Lui mi zittì dicendomi,
testualmente: "Bonifacio era stato un mio allievo. Mi era devoto. Faceva quello
che io gli dicevo". Il tono fu così perentorio, accompagnato da gesti
inconfondibili, che non osai ribattere. E gli lasciai continuare il racconto. La
prima cosa da fare, secondo la disciplina allora esistente in materia di grazia,
era rintracciare la Besuschio e farle chiedere l'atto di clemenza. Sembrerà
curioso o impossibile, ma per un paio di giorni Leone non riuscì a sapere dove
la detenuta fosse rinchiusa. Alla fine se ne conobbe la condizione di ricoverata
in un ospedale, dove fu mandato un ufficiale in borghese dei Carabinieri per
proporle di firmare la domanda di grazia. Ma, o perché convinta di suo o perché
raggiunta precedentemente da ordini superiori dei suoi compagni di lotta, la
donna rifiutò. Mi risulta da Internet che, nata a Verona 67 anni fa, la signora
sia ancora viva. Basterebbe forse rintracciarla e cercare di farla parlare per
saperne di più, e meglio. In mancanza di una domanda di grazia Bonifacio ritenne
che non si potesse andare oltre. Ma Leone lo sorprese dicendo di essere pronto
ad innovare procedura e prassi per concedere la grazia lo stesso, di sua
iniziativa. Pertanto dispose di procedere chiedendo soltanto di avere un minimo
di copertura politica. Il segretario socialista Bettino Craxi, contattato da
Vassalli, garantì subito e volentieri la sua disponibilità, avendo pubblicamente
contestato la linea della fermezza, almeno per come era stata gestita sino ad
allora. E fu lo stesso Craxi, falliti gli altri tentativi riferiti da Caminiti
ai lettori del Dubbio, a contattare l'allora presidente del Senato Fanfani per
avere un aiuto, che gli fu promesso nell'incontro già ricordato nell'abitazione
di Ettore Bernabei. Tutto era quindi pronto quel 9 maggio, giorno della riunione
della direzione democristiana, per chiudere la vicenda: Leone pronto a firmare,
Fanfani pronto a sostenerne l'iniziativa presa autonomamente. Ma i terroristi,
con una "tempestività" che angosciò Leone fino alla morte, precedettero tutti
ammazzando Moro. E risparmiandosi l'incomodo, diciamo così, di ridiscutere
l'epilogo del sequestro di fronte al fatto nuovo che sarebbe stato il
provvedimento di grazia alla loro compagna di lotta. Fu una tempestività casuale
o di che altro tipo? E di che origine? Carceraria, politica, burocratica? Sono
le domande che il povero Leone si è portato anche nella tomba e che lasciano
insoluto forse il più decisivo dei tanti misteri del caso Moro. E' improbabile
che gli autori superstiti del sequestro, di cui è stata lamentata più volte, e
giustamente, nonostante i tanti libri, le tante deposizioni, le tante interviste
rilasciate, una ostinata reticenza su tanti passaggi e aspetti della loro
infausta avventura, troveranno la voglia e il modo di dare finalmente qualche
credibile risposta.
Cossiga: non potevo
trattare. Così ho concorso ad ammazzare Moro,
scrive il 10/03/2008 Roberto Arditti su "Il Tempo". L'INTERVISTA.
Presidente Cossiga del
rapimento e uccisione di Aldo Moro abbiamo una versione definitiva e veritiera o
c'è ancora molto da scoprire?
«Facciamo
un discorso un po' scientifico: esiste la Storia ed esiste la fantasia. Quando
la Storia non combacia con le proprie scelte ideologiche si esercita la fantasia
e si ha quella specifica forma di storia che si chiama dietrologia. Moro è stato
ucciso dalle Brigate Rosse e le Brigate Rosse sono un fatto tutto italiano e,
come dice giustamente quella gran signora di Rossana Rossanda, un fatto tutto
interno alla sinistra italiana e alla storia della Resistenza. Prima di fare il
colpo, con quella potenza geometrica di fuoco, i brigatisti si addestrarono.
Probabilmente le armi che avevano erano state fornite dall'Olp».
Qual è il suo ricordo di
quella mattina?
«Io
abitavo allora a via Cadlolo, quasi di fronte all'Hotel Hilton, e uscivo molto
presto la mattina. Mi fermavo a un'edicola a guardare le riviste che non mi
compravano, che erano quelle di elettronica. Lì mi raggiunse il caposcorta, che
mi disse che mi cercava il capo della polizia. Io andai alla macchina e il capo
della polizia mi disse: "hanno annientato la scorta di Moro. Lui non si sa.
Forse l'hanno ucciso, forse l'hanno ferito, forse è al Policlinico Gemelli,
forse è morto". Io feci avviare la sirena e andai alla Presidenza del Consiglio.
Era il giorno in cui il governo si doveva presentare alle Camere, con Enrico
Berlinguer che voleva informare Andreotti che non avrebbe più votato il suo
governo perché aveva messo degli uomini che rappresentavano per lui simboli
negativi. Erano nomi che Moro aveva imposto, uomini della destra e del
centro-destra della Dc».
Istituzioni e sistema
politico sembrarono del tutto impreparati ad una notizia del genere. O no?
«Anzitutto
erano stati demoliti i servizi di informazione e di sicurezza con due grandi
operazioni di disinformazione del Kgb. Operazioni che avevano come obiettivo
quello di scompaginare i servizi segreti e quella forza di polizia che loro
consideravano più pericolosa, e cioè i Carabinieri. La prima è il Piano Solo. I
giornalisti che fecero la campagna non lo sapevano, ma il boccone avvelenato,
per varie tappe, partì dal Kgb. La seconda è la P2. Poi vi fu un terzo tentativo
di disinformazione, pensato contro Berlinguer. Fu quello della compravendita dei
terreni di famiglia, ma fallì. Allora io dissi: "Mio Dio, se anche il Kgb
sbaglia siamo fregati"».
Quale fu a suo giudizio il
legame tra Br e Mosca?
«Alcuni
parlano delle Br strumentalizzate dall'Unione Sovietica che non voleva il
compromesso storico. Non è vero. L'Unione Sovietica voleva il compromesso
storico, perché era comunque un modo di attenuare alcuni aspetti della nostra
politica atlantica. Enrico Berlinguer, dice a Pansa, alla vigilia del '76:"se
andremo al potere manterremo la nostra appartenenza alla Nato, perché tra
l'altro la Nato è un ombrello che garantisce anche la nostra indipendenza". Il
marxista-leninista Enrico Berlinguer, non stalinista, mai avrebbe reso una
simile intervista se Mosca non gli avesse detto: "falla pure, pensa a vincere e
basta". Poi, Aldo Moro è uno dei fondatori di Gladio…»
Quindi?
«Aldo
Moro era un uomo abile, ma Stay Behind è stata fondata per volontà di Moro, di
Taviani, di Martino e con l'aiuto tecnologico di Enrico Mattei. Comunque, io ho
preso un pugno in faccia in vita mia alla Camera».
Da chi?
«Da
Pajetta».
Quando?
«Quando
Moro fece il discorso in difesa dell'intervento americano nel Vietnam».
Aldo Moro era quindi un
uomo politico italiano e occidentale senza se e senza ma?
«Senza
se e senza ma. Capiva, però, che in questo Paese non si sarebbe potuto governare
a lungo senza trovare un accordo con i comunisti. L'accordo che De Gasperi aveva
già trovato. De Gasperi non aveva già stretto un accordo con Togliatti? E la
Costituzione italiana cos'è? Un patto tra le due forze».
Nel circuito dei grandi
protagonisti politico-istituzionali della vita italiana del dopoguerra, il posto
di Aldo Moro qual è?
«Gli
uomini di Stato italiani sono stati Cavour, che non parlava l'italiano bene,
pensava in inglese e scriveva in francese. Il secondo è stato Giolitti, che ha
fatto l'Italia moderna. Poi Mussolini, anche se io sono stato educato a casa mia
a pane, latte, antifascismo e repubblicanesimo. E poi De Gasperi. Sarebbe stato
Togliatti un grande uomo di Stato. Il più grande uomo di governo dopo Giolitti e
Mussolini fu Andreotti; il più grande leader politico Aldo Moro».
Ma per liberare Aldo Moro
fu fatto, dal punto di vista delle indagini, tutto il possibile?
«Tutto
il possibile, ma eravamo troppo deboli. Una mia frase tratta da un'intervista
rilasciata al suo collega Aldo Cazzullo è stata equivocata. Non è vero che il
capo del commando mi ha detto che mille persone conoscevano il nascondiglio di
Aldo Moro. Lui mi disse che più di mille persone, anche sindacalisti del Pci, ci
avrebbero potuto indicare nomi, cognomi e abitazioni dei brigatisti rossi. Il
Partito Comunista è diventato un partito di Stato, io ho collaborato con esso,
chiamo Massimo D'Alema "Il meglio figo del bigoncio". Ma, anche per come noi li
abbiamo trattati nei primi vent'anni, l'antipatia per i Servizi e per le forze
di polizia gli è rimasta. Hanno cancellato Ugo Pecchioli. Per revocarlo hanno
chiamato me. Hanno cancellato Rossa, come è raccontato nel libro della figlia.
Perché, in fondo, per un vero militante comunista, un compagno, anche se sbaglia
come i brigatisti, come diceva Rossana Rossanda, non si tradisce».
Se guardiamo invece ai 55
giorni dal punto di vista politico e della gestione che i vertici istituzionali
fecero nel caso, qui è evidente che la vicenda si complica, cioè liberare Moro
significava accettare le condizioni proposte dalle Brigate Rosse…
«La
condizione era una sola: non la liberazione dei prigionieri, né tantomeno come
credeva ingenuamente il Vaticano il denaro. Era il riconoscimento politico in
modo da aggirare il Partito comunista imborghesito di Berliguer».
C'era qualcuno favorevole a
questo riconoscimento?
«Si
nascondevano sotto lo scambio dei prigionieri nelle trattative. E poi c'era chi
voleva far saltare Andreotti».
Ma nei 55 giorni, a suo
giudizio, si arrivò vicini a liberare Moro?
«No.
Il loro leader mi disse che avevamo sbagliato tutto, che avremmo dovuto usare i
vigili urbani, non le forze speciali. Però loro si accorsero che noi stavamo per
arrivare perchè alla fine su mia iniziativa dividemmo la città di Roma in tanti
quadratini».
Questo a suo giudizio
indusse le Brigate Rosse ad accelerare la conclusione del processo e ad uccidere
Moro?
«Sì».
Guardiamo alla vicenda
nella sua gestione politico e istituzionale. Poteva andare diversamente?
«Quando
io andai a trovare questi signori in carcere, gli chiesi come mai non avevano
capito che loro avevano vinto. E gli dissi che non avrebbero vinto ma stravinto,
se avessero fatto il processo a Moro, lo avessero condannato a morte, e dopo che
Paolo VI ne aveva chiesto la liberazione, loro avessero detto: "In omaggio a
Paolo VI che ci ha riconosciuto, lo liberiamo"».
E loro perché non lo
liberarono?
«Perché
a mio avviso loro avevano il mito della esemplarità: siamo creduti soltanto se
siamo feroci, cioè il processo rivoluzionario, le purghe, la confessione».
Perché secondo lei allora è
così viva ancora la tesi: "Moro doveva morire"?
«Lei
sa che per alcuni gli assassini di Aldo Moro si chiamano, Paolo VI, Giulio
Andreotti, Benigno Zaccagnini e Francesco Cossiga. Comunque fino a quando lo
dice la moglie e i figli capisco, sempre sono stati privati di un marito di un
genitore. Ma anche per una parte della sinistra Dc, non quella di base però, non
è possibile che Moro sia stato ucciso da sinistra. Moro deve essere stato ucciso
da destra e dall'imperialismo americano».
Lei porta ancora i segni
della sofferenza di quei giorni...
«Quando
io dico che ho concorso ad ammazzarlo è vero, anche se non sono un assassino. A
differenza di altri io sapevo benissimo che la linea della fermezza, salvo un
miracolo, avrebbe portato alla sua morte».
Lo pensava anche Andreotti?
«Sì.
Ma che sperava più di me».
E Berlinguer?
«Assolutamente».
In una lettera indirizzata
a lei Moro evoca la ragione di Stato. Scrive così: "io mi trovo sotto un dominio
pieno e incontrollato sottoposto ad un processo popolare che può essere
opportunamente graduato…
«Un
momento, ecco l'inizio del riconoscimento. Lui trattava. Un processo popolare.
Riconosce la legittimità popolare e democratica delle Br al processo».
"Che sono in questo Stato,
avendo tutte le conoscenze e sensibilità che derivano dalla lunga esperienza,
con il rischio di essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe
essere sgradevole o pericolosa in determinate occasioni", Ecco, scrive Moro "il
sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità mentre
un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurli a salvarli è
inammissibile".
«Esatto.
Lui era un cattolico sociale e riteneva che contassero innanzitutto la società e
la persona e che lo Stato fosse una sovrastruttura tecnica. E che lo Stato non
potesse essere uno Stato di cui si doveva tutelare il prestigio».
È autentico il Moro che
scrive così?
«È
autentico. E cerca di trattare con le Br».
Gli appelli che Moro fa
alla al suo partito che effetto ebbero?
«Beh,
alla fine ebbero effetto, tanto è vero che loro uccidono Moro il giorno in cui
forse, su proposta di Fanfani, la direzione del partito avrebbe convocato il
Consiglio nazionale, e il Consiglio nazionale avrebbe votato per le trattative.
E poi il Partito comunista si fidava solo di Andreotti e di me. Appena uscì la
prima lettera di Moro Ugo Pecchioli, venne da me e mi disse: "Che Moro esca vivo
o che Moro esca morto, dopo questa lettera Moro è per noi politicamente morto. E
quando Andreotti, con il mio consenso, permise alla Dc, di cercare la strada di
Amnesty International, la strada della Croce Rossa e così via, vennero nel mio
studio Enrico Berlinguer e Pecchioli a dire: "Adesso basta"».
In un'altra missiva che
manda a lei, Moro entra nel merito della trattativa, addirittura indicando un
Paese, l'Algeria, come possibile Paese che avrebbe potuto ospitare i terroristi
di cui si chiedeva la liberazione. Questa strada fu concretamente esplorata?
«Fu
esplorata dal ministro della Giustizia di allora, che poi divenne presidente
della Corte Costituzionale, ed era favorevolissimo Giovanni Leone. In una
burrascosa riunione del comitato per l'informazione e la sicurezza, fu scartata
con violenza da Carlo Donat Cattin, che non pensava neanche lontanamente che il
figlio fosse di Prima Linea».
Trent'anni dopo. Poteva
finire diversamente?
«Se
avessimo trattato e cioè avessimo riconosciuto soggettività politica alle Br,
sarebbe saltato certamente il compromesso storico, Moro sarebbe uscito e avrebbe
guidato una crociata anticomunista. Però avremmo sfasciato le forze di polizia
che non avrebbero più creduto al potere politico».
In questo che lei dice pesa
il fatto che cinque uomini della scorta erano stati uccisi?
«Certo.
E che la moglie di uno di questi aveva minacciato di darsi fuoco davanti a
piazza del Gesù se noi avessimo fatto le trattative».
L'uccisione di Moro ha
cambiato la storia d'Italia?
«L'ha
cambiata perché ha interrotto il compromesso storico. Perché Berlinguer credeva
non alla Dc ma solo ad Aldo Moro. Dopo che fu ucciso Moro lui perse le
amministrative, vinte dalla Dc perché era il partito del martire e perché nel
immaginario collettivo le Br non erano verdi o bianche, erano rosse».
E questa è l'influenza più
grande?
«Sì.
E lì Berlinguer compì forse due errori: aver fatto il compromesso storico troppo
in fretta e averlo finito troppo in fretta.
Dove è continuato il suo
dialogo con Moro in questi trent'anni?
«In
chiesa. Solo in chiesa». Roberto Arditti
"Il Papa voleva pagare 10
miliardi per Moro",
scrive Francesca Musacchio il 10/03/2015 su "Il Tempo". Paolo VI voleva liberare
Aldo Moro, magari trattando con le Brigate Rosse. Aveva persino messo a
disposizione 10 miliardi di lire per il pagamento del riscatto. Lo Stato, però,
non avrebbe dimostrato attitudine ad una trattativa con i rapitori, il clima non
era favorevole. «Io avrei trattato, potevano convocare la Camera, fare finta di
discutere per prendere tempo, come mai è stato detto no a tutto? Se Fanfani
avesse detto trattiamo questi si sarebbero fermati». L'ex presidente della
Democrazia cristiana, però, forse lo avrebbe potuto salvare solo la divina
provvidenza. In ogni caso, monsignor Antonello Mennini, sostiene di non essere
mai stato nel covo delle Br, dove era detenuto lo statista, e di non averne mai
raccolto l’ultima confessione. «Mi avrebbe fatto piacere farlo. Forse avrei
potuto portargli un po' di conforto», spiega. «E poi, diciamo la verità, di che
cosa doveva confessarsi quel povero uomo?» Quasi tre ore di audizione, ieri,
davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta che si occupa della morte di
Aldo Moro per il nunzio apostolico in Gran Bretagna, monsignor Antonio Mennini:
il «postino» incaricato, per molti, di essere il "canale segreto" tramite cui i
carcerieri di Moro e lo stesso leader Dc, recapitavano i messaggi dalla prigione
del popolo. Un fiume in piena di racconti, domande e risposte. La verità sulla
morte dello statista, avvenuta il 9 maggio del 1978 dopo 55 giorni di prigionia,
potrebbe essere molto vicina o forse ancora troppo lontana. Le parole del prete,
che ai tempi aveva poco più di trent'anni, non hanno convinto tutti. «Non era
quello che mi aspettavo, non mi convince che lui non ci sia stato nel carcere
brigatista - dichiara Gero Grassi, vicepresidente della commissione - Che dica
la verità bisogna darlo per scontato, perché non abbiamo elementi per
smentirlo», dice, riferendosi alla circostanza, negata dal prelato, di aver
visto Moro durante i 55 giorni. «Il percorso di questi anni - aggiunge - ci
spingeva a pensare che ci fosse stato un canale di ritorno e che qualcuno fosse
stato da Moro. E ritenevamo fosse lui. Ora lui smentisce, dicendo che potrebbe
essere stato un altro sacerdote, amico dei brigatisti. Ne prendiamo atto. Oggi
viene fuori che è stata altra persona, la cercheremo». E proprio su questa nuova
ipotetica figura potrebbe aprirsi un altro capitolo della terribile vicenda. Nè
è convinto il presidente della commissione Giuseppe Fioroni: "Da monsignor
Mennini una cosa del tutto nuova sulla vicenda Moro: c'era un canale di ritorno
che si interrompe intorno al 5 maggio». Per Fioroni è questa la novità che
emerge dopo la lunga deposizione del Nunzi. Mennini recapitò ai familiari alcune
delle lettere del presidente Dc, scritte dalla prigione brigatista. «Don
Antonello ha detto che nell’ultima telefonata che gli fecero i brigatisti, il 5
maggio del 1978, quando al telefono lo chiamò il professor Nicolai (Valerio
Morucci) - aggiunge - si sentì dire che si faceva riferimento a lui per la
consegna della lettera di addio di Moro, perché la persona che dovevano
contattare non c'era più, la persona individuata non era più reperibile».
Secondo Fioroni un elemento nuovo «che ci dice come si arriva al 9 maggio, senza
un canale utile per la trattativa» sulla liberazione di Moro. Ipotesi, nuovi
indizi, trattative mai iniziate e ancora dubbi e incertezze sul sequestro e il
rapimento dello statista. Certo è che per il prelato, in quelle condizioni, Aldo
Moro si sarebbe potuto salvare solo grazie all'intervento divino. Nel marzo del
1978, in pieno rapimento, Mennini si reca al Viminale per incontrare l'allora
ministro dell'Interno Francesco Cossiga. A ricostruire l'incontro è lo stesso
Nunzio: «Ci venne indicato un sacerdote dei Pallottini con presunte doti di
sensitivo: fu lui ad indicare su una mappa un punto dell’Aurelia. Ne parlai con
il professor Tritto (assistente di Moro, ndr) - racconta ancora don Antonello -
e lui disse che era importante, che dovevamo dirlo al ministro e ottenne un
appuntamento. Fummo ricevuti al Viminale dove ci tennero a bagnomaria' per 3 o 4
ore, ogni tanto Cossiga entrava e chiedeva a Tritto se era possibile avere
qualche indumento di Moro, qualche scritto, ipotizzando pure il coinvolgimento
del sensitivo consultato nel caso dell'omicidio di Milena Sutter». Era un clima
«poco esaltante», ricorda il nunzio, «ogni tanto veniva il capo di gabinetto che
parlava di una fila di persone importanti che chiedevano biglietti omaggio per
lo spettacolo pasquale dell’Opera. Mi è stato rimproverato - conclude monsignor
Mennini - di non aver informato la polizia del contatto telefonico con le Br ma
non volevo rischiare di bloccarlo, volevo solo essere utile a una persona alla
quale volevo bene e fare nel mio piccolo tutto quello che potevo. E poi, quello
che ho visto quel giorno al Viminale mi era bastato...». E alla fine: «Sono
convinto di non aver convinto nessuno. Ma ripeto che non ho, purtroppo, potuto
confessare Moro. So che c'è questa leggenda metropolitana su di me». Francesca
Musacchio
Papa Francesco fa
testimoniare il confessore di Aldo Moro,
scrive il 7/03/2015 "Il Tempo". Sarà ascoltato il 9 marzo. Secondo Cossiga, il
prete Mennini, mediatore tra il Vaticano e le Br, avrebbe confessato lo statista
durante la prigionia. Passi avanti per svelare il mistero del sequestro di Aldo
Moro. E' stato papa Francesco in persona a volere che Antonio Mennini, ora
nunzio apostolico nel Regno Unito, sia ascoltato dalla Commissione d'inchiesta
sulla vicenda. Secondo l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga,
infatti, Mennini, all'epoca giovane sacerdote, avrebbe addirittura confessato lo
statista durante la prigionia. Il prete sarebbe stato in qualche modo un canale
di mediazione tra il Vaticano e le brigate: Paolo VI era un amico personale di
Moro. La deposizione avverrà il 9 marzo, quando opererà la nuova Commissione
parlamentare d'inchiesta sul delitto di via Fani. Finora Mannini non aveva mai
parlato in tribunale né rilasciato interviste. Ha sempre avuto un basso profilo,
pur ricoprendo ruoli importanti all'interno della Santa Sede nel corso della sua
carriera. E' un chiaro segnale della volontà del Pontefice di collaborare a ogni
livello con le autorità italiane, all'insegna della massima trasparenza. Sarà il
nunzio, infatti, a venire a Roma a deporre a San Macuto, sede della Commissione,
pur essendo un diplomatico e godendo perciò di immunità speciali. Le
dichiarazioni Francesco Cossiga. "Don Antonello Mennini raggiunse Aldo Moro nel
covo delle Brigate Rosse e noi non lo scoprimmo. Ci scappò don Mennini”. Sarebbe
stato il canale segreto tra i terroristi e il Vaticano. Dopo la morte di Aldo
Moro, Mennini fu mandato dal Vaticano all’estero, destinato alla carriera
diplomatica.
Il confessore di Aldo Moro:
"Mai stato nel covo delle Br",
scrive il 9/03/2015 "Il Tempo". Monsignor Mennini in audizione davanti alla
Commissione d'inchiesta sul rapimento e la morte del leader Dc. Nel 1978 fece
avere alla famiglia alcune lettere scritte dallo statista sequestrato. Niente di
nuovo, nessuna notizia sconvolgente. Monsignor Antonello Mennini parla davanti
alla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo
Moro. L'attuale Nunzio apostolico vaticano in Gran Bretagna nel 1978 era
sacerdote nella chiesa di Santa Lucia e fece avere alla famiglia alcune lettere
scritte dal leader Dc durante i 55 giorni del sequestro. Ma non entrò mai nel
covo della Brigate Rosse. Almeno così ha raccontato. "Purtroppo non ho avuto la
possibilità di confessarlo e dargli la comunione - ha detto davanti alla
Commissione - Nella coscienza dei miei doveri sacerdotali ne sarei stato molto
contento. In ogni caso se avessi avuto un'opportunità del genere credete che
sarei stato così imbelle, che sarei andato lì dove tenevano prigioniero Moro
senza tentare di fare niente? Sicuramente mi sarei offerto di prendere il suo
posto, anche se non contavo nulla, avrei tentato di intavolare un discorso, come
minimo di ricordare il tragitto fatto. E poi, diciamo la verità di che cosa
doveva confessarsi quel povero uomo?". Il nunzio apostolico ha sottolineato di
essere stato già ascoltato sulla vicenda in sede parlamentare e giudiziaria per
ben sette volte e ha confermato che "di un'eventuale confessione non avrei
potuto dire nulla, né sui contenuti né sulla circostanze temporali e logistiche,
ma non avrei difficoltà alcuna ad ammettere di essere andato nel covo delle Br.
Ma non ci sono mai stato". I dubbi di Cossiga Monsignor Mennini ha poi parla
dell'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga che ai tempi del rapimento
di Aldo Moro era ministro dell'Interno: "Se riteneva che avessi raggiunto il
covo delle Br ma perché non farne parola con i miei superiori o con lo stesso
Santo Padre? Cossiga l'ho incontrato varie volte e non ha mai sollevato questa
cosa, capisco che poteva non sollevarla con me, ma non poteva esimersi dal
parlarne con Sodano o con il Santo Padre". La trattativa "Immagino che il Santo
Padre volesse che Moro fosse liberato - ha proseguito nel suo racconto - ma il
clima che c'era era tale, queste adunate oceaniche dei sindacati che dicevano
che non si doveva trattare. Che poteva fare il povero Papa? Quindi ha cercato
un'altra strada, quella del riscatto. Due o 3 anni più tardi mi raccontarono che
il Santo Padre aveva chiesto di mettere a disposizione 10 miliardi di lire,
perché si era fatto balenare l'idea che le Br potessero accontentarsi solo di un
riscatto. Io avrei trattato, potevano convocare la Camera, fare finta di
discutere per prendere tempo, come mai è stato detto no a tutto?". Per monsignor
Mennini "se Fanfani avesse detto trattiamo questi si sarebbero fermati. Io ho
avuto la convinzione e l'ispirazione di servire una persona a cui volevo molto
bene e tentare nel mio piccolo di sottrarlo a quella morte immeritata". Il
canale di ritorno Per Giuseppe Fioroni, presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, "Mennini ha
comunicato una cosa per tutti noi totalmente nuova, che il professor Nicolai
nella telefonata del 5 maggio lancia un messaggio finale alla signora Moro,
comunicandole che la persona che dovevano rintracciare non era stata reperita e
che quindi si tornava a far ricorso a don Mennini per lasciare la missiva in cui
il presidente Moro annunciava la fine della propria vita di lì a pochi giorni.
Questo conferma che c'era un canale di ritorno che stando alle conoscenze fino
ad oggi acquisite, si interrompe intorno al 5 di maggio, poco prima o poco
dopo". Il sacerdote, amico e confessore del presidente della Dc prima del
rapimento e dell'uccisione, ha infatti ammesso che nella telefonata del 5 maggio
"il professor Nicolai mi disse di riferire alla signora Moro che purtroppo non
avevano potuto trovare la persona da lei indicata e che avevano dovuto far
ricorso di nuovo a me". "Per la prima volta - continua Fioroni - Mennini fa
riferimento chiaramente ad un canale di ritorno, un canale che non c'è più. È un
dato: il canale di ritorno c'era ed improvvisamente al 5 maggio o non viene
reperito o non c'era più. Questo - ha concluso Fioroni - adesso sarà oggetto di
lavoro da parte della Commissione".
Moro, la prigione era
un'altra,
scrive "Il Tempo" il 23/10/2007. Per questo, secondo Galloni, le speranze di
saperne qualcosa di più sul sequestro e l'omicidio di Aldo Moro sono affidate
agli archivi americani. «La verità la sapremo solo quando cadrà il segreto sui
documenti conservati a Washington», ha osservato l'ex nel suo intervento alla
presentazione del libro dello storico Giuseppe De Lutiis, «Il golpe di via Fani»
(Sperling&Kupfer). Gli Stati Uniti, secondo l'ex «ufficiale di collegamento tra
la democrazia Cristiana e il Viminale», come lo ha definito Francesco Cossiga,
dovevano essere al corrente degli «interna corporis» della vita politica
italiana, visto che il suo nome è ampiamente citato in alcuni rapporti di
Washington. «In uno di questi - ha spiegato - l'ambasciatore Usa rimprovera
Fanfani di non aver assunto provvedimenti disciplinari nei confronti di noi
"basisti" che avevamo aperto a sinistra». Quanto al sequestro Moro, Galloni, che
sta per dare alle stampe un suo libro sulla vicenda, ha ricordato che il 5
maggio 1978, quattro giorni prima dell'esecuzione dell'ostaggio da parte delle
Brigate Rosse, si incontrò con Amintore Fanfani. «Mettemmo a punto la riunione
del 9 maggio. Egli disse: "la figura di Moro come uomo politico è distrutta,
l'unica cosa che dobbiamo fare è salvargli la vita"». Ma come? «Qui ci sono
misteri enormi», ha aggiunto l'ex vicesegretario Dc. «L'8 aprile il generale del
Sid, Vito Miceli, partì per un viaggio misterioso a Washington dove prese
contatto - ricorda - con grossi esponenti della Cia. In quella sede si disse che
bastava scoprire il covo dove Moro era prigioniero». Gli Usa sapevano dunque
dove le Br tenevano rinchiuso Aldo Moro? «I servizi segreti sanno tante cose più
dei giudici», ha detto Rosario Priore, l'ex giudice istruttore dell'inchiesta
sulla strage di via Fani e l'omicidio del presidente Dc alla presentazione del
libro di De Lutiis che larga parte dedica ai risvolti internazionali della
vicenda. Sull'evoluzione del sequestro di Moro, gli apparati, a giudizio di
Giovanni Pellegrino, ex presidente della Commissione stragi, «hanno certamente
influito. Del resto le Br, sono smentite dallo stesso Moro: quello ritrovati
nella renault rossa in via Caetani non era il corpo di un uomo tenuto per 55
giorni in un buco dove non poteva neanche lavarsi. Fu prigioniero in condizioni
diverse e in un luogo diverso».
Il Caso Moro di Gianluca
Neri. “…E quando ci domanderanno che cosa stiamo facendo, tu potrai
rispondere loro: Noi ricordiamo. Ecco dove alla lunga avremo vinto noi. E verrà
il giorno in cui saremo in grado di ricordare una tal quantità di cose che
potremo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia e scavare, in
tal modo, la più grande fossa di tutti i tempi, nella quale sotterrare la
guerra.” Sono le ultime parole di “Fahrenheit
451” di Ray
Bradbury e quelle che aprono questo nuovo
spazio su Macchianera: un ripassino - utile a
tutti - della storia recente italiana. Nella speranza che la storia sopravviva
alla riscrittura, non fosse altro che perché noi
ricordiamo. Si inizia, un capitolo al giorno, con “Il
caso Moro”, di Sergio Flamigni e Michele
Gambino. Il 16 marzo 1978 Aldo Moro fu rapito, dopo il massacro degli agenti
della sua scorta. Il 9 maggio fu ucciso. In quei cinquantacinque giorni accadde
che gli inquirenti indagarono nella direzione sbagliata, al vertice del
ministero dell’Interno si insediò un Comitato di iscritti alla Loggia P2, un
consulente americano consigliò di non “sopravvalutare” l’ostaggio, verbali
vennero redatti e poi sottratti, bobine furono manipolate, gladiatori furono
allertati, sedute spiritiche indirizzarono le inchieste. Alla fine, con la morte
del prigioniero delle Br, una intera politica, quella di Moro, fu rovesciata.
Per questo il caso Moro è il più grande mistero della Repubblica. Questo
racconto lo ricostruisce minuziosamente, sulla base delle testimonianze e della
carte emerse nei quattordici anni che seguirono, fino alla pubblicazione.
• Sergio
Flamigni, che fu membro della commissione parlamentare d’indagine sull’“affare
Moro”, è uno dei maggiori conoscitori dei “cinquantacinque giorni” (su cui
ha scritto il libro “La tela del ragno”).
• Michele
Gambino, giornalista, ha iniziato l’attività nei primi anni ‘80 con “I Siciliani”
di Giuseppe Fava. Dal 1990 fino alla chiusura
del giornale è inviato del settimanale “Avvenimenti”. Specializzato in inchieste
su criminalità economica, mafia, politica interna ed estera, ha realizzato
decine di reportage dai teatri di guerra di tutto il mondo. Ha collaborato come
autore e inviato in diverse trasmissioni televisive della Rai e
ha scritto libri-inchiesta e saggi su argomenti d’attualità. E’ uno degli
insegnanti della “bottega di giornalismo” della scuola torinese “Holden” di Alessandro
Baricco e vice-direttore di “Pippol”.
(Pubblicato da
“Avvenimenti” il 12/2/1992)
CAPITOLO I.
Roma, giovedì 16 marzo
1978, ore 9.30.
Il transatlantico di Montecitorio è insolitamente affollato,
vista l’ora: gruppi di parlamentari vanno su e giù lungo i corridoi in attesa
della votazione che sancirà la nascita del quarto governo Andreotti.
Particolarmente animati i capannelli dei deputati comunisti: sta per nascere la
prima maggioranza di cui il Pci fa parte. Ma alcuni di loro polemizzano con le
indicazioni del partito, che impone di votare l’appoggio esterno a un monocolore
dc zeppo delle vecchie facce dei ministri di sempre. All’improvviso una notizia
interrompe il filo dei discorsi: mezz’ora prima in via Fani, ampia e tranquilla
strada del quartiere Trionfale, un commando di brigatisti rossi ha sequestrato
l’onorevole Aldo Moro, regista insieme a Berlinguer dell’accordo tra
democristiani e comunisti. Quattro uomini della scorta, Oreste Leonardi,
Raffaele lozzino, Domenico Ricci e Giulio Rivera, sono stati uccisi. Il quinto,
Francesco Zizzi, morirà più tardi in ospedale. Le forze dell’ordine si sono già
messe in moto, ma è un agitarsi privo di logica. I percorsi dei brigatisti in
fuga si sovrappongono a quelli delle volanti in arrivo senza mai incrociarsi. In
via Bitossi una radiomobile riceve l’ordine di spostarsi per dirigersi verso via
Fani un attimo prima che la Fiat 128 blu con a bordo Moro e i suoi sequestratori
arrivi proprio nel punto in cui l’auto della polizia si trovava.
Alla centrale operativa della questura di Roma presta servizio quel 16 marzo il
commissario Antonio Esposito, poi risultato iscritto alla P2.
Lo stesso nome, con l’indirizzo e il numero di telefono, verrà trovato in
possesso di uno dei componenti del commando brigatista, Valerio Morucci. Ma
nessuno gli chiederà mai perché. Le cronache dell’agguato, il giorno dopo, si
dilungheranno sulla «professionalità» degli
assalitori. In realtà a uccidere la scorta lasciando incolume Aldo Moro sono
stati due soli componenti del commando; dei 97 bossoli ritrovati in via Fani
dopo la sparatoria 62 furono sparati da una sola arma, altri 20 da un secondo
killer. I restanti tre uomini del commando spararono quindi 15 proiettili in
tutto. Agli atti del processo c’è la deposizione di uno dei testimoni
dell’agguato, esperto di armi, che descrive con sincera ammirazione la «tecnica»
di uno degli assalitori. Il numero e la composizione dell’intero gruppo che
partecipò all’agguato non è mai stato chiarito, ma c’è il fondato sospetto che
tre componenti del commando non siano mai stati identificati. Lo stesso Valerio
Morucci ha parlato prima di dodici e poi di nove componenti. Ma di sicuro tra i
brigatisti condannati per il sequestro Moro non c’è nessuno che abbia le
capacità «militari» messe in
mostra dal superkiller di via Fani. Esiste anche l’ipotesi che alcuni dei
proiettili sparati in via Fani provengano da un deposito di «Operazione
Gladio». E’ una pista che nasce dall’interrogazione presentata di recente da
un deputato di Democrazia Proletaria, Luigi Cipriani che ha riletto con gli
occhiali di “Gladio” le
carte del primo processo Moro. Trovandovi un particolare che potrebbe rivelarsi
di straordinaria portata: secondo il perito del tribunale, 39 dei bossoli
ritrovati in via Fani provengono da uno stock in dotazione «a
forze militari non convenzionali». Essi sono inoltre ricoperti di una
vernice protettiva adatta alle lunghe conservazioni.
Ore 9,45.
Nella zona di via Fani saltano le linee telefoniche. La conseguenza è una
parziale paralisi delle comunicazioni tra le forze dell’ordine. La Sip spiegherà
che si è trattato di un sovraccarico delle linee. Si scoprirà, anni dopo, che
all’interno della Sip operano strutture dei servizi segreti. Pochi giorni prima
del sequestro Moro una squadra di telefonisti era stata notata all’interno del
garage del palazzo in cui abitava il presidente della Dc. Sul luogo della strage
sono accorsi i vertici di carabinieri, polizia e magistratura. Dirà il generale
dei Cc Corsini: “Devo dire che lì ho
trovato una grossa confusione, in parte creata da noi…”.
Ore 9,50.
Vengono
istituiti i primi posti di blocco. I brigatisti hanno avuto quasi un’ora di
tempo per raggiungere un luogo sicuro.
Ore 10.
Alla Camera la seduta di insediamento del nuovo governo è rinviata. Negli stessi
minuti Licio Gelli riceve nella sua stanza all’Excelsior due ospiti mai
identificati. Testimonianza della segretaria del capo della P2,
Nadia Lazzerini: “Ad un certo punto Gelli
disse: «Il più è fatto»”.
Ore 10,06.
Il Gr2 trasmette un editoriale del suo direttore, Gustavo Selva, che invoca
misure speciali e lo stato di guerra. Anche il nome di Selva fu trovato nelle
liste dellaP2. La campagna per le misure
speciali e lo stato di emergenza verrà condotta con particolare forza dal
“Corriere della Sera”, diretto da un iscritto alla P2,
Franco Di Bella. Per lo “stato di
pericolo pubblico” e per
l’interrogatorio degli indiziati senza difensore si esprimerà anche il capo del
Sisde (il servizio segreto civile) Giulio Grassini, piduista.
Ore 10,08.
Con una telefonata alla redazione milanese dell’Ansa le Brigate rosse
rivendicano l’azione e aggiungono che “Moro
è solo l’inizio”.
Ore 10,30.
Cgil, Cisl e Uil proclamano lo sciopero generale, la Corte Costituzionale
sospende per mezz’ora la seduta in segno di lutto, nelle scuole e nelle
Università gli studenti si riuniscono in assemblea.
Sui tavoli di prefetti, questori, commissari di polizia e guardie di frontiera
arriva un telegramma urgente. Con “massima
precedenza assoluta” il capo
dell’Ucigos, Antonio Fariello, capo di un ufficio creato nello spazio di un
mattino dal ministro dell’Interno Cossiga e suo uomo di fiducia, ordinava di
disporre immediatamente il “Piano
Zero”. Mezz’ora dopo il centralino del ministero dell’interno era intasato
dalle telefonate di allarmati funzionari che da tutta Italia chiedevano cosa mai
fosse il “Piano Zero”. Si scoprì
a tarda sera che si trattava di un piano di emergenza per mobilitare le forze
dell’ordine della provincia di Sassari. Fariello, che era stato questore di
quella città, era convinto che il piano valesse su tutto il territorio
nazionale. Un errore incredibile, ma solo il primo di una lunga serie. Per la
cronaca, nel 1987 il dottor Fariello, lasciata la polizia, fu assunto come capo
della sorveglianza della Banca Nazionale del Lavoro. Direttore generale
dell’istituto di credito era all’epoca Giacomo Pedde, cugino di Francesco
Cossiga.
Ore 11,30.
Al Viminale il ministro dell’interno Francesco Cossiga convoca i vertici delle
forze di polizia, dei servizi segreti e delle forze armate. Viene formato il
comitato tecnico operativo che dovrà coordinare le indagini. Si scoprirà, tre
anni dopo, che molte delle persone riunite intorno a quel tavolo sono iscritte
alla P2. L’operato del comitato di crisi è uno
dei “buchi neri” del
caso Moro. Dei verbali delle riunioni vi è traccia solo fino al 3 aprile. In
realtà però Cossiga prestò scarsissima attenzione a quel comitato. Al punto da
frequentarlo solo saltuariamente a partire dal 21 marzo, cinque giorni dopo il
sequestro di Aldo Moro. Accanto al comitato “ufficiale”,
composto dai rappresentanti di forze dell’ordine e servizi segreti, Cossiga ne
costituì un secondo, denominato “gruppo
gestione crisi”, che lavorò in modo del tutto misterioso. Formalizzato su
proposta dello stesso Cossiga da un documento del Cesis (il comitato di
coordinamento dei servizi segreti) del 16 marzo, il comitato di “gestione
crisi” fu caratterizzato dalla
presenza di alcuni amici personali del ministro, parte dei quali iscritti alla
loggia di Gelli: come il professor Franco Ferracuti, uno psichiatra che ebbe
grande peso, insieme al “consulente
di crisi” del dipartimento di Stato
americano Steve Pieczenik, nel far passare la tesi del Moro “fuori
di sé”, e quindi della inattendibilità delle sue lettere dal carcere
brigatista. Conosciuto come un collaboratore della Cia, Ferracuti fu poi
coinvolto nelle indagini sulla strage di Bologna per la sua amicizia con
l’ideologo “nero” Semerari;
lo stesso Ferracuti, come risulta dall’interrogatorio di un neofascista,
all’epoca del sequestro Moro informava gli esponenti del terrorismo nero sullo
stato delle indagini. Dagli interrogatori di Ferracuti e di altri componenti di
questo “comitato-ombra” risulta
che esso si riuniva in luoghi sempre diversi con scadenze non prefissate, e che
il numero dei presenti variava di volta in volta. A proposito dei verbali delle
riunioni del comitato di crisi, affannosamente e inutilmente richiesti al
ministero dell’Interno, molti anni dopo, dalla commissione parlamentare sulle
stragi, una testimonianza preziosa è venuta da uno dei suoi componenti, il
criminologo Franco Ferracuti: “Concluso
il caso Moro, ho parlato con Cossiga, e gli ho spiegato che le carte sul “caso”
erano un pezzo della storia d’Italia, e che ci si doveva preoccupare di salvarle
tutte. Lui mi aveva risposto di esserne consapevole, e che se ne sarebbe
occupato. Certo, per quello che dico non ho prove, ma quando sono tornato ho
chiesto ad alcuni amici del Viminale dove erano finiti tutti quei materiali. Mi
hanno risposto che era sparito tutto. Forse Cossiga… per motivi storici, o
qualcosa del genere”. In un libro pubblicato oltre dieci anni dopo l’agguato
di via Fani, “L’ombra di Moro”,
Adriano Sofri è tornato sulla questione del comitato-ombra. Di che si tratti,
l’ex leader di Lotta Continua lo ha spiegato in una intervista al settimanale
“Il Sabato”: “Mi è stato detto -
afferma Sofri - che durante i giorni
del rapimento Moro c’era una specie di comitato-ombra che si occupava
dell’emergenza. Questo gruppo di persone era insediato al ministero della Marina
Militare con la presenza personale di Licio Gelli”. Sofri spiega di aver
avuto la notizia da “una persona accreditata
per non dire sciocchezze”, ma non più in vita. Sempre secondo Sofri gli
altri componenti del gruppo di esperti scelto da Cossiga chiamavano
affettuosamente Gelli “Micio Micio”. Il
capo della P2 avrebbe avuto addirittura a
disposizione una stanza all’interno dell’edificio della Marina militare, in
piazzale della Marina 1, a Roma. Sofri non è un personaggio di secondo piano in
questa vicenda: egli seguì da vicino gli sviluppi del caso Moro, tenendo
contatti sia con i vertici del Psi che con gli ambienti dell’estremismo rosso.
Della presenza di Gelli tra i consiglieri di Cossiga parla anche un altro libro;
si chiama “I giorni del diluvio”, e l’ha
scritto, sotto falso nome, il senatore Francesco Mazzola, sottosegretario alla
Difesa, con delega alla Marina Militare e grande amico di Cossiga. Mazzola, che
fece parte del “comitato gestione crisi”,
nel libro chiama Gelli “il marchese”. Ci
sono infine altre due testimonianze non smentibili: la prima è del funzionario
del Sisde, Elio Cioppa, piduista, il quale davanti alla commissione P2 ha
testimoniato che “durante il sequestro Moro
il capo del servizio, generale Grassini (anch’egli
iscritto alla P2, N.d.R.), gli affidò un
accertamento da compiere specificando che lo spunto… proveniva da una riunione a
cui era presente Gelli”. Questo fu il giudizio di Tina Anselmi, che
presiedette la commissione parlamentare: “Il
capo della Loggia agiva dunque ormai come elemento pienamente inserito al
massimo livello in uno dei gangli essenziali dello Stato”. La seconda
testimonianza è di un sincero amico dei vertici democristiani, il giornalista
Umberto Cavina, all’epoca del sequestro capo ufficio stampa della Dc, il quale
ha dato per certa la presenza di Gelli al Ministero dell’Interno durante il
sequestro Moro. Gelli partecipò alle famose riunioni negli uffici della Marina
Militare sotto il falso nome di ingegner Luciani. “Ingegner
Lucio Luciani” è il nome di copertura che
Licio Gelli ha spesso usato nelle lettere di raccomandazione pubblicate tra gli
atti della commissione d’inchiesta della P2.
Come “ingegner Luciani”, il capo della P2 prenota
spesso una camera all’Excelsior di Roma. Nella seconda metà di gennaio del 1992
attraverso canali misteriosi è saltato fuori un documento che prova le
frequentazioni di Licio Gelli al ministero della Marina: si tratta di due
tesserini, datati 1979 e intestati all’ingegner Lucio Luciani, che permettono
l’accesso alla biblioteca del ministero. Forse qualcuno conserva ancor oggi
altre e più importanti tessere, che Licio Gelli utilizzò per accedere agli
uffici del ministero nei giorni tra marzo e maggio del 1978, quelli in cui si
consumò il caso Moro. Forse, quei tesserini fanno parte del gioco di ricatti che
apparentemente coinvolge, a volte in veste di ricattato, altre in quelle di
ricattatore, il Presidente della Repubblica (Francesco
Cossiga, all’epoca della pubblicazione di questo scritto, N.d.R.).
Ore 18,06.
Alla Procura di Roma si
svolge un summit presieduto dal capo dell’ufficio, il dottor Giovanni Di Matteo.
Vi partecipano tutti i sostituti procuratori. Si concorda che il sostituto di
turno incaricato delle indagini, il dottor Infelisi, sarà affiancato da un
gruppo di magistrati. In realtà nei giorni successivi De Matteo cambierà idea.
Infelisi condurrà da solo le indagini, ma continuerà anche a svolgere il normale
lavoro di routine: “Il telefono del
mio ufficio a volte non funzionava -
racconterà Infelisi - dovevo usare il
telefono a gettoni nel corridoio - spesso mancavano i gettoni…”.
CAPITOLO II.
La sera del 15 marzo, una
manciata di ore prima del sequestro di Aldo Moro, un non vedente di Siena,
Giuseppe Marchi, racconta in trattoria il seguente episodio: mentre rientrava a
casa col suo cane ha udito alcuni uomini parlare con accento straniero dentro
una macchina in sosta. Uno di loro ad un certo punto ha detto: “hanno
rapito Moro e le guardie del corpo”. Scriverà il giudice Ernesto Cudillo: “E’
possibile che il Marchi non abbia afferrato bene il significato della frase, che
non si riferiva ad un fatto accaduto, ma che doveva accadere”. L’episodio
comunque venne lasciato cadere. Marchi abitava in una zona del centro storico
chiusa agli automezzi. Nessun accertamento venne fatto sulle auto che avevano
accesso alla zona chiusa. Alle 8,30 del 16 marzo, mezz’ora prima dell’agguato,
Renzo Rossellini, direttore di Radio Città futura, parlò di un possibile
attentato a Moro. Rossellini spiegò in seguito che la voce sul sequestro di Moro
circolava da tempo. Nel febbraio del ‘78 il “Male” aveva addirittura pubblicato
una finta “lettura della mano” del
presidente della Dc: “La mano di
costui, forse ripresa in un carcere, è inequivocabilmente di tipo assassino… e
la linea del destino indica che il soggetto, dopo alterne vicende, farà una
brutta fine. Notevole il reticolo sull’indice, segno certo di carcerazione”.
Ad un sequestro di un esponente Dc, e alla fine di Aldo Moro, avevano alluso
anche alcuni detenuti e il giornalista Mino Pecorelli, direttore della rivista
Op, legata ad un preciso settore dei servizi segreti, quello che faceva capo al
piduista Vito Miceli. Il sequestro Moro piomba su una struttura dei servizi
segreti completamente trasformata sotto la pignola guida del superesperto
ministro dell’interno Francesco Cossiga: a capo dei due nuovi servizi segreti,
il Sismi (militare) e il Sisde (civile), sono stati nominati i generali Giuseppe
Santovito e Giulio Grassini; la nomina di quest’ultimo ha suscitato molte
polemiche tra le forze dell’ordine, poiché Grassini, un carabiniere, si trova a
guidare una struttura di polizia. Molti, inoltre, si aspettavano per quel posto
la nomina di Emilio Santillo, abile e apprezzato capo del Servizio di sicurezza
antiterrorismo. Santillo invece non solo non avrà quel posto, ma verrà
scientificamente messo da parte. Lui, massimo esperto di antiterrorismo in
Italia, sarà praticamente escluso dalla gestione delle indagini su Moro. Forse
paga il fatto di aver stilato, negli anni precedenti, ben tre rapporti allarmati
sulle attività di Licio Gelli e della Loggia P2.
Nell’unica occasione in cui gli chiederanno un consiglio sulle mosse da fare,
Santillo - significativamente, provocatoriamente - consiglierà una retata
intorno a villa Wanda, la villa di Gelli nei dintorni di Arezzo. Ma il gioco ad
incastro delle coincidenze nefaste non è finito: il 21 gennaio del 1978 Cossiga
crea l’Ucigos (ufficio centrale informazioni generali operazioni speciali) e vi
pone a capo un suo uomo di fiducia, il questore Antonio Fariello, che in almeno
un paio di occasioni avrà un ruolo non indifferente nel ritardare e intralciare
le indagini sul sequestro Moro. A capo del Cesis, l’organo incaricato di
coordinare il lavoro dei due servizi segreti in quel marzo 1978, c’è da due mesi
Gaetano Napoletano, un ex partigiano con alle spalle una brillante carriera di
prefetto e una fama di uomo lontano dai giochi di Palazzo. Quando esplode il
caso Moro, Napoletano si accorge subito di essere una specie di intruso nel
gruppo di piduisti incaricato di gestire le indagini. Non viene invitato a far
parte del Comitato tecnico operativo incaricato di gestire la crisi; non ha
ancora una sede, i suoi uomini vengono pagati una miseria e Cossiga (insieme al
presidente del Consiglio Andreotti) continua allegargli la promessa nomina ad
ambasciatore, l’unica che gli avrebbe permesso di stare gerarchicamente un
gradino sopra Santovito e Grassini. I due capi piduisti dei servizi, infatti,
trattano Napoletano come un rompiscatole, non rispondono alle sue lettere, gli
impediscono persino l’accesso ai loro uffici. “Non
prendo ordini da nessuno” è la
risposta di Santovito all’ennesima sollecitazione del Cesis. Sette giorni dopo
il sequestro di Moro, sconsolato, Napoletano prende carta e penna e scrive ad
Andreotti e Cossiga: “nulla si sa di
quanto il Sisde stia predisponendo per accentuare una valida lotta al
terrorismo”. Nessuna risposta, e Napoletano si arrende: il 23 aprile, con
Moro ancora prigioniero delle Br, il capo del Cesis si dimette dall’incarico (“Motivi
di salute”, spiegherà Andreotti). In realtà di salute Napoletano sta
benissimo. Ciò che gli duole, semmai, è la coscienza. Lo sostituisce Walter
Pelosi, piduista. E con lui si completa l’allegra brigata di uomini legati a
filo doppio a Licio Gelli incaricati di condurre le indagini sul rapimento del
presidente della Democrazia Cristiana; l’uomo che, contro il parere degli
americani, della destra Dc e della massoneria conduce una politica di
collaborazione con il Pci, magari solo alla scopo di depotenziarlo. Parlando
dell’operato degli investigatori davanti alla commissione d’inchiesta sul caso
Moro l’allora procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma Pietro
Pascalino si lascerà sfuggire queste parole: “Non
spetta a me dire perché si preferì fare operazioni di parata invece che
ricerche. Ma allora si fecero operazioni di parata”.
Roma, sabato 18 marzo,
ore 9,30.
Gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo si presentano al terzo piano della
palazzina al numero 96 di via Gradoli, una stradina residenziale sulla via
Cassia. Una “soffiata” molto
precisa, forse proveniente da ambienti vicini ai servizi segreti, ha segnalato
che lì, all’interno 11, c’è un covo delle Br. Gli agenti bussano alla fragile
porta di legno, ma nessuna risponde. Apre invece l’inquilina dell’interno 9,
Lucia Mokbel, e racconta di aver sentito provenire dall’appartamento sospetto
dei ticchettii simili a segnali Morse. Secondo le disposizioni vigenti i
poliziotti dovrebbero a quel punto sfondare la porta, o quantomeno piantonare il
palazzo. Invece vanno via. Al processo Moro presenteranno un rapporto di
servizio grossolanamente falso, costruito a posteriori, stando al quale i vicini
avrebbero fornito “rassicurazioni” sull’onestà dell’inquilino
dell’interno 11, il ragionier Borghi, alias Mario Moretti. Saranno sbugiardati
pubblicamente, ma mai puniti. Il 3 aprile si riparlerà di “Gradoli”:
nel corso di una seduta spiritica, a cui partecipa il futuro presidente
dell’Iri, Romano Prodi, una “entità” avrebbe
indicato Gradoli” come luogo in
cui è tenuto prigioniero Aldo Moro. Sulla base della segnalazione dall’aldilà il
6 aprile una perlustrazione viene organizzata a Gradoli, un paesino in provincia
di Viterbo. Al ministero dell’Interno, che aveva in precedenza ricevuto la
segnalazione su via Gradoli, nessuno mette in collegamento le due cose. E’ la
moglie di Moro, Eleonora, a chiedere se non potrebbe trattarsi di una via di
Roma. Cossiga in persona, secondo la testimonianza resa in commissione da Agnese
Moro, risponde di no. In realtà via Gradoli esiste, e sta sulle pagine gialle.
Il 18 aprile quella porta dietro cui forse era stato nascosto, fino a qualche
giorno prima, lo stesso Aldo Moro, viene finalmente sfondata. Non da polizia e
carabinieri però, ma da pompieri; che ci arrivano a causa di un allagamento.
Anche se i brigatisti lo hanno sempre negato, si tratta di una messinscena
organizzata perché il covo venga scoperto: il telefono della doccia è sorretto
da una scopa e puntato contro una fessura nel muro aperta con uno scalpello in
modo da far filtrare meglio l’acqua lungo i muri fino all’appartamento dei
vicini, che infatti daranno l’allarme. L’allagamento si verifica lo stesso
giorno in cui un falso comunicato delle Br spedisce migliaia di carabinieri e
poliziotti a cercare il cadavere di Moro nel lago gelato della Duchessa. Si
tratta di due episodi di difficile lettura. Alcuni brigatisti del gruppo
dirigente dichiareranno, molti anni dopo, che la scoperta del covo e il falso
comunicato li spinsero ad affrettare i tempi dell’operazione Moro verso la
decisione di sopprimere l’ostaggio; proprio come voleva Moretti, rappresentato
della cosiddetta “ala dura” delle
Br.
Ore 12.
Desta grande sensazione un editoriale del “Washington Post”, riportato dal
“Corriere della Sera”. Il titolo è: “Si
spera che dopo il delitto nasca un nuovo modo di governare”. Secondo gli
americani l’uccisione di Moro (che peraltro è ancora vivo) potrebbe concludere “la
vecchia tradizione italiana di governi deboli”. Quell’editoriale è un
riflesso di un fastidio molto diffuso negli ambienti politici statunitensi verso
Aldo Moro, ritenuto il principale colpevole della “apertura”
verso il Pci. Nel settembre del 1974 Moro, in veste di ministro degli
Esteri, aveva incontrato a Washington il segretario di Stato americano Henry
Kissinger. L’uomo “forte” dell’amministrazione
americana, notoriamente legato ai circoli massonici internazionali, aveva
affrontato il ministro italiano a muso duro: “Onorevole-
gli aveva detto - lei deve smettere
di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo paese a
collaborare direttamente. Qui, o lei smette di fare questa cosa, o lei la
pagherà cara. Veda lei come la vuole intendere”. Moro fu molto turbato.
Interruppe la visita con qualche giorno di anticipo, a causa di un malore, e
confidò al suo segretario, Corrado Guerzoni, la volontà di non fare più politica
per due o tre anni. Tornato a casa riferì alla moglie, parola per parola, ciò
che gli era stato detto. Non lo faceva quasi mai. Il 3 marzo del 1978, tredici
giorni prima di via Fani, la Corte Costituzionale aveva scagionato Moro
dall’accusa di essere “Antelope Cobbler”, nome in codice dell’uomo politico
italiano che aveva intascato una tangente da un milione di dollari per
l’acquisto dagli americani della Lockheed di 18 aerei militari. La complessa
manovra di accusa nei confronti di Moro era partita dagli uffici di Kissinger;
in Italia vi aveva attivamente partecipato Howard Stone, ex capo stazione della
Cia a Roma e iscritto alle liste della P2.
CAPITOLO III.
Tra gli esperti chiamati da
Cossiga a comporre il comitato di crisi nei giorni del sequestro c’era Steve
Pieczenick, uomo del dipartimento di Stato americano. Nella sua audizione
davanti alla commissione parlamentare sul caso Moro, Cossiga lodò il consulente
americano, parlando di “qualificata
collaborazione a livello di gestione della crisi”, ma non disse una parola
sull’attività svolta da Pieczenick; sappiamo in compenso cosa scrisse l’inviato
del Dipartimento di Stato in un documento di cui esiste copia presso
l’ambasciata americana di Roma: secondo il consulente di Cossiga “è
essenziale dimostrare che nessun uomo è indispensabile alla vita della nazione”.
Più che alla liberazione di Moro, Pieczenick appariva interessato alla
svalutazione del ruolo di Moro nella politica italiana. Il lavoro di Pieczenik
in Italia è racchiuso in una trentina di cartelle dattiloscritte sotto il titolo “Ipotesi
sulla strategia e tattica delle Br e ipotesi sulla gestione della crisi”. Si
tratta di una lettura sorprendente. La prima parte del documento consiste in una
serie di domande poste dal ministro Cossiga e nelle risposte dell’americano. La
domanda numero 9 di Cossiga è: “Come
possiamo creare strumenti idonei di controllo dei magistrati?”. Pieczenik
consiglia di “sfruttare in maniera
discreta nuove leggi per accrescere la vostra capacità di controllo e di
informazione”. Nel capitolo “Governo:
strategia”, il consulente americano spiega che è necessario “conservare
il controllo dei rapporti con le Br”. Una frase che lascia intendere che dei
rapporti già esistono, e si tratta solo di non cederli “ad
altri”. Una affermazione che, alla luce delle conoscenze che si hanno, è del
tutto sorprendente. La famiglia di Moro, secondo Pieczenik, deve essere convinta
a collaborare, e in caso contrario “va
isolata”. I suoi componenti vanno messi sotto sorveglianza
“apparentemente ai fini della loro sicurezza, ma anche per raccogliere elementi
informativi”. Altro consiglio è quello di “abbassare
l’intero livello della direzione della crisi: tenere tutte le decisioni lontano
da Andreotti e, possibilmente, da Cossiga”.
Sabato 18 marzo, ore 15.
All’Hotel Hilton di Roma si aprono i lavori del convegno che riunisce i “maestri
venerabili” delle 496 logge della
massoneria di palazzo Giustiniani. Licio Gelli, capo della P2,
è il personaggio più riverito.
Ore 16.
Al Viminale è riunito
il comitato tecnico operativo. Il ministro Cossiga dà notizia della prossima
approvazione di un decreto legge che dà mano libera alle forze di polizia per
fermi, intercettazioni e interrogatori. Il capo del Sismi, generale Santovito,
annunzia che è stato rafforzato il pattugliamento sul fronte iugoslavo.
Ore 21.
A Milano vengono
assassinati a freddo due giovani militanti di sinistra del circolo Leoncavallo,
Fausto Tinelli e Lorenzo Jucci. L’agguato, che serve ad alimentare la tensione,
è condotto in maniera che gli inquirenti definiranno “professionale”.
Le indagini si fermeranno su un binario morto.
Lunedì 20 marzo, ore 10.
Il sostituto procuratore Infelisi interroga Gianfranco Moreno. L’uomo era stato
visto molti mesi prima del sequestro Moro nel giardino dell’abitazione del
presidente della Dc, in via Savoia, ed era scappato quando si era accorto di
essere osservato. La polizia lo aveva rintracciato e interrogato. Moreno aveva
negato di essere mai stato in via Savoia, e la cosa era finita lì. Davanti a
Infelisi Moreno cambia versione: sì, è stato effettivamente in via Savoia la
sera in cui è stato notato; lo ha fatto per accompagnare un amico, Gerardo
Serafino. Quest’ultimo risulterà essere un collaboratore dell’onorevole
democristiano Gian Aldo Arnaud, amico di Gelli e iscritto alla P2.
Moreno, inoltre, potrebbe aver frequentato la sede della “Radionica”, una
società diretta da un ex nazista legato ai servizi segreti, tale Schuller.
Nonostante questo anche la pista Moreno verrà presto abbandonata.
Mercoledì 22 marzo.
Telefonate anonime minacciano Maria Cristina Rossi, giornalista dell’agenzia di
stampa Asca. La Rossi entra nella storia del caso Moro per via di alcune
fotografie scattate in via Fani ancora prima dell’arrivo della polizia. A farle,
dal balcone di casa, è stato suo marito, Gherardo Nucci. Lo stesso pomeriggio
del 16 marzo Maria Cristina Rossi, dopo aver fatto sviluppare il rullino, è
andata da Infelisi per consegnarglielo: davanti a lei il magistrato ha preso i
fotogrammi sulla strage restituendole gli altri. Quelle foto spariranno dalle
carte del processo. Infelisi dirà dapprima di aver restituito le foto alla Rossi
perché poco importanti; successivamente affermerà di non aver acquisito le foto
perché “di nessun valore probatorio”.
E’ probabile, invece, che quelle fotografie, le uniche scattate subito dopo la
strage, potessero dire molte cose: forse esse ritraevano l’uomo brizzolato, sui
cinquant’anni, in borghese, che arrivò subito sul luogo dell’eccidio dando
ordini - secondo i testimoni - “come
un poliziotto”. E che forse porterà via una delle cinque borse piene di
documenti che Moro teneva sempre con se. Quell’uomo, si scoprirà soltanto nel
1991, è il colonnello Angelo Guglielmi, appartenente all’epoca al famigerato “Ufficio
K” del Sismi, la centrale direttiva
di“operazione Gladio”. “Mi
trovavo in via Fani - disse poi
Guglielmi - per puro caso”. Ecco
cosa scriveva Steve Pieczenik nel 1978: “Sono
sempre dell’opinione che il rapimento di Moro ha avuto un appoggio interno, come
dimostra il fatto che la borsa più importante che Moro aveva con sé non si è
ritrovata. Altre prove sono il fatto che il rapimento è avvenuto nell’unico
giorno in cui Moro non si è recato in chiesa con il nipote, e che tutta
l’operazione si è svolta in maniera estremamente ‘pulita’”. Nei giorni
successivi alla strage circolò la voce che gli agenti della scorta di Moro,
fossero rimasti inerti per qualche motivo molto particolare, come ad esempio il
fatto di aver riconosciuto qualche volto noto tra gli assalitori. Ma la voce non
trovò ovviamente conferma. Ma l’importanza di quelle foto è resa più chiara da
una telefonata intercettata dalla polizia il primo maggio del 1978, otto giorni
prima dell’uccisione di Moro. Al telefono ci sono Sereno Freato, segretario di
Moro, e Benito Cazora, il deputato Dc incaricato in quelle settimane di “sondare” gli
ambienti della malavita organizzata.
Cazora - “Mi servono le foto
del 16 marzo”.
Freato - “Quelle del posto
lì…”
C - Sì, perché loro … (qui il
nastro è cancellato) pare che uno stia proprio lì, mi è stato comunicato da
giù”.
F - “E’ che non ci sono. Ah,
le foto di quelli, dei nove?”.
C - “No, no. Dalla Calabria mi
hanno telefonato per avvertirmi che in una foto presa sul posto quella mattina
lì, si individua un personaggio noto a loro”.
F - “E’ un problema questo”.
C - “Per questo ieri ti avevo
telefonato”.
F - “Come si può fare? Bisogna
riflettere un momento, sentire, dire al ministro. Saran tante”.
C - Una copia, capito, può
darsi che sia sui giornali del 16 o del 17 marzo”.
Nei giorni in cui si svolgeva
quella telefonata Cazora stava intrattenendo rapporti con l’andrangheta
calabrese in cerca di notizie utili. La presenza di uomini della malavita
organizzata intorno al sequestro Moro è un altro dei “buchi neri”
dell’inchiesta.
Martedì 28 marzo.
Una telefonata anonima segnala all’Ucigos i nomi di cinque brigatisti che “abitano
alla Prenestina e frequentano la casa della studentessa”. Tra essi c’è
Teodoro Spadaccini, già condannato e in libertà vigilata. Individuarlo e
pedinarlo sarebbe dunque facilissimo. Eppure, incredibilmente, l’Ucigos, diretto
dal questore Fariello, quello del “piano
Zero”, non trasmette subito quell’appunto alla Digos, come avrebbe dovuto.
Lo fa soltanto il 29 aprile, trentadue giorni dopo la segnalazione anonima. Un
ritardo fatale, perché dopo la segnalazione alla Digos bastano due giorni per
organizzare il pedinamento di Spadaccini e risalire, grazie ad esso, alla
tipografia di via Foà, impiantata e frequentata durante i giorni del sequestro
Moro dall’uomo che dirige l’operazione Moro, Mario Moretti. L’irruzione nella
tipografia avviene il 17 maggio, otto giorni dopo l’uccisione di Moro.
All’interno la polizia trova una macchina stampatrice AB
DIK 360 proveniente dal Rus (reparto unità speciali), uno degli uffici
del Sismi - lo sappiamo solo adesso - da cui dipende “Operazione
Gladio”. Con quella macchina le Brigate rosse stampavano i loro volantini
durante il sequestro. A portarla nella tipografia, stabiliranno le indagini, era
stato il solito Moretti. Richiesto di spiegazioni il Sismi rovescia su
magistratura e commissioni d’inchiesta una valanga di bugie: il Rus sarebbe un
ufficio di “sostegno al personale di leva in
servizio” (falso) e la stampatrice sarebbe
stata venduta come “rottame” dal
colonnello del Sismi Federico Appel a suo cognato Renato Bruni, per trentamila
lire. In realtà tra i “rottami” di
cui il Sismi si è liberato in quegli anni non risulta esserci nessuna
stampatrice. Inoltre la AB DIK 360 era stata
comprata per dieci milioni e mezzo tre anni prima ed era ancora in ottime
condizioni. Se la versione di Appel fosse vera egli dovrebbe almeno essere
incriminato per peculato, cosa che non è accaduta. Ma tutta la versione del
Sismi sui passaggi di mano della stampatrice fino alla tipografia delle Br
risulterà inventata a tavolino. E Moretti, dal
canto suo, non ha mai dato una spiegazione convincente della provenienza della
macchina.
Mercoledì 29 marzo.
Le Brigate Rosse diffondono ai giornali tre lettere di Aldo Moro indirizzate al
suo principale collaboratore, Saverio Rana, alla moglie e al ministro Cossiga.
“Io mi trovo sotto un dominio pieno e incontrollato” scrive
Moro; che avverte anche del “rischio di
essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e
pericolosa in determinate situazioni”. A Cossiga
Moro suggerisce i primi passi da fare per l’avvio di una trattativa. Il
presidente della Dc è convinto - e le Br glielo hanno fatto credere - che le sue
lettere resteranno riservate. Mentre vengono commissionate le perizie che devono
stabilire se la calligrafia è quella del prigioniero, il presidente del
Consiglio Andreotti mette le mani avanti: “Quale
che sia il responso dei periti, la condizione di Moro è tale da togliere ogni
validità morale agli scritti”.
Giovedì 30 marzo, ore 9.
Il sostituto
Infelisi rinvia l’annunciato sopralluogo in via Fani, per ricostruire l’agguato.
Lui e gli altri investigato hanno lavorato tutta la notte sull’arrivo delle
lettere delle Br. Quattordici giorni dopo la strage il magistrato che indaga non
ha ancora visto la scena del delitto.
Ore 10.
Appellandosi a un decreto legge introdotto apposta nove giorni prima, il
ministro dell’Interno Cossiga chiede al procuratore Capo Giovanni De Matteo di
trasmettergli una copia di tutti gli atti, comprese le eventuali registrazioni
delle comunicazioni telefoniche, raccolte fino a quel momento nell’inchiesta sul
sequestro Moro. La copia di atti e bobine richiesta da Cossiga diventerà
importantissima nel momento in cui si scoprirà che molte registrazioni
telefoniche sono scomparse o sono state cancellate da una misteriosa “manina”.
Più volte richiesto dalla commissione di indagine su Moro di consegnare i
documenti in suo possesso, l’allora ministro Cossiga non ha mai risposto. La
vicenda è tornata d’attualità nel gennaio del 1992, grazie ad una lettera con
cui il presidente della commissione Stragi Libero Gualtieri chiedeva al ministro
dell’Interno Scotti di accertare se gli archivi del Viminale contenessero la
famosa documentazione. La risposta di Scotti alimenta il mistero: “non
risulta documentazione trasmessa dall’autorità giudiziaria”. Dunque: o De
Matteo ha trasmesso quella documentazione e qualcuno (alias Cossiga) ha pensato
bene di farla scomparire, oppure De Matteo non ha spedito nulla. In questo caso,
però, in base alla legge il procuratore avrebbe dovuto motivare per iscritto,
entro cinque giorni dalla richiesta di Cossiga, il suo rifiuto. E questo rifiuto
non è agli atti. L’ottantenne De Matteo, intervistato dai giornali, spiega: “io
non ricordo nulla di quelle vicende, ma è certo che se avessi rifiutato di
consegnare i documenti avrei motivato la mia decisione per iscritto”. Ma la
soluzione del giallo, in realtà, l’aveva data lo stesso Cossiga in maniera
definitiva il 23 gennaio del 1980. Quel giorno, l’ex ministro dell’Interno venne
ascoltato dalla commissione Moro. Ad una domanda dell’onorevole Stefano Rodotà
sui suoi rapporti con la magistratura nei giorni del sequestro, Cossiga rispose: “Non
ci furono conflitti, ci furono diversità di opinioni che poi si risolsero. Non
vi fu mai un rifiuto alle richieste ufficiali”. Quella di avere la copia
degli atti dell’inchiesta fu appunto una richiesta ufficiale, a cui tra l’altro
Cossiga dava grande importanza, al punto da utilizzare un decreto legge
introdotto appositamente appena nove giorni prima. Quindi le bobine gli furono
consegnate. Resta da vedere che fine abbiano fatto, e perché Cossiga abbia
sempre negato di averle. Le copie sono di decisiva importanza proprio perché gli
originali non sono affidabili. Dagli uffici della Procura della Repubblica di
Roma sono sparite ad esempio le bobine contenenti le intercettazioni compiute
dal 27 aprile al 4 maggio sull’apparecchio di don Antonello Mennini, uno degli
intermediari tra Moro o la sua famiglia. Altre volte le registrazioni risultano
cancellate in parte, come nel caso di una telefonata tra Cossiga e un
collaboratore di Moro, Nicola Rana; si parla della questione dell’auto blindata
che Cossiga, secondo la famiglia Moro, avrebbe negato al loro congiunto poco
prima del 16 marzo. Cossiga: “Scusa se ti disturbo, io ieri ho dovuto smentire…
perché la ‘Nazione’, un certo Paglia che io non conosco… aveva detto che in sua
presenza Moro mi aveva chiesto una macchina corazzata e che io gliel’avevo
rifiutata”. Rana: “Eh!”. (Segue un fischio che cancella il seguito della
registrazione). Molte interrogazioni sono state rivolte in questi anni al
ministero della Giustizia sul perché di sparizioni e manomissioni. Il 14 maggio
del 1986, il ministro Martinazzoli dispose sulla vicenda un’inchiesta
ministeriale che si concluse il 30 luglio. Ma in quegli stessi giorni scoppiò la
crisi del governo Craxi, e Martinazzoli fu l’unico ministro ad essere
sostituito. Bisognò attendere un altro anno per avere una risposta dal nuovo
ministro, Virginio Rognoni, il quale affermò che “…all’epoca
dei fatti presso la procura della Repubblica di Roma non veniva compilato un
apposito registro delle intercettazioni effettuate… Di conseguenza gli ispettori
non hanno avuto a disposizione il parametro di raffronto certo tra le bobine a
suo tempo incise e quelle oggi esistenti”.
CAPITOLO IV.
Lunedì 3 aprile, ore
5,30. La
polizia irrompe in più di duecento appartamenti di Roma abitati da giovani di
estrema sinistra, 129 persone finiscono nei cellulari e poi alla Digos, 41
vengono arrestate. Tra i fermati ci sono decine di persone del tutto estranee
all’area dei fiancheggiatori e simpatizzanti delle Br. Si trascura invece di
approfondire un rapporto del capo della Digos che indica Valerio Morucci e
Adriana Faranda, i “postini” del sequestro Moro, come appartenenti alla colonna romana
delle Br. “Il mancato seguito d’indagine sorprende per diversi motivi” scriverà
la commissione d’inchiesta. Evidentemente gli inquirenti preferiscono pescare
nel mucchio, alimentando tensioni e confusioni, piuttosto che seguire le piste
più concrete.
Ore 12.
Al Viminale
il comitato tecnico operativo si riunisce per fare il punto della situazione. E’
l’ultima seduta della quale sono disponibili i verbali. Di tutto quello che
verrà detto nelle riunioni successive la commissione parlamentare d’inchiesta e
i magistrati non sono mai stati informati. Uno dei partecipanti, il senatore
Mazzola, ha però affermato che i verbali venivano redatti. L’onorevole Lettieri,
che in qualità di sottosegretario partecipò a quasi tutte le riunioni, ha fatto
anche il nome del funzionario incaricato di verbalizzare, tale Pellizzi.
Martedì 4 aprile, ore 10.
Mentre alla Camera Andreotti risponde a decine di interrogazioni sul sequestro
Moro, arriva la notizia che le Br hanno recapitato il comunicato numero 4 e una
lettera di Moro al segretario della Dc, Benigno Zaccagnini. La strategia
annunciata nel documento è quella del massimo ricorso alla violenza per
provocare il massimo di reazione di annullamento degli spazi democratici. Nella
lettera a Zaccagnini, Moro chiede al suo partito di assumersi “le
responsabilità che sono ad un tempo individuali e collettive”. Poi si
rivolge al Pci, schierato contro ogni trattativa, il quale “non
può dimenticare che il mio drammatico prelevamento è avvenuto mentre si andava
alla Camera per la consacrazione del governo che m’ero tanto adoperato a
costruire”. Come a sottolineare che la ragione del sequestro è proprio la
politica d’intesa con i comunisti.
Mercoledì 5 aprile, ore
9. Un
funzionario della Sip comunica alla Digos che non si è riusciti ad intercettare
la telefonata al “Messaggero” con cui le Br annunziavano il comunicato numero 4.
Cinque linee telefoniche erano andate in tilt proprio nel momento in cui i
brigatisti telefonavano. Un episodio simile si verificò di nuovo il 2 maggio. Il
comportamento della Sip durante tutto il sequestro è un altro dei punti male
esplorati dalle varie inchieste succedutesi. Il dottor Domenico Spinella, capo
della Digos, dichiarò in commissione di aver constatato “un
atteggiamento di assoluta non collaborazione da parte della Sip, che ancora oggi
dovrebbe essere perseguito dall’autorità giudiziaria”. La Sip dipendeva
all’epoca dalla Stet, di cui era amministratore delegato Michele Principe,
iscritto alla loggia P2.
Lunedì 10 aprile, ore 10.
Con le solite telefonate ai giornali di Roma, Milano, Torino e Genova le Br
rendono pubblico il comunicato numero 5. Vi si legge che l’interrogatorio del
prigioniero prosegue, e si sta centrando “sulle
trame sanguinarie e terroristiche che si sono dipanate nel nostro paese…
L’informazione e la memoria di Aldo Moro non fanno certo difetto ora che deve
rispondere davanti al tribunale del popolo mentre confermiamo che tutto verrà
reso noto al popolo e al movimento rivoluzionario che saprà utilizzarlo
opportunamente, anticipando le dichiarazioni che il prigioniero Moro sta
facendo, quella imparziale e incompleta che riguarda il terrorista di Stato
Emilio Taviani”. La minaccia delle Br di utilizzare i segreti inconfessabili
del potere democristiano non verrà mai mantenuta. Soltanto nell’ottobre del
1990, grazie alla scoperta degli originali del memoriale Moro, in via
Montenevoso a Milano, sapremo di quali micidiali ordigni Moro aveva fornito le
Br: l’esistenza di Gladio, l’ammissione dell’uso della strategia della tensione
in rapporto con i servizi segreti d’oltreconfine, i giudizi pesantissimi, sia
dal punto di vista umano che politico, su Andreotti e Cossiga. In quel 1978 le
Br hanno in mano la santabarbara che potrebbe far esplodere il cuore segreto e
inconfessabile della Dc. “Non ci eravamo resi conto della portata di quelle
rivelazioni”, dirà Prospero Gallinari, uno dei registi del sequestro. “Tale
incomprensibile comportamento omissivo da parte delle Br -
scrivono i giudici che hanno archiviato l’inchiesta sulla scoperta delle carte
di via Montenevoso - poteva e può
consentire l’ipotesi di un utilizzo delle stesse da parte di “centri” esterni,
di qualsivoglia genere, operanti, se del caso, in un più ampio e composito
scenario internazionale. E,
evidentemente, non in sintonia con le prospettive politiche che erano proprie
delle scelte di Moro”.
Martedì 11 aprile, ore
8.
A Torino
viene ucciso dalle Br l’agente di custodia Lorenzo Cotugno, uno dei tanti
ragazzi del sud sbarcati a Torino in cerca di fortuna. Ferito e arrestato il
terrorista Cristoforo Piancone. I giornali pubblicano la notizia secondo cui un
democristiano genovese già gambizzato dalle Br, Filippo Peschiera, sarebbe stato
incaricato di avviare una trattativa con le Br. Ma si tratta probabilmente di
una delle notizie false che il ministero dell’Interno divulga, seguendo le
direttive del “consigliere” americano
Steve Pieczenik. Scrive infatti l’esperto: “E’
importante che la stampa riceva ogni giorno un pacchetto controllato di notizie.
Il governo deve esercitare un attento controllo su tutte le notizie fornite agli
organi di diffusione con il preciso intento di diminuire l’intensità del “caso
Moro” e di manovrare una strategia che offra al governo la massima flessibilità
tattica. La strategia del temporeggiamento deve essere presentata in maniera da
far ritenere che il governo ha già studiato piani alternativi di vario genere ma
che la loro attuazione richiede del tempo. Ovviamente la stampa non ne sarebbe
soddisfatta e sfornerebbe una serie di notizie erronee. Ciò però è sempre di
gran lunga meglio che non avere il controllo delle notizie”.
Giovedì 12 aprile, ore 8.
La polizia perquisisce tutte le abitazioni del numero 10 di via Bonucci, a Roma.
A poche decine di metri c’è via Montalcini, dove al numero 8 c’è un covo delle
Br. Forse si tratta di una delle “prigioni” di
Moro.
Ore 11.
Il
presidente del Consiglio Andreotti riceve il procuratore capo De Matteo. Il
magistrato è favorevole a mettere una taglia sulla testa dei brigatisti.
Andreotti obietta che questo potrebbe mettere in pericolo la vita di Moro.
Sabato 15 aprile, ore 11.
A Genova,
Milano, Torino e Roma viene fatto trovare il comunicato numero 6. E’ la sentenza
del “processo” popolare: “Aldo
Moro è colpevole e perciò viene condannato a morte”. Il resto del comunicato
è un balletto di contraddizioni: “Non
ci sono segreti che riguardano la Dc, non ci sono quindi clamorose rivelazioni
da fare”. E subito dopo: “L’interrogatorio
ad Aldo Moro ha rivelato le turpi complicità del regime, ha additato con fatti e
nomi i veri e nascosti responsabili delle pagine più sanguinose della storia
degli ultimi anni, ha messo a nudo gli intrighi di potere, le omertà che hanno
coperto gli assassini di Stato, ha indicato l’intreccio degli interessi
personali, delle corruzioni, delle clientele che lega in modo indissolubile i
vari personaggi della putrida cosca democristiana e questi (nessuno si stupirà)
agli altri dei partiti loro complici”. Tutte queste informazioni, scrivono
le Br, “saranno rese note attraverso
la stampa e i mezzi di divulgazione clandestina, perché la stampa del regime è
sempre al servizio del nemico di classe”. In realtà la stampa clandestina
non pubblicherà nulla sul processo a Moro. Per la seconda volta le Br non
mantengono la promessa; la prima era stata quando avevano scritto che tutto
quanto detto da Moro sarebbe stato reso noto al “popolo”.
Ore 9,25.
Una telefonata anonima alla redazione del “Messaggero” annuncia che in piazza
Belli ci sono due messaggi delle Br. II tecnico
della Sip incaricato dell’intercettazione non riesce a stabilire da dove venga
la telefonata perché la linea cade nel momento decisivo. Il giornalista del
quotidiano romano che corre in piazza Belli trova una sola busta, contenente il
comunicato numero 7. Vi si annuncia che Moro è stato giustiziato “mediante
suicidio”, e che il corpo si trova in fondo al lago della Duchessa, nei
dintorni di Rieti. In quelle stesse ore avviene la “scoperta” del
covo di via Gradoli.
Ore 10.
Iniziano le ricerche del cadavere di Aldo Moro tra i ghiacci del lago della
Duchessa. Ma Giannino Guiso, avvocato dei brigatisti, anticipa tutti definendo
il comunicato numero 7 “una
provocazione del Viminale”. Si accerterà in seguito che a scrivere quel
comunicato fu Tony Chicchiarelli, un pregiudicato appartenente alla “banda
della Magliana”, un gruppo di criminali comuni in contatto con elementi
della P2,
con gli estremisti di destra e di sinistra e con i servizi segreti. Ma chi mise
in campo Chicchiarelli? Qualcuno ha fatto notare una strana coincidenza: pochi
giorni prima di quel 18 aprile l’allora magistrato Claudio Vitalone suggerì al
ministro dell’Interno Cossiga “una
contromossa per non lasciare i brigatisti padroni della partita”.
“Cossiga approvò la proposta -
racconta Vitalone - e quando uscì il
comunicato del lago della Duchessa io trasalii perché mi parve proprio
l’applicazione tardiva del mio suggerimento, ma realizzata male perché mancava
il preventivo rapporto all’autorità giudiziaria”. Fu il ministro Cossiga, da
cui dipendevano i servizi segreti, a organizzare quel depistaggio? E perché
l’incarico venne dato proprio a Tony Chicchiarelli, un uomo ambiguo, che sembra
sapere molto sui sequestratori di Moro? In casa sua verranno trovati due
spezzoni di foto scattate a Moro nella prigione brigatista. Con alcuni amici
Chicchiarelli si era addirittura vantato di essere stato lui a scattare la
famosa foto di Moro con un giornale in mano con un drappo delle Br sullo sfondo.
E ancora: chi diede l’ordine, qualche anno dopo, di eliminare Chicchiarelli,
testimone scomodo dei segreti del caso Moro?
Milano, Giovedì 20
aprile, ore 9.
La colonna
Br Walter Alasia uccide il maresciallo Franco De Cataldo, agente di custodia a
San Vittore.
Roma, Ore 12,10.
Le Br fanno ritrovare il comunicato numero 7, stavolta autentico, con una foto
di Aldo Moro ritratto con in mano una copia della “Repubblica” del 19 aprile. E’
la prova che il prigioniero è vivo. Si sviluppa tra i partiti la polemica sulla “trattativa”.
In realtà, si scoprirà poi, quel furioso contrasto - che divise l’opinione
pubblica - coprì la sostanza vera del problema: lo Stato era o no impegnato a
cercare la prigione di Moro per liberarlo?
Venerdì 21 aprile, ore
11. Al
termine della riunione della segreteria, la Dc fa leggere al deputato Giuseppe
Pisanu un comunicato. Il partito riafferma “la
propria indefettibile fedeltà alle Stato democratico, alle sue istituzioni, alle
sue leggi”. Ma ciononostante ritiene che una organizzazione come la Caritas
internazionale è autorizzata ad esplorare le possibili vie di una trattativa con
le Br. Vale la pena ancora una volta di rileggere i “consigli” di
Pieczenik a Cossiga: “Cercare di
trovare un intermediario indipendente, scelto dal governo, che agisca a nome di
organismi umanitari… Egli deve esplorare altre opzioni diverse dallo scambio e
cercare di guadagnare tempo. Come elemento base offrire la vita dei brigatisti
in cambio di quella di Moro. Tenersi pronti a sconfessarlo”.
Ore 16.
In consiglio
dei ministri Cossiga informa i colleghi sugli ultimi sviluppi delle indagini:
assicura la massima collaborazione di forze dell’ordine e magistratura. In
realtà le indagini sono ferme al punto di partenza.
Sabato 22 aprile, ore
12,30.
L’ “Osservatore Romano” riporta in prima pagina una lettera del Papa alle Br.
L’appello agli “uomini delle Brigate
Rosse” commuove gli italiani. La Dc
lo accoglie con “commosso
ringraziamento”. Meno commossa è la signora Eleonora Moro: il Papa, infatti,
chiede la liberazione di Moro “semplicemente,
senza condizioni”. Secondo i familiari del sequestrato il pontefice avrebbe
voluto fare di più, ma ha subito forti pressioni in senso contrario.
Ore 22,05.
Da mezz’ora
la polizia ha messo sotto controllo il telefono di Don Antonello Mennini, un
parroco di cui Moro si è già servito dalla prigione per recapitare lettere
riservate. Al numero del prete arriva una telefonata.
Uomo - “Lello?”.
Don Mennini - “Sì”
U - “Si é fatto tutto quello
che si poteva fare, cara primula rossa. Adesso è pericoloso”.
A questo punto avviene un
fatto che ha dell’incredibile: l’agente che intercetta la telefonata, Giorgio
Felli, si inserisce ripetendo le parole “si
è fatto quello che si è potuto”. Tanto basta perché il prete e il suo
interlocutore capiscano di essere intercettati e interrompano la conversazione.
L’agente Felli spiegherà di aver commesso un errore tecnico. Ma l’apparecchio
che usa, un Ghr 4000, non ha
tasti che premuti per errore possano causare il pasticcio di cui Felli è stato
protagonista. Inoltre Felli, nel tenere sotto controllo il telefono di don
Mennini, continuerà a dimenticarsi di trascrivere i numeri telefonici dei suoi
interlocutori. E ancora: dal processo sono scomparse tutte le intercettazioni
dal 24 aprile al 4 maggio. Dalle manomissioni si è invece salvata la
registrazione del 9 maggio, il giorno del ritrovamento del cadavere di Moro. Un
monsignore chiede di don Mennini e gli dice: “L’hanno
ammazzato” e poi “ho
da dirti dei segreti”. L’agente Felli ancora una volta dimentica di
individuare il chiamante. E fa lo stesso il giorno dopo, quando Don Mennini
parla con un altro monsignore e gli dice che si sarebbe potuto fare qualcosa
perché “la segreteria sapeva di quel
nome”.
Lunedì 24 aprile, ore 10.
Le Br depositano con le solite modalità una lettera di Moro a Zaccagnini e il
comunicato numero 8, che contiene i termini di una eventuale trattativa. E’ una
lista di tredici detenuti da liberare in cambio della vita del presidente della
Dc. La lettera di Moro a Zaccagnini, dal canto suo, contiene questa frase: “Per
una evidente incompatibilità chiedo che ai miei funerali non partecipino
autorità dello Stato, né uomini di partito perché non degni di accompagnarmi con
la loro preghiera e il loro amore”.
Martedì 25 aprile.
Il settimanale “Panorama” scrive che “potenti
gruppi di pressione politici, economici, militari, stanno cercando di convincere
il presidente Jimmy Carter che, dopo il rapimento Moro, la situazione in Italia
sta precipitando”. Tra i notabili della destra americana la rivista cita
Kissinger e Michael Ledeen, uno strano personaggio che ha buoni agganci nei
nostri servizi segreti piduisti e intrattiene cordiali rapporti col ministro
Cossiga.
Mercoledì 26 aprile, ore
9.
L’ex presidente
della regione Lazio, Girolamo Mechelli, viene ferito alle gambe mentre esce da
casa. Il giorno dopo a Torino toccherà a Sergio Palmieri, addetto alle relazioni
sindacali della Fiat.
Iniziano i contatti tra esponenti del Psi e simpatizzanti delle Br. Viene
stabilito un contatto con Valerio Morucci attraverso Franco Piperno e Lanfranco
Pace. Quest’ultimo era tra le persone fermate per alcuni giorni dopo la
maxi-retata del 3 aprile. Nonostante sia ufficialmente nel mirino della polizia
egli sarà libero di incontrarsi a più riprese in quei giorni con Morucci e la
Faranda in una Roma che sembra in stato d’assedio.
Sabato 29 aprile.
Undici lettere di Aldo Moro partono dal carcere delle Br, indirizzate a uomini
politici. Da una di esse prende spunto l’ennesimo “giallo” del
caso Moro. Si tratta di quella indirizzata all’onorevole Dell’Andro. Attraverso
canali sotterranei Moro la fa avere al solito don Mennini, accompagnandola con
un biglietto che contiene meticolose e del tutto superflue indicazioni per
rintracciare Dell’Andro; eccole: “On.
Renato Dell’Andro: può essere all’albergo Minerva (mi pare proprio che si chiami
così, proprio di fronte alla chiesa) o al ministero della Giustizia, o infine
alla sede del gruppo Dc a Montecitorio. Se per dannata ipotesi avessi sbagliato
il nome dell’albergo sappi che i due alberghi sono così”. A questo punto
Moro traccia sul foglio un rettangolo che raffigura piazza della Minerva con due
edifici su angoli opposti. Ma non si tratta, come sarebbe logico, dei due
alberghi citati nel messaggio; uno dei due, infatti, è la chiesa della Minerva,
a cui Moro non ha minimamente accennato. La chiesa della Minerva, in compenso, è
assiduamente frequentata da padre Felix Morlion, un domenicano legato ai servizi
segreti francesi, belgi e soprattutto americani. In Italia Morlion ha messo in
piedi una rete di spionaggio che, stando ad un documento riservato acquisto
dalla commissione Stragi, produce un rapporto quotidiano sulla situazione
politica, “in soli dodici esemplari”,
che viene trasmesso “ad altissime
personalità e ai dirigenti dei servizi collegati”. Di Morlion e dei suoi
presunti rapporti con Ali Agca, il mancato killer di papa Giovanni Paolo II,
si stanno già occupando i magistrati romani. Sulla possibilità che Moro si
servisse delle lettere per mandare messaggi in codice, ha molto insistito suo
fratello, Alfredo Carlo. “Mi sembra
di poter sostenere - ha sostenuto
egli di fronte alla commissione Stragi nell’ottobre del 1990, dopo aver letto la
documentazione ritrovata in via Montenevoso - che
da varie lettere, ovviamente tra le righe, emerge il tentativo di far percepire
all’esterno che la situazione doveva essere assai più complessa di un mero
rapimento da parte di un piccolo nucleo di terroristi”. In una lettera, fa
notare Alfredo Moro, il fratello, a proposito del sequestro, parla di “un
ordine brutale partito chi sa da chi”.
Domenica 30 aprile, ore
11. In
casa Moro squilla il telefono. E’ Mario Moretti, l’uomo che ha in mano la
gestione del sequestro Moro. Parla con Maria Fida, figlia del presidente della
Dc. Comunica che “la decisione è
stata già presa”, e che solo “un
intervento di Zaccagnini, immediato e chiarificatore”, può modificare la
situazione.
Lunedì primo maggio.
In tutta Italia milioni di lavoratori scendono in piazza contro il terrorismo.
Enrico Berlinguer e Alessandro Natta incontrano Andreotti e protestano per
l’inefficacia delle indagini: “Non si
scopre nulla - accusa il segretario
del Pci - e non si seguono le mosse
di quanti, nella clandestinità, prendono contatti con familiari e avvocati”.
Quasi in risposta a queste parole il procuratore generale di Roma, Pietro
Pascalino, dispone l’avocazione dell’inchiesta “per
ragioni di opportunità”. Un solo sostituto procuratore, Luciano Infelisi, ha
condotto fino a quel momento le indagini. Qualcuno ricorda che poco tempo prima,
per indagare sullo scandalo del calcio-scommesse, era stato creato un “pool” di
magistrati. Non solo: il ruolo della Procura è chiaramente subordinato a quello
del ministero dell’Interno. Al punto che Infelisi riceveva da Cossiga con
parecchi giorni di ritardo le lettere spedite da Moro.
CAPITOLO V.
Martedì 2 maggio.
Sulla rivista O.P. Carmine
Pecorelli, un giornalista iscritto alla P2 e
portavoce di alcuni settori dei servizi segreti, definisce l’agguato di via
Fani: “Il segno di un lucido superpotere”.
Per Pecorelli “le Br non rappresentano il
motore principale del missile, esse agiscono come motorino per la correzione di
rotta dell’astronave Italia”. Per alcuni dei terroristi egli prevede “trattamenti
di favore quando la pacificazione nazionale sarà compiuta”. Pecorelli mostra
di sapere molte cose sul caso Moro, forse troppe. Al punto che i magistrati
impegnati nel quarto processo Moro rileggeranno con attenzione tutte le vecchie
annate di O.P., alla ricerca di nuovi spunti di
indagine. Parecchio tempo prima dell’agguato di via Fani Pecorelli già scrive su “Moro…Bondo”,
fa un oroscopo in cui prevede per il politico democristiano la morte dopo una
lunga detenzione: commissiona e pubblica una vignetta in cui Moro ha falce e
martello appuntati sul petto; sembra conoscere fin dall’inizio i retroscena: “Il
cervello direttivo che ha organizzato la cattura di Moro -
scrive Pecorelli dopo il sequestro - non ha
niente a che vedere con le Brigate Rosse tradizionali. Il commando di via Fani
esprime in forma desueta ma efficace la nuova strategia politica italiana.
Curcio e compagni non hanno nulla a che vedere con il grande fatto tecnicistico
politico del sequestro Moro”. E ancora: “Il
caso Lockheed e l’agguato di via Fani sono due episodi di stabilizzazione ad
altissimo livello, episodi di solito trattati dalle reti internazionali dello
spionaggio”. Il 23 maggio del 1978, sul primo numero dopo l’uccisione di
Moro, O.P. pubblicò una sibillina cronaca del
ritrovamento del cadavere: Pecorelli si soffermò sul muro al quale era addossata
la Renault rossa: “Dietro ci sono i ruderi
del teatro di Balbo, il terzo anfiteatro di Roma; ho letto in un libro che a
quel tempo gli schiavi fuggiaschi e i prigionieri vi venivano condotti perché si
massacrassero tra di loro. Chissà cosa c’era nel destino di Moro perché la sua
morte venisse scoperta proprio contro quel muro? Il sangue di allora e il sangue
di oggi”. Quell’accenno a schiavi e prigionieri che combattono nell’arena,
piazzato nel mezzo di un articolo che parlava d’altro era allora
incomprensibile. Diventò trasparente dopo la scoperta di Gladio. Chi altri, se
non i gladiatori, “combattono nell’arena” tra
di loro? O.P. è anche il solo giornale a
scrivere dei rapporti tra criminalità organizzata e Br intorno al sequestro: la
magistratura inizierà ad occuparsene molti anni dopo. Scriveva Pecorelli nel
numero del 17 ottobre 1978, alcuni mesi dopo l’uccisione del presidente della
Dc: “Il ministro di polizia (Cossiga,
N.d.R.) sapeva tutto, sapeva persino
dove era tenuto prigioniero Moro, dalle parti del ghetto… perché un generale dei
carabinieri era andato a riferirglielo di persona nella massima segretezza”.
Continuava Pecorelli: “Il ministro
non poteva decidere nulla su due piedi, doveva sentire più in alto… magari fino
alla loggia di Cristo in paradiso (la
massoneria, N.d.R.)”. Ed ecco, sempre secondo Pecorelli, la risposta di
Cossiga al generale dei carabinieri: “Abbiamo
paura di farvi intervenire perché se per caso ad un carabiniere parte un colpo e
uccide Moro, oppure i terroristi lo ammazzano, chi se la prende la
responsabilità?”. Il fatto che le forze dell’ordine avessero individuato la
prigione di Moro durante i giorni del sequestro ha avuto, nel corso di questi
anni, diverse conferme: l’ultima, a sorpresa, dallo stesso Cossiga: il 10 giugno
scorso 1991, poco dopo la riesumazione delle rivelazioni di Pecorelli fatta da
“Avvenimenti”, il presidente rivelò che reparti speciali degli incursori della
Marina erano stati sul punto di intervenire “dove
si era convinti di aver trovato la prigione di Moro”; Cossiga parlò anche di
un ufficiale medico che si era offerto “per
fare scudo a Moro col suo corpo durante l’assalto alla prigione Br”.
Cossiga, ascoltato a lungo dalla commissione di indagine sul sequestro Moro nel
maggio del 1980, non aveva parlato di questo e di altri episodi. L’“eroico”
ufficiale medico citato da Cossiga è Decimo Garau, istruttore di Gladio, che
al giudice di Venezia Carlo Mastelloni ha confermato le rivelazioni di Cossiga;
Garau ha anche detto che il reparto incaricato di liberare Moro si allenò nei
giorni del sequestro all’interno della caserma del Rud (Raggruppamento
Unità Difesa) di Cerveteri; che è,
come si è poi scoperto, il centro di addestramento degli uomini della
specialissima e segreta “sezione K” del
Sismi. C’è anche una coincidenza impressionante: Garau e i suoi si addestravano
tra i casolari della Tolfa, a nord di Cerveteri; nelle suole delle scarpe di
Aldo Moro i periti hanno trovato terra proveniente proprio dalla zona della
Tolfa. E ancora: “gli incursori si
esercitavano in operazioni di esfiltrazione” immaginando
che il sequestrato venisse rinchiuso in una cassa; si tratta proprio del metodo
usato dai brigatisti per trasportare Moro nel loro covo subito dopo il
sequestro. Si ricorderà che il colonnello Guglielmi, l’uomo che ritroviamo “casualmente” la
mattina del 16 marzo 1978 a poche decine di metri dal luogo in cui viene
sequestrato il presidente della Dc, apparteneva alla “sezione
K”. Pecorelli, l’uomo dei misteri, venne ucciso nel novembre del 1979 da un
killer mai identificato. Due mesi prima aveva scritto: “Torneremo
a parlare di questo argomento (il
caso Moro, N.d.R.), del furgone, dei piloti, del giovane dal giubbotto
azzurro visto in via Fani, del rullino fotografico, del garage compiacente che
ha ospitato le macchine servite all’operazione, del prete contattato dalle Br,
della intempestiva lettera di Paolo (il
papa, N.d.R.), del passo carraio al centro di Roma, delle trattative
intercorse”. Tra le cose a cui accenna Pecorelli alcune non sono mai entrate
nelle indagini. Si tratta probabilmente di quella “zona
d’ombra” del caso Moro conosciuta
solo da pochissimi di coloro che allora ebbero un ruolo nella vicenda. Tra le
molte carte sparite ci sono anche quelle di Pecorelli: secondo una nota inviata
alla commissione Moro dal comando generale dei carabinieri molto materiale venne
sequestrato in casa e nell’ufficio del giornalista dopo la sua morte. Ma nessuno
è in grado di dire che fine abbia fatto.
Mercoledì 3 maggio, ore
17.
In piazza
Barberini, sotto un bel sole, Mario Moretti incontra Morucci e la Faranda e
comunica loro la decisione di uccidere Moro. I due sono contrari, ma non c’è più
nulla da fare.
Venerdì 5 maggio, ore 10.
Le Br diffondono il comunicato numero 9: “A
parole non abbiamo più niente da dire alla Dc… Concludiamo quindi la battaglia
iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Moro è stato condannato”.
Lunedì 8 maggio, ore 11.
Un brigatista telefona a un parroco della Val di Susa e gli chiede di riferire
ad Eleonora Moro che “Il mandarino è
marcio”. E’ l’anagramma della frase “il
cane morirà domani”.
Martedì 9 maggio, ore 10.
Il cadavere di Aldo Moro viene lasciato dai brigatisti nel cofano di una Renault
4 rossa, in via Caetani, a uguale distanza dalle sedi della Dc e del Pci
(*). Il presidente della Dc è stato ucciso,
dopo che i brigatisti gli hanno ordinato di rannicchiarsi nel portabagagli
dell’auto, da una raffica di pistola mitragliatrice Skorpion al petto e da due
colpi di una pistola calibro 9. L’esecuzione materiale è stata attribuita in
diversi processi a Prospero Gallinari, ma esistono dei dubbi sul fatto che sia
stato realmente lui a sparare. E’ solo l’ultimo dei misteri del caso Moro: a
distanza di quattordici anni e di quattro processi non ci sono certezze su nulla
di ciò che riguardi il più traumatico omicidio della storia italiana del
dopoguerra. Anche per questo, all’ombra del caso Moro, si gioca ancora oggi una
partita dai contorni non sempre decifrabili.(*) In realtà questo
passaggio del racconto contiene un’imprecisione: magrado per anni i cronisti
abbiano riportato l’aneddoto del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in un
luogo che si trovava ad eguale distanza tra le sedi del Pci e della Dc, come si
evince dalla piantina allegata, ciò non risponde a verità: via Caetani non è
affatto equidistante da via delle Botteghe Oscure e Piazza del Gesù. Resta
comunque nelle vicinanze di entrambe (motivo per cui, probabilmente, dal punto
di vista giornalistico, la dicitura “nei
pressi” è risultata meno
accattivante di “equidistante”),
ma risulta più vicina alla prima (della quale è una traversa) che alla seconda.
In ogni caso, per arrivare a via Caetani partendo da Piazza del Gesù e facendo
tappa forzata in via delle Botteghe Oscure, si percorrono a piedi in totale solo
204 metri (N.d. Gianluca Neri).
CAPITOLO VI.
Il 23 maggio del 1980
Francesco Cossiga fu interrogato dalla commissione d’inchiesta sul caso Moro. Da
alcuni mesi era presidente del Consiglio. Dimessosi all’indomani della
conclusione tragica della vicenda Moro (da lui seguita nel ruolo-chiave di
ministro dell’Interno) era rapidamente tornato al vertice del potere, alla guida
di un governo comprendente, dopo molti anni, anche il Psi. Quando Cossiga
depose, ancora molti particolari sulle indagini durante i 55 giorni del
rapimento non erano noti. Furono scoperti in seguito, dalla magistratura o dalla
stessa commissione parlamentare. Ma Cossiga, certamente, sapeva tutto, visto che
era stato il massimo responsabile delle ricerche. Eppure su molti punti non
disse la verità alla commissione. Siamo andati a rileggere il verbale
dell’interrogatorio. Ecco le più clamorose inesattezze (ma più congruamente
possono essere definite affermazioni false) contenute nella deposizione di
Francesco Cossiga.
“QUALCOSA STA
PER ACCADERE”.
“Per quanto mi consta, ed ho fiducioso motivo di ritenere che tutto mi consti a
questo riguardo, non risulta pervenuta alle autorità di governo, né agli organi
di polizia, né ai servizi di informazione e di sicurezza, in via preventiva,
alcuna notizia informativa su azioni terroristiche o che potessero far pensare
in qualche modo alla preparazione di azioni terroristiche”. Falso. Nella
risoluzione strategica numero 4 delle Br veniva data ai militanti la specifica
direttiva di colpire gli uomini del potere democristiano “a
partire dagli organismi centrali” (Moro
era presidente della Dc). Inoltre altre fonti hanno rivelato il seguente
episodio. Alla questura di Roma era giunto tre mesi prima dell’agguato un
avvertimento preciso e giudicato dagli esperti molto credibile: “Si
sta concretamente preparando l’irlandizzazione di Roma” (Cossiga
farà spesso riferimento, nella sua deposizione, al “modello
irlandese” di terrorismo). La
questura trasmise subito l’appunto al capo della polizia, che ne informò
direttamente Cossiga. Riferisce la fonte: “Cossiga
fu talmente preoccupato dalla minaccia contenuta nel messaggio da mettersi le
mani nei capelli”. Infine: il 6 marzo era pervenuta al Sismi (tramite la
branca dei servizi operante nelle carceri, diretta dal generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa) la segnalazione, da parte di un detenuto nel carcere di
Campobasso, che “ci sarà un altro
attentato a grossa personalità di Roma”.
PERCHE’
SENZA AUTO
BLINDATA?
“Se debbo
dare un giudizio ex post, la protezione dell’onorevole Moro era insufficiente,
ma se debbo dare un giudizio rispetto all’epoca, debbo dire che la protezione
era secondo gli standards comuni”. Falso. E’ stato appurato che in quello stesso
periodo personaggi di minor rilievo e responsabilità dell’onorevole Moro avevano
un’auto blindata, fornita dal ministero. Moro no.
LA VETTURA
DI ANDREOTTI.
“Nel 1978 il
presidente del Consiglio dei ministri in carica, onorevole Andreotti, non usava
l’auto blindata, pur avendone la disponibilità”. Falso. Alcuni anni dopo sono
stati gli stessi brigatisti a dichiarare che, nella fase preparatoria del
rapimento, rinunciarono al sequestro di Andreotti proprio perché egli era “più
protetto” grazie anche all’auto
blindata.
MA I
FAMILIARI ERANO IN ALLARME.
“A quanto mi consta,
nell’autorimessa della Presidenza del Consiglio esisteva un’autovettura
blindata, esattamente una “130”, e quindi, se fosse stata richiesta, avrebbe
potuto essere messa a disposizione; non solo, ma se fosse stata richiesta al
ministero dell’Interno, non vi sarebbe stato nessun motivo per non mettere a
disposizione questa autovettura… data la confidenza che l’onorevole Moro aveva
con me; devo dire che la macchina me l’avrebbe senz’altro chiesta e, se l’avesse
chiesta, gli sarebbe stata data senza difficoltà. E non aggiungo altro”. Falso.
I familiari dell’on. Moro e le signore Ricci e Leonardi, mogli di due uomini
della scorta, hanno dichiarato che l’auto era stata chiesta al ministero, anche
perché attorno a Moro erano stati notati strani movimenti e strani personaggi.
In particolare il maresciallo Leonardi era “fuori
dalla grazia di Dio” perché sapeva
che era stata segnalata la presenza di “brigatisti
non di Roma”. Su allarmi e minacce Leonardi fece rapporto al Comando
generale dei Carabinieri.
APPENDICE.
«CHI NASCONDE
LA VERITÀ»
Intervista di Michele Gambino a Sergio Flamigni. Le tagliatelle di casa
Flamigni sono buone come sempre. Piazzato tra la bottiglia del vino e il pane,
il registratore continua a incidere la cadenza romagnola del padrone di casa: «Perché
vedi, in via Montenevoso…». La moglie sorride, allarga le braccia: «Sergio,
almeno a tavola cambia discorso», ma poi non si perde una parola. Alle
nostre spalle c’è un grande tavolo ingombro di documenti, ritagli di giornali,
verbali di polizia. Sono i materiali grezzi da cui Sergio Flamigni, ex senatore
comunista, membro della commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro,
ricava da quindici anni, le analisi e le scoperte che tanto fanno infuriare il
senatore Francesco Cossiga - «quel
poveretto di Flamigni» - e per altri
versi una parte della sinistra italiana, alcuni ex brigatisti compresi. E che
costringono i Servizi segreti a tenere discretamente sotto osservazione la
villetta di Flamigni a Oriolo Romano, quaranta chilometri a nord di Roma, e
soprattutto il suo telefono.
«Degli
insulti di Cossiga non mi preoccupo. A me, uomo di sinistra, fanno male
piuttosto gli attacchi e di una parte della sinistra, preoccupata più di
difendere l’identità del fenomeno brigatista che di guardare i fatti».
Ecco, parliamo dei fatti…
«Prima,
se permetti, vorrei sgombrare il campo da un equivoco a cui mi hanno crocefisso:
io sono convinto che le brigate rosse siano state un fenomeno autonomo, con una
sua dimensione storica e forti legami nelle fabbriche e nella società. E che
attorno a loro, in un certo periodo, si siano sviluppate ampie aree di
fiancheggiamento: l’Autonomia, Potere operaio…»
Questo è innegabile.
«Certo.
Eppure mi dipingono come il dietrologo di professione, uno convinto che le Br
fossero una emanazione della Cia e dei Servizi segreti italiani. Io invece dico
solo che nel Paese di Gladio, della P2,
delle deviazioni, della strategia della tensione svolta in funziona
stabilizzante, nessuno può garantire che queste strutture occulte non abbiano
approfittato del fenomeno brigatista. È difficile sostenere, come fanno i
brigatisti, che nel periodo successivo all’arresto di Curcio le Br non abbiano
avuto infiltrati nel loro gruppo. Basta pensare a un personaggio come Federico
Umberto D’Amato, piduista, ex capo della divisione affari riservati del
Viminale, poi consulente dei ministri dell’Interno, uomo con solidi legami negli
ambienti dei Servizi segreti internazionali. Lui nel ‘74 all’epoca del sequestro
Sossi, disse: «noi i brigatisti li conosciamo tutti uno per uno», e fu questa
imprudente dichiarazione a costargli la direzione degli affari riservati».
Fu lui, tra l’altro, uno
dei fondatori del club di Berna.
«Si,
questo circolo in cui i capi dei Servizi di tutta Europa si riunivano
periodicamente proprio per studiare le tecniche di infiltrazione nei movimenti
studenteschi. E poi basta leggere le dichiarazioni recenti di William Colby, ex
capo della Cia, il quale spiega che l’infiltrazione è il metodo naturale di
lotta al terrorismo; o del generale dei carabinieri Nicola Bozzo, un grande
esperto di lotta al terrorismo, che ha raccontato di come alcuni militari si
iscrivessero all’Università, mimetizzandosi al punto da laurearsi».
Da un lato ci sono i
brigatisti, o molti di loro, che negano qualsiasi infiltrazione. Dall’altro c’è
un ufficiale, il generale Delfino, accusato di aver piazzato nelle Br un mafioso
calabrese, Antonio Nirta, che invece di collaborare con le autorità avrebbe
addirittura partecipato al sequestro di Moro. Un bel corto circuito…
«È
possibile che i brigatisti siano in buona fede quando affermano di non aver
subito infiltrazioni. Sono sicuro, anzi, che la maggior parte di essi non si
sono resi conto di molte delle cose che accadevano. Io sono convinto che gente
come Azzolini, Bonisoli, la Mantovani, Gallinari e probabilmente lo stesso
Moretti credessero davvero di fare la rivoluzione. Ma mentre gli uomini della
prima fase brigatista, come Franceschini, ammettono ad esempio, di aver avuto
rapporti con i Servizi israeliani, o considerano la possibilità di essere stati
strumentalizzati inconsapevolmente, quelli della seconda leva assumono un
atteggiamento incomprensibile, di totale chiusura. In nome della loro purezza
finiscono per coprire gravissime responsabilità di organi e uomini delle
istituzioni nelle manovre che certamente vi furono intorno al caso Moro».
Nell’elenco di brigatisti
in buona fede che hai appena fatto manca il nome di Valerio Morucci. Non sembra
una omissione casuale.
«Non
ho elementi per accusare nessuno in particolare. Su Morucci è intervenuto di
recente Franceschini, il quale afferma - sulla base di sue conoscenze - che
Morucci dietro la qualifica di dissociato ha agito in realtà come un pentito.
Inoltre non è un mistero che la sua entrata nelle Br non fu delle più semplici:
Morucci nasce come membro del servizio d’ordine di Potere Operaio, poi si dedica
all’introduzione di armi e ordigni dalla Svizzera. Nel novembre del ‘72 viene
arrestato ma dopo un mese e di nuovo in libertà. È noto che la rapidità di
questa scarcerazione insospettì i vertici brigatisti di allora, e infatti la
richiesta di ingresso nella organizzazione di Morucci venne accolta soltanto
quattro anni dopo nel ‘76 da Mario Moretti».
Un altro capitolo oscuro è
senza dubbio quello delle rivelazioni di Morucci: dalle prime affermazioni, poi
ritrattate, alla storia del memoriale fatto arrivare a Cossiga, fino alle ultime
rivelazioni.
«Andiamo
con ordine: Morucci disse durante i primi interrogatori che i partecipanti
all’azione erano stati dodici, e forse di più. Poi scese a nove; in entrambi i
casi, coerentemente con la sua posizione di dissociato, si rifiutò di fare nomi.
Nel 1990 salta fuori la storia del memoriale. Morucci lo compila probabilmente
nel 1986. Nel 1990 lo consegna in carcere a suor Teresa Barillà, una persona che
ha già collaborato con i Servizi segreti in quella brutta storia che è il caso
Cirillo. La suora fa pervenire il memoriale all’allora capo dello Stato Cossiga
il 13 marzo del 1990. Più di un mese dopo Cossiga lo consegna al capo della
polizia, e questi a sua volta lo dà ai magistrati. Ma la cosa più importante è
che nel memoriale Morucci fa i nomi dei nove brigatisti che, secondo la sua
versione dei fatti, parteciparono all’agguato. E non si capisce perché Morucci,
che per la magistratura è un dissociato, per la Dc si comporti da vero e proprio
pentito. Viene in mente una dichiarazione di Franceschini. Te la leggo: «A un
certo punto ho cominciato a chiedermi: di chi abbiamo fatto il gioco: i miei
dubbi sono cominciati quando settori della Dc hanno cominciato a venire da noi
brigatisti in carcere. Pensavamo che venissero per cercare insieme di fare
chiarezza. Invece no: mi rendevo conto che venivano da noi per conquistare
silenzi».
C’è una voce che circola da
tempo dentro le carceri: la voce secondo cui un emissario della Dc avrebbe
trattato in carcere con i brigatisti detenuti: il silenzio sulle zone oscure del
sequestro Moro in cambio di permessi e altri favori, con la prospettiva futura
di una amnistia. E sgradevole parlarne, perché si parte da una voce non
confermata e si mette in gioco la legittima aspirazione alla libertà di gente in
galera da anni. Ma certo colpisce la disparità di trattamento carcerario, ad
esempio, tra un Curcio e un Morucci. Ma tornando alle rivelazioni dello stesso
Morucci, l’ultima novità è il coinvolgimento di Rita Algranati come decima
partecipante.
«Anche
qui resta da chiarire un mistero: a me risulta da fonte sicura che nell’estate
del 1993 il Sisde contattò in Nicaragua Alessio Casimirri, un altro dei
partecipanti all’agguato di via Fani. Mi è stato riferito che fu Casimirri,
marito separato della Algranati, a fare questo nome. La cosa rimase segreta
finché, in coincidenza con l’esplodere del caso Delfino-Nirta, Morucci decise
improvvisamente di piazzare sulla scena dell’agguato la Algranati, anche se in
un ruolo secondario. Mi chiedo se dietro il balletto delle rivelazioni non ci
sia la volontà di fare polverone, o peggio ancora se intorno al caso Moro non si
giochi uno spezzone della lotta intestina tra Servizi segreti».
Resta comunque il fatto che
tutte le versioni dei fatti fin qui proposte da Morucci sono incomplete: una
perizia dell’ottobre `93, ordinata nell’ambito del quarto processo Moro, ha
stabilito che in via Fani spararono sette armi, e da entrambi i lati della
strada. Morucci aveva parlato di sei armi e di colpi provenienti da un solo
lato. Resta il mistero del formidabile killer che sparò 62 dei 97 colpi esplosi
in via Fani. E a questo punto, fatalmente, tocca parlare delle rivelazioni del
pentito Morabito sulla presenza di Antonio Nirta nel commando.
«Su
questo io non ho informazioni di prima mano, e l’ipotesi del coinvolgimento di
un uomo della ‘ndrangheta in via Fani - per di più un personaggio che agirebbe
su mandato di un carabiniere - è così preoccupante che dobbiamo essere molto
cauti. Certamente sulle presenze calabresi intorno al sequestro Moro c’erano già
da anni molti elementi concreti, dalla storia arcinota delle foto sparite agli
strani viaggi di brigatisti e inquirenti in Calabria prima e durante il
sequestro. Di recente - dopo averlo taciuto a lungo - l’ex deputato
democristiano Benito Cazora ha detto che pochi giorni dopo il sequestro i suoi
informatori calabresi lo condussero nei pressi di via Gradoli, spiegandogli che
lì era tenuto Moro. Bisogna quantomeno chiedersi come facessero i mafiosi a
essere così bene informati, dal momento che in via Gradoli c’era effettivamente
un covo brigatista».
E che covo: insieme alla
base milanese di via Montenevoso - quella dei memoriali di Moro - via Gradoli è
il luogo in cui si concentra il maggior numero di misteri del caso Moro: i
calabresi lo conoscono, il suo nome salta fuori nel corso di una seduta
spiritica a cui partecipa Romano Prodi, tre poliziotti arrivano davanti al suo
ingresso ma lasciano perdere perché nessuno risponde alla scampanellata, infine
qualcuno degli occupanti vi calamita la polizia con il trucco dell’allagamento.
Nell’ultima edizione del tuo libro, “La tela del regno”, tu aggiungi una nuova
perlina a questa collana di misteri…
«Sì.
Di fronte a me ad altri due testimoni l’ex ufficiale dei Servizi Antonio La
Bruna ha dichiarato che il 17 marzo, un giorno dopo il sequestro Moro, il Sismi
ricevette una segnalazione di via Gradoli».
E infatti il 18 la polizia
va sul posto, ma non trova nessuno. Una volta tanto le cose quadrano.
«Sì,
ma La Bruna dice anche che il Sismi conosceva l’identità dell’informatore. Ma
non lo ha fatto al magistrato. Eppure sarebbe stato un particolare prezioso.
Teniamo conto del fatto che a quindici anni di distanza dal sequestro non
sappiamo ancora nemmeno quante furono le prigioni di Moro».
Secondo Giorgio Bocca
intorno a via Gradoli non c’è nessun mistero. I poliziotti rinunziarono a
intervenire soltanto per paura. Lui e molti altri insospettabili e autorevoli
commentatori, anche a sinistra, leggono i misteri del caso Moro come un lungo
elenco di cialtronerie. Una storia molto italiana insomma.
«Ci
furono senza dubbio deficienze e approssimazioni. Ma non bastano a spiegare
tutto. La paura dei poliziotti può chiarire uno dei misteri di via Gradoli, non
gli altri. E via Gradoli è solo un episodio. Prendiamo la ricostruzione
dell’agguato: a un certo punto compare un misterioso uomo con la paletta, che
dirige il traffico e poi scompare nel nulla. Secondo Bocca si tratta di una
invenzione. Ma ci sono due testimoni. Oppure i due uomini a bordo della moto
Honda, che sparano al motorino dell’ingegner Marini. Tutti i brigatisti negano
che quei due fossero dei loro. Eppure esistono, ne parlano ben tre testimoni».
All’inizio dicevi: stiamo
ai fatti. Vogliamo elencare quelli che risultano inspiegabili se non si ipotizza
la “tela di ragno”, vale a dire quella serie di coperture - probabilmente non
richieste - che sembrano accompagnare tutta l’azione brigatista durante i 55
giorni del sequestro?
«L’elenco
è davvero lungo. Io mi limiterei agli interrogativi fondamentali: Perché tutti
gli uomini scelti dal ministro Cossiga per seguire le fasi del sequestro sono
iscritti alla P2?
Perché, malgrado le molte segnalazioni, il covo di via Gradoli non viene
individuato subito? Chi e perché decide a un certo punto di farlo scoprire
accelerando in questo modo la decisione del vertice Br di uccidere Moro? Perché
le Br utilizzano durante il sequestro una stampatrice che viene dall’ufficio
“Rus” (Raggruppamento Unità Speciali) del Sismi, l’ufficio di Gladio? Perché il
giudice Infelisi fa sparire il rullino contenente la foto in cui si vede l’uomo
della ‘ndrangheta in via Fani? Chi ha manipolato o fatto sparire molte delle
intercettazioni telefoniche effettuate durante il sequestro del presidente della
Dc? Perché le Br decisero di non rendere pubbliche le rivelazioni di Moro sulla
strategia della tensione e su Gladio, i suoi giudizi su Andreotti e Cossiga?
Quali uomini del potere vennero in possesso all’indomani della scoperta del covo
di via Montenevoso, del memoriale di Moro scoperto soltanto nel 1990 in una
intercapedine del muro? Chi ha in mano le trascrizioni complete, o addirittura
le bobine registrate, degli interrogatori di Moro in carcere? Leggendo il
memoriale appare evidente che Moro rimanda spesso a capitoli delle sue
rivelazioni che sono spariti. Perché non è stato fatto nessuno sforzo per
individuare il luogo in cui si riuniva il comitato esecutivo delle Br; quello,
per capirci, presso cui si recava Moretti periodicamente, e in cui venivano
battuti macchina i comunicati che scandirono il sequestro. C’erano indizi che
portavano nella zona di Firenze, ma furono lasciati cadere. E infine: qual è il
filo che lega il caso Moro ad altri due misteri italiani, gli omicidi di Carmine
Pecorelli e di Carlo Alberto Dalla Chiesa? Dalla Chiesa è l’ufficiale che
gestisce l’operazione di via Montenevoso, quella sera stessa i suoi uomini lo
accompagnano all’aeroporto di Milano e alle due del mattino, secondo la
testimonianza di Franco Evangelisti, Dalla Chiesa si presenta ad Andreotti.
Pecorelli, giornalista legato ad ambienti dei Servizi e alla P2,
sa molte cose del caso Moro. Ricordiamo che il suo settimanale, “Op”, esce in
edicola proprio nei giorni del sequestro, e inizia una campagna di stampa che
riguarda lo scandalo Rateasse, Caltagirone e Arcaini. Gli stessi temi sui cui si
sofferma, all’interno della prigione del popolo, Aldo Moro».
E un lungo elenco…
«Potrebbe
esserlo di più. Contrariamente a quanto dice il senatore Cossiga, che ha più
volte pubblicamente elogiato i magistrati che hanno condotto le indagini sul
sequestro Moro, su un dato credo che noi cosiddetti “dietrologi” e coloro che la
pensano come Giorgio Bocca, possiamo trovarci d’accordo: non esiste altro caso
giudiziario in cui le indagini siano state condotte, nel corso di molti anni,
con tanta superficialità e sacrificio della verità. È impressionante la
differenza di analisi investigativa sprigionata durante il sequestro Sossi
rispetto al caso Moro. Del rapimento del magistrato sappiamo tutto nei dettagli;
di Moro molto poco. Eppure la differenza di peso tra i due episodi è evidente, e
oltretutto all’epoca del rapimento di Sossi, il 1974, lo stato delle conoscenze
sul terrorismo era di molto inferiore a quello che se ne aveva quattro anni
dopo. Vedendo “Jfk”, il film sul delitto Kennedy, ho trovato una serie
impressionante di analogie col caso Moro. Anche quello è un delitto politico,
anche quella è una vicenda in cui le indagini vengono condotte con incredibile
timidezza e reticenza. Con la differenza che nel caso Kennedy a un certo punto
emerge la figura del Procuratore Garrison, che combatte contro i depistatori
alla ricerca della verità. Da noi un personaggio equivalente purtroppo non è
esistito. Almeno tra i magistrati».
Periodicamente - in momenti
delicati della vita politica - emergono nuove rivelazioni sul caso Moro. Cosa
vuoi dire?
«Dietro
ogni segreto del sequestro Moro ci sono dei depositari - beneficiari di quel
segreto. Abbiamo parlato dei materiali di via Montenevoso, ma c’è dell’altro. Ad
esempio i rapporti sullo stato delle indagini che pervenivano quotidianamente al
comitato di crisi, riunito al Viminale sotto la direzione di Cossiga. Essi non
pervennero mai né alla commissione Moro, né a quella sulle stragi che li ha
chiesti più di recente. Chi detiene questo tipo di carte detiene un potere che
può far valere in un determinato momento».
Questo è per l’appunto un
momento delicato per i poteri paralleli. C’è in corso una lotta feroce
all’interno dei servizi di sicurezza…
«E
infatti, come sempre, rispunta il caso Moro, che è una vera miniera di misteri.
La situazione mi ricorda da vicino il 1974, quando all’interno del Sid era in
corso la faida tra Miceli e Maletti; anche quella fu una fase molto ricca di
rivelazioni, i magistrati poterono fare un buon lavoro: i golpe, la Rosa dei
Venti. Il fatto è che finché sul caso Moro la magistratura sia accontenterà
della versione ufficiale dei fatti e delle dichiarazioni dei brigatisti, il
campo verrà lasciato libero a chi gestisce pezzi di verità a proprio uso e
consumo».
Abbiamo parlato a lungo.
C’è qualcosa che è rimasto fuori dalla nostra discussione?
«Vorrei
solo che fosse chiaro che se dopo 15 anni siamo ancora a questo punto la
responsabilità è dovuta al fatto che i primi a non volere la verità sono i due
uomini politici che il maggior ruolo hanno svolto intorno a questa vicenda; e mi
riferisco ovviamente a Giulio Andreotti e Francesco Cossiga. Entrambi tacciono
su quello che sanno».
Il caso Moro - Dal
sequestro all`omicidio, i 55 giorni che cambiarono l`Italia,
scrive “La storia siamo noi” della Rai. La Storia siamo noi racconta le tappe di
quel terribile momento storico: dal rapimento in via Fani alla
ricostruzione del luogo in cui Aldo Moro fu confinato, dall'esecuzione al
rinvenimento del suo corpo, il 9 maggio '78.Giovedì 16 marzo 1978 le Brigate
Rosse raggiungono l'apice della loro strategia del terrore: portare l'attacco al
cuore dello Stato. Alle 9.02 del mattino, in via Fani all'incrocio
con Via Stresa, nel quartiere Trionfale a Roma, un commando composto da circa 19
brigatisti rapisce il Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, e uccide
i cinque componenti della scorta: il Maresciallo dei Carabinieri Oreste Leonardi,
l'appuntato Domenico Ricci, il Brigadiere Francesco Zizzi,
l'agente Raffaele Jozzino e
l'agente Giuliano Rivera.
L'agguato.
Ma cosa successe realmente quella mattina, chi e quanti erano i brigatisti che
presero parte all'agguato e al rapimento? Secondo la deposizione di Valerio Morucci al
processo Moro Quater questa
era la logistica del commando Br:
" Io ho detto che l'auto 128 targata corpo diplomatico era guidata da Mario
Moretti, che lo sbarramento all'incrocio di Via Fani è
stato fatto da Barbara Balzerani,
che la 132 dove è poi stato caricato l'onorevole Moro era guidata da Bruno
Seghetti, che le quattro persone che hanno aperto il fuoco erano dal basso, Io,
Fiore, Gallinari e Bonisoli".
Questa dunque la ricostruzione secondo la deposizione al processo Moro Quater di
Valerio Morucci,
unico dei Brigatisti presenti a Via Fani ad
essersi dissociato. Più in dettaglio la disposizione era dunque la seguente:
alla guida della 128 bianca che ha il compito di frenare bruscamente e causare
il tamponamento con la 130 Fiat su cui viaggiava Moro c'è Mario Moretti. A
controllare l'incrocio c'è Barbara Balzerani armata
di un mitra e di una paletta per far defluire il traffico. A sparare sono
Valerio Morucci e Raffele Fiora,
collocati sul lato sinistro della vettura di Moro, mentre a sparare sull'Alfetta
di scorta sono invece Prospero Gallinari e
Franco Bonisoli anch'essi
collocati sul lato sinistro della vettura. Su Via Stresa c'è la 132 guidata da
Bruno Seghetti che ha il compito di fare marcia indietro su ViaFani e
caricare l'Onorevole Moro. Ma a chiudere la scena dell'agguato, quello che nella
terminologia brigatista viene chiamato il "cancelletto superiore"
c'è un'altra 128 messa di traverso da
cui scendono altri due brigatisti. Non tutto quadra dunque con il racconto di Morucci.
ll primo
ottobre del 1993 su incarico della Corte i periti balistici depositano una nuova
perizia dove si afferma che, contrariamente a quanto dichiarato da Morucci,
a sparare sulla 130 c'è stato almeno un altro brigatista collocato sul lato
destro dell'auto dalla parte del passeggero. Si scoprirà in
seguito che del gruppo di fuoco fecero parte anche Alessio Casimirri e Alvaro Lo Jacono.
Un'altra componente del commando invece è Rita Algranati,
moglie di Casimirri.
Del ruolo della "compagna Marzia" nella strage di via Fani hanno
parlato successivamente Valerio Morucci e
Adriana Faranda.
"Le unità del commando - ha raccontato Faranda -
erano dieci. Rita Algranati stava
all'incrocio con via Trionfale per segnalare l'arrivo di Moro e della sua scorta
a Moretti che era sulla 128".
La moto Honda e il rullino fotografico scomparso.
Altre zone d'ombra permangono sulla dinamica dei fatti quel giorno a Via Fani.
Quello stesso giorno si trovò a passare in motorino l'ingegnere Alessandro
Marini che ha dichiarato che due persone a bordo di una motocicletta Honda esplosero
dei colpi contro di lui. Ma le Brigate Rosse hanno sempre negato che quella moto
e i suoi due occupanti facessero parte del commando. Il 15 ottobre del 1993 un
pentito della 'Ndrangheta Saverio Morabito ha
dichiarato che a Via Fani quel
giorno c'era anche Antonio Mirta,
altro appartenente alla mafia calabrese, e infiltrato nel commando brigatista.
Sergio Flamigni,
membro della Commissione Moro e autore di molti libri sull'argomento, riferisce
che quando seppe della deposizione di Morabito gli
vennero alla mente diversi elementi agli atti della Commissione che avvaloravano
l'ipotesi della presenza di un calabrese a Via Fani.
Vi era la testimonianza dell'Onorevole Benito Cazora,
allora deputato della Democrazia Cristiana che riferì alla
commissione che venne avvicinato da un calabrese che in una certa fase ebbe a
chiedergli di un rullino di foto scattate a ViaFani.
Quelle foto furono scattate immediatamente dopo la fuga del commando brigatista
da un abitante in ViaFani:
il carrozziere Gerardo Nucci e
furono visionate dal giudice Infelisi che
le ritenne molto importanti, fatto sta che questo rullino fotografico è
scomparso. Forse su quel rullino potrebbe essere impressa l'immagine di questo
infiltrato. Queste fotografie sono diventate uno dei tanti misteri del caso
Moro.
Le indagini: negligenze ed omissioni.
Le ricerche per trovare Aldo Moro partono subito dopo l'eccidio, ma partono
subito con il piede sbagliato. Lo stesso sedici marzo il dottor Fardello dell'Ucigos emana
a mezzo telegramma l'ordine di attuare il piano Zero, elaborato per la provincia
di Sassari, ma del tutto sconosciuto alle altre questure italiane. L'ordine
viene revocato in meno di ventiquattro ore ma del resto la Commissione
Parlamentare d'Inchiesta ha accertato che nel '78 era ancora in vigore un
sistema per la tutela dell'ordine pubblico risalente agli anni Cinquanta. Questo
nonostante il Settantasette avesse
rappresentato l'apice dell'escalation terroristica con 2000 attentati, 42
omicidi, 47 ferimenti, 51 sommosse nelle carceri e 559 evasioni. Estese a tutta
Italia le ricerche si concentrano
soprattutto su Roma. Dal 16 marzo al 10 maggio sempre nel territorio
urbano di Roma vengono impiegati 172.000 unità tra carabinieri e poliziotti che
effettuano 6000 posti di blocco e 7000 perquisizioni domiciliari controllando in
totale 167.000 persone e 96.000 autovetture. Qualcuno dirà che si è trattato
soprattutto di operazioni di parata. La Commissione Parlamentare d'Inchiesta
conclude che la punta più alta di attacco terroristico ha coinciso con
la punta più bassa del funzionamento dei servizi informativi e di sicurezza.
Sergio Flamigni,
membro della Commissione Moro, afferma: "Le indagini di quei 55 giorni furono
contrassegnate da una serie di errori,
omissioni e negligenze. Basti citarne una:
la segnalazione giunta
all'Ucigos al Viminale,
una telefonata che comunicava i nomi dei quattro brigatisti, le auto che
usavano. Bene, questa segnalazione fu trasmessa dall'Ucigos alla
Digos che era il corpo operativo per agire in quel momento con oltre un mese di
ritardo. Quando la Digos ebbe modo di avere questa segnalazione immediatamente
individuò uno
dei brigatisti che tra l'altro era tenuto a presentarsi al Commissariato di
Pubblica Sicurezza perché era in libertà vigilata. Immediatamente seguendo
questa brigatista si giunge a individuare la tipografia di Via Pio Foà dove
le Brigate Rosse stampavano i comunicati dei 55 giorni. Se questa comunicazione
fosse stata trasmessa un mese prima, forse si poteva con ogni probabilità
individuare la traccia che portava alla prigione di Moro". Robert Katz,
scrittore e giornalista: "Quasi tutti quelli che hanno avuto a che fare con le
indagini erano iscritti alla P2,
mi meraviglio che tutte le indagini di oggi sono puntate sulle Brigate Rosse,
quando la parte più interessante è come si sono svolte le indagini". Ma il ruolo
della P2 nel
sequestro Moro non è mai stato chiarito né dalla Commissione Moro né dalla
stessa Commissione sulla Loggia P2.
Interessi stranieri intorno alla morte di Moro.
Secondo Sergio Flamigni gli
interessi stranieri intorno alla sorte di Moro convergevano verso
la sua eliminazione. Del resto il conto fra Moro e, ad esempio, il Dipartimento
di Stato americano si apre già nel 1964 quando Moro apre ai socialisti e
sostiene un superamento del centrismo. Gli americani contestano, ma poi si
adeguano. Ma quando Moro vuole passare a un'altra fase di alleanza con i
comunisti si apre un altro problema. E da quel momento lo vogliono ucciso, prima
politicamente, tentando di attribuirgli lo
scandalo Lockheed.
Secondo una voce che proviene dall'ambasciata americana a Roma e da uno dei
servizi segreti americani. Moro sarebbe l'"antelope Cobbler"
(nome in codice del destinatario italiano delle bustarelle), poi l'Alta Corte
Costituzionale appura che Moro non ha nulla a che fare con l'antelope Cobbler.
Corrado Guerzoni,
uno dei più stretti collaboratori di Moro, che lo ha accompagnato diverse volte
negli Stati Uniti, ha detto che il Segretario di Stato americano Henry Kissinger minacciò Moro
per la sua politica di apertura al partito Comunista. Circostanza che Kissinger ha
sempre smentito anche nell'intervista che
Kissinger ha
concesso a Minoli nel
1983.
I comunicati.
Nel Comunicato Numero 1 delle BR, si legge: "Questa mattina abbiamo sequestrato
il Presidente della Democrazia Cristiana ed eliminato le sue guardie del corpo,
teste di cuoio di Cossiga" (all'epoca
Ministro dell'Interno). Nel comunicato n. 6 del 15 aprile 1978 i brigatisti
annunciano che l'interrogatorio è terminato e annunciano la sentenza di condanna
a morte. Nel comunicato n. 7 affermano che: "Il rilascio del prigioniero Aldo
Moro può essere preso in considerazione solo in relazione alla liberazione di
prigionieri comunisti", i nomi dei quali verranno specificati nel successivo
comunicato il n. 8 del 24 aprile: Sante Notarnicola,
Mario Rossi, Giuseppe Battaglia, Augusto Viel,
Domenico Delli Veneri,
Pasquale Abatangelo,
Giorgio Panizzari,
Maurizio Ferrari, Alberto Franceschini,
Renato Curcio, Roberto Ognibene,
Paola Besuschio molti
dei quali detenuti a Torino, dove è in corso il processo ai capi storici delle
prime Brigate. Nell'ultimo comunicato annunciano la conclusione della "battaglia
iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato"
e la promessa che: "Le risultanze dell'interrogatorio di Aldo Moro e le
informazioni in nostro possesso, ed un bilancio complessivo politico militare
della battaglia che qui si conclude, verrà fornito al Movimento Rivoluzionario e
alle O.C.C. attraverso gli strumenti di propaganda clandestini". Ma questa
diffusione benchè promessa non avverrà mai.
Le posizioni dei partiti.
I partiti reagiscono dividendosi in
sostenitori della cosiddetta "linea della fermezza" e fautori della trattativa
con i brigatisti. Per la "fermezza" si schierano la maggior parte dei partiti:
la DC, il PCI, il PLI,
il PSDI e
il PRI
di Ugo La Malfa,
il quale arriva a proporre il ripristino della pena capitale per i rapitori. Per
la trattativa, i socialisti di Bettino Craxi, i radicali di Marco Pannella, la
sinistra non comunista, una componente del cattolicesimo dissidente e uomini di
cultura come Leonardo Sciascia. Oltre all'ONU, ad
Amnesty International,
ad esponenti politici ed organizzazioni umanitarie da tutto il mondo, si mobilita per
la liberazione di Moro anche Papa Paolo VI suo amico personale di vecchia data,
che attraverso la Radio Vaticana diffonde un appello "agli uomini delle Brigate
Rosse" in cui, tuttavia, il Sommo Pontefice chiede che l'ostaggio venga liberato
"senza condizioni", così avallando secondo un'interpretazione ormai condivisa la
linea della fermezza. Sandro Pertini,
futuro Presidente della Repubblica, dice di non voler seguire il funerale di
Moro, ma neanche quello della Repubblica.
Le lettere di Moro.
Nelle lettere è soprattutto la personalità di Moro ad emergere in modo diretto e
senza filtri. Le lettere inviate dalla prigionia, infatti, raccontano la
sofferenza e la dignità dell'uomo che pagò con la vita la sua dedizione allo
Stato e che non trovò conforto in un mondo politico lontano dalla cosiddetta
"prigione del popolo" in cui era ostaggio.
Il 9 maggio.
Dopo 54 difficilissimi giorni,
segnati da ulteriori attentati delle BR, ma anche dalle strazianti lettere di
Moro dalla cosiddetta "prigione del popolo" brigatista, il 9 maggio 1978 la
telefonata del brigatista Valerio Morucci
annuncia la morte di Moro. Il corpo viene fatto ritrovare a Roma, nel bagagliaio
di una Renault rossa a via Caetani,
poco distante dalle sedi del PCI e della DC. All'omicidio di Moro segue una
forte crisi istituzionale: poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di Moro,
Francesco Cossiga si
dimette da Ministro dell'Interno; in giugno, travolto dalle polemiche (non
legate al caso Moro) si dimette anche il Presidente della Repubblica, Giovanni
Leone. Poi, nel 1979, il PCI dichiara di considerare chiusa l'esperienza
dell'unità nazionale.
Quattro processi per la
verità giudiziaria,
scrive “Il Sole 24 ore”. I grandi processi per il caso Moro sono quattro anche
se si è arrivati al Moro-quinquies. Infatti il primo e il secondo procedimento
furono unificati in un unico processo. Ecco un riepilogo basato su fonte Ansa:
MORO-UNO E MORO-BIS -
Il 24 gennaio 1983 i giudici della 1/a Corte d'Assise (presidente Severino
Santiapichi) emettono la sentenza del processo per la strage di via Fani e il
rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. Il processo unifica i procedimenti
Moro-uno e Moro-bis. La sentenza condanna all'ergastolo 32 persone: Renato
Arreni, Lauro Azzolini, Barbara Balzerani, Franco Bonisoli, Anna Laura
Braghetti, Giulio Cacciotti, Raffaele Fiore, Prospero Gallinari, Vincenzo
Guagliardo, Maurizio Iannelli, Natalia Ligas, Alvaro Loiacono, Mario Moretti,
Rocco Micaletto, Luca Nicolotti, Mara Nanni, Cristoforo Piancone, Alessandro
Padula, Remo Pancelli, Francesco Piccioni, Nadia Ponti, Salvatore Ricciardi,
Bruno Seghetti, Pietro Vanzi, Gian Antonio Zanetti, Valerio Morucci, Adriana
Faranda, Carla Maria Brioschi, Enzo Bella, Gabriella Mariani, Antonio Marini e
Caterina Piunti. Il 14 marzo 1985 la Corte d' Assise d'appello conferma 22
condanne all'ergastolo. Ridotta la pena per Natalia Ligas, Mara Nanni, Gian
Antonio Zanetti, Valerio Morucci, Adriana Faranda, Carla Maria Brioschi, Enzo
Bella, Gabriella Mariani, Antonio Marini e Caterina Piunti. Il 14 novembre 1985
la Cassazione conferma quasi integralmente la sentenza, tranne per le posizioni
di 17 imputati minori per i quali si chiede la rideterminazione della pena.
MORO-TER
- Il 12 ottobre 1988: si
conclude con 153 condanne (26 ergastoli e 1.800 anni complessivi di detenzione)
e 20 assoluzioni il processo denominato «Moro-ter», riguardante le azioni delle
Br a Roma tra il 1977 e il 1982. La 2/a Corte d'Assise (presidente Sergio
Sorichilli condanna all'ergastolo Susanna Berardi, Barbara Balzerani, Vittorio
Antonini, Roberta Cappelli, Marcello Capuano, Renato Di Sabbato, Vincenzo
Guagliardo, Maurizio Iannelli, Cecilia Massara, Paola Maturi, Franco Messina,
Luigi Novelli, Sandra Padula, Remo Pancelli, Stefano Petrella, Nadia Ponti,
Giovanni Senzani, Paolo Sivieri, Pietro Vanzi, Enrico Villimburgo, i latitanti
Rita Algranati e Alessio Casimirri e gli imputati in libertà per decorrenza dei
termini di detenzione Eugenio Pio Ghignoni, Carlo Giommi, Alessandro Pera e
Marina Petrella. Il 6 marzo 1992 la terza Corte d' Assise d' appello conferma la
condanna all'ergastolo per 20 imputati del processo 'Moro-ter'. Pena ridotta per
Alessandro Pera, Eugenio Ghignoni, Paola Maturi e Franco Messina e ad altri due
imputati. Il 10 maggio 1993 una sentenza della prima sezione penale della Corte
di Cassazione (presidente Arnaldo Valente) conferma le condanne emesse in
appello per gli imputati del Moro-ter. Annullata, con rinvio ad altra sezione
penale della corte d'appello di Roma, solo la sentenza nei riguardi di Eugenio
Ghignoni, condannato in appello a 15 anni.
MORO-QUATER
- Il 1° dicembre 1994 il processo «Moro-quater», che si occupa di alcuni
risvolti del caso non risolti dai processi precedenti e di alcuni episodi
stralciati dal Moro-ter, si conclude con una sentenza della prima Corte di
Assise (presidente Severino Santiapichi) che condanna all'ergastolo Alvaro
Loiacono, in carcere in Svizzera per altre vicende, riconosciuto colpevole di
concorso nel rapimento e nell' uccisione dell'ex presidente della Dc Aldo Moro e
di altri omicidi. Il 3 giugno 1996 la sentenza è confermata dai giudici della
Corte di Assise di appello di Roma e, il 14 maggio 1997, dalla Cassazione.
MORO-QUINQUIES -
Il 16 luglio 1996 i giudici della seconda Corte d'Assise emettono la sentenza
del processo Moro-quinquies e condannano all' ergastolo Germano Maccari per
concorso nel sequestro e nell' omicidio di Aldo Moro e nell'eccidio della scorta
e Raimondo Etro a 24 anni e sei mesi. Il 19 giugno 1997, in appello, la pena per
Maccari è ridotta a 30 anni. La Cassazione disporrà un nuovo processo e il 28
ottobre 1998 la nuova sentenza d'appello condanna Maccari a 26 anni ed Etro a 20
anni e 6 mesi. La condanna per Etro diventa definitiva nel 1999, mentre Maccari
sarà di nuovo processato in appello e la sua pena ridotta a 23 anni.
Morto Prospero Gallinari:
gestì il sequestro e l’omicidio di Moro.
Probabile un attacco cardiaco nel suo appartamento a Reggio Emilia. Era malato
da tempo. E' una delle figure più misteriose e controverse del terrorismo,
scrive Antonella Beccaria il 14 gennaio 2013 su "Il Fatto Quotidiano". Erano le
prime ore della mattinata quando al 118 di Reggio Emilia è arrivata una
richiesta di soccorso per un uomo che si sentiva male dentro la sua auto. Quando
i paramedici sono arrivati, hanno caricato il paziente sull’ambulanza e lo hanno
trasportato d’urgenza all’ospedale, ma l’uomo è morto appena dopo. A quel punto
si è scoperto che si trattava di Prospero Gallinari, 62 anni compiuti lo scorso
1 gennaio. L’ex brigatista rosso nato a Reggio Emilia nel 1951, alla fine del
1969 aveva aderito con Alberto Franceschini, Tonino Paroli e altri militanti al
“gruppo dell’appartamento” dopo un passato iniziato quando aveva 14 anni nella
Fgci, la Federazione giovanile comunista italiana. Deluso dalle posizioni del
Pci, alla fine dell’anno che si era concluso con la strage di piazza Fontana
aveva partecipato a Chiavari ai lavori costitutivi del Collettivo politico
metropolitano (Cpm) e aveva iniziato il percorso che lo avrebbe condotto alla
clandestinità e alla lotta armata. In un primo momento, simpatizza con le idee
di Corrado Simioni. Sono gli anni che precedono il 1972 e non si può parlare in
quel periodo di militanza nelle Brigate Rosse. Si può invece parlare di un’idea
di “superclandestinità” che tuttavia Gallinari non riesce a comprendere fino in
fondo. All’inizio rimane in un appartamento di Porto Marghera in attesa
dell’azione, ma quando si rende conto che quell’azione non giungerà mai, torna a
Reggio e di qui parte poi per Milano. Lui, operaio, nei primissimi anni Settanta
partecipa alle vertenze della Magneti Marelli e il primo arresto risale al 30
ottobre 1974 a cui ne seguirà un secondo con relativa evasione. In occasione del
primo arresto Si trova a Torino insieme a un altri brigatista, Alfredo Bonavita,
e due anni più tardi sarà processato per due sequestri di persona. Il primo è
quello di Bruno Labate, segretario provinciale della Cisnal, catturato il 12
settembre 1973 in via Baiamonti, sempre nel capoluogo piemontese. Il secondo
rapimento è quello del magistrato genovese Mario Sossi e risale al 23 maggio
1974. L’evasione avviene invece nel 1977, quando Gallinari si trova rinchiuso
nel carcere di Treviso e da qui raggiunge Roma, dove si riunisce alla colonna
romana delle Brigate Rosse. È l’uomo che, nei 55 giorni del sequestro di Aldo
Moro, non uscirà mai dalla “prigione del popolo” dove viene segretato il
presidente della Democrazia Cristiana. Partecipa a ciascuna delle fasi di questo
evento: dal rapimento in via Fani, il 16 marzo 1978, quando la scorta dello
statista scudocrociato è sterminata dal commando brigatista, fino all’omicidio,
il 9 maggio dello stesso anno, per il quale Gallinari sarà a lungo indicato come
esecutore materiale. A discolparlo, nel 1993, è Mario Moretti, che nel libro
intervista scritto con Rossana Rossanda e Carla Mosca si attribuisce la
paternità del delitto. Dopo il sequestro Moro, in carcere Prospero Gallinari
tornerà l’anno successivo, il 24 settembre 1979, arrestato a Roma, e in suo
possesso sono rinvenuti i documenti per l’evasione dalla prigione speciale
dell’Asinara dei detenuti che si erano dichiarati prigionieri politici. Accusato
nel 1982 dal pentito Antonio Savasta di essere stato con Anna Laura
Braghetti tra i carcerieri di Moro, il 21 aprile 1987 si scopre un altro
progetto di evasione, questa volta dall’istituto penitenziario di Rebibbia. Nel
1987 Renato Curcio, Mario Moretti, Maurizio Iannelli e Pietro
Bertolazzi scrivono al Manifesto una lettera per dichiarare chiusa
l’esperienza della lotta armata e nell’ottobre 1988 Gallinari sottoscrive un
documento in cui si dichiara che la “guerra è finita” e viene lanciata la
proposta dell’amnistia per i prigionieri politici. Sofferente per disturbi
cardiaci fin dall’inizio degli anni Novanta e per questo sottoposto a interventi
chirurgici, il suo legale avanza la prima richiesta di scarcerazione (richiesta
respinta). Nel 1994 subisce un ricovero per un’ischemia cerebrale e nel marzo di
quell’anno, per le festività pasquali, sempre per ragioni di salute, gli vengono
concessi i primi 5 giorni di permesso, che trascorre a Reggio Emilia con la
madre. Nel 1996, mentre proseguono i processi, la sua pena sarà sospesa e
tornerà definitivamente nella città emiliana, dove è morto.
Caso Moro, le risposte a
tutte le domande dei lettori.
Il
giornalista Giovanni Bianconi replica a tutti i partecipanti della videochat.
Il giornalista del "Corriere della Sera" Giovanni Bianconi,
esperto di giudiziaria e da anni attento alle vicende del rapimento Moro, ha
partecipato ad una videochat su Corriere.it dal titolo "Il caso Moro. Il dietro
le quinte del sequestro". Bianconi, oltre a parlare del suo ultimo libro "Dietro
le quinte del sequestro Moro" ha ricevuto tantissime domande dai lettori.
Dato che durante la diretta non è riuscito a rispondere a tutti, ha deciso di
rispondere per scritto alle questioni sollevate da chi seguiva la videochat.
Tante ed interessanti. Ne esce così un nuovo spaccato su una vicenda,
quella del sequestro Moro di cui ora ricorrono i trent'anni, che interessa
ancora molto e di cui ancora non è stato detto tutto. Oltre alle risposte in
questa pagina, ci sono altre due parti specificatamente dedicate al ruolo dei servizi
segreti nella vicenda Moro e al giallo di Gradoli e la seduta spiritica.
Dinamica del rapimento
Caro Giovanni, sono un collega di RaiSat, ho letto il tuo libro e
ho trovato la tua una chiave interpretativa molto interessante. Che ne dici
riguardo alla dinamica del rapimento del Presidente Dc a Via Fani e
dell'esplosione di circa 70 colpi da parte di due soli tiratori? Grazie per
l'attenzione Alessandro, Roma.
La dinamica che si conosce,
ricostruita da uno dei quattro tiratori “ufficiali” delle Br, cioè Valerio
Morucci, consiste nell’apertura del fuoco da un solo lato delle due macchine (di
Moro e della scorta) da colpire, e cioè il lato sinistro delle auto. Morucci
stesso riferisce che alcune delle armi si incepparono, e questo potrebbe
spiegare perché a sparare la maggior parte dei colpi siano state solo due armi.
Le diverse perizie prodotte nei processi hanno dato risultati che (come quasi
tutte le perizie, in quasi tutti i processi) sono stati contraddetti da altre
considerazioni tecniche, col risultato che sono stati ritenuti compatibili o
meno (a seconda dei punti di vista) con le dichiarazioni dei testimoni. Cosa che
è puntualmente successa anche con Valerio Morucci. E’ molto difficile
raggiungere delle verità, ancorché processuali, solo attraverso le perizie.
E la giustizia?
A costo di sembrare naif, trovo assurdo che i brigatisti siano
liberi e personaggi televisivi e le vittime dimenticate con i loro famigliari.
Tutto il resto è retorica. Roberto da Parigi.
E’ sicuramente ingiusto che le
vittime siano dimenticate, e questa è una responsabilità dei mezzi
d’informazione prima ancora che dello Stato che forse s’è occupato troppo poco
delle persone uccise o ferite. Questo però ha poco a che fare con la rimessa in
libertà di alcuni terroristi al termine di specifici e personali percorsi
giudiziari che in molti casi si sono conclusi (ad oltre venti anni dagli
arresti) con il lavoro esterno al carcere la semilibertà o la liberazione
condizionale anche per chi era stato condannato all’ergastolo. Credo che
occuparsi in maniera più adeguata delle vittime renderebbe forse meno stridente
la realtà dei terroristi che lasciano le prigioni (nella quasi totalità dei casi
senza creare ulteriori problemi di sicurezza alla collettività) con il senso di
ingiustizia rispetto alla irrimediabilità dei “danni” da loro provocati.
Assassini impuniti.
Per quale motivo non si è voluto punire fermamente gli artefici
di questa tragica stagione politica?Ancora oggi si parla di tregua
politica..forse perché esistono ancora frange politiche che non hanno mai
rinnegato quegli atti? Samuele Cagliari.
Non so a quali frange
politiche si riferisca, ma nella sinistra italiana, dalla quale provenivano la
quasi totalità dei terroristi di sinistra, la “presa di coscienza” di una realtà
negata all’inizio dell’esperienza della lotta armata risale ormai ad almeno
trent’anni fa, cioè proprio dal sequestro Moro. La “tregua politica” di cui ogni
tanto si parla sarebbe in realtà una “soluzione politica” per i brigatisti che
ancora hanno a che fare col carcere, partendo dalla considerazione che non si
trattava di criminali comuni ma, appunto, politici, figli di una determinata
stagione ormai definitivamente chiusa. Tuttavia rispetto a questa soluzione
“generale” resta da un lato la difficoltà dovuta ai danni provocati alle vittime
e alle rispettive famiglie, e dall’altro l’esistenza di frange di terroristi
che, dal carcere, non hanno rivisto nulla e continuano a sostenere la validità
della lotta armata. Rimettere in circolazione anche loro (seppure dopo tanti
anni di carcere) sarebbe effettivamente un problema, e anche per questo si è
andati avanti finora (e prevedibilmente si andrà avanti ancora per molto tempo)
con le soluzioni individuali anziché collettive. Infine, servirebbe un dibattito
generale s un’epoca che ha prodotto anche il terrorismo, al quale la classe
politica e l’opinione pubblica non sembrano al momento particolarmente
disposte.
Dietrologie
Secondo Lei bisognerebbe trattare anche con la Mafia? Trattare
con la mafia per il rilascio di un politico sarebbe un atto di debolezza o di
forza? Daniele, Padova.
E i rapporti con la criminalità organizzata? Rinfrescare
la memoria è sempre importante. Tra le cose che ricordo in modo non preciso
vorrei Lei potesse ricordare che tipo di rapporti intercorsero tra le br e la
criminalità organizzata, mafia e camorra. Ci fu una sorta di giustificazione
rivoluzionaria anche a questi rapporti? Vincenzo G. Roma.
Pippo Calò
Ci sono novità sul ruolo della Banda della Magliana e di Pippo
Calò , eventualmente, nella vicenda del Caso Moro? Marco Roma.
Certo non sarebbe un atto di
forza. Secondo le dichiarazioni di alcuni pentiti di mafia riscontrate da alcune
indagini) durante il sequestro Moro ci fu un tentativo da parte di “settori
delle istituzioni” – in particolare servizi segreti ed esponenti di partito – di
coinvolgere la mafia (ma anche la camorra napoletana e la ‘ndrangheta calabrese)
affinché si attivassero per raccogliere informazioni sulla prigione di Moro
(attraverso il loro “controllo del territorio”, che evidentemente era o si
riteneva più efficace di quello esercitato dallo Stato) o per sondare i
brigatisti detenuti nelle carceri. Ma non si arrivò a nulla. Il pentito di mafia
Tommaso Buscetta ha anche riferito che a un certo punto il suo capomafia Stefano
Bontate fu invitato proprio da Pippo Calò a non darsi più da fare perché
all’interno del suo partito (cioè la Dc) non c’era più la volontà di liberare
Moro. I rapporti tra criminalità organizzata e brigatisti. Sotto questo punto di
vista, sarebbero dovuti avvenire in carcere, cioè nei comuni luoghi di
detenzione. Fuori, questi rapporti sono sempre stati negati dai brigatisti (e
quindi mai giustificati da motivi “rivoluzionari”), mentre da parte di mafiosi o
‘ndranghetisti non sono mai stati svelati; le informazioni che potevano dare
erano più legate al controllo del territorio o ai contatti con uomini delle
istituzioni che a loro volta (per altre vie) sapevano o pensavano di sapere
qualcosa sulle Br o la prigione di Moro. Il ruolo della banda della Magliana è
stato evocato soprattutto sul piano del “controllo del territorio”, visto che la
“prigione del popolo” si trova vicino al quartiere della Magliana, ma non c’è
nessun riscontro concreto. Piuttosto il presunto autore del falso comunicato n.
7 delle Brigate rosse (quello che annunciava l’avvenuta esecuzione di Moro e
“sepoltura” del lago della Duchessa), il falsario Tony Chichiarelli (assassinato
nel 1984) aveva dei contatti con la Magliana, ma lì il mistero riguarda chi ha
ordinato quel falso, e non furono le Br. In ogni caso bisogna tenere presente
che nella primavera del 1978 la banda della Magliana per come fu successivamente
conosciuta (cioè un’entità criminale che aveva quasi assunto il controllo delle
attività illecite su Roma, e che è stata utilizzata per diversi “servizi”
esterni ai propri interessi) era appena agli albori, visto che si formò nel
novembre del ’77 con un sequestro di persona, e prese piede soltanto negli anni
successivi.
Craxi e la trattativa.
Cosa pensa del tentativo di craxi di aprire una trattativa e
cercare canali per entrare in contatto con le BR? era un posizione politica
interessata solo ad intralciare il compromesso storico o una posizione
"umanitaria"? Come spiega la vicinanza del PSI all'ambiente che oggi definiremo
antagonista? Dario Sassari.
Craxi A suo avviso, la linea di
Craxi, la linea della trattativa era volta solo a distaccarsi dal resto dei
partiti per prendersi un suo spazio di fronte all'elettorato o aveva capito che
c'era margine per salvare Moro? Antonio da Formia.
Tra i motivi che spinsero
Craxi, nella seconda parte del sequestro, a “smarcarsi” dalla fermezza fino a
quel momento condivisa con la Dc, il Pci e gli altri partiti della maggioranza,
ci fu probabilmente anche qualche considerazione politica sul futuro del suo
partito, a cominciare dalla necessità di non restare schiacciati (e senza un
ruolo) dai due principali partiti che perseguivano il cosiddetto “compromesso
storico2. Tuttavia, al di là delle motivazioni che lo spinsero a diversificare
la sua posizione, resta la strada da lui indicata, ed effettivamente percorsa
attraverso un contatto concreto che arrivò ai brigatisti rossi: quel contatto
però non portò a nulla di concreto anche per il modo in cui fu condotto da Craxi
(senza avvisare gli investigatori e gli altri partiti), per stessa ammissione
degli “intermediari” che per suo conto entrarono in contatto con le Br.
Riconoscimento?
Come sarebbe stato possibile mantenere lo stato democratico, pur
con tutti i suoi problemi, dopo che fosse stata data una patente di legittimità
politica alle BR? a me pare una cosa folle. Paolo, Bologna.
La sua opinione è la stessa di
chi, all’epoca, non volle distaccarsi mai – anche in linea di principio – dalla
linea della fermezza. Si potrebbe replicare che per essere credibili su questo
fronte bisognerebbe esserlo poi altrettanto sulla garanzia di sconfiggere le Br
sotto il profilo investigativo e della repressione, cosa che nel periodo del
sequestro non avvenne minimamente. Inoltre un “riconoscimento politico” non è
un’entità immutabile, e nel corso di un dialogo a distanza si possono dire tante
cose e poi dirne altre, anche solo per tenere aperto un canale che eviti
l’uccisione dell’ostaggio, e nemmeno questo è accaduto.
Prova di forza.
Non sarebbe stata una prova di forza da parte delle Br liberare
Moro? Non si sarebbero conquistate il favore del popolo? Non sarebbe stato
questo un riconoscimento politico più forte rispetto quello dello Stato?
Cristian Favarin - Modena.
Questo è ciò che hanno provato
a sostenere i brigatisti “dissidenti” rispetto alla decisione di uccidere Moro,
una ristrettissima minoranza che non è riuscita a imporre la propria opinione su
quella della maggioranza che – invece – sosteneva che non poteva finire come
quattro anni prima, nel 1974, con sequestro Sossi, liberato senza contropartita
politica.
Il ruolo della DC.
Si vuol far passare la morte di moro come responsabilità della
DC. ma Moretti & C. non erano mica iscritti alla DC... Franco da Bolotana.
Certamente no, e infatti
qualunque discussione sul ruolo della Dc e sulle eventuali “mancanze” del
partito di Moro rispetto a quella situazione particolare (a cominciare da quelle
imputate dallo stesso Moro al suo partito nelle lettere dalla “prigione del
popolo”) non può prescindere dalla riconferma della primaria e diretta
responsabilità dei brigatisti rossi nel sequestro e nella decisione di uccidere
Moro. Non negata, del resto, dagli stessi brigatisti.
Le talpe.
Buongiorno, vorrei sapere se secondo lei, al momento del
rapimento del defunto vi erano delle ''talpe'' all'interno della Democrazia
Cristiana o addirittura all'interno della Guardia personale di Moro. Grazie e
saluti Carlo da Milano.
Non risulta da nulla.
Segreti rivelati.
Moro ha rivelato segreti che le br hanno girato all'URSS?
Giorgio, Lecco.
Non risulta da nulla, né che
Moro abbia rivelato particolari segreti né che le Br li abbiano girati all’Urss.
Trattativa si o no?
Perchè per Moro non si volle trattare, quando poi per Ciro
Cirillo si scomodarono i camorristi? Marco Sulmona.
Due pesi, due misure.
E' accertato che la dc scelse di non trattare con i terroristi
per Moro, salvo poi affidarsi alla camorra di Cutolo per la liberazione
dell'assessore cirillo. E' plausibile affermare che moro non sia stato ucciso
solo dalle BR? Peppe Salerno.
Questo problema è esattamente
ciò che viene rimproverato da molti (ad esempio alcuni familiari di Aldo Moro)
quando si dice che lo Stato non poteva trattare, ed è uno degli argomenti per
contestare la cosiddetta “linea della fermezza” irremovibilmente tenuta durante
il sequestro Moro. Prima (con Sossi) e dopo (con Cirillo e D’Urso) si è
trattato; oppure si è riusciti a liberare l’ostaggio (come nel casi del gen.
statunitense James Lee Dozier). Nel caso di Moro non s’è fatta né l’una né
l’altra cosa, e questo è uno degli argomenti con i quali si può sostenere che
forse, all’interno dello Stato, c’era anche chi, dal momento del rapimento, ha
pensato che sarebbe stato meglio che Moro non tornasse a casa.
Corpo nella Renault 4
E' vero che le scarpe dell'on. Moro presentavano tracce di
sabbia? Pippo Trapani.
Sì, e i brigatisti hanno
spiegato che quello fu un depistaggio organizzato da loro stessi. Andarono a
raccogliere la sabbia e altri detriti, poi applicati alle scarpe e ai vestiti di
Moro, per far credere agli investigatori che la prigione fosse stata in una
località di mare.
I media.
C'è una colpa dei media nel caso moro? Cristiano - Milano.
Forse la principale fu quella,
da parte della grande maggioranza de giornali, di aderire senza troppa criticità
(e in qualche caso di sostenere), anche attraverso interviste a presunti
esperti) la non autenticità morale delle lettere di Moro. Durante il sequestro,
poi, furono anche pubblicate molte notizie sulle indagini o sull’universo
brigatista (per come si conosceva allora) poi rivelatesi completamente false. Ma
di questo è difficile dare la colpa ai giornali, che probabilmente si limitavano
a pubblicare ciò che veniva riferito (anche non ufficialmente) da inquirenti e
investigatori. Oppure dai politici, come nel caso della falsa notizia di una
delle vedove di via Fani che si sarebbe bruciata davanti alla sede della Dc se
lo Stato avesse trattato per liberare Moro. Probabilmente, da questo punto di
vista i giornali rispecchiavano (forse in maniera troppo acritica) lo stato
delle conoscenze e di volontà di veicolare certe informazioni degli inquirenti e
dei politici.
Il covo di via Montalcini.
Dott. Bianconi, c'è chi sostiene che il covo di via Montalcini
non sia stato l'unico luogo della prigionia di Moro: si pensa a una seconda
sede, molto più vicina al luogo dove fu rinvenuto il cadavere, via Caetani. Lo
ritiene possibile? Andrea Pisa.
In teoria è possibile, ma non
è provato da nulla. Chi lo dice fonda le sue certezze soprattutto sulla distanza
tra la prigione di via Montalcini e il luogo in cui fu trovato il cadavere di
moro, considerando troppo rischioso per i brigatisti percorrere quel lungo
tragitto con il corpo dell’ostaggio in macchina. E poi sul fatto che la salma di
moro fu fatta trovare ben curata nell’igiene personale, e gli arti non troppo
indeboliti da due mesi di costrizione in un luogo troppo ristretto. Queste due
considerazioni, però, non sono in contrasto insanabile col fatto che Moro sia
stato tenuto sempre nella stessa prigione, e alimentano altre “controdeduzioni”;
i rischi del trasbordo del prigioniero vivo in un altro covo, ad esempio,
sarebbero stati in qualunque altro momento anche più gravi di quelli corsi nel
trasporto del cadavere. . Del resto quell’appartamento è stato scoperto, a terra
ci sono tuttora i segni del tramezzo (costruito e poi abbattuto dai brigatisti)
nella stanza in cui fu costruita la prigione, e ci sono testimoni che hanno
visto la Renault 4 rossa nel garage di via Montalcini la mattina del 9 maggio:
fatto poco conciliabile con l’ipotesi che il trasporto in via Castani su quella
macchina (dove furono trovati anche i bossoli dei colpi che hanno ucciso Moro)
sia avvenuto da un altro luogo.
Archivi.
E' vero che saranno aperti archivi coperti fino ad ora dal
segreto di stato riguardo il caso Moro. Se si, di che natura? Cosa ci si
troverà? Carlo, Barcellona.
La nuova legge sul segreto di
Stato rende possibile la rimozione del segreto e l’apertura degli archivi di
documenti riservati a trent’anni di distanza dai fatti. Questo significa che da
quest’anno anche eventuali documenti segreti sul caso Moro (se ce ne sono)
potrebbero essere resi pubblici. Che cosa ci si troverà, ovviamente, si potrà
sapere solo dopo l’eventuale loro pubblicazione.
Paolo VI.
Alla luce delle Sue conoscenze dott. Bianconi, quale fu il ruolo
di Sua Santità Paolo VI, durante i terribili giorni del sequestro? Nicola da
Padova.
Il più importante fu quello
dell’appello divulgato il 22 aprile, dopo la lettera a lui indirizzata fattagli
avere da Moro. In quella famosa lettera agli “omini delle Brigate rosse il papa
li invitò a liberare l’ostaggio “semplicemente, senza condizioni”: un
particolare in linea con la linea della fermezza tenuta dal governo e, secondo
l’opinione che ho ricavato da testimonianze e documenti, in qualche modo
caldeggiata dal presidente del Consiglio Andreotti. Moro, che conosceva Paolo VI
da lunga data, rimase deluso da quella lettera (cosa che scrisse anche alla
moglie). Su altri piani gli uomini di Chiesa hanno tentato di aprire altri
canali attraverso i cappellani delle carceri, o promuovere una raccolta di
denaro per un eventuale riscatto da consegnare ai brigatisti in cambio della
libertà dell’ostaggio. Iniziative sicuramente gradite al papa, se non da lui
promosse, che però non portarono a nulla.
Chi fu il "cecchino" di Via Fani?
Allo stato delle indagini e dei suoi studi, chi fu la persona
che, in Via Fani, usò la mitraglietta Skorpion con la quale furono assassinati
quasi tutti i membri della scorta di Aldo Moro? Stefano Reggio Emilia.
Da quanto s’è accertato nei
processi (attraverso le dichiarazioni di uno degli sparatori, cioè Valerio
Morucci), a fare fuoco sulle due auto di Moro e della scorta furono lo stesso
Morucci e gli altri brigatisti Raffaele Fiore, Franco Bonisoli e Prospero
Gallinari.
DC e altri.
Mi ha colpito molto il personaggio Zaccagnini (l'onesto ZAC)
davvero è stato così onesto nei confronti della famiglia Moro? E della richiesta
in passato della Faranda di equiparare le BR che hanno scontato la pena ai
familiari delle vittime cosa ne pensa? Ci sono ad oggi ancora punti oscuri del
sequestro? Alessandro Poggio Moiano.
La famiglia Moro ha sempre
rimproverato a Zaccagnini l’immobilismo della Democrazia cristiana che – a loro
giudizio, ma anche, per molti versi, oggettivamente – contribuì ad arrivare alla
tragica conclusione del sequestro. Zaccagnini si sentiva stretto tra il
desiderio di fare qualcosa di utile per salvare il suo maestro e amico Moro e la
convinta adesione all’impossibilità di fare qualche passo che legittimasse le Br
sul piano politico; probabilmente rimasto lui stesso vittima di questa strettoia
dalla quale non è riuscito a uscire. L’idea di equiparazione che lei attribuisce
ad Adriana Faranda (che non so quando e come sia stata espressa, e in quali
precisi termini) mi sembra difficile anche solo da immaginare, visto che è
difficile mettere sullo stesso piano chi si è trovato vittima di scelte compiute
da altri e chi invece s’è trovato in carcere per scelte fatte da se stesso.
Perchè
Perchè le brigate rosse non pubblicarono subito il testo degli
interrogatori di Moro? Il contenuto di quei documenti non sarebbe stato più
destabilizzante della morte dell'ostaggio? Marco - Roma.
Perchè le br non hanno mai reso pubblici gli interrogatori di
Moro? Le informazioni contenute in quei documenti (in parte ritrovate in via
monte nevoso) non sarebbero state molto più destabilizzanti dell'uccisione
dell'ostaggio? Marco T. - Roma.
Le Br stavano trascrivendo il
testo del cosiddetto “memoriale di Moro”, che poi sarebbero le sue risposte ai
temi sottopostigli dai brigatisti nell’interrogatorio, a loro detta per la
pubblicazione annunciata nell’ultimo comunicato emesso durante il sequestro. Ma
nell’ottobre del 1978 i carabinieri fecero irruzione nel covo milanese di via
Montenevoso arrestando due dei quattro membri del comitato esecutivo (cioè il
“governo” dell’organizzazione) Bonisoli e Azzolini, e sequestrando quelle carte
che, di conseguenza, non poterono più essere diffuse dalle Br che videro
bloccata l’operazione che stavano facendo.
Chi sono i mandanti?
Mi sembra chiara la domanda spero altrettanto nella risposta.
Saluti Renato dalla Comasina.
A costo di deluderla, credo
che i mandanti del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro siano semplicemente i
brigatisti che l’hanno realizzato e commesso. Altro discorso sarebbe quello su
chi aveva interesse a che finisse in quel modo, e bisognerebbe discuterne a
lungo.
Nuove indagini.
Vi sono nuove indagini? E se vi fossero, o si facessero con nuove
metodologie RIS, si avrebbe qualche novità? Donato Toritto.
Al momento non mi risulta che
ci siano nuove indagini, nonostante la richiesta di riapertura fatta da Maria
Fida Moro sulle mosse di uno studente sovietico che seguiva le mosse di Moro
all’università. Non mi pare che su quel fronte si siano raggiunti risultati di
rilievo. Non credo che dalle nuove metodologie di indagini scientifiche possano
arrivare conclusioni differenti da quelle che si conoscono.
Perchè l'esecuzione?
Perchè condannare a morte Moro, quando un Moro libero avrebbe
messo fine al sistema politico vigente? Può trattarsi solo di miopia politica?
Antonio di Formia.
Perché le Br ritennero di non
aver ottenuto nemmeno la minima parte di ciò che avevano chiesto allo Stato, e
valutarono che liberare il prigioniero avrebbe significato ammettere la propria
sconfitta politica. Qualcuno all’interno delle Br era di altra opinione e
propose di liberarlo ugualmente, ma era in netta minoranza e prevalse – dopo una
consultazione formale – la decisione di uccidere Moro.
Misteri Italiani.
Quanti Misteri Italiani ci sono ancora che non si nulla? Emanuele
Terni.
Tanti, purtroppo.
Dalla Chiesa.
Quale ruolo positivo o negativo ha avuto generale Dalla Chiesa
nel sequestro Moro? Lino - Olbia.
Nelle indagini sul sequestro
praticamente nessuno, essendo stato il suo nucleo sciolto prima del marzo 1978.
Dopo l’omicidio di Moro, invece, Dalla Chiesa fu richiamato a occuparsi di
terrorismo e cinque mesi dopo furono i suoi uomini ad entrare nella base
brigatista milanese di via Montenevoso, arrestate gli occupanti e trovare il
famoso memoriale (almeno una parte, perché un’altra saltò fuori dal retro di un
pannello murato a dodici anni di distanza, sempre nello stesso appartamento).
Memoriale Moro.
Cosa pensa dei memoriali ritrovati negli anni novanta? Sono
attendibili? Le informazioni in essi contenuti sono significative? Samuele
Cagliari.
Attendibili lo sono, perché
sono scritti da Moro come quello trovato nel ’78. L informazioni che Moro aveva
fornito ai brigatisti non rivelavano segreti inconfessabili o chissà che altro,
e furono gli stessi terroristi a giudicarle di scarso rilievo.
Fine del segreto di Stato.
Passati ormai 30 anni da questo triste episodio della nostra
storia, non dovrebbe andare in "scadenza" il segreto di stato sui documenti e
sul memoriale? E' incredibile come su una vicenda del genere ci siano ormai
talmente tante versioni e tanti studi poter dire tutto ed il contrario di tutto
Cristina, Milano.
Ufficialmente sul caso Moro
non è mai stato apposto alcun segreto di Stato. Diverso discorso sarebbe se
venissero aperti gli archivi dei servizi segreti e si trovassero documenti
riservati di cui finora non s’è saputo nulla.
Quarto uomo.
E' mai esistito un quarto brigatista, come dice Flamigni, e se sì
è possibile che fosse un altissimo esponente dello Stato? Marco Salerno.
Il “quarto” brigatista era il
quarto carceriere di Moro rispetto ai tre di cui già si conosceva l’identità
(Mario Moretti, Prospero Gallinari e Anna Laura Traghetti) e dal 1993 si sa chi
fosse: era Germano Maccari, un brigatista “di borgata” come molti altri, che non
aveva nulla a che fare con lo Stato.
Perchè lo hanno ucciso?
Perchè la Cia si è infiltrata nelle BR e ha ucciso Moro? Per via
del "compromesso storico"? Andrea Bari.
Io non so (e sinceramente non
credo) che la Cia si sia infiltrata nelle Br, quindi…
Le svolte della Storia.
La vicenda di Moro secondo
alcuni rappresenta una di quelle svolte della storia, che accadono ogni tanto:
una sorta di impennata "negativa". Lei che ne pensa di questa lettura
dell'episodio? Francesco da Conversano (Ba).
Sicuramente fu una svolta,
perché ha cambiato il corso della storia dell’Italia repubblicana.
L'inizio della fine.
Gentile Bianconi, lei si sente di sposare la tesi che le Br con
il sequestro prima e l'uccisione poi dell'on.Moro si sia avviata con le sue mani
verso la fine? Matteo Milano.
Rapimento.
Come si spiega che con il rapimento di Aldo Moro ci fu un'apice
del terrorismo che poi negli anni 80 tutto rotolò nel dimenticatoio con la fine
Terrorismo Rosso? Renzo-Milano.
Dal punto di vista politico è
una lettura che può essere fatta, ma sul piano militare e della propaganda il
periodo di massima espansione delle Br (sia per adesioni che per azioni
commesse) è successivo al sequestro, nel 1979. Poi dall’80, con i pentiti, è
cominciata la sconfitta “militare”. Fu quella la vera e decisiva “arma” messa in
campo dallo Stato nella lotta al terrorismo, che si andò esaurendo con gli
arresti andati avanti per tutto il decennio Ottanta. Poi è rispuntato nel ’99,
con altri presupposti e con altre dimensioni.
Non come, ma perchè?
Sono stati consumati fiumi di inchiostro per indagare su come
venne rapito Moro, sui depistaggi delle indagini e altri misteri, a volte fin
troppo fantasiosi. Questo probabilmente oscura la domanda più importante: perchè
venne rapito? Come mai non era protetto abbastanza?
Perché è stato rapito l’hanno
spiegato abbastanza chiaramente i suoi rapitori, durante e dopo il sequestro.
Sulla protezione, certamente insufficiente visto ciò che è accaduto, c’è da
ricordare che in quel periodo erano pochissimi gli uomini politici a cui era
dedicato un servizio di protezione migliore, cioè con 5 agenti di scorta
intorno. La differenza l’avrebbe fatta, probabilmente l’auto blindata, ma non è
detto che le Br non avrebbero escogitato in quel caso un piano alternativo, o
usato le armi adeguate.
Tragitto casa Moro–Montecitorio.
Buongiorno, ho letto su uno dei numerosi libri che trattano il
caso che le Br già sapessero del tragitto del segretario Dc . Com'è possibile
datosi che Moro e la scorta cambiavano tragitto ogni giorno? Grazie Franz da
Roma.
Non è esatto che Moro
cambiasse tragitto ogni giorno. Ne aveva due o tre a secondo di dove doveva
recarsi. Ma un edicolante di via Fani disse alla polizia il giorno stesso del
sequestro che vedeva passarlo quasi ogni mattina.
Anni di piombo.
Cosa sono e perché si chiamano cosi esattamente gli anni di
piombo? grazie Gregorio Oxford.
La definizione del periodo
prende il nome da un film tedesco della regista Von Trotta che trattava il tema
del terrorismo in Germania, e si riferisce al piombo sparato dai gruppi armati
in quegli anni.
Prigionia.
Caro Bianconi, cosa ci può dire dei tanti misteri sul caso, come
ad esempio quello sul luogo della prigionia? E, soprattutto, cosa ne pensa delle
clamorose rivelazioni fatte dall'ex vicepresidente del CSM ed ex vicesegretario
della Democrazia Cristiana Giovanni Galloni qualche anno fa a Rainews24?
Segreta.
Io credo che sulla prigione
non ci siano troppi misteri, e che effettivamente fu nell’appartamento di via
Montalcini dove abitava Anna Laura Traghetti. Quanto alle rivelazioni
dell’onorevole Galloni, il quale ha riferito nel 2005 presunte confidenze che
gli avrebbe fatto Moro prima di essere rapito, mi chiedo solo come mai non ne
abbia mai fatto cenno durante i giorni del sequestro, quando lui stesso
partecipò non si sa bene a che titolo (era uno dei due vice-segretari della
Democrazia cristiana) alle prime riunioni del comitato tecnico del Viminale per
affrontare l’emergenza.
Moro e Banda della Magliana.
Buongiorno Bianconi, mi può chiarire i collegamenti tra il caso
Moro e la Banda della Magliana? Grazie Andrea Shanghai.
In realtà di chiaro non c’è
nulla. Non fosse perché la “banda della Magliana” in quanto tale nel 1978 s’era
messa insieme da pochi mesi e non s’era ancora affermata sul territorio romano
con il proprio primato sul piano criminale. Inoltre non era un’organizzazione
verticistica da coinvolgere in quanto “entità”. Secondo alcune testimonianze ci
fu, tra i membri della banda, chi fu contattato per avere qualche informazione
sulla prigione di Moro, perché si pensava che attraverso il “controllo del
territorio” dei banditi potessero arrivare informazioni sconosciute alle forze
dell’ordine, ma non ne venne fuori nulla di concreto.
Dominio pieno e incontrollato.
A cosa si riferisce Moro quando in una delle sue lettere fa una
profonda riflessione sulla situazione del suo partito e parla di un dominio
pieno e incontrollato? Non era forse un messaggio in codice per farsi trovare?
Condominio pieno di gente e non ancora controllato(incontrollato) Saluti Elio da
Tempio Pausania.
Se anche fosse stato quello il
messaggio (come qualcuno ritenne, già all’epoca), l’indicazione sarebbe stata
talmente vaga da rivelarsi inutile, visto che a Roma, all’epoca, c’erano
migliaia e migliaia di condomini pieni e non controllati dalle forze
dell’ordine. Ma quella è una frase precisa, “dominio pieno e incontrollato” può
anche voler dire ciò che significa in italiano, e cioè che Moro non controllava
la situazione proprio perché si trovava nel "pieno dominio” dei suoi carcerieri,
situazione che lo spingeva a dire il resto delle cose scritte in quella lettera.
Il vaticano.
Ma effettivamente il concordato fra comunisti e democristiani
poteva essere accettato dalla politica del vaticano, se così fosse perché poi
brigatisti hanno potuto aver scampo grazie anche all'interessamento di alcuni
funzionari della santa sede. A chi faceva paura questo nuovo governo? Antonio
Roma.
I buoni rapporti tra Moro e
Paolo VI, così come quelli tra Andreotti e la santa Sede, fanno ritenere che le
mosse dei due uomini politici non fossero così mal viste dalla dirigenza
vaticana del 1978. Non credo che quello che è accaduto circa l’interessamento di
alcuni religiosi al destino di alcuni brigatisti detenuti abbia a che fare con
la politica vaticana di quella stagione.
Moro e misteri.
Secondo lei è vero che Moro poteva realmente essere ritrovato ed
è vero che il rapimento Moro è stata una faccenda che ha travalicato i confini
nazionali mettendo in campo anche "forze" estere? Emanuele Roma.
Certo le indagini fatte per
individuare i brigatisti che l’avevano sequestrato e la prigione dove era tenuto
non rappresentarono il massimo della professionalità e dell’efficienza. La
polizia e i carabinieri conoscevano fin dall’inizio del sequestro i nomi di
alcuni brigatisti che effettivamente avevano a che fare con il rapimento Moro,
ma non furono in grado di arrivare a nulla durante i 55 giorni. Subito dopo
l’omicidio di Moro, lo Stato richiamò in servizio antiterrorismo il generale
dalla Chiesa, e i pochi mesi fu trovato il covo milanese di via Monte nevoso
dove furono arrestati due dei quattro membri del comitato esecutivo delle Br e
buona parte delle lettere e del memoriale di Moro.
I documenti.
Dove si trovano i vari documenti che lei cita? Sono riservati o
liberamente consultabili? E se consultabili, sono stati usati per altre
pubblicazioni? Paola da Roma.
Io ho lavorato su atti
giudiziari e parlamentari in gran parte pubblici, oltre che sulla memorialistica
e sulle testimonianze dei protagonisti che ho personalmente intervistato.
Le armi nel bagagliaio.
Quando venne sequestrato Moro, in via Fani, i cinque uomini della
scorta stavano in un'auto che seguiva quella dell'esponente politico. Mi risulta
che essi non abbiano potuto rispondere al fuoco delle Brigate Rosse perché
tenevano le armi nel bagagliaio della macchina! Perché questa leggerezza? Vito -
Palermo.
Uno dei mitra in dotazione
alla scorta di Moro era nel bagagliaio dell’Alfetta di scorta, altre armi erano
invece a disposizione degli agenti, che però non ebbero il tempo di usarle. Uno
dei cinque uomini della sicurezza, l’agente Iozzino, riuscì a uscire dall’auto e
sparare un paio di colpi, ma fu subito ucciso da uno dei brigatisti che
parteciparono all’agguato.
Morte annunciata.
L'attenzione di Moro nei confronti del Pci creava problemi sia a
destra che a sinistra, rompeva gli schemi nell'Alleanza Atlantica e nel Patto di
Varsavia. La fine di Aldo Moro fu quindi inevitabile: "Una morte annunciata",
come scrisse più tardi il fratello Carlo Alfredo Moro? Francesco Fondelli -
Firenze.
Certamente la politica di Moro
veniva seguita a livello internazionale, e certamente anche le superpotenze
dell’epoca, Usa e Urss, erano interessate agli sviluppi della politica italiana
così come Moro – insieme ad altri – la stava conducendo. Ma di qui a immaginare
un ruolo delle forze straniere nella decisione delle Br di uccidere l’ostaggio
ce ne corre. Non foss’altro perché con le ipotesi senza prove (e in questo caso
le prove mancano) non si può fare la storia. E’ comunque più verosimile – semmai
– un condizionamento esterno degli eventi che possa aver indotto i brigatisti a
uccidere Moro che non un intervento diretto sulle loro scelte.
Le foto di via Fani.
Vorrei sapere se esistono le foto scattate a via Fani da una
signora durante l'attacco. Ci sono ancora, ci sono mai state? Marco Sulmona.
Una testimone ha riferito che
suo marito scattò delle foto in via Fani subito dopo l’agguato e che poi il
rullino fu consegnato alla magistratura. Quel rullino, poi, è sparito. E’ uno
dei misteri dell’inchiesta sul rapimento Moro, mai risolto. Tuttavia è da
precisare che le foto si riferivano al dopo, cioè quando i brigatisti se n’erano
già andati portandosi via Moro.
Affaire Moro.
Secondo lei, Andreotti e Cossiga potrebbero chiarire i dubbi
rimasti sull'affaire Moro? Se si perchè? grazie Giuliano Arezzo.
Potrebbero raccontare molte
verità su come loro – e quindi il governo – si comportarono nei 55 giorni. Per
quel poco che l’hanno fatto, purtroppo, molte cose non sembrano coincidere con
la verità.
Guardare avanti.
Ero piccolo a quel tempo, ma ho il ricordo vivo delle immagini
televisive e del clima che si respirava. L'ho rivissuto da più grande con l'11
settembre. La domanda però che mi faccio è: perchè c'è bisogno di parlarne
ancora dopo 30 anni? Non è forse questo un modo per non guardare avanti? Lodi.
Sinceramente non credo.
Piuttosto, visto che questa vicenda ha segnato in modo irreversibile la storia
d’Italia, approfondirla e cercare di chiarirla il più possibile, anche per i più
giovani, potrebbe essere un modo per affrontare meglio il futuro. Come del resto
dimostra l’intervento di un’altra persona che trascrivo qui sotto.
Ieri, oggi, e domani?
Dopo 30 anni di duro lavoro, si sa tanto ma non abbastanza.
Basteranno altri 30 per vedere un po' più chiaro? Perchè si continua a bussare
ad una porta che nessuno vuole aprire? Saluti e buon lavoro Pietro dall' Olanda.
Li conosciamo tutti?
Da quanti terroristi era composto il commando che operò il 16
marzo? E li conosciamo tutti? Angelo Garbellano Montescaglioso.
Per quello che se ne sa sì. Il
gruppo era composto da dieci persone, tutti individuati. Una sola non è stata
condannata (ma è detenuta, con l’ergastolo da scontare, per altri reati mentre
un altro è stato condannato ma mai arrestato (è tutt’ora latitante all’estero,
in Nicaragua). Gli altri hanno scontato pene variabili, e sono tutti liberi,
“similiberi” o in regime di detenzione “attenuata”.
Memoriale.
Quanta parte del memoriale Moro è' stato ritrovato? Da chi? E'
stato reso tutto pubblico o è stato segretato? Grazie Giorgio - Torino.
Quello ritrovato è stato reso
pubblico, in due fasi che coincidono coi due ritrovamenti (1978 e 1990) Non è
certo, però, che sia la versione integrale di quanto Moro ha scritto. Inoltre è
stata ritrovata solo la fotocopia, mentre dell’originale non s’è mai avuta
notizia.
Alla fine.
Secondo lei su questa vicenda si è già detto tutto? Ho letto il
suo (bellissimo) libro e (mi sembra) emerga una classe politica ed un apparato
investigativo non all'altezza. Ma personaggi come Moretti o altri cosa
nascondono? Sulla Dc solo un giudizio politico o anche storico? Grazie Ettore
Froio.
Anche Moretti e altri
brigatisti, potrebbero certamente aggiungere dettagli o sciogliere interrogativi
che ancora restano insoluti (per esempio il destino dell’originale del memoriale
Moro); allo stesso modo i dirigenti democristiani dell’epoca, in modo da
consentire un giudizio storico oltre che politico sul comportamento di quello
che fui il partito di Moro.
Moro.
Chi ha voluto Moro
morto non certo i brigatisti (solo esecutori). Tu che ne pensi? Aurelio Mazara
del Vallo.
....doveva morire.....
Salve, un nuovo libro. E' presto per parlarne, o lo Statista era
scomodo in un periodo di guerra fredda, che sappiamo, come influisca su milioni
di grandi elettori (la gente che va al voto). I bilanci sulla sicurezza e sulla
salute passano come fiumi in piena. Lei, di cosa è convinto del caso Moro?
Albino da Roma.
Sinceramente penso che i
brigatisti l’hanno voluto visto che l’hanno ucciso e avrebbero potuto non farlo.
Dopodiché, molti altri potrebbero aver voluto la morte dell’ostaggio, magari
anche cercando di “indirizzare” le indagini o la politica italiana in maniera
che le Br uccidessero Moro.
Bobine.
Risulterebbe che l'interrogatorio di Moro sia stato registrato.
Dove sono finite le bobine? e ancora, a proposito delle trascrizioni trovate in
via Monte Nevoso, erano le uniche in circolazione? Roberto Milano.
L’interrogatorio, secondo le
testimonianze dei brigatisti presenti nella prigione di Moro, fu inizialmente
registrato per poi essere trascritto, ma dopo i primi giorni i brigatisti si
resero conto che il lavoro sarebbe stato lungo e difficile. Allora decisero di
rinunciare, e le bobine con la voce di Moro sarebbero state distrutte. Quanto
alle “risposte scritte” dell’ostaggio alle domande dei suoi carcerieri, cioè il
cosiddetto memoriale, quello trovato è solo la fotocopia e non è escluso che ci
possano essere altre parti mai uscite.
Carriere folgoranti.
E' curioso scoprire come i protagonisti principali e marginali
alla vicenda Moro abbiano intrapreso carriere di tutto rispetto negli anni a
seguire, in particolare mi riferisco a Tavaroli e Mancini comandati allora dal
Gen. Dalla Chiesa nella sezione antiterrorismo. Coincidenze? Badiani Firenze.
Dai dati anagrafici che
ricordo mi pare che Mancini e Tavaroli avessero all’epoca del sequestro Moro
meno di vent’anni, quindi ritengo che con il sequestro Moro c’entrassero poco o
nulla. Hanno partecipato ad operazioni antiterrorismo solo negli anni
successivi.
Rimorso o fallimento?
Vorrei sapere una Sua opinione, non avendo vissuto direttamente
quegli anni a causa della giovane età, sulle dimissioni dell'allora Ministro
degli Interni Cossiga. Fu effettivamente la constatazione del fallimento dello
Stato oppure il rimorso per non essere riusciti a salvare Moro? Pietro De Montis
- Modena.
Probabilmente tutte e due le
cose….
Realtà dei fatti.
Secondo voi l'On. Aldo Moro è stato veramente abbandonato dalle
istituzioni e dal suo partito (Zaccagnini, Andreotti Etc.) Armando L'Aquila.
Che ciò sia avvenuto mi pare
indubbio. Il problema è se questa sia stata una scelta obbligata, come gli
uomini di governo e di partito di allora dissero e dicono ancora oggi, oppure se
se ne poteva fare un’altra…
Teoria del complotto.
Pur non avendo mai creduto alla teoria del complotto
internazionale sono sempre rimasto incuriosito dalla vicenda. Vorrei sapere cosa
pensa dei punti oscuri come: 1-presenza di almeno un soggetto non identificato
sul luogo dell'agguato; 2-luogo della prigionia; 3-memoriale Giuseppe Firenze.
Al momento non risulta che ci
sia un soggetto non identificato in via Fani. Si continua piuttosto a parlare di
una moto con due persone a bordo dalla quale sarebbero partiti dei colpi contro
un testimone, ma i brigatisti hanno sempre smentito che quelli ipotetici)
motociclisti facessero parte del commando. Il luogo della prigionia è
l’appartamento di via Montalcini appositamente acquistate dalle Br. Qualcuno
sostiene che dev’esserci almeno un’altra prigione, ma non solo non s’è mai
saputo nemmeno indicare dove fosse; non s’è mai nemmeno saputo spiegare
adeguatamente per quale motivo dovrebbe esserci. Sul memoriale resta il mistero
dell’originale (quelle trovate sono solo le fotocopie) e se sia completo.
Giovanni Bianconi.
10
marzo 2008
(ultima modifica: 30 giugno 2008) Corriere della Sera”.
Papa Francesco "riapre" il
caso Moro.
Antonio Mennini, ora nunzio apostolico nel Regno Unito, sarà ascoltato dalla
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda: c'è l'ok di Papa Francesco.
L'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga aveva detto che Mennini,
all'epoca giovane sacerdote, avrebbe addirittura confessato Aldo Moro durante la
prigionia, scrive il 07 marzo 2015 "Today". Parlare di svolta, forse, non è
un'esagerazione. Perché il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro restano una delle
pagine più oscure e drammatiche della storia italiana. E la verità, tutta la
verità, non è mai venuta alla luce. I misteri che avvolgono il sequestro del
cinque volte Presidente del Consiglio e Segretario della Democrazia Cristiana
sono ancora tanti. Papa Francesco a sorpresa ha dato il via libero in modo
che Antonio Mennini, ora nunzio apostolico nel Regno Unito, venga ascoltato
dalla Commissione d'inchiesta sulla vicenda. Che cosa c'entra un prete con il
sequestro Moro. L'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga aveva detto
che Mennini, all'epoca giovane sacerdote, avrebbe addirittura confessato Aldo
Moro durante la prigionia. Oggi il Corriere della Sera ricorda come
secondo alcune voci mai confermate, ma evidentemente persistenti, Mennini era
diventato un canale di mediazione, l'unico, tra il Vaticano e le Brigate rosse:
il Papa Paolo VI era un amico personale di Moro. C'è grande attesa per la
deposizione del prossimo 9 marzo, quando opererà la nuova Commissione
parlamentare d'inchiesta sul delitto di via Fani. Nei quasi 37 anni che ormai ci
separano da quei drammatici giorni, Mennini non ha mai parlato in tribunale né
rilasciato interviste di alcun tipo. Il segnale che Papa Francesco vuole dare è
chiaro: collaborazione e trasparenza totale con le autorità italiane, un netto
cambio di passo rispetto al passato. In tutti questi anni Mennini non si è mai
esposto, ha ricoperto per il Vaticano vari incarichi. Tra due giorni il nunzio
arriverà a Roma a deporre a San Macuto, sede della Commissione, nonostante sia
un diplomatico e goda di immunità speciali.
ALDO MORO, LA GENUINITA’
DELLE LETTERE E LA TRATTATIVA.
Il rapimento Moro e
l’umanista dell’Osservatore.
Approfondimento della rubrica
“Piccole Note” de “Il Giornale” il 16 marzo 2016. Quella che pubblichiamo è una
lettera inedita di Guido Gonella, illustre esponente politico della Democrazia
cristiana, consegnata ai familiari nei giorni bui del rapimento di Aldo Moro. È
datata infatti 2 maggio 1978, pochi giorni prima del tragico epilogo di quella
oscura vicenda, iniziata il 16 marzo con il rapimento dello statista
democristiano e l’uccisione della sua scorta (oggi ricorre l’anniversario). La
rendiamo nota per gentile concessione della famiglia, anche perché crediamo che
abbia un certo valore storico. Questo il testo della missiva: «Nel caso in cui
fossi catturato non credete ad alcun scritto o parola che mi fosse attribuito
dagli aggressori. Per la mia liberazione non fate nulla che sia in contrasto con
i doveri morali e civili. Auguro che ogni mio sacrificio sia utile alla causa
per la quale ho combattuto in tutta la mia vita. Abbraccio i miei figli diletti,
le loro famiglie, i miei cari amici e collaboratori, e confido che preghino con
me per la salvezza della mia anima e perché Dio sia misericordioso verso questo
suo figlio che desidera morire nella sua fede cristiana». Firmato Guido Gonella.
Diversi gli spunti di interesse di tale scritto. Ne accenniamo di seguito in un
articolo forse troppo lungo per la lettura via internet (ma si può stampare).
Purtroppo l’analisi della missiva necessita di uno sviluppo articolato. Ce ne
scusiamo con i lettori. Anzitutto va rilevato come nella sua lettera Gonella
chiede ai familiari di non dare alcun peso a scritti e parole che gli fossero
attribuiti in caso di rapimento. Un’indicazione importante perché evidenzia la
percezione che lo scrivente aveva riguardo le lettere che Moro inviava dalla
dura prigione brigatista. Su tali scritti si è svolto, negli anni, un dibattito
notevole, in particolare sulla loro autenticità e la possibile costrizione
subita o meno da Moro nel redigerli. Non interessa in questa sede riprendere
l’articolato dibattito che, al di là delle diverse interpretazioni, ha visto una
convergenza riguardo la loro genuinità. Val la pena, però, accennare che nella
sua lettera Gonella mostra di non ritenere affatto autentiche tali missive (il
cosiddetto Memoriale sarà ritrovato solo in seguito). O quantomeno
reputa siano state estorte allo statista dai suoi feroci carcerieri. Il fatto
che tale convinzione fosse affidata a una lettera privata della quale non
era prevista né richiesta postuma pubblicizzazione rende tale convinzione scevra
da ogni retroscena di carattere politico. Così la missiva di Gonella rende
l’idea di una convinzione che, di là del dibattito sul tema, aleggiava in quei
giorni all’interno della Democrazia cristiana, o in parte di essa, e nell’intero
Paese (sui giornali, ad esempio). Una considerazione che va tenuta presente
anche per capire meglio il complesso clima, anche psicologico, che si respirava
nell’Italia del tempo. Ma al di là delle indicazioni psicologiche fornite dalla
lettera in questione, essa ha anche altra e più importante valenza. È
possibile che anche altri esponenti democristiani abbiano scritto missive simili
in quei terribili giorni, tra questi sembra Paolo Emilio Taviani. E però è
sicuro che non c’era alcun ordine di scuderia in proposito. Così appare alquanto
strano che a redigere un documento del genere sia stata una figura come Guido
Gonella. Fondatore della Democrazia cristiana insieme ad Alcide De Gasperi,
egli fu uno degli uomini politici più rilevanti del dopoguerra: non solo nel
partito che aveva contribuito a fondare, ma anche nell’ambito dello Stato. E
però la sua storia politica si era di fatto esaurita con la morte di De Gasperi,
del quale rappresentava una sorta di anima gemella. Certo, aveva ricoperto
alcuni incarichi importanti anche successivamente, come una sorta di saggio
decano al quale ricorrere in particolari circostanze, ma al tempo del rapimento
Moro quell’impegno pubblico apparteneva al passato ed egli era ormai fuori da
ogni gioco politico di rilievo. Eppure, nonostante fosse uomo rigoroso e affatto
incline a indulgere al timore (per lui parla la storia), si sentiva
tanto minacciato da redigere una sorta di testamento spirituale. Per comprendere
tale iniziativa ci può forse soccorrere la storia. Gonella era forse l’esponente
della Democrazia cristiana più legato al Vaticano (insieme a Moro e ad
Andreotti), e in particolare a Paolo VI. Quel Montini che, giovane monsignore,
aveva ricoperto la delicatissima carica di sostituto della Segreteria di Stato
e, durante il regime fascista, volle fosse affidato proprio a Gonella l’incarico
di redigere una rubrica di Esteri sull’Osservatore romano: gli Acta diurna, che
in quegli anni costituì una delle poche voci libere del Paese. Una rubrica che,
grazie all’accuratezza delle informazioni e all’intelligenza dell’illustre
cronista, divenne un faro di orientamento non solo per i cattolici ma per
l’intero antifascismo italiano, militante e non. Tanto che Gonella subì le
conseguenze del caso: arrestato, anche se per pochi giorni (fu rilasciato grazie
all’intercessione di Montini), fu costretto anche ad abbandonare l’insegnamento
e la sua rubrica. Insomma, l’esponente Dc aveva un rapporto intimo con Montini.
Un filo che non si sarebbe interrotto negli anni. E qui torniamo ai drammatici
giorni del rapimento Moro. Paolo VI ebbe molto a cuore la sorte dello statista
sequestrato, uno dei suoi pupilli quando era assistente ecclesiastico
della Fuci. Tanto che si spese fino in fondo per la sua sorte, non solo
chiedendone ai brigatisti «in ginocchio» la liberazione, ma anche propiziando
alcuni tentativi esperiti in tal senso. Uno di questi è stato rivelato in
anni recenti da Giulio Andreotti (vd dopo), che ha parlato a più riprese
di un tentativo di accordo con le brigate rosse. Un tentativo giocato
sottotraccia, in un negoziato segreto condotto da monsignor Curoni, il
coordinatore nazionale dei cappellani delle carceri, grazie a un contatto con un
detenuto. La trattativa prevedeva il rilascio di Moro in cambio di una somma di
denaro. Un tentativo condotto di comune accordo tra Andreotti, allora capo del
governo, e Paolo VI tramite il suo segretario personale, monsignor Pasquale
Macchi. E che si era quasi concretizzato prima di saltare a causa della
mendacità del tramite con i terroristi. Così Andreotti: «Comunque proprio il 9
maggio, mentre Moro veniva ucciso, il falso mediatore stava per avere un
colloquio dall’apparenza conclusiva». È possibile che in tale trattativa, o
forse in altre e meno aleatorie rimaste ancora segrete, abbia avuto un ruolo
anche Gonella, dato il suo antico legame con Paolo VI e con Andreotti (al quale
lo legava il passato fucino e l’antica comune vicinanza a De Gasperi). Proprio
queste prossimità facevano di Gonella il tramite ideale tra il Presidente del
Consiglio e il Papa. Un tramite ideale anche sotto un altro profilo: la sua
marginalità rispetto ad altre figure della Dc gli consentiva una libertà di
azione (e di “discrezione”) impossibile ad altri. Si tratta solo di un’ipotesi.
Il rigore morale di Gonella, che sulla vicenda Moro e altro ha conservato
una riservatezza assoluta anche con i familiari, non ci consente di dare
ulteriori elementi in proposito. E però, un possibile ruolo di Gonella in tal
senso sembra potersi desumere anche da un altro piccolo indizio. Nella lettera
(vd dopo) dal carcere brigatista recapitata a Benigno Zaccagnini il 24 aprile
(alcuni giorni prima della missiva-testamento di Gonella), nella quale usava
toni molto duri contro la Dc e “preannunciava” il suo prossimo assassinio, Moro
faceva cenno proprio a Gonella, indicandolo come «umanista dell’Osservatore».
Tanti e diversi hanno ipotizzato che tra le righe delle sue missive Moro celasse
messaggi in codice per i suoi interlocutori. Messaggi che la sua condizione di
prigioniero costringeva all’implicito; un implicito che la sua cultura e la
lunga esperienza politica gli consentivano di dosare in maniera mirabile. Nel
caso specifico l’espressione «umanista dell’Osservatore» riferita a Gonella
appare alquanto insolita, sia nell’associazione che nella terminologia. Viene
richiamata infatti una storia non attuale, ma che riguarda il fascismo: a quel
periodo infatti risale la collaborazione di Gonella con il quotidiano vaticano,
come a tracciare un collegamento tra la situazione presente e quella di allora.
Ancor più singolare la definizione di «umanista» associata a Gonella: egli
infatti non era certo assurto a notorietà per la sua propensione alla cultura
classica e alle arti, ma per l’impegno politico e l’attività giornalistica.
Tale termine allora potrebbe rimandare ad altro. Si noti, infatti, che la parola
umanista (o umanistica, termini interscambiabili perché di uguale significato)
abbia certa qual assonanza con la parola «umanitaria». E proprio la «soluzione
umanitaria» era il tema ricorrente delle missive del rapito; soluzione alla
quale affidava le sue speranze di liberazione nell’ambito di una trattativa con
i brigatisti. Peraltro colpisce come il nome di Gonella nella lettera di
Moro sia indicato dopo quello di altri esponenti Dc: «Gui, Misasi, Granelli,
Gava, Gonella». E solo al nome di Gonella è associata una notazione particolare,
«l’umanista del Vaticano», appunto. Un cenno che non viene speso per gli altri…
Insomma, la missiva a Zaccagnini potrebbe contenere un suggerimento, implicito
ma intellegibile ai suoi interlocutori (ai quali lo univano anni di comune
militanza e affinità elettive, come accenna anche in quella lettera), di
affidare proprio a Gonella il compito di tramite, nel segreto, in una trattativa
umanitaria da condurre attraverso il Vaticano. Il riferimento all’Osservatore
romano contenuto nella lettera di Moro, allora, nel richiamare l’antico incarico
di Gonella, potrebbe essere un’ulteriore indicazione in tal senso. Si tratta
solo di ipotesi, ma crediamo abbiano certa qual ragionevolezza di fondo.
Colpisce anche la data, prossima a quel fatidico 5 maggio in cui le brigate
rosse divulgano il Comunicato numero 9 (vd dopo), nel quale viene annunciata la
sentenza di morte dello statista Dc. Giorni delicatissimi dunque, che
precipitavano verso la tragedia. Di per sé, però, tale circostanza non avrebbe
dovuto cambiare la percezione del rischio personale da parte di Gonella, data
appunto la sua posizione defilata rispetto ai suoi compagni di partito e di
altri protagonisti della vita pubblica di allora. E però è possibile invece che
l’incrudelirsi del momento, o qualche incarico particolare, abbia indotto
Gonella a percepire un pericolo ulteriore connesso a un suo (possibile) ruolo di
mediatore tra Palazzo Chigi e Vaticano. Un rischio proporzionale alla decisione
delle Brigate rosse, o meglio di parte di esse, di chiudere la vicenda in via
definitiva, sbarrando la strada a possibili ipotesi alternative. Val la pena, in
conclusione, soffermarsi su un’altra indicazione fornita dal documento inedito.
Nella lettera di Gonella le brigate rosse non sono mai indicate con il
loro nome, nonostante il riferimento sia palese. L’esponente democristiano, da
uomo di grande intelligenza e da lucidissimo giornalista, sapeva dar peso alle
parole, come anche al non detto. Così quella omissione suona alquanto
significativa. E va letta nel contesto integrale del documento, nel quale lega
quella tragica temperie presente al passato, il contrasto al terrorismo con
quello al fascismo, come parte di un’unica lotta per la libertà. Cenno
particolarmente significativo per la percezione che l’esponente della Dc, e non
solo lui, aveva della sfida costituita dal terrore brigatista. Un’ultima nota va
infine spesa per evidenziare lo spessore umano che traspare dalla missiva e la
profonda fede che la sottende. Altri tempi, altri politici. La storia della
Democrazia cristiana, e di tanta politica italiana, è anche questa. Tenerlo
presente aiuterebbe anche a dissipare le nebbie del presente.
Monsignor Pasquale Macchi
ha presentato il 15 giugno 1998, il suo libro Paolo VI e la tragedia di Moro.
Ogni anno il 6 agosto, festa della Trasfigurazione e anniversario della morte
del papa Paolo VI, don Pasquale Macchi era lì in San Pietro per la messa di
suffragio. Constatava con gioia che non si verificava un calo di partecipazioni.
Anzi, dalla Cappella nelle Grotte Vaticane si era dovuto spostare la
celebrazione nella Basilica; esattamente all’altare della Cattedra, scrive
Giulio Andreotti ad aprile 2006 su “30 Giorni”, mensile internazionale diretto
da Giulio Andreotti dal 1993 al 2012. Ogni anno il 6 agosto, festa della
Trasfigurazione e anniversario della morte del papa Paolo VI, don Pasquale
Macchi era lì in San Pietro per la messa di suffragio. Constatava con gioia che
non si verificava un calo di partecipazioni. Anzi, dalla Cappella nelle Grotte
Vaticane si era dovuto spostare la celebrazione nella Basilica; esattamente
all’altare della Cattedra. Qualche vuoto tra noi vecchi fucini non era dovuto a
intiepidimento del ricordo o alla calura di agosto. Uno ad uno si ritorna –
speriamo bene – alla Casa del Padre. La nuova devozione a Gesù
Misericordioso accresce la speranza che non vada male. A Roma Macchi veniva
altre volte, nel corso dell’anno, soggiornando con due amici sacerdoti che
l’hanno preceduto: padre Carlo Cremona e monsignor Donato De Bonis. Ora si
ritrovano lassù. Del suo Papa don Pasquale ha sempre coltivato la memoria con
affetto filiale e con grande intelligenza, sottolineando in particolare
l’apertura all’arte contemporanea, di cui le nuove stanze nei Musei Vaticani
rappresentano la punta più elevata. Al riguardo posso ricordare un episodio
divertente. Quando cinquant’anni fa il mercato delle litografie di Chagall aveva
quotazioni quasi irrilevanti, acquistai a Parigi una della serie biblica, che
faceva spicco nel mio studio. Con garbo don Macchi mi fece capire che avrebbe
figurato bene in Vaticano: d’accordissimo. Qualche tempo dopo mia moglie,
visitando il Museo stesso (in occasione dell’acquisizione di opere di Manzù), fu
colpita dalla somiglianza della litografia di Chagall con quella... mia. Ma non
era solo passione artistica a spingere Macchi (e papa Montini). Era un mezzo per
esercitare apostolato evangelizzatore in un ambiente da molto tempo quasi del
tutto divaricato dalla Chiesa. Macchi continuò anche a Loreto e dopo. Basti
pensare al sostegno verso Floriano Bodini, con le due bellissime statue di Paolo
VI al Sacro Monte di Varese e nell’Aula Nervi. Perché Macchi non ne ha parlato
nel libro e anche dopo non descrisse il fatto? Credo che si aveva il timore,
fino a che monsignor Curoni era vivo, che i giudici potessero costringere lui e
il cappellano milanese a render noto il nome del carcerato che aveva avanzato la
proposta. La nostra legislazione penale ammette il diritto di non rispondere
invocando il segreto confessionale? Comunque proprio il 9 maggio, mentre Moro
veniva ucciso, il falso mediatore stava per avere un colloquio dall’apparenza
conclusiva. Dei libri scritti da Macchi particolare valore storico ha il diario
sulle tremende settimane della cattura e dell’assassinio di Aldo Moro. Quasi
ogni sera don Pasquale veniva a casa mia per aggiornare il Pontefice, studiare
possibili interventi, confortarci reciprocamente. Nel libro vi è solo una
omissione, riguardo all’ipotesi del pagamento di un riscatto che la Santa Sede
era prontissima a versare. Questo non urtava – come le trattative politiche con
le Brigate – contro invalicabili questioni di principio e lo incoraggiai.
Tramite il coordinatore nazionale delle Carceri monsignor Curoni, un cappellano
milanese aveva trasmesso questa richiesta-proposta. Ma era un tramite valido?
Macchi mi disse che gli avevano chiesto una “prova” che fosse veramente
collegato. La dette dicendo di non prendere sul serio il comunicato delle
Brigate del giorno successivo. Fu quello clamoroso che annunciava la morte di
Aldo, il cui cadavere si diceva essere stato gettato nel lago reatino della
Duchessa. Grande emozione, immediato sopralluogo e ricerca: vi era un cadavere,
ma non era Moro. Le Brigate Rosse si affrettarono a denunciare la falsità del
comunicato, dando quasi a credere che fosse una manovra governativa. Tutto però
si dissolse con l’assassinio del 9 maggio e il ritrovamento emblematico della
salma in via delle Botteghe Oscure. Da tutto quel che si è appreso sembra certo
che la richiesta di riscatto non era partita né aveva possibilità di sbocco nei
carnefici di Moro e della sua scorta. È stata anzi collegata a un personaggio di
cronaca nerissima, già autore di un assalto a un furgone valori. Perché Macchi
non ne ha parlato nel libro e anche dopo non descrisse il fatto? Credo che si
aveva il timore, fino a che monsignor Curoni era vivo, che i giudici potessero
costringere lui e il cappellano milanese a render noto il nome del carcerato che
aveva avanzato la proposta. La nostra legislazione penale ammette il diritto di
non rispondere invocando il segreto confessionale? Comunque proprio il 9 maggio,
mentre Moro veniva ucciso, il falso mediatore stava per avere un colloquio
dall’apparenza conclusiva. A dare speranza che l’epilogo non fosse quello
tragico aveva dato motivo negli ultimi giorni la lettera di Aldo nella quale
chiedeva di passare dal Gruppo parlamentare democristiano a quello “Misto”.
Rientrava negli sforzi per sfuggire alla morte accreditando verso i suoi
carcerieri l’ipotesi che vivo e libero sarebbe stato un feroce contestatore
contro di noi e contro i comunisti. Il libro-cronaca di don Macchi è chiarissimo
su un punto. Quando Paolo VI scrisse la lettera ai rapitori, invocando che
rilasciassero Moro senza condizioni, non aveva avuto alcun suggerimento. Come,
poi, il Papa avesse vissuto la tragedia lo si vide a San Giovanni in Laterano
quando non solo stigmatizzò i carnefici, ma rimproverò Dio per non aver
ascoltato la sua preghiera. In tanti eventi – non certo paragonabili a questo –
Macchi fu fedelissimo esecutore degli ordini di Paolo VI. La carità del Papa –
nel senso più vasto del termine – era di una profondità e vastità infinite. Don
Macchi ne restò sempre edificato.
Lettera a Benigno
Zaccagnini. Recapitata il 24 aprile.
"Caro Zaccagnini, ancora una volta, come qualche giorno fa m'indirizzo a te con
animo profondamente commosso per la crescente drammaticità della situazione.
Siamo quasi all'ora zero: mancano più secondi che minuti. Siamo al momento
dell'eccidio. Naturalmente mi rivolgo a te, ma intendo parlare individualmente a
tutti i componenti della Direzione (più o meno allargata) cui spettano
costituzionalmente le decisioni, e che decisioni! del partito. Intendo
rivolgermi ancora alla immensa folla dei militanti che per anni ed anni mi hanno
ascoltato, mi hanno capito, mi hanno considerato l'accorto divinatore delle
funzioni avvenire della Democrazia Cristiana. Quanti dialoghi, in anni ed anni,
con la folla dei militanti. Quanti dialoghi, in anni ed anni, con gli amici
della Direzione del Partito o dei Gruppi parlamentari. Anche negli ultimi
difficili mesi quante volte abbiamo parlato pacatamente tra noi, tra tutti noi,
chiamandoci per nome, tutti investiti di una stessa indeclinabile
responsabilità. Si sapeva, senza patti di sangue, senza inopinati segreti
notturni che cosa voleva ciascuno di noi nella sua responsabilità. Ora di questa
vicenda, la più grande e gravida di conseguenze che abbia investito da anni la
D.C., non sappiamo nulla o quasi. Non conosciamo la posizione del Segretario né
del Presidente del Consiglio; vaghe indiscrezioni dell'On. Bodrato con accenti
di generico carattere umanitario. Nessuna notizia sul contenuto; sulle
intelligenti sottigliezze di Granelli, sulle robuste argomentazioni di Misasi
(quanto contavo su di esse), sulla precisa sintesi politica dei Presidenti dei
Gruppi e specie dell'On. Piccoli. Mi sono detto: la situazione non è matura e ci
converrà aspettare. E' prudenza tradizionale della D.C. Ed ho atteso fiducioso
come sempre, immaginando quello che Gui, Misasi, Granelli, Gava, Gonella
(l'umanista dell'Osservatore) ed altri avrebbero detto nella vera riunione, dopo
questa prima interlocutoria. Vorrei rilevare incidentalmente che la competenza è
certo del Governo, ma che esso ha il suo fondamento insostituibile nella D.C.
che dà e ritira la fiducia, come in circostanze così drammatiche sarebbe
giustificato. E' dunque alla D.C. che bisogna guardare. Ed invece, dicevo,
niente. Sedute notturne, angosce, insofferenza, richiami alle ragioni del
Partito e dello Stato. Viene una proposta unitaria nobilissima, ma che elude
purtroppo il problema politico reale. Invece dev'essere chiaro che politicamente
il tema non è quello della pietà umana, pur così suggestiva, ma dello scambio di
alcuni prigionieri di guerra (guerra o guerriglia come si vuole), come si
pratica là dove si fa la guerra, come si pratica in paesi altamente civili
(quasi la universalità), dove si scambia non solo per obiettive ragioni
umanitarie, ma per la salvezza della vita umana innocente. Perché in Italia un
altro codice? Per la forza comunista entrata in campo e che dovrà fare i conti
con tutti questi problemi anche in confronto della più umana posizione
socialista? Vorrei ora fermarmi un momento sulla comparazione dei beni di cui si
tratta: uno recuperabile, sia pure a caro prezzo, la libertà; l'altro, in nessun
modo recuperabile, la vita. Con quale senso di giustizia, con quale pauroso
arretramento sulla stessa legge del taglione, lo Stato, con la sua inerzia, con
il suo cinismo, con la sua mancanza di senso storico consente che per una
libertà che s'intenda negare si accetti e si dia come scontata la più grave ed
irreparabile pena di morte? Questo è un punto essenziale che avevo immaginato
Misasi sviluppasse con la sua intelligenza ed eloquenza. In questo modo si
reintroduce la pena di morte che un Paese civile come il nostro ha escluso sin
dal Beccaria ed espunto nel dopoguerra dal codice come primo segno di autentica
democratizzazione. Con la sua inerzia, con il suo tener dietro, in nome della
ragion di Stato, l'organizzazione statale condanna a morte e senza troppo
pensarci su, perché c'è uno stato di detenzione preminente da difendere. E' una
cosa enorme. Ci vuole un atto di coraggio senza condizionamenti di alcuno.
Zaccagnini, sei eletto dal congresso. Nessuno ti può sindacare. La tua parola è
decisiva. Non essere incerto, pencolante, acquiescente. Sii coraggioso e puro
come nella tua giovinezza. E poi, detto questo, io ripeto che non accetto
l'iniqua ed ingrata sentenza della D.C. Ripeto: non assolverò e non
giustificherò nessuno. Nessuna ragione politica e morale mi potranno spingere a
farlo. Con il mio è il grido della mia famiglia ferita a morte, che spero possa
dire autonomamente la sua parola. Non creda la D.C. di avere chiuso il suo
problema, liquidando Moro. Io ci sarò ancora come un punto irriducibile di
contestazione e di alternativa, per impedire che della D.C. si faccia quello che
se ne fa oggi. Per questa ragione, per una evidente incompatibilità, chiedo che
ai miei funerali non partecipino né Autorità dello Stato né uomini di partito.
Chiedo di essere seguito dai pochi che mi hanno veramente voluto bene e sono
degni perciò di accompagnarmi con la loro preghiera e con il loro
amore. Cordiali saluti 24-4-78 Aldo Moro On. Benigno Zaccagnini. P.S. Diffido a
non prendere decisioni fuori dagli organi competenti di partito".
Comunicato n. 9. Il
comunicato numero nove delle Br è trovato il 5 maggio 1978.
"ALLE ORGANIZZAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI, AL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO, A TUTTI
I PROLETARI. Compagni, la battaglia iniziata il 16 marzo con la cattura di Aldo
Moro è arrivata alla sua conclusione. Dopo l'interrogatorio ed il Processo
Popolare al quale è stato sottoposto, il Presidente della Democrazia Cristiana è
stato condannato a morte. A quanti tra i suoi compari della DC, del governo e
dei complici che lo sostengono, chiedevano il rilascio, abbiamo fornito una
possibilità, l'unica praticabile, ma nello stesso tempo concreta e reale: per la
libertà di Aldo Moro, uno dei massimi responsabili di questi trent'anni di
lurido regime democristiano la libertà per tredici Combattenti Comunisti
imprigionati nei lager dello Stato imperialista. LA LIBERTA QUINDI IN CAMBIO
DELLA LIBERTA. In questi 51 giorni la risposta della DC, del suo governo e dei
complici che lo sostengono, è arrivata con tutta chiarezza, e più che con le
parole e con le dichiarazioni ufficiali, l'hanno data con i fatti, con la
violenza controrivoluzionaria che la cricca al servizio dell'imperialismo ha
scagliato contro il movimento proletario. La risposta della DC, del suo governo
e dei complici che lo sostengono, sta nei rastrellamenti operati nei quartieri
proletari ricalcando senza troppa fantasia lo stile delle non ancora dimenticate
SS naziste nelle leggi speciali che rendono istituzionale e "legale" la tortura
e gli assassinii dei sicari del regime negli arresti di centinaia di militanti
comunisti (con la lurida collaborazione dei berlingueriani) con i quali si
vorrebbe annientare la resistenza proletaria. Lo Stato delle multinazionali ha
rivelato il suo vero volto, senza la maschera grottesca della democrazia
formale, è quello della controrivoluzione imperialista armata, del terrorismo
dei mercenari in divisa, del genocidio politico delle forze comuniste. Ma tutto
questo non ci inganna. La ferocia, la violenza sanguinaria che il regime scaglia
contro il proletariato e le sue avanguardie, sono soltanto le convulsioni di una
belva ferita a morte e quello che sembra la sua forza dimostra invece la sua
sostanziale debolezza. In questi 51 giorni la DC e il suo governo non sono
riusciti a mascherare, neppure con tutto l'armamentario della controguerriglia
psicologica, quello che la cattura, il processo e la condanna del Presidente
della DC Aldo Moro, è stato nella realtà: una vittoria del Movimento
Rivoluzionario, ed una cocente sconfitta delle forze imperialiste. Ma abbiamo
detto che questa è stata solo una battaglia, una fra le tante che il Movimento
Proletario di Resistenza Offensivo sta combattendo in tutto il paese, una fra le
centinaia di azioni di combattimento che le avanguardie comuniste stanno
conducendo contro i centri e gli uomini della controrivoluzione imperialista,
imprimendo allo sviluppo della Guerra di Classe per il Comunismo un formidabile
impulso. Nessun battaglione di "teste di cuoio", nessun super-specialista
tedesco, inglese o americano, nessuna spia o delatore dell'apparato di Lama e
Berlinguer, sono riusciti minimamente ad arrestare la crescente offensiva delle
forze Comuniste Combattenti. A questa realtà la maggiore sconfitta delle forze
imperialiste. Estendere l'attività di combattimento, concentrare l'attacco
armato contro i centri vitali dello Stato imperialista, organizzare nel
proletariato il Partito Comunista Combattente è la strada giusta per preparare
la vittoria finale del proletariato, per annientare definitivamente il mostro
imperialista e costruire una società comunista. Questo oggi bisogna fare per
inceppare e vanificare i piani delle multinazionali imperialiste, questo bisogna
fare per non permettere la sconfitta del Movimento Proletario e per fermare gli
assassini capeggiati da Andreotti. Per quanto riguarda la nostra proposta di uno
scambio di prigionieri politici perchè venisse sospesa la condanna e Aldo Moro
venisse rilasciato, dobbiamo soltanto registrare il chiaro rifiuto della DC, del
governo e dei complici che lo sostengono e la loro dichiarata indisponibilità ad
essere in questa vicenda qualche cosa di diverso da quello che fino ad ora hanno
dimostrato di essere: degli ottusi, feroci assassini al servizio della borghesia
imperialista. Dobbiamo soltanto aggiungere una risposta alla "apparente"
disponibilità del PSI. Va detto chiaro che il gran parlare del suo segretario
Craxi è' solo apparenza perchè non affronta il problema reale: lo scambio dei
prigionieri. I suoi fumosi riferimenti alle carceri speciali, alle condizioni
disumane dei prigionieri politici sequestrati nei campi di concentramento,
denunciano ciò che prima ha sempre spudoratamente negato; e cioè che questi
infami luoghi di annientamento esistono, e che sono stati istituiti anche con il
contributo e la collaborazione del suo partito. Anzi i "miglioramenti" che il
segretario del PSI come un illusionista cerca di far intravvedere, provengono
dal cappello di quel manipolo di squallidi "esperti" che ha riunito intorno a
se', e che sono (e la cosa se per i proletari detenuti non fosse tragica sarebbe
a dir poco ridicola) gli stessi che i carceri speciali li hanno pensati,
progettati e realizzati. Combattere per la distruzione delle carceri e per la
liberazione dei prigionieri comunisti, è la nostra parola d'ordine e ci
affianchiamo alla lotta che i compagni e il proletariato detenuto sta conducendo
all'interno dei lager dove sono sequestrati e lo faremo non solo idealmente ma
con tutta la nostra volontà militante e la nostra capacità combattente. Le
cosiddette "proposte umanitarie" di Craxi; qualunque esse siano, dal momento che
escludono la liberazione dei tredici compagni sequestrati, si qualificano come
manovre per gettare fumo negli occhi, e che rientrano nei giochi di potere,
negli interessi di partito od elettorali che non ci riguardano. L'unica cosa
chiara e che sullo scambio dei prigionieri la posizione del PSI è la stessa, di
ottuso rifiuto, della DC e del suo governo, e questo ci basta. A parole non
abbiamo più niente da dire alla DC, al suo governo e ai complici che lo
sostengono. L'unico linguaggio che i servi dell'imperialismo hanno dimostrato di
saper intendere è quello delle armi, ed è con questo che il proletariato sta
imparando a parlare. Concludiamo quindi la battaglia iniziata il 16 marzo,
eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato. PORTARE L'ATTACCO ALLO
STATO IMPERIALISTA DELLE MULTINAZIONALI! ATTACCARE LIQUIDARE DISPERDERE LA DC
ASSE PORTANTE DELLA CONTRORIVOLUZIONE IMPERIALISTA! RIUNIFICARE IL MOVIMENTO
RIVOLUZIONARIO COSTRUENDO IL PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE! Per il Comunismo
Brigate Rosse. "P.S. - Le risultanze dell'interrogatorio ad Aldo Moro e le
informazioni in nostro possesso, ed un bilancio complessivo politico-militare
della battaglia che qui si conclude, verrà fornito al Movimento Rivoluzionario e
alle O.C.C. attraverso gli strumenti di propaganda clandestini"".
LETTERE DI MORO DALLA
"PRIGIONE DEL POPOLO".
1) A
Eleonora Moro (recapitata il 29 marzo). Mia carissima Noretta, Desidero farti
giungere nel giorno di Pasqua, a te ed a tutti, gli auguri più fervidi ed
affettuosi con tanta tenerezza per la famiglia ed il piccolo in particolare.
Ricordami ad Anna che avrei dovuto vedere oggi. Prego Agnese di farti compagnia
la notte. Io discretamente, bene alimentato ed assistito con premura. Vi
benedico, invio tante cose care a tutti e un forte abbraccio. Aldo.
2) A
Nicola Rana (recapitata il 29 marzo). Carissimo Rana. Le rivolgo il più
affettuoso pensiero e La ringrazio tanto per quel che ha fatto e fa a sostegno
della mia famiglia e mio. Ed ecco che ancora ho bisogno di Lei in un momento
cruciale. Le accludo una lettera da far pervenire a mia moglie ed ai miei, dei
quali non so nulla. E poi ancora una lettera sul caso politico da portare nelle
proprie mani del Ministro Cossiga e con la comprensibile immediatezza. La mia
idea e speranza è che questo filo, che cerco di allacciare, resti segreto il più
a lungo possibile, fuori da pericolose polemiche. Ciò vuol dire che la risposta,
o una prima risposta, quando verrà, non dovrebbe passare per i giornali, ma per
una lettera o comunicazione a Lei pervenuta dal Ministro. Si concorderà poi come
inoltrarla. Presupposto di tutto è che non vi sia sorveglianza alcuna presso la
Sua portineria già dalla prima volta. Il Ministro verbalmente, dovrebbe
impegnarsi a bloccare ogni sorveglianza nel corso dell'operazione. E' chiaro che
un incidente farebbe crollare tutto con danno incalcolabile. Grazie tante e i
più affettuosi saluti. Suo Aldo Moro.
3) A
Francesco Cossiga (recapitata il 29 marzo). Caro Francesco, mentre t'indirizzo
un caro saluto, sono indotto dalle difficili circostanze a svolgere dinanzi a
te, avendo presenti le tue responsabilità (che io ovviamente rispetto) alcune
lucide e realistiche considerazioni. Prescindo volutamente da ogni aspetto
emotivo e mi attengo ai fatti. Benché non sappia nulla né del modo né di quanto
accaduto dopo il mio prelevamento, è fuori discussione - mi è stato detto con
tutta chiarezza - che sono considerato un prigioniero politico, sottoposto, come
Presidente della D.C., ad un processo diretto ad accertare le mie trentennali
responsabilità (processo contenuto in termini politici, ma che diventa sempre
più stringente). In tali circostanze ti scrivo in modo molto riservato, perché
tu e gli amici con alla testa il Presidente del Consiglio (informato ovviamente
il Presidente della Repubblica) possiate riflettere opportunamente sul da farsi,
per evitare guai peggiori. Pensare quindi fino in fondo, prima che si crei una
situazione emotiva e irrazionale. Devo pensare che il grave addebito che mi
viene fatto, si rivolge a me in quanto esponente qualificato della DC nel suo
insieme nella gestione della sua linea politica. In verità siamo tutti noi del
gruppo dirigente che siamo chiamati in causa ed è il nostro operato collettivo
che è sotto accusa e di cui devo rispondere. Nella circostanza sopra descritta
entra in gioco, al di là di ogni considerazione umanitaria che pure non si può
ignorare, la ragione di Stato. Soprattutto questa ragione di Stato nel caso mio
significa, riprendendo lo spunto accennato innanzi sulla mia attuale condizione,
che io mi trovo sotto un dominio pieno ed incontrollato, sottoposto ad un
processo popolare che può essere opportunamente graduato, che sono in questo
stato avendo tutte le conoscenze e sensibilità che derivano dalla lunga
esperienza, con il rischio di essere chiamato o indotto a parlare in maniera che
potrebbe essere sgradevole e pericolosa in determinate situazioni. Inoltre la
dottrina per la quale il rapimento non deve recare vantaggi, discutibile già nei
casi comuni, dove il danno del rapito è estremamente probabile, non regge in
circostanze politiche, dove si provocano danni sicuri e incalcolabili non solo
alla persona, ma allo Stato. Il sacrificio degli innocenti in nome di un
astratto principio di legalità, mentre un indiscutibile stato di necessità
dovrebbe indurre a salvarli, è inammissibile. Tutti gli Stati del mondo si sono
regolati in modo positivo, salvo Israele e la Germania, ma non per il caso
Lorenz. E non si dica che lo Stato perde la faccia, perché non ha saputo o
potuto impedire il rapimento di un'alta personalità che significa qualcosa nella
vita dello Stato. Ritornando un momento indietro sul comportamento degli Stati,
ricorderò gli scambi tra Breznev e Pinochet, i molteplici scambi di spie,
l'espulsione dei dissidenti dal territorio sovietico. Capisco che un fatto di
questo genere, quando si delinea, pesi, ma si deve anche guardare lucidamente al
peggio che può venire. Queste sono le alterne vicende di una guerriglia, che
bisogna valutare con freddezza, bloccando l'emotività e riflettendo sui fatti
politici. Penso che un preventivo passo della S. Sede (o anche di altri? di
chi?) potrebbe essere utile. Converrà che tenga d'intesa con il Presidente del
Consiglio riservatissimi contatti con pochi qualificati capi politici,
convincendo gli eventuali riluttanti. Un atteggiamento di ostilità sarebbe una
astrattezza ed un errore. Che Iddio vi illumini per il meglio, evitando che
siate impantanati in un doloroso episodio, dal quale potrebbero dipendere molte
cose. I più affettuosi saluti. Aldo Moro.
4) A
Eleonora Moro (non recapitata). 27-3-78. Mia Carissima Noretta, vorrei dirti
tante cose, ma mi fermerò alle essenziali. Io sono qui in discreta salute,
beneficiando di un'assistenza umana ed anche molto premurosa. Il cibo è
abbondante e sano (mangio ora un po' più di farinacei); non mancano mucchietti
di appropriate medicine. Puoi comprendere come mi manchiate tutti e come passi
ore ed ore ad immaginarvi, a ritrovarvi, ad accarezzarvi. Spero che anche voi mi
ricordiate, ma senza farne un dramma. E' la prima volta dopo trentatré anni che
passiamo Pasqua disuniti e giorni dopo il trentatreesimo di matrimonio sarà
senza incontro tra noi. Ricordo la chiesetta di Montemarciano ed il semplice
ricevimento con gli amici contadini. Ma quando si rompe così il ritmo delle
cose, esse, nella loro semplicità, risplendono come oro nel mondo. Per quanto mi
riguarda, non ho previsioni né progetti, ma fido in Dio che, in vicende sempre
tanto difficili, non mi ha mai abbandonato. Intuisco che altri siano nel dolore.
Intuisco, ma non voglio spingermi oltre sulla via della disperazione.
Riconoscenza e affetto sono per tutti coloro che mi hanno amato e mi amano, al
di là di ogni mio merito, che al più consiste nella mia capacità di riamare. Non
so in che forma possa avvenire ma ricordami alla Nonna. Cosa capirà della mia
assenza? Cose tenerissime a tutti i figli, a Fida col marito, ad Anna col marito
ed il piccolino in seno, ad Agnese, a Giovanni, ad Emma. Ad Agnese vorrei
chiedere di farti compagnia la sera, stando al mio posto nel letto e
controllando sempre che il gas sia spento. A Giovanni, che carezzo tanto, vorrei
chiedessi dolcemente che provi a fare un esame per amor mio. Ogni tenerezza al
piccolo di cui vorrei raccogliessi le voci e qualche foto. Per l 'Università
prega Saverio Fortuna di portare il mio saluto affettuoso agli studenti ed il
mio rammarico di non poter andare oltre nel corso. Ricordami tanto a fratelli e
cognati ed a tutti gli amati collaboratori. A Rana in particolare vorrei
chiedere di mantenere qualche contatto col Collegio e di ricordarmi a tutti. Mi
dispiace di non poter dire di tutti, ma li ho tutti nel cuore. Se puoi, nella
mia rubrichetta verde, c'è il numero di M.L. Familiari, mia allieva. Ti prego di
telefonarle di sera per un saluto a lei e agli amici Mimmo, Matteo, Manfredi e
Giovanna, che mi accompagnano a Messa. Ed ora alcune cose pratiche. Ho lasciato
lo stipendio al solito posto. C'è da ritirare una camicia in lavanderia. Data la
gravidanza ed il misero stipendio del marito, aiuta un po' Anna. Puoi prelevare
per questa necessità da qualche assegno firmato e non riscosso che Rana potrà
aiutarti a realizzare. Spero che, mancando io, Anna ti porti i fiori di
giunchiglie per il giorno delle nozze. Sempre tramite Rana, bisognerebbe cercare
di raccogliere 5 borse che erano in macchina. Niente di politico, ma tutte le
attività correnti, rimaste a giacere nel corso della crisi. C'erano anche vari
indumenti da viaggio. Ora credo di averti stancato e ti chiedo scusa. Non so se
e come riuscirò a sapere di voi. Il meglio è che per risponderne brevemente usi
giornali. Spero che l'ottimo Giacovazzo si sia inteso con Giunchi. Ricordatemi
nella vostra preghiera così come io faccio. Vi abbraccio tutti con tanto tanto
affetto ed i migliori auguri. Vostro Aldo. P.S. Accelera la vendita
dell'appartamentino di nonna, per provvedere alle necessità della sua malattia.
5) A
Benigno Zaccagnini (recapitata il 4 aprile). Caro Zaccagnini, scrivo a te,
intendendo rivolgermi a Piccoli, Bartolomei, Galloni, Gaspari, Fanfani,
Andreotti e Cossiga ai quali tutti vorrai leggere la lettera e con i quali tutti
vorrai assumere le responsabilità, che sono ad un tempo individuali e
collettive. Parlo innanzitutto della D.C. alla quale si rivolgono accuse che
riguardano tutti, ma che io sono chiamato a pagare con conseguenze che non è
difficile immaginare. Certo nelle decisioni sono in gioco altri partiti; ma un
così tremendo problema di coscienza riguarda innanzitutto la D.C., la quale deve
muoversi, qualunque cosa dicano, o dicano nell'immediato, gli altri. Parlo
innanzitutto del Partito Comunista, il quale, pur nella opportunità di affermare
esigenze di fermezza, non può dimenticare che il mio drammatico prelevamento è
avvenuto mentre si andava alla Camera per la consacrazione del Governo che m'ero
tanto adoperato a costituire. E' peraltro doveroso che, nel delineare la
disgraziata situazione, io ricordi la mia estrema, reiterata e motivata
riluttanza ad assumere la carica di Presidente che tu mi offrivi e che ora mi
strappa alla famiglia, mentre essa ha il più grande bisogno di me. Moralmente
sei tu ad essere al mio posto, dove materialmente sono io. Ed infine è doveroso
aggiungere, in questo momento supremo, che se la scorta non fosse stata, per
ragioni amministrative, del tutto al disotto delle esigenze della situazione, io
forse non sarei qui. Questo è tutto il passato. Il presente è che io sono
sottoposto ad un difficile processo politico del quale sono prevedibili sviluppi
e conseguenze. Sono un prigioniero politico che la vostra brusca decisione di
chiudere un qualsiasi discorso relativo ad altre persone parimenti detenute,
pone in una situazione insostenibile. Il tempo corre veloce e non ce n'è
purtroppo abbastanza. Ogni momento potrebbe essere troppo tardi.
Di questa lettera esiste
anche un’altra versione, mai recapitata, che fu rinvenuta nel covo di via
Montenevoso nel 1990.
Il testo di questa versione
(in minuta) differisce da quello recapitato solo in alcuni passaggi che verranno
modificati e resi più sfumati, meno duri. Si discute qui, non in astratto
diritto (benché vi siano le norme sullo stato di necessità), ma sul piano
dell'opportunità umana e politica, se non sia possibile dare con realismo alla
mia questione l'unica soluzione positiva possibile, prospettando la liberazione
di prigionieri di ambo le parti, attenuando la tensione nel contesto proprio di
un fenomeno politico. Tener duro può apparire più appropriato, ma una qualche
concessione è non solo equa, ma anche politicamente utile. Come ho ricordato in
questo modo civile si comportano moltissimi Stati. Se altri non ha il coraggio
di farlo, lo faccia la D.C. che, nella sua sensibilità ha il pregio di
indovinare come muoversi nelle situazioni più difficili. Se così non sarà,
l'avrete voluto e, lo dico senza animosità, le inevitabili conseguenze
ricadranno sul partito e sulle persone. Poi comincerà un altro ciclo più
terribile e parimenti senza sbocco. Tengo a precisare di dire queste cose in
piena lucidità senza avere subìto alcuna coercizione della persona; tanta
lucidità almeno, quanta può averne chi è da quindici giorni in una situazione
eccezionale, che non può avere nessuno che lo consoli, che sa che cosa lo
aspetti. Ed in verità mi sento anche un po' abbandonato da voi. Del resto queste
idee già espressi a Taviani per il caso Sossi ed a Gui a proposito di una
contestata legge contro i rapimenti. Fatto il mio dovere d'informare e
richiamare, mi raccolgo con Iddio, i miei cari e me stesso. Se non avessi una
famiglia così bisognosa di me, sarebbe un po' diverso. Ma così ci vuole davvero
coraggio per pagare per tutta la D.C. avendo dato sempre con generosità. Che
Iddio v'illumini e lo faccia presto, com'è necessario. Affettuosi saluti. Aldo
Moro.
6) A
Eleonora Moro (recapitata, forse, il 6 aprile). Carissima Noretta, se gli uomini
saranno ancora una volta buoni con me, dovrebbero pervenirti questo saluto caro
e le connesse indicazioni, le quali sono date per mia relativa tranquillità. Una
risposta, se possibile, coprirebbe meglio l'inevitabile solitudine (almeno due
righe dì messaggio per giornale). Ma se questo non è possibile, io mi consolo
immaginando, ricordando, ripercorrendo gli itinerari, che ora si scoprono
splendidi, della nostra vita, spesso tanto difficile, di ogni giorno. Vi
abbraccio tutti e vi benedico. E voi pure fatelo per me, senza però turbarvi. La
giovinezza ha il dono della fermezza e di un po’ di alternativa. Lo poso gli
occhi dove tu sai e vorrei che non dovesse mai finire. Naturalmente nulla alla
stampa o a chiunque di quel che scrivo. Un grande abbraccio per tutti. Aldo.
7) A
Eleonora Moro (recapitata il 6 aprile). Sono intatto e in perfetta lucidità. Non
è giusto dire che non so (no) più capace. Urge Mia Carissima Noretta, questi
fogli che ti accludo sono tutti, a loro modo, importanti e li dovrai leggere
perciò con la dovuta attenzione. Ma è questo quello più urgente ed importante,
perché riguarda la mia condizione che va facendosi sempre più precaria e
difficile per l'irrigidimento totale delle forze politiche ad un qualche inizio
di discorso su scambi di prigionieri politici, tra i quali sono anch'io. Non so
se tu hai visto bene i miei due messaggi (altrimenti li puoi chiedere subito a
Guerzoni). E' da quelli che bisogna partire, per mettere in moto un movimento
umanitario, oggi nelle Camere assolutamente assente malgrado le loro tradizioni.
Solo Saragat ed un po' i socialisti hanno avuto qualche debole cenno a motivi
umanitari. Degli altri nessuno ed in ispecie la D.C. cui avevo scritto nella
persona di Zaccagnini e di altri esponenti: ricordando tra l'altro a Zaccagnini
che egli mi volle (per i suoi comodi) a questo odiato incarico, sottraendomi
alle cure del piccolo che presentivo di non dovere abbandonare. Son giunto a
dirgli che egli moralmente avrebbe dovuto essere al mio posto. La risposta è
stata il nulla. Ora si tratta di vedere che cosa ancora con la tua energia, in
pubblico ed in privato, puoi fare, perché se questo blocco non comincia a
sgretolarsi un poco, ne va della mia vita. E cioè di voi tutti, carissimi, e
dell'amato piccolo. Sarebbe per me una tragedia morire, abbandonandolo. Si può
fare qualche cosa presso: Partiti (specie D.C., la più debole e cattiva), i
movimenti femminili e giovanili, i movimenti culturali e religiosi. Bisogna
vedere varie persone, specie Leone, Zaccagnini, Galloni,
Piccoli, Bartolomei, Fanfani, Andreotti (vorrà poco impegnarsi) e Cossiga. Si
può dire ad Ancora di lavorare con Berlinguer: i comunisti sono stati durissimi,
essendo essi in ballo la prima volta come partito di governo. Il Vaticano va
ancora sollecitato anche per le diverse correnti interne, si deve chiedere che
insista sul governo italiano. Tempi di Pio XII che contendeva ai Tedeschi il
giovane Prof. Vassalli, condannato a morte. Si dovrà ritentare. E poi vedi tu
nelle direzioni possibili con il meglio di te. E' un estremo tentativo. Tieni
presente che nella maggior parte degli stati, quando vi sono ostaggi, si cede
alla necessità e si adottano criteri umanitari. Questi prigionieri scambiati
vanno all'estero e quindi si realizza una certa distensione. Che giova tenerli
qui se non per un'astratta ragione di giustizia, con seguiti penosi per tutti e
senza che la sicurezza dello Stato sia migliorata? Ma vedi tu se puoi
coinvolgere rapidamente. La mia pena è Luca. Lo amo e lo temo senza di me. Sarà
il dolore più grande. Forse non si deve essere, neppur poco felici. Ti abbraccio
forte. Aldo.
8) A
Francesco Cossiga (non recapitata). Caro Cossiga, torno su un argomento già noto
e che voi avete implicitamente ed esplicitamente respinto. Eppure esso
politicamente esiste e sarebbe grave errore ritenere che, essendo esso pesante e
difficile, si possa fare come se non esistesse. Io ti dico di rifletterci
seriamente, non di rispondermi, anche se la laconicità e impersonalità della
precedente reazione mi ha, te lo dico francamente, un po' ferito. Fatto sta che
esiste un problema, postosi in molti e civili paesi, di pagare un prezzo per la
vita e la libertà di alcune persone estranee, prelevate come mezzo di scambio.
Nella grande maggioranza dei casi la risposta è stata positiva ed è stata
approvata dall'opinione pubblica. Il grado di pericolosità della situazione non
si è d'altra parte accresciuto, trattandosi di persone provate da lunga
detenzione, meritevoli di un qualche riconoscimento sul piano umano (io comincio
a capire che cos'è la detenzione) ed infine neutralizzati dal fatto di essere
dislocati in territorio straniero che, se si ha buona volontà, data la nostra
amicizia con tanti Paesi (es. Algeria) non dovrebbe essere difficile reperire.
Certo, è in questione un principio: ma anche i principi devono fare i conti con
la realtà. Ricordo, se non ricordo male, un caso francese particolarmente
significativo. Nella mia più sincera valutazione, ed a prescindere dal mio caso
anche se doloroso, sono convinto che oggi esiste un interesse politico
obiettivo, non di una sola parte, per praticare questa strada. Se gli stranieri
vi consigliano in altro modo, magari in buona fede, sbagliano. E le conseguenze
ne sarebbero evidenti. Se mai potessi parlarti, ti spiegherei meglio e ti
persuaderei. Vi chiedo di avere fiducia, come in altri casi, nella mia
valutazione e nel mio consiglio. Forse che non ho indovinato, con mesi di
anticipo, che con i comunisti si andava verso la crisi e che bisognava
prepararvisi per febbraio-marzo? E così è stato. Potrei immodestamente
continuare gli esempi, ma mi sembra assurdo farlo, specie in questo momento di
declino. A me interessa risolvere per il meglio il problema concreto.
Consentimi di aggiungere che
le iniziative concitate degli ultimi giorni hanno avuto l'inevitabile effetto di
eccitare lo sdegno e la reazione delle persone che mi custodiscono, senza
conseguire, d'altra parte, alcun apprezzabile risultato. Insomma nuova tensione
nel paese, nuove difficoltà, nuovi rischi. Vorrei pregarti che, almeno su quel
che ti ho scritto, vi fosse, a differenza delle altre volte, riservatezza.
Perché fare pubblicità su tutto? Potresti farti recapitare questa mia in luogo
più riservato e rifletterci su, senza riunioni plenarie. Finché non siano
mature. Grazie dell'attenzione. Cordiali saluti. Aldo Moro.
9) A
Eleonora Moro (recapitata l'8 aprile dopo essere stata intercettata dalla
Polizia la sera stessa). Qualche concetto più toccante della lettera potresti
dare in dichiarazione Segreto RAI TV (Guerzoni). Mia carissima Noretta, anche se
il contenuto della tua lettera al Giorno non recasse motivi di speranza (né io
pensavo che li avrebbe recati), essa mi ha fatto un bene immenso, dandomi
conferma nel mio dolore di un amore che resta fermo in tutti voi e mi accompagna
e mi accompagnerà per il mio Calvario. A tutti dunque il ringraziamento più
vivo, il bacio più sentito, l'amore più grande. Mi dispiace, mia carissima, di
essermi trovato a darti questa aggiunta d'impegno e di sofferenza. Ma credo che
anche tu, benché sfiduciata, non mi avresti perdonato di non averti chiesto una
cosa che è forse un inutile atto di amore, ma è un atto di amore. Ed ora, pur in
questi limiti, dovrei darti qualche indicazione per quanto riguarda il tuo
tenero compito. E' bene avere l'assistenza discreta di Rana e Guerzoni. Mi pare
che siano rimasti taciti i gruppi parlamentari, ed in essi i migliori amici,
forse intimiditi dal timore di rompere un fronte di autorità e di rigore. Ed
invece bisogna avere il coraggio di rompere questa unanimità fittizia, come
tante volte è accaduto. Quello che è stupefacente è che in pochi minuti il
Governo abbia creduto di valutare il significato e le implicazioni di un fatto
di tanto rilievo ed abbia elaborato in gran fretta e con superficialità una
linea dura che non ha più scalfito: si trattava in fondo di uno scambio di
prigionieri come si pratica in tutte le guerre (e questa in fondo lo è) con la
esclusione dei prigionieri liberati dal territorio nazionale. Applicare le norme
del diritto comune non ha senso. E poi questo rigore proprio in un Paese
scombinato come l'Italia. La faccia è salva, ma domani gli onesti piangeranno
per il crimine compiuto e soprattutto i democristiani. Ora mi pare che manchi
specie la voce dei miei amici. Converrebbe chiamare Cervone, Rosati, Dell'Andro
e gli altri che Rana conosce ed incitarli ad una dissociazione, ad una rottura
dell'unità. E' l'unica cosa che i nostri capi temono. Del resto non si curano di
niente. La dissociazione dovrebbe essere pacata e ferma insieme. Essi non si
rendono conto quanti guai verranno dopo e che questo è il meglio, il minor male
almeno. Tutto questo andrebbe fatto presto, perché i tempi stringono. Degli
incontri che riuscirai ad avere, se riuscirai, sarà bene dare notizia con
qualche dichiarazione. Occorre del pubblico oltre che del privato. Su questo
fatti guidare da Guerzoni. Nel risvolto del "Giorno" ho visto con dolore ripreso
dal solito Zizola un riferimento dell'Osservatore Romano (Levi). In sostanza: no
al ricatto. Con ciò la S. Sede, espressa da questo Sig. Levi, e modificando
precedenti posizioni, smentisce tutta la sua tradizione umanitaria e condanna
oggi me, domani donne e bambini a cadere vittime per non consentire il ricatto.
E' una cosa orribile, indegna della S. Sede. L'espulsione dallo Stato è
praticata in tanti casi, anche nell'Unione Sovietica, e non si vede perché qui
dovrebbe essere sostituita dalle stragi di Stato. Non so se Poletti può
rettificare questa enormità in contraddizione con altri modi di comportarsi
della S. Sede. Con queste tesi si avvalla il peggior rigore comunista ed a
servizio dell'unicità del comunismo. E' incredibile a quale punto sia giunta la
confusione delle lingue. Naturalmente non posso non sottolineare la cattiveria
di tutti i democristiani che mi hanno voluto nolente ad una carica, che, se
necessaria al Partito, doveva essermi salvata accettando anche lo scambio dei
prigionieri. Sono convinto che sarebbe stata la cosa più saggia. Resta, pur in
questo momento supremo, la mia profonda amarezza personale. Non si è trovato
nessuno che si dissociasse? Bisognerebbe dire a Giovanni che significa attività
politica. Nessuno si è pentito di avermi spinto a questo passo che io
chiaramente non volevo? E Zaccagnini? Come può rimanere tranquillo al suo posto?
E Cossiga che non ha saputo immaginare nessuna difesa? Il mio sangue ricadrà su
di loro. Ma non è di questo che voglio parlare; ma di voi che amo e amerò
sempre, della gratitudine che vi debbo, della gioia indicibile che mi avete dato
nella vita, del piccolo che amavo guardare e cercherò di guardare fino
all'ultimo. Avessi almeno le vostre mani, le vostre foto, i vostri baci. I
democratici cristiani (e Levi dell'Osservatore) mi tolgono anche questo. Che
male può venire da tutto questo male? Ti abbraccio, ti stringo, carissima
Noretta e tu fai lo stesso con tutti e con il medesimo animo. Davvero Anna si è
fatta vedere? Che Iddio la benedica. Vi abbraccio. Aldo.
10) A
Don Virgilio Levi (non recapitata). Signor Vice Direttore dell'Osservatore
Romano, prima di rispondere a chicchessia, ed in ispecie a persona della Sua
autorità, sarebbe doveroso informarsi, andare fin nei dettagli, pesare ogni
cosa. Ma come può adempiere ad un così elementare dovere una persona che sia
nella mia difficile condizione, la quale, pur sentendo e capendo pochissimo
nelle circostanze in cui si trova, ha però il dovere di non abbandonarsi, di
reagire, di rettificare, di chiarire? Mi è parso di cogliere in questi giorni, a
quanto mi è stato riferito, una certa diversità di accenti nell'Osservatore
Romano su un tema così complesso, con un indurimento finale però che sarebbe
stato registrato con compiacimenti da quelli che potremmo chiamare i fautori
della linea dura, quelli, in una parola, che accettano il sacrificio di vite
innocenti, purché si sfugga, come si dice, ad ogni ricatto. Con riserva di avere
almeno approssimativamente capito, vorrei rispondere con alcune pacate
osservazioni. E' certo naturale che la Chiesa si preoccupi della stabilità
dell'ordine sociale e dell'ordine giuridico in ispecie. Essa è infatti in
qualche modo partecipe della sorte dell'umanità e quindi del retto funzionamento
degli istituti che la società si è dati, per raggiungere le proprie finalità. Ma
il fatto è che vi sono circostanze eccezionali, nelle quali il raggiungimento
degli obiettivi normali risulta altamente costoso e va in particolare a
detrimento di altri beni e valori, che, di per sé, meritano di essere tutelati.
Sapendo con certezza che, per giungere ad un certo risultato, devono essere
compiuti sacrifici gravi o gravissimi e travolte cose che hanno un pregio in sé,
sapendo che per raggiungere un fine di giustizia vite innocenti devono essere
sacrificate, io credo che sia doveroso fermarsi un momento a valutare e
comparare. Credo che questa attenzione, questa trepidazione, questa delicatezza
siano doverose per tutti, quale che sia la loro fede, per semplici doveri di
umanità. E non si spiega così il fatto che Stati di diversa cultura, di fronte
al fenomeno crescente del terrorismo, il più delle volte si siano fermati
attoniti e poi abbiano deciso non in favore della regola astratta, ma della
ragione di vita concreta? Così avviene il più delle volte in questo mondo così
civile e così incivile insieme, ma dove degli strappi sono ritenuti necessari
per evitare guai peggiori. Io non posso certo dire nulla in un caso che mi
riguarda, ma sono purtroppo sicuro che il prevalere di una regola di durezza,
accada quel che accada, malgrado l'ottimismo di tanti, porterebbe nel nostro
Paese, già così provato, giorni di estrema durezza e carichi d'incognite.
Perché, come ho detto più volte, si tratta qui di un fenomeno politico nel quale
occorre andare più a fondo e, per farlo, forse ci dev'essere il momento per
farlo. Si tratterebbe del resto di un evento da negoziare e misurare, con
opportune garanzie, tali da assicurare la convivenza proprio mentre si rompe per
un istante il cerchio infernale dell'azione e della reazione. Considerazioni di
questo tipo, a prescindere dalle mie condizioni ben pesanti e dalle gravi
preoccupazioni per la famiglia, mi son permesso di sottoporle, sapendo che la
Chiesa non sarà mai ultima a capire le ragioni dell'umanità. Chi lo pensa, non
conosce la Chiesa. Con fiducia e deferenza. Aldo Moro.
11) A
Papa Paolo VI (non recapitata). Beatissimo Padre, nella difficilissima
situazione nella quale mi trovo e memore della paterna benevolenza che la
Santità Vostra mi ha tante volte dimostrato, e tra l'altro quando io ero giovane
dirigente della Fuci, ardisco rivolgermi alla Santità Vostra, nella speranza che
voglia favorire nel modo più opportuno almeno l'avvio di quel processo di
scambio di prigionieri politici, dal quale potrebbero derivare, in questo
momento estremamente minaccioso, riflessi positivi per me e la mia disgraziata
famiglia che per ragioni oggettive è in cima alle mie angosciate preoccupazioni.
Immagino le ansie del Governo. Ma debbo dire che siffatta pratica umanitaria è
in uso presso moltissimi governi, i quali danno priorità alla salvezza delle
vite umane e trovano accorgimenti di allontanamento dal territorio nazionale per
i prigionieri politici dell'altra parte, soddisfacendo così esigenze di
sicurezza. D'altra parte, trattandosi di atti di guerriglia, non si vede quale
altra forma di efficace distensione ci sia in una situazione che altrimenti
promette giorni terribili. Avendo intravisto qui nella mia prigione un severo
articolo dell'Osservatore, me ne sono preoccupato fortemente. Perché quale altra
voce, che non sia quella della Chiesa, può rompere le cristallizzazioni che si
sono formate e quale umanesimo più alto vi è di quello cristiano? Perciò le mie
preghiere, le mie speranze, quelle della mia disgraziata famiglia che la Santità
vostra volle benevolmente ricevere alcuni anni fa, s'indirizzano alla Santità
vostra, l'unica che possa piegare il Governo italiano ad un atto di saggezza. Mi
auguro si ripeta il gesto efficace di S.S. Pio XII in favore del giovane Prof.
Vassalli, che era nella mia stessa condizione. Voglia gradire, Beatissimo Padre,
con il più vivo ringraziamento per quanti beneficeranno della clemenza, i più
devoti ossequi. Aldo Moro.
12) A
Eleonora Moro (non recapitata). Mia dolcissima Noretta, bacioni al pupo. Temo
che tu abbia troppo da affaticarti nell'improba impresa. Credo che la chiave sia
in Vaticano, che deve essere stato però duramente condizionato dal Governo. Ho
pensato perciò di preparare una mia lettera personale al Papa, che ti accludo,
lasciando a te di stabilire se sia o meno il caso d'inoltrarla e tramite chi.
Salvo abbia scelto Poletti, ti ricordo Pignedoli che dovrebbe avere qualche buon
ricordo e Maria Righetti. Soprattutto bisognerebbe evitare che, sotto pressione
del Governo, continuino posizioni dure del giornale. Forse potresti fare una
telefonata al vecchio Manzini (Raimondo), sempre così buono. Per il resto c'è da
dare la caccia a questi parlamentari amici. Hanno avuto il torto di far passare
attoniti i primi giorni, lasciando cristallizzare la situazione. Anche di Tullio
non so nulla, né so se abbia fatto qualcosa. Benché una lettera stampata non è
tutto quello che si possa desiderare, tu non puoi immaginare quale manna dal
cielo sia per me. La leggo e la rileggo: ci penso su. E' tutta la mia vita. E
così voi siete la mia vita. Vi benedico tutti in un unico grande abbraccio.
Pensatemi come io vi penso ed amatemi come vi amo. Tuo Aldo. Mi veniva un'altra
idea. Pompei è vicinissimo al Papa e gli può spiegare tutto. Si potrebbe
chiamarlo tramite Maria Righetti, spiegandogli che dovrebbe fare (poiché
dovrebbe operare da privato contro gli intendimenti del governo). Ma dovrebbe
arrivare ad horas. Da Parigi ci sono partenze a tutte le ore.
13) Su
Paolo Taviani (recapitata tra il 9 e il 10 aprile, allegata al comunicato n° 5).
Filtra fin qui la notizia di una smentita opposta dall'On. Taviani alla mia
affermazione, del resto incidentale, contenuta nel mio secondo messaggio e cioè
che delle mie idee in materia di scambio di prigionieri (nelle circostanze delle
quali ora si tratta) e di modo di disciplinare i rapimenti avrei fatto parola,
rispettivamente, all'On. Taviani ed all'On. Gui (oggi entrambi Senatori). L'On.
Gui ha correttamente confermato; l'On. Taviani ha smentito, senza evidentemente
provare disagio nel contestare la parola di un collega lontano, in condizioni
difficili e con scarse e saltuarie comunicazioni. Perché poi la smentita? Non
c'è che una spiegazione, per eccesso di zelo cioè, per il rischio di non essere
in questa circostanza in prima fila nel difendere lo Stato. Intanto quello che
ho detto è vero e posso precisare allo smemorato Taviani (smemorato non solo per
questo) che io gliene ho parlato nel corso di una direzione abbastanza agitata
tenuta nella sua sede dell'Eur proprio nei giorni nei quali avvenivano i fatti
dai quali ho tratto spunto per il mio occasionale riferimento. E non ho
aggiunto, perché mi sarebbe parso estremamente indiscreto riferire l'opinione
dell'interlocutore (non l'ho fatto nemmeno per l'On. Gui), qual era l'opinione
in proposito che veniva opposta in confronto di quella che, secondo il mio
costume, facevo pacatamente valere. Ma perché l'On. Taviani, pronto a smentire
il fatto obiettivo della mia opinione, non si allarmi nel timore che io voglia
presentarlo come se avesse il mio stesso pensiero, mi affretterò a dire che
Taviani la pensava diversamente da me, come tanti anche oggi la pensano
diversamente da me ed allo stesso modo di Taviani. Essi, Taviani in testa, sono
convinti che sia questo il solo modo per difendere l'autorità ed il potere dello
Stato in momenti come questi. Fanno riferimento ad esempi stranieri? O hanno
avuto suggerimenti? Ed io invece ho detto sin d'allora riservatamente al
Ministro ed ho ora ripetuto ed ampliato una valutazione per la quale in fatti
come questi, che sono di autentica guerriglia (almeno cioè guerriglia), non ci
si può comportare come ci si comporta con la delinquenza comune, per la quale
del resto all'unanimità il Parlamento ha introdotto correttivi che riteneva
indifferibili per ragioni di umanità. Nel caso che ora ci occupa si trattava
d'immaginare, con opportune garanzie, di porre il tema di uno scambio di
prigionieri politici (terminologia ostica, ma corrispondente alla realtà) con
l'effetto di salvare altre vite umane innocenti, di dare umanamente un respiro a
dei combattenti, anche se sono al di là della barricata, di realizzare un minimo
di sosta, di evitare che la tensione si accresca e lo Stato perda credito e
forza, se è sempre impegnato in un duello processuale defatigante, pesante per
chi lo subisce, ma anche non utile alla funzionalità dello Stato. C'è insomma un
complesso di ragioni politiche da apprezzare ed alle quali dar seguito, senza
fare all'istante un blocco impermeabile, nel quale non entrino nemmeno in parte
quelle ragioni di umanità e di saggezza, che popoli civilissimi del mondo hanno
sentito in circostanze dolorosamente analoghe e che li hanno indotti a quel
tanto di ragionevole flessibilità, cui l'Italia si rifiuta, dimenticando di non
essere certo lo Stato più ferreo del mondo, attrezzato, materialmente e
psicologicamente, a guidare la fila di Paesi come Usa, Israele, Germania (non
quella però di Lorenz), ben altrimenti preparati a rifiutare un momento di
riflessione e di umanità. L'inopinata uscita del Sen. Taviani, ancora in questo
momento per me incomprensibile e comunque da me giudicata, nelle condizioni in
cui mi trovo, irrispettosa e provocatoria, m'induce a valutare un momento questo
personaggio di più che trentennale appartenenza alla D.C. Nei miei rilievi non
c'è niente di personale, ma sono sospinto dallo stato di necessità. Quel che
rilevo, espressione di un malcostume democristiano che dovrebbe essere corretto
tutto nell'avviato rinnovamento del partito, e la rigorosa catalogazione di
corrente. Di questa Appartenenza Taviani è stato una vivente dimostrazione con
virate così brusche ed immotivate da lasciare stupefatti. Di matrice
cattolico-democratica Taviani è andato in giro per tutte le correnti, portandovi
la sua indubbia efficienza, una grande larghezza di mezzi ed una certa
spregiudicatezza. Uscito io dalle file dorotee dopo il '68, avevo avuto chiaro
sentore che Taviani mi aspettasse a quel passo, per dar vita ad una formazione
più robusta ed equilibrata, la quale, pur su posizioni diverse, potesse essere
utile al migliore assetto della D.C. Attesi invano un appuntamento che mi era
stato dato e poi altri ancora, finché constatai che l'assetto ricercato e
conseguito era stato diverso ed opposto. Erano i tempi in cui Taviani parlava di
un appoggio tutto a destra, di un'intesa con il Movimento Sociale come formula
risolutiva della crisi italiana. E noi che, da anni, lo ascoltavamo proporre
altre cose, lo guardavamo stupiti, anche perché il partito della D.C. da tempo
aveva bloccato anche le più modeste forme d'intesa con quel partito. Ma, mosso
poi da realismo politico, l'On. Taviani si convinse che la salvezza non poteva
venire che da uno spostamento verso il partito comunista. Ma al tempo in cui
avvenne l'ultima elezione del Presidente della Repubblica, il terrore del valore
contaminante dei voti comunisti sulla mia persona (estranea, come sempre, alle
contese) indusse lui e qualche altro personaggio del mio Partito ad una sorta di
quotidiana lotta all'uomo, fastidiosa per l'aspetto personale che pareva avere,
tale da far sospettare eventuali interferenze di ambienti americani,
perfettamente inutile, perché non vi era nessun accanito aspirante alla
successione in colui che si voleva combattere.
Nella sua lunga carriera
politica che poi ha abbandonato di colpo senza una plausibile spiegazione, salvo
che non sia per riservarsi a più alte responsabilità, Taviani ha ricoperto, dopo
anche un breve periodo di Segretario del Partito, senza pero successo, i più
diversi ed importanti incarichi ministeriali. Tra essi vanno segnalati per la
loro importanza il Ministero della Difesa e quello dell'Interno, tenuti entrambi
a lungo con tutti i complessi meccanismi, centri di potere e diramazioni segrete
che essi comportano. A questo proposito si può ricordare che l'Amm. Henke,
divenuto Capo del Sid e poi Capo di Stato Maggiore della Difesa, era un suo uomo
che aveva a lungo collaborato con lui. L'importanza e la delicatezza dei
molteplici uffici ricoperti può spiegare il peso che egli ha avuto nel partito e
nella politica italiana, fino a quando è sembrato uscire di scena. In entrambi i
delicati posti ricoperti ha avuto contatti diretti e fiduciari con il mondo
americano. Vi è forse, nel tener duro contro di me, un'indicazione americana e
tedesca? Aldo Moro.
14) A
Maria Fida Moro e Demetrio Bonini (non recapitata). Miei carissimi Fida e Demi,
credo di essere alla conclusione del mio calvario e desidero abbracciarvi forte
forte con tutto l'amore che, come sapete, vi porto. Forse in qualche momento
sarò stato nervoso o non del tutto capace di comprensione. Ma l'amore dentro è
stato grande in ogni momento con un desiderio profondo della vostra felicità
sempre in una vita retta, quale voi conducete. Con Luca, dicevo, mi avete dato
la gioia più grande che io potessi desiderare. Questa è per me la punta più
acuta di questa dolorosissima vicenda. Non vedere il piccolo e non potergli dare
tutto l'amore, tutto l'aiuto, tutto il servizio che avevo progettato. So poi i
problemi di Fida che tutti dobbiamo aiutare. Ho già detto a quanti lo amano che
gli siano vicini, che facciano la mia parte, che prendano il mio posto. Anche
tu, Demi carissimo, tienilo pieno d'amore come egli merita; tienilo tra le
braccia come vorrei tenerlo e come sarei felice di fare, lasciando ogni altra
cosa. Vivete uniti con la nonna, con gli zii, con gli amici. Per ogni cosa
consigliatevi con il carissimo Rana. Ricordatevi di me che ricordo e prego. Che
Iddio vi aiuti a passare questo brutto momento e dia a voi ed al piccolo tutta
la felicità. Che Iddio vi benedica come io vi benedico e vi abbraccio dal
profondo del cuore. Papà per Fida e Demi. P.S. Se il piccolo, come spero, deve
andare al mare, la nonna inviti la Signora Riccioni* con due
bambinetti. Ho paura che stia solo. Mi raccomando.
* Si
tratta della moglie di Otello Riccioni, l’appuntato dei carabinieri assegnato
alla scorta di Moro, che la mattina del 16
marzo 1978 non era in servizio.
15) A
Agnese Moro (non recapitata). Mia carissima Agnese, so che tu sei tanto forte e
brava. Perciò ti posso parlare con coraggio, mentre vedo ogni momento più cadere
le speranze. Ti ho voluto e ti voglio tanto bene, dolcissima Agnesina, che ho
concorso a tirar su, con il suo chilo e ottocento grammi, dosando goccia goccia
con il cucchiaino il latte che non potevi succhiare. Sì qualche volta ti sarai
un po' irritata con me; ma sai bene che l'amore è stato continuo ed infinito,
che ti ho atteso ogni sera pieno di angoscia finché non ti vedevo, che ti ho
seguito nel tuo studio, nel tuo lavoro (nel quale occorre perseverare), nelle
tante cose intelligenti e vive che andavi creando. Ed ho cercato di seguirti e
secondarti in ogni tuo desiderio. Ora è probabile che noi siamo lontani o vicini
in un altro modo. Ebbene, credimi che ti sono vicino più che mai, che ti stringo
forte a me, che desidero per te pace e felicità. E' inutile che ti raccomandi la
famiglia, la mamma, il carissimo Luca. Dagli tu l'amore e l'appoggio che io non
gli potrò dare, ritraine tu la gioia dolcissima degli occhietti vispi e della
profonda bontà. Questa è ora la mia pena più acuta, la mia angoscia mortale.
Finché sarà necessario sostituiscimi. Gioisco nel ricordarti piccola, sulla
gamba del cuore con il dott. Tani del tuo libriccino di bimba. Ti amo tanto,
Agnesina carissima e ti ringrazio del tuo sorriso sempre così largo e della tua
dolce carezza alla sera. Una tua carissima lettera da Helsinki per me è a
Bellamonte, nell'armadio della stanza matrimoniale in alto o forse nel taschino
del mio pullover nero. Non la perdere: mi è cara. Ti abbraccio forte forte e ti
benedico con tanti auguri e tanta speranza. Papà.
16) A
Anna Moro e Mario Giordano (non recapitata). Miei carissimi Anna e Mario, credo
di essere ad un momento conclusivo e desidero abbracciarvi forte forte con tutto
l'amore che meritate. C'è stato certo qualche momento di difficoltà dovuto ad un
momento particolarmente impegnativo. Spero che sia davvero cancellato tutto e
che siate uniti e in salute, come mamma mi scrive tramite il giornale. Tu sai,
Anna mia, quanto bene ti ho voluto da sempre, come ho goduto della tua
confidenza e fiducia, come sono riuscito a vincere alcune tue amarezze. Poi è
venuto Mario ed io sono stato felice che un'altra persona cara abbia preso a
svolgere la funzione che era stata mia. E ne sono felice tuttora. Non per questo
però ti ho voluto e ti voglio meno bene. Sei sempre la mia piccolina della gamba
destra, mentre Agnese era per parte sua quella della gamba del cuore. Tempi
felici. Niente ha potuto annullare la grandezza dell'amore. A qualsiasi età i
figli sono i nostri piccoli. E tu sei la mia piccola. Come vorrei vedere nascere
il tuo bimbo. Che venga su bello, buono, vispo, felice. Mi parrà di averlo
conosciuto. Non so darvi nessun consiglio. Vogliatevi bene sempre e siate uniti
alle vostre due famiglie. Tutte ne hanno diritto: una, la nostra, un particolare
bisogno. Siate buoni e puliti come siete stati sempre. Iddio vi aiuterà. Quello
che Egli vi toglie, vi darà in altro modo. Certo tutto questo pesa. Ma sia fatta
la volontà del Signore. Carissimi, vi abbraccio forte dal profondo del cuore e
vi benedico. Ricordatemi ai vostri cari. Papà per Anna e Mario.
17) A
Luca Bonini (non recapitata). Mio carissimo Luca, non so chi e quando ti
leggerà, spiegando qualche cosa, la lettera che ti manda quello che tu chiamavi
il tuo nonnetto. L'immagine sarà certo impallidita, allora. Il nonno del casco,
il nonno degli scacchi, il nonno dei pompieri della Spagna, del vestito di
torero, dei tamburelli. E' il nonno, forse ricordi, che ti portava in braccio
come il S.S. Sacramento, che ti faceva fare la pipì all'ora giusta, che tentava
di metterti a posto le coperte e poi ti addormentava con un lungo sorriso, sul
quale piaceva ritornare. Il nonno che ti metteva la vestaglietta la mattina, ti
dava la pizza, ti faceva mangiare sulle ginocchia. Ora il nonno è un po'
lontano, ma non tanto che non ti stringa idealmente al cuore e ti consideri la
cosa più preziosa che la vita gli abbia donato e poi, miseramente, tolta. Luca
dolcissimo, insieme col nonno che ora è un po' fuori, ci sono tanti che ti
vogliono bene. E tu vivi e dormi con tutto questo amore che ti circonda.
Continua ad essere dolce, buono, ordinato, memore, come sei stato. Fai compagnia
oltre che a Papà e Mamma, alla tua cara Nonna che ha più che mai bisogno di te.
E quando sarà la stagione, una bella trottata coi piedini nudi sulla spiaggia e
uno strattone per il tuo gommoncino. La sera, con le tue preghiere, non manchi
la richiesta a Gesù di benedire tanti ed in ispecie il Nonno che ne ha
particolare bisogno. E che Iddio pure ti benedica, il tuo dolcissimo volto, i
tuoi biondi capelli che accarezzo da lontano, con tanto amore. Ti abbraccia
tanto nonno. Aldo.
18) A
Giovanni Moro (non recapitata). Mio carissimo Giovanni, tu sei il più piccolo e
insieme, in un certo senso, il capo della famiglia. Ti devo trattare da uomo,
anche se non riesco a distaccarmi dalla tua immagine di piccolino, tanto amato e
tanto accarezzato. Lo so c'è stato poi il momento in cui hai rivendicato la tua
autonomia ed hai forse avuto un po' fastidio di un padre un tantino opprimente
(s'intende per amore). Ma è stato poi bello, quando, passata quell'età critica,
sei stato tu stesso che sei tornato a carezzarmi di quando in quando. Ed io la
tua carezza non l'ho dimenticata, né, in quest'ora triste, la dimentico. Così
sei restato il mio piccolino, che avrei voluto accompagnare un po' più a lungo
nella vita. Che anno terribile. Che anno incomprensibile. Povero libro del buon
Mancini che avrei dovuto leggere e che avevo con me in macchina da qualche
parte. Che ne sarà stato? E' meglio non
pensare. Voglio solo dire, senza contrastare la tua vocazione, che vi sono in
politica fattori irrazionali che creano situazioni difficilissime. E' meglio
essere prudenti e difendersi dall'incomprensione. Sarei più tranquillo per
te e per Emma (che ricordo tanto e che ti farà buona compagnia), se non ti
avviassi su questa strada. Io volentieri tornerei indietro, come consigliava la
mamma, ma sono stato preso dal laccio di questa infausta presidenza del
Consiglio nazionale. Sia fatta la volontà di Dio. Tu studia, prega, opera per il
bene, aiuta la famiglia ed il piccolo Luca che mi fa finire nell'angoscia. Fai
un po' meno fuori, un po' più per questo bambino carissimo che mi strazia il
cuore. Sii prudente, saggio, misurato in tutto. Consigliati con Don Mancini che
mi saluterai tanto. Quanto la sua previsione, fatta di amore, non ha avuto
riscontro nella realtà. Ti abbraccio forte forte con Emma, piccolo mio e ti
benedico dal profondo del cuore. Il tuo papà.
19) A
Corrado Guerzoni (non recapitata). Carissimo Guerzoni, nel dirLe addio, La
ringrazio del bene che mi ha voluto e che ha fatto per me. In questa vicenda
tutto per me è incomprensibile. Un diverso comportamento sarebbe stato un atto
di prudenza e di saggezza che nulla avrebbe pregiudicato. Non mi tocca nulla di
quel che attiene al potere; moltissimo quello che riguarda la mia disgraziata
famiglia, per la quale anche Lei avrà un occhio di comprensione. Mi ricordi ai
suoi collaboratori e si abbia un abbraccio cordiale di chi le ha voluto molto
bene. Aldo Moro. (La lettera prosegue con un capoverso
non pubblicato.).
20) a
Maria Luisa Familiari. (Lettera il cui contenuto non è
stato reso noto per volontà della famiglia Moro).
21) A
Nicola Rana (non recapitata). Dott. Nicola Rana Via Giovagnoli 27 Roma.
Carissimo Rana, lei sa quanto Le devo da ogni punto di vista.E' stato
confidente, consolatore ed amico. Non capisco a fondo perché questo avviene e le
ragioni degli uomini che sono stati amici. Accetto dal Signore quanto egli mi
manda. Mi resta l'acutissima preoccupazione della famiglia che resta priva di
guida e l'ansia per il piccolo amatissimo, di cui Lei conosce le vicissitudini.
Io non cesso di pensarci e di guardarlo, come faccio del resto per le persone
care in queste ore infinitamente tristi. E' inutile che Le dica che nella mia
tragedia, mi resta la speranza che Ella con saggezza ed amore continui ad
occuparsi di noi, tra l'altro consigliando persone estremamente inesperte e
fragili. Farò la stessa raccomandazione a Freato. Due, amati e amici, sono
ancora poco in una disgrazia come questa. Controlli anche molto bene le
eventuali proposte di alienazione di qualche cosa mobile. Un abbraccio forte con
infinita gratitudine. Aldo Moro. Un abbraccio a Melpignano, a Ticconi, a tutti.
Sono state recuperate delle borse in macchina? O sono sequestrate come corpo di
reato? Si può sbloccare?
22) A
Sereno Freato (non recapitata). Carissimo Freato, la mia allucinante vicenda mi
ha dato l'impressione di essere rimasto senza amici. So che non è così, anche se
alcuni (o tanti) che potevano, non si sono adoperati. Mi pare così assurdo non
si sia accettato uno scambio che non pregiudicava niente, dovendo gli scambiati
lasciare l'Italia. Ma non voglio fare lamentele ed accetto da Dio il mio
destino. Ma il problema non è mio, ma di una famiglia di cui Lei, così buono ed
affettuoso per tanti anni, conosce tutte le complessità. Non posso quindi che
ritornare a Lei, pur sapendo che Ella è preso da cose più grandi di queste, per
pregarla, insieme con Rana, di guidare, consigliare, aiutare questa famiglia. Ho
mille preoccupazioni, ma in cima c'è la non buona salute di mia moglie e la
sorte dell'amatissimo Luca con le difficoltà che Ella conosce. Mi affido a Dio
ed agli uomini cari come Lei. Chi l'avrebbe detto? E vi era chi progettava,
mentre io non progettavo. Dio sa che cosa darei solo per aiutare i miei e basta.
Quanto costa lo spettacolo di una apparente grandezza. Aiuti dunque i miei, caro
Freato, con la sua immensa bontà. E stia certo di aver fatto la scelta migliore,
che io, purtroppo, non ho fatto. La benedico, insieme ai suoi e l'abbraccio con
tutto il cuore. Suo Aldo Moro. Dott. Sereno Freato Via S. Valentino 21.
23) Messaggio
(non recapitata). Prego la cortesia della stampa di voler telefonare questo
messaggio a casa mia (3379308). Famiglia Moro. Stringendomi con tanto affetto a
voi vi prego darmi cortese tramite stampa urgenti notizie famiglia et familiari,
dettagliando se ricevute mie notizie. Rassicuratemi incidente ferroviario
Bologna. Abbraccio forte. Non tardate. Aldo.
24) A
Eleonora Moro (non recapitata). Genesi 44-29 segg."e se mi togliete anche
questo, e se gli avviene qualche disgrazia, voi farete scendere la mia canizie
con dolore nel soggiorno dei morti. Or dunque, quando giungerò da mio padre, tuo
servitore, se il fanciullo, all'anima del quale è legata, non è con noi, avverrà
che, come avrà veduto che il fanciullo non c'è, egli morrà e i tuoi servitori
avranno fatto scendere con cordoglio la canizie del tuo servitore nostro padre
nel soggiorno dei morti. ...Perché come farei a risalire da mio padre senz'aver
meco il fanciullo? Ah, ch'io non vegga il dolore che ne verrebbe a mio padre".
Così Luca lontano fa scendere la mia canizie con dolore nel soggiorno dei morti.
Mia dolcissima Noretta, ti mando alcune lettere da distribuire che vorrei
proprio arrivassero come mi è stato promesso. Aggiungo due testamenti che ho già
mandato, ma che temo possono non essere arrivati. Uno è il mio lascito ad Anna
della mia quota di condominio al terzo piano. L'altro è un lascito a Luca, il
mio archivio che, come esecutori testamentari il Sen. Spadolini ed il Dott.
Guerzoni dovrebbero opportunamente alienare ad Istituto o Biblioteca,
preferibilmente italiani, per costituire una piccola rendita per il piccolo, al
quale va la mia infinita tenerezza. Carissima, vorrei avere la fede che avete tu
e la nonna, per immaginare i cori degli angeli che mi conducono dalla terra al
cielo. Ma io sono molto più rozzo. Ho solo capito in questi giorni che vuol dire
che bisogna aggiungere la propria sofferenza alla sofferenza di Gesù Cristo per
la salvezza del mondo. Il Papa forse questa mia sofferenza non l'ha capita. E
sembra, d'altro canto, impossibile che di tanti amici non una voce si sia
levata. Pacatamente direi a Cossiga che sono stato ucciso tre volte, per
insufficiente protezione, per rifiuto della trattativa, per la politica
inconcludente, ma che in questi giorni ha eccitato l'animo di coloro che mi
detengono. Salvi dovrebbe ripensare all'inutilità di questo lavoro e del mio
sacrificio. Ma ormai è fatta. Mi è stato promesso che restituiranno il corpo ed
alcuni ricordi. Speriamo che si possa. E voi siate forti e pregate per me che ne
ho tanto bisogno. Tutto è così strano. Ma Iddio mi dia la forza di arrivare fino
in fondo e mi faccia rivedere poi i tanto dolci visi che ho tanto amato ed ai
quali darei qualunque cosa per essere ancora vicino. Ma non ho, purtroppo, tutto
quello che dovrei dare. Così fosse possibile. Dopo si vedrà l'assurdità di tutto
questo. Ed ora dolcissima sposa, ti abbraccio forte con tutto il cuore e stringo
con te i nostri figli e i nipoti amatissimi, sperando di restare con voi così
per sempre. Un tenerissimo bacio. Aldo.
25) A
Eleonora Moro. Mia dolcissima Noretta, credo di essere giunto all'estremo delle
mie possibilità e di essere sul punto, salvo un miracolo, di chiudere questa mia
esperienza umana. Gli ultimi tentativi, per i quali mi ero ripromesso di
scriverti, sono falliti. Il rincrudimento della repressione, del tutto inutile,
ha appesantito la situazione. Non sembra ci sia via di uscita. Mi resta
misterioso, perché è stata scelta questa strada rovinosa, che condanna me e
priva di un punto di riferimento e di equilibrio. Già ora si vede che vuol dire
non avere persona capace di riflettere. Questo dico, senza polemica, come
semplice riflessione storica. Ora vorrei abbracciarti tanto e dirti tutta la
dolcezza che provo, pur mescolata a cose amarissime, per avere avuto il dono di
una vita con te, così ricca di amore e di intesa profonda. Dio sa quanto avrei
sperato di accompagnarvi ancora un poco, di dare custodia ed aiuto
all'amatissimo Luca, di aiutare tutti a superare le prove del duro cammino. Ho
tentato tutto ed ora sia fatta la volontà di Dio, credo di tornare a voi in
un'altra forma. Non mi so immaginare onorato da chi mi ha condannato. Ma fa tu,
con spirito cristiano e senso di opportunità. Vi ho affidato a Freato e Rana per
ogni necessità ed ho fiducia che Iddio vi aiuti. Tu curati e cerca di essere più
tranquilla che puoi. Ci rivedremo. Ci ritroveremo. Ci riameremo. Ho scritto a
tutti per Luca, perché siano impegnati per lui. A te debbo dire grazie, infinite
grazie, per tutto l'amore che mi hai dato. Amore un po' geloso che mi faceva
innervosire, quando ti vedevo sprofondata in un libro. Ma amore autentico che
resterà. Io pregherò per te e tu per me. Che Iddio aiuti la cara famiglia. In
estate, al mare, fatti fare compagnia dalla famiglia di Riccioni per te e per il
piccolo. Ho lasciato il mio archivio a Luca da vendere tramite il Sen. Spadolini
e il Dott. Guerzoni per costituire un piccolo peculio che lo aiuti a mantenersi
nella vita. Ho dimenticato di dire, ma tu dillo a Guerzoni che per le foto i
familiari e gli esecutori testamentari scelgano quelle che vale la pena di
conservare alla famiglia. Nel magnetofono più grande, che è nel mio studio, ci
sono già raccolte vocette di Luca trasferite da quello tascabile. Si può mano a
mano trasferire e completare. Le bobine sono in camera nostra; film e foto sulla
scrivania dello studio. Vorrei, come piccolo ricordo, che il biro della mia
vestaglia da giorno andasse a Luca che lo amava (e il portacenere a Giovanni),
un altro pennarello marrone nel comò a Giovanni, un biro uguale al primo sulla
chiffonière ad Agnese, mentre Fida e Anna e tu potreste scegliere in quel mobile
quel che volete. Sentite Manzari, vedi di fare testamento. Io ne ho mandati due
che spero siano arrivati e rinvierò in copia. Non mancare di fare e far fare la
vaccinazione antinfluenzale, se viene la russa. Fatti seguire da Giovanni anche
come amico. Tramite Rana fa controllare la stabilità del tetto sulla nostra
stanza e cura che il gas sia chiuso la sera. (Agnese). Per la tomba di Torrita
almeno nell'immediato c'è il rischio di sicurezza. Forse converrebbe allogare
altrove, [...] stesso o nella chiesa con speciale permesso. Forse, per ora:
consigliati con Freato. Chissà quante cose ho dimenticato. State più uniti che
potete e tenete unite anche le mie cose con voi, perché sono vostro. Ho pregato
molto La Pira. Spero che mi aiuti in altro modo. Ringrazio tutti, tutti i
parenti ed amici con grande affetto. Che Iddio ci aiuti. Ricordati che sei stata
la cosa più importante della mia vita. Ricordatemi discretamente a Luca con
qualche foto e qualche descrizione, che non si senta del tutto senza nonno. E
poi che sia felice e non faccia i miei errori generosi ed ingenui. Ti abbraccio
forte forte e ti benedico dal profondo del cuore. A nonna un bacio, nella forma
che troverai. Aldo.
26) A
Papa Paolo VI (recapitata tramite Don Mennini alla S.ra Moro che a lui la
riaffida per recapitarla in Vaticano.) Alla stampa, da parte di Aldo Moro, con
preghiera di cortese urgente trasmissione all'augusto Destinatario e molte
grazie. A S.S. Paolo VI. Città del Vaticano. In quest'ora tanto difficile mi
permetto di rivolgermi con vivo rispetto e profonda speranza alla Santità
vostra, affinché con altissima autorità morale e cristiano spirito umanitario
voglia intercedere presso le competenti autorità governative italiane per
un'equa soluzione del problema dello scambio dei prigionieri politici e la mia
restituzione alla famiglia, per le cui necessità assai gravi sono indispensabili
la mia presenza ed assistenza. Solo la Santità Vostra può porre di fronte alle
esigenze dello Stato, comprensibili nel loro ordine le ragioni morali e il
diritto alla vita. Con profonda gratitudine, speranza e devoto ossequio. Dev.mo
Aldo Moro.
27) A
Benigno Zaccagnini (non recapitata). Prego la cortesia della stampa di
trasmettere all'illustre destinatario in Piazza del Gesù, curandone il personale
recapito. Molti ringraziamenti. Caro Zaccagnini, in quest'ora tanto drammatica
mi rivolgo con fiducia e viva preghiera a te ed agli amici, affinché con spirito
cristiano ed autentica saggezza politica vogliate favorire, anche decisamente
influenzando altre forze politiche, un'equa trattativa umanitaria, che abbia ad
oggetto, con garanzie di sicurezza, scambio di prigionieri politici et consenta
mia restituzione alla famiglia, che, per ragioni a te note, ha assoluto bisogno
di me. Ricordando le grandi pressioni da te esercitate perché accettassi questo
ufficio ed infine la mia disciplinata e rassegnata adesione alla tua richiesta,
sento che con gli amici hai il dovere di aiutarmi in questo frangente.
Altrimenti non potrai perdonare te stesso. Con fiducia, profonda gratitudine e
viva cordialità. Aldo Moro.
28) A
Benigno Zaccagnini (Recapitata tramite Don Mennini il 20 aprile). Caro
Zaccagnini, mi rivolgo a te ed intendo con ciò rivolgermi nel modo più formale
e, in certo modo, solenne all'intera Democrazia cristiana, alla quale mi
permetto di indirizzarmi ancora nella mia qualità di Presidente del Partito. E'
un'ora drammatica. Vi sono certamente problemi per il Paese che io non voglio
disconoscere, ma che possono trovare una soluzione equilibrata anche in termini
di sicurezza, rispettando però quella ispirazione umanitaria, cristiana e
democratica, alla quale si sono dimostrati sensibili Stati civilissimi in
circostanze analoghe, di fronte al problema della salvaguardia della vita umana
innocente. Ed infatti, di fronte a quelli del Paese, ci sono i problemi che
riguardano la mia persona e la mia famiglia. Di questi problemi, terribili ed
angosciosi, non credo vi possiate liberare, anche di fronte alla storia, con la
facilità, con l'indifferenza, con il cinismo che avete manifestato sinora nel
corso di questi quaranta giorni di mie terribili sofferenze. Con profonda
amarezza e stupore ho visto in pochi minuti, senza nessuna valutazione umana e
politica, assumere un atteggiamento di rigida chiusura. L'ho visto assumere dai
dirigenti, senza che risulti dove e come un tema tremendo come questo sia stato
discusso. Voci di dissenso, inevitabili in un partito democratico come il
nostro, non sono artificiosamente emerse. La mia stessa disgraziata famiglia è
stata, in certo modo, soffocata, senza che potesse disperatamente gridare il suo
dolore ed il suo bisogno di me. Possibile che siate tutti d'accordo nel volere
la mia morte per una presunta ragion di Stato che qualcuno lividamente vi
suggerisce, quasi a soluzione di tutti i problemi del Paese? Altro che soluzione
dei problemi. Se questo crimine fosse perpetrato, si aprirebbe una spirale
terribile che voi non potreste fronteggiare. Ne sareste travolti. Si aprirebbe
una spaccatura con le forze umanitarie che ancora esistono in questo Paese, si
aprirebbe, insanabile, malgrado le prime apparenze, una frattura nel partito che
non potreste dominare. Penso ai tanti e tanti democristiani che si sono abituati
per anni ad identificare il partito con la mia persona. Penso ai miei amici
della base e dei gruppi parlamentari. Penso anche ai moltissimi amici personali
ai quali non potreste fare accettare questa tragedia. Possibile che tutti questi
rinuncino in quest'ora drammatica a far sentire la loro voce, a contare nel
partito come in altre circostanze di minor rilievo? Io lo dico chiaro: per parte
mia non assolverò e non giustificherò nessuno. Attendo tutto il partito ad una
prova di profonda serietà ed umanità e con esso forze di libertà e di spirito
umanitario che emergono con facilità e concordia in ogni dibattito parlamentare
su temi di questo genere. Non voglio indicare nessuno in particolare, ma
rivolgermi a tutti. Ma è soprattutto alla D.C. che si rivolge il Paese per le
sue responsabilità, per il modo come ha saputo contemperare sempre sapientemente
ragioni di Stato e ragioni umane e morali. Se fallisse ora, sarebbe per la prima
volta. Essa sarebbe travolta dal vortice e sarebbe la sua fine. Che non avvenga,
ve ne scongiuro, il fatto terribile di una decisione di morte presa su direttiva
di qualche dirigente ossessionato da problemi di sicurezza, come se non vi fosse
l'esilio a soddisfarli, senza che ciascuno abbia valutato tutto fino in fondo,
abbia interrogato veramente e fatto veramente parlare la sua coscienza.
Qualsiasi apertura, qualsiasi posizione problematica, qualsiasi segno di
consapevolezza immediata della grandezza del problema, con le ore che corrono
veloci, sarebbero estremamente importanti. Dite subito che non accettate di dare
una risposta immediata e semplice, una risposta di morte. Dissipate subito
l'impressione di un partito unito per una decisione di morte. Ricordate, e lo
ricordino tutte le forze politiche, che la Costituzione Repubblicana, come primo
segno di novità, ha annullato la pena di morte. Così, cari amici, si verrebbe a
reintrodurre, non facendo nulla per impedirla, facendo con la propria inerzia,
insensibilità e rispetto cieco della ragion di Stato che essa sia di nuovo, di
fatto, nel nostro ordinamento. Ecco nell'Italia democratica del 1978,
nell'Italia del Beccaria, come nei secoli passati, io sono condannato a morte.
Che la condanna sia eseguita, dipende da voi. A voi chiedo almeno che la grazia
mi sia concessa; mi sia concesso almeno, come tu Zaccagnini sai, per essenziali
ragioni di essere curata, assistita, guidata che ha la mia famiglia. La mia
angoscia in questo momento sarebbe di lasciarla sola - e non può essere sola –
per l'incapacità del mio partito ad assumere le sue responsabilità, a fare un
atto di coraggio e responsabilità insieme. Mi rivolgo individualmente a ciascuno
degli amici che sono al vertice del partito e con i quali si è lavorato insieme
per anni nell'interesse della D.C. Pensa ai sessanta giorni cruciali di crisi,
vissuti insieme con Piccoli, Bartolomei, Galloni, Gaspari sotto la tua guida e
con il continuo consiglio di Andreotti. Dio sa come mi sono dato da fare per
venirne fuori bene. Non ho pensato no, come del resto mai ho fatto, né alla mia
sicurezza né al mio riposo. Il Governo è in piedi e questa è la riconoscenza che
mi viene tributata per questa come per tante altre imprese. Un allontanamento
dai familiari senza addio, la fine solitaria, senza la consolazione di una
carezza, del prigioniero politico condannato a morte. Se voi non intervenite,
sarebbe scritta una pagina agghiacciante nella storia d'Italia. Il mio sangue
ricadrebbe su di voi, sul partito, sul Paese. Pensateci bene cari amici. Siate
indipendenti. Non guardate al domani, ma al dopo domani. Pensaci soprattutto tu,
Zaccagnini, massimo responsabile. Ricorda in questo momento - dev'essere un
motivo pungente di riflessione per te - la tua straordinaria insistenza e quella
degli amici che avevi a tal fine incaricato - la tua insistenza per avermi
Presidente del Consiglio Nazionale, per avermi partecipe e corresponsabile nella
fase nuova che si apriva e che si profilava difficilissima. Ricordi la mia
fortissima resistenza soprattutto per le ragioni di famiglia a tutti note. Poi
mi piegai, come sempre, alla volontà del Partito. Ed eccomi qui, sul punto di
morire, per averti detto di sì ed aver detto di sì alla D.C. Tu hai dunque una
responsabilità personalissima. Il tuo sì o il tuo no sono decisivi. Ma sai pure
che, se mi togli alla famiglia, l'hai voluto due volte. Questo peso non te lo
scrollerai di dosso più. Che Dio ti illumini, caro Zaccagnini, ed illumini gli
amici ai quali rivolgo un disperato messaggio. Non pensare ai pochi casi nei
quali si è andati avanti diritti, ma ai molti risolti secondo le regole
dell'umanità e perciò, pur nella difficoltà della situazione, in modo
costruttivo. Se la pietà prevale, il Paese non è finito. Grazie e cordialmente
tuo Aldo Moro.
29) A
Eleonora Moro (recapitata il 20 aprile). Carissima e amata, siamo al momento
decisivo estremamente rischioso. Vi sono vicino e vi amo con tutto il cuore.
Baci a tutti a Luca in particolare. Ora occorre trasmettere di urgenza queste
lettere, determinanti, per cui devi convocare le squadre di Giovanni e Agnese o
altri che creda idonei, al più presto. Tutto urge, urge. Due sono le più
importanti: lettera mia al Papa. Non so se già hai predisposto qualcosa. Occorre
inviare mani sicure e rapide es: Poletti, Pignedoli, se c'è Pompei (improbabile
è a Parigi), Bottai, che dovresti fare venire a casa, senza mai nulla dire al
telefono. Infine, ma potrebbe essere la soluzione più facile, chiamare Antonello
Mennini, Vice Parroco di S. Lucia che puoi fare venire a casa. Infine vedi tu.
Presto e bene per quel poco che può valere. Lettera a Zaccagnini. E' la più
importante. Occorre arrivi integra. Vedi di mandarla per il migliore tramite a
lui e avverti i giornalisti circostanti che la rendano pubblica. Mi raccomando.
Ti abbraccio tanto con tutti.
30) Al
segretario generale delle Nazioni Unite Kurt Waldheim. Signor Presidente,
desidero innanzitutto ringraziarla, nella drammatica situazione nella quale mi
trovo, per il fervido messaggio che ha voluto formulare per la salvezza della
mia vita. E' un segno, tanto autorevole quanto gradito, oltre che del suo ben
noto spirito umanitario, della benevolenza della quale mi fa oggetto da anni, da
quando cioè ebbi la ventura di trattare lungamente con lei dei problemi
dell'Alto Adige e di giungere poi alla felice conclusione di Copenaghen. In
tutto questo tempo ci siamo scambiati reciproca simpatia e stima. Bene, ora io
mi trovo nella condizione di prigioniero politico ed intorno a questa mia
posizione è aperta una vertenza tra il governo italiano e le BR intorno a
qualche scambio di prigionieri delle due parti. Il suo alto appello umanitario
non ha potuto così conseguire il risultato desiderato, poiché il governo oppone
la richiesta di un gesto gratuito ed unilaterale, mentre l'altra parte chiede
una contropartita da concordare. In verità sia in Italia sia all'estero non
mancano casi di scambi di prigionieri. La cosa, benché presenti qualche
difficoltà, non è di per sé né assurda né irrisolvibile. Vi sono ostacoli
politici ai quali il governo attribuisce caratteri di durezza. Gli ostacoli non
sono però insuperabili; la Sua presenza in Italia, la conoscenza del
contenzioso, la Sua abilità diplomatica, la Sua capacità mediatrice, dovrebbero
poter sbloccare la difficile situazione, salvare la mia vita, creare un'area di
distensione utile alla pace. Forse il suo sacrificio, con adeguata pressione su
una posizione irragionevole del governo italiano, potrebbe fare il miracolo che
attendo non per me, ma per la mia disgraziata famiglia. Purtroppo il correre del
tempo è inesorabile. Ed io sono obbligato a supplicare che l'emergenza sia
affrontata senza ritardo. La ringrazio, eccellenza, per quanto Ella potrà e
vorrà fare ed in nome anche dei miei le porgo gli ossequi più devoti. Aldo Moro.
31) A
Luigi Cottafavi. All'Ambasciatore Cottafavi. Carissimo Cottafavi, mi piacerebbe
parlare così distesamente come mi è accaduto di fare l'ultima volta purtroppo le
circostanze sono diverse. La mia disgraziata situazione mi induce a fare per suo
affettuoso tramite un fervido appello a Waldheim, il quale, pur restando nei
limiti umanitari che non sono sufficienti a sbloccare la situazione, ha usato un
tono più caldo, dando l'impressione di poter fare all'occorrenza qualche cosa di
più, forse in nome di vecchi rapporti di amicizia e di collaborazione. Da qui,
accompagnata da una lettera che Le accludo, la mia supplica a Lei, perché me lo
porti di urgenza in Italia. Bisognerebbe fare davvero uno strappo. E bisogna
aggiungere che non avrà un compito facile per le resistenze del governo che
vorrebbe risolvere in termini umanitari (e cioè non pagando niente) la
questione. E ciò dimenticando che in moltissimi altri paesi civili si hanno
scambi e compensazioni e che in Italia stessa per i casi dei Palestinesi ci
siamo comportati in tutt'altro modo. Aggiungo che, trattandosi di un fatto
politico, trattandosi di una mediazione, c'è un termine ragionevole di
trattativa e che soprattutto al Presidente dell'ONU non dovrebbe essere
rifiutata. E' insomma, caro Cottafavi, un estremo tentativo il cui successo è
largamente affidato, se Dio vorrà, a che si metta in moto presto e con le ali.
Se l'ONU salvasse una vita umana, strappandola a quest'Italia inetta, sarebbe
una bella cosa. Grazie l'abbraccio. Aldo Moro. Un incontro a Ginevra sotto
l'egida della Croce Rossa sarebbe possibile?
32) A
Franco Malfatti (il destinatario ha dichiarato di non aver ricevuto la lettera).
All'Ambasciatore Franco Malfatti segretario generale della Farnesina. Carissimo
Ambasciatore, nella disperata situazione in cui mi trovo, sono nella necessità
di rivolgermi a Lei, per trasmettere un appropriato messaggio al vecchio collega
ed amico Waldheim, presidente dell'ONU, messaggio che è richiesta di urgente
aiuto, ma, come Ella ben sa, non è di contenuto semplicemente umanitario. Nella
condizione in cui sono non riesco a contattare efficacemente Cottafavi. E allora
mi rivolgo a Lei con la fiducia di sempre, avendo come supremo obiettivo una
rapida visita di Waldheim in Italia. Anche sul piano psicologico, non sarebbe
cosa da poco. Ovviamente ogni collaborazione dell'ambasciatore Vinci non potrà
che essere estremamente utile. Grazie e con l'affetto di sempre, mi creda suo.
Aldo Moro. Amb. Franco Malfatti. Segretario generale della Farnesina. Un
incontro a Ginevra sotto l'egida della Croce Rossa sarebbe possibile?
33) A
Giuseppe Manzari (il destinatario ha dichiarato di non aver mai ricevuto la
lettera). Carissimo Peppino, ti sarei grato t'informassi buona fonte circa la
ragione per la quale si è bloccata la richiesta di Young di portare il nostro
caso al Consiglio di Sicurezza e se c'è ancora una possibilità in tal senso e
che cosa si può fare con la dovuta urgenza. La risposta tienila per te, che ti
sarà comandata al momento opportuno. Grazie e affettuosamente tuo Aldo Moro. Ad
un cenno si dovrebbe essere in condizioni di chiamare qui l'Amb. Cottafavi.
Nulla per ora. Poi si vedrà. Avv. Giuseppe Manzari, presidente Sezione Consiglio
di Stato, Capo del Contenzioso diplomatico.
34) A
Flaminio Piccoli (non recapitata). Caro Piccoli, mi rivolgo a te con la fiducia
e l'affetto che sai. Sei tu ora, punto di riferimento. E vedo il segno della tua
presenza nel fatto che sia stato sin qui evitato il peggio, la chiusura
indiscriminata. Guardando agli aspetti umanitari, che sono essenziali e valgono
per tutti i Paesi, bisogna rapidamente approfondire questa breccia. Andare
avanti, cioè, nel concreto, senza illudersi che invocazioni umanitarie possano
avere il minimo effetto. Non dividete sul sangue la D.C., non illudetevi di
risolvere così i problemi del paese, date fiducia, ora che si manifesta intero,
all'umanitarismo socialista, anche se vi fosse la sfida della crisi, la cui
composizione del resto è stata così faticosamente accettata. La crisi, per
questo motivo che lascia allo scoperto i comunisti, non ci sarebbe o almeno
sarebbe risolvibile. Non lasciate allo scoperto i vecchi amici che hanno dato
fino all'ultimo. Sarebbe un fatto obbrobrioso e immorale. Sarebbe un eroismo su
basi fragilissime. Scusa queste considerazioni che, soprattutto per la famiglia
dovevo fare, ed abbiti i più cordiali saluti. Aldo Moro. On. Flaminio Piccoli,
Presidente del gruppo Parlamentare, Camera della D.C.
35) A
Benigno Zaccagnini (non recapitata). On. Benigno Zaccagnini. Aggiungi che la mia
protezione è stata assolutamente insufficiente e non è giusto farne ricadere la
responsabilità su di me. Caro Zac, se si proroga, come si deve, dev'essere per
fare davvero qualche cosa, non per perdere tempo. So che tutto è difficile ma
spero non ti sottrarrai a questa responsabilità (il contrario sarebbe disumano e
crudele) di far procedere il negoziato verso una conclusione ragionevole ma
positiva. Non puoi capire che cosa si prova in queste ore. Non cedere a nessuno,
non ammettere tatticismi. La responsabilità è tua, tutta tua. Se fossi nella tua
condizione non accetterei mai di dire di sì all'uccisione, di pagare con la vita
la prigionia che non si crede di poter interrompere. Ma stai bene attento alla
scala dei valori. Con [parola indecifrabile] Aldo Moro.
36) A
Giovanni Leone (recapitata il 29 aprile). Alla Stampa, da parte di Aldo Moro,
con preghiera di cortese urgente trasmissione al suo illustre Destinatario.
Molti ringraziamenti. All'On. Prof. Giovanni Leone. Presidente della Repubblica
Italiana. Faccio vivo appello, con profonda deferenza, al tuo alto senso di
umanità e di giustizia, affinché, d'accordo con il Governo, voglia rendere
possibile una equa e umanitaria trattativa per scambio di prigionieri politici,
la quale mi consenta di essere restituito alla famiglia, che ha grave e urgente
bisogno di me. Le tante forme di solidarietà sperimentate, t'indirizzino per la
strada giusta. Ti ringrazio profondamente e ti saluto con viva cordialità. Aldo
Moro.
37) A
Amintore Fanfani (recapitata il 29 aprile). Onorevole Presidente del Senato, in
questo momento estremamente difficile, ritengo mio diritto e dovere, come membro
del Parlamento italiano, di rivolgermi a Lei che ne è, insieme con il Presidente
della Camera, il supremo custode. Lo faccio nello spirito di tanti anni di
colleganza parlamentare, per scongiurarla di adoperarsi, nei modi più opportuni,
affinché sia avviata, con le adeguate garanzie, un'equa trattativa umanitaria,
che consenta di procedere ad uno scambio di prigionieri politici ed a me di
tornare in seno alla famiglia che ha grave ed urgente bisogno di me. Lo spirito
umanitario che anima il Parlamento ebbe già a manifestarsi in sede di
Costituente, alla quale anche in questo campo ebbi a dare il mio contributo, e
si è fatto visibile con l'abolizione della pena di morte ed in molteplici leggi
ed iniziative. D'altra parte non sfuggono alle Assemblee né i problemi di
sicurezza, che però possono essere adeguatamente risolti, né la complessità del
problema politico per il quale non sarebbero sufficienti scelte semplici e
riduttive. Al di là di questa problematica io affido a Lei, signor Presidente,
con fiducia ed affetto la mia persona, nella speranza che tanti anni di stima,
amicizia e collaborazione mi valgano un aiuto decisivo, che ricostituisca il
Plenum del Parlamento e che mi dia l'unica gioia che cerco, il ricongiungimento
con la mia amata famiglia. Con i più sinceri e vivi ringraziamenti, voglia
gradire i miei più deferenti saluti. Suo Aldo Moro. On. Prof. Amintore Fanfani,
Presidente del Senato della Repubblica.
38) A
Pietro Ingrao (recapitata il 29 aprile). Onorevole Presidente della Camera, in
questo momento estremamente difficile, ritengo mio diritto e dovere, come membro
del Parlamento italiano, di rivolgermi a Lei che ne è, insieme con il Presidente
del Senato, il supremo custode. Lo faccio nello spirito di tanti anni di
colleganza parlamentare, per scongiurarla di adoperarsi, nei modi più opportuni,
affinché sia avviata con le adeguate garanzie, un'equa trattativa umanitaria,
che consenta di procedere ad uno scambio di prigionieri politici ed a me di
tornare in seno alla famiglia che ha grave ed urgente bisogno di me. Lo spirito
umanitario che anima il Parlamento ebbe già a manifestarsi in sede di
Costituente, alla quale anche in questo campo ebbi a dare il mio contributo, e
si è fatto visibile con l'abolizione della pena di morte ed in molteplici leggi
ed iniziative. D'altra parte non sfuggono alle Assemblee né i problemi di
sicurezza, che possono però essere adeguatamente risolti, né la complessità del
problema politico per il quale non sarebbero sufficienti scelte semplici e
riduttive. Al di là di questa problematica io affido a Lei, Signor Presidente,
con fiducia ed affetto la mia persona, nella speranza che tanti anni di stima,
amicizia e collaborazione mi valgano un aiuto decisivo che ricostituisca il
Plenum del Parlamento e che mi dia l'unica gioia che cerco, il ricongiungimento
con la mia amata famiglia. Con i più sinceri e vivi ringraziamenti, voglia
gradire i miei più deferenti saluti. Suo Aldo Moro. On. Pietro Ingrao,
Presidente della Camera dei deputati.
39) A
Flaminio Piccoli (recapitata il 29 aprile). On. Flaminio Piccoli. Presidente
Gruppo D.C. occorrendo puoi parlare anche di me. Caro Piccoli, non ti dico tutte
le cose che vorrei per brevità e per l'intenso dialogo tra noi che dura da anni.
Ho fiducia nella tua saggezza e nel tuo realismo, unica antitesi ad un
predominio oggi, se non bilanciato, pericoloso. So che non ti farai complice di
un'operazione che, oltretutto, distruggerebbe la D.C. Non mi dilungo, perché so
che tu capisci queste cose. Aggiungo qualche osservazione per il dibattito
interno che spero abbia giuste proporzioni e sia da te responsabilmente guidato.
La prima osservazione da fare è che si tratta di una cosa che si ripete come si
ripetono nella vita gli stati di necessità. Se n'è parlato meno di ora, ma
abbastanza, perché si sappia come sono andate le cose. E tu, che sai tutto, ne
sei certo informato. Ma, per tua tranquillità e per diffondere in giro
tranquillità, senza fare ora almeno dichiarazioni ufficiali, puoi chiamarti
subito Pennacchini che sa tutto (nei dettagli più di me) ed è persona delicata e
precisa. Poi c'è Miceli e, se è in Italia (e sarebbe bene da ogni punto di vista
farlo venire) il Col. Giovannoni, che Cossiga stima. Dunque, non una, ma più
volte, furono liberati con meccanismi vari palestinesi detenuti ed anche
condannati, allo scopo di stornare gravi rappresaglie che sarebbero poi state
poste in essere, se fosse continuata la detenzione. La minaccia era seria,
credibile, anche se meno pienamente apprestata che nel caso nostro. Lo stato di
necessità è in entrambi evidente. Uguale il vantaggio dei liberati, ovviamente
trasferiti in Paesi Terzi. Ma su tutto questo fenomeno politico vorrei
intrattenermi con te, che sei l'unico cui si possa parlare a dovuto livello. Che
Iddio lo renda possibile. Naturalmente comprendo tutte le difficoltà. Ma qui
occorrono non sotterfugi, ma atti di coraggio. Dopo un po' l'opinione pubblica
capisce, pur che sia guidata. In realtà qui l'ostacolo è l'intransigenza del
partito comunista che sembra una garanzia. Credo sarebbe prudente guardare più a
fondo le cose, tenuto conto del più duttile atteggiamento socialista cui fino a
due mesi fa andavano le nostre simpatie. Forse i comunisti vogliono restare soli
a difendere l'autorità dello Stato o vogliono di più. Ma la D.C. non ci può
stare. Perché nel nostro impasto (chiamalo come vuoi) c'è una irriducibile
umanità e pietà: una scelta a favore della durezza comunista contro
l'umanitarismo socialista sarebbe contro natura. Importante è convincere
Andreotti che non sta seguendo la strada vincente. E' probabile che si
costituisca un blocco di oppositori intransigenti. Conviene trattare. Grazie e
affettuosamente Aldo Moro.
40) A
Riccardo Misasi (recapitata il 29 aprile). Carissimo Riccardo, un grande
abbraccio e due parole per dirti che mi attendo, con l'eloquenza ed il vigore
che ti sono propri, una tua efficace battaglia a difesa della vita, a difesa dei
diritti umani, contro una gretta ragion di Stato. Tu sai che gli argomenti del
rigore, in certe situazioni politiche, non servono a nulla. Si tratta di ben
altro che dovremmo sforzarci di capire. Se prendi di petto i legalisti, vincerai
ancora una volta. Non illudetevi di invocazioni umanitarie. Vorrei poi dirti
che, se dovesse passarsi, come ci si augura, ad una fase ulteriore, la tua
autorità ed esperienza di Presidente della Commissione Giustizia, dovrebbero
essere, oltre che per le cose in generale che interessano, preziose per alcuni
temi specifici che tu certo intuisci. Grazie e tanti affettuosi saluti. Aldo
Moro. On. Riccardo Misasi.
41) A
Renato Dell'Andro (recapitata il 29 aprile). Carissimo Renato. in questo momento
così difficile, pur immaginando che tu abbia fatto tutto quello che la coscienza
e l'affetto ti suggerivano, desidero aggiungere delle brevi considerazioni. Ne
ho fatto cenno a Piccoli e a Pennacchini ed ora lo rifaccio a te, che immagino
con gli amici direttamente e discretamente presenti nei dibattiti che si
susseguono. La prima riguarda quella che può sembrare una stranezza e non è e
cioè lo scambio dei prigionieri politici. Invece essa è avvenuta ripetutamente
all'estero, ma anche in Italia. Tu forse già conosci direttamente le vicende dei
palestinesi all'epoca più oscura della guerra. Lo scopo di stornare grave danno
minacciato alle persone, ove essa fosse perdurata. Nello spirito si fece ricorso
allo stato di necessità. Il caso è analogo al nostro, anche se la minaccia, in
quel caso, pur serissima, era meno definita. Non si può parlare di novità né di
anomalia. La situazione era quella che è oggi e conviene saperlo per non
stupirsi. Io non penso che si debba fare, per ora, una dichiarazione ufficiale,
ma solo parlarne di qua e di là, intensamente però. Ho scritto a Piccoli e a
Pennacchini che è buon testimone. A parte tutte le invenzioni che voi saprete
fare, è utile mostrare una riserva che conduca, in caso di esito negativo, al
coagularsi di voti contrari come furono minacciati da De Carolis e altri,
Andreotti che (con il PCI) guida la linea dura, deve sapere che corre gravi
rischi. Valorizzare poi l'umanitarismo socialista, più congeniale alla D.C. e
che ha sempre goduto, e specie in questa legislatura, maggiori simpatie. Forza,
Renato, crea, fai, impegnati con la consueta accortezza. Te ne sarò tanto grato.
Ti abbraccio. Aldo Moro. On. [parola illeggibile] Renato Dell'Andro S.p.M.
42) A
Tullio Ancora (recapitata il 29 aprile). Caro Tullio, un caro ricordo ed un
caloroso abbraccio. Senza perdersi in tante cose importanti, ma ovvie,
concentrati in questo. Ricevo come premio dai comunisti dopo la lunga marcia la
condanna a morte. Non commento. Quel che dico, e che tu dovresti sviluppare di
urgenza e con il garbo che non ti manca, è che si può ancora capire (ma male) un
atteggiamento duro del PCI, ma non si capirebbe certo che esso fosse legato al
quadro politico generale la cui definizione è stata così faticosamente raggiunta
e che ora dovrebbe essere ridisegnato. Dicano, se credono, che la loro è una
posizione dura e intransigente e poi la lascino lì come termine di riferimento.
E' tutto, ma è da fare e persuadere presto. Affettuosamente Aldo Moro. Dott.
Tullio Ancora. Via Livorno 44
Roma.
43) A
Giulio Andreotti (recapitata il 29 aprile). Caro Presidente, so bene che ormai
il problema, nelle sue massime componenti, è nelle tue mani e tu ne porti
altissima responsabilità. Non sto a descriverti la mia condizione e le mie
prospettive. Posso solo dirti la mia certezza che questa nuova fase politica, se
comincia con un bagno di sangue e specie in contraddizione con un chiaro
orientamento umanitario dei socialisti, non è apportatrice di bene né per il
Paese né per il Governo. La lacerazione ne resterà insanabile. Nessuna unità
nella sequela delle azioni e reazioni sarà più ricomponibile. Con ciò vorrei
invitarti a realizzare quel che si ha da fare nel poco tempo disponibile.
Contare su un logoramento psicologico, perché son certo che tu, nella tua
intelligenza, lo escludi, sarebbe un drammatico errore. Quando ho concorso alla
tua designazione e l'ho tenuta malgrado alcune opposizioni, speravo di darti un
aiuto sostanzioso, onesto e sincero. Quel che posso fare, nelle presenti
circostanze, è di beneaugurare al tuo sforzo e seguirlo con simpatia sulla base
di una decisione che esprima il tuo spirito umanitario, il tuo animo fraterno,
il tuo rispetto per la mia disgraziata famiglia. Quanto ai timori di crisi, a
parte la significativa posizione socialista cui non manca di guardare la D.C., è
difficile pensare che il PCI voglia disperdere quello che ha raccolto con tante
forzature. Che Iddio ti illumini e ti benedica e ti faccia tramite dell'unica
cosa che conti per me, non la carriera cioè, ma la famiglia. Grazie e
cordialmente tuo Aldo Moro. On. Giulio Andreotti. Presidente del Consiglio dei
Ministri.
44) A
Bettino Craxi (recapitata il 29 aprile). Caro Craxi, poiché ho colto, pur tra le
notizie frammentarie che mi pervengono, una forte sensibilità umanitaria del tuo
Partito in questa dolorosa vicenda, sono qui a scongiurarti di continuare ed
anzi accentuare la tua importante iniziativa. E' da mettere in chiaro che non si
tratta di inviti rivolti agli altri a compiere atti di umanità, inviti del tutto
inutili, ma di dar luogo con la dovuta urgenza ad una seria ed equilibrata
trattativa per lo scambio di prigionieri politici. Ho l'impressione che questo o
non si sia capito o si abbia l'aria di non capirlo. La realtà è però questa,
urgente, con un respiro minimo. Ogni ora che passa potrebbe renderla vana ed
allora io ti scongiuro di fare in ogni sede opportuna tutto il possibile
sull'unica direzione giusta che non è quella della declamazione. Anche la D.C.
sembra non capire. Ti sarei grato se glielo spiegassi anche tu con l'urgenza che
si richiede.
Credi, non c'è un minuto da
perdere. E io spero che o al San Rafael o al Partito questo mio scritto ti
trovi. Mi pare tutto un po' assurdo, ma quello che conta non è spiegare, ma, se
si può fare qualcosa, di farlo. Grazie infinite ed affettuosi saluti Aldo Moro.
On. Bettino Craxi. Segretario del Partito Socialista Italiano.
45) A
Erminio Pennacchini (recapitata il 29 aprile). Carissimo Pennacchini, ho avuto
sempre grande stima di te, per tutto, ma soprattutto per la cristallina onestà.
E' quindi naturale che in un momento drammatico mi rivolga a te per un aiuto
prezioso che consiste semplicemente nel dire la verità. Dirla, per ora, ben
chiara agli amici parlamentari ed a qualche portavoce qualificato dell'opinione
pubblica. Si vedrà poi se ufficializzarla. Si tratta della nota vicenda dei
palestinesi che ci angustiò per tanti anni e che tu, con il mio modesto
concorso, riuscisti a disinnescare. L'analogia, anzi l'eguaglianza con il mio
doloroso caso, sono evidenti. Semmai in quelle circostanze la minaccia alla vita
dei terzi estranei era meno evidente, meno avanzata. Ma il fatto c'era e ad esso
si è provveduto secondo le norme dello Stato di necessità, gestite con somma
delicatezza. Di fronte alla situazione di oggi non si può dire perciò che essa
sia del tutto nuova. Ha precedenti numerosi in Italia e fuori d'Italia ed ha,
del resto, evidenti ragioni che sono insite nell'ordinamento giuridico e nella
coscienza sociale del Paese. Del resto è chiaro che ai prigionieri politici
dell'altra parte viene assegnato un soggiorno obbligato in Stato Terzo. Ecco, la
tua obiettiva ed informata testimonianza, data ampiamente e con la massima
urgenza, dovrebbe togliere alla soluzione prospettata quel certo carattere di
anomalia che taluno tende ad attribuire ad essa. E' un intermezzo di guerra o
guerriglia che sia, da valutare nel suo significato. Lascio alla tua prudenza di
stabilire quali altri protagonisti evocare. Vorrei che comunque Giovannoni fosse
su piazza. Ma importante è che tu sia lì, non a fare circolo, ma a parlare
serenamente secondo verità. Tra l'altro ricordi quando l'allarme ci giunse in
Belgio? Grazie per quanto dirai e farai secondo verità. La famiglia ed io, in
tanta parte, dipendiamo da te, dalla tua onestà e pacatezza. Affettuosamente
Aldo Moro.
46) A
Maria Luisa Familiari (la destinataria ha dichiarato di non aver ricevuto la
lettera). C'è anche una lettera per Zaccagnini da portare in casa, vicino casa
mia o a Piazza del Gesù con molte raccomandazioni. Carissima Maria Luisa
(Familiari) in questa, probabilmente inutile, corsa contro la morte, ricorro a
te, col sistema dell'altro giorno, partendo questa volta da casa tua invece che
dall'ufficio, dato il giorno festivo. Si tratta di portare entro oggi domenica a
destinazione queste lettere nelle proprie mani dei destinatari, o almeno quasi
nelle loro mani. Dato che è domenica andare a casa, assicurarsi, essere certi
che sarà consegnata a breve scadenza, andare fuori se l'interessato fosse fuori
in un posto definito e sicuro. Il più importante è l'on. Piccoli che abita non
lontano da casa mia e in alternativa si potrebbe trovare (improbabile) nel suo
ufficio a Montecitorio o più probabilmente a Piazza del Gesù. Poi c'è l'on.
Riccardo Misasi, Presidente della Commissione di giustizia, di cui non ho idea
dove possa abitare. Se la Camera, date le circostanze, è aperta chiedere là o a
Piazza del Gesù o alla segreteria on. Dell'Andro o al Ministero della giustizia.
Queste frasi qui dette sono le più importanti. Poi c'è quella indirizzata al
Dott. Tullio Ancora, Via Livorno 44, non lungi da Piazza Fiume. Anche lì dare a
mano. Ce n'è poi una per il presidente del Consiglio Andreotti che potrebbe
essere recapitata al limite nella sua casa in Corso Vittorio Emanuele, non
lontano dalla Chiesa Nuova. In mancanza di tutto anche in Piazza del Gesù. C'è
infine una per l'on. Craxi che credo abiti all'Albergo San Raphael presso il
Panteon o in mancanza alla sede del P.S.I. in via del Corso, con molte
raccomandazioni. Scusami tanto, abbracciami tutti, voglia anche tu un po' di
bene a Luca. E Dio ti benedica e ti premi di tutto. Aldo Moro. P.S. Fai tutto
con l'aiuto dei carissimi amici, specie Mimmo, Matteo e Gianni. Sarà brutta
domenica, ma pensa alla mia.
47) Ai
Presidenti delle Camere (non recapitata). Signori Presidenti delle Camere, è
nota la mia difficile condizione. Sono prigioniero politico delle Brigate Rosse
e sottoposto, quale Presidente del Consiglio Nazionale della D.C., a giudizio
sulla base di accuse che riguardano insieme me ed il gruppo dirigente del
Partito. In relazione a questo mio stato di detenzione si è prospettata la
opportunità di uno scambio dei prigionieri politici delle due parti, secondo
modalità da trattare. Di questa possibilità io mi sono fatto portatore in due
messaggi, che, malgrado le mie argomentazioni umanitarie e politiche, non hanno
avuto in Parlamento favorevole accoglienza. A questo punto ritengo di invocare
la umanitaria comprensione delle due Assemblee e dei loro Presidenti per una
soluzione che, a mio avviso, non pregiudicherebbe in nessun modo né i diritti
dello Stato, né i legittimi interessi dei prigionieri politici, tra i quali io
mi trovo. Questa soluzione dovrebbe essere negoziata tramite la Croce Rossa di
Ginevra e dovrebbe concretarsi in una legge straordinaria ed urgente del
Parlamento, la quale mi conferisca lo status di detenuto in condizioni del tutto
analoghe, anche come modalità di vita, a quelle proprie dei prigionieri politici
delle Brigate Rosse. Per legge io verrei così vincolato a questi prigionieri e
non potrei fruire di atti di clemenza o di scambi, se non in quanto gli altri ne
beneficiassero. Ovviamente la garanzia alle Brigate Rosse dovrebbe essere data
tramite il negoziato con la Croce Rossa e la legge obbligante che il Parlamento
poi voterebbe, ritenendo in essa assorbita l'autorizzazione a procedere e ad
arrestare. So bene che si possono fare contro questa tutte le possibili
obiezioni. Sta di fatto però che è questo l'unico modo per salvare la vita ed
ottenere condizioni di detenzione accettabili, e che io accetto, fino a che non
maturino le condizioni di un miglior assetto della materia. Infatti una prigione
clandestina non può durare a lungo, né offrire, per ragioni tecniche, più di
quel che offre. In una prigione comune, per quanto severa, io avrei delle
migliori possibilità ambientali, qualche informazione ed istruzione, assistenza
farmaceutica e medica ed un contatto, almeno saltuario, con la famiglia. Voglia
il Parlamento nel suo alto senso di giustizia e di umanità vagliare la mia
proposta, non recidendo l'esile filo nel quale si esprimono le mie poche
speranze. Con ossequi Aldo Moro.
48) A
Eleonora Moro (non recapitata). Mia dolcissima Noretta, non mi soffermo sulle
tante cose tenere che vorrei dire per tutti voi. C'è una cosa importante ed
urgente da fare: un tuo incontro con Zaccagnini, Piccoli, Bartolomei, Galloni e
Gaspari. Devi dire loro, prima privatamente, poi pubblicamente col tenore che
uso in questi giorni (ce ne sarà uno ancora domani) che essi mi conducono a
morte sicura, escludendo qualsiasi trattativa su scambi di prigionieri,
salvaguardia di ostaggi e poi anche sulle proposte ultime e minime dell'on.
Craxi. Non si debbono fare illusioni in proposito. Possono darti tutte le
assicurazioni che vogliono, ma non hanno niente in mano. Dato che il tempo
corre, la via della prudenza, dell'attesa, della fiducia è impercorribile, anche
di fronte a TV e radio devi dire (chiariscilo per me a Guerzoni) che tu chiedi
un'assunzione di responsabilità della D.C. e ad essa dovrai dolorosamente
attribuire la responsabilità. Sei mia moglie, rappresenti la famiglia, puoi
dirlo, con esito drammatico. Sii dura come sai esserlo [...]
Aldo [...] seguono
due righe incomprensibili.
49) A
Corrado Guerzoni (il destinatario ha dichiarato di non aver mai ricevuto la
lettera). Se non la ricevono, va pure detto in TV. Chiamare subito Guerzoni.
Carissimo Guerzoni, ci deve essere un mio appello al partito, presso mia moglie,
da diffondere molto e presto. Inoltre è ritenuto qui essenziale che mia moglie
si rechi al partito (Zac + 5) e dica loro nettamente che il rifiuto della D.C. a
trattare seriamente, anche nelle forme minime proposte da Craxi, comporta la mia
morte, la cui responsabilità la famiglia deve ad essa attribuire. Questo va
sistematicamente ripetuto dopo a mezzo TV. Le sarò grato se accompagnasse e
aiutasse, perché è la prima volta che mia moglie fa questo e ne è terrorizzata.
Ma almeno la Radio dovrebbe essere più facile. Quanto all'opportunità lasci me
giudicare. Scusi tanto, grazie per il doppio lavoro e molta cordialità. Aldo
Moro. In caso di indisponibilità dell'altra parte o di cogenti ragioni di salute
di mia moglie, bisogna mandare subito una lettera alla D.C. che esprima i noti
concetti e che sia subito pubblicata. Guerzoni di domenica reperibile in casa
via Flaminia N° reperibile nel catalogo. Ovvero in via di Forte Trionfale, 79
lunedì in ufficio. Mi raccomando: questa diffida è essenziale e deve essere
immediata.
50) A
Don Antonello Mennini (il destinatario ha dichiarato di non aver mai ricevuto la
lettera). Antonello Mennini. Carissimo Antonello, avrei da dire molte cose, ma
le rimando perché meno urgenti. ci sarebbe da consegnare tre lettere importanti
di persona e con molta urgenza. 1 Onorevole Piccoli. Dovrebbe essere tra molta
confusione al suo ufficio nel gruppo parlamentare della Camera. Bisogna stanarlo
e dargliela, dicendo che viene da me. 2 On. Renato Dell'Andro. Può essere
all'albergo Minerva (mi pare proprio si chiami così, tutto di fronte alla
chiesa) o al Ministero della giustizia o infine alla sede del Gruppo D.C. a
Montecitorio. Se per dannata ipotesi, avessi sbagliato il nome dell'albergo,
sappi che i due alberghetti di cui si tratta sono così: Chiesa Minerva Questo a
destra è Dell'Andro. 3 On. Pennacchìni potrebbe essere allo stesso Gruppo al suo
nuovo ufficio di Presidente della Commissione parlamentare per i servizi
d'informazione, di quest'ultimo non conosco la sede, che è però vicinissima alla
Camera dove la conoscono. L'importante è che arrivi e arrivi subito. Per
semplificazione si può affidare a Dell'Andro, di persona, l'operazione
Pennacchini. Quindi: partire da Piccoli, poi Dell'Andro, per suo tramite o
direttamente, Pennacchini. In extremis, lasciare di persona a Dell'Andro per gli
altri due sollecitandolo. Se possibile, S.Em. Poletti potrebbe far osservare a
S.S. che il Suo bellissimo messaggio, equivocandosi tra restituzione umanitaria
e scambio dei prigionieri, si presta purtroppo ad essere utilizzato contro di
me. Essenziale sarebbe dire ad Andreotti il sincero desiderio che le cose vadano
nel modo desiderato da noi e cioè mediante scambio. Se si vuole il risultato,
questa è la via. Altrimenti tutto s'incaglia. Grazie, benedicimi, proteggimi e
voglimi bene. Tuo Aldo Moro.
51) A
Don Antonello Mennini (il destinatario ha dichiarato di non aver mai ricevuto la
lettera). Mio carissimo Antonello, scusa se profitto così spesso di te. E' che
sei non solo il più caro, ma il più utile e capace nella difficilissima
situazione. 3 cose. I. ho chiesto ieri a mia moglie (ma il messaggio sarà stato
fatto passare? e le sue parole saranno state trasmesse?) che dica fermamente che
invoca salvezza per me, nell'unico modo possibile, come tante altre volte è
avvenuto, cioè di uno scambio di prigionieri. E poi commosse parole di
circostanza. Il fatto che l'appello di mia moglie non arrivi mi allarma sulla
salute sua, ma genera forse l'impressione che la famiglia sia più vicina alla
linea ufficiale anziché a me, il che è falso. II. Vorrei raccogliessi notizie
sulla salute di casa e ti tenessi pronto a rispondere, quando mi sarà possibile
di domandartelo. Mi potrebbero scrivere qualche rigo? Tramite te? III. ed è di
particolare urgenza (precede le altre cose) prendere contatto telefonico con
l'On. Dell'Andro (Ministero Giustizia) o con Sen. Rosa (Marina Mercantile) o
Sen. Gui e Sen. Cervone, pregando di preparare bene la progettata riunione (a
quanto sento) sulla mia disgraziata vicenda, tenendo contatto con gli altri
amici e in particolare l'On. Misasi. E' necessario avere una seria linea
alternativa a quella del Governo, la quale riecheggi un po' la ispirazione
socialista. Bisogna far capire che lo scambio è stato quasi sempre fatto quando
erano in gioco ostaggi e a quelli dell'altra parte è stato dato riparo
all'estero con esclusione dal territorio nazionale. Dì tante cose care a mia
moglie e a chi vedi dei miei. Benedicimi e aiutami nel Signore. Ti abbraccio
forte. Tuo Aldo Moro. P.S. Un'ultima cosa urgente da dire a mia moglie, che
faccia riscuotere subito a Rana alcuni assegni da me firmati in mansarda. E'
necessario per evitare complicazioni ereditarie. Grazie. P.S. Dì al Card.
Poletti che mia moglie purtroppo non sta bene. Che supplichi il Papa di fare di
più, insistendo personalmente con Andreotti e non lasciandosi convincere dalla
ragione di Stato. Altre volte è stata superata.
52) A
Eleonora Moro (recapitata il 24 aprile). Carissima Noretta, come ultimo
tentativo fai una protesta ed una preghiera con tutto il fiato che hai in gola,
senza sentire i consigli di prudenza di chicchessia e dello stesso Guerzoni. Ti
abbraccio forte forte. Aldo.
53) A
Benigno Zaccagnini (recapitata il 24 aprile). Caro Zaccagnini, ancora una volta,
come qualche giorno fa m'indirizzo a te con animo profondamente commosso per la
crescente drammaticità della situazione. Siamo quasi all'ora zero: mancano più
secondi che minuti. Siamo al momento dell'eccidio. Naturalmente mi rivolgo a te,
ma intendo parlare individualmente a tutti i componenti della Direzione (più o
meno allargata) cui spettano costituzionalmente le decisioni, e che decisioni!
del partito. Intendo rivolgermi ancora alla immensa folla dei militanti che per
anni ed anni mi hanno ascoltato, mi hanno capito, mi hanno considerato l'accorto
divinatore delle funzioni avvenire della Democrazia Cristiana. Quanti dialoghi,
in anni ed anni, con la folla dei militanti. Quanti dialoghi, in anni ed anni,
con gli amici della Direzione del Partito o dei Gruppi parlamentari. Anche negli
ultimi difficili mesi quante volte abbiamo parlato pacatamente tra noi, tra
tutti noi, chiamandoci per nome, tutti investiti di una stessa indeclinabile
responsabilità. Si sapeva, senza patti di sangue, senza inopinati segreti
notturni che cosa voleva ciascuno di noi nella sua responsabilità. Ora di questa
vicenda, la più grande e gravida di conseguenze che abbia investito da anni la
D.C., non sappiamo nulla o quasi. Non conosciamo la posizione del Segretario né
del Presidente del Consiglio; vaghe indiscrezioni dell'On. Bodrato con accenti
di generico carattere umanitario. Nessuna notizia sul contenuto; sulle
intelligenti sottigliezze di Granelli, sulle robuste argomentazioni di Misasi
(quanto contavo su di esse), sulla precisa sintesi politica dei Presidenti dei
Gruppi e specie dell'On. Piccoli. Mi sono detto: la situazione non è matura e ci
converrà aspettare. E' prudenza tradizionale della D.C. Ed ho atteso fiducioso
come sempre, immaginando quello che Gui, Misasi, Granelli, Gava, Gonella
(l'umanista dell'Osservatore) ed altri avrebbero detto nella vera riunione, dopo
questa prima interlocutoria. Vorrei rilevare incidentalmente che la competenza è
certo del Governo, ma che esso ha il suo fondamento insostituibile nella D.C.
che dà e ritira la fiducia, come in circostanze così drammatiche sarebbe
giustificato. E' dunque alla D.C. che bisogna guardare. Ed invece, dicevo,
niente. Sedute notturne, angosce, insofferenza, richiami alle ragioni del
Partito e dello Stato. Viene una proposta unitaria nobilissima, ma che elude
purtroppo il problema politico reale. Invece dev'essere chiaro che politicamente
il tema non è quello della pietà umana, pur così suggestiva, ma dello scambio di
alcuni prigionieri di guerra (guerra o guerriglia come si vuole), come si
pratica là dove si fa la guerra, come si pratica in paesi altamente civili
(quasi la universalità), dove si scambia non solo per obiettive ragioni
umanitarie, ma per la salvezza della vita umana innocente. Perché in Italia un
altro codice? Per la forza comunista entrata in campo e che dovrà fare i conti
con tutti questi problemi anche in confronto della più umana posizione
socialista? Vorrei ora fermarmi un momento sulla comparazione dei beni di cui si
tratta: uno recuperabile, sia pure a caro prezzo, la libertà; l'altro, in nessun
modo recuperabile, la vita. Con quale senso di giustizia, con quale pauroso
arretramento sulla stessa legge del taglione, lo Stato, con la sua inerzia, con
il suo cinismo, con la sua mancanza di senso storico consente che per una
libertà che s'intenda negare si accetti e si dia come scontata la più grave ed
irreparabile pena di morte? Questo è un punto essenziale che avevo immaginato
Misasi sviluppasse con la sua intelligenza ed eloquenza. In questo modo si
reintroduce la pena di morte che un Paese civile come il nostro ha escluso sin
dal Beccaria ed espunto nel dopoguerra dal codice come primo segno di autentica
democratizzazione. Con la sua inerzia, con il suo tener dietro, in nome della
ragion di Stato, l'organizzazione statale condanna a morte e senza troppo
pensarci su, perché c'è uno stato di detenzione preminente da difendere. E' una
cosa enorme. Ci vuole un atto di coraggio senza condizionamenti di alcuno.
Zaccagnini, sei eletto dal congresso. Nessuno ti può sindacare. La tua parola è
decisiva. Non essere incerto, pencolante, acquiescente. Sii coraggioso e puro
come nella tua giovinezza. E poi, detto questo, io ripeto che non accetto
l'iniqua ed ingrata sentenza della D.C. Ripeto: non assolverò e non
giustificherò nessuno. Nessuna ragione politica e morale mi potranno spingere a
farlo. Con il mio è il grido della mia famiglia ferita a morte, che spero possa
dire autonomamente la sua parola. Non creda la D.C. di avere chiuso il suo
problema, liquidando Moro. Io ci sarò ancora come un punto irriducibile di
contestazione e di alternativa, per impedire che della D.C. si faccia quello che
se ne fa oggi. Per questa ragione, per una evidente incompatibilità, chiedo che
ai miei funerali non partecipino né Autorità dello Stato, né uomini di partito.
Chiedo di essere seguito dai pochi che mi hanno veramente voluto bene e sono
degni perciò di accompagnarmi con la loro preghiera e con il loro amore.
Cordiali saluti. 24-4-78. Aldo Moro. On. Benigno Zaccagnini. P.S. Diffido a non
prendere decisioni fuori dagli organi competenti di partito.
54) A
Eleonora Moro (non recapitata). Mia dolcissima Noretta, credo che questa sia
proprio l'ultima. Per ragioni misteriose mi sembra preclusa qualsiasi speranza.
Non si sa neppure approssimativamente, che cosa accade, in che si concludano le
varie iniziative delle quali una volta si parla. Il Papa non può fare niente
neppure dimostrativamente, in questo caso? Perché avevamo tanti amici, a
schiere. Non una voce che io sappia, si è levata sin qui. Di voi ho ricevuto la
sola lettera del "Giorno", che volevo portare sul petto, così per farmi
compagnia, all'atto di morire. Ma si è perduta nel pulire la prigione. Per
quanto abbia chiesto, non ho saputo altro. Quasi pensavo di aver fatto qualcosa
di vergognoso. Ma è il meccanismo, deve essere così. Ed a voi devono avere
consigliato (proibito) di fare qualsiasi protesta, che non sarebbe servita a
nulla, ma avrebbe dimostrato che io qualche persona cara l'ho ancora. E' stato
tutto freddamente determinato ed io sono stato trattato come se solo mi fossi
servito della D.C. Ma non hanno nemmeno un momento esaminato la situazione, per
vedere che cosa era opportuno fare, salvare il salvabile, capire. Una spaventosa
improvvisazione. Per me, è finita. Penso solo a voi e, se non sono oppresso fino
alla follia, vi richiamo, vi rivedo, da grandi e da piccoli, da anziani e da
giovani e tra tutti il dilettissimo Luca con cui passo ancora i momenti
disponibili. E poi il dubbio della vostra salute, la ragione del vostro
silenzio. Spero che Freato e Rana vi seguano. I nostri dopo 40 giorni si saranno
un po' abituati, ma dimenticati, spero, no. Se a Torrita non venite, comincia
col tenermi a Roma, o nella chiesa di Torrita. Abbracciameli tutti tutti, uno ad
uno, ogni giorno, come avrei fatto. Ricordatemi un po', per favore. Lo sono cupo
e un po' intontito. Credo non sarà facile imparare a guardare e a parlare con
Dio e con i propri cari. Ma c'è speranza diversa da questa? Qualche volta penso
alle scelte sbagliate, tante; alle scelte che altri non hanno meritato. Poi dico
che tutto sarebbe stato eguale, perché è il destino che ci prende. Mentre
lasciamo tutto resta l'amore, l'amore grande grande per te e per i nostri frutti
di tanta incredibile e impossibile felicità. Che di tutto resti qualcosa. Ti
abbraccio forte, Noretta mia. Morirei felice, se avessi il segno di una vostra
presenza. Sono certo che esiste, ma come sarebbe bello vederla. Aldo.
55) Ai
parenti (non recapitata). A fratelli, cognati, zii un grande abbraccio grazie. A
Nonna tante cose care. Vede che non si può fare previsioni? Aldo.
56) A
Corrado Guerzoni (non recapitata). Rai II Rete. Caro Guerzoni, in questo momento
drammatico mi sento accanto a Lei, infinitamente grato per il bene che mi ha
voluto, per quanto ha operato per me, per quanto avrà certo fatto in questa
circostanza. Molte cose mi risultano incomprensibili e non voglio rifletterci
su. Mi angoscia la famiglia che resta sola, specie Luca. L'affido a Dio ed a
buoni amici a cui debbo tanta riconoscenza. Mi ricordi alla Sig.ra De Candido e
si abbia un grande abbraccio dal suo Aldo Moro.
57) A
Maria Fida Moro e Demetrio Bonini (non recapitata). Carissimi Maria Fida e Demi,
casa figli amati vi riscrivo, nel forte dubbio che le mie precedenti lettere di
addio siano state, chissà perché, sequestrate. Volevo dirvi (ed ora ve lo dico,
purtroppo, meno bene) tutto il mio amore, tutta la mia stima, tutto il legame
con voi. Vi ho già detto che con Luca mi avete dato la cosa più grande della mia
vita, quella che più angoscia lasciare. Lo terrò stretto a me fino all'ultimo
istante, sperando che non gli resti il segno di questa vicenda ma che,
misteriosamente, l'amore rimanga. So la fragilità di Fida che ha bisogno di
essere aiutata. Ho cercato di farlo con più gioia che sia dato immaginare. Ma
ora occorrono altri e da tutti invoco questa collaborazione. Anche tu Demi caro,
che già fai tanto, stai in questa circostanza più vicino a tuo figlio tienilo
fra le braccia come lo terrei io, riversa su di lui il tuo amore. Camminate per
la vostra strada diritti e saggi, ora che i tempi si fanno sempre più difficili.
Fida ricordi il mio amore dal primo istante, la cura infinita e confidente, il
desiderio di aiutarla sempre. Siate uniti nell'amore e nella famiglia, senza
alcuna distrazione. Non c'è cosa più grande di questa. Che Iddio vi benedica dal
profondo, vi tenga stretti a me e tra voi. Un tenerissimo abbraccio dal vostro
Papà. Aldo. Ricorda quella piccola dichiarazione creditoria. P.S. Mi consola
pensare che, prendendo io quel che sta per arrivare, lo scanso agli altri, lo
scanso a Luca e Luca potrà star bene. E questo è l'essenziale. Baciatelo tanto
per me e forte forte, ciao a voi altri. C'è tutto tra la nostra storia e la
storia.
58) A
Anna Maria Moro e Mario Giordano (non recapitata). Carissimi Anna e Mario, nel
dubbio che una mia precedente non sia stata recapitata per sequestro, desidero
dirvi alla meno peggio, e per quando questa carta vi perverrà, tutto il mio
profondo attaccamento, tutto il mio amore per voi, tutta la dolce attesa e
curiosità per la vostra creatura. Tu sai, Annina, quanto ti ho amata sempre e
condotta con la tua cuffietta, seria seria, per strada. Ti sono stato sempre
vicino, partecipe della tua ansia, pronto a consolarti. Poi Mario è venuto
dolcemente a rilevarmi in parte delle mie funzioni. Ma tu sei sempre rimasta la
piccolina del tuo papà, sulla mia gamba destra, a cavallo. Così ti ricordo e ti
ricorderò, anche se il ricordo si prolunga fino al Liceo, all'Università, alla
Laurea e via. Se c'è stato qualche momento difficile esso è superato. Siate
uniti come non mai in questo momento, che la tua creatura nasca tra gente che la
ama. E noi tutti l'amiamo. Vi sentiremo vicini vi siamo vicini. Siate retti,
operosi, buoni, come sempre. Questa brutta vicenda vi farà ancora più seri.
Sentitemi sempre con voi e ricordatemi rispettosamente alla famiglia di Mario.
Vi benedico dal profondo del cuore, vi abbraccio forte forte, vi stringo a me
con la piccolissima. Che Iddio vi aiuti nella pur difficile vita che vi aspetta.
Papà.
59) A
Luca Bonini (non recapitata). Mio carissimo Luca, non so chi e quando ti leggerà
questa lettera del tuo caro nonnetto. Potrai capire che tu sei stato e resti per
lui la cosa più importante della vita. Vedrai quanto sono preziosi i tuoi
riccioli, i tuoi occhietti arguti e pieni di memoria, la tua inesauribile
energia. Saprai così che tutti ti abbiamo voluto un gran bene ed il nonno,
forse, appena un po' più degli altri. Per quel poco che è durato sei stato tutta
la sua vita. Ed ora il nonno Aldo, che è costretto ad allontanarsi un poco, ti
ridice tutto il suo infinito affetto ed afferma che vuole restarti vicino. Tu
non mi vedrai, forse, ma io ti seguirò nei tuoi saltelli con la palla, nella tua
corsa al [...] nel guizzare nell'acqua, nel tirare la corda al motore. Io sarò
là e ti accarezzerò, come sempre ti ho accarezzato, dolcemente il visino e le
mani. Ti sarò accanto la notte, per cogliere l'ora giusta della pipì, e farti
poi dolcemente riaddormentare. E la mattina portarti la vestaglietta, magari con
le scarpette pronte in mano in attesa della pizza o del pane fresco. Queste sono
state le grandi gioie di nonno e, per quanto è possibile lo resteranno. Cresci
buono, forte, allegro serio. Il nonno ti abbraccia forte forte, ti benedice con
tutto il cuore, spera sia in mezzo a gente che ti vuol bene e che forma anche la
tua psiche. Con tanto amore, il nonno.
60) A
Giovanni Moro (non recapitata). Mio Carissimo Giovanni, credevo di avere scritto
una lettera di amore e di ricordo per ciascuno di voi. Ed ora mi viene l'assurda
(ma reale) preoccupazione che tutto sia andato disperso in perquisizioni
giudiziarie o di polizia. Mi affretto perciò a scrivertene un'altra, sperando
che, restando in deposito qualche tempo sia più fortunata. Voglio dire a te ed
Emma tutto l'amore e la fiducia che vi porto e l'angoscia che mi prende nel
dovervi lasciare soli così giovani. Ma siete di buona tempra e di grande
serietà. Non perciò il dolore è meno grande. Giovanni caro, io ti ricordo
piccolissimo, ti ho seguito con tutto l'amore, ti ho dato la gioia del gioco e
della compagnia. Ho rispettato il momento nel quale cercavi la tua autonomia, ma
mi sono allietato tanto, quando tu, proprio tu, sei tornato qualche volta a
carezzarmi come da piccolo. Ammiro il tuo impegno nello studio (ma [...] qualche
esame in più) e rispetto la tua vocazione. Ma la politica ha delle irrazionalità
per cui non conviene restarvi al di la dell'età dell'esperienza umana. Non far
mancare neppure tu a Luca l'affetto e la compagnia di cui ha tanto bisogno.
Avrei voluto assicurarglieli io. Come si fa? Non è male se resti un po' di più
in casa. Anche lo spirito è più sereno. Ti stringo con Emma in un grande
abbraccio nel quale mi pare di trovare la tua dolce infanzia. Che Iddio ti
benedica, t'illumini, ti aiuti, ti ridia poco a poco, non la dimenticanza ma la
serenità. E siate tutti uniti, ch'è l'unica cosa che conta. Con Emma ti
abbraccio forte forte, il tuo papà.
61) A
Agnese Moro (non recapitata). Mia dolcissima Agnese, mi viene l'atroce dubbio
che le mie lettere siano state tutte o quasi sequestrate. Capisco così certi
vuoti angosciosi e temo che si siano disperse alcune lettere di addio che vi
avevo indirizzato. Le rifarò ora male, purtroppo, sperando che questa resti in
deposito fin quando non possa esserti sicuramente consegnata. Volevo dirti
Agnesina (e lo faccio tanto male) tutto il mio amore e l'angoscia di doverti
lasciare. Ricordo la tua dolce faccina (campagna, fiori e altre cose). Ti sono
stato sempre vicino con tutto il cuore, anche se posso avere sbagliato, posso
non averti capito e soddisfatto. Di qui qualche breve strillotto. Ma poi subito
dopo il sorriso, l'abbraccio, la richiesta affettuosa. E l'attesa la sera,
angosciata, finché non fossi tornata. Il tuo saltellare sulla gamba del cuore. E
starti dietro per la scuola, la tua esperienza e il tuo lavoro (nel quale devi
perseverare) distante nella forma, vicinissimo nella sostanza. Ora sei più sola,
ma hai carattere forte e serio e camminerai nella vita sulla tua strada. Non
dimenticare, come mi promettesti d'estate, e non far dimenticare l'amatissimo
Luca. La mia tremenda angoscia si attenua, se penso a te, che ci sei, che sei al
mio posto nel letto, che controlli la porta ed il gas chiusi. Lasciami pensare
che sarà così fin quando sarà necessario. Ricordati che a Bellamonte c'è una tua
carissima lettera a me da Helsinki. Non ricordo se nell'armadio della
matrimoniale o in un mio pulloverino. Mi è cara. Tienila. Ti stringo forte forte
in un abbraccio pieno di amore e di augurio. Che Iddio ti benedica, ti dia la
tua gioia, ti conforti nell'amore, ti faccia sentire vicino vicino, giorno e
notte il tuo amato papà.
62) A
Nicola Rana. (Il testo non è stato reso noto).
63) Testamento
in favore della figlia Anna (Il testo non è stato reso
noto).
65) A
Sereno Freato (non recapitata). Dott. Sereno Freato, Via San Valentino 21.
Carissimo Freato, non so, se scrivo o riscrivo, perché molte cose devono essere
state sequestrate e non si è certi di niente. In questa vicenda allucinante ho
pensato spesso a noi ed anche agli errori delle nostre scelte. Desidero ridirLe,
dopo tanti anni di collaborazione, quanto le voglia bene e Le sia grato di
tutto. Per noi è oscuro d'ora in avanti. Una sola cosa è chiara: Le affido i
miei carissimi con la collaborazione di Rana; Le affido Luca mio amore. Mi
ricordi ai Suoi, mi ricordi agli amici. Non voglio, lasciando dire niente di
cattivo, anche se ci sarebbe da dire e da stupire di fronte al poco che è stato
fatto per me. Domani magari si pentiranno. Con tanta amicizia ed amarezza
l'abbraccio con tutto il cuore affidandomi a Lei, Suo Aldo Moro. Dott. Sereno
Freato. Via S. Valentino 21 Roma.
66) A
Don Antonello Mennini (non recapitata). Carissimo Antonello, temo - e mi
angoscia - che siano state, senza darne notizia, sequestrate lettere di affetto
tra persone care in una situazione drammatica come questa. Alcune le ho
ricostruite. Altre, contenenti alcune indicazioni chissà dove e come si potranno
ritrovare. Ho pensato dunque di unire il tutto, di chiamarti, di darti il
pacchetto, perché lo tenga per te. Evidentemente sorpassando casa, si rischia
(credo) la perquisizione. Terrai tutto per te e, a tempo debito, ne parlerai a
voce con mia moglie, per vedere il da farsi. Dovrebbe esserti di consiglio il
mio ex capo gabinetto S.E. Manzari ora al Ministero degli esteri come capo
ufficio legislativo, senza il cui consiglio non far niente. Anzi ti prego, a
voce (abita in via Livio Andronico, non lontano da me) digli tutta questa
vicenda perché la veda anche legalmente e ti aiuti a recuperare quel che fu
sottratto. Del nuovo nulla fino ad accordo con mia moglie e lui. Tieni tutto.
Poi si potrà vedere. Bisogna essere certi che all'entrata in casa non si sia
intercettati. Non mi pare giusto che s'impedisca in queste circostanze di
parlare tra persone che si vogliono bene. Il fatto che tu te ne occupi mi
tranquillizza. Aggiungi la tua preghiera, sempre cara e sempre valida. Il Papa
non poteva essere un po' più penetrante? Speriamo che lo sia stato anche senza
dirlo. Benedicimi e aiutati. Ti abbraccio, Aldo Moro. Le lettere fuori casa,
essendo in zona, si potranno dare allerta però a Rana e Freato salvo non le
ritirino personalm [...][...] questa
frase è monca e di difficile lettura.
67) A
Eleonora Moro (non recapitata). Non mi disperdere le cose da vestire [...]. Fa
come se fossi lì non disturbarti per la tomba. Mia dolcissima Noretta, mi viene
ora il dubbio atroce che un'infinità di mie lettere e due piccoli testamenti
siano stati sequestrati, incomprensibilmente, dall'autorità. Come spiegare
l'appassionata reiterata richiesta di un tuo messaggio stampa, mai pervenuto? E
altre, e altre cose. Avevo scritto a tutti i nostri cari in punto di morte, con
l'animo aperto in quel momento supremo. Volevo lasciare qualche certezza di
amore e qualche motivo di riflessione. Ed ora temo che tutto questo sia
disperso, per ricomparire, se comparirà, chissà quando e come. Allora ho deciso
di scrivere alla meglio, per dire l'essenziale e di affidare tutto a Don
Antonello Mennini, che lo tenga con sé, finché non abbia parlato di persona con
te e sono certo di poter dare senza pericolo. Noretta mia carissima, in questa
vicenda allucinante riconosco le mie ingenuità, ma coperte dalla buona fede che
si lega alle mie scelte giovanili di passare dall'Azione Cattolica alla D.C.
Sono stato poco a Torrita, tenetemi [...] con voi a Roma. Mi è atroce pensare
quanto questa vicenda vi toglie e soprattutto all'amatissimo Luca che avrebbe
avuto diritto all'assistenza e alla gioia. Quanto mi è angosciante lasciarlo
solo. Prego Iddio che gli susciti intorno volti cari, sorrisi teneri, autentico
interessamento. Io pregherò per lui fino all'ultimo istante. E l'immagino con
te, con Agnese, con tutti i suoi cari, con qualche ricordo del nonno che gli
evocherete con qualche fotografia, con qualche richiamo. Mi sarebbe dolce
sentirmi non assente. E a te, gioia amata, grazie di tutto. Nel fondo credo di
averti dato tutto l'amore anche se con qualche distrazione d'ufficio. Quanto
meno bisognerebbe dare all'ufficio e più alla famiglia. Sei stata la mia gioia
più grande, fonte, talvolta di piccola gelosia, solo non ti vedessi magari
rivolta a me. Che Iddio ci aiuti tutti. Freato e Rana dovrebbero aiutarvi. Iddio
vi benedica dal profondo e mi stringa a voi in un amore eterno. Mi consola
pensare che, prendendo quel che viene, lo storno da voi. Eri troppo…(La
lettera si interrompe a questo punto).
68) A
Eleonora Moro (Il testo non è stato reso noto).
69) A
Eleonora Moro (non recapitata). Per Noretta. Dammi la felicità di un messaggio
tramite Guerzoni per sabato mattina forse si fa ancora in tempo e dimmi se hai
ricevuto lettere ai figli e nipoti e due piccoli testamenti.
70) Ai
familiari (recapitata il 24 o il 25 aprile). A tutti i miei carissimi ed a
Noretta, amata sposa e madre. Mi piacerebbe avere un cenno, anche minimo di
risposta, per tranquillizzarmi sulla salute di tutti. Aldo.
71) Alla
Democrazia Cristiana (recapitata il 28 aprile). Lettera al Partito della
Democrazia Cristiana. Dopo la mia lettera comparsa in risposta ad alcune
ambigue, disorganiche, ma sostanzialmente negative posizioni della D.C. sul mio
caso, non è accaduto niente. Non che non ci fosse materia da discutere. Ce n'era
tanta. Mancava invece al Partito, al suo segretario, ai suoi esponenti il
coraggio civile di aprire un dibattito sul tema proposto che è quello della
salvezza della mia vita e delle condizioni per conseguirla in un quadro
equilibrato. E' vero: io sono prigioniero e non sono in uno stato d'animo lieto.
Ma non ho subito nessuna coercizione, non sono drogato, scrivo con il mio stile
per brutto che sia, ho la mia solita calligrafia. Ma sono, si dice, un altro e
non merito di essere preso sul serio. Allora ai miei argomenti neppure si
risponde. E se io faccio l'onesta domanda che si riunisca la direzione o altro
organo costituzionale del partito, perché sono in gioco la vita di un uomo e la
sorte della sua famiglia, si continua invece in degradanti conciliaboli, che
significano paura del dibattito, paura della verità, paura di firmare col
proprio nome una condanna a morte. E devo dire che mi ha profondamente
rattristato (non avrei creduto possibile) il fatto che alcuni amici da Mons.
Zama, all'avv. Veronese, a G.B. Scaglia ed altri, senza né conoscere, né
immaginare la mia sofferenza, non disgiunta da lucidità e libertà di spirito,
abbiano dubitato dell'autenticità di quello che andavo sostenendo, come se io
scrivessi su dettatura delle Brigate Rosse. Perché questo avallo alla pretesa
mia non autenticità? Ma tra le Brigate Rosse e me non c'è la minima comunanza di
vedute. E non fa certo identità di vedute la circostanza che io abbia sostenuto
sin dall'inizio (e, come ho dimostrato, molti anni fa) che ritenevo accettabile,
come avviene in guerra, uno scambio di prigionieri politici. E tanto più quando,
non scambiando, taluno resta in grave sofferenza, ma vivo, l'altro viene ucciso.
In concreto lo scambio giova (ed è un punto che umilmente mi permetto sottoporre
al S. Padre) non solo a chi è dall'altra parte, ma anche a chi rischia
l'uccisione, alla parte non combattente, in sostanza all'uomo comune come me. Da
che cosa si può dedurre che lo Stato va in rovina, se, una volta tanto, un
innocente sopravvive e, a compenso, altra persona va, invece che in prigione, in
esilio? Il discorso è tutto qui. Su questa posizione, che condanna a morte tutti
i prigionieri delle Brigate Rosse (ed è prevedibile ce ne siano) è arroccato il
Governo, è arroccata caparbiamente la D.C., sono arroccati in generale i partiti
con qualche riserva del Partito Socialista, riserva che è augurabile sia
chiarita d'urgenza e positivamente, dato che non c'è tempo da perdere. In una
situazione di questo genere, i socialisti potrebbero avere una funzione
decisiva. Ma quando? Guai, Caro Craxi, se una tua iniziativa fallisse. Vorrei
ora tornare un momento indietro con questo ragionamento che fila come filavano i
miei ragionamenti di un tempo. Bisogna pur ridire a questi ostinati immobilisti
della D.C. che in moltissimi casi scambi sono stati fatti in passato, ovunque,
per salvaguardare ostaggi, per salvare vittime innocenti. Ma è tempo di
aggiungere che, senza che almeno la D.C. lo ignorasse, anche la libertà (con
l'espatrio) in un numero discreto di casi è stata concessa a palestinesi, per
parare la grave minaccia di ritorsioni e rappresaglie capaci di arrecare danno
rilevante alla comunità. E, si noti, si trattava di minacce serie, temibili, ma
non aventi il grado d'immanenza di quelle che oggi ci occupano. Ma allora il
principio era stato accettato. La necessità di fare uno strappo alla regola
della legalità formale (in cambio c'era l'esilio) era stata riconosciuta. Ci
sono testimonianze ineccepibili, che permetterebbero di dire una parola
chiarificatrice. E sia ben chiaro che, provvedendo in tal modo, come la
necessità comportava, non si intendeva certo mancare di riguardo ai paesi amici
interessati, i quali infatti continuarono sempre nei loro amichevoli e fiduciosi
rapporti. Tutte queste cose dove e da chi sono state dette in seno alla D.C.? E'
nella D.C. dove non si affrontano con coraggio i problemi. E, nel caso che mi
riguarda, è la mia condanna a morte, sostanzialmente avvallata dalla D.C., la
quale arroccata sui suoi discutibili principi, nulla fa per evitare che un uomo,
chiunque egli sia, ma poi un suo esponente di prestigio, un militante fedele,
sia condotto a morte. Un uomo che aveva chiuso la sua carriera con la sincera
rinuncia a presiedere il governo, ed è stato letteralmente strappato da
Zaccagnini (e dai suoi amici tanto abilmente calcolatori) dal suo posto di pura
riflessione e di studio, per assumere l'equivoca veste di Presidente del
Partito, per il quale non esisteva un adeguato ufficio nel contesto di Piazza
del Gesù. Sono più volte che chiedo a Zaccagnini di collocarsi lui idealmente al
posto ch'egli mi ha obbligato ad occupare. Ma egli si limita a dare
assicurazioni al Presidente del Consiglio che tutto sarà fatto come egli
desidera. E che dire dell'On. Piccoli, il quale ha dichiarato, secondo quanto
leggo da qualche parte, che se io mi trovassi al suo posto (per così dire
libero, comodo, a Piazza ad esempio, del Gesù), direi le cose che egli dice e
non quelle che dico stando qui. Se la situazione non fosse (e mi limito nel
dire) così difficile, così drammatica quale essa è, vorrei ben vedere che cosa
direbbe al mio posto l'On. Piccoli. Per parte sua ho detto e documentato che le
cose che dico oggi le ho dette in passato in condizioni del tutto oggettive. E'
possibile che non vi sia una riunione statutaria e formale, quale che ne sia
l'esito? Possibile che non vi siano dei coraggiosi che la chiedono, come io la
chiedo con piena lucidità di mente? Centinaia di parlamentari volevano votare
contro il Governo. Ed ora nessuno si pone un problema di coscienza? E ciò con la
comoda scusa che io sono un prigioniero. Si deprecano i lager, ma come si
tratta, civilmente, un prigioniero, che ha solo un vincolo esterno, ma
l'intelletto lucido? Chiedo a Craxi, se questo è giusto. Chiedo al mio partito,
ai tanti fedelissimi delle ore liete, se questo è ammissibile. Se altre riunioni
formali non le si vuol fare, ebbene io ho il potere di convocare per data
conveniente e urgente il Consiglio Nazionale avendo per oggetto il tema circa i
modi per rimuovere gli impedimenti del suo Presidente. Così stabilendo, delego a
presiederlo l'On. Riccardo Misasi. E' noto che i gravissimi problemi della mia
famiglia sono la ragione fondamentale della mia lotta contro la morte. In tanti
anni e in tante vicende i desideri sono caduti e lo spirito si è purificato. E,
pur con le mie tante colpe, credo di aver vissuto con generosità nascoste e
delicate intenzioni. Muoio, se così deciderà il mio partito, nella pienezza
della mia fede cristiana e nell'amore immenso per una famiglia esemplare che io
adoro e spero di vigilare dall'alto dei cieli. Proprio ieri ho letto la tenera
lettera di amore di mia moglie, dei miei figli, dell'amatissimo nipotino,
dell'altro che non vedrò. La pietà di chi mi recava la lettera ha escluso i
contorni che dicevano la mia condanna, se non avverrà il miracolo del ritorno
della D.C. a se stessa e la sua assunzione di responsabilità. Ma questo bagno di
sangue non andrà bene né per Zaccagnini, né per Andreotti, né per la D.C., né
per il paese. Ciascuno porterà la sua responsabilità. Io non desidero intorno a
me, lo ripeto, gli uomini del potere. Voglio vicino a me coloro che mi hanno
amato davvero e continueranno ad amarmi e pregare per me. Se tutto questo è
deciso, sia fatta la volontà di Dio. Ma nessun responsabile si nasconda dietro
l'adempimento di un presunto dovere. Le cose saranno chiare, saranno chiare
presto. Aldo Moro.
72) Alla
Democrazia Cristiana [seconda versione]
(non recapitata). (Alla Democrazia cristiana [seconda versione] edizione più
stringata e prudente tenuto conto dei palestinesi e dell'iniziativa Craxi. E' in
alternativa all'altra, valutare attentamente le circostanze.) Dopo la mia
lettera comparsa in risposta ad alcune ambigue, disorganiche, ma sostanzialmente
negative posizioni della D.C. sul mio caso, non è accaduto niente. Non che non
ci fosse materia da discutere. Ce n'era tanta. Mancava invece al Partito nel suo
insieme il coraggio di aprire un dibattito sul tema proposto che è tema della
salvezza della mia vita e delle condizioni per conseguirla in un quadro
equilibrato. E' vero, io sono prigioniero e non ho l'animo lieto. Ma non ho
subito nessuna coercizione, non sono drogato, scrivo con il mio stile per brutto
che sia, ho la mia solita calligrafia. Ma sono, si dice, un altro e non merito
di essere preso sul serio. Allora ai miei argomenti neppure si risponde. E se io
faccio l'onesta domanda che si riunisca la direzione o altro organo
costituzionale del partito, perché sono in gioco la vita di un uomo e la sorte
della sua famiglia, si continua invece in conciliaboli. Qualcuno sembra dubitare
dell'autenticità di quello che vado sostenendo. Come se io scrivessi sotto
dettatura delle Brigate Rosse. Ma tra le Brigate Rosse e me non c'è la minima
comunanza di vedute. E non fa certo identità di vedute il fatto che io abbia
sostenuto sin dall'inizio (e come ho dimostrato, molti anni fa) che ritenevo
accettabile, come avviene in guerra, uno scambio di prigionieri politici. E
tanto più quando, non scambiando, taluno resta in grave sofferenza, ma vivo,
l'altro viene ucciso. In concreto lo scambio giova non solo al detenuto, ma
anche a chi rischia l'uccisione, alla parte non combattente. Da che cosa si può
dedurre che lo Stato va in rovina, se una volta tanto un innocente sopravvive e,
a compenso, altra persona va, invece che in prigione, in esilio? Il discorso è
tutto qui. Su questa posizione, che condanna a morte i prigionieri delle Brigate
Rosse (e potrebbero esservene) - è arroccato il Governo, è arroccata
caparbiamente la D.C., sono arroccati in generale i partiti con qualche
rilevante riserva del Partito Socialista che non è lecito lasciar cadere. Vorrei
ora tornare un momento indietro con questo ragionamento che fila come filavano i
miei ragionamenti di un tempo. Bisogna pur ridire a questi ostinati immobilisti
della D.C. che in moltissimi casi scambi sono stati fatti in passato, dovunque,
per salvaguardare ostaggi e salvare vittime innocenti. Ma è tempo di aggiungere
che anche in Italia la libertà è stata concessa con procedure appropriate a
Palestinesi, per parare gravi minacce di rappresaglia capaci di rilevanti danni
alla comunità. E si noti si trattava di minacce serie e temibili, ma non aventi
sempre il grado d'immanenza di quelle che oggi ci occupano. Ma allora il
principio era stato accettato. Vi sono testimoni ineccepibili ai quali far
riferimento. E sia ben chiaro che, provvedendo come la necessità comportava, non
si intendeva certo mancare di riguardo a paesi profondamente amici, i quali
infatti continuarono sempre nei loro amichevoli e fiduciosi rapporti. Questi
rilievi in quali dibattiti sono stati fatti e, dico, con particolare riguardo
alla D.C., chiamata ad affrontare con coraggio i problemi? E nel caso che ci
riguarda è la mia condanna a morte che sarebbe sostanzialmente avvallata dalla
D.C., la quale, arroccata su discutibili principi, nulla fin qui fa, per evitare
che un uomo, chiunque egli sia, ma poi un suo esponente di prestigio, un
militante fedele sia condotto a morte. Un uomo che aveva chiuso la sua carriera
con la serena rinuncia a presiedere il Governo ed è stato letteralmente
strappato da Zaccagnini dal suo posto di pura riflessione e di studio, per
assumere l'equivoca veste di Presidente del partito. Sono più volte che chiedo a
Zaccagnini di collocarsi lui idealmente al posto che egli mi ha obbligato a
occupare. Ma egli sembra piuttosto intento a rassicurare il Presidente del
Consiglio che sarà fatto come egli desidera. Possibile che non vi sia una
riunione statutaria e formale? Centinaia di parlamentari minacciavano tempo fa
di votare contro il governo. Più modestamente non si pone ora per taluno un
problema di coscienza? Ma come si tratta civilmente in Italia un prigioniero che
ha un vincolo esterno, ma l'intelletto lucido? Lo chiedo a Craxi. Lo chiedo al
mio partito, ai tanti amici fedeli delle ore liete. Se altro non si ritiene di
fare, ricordo che io potrei convocare il Consiglio Nazionale sul tema del mio
impedimento e del modo di rimuoverlo. Il Capo dello Stato ha il modo di far
funzionare tutti gli organi previsti dalla Costituzione. Se poi nulla di
costruttivo avverrà, sarò costretto ad affermare la responsabilità della D.C.
ufficiale e di quanti non si fossero da essa tempestivamente dissociati, è noto
poi che i gravissimi problemi della mia famiglia sono la ragione fondamentale
della mia lotta contro la morte.
73) Alla
Democrazia Cristiana [terza versione]
(non recapitata). Lettera al partito. Dopo la mia lettera comparsa in risposta
ad alcune ambigue, disorganiche, ma sostanzialmente negative posizioni della DC
sul mio caso, non è accaduto niente. Non che non ci fosse materia da discutere.
Ce n'era tanta. Mancava invece al Partito, al suo segretario, ai suoi esponenti
il coraggio civile di aprire un dibattito sul tema proposto, che è quello della
salvezza della mia vita e delle condizioni per conseguirla in un quadro
equilibrato. E' vero: io sono prigioniero e non sono in uno stato d'animo lieto.
Ma non ho subito nessuna coercizione, non sono drogato, scrivo con il mio stile
per brutto che sia, ho la mia solita calligrafia. Ma sono, si dice, matto e non
merito di essere preso sul serio. Allora ai miei argomenti neppure si risponde.
E se io faccio l'onesta domanda che si riunisca la direzione o altro organo
costituzionale del partito, perché sono in gioco la vita di un uomo e la sorte
della sua famiglia, si continua invece in degradanti conciliaboli, che
significano paura del dibattito, paura della verità, paura di firmare col
proprio nome una condanna a morte. E devo dire che mi ha profondamente
rattristato (non avrei creduto possibile) il fatto che alcuni amici, da Mons.
Zama, all'avv. Veronese, a GB Scaglia ed altri, senza né conoscere né immaginare
la mia sofferenza, non disgiunta da lucidità e libertà di spirito, abbiano
dubitato dell'autenticità di quello che andavo sostenendo, come se io scrivessi
su dettatura delle Brigate Rosse. Perché questo avvallo alla pretesa mia non
autenticità? Ma tra le Brigate Rosse e me non c'è la minima comunanza di vedute.
E non fa certo identità di vedute la circostanza che io abbia sostenuto sin
dall'inizio (e come ho dimostrato molti anni fa) che ritenevo accettabile, come
avviene in guerra, uno scambio di prigionieri politici. E tanto più quando, non
scambiando, taluno resta in grave sofferenza, ma vivo, l'altro viene ucciso. In
concreto lo scambio giova (ed è un punto che umilmente mi permetto sottoporre al
S. Padre) non solo a chi è dall'altra parte, ma anche a chi rischia l'uccisione,
alla parte non combattente, in sostanza all'uomo comune come me. Da che cosa si
può dedurre che lo Stato va in rovina, se, una volta tanto, un innocente
sopravvive e, a compenso, altra persona va, invece che in prigione, in esilio?
Il discorso è tutto qui. Su questa posizione, che condanna a morte tutti i
prigionieri delle B.R. (ed è prevedibile ce ne siano) è arroccato il Governo, è
arroccata caparbiamente la DC, sono arroccati in generale i partiti con qualche
riserva del PSI, riserva che è augurabile sia chiarita d'urgenza e
positivamente, dato che non c'è tempo da perdere. In una situazione di questo
genere, i socialisti potrebbero avere funzione decisiva. Ma quando? Guai, Caro
Craxi, se una tua iniziativa fallisse. Vorrei ora tornare un momento indietro
con questo ragionamento che fila come filavano i miei ragionamenti di un tempo.
Bisogna pur ridire a questi ostinati immobilisti della DC che in moltissimi casi
scambi sono stati fatti in passato, ovunque, per salvaguardare ostaggi, per
salvare vittime innocenti. Ma è tempo di aggiungere che, senza che almeno la DC
lo ignorasse, anche la libertà (con l'espatrio) in un numero discreto di casi è
stata concessa a Palestinesi, per parare la grave minaccia di ritorsioni e
rappresaglie capaci di arrecare danno rilevante alla comunità. E, si noti, si
trattava di minacce serie, temibili, ma non aventi il grado di immanenza di
quelle che oggi ci occupano. Ma allora il principio era stato accettato. La
necessità di fare uno strappo alla regola della legalità formale (in cambio
c'era l'esilio) era stata riconosciuta. Ci sono testimoni ineccepibili: i quali
potrebbero avvertire il dovere di dire una parola chiarificatrice. E sia ben
chiaro che, provvedendo in tal modo, come la necessità comportava, non si
intendeva certo mancare di riguardo ai paesi amici interessati, i quali infatti
continuarono sempre nei loro amichevoli e fiduciosi rapporti. Tutte queste cose
dove e da chi sono state dette in seno alla DC? E nello stesso Parlamento in un
dibattito approfondito? Io ho scritto ai presidenti delle assemblee, ma non ho
rilevato, forse per la mia condizione, alcuna risposta. A me però interessa la
DC dove non si affrontano con coraggio i Problemi. E, sul caso che mi riguarda,
è la mia condanna a morte, sostanzialmente avvallata dalla DC, la quale
arroccata sui suoi discutibili principi, nulla fa per evitare che un uomo,
chiunque egli sia, ma poi un suo esponente di prestigio, un militante fedele sia
condotto a morte. Un uomo che aveva chiuso la sua carriera con la sincera
rinuncia a presiedere il governo, ed è stato letteralmente strappato da
Zaccagnini (e dai suoi amici tanto abilmente calcolatori) dal suo posto di pura
riflessione e di studio, per assumere l'equivoca veste di presidente del partito
per il quale non esisteva un adeguato ufficio nel contesto di Piazza del Gesù.
Son più volte che chiedo a Zaccagnini di collocarsi lui idealmente al posto che
egli mi ha obbligato ad occupare. Ma egli si limita a dare assicurazioni al
presidente del consiglio che tutto sarà fatto come egli desidera. Possibile che
non vi sia una riunione statutaria e formale, quale che ne sia l'esito?
Possibile che non vi siano dei coraggiosi che la chiedono, come io la chiedo in
piena lucidità di mente? Centinaia di parlamentari volevano votare contro il
governo. Ed ora nessuno si pone il problema di coscienza? E ciò con la comoda
scusa che io sono un prigioniero. Si deprecano i lager, ma come si tratta,
civilmente, in Italia un prigioniero, che ha solo un vincolo esterno, ma
l'intelletto lucido? Chiedo a Craxi, se questo è giusto. Chiedo al mio partito,
ai tanti fedelissimi delle ore liete, se questo è ammissibile. Le altre riunioni
formali non le si vuol fare. E io ho il potere di convocare per data conveniente
e urgente il consiglio nazionale avendo per oggetto il tema circa i modi per
rimuovere gli impedimenti del suo presidente. Dovrebbe presiederlo per mia
delega l'On. Riccardo Misasi. Chiedo al capo dello Stato che tali organi,
previsti dalla costituzione, siano fatti funzionare. Non può esservi arbitrio in
queste cose. Sono attento a sentire i nomi e ad accogliere gli atteggiamenti. Se
poi nulla avverrà, dovrò affermare in pieno la responsabilità della DC ufficiale
e di quanti non si fossero da essa tempestivamente dissociati. E' noto che i
gravissimi problemi della mia famiglia sono la ragione fondamentale della mia
lotta contro la morte. (Le righe che seguono sono da rivedere a secondo
dell'utilità che possono avere per sua espressa opinione). E notò... k... contro
la morte. In tanti anni e in tante vicende i desideri sono caduti e lo spirito
si è purificati. E, pur vero con le mie tante colpe, credo di aver vissuto con
generosità nascoste e delicate intenzioni. Muoio, se così deciderà il mio
partito, nella pienezza della mia fede cristiana e nell'amore immenso per una
famiglia esemplare che io adoro e spero di vigilare dall'alto dei cieli. Proprio
ieri ho letto la tenera lettera di amore di mia moglie, dei miei figli,
dell'amatissimo nipotino, dell'altro che non vedrò. La pietà di chi mi recava la
lettera ha escluso i contorni che dicevano la mia condanna, se non avverrà il
miracolo del ritorno della DC a se stessa e la sua assunzione di responsabilità.
Ma questo bagno di sangue non andrà bene né per Zaccagnini, né per Andreotti, né
per la DC, né per il paese. Ciascuno porterà la sua responsabilità. Io non
desidero intorno a me, lo ripeto, gli uomini del potere. Voglio vicino a me
coloro che mi hanno amato davvero e continueranno ad amarmi e pregare per me. Se
tutto questo è deciso, sia fatta la volontà di Dio. Ma nessun responsabile si
nasconda dietro l'adempimento di un presunto dovere. Le cose saranno chiare,
saranno chiare presto. Segue firma...
74) A
Riccardo Misasi (non recapitata). Caro Riccardo, avendoti prescelto, solo per
l'antica amicizia e stima quale mio portavoce, si tratti poi del Consiglio
nazionale, o della Direzione del Partito, invio a te alcune considerazioni utili
per il dibattito, le quali però, a differenza delle altre, hanno carattere
confidenziale e non sono destinate alla pubblicazione. Ciò vuol dire che tu
richiamerai discretamente su di esse, a mio nome, l'attenzione degli
ascoltatori, ovviamente insieme alle altre argomentazioni sulle quali, per
essere state esse già pubblicate si potrà essere più netti e chiari. Mi pare
però ci sia qualche cosa che, nel foro interno, non è possibile ignorare. Oltre
ad essere parte in causa, quale Presidente pro-tempore del Consiglio Nazionale,
adempio con questi miei scritti la mia funzione di stimolo alla riflessione non
senza rilevare con disappunto che del mio primo scritto si è profilata una
specie di blocco o censura, che reputo inammissibili. Scorrendo rapidamente
qualche giornale in questi giorni, fra alcune cose false, assurde e francamente
ignobili, ho rilevato che andava riaffiorando la tesi (la più comoda) della mia
non autenticità e non credibilità. Moro insomma non è Moro, tesi nella quale si
sono lasciati irretire, come ho documentato, amici carissimi, ignari di
prestarsi ad una vera speculazione. Per qualcuno la ragione di dubbio è nella
calligrafia, incerta, tremolante, con un'oscillante tenuta delle righe. Il
rilievo è ridicolo, se non provocatorio. Pensa qualcuno che io mi trovi in un
comodo e attrezzato ufficio ministeriale o di partito? Io sono, sia ben chiaro
un prigioniero politico ed accetto senza la minima riserva, senza né pensiero,
né un gesto di impazienza la mia condizione. Pretendere però in queste
circostanze grafie cristalline e ordinate e magari lo sforzo di una copiatura,
significa essere fuori della realtà delle cose. Quello che io chiedo al partito
è uno sforzo di riflessione in spirito di verità. Perché la verità, cari amici,
è più grande di qualsiasi tornaconto. Datemi da una parte milioni di voti e
toglietemi dall'altra parte un atomo di verità, ed io sarò comunque perdente. Lo
so che le elezioni pesano in relazione alla limpidità ed obiettività dei giudizi
che il politico è chiamato a formulare. Ma la verità è la verità. E' per questo
che ho ascoltato (dirò poco) con sommo rammarico la reazione dell'On. Zucconi
alla nota proposta dell'On. Craxi. Si tratterebbe, cito a memoria, di una vana
caccia di voti delle sinistre democristiane. Del resto il dialogo di altri
esponenti politici con l'On. Craxi non è di maggior delicatezza. Ecco cosa
resta, in Parlamento, di un'iniziativa e politica insieme: la raccolta di
qualche centinaia di voti. Vogliamo, colleghi democristiani, alzarci un po' al
di sopra di queste cose? Vogliamo occuparci un po' meno di voti e più di umanità
e di politica? In un tema come questo gli argomenti sono quelli che sono, non si
possono moltiplicare. Ma quel che importa è che su di essi cada una seria
riflessione. C'è un punto di partenza politico, sul quale mi soffermerò un
momento con delicatezza. Perché non mi interessano le persone, ma la
concatenazione degli avvenimenti. Io non so che cosa sia avvenuto, come non so
tante altre cose, nei minuti tra il mio rapimento e la presentazione del Governo
alle Camere con l'enunciazione della c.d. linea rigida di difesa della
Costituzione (ma in che senso, poi?). Vi fu un fatto di rilevante gravità. La
circostanza che il Governo fosse appena formato, non senza qualche riserva,
autorizza a passare sopra al discorso dei fatti accaduti e delle conseguenti
responsabilità? Il servizio di scorta era di gran lunga al di sotto delle sue
esigenze operative. Il rapito, del resto trattato con rispetto, si trovava ad
essere il Presidente del Consiglio Naz. del Partito, carica, a mio avviso,
onorifica e ambigua, ma che, come i fatti dimostrano, aveva ingenerato in altri
l'impressione che si trattasse del personaggio chiave della politica italiana e,
per giunta, presunto candidato alla Presidenza della Repubblica (candidatura mai
accettata). Possibile che per questo personaggio il metodo tradizionale di
scorta palesemente insufficiente, non sia stato almeno ritoccato data la
particolarità delle circostanze? Possibile che questa strategia dipendesse da un
modesto funzionario? Possibile che tutti i personaggi che si consultarono sul
fatto del giorno, non abbiano almeno tenuto conto del fatto che la persona
sequestrata fosse persona di un certo rilievo nella vita del Partito e dello
Stato? In proposito vi fu, nel mio primo messaggio, qualche cauto accenno, il
quale per altro non fu né valutato né raccolto dai saggi che si avvicendarono ad
esprimere il loro consenso alla tesi intransigente. Insomma: poco fu fatto
prima, nulla fu fatto dopo. E questa è la base, francamente incredibile, del
rigore manifestatosi successivamente. Leggevo ieri una cosa ben chiara e netta
dell'on. Riccardo Lombardi. In sostanza così all'incirca ragiona l'anziano e
saggio parlamentare socialista, se i prigionieri in questa vicenda fossero
numerosi, e si ponesse per essi un problema di scambio, non v'è dubbio che lo
Stato tutelerebbe meglio i propri interessi (a parte i problemi umanitari)
accedendo allo scambio e non li tutelerebbe negandolo. Che cosa cambia in linea
di principio se il prigioniero è uno? Il che vuol dire che la persecuzione ad
ogni costo, in quella forma, dell'atto illecito, non risponderebbe ad una
ragione sostanziale. Nella sostanza, nel merito delle cose cioè sono le
circostanze che debbono indurre a valutare che cosa sia conveniente fare nel
rispetto della vita, nel rapporto tra detenzione ed uccisione, nella tutela dei
giusti interessi dello Stato, nel riconoscimento delle ragioni umanitarie. Ecco
perché queste cose sono e non possono essere disciplinate nel segno dello Stato
di necessità, salvo le ipotesi più semplici alle quali fa riferimento
saggiamente l'On. Craxi. La casistica, sulla quale più volte mi sono soffermato
è al riguardo altamente indicativa, dagli innumerevoli casi di salvezza di
ostaggi fino ai casi dei palestinesi di cui si è parlato. Del resto, senza
soffermarsi troppo su casi assai delicati e bisognosi di approfondimento, non si
può negare che taluni fenomeni, a differenza di altri, hanno carattere di
guerriglia con una propria fisionomia politica e giuridica, ponendo problemi che
proprio le attuali circostanze mettono in evidenza ed alla cui soluzione (e ci
si muove in questa direzione) non può essere estraneo il Comitato per la Croce
Rossa internazionale ed il cosiddetto diritto umanitario che è in elaborazione.
E quanto alla natura dei fatti basterà ricordare le vicende dell'Alto Adige. E
nella casistica cui accennavo si aggiunga il caso Lorenz nella stessa Germania.
I fatti sono dunque tanto chiari che il categorico rifiuto di prenderli in
considerazione in questo momento non può apparire che un partito preso, un
allineamento su posizioni esterne, una deformazione del volto umano dell'Italia.
Questa rigidezza non corrisponde alla linea politica della D.C., giunta
all'assurdo rifiuto della proposta Craxi. A questa deformazione la direzione
D.C. deve dire basta prima che il danno diventi ancor più grave e irreparabile.
(La lettera si interrompe così ed è priva di
firma e di seguito).
75) Frammento
(fogli non recapitati). (...) comprensibile ragione, con le cose serie. Quello
che io chiedo al Partito è uno sforzo serio di riflessione, in spirito di
verità. Perché la verità, cari amici, è più grande di qualsiasi tornaconto
elettorale. Datemi da una parte milioni di voti e toglietemi dall'altra parte un
atomo di verità ed io sarò comunque perdente. Lo so che le elezioni ci sono
purtroppo, e pesano (dico, per questo, purtroppo) in relazione alla limpidità ed
obiettività dei giudizi che il politico, in circostanze come queste, è chiamato
a formulare. E’ per questo che ho ascoltato (mi dispiace di non avere altra
parola da usare) con disgusto la reazione dell'On. Zucconi alla nota proposta
dell'On. Craxi. Si tratta, cito, a memoria, di una vana caccia di voti della
sinistra democristiana. Ecco, dunque, che cosa resta nel Parlamento italiano di
un'iniziativa umanitaria e politica insieme: la caccia a qualche decina o
centinaia di voti. Del resto il dialogo tra l'On. Craxi e altri esponenti
politici è ugualmente delicato. Vogliamo colleghi democristiani, alzarci un po'
al di sopra di queste cose? Vogliamo occuparci un po' meno di voti e più invece
di umanità e di politica? Se il Consiglio non sapesse farlo, esso sarebbe
fallito. Che miserabile immagine di una nuova D.C. (di cui è alfiere Zucconi) ne
verrebbe fuori! In un tema come questo non è che gli argomenti possano essere
moltiplicati a dismisura. Essi ci sono, sono stati enunciati, possono essere
sviluppati ed integrati, ma quel che è essenziale è che su essi cada la più
seria riflessione, senza affidarsi al caso. Ed il discorso deve cominciare in
sede politica, benché la cosa sia spiacevole, dalla responsabilità per quel che
è avvenuto, non dal da farsi (più o meno bene) visto che talune cose gravi e
preoccupanti sono avvenute. Sia ben chiaro che io non intendo infierire contro
la persona…(Fogli non rinvenuti tra quelli della lettera a Misasi.
Probabilmente si tratta di un frammento di lettera) (La
lettera è tronca).
76) A
Elio Rosati (non recapitata). Mio carissimo Elio, non solo per l'antica e cara
amicizia che ti porto, ma per istintiva intuizione ho pensato a te, mano a mano
che andavo considerando, giorno per giorno, la situazione ed, in essa, da un
lato la mia, dall'altro quella della D.C.. Del poco che so, so almeno questo,
che fedele al tuo costume, non hai avuto incertezze e paure hai rifiutato il
conformismo ed il quieto vivere, ti sei impegnato con una posizione autonoma,
quando altri si andavano imbrancando acriticamente sotto il pretesto
dell'interesse di partito e di una unità malintesa, della D.C. Oggi quello che
si nota è la mancanza di coraggio e questo fa sì che il nostro appaia un partito
acritico, tutto arroccato su una medesima posizione. E tu sai che questo non è
invece mai avvenuto e che la dialettica è stata aperta tra noi. Ebbene, oggi tu
rimani pressoché solo ad adempiere questo compito essenziale, tu rimani solo a
rompere il ghiaccio. Ma sai pure, che sotto la scorza dell'indifferenza e del
conformismo, una parte notevole della base democristiana ripugna profondamente
alla mia attuale condizione ed al grosso rischio che essa comporta. Nessuno
parla, ma molti temono. Ed io credo che se uno alzasse la sua voce, una voce
limpida, come la tua, proprio in questi giorni che coincidono con una grossa
riunione della Direzione DC, le voci di consenso, sensibili, anche se forse non
maggioritarie, non mancherebbero. Io non vedo altri che te che possa dire questa
parola e guidare, al massimo possibile insieme con Misasi, un movimento di
opinione pubblica che bilanci le ferree esigenze di regime che si esprimono
sulla stampa. Bisogna parlare subito, alto, forte, con chiarezza, utilizzando la
stampa anche settimanale e, ovviamente, tenendo d'occhio l'andamento della
Direzione sulla quale non mi faccio però soverchie illusioni. Poiché si tratta
di problemi di coscienza (e nessuna è più limpida della tua), desidero dirti,
per così dire, solennemente che la proposta di scambio od altra simile, specie
se attuata immediatamente, sarebbe stata la meno onerosa per la D.C. Aggiungo
che tutte le altre saranno forzatamente più onerose e sarebbero perciò da
evitare, se prevalesse, come dovrebbe prevalere, il buon senso. Tutto quello che
farai nei prossimi giorni, con la forza della disperazione, (e cerca di farlo
capire agli altri) è il meglio per la D.C., è un salto di salvezza su di un
abisso. Non ti dico altro, perché so che tu capisci per immediata intuizione. Mi
auguro tanto che tu riesca, associando tutte le altre forze disponibili. Perché
tanti amici sono diventati così timidi: se fossero insieme quelli sui quali
abbiamo sempre contato, la partita sarebbe vinta. Il silenzio è un delitto. Che
c'è di male chiedere la salvezza di un amico quando, oltretutto, altrimenti, si
corre un rischio mortale? Datti da fare dunque come avrai già fatto. Non si
parli di elezioni. Nelle condizioni presenti, pagheremmo un prezzo estremamente
alto. Grazie per quanto farai, parlando in giro e nei corridoi delle camere,
raccogliendo firme, rilasciando interviste. Ricordami ai tuoi ed abbiti il più
cordiale abbraccio. Tuo Aldo. P.S. Anche gli amici di Bari hanno attenuato la
loro voce per presunte ragioni elettorali. Dì loro che rischiano di essere
puniti ben più gravemente, che se avessero detto che intendevano salvare un
vecchio amico per ragioni umanitarie. On. Elio Rosati.
77) A
Corrado Guerzoni (non recapitata). Guerzoni, Telefonare a Bottai, per chiedere
se Cottafavi ha notizie dell'esito del mio appello a Waldheim e che cosa conta
di fare. Dell'esito della telefonata Lei si tenga informato, in modo che, a
momento opportuno, si possa sapere qualche cosa. M.
78) A
Giuseppe Saragat (non recapitata). Caro Saragat, desidero ringraziarti nel modo
più vivo per le alte e nobili parole con le quali hai voluto esprimermi la tua
comprensione e solidarietà. Questo tuo atteggiamento è in linea con
l'ispirazione umanitaria che ha qualificato e qualifica la tua figura nella
politica italiana. Tutto ciò mi conforta e mi incoraggia molto nella
difficilissima prova. Grazie ancora e cordialissimi saluti ed auguri. Tuo Aldo
Moro. Sen. Giuseppe Saragat. Palazzo Madama.
79) A
Corrado Guerzoni (non recapitata). Indicazioni per Guerzoni con infiniti
ringraziamenti distribuire, senza fretta, le mie lettere a mia moglie e Sen.
Saragat. ricercare con urgenza l'on. Riccardo Misasi che dovrebbe essere alla
Commissione Giustizia della Camera o Piazza del Gesù o Gruppo Parlamentare. La
prima è la più probabile. Sappia che egli è il mio portavoce e deve mettere in
moto la Direzione. Dargli copia dei miei tre scritti, l'ultimo, come si legge,
dovrebbe essere destinato a riferimento orale senza pubblicazione. Se però
l'andamento della Direzione, Dio non voglia, fosse davvero deludente e
preclusivo di positivi sviluppi, Lei potrà allora diramare alla stampa il testo
dopo averne lealmente informato Misasi. Il punto delicato, come si intende, è il
comportamento del Ministro, di cui non vorrei forzare le dimissioni, poiché
preferisco soluzioni costruttive. Ma se l'atteggiamento altrui mi obbliga non ho
scelta. Grazie tante ed i più affettuosi saluti. Aldo Moro. Gira ./. Aggiungo
una lettera appello per Elio Rosati, che è la persona che più amo e stimo.
Anch'essa è urgente anzi urgentissima per una mobilitazione dell'opinione
pubblica che finora è mancata. Dispiace molto questo scarso rispetto della
verità e, poi, dell'utilità del Partito. A parte i membri del Governo, la cui
posizione è particolare (ma che potrebbero ispirare altri), ce n'è altri da
recuperare. Freato ci riesce almeno un po'? E' possibile far capire che quello
che si propone ed ora si respinge è il meglio per la D.C. e sarà rimpianto tra
pochissimi giorni? Che pensa dell'iniziativa di Craxi? Ha uno spessore? Freato
riesce a pilotare Signorile? Affettuosamente. Aldo Moro. Non so l'indirizzo di
Rosati. O è alla Camera o in casa non lontano dalla mia. Forse Freato lo conosce
o può conoscere.
80) A
Eleonora Moro (non recapitata). Mia carissima Noretta, vi sono molto vicino e
gratissimo agli amici che, come vedo, vi confortano vi aiutano. Io
discretamente. Mi spiace vedere la tua foto sulla stampa con atteggiamento così
provato. Che Iddio ci aiuti. Mi pare che le parole rivolte al Partito siano
riuscite vere ed efficaci. Speriamo che portino un salutare ripensamento ed una
giusta discussione sulla quale si sia, com’è naturale, più sereni. Vi abbraccio
tutti dal profondo del cuore. Aldo Moro. PS: Fai, ti prego, al più alto livello
un ultimo sforzo con il Papa per una soluzione mediatrice. Non puoi immaginare
quanto sia più costruttiva. Prego la Provvidenza di ispirarlo e di spiegargli
con umiltà profondissima di non respingere questa mia. Il danno sarà
grandissimo. E’ un dovere di coscienza. Pignedoli? Poletti?
81) A
Benigno Zaccagnini (non recapitata). Zaccagnini, ti scongiuro. Fermati, in nome
di Dio. Fin qui mi hai sempre ascoltato. Perché ora vuoi fare di tua testa. Non
sai. Non ti rendi conto di quale grande male tu stia preparando al Partito.
Finché sei ancora in tempo, poche ore, fermati e prendi la strada onesta di una
trattativa ragionevole. Che Dio ti assista. Aldo Moro.
82) A
Benigno Zaccagnini (non recapitata). Caro Zaccagnini, ecco, sono qui per
comunicarti la decisione cui sono pervenuto nel corso di questa lunga e
drammatica esperienza ed è di lasciare in modo irrevocabile la Democrazia
Cristiana. Sono conseguentemente dimissionario dalle cariche di membro e
presidente del Consiglio Nazionale e di componente la Direzione Centrale del
Partito. Escludo ovviamente candidature di qualsiasi genere nel futuro. Sono
deciso a chiedere al Presidente della Camera, appena potrò, di trasferirmi dal
Gruppo Parlamentare della D.C. al Gruppo Misto. E' naturale che aggiunga qualche
parola di spiegazione. Anzi le parole dovrebbero essere molte, data la
complessità della materia, ma io mi sforzerò di ridurle al minimo, cominciando,
com'è ovvio, dalle più semplici. Non avendo mai pensato, anche per la feroce
avversione di tutti i miei familiari, alla Presidenza della Repubblica, avevo
immaginato all'inizio di legislatura di completare quella in corso come un
vecchio al quale qualche volta si chiedono dei consigli e con il quale si ama
fare un commento sulle cose, che l'età ed il personale disinteresse rendono,
forse, obiettivo. Come più volte ti ho detto, fosti tu a deviare questo corso
delle cose, mentre furono ancora tuoi amici che fecero riserve, sempre
nell'illusione che io dovessi dare ancora qualche cosa al Partito, non appena si
accennò ad una presidenza di Assemblea, per concludere in tal modo la mia
attività politica. Così mi sono trovato in un posto difficile e ambiguo, che
dava all'esterno la sensazione di un predominio (inesistente) della D.C. ed
all'interno creava imbarazzi, gelosie, equivoci, timori. Essendoci lasciati in
ottima intesa la sera del martedì, già pochi giorni dopo, qui dove sono, avevo
la sensazione di avervi in qualche modo liberato e che io costituissi un peso
per voi non per il fatto di non esserci, ma piuttosto per il fatto di esserci. E
questo per ragioni obiettive, perché non c'è posto, accanto al Segretario
Politico eletto dal Congresso, per un Presidente del Partito che abbia rispetto
di sé e delle cose. E se il vostro profondo pensiero coincideva con quello che
io avevo fatto valere, perché non accontentarci tutti in una volta? Aggiungerò
poi (e questo va al di là della Presidenza del Consiglio Nazionale di cui
abbiamo parlato sin qui) che io non ho compreso e non ho approvato la vostra
dura decisione, di non dar luogo a nessuna trattativa umanitaria, anche
limitata, nella situazione che si era venuta a creare. L'ho detto cento volte e
lo dirò ancora, perché non scrivo sotto dettatura delle Brigate Rosse, che,
anche se la lotta è estremamente dura, non vengono meno mai, specie per un
cristiano, quelle ragioni di rispetto delle vittime innocenti ed anche, in
alcuni casi, di antiche sofferenze, le quali, opportunamente bilanciate e con il
presidio di garanzie appropriate, possono condurre appunto a soluzioni umane.
Voi invece siete stati non umani, ma ferrei, non attenti e prudenti, ma ciechi.
Con l'idea di far valere una durissima legge, dalla quale vi illudete di
ottenere il miracoloso riassetto del Paese, ne avete decisa fulmineamente
l'applicazione, non ne avete pesato i pro e i contro, l'avete tenuta ferma
contro ogni ragionevole obiezione, vi siete differenziati, voi cristiani, dalla
maggior parte dei paesi del mondo, vi siete probabilmente illusi che l'impresa
sia più facile, meno politica, di quanto voi immaginate, con il vostro irridente
silenzio avete offeso la mia persona, e la mia famiglia, con l'assoluta mancanza
di decisioni legali degli organi di Partito avete menomato la democrazia che è
la nostra legge, irreggimentando in modo osceno la D.C., per farla incapace di
dissenso, avete rotto con la tradizione più alta della quale potessimo andar
fieri. In una parola, l'ordine brutale partito chissà da chi, ma eseguito con
stupefacente uniformità dai Gruppi della D.C., ha rotto la solidarietà tra noi.
In questa (cosa grossa, ricca di implicazioni) io non posso assolutamente
riconoscermi, rifiuto questo costume, questa disciplina, ne pavento le
conseguenze e concludo, semplicemente, che non sono più democratico cristiano.
Essendo scontata in ogni caso dal momento del mio rapimento (e della vostra
mistica inerzia) il mio abbandono della Direzione e del Consiglio Nazionale,
restava, se il vostro comportamento fosse stato diverso e più costruttivo, la
possibilità della mia permanenza senza alcun incarico nella famiglia democratica
cristiana e che è stata mia per trentatré anni. Oggi questo è impossibile,
perché mi avete messo in una condizione impossibile. E perciò il mio ritiro da
semplice socio della D.C. è altrettanto serio, rigido ed irrevocabile quanto lo
è il mio abbandono dalle cariche nelle quali avevamo creduto di poter lavorare
insieme. Tutto questo è finito, è assolutamente finito. Ed ora che posso
parlare, senza che nessuno pensi ad una pretesa di successione, a parte il mio
durissimo giudizio sul Presidente del Consiglio e su tutti coloro che hanno
gestito in modo assolutamente irresponsabile questa crisi, c'è, per dovere di
sincerità ed antica appannata amicizia, la valutazione su di te, come, per così
dire, il più fragile Segretario che abbia avuto la D.C., incapace di guidare con
senso di responsabilità il partito e di farsi indietro quando si diventa
consapevoli, al di là della propaganda, di questa incapacità. Guidare e non
essere guidato è il compito del Segretario del più grande partito italiano.
Giunti a questo punto, i motivi di dissenso, che non ci faranno incontrare più,
sono evidentemente molti. Tu non penserai che possa trattarsi solo del modo
chiuso e retrivo che ha caratterizzato il vostro comportamento in questa
vicenda, nella quale vi sembrerà di avere conseguito chissà quale straordinario
successo. Questa è una spia, la punta dell'iceberg, ma il resto è sotto. Ho
riflettuto molto in queste settimane. Si riflette guardando forme nuove. La
verità è che parliamo di rinnovamento e non rinnoviamo niente. La verità è che
ci illudiamo di essere originali e creativi e non lo siamo. La verità è che
pensiamo di fare evolvere la situazione con nuove alleanze, ma siamo sempre là
con il nostro vecchio modo di essere e di fare, nell'illusione che, cambiati gli
altri, l'insieme cambi e cambi anche il Paese, come esso certamente chiede di
cambiare. Ebbene, caro Segretario, non è così. Perché qualche cosa cambi,
dobbiamo cambiare anche noi. E, a parte il fatto che davvero altri (socialisti
ieri, comunisti oggi) siano in grado di realizzare una svolta in accordo con noi
- il che possiamo augurarci e sperare - la D.C. è ancora una così gran parte del
Paese, che nulla può cambiare, se anch'essa non cambia. E per cambiare non
intendo la moralizzazione, l'apertura del Partito, nuovi e più aperti indirizzi
politici. Si tratta di capire ciò che agita nel profondo la nostra società, la
rende inquieta, indocile, irrazionale, apparentemente indominabile. Una società
che non accetti di adattarsi a strategie altrui, ma ne voglia una propria in un
limpido disegno di giustizia, di eguaglianza, di indipendenza, di autentico
servizio dell'uomo. Ecco tutto. Benché sia pessimista, io mi auguro che facciate
più di quanto osi sperare. Non era questa la conclusione cui avevo pensato né
l'addio immaginato per te ed i colleghi. Ma le cose sono così poco nelle nostre
mani, specie se esse sono troppo deboli o troppo forti. Che Iddio ti aiuti ed
aiuti il Paese. Cordialmente. Aldo Moro.
83) A
Benigno Zaccagnini (non recapitata). Caro Zaccagnini, la lunga e tormentata
vicenda della mia prigionia presso le Brigate Rosse pone dei problemi ai quali è
doveroso e sempre più urgente rispondere. Mi riferisco all'atteggiamento di
totale indifferenza assunto dal Partito nei confronti della mia persona e della
mia famiglia, la quale paga un prezzo altissimo per un modo di fare che non ha
assolutamente precedenti nella D.C.. Quest'ultima è venuta incontro, più o meno,
alle necessità che premevano sui suoi associati, ma mai, come in questo caso, è
restata del tutto fuori da una vicenda gravissima, delicatissima e per la quale
non era certo priva di mezzi d'intervento. Si poteva fare, solo che si fosse
voluto rimuovere una inconsistente pregiudiziale, ed invece non si è fatto. Il
culto esasperato del rispetto della legalità formale ha reso rigidi e
insensibili, ha ridotto ad essere soffocante, come mai era stata, la disciplina
di partito, ha tolto ogni libertà di ragionevole movimento, ed ha sacrificato,
con me e con la mia famiglia, quelle ragioni umanitarie che militano a favore,
oltre che di vittime innocenti, ma anche di persone condannate le cui condizioni
di salute e di vita abbisognano di particolare cura e per le quali si offre
l'ospitalità, caritatevole o amichevole, di un paese straniero. Questi sono i
principi sanciti nella nostra coscienza civile, e nei paesi più evoluti non
manca mai una giusta considerazione di ragioni umanitarie, siano esse
prevalenti, di volta in volta, per le vittime innocenti o per persone ormai
condannate. Io pensavo che, al di là della mia persona sofferente ed in
pericolo, in un partito d'ispirazione cristiana a queste cose non si potesse
guardare con indifferenza. E proprio mentre i socialisti, sia pure in modo
incompiuto, si fanno carico di cose delle quali ben prima proprio i cristiani
dovevano avere la maggiore sensibilità. Da qui un profondo stupore ed un
profondo disagio. Certo l'impresa portata a termine dalle Brigate Rosse è di
notevole rilievo politico: ma è pur vero che essa pone in luce quei problemi
umanitari dei quali parlavo innanzi e dei quali né il partito, né tu potete
assolutamente disinteressarvi. Ed invece ve ne disinteressate con sfacciato
cinismo, essendo del resto in buona compagnia. Mi stupisco del fatto che così si
manifesti la tua sensibilità umana e cristiana. Questo, a prescindere da tante
altre cose, per gli aspetti personali e per quelli obiettivi, è un capitolo
importante, ed altamente deludente, dei miei rapporti con la D.C. Questo disagio
di fondo l'ho capito ogni giorno di più, questa incomprensione, questa diversità
tra noi diventano ogni giorno più vistose, rendendomi impossibile di ritrovarmi
con gli antichi amici con la scioltezza e la naturalezza di sempre. Questa
irremovibile intolleranza, che nasce, sia ben chiaro, da un fatto morale più che
politico mi induce a questo punto a rendere formali le mie dimissioni dal
Partito, intendo non solo dalle cariche, comprese quelle ipotetiche e future, ma
proprio dal corpo, dalla famiglia della D.C. Passerò perciò, per la durata della
legislatura al Gruppo Misto. Dopo tanti anni di amicizia, che ha sofferto
anch'essa di questa crisi ci troviamo su posizioni estremamente lontane ed
incongiungibili. Stranamente vedo in te quell'arroganza del potere che abbiamo
tante volte lamentato in altri e che, ricordalo, il paese sente con crescente
insofferenza, senza che possa essere questa assurda gara di resistenza nello
sbarazzarci di ogni ragione umanitaria a farcelo perdonare. Sia dunque ben
chiaro, perché non vi siano equivoci, che non si pone solo il problema della mia
persona per quel che poco significa per la D.C., ma il problema oggetto del modo
di reagire con senso cristiano e democratico di fronte a situazioni di obiettivo
pericolo e che richiedono interventi umanitari. Ritengo dunque sbagliata e
urtante la linea del partito che hai assunto e che incautamente si è fatto in
modo che tu assumessi. La colpa è grave in entrambi i casi. Siamo guidati male,
in modo insicuro e non coerente ai principi. Ma in un travaglio così complesso
non sono solo queste le ragioni della mia decisione. (La
lettera si interrompe senza conclusione).
84) A
Eleonora Moro (non recapitata). A Noretta, la lettera di dimissioni a Zaccagnini
è da spedire o rendere pubblica a giudizio concorde tuo, di Freato, Rana e
Guerzoni. Credo ci sia una buona uscita dell'Università.
85) A
Eleonora Moro (recapitata il 5 maggio). Ora, improvvisamente, quando si
profilava qualche esile speranza, giunge incomprensibilmente l'ordine di
esecuzione. Noretta dolcissima, sono nelle mani di Dio e tue. Prega per me,
ricordami soavemente. Carezza i piccoli dolcissimi, tutti. Che Iddio vi aiuti
tutti. Un bacio di amore a tutti. Aldo.
86) A
Eleonora Moro (recapitata il 5 maggio). Tutto sia calmo. Le sole reazioni
polemiche contro la D.C. Luca no al funerale. Mia dolcissima Noretta, dopo un
momento di esilissimo ottimismo, dovuto forse ad un mio equivoco circa quel che
mi si veniva dicendo, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Non mi pare il
caso di discutere della cosa in sé e dell'incredibilità di una sanzione che cade
sulla mia mitezza e la mia moderazione. Certo ho sbagliato, a fin di bene, nel
definire l'indirizzo della mia vita. Ma ormai non si può cambiare. Resta solo di
riconoscere che tu avevi ragione. Si può solo dire che forse saremmo stati in
altro modo puniti, noi e i nostri piccoli. Vorrei restasse ben chiara la piena
responsabilità della D.C. con il suo assurdo ed incredibile comportamento. Essa
va detto con fermezza così come si deve rifiutare eventuale medaglia che si
suole dare in questo caso. E' poi vero che moltissimi amici (ma non ne so i
nomi) o ingannati dall'idea che il parlare mi danneggiasse o preoccupati delle
loro personali posizioni, non si sono mossi come avrebbero dovuto. Cento sole
firme raccolte avrebbero costretto a trattare. E questo è tutto per il passato.
Per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi, il ricordo
di tutti e di ciascuno, un amore grande grande carico di ricordi apparentemente
insignificanti e in realtà preziosi. Uniti nel mio ricordo vivete insieme. Mi
parrà di essere tra voi. Per carità, vivete in una unica casa, anche Emma se è
possibile e fate ricorso ai buoni e cari amici, che ringrazierai tanto, per le
vostre esigenze. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi,
capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue
mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono
le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto ed
a te e tutti un caldissimo abbraccio pegno di un amore eterno. Vorrei capire,
con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce,
sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e tienimi stretto. Bacia e
carezza Fida, Demi, Luca (tanto tanto Luca), Anna, Mario, il piccolo non nato,
Agnese Giovanni. Sono tanto grato per quello che hanno fatto. Tutto è inutile,
quando non si vuole aprire la porta. Il Papa ha fatto pochino: forse ne avrà
scrupolo (La lettera appare incompiuta e priva di
firma.
ALDO MORO E LO SPARTITISMO.
NON VI REGGO PIU’.
Il testo più esplicito e
diretto di Rino dà il titolo all'album uscito nel 1978.
"Nuntereggaepiù" è un
brillante catalogo dei personaggi che invadono radio, televisioni e giornali.
Clamorosa la coincidenza con quello che succederà nel 1981, quando la
magistratura scopre la lista degli affiliati alla P2 di Licio Gelli, loggia
massonica in cui compaiono alcuni nomi citati nella filastrocca di Rino.
A dispetto del titolo, nel
brano non c'è un briciolo di reggae. Il titolo gioca sull'assonanza fra il
genere musicale giamaicano e la coniugazione romanesca del verbo reggere. Come
già era accaduto in "Mio fratello è figlio unico", il finale è dissonante
rispetto al tema trattato, con l'introduzione di una frase d'amore:
" E allora amore mio ti amo
Che bella sei
Vali per sei
Ci giurerei. "
È uno sfottò come un altro per
dire: "Vabbè, visto che vi ho detto tutte 'ste cose, visto che tanto la canzone
non fa testo politico, la canzone non è un comizio, il cantautore non è
Berlinguer né Pannella, allora a questo punto hanno ragione quelli che fanno
solo canzoni d'amore..". Possiamo immaginare che, oggi, sarebbero entrati di
diritto nella filastrocca Umberto Bossi o Antonio Di Pietro per la politica,
Fabio Fazio e Maria De Filippi o il Grande Fratello per la tivvù, calciatori
super pagati come Totti, Vieri e Del Piero e chissà quante altre invadenti
presenze del nostro quotidiano destinate a ronzarci intorno per altri vent'anni.
Quando incide la versione spagnola, che in ottobre scala le classifiche
spagnole, "Corta el rollo ya" ("Dacci un taglio”), inserisce personaggi di
spicco dell'attualità iberica, come il politico Santiago Carrillo, il calciatore
Pirri (che più avanti sarà vittima di un rapimento), la soubrette Susana Estrada
e altri. Qui sta la grandezza di Rino Gaetano, se leggete oggi il testo di "Nun
te reggae più" vi accorgerete che i personaggi citati sono quasi tutti ancora
sulla breccia e, se scomparsi o ritirati dalla vita pubblica, hanno lasciato un
segno indelebile nel loro campo, si pensi a Gianni Brera o all'avvocato Agnelli,
o a Enzo Bearzot che, un anno dopo la dipartita del cantautore calabrese,
regalerà con la sua nazionale (Causio, Tardelli, Antognoni) il terzo mondiale di
calcio dopo quarantaquattro anni.
Abbasso e Alè (nun te reggae
più)
Abbasso e Alè (nun te reggae
più)
Abbasso e Alè con le canzoni
senza patria o soluzioni
La castità (Nun te reggae più)
La verginità (Nun te reggae
più)
La sposa in bianco, il maschio
forte,
i ministri puliti, i buffoni
di corte
..Ladri di polli
Super-pensioni (Nun te reggae
più)
Ladri di stato e stupratori
il grasso ventre dei
commendatori,
diete politicizzate,
Evasori legalizzati, (Nun te
reggae più)
Auto blu, sangue blu,
cieli blu, amori blu,
Rock & blues (Nun te reggae
più!)
Eja-eja alalà, (Nun te reggae
più)
DC-PSI (Nun te reggae più)
DC-PCI (Nun te reggae più)
PCI-PSI, PLI-PRI
DC-PCI, DC DC DC DC
Cazzaniga, (nun te reggae più)
avvocato Agnelli,
Umberto Agnelli,
Susanna Agnelli, Monti
Pirelli,
dribbla Causio che passa a
Tardelli
Musiello, Antognoni,
Zaccarelli.. (nun te reggae più)
..Gianni Brera,
Bearzot, (nun te reggae più)
Monzon, Panatta, Rivera,
D'Ambrosio
Lauda, Thoeni, Maurizio
Costanzo, Mike Bongiorno,
Villaggio, Raffà e Guccini..
Onorevole eccellenza
Cavaliere senatore
nobildonna, eminenza
monsignore, vossia
cheri, mon amour!.. (Nun te
reggae più!)
Immunità parlamentare (Nun te
reggae più!)
abbasso e alè!
Il numero cinque sta in
panchina
si e' alzato male stamattina
– mi sia consentito dire: (nun
te reggae più!)
Il nostro è un partito serio..
(certo!)
disponibile al confronto
(..d'accordo)
nella misura in cui
alternativo
alieno a ogni compromess..
Ahi lo stress
Freud e il sess
è tutto un cess
si sarà la ress
Se quest'estate andremo al
mare
soli soldi e tanto amore
e vivremo nel terrore
che ci rubino l'argenteria
è più prosa che poesia...
Dove sei tu? Non m'ami più?
Dove sei tu? Io voglio, tu
Soltanto tu, dove sei tu? (Nun
te reggae più!)
Uè paisà (..Nun te reggae più)
il bricolage,
il '15-18, il prosciutto
cotto,
il '48, il '68, le P38
sulla spiaggia di Capo Cotta
(Cardin Cartier Gucci)
Portobello, illusioni,
lotteria, trecento milioni,
mentre il popolo si gratta,
a dama c'è chi fa la patta
a sette e mezzo c'ho la
matta..
mentre vedo tanta gente
che non ha l'acqua corrente
e nun c'ha niente
ma chi me sente? ma chi me
sente?
E allora amore mio ti amo
che bella sei
vali per sei
ci giurerei
ma è meglio lei
che bella sei
che bella lei
vale per sei
ci giurerei
sei meglio tu
nun te reg più
che bella si
che bella no
nun te reg più!
NUN TE REGGAE PIÙ, NUN TE
REGGAE PIÙ, NUN TE REGGAE PIÙ...
LA LIBERTA' Giorgio Gaber
(1972)
Vorrei essere libero, libero
come un uomo.
Vorrei essere libero come un
uomo.
Come un uomo appena nato che
ha di fronte solamente la natura
e cammina dentro un bosco con
la gioia di inseguire un’avventura,
sempre libero e vitale, fa
l’amore come fosse un animale,
incosciente come un uomo
compiaciuto della propria libertà.
La libertà non è star sopra un
albero,
non è neanche il volo di un
moscone,
la libertà non è uno spazio
libero,
libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero
come un uomo.
Come un uomo che ha bisogno di
spaziare con la propria fantasia
e che trova questo spazio
solamente nella sua democrazia,
che ha il diritto di votare e
che passa la sua vita a delegare
e nel farsi comandare ha
trovato la sua nuova libertà.
La libertà non è star sopra un
albero,
non è neanche avere
un’opinione,
la libertà non è uno spazio
libero,
libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un
albero,
non è neanche il volo di un
moscone,
la libertà non è uno spazio
libero,
libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero
come un uomo.
Come l’uomo più evoluto che si
innalza con la propria intelligenza
e che sfida la natura con la
forza incontrastata della scienza,
con addosso l’entusiasmo di
spaziare senza limiti nel cosmo
e convinto che la forza del
pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un
albero,
non è neanche un gesto o
un’invenzione,
la libertà non è uno spazio
libero,
libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un
albero,
non è neanche il volo di un
moscone,
la libertà non è uno spazio
libero,
libertà è partecipazione.
“LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE”
– Dal
testo di Gaber alla realtà che ci circonda.
Così cantava il mitico Gaber
in una delle sue canzoni “La libertà non è star sopra un albero, non è
neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è
partecipazione.” Come rispondereste alla domanda “chi è colui che può
definirsi libero?”, certamente molti diranno subito “colui che può
fare ciò che vuole, esprimere le proprie opinioni, manifestare la
propria fede e via discorrendo” … invece non proprio. Non proprio perché
questa sarebbe anarchia o per lo meno la rasenterebbe; per capire meglio il
significato di tale termine, allora, prendiamo in esame la frase di Gaber
libertà è partecipazione: partecipare, filologicamente inteso significa
“essere parte di …” e quindi essere inseriti in un dato contesto. Libertà
non è dunque dove non esistono limitazioni ma bensì dove queste vigono in
maniera armoniosa e, naturalmente, non oppressiva. Posso capire che la cosa
strida a molti ma se analizzata in maniera posata si potrà evincere come una
società senza regole sia l’antitesi di sé stessa. Dove sta la
libertà, allora? Innanzitutto comincerei parlando di rispetto:
rispetto per l’altro, per le sue idee, per la sua persona:
se non ci rispettiamo vicendevolmente non otterremo mai un vivere civile e
quindi alcuna speranza di libertà. La libertà è un diritto innegabile.
Chi ha il diritto di stabilire quali libertà assegnare a chi?
Pensiamo agli schiavi di ieri e , purtroppo, anche di oggi: perché negare loro
le libertà? Per la pigrizia di chi gliele nega, chiaramente; su questo si basa
il rapporto padrone-schiavo (anche quello hegeliano del servo-padrone), sulla
forza ed il terrore, terrore non dell’asservito ma del servito. Dall’Antichità
al Medioevo, dal Rinascimento ad oggi gli uomini hanno sempre tentato di
esercitare la propria egemonia sugli altri, secondo diritti divini, di nobiltà
di natali, tramite l’ostentazione della propria condizione economica e via
discorrendo, falciando così in pieno il diritto alla libertà di alcuni.
“Libertà è partecipazione”, tale frase continua a ronzarmi in testa e mi sprona
ad esortare: rispettiamoci per essere liberi… a tali parole mi sovviene la
seconda strofa del nostro inno nazionale (di cui pochi, ahime, conoscono
l’esistenza, poiché molti ritengono che il nostro inno sia costituito d’una sola
strofa):
“Noi
fummo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popolo,
perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l’ora suonò.”
e quindi l’invito della terza
strofa: “Uniamoci, amiamoci”
Dignità,
rispetto dell’altro, partecipazione, lievi
seppur necessarie limitazioni: questi sono gli ingredienti per un’ottima
ricetta di libertà, non certo paroloni da politicanti come “lotta alla
criminalità”, “lotta all’evasione fiscale”, “lotta alle cricche”, giusto
per citare le più quotate in questi ultimi tempi. La libertà necessita di
semplicità, non certo di pompose cerimonie: essa è bella come una ragazza a
quindici-sedici anni (o per lo meno, rifacendomi allo Zibaldone
leopardiano), tutta acqua e sapone e sempre con un sorriso gentile pronto
per tutti. Forse è anche per questo che gli uomini raffigurano la Libertà come
una giovane donna…!
IO SE FOSSI DIO di Giorgio
Gaber – 1980
Io se fossi Dio
E io potrei anche esserlo
Se no non vedo chi.
Io se fossi Dio non mi farei
fregare dai modi furbetti della gente
Non sarei mica un dilettante
Sarei sempre presente
Sarei davvero in ogni luogo a
spiare
O meglio ancora a criticare,
appunto
Cosa fa la gente.
Per esempio il cosiddetto uomo
comune
Com'è noioso
Non commette mai peccati
grossi
Non è mai intensamente
peccaminoso.
Del resto poverino è troppo
misero e meschino
E pur sapendo che Dio è il
computer più perfetto
Lui pensa che l'errore
piccolino
Non lo veda o non lo conti
affatto.
Per questo io se fossi Dio
Preferirei il secolo passato
Se fossi Dio rimpiangerei il
furore antico
Dove si amava, e poi si odiava
E si ammazzava il nemico.
Ma io non sono ancora nel
regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei
vostri sfaceli.
Io se fossi Dio
Non sarei mica stato a
risparmiare
Avrei fatto un uomo migliore.
Si, vabbè, lo ammetto
non mi è venuto tanto bene
ed è per questo, per predicare
il giusto
che io ogni tanto mando giù
qualcuno
ma poi alla gente piace
interpretare
e fa ancora più casino.
Io se fossi Dio
Non avrei fatto gli errori di
mio figlio
E specialmente sull'amore
Mi sarei spiegato un po'
meglio.
Infatti voi uomini mortali per
le cose banali
Per le cazzate tipo
compassione e finti aiuti
Ci avete proprio una bontà
Da vecchi un po'
rincoglioniti.
Ma come siete buoni voi che il
mondo lo abbracciate
E tutti che ostentate la
vostra carità.
Per le foreste, per i delfini
e i cani
Per le piantine e per i
canarini
Un uomo oggi ha tanto amore di
riserva
Che neanche se lo sogna
Che vien da dire
Ma poi coi suoi simili come fa
ad essere così carogna.
Io se fossi Dio
Direi che la mia rabbia più
bestiale
Che mi fa male e che mi
porta alla pazzia
È il vostro finto impegno
È la vostra ipocrisia.
Ce l'ho che per salvare la
faccia
Per darsi un tono da cittadini
giusti e umani
Fanno passaggi pedonali e poi
servizi strani
E tante altre attenzioni
Per handicappati sordomuti e
nani.
E in queste grandi città
Che scoppiano nel caos e nella
merda
Fa molto effetto un pezzettino
d'erba
E tanto spazio per tutti i
figli degli dèi minori.
Cari assessori, cari furbastri
subdoli altruisti
Che usate gli infelici con
gran prosopopea
Ma io so che dentro il vostro
cuore li vorreste buttare
Dalla rupe Tarpea.
Ma io non sono ancora nel
regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei
vostri sfaceli.
Io se fossi Dio maledirei per
primi i giornalisti e specialmente tutti
Che certamente non sono brave
persone
E dove cogli, cogli sempre
bene.
Signori giornalisti, avete
troppa sete
E non sapete approfittare
della libertà che avete
Avete ancora la libertà di
pensare, ma quello non lo fate
E in cambio pretendete
La libertà di scrivere
E di fotografare.
Immagini geniali e
interessanti
Di presidenti solidali e di
mamme piangenti
E in questo mondo pieno di
sgomento
Come siete coraggiosi, voi che
vi buttate senza tremare un momento:
Cannibali, necrofili,
deamicisiani, astuti
E si direbbe proprio
compiaciuti
Voi vi buttate sul disastro
umano
Col gusto della lacrima
In primo piano.
Si, vabbè, lo ammetto
La scomparsa totale della
stampa sarebbe forse una follia
Ma io se fossi Dio di fronte a
tanta deficienza
Non avrei certo la
superstizione
Della democrazia.
Ma io non sono ancora nel
regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei
vostri sfaceli.
Io se fossi Dio
Naturalmente io chiuderei la
bocca a tanta gente.
Nel regno dei cieli non vorrei
ministri
Né gente di partito tra le
palle
Perché la politica è schifosa
e fa male alla pelle.
E tutti quelli che fanno
questo gioco
Che poi è un gioco di forze
ributtante e contagioso
Come la febbre e il tifo
E tutti quelli che fanno
questo gioco
C' hanno certe facce
Che a vederle fanno schifo.
Io se fossi Dio dall'alto del
mio trono
Direi che la politica è un
mestiere osceno
E vorrei dire, mi pare a
Platone
Che il politico è sempre meno
filosofo
E sempre più coglione.
È un uomo a tutto tondo
Che senza mai guardarci dentro
scivola sul mondo
Che scivola sulle parole
E poi se le rigira come lui
vuole.
Signori dei partiti
O altri gregari imparentati
Non ho nessuna voglia di
parlarvi
Con toni risentiti.
Ormai le indignazioni son cose
da tromboni
Da guitti un po' stonati.
Quello che dite e fate
Quello che veramente siete
Non merita commenti, non se ne
può parlare
Non riesce più nemmeno a farmi
incazzare.
Sarebbe come fare inutili
duelli con gli imbecilli
Sarebbe come scendere ai
vostri livelli
Un gioco così basso, così
atroce
Per cui il silenzio sarebbe la
risposta più efficace.
Ma io sono un Dio emotivo, un
Dio imperfetto
E mi dispiace ma non son
proprio capace
Di tacere del tutto.
Ci son delle cose
Così tremende, luride e
schifose
Che non è affatto strano
Che anche un Dio
Si lasci prendere la mano.
Io se fossi Dio preferirei
essere truffato
E derubato, e poi deriso e poi
sodomizzato
Preferirei la più tragica
disgrazia
Piuttosto che cadere nelle
mani della giustizia.
Signori magistrati
Un tempo così schivi e
riservati
Ed ora con la smania di essere
popolari
Come cantanti come calciatori.
Vi vedo così audaci che siete
anche capaci
Di metter persino la mamma in
galera
Per la vostra carriera.
Io se fossi Dio
Direi che è anche abbastanza
normale
Che la giustizia si amministri
male
Ma non si tratta solo
Di corruzioni vecchie e nuove
È proprio un elefante che non
si muove
Che giustamente nasce
Sotto un segno zodiacale un
po' pesante
E la bilancia non l'ha neanche
come ascendente.
Io se fossi Dio
Direi che la giustizia è una
macchina infernale
È la follia, la perversione
più totale
A meno che non si tratti di
poveri ma brutti
Allora si che la giustizia è
proprio uguale per tutti.
Io se fossi Dio
Io direi come si fa a non
essere incazzati
Che in ospedale si fa morir la
gente
Accatastata tra gli sputi.
E intanto nel palazzo comunale
C'è una bella mostra sui
costumi dei sanniti
In modo tale che in questa
messa in scena
Tutto si addolcisca, tutto si
confonda
In modo tale che se io fossi
Dio direi che il sociale
È una schifosa facciata
immonda.
Ma io non sono ancora nel
regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei
vostri sfaceli.
Io se fossi Dio
Vedrei dall'alto come una
macchia nera
Una specie di paura che forse
è peggio della guerra
Sono i soprusi, le estorsioni
i rapimenti
È la camorra.
È l'impero degli invisibili
avvoltoi
Dei pescecani che non si
sazian mai
Sempre presenti, sempre più
potenti, sempre più schifosi
È l'impero dei mafiosi.
Io se fossi Dio
Io griderei che in questo
momento
Son proprio loro il nostro
sgomento.
Uomini seri e rispettati
Cos'ì normali e al tempo
stesso spudorati
Così sicuri dentro i loro
imperi
Una carezza ai figli, una
carezza al cane
Che se non guardi bene ti
sembrano persone
Persone buone che
quotidianamente
Ammazzano la gente con una tal
freddezza
Che Hitler al confronto mi fa
tenerezza.
Io se fossi Dio
Urlerei che questi terribili
bubboni
Ormai son dentro le nostre
istituzioni
E anzi, il marciume che ho
citato
È maturato tra i consiglieri,
i magistrati, i ministeri
Alla Camera e allo Senato.
Io se fossi Dio
Direi che siamo complici
oppure deficienti
Che questi delinquenti, queste
ignobili carogne
Non nascondono neanche le loro
vergogne
E sono tutti i giorni sui
nostri teleschermi
E mostrano sorridenti le
maschere di cera
E sembrano tutti contro la
sporca macchia nera.
Non ce n'è neanche uno che non
ci sia invischiato
Perché la macchia nera
È lo Stato.
E allora io se fossi Dio
Direi che ci son tutte le
premesse
Per anticipare il giorno
dell'Apocalisse.
Con una deliziosa indifferenza
E la mia solita distanza
Vorrei vedere il mondo e tutta
la sua gente
Sprofondare lentamente nel
niente.
Forse io come Dio, come
Creatore
Queste cose non le dovrei
nemmeno dire
Io come Padreterno non mi
dovrei occupare
Né di violenza né di orrori né
di guerra
Né di tutta l'idiozia di
questa Terra
E cose simili.
Peccato che anche Dio
Ha il proprio inferno
Che è questo amore eterno
Per gli uomini.
IL CONFORMISTA
di Giorgio Gaber – 1996
Io sono un uomo nuovo
talmente nuovo che è da tempo
che non sono neanche più fascista
sono sensibile e altruista
orientalista ed in passato
sono stato un po' sessantottista
da un po’ di tempo
ambientalista
qualche anno fa nell'euforia
mi son sentito come un po' tutti socialista.
Io sono un uomo nuovo
per carità lo dico in senso
letterale
sono progressista al tempo
stesso liberista
antirazzista e sono molto
buono
sono animalista
non sono più assistenzialista
ultimamente sono un po'
controcorrente son federalista.
Il conformista è uno che di
solito sta sempre dalla parte giusta,
il conformista ha tutte le
risposte belle chiare dentro la sua testa
è un concentrato di opinioni
che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani
e quando ha voglia di pensare
pensa per sentito dire
forse da buon opportunista si
adegua senza farci caso
e vive nel suo paradiso.
Il conformista è un uomo a
tutto tondo che si muove senza consistenza,
il conformista s'allena a
scivolare dentro il mare della maggioranza
è un animale assai comune che
vive di parole da conversazione
di notte sogna e vengon fuori
i sogni di altri sognatori
il giorno esplode la sua festa
che è stare in pace con il mondo
e farsi largo galleggiando
il conformista
il conformista.
Io sono un uomo nuovo e con le
donne c'ho un rapporto straordinario
sono femminista
son disponibile e ottimista
europeista
non alzo mai la voce
sono pacifista
ero marxista-leninista e dopo
un po' non so perché mi son trovato cattocomunista.
Il conformista non ha capito
bene che rimbalza meglio di un pallone
il conformista aerostato
evoluto che è gonfiato dall'informazione
è il risultato di una specie
che vola sempre a bassa quota in superficie
poi sfiora il mondo con un
dito e si sente realizzato
vive e questo già gli basta e
devo dire che oramai
somiglia molto a tutti noi
il conformista
il conformista.
Io sono un uomo nuovo
talmente nuovo che si vede a
prima vista
sono il nuovo conformista.
Una canzone molto ironica
quella di Giorgio Gaber, un’analisi su chi sia veramente il
conformista e proprio per questo proviamo prima di tutto a capire noi cosa
sia il conformismo, perchè senza di quello non possiamo comprendere cosa ci
voglia dire Gaber con questa canzone.
Il termine conformismo indica
una tendenza a conformarsi ad opinioni, usi, comportamenti e regole di un
determinato gruppo sociale. Attenzione però qui stiamo parlando di gruppo
sociale qualunque e non per forza quello “dominante” (come in genere molti
pensano) che sarebbe anche piuttosto difficile da identificare visto che la
nostra società è molto grande, complessa ed esistono infinite sfumature. Questo
vuol dire che se apparteniamo ad un gruppo sociale che accettiamo in modo
assoluto allora siamo conformisti rispetto a quel gruppo. Il prete per esempio è
un conformista rispetto al suo gruppo sociale di preti che a loro volta fanno
riferimento al Papa. Chi per esempio appartiene ad una famiglia malavitosa e fa
il bullo a scuola insieme ad altri bulli suoi amici che disturbano, rubano ecc.
è un conformista rispetto al suo gruppo sociale di delinquenti. Molti giovani
pensano ingenuamente che conformismo vuol dire solo mettersi giacca, cravatta e
comportarsi bene, mentre anticonformismo vuol dire mettersi maglietta, jeans e
comportarsi male, ma non è così.
Con questa canzone Gaber
prende in giro il conformista, facendone notare tutte le sue possibili
caratteristiche che lo contraddistinguono e allo stesso tempo ne fa emergere
tutta una serie di contraddizioni: guardiamo per esempio alla prima strofa in
cui il conformista nel giro di pochi anni passa prima ad essere “fascista“,
per poi diventare “orientalista“, ricordandosi però di essere stato un “sessantottista”
e da tempo anche “ambientalista” e pure “socialista“! Da subito quindi
una forte critica implicita all’uomo conformista, che alla fine continuando a
cambiare idea, risulta essere tutto tranne che conformista. Questa
successione di cambio di idee improvvise, seguendo la massa a seconda di cosa
sia più comodo e non secondo ciò in cui si creda veramente, porta Gaber a dare
lui stesso la definizione del conformista moderno:
“Il conformista è uno che
di solito sta sempre dalla parte giusta,
il conformista ha tutte le
risposte belle chiare dentro la sua testa
è un concentrato di
opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani
e quando ha voglia di
pensare pensa per sentito dire
forse da buon opportunista
si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso”
La critica dunque è forte, un
uomo che non è quasi più in grado di pensare con la sua testa, ma si adegua alle
circostanze creandosi un mondo tutto suo in cui vivere senza problemi e senza
lotte. Ma come è abituato a fare, Gaber lancia una frecciatina a tutti
noi, perchè guardandoci in faccia, probabilmente i primi ad essere conformisti
siamo proprio noi:“e devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi, il
conformista“.
LA DEMOCRAZIA di Giorgio
Gaber – 1997
Dopo anni di riflessione sulle
molteplici possibilità che ha uno stato di organizzarsi ho capito che la
democrazia... è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c’è la dittatura,
la democrazia e... basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura chi l’ha vista
sa cos’è, gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. lo,
da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico, non per scelta, per
nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico
pazienza, apostolico non so cosa sia, ma anche romano... Va be’, del resto come
si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c’è scritto che la parola
"democrazia" deriva dal greco e significa "potere al popolo". L’espressione è
poetica e suggestiva. Sì, ma in che senso potere alta popolo? Come si fa? Questo
sul vocabolario non c’è scritto. Però si sa che dal ‘45, dopo il famoso
ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto di voto. È
nata così la “Democrazia rappresentativa” nella quale tu deleghi un partito che
sceglie una coalizione che sceglie un candidato che tu non sai chi sia e che tu
deleghi a rappresentarti per cinque anni. E che se io incontri ti dice: “Lei non
sa chi sono io!” Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo. Ci sono
delle forme ancora più partecipative. Per esempio il referendum è addirittura
una pratica di “Democrazia diretta”... non tanto pratica, attraverso la quale
tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve
decidere sulla Variante di Valico Barberino-Roncobilaccio ha qualche difficoltà.
Anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire un “Sì” se vuoi dire no e un
“No” se vuoi dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccarla.
Comunque il referendum ha più che altro un valore folkloristico, perché dopo
aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati tutto resta come
prima. Un altro grande vantaggio che la democrazia offre a mia nonna, cioè al
popolo, è la libertà di stampa. Nei regimi totalitari, per esempio durante il
fascismo, si chiamava propaganda e tu non potevi mai sapere la verità. Da noi si
chiama “informazione”, che per maggior chiarezza ha anche il pregio di esser
pluralista. Sappiamo tutto. Sappiamo tutto, ma anche il contrario di tutto.
Pensa che bello. Sappiamo che l’Italia va benissimo, ma che va anche malissimo.
Sappiamo che l’inflazione è al 3, o al 4, o al 6, o anche al 10%. Che
abbondanza! Sappiamo che i disoccupati sono il 12% e che aumentano o
diminuiscono a piacere, a seconda di chi lo dice. Sappiamo dati, numeri,
statistiche. Alla fine se io voglio sapere quanti italiani ci sono in Italia,
che faccio? Vado sulla Variante di Valico Barberino-Roncobilaccio e li conto:
Zzzz! Chi va al sud. Zzzz! Chi va al nord! Altro che Istat! Comunque è
innegabile che fra un regime totalitario e uno democratico c’è una differenza
abissale. Per esempio, durante il fascismo non ti potevi permettere di essere
antifascista. In democrazia invece si può far tutto, tranne che essere
antidemocratici. Durante il fascismo c’era un partito solo al potere. O quello o
niente. In democrazia invece i partiti al potere sono numerosi e in crescita.
Alle ultime elezioni, fra partiti, liste autonome, liste di area, gruppi misti,
eccetera, ce ne sono stati duecentoquarantotto. Più libertà di cosi si muore!
Del resto una delle caratteristiche della democrazia è che si basa
esclusivamente sui numeri… come il gioco del Lotto, anche se è meno casuale, ma
più redditizio. Più largo è il consenso del popolo, più la democrazia, o chi per
lei, ci guadagna. Quello del popolo è sempre stato un problema, per chi governa.
Se ti dà il suo consenso vuoi dire che ha capito, che è cosciente, consapevole,
e anche intelligente. Se no è scemo. Comunque l’importante è coinvolgere più
gente possibile. Intendiamoci, la democrazia non è nemica della qualità. È la
qualità che è nemica della democrazia. Mettiamo come paradosso che un politico
sia un uomo di qualità. Mettiamo anche che si voglia mantenere a livelli alti.
Quanti lo potranno apprezzare? Pochi, pochi ma buoni. No, in democrazia ci
vogliono i numeri, e che numeri. Bisogna allargare il consenso, scendere alla
portata di tutti. Bisogna adeguarsi. E un’adeguatina oggi, un’adeguatina
domani... e l’uomo di qualità a poco a poco ci prende gusto... e “tac”, un’altra
abbassatina... poi ce n’è un altro che si abbassa di più, e allora anche lui...
“tac”... “tac”... ogni giorno si abbassa di cinque centimetri. E così, quando
saremo tutti scemi allo stesso modo, la democrazia sarà perfetta.
DESTRA-SINISTRA di Giorgio
Gaber – 2001
Destra-Sinistra
è un singolo di Giorgio Gaber, pubblicato nel 2001, tratto dall'album La mia
generazione ha perso.
La canzone vuol mettere
ironicamente in risalto le presunte differenze tra destra e sinistra politiche,
delle quali è una bonaria critica. Tutta la canzone verte infatti su luoghi
comuni anziché sulle differenze di tipo idealistico, ed è lo stesso Gaber a
specificare che, attualmente, le differenze fra le due parti sono ormai minime,
e che chi si definisce di una fazione rispetto ad un'altra lo fa per mera
«ideologia», e per «passione ed ossessione» di una diversità che «al momento
dove è andata non si sa». In altre parole, la differenza fra chi si definisce di
una parte piuttosto che dall'altra è solamente ostentata, ed è nulla per quanto
riguarda il lato pratico.
Tutti noi ce la prendiamo con
la storia
ma io dico che la colpa è
nostra
è evidente che la gente è poco
seria
quando parla di sinistra o
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Fare il bagno nella vasca è di
destra
far la doccia invece è di
sinistra
un pacchetto di Marlboro è di
destra
di contrabbando è di sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Una bella minestrina è di
destra
il minestrone è sempre di
sinistra
tutti i films che fanno oggi
son di destra
se annoiano son di sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Le scarpette da ginnastica o
da tennis
hanno ancora un gusto un po'
di destra
ma portarle tutte sporche e un
po' slacciate
è da scemi più che di
sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
I blue-jeans che sono un segno
di sinistra
con la giacca vanno verso
destra
il concerto nello stadio è di
sinistra
i prezzi sono un po' di
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
I collant son quasi sempre di
sinistra
il reggicalze è più che mai di
destra
la pisciata in compagnia è di
sinistra
il cesso è sempre in fondo a
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
La piscina bella azzurra e
trasparente
è evidente che sia un po' di
destra
mentre i fiumi, tutti i laghi
e anche il mare
sono di merda più che
sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
L'ideologia, l'ideologia
malgrado tutto credo ancora
che ci sia
è la passione, l'ossessione
della tua diversità
che al momento dove è andata
non si sa
dove non si sa, dove non si
sa.
Io direi che il culatello è di
destra
la mortadella è di sinistra
se la cioccolata svizzera è di
destra
la Nutella è ancora di
sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Il pensiero liberale è di
destra
ora è buono anche per la
sinistra
non si sa se la fortuna sia di
destra
la sfiga è sempre di sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Il saluto vigoroso a pugno
chiuso
è un antico gesto di sinistra
quello un po' degli anni '20,
un po' romano
è da stronzi oltre che di
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
L'ideologia, l'ideologia
malgrado tutto credo ancora
che ci sia
è il continuare ad affermare
un pensiero e il suo perché
con la scusa di un contrasto
che non c'è
se c'è chissà dov'è, se c'é
chissà dov'é.
Tutto il vecchio moralismo è
di sinistra
la mancanza di morale è a
destra
anche il Papa ultimamente
è un po' a sinistra
è il demonio che ora è andato
a destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
La risposta delle masse è di
sinistra
con un lieve cedimento a
destra
son sicuro che il bastardo è
di sinistra
il figlio di puttana è di
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Una donna emancipata è di
sinistra
riservata è già un po' più di
destra
ma un figone resta sempre
un'attrazione
che va bene per sinistra e
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Tutti noi ce la prendiamo con
la storia
ma io dico che la colpa è
nostra
è evidente che la gente è poco
seria
quando parla di sinistra o
destra.
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Ma cos'è la destra cos'è la
sinistra...
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Basta!
IO NON MI SENTO ITALIANO di
Giorgio Gaber – 2003
La canzone "Io non mi sento
italiano" è tratta dall'omonimo album uscito postumo di Giorgio Gaber, nel
gennaio 2003, titolo che all'apparenza è di forte impatto evocativo che sa di
delusione, di rabbia, di denuncia. Ma poi, per ribilanciare l'affermazione,
basta leggere la frase nel seguito, “Io non mi sento italiano, ma per fortuna o
purtroppo lo sono”, c'è un grande concetto all'interno, quello di appartenenza,
a cui Gaber è legato, che lascia trasparire la sua dolcezza, nonostante il
sentimento di sdegno di cui si fa portavoce. Stupisce, e non poco, a distanza di
anni, la modernità del testo, l'attualità delle situazioni, che già allora
Giorgio Gaber raccontava come quotidianità di quel paese, in quel periodo
storico. Album registrato poco prima della sua scomparsa, fu scritto con Sandro
Luporini, pittore di Viareggio, suo compagno di scrittura in tutte le sue
produzioni più importanti musicali e teatrali. Giorgio Gaber, è il suo nome
d'arte, si chiama in effetti Giorgio Gaberscik e nasce a Milano il 25 gennaio
1939 (scompare a Montemagno di Camaiore il 1º gennaio 2003), da padre di origine
istriane-goriziano slovene e madre veneziania. Inizia a suonare la chitarra da
bambino a 8-9 anni per curare un brutto infortunio ad un braccio. Diventa un
ottimo chitarrista e, con le serate, da grande, si pagherà gli studi
universitari. E' il 1970 l'anno della svolta artistica di Giorgio Gaber. Gaber è
celebre ma si sente “ingabbiato”, costretto a recitare un ruolo nella parte di
cantante e di presentatore televisivo. Rinuncia così alla grandissima notorietà,
si spoglia del ruolo di affabulatore e porta "la canzone a teatro" (creando il
genere del teatro canzone). Gaber si presenta al pubblico così com'è, ricomincia
da capo. Per questo crea un personaggio che non recita più un ruolo, il «Signor
G», recita se stesso. Quindi un signore come tutti, “una persona piena di
contraddizioni e di dolori”.
TESTO - Io non mi sento
italiano - parlato:
Io G. G. sono nato e vivo a
Milano.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Mi scusi Presidente
non è per colpa mia
ma questa nostra Patria
non so che cosa sia.
Può darsi che mi sbagli
che sia una bella idea
ma temo che diventi
una brutta poesia.
Mi scusi Presidente
non sento un gran bisogno
dell'inno nazionale
di cui un po' mi vergogno.
In quanto ai calciatori
non voglio giudicare
i nostri non lo sanno
o hanno più pudore.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Mi scusi Presidente
se arrivo all'impudenza
di dire che non sento
alcuna appartenenza.
E tranne Garibaldi
e altri eroi gloriosi
non vedo alcun motivo
per essere orgogliosi.
Mi scusi Presidente
ma ho in mente il fanatismo
delle camicie nere
al tempo del fascismo.
Da cui un bel giorno nacque
questa democrazia
che a farle i complimenti
ci vuole fantasia.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Questo bel Paese
pieno di poesia
ha tante pretese
ma nel nostro mondo
occidentale
è la periferia.
Mi scusi Presidente
ma questo nostro Stato
che voi rappresentate
mi sembra un po' sfasciato.
E' anche troppo chiaro
agli occhi della gente
che tutto è calcolato
e non funziona niente.
Sarà che gli italiani
per lunga tradizione
son troppo appassionati
di ogni discussione.
Persino in parlamento
c'è un'aria incandescente
si scannano su tutto
e poi non cambia niente.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Mi scusi Presidente
dovete convenire
che i limiti che abbiamo
ce li dobbiamo dire.
Ma a parte il disfattismo
noi siamo quel che siamo
e abbiamo anche un passato
che non dimentichiamo.
Mi scusi Presidente
ma forse noi italiani
per gli altri siamo solo
spaghetti e mandolini.
Allora qui mi incazzo
son fiero e me ne vanto
gli sbatto sulla faccia
cos'è il Rinascimento.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Questo bel Paese
forse è poco saggio
ha le idee confuse
ma se fossi nato in altri
luoghi
poteva andarmi peggio.
Mi scusi Presidente
ormai ne ho dette tante
c'è un'altra osservazione
che credo sia importante.
Rispetto agli stranieri
noi ci crediamo meno
ma forse abbiam capito
che il mondo è un teatrino.
Mi scusi Presidente
lo so che non gioite
se il grido "Italia, Italia"
c'è solo alle partite.
Ma un po' per non morire
o forse un po' per celia
abbiam fatto l'Europa
facciamo anche l'Italia.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo
sono.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo
per fortuna o purtroppo
per fortuna
per fortuna lo sono.
Ci sedemmo dalla parte del
torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini che lottano
un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono
quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che
lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Citazioni di Bertolt
Brecht.
Storia e origini
della “Casta” politica italiana. Il racconto di “Lei non sa chi ero io!” di
Filippo Maria Battaglia: alla base, gli stipendi alti,, scrive Filippo Maria
Battaglia su “L’Inkiesta”. Quando è nata la “Casta” politica italiana? Non certo
con gli insulti dei grillini o con il libro di Gian Antonio Stella e Sergio
Rizzo. La “Casta” nasce ben prima. Così come i festini hard che fanno scandalo
sui giornali. E lo racconta bene Filippo Maria Battaglia nel suo libro Lei non
sa chi ero io! edito da Bollati Boringhieri editore. Ecco un estratto: Stipendi
d’oro in Aula e amanti al Colle: arriva «la casta». “Cinque milioni di lire in
un anno, venticinque per un intero mandato. A tanto ammonta il compenso dei
parlamentari nel 1963. A fare i conti nelle tasche degli eletti, alla fine della
terza legislatura, è «Il Borghese»: un onorevole incassa in un mese quanto nove
operai per partecipare a poco più di centoquaranta sedute l’anno. Lo stipendio,
in realtà, si ferma a 740mila lire ma in soccorso della busta paga arriva il
«rimborso spese». Da regolamento dovrebbe essere variabile sulla base delle
presenze in Aula, certificate da un apposito registro, che però non è
controllato da nessuno. «Un collega comunista con un libretto in mano – è la
denuncia di un deputato dc al quotidiano «Il Tempo» – metteva firme di presenza,
oltre che per sé, per alcuni suoi colleghi assenti, che avrebbero così
percepito il gettone». L’inchiesta di Montecitorio scatta subito ma si chiude
con una semplice censura generica. In questi mesi il conto corrente
dell’onorevole si arricchisce poi di nuove e imprevedibili
agevolazioni: treni, navi e autostrade gratis per sé e «per la sua famiglia,
compresi i cugini lontanissimi, o dichiarati tali»; crociere senza sborsare un
lira, «e non solo in Italia»; aerei a metà prezzo; e ancora ingressi liberi e
illimitati in teatri, stadi, cinema, vernissage e musei: ormai «il parlamentare
paga proprio quando non ne può fare a meno». «Oggi come oggi – nota Montanelli
– circa la metà dei nostri parlamentari non ha altra attività che quella
politica, la quale così viene a rappresentare per essi, oltre che una
vocazione, una “sistemazione”». Ne è una conferma l’arrivo della pensione.
Introdotta nel 1959, è ovviamente reversibile e prevede un assegno mensile di
50mila lire dopo cinque anni di contributi, con l’aumento di 10mila lire per
ogni anno in più fino a un massimo di 200mila lire mensili. Il risultato? Un ex
deputato con quattro legislature alle spalle, a 60 anni incassa 2 milioni e
400mila lire l’anno. «Una scelta aberrante», commenta don Sturzo. Gli onorevoli
fanno pure incetta di esenzioni fiscali, prestiti (i settimanali parlano di
linee di credito di centinaia di milioni, spesso non garantite) e mutui concessi
a tassi di favore, i cui interessi sono in buona parte pagati dallo Stato. Amaro
e profetico il commento del prete di Caltagirone: se si considera «la tendenza
di dare posti di consolazione a ministri, sottosegretari e deputati fuori uso»,
i nostri parlamentari, più che a rappresentare il popolo, sembrano ormai
impegnati a «voler creare o consolidare una casta». La sfilza di episodi di
malcostume che a vario titolo si affastellano nelle prime legislature del
Dopoguerra non aiuta. Presi singolarmente non hanno particolare rilievo, ma uno
dietro l’altro restituiscono un quadro non esattamente edificante degli eletti.
Riguardano democristiani, monarchici e socialdemocratici alle prese con reati
vari e quasi tutti si risolvono con un nulla di fatto. Ampio il campionario
giudiziario: truffe, fallimenti, minacce, usura, violenza privata e persino
correità in adulterio causate tra l’altro da «morbose e innaturali tenerezze
verso ex segretari particolari». Le cronache di questi mesi regalano poi
inaspettate descrizioni di feste della Roma bene, quasi sempre trasversali, dove
si ritrovano «tutti: liberali, comunisti, preti, belle donne e brutte donne», e
soprattutto un altro scandalo a luci rosse. Compare sui quotidiani il 14
febbraio 1961 e riguarda la «scoperta da parte della Polizia dei Costumi di una
casa-squillo di alto rango per “amatori” facoltosi», dove «alcune divette,
indossatrici e signorine di buona famiglia piuttosto note nei ritrovi di Via
Veneto», coordinate dall’ex parrucchiera Mary Fiore, «danno sollazzi a nomi
conosciuti», anche della politica. Passano pochi giorni, aumentano le
indiscrezioni e le «squillo da un milione» diventano un nuovo strumento di
«lotta fra frazioni Dc». Ma le identità dei clienti non vengono fuori: i
rotocalchi che li annunciano vengono subito ricompensati per il loro silenzio. I
ricatti – scrivono i settimanali – sono ormai «l’arma segreta della vita
politica nazionale». In particolare, nota Eugenio Scalfari, il mirino è
indirizzato sui democristiani di sinistra, colpevoli «di fornicare di giorno con
il diavolo in berretto frigio, e di notte col diavolo in gonnella». Tra i più
ghiotti di fascicoli e pettegolezzi condizionanti, il presidente della
Repubblica Giovanni Gronchi, che riceve puntuali report da Giovanni De Lorenzo,
a capo del Sifar, il servizio segreto militare. Sotto la direzione del generale
(che di lì a breve sarà protagonista di una delle pagine più controverse
della storia repubblicana, legata al Piano Solo) vengono schedati migliaia di
politici, ecclesiastici e grand commis. Il risultato? Oltre 150mila fascicoli
che quasi mai hanno a che fare con la necessità di sicurezza (compito per il
quale è nato il servizio segreto) e che spesso si rivelano
inattendibili. Alcuni sono mastodontici: «Per l’onorevole Fanfani – racconterà
anni dopo il generale Aldo Beolchini – c’erano quattro volumi, ciascuno gonfio
come un doppio dizionario». Sui maneggi tra Quirinale e De Lorenzo con la
complicità di diversi politici si mormora durante tutto il settennato di
Gronchi, ma è al giornalista Renzo Trionfera che si devono le inchieste più
dettagliate sul Colle. La sua presidenza – scrive – è affollata «di personaggi
squalificati, di affaristi, di maneggioni del sottogoverno: uomini e donne
potentissimi», intenti a «colpi miliardari», culminati col tentativo di
«comperare voti in Parlamento e simpatie esterne» per intercessione della mano
munifica di Enrico Mattei che mette a disposizione «un miliardo tondo» con
l’obiettivo di «raddoppiare il festoso mandato» del presidente. Gronchi si
infurierà più volte per quelle inchieste: prima minacciando l’editore Angelo
Rizzoli srl, poi – dopo l’esplosione del caso nel 1967 – difendendosi in modo
impacciato in Aula. I traffici attribuiti all’entourage del Colle sono tanti:
tra i più noti, quello legato a un francobollo, il cosiddetto «Gronchi Rosa».
Il 3 marzo 1961 viene emesso dalle Poste in coincidenza di un viaggio
presidenziale in Sudamerica. Per un errore nei confini tra Perù ed Ecuador,
viene ritirato solo diverse ore dopo una limitata distribuzione. E «tanto è
bastato – denunciano i giornali – perché alcuni signori, stranamente bene
informati, abbiano fatto incetta del prezioso pezzetto di carta». Ma le
attività del settennato non si limitano qui. Il presidente, infatti, oltre a
essere goloso di dossier e maldicenze, ne è un indiscusso protagonista. «I
romani – racconterà il settimanale «Abc» – parlano spesso della porticina che
Gronchi ha fatto aprire su un lato del Quirinale, in via dei Giardini. Si
mormora che di lì passino le amicizie femminili del Presidente, che non
potrebbero introdursi per il portone principale senza dare adito a
pettegolezzi». Amicizie che costano al Parlamento diversi provvedimenti ad
personam: uno di questi sarà ribattezzato «legge Pompadour» proprio perché
«destinato a una delle sue favorite». Il caso più clamoroso del settennato ha
però a che fare con la nomina di un anonimo ragioniere, Torello Ciucci,
«esercente di cinematografo a Pontedera», a presidente dell’Enic, l’Ente
nazionale industrie cinematografiche. Un colosso industriale, valutato in
diversi miliardi, che in poco meno di un anno viene svuotato dei suoi beni e
venduto a un prezzo irrisorio. La manovra non passa inosservata: è la rivista
di spettacolo «Intermezzo» a scrivere una lettera aperta indirizzata allo stesso
Gronchi, a cui si chiede di sollecitare un’indagine. Intanto alcuni periodici
informano che Torello Ciucci, ribattezzato «il ragioniere tutto d’oro», si «è
installato in un appartamento sfarzoso» a Roma, insieme alla moglie, «signora
Dilva, intima del Quirinale»,31 che segue il presidente in più di una
trasferta. La vicenda arriva in Aula, ma come da copione avrà esiti
impalpabili. L’ultimo scorcio della legislatura regala però anche
un’inaspettata condanna lampo. È quella di Ebe Roisecco, un’intraprendente
donna d’affari assai vicina agli ambienti Dc. «Accusata di una lunga serie di
truffe (nove in tutto)», nei primi anni del Dopoguerra è dedita alle
importazioni di prodotti (e soprattutto al traffico delle necessarie licenze),
fino a quando non viene incastrata per colpa di un assegno falso, e, dopo la
condanna in primo grado a dieci anni e otto mesi, decide di parlare. In un lungo
memoriale, pubblicato il 3 marzo 1960, tira in ballo i nomi di democristiani e
socialdemocratici, parla «di una fitta rete di amicizie» e ammette di aver fatto
«guadagnare laute provvigioni ai partiti, soprattutto a quello
saragattiano» (leggi Psdi). La confessione imbarazza la maggioranza ma non la
scalfisce. Nessuna indagine suppletiva: l’unico effetto che sortisce è quello
di far accelerare sensibilmente il processo, che resta a carico della sola
Roisecco. La sentenza d’Appello arriva il 13 luglio, tre mesi dopo il primo
grado. Passano appena cinque giorni e arrivano le motivazioni. L’8 agosto
scadono i termini per il ricorso e il 10 settembre si è già in Cassazione. Ai
magistrati basta poco più di un quarto d’ora «per chiudere il caso e le
polemiche» e soprattutto il rischio di prescrizione, che sarebbe scattata 12 ore
dopo. Una celerità improvvisa e inusuale, notata da diversi quotidiani: «Sulla
“signora mezzomiliardo” si chiudono le porte del carcere, che rappresentano
sempre una forma di validissima censura». I maneggi di Ebe Roisecco non sono
isolati. Il traffico delle licenze e delle importazioni, in questi anni, è
fiorente e frequentatissimo. Non è un caso che di qui nasca l’ultimo affaire
che precede l’insediamento del primo governo di centrosinistra. Riguarda
l’Azienda del monopolio delle banane, un’eredità del fascismo nata per
garantire che si consumino solo frutti tropicali prodotti «nei territori
dell’Impero» e sopravvissuto al regime grazie a una giustificazione formale: la
tutela italiana sulla Somalia. Tocca al ministro delle Finanze, il dc
Trabucchi, regolare l’indizione delle aste per i grossisti che aspirano alla
concessione. «Lo schema – nota Livio Zanetti – è evidente: da una parte ci sono
gli ex gerarchi della Somalia che devono continuare a coltivare le loro banane
senza preoccuparsi di migliorarne la produzione perché tanto lo smercio è
garantito; dall’altra gli armatori che hanno diritto al loro nolo assicurato;
più in là ancora i grossisti, che non rinunciano a prelevare la loro taglia
sul consumatore. E in mezzo, a regolare il buon funzionamento del meccanismo, i
funzionari del monopolio». A una di quelle aste, sulla carta segreta, i vecchi
concessionari azzeccano al centesimo il canone minimo nelle zone in cui non ci
sono concorrenti e il canone massimo dove hanno rivali. I contendenti, rimasti a
bocca asciutta, fiutano la magagna e, complice una minuta di verbale dove
risulta che i grossisti avrebbero pagato decine di milioni per conoscere in
anticipo le cifre, decidono di informare con un telegramma il premier Fanfani.
L’asta è annullata, il presidente dell’Azienda monopolio banane Franco Bartoli
Avveduti, ex segretario di Trabucchi, finisce in manette, rinviato a giudizio
insieme ad altre 124 persone. In tribunale, mostra diverse lettere e dice di
aver ricevuto «segnalazioni scritte e orali di influenti personalità Dc perché
venissero ammessi all’asta ed informati dei prezzi minimi e massimi alcuni
concessionari di Bologna, Palermo, Verona e Brescia». Il ministro dc e il suo
entourage, racconta Avveduti, sono tra i più attivi a chiedere e a sollecitare
indicazioni. Eppure vengono appena sfiorati dalle indagini e se la cavano.
Almeno per ora. Passano meno di due anni e con l’inizio della nuova legislatura,
Trabucchi, che nel frattempo non è più nel governo, si ritrova coinvolto in un
altro scandalo, sempre riferito allo stesso periodo. È accusato di un’altra
irregolarità risalente a quando era al dicastero: «Avere abusivamente concesso
licenze di importazione di tabacco messicano a due società private e di averne
ricavato grossi utili» a favore della Democrazia cristiana. L’ex ministro –
difeso da un giovane deputato sardo, Francesco Cossiga – respinge tutti gli
addebiti. Stavolta, però, non basta: non c’è tempo per nessuna commissione di
inchiesta. Il Parlamento, con la nuova maggioranza allargata ai socialisti, si
riunisce in seduta comune per decidere sulla messa in stato d’accusa davanti
alla Corte Costituzionale, a cui tocca decidere sui reati ministeriali. La Dc si
ritrova isolata e finisce in minoranza: 461 voti a favore della richiesta contro
440. Ma Trabucchi per meno di 20 voti la scampa grazie a un regolamento che «in
barba alla Costituzione» – nota Alessandro Galante Garrone su «La Stampa» – «ha
imposto una maggioranza speciale anche per la messa in stato d’accusa dei
ministri» e non solo per il presidente della Repubblica. Alla Camera succede il
finimondo: comunisti, socialisti e repubblicani si indignano, volano insulti e
«infamanti accuse». Il giorno dopo, però, l’aria si fa più serena, quantomeno
nella maggioranza. Il caso è chiuso, dice «L’Avanti», «c’è solo da augurarsi
che l’opinione pubblica non rimanga scossa sino alla sfiducia». Alle accuse
rivolte a ministri e parlamentari, il presidente del Consiglio Aldo Moro
replicherà deciso: «La nostra classe politica è profondamente onesta. La fibra
è buona e non merita la sfiducia del Paese». È il 24 ottobre 1965. Da quasi
due anni il Psi è entrato nella «stanza dei bottoni». Dopo una lunga
gestazione, l’apertura a sinistra è diventata cronaca politica. Ma nonostante
le rassicurazioni di Moro e dei suoi alleati, il caso Trabucchi non sarà
l’ultimo colpo di coda di una stagione ormai archiviata. Al contrario.
L’ingresso dei socialisti nel governo, più che a coincidere con un cambio di
rotta, finirà col dare stabilità a un sistema ormai già collaudato,
perfezionandone i tic, puntellandone i vizi e ampliando il senso di privilegio e
impunità.”
Ora è noto ormai che
anche le Brigate Rosse eseguirono il sequestro Moro per affarismo e rifiutarono
dieci miliardi di vecchie lire da parte del Papa Paolo VI per liberare Aldo Moro
perchè qualcun altro le remunerò di più.
Così i parlamentari sono
diventati milionari.
Quando nacque la Repubblica i costituenti guadagnavano 1.300 euro odierni.
Adesso deputati e senatori incassano tredici volte più di un operaio. Il tutto
grazie a una serie di leggi che nel tempo hanno gonfiato le retribuzioni. E a
provvedimenti ad hoc, furbizie, trucchi e tanta sfacciataggine. Che abbiamo
ricostruito, scrive Paolo Fantauzzi su “L’Espresso”. «Onorevoli colleghi,
l'opinione pubblica non ha in questo momento molta simpatia e fiducia per i
deputati. Vi è un'atmosfera di sospetto e discredito, la convinzione diffusa che
molte volte l'esercizio del mandato parlamentare possa servire a mascherare il
soddisfacimento di interessi personali e diventi un affare, una professione, un
mestiere». La solita tirata contro la casta di qualche parlamentare del
Movimento cinque stelle? Macché. Frasi di Piero Calamandrei, giurista,
antifascista, partigiano e deputato eletto col Partito d'azione all'Assemblea
costituente. Parole pronunciate nel lontano 1947, mentre a Montecitorio era in
discussione l'articolo 69 della Costituzione, relativo allo stipendio dei
parlamentari. Il paradosso è che all'epoca i costituenti guadagnavano quanto un
precario di oggi: 25 mila lire al mese, circa 800 euro. Più un gettone di
presenza da 1.000 lire al giorno (30 euro), ma solo quando le commissioni si
riunivano in giorni differenti rispetto all'Aula. Insomma, per quanto diligenti,
i 556 rappresentanti che scrissero la Costituzione non riuscivano a portare a
casa più di 1.300 euro al mese. Roba da far apparire i grillini - che, al netto
dei rimborsi, trattengono circa 3 mila euro - degli sfacciati crapuloni. E in
effetti nel dopoguerra lo stipendio dei parlamentari non era altissimo in
termini assoluti ma comunque più che dignitoso per una nazione ancora sconvolta
dall'economia di guerra, fame, mercato nero e inflazione vertiginosa. Un Paese
senza dubbio più povero ma di certo meno "squilibrato" a favore del Palazzo,
visto che un operaio di terzo livello arrivava a raggranellare 13 mila lire al
mese, un terzo di un deputato. Mentre dopo quasi 70 anni - come mostra la
tabella elaborata dall'Espresso - chi siede in Parlamento guadagna quasi 10
volte più di un impiegato e 13 più di una tuta blu. All'alba della nuova Italia,
retribuire i parlamentari era considerato un decisivo fattore di indipendenza e
democrazia, tale da consentire anche alle classi non abbienti di partecipare
alla vita politica. Senza però esagerare, vista la drammatica situazione del
Paese. Per questo nel giugno 1946 fu fissata provvisoriamente la somma di 25
mila lire. Ma l'inflazione era tale che a febbraio 1947 fu necessario portarla a
30 mila lire (740 euro) e a settembre a 50 mila lire (850 euro), elevando il
gettone di presenza a 3 mila lire al giorno (51 euro), dimezzato per i residenti
a Roma. La prima legge sul tema, varata nell'estate 1948 dal governo De Gasperi,
è figlia di questa mentalità che allora ispirava la giovane e fragile democrazia
italiana: "Ai membri del Parlamento è corrisposta una indennità mensile di L.
65.000, nonché un rimborso spese per i giorni delle sedute parlamentari alle
quali essi partecipano". Tradotto ai giorni nostri: 1.230 euro fissi più un
gettone da 100 euro scarsi al giorno (5mila lire) legato alla presenza
effettiva. Togliendo fine settimana più i lunedì e i venerdì, in cui le
convocazioni sono rare, non più 2.500 euro al mese dunque. Tutto esentasse,
visto che lo stipendio era considerato un rimborso spese e non un reddito. Ma
comunque una chimera se si considera che oggi i rimborsi sono prevalentemente
forfettari, che le decurtazioni per gli assenteisti valgono solo per i giorni in
cui si vota e che per risultare presenti è sufficiente partecipare a una
votazione su tre. Che l'aria sarebbe ben presto cambiata lo dimostra una legge
emanata dal governo Segni nel 1955: "Disposizioni per le concessioni di viaggio
sulle ferrovie dello Stato". Pensata per garantire l'esercizio del mandato
popolare, finì per trasformarsi in un privilegio ingiustificato per una pletora
sterminata di soggetti. Non solo i politici in carica e il Capo dello Stato ma
anche gli ex: presidenti del Consiglio, ministri e sottosegretari (bastava un
anno), parlamentari, alti papaveri dei dicasteri, cardinali, familiari del
ministro e del sottosegretario ai Trasporti e perfino quelli dei dipendenti
delle Camere. Un privilegio al quale, col passare del tempo, si sarebbero
aggiunti una innumerevole serie di altri benefit - molti ancora esistenti - dai
biglietti aerei alla telefonia fissa (e poi mobile), dalle tessere autostradali
agli sconti sui trasporti marittimi. E così nel 1963, in appena 15 anni, grazie
ai bassi salari che furono alla base del miracolo economico, col suo mezzo
milione al mese un parlamentare era già arrivato già a guadagnare il quintuplo
di un impiegato (il cui salario si aggirava sulle 100 mila lire) e otto volte
più di un operaio (poco sopra le 60 mila lire). Ma è con la legge varata nel
1965 dal centrosinistra (premier Aldo Moro, vicepresidente il socialista Pietro
Nenni) che si deve l’esplosione dei redditi dei nostri rappresentanti: lo
stipendio veniva infatti agganciato a quello dei presidenti di sezione della
Cassazione e fra l'altro soggetto a imposta solo per il 40%. Inoltre a titolo di
rimborso per le spese di soggiorno a Roma si istituiva la diaria (esentasse).
Ciliegina sulla torta: siccome la legge non lo specificava, le 120 mila lire per
vivere nella capitale (1.250 euro di oggi) furono accordate anche quelli che vi
risiedevano già. Un capolavoro. Tuttora in vigore, sia pure con qualche
modifica. Certo, anche i comuni mortali hanno avuto le loro soddisfazioni. Negli
anni '70, ad esempio, per effetto delle lotte sindacali, i lavoratori dipendenti
e in particolar modo degli operai hanno conosciuto un aumento delle retribuzioni
che ha fatto diminuire il distacco dagli onorevoli. Al punto che nel 1977 un
metalmeccanico poteva guadagnare un quarto di un parlamentare: rispetto al 1963,
un dimezzamento dello "spread". Poi il governo Craxi taglia la scala mobile e la
forbice torna ad allargarsi inesorabilmente. E sia tute blu che impiegati
cominciano a perdere progressivamente potere d'acquisto: i loro salari reali
scendono lentamente, mentre deputati e senatori iniziano a stappare bottiglie di
champagne. Per festeggiare una busta paga che in un trentennio raddoppia il suo
valore: dai 7 mila euro degli anni '80 (rivalutati al 2014) oggi siamo arrivati
a quasi 14 mila. Gli impiegati, invece, si aggirano sui 1.500 euro al mese,
mentre i metalmeccanici sono inchiodati da allora fra 1.100 e 1.200 euro. Nel
mezzo, ci sono i generosi regali che i parlamentari si fanno nel corso del
tempo. Nel 1986, ad esempio, l’indennità viene equiparata completamente a quella
dei presidenti di sezione della Corte suprema (era al 91,3%), che regala in un
colpo solo 400 mila lire nette in più al mese più dieci mensilità arretrate:
cinque mesi di lavoro di un operaio. Ma le disparità sono anche nella
dichiarazione dei redditi. Già, perché un terzo dell'indennità per deputati e
senatori, dopo lunghe lotte assimilata al lavoro dipendente, resta esente dalle
imposte (solo dal 1995 la tassazione è al 100% come tutti i comuni mortali).
Senza contare che grazie a una generosa interpretazione del Testo unico delle
imposte sui redditi (governo Craxi), come ha raccontato sull’Espresso Stefano
Livadiotti, il prelievo fiscale si aggira attorno al 19 per cento. Intanto, anno
dopo anno, i rimborsi aumentano a dismisura, dai viaggi di studio alle spese
telefoniche, dai costi di trasporto a quelli di spostamento. Fino alle spese
postali, in seguito soppresse: nel 1988 a ogni deputato veniva riconosciuto ogni
mese il corrispettivo di 500 francobolli (erano 300 fino a un paio di anni
prima), circa 350 euro odierni. Che poi si spedissero davvero tutte quelle
missive, poco importa. Non fossero bastati i benefit, a fine anni '80 per le
deputate finì in busta paga perfino l’indennizzo per il coiffeur. Già, perché
non essendoci a Montecitorio il parrucchiere (al contrario dei colleghi maschi,
che possono contare sul barbiere), alle parlamentari viene assegnato un rimborso
forfettario sostitutivo. Come dire: scusate il disservizio, la messa in piega la
offriamo noi. Questo aumento degli stipendi, fra l'altro, ha prodotto effetti a
cascata anche sugli enti locali. Perché se gli eletti nelle Camere si sono
agganciati ai magistrati di Cassazione, i consiglieri regionali hanno fatto
altrettanto con i parlamentari. E ogni ritocco all’insù sancito dall'Istat è
costato miliardi e miliardi di lire a tutta la collettività. L'ultimo colpo
grosso - prima della sterilizzazione degli stipendi avviata nel 2006 e dei vari
piccoli tagli apportati negli ultimi anni - risale al 1997: quasi 7 milioni al
mese in più sotto forma di “spese di segreteria e rappresentanza” al posto dei
precedenti contributi per i portaborse, che venivano erogati al gruppo
parlamentare di appartenenza. In questo modo, non solo i soldi sono finiti
direttamente sulla busta paga dell'onorevole, ma non è stato nemmeno più
necessario rendicontarli (dal 2012 basta documentare il 50%). Risultato: come ha
raccontato l'Espresso, in maniera assolutamente lecita molti parlamentari si
sono tenuti i soldi e vari collaboratori hanno continuato a lavorare a nero. Che
avesse ragione Calamandrei?
Pansa intervista Pansa su
“Libero Quotidiano”: "Devo tutto alla guerra".
In tanti anni di
professione, immagino che tu sia stato costretto ad affrontare non poche delle
emergenze che hanno tormentato l'Italia. Quale di loro ricordi?
«Almeno tre. La prima è il
terrorismo, soprattutto quello delle Brigate Rosse. Oggi non ce ne ricordiamo
più, ma è stata una seconda guerra civile durata quasi un ventennio. Con
un'infinità di morti ammazzati, centinaia di feriti, allora si diceva
gambizzati, e un delitto che ricordo come fosse avvenuto ieri: il sequestro e
l'assassinio di Aldo Moro. Tuttavia l'aspetto peggiore, e infame, di quel
mattatoio fu il comportamento di una parte importante della borghesia di
sinistra. Eccellenze della cultura, dell'università, del giornalismo, delle
professioni liberali. E della politica comunista e socialista. Per anni negarono
l'esistenza del terrorismo rosso. Sostenevano che si trattava di fascisti
travestiti da proletari. Soltanto qualcuno ha fatto ammenda di quella farsa
tragica. Ma pochi, per non dire pochissimi. Molti pontificano ancora e si
considerano la crema dell'Italia».
L’ITALIA DELLE TRATTATIVE.
La storia compromettente
del "compromesso storico".
Quarant'anni
fa Enrico Berlinguer rilanciò l'idea (che fu di Togliatti nel dopoguerra) della
collaborazione fra Pci e Dc. Ma il flirt durò poco. E indebolì entrambi i
partiti, scrive Francesco Perfetti Venerdì 27/09/2013 su "Il Giornale". La
proposta di un «compromesso storico» fra cattolici e comunisti la lanciò
l'allora segretario del Pci Enrico Berlinguer tra la fine di settembre e
l'inizio di ottobre 1973 dalle pagine di Rinascita, la rivista ideologica del
partito fondata da Palmiro Togliatti, in tre articoli pubblicati con il titolo
generale Riflessioni sull'Italia dopo i fatti del Cile. Nel Paese
latino-americano si era appena consumato il colpo di Stato del generale Pinochet
contro Salvador Allende: era stata interrotta traumaticamente la «via cilena al
comunismo». Divenuto segretario del Pci nel marzo 1972 dopo esserne stato
vice-segretario, Berlinguer si era formato ed era cresciuto politicamente
all'ombra di Togliatti e durante la lunga segreteria di Luigi Longo si era
rafforzata la sua autorevolezza. Aveva portato avanti la linea del «dissenso»
dall'Urss dopo l'invasione della Cecoslovacchia del 1968, ma al tempo stesso
aveva negato la possibilità di un abbandono dell'internazionalismo e di una
posizione di rottura nei confronti dell'Unione Sovietica. I fatti cileni
suggerirono a Berlinguer una proposta politico-strategica che egli rese nota
attraverso quegli articoli senza che fosse prima discussa dagli organismi
dirigenti del partito. Ciò anche se in maggio sulla rivista Il Contemporaneo,
supplemento mensile di Rinascita, era apparso un ampio dibattito sulla
«questione democristiana», in cui Alessandro Natta aveva accennato alla
necessità di una intesa fra socialisti, comunisti e cattolici e Gerardo
Chiaromonte aveva osservato che sarebbe stato difficile per i comunisti
governare anche ottenendo la maggioranza assoluta dei voti a causa della
estensione e della influenza delle forze avversarie. Ciò non toglie, peraltro,
che la paternità dell'idea del compromesso storico, così come venne presentata,
sia senza dubbio attribuibile a Berlinguer. Il caso cileno offriva una lezione
importante. Dimostrava che l'unità delle sinistre, da sola, non era sufficiente
a garantire la governabilità e che bisognava puntare alla collaborazione fra
tutte le forze popolari, partito comunista e democrazia cristiana in primis, e
quindi a un sistema di alleanze sociali che coinvolgesse ceti diversi. Al fondo,
c'era la convinzione che solo così sarebbe stato possibile sbloccare il sistema
politico italiano che, di fatto, anche per la sua collocazione internazionale,
non consentiva una alternanza. La formulazione della proposta era chiara: «la
gravità dei problemi del paese, le minacce sempre incombenti di avventure
reazionarie, e la necessità di aprire finalmente alla nazione una sicura via di
sviluppo economico, di rinnovamento sociale e di progresso democratico rendono
sempre più urgente e maturo che si giunga a quello che può essere definito il
nuovo grande compromesso storico tra le forze che raccolgono e rappresentano la
grande maggioranza del popolo italiano». In altre parole, Berlinguer metteva in
soffitta l'idea della «alternativa di sinistra» e la sostituiva con quella di
una «alternativa democratica» che avrebbe consentito riforme radicali evitando
il pericolo di derive reazionarie. La proposta poteva sembrare una novità. E
come tale alimentò il dibattito politico. Ma non era così. Il filosofo cattolico
Augusto Del Noce osservò che essa era «condizionata interamente dalla linea
gramsciana» tanto che, riferita al pensiero di Gramsci, si configurava come
«offerta» frutto della «constatazione della "maturità storica" per il passaggio
dell'Italia al comunismo e per il transito dalla vecchia alla nuova Chiesa».
D'altro canto lo stesso Berlinguer precisò che l'offerta di compromesso storico
non era una «apertura di credito alla Dc», ma doveva intendersi come
«sollecitazione continua» per una trasformazione radicale della stessa Dc che ne
valorizzasse la «componente popolare» a scapito delle «tendenze conservatrici e
reazionarie». A ben vedere, il discorso di Berlinguer riprendeva, con altre
parole e in un contesto diverso, il progetto che, all'indomani del secondo
conflitto mondiale, Palmiro Togliatti aveva sintetizzato nella celebre
espressione «democrazia progressiva» fondata sulla collaborazione fra le «grandi
forze popolari», ovvero comunisti, socialisti e cattolici. Esisteva, per dirlo
con Del Noce, una «continuità Gramsci-Togliatti-Berlinguer e delle formule della
via "nazionale" e "democratica" e dell'accordo dei partiti di massa». Nella
visione berlingueriana il compromesso storico avrebbe dovuto rappresentare lo
strumento per «sbloccare» il sistema politico italiano che - in virtù della
tacita ma accettata conventio ad excludendum nei confronti del Pci per i suoi
legami con Mosca e per la sua monolitica struttura interna di tipo leninista -
precludeva ai comunisti l'ingresso nelle stanze del potere. Le opposizioni, più
che le perplessità, furono numerose sia all'interno del Pci, dove molti
pensavano ancora all'ipotesi della trasformazione del Paese in una «democrazia
popolare», sia all'interno della Dc, del Psi e dei partiti laici minori,
preoccupati, non a torto, che il compromesso storico si risolvesse nell'incontro
fra due «religioni secolari». Comunque sia, alla prova dei fatti il compromesso
storico non si realizzò. Gli anni fra il 1974 e il 1978 furono, sì, quelli della
grande avanzata elettorale del Pci e del suo ingresso nell'area di potere con
l'appoggio esterno al governo monocolore di «solidarietà nazionale» di
Andreotti. Ma, al tempo stesso, furono anni - particolarmente difficili anche
per l'offensiva del «partito armato» delle Brigate Rosse - che mostrarono come
la «strategia dell'attenzione» nei confronti del Pci teorizzata da Aldo Moro
fosse sostanzialmente velleitaria. Alla fine proprio il rapimento e l'assassinio
di Moro chiusero traumaticamente la strada al compromesso storico. E aprirono
una nuova stagione della politica italiana dominata dalla figura di Bettino
Craxi e destinata a sua volta a esaurirsi con la fine ingloriosa della prima
repubblica sotto i colpi di maglio della «rivoluzione giudiziaria» di
Tangentopoli.
La beatificazione di
Berlinguer sempre fedele a Stalin,
scrive Mario Cervi su “Il Giornale”. Un supplemento di 100 pagine dell'Unità,
convegni e dibattiti, o fervidi elogi del mondo politico, gli applausi dei
grillini: per i trent'anni dalla morte di Enrico Berlinguer il ricordo prende i
connotati della venerazione se non della santificazione laica. Omaggi più che
meritati se si riferiscono all'uomo. Che fu onesto, intelligente, riservato in
un mondo di ciarlatani, gran lavoratore. Per dirlo in sintesi una persona per
bene. Il culto per lui di chi ha nostalgia dal Partito (...) (...) comunista
italiano e alimenta ancora speranze in fulgide sorti progressive della sinistra
è non solo giustificato ma doveroso. Perché riguarda chi fu comunista
nell'essenza e in tutte le implicazioni del termine. E lo restò sfidando i fatti
e le e delusioni con la tenacia indomabile dei credenti. Gian Carlo Pajetta
disse, con il sarcasmo d'obbligo, che «si iscrisse giovanissimo alla direzione
del Pci». Lasciando con questo intendere che il ragazzo di buona famiglia
borghese fosse stato agevolato nello scalare la Nomenklatura delle Botteghe
Oscure. Un raccomandato. In effetti l'ascesa di Berlinguer ai vertici comunisti
ebbe l'avallo di Palmiro Togliatti che ai compagni altolocati indirizzò un
biglietto così concepito: «Questo è il compagno Berlinguer che viene dalla
Sardegna. Utilizzatelo nella vostra organizzazione». In verità, pur con
l'iniziale e potente spinta di Ercoli, la successione di Togliatti e di Longo
gli spettava di diritto: per le sue qualità e per la sua ortodossia ideologica.
Alla valanga di articoli di questi giorni ne aggiungo uno mio. Con l'ambizione
di non voler offendere una memoria, ma anche di non aggiungermi ai gloria
imperversanti. Il primo incarico di gran rilievo del ragazzo sardo fu la guida
della Federazione giovanile comunista italiana. Il che gli dava accesso ai sommi
uffici, compreso quello del sommo tra i sommi, il Migliore. Al rispetto delle
gerarchie ci teneva molto. Gli era stato assegnato un segretario particolare,
Mario Pirani, (ora editorialista di Repubblica), e s'era accorto che Pirani
sfogliava prima di lui la mazzetta dei quotidiani. «Dice con piglio da dirigente
- cito dalla biografia di Chiara Valentini - che il primo a sfogliarli vuole
essere lui». Non era incline all'ironia e nemmeno alle confidenze. Aveva da poco
compiuto i 24 anni - attingo di nuovo al saggio citato - quando andò per la
prima volta in Unione Sovietica con una delegazione di giovani partigiani.
Rimase estasiato. Ripeteva in ogni discorso che «la gioventù sovietica felice
canta nelle piazze la sua canzone preferita, Com'è bello vivere nel Paese dei
Soviet». Ammirava sconfinatamente Stalin che ebbe la fortuna - almeno lui la
ritenne tale - di incontrare. Togliatti era il Maestro: da lui aveva mutuato il
vezzo d'indirizzare bigliettini in inchiostro verde ai collaboratori. Alla fine
del viaggio russo fece firmare dalla delegazione un documento unitario che
esaltava le conquiste e le libertà dello stalinismo. Al ritorno a Roma ci fu chi
ebbe l'audacia di chiedergli qualcosa sulle donne russe, su come si vestivano,
su come si truccavano. La risposta può essere collocata nella casistica del
fanatismo quasi delirante. «Nel Paese del socialismo le donne non hanno bisogno
di nessun orpello per attrarre gli uomini. In Urss non ci sono donne. Ci sono
compagne sovietiche». Sciocchezze d'un ventenne, si dirà. Invece quel ventenne
non era per niente sciocco, era un apparatchik inflessibile che nella sostanza
rimase tale fino all'ultimo, quando un malore lo uccise e Sandro Pertini
presidente della Repubblica, tanto si agitò da dare l'impressione che
protagonista del funerale fosse lui. Ebbe anche nell'abbigliamento e nel
linguaggio tratti da asceta. In un suo volumetto Dietro la vetrina a Botteghe
oscure, il vecchio militante Fidia Gambetti, messo a dirigere la biblioteca di
Rinascita a Roma, così scrisse: «Da Bologna ritorna vincitore Berlinguer, unico
e naturale successore di Togliatti e di Longo. Con il suo aspetto sofferente di
sempre, più piegato che mai sotto gli sfuggenti colli del soprabito e della
giacca. Se dovessi dare un giudizio non potrei che rispondere non lo conosco.
Non ha mai messo piede in libreria. Il primo a comparire è il grande sconfitto,
Napolitano, sereno e signore come sempre». Ho indugiato su questi aspetti
marginali della vita di Berlinguer non per sminuirlo ma per collocarlo sul podio
che gli spetta e che a mio avviso è quello d'un conformista preparato e anche
illuminato, non quello degli innovatori. Fu preso a rimorchio dai cambiamenti,
talvolta rassegnandosi a malincuore. Anche gli strappi che gli sono valsi inni
d'ammirazione erano tutto sommato prudenti e inevitabili. Non si rese mai conto
del baratro verso il quale il comunismo si stava avviando, o se si rese conto lo
tenne per sé. Ha scritto Alfredo Reichlin nell'inserto dell'Unità: «È vero, noi
non fummo liberaldemocratici. Non avevamo letto i libri dei politologi americani
e a Botteghe Oscure del modello Westminster non si parlava». Concesso. Ma la
straordinaria vittoria del capitalismo sul comunismo che già era nell'aria non
derivava dalla genialità dei politologi, derivava dal disastro di un'utopia
tirannica. Berlinguer non sarebbe stato un tiranno. Probabilmente dei tiranni in
cui aveva fiducia sarebbe stato vittima. Dopo averli osannati. A Berlinguer
viene accreditato l'aver posto la «questione morale». Credo fosse sincero nel
metterla sul tappeto. Credo anche che con la sua condotta privata si sia
dimostrato degno della battaglia contro la corruzione. Non lo fu come massimo
dirigente del Pci foraggiato e mantenuto dall'Urss. Personalmente accredito a
Enrico Berlinguer, senza distinguo, la scelta della fermezza dopo il sequestro
di Aldo Moro e la strage della sua scorta. La scelta arrivò dopo un lungo
flirtare del Pci con le frange eversive della sinistra. Ma fu una scelta decisa.
Molti anche oggi spiegano che il negoziato con i terroristi assassini sarebbe
stato la via migliore per salvare la vita del leader democristiano. Io ritengo
che una trattativa svolta ignorando il sacrificio di cinque servitori dello
Stato sarebbe stata ignobile.
Berlinguer, anatomia di una
sconfitta.
Il libro di Claudia Mancina analizza la criticamente l'attività del leader di
Botteghe Oscure, scrive “Europa Quotidiano”. Claudia Mancina ha vissuto
dall’interno i travagli del Pci e cerca in questo veloce ma denso volumetto (Berlinguer
in questione, edito da Laterza, 2014) di sviluppare un bilancio critico
molto argomentato della leadership di Enrico Berlinguer. Ne esce fuori un
ritratto molto simile, quasi identico, a quello delle memorie sull’Italia
dell’ex-ambasciatore francese Gilles Martinet, inviato a Roma nel 1981.
Berlinguer appare «più umano, più autentico, più comunicativo» di Palmiro
Togliatti, al punto che ciò «lo rese accetto anche a chi non avrebbe mai votato
comunista», essendo peraltro alla guida di un partito che dopo il dissenso sulla
Cecoslovacchia aveva espanso i suoi consensi nei ceti medi urbani, specie
giovanili. Eppure, se quelle erano le premesse personali, il bilancio
strettamente politico è quello di una sconfitta: al di là delle diverse
strategie (dal compromesso storico alla regressione neo-identitaria successiva)
Berlinguer elude l’unica possibile opzione, quella della trasformazione
esplicita in una moderna forza inserita nel socialismo europeo, ossia dentro
l’orizzonte dell’economia di mercato. Volendo mantenere un riferimento
rivoluzionario (anche se i contenuti con cui esso si identifica si modificano,
dall’ammirazione per l’Urss si passa a una sorta di diversità etica, di ripulsa
morale per la società dei consumi lontana dall’apertura modernizzante del
marxismo) ma al contempo anche delineare una prospettiva credibile di accesso al
governo, la soluzione consiste nell’idea di farsi legittimare da un sistema di
alleanze. Come, nonostante le differenze e gli accenti, la elude la prospettiva
“comunista e riformista” rivendicata ancora qualche mese fa da Emanuele Macaluso
nel suo ultimo libro, in alternativa all’opposta ricostruzione di Enrico
Morando. In questo senso è la storia politica del Pci, come sostengono Mancina e
Morando, ad essere tramontata come tale nel segno della sconfitta, al di là
delle energie che essa ha liberato dopo quella sconfitta. Da qui il rapido
declino che si manifesta subito dopo la sua scomparsa, che lascia in eredità il
referendum sulla scala mobile, voluto non per ragioni di contenuto ma per
difendere il potere di veto del proprio partito. Un’impostazione che si riflette
sulle questioni elettorali e istituzionali dove paradossalmente un partito di
sinistra, che dovrebbe essere in astratto preoccupato di garantire forza ai
governi per riequilibrare le disuguaglianze sociali, finisce per difendere a
lungo regole iper-garantistiche varate nel periodo della frattura verticale
della Guerra fredda. Anche il Pci, insieme alle forze di maggioranza,
contribuisce quindi attivamente all’esito catastrofico del primo sistema di
partiti, che nel suo insieme, come nota Pietro Scoppola richiamato da Mancina,
non riesce a uscire da quella sorta di grande coalizione anomala che era la
solidarietà nazionale per giungere ad una fisiologica democrazia dell’alternanza
europea, come avrebbe voluto Aldo Moro. Alla fine Mancina ci propone un
paradosso: la personalità politica che più ha insistito per una continuità
ideale con alcuni aspetti di Berlinguer, Walter Veltroni, è quella che si è più
battuta per una trasformazione post-ideologica, per un nuovo centrosinistra a
vocazione maggioritaria che non avesse bisogno di protesi centriste; viceversa
la persona più critica con Berlinguer in nome di una visione realistica della
politica, D’Alema, rivendicando orgogliosamente la continuità con la storia del
Pci ha poi sempre voluto alleati centristi per accedere al governo. Alla fine,
però, la mutazione molto netta del centrosinistra è arrivata, dando ragione alla
frase di Aldo Moro che Mancina premette: «Perché qualcosa cambi, dobbiamo
cambiare anche noi».
Scandalizzarsi è un'ipocrisia
Quante vite salvate da un patto. Dai sequestri De Martino e Cirillo ai rapimenti
di Mastrogiacomo e Sgrena: i negoziati con camorra, Br e terroristi islamici
hanno consentito di evitare spargimenti di sangue, scrive “Il Giornale”. Esiste
uno Stato immaginario che non si piega e non scende a patti, e anche nei momenti
più difficili preferisce affrontare le conseguenze più tragiche anziché trattare
col nemico. Ed esiste poi uno Stato reale che ufficialmente fa la faccia feroce
ma sotto traccia incontra, dialoga, si aggiusta. Che promette, e a volte
mantiene. Che riceve promesse, e quasi sempre qualcosa incassa. Se davvero -
perché di questo in fondo si tratta - qualcuno ha trattato con Cosa Nostra la
consegna di Totò Riina, beh, non sarà stata né la prima né l'ultima volta che il
do ut des ha fatto la sua silenziosa comparsa nella guerra tra Stato e
antistato. Il catalogo è lungo e ricco, e appartiene in buona parte alle
cronache del terrorismo: quello domestico, all'epoca della furia omicida delle
Brigate rosse e dei loro epigoni, quanto quello islamico in giro per il mondo.
Ma non è che le vicende del crimine organizzato non portino anch'esse traccia di
accordi sottobanco: nella sentenza d'appello ai calabresi che nel 1997 rapirono
a Milano Alessandra Sgarella, una piccola nota a piè di pagina dà atto che a un
boss in carcere vennero promessi benefici penitenziari in cambio delle sue
pressioni per la liberazione dell'ostaggio. Si poteva fare, non si poteva fare?
Si fece e basta, e la Sgarella tornò a casa dopo quasi un anno di terribile
prigionia. Non fu, giurano gli addetti ai lavori, l'unica volta che un sequestro
dell'Anonima si risolse così. D'altronde esiste un precedente storico anche se
poco esplorato, il memorabile sequestro di Guido De Martino, figlio del
segretario del Psi, rapito nel 1977 dalla malavita napoletana e rilasciato dopo
una colletta tra banche, partiti, servizi. Nei rapporti con il terrorismo di
ogni risma ed etnia, la trattativa sotterranea è invece - almeno in Italia - una
prassi e quasi un'arte, spesso esercitata quasi alla luce del sole. A partire
dal caso più noto e peggio concluso, quando intorno al sequestro del presidente
democristiano Aldo Moro sorse addirittura un «partito della trattativa» che
agiva per pubblici proclami senza che nessuno si indignasse o aprisse inchieste;
e persino gli emissari della trattativa nel fronte brigatista avevano nomi e
cognomi di pubblico dominio, e pubblicamene discusse se erano le possibili
contropartite alla liberazione di Moro. Poi finì come finì, ma nessuno finì
sotto inchiesta per avere cercato di salvare Moro. Nessuno venne incriminato per
avere trattato sottobanco con frange di brigatisti la consegna di James Lee
Dozier, il generale americano sequestrato subito dopo Moro. Si indagò, invece,
ma senza quagliare granché, sulla più spudorata delle trattative, quella che
portò alla liberazione dell'assessore napoletano Ciro Cirillo, sequestrato anche
lui dalle Brigate Rosse, e tornato a casa dopo che per salvarlo si era mosso una
specie di circo fatto di agenti segreti, politici, imprenditori, tutti a baciare
la pantofola di Raffaele Cutolo, il capo della Nuova camorra organizzata che nel
supercarcere dove era richiuso riceveva visite una dopo l'altra. Il pasticcio
era tale che qualche anno fa Cirillo, ormai ottuagenario, disse di non voler
raccontare nulla fino alla morte. «È tutto scritto in un memoriale da un
notaio». Ma dove la decisione di scendere a patti è stata una costante, tanto
notoria quanto inconfessata, è quando l'Italia si è trovata a fare i conti con
il terrorismo islamico: una prassi così costante da suscitare l'indignazione
degli alleati e della loro intelligence, ma resa inevitabile dalla commozione
con cui vengono seguiti i casi dei nostri connazionali rapiti qua e là per il
mondo. Per i poveri Quattrocchi e Baldoni, rapiti e ammazzati in Irak, per
allacciare una trattativa mancò il tempo, non la volontà. Da allora in poi, è
quasi incalcolabile il fiume di fondi riservati dei servizi segreti finiti nelle
tasche della jihad pur di riportare in patria i malcapitati. Si racconta che la
telefonata a casa che i rapitori concessero a Domenico Quirico, l'inviato della
Stampa sequestrato in Siria, sia costata all'erario una robusta bolletta. E
cifre ben maggiori sono servite per ottenere il rilascio delle due Simone, la
Pari e la Torretta, sequestrate nel 2004 a Baghdad, o dell'inviato speciale di
Repubblica Daniele Mastrogiacomo. Qualche dettaglio emerse a margine della
vicenda finita tragicamente della giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena: il
4 marzo 2005 un funzionario del Sismi consegnò a un emissario dei rapitori il
riscatto, in Kuwait o negli Emirati Arabi. L'emissario diede il via libera, a
Baghdad la giornalista venne liberata e consegnata a un'altra squadra del Sismi.
Ma sulla strada per l'aeroporto l'auto dei nostri 007 fu attaccata per errore da
un posto di blocco degli americani, nell'uragano di colpi il capodivisione
Andrea Calipari perse la vita, il suo collega Andrea Carpani venne centrato al
petto, anche l'autista venne sfiorato, e solo la Sgrena uscì miracolosamente
incolume. Nonostante lo choc e le polemiche, neanche i retroscena di quella
trattativa sono mai stati ufficialmente resi noti. La sostanza è che si tratta,
da sempre. E forse anche nel 1992, quando magistrati e poliziotti venivano fatti
saltare in aria col tritolo insieme a interi tratti di autostrada, ci fu chi
decise di tastare gli umori dell'altra parte, e non arretrò inorridito quando la
testa di Riina venne offerta in cambio di questa o quella concessione.
UN COMPROMESSO NON STORICO.
Aldo Moro, l’archivio
privato sepolto (e secretato) a Palazzo Chigi.
Nel suo nuovo libro, lo
storico Massimo Mastrogregori segue le tracce dei faldoni in cui il presidente
Dc ucciso dalle Br conservava tutte le carte, comprese quelle più riservate. Per
esempio sullo scandalo petroli. Almeno 18 fascicoli sono ora sotto chiave alla
presidenza del Consiglio, di altri arrivati all'ufficio legislativo dal
Tribunale di Torino si sono perse completamente le tracce, scrive Stefania
Limiti il 20 novembre 2016 su "Il Fatto Quotidiano. La figura di Aldo Moro è
un’inesauribile fonte di questioni aperte. Non solo il rapimento e la morte, gli
americani e la Dc, Cossiga e Andreotti. Lo è anche il suo archivio privato. Uomo
di pensiero immerso nell’azione politica, Moro curò attentamente la raccolta
degli atti della sua intensa attività. Era così prudente e diffidente (non a
torto) che arrivò a compartimentarli: al suo portavoce Guerzoni la chiave
dell’armadio dei discorsi, a Rana e Freato, uomini chiave dei suoi uffici,
quella dell’archivio della segreteria (e i materiali più riservati da custodire
altrove), agli ambasciatori Pompei e Cottafavi quella della raccolta degli atti
diplomatici. La sera andava in scena il rituale delle borse: di stanza in stanza
Moro consegnava, o riceveva e metteva in borsa, i documenti di competenza dei
singoli collaboratori, uno per uno. Dopo il suo sequestro il controllo di quelle
carte passò inevitabilmente ai suoi principali collaboratori, più o meno
d’accordo con i familiari. Ma se ne preoccupava anche la polizia, che pare
sorvegliasse l’ingresso dello studio di via Savoia giorno e notte anche durante
i 55 giorni (non avendo vigilato a sufficienza prima). Lo storico Massimo
Mastrogregori, che ha già dato prova di abilità con La lettera blu (Ediesse), in
cui affronta il tema sensibile della costruzione dell’ostaggio, svela in un
nuovo lavoro titolato Moro. La biografia politica del democristiano più
celebrato e discusso nella storia della Repubblica, per i tipi di Salerno
editore, che documenti privati del presidente democristiano sono tutt’oggi
custoditi e, soprattutto, segretati presso gli archivi della Presidenza del
Consiglio. Mastrogregori ha inseguito per anni la storia delle carte private di
Moro. “Una pista precisa portava all’archivio del tribunale di Torino, che si
trova in un capannone, luminoso e sterminato, fuori città, a Pianezza: ottanta
armadi “compatti” alti otto metri e lunghi trenta, ventisei file di scaffali
ciascuno. I documenti del processo sullo “scandalo dei petroli” occupano decine
di faldoni, riordinati da un’archivista bravissima, ma poco catalogati. I
tasselli mancanti della storia dell’archivio di Moro – mai raccontata finora –
saltano fuori da quelle carte quasi per caso, un minuto prima di rinunciare”. Un
filo sottile e assai tortuoso che lo storico ha pazientemente riavvolto fino in
fondo, tanto da affermare con precisione che almeno diciotto fascicoli sin dal
1984 giacciono coperti dal segreto a Palazzo Chigi – mentre di parte dei
documenti dell’archivio di Torino versati nel febbraio di quell’anno all’ufficio
legislativo della presidenza del Consiglio si sono perse completamente le
tracce. L’aspetto inquietante del suo racconto riguarda anche il possibile
contenuto di queste carte, formalmente in possesso di Giovanni Moro dal marzo
1983: poco dopo collaboratori e familiari di Moro furono coinvolti in
un’inchiesta giudiziaria, lo scandalo petroli, e lo studio di via Savoia fu
perquisito dalla Guardia di Finanza. Il 20 aprile 1983 Freato fu arrestato con
l’accusa di aver favorito la nomina del generale Raffaele Giudice al vertice
della Guardia di Finanza. Il 23 aprile scattò la perquisizione dei finanzieri:
“Lo studio era composto di quindici locali, compresi bagni, ingressi corridoi e
cantina, ma furono attratti specialmente dalle tre stanze in fondo al corridoio
principale: le due ultime a destra, comunicanti, contenevano cinque armadi
blindati, più uno piccolo; l’ultima a sinistra uno schedario di legno. Lo “scopo
della perquisizione” era quello di trovare tracce dei rapporti con ufficiali
della finanza, funzionari dell’amministrazione finanziaria, petrolieri; nello
schedario, in effetti, i finanzieri rinvennero e sequestrarono le schede
intestate ad alcuni imputati, ma non c’erano i fascicoli corrispondenti alle
schede: mancavano tutti i fascicoli, da uno a tredicimila”. Le ricerche di
Mastrogregori sono dunque destinate a aprire nuove rivelazioni sulla figura e
l’azione politica di Aldo Moro. Assai meno convincente la tesi politica del suo
lavoro: Moro non cercò un’intesa stabile con il Pci, dunque la tesi che il
compromesso storico sia all’origine della sua morte è fasulla. In effetti, chi
mai può contestare che Moro fosse un anticomunista? Ma il Presidente sapeva che
la Dc non poteva farcela senza il sostegno della classi popolari: da qui il suo
disegno innovativo e riformatore. La tesi dello storico assomiglia molto a un
sillogismo sterile, che non poteva non affascinare Paolo Mieli, secondo il quale
in Italia non ci sono misteri. Gli ha dedicato due pagine sul Corriere senza
accennare però alla parte più succulenta: le carte scomparse.
Moro non voleva allearsi
col Pci. Un compromesso (non) storico.
Il libro riesamina i rapporti di Moro con la sinistra; smentisce
l’interpretazione consueta del suo atteggiamento verso i comunisti nel periodo
della solidarietà nazionale, scrive Paolo Mieli il 13 novembre 2016 su “Il
Corriere della Sera”. Una stretta di mano tra il segretario del Pci Enrico
Berlinguer e il presidente della Dc Aldo Moro. La foto venne scattata il 3
maggio 1977, durante il periodo degli accordi ad ampio raggio di solidarietà
democratica. Moro sarebbe stato assassinato un anno dopo dai terroristi delle
Brigate rosse. A cent’anni dalla nascita è giunto il momento di smetterla di
credere «alla favola che sia stato ucciso perché stava preparando il compromesso
storico con i comunisti». È questo il punto di partenza di un importante libro
di Massimo Mastrogregori, Moro (che sta per essere pubblicato per i tipi della
Salerno), particolarmente attento ai rapporti tra lo statista democristiano e i
partiti di sinistra. Rapporti che promettevano di evolversi in qualcosa di più
impegnativo allorché Moro, già leader della Federazione degli universitari
cattolici, tra il 1944 e il 1945 guardò per così dire con interesse al mondo
socialista e a quello comunista. Ne è testimonianza un suo articolo su «La
Rassegna» del 6 luglio 1944, in cui disegna uno scenario («assai ardito», lo
definisce Mastrogregori) di conciliazione del mondo occidentale con quello
sovietico. Tesi non in sintonia con le idee che all’epoca circolavano in
Vaticano: passeranno tre settimane e il 1° agosto Papa Pio XII si pronuncerà
esplicitamente contro la collaborazione con comunisti e socialisti. Ma l’uomo
politico insisterà nelle sue relazioni con i partiti di Palmiro Togliatti e
Pietro Nenni. La sua rivista, «Studium», ospiterà nel numero 7-8 del 1945 la
pubblicità del periodico comunista «Società» (edito da Einaudi) e nel numero di
dicembre comparirà un articolo che suggerirà ai cattolici di avvicinare e
riconquistare i comunisti. Lui stesso, stando ad alcune testimonianze
dell’epoca, li avvicinò. Nei diari di Antonio Segni alla data 19 marzo 1960 è
annotato che l’uomo dell’Ufficio affari riservati, Federico Umberto D’Amato, gli
avrebbe riferito di un colloquio con l’ex dirigente comunista Eugenio Reale
secondo il quale Moro nel 1944 aveva presentato — al segretario del Pci pugliese
Antonio Di Donato — una domanda di iscrizione al partito di Togliatti. Dopo che
questa richiesta era stata respinta (per decisione, a suo dire, dello stesso
Reale), Moro ne aveva presentata una seconda, al segretario locale del Psi
Eugenio Laricchiuta. Anch’essa rigettata, ma di cui, in anni successivi, furono
in grado di riferire circostanziatamente Giuseppe Saragat e Francesco De
Martino. Qui Mastrogregori prende per buone le testimonianze (in particolare
quella di Reale), ma ipotizza che il giovane politico pugliese fosse stato
autorizzato dalla Chiesa a «svolgere una missione presso i partiti
anticristiani». In ogni caso Moro, entrato subito dopo nella Dc, continuò a
manifestare attenzione nei confronti dei comunisti. Ai lavori della Costituente
Alcide De Gasperi notò che quel politico alle prime armi aveva «sostenuto gli
articoli sociali di sinistra» e lo definì (in privato) «un professore che ha
combinato qualche guaio». Togliatti si accorse di «quel giovane di Bari»:
secondo le testimonianze di Nilde Iotti e Luciano Barca, affidò al parlamentare
comunista Renzo Laconi il compito di interloquire costantemente con lui. E
decise di accordare alcune concessioni alla scuola cattolica (materia su cui
Moro era relatore) anche a costo di scontentare un grande intellettuale,
Concetto Marchesi, che proprio con Moro non aveva trovato l’accordo. Dopodiché,
negli anni della guerra fredda, Moro fu un anticomunista inflessibile. Ma, nel
contempo, si segnalò per alcuni gesti di duttilità nei confronti dei partiti di
sinistra. Nel voto decisivo che il 27 maggio del 1947 escluse comunisti e
socialisti dal governo, Moro si astenne. Quando si discusse del Patto atlantico,
da sottosegretario agli Esteri fece avere a Giuseppe Dossetti documenti
riservati utili a rafforzarne le convinzioni antiamericane: di nuovo si ebbe qui
la reazione indispettita di De Gasperi. Fu relatore su un progetto assai
benevolo per il pagamento delle riparazioni di guerra all’Unione Sovietica. La
sera del 22 dicembre 1950 disertò il voto su una mozione governativa a favore
dell’intervento statunitense in Corea. In privato però rimproverava al Pci di
non essersi schierato dalla parte di Tito nella controversia con Stalin e nel
1953, alla morte del dittatore sovietico, criticava Nenni per qualche suo
eccesso nelle espressioni di compianto. Il 19 ottobre del 1954 il democristiano
Giuseppe Togni tuonò contro i comunisti «sudditi di un Paese straniero»: Moro,
da capogruppo della Dc, prese le distanze. Nella seconda metà degli anni
Cinquanta, soprattutto dopo le mancate conseguenze tratte in casa comunista
dalle rivelazioni di Nikita Krusciov sui crimini di Stalin e la repressione
sovietica in Ungheria, Moro fu sempre più netto nella sua ostilità al Pci. Nel
1956 fu tra i principali promotori di Stay behind e nel luglio del 1960 difese
fino all’ultimo il governo Tambroni sostenuto dai voti missini. Anche quando fu
chiaro che sarebbe stato travolto dalle manifestazioni di piazza. Quando poi si
trattò di edificare il centrosinistra, fu il regista di una costruzione assai
complessa, riuscendo là dove non erano riusciti né Giovanni Gronchi, né Amintore
Fanfani. Nenni all’inizio lo sottovalutò: quando Moro, nel 1959, fu eletto
segretario della Dc, il leader socialista non ritenne neanche di prenderne nota
nel suo diario. Poi però i due si intesero sempre di più e Nenni, divenuto suo
vice alla guida del governo, ebbe modo di accorgersi di quanto invece Moro
diffidasse di Ugo La Malfa. Nell’estate del 1964 Moro non credette che fosse in
atto un colpo di Stato da parte del generale Giovanni De Lorenzo. E non se ne
convinse neanche nel 1967, quando, sulla scia delle rivelazioni dell’«Espresso»,
Nenni si persuase che nel luglio di tre anni prima l’Italia era stata sull’orlo
di un golpe. Fu Moro a escogitare la formula grazie alla quale Giuseppe Saragat,
alla fine del 1964, fu eletto presidente della Repubblica. Poi nel 1968 i
socialisti unificati non otterranno l’atteso premio dalle urne, il suo governo
entrerà in crisi e lui inizierà a cercare di coinvolgere i comunisti. «Moro
nella veste insolita di estremista», si allarma Nenni nei suoi diari.Niente di
più lontano dal vero. Moro capisce che la Dc, per restare centrale nel sistema
politico, deve dar vita ad equilibri «più avanzati», ma non riesce a convincere
a fondo né la gran parte dei suoi compagni di partito, né l’alleato americano. E
neanche i comunisti, il cui giudizio nei suoi confronti è altalenante. Ancora
nel 1976, quando il Pci di Enrico Berlinguer entra nell’area di governo, le
esitazioni sono molte. Così «l’idea di un Moro demiurgo della politica italiana,
abile regista eliminato col sequestro e l’assassinio per deviare sviluppi
politici ben definiti e avviati, ancorché molto diffusa», scrive Mastrogregori,
«non è per niente realistica». Di conseguenza anche le pagine dedicate al
rapimento e all’uccisione dello statista (1978) sono assai meno dietrologiche di
quanto è consueto trovare nelle ricostruzioni anche accurate sulla sua vita. Ma
allora quali furono i veri rapporti di Moro con il Pci? Nel suo recente L’arte
del non governo (Marsilio), Piero Craveri osserva che c’era una sintonia solo
apparente tra la visione di Moro «di una democrazia che doveva essere operante»
e la proposta di Berlinguer del compromesso storico. Per Moro «l’unione delle
forze politiche ai fini di una “solidarietà nazionale” era di natura transeunte
e si fondava logicamente, come in tutte le democrazie liberali, sulla situazione
di straordinaria emergenza che si era venuta creando, i cui caratteri erano
politici ed economico-sociali». Per Berlinguer avrebbe dovuto avere invece
carattere «permanente», andava considerata come «un approdo» la cui finalità era
di «carattere istituzionale». Anche Guido Formigoni, in Aldo Moro. Lo statista e
il suo dramma (il Mulino), insiste su questo punto: il processo che aveva in
mente lo statista democristiano, «doveva consolidare il sistema democratico e
accompagnare l’evoluzione ideologica e politica del maggior partito di
opposizione, senza cedere per principio a logiche strettamente consociative,
oppure allo schema berlingueriano del compromesso storico». Altro che abbraccio
tra Dc e Pci. Quella rappresentata dalla statua di Maglie di Aldo Moro con
l’«Unità» sottobraccio è quantomeno una forzatura. La sinistra politica e
culturale guardò sempre a lui con diffidenza. Natalia Ginzburg lo definì
«dromedario grande e triste»; Giorgio Agosti lo descrisse come «viscidamente
pretesco» e «infido»; Palmiro Togliatti irrise a quel «De Gasperi alessandrino»;
per Pietro Ingrao fu nient’altro che un «gesuita»; per Davide Lajolo dava «il
senso della pioggia uggiosa delle scure giornate invernali», era «un Mefistofele
di sacrestia, dalle parole foderate di grigio e dalla smorfia dolciastra, che
sta seduto al banco del governo con la stessa noia con cui sta genuflesso in
chiesa, molle e resistente come la gomma»; Pier Paolo Pasolini scrisse che la
sua era «la lingua della menzogna». Del resto, in un volumetto del 1976 cioè
l’epoca dell’unità nazionale — Moro(Feltrinelli), libro peraltro simpatizzante
nei confronti dello statista democristiano — un importante giornalista
comunista, che dell’«Unità» fu condirettore, Aniello Coppola, scriveva di lui in
toni quasi sprezzanti: quell’uomo era «certamente uno dei principali
responsabili» della «degenerazione degli apparati pubblici, del decadimento
dello Stato, della riduzione della politica a gioco di formule e a mera
diplomazia istituzionale». Era anzi «l’emblema di questo modo — sempre più
contagioso — di fare politica». Ma davvero lo statista democristiano fu
l’emblema di questo modo di fare politica? Nel libro Intervista su Aldo Moro, a
cura di Alfonso Alfonsi (Rubbettino), George L. Mosse ha osservato che «la
carriera politica di Aldo Moro assume un significato di interesse generale
perché è strettamente collegata a quella crisi del sistema di governo
parlamentare manifestatasi in tutta la sua gravità nel corso del XX secolo».
Emilio Gentile ha recentemente osservato come queste acute osservazioni di Mosse
(del 1979) «si leggono oggi con maggiore inquietudine», se si stabilisce un
confronto tra la crisi della democrazia parlamentare degli anni Settanta e
quella attuale. Mosse notò che a Moro non piaceva la televisione ed era incapace
di usare i mezzi di comunicazione più moderni. Anche Mastrogregori mette in
risalto come Moro non sapesse «parlare al popolo» né usare la televisione. Andò
a Londra in treno — nella vettura presidenziale costruita nel 1940 per
Mussolini, dotata di camera da letto, studio, saloncino, sala da pranzo —
mettendoci due giorni per arrivare a Victoria Station: «Trasmetteva un’immagine
di lentezza e di arretratezza». Il modo di comunicare più avveniristico per lui
era scrivere editoriali molto molto complessi per «Il Giorno» (ne stava
correggendo uno, in auto, anche la mattina in cui fu rapito). Tutto ciò —
sosteneva Mosse — nel momento in cui, per vincere la sfida dei movimenti
antidemocratici, gli uomini politici avrebbero dovuto imparare a usare miti,
simboli, riti collettivi, ogni strumento della moderna comunicazione di massa.
Anche se in questo Mosse intravedeva alcuni pericoli: «Nel destino di Moro si
prefigurava il paradosso della democrazia parlamentare… se si vuole essere uno
statista bisogna essere in una certa misura un capo carismatico, bisogna fare
appello, a seconda dei casi, al sentimento nazionale e ad altre passioni, per
condurre la gente verso nuove mete». Nella consapevolezza che «se si fa tutto
ciò, si corre il rischio di trasformare il sistema in una dittatura». Moro in
ogni caso si rifiutò di far propri questi nuovi modelli. Ai quali invece si
adattò — in una certa misura — Berlinguer. E dagli «appunti» di un collaboratore
di Moro, Andrea Negrotto di Cambiano, si è appreso che, anche per questo, il
leader democristiano considerò quello comunista «non dotato, purtroppo, di
quella vera grande visione politica» di cui era accreditato; al più «un grande
tattico, capace di sfruttare con abilità le situazioni contingenti». È solo per
motivi «di propaganda e apologetici», conclude Mastrogregori, che ci si è poi
concentrati sulla figura di Moro come «tessitore di un accordo con il Pci». In
realtà «egli fu, negli ultimi due anni della sua vita, più il negoziatore di una
tregua armata — non solo metaforicamente — che non il creatore di nuovi
equilibri sul punto di realizzarsi». Un giudizio in controtendenza.
I due prigionieri.
Gramsci, Moro e la storia del Novecento italiano. Massimo Mastrogregori.
Anno 2008 Editore Marietti. Quelle di Gramsci e di Moro sono due storie diverse:
un comunista e un cristiano; un rivoluzionario sconfitto e un democratico che
guida il partito al governo da trent’anni; due tempi diversi; due mondi diversi.
Ma analogie e comparazioni possono aiutarci a vedere cose nuove, rivelano
connessioni nascoste. La luce proiettata su una storia si riflette sull’altra,
le due esperienze si illuminano a vicenda. Questo saggio di storia comparata le
racconta entrambe, come due vite parallele. Dei due prigionieri offre un
ritratto, un’analisi del contesto storico e un’interpretazione dei testi che
scrissero nel carcere: Quaderni e lettere di Gramsci, Memoriale e lettere di
Moro. Sollecitati dalle questioni fatte filtrare abilmente da compagni di
partito e dai familiari o nel dialogo drammatico con i carcerieri-inquisitori, i
due prigionieri scrivono lettere, appunti e "memoriali" in cui cercano di
interpretare e risolvere la situazione tragica che si è creata. Così, nelle dure
condizioni di prigionia, prosegue la loro riflessione sulle crisi del Novecento
italiano – il fascismo, la rivoluzione, il comunismo, la democrazia. E diventa,
per certi versi, addirittura più acuta.
Nuovi studi sul sequestro
Moro, a cura
di Massimo Mastrogregori, con Contributi di M. Mastrogregori, F. M. Biscione, M.
Napolitano, P. Varvaro, 2010, pp. 308, figure in bianco/nero e a colori n.t.
Fabrizio Serra editore. «Nell'archivio del tribunale penale di Roma è conservata
la lettera che Moro indirizzò dal carcere del popolo, alla fine di aprile 1978,
al partito della Democrazia cristiana. L'originale è riprodotto in facsimile
alla fine di questo saggio. Qui la trascrivo, foglio per foglio, non solo per
consentire a chi dovesse leggere di farsi un'idea del suo contenuto, ma anche
per far vedere che essa è stata scritta dall'ostaggio con penne di colore
diverso, blu e nera ...Forse tutte le storie sono complicate, ma questa del
sequestro di Aldo Moro e di ciò che scrisse nel covo brigatista lo è in modo
speciale ... Sono a metà di un lavoro su queste carte, che dura ormai da qualche
anno. Confesso che i punti interrogativi sono parecchi. Questo però non vuol
dire che non si possano proporre elementi nuovi: vedrete che proprio
l'osservazione di questo singolare documento in due colori potrà condurre a
qualche risultato nell'interpretazione di alcuni punti di questa vicenda. Si
tratta delle carte, quindi delle lettere di Aldo Moro, soprattutto, e del
cosiddetto memoriale, indirettamente ma si tratta anche, più in generale, del
sequestro. Il modo in cui leggiamo questi scritti e ne ricostruiamo la storia
dipende, strettamente, anche dall'interpretazione data al sequestro. Perché di
questa storia sappiamo tante cose, nel senso che sono disponibili molte
testimonianze e osservazioni di imputati, detenuti, poliziotti, giudici,
giornalisti, studiosi eppure resta la sensazione che lettere e memoriale siano
documenti sfuggenti, elusivi ... In realtà, la storia di Moro è interessante
perché è un po’ il paradigma di una grande storia. Perché molti ancora
continuano a scavare in queste vicende e ogni anno il discorso sembra
ricominciare da capo, in un modo che a qualcuno specie all'estero potrebbe
sembrare irritante? Forse perché è stata un'operazione terroristica, nella quale
alcuni elementi d'incertezza, o controversia, si sono aggiunti all'oscurità e
segretezza, di moventi e obiettivi, che sono proprie delle operazioni
terroristiche ... Ma anche perché abbiamo la sensazione che si sia sollevato,
con quell'episodio, per un momento, un velo: è successo qualcosa che potrebbe
dirci molto sulla storia italiana più profonda» (Massimo Mastrogregori)
La lettera blu: Le Brigate
rosse, il sequestro Moro e la costruzione dell’ostaggio.
La morte di Moro è sempre stata rievocata entro uno schema cromatico che poneva
in conflitto il rosso delle brigate e il nero delle stragi e dei servizi
deviati. Era come se non si potesse prescindere dai termini di una lunga guerra
civile nazionale, mai completamente risoltasi. Questo libro, invece, ci parla di
quel la guerra con una lingua compiutamente post-bellica. Il Moro di
Mastrogregori – certo, nelle condizioni disperate nelle quali si trovò costretto
negli ultimi giorni della sua esistenza – restò politicamente lucido, combattivo
nei confronti dei suoi nemici, impegnato a costruire il terreno di un dialogo
tra tutte le parti. Anzi, l’analisi filologica delle lettere – dove questa volta
è il blu dell’inchiostro a guidare l’attenzione del ricercatore – sembra
suggerire una chiave di lettura assolutamente originale. Insomma, il leader
cattolico non si arrendeva affatto ai carcerieri, non ne propugnava il
riconoscimento politico, ma recitava una parte, metteva in scena un personaggio,
collaborava alla costruzione di se stesso come ostaggio, «accettando di pagare
un prezzo per questo (dare corpo alla propaganda terroristica)». Sicché, se il
rosso e il nero erano i colori con i quali poteva essere descritta la
vittima-martire, il blu della lettera di Moro sembra raccontare la vicenda di un
politico che non si arrese mai a un destino già scritto, perché voleva
«assolutamente tornare libero […] perché non sopportava di non poter camminare».
Recensione di Michelangela Di
Giacomo. Massimo Mastrogregori, La lettera blu. Le Brigate Rosse, il sequestro
Moro e la costruzione dell’ostaggio. Ediesse, Roma, 2012. Massimo Mastrogregori
torna in questo suo ultimo lavoro a riflettere su un tema a lui già caro da
qualche anno: gli scritti del sequestro Moro. Dopo aver analizzato il
“memoriale”, si sofferma ora su “la lettera blu”, la lettera che Moro indirizzò
al partito della Democrazia Cristiana alla fine di aprile del 1978, scritta con
due inchiostri, nero e, appunto, blu. Il testo della lettera è oggetto ma
soprattutto strumento dell’autore per costruire un percorso di ragionamento,
accompagnando il lettore in un crescendo logico da alcune “deduzioni
preliminari” fino ad una conclusione chiara e strutturata. Un percorso maieutico
che l’autore conduce non per, ma con il lettore, evidente riverbero
dell’originale esperienza seminariale dalla quale il libro nasce. L’Aldo Moro di
cui parla Mastrogregori è uno dei protagonisti di una recita collettiva,
condivisa da lui stesso, dalle Br, dai suoi collaboratori e familiari e
dall’apparato pubblico. Una recita il cui risultato è un corpus di lettere, in
cui è evidente la parte di ciascuno. Mastrogregori non si lascia ingannare dal
tentativo tutto filologico dell’identificare nella lettera le parti ascrivibili
a ciascuno di quegli attori, ma la usa da storico, come banco di prova della sua
teoria della “costruzione dell’ostaggio”, una teoria in cui la domanda
ricorrente è “perché Moro scrive? Perché si presta a interpretare un ruolo?”. Il
punto dunque è abbandonare la falsa questione dell’autenticità dei suoi messaggi
– e le tre immagini che da quella discussione si sono create di Moro: quella dei
brigatisti che ne attestavano la veridicità; quella della scena pubblica che
sminuiva il personaggio; e soprattutto quella della famiglia e di alcune
interpretazioni successive al sequestro che lo trasformano in una vittima. Il
libro spiega come viene costruita la prima immagine, accenna alla costruzione
della seconda e per conseguenza smonta la terza. Il tentativo riesce, pur con
una certa complessità – stilistica e costruttiva – che tuttavia rispecchia la
complessità dell’oggetto preso in considerazione. Complessità che lo stesso
autore non manca di sottolineare a più riprese e che non deve essere mai persa
di vista al momento di avvicinarsi agli studi sul sequestro Moro – una dicotomia
tra troppo e troppo poco, in cui anche il pieno lascia lo storico perplesso
sulla possibilità di considerarlo attendibile e in cui molto è lasciato
all’esigenza di immaginare. Mastrogregori immagina molto, rende il testo
intrigante calandosi nel personaggio, schizzando le sensazioni che Moro deve
aver vissuto dalla violenza del sequestro al vedersi costretto ad abbandonare il
se stesso persona fuori dalla cella per entrare nel se stesso personaggio. E
allora la spiegazione del perché Moro scrive diventa più chiara e si lega alla
duplicità di una persona che non ha cessato di esistere pur nella scelta di
accettare il personaggio che poi scrive: chiuso nel covo dei terroristi, scrive
perché fare politica è stato il suo mestiere, una parte importante della sua
vita, e gli viene naturale continuare a farla, anche in quella situazione
inimmaginabile e disperata. Ma anche perché vuole assolutamente tornare libero,
per fare tante cose: per esempio, perché non sopportava di non poter camminare.
(p. 129) Nella duplicità politica-persona risiede la “convenzionalità” dei suoi
argomenti, che l’autore interessantemente definisce come il frutto di un
complesso equilibrio tra il personaggio sequestrato e l’espressione di
sentimenti propri della persona Aldo Moro. Convenzionale in quanto piegato dalla
situazione, non in quanto asettico. L’autore non manca di considerare il punto
di vista dall’esterno della cella – di chi a quella recita ha partecipato
contribuendo a costruirne una scenografia tanto adeguata quanto ingannevole: la
scena di una Repubblica da difendere, quella stessa Repubblica accusata
pubblicamente da più parti in quello stesso periodo. Né manca di sottolineare un
aspetto indispensabile per capire gli scritti dei 55 giorni: il fatto che siano
alla fine di un trentennio, politico ed umano. Giusto dunque sottolineare la
lunga permanenza di Moro sotto scorta, la sua preoccupazione per le eventuali
ricadute internazionali dell’instabilità italiana, il suo sotterraneo e
incessante lavorio per promuovere nuovi equilibri. Il volume risulta dunque
agile ma denso. Denso per la ricchissima bibliografia (36 pagine di apparato
critico, oltre che la riproduzione fotografica della lettera e la sua
trascrizione) e per essere un condensato di un discorso che sicuramente nella
riflessione dell’autore è molto più vasto, come plausibilmente emergerà dai
prossimi lavori che egli stesso annuncia a conclusione del volume. Un utile
tassello, dunque, per contribuire ad un approccio storico alla vicenda Moro, un
approccio che deve crearsi un proprio spazio dissipando l’eccesso di opinioni,
studi, ricostruzioni che si sono negli anni accumulate intorno a quella vicenda
da prospettive giudiziarie, giornalistiche, memorialistiche e politiche.
ALDO MORO. LA STORIA VA RISCRITTA.
Chi e perché ha ucciso Aldo
Moro? Scrive
Federica Squillante il 12 giugno 2016 “Zerottonove”. Si è tenuto stamane a Sarno
un incontro con l’Onorevole Gero Grasso che ha discusso a lungo sul rapimento e
l’uccisione di Aldo Moro. Questa mattina presso il Green Bar di Sarno si è
tenuto un incontro con l’Onorevole Gero Grassi, Vicepresidente gruppo PD Camera
dei Deputati e Componente della Commissione d’Inchiesta sul caso di Aldo Moro.
L’evento è stato coordinato da Antonio Orza ed erano presenti anche il Sindaco
Giuseppe Canfora, il Segretario Provinciale PD Nicola Landolfi ed il Segretario
Cittadino PD Domenico Manzo. Il Sindaco Canfora ha inaugurato l’incontro con i
saluti istituzionali, durante i quali ha dichiarato: “La verità è senza sé e
senza ma”, ricordando il grande lavoro svolto da Aldo Moro per la realizzazione
del Compromesso storico. L’Onorevole Grassi ha dato il via al suo
intervento annunciando che quello di oggi era il suo 299° incontro in 2 anni per
diffondere la verità sul caso Moro. L’Onorevole ha poi proseguito illustrando i
numerosi retroscena che hanno portato
al rapimento del Presidente della Democrazia Cristiana il 16 marzo del 1978 e al
suo omicidio il 9 maggio dello stesso anno dopo 55 giorni di prigionia.
Infatti, Gero Grassi lavora ormai da anni nella Commissione e sul suo sito è
possibile consultare tutti i documenti da lui rintracciati e che vanno a
testimoniare i numerosi rapporti fra CIA, GLADIO, Carabinieri e molti esponenti
politici. Durante il suo intervento l’Onorevole ha più volte ricordato anche le
grandi iniziative portate avanti da Aldo Moro, a cominciare dal suo accordo col
Direttore della RAI negli anni ’50 per dare forma al programma tv “Non è mai
troppo tardi” che contribuì a far diminuire l’analfabetismo nei suoi 20 anni di
messa in onda. Grassi ha anche raccontato le diverse minacce e pericoli che
negli anni Moro subì, a cominciare dal “Piano Solo” del 1963 durante il quale i
Carabinieri volevano rapirlo e ucciderlo fino ad arrivare agli scontri con Henry
Kissinger, il Segretario di Stato degli Stati Uniti. Il “Caso Frizz”, come
le Brigate Rosse usavano definirlo a causa del ciuffo di capelli bianchi
del Presidente Democristiano, si concluse in soli 3 minuti durante i quali Aldo
Moro fu rapito in Via Fani, a Roma. Dalle indagini svolte dall’Onorevole sono
emersi inoltre diversi rapporti tra la Mafia siciliana, la Banda della Magliana,
le Brigate Rosse e diversi politici di alto rango come Giulio Andreotti e
l’allora Ministro dell’Interno Francesco Cossiga, che si dimise subito dopo la
morte di Aldo Moro. Grassi ha poi concluso il suo intervento ricordando anche la
morte del giornalista Peppino Impastato, avvenuta a Palermo lo stesso giorno del
ritrovamento del cadavere di Moro. La sua ricerca della verità su quello che
sarebbe stato di certo il successivo Presidente della Repubblica Italiana non è
però conclusa, essendoci ancora diversi aspetti da analizzare.
L’Onorevole continuerà infatti il suo viaggio in giro per l’Italia per istruire
soprattutto i più giovani su queste oscure vicende della Prima Repubblica del
nostro Paese.
Quelle due nuove
perizie che riaprono il caso Moro.
Grassi: cambiano ora e sequenza dell'omicidio del presidente, scrive “La
Gazzetta del Mezzogiorno” del 12 giugno 2016. «Il libro “Morte di un
Presidente”, scritto dal giornalista Paolo Cucchiarelli, contiene tra l’altro
due perizie depositate in Commissione Moro/2 insieme a tante novità: quella
balistica del perito Gianluca Bordin e quella medica del prof. Alberto Bellocco,
relative al decesso di Aldo Moro. Contengono rivoluzionarie verità a suffragio
di alcune tesi da noi pubblicamente sostenute nel tempo», è quanto afferma Gero
Grassi, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera e componente commissione
d’inchiesta. Bellocco e Bordin provano che l’ora del decesso, a differenza di
quanto sostenuto dai brigatisti e dalla perizia dell’epoca, è riconducibile alle
4,35 del 9 maggio 1978. Per quanto attiene la direzione dei proiettili, si
dimostra che lo sparatore è accanto al conducente dell’auto e che Moro è seduto
dietro il conducente. «E’ impossibile - dice Grassi - che il Presidente Moro sia
sdraiato nel bagagliaio, come sostengo da oltre due anni, in quanto sono
presenti tracce ematiche sul lato interno del finestrino laterale posteriore
sinistro e sul tettuccio interno, a livello del sedile posteriore
dell’autoveicolo. Analogamente è inspiegabile il ritrovamento sul corpo di Moro,
tra la camicia ed il gilet, di fazzoletti di carta, atti a tamponare la
fuoriuscita di sangue. Esiste una assoluta discrepanza tra i fori di ingresso e
i proiettili usciti o ritenuti. Se ne deduce che i colpi non furono 11, come
sostenuto da tutti sinora, ma 12 e che il dodicesimo colpo potrebbe trovarsi
ancora nel corpo di Moro. Un accertamento che può essere effettuato
semplicemente da un esame radiografico che al tempo fu realizzato, ma che non
risulta agli atti». Le armi che hanno sparato sono una pistola mitragliatrice
cecoslovacca Skorpion ed una pistola Walther PPK/S. «All’epoca - denuncia il
parlamentare - non fu realizzata una perizia comparativa rigorosa fra i reperti
rinvenuti sulla scena del crimine ed i test sparati dalle armi. Resta il dubbio
che le armi individuate come reali siano state veramente quelle utilizzate per
sparare». Le sequenze di sparo sono tre. Il presidente Moro fu colpito da due
distinte sequenze a colpo singolo: 4 colpi e poi ancora 4 colpi sparati con la
mitraglietta. Poi colpi singoli, tre con la Skorpion ed uno con la pistola
Browning. I reperti balistici rinvenuti sulla scena del crimine e dopo
l’autopsia sono questi: 9 bossoli ed 11 proiettili. Mancano 3 bossoli ed un
proiettile. Secondo Grassi, «la piantina della vettura con la dislocazione dei
reperti è errata. La perizia dell’epoca riporta in posizione errata 7 reperti su
10 e gli stessi periti parlano di depistaggio. La ubicazione nella parte
anteriore dell’auto dei bossoli 7,65, sparati dalla Skorpion non è logica e
provata. Il corpo di Moro non può, in base alle perizie, essere attinto dai
colpi nella posizione in cui è ritrovato nel bagagliaio. Moro è in posizione
diversa rispetto a quanto detto dalle perizie dell’epoca, il suo corpo è stato
spostato almeno due volte. L’arma che uccide Moro ha il silenziatore ed i
brigatisti non sanno dire il numero esatto dei colpi silenziati sparati. Moro
dopo la sparatoria si accascia sul suo fianco destro. A questo punto, ancora
vivo è tirato fuori dall’abitacolo e spostato nel cofano. Nello spostamento dal
corpo cadono evidenti macchie di sangue, ancora oggi visibili sul paraurti della
Renault 4». In base a questa ricostruzione «Moro vivo è disteso nel cofano della
Renault ed avvolto in una coperta. Continuano i colpi: altri due, uno dalla
mitraglietta Skorpion e l’altro dalla Browning. Il libro di Cucchiarelli
racconta tante altre cose terribili ma possibili. Qui ci preme sottolineare
ancora alcune osservazioni. Come mai in tanti si sforzano di spiegarci da tempo
che sull’eccidio di via Fani e sull’omicidio Moro si sa tutto? Lo fanno molti
dei protagonisti e quindi difendono la verità o le proprie inadempienze e le
proprie complicità?». Le perizie di Bordin e Bellocco ed il lavoro di
ricostruzione di Cucchiarelli evidenziano ancora una volta le «bugie delle
Brigate Rosse che non riescono nemmeno a raccontare la verità sull’omicidio.
Vuoi vedere - ipotizza Gero Grassi - che ha ragione Ettore Bernabei, mitico
presidente della Rai, quando pubblicamente afferma che “quei quattro straccioni
delle brigate rosse non sono stati i protagonisti del caso Moro”. Oppure ha
ragione il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro quando il 25 maggio
1998, all’Università di Bari e il 19 giugno 1998 alla Commissione Stragi,
sostiene che “Gli uomini delle BR non furono altro che colonnelli e non
strateghi dell’Antistato”».
La verità sulla strategia
che volle Moro morto.
"Morte di un Presidente", il libro del giornalista investigativo Paolo
Cucchiarelli, esperto di trame e stragi. Il libro di Paolo Cucchiarelli riapre
il "mistero" irrisolto del sequestro e l'omicidio dell'onorevole Aldo Moro.
Attraverso l'incrocio di dati testuali, fattuali e storici e con il supporto
delle evidenze fotografiche spesso inedite, il libro disegna una nuova unitaria
cornice di quei 55 giorni di terrore. Il ruolo dell' "Amerikano", scrive Simona
Zecchi il 10 giugno 2016 su “La Voce di New York”. Intendiamoci. Le inchieste
giornalistiche che ricostruiscono il “caso Moro” a oggi sono tantissime, molte
di queste sono dettagliate e forniscono tante risposte a svariati
interrogativi. La Voce di New York da par suo ha seguito in particolare
attraverso una sua inchiesta specifica, e continua a farlo, il filone
riguardante la presenza della ‘Ndrangheta in Via Fani il giorno del sequestro, e
l’eventuale supporto dato al commando BR quel mattino quando la scorta del
Presidente della Dc fu eliminata: una strage. Per questo filone la Commissione
Parlamentare d’Inchiesta non ha ancora terminato le sue indagini. Ciò che
mancava, invece, era un quadro unitario che insieme a una minuziosa e
convincente spiegazione sulle modalità, il “come”, l’onorevole Dc Aldo Moro è
stato davvero ucciso, consegnasse all’opinione pubblica, alla storia e, volendo,
anche all’autorità giudiziaria una risposta univoca sulla cornice in cui
maturarono le cose. La minuziosa ricostruzione presente in Morte di un
Presidente, il libro di Paolo Cucchiarelli (Ponte alla Grazie, 2016) in libreria
dal 9 giugno, è avvalorata dal supporto di un perito balistico Gianluca Bordin e
un medico legale Alberto Bellocco. La nuova cornice che ci viene consegnata
sembra dunque il risultato di un processo complesso in cui diversi elementi
hanno concorso non per caso a una risoluzione tragica e finale. Una strategia,
come ha rivelato Steve Pieczenik “l’Amerikano”, fatta convergere verso un’unica
direzione, una trappola per le stesse BR. In mezzo, un tentato golpe della P2 e
dell’estrema destra avuto luogo nel 1977, che nel libro per la prima volta viene
rivelato, a fare da traino. Ma le novità di questa inchiesta, accompagnate da
fotografie che ne mostrano la valenza, sono plurime. Qui ne indichiamo solo
alcune:
– le innumerevoli tracce di
sabbia e tessuto, tra le altre, attraverso le quali l’autore dimostra quali e
quante sono state le vere “prigioni” di Moro contrariamente alla storiografia
ufficiale e alle bugie delle BR: ben cinque.
– la modalità e il vero luogo
ove fu ucciso Moro – poi condotto in Via Caetani – e le anomalie del pollice
sinistro trapassato da un proiettile, non mostrato in nessuna perizia, che
smontano la dinamica sin qui riferita sul momento dell’uccisione;
– la coperta non bucata (!)
con la quale fu celato Moro – secondo i BR – prima di ucciderlo;
– la posizione in cui Moro si
trovava quando il suo corpo fu rinvenuto nel bagagliaio della Renault4 (destra)
opposta a quella da cui arrivarono i colpi (lato sinistro). Come si vede nella
foto sopra.
E ancora tanti altri i nuovi
elementi presenti, non solo di tipo criminale-giudiziario ma anche
storico-fattuali. Ma intanto il lettore e tanti altri esperti, e appassionati si
chiederanno: perché dopo tanti anni (38) indugiare ancora sui dettagli, sulle
dinamiche della prigionia, sulle parole di Moro (che qui acquisiscono una
lettura tutta nuova), sui proiettili, sulle contraddizioni che hanno trafitto i
cinquantacinque giorni del sequestro? Perché dunque, se ben 5 processi e diverse
commissioni d’inchiesta inclusa l’ultima, e non solo quelle dedicate
espressamente al caso, se ne sono occupati? Come in tanti altri casi irrisolti e
cruciali della nostra Repubblica, tutte queste evidenze sono state: o non
considerate, o fatte sparire o, come a volte succede, non si è avuto il coraggio
da parte della magistratura e degli organi inquirenti di approfondire il vero
motivo politico che sta “dietro” e avanti a tutta la vicenda partendo anche
dagli elementi più “banali”: le foto del corpo che parla. Ma veniamo al cuore
del nostro articolo. Nel novembre del 2014, l’allora procuratore generale di
Roma, Luigi Ciampoli, aveva chiesto alla procura della Repubblica di procedere
formalmente a carico di Steve Pieczenik, funzionario del Dipartimento di Stato
Usa ai tempi del sequestro, in quanto vi erano “gravi indizi circa un suo
concorso nell’omicidio” del presidente della Democrazia cristiana. Nel 2008
Pieczenik, infatti, psichiatra esperto di tecniche di contro-terrorismo ed
elemento formalmente distaccato dall’intelligence americana, ma a essa contiguo,
scrive un libro con il giornalista francese Emanuel Amara “Nous avons toué
Moro” che verrà preso in considerazione appunto solo nel corso del 2014.
Quell’anno il magistrato Luca Palamara vola negli Usa supportato
dall’amministrazione Obama, la quale impone a Pieczenik di collaborare, pena
l’imputazione nel proprio paese, e lo sente come testimone dei fatti. Poi
succede che questa parte d’indagine che la procura gestisce insieme a un
delicato filone che dopo archivia (quello relativo alla presenza della Honda blu
in Via Fani) venga avocata dalla procura generale, Ciampoli appunto. A oggi non
è dato sapere cosa ne è stato di questa indagine. Già solo questi antecedenti
spiegano il livello di complessità di questa vicenda ancora a 38 anni dai fatti
e anche quanto sia tuttoggi ostacolato il percorso verso la verità. Chi scrive
inoltre aveva fatto richiesta tramite Foia – Freedom of information act – (in
foto qui è visibile il timbro Cia a risposta) di desecretare la documentazione
che appariva sotto chiave su Cia e caso Moro. Si trattava di un articolo
del Washington Post del 29 maggio 1978 che riguardava proprio Pieczenik, su cui
torneremo dopo. Articolo fino a poco tempo fa non disponibile on line. Lo è
ora (ndr più avanti ne spiegheremo la rilevanza) e certo non sarà l’unica cosa
secretata ma questo è quanto ci hanno risposto. Paolo Cucchiarelli nella sua
inchiesta dedica un intero capitolo al solerte funzionario americano dal titolo
“L’Amerikano e il Grande vecchio” e ci svela i nuovi elementi che hanno retto
sinora tutto l’affaire, i cui prodromi erano stati già anticipati in una
intervista rilasciata al giornalista di Radio24 Gianni Minoli nel novembre del
2013, intervista interamente acquisita dalla procura. Questi i maggiori punti in
essa da rilevare: “No non ero favorevole all’iniziativa del Vaticano volta a
trarre fuori dal sequestro Aldo Moro attraverso il riscatto; fui proprio io a
bocciarla. In quel momento stavamo chiudendo tutti i possibili canali attraverso
cui Moro avrebbe potuto essere rilasciato. Le ripeto il punto non era Moro in
quanto uomo: la posta in gioco erano le brigate rosse e la destabilizzazione
delle BR in Italia. L’obiettivo di Moro era restare vivo e a questo scopo era
pronto a minacciare lo stato il suo stesso partito e i suoi stessi amici. Quando
mi resi conto (di questo ndr) dissi: “nel quadro di questa crisi quest’uomo si
sta trasformando in un peso e non in un bene da salvaguardare. […] Si ho detto
io a Cossiga di suggerire di screditare la posta in gioco e cioé
l’ostaggio (facendo dichiarare che le lettere non erano frutto di quanto da lui
realmente scritto ndr). Erano tutti convinti che se i comunisti fossero arrivati
al potere e la Dc avesse perso si sarebbe verificato un effetto valanga. Gli
italiani non avrebbero più controllato la situazione; gli USA avevano un preciso
interesse per quanto riguardava la sicurezza nazionale soprattutto l’Europa del
Sud. Mi dicevo “di cosa ho bisogno”? Qual è il centro di gravità che al di là di
tutto sarebbe stato necessario per evitare di destabilizzare l’Italia? A mio
giudizio quel centro di gravità si sarebbe creato sacrificando Aldo Moro.
L’autore mette infila queste e altre innumerevoli dichiarazioni rilasciate nel
tempo da Pieczenik e nel testo ne dimostra l’estrema validità attraverso una sua
indagine al netto dei giudizi che da sempre circolano sull’esperto in
terrorismo. La trappola in cui caddero le BR, che se avessero liberato Moro ne
avrebbero guadagnato politicamente (ed era ciò che più di tutto Pieczenik
temeva) ricade nello schema più ampio detto dell’ “omicidio derivativo”, termine
utilizzato anche nelle indagini sull’omicidio del funzionario Luigi
Calabresi avvenuto il 17 maggio 1972 (indagini di recente dato temporale, cadute
nel buco nero del segreto istruttorio di cui più nulla si è saputo, sui reali
motivi che l’avrebbero portato alla morte) in un rapporto del Ros del 24/11/2000
presente negli atti sulla strage di Brescia del 1974: un omicidio cioè voluto da
terzi che costringe tutti, mandanti ed esecutori, ad agire verso un unico
risultato, costruendo così attraverso una serie di fitte azioni e concause un
intrico il cui bandolo diventa quasi impossibile sciogliere. E’ una tecnica di
contro-terrorismo dunque utilizzata in questo paese non solo nel caso Moro
all’interno di schemi precisi, adottata da “terzi” alla cui macabra risoluzione
però il nostro Stato si è piegato. I nostri servizi segreti al tempo del
sequestro Moro si trovavano in un momento di riorganizzazione delicato: il SID
stava per lasciare il posto al Sismi e Sisde in una ventata di riforma che
porterà ad altri scandali e abusi. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si
ritrovava sguarnito e indebolito dallo scioglimento del suo gruppo di
antiterrorismo e l’allora ministro dell’Interno Francesco Cossiga aveva chiesto
alla Cia attraverso il Cesis di aiutare l’Italia ad affrontare quel grave
momento di crisi. La Cia (ed è questo che l’articolo del WP rivela) non potendo
ufficialmente dare man forte a causa della legge imposta dal Congresso americano
del 30 dicembre 1974 che impediva “ogni possibile operazione undercover in
territori stranieri” manda l’Amerikano, un loro esterno, ma contiguo,
affidandogli l’intera operazione: che è come dire la stessa cosa. L’inchiesta
rivela poi che l’esperto americano in realtà rimane per l’intero arco del
sequestro fino a dopo la morte, contrariamente a quanto da lui stesso comunque
riferito nell’arco degli anni. E’ Pieczenik che scopre “il Grande
Vecchio” nascosto dietro le BR, sostiene il giornalista Cucchiarelli attraverso
le sue parole. Non un personaggio singolo (materia questa buona per le fiction)
ma un gruppo di intellettuali che gestisce e media con lui le operazioni.
L’analista utilizza, nel tempo, come è proprio di questi schemi che si
perpetrano, verità e falsità insieme, in modo che l’intero quadro poi non si
veda ma la forza della inchiesta giornalistica è quella di renderle tutte in
chiaro. Sono diverse le novità che caratterizzano la funzione di questo
personaggio le quali si intersecano con tutto ciò che non è stato possibile
spiegare sino a ora su Via Fani (l’agguato e la strage e gli eventi che
l’avevano prevista) e Via Cateani (la morte). Un quadro che finalmente il
lettore potrà approfondire insieme a tante altre scoperte presenti nel
libro Morte di un Presidente di Ponte alle Grazie. Verità che né lo Stato né le
Br hanno potuto mai raccontare sulla prigionia e la morte di Aldo Moro.
Delitto Moro: il corpo
trascinato più volte. Nuova verità choc.
La maglietta mostra due sgocciolature di sangue; il corpo non è stato sempre
riverso nel bagagliaio, scrive Patrizio J. Macci il 9 giugno 2016 su “Affari
Italiani”. Cancellate la sequenza di Aldo Moro ucciso da due terroristi delle
Brigate Rosse in un garage, la mattina del 9 maggio 1978 all'interno del
portabagagli di una Renault 4 di colore rosso e con targa falsa. Dimenticate la
mitraglietta Skorpion ritrovata sotto il letto di un terrorista a Roma in Viale
Giulio Cesare. Dimenticate anche l'ora della spietata esecuzione perché non è
nell'intervallo di tempo che è stato sempre dato per certo. Dimenticate i colpi
sparati verso il corpo di Moro mentre è avvolto in una coperta. I documenti
giudiziari delle indagini sottoposti a un'analisi incrociata rivelano una
dinamica diversa. Completamente divergente dalla "verità ufficiale" e che non è
mai stata raccontata dallo Stato e neanche dalle Brigate Rosse fino ad oggi. La
ricostruzione dei fatti divulgata è peggiore del lavoro svolto dalla Commissione
Warren che si occupò dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. Sottoposte al
vaglio di un'accurata analisi critica le tessere del puzzle non combaciano. I
primi a chiedere rigore nelle indagini erano stati proprio i terroristi Morucci
e Faranda nel 1980, chiedendo una nuova perizia sulle armi usate per
l'esecuzione. La loro richiesta rimase inascoltata, nessuno ha mai saputo il
perché. A far parlare le carte del Caso Moro (e solo quelle, senza dietrologie e
fiction di alcun genere) è Paolo Cucchiarelli, giornalista d'inchiesta romano
che ha riversato il frutto di dieci anni di indagine in un volume zeppo di
documenti con indice dei nomi "Morte di un presidente" (Ponte alle Grazie
Editore). Per la prima volta il focus dell'inchiesta giornalistica non è il
momento del sequestro ma l'esecuzione dell'Onorevole Aldo Moro, i luoghi nei
quali è stato rinchiuso durante la prigionia e le armi usate dai terroristi per
uccidere il Presidente. Avvalendosi della consulenza del perito balistico
Gianluca Bordin e del professor Alberto Bellocco Cucchiarelli ha vagliato
migliaia di pagine di perizie, analisi e documenti giudiziari. Moro è stato
ucciso con una modalità che non ha nulla a che vedere con quanto riportato nei
diversi processi e nelle commissioni parlamentari che si sono occupate del caso.
Le perizie sono state lacunose, pasticciate e imprecise. I reperti alterati in
maniera irreversibile senza che ce ne fosse una motivazione. I documenti
presenti all'interno del volume parlano chiaro: le due armi poi sequestrate
coincidono per marca e modello con quelle utilizzate, ma non vi è alcun
riscontro scientifico che siano "quella" mitraglietta e "quella" pistola.
Bastava osservare le foto dell'epoca per averne la certezza. La maglietta che
Moro indossava sotto la camicia mostra due sgocciolature di sangue distinte, non
una macchia univoca. Indice che il corpo non è stato sempre riverso nel
bagagliaio ma spostato più di una volta. La fine di Moro coincide con
un'operazione di rimozione di elementi fondamentali del Caso che non dovevano
essere divulgati all'epoca nè mai. La lettura in sequenza delle carte fa
emergere un altro finale. Per arrivare a queste conclusioni bastava utilizzare
il metodo usato per analizzare il più banale degli accadimenti: il nesso causale
tra il rovesciamento di un bicchiere sul tavolo e la fuoriuscita del liquido in
esso contenuto. L'intera vicenda è da riscrivere, i corpi del reato dovrebbero
essere prelevati dal magazzino polveroso dove giacciono e sottoposti a nuove
analisi, i testimoni dell'epoca ancora in vita interrogati sulle loro
dichiarazioni. I due casi giudiziari sui quali non ci si deve mai stancare di
chiedere verità a squarciagola sono l'omicidio di Aldo Moro e quello di Pier
Paolo Pasolini, legati a doppio filo. Capri espiatori che hanno pagato con le
proprie vite le rispettive eresie. Il volume è uno squarcio di verità in quasi
quarant'anni di nebbia impenetrabile su quanto accaduto in quei cinquantacinque
giorni del 1978.
Moro, gli indizi che
smontano il racconto delle Br.
La nicotina in corpo. La
ferita alla mano. E quei granelli di sabbia sui vestiti. Un'inchiesta di
Cucchiarelli smentisce le Brigate rosse, scrive Fabrizio Colarieti il 9 Giugno
2016 su “Lettera 43”. Si tratta di dettagli nascosti, elementi rimasti sotto la
superficie, solo in apparenza marginali, che sollevano nuovi interrogativi sul
sequestro e sull'omicidio di Aldo Moro. E raccontano un’altra storia rispetto a
quella narrata finora dai brigatisti, ma anche dai rappresentanti dello Stato.
Dare una risposta alle tante domande su quanto avvenne nel tempo trascorso tra
la strage di via Fani del 16 marzo 1978, la prigionia nel covo di via Montalcini
e il ritrovamento del corpo del presidente Moro, in via Caetani, il 9 maggio
successivo, è l’obiettivo delle indagini che sta conducendo, da quasi due anni,
la Commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Beppe Fioroni. Per
cogliere quell’«evidenza invisibile», di cui aveva parlato Leonardo Sciascia già
nell’agosto del 1978, Paolo Cucchiarelli, giornalista dell’Ansa, nel libro Morte
di un presidente (Ponte alle Grazie), propone una minuziosa ricostruzione
fondata sull’analisi dei tanti indizi materiali. Che Lettera43.it è in grado di
anticipare. Un lavoro che disegna una trama complessa, ma capace di demolire il
castello di bugie e contraddizioni che negli anni ha reso impossibile
l’accertamento della verità, fuori e dentro i tribunali. Ciò che fino a oggi
sembrava incomprensibile o caotico – le allusioni delle lettere di Moro dalla
“prigione del popolo”, il comportamento paradossale dei suoi carcerieri, le
oscillazioni dei politici, il coinvolgimento del Vaticano, della malavita
organizzata, di Gladio, della P2, dei servizi segreti statunitensi, e
soprattutto l’identità di chi uccise il presidente della Democrazia cristiana –
appare così dotato di saldatura logica. Piccoli elementi, in alcuni casi
inediti, in altri già noti ma su cui nessuno prima aveva ragionato, assumono un
altro significato. Come i granelli di sabbia marina del tratto tra Focene e
Palidoro, ma anche di Fregene, che furono trovati sul telone cerato che accolse
il corpo di Moro in via Caetani, nel risvolto dei pantaloni, sulle suole delle
scarpe (proveniente da due luoghi diversi), sui parafanghi della R4, sul
cappotto e la giacca del presidente. Durante l’autopsia i medici trovarono
tracce di sabbia anche su un calzino che, con ogni probabilità, si era
depositata per contatto diretto. E c’era salsedine sul colletto della camicia di
Moro e sui proiettili utilizzati per ucciderlo. E sul corpo c’erano anche un
capolino, una spighetta, foglie di Bosso, peli di cane e alcuni capelli rossi di
una donna. Sempre sulle suole fu evidenziata anche la presenza di bitume fresco
utilizzato per il lavaggio al largo delle cisterne delle petroliere e di
materiale polimerico termoindurente, di solito usato per riparare le barche di
resina, per contrastare la presenza della salsedine in piccoli ambienti, tipo
rimesse, cantieri e stabilimenti balneari. L'attenzione sulla costa romana, come
possibile ultima prigione, prima dell'uccisione a Roma, fu immediata, ma con il
tempo passò in secondo piano. L'ipotesi, in base a incroci documentali,
testimoniali e fattuali, è che Moro sia stato tenuto, poco prima di essere
portato a Roma, in uno stabilimento balneare. Quelle dosi consistenti di
nicotina ritrovate nel corpo di Moro. Ci sono poi piccoli e banali elementi che
la vittima “racconta” con il suo corpo. È noto, ad esempio, che Moro fumasse per
allentare la tensione, ma era solo un vezzo. Non si capisce, quindi, come mai
nelle urine del presidente fu ritrovata, durante l'autopsia, un’alta percentuale
di nicotina. Un elemento, apparentemente insignificante, su cui nessuno si era
mai concentrato. Sappiamo che durante quei 55 giorni il presidente fu costretto
a vivere chiuso in una “prigione”, ricavata nell'appartamento di via Montalcini,
lunga circa due metri e larga poco più di uno. Ed è altrettanto noto che il
presidente soffrisse di claustrofobia, tanto che una volta si sentì male in un
ascensore che si era bloccato. Dunque, nel luogo dove era detenuto, non solo
rischiava continue crisi, ma, di certo, non avrebbe potuto fumare e assorbire un
tasso così alto di nicotina. Quando il brigatista Mario Moretti, la mente del
sequestro, uscì da quel tugurio dopo la prima visita a Moro, raccontò un'altra
carceriera, Anna Laura Braghetti, si sfilò il passamontagna con un gesto di
esasperazione perché gli sembrava di soffocare. Mezz’ora dopo il presidente ebbe
la prima crisi respiratoria che spinse i brigatisti a lasciare aperta la porta
per un po’ di tempo. Nessuno accenna al fatto che Moro fumasse durante la
prigionia, nonostante i precisi racconti che lo mostrano immobile a leggere e
scrivere per 55 giorni o ad ascoltare la messa registrata. Se questo è vero,
come ha fatto il presidente a incamerare nel suo corpo tanta nicotina? La
assorbì passivamente? Oppure quello non era il luogo dove fu realmente detenuto?
Ma non è tutto. Il presidente, al momento del ritrovamento nel baule della R4
rossa, era steso sul fianco sinistro, la testa verso il muro di via Caetani, al
quale era accostata l'auto, i piedi, in posizione innaturale, piegati verso il
centro della strada. Sembra impossibile che, avendo saputo che sarebbe stato
trasferito altrove in tali condizioni, possa aver accettato, anche solo per un
secondo, di subire quella postura del tutto innaturale. Le foto danno
l’impressione netta di una sorta di “deposizione” nel portabagagli. Da morto o
agonizzante. L'espressione di un uomo che attende di essere liberato. Se è vero
che tutto fu meticolosamente preparato la sera prima, dopo che la decisione di
uccidere Moro era stata votata, perché i brigatisti non sgomberarono per tempo
l'auto dalle catene per la neve e dal triangolo trovato sui sedili posteriori?
Sembra quasi che la scelta di costringere Moro, alto un metro e settantotto, in
un “loculo” largo un metro e quindici nella parte più stretta sia stata il
frutto di un’emergenza, di “qualcosa” di imprevisto. Un dettaglio che non
ricorda nessuno dei tre Br presenti nel garage quella mattina. Evidentemente,
scrive Cucchiarelli, furono tolti dal portabagagli all’ultimo minuto, in fretta
e furia, dopo che – secondo i brigatisti – a Moro, appena uscito dalla cesta di
vimini, era stato detto di stringersi in quello spazio angusto. Di certo Moro ha
il volto sereno; non sembra aver avuto sentore che stava per essere ucciso; non
se lo aspettava. La sua espressione è quella di un uomo che attende di essere
liberato. Moro fu colpito nella parte sinistra del torace, dunque in una zona
ristretta. Ma se non era stato spostato dal momento dell’uccisione, perché,
quando si aprì il portabagagli della R4, il suo corpo giaceva sulla sinistra
mostrando il fianco destro verso il portellone e non il contrario? Come poteva
essere stato colpito a sinistra, dettaglia ancora Cucchiarelli, se chi apre il
portellone “vede” e potrebbe colpire solo la parte destra del corpo del
presidente? I periti, al contempo, sostengono che Moro non sia stato colpito dal
sedile posteriore dell’auto: quindi, come e da dove è stato colpito? C’è un
altro particolare che cozza con la logica del racconto delle Br: Moro ha una
ferita, ben visibile, alla mano sinistra, come se l’avesse alzata per difendere
il torace dai colpi in arrivo. Un proiettile attraversò infatti il pollice
sinistrò da parte a parte. Eppure, anche la mano destra è insanguinata, come se
il presidente le avesse alzate entrambe per ripararsi e il sangue della mano
trapassata dal colpo fosse schizzato anche sul pollice destro. Innanzitutto, la
ferita sul pollice sinistro non ci dovrebbe nemmeno essere perché Moro, secondo
la ricostruzione delle Br, non si rese conto che stava per essere ucciso e non
era certo in grado di percepire, da sotto la coperta stesa su di lui, la
direzione da cui gli si stava per sparare. Quello rimasto impresso sulle due
mani è un gesto naturale, istintivo, possibile solo, però, se Moro avesse avuto
il viso scoperto, se avesse visto cosa gli stava per accadere e da dove
proveniva la minaccia. Inoltre, perché alzare anche la mano destra se a essere
colpito fu il lato sinistro del corpo? Moro si è forse piegato e girato di poco
verso la sua destra come per “parare un colpo” che stava giungendo, indirizzato
verso l’emitorace sinistro, con una inclinazione leggermente dal basso verso
l’alto? Ha chiuso le mani “a conchiglia”, alzandole, per difendere il cuore dai
proiettili in un istintivo gesto di protezione?
Aldo Moro, “nell’autopsia
la firma del killer”.
La rivelazione di don Fabbri. Di fronte alla Commissione parlamentare il braccio
destro dell'allora cappellano delle carceri don Cesare Curioni. Che davanti alle
foto dell'esame autoptico si disse certo di riconoscere la "firma" di un ex
detenuto che conosceva bene. Ma poi "fece un accordo con Andreotti" per essere
tenuto fuori dal caso. Secretate le rivelazioni sui 10 miliardi di lire raccolti
da Paolo VI con l'obiettivo di liberare il presidente Dc, scrive di Stefania
Limiti il 4 febbraio 2016 su "Il Fatto Quotidiano". “Studiate l’autopsia, lì c’è
la firma del killer di Aldo Moro”. L’audizione di don Fabio Fabbri, il braccio
destro del cappellano delle carceri Cesare Curioni, scorreva liscia,
interessante ma senza particolari novità. La trattativa voluta da Paolo VI; il
misterioso intermediario, forse due, che Curioni incontrava quasi sempre
a Napoli, nelle toilette della metropolitana, qualche volta andò anche al Nord;
i 10 miliardi raccolti dal Papa – “non erano soldi dallo Ior, questo lo so per
certo”, dice Fabbri in uno dei passaggi che fin lì si annuncia come il più
intrigante, tanto che la seduta per qualche minuto viene segretata (in serata in
presidente Fioroni farà sapere che Fabbri ha fornito notizie utili per
identificare la provenienza di quei soldi); l’interruzione dei contatti che, per
tutta la durata del sequestro furono intensi, almeno una volta alla settimana;
l’agente segreto “Gino“, che lo segue durante i 55 giorni, e poi incontra anche
dopo: non sa il suo nome ma dà tutte le indicazioni per rintracciarlo, “era lo
zio di una donna di cui ho celebrato il matrimonio”. Ma ecco che, passata una
buona oretta dall’inizio, il sacerdote fa un leggero movimento sulla sedia e
dice: “A questo punto ve lo devo dire: ma l’avete guardata bene l’autopsia?”.
Silenzio in sala, come si suol dire. Fabbri prende a spiegare che il primo a cui
furono mandate le foto dell’autopsia, proprio appena fatta, fu proprio Curioni:
“Io ero lì con lui, come sempre, le guardammo insieme, in tutto erano 5, 6,
forse 8. Si vedeva in modo chiaro che sei colpi erano stati sparati attorno al
cuore di Moro, fotografato separatamente. Curioni ebbe un sussulto, ‘io conosco
il killer, è un professionista, quella è la sua firma”. Bisogna tener presente,
per cogliere il peso di questo inedito ricordo (ebbene sì, dopo 38 anni) che
monsignor Curioni conosceva molto bene il mondo dei penitenziari italiani: sin
dal periodo dell’attentato a Togliatti (14 luglio 1948), aveva una intensa
attività e frequentissime relazioni dentro le carceri italiane, ne respirava
l’aria, conosceva bene i suoi abitanti, captava gli umori, sentiva le
confidenze. Ebbene di quell’uomo, il killer di professione, si parlava
nell’ambiente criminale, e le dicerie erano rimbalzate anche al suo orecchio:
tra quelle più macabre c’era il particolare di quella firma, i sei colpi attorno
al cuore. Curioni nel tempo aveva messo ben a fuoco l’identità di
quell’inquietante personaggio perché lo aveva conosciuto in passato, quando era
ancora solo un piccolo delinquente e venne portato al Beccaria, il carcere
minorile di Milano. Forse negli anni aveva avuto qualche altra notizia di lui,
sapeva che era stato a lungo all’estero. Fino a quel giorno in cui vede il cuore
di Moro e crede di riconoscere quella firma. La scena finisce qui. L’audizione è
finita. C’è una nuova pista da seguire. Ma sarà possibile trovare riscontri,
fare qualche passo in avanti più concreto? Avrà mai un volto questo killer?
Vedremo, forse ci saranno sviluppo investigativi. L’inchiesta va avanti, ma che
amarezza quella frase del sacerdote, persa tra l’immagine di un cuore colpito a
morte e quella di killer maniacale: Fabbri svela che ci fu un “successivo
accordo tra Andreotti e don Cesare che aveva chiesto al presidente del Consiglio
la garanzia che non sarebbe mai stato chiamato a parlare del suo coinvolgimento
nel caso Moro. Una richiesta che venne accolta dal presidente Andreotti”.
La Commissione ha rinvenuto
negli archivi della Polizia una relazione di Domenico Spinella, dirigente della
Digos, nella quale si dà conto di un incontro riservatissimo svoltosi nello
studio di Aldo Moro la sera del 15 marzo 1978 e in quella occasione il
presidente della Dc fece sapere di ritenere urgente l'attivazione di “un
servizio di vigilanza”.
LA MEMORIA TRADITA. Due Br
in cattedra alla scuola delle toghe.
Gli ex Faranda e Bonisoli
invitati a un incontro sulla giustizia riparativa, scrive Marzio Laghi il 3
febbraio 2016 su “Il Tempo”. L’ex «postina» del rapimento Moro sale in cattedra.
L’ex brigatista rossa Adriana Faranda è stata invitata a parlare a un corso di
formazione per magistrati nella Scuola di Castelpulci a Scandicci, a Firenze, di
«giustizia riparativa» e di alternative al processo e alla pena. Il corso,
organizzato per la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati, si
svolgerà da oggi al 5 febbraio e coinvolge anche altri protagonisti della lotta
armata, oltre che alcune delle vittime del terrorismo degli Anni Settanta. Con
la Faranda ci dovrebbero essere Franco Bonisoli, componente del «commando» che
il 16 marzo 1978 sterminò la scorta di Aldo Moro e rapì il presidente della
democrazia Cristiana e si dissociò dalla lotta armata dopo la condanna, la
figlia dello statista Dc Agnese Moro, il presidente del comitato delle vittime
della strage di piazza della Loggia di Brescia Manlio Milani, marito di Livia
Bottardi, morta nell’attentato, la figlia del sindacalista ucciso dalle Br Guido
Rossa, Sabina. Quindi, i moderatori del gruppo cioé Claudia Mazzucato, il padre
gesuita Guido Bertagna e il criminologo Adolfo Ceretti, docente alla Bicocca.
Nella giornata di giovedì 4 febbraio è prevista una sessione sul tema: «Incontro
con la giustizia riparativa: testimonianze, riflessioni, confronto», sui temi
del rapporto reo-vittima; le persone offese e il processo penale; il reo, la
sanzione e il reinserimento sociale. L’iniziativa ha suscitato polemiche. «Sono
sorpreso, non voglio entrare nel merito dell'opportunità di invitare Adriana
Faranda, perché rispetto l'autonomia della magistratura. Ma la giustizia
riparativa parte dalla verità e non da bugie o da racconti verosimili - ha
dichiarato il presidente della Commissione d'inchiesta sul caso Moro, Giuseppe
Fioroni - Il Paese aspetta di sapere cosa accadde durante i 55 giorni e l'esatto
susseguirsi degli eventi nelle ore che segnarono tragicamente la vita di Aldo
Moro e degli uomini della sua scorta. Verità e rispetto per la sofferenza dei
familiari delle vittime: per me questi due imperativi etici vengono prima di
tutto». Già il 29 gennaio Agnese Moro e Adriana Faranda si erano sedute attorno
allo stesso tavolo per l'iniziativa «L'arma della riconciliazione», che si è
svolta a Siracusa, al centro convegni del santuario Madonna delle Lacrime. Con
loro c’era il gesuita padre Guido Bertagna, animatore di un gruppo che ha fatto
fare cammini di riconciliazione tra carnefici e vittime dell'epoca del
terrorismo. L'incontro si inserisce nell'ambito delle iniziative in programma
nell'Anno Santo dedicato alla misericordia. «Ci chiediamo cosa significano, in
concreto, nella vita delle persone credenti e non credenti, parole come
misericordia, giustizia, perdono, riconciliazione - ha detto don Nisi Candido,
direttore dell'Istituto superiore di scienze religiose San Metodio che organizza
l'incontro come riferisce il Sir -, ma ci chiediamo soprattutto se è possibile
chiedere perdono e se è davvero possibile perdonare. Adriana Faranda e Agnese
Moro hanno compiuto, ciascuna in modo singolare, percorsi di vita che si sono
misteriosamente intrecciati: anzitutto per via del sequestro e dell'omicidio del
presidente Moro. Eventi drammatici e incancellabili nella storia personale, che
segnano tra l'altro anche la storia della nostra società italiana, all'interno
dei quali nasce il desiderio di una qualche riparazione del torto compiuto o di
accoglienza dell'altro: così sorge una possibilità di riconciliazione».
Due ex Br alla scuola dei
magistrati: scandalo?
Faranda e Bonisoli avrebbero dovuto partecipare a un seminario
sulla "giustizia riparativa". Polemiche. Ma è quello che hanno cercato di fare:
riparare, scrive il 3 febbraio 2016 Maurizio Tortorella su “Panorama". La Scuola
della magistratura ha deciso di annullare l'incontro, nell'ambito di un corso di
formazione per i giudici, al quale avrebbe dovuto partecipare l'ex terrorista
Adriana Faranda. Lo annuncia con un comunicato in cui definisce l'incontro
stesso "inopportuno". Il Comitato direttivo della Scuola, che si è riunito oggi,
"ha preso atto delle posizioni espresse, anche con dolore, da numerosi
magistrati e familiari delle vittime - sottolinea la nota - sull'inopportunità
di coinvolgere nella formazione della Scuola, persone condannate per gravissimi
reati di terrorismo, nell'ambito del corso “Giustizia riparativa ed alternative
al processo e alla pena”. Ha quindi proceduto a una nuova considerazione
dell'iniziativa, interamente programmata e definita nei suoi particolari dal
precedente Comitato direttivo". Adriana Faranda, 65 anni, e Franco Bonisoli, 61
anni: due ex brigatisti, ex terroristi, entrambi coinvolti nel rapimento di Aldo
Moro. La prima è stata la "postina" delle Brigate rosse durante il sequestro e
ha fatto 15 anni di carcere, dal 1979 al 1994; il secondo ha sparato in via
Fani, poi è stato arrestato nel 1978, condannato all'ergastolo nel 1983 e
attualmente è in semilibertà. Che cosa li unisce? Che entrambi si sono
dissociati dal terrorismo negli anni Ottanta, durante la detenzione (e per
questo hanno ottenuto benefici e sgravi di pena). Faranda si oppose anche
all'omicidio di Moro e per questo uscì dalle Br per dare vita a un'altra
formazione di lotta armata. L'altro elemento che mette insieme Faranda e
Bonisoli è la polemica che ha accolto la notizia sulla loro presenza a un
seminario organizzato dalla Scuola della magistratura di Scandicci, vicino a
Firenze. Il tema del seminario è la "giustizia riparativa", quella forma di
risarcimento che mette di fronte le vittime e gli autori dei reati. La polemica
monta, e certo non è ingiustificata: sui giornali si leggono le proteste di
figli di magistrati uccisi dai terroristi, che inevitabilmente manifestano
sconcerto; alti magistrati, impegnati nell'antiterrorismo, criticano la scelta
di "aprire un dialogo in una sede istituzionale con chi ha ucciso per sovvertire
lo Stato e la Costituzione"; altri che "esprimono dissenso". Buonismo,
perdonismo o pentitismo non fanno certamente parte del bagaglio ideale di chi
scrive questa rubrica, né della tradizione di Panorama. Ma va detto che Faranda
negli ultimi anni si è impegnata personalmente e con apparente onestà
intellettuale in un percorso di giustizia riparatrice. Nel 2015 ha partecipato
alla stesura di un saggio (Il Saggiatore editore) intitolato Il libro
dell'incontro: vittime e responsabili della lotta armata a confronto. E
Bonisoli, che nel 1977 aveva "gambizzato" Indro Montanelli nell'attentato
milanese dei giardini di via Palestro, del giornalista divenne amico dopo
avergli chiesto di perdonarlo. Altre volte si è correttamente contestata la
presenza in televisione di terroristi (a volte nemmeno troppo dissociati...),
non si sa perché titolati a concionare su questo o su quel tema di attualità.
Questo caso, invece, pare diverso: chiedere a due ex brigatisti, impegnati in
qualche modo nel tema della riparazione, di partecipare su quella materia a un
seminario chiuso, specialistico, e in particolare destinato a un pubblico di
magistrati, non pare né uno strafalcione istituzionale, né una provocazione, né
una volgarità all'italiana. E, se pure sono più che comprensibili le
sensibilità ferite di chi ha avuto un parente ucciso, la polemica non ha molte
ragioni.
Vorrei che qualcuno scrivesse
sulle prime pagine dei giornali il nome di colui che, nel governo italiano,
incaricò, personalmente, con la sua firma, l'Avvocatura dello Stato di agire a
sostegno dei generali felloni, scrive Giulietto Chiesa. I denari pubblici usati
per nascondere la verità ai cittadini che avevano pagato le tasse. E, di nuovo,
alti tribunali della Repubblica recepirono il messaggio mafioso e assolsero
contro ogni evidenza. Io penso che un futuro governo democratico di questo paese
dovrà assumersi, pubblicamente, senza equivoci, il compito di accompagnare la
caccia ai colpevoli delle stragi di Stato con la caccia a coloro che, annidati
come avvoltoi a diversi livelli dei gangli cruciali dello Stato, permisero loro
di restare impuniti. Se si ripercorre l'intera storia della strategia della
tensione: dalla bomba nera di Piazza Fontana a Milano, fino al rapimento di Aldo
Moro e all'uccisione dei cinque ufficiali della sua scorta, fino ai giorni
nostri, alle stragi di Via Capaci e di Via Amelio, non è difficile scorgere un
filo di catrame di complicità che s'attorciglia all'interno delle magistrature
che avrebbero dovuto sancire verità storiche e politiche e che, invece, le
cancellarono. Certo i felloni e i criminali furono molti e, appunto, furono
piazzati a diversi piani della macchina del falso che doveva cancellare il
sangue. Dov'era la prigione in cui Aldo Moro rimase prigioniero? C'era, ai
vertici, chi lo sapeva mentre Moro era ancora vivo, ma tacque. Chi furono, nei
servizi segreti, coloro che muovevano gl'infiltrati all'interno delle Brigate
Rosse? Chi diede ai capi delle BR la sede di via Gradoli? Leggo l'ultimo libro
di Ferdinando Imposimato, che ripercorre criticamente tutte le indagini sulle
stragi impunite per farci toccare con mano come moltissime verità essenziali
fossero state scoperte da inquirenti intelligenti e onesti, per poi essere
occultate, nascoste, da giudici complici. E' questa la grande indagine sulle
stragi che dovrebbe essere riaperta. Da anni siamo governati da "delinquenti
abituali" e meno abituali (ma non per questo meno assidui) che accusano le
"toghe rosse" di avere esercitato una giustizia di parte. Ma noi vediamo –
perché è ormai impossibile non vedere, perché davvero, talvolta, funziona il
proverbio che dice che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, come la
sentenza della Cassazione civile su Ustica dimostra - che noi siamo stati per
cinquant'anni in preda alle "toghe nere". Ho detto "siamo stati"? Mi devo
correggere: siamo ancora. Se ci sono voluti 33 anni per restituire un po' di
giustizia agli 81 morti di Ustica, se Licio Gelli gira ancora, libero, in
Italia, è perché lo siamo ancora. E' in questo groviglio di fili, in questo
brodo di liquame, che la democrazia italiana è affogata. Quando, come
parlamentare europeo, partecipai alla Commissione Straordinaria d'indagine sulle
carceri segrete della Cia in Europa, scoprii che i servizi segreti di tutta
l'Europa altro non erano che delle succursali agli ordini diretti della Cia.
Questa era anche la nostra "sovranità". Il nostro servizio segreto, allora
guidato da Niccolò Pollari, era in prima fila a portare il caffè ai capi d'oltre
oceano. E adesso? Lo stesso giorno della notizia di Ustica i giornali italiani
ci hanno fatto sapere, alla trentesima pagina, che un terzo governo italiano -
dopo quello di Prodi e quello di Berlusconi è stata la volta di Mario Monti - ha
confermato il segreto di stato sui documenti del sequestro di Abu Omar. Chi
hanno coperto i nostri primi ministri? Segreti nostri e segreti altrui. Segreti
sporchi. Questi capi di governo dovrebbero essere processati per alto tradimento
degl'interessi nazionali dell'Italia. Invece due di loro ce li troviamo in lizza
per il prossimo parlamento, uno dei due senatore a vita. Mandarli via tutti sarà
indispensabile, ma prima li si dovrebbe chiamare a rispondere di quello che
hanno fatto o hanno permesso che si facesse.
Scrive Michele Imperio su “La
notte on line”. Dopo tanti anni di attività professionale ho ormai maturato la
convinzione che due segmenti politici dello intero schieramento politico
nazionale e precisamente la destra neofascista oggi di Mario Monti e di
Gianfranco Fini ma ieri anche di altri soggetti politici e la Sinistra politica
democristiana, da non confondersi con la Sinistra sociale democristiana (Cisl e
vecchia corrente di Forze Nuove) e nemmeno con la sinistra morotea democristiana
(Aldo Moro e Piersanti Mattarella ieri, Dario Franceschini e Giuseppe Gargani
oggi) che erano e sono un’altra cosa, la Sinistra politica democristiana –
dicevo – (Prodi Romano, Scalfaro Oscar Luigi, Mancino Nicola e De Mita Ciriaco
ieri Renzi Matteo oggi e il loro regista di sempre De Benedetti Carlo, questi
due segmenti politici – dicevo – non svolgono semplicemente un’attività politica
ma esercitano anche una funzione di intelligence di tipo deviato, continua
Michele Imperio. Forse dispiacerò qualcuno ma voglio ricordare a me stesso che
in seguito alle indagini sulla strage di Peteano il terrorista neofascista
Vincenzo Vinciguerra - reo confesso per la strage – rivelò che nell’ormai
lontano 1982 il segretario del MSI di allora Giorgio Almirante aveva fatto
pervenire la somma di 35.000 dollari a tal Carlo Cicuttini, dirigente del MSI
friulano e coautore della strage, affinché egli modificasse la sua voce durante
la sua latitanza in Spagna mediante un apposito intervento alle corde vocali.
Tale intervento si rendeva necessario perché Cicuttini, oltre ad aver collocato
materialmente la bomba assieme a Vinciguerra, si era reso autore della
telefonata che aveva attirato in trappola i poveri carabinieri, poi trucidati.
La sua voce era stata identificata mediante successivo confronto con la
registrazione di un comizio del MSI da lui tenuto. Che cosa avevano scoperto
quei poveri carabinieri se è vero come è vero che nel giugno del 1986, a seguito
dell’emersione di documenti che provavano il passaggio del denaro tramite una
banca di Lugano, il Banco di Bilbao ed il Banco Atlantico, Giorgio Almirante e
l’avvocato goriziano Eno Pascoli vennero rinviati a giudizio per il reato di
favoreggiamento aggravato verso i due terroristi neofascisti? Ed è emblematico
anche come andò la cosa. Enzo Pascoli venne condannato; Giorgio Almirante
invece, dopo un’iniziale condanna, si fece più volte scudo dell’immunità
parlamentare, all’epoca ancora riconosciuta a deputati e senatori, si sottrasse
perfino agli interrogatori e infine si avvalse di un’amnistia grazie alla quale
uscì definitivamente dal processo. Nonostante la legge ne prevedesse la
rinunciabilità. Cicuttini, dirigente del MSI friulano – mai disconosciuto da
Giorgio Almirante ripeto – fuggito in Spagna, venne catturato a ventisei anni
dalla strage, nell’aprile del 1998, quando fu vittima egli stesso di una
trappola: la procura di Venezia gli fece offrire un lavoro a Tolosa dove,
recatosi convinto di intraprendere le trattative contrattuali, venne arrestato
dalla polizia ed estradato dalla Francia. Questi agenti deviati neofascisti ci
sono ancora, probabilmente essi si riconoscono ora nella corrente politica di
Mario Monti (che non a caso fa la guerra al partito di Gianni Alemanno, Giorgia
Meloni, La Russa, Giorgio Crosetto, Adriana Poli Bortone) e sono infiltrati
ovunque, nella classe politica, nei Servizi, nella Polizia, nei Carabinieri,
Ovunque. Ma sono infiltrati anche e sopratutto in alcuni segmenti della
Magistratura associata (Magistratura indipendente). Analogamente avviene per la
Sinistra Politica Democristiana. Ricordo anche qui che quando nel 1978 la
polizia stava per scoprire la prigione di Aldo Moro in via Gradoli sulla Cassia
a Roma, il giovane Romano Prodi si presentò personalmente alla Polizia di Roma
per depistare quelle indagini e spostare le stesse da via Gradoli in Roma in
Gradoli città dell’Abruzzo, e ciò perché Aldo Moro non fosse salvato ma fosse
assassinato. Dopo che qualcuno (Riccardo Misasi Sinistra D.C.?) aveva mobilitato
quindici picciotti della 'nrdina calabrese dei Nirta inducendoli a portarsi il
16 maggio 1978 in via Fani il giorno del rapimento Moro pronti ad intervenire
nel caso le cose non si fossero messe nel verso giusto degli stragisti. La
storia di Vittorio Mangano stalliere di Silvio Berlusconi (finanza laica) negli
anni 70 non viene mai raccontata mai nella sua completezza. Prima del’assunzione
di Mangano come stalliere Silvio Berlusconi fece tenere negli uffici della
Edilnord una riunione cui parteciparono dopo essere appositamente venuti da
Palermo, Stefano Bontade e Mimmo Teresi, all’epoca numeri 1 e n. 2 di Cosa
Nostra Siciliana. Costoro decisero di ingaggiare il Mangano per dare un segnale
alla Ndrangheta calabrese allora eterodiretta da soggetti della Sinistra poltica
democristiana (Nicola Mancino, Riccardo Misasi e company?) affinchè si
comprendesse che Berlusconi fosse sotto la protezione di Cosa Nostra e quindi
che i figli di Berlusconi (finanza laica) non potevano essere rapiti e
sequestrati. Questo particolare però non viene mai rimarcato. Perché? Perchè
altrimenti si porrebbe in modo naturale il quesito: Perché mai analoghe
attenzioni non furono mai rivolte dalla Ndrangheta nei confronti dei figli di
Carlo De Benedetti o dei figli o dei nipoti di Giovanni Agnelli (finanza ebrea e
finanza cattolica?) Magistrati e politici dell’uno e del’altro segmento politico
(Destra neofascista e Sinistra politica democristiana) hanno sempre provveduto a
clamorose coperture e depistaggi. Ma per farlo essi devono poter accelerare le
proprie carriere. E come accelerare le carriere di questi? Stroncando le
carriere dei loro rivali! Così come certamente è stata accelerata la carriera di
Marco Dinapoli, Magistratura Indipendente, attuale Procuratore Capo della
Repubblica di Brindisi. Chi di noi non si è sentito inorridito dai rapporti di
amorosi sensi emersi dalle indagini fra questo Procuratore della Repubblica di
Brindisi e il terrorista neofascista autore dell’odiosa strage di Brindisi
Giovanni Vantaggiato rapporti di amorosi sensi intesi a far si che Vantaggiato
non fosse imputato dell’aggravante del gesto a scopo terroristico e si
scappottasse quindi la pena dell’ergastolo? Procura della Repubblica di Potenza
e CSM si erano già messi meritoriamente all’opera quando anche i lampioni hanno
compreso che un alto vertice istituzionale (probabilmente proprio il Presidente
della Repubblica) ha bloccato tutto. Ebbene quell’attentato è servito. E’
servito a mandare un messaggio ad alcuni valorosi Magistrati per cui chiunque si
fosse avvicinato troppo alla vera verità sulla strage di Capaci (simboleggiata
dalla scuola brindisina Falcone e Morvillo) era un uomo morto. E proprio in quei
giorni il valoroso Procuratore Capo della Repubblica di Caltanisetta stava
scoprendo interessanti novità in ordine alla strage di Capaci. Dalle indagini
stavano infatti emergendo responsabilità di altri soggetti neofascisti che
avevano materialmente partecipato alla strage e il cui nominativo non era mai
emerso prima di allora nelle indagini stesse. Ebbene anche il valoroso
Procuratore di Caltanisetta Sergio Lari si è fermato e di quelle indagini non si
ha più notizia. Questo caso dimostra che cellule stragiste e criminali sia della
Destra neofascista diciamo così finiana e montiana che anche della Sinistra
Politica Democristiana (oggi renziana) sono presenti anche all’intero della
Magistratura e anzi i Magistrati che vi aderiscono godono di carriere
accelerate. Il caso Di Giorgio (il Magistrato di Taranto condannato a quindici
anni di reclusione) (ma da chiamarsi ora il caso Argentino-Di Giorgio) è stato
finora prospettato come una sorta di lunghissimo qui pro quo fra un Magistrato
della città di Castellaneta (piccolo paese in provincia di Taranto) e un
parlamentare della stessa cittadina pugliese, il senatore del P.D. Rocco Loreto
(nella foto), mentre invece questo caso trascende e di molto questo singolo
aspetto del problema, perché esso è conseguenza del fatto che nella provincia di
Taranto opera da moltissimo tempo una cellula stragista e criminale
istituzionale della Sinistra politica democristiana con presenze attiva ancora
oggi anche all’interno delle Istituzioni e segnatamente nella Magistratura e il
caso Di Giorgio-Argentino è un singolo capitolo di una guerra in corso fra
Magistratura laica e Magistratura cattolica, analogo al conflitto in essere, da
sempre, fra finanza laica e finanza cattolica, se volete anche fra criminalità
laica e criminalità cattolica (laddove il termine cattolico è adoperato
ovviamente in senso lato, molto lato), delle cui prove dirò fra poco.
La storia dei contemporanei
dopo anni va riscritti dai posteri.
1978 – 1979: gli anni
della “svolta”.
Un giorno forse si scopriranno i fili che tennero insieme nel ‘78 personaggi
delle Brigate Rosse, esponenti della Banda della Magliana, apparati deviati dei
servizi e massoni “piduisti” durante e dopo il rapimento e l’uccisione del
presidente della DC, Aldo Moro, l’uomo dell’apertura governativa al PCI. Una
brutta fine la fece anche il giornalista Mino Pecorelli, perché si vantava si
saperne molto e di rivelare nomi e cifre, che avrebbero squarciato il velo
dell’ipocrisia che coprivano gli intrecci perversi. Moro e Pecorelli furono
dunque le vittime ancestrali che segnano il confine della “Terra di mezzo”: il
punto di convergenza e di non ritorno tra malavita organizzata, ambienti
dell’estrema destra terroristica e del brigatismo rosso, settori dei servizi
deviati, massoneria coperta, mondo degli affari e della politica che conta.
Qualcuno che ne sapeva più degli altri è purtroppo morto, portando con sé i
segreti inconfessabili di quel “delitto di stato”. Si era battuto per
liberazione di Moro, aveva perso e si era dimesso dal governo. Più tardi salì al
Colle, con un accordo bipartisan e un’unanimità mai più ripetuta. Le sue carte e
le sue registrazioni non sono mai state ancora lette né decifrate. E forse non
sarà sufficiente neppure aprire gli “armadi della vergogna” di Forte Braschi per
decrittarne i segreti tra gli impolverati faldoni. Ma una concomitanza salta
agli occhi: da quel periodo, i reduci della Banda della Magliana estendono i
loro tentacoli mafiosi e, nonostante sanguinarie vendette personali ed alcune
coraggiose indagini, il sistema di quei balordi si è andato affermandosi e
incuneandosi negli sulla vita politica e affaristica della Capitale. Durante il
periodo epico e di rottura col passato della seconda metà degli anni Settanta,
grazie alla Rinascita democratica, sociale e culturale avviata dalle
“amministrazioni rosse” con i sindaci comunisti (Argan, Petroselli e Vetere),
Roma sembrava aver chiuso per sempre con l’epoca dei palazzinari, con le
periferie “accattone” (850 mila abitanti reclusi in quartieri fuorilegge per il
Piano Regolatore, senza servizi primari e trasporti), con la malavita rozza e
“pastasciuttara”. La città fu restituita ai suoi abitanti, le periferie
divennero parte integrante del sistema urbanistico, l’integrazione generò un
circuito virtuoso di convivenza e di drastica diminuzione dell’allarme sociale e
criminale. Ma sotto, sotto, covavano i prodromi degli epigoni del “Signore degli
anelli”. In realtà i “Signori delle tenebre” cominciavano ad uscire dal mondo
dei morti per conquistare la “Terra di mezzo” e volare verso le vette rarefatte
di Valinor, utilizzando i mostri della “Terra di sotto” per stroncare qualsiasi
opposizione. Una mitologia, creata dallo scrittore inglese Tolkien, cara ai
giovani della destra più nostalgica e violenta che, abbandonati i pestaggi e gli
assalti ai “rossi”, negli anni Ottanta s’infilano i golfini di cachemire,
indossano cappotti loden e si introducono negli ambienti del generone romano.
Dalla “corruzione
partitica a quella parcellizzata”.
Con gli anni Ottanta, la
rottura della non-belligeranza tra il PSI e il PCI, l’ascesa di Craxi e l’arrivo
sulla scena affaristico-politica dei nuovi “cavalieri bianchi”, si apre la
voragine di Tangentopoli, che poi passerà dai finanziamenti occulti ai partiti,
a quelli ben più disseminati dei singoli esponenti. E qui trovano spazio anche
le “larghe intese” tra destra e sinistra: tutti cercano di guadagnarci qualcosa,
perché “tengono famiglia” e perché hanno come mito di riferimento il mondo
virtuale creato dai media berlusconiani e dall’affermarsi di valori consumistici
decadenti. I partiti tradizionali “di massa”, con la cosiddetta crisi delle
ideologie (in realtà con l’affermarsi dell’unica ideologia dominante, questa
capitalista- liberista) si riducono in partiti elettoralistici, buoni per
condurre le campagne di propaganda al servizio di leader “padri padroni”.
Scompare la selezione dei quadri intermedi, la lunga trafila interna, per
immettere personale politico adeguato ai ruoli e agli incarichi istituzionali,
locali e nazionali. L’importante è conquistare gruppi di voti nei settori più
“sensibili”, grazie alle amicizie inconfessabili, ai finanziamenti sottotraccia,
alle tessere gonfiate. Non importa con chi e in che modo allearsi in questo
pantano melmoso, basta far eleggere uomini e donne “capaci a disobbligarsi” con
i veri padroni della città. Si privilegiano i legami familiari, i circoli e i
salotti che contano, alcune categorie lavorative e imprenditoriali, si ricorre
al voto di scambio/posti di lavoro nei servizi pubblici, alle promesse di nuovi
appalti sempre più gonfiati. Le Primarie e le Parlamentarie del PD sono state le
occasioni per imporsi da parte di questo sistema melmoso negli ultimi anni:
personaggi politici quasi sconosciuti agli elettori ai vari circoli, che
venivano “bloccati” e posizionati ai primi posti, a danno di esponenti noti da
tempo e dal passato trasparente; carriere politiche inventate all’ultimo minuto,
per arricchire curricula inconsistenti; trascorsi inconfessabili cancellati, di
chi nel volgere di pochi anni era passato dalla destra finiana, a quella
berlusconiana, per poi entrare nel PD. Alle forti ascendenze di Walter Veltroni
e Goffredo Bettini, da una parte, e Massimo D’Alema, dall’altra, che per decenni
hanno scelto e imposto i loro candidati sia dentro il partito che nelle
amministrazioni locali, si sono affiancati i “nuovi padroni” di Roma, che hanno
generato i “mostri” della sinistra che potevano gemellarsi con i “mostri” della
destra. Nel frattempo però, qualcosa di importante era cambiato a Roma: il
vecchio “Porto delle Nebbie”, il fortilizio di Piazzale Clodio si era come
aperto alla luce del sole. Aria nuova stava entrando tra gli uffici tetri del
Palazzaccio, proprio sotto la “collina del disonore”, quella di Monte Mario,
simbolo negli anni Cinquanta/Sessanta della prima inchiesta giornalistica
scandalistica dell’Espresso sulle speculazioni edilizie. E’ come se il cerchio
si chiudesse attorno al “Mondo di Mezzo”, grazie ad un pool di giudici, guidati
da un binomio esperto nella lotta alla mafia e alla ‘ndrangheta, impersonato dal
Procuratore Capo Giuseppe Pignatone e dal suo Aggiunto Michele Prestipino. Se
l’opinione pubblica, i media e i corpi intermedi della società sapranno creare
attorno a loro una rete di protezione, forse allora per la prima volta, anche la
Casta dovrà operare per “purificarsi”. Ma se ai primi segnali di qualche errore
giudiziario, più o meno formale, ci si trovasse di fronte al solito coro
mediatico del “garantismo” ad oltranza, che già fece arenare l’inchiesta di Mani
Pulite, allora i “Pupari” della Terra di Mezzo e gran parte della Casta potranno
cantare vittoria: autoassolversi. E l’Italia sprofonderà ancora di più non solo
nelle classifiche di Transparency International (oggi al 69° posto su 177 con 43
punti su 100), ultima tra i 28 paesi dell’UE con la Romania, e tra gli ultimi
paesi del club esclusivo del G20. Ma soprattutto saranno i mercati finanziari
internazionali e le maggiori cancellerie del mondo a condannarci alla decadenza,
a causa proprio della corruzione politica, del finanziamento occulto dei
partiti, il controllo sui grandi appalti pubblici e il carsico fenomeno
dell’evasione fiscale.
Mafia Capitale, Ancora una
volta la magistratura commissaria la politica italiana, scrive Lanfranco
Caminiti su “Il Garantista”. Se restiamo inchiodati a discutere di 416 bis, a
proposito dell’ordinanza “Mafia Capitale” che ha letteralmente sconquassato la
vita politica e amministrativa di Roma e del Lazio, cioè se la fattispecie
dell’associazione di tipo mafioso contestata dalla procura di Roma sia
corrispondente o no al vasto fenomeno di corruzione che ha provocato arresti,
indagini e dimissioni a catena, non ne usciamo vivi, schierati in trincea di
opinione da una parte o dall’altra. Certo, è una battaglia di garanzia e di
diritti, ma questo non è tutto. Non ci vuole la zingara per immaginare – come ha
già scritto il direttore di questo giornale – che i pubblici ministeri e il
procuratore capo Pignatone sapessero benissimo quale valanga stessero
provocando. Quale valanga politica. Non solo l’evidente questione se il Comune
di Roma vada sciolto e commissariato, dato che è “quasi giurisprudenza” – quanto
meno è la teoria di Gratteri, procuratore di Reggio Calabria, non proprio
l’ultimo in merito – che basti anche solo la “infiltrazione mafiosa” di un
assessore perché tutto il consiglio vada sciolto. E dato che questa teoria è
stata largamente applicata, al Sud almeno, non si capisce perché Roma dovrebbe
godere di uno statuto privilegiato. E l’altro versante, quello che lambisce il
ministro Poletti, in quanto già capo della Lega delle coop, anche se non c’è
alcuna sussistenza di reato né tanto meno alcuna indagine in merito, non è un
effetto collaterale da meno. Sarà un effetto mediatico, ma di questo campa la
politica. D’altronde, ci si obietterà, non ci più sono “santuari” inaccessibili
e il tribunale di Roma, come altri, non è più un “porto delle nebbie” dove tutto
si insabbia, e è meglio così. Il punto perciò è che l’indagine “Mafia Capitale”,
al di là degli aspetti folckloristici sul “Pirata o “er Cecato” Carminati e su
tutta la mole di intercettazioni che lasciano trapelare avidità e pochezza nel
mondo dell’amministrazione della cosa pubblica, è soprattutto una “cosa
politica”. L’indagine “Mafia Capitale” è una questione squisitamente politica.
Era il 17 febbraio 1992 quando arrestarono Mario Chiesa, socialista, che
ricopriva la carica di presidente del Pio Albergo Trivulzio a Milano, e che
venne colto in flagrante mentre accettava una tangente di sette milioni di lire.
Era l’inizio di Tangentopoli. Il “mariuolo” – come lo definì Bettino Craxi –
Mario Chiesa sarà il primo tassello di un domino che getterà giù l’impianto
politico della Prima repubblica. È una storia che tutti sanno. Si ricordano meno
alcuni caratteri della vita politica di allora, in senso sociale, ampio, di
partecipazione. Alle elezioni politiche del 5 aprile 1992 – poco dopo l’arresto
di Chiesa, perciò – votarono per la Camera in 41 milioni 479.764, cioè l’87,35
per cento degli italiani; e per il Senato, in 35 milioni 633.367, cioè l’86,80
per cento. Alle elezioni politiche del 1994, quando ormai Tangentopoli era un
diluvio, un giudizio universale, e Berlusconi era sceso in campo votarono per la
Camera in 41 milioni 546.290, cioè l’85,83 per cento; e per il Senato, votarono
in 35 milioni 873.375, cioè l’85,83 per cento. Sono dati dell’archivio del
ministero dell’Interno, e sono numeri incommensurabili rispetto la
partecipazione attuale al voto. Il sindaco Marino, per dire, che di questo
stiamo parlando, è stato eletto con il 45,05 per cento degli aventi diritto di
voto. Meno di uno su due romani andò a votare. Lo sconquasso politico di
Tangentopoli non provocò il vuoto, o quanto meno il vuoto della po-itica che non
esiste in natura fu colmato da Berlusconi e dalla Lega, mentre i grandi partiti
di massa ancora tenevano. Aggiungo un paio di dati: nel 1991 gli iscritti al
Pci/Pds sono 989.708, quasi un milione; l’anno prima ne aveva un milione 264.790
e nel 1987 un milione e mezzo. Insomma, siamo dopo la caduta del muro di Berlino
e c’è sconcerto, ma il “partito comunista più forte dell’occidente” tiene ancora
botta. Se li confrontiamo, questi numeri – tratti dalle ricerche dell’istituto
Cattaneo – con la sconfortantissima polemica tutta intestina sugli iscritti
attuali del Pd, che non arrivano nemmeno ai trecentomila, si capisce di costa
sto parlando. E gli iscritti alla Democrazia cristiana, sempre nel 1991, erano
un milione 390.918, mentre l’anno prima ne aveva sopra i due milioni. Ora, la
differenza evidente tra l’indagine “Mafia Capitale” con altri episodi di
corruzione della cosa pubblica, tanto per dire il “caso Fiorito” che pure portò
alle dimissioni della giunta Polverini, con il suo contorno di feste da
Trimalcione e sprechi privati giustificati da pizzini volanti, sta nel carattere
di “sistema”: mentre il caso Fiorito, che pure riguardava una pletora di
consiglieri che allegramente spendevano i lauti soldi dei loro stipendi ha
aspetti erratici e casuali – e peraltro molti si appellavano alle larghe maglie
di discrezionalità che la legge offriva loro –, quello che risulta e risalta
dall’indagine della procura di Roma è un “sistema” di gestione di flussi
finanziari, con la triangolazione tra soggetti pubblici, soggetti privati,
cooperative sociali. È qualcosa, insomma, che somiglia molto più a una
Tangentopoli che a una Parentopoli. L’anomalia, insomma, è quel signore che
teneva in casa centinaia di migliaia di euro “bloccati”: gli altri spendevano,
compravano case, automobili, affittavano ville, insomma alimentavano e drogavano
il Pil della città, con l’economia criminale. Certo, Tangentopoli era il
“sistema Italia” e qui parliamo di un “sistema Roma”. Però, la valenza politica
di Roma Capitale è sempre stata tale da avere un risvolto nazionale. Che sia
implicato o meno un ministro. La differenza tutta politica tra il 1992 e adesso
sta nei numeri che ho dato prima. Il sistema politico è esangue. E neppure il
grillismo è riuscito a trasfondervi qualcosa. Il sistema politico è stretto
nella tenaglia tra il renzismo (che, va ricordato, non ha mai avuto alcun
suffragio elettorale) e l’astensionismo ormai dilagante. Paragonate l’affluenza
in Emilia Romagna nel 1992 (per la Camera, Circoscrizione
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì: 94,44 per cento; Circoscrizione
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia: 92, 99 per cento) con il misero 37,7 per
cento delle regionali di qualche giorno fa, e si capisce di cosa stia parlando.
Il professor De Rita è intervenuto più volte recentemente a proposito del
declino dei “corpi intermedi” – della politica, delle istituzioni – e della
fragilità complessiva che questo comporterebbe nel sistema Paese, un vuoto non
sostituibile con il verticismo e l’avocazione verso il centro che il presidente
del Consiglio sembra privilegiare. Il fatto è che il renzismo non sembra coprire
il vuoto della partecipazione politica, anzi all’opposto sembra incassarne gli
effetti. Non è solo una caduta di stile la battuta arrogante di indifferenza
rispetto la scarsa affluenza alle urne. Forse è vero che la magistratura vuole
mostrare di poter tenere sempre sotto schiaffo la politica, qualsiasi. O forse,
in un certo senso l’indagine della procura di Roma di Pignatone sembra dare una
mano al renzismo. È un’indagine rottamatoria. E di lunga durata. E in quanto
tale ne prolunga la vita, lo rende ineluttabile. Proprio l’opposto di
Tangentopoli. E la risposta politica è: si commissaria il partito, si avocano a
sé le decisioni. Se sarà il caso, si procede anche sfidando le urne a livello
locale: si può vincere anche con il trenta per cento di voti, o pure meno.
Forse, non è di questo che ha bisogno Roma. E neppure il Paese…
Caso Moro, un mese prima di
via Fani un documento anticipava il rapimento,
scrive Gero Grassi, Vicepresidente Gruppo Pd, Camera dei Deputati, il 6 gennaio
2016 su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. I documenti ci sono da sempre ma o non
sono stati capiti, oppure sono stati accantonati perché capiti troppo bene da
parte di Governo, Magistratura, Servizi e Commissioni precedenti. In base alla
ragione di Stato. L’attuale Commissione Moro ed il presidente Giuseppe Fioroni
invece li hanno letti, riletti ed attenzionati ora, con opportune indagini e
ricostruzioni. Quale è la vicenda? Il documento originale, sotto riprodotto
fedelmente, il 18 febbraio 1978, parte da Beirut, presumibilmente dal Colonnello
Stefano Giovannone. Dice notizia riservatissima. È forse la prima notizia del
rapimento di Aldo Moro perché i terroristi, di cui parla il documento, sono le
Brigate Rosse e la Banda Baider Meinhof tedesca. La “fonte 2000” cita Habbash e
parla di operazione terroristica di notevole portata che salvaguarderebbe
impegni finalizzati ad escludere il nostro Paese da piani terroristici (Lodo
Moro). Attenzione: nella chiusura del documento si dice di «non diramare la
notizia ai Servizi collegati all’OLP» e questa è affermazione straordinariamente
importante perché conferma grandi rapporti tra parte dei nostri Servizi e
l’Organizzazione per la liberazione della Palestina. Lasciamo il documento al
lettore e, per ora, alla sua fantasia. Aggiungiamo che, in una delle lettere
scritte dal carcere delle BR, Moro cita il colonnello Giovannone, deceduto anni
dopo improvvisamente. Così come misteriosamente è “suicidato”, anni dopo, il
capitano dei carabinieri Mario Ferrario, altro protagonista di questa storia.
Analogamente sospetta è la scomparsa, nell’agosto 1980, a Beirut di due giovani
giornalisti italiani, mai più ritrovati: Graziella De Palo ed Italo Toni che
avevano denunciato la copertura, da parte dei nostri Servizi Segreti, della
internazionale e clandestina vendita di armi italiana. Il Maresciallo Oreste
Leonardi, capo scorta di Moro, a fine febbraio 1978, è fortemente preoccupato e
ai suoi superiori evidenzia necessità di maggiore protezione. Moro certamente ha
saputo di questo documento e il 15 marzo 1978, giorno prima dell’eccidio di via
Fani, chiama il Capo della Polizia, non certo per aumentare la scorta al suo
studio, come invece sostengono dopo lo stesso Capo della Polizia e i suoi
collaboratori Sereno Freato e Nicola Rana. Chiama perché sa ed ha paura. A
questo punto va citato, perché potrebbe avere grande connessione, il documento
che il 2 marzo 1978, secondo G71, al secolo il gladiatore Antonino Arconte,
parte dal Ministero della Difesa, a firma dell’Ammiraglio Remo Malusardi, Capo
della X Divisione SB (Gladio), con il quale si invita il Colonnello Giovannone
(G219), Capo dei nostri Servizi Segreti in Medio Oriente, a “prendere contatti
immediati con i Gruppi del terrorismo mediorientale al fine di ottenere
informazioni e collaborazioni per la liberazione di Aldo Moro”. 14 giorni prima
del rapimento. Io non so se la connessione tra i due documenti è certa. Le
indagini verificheranno cosa lo Stato italiano ha fatto per rispondere al
documento proveniente da Beirut. So che la perizia “Gabella” dice vero il
documento Arconte, così come so che a questo documento nessuna presta grande
attenzione e fede. Non so se Arconte dice il vero, ma è verosimile che Arconte
abbia intercettato una notizia successiva al documento Habbash. So per certo che
le armi ai palestinesi le vendevano gli italiani e che i palestinesi le hanno
date anche alle Brigate Rosse. So infine che sulla porta di casa, quella mattina
del 16 marzo 1978, negli occhi di Aldo Moro, mentre Maria Fida gli impediva di
portare insieme il figlio Luca, di due anni e mezzo, c’era la consapevolezza che
qualcosa di grave stava per succedere ed il Maresciallo Leonardi, nella
telefonata alla moglie di qualche minuto prima, aveva lanciato strani e
preoccupanti segnali di immediato pericolo.
“Il consulente di Cossiga
deve essere indagato per concorso nell’omicidio di Aldo Moro”.
La richiesta del pg Luigi Ciampoli contro Steve Pieczenik, l’ex funzionario del
Dipartimento di Stato americano coinvolto nell’unità di crisi durante il
rapimento, scrive Raphaël Zanotti su “La Stampa”. La richiesta è di quelle
shock: il pg Luigi Ciampoli chiede che la procura generale proceda nei confronti
di Steve Pieczenik, ex funzionario del Dipartimento di Stato americano e
superconsulente di Francesco Cossiga, per concorso nell’omicidio dell’onorevole
Aldo Moro avvenuta in Roma il 9 maggio 1978. Secondo il pg, che ieri è stato
sentito dalla commissione parlamentare istituita sulla vicenda, sarebbero emersi
gravi indizi nei suoi confronti in merito all’istigazione o perlomeno al
rafforzamento del proposito criminale delle Br di uccidere lo statista italiano.
Elementi contenuti nelle oltre cento pagine di richiesta d’archiviazione che il
pg ha consegnato al tribunale per quanto riguarda le rivelazioni dell’ex
ispettore di polizia Enrico Rossi che aveva ipotizzato la presenza di agenti dei
Servizi Segreti a bordo di una moto Honda, in via Fani, la mattina del
rapimento. Non è stato possibile identificare quelle misteriose presenze, ma
altri elementi sono emersi dall’indagine. Elementi che portano a una possibile
responsabilità di Pieczenik. D’altra parte un ruolo centrale nel drammatico
sviluppo di quei giorni se l’era ritagliato lo stesso Pieczenik, psicologo, in
un libro confessione (edito in Italia da Cooper nel 2008 e passato sotto
silenzio dal titolo «Abbiamo ucciso Aldo Moro. Dopo 30 anni un protagonista esce
dall’ombra»). Nel libro Pieczenik raccontava: «Ho messo in atto una
manipolazione strategica che ha portato alla morte di Aldo Moro». Il
superconsulente racconta come, all’epoca, sarebbe riuscito a portare i comitati
dell’unità di crisi dalla sua parte sostenendo di essere l’unico ad avere a
cuore la sorte di Aldo Moro visto che era l’unico a non conoscerlo
personalmente. In realtà, rivelava qualche anno fa, l’obiettivo era eliminare
Moro: lo si voleva uccidere, ma a farne le spese sarebbero state le Br. Sempre
secondo Pieczenik l’operazione sarebbe stata condotta facendo crescere la
tensione in modo spasmodico, così da mettere le Br con le spalle al muro e non
lasciare loro alcuna via d’uscita se non uccidendo Moro. «Mi aspettavo che si
rendessero conto del loro errore e che lo liberassero facendo fallire il mio
piano - racconta ancora Pieczenik - Fino alla fine ho avuto paura che lo
liberassero. Per loro sarebbe stata una grande vittoria». Tutti sappiamo come
andò. Pieczenik venne mandato dagli Stati Uniti a Roma come super esperto di
terrorismo. «La sua autoreferenzialità era esasperata e quasi schizofrenica - ha
detto ancora il pg Ciampoli - In un’intervista a Giovanni Minoli su Rai Storia
raccontò che Moro doveva morire perché in questo modo si sarebbero
destabilizzate le Brigate Rosse. Noi abbiamo acquisito il cd di quell’intervista
televisiva e tutto il girato completo e siamo convinti che la sua posizione
meriti un approfondimento da parte della Procura». Nell’intervista televisiva di
Minoli, Pieczenik aveva spiegato anche i motivi della sua azione: «Quando sono
arrivato in Italia c’era una situazione di disordine pubblico: c’erano
manifestazioni e morti in continuazione. Se i comunisti fossero arrivati al
potere e la Democrazia Cristiana avesse perso, si sarebbe verificato un effetto
valanga. Gli italiani non avrebbero più controllato la situazione e gli
americani avevano un preciso interesse in merito alla sicurezza nazionale. Mi
domandai qual era il centro di gravità che al di là di tutto fosse necessario
per stabilizzare l’Italia. A mio giudizio quel centro di gravità si sarebbe
creato sacrificando Aldo Moro». Impossibile risalire all’identità delle due
persone a bordo della Honda, quella mattina in via Fani, segnalati in una
lettera anonima arrivata nel 2010 alla questura di Torino. Non erano sicuramente
Peppo e Peppa (i due agenti dei Servizi il cui coinvolgimento era già stato
escluso dalla polizia). E nemmeno Antonio Fissore, il fotografo piemontese morto
nel 2012 in Toscana che l’anonimo dichiarava essere un agente segreto sotto il
comando del colonnello Camillo Guglielmi dei Servizi. In realtà i magistrati
hanno appurato che quella mattina Fissore era su un volo Levaldigi-Varese con
rientro su Levaldigi alle 17.15. I magistrati hanno anche risentito l’ingegner
Alessandro Marini, l’uomo che quella mattina in via Fani per un miracolo non
venne colpito dai proiettili sparati dall’uomo sul sellino posteriore della
Honda che s’infransero sul parabrezza del suo motorino. La Procura generale ha
appurato che in quei giorni Marini aveva denunciato di aver ricevuto minacce
(senza però saper spiegare quali) e che per questo motivo venne montato nel suo
appartamento un baracchino per intercettare le chiamate in entrata al suo
telefono. Incredibile ma vero, a 36 anni di distanza quel baracchino non era mai
stato smontato e la Procura generale lo ha acquisito. Figura centrale
nell’inchiesta, il colonnello Camillo Guglielmi, in servizio all’ufficio “R”
della VII divisione del Sismi nonché istruttore abba base Gladio di Capo
Marrangiu dove gli agenti venivano addestrati anche alla strategia della
tensione. Il pg Ciampoli ha riferito che nei suoi confronti si potrebbe
ipotizzare un’accusa per concorso nel rapimento di Aldo Moro e nell’omicidio
degli uomini della scorta, ma è impossibile procedere perché il colonnello è nel
frattempo morto. L’unica cosa certa, però, è che quella mattina intorno alle 9
il colonnello si trovava in via Fani senza un motivo ragionevole. Alla Corte
d’assise ha riferito che era lì per caso, perché doveva andare a pranzo con un
collega che viveva nelle vicinanze. Una versione ritenuta «risibile» dal pg
Ciampoli, nonché smentita dallo stesso collega. Il suo ruolo nel rapimento,
dunque, rimane per ora un mistero.
Consulente Usa accusato di
concorso in omicidio nel sequestro di Aldo Moro.
La procura di Roma accusa lo 007 americano Steve Pieczenik: "Deve essere
processato, ci sono gravi indizi circa il suo concorso al delitto di Via Fani",
scrive Ivan Francese su “Il Giornale”. Ci sono importanti novità giudiziarie sul
rapimento e sulla morte di Aldo Moro, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse
nel 1978. ll procuratore generale di Roma Luigi Ciampoli ha chiesto alla procura
di procedere nei confronti dello 007 americano Steve Pieczenik, ex funzionario
del Dipartimento di Stato Usa e superconsulente del Governo italiano, verso cui
vi sarebbero "gravi indizi circa un suo concorso nell'omicidio" dello statista.
Il presunto coinvolgimento di Pieczenik è emerso nel corso della richiesta di
archiviazione che il pg Ciampoli aveva inoltrato ieri al gip del Tribunale
romano per un'altra inchiesta: quella relativa alle rivelazioni dell'ex
poliziotto Enrico Rossi, che aveva insinuato la presenza di uomini dei servizi
segreti al momento del rapimento di Moro. Ciampoli ha quindi ordinato la
trasmissione della richiesta di archiviazione alla procura romana "perché
proceda nei confronti di Steve Pieczenik in ordine al reato di concorso
nell'omicidio di Moro". Pieczenik, all'epoca consulente del Viminale guidato da
Francesco Cossiga, faceva parte del comitato di crisi istituito dal ministero
dell'Interno nel giorno del sequestro dello statista democristiano. Dalla
procura generale di Roma viene evidenziato che a carico di Piezcenik "sono
emersi indizi gravi circa un eventuale concorso nell'omicidio, fatto apparire,
per atti concludenti, integranti ipotesi di istigazione, lo sbocco necessario e
ineludibile, per le Brigate Rosse, dell'operazione militare attuata in
via Fani, il 16 marzo 1978, o, comunque, di rafforzamento del proposito
criminoso, se già maturato dalle stesse Br". Pieczenik ha studiato ad
Harvard e al Mit, è stato psichiatra ed esperto di terrorismo: nel dibattito
storiografico è considerato un personaggio cruciale nella storia dei rapporti
tra Italia ed Usa durante gli anni delicatissimi dell'esplosione del terrorismo.
Nel 2008 pubblicò un libro-intervista in cui rivelò di aver sviluppato un piano
di "manipolazione strategica" che conducesse all'uscita di scena di Moro,
considerata ineludibile nel piano di "stabilizzazione" del nostro Paese.
Decisivo sarebbe stato il suo ruolo nell'impedire un'iniziativa vaticana (Papa
Paolo VI era amico personale di Moro, ndr) per raccogliere denaro da
destinare alla liberazione del presidente Dc: "In quel
momento stavamo chiudendo tutti i possibili canali attraverso cui Moro avrebbe
potuto essere rilasciato. Non era per Aldo Moro in quanto uomo: la posta in
gioco erano le Brigate rosse e il processo di destabilizzazione dell'Italia".
L'americano che aiutò
Cossiga: "L'ordine degli Usa non era di far rilasciare Moro ma di stabilizzare
l'Italia".
La testimonianza dello psichiatra americano che nel 1978 arrivò in Italia per
aiutare il ministro dell'Interno Cossiga dopo la strage di via Fani, scrive
Raffaello Binelli su “Il Giornale”. Nelle drammatiche settimane del sequestro
Moro "nessuno era in grado di fare qualcosa, né i politici, né i pubblici
ministeri, né l'antiterrorismo. Tutte le istituzioni erano assenti". Ad
affermarlo, 36 anni dopo, è lo psichiatra statunitense Steve Pieczenik. Già
assistente al sottosegretario di Stato del governo americano e capo dell'Ufficio
per la gestione dei problemi del terrorismo internazionale, Pieczenik nella
primavera del lontano 1978 fu inviato in Italia per assistere il ministro
dell'Interno Francesco Cossiga. Rimasto nell'ombra per molti anni, alla fine di
maggio è stato interrogato dal pm Luca Palamara, che è andato a sentirlo in
Florida. Ne parla oggi Giovanni Bianconi in un articolo sul Corriere della
sera. Fu Cossiga a chiedere l'aiuto del dottor Pieczenik al segretario di
Stato Cyrus Vance: "Ero appena riuscito a negoziare il rilascio di 500
ostaggi americani a Washington in tre diversi palazzi utilizzando tre
ambasciatori arabi". Insomma, si era guadagnato una certa fama e così fu
chiamato in Italia, dove sbarcò una decina di giorni dopo la strage di via Fani.
Lo psichiatra svela quale fosse l'intenzione del suo Paese: "L'ordine non era
di far rilasciare l'ostaggio, ma di aiutarli nelle trattative relative ad Aldo
Moro e stabilizzare l'Italia". Per gli Stati Uniti, dunque, la vita dello
statista della Democrazia cristiana era un particolare secondario. La tesi
americana, maggioritaria (a livello politico) anche in Italia, era questa: "In
una situazione in cui il Paese è totalmente destabilizzato e si sta frantumando,
quando ci sono attentati, procuratori e giudici uccisi, non ci possono essere
trattative con organizzazioni terroristiche... se cedi l'intero sistema cadrà a
pezzi". E il cedimento non ci fu. Anche se costò la vita a Moro. Ma cosa
fece di concreto Pieczenik, oltre a passare le sue giornate nell'ufficio di
Cossiga? "Dovevo valutare che cosa era disponibile in termini di sicurezza,
intelligence, capacità di attività di polizia. E la risposta è stata: niente".
Prosegue mostrando un quadro a dir poco imbarazzante per il nostro Paese: "Ho
chiesto a Cossiga che cosa sapeva delle trattative per gli ostaggi e lui non
sapeva niente...". E poi ancora: "Dovevamo valutare la capacità delle Br
nelle trattative e sviluppare una strategia di non-negoziazione,
non-concessione". Su precisa domanda del pm Palamara (è vero
che lo Stato italiano ha lasciato morire Moro?) il dottor Pieczenik risponde di
no: "L'incompetenza dell'intero sistema ha permesso la morte di Moro. Nessuno
era in grado di fare niente... tutte le istituzioni erano insufficienti e
assenti". E sottolinea che andò via prima dell'omicidio, dopo essersi reso
conto che l'America poteva stare tranquilla: "Cossiga era un uomo
estremamente intelligente che ha capito molto in fretta ciò che doveva fare, ed
è stato in grado di attuarlo... nessuno scambio di terroristi e nessun altro
scambio". Seppe della morte dello statista italiano quando era già in
America. E fece questa constatazione: "Ho pensato che sfortunatamente erano
dei dilettanti e avevano fatto davvero un grande sbaglio. La peggiore cosa che
un terrorista può fare è uccidere il proprio ostaggio. Uccidendo Aldo Moro hanno
vinto la causa sbagliata e creato la loro autodistruzione". Ai microfoni di
Mix24 nel settembre dell'anno scorso Pieczenick aveva svelato altri particolari
interessanti a Giovanni Minoli, parlando chiaramente di una "manipolazione
strategica al fine di stabilizzare la situazione dell'Italia" in quel
periodo. E rivelò persino di aver temuto che Moro venisse alla fine rilasciato.
"A un certo punto - raccontò ancora lo psichiatra a Mix24 - per poter incidere
in una situazione di crisi, sono stato costretto a sminuire la posizione e il
valore dell'ostaggio, a Cossiga ho suggerito di screditare la posta in gioco"
fino a suggerirgli di dire che "quello delle lettere, le ultime soprattutto, non
era il vero Aldo Moro". E infine giocò un ruolo determinante nel bocciare
l'iniziativa del Vaticano di raccogliere una cospicua somma di denaro per pagare
un riscatto. "In quel momento stavamo chiudendo tutti i possibili canali
attraverso cui Moro avrebbe potuto essere rilasciato. Non era per Aldo Moro in
quanto uomo: la posta in gioco erano le Brigate rosse e il processo di
destabilizzazione dell'Italia". Già in un libro del 2008 ("Abbiamo ucciso
Aldo Moro", Cooper edizioni) Pieczenick aveva svelato l'importanza della
manipolazione delle informazioni, nella difficile gestione del sequestro Moro.
Il 18 aprile 1978 fu diramato il falso comunicato del lago della Duchessa (il
luogo dove si sarebbe trovato il corpo di Moro, ndr). Secondo lo psichiatra
americano era un tranello elaborato dai servizi segreti italiani che era stato
"deciso nel comitato di crisi". Il falso comunicato serve a preparare l’opinione
pubblica al peggio. Ma sarebbe servito soprattutto a choccare i brigatisti. Una
mossa che, alla fine dei conti, metteva in conto l’omicidio di Moro. Che poco
dopo sarebbe puntualmente arrivato.
Ho manipolato le Brper far
uccidere Moro.
Dopo 30 anni le rivelazioni del «negoziatore» Usa, scrive “La Stampa”. «Ho
mantenuto il silenzio fino ad oggi. Ho atteso trent’anni per rivelare questa
storia. Spero sia utile. Mi rincresce per la morte di Aldo Moro; chiedo perdono
alla sua famiglia e sono dispiaciuto per lui, credo che saremmo andati
d’accordo, ma abbiamo dovuto strumentalizzare le Brigate Rosse per farlo
uccidere. Le Br si erano spinte troppo in là». Chi parla è Steve Pieczenick. Un
uomo misterioso, che volò in Italia nei giorni del sequestro Moro, inviato
dall’amministrazione americana ad «aiutare» gli italiani. Pieczenick non ha mai
parlato di quello che fece in quei giorni. Dice addirittura di essersi impegnato
con il governo italiano di allora a non divulgare mai i segreti di cui è stato a
conoscenza. Ed è un fatto che né la magistratura, né le varie commissioni
parlamentari sono mai riuscite a interrogarlo. Finalmente però l’uomo del
silenzio ha parlato con un giornalista, il francese Emmanuel Amara, che ha
scritto un libro («Abbiamo ucciso Aldo Moro», Cooper edizioni) sul caso. Le
rivelazioni sono sconvolgenti. Pieczenick, che è uno psichiatra e un esperto di
antiterrorismo, avrebbe avuto un ruolo ben più fondamentale in quei giorni. E
che ruolo. «Ho manipolato le Br», dice. E l’effetto finale di questa
manipolazione fu l’omicidio di Moro. Il «negoziatore» Pieczenick arriva a Roma
nel marzo 1978 su mandato dell’amministrazione Carter per dare una mano a
Francesco Cossiga. E’ convinto che l’obiettivo sia quello di salvare la vita
allo statista. Ben presto si rende conto che la situazione è molto diversa da
quanto si pensi a Washington e che l’Italia è un paese in bilico, a un passo
dalla crisi di nervi e dalla destabilizzazione finale. Da come maltratta
l’ambasciatore e il capostazione della Cia si capisce che Pieczenick è molto più
di un consulente. E’ un proconsole inviato alla periferia dell’impero. «Il capo
della sezione locale della Cia non aveva nessuna informazione supplementare da
fornirmi: nessun dossier, nessuno studio o indagine delle Br... Era incredibile,
l’agenzia si era completamente addormentata. Il colmo era il nostro ambasciatore
a Roma, Richard Gardner. Non era una diplomatico di razza, doveva la sua nomina
ad appoggi politici». Cossiga è molto franco con lui. «Mi fornì un quadro
terribile dalla situazione. Temeva che lo Stato venisse completamente
destabilizzato. Mi resi conto che il paese stava per andare alla deriva». Nella
sua stanza all’hotel Excelsior, e in una saletta del ministero dell’Interno,
Pieczenick comincia lo studio dell’avversario. Scopre che invece sono i
terroristi a studiare lui. «Secondo le fonti di polizia dell’epoca,
ventiquattr’ore dopo il mio arrivo mi avevano già inserito nella lista degli
obiettivi da colpire. Fu allora che capii qual era la forza delle Brigate Rosse.
Avevano degli alleati all’interno della macchina dello Stato». Una sgradevole
verità gli viene spiegata in Vaticano. «Alcuni figli di alti funzionari politici
italiani erano in realtà simpatizzanti delle Brigate Rosse o almeno gravitavano
nell’area dell’estrema sinistra rivoluzionaria. Evidentemente era in questo modo
che le Br ottenevano informazioni importanti». Così gli danno una pistola. «Ogni
volta che uscivo in strada stringevo più che mai la Beretta che avevo in tasca».
Comincia una drammatica partita a scacchi. «Il mio primo obiettivo era
guadagnare tempo, cercare di mantenere in vita Moro il più a lungo possibile, il
tempo necessario a Cossiga per riprendere il controllo dei suoi servizi di
sicurezza, calmare i militari, imporre la fermezza a una classe politica
inquieta e ridare un po' di fiducia all’economia». Ma la strategia di Pieczenick
diventa presto qualcosa di più. E’ il tentativo di portare per mano i brigatisti
all’esito che vuole lui. «Lasciavo che credessero che un’apertura era possibile
e alimentavo in loro la speranza, sempre più forte, che lo Stato, pur mantenendo
una posizione di apparente fermezza, avrebbe comunque negoziato». Alla quarta
settimana di sequestro, però, quando comincia l’ondata delle lettere di Moro più
accorate, tutto cambia. Una brusca gelata. Il 18 aprile, viene diramato il falso
comunicato del lago della Duchessa. Secondo Pieczenick è un tranello elaborato
dai servizi segreti italiani. «Non ho partecipato direttamente alla messa in
atto di questa operazione che avevamo deciso nel comitato di crisi». Il falso
comunicato serve a preparare l’opinione pubblica al peggio. Ma serve soprattutto
a choccare i brigatisti. Una mossa che mette nel conto l’omicidio di Moro. E
dice Pieczenick: il governo italiano sapeva che cosa stava innescando. «Fu
un’iniziativa brutale, certo, una decisione cinica, un colpo a sangue freddo: un
uomo doveva essere freddamente sacrificato per la sopravvivenza di uno Stato. Ma
in questo genere di situazioni bisogna essere razionali e saper valutare in
termini di profitti e perdite». Le Br di Moretti, stordite, infuriate, deluse,
uccidono l’ostaggio. E questo è il freddo commento di Pieczenick: «L’uccisione
di Moro ha impedito che l’economia crollasse; se fosse stato ucciso prima, la
situazione sarebbe stata catastrofica. La ragion di Stato ha prevalso totalmente
sulla vita dell’ostaggio».
“Quel giorno ero in via
Montalcini e arrivò l’ordine di non intervenire”.
L’ex brigadiere della Finanza finito sotto accusa per le clamorose dichiarazioni
sul caso Moro racconta per la prima volta la sua verità: «Con altri militari
presidiavamo il palazzo adiacente la prigione di Moro. Quando tutti finì ci
venne ordinato di dimenticare quello che era successo». Roma, via Caetani, 9
maggio 1978. Il cadavere di Aldo Moro viene fatto ritrovare tra la sede del Pci
e della Dc. Due giorni prima l’ex finanziere novarese assicura che era in
servizio di vigilanza in un palazzo di via Montalcini, scrive Carlo Bologna su
“La Stampa”. Giovanni Ladu, ex brigadiere della Finanza in pensione da un anno
e mezzo, vive a Novara. Il suo nome è venuto alla ribalta in occasione della
pubblicazione del libro dell’ex giudice Ferdinando Imposimato al quale Ladu si
era rivolto anche con un’altra identità, quella di un fantomatico Oscar Puddu,
per rafforzare la tesi del mancato blitz nel covo delle Brigate Rosse in cui era
prigioniero Moro. L’ex magistrato, dopo la pubblicazione del libro, si è rivolto
alla Procura di Roma sollecitando nuove indagini. C’è voluto poco per scoprire
che Ladu e Puddu sono la stessa persona. Ora l’ex finanziere è indagato per
calunnia. Per la prima volta ha deciso di rilasciare a La Stampa un’intervista
sulla sua versione dei fatti. Respinge l’etichetta di «calunniatore». Giovanni
Ladu, ex brigadiere della Guardia di Finanza, parla per la prima volta accanto
ai suoi difensori, gli avvocati Gianni Correnti e Giorgio Legnazzi. Nel 1978,
nei giorni del sequestro Moro, era un bersagliere di leva. È indagato dalla
Procura di Roma perché sostiene che lo Stato era a conoscenza della prigione
dello statista ed ha fatto un passo indietro due giorni prima che venisse
ritrovato nella Renault rossa in via Caetani. Lui, con altri gruppi pronti al
blitz per liberare il leader Dc, garantisce che il 7 maggio era in via
Montalcini. Dall’«alto» arrivò l’ordine che l’ex giudice Imposimato, nel libro
«I 55 giorni che hanno cambiato l’Italia» traduce in una denuncia-bomba: la
liberazione fu impedita da Cossiga e Andreotti. Imposimato solo a libro stampato
si è affidato alla Procura.
Ladu, la sua è una verità
contestata.
«Le e-mail a Imposimato sono
state mandate dal 2012 a maggio di quest’anno però quei fatti del ’78 sono stati
resi noti ai miei superiori, inizialmente a voce al mio comandante Alessandro
Falorni. Dopo le opportune verifiche è stato contattato il giudice che si era
occupato del caso Moro».
Lei ha iniziato a
raccontare questi fatti nel 2008, perché solo allora? Temeva una rappresaglia?
«Sì, anche perché quando finì
tutto, ci era stato detto di dimenticare quello che era successo».
Ma lei chi era in quei
giorni?
«Avevo 19 anni, l’anno primo
avevo finito il diploma. Ero in servizio di leva obbligatoria ai bersaglieri
della caserma Valbella, ad Avellino».
Vi avevano preparato a
questa missione?
«No. Ci hanno imbarcato su un
pullman “dovete andare a Roma”. Sulle prime ci portano alla caserma dei
carabinieri vicino all’hotel Ergife».
Sapevate che c’erano altri
gruppi pronti a intervenire in quella che sarebbe risultata la prigione di Moro?
«Inizialmente no. Poi
prendiamo possesso di un appartamento adiacente allo stabile dove, scopriremo
poi, c’era Moro. Eravamo dieci militari, non in divisa. Non avevamo attrezzature
di ascolto (queste attrezzature sono state poi messe in una cascina abbandonata
che era di fronte al palazzo, lì c’era una postazione di controllo già
predisposta prima che arrivassimo. Noi dovevamo solo verificare chi entrava e
usciva, se c’erano persone sospette».
Quando avete intuito che
poteva essere il covo?
«Ci avevano detto che c’era un
noto personaggio in quell’appartamento, messo in condizione di non uscire. Moro
era stato rapito il 16 marzo, in Italia si parlava solo di quello».
E arriva il 7 maggio 1978,
con l’ordine di smobilitare senza liberare il «personaggio». In seguito
scoprirete che là dentro c’era proprio il presidente della Dc.
«Certo, leggendo i giornali.
Io mi sono anche strizzato sotto. Rientrato ad Avellino sono stato destinato
subito al reggimento, alla caserma dei bersaglieri di Persano (Salerno)».
I dieci commilitoni non li
ha più sentiti?
«No, non so nemmeno che fine
abbiamo fatto. Nessun contatto».
Dopo trent’anni, nel 2008,
decide di parlare. Perché?
«Ogni anno, in occasione
dell’anniversario dell’uccisione di Moro, venivano riferite falsità».
Non ha mai cercato di
«vendere» la sua verità?
«Assolutamente no, all’epoca
ero ancora in servizio. Non ho avuto, né cerco compensi. Ho fatto i miei
passaggi rivolgendomi ai miei superiori gerarchici, loro hanno poi informato il
procuratore di Novara Francesco Saluzzo al quale ho fornito un memoriale di tre
pagine. Non ho fatto alcun nome, nessun riferimento ai vertici dello Stato. Ho
soltanto indicato i fatti di cui sono a conoscenza. E non sono state ravvisate
ipotesi di calunnia perché nel 2011 questo procedimento è stato archiviato».
Lei, in questa prima fase,
è Giovanni Ladu. Poi nel 2012 si ripresenta con il nome fittizio di Oscar Puddu.
Al punto che Imposimato ci casca, pensa che Ladu e Puddu siano due persone
distinte. Perché questo espediente?
«Volevo che si riaprisse il
caso, per venire a capo di questa vicenda. L’ex giudice faceva delle domande, io
rispondevo. Ci siamo scambiati 84 mail, da privato a privato. Io ero in pensione
dalla Finanza, Imposimato dalla magistratura».
Imposimato, anche sulla
base della sue rivelazioni, arriva a scrivere che «Moro fu vittima della ferocia
delle Br ma anche di un complotto ordito da Andreotti e Cossiga».
«Mai fatti quei nomi, sono
conclusioni di Imposimato. Lui mi chiese se erano al corrente dell’ipotesi di un
blitz e della decisione di fermarlo».
Il figlio di Cossiga ha
definito le sue ricostruzioni da «trattamento sanitario obbligatorio».
«Non sono matto, né mitomane.
E non ho mai detto che Cossiga ha ordinato quel delitto».
E a chi parla di
depistaggio, cosa risponde?
«Nessuna intenzione di alzare
polveroni o coprire qualcuno, chiedo l’opposto: che si arrivi alla verità. Non
volevo nemmeno tutto questo clamore. Quando ho visto il mio nome nel libro di
Imposimato mi sono pure arrabbiato. Ho fatto tutto questo anche contro il volere
della mia famiglia ma sentivo che dovevo togliermi un peso. Tutti gli altri
hanno seguito l’ordine di dimenticare, io non ci sono riuscito».
L’ex ispettore e i misteri
del caso Moro “Parlerò solo con pm e in Parlamento”.
Enrico Rossi aveva indagato su
una lettera inviata nel 2009 a La Stampa Al centro i due motociclisti sulle
Honda comparsi in via Fani. C’era un torinese? Scrivono Grazia Longo e Massimo
Numa su “La Stampa”. L’ex ispettore della Digos Enrico Rossi sa di essere, da
poche ore, al centro dell’attenzione. Ha rivelato all’Ansa alcuni retroscena del
caso Moro, in particolare sul ruolo - mai chiarito - di un motociclista, in
sella a una Honda, comparso in via Fani nell’ora X del rapimento di Aldo Moro e
della strage della sua scorta. Deciso a raccontare la «sua» verità, perchè gli
accertamenti che furono svolti in allora dai suoi colleghi in modo scrupoloso
non portarono a nulla. «Tutto è partito - ha detto Rossi all’Ansa - da una
lettera anonima scritta dall’uomo che era sul sellino posteriore dell’Honda in
via Fani quando fu rapito Moro. Diede riscontri per arrivare all’altro. Dovevano
proteggere le Br da ogni disturbo. Dipendevano dal colonnello del Sismi che era
lì». Le ricerche dell’ispettore sono nate da una lettera anonima inviata
nell’ottobre 2009 alla redazione de La Stampa. Questo il testo: «Quando
riceverete questa lettera, saranno trascorsi almeno sei mesi dalla mia morte
come da mie disposizioni. Ho passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di
quanto non ho fatto e cioè raccontare la verità su certi fatti. Ora è tardi, il
cancro mi sta divorando e non voglio che mio figlio sappia. La mattina del 16
marzo ero su di una moto e operavo alle dipendenze del colonnello Guglielmi, con
me alla guida della moto un altro uomo proveniente come me da Torino; il nostro
compito era quello di proteggere le Br nella loro azione da disturbi di
qualsiasi genere. Io non credo che voi giornalisti non sappiate come veramente
andarono le cose ma nel caso fosse così, provate a parlare con chi guidava la
moto, è possibile che voglia farlo, da allora non ci siamo più parlati, anche se
ho avuto modo di incontralo ultimamente...Tanto io posso dire, sta a voi
decidere se saperne di più». La polizia avviò così le prime indagini. In una
casa di Cuneo, dove l’uomo ha vissuto con la prima moglie, vengono trovate due
armi regolarmente denunciate: una Beretta e una Drulov, un’automatica di
precisione di fabbricazione cecoslovacca. E le pagine originali di Repubblica
dei giorni del sequestro Moro. Rossi afferma di aver chiesto di sentire la
coppia e di ordinare una perizia sulle armi. Ma non accadde nulla. Sui dettagli
dell’indagine Rossi è pronto a testimoniare. «Ma solo con la magistratura e
nelle commissioni parlamentari. Aspetto di essere convocato». Che l’Honda blu
presente in via Fani il 16 marzo del 1978 rappresenti un mistero è un dato
assodato. Tutte da chiarire sono invece le rivelazioni di Rossi: la procura di
Roma, che si sta occupando del caso, non ha per ora trovato riscontri.
L’attività degli inquirenti, comunque, prosegue. Intanto la memoria ricorre a
pochi mesi fa, quando - il 6 novembre scorso - l’ex brigadiere della Guardia di
Finanza Giovanni Ladu è stato indagato per calunnia dalla procura della capitale
proprio perché, secondo la pubblica accusa, aveva fornito informazioni false sul
caso Moro.
La moto Honda di via Fani
Un mistero lungo 36 anni.
Le rivelazioni di un ex poliziotto: “A bordo c’erano due 007”, scrive “La
Stampa”. Per una volta sono tutti d’accordo: magistrati e Br. La Honda blu
presente in via Fani il 16 marzo del 1978 è un mistero. I capi brigatisti hanno
sempre negato che a bordo ci fossero due loro uomini, ma da quella moto si
spararono - sicuramente - gli unici colpi verso un “civile” presente sulla scena
del rapimento, l’ingegner Alessandro Marini, uno dei testimoni più citati dalla
sentenza del primo processo Moro. Mario Moretti e Valerio Morucci sono stati
sempre chiarissimi su quella moto blu di grossa cilindrata: «Non è certamente
roba nostra». L’ingegner Marini si salvò solo perché cadde di lato quando una
raffica partita da un piccolo mitra fu scaricata contro di lui “ad altezza
d’uomo” proprio da uno dei due che viaggiavano sulla moto. I proiettili
frantumarono il parabrezza del suo motorino con il quale l’ingegnere cercava di
“passare” all’incrocio tra via Fani e via Stresa. Marini fu interrogato alle
10.15 del 16 marzo. Il conducente della moto - disse - era un giovane di 20-22
anni, molto magro, con il viso lungo e le guance scavate, che a Marini ricordò
«l’immagine dell’attore Edoardo De Filippo». Dietro, sulla moto blu, un uomo con
il passamontagna scuro che esplose colpi di mitra nella direzione dell’ingegnere
perdendo poi il caricatore che cadde dal piccolo mitra durante la fuga. La sera
a casa Marini arrivò la prima telefonata di minacce: `Devi stare zitto´. Per
giorni le intimidazioni continuarono. Si rafforzarono quando tornò a
testimoniare ad aprile e giugno. Poi l’ingegnere capì l’aria, si trasferì in
Svizzera per tre anni e cambiò lavoro. Il caricatore cadde certamente dalla moto
e Marini, dicono le carte, lo fece ritrovare ma questo non sembra essere stato
messo a raffronto con i tre mitra (ritrovati in covi Br) che spararono in via
Fani (ce ne è anche un quarto, mai ritrovato). Di certo da quella moto si sparò
per uccidere Marini, tanto che i brigatisti sono stati condannati in via
definitiva anche per il tentato omicidio dell’ingegnere. Marini d’altra parte
confermò più volte durante i processi il suo racconto e consegnò il parabrezza
trapassato dai proiettili. A terra in via Fani rimasero quindi anche i
proiettili sparati dal piccolo mitra ma le perizie sembrano tacere su questo
particolare. Sarebbe questa l’ottava arma usata in via Fani: 4 mitra, 2 pistole,
oltre alla pistola dell’agente Zizzi, che scortava Moro, e quella in mano
all’uomo della Honda: il piccolo mitra. Su chi fossero i due sulla Honda tante
ipotesi finora: due autonomi romani in “cerca di gloria” (ma perché allora
sparare per uccidere?); due uomini della `ndrangheta (ma non si è andati oltre
l’ipotesi); o, come ha ventilato anche il pm romano Antonio Marini che ha
indagato a lungo sulla vicenda, uomini dei servizi segreti o della malavita. I
Br negano ma, ha detto il magistrato, «una spiegazione deve pur esserci. Io vedo
un solo motivo: che si tratti di un argomento inconfessabile». Uomini della
malavita o dei servizi? «Allora tutto si spiegherebbe». Certo che quella mattina
a pochi passi da via Fani c’era, per sua stessa ammissione, Camillo Guglielmi,
indicato alternativamente come addestratore di Gladio o uomo dei servizi
segreti, invitato a pranzo alle 9.15 di mattina da un suo collega. E Guglielmi è
proprio l’uomo dei servizi chiamato in causa nella lettera anonima che ha dato
il via a Torino agli accertamenti sui due uomini a bordo Honda, poi trasferiti a
Roma. A Guglielmi si è addebitata anche la guida di un gruppo clandestino del
Sismi incaricato di “gestire” il rapimento Moro secondo un’inchiesta che è anche
nell’archivio della Commissione stragi, in Parlamento.
Il martire del terrorismo
su cui l'Italia resta spaccata.
C'è chi ha avviato il processo per la sua beatificazione, chi lo considera un
cattocomunista responsabile di molti dei problemi italiani: Aldo Moro rimane uno
dei personaggi più controversi della Prima Repubblica, scrive Livio Caputo su
“Il Giornale”. C'è chi ha avviato il processo per la sua beatificazione, chi lo
considera un cattocomunista responsabile di molti dei problemi italiani. C'è chi
esalta tuttora la sua politica di avvicinamento al Partito Comunista di Enrico
Berlinguer (le famose convergenze parallele), chi è convinto che il suo progetto
di compromesso storico avrebbe addirittura messo in discussione la nostra
appartenenza al blocco occidentale. C'è chi ha parole di elogio per la sua
politica estera filoaraba, chi la critica al punto di averlo ribattezzato
Al-Domor. C'è chi ritiene che con le sue ripetute prese di distanza dagli Stati
Uniti d'America abbia fatto gli interessi dell'Italia, chi lo esecra ancora per
avere concluso il famigerato trattato di Osimo con la Jugoslavia di Tito. A
quasi trentacinque anni dal suo rapimento ed assassinio ad opera delle Brigate
Rosse, Aldo Moro, primo capo di un governo di centro-sinistra e poi per cinque
volte presidente del Consiglio tra il 1963 e il 1976, rimane uno dei personaggi
più controversi della Prima Repubblica. Pugliese di nascita, laureato in legge,
profondamente cattolico, Moro ha fatto parte fin dal principio della corrente
dossettiana di sinistra, critica della politica centrista di Alcide De Gasperi,
ed è rimasto sempre su queste posizioni. Quando fu rapito il 16 marzo del 1978,
era presidente del partito e si apprestava a realizzare il suo obbiettivo di
inserire formalmente il Partito comunista italiano nei meccanismi del potere. I
cinquantacinque giorni della sua prigionia furono i più drammatici degli anni
del terrorismo, spaccando governo, partiti e parlamento in un fronte della
fermezza, contrario a ogni trattativa per la sua liberazione per non dare un
riconoscimento politico alle Brigate Rosse (Giulio Andreotti, Francesco Cossiga,
il Partito Comunista Italiano) e un fronte possibilista disponibile a negoziare
uno scambio di prigionieri coi rapitori (Bettino Craxi, Amintore Fanfani, il
Vaticano). Durante la prigionia scrisse 86 lettere, di cui alcune ferocemente
critiche verso i dirigenti della Democrazia Cristiana («Il mio sangue ricadrà su
di loro»). Ma tutto fu inutile: il 9 maggio il suo corpo crivellato di colpi fu
ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa a pochi metri da piazza del Gesù
a Roma. Per protesta, i familiari rifiutarono i funerali di Stato. Vari aspetti
della vicenda sono ancora circondati dal mistero, dando vita a una pletora di
teorie complottistiche che attribuiscono il suo assassinio alla P2, alla CIA, al
KGB o addirittura ad ambienti democristiani. Inutile dire che nessuna è stata
provata.
Troppi bugiardi sul
memoriale Moro.
La figlia legge il libro di Gotor sugli scritti dalla prigionia
"È il momento per chi ha sempre taciuto di dire la verità", scrive Agnese Moro
su “la Stampa”. Il nuovo libro dello storico Miguel Gotor, Il memoriale della
Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere
italiano (Einaudi, 2011, 622 pagine, 25 euro) è un lavoro interessante, che
ci accompagna nelle avventurose traversie di quel Memoriale che raccoglie
le risposte che mio padre, Aldo Moro, diede alle Brigate Rosse, durante gli
interrogatori ai quali fu sottoposto nel corso della sua prigionia (16 marzo - 9
maggio 1978). L'Autore ha fatto un minuzioso lavoro di ricostruzione delle
vicende che interessarono quello scritto: la pubblicazione, nel corso del
sequestro, di alcune pagine riguardanti l'onorevole Paolo Emilio Taviani; il
ritrovamento, da parte degli uomini del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,
nell'ottobre del 1978, nel covo di via Monte Nevoso a Milano, di un testo
consistente in fotocopie di un dattiloscritto; il secondo ritrovamento,
nell'ottobre del 1990, sempre nello stesso covo brigatista, di fotocopie di
lettere e di un manoscritto, il cui contenuto è parzialmente diverso da quello
del dattiloscritto rinvenuto nel '78. Fino ad arrivare alla ragionevole e
documentata ipotesi della esistenza di un manoscritto più ampio di quello del
'90 (identificato dall'Autore come ur-memoriale), fin qui mai ritrovato. Le
tracce di questo testo originario vengono seguite da Gotor attraverso una
raccolta di dichiarazioni di chi quel testo - con ogni probabilità - lo vide e
lo lesse. Testimoni che, nel libro, sono divisi in due gruppi: i morti (il
generale Dalla Chiesa, il giornalista Mino Pecorelli) e i sopravvissuti (i
brigatisti, alcuni giornalisti ad essi in qualche modo contigui, esponenti
dell'area dell'autonomia, Francesco Cossiga). C'è un grande lavorio attorno al
Memoriale: impossessarsene, ritrovarlo, delegittimarlo (assieme al suo autore),
farlo sparire, edulcorarlo. Tutto sembra ruotare attorno alla figura di Giulio
Andreotti, sul quale mio padre avrebbe fatto - è questa l'ipotesi -
dichiarazioni molto compromettenti. La posta in gioco nella gara drammatica per
il recupero e la pubblicazione del manoscritto originale, o, al contrario,
perché ciò non avvenga, riguarda, infatti, la presa del potere in Italia, che si
gioca proprio attorno alla figura di Giulio Andreotti, e degli ambienti
emergenti che a lui fanno riferimento. Si tratta di una destra profonda, ben più
ampia di quella rappresentata come tale in Parlamento, alla quale non sono
estranee la loggia massonica deviata P2, pezzi dei servizi segreti, la
criminalità organizzata, i grandi interessi privati. Una presa di potere che poi
effettivamente avverrà, almeno al livello nazionale, con un cambiamento radicale
della finalità e della qualità della nostra vita democratica. Non si tratta,
purtroppo, di una spy-story, o di uno scritto «a tesi». E' piuttosto la
puntigliosa e precisa ricostruzione di un pezzo importante di storia del nostro
Paese, che Gotor fa passare sotto i nostri occhi senza abbellimenti. E con una
drammaticità non retorica, dal momento che è una storia piena di speranze e di
sangue. Al termine di una lettura che mi ha particolarmente, e ovviamente,
coinvolta, mi pongo tre quesiti. Il primo riguarda il manoscritto completo:
esiste ancora da qualche parte? Sarebbe davvero bellissimo che fosse così,
perché ci aiuterebbe a comprendere meglio quello che avvenne allora. Se qualcuno
ne sapesse qualcosa sarebbe il momento di dirlo. Il secondo quesito riguarda la
consapevolezza o l'inconsapevolezza del mondo politico nel suo insieme rispetto
a quanto stava avvenendo, ovvero alla lotta per il potere combattuta con tenacia
da forze ostili alla democrazia repubblicana, con tutto quello che essa comporta
in termini di sovranità di ogni cittadino, solidarietà e impegno per la
costruzione della giustizia. Quanti sapevano? Chi sapeva in quel 1978? Il terzo
quesito: quanto hanno pesato le vicende che Miguel Gotor descrive nel libro
sulla decisione di non far nulla (come disse papà in una delle sue lettere: «Non
c'è niente da fare quando non si vuole aprire la porta») per salvare Moro? Il
valore di un libro non si vede solo dalle cose alle quali dà una risposta, ma
anche dai quesiti che pone in tutta evidenza, senza che si possa sfuggire loro.
Personalmente sono convinta che sia venuto il tempo di unire le forze per dare
una compiuta ricostruzione e spiegazione di quegli anni difficili. Unire le
forze: gli storici, i protagonisti attivi nella lotta armata, nelle attività
eversive, nella politica, nei Servizi o nell' antiterrorismo, coloro che
custodiscono i documenti e chiunque possa dare un contributo per chiarire le
cose. E noi che abbiamo patito i frutti avvelenati di quella stagione. E' una
strada certamente complessa e dolorosa, ma è necessario percorrerla se vogliamo
avere quella verità che come Paese attendiamo da troppo tempo. E' il prezzo che
dobbiamo pagare se vogliamo rimettere il passato al suo posto, e riprendere, con
mitezza e serenità, il cammino che quegli anni terribili hanno interrotto.
24 Marzo 2014, tutta Italia
ne parla. Moro: nuove rivelazioni, vecchi errori. Un ispettore di Polizia
in pensione: «Quella mattina i servizi segreti coprirono le Br da possibili
interferenze»,
scrive Gabriele Paradisi su “Il Tempo”. Giovedì 16 marzo 1978, ore 9.02. In via
Fani a Roma un commando delle Brigate rosse sequestra il presidente della
Democrazia cristiana, onorevole Aldo Moro e uccide i cinque uomini della sua
scorta. Secondo quanto appurato nel corso di numerosi processi, i brigatisti
presenti sul luogo dell'agguato erano in tutto dodici. Ma nell'Italia dei
misteri non potevano mancare altre inquietanti presenze, mai del tutto accertate
o sulle quali mai si è fatta sufficientemente luce. Ad esempio quella del
colonnello del Sismi Camillo Guglielmi, presente all'ora della strage in via
Stresa nei pressi del tragico incrocio con via Fani, ma anche quella di una moto
di grossa cilindrata, una Honda blu per la precisione, con due persone a bordo
(«Peppo» e «Peppa», come li definì il brigatista Raimondo Etro). Un testimone,
l'ingegner Alessandro Marini, in sella al suo motorino, testimoniò di esser
stato preso a fucilate proprio da costoro. Ora, a 36 anni di distanza, in
un'ennesima esternazione che poggia guarda caso su presunte dichiarazioni di un
morto, le due sopracitate vicende sembrano trovare un legame. L'ispettore di
polizia in pensione Ernesto Rossi infatti, ha raccontato all'Ansa che l'uomo
seduto sul sellino posteriore della Honda, nel frattempo defunto, era in realtà
un uomo dei servizi alle dipendenze proprio del colonnello Guglielmi.
Quest'uomo, di cui non viene fornito il nome, avrebbe scritto una lettera nel
2009, resa disponibile solo sei mesi dopo la sua morte, in cui finalmente si
liberava del suo terribile segreto: egli e il guidatore della Honda (un
torinese) erano lì in via Fani per conto dei servizi e per proteggere l'azione
delle Br da qualsiasi interferenza possibile. La stagione delle nuove
rivelazioni clamorose, iniziata mesi fa con la notizia sull'ora effettiva del
ritrovamento del corpo di Moro in via Caetani il 9 maggio 1978, sembra dunque
riprendere vigore. Ma vediamo cosa possiamo dire al momento circa questa nuova
rivelazione dell'ispettore Rossi. Da quel che è dato sapere il parabrezza della
motoretta dell'ingegner Marini fu effettivamente colpito da proiettili; il
colonnello Guglielmi era sicuramente in netto anticipo sull'orario del presunto
invito a pranzo ricevuto da un collega che abitava in via Stresa; infine lo
stesso Vladimiro Satta, serio studioso del caso Moro e puntuale demolitore di
numerose dietrologie sorte sulla vicenda, circa l'identità dei due motociclisti
sulla Honda, in un suo libro del 2006 («Il caso Moro e i suoi falsi misteri»,
Rubbettino editore) ha riconosciuto che questo è «l'interrogativo più importante
sul caso Moro, tra i pochi che rimangono aperti» e l'interpretazione complessiva
della vicenda Moro cambierebbe se «venisse fuori che i due della moto Honda non
erano brigatisti, bensì agenti di chissà chi». Dunque, come abbiamo riassunto,
possiamo concludere che vi sono sicuramente dei passaggi, nella tragica storia
del sequestro e uccisione di Aldo Moro, che non hanno ancora oggi ricevuto
adeguate spiegazioni. La storia della Honda è uno di questi. Ma una cosa è
evidenziare le incongruenze mai spiegate e cercare di fugare le ombre che le
circondano, con ricerche serie che si basino su riscontri documentali, altro è
insinuare in questi snodi oscuri e irrisolti nuove romanzesche fantasie che
aggiungono solo confusione e alimentano la bulimia dei complottisti ad ogni
costo. L'ispettore Rossi ha dichiarato che parlerà solo ai magistrati e al
Parlamento. Bene. Tutto ciò che concretamente metterà a disposizione sarà dunque
vagliato e pesato nelle sedi opportune, ma se si tratterà solo di parole di
morti, non più riscontrabili, temiamo che aiuteranno ben poco a risolvere
qualsiasi mistero. Forse, il compito di chiarire una volta per tutte queste zone
d'ombra, potrebbe essere adeguatamente svolto dalla prevista nuova commissione
bicamerale d'inchiesta sul caso Moro. Solo questo ci sembra il luogo deputato
agli approfondimenti, oggi più che mai possibili anche in virtù del materiale
documentale attualmente disponibile presso archivi un tempo inaccessibili.
L’altra verità: il lavoro
dei nostri 007 «bruciato» da una soffiata dell’Unità,
scrive Luca Rocca su “Il Tempo”. I misteri, o cosiddetti tali, sul caso Moro,
vivono ormai di vita propria. Si perpetuano ciclicamente, fanno discutere,
sospettare, ma poi non succede nulla e la verità rimane quella «ufficiale», che
vuole le Brigate Rosse da una parte e lo Stato dall’altra. E quegli stessi
misteri, apparentemente capaci di squarciare il velo su una delle pagine più
tragiche della storia italiana, si accodano poi a quelli che li hanno preceduti
e che sul rapimento e l’uccisione del presidente della Democrazia Cristiana non
hanno mai aggiunto nulla di decisivo. Ed è probabilmente questo il destino che
attende anche le ultime rivelazioni che vogliono gli immancabili servizi segreti
italiani presenti, a bordo di una moto, in via Fani quel maledetto 16 marzo
1978, per «scortare» e quindi «aiutare» le Br a rapire Moro e uccidere gli
uomini della sua scorta. Una versione fornita dall’ex ispettore di polizia
Enrico Rossi, priva di riscontri ma che soprattutto fa a pugni con un fatto
accertato che contraddice totalmente le sue parole. Gli 007 italiani, secondo
quanto riportato in un rapporto del Sisde, nel 1993 cercarono, infatti, in tutti
i modi di ottenere la «collaborazione» di Alessio Casimirri, componente del
commando brigatista di via Fani, attraverso un «sottile» tentativo di
convincerlo a raccontare la «sua» verità sul rapimento Moro. E quando ormai
erano sul punto di riuscirci, una soffiata stranissima al quotidiano l’Unità,
che riportò la notizia dell’intenzione di Casimirri, nome di battaglia
«Camillo», di «collaborare» coi nostri 007, provocò l’interruzione della
trattativa fra la primula rossa e i nostri Servizi, avviata grazie
all’inconsapevole ruolo del fratello di Casimirri. Ma ecco come andarono i
fatti. Gli 007 «monitorano» il fratello di Casimirri tramite un proprio agente
che si finge poliziotto. Attraverso di lui potrebbero arrestare Alessio lontano
dal Nicaragua, lo Stato che lo protegge. Quando il finto poliziotto capisce che
Casimirri non ha intenzione di lasciare la sua nuova «patria», decide di svelare
la sua identità: «Sono un agente del Sisde. Posso far parlare Alessio con due
funzionari che seguono questa cosa». L’operazione «Camillo», preparata a lungo e
in grandissimo segreto, era praticamente conclusa, mancava solo qualche piccolo
dettaglio. Ma ecco che il quotidiano comunista va in edicola con
un’indiscrezione su quanto stava avvenendo. Il risultato è quello sperato da chi
poi rese vana un’operazione che avrebbe potuto risolvere uno dei misteri
d’Italia. L’ex brigatista, ormai bruciato, pose subito fine alla trattativa. Il
tentativo dei nostri servizi segreti di accertare tutta la verità sul rapimento
Moro attraverso quello che è forse l’unico ancor oggi in grado di svelarla,
finisce così a causa di un articolo pubblicato dal quotidiano «rosso». La
domanda, dunque, è una sola: perché se i Servizi presero segretamente parte al
rapimento Moro, come qualcuno vorrebbe far credere oggi (dopo più tentativi di
far crederlo in passato), poi fecero di tutto per conoscere la verità facendo
vuotare il sacco alla «pregiata» primula rossa?
Un'altra «verità» sul caso
Moro: le Br aiutate dai soliti servizi,
scrive “Il Giornale”. Più che un giallo è una saga senza fine. Il sequestro e la
morte di Aldo Moro sono una fabbrica sempre in attività di rivelazioni e scoop.
Con raccapricciante puntualità escono di anno in anno memoriali inediti, lettere
di protagonisti fin lì ai margini, confessioni naturalmente postume, analisi di
investigatori del giorno dopo. La verità pare finalmente a portata di mano, a un
centimetro dall'opinione pubblica che la reclama, ma poi a ben vedere sfuma
all'orizzonte come un miraggio. E la ruota continua a girare e a macinare
dettagli ancora sconosciuti, vai a sapere se veri o solo verosimili. È un
meccanismo avvincente ma accecante che segna alcune grandi pagine storiche:
l'assassinio di John Kennedy, la morte di Olof Palme, la tragedia di Aldo Moro.
Ci riempiono di dati e alla fine ne sappiamo meno di prima. Forse ci depistano,
di sicuro ci confondono. Capita anche questa volta: un poliziotto in pensione,
un ispettore che si è sempre occupato di terrorismo, dice di avere risolto un
capitolo di quel 16 marzo 1978, forse la giornata più buia nella notte della
Prima repubblica. Quella mattina in via Fani le Br sequestrano Aldo Moro e
massacrano la sua scorta. Fra i tanti misteri di quell'azione c'è anche quello
della Honda blu avvistata in via Fani. Dalla Honda furono quasi sicuramente
sparati i colpi che sfiorarono l'ingegner Alessandro Marini, l'unico civile
coinvolto in quella carneficina. Chi erano i due giovani in sella alla moto? I
brigatisti sono sempre stati categorici: «Noi con la Honda non c'entriamo». E
però non si è mai saputo chi fossero il conducente e il passeggero che aprì il
fuoco contro Marini e centrò il suo motorino. Ora l'ispettore Enrico Rossi ci dà
la soluzione, che però non è verificabile. Rossi sostiene che i due erano agenti
segreti alle dipendenze del colonnello del Sismi Camillo Guglielmi e avevano un
compito ben preciso: «Proteggere le Br da qualsiasi disturbo». Sì, il ruolo
degli 007, guidati da Guglielmi che tanto per cambiare era in quel tratto
affollato di strada per sovrintendere alle operazioni, era quello di aiutare i
terroristi a portare a termine la loro sanguinaria impresa. Una tesi che
s'iscrive alla nutritissima scuola dietrologica e predilige una lettura di via
Fani multistrato: con i brigatisti esecutori di un disegno orchestrato da menti
raffinatissime, nascoste negli apparati dello Stato e oltre i confini. Una tesi
suggestiva che però, modesto dettaglio, ha sempre trovato l'opposizione feroce
dei brigatisti: tutti, a cominciare da Mario Moretti, hanno sempre catalogato
alla voce fantascienza i tentativi di inserire Sismi, Cia, Kgb e chi più ne ha
più ne metta in via Fani o in qualche segmento della prigionia e dell'esecuzione
di Moro. La vicenda s'innesca con la scioccante missiva anonima recapitata a un
quotidiano nell'ottobre 2009: «Quando riceverete questa mia lettera saranno
passati almeno sei mesi dalla mia morte», imminente per un tumore inesorabile.
«La mattina del 16 marzo - prosegue il testo - ero su una moto e operavo alle
dipendenze del colonnello Guglielmi. Con me alla guida c'era un altro uomo
proveniente come me da Torino. Il nostro compito era quello di proteggere le Br
nella loro azione da disturbi di qualsiasi genere». Insomma, quella mattina lo
Stato, o meglio la sua parte più oscura, stava con i terroristi. Rossi legge la
lettera casualmente nel febbraio 2011 e s'imbatte in alcuni particolari
inquietanti: la missiva non è stata protocollata e non sono stati disposti
accertamenti. Nulla di nulla. Lui, invece, si dà da fare. Uno dei due
motociclisti è morto, ma l'altro è ancora vivo e Rossi lo stana facilmente.
Dettaglio molto interessante: l'uomo possiede due pistole regolarmente
denunciate e una delle due è una Drulov cecoslovacca, un'arma che assomiglia a
una mitraglietta. Rossi telefona all'ex agente che gli indica dove è la prima
pistola, ma tace sulla seconda. Allora scatta la perquisizione con sorpresa
finale. In cantina ecco spuntare la Drulov, poggiata sopra la copia
dell'edizione straordinaria di Repubblica di quel fatidico 16 marzo. Sembra di
stare dentro un film. Che però s'interrompe sul più bello: intervengono, non si
sa bene perché, i carabinieri, di fatto l'inchiesta esce dal perimetro di Rossi
e s'impantana. Niente perizie. Niente interrogatori. Niente di niente. Rossi
protesta, ma fa un buco nell'acqua. Decide di andare in pensione, a 56 anni, poi
scopre che l'uomo delle due pistole è morto, fatalità, dopo l'estate del 2012.
Non gli resta che raccontare all'agenzia Ansa quello che ha capito. Prima di
aggiungere ancora un elemento: «Il guidatore somigliava a Eduardo De Filippo»,
proprio come aveva messo a verbale l'ingegner Marini. Tutto torna. Anche troppo.
Ma nulla è certo. In ogni caso il fascicolo è confluito nell'ennesima inchiesta
aperta dalla procura di Roma sul caso Moro.
Caso Moro: «007 dovevano
proteggere Br».
Ha del clamoroso la notizia riportata oggi dall'Agenzia Ansa a
proposito del sequestro Moro, scrive “L’Unità”. "Tutto è partito da una lettera
anonima scritta dall'uomo che era sul sellino posteriore dell'Honda in via Fani
quando fu rapito Moro. Diede riscontri per arrivare all'altro. Dovevano
proteggere le Br da ogni disturbo. Dipendevano dal colonnello del Sismi che era
lì". Enrico Rossi, ispettore di polizia in pensione, racconta all'ANSA la sua
inchiesta. «L'ispettore racconta che tutta l'inchiesta è nata da una lettera
anonima inviata nell'ottobre 2009 a un quotidiano. Questo il testo: "Quando
riceverete questa lettera, saranno trascorsi almeno sei mesi dalla mia morte
come da mie disposizioni. Ho passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di
quanto non ho fatto e cioè raccontare la verità su certi fatti. Ora è tardi, il
cancro mi sta divorando e non voglio che mio figlio sappia. La mattina del 16
marzo ero su di una moto e operavo alle dipendenze del colonnello Guglielmi, con
me alla guida della moto un altro uomo proveniente come me da Torino; il nostro
compito era quello di proteggere le Br nella loro azione da disturbi di
qualsiasi genere. Io non credo che voi giornalisti non sappiate come veramente
andarono le cose ma nel caso fosse così, provate a parlare con chi guidava la
moto, è possibile che voglia farlo, da allora non ci siamo più parlati, anche se
ho avuto modo di incontralo ultimamente..."» riporta l'Ansa. «L'anonimo fornì
anche concreti elementi per rintracciare il guidatore della Honda. "Tanto io
posso dire, sta a voi decidere se saperne di più". Il quotidiano all'epoca passò
alla questura la lettera per i dovuti riscontri. A Rossi, che ha sempre lavorato
nell'antiterrorismo, la lettera arriva sul tavolo nel febbraio 2011 "in modo
casuale: non è protocollata e non sono stati fatti accertamenti, ma ci vuole
poco a identificare il presunto guidatore della Honda di via Fani". Sarebbe lui
l'uomo che secondo uno dei testimoni più accreditati di via Fani - l'ingegner
Marini - assomigliava nella fisionomia del volto ad Eduardo De Filippo. L'altro,
il presunto autore della lettera, era dietro, con un sottocasco scuro sul volto,
armato con una piccola mitraglietta. Sparò ad altezza d'uomo verso l'ingegner
Marini che stava "entrando" con il suo motorino sulla scena dell'azione»
continua l'Ansa. «"Chiedo di andare avanti negli accertamenti - aggiunge Rossi -
chiedo gli elenchi di Gladio, ufficiali e non, ma la "pratica" rimane ferma per
diversi tempo. Alla fine opto per un semplice accertamento amministrativo:
l'uomo ha due pistole regolarmente dichiarate. Vado nella casa in cui vive con
la moglie ma si è separato. Non vive più lì. Trovo una delle due pistole, una
beretta, e alla fine, in cantina poggiata o vicino ad una copia cellofanata
della edizione straordinaria de La Repubblica del 16 marzo con il titolo 'Moro
rapito dalle Brigate Rosse', l'altra arma". E' una Drulov cecoslovacca, una
pistola da specialisti a canna molto lunga che può anche essere scambiata a
vista da chi non se ne intende per una piccola mitragliatrice. Rossi insiste:
vuole interrogare l'uomo che ora vive in Toscana con un'altra donna ma non può
farlo. "Chiedo di far periziare le due pistole ma ciò non accade". Ci sono
tensioni e alla fine l'ispettore, a 56 anni, lascia. Va in pensione, convinto
che si sia persa "una grande occasione perché c'era un collegamento oggettivo
che doveva essere scandagliato". Poche settimane dopo una "voce amica" gli fa
sapere che l'uomo della moto è morto e che le pistole sono state distrutte.
Rossi attende molti mesi- dall'agosto 2012 - prima di parlare, poi decide di
farlo, "per il semplice rispetto che si deve ai morti"» conclude l'Ansa.
L’ex ispettore e i misteri del
caso Moro: “Parlerò solo con pm e in Parlamento”. Enrico Rossi aveva indagato su
una lettera inviata nel 2009 a La Stampa. Al centro i due motociclisti sulle
Honda comparsi in via Fani. C’era un torinese? Scrivono Grazia Longo e Massimo
Numa su “La Stampa”. L’ex ispettore della Digos Enrico Rossi sa di essere, da
poche ore, al centro dell’attenzione. Ha rivelato all’Ansa alcuni retroscena del
caso Moro, in particolare sul ruolo - mai chiarito - di un motociclista, in
sella a una Honda, comparso in via Fani nell’ora X del rapimento di Aldo Moro e
della strage della sua scorta. Deciso a raccontare la «sua» verità, perchè gli
accertamenti che furono svolti in allora dai suoi colleghi in modo scrupoloso
non portarono a nulla. «Tutto è partito - ha detto Rossi all’Ansa - da una
lettera anonima scritta dall’uomo che era sul sellino posteriore dell’Honda in
via Fani quando fu rapito Moro. Diede riscontri per arrivare all’altro. Dovevano
proteggere le Br da ogni disturbo. Dipendevano dal colonnello del Sismi che era
lì». Le ricerche dell’ispettore sono nate da una lettera anonima inviata
nell’ottobre 2009 alla redazione de La Stampa. Questo il testo: «Quando
riceverete questa lettera, saranno trascorsi almeno sei mesi dalla mia morte
come da mie disposizioni. Ho passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di
quanto non ho fatto e cioè raccontare la verità su certi fatti. Ora è tardi, il
cancro mi sta divorando e non voglio che mio figlio sappia. La mattina del 16
marzo ero su di una moto e operavo alle dipendenze del colonnello Guglielmi, con
me alla guida della moto un altro uomo proveniente come me da Torino; il nostro
compito era quello di proteggere le Br nella loro azione da disturbi di
qualsiasi genere. Io non credo che voi giornalisti non sappiate come veramente
andarono le cose ma nel caso fosse così, provate a parlare con chi guidava la
moto, è possibile che voglia farlo, da allora non ci siamo più parlati, anche se
ho avuto modo di incontralo ultimamente...Tanto io posso dire, sta a voi
decidere se saperne di più». La polizia avviò così le prime indagini. In una
casa di Cuneo, dove l’uomo ha vissuto con la prima moglie, vengono trovate due
armi regolarmente denunciate: una Beretta e una Drulov, un’automatica di
precisione di fabbricazione cecoslovacca. E le pagine originali di Repubblica
dei giorni del sequestro Moro. Rossi afferma di aver chiesto di sentire la
coppia e di ordinare una perizia sulle armi. Ma non accadde nulla. Sui dettagli
dell’indagine Rossi è pronto a testimoniare. «Ma solo con la magistratura e
nelle commissioni parlamentari.
Aspetto di essere convocato». Che l’Honda blu presente in via Fani il 16 marzo
del 1978 rappresenti un mistero è un dato assodato. Tutte da chiarire sono
invece le rivelazioni di Rossi: la procura di Roma, che si sta occupando del
caso, non ha per ora trovato riscontri. L’attività degli inquirenti, comunque,
prosegue. Intanto la memoria ricorre a pochi mesi fa, quando - il 6 novembre
scorso - l’ex brigadiere della Guardia di Finanza Giovanni Ladu è stato indagato
per calunnia dalla procura della capitale proprio perché, secondo la pubblica
accusa, aveva fornito informazioni false sul caso Moro.
Sequestro Moro, il fantomatico
007 era un fotografo che viveva a Bra. Secondo l’autore della lettera anonima
c’era lui sulla moto. Ma l’ex moglie: “Nel ’78 era sempre a casa con la sua
famiglia”, scrive Massimo Numa su “La Stampa”. Nome: Antonio Fissore, originario
di Bra (Cuneo), morto a Firenze nell’agosto 2012. A marzo aveva compiuto 67
anni. Sarebbe lui l’agente X che, in sella a una Honda blu, con un «collega»
avrebbe partecipato al sequestro Moro, il 16 marzo 1978, proteggendo la fuga dei
killer delle Br. La moglie separata, Franca Faccin, lo difende: «Nel ’78 era a
casa con noi, a Bra, mai stato nei Servizi». Professione fotografo, regista tv,
esperto di comunicazione, commesso dal 2001 al 2010 in un negozio di
dischi-video nel quartiere San Paolo a Torino. Aveva conseguito il brevetto di
pilota civile nella scuola di volo dell’aeroporto di Levaldigi. Alle spalle una
famiglia benestante di coltivatori. Sposato con Franca Faccin, 68 anni, padre di
due figli già grandi, Flavio (titolare di una società di produzione tv, la
Fimedia) e Davide, operaio. Nel 2000 si separa e inizia una relazione (durata
sino al 2010) con Tiziana A., torinese, commessa nello stesso negozio. Poi si
lega a una terza donna, Monica M. e va a vivere con lei a Firenze, non lontano
da via Villamagna. Un uomo alto 1,90, calvo, baffi. Distinto. Secondo l’autore
della lettera anonima inviata alla redazione de La Stampa nell’ottobre 2009,
Fissore sarebbe stato lo 007 che spianò una mitraglietta contro un testimone,
per indurlo ad allontanarsi. L’anonimo era in fin di vita, gravemente malato.
Non conosceva il nome del collega con cui operò in via Fani ma offriva
indicazioni per identificarlo come il «marito» della commessa del negozio. La
moglie, Franca Faccin, 68 anni, vive ancora nella villetta sulla collina di Bra.
Accetta di rispondere a tre domande. Nei primi Anni 70, in particolare nel ’78,
dov’era suo marito? «Qui con noi a Bra, non si è mai allontanato, di certo non
andò mai a Roma». E la militanza nei Servizi Segreti? Ha mai avuto percezione di
una sua doppia vita? «Non ha mai lavorato per i Servizi, era fotografo e regista
tv». Pare in una tv privata piemontese. Le armi. Sapeva che in casa erano
custodite una pistola cecoslovacca, rara, e una semi-automatica Beretta? «Certo,
le ha prese la polizia, in casa non ho più neppure una sua foto». L’autore della
lettera anonima spiega di essersi deciso, prima di morire, per il rimorso di
avere partecipato alla strage della scorta di Moro, di rivelare la verità. Non
sa il nome del collega con cui era sulla Honda ma tutti e due - sostiene
l’anonimo - erano al comando del colonnello dell’Ufficio R del Sismi, Camillo
Guglielmi, che, quella mattina alle 9.15 era effettivamente in via Fani («Stavo
andando a trovare un collega», aveva poi detto ai pm romani) dunque per caso. I
due agenti avrebbero dovuto proteggere la fuga dei killer dopo la strage. La
Digos di Torino individua subito Antonio Fissore, attraverso la sua ex amante di
Torino. Si mettono in contatto con lui, sanno che aveva denunciato il possesso
di due armi. Le vanno a cercare, il 24 maggio 2012, nella villetta di Bra.
Trovate in una scatola di cartone. C’è anche una copia di Repubblica del 16
marzo 1978. Poi libri e saggi su temi-storico politici e ritagli di giornale,
sempre su fatti di grande rilievo, come la prima guerra in Iraq di Bush padre.
Poi una busta con un foglio dell’ex parlamentare dc Franco Mazzola, nel ’78
sottosegretario alla Difesa, ritenuto uno dei depositari dei segreti del caso
Moro. Fissore viene denunciato per «incauta custodia» delle armi ma il
procedimento della procura di Alba viene archiviato dopo la sua morte. Gli
elementi dell’indagine finiscono in una nota inviata alla procura di Torino che,
per competenza, trasferisce il fascicolo a Roma. L’indagine viene archiviata.
Non erano emersi infatti, al di là degli elementi «suggestivi» e «sospetti»
contenuti nella lettera, alcun indizio che potesse collegare il fotografo a via
Fani. Chiude il sindaco di Bra, Renata Sibille: «Faceva il fotografo nei
matrimoni, ha lavorato in un negozio nel centro. Una persona gentile e
riservata. Lui uno 007? Impossibile».
Per una volta sono tutti
d’accordo: magistrati e Br. La Honda blu presente in via Fani il 16 marzo del
1978 è un mistero, scrive Paola Cucchiarelli su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. I
capi brigatisti hanno sempre negato che a bordo ci fossero due loro uomini, ma
da quella moto si spararono – sicuramente – gli unici colpi verso un civile
presente sulla scena del rapimento, l’ingegner Alessandro Marini, uno dei
testimoni più citati dalla sentenza del primo processo Moro. Mario Moretti e
Valerio Morucci sono stati sempre chiarissimi su quella moto blu di grossa
cilindrata: Non è certamente roba nostra. L'ingegner Marini si salvò solo perchè
cadde di lato quando una raffica partita da un piccolo mitra fu scaricata contro
di lui ad altezza d’uomo proprio da uno dei due che viaggiavano sulla moto. I
proiettili frantumarono il parabrezza del suo motorino con il quale l’ingegnere
cercava di passare all’incrocio tra via Fani e via Stresa. Marini fu interrogato
alle 10.15 del 16 marzo. Il conducente della moto – disse – era un giovane di
20-22 anni, molto magro, con il viso lungo e le guance scavate, che a Marini
ricordò "l'immagine dell’attore Edoardo De Filippo". Dietro, sulla moto blu, un
uomo con il passamontagna scuro che esplose colpi di mitra nella direzione
dell’ingegnere perdendo poi il caricatore che cadde dal piccolo mitra durante la
fuga. La sera a casa Marini arrivò la prima telefonata di minacce: Devi stare
zitto. Per giorni le intimidazioni continuarono. Si rafforzarono quando tornò a
testimoniare ad aprile e giugno. Poi l'ingegnere capì l’aria, si trasferì in
Svizzera per tre anni e cambiò lavoro. Il caricatore cadde certamente dalla moto
e Marini, dicono le carte, lo fece ritrovare ma questo non sembra essere stato
messo a raffronto con i tre mitra (ritrovati in covi Br) che spararono in via
Fani (ce ne è anche un quarto, mai ritrovato). Di certo da quella moto si sparò
per uccidere Marini, tanto che i brigatisti sono stati condannati in via
definitiva anche per il tentato omicidio dell’ingegnere. Marini d’altra parte
confermò più volte durante i processi il suo racconto e consegnò il parabrezza
trapassato dai proiettili. A terra in via Fani rimasero quindi anche i
proiettili sparati dal piccolo mitra ma le perizie sembrano tacere su questo
particolare. Sarebbe questa l'ottava arma usata in via Fani: 4 mitra, 2 pistole,
oltre alla pistola dell’agente Zizzi, che scortava Moro, e quella in mano
all’uomo della Honda: il piccolo mitra. Su chi fossero i due sulla Honda tante
ipotesi finora: due autonomi romani in cerca di gloria (ma perchè allora sparare
per uccidere?); due uomini della 'ndrangheta (ma non si è andati oltre
l’ipotesi); o, come ha ventilato anche il pm romano Antonio Marini che ha
indagato a lungo sulla vicenda, uomini dei servizi segreti o della malavita. I
Br negano ma, ha detto il magistrato, "una spiegazione deve pur esserci. Io vedo
un solo motivo: che si tratti di un argomento inconfessabile". Uomini della
malavita o dei servizi? "Allora tutto si spiegherebbe". Certo che quella mattina
a pochi passi da via Fani c'era, per sua stessa ammissione, Camillo Guglielmi,
indicato alternativamente come addestratore di Gladio o uomo dei servizi
segreti, invitato a pranzo alle 9.15 di mattina da un suo collega. E Guglielmi è
proprio l’uomo dei servizi chiamato in causa nella lettera anonima che ha dato
il via a Torino agli accertamenti sui due uomini a bordo Honda, poi trasferiti a
Roma. A Guglielmi si è addebitata anche la guida di un gruppo clandestino del
Sismi incaricato di gestire il rapimento Moro secondo un’inchiesta che è anche
nell’archivio della Commissione stragi, in Parlamento.
Gli ingredienti di un giallo
ci sono tutti: la confessione post mortem, l’indagine di un poliziotto, la
distruzione delle prove e la magistratura – quella romana - che comunque indaga:
fine, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Ma non è così se si parla del caso
Moro. «Tutto è partito da una lettera anonima scritta dall’uomo che era sul
sellino posteriore dell’Honda in via Fani. Diede riscontri per arrivare
all’altro, quello che guidava la moto». Enrico Rossi, ispettore di Ps in
pensione, racconta la sua inchiesta passeggiando sulle colline di Torino, a due
passi da Superga. Spiega con puntiglio e gentilezza sabauda che, secondo colui
che inviò la lettera anonima – che si qualificava come uno dei due sulla moto –
gli agenti avevano il compito di «proteggere le Br da disturbi di qualsiasi
genere. Dipendevano dal colonnello del Sismi Camillo Guglielmi che era in via
Fani la mattina del 16 marzo 1978». Tutta l’inchiesta è nata da una lettera
anonima inviata a un quotidiano nell’ottobre 2009. Eccola: «Quando riceverete
questa lettera, saranno trascorsi almeno sei mesi dalla mia morte come da mie
disposizioni. Ho passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di quanto non
ho fatto e cioè raccontare la verità su certi fatti. Ora è tardi, il cancro mi
sta divorando e non voglio che mio figlio sappia. La mattina del 16 marzo ero su
di una moto e operavo alle dipendenze del colonnello Guglielmi, con me alla
guida della moto un altro uomo proveniente come me da Torino; il nostro compito
era quello di proteggere le Br nella loro azione da disturbi di qualsiasi
genere. Io non credo che voi giornalisti non sappiate come veramente andarono le
cose ma nel caso fosse così, provate a parlare con chi guidava la moto, è
possibile che voglia farlo, da allora non ci siamo più parlati, anche se ho
avuto modo di incontralo ultimamente...». L'anonimo forniva elementi per
rintracciare il guidatore della Honda: il nome di una donna e di un negozio di
Torino. «Tanto io posso dire, sta a voi decidere se saperne di più". Il
quotidiano all’epoca passò alla questura la lettera per i dovuti riscontri. A
Rossi, che ha sempre lavorato nell’antiterrorismo, la lettera arriva sul tavolo
nel febbraio 2011 in modo casuale. Non è protocollata e non sono stati fatti
accertamenti, ma ci vuole poco a identificare il presunto guidatore della Honda
di via Fani che secondo un testimone ritenuto molto credibile era a volto
scoperto e aveva tratti del viso che ricordavano Eduardo De Filippo. "Non so
bene perchè ma questa inchiesta trova subito ostacoli. Chiedo di fare riscontri
ma non sono accontentato. L'uomo su cui indago ha, regolarmente registrate, due
pistole. Una è molto particolare: una Drulov cecoslovacca; pistola da
specialisti a canna molto lunga, di precisione. Assomiglia ad una mitraglietta.
Per non lasciare cadere tutto nel solito nulla predispongo un controllo
amministrativo nell’abitazione. L'uomo si è separato legalmente. Parlo con lui
al telefono e mi indica dove è la prima pistola, una Beretta, ma nulla mi dice
della seconda. Allora l’accertamento amministrativo diventa perquisizione e in
cantina, in un armadio, ricordo, trovammo la pistola Drulov poggiata accanto o
sopra una copia dell’edizione straordinaria cellofanata de La Repubblica del 16
marzo». Il titolo era: «Aldo Moro rapito dalle Brigate Rosse». «Nel frattempo –
continua Rossi – erano arrivati i carabinieri non si sa bene chiamati da chi.
Consegno le due pistole e gli oggetti sequestrati alla Digos di Cuneo. Chiedo
subito di interrogare l’uomo che all’epoca vive in Toscana. Autorizzazione
negata. Chiedo di periziare le due pistole. Negato. Ho qualche incomprensione
nel mio ufficio. La situazione si congela" e non si fa nessun altro passo, che
io sappia». «Capisco che è meglio che me ne vada e nell’agosto del 2012 vado in
pensione a 56 anni. Tempo dopo, una "voce amica" di cui mi fido – dice l’ex
poliziotto – m'informa che l’uomo su cui indagavo è morto dopo l’estate del 2012
e che le due armi sono state distrutte senza effettuare le perizie balistiche
che avevo consigliato di fare. Ho aspettato mesi. I fatti sono più importanti
delle persone e per questo decido di raccontare l'inchiesta "incompiuta"». Rossi
ricorda, sequestrò una foto, che quell'uomo aveva un viso allungato, simile a
quello di De Filippo: «Sì, gli assomigliava». Fin qui l’ex ispettore, che
rimarca di parlare senza alcun risentimento personale ma solo perchè «quella è
stata un’occasione persa. E bisogna parlare per rispetto dei morti». Il signore
su cui indagava Rossi è effettivamente morto – ha accertato l’ANSA – nel
settembre del 2012 in Toscana. Le pistole sembrerebbero essere state
effettivamente distrutte, ma il fascicolo che contiene tutta la storia dei due
presunti passeggeri della Honda è stato trasferito da Torino a Roma dove è
tuttora aperta un’inchiesta della magistratura sul caso Moro.
Il caso Moro tra nuove
rivelazioni e vecchie dimenticanze.
Grande rumore sullo strano caso dei due agenti segreti presunti «fiancheggiatori
delle Br». Ma tutti ignorano una sicura verità: e cioè che nel 1979 gli
assassini di Moro furono arrestati nella casa romana del capo del Kgb in Italia,
scrive Maurizio Tortorella su “Panorama”. Grande rumore stanno facendo le
rivelazioni di un ispettore a riposo della polizia torinese, il quale ha
dichiarato ai magistrati che il giorno del rapimento di Aldo Moro, in via Fani a
Roma, su una moto Honda sarebbero stati inviati due agenti dei servizi segreti
con il paradossale compito di «aiutare le Brigate rosse» nell'impresa. Come
sempre in questi casi c'è chi è scettico e pensa all'ennesimo depistaggio, chi
ci crede e grida allo Stato complice. E c'è chi fa spallucce, come se ormai
sulla vicenda dovesse comunque scendere il silenzio: tanto... A me, ogni volta
che si parla del caso Moro, torna invece alla memoria un documento che rimase
sepolto nelle carte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso
Mitrokhin, l'ex spione russo che aveva copiato migliaia di documenti del Kgb,
nei quali si trattava anche dell'Italia. Era il 2002. La commissione Mitrokhin
aveva analizzato il ruolo di Giorgio Conforto, detto «Dario», nato nel 1908 e
morto nel 1986, considerato il più antico e importante agente sovietico in
Italia, tanto da essere perfino decorato con la stella all'Ordine di Lenin. E
sull'agente Dario, ex dirigente del ministero degli Esteri (nel 1932 era stato
infiltrato dal Kgb nel Partito nazionale fascista), la commissione Mitrokhin
aveva scoperto un anomalo ruolo nel rapimento di Moro. In un'audizione era stato
l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, ministro dell'Interno nel
periodo del sequestro, a rivelare che il 29 maggio 1979 era stato proprio
Conforto a segnalare alla questura di Roma che i due brigatisti Adriana Faranda
e Valerio Morucci, un anno prima attivi nel rapimento dello statista, erano a
casa dell'agente segreto. La polizia, subito accorsa all'indirizzo (il quarto
piano di viale Giulio Cesare, 47), vi aveva fatto un'importante scoperta: con i
due latitanti c'era la mitraglietta Skorpion usata per uccidere il leader della
Dc. La figlia di Dario, Giuliana Conforto, docente universitaria e titolare
dell'appartamento, fu arrestata per favoreggiamento e poi scagionata. Nella
commissione Mitrokhin c'era stato chi si era convinto che la soffiata di Dario
fosse in realtà il prezzo di uno scambio strategico: «Non è inverosimile» aveva
dichiarato Enzo Fragalà, l'ottimo commissario di An ucciso nel febbraio 2010 in
circostanze mai del tutto chiarite «che Conforto sia riuscito, in un sol colpo,
a eliminare con Morucci e Faranda l'ala trattativista delle Br, più lontana
dagli interessi del Kgb, e anche a ottenere l'immunità per la figlia». Ecco,
ogni volta che esce qualche strana novità sul caso Moro, a me viene in mente
invece l'agente Dario, con la sua bella stella all'Ordine di Lenin. E ogni volta
mi domando quanto strano sia questo Paese, che si appassiona alle storie più
strane e nulla sa di altre storie, peraltro sicuramente vere, come quella di
Giorgio Conforto e del suo appartamento in viale Giulio Cesare. Poi sorrido nel
domandarmi che cosa sarebbe mai accaduto se nel 1979 si fosse scoperto che i due
brigatisti-rapitori e la mitraglietta che aveva ucciso Moro fossero stati
ospitati non nella casa della figlia del capo del Kgb in Italia, ma in quella
della figlia del capo della Cia.
Caso Moro: tutti i misteri.
Le rivelazioni dell'ex poliziotto, Enrico Rossi, sulla complicità di alcuni 007
alimentano nuovi misteri che si intrecciano a quelli mai svelati sul rapimento
dello statista democristiano, scrive Nadia Francalacci su “Panorama”. E’ un
altro mistero. Che si aggiunge e si intreccia agli altri fatti “oscuri”
che avvolgono il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Lui si chiama Enrico
Rossi, è un ex ispettore della Digos, e dopo tre anni ha deciso di raccontare,
tra rabbia e amarezza la sua indagine sul caso Moro nata, nel 2009, da una
lettera anonima inviata a un quotidiano. "Quando riceverete questa lettera,
saranno trascorsi almeno sei mesi dalla mia morte come da mie disposizioni. Ho
passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di quanto non ho fatto e cioè
raccontare la verità su certi fatti. Ora e' tardi, il cancro mi sta divorando e
non voglio che mio figlio sappia. La mattina del 16 marzo ero su di una moto e
operavo alle dipendenze del colonnello Guglielmi, con me alla guida della moto
un altro uomo proveniente come me da Torino; il nostro compito era quello di
proteggere le Br nella loro azione da disturbi di qualsiasi genere. Provate a
parlare con chi guidava la moto, è possibile che voglia farlo, da allora non ci
siamo più parlati, anche se ho avuto modo di incontralo ultimamente...". E
l'anonimo fornì, nella lettera, anche concreti elementi per rintracciare il
guidatore della Honda. Elementi che Enrico Rossi non trascurò. Infatti l’ex
poliziotto precisa: “Sono riuscito a rintracciare nel 2011 gli uomini sulla
Honda ma mi fermarono. E non sono riuscito ad interrogare quello che era alla
guida”. Adesso, però, sono morti entrambi. Ma questa lettera che ha riaperto,
l’ennesima indagine finita nel nulla sul rapimento e uccisione dell’ex statista
democristiano, ha creato anche nuovi interrogativi, misteri e forse anche nuovi
tentativi di depistaggio. Perché infatti proprio adesso queste nuove
rivelazioni? Certo è che sia per i brigatisti che per gli stessi magistrati,
quella Honda blu presente sul luogo del rapimento è stata in passato ed è
tutt’ora un mistero. E su questo punto, per una volta, sono tutti d'accordo.
La misteriosa moto blu:
La Honda blu presente in via Fani il 16 marzo del 1978 e' un rompicapo. I capi
brigatisti hanno sempre negato che a bordo ci fossero due loro uomini, ma da
quella moto si spararono gli unici colpi verso un civile presente sulla scena
del rapimento, l'ingegner Alessandro Marini, uno dei testimoni più citati dalla
sentenza del primo processo Moro. Mario Moretti e Valerio Morucci sono stati
sempre chiarissimi su quella moto blu di grossa cilindrata: Non è certamente
roba nostra. L'ingegner Marini si salvò solo perchè cadde di lato quando una
raffica partita da un piccolo mitra fu scaricata contro di lui ad altezza d'uomo
proprio da uno dei due che viaggiavano sulla moto. Marini fu interrogato alle
10.15 del 16 marzo e disse che il conducente della moto era un giovane di 20-22
anni, molto magro, con il viso lungo e le guance scavate, che gli ricordava
l'attore Edoardo De Filippo". Dietro, sulla moto blu, un uomo con il
passamontagna scuro, l’autore della lettera, che esplose colpi di mitra nella
direzione dell'ingegnere perdendo poi il caricatore che cadde dal piccolo mitra
durante la fuga. La sera a casa Marini arrivò la prima telefonata di minacce:
Devi stare zitto. Per giorni le intimidazioni continuarono. Poi l'ingegnere capì
e decise di trasferirsi in Svizzera per tre anni.
Il mitra dello 007:
A terra in via Fani rimasero quindi anche i proiettili sparati dal piccolo mitra
ma le perizie sembrano tacere su questo particolare. Sarebbe questa l'ottava
arma usata in via Fani: 4 mitra, 2 pistole, oltre alla pistola dell'agente
Zizzi, che scortava Moro. Infine quella in mano all'uomo della Honda: il piccolo
mitra. Il caricatore cadde dalla moto e Marini lo fece ritrovare ma questo non
sembra essere stato messo a raffronto con i tre mitra (ritrovati in covi Br) che
spararono in via Fani. Sulla scena ce n’è anche un quarto ma non fu mai
ritrovato. Ma i misteri sul caso Moro sono davvero tanti e tutti intrecciati tra
loro quasi a formare, volutamente, una ragnatela di false verità.
Il trasbordo del
presidente e le foto sparite nel nulla:
Quella mattina, subito dopo l’attacco rapido e sanguinario del commando, il
trasbordo del presidente DC avvenne invece piuttosto lentamente, una calma quasi
surreale visto ciò che era appena accaduto. Così lo descrisse una testimone. Ma
non era la sola. Al numero 109 di Via Fani, un altro spettatore scatta dal
balcone di casa una dozzina di foto della scena della strage a pochi secondi
dalla fuga del commando. Di quelle foto, consegnate quasi subito alla
magistratura dalla moglie dell’uomo, una giornalista dell’agenzia ASCA, non si
saprà più nulla.
Strane presenze in via
Fani, l'uomo dei Servizi:
Chi era veramente presente quella mattina in via Fani? Le Commissioni
parlamentari hanno ormai confermato, tanto per riportare alcuni nomi alquanto
"particolari", che quella mattina alle nove, in via Stresa, a duecento metri da
via Fani, c'era un colonnello del SISMI, il colonnello
Guglielmi, il quale faceva parte della VII divisione ovvero di quella
divisione del Sismi che controllava Gladio e al quale fa riferimento l’ex agente
007 a bordo della Honda che ha sparato a Marini e poi scritto la lettera nel
2009. Guglielmi, che dipendeva direttamente dal generale Musumeci, esponente
della P2 implicato in vari i depistaggi e condannato nel processo sulla strage
di Bologna, confermò che quella mattina era in via Stresa, a duecento metri
dall'incrocio con via Fani, perché doveva andare a pranzo da un amico.
Le borse del presidente:
Poi c’è il mistero sulla sparizione di alcune delle borse di Moro. Secondo la
testimonianza della moglie Eleonora Moro, il presidente usciva abitualmente di
casa portando con se cinque borse: una contenente documenti riservati, una di
medicinali ed oggetti personali; nelle altre tre vi erano ritagli di giornale e
tesi di laurea dei suoi studenti. Subito dopo l'agguato sull'auto di Moro
vennero però rinvenute solamente tre borse. La signora Moro dichiarò: "I
terroristi dovevano sapere come e dove cercare, perché in macchina c'era una
bella costellazione di borse".
La seduta "spiritica":
Tra le vicende inusuali accadute durante i 55 giorni del rapimento Moro è da
menzionare anche quella del 2 aprile 1978. Nella casa di campagna di Alberto Clò
a Zappolino, alle porte di Bologna, si riunì un gruppo di professori
universitari con tanto di mogli e bambini. Erano presenti l'ex presidente del
Consiglio Romano Prodi con la moglie Flavia. Secondo i racconti, per allentare
la noia di una giornata di pioggia, a qualcuno dei partecipanti venne la
bizzarra idea di tenere una seduta spiritica. I partecipanti avrebbero quindi
evocato gli spiriti di don Luigi Sturzo e Giorgio La Pira, chiedendo loro
dove si trovasse la prigione di Aldo Moro. Gli spiriti formarono le parole
Bolsena-Viterbo-Gradoli e indicarono anche il numero 96. Secondo i racconti
dei partecipanti, fu proprio il terzo nome ad incuriosirli, tanto da prendere un
atlante per controllare se esistesse una località chiamata Gradoli. Il 4 aprile,
a Roma per un convegno, Prodi parlò di questa indicazione a Umberto Cavina, capo
ufficio stampa della DC, che la trasmise a Luigi Zanda, addetto stampa del
ministro dell'Interno, il quale fece un appunto per il capo della polizia,
Giuseppe Parlato. Parlato ordinò di perquisire la zona lungo la statale 74, nel
piccolo tratto in provincia di Viterbo, in località Gradoli, casa isolata con
cantina. Il rastrellamento della zona viene effettuato il 6 aprile, senza
risultati. Poi si scoprirà dopo la verità.
La figura discussa e
controversa del brigatista Mario Moretti, ideatore del rapimento Moro:
Moretti, deus ex machina del rapimento, sembra in base ad una relazione
parlamentare che fosse conosciuto alle forze dell’ordine prima ancora della
strage di via Fani e la cui latitanza sia stata in qualche modo “protetta” da
coloro che avrebbero dovuto contrastare il fenomeno terroristico. Mario Moretti
è infatti sfuggì alla cattura, mentre venivano regolarmente arrestati i suoi
compagni, a via Boiardo a Milano, nel 1972 e a Pinerolo, Torino, nel 1974. Non
solo ci sono altri tre interrogativi ai quali non si è mai dato una risposta
certa e che proverebbero la vicinanza di Moretti ai nostri apparati di
sicurezza. I tre fatti potrebbero essere così riassunti: 1- il mandato di
cattura nei confronti di Moretti viene spiccato solo il 19 maggio 1978, a non il
24 aprile quando viene emesso nei confronti degli altri brigatisti; 2- il nome
di Moretti non compare tra quelli dei terroristi sui quali il Capo della Polizia
ipotizza di istituire una taglia; 3- la comunicazione del ministero dell’Interno
inerente le ricerche di Moretti è l’unica della quale non viene segnalata
l’urgenza. La Relazione presentata dall’on. Walter Bielli nel 25 luglio 2001
alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia, avanza anche
pesanti dubbi sull’operato della magistratura romana durante i 55 giorni del
sequestro del presidente della DC.
L'ASSASSINIO DI MORO
(1978) - Il "mistero dei misteri", dopo le ultime dichiarazioni fatte da
politici autorevoli, presenta risvolti inquietanti.
Dietro la morte del dirigente
DC uno spietato gioco delle parti, scrive Giuseppe Dell’Acqua. Lo "slogan" che
nell'Aprile del 1978 echeggiava in Italia tuona ancora forte nella mente di chi,
il 9 Maggio 1978, ha assistito in diretta tv alla prima vera "morte della
Repubblica". Simbolo di uno Stato che crolla è il corpo senza vita
dell'onorevole Aldo Moro nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, parcheggiata in
Via Caetani a Roma. Perchè durante i 55 giorni di prigionia dello statista, la
frase "nè con lo stato nè con le BR'' era sulla bocca di tutti? Com'è possibile
che gli italiani arrivino a mettere in dubbio l'appartenenza ad uno Stato, ad
una società; arrivino a mettere in dubbio se stessi. Il 16 marzo scorso è
ricorso il 28° anniversario della strage di Via Fani (16 marzo 1978) ed è
passato ancora una volta nel silenzio di tutti; quotidiani, riviste, TG,
programmi TV, nessuno ha nemmeno accennato alla morte dei cinque agenti di
scorta. A distanza di tempo è bene ricordare che il mistero del sequestro Moro
non è ancora stato svelato e soprattutto che la dichiarazione rilasciata il 5
luglio 2005 dall'onorevole Galloni (vice segretario vicario della DC nel 1978)
inerente la "certa" presenza della CIA e del MOSSAD all'interno delle BR, ha
alzato un grosso polverone che nel giro di pochi giorni, come per incanto, si è
dissolto in un semplice ricordo. Le dichiarazioni di Galloni, Andreotti e
addirittura della Santa Sede, i documenti del "Dossier e dell'Archivio
Mitrokhin", devono obbligatoriamente portare la coscienza di "qualcuno" a
pensare che forse sia giunto il momento di parlare per far conoscere all'Italia,
la verità.
16 marzo 1978, Via Fani ore
9.05: " ...un nucleo armato delle Brigate Rosse ha
catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della DC.
La sua scorta armata, composta da cinque agenti...è stata completamente
annientata..."
Con questo comunicato le
Brigate Rosse, il 17 marzo, rivendicano il sequestro del presidente della
Democrazia Cristiana, Aldo Moro e l'uccisione del maresciallo dei carabinieri
Oreste Leopardi, dell'appuntato Domenico Ricci, del brigadiere Francesco Izzi e
degli agenti Raffaele Iozzino e Giulio Rivera. Il 16 marzo 1978 la Camera dei
Deputati è pronta a votare la fiducia al 4° governo Andreotti che nasce dopo una
crisi lunga e difficile, durata quasi 8 settimane. A rendere particolare
quest'evento è che, per la prima volta negli ultimi 30 anni, fanno parte del
governo anche esponenti del Partito Comunista Italiano, avvicinati alla
Maggioranza dal nuovo progetto politico, denominato "compromesso storico";
artefice della cosiddetta "svolta a sinistra" è proprio l'onorevole Aldo Moro.
D'origini pugliesi Moro è stato capo del governo in cinque diverse occasioni dal
1963 (I governo) al 1976 (V governo) e ad oggi, è considerato come uno dei più
grandi statisti italiani perché è riuscito a comprendere prima di tutti l'ondata
di innovazione che stava colpendo la politica italiana. Moro dal 16 marzo al 9
maggio 1979 resterà per tutto il periodo chiuso nella "prigione del popolo"
delle Brigate Rosse. Chi erano le BR e soprattutto qual era il loro principale
obiettivo? Le BR "nascono" in un convegno dei militanti del Comitato Politico
Metropolitano (CPM) a Chiavari, in Liguria nell'autunno del 1970. Il CPM era una
"Struttura Articolata di Lavoro in cui i militanti realizzano da una parte le
condizioni per una riflessione politica.e dall'altra consentono una crescita
politica omogenea della lotta."; erano gruppi di studenti ed operai che si
riunivano in "assemblee" per discutere di politica e per cercare di "risolvere"
i problemi della società attraverso "lotte e volantini". In questo convegno è
sostenuta la necessità di intraprendere una lotta armata, della guerriglia e
quindi, della clandestinità: "Non è con le armi della critica e della
chiarificazione che s'intaccano la corazza del potere capitalistico e le croste
della falsa coscienza delle masse. Che la lotta di classe nel suo procedere
incontri la violenza del sistema, è inutile ripetercelo. Il problema della
violenza non è separabile dall'illegalità. lo scontro violento è una necessità
intrinseca necessaria nello scontro di classe.". La parola d'ordine negli
anni '70 è "lotta di classe", ed è proprio questo lo scopo principale delle
"neonate" BR che, infatti, si autodefinirono "combattenti del proletariato".
I loro punti di riferimento erano "il marxismo-leninismo, la rivoluzione
culturale cinese e l'esperienza in atto dei movimenti guerriglieri
metropolitani, non accettando gli schemi che hanno guidato i partiti comunisti
europei nella fase rivoluzionaria della loro storia." Le BR avevano
intenzione di realizzare quello che Lenin riuscì a fare in Russia nel 1917: una
"rivoluzione comunista", ma allo stesso tempo rinnegavano il modo con il quale i
partiti comunisti europei hanno affrontato la "politica rivoluzionaria" fino a
quel momento. L'obiettivo principale quindi era la lotta di classe che doveva
portare il "proletariato", il "solo, unico, autentico, comunismo rivoluzionario"
al potere. Secondo il parere di molti storici, il vero obiettivo delle Brigate
Rosse era quello di essere riconosciute politicamente ed il discorso fino a qui
fatto rafforza l'idea di BR come partito politico, pronto a guidare la nazione.
Un esponente di spicco del partito armato però, nega questa tesi: Mario Moretti.
Capo indiscusso delle BR, ideatore del sequestro Moro e quindi punto massimo
delle ideologie brigatiste, nel suo libro "Mario Moretti, Brigate Rosse, Una
storia italiana" alla domanda di Carla Mosca e Rossana Rossanda sulla trattativa
che le BR stavano avendo con il Governo per la liberazione di Aldo Moro,
risponde: "Dire "trattativa" mi fa rabbrividire. E' diventata sinonimo di
"cedimento". Noi non volevamo ne trattavamo nessun riconoscimento istituzionale.
Come potevamo chiedere una patente di legittimità allo stato che stavamo
combattendo?" Le BR volevano solo l'"ammissione di uno stato di fatto"
che valeva a dire " qualcuno dello Stato ammettesse: si, in Italia ci sono
dei detenuti politici, dunque c'è un soggetto politico con il quale dobbiamo
interloquire". Non gli serviva essere riconosciute politicamente o
istituzionalmente, a loro bastava solo essere "riconosciute" come avversario,
come nemico da battere. Il linguaggio, leggermente "conflittuale", è appropriato
nel descrivere "gli anni di piombo" ed in particolare il sequestro Moro che ha
rappresentato, per la società italiana, una vera e propria "guerra civile" dove
non ci sono due ideologie politico-sociale a lottare tra loro, ma tre
istituzioni: lo "Stato" rappresentato dal Governo, l'"Anti-Stato" rappresentato
dalle Brigate Rosse e la "Nazione" rappresentata dal popolo italiano. E' proprio
questo terzo elemento che rende l'"Affaire Moro" un macigno, ancora oggi, che
grava insopportabile sulla Repubblica Italiana; per la prima volta si è messa in
dubbio l'appartenenza ad uno Stato, "né con lo Stato né con le BR" è lo slogan
del 1978 e questo significa che non solo, un popolo non riconosce più
l'avversario nel "cattivo" ma addirittura, non riesce a capire chi è veramente
il "nemico" da battere. Si colloca quindi in una posizione intermedia, al centro
dei due "fuochi". Questo comporta la distruzione di un'identità che mai l'Italia
Repubblicana proverà ancora.
Il mistero Moro è una delle
più grandi "ombre" dello Stato italiano; ha rappresentato il culmine di una
"stagione di piombo" che si è protratta dal dicembre del 1969 all'agosto del
1980 in corrispondenza di due avvenimenti che hanno sconvolto la nazione: le
stragi rispettivamente di Piazza Fontana (12 dicembre 1969) e della stazione
centrale di Bologna (2 agosto 1980). In quest'intervallo di tempo, denominato
"Anni di Piombo", l'Italia intera fu colpita da gravi atti terroristici "neri" e
"rossi". I colori purtroppo distinguono il terrorismo di stampo fascista o più
semplicemente quello di "estrema Destra" (Nero) da quello di marchio comunista o
di "estrema Sinistra"(Rosso). E' solo una coincidenza che i due attentati
"spartiacque" si tingono di "nero" non solo per l'alone di mistero che tuttora
li circonda, ma anche per le dirette responsabilità dell'azione. E' bene
ricordare che dopo la strage alla stazione di Bologna, gli attentati
continueranno, anche se, avranno volti nuovi e del tutto diversi quali la mafia,
la camorra e la ndrangheta, per non parlare poi del terrorismo moderno; ma
questo è un altro discorso. Come ogni "dopoguerra" che si rispetta, anche la
"stagione di piombo" ha il suo bilancio, un bilancio che come ricorda un gran
maestro del giornalismo Sergio Zavoli "...non potrà mai essere a misura delle
vite distrutte, delle ferite ancora aperte; ma occorre farlo, perché quanto
detto si possa tradursi, alla fine, anche in qualcosa di assolutamente
incontestabile come la fredda oggettività dei numeri.". 429 vittime, 2000
feriti, 199 morti e 782 feriti in 10 stragi, 144 vittime rivendicate dal
terrorismo "rosso" 86 delle quali solo da parte delle Brigate Rosse e 36 vittime
rivendicate dal terrorismo "nero", sono solo alcuni dei "numeri", tragici, che
il terrorismo porta con se. È subito evidente che ben 86 delle 144 vittime
rivendicate, appartengono alle BR, sintomo che sia stata la più grande
"organizzazione terroristica italiana" della storia repubblicana. La domanda a
cui sarà impossibile dare una risposta, è se le BR sono un "frutto" concimato,
raccolto e mangiato esclusivamente da "contadini" italiani o se invece
"qualcuno", di più grande, le ha "usate" per raggiungere i suoi obiettivi? E'
questo il capitolo più difficile della storia del sequestro Moro e delle BR; la
possibile influenza, nelle BR d'organizzazioni più grandi e più segrete, non
appartenenti allo stato italiano, è da anni un punto cruciale su cui storiografi
e critici s'interrogano.
Le ultime dichiarazioni
dell'onorevole Galloni, rilasciate martedì 5 luglio 2005 alla rete televisiva
"RAINews24", sembrano confermare l'ipotesi di una "collaborazione" tra le BR e i
servizi segreti stranieri. Galloni, vice segretario della DC all'epoca del
sequestro Moro disse: "Moro mi disse che sapeva per certo che i servizi
segreti sia americani sia israeliani avevano degli infiltrati all'interno delle
Brigate Rosse. Però non erano stati avvertiti di questo". La possibile
presenza della CIA e del MOSSAD all'interno delle BR, apre nuovi ed inquietanti
scenari sul caso Moro, chiudendo definitivamente le porte alla "pista russa" che
fino ad oggi ha ipotizzato che a "decidere" la sorte dell'onorevole Aldo Moro
sia stato il KGB russo. Nel raccontare la "Storia contemporanea" bisogna tener
conto che esistono due "binari" che viaggiano nella stessa direzione e velocità
e che però "trasportano" due "versioni dei fatti" distinte e separate. Il
binario è quello del "conosciuto", della storia scritta sui libri, raccontata
dai nonni o semplicemente vista in TV; il secondo invece porta con se una
"storia" misteriosa, non conosciuta e che nessun libro di storia, nessun
documentario TV e "forse" nessun nonno potrà mai raccontare: è la "Storia"
scritta dai Servizi Segreti. I contatti tra le BR e i servizi segreti stranieri
non sono molto documentati e quindi sono esclusivamente frutto d'ipotesi o
d'invenzioni fantapolitiche che a volte hanno anche un fondamento.
Nell'"Archivio Mitrokhin" - la raccolta di documenti segreti che Vasilij
Mitrokhin, capoarchivista del KGB, consegnò agli inglesi del MI6 nel 1992 e che
nel 1999 fu pubblicata con la partecipazione di Christopher Andrew, massimo
esperto storico del KGB - ci sono due dichiarazioni molto importanti per la
politica italiana: "nell'estate del 1967, Giorgio Amendola, a nome della
Direzione del PCI, chiede formalmente l'assistenza sovietica per preparare il
partito alla sopravvivenza come movimento illegale e clandestino nel caso di un
colpo di Stato. Fino al 1976 i trasferimenti di fondi al Partito comunista sono
stati molto più semplici a Roma che negli Stati Uniti, dal momento che i capi
del PCI visitano regolarmente l'ambasciata sovietica, è possibile evitare la
trafila di contatti clandestini e nascondigli segreti. Aiuti finanziari
aggiuntivi arrivano da Mosca anche attraverso contratti lucrosi con società
controllate dal PCI". La prima indiscrezione ci rivela che il PCI è
finanziato direttamente dal KGB, mentre la seconda ci ricorda che: "Il PCI si
preoccupava in particolar modo del sostegno che le Brigate Rosse ricevono dai
servizi segreti cecoslovacchi, quando le BR assaltano nel centro di Roma
l'automobile del presidente della DC, l'onorevole Aldo Moro, le preoccupazioni
dei leader del PCI raggiungono l'apice, teme una fuoriuscita di notizie sul
sostegno dato dai servizi segreti cecoslovacchi (StB) alle BR. Una delegazione
del PCI a Praga è stata messa a tacere quando ha cercato di sollevare la
questione dell'aiuto alle BR, alcuni esponenti delle quali sono stati invitati
in Cecoslovacchia." Riassumendo, ci rendiamo conto che il PCI prelevava
soldi dal KGB ed era a conoscenza che i servizi segreti cecoslovacchi
"aiutavano" in qualche modo le BR, ma aveva paura che ciò si venisse a sapere.
Perché? Forse perché in questo modo anche la collaborazione tra PCI e KGB
sarebbe stata scoperta e soprattutto perché il PCI sarebbe stato accusato di
aiutare indirettamente, attraverso gli amici cecoslovacchi (StB), le Brigate
Rosse. In un momento caldo come quello dell'immediato "dopo-Moro", ciò avrebbe
suscitato forti polemiche che avrebbero sancito il definitivo "crollo" del PCI
proprio nel momento in cui si stava - per la prima volta nella sua storia -
avvicinando al governo. Che il PCI ricevette finanziamenti dai servizi segreti
Russi è accertato dall'Archivio Mitrokhin mentre la "collaborazione" tra BR e
StB non è mai stata confermata. Nel "Dossier Mitrokhin" - la raccolta di
documenti che gli Inglesi tra il 1995 ed il 1999 hanno inviato ai servizi
segreti italiani - c'è il "Rapporto Impedian numero 143" che dice: "Nel
dicembre del '75 Yuriy Andropov notificò quanto segue al Comitato Centrale del
PCUS. Il Ministro degli Affari Interni Cecoslovacco, OBZINA, aveva informato il
rappresentante del KGB sovietico a Praga di un incontro avvenuto il 16 settembre
1975. L'incontro era stato tra Antonin VAVRUS, Capo del Dipartimento
Internazionale del Comitato centrale del Partito Comunista Cecoslovacco e
Salvatore CACCIAPUOTI, vice presidente della Commissione Centrale di Controllo
del Partito Comunista Italiano (PCI). CACCIAPUOTI affermò di essere stato
autorizzato dalla dirigenza del PCI a informare il Comitato centrale del Partito
Comunista Cecoslovacco che le agenzie ufficiali italiane erano in possesso di
alcuni documenti.che confermavano che una delle basi dell'organizzazione
terroristica italiana "Brigate Rosse" era ubicata in Cecoslovacchia e che le
agenzie di sicurezza cecoslovacche stavano cooperando con essa." Ancora più
dirette sono le accuse che nel settembre del '74 il capitano dei carabinieri
Gustavo Pignoro del nucleo antiterrorismo del generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa fa ad Alberto Franceschini - uno dei fondatori delle BR - affermando che
al momento della sua cattura, era appena arrivato da Praga. Dopo soli 6 mesi
(marzo 1975) a conferma di quanto detto, gli appunti dei servizi segreti
italiani rivelano che Franceschini soggiornò in Cecoslovacchia dal giugno '73 al
giugno '74 frequentando il campo di addestramento di Karlovy Vary. A distanza di
30 anni arriva l'inattesa quanto impensata smentita. Un articolo, scritto
sull'"Espresso" del 27 maggio 2005, risolve tutti gli equivoci e spegne
l'incendio fin qui alimentato. Nell'ottobre del '99 il SISMI - l'apparato dei
servizi segreti italiani - ha chiesto ai servizi segreti dell'ex unione
sovietica tutta la documentazione riguardante i possibili appoggi della StB alle
BR. Da questi documenti è venuto fuori che Franceschini e Curcio - capo storico
delle BR - sono veramente stati a Praga, ma non si trattava dei fondatori delle
BR. Uno è l'avvocato Renato Curcio, nato a Catanzaro l'1/3/1931, presente in
Cecoslovacchia il 7 ed 8 agosto 1972. L'altro è un commerciante di Foiano
(Arezzo), Sergio Franceschini nato nel 1917, presente a Karlovy Vary agli inizi
degli anni '70. Grazie a Nicola Biondo, consulente della Commissione Mitrokhin
che per primo ha letto e studiato i documenti provenienti dall'Unione Sovietica,
un primo gran mistero è stato svelato e soprattutto, ritornando alle
dichiarazioni di Galloni sulla presunta collaborazione BR-USA, possiamo
analizzare da un diverso punto di vista l'intero "Affaire Moro". Il rapporto USA
- Moro è sempre stato in primo piano fin da quel drammatico 16 marzo del 1978.
Aldo Moro era stato più volte minacciato di morte nel caso in cui non avrebbe
abbandonato immediatamente la carriera politica. Di fronte alla Commissione
Parlamentare d'inchiesta, Eleonora Moro - moglie dello statista ucciso -
ricordando il viaggio negli USA che il marito fece nel 1974 come ministro degli
Esteri insieme al Presidente della Repubblica Leone, dice: "È una delle
pochissime volte in cui mio marito mi ha riferito con precisione che cosa gli
avevano detto, senza svelarmi il nome della persona... adesso provo a ripeterla
come la ricordo: "Onorevole, lei deve smettere di perseguire il suo piano
politico per portare tutte le forze del suo Paese a collaborare direttamente.
Qui, o lei smette di fare questa cosa, o lei la pagherà cara. Veda lei come la
vuole intendere". "Secondo alcuni collaboratori dell'onorevole Moro "il
presidente fu molto scosso dall'incontro avuto con il segretario di Stato, Henry
Kissinger, tanto è vero che il giorno dopo nella Chiesa di S. Patrick si sentì
male e disse di voler interrompere per molto tempo l'attività politica". Il
segretario di Stato USA, Kissinger, era molto ostile a Moro tanto che arrivò ad
affermare che non credendo nei dogmi, non potesse credere nella sua impostazione
politica e per questo lo riteneva un elemento "fortemente negativo".
Sulle minacce che il presidente della DC subì prima del sequestro, è importante
ricordare che tanti avvenimenti fecero presagire ad un triste epilogo. In
principio fu il caso della macchina blindata che doveva essere pronta per il
dicembre del 1977 e che invece non arrivò mai. Andreotti che Cossiga hanno
sempre smentito che Moro fece richiesta di un'auto blindata. Il maresciallo
Leonardi, responsabile della scorta, fece raddoppiare la dotazione abituale di
proiettili della sua pistola e quella degli agenti di scorta. Altri eventi,
fecero capire che nell'entourage di Moro c'era uno stato d'animo preoccupato.
Solo negli ultimi anni è giunta la notizia che il 15 marzo 1978 - il giorno
prima della strage - il capo della Polizia ha visitato Moro nel suo ufficio,
tranquillizzandolo sull'eventualità d'attentati nei suoi confronti. A Moro fu
assicurato che i servizi segreti avevano la situazione sotto controllo e che non
correva nessun pericolo immediato. "Ironia della sorte", il giorno dopo Moro fu
rapito. Nella prima metà degli anni '50 la CIA chiese la collaborazione del
SIFAR, il Servizio Informazioni Forze Armate. A capo dei servizi segreti
italiani nel 1962 era Giovanni De Lorenzo che sottoscrisse un patto con la CIA:
"deve [De Lorenzo] impegnarsi a rispettare gli obiettivi di un piano
permanente d'offensiva anti-comunista chiamato in codice << Demagnetize >>. Il
piano consiste in una serie di operazioni politiche, paramilitari e
psicologiche, atte a ridurre la presenza, la forza, le risorse materiali e non
ultimo l'influenza nel governo del Partito comunista in Italia.Del piano
Demagnetize il governo italiano NON deve essere a conoscenza essendo evidente
che esso può interferire con la loro rispettiva sovranità nazionale". Al
primo arruolamento di Gladio partecipò un colonnello del SIFAR, Renzo Rocca che
"per i primi sei mesi del '63, su preciso mandato del generale della CIA
Walters, s'impegnò nella campagna volta a impedire la formazione del primo
centro sinistro organico preseduto da Moro". Il 27 giugno 1968, Rocca fu
trovato morto in un ufficio al sesto piano di un palazzo di via Barberini 86 a
Roma. Rocca aveva il compito di commerciare armi con i paesi Africani e
soprattutto, doveva instaurare rapporti con i servizi segreti israeliani e
palestinesi. Altro "007" che ebbe il compito di allacciare rapporti con i
palestinesi fu il colonnello Stefano Giovannone. Un comunicato Ansa del 10
maggio 2002 dice: "Il colonnello, nel 1984, nell'inchiesta a Venezia su un
traffico d'armi BR-Olp, avrebbe parlato di un proprio interessamento presso i
palestinesi, e in particolare, presso il leader Arafat, per cercare aiuti per
ottenere la liberazione di Aldo Moro, dopo il suo sequestro. I contatti tra i
palestinesi e le BR.sarebbero avvenuti, ma non ebbero esito positivo perché
Arafat fece una dichiarazione pubblica, proprio contro le BR". Il nome di
Giovandone lo fece anche Aldo Moro durante i giorni di prigionia, indicandolo
come "personalità in grado di intervenire" per cercare di ottenere la sua
liberazione. Lo stesso Mario Moretti, capo delle BR, prese contatti con la
guerriglia palestinese che arrivò a fornirgli delle armi. Tutto ciò avvenne un
anno prima del sequestro Moro. Da queste testimonianze, ci rendiamo conto che
CIA, SISMI, MOSSAD, OLP e BR erano in contatto tra loro e che almeno tre di loro
erano legati da un'alleanza forte e ben radicata. Probabilmente sarà proprio
quest'alleanza a decidere le sorti del presidente della DC. Nella vicenda Moro
sono implicate tutte le più importanti istituzioni militari, a porre l'accento
ancora una volta sul fatto che il 9 Maggio 1978 - giorno del ritrovamento del
cadavere di Moro - ha rappresentato la fine di una "guerra civile" e l'inizio di
un costante declino di un partito che è stato alla guida del paese dal primo
giorno della Repubblica. Politici, industriali, operai, studenti, casalinghe;
tutto il Paese è stato, per cinquantacinque giorni, coinvolto in un drammatico
evento che ha scosso l'immaginario collettivo, facendo venire meno quei punti di
riferimento che la società si era data: Stato, Nazione, Chiesa. La certezza che
Moro non si sarebbe salvato era molto alta, al punto di giungere ad affermare
che Moro non è morto il 9 maggio 1978 ucciso dai colpi della pistola di Mario
Moretti; Aldo Moro "è morto" il 22 aprile, quando il Santo Padre Paolo VI,
decise di rivolgersi alle BR: "Ed in questo nome supremo di Cristo, che io mi
rivolgo a voi che certamente non lo ignorate, a voi, ignoti e implacabili
avversari di questo uomo degno e innocente; e vi prego in ginocchio, liberate
l'onorevole Aldo Moro, semplicemente, senza condizioni." La lettera che
Paolo VI scrisse agli "uomini delle Brigate Rosse" fu pubblicata
sull'Osservatore Romano e, stando alle testimonianze dei brigatisti, segnò
fortemente l'animo del Presidente. Anna Laura Braghetti - l'unica donna del
gruppo brigatista che ha vissuto nella stessa casa dove lo statista fu tenuto
prigioniero - racconta che "fu il papa a far precipitare ulteriormente la
situazione. Moro gli aveva scritto tempo prima, supplicandolo di intervenire. Ma
il papa non lo ascoltò.per Moro segnò il momento peggiore di quei 55 giorni, Fra
tutte le cattive notizie che Mario [Moretti] gli portò, nessuna lo scosse come
il documento del Papa. Capi che il cerchio si era saldato nel punto esatto in
cui lui aveva confidato - e calcolato - che si spezzasse." Il messaggio era
solo l'ultimo dei tanti appelli umanitari che le BR ricevettero durante i giorni
di prigionia. Questa lettera però conteneva qualcosa di diverso; il Papa si era
già rivolto ai sequestratori e non aveva mai chiuso la porta del dialogo. Quel
giorno però, l'appello di Paolo VI, mise la parola "fine" alle trattative. Fu la
presenza di due parole, "Senza Condizioni", che fece cadere nel vuoto le
ultime speranze di liberazione. Su queste "quindici lettere" si potrebbero
scrivere volumi interi; C'è chi in questa frase indica la presenza dei Servizi
Segreti di mezzo mondo, chi invece è certo che fu aggiunta a posteriori sotto
suggerimento di Giulio Andreotti, capo di quella DC, che aveva sul piatto della
bilancia la legge sull'Aborto tanto cara alla Chiesa. Come giusto che sia è
stupido, e poco professionale, cercare di seguire l'una o l'altra tesi. Sono i
documenti che "parlano" e in questo caso sono tutti a favore della chiarezza del
Pontefice. Da nessuna parte, su nessun foglio, in nessun interrogatorio, ci sono
prove che confermano quanto ipotizzato; l'unica cosa certa è che Moro era un
fedele credente e praticante assiduo. Ogni domenica, infatti, seguiva la Santa
Messa nella chiesa di Santa Chiara tanto che i Brigatisti pensarono di
sequestrarlo proprio durane la funzione religiosa, salvo poi rinunciare per le
troppe difficoltà "militari". Per Moro la religione veniva subito dopo la
famiglia, a cui tanto era legato e di cui tanto andava fiero.
Alla famiglia è rivolta
l'ultima drammatica lettera che Moro scrisse prima di morire.
"Mia dolcissima Noretta
[Eleonora Moro], dopo un momento di esilissimo ottimismo, siamo ormai, credo, al
momento conclusivo. Vorrei restasse ben chiara la piena responsabilità della
DC.Uniti nel mio ricordo vivete insieme. Mi parrà di essere tra voi, bacia e
carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. Sii
forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Vorrei capire
con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce
sarebbe bellissimo. Tutto è inutile, quando non si vuole aprire la porta. Il
Papa ha fatto pochino: forse ne avrà scrupolo."
Dopo aver attribuito le
responsabilità della sua mancata liberazione alla DC, si rivolge alla famiglia
in un tono affettuoso, ma allo stesso tempo autoritario di chi fondamentalmente
è ancora "il capo di famiglia". Moro infine - e solo alla fine - si rivolge a
quella Chiesa o meglio a quel Papa, che "ha fatto pochino" per salvarlo e
per riportarlo tra le braccia dei propri cari. Il mistero è proprio qui. Moro
sostenne che "tutto è inutile, quando non si vuole aprire la porta" ma
perché? Era forse a conoscenza che la Chiesa ebbe qualche possibilità di
salvarlo? Effettivamente la Santa Sede aveva pronto un "piano" per liberare lo
statista attraverso il pagamento di un riscatto. Già durante i 55 giorni di
prigionia si era a conoscenza dell'intenzione della Chiesa di aprire una
trattativa con le BR; Andreotti ricorda: " Il Papa aveva fatto prendere delle
iniziative, vi era stata la disponibilità a pagare anche una cifra molto forte,
se fosse stato questo il mezzo per poter salvare Moro, avevano cercato in tutti
i modi di avere contatti". A distanza di quasi 27 anni lo stesso Andreotti
conferma quella voce, in un intervento al Senato del 9 Marzo 2005: "E però è
vero che con pieno consenso, anzi con nostro grato animo, fu fatto a nome del
Santo Padre Paolo VI un tentativo di riscatto. Purtroppo il loro tramite si
dimostrò inefficace o addirittura millantatore." A confermare ufficialmente
le intenzioni della Santa Sede è mons. Fabio Fabbri, stretto collaboratore di
mons. Cesare Curioni - ispettore centrale dei cappellani carcerari italiani -
all'epoca del sequestro. La dichiarazione fatta a Vladimiro Satta - giornalista
del periodico "Nuova Storia Contemporanea" - indica in dieci miliardi di lire la
somma che il Vaticano era pronto a pagare per la liberazione d'Aldo Moro; una
cifra elevatissima per il tempo e soprattutto per la causa. Liberare Moro
sarebbe stato un colpo durissimo per la DC e soprattutto per la Santa Sede:
"Moro vivo sarebbe molto più pericoloso di un Moro morto" è il pensiero che
circolava, durante i cinquantacinque giorni di prigionia, nelle menti degli
uomini politici più importanti per il paese. Moro libero poteva essere una mina
vagante nella politica italiana, andando contro quei "compagni di partito" che
avevano dimostrato d'essere tutto, tranne che amici. Era chi aveva rivelato alle
BR le linee guida della politica democristiana e quindi, forse, aveva "detto"
cose che era meglio non sapere. Proprio per questo il SISMI si era preparato un
piano denominato "Victor", da mettere in atto nel caso in cui Moro fosse stato
liberato. Il progetto era quello di trasferire Moro in un centro clinico,
immediatamente e prima d'ogni incontro con familiari e colleghi di partito.
L'azione era assegnata al reparto medico degli incursori di Marina, sede
principale di Gladio. Sia per la DC sia per la Chiesa quindi, la liberazione di
Moro doveva essere evitata assolutamente. Le trattative tra Chiesa e BR
fallirono proprio la mattina del ritrovamento del cadavere di Moro. Molti
storici indicano nel "contatto", un personaggio noto alla cronaca per un altro
tragico evento di quei 55 giorni: il falso comunicato n°7, quello del Lago della
Duchessa. L'autore di quel comunicato fu un falsario legato alla "Banda della
Magliana" (gruppo criminale romano) ed ai Servizi Segreti Americani: un certo
Tony Ciccarelli. Era lui, secondo le testimonianze, il tramite tra la Chiesa e
le BR. Ancora una volta entrano in scena i Servizi Segreti e questa volta però
lasciano indelebilmente le tracce del loro passaggio.
Il 16 marzo 1978 alle ore 9.00
i Servizi Segreti Italiani erano presenti in Via Fani.
Il colonnello del SISMI
Camillo Gugliemi, specializzato in "addestramento a scopo di imboscata" delle
unità di combattimento "stay behind" alla base Nato in Sardegna, quella mattina
era in Via Stresa a soli 200 metri dall'incrocio con via Fani. Guglielmi la
mattina del 16 marzo avrebbe ricevuto una telefonata dal generale Musameci (P2):
"Corri a via Fani a vedere cosa sta succedendo. Un informatore mi ha detto
che le BR vogliono rapire Moro". Il militare non ha mai smentito la sua
presenza in Via Fani, giustificandola però in un modo un po' "particolare". Egli
dichiarò che "doveva andare a pranzo da un amico". In tutte le famiglie
"normali" di solito, l'ora di pranzo è intorno alle 13.00 - 13.30 e non alle
nove di mattina quando invece si è appena finiti di fare colazione. Mettendo da
parte l'ironia, è strano che ci si presenti così di buon'ora a casa di un amico
solo per pranzare. Questo stesso amico ha confermato che quella mattina
Guglielmi aveva bussato alla porta della sua casa, ma ha sempre riferito che non
era mai stato programmato un pranzo insieme. Fatto più inquietante è però che a
poco più di 200 metri da un colonnello del SISMI furono sparati più di 90
proiettili, ci fu un tamponamento e fu rapito un grande esponente della politica
italiana. Come mai un agente dei Servizi Segreti non ha avuto nemmeno l'idea di
intervenire per vedere semplicemente quello che stava accadendo? Guglielmi ha
sempre nascosto la sua presenza sul luogo della strage fino al 1991, quando un
ex agente del SISMI, Pierluigi Ravasio, lo confidò all'Onorevole Cipriani.
Ravasio disse anche che nelle BR era infiltrato uno "007". La spia era uno
studente di giurisprudenza dell'università di Roma il cui nome di copertura era
"Franco". Egli avvertì con mezz'ora d'anticipo che Aldo Moro quella mattina
sarebbe stato rapito. Se mezz'ora non bastò per evitare la strage, il 16
febbraio 1978 - un mese prima dell'attentato - dal carcere di Matera, Salvatore
Senatore disse: "è possibile che Moro sia rapito a breve". Altro
preavviso giunse quindici giorni prima del sequestro. Renzo Rossellini,
animatore di radio Città Futura, informò i dirigenti del PSI che Moro sarebbe
stato rapito. Bettino Craxi, però, lo convocò solo a sequestro compiuto. Lo
stesso Rossellini alle otto del mattino - un'ora prima del sequestro - in una
trasmissione radiofonica, aprì con la notizia dell'avvenuto sequestro d'Aldo
Moro. Le notizie, secondo il generale Santovito (P2), giunsero al SISMI centrale
solamente dopo il 16 marzo. Purtroppo la registrazione della trasmissione
radiofonica, così come le famose foto scattate da Gherardo Nucci pochi minuti
dopo l'attentato, è scomparsa nel nulla. Nessuna prova, però, è più schiacciante
di quella fornita da Antonino Arconte, nome in codice G.71. Arconte faceva parte
di una struttura militare riservatissima: la "Gladio delle centurie" che operava
fuori la nazione Italia al fine di evitare possibili colpi di Stato. Gladio fu
istituito negli anni '50 con lo scopo di controllare e neutralizzare la capacità
offensiva dei comunisti in caso di guerra civile. Naturalmente da quel momento
si è evoluta e specializzata diventando un organo militare fondamentale per i
Servizi Segreti italiani. "Il gran segreto" intorno al quale ruotavano gli
interrogatori delle BR a Moro era proprio Gladio. L'argomento principale era la
struttura di guerriglia e controguerriglia usata dal corpo speciale dei servizi
segreti. Questa "seconda faccia" di Gladio doveva assolutamente restare segreto
perché coinvolgeva i rapporti con gli USA e in particolare perché infrangeva le
leggi della legislazione italiana. La legge 801/77, all'articolo 10, sancisce: "Nessuna
attività, comunque idonea per l'informazione e la sicurezza, può essere svolta
al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini
previsti dalla presente legge". La legge di riforma dei servizi segreti 801
del '77 impone, per quanto riguarda gli agenti dei servizi segreti, di svolgere
solo operazioni di "intelligence" e non operazioni armate. Il compito degli 007
italiani era solo quello di raccogliere informazioni e non di attuare operazioni
militari. Gladio invece era coinvolta in molte operazioni militari all'estero ed
anche in Italia tanto che il Ministro Formica dichiarò che "nell'Italia
Repubblicana si è costituito un esercito assolutamente incompatibile con il
nostro ordinamento; uno stato democratico può certamente avere dei piani
segreti.ma non può avere assolutamente una milizia clandestina.". Gladio
agiva in modo clandestino e quindi andava contro la legge. Ecco perché
rappresentò il "gran segreto" con il quale le BR volevano minacciare lo Stato.
Ad un certo punto del sequestro, infatti, ci si rese conto che le trattative non
erano volte alla liberazione di Moro bensì alla consegna dei documenti raccolti
dai terroristi; ma questo è un argomento che tratteremo più avanti. Ritornando
ad Arconte, "il gladiatore" attraverso un sito internet prima, ed un libro poi,
parlò di una sua missione in Medio Oriente che ebbe sviluppi importanti nel
sequestro Moro". Partii dal porto della Spezia il 6 marzo 1978, a bordo del
mercantile Jumbo Emme. Sulla carta era una missione molto semplice: avrei dovuto
ricevere da un nostro uomo a Beirut dei passaporti che avrei poi dovuto
consegnare ad Alessandria d'Egitto. Dovevo poi aiutare alcune persone a fuggire
dal Libano in fiamme, nascondendole a bordo della nave. Ma c'era un livello più
delicato e più segreto in quella missione. Dovevo infatti consegnare un plico a
un nostro uomo a Beirut. In quella busta c'era l'ordine di contattare i
terroristi islamici per aprire un canale con le BR, con l'obiettivo di favorire
la liberazione di Aldo Moro". Il plico che contiene l'ordine di aprire un
canale per la liberazione di Moro è autenticato dal notaio Pietro Ingozzi
d'Oristano ed è firmato del Capitano di Vascello della Marina della X Divisione
"Stay Behind". Il documento è datato 2 marzo 1978 e fu consegnato a Beirut il 13
marzo dello stesso anno. Moro sarà rapito il 16 di marzo, due settimane dopo la
data d'emissione e ben diciotto giorni prima della "cartolina di mobilitazione"
che giunse ad Arconte il 26 febbraio 1978. Arconte però non è l'unico testimone
del viaggio. Un secondo "gladiatore" lo accompagnò in missione: Pierfrancesco
Cangedda, nome in codice "Franz". Egli fu inviato tempo prima in Cecoslovacchia
per raccogliere informazioni sull'addestramento delle BR; un tema di grande
interesse per la Commissione Mitrokhin. "Franz" è a conoscenza dei legami tra il
terrorismo tedesco dell'occidente e le BR. Cosa centra il terrorismo tedesco?
Forse non tutti sanno che l'operazione di Via Fani è stata la perfetta copia
dell'operazione della Baader-Meinhof - organizzazione terroristica nata nella
Repubblica Federale Tedesca nel 1971 - del 5 settembre 1977, quando fu rapito
l'industriale Hans Schleyer. La Procura di Roma tramite i NOS ha interrogato i
due "gladiatori" nel novembre 2000, solo che, ad oggi, non si conoscono gli
esiti. In tutta questa vicenda, l'unica certezza è che nei Servizi Segreti si
sapeva con largo anticipo che Moro sarebbe stato sequestrato. Falco Accame, è
stato presidente della Commissione difesa della Camera dal 1976; egli ha
apertamente dichiarato che "nell'agguato di Via Fani Guglielmi incarnava la
presenza di Gladio col compito di verificare che tutto andasse bene ". Falsa
che sia questa ipotesi, Gladio era presente in Via Fani "sottoforma di
proiettile"; è poco nota la vicenda che i bossoli rinvenuti sul luogo della
strage - 92 sparati e ben 46 da una sola arma, una "mitraglietta Scorpion" di
fabbricazione cecoslovacca - presentavano una particolare vernice che si usa
normalmente contro la ruggine. Questa speciale vernice rende quasi certa la
provenienza delle armi, poiché è la stessa usata da Gladio per preservare i
proiettili nei depositi sotterranei. Perché pur sapendo in anticipo delle
intenzioni dei brigatisti, non si è fatto niente di concreto per la liberazione
di un uomo, prima che di un politico.
Caso Moro, i palestinesi avvertirono l'Italia.
E il bar di via Fani aggiunge un mistero, scrive Alberto Custodero l'11 Dicembre
2015 su "La
Repubblica".
Fioroni: "Trovate tante bugie e omissioni". Grassi: "Venti bierre
in via Fani, non dodici". La relazione dopo un anno di indagini della
Commissione bicamerale sul rapimento dello statista democristiano. È giallo su
una donna e un tedesco a bordo di una moto nel luogo della strage. Nelle carte
la testimonianza di Raffaele Cutolo sui rapporti 'ndrangheta-Br. Olp, Raf
tedesca, servizi segreti, informatori, infiltrati, traffico d'armi, banda della
Magliana, killer sconosciuti, armi sparite, fiancheggiatori mai identificati. E
poi verità monche, memoriali smentiti, inchieste incompiute, testimoni
inattendibili. A trentasette anni dal sequestro di Aldo Moro e dal massacro
della sua scorta, intrighi e misteri come un muro di nebbia nascondono ancora
parte della verità sulla morte dello statista democristiano. Hanno fatto tutto
da sole le Brigate Rosse, o c'è stato lo zampino di qualche intelligence (non
necessariamente italiana) dietro il rapimento del presidente Dc che, proprio il
16 marzo del 1978, giorno della strage di via Fani, stava per dare vita al primo
compromesso storico (un governo che nascesse con l'appoggio del Pci) della
storia della Repubblica? Per tentare di squarciare il velo di omertà sul
rapimento Moro, un anno fa è stata istituita una Commissione bicamerale
d'inchiesta presieduta da Giuseppe Fioroni (Pd). In passato ce n'è stata
un'altra dedicata al sequestro e alla morte del politico scudocrociato, ma il
caso Moro è stato indagato a fondo anche dalla Commissione Stragi e da quella
sulla P2. Oggi, a un anno dalla sua istituzione, è stato presentato un primo,
provvisorio bilancio dell'indagine parlamentare. La relazione è stata approvata
all'unanimità. "Il Paese e la memoria di Aldo Moro - ha dichiarato Fioroni -
meritano verità. Ma fino ad ora, e con un solo anno di lavoro, abbiamo trovato
tante bugie e omissioni. Molte le novità, riscriveremo in parte i 55 giorni".
Ecco in sintesi le novità più rilevanti. Gli argomenti oggetto di indagine. La
Commissione ha affidato perizie sulle armi, sui bossoli e sulle auto. In parte
sono tutt’ora in corso esami del contenuto di audiocassette a suo tempo
sequestrate in alcuni covi delle Brigate Rosse, l’identificazione di persone che
compaiono ritratte in fotografie scattate in via Fani e nelle aree adiacenti il
16 marzo 1978, la comparazione di alcuni profili vocali, lo svolgimento di esami
grafologici, nonché l’estrazione di profili genetici (dna) da reperti rinvenuti
nel covo di via Gradoli, nella Fiat 128 con targa diplomatica usata per
l’agguato in via Fani (dentro c'erano anche 39 mozziconi di sigaretta, ndr)
e nella Renault 4 nella quale venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, come pure
dagli abiti da lui indossati. Sono state ascoltate 50 persone informate su
diverse circostanze di interesse: alcune di loro – pur avendo rilasciato
all’epoca dei fatti dichiarazioni a organi di informazione – non erano mai state
sentite finora dall’autorità giudiziaria o in sede parlamentare. Sono stati,
infine, affidati allo Scico della Guardia di finanza alcuni accertamenti
relativi a società immobiliari, finanziarie e commerciali che, a vario titolo,
sono state oggetto di attenzione nel corso delle indagini sulla strage di via
Fani e sul covo di via Gradoli. I palestinesi avvertirono, eccezionale
documento. La Commissione ha acquisito un documento definito "di notevole
interesse", datato 18 febbraio 1978 e proveniente da Beirut. E' un 'dispaccio'
della 'Fonte 2000': "Vicedirettore informato ALT. Mio abituale interlocutore
rappresentante 'FPLP' Habbash incontrato stamattina habet vivamente
consigliatomi non allontanarmi Beirut, in considerazione eventualità dovermi
urgentemente contattare per informazioni riguardanti operazione terroristica di
notevole portata programmata asseritamente da terroristi europei che potrebbe
coinvolgere nostro Paese se dovesse essere definito progetto congiunto discusso
giorni scorsi in Europa da rappresentanti organizzazioni estremiste ALT. At mie
reiterate insistenze per avere maggiori dettagli interlocutore habet
assicuratomi che 'FPLP' opererà in attuazione confermati impegni miranti
escludere nostro Paese da piani terroristici genere, soggiungendo che mi fornirà
soltanto se necessario elementi per eventuale adozione adeguate misure da parte
nostra autorità. ALT. Fine. Da non diramare ai servizi collegati OLP Roma". È
evidente che, se fosse effettivamente dimostrata una relazione con il sequestro
di Aldo Moro, il documento in questione aprirebbe prospettive di interpretazione
del tutto nuove e, allo stato, imprevedibili". Venti bierre in via Fani, non
dodici. "La ricostruzione dei fatti di via Fani è diversa, anche nei numeri, da
quella che ci è stata sempre raccontata: almeno 20 persone, con ruoli attivi e
omissivi, hanno agito quel 16 marzo del 1978 e non tutte erano delle Br". E non
dodici, come finora accertato dall'autorità giudiziaria". Lo ha detto Gero
Grassi, deputato Pd ed esponente della Commissione. Bossoli, smentito appunto
Questura. "È certo che nessuno dei bossoli rinvenuti in via Fani provenisse da
un deposito dell’Italia settentrionale le cui chiavi sono in possesso di sole
sei persone", come al contrario si affermava nell’appunto 'segretissimo' della
Questura di Roma del 27 settembre 1978. Contatti Br-famiglia Moro. Fioroni:
"Voglio ricordare l’importanza, forse sottovalutata, di monsignor Antonio
Mennini che aveva un rapporto di conoscenza con Moro, pur non essendo il suo
confessore, contrariamente a quanto è stato sempre divulgato, e che in tre
occasioni fu incaricato dalle Brigate Rosse di recarsi a prendere, in diversi
punti della città, lettere di Aldo Moro e di recapitarle alla signora Eleonora
Moro. Nella prima occasione (20 aprile), tra le persone presenti nella piazza
dove si era recato c'era anche Valerio Morucci. Da alcune parole di Mennini si
può argomentare con fondata certezza l’esistenza di un "canale di ritorno" nelle
comunicazioni tra i brigatisti e l’esterno, sicuramente con la signora Eleonora
Moro, mai ammessa dagli stessi protagonisti". Radio città futura, "ascolto
riservato in Questura". "In merito poi alla nota vicenda dell’annuncio – sia
pure in forma dubitativa (“forse rapiscono Moro”) – che l'emittente radiofonica Radio
Città Futura e il suo direttore Renzo Rossellini avrebbero dato il 16 marzo
1978 dell’imminente sequestro di Aldo Moro, con circa tre quarti d’ora di
anticipo rispetto al verificarsi dell’evento (notizia che la magistratura
apprese solo il 27 settembre 1978, quando essa divenne di dominio pubblico,
visto che la Polizia mantenne un prolungato silenzio) la Commissione ha
ricercato elementi che potessero confermare l’effettivo annuncio del rapimento
da parte di Radio Città Futura, tenendo conto di quanto già emerso nel corso
degli accurati approfondimenti condotti dalla Commissione parlamentare di
inchiesta istituita nella VIII legislatura. Tra gli elementi di novità acquisiti
agli atti della Commissione, grazie alle complesse verifiche delegate agli
Uffici della Direzione centrale della polizia di prevenzione e tuttora oggetto
di ulteriori approfondimenti e riscontri, va annoverata l’esistenza di
un’ulteriore struttura informale di ascolto delle trasmissioni di Radio Città
Futura e Radio Onda Rossa: anche presso gli uffici della DIGOS romana, in
attuazione di un indirizzo operativo voluto dallo stesso questore De Francesco,
all’epoca dei fatti veniva espletato un servizio dedicato all’ascolto delle
suindicate emittenti. Un tedesco e una donna sulla moto in via Fani. "Sono state
raccolte testimonianze in base alle quali si può supporre la presenza in via
Fani di due motociclette: occorre indagare in merito alla questione aperta e
cruciale relativa al ruolo svolto dai loro passeggeri, in tutto quattro. Una
sentenza definitiva ha assunto che gli ignoti a bordo della moto Honda di cui
parlò subito l'ingegner Alessandro Marini si siano resi responsabili di tentato
omicidio ai suoi danni. Si può supporre, sulla base agli elementi raccolti fino
ad ora, che una moto era presente nella parte superiore di via Fani, prendendo
la fuga verso via Stresa, ed un’altra indugiò sul luogo dell’agguato. La
Commissione ha ascoltato due testimoni oculari, da quanto risulta mai ascoltati
in precedenza. Si tratta di Giovanni De Chiara, che abitava in via Fani 106 e
che vede allontanarsi a sinistra, su via Stresa, una motocicletta con a bordo
due persone, delle quali una aveva sparato verso qualcuno, e di Eleonora
Guglielmo, allora 'ragazza alla pari' presso l’abitazione di De Chiara, la quale
riferisce di voci che dicevano "achtung, achtung", e di una motocicletta
di grossa cilindrata che partì, seguendo un’auto sulla quale era stato spinto un
uomo all’interno, dirigendosi da via Fani in direzione opposta verso via Stresa.
La motocicletta aveva a bordo due persone; il passeggero aveva capelli di colore
scuro, con una pettinatura a chignon e un boccolo che scendeva e pertanto
la signora Guglielmo ritiene che fosse una donna". Cutolo e 'ndrangheta. "Cutolo
– ascoltato in carcere da alcuni collaboratori della Commissione – ha riferito
di aver appreso durante la sua detenzione da un boss della ‘ndrangheta di
contatti intercorsi, con riferimento al sequestro Moro, tra le Brigate Rosse e
ambienti ‘ndranghetisti in relazione al reperimento di armi. La
Commissione ha accertato che nel carcere in cui all’epoca si trovava Cutolo vi
era un solo detenuto appartenente alla malavita organizzata calabrese, il cui
nome era compatibile con quello riferito dalla stesso Cutolo". Non è certo una
novità il dibattito su presunti rapporti tra 'ndrangheta e bierre: nel 1993 si è
svolto il processo Moro quater che ha avuto come oggetto proprio la presenza o
meno del 'ndranghetista Antonio Nirta tra rapitori di Moro. Il suo nome fu fatto
dal pentito Saverio Morabito al pm Alberto Nobili. Bar Olivetti e Banda della
Magliana. "Si tratta di un filone di indagine dal quale ci aspettiamo proficui
sviluppi, mentre di notevole interesse sono le novità relative al bar Olivetti,
situato in prossimità del luogo dell’agguato. Infatti, alcuni testimoni hanno
riferito che il bar non era affatto chiuso in quelle settimane, come invece
hanno riferito tutte le indagini nel corso di questi 37 anni e di conseguenza la
sterminata pubblicistica esistente. Alcuni testi dichiarano di aver preso il
caffè o di aver usato il telefono proprio nella mattina del 16 o di essere
clienti abituali. La possibilità che il bar fosse aperto al pubblico dopo la
strage, nonostante la situazione giuridica formale fosse di attività in
liquidazione, pone seri interrogativi sulla dinamica dell'agguato, per come è
stata sempre ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni degli stessi
brigatisti, i quali hanno asserito di aver atteso l'arrivo delle auto al
servizio di Aldo Moro nascosti dietro le fioriere prospicienti il bar. Questa
ricostruzione – non del tutto convincente, tenuto conto che le fioriere potevano
offrire un riparo poco efficace a più persone destinate a stazionare in attesa
per un lasso di tempo non trascurabile – deve essere quanto meno riconsiderata
alla luce dei nuovi elementi acquisiti dalla Commissione. Il mistero del bar e
di Tullio Olivetti. Il titolare del bar, Tullio Olivetti, era un personaggio
molto noto agli ambienti investigativi per essere stato coinvolto in una
complessa vicenda relativa a un traffico internazionale di armi, ma sempre
uscito 'pulito' da tutte le indagini, contrariamente ai suoi presunti complici,
tanto da far ipotizzare, scrivono i commissari, "che la sua posizione
sembrerebbe essere stata 'preservata' dagli inquirenti e che egli possa avere
agito per conto di apparati istituzionali ovvero avere prestato collaborazione".
Il nome di Olivetti, tra l'altro, figura negli elenchi predisposti dalla
Questura di Bologna delle persone presenti in città nei giorni antecedenti la
strage alla stazione del 2 agosto 1980. L'indagine che riguardava Olivetti
iniziò formalmente il 29 gennaio 1977, con un rapporto a firma del tenente
colonnello Antonio Cornacchia, ed aveva al centro le attività di un certo Luigi
Guardigli, amministratore della società RA.CO.IN che si occupava, tra l’altro,
di compravendita di armi per Paesi stranieri. "Tullio Olivetti - si legge nella
relazione della nuova commissione - venne subito indicato da Guardigli come
trafficante d’armi e di valuta falsa (aveva riciclato 8 milioni di marchi
tedeschi, provento di un sequestro avvenuto in Germania) che vantava alte
aderenze politiche, era in contatto con ambienti della criminalità organizzata;
in una circostanza, nella villa di una persona presentatagli proprio da Tullio
Olivetti, Guardigli aveva trovato ad attenderlo il mafioso Frank Coppola
(indicato come persona che intervenne per dissuadere alcuni elementi della
criminalità organizzata - in precedenza sollecitati da uomini politici ad
attivarsi – dal fornire notizie utili a localizzare il luogo dove era tenuto
prigioniero Aldo Moro) che gli aveva chiesto di dare seguito ad una richiesta di
armi fattagli da tale Vinicio Avegnano, in stretti rapporti con ambienti
neofascisti e con quelli, non meglio precisati, dei Servizi, anch’egli indicato
come amico di Olivetti". Ma le indagini su Olivetti non vanno avanti perché la
credibilità del suo accusatore viene distrutta da una perizia psichiatrica
eseguita dal professor Aldo Semerari. Nella sua consulenza, infatti, Semerari
definì Guardigli "una personalità mitomane, con una condizione psicopatica di
vecchia data, e, allo stato, permanente. I suoi atti e le sue dichiarazioni sono
espressioni sintomatologiche di tale anomalia". "Il complesso di queste
circostanze - scrivono i commissari - , anche in considerazione dei rapporti tra
Olivetti e Avegnano, impone ulteriori accertamenti sull’ipotesi che il primo
fosse un appartenente o un collaboratore di ancora non meglio definiti ambienti
istituzionali; sarebbe, infatti, circostanza di assoluto rilievo verificare
un’eventuale relazione tra i Servizi di sicurezza o forze dell’ordine e Tullio
Olivetti, titolare del bar di via Fani, 109. Il criminologo Aldo Semerari –
figura al centro di quella definitiva più volte Agenzia del crimine, cioè un
crocevia di ambienti della banda della Magliana, della destra eversiva, della P2
e di organismi di intelligence – venne assassinato nel 1982 e il suo
cadavere decapitato fu ritrovato il 1° aprile dello stesso anno a Ottaviano, in
un’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione del camorrista Vincenzo Casillo,
braccio destro di Raffaele Cutolo". Nel bar la figlia di Gronchi. Tra le altre
cose, Olivetti aveva amministrato il bar dapprima in proprio, come impresa
individuale, poi insieme ad altre persone, come Olivetti s.p.a., con un
consiglio di amministrazione composto da Gianni Cigna (in qualità di
presidente), dallo stesso Tullio Olivetti (in qualità di consigliere) e da Maria
Cecilia Gronchi (in qualità di consigliere), moglie di Cigna e figlia dell’ex
presidente della Repubblica. Un'altra area di indagine: informatori e
infiltrati. Nel corso di numerose audizioni, la Commissione ha infatti avuto
modo di constatare che le Brigate Rosse sono state oggetto di un attento e
prolungato monitoraggio da parte degli apparati di sicurezza. Lo confermano la
lettera scritta da Duccio Berio nel 1972 al suocero Alberto Malagugini, nella
quale si riferiscono i contatti intercorsi con un sedicente appartenente al SID
che gli propose di infiltrarsi nelle BR; la vicenda di frate Girotto e l’arresto
di Curcio e Franceschini; le circostanze riferite in audizione dall’ex giudice
Pietro Calogero, che dimostrano che almeno fino al 1974 i servizi di intelligence dell’epoca
potevano contare su “resoconti periodici di informatori infiltrati” nelle
Brigate Rosse e in altre formazioni dell’estremismo di sinistra. Pur se è
ragionevole ritenere che, dopo la cattura dei vertici delle BR grazie a Silvano
Girotto nel 1974, i brigatisti abbiano rafforzato le cautele per evitare
ulteriori infiltrazioni, non può non sorprendere che il flusso informativo sopra
menzionato si sia inaridito proprio nella fase antecedente al del sequestro di
Aldo Moro. Datazione dell’ingresso nelle Br di Giovanni Senzani. La Commissione
continua a svolgere accertamenti su numerose circostanze di rilievo. Da
verificare il ruolo di Senzani, estraneo alle sentenze giudiziarie del caso Moro
e a detta dall’allora Procuratore di Firenze Tindari Baglione, oggi deceduto,
sicuramente consulente del Ministero e delle bierre, e il ruolo da lui ricoperto
durante il periodo del sequestro. Il superclan e l'istituto Hyperion. Da
verificare l’esatta ricostruzione delle complesse vicende connesse alla
fuoriuscita degli appartenenti al cosiddetto Superclan e all’attività
dell’istituto Hypérion di Parigi sul quale la Commissione ha cominciato a
lavorare grazie alle sollecitazioni dei componenti del Movimento 5 Stelle. La
pista tedesca. Da verificare il coinvolgimento della Raf nel caso Moro, oggetto
d’accertamento fin dalle prime indagini e sulla quale la Commissione insisterà
perché appare rilevante la circostanza che nel covo di via Gradoli siano state
trovati due moduli di carte d'identità appartenenti al medesimo stock, rubato
del 1972, del modulo utilizzato per la carta d'identità falsificata che risultò
nella disponibilità di Elisabeth von Dyck, appartenente alla Raf e che, inoltre,
la targa del pullmino visto a Viterbo il 21 marzo 1978 sia stata rinvenuta in
Germania, danneggiata e senza alcun veicolo, pochi giorni dopo l'uccisione di
Aldo Moro, e che Ehehalt, cui era intestata la targa, si sia rifiutato di
rispondere a domande sulla stessa e sul veicolo.
IL MISTERO MORO.
Sono stati - e sono destinati a restare - i 55 giorni più misteriosi dell’intera
storia dell’Italia repubblicana.
Ancora oggi soltanto rievocare
il caso Moro vuol dire preparasi ad entrare in un ramificato tunnel di segreti e
interrogativi, di domande senza risposta e di inconfessabili trame.
Il tempo che corre non solo ci
allontana dalla completa verità sulla strage di via Fani, la lunga detenzione di
un uomo politico di primo piano e la sua orrenda fine, ma rende tutto più
complesso.
Il trascorrere degli anni che
sempre più ci fa apparire lontano quel tragico evento, anziché semplificare il
quadro di insieme della vicenda, tende ad aggiungere nuovi tasselli ad un
mosaico che appare ormai infinito. Aldo Moro, presidente della DC, per almeno
vent’anni personaggio centrale della politica italiana, viene sequestrato da un
commando delle Brigate Rosse il 16 marzo 1978, in via Fani a Roma, alla vigilia
del voto parlamentare che – per la prima volta dal 1947 - sancisce l’ingresso
del partito comunista nella maggioranza di governo.
Per rapirlo la sua scorta,
composta da cinque uomini, viene sterminata. Il gruppo armato che s’impadronisce
di Moro afferma di volerlo processare, per processare tutta la Democrazia
Cristiana, forse addirittura non rendendosi conto di aver gettato sulla scena
politica nazionale una bomba Cristiana, forse addirittura non rendendosi conto
di aver gettato sulla scena politica nazionale una bomba ad alto potenziale. I
55 giorni in cui Moro sarà detenuto in un "carcere del popolo" apriranno infatti
una serie di enormi contraddizioni in seno all’intera classe politica italiana,
mentre i brigatisti finiranno col dimostrarsi – con i loro documenti miopi e
vetusti - completamente avulsi dalla realtà storica del paese.
La fine di Moro è nota: il 9
maggio 1978 Mario Moretti, capo dell’organizzazione armata, lo ucciderà,
"eseguendo la sentenza", così come scritto nell’ultimo comunicato delle BR. Quel
colpo di pistola, con tanto di silenziatore, risulta assordante ancora oggi.
Cinque diversi procedimenti
giudiziari con più di una decina di sentenze, una sesta inchiesta avviata (" Il
Moro sesties"); i particolareggiati racconti dei brigatisti rossi ("pentiti" o
dissociati); il lungo lavoro di una commissione parlamentare d’inchiesta (la
commissione Moro); l’impegno di un altro organismo parlamentare (la commissione
stragi); almeno una ventina di libri. Eppure l’ombra di Aldo Moro continua a
muoversi nelle segrete stanze del potere con il suo fardello di misteri, di
punti non chiariti, di dubbi ed interrogativi.
Anche se il tempo passa e ci
allontana sempre più da quei tremendi 55 giorni, il caso Moro continua a
rappresentare il nodo dei nodi dei misteri d’Italia.
Sommersi dallo stillicidio di
notizie – spesso contraddittorie – che da quasi un quarto di secolo ci vengono
propinate con ossessiva regolarità, è sempre più facile giungere ad una
conclusione: nell’affaire Moro la volontà di attacco allo Stato di un
manipolo di terroristi si è perfettamente intrecciata con la capacità di quello
stesso Stato di gestire l’intera, tragica vicenda a proprio vantaggio.
A distanza di tanti anni
ancora non sappiamo: quanti brigatisti parteciparono all’assalto di via Fani; se
tra loro ci fossero elementi esterni; se quell’attacco fu, in qualche modo,
teleguidato; dove Moro fu custodito; cosa effettivamente il prigioniero raccontò
ai suoi secondini; chi decise effettivamente di ucciderlo e, soprattutto,
perché; che fine hanno fatto "le rivelazioni integrali" (il famoso
memoriale Moro).
Non sappiamo neppure se quella
delle forze dell’ordine chiamate a liberare il prigioniero fu solo clamorosa
inefficienza oppure occulta connivenza con i sequestratori. Sappiamo però che
sia gli uomini dei servizi segreti, sia quelli della P2 nel caso Moro ebbero un
ruolo per certi versi determinante.
L’eco suscitato dalle
clamorose dichiarazioni rilasciate dall’On. Giovanni Galloni, Vice Segretario
Vicario della DC ai tempi del rapimento di Aldo Moro, aprono squarci nuovi su
cosa accadde in quella primavera del 1978.
Dice Galloni: "Moro mi
disse che sapeva per certo che i servizi segreti sia americani sia israeliani
avevano degli infiltrati all'interno delle Brigate Rosse. Però non erano stati
avvertiti di questo".
Altre inquietanti
testimonianze intervengono a a dissipare la nebbia disinformativa.
La testimonianza di
Francesco Fonti raccolta da Riccardo Bocca.
Il pentito della 'ndrangheta
Francesco Fonti rivela come, dietro richiesta di parte della Democrazia
cristiana, cercò la prigione di Aldo Moro durante il suo rapimento: dai contatti
con il Sismi a quelli con la banda della Magliana e Cosa Nostra. Fino
all'incontro con il segretario Dc Benigno Zaccagnini.
Si chiama Francesco Fonti,
e il suo nome rimbalza tra giornali e televisioni. Grazie al dossier che ha
consegnato alla Direzione nazionale antimafia, pubblicato da
"L'espresso"
nel 2005, i
magistrati della Procura di Paola e la regione Calabria hanno individuato il 12
settembre 2009, al largo della costa cosentina, il relitto di un mercantile
carico di bidoni: il primo passo verso una verità che riguarda il traffico
internazionale di scorie tossiche e radioattive. Un intreccio tra politica,
servizi segreti e malavita organizzata."Soltanto un aspetto, per quanto grave,
della mia attività", lo definisce Fonti (condannato a 50 anni di carcere, prima
di iniziare la collaborazione con i giudici). E sempre Fonti decide di rivelare
all’Espresso un altro capitolo della sua vita criminale:
il ruolo che
avrebbe avuto nel tentativo di salvare la vita al presidente della Democrazia
cristiana, Aldo Moro,
rapito il 16 marzo 1978 dalle Brigate Rosse e trovato morto nel centro di Roma
il 9 maggio seguente. Un compito, dice, affidatogli dal boss Sebastiano Romeo,
dietro richiesta di una parte della Dc. Ecco il drammatico racconto, in prima
persona, di quelle tre settimane, pubblicato da “L’espresso” del 22 settembre
2009.
"Il mattino del 20 marzo 1978
si presenta nel mio appartamento a Bovalino, sulla costa jonica in provincia di
Reggio Calabria, Giuseppe Romeo, fratello del boss Sebastiano che in quel
momento è al vertice della famiglia di San Luca: "Sebastiano ti vuole incontrare
immediatamente", dice Giuseppe. E sono parole che non prevedono repliche.
Sebastiano non è soltanto il mio capo, ma anche uno degli uomini più potenti
della 'ndrangheta. Dunque non discuto e obbedisco, ritrovandomi poco dopo seduto
al tavolo ovale del suo salone. Sono preoccupato, non so cosa aspettarmi, ma lui
non perde tempo: "Ciccio, hai visto questa brutta storia di Aldo Moro?", dice.
"Ecco, dobbiamo intervenire. Devi salire di corsa a Roma. Devi individuare,
tramite i nostri paesani e i contatti che hai con questi cazzi di servizi
segreti, dove si nascondono i brigatisti che hanno rapito il presidente".
Non mi lascia aprire bocca,
Sebastiano. È innervosito dall'allarme nazionale procurato dal caso Moro, un
clamore che sta disturbando gli affari della nostra organizzazione. "Ho ricevuto
pressioni a due livelli", spiega: "Mi hanno chiamato Riccardo Misasi e Vito
Napoli (figure di spicco della Democrazia cristiana calabrese), ma anche certi
personaggi da Roma...". Non precisa chi sono, queste persone. Ribadisce, invece,
che la missione è di importanza straordinaria, e non avrebbe accettato un mio
fallimento.
Con questa premessa parto per
la Capitale il giorno dopo. Salgo sulla mia Renault 5 Alpine grigia metallizzata
e scarico i bagagli all'hotel Palace di via Nazionale, dove ho già soggiornato e
dove consegno documenti falsi intestati a un inesistente Michele Sità. Poi mi
metto in contatto con un agente del Sismi che si fa chiamare Pino: un trentenne
atletico, alto circa un metro e ottanta, con capelli corti pettinati
all'indietro. L'ho conosciuto anni prima tramite Guido Giannettini, il quale ha
cercato di blandirmi per ottenere informazioni sulla gerarchia interna della
'ndrangheta. Visto il solido rapporto tra me e Pino, gli chiedo cosa sappiano i
servizi del caso Moro, e se abbiano scoperto dove si trovano i carcerieri delle
Br. Lui risponde vago, dicendo che è una storiaccia, e che neppure lui è
riuscito a capire come stiano le cose. In compenso, mi invita a parlare con il
segretario della Democrazia cristiana Benigno Zaccagnini, il quale sta lavorando
sotto traccia per aiutare Moro. Un'ipotesi diventata, poche ore dopo, un vero
appuntamento.
Al termine di una giornata
convulsa (durante un ultimo controllo alla Fiat 130 su cui viaggiava Moro, è
stata trovata una terza borsa non elencata nel verbale della prima
perquisizione) rivedo infatti l'agente Pino, che nel frattempo ha parlato con
Zaccagnini. E mi dice di presentarmi il giorno dopo, alle 10 della mattina, al
Café De Paris di via Veneto. Specificando: "In mano devi tenere la "Gazzetta del
sud"", di cui mi consegna una copia. "In questo modo, il segretario ti
riconoscerà facilmente".
Il mattino del 22
marzo,
mentre al Viminale si riunisce il Comitato tecnico operativo gestito dal
ministro dell'Interno Francesco Cossiga, arrivo puntuale all'appuntamento. Mi
siedo a un tavolino nel dehors del Cafè de Paris, e aspetto circa dieci minuti.
Dopodiché arriva il segretario Zaccagnini: dà un'occhiata attorno, mi individua
e si accomoda di fronte a me. Forse, penso, ha qualche indicazione chiave da
riferirmi. Ma non è così: "È un brutto momento per la coscienza di tutto il
mondo politico", inizia senza neppure avermi detto buongiorno. Si vede che è
imbarazzato, e irritato, per essere costretto a incontrare uno come me. "Mi
creda", prosegue, "non avrei mai immaginato un giorno di sedermi davanti a lei
in qualità di petulante. Non sono mai sceso a compromessi, ma se sono venuto a
incontrarla, significa che il sistema sta cambiando. Faccia in modo che quella
di oggi non sia stata una perdita di tempo, ma piuttosto una svolta decisiva. Ci
dia una mano e la Dc, di cui mi faccio garante, saprà sdebitarsi". Poi sorseggia
un sorso d'acqua, si alza per andarsene e aggiunge: "Noi non ci siamo mai
incontrati... Se ci saranno notizie che vorrà darmi di persona, le dirà
all'agente Pino".
La mia risposta, visto
l'atteggiamento scostante del segretario, è gelida. Mi limito a comunicargli che
mi sono attivato per recuperare le informazioni utili. E aggiungo: "Sicuramente
le nostre ricerche saranno fruttuose, e le saranno comunicate da me in prima
persona". Parole che pronuncio con convinzione. Non posso sapere che questa sarà
la prima e unica volta che incontrerò Benigno Zaccagnini, e tantomeno che nelle
settimane seguenti succederanno fatti anche per me sorprendenti.
A partire dall'incontro con un
malavitoso capitolino, noto con il soprannome di "Cinese" per i baffetti alla
mongola. Non so quale sia il suo vero nome, ma è certamente inserito nella
celebre banda della Magliana. Me lo spiega il referente romano di Cosa nostra,
Pippo Calò, il quale garantisce che può essermi utile: "Quelli sanno tutto?",
dice. E aggiunge che, in quelle stesse ore, anche Cosa Nostra sta lavorando per
i politici romani all'individuazione dei carcerieri di Aldo Moro. "So bene che
le promesse dei politici non vengono mantenute", mi dice, "ma dobbiamo aiutarli
per cercare di ottenere l'annullamento degli ergastoli inflitti ai nostri
uomini". Da parte mia, ho forti perplessità a trattare con la malavita romana,
perché in Calabria si dice che con i romani si può mangiare e bere, ma non fare
affari. Parlano troppo. Si vantano e cacciano tutti nei guai. Così, quando
incontro il Cinese tramite Bruna P., una donna con la quale ho una relazione, e
che ha un negozio di biancheria intima dove ricicla soldi della Magliana, sono
molto prudente. Ci vediamo il
25 marzo,
giorno in cui le Br diffondono il loro secondo comunicato, in una birreria di
via Merulana, a poche decine di metri da piazza San Giovanni. E il mio
interlocutore non tarda a fare lo sbruffone: "Lo sanno tutti dove sono nascosti
Mario Moretti e tutti gli altri!", ride. Impugna un boccale di birra da un
litro, e nonostante la delicatezza del tema parla a voce alta nel locale
affollatissimo: "I rapitori di Moro si trovano in un appartamento in via
Gradoli, dalle parti della Cassia", dice. Non mi indica il numero esatto, ma in
ogni caso non ha dubbi: "Se lo volessero trovare, Moro, non ci vorrebbe niente.
Però chi lo vo' trovà, a quello?", conclude con un'altra risata.
Inutile dire che rimango
perplesso: da una parte mi fa divertire, come si comporta il Cinese, dall'altra
temo di buttare il mio tempo. Com'è possibile, mi domando, che tutta la malavita
di Roma sia al corrente di dove si trova il covo delle Brigate rosse? Ci
vogliono ben altre conferme, penso, prima di contattare Zaccagnini; e anche per
questo decido di parlare con Angelo Laurendi, un 'ndranghetista di Sant'Eufemia
D'Aspromonte che conosco da tempo e che spero possa darmi notizie interessanti.
Una speranza, purtroppo, infondata, ma questo non significa che la nostra
chiacchierata sia inutile. Angelo, infatti, mi accompagna sulla sua Lancia Appia
nel comune di Ciampino, e per la precisione in un negozio di mobili il cui
proprietario è Morabito di Reggio Calabria, un 'ndranghetista di cui non conosco
il nome di battesimo. È comunque in quel momento un uomo tarchiato, sulla
quarantina abbondante, con la barba scura e una piccola cicatrice sullo zigomo.
Mi accoglie cordiale e rispettoso in ufficio, e quando domando se gli risulta di
un appartamento delle Brigate rosse in via Gradoli, annuisce: "Voi potete stare
sicuro che qualcosa c'è, in via Gradoli", dice. "Mi hanno detto che i brigatisti
gestiscono un appartamento, lì, e probabilmente c'entra con Moro".
A questo punto, capisco che
l'indicazione datami in prima battuta dalla banda della Magliana non è così
improbabile. Perciò ricontatto l'agente Pino, gli faccio credere di non sapere
ancora nulla, e insisto per ottenere nuovamente aiuto. Una richiesta che non può
rifiutare, visto il nostro legame, tant'è che dopo avere premesso che sono in
atto vari depistaggi, mi suggerisce di parlare con l'appuntato dei carabinieri
Damiano Balestra, addetto all'ambasciata di Beirut sotto il comando del
colonnello del Sismi Stefano Giovannone, il quale gli ha raccomandato di salvare
a tutti i costi il presidente Moro (non a caso, in una sua lettera durante la
prigionia, Moro invoca proprio l'intervento di Giovannone). "Balestra ha ottime
fonti", dice l'agente Pino. E non sta esagerando. Ne ho la riprova quando ci
vediamo tutti e tre (io, Pino e Balestra) negli ultimissimi giorni di marzo,
davanti a un bar nel quartiere romano dell'Alberone, dalle parti di via
Tuscolana. È pomeriggio, e parliamo a bordo della Lancia di Pino. Il discorso
dell'appuntato Balestra è chiarissimo: "Io sto dando l'anima", dice, "per
arrivare alla liberazione del presidente, ma continuo a sbattere contro un muro.
Ogni informazione che ricevo è vera e falsa allo stesso tempo. Non distinguo più
tra chi mi vuole aiutare e chi cerca di farmi girare a vuoto. In più c'è la
guerra politica, con i socialisti che vogliono vivo Moro, e gran parte della Dc
che finge di volerlo liberare". Poi sussurra: "In questo covo di cui si
vocifera, in via Gradoli 96, non abita nessuno. O almeno, così dice chi ha
verificato (un primo sopralluogo in via Gradoli 96 è avvenuto il 18 marzo: sono
stati perquisiti tutti gli appartamenti tranne quello affittato dalle Br, dove
l'inquilino non ha risposto al campanello e gli agenti se ne sono andati)". In
ogni caso, insiste Balestra, ha la certezza che in quella casa bazzichino i
brigatisti, anche se non sono stati fermati.
È qui che capisco quanto la
mia trasferta romana rischi di essere inutile. Il dramma di Moro campeggia sulle
prime pagine dei giornali, i partiti si mostrano formalmente costernati, ma
dietro le quinte si consuma qualcosa di inconfessabile. Chi si batte veramente,
con tutte le forze, per individuare i covi delle Br, non viene appoggiato. Anche
se è una persona seria come il democristiano siciliano di corrente fanfaniana
Benito Cazora (scomparso nel 1999); un parlamentare che cerca di incontrare
chiunque possa svelargli dove si nascondano i brigatisti e dove sia segregato
Moro. Tra gli altri, il deputato parla con un certo Salvatore Varone,
'ndranghetista che noi chiamavamo Turi, ma che si presenta a Cazora come Rocco,
incontrandolo in varie occasioni delle quali non conosco i particolari.
Posso invece riferire, per
quel che mi riguarda, che contatto l'onorevole Cazora tramite Morabito di
Ciampino, il quale dice che questo parlamentare "sta impazzendo per avere
informazioni sul presidente Moro". Fisso quindi un incontro con lui a Roma, nel
ristorante Rupe Calpurnia, dove noi 'ndranghetisti abbiamo festeggiato il
compleanno dell'affiliato Rocco Sergi. Il nostro dialogo è breve e teso, e si
svolge in presenza degli 'ndranghetisti Morabito e Laurendi. Cazora è
angosciato, in effetti. Mi spiega che ha già parlato con un altro calabrese,
Rocco, e che è perplesso perché ha fatto lo spaccone: "Sostiene", mi dice
Cazora, "che può recuperare informazioni visto che i calabresi a Roma sono 400
mila, e perciò possono controllare il territorio'. Io, dentro di me, penso che
sono strane frasi, per uno come Varone che nella 'ndrangheta conta come il due
di picche. In ogni caso, non faccio commenti perché non so chi frequenti Varone.
Mi limito a informare il deputato che mi sto muovendo, dietro un mandato
politico, per trovare il covo dei brigatisti, anche se non ho notizie certe. Al
che lui risponde: "Mi auguro sinceramente che abbiate più fortuna di me, grazie
alle vostre amicizie". Intanto i giorni passano, e la situazione si fa sempre
più drammatica. Il 29 marzo le Brigate rosse recapitano il terzo comunicato, con
allegata una lettera di Aldo Moro per il ministro dell'Interno Cossiga. Il 4
aprile tocca a un quarto comunicato, trovato con l'angosciante missiva in cui
Moro si rivolge a Zaccagnini (sulla trattativa per la liberazione, il presidente
scrive: "Tener duro può apparire più appropriato, ma una qualche concessione è
non solo equa, ma anche politicamente utile. Come ho ricordato in questo modo
civile si comportano moltissimi Stati. Se altri non ha il coraggio di farlo, lo
faccia la Dc che, nella sua sensibilità ha il pregio di indovinare come muoversi
nelle situazioni più difficili. Se così non sarà, l'avrete voluto e, lo dico
senza animosità, le inevitabili conseguenze ricadranno sul partito e sulle
persone"). È evidente, dopo simili parole, che il dramma del sequestro rischia
di incanalarsi verso la peggiore conclusione, e io stesso temo di fallire la
missione. Ma mentre il clima si invelenisce, e le speranze di salvare Moro
diminuiscono, mi ricontatta l'agente Pino per farmi sapere che Giuseppe
Sansovito, numero uno (piduista) del Sismi, ha espresso il desiderio di
parlarmi. E così accade. Di lì a poco, Pino mi porta dal capo a Forte Braschi, e
dopo un dialogo interlocutorio Santovito mi chiede se ho notizie precise
riguardo a un appartamento in via Gradoli 96. Gli rispondo che, in effetti, ho
sentito questo indirizzo da amici, e lui commenta: "Tutto vero, Fonti: è giunto
il momento di liberare il presidente Moro". In ogni caso, aggiunge congedandomi,
"teniamoci in contatto tramite Pino".
La mattina dopo, quella di
domenica 9 aprile (o di lunedì 10, non vorrei sbagliarmi), lascio la Capitale e
mi precipito a San Luca da Sebastiano Romeo. Sono soddisfatto perché non
soltanto so dove probabilmente sono nascosti i brigatisti, ma c'è anche il
preannuncio datomi dal colonnello Santovito della futura liberazione del
presidente Moro. Quando però incontro Sebastiano, lui ascolta con attenzione il
mio resoconto per una mezz'ora, dopodiché mi stronca: "Sei stato bravo",
riconosce. "Peccato che da Roma i politici abbiano cambiato idea: dicono che, a
questo punto, dobbiamo soltanto farci i cazzi nostri". Una frase assurda,
imprevedibile, che lì per lì incasso in silenzio, ma che di fatto vanifica il
mio lavoro nella Capitale. Sono stanchissimo, amareggiato. Ho indagato come si
deve, a Roma, e adesso dovrei fottermene come se ne fotte l'intera classe
politica. Ci provo con tutto il cuore, ma non ci riesco: sono un 'ndranghestista
di primo livello con tanto di sgarro (indispensabile per accedere al massimo
livello dell'organizzazione), ma sono anche una persona che sa dire di no, a
volte: e questa è una di quelle volte. Dopo l'incontro con Romeo, dunque, torno
a Bovalino e telefono alla Questura di Roma, presentandomi al centralinista come
Rocco. "Andate a Roma, in via Gradoli al numero 96", scandisco, "e troverete i
carcerieri di Aldo Moro". "Da dove sta chiamando?", domanda il centralinista
allarmato. "Chi parla? Chi è lei?", insiste. Ovviamente non rispondo; abbasso la
cornetta e provo a non pensarci più.
Una promessa impossibile da
mantenere. Poco dopo, il 18 aprile 1978, il covo di via Gradoli 96 viene
scoperto per una strana perdita d'acqua. Dei brigatisti, come logico viste le
premesse, non c'è traccia. E a questo punto so bene il perché: non c'è stata la
volontà di agire. C'è invece, molti anni dopo, nel 1990, il mio incontro nel
carcere di Opera (provincia di Milano) con il capo delle Br Mario Moretti, colui
che ha ammesso di avere ucciso il presidente Moro, assieme al quale frequento
casualmente un corso di informatica. I nostri rapporti si fanno presto cordiali,
piacevoli; lui sa esattamente chi sono e mi rispetta. Io pure. Finché un giorno,
mentre armeggiamo al computer, una guardia gli consegna una busta e annuncia:
"Moretti, c'è la solita lettera". Lui la apre senza nascondersi, estrae un
assegno circolare, lo firma sul retro per girarlo all'ufficio conti correnti che
permette l'incasso, e mi dice: "Questa, Ciccio, è la busta paga che arriva
puntualmente dal ministero dell'Interno". Frase che all'istante scambio per una
battuta, per uno scherzo tra carcerati: sbagliando. Qualche tempo dopo, un
brigadiere che credo si chiami Lombardo mi confida che, per recapitare soldi a
Moretti, lo hanno fatto risultare come un insegnante di informatica, e in quanto
tale è stato retribuito. L'ennesimo mistero tra i misteri del caso Moro, dico a
me stesso; l'ennesima zona grigia in questa storia tragica.
“Doveva morire”. Chi ha
ucciso Aldo Moro. Il giudice dell'inchiesta racconta.
Libro di Ferdinando Imposimato
e Sandro Provvisionato.
Il caso Moro è una tragedia
per la quale non tutti hanno pagato le loro colpe. Perché il suo sacrificio e
quello dei cinque uomini della scorta non sia vano, scrivono gli autori,
occorrono ulteriori indagini e l'istituzione di una commissione d'inchiesta
internazionale, formata da giuristi indipendenti. Dopo decenni, nonostante il
tempo abbia portato a naturale declino molti dei motivi ispiratori di quella
triste stagione, resta a noi la sensazione di un cammino incompiuto della
democrazia nel nostro Paese. Un Paese che non sa fare i conti con il proprio
passato cammina a rilento, circondato da troppe ombre e da troppi fantasmi.
«Vede, a coloro che lo hanno
fatto uccidere non posso stringere la mano….perchè uno può dire li perdono e io
nel profondo li ho perdonati. Ma quando li vedo, attraverso la strada e vado
dall'altra parte». Nella breve intervista posta a conclusione del
libro-inchiesta scritto dal giudice Ferdinando Imposimato e dal giornalista
Sandro Provvisionato, Eleonora, moglie di Aldo Moro, lo statista democristiano
sequestrato e assassinato dalle Br, non pronuncia mai i nomi dei "quattro
stupidi mascalzoni" le cui "perverse mire" hanno causato la morte di un
innocente. Ma quei nomi ricorrono nelle oltre 350 pagine di minuziosa
ricostruzione di uno dei grandi misteri mai compiutamente risolti della storia
italiana del dopoguerra. I nomi non sono solo "di quei poveretti" che gli hanno
sparato, ma anche e soprattutto dei dirigenti DC, Andreotti e Cossiga in testa,
che nulla fecero, meglio tutto misero in atto per impedire l'apertura di un
canale di trattative per liberare l'amico di Partito, simbolo non solo del
gruppo dirigente democristiano, ma responsabile dell'apertura al Pci, del
tentativo di cancellare " il fattore K " ovvero l'esclusione pregiudiziale dei
comunisti da qualsiasi ipotesi di governo o di maggioranza.
" Doveva morire ". A partire
dal titolo, il libro di Imposimato e Provvisionato indica con nettezza una tesi.
Aldo Moro è stato volutamente abbandonato al suo destino dal gruppo dirigente DC
e non per la superiore " ragion di stato ", ovvero la volontà di non cedere al
ricatto terrorista. La sua morte dopo il sequestro, a giudizio degli autori, non
aveva alternative "per stabilizzare la situazione interna e salvare milioni di
italiani dal comunismo". Non solo: l'allora ministro degli Esteri conosceva
troppi segreti, dall'organizzazione paramilitare Gladio allo scandalo Lockheed,
dai finanziamenti occulti della Dc all'affare Montedison fino ai veri burattinai
di quel processo di destabilizzazione che tenne sotto scacco per troppo tempo il
nostro Paese, passato sotto il nome di strategia della tensione.
Libro di parte, dunque.
Imposimato è uno dei magistrati incaricati dell'indagine poi arenatasi per
l'incomprensibile decisione di avocare l'inchiesta alla procura generale,
togliendo ogni capacità investigativa ai giudici istruttori. E' lui "la voce
narrante" dell'inchiesta, cucita dalle abili mani di un cronista di razza,
Sandro Provvisionato, responsabile degli speciali del Tg 5 e con alle spalle una
lunga carriera e dodici anni trascorsi all'Ansa, da praticante fino a capo della
redazione politica. La tesi non è perciò frutto di un generico anatema, ma la
puntigliosa ricostruzione dei cinquantacinque giorni del sequestro e dei fatti
che precedettero e seguirono il tragico evento. Un'inchiesta densa di fatti,
documenti, testimonianze che fanno da supporto all'ipotesi istruttoria. Il filo
da dipanare si presenta con tale groviglio che non tutti i nodi si sciolgono al
termine della disamina. Ci sono parti, soprattutto relative al coinvolgimento di
servizi segreti di altri paesi o ai legami del terrorismo internazionale, che si
fermano sulla soglia di ipotesi, sia pure plausibili. Sono invece le pagine
dedicate alla ricostruzione del sequestro che si presentano con un impianto di
indiscutibile robustezza.
Una particolare citazione
merita il capitolo delle occasioni mancate, ovvero delle opportunità di giungere
alla prigione dove era tenuto Aldo Moro o all'arresto di carcerieri e complici.
Il 18 marzo 1978, solo due giorni dopo la strage di via Fani, i poliziotti
bussano alla porta di via Gradoli, dove vivono il capo delle BR Mario Moretti e
la sua compagna Barbara Balzerani, due dei brigatisti che componevano il
commando di via Fani. Gli agenti non ottengono risposta e se ne vanno. La base
brigatista verrà scoperta trentadue giorni dopo il rapimento. La prigione di via
Montalcini viene ufficialmente trovata solo nel 1980. Ma l'Ucigos, struttura di
servizi alle dirette dipendenze del ministro degli interni, c'era arrivata due
anni prima raccogliendo significative testimonianze degli inquilini rimaste
senza esito. Infine l'incredibile vicenda dell'appartamento di Via Monte Nevoso
8 a Milano, forse la ricostruzione più completa e ricca di documentazione tra le
molte proposte di questi anni sul caso. Nello stabile i carabinieri fanno
irruzione il primo ottobre 1978, a ridosso della nomina del generale Dalla
Chiesa a capo dei reparti speciali antiterrorismo. Nel blitz vengono catturati i
brigatisti Nadia Mantovani, Lauro Azzolini e Franco Bonisoli, ma soprattutto
viene trovato il memoriale Moro. Tutto? No, perché a dispetto di cinque giorni
di attento scandaglio, ai militari stranamente sfugge una parte dei manoscritti,
celata dietro un pannello in cartongesso che verrà rimosso dodici anni dopo dai
nuovi inquilini. Dietro quel fragile paravento verranno fatte trovare le carte
più scottanti del memoriale, le risposte dello statista DC alle domande scritte
di Moretti. Guarda caso, quelle domande riguardano proprio i misteri prima
ricordati, da Gladio in poi, che rendevano crudelmente improponibile il ritorno
alla libertà di Aldo Moro.
Il duro j'accuse contro i
dirigenti DC alla guida del governo in quei giorni drammatici, Andreotti e
Cossiga in testa, è condotto con rigore documentale. «Nella storia del delitto
Moro la prudenza è d'obbligo- scrive Imposimato nelle conclusioni- Occorre
evitare di passare da una verità di comodo a una scarsamente dimostrata. Ma
occorre anche evitare l'errore opposto: pretendere prove matematiche e assolute,
granitiche per dimostrare un fatto. La verità non è facile da scoprire, ma non è
possibile chiudere gli occhi di fronte a una storia che ha nei documenti
occultati e fortunosamente ritrovati il suo fondamento indiscutibile.
Con l trascorrere
degli anni e l'acquisizione di nuove prove – afferma Imposimato – e soprattutto
dopo il lavoro di redazione di questo libro mi appare chiara una cosa: il
sequestro Moro, partito come azione brigatista alla quale non è estranea
l'appoggio della Raf e l'interessamento, per motivi opposti, di Cia e Kgb, è
stato gestito direttamente dal Comitato di crisi costituito presso il Viminale.
Il delitto Moro non ha avuto una sola causa. Ma ha rappresentato il punto di
convergenza di interessi disparati. In questa operazione perfettamente riuscita,
sono intervenuti la
massoneria internazionale,
agenti della Cia (Ferracuti,
criminologo che tracciò il profilo del Moro non più Moro dentro il covo delle
Br), del Kgb (l'agente
Sokolov
presentatosi a Moro come studente borsista), la
mafia
(Pippo Calò che si interessò con i suoi contatti con la Banda della Magliana per
scoprire il covo) ed esponenti del
governo
(Cossiga ministro dell'interno ed Andreotti presidente del Consiglio), gli
stessi inseriti nel comitato di crisi. Tutti questi dopo il 16 marzo 1978, hanno
vanificato le opportunità emerse per salvare la vita di Moro,
spingendo di
fatto le Br ad ucciderlo».
ALDO MORO E GIULIO ANDREOTTI.
Il paradiso può attendere,
aveva detto a metà ottobre citando il famoso “Heaven can wait” di Warren
Beatty e Buck Henry, scrive Paolo Guzzanti su “Panorama”. Ma stavolta il cielo
si è stancato di aspettare e non ha concesso proroghe. E così, dopo Francesco
Cossiga che a confronto è morto giovane, il grande Giulio, il divo Giulio,
l’uomo più sospettato e più esaltato della politica italiana, l’enigmatico,
l’astuto, quello di cui Craxi diceva “tutte le volpi finiscono in pellicceria”,
ha sgombrato il campo della storia viva, per andare ad abitar d’ora in più nella
storia stampata, filmata, certificata, ma non più viva. Non c’è niente di peggio
quando muore un personaggio importante, di un cronista che comincia con
l’avvertire che “io lo conoscevo bene”. Ma il fatto è che io lo conoscevo
veramente bene e lui mi conosceva altrettanto bene e non ci piacevamo
moltissimo. L’ultima grande performance Andreotti l’ha infatti prodotta sul
piccolo proscenio della Commissione parlamentare d’inchiesta Mitrokhin di cui
sono stato per quattro anni il presidente e lui, Giulio, per quattro anni un
commissario assiduo, puntiglioso, provocatorio, divertente, odioso, sempre dalla
parte della Russia sovietica e dunque anche in quell’occasione beniamino dei
comunisti che nella commissione Mitrokhin si proponevano il compito di
ostacolare in ogni modo e impedire ridicolizzando, che si arrivasse a trovare la
verità sugli agenti sovietici in Italia, intendendosi per agenti non le spie, ma
proprio coloro che agivano come agenti di influenza. Andreotti era lì, pronto
alla rievocazione, pronto alla battuta, pronto a sabotare con armi sottilissime
tutto il lavoro costruttivo che facevamo. L’ex ministro degli esteri di Gheddafi
mi disse a Tripoli durante una pausa dei nostri lavori durante l’incontro con la
Commissione Esteri: “Se c’è un uomo che noi in Italia abbiamo sempre adorato,
veramente adorato oltre che rispettato, è il vostro Giulio Andreotti, che dio lo
protegga e lo benedica”. Pensavo si riferisse soltanto al notissimo e in
qualche caso sfacciato atteggiamento filo arabo del senatore a vita, ma non si
trattava soltanto di questo: “Lui era qui con noi quella sera in cui a Mosca
annunciarono la fine dell’Unione Sovietica e ammainarono la bandiera rossa dal
Cremlino. Noi piangevamo, eravamo commossi e anche disperati. Andreotti era
terreo, traumatizzato. Poi disse: da adesso il mondo sarà molto diverso e non
sarà certamente migliore perché sarà un mondo americano”. Questa sua
affermazione fa un po’ il paio con quella dei tempi in cui, caduto il muro di
Berlino, si prospettava la riunificazione tedesca, disse: “Io amo talmente i
tedeschi che di Germanie ne vorrei sempre almeno due”. Il suo credo politico
era quello del debito pubblico senza troppi freni e navigare a vista, usando
buon senso e una certa sfacciataggine unita a cinismo. Se fu riconosciuto
colpevole di aver intrattenuto rapporti di reciproco rispetto e qualcosa di più
con la mafia almeno per un certo periodo, ciò ha senso: Andreotti rispettava i
poteri costituiti e la mafia era un antico marchio di fabbrica di potere
costituito. E poi, come disse in un’altra circostanza “è sempre meglio tirare a
campare che tirare le cuoia”. Ricordo personale: la madre di mia madre e la
madre di Giulio, Rosa Andreotti, erano molto amiche perché avevano entrambe
avuto i loro figli al Collegio degli Orfani in via degli Orfani. La loro
amicizia si estese ai figli: mia madre, mio zio e lui, Giulio, anche perché
vivevano tutti nella stessa magnifica strada, via Parione nel quartiere Parione
di Roma, alle spalle di piazza Navona. Mia nonna mi raccontava che Rosa
Andreotti parlando del figlio bambino diceva: “Questo figlio non è normale,
non somiglia agli altri bambini. Ha qualcosa dentro di sé che non capisco, che
nessuno capisce. O sarà disperato o diventerà qualcuno”. Mia madre mi
raccontava che il piccolo Giulio evitava tutti i giochi che impegnavano il
fisico, come correre, e aveva sempre un taccuino in tasca per fare il
giornalista. Così un paio di volte l’anno capitava a casa nostra per un caffè e
io diffidavo moltissimo di questa presenza e speravo che se ne andasse presto
perché ero un tipico adolescente di sinistra e Andreotti sembrava già allora il
devoto Satana che poi è stato dipinto. Se uno scorre le foto della sua vita vede
che è stato un uomo attentissimo alla vita cinematografica, amico stretto di
Federico Fellini il quale lo considerava una parte essenziale del paesaggio
italiano, ma anche in senso positivo. Frequentava le attrici, gli attori, i set
cinematografici, aveva i capelli nerissimi imbrillantinati e pettinati
all’indietro come Rodolfo Valentino e benché avesse la gobba, aveva anche un suo
charme, un certo sex appeal. Era un uomo di destra all’inizio della carriera (il
politico più longevo, con più incarichi di governo, una eterna carriera
parlamentare) e veniva dalla nidiata di Alcide de Gasperi che lo volle
giovanissimo sottosegretario nel pieno della guerra fredda, con un’Italia che
sapeva di polvere e macerie e che era tutta da ricostruire, ma che già godeva,
si industriava, costruiva e attraversava il boom economico, la magica crescita
che proiettò il Paese dalla preistoria della guerra al XX secolo dell’industria,
dell’arte, del reddito, della Seicento Fiat e delle autostrade, della commedia
all’italiana, del cinema leggero e un po’ ignorante, e Andreotti era sempre
ovunque. Poi lui chiuse personalmente la sua guerra fredda e diventò lentamente
ma con costanza il divo dei comunisti italiani. Condivideva con Cossiga questa
passione per gli ex nemici: i comunisti, compresi quelli russi, erano per lui,
per loro, gente carismatica, muta, pesante, importante, spartana e allo stesso
tempo ricca per le grandi risorse minerarie dell’allora Unione Sovietica.
Cominciò così la marcia di avvicinamento di Andreotti al Pci di Enrico
Berlinguer e i due insieme vararono la bozza di quel patto politico
rischiosissimo che poi si è chiamato “compromesso storico” e sul cui altare Aldo
Moro ha lasciato la pelle. La storia del Compromesso storico è la storia stessa
di Andreotti. Aldo Moro accettò di aprire in piena guerra fredda ai comunisti,
contando su un accordo di massima con gli americani. I termini di questo accordo
sono stati pubblicati da Maurizio Molinari e Paolo Mastrolilli per Laterza nel
settembre del 2005 e consiste in una raccolta di documenti fondamentali che
mostra come gli Stati Uniti fossero estremamente e positivamente interessati al
Compromesso storico, purché il Pci si sganciasse una volta per tutte dall’Urss,
rompesse con il dovuto clamore accettando la prevedibile scissione, ed entrasse
a pieno titolo nel novero dei partiti democratici italiani indispensabili per il
ricambio della classe dirigente. E’ importante ricordarlo perché poi è stata
fatta passare la vulgata secondo cui Moro voleva fare il compromesso storico con
Berlinguer, ma la Cia lo fece rapire da brigatisti rossi controllati da
Langley, Virginia, per far fallire l’eroico progetto. Secondo il progetto
originale invece, di cui Andreotti fu un notaio e non l’unico, Moro doveva
diventare presidente della Repubblica dopo Giovanni Leone e garantire dal
Quirinale l’intera operazione. Andreotti sarebbe diventato il presidente del
Consiglio del primo governo sostenuto in Parlamento del Patito comunista e a
quel primo passo avrebbe dovuto far seguito il taglio del cordone ombelicale con
Mosca e un secondo governo, benedetto anche dai Paesi della Nato, con ministri
comunisti. L’attacco di via Fani, la prigionia interrogatorio e l’esecuzione di
Aldo Moro, misero fine al progetto. Al Quirinale andò Sandro Pertini, ma
Andreotti decise di resistere sulla vecchia linea e di dare comunque vita con i
comunisti al nuovo governo con il loro appoggio determinante e ufficiale. Questo
esperimento nacque nel sangue e visse poco e male. I comunisti erano molto
spaventati da quel che era successo e non vollero tagliare con Mosca, dove i
dirigenti del Pci seguitarono a ritirare ogni anno un gigantesco finanziamento
illegale che drogava la politica italiana, anche perché costituiva un alibi per
tutti coloro che in Italia erano disposti a commettere illeciti con la scusa di
finanziare il proprio partito. Poi i comunisti decisero di chiudere la partita e
si ritirarono definitivamente. Ma Giulio Andreotti non mollò. La mia impressione
(molto più di una impressione) è che sia lui che Cossiga fecero non soltanto il
possibile, ma specialmente l’impossibile per salvare la vita a Moro accettando
accordi che poi saltarono perché la controparte era decisa a liquidare
l’ostaggio e lo fece. Quegli eventi non sono mai stati ben chiariti e io penso
che la devastazione della Commissione Mitrokhin di cui Andreotti fu parte attiva
controllando strettamente ogni fase dell’inchiesta, fosse dovuta proprio al
fatto che eravamo arrivato al nocciolo della questione. Andreotti lo sapeva, lo
temeva e non per caso il suo amico Cossiga lo volle nominare a sorpresa senatore
a vita per neutralizzarlo e promuoverlo su uno scranno dal quale non avrebbe più
fatto politica. Il processo di Palermo per i pretesi rapporti con Cosa Nostra fu
una sorta di corollario di quelle vicende. Andreotti si lasciò processare
docilmente, scrisse molti libri sostenendo che doveva pagarsi gli avvocati, fra
cui il professor Coppi, per difendersi e fu sempre lì, a Palermo, pienamente a
disposizione su quei banchi, come lo era stato davanti a me per quattro anni
nella Commissione Mitrokhin. Difendeva un passato, certamente ha difeso fino
alla morte con Cossiga e come Cossiga il segreto su ciò che realmente accadde
durante i cento giorni del rapimento Moro ed ebbe modo di sviluppare sempre la
sua politica filo araba, diventando così la bestia nera degli israeliani. Lo
andai a trovare più volte nel suo studio in piazza San Lorenzo in Lucina, dove
andava ogni mattina prestissimo. Lì riceveva giornalisti, politici, industriali,
gente di cultura e gente decisamente lontana dalla cultura. Io penso che sapesse
qualcosa in più, qualcosa che anche io ho sospettato e di cui ho scritto molto,
sulle vere ragioni che possono aver fatto scattare la decisione di uccidere
Falcone quando non era più un nemico sul campo della mafia, ma un alto burocrate
romano del ministero di Grazia e Giustizia. Quando il mio amico Giancarlo Lehner
annunciò l’intenzione di voler scrivere della collaborazione di Falcone con i
giudici russi, il procuratore generale Stepankov in particolare, per indagare
sul tesoro del Kgb e del Pcus portato in Italia per essere riciclato sotto la
protezione di alte figure della finanza, Andreotti lo mandò a chiamare e gli
ricordò di avere lui stesso, come ministro degli esteri, inviato dei fonogrammi
a Mosca per facilitare gli incontri segreti di Falcone. Gli disse che per lui
avrebbe recuperato quei fonogrammi che avrebbero costituito la prova scritta di
quel che stava facendo Falcone quando fu eliminato. Lo richiamò qualche giorno
dopo per dirgli: “Alla Farnesina mi dicono che hanno perso quei documenti. Ora,
alla Farnesina non hanno mai perso nulla e mai si perde nulla. Lo prenda come un
messaggio: lasci perdere la sua inchiesta e passi ad altro, sarà più salutare
per lei”.
COME MORI' MORO?
Omicidio Moro, il Ris
smentisce la versione Br: “Gli spararono di fronte”.
Il comandante del reparto scientifico dei carabinieri ha illustrato in
commissione parlamentare la perizia sul'assassinio. Secondo la quale il
presidente della Dc fu ucciso da colpi sparati da killer che potè guardare in
faccia. Il brigatista Moretti ha sempre raccontato invece che l'ostaggio fu
messo sotto una coperta in modo che non si accorgesse dell'esecuzione, scrive
Stefania Limiti il 23 febbraio 2017 su “Il Fatto Quotidiano”. Non era
sdraiato Aldo Moro quando fu colpito a morte, e chi gli ha sparato gli stava di
fronte. Lo assicura il Ris, interpellato dalla Commissione parlamentare
d’inchiesta nel tentativo di analizzare il delitto politico più importante del
‘900 italiano come si fa con un cold case. Il comandante del Ris, Luigi Ripani,
ha svolto il suo compito isolando “tutti gli elementi oggettivi”. Perché, pur a
distanza di molti anni, è possibile stabilire alcuni punti fermi per capire quel
che non ci hanno voluto raccontare di ciò che accadde qualche momento prima che
il presidente della Democrazia cristiana diventasse un fagotto gettato dietro il
sedile posteriore della Renault color amaranto parcheggiata in via Caetani.
Ebbene, ciò che raccontano gli elementi oggettivi raccolti dal Reparto
investigativo dei Carabinieri è questo: l’omicidio sarebbe avvenuto con una
serie di tre spari, due armi e 12 proiettili esplosi. La prima serie da tre,
quella che colpisce inizialmente Moro, secondo la ricostruzione esposta oggi,
avviene mentre il prigioniero delle Brigate rosse “è seduto sul pianale, sopra
la coperta, con il busto eretto e le spalle rivolte verso l’interno
dell’abitacolo, il portellone aperto”. I tre colpi lo raggiungono “con direzione
ortogonale al torace”. Moro si accascia e viene colpito da altri spari della
mitraglietta Skorpion. Infine due spari, stavolta da due armi diverse: uno di
una pistola Walther Pkk, calibro 9, l’altro ancora della Skorpion, un calibro
7.65. Quelle sono sicuramente le armi usate. “Faremo altre indagini per capire
da dove venga quella Walther Pkk”, ha detto il presidente della
Commissione Giuseppe Fioroni il quale sottolinea “l’assoluta novità di una
ricostruzione che smentisce quel che i brigatisti hanno sempre raccontato”. Il
primo ad auto-accusarsi di essere stato il killer di Moro fu Prospero Gallinari,
poi Mario Moretti disse di essere stato lui, infine accreditarono la versione
che dava la responsabilità a Germano Maccari: il racconto brigatista, insomma,
non è mai stato fermo, ma non solo. Proprio riguardo a quegli ultimi istanti il
capo dell’operazione, Mario Moretti, raccontò di aver fatto sistemare Moro nel
bagagliaio della R4, di averlo fatto mettere sotto la coperta e, soltanto
allora, di avergli sparato: accompagnato in auto, fatto sedere dietro, nel vano
dei bagagli, con la prospettiva di uno spostamento o forse di un atto definitivo
di libertà, il racconto brigatista ha tenuto a spiegare che Moro fu colpito
nella sua totale inconsapevolezza di quel che stava avvenendo. “Salga
Presidente, si accomodi”. Ebbene, la ricostruzione del Ris dice di no. La
balistica afferma il contrario. “E l’ipotesi che si fossero trovati in un garage
– quello di via Montalcini, come hanno sempre sostenuto le Br – è alquanto
improbabile”, ha detto il colonnello Ripani in conclusione. Troppe manovre e
quei dieci colpi sparati senza silenziatore avrebbero allertato il palazzo. La
perizia contiene molti altri spunti e non esclude una seconda versione, ritenuta
tuttavia meno probabile, in base alla quale Moro è seduto sul sedile posteriore
della Renault4 e i primi colpi partono dalla parte anteriore dell’auto, dove poi
furono ritrovati 5 bossoli, la cui presenza non contrastata affatto con la prima
versione, quella che vuole Moro seduto sul portabagagli. In entrambi i casi, c’è
certezza sul fatto che lo sparatore fosse inizialmente in posizione frontale. La
dinamica di quegli ultimi attimi di vita è, dunque, riscritta
definitivamente. Il racconto del Ris è scarno, essenziale, e lascia vedere al di
là un’immagine, quella di un delitto compiuto da professionisti del crimine,
come suggerì il presidente della Commissione Stragi Giovanni Pellegrino. Non da
militanti rivoluzionari che avevano scelto la lotta armata.
CASO MORO, IL RIS APRE
NUOVI SCENARI E SMENTISCE LA VERSIONE DEI BRIGATISTI.
Secondo Luigi Ripani, tenente colonnello e comandante del Reparto investigazioni
scientifiche dei Carabinieri, che ha ricostruito gli ultimi momenti di vita
dell'uomo politico presso la Commissione d’inchiesta sul rapimento e la morte di
Aldo Moro, la fine dello statista democristiano non è affatto come la
conoscevamo attraverso le “confessioni” dei brigatisti, scrive Manuel Gandin su
"Famiglia Cristiana" il 26/02/2017. La morte di Aldo Moro, il leader della Dc
ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 non è come la conoscevamo attraverso
le “confessioni” dei brigatisti. Lo afferma Luigi Ripani, tenente colonnello e
comandante del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) dei Carabinieri, che ha
ricostruito gli ultimi momenti di vita del presidente democristiano in audizione
presso la Commissione d’inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro,
presieduta dall’onorevole Giuseppe Fioroni. Secondo la versione delle Br Aldo
Moro non vide chi gli sparò perché gli fu detto che sarebbe stato liberato, e
perché gli venne messa una coperta addosso. Ma Ripani smonta la tesi: il leader
rapito era “seduto sul pianale, sopra la coperta, con il busto eretto e le
spalle rivolte verso l’interno dell’abitacolo, il portellone aperto”. Il capo
delle Br, Mario Moretti, invece, ha sempre raccontato che Moro fu fatto
sdraiare nel bagagliaio della famosa Renault 4 rossa, che gli fu messa addosso
una coperta e poi venne ucciso. Moretti ha anche affermato che a Moro non fu
detto che lo avrebbero ucciso: “Salga, presidente, si accomodi”. Inoltre, il
vecchio capo Br dichiarò, in una storica intervista a Sergio Zavoli per la serie
Tv della Rai “La notte della Repubblica”, che la verità non venne detta a Moro
per “rispetto, per pietà”. Ora, la ricostruzione del comandante del Ris
contraddice anche la parte più “virtuosa”, se così si può dire, della versione
brigatista. La versione di Moretti e compagni non è mai stata univoca.
Inizialmente le Br “accettarono” la versione dell’inchiesta secondo cui a
sparare fosse stato Prospero Gallinari, salvo poi “ammettere” che il killer del
presidente della Dc era proprio Moretti. Infine, terza versione, il giustiziere
di Moro diventa Germano Maccari. Le conseguenze della ricostruzione del Ris,
aprono nuovi scenari, sempre più misteriosi e inquietanti. Le armi utilizzate
dalle Br per uccidere Moro furono due, una mitraglietta Skorpion calibro 7,65 e
una pistola Walther Pkk calibro 9. Secondo Ripani, furono sparati dodici colpi
in tre momenti differenti. I primi tre colpi hanno raggiunto il rapito “con
direzione ortogonale al torace”. Moro si accasciò e venne colpito da altri spari
della Skorpion. Infine due ultimi spari, uno dalla Walther Pkk, l’altro ancora
dalla Skorpion. Ma se davvero questa è la versione più vicina alla verità, com’è
possibile che nessun inquilino del palazzo di via Montalcini, presunto covo
delle Br, abbia sentito le tre serie di ben dodici colpi? Dice Ripani:
“L’ipotesi che si fossero trovati in un garage di via Montalcini, come sostenuto
dalle Br, è alquanto improbabile”. E allora tornano i dubbi su quanti e quali
siano stati i covi reali delle Br durante i 55 giorni del rapimento Moro. Così
come si presenta una nuova domanda, anch’essa inquietante: il Ris parla dodici
colpi. Perché la perizia effettuata nel 1978 ammette invece soli undici colpi?
La ricostruzione del comandante del Ris, dice il presidente della Commissione,
Giuseppe Fioroni, è “inedita” e mette in discussione la verità fornita dai
brigatisti. E ad aumentare i dubbi, c’è anche un’altra affermazione di Ripani,
derivata dall’analisi dei vestiti indossati da Moro: “Sul bavero sinistro della
giacca dell’onorevole erano presenti macchie biancastre. Dagli accertamenti è
emerso che si trattava di saliva, compatibile con la posizione in cui è stato
trovato il cadavere e con la circostanza che la morte non sia arrivata
nell’immediatezza”. E, dunque, com’è morto Aldo Moro? E dove? E
quando? Bisognerebbe ritornare al celebre titolo del settimanale L’Europeo del
16 luglio 1950: “Di sicuro c’è solo che è morto”. Quel titolo corredava un
famoso articolo di Tommaso Besozzi sull’uccisione del bandito Salvatore
Giuliano. Lo stesso titolo potrebbe andare bene anche per la fine di Aldo Moro.
Caso Moro, "ucciso mentre
era seduto o stava in piedi",
scrive il 2/03/2017 "Adnkronos.com". Moro? E' stato ucciso in modo diverso da
come abbiamo saputo e forse, addirittura, non dentro la macchina, la Renault 4
rossa poi ritrovata a via Caetani. Di sicuro gli hanno sparato mentre era seduto
o in piedi, con il busto eretto. E le armi, che erano due (una Skorpion e una
Walther) gli furono puntate contro, verso il busto, per sparare quasi a
bruciapelo. Nella seconda puntata dell'audizione del comandante del Ris di Roma,
Luigi Ripani, presso la Commissione parlamentare che indaga sulla morte di Moro,
la ricostruzione fatta dai 'tecnici' dell'arma dei carabinieri, ribadisce i
punti fermi della scorsa settimana, che le domande dei membri della Commissione,
cercano di far meglio emergere. E infatti qualche aggiunta arriva. Ma,
sostanzialmente, le modalità dell'omicidio di Moro, la mattina del 9 maggio del
1978, sono discordanti con quanto è agli atti, dopo le dichiarazioni dei
brigatisti che in tre - Moretti, Maccari e Gallinari - si sono autoaccusati
degli spari contro il leader Dc. Per il Ris è da acquisire agli atti che Moro,
poco prima di essere ucciso, fosse in posizione eretta, forse seduto sul pianale
della R4, con le spalle rivolte all'abitacolo ed è stato colpito dai primi spari
in quella posizione, poi adagiato sul portabagagli, posizione da cui invece
inizia il racconto brigatista, con la 'pietosa' coperta posta sul corpo e sul
volto prima degli spari ravvicinati. Per il Ris, inoltre a sparare i primi tre
colpi, 'ortogonali' e diretti al torace, è stata la mitraglietta Skorpion e non
la Walther Pkk, come ricorda Maccari e che all'ultimo, uno dei colpi è di
calibro 9, sparati dalla Walther, appunto. Tra le novità, di questa seconda
parte dell'audizione dei Ris quanto detto da Ripani, che, a un certo punto,
allontana la scena dell'omicidio dalla macchina emblema degli anni di piombo, la
R4 dei brigatisti. "Io credo che Moro - sottolinea il comandante del Reparto
investigazioni scientifiche dei Carabinieri - seduto, magari su una sedia o su
un bancone", mentre era a una certa distanza dall'auto. Parole che riaprono
anche la questione del garage di via Montalcini, dove i brigatisti dicono di
aver ucciso il leader Dc, ma che potrebbe non essere posto dove poter sparare 12
colpi senza essere scoperti. Un dubbio che viene sottolineato anche dal
presidente Fioroni: "A questo punto faremo una sorta di incidente probatorio,
'ricostruendo' le fasi finali dell'omicidio, soprattutto per verificare se la
dinamica proposta dal Ris, che smentisce quella brigatista, sia possibile in
quel garage, in particolare rispetto ai 12 spari esplosi", di cui alcuni
addirittura senza silenziatore.
L’auto parcheggiata in via
Caetani per tenere il posto alla R4 con Moro.
La ricostruzione attraverso le
voci di chi non si è pentito e le carte dell’Archivio di Stato. Una Renault 6
verde, spostata e portata via quando arrivò la Renault. Sono alcuni particolari
nel volume Brigate rosse - Dalle fabbriche alla campagna di primavera, scrive
Giovanni Bianconi il 4 marzo 2017 su "Il Corriere della Sera". Per essere sicuri
di non avere problemi di parcheggio al momento di «consegnare» il cadavere di
Aldo Moro, al centro di Roma, i brigatisti rossi decisero che uno di loro
andasse a occupare il posto la sera prima in via Caetani; con la sua macchina,
ché altre a disposizione non ce n’erano in quel momento e rubarne una sarebbe
stato rischioso. Una Renault 6 verde, spostata e portata via quando arrivò la
Renault 4 rossa con il suo carico di morte. E in via Mario Fani, dove Moro era
stato rapito, i terroristi si mossero con una certa sicurezza anche perché
alcuni di loro avevano già fatto appostamenti quando, prima di arruolarsi nelle
Br, volevano sparare a Pino Rauti, il deputato missino che abitava proprio in
quella strada e che la mattina del 16 marzo 1978 fu uno dei primi a dare
l’allarme telefonando al 113.
Il furgone «di scorta». La via
di fuga per portare l’ostaggio nella «prigione del popolo» dove restò chiuso per
55 giorni è stata ripercorsa metro dopo metro da uno degli assalitori: vie
secondarie e poco frequentate, di cui altri militanti che parteciparono
all’azione erano stati frequentatori abituali: una faceva la maestra d’asilo da
quelle parti, un altro aveva un negozio di caccia e pesca nella zona. Tutto filò
liscio, e non ci fu bisogno di utilizzare un furgone parcheggiato lungo il
tragitto, per eventuali emergenze che non si verificarono. Sono alcuni
particolari contenuti in Brigate rosse - Dalle fabbriche alla campagna di
primavera (DeriveApprodi, pag. 534, euro 28), primo volume di un lavoro condotto
da Marco Clementi, Elisa Santalena e Paolo Persichetti, due storici di
professione e un «ricercatore indipendente» (Persichetti) che ha la
particolarità di aver aderito alle Br-Unione dei comunisti combattenti, e per
questo è stato arrestato, condannato e ha scontato la pena dopo essere stato
estradato dalla Francia. Gli autori hanno potuto contare sulle testimonianze
inedite di alcuni ex brigatisti non pentiti né dissociati, ma soprattutto hanno
consultato per mesi le carte trasmesse all’Archivio di Stato dagli apparati di
sicurezza in seguito alle direttive degli ex presidenti del Consiglio Prodi e
Renzi, che hanno tolto il segreto su molta documentazione relativa ai cosiddetti
«anni di piombo». È la prima ricerca di questo tipo, la cui conclusione porta a
sostenere che il sequestro Moro fu la logica evoluzione della strategia messa in
campo dalle Br all’inizio degli anni Settanta, e il suo epilogo la tragica ma
quasi inevitabile conseguenza della contrapposizione frontale fra lo Stato e i
partiti che lo rappresentavano da un lato, e i terroristi dall’altro. Senza
misteri che nasconderebbero patti segreti, verità indicibili, collaborazioni
occulte e inquinamenti dell’azione brigatista. Una sorta di contro-inchiesta
rispetto a quella condotta dalla nuova commissione parlamentare incaricata di
provare a svelare nuovi segreti del caso Moro, ancora in attività e già foriera
di scoperte e ulteriori acquisizioni; ultima in ordine di tempo le modalità
dell’esecuzione di Moro la mattina del 9 maggio: con l’ostaggio colpito a morte
non quando era già rannicchiato nel bagagliaio della Renault 4, come riferito
finora dai terroristi, ma seduto sul pianale e poi caduto all’indietro. Una
sorta di fucilazione.
I dossier di dalla Chiesa. Nel
libro ci si sofferma su altri aspetti, come la centralità di un altro «covo»
romano brigatista rispetto a quello molto noto di via Gradoli scoperto durante i
55 giorni, in via Chiabrera, al quartiere Ostiense, dove si svolse la riunione
operativa dell’8 maggio in cui si assegnarono i compiti per l’indomani. E
vengono contestati e ribaltati, anche sulla base dei documenti redatti all’epoca
dalle forze di polizia, alcuni presunti misteri come quelli relativi al
ritrovamento delle macchine utilizzate dai brigatisti per il sequestro, o alla
scoperta del corpo di Moro. Dagli atti consegnati dall’Arma dei carabinieri
emerge l’attività del Nucleo speciale guidato dal generale dalla Chiesa,
ricomposto nell’estate del ’78. Dalle relazioni semestrali inviate al ministro
dell’Interno, si evince una vastissima operazione di raccolta dati e schedature
a tappeto, con «più di 16.161 fascicoli e circa 19.780 schede personali, che
oggi purtroppo non risultano consultabili (potrebbero anche essere andati
distrutti), 9.200 servizi fotografici, di cui 7.391 riferentisi a soggetti e
1.451 a luoghi di interesse operativo». La maggior parte dei fascicoli
riguardavano attività svolte a Roma (4.916) e Milano (4.200), ma anche a Napoli
(2.100), Torino, Genova, Firenze, Padova e altre città. Consultabili sono
invece, presso la Fondazione Gramsci, i verbali delle Direzioni del Pci, nelle
quali i dirigenti scelsero non solo di sposare da subito la cosiddetta «linea
della fermezza», ma di non attribuire alcuna attendibilità a ciò che Moro
scriveva dal carcere brigatista in cui era segregato. «Bisogna negare valore
alle cose che ha detto e potrà dire, ciò gioverà alla nostra posizione»,
sintetizzò Emanuele Macaluso nella riunione del 30 marzo. Fu uno dei passaggi
chiave del fronte del rifiuto su cui si ritrovarono i partiti di governo, con
l’eccezione finale dei socialisti che provarono a smarcarsi. Storie che
avvinghiarono l’Italia di 39 anni fa, e oggi si arricchiscono di dettagli e
punti di vista di allora su cui ci si continua a interrogare.
CASO MORO, SE LA
COMMISSIONE PARLAMENTARE GUARDA ALTROVE.
Che il presidente della Dc sia
stato ucciso da seduto o da sdraiato cambia poco. Cambierebbe invece sapere se
pezzi dello Stato conoscevano le mosse di stragisti e terroristi e, se sì,
perché li abbiano lasciati fare, scrive Annachiara Valle su "Famiglia Cristiana”
il 3/03/2017. Sul caso Moro tutto da rifare? Così dicono i commenti sui lavori
della Commissione presieduta da Giuseppe Fioroni. In realtà che sia tutto da
rifare il Ris non lo dice. Non lo dice la perizia effettuata dagli uomini del
colonnello Luigi Ripani e non lo dicono neppure, in audizione, lo stesso
comandante del Reparto investigazioni scientifiche di Roma e il suo tenente
colonnello Paolo Fratini. Seppur tirati di qua e di là dalle domande dei membri
della Commissione Moro, i due carabinieri si limitano a mostrare le evidenze
scientifiche e a formulare due ipotesi di cui una definita, «sulla base degli
elementi oggettivi raccolti», la «più probabile». La «scena del crimine», per i
Ris, è certamente la Renault 4 dove il corpo di Aldo Moro fu ritrovato la
mattina del 9 maggio. Rispetto alla ricostruzione degli ultimi momenti del
presidente fatta da Germano Maccari nell’udienza presso la Corte d’assise di
Roma, il 19 giugno 1996, la differenza è sulla posizione di Moro al momento dei
primi colpi sparatigli – già sdraiato secondo il brigatista, seduto sul pianale
dell’automobile secondo il Ris -, mentre gli altri proiettili lo hanno raggiunto
nella posizione indicata dai brigatisti. Non è la prima volta che la Commissione
crea scoop e nuovi scenari sul caso Moro. I lettori ricorderanno anche la
vicenda delle cassette di via Gradoli sulle quali nel 2015 – anche lì eravamo in
prossimità dell’anniversario della strage di via Fani – Gero Grassi, uno dei
componenti della Commissione, aveva dichiarato: «Le cassette sono state
ritrovate tra i reperti del covo brigatista di via Gradoli grazie al lavoro
della dottoressa Antonia Giammaria, magistrato distaccato presso l'organismo
parlamentare. Da quel che si conosce dagli atti erano 18 le cassette registrate
ritrovate nel covo e mai ascoltate: ad oggi ne manca dunque una. Per il momento
le cassette sono nella cassaforte della Commissione». Peccato però che, proprio
sulle quelle audiocassette «mai ascoltate»» ci fosse tanto di verbale dell’epoca
della Digos con il contenuto dettagliato di ciascuna. Il vero quesito allora è
sugli obiettivi della Commissione e sul perché non si riesca ad allargare lo
sguardo su quanto successe nel nostro Paese in quegli anni soprattutto
sul fronte dello stragismo, dei depistaggi e dei rapporti tra settori deviati
dello Stato e terrorismo. Sul rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, lo avevamo
già scritto fin dal nascere della Commissione, si sa tanto. Quello che manca è
un quadro in cui collocare tutta la vicenda e quello che accadde dopo. Senza
immaginare un "Grande vecchio" - che probabilmente non c'è mai stato - manca di
sapere se e quanto si sapesse su terrorismo di destra e di sinistra, sul se e
sul quanto si lasciò fare (perché ad esempio, una volta individuato il covo di
via Montalcini si lascia che la Braghetti traslochi senza arrestarla e lasciando
così che possa uccidere due anni dopo Bachelet?), sul se e quanto i brigatisti
furono “usati”, loro malgrado, anche da pezzi dello Stato, sul se e quanto lo
stragismo di destra fosse funzionale a una svolta autoritaria nel Paese…E mentre
i dietrologi del caso Moro giocano ai piccoli detective quasi fossimo in un
episodio della serie televisiva Csi, sulle questioni vere che hanno cambiato la
storia del nostro Paese si continua a tacere. Perciò ci permettiamo noi di porre
un quesito alla Commissione, nella convinzione che la nostra domanda sia anche
quella di tanti italiani: perché non si indaga, finalmente e fino in fondo,
sulle implicazioni e i coinvolgimenti delle istituzioni e degli apparati dello
Stato in questa vicenda?
CHI VOLLE LA MORTE DI MORO?
Come e perché NON hanno voluto salvare Aldo Moro, scrive il
13 marzo 2014
da Pino
Nicotri.
Domenica 16 marzo ricorre l’anniversario del rapimento dell’onorevole
democristiano Aldo Moro, ex ministro ed ex capo del governo, e del massacro
della sua scorta, avvenuti per opera delle Brigate Rosse nel 1978. Moro come è
noto è stato ucciso dopo 55 giorni di prigionia, il 9 luglio, in un angusto
“carcere del popolo” ricavato dietro una parete di un appartamento in via
Camillo Montalcini n. 8 a Roma. Desidero raccontare quanto ho appreso
casualmente nell’agosto 1993 riguardo la mancata possibilità che lo Stato
italiano liberasse Moro. E come è stata sprecata la possibilità di fare piena
luce sui perché e per ordine di chi il manipolo di “baschi neri” del ministero
dell’Interno venne bloccato pochi minuti prima di assaltare la prigione
brigatista. Prima però è bene inquadrare la vicenda nel suo contesto storico non
sufficientemente noto. Vado quindi per ordine. Un primo tentativo di assassinare
moralmente Moro è del 1976 e porta già la firma di Kissinger. Negli Usa la
commissione Frank Church del senato USA comincia quell’anno le sue indagini
sulle attività delle multinazionali tese a organizzare in tutto il mondo
scandali contro le frazioni pro-sviluppo dei propri Paesi e scopre, tra l’altro,
che la potente industria aeronautica militare Lockheed usava corrompere con
ricche bustarelle i politici di più parti del globo per convincerli ad
acquistare i propri aerei. A prendere le mazzette in Italia era un misterioso
personaggio soprannominato in codice Antelope Cobbler. Per farne naufragare la
politica di apertura ai comunisti e ai palestinesi, è un assistente del
Dipartimento di Stato, cioè di Kissinger, tale Loewenstein, filosionista e
antiarabo come il suo famoso principale, a proporre di dare in pasto alla stampa
Moro indicandolo come l’Antelope Cobbler. La proposta è resa operativa da Luca
Dainelli, ambasciatore italiano negli Usa e membro dell’International Institute
for Strategic Studies. Il complotto contro Moro però non riuscì. Pur messo sotto
accusa, la corte Costituzionale ne archiviò la posizione il 3 marzo 1978. Vale a
dire, 13 giorni prima dell’agguato di Via Fani. Ad agguato avvenuto, la
Segreteria di Stato Usa invia in Italia il suo funzionario Steve Pieczenik a
dirigere «l’unità di crisi» che, avallata dal primo ministro dell’epoca Giulio
Andreotti e comprendente l’allora ministro dell’Interno Francesco Cossiga,
decideva la linea da tenere nei confronti delle Brigate Rosse e delle condizioni
da loro poste per liberare l’ostaggio. Uno dei compiti, anch’esso riuscito in
pieno, ammesso dall’americano era far credere ai giornali e all’opinione
pubblica che le molte lettere scritte da Moro durante la prigionia, ricche di
accuse ai politici, non erano spontanee, bensì frutto di un «lavaggio del
cervello», e che quindi non se ne doveva tenere conto. Tutti i giornali fecero
infatti a gara a delegittimare il contenuto delle molte lettere di Moro
recapitate dai brigatisti a familiari e collaboratori del rapito nonché ad
alcune redazioni. La strategia impostata dall’esperto «amerikano» ricalcava
fedelmente quanto previsto dal Field Manual redatto nel 1970 dalla Cia per
definire il comportamento Usa verso i propri alleati in caso di loro gravi
crisi. Si tratta di una strategia che definisce il terrorismo «fattore interno
stabilizzante», secondo il principio «destabilizzare al fine di stabilizzare». E
che non si fa scrupolo di prevedere la strumentalizzazione di eventuali gruppi
eversivi dei Paesi alleati se essa può risultare positiva per gli interessi
americani. Leggiamo ora cosa ha detto Pieczenik in una intervista all’«Italy
Daily» del 16 marzo 2001 riguardo il suo compito durante il sequestro Moro:
“Stabilizzare l’Italia, in modo che la Democrazia Cristiana non cedesse… e
assicurare che il sequestro non avrebbe condotto alla presa del governo da parte
dei comunisti… Il mantenimento delle posizioni della DC: quello era il cuore
della mia missione. Nonostante tutte le crisi di governo, l’Italia era stato un
Paese molto stabile, saldamente in mano alla DC. Ma in quei giorni il Partito
comunista di Berlinguer era molto vicino a ottenere la maggioranza, e questo non
volevamo che accadesse… Io ritengo di avere portato a compimento tale incarico.
Una spiacevole conseguenza di ciò fu che Moro dovette morire… Nelle sue lettere
Moro mostrò segni di cedimento. A quel punto venne presa la decisione di non
trattare. Politicamente non c’era altra scelta. Questo però significava che
sarebbe stato giustiziato… Il fatto è che lui, Moro, non era indispensabile ai
fini della stabilità dell’Italia”. Più chiari e cinici di così! Intervistato per
il quotidiano «l’Unità» del 9 maggio 2007 dal giornalista Marco Dolcetta, ecco
cosa ha detto «l’amerikano » inviato dalla Segreteria di Stato ripetendolo
inoltre nel suo libro dal titolo quanto mai esplicito “Noi abbiamo ucciso Aldo
Moro”, edito in Francia da Patrick Robin: ” Il primo punto della mia strategia
consisteva nel guadagnare del tempo, mantenere in vita Moro e al tempo stesso il
mio compito era di impedire l’ascesa dei comunisti di Berlinguer al potere,
ridurre la capacità degli infiltrati nei Servizi e immobilizzare la famiglia
Moro nelle trattative. Cossiga non gestiva interamente la strategia che volevo
sviluppare.[…] Fra gli altri, i simpatizzanti di estrema sinistra comprendevano
anche i figli di Bettino Craxi e una delle figlie di Moro […]. Lessi le molte
lettere di Moro e i comunicati dei terroristi. Vidi che Moro era angosciato e
stava facendo rivelazioni che potevano essere lesive per l’Alleanza Atlantica.
Decisi allora che doveva prevalere la Ragione di Stato anche a scapito della sua
vita. Mi resi conto così che bisognava cambiare le carte in tavola e tendere una
trappola alle Br. Finsi di trattare. Decidemmo quindi, d’accordo con Cossiga,
che era il momento di mettere in pratica una operazione psicologica e facemmo
uscire così il falso comunicato della morte di Aldo Moro con la possibilità di
ritrovamento del suo corpo nel lago della Duchessa. Fu per loro un colpo mortale
perché non capirono più nulla e furono spinti così all’autodistruzione.
Uccidendo Moro persero la battaglia. Se lo avessero liberato avrebbero vinto.
Cossiga ha approvato la quasi totalità delle mie scelte e delle mie proposte e
faceva il tramite con Andreotti […]. Sono stato io a decidere che il prezzo da
pagare era la vita di Moro. […] Cossiga era sempre informato sulla mia strategia
e non poteva fare altro che accettare. Le Br invece potevano fermarsi in un
attimo ma non hanno saputo farlo o voluto”. Insomma, mettere nel sacco Le Br ed
eliminare Moro: due piccioni con una fava. Riguardo le responsabilità quanto
meno morali di Cossiga nella volontà politica di fare uccidere Moro, mi sono
casualmente imbattuto in due testimoni di eccezione: un gesuita confessore della
chiesa del Gesù in piazza del Gesù e l’ex confessore di Cossiga ai tempi del
sequestro Moro. Cominciamo dal gesuita.
«Lo stesso attentato a Moro, no? La prigione di Moro». «Sì?»
«Erano arrivati alla casa vicina a dove stava lui. Hanno avuto l’ordine di
fermarsi. Lo so perché un mio alunno faceva parte di queste cose qui. Me lo ha
detto lui: “Noi abbiamo avuto l’ordine
di fermarci e tornare indietro”. Erano arrivati a pochi… A venti metri erano
arrivati. Quindi lo sapevano benissimo. Cioè, lo sapevano. Setacciando casa per
casa, alla fine lo dovevano
trovare».
«Via Montalcini?»
«Adesso non so perché io non sono addentro alle segrete cose. Però questo me lo
ha detto un mio alunno che stava lì, insomma, ecco, faceva parte di quelli lì.
Hanno dovuto rimettere, capito? Ma non parliamo male che non è questa né la sede
né il luogo né il caso».
Questa è una parte del mio dialogo al cardiopalma con un gesuita confessore
della Chiesa del Gesù in uno dei primi giorni dell’agosto 1993. Stavo scrivendo
il libro Tangenti in confessionale, spacciandomi nei confessionali delle chiese
più rappresentative d’Italia – dal duomo di Torino alla basilica di S. Pietro in
Vaticano fino a S. Gennaro a Napoli – per un politico che accettava le mazzette
dagli industriali e a volte, al contrario, per un industriale che le pagava ai
politici. Dalle risposte dei preti confessori volevo capire e documentare il
comportamento e l’influenza della Chiesa nei confronti di un fenomeno come
quello della corruzione e delle tangenti, troppo diffuso per esserle ignoto. E
infatti… Mi «confessavo» con un mini registratore avvolto in un giornale tenuto
in mano perché stesse il più vicino possibile alla bocca dei religiosi. La tarda
mattinata di un giorno tra il 2 eil 4 agosto sono andato nella chiesa del Gesù,
in piazza del Gesù. Una scelta dovuta al fatto che in quella piazza c’era la
sede della direzione nazionale della Democrazia Cristiana e al fatto che in
quella chiesa Andreotti andava a messa quasi ogni mattina, dove presumevo si
confessasse anche. Inoltre proprio a pochi metri di distanza, nella adiacente
via Caetani, era stato lasciato a suo tempo il cadavere di Moro trasportato da
via Montalcini con una Renault rossa. Più simbolismi di così! Entrato in chiesa,
mi sono diretto verso il primo confessionale a destra, dove c’era un religioso
in attesa di penitenti. Non avrei immaginato neppure da lontano che il discorso
sarebbe piombato nel caso Moro, e in modo così tranchant: io parlavo di tangenti
e il confessore per dirmi che era un andazzo molto noto e tollerato mi stava
dicendo che era noto tanto quanto a suo tempo il luogo della prigione di Moro!
Il cuore m’è schizzato in gola e ho cominciato a sudare non solo per il caldo.
La storia che mi ha raccontato quel gesuita è la seguente: «Un mio ex alunno si
era arruolato nella polizia ed era entrato nel corpo delle “teste di cuoio”. Un
giorno è venuto a chiedermi l’autorizzazione morale per infiltrasi nelle Brigate
Rosse, voleva cioè sapere da me se l’infiltrarsi era morale o immorale. Gli
dissi che era morale. Passato del tempo, quel mio ex alunno è tornato da me
schifato. Mi ha raccontato che mentre stavano andando a liberare Moro ed erano
arrivati a una ventina di metri dalla sua prigione, all’improvviso ricevettero
l’ordine di tornare indietro. Il mio ex alunno rimase talmente schifato che si è
dimesso dalla polizia. Ora lavora nella falegnameria del padre». Chiaro quindi
che si trattava della prigione di via Montalcini, altrimenti non si
spiegherebbero lo schifo e lo scappar via dalla polizia. Ero sconvolto. Ma uno o
due giorni dopo sarei rimasto ancora più sconvolto. Sono andato infatti a
confessarmi anche nella chiesa di S. Lorenzo in Lucina, nella omonima piazza,
scelta perché in quella piazza aveva il suo storico ufficio privato l’ancor più
storico Andreotti. Mi si è presentato un parroco con i capelli a spazzola e
l’accento pugliese. Anziché nel confessionale, mi ha sorpreso facendomi
accomodare in sagrestia, seduti uno di fronte all’altro su banali sedie e
separati da nulla. Ero teso perché temevo si capisse che il giornale che
stringevo nervosamente in mano nascondeva quello che nascondeva. Ma a un certo
punto ho rischiato di cadere dalla sedia: quel parroco – anche lui per
consolarmi dicendo che il fenomeno delle mazzette era noto e tollerato quanto
certi «misteri» del caso Moro – mi stava dicendo che era stato il confessore di
Cossiga all’epoca del sequestro Moro! «Quando, durante l’affare Moro, Cossiga
era ministro degli Interni e lo confessavo io, in quel frangente dicevo:
“Professore, io la posso solo assolvere dei suoi peccati. Ma la situazione sua
se la deve andare a sbrigare da qualche altro”. Allora c’era Ferretto, c’era
Dossetti [compagni d’Università di Moro che dopo avere fatto politica hanno
infine scelto la vita in convento, ndr]. Dicevo: “Vada a sentire loro. Perché,
anche, loro sono quelli che, avendo fatto carriera con lei, con Moro e col
partito, a un certo punto hanno fatto un’altra scelta, possono aiutarla adesso”.
A questo tipo di sollecitazione lui diceva: “Lascio perdere tutto”». Il suo ex
confessore mi stava dicendo che Cossiga aveva un enorme peso sulla coscienza per
le scelte fatte. Lo straordinario racconto del parroco di S. Lorenzo in Lucina
confermava in pieno non solo quanto più volte più o meno chiaramente trapelato e
in parte ambiguamente ammesso dallo stesso Cossiga, ma anche quanto
raccontato dall’«amerikano» Pieczenik, all’epoca assai poco noto in Italia e a
me del tutto ignoto. Le due confessioni hanno avuto un seguito ciascuna. Il
primo è che ho scritto a Cossiga chiedendo lumi sulle pesanti parole del suo ex
confessore e ne ho ricevuto la seguente risposta: «Caro Nicotri, si tratta di
una faccenda troppo importante per lasciarla trattare a un prete». Il secondo è
che dopo la pubblicazione del mio libro, il pubblico ministero Franco Jonta mi
ha convocato per interrogarmi e chiedermi chi fosse esattamente quel confessore.
Nonostante il tono perentorio del magistrato, con velata minaccia di guai
giudiziari, ho opposto il segreto professionale, specificando però che ero
disponibile a rispondere, ma solo dopo che l’Ordine dei giornalisti mi avesse
sciolto, su mia richiesta, dall’obbligo del segreto. Tornato a Milano, ho
chiesto per iscritto di esserne sollevato data l’importanza dell’argomento e
della mia testimonianza. Ottenuto il permesso, sono stato riconvocato a Roma da
Jonta, e questa volta gli ho portato una copia del nastro con il dialogo nel
confessionale. Man mano che ascoltava il nastro il magistrato si incupiva sempre
di più. E ogni tanto continuava a ripetermi: «Ma non le sembra strano?» Ho
cominciato a sentirmi a disagio, e a un certo punto ho temuto che magari venissi
accusato di avere falsificato il nastro. All’ennesimo «Ma non le sembra strano?»
mi sono stufato e ho ribattuto: «A me sembra strano, anzi stranissimo, però la
sua è una domanda che dovrebbe rivolgere non a me, ma al confessore». Silenzio
di gelo. Finito il nastro Jonta guardandomi in modo che mi è parso ostile mi ha
chiesto: «E chi sarebbe questo confessore?» «Credo lei volesse dire “chi è” e
non “chi sarebbe”. Comunque la risposta è semplice: quello che riceve nel primo
confessionale a destra entrando in chiesa», ho risposto specificandone anche il
cognome: «C’è affissa una targhetta in ottone con scritto come si chiama il
confessore e gli orari durante i quali è presente». «E che lo interrogo a fare?
È chiaro che mi opporrà il segreto del confessionale». «Be’, ma scusi, dottor
Jonta, per arrivare a questa conclusione non c’era bisogno di farmi sciogliere
dall’obbligo del segreto e farmi tornare a Roma. Ma se non intende interrogarlo,
qual è il motivo per cui ne vuole sapere il nome? Qualcuno vuole forse chiedere
anche a lui di tacere?» «Ma come si permette!» «Guardi che quel confessore non
può assolutamente accampare il segreto perché ha detto chiaro e tondo, come lei
ha sentito ascoltando il nastro, che il suo ex alunno in realtà non è andato a
confessarsi, a parlare cioè dei propri peccati, ma solo a chiedergli un
consiglio. Lei perciò può e anzi deve interrogarlo. E se non risponde lo può
anche arrestare o comunque mandare sotto processo. Proprio come ha minacciato di
fare con me. O devo pensare che secondo lei io ho meno diritti del gesuita?»
«Nicotri, guardi che qui cosa fare lo decido io. Lei non può certo starmi a dire
cosa devo o non devo fare». «Con la sua coscienza se le vede lei. Comunque
guardi che questa è l’unica occasione di chiarire finalmente la bruttissima
faccenda della mancata liberazione di Moro. E in ogni caso, confessore o non
confessore, è sicuro che non ce ne sono tante di ex teste di cuoio figli di
falegnami infiltrate nelle Brigate Rosse e scappate dalla polizia dopo la
faccenda Moro per andare a fare il falegname dal papà. Se questo ex poliziotto
lo cercate, lo trovate di sicuro. Se lo volete trovare, naturalmente». «Ah, ma
allora lei non vuole capire! Qui comando io, e lei non deve assolutamente dirmi
cosa cavolo devo fare!» Conclusione? La prima è che sono uscito dal palazzo di
Giustizia vergognandomi. Vergognandomi della mia disponibilità con il
magistrato. E vergognandomi d’essermi fatto sciogliere dall’obbligo del segreto.
Mi sentivo molto a disagio, in imbarazzo con me stesso. La seconda conclusione:
è chiaro come il sole che NON si è voluto chiarire il «mistero» della
prigione di Moro. Esattamente come a suo tempo non si voleva che la si trovasse.
I «consigli» di Pieczenik parlano chiaro. I pesi sulla coscienza e le ammissioni
di Cossiga anche. Il cadavere di Moro pure.
Moro, retorica e ipocrisia
nell’anniversario della morte ma silenzio sui tanti misteri irrisolti,
scrive venerdì 9 maggio 2014 “Il Secolo d’Italia”. L’ipocrisia va in scena fra
via Caetani, dove fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, il cimitero di Torrita
Tiberina, dove il leader Dc è sepolto e Facebook dove scorrono paludati e
inutili interventi istituzionali densi di chiacchiere e retorica a buon
mercato. Nell’anniversario del ritrovamento della Renault 4 all’interno della
quale fu scoperto il cadavere di Aldo Moro, trentasei anni dopo i fatti, le
istituzioni si ritrovano a commemorare l’esponente democristiano senza che lo
Stato si sia dimostrato in grado di chiarire definitivamente i mille dubbi sulla
vicenda e di allontanare il sospetto che tanto il sequestro, quanto l’omicidio
e, poi, l’esfiltrazione dei brigatisti che parteciparono all’omicidio siano
stati eterodiretti e gestiti. Anni di indagini, decine di libri, una Commissione
Parlamentare e ben cinque processi non sono riusciti a stabilire definitivamente
come andarono effettivamente i fatti e se vi furono coinvolti altri soggetti
oltre ai brigatisti. I misteri che ancora aleggiano sull’intera vicenda e gli
interrogativi ancora senza risposta sono tali e tanti che riesce difficile
comprendere come le istituzioni possano rievocare quegli avvenimenti senza
provare il benché minimo imbarazzo. Sarebbe sufficiente ricordare la quantità
industriale di reperti e documenti scomparsi senza lasciar traccia nel corso
degli anni. Come le oltre 10 foto che un abitante della zona del sequestro,
Gherardo Nucci, scatta subito dopo l’agguato a via Fani dall’alto, dalla
terrazza di casa. La moglie di Nucci, giornalista dell’Asca, le consegna subito
alla magistratura. E non si ritroveranno mai più. Eppure quelle foto sembrano
interessare moltissimo la Democrazia Cristiana: un’intercettazione cristallizza
lo strano colloquio fra Sereno Freato, il capo della segreteria di Moro che
tentò di gestire una trattativa con le Br nei giorni del sequestro e Benito
Cazora, anche lui diccì di spicco incaricato da piazza del Gesù di tenere i
rapporti con le cosche calabresi per cercare di avere notizie sul rapimento. La
preoccupazione che emerge è che quelle foto hanno immortalato qualcuno che non
doveva essere ripreso lì in quel momento. Perché? Chi era? Mistero. Non l’unico,
però. Subito dopo il sequestro un inspiegabile e provvidenziale blackout mandò
in tilt tutte le comunicazioni nella zona dell’agguato impedendo, di fatto, il
corretto coordinamento fra le forze dell’ordine. I brigatisti sostennero che
alcuni compagni che lavoravano alla Sip avevano provveduto a isolare le
comunicazioni ma, il giorno prima del sequestro, la struttura interna della Sip
che era in rapporti con il Sismi venne allertata come accadeva, di norma, quando
erano previsti eventi eccezionali. Uno dei misteri più fitti e irrisolti è
quello relativo alle presenze sul luogo esatto del sequestro. Si scoprì che il
colonnello del Sismi, Camillo Guglielmi, era presente sul posto. Interrogato,
disse che lo attendeva a pranzo un amico che lo aveva invitato. A parte il fatto
che l’agguato a Moro avvenne alle 9 di mattina e, dunque, ben prima dall’orario
di pranzo ma l’amico di Guglielmi, interpellato a sua volta, disse di non aver
mai invitato il colonnello del Sismi a pranzo e che, anzi, si stupì quando lo
vide presentarsi alle 9 del mattino insalutato ospite. La presenza di Guglielmi
sul luogo della strage sarebbe perfino passata inosservata se non l’avesse
rivelata un ex-agente dei Servizi, Pierluigi Ravasio il quale raccontò che i
Servizi avevano infiltrato fra le br uno studente di giurisprudenza, nome in
codice “franco”, il quale avvertì, mezz’ora prima, che Moro stava per essere
rapito. Di certo il mistero ben si accompagna alla famosa “seduta spiritica”
durante la quale, secondo Prodi, il fantasma evocato di La Pira pronunciò la
parola “Gradoli”. Partirono tutti per il paesino viterbese di Gradoli senza
pensare che a Roma esisteva una via Gradoli dove, effettivamente, Moro era
detenuto. Con scarso senso del ridicolo, Prodi ha ripetuto la storiella della
seduta spiritica perfino davanti ai commissari della Commissione parlamentare
d’inchiesta. Qualcuno ha inevitabilmente ricordato al professore bolognese che
all’Università di Bologna, dove lui insegnava, era molto attiva Autonomia
Operaia che fiancheggiava le Brigate Rosse. E forse qualcuno fece arrivare
all’orecchio del profesore la parola Gradoli “ufficializzata” poi con la seduta
spiritica. Proprio recentemente il mistero sulla presenza del colonnello
Guglielmi si è riacceso perché quel giorno, quando l’esplosione della
“geometrica potenza” dei brigatisti falcidiò la scorta di Moro senza minimamente
colpire né i brigatisti né lo stesso Moro, una moto Honda con due uomini a bordo
transitò sulla scena e il passeggero sparò alcuni colpi di pistola contro un
abitante della zona, l’ingegner Alessandro Marini, che, con il motorino, si
stava immettendo proprio lì dove i br stavano portando a termine il rapimento.
Chi erano quei due sulla moto che sbarrarono il passo all’ignaro testimone? Non
si è mai saputo. Gli stessi br assicurarono che non appartenevano al loro
gruppo. Ma, nei mesi scorsi, un ispettore di polizia in pensione, Enrico Rossi,
ha rivelato che a bordo di quella moto vi erano due uomini dei Servizi segreti
gerarchicamente dipendenti dal colonnello Guglielmi. A distanza di anni dai
fatti l’ispettore Rossi perquisisce la casa di uno dei due uomini, trova una
pistola cecoslovacca Drulov compatibile con la descrizione fatta dai testimoni
su quella utilizzata dai due uomini a bordo della Honda e la consegna alla Digos
di Cuneo. Quella pistola non sarà mai periziata e verrà distrutta. Scompare,
così, un’altra prova. Un altro mistero ruota attorno al cosiddetto “Tex Willer”
che sparò, quel giorno, in via Fani. Dei 91 bossoli ritrovati, 49 provenivano
dall’arma di un’unica persona, un killer preciso, freddo e incredibilmente
professionale. Gli stessi testimoni che assistono al sequestro, fra i quali un
esperto di armi, restano choccati dalla precisione e dalla capacità di chi sparò
quei 49 colpi sul totale dei 91 bossoli ritrovati e periziati. I brigatisti
hanno più volte sostenuto che non c’era, fra loro, nessuno così particolarmente
addestrato a sparare perché ritenevano rischioso addestrarsi a sparare. I
testimoni collocano il superkiller all’incrocio con via Stresa. Lì c’era Valerio
Morucci al quale però l’arma, come racconta lui stesso, si inceppò dopo 2 o 3
colpi. I misteri mai risolti davvero sono centinaia e centinaia. Una specie di
gigantesco puzzle che non coincide mai. Fra le carte sequestrate a Valerio
Morucci c’era il numero, riservato, di Marcinkus, non proprio uno stinco di
santo. Che cosa c’entrano Morucci e le br con Marcinkus? Mistero. La
mitraglietta Skorpion con la quale fu ucciso Moro fu ritrovata sopra un armadio
nell’appartamento di viale Giulio Cesare di Giuliana Conforto, figlia di Giorgio
Conforto, agente del Kgb il cui nome spunta dal dossier Mitrokhin. La lista
degli interrogativi rimasti senza risposta è infinita. Forse, allora, ha ragione
la figlia dell’esponente Dc, Maria Fida Moro: «Tanti vogliono dimenticare, molti
non vogliono sapere, troppi ignorano e alzano le spalle eppure questa nazione
non si salverà e affonderà se non vorrà capire e sapere perché nessuno mi toglie
dalla testa che Aldo Moro è stato liquidato con il concorso di tanti perché ci
si avviasse verso la realtà che viviamo oggi. Ripeto: questo Stato morirà e si
dissolverà a causa della ignoranza e della cecità se quel nodo non verrà
sciolto. Ecco perché sostengo, senza aspettative, l’azione di quella
magistratura che ritiene che ben poco è chiaro in quella cruciale vicenda”.
Sequestro Moro, ricostruito
l’agguato in 3D: non andò come dicono le Br,
scrive Giulia Melodia giovedì 11 giugno 2015 su “Il Secolo d’Italia”. Sequestro Moro,
le cose non andarono come i Br hanno fin qui sostenuto. Secondo quanto
ricostruito per la prima volta con slide in 3D, sulla base dei dati delle
autopsie, delle perizie balistiche e della collocazione dei bossoli sul terreno,
la dinamica dell’agguato smentisce in gran parte le dichiarazioni rese dai
brigatisti di quel giorno e la versione dei fatti fin qui accreditata. E allora,
in base alle nuove acquisizioni, lo schema dell’accerchiamento e dell’azione
terroristica sarebbe questo: quattro killer che sparano sulle auto in via Fani;
colpi singoli e mirati scaricati subito sulla 130 ancora in movimento per
evitare di uccidere Moro e colpire invece in maniera mirata gli uomini in
macchina con lui; raffiche sulle altre auto per colpire gli uomini della scorta.
Poi la mattanza e gli stessi killer che si spostano (tutti o in parte) da una
dislocazione di fuoco sulla sinistra del corteo delle auto alla destra delle
stesso per uccidere con 17 colpi Iozzino, l’unico uscito dall’auto per reagire,
e infliggere dei colpi di grazia scaricati su uomini già morti e che hanno come
conseguenza, per il rinculo delle armi, anche i colpi che si infilano sulla
sinistra fin dentro le abitazioni. Tutto questo, ricostruito con slide in 3D
sulla base dei dati delle autopsie, delle perizie balistiche e della
collocazione dei bossoli sul terreno, va a ricomporre la dinamica del 16 marzo
1978 smentendo in gran parte le stesse affermazioni dei brigatisti che
sostengono di aver sparato solo dal lato sinistro del corteo di auto. I
riscontri incrociati sui dati disponibili parlano infatti di 7
tiratori sul lato sinistro,
e non quattro come sostenuto prima dal memoriale Morucci che
ha «stabilizzato» la versione delle Br per via Fani, ed ora proposto nelle
analisi per la Commissione
Moro.
Audizione lunghissima stanotte per la commissione Moro che ha visto illustrare
due relazioni frutto di una complessa serie di accertamenti fatti dalla Polizia
scientifica e dai tecnici per conto della Commissione utilizzando le più moderne
tecniche di ricostruzione della scena del crimine. La prima relazione, di Laura
Tintisona,
ha “smontato” molte delle contraddizioni e degli elementi di dubbio avanzati da
alcuni libri negli ultimi mesi, chiarendo anche che le due auto presenti in
prossimità del corteo di Moro, cioè una Mini Clubman e una Mini Cooper, erano
intestate e in uso a persone che hanno dichiarato di non aver mai avuto rapporti
con i servizi segreti. Chiarito anche l’orario di arrivo di una Alfasud che
trasportava il Dottor Spinella a via Fani e interrogato anche il “signore con il
cappotto color cammello”, Bruno Barbaro, tra i primi a soccorrere gli uomini
della scorta, che ha confermato le precedenti testimonianze. Su ognuno dei
soggetti sono state fatti accertamenti approfonditi sia su possibili legami,
anche economici o imprenditoriali, con strutture dei servizi segreti, sia sulla
loro attività e sulla “logica” della loro presenza in via Fani quella mattina.
Altro passaggio importante quello delle armi usate. Sono state recuperate la
pistola Smith&Wesson e la pistola mitragliatrice Fna 43, il caricatore caduto a
Fiore in via Fani e altri reperti trovati in terra, tutti i bossoli e parte dei
proiettili. Mancano i proiettili rinvenuti sul corpo del maresciallo Leonardi,
due rinvenuti nell’Alfetta di scorta, i proiettili rinvenuti nella 130 e nella
Mini. In sede di perizia è stato trovato, in un pannello di una delle auto, un
proiettile. La perizia afferma anche che non sono state rilevate particolarità
sui bossoli di via Fani. La relazione di Federico Boffi ha riguardato la
ricostruzione in 3D. L’incrocio degli elementi indica che le macchine furono
colpite in movimento; che non ci fu un vero e proprio tamponamento e del
tentativi di “svincolamento” in retromarcia, come affermano i Br, ma solo dei
sobbalzi della macchina che si andò ad appoggiare alla 128 delle Br e che le
anomalie nei colpi sparati sul Maresciallo
Leonardi sono
spiegabili con il fatto che si era girato rispetto al punto di fuoco per cercare
di sottrarre ai colpi il Presidente Moro. Confermato che un secondo Fna sparò 49
colpi, ma l’arma ancora non è stata ritrovata. Miguel
Gotor (Pd)
ha fatto notare che i 4 tiratori rappresentano la versione minima data dalle Br
fin dall’inizio (poi smentita dalle successive acquisizioni) che cozza con il
racconto sciorinato nella memoria Br in cui si parla di un fucile inceppato, di
gente che se la faceva sotto, di pistole inefficienti, cambi di caricatore ecc.
Stesse perplessità da parte di Gero
Grassi.
La commissione trasmetterà alla magistratura l’insieme dei documenti e la
ricostruzione in 3D illustrata ai commissari.
Quella verità nascosta
sulla morte di Moro: Cossiga sapeva già tutto.
L'agente che ispezionò per primo la Renault 4 in via Caetani dimostra che
l'allora ministro mentì sui tempi dell'esecuzione, scrive Paolo Guzzanti,
Domenica, 30/06/2013 su “Il Giornale”. Oggi
proviamo soltanto rabbia perché è troppo tardi: i due che sapevano tutto se ne
sono andati in silenzio e per sempre: Cossiga e Andreotti. Il primo era anche un
mio amico, ma sapevo che su Moro mentiva. Oggi ne abbiamo una prova. Lo avevo
aggredito un paio di volte su questo tema, ma lui cambiava discorso. Andreotti
era rimasto una sfinge. Sapeva di Moro, sapeva di Falcone. La vitiligine, diceva
Cossiga: portava come prova del suo choc di fronte alla vista del cadavere di
Aldo Moro in via Caetani, il fatto che il suo corpo - viso e braccia in
particolare - si fosse coperto di macchie biancastre. Ho sempre pensato che
quella reazione sproporzionata dimostrasse che lui, Cossiga, fosse sopraffatto
più che dal dolore per una morte ampiamente annunciata, dalla traumatica
sorpresa: non se l'aspettava, aveva informazioni sbagliate. Era sicuro (con
Andreotti) di aver ottenuto la liberazione di Moro e invece si trovava di fronte
il suo cadavere. Ma adesso ne impariamo una nuova e la impariamo da Vitantonio
Raso che fu uno dei due antisabotatori che 35 anni fa, il 9 maggio del 1978,
scoprirono il cadavere di Moro nella Renault rossa due ore prima di quanto la
storia e i verbali abbiano tramandato. Lo racconta nel libro La bomba umana
scritto con il giornalista Paolo Cucchiarelli dell'Ansa. Ora sappiamo che
Cossiga arrivò subito dopo il ritrovamento e che ben lungi dall'essere
sconvolto, fu impassibile, freddo. Venne subito per constatare il ritrovamento
del cadavere, salvo due ore dopo ripetere l'intera scena, in seguito alla
telefonata ufficiale di Moretti. Ma quando la telefonata fu fatta, Moro era già
stato ritrovato. E ancora sanguinava di ferite fresche. Dunque fu trovato pochi
minuti dopo l'uccisione, o al massimo mezz'ora dopo. Eccoci dunque di fronte a
una messa in scena: le ore non sono quelle e neanche le reazioni e i sentimenti
sono quelli. C'è un prima sconosciuto e un dopo che fu creato soltanto per
l'opinione pubblica e la stampa. Una messinscena. C'è dunque una controstoria,
una storia vera che si sovrappone a quella di facciata e che si aggiunge alle
tante false storie e depistaggi che accompagnano la vicenda, la madre di tutti i
traumi della Repubblica, dei ricatti, delle falsità che inquinano la politica.
Cossiga dunque mentì. Oggi abbiamo anche - oltre all'annunciata uscita del libro
La bomba umana dell'agente Raso - la testimonianza a sostegno di questa novità,
dell'ex ministro socialista Claudio Signorile, allora titolare dei Trasporti nel
governo Craxi, il quale per puro caso era al Viminale per prendere un caffè con
Cossiga - «e non un aperitivo» come ha voluto sottolineare per spostare indietro
le lancette dell'orologio - il quale ricorda oggi che udì con Cossiga via radio
il messaggio in cui si diceva che due agenti anti sabotatori stavano forzando
una R4 sospetta in via Caetani, e poi che nel portabagagli della macchina era
stato rinvenuto il cadavere «della nota personalità», vale a dire di Moro. Raso
fornisce un'ulteriore informazione: le ferite mortali di Moro, ucciso con una
mitraglietta Skorpion, sembravano recentissime. Raso se ne intendeva perché
aveva visto le ferite mortali degli uomini della scorta di Moro in via Fani. Due
ore dopo l'eccidio, il sangue era già secco. Nel caso di Moro, il sangue ancora
sgorgava. E Cossiga, piombato sul posto con alcuni collaboratori del ministro
degli Interni si comportava, ricorda Raso, come se fosse già al corrente di
tutto e non fosse affatto sorpreso. E il trauma? E la vitiligine? La vitiligine
era vera, intendiamoci. E di sicuro quella malattia colpì la sua pelle quel
giorno e non prima, né dopo, ma il trauma doveva esserci stato in un momento
ancora precedente, quello del sopralluogo segreto. Ma quando Cossiga aveva
saputo? Moro fu eliminato proprio mentre era in corso a pochi metri dal luogo
del ritrovamento una riunione convocata da Amintore Fanfani per accettare la
richiesta dei sedicenti brigatisti rossi che chiedevano uno scambio: un
«prigioniero di Stato» contro Moro. Era fatta. Così sembrava. Ma il regista vero
dell'operazione Moro la pensava diversamente e prima che la Dc potesse
annunciare la decisione di cedere alle richieste delle Br, fece condurre Moro
probabilmente ancora vivo in via Caetani dove fu eliminato. Queste rivelazioni
riaprono, direi per fortuna, il caso Moro sul quale hanno indagato quattro
processi e una Commissione parlamentare d'inchiesta, senza mai venire a capo
della vera storia. Io presumo di aver capito un po' di più attraverso i lavori
della Commissione Mitrokhin di cui sono stato presidente e di cui fu un
animatore l'onorevole Enzo Fragalà, che poi fu assassinato. Si discuteva se le
Br che rapirono e uccisero Moro fossero composte soltanto da pretesi
rivoluzionari comunisti, o anche da altri elementi non italiani. La questione
era se le Br fossero state «eterodirette». Ebbene, la Commissione Mitrokhin fu
in grado di provare che le Br contenevano al proprio interno certamente elementi
che erano sotto il controllo del Kgb sovietico e della Stasi tedesca orientale.
Questa certezza fu raggiunta attraverso una rogatoria internazionale che si
svolse presso la Procura generale di Budapest nel dicembre del 2005, quando
durante una riunione cui parteciparono membri della Commissione il procuratore
ci mostrò una grande valigia piena di documenti in cui, disse, c'erano tutte le
prove dei legami fra terrorismo rosso e Kgb. In particolare fu fatto il nome del
brigatista Antonio Savasta che per quanto ne so è scomparso dalla circolazione.
Il giorno dopo a queste rivelazioni la Procura di Budapest ci comunicò con
rammarico di non poterci consegnare la documentazione a causa dei trattati
diplomatici che legano i Paesi dell'ex Patto di Varsavia con la Federazione
Russa. Ma quel che accadde a Budapest non ce lo siamo sognato. Cossiga, dopo il
ritrovamento del corpo di Moro, passò molto tempo andando in pellegrinaggio in
tutte le carceri in cui si trovavano i brigatisti con cui ebbe lunghissimi
colloqui. Da quel momento Cossiga impedì di fatto che qualcuno si azzardasse a
negare il carattere puramente italiano dei «compagni che sbagliano» e i
brigatisti uscirono quasi tutti di galera. Così Moro fu assassinato due volte.
Andreotti face parte della Commissione Mitrokhin e si comportò di fatto come un
sabotatore di tutte le ipotesi che potessero ricondurre alle responsabilità
sovietiche. La vera storia è ancora tutta da scrivere e la rivelazione di questo
testimone riapre uno spazio sigillato per decenni. Perché Cossiga mentì? Perché
già sapeva? Perché credeva di aver salvato Moro e invece fu beffato e
addirittura si ammalò per il trauma?
Ferdinando Imposimato:
"Aldo Moro ucciso dalle Br per volere di Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e
Nicola Lettieri",
scrive su
L'Huffington Post il
10/07/2013.
"L'uccisione di Moro è avvenuta per mano delle Brigate Rosse, ma anche e
soprattutto per il volere di Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e del
sottosegretario Nicola Lettieri". Ferdinando
Imposimato, al tempo giudice istruttore della vicenda del
sequestro e dell'uccisione di Moro, interviene sul Caso Moro. E lo fa da Reggio
Calabria, sul palco della rassegna Tabularasa dell'associazione Urba/Strill.it.
"Se non mi fossero stati
nascosti alcuni documenti - ha aggiunto - li avrei incriminati per concorso in
associazione per il fatto. I servizi segreti avevano scoperto dove le Br lo
nascondevano, così come i carabinieri. Il generale Dalla Chiesa avrebbe voluto
intervenire con i suoi uomini e la Polizia per liberarlo in tutta sicurezza, ma
due giorni prima dell'uccisione ricevettero l'ordine di abbandonare il luogo
attiguo a quello della prigionia". "Quei politici - ha detto Imposimato - sono
responsabili anche delle stragi: da Piazza Fontana a quelle di Via D'Amelio. Lo
specchietto per le allodole si chiama Gladio. A Falcone e Borsellino rimprovero
soltanto di non aver detto quanto sapevano, perché avevano capito e intuito
tutto, tacendo per rispetto delle istituzioni. Per ucciderli Cosa Nostra ha
eseguito il volere della Falange Armata, una frangia dei servizi segreti". Lo
stesso Imposimato all'inizio di giugno ha presentato un esposto alla Procura di
Roma. Secondo il giudice le forze dell'ordine sapevano dov'era la prigione di
Moro. Così i magistrati di Roma hanno aperto un fascicolo senza ipotesi di reato
né indagati aperto per valutare se esistano nuovi indizi per riaprire le
indagini sulla morte di Aldo Moro. "Massima fiducia nella volontà dei giudici di
accertare la verità sulla morte di Moro". Nel testo le rivelazioni di 4
appartenenti a forze dell'ordine e armate secondo cui il covo Br di via
Montalcini fu monitorato per settimane. Ma non è l'unica indagine che "riapre"
il Caso Moro. Le dichiarazioni di Imposimato arrivano dopo che la procura di
Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo alle
dichiarazioni di due artificieri che spostano alle 11 l'ora del ritrovamento
della Renault 4 con
il cadavere di Aldo Moro e la presenza dell'allora ministro degli Interni,
Francesco Cossiga, in via Caetani. Già, perché Vitantonio
Raso e il suo collega Giovanni Circhetta non
sono mai stati interrogati. E nei giorni scorsi hanno deciso di raccontare la
propria verità. Gli antisabotatori, che per primi arrivarono all'R4 rossa, con
il corpo di Moro nel bagagliaio, in via Caetani, il
9 di maggio di 35 anni fa,
spostano l'ora del ritrovamento dell'auto e del cadavere dello statista a prima
delle 11, mentre era delle 12.30 la famosa telefonata delle Br che annunciava
l'uccisione di Moro ed il luogo dove trovarne il corpo.
C’è chi dice no alla
riapertura del caso Moro. Strano a dirsi, è “Famiglia cristiana”…,
scrive Gloria Sabatini mercoledì 7 agosto 2013 su “Il Secolo d’Italia”. C’è chi
vuole la verità sui troppi buchi neri, sugli omissis,
sulle “strane coincidenze” che hanno caratterizzato il drammatico caso Moro, dal
sequestro del leader della Democrazia cristiana fino al ritrovamento del corpo a
via Fani. E
chi si accontenta della vulgata ufficiale e non vuole scavare oltre. C’è chi non
si arrende dopo 35 anni e chi non vuole che si continui a indagare perché… è già
è tutto noto. Ed è curioso che il portavoce del “partito” del no a una nuova
commissione d’inchiesta sul caso Moro sia Famiglia
Cristiana. E
non importa se l’iniziativa parlamentare per fare luce sui misteri e gli enigmi
di uno dei casi più amari del dopoguerra, promossa da Fioroni e Grassi, sia
stata sottoscritta dai capigruppo di Pd, Pdl, Scelta Civica, Sel, Fratelli
d’Italia, centrodemocratico, Lega e da altri novanta deputati. Nell’eloquente
pezzo a firma Anna Chiara Valle dal titolo Commissione
Moro? Non serve si
sostiene che, a differenza di Piazzale della Loggia, Piazza Fontana, Italicus,
Pecorelli, sulla morte di Aldo Moro si sa tutto. Questa la tesi del settimanale
di ispirazione cattolica, spesso criticato per le sue prese di posizioni da
associazioni ed esponenti del mondo cattolico, che hanno persino invocato
l’intervento del Vaticano. Non si contano gli interventi a gamba tesa
sull’attualità politica, l’ultimo dei quali l’invito a Berlusconi a «lasciare
per sempre» dopo gli attestati solidarietà dei suoi “cortigiani”. Eppure nuove
rivelazioni e dichiarazioni hanno riacceso i riflettori sul caso Moro lasciando
il sospetto, se non la certezza, che la morte del presidente Dc poteva essere
evitata. Non bastano per riaprire le carte le rivelazioni shock comparse in un
libro, in cui si sostiene che lo Stato sapesse della morte del politico
democristiano prima della telefonata delle Br, e le dichiarazioni di Imposimato,
che è stato ancora più diretto e pesante: «L’uccisione
di Moro è avvenuta per mano delle Brigate Rosse, ma anche e soprattutto per il
volere di Giulio Andreotti, di Francesco Cossiga e del sottosegretario Nicola
Lettieri»? Tutti e tre morti. L’esito dell’unica commissione d’inchiesta
istituita nel ’79 non portò a nulla se non alle rocambolesche testimonianze di
Prodi a proposito di una seduta spiritica durante la quale venne fuori il nome
“Gradoli”. Si fece un blitz in località Gradoli, senza esito, ignorando il
piccolo particolare che a Roma esistesse una via Gradoli. Questo è solo uno dei
tanti elementi che caratterizza l’incredibile coltre di fumo che circonda
tutt’ora il caso Moro, di cui si parla solo in occasione delle ricorrenze. Ma
per il settimanale cattolico diretto da don Antonio Sciortino si tratta di
«sensi di colpa, non di casi concreti». Tutti ormai acclarati, secondo il
settimanale, dopo le sentenze dei processi Moro quater e Moro quinquies e dopo i
risultati di una apposita Commissione bicamerale d’inchiesta. Poi la chicca
finale, che poco c’azzecca con le trattative del partito-Stato con le Br, per Famiglia
Cristiana «ci
si dovrebbe chiedere perché si sia riusciti a far luce quasi interamente sul
fenomeno del terrorismo di sinistra e si sia rimasti pressoché all’oscuro delle
trame eversive di destra». Insomma la commissione Moro non s’ha da fare né ora
né mai.
Moro, quei misteri mai
chiariti su Igor Markevitch e Giovanni Senzani,
scrive Roberto Frulli giovedì 7 maggio 2015 su “Il Secolo D’Italia”. Si
riaccendono i riflettori sull’enigmatica figura di Igor
Markevitch,
il direttore d’orchestra russo di origine ebree e naturalizzato italiano,
indicato da una fonte del Sismi degna
del maggior credito come uno degli uomini che interrogarono Moro.
Torna infatti in libreria il libro scritto a quattro mani da Giovanni
Fasanella e Giuseppe
Rocca – “La
storia di Igor Markevič” –
e riaffiorano domande rimaste incredibilmente per tanti anni senza risposta su
chi fosse davvero questo personaggio eclettico e multiforme, strettamente
imparentato con una delle più importanti famiglie della nobiltà romana, i Caetani,
attraverso la moglie, la duchessa
Topazia e
finito come attore primario nella vicenda drammatica del sequestro e
dell’omicidio dell’esponente democristiano assassinato dalle
Brigate Rosse.
E’ oramai ampiamente assodato, secondo un rapporto del Ros
dell’Arma,
che fu Giovanni
Senzani,
il “capo” mai entrato nella vicenda Moro,
a presentare Markevitch a Mario
Moretti.
Ma, incredibilmente, Senzani,
«personaggio di levatura intellettuale e politica di gran lunga superiore a
quella dei brigatisti finora noti e membro della direzione strategica brigatista
all’epoca del sequestro», spiega
Fasanella,
pur inquisito e condannato per reati compiuti prima e dopo il sequestro e l’omicidio
Moro,
non è mai comparso in un’inchiesta sul caso dell’esponente Dc. Insomma Senzani,
che pure rappresenta uno snodo fondamentale nelle vicende brigatiste quanto nel
sequestro e nell’omicidio Moro,
– viene ricordato soprattutto per il rapimento
di Roberto Peci,
“colpevole” di essere fratello del pentito
Patrizio Peci,
che Senzani interrogò
per settimane e di cui filmò minuziosamente l’esecuzione – è passato indenne in
tutti i processi senza mai essere chiamato a rendere conto di quanto sapeva. Ora
la nuova Commissione d’inchiesta creata per fra luce sulla vicenda Moro potrebbe
e, anzi, secondo
Fasanella,
dovrebbe convocare Senzani.
Perché davvero sono troppe le incongruenze e i punti che non tornano. A
cominciare dalla figura di Igor
Markevitch e
dal ruolo che ha avuto nella vicenda Moro dove
giocò da intermediario – «non da Grande vecchio», ci tiene a specificare Fasanella,
– tra alcuni servizi segreti esteri di rango e le Brigate Rosse per la
liberazione di Aldo Moro che era detentore di segreti Nato sensibili e in una
sua lettera a Cossiga, allora ministro dell’Interno, aveva minacciato di
rivelarli ai brigatisti. Peraltro, fa notare Fasanella, «nessuno ha mai chiarito
con elementi convincenti perché si scelse via
Caetani
per riconsegnare il cadavere
di Aldo Moro».
Roma era praticamente militarizzata. C’erano posti di blocco dappertutto. Era
più facile incappare in un controllo che sfuggirgli. E via castani si trovava al
centro di un quadrilatero fondamentale: da una parte c’era la sede del Pci di
via delle Botteghe Oscure, dal lato opposto c’era la sede della Democrazia
Cristiana di piazza del Gesù. Guarda caso via
Michelangelo Caetani la
strada dove fu lasciata dai brigasti rossi la Renault
4 rossa con
il
cadavere di Aldo Moro costeggia
proprio Palazzo
Caetani,
dove tra l’altro due agenti
del Sismi lo
avevano cercato mentre era ancora in vita. E i risultati dell’autopsia e gli
esami compiuti su alcuni materiali rinvenuti sulle ruote della Renault
rossa e
nei risvolti dei pantaloni di Moro,
hanno dimostrato che «il presidente
della Dc fu
assassinato non più di un’ora prima del ritrovamento del cadavere, e fu ucciso
in un luogo distante non più di 40 metri da via
Caetani».
Dunque Moro fu
tenuto prigioniero lì vicino. Dove? Forse proprio nelle secrete
sotterranee di Palazzo Caetani?
Ci sono molti, troppi, punti di contatto fra i personaggi e gli ambienti solo
apparentemente lontani. Sono gli stessi brigasti a spiegare gli inizi della loro
avventura che doveva essere la continuazione ideale, ma anche operativa, della
lotta partigiana. Le prime armi per i Br arrivarono proprio da lì. E Markevitch aveva
partecipato alla Resistenza nelle formazioni
partigiane “rosse” dei Gap.
Non solo. Un rapporto del Sismi datato
1980 recita testualmente: «Il 14 ottobre 1978 fonte del servizio segnalava che
un certo Igor,
della famiglia
dei duchi Caetani,
avrebbe avuto un ruolo di primo piano nell’organizzazione delle Br che,
in particolare, avrebbe condotto tutti gli interrogatori
di Moro,
della cui esecuzione sarebbero stati autori materiali certi “Anna” e “Franco”.
Markevitch, torna la pista fiorentina mai percorsa fino in fondo. L’idea che si
è fatta strada è che Markevitch fu
la testa pensante di quell’interrogatorio che, secondo gli analisti, mostrava,
nelle domande, un profilo psicologico non compatibile con quello dei brigatisti.
E che, inoltre, dato che il coordinamento del sequestro fu collocato a Firenze,
i brigasti furono ospitati e coordinati in una villa del capoluogo toscano nella
quale, durante i primi 15 giorni del sequestro Moro,
si riuniva il
Comitato esecutivo dei brigatisti.
Successive indagini giudiziarie hanno identificato questo immobile nel
feudo Caetani La Farnia,
a metà strada fra Firenze e Fiesole.
Secondo Fasanella, Igor
Markevitch era
sostanzialmente chiamato a gestire la vicenda per evitare «il rischio di una
grave destabilizzazione degli equilibri interni italiani e internazionali» che
sarebbero, appunto, derivati dai segreti
Nato di
cui Moro era
uno dei custodi. Ma qualcosa, forse, non andò com’era previsto che andasse.
Nelle ultime ore frenetiche, forse, addirittura, negli ultimi secondi di vita
dell’esponente Dc, «man mano che la trattativa procedeva, ci furono passaggi di
mano dell’ostaggio, a cui corrisposero anche trasferimenti fisici da un covo
all’altro. Alla fine, Moro arrivò
là dove avrebbero dovuto liberarlo. E dove, invece, fu assassinato». Di qui la
domanda ovvia. Ci sono elementi che la Commissione
Moro potrebbe
sviluppare nelle sue indagini su Igor?
«Sì. Innanzitutto dovrebbe cercare di spiegare perché Moro venne
assassinato, mentre invece la sua liberazione sembrava ormai certa. Quanto a Markevitch:
chi gli chiese di intervenire e perché venne chiesto proprio a lui? Aveva legami
con ambienti diplomatici, dell’intelligence e intellettuali che per varie
ragioni avevano avuto a che fare con il terrorismo?
La figura chiave per rispondere a queste domande è l’ex-brigatista fiorentino Giovanni
Senzani. Bisogna
ripartire da lui. E sarei davvero sorpreso – ammette
Fasanella –
se la Commissione parlamentare e la magistratura non avessero ancora deciso di
ascoltarlo».
Moro, 37 anni dopo emergono
le “verità indicibili” sul patto Dc-Br,
scrive Antonio Marras sabato 9 maggio 2015 su “Il Secolo D’Italia”. Sono passati
trentasette anni dalla morte di Aldo
Moro.
Il 9 maggio del 1978, il cadavere del giurista, ucciso dalle Brigate Rosse con
dieci cartucce dopo 55 giorni di sequestro, venne ritrovato in
via Caetani a Roma nel
portabagagli di una Renault 4 rossa rubata. L’auto venne parcheggiata dai
brigatisti vicino a piazza del Gesù, dov’era la sede nazionale della Democrazia
Cristiana, e a via delle Botteghe Oscure, dove si trovava la sede nazionale del
Partito Comunista Italiano. Commemorazioni e ricordi a parte, proprio in questi
giorni esce un libro con delle nuove rivelazioni su quel sequestro che cambiò
la storia d’Italia. È una vera e propria anatomia del delitto politico più
importante del 900 italiano quella scritta da Stefania
Limiti e Sandro
Provvisionato per
Chiarelettere. Di recente arrivato nelle librerie, “Complici. Il patto segreto
tra Dc e Br” passa al microscopio i momenti salienti del caso Moro e la
conclusione è impietosa: ci hanno raccontato solo una verità
“aggiustata”,
cioè frutto di un accordo tra i due protagonisti visibili, la
Dc e le Br,
entrambi intenzionati a non far emergere le zone indicibili della vicenda. Gli
uni per mantenere la propria purezza rivoluzionaria, gli altri per difendersi
dai sospetti di non aver saputo, o peggio voluto salvare la vita dell’uomo che
rappresentava il cuore del partito e come dissero le Br dello Stato. Sono tante
le cose raccontate ma non credibili a cominciare dal momento dell’agguato
a via Fani,
azione di alta precisione militare realizzata senza nessuna preparazione e con
un armamento composto da residuati bellici da un gruppo di brigatisti dal numero
ancora imprecisato: 10, 12, 9, non si sa. Più
di 90 proiettili sparati,
in un minuto e mezzo. Le perizie balistiche dicono anche che metà dei colpi
furono sparati da una sola arma mai ritrovata. Chi è il killer che spara a
raffiche brevi? Morucci ha raccontato che il suo mitra e quello di Fiore si
erano inceppati. E hanno perso diversi secondi per cercare di sbloccarli. Sulla
base delle perizie, inoltre, è sicuro – dicono gli autori – che c’era anche uno
sparatore molto preciso da destra: perché le Br lo negano? Tanti altri sono i
punti affatto spiegati: il rapporto tra il “dissociato” Morucci ed alcuni
emissari della Dc; il quarto uomo fu davvero Germano
Maccari? E
perché Raimondo Etro – secondo gli autori del libro – sarebbe stato indotto a
indicarlo tra i partecipanti ad una riunione al posto di Maurizio Iannelli per
rafforzarne il suo ruolo nel gruppo e quindi la responsabilità che poi gli fu
scaricata addosso, cioè di aver partecipato all’omicidio del Presidente della
Dc? Il diretto interessato, Raimondo
Etro,
nega di aver mai partecipato a quell’incontro e di aver mai chiesto di
“sostituire” Iannelli con Maccari perché sarebbe stato “più utile”, come
sostenuto nel libro: «Non mi spiego quale sia la fonte di questa ricostruzione
visto che nel libro è anche scritto che queste affermazioni non hanno mai
trovato conferma», chiarisce l’ex
terrorista Etro.
Ricostruita nei dettagli (e con non poche sorprese) anche tutta la vicenda del
ritrovamento delle carte nel covo in via Monte Nevoso. E infine perché la
Risoluzione della direzione strategica, cioè il bilancio finale dell’Operazione
Moro, fu scritta in gran parte dai brigatisti detenuti? Presentando il libro a
Milano, Alberto
Franceschini,
tra i fondatori delle Br, ha detto: “Ci arrivò in carcere solo una prima parte
di quel documento. Ho sempre avuto il sospetto che a scrivere quella parte sia
stato Giovanni
Senzani.
Lo stile era quello”. Senzani, cioè il “convitato di pietra” del caso Moro,
sempre sfuggito ad ogni inchiesta.
37 ANNI DOPO.
Ris indagano sui reperti di via Gradoli e sul DNA di Aldo Moro,
scrive l'11 agosto 2015 “Il Secolo XIX”. Come era già stato anticipato in
commissione Moro recentemente dal Presidente Giuseppe Fioroni, la commissione ha
dato incarico
al Ris dei carabinieri di
indagare su alcuni reperti di via Gradoli tenendo conto anche del profilo
genetico di Aldo Moro. Secondo quanto riferito da più fonti nella recente
relazione sul tema sarebbero stati prelevati alcuni reperti per compararlo con
il profilo genetico di Moro, compresi gli abiti che il Presidente indossava
quando venne ucciso. Nel
1978 non esistevano ancora gli esami del Dna e
il Ris sta lavorando per «estrarre» dai campioni il maggior numero di dati.
Intanto sono emersi tre «incroci testimoniali» che indicano che Moro può essere
stato per un certo periodo «prigioniero»
in via Gradoli ma non per forza nel covo Br al
secondo piano del civico 96 scala A interno 11. Una relazione di lavoro di uno
dei magistrati della commissione Moro, Antonia Giammaria - secondo quanto
riferito- ha riaperto il «dossier Gradoli» e ora si dovrebbe andare avanti in
questo ipotesi di lavoro quantomeno per chiarire la questione e far cadere certe
testimonianze accumulatesi nel tempo. La terna di riscontri riguardano Raffaele
Cutolo, Alessandro D’Ortenzi, vicino alla banda della Magliana e
punto di incontro tra questa e il criminologo Aldo Semerari e il nefrologo
Giovanni Pedroni, il «medico dell’Anello», il servizio segreto clandestino che
rispondeva politicamente a Giulio Andreotti. Interrogato recentemente Pedroni ha
confermato quanto detto in una intervista all’Ansa e ripetuto durante il
processo per la strage di Brescia e cioè che seppe direttamente che la struttura
di intelligence di cui faceva parte aveva saputo dal boss camorrista Raffaele
Cutolo che Moro era in via Gradoli che c’era la possibilità di intervenire ma
che dai
vertici politici ci fu un drammatico stop.
«Noi potevamo liberarlo, tranquillamente, senza problemi. La politica ci ha
sbarrato la strada affinché non intervenissimo. C’era un ordine superiore di non
intervenire, e potevamo farlo. Moro d’altra parte se l’è proprio cercata. Un
dato è certo: alle cancellerie internazionali Moro non piaceva per nulla;
Kissinger non lo poteva vedere. Aveva espressioni durissime per Moro che dava
fastidio in Italia ma anche all’estero. Si scelse di non intervenire, lasciando
le cose al loro destino. Lasciando che Moro venisse ucciso. Chi
fa fuori Moro? Le Br? Mah...
Non lo so». «Si è
deciso di lasciare morire Moro: le ragioni e il perché riguardano però la
politica». L’Anello si era preparato ad intervenire direttamente per la
liberazione, cosa questa che anche Cutolo aveva ipotizzato in cambio di un «via
libera» alla gestione della cocaina su Roma. Cutolo stesso in moltissime
dichiarazioni anche recenti («Se parlo io viene giù il Parlamento») ha sostenuto
che lui sapeva bene che Moro era in via Gradoli e che suoi uomini avrebbero
potuto liberarlo per consegnarlo «allo Stato». L’ultimo «incrocio» arriva da
D’Ortenzi che si
era rifugiato nel 1978 al n. 91 di via Gradoli che
è dirimpetto alle finestre della base Br. Da quell’osservatorio privilegiato
D’Ortenzi si rese subito conto che in quel luogo poteva esserci Moro e che la
polizia aveva fatto un «controllo» sullo strabile. Ora anche D’Ortenzi potrebbe
essere ascoltato, forse a settembre, mentre su Cutolo si deve ancora decidere
anche perché le sue dichiarazioni, anche processuali, sono sotto gli occhi di
tutti. Da anni. Un’altra novità è risultata dal fatto che nel covo Br di via
Gradoli durante il rapimento Moro abitava anche una
persona bionda «dagli occhi di ghiaccio» che
usciva dalla stabile la mattina molto presto vestito da aviatore o comunque con
una divisa che ricordava l’Aviazione commerciale. La nuova rivelazione arriva da
una testimone interrogata da uno dei magistrati della commissione che ha
riaperto il «dossier Gradoli».
Armida Chamoun, come aveva fatto nel 1978 il marito, ha raccontato che lo
stabile dove era il covo Br (lei viveva nel seminterrato del n.96) era
sottoposto ad una vera e propria «sorveglianza» all’ingresso del palazzo da un
gruppo di giovanotti, che la sera le lampade dell’ingresso dello stabile
venivano allentate per garantire oscurità; che c’era una coppia che saliva nel
covo Br indossando il casco da motociclista fin dentro l’appartamento e che si
era incontrata diverse volte sull’autobus che la portava da via Gradoli a via
Trionfale con un uomo biondo, con occhi azzurri, che la signora definisce «di
ghiaccio», e che lo stessa persona indossava una strana divisa da aviatore o
comunque azzurrina. Da ricordare che in Via Gradoli fu ritrovato l’elenco con
gli acquisti
fatti per vestire un uomo da aviatore (berretto,
divisa ecc.) In testa all’appunto una intestazione «Fritz». Lo stesso uomo fu
visto dalla Chamoun, come detto in un recente verbale che è ora in commissione,
nello stabile di via Gradoli 96 mentre scendeva dal covo Br sempre molto presto
la mattina. Durante un incontro sul portone «l’aviere» aveva scantonato
rapidamente per non incrociare la signora. Ora la commissione potrebbe
verificare se altri inquilini di via Gradoli abbiano
incrociato «l’aviere biondo dagli occhi di ghiaccio». Il dossier Gradoli,
seguito dal magistrato Giammaria, potrebbe riservare altre sorprese perché le
dichiarazioni Br su via Gradoli, su come e quando la base fu abbandonata, e se
la scoperta fu frutto solo di un genuino allagamento o di un «intervento»
esterno, sono piene di contraddizioni su tutti questi aspetti, contraddizione
che i magistrati della commissione intendono allineare e riscontrare. Ad esempio
il 5 novembre del 1993 una degli abitanti «ufficiali» dell’appartamento, Barbara
Balzerani, dice a verbale che la base fu
sgomberata il giorno di via Fani (16
marzo) ma che ciò non avvenne totalmente: «Ci siamo rientrati soltanto dopo la
fine del sequestro cioè il 9 maggio», il che è impossibile se si sta parlando
dello stesso appartamento scoperto il 18 aprile. «Insisto nel dire che la base è
caduta dopo la fine del sequestro e la caduta la daterei nell’estate del 1978».
L’8 novembre la Balzerani corregge il tiro: «La base è stata sgomberata la
mattina di via Fani.«Fui
io stessa a rientrarci per
prima dopo che erano venute meno alcune ragioni di sicurezza». Mario Moretti, il
compagno ufficiale della Balzerani in via Gradoli, dice che loro due uscirono
insieme la mattina del 18 aprile, cosa questa smentita da diverse testimonianze
degli inquilini anche perché quell’appartamento fu visitato dalla polizia tre
volte: il 18 marzo, il 25 marzo e il 18 aprile. Ci sono testimonianze anche di
inquilini che hanno parlato dei dialoghi che filtravano dalle mura della base
Br: in uno si sente una donna chiamare a gran voce “Gianni, Gianni”. E Moretti
si chiama Mario o se si tiene conto del nome di battaglia, “Maurizio”.
Moro, ecco i documenti
inediti dalla cassaforte della Fondazione Spadolini,
scrive Paolo Lami martedì 13 ottobre 2015 su “Il Secolo D’Italia”. Spuntano da
una cassaforte della Fondazione
Spadolini gli
ultimi documenti, inediti e segreti, sul sequestro di Aldo Moro. La Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro ha
acquisito da un armadio blindato della Fondazione
Spadolini a Firenze una
serie di appunti e note riguardanti colloqui inediti tra Giovanni
Spadolini e Francesco
Cossiga riguardanti
in gran parte la vicenda
Moro. I
documenti non appena digitalizzati saranno restituiti alla Fondazione dove erano
custoditi da tempo. «Ci sono molte carte segrete perché riguardanti aspetti
delicati della politica. Non memorie o altro ma corrispondenza oppure, come in
questo caso, resoconti sbobinati di colloqui registrati. Spadolini è morto da 21
anni ma stiamo ancora ordinando alcune carte e messo in ordine i 100.000 volumi
della sua biblioteca», spiega Cosimo
Ceccuti,
responsabile della Fondazione
Spadolini,
rivelando che «il magistrato ha esaminato il settore delle carte
segregate e, a sua discrezione, ne ha estratte alcune. La selezione è stata
fatta tra le carte che erano in cassaforte». Oltre ad una lettera di Cossiga,
nota, che ricostruisce l’atteggiamento del Pci subito
dopo la diffusione della
prima lettera di Moro all’allora ministro
dell’Interno (Pecchioli:
«L’onorevole Moro sia
che muoia sia che torni dalla prigionia per noi è morto») ci sarebbero gli
appunti, redatti da Spadolini,
inerenti alcuni colloqui con l’allora capo dello Stato. L’acquisizione sarebbe
avvenuta prima dell’estate da parte del magistrato Antonia
Giammaria anche
se erano destinate a rimanere segrete per 50 anni. Cossiga a
fronte di quell’episodio riguardante il Pci aveva allegato una serie di
documenti tutti noti (parte del memoriale
Morucci e
due lettere
di Moro).
Spadolini era
stato nominato da Moro esecutore
testamentario ma la cosa si seppe solo nel 1990 quando vennero ritrovate le
carte dietro il pannello della base
Br di via Monte Nevoso.
La documentazione inedita riguarderebbe alcuni bloc-notes
riservati sulla
questione Moro del
18-19 e 21 ottobre 1990 che sintetizzano colloqui inediti tra i due uomini
politici.
Spadolini era
rimasto sorpreso della nomina
di Moro e
aveva sostenuto che oltre alla lettere ritrovate ce ne erano sicuramente delle
altre.
Spadolini riportava
anche la posizione socialista che ipotizzava nella scoperta delle carte
di Moro una
iniziativa dei servizi
segreti americani o israeliani.
In un colloquio
Cossiga
informava
Spadolini di
una iniziativa della famiglia
Moro che
voleva intentare una causa civile sia contro Cossiga sia
contro
Andreotti per
non aver fatto abbastanza per liberare Moro e
aver impedito la trattativa.
Cossiga definiva
questa iniziativa possibile sul piano giuridico, inammissibile sul piano
politico.
Cossiga spiegava,
secondo gli appunti di Spadolini che
riportavano fedelmente le affermazioni di Cossiga,
che solo una minima parte della Dc esprimeva
solidarietà a Moro.
La Dc era
profondamente spaccata al suo interno. Spadolini riteneva
infondata la posizione socialista e si aspettava sostegno da Cossiga che
invece affermava che l’Italia,
in quel momento era il paese maggiormente in sintonia con il mondo arabo e che
l’interpretazione che ipotizzava una qualche azione o cointeressenza del Mossad non
poteva essere esclusa, pur non avendo di elementi concreti al riguardo. A
riscontro della sua tesi, Cossiga sosteneva
che uomini assolutamente insospettabili in Italia risultavano
aderenti al Mossad. Spadolini annota
che questa ultima affermazione, cioè che uomini assolutamente insospettabili
erano al servizio di Israele,
è l’aspetto centrale del colloquio con Cossiga.
Negli appunti si affronta anche il tema dei rapporti conflittuali tra la signora Moro e
due suoi figli e ci si dilungava sulla ipotizzata azione di risarcimento civile.
Altro appunto acquisto riguarderebbe l’incontro
al Quirinale tra Cossiga e il Comitato parlamentare per i servizi segreti sul
caso Gladio dove
si parlerebbe anche dell’interpretazione che dietro le Br ci
sarebbe
Gelli e
la P2. Cossiga parla
a lungo di una lettera ricevuta dal senatore
Imposimato che
esortava Cossigaa
non prestare attenzione all’ondata di allucinanti e vergognose farneticazioni
dei dietrologi di turno compreso un libro del senatore Flamigni. Imposimato chiudeva
la lettera a Cossiga
con questa affermazione: «La verità è una sola: dietro le Br c’erano
solo e soltanto le Br».
La
Commissione Moro acquisisce gli appunti inediti di Cossiga,
scrive “Il Gazzettino” il
13 Ottobre 2015.
La Commissione Moro ha acquisito da un armadio blindato della Fondazione
Spadolini a Firenze una serie di appunti e note riguardanti colloqui inediti tra
Giovanni Spadolini e Francesco Cossiga riguardanti in gran parte la vicenda
Moro. I documenti non appena digitalizzati saranno restituiti alla Fondazione
dove erano custoditi da tempo. A
quanto si è saputo, oltre ad una lettera di Cossiga, nota, che ricostruisce
l'atteggiamento del Pci subito dopo la diffusione della prima lettera di Moro
all'allora ministro dell'Interno (Pecchioli: «L'onorevole Moro sia che muoia sia
che torni dalla prigionia per noi è morto») ci sarebbero gli appunti, redatti da
Spadolini, su dei colloqui con l'allora capo dello Stato. L'acquisizione sarebbe
avvenuta prima dell'estate da parte del magistrato Antonia Giammaria anche se
erano destinate a rimanere segrete per 50 anni. Cossiga a fronte di
quell'episodio riguardante il Pci aveva allegato una serie di documenti tutti
noti (parte del memoriale Morucci e due lettere di Moro). Spadolini era stato
nominato da Moro esecutore testamentario ma la cosa si seppe solo nel 1990
quando vennero ritrovate le carte dietro il pannello della base Br di via Monte
Nevoso. La documentazione inedita riguarderebbe alcuni bloc-notes riservati
sulla questione Moro del 18-19 e 21 ottobre 1990 che sintetizzano colloqui
inediti tra i due uomini politici. Spadolini era rimasto sorpreso della nomina
di Moro e aveva sostenuto che oltre alla lettere ritrovate ce ne erano
sicuramente delle altre. Spadolini riportava anche la posizione socialista che
ipotizzava nella scoperta delle carte di Moro una iniziativa dei servizi
americani o israeliani. In un colloquio Cossiga informava Spadolini di una
iniziativa della famiglia Moro che voleva intentare una causa civile sia contro
Cossiga sia contro Andreotti per non aver fatto abbastanza per liberare Moro e
aver impedito la trattativa. Cossiga definiva questa iniziativa possibile sul
piano giuridico, inammissibile sul piano politico. Cossiga spiegava, secondo gli
appunti di Spadolini che riportavano fedelmente le affermazioni di Cossiga, che
solo una minima parte della Dc esprimeva solidarietà a Moro. La Dc era
profondamente spaccata al suo interno. Spadolini riteneva infondata la posizione
socialista e si aspettava sostegno da Cossiga che invece affermava che l'Italia,
in quel momento era il paese maggiormente in sintonia con il mondo arabo e che
l'interpretazione che ipotizzava una qualche azione o cointeressenza del Mossad
non poteva essere esclusa, pur non avendo di elementi concreti al riguardo. A
riscontro Cossiga sosteneva che uomini assolutamente insospettabili in Italia
risultavano aderenti al Mossad. Spadolini annota che questa ultima affermazione,
cioè che uomini assolutamente insospettabili erano al servizio di Israele, è
l'aspetto centrale del colloquio con Cossiga. Negli appunti si affronta anche il
tema dei rapporti conflittuali tra la signora Moro e due suoi figli e ci si
dilungava sulla ipotizzata azione di risarcimento civile. Altro appunto acquisto
riguarderebbe l'incontro al Quirinale tra Cossiga e il Comitato parlamentare per
i servizi segreti sul caso Gladio dove si parlerebbe anche dell'interpretazione
che dietro le Br ci sarebbe Gelli e la P2. Cossiga parla a lungo di una lettera
ricevuta dal Senatore Imposimato che esortava Cossiga a non prestare attenzione
all'ondata di allucinanti e vergognose farneticazioni dei dietrologi di turno
compreso un libro del senatore Flamigni. Imposimato chiudeva la lettera a
Cossiga con questa affermazione: «La verità è una sola: dietro le Br c'erano
solo e soltanto le Br».
Caso Moro, sapremo mai la
verità? Si
chiede Alessandro
Ceccarelli il
24 marzo 2014
su Dazebao.
Nuove polemiche dopo le rivelazioni di un ispettore di polizia oggi in pensione.
“Quando
si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre
illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi”. (Aldo Moro). Proprio la
scorsa settimana è ricorso il 36° anniversario del rapimento di Aldo Moro e del
massacro dei cinque agenti della scorta da parte delle Brigate rosse. Cinque
processi, il primo nel 1983 e l’ultimo nel 1999, non sono bastati per fare
chiarezza sull’episodio più drammatico della nostra storia repubblicana. Dopo la
morte dello statista democristiano l’Italia non fu più la stessa. Anche il
Partito Comunista dopo l’assassinio del suo interlocutore preferito (per il
compromesso storico, ndr), iniziò il suo lento e inesorabile declino. Le ultime
rivelazioni di un ex ispettore di polizia oggi in pensione, tal Enrico Rossi,
hanno scatenato i polemisti, i dietrologisti e i complottisti. Intanto il
Procuratore Generale della Capitale, Luigi Ciampoli, ha chiesto gli atti
dell’indagine alla Procura di piazzale Clodio per “le opportune valutazioni”.
Che cosa ha detto l’ex ispettore di polizia di così sconvolgente? In estrema
sintesi, uomini dei servizi segreti (Sismi) quel giorno (16 marzo 1978) erano in
via Fani, angolo via Stresa per “proteggere” il blitz dei nove brigatisti contro
Aldo Moro e la sua scorta. “Anche se la politica non vuole occuparsi del caso
Moro, i suoi misteri sono destinati a rivelarsi nel corso del tempo. Le novità
di oggi sono sconvolgenti e mettono a tacere i detrattori della nuova
Commissione d’inchiesta. Il merito va a quel giornalismo d’inchiesta che sa
muoversi con cautela, indipendenza e determinazione”. Lo afferma Gero Grassi,
vicepresidente dei deputati del Pd, riguardo alle ultime rivelazioni di un
ispettore di Polizia in pensione, Enrico Rossi, su una lettera anonima scritta
dall’uomo che era sul sellino posteriore dell’Honda in via Fani quando fu rapito
Moro. Nella missiva l’uomo sosteneva di essere alle dipendenze dell’ufficiale
del Sismi che si trovava in via Fani all’ora del rapimento, e di avere avuto il
compito di “proteggere le Brigate rosse da ogni disturbo”. “Ora – avverte
Grassi, promotore della proposta di legge che istituisce l’organismo
parlamentare di cui si attende l’approvazione al Senato- non si potrà più dire
che l’agguato di Mario Fani fu il frutto della geometrica potenza delle Brigate
Rosse che furono in realtà quantomeno osservate e tutelate nei loro propositi.
Era del resto scritto negli atti della Magistratura che l’evento di via Fani non
era riconducibile solo alle Brigate Rosse. Lo hanno dichiarato più volte Alberto
Franceschini e la vedova del maresciallo Oreste Leonardi: i nodi critici della
mattina del 16 marzo sono tutti inseriti nel dossier ‘Moro’ pubblicato dal
Gruppo Pd della Camera che evidentemente aveva visto giusto”. “A questo punto
-conclude- abbiamo la responsabilità di raccogliere questa ed altre recenti
novità e tentare di ricostruire una nuova versione dei fatti per capire chi ha
tramato per ottenere la morte di Moro”. Della necessità di una commissione
d’inchiesta parla anche il deputato del Pd Davide Zoggia: “Quello che sta
emergendo in queste ore, in merito al rapimento e all’uccisione di Moro e della
sua scorta, dimostra l’assoluta necessità della costituzione di una Commissione
d’inchiesta, come già deliberato dalla Camera. Ora si tratta di accelerare
perché anche il Senato la approvi, cosicché si possa partire immediatamente per
contribuire a fare chiarezza su uno dei casi che ha cambiato la storia del
Paese”. Stessa linea quella del senatore Andrea Marcucci (Pd), presidente della
commissione Cultura a Palazzo Madama: “Le rivelazioni di queste ore sulle
presenze in via Fani durante il rapimento di Aldo Moro confermano la assoluta
necessità di ricostituire una Commissione di inchiesta parlamentare. Dopo il via
libera della Camera, il Pd chiederà una rapida approvazione anche in Senato. A
distanza di 36 anni, forse è più facile arrivare alla verità oggi, in un
contesto nazionale ed internazionale completamente cambiato”.
Chi volle la morte di Moro? Dopo quattro libri Pierfranco Bruni
pubblica un testo scioccante sulla morte dello statista.
Pierfranco Bruni protagonista di quegli anni in una Roma di fuoco, pubblica un
testo scioccante sul partito della fermezza che vide insieme i comunisti e i
democristiani rileggendo tutte le lettere dello statista e le pagine dei
quotidiani del 1978, scrive il
14 gennaio 2016
"La Voce di Maruggio”.
Chi volle affossare le trattative per cercare di salvare Aldo Moro? Chi
moralmente è responsabile? Chi giudico’ lo statista rapito un uomo folle? Chi si
affidò ad una seduta spiritica? Pierfranco
Bruni,
attento testimone e proragonista di quegli anni, in occasione del centenario
della nascita di Aldo Moro (1916 – 2016) attraversa, in un nuovo romanzo –
saggio, il destino tragico di una stagione di terrore tra le macerie degli anni
di piombo e il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Bruni rilegge le
drammatiche ultime lettere dello statista ucciso nel 1978 in un testo dal
titolo: “Il
perduto equilibrio”,
editore “Il
Coscile”,
Castrovillari (0981 22632), già in libreria. Con un sottotitolo preciso: “Nei
giorni tristi di Aldo Moro”.
Al centro del libro c’è la storia d’amore e la passione di due giovani che si
raccontano raccontando i giorni di fuoco in una città misteriosa, lacerante e
devastata come Roma. Si incontrano a Piazza di Spagna, tra le vie di Roma,
all’Università e si amano nella disperazione di capire il dolore che
attraversava un tempo tragico. Marika, una terrorista della quale si perdono le
tracce (e si scopre, alla fine, che viene uccisa in uno scontro con le forze
dell’ordine) e un io narrante che definisce una temperie di guerriglia in una
meditazione non solo meramente politica ma anche umana e profondamente legata
alla storia di un intreccio ideologico. Un libro, che fa riflettere anche per le
proiezioni letterarie e culturali e per le metafore che fanno da sfondo al
percorso narrante. Bruni rimette in campo la metafora di Alice (Moro) nel Paese
delle Meraviglie (un’Italia illusa e disillusa) in un contesto in cui il
processo politico si disputava tra la “libertà” della fermezza e la “libertà”
della trattativa. La disperazione che ha portato alla morte di Moro si intreccia
con la disperazione di un amore che rivela un vuoto di coscienze e il senso del
perduto tra due giovani che avrebbero potuto vivere oltre la stessa ideologia il
loro amore come favola e incantesimo. Gli anni di piombo distruggono anche la
fantasia degli amori. Nel romanzo, che ricostruisce la stagione degli anni di
piombo, Pierfranco Bruni sottolinea una precisa posizione che è quella che Moro
si sarebbe potuto salvare se non fosse stata adottata la strategia della
fermezza da parte di alcuni partiti politici. Il libro, nel ricostruire quella
vicenda, pone all’attenzione anche uno stato d’animo che travagliava la
generazione dei ventenni che allora discutevano di politica e frequentavano gli
ambienti universitari. Un libro che raccorda storia ed emozioni nel racconto
stesso di due giovani che parlano di amore, passione e rivoluzione. Il concetto
di “rivoluzione” diventa la chiave di lettura sia sul piano politico –
ideologico che su quello strettamente sentimentale – passionale. Eros e morte
sono costantemente in conflitto. Marika è eros ma è anche la bellezza infranta
dall’ideologia della morte. Bruni sostiene, tra l’altro, che la vicenda Moro non
fu ben capita né a sinistra né a destra. Sia la sinistra che la destra tirarono
in ballo la “ragion di Stato”. Da questo punto di vista Bruni condivide la
posizione di Leonardo Sciascia posta nel 1978 con “L’Affaire Moro”. Il partito
della fermezza non capì la vera questione. Pierfranco Bruni aveva già affrontato
questa problematica in altri romanzi. Già nel 1998 aveva pubblicato il romanzo
“L’ultima primavera. Aldo Moro, la tragedia di uno statista” che ha avuto tre
edizioni. Nel 2004 un altro importante romanzo, dal titolo “Quando fioriscono i
rovi”, filtra gli anni di piombo con la presenza di Moro all’interno di un
contesto poetico – lirico, in cui l’amore è rivoluzione e l’ideologia resta la
vera devastazione che ha colpito gli anni di piombo. “Il
perduto equilibrio.
Nei giorni tristi di Aldo Moro” ritorna come riferimento fondamentale per
riportare sulla scena il personaggio di Marika, la passione e la metafora di
Moro – Alice nel Paese delle Meraviglie. Ci sono capitoli molto duri nei quali
si legge: “Si può morire al momento giusto? È un grido. Un urlo che non smette
di farsi eco. Dalle grotte degli anni continua a farsi ascoltare. La morte
giunge al momento giusto. La metafora è un agguato. Le metafore sono un agguato.
Tra le parole creano ferite. Ma solo tra le parole si possono capire le
metafore. “Ci
si perde e ci si ritrova tra le pieghe di un raccontare che non racconta perché
le metafore non hanno il senso del narrativo. Restano fisse nell’oblò delle
immagini. E questa morte che giunge al momento giusto è una morte ingiusta… Ma
può giudicarsi giusta la morte, una morte… Questa morte…”.
Oppure: “Guardare
al dopo domani. Mi pare che sia una osservazione profetica questa di Aldo Moro.
Soprattutto negli anni successivi alla sua tragica morte si sono consumati nei
viali della tristezza i valori di un umanesimo che doveva stare al centro di una
politica testimoniata. Chi ha vissuto il tempo delle idee non può che
testimoniarsi oltre ogni ideologia”.
Il 1978 resta centrale, sostiene Bruni, e il libro va alla ricerca di alcune
motivazioni che proprio nel corso del rapimento Moro esplosero. “Un
anno terribile.Mentre si leggeva Il suicidio della rivoluzione di Augusto Del
Noce – dice Bruni – c’era qualcuno che la rivoluzione si illudeva di farla
realmente. Ma Moro rappresentava proprio la centralità di una situazione che
stava per esplodere definitivamente. Moro era cosciente di ciò. Da allora, sul
piano politico, sono cambiate tante cose. La fine della Dc è cominciata con la
morte di Moro. E’ tempo ormai non di interpretare i fatti ma di entrare dentro i
fatti attraverso la lettura di una realtà sia di politica nazionale che
internazionale”.
Il testo di Bruni presenta alcuni aspetti di una marcata lirica tragicità e
riporta sulla scena le lettere che Moro scrisse dal “carcere”
delle Brigate rosse e che furono diffuse proprio nel corso dei cinquantacinque
giorni della prigionia dello statista democristiano offrendo una incisiva
meditazione attraverso un’ampia discussione problematica sia storica che
politica stessa. Le lettere dello statista democristiano, sostiene Bruni,
offrivano una precisa chiave di lettura. Tra l’altro Bruni analizza il tempo di
una generazione e, attraverso annotazioni di diario personale, ripercorre la
storia di un giovane degli anni Settanta che si lascia alle spalle una madre
cattolica e profondamente democristiana e un padre fascista e nostalgico del
Mussolini regime. Tutto questo all’interno di una tragedia che accomunava una
generazione. Ma è la storia d’amore con il personaggio di Marika, bella,
sfuggente che ha gli occhi di “verde
luna”, che
campeggia lungo i giorni tristi della tragedia di Aldo Moro. Oggi, questo testo,
nel centenario della nascita dello statista, si presenta di grande attualità ed
emerge chiaro un preciso atto di accusa rivolto a tutti coloro che non capirono
la portata tragica degli avvenimenti e non diedero ascolto al messaggio umano
proveniente da quelle drammatiche lettere. La voce di Moro continua ancora oggi
in un recitativo drammatico. Un libro che affronta con spirito critico e
coraggioso una tragedia in una dimensione tra storia e letteratura.
SEQUESTRO
MORO TRA MONTANELLI E SCIASCIA.
Montanelli e Sciascia,
scrive
Valter Vecellio il 9 gennaio 2016 su “L’Opinione”.
Le biblioteche private, è noto, “parlano”, dicono tanto di una persona. I libri
allineati negli scaffali, se li si sa interrogare raccontano molto dei loro
proprietari, i loro interessi, il tipo di “percorso” di una vita: prima certi
autori, visceralmente amati, e poi sostituiti da altri; i segni sul dorso, le
sottolineature e le notazioni; la stessa collocazione ci dicono quali sono i
preferiti, quelli a cui si chiede “consiglio”; quelli che sono “invecchiati”,
riposti dopo una breve o lunga frequentazione, in scaffali più periferici: li si
guarda ogni tanto con un misto di tenerezza, pensando magari alle ore sudate su
quelle pagine ingiallite che poco o nulla hanno poi lasciato… Ci sono i libri
preziosi, anche nella veste tipografica, quelli che ci si può permettere quando
il denaro non è più un problema; magari a fianco di edizioni “povere”,
economiche: preziosi perché acquistati con le poche monete che da ragazzi
ballano quasi sole in tasca. Un’abitazione priva di libri rivela molto del suo
“inquilino”, quasi sempre è consigliabile diffidarne. Una abitazione dove i
libri abbondano, al contrario fornisce una quantità di indizi che può essere
divertente cercare di cogliere. A patto, beninteso, di saper e voler vedere, e
non solo guardare. Per questo sono interessanti, importanti i repertori che
raccolgono titoli di volumi di uno scrittore, un artista, perfino un politico.
Lo stesso ordine di collocazione: la “geometria” scelta, oppure allineati per
argomenti, genere; o per autore; o alla rinfusa, come viene… E si viene
afferrati da un senso di malinconia, quando si constata che un certo volume è
vergine, non lo si è neppure sfogliato, che le sue pagine sono addirittura
intonse. Il suo possessore magari potrà sostenere, a sua difesa, che ha un
rispetto maniacale dell’oggetto libro, che intenzionalmente è ha cura di non
lasciare alcuna traccia. Balle. Lo si vede, c’è sempre un lievissimo segno,
quando un libro lo si “vive”. I libri di un autore, dunque. Recentemente è stato
pubblicato un volume, “Tra i libri di Indro”, curato da Federica Depaolis; come
informa la nota editoriale, “la
libreria personale del grande giornalista (Indro Montanelli, appunto, ndr.),
oggi conservata presso la Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, viene qui
indagata alla luce della recente riflessione sulle biblioteche d’autore. Ne
viene fuori un viaggio tra i libri di Indro, quelli che sono giunti fino a noi,
col loro carico di segni e indizi nascosti, e quelli che pur avendo giocato un
ruolo chiave nella formazione montanelliana hanno lasciato tracce fragili o
addirittura inesistenti sugli attuali scaffali d’autore”.
Premessa fondamentale, opportunamente lo rileva Marcello Staglieno nel saggio
introduttivo: “Con attenta cura, Federica Depaolis guarda, negli anni, sia allo
stratificarsi della libreria montanelliana sia ai suoi periodici ‘smagrimenti’,
sino alla consistenza attuale. Prima tiene conto dei successivi spostamenti
della famiglia da Fucecchio a Rieti e a Nuoro, quindi insegue Indro nei
venturosi spostamenti in mezz’Europa e nel continente americano, in un
peregrinare che si conclude con il suo approdo al ‘Corriere della Sera’…”. Si
sta comunque parlando di un personaggio, di un grande giornalista, consapevole
dei suoi limiti e delle sue pigrizie: “Io
potrei avere un grossissimo archivio di cose interessanti che non si potevano
scrivere ma che avevano qualche diritto di essere registrate…Invece per
pigrizia, per disordine, per incapacità di un lavoro ordinato, ho lasciato
perdere. E’ un mio delitto”.
La fondazione Montanelli-Bassi di Fucecchio è qualcosa che merita una visita e
una riflessione per quello che è e rappresenta; qui, quello che interessa e
preme è indagare sull’intreccio tra due personaggi che molto hanno in comune e
al tempo stesso non possono essere più diversi: per interessi, stile di vita,
percorsi umani e culturali: Montanelli e Leonardo Sciascia. I due si conoscono,
si frequentano, si “seguono”. Spesso le loro scelte divergono, ma si stimano,
non è arbitrario dire che sono amici. Giuseppe Traina in quell’utilissimo
baedeker per orientarsi nell’opera sciasciana che è “Leonardo Sciascia”, scrive
del piacere che lo scrittore prova ogni volta che approda a Milano: “la
città italiana che ama di più per le memorie manzoniane e stendhaliane che
conserva, per gli amici che vi ritrova: Scianna, Montanelli, Sciardelli e
Consolo, il critico e manzonista Giancarlo Vigorelli, lo scrittore Daniele Del
Giudice, lo stendhalista Gian Franco Grechi, i giornalisti Enzo Biafi, Piero
Ostellino, Matteo Collura…”.
Quando poi decide di candidarsi al Parlamento nelle liste radicali, da
Montanelli viene una sorta di avallo, perché per lui Pannella e i radicali sono
“figli
non degeneri, soltanto un po’ discoli di un certo filone liberaldemocratico”.
Quando chiedono a Sciascia cosa pensi di questo giudizio, lo scrittore risponde
che si tratta di “un’analisi
abbastanza probante, direi…E il consenso di Montanelli non mi impressiona, non
mi imbarazza”.
Una significativa traccia di questo rapporto amicale la troviamo in “Lettere
dal centro del mondo”, il carteggio durato una vita tra Mario La Cava e
Sciascia, amorevolmente curato da Milly Curcio e Luigi Tassoni. Il 9 marzo del
1971 La Cava scrive: “In un articolo di Montanelli ti vedo accomunato ai grandi.
Insomma sei trattato bene…”. “I grandi”: Montanelli lo ribadisce su “Il
Giornale” del 21 novembre 1989, ha appena saputo della morte di Sciascia: “Sciascia
ci ha detto addio alla Sciascia; senza una parola. L’ultima, o una delle ultime,
l’ha rivolta per posta a me: un biglietto vergato con grafia malferma, che
diceva tra l’altro: ‘Mi annoio (alla lettera) mortalmente’, ed è l’unica
allusione che facesse, nonostante le sofferenze, alla sua imminente fine. Non
aveva mai voluto parlare (se non – credo – qualche volta con Bufalino con
impegno di segreto), della sua malattia. Era una delle tante cose, se non tutte,
di cui Sciascia non parlava. In questa Italia garrula dove tutti parlano di
tutto, si potrebbe scrivere un saggio sui silenzi di Sciascia…Io lo considero
l’ultimo cui si convenga la qualifica di ‘grande’. Non pretendo di aver
penetrato i segreti di Sciascia. Ma due cose credo di aver capito bene, di lui:
la sua assoluta, direi irrefrenabile, libertà, e il coraggio della solitudine.
Il vuoto ch’egli lascia come scrittore è certamente grande: nessuno saprà mai
più darci gli ‘spaccati’ di Sicilia che ci dava lui. Ma ancora più grande è il
vuoto che lascia come uomo. Di rispetto o meno, e qualunque cosa voglia dire, in
siciliano, questa parola”.
Ci sono, lì a
Fucecchio, tra le migliaia di libri conservati, quelli di Sciascia? Sì, ce ne
sono: il repertorio li colloca tra il 1572 al 1582. Nel dettaglio: “A futura
memoria: se la memoria ha un futuro”; “Atti relativi alla morte di Raymond
Roussel”, due copie; “La corda pazza: scrittori e cose della Sicilia”; “Dalle
parti degli infedeli”; “Nero su nero”; due copie, la prima edizione Einaudi, e
la successiva di Adelphi; “Le parrocchie di Regalpetra”; “Morte
dell’Inquisitore”; “Porte Aperte”; “I pugnalatori”; “La scomparsa di Majorana”;
“Una storia semplice”, due copie. Curiose queste “presenze”; e ancor più curiose
le “assenze”. Possibile che Montanelli non abbia avuto tra le mani, e non abbia
attentamente compulsato “Il giorno della civetta”? E “A ciascuno il suo”? Per
non dire di “Todo Modo”, o de “Il contesto”… E manca anche uno dei più belli e
intensi: “Il mare colore del vino”. Possibile che si siano persi in traslochi e
cambi di abitazione; meno probabile che siano rimasti vittime dei periodici
“smagrimenti”. Fatto è che non ci sono, lì a Fucecchio, dove si è avuto cura di
riprodurre, tra l’altro la “Stanza” di Montanelli a Roma e a Milano: ricostruite
secondo l’allestimento originario; e manca anche un libro importante della
produzione sciasciana: “l’Affaire Moro”. In quel libro, oltre che in
articoli per giornali e in una quantità di interviste, Sciascia sostiene che
Aldo Moro rapito (e poi ucciso) dalle Brigate Rosse, quando scrive le lettere
nel disperato tentativo di guadagnare tempo e di convincere le istituzioni e la
politica a un qualche tipo di “trattativa”, era lui, proprio lui. Non è
manipolato, drogato, plagiato, come certi suoi amici sostengono non c’è un
“suggeritore”. E’ il Moro di sempre. Quel pamphlet solleva, ancora prima di
uscire, feroci, violentissime polemiche; da parte soprattutto del PCI, per quel
che riguarda i partiti; e “La Repubblica” di Eugenio Scalfari, tra i giornali.
Anche Montanelli si schiera in quello che viene battezzato il “partito della
fermezza”, ma sue sono ragioni diverse da quelle dei comunisti, di Scalfari. Lo
spiega bene, anni dopo, nella risposta a un lettore, il signor Giuliano
Castiglia di Cefalù. Montanelli da tempo ha lasciato il “Giornale”, la breve e
sfortunata stagione de “La Voce” è alle spalle; è tornato al “Corriere della
Sera”. Il 14 settembre del 1999 scrive: “Caro
Castiglia, debbo confessare che sull’affare Moro mi trovai (ma solo nelle nostre
private conversazioni) in disaccordo con Sciascia, perché a Moro io non
concedevo gli alibi che Leonardo invece gli riconosceva. Il nostro contrasto,
per ridurlo all’osso, consisteva in questo. Io, nel mio realismo
guicciardiniano, dicevo (e continuo a dire): a me i sentimenti, i rovelli, i
cedimenti e le astuzie di Moro non interessano perché un uomo di Stato, che
dello Stato scala la vetta fino a diventarne, come Moro era diventato,
l’incarnazione e il simbolo, dai sentimenti e dai rovelli non può lasciarsi
dominare. In mano ai terroristi, l’uomo Moro ha tutto il diritto di avere paura,
come certamente l’avrei io, se mi trovassi nelle sue condizioni. Ma l’uomo di
Stato Moro non può chiedere allo Stato di genuflettersi davanti alla violenza,
come Moro faceva nelle sue pietose (in tutti i sensi) lettere, e di scendere a
patti con essa. Ecco il mio dissenso da Sciascia, che mai incise sulla nostra
amicizia, e che durò fino a quando ci accorgemmo che non parlavamo della stessa
cosa. Io lo parlavo da giornalista impegnato (se lei mi concede di attribuirmi
queste altre due qualifiche), da storico e da moralista. Sciascia parlava da
romanziere, che in Moro riconosceva, o credeva di riconoscere, uno dei
personaggi della sua narrativa intesa a smontarne e a ricostruirne, da maestro
qual era, i ghirigori psicologici, le ambiguità, gli autoinganni. Non voleva né
condannarlo né assolverlo. Voleva soltanto spiegarlo. Quando io gli parlavo
dello Stato e dei doveri ch’esso impone, capivo che non mi seguiva. A lui
interessava l’uomo, non lo statista. Di tutti coloro che sostenevano la tesi
della trattativa, Sciascia è l’unico che non mi abbia fatto arrabbiare. Prima di
tutto perché tenevo troppo alla sua amicizia (come credo che lui tenesse alla
mia) per metterla in forse su una questione di principio. Eppoi perché anche se
lui non capiva me quando parlavo dello Stato che lui, da buon siciliano,
considerava, se non una fanfaluca, certamente una pura astrazione, io capivo lui
quando parlava dell’uomo Moro, anche se in quello che nella sua tortuosità
ricostruiva lui, io non riconoscevo affatto quello vero, quali sono invece,
scolpiti nel granito, i personaggi della sua narrativa. Amici siciliani,
tenetevelo caro, Sciascia. Non solo come scrittore, ma anche come siciliano.
Nessuno lo è stato più e meglio di lui. Le accuse che gli sono state lanciate, o
meglio insinuate, di eccessiva indulgenza verso la mafia sono del tutto fuori
bersaglio. Sciascia non ha mai giudicato la mafia; l’ha spiegata, anche se non
posso escludere che ne andasse un po’ fiero in quanto parte (e che parte!) della
sua sicilianitudine, come il ficodindia lo è del suo paesaggio”.
A Sciascia si
rimprovera tutto: quello che scrive e dice; e anche il silenzio (lo fa il
direttore di “Paese Sera” Aniello Coppola). Insomma, non va bene nulla;
soprattutto non va bene il rifiuto di Sciascia di “intrupparsi”, il suo non
voler essere “sentinella”; gli si incolla la paternità dello slogan “Né con lo
Stato, né con le Brigate Rosse”. Tutto “solo” perché si ostina a ragionare in
proprio, con la sua testa. Qualcosa di imperdonabile, allora come ora; come
sempre. Tra i pochi che difendono Sciascia, c’è Montanelli, che pure sostiene le
ragioni della “linea della fermezza”. E’ al “Giornale” dell’amico Montanelli,
che Sciascia, l’11 ottobre del 1978, affida una “lettera al direttore” dove
sviluppa e chiarisce le sue ragioni: “Caro
Montanelli, vedo con ritardo, qui in campagna, il tuo articolo sul ‘Giornale’
del 23 settembre. Mi dispiace che anche tu abbia scritto di questo mio pamphlet
sul caso Moro prima di conoscerlo interamente; e ancora di più mi dispiace che
intitolando il tuo articolo ‘Todo Modo’, e riferendolo al mio racconto ‘Todo
Modo’ di fatto parlato di un libro che io non ho mai scritto. ‘Todo Modo’ non
descrive, come invece tu affermi, ‘una vicenda sorprendentemente analoga a
quella di via Fani e con un protagonista sorprendentemente simile a Moro,
riprodotto in una versione così ripugnante che quasi giustifica il delitto’. Per
nulla. Protagonista di ‘Todo Modo’ è un prete; e non ripugnante. Non c’è nel
racconto un solo elemento che ricordi l’agguato di via Fani. Ma lasciando da
parte questo errore, che tu certamente riconoscerai davanti ai tuoi lettori,
quel che desidero discutere con te è il personaggio Modo e il suo comportamento
nella vicenda in cui è rimasto vittima. Dal momento in cui ho deciso di scrivere
un libro sull’affaire Moro, e fino a oggi, ho vissuto e vivo come una esperienza
religiosa, come un processo di reversibilità. Illuminista per come ‘l’Unità’ mi
etichetta, laico e laicista, incommensurabilmente lontano dal Moro cattolico e
dal Moro democristiano, ho sentito religiosamente il dovere di riscattare Moro
prigioniero e vittima delle BR dalla vita in cui l’avete relegato. Anche tu,
purtroppo. Ed è quello che non capisco. Capisco che questa operazione la
facciano i vili. Capisco che la facciano certi cattolici. Capisco che la
facciano certi retori. Non capisco che la faccia un uomo libero, un laico in
ogni senso laico. Che tu ti sia nettamente posto dalla parte di coloro che non
volevano che lo Stato cedesse al ricatto, lo capisco benissimo; e lo dico anche
nel libro che sta per uscire. Non capisco però il bisogno di giustificare la tua
posizione, in sé legittima, adducendo come controparte il comportamento di Moro.
Per capire, dovrei attribuirti un senso di colpa; e quindi anche se inconscia,
una certa malafede. Io credo che certe tue prese di posizione che sembrano
fredde o addirittura ciniche siano dettate da emotività e passione. Mi
piacerebbe invece che tu avessi tanta freddezza da far tabula rasa della tua
passione per lo Stato e da metterti di fronte a tutti i documenti dell’affaire
come se ritrovati dal fondo di un archivio: ti apparirebbe chiaro che Moro non
solo – cosa che sai già – si è comportato coerentemente al suo essere ‘cavallo
di razza’, e di razza democristiana; ma che non si è comportato vilmente. C’è un
fatto semplicissimo da tener presente: quelle sue lettere che tu consideri
espressione di viltà non sono dirette ai suoi nemici, ma ai suoi amici: a coloro
cioè che coerentemente al loro essere democristiani (e lasciamo stare, per
carità, il loro essere cristiani), avrebbero dovuto salvarlo. Per bollare Moro
di viltà dovremmo sapere come si è comportato di fronte ai suoi nemici. E nulla
ci dice che si sia comportato vilmente. Al contrario, anzi: nei suoi riguardi
c’è, da parte delle BR, e ravvisabile nei documenti, una crescita di rispetto. E
in quanto alla sua fede, e sul fatto che nelle lettere parla poco di Dio e solo,
come tu dici, ‘di striscio’. Le lettere sono di un uomo politico e dirette a
uomini politici. Non scriveva al Padreterno, né le BR sarebbero state in grado
di recapitarle. E di Dio, peraltro, ne parla: serenamente invocandolo alla
disperata impresa di far luce nella mente dei suoi amici. Ma non voglio abusare
dello spazio del tuo giornale; e tanto più che finirei col ripetere cose che ho
già detto nel pamphlet. Voglio, per concludere, ringraziarti di aver dato come
impensabile il fatto che io possa essermi messo al servizio di una manovra che
‘vuol mettere sotto accusa tutti gli uomini del Presidente’. Non so di nessuna
manovra, né riesco a individuare a quale Presidente tu alluda. Ma anche se c’è
in corso una qualche manovra, il fatto che io – cercando la verità – possa
concorrervi, non è ragione sufficiente a farmi tacere. Per troppi anni in questo
nostro Paese è stato avanzato il ricatto agli uomini di destra di non dire certe
cose che facevano il gioco della sinistra e agli uomini della sinistra di non
dire certe cose che facevano il gioco della destra. E il risultato ne è
l’endemica ed epidermica menzogna in cui l’Italia continua a vivere. Non ti pare
che sia proprio questo il caso di dire che basta? Ti ringrazio e ti saluto
cordialmente”.
Di Montanelli,
Sergio Romano cura i “Diari”, brevi annotazioni, “schizzi”, partono dal 1957, si
concludono nel 1978. Quello che segue è un quasi epigramma del 10 aprile 1972: “Clerici,
Sciascia e Laurenzi a cena da me. Immoto e inespressivo, Sciascia parla alla
velocità di una parola all’ora, e bisogna sollecitarlo con sguardi interrogativi
e lasciargli un ampio spazio di silenzio per indurlo a pronunciarla…”.
Sempre intorno all’amicizia. In un fondo Montanelli a Pavia è conservata una
lettera poi riprodotta nel volume “Nella mia lunga e tormentata esistenza.
Lettere da una vita”. La lettera è del 24 agosto 1988: “Caro
Sciascia, la gioia che mi dà la tua disponibilità a mandarci qualcosa è superata
solo dal dispiacere per i triboli dei tuoi occhi e da quel senso di
disperazione. Per la collaborazione, so benissimo che non puoi e non vuoi
impegnarti, e io non ti tormenterò mai per sollecitarla. Ad occhi io per fortuna
sto ancora abbastanza bene, ma capisco che tormento debba essere il sentirseli
indeboliti. Mi pare stano però che con tutti i progressi che l’oftalmia ha fatto
in questi ultimi tempi non abbiano trovato qualche rimedio al male che ti
affligge. Ti sei dato un po’ daffare, oppure il pessimismo e il fatalismo
siciliani hanno avuto la meglio anche su questa minaccia? Non voglio affaticarti
oltre. Se mi manderai qualcosa, dimmi come e dove vorrai che sia pubblicato: io
me ne sentirò comunque miracolato. Quanto all’antologia di racconti, è già per
me un alto onore che tu e Bufalino abbiate pensato al mio Della Rovere (che si
trova anche nel volume ‘Incontri’, anzi lo apre), così orrendamente sfregiato,
nell’omonimo film, dal duo Rossellini-De Sica. Se posso esserti utile, caro
Sciascia, sono a tua disposizione. Sappi che non ti ammiro soltanto. Ti voglio
anche molto bene”.
Sempre nel citato fondo pavese, un biglietto, datato 27 ottobre 1989: “Carissimo
Leonardo, il tuo biglietto ha fatto più piacere a me di quanto l’intervista
possa averne fatto a te. Ma tengo subito a dirti che con me non hai nessun
debito. Sono io che ne ho, verso di te, uno inestinguibile: l’esempio che ci hai
dato. Non raccolgo i tristi presagi che fai balenare nella tua lettera:
appartengono, credo, alla tua sicilianità. Ma sono convinto che ne verrai fuori.
Ti mando il mio fraterno abbraccio, dolente solo di doverlo fare per lettera”.
Non si tratta, purtroppo, di “tristi presagi”; piuttosto è lucida consapevolezza
del proprio essere. Sciascia muore il 20 novembre. E’ a quel “biglietto” che fa
riferimento Montanelli nel suo articolo di ultimo saluto all’amico scomparso. Ci
porta lontano nel ricordo, e nella non inutile operazione di ricostruzione di
episodi e fatti di cui è bene non smarrire la memoria, questo bel repertorio
curato da Depaolis; ed è un letterale diletto perdersi in questa libera, e anche
un po’ bizzarra, concatenazioni di pensieri che è capace di provocare. “Le
illuminazioni che vengono dagli scaffali sono parziali”, scrive Depaolis, “ma
non sono affatto di secondo piano. Invitano a scavare tra le fonti di cui un
autore può essersi presumibilmente servito, permettono di ripercorrere il suo
tragitto di lettore, aprono nuovi sbocchi sul suo universo culturale. Per la sua
attività creativa, scrive Nora Moll riferendosi a Sciascia, i libri degli altri
hanno uno statuto non inferiore alla propria esperienza vissuta o alle
informazioni provenienti dalla realtà”.
Appunto.
SEQUESTRO
MORO: I SEGRETI.
Tra Andreotti e Moro,
scrive
Giovanni Di Capua il
7
maggio 2014 su “Formiche”.
Per pura
coincidenza vengono in questi giorni ricordati il
primo anniversario della
scomparsa di Giulio
Andreotti e
il trentaseiesimo dell’assassinio di Aldo
Moro,
le cui esperienze politiche si intrecciarono (e spesso si contrastarono) e sulle
cui diverse sorti, come sui reciproci sostegni, si parlerà ancora a lungo.
Proprio una settimana fa venivano rese note alcune
lettere segrete di
Andreotti (una delle quali scritta nel corso del sequestro Moro, col presidente
del consiglio dell’epoca che si chiedeva perché mai i brigatisti rossi avessero
preso Moro e non lui, che pure rappresentava anche formalmente lo Stato da
abbattere), che fanno ancora una volta trasparire antiche ruggini fra i due,
come anche mai interrotte comprensioni umane. L’impressione che traggo nel
rifiorire, quasi annuale, di interrogativi sulle condizioni di uffici centrali
della nazione, con la loro consueta impreparazione ad ogni evento straordinario
(oggi, l’insopportabile cedimento al potere degli ultrà calcistici che ricorrono
anche all’assassinio di poliziotti e di tifosi avversari), e la riproposizione
di antiche domande (spacciate per nuove) sul numero, la funzione, il ruolo dei
servizi segreti delle principali intelligence del mondo, è che in troppi, specie
nella cultura e nella politica di sinistra, si sbracciano a chiedere nuove
commissioni parlamentari d’inchiesta, senza delle quali – si sostiene – non si
potrà mai accertare la veridicità dei fatti di quel lontano 1978 (precedenti e
successivi). Io credo che questi gorgheggi mediatici, sobillati da gruppi
parlamentari nuovi ma di antico riferimento a protagonisti comunisti dell’epoca,
valgano a distogliere – ancora una volta – l’attenzione di cittadini, politici,
ricercatori e storici dalle responsabilità politiche, non dalle vittime, ma
dall’ampia folla che sorreggeva le imprese brigatiste in funzione di una
opposizione concreta, continua, armata, intrigante e opportunista alla linea di
solidarietà che si stava faticosamente costruendo fra la Dc di Moro,
Zaccagnini e Andreotti e
il Pci di Berlinguer e
che, invece, la sinistra nel suo complesso, pur con le sue interne divisioni,
cercava in vario modo di ostacolare, bloccare, respingere. Sì, certo, le brigate
rosse si trovarono impigliate in un gioco di interessi internazionali più grandi
di loro; al punto da non potere più controllare i loro stessi progetti a mano a
mano che le settimane passavano senza che alcuna delle richieste politiche dei
terroristi fosse accolta. Ma si continua quasi ad allontanare l’attenzione dalla
vasta area di consenso che la protesta brigatista incarnava, esprimendo un
ribellismo diffuso proprio del ventre comunista e di quel piccolo mondo
intellettuale radical-borghese-socialista che non tollerava più il primato
politico ed elettorale democristiano. Se un’indagine parlamentare è necessaria,
essa riguarda le coperture finanziarie e militari straniere ai disegni
brigatisti, non sulla presunta estraneità dei terroristi rossi ad un popolo
italiano di sinistra: che sapeva d’essere minoritario e di non potere mai
diventare maggioranza per via democratica-parlamentare, e piuttosto innalzava le
proprie bandiere sulle demarcazioni internazionali in nome di una unità d’azione
fra tutti i ribelli della terra e di sentimenti marxistici e anticlericali. A
dirla tutta, temo si tenda a rimestare episodi in fondo marginali solo perché
non spiegati per distogliere l’attenzione dai possibili mandanti e ispiratori e
finanziatori dei terroristi. E questo sarebbe il modo peggiore per ricordare
Moro e la sua scorta, uccisi da un furore antidemocratico, mentre i brigatisti
non erano arcangeli di virtù, di libertà né costruttori di democrazia
sinistrorsa. Cioè minoritaria.
Le domande in attesa di
risposta su Aldo Moro,
scrive
Gero
Grassi l'8 maggio 2014 su
“Formiche”.
L'intervento di Gero Grassi, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera dei
deputati, pubblicato sulla rivista Formiche di maggio, dedicata ad Aldo Moro, il
presidente della Dc rapito dalle Brigate rosse e trovato senza vita in via
Caetani il 9 maggio di trentasei anni fa.
Il 16 marzo 1978, a Roma, in via Fani, le Brigate rosse uccidono gli uomini
della scorta e rapiscono il presidente Dc
Aldo Moro: Oreste Leonardi, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino,
Domenico Ricci e Francesco Zizzi. Dal
1978 si svolgono cinque processi, si realizza nel 1979 la I Commissione Moro, 4
Commissioni sul terrorismo negli anni 1992, 1994, 1996, 2001, la Commissione P2.
La Camera ha approvato, su iniziativa degli onorevoli Pd Giuseppe
Fioroni, Gero Grassi e Roberto Speranza, con
proposta firmata da tutti i gruppi, la legge istitutiva la seconda Commissione
d’indagine sul rapimento e la morte di Moro. Perché dopo 36 anni ancora una
indagine? La verità non è ancora emersa. Lo dicono la magistratura e le
commissioni. “La verità è più grande di qualsiasi tornaconto. La verità è sempre
illuminante e ci aiuta a essere coraggiosi”, dice Moro. Ho letto gli atti dei
processi Moro e delle commissioni. Per il gruppo Pd della Camera ho realizzato
una sintesi testuale, pubblicata sui siti deputatipd.it
e gerograssi.it. Di
seguito alcuni punti controversi e oscuri della vicenda. Anzitutto la dinamica
dell’eccidio di via Fani. Non tutti i partecipanti sono individuati, soprattutto
chi non fa parte delle Br. Alessio
Casimirri è
in Nicaragua. Non è mai stato arrestato e lo Stato non ne ha mai chiesto
l’estradizione, ma ha speso oltre un miliardo e mezzo per mandare i servizi
segreti a trovarlo. Perché? Completamente oscuri poi sono i nomi dei due della
moto Honda, condannati per omicidio in un processo, ma mai identificati. I
brigatisti affermano alla magistratura che i due non sono dei loro. La
magistratura parla di motivazioni inconfessabili a proposito della non
conoscenza della identità. Ancora, dove è stato tenuto prigioniero Moro? I
brigatisti dicono in via Montalcini, a Roma. La magistratura accerta che le
prigioni sono almeno due. Perché i brigatisti non dicono la verità? Chi fa parte
della intelligentia che scrive i documenti delle Brigate rosse e che si riunisce
a Firenze? Quali i rapporti tra i componenti del comitato del ministero degli
Interni che si occupa del caso Moro durante i 55 giorni e la P2, considerati i
tantissimi piduisti presenti? Perché generali dei Carabinieri e magistrati nel
periodo del rapimento si incontrano con Gelli nella sua villa di Arezzo per
discutere del caso Moro? È vero che durante i 55 giorni al ministero degli
Interni entra tale ingegnere Luciani, in realtà Licio Gelli? Perché all’interno
della magistratura si verificano divisioni devastanti, tanto che il Procuratore
capo della Repubblica di Roma e il Sostituto procuratore che segue l’inchiesta
non si parlano e lo dimostrano in occasione dell’episodio del lago della
Duchessa, quando il Sostituto non segue il Procuratore al lago, dichiarando di
sapere che il comunicato n. 7 delle Br è falso? Quali i rapporti tra Br e la
banda della Magliana, camorra, mafia e ‘ndrangheta? La magistratura accerta che
il comunicato Br n. 7 è realizzato da Tony
Cucchiarelli, capo
della banda della Magliana. Un affiliato della ‘ndrangheta dichiara di sapere il
perché della scomparsa dalla scrivania del giudice del rullino fotografico
scattato dopo l’eccidio di via Fani. Un affiliato di Cutolo dichiara che in via
Montalcini la camorra aveva abitazio¬ni-rifugio. Quale la verità sulla seduta
spiritica di via Gradoli? Chi fa la soffiata come chiede il giudice Priore?
Perché nessuno sa dell’esistenza di via Gradoli, nonostante il 18 marzo ci sia
stata una ispezione della Polizia, il prefetto Parisi dispone di 4 appartamenti
in via Gradoli e i servizi segreti hanno appartamenti? Perché don Antonello
Mennini, vice parroco della Chiesa di Santa Lucia e latore di diverse lettere
delle Br non si è mai fatto interrogare dalle commissioni d’inchiesta,
rifugiandosi dietro il suo stato di ministro del culto? È vero, come sostiene Corrado
Guerzoni,
capo ufficio stampa di Moro, che don Antonello si reca nella prigione e porta la
comunione al presidente Moro? Quali influenze hanno avuto la Cia, il Kgb, l’Ira,
il Mossad, la banda Baader-Meinhof e i servizi segreti bulgari e cecoslovacchi?
La testimonianza di Alberto
Franceschini non
è mai stata smentita. Mario
Moretti e Alessio Casimirri sono
brigatisti o uomini dei servizi segreti? Franceschini e Curcio sostengono, senza
dubbio, che Moretti è un infiltrato e che i carabinieri troppe volte hanno
mancato il suo arresto. Chi ha la copia del memoriale Moro ritrovato in via
Montenevoso a Milano nel 1978? Perché è stata fotocopiata fuori
dall’appartamento senza la presenza del giudice? Perché tutti quelli che hanno
visto o letto il memoriale sono stati uccisi: i generali Dalla
Chiesa e Galvaligi,
il colonnello Varisco,
Chichiarelli, Pecorelli e
infine la morte sospetta del colonnello Bonaventura, il
giorno prima la sua audizione? Perché il giudice Pomarici non
ha mai creduto al senatore Flamigni quando questi diceva che in via Montenevoso
c’era ulteriore materiale delle Brigate rosse, ritrovato dopo 12 anni da un
muratore? Perché i carabinieri e il giudice hanno sostenuto che l’appartamento
di via Montenevoso era stato scarnificato mattonella per mattonella, impedendo
per dodici anni la scoperta? Perché nell’omicidio Dalla Chiesa gli autori del
delitto rubano la borsa che il generale porta con sé dai tempi del rapimento
Moro e poi si recano nella sua abitazione prelevando dalla cassaforte
documentazione riservata? Perché quando pare che si stia profilando la
liberazione di Moro, il 9 maggio 1978 in via Caetani si trova il corpo del
presidente? Chi lo uccide? Dove? A che ora?
Eleonora Moro, alla
Commissione nel 1980: “L’onorevole Moro, da penalista, non avrebbe approvato la
condotta dei brigatisti; però avrebbe voluto distruggere o rimuovere le cause
che portavano i ragazzi a fare cose di questo genere, in modo che potessero
esprimere il loro pensiero, la loro sfiducia e tutto quello che volevano dire
con armi proprie, con quelle dell’uomo che parla e fa valere la propria
intelligenza, il peso della propria persona matura”. In tutta Italia il gruppo
Pd della Camera organizza manifestazioni nel corso delle quali racconto ai
cittadini “Chi e perché ha ucciso Aldo Moro”. Due ore di religioso silenzio da
parte dei tantissimi presenti, quale omaggio a una persona mite e buona come
Aldo Moro.
Aldo Moro, frammenti di un
delitto politico,
scrive
Giovanni Di Capua l'8 maggio
2014 su “Formiche”.
Intervento pubblicato sulla rivista Formiche di maggio, dedicata ad Aldo Moro,
il presidente della Dc rapito dalle Brigate rosse e trovato senza vita in via
Caetani il 9 maggio di trentasei anni fa.
Era il 9 maggio 1978 quando in via Caetani venne ritrovato il corpo senza vita
di Aldo
Moro. Erano
trascorsi 55 giorni da quel 16 marzo, quando il Parlamento era convocato a
giudicare il iv governo Andreotti, zeppo
di ministri dorotei e della destra democristiana, chiamato a superare lo scoglio
delle fortissime resistenze dell’apparato e della base del Pci di Berlinguer a
solidarizzare con la Dc, l’avversario di sempre. Moro si era speso per
convincere (ma non riuscendovi totalmente) i riottosi democristiani a un accordo
politico coi comunisti, dei quali continuavano a non fidarsi. Le tensioni fra i
partiti della strana maggioranza non erano dovute a stati d’animo, anche se si
trascinavano dietro odi e rancori risalenti alla guerra civile del 1943-1945 e a
quelli maturati dopo il 18 aprile 1948. Tutti i partiti, anche per effetto di un
dilagante terrorismo (l’anno emblematico della violenza armata era stato il
1977) erano smarriti. Nessuno di essi era in grado di proporre un sistema di
governo chiaramente alternativo al centro-sinistra, o a una coalizione
Psi-Pci-gruppi più a sinistra, ovvero a una coalizione straordinaria ma pur
sempre provvisoria fra Dc e Pci. La strage di via Fani trovò un’Italia
complessivamente impreparata ad affrontare l’emergenza terroristica.
Incredulità, sgomento, sottostima della potenza di fuoco delle Brigate rosse e
del loro ardire anti-Stato, furono i sentimenti che dominarono le prime
settimane del sequestro. Per qualche tempo i cittadini accettarono la generale
limitazione di libertà, se quella era la condizione – in via eccezionale – per
frenare la sconosciuta (e sospetta raffinatissima) arditezza dei brigatisti. I
quali si fecero ben presto vivi coi loro comunicati, scritti con parole di
guerra ideologica, politica e militare, dimostranti una lunga (e non solo
recente) preparazione. Se per la prima settimana la maggioranza degli italiani
si strinse attorno alla cosiddetta “linea della fermezza”, voluta da Berlinguer,
fatta propria da Zaccagnini e
Andreotti ma anche dai socialisti, dal momento del chiaro depistaggio
dell’annuncio brigatista che il corpo di Moro fosse rintracciabile nel lago
della Duchessa, il fronte unitario della fermezza venne frantumato dalla
improvvisa insorgenza della capacità trainante della linea trattativista
lanciata da Craxi. Il
trattativismo ebbe in realtà due versioni. La prima, politico-culturale, facente
capo al Psi e apertamente sostenuta dai radicali e dal gruppo del manifesto,
favorevole allo scambio politico richiesto dai brigatisti. La seconda, formulata
da Paolo
VI operò
per riscattare la vita a Moro; fece appello alla sensibilità umana dei
brigatisti e confidò nella disponibilità di alcuni uomini dello Stato (il
presidente Leone e l’ex segretario democristiano Fanfani) per una sorta di
scambio di prigionieri che, in ogni caso, si risolvesse con la liberazione di
Moro e con quella di terroristi non macchia¬tisi di reati di sangue o malati.
L’assassinio di Moro, effettuato il 9 maggio, proprio il giorno in cui si
delineava la possibilità di uno sbocco del tipo concordato fra il pontefice e
alcuni alti esponenti dello Stato, ridimensionò entrambe le forme trattativiste.
Teoricamente si coniugò con la linea della intransigenza e provocò la rottura
tra la famiglia Moro e la Chiesa e con l’universo politico; nonché la
restaurazione apparente dello Stato di diritto, non indulgente sino a farsi
sopraffare dal sovversivismo. Due gli effetti più vistosi: la linea della
corresponsabilità di governo fra Dc e Pci si liquefece progressivamente;
lasciando impantanati i due maggiori partiti italiani in un cabotaggio
parlamentare che via via portò all’inversione di marcia del Pci e all’abbandono
definitivo della solidarietà nazionale. Leone si dimise anticipatamente da capo
dello Stato sotto l’aggressione giornalistica di Camilla
Cederna, lasciando
spazio di manovra, nelle presidenziali di luglio, ai tatticismi velenosi, tutti
interni al variopinto mondo di sinistra, che portarono all’elezione di Pertini
(candidato assembleare non desiderato da Craxi) al Quirinale. La Dc s’impigliò
in un isolamento dal quale non si sarebbe mai più ripresa: in parte perdendo la
sua centralità, che risaliva al dicembre 1945. Dalla morte di Moro certo non
trasse vantaggio la Dc, che restò marchiata dalla fermezza, senza che le fosse
riconosciuto il contributo di sangue che aveva versato comunque salvando lo
Stato dall’assalto brigatista. Continuarono invece a incontrare consensi quegli
intellettuali che si erano attestati sulla linea pilatesca “né con lo Stato, né
con le Br”, sposata da non pochi media. La segreteria Zaccagnini risultò
fortemente contestata dalla famiglia Moro, dai socialisti e dalla destra
democristiana e clericale. Il Pci di Berlinguer tornò all’opposizione, ma lasciò
anche cadere definitivamente la sua linea del compromesso storico (proposta
nell’autunno 1973) che, pur non essendo stata accolta dalla Dc, aveva richiamato
l’attenzione di Moro per il suo intrinseco significato di politica funzionale a
una democrazia matura che l’Italia non avrebbe mai sostanzialmente conosciuto. A
guadagnare un po’ di potere fu l’autonomismo socialista, rinforzato dal codazzo
radicale e da una più rilevante simpatia del liberalismo riformista. Ma il
brigatismo rosso, pur mandato disperso dagli arresti, da processi interminabili,
da condanne che apparvero persino generose, lasciò un segno nell’indifferenziato
mondo della sinistra antagonista. Sino a fare breccia in un Pci che, dimenticato
totalmente Berlinguer, anche nelle sue successive trasformazioni rimase
attestato sulle posizioni di un partito di lotta e di governo: non dissimili da
quelle di partenza dell’aprile 1944 imposte da Togliatti.
I veri segreti su Moro,
scrive
Francesco Damato
il 4 novembre 2014 su “Formiche”. Solerte come aveva promesso
nella seduta del 29 ottobre scorso dell’apposita commissione parlamentare
d’indagine presieduta da Giuseppe
Fioroni,
il sottosegretario Marco
Minniti,
delegato dal presidente del Consiglio ai rapporti con i servizi segreti, ha
“segnalato” a Matteo
Renzi la
richiesta unanime votata dalla stessa commissione di estendere alla tragica
vicenda di Aldo
Moro la
declassificazione, cioè la desecretazione, già programmata per i documenti sulle
stragi compiute fra il 1969 e il 1984. In effetti, anche quella che si concluse
il 9 maggio del 1978 con l’assassinio di Moro, dopo 55 giorni di penosa e
drammatica prigionia, fu una strage, essendo tutto cominciato la mattina del 16
marzo con lo sterminio della scorta del presidente della Democrazia Cristiana.
Che era composta di cinque uomini, fra agenti di polizia e carabinieri.
D’altronde, la vicenda Moro è stata già trattata nell’ambito delle stragi dalle
omonime commissioni parlamentari d’inchiesta succedutesi fra il 1988 e il 2001,
per ben quattro legislature, specie dall’ultima, presieduta da Giovanni
Pellegrino,
illustre avvocato e giurista eletto senatore nelle liste dei Ds-ex Pci. Fu
proprio Pellegrino che alla fine inviò un esposto alla Procura di Roma per
prospettare la necessità di riaprire le indagini giudiziarie sul sequestro Moro
in base agli elementi raccolti dalla sua commissione. Indagini che però la
Procura romana ritenne di concludere con l’archiviazione, per quanto clamorosi
fossero gli elementi nuovi raccolti in sede parlamentare, sui quali lo stesso
Pellegrino, intervistato da Giovanni
Fasanella e Claudio
Sestieri,
si soffermò a lungo in un prezioso libro pubblicato da Einaudi nel
2000, per la collana “Gli struzzi”, intitolato “Segreto
di Stato- La verità da Gladio al caso Moro”.
In quel libro il presidente della commissione riferì, fra l’altro, di
un’audizione del magistrato Tindari Baglione, destinato a diventare procuratore
generale a Firenze ma fattosi le ossa come inquirente occupandosi di terrorismo.
“Alla domanda – disse Tindari Baglione – se eravamo più preparati noi (e cioè la
magistratura inquirente e le forze di polizia) o loro (i brigatisti), la mia
risposta con una battuta potrebbe essere che avevamo gli stessi consulenti”. Su
questa storia inquietante dei consulenti comuni alle brigate rosse e a chi
doveva o avrebbe dovuto combatterle, ma ne fu probabilmente condizionato o
deviato, potrebbero forse aiutare a capire e scoprire qualcosa i documenti
ancora riservati di cui è stata chiesta la declassificazione a Matteo Renzi.
Documenti che risultano essere addirittura 12.500, di cui 474 di provenienza
straniera, per i quali le procedure e gli esiti della declassificazione
potrebbero risultare più lenti e incerti degli altri, non dipendendo la
rimozione del segreto solo dal presidente del Consiglio. Ma i 12.026 di
pertinenza solo italiana, declassificabili entro giugno dell’anno prossimo
secondo le procedure stabilite nelle direttive adottate in materia dallo stesso
Renzi subito dopo il suo arrivo a Palazzo Chigi per fare luce completa sulle
troppe stragi rimaste parzialmente o del tutto impunite, potrebbero risultare
utili a svelare i segreti che ancora gravano sulla tragica fine di Moro. Che non
fu certo ucciso dalle “giubbe rosse”, come ricorda il titolo sarcastico di un
libro scritto a quattro mani dallo stesso Renzi con Lapo Pistelli, quando i due
andavano d’amore e d’accordo, ma dalle brigate rosse. Ad uno dei segreti
perduranti della vicenda Moro si riferì nel 1998, in un’intervista fattagli per Il
Foglio in
occasione del ventesimo anniversario del sequestro del leader democristiano, Giovanni
Leone,
presidente della Repubblica all’epoca dei fatti, raccontandomi i particolari
della grazia che il 9 maggio 1978 egli si accingeva a firmare al Quirinale, a
dispetto della linea della fermezza adottata dal governo, per uno dei tredici
detenuti per terrorismo di cui le brigate rosse il 24 aprile avevano chiesto la
scarcerazione in cambio di Moro. Si trattava di Paola
Besuschio,
condannata in via definitiva ma non per fatti di sangue, e ricoverata in quei
giorni in un ospedale. Dove peraltro la detenuta, rintracciata con una certa
fatica, aveva rifiutato di chiedere la grazia, che Leone decise di concederle lo
stesso, sperando che il suo atto di clemenza potesse provocare fra i brigatisti
un ripensamento sulla decisione già annunciata di uccidere Moro. Ma i terroristi
lo precedettero di qualche ora ammazzando l’ostaggio. “A delitto consumato, mi
convinsi che i brigatisti fossero al corrente di quel che stava maturando e, non
volendo la liberazione di Moro, avessero affrettato quella mattina
l’assassinio”, mi disse Leone. Che aggiunse, ancora tormentato da chissà quali
sospetti: “Quei brigatisti erano troppo informati”. Davvero troppo per via forse
dei consulenti in comune con lo Stato. Sulla pelle del povero Moro essi
risparmiarono ai vertici delle brigate rosse l’esplosione di contrasti ancora
più forti di quelli già verificatisi nella gestione del sequestro.
Ecco la nuova fuffa su Aldo
Moro, scrive
Francesco Damato il
21 novembre 2014 su “Formiche”.
Se quella di Aldo
Moro non
fosse stata e non fosse tuttora un’autentica tragedia, con quella sua orribile
morte nel 1978 e i tanti misteri rimasti irrisolti, ci sarebbe da ridere della
nuova commissione d’inchiesta parlamentare, costituita per fare più luce su
quella vicenda. Una commissione che sta scambiando lucciole per lanterne e che
soffre anch’essa di annuncite: la malattia politica del presidente del Consiglio Matteo
Renzi e
del suo governo. Il primo annuncio della commissione è stato quello di chissà
quali e quanti documenti in via di desecretazione, al pari di quelli sulle
stragi promessi da Renzi appena insediato a Palazzo Chigi. Ma il ministro
dell’Interno Angelino
Alfano si
è premurato di precisare di persona ai commissari di avere tirato fuori dagli
armadi del Viminale, a proposito della vicenda Moro, un faldone di carte solo
parzialmente divulgabili. E per giunta riferibili ad un arco di tempo – dal 1999
in poi – tanto lontano dal 1978 da fare ritenere improbabile una loro utilità
per capire che cosa non avesse funzionato all’epoca del sequestro dell’allora
presidente della Dc. Un latro annuncio è stato quello del successo – chiamiamolo
così – conseguito dalla commissione con il ritrovamento dell’auto nel bagagliaio
della quale Moro fu ucciso e venne fatto trovare dopo qualche ora a metà strada
fra le sedi nazionali del Pci e della Dc, come se in quella macchina fosse
ancora possibile rinvenire elementi preziosi per la ricerca delle verità
mancanti. La R4 rossa così tristemente famosa per le immagini televisive del
ritrovamento del cadavere di Moro non aveva fatto alcuna fine misteriosa. E’
stata “ritrovata” regolarmente custodita in un garage del Ministero
dell’Interno, ceduta qualche anno fa allo Stato dal proprietario, al quale i
brigatisi rossi l’avevano rubata durante il sequestro di Moro, e destinata a un
museo storico delle macchine della Polizia. Fra le quali andrebbero
evidentemente annoverate anche quelle usate contro lo Stato dai criminali. Degli
annunci della o alla commissione d’inchiesta parlamentare sulla vicenda Moro fa
parte anche il “procedimento formale” comunicato dal Procuratore generale della
Corte d’Appello di Roma, Luigi
Ciampoli,
contro il funzionario americano della Cia Steve
Pieczenik,
accorso alla richiesta di aiuto dell’allora ministro dell’Interno Francesco
Cossiga a
fronteggiare l’emergenza, ma sospettato di avere deliberatamente concorso con i
suoi consigli all’assassinio dell’ostaggio.
Matteo Renzi sarà
stato il primo a sobbalzare di fronte a questa ipotesi. Che smentirebbe anche
quell’arguto libretto da lui scritto nel 1999 con l’amico Lapo
Pistelli proprio
per contestare dietrologie di questo tipo. Un libretto sarcasticamente ed
efficacemente chiaro sin dal titolo e dalla vignetta di copertina raffigurante
una guardia canadese: “Ma le giubbe rosse non uccisero Aldo Moro”. Ad ammazzare
Moro, 55 giorni dopo averne sterminato la scorta, non furono infatti né i
canadesi né gli alleati americani, ma più semplicemente le Brigate rosse
italiane. Che riuscirono a realizzare da sole la loro più eclatante operazione
militare e politica, bastando e avanzando per il loro successo la inadeguatezza
degli apparati di sicurezza dello Stato, un po’ di “consulenti in comune” che
incredibilmente avevano lo stesso Stato e i terroristi, secondo le rivelazioni
di un magistrato esperto di terrorismo all’ultima commissione d’inchiesta
parlamentare sulle stragi presieduta da Giovanni
Pellegrino,
e l’impotenza cui il governo si condannò con le giaculatorie di una retorica
linea della fermezza. Una linea non a caso tradita nella occasione successiva,
tre anni dopo, quando fu sequestrato dalle brigate rosse e liberato con la
mediazione addirittura della camorra Ciro
Cirillo,
un assessore regionale democristiano della Campania la cui vita fu evidentemente
e scandalosamente ritenuta più preziosa di quella di Moro.
SEQUESTRO
MORO: LE COMMISSIONI D’INCHIESTA.
(com)Missione impossibile.
Molto chiasso, zeru tituli. Ci casca pure Renzi. Inchiesta sull’allegra
inutilità delle commissioni di inchiesta, scrive
Mario
Sechi
il 26
Dicembre 2015 su “Il Foglio”. Ricordate la commissione Stragi? Al telefono i
commessi rispondevano così alle chiamate, per dire della serietà e compostezza
istituzionale: “Straaaaaaggiiiiiiii, dica!” Mancavano i manifestanti al portone
di Bankitalia. Sono arrivati. Lo scenario ora è completo. Quasi. Alla
sceneggiatura del qualunquismo bancario manca la commissione parlamentare che
studia, accusa, ausculta, prende le misure. Commissione d’inchiesta o
d’indagine? Dilemma. Con poteri della magistratura o senza? Rebus. Si vedrà. Al
cronista in questo caso viene in mente il vecchio detto che circola in
Transatlantico: quando si vuole insabbiare bene un caso, si fa una bella
commissione d’inchiesta parlamentare. Così quando qualche giorno fa Renato
Brunetta ha proposto di istituirne una per indagare su banche e risparmiatori e
Matteo Renzi ha detto di non essere contrario all’idea (ma poi si vedrà) sul
taccuino sono cominciati a piovere un po’ di ricordi. Si può fare la commissione
sugli obbligazionisti (in)subordinati? Certo, occasione succulenta per chi fa il
nostro mestiere, ma vedrete quale opera magna ne verrà fuori. Una commissione
d’inchiesta (o d’indagine, fate voi) serve ad alimentare il caos, fare manovre
da sottosopra (per esempio indicare l’exit al governatore di Bankitalia, Ignazio
Visco), portare in prima pagina un presidente che diventa protagonista per mesi
(intere carriere sono state create così), scodellare rivelazioni e far bollire
scoop di cartapesta. E poi c’è tutto il traffico dentro e fuori, i senatori e
deputati, i segretari, i consulenti esterni. La commissione parlamentare mette
in moto una macchina che voi umani non potete immaginare. L’argomento è
perfetto: le banche e il povero risparmiatore mai stato investitore, al massimo
investito. Il massimo per esprimersi ai minimi livelli. La storia conferma con
puntualità svizzera e beffardaggine italiana il quadro. Qualche giorno fa è
morto Licio Gelli, novantasei anni, nessuno ne ricordava l’esistenza. Ma quando
è comparso il lancio d’agenzia sul passaggio all’altro mondo, zac! Sui giornali
e i telegiornali sono comparsi titoli da strillone e pensosi commenti che
avevano il tono del mistery: “Quanti segreti si è portato nella tomba…”. Ma
come? Non aveva chiarito tutto la super commissione di inchiesta sulla loggia
massonica P2 guidata da Tina Anselmi? Perbacco, come no? Anno 1981, venti
senatori e venti deputati si spremono le meningi e compulsano i volumi di
Sherlock Holmes sull’arte dell’investigazione, due legislature e tre anni di
lavoro, una relazione conclusiva di Tina Anselmi, cinque relazioni di minoranza
(Teodori, Pisanò, Matteoli, Ghinami, Bastianini), ventiquattro volumi di
allegati per un leggerissimo totale di novantatré tomi, senza considerare gli
indispensabili Indici. Quella che sui giornali di ieri fu la Verità della
commissione Anselmi, diventa oggi il segreto sigillato nella bara di Gelli.
Strepitoso testacoda dell’archivista. E’ una storia lunga quella delle
commissioni d’inchiesta, specialità del menù politico, sollazzo dei cronisti, un
forno a legna sempre acceso, pronto all’ordinazione in sala, un cotto e mangiato
del nostro costume nazionale e irrazionale. E’ il bisogno patrio della
complicazione per evitare la spiegazione, il rapporto parlamentare come arma di
distrazione di massa, un percorso di secolare inganno e meraviglia che comincia
nel 1918 con la commissione sulla disfatta di Caporetto: 241 sedute dal 15
febbraio 1918 al 25 giugno 1919, 2.310 documenti e 1.012 testimoni. Due volumi
pesantissimi furono consegnati al presidente del Consiglio Francesco Saverio
Nitti. Tutto per scoprire (e coprire con pietoso coperchio istituzionale) che la
dodicesima battaglia dell’Isonzo sotto il comando supremo del generale Luigi
Cadorna era entrata di dritto e di rovescio nel guinness dei fiaschi militari:
13 mila morti, 30 mila feriti e 265 mila prigionieri. Queste, più o meno, le
stime della storia. Sbandamento, fuga, massacro, “la madre di tutte le batoste”.
Caporetto è la biografia delle commissioni parlamentari, della loro
proliferazione come arma non convenzionale, indice alfabetico da emicrania di
una nazione analfabeta (d’andata ieri e di ritorno oggi) e senza sprezzo del
ridicolo. L’elenco avrebbe fatto impazzire François Rabelais di buffonesca
gioia. Perché pantagruelico è il menù delle commissioni parlamentari
d’inchiesta. C’è un problema? Risolto! Si indaga con un collegio di deputati e
senatori, tiratori scelti di una battaglia che ha sempre altri scopi rispetto
agli alti scopi. Varata la Repubblica, se ne avviarono subito due, di
commissioni, sulla disoccupazione e sulla miseria. Correva l’anno 1948, fu il
preludio di una sinfonia dove ieri e oggi quasi s’odono i tromboni. I veri
solisti dello spartito d’indagine. Prima legislatura, due commissioni così
scontate non potevano bastare, si capì subito che occorreva impegnarsi di più,
così arrivarono le commissioni speciali, diverse dalle investigative ma sempre
usate con clamore e senza candore: per le alluvioni dell’autunno 1951, sulla
Cassa per il Mezzogiorno, per istituire il Cnel, per i funerali di Vittorio
Emanuele Orlando, per le locazioni, per l’ordinamento degli enti locali in
Sicilia (l’isola diventerà fonte di un serial di inesauribile fantasia), sui
provvedimenti speciali per la città di Napoli (altra saga immaginifica, giunta
fino ai nostri giorni), arrivò prontamente quella sul debito pubblico e
subitissimo fu istituita la commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni, poi
mutata in Rai e domani chissà. Neanche le onde elettromagnetiche sfuggirono al
radar parlamentare. Ecco, questa è la partenza, il principio di tutto, da questa
sorgente sulfurea salgono e scendono, su e giù per i rami della storia, tutte le
altre commissioni. Un tripudio di invenzioni politiche e impolitiche che non ha
rivali nella storia d’Oriente e d’Occidente. Essenza e distillato del nostro
bizantinismo. La seconda legislatura fece partire l’inchiesta sulle condizioni
dei lavoratori che affiancò quella sulla miseria, quella sulle ricompense al
merito militare e civile, un’altra alluvione in autunno nel 1953 (in Calabria,
altra lunga serie di morti e parole) alla quale si aggiunse in passerella quella
sull’alluvione estate e autunno sempre del 1953, fece l’esordio la commissione
speciale sulla città di Roma (telenovela giunta fino all’indimenticabile puntata
marziana su Ignazio Marino), una sui provvedimenti straordinari per l’Abruzzo e
ancora provvedimenti altrettanto straordinari per la Calabria. E’ il giro
d’Italia del disastro con l’assegno di risarcimento incorporato, il vedo,
stravedo e provvedo, il ciclo economico dell’emergenza e del fondo assegnato in
eterno, del dico, non vi dico ma soprattutto spendo. E votate, mi raccomando. La
terza legislatura della Repubblica ha già un discreto allenamento sulla materia,
l’ingranaggio di costruzione e costituzione del collegio pronto a tutto è
oliatissimo. Signore e signori, italiani! Il grande tema dell’oggi rimbalza dal
passato come in ritorno al futuro, ecco la commissione d’inchiesta sull’Anonima
banchieri, nota come “caso Giuffrè”, da Giovan Battista Giuffrè, ribattezzato il
banchiere di Dio per i suoi agganci vaticani, impiegato di Imola che
modestamente sapeva il fatto suo e non aveva bisogno dell’obbligazionista
(in)subordinato per agire: garantiva un tasso di interesse del cento per cento e
usava quello che divenne un classico della truffa: lo “Schema Ponzi”. Come
funzionava (e funziona)? Una catena di Sant’Antonio di allocchi dove i primi
investitori venivano rimborsati con i soldi versati dagli ultimi e quando i
rimborsi superarono i versamenti… crash! Il caso Giuffrè fu un terremoto
politico, il ministro delle Finanze Luigi Preti aprì il caso per affondare –
tramite Amintore Fanfani (toh! è subito Arezzo) il suo predecessore Giulio
Andreotti, accusandolo di “mancata vigilanza”, in sostanza di aver coperto
Giuffrè. Spuntò un memoriale. Falso. La verità? Che importava, si faceva
politica anche così. Tra gli stangati, i Frati Cappuccini, naturalmente il Papa
istituì una bella commissione d’inchiesta, cardinalizia. E’ la storia che si
diverte a srotolare un anticipo del futuro: sono gli anni in cui nasce la
commissione Antimafia (esordio nel 1962) ma già si profila all’orizzonte tutto
il capitolo retorico sulla corruzione e come un razzo decolla la commissione
sulla costruzione dell’aeroporto di Fiumicino. Il domani, il nostro scintillante
oggi, era già scritto, previsto, sottoscritto e, naturalmente rimborsato a piè
di lista dal contribuente spesso ignaro, ma in fondo consenziente sul tran tran
della spesa e della costruzione del debito. Italiani che alimentano un’alluvione
di leggi e denari che corrono pericolosamente a valle. E le tragedie, immani.
Eccolo, il disastro del Vajont, la commissione sulla strage fa la sua comparsa
nella quarta legislatura, lavora cinque anni (dal 1963 al 1968, produce una
relazione finale e due di minoranza. Sono trascorsi 52 anni da quella tragica
notte del 9 ottobre 1953 e ancora si inseguono una, due, tre, tante verità sulla
frana del Monte Toc e la tracimazione delle acque del bacino su Longarone: 1917
morti. Altro disastro, altra commissione d’inchiesta, quella sul terremoto del
Belice. Il diluvio e il movimento tettonico, lo scroscio e il crollo, nessun
tema può restare scoperto, ogni pagliuzza e trave sono sottoposte all’analisi
dei parlamentari. Si battano i piatti e si alzino i tromboni, la quinta
legislatura manda in scena la commissione d’inchiesta sulla criminalità in
Sardegna e quella che aprirà una feconda stagione di spie, spioni, colpi di
stato semiveri, semiseri e molto immaginari, ecco la commissione che indaga
sullo scandalo Sifar e, naturalmente l’accompagnamento delle puntuali alluvioni
del 1968. Volete comparare l’opera di Ian Flemins su James Bond con il
raccontone sul Sifar italiano, la schedatura italica, terreno di pascolo del
giornalismo pistarolo a cui nulla sfugge? Una relazione di maggioranza, quattro
di minoranza, altri due bei volumoni di storia patria e un vulcano di
rivelazioni che continuano a seconda dell’archivio e del tomo. Siamo già in una
fase che richiederà palazzi, stanze, biblioteche, futuri terabyte
d’archiviazione. Calma e gesso, nella sesta legislatura entra nell’indice delle
indagini senza fine e senza soluzione quella sulla “giungla retributiva”, un
chiaro mai più senza che dà un colpo decisivo allo stato confusionale del
contribuente italiano. La settima legislatura ha il suo disastro e l’automatica
commissione: incidente all’Icmesa, l’inquinamento chimico di Seveso. Tripletta
incredibile nell’ottava legislatura con tre commissioni d’inchiesta da
abbonamento premium e serial tv garantito: Moro, Loggia P2, Sindona. Siamo nel
1978, annus horribilis, nel 1979 il Parlamento si trasforma nell’agenzia
investigativa Pinkerton. Non manca un terremoto con relativa commissione
incorporata, stavolta in Campania e Basilicata. E la corruzione? C’è sempre e
trova risposta immediata e cura indefinita nello spazio e nel tempo. Ecco i
parlamentari aprire i lavori della commissione d’inchiesta sui fondi neri
dell’Iri. Vaste programme. Siamo nella nona legislatura, partenza nell’anno
1983, i collegi d’indagine precedenti hanno funzionato così bene che viene
formata con velocità supersonica la “Commissione parlamentare d'inchiesta sui
risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito
l'individuazione dei responsabili delle stragi”. Epigrafe da tesi di laurea a
Tubinga, stragi rigorosamente irrisolte. Al telefono i commessi rispondevano
così alle chiamate, per dire della serietà e compostezza istituzionale:
“Straaaaaaggiiiiiiii, dica!”. Ma no dai, stavolta si fa sul serio, non ci sono
dubbi, il momento è grave, bisogna rifare la Repubblica! Allo scopo viene
attrezzata anche una commissione che d’indagine non è ma va citata come nuovo
inizio di un altro ciclo eterno, quello delle riforme istituzionali, la famosa
commissione Bozzi, destinata a suscitare fiumi di citazioni negli anni a venire
e a non arrivare ad alcuna riforma. Al massimo tavoli. Rovesciati come in
saloon. La sabbia nella clessidra è giunta al livello della targhetta del 1987,
altro anno turbolento. Ad Atlanta, Stati Uniti, la filiale della Banca nazionale
del lavoro concede prestiti a un dittatore iracheno chiamato Saddam Hussein. E’
in guerra con l’Iran, deve finanziare l’acquisto di armi, cerca soldi. Gli
americani guardano dentro la cassaforte e scoprono che i soldi passano
attraverso il manager della banca italiana, Christopher P. Drogoul. Il nome in
codice dell’operazione è un’anticipazione della tarantella suonata dalla
commissione di inchiesta in Italia: “Perugina”, come i baci. Cose che accadono
all’estero, lontano dagli occhi, dal cuore e soprattutto dal bilancio dello
Stato. A proposito di oltre confine, non disperate, nell’undicesima legislatura
si fa una bella commissione sulla Cooperazione all’estero. La dodicesima e
tredicesima legislatura sono il canto del cigno della prima repubblica e la
nascita della seconda. Forse. Nel 1994 cambia lo scenario politico, i partiti
storici sono stati decimati dalla magistratura, c’è un tal Di Pietro, c’è
Berlusconi, c’è Bossi, resistono i post comunisti, bisogna dare un segnale di
svolta e si torna a sventolare la bandiera dei temi sociali, perdinci. Il Senato
apre i lavori d’indagine niente meno che su caporalato, ciclo rifiuti e sistema
sanitario, alla Camera rispondono prontamente, non perdono un colpo, cribbio,
con le investigazioni sull’Acna di Cengio. Montecitorio e Palazzo Madama puntano
la lente sul dissesto di Federconsorzi, per liquidare meglio i resti della Dc,
figuriamoci. Ottocento ex dipendenti ancora oggi cercano risarcimento. Tono
minore, in ogni caso, rispetto all’impegno da detective del passato. Ma il
riscatto pieno, il ritorno agli anni ruggenti arriva nella quattordicesima
legislatura dove il centrodestra berlusconiano infila un triplete di commissioni
da sballo mediatico: Mitrokhin, TeleKom Serbia e crimini nazifascisti. Le prime
due avevano un camion di documenti sui quali riscrivere un pezzo di storia, la
terza era un esercizio accademico. Il dossier Mitrokhin nel Regno Unito fece il
botto, in Italia venne trattato come un feuilleton, salvo poi coprire con il
segreto i documenti della commissione che oggi non sono disponibili neanche per
gli studiosi. Stranezze. Lo scandalo Telekom Serbia invece aveva solida
documentazione diplomatica, giri di soldi già tracciati, un conte come
intermediario e altre sagome nell’ombra, depositi a San Marino, insomma un
dossier eccellente per essere una cosa seria, ma in commissione accreditarono un
teste, Igor Marini, che con i suoi racconti tanto finti e precisi da sembrare
veri finì per portare la storia verso un epilogo grottesco. Fu un naufragio da
manuale. Il Senato in quel periodo, siamo nel 2001, esercitò il suo sapere sul
fiume Sarno, sulle morti bianche, sull’uranio impoverito, sul sistema sanitario.
C’era l’Italia da rivoltare, altro che, e i parlamentari erano pronti alla
grande missione. Alla Camera si occuparono della morte di Ilaria Alpi e di Miran
Hrovatin, anche qui un risultato finale con molto rumore sui giornali ma zero
tituli. Al grande polverone, seguì un periodo di più modesti obiettivi, di
dimesso impegno, così la quindicesima legislatura lascia sul taccuino del
cronista poche tracce, a meno che non si provi folgorazione per l’intrigante
caccia parlamentare agli errori sanitari. La sedicesima legislatura non offre
colpi di scena, fa il punto sulle morti bianche, non si entusiasma nessuno in
redazione con relazioni sulla pirateria e la contraffazione. Così, trascinati
dalla corrente come un gigantesco albero sradicato dalla storia, si arriva ai
giorni nostri, dove si capisce che c’è un fermento, una gran voglia, un
desiderio di ribalta, di cagnara, di zuffa politica inespressa, di sottovuoto
spinto a cui dare sfogo creativo. Ma ancora non ci siamo, i fermenti non sono
così potenti, è una diciassettesima legislatura che si apre al Senato sotto la
guida di Pietro Grasso e le commissioni sono dunque un derivato del suo stato
gassoso; una commissione sugli infortuni sul lavoro (riecco l’impegno sociale),
una sulle intimidazioni agli amministratori locali, e la quanto mai puntuale
commissione d’inchiesta sul rogo del traghetto Moby Prince, a soli 24 anni dalla
collisione tra la nave passeggeri e la petroliera Agip Abruzzo al largo del
porto di Livorno. Si sa, il Parlamento in queste cose è tempestivo. Nell’impero
di Laura Boldrini il recital è un po’ più vispo: pirateria e contraffazione,
effetti dell’uranio impoverito, ciclo dei rifiuti e illeciti ambientali,
l’antimafia bindiana in versione extended, dove c’è la Boldrini ovviamente c’è
un’indagine sui migranti e infine il flashback, la fenomenale macchina del tempo
di Montecitorio in piena azione: la commissione d’inchiesta sul rapimento e
sulla morte di Aldo Moro. Trentasette anni dopo. Ancora audizioni,
ricostruzioni, rivelazioni. Se ne sentiva il bisogno. Aprite il taccuino,
prendete appunti. A volte ritornano.
Aldo Moro, i primi misteri
svelati dalla Commissione Fioroni,
scrive
Francesco Damato
il 4 Gennaio 2016 su “Formiche”. Primo di una serie di 3
articoli dell'editorialista Francesco Damato. Buon anno, in particolare, a Giuseppe
Fioroni,
ex ministro della Pubblica Istruzione, deputato del Partito Democratico, alla
guida dall’autunno del 2014 della commissione parlamentare d’inchiesta,
l’ennesima, sul sequestro e sulla morte di Aldo
Moro,
avvenuti dal 16 marzo al 9 maggio del 1978, quasi 38 anni fa. Era alla guida del
governo
Giulio Andreotti con
un “monocolore” democristiano appoggiato esternamente dal Partito Comunista
Italiano. Il cui passaggio dall’astensione al voto di fiducia era stato appena
concordato per ragioni di emergenza e cosiddetta “solidarietà nazionale” fra lo
stesso Moro, presidente e regolo della Dc, e il segretario delle Botteghe Oscure Enrico
Berlinguer.
Questa commissione – l’ennesima, ripeto, nata anche per questo fra lo
scetticismo dei più – dovrà concludere entro questo 2016, salvo proroghe, i suoi
lavori inquirenti. Che sono stati e sono tuttora condotti, secondo la
prescrizione dell’articolo 82 della Costituzione, “con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”. Limitazioni, tuttavia, che non
sono proprio le stesse, ma maggiori, non potendo la commissione disporre, per
esempio, intercettazioni o arresti, ma solo l’accompagnamento coattivo dei
testimoni eventualmente indisponibili ad essere interrogati. Interventi sulla
segretezza delle comunicazioni e sulla libertà personale potrebbero essere
disposte solo dalla magistratura ordinaria per procedimenti giudiziari da essa
aperti recependo indicazioni o sollecitazioni della commissione parlamentare. Ma
in tal caso si potrebbero creare nuovi e più delicati problemi di rapporti fra
inquirenti diversi. In attesa della fine dei lavori e della relazione
conclusiva, il presidente Fioroni ha già prodotto con voto unanime della
commissione, e per disposizione della stessa legge istitutiva, un rapporto
parziale di circa 200 pagine sulle indagini già eseguite. Un rapporto pubblicato
il 10 dicembre scorso alla Camera nel bollettino delle giunte e delle
commissioni, da cui si evincono già elementi sufficienti a fare ammettere anche
ai più scettici che una ulteriore inchiesta parlamentare occorresse e occorra
davvero, visti i vuoti lasciati dalle precedenti, e anche dai vari processi e
verdetti giudiziari che si sono susseguiti sulla tragica vicenda Moro, che
“presenta profili di straordinario rilievo nella storia della nostra
Repubblica”, come ha scritto Fioroni. Responsabili dei vuoti, o della nebbia che
da 38 anni pesa sul sequestro e sull’assassinio di Moro sono pure i brigatisti
catturati, condannati ed anche usciti dal carcere per avere scontato la pena,
autori persino di libri, memoriali e interviste sulle loro gesta, ma
irriducibilmente reticenti. Fra i documenti di “notevole interesse” acquisiti
dalla commissione, grazie anche alla declassificazione disposta l’anno scorso
dal presidente del Consiglio Matteo
Renzi negli
archivi dello Stato, ve n’è uno originale dei servizi segreti italiani – Ufficio
R, reparto D, 1626 – proveniente da Beirut e datato 18 febbraio 1978, quasi un
mese prima del sequestro Moro. Si giravano a Roma informazioni palestinesi
“riguardanti operazione terroristica di notevole portata programmata
asseritamente da terroristi europei che potrebbero coinvolgere nostro Paese, se
dovesse essere definito progetto congiunto discusso giorni scorsi in Europa da
rappresentanti organizzazioni estremiste”. La nota, proveniente in particolare
da “fonte 2000”, assicurava la disponibilità dei palestinesi di Habbash a
prodigarsi, nell’occorrenza, per proteggere gli interessi italiani, secondo una
consuetudine concordata a suo tempo e nota come “lodo Moro”. E si chiudeva con
la raccomandazione di non diramare la notizia “ai servizi collegati Olp Roma”,
di cui evidentemente le fonti palestinesi di Beirut non si fidavano. Moro, cui
certo non mancavano per la sua lunga e autorevole esperienza di governo, da
presidente del Consiglio a ministro degli Esteri, collegamenti con i servizi,
aveva probabilmente saputo qualcosa di quel che da Beirut si era comunicato se,
una volta sequestrato, in una delle prime lettere inviate dal covo in cui lo
avevano rinchiuso le brigate rosse raccomandò che fossero attivati i contatti
del governo con il colonnello Stefano
Giovannone,
operativo per i servizi segreti in Medio Oriente. Moro aveva evidentemente più
di qualche sospetto sui collegamenti internazionali delle brigate rosse,
sbrigativamente eliminate da molti studiosi come un fenomeno solo o
prevalentemente endogeno, cioè nazionale. Egli riteneva che qualcuno o qualcosa
potesse incidere sui suoi rapitori dall’estero. Sarà stata poi una curiosa
coincidenza, ma fu proprio dopo quell’allarme inviato da Beirut il 12 febbraio
1978 che il capo della scorta di Moro, il maresciallo dei Carabinieri Oreste
Leonardi,
apparve particolarmente nervoso, anche a me che ebbi modo di incontrarlo
incidentalmente qualche giorno prima del sequestro. Ma si pose anche al vertice
della Polizia il problema di una maggiore protezione del presidente della Dc,
nel cui ufficio romano di via Savoia il capo della Polizia mandò il 15 marzo,
cioè due giorni prima del sequestro, il dirigente dell’ufficio politico della
Questura di Roma, Domenico
Spinella,
per “concordare – riferisce la documentata relazione di Fioroni – l’istituzione
di un servizio di vigilanza a tutela” dello stesso ufficio nei giorni e nelle
ore in cui non fossero presenti, con Moro, gli agenti della scorta. Un servizio
di vigilanza “la cui attivazione era stata poi pianificata con decorrenza 17
marzo”, quando purtroppo Moro sarebbe stato già sequestrato e la scorta
sterminata in via Fani, a poche centinaia di metri di distanza dalla casa di via
di Forte Trionfale, mentre il presidente della Dc cercava di raggiungere la
Camera. Dove Andreotti si accingeva a presentare la riedizione del suo
“monocolore” democristiano per ottenere la fiducia dai comunisti.
Sequestro Moro, cosa ha
scovato la Commissione Fioroni. Secondo di una serie di tre articoli
dell'editorialista Francesco Damato. Non trascorsero inutilmente, per il
povero Aldo
Moro e
quanti avrebbero dovuto proteggerlo, soltanto i 26 giorni seguiti alla segnalazione
del 18 febbraio 1978 dalla “fonte 2000” di Beirut dei servizi segreti italiani,
informati dai palestinesi di un’operazione nel nostro Paese concordata o a
conoscenza a livello terroristico internazionale. Purtroppo trascorsero
inutilmente anche gli ultimi, sessanta minuti- come vedremo- che precedettero il
tragico sequestro del presidente della Dc, avvenuto il 16 marzo fra le 9 e tre
minuti e le 9 e 5 minuti, dopo 93 colpi d’armi da fuoco di cui 49 sparati da una
sola fonte e 2 soltanto da uno degli agenti di scorta di Moro: il poliziotto Raffaele
Iozzino.
Gli altri quattro della quadra non ebbero neppure il tempo e il modo di tentare
una reazione armata. Pochi minuti dopo le ore otto, quando Moro era ancora a
casa e la scorta si accingeva a raggiungerlo per accompagnarlo alla Camera,
lungo un percorso rivelatosi – ahimè – troppo abituale, nell’abitazione romana
del senatore moroteo Vittorio
Cervone la
domestica Clara
Giannettino trasecolò
ascoltando alla Radio
Città Futura,
diretta da Renzo
Rossellini e
appartenente all’area extraparlamentare di sinistra non certamente ignota alle
forze dell’ordine, che “forse rapiscono Moro”. A sequestro avvenuto, e su
segnalazione di Cervone, il capo della Polizia incaricò il vice questore Umberto
Improta di
ascoltare la signora. Che fu interrogata nel pomeriggio e risultò senza
precedenti sfavorevoli e sana di mente, “in un appunto redatto su carta
intestata del Ministero dell’Interno, senza destinatario né protocollo”, come si
legge nella relazione del presidente della nuova commissione parlamentare
d’indagine sul caso Moro, il deputato Giuseppe
Fioroni,
pubblicata il 10 dicembre scorso nell’apposito bollettino della Camera.
L’appunto tuttavia conteneva anche “osservazioni aggiuntive” che, secondo la
relazione di Fioroni, minavano alla radice l’attendibilità della signora,
ritenuta “di livello culturale molto scadente, se non inesistente, abituata ad
ascoltare soltanto canzonette e, quindi, di scarsissima ginnastica mentale”.
Pertanto la donna, secondo l’impressione del dottor Improta riferita nella
relazione di Fioroni “in buona fede e sotto la spinta emotiva della drammatica
notizia avrebbe frainteso il significato di un comunicato radio riguardante
Moro”. E la cosa, in mancanza di una registrazione delle trasmissioni di quella
radio da parte dei centri autorizzati di controllo, finì nella nebbia, anche
giudiziaria, fra le inutili proteste levate dopo qualche mese da Cervone in una
intervista a Famiglia
Cristiana.
La nuova commissione parlamentare d’inchiesta ha giustamente riaperto e
approfondito la vicenda. La relazione di Fioroni dice: “Eppure Improta conosceva
personalmente Rossellini”, il direttore cioè della radio ascoltata dalla
collaboratrice di Cervone. “Esisteva da tempo un contatto, riconosciuto da
entrambi anche nel corso di audizioni parlamentari. Si trattava anzi di un
rapporto privilegiato, secondo quanto riferito a collaboratori della Commissione
dall’allora funzionario della Digos Vittorio Fabrizio”. Che “lasciò il servizio
poco dopo la strage di via Fani, rimase del tutto estraneo all’inchiesta e non
fu mai ascoltato dai magistrati inquirenti”, ha tenuto ad annotare Fioroni
mostrando uno stupore condivisibile. Inoltre, Improta “circa due settimane prima
dei fatti di via Fani, secondo una dichiarazione del tutto attendibile, avrebbe
ricevuto da Rossellini significative informazioni su eventi eclatanti in vista”.
Ma non è finita. La relazione Fioroni fa rilevare che “Rossellini conviveva con Giovanna
Francesca Chantal Personè,
militante di sinistra, sospettata all’epoca di essere vicina alle Brigate Rosse,
coinvolta in indagini per reati associativi”, per cui “tale circostanza rende
possibile l’ipotesi ch’egli potesse disporre di elementi di conoscenza tali da
consentirgli di formulare, sia pure in forma dubitativa, previsioni affidabili
circa iniziative di tipo terroristico”. Previsioni, d’altronde, confermate dallo
stesso Rossellini davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sulle stragi
presieduta dall’allora senatore
Giovanni Pellegrino ammettendo
di avere già riferito nell’autunno del 1978 ad un giornalista del francese Le
Matin che
“nel suo ambiente si parlava molto di un eventuale attentato delle Brigate Rosse
in coincidenza con la votazione alla Camera del governo e con l’entrata del
Partito Comunista nella maggioranza”. No. Non è finita neppure con questo. Il
presidente della Commissione ha voluto inserire nella sua relazione il testuale
racconto fatto di quella tragica mattina del 16 marzo 1978 nella Questura di
Rona, e non solo in via Fani, da Vittorio Fabrizio: “Già nelle prime ore della
mattinata circolava la notizia, nell’ambiente dell’Ufficio politico della
Questura, che il rapimento fosse stato annunziato da Radio
Città Futura” prima
dell’evento. “Nel corso della giornata – ha riferito sempre l’ex funzionario
della Digos – ho commentato riservatamente questo dato con i miei colleghi
dottor Infelisi –da
non confondere, osservo, con l’omonimo magistrato inquirente, Luciano – e
dottor De Stefano, entrambi a conoscenza della stessa circostanza. Si è trattato
di un colloquio molto cauto perché eravamo tutti consapevoli” dell’abnormità
della situazione “meritevole di approfondimento”. “Mi resi immediatamente conto
– continua il racconto – che se la notizia fosse stata rappresentata al
dirigente dell’ufficio politico, dottor Spinella, in tempo reale, come la
rilevanza dell’evento lasciava presumere, ciò avrebbe avuto conseguenze
colossali”. Avrebbero potuto quanto meno allertare telefonicamente la scorta di
Moro, e sventare l’operazione, par di capire. Il caso – o solo il caso? – volle
tuttavia che proprio il dirigente dell’ufficio politico della Questura, Domenico
Spinella,
corresse sul posto del sequestro in tempi così rapidi da precedere di poco
l’allarme della sala operativa, secondo orari e tempi su cui la commissione ha
attentamente indagato ascoltando, fra gli altri, l’allora autista del dirigente
di polizia, Emilio
Biancone.
Sequestro Moro, tutte le
ombre descritte dalla Commissione Fioroni.
Terzo e ultimo di una serie di
tre articoli dell'editorialista Francesco Damato.
Ammetto che fui fra gli
scettici, come il mio amico Mario
Sechi,
quando comparvero le prime notizie sulla decisione della nuova commissione
d’inchiesta parlamentare sul sequestro e l’uccisione di Aldo Moro di riaprire
anche il capitolo del bar all’angolo tra via Fani e via Stresa. Dietro le cui
fioriere la mattina del 16 marzo 1978 si erano nascosti i brigatisti rossi
travestiti da avieri per assaltare le auto su cui viaggiavano il presidente
della Dc e la scorta. Di quel bar – noto come Olivetti, dal cognome di uno dei
proprietari, di nome Tullio – si era tanto scritto e discusso, all’epoca del
sequestro e dopo, che mi parve curioso il tentativo di scoprire qualcosa ancora
di inedito. Sbagliavo. La lettura dei passaggi della prima relazione del
presidente della Commissione, Giuseppe
Fioroni,
a poco più di un anno dall’inizio delle indagini e a circa uno dalla fine, salvo
proroghe, mi ha fatto drizzare i capelli. E vi spiego, anzi vi racconto, perché.
E’ quanto meno inquietante la storia di quel bar, frequentato per un po’ anche
dalla scorta di Moro, almeno sino a quando il maresciallo non notò qualcosa di
talmente strano da sconsigliare alla figlia dello statista, Maria Fida, che ogni
tanto vi andava pure lei, di mettervi più piede. Il caso – o solo il caso? –
volle che quel locale chiudesse per fallimento nell’estate del 1977. E chiuso
apparve, o fu, anche quella mattina. Eppure, a sequestro appena avvenuto, a quel
bar potettero accedere per consumare qualcosa e fare le telefonate di servizio
alle loro testate giornalisti e operatori televisivi. Alcuni dei quali,
ascoltati dalla commissione, hanno raccontato di esserne poi stati bruscamente
allontanati, ma non prima di avere notato, fra i presenti, “tre persone – dice
Fioroni nella relazione – dai tratti somatici del Nord Europa che, tenuto conto
delle uniformi dell’aeronautica da essi indossate e da alcune parole pronunciate
da uno di loro, potevano provenire da un’area geografica di lingua tedesca”.
Tedesche furono anche quelle grida di “achtung, acthung” ascoltate in via Fani
nella fase finale dell’azione dei brigatisti dalla testimone Eleonora
Guglielmo.
Tedesche erano le targhe di un pullmino e di un’auto con uomini armati avvistate
a Viterbo qualche giorno dopo il sequestro di Moro dal maresciallo dei
Carabinieri Roberto
Lauricella e
segnalate alla Questura locale, dove il sottufficiale fu interrogato il 6
aprile. Seguirono anche deposizioni giudiziarie. Di almeno una di quelle targhe,
il 18 maggio successivo, la polizia locale rinvenne in Germania resti
bruciacchiati durante una perquisizione in una tipografia, non riuscendo però a
ottenere risposte di chiarimento dal titolare. Tedesca era anche la nota
terrorista Elisabeth
von Dyck uccisa
il 4 maggio 1979 a Norimberga in un conflitto a fuoco con la polizia, che le
trovò addosso – riferisce Fioroni nella sua relazione- “una carta d’identità e
una patente italiane falsamente intestate a tale Fiorella
Marabucci,
persona risultata completamente estranea agli ambienti terroristici”. Ma “il
modulo di tale carta d’identità –si legge ancora nella relazione di Fioroni-
faceva parte di uno stock di moduli in bianco rubati nel 1972 a Sala Comacina
(Como)”, due dei quali “furono rinvenuti” nel 1978, durante il sequestro Moro,
nel covo brigatista romano di via Gradoli, scoperto dalla Polizia per una
curiosissima perdita d’acqua dalla doccia. Era la base a disposizione di Mario
Moretti, il capo dell’operazione del sequestro di Moro. Tedeschi erano anche gli
otto milioni di marchi, provenienti da un sequestro in Germania e riciclati in
Italia proprio da Tullio
Olivetti,
indicato in “atti della polizia di prevenzione” come un trafficante di valuta
dal trafficante d’armi Guardigli, finito nel 1977 sotto indagine giudiziaria con
una ventina di persone e arrestato. “Ma Tullio Olivetti non venne colpito da
alcun provvedimento”, annota Fioroni nella relazione. Probabilmente gli
inquirenti diedero credito ad una perizia psichiatrica del criminologo Aldo
Semerari,
destinato ad essere ucciso nel 1982, e fatto trovare decapitato in auto a
Ottaviano nei pressi dell’abitazione del camorrista Vincenzo
Casillo,
braccio destro di Raffaele
Cutolo.
In quella perizia Guardigli, la cui compagna Maria
Pia Lavo aveva
fatto parte peraltro della segretaria di
Franco Evangelisti,
il noto sottosegretario di Giulio
Andreotti a
Palazzo Chigi, venne definito “una personalità mitomane, con una condizione
psicopatica di vecchia data e, allo stato, permanente”, per cui “i suoi atti e
le sue dichiarazioni sono espressioni sintomatologiche di tale anomalia”.
Insomma, nella strada del sequestro di Moro c’erano troppe tracce e ombre
tedesche. Oltre al colonnello dei servizi segreti italiani Camillo
Guglielmi,
presente la mattina del 16 marzo 1978 da quelle parti per fare visita con la
moglie ad un collega e trattenervisi a casa per colazione, anche lui finito, per
quanto ormai morto, sotto le lenti della Commissione presieduta da Fioroni. Per
non parlare degli altri misteri di quella maledetta strada e in quella non meno
maledetta mattina: i due passeggeri della Honda passata dopo la strage per
verificare la situazione, le fotografie scattate durante o dopo il sequestro
dall’appartamento in cui abitava la giornalista Cristina
Rossi,
affrettatasi a consegnarne il rullino al magistrato Luciano
Infelisi.
Ma esso si perse, diciamo così, nei cassetti degli uffici giudiziari. E siamo
ancora in via Fani e a quella mattina. Figuratevi il resto, successo ormai
lontano da via Fani, in quei 55 giorni che precedettero l’ultimo atto della
tragedia: l’uccisione di Moro nella Renault rossa posteggiata nel box del covo
brigatista di via Montalcini, e poi lasciata in sosta in via Caetani, a mezza
strada, simbolica e di fatto, fra le sedi nazionali della Dc e del Pci. E tutto
questo mentre il presidente della Repubblica Giovanni
Leone si
accingeva a concedere autonomamente la grazia ad una terrorista, Paola
Besuschio,
contenuta nell’elenco dei 13 detenuti con i quali i brigatisti rossi avevano
reclamato di scambiare Moro. Di quella grazia, i terroristi furono avvertiti in
tempo per accelerare l’uccisione dell’ostaggio, evitando di dividersi, ancor più
di quanto già non fossero, nella valutazione della sua congruità per il rilascio
del prigioniero. Forza, Fioroni e la commissione d’inchiesta parlamentare che
presiede. Buon anno, e buon lavoro.
RILETTURA CRITICA DELLA
STORIA DELLE BRIGATE ROSSE E DEL RAPIMENTO DI ALDO MORO.
Moro e «i fasti del
40ennale»: il post che fa litigare gli ex Br. L’ex terrorista Balzerani: «Chi mi
ospita?».
Etro: «Vergogna, ci vediamo all’inferno», scrive Fabrizio Caccia il 15 gennaio
2018 su "Il Corriere della Sera". Brigatisti contro. A due mesi
dall’anniversario di via Fani, 16 marzo 1978, il giorno del sequestro di Aldo
Moro e dell’eccidio della sua scorta, compare un post su Facebook: «Chi mi
ospita oltre confine per i fasti del 40ennale?». Il tono sembra ironico. Chi
scrive, però, non è una persona qualunque: è Barbara Balzerani, l’ex «Primula
Rossa» delle Br, che in via Fani quel giorno c’era, anche se non sparò. Il post
sul profilo Fb della Balzerani è del 9 gennaio e proprio ieri, poco prima
d’essere cancellato, viene letto da un altro ex brigatista, Raimondo Etro, che
reagisce male e scrive a sua volta una lettera aperta («Signora Barbara
Balzerani, mi rivolgo a lei...») per «chiederle di tacere semplicemente in nome
dell’umanità verso le vittime, inclusi quelli caduti tra noi...». La missiva
viene inviata per conoscenza a poche altre persone, tra cui Giovanni Ricci,
figlio di Domenico, l’appuntato dei carabinieri che in via Fani guidava l’auto
dove viaggiava Aldo Moro e l’onorevole dem Gero Grassi, membro della commissione
parlamentare d’inchiesta sul delitto Moro, che più tardi gli risponderà:
«Grazie. Bravo!». Anche Etro, però, non è uno qualunque: a lui furono affidate
in custodia le armi di via Fani, una settimana dopo la strage: «C’erano un
kalashnikov, una mitraglietta, alcune pistole - ricorda l’uomo parlando col
Corriere - Le ebbi, mi pare, da Morucci o Casimirri, le tenni in casa di mia
madre per un po’, vicino piazza Mazzini...». Oggi ha 61 anni e vende libri e
francobolli su eBay, ma si è fatto 16 anni di carcere per il concorso nella
strage di via Fani (partecipò nei mesi precedenti soltanto alla preparazione) e
nell’omicidio del giudice Riccardo Palma («La mattina del 14 febbraio 1978 -
racconta - c’ero anch’io insieme a Prospero Gallinari, Alvaro Lojacono e Alessio
Casimirri. Ma la mia pistola, diciamo, s’inceppò...»). La lettera aperta alla
sua ex compagna di lotta è durissima. Etro, tra l’altro, scrive: «Dopo avere
letto il suo commento su Facebook nel quale – goliardicamente dice lei – chiede
di “essere ospitata oltre confine per i fasti del quarantennale”.... avendo
anch’io fatto parte di quella setta denominata Brigate rosse...provo vergogna
verso me stesso...e profonda pena verso di lei, talmente piena di sé da non
rendersi neanche conto di quello che dice». C’è un passaggio, poi, piuttosto
inquietante: «Per nascondere di avere agito per conto e per fini che con la
cosiddetta rivoluzione proletaria non avevano nulla a che fare lei nega
addirittura l’evidenza. Non voglio entrare nel merito delle chiacchiere “chi
c’era o chi non c’era in via Fani, infiltrazioni, depistaggi o altro”. Mi limito
a dire semplicemente: “ci hanno lasciati fare”....». Etro ha rotto da tempo coi
“compagni” e col suo passato e anche la Balzerani, che compirà giusto domani 69
anni, oggi è una libera cittadina che scrive libri, avendo finito di scontare la
sua pena nel 2011. Ma mai pentita nè dissociata. E nella lettera Etro la
incalza: «Le Brigate rosse hanno rappresentato l’ultimo fenomeno di un’eresia
politico-religiosa che nel tentativo maldestro di portare il Paradiso dei
cristiani sulla terra...ha creato l’Inferno...Inoltre lei dimentica che chi le
permette di parlare liberamente...è proprio quello Stato che noi volevamo
distruggere...così pregni di quella stessa schizofrenia che al giorno d’oggi
affligge i musulmani che da una parte invidiano il nostro sistema sociale,
dall’altra vorrebbero distruggerlo». E la chiusa è altrettanto drammatica: «Il
silenzio sarebbe preferibile all’ostentazione di sè, per il misero risultato di
avere qualche applauso da una minoranza di idioti che indossano la sciarpetta
rossa o la kefiah. Ci rivedremo all’Inferno».
La «postina» del sequestro
che si dissociò in carcere. Il ritratto di Adriana Faranda,
scrive il 3 Febbraio 2016 "Il Tempo". Fu tra i dirigenti della colonna romana
delle Br che organizzò ed eseguì il rapimento Moro. Adriana Faranda, 66 anni,
entrò a far parte delle Brigate Rosse con l’allora suo compagno Valerio Morucci
nell'autunno 1976. Si distaccò dall’organizzazione per contrasti sulle scelte
strategiche nel gennaio 1979. Arrestata il 30 maggio di quell’anno con Morucci,
durante gli anni ottanta si è dissociata dal terrorismo e ha beneficiato in
seguito delle riduzioni di pena previste dalla legge. È uscita dal carcere nel
1994.
Inizialmente la Faranda entra
in Potere Operaio, nel 1970 sposa Luigi Rosati (all'epoca dirigente di PotOp):
dalla loro unione nasce nel 1971 la figlia Alexandra Rosati. Nel 1973 con Bruno
Seghetti, Morucci e altri fu tra i fondatori del gruppo estremistico Lotta
Armata Potere Proletario, poi l’adesione alle Bierre. Con Mario Moretti,
Prospero Gallinari, Seghetti, Morucci, Germano Maccari e Barbara Balzerani
organizzò il sequestro di Aldo Moro. Durante i drammatici 55 giorni del
sequestro fece la «postina». Insieme con Morucci si oppose all'omicidio del
politico e questo la portò all'uscita dall'organizzazione, che lasciò per
tentare di creare con Morucci e altri una nuova formazione di lotta armata, il
Movimento Comunista Rivoluzionario (MCR) . Era però stata riconosciuta dopo il
rapimento dello statista come colei che aveva acquistato le finte uniformi usate
per compiere l'agguato di via Fani e fu in seguito arrestata a Roma nel maggio
1979 insieme al Morucci e a Giuliana Conforto. Fu tra i promotori del movimento
della «dissociazione».
A Mosca la verità sulla
morte dello statista.
Stretti legami tra le Br e gli agenti del KGB. Antonio Selvatici
"Nel luglio del 1977 c’è stato un incontro tra le Br e il KGB a Mosca": sono gli
archivi dell’Est che parlano, scrive il 17 Marzo 2015 Il Tempo. "Nel luglio del
1977 c’è stato un incontro tra le Br e il KGB a Mosca": sono gli archivi
dell’Est che parlano. La nuova inchiesta voluta dai familiari delle vittime di
via Fani ed ora sulla scrivania del Procuratore generale presso la corte di
Appello del Tribunale di Roma Antonio Marini riguardante il rapimento di Aldo
Moro e l’uccisione degli uomini della scorta non può e non deve concentrarsi
solamente su quanto in quegli anni è accaduto in Italia. Il recinto del
terrorismo era più ampio. Allora, quando la fumante P38 era un simbolo ed uno
strumento di morte gli investigatori per cercare di arginare il fenomeno non si
sono molto concentrati sulle ricerche oltre confine. Ora, dopo la caduta del
Muro e la conseguente apertura degli archivi, sappiamo che uomini delle Brigate
Rosse hanno avuto frequenti rapporti sia con altri gruppi terroristici, sia con
agenti dell’Est comunista, sia con uomini del Pci conviti che la Resistenza del
dopoguerra li «aveva traditi» non compiendo l’atto finale. Negli anni passati
«sprovincializzare» le inchieste del terrorismo degli Anni di Piombo poteva
significare affrontare o scontrarsi con noti ostacoli ideologici. Oggi i tempi
sono cambiati. Sarebbe quindi un buon gesto se gli investigatori italiani che
indagano per conto del procuratore Antonio Marini ritrovassero il testo di una
richiesta di rogatoria internazionale partita da un reparto speciale della
polizia di Praga che chiedeva a Roma delucidazioni riguardanti la mitraglietta
Skorpion: la micidiale arma utilizzata per ammazzare Aldo Moro. Sembra proprio
che gli investigatori d’Oltralpe fossero riusciti a mappare il percorso della
Skorpion.
IL PCI SAPEVA? Cinque giorni
prima che Aldo Moro venisse ucciso il noto dirigente del Pci Giorgio Amendola
consigliò a Vladmir Koucky, l’allora ambasciatore cecoslovacco in Italia, di
essere prudenti nel trafficare con i terroristi italiani. Era una questione di
possibile imbarazzo politico: se si fosse venuto a sapere che un Paese amico
trafficava con i terroristi rossi italiani, la cosa avrebbe creato difficoltà in
casa Pci. Già nella primavera del 1976 il dirigente del Pci Salvatore
Cacciapuoti si recò a Praga per comunicare ai cecoslovacchi che due brigatisti
avevano raccontato al loro legale che erano stati addestrati in Cecoslovacchia.
La figlia Alba di Salvatore Cacciapuoti ha successivamente confermato
l’accaduto: «mio padre era stato incaricato da Enrico Berlinguer di denunciare
al governo cecoslovacco l’appoggio del suo servizio segreto alle Brigate rosse».
LE BRIGATE ROSSE NELL’ARCHIVIO
STASI DI BERLINO. I documenti custoditi negli sterminati archivi suggeriscono
scenari poco considerati. Ad esempio, un documento della Stasi ci dice che nel
settembre del 1978 si tenne a Dubrovnik in Jugoslavia il «Congresso segreto
internazionale» dove erano presenti i rappresentanti di alcune organizzazioni
terroristiche tra cui Settembre nero, FPLP di Wadi Haddad, le RAF e,
naturalmente, le Brigate Rosse. Un altro documento: «nel luglio del 1977 c’è
stato un incontro fra le Br e il Kgb a Mosca». Gli uomini della Stasi
raccoglievano informazioni sui brigatisti italiani. Alcuni di loro (Renato
Curcio, Lauro Azzolini, e Barbara Balzerani) sono intestatari di schede che ho
potuto visionare. Su alcune di queste (allora non si usava il computer) vi è una
nota, talvolta vergata a penna altre scritta a macchina, il cui testo è chiaro:
«Album di amici sul terrorismo internazionale». Tale album è un elenco di
terroristi compilato dal Kgb in forma di libro. Ma allora, chi era amico di chi?
Poi un mistero, vi è un documento scomparso. È quello dell’«Archivio Moro» che
troviamo citato nel retro della scheda di Valerio Morucci.
BRIGATE ROSSE E CARLOS. Lo
stesso archivio di Berlino suggerisce anche che Giorgio Bellini «in base alle
nostre conoscenze manterrebbe un collegamento continuativo con Carlos per conto
delle Brigate Rosse». Carlos, vale a dire Ilich Ramìrez Sànchez, noto terrorista
internazionale una volta a capo del gruppo «Separat», oggi è detenuto in Francia
dove sta scontando l’ergastolo. Ed a Bettola, piccolo paese dell’Appennino
piacentino noto per essere il luogo in cui è nato Pier Luigi Bersani, ha vissuto
per molti anni sotto falso nome Antonio Expedito Carvalho Perera, poi
riconosciuto come un fiancheggiatore di Carlos.
BRIGATE ROSSE, OLP E
ARMI. Sappiamo che le Brigate Rosse venivano rifor nite di armi dai palestinesi.
Non dimentichiamo i rapporti tra Mario Moretti e Abu Iyyad, la collaborazione è
stata così descritta in un testo di terrorismo internazionale: «l’Olp consegna
armi alle Br; membri delle Br hanno il permesso di addestrarsi nei campi
palestinesi in Medio Oriente; l’Olp offre assistenza ai membri Br fuggitivi; le
Br immagazzinano armi in Italia perché possono essere usati dall’Olp; le Br
parteciperanno ad attacchi contro individui israeliani in Italia». Il 9 marzo
1982, durante un’udienza del processo al rapimento del generale americano James
Lee Dozier, il brigatista Antonio Savasta ammise: «il rappresentante dell’Olp
chiarì che il contatto con noi era stato richiesto per costruire un fronte di
lotta contro Israele da noi, e con la Raf, in Germania. In seguito a ciò l’Olp
ci inviò armi e esplosivo plastico».
«Per il Comunismo, Brigate
Rosse» analisi storica di un fenomeno italiano. Rilettura critica della storia
delle BR e del rapimento di Aldo Moro. Un approfondimento di Roberto Bartali.
“Nel rileggere 18 anni di lotta armata in Italia ci si accorge che ogni tanto,
qua e là, rimangono dei buchi neri nel terrorismo rosso, buchi coperti anche di
segreti, spesso inconfessabili, di chi contro quella stagione di utopie
rivoluzionarie e sanguinarie ha esercitato l'arma della repressione in nome
dello Stato, ma anche di chi a Sinistra ha assistito alla gestazione ed alla
nascita del fenomeno BR. A parziale conferma di ciò e nella stessa direzione del
mio pensiero - per quanto sarebbe comprensibile se a qualcuno sembrasse
inopportuno fare della mera dietrologia con quanto affermato da un ex terrorista
- vanno le parole di Patrizio Peci, primo "pentito" delle Brigate rosse: "Lo
stato allora [agli inizi dell'attività brigatista] - poi non più - ti lasciava
gli spazi per poter sperare nella vittoria [...] lo stato poteva avere interesse
a lasciare spazio alla lotta armata. Interessi velati, e magari contrapposti, ma
certamente tesi a creare confusione. Altrimenti la lotta al terrorismo sarebbe
stata più immediata e aspra. Ci avrebbero stroncato subito, come hanno fatto
quando gli è parso il momento". Il fatto è che non ritengo ammissibile parlare
di dietrologia quando in ballo ci sono anche dei morti ammazzati, ma soprattutto
quando perfino a distanza di 25-30 anni dagli accadimenti continuano ad emergere
nuovi frammenti di verità fino ad ora nascoste. Analizzando la storia della
folle epopea brigatista, ci si accorge che sono presenti con una certa costanza
degli accadimenti "particolari", delle coincidenze strane, così prodigiosamente
tempestive, da far supporre - pur nella scarsità di prove certe - degli
interventi esterni ben mirati in una determinata direzione. Non possiamo però
esimerci dall'aprire una finestra su una certa parte della Sinistra italiana, ed
in modo particolare su quell'area "dura" che dal 25 Aprile 1945 (ma forse
sarebbe meglio far risalire il tutto alla c.d. "Svolta di Salerno") non ha mai
smesso di sognare la rivoluzione. Un grigio alone di mistero e di 'indicibilità'
avvolge ancora certi aspetti degli anni immediatamente successivi alla fine
della Seconda guerra mondiale ed in particolare gli avvenimenti che riguardano
l'evoluzione di quella che fu Resistenza una volta finita la guerra. Basti
pensare alle violente polemiche che il volume scritto da Pansa (Il sangue dei
vinti) ha provocato. Questo ha probabilmente due ordini di ragioni: il primo
concerne il fatto che la Resistenza, in quanto elemento decisivo e fondante
della Repubblica, ha assunto e continua ad avere -per certi aspetti giustamente-
un alone di mito. Il partigiano che combatte per la libertà dal nazi-fascismo fa
parte della storia, del costume e del sentire comune della maggior parte degli
Italiani. Il mito del partigiano è dunque un elemento fondamentale dell'Italia
post-fascista anche perchè aiuta -se così si può dire- a "ripulire" gli italiani
dalla macchia costituita dal diffuso sostegno al regime di Mussolini e -perchè
no- da quel brusco cambio di alleanze (che per taluni fu un vero tradimento o,
come la chiama Elena Aga Rossi, una "morte della Patria") che fu l'8 Settembre.
Il secondo aspetto che non consente una tranquilla trattazione dell'argomento
"Resistenza dopo la fine della Resistenza" è invece decisamente meno nobile, e
riguarda direttamente la storia del PCI, un partito che -è bene ricordarlo- ebbe
poi un ruolo fondamentale nella sconfitta del terrorismo nostrano, ma che
dall'immediato dopo-guerra ha mantenuto un reale dualismo al proprio interno: un
lato ufficiale fieramente democratico, l'altro nascosto e con delle mai dome
velleità insurrezionali. Detto per inciso, per 50 anni hanno convissuto
all'interno del PCI due anime frontalmente contrapposte, e se è vero che l'ala
dura che faceva riferimento a Pietro Secchia venne pesto messa in minoranza, è
anche vero che soldi provenienti da Mosca sono continuati ad arrivare in Via
delle Botteghe oscure fino a tempi relativamente recenti (vedere pubblicazioni
di Victor Zaslavsky), e che una parte del PCI ha continuato ad avere con il
blocco sovietico un atteggiamento di "vicinanza" nonostante i vari
allontanamenti e strappi che via via il partito ufficialmente faceva dal PCUS.
Non possiamo, in qualità di ricercatori, esimerci dal sottolineare come almeno
2000 uomini dalla fine della guerra sono passati dai campi di addestramento in
Cecoslovacchia, e di questi una buona parte era costituita da ex partigiani che
si erano macchiati di crimini nel dopoguerra e che per sfuggire alla giustizia
italiana erano stati fatti scappare in quel paese con l'aiuto del PCI. Non
possiamo non notare come già nel '52 il Sifar avesse scoperto che questi uomini
frequentavano corsi di addestramento al sabotaggio, psicologia individuale e di
massa, preparazione di scioperi e disordini di piazza, l'uso delle armi; come
trasmissioni in lingua italiana provenissero da Praga (Radio Italia Oggi) con il
preciso scopo di fornire una controinformazione comunista e che gli stessi
uomini che gestivano le trasmissioni avevano teorizzato una insurrezione
rivoluzionaria per il 1951 (abortita per una fuga di notizie che allarmò, e non
poco, i nostri servizi segreti); come l'addestramento di giovani comunisti
italiani sia proseguito fino a tutti gli anni '70, quindi ben dopo il seppur
pesante strappo operato dal PCI dopo la fine della 'Primavera di Praga'. La
domanda che ci si deve porre, in relazione all'argomento di questa
pubblicazione, riguarda dunque i rapporti che le Brigate Rosse possono aver
avuto con l'area dei Secchiani e con l'Stb (servizio segreto cecoslovacco) nei
loro 15 anni di storia, se quel passaggio simbolico di armi dalle mani dei
vecchi partigiani alle nascenti BR di cui parla Franceschini non nasconda in
realtà anche un passaggio di contatti ed aiuti con i paesi di oltrecortina e con
la Cecoslovacchia in primis, se con la morte di "Osvaldo" Feltrinelli nelle BR
siano confluiti solo i membri dei suoi GAP o anche tutta la rete di contatti
internazionali che l'editore-guerrigliero aveva. La storia la si scrive leggendo
gli avvenimenti a 360°, senza paraocchi politici o ideologici, così se è
corretto considerare l'influenza che gli USA, la CIA, certi ambienti
filo-atlantici e l'area neo-fascista hanno avuto nella storia repubblicana, è
anche corretto considerare la fazione che ad essi era contrapposta, comprese le
eventuali 'macchie'; non per infangare ma per studiare a fondo, per
capire. Tutto il percorso evolutivo delle Br è caratterizzato, a cominciare dai
suoi albori, dalla presenza di infiltrati di varia natura; ciò, se non fosse
abbondantemente provato da riscontri e testimonianze, risulterebbe inoltre
perfino facile da ipotizzare alla luce del fatto che forze di varia natura erano
riuscite ad insinuarsi con successo già negli ambienti più "caldi" del periodo
storico che della lotta armata fu un po' la culla: il '68. E' da considerare che
già nell'estate 1967 la CIA aveva promosso la "Chaos Operation" per contrastare
il movimento non violento e pacifista americano che si batteva per i diritti
civili e contro la guerra del Vietnam. Quindi aveva deciso di estenderla su
scala internazionale, in particolare in Europa, per contrastare anche il
movimento studentesco-giovanile del vecchio continente, inquinandone gli assunti
anti-autoritari e non violenti. L'operazione consisteva anche
nell'infiltrazione, a scopo di provocazione, nei gruppi di estrema sinistra
extraparlamentare (anarchici, trotzkisti, marxisti-leninisti, operaisti,
maoisti, castristi) in Italia, Francia, Germania Occidentale con l'obbiettivo di
accrescerne la pericolosità inducendo ad esasperare le tensioni politico-sociali
con azioni aggressive, così da determinare un rifiuto dell'ideologia comunista e
favorire spostamenti "a destra" (secondo la logica di "destabilizzare per
stabilizzare"). In tale direzione - dunque una conferma di quanto detto - va
anche un rapporto dedicato alla contestazione studentesca datato Febbraio 1971 e
redatto in forma riservata proprio nell'ambito della "Operazione Chaos"
dall'Ufficio Affari riservati del Viminale: "almeno all'origine si deve rilevare
la spinta di qualche servizio segreto americano [alludendo alla CIA] che ha
finanziato elementi estremisti in campo studentesco". Un ulteriore dato
interessante lo ritroviamo nella lettura del resoconto sulla riunione del
coordinamento delle forze di polizia che si tenne a Colonia il 19 Gennaio 1973 e
dedicata al problema dell'infiltrazione nei gruppi terroristici Br e RAF e nei
gruppi della sinistra extraparlamentare. Risulta infatti evidente che
l'intendimento dei vari servizi segreti non era quello di predisporre semplici
confidenti o informatori ma anche veri e propri terroristi, in grado di arrivare
al vertice del gruppo da infiltrare. E che dire delle strane "premonizioni"
avute dall'allora capo del SID, Miceli, nel 1974? Egli, interrogato innanzi al
giudice tamburino nel settembre di quell'anno dichiarò con una inquietante
lungimiranza: "Ora non sentirete più parlare di terrorismo nero, ora sentirete
parlare soltanto di quegli altri". Alla luce di ciò, non appare sconvolgente
scoprire che le infiltrazioni all'interno delle Br cominciarono piuttosto
presto. La prima talpa di cui si hanno notizie certe fu Marco Pisetta; già
compagno di Renato Curcio e di Mara Cagol alla libera università di Trento,
grazie alla sua testimonianza (il suo memoriale, che sosterrà essergli stato
ispirato direttamente da uomini dei servizi segreti, fornirà una prima e
importante fonte, anche cronologica, di dati sulla nascita della Br) il 2 Maggio
1972 venne individuata la principale base milanese delle Br, in Via Boiardo, ed
arrestato un primissimo nucleo di brigatisti. Ma all'interno delle Br l'Ufficio
Affari Riservati del Viminale era riuscito ad infiltrare un altro agente, ed
anzi era stato proprio questo - nome di battaglia "Rocco" - a prelevare
materialmente il giudice Sossi insieme ad Alfredo Bonavita per portarlo alla
così detta "Prigione del Popolo". Francesco Marra, questo il nome di battesimo
di "Rocco", era un paracadutista addestratosi in Toscana e in Sardegna all'uso
delle armi e con una sorta di specializzazione nella pratica delle
"gambizzazioni" (della quale faranno ampio ricorso le Br nel corso degli anni)
prima di entrare nelle Brigate Rosse; in seguito, a differenza di Pisetta, la
doppia identità di Marra non è venuta alla luce, ed il suo nome è rimasto fuori
da tutti i processi, stranamente coperto anche dal brigatista Alfredo Bonavita
dopo il suo pentimento. Per sua stessa ammissione, Marra si era infiltrato nelle
Br per conto del brigadiere Atzori, braccio destro del Generale dei Carabinieri
Francesco Delfino. Tra gli avvenimenti "strani" della vita delle Br è
impossibile non menzionare anche l'infiltrazione da parte dei Carabinieri di
Silvano Girotto, la terza infiltrazione all'interno del gruppo nei suoi primi
quattro anni di vita, un'ulteriore defayans della banda di Curcio e compagni che
dimostra come a confronto con l'esperienza ed il mestiere del servizio di
sicurezza dello stato - o quantomeno di parte di esso - le prime Brigate Rosse
possano essere tranquillamente definite come "Tupamaros all'amatriciana". Reso
noto dai rotocalchi come "Frate Mitra", Girotto era un ex francescano con dei
trascorsi - a dire il vero poco chiari - di guerrigliero in Bolivia ma che tra
le forze extraparlamentari (Lotta Continua in primis) godeva di una fama di
tutto rispetto, e che riuscì a far catturare in un sol colpo due capi storici
delle Brigate Rosse del calibro di Alberto Franceschini e Renato Curcio, l'8
Giugno 1974. Come racconta lo stesso Franceschini "Frate mitra appena rientrato
in Italia cercò subito di entrare in contatto con le Br [...] si fece precedere
da alcune lettere dei dirigenti del Partito Comunista di Cuba in cui si
attestava di essere addestrato alla guerriglia e vantò rapporti anche con i
Tupamaros. La cosa non poteva non interessarci". Dopo alcuni tentennamenti i
brigatisti si fecero convincere ad incontrare Girotto, e durante il terzo
incontro, a Pinerolo, la trappola dei Carabinieri scattò inesorabile. I lati
oscuri riscontrabili in merito a questo arresto sono diversi: anzi tutto bisogna
fare riferimento ad una telefonata ricevuta dalla moglie dell'avvocato - con
note simpatie brigatiste - Arrigo Levati che mise in preallarme l'organizzazione
sui rischi di quell'ultimo appuntamento. Da più parti, ivi compresi i diretti
interessati, si ipotizza che gli autori di quella telefonata furono gli agenti
del Mossad, il servizio segreto israeliano, da sempre interessato alle attività
delle Br per via dell'instabilità che la loro azione terroristica avrebbe potuto
portare ad un governo - quello italiano, appunto - che da tempo stava seguendo
una linea in politica estera definibile come filo-araba. A confermare questa
ipotesi ci sono i racconti degli stessi terroristi, (Moretti e Peci) i quali
affermano che già nel 1974 il Mossad si era fatto vivo con l'organizzazione
offrendo armi e denaro, in più, per rompere la loro iniziale diffidenza, gli
posero - come si suole dire - su di un piatto d'argento l'indirizzo del
nascondiglio del "traditore" Pisetta, che era stato portato dalla polizia
italiana in Germania. Alla luce di questi elementi non ritengo impossibile dare
credito alla veridicità di questa ipotesi, una congettura che, tra le altre
cose, è condivisa sia da Giorgio Bocca sia - però solo indirettamente - dal
Generale Delfino, ma che non cambia l'interessante realtà delle cose: attorno
alle Br ruotavano, fin dall'inizio, tutta una serie di interessi particolari,
anche molto differenti tra loro. E' un fatto, comunque, che la telefonata di
avvertimento ci fu veramente, e fu lo stesso Moretti ad essere incaricato di
darsi da fare per cercare di rintracciare Curcio prima dell'appuntamento con
Girotto; una ricerca che però si rivelò vana, come altrettanto vane e poco
convincenti sono - a mio modesto parere - le spiegazioni fornite da Moretti per
giustificare il suo fallimento in quella occasione. E poi, come ha scritto
Franceschini, pur conoscendo ora e luogo dell'appuntamento arrivò con un'ora di
ritardo, quando eravamo già stati arrestati". Come afferma sempre Franceschini:
"Quella era la seconda volta che i servizi di sicurezza avrebbero potuto
arrestare tutti i brigatisti e porre fine all'esperienza delle Br [...] noi
avevamo concordato con Girotto di dare vita a una scuola di addestramento, da
lui diretta, alla cascina Spiotta, dove nel giro di un mese tutti gli
appartenenti all'organizzazione, un po' alla volta, avrebbero partecipato ad un
breve corso di addestramento. Se chi lo aveva infiltrato avesse chiesto a
Girotto di continuare a stare al gioco dopo un mese sarebbe stato in grado di
far arrestare non solo me e Curcio, ma tutti i brigatisti. E il fatto che questo
non sia avvenuto è la riprova che l'organizzazione delle Br poteva tornare
comoda per qualcuno delle alte sfere dei servizi di sicurezza e del potere". Si
deve fare menzione anche del vertice che i dirigenti delle Br avevano avuto
giorni prima a Parma, una riunione durante la quale era stato deciso di
estromettere Moretti dal "Comitato Esecutivo" per via dell'intransigenza
dimostrata durante la trattativa per la liberazione di Sossi. Questa dato va
tenuto presente allorché alcuni osservatori - e Sergio Flamigni tra tutti -
ritengono che Mario Moretti non abbia volutamente rintracciato Curcio e
Franceschini il giorno del loro arresto. L'ipotesi si accredita maggiormente se
si considerano altre due (chiamiamole così) "stranezze": prima di tutto il fatto
che se i Carabinieri avessero aspettato solamente qualche ora in più sarebbero
stati in grado di annientare tutta la dirigenza delle Brigate Rosse arrestando,
appunto, anche Moretti. La seconda cosa bizzarra è che nonostante durante le
proprie esposizioni davanti alla "Commissione Moro" il Generale Carlo Alberto
dalla Chiesa abbia parlato chiaramente di foto scattate a tutti i brigatisti
durante i primi incontri con Frate Mitra (e Moretti era presente al 2° di quegli
incontri), le foto segnaletiche su Moretti non comparvero mai al processo di
Torino contro il "nucleo storico" delle Br, ed in più egli non sarà coinvolto in
nessuna inchiesta giudiziaria prima del caso Moro. Insomma, le sue foto
segnaletiche erano note alle forze di polizia almeno quanto la sua identità,
però - misteriosamente - non fecero la loro apparizione ufficiale se non molto
più tardi. La conclusione cui si vuole arrivare, e che appare tanto perfida per
lucidità quanto logica, è che per un motivo o per un altro le forze dell'ordine
lasciarono volutamente in libertà Mario Moretti, in modo che egli potesse
riorganizzare le Br a modo suo, seguendo cioè una logica di spietata
"militarizzazione", base di partenza necessaria per una svolta sanguinaria del
gruppo. Proprio come voleva il Mossad. Per correttezza vanno menzionate altre
ipotesi plausibili circa il mancato avvertimento di Curcio da parte di Moretti:
la prima va obbligatoriamente in contro a quanto raccontato dallo stesso
Moretti, e secondo la quale lui avrebbe profuso il massimo impegno nella ricerca
dei suoi compagni di avventura, ma solo il caso avrebbe influito negativamente
sulla sua caccia. L'altra ipotesi che mi viene di fare, in vero trascurata dagli
altri osservatori, è che Moretti abbia di sua volontà evitato di avvertire della
trappola il duo Franceschini-Curcio in virtù dell'estromissione dal Comitato
Esecutivo impostagli nella riunione di Parma. E' - la mia - un'ipotesi che,
volendo considerare anche l'aspetto umano della storia, collegando quindi il
tutto al risentimento personale ed all'ambizione di Moretti, si pone a cavallo
tra chi sostiene la completa mala fede del futuro leader del gruppo e chi invece
si dice convinto delle sue buone intenzioni. In direzione opposta si va invece
considerando un altro fatto. Nella riunione di Parma, infatti, erano state altre
le cose interessanti al vaglio delle Br, e di ciò parla lo stesso Renato Curcio
nel suo libro-intervista "A viso aperto". Raccontando la storia della sua prima
cattura, Curcio dice che Mario Moretti, che doveva avvertirlo del pericolo che
correva, "non ritiene necessario agire subito perché sa che io e Franceschini
stiamo lavorando a un certo libricino in una casa di Parma e che da quel posto
non mi sarei mosso fino a sabato notte o domenica mattina". Alla domanda di
Scialoja " Di che libricino si trattava?", Curcio rispose: " Avevamo compiuto
un'incursione negli uffici milanesi di Edgardo Sogno impadronendoci di centinaia
di lettere e elenchi di nomi di politici, diplomatici, militari, magistrati,
ufficiali di polizia e dei carabinieri [insomma tutta la rete delle adesioni al
cosiddetto "Golpe bianco" preparato dall'ex partigiano liberale con l'appoggio
degli americani ]. Giudicavamo quel materiale esplosivo e lo volevamo
raccogliere in un documento da rendere pubblico. Purtroppo avevamo tutto il
malloppo con noi al momento dell'arresto e così anche quella documentazione
preziosa finì in mano ai carabinieri. Qualche anno dopo, al processo di Torino,
chiesi al presidente Barbaro di rendere noto il contenuto del fascicolo che si
trovava nella mia macchina quando mi arrestarono e lui rispose imbarazzato: "Non
si trova più" [...] Qualcuno deve averlo trafugato dagli archivi giudiziari ".
Sarebbe interessante invece sapere qualcosa di più su quella sparizione. Anche
in questo caso, l'intervento provvidenziale dell'infiltrato Girotto, oltre ad
arrestare Franceschini e Curcio, servì a recuperare delle carte "imbarazzanti",
dello stesso tipo dei memoriali e dei resoconti dell'interrogatorio di Moro
nella Prigione del popolo... A questo punto un'altra supposizione nasce
spontanea: l'arresto di Pinerolo da parte dei Carabinieri scattò in quanto essi
sapevano della enorme pericolosità delle carte cadute in mano delle Br e dunque
dovevano recuperarle in ogni modo? In questa ipotesi altri due scenari si aprono
innanzi a noi: col primo si considera che fu dunque merito di quell'arresto
"urgentemente anticipato" se Moretti ed il resto delle Br si salvarono dalla
cattura. Il secondo considera poi la sicurezza con la quale i Carabinieri,
arrestando Curcio e Franceschini, agirono al fine di trovare - assieme a loro -
i fogli in questione. In questo caso chi altro della Direzione Strategica - se
non Moretti - era a conoscenza del fatto che quelle carte erano proprio in
viaggio per Pinerolo (e dunque può aver fatto una "soffiata")? Quella di Moretti
è dunque una figura centrale nell'analisi del fenomeno Br, in primis perché ha
vissuto quasi l'intera avventura del gruppo [girando - tra le altre cose -
impunemente per lo stivale durante il rapimento Moro nonostante fosse il nemico
pubblico n°1], poi perché a lui è legata la gestione del rapimento di Aldo Moro,
apoteosi di quelle "coincidenze" particolari di cui adesso parleremo. E' da
sottolineare come nel 1970 Nel 1970 un gruppo fuoriuscito dal CPM e composto,
oltre che da Moretti, da Corrado Simioni, Prospero Gallinari, Duccio Berio e
Vanni Mulinaris, andò a creare una struttura "chiusa e sicura", superclandestina
che potesse entrare in azione, come racconta Curcio, "...quando noi,
approssimativi e disorganizzati, secondo le loro previsioni saremmo stati tutti
catturati". Dopo poco tempo il gruppo (fatti salvi Moretti e Gallinari) si
trasferì a Parigi dove, sotto la copertura della scuola lingue Hyperion, agiva -
secondo alcuni - come una vera centrale internazionale del terrorismo di
sinistra. I contatti tra Moretti e il Superclan continuarono nel corso degli
anni 12, ed è singolare sia il fatto che a gestire il rapimento Moro fu proprio
il duo Moretti-Gallinari, lo stesso che rappresentò nel corso degli anni l'ala
più militarista e sanguinaria delle Br, sia che la stessa scuola aprì un ufficio
di rappresentanza a Roma in via Nicotera 26 [nello stesso edificio dove avevano
sede alcune società di copertura del SISMI] poco prima del rapimento del leader
DC per poi chiuderla immediatamente dopo, nell'estate del '78. Sulla "questione
Moretti" Franceschini parla chiaro: " Non ho sempre pensato che Moretti fosse
una spia ", " La prima persona che mi ha detto questo è stato Renato [Cucio,
ndr.]. Era nel 1976 alle Carceri Nuove di Torino e Curcio era stato da poco
arrestato per la seconda volta: Il dubbio era nato proprio dalla dinamica del
suo arresto. Dai sospetti di Curcio ebbe origine un'inchiesta interna fatta da
Lauro Azzolini e Franco Bonisoli, i quali aprirono un'istruttoria che però non
portò ad alcun risultato", ma un'altra inchiesta era già stata aperta "da
Giorgio Semeria ", che già dall'esterno aveva avuto il sospetto "che Mario fosse
una spia per una serie di cose avvenute a Milano". Franceschini racconta anche,
che dopo il suo arresto (nel 1974) fu interrogato dal giudice Giancarlo Caselli
che gli mostrò le foto degli incontri con frate Mitra "Le foto in cui c'ero io -
dice Franceschini - e una foto con Moretti indicato con un cerchietto. Mi chiese
se lo conoscevo e risposi di no. Lui si mise a ridere e mi disse: "Se non lo
conosce, almeno si ponga il problema del perché l'operazione è stata fatta
quando c'era lei e non quando c'era quella persona" ". Riporto questa
testimonianza perché trovo doveroso completare il quadro, ad ogni modo non è
difficile ipotizzare che usando quelle parole il giudice Caselli avesse avuto in
mente, in qual momento, altre mire; resta comunque il fatto che alcune di quelle
foto non sono più state trovate. Da citare infine una frase pronunciata dal
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa di fronte alla Commissione Moro: "...le
Brigate rosse sono una cosa, le Brigate rosse più Moretti un'altra ". Prima di
passare oltre mi è sembrato quantomeno doveroso citare l'ex capo dell'ufficio
"D" del SID Generale Maletti, ed in particolare una sua intervista rilasciata al
settimanale Tempo nel giugno 1976 in merito alle Br: "Nell'estate del 1975 [...]
avemmo sentore di un tentativo di riorganizzazione e di rilancio [...] sotto
forma di un gruppo ancora più segreto e clandestino, e costituito da persone
insospettabili, anche per censo e cultura e con programmi più cruenti [...]
questa nuova organizzazione partiva col proposito esplicito di sparare, anche se
non ancora di uccidere [...] arruolavano terroristi da tutte le parti, e i
mandanti restavano nell'ombra, ma non direi che si potessero definire "di
sinistra" ". Il culmine delle "stranezze" inerenti le Brigate rosse lo
ritroviamo però nel rapimento dell'On. Moro. I 55 drammatici giorni del
sequestro dello statista DC furono segnati fin dall'inizio da una serie
incredibile di "coincidenze". Iniziamo col dire che quella mattina del 16 Marzo
1978, giunta in via Fani l'auto di Aldo Moro (una normalissima "auto blu",
incredibilmente non blindata se consideriamo il periodo e l'importanza del
personaggio) e quella della scorta vengono bloccate da un commando delle Brigate
Rosse che apre il fuoco. In pochi istanti fu la strage: vengono uccisi gli
agenti Iozzino, Ricci e Rivera, Francesco Zizzi, gravemente ferito, morirà poco
dopo, il maresciallo Leonardi viene freddato mentre girato su di un fianco cerca
di far da scudo all'onorevole. Aldo Moro venne prelevato a forza e trascinato in
una FIAT 128 blu scuro targata "Corpo Diplomatico" che in breve si dileguò. Il
trasbordo del presidente DC - secondo la testimonianza diretta di
un'involontaria spettatrice dell'accaduto - avvenne piuttosto lentamente, una
calma quasi surreale visto ciò che era appena accaduto. Intanto al numero 109 di
Via Fani, un altro fortuito spettatore - Gherardo Nucci - scatta dal balcone di
casa una dozzina di foto della scena della strage a pochi secondi dalla fuga del
commando; dopo i primi scatti il Nucci sente il rumore delle sirene e vede
arrivare sul posto un auto della polizia seguita poi da altre. Di quelle foto,
consegnate quasi subito alla magistratura inquirente dalla moglie, non si saprà
più nulla; qualche "manina" le ha fatte sparire. A tale proposito è da
sottolineare come quelle foto, che evidentemente avevano immortalato qualcosa (o
meglio qualcuno) di importante, furono al centro di strani interessamenti da
parte di un certo tipo di malavita, la 'drangheta calabrese, di cui avremo modo
di parlare in seguito e che ad una prima analisi sembrerebbe un'intrusione
completamente fuori luogo trattandosi di terrorismo di sinistra, dunque
politico. Ecco, ad esempio, uno stralcio delle intercettazioni telefoniche
effettuate sull'apparecchio di Sereno Freato, "uomo ombra" di Moro, nel caso
specifico egli stava parlando con l'On. Benito Cazora, incaricato dalla DC di
tenere i rapporti con la malavita calabrese per cercare di avere notizie sulla
prigione di Moro:
Cazora: "Un'altra questione,
non so se posso dirtelo".
Freato: "Si, si, capiamo".
Cazora: "Mi servono le foto
del 16, del 16 Marzo".
Freato: "Quelle del posto,
lì?"
Cazora: "Si, perchè loro...
[nastro parzialmente cancellato]...perchè uno stia proprio lì, mi è stato
comunicato da giù".
Freato: "E' che non ci sono...
ah, le foto di quelli, dei nove?"
Cazora: "No, no ! dalla
Calabria mi hanno telefonato per avvertire che in una foto presa sul posto
quella mattina lì, si individua un personaggio... noto a loro".
Freato: "Capito. E' un pò un
problema adesso".
Cazora: "Per questo ieri sera
ti avevo telefonato. Come si può fare?"
Freato: "Bisogna richiedere un
momento, sentire".
Cazora: "Dire al ministro".
Freato: "Saran tante!"
Traspare lampante dunque la
preoccupazione di certi ambienti malavitosi calabresi, le foto scattate dalla
terrazza di casa Nucci avrebbero potuto portare gli inquirenti su di un sentiero
piuttosto pericoloso sia per la persona loro "cara", sia per la precisa
ricomposizione dello scenario di quella tragica mattina. Ecco poi un altro
singolare accadimento: lo stesso giorno dell'eccidio di via Fani alle ore otto
di mattina la notizia che stava per essere compiuta un'azione terroristica ai
danni di Moro fu diffusa da un'emittente radiofonica, Radio Città Futura, da
parte del suo animatore Renzo Rossellini. Poiché non si può pensare ad una
divinazione, né appare credibile che si trattasse della conclusione di un
ragionamento politico collegato agli avvenimenti parlamentari che nella stessa
giornata sarebbero avvenuti (l'inizio del dibattito alla Camera dei deputati
sulla fiducia al governo di solidarietà nazionale), non resta che concludere
che, nonostante la rigida compartimentazione di tipo militare che caratterizzava
le Br (il famoso "cubo di acciaio" di cui ha parlato tra gli altri anche
Prospero Gallinari) da qualche crepa le notizie sulla preparazione dell'agguato
fossero filtrate nell'area magmatica degli ambienti dell'Autonomia Romana (con
cui Rossellini era in contatto), che oggi sappiamo fossero stati abbondantemente
infiltrati da parte delle forze dell'ordine. Tra l'altro la sede della radio era
distante pochi passi da quella del "Collettivo di Via dei Volsci", sede storica
dell'Autonomia romana. Lo stesso Rossellini il 4 ottobre '78 dichiarò in una
intervista al quotidiano francese Le Matin (ma successivamente apparve anche su
"Lotta Continua") che: "spiegavo che le Br avrebbero in tempi molto ravvicinati,
poteva anche essere lo stesso giorno, compiuto un'azione spettacolare, e tra le
ipotesi annunciavo anche la possibilità di un attentato contro Moro".
Successivamente Rossellini smentì il contenuto dell'intervista, l'annuncio quel
16 Marzo era però stato ascoltato da diversi testimoni, casualmente non dal
Centro di ascolto dell'Ucigos (che registrava ed ascoltava tutte le radio
private...) che incredibilmente interruppe la registrazione dalla 8,20 alle
9,33. Un'altra cosa che salta subito agli occhi è la particolarità della data
scelta dalle Br per portare a termine l'azione, un giorno simbolo per tutti i
nemici del c.d. Compromesso Storico. Le testimonianze dei brigatisti dissociati,
anche su questa scelta, non fanno alcuna chiarezza: Valerio Morucci - uno dei
componenti del gruppo di fuoco - riferendo sull'accaduto ha affermato in più di
un'occasione che quello in pratica era solo un tentativo, e che nel caso l'auto
di Moro quella mattina non fosse giunta, le Br avrebbero aspettato anche il
mattino dei giorni seguenti. Di fatto però la sera prima dell'agguato vennero
squarciate le gomme del fioraio che ogni mattina sostava in Via Fani, e ciò
rende sicuro che l'azione fosse stata programmata per il 16 Marzo. Come però le
Br potessero essere sicure del passaggio di Moro e della sua scorta da quella
via proprio quella mattina, alla luce del fatto che il percorso veniva cambiato
tutte le mattine, resta tutt'oggi un mistero. Compiuta la strage e sequestrato
Moro i terroristi riuscirono a dileguarsi grazie ad una sorprendente
coincidenza: una volante della polizia stazionava come ogni mattina in Via
Bitossi nei pressi del giudice Walter Celentano, luogo dove stavano per
sopraggiungere le auto dei brigatisti in fuga; proprio qualche istante prima
dell'arrivo dei brigatisti, un ordine-allarme del COT (centro operativo
telecomunicazioni) fece muovere la pattuglia. In via Bitossi era parcheggiato il
furgone con la cassa di legno sulla quale sarebbe stato fatto salire Moro. Un
tempismo perfetto. I brigatisti avevano la certezza che quella volante si
sarebbe spostata? L'unica certezza cui possiamo fare appello per questa
circostanza è che tra i reperti sequestrati a Morucci dopo il suo arresto verrà
trovato un appunto recante il numero di telefono del commissario capo Antonio
Esposito (affiliato alla P2...), in servizio guarda caso proprio la mattina del
rapimento. Secondo il racconto degli esecutori, il commando brigatista, una
volta effettuato un cambio di auto nella già citata Via Bitossi, con il
sequestrato chiuso in una cassa contenuta in un furgone guidato da Moretti e
seguito da una Dyane al cui volante era Morucci, fa perdere le proprie tracce.
Le Br per portare a termine il sequestro del segretario del maggior partito
politico italiano e fronteggiare eventuali posti di blocco fecero uso solamente
di due auto, veramente strano se si considera che per rapire Valeriano Gancia le
stesse Br ne avevano usate tre. I dubbi si fanno insistenti se si pensa che,
sempre secondo il racconto fatto dai terroristi, il trasbordo dell'On. Moro sul
furgone che doveva portarlo nel covo-prigione di Via Montalcini avvenne in
piazza Madonna del cenacolo, una delle più trafficate e per giunta piena zeppa
di esercizi commerciali a quell'ora già aperti, mentre il furgone che doveva
ospitare il rapito (e del quale, al contrario delle altre auto usate, non verrà
mai ritrovata traccia) era stato lasciato privo di custodia, in modo tale che se
qualcuno avesse parcheggiato in doppia fila, le Br avrebbero compromesso tutta
l'operazione. Adriana Faranda in merito a questo particolare - anche di fronte
alla Commissione stragi - ha risposto che in caso di contrattempi di questo tipo
Moretti avrebbe portato il prigioniero alla prigione del popolo con l'auto che
aveva in quel momento, un'affermazione alla quale non mi sento di credere visto
l'inutile pericolo che i brigatisti avrebbero corso e considerando che, come
hanno più volte dimostrato dimostrato, non erano affatto degli sprovveduti. Non
è però difficile ipotizzare che i brigatisti vogliano coprire qualche altro
compagno che magari non stato ancora identificato. Poco dopo la strage un
tempestivo black-out interruppe le comunicazioni telefoniche in tutta la zona
tra via Fani e via Stresa, impedendo così le prime fondamentali chiamate di
allarme e coprendo di fatto la fuga delle Br. Secondo il procuratore della
Repubblica Giovanni de Matteo - ma anche per gli stessi brigatisti -
l'interruzione venne provocata volontariamente, tutto il contrario di quanto
sostenuto dall'allora SIP, che attribuì il blocco delle linee al " sovraccarico
nelle comunicazioni ". Su questo punto i brigatisti hanno affermato che il
merito di tale interruzione era da attribuirsi a dei "compagni" che lavoravano
all'interno della compagnia telefonica. Però coincidenza volle che il giorno
prima (il 15 Marzo alle 16:45) la struttura della SIP che era collegata al
servizio segreto militare (SISMI), fosse stata posta in stato di allarme,
proprio come doveva accadere in situazioni di emergenza quali crisi nazionali
internazionali, eventi bellici e...atti di terrorismo. Una strana premonizione
visto che era giusto il giorno prima del rapimento di Moro. Un mistero inerente
al giorno del rapimento riguarda poi la sparizione di alcune delle borse di
Moro. Secondo la testimonianza di Eleonora Moro, moglie del defunto presidente,
il marito usciva abitualmente di casa portando con se cinque borse: una
contenente documenti riservati, una di medicinali ed oggetti personali; nelle
altre tre vi erano ritagli di giornale e tesi di laurea dei suoi studenti.
Subito dopo l'agguato sull'auto di Moro vennero però rinvenute solamente tre
borse. La signora Moro in proposito ha delle precise convinzioni: " I terroristi
dovevano sapere come e dove cercare, perché in macchina c'era una bella
costellazione di borse ". Nonostante l'enorme quantità di materiale brigatista
sequestrato negli anni successivi all'interno delle numerose basi scoperte,
delle due borse di Moro non è mai stata rinvenuta traccia, un fatto di rilievo
se si considera soprattutto il contenuto dei documenti che il presidente portava
con se. Corrado Guerzoni, braccio destro dell'onorevole Moro, ha affermato che
con ogni probabilità quelle borse contenevano anche la prova che il
coinvolgimento del presidente DC nello scandalo Lockheed era stato frutto di una
"imboccata" fatta dal segretario di stato americano, Kissinger. Un punto,
questo, da tenere molto in considerazione, come suggerito dalle tesi del Partito
Operaio Europeo. Questo delle borse scomparse (e dei documenti da esse
contenute...) è un punto sul quale l'alone di mistero tarda a scomparire, tant'è
che nea relazione del presidente della Commissione stragi del Luglio '99, il
senatore Pellegrino continua ad indicarlo come di cruciale importanza. Chi era
veramente presente quella mattina in via Fani? Le Commissioni parlamentari hanno
ormai confermato, tanto per riportare alcuni nomi alquanto "particolari", che
quella mattina alle nove, in via Stresa, a duecento metri da via Fani, c'era un
colonnello del SISMI, il colonnello Guglielmi, il quale faceva parte della VII
divisione (cioè di quella divisione del Sismi che controllava Gladio...).
Guglielmi, che dipendeva direttamente dal generale Musumeci - esponente della P2
implicato in vari i depistaggi e condannato nel processo sulla strage di Bologna
- ha confermato che quella mattina era in via Stresa, a duecento metri
dall'incrocio con via Fani, perché, com'egli stesso ha detto: " dovevo andare a
pranzo da un amico ". Dunque, benché si possa definire quantomeno "singolare"
presentarsi a casa di un amico alle nove di mattina per pranzare, sembra
addirittura incredibile che nonostante a duecento metri di distanza dal
colonnello ci fosse un finimondo di proiettili degno di un film western, egli
non sentì nulla di ciò che era avvenuto ne tanto meno poté intervenire magari
solo per guardare cosa stesse accadendo. Ma il particolare più inquietante è che
il Guglielmi non era un gladiatore qualsiasi, bensì colui che nel campo di
addestramento sardo di Capo Marragiu si occupava dell'addestramento delle truppe
per le azioni di comando... A dire il vero l'incredibile presenza a pochi metri
dal luogo della strage di Guglielmi è stata rivelata solo molti anni dopo
l'accaduto, nel 1991, da un ex agente del SISMI - Pierluigi Ravasio - all'On.
Cipriani, al quale lo stesso confidò anche che il servizio di sicurezza
disponeva in quel periodo di un infiltrato nelle Br: uno studente di
giurisprudenza dell'università di Roma il cui nome di copertura era "Franco" ed
il quale avvertì con mezz'ora di anticipo che Moro sarebbe stato rapito. Ad ogni
modo resta il dato di fatto, perché ormai appurato, che la mattina del rapimento
di Aldo Moro un colonnello dei Servizi segreti si trovava nei pressi di via Fani
mentre veniva uccisa la scorta e rapito il presidente della DC e in più lo
stesso ha taciuto questo importante fatto per più di dieci anni. Per la verità
oggi sappiamo anche che alcune precise segnalazioni su di un possibile attentato
a Moro erano pervenute ai Servizi segreti, per esempio un detenuto della casa
circondariale di Matera aveva segnalato che "è possibile il rapimento di Moro";
la soffiata venne riferita alla locale sezione dei Servizi, ma, secondo quanto
riferito dal generale Santovito (P2) essa giunse al SISMI centrale solamente a
sequestro già avvenuto. È quantomeno singolare che una segnalazione così
precisa, e che avrebbe dovuto riguardare una personalità così importante per la
vita politica del paese, abbia seguito un iter burocatico così lento invece di
attivare immediatamente delle efficaci procedure di controllo. Evidentemente, e
la presenza di Guglielmi in Via Fani lo dimostra, all'interno dei Servizi c'è
chi aveva dato credito alla soffiata, ma invece di prevenire era andato a
controllare lo svolgimento dei fatti. Del resto il collega di Guglielmi, da cui
l'agente segreto si sarebbe dovuto recare per pranzo, interrogato, ha confermato
che egli si era effettivamente presentato nella sua abitazione ma ha anche
dichiarato che non era da lui atteso, perchè non era affatto programmato un
pranzo. L'ultima clamorosa novità inerente il fatto che qualcuno, negli apparati
dello Stato, sapeva che le Brigate Rosse volevano rapire Moro è emersa - a dire
il vero qualche anno fa - dall'oceano del web, in un sito costruito da un ex
agente segreto del Sid, Antonino Arconte. Nome in codice G.71, Arconte faceva
parte di una struttura riservatissima, la Gladio delle centurie, che aveva
compiti operativi oltre confine: trecento uomini superaddestrati, che si
muovevano all'interno delle strategie della Nato. Arconte, sardo di Cabras,
raccontò la sua storia di soldato e di 007 sul suo
sito geocities.com/Pentagon/4031). Arruolatosi nel 1970 a soli 17 anni,
partecipò a una selezione per entrare nei corpi speciali dell'Esercito. Passò
poi al Sid (Servizio informazioni della Difesa), allora guidato dal generale
Vito Miceli. Così cominciò la sua avventura in un mondo sotterraneo e
silenzioso, muovendosi per tutto il mondo con la copertura di uomo di mare della
marineria mercantile. Intervistato Arconte, l'agente G.71, parlò di una sua
missione in Medio Oriente, che si intrecciò con la tragedia di Aldo Moro. Ecco
cosa disse: "Partii dal porto della Spezia il 6 marzo 1978, a bordo del
mercantile Jumbo Emme. Sulla carta era una missione molto semplice: avrei dovuto
ricevere da un nostro uomo a Beirut dei passaporti che avrei poi dovuto
consegnare ad Alessandria d'Egitto. Dovevo poi aiutare alcune persone a fuggire
dal Libano in fiamme, nascondendole a bordo della nave. Ma c'era un livello più
delicato e più segreto in quella missione. Dovevo infatti consegnare un plico a
un nostro uomo a Beirut. In quella busta c'era l'ordine di contattare i
terroristi islamici per aprire un canale con le Br, con l'obiettivo di favorire
la liberazione di Aldo Moro". E qui, ecco il mistero: il documento è del 2 marzo
'78 e viene consegnato a Beirut il 13. Moro verrà rapito dalle Br il 16. Cioé,
nel mondo sotterraneo degli 007 qualcuno si mosse per liberare il presidente
della Dc, prima del rapimento. Quindi, si sapeva che Moro sarebbe stato
sequestrato. Recentemente una perizia ha confermato che il documento "a
distruzione immediata" che è stato fornito da Arconte è originale. Insomma,
Gladio sapeva, e con buon anticipo, che Moro stava per essere rapito. Ma
torniamo alla mattna della strage. Come ormai accertato anche in sede
parlamentare, un tiratore scelto addestratissimo armato di mitra a canna corta,
risolse gli aspetti più difficili e delicati della difficile operazione: con una
prima raffica, sparata a distanza ravvicinata, colpì i carabinieri Leonardi e
Ricci seduti nei pressi di Moro, lasciando però illeso l'onorevole DC. Fu un
attacco militare di estrema precisione: la maggioranza dei colpi (49 su di un
totale di 93 proiettili ritrovati dalle forze dell'ordine) sparata da una sola
arma, un vero e proprio "Tex Willer" descritto dai testimoni (tra i quali un
esperto di armi, il Lalli) come freddo e di altissima professionalità. Gli
esperti hanno sempre concordato sul fatto che non poteva essere un autodidatta
delle Br; nessuno dei membri del commando aveva una capacità tecnica di sparare
come quello che alcuni testimoni hanno definito appunto "Tex Willer" ed invece,
secondo le perizie, praticamente tutti i colpi letali furono sparati da uno solo
dei membri del commando. A ciò si somma il fatto che, secondo una perizia
depositata in tribunale, in Via Fani non si sparò solamente da un lato della
strada (quello cioè dove si trovavano i quattro brigatisti i cui nomi sono ormai
noti), mentre tale ricostruzione è sempre stata negata dai diretti interessati.
L'azione, definita degli esperti come "un gioiello di perfezione, attuabile solo
da due categorie di persone: militari addestrati in modo perfetto oppure da
civili che si siano sottoposti ad un lungo e meticoloso addestramento in basi
militari specializzate in azioni di commando", risulta veramente straordinaria
se si pensa che, come ha testimoniato Adriana Faranda (anch'ella in azione quel
giorno): "gli addestramenti all'uso delle armi da parte dei brigatisti erano
estremamente rari perché era considerato pericoloso spostarsi fuori Roma". La
stessa Faranda ha però recentemente aggiunto che: " ...era convinzione delle
Brigate rosse che la capacità di usare un'arma non era tanto un presupposto
tecnico ma piuttosto di volontà soggettiva, di determinazione, di convinzione
che si metteva nel proprio operato". Insomma, una - poco credibile - apologia
del "fai da te" a dispetto dell'estrema difficoltà dell'azione. Nata quasi venti
anni fa dal lavoro di Zupo e Recchia autori del libro "Operazione Moro", la
figura di del superkiller è stata ripresa, acriticamente in tutte le successive
inchieste. Zupo e Recchia affermano: " Il lavoro da manuale è stato compiuto
essenzialmente da due persone una delle quali spara 49 colpi l'altra 22 su un
totale di 91 [...] il superkiller quello dei 49 colpi, quasi tutti a segno,
quello che ha fatto quasi tutto lui, viene descritto con autentica ammirazione
dal teste Lalli anche lui esperto di armi". La perizia balistica identifica sul
luogo dell'agguato 91 bossoli sparati da 4 armi diverse. Ed effettivamente 49
bossoli si riferiscono ad un'arma e 22 ad un'altra. Occorre però notare che più
volte la perizia mette in evidenza la parzialità delle risultanze data la
vastità del campo d'azione e la ressa creatasi subito dopo il fatto: " Non è da
scartarsi nella confusione del momento, che curiosi abbiano raccolto od
asportato bossoli, o che essi calpestati o catapultati da colpi di scarpa od
altro siano rotolati in luoghi ove poi non sono stati più trovati (ad esempio un
tombino) ed infine che i bossoli proprio non siano caduti a terra perché
trattenuti dentro eventuali borse, ove era trattenuta l'arma che sparava ".
Bisogna quindi precisare che 91 non sono i colpi sparati, ma soltanto i bossoli
ritrovati sul terreno. Tenendo presente che i colpi sparati potrebbero essere
molti di più dei 91 bossoli ritrovati, il fatto che 49 colpi sono stati sparati
da un'unica arma acquista un valore del tutto relativo. Se dai bossoli, poi, si
passa all'analisi dei proiettili, il dato diventa ancor più aleatorio. La
perizia, infatti, afferma: " I proiettili ed i frammenti di proiettili repertati
sono relativamente molto pochi, un quarto circa dei proiettili che si sarebbero
dovuti trovare in relazione al numero dei bossoli. Non tutti i proiettili, e
forse la maggior parte, nello stato come sono, abrasi, dilaniati, deformati e
scomposti sono utili per definire le caratteristiche della presumibile arma".
Quanto poi all'affermazione dei 49 colpi quasi tutti a segno le risultanze
balistiche dicono: " Nei cadaveri in particolare a fronte di almeno 36 ferite da
armi fuoco sono stati repertati soltanto 13 proiettili calibro 9 mm 8 di cui
sparati da un'arma e 5 da un'altra ". Come si può notare quindi è cosa certa, ed
emerge dalla perizia, la presenza in Via Fani di un terrorista che esplode un
numero veramente rilevante di colpi. L'altro elemento che è servito per creare
la figura del superkiller è l'ormai famosa testimonianza del benzinaio Lalli che
afferma: " Ho notato un giovane che all'incrocio con Via Fani sparava una
raffica di circa 15 colpi poi faceva un passo indietro per allargare il tiro e
sparava in direzione di un'Alfetta [...] L'uomo che ha sparato con il mitra, dal
modo con cui l'ha fatto mi è sembrato un conoscitore dell'arma in quanto con la
destra la impugnava e con la sinistra sopra la canna faceva in modo che questa
non s'impennasse inoltre ha sparato con freddezza e i suoi colpi sono stati
secchi e precisi". Lalli parla quindi di una persona esperta nel maneggiare le
armi, nulla può chiaramente dire sulla precisione del killer. Ma è veramente
indecifrabile questo personaggio che maneggia così bene le armi? Nella sua
dichiarazione, Lalli assegna all'esperto sparatore un posto ben preciso: " egli
è situato all'incrocio con Via Stresa ". Secondo le ricostruzioni quella
posizione è occupata da Valerio Morucci. Perché allora ci sono dubbi
sull'identità del brigatista? Evidentemente Morucci potrebbe anche possedere le
qualità "tecniche" indicate dal Lalli. Per sincerarcene diamo uno sguardo alla
sua "carriera": Morucci entra in Potere Operaio all'inizio degli anni settanta,
come responsabile del servizio d'ordine ed è tra i primi a sollecitare una
militarizzazione del movimento. Nel febbraio del 1974 è arrestato dalla polizia
svizzera perché in possesso di un fucile mitragliatore e cartucce di vario
calibro. Alla fine del 1976, al momento dell'entrata nelle Br, devolve
all'organizzazione diverse pistole, munizioni, e la famosa mitraglietta
skorpion, già usata nel ferimento Theodoli, ed in seguito utilizzata per
uccidere Moro. Come componente della colonna romana delle Br partecipa a quasi
tutti gli attentati che insanguinano Roma nel 1977. Infine, quando insieme con
la Faranda esce dalle Br, pur essendo ormai un isolato senza concrete
prospettive militari, decide di riprendersi le proprie armi. Un vero arsenale
formato da pistole, mitra e munizioni rinvenuto in casa di Giuliana Conforto al
momento del suo arresto, il 29 Maggio 1979. A conferma del rapporto quasi
maniacale che Morucci ha con le armi ci sono moltissime testimonianze di
compagni brigatisti. Carlo Brogi, un militante della colonna romana nel processo
Moro afferma: " Morucci aveva con le armi un rapporto incredibile, anche perché,
come lui stesso mi ha detto, molte delle armi che aveva portato via le aveva
portate lui nell'organizzazione provenendo dalle F.A.C. e che queste armi erano
il risultato d'anni di ricerche per modificarle, per trovare i pezzi di
ricambio, insomma erano sue creature. Pertanto per lui separarsene era un
insulto a tutto il suo lavoro". Credo che, viste le caratteristiche di Morucci,
affermare che fosse in grado di maneggiare correttamente un fucile sia davvero
il minimo. Però Morucci - ed è stato confermato più volte anche in Commissione
stragi - ha affermato che il suo mitra si inceppò dopo 2 o 3 colpi. Dunque egli
non può essere il super killer e probabilmente è anche sbagliata la
ricostruzione fatta circa la posizione dei vari brigatisti in Via Fani; se a ciò
si aggiunge il fatto che nessuno degli altri membri del commando aveva una
preparazione da "commando", la domanda sorge spontanea: ma allora chi era il
"Tex Willer" ? I "misteri" sull'azione militare non sono però finiti. In via
Fani, dei 93 colpi sparati contro la scorta dell'onorevole Moro, furono raccolti
trentanove bossoli sui quali il perito Ugolini, nominato dal giudice Santiapichi
nel primo processo Moro, disse quanto segue: " Furono rinvenuti colpi ricoperti
da una vernice protettiva che veniva impiegata per assicurare una lunga
conservazione al materiale. Inoltre questi bossoli non recano l'indicazione
della data di fabbricazione ". In effetti vi era scritto "GFL", Giulio Fiocchi
di Lecco, ma il calibro non veniva indicato - come normalmente fanno invece le
ditte costruttrici - e nemmeno la data di fabbricazione di quei bossoli. Il
perito affermò che " questa procedura di ricopertura di una vernice protettiva
veniva usata per garantire la lunga conservazione del materiale. Il fatto che
non sia indicata la data di fabbricazione è un tipico modo di operare delle
ditte che fabbricano questi prodotti per la fornitura a forze statali militari
non convenzionali ". Alla luce di tali rilievi, mi chiedo come sia potuto
accadere che in via Fani fossero usati proiettili di questo tipo. In ogni caso,
sarebbe interessante sapere come mai questo tipo di proiettili finirono nelle
mani delle Brigate rosse e di quel commando che assassinò la scorta di Aldo
Moro. Un altro ragionamento poi avvalora la tesi del killer estraneo alle
Brigate rosse. Per quale ragione i terroristi del gruppo di fuoco indossavano
delle divise dell'ALITALIA? Quello fu effettivamente un accorgimento abbastanza
singolare, talmente strano da richiamare l'attenzione dei passanti anziché
distoglierla. La spiegazione che viene da trovare risiede nel fatto che forse
non tutti i brigatisti del commando si conoscevano fra loro, così la divisa
serviva appunto al reciproco riconoscimento, in pratica per non spararsi a
vicenda. Una conferma dunque della teoria del Killer "esterno". Ma chi poteva
essere questo killer professionista? Due persone piuttosto ben informate, Renato
Curcio e Mino Pecorelli, in merito a tale questione hanno parlato di
"occasionali alleati" delle Br; gruppi legati alla delinquenza comune che
avrebbero per l'occasione "prestato" alcuni uomini per portare a termine quella
strage. E quale luogo migliore delle carceri italiane avrebbe potuto fungere da
punto di incontro da due realtà tanto diverse? E' infatti al loro interno che si
parlò molto del sequestro (o comunque di un attentato) di un'alta personalità
politica, tanto che il SISMI ne era stato debitamente informato in tempo utile
[un detenuto comune, Salvatore Senese, informò il 16 febbraio 1978 appunto il
SISMI che le Brigate rosse stavano progettando un simile sequestro]. Il
riferimento che Mino Pecorelli fa sul suo giornale "OP" a Renato Curcio non
appare quindi casuale, perché proprio lui potrebbe aver rappresentato il tramite
ideale fra i suoi compagni liberi e gli ambienti malavitosi ai quali chiedere
temporaneo soccorso. Certi indizi puntano direttamente in Calabria. Di questo
parere sembra essere oggi anche Francesco Biscione che afferma: " probabilmente
allorché Moretti costituì la colonna romana delle Brigate rosse (fine 1975)
aveva già rapporti (viaggi in Sicilia e in Calabria) o con settori criminali o
con compagni dell'area del partito armato in grado di metterlo in contatto con
segmenti del crimine organizzato ". E ricorda tre episodi che potrebbero
costituire un serio indizio in tal senso: " La presenza del Moretti è accertata
- scrive - a Catania il 12 dicembre 1975 (insieme con Giovanna Currò, probabile
copertura di Barbara Balzerani) presso l'hotel Costa e il 15 dicembre presso il
Jolly hotel. Il 6 febbraio 1976 Moretti ricomparve nel Mezzogiorno con la
sedicente Currò, a Reggio Calabria presso l'hotel Excelsior. Oltre al fatto che
non sono mai state chiarite le finalità dei viaggi - prosegue Biscione - questa
circostanza sembra possedere un altro motivo di curiosità: i viaggi, o almeno il
secondo di essi avvennero all'insaputa del resto dell'organizzazione tant'è che
quando l'informazione venne prodotta in sede processuale suscitò lo stupore di
altri imputati ". Il terzo è stato rivelato da Gustavo Selva: dopo la
conclusione del sequestro di Aldo Moro " nel luglio 1978 venne arrestato il
pregiudicato calabrese, Aurelio Aquino, e trovato in possesso di molte banconote
segnate dalla polizia perché parte del riscatto del sequestro Costa operato
dalle Br ". E' ovvio che con quei soldi le Br potrebbero aver pagato alla
'ndrangheta qualche partita di armi, ma anche il "prestito" di un killer
professionista. Il forte sospetto resta dunque intatto. Da valutare, infine, con
la dovuta cautela, l'appunto di Mino Pecorelli ritrovato dopo la sua morte fra
le sue carte: " Come avviene il contatto Mafia-Br-Cia-Kgb-Mafia. I capi Br
risiedono in Calabria. Il capo che ha ordito il rapimento, che ha scritto i
primi proclami B.R., è il prof. Franco Piperno, prof. fis. univ. Cosenza ";
anche volendo considerare tutto questo una mera illazione si può comunque, in
questo caso, concordare con Francesco Biscione che considera come l'appunto si
riferisce ad un'ipotesi ricostruttiva che connette gli indizi riguardanti
l'esistenza in Calabria di un terminale decisivo, sebbene di incerta
definizione, dell'intera operazione del sequestro Moro. In questo modo trova una
logica spiegazione la probabile presenza in via Fani di un killer di "alta
professionalità", un professionista che il pentito calabrese Saverio Morabito ha
indicato in Antonio Nirta, detto "due nasi" per la sua capacità di usare la
lupara, anche se alcune testimonianze più recenti puntano invece il dito contro
Agostino De Vuono, anch'egli calabrese ed esperto tiratore tutt'oggi latitante;
l'incorgnita comunque resta. Le teorie e le supposizioni sul nome del Killer
lasciano però il tempo che trovano di fronte ai fatti: quella mattina del 16
Marzo 1978 le Brigate rosse vennero aiutate, e da più parti, a compiere
un'azione troppo più grande delle loro capacità. Ed anche Alberto Franceschini
continua ad esternare forti dubbi in merito. Ultima particolarità da annotare
riguardo alla tragica giornata del 16 Marzo 1978 è una deposizione di Nara
Lazzarini, segretaria di Licio Gelli, fatta nel 1985 al processo
Pazienza-Musumeci; la Lazzarini ha ricordato infatti che la mattina della strage
di Via Fani il Gran Maestro della P2 ricevette la visita di due persone
all'Hotel Excelsior di Roma, e durante il colloquio a Gelli sfuggirono le
seguenti parole: " Il più è fatto ". Può non voler dire nulla, è però una
testimonianza attendibile e come tale la riporto. E' ormai "verità processuale"
(il che non vuol dire che sia verità) che Aldo Moro sia stato tenuto
prigioniero, per tutti i 55 giorni del sequestro, nell'appartamento all'interno
1 di via Montalcini 8, nel quartiere Portuense, a Roma. Un primo accenno ad una
prigione di Moro era comparsa in un fumetto pubblicato all'inizio di giugno del
1979 dal primo numero di "Metropoli", periodico dell'Autonomia operaia. Nel
fumetto (disegni di Beppe Madaudo, sceneggiatura di Melville, pseudonimo usato
da Rosalinda Socrate) la tavola con l'interrogatorio di Moro era preceduta da
una didascalia che diceva: " Mentre a via Fani cominciano le indagini, nella
stanza interna di un garage del quartiere Prati comincia l'interrogatorio di
Moro ". Interrogato, Madaudo disse di aver ricalcato il disegno da "Grand
Hotel". Certo è che in quel fumetto saltavano fuori notizie allora sconosciute,
segno evidente che gli ambienti dell'Autonomia non erano poi così male
informati. Dopo la versione disegnata, il primo a parlare della prigione dello
statista DC è stato il pentito Patrizio Peci, che ha raccontato però di aver
appreso che Moro fu tenuto nascosto nel retrobottega di un negozio poco fuori
Roma. La versione di Peci venne in seguito smentita da Antonio Savasta,
catturato il 28 gennaio 1982 alla fine del rapimento Dozier. Il Savasta cominciò
subito a collaborare e disse di aver saputo che Moro venne tenuto prigioniero in
un appartamento di proprietà di Anna Laura Braghetti. All'inizio l'attenzione
degli inquirenti si concentrò sull'appartamento che era stato del padre in via
Laurentina 501, ma poco dopo le indagini si orientarono su via Montalcini, una
casa acquistata nel giugno 1977 per 50 milioni circa, e dove Anna Laura
Braghetti si era trasferita nel dicembre dello stesso anno. Due anni dopo anche
Valerio Morucci e Adriana Faranda hanno confermato che Moro trascorse tutta la
sua prigionia nell'appartamento abitato non solo dalla Braghetti ma anche da
Prospero Gallinari, e frequentato da Mario Moretti e da - ma lo si è saputo
molto dopo - Germano Maccari, il fantomatico "Ingegner Altobelli". Prima cosa
bizzarra è il fatto che il 5 luglio 1980 il giudice Ferdinando Imposimato
apprese che l'UCIGOS, nell'estate 1978, aveva svolto indagini sulla Braghetti e
via Montalcini. L'appunto sulle indagini gli venne consegnato il 30 Luglio, ma
era in forma anonima e non conteneva i nomi di chi aveva svolto le indagini.
Sempre a tale proposito, nel febbraio 1982 sul quotidiano "La Repubblica" Luca
Villoresi scrisse: " Sono passati pochi giorni dalla strage di via Fani quando
alla polizia arriva una prima segnalazione, forse una voce generica, forse una
soffiata precisa [...] ma all'interno 1 di via Montalcini 8 gli agenti non
bussano ". Nel 1988 si venne poi a sapere che verso la metà di luglio 1978,
pochi mesi dopo il sequestro, l'avv. Mario Martignetti (che sembra lo avesse
saputo da una coppia di suoi parenti) segnalò all'On. Remo Gaspari che una
Renault 4 rossa come quella in cui le Br lasciarono il cadavere di Moro era
stata vista in via Montalcini 8 nel periodo del rapimento ed era scomparsa dopo
la morte di Moro. Gaspari informò il ministro Rognoni il quale attivò le
indagini subito affidate all'UCIGOS. In seguito, l'ispettrice dell'UCIGOS
incaricata del caso ha riferito che dalle indagini era emerso che, fino al
giugno 1978, con la Braghetti abitava un uomo che si faceva chiamare Ingegner
Altobelli. L'ispettrice disse anche che, ritenendo che una perquisizione a due
mesi dalla morte di Moro avrebbe dato esito negativo e avrebbe insospettito la
Braghetti, preferì farla pedinare per cercare di arrivare ad Altobelli o
scoprire se frequentava gruppi eversivi. I pedinamenti durarono fino alla metà
di Ottobre ma ebbero risultati negativi perché la Braghetti usciva puntualmente
per recarsi al lavoro e al ritorno a casa faceva cose normali. Il 16 ottobre
1978, un appunto dell'UCIGOS informò la magistratura che gli inquilini
dell'interno 1 non destavano sospetti. I pedinamenti e le richieste di
informazioni sul suo posto di lavoro (di cui la Braghetti viene a sapere)
spinsero però la terrorista ad entrare in clandestinità e a lasciare (il 4
ottobre '78) l'appartamento, che nel frattempo aveva venduto ad una signora
(moglie del segretario particolare dell'ex ministro Ruffini). Nell'agosto 1978
la Braghetti ebbe un'accesa disputa con l'ex inquilino dell'appartamento,
Gianfranco Ottaviani, che aveva mantenuto la disponibilità della cantina; la
Brigatista scardinò la porta della cantina e l'ex inquilino chiamò
immediatamente la polizia. Per una lite banale la brigatista rischiò così un
pericoloso intervento della polizia. Ma invece proprio quella lite venne usata
dall'UCIGOS per spiegare che la Braghetti e Altobelli, che risultava trasferito
in Turchia da qualche mese per motivi di lavoro, non erano sospettabili, perché
altrimenti avrebbero evitato la lite con l'intervento del 113. Solo nel 1993 si
è arrivati alla vera identità del così detto "quarto uomo", Germano Maccari, che
sembra proprio essere quell'ing. Altobelli a cui erano intestate le utenze di
luce e gas, come lui stesso ammette nel 1996. Stranamente l'individuazione di
Maccari avvenne proprio lo stesso giorno in cui trapelarono dalla stampa le
dichiarazioni di Saverio Morabito secondo il quale Antonio Nirta, killer della
mafia calabrese e confidente del generale dei carabinieri Francesco Delfino, era
stato " uno degli esecutori materiali del sequestro dell'on. Aldo Moro " . Molto
interessante mi è parsa una circostanza apparsa nel suo recente libro "Il
delitto Moro" da Francesco Biscione, e riguardante il fatto che nelle immediate
vicinanze di via Montalcini, a pochi passi dal covo delle Br, abitavano numerosi
esponenti della Banda della Magliana. L'elenco è molto dettagliato: " In via G.
Fuggetta 59 (a 120 passi da via Montalcini) abitavano Danilo Abbruciati, Amelio
Fabiani, Luciano Mancini; in via Luparelli 82 (a 230 passi dalla prigione del
popolo) abitavano Danilo Sbarra e Francesco Picciotto (uomo del Boss Pippo
Calò); in via Vigna due Torri 135 (a 150 passi) abitava Ernesto Diotallevi,
segretario del finanziere P2ista Carboni); infine in via Montalcini al n°1 c'era
Villa Bonelli, appartenente a Danilo Sbarra ". In effetti la "Prigione del
Popolo" era situata proprio nel quartiere romano della Magliana, una zona
notoriamente controllata in modo capillare da quel particolare tipo di malavita
collegato, come poi si è saputo con certezza, a settori dei servizi segreti,
alla P2 e all'eversione nera. Se davvero Aldo Moro è stato tenuto nel territorio
della Banda della Magliana per tutto il periodo del sequestro, appare altamente
improbabile che la malavita della zona non ne fosse venuta a conoscenza. Ma lo
Stato si stava dando da fare per rintracciare la "Prigione del Popolo"? Ad un
osservatore inesperto i numeri sembrerebbero dire di si. Dalla relazione della
Commissione Moro emerge che dal 16 marzo al 10 maggio '78 vennero attuati 72.460
posti di blocco di cui 6.296 nella sola Roma; effettuate 37.702 perquisizioni
domiciliari di cui 6.933 nelle case dei cittadini della capitale; controllate
6.413.713 persone (cioè circa un italiano ogni 10) impegnando ogni giorno 13.000
uomini delle forze dell'ordine con l'ausilio di 2.600 automezzi. Questa enorme
mobilitazione non portò apparentemente a nulla, anzi, nel periodo del rapimento
Moro le Br commisero 2 omicidi, 6 ferimenti, 5 incendi di auto ed un attentato
contro una caserma dei Carabinieri. Come ha affermato il Procuratore generale di
Roma Pascalino: «Tante volte si fanno azioni dimostrative per tranquillizzare la
popolazione [...] non posso spiegarlo, non sta a me spiegare perchè si prferì
fare operazioni di parata anzichè ricerche. E in quei giorni si fecero
operazioni di parata». Però non ho usato il termine "apparentemente" a caso:
nonostante tutto le forze di polizia il 3 aprile '78 era riuscita a fermare o
individuare molti personaggi legati o vicini alle Br. Tanto per fare alcuni nomi
importanti si potrebbero citare Valerio Morucci, Adriana Faranda, Bruno
Seghetti. Incredibilmente però queste operazioni di controllo non ebbero alcun
seguito di indagine. Per quanto riguarda la gestione del rapimento, il campo si
ristringe, diminuiscono drasticamente le prove e di contro aumenta il numero di
indizi e deduzioni logiche possibili. Due avvenimenti accaduti il 18 aprile
segnarono a mio avviso gli sviluppi successivi del rapimento proprio in questa
direzione: la misteriosa scoperta del covo di via Gradoli ed il quasi
contemporaneo ritrovamento del falso comunicato n°7. La scoperta di una base
delle Br in Via Gradoli avvenne in un modo casuale ma alquanto strano: i
pompieri furono chiamati dagli inquilini dei piani inferiori per una perdita
d'acqua dall'appartamento dove andava a dormire il leader delle Br, Mario
Moretti (colui che interrogò Aldo Moro). L'ipotesi che ho cercato di avvalorare
- come sempre tra mille difficoltà e poche prove certe - è che quel covo, sia
stato "bruciato" da qualcuno [servizi segreti? Un infiltrato? Oppure dei
brigatisti contrari all'uccisione di Moro?] grazie al trucchetto della doccia
rivolta verso il muro per permettere a chi di dovere di recuperare le carte di
Moro riguardanti la P2, Gladio e tutto ciò che era probabilmente contenuto nelle
sue borse scomparse nonché le confessioni fatte dal presidente alle Br. Un'altra
teoria riguarda il fatto che la scoperta del covo di via Gradoli fu in qualche
modo pilotata dallo stesso Moretti per indurre un certo stato d’animo
nell'organizzazione, per forzare la mano con i propri compagni e farli
convincere che non c'era più tempo. Comunque sia, il tutto venne fatto in modo
assai rumoroso per permettere agli inquilini di essere informati per tempo dalla
TV e poter così continuare a gestire il rapimento. Serviva però un diversivo,
qualcosa che distogliesse l'attenzione generale dal covo; ecco che lo stesso
giorno "qualcuno" fece ritrovare il falso comunicato N°7, quello dove si
sosteneva che il cadavere di Aldo Moro si trovava in fondo al Lago della
Duchessa. Allo stesso tempo questa doppia operazione ha probabilmente segnato in
modo decisivo il rapimento, nel senso che questo era un chiaro avvertimento
rivolto alle stesse Br: "Guardate che possiamo prendervi quando vogliamo, che
non vi venga in mente di far concludere il sequestro in un modo differente da
quello indicato dal falso comunicato perché potreste pagarlo caro...". Dunque
mentre il comunicato arrivava al Viminale, i vigili del fuoco arrivavano in via
Gradoli: le due messinscene che procedettero in perfetta sincronia, due
"sollecitazioni" fatte affinché il sequestro si concludesse rapidamente e nella
maniera più idonea. Nello stesso comunicato - oltre a suggerire ai brigatisti
quale fosse l'epilogo più opportuno del rapimento - si trovano infatti dei
precisi "segnali" che dovevano indirizzare le Br in tale direzione, come
l'accenno alla morte di Moro mediante suicidio, proprio come era accaduto ai
capi della RAF in Germania nel carcere di Stammheim. Non è affatto credibile poi
che l'appartamento di Via Gradoli 96 sia stato lasciato da Moretti e Barbara
Balzerani nelle condizioni in cui è stato descritto nei verbali della polizia:
bombe a mano sparse sul pavimento, un cassetto messo in bella mostra sul letto e
contenente una pistola mitragliatrice, documenti e volantini disseminati ovunque
[proprio come se qualcuno avesse messo sottosopra il covo per cercare
qualcosa...]. E pare perfino incredibile che le forze dell'ordine si siano
comportate in un modo così "rumoroso" (volanti giunsero a sirene spiegate e
immediatamente si formò una piccola folla di curiosi e giornalisti) subito dopo
la scoperta del covo, quando invece dopo il ritrovamento della base di Robbiano
di Mediglia avevano atteso con la massima discrezione il rientro dei terroristi
arrestandoli uno dopo l'altro. A mio avviso, l'occulta regia della duplice
manovra del 18 Aprile poté procedere liberamente all'interno del covo
predisponendo una messinscena, allo stesso tempo diffuse un comunicato falso ma
"tecnicamente" verosimile, chiaro segnale di una perfetta conoscenza dei
retroscena del sequestro e di come le Br e Moretti lo stessero conducendo.
Appare comunque quantomeno bizzarra anche la scelta (effettuata da Moretti nel
1975) di Via Gradoli come luogo adatto a stabilirvi un covo delle Br, e non un
covo qualsiasi, ma il primo e principale punto di riferimento dei brigatisti a
Roma, abitato nell'ordine da Franco Bonisoli, Carla Brioschi, Valerio Morucci,
Adriana Faranda, Mario Moretti e Barbara Balzerani ma noto anche ad altri
brigatisti. La bizzarria risiede nel fatto che via Gradoli era una strada
stretta e circolare, lunga seicento metri e con un solo accesso-uscita sulla via
cassia; dopo un breve tratto rettilineo di appena cento metri la strada
disegnava un circuito di mezzo chilometro e ritornava al breve tratto
"obbligatorio", dal quale si poteva agevolmente controllare gli spostamenti di
tutti gli abitanti della via, l'esatto opposto, dunque, delle normali cautele
adottate normalmente dai brigatisti. Caso vuole poi che al n° 89 di via Gradoli,
nell'edificio che fronteggiava - dalla parte opposta della strada - il civico 96
con il covo delle Br, abitava il sottufficiale dei Carabinieri Arcangelo
Montani, agente del SISMI. Ma i servizi segreti non si limitavano solamente a
controllare la via, via avevano addirittura stabilito un proprio ufficio; di
questo un ex militante di Potere operaio aveva avvisato le Br, ma esse, una
volta localizzato con precisione quell'ufficio, decisero incredibilmente di
mantenere ugualmente il covo in quella strada. Tornando ai giorni del rapimento,
una delle possibili implicazioni logiche che la scoperta "accidentale" del covo
comportò fu quella di far diventare anche la prigione di via Montalcini
piuttosto insicura, dunque è possibile - anzi, assai probabile - che Moro sia
stato portato velocemente in un altro covo-prigione. Le carte di Moro
all'interno del covo "bruciato" furono forse ritrovate, ma probabilmente non
nella loro totalità, e la cosa dovette suscitare le ire degli interessati,
tant'è vero che - ma qui forse le mie ipotesi diventano troppo fantasiose - chi
nel corso degli anni ne è stato probabilmente in possesso è stato in qualche
modo eliminato (Pecorelli e Dalla Chiesa, tanto per fare due nomi). Con il
duplice messaggio del 18 Aprile, rivolto chiaramente al vertice Br, la gestione
del sequestro entrò in una nuova fase; non c'era altro tempo, le Brigate rosse
non avevano più la possibilità di proseguire la "campagna di primavera" da loro
progettata ma dovevano piegarsi a delle volontà indiscutibilmente superiori:
apparati "deviati" dello stato ed il loro occasionale "braccio destro", la
"Banda della Magliana" cui apparteneva Chichiarelli. Come vedremo, molti indizi
ci indirizzano proprio in questo sentiero. Ma esiste un'altra ipotesi da
valutare. Come sostenuto dal recente volume 'Il Misterioso intermediario' di
Fasanella e Rocca: "A lasciare aperta la doccia potrebbe essere stato lo stesso
Moretti. E usando la logica capovolta, che spiega molti episodi di queste trame
occulte, se ne può comprendere anche il perché. Il capo brigatista si era
impossessato della gestione del sequestro, esautorando di fatto i compagni.
Forse voleva che ai militanti giungesse il messaggio che a Roma non c'era più
nessun nascondiglio sicuro, visto che era stata scoperta perfino la base del
capo; e che di conseguenza, bisognava affrettarsi a portare Moro fuori città".
Ma se il 18 Aprile '78 fu la data dalla quale cambiò materialmente la gestione
del rapimento, il momento in cui venne presa - e da più parti - la decisione di
intervenirvi direttamente fu con ogni probabilità immediatamente successiva, e
precisamente quando venne resa nota la prima lettera di Moro a Cossiga, in cui
sollecitava la trattativa con le Br invocando la ragion di stato e non motivi
umanitari. Quella lettera doveva restare segreta e nelle intenzioni di Moro
doveva servire ad aprire un canale diretto per la trattativa. Invece Mario
Moretti la allegò al comunicato numero 3 delle Br, in cui si annunciava che il
processo a Moro stava continuando " con la piena collaborazione del prigioniero
", e la fece recapitare ai giornali. A quel punto probabilmente si attivarono
molti servizi segreti: quelli occidentali per proteggere gli eventuali segreti
rivelati da Moro, quelli orientali per carpirli. I primi promettendo
salvacondotti ai brigatisti; i secondi aiuti e appoggi alla rivoluzione. Una
conferma che la base Br di Via Gradoli 96 - "centrale operativa" del sequestro
Moro - fosse nota a molti si ebbe pochi giorni dopo il rapimento di Moro, quando
cinque agenti del commissariato "Flaminio Nuovo", guidati dal maresciallo
Domenico Merola perquisirono appunto gli appartamenti di via Gradoli 96. Durante
il primo processo, Merola racconta che l'ordine era venuto, la sera prima
dell'operazione, dal commissario Guido Costa. " Non mi fu dato l'ordine di
perquisire le case. - dice il maresciallo ai giudici - era solo un'operazione di
controllo durante la quale furono identificati numerosi inquilini, mentre molti
appartamenti furono trovati al momento senza abitanti e quindi, non avendo
l'autorizzazione di forzare le porte, li lasciammo stare, limitandoci a chiedere
informazioni ai vicini. L'interno 11 fu uno degli appartamenti in cui non
trovammo alcuno. Una signora che abitava sullo stesso piano ci disse che li'
viveva una persona distinta, forse un rappresentante, che usciva la mattina e
tornava la sera tardi ". " Fui io a disporre i controlli dei mini appartamenti
della zona - conferma il vice questore Guido Costa - in seguito ad un ordine
impartito dal questore, che allora era Emanuele De Francesco. L'esito
dell'operazione fu negativo ". La data della mancata perquisizione del covo è il
18 marzo 1978, due giorni dopo il rapimento, almeno secondo la relazione
informativa scritta da Merola e consegnata da De Francesco ai giudici solo nel
1982, perché fino a quel momento non era stato possibile trovarla. Nell'estate
del 1978, il giornalista Sandro Acciari scrisse sul "Corriere della sera" che
tra il 16 e il 17 marzo, alla segreteria del ministero dell'Interno era arrivata
una segnalazione anonima dell'esistenza di un covo delle Br in via Gradoli e che
il ministro Cossiga aveva incaricato il capo della polizia Parlato di disporre
perquisizioni nella zona. Parlato, interrogato dal giudice Achille Gallucci
aveva smentito questo fatto. Nel 1982, al processo, Acciari disse di aver
appreso la notizia, a livello di indiscrezione, negli ambienti del palazzo di
giustizia, e di avere avuto conferma da Luigi Zanda, all'epoca addetto stampa
del ministro dell'Interno Cossiga. Acciari ha precisato però di aver saputo in
seguito dallo stesso Zanda che nella loro conversazione telefonica ci fu un
equivoco, perché Zanda credeva che Acciari si riferisse alla vicenda della
seduta spiritica in cui emerse il nome "Gradoli". Anche il giornalista Mino
Pecorelli, ucciso un anno dopo in circostanze ancora oscure, e anche lui
presente nelle liste della P2, scrisse sul numero del 25 aprile 1978 del suo
settimanale "OP": " Nei primi dieci giorni dopo il sequestro di Moro, in seguito
ad una soffiata preziosa, via Gradoli e in modo speciale lo stabile numero 96
erano stati visitati ben due volte da squadre di polizia. Ma davanti alle porte
degli appartamenti trovati disabitati, i poliziotti avevano desistito. Avevano
bussato doverosamente anche alla porte dell'appartamentino-covo e non ricevendo
l'invito ad entrare se n'erano andati ". Prima di procedere oltre mi preme
sottolineare quanto affermato da Flamigni sulle fonti di Pecorelli (già
affiliato alla P2 ma ai tempi del rapimento 'dissociato'): "la rete informativa
e le fonti di Pecorelli durante i 55 giorni del sequestro Moro risulteranno
documentate dalle agende del giornalista. Vi erano annotati contatti, telefonate
e incontri [...] soprattutto con appartenenti ai servizi segreti: dal P2ista
Umberto D'Amato (esperto di intelligence, consigliere del ministro dell'interno
e capo della Polizia), a Vito Miceli (ex capo del SID, affiliato alla P2) dal
generale Maletti (P2) al capitano Labruna (P2) al capitano d'Ovidio (P2)". Ma
c'erano anche incotri con i magistrati Infelisi e DeMatteo, con avvocati, con
politici di varie forze politiche, con il venerabile maestro Licio Gelli. Le
informazioni a sua disposizione erano dunque sempre di primissima mano. Tra le
vicende inusuali accadute durante i 55 giorni del rapimento Moro è da menzionare
- se non altro per il nome dei presenti - anche quella del 2 aprile 1978. Nella
casa di campagna di Alberto Clò a Zappolino, alle porte di Bologna, si riunì un
gruppo di professori universitari con tanto di mogli e bambini. Erano presenti
l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi con la moglie Flavia, Alberto,
Adriana, Carlo e Licia Clò, Mario Baldassarri e la moglie Gabriella, Francesco
Bernardi, Emilia Fanciulli. Secondo i racconti, per allentare la noia di una
giornata di pioggia, a qualcuno dei partecipanti venne la bizzarra idea di
tenere una seduta spiritica. I partecipanti avrebbero quindi evocato gli spiriti
di don Luigi Sturzo e Giorgio La Pira chiedendo loro dove si trovasse la
prigione di Aldo Moro. Gli spiriti - incredibilmente - formarono le parole
Bolsena-Viterbo-Gradoli e indicarono anche il numero 96. Secondo i racconti dei
partecipanti, fu proprio il terzo nome ad incuriosirli, tanto da prendere un
atlante per controllare se esistesse una località chiamata Gradoli. Il 4 aprile,
a Roma per un convegno, Prodi parlò di questa indicazione a Umberto Cavina, capo
ufficio stampa della DC, che la trasmise a Luigi Zanda, addetto stampa del
ministro dell'Interno, il quale fece un appunto per il capo della polizia,
Giuseppe Parlato. Parlato ordinò di perquisire la zona lungo la statale 74, nel
piccolo tratto in provincia di Viterbo, in località Gradoli, casa isolata con
cantina. Il rastrellamento della zona viene effettuato il 6 aprile, senza
risultati. Nel luglio 1982, al processo, Eleonora Moro, moglie di Aldo Moro, ha
raccontato che, quando venne a sapere della seduta spiritica (in
quell'occasione, la signora Moro dice però che l'indicazione Gradoli venne fuori
" due o tre giorni dopo il rapimento " e questo contrasta con la data indicata
per la seduta spiritica), riferì " la cosa all'on. Cossiga e ad un funzionario
che credo fosse il capo, il responsabile delle indagini, ma non ricordo come si
chiamasse. Chiesi loro - continua la signora Moro - se erano sicuri che a Roma
non esistesse una via Gradoli e perché avessero pensato subito, invece, al paese
Gradoli. Mi risposero che una tale via non c'era sulle pagine gialle della
città. Ma quando se ne andarono da casa, io stessa volli controllare l'elenco e
trovai l'indicazione della strada. In seguito mi dissero che erano stati a
vedere in quella zona, ma avevano trovato solo alcuni appartamenti chiusi. Si
giustificarono dicendo che non potevano sfondare le porte di ogni casa della
strada ". Il giorno dopo Giovanni Moro, figlio di Aldo, conferma che fu Cossiga
a sostenere che via Gradoli non esisteva nello stradario di Roma. Cossiga ha
però escluso di essere lui la persona che negò l'esistenza di via Gradoli. Nel
1995, la relazione sulle stragi e il terrorismo presentata dal presidente della
commissione parlamentare Giovanni Pellegrino sostenne che l'indicazione di
Gradoli era filtrato negli ambienti dell'Autonomia bolognese e il riferimento
alla seduta spiritica non era altro che un trasparente espediente di copertura
della fonte informativa. A parziale conferma di ciò sta anche la testimonianza
di Giulio Andreotti che, davanti alla Commissione, ha detto: " non credo alla
storia di Gradoli a cui si arrivò con la seduta spiritica. Quell'indicazione
venne dall'Autonomia operaia di Bologna. Non lo si disse per non dover inguaiare
qualcuno ". Pochi giorni dopo, Bettino Craxi intervenne sul caso Moro sostenendo
che " nessuno può credere alla tesi della seduta spiritica dal momento che le
notizie su via Gradoli si seppero da ambienti legati strettamente
all'organizzazione terroristica. Gli stessi che ci diedero notizie anche di via
Montalcini ". " Gradoli - ha confermato in quei giorni l'avv. Giancarlo Ghidoni,
difensore di molti esponenti dell'autonomia bolognese - era una parola che
nell'ambiente di Autonomia Operaia si sussurrava. L'organizzazione all'epoca del
sequestro Moro premeva perché lo statista non fosse ucciso e fosse liberato.
L'Autonomia era molto preoccupata, voleva che cessassero certe attività,
convinta che il fucile stesse sopravanzando la testa, e che certe cose andassero
a danno della sinistra rivoluzionaria [...] Una persona, di cui non posso
ovviamente rivelare il nome, mi disse: "Hanno detto che Moro è a Gradoli.
Intendeva proprio il paesino del viterbese dove andarono a cercare Moro, non la
via romana con lo stesso nome. Evidentemente le informazioni che aveva erano
parziali" ". Infine, da una nota della DIGOS del 19 agosto 1978, che riprende un
appunto precedente dell'UCIGOS, risulta che via Gradoli era sotto controllo già
in epoca precedente al sequestro Moro per la segnalazione nella strada della
ripetuta presenza di un furgone Volkswagen di proprietà di Giulio De Petra,
militante di Potere Operaio, il cui numero telefonico era nell'agenda di
Morucci. Le cose non devono però sorprendere; in effetti Valerio Morucci era
ritenuto un valido appoggio "militare" da parte di tutte l'ala dura dell'ormai
disciolto Potere Operaio, pochi però sanno che egli agiva d'intesa con Piperno e
Pace svolgendo il ruolo di cerniera tra le Br e l'Autonomia nell'ambito della
progettata unificazione di tutte le organizzazioni armate, al fine di rendere
praticabile " l'irlandizzazione della capitale ". Nel 1997 l'on. Enzo Fragalà,
chiedendo l'audizione di Prodi in commissione parlamentare d'inchiesta sulle
stragi e il terrorismo, ha detto: " in via Gradoli vi erano quattro interni 11,
due civici 96 con due scale ciascuna. Vi furono indicazioni diverse fra DIGOS e
commissariato Flaminio Nuovo sulle scale da perquisire; vi sono legami di
società intestatarie di alcuni interni 11 e altre società collegate con il
ministero dell'Interno e con il Sisde; all'interno del covo Br fu ritrovato il
numero di telefono dell'immobiliare Savellia, società di copertura del Sisde;
perché non si é indagato sui mini-appartamenti di via Gradoli 96 e 75 intestati
all'ex capo della polizia Parisi e sui rapporti tra Domenico Catracchia, già
amministratore del palazzo, e lo stesso Parisi ? ". All'Immobiliare "Savellia"
era intestato anche un palazzo in via di Monte Savello (vicino al ghetto ebraico
e a via Caetani), di cui c'erano tracce in un appunto di Moretti. L'8 marzo
1998, l'ex deputato socialista Falco Accame, criticando la mancata attuazione
del "piano Paters", segnalò l'appartamento di via Gradoli come riconducibile
alla società immobiliare Savellia, società di copertura del SISDE. Secondo
Accame, come per Fragalà, " i mini appartamenti di via Gradoli, numeri 96 e 75,
erano intestati all'ex capo di polizia ". Attualmente l'Immobiliare Savellia
risulta di proprietà del Sovrano Ordine di Malta. In Via Gradoli i servizi
segreti italiani disponevano però anche di un ufficio; la cosa venne riferita
alle Br da un'ex militante di Potere Operaio, ma nonostante questo, i brigatisti
decisero di mantenere ugualmente il loro covo in quella strada, in barba a
qualsiasi legge della logica e della sicurezza (tanto più che nella stessa via
Gradoli c'era anche un covo frequentato da estremisti di destra) 46. Anche
questo fatto risulta essere piuttosto strano. C'è però un'altra pista da
seguire: c'era qualcuno che all'interno delle Brigate rosse riteneva talmente
sbagliata l'operazione in progetto da tentare di farla fallire avvertendo in
anticipo le forze istituzionali ? Un'ipotesi da fare è che all'interno delle
Brigate rosse vi fosse un partito della trattativa che mirava alla salvezza
della vita di Moro e che questo gruppo, oltre a discutere per tentare di far
maggioranza sulla propria opinione, abbia messo addirittura lo Stato sulle
tracce, per esempio, del covo di via Gradoli. Infatti, scoprire quel covo
avrebbe significato arrivare subito a Moretti. Ed a via Gradoli fu mandata per
ben tre volte la Polizia ed addirittura fu fatta arrivare a Prodi ed a Clò
l'indicazione "Gradoli", che poi fu mistificata con la famosa seduta spiritica
di cui tutti sappiamo. E' vero che vi era questo partito della trattativa
(altrimenti detto "ala Movimentista") all'interno delle Brigate rosse il quale,
ritenendo politicamente disastrosa l'uccisione di Moro, tentò in tutti i modi di
far scoprire il covo di via Gradoli, alla fine addirittura col telefono della
doccia in cima ad un manico di scopa messo contro il muro per far allagare
l'appartamento di modo che, visto che non se ne poteva più di uno Stato che non
riusciva a scoprire il covo, fossero almeno i pompieri ad arrivarvi, trovando
sul muro steso il drappo delle Brigate rosse e sul tavolo tutte le armi affinché
fosse chiarissima l'indicazione che si trattava proprio di un covo dei
terroristi? E' bene ricordare che la porta del covo non era stata scassinata e
inoltre che per motivi di sicurezza, era abitudine dei brigatisti non avere più
di due chiavi di ogni covo, dunque siccome Via Gradoli 96 era in quel periodo
frequentata solo da Moretti e da Barbara Balzerani, è logico supporre che
solamente loro avessero le chiavi. Questa spiegazione è supportata - ovviamente
- dalla Faranda, cioè da colei che (assieme a Morucci) potrebbe essere
l'artefice di un tale piano essendo il duo notoriamente contro un epilogo
tragico del rapimento Moro. Dagli atti del processo "Metropoli" traspare (a mio
avviso perfino in modo un pò eccessivo) che Morucci e Faranda erano pedine in
mano a Piperno, leader dell'Autonomia, e guarda caso è proprio dalle file
dell'Autonomia che provenivano tutti i "messaggi" a favore degli inquirenti (da
quello di Radio città futura a quello emerso nella seduta spiritica di Prodi).
Dunque Morucci e la Faranda, nel periodo di circa due mesi in cui lo avevano
abitato, avevano fatto delle copie della chiave che apriva il covo di Via
Gradoli ? Furono loro ad architettare il tutto ? E' una possibilità, è in quanto
tale la riporto, però oggettivamente non mi sento di dargli troppo peso, anche e
soprattutto in considerazione della "coincidenza" temporale con il ritrovamento
del falso comunicato n° 7, vero punto di svolta del sequestro. A dire il vero
c'è un'altra possibilità, cioè che effettivamente il nome Gradoli sia stato
fatto saltar fuori proprio come riferimento al paesino di Gradoli -sito nella
zona di Bolsena- e poi effettivamente rastrellato da circa 2000 agenti, perché
l'operazione di polizia in quel paese serviva a dare l'allarme agli occupanti di
via Gradoli che, infatti, dopo poco abbandonarono il covo. A questa ipotesi mi
sento di rispondere che in questo caso i brigatisti avrebbero certamente evitato
di abbandonare il covo con tutto il materiale che vi è stato poi ritrovato, armi
e documenti in primis, e poi la perquisizione del paesino è un pò troppo
antecedente. A questo punto sorge però spontanea un'altra domanda: a Moretti e
alla Balzerani deve aver fatto piuttosto paura sentire che la polizia stava
perlustrando un posto con lo stesso nome della via ove si recavano a dormire,
questo però solo usando la logica, una logica che gli avrebbe dovuto suggerire
di abbandonare velocemente quel covo, un logica che invece non li ha guidati, se
è vero com'è vero che i due brigatisti hanno dormito in quell'appartamento fino
alla sera precedente la sua scoperta. Come potevano essere sicuri che la polizia
non sarebbe arrivata e avrebbe messo sotto sopra anche la Via Gradoli dopo il
paesino Gradoli del Viterbese ? Fu incoscenza o certezza ? L'8 maggio 1978, alla
vigilia dell'uccisione di Aldo Moro: il Corriere della Sera pubblicò in prima
pagina un articolo, firmato da Sandro Acciari e Andrea Purgatori, che parlava di
elenchi trovati nel covo Br di via Gradoli, scoperto il 18 aprile. Gli elenchi
di cui si parlava sarebbero stati due: uno contenente nomi di politici,
militari, industriali e funzionari di enti pubblici, l'altro di esponenti della
DC a livello regionale, provinciale e comunale. L'articolo rendeva noti anche
alcuni dei nomi contenuti nel primo elenco: Loris Corbi, Beniamino Finocchiaro,
Michele Principe, Publio Fiori. Del secondo elenco era citato solo Girolamo
Mechelli (ferito in un attentato il 26 aprile 1978), la cui presenza nelle liste
venne però smentita dalla DIGOS, che così confermò implicitamente l'esistenza
degli elenchi. Il giorno dopo, il 9 maggio, mentre tutti i giornali si
occupavano della vicenda, il Corriere della sera pubblicò un altro articolo
sullo stesso argomento e vennero fatti anche i nomi di Gustavo Selva e dell'on.
Giacomo Sedati (DC). Il 10 maggio i giornali furono completamente occupati dalla
notizia dell'avvenuta uccisione di Moro, verificatasi il 9, e quindi la serie di
rivelazioni si interruppe. Naturalmente questi elenchi, trovati in un covo Br,
vennero ritenuti una "schedatura" di potenziali vittime di attentati, un'ipotesi
rafforzata dal fatto che Fiori era già stato ferito in un agguato, il 2 novembre
1977. Nel 1978 però erano ancora sconosciuti gli elenchi dei presunti iscritti
alla P2 [ poi trovati dalla Guardia di Finanza a Castiglion Fibocchi nel 1981 ]
e nessuno poteva far caso ad un qualsiasi legame esistente tra quei nomi. Solo
adesso possiamo notare infatti che, a parte Sedati, i nomi delle altre cinque
persone (su sei), Corbi, Principe, Finocchiaro, Fiori e Selva comparivano anche
nelle liste della P2, composta, in effetti, soprattutto da politici, militari,
industriali e funzionari di enti pubblici, come l'elenco trovato in via Gradoli.
E' una coincidenza un po' strana, soprattutto se si pensa che la stessa mattina
del 18 aprile, giorno della scoperta del covo di via Gradoli, "qualcuno"
architettò il falso comunicato del lago della Duchessa. Il falso comunicato,
preparato da Toni Chichiarelli (falsario legato alla banda della Magliana) e
tutto ciò che logicamente ne sarebbe seguito, sembra dunque essere stato
organizzato anche per distrarre l'attenzione generale dal materiale ritrovato in
via Gradoli. Se però questo materiale si trovava in via Gradoli insieme ad un
elenco di iscritti e funzionari locali della DC, è probabile che provenisse da
quelle famose borse di Moro che sembrano non esser mai state ritrovate (i
brigatisti - o meglio Gallinari che ne fu incaricato - hanno detto di aver
bruciato tutte le carte di Moro) e che poteva contenere informazioni su apparati
dei servizi segreti paralleli e altre organizzazioni di sicurezza allora
sconosciute (Gladio, P2, ecc...). Assolutamente incredibile - anche a detta
della Commissione Moro - fu poi il ritardo con il quale venne studiato il
materiale ritrovato all'interno del covo di Via Gradoli: un'analisi attenta
avrebbe infatti permesso alle forze di polizia di arrivare facilmente alla
tipografia Triaca di Via Foà, ove le Br stampavano tutto il loro materiale e
dove lo stesso Moretti spesso passava. Le forze di pubblica sicurezza giunsero
all'individuazione della tipografia soltanto dopo la conclusione del rapimento
di Aldo Moro. Obbligatorio adesso fare un excursus sulla figura del falsario
Toni Chichiarelli, colui che scrisse il falso comunicato n°7, ed a questo
proposito nulla mi è sembrato meglio delle parole con cui il defunto On.
Cipriani argomentò le sue scoperte di fronte alla Commissione Parlamentare: "
Toni Chichiarelli è un personaggio romano legato alla banda della Magliana, con
tutto ciò che ne consegue: conosciamo infatti i collegamenti della banda della
Magliana con la mafia, con la destra eversiva e con i servizi segreti, in
particolare con la persona del generale Santovito che guarda caso faceva parte
di uno dei comitati di crisi. Toni Chichiarelli era anche in contatto con un
informatore, un agente del Sisde, tale Dal Bello, un personaggio di crocevia
anche con la malavita romana, con i servizi segreti e la banda della Magliana.
Toni Chichiarelli interviene nella vicenda Moro dimostrando di essere un
personaggio assai addentro alla vicenda stessa (questo è quanto scrive il
giudice Monastero che ha condotto l'istruttoria sull'assassinio di Toni
Chichiarelli), come dimostrano due episodi. Il primo, che è stato chiarito, è il
seguente: Toni Chichiarelli è l'autore del comunicato n.7, il falso comunicato
del Lago della Duchessa; ed è anche l'autore del comunicato n.1 in codice,
firmato Brigate rosse-cellula Roma sud. Toni Chichiarelli fece trovare un
borsello su un taxi, all'interno di questo borsello erano contenuti alcuni
oggetti che facevano capire che lui conosceva dal di dentro la vicenda Moro.
Fece trovare infatti nove proiettili calibro 7,65 Nato, una pistola Beretta
calibro 9 (e si sa che Moro è stato ucciso da undici colpi, dieci di calibro
7,65 e uno di calibro nove); fece trovare dei fazzoletti di carta marca Paloma,
gli stessi che furono trovati sul cadavere di Moro per tamponare le ferite; fece
trovare quindi una serie di messaggi in codice, e una serie di indirizzi romani
sottolineati; fece trovare dei medicinali e anche un pacchetto di sigarette,
quelle che normalmente fumava l'onorevole Moro; inoltre un messaggio con le
copie di schede di cui farà ritrovare poi l'originale in un secondo episodio. Vi
è un secondo aspetto. Dopo la rapina della Securmark, ad opera della banda della
Magliana con Toni Chichiarelli come mente direttiva, quest'ultimo fa trovare -
lo scrive il giudice Monastero - una busta contenente un altro messaggio con gli
originali di quattro schede riguardanti l'on. Ingrao ed altri personaggi. Questa
volta, come dicevo, ci sono gli originali: si tratta di schede relative ad
azioni che erano state programmate e previste; fa trovare però anche un
volantino falso di rivendicazione delle Brigate rosse. Il giudice poi scrive:
"Si rinveniva una foto Polaroid dell'onorevole Moro apparentemente scattata
durante il sequestro". Viene eseguita una perizia di questa foto, e si rileva
che non si tratta di un fotomontaggio. Come sappiamo, delle Polaroid non si
fanno i negativi; è quindi una foto originale di Moro in prigione che
Chichiarelli, dopo l'episodio del borsello, fa ritrovare in questo secondo
messaggio, con le schede originali che riguardano Pietro Ingrao, Gallucci, il
giornalista Mino Pecorelli, che sarà in seguito ucciso, e l'avvocato Prisco ".
Anche volendo ignorare buona parte delle coincidenze riscontrate e tutte le
deduzioni fattibili, resta intatta una domanda: come mai ad un certo punto del
rapimento Moro si iniziano a trovare tracce che portano direttamente alla Banda
della Magliana ? Il bello è che la pista legata a questa feroce banda romana non
si esaurisce, ma riguarda anche la morte di Aldo Moro. Ai miei occhi, infatti, è
sempre stata poco credibile la versione raccontata dalle Br secondo la quale
Moretti, che aveva discusso con il presidente DC per 55 lunghi giorni, con una
freddezza fuori dal normale comunica al prigioniero che verrà liberato, poi gli
spara a sangue freddo con due armi differenti perché la prima si inceppa, poi
sale sulla Renault rossa e porta il cadavere dello statista fino a Via Caetani,
poi non contento va a scrivere il comunicato conclusivo del rapimento. No,
riesce veramente difficile credere a questa novella di un Moretti "superuomo".
La verità forse è altrove, anche per altri motivi. Vediamo dunque cosa dicono
gli appunti di Luigi Cipriani sul come venne ucciso il presidente della
Democrazia cristiana: " Degli 11 colpi i primi due [sono stati sparati] col
silenziatore, gli altri quando era già morto. Perché questo rituale? Dopo i
primi due colpi Moro ha agonizzato per 15 minuti. Solo i primi due colpi hanno
lasciato tracce sulla Renault, Moro è stato ucciso in macchina e portato altrove
? ". A conferma dei dubbi evidenziati dai quesiti che si poneva Cipriani,
Francesco Biscione ha scritto: "...laddove la comune versione dei brigatisti
lasciava trasparire una falla che nasconde verosimilmente una menzogna è nella
narrazione delle modalità con cui l'ostaggio sarebbe stato ucciso ". Non è il
solo che, a posteriori, si affianca a Luigi Cipriani. Nella sentenza del
cosiddetto Moro-quinquies gli stessi magistrati giudicanti non possono esimersi
dall'evidenziare il loro scetticismo sulla versione fornita dai brigatisti rossi
sottolineando, ad esempio, l'impossibilità da parte dei carcerieri di " ritenere
in anticipo che l'on. Moro, chiuso in una cesta da dove poteva avere una
discreta percezione della situazione ambientale, non essendo né narcotizzato né
imbavagliato, avrebbe continuato remissivamente a tacere senza chiedere aiuto
nemmeno lungo il tragitto per le scale fino al box, pur percependo voci come
quella della Braghetti. Non si comprende - scrivono ancora i magistrati - come i
brigatisti abbiano accettato un simile e gratuito rischio quando avrebbero
potuto facilmente evitarlo ad esempio uccidendo l'on. Moro nella sua stessa
prigione e trasportandolo poi da morto; ed incredibile sembra il fatto che si
sia programmata l'esplosione di una serie di colpi, quanti risultano dalle
perizie, in un box che si apriva nel garage comune degli abitanti dello stabile,
essendo noto che anche i colpi delle armi silenziate producono rumori
apprezzabili che potevano essere facilmente percepiti da persone che si
trovassero a passare, così come furono distintamente percepiti dalla Braghetti
". Alle condivisibili considerazioni dei giudici del quinto processo Moro,
dobbiamo aggiungere il rilievo che i colpi sparati con il silenziatore furono
soltanto due. E gli altri 9, esplosi senza il silenziatore, non li ha avvertiti
nessuno? Ne erano così certi i brigatisti rossi Mario Moretti e Germano Maccari
? E, infine, perché lasciare Aldo Moro agonizzante per altri 15 lunghissimi
minuti, come conferma la perizia medico-legale, senza che un rantolo, un gemito,
un grido disperato sia veramente uscito dalla bocca di un uomo morente e ferito
? In conclusione, " anche su questo punto, la versione delle Brigate rosse non
sta in piedi, o almeno zoppica fortemente [...] un uomo che, senza essere
narcotizzato, senza essere legato ed imbavagliato, si fa infilare in una cesta,
deporre nel portabagagli di un'auto, ricevere nel corpo due pallottole che lo
lasciano in vita per altri 15 minuti; e in tutto questo tempo non tenta la
disperata reazione di chi non ha più nulla da perdere, effettivamente non è
credibile ". La passività di Aldo Moro, se mai ci fu, può trovare solo logica e
coerente spiegazione in due fattori: il luogo dove si trovava, solitario, dove
il suo urlo disperato si sarebbe perso nel silenzio; il numero dei suoi
uccisori, tale da scoraggiarne a priori ogni tentativo di fuga o reazione
violenta 51. " Un testimone - scriveva Cipriani - vide una Renault rossa presso
la spiaggia di Fregene col posteriore aperto. La perizia sulla sabbia dei
pantaloni di Moro confermò che il litorale corrisponde a quello. Sabbia trovata
in molte parti dei vestiti, calze, scarpe e sul corpo compreso bitume e sulle
ruote della Renault. Sul battistrada - concludeva Cipriani - fu trovato un
frammento microscopico di alga analogo ad altro rinvenuto sul corpo ". E gli
accertamenti ulteriori confermano pienamente questa realtà: " Le risultanze
tecniche - ricorda Biscione - riguardano innanzitutto la sabbia e i frammenti di
flora mediterranea trovati nelle scarpe, negli abiti e sul corpo di Moro, come
pure sulle gomme e sui parafanghi dell'auto di Moretti rinvenuta in via Caetani.
Le tracce sugli abiti e sulle scarpe lascerebbero pensare ad una permanenza o ad
un passaggio presso il litorale romano (la perizia giudica quel tipo di sabbia
proveniente da una zona compresa tra Focene e Palidoro) ". Mario Moretti e
compagni, quindi, affermano il falso, come asseriva giustamente perentorio Luigi
Cipriani nei suoi appunti: " Savasta e Morucci mentono [o forse non sono a
conoscenza della verità ndr.] dicendo che la sabbia era un depistaggio...".
Concorda con l'ex parlamentare di Democrazia Proletaria anche Francesco
Biscione, il quale scrive: " ...lascia fortemente perplessi la machiavellica
spiegazione di Morucci (confermata da Moretti e ribadita anche dalla Braghetti
nel corso del processo Moro-quater) secondo la quale ai primi di maggio 1978
alcuni militanti [la Faranda e la Balzerani] furono incaricati di andare a
reperire sulle spiagge del litorale laziale acqua marina, sabbia, catrame, parti
di piante da mettere sui vestiti e sotto le scarpe di Moro per depistare le
indagini successive al ritrovamento del cadavere...". Quali vantaggi si
proponessero di ricavare i brigatisti facendo credere agli inquirenti ed
all'opinione pubblica di aver custodito Aldo Moro sul litorale laziale piuttosto
che in un appartamento al centro di Roma ? A mio parere nessuno. C'è poi la
testimonianza di Pierluigi Ravasio, ex carabiniere-paracadutista, ex addetto
all'ufficio sicurezza interna della VII sezione del Sismi a Roma, che venne resa
allo stesso Luigi Cipriani. L'ex agente del Sismi e componente delle Stay-behind
affermò che "il suo gruppo indagò sul caso Moro e venne a conoscenza del fatto
che Moro era tenuto dai malavitosi e riferito ciò ai superiori, le indagini
vennero fermate, il loro gruppo sciolto ed i componenti dispersi, mentre i
rapporti che quotidianamente venivano compilati furono bruciati...". Francesco
Biscione, pur con cautela, non può fare a meno di rilevare che " se si pensa che
nel maggio 1991, allorché fu raccolta l'intervista, era pressoché sconosciuto il
ruolo svolto durante il sequestro di Moro dalla banda della Magliana, si è
portati a dubitare che le parole di Ravasio siano frutto di pura fantasia
(semmai, per una certa brutalità nei riferimenti si sarebbe indotti a credere
che egli fosse a conoscenza di questa vicenda non per averla vissuta in prima
persona, bensì per averne avuto notizia da altri)...". Che il racconto di
Pierluigi Ravasio sia quantomeno credibile lo dimostrano non solo il preciso
riferimento fatto alla presenza del colonnello Camillo Guglielmi, suo diretto
superiore al Sismi, in via Fani il 16 marzo 1978, quanto soprattutto le tracce
di sabbia e bitume trovate sui vestiti, il corpo di Aldo Moro e la Renault rossa
sulla quale venne poi trasportato in via Caetani. Bisogna anche rilevare, a
favore della veridicità di quanto narrato dall'ex agente del Sismi, che le sue
dichiarazioni, divulgate da Cipriani, caddero in un momento in cui l'intervento
della malavita nel sequestro Moro veniva dato per certo, un fatto ormai
acquisito ma datato ad operazione di prelievo avvenuta e considerato cessato, a
seguito delle pressioni esercitate dai nemici politici dell'esponente
democristiano prigioniero, entro i primi giorni di aprile del 1978. Anche il
"premio" concesso ai delinquenti della Magliana dallo Stato e dai suoi apparati
è perfettamente verosimile: " Come ricompensa per il rapimento e la gestione del
caso Moro - ha raccontato Ravasio - il Sismi consentì alla banda di compiere
alcune rapine impunemente. Una avvenne nel 1981 all'aeroporto di Ciampino,
quando i malavitosi travestiti da personale dell'aeroporto sottrassero da un
aereo una valigetta contenente diamanti provenienti dal Sudafrica. Una seconda
avvenne nei pressi di Montecitorio dove furono aperte molte cassette di
sicurezza e da alcune, appartenenti a parlamentari, furono sottratti documenti
che interessavano il Sismi ". Fatti che ci riportano alla rapina alla Brink's
Securmark ed a quella strana rivendicazione che ebbe con tutta probabilità il
valore di un avvertimento allo Stato perché non perseguisse i suoi autori. Un
solo punto, nel racconto di Pierluigi Ravasio, suscita perplessità ed interesse
insieme: la pretesa che il sequestro fu organizzato e gestito da " ex detenuti e
malavitosi ", dal suo inizio alla sua conclusione. Sappiamo, viceversa, che i
brigatisti rossi in via Fani c'erano, come furono presenti durante tutte le fasi
dell'operazione, eliminazione fisica di Aldo Moro compresa, sebbene su questo
punto la verità venne presumibilmente esposta in forma criptica, da un ex
appartenente alle Stay-behind che, con le sue rivelazioni, si era già esposto
molto alle reazioni ed alle rappresaglie dello Stato. Dunque c'è un tassello che
non ha ancora trovato la sua collocazione ufficiale, è il tassello determinante,
quello che da solo sarebbe in grado di spiegare ciò che è rimasto di totalmente
oscuro - ma non di insolubile - nel sequestro di Aldo Moro: i brigatisti rossi
guidati da Mario Moretti, furono obbligati a cedere il loro ostaggio con tutta
la documentazione da lui prodotta nei giorni della prigionia, agli "amici" della
banda della Magliana ? Ha fondamento concreto questa intuizione di Luigi
Cipriani, poggiata su indizi concreti e da lui esposta di fronte alla
commissione parlamentare ? Cipriani aveva individuato in Antonio Chichiarelli la
figura chiave per comprendere la reale dinamica del sequestro di Aldo Moro e del
suo omicidio. Il mio personale punto di vista è che probabilmente ci fu un
passaggio di mano dalle Br alla banda della Magliana, e che le altre
organizzazioni malavitose (Mafia, Camorra, la banda di Francis Turatello), che
all'inizio del rapimento erano state "attivate" dal mondo politico per ritrovare
Moro, ad un certo punto - dopo aver fatto il loro compito - vennero bloccate. E
di questo fatto sono sicuri perfino i membri della Commissione parlamentare
d'inchiesta. D'altronde lo dimostrano le molte testimonianze: durante i 55
giorni le organizzazioni malavitose si erano mobilitate - affiancando le polizie
ufficiali - nella ricerca del leader DC su precisa richiesta dei vari esponenti
politici dell'ex "scudo crociato". Dopo poche settimane, improvvisamente, Mafia,
Camorra e ndrangheta si ritirarono, lasciando ai loro emissari nella capitale il
compito di compiacere la volontà del potere politico. Dai primi di Aprile, la
parola d'ordine divenne quella lanciata, senza mezzi termini a Francesco Varone,
a casa di Frank Coppola: " Quell'uomo deve morire ". Probabilmente, una volta
certe delle sorti di Moro, le cosche ritirarono i loro scagnozzi. " Un'accurata
lettura - ricorda Francesco Biscione - di documenti giudiziari quali
intercettazioni telefoniche e altri riscontri ha consentito al giudice Giovanni
Salvi di stabilire che attorno al 10 aprile cessò del tutto l'attivazione di
Cosa nostra ". A conferma di questo percorso, narrato a più riprese anche da
alcuni pentiti, si aggiunge poi la testimonianza di Raffaele Cutolo che
riferisce come Nicolino Selis gli disse che, del tutto casualmente, era venuto a
conoscere la collocazione del covo nel quale era tenuto sequestrato Aldo Moro. A
dire di Nicolino Selis - racconta Cutolo - la prigione del parlamentare
democristiano si trovava nei pressi di un appartamento che egli teneva come
nascondiglio per eventuali latitanze. Dopo aver proposto l'ubicazione della
"prigione del popolo" ad alcuni esponenti della DC, l'ex boss della camorra si
sentì dire: " Fatti gli affari tuoi ". Dunque siamo in possesso di un paio di
indizi che indicano la strada indicata all'inizio del ragionamento. A questo
punto del discorso si inserisce perfettamente anche la domanda posta da Michela
Cipriani, moglie del defunto deputato di Democrazia Proletaria: " Perché [
parlando delle Br ] non svelare e gestire politicamente il memoriale-bomba che
parlava fra l'altro di Stay behind e che costituiva il maggior risultato
politico conseguito dalla lotta armata? ". Eppure, nel terzo comunicato del 29
marzo 1978, i brigatisti avevano annunciato trionfanti che l'interrogatorio di
Aldo Moro "...prosegue con la completa collaborazione del prigioniero. Le
risposte che fornisce chiariscono sempre più le linee controrivoluzionarie che
le centrali imperialiste stanno attuando [...] proprio sul ruolo - prosegue il
comunicato - che le centrali imperialiste hanno assegnato alla DC, sulle
strutture e gli uomini che gestiscono il progetto controrivoluzionario, sulla
loro interdipendenza e subordinazione agli interessi imperialisti
internazionali, sui finanziamenti occulti, sui piani economici-politici-militari
da attuare in Italia [...] il prigioniero politico Aldo Moro ha cominciato a
fornire le sue illuminanti risposte. Le informazioni che abbiamo così modo di
reperire, una volta verificate, verranno rese note al movimento rivoluzionario
che saprà farne buon uso nel prosieguo del processo al regime che con
l'iniziativa delle forze combattenti si è aperto in tutto il paese ". Quindi
nella primissima fase del rapimento le Br, di fronte ad un Moro che gli
raccontava situazioni cui probabilmente non osavano nemmeno sperare, cantano
vittoria. Poi però - incredibilmente - si assistette ad un repentino cambio di
rotta. Un'allucinante retromarcia delle Br si nota - è bene dirlo - già nel
comunicato n°6 del 15 aprile 1978, prima quindi che venisse inviato ai
brigatisti - come afferma nel suo libro Francesco Biscione - il messaggio del 18
Aprile che di fatto imponeva loro di uccidere Aldo Moro. Mario Moretti ed i suoi
compagni informarono infatti che: " l'interrogatorio di Aldo Moro è terminato.
Rivedere trenta anni di regime democristiano, ripercorrere passo passo le
vicende che hanno scandito lo svolgersi della controrivoluzione imperialista nel
nostro paese, riesaminare i momenti delle trame di potere, da quelle pacifiche a
quelle più sanguinarie, con cui la borghesia ha tessuto la sua offensiva contro
il movimento proletario, individuare attraverso le risposte di Moro le
responsabilità della DC, di ciascuno dei suoi boss, nell'attuazione dei piani
voluti dalla borghesia imperialista e dei cui interessi la DC è sempre stata
massima interprete, non ha fatto altro che confermare delle verità e delle
certezze che non da oggi sono nella coscienza di tutti i proletari...". La
deduzione che viene da fare è che evidentemente a Moretti, attraverso chissà
quali canali, erano già giunte pressioni di una certa entità, interferenze tali
da far tremare la dirigenza delle Br. I brigatisti fecero dunque intendere in
modo esplicito che Aldo Moro aveva parlato di tutto e di tutti, però conclusero
in una forma oscura: " Non ci sono segreti che riguardano la DC, il suo ruolo di
cane da guardia della borghesia, il suo compito di pilastro dello Stato delle
multinazionali, che siano sconosciuti al proletariato..." 60. Ma il messaggio
per la DC, lo Stato ed i suoi apparati istituzionali era lampante: Mario Moretti
ed i brigatisti rossi che hanno gestito il sequestro Moro informavano che non
avrebbero rivelato niente di quanto appreso. " Non ci sono segreti che
riguardano la DC " scrissero, quindi " cosa mai si potrà dire al proletariato
che già non sappia ? ". Alla luce del memoriale ritrovato nel 1990 a Milano, nel
covo di Via Montenevoso, e dello studio compiuto da Biscione [agli atti
processuali], sappiamo che non era certamente così. Esaminando in dettaglio le
dichiarazioni contraddittorie rese dai brigatisti su questo specifico punto si
giunge alla conclusione che, con molta furbizia, alcuni di loro possono aver
mantenuto segreti il memoriale ed il suo contenuto per poi usarlo come merce di
scambio quando se ne fosse presentata la necessità nell'ambito di una futura
trattativa in campo giudiziario. Ed il trattamento carcerario riservato ad
alcuni di loro dal 1987 in poi (ad esempio a Mario Moretti e Barbara Balzerani)
avvalorava questa ipotesi: per quanto non sia poco il tempo che hanno passato in
prigione, si deve convenire che è molto poco rispetto a quanto avrebbero dovuto
effettivamente trascorrere. Salta agli occhi per esempio la differenza tra un
Moretti che si è fatto a malapena 20 anni di carcere essendo condannato a più
ergastoli per vari reati di sangue, ed un Franceschini che si è fatto poco meno
pur non avendo mai sparato un solo colpo di pistola. Forse la differenza l'hanno
fatta proprio quei segreti sul caso Moro che Moretti, tacendo, ha posto a suo
favore sul piatto della "bilancia giudiziaria" ? Come non sottolineare poi la
mancanza delle registrazioni degli interrogatori di Moro. I nastri registrati -
che avrebbero fatto conoscere meglio l'andamento dei colloqui e lo sviluppo
delle strategia posta in essere da Moro - non si sono mai trovati; i brigatisti
affermano di aver distrutto il tutto per motivi di sicurezza, ma questa
affermazione appare assai poco credibile. Poiché si da per acquisito che ad
interrogare lo statista DC fu Moretti, e poiché Moretti si era già esposto,
bruciandosi, con la lunga telefonata fatta alla famiglia del sequestrato, non ha
alcun senso nascondere la voce dell'interrogante per impedirne una eventuale
identificazione, a meno che gli interrogatori non siano stati fatti da una
persona del tutto diversa (ancora sconosciuta ed importante, dunque da
proteggere) dai brigatisti finora noti. La presenza insistente della malavita,
impegnata a gestire il sequestro di Aldo Moro rivestendo il duplice ruolo di
fiancheggiatore dello "Stato sotterraneo" (che lo voleva morto) e dei brigatisti
rossi che non sapevano più cosa fare, può essere provata dal comunicato n°7 del
20 aprile 1978 che " appare allo stesso tempo - scrive Biscione - l'ultimo della
prima serie ed il primo della seconda... - perché - [...] iniziava da parte
delle Brigate rosse l'offensiva sulla trattativa: il rilascio del prigioniero
Aldo Moro può essere preso in considerazione solo in relazione alla liberazione
dei prigionieri comunisti. La DC dia risposta chiara e definitiva se intende
percorrere questa strada; deve essere chiaro che non ce ne sono altre
disponibili; seguiva l'ultimatum: 24 ore di tempo per una risposta a partire
dalle ore 15 del 20 aprile ". Erano passati solo due giorni dal comunicato del
lago della Duchessa, redatto da Toni Chichiarelli ed ispirato, scrivono gli
stessi brigatisti su indicazione di Aldo Moro " da Andreotti ed i suoi complici
", ed i carcerieri del presidente della Democrazia cristiana abbandonano l'alta
politica e passano al concreto : " Il comunicato n°7 è anche il primo - rileva
Biscione - che non porta in chiusura lo slogan consueto "portare l'attacco allo
Stato imperialista", ma "libertà per tutti i comunisti imprigionati" ". Un
segnale preciso a quanti in carcere attendevano che si realizzasse lo scopo
primario dell'operazione Moro: la liberazione dei detenuti ed allo stesso tempo
un modo per tenere buoni i membri del nucleo storico. Dunque la minaccia venne
recepita da Moretti, il quale rivolse anch'egli un messaggio rassicurante ai
detenuti, non solo comunisti ma anche malavitosi. Avevano - ed in questo ha
probabilmente ragione Biscione - indubbiamente compreso, insieme al resto,
l'ordine di uccidere Aldo Moro, ma sottolineavano l'inutilità del gesto se
questo fosse stato eseguito senza avere ottenuto almeno la scarcerazione dei
detenuti, divenuta l'obiettivo primario di un sequestro che aveva invece
prodotto, sul piano politico, frutti eccezionali come la confessione del
presidente della Democrazia cristiana su fatti e misfatti del sistema di potere
italiano. Considerato però che di questa confessione i brigatisti non avrebbero
mai potuto fare uso, ed avendo pubblicamente annunciato questa loro rinuncia, la
scarcerazione di un numero ragionevole di detenuti avrebbe permesso loro di
salvare le apparenze e di riportare un simulacro di vittoria restituendo vivo
Aldo Moro. Da qui la cancellazione, in tutta fretta, dello slogan " portare
l'attacco al cuore dello Stato imperialista " con l'unico che potesse avere un
significato per coloro che stavano in galera, " libertà per tutti i comunisti
imprigionati ". Così nel comunicato n°8 le Br chiesero la liberazione di 13
detenuti, in questo modo venne segnata, definitivamente, la sorte di Aldo Moro,
e per motivi opposti a quelli che gli storici ufficiali ritengono. Questi
ultimi, difatti, sono convinti che " l'insostenibile richiesta dello scambio
tredici contro uno, rendeva ancor più fioca la voce già flebile e minoritaria
dei sostenitori della trattativa. Che il significato del comunicato n°8 fosse
l'attestazione di una posizione nuova che, contrariamente a varie ragionevoli
aspettative, manifestava che si stava andando verso l'esecuzione dell'ostaggio
fu dunque - conclude Biscione - una considerazione abbastanza diffusa ". Secondo
i calcoli dei brigatisti, fissando in tredici il numero dei liberandi, davano
prova di quella ragionevolezza che li avrebbe condotti a condurre, finalmente,
una trattativa riservata e diretta con la Democrazia cristiana per poi stabilire
con Piazza del Gesù un accordo di cui solo una parte avrebbe avuto pubblicità;
l'altra parte avrebbe dovuto rimanere segreta, uno di quegli scambi
"all'italiana" destinati ad essere taciuti per sempre da entrambe le parti.
Qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che quella compiuta da Mario Moretti
e dai suoi compagni (la richiesta di uno scambio 13 ad 1) sia stata una mossa
per chiudere ogni possibilità ad ogni altra probabile trattativa e, quindi,
poter procedere all'esecuzione di Aldo Moro scaricandone ogni responsabilità
sulla Democrazia cristiana. Così probabilmente non fu, e per convincersene è
sufficiente riascoltare la telefonata che, con totale e stupefacente imprudenza,
un Mario Moretti al colmo dell'agitazione nervosa, fece a casa della famiglia
Moro il 30 Aprile 1978: " Solo un intervento diretto, immediato, chiarificatore
e preciso di Zaccagnini può modificare la situazione " dice Mario Moretti che
usa un tono giustificatorio " sa, una condanna a morte non è una cosa sulla
quale si possa prendere alla leggera [...]". "Non possiamo fare altrimenti...",
conclude un Moretti che appare nella posizione di chi subisce una decisione, non
l'assume e tanto meno la impone. Egli si rivolse alla famiglia forse perché
credeva che Eleonora Moro potesse contare qualcosa, dimostrò di essere informato
sui movimenti che i congiunti del presidente avevano fatto, a riprova che
riteneva la "carta umanitaria" essenziale, perché era l'ultima cosa che gli è
rimasta in mano essendo stato costretto a rinunciare all'altra, la più
importante, quella decisiva: le rivelazioni di Moro su uomini e fatti. L'ultimo
tentativo lo fece, per loro conto, Daniele Pifano che incontrò il rappresentante
del Procuratore generale Pietro Pascalino, il sostituto procuratore Claudio
Vitalone, e gli propose lo scambio di uno contro uno, un detenuto magari malato
contro Aldo Moro e, ricevuto un rifiuto, ripiegò sul suggerimento della
"soppressione delle norme restrittive dei colloqui dei carcerati con i
familiari". Ma ormai la questione Moro era irrimediabilmente arrivata al
capolinea. Lo "Stato parallelo" non si era esposto in prima persona ma aveva
fatto ricorso ad un altro tipo di "occasionali alleati", la spietata Banda della
Magliana cui Tony Chichiarelli era legato. Ciò venne confermato anche dall'on.
Benito Cazora, recentemente scomparso: " ...recentemente - scriveva Luigi
Cipriani - il senatore Cazora ha confermato al magistrato romano che sta
indagando sulle trattative condotte durante il sequestro Moro, che si ebbe
coscienza del fatto che il presidente della DC fosse "custodito" dalla Banda
della Magliana ". L'ex parlamentare di Democrazia proletaria poté così
legittimamente avere una ulteriore e definitiva conferma della sua tesi e di
quanto aveva dichiarato il 14 settembre 1978 al quotidiano Repubblica il
senatore democristiano Giovaniello, molto vicino ad Aldo Moro ed alla sua
famiglia: " Quando sapemmo che Moro stava per essere affidato a criminali comuni
per il terribile atto conclusivo, facemmo le cose più impensabili per arrivare
prima degli altri, ma senza fortuna ". Nel sequestro di Aldo Moro fu dunque un
livello di potere occulto, e non Mario Moretti ed i suoi compagni, a stabilire
tempi e modalità della prigionia e, infine, della sua morte. Lo stesso Stato che
Aldo Moro conosceva come debole, insicuro, pronto a compromessi di ogni sorta,
aveva improvvisamente risposto con una fermezza ed una decisione fino ad allora
sconosciute; il destino dello statista DC era segnato, questo lui lo capì bene,
come traspare evidente dalle sue ultime lettere, pesantissime quanto profetiche
nei confronti di un partito - la DC - che pensava di conoscere come nessun
altro. Durante il sequestro era accaduto qualcos'altro di molto, troppo,
pericoloso: Aldo Moro stava parlando di tutto e tutti: delle trattative segrete
per la nascita del centro-sinistra, del tentativo di golpe di De Lorenzo, della
strage di P.zza Fontana, del ruolo della DC nella strategia della tensione,
della riforma dei servizi segreti, dell'affare "Lockeed", dei piani
anti-guerriglia previsti per il nostro paese dalla NATO, del sistema di potere e
di sostentamento economico del colosso democristiano. Il rischio che queste
verità venissero alla luce in quegli anni era veramente pesante, un rischio
troppo elevato per i sostenitori e gli oltranzisti dell'alleanza atlantica, gli
unici effettivi artefici della politica interna italiana. Fu così, il presidente
della Democrazia cristiana si ritrovò schiacciato dalla forza delle due
superpotenze, dei loro alleati e dalle loro reciproche paure, ansie dalle quali
vennero liberate dalle "ignare" Brigate rosse proprio con il sequestro. "
L'agguato di via Fani, l'eccidio della scorta ed il sequestro dell'onorevole
Moro, lo scenario tragico dei luoghi della strage appena consumata, la
rivendicazione e i successivi comunicati delle Br, la prigionia di Moro in un
luogo sconosciuto e il processo cui questi veniva sottoposto, gli appelli sempre
più pressanti e drammatici dell'ostaggio, il disconoscimento ufficiale della
loro "autenticità", il rifiuto della trattativa, la sterile polemica che si aprì
tra i fautori di questa e i sostenitori della fermezza, l'immane mobilitazione
dell'apparato istituzionale di sicurezza, l'avvitarsi della vicenda verso il suo
tragico epilogo, il macabro rinvenimento della salma di Moro in un luogo
centrale della capitale dello Stato, equidistante dalle sedi dei due maggiori
partiti presenti in Parlamento, le dimissioni del Ministro dell'Interno: queste
furono le tessere che composero il mosaico visibile degli eventi, dove il
delitto Moro, valutato come fatto storico, apparve come il momento di maggiore
intensità offensiva del partito armato e, specularmente, come il momento in cui
lo Stato si rivelò più impotente nel dare risposta appena adeguata
all'aggressione eversiva ". Questo il parere espresso dalla Commissione Stragi
durante l'ultima legislatura, un giudizio che pur non apparendo del tutto
asettico, certamente non si lascia andare a nessun tipo di accusa diretta. E'
esistito dunque (e, data la portata degli indizi, è proprio sotto gli occhi di
tutti) un "lato oscuro", una sorta di mondo sotterraneo e parallelo a quello
ufficiale che ha operato incessantemente sia lungo la vita delle Br, sia - e con
maggiore visibilità ed incidenza - nei 55 giorni del rapimento di Aldo Moro.
Anche la commissione parlamentare [della XII legislatura] sul caso Moro, pur con
tutte le sue consuete e dovute cautele, è giunta ad affermare ad esempio che: "
le nuove acquisizioni consentono di ritenere certo o almeno altamente probabile
(come già affermato in alcune delle relazioni di minoranza della Commissione
Moro, in particolare quella dell'onorevole Sciascia) il carattere intenzionale
di almeno alcune delle omissioni, di almeno alcune delle inerzie che
contribuirono al tragico epilogo della vicenda Moro ". O ancora che:
"...inizialmente la criminalità organizzata si era attivata e sia stata attivata
dall'esterno per favorire la liberazione di Moro: e che tale intervento si
arrestò per valutazioni interne alla criminalità organizzata e per input esterni
probabilmente coincidenti. Analogamente impressionante è la convergenza di
indicazioni verso un intreccio fitto - e non ancora pienamente disvelato - di
ambigui rapporti che legarono in ambito romano uomini di vertice delle
organizzazioni mafiose e della criminalità locale al mondo di uno oscuro
affarismo, ad esponenti politici, ad appartenenti alla Loggia P2, a settori
istituzionali, in particolare dei servizi segreti ". Le Br che avevano
progettato il sequestro di Aldo Moro con il ferreo convincimento che il mondo
politico italiano avrebbe implorato pietà per la sua vita, si erano con ogni
probabilità ritrovati nella condizione opposta: loro a cercare di salvare
l'ostaggio ed il mondo politico - o almeno una parte di esso - a livello
sotterraneo, a pretendere la sua morte senza condizioni. E con ogni probabilità
quelle "15 gocce di Atropina", come citava un appunto rinvenuto in Via Gradoli e
scritto da Mario Moretti, servirono alle Br per anestetizzare Moro e portarlo
via dal covo prigione di Via Montalcini; forse proprio per consegnarlo alla
Banda della Magliana. Sebbene - come sempre - manchino le prove per dimostrare
che anche l'assassinio di Aldo Moro sia da far rientrare tra le interferenze
attuate in Italia dal c.d. "oltranzismo atlantico", è certamente un dato di
fatto che nel 1978, poco dopo l'assassinio di Aldo Moro, l'auspicato intervento
del capitalismo occidentale e dei suoi investimenti avvenne massiccio. Le
autorità monetarie consentirono a numerose banche Usa di aprire filiali nel
nostro paese (Manifactures Hannover trust, Inrving trust Company, Wells fargo)
con relativi sportelli (Security pacific). Alcune banche estere, tedesche
americane e svizzere, dirottano i risparmi dei loro clienti verso la borsa di
Milano. Tutti i titoli azionari - compresi quelli delle industrie decotte -
subirono aumenti rilevanti: le Montedison salirono del 102%, le SNIA del 60,8%,
Acqua marcia del 70,8%, Rinascente del 95,2%, le Fiat aumentarono del 40,5%
superando per la prima volta le tremila lire. Un vero pompaggio di ottimismo nel
capitalismo italiano, proprio nel momento in cui i governi di unità nazionale
entravano in crisi e l'assassinio di Moro rimetteva in moto le forze della
destra DC. Anche questa fu una semplice coincidenza ? Mino Pecorelli, già
nell'ottobre del 1978, aveva scritto che il ministro dell'Interno, Francesco
Cossiga, sapeva tutto: " perché non ha fatto nulla ? [...] Il ministro non
poteva decidere nulla su due piedi, doveva sentire più in alto. E qui sorge il
rebus - ironizzava Pecorelli - quanto in alto ? magari sino alla loggia di
Cristo in Paradiso?..." . A chi si riferiva il direttore di "OP" ? Manco a dirlo
anche su questo punto le opinioni degli osservatori divergono: " non paiono
esservi dubbi sul fatto - si affretta a scrivere Francesco Biscione - che la
"loggia di Cristo in Paradiso" alla quale il ministro si sarebbe rivolto per
avere lumi sul da farsi fosse la P2 ". Stefano Fratini -sul suo sito internet-
afferma invece che " Mino Pecorelli si riferiva a quella che egli stesso
definiva la "Loggia vaticana", una loggia massonica di cui possedeva un elenco
di nomi di cardinali ed alti dignitari ecclesiastici, completo di numero di
matricola e data di iniziazione (nel numero di "OP" del 12 settembre 1978
Pecorelli pubblicò un elenco di affiliati alla loggia vaticana fra i quali, per
limitarci ad un esempio, compariva il nome del cardinale Sebastiano Baggio,
indicato come "Seba, numero di matricola 85/2640 e data di iniziazione il 14
agosto 1957"). Loggia o non loggia, il riferimento alle gerarchie ecclesiastiche
è trasparente; inequivocabile dunque il fatto che anche dal Sacro Soglio
qualcuno impose ad un Papa forse troppo debole l'avallo alla condanna di Aldo
Moro". Difficile dire chi abbia ragione; a far pendere la bilancia dalla parte
delle tesi di Fratini stanno tuttavia alcune frasi scritte da Aldo Moro e
presenti più di una volta tra le 93 lettere manoscritte ritrovate nel 1990 nel
covo di via Monte Nevoso a Milano [mentre le Br ne fecero recapitare solo 30
durante il sequestro]. "La chiave è in Vaticano", scrisse infatti lo statista
DC, e di nuovo: " il Papa ha fatto un pò pochino...". Concludo ancora con le
parole dell'informatissimo Mino Pecorelli: "L'agguato di Via Fani porta il segno
di un lucido superpotere. La cattura di Moro rappresenta una delle più grosse
operazioni politiche compiute negli ultimi decenni in un paese industriale
integrato nel sistema occidentale. L'obiettivo primario è senz'altro quello di
allontanare il PCI dall'area di potere nel momento in cui si accinge all'ultimo
balzo. Perchè è comunque interesse delle due superpotenze mondiali mortificare
l'ascesa del PCI, cioè del leader dell'eurocomunismo, dl comunismo che aspira a
diventare democratico e democraticamente governare un paese industriale. Ciò non
è gradito agli americani [...] e ancor meno è gradito ai sovietici [...] Ancora
una volta la logica di yalta è passata sulle teste delle potenze minori. e'
Yalta che ha deciso Via Mario Fani". Teorie, illazioni, supposizioni, castelli
accusatori privi di fondamenta per la loro quasi totalità direbbe un giurista.
Tutta la ricostruzione della storia delle Br, come ho cercato di mostrare, è
costellata da precise interferenze . Emerge limpida una sola verità: non si
hanno certezze. La realtà è ancora là, tutta da dimostrare. E' vero, esiste - ed
è alquanto palese - un preciso sentiero indicato dagli indizi che ho
riscontrato, però le prove certe e documentabili permangono in numero troppo
esiguo per poter emettere delle sentenze, per avvalorare una tesi in modo
definitivo. L'avventura brigatista, ed in questo concordo con la Commissione
Gualtieri, non può e non deve considerarsi ancora materia per gli storici, ciò
almeno fino a quando i dati a nostra disposizione non consentiranno di colmare i
diversi vuoti di conoscenza che riguardano l'azione delle Br e quella dello
Stato (ma soprattutto di chi ha agito nel nome suo...). Dalla morte di Aldo Moro
sono passati 25 anni, sono stati fatti cinque processi (ed un sesto è in
preparazione), i cosiddetti 'anni di piombo' sono finiti, la classe politica che
in quegli anni governava l'Italia è stata spazzata via dall'esplosione di quel
fenomeno giudiziario passato alla storia come "tangentopoli", molti dei
brigatisti che parteciparono all'"Operazione Friz" hanno dichiarato come
conclusa ed irripetibile l'esperienza della lotta armata e delle Brigate rosse,
eppure di tanto in tanto emergono nuovi fatti, prove non emerse prima d'ora,
testimonianze sconosciute o sottovalutate che costringono di volta in volta gli
studiosi a riscrivere la storia e la magistratura ad aprire nuove indagini.
L'ultima sconvolgente novità è emersa recentemente grazie alle rivelazioni di
Antonino Arconte, ex agente segreto (nome in codice G71 VO 155 M, cioè agente
della struttura Gladio, anno addestramento 1971, Marina Militare, Volontario
numero 155) appartenente alla "Seconda Centuria Lupi" della struttura Stay
Behind. Lo stesso Arconte definisce la struttura di intelligent di cui faceva
parte come 'Gladio delle Centurie', gruppo appartenente ad un servizio segreto
di cui si ignorava perfino l'esistenza, il SIMM (Servizio Informazioni Marina
Militare) che aveva compiti operativi solo all'estero. Uomini super-addestrati
che si muovevano all'interno delle strategie della Nato ed in linea con modelli
operativi ispirati a quelli della CIA. Analizzando il racconto di Arconte,
emerge come la 'Gladio delle Centurie' fosse una struttura ben diversa da quella
'Gladio' la cui esistenza venne svelata in Parlamento da Giulio Andreotti il 2
agosto 1990: non una rete di agenti ideata per fronteggiare una possibile
invasione da parte delle truppe del Patto di Varsavia, ma una struttura
informativa e operativa che agiva esclusivamente oltre confine, veri e propri
reparti irregolari operanti fuori da quanto previsto dalla Costituzione e al di
fuori della dipendenza dal Capo dello Stato, che, per l'Art. 87 della
Costituzione, è il Capo delle Forze Armate.Arconte ha raccontato come i primi
giorni di Marzo 1978 ricevette l'ordine di partire per una missione in Medio
Oriente con il compito di " ricevere da un nostro uomo a Beirut dei passaporti
che avrei poi dovuto consegnare ad Alessandria D'Egitto. Dovevo poi aiutare
alcune persone a fuggire dal Libano in fiamme. Ma c'era un livello più delicato
e più segreto in quella missione. Dovevo consegnare un plico a un nostro uomo a
Beirut ". Si imbarcò così il 6 Marzo dal porto di La Spezia sul mercantile
'Jumbo Emme'. A Beirut Arconte incontrò l'agente G-219 e una volta tornati sulla
nave gli consegnò il plico; al suo interno vi era un foglio di carta azzurra
firmato dal capitano di vascello Remo Malusardi della X Divisione "S.B." (Stay
Behind) della direzione del personale del Ministero della Marina e conteneva un
'ordine a distruzione immediata'. Il documento porta la data del 2 marzo 1978, e
cioè 14 giorni prima del rapimento dell'On. Moro e dell'uccisione della sua
scorta, ed ordinava ai "gladiatori" di prendere contatti con i movimenti di
liberazione nel vicino Oriente, perché questi intervenissero sulle Brigate
Rosse, ai fini della liberazione di Moro. Contravvenendo agli ordini l'agente
G-219 non distrusse il foglio e lo conservò fino a quando, verso i primi di
luglio del 1995, decise di consegnarlo proprio ad Arconte durante un incontro
avvenuto ad Olbia. Mario Ferraro venne trovato impiccato a casa sua, a Roma, un
mese dopo questo incontro. L'ordine a distruzione immediata, autenticato dal
notaio Angozzi, di Oristano, è stato recentemente sottoposto ad una perizia per
verificarne l'autenticità. La risposta del perito è stata: " Il documento di
Arconte è compatibile con l'epoca dei documenti di raffronto ", quindi dimostra
che ambienti dei sevizi segreti erano al corrente del sequestro Moro prima che
avvenisse, e anziché dare l'allarme si predisponevano a iniziative legate allo
scenario del dopo-sequestro. Il ministro della Difesa non ha risposto alle
interpellanze parlamentari (una delle quali del senatore Giulio Andreotti) sulla
vicenda, nonostante sia trascorso un anno dalla loro presentazione e nonostante
ripetuti solleciti. Come dicono gli inglese "The story continues...". Ma fino a
quando non si riuscirà a fare piena luce sui lati oscuri, finché continueranno
ad esistere dubbi e ad emergere nuove verità sulla 'Prima Repubblica' questa
continuerà a gettare un'ombra sul presente, e non ci potrà essere una vera
transizione verso la "Seconda Repubblica".”
BRIGATE ROSSE E RISCRIZIONE
DELLA STORIA: LE VERITA' NEGATE.
Macchiarini e il primo
sequestro-lampo delle Br.
L'ex dirigente della Sit Siemens «processato» nel 1972: fu il primo atto dei
terroristi rossi, scrive Stefano Zurlo, Giovedì 13/09/2018, su "Il Giornale". Un
nome diventato simbolo: Idalgo Macchiarini. La sua foto, con due pistole premute
sulle guance e un cartello appeso al collo con la stella a cinque punte, segna
la storia del terrorismo italiano e l'incipit delle Brigate rosse. Era il 3
marzo 1972 e il sequestro lampo del dirigente della Sit Siemens durò venti
minuti di orologio, ma quei venti minuti segnano il primo capitolo degli anni di
piombo e il debutto sulla scena della prima generazione di terroristi: Renato
Curcio e la sua donna Mara Cagol che successivamente sarebbe stata uccisa in un
conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, Alberto Franceschini, Mario Moretti,
l'unico capo che sarebbe sgusciato sempre fra retate e arresti, avrebbe condotto
sei anni più tardi, nel 1978, l'interrogatorio del prigioniero Aldo Moro e
sarebbe stato ammanettato solo nel 1981. Tre componenti miscelate all'ombra
della Madonnina: i duri di Reggio Emilia, fuoriusciti dalla Fgci, come
Franceschini che non avevano mai abbandonato il sogno della rivoluzione che il
partito Comunista con la svolta di Salerno aveva progressivamente mandato in
soffitta; gli studenti di sociologia di Trento, come Curcio; e gli operai
reclutati a Milano, alla Sit Siemens, come Moretti. L'atto di fondazione è un
pranzo in una trattoria in provincia di Reggio Emilia, nell'agosto 1970 e a cui
partecipano un'ottantina di militanti, provenienti da Sinistra proletaria e dal
Collettivo politico metropolitano. È l'onda lunga del Sessantotto: nascono le
formazioni della sinistra radicale, ma c'è anche chi punta dritto verso la lotta
armata. Già il 14 agosto alla Sit Siemens compaiono i primi volantini, ma si
tratta di gesti da educande al confronto con la mattanza che seguirà negli anni
successivi. La prima azione importante è proprio il rapimento di Macchiarini,
scomparso qualche giorno fa a Imperia dopo essere rientrato nell'anonimato. Lo
rilasciano quasi subito. E nel volantino di rivendicazione lo definiscono «un
cane rognoso», per poi concludere con un motto che risuonerà cupo infinite volte
nella stagione degli omicidi seriali: «Colpirne uno per educarne cento». La
forza della formazione viene sottovalutata, anche se i primi arresti arrivano
già nel '72 grazie all'infiltrato Marco Pisetta. C'è un pregiudizio culturale
che impedisce di leggere la realtà per quello che è: a sinistra ritengono le Br
sedicenti, fascisti travestiti o manovrati da indecifrabili poteri forti. Ci
vorrà l'onestà intellettuale di Rossana Rossanda, che conierà l'immagine
suggestiva dell'album di famiglia, per scoprire l'ovvio. Ma con grave ritardo.
Intanto, il servizio d'ordine di Lotta continua, uno dei gruppi più dinamici
della sinistra a sinistra del Pci, si militarizza e va verso il partito armato:
è la genesi di Prima linea, l'altra grande sigla dell'eversione tricolore.
Vengono da Lc Ovidio Bompressi e Leonardo Marino che il 17 maggio 1972, a
Milano, uccidono il commissario Luigi Calabresi. Le Br vanno avanti con i
sequestri e le azioni dimostrative ma il sangue resta un tabù. Fino al 17 giugno
1974 quando ammazzano Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, prime croci di una
Spoon River interminabile che si concluderà solo alla fine degli anni Ottanta;
con nuove fiammate dopo il Duemila.
IL CASO CIRILLO LA
TRATTATIVA STATO-BR-CAMORRA. Fermate quel giudice, scrive Tullio Pironti
Editore.
Carlo Alemi. Presentazione di Luigi Necco Prefazione di Franco Roberti.
«Generalmente, questo tipo di
trattative non lascia traccia; in questo caso però, grazie a un magistrato
coraggioso e tenace, il giudice Carlo Alemi, disponiamo di informazioni assai
precise a proposito delle ambigue trattative che si svolsero tra il potere e la
mafia allo scopo di salvare il Cirillo». Jacques de Saint-Victor
«A dodici anni dal sequestro
una sentenza sposa in pieno le conclusioni di Alemi. La trattativa c’è stata,
l’hanno condotta i politici e i soldi per pagare il riscatto non sono stati il
frutto di una spontanea offerta di amici e parenti di Cirillo». Bruno De Stefano
«Carlo Alemi, unico magistrato
inquirente che ha osato sospettare dei notabili democristiani, uscendo dal
circuito costituzionale (come dirà il Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita
in pieno Parlamento per controbattere alle richieste di dimissioni del Ministro
dell’Interno Antonio Gava) finisce davanti al Consiglio Superiore della
Magistratura. […] La Procura della Repubblica, che al contrario non sospetta
nulla, al processo di primo grado sulla trattativa è rappresentata dal sostituto
procuratore Alfonso Barbarano, il quale si oppone a qualsiasi richiesta degli
avvocati mirante ad approfondire i retroscena della liberazione di Cirillo».
Marisa Figurato
«Sulle trattative, sui
rapporti con la camorra, sulla partecipazione dei politici, nessuno di loro dice
nulla, a parte: “non ricordo”, “ho rimosso”. […] E rischia anche lui, il dottor
Alemi. Dopo il primo processo alle BR napoletane vuole andare più a fondo sulle
trattative, sul coinvolgimento di Cutolo e anche su quello di eventuali
politici». Carlo Lucarelli
«È provato che, in occasione
del sequestro Cirillo, vi sono stati fatti di gravissima degenerazione e
deviazione dei nostri Servizi di Sicurezza». Relazione della Commissione
parlamentare di inchiesta del Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
[Presidenza del senatore Libero Gualtieri, 4 ottobre 1984]
«Per quanto riguarda il
giudice Carlo Alemi, l’Italia dovrebbe essere orgogliosa di aver avuto servitori
dello Stato così tenaci e indipendenti. La vicenda Cirillo la dice lunga sulla
solitudine che alcuni magistrati italiani hanno dovuto sopportare per tentare di
fare giustizia. Speriamo che finalmente Alemi trovi il tempo di scrivere le sue
memorie e raccontarci, sciolto da altri vincoli, tutto ciò che non ha potuto
scrivere negli atti giudiziari». Isaia Sales
«La sentenza istruttoria del
giudice Carlo Alemi si segnala per il suo coraggio civile e per aver messo in
luce, pur all’interno di rigide regole processuali, contraddizioni e lacune
delle versioni ufficiali sui fatti, complicità e distrazioni dell’apparato
statale, pesanti compromissioni della DC nazionale e campana in tutta la
storia». Nicola Tranfaglia
È la sera del 27 aprile del
1981 quando Ciro Cirillo, assessore regionale ai Lavori Pubblici della Regione
Campania, viene sequestrato nel garage di casa, a Torre del Greco, da un
commando di cinque uomini appartenenti alle Brigate Rosse, capeggiati da
Giovanni Senzani. Nel conflitto a fuoco che segue perdono la vita l’agente di
scorta di Cirillo, il brigadiere Luigi Carbone, l’autista Mario Cancello, e
viene gambizzato Ciro Fiorillo, segretario dell’assessore. Ex presidente della
Regione, democristiano “doroteo” molto vicino ad Antonio Gava, Cirillo è uno
degli uomini politici più addentro ai meccanismi del potere; da qualche mese,
inoltre, è diventato presidente della Commissione incaricata di gestire gli
appalti del post-terremoto del 1980. Lo Stato annuncia la linea dura: come già
per Aldo Moro tre anni prima, non tratterà con le BR. Cirillo verrà rilasciato
dopo 89 giorni di prigionia, all’alba del 24 luglio, in un palazzo abbandonato
di via Stadera, a Poggioreale. La liberazione era stata annunciata il giorno
prima da un comunicato, in cui i rapitori dichiaravano che a sobbarcarsi l’onere
del riscatto - un miliardo e 450 milioni di lire - era stata la Democrazia
Cristiana, suscitando un enorme scandalo, nonché l’immediata smentita da parte
dei familiari, che si assunsero la totale responsabilità di quel pagamento. La
stessa liberazione fu costellata da episodi controversi, come quello per cui
Cirillo, invece di essere tradotto in Questura, come da disposizioni della
magistratura, venne portato a casa, dove vano sarà il tentativo di
interrogatorio da parte dell’allora pubblico ministero di Napoli Libero Mancuso,
causa stato di semincoscienza ascrivibile a choc - salvo poi colloquio
personale, a porte chiuse, con Antonio Gava e Flaminio Piccoli, esponenti di
spicco del partito. Fin da subito emersero dubbi anche in merito alla cifra
pagata per il riscatto: si vociferava, infatti, che l’ammontare fosse stato
pattuito grazie all’intercessione della camorra, cui sostanzialmente si doveva
il merito del rilascio, e che la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo -
il più sanguinario capo camorra dell’epoca - ne avesse incassato almeno una
metà: la somma sarebbe stata messa insieme da un gruppo di imprenditori edili,
“amici” della DC - legati a doppio filo a Cirillo per questioni di appalti - e i
“colloqui”, tanto con funzionari dei Servizi Segreti che con esponenti politici,
si sarebbero svolti direttamente nell’“allegro” carcere di Ascoli Piceno, in cui
era detenuto ‘o Professore, per il tramite di faccendieri senza scrupoli. Inizia
così quella che il presidente emerito Giorgio Napolitano ha definito «una delle
pagine più nere dell’esercizio del potere nell’Italia democratica»: il sequestro
è destinato infatti a divenire uno dei più clamorosi casi politici e giudiziari
degli anni bui della Repubblica Italiana. A indagare sul caso Cirillo è il
magistrato Carlo Alemi che, in qualità di giudice istruttore, diventa
protagonista di alcune delle vicende più oscure e sanguinose degli anni di
piombo, conoscendo e interrogando i personaggi più ambigui implicati nelle
intricate trame della politica, della malavita organizzata, del terrorismo rosso
e dei Servizi Segreti, fino a divenire, suo malgrado, inconsapevole agnello
sacrificale. Gli elementi che si intrecciano nella sua ricostruzione sono tanti:
fatti di cronaca nera, crimini mafiosi, ipotesi investigative, tentativi di
depistaggi da parte di organi dello Stato, sparizione di documenti, misteri
irrisolti, testimonianze scottanti, raggiri politici, Servizi deviati. È Alemi
l’autore della straordinaria istruttoria condotta sul caso, affidatagli il 1°
settembre del 1981 e conclusasi il 28 luglio del 1988, con il deposito della
sentenza-ordinanza di 1.534 pagine destinata a fare Storia, un J’Accuse che
scatenerà una vera e propria tempesta politica in Parlamento: c’è stata
mediazione politica da parte di esponenti della DC, così come ci sono stati
contatti e intercessioni con i brigatisti per il tramite di Servizi Segreti e
Nuova Camorra Organizzata. Vengono chieste le dimissioni di Gava, divenuto
intanto, con il nuovo governo De Mita, ministro degli Interni; il Presidente del
Consiglio lo difende, respingendo al mittente le accuse, attaccando
violentemente Alemi per le sue «opinioni indebitamente espresse e illazioni» e
asserendo che il giudice ha abusato delle procedure, «ponendosi così fuori dal
circuito costituzionale». L’esito dell’istruttoria, che Carlo Alemi portò
avanti, con coraggio e ostinazione, mettendo a rischio la sua stessa vita, tra
minacce di morte - il suo nome figurava nell’agenda della “Primula Rossa”
Barbara Balzerani - scorte negate, procedimenti per diffamazione e commissioni
d’inchiesta - portò alla comminazione di 30 ergastoli. La sua ordinanza è
diventata nel tempo oggetto di studio tanto nelle forze dell’ordine che nelle
università italiane e negli atenei stranieri, in quanto documentazione
preziosissima atta a testimoniare e ricostruire la storia dell’organizzazione
terroristica nota con il nome di Brigate Rosse. Oggi, magistrato in pensione,
per la prima volta e in esclusiva, il narratore d’eccezione della trattativa
Stato-BR-camorra per la liberazione di Ciro Cirillo parla e racconta, svelando,
in pagine dure e toccanti a un tempo, tra ricordi intimi e analisi storiche
lucide e rigorose, chi effettivamente vi prese parte, per conto di chi e per
quali motivi si siano mossi i Servizi Segreti e perché lo Stato, diversamente da
quanto fece con Aldo Moro, trattò con i brigatisti.
Carlo Alemi nasce ad Addis
Abeba, in Etiopia, nel 1941. Magistrato di lungo corso, noto in particolare per
le indagini sulle Brigate Rosse, sulla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele
Cutolo e sul sequestro Cirillo, nonché per quelle legate all’incendio della
raffineria dell’Agip e alla dichiarazione di insolvenza della Banca di credito
campano del noto faccendiere Gianpasquale Grappone, ha chiuso la sua carriera
come presidente del Tribunale di Napoli.
Sul caso Cirillo parla
Carlo Alemi.
Ieri qui si è parlato della cattura del camorrista Pasquale Scotti dopo
trent’anni di latitanza e di come oggi potrebbe dare la sua versione sulla
vicenda del rapimento e soprattutto della liberazione dell’assessore campano
Ciro Cirillo, rapito dalle BR nel 1981 e liberato dopo una trattativa, scrive
Massimo Bordin il 29 Maggio 2015 su "Il Foglio". Ieri qui si è parlato della
cattura del camorrista Pasquale Scotti dopo trent’anni di latitanza e di come
oggi potrebbe dare la sua versione sulla vicenda del rapimento e soprattutto
della liberazione dell’assessore campano Ciro Cirillo, rapito dalle BR nel 1981
e liberato dopo una trattativa, in quel caso ci fu davvero, con molti punti
oscuri. Il magistrato che se ne occupò, Carlo Alemi, allora giudice istruttore
napoletano, oggi in pensione, è stato intervistato due giorni fa dal Mattino. Ha
rievocato la vicenda che effettivamente vide interagire camorra di Raffaele
Cutolo e servizi segreti con le brigate rosse e i politici locali. Faccenda
delicata, facilissima ai depistaggi e a ricostruzioni romanzate. Se Scotti
dovesse parlare è essenziale la massima professionalità dei PM. Alemi è la
memoria storica dell’inchiesta. Ieri ha spiegato al giornalista del Mattino che
per il sequestro venne richiamato in servizio il generale Santovito, capo del
SISMI, che era stato allontanato due anni prima per lo scandalo P2. Solo che la
scoperta degli elenchi di Gelli e il conseguente allontanamento di Santovito
risalgono al 1981, poche settimane prima del sequestro dell’assessore campano.
Cominciamo malissimo.
Morto Cirillo. Giudice
Alemi: ''Tutto chiaro per me, lo Stato trattò con la Camorra'',
scrive il 31 Luglio 2017 Stella Cervasio su "La Repubblica" (Antimafia Duemila).
Carlo Alemi fu giudice istruttore di un caso con uno strascico lungo trent'anni,
su cui si riaccendono i riflettori dopo la scomparsa ieri all'età di 96 anni
di Ciro Cirillo. Alemi ascolta, poi dice con sicurezza: "Un caso chiaro, per me.
È la prima volta che l'intervento della camorra in una trattativa con lo Stato è
stata riconosciuta nella sentenza di II grado e in Cassazione, negli atti delle
Commissioni parlamentari sui servizi segreti e sulla camorra".
C'era anche il terrorismo, in
quella trattativa per il rilascio del politico. Senzani, capo del commando
brigatista che lo rapì aveva lavorato nel Centro servizi culturali, a pochi
passi dalla casa di Cirillo.
"Senzani fu indicato come
infiltrato dei servizi segreti nelle Br ed è stato condannato anche per il
sequestro Cirillo".
L'ex assessore dc però ha
continuato a negare che ci sia stata una trattativa.
"L'ha scritto nel libro "Io,
Cirillo e Cutolo" anche il suo segretario e sindaco di Giugliano Giuliano
Granata che erano andati in carcere a parlare con il boss. In quel libro ha
scritto anche cose che a me aveva assolutamente negato".
Che cosa resta di oscuro,
allora, in questa vicenda?
"Ciò che non è emerso ancora è
il vero contenuto delle trattative che ci sono state tra Cutolo e lo Stato. L'ex
presidente dell'Avellino, Antonio Sibilia, interrogato dai magistrati per altre
vicende disse che il business della ricostruzione post-terremoto era partito
dopo il sequestro Cirillo".
Fu rapito per il piano della
ricostruzione?
"Se non si fosse bruciato,
Cirillo avrebbe gestito tutta la ricostruzione post terremoto. Dopo il rapimento
non glielo hanno più consentito, si era ampiamente esposto nella ricostruzione.
Avrebbe gestito i miliardi degli appalti. Galasso lo dichiara quando viene
arrestato. Non ci sono dubbi neanche sul fatto che sia intervenuta la camorra".
Chi poteva essere al corrente
di tutto?
"Secondo me Raffaele Russo è
una figura che è emersa poco in quella vicenda e che invece ha partecipato a
molte riunioni che si tenevano nell'ufficio di Gava. Fu citato nelle deposizioni
da Savarese, il gestore dell'hotel Le Axidie di Vico Equense, che aveva gestito
la raccolta di soldi. Il grosso del denaro venne dai costruttori, se si fa due
più due si possono collegare facilmente l'affare ricostruzione e gli
imprenditori".
Cirillo dichiarò che la sua
vicenda servì per incastrare Gava e questo le valse la definizione di toga rossa
e anche un procedimento disciplinare.
"Rossa? Io però la giornalista
dell'Unità l'ho arrestata per il falso. Non è stato facile lavorare in quegli
anni: ricordo che avevo il telefono sotto controllo. Agli amici che mi
chiedevano quando finiva l'inchiesta dicevo "la chiudo presto, non è emerso
nulla". Forse per questo mi hanno lasciato stare".
Che cosa ricorda di Cirillo?
"Da lui e dai familiari
nessuna collaborazione. C'erano disposizioni che venivano dall'alto. Ai
magistrati che dovevano incontrarlo appena rilasciato, Libero Mancuso e Carmine
Pace fu impedito di vederlo, ma lui si era incontrato con Gava e con Piccoli. Io
lo interrogai e lui mantenne una posizione negatoria. In seguito ha sostenuto
che ero un comunista che voleva sfidare la Dc. Ma quando lo incontrai per la
presentazione al Suor Orsola del servizio di Giovanni Minoli "La storia siamo
noi" sul caso Cirillo mi definì "un giudice onesto e corretto, ce ne vorrebbero
tanti come lui". Qualche anno dopo però è tornato alla vecchia tesi: ha detto
che volevo fregare la Dc".
Come lo ricorda, chi era il
vero Cirillo?
"Era l'uomo di fiducia di
Gava. In quella trasmissione di Minoli avevo rilasciato un'intervista
dettagliata ma l'hanno quasi completamente tagliata. Mi dissero che Gava aveva
accettato di partecipare se fossero state accorciate le mie frasi".
Il giudice Alemi: "Nel mio
libro i segreti della trattativa Stato-camorra. Cirillo serviva vivo alla Dc".
Intervista a
"Repubblica" su quanto accadde per la liberazione dell'ex assessore sequestrato
dalle Br, scrive Dario Del Porto il 24 giugno 2018 su "La Repubblica". «Se lo
Stato ha trattato una volta con la criminalità organizzata, come è accaduto per
Ciro Cirillo, significa che può essere successo altre volte. E siccome nulla è
veramente cambiato da allora, non possiamo escludere che accada di nuovo», dice
Carlo Alemi, il magistrato che ha indagato sul rapimento e la successiva
liberazione dell’allora potentissimo assessore regionale democristiano ai Lavori
pubblici. Il 27 aprile del 1981, un commando delle Brigate Rosse composto da
cinque persone agli ordini di Giovanni Senzani, dopo aver ucciso l’agente di
scorta Luigi Carbone e l’autista Mario Cancello, neutralizzò Cirillo per
rinchiuderlo in una “prigione del popolo”. Ma a differenza di quanto accaduto
tre anni prima con Aldo Moro, il 24 luglio successivo, l’ostaggio fu rilasciato.
«Le sentenze della Corte d’Appello e della Cassazione hanno sancito che ci fu
una trattativa», sottolinea Alemi, all’epoca giudice istruttore, poi presidente
del tribunale di Napoli, che ha scritto per Pironti un libro dal titolo
inequivocabile: «Il caso Cirillo. La trattativa Stato-Br-camorra», che sarà
presentato martedì alle 17 all’Istituto studi filosofici.
Perché ha aspettato 37 anni
per raccontare la sua verità sul caso Cirillo, presidente Alemi?
«Mi sembrava doveroso lasciare
la magistratura, prima. Non sono d’accordo con quei colleghi che scrivono libri
quando ancora i procedimenti sono in corso. Ciò nonostante, non avrei mai
scritto questo libro senza le insistenze di Luigi Necco (recentemente scomparso
n.d.r.) un giornalista che aveva vissuto da cronista quegli anni, venendo anche
ferito alle gambe dalla camorra. Necco mi aveva più volte invitato a raccogliere
le mie memorie di quella vicenda e mi ha assistito nella scrittura».
Chi trattò per liberare
Cirillo?
«Lo Stato. E non mi si venga a
dire che quei soggetti non rappresentavano lo Stato: gli attori di questa
vicenda erano ai vertici dell’amministrazione pubblica, dei servizi segreti, del
ministero della Giustizia, del partito che aveva la maggioranza relativa in
Parlamento».
Perché Moro fu ucciso, mentre
Cirillo tornò a casa?
«Cirillo gestiva la
ricostruzione post terremoto, dunque serviva vivo alla Dc. Nessuno, invece,
voleva che Aldo Moro rimanesse in vita. Non il suo partito, non gli americani e
neppure i socialisti, che a parole erano per la trattativa ma temevano il
compromesso storico».
Il boss della camorra Raffaele
Cutolo che ruolo ebbe?
«Quello di intermediario».
In cambio di cosa?
«Aveva ricevuto promesse ben
precise: la liberazione anticipata o almeno la dichiarazione di infermità
mentale e favori per i camorristi detenuti».
Il patto però non fu
mantenuto.
«Innanzitutto perché il
documento pubblicato dall’Unità, attribuito ai Servizi ma risultato falso, in
cui si riferiva di una visita nel carcere di Ascoli Piceno di Francesco
Patriarca, Antonio Gava e Vincenzo Scotti, fece saltare tutto. E poi perché al
Quirinale c’era Sandro Pertini, un presidente di straordinaria autonomia e
autorevolezza».
Molti attori di questa storia
sono morti, come Gava e lo stesso Cirillo. Restano altri misteri insoluti?
«L’omicidio del dirigente
della squadra mobile Antonio Ammaturo. È una bruttissima pagina per il nostro
Paese. Basti pensare che, fra i documenti scomparsi durante le indagini, figura
la relazione sul caso Cirillo che Ammaturo aveva trasmesso ai suoi superiori.
Manca anche la copia che il commissario aveva consegnato al fratello, a sua
volta vittima di uno strano incidente di caccia».
Cosa ha rappresentato per lei
questa indagine?
«Un impegno difficilissimo,
portato avanti nonostante una totale mancanza di collaborazione da parte di chi
aveva indagato, di chi avrebbe dovuto testimoniare, e nell’isolamento dei
colleghi, tranne uno: Raffaele Bertoni. Ho dedicato il libro a mia moglie,
perché mi ha aiutato a proteggere la privacy e la serenità della mia famiglia.
Al tempo stesso però ho ricevuto attestati di stima da parte di tante persone,
alcune anche insospettabili».
Ad esempio?
«Mentre il Mattino diretto da
Pasquale Nonno mi attaccava violentemente, mi arrivò la lettera di un
brigatista: “Giudice - diceva - leggendo quello che scrivono, sono contento di
essere stato arrestato da lei”».
Cirillo, il sequestro e la
trattativa Stato-camorra: tutti i segreti degli anni di piombo»,
scrive Domenica 30 Luglio 2017 Il Mattino. «Il processo sul mio rapimento fu
fatto all’ombra di Antonio Gava. Nel senso che i magistrati che si occupavano
del mio caso in realtà volevano coinvolgere soprattutto lui. La verità su quella
vicenda? È quella che ho ripetuto in tutti questi anni». Lucido come sempre,
così, nel giorno del suo 95esimo compleanno, Ciro Cirillo ricordò una della
pagine più oscure della storia della Repubblica italiana. Più volte Cirillo
raccontò di avere saputo che per la sua liberazione fu pagato un riscatto di un
miliardo e 450 milioni di lire. Ma dell’accordo Stato-camorra, con il supporto
dei servizi segreti e il coinvolgimento - per alcuni decisivo - di Raffaele
Cutolo, ha sempre escluso categoricamente l’esistenza: «La verità - ripeteva -
l’ho detta in tutti questi anni. Ogni altra trattativa posso escluderla». Da
allora, dal giorno della liberazione, Cirillo lasciò il mondo della politica: «È
stata una delle cose più brutte dell’intera vicenda legata al mio sequestro da
parte della Br», ripeteva spesso. Ma, con orgoglio, rivendicava: «Chi parlava di
una politica ‘marcia’ in quel periodo oggi dovrebbe essersi ricreduto.
Nell’attuale vita politica c’è purtroppo un'evidente influenza da parte della
magistratura, che spesso finisce con il condizionare l’elettorato. Ricordo
quando fui indagato perché, da presidente della Provincia, si riteneva che non
avessi vigilato in maniera corretta sul presunto inquinamento del Lago d’Averno.
Nonostante la chiara tesi del mio avvocato, che non era un iscritto al partito,
il giudice di primo grado ci fece capire che dovevo essere condannato. E così
fu. E sapete come finì? Fui assolto in Appello».
Br-camorra, il giudice
Carlo Alemi: "Cirillo mente ancora".
Dopo 35 anni dal sequestro
l'esponente Dc esclude contatti tra Stato, Br e camorra. Il magistrato Carlo
Alemi che indagò sul caso: “Affermazioni incredibili, totalmente discordanti con
quanto stabilito dai processi”, scrive Gianmaria Roberti il 25 febbraio 2016 su
"L'Espresso". Chiamatela rimozione, un processo freudiano che spinge in soffitta
le verità più indigeste. Accade per i passaggi inconfessabili della storia
nazionale, molti ancora coperti dal segreto di Stato. La rimozione – o
l’alterazione della verità dei fatti – si è riproposta in questi giorni a
proposito del caso Cirillo ovvero per quel drammatico episodio in cui le
istituzioni dello Stato riconobbero nella camorra un interlocutore di pari
grado, chiedendo l'aiuto di Raffaele Cutolo, il più sanguinario capo camorra
dell’epoca. Avvenne nel 1981, per il rapimento di Ciro Cirillo, assessore Dc ai
lavori pubblici della Campania e presidente della commissione che doveva gestite
tutti gli appalti del post terremoto del 1980. Una vicenda seppellita nel
capitolo delle storie più imbarazzanti. Al punto che anche oggi è difficile
accendere i riflettori. Cirillo fu sequestrato il 21 aprile da un commando delle
Br guidato da Giovanni Senzani, durante un assalto in cui vennero uccisi
l'autista e un agente di scorta. I brigatisti lo liberarono il 24 luglio di
quell'anno dietro il pagamento di un riscatto da 1,5 miliardi di lire. E si
parlò di altri 1,5 miliardi finiti alla camorra. Nel mezzo, si avverò il copione
in cui lo Stato e l’antistato si siedono allo stesso tavolo per negoziare.
Eppure all'inizio di febbraio di quest’anno il 95enne Ciro Cirillo sente il
bisogno di riemergere dall'oblio a cui si era autoconsegnato per 35 anni. Ma lo
fa per negare ogni trattativa finalizzata al suo rilascio, con la mediazione del
boss. "Lo escludo, assolutamente", ha dichiarato in un'intervista alla tv
svizzera italiana. E riattizzando il fuoco di antiche accuse, aggiunge: "Ci fu
un'istruttoria, da parte del giudice Carlo Alemi, che aveva un solo obiettivo,
incastrare Antonio Gava, allora ministro dell’Interno". Di nuovo salta fuori il
nome dello scomparso leader del grande centro. E, come in un gioco di specchi,
queste parole fanno rompere il riserbo a chi condusse l'inchiesta, il magistrato
Alemi per anni perseguitato per la sua coerenza e per la fedeltà al principio di
legalità. Il segretario democristiano De Mita lo bollò in pieno Parlamento come
“giudice al di fuori dal circuito costituzionale". Il quotidiano della Dc definì
il suo lavoro diffamazione a mezzo giudice. A rischio della vita Alemi seguì con
ostinazione e provò la pista del patto tra esponenti dello Stato, Br e Nuova
camorra organizzata. Un'intesa raggiunta col frenetico andirivieni di funzionari
dei servizi, di camorristi latitanti, di esponenti Dc e della massoneria come
Francesco Pazienza nel carcere di Ascoli Piceno, dove il boss era detenuto. Da
magistrato in pensione Alemi ne parla ora con “l’Espresso”: “Mi sembra
incredibile - dice - che il dottor Cirillo abbia oggi fatto quelle affermazioni,
totalmente discordanti peraltro con quanto affermò, in mia presenza ed al mio
indirizzo, il 19 maggio 2008, all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in
occasione della presentazione del documentario “La trattativa” del programma Rai
“La storia siamo noi”, allorché mi disse: “Anzi penso che mai come in questo
momento avremmo tutti bisogno di magistrati coraggiosi e onesti come lei”. Non
credo possa essere considerato “onesto” un magistrato che utilizza il proprio
lavoro per “danneggiare un partito politico”. “Mi sembra di tornare – racconta
Alemi – ai giorni in cui subivo attacchi di ogni sorta ed ero dipinto come il
giudice comunista che utilizzava il proprio lavoro per distruggere la Democrazia
Cristiana. Per tali false affermazioni, il direttore del Mattino dell’epoca, fu
condannato per diffamazione nei miei riguardi. Il procedimento disciplinare
"tempestivamente" attivato nei miei confronti dal Ministro della Giustizia si
concluse con il riconoscimento della totale correttezza del mio operato. Eguale
sorte ebbe il procedimento per diffamazione attivato nei miei confronti
dall’onorevole Scotti. Le conclusioni della mia istruttoria, secondo cui c’era
stata una trattativa con le Br e la Nco, da parte dei massimi esponenti dei
Servizi e del Ministero, oltre che di esponenti politici Dc, sono state
pienamente confermate oltre che dalla sentenza di appello - confermata in
Cassazione - anche dalle due commissioni di inchiesta parlamentare che hanno
indagato sulla vicenda. Che il partito Dc abbia partecipato alla trattativa con
il consenso, o quanto meno "con l’avallo" dei massimi esponenti del partito -
l’allora segretario Flaminio Piccoli e l’onorevole Gava -, difatti, non l'ha
affermato solo il giudice Alemi, ma - aggiunge il magistrato - lo ha confermato
la sentenza definitiva del processo che ha concluso per la “sostanziale verità
dell’affermazione, secondo cui la Dc aveva trattato con le Br per Cirillo con
l’intermediazione della camorra di Cutolo”. Insomma non fu Cutolo a ricattare o
minacciare, furono i ras della Balena Bianca a cercarlo per agganciare i
brigatisti. Nei documenti parlamentari la realtà è consacrata già nel 1984 dal
comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza, presieduto dal
senatore Libero Gualtieri, e nel 1993 dalla commissione antimafia con la
presidenza di Luciano Violante. La relazione Violante, approvata dalla
commissione, sanciva che “la negoziazione, decisamente smentita nei primi tempi,
è oggi riconosciuta senza infingimenti”. Nelle audizioni a Palazzo San Macuto il
prefetto Parisi e il generale Mei, ai vertici dei servizi all'epoca dei fatti,
ammisero la trattativa. Lo stesso fece Vincenzo Scotti, ministro degli Interni
della Dc nei primi anni '90, però negando di avervi partecipato. “L’onorevole
Scotti e la Democrazia Cristiana – ricorda Alemi – avevano querelato l'Unità per
la vicenda del falso documento del Viminale, in cui si attestavano le visite a
Cutolo in carcere dello stesso Scotti e del senatore Patriarca. Ma se a Scotti i
giudici diedero ragione, al partito no, arrivando ad assolvere il direttore
Petruccioli dal reato di diffamazione ed a condannare il partito Dc alle spese
del procedimento. Pertanto quel documento, falso nella forma, fu ritenuto
veritiero nella sostanza”. Raffaele Cutolo, memore di quelle promesse mai
mantenute, in un'intervista a Repubblica l'anno scorso tornò a lanciare sinistri
messaggi dalla cella del 41 bis. “Rifiutò ancora una volta di fornire la sua
versione dei fatti, assumendo che, se avesse parlato, avrebbe potuto far ballare
mezzo Parlamento, anche perché molti di quelli che oggi sono ai vertici delle
istituzioni sono o tuttora protagonisti oppure eredi e promanazione di quelli
che allora chiesero il suo aiuto. Se usa questo linguaggio, certo - riflette
Alemi - si rivolge a personaggi attivi ai suoi tempi e operativi anche oggi. Ma,
evidentemente, nessuno ha interesse a scoprire chi essi siano e quali i reali
termini della trattativa, che ha sicuramente costituito una delle pagine più
sporche nella vita della nostra Repubblica”. Pagine che a molti fa comodo
dimenticare.
ALEMI: "SONO VIVO PER
MIRACOLO",
scrive Giovanni Marino il 24 settembre 1994 su "La Repubblica". "Cosa provo
adesso? Amarezza e soddisfazione. Penso con amarezza a quello che ho dovuto
subire per aver lavorato correttamente. Sono stato attaccato a tutti i livelli
per esser arrivato troppo in alto. Così andavano le cose in quell' Italia,
sicuramente oggi gli stessi attacchi non avrebbero la virulenza e la protervia
di allora. Ma provo anche soddisfazione perchè, senza l'apporto della procura,
con un contributo assai limitato e spesso inquinato delle forze dell'ordine, tra
depistaggi, testimoni uccisi, improvvisamente morti oppure pressati affinchè
negassero pure l'evidenza, io sono comunque riuscito a ricostruire la vicenda
Cirillo esattamente così come oggi i molti pentiti e le investigazioni dei
colleghi ricostruiscono. La mia inchiesta, vecchia ormai di sei anni, trova
pieno riscontro oggi. Sei anni dopo...". Carlo Alemi, il coraggioso pioniere del
caso Cirillo, l'antesignano di Di Pietro, si gode con equilibrio e persino con
un po' di timidezza la sua grande e definitiva vittoria. Sì, il giudice Carlo
Alemi, il “perseguitato”, aveva visto giusto nella sua contrastata indagine sul
sequestro (' 81) di Ciro Cirillo, all' epoca assessore dc, liberato a tre mesi
dal rapimento dopo una trattativa proibita tra dorotei, br, servizi segreti e
camorristi. Adesso la nuova inchiesta della procura di Napoli smentisce, nero su
bianco, i molti che attaccarono Alemi con bordate terrificanti. Alemi ha vinto.
Dall' ufficio di capo della procura circondariale di Caserta il giudice racconta
il ' suo' caso Cirillo. Procuratore Alemi, il caso Cirillo è costellato da
omicidi, morti ' naturali' troppo improvvise per essere credibili; ha mai temuto
per la sua vita? "Onestamente io mi ritengo fortunato di essere vivo. Il primo
successo dell'inchiesta è poter raccontare ancora queste cose. A volte si può
morire perchè qualcuno distorce la tua immagine e ti dipinge come un giudice non
imparziale". Sembra proprio il suo caso... "Sono stato dipinto come un pazzo.
Qualche procuratore andava a dire in giro che ero folle, qualcun altro diceva
che ero spinto dal mio comunismo e volevo solo screditare la democrazia
cristiana". Lei è comunista o lo è mai stato? "Non ero comunista ma per reazione
alle accuse mi sarebbe venuta voglia di diventarlo". Quali segni ha lasciato nel
giudice Alemi il caso Cirillo? "Nel corso dell'indagine ho fatto esperienze
professionali, umane e morali indimenticabili. Purtroppo per molto tempo non ho
avuto il riconoscimento della bontà del mio lavoro, l'unico che mi interessava".
Come si sentì quando il presidente del Consiglio Ciriaco De Mita in pieno
parlamento la definì un giudice fuori dal circuito costituzionale? "Era tutto
così irreale quel 5 agosto ' 88 quando lessi sui giornali l'esternazione del
presidente. Ero in vacanza, sul litorale Domitio e mi sembrò di leggere cose e
riferimenti che riguardavano un'altra persona, non me. Non pensavo che si
sarebbe mai arrivato a quei livelli". Ci racconti tutti i bastoni tra le ruote
di quell' inchiesta scomoda. "Rischiamo di far notte. Cito qualche episodio,
significativo del clima. Un pentito racconta di un incontro tra un boss e un
politico in un ristorante romano, La Conchiglia. Chiedo agli investigatori di
verificare l'esistenza del ristorante, di fornirmi l'indirizzo. Per otto anni mi
hanno detto che quel ristorante non esisteva. Invece esisteva, era ben visibile
e persino conosciuto... e poi, un altro episodio: la commissione sui servizi
segreti conclude i suoi lavori sul caso Cirillo e la consegna alla presidenza
del Consiglio; vengo a sapere che oltre alla relazione approvata ne esiste
un'altra, del presidente Gualtieri con frasi non trasfuse nel lavoro conclusivo
della commissione. La chiedo all' onorevole Bettino Craxi, allora presidente del
Consiglio, con una lettera ufficiale inviata a Palazzo Chigi. Attendo per sei
mesi: nessuna risposta. Sollecito e dalla presidenza del Consiglio replicano:
“Qui non è arrivato niente”. Chiedo alla Digos come sia possibile e loro mi
portano il riscontro che cercavo: quella lettera è arrivata, eccome se è
arrivata...". Qualche altro depistaggio... "In breve posso ricordare i registri
del carcere di Ascoli Piceno regolarmente manomessi, il poliziotto della
stradale che mi ha strappato davanti agli occhi, ai miei occhi, il rapporto sul
ritrovamento di Cirillo". Cosa accadde con quel rapporto? "Come risulta dall'
indagine, Cirillo fu ritrovato dalla polizia stradale. Ma poi quell' auto fu '
accerchiata' dalle volanti del funzionario Biagio Giliberti che si presero
Cirillo e lo riportarono a casa. Il risultato fu che per tre giorni Cirillo vide
tutti, a cominciare dai massimi vertici dc, tranne i magistrati. Di questo '
accerchiamento' , proprio con queste parole, parlava il rapporto del poliziotto
della stradale. Ma quando lo convocai e gli chiesi di mostrarmelo lui,
prontissimo, lo fece in mille pezzettini davanti a me, esterrefatto. Di più:
tentò di ingoiarli e solo quando gli feci presente che stava commettendo
un'omissione gravissima, mi diede quei frammenti". Ha letto cosa dicono oggi i
magistrati su Antonio Gava? "Posso dire che già dalla lettura dei miei atti,
della mia inchiesta, emergeva con chiarezza il ruolo primario di Antonio Gava
nelle trattative con Cutolo per la liberazione di Cirillo". Perchè i capi dc
volevano Cirillo libero a tutti i costi e ad ogni costo? "Attenzione, il
processo racconta che il primo intervento fatto su Cutolo puntava a far
terminare in fretta il sequestro: con Cirillo o morto o libero". L' importante
era fare in fretta... "Sì, era importante perchè da un lungo sequestro temevano
sarebbe potuta derivare una lunga confessione di Cirillo alle BR su ciò che
sapeva della Dc. Un pericolo da evitare ad ogni costo". E' stato scoperto tutto
sul caso Cirillo? "No, appena il dieci per cento della verità. Il nodo resta il
dopo terremoto. E' lì che bisogna insistere".
La strana storia del
professor Senzani e del sequestro dell’assessore Cirillo,
scrive Francesco Damato il 30
Agosto 2017 su "Il Dubbio". A un mese dalla morte dell’ex amministratore Dc
rapito dalle Br non è venuto alla luce nessun memoriale segreto, come aveva
promesso. Così resta il mistero. A un mese ormai dal 30 luglio, giorno della
morte di Ciro Cirillo, l’assessore regionale campano della Dc sequestrato dalle
brigate rosse fra il 27 aprile e il 24 luglio del 1981, e liberato dopo una
misteriosa trattativa in cui fu coinvolta, a dir poco, la camorra guidata in
carcere da Raffaele Cutolo, si può forse scrivere che egli non ha davvero
lasciato memoriali o altro a qualche notaio. Lo aveva annunciato dopo la
liberazione, fra le polemiche politiche e le indagini giudiziarie, per poi
smentire, cioè per ripensarci. Sulle minacce hanno forse prevalso le promesse
agli amici altolocati del suo partito, alquanto malmessi nella esposizione
mediatica per avere violato con lui quella cosiddetta linea della fermezza, cioè
di rifiuto di ogni cedimento al terrorismo, che tre anni prima era costata la
vita ad Aldo Moro. La cui tragica scomparsa, preceduta dalla strage della sua
scorta, aveva portato alla fine della politica di cosiddetta solidarietà
nazionale col Pci di Enrico Berlinguer e a quella che Carlo Donat-Cattin, molto
amico del presidente democristiano, definì “l’infarto della Democrazia
Cristiana”. Esponente del potente gruppo di Antonio Gava – che a sua volta
deteneva l’azione d’oro, diciamo così, della segreteria del partito detenuta da
Flaminio Piccoli – l’assessore Cirillo aveva tra le mani, nel momento in cui fu
sequestrato, la ricostruzione dell’Irpinia e delle altre zone meridionali
danneggiate dal terremoto del 1980: quello che aveva mandato su tutte le furie,
per i ritardi e altri pasticci dei soccorsi, il presidente della Repubblica
Sandro Pertini. Forse le Brigate rosse non avevano pensato proprio a quei lavori
di ricostruzione quando decisero di mettergli le mani addosso. Ma ci pensò la
camorra, più lesta dello Stato nel controllo del territorio e probabilmente
nell’individuazione del covo brigatista in cui il sequestrato era stato
rinchiuso. Pertanto le Brigate rosse, avventuratesi in una zona off limits con
una imprudenza che si erano risparmiate in una regione, per esempio, come la
Sicilia, dovettero fare i conti anche con i camorristi per portare avanti e
chiudere la loro avventura. Furono pagati per la liberazione, versati di notte a
Roma su un tram al regista del sequestro in persona, Giovanni Senzani (poi
condannato per questo ad uno degli ergastoli accumulati) un miliardo e mezzo di
lire. Eppure Senzani, che vive ormai in piena e legittima libertà dal 2010, ha
sempre smentito che dietro quel pagamento ci fosse stata qualche trattativa in
cui fossero state coinvolte Brigate rosse, Democrazia Cristiana e camorra. Nelle
Brigate rosse Senzani aveva assunto ruoli apicali dopo la cattura a Milano,
proprio in quel 1981, di Mario Moretti che nel 1978 aveva diretto a Roma il
sequestro e l’assassinio di Aldo Moro – e del compagno di idee e di lotta Enrico
Fenzi. Di cui peraltro Senzani era cognato, avendone sposato la sorella. Oltre
al sequestro Cirillo, toccò a Senzani gestire, nello stesso anno, il rapimento
ma poi anche l’esecuzione, con altra condanna, di Roberto Peci, che pagò la
colpa di essere fratello di Patrizio, il terrorista pentito che aveva permesso
di sgominare mezza organizzazione sotto gli incalzanti interrogatori del
generale Carlo Alberto dalla Chiesa e del magistrato Gian Carlo Caselli. In uno
scenario quasi esoterico che si ritrova navigando tranquillamente per internet,
il povero Roberto Peci fu trattenuto dai suoi aguzzini per 55 giorni e ucciso
con undici colpi d’arma di fuoco: 55 quanti erano stati i giorni di prigionia di
Aldo Moro, tre anni prima, e 11 quanti i colpi sparati contro l’inerme
presidente della Dc processato dal fantomatico tribunale del popolo delle
Brigate rosse. È curiosa davvero la storia di questo Senzani: una storia che ho
avuto la sfortuna di incrociare personalmente con una vertenza giudiziaria
finita anche all’esame dell’ultima commissione parlamentare d’inchiesta sul
sequestro e sull’assassino di Moro, presieduta da Giuseppe Fioroni. Siamo a
cavallo fra il 2000 e il 2001. Dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulle
stragi incompiute, presieduta dal senatore Giovanni Pellegrino, dei Democratici
di sinistra, arrivano voci clamorose sul ruolo che avrebbe svolto Senzani anche
nel sequestro di Moro, tre anni prima dei fatti terroristici che gli avrebbero
procurato processi e condanne. Mi avvicina in Transatlantico, a Montecitorio,
l’amico Nicola Lettieri, sottosegretario democristiano all’Interno all’epoca del
rapimento del presidente del suo partito, e mi confida la sua inquietudine
ritenendo che durante il sequestro proprio Senzani, da lui ritenuto quanto meno
consulente del Ministero della Giustizia come criminologo, anche se lo stesso
Senzani definirà pure questa una fandonia in una intervista del 2014
al Garantista, fosse stato contattato dal Viminale per aiutare politici e
funzionari a interpretare i comunicati delle Brigate rosse. Tracce di questa
presunta consulenza tuttavia non si trovano fra le carte del Viminale. Me lo
escluse, su richiesta formulatagli personalmente, anche Francesco Cossiga,
ministro dell’Interno all’epoca dei fatti. Vengono invece fuori dalla
commissione di Pellegrino altri fatti, come una deposizione del magistrato
toscano Tindari Baglioni, occupatosi di terrorismo a Firenze. Che, invitato a
dire se il sequestro Moro fosse stato possibile più per la debolezza dello Stato
che per la forza delle Brigate rosse, risponde che entrambi avevano in comune un
consulente, appunto Senzani. Del quale viene riferito alla stessa commissione
che la Procura di Firenze chiese l’arresto dopo il fermo di un giovane armato
che abitava presso di lui. Il capo della Digos locale, sempre secondo il
racconto alla commissione, chiese prudenza trattandosi di un collaboratore dello
Stato, comunque arrestato nel 1979, ma per soli cinque giorni, come dallo stesso
Senzani ricordato poi nella già citata intervista del 2014 al Garantista. Egli
comparirà solo due anni dopo quel breve arresto sulla scena del terrorismo con i
sequestri di Roberto Peci e di Ciro Cirillo. Che in quella stagione tuttavia,
come ha ricordato sul Dubbio Paolo Comi, non furono gli unici due rapiti dalle
Brigate rosse o affini. Furono prelevati dai terroristi anche il povero Giuseppe
Taliercio, del polo petrolchimico della Montedison a Mestre, trovato poi ucciso,
e Renzo Sandrelli dell’Alfa Romeo, fortunatamente sopravvissuto.
Quando la Commissione stragi
conclude i propri lavori, nel finale della legislatura 1996- 2001, prendendo la
decisione di inviare un rapporto alla Procura di Roma per chiedere praticamente
un’indagine sul ruolo di Senzani nel sequestro Moro, ed esce anche un libro-
intervista del presidente Pellegrino, pieno di riferimenti allo stesso Senzani,
scrivo un articolo sul Giornale diretto da Maurizio Belpietro per auspicare un
chiarimento sulla vicenda. Senzani, in regime allora di semilibertà,
dichiaratosi sempre estraneo – ripeto – al sequestro Moro e alla sua gestione,
si sente diffamato non dalla Commissione stragi, dai magistrati da essa
ascoltato o dal suo presidente ma curiosamente da me. E mi denuncia. La solerte
Procura di Monza manda immediatamente agenti della Polizia giudiziaria al
Giornale per rilevare la mia identità e mi comunica già dopo un paio di mesi, a
maggio, la chiusura delle indagini, senza mai interrogarmi e – temo – senza
neppure leggere o solo sfogliare il libro intervista di Pellegrino e
quant’altro. L’udienza dal giudice per le indagini preliminari, finalizzata al
rinvio a giudizio, viene fissata per i primi giorni di luglio, ma salta per
qualche errore di notifica e viene rinviata a pochi giorni prima di Natale.
L’avvocato del Giornale, cui
naturalmente ho provveduto ad inviare tutta la documentazione raccolta, compresi
alcuni verbali delle audizioni della Commissione stragi segnalatimi dallo stesso
presidente, rimane colpito dai tempi dell’inchiesta giudiziaria, rapidissimi
come una freccia rossa dei giorni nostri. Prende – presumo – i suoi contatti,
assume le informazioni del caso e, sentendo puzza di misteriosi interventi,
anche in relazione al rapporto della Commissione stragi inviato alla Procura di
Roma, che in effetti dopo qualche anno archivierà i dubbi e le sollecitazioni
degli inquirenti parlamentari, mi consiglia di chiudere la vicenda patteggiando.
E così avviene, immagino con soddisfazione di Senzani e dell’accusa.
Anche Paolo Comi, pur non
conoscendo forse la mia disavventura, nella rievocazione del sequestro di Ciro
Cirillo ha giustamente e prudentemente scritto di Senzani sul Dubbio con una
certa cautela, da me condivisa dopo l’esperienza avuta, ricordandone certamente
il ruolo, d’altronde sanzionato in sede giudiziaria e definitiva, ma anche
riportandone le smentite già ricordate ad una gestione delle trattative per il
rilascio dell’assessore democristiano estesa alla Dc, alla camorra, ai servizi
segreti e a quant’altro.
Eppure lo storico boss della
camorra Raffaele Cutolo si è personalmente e ripetutamente vantato della
collaborazione chiestagli e da lui concessa a pezzi importanti della Dc e dello
Stato, intesi questi ultimi come servizi segreti, per arrivare alla liberazione
di Cirillo. E non credo proprio che lo avesse fatto a titolo di generosità e di
patriottismo, non essendo la camorra, in nessuna delle sue ramificazioni,
un’associazione né benefica né patriottica. Anch’essa evidentemente riteneva di
poterne trarre vantaggio, come poi si capì con la spartizione degli appalti per
la ricostruzione delle zone della Campania danneggiate dal terremoto del 1980.
Non mancarono d’altronde inchieste giudiziarie sul ruolo della camorra nella
gestione del sequestro Cirillo, con grossi e inquietanti tentativi di
depistaggio. Il più clamoroso dei quali fu certamente il falso dossier passato
ad una giornalista dell’Unità che chiamava in causa, fra gli altri, il
democristiano Enzo Scotti, soprannominato Tarzan nel partito per la facilità con
cui passava da una corrente all’altra e destinato a diventare dopo molti anni
ministro dell’Interno. Il giornale del Pci dovette scusarsi e il suo direttore
Claudio Petruccioli dimettersi. Allora il giornalismo era una cosa seria, o più
seria di adesso, e si usava fare così. Che era poi il modo più efficace anche
per limitare i danni del depistaggio, evitando che si parlasse troppo a lungo
non delle indagini sul sequestro Cirillo ma dell’infortunio del giornale del
principale partito di opposizione.
Chi trattò con la camorra
per salvare Cirillo?
Forse nessuno, scrive Paolo Comi l'1 Agosto 2017 su "Il Dubbio". Il vecchio
assessore democristiano è morto domenica a 96 anni. Fu al centro di un mistero
mai risolto e di gigantesche polemiche. A 96 anni, domenica, è morto Ciro
Cirillo, gran democristiano anni 70 in Campania. Aveva sessant’anni, il 21
aprile del 1981, quando un commando delle Br lo aspettò sotto casa, a Torre del
Greco, la sera, all’ora di cena, e appena la sua auto si fermò, il commando
iniziò a sparare, come si faceva in quegli anni. Restarono sull’asfalto, morti
stecchiti, il suo autista e la guardia del copro, un maresciallo dei
carabinieri. Mentre il suo segretario particolare, un ragazzo di trent’anni, si
salvò, ma con la gamba maciullata. Lui restò illeso. I brigatisti lo sollevarono
di peso, lo gettarono nel cassone d’un furgone e lo portarono nella prigione del
popolo. Li guidava un certo Giovanni Senzani, che era stato un consulente del
ministero di giustizia, era uno studioso, un sociologo. Ala militarista delle
Br. Da quel giorno iniziarono mesi di fuoco, paragonabili forse solo ai due mesi
di tre anni primi, quelli celebri del rapimento di Aldo Moro nel 1978. Diamo
un’occhiata alle date che separano l’inizio di aprile all’inizio di agosto del
1981. 4 aprile, notte, una strada di periferia a Milano, al polizia intercetta
Mario Moretti ed il professor Enrico Fenzi che stanno andando a trovare un
esponente della mala che loro non sanno essere un confidente della questura.
Moretti e Fenzi vengono bloccati, immobilizzati e disarmati. Moretti è
considerato il capo assoluto delle Br, l’erede di Curcio, il cervello del
sequestro Moro e anche l’uomo che ha sparato al presidente della Dc. Fenzi è uno
dei leader dell’ala militare delle Br, e Moretti è in lite con lui. Fatto sta
che le Br sono decapitate. Prendono il comando Barbara Balzerani, che guida i
movimentisti, e, appunto, Senzani del quale abbiamo già parlato come leader dei
militaristi. Però tutto si può dire meno che l’arresto di Moretti abbia
indebolito l’organizzazione. Passano poco più di due settimane dal colpo a
favore della polizia e Senzani risponde. 21 aprile, rapito Ciro Cirillo. 20
maggio, Porto Marghera, un commando, pare guidato da Antonio Savasta, entra in
casa di un dirigente del Petrolchimico della Montedison, un certo Giuseppe
Taliercio, e se lo porta via. Due settimane dopo un altro dirigente d’azienda,
Renzo Sandrucci, uomo Alfa Romeo, viene sequestrato a Milano. È il 3 giugno. La
settimana successiva, il 10 giugno, tocca a a Roberto Peci, che è il fratello di
Patrizio Peci, il primo pentito della storia delle Br. Roberto non ha neanche 30
anni. Il suo rapimento è una vendetta trasversale. A questo punto le Brigate
Rosse si trovano ad avere contemporaneamente nelle loro mani quattro
prigionieri. Un giorno sì e uno no arrivano proclami, dichiarazioni,
confessioni, fotografie, richieste di riscatto. E le azioni militari non si
limitano alla gestione delle prigioni del popolo e agli interrogatori. Si spara,
si ferisce, si uccide per strada. Negli stessi giorni dei quattro rapimenti
vengono uccisi Raffaele Cinotti, Mario Cancello, Luigi Carbone, Sebastiano
Vinci. Ciascuno in un giorno diverso e in un luogo diverso: tutti e quattro
poliziotti. Era quello il clima in quegli anni. Non è facile crederci, magari,
ma la lotta politica avveniva in questo clima qui. Eppure non prevaleva la
pulsione repressiva, illiberale. Pensate che in quegli stessi anni il Parlamento
approvava le leggi-Gozzini, e cioè una serie di norme, che oggi vengono
considerate dai più ultraliberali, che attenuano le pene, introducono premi e
semilibertà e misure alternative al carcere…I quattro sequestri hanno esiti
diversi. Il 5 luglio si conclude tragicamente il sequestro di Taliercio.
L’ingegnere viene ucciso in modo barbaro. L’autopsia stabilisce che era ferito,
aveva dei denti rotti e non mangiava da cinque giorni. Taliercio si era
rifiutato di collaborare, probabilmente aveva mantenuto un atteggiamento di
sfida. Il processo per la sua morte si concluderà con tre condanne all’ergastolo
per tre brigatisti poco conosciuti, mentre il leader della colonna, il romano
Antonio Savasta, che collabora con gli inquirenti, se la cava con dieci anni. Il
nome di Taliercio, chissà perché, scompare dal Pantheon degli eroi di quegli
anni. Non so quanti siano gli italiani che oggi, se gli chiedi a bruciapelo chi
era Taliercio, sono in grado di rispondere. Temo poche centinaia. Il 23 e il 24
luglio, nel giro di poche ore, si concludono positivamente il sequestro
Sandrucci e quello Cirillo. Vengono liberati tutti e due. Per tutti e due è
stato pagato un riscatto. Pochi giorni dopo, il 3 agosto, la notizia atroce
dell’uccisione di Roberto Peci, che ha una figlioletta di un anno, viene
processato dal tribunale dei terroristi davanti a una telecamera, e poi, davanti
alla telecamera, ucciso con una mitraglietta. La cassetta di questo obbrobrio
viene mandata ai giornali. Di suo fratello Patrizio, che era l’obiettivo di
questa spietatezza, non si saprà mai più niente. Ha cambiato nome, ha cambiato
connotati – pare – con una operazione di chirurgia plastica, vive in una
località sconosciuta. Ora dovrebbe avere un po’ meno di settant’anni. Di come si
sia ottenuta la liberazione di Sandrucci non si sa molto e non si parla molto.
La liberazione di Cirillo invece solleva un pandemonio di polemiche. Questo
Cirillo è l’ex presidente della Regione, è un uomo forte della cosiddetta
corrente del Golfo, cioè quella corrente democristiana che fa capo ad Antonio
Gava e che è il braccio napoletano dei dorotei. Cirillo, al momento del
sequestro, è l’assessore all’urbanistica della Campania e si occupa dell’immenso
affare della ricostruzione dopo il terremoto del 1980. I giornali raccontano che
per liberarlo, il suo partito, che appena tre anni prima non ha voluto trattare
con le Br per salvare Moro, ha trattato invece, eccome, non solo con le Br ma
anche con la camorra di Raffaele Cutolo che avrebbe fatto da intermediaria. Non
si saprà mai se è vero. Si sa che un riscatto di un miliardo e 400 milioni di
lire (cifra molto alta per quell’epoca, quando un’automobile di media cilindrata
costava circa quattro- cinque milioni) è stato pagato a Roma, il 21 luglio,
all’interno di un tram (il numero 19) che va dalla stazione Termini a
Centocelle. I soldi li porta in un borsone un amico di Cirillo e li consegna a
Giovanni Senzani in persona, che acchiappa la borsa, scende al volo da un tram e
vola via con una Fiat 128 che lo aspetta alla fermata. La Dc raccolse i soldi?
Il segretario democristiano Flaminio Piccoli sapeva? E Antonio Gava? L’anno dopo
l’Unità, cioè il giornale del Pci, pubblica uno scoop clamoroso: è stato il
ministro Vincenzo Scotti in persona a trattare con la camorra, anzi è andato
personalmente in carcere a discutere con Raffaele Cutolo. E’ una bomba atomica
sulla politica italiana. Ma poche ore dopo l’uscita del giornale si scopre che
il documento che accusa Scotti è falso. E’ una contraffazione realizzata da un
certo Gino Rotondi (che non si saprà mai se lavorava per la camorra, o per i
servizi segreti, o se era un mitomane) che la consegna a una giovanissima
cronista del giornale dei comunisti. Lo scandalo a quel punto si rovescia e
travolge tutti i dirigenti dell’Unità, a partire dal direttore, il giovane
Claudio Petruccioli, che si dimette dopo poche ore, e persino qualche dirigente
del Pci, e precisamente il vice di Berlinguer, Alessandro Natta, che si dimette
anche lui dal suo incarico. Il capogruppo Giorgio Napolitano prende la parola
alla Camera e chiede scusa a nome del partito e del giornale. Allora le cose
andavano così, a voi verrà da sorridere ma è la verità: se un giornale
pubblicava una notizia falsa (cosa che oggi avviene quasi tutti i giorni su
moltissimi giornali) poi era un casino e addirittura il direttore ci rimetteva
il posto. Non potevi neppure mettere in pagina delle intercettazioni un pop’
contraffatte, perché rischiavi grosso…Il caso Cirillo finì così. La Dc se la
cavò. Nessuno mai seppe la verità. Recentemente Giovanni Senzani – che oggi è
libero e un paio d’anni fa ha presentato un suo film, pare piuttosto bello, a
Locarno – in una intervista al “Garantista” ha giurato che non ci fu nessuna
trattativa né con la camorra né con la Dc. Che pagarono i parenti di Cirillo.
Lui, Cirillo, una volta libero fu costretto a ritirarsi dalla politica. In
un’intervista a Repubblica disse che la verità l’aveva detta a un notaio e che
sarebbe diventata pubblica dopo la sua morte, Cioè ora. Poi però smentì, e disse
che non c’era nessun segreto. Adesso aspettiamo un paio di giorni per vedere se
esce fuori ‘ sto notaio. Altrimenti ci dovremo rassegnare all’idea che
probabilmente furono davvero i parenti di Cirillo a tirare fuori il miliardo e
rotti e che la Dc non c’entrava niente.
Rapimento Cirillo: le Br,
Cutolo e la Dc. Così D'Avanzo raccontò la trattativa. E il suo clamoroso prezzo.
L'articolo di Giuseppe D'Avanzo su Repubblica del primo febbraio 1985. "Può
dirsi sufficientemente provato che nelle trattative per il rilascio di Ciro
Cirillo sono intervenuti esponenti democristiani ed esponenti dei servizi
segreti". Il giudice istruttore di Napoli, Carlo Alemi, non ha dubbi. Nella
lunga ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio dei brigatisti della colonna
napoletana delle Br il magistrato affronta al capitolo nono "le trattative per
il sequestro Cirillo". Soltanto tredici pagine, ma un rosario di testimonianze
sufficienti a fargli chiedere un'ulteriore "approfondita istruttoria" per
conoscere "l'esatto ruolo svolto dalla Nuova camorra organizzata di Raffaele
Cutolo per il rilascio di Cirillo; l'intervento di esponenti di partiti politici
che hanno fatto da tramite ed eventualmente da garanti tra le Br e Cutolo nello
sviluppo della trattativa; il ruolo svolto durante i giorni del sequestro dai
servizi segreti e se questo sia stato contenuto nell'ambito dei compiti
istituzionali". Le tredici pagine, tuttavia, con le testimonianze dei brigatisti
pentiti già disegnano lo scenario della trattativa, i suoi protagonisti, il
prezzo che gli intermediari si dicevano pronti a pagare per la liberazione
dell'assessore regionale Dc. E se il prezzo è clamoroso - forse fu offerta anche
l'indicazione del luogo dove era custodito Patrizio Peci -, altrettanto
clamoroso è l'unico nome di protagonista che salta fuori, Gava: nome sussurrato
da tempo ma mai entrato finora in un'inchiesta giudiziaria. A vuotare il sacco
sono stati Pasquale Aprea e Maria Rosaria Perna, i carcerieri di Cirillo nei due
mesi della sua prigionia. "Nella prima decade di maggio - hanno raccontato -
durante la fase in cui il sequestro andava politicamente malissimo, le Br con lo
spostamento dei compagni detenuti ad Ascoli seppero che la camorra dietro
pressioni di esponenti politici napoletani offriva per la liberazione di Cirillo
5 miliardi, armi a volontà, un elenco di magistrati napoletani con relativi
indirizzi. Anzi si offriva di effettuare agguati ai danni di magistrati indicati
dalle Brigate rosse". Antonio Chiocchi, uno dei fondatori della colonna
napoletana, riferì in più occasioni ai due che "Gava era andato da Cutolo per
trattare la liberazione di Cirillo presso le Brigate rosse". Silvio o Antonio
Gava? Il magistrato non lo scrive. Inizialmente la trattativa si arena di fronte
al rifiuto dei terroristi. Maurizio Stoccoro, un altro pentito, ha confermato di
aver saputo da Giovanni Planzio, capo storico della colonna, "che Cutolo era
intervenuto per sollecitare il rilascio di Cirillo in quanto alla camorra
serviva che venissero allentati i posti di blocco della Polizia che ne
impedivano tutti i traffici illeciti". "Cutolo ci offrì - ha raccontato Stoccoro
- denaro, due o più miliardi, molte armi. Quante ne avessimo volute". Un'offerta
che non interessò le Brigate rosse. L'attacco delle Br, infatti, - ha spiegato
Stoccoro ai magistrati - era rivolto alla Dc proprio per dimostrare che mentre
la Democrazia cristiana per Moro non aveva voluto trattare, aveva invece
trattato per Cirillo". A maggio la trattativa ha una svolta. Comincia
l'andirivieni di camorristi e brigatisti nel carcere di Ascoli Piceno e di
Palmi. Giovanni Planzio ha detto ai giornalisti che "per Cirillo cominciarono a
muoversi i servizi segreti". Con l'arrivo ad Ascoli Piceno degli uomini del
colonnello Musumeci aumenta anche il prezzo offerto alle Brigate rosse.
Intermediari Luigi Bosso, un delinquente comune politicizzatosi in carcere, e
Sante Notarnicola. "Alle Brigate rosse - annota il giudice istruttore - viene
offerto un grosso quantitativo di mitra, un elenco di carabinieri e di
magistrati dell'antiguerriglia, l'indicazione del luogo in cui era custodito
Patrizio Peci". Il superpentito delle Br era in quelle settimane - siamo nella
primavera dell'81 - nelle mani delle squadre speciali del generale Dalla Chiesa.
Chi dichiarò la disponibilità di far conoscere alle Brigate rosse il
preziosissimo indirizzo? Gli omissis dell'ordinanza lasciano la domanda senza
risposta. Ad avviare finalmente la trattativa fu Giovanni Senzani, il leader
della colonna Napoli. Ha raccontato Maria Rosaria Aprea: "Una sera Senzani,
entrando a casa, disse: "Qui ci facciamo pure i soldi". Antonio Chiocchi e
Pasquale Aprea si ribellarono con asprezza al loro capo. Ma Senzani ribadì "la
correttezza politica di tale richiesta". "Gli obiettivi politici - spiegò - sono
stati raggiunti. La corresponsione di sussidi ai disoccupati, la smobilitazione
della roulottopoli dei terremotati, la pubblicazione dei verbali di
interrogatorio di Cirillo. E' giusto - conclude il criminologo - espropriare
Cirillo, la sua famiglia, la Democrazia cristiana"". L'intera ricostruzione
della trattativa è stata confermata da altri pentiti. Michele Galati, membro del
direttivo della "colonna veneta" delle Br, nel carcere di Cuneo incontrò i
brigatisti Moretti, Guagliardo, Franceschini. Il giudizio politico che
espressero sulla trattativa fu lapidario. "Le Br - sostennero Moretti e
Franceschini - non avevano alcun interesse ad un pagamento da parte di alcuni
palazzinari napoletani ma puntarono immediatamente ad una trattativa che vedesse
direttamente coinvolta la Dc". Enrico Fenzi, brigatista e cognato di Senzani,
molto vicino al leader Mario Moretti, ha riferito, dal suo canto, ai giudici:
"Moretti ripetè più di una volta che era venuto fuori e bisognava pur dirlo che
se Cirillo non era stato ammazzato ciò era dovuto all'intervento di Cutolo".
Testimonianze confermate dal maresciallo Angelo Incandela, comandante degli
agenti di custodia del carcere di Cuneo: "Sì, il pentito Sanna ci tracciò tutto
il quadro delle trattative intercorse tra servizi segreti, camorra e Brigate
rosse al fine di ottenere la liberazione di Cirillo". E Luigi Bosso ha
confermato, prima della sua morte improvvisa, che fu "Cutolo ad attribuirgli
l'incarico di entrare in contatto con i brigatisti di Palmi, latore di questo
messaggio: la Dc è disposta a trattare a tutti i livelli attraverso il canale di
Cutolo".
“ARMI E BAGAGLI” DI ENRICO
FENZI. Il
racconto dall’interno del terrorismo italiano, scrive Francesco Vannutelli il 15
febbraio 2016. Nel 1987 uscì per l’editore genovese Costa & Nolan Armi e
bagagli, un libro fondamentale per capire quello che erano state le Brigate
rosse negli anni immediatamente precedenti, tra i più complicati nella breve
storia della Repubblica italiana. A scriverlo era stato Enrico Fenzi,
un’esponente della colonna genovese che aveva deciso di raccogliere in forma
narrativa i ricordi degli anni della lotta armata, tratteggiando quello che è
uno dei più interessanti quadri d’insieme dall’interno degli anni di piombo in
Italia. Oggi questa opera importantissima torna in libreria grazie a Egg
edizioni. Enrico Fenzi, sulla sua pagina Wikipedia è definito in apertura come
«ex terrorista e storico della letteratura italiana». Come studioso, è ritenuto
tra i massimi di Dante e Petrarca (nel 2008 ha pubblicato la
monografia Petrarca per Il Mulino). Come terrorista, è stato un esponente della
colonna genovese delle Brigate rosse, il nucleo terroristico fondato
direttamente da Mario Moretti e Rocco Micaletto che nel giugno del 1976 fu
co-responsabile, insieme al comitato esecutivo centrale, del primo omicidio di
natura puramente politica delle BR: l’assassinio del giudice Francesco Coco e di
due uomini della sua scorta. Tra il 1975 e il 1981, il nucleo ligure fu
responsabile di una serie di attività tra le quali sei omicidi e quindici
ferimenti. La colonna genovese fu, tra le sei divisioni delle Brigate rosse (le
altre avevano sede a Milano, Torino, nel Veneto, a Roma e a Napoli), una delle
più organizzate sul piano dell’azione militare e delle più coese dal punto di
vista ideologico, con l’attenzione della lotta rivolta quasi esclusivamente alla
questione operaia. «Che avveniva nelle fabbriche? Quello era il grande
continente sconosciuto, e la meta di tutti i nostri andirivieni», è
l’interrogativo che pone Fenzi, che mostra la tendenza costante della colonna
alla ricerca di un programma che «permettesse di entrarci, in quel continente
desiderato e irraggiungibile». Solo che nelle fabbriche non c’era più un terreno
in cui far fiorire un discorso. «I giovani operai arrabbiati di qualche anno
prima erano spariti», e le misure estreme che i brigatisti provarono ad
adottare, incluso l’omicidio dell’operaio e sindacalista Guido Rossa, si
rivelarono essere, il più delle volte, delle armi a doppio taglio. Il sistema
non veniva ferito, il movimento perdeva di consenso tra gli operai, e non
bastavano i goffi tentativi di spiegazione (nel volantino di rivendicazione
dell’omicidio di Rossa si legge chiaro «È stato un errore») per riavvicinare la
colonna alla classe operaia genovese.
Enrico Fenzi entrò nelle
Brigate rosse a quarant’anni, con una carriera solida di docente universitario
già avviata. Da molti è stato considerato uno degli ideologi del movimento.
All’interno della colonna conservò in verità una posizione marginale, mantenendo
soprattutto contatti personali con alcuni degli esponenti di spicco. Il ruolo di
ideologo che la cronaca gli ha attribuito in base alla sua posizione di
intellettuale lo ha sempre rifiutato. Per sé, ha sempre rivendicato il ruolo di
militante semplice, di «manovale», come si è voluto definire parlando con Sergio
Zavoli nel programma La notte della Repubblica. Non ha mai partecipato alla
stesura di documenti brigatisti, anzi ha ammesso di averli letti raramente. Ha
preso parte a una sola azione violenta, facendo da copertura a Luca Nicolotti,
Francesco Lo Bianco e Alberto Franceschini durante il ferimento di Carlo
Castellano, dirigente del gruppo Ansaldo ed esponente del Partito Comunista
Italiano. Per il resto, ha distribuito volantini. Dagli anni Ottanta scelse la
strada della clandestinità dopo essere stato inquisito e assolto dall’accusa di
banda armata (Carlo Alberto Dalla Chiesa parlò di «ingiustizia che assolve»,
commentando la sentenza). La sua adesione nacque dalla visione del mondo
capitalistico come un «dinosauro morente» contro il quale sentiva la «necessità
minuziosa e concreta della lotta armata». La vera radice della sua visione
politica l’ha trovata dopo gli anni della militanza nel Sartre della Critica
della ragione dialettica, quello che vede «l’uomo come avvenire dell’uomo» e
rivendica il ruolo del gruppo rivoluzionario in azione come unico in grado di
riappropriarsi della totalità. È in questa prospettiva che inquadra l’azione
terroristica come un modello in grado di ricomporre «i frammenti del presente,
per riappropriarsene alla luce di una totalità integralmente attualizzata». Il
brigatista come lo Spirito Assoluto di Hegel, come tentativo di realizzare «il
progetto e la verità della Storia». Per Fenzi, le Brigate rosse sono state il
momento terminale del comunismo italiano come movimento che ha attraversato
nella realtà locale le fasi storiche dell’intera vicenda politica globale. «La
sconfitta delle Brigate rosse ha avuto, qui da noi, lo stesso valore e lo stesso
senso che avrà vent’anni dopo, emblematicamente, il crollo del muro di Berlino.
Non solo: per le sue caratteristiche l’esperienza italiana è stata per molti
aspetti un’esperienza centrale, perché in essa gli elementi della tradizione
comunista sono arrivati al loro capolinea». Armi e bagagli non pretende di
essere una giustificazione ideologica degli anni della militanza: «non c’è
rimedio a ciò che è stato fatto […], il male compiuto ridicolizza le pretese
delle parole». Per questo, Fenzi rivendica a più riprese per la sua opera la
natura «dichiaratamente narrativa». «È un libro, non un atto di autocoscienza».
Comunque l’autore la voglia vedere, la profondità di un’analisi così acuta e
dettagliata, che intreccia la storia con la riflessione politica in una forma
che sa accompagnarsi anche con la narrazione più letteraria, è la linfa di un
documento fondamentale per comprendere il passato e vedere anche al presente.
Alla casa editrice Egg va il merito di aver riproposto Armi e bagagli in questa
nuova versione.
La dannazione perpetua del
prof. Fenzi.
Dalle Br si è dissociato 31 anni fa. Eppure, invitato oggi a partecipare a una
Lectura Dantis, è stato attaccato per il suo passato, scrive il 16 aprile 2013
"Il Corriere della Sera”. Cosa facciamo de La resurrezione di Lazzaro o
del Davide con la testa di Golia dipinti da Caravaggio “dopo” avere ammazzato
Ranuccio Tomassoni in una rissa seguita a un fallo durante una partita di
pallacorda? Li bruciamo? E dei saggi scritti da Enrico Fenzi “dopo” essere
entrato nelle Br, dalle quali si è dissociato 31 anni fa, che facciamo: li
mandiamo al rogo? Anche se hanno titoli tipo Petrarca e l’eternità del mondo:
appunti per un commento al De ignorantia, Ancora sulla Epistola a Moroello e
sulla “montanina” di Dante (Rime, 15) o L’ermeneutica petrarchesca tra libertà e
verità? Per carità, nessun paragone tra il grande pittore milanese e il docente
universitario genovese. Ma le responsabilità penali e le opere pittoriche o
letterarie sono cose diverse. E se è insopportabile ascoltare ogni tanto degli
ex terroristi di destra e di sinistra discettare di politica magari dando pure
qualche lezioncina, e se è assolutamente comprensibile che i familiari delle
vittime si levino a urlare “ma stattene zitto, almeno: taci!”, è impossibile
essere d’accordo con la condanna eterna, nei secoli dei secoli, di chi ha
sbagliato, si è riconosciuto colpevole e ha pagato senza pietire sconti. Per
carità, massima solidarietà umana con le sofferenze di chi ha subito un lutto
irrimediabile per mano di commandos delle Brigate Rosse, di Prima Linea, dei
Nar… Ma sconcerta leggere quanto ha detto Valerio Vagnoli, preside di un
istituto alberghiero, scagliandosi contro l’invito a Enrico Fenzi a una “Lectura
Dantis” organizzata dalla Società Dantesca Italiana, con Vittorio Sermonti:
«Provo fastidio a vedere delle personalità che hanno partecipato a dare
all’Italia lo spettacolo degli anni di inferno del terrorismo, elevarsi al ruolo
di educatori, occupare cattedre e aule universitarie, o leggere uno dei poeti
che sulla libertà non ha detto delle banalità». Era il 1982 quando Enrico Fenzi
si dissociò dalla lotta armata. L’anno in cui veniva ucciso Carlo Alberto Dalla
Chiesa, Giovanni Spadolini festeggiava a Palazzo Chigi la vittoria della
Nazionale ai Mondiali di calcio e in Libano veniva compiuto il massacro di Sabra
e Shatila. E mancavano vent’anni all’assassinio Br di Marco Biagi. Era
tantissimo tempo fa. Come ha scritto giustamente Giulia Fenzi, la figlia minore,
il dantista «è stato tanti anni in carcere e in un Paese in cui pochissimi
pagano per quello che hanno fatto, ha pagato il suo debito non solo con la
detenzione ma anche, com’è ovvio, con difficoltà di ogni genere, e noi con lui.
Bene, è giusto. Chi sbaglia paga, ma poi c’è, o ci dovrebbe essere, il fine
pena». Lo ha scritto sul Corriere anche Katia Malavenda, che come avvocato
specializzata nel diritto d’informazione conosce bene il tema del diritto
all’oblio e ha spiegato come quello di “rifarsi una vita, senza che il passato,
oramai definitivamente archiviato, continui a condizionare il presente” è un
diritto che “va riconosciuto a tutti, ma proprio a tutti, in particolare a chi,
dopo il clamore, ha scelto di non esporsi, ma non per questo ha rinunciato a
vivere. E allora, come la mettiamo con la damnatio perpetua che sembra inseguire
alcune categorie di soggetti, fra cui Enrico Fenzi, la cui vicenda è solo uno
spunto di riflessione?”. Nessuno oserebbe contestare il diritto che un galeotto
tornato in libertà dopo avere scontato la sua pena possa tornare a fare il
falegname, l’idraulico, il fabbro, il sarto o il giardiniere. Nessuno. Perché
dunque uno studioso di Dante e Petrarca con 61 saggi classificati nell’indice di
ricerca delle biblioteche italiane (neppure uno di politica) dovrebbe smettere
di occuparsi di Dante e Petrarca o essere addirittura rimproverato di volere
“leggere uno dei poeti che sulla libertà non ha detto delle banalità”? Non è
mica Cesare Battisti, il professor Fenzi. Non è un assassino che non ha mai
pagato e rifiuta di chiedere perdono e accusa la giustizia italiana e invoca
malintese solidarietà militanti. È uno studioso che ha passato la vita intera,
compreso il periodo in clandestinità (“Avevo preso l’impegno con l’Utet per fare
l’introduzione a un’opera di Dante. Una cosa importante. Passato alla latitanza
mi chiesi: cosa faccio, tiro il bidone? Finii il lavoro da clandestino e lo
spedii”) a leggere e studiare. E si beccò 18 anni di carcere pur avendo
partecipato direttamente a un solo atto di sangue, il ferimento alle gambe del
dirigente dell’Ansaldo Carlo Castellano: «Credo che avessero deciso di
coinvolgermi per una forma di battesimo. Come a dire “ora sei dei nostri”. Se ci
ripenso adesso non mi ci vedo: cosa ci facevo lì?». Commise un gesto terribile?
Certo. Se n’è pentito? Sì, da oltre tre decenni. Ha pagato? Sì. È stato un
“cattivo maestro”? Difficile da sostenere: «No, quello non lo sono mai stato.
Non lo dico né come un merito né come un demerito. Io sono del tutto alieno da
ogni attività di indottrinamento. Non ho mai convinto nessuno a entrare nelle
Br. Caso mai ho detto a tanta gente: lascia perdere. E poi l’indottrinamento si
fa scrivendo di politica…». Lui ha sempre scritto di Petrarca. Guai a
dimenticare. Ma è giusto tenere le persone inchiodate per tutta la vita agli
errori, confessati, del passato?
Fenzi: "Sulle Br la luce
deve venire dall'alto".
Per la prima volta del suo arresto nel blitz del '79 contro la
colonna genovese, il professore parla in pubblico a Palazzo Ducale. E rimette in
campo le responsabilità mai chiarite, scrive Donatella Alfonso il 10 dicembre
2013 su "La Repubblica". Enrico Fenzi PER dire che no, non sono le carte
giudiziarie a raccontare la vera storia delle Br Enrico Fenzi, chiama in causa
Alessandro Manzoni e la sua Pentecoste, ritrovando - per la prima volta in
pubblico - il suo essere, prima di tutto, un italianista di valore, com'era
fino a quel 17 maggio del '79 in cui fu arrestato nel blitz contro la colonna
genovese delle Br. Perché la luce deve venire dall'alto, spiega Fenzi,
dissociato e poi condannato a 18 anni di carcere totalmente scontati,
intervenendo al Minor Consiglio del Ducale in chiusura della presentazione, con
Gad Lerner, del libro di Andrea Casazza "Gli imprendibili", dedicato appunto
alla colonna genovese. Una luce interiore che deve venire dall'alto, insomma:
come quella della Pentecoste. E quindi, rilancia Fenzi, dai segreti di quello
stato che si voleva colpire al cuore, e dai rapporti internazionali: perché "le
cose vere sono tutte da dire" a partire "da quella famosa barca carica di armi:
erano quattro tonnellate, ce le aveva date l'Olp", e ci furono pressioni dei
servizi perché "io incastrassi l'onorevole Mancini". Da dove farla arrivare,
questa luce? E poi, da fronte diverso, ma ancora a insistere verso uno stato
responsabile della solitudine dei magistrati e di tante pagine oscure è il
figlio di De Vita, presidente della Corte d'Appello che decise la scarcerazione
della XXII Ottobre per liberare Sossi, poi fermata da Coco. Quella luce,
manzoniana o meno che sia, si accenderà mai?
Terrorismo a Genova. Enrico
Fenzi e il rapimento Sossi: sangue e memoria,
scrive Franco Manzitti il 10 dicembre 2013 su "Blitz Quotidiano". Enrico Fenzi,
prima d’ora non aveva mai parlato in pubblico a Genova della sua storia
brigatista, della sua militanza nel partito armato negli “anni di piombo”, dei
suoi processi, della sua condanna, della sua dissociazione, di quel che erano
gli uomini della “stella a cinque punte”, che avevamo tenuto in scacco lo Stato,
rapito e ucciso Aldo Moro, il presidente della Dc. Enrico Fenzi era stato
inghiottito prima dal carcere duro, dai processi a suo carico, dalla condanna
definitiva a 18 anni, poi dal suo pentimento che non c’era mai stato, poi dal
silenzio e dalla mimetizzazione nei caruggi di Genova, da dove era partita la
sua “banda armata” e dove era tornato “dopo”, come antiquario, poi come
ristoratore, sempre come professore, ex docente alla Facoltà di Lettere, esperto
di Dante e Francesco Petrarca, ex maestro, anzi bollato per sempre come “cattivo
maestro” di una generazione sessantottina e poi “rivoluzionaria”. E di colpo, in
fondo a uno dei saloni storici del Palazzo Ducale genovese, in fondo al
pubblico, alla fine della presentazione di un libro sulla colonna genovese delle
Br, è spuntato in piedi Enrico Fenzi, il “professore”, oggi quasi
settantacinquenne e ha chiesto di parlare, il maglione scuro, il volto pallido,
la voce un po’ emozionata per commentare quella storia appena raccontata sulle
Br di cui aveva fatto parte. “E’ la prima volta che parlo in pubblico di questo”
– ha annunciato davanti a duecento persone, all’autore del libro, Andrea
Casazza, giornalista del “Secolo XIX” e agli altri relatori di quella
presentazione, Gad Lerner, Giuliano Galletta, critico letterario, anche lui
giornalista de “Il Secolo XIX “ e Cesare Manzitti, avvocato, difensore di
imputati coinvolti in quei lontani processi anni Settanta-Ottanta, quando Genova
era in cima alle cronache del terrorismo. Il libro è intitolato “Gli
imprendibili” e lo ha stampato la casa editrice “Derive e Approdi”, un tomo di
500 pagine, che per la prima volta cerca di ricostruire la storia di quella
colonna Br che rapì Mario Sossi e uccise il procuratore della
Repubblica Francesco Coco e la sua scorta e giustiziò altri servitori dello
Stato di polizia e carabinieri e l’operaio e sindacalista dell’Italsider Guido
Rossa, che aveva denunciato un “postino” dei terroristi, sequestrò e gambizzò e
tenne in scacco Genova per quasi un decennio nel segreto più impenetrabile,
svelato solo quando i primi pentiti squarciarono il velo del terrore. Enrico
Fenzi era uno di questi “imprendibili”, anche se a Genova era stato già
arcinoto, un “maestro” della “rivoluzionaria” Facoltà di Lettere, uno di quelli
che esaminava gli studenti a gruppi e fiancheggiava politicamente le ali più
estreme dei partiti, allora chiamati extraparlamentari. E anche se era incappato
in un blitz rimasto famoso, perché catturò nel 1979 una quindicina di presunti
brigatisti rossi, caduti nelle maglie dei carabinieri del generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa, poi tutti assolti in primo grado nel famoso processo che lo stesso
generale avrebbe bollato come l’ “ingiustizia che assolve”, aveva fatto carriera
nel partito armato, fino alla sua cattura a Milano, insieme con uno dei killer
di Aldo Moro, il terribile Mario Moretti. Si alza e parla quasi quaranta anni
dopo tutto questo, dopo il sangue, la morte, il terrore, gli equivoci di Genova,
della sinistra, degli album di famiglia del Pci, le catture e i processi, Enrico
Fenzi “perchè deve levarsi qualche sassolino dalle scarpe” e vuole dire la sua
verità, davanti a quel pubblico “informato sui fatti”, ma lontano anni luce da
quel tempo, perchè oggi siamo in un altro tempo, truce come quello, ma macchiato
di altri colori. “Non è vero che mi è stato perdonato tutto “- incomincia Fenzi
con il suo tono da ex professore che alza la voce per la prima volta – sono
stato condannato a 18 anni e ne ho scontati diciassette, di cui sette più tre in
galera e gli altri con altre misure. Ho pagato abbondantemente, ma non sono mai
stato reintegrato nel mio lavoro e non mi sono mai stati restituiti i diritti
civili”. Fenzi ha un tono duro, ma quasi non rivendicativo, come di chi vuole
uscire da una cappa di buio che lo ha coperto per questi quaranta anni in cui il
mondo è cambiato, ma lui è rimasto sotto la cappa di una specie di condanna
permanente, dopo essere uscito dalle Br, come se ne può uscire senza essersi
pentito, ma da dissociato critico, capovolto rispetto a come era entrato nella
clandestinità, nella lotta armata, a fianco dei killer, di quelli che sparavano,
uccidevano e gambizzavano per fare la rivoluzione. Troppo tempo è passato e
Fenzi in quel salone dove il ricordo difficile da ricostruire della colonna
genovese delle Br, quella sgominata nel 1980, in quell’appartamento di via
Fracchia, sulle alture di Oregina, dove sempre gli uomini del generale dalla
Chiesa, con le chiavi della casa consegnate dal pentito numero uno, Patrizio
Peci, entrarono sparando con i fucili a pompa attraverso i muri e
“seccando” Riccardo Dura, il capo colonna di 29 anni e Anna Maria Ludmann,
l’ineccepibile professorina di 32, e Lorenzo Betassa di 25 anni e Roberto
Panciroli di 28, “gli imprendibili”, di cui mai si era conosciuto il nome e il
volto, malgrado sparassero e uccidessero da anni, appunto Enrico Fenzi in quel
salone sembra una icona del passato, crocefisso alla sua colpa, ma anche a una
memoria che non si può cancellare, seppure collocata in un altro mondo. Passato
e sepolto. Ci ha provato l’autore del libro a spiegare il suo grande sforzo di
ricostruire quegli anni e quei protagonisti, quella storia attraverso gli atti
processuali e le testimonianze e gli intrighi delle inchieste spericolate e
delle sentenze conclusive. E gli hanno detto che il suo non è un libro di
storia, ma il documento preciso, perfino minuzioso, di una vicenda raccontata da
un cronista che tenta una cronaca trenta anni dopo i fatti. Fenzi non ci sta del
tutto a quella ricostruzione, a quei commenti, che approva, ma che vuole in
parte rettificare, perchè la storia va messa a posto e lui sta zitto da quasi
tutta la vita. Era un quarantenne allora, nel 1979, quando i carabinieri gli
puntarono i fari addosso e uno dei primi rapporti di polizia lo descrive così
come Andrea Casazza riporta nel suo libro: “Fenzi Enrico, 40 anni, è alto un
metro e settanta, è di media corporatura, è praticamente calvo nella parte
anteriore del cranio, ha i capelli grigi, lunghi, un po’ arricciati, sul collo e
arruffati sopra le orecchie e non ha inflessioni dialettali, parla in perfetto
italiano con scioltezza e proprietà, veste in maniera sportiva (jeans e
pantaloni di velluto, mocassini tubolari, magliette tipo Lacoste) è professore
di italiano all’Università di Genova, è nativo di Bardolino( Verona), è separato
dalla moglie Chelli Maria Grazia, è stato più volte perquisito.” Non ci sta del
tutto Fenzi, perchè la storia delle Br di cui tutti hanno scritto e tutti hanno
parlato e straraccontato “non si può fare solo attraverso la cronaca
giudiziaria, la storia di quello che sono state le Br nessuno l’ha mai scritta.”
Ecco nella sala un po’
attonita del palazzo Ducale, nel giorno in cui i “forconi” bloccano la città,
con una rivoluzione così diversa da quella di quaranta anni prima imposta dalle
Br, un nucleo armato fatto di poche decine di persone (così si racconta negli
“Imprendibili), ecco che il prof torna in cattedra, con tono sommesso,
sofferente: “Un sassolino dalle scarpe proprio vorrei levarmelo, perché sono
diventato io, Fenzi, l’ombrello sotto il quale si sono protetti tutti, tra
catture e processi. Va bene, mi sono dissociato, ma non ho aggiunto nulla a
quello che gli altri raccontavano sulle Br, cento, duecento volte. Ero il più
vecchio, ero un professore e mi hanno usato così…. ma la storia non è solo
quella che è stata ricostruita a questo modo….”
E allora quale sarà questa
storia da risistemare? Fenzi elenca anche un po’ polemico e quasi sfuggente
quello che la cronaca giudiziaria non può sistemare, non può storicizzare: “ Mi
hanno minacciato in cella che non avrei visto il giorno dopo se non ignoravo
quel particolare a cui loro tenevano……hanno nascosto una pistola in casa mia per
accusarmi nel processo del blitz…….ci sono verità che sono rimaste sepolte,
mentre veniva distrutta la colonna veneta delle Br e si liberava il generale
americano Doziere i brigatisti catturati venivano torturati con un sistema anche
legalizzato e tutti si pentivano e parlavano e la colonna genovese veniva
scoperchiata dalle rivelazioni di Bozzo e Cristiani…..che avevo di più da dire
io, da aggiungere…..”
Sono veramente pezzi di storia
questi sassolini che Fenzi si leva dalle sue scarpe di oggi, di uno che oramai
da decenni è “fuori” e ha tentato invano una risalita? “Avete raccontato di
quello yactht che era partito da Tripoli del Libano e aveva portato
sull’Adriatico quattro tonnellate di armi non solo per la colonna genovese, ma
per tutte le colonne italiane: quella barca era dello Olp di Arafat.”
Fenzi mescola la storia con la
“sua” storia. “Ho testimoniato, ho aiutato Giuliano Naria [il brigatista
accusato erroneamente di avere ucciso Francesco Coco, il Pg di Genova l’8 giugno
del 1976], ho aiutato Sergio Adamoli,[il figlio del famoso sindaco comunista
della Genova anni Cinquanta]. Che avevo da aggiungere? Per come mi sono
comportato ho dovuto scontare più anni di carcere di quelli che mi spettavano.”
La penultima parola del prof
delle Br è per Francesco Berardi, il “postino” che faceva propaganda dentro
all’Italsider, distribuendo volantini Br e che, una volta “beccato”, aveva fatto
il suo nome agli inquirenti e che finì suicida, impiccato in cella nel
supercarcere di Cuneo. Fenzi ci tiene forse a dimostrare in pubblico che non ha
mai avuto nulla contro quella figura piccola e tragica del postino, anche se fu
Berardi a tirargli dietro i segugi di Dalla Chiesa, dopo l’omicidio di Guido
Rossa, giustiziato per avere deposto in udienza contro lo sciagurato postino.
“Lui si è veramente giocato la vita e non possso dimenticarlo.”.
L’ultima parola di Fenzi è,
invece, una citazione letteraria e come non poteva essre diversamente per un
professore dalla carriera troncata che ogni volta che tenta di riemergere,
magari in un convegno sul Petrarca, di cui continua ad essere uno studioso fine
e raffinato, viene subito censurato da chi non dimentica? La citazione è per
“Pentescoste”, la poesia di Alessandro Manzoni, che invoca la luce che cada sui
“vari color”.
Per quest’uomo, oramai
anziano, spezzato ma resistente al tempo, al logorio dei processi, delle accuse,
al peso di una storia cancellata dalla memoria, ma ancora in grado di fare male,
ogni volta che riemerge con la sua caterva di lutti e di sofferenze, quella
sulla luce è una invocazione che il pubblico, arrivato a seguire la
presentazione del libro, accoglie con una specie di timido applauso. In quella
sala ci sono molti reduci di un tempo macerato dai ricordi, con i famigliari
delle vittime, silenziosi, con i compagni di strada nelle frange di Autonomia
Operaia, di Lotta Continua, dei gruppi border line, tra l’estremismo verbale dei
partiti extra e il partito veramente armato, con i cronisti dell’epoca, con un
pubblico genovese, quasi sperduto in quella memoria. E così, dopo lo sfogo del
professore, chi arriva a spingere le spine nelle ferite di questa lunga memoria
mezza perduta, mezza irrisolta?
Arriva il figlio di un alto
magistrato dell’epoca, Beniamino De Vita, che fu indirettamente vittima di quel
terrorismo, quando, da presidente della Corte d’Assise d’Appello, durante il
sequestro del magistrato Mario Sossi, emise un provvedimento che consentiva di
liberare i cosidetti “nonni delle stesse Br,” gli esponenti della banda XII
Ottobre, condizione richiesta per non giustiziare lo stesso Sossi. “Sono il
figlio di un magistrato che è stato lasciato solo dallo Stato davanti al ricatto
dei terroristi” – racconta, questo figlio, che esce da un’ombra molto più
assoluta di quella da cui è risbucato Fenzi. Anche questa è una testimonianza
che arriva non solo fuori tempo massimo, ma come da un altro mondo, oggi quasi
extraterrestre, perchè rievoca uno scontro, quello tra il terrorismo e i giudici
che è seminato di croci in un cimitero dimenticato. Altro che i match
berlusconiani con i giudici! Fuori dal Palazzo Ducale, dove queste memorie
muovono antichi brividi, ci sono i rimbombi della nuova rivoluzione, quella dei
Forconi. Che hanno bloccato la città, paralizzato il suo traffico, fatto tremare
i palazzi con le bombe carte.
"A Genova in via Fracchia
fu un'esecuzione", rivelazioni sulla strage Br legata al Caso Moro.
«A Riccardo Dura spararono un unico colpo alla nuca. Non andò come dissero i
carabinieri». Così rivela all'Espresso Luigi Grasso, autore della denuncia che
ha riaperto l'inchiesta sull'irruzione del 1980 nel covo genovese delle Br. Un
blitz che interessa anche alla Commissione Moro: nell'appartamento sarebbero
stati nascosti documenti del presidente Dc. Ma nei rapporti successivi
all'operazione non ve ne è traccia, scrive Federico Marconi il 29 agosto 2017 su
"L'Espresso". Un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Genova
riapre le indagini sull'irruzione dei carabinieri nel covo delle Brigate rosse
di via Fracchia, trentasette anni dopo il blitz in cui persero la vita quattro
esponenti della colonna genovese delle Brigate rosse. Sul covo genovese delle Br
si stanno concentrando anche le indagini della Commissione parlamentare di
inchiesta sul rapimento e l'uccisione di Aldo Moro: nell'archivio brigatista
sarebbero stati tenuti documenti relativi alla prigionia dello statista ucciso
il 9 maggio 1978.
IL BLITZ. Il 28 marzo 1980,
poco dopo le quattro del mattino, i carabinieri del nucleo speciale
antiterrorismo del generale Dalla Chiesa entrarono nell’appartamento al primo
piano di un palazzo nel quartiere Oregina di Genova. «I carabinieri, fatti segno
a colpi di arma da fuoco, hanno reagito prontamente, sostenendo un violento
conflitto nel corso del quale i quattro occupanti dell’appartamento, tre uomini
e una donna, sono rimasti uccisi, mentre un sottufficiale dell’Arma è rimasto
ferito» riporta il comunicato del comando generale che venne diffuso al termine
dell’operazione. I quattro brigatisti uccisi erano Annamaria Ludmann,
proprietaria dell’appartamento, Lorenza Betassa, Pietro Panciarelli e Riccardo
Dura, l’assassino del sindacalista Guido Rossa. Come scritto nel comunicato
dell'Arma, i brigatisti avrebbero aperto il fuoco dopo l'irruzione, ferendo il
maresciallo Benà ad un occhio. Solo allora i carabinieri avrebbero sparato,
uccidendo i quattro. Ma per Luigi Giuseppe Grasso quella notte le cose non
andarono così. Per questo lo scorso 11 agosto ha presentato un esposto in
procura, con cui denuncia «l’omicidio volontario, non so se anche premeditato,
di Riccardo Dura». L’Espresso ha contattato Grasso, classe 1947, sfortunato
protagonista di un errore giudiziario negli anni ‘80. Venne arrestato dal nucleo
antiterrorismo il 17 maggio 1979 con l’accusa di essere una delle menti delle Br
genovesi: nel 1984 fu condannato a tre anni di carcere per “partecipazione a
banda armata” . Dopo un lungo iter giudiziario, Grasso è stato risarcito dallo
Stato italiano per la sua ingiusta reclusione. E fu proprio nel corso di questa
vicenda che, nel gennaio 2000, riuscì a mettere le mani sul fascicolo riservato
di via Fracchia. «L’azione di via Fracchia era una perquisizione disposta dal
magistrato Di Noto al fine di “acquisire nuovi o ulteriori elementi” a carico
mio e degli altri presunti brigatisti arrestati nel maggio del ‘79» afferma
Grasso all’Espresso «si doveva perquisire un appartamento sospetto, dato il
processo che si sarebbe aperto una quindicina di giorni dopo». E proprio per ciò
che è scritto nel mandato di perquisizione che Grasso riesce a ottenere il
fascicolo su via Fracchia: «Ancora ricordo il commento del responsabile
dell’archivio del Tribunale. “C’è stata un’esecuzione”, mi disse non appena
leggemmo i documenti».
L'ESPOSTO. L’esecuzione fu
quella di Riccardo Dura. «Come riporta l’autopsia, è stato ucciso da un unico
colpo di rivoltella alla nuca, a una distanza tra trenta centimetri e un metro,
dall’alto verso il basso. Non aveva nessun graffio, contusione, né proiettile di
fucile nel corpo» prosegue Grasso. Sul corpo del brigatista non ci sono colpi di
mitragliamento «come invece ci sono sugli altri tre, la cui agonia deve essere
stata straziante. Non escludo che, per quanto terribile sia solo immaginarlo,
gli spari che li hanno raggiunti in testa siano stati dei “colpi di grazia”».
Nelle quattro pagine dell’esposto, che l'Espresso ha potuto leggere, vengono
indicati altri elementi che contrastano con la versione ufficiale del blitz del
28 marzo. Come il ferimento del Maresciallo Benà. «Il foglio di ricovero del
carabiniere indica le sei del mattino, un’ora e mezza dopo l’inizio del blitz.
Alle cinque e mezza viene avvertito il chirurgo oculistico dell’Ospedale San
Martino, dove viene portato da un’auto dei carabinieri» si legge nella denuncia
«Il ferimento del carabiniere avvenne evidentemente più tardi e in altro modo.
Lo sparo, secondo i rapporti, sarebbe partito dalla pistola del brigatista
Lorenzo Betassa, frontalmente. Ma il foro d’entrata non corrisponde: il
proiettile entra da dietro. È stato fuoco amico, forse nel trambusto seguito al
terribile evento». «I carabinieri hanno detto di aver sfondato la porta
dell’appartamento. Alcuni giornalisti hanno scritto invece che i carabinieri
avevano avuto le chiavi da Patrizio Peci e Rocco Micaletto (due capi delle Br
che hanno collaborato con la giustizia, ndr). Per me le cose non sono andate in
nessuno dei due modi» afferma Grasso all’Espresso «non è credibile che i
brigatisti dormissero senza una sentinella in un appartamento “caldo”, né che
non avessero la porta serrata. Magari quella notte la porta è stata aperta a
qualcuno di conosciuto, di cui ci si poteva fidare». A sostegno di questa
ipotesi, nell’esposto sono riportati alcuni eventi: «Le sorelle di A. R., un mio
conoscente, che vivevano nel quartiere Oregina, avrebbero udito delle grida
“Traditore, traditore” di una voce di donna». E ancora: «Il 1 gennaio del 2000
andai al bar Guarino di Castelletto con delle persone. Mentre conversavano,
indicarono una persona, e dissero “lui è l’unico che si è salvato in via
Fracchia”. A tal proposito, la moglie di Guido Rossa ha raccontato di un uomo
portato via dall’appartamento, coperto da un giaccone».
LE INDAGINI DELLA COMMISSIONE
MORO. Sull’operazione di via Fracchia sta indagando anche la Commissione
parlamentare d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Le morti dei
quattro Br, infatti, potrebbero essere collegate al rapimento e all'uccisione
dello statista. Nell’archivio che i brigatisti tenevano nell’appartamento
sarebbero stati trovati manoscritti e registrazioni del presidente della Dc
durante i 55 giorni di prigionia. Lo scorso 26 aprile è stato ascoltato il
colonnello Michele Riccio, a capo del blitz del 28 marzo 1980, che ha
dichiarato: «Siamo arrivati all’appartamento su indicazione di Patrizio Peci e
di un altro brigatista arrestato. Abbiamo fatto degli scavi nel giardino da cui
è uscito fuori parte dell’archivio brigatista». Ma nei documenti delle indagini,
il giardino non è mai indicato. Il 19 giugno è stato sentito anche il giudice
Luigi Carli, che si è occupato del fascicolo di via Fracchia: «Durante riunioni
con i giudici torinesi, ho sentito parlare del ritrovamento delle carte di
Moro». Neanche di queste c’è traccia nei rapporti. «Le audizioni che abbiamo
svolto in Commissione hanno fatto chiarezza sul ritrovamento di buste di
documenti nell'appartamento di via Fracchia che non risultavano negli atti
successivi alla perquisizione» dichiara all'Espresso Giuseppe Fioroni,
presidente della Commissione Moro «non si può ancora avere la certezza assoluta
che queste carte riguardassero Moro, nonostante il giudice Carli abbia riferito
che ne sentì chiaramente parlare nel corso di una riunione con i colleghi di
Torino». La commissione si sta occupando anche del possibile coinvolgimento
della colonna genovese delle Br nel sequestro Moro: «Ci sono alcuni elementi
emersi che fanno riferimento a forti collegamenti tra Mario Moretti (capo della
colonna brigatista che rapì e uccise il presidente Dc, ndr) ed esponenti di
Genova. Ma al momento non mi è possibile dire più di questo» aggiunge Fioroni.
«Non mi interessa sapere cosa è stato trovato nell’appartamento» conclude Grasso
«la mia denuncia si riferisce solo alle anomalie nell’uccisione di Dura e nel
ferimento del maresciallo Benà. Al colonnello Riccio, che aveva guidato le
operazioni, andrebbe chiesto cosa è veramente successo. Lui conosce gli uomini
che erano con lui quella notte e chi e perché ha sparato. Fu attacco di nervi?
Una disobbedienza? Un ordine?».
Se un ricercatore vuole
riscrivere la storia d'Italia.
Il terrorismo come un "cold case", scrive Paolo Guzzanti, Lunedì 28/08/2017, su
"Il Giornale". Si riapre il lungo e ancora inedito dossier sui cosiddetti «anni
di piombo», vale a dire lo scontro angoscioso e sanguinoso fra Stato e
terroristi comunisti che si erano dati il nome di «brigatisti rossi» con la
riapertura dell'indagine su quel che avvenne nel «covo» di via Fracchia a Genova
dove quattro membri delle Brigate rosse (fra cui una donna, Annamaria Ludman
proprietaria dell'appartamento) furono uccisi dai corpi speciali del generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'inchiesta è stata riaperta dal procuratore di
Genova Francesco Cozzi su denuncia di Luca Grasso, un ricercatore universitario
che ha ottenuto e studiato il rapporto dell'allora capitano Michele Riccio che
guidò l'assalto nella notte del 28 marzo 1980. Grasso sostiene che almeno uno
dei brigatisti uccisi, Riccardo Dura, non morì durante lo scontro a fuoco ma fu
giustiziato inerme con un colpo alla nuca. Bisogna avere non meno di
cinquantacinque anni avere memoria di quel sanguinosissimo scontro voluto dal
generale Calo Alberto dalla Chiesa, poi barbaramente trucidato a Palermo con sua
moglie Emanuela Setti Carraro, quando era prefetto del capoluogo siciliano dove
custodiva documenti mai più rintracciati sui legami fra Brigate rosse e servizi
dello Stato, nella sua cassaforte. Quello di via Fracchia fu l'episodio che mise
fine alle attività delle Brigate rosse le quali di fatto si arresero poco dopo
in seguito al fallito rapimento del generale americano James Lee Dozier,
liberato dopo quarantacinque giorni di prigionia nel gennaio del 1982. A portare
i carabinieri nel covo di via Fracchia fu il primo grande pentito della banda
armata delle Brigate rosse, Patrizio Peci, il cui fratello Roberto fu fucilato
da un vero plotone d'esecuzione brigatista, esecuzione che fu filmata e diffusa
in tempi in cui ancora non esisteva internet. Il caso del pentimento di Patrizio
e dell'assassinio per rappresaglia di Roberto Peci, costituì uno degli atti
finali di una guerriglia cominciata all'inizio degli anni Settanta con il
rapimento del giudice Mario Sossi e che insanguinò l'Italia per oltre un
decennio, con un'ecatombe di servitori dello Stato e giornalisti, assassinati a
freddo per il valore simbolico delle loro morti. La più famosa delle vittime fu
Aldo Moro, il segretario della Democrazia cristiana che avrebbe dovuto di lì a
poco essere eletto presidente della Repubblica, rapito e trucidato nel
bagagliaio di una Renault nel maggio del 1978 dopo quaranta giorni di
interrogatori mai rivelati. L'irruzione dei corpi speciali in via Fracchia, in
cui rimase ferito il maresciallo Rinaldo Benà, si concluse con un bilancio mai
visto prima nella lunga lotta fra Stato e brigatisti rossi: i quattro terroristi
furono uccisi nell'appartamento in cui avevano il loro covo e domicilio: fu una
strage che tutta l'opinione pubblica considerò un avvertimento ai brigatisti
ancora attivi per far sapere che lo Stato aveva deciso di colpire senza fare più
prigionieri. Il ricercatore universitario Luca Grasso ha lavorato per molto
tempo sul rapporto ancora segreto sui fatti di via Fracchia e si è rivolto alla
magistratura chiedendo di indagare sulle vere circostanze dell'uccisione di
Riccardo Dura che, secondo quanto risulta dai documenti esaminati sarebbe stato
giustiziato con un colpo alla nuca e dunque deliberatamente assassinato. Il
procuratore di Genova Francesco Cozzi ha dichiarato «un atto dovuto» la
riapertura dell'inchiesta.
Genova, 37 anni dopo
procura apre inchiesta per omicidio sulla morte di Riccardo Dura.
Nel blitz nel covo delle Br in via Fracchia fu ucciso con un solo colpo alla
nuca. L'esposto di un assistente universitario all'epoca arrestato e poi
prosciolto e risarcito. Il procuratore: "Un atto dovuto l'apertura del
fascicolo", scrive il 27 agosto 2017, "La Repubblica". A 37 anni di distanza dal
blitz genovese nel covo Br di via Fracchia in cui vennero uccisi dai carabinieri
quattro brigatisti rossi la procura della repubblica di Genova, in seguito alla
presentazione di un esposto denuncia di un cittadino, ha aperto un fascicolo per
omicidio "in danno di Riccardo Dura", uno dei terroristi uccisi. "Un atto
dovuto", come spiega all'Ansa il procuratore di Genova Francesco Cozzi nel
confermare l'apertura del fascicolo. Che aggiunge: "Adesso valuteremo modi e
tempi di eventuali accertamenti". A presentare l'esposto nei giorni scorsi, come
scrive il Secolo XIX che stamane ha anticipato la notizia, è stato Luigi Grasso,
ricercatore universitario che nel 1979 venne accusato di terrorismo e negli anni
successivi completamente prosciolto. "Quello di Dura è stato un omicidio
volontario, venne ucciso con un solo colpo alla nuca" si legge nell'esposto
presentato da Grasso. L'eventuale inchiesta sarà affidata dai magistrati ai
poliziotti dell'antiterrorismo. Grasso alla decisione di presentare l'esposto è
arrivato dopo una ricerca personale negli archivi giudiziari che gli ha permesso
di ottenere il fascicolo di via Fracchia: in cui c'è la ricostruzione dei fatti
spiegata da Michele Riccio, l'allora capitano che guidò l'assalto, uomo di
fiducia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa al quale era stato affidato il
compito di condurre la battaglia contro le Br. Dalla lettura di quei fatti
Grasso è arrivato alla conclusione che l'uccisione del brigatista Riccardo Dura
è un omicidio volontario. Grasso aveva già manifestato i suoi dubbi su via
Fracchia 19 anni fa durante la presentazione di un libro di Enrico Fenzi,
docente universitario arrestato e condannato per episodi legati alla stagione
brigatista. ''La vera luce sulla colonna genovese delle Brigate rosse non è
stata ancora fatta - disse Grasso prendendo la parola - Il blitz del 17 maggio
del '79 in cui vennero arrestati Enrico Fenzi e altre 16 persone è stato frutto
di una finta inchiesta messa in atto per favorire il permanere a Genova della
colonna brigatista, poi sgominata nell' 80 in via Fracchia dagli uomini del
generale Dalla Chiesa''. Grasso enunciò la sua tesi nel corso del dibattito sul
libro ''Armi e bagagli'' di Enrico Fenzi, svoltosi a Genova nel convento di
Santa Maria di Castello. Grasso venne arrestato insieme al professore genovese,
poi prosciolto e risarcito dallo Stato per riparare all' errore giudiziario
(venne arrestato anche per il delitto Coco) nei suoi confronti. ''La vera realtà
- sostenne Grasso - è che Enrico, io e gli altri siamo stati arrestati non come
brigatisti, ma per depistare le indagini. Contesto perciò quanto scritto da
Fenzi nel suo libro, che considero un buon romanzo, ma senza validità storica''.
A queste parole Fenzi, fino a quel momento tra il pubblico, puntualizzò: ''A
Grasso dico solo che non è mai appartenuto alle Bierre, che è stato perciò
condannato ingiustamente. Nel libro ho raccontato le cose che ho vissuto io''.
Irruzione di via Fracchia.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. La cosiddetta irruzione di via Fracchia,
o strage di via Fracchia, fu un sanguinoso episodio degli anni di piombo
avvenuto a Genova in un appartamento in via Umberto Fracchia 12 nella notte del
28 marzo 1980. Grazie alle informazioni fornite dal militante delle Brigate
Rosse Patrizio Peci, arrestato nel febbraio 1980 a Torino, i carabinieri del
generale Carlo Alberto dalla Chiesa poterono individuare l'importante base
dell'organizzazione terroristica e organizzare di notte un'irruzione all'interno
dell'appartamento. L'azione si concluse con un violento conflitto a fuoco che
provocò la morte dei quattro brigatisti presenti, tre militanti clandestini
delle colonne genovese e torinese e la giovane proprietaria dell'appartamento,
oltre al ferimento del maresciallo dei carabinieri Rinaldo Benà. Le modalità
dell'irruzione e l'esatta dinamica dei fatti rimasero non del tutto chiari e
suscitarono polemiche, facendo sorgere dubbi sull'operato dei carabinieri e
sull'effettiva necessità di uccidere tutti i brigatisti sorpresi
nell'appartamento. L'irruzione di via Fracchia ebbe conseguenze decisive a
Genova e provocò il rapido collasso della pericolosa organizzazione brigatista
presente nella città che, a partire dal 1976, si era resa protagonista di una
lunga e cruenta serie di attentati contro magistrati, politici, dirigenti
industriali e forze dell'ordine.
Le Brigate Rosse, dopo aver
esteso la loro attività inizialmente a Milano e Torino, avevano sequestrato
a Genovanella primavera del 1974 il magistrato Mario Sossi; una vera colonna
brigatista tuttavia non venne costituita fino al 1976 dopo l'intervento nella
città di due importanti e capaci militanti dell'organizzazione, Mario
Moretti e Rocco Micaletto. Fu a Genova che i brigatisti organizzarono e
portarono a termine per la prima volta un attentato mortale uccidendo l'8 giugno
1976 il giudice Francesco Coco e i due uomini della sua scorta[3]. La nuova
colonna genovese delle Brigate Rosse si caratterizzò subito per la dura
efficienza clandestina, per la rigida compartimentazione e per il suo costante
tentativo di sviluppare la propaganda e il proselitismo all'interno delle grandi
fabbriche della città, cercando di ottenere l'adesione alla lotta armata delle
frange estremistiche operaie ed entrando in aspro conflitto con la potente
struttura organizzativa del PCI. I principali dirigenti della colonna
organizzarono a Genova una struttura particolarmente rigida, con una dura
disciplina tra i militanti e con una buona capacità militare, che fu in grado di
potenziare progressivamente la sua attività terroristica senza cedimenti e senza
che le forze dell'ordine riuscissero a individuare e arrestare i componenti né
fermarne l'azione. I militanti clandestini più importanti erano persone
completamente sconosciute agli inquirenti, come Riccardo Dura "Roberto"
personalità estremamente radicale dalla violenta carica ideologica, mentre
alcuni dei componenti principali della colonna, Rocco Micaletto "Lucio" e Luca
Nicolotti "Valentino", erano dirigenti particolarmente determinati trasferitisi
temporaneamente da Torino. Mentre dal punto di vista dell'efficienza militare la
colonna genovese per quattro anni a partire dal 1976 dispiegò una continua e
crescente attività terroristica con un impressionante numero di ferimenti e
omicidi, dal punto di vista politico i brigatisti non riuscirono a scardinare la
predominante influenza del PCI sulla forte base operaia delle grandi fabbriche e
del porto. La esasperata conflittualità dei brigatisti contro il PCI giunse al
punto di provocare attacchi dell'organizzazione contro dirigenti dell'industria
di stato legati al partito e soprattutto fu una delle cause principali
dell'attentato contro il sindacalista comunista Guido Rossa che, accusato di
delazione all'interno dell'Italsider, venne ucciso nel gennaio 1979 in via
Fracchia, nei pressi della sua abitazione in via Ischia, da un nucleo armato
guidato da Riccardo Dura.
Nonostante il sostanziale
rifiuto da parte della base operaia delle istanze estremistiche delle Brigate
Rosse e il conseguente loro crescente isolamento, i brigatisti della colonna
genovese continuarono nell'inverno 1979-1980 a moltiplicare gli attacchi sempre
più cruenti che colpirono le cosiddette "strutture dell'apparato repressivo
dello stato" e in particolare i carabinieri; a dicembre 1979 e gennaio 1980
quattro militari dell'Arma vennero uccisi in due sanguinosi agguati,
a Sampierdarena e in via Riboli, da gruppi di fuoco dell'organizzazione. Mentre
le altre colonne brigatiste, soprattutto a Torino e Milano, erano sottoposte
alla sempre più efficace pressione delle forze dell'ordine che aveva provocato
la cattura di numerosi militanti e la scoperta di basi dell'organizzazione, le
Brigate Rosse genovesi mantenevano la loro capacità di attacco e non davano
segni di cedimento militare; nessun importante membro della colonna era stato
catturato e i brigatisti disponevano di basi sicure all'interno della città. La
situazione dei brigatisti, in particolare a Torino, era divenuta così critica, a
causa dell'azione di contrasto delle forze di polizia, che due militanti della
colonna torinese, Lorenzo Betassa "Antonio" e Piero Panciarelli "Pasquale",
avevano abbandonato la città e si erano trasferiti a Genova, ritenuto centro
ancora relativamente sicuro. Fu quindi proprio a Genova che le Brigate Rosse
organizzarono, nel dicembre 1979, un'importante riunione della "Direzione
Strategica" con la partecipazione di militanti di tutte le colonne attive
in Italia. L'incontro si svolse in un ampio appartamento al piano terra di un
edificio in via Umberto Fracchia 12 nel quartiere Oregina, di proprietà
di Annamaria Ludmann "Cecilia", trentaduenne militante regolare non clandestina
dell'organizzazione, che contemporaneamente alla sua attività nella lotta armata
aveva mantenuto la sua vita apparentemente normale di impiegata presso una
scuola svizzera, il centro culturale Galliera. In precedenza nel suo
appartamento in via Fracchia, ritenuto assolutamente sicuro, la Ludmann aveva
ospitato numerosi militanti clandestini della colonna tra cui Micaletto e
Nicolotti. Alla riunione della "Direzione Strategica" in via Fracchia 12
nell'appartamento della Ludmann parteciparono tutti i clandestini più importanti
dell'organizzazione: per la colonna milanese Mario Moretti e Barbara
Balzerani "Sara", per il Veneto Vincenzo Guagliardo "Pippo" e Nadia
Ponti "Marta", per la colonna genovese Dura, Nicolotti e Francesco Lo
Bianco "Giuseppe", per la colonna romana Bruno Seghetti "Claudio", Maurizio
Iannelli e Antonio Savasta "Diego". Da Torino arrivarono in via Fracchia, oltre
a Lorenzo Betassa, i due dirigenti più esperti rimasti della colonna, Rocco
Micaletto e Patrizio Peci "Mauro".
Genova 28 marzo 1980.
Antefatti. Patrizio Peci, "Mauro", il brigatista della colonna di Torino che
decise di collaborare con i carabinieri, fornendo precise indicazioni su basi e
militanti delle Brigate Rosse. Il 19 febbraio 1980 a Torino, in Piazza Vittorio,
i carabinieri del generale Carlo Alberto dalla Chiesa arrestarono prima Patrizio
Peci e quindi Rocco Micaletto; anche se Peci nelle sue memorie ritiene che la
cattura avvenne per un caso fortuito, in realtà i carabinieri da alcuni mesi
avevano individuato e controllato i due importanti dirigenti della colonna
torinese. Dopo alcune settimane di detenzione, Patrizio Peci prese la
sorprendente e inattesa decisione di collaborare con i carabinieri; il
brigatista ebbe anche un colloquio con il generale dalla Chiesa, quindi
incominciò a fornire al colonnello Nicolò Bozzo, uno dei principali
collaboratori del generale, informazioni dettagliate sulla struttura
dell'organizzazione, le sue basi, i suoi militanti e i responsabili degli
attentati di cui era a conoscenza. Egli era soprattutto informato sulle vicende
delle Brigate Rosse a Torino ma, avendo partecipato alla "Direzione Strategica"
del dicembre 1979 a Genova, ricordava anche sommariamente il luogo dove si era
svolta quella riunione. Peci avrebbe riferito al colonnello Bozzo che, dopo
essere giunto alla stazione di Genova, era stato accompagnato su un autobus da
due brigatisti fino a un appartamento al piano terreno lungo una strada in
salita il cui nome, via Fracchia, egli ricordava in quanto lo collegava con un
personaggio dell'attore Paolo Villaggio. Peci ricordava inoltre che
l'appartamento era gestito da una donna. Altre fonti hanno supposto che Peci
accompagnò direttamente i carabinieri in un sopralluogo dello stabile e confermò
la presenza di una base delle Brigate Rosse. Secondo il colonnello Bozzo invece
le informazioni di Peci furono confermate anche da precedenti indizi raccolti
sulla possibile presenza di un "covo" brigatista, in base alle testimonianze
fornite dopo l'assassinio di Guido Rossa avvenuto l'anno prima nella stessa via.
Dopo l'individuazione dell'appartamento, la base brigatista venne sorvegliata
per alcuni giorni dagli uomini delle forze dell'ordine; in origine l'irruzione
all'interno avrebbe dovuto essere affidata agli agenti dell'UCIGOS e l'azione
venne pianificata per la notte del 27 marzo, ma infine il generale dalla Chiesa
intervenne e ottenne che l'operazione fosse affidata ai carabinieri che erano
stati sanguinosamente colpiti dai brigatisti nei mesi precedenti. L'irruzione in
via Fracchia sarebbe stata effettuata la notte del 28 marzo in connessione e
contemporaneamente con una operazione globale antiterrorismo in tutta l'Italia
settentrionale condotta dai carabinieri sulla base delle importanti e precise
informazioni fornite da Peci, la cui delazione, iniziatasi da alcuni giorni, era
stata mantenuta strettamente segreta. La sera di giovedì 27 marzo Annamaria
Ludmann venne osservata rincasare intorno alle ore 19:00, e subito dopo
arrivarono altri due giovani sconosciuti; Peci aveva descritto le
caratteristiche generali dell'appartamento e aveva evidenziato come fosse
adibito anche a deposito di armi ed esplosivi e vi fossero disponibili
attrezzature per la fabbricazione di targhe contraffatte. Egli non era a
conoscenza di chi fossero gli occupanti abituali della base oltre alla giovane
proprietaria, ma i carabinieri ritennero che l'appartamento ospitasse parecchi
militanti particolarmente pericolosi dell'organizzazione. Il generale dalla
Chiesa riferirà nel maggio 1980 che non si pensava di trovare la Ludmann
all'interno dell'abitazione, mentre si ipotizzava che fossero presenti due
latitanti e due "regolari". In effetti sembrerebbe evidente che i carabinieri
ignoravano chi fossero i brigatisti presenti nella base e che l'irruzione venne
effettuata in fretta senza una preliminare e accurata preparazione come era
previsto dalle tecniche investigative del nucleo antiterrorismo del generale.
Secondo Michele Riccio, che fu l'ufficiale dei carabinieri che diresse
l'irruzione, l'azione venne affrettata soprattutto per coordinarla con le
previste operazioni contro le Brigate Rosse in Piemonte che erano in corso di
svolgimento; egli inoltre avrebbe preferito attendere il primo mattino per
arrestare prima la Ludmann all'uscita dall'appartamento; sarebbe stato il
generale dalla Chiesa in persona a ordinare l'assalto in piena notte.
L'irruzione secondo la
relazione dei carabinieri. L'edificio n. 12 di via Umberto Fracchia comprendeva
diciassette appartamenti in totale; l'interno 1, la base delle Brigate Rosse di
proprietà di Annamaria Ludmann, si trovava nel seminterrato a cui si accedeva,
dopo aver raggiunto, salendo sette scalini, l'androne di ingresso, discendo una
rampa di dodici scalini. Nella stanza del seminterrato si trovavano due porte,
una che dava accesso a cinque cantine e una, quella di sinistra, che era la
porta d'ingresso dell'appartamento; sul campanello c'era la scritta "Corrado
Ludmann", il padre deceduto di Annamaria. L'appartamento, ampio circa 120 metri
quadrati, era composto da un ingresso, un lungo e stretto corridoio e sei stanze
che si aprivano sul corridoio: la cucina, la sala da pranzo, il bagno, una
camera da letto, un ripostiglio e sulla sinistra in fondo al corridoio, un
salone; il locale disponeva anche di un giardino, a cui si accedeva dalla cucina
e dalla sala da pranzo, che conduceva alla parte posteriore dell'edificio.
L'appartamento, situato sotto il livello del suolo e senza vie d'uscita
alternative, era ubicato in uno spazio ristretto e non si prestava facilmente a
un'irruzione di sorpresa; il rischio di un conflitto a fuoco era elevato in caso
di resistenza dei brigatisti. Il colonnello Bozzo affidò la direzione
dell'operazione al capitano Michele Riccio il quale ebbe a disposizione il
personale del nucleo operativo della Legione carabinieri di Genova; gli uomini
incaricati dell'irruzione circondarono preliminarmente in forze tutta la zona
equipaggiati con giubbotti antiproiettile, pistole mitragliatrici Beretta M12 e
caschi protettivi; vennero messe a disposizione anche armi pesanti tra cui un
fucile a pompa Benelli in grado di frantumare le pareti divisorie
dell'appartamento; essendo possibile una resistenza con le armi dei brigatisti e
quindi uno scontro a fuoco venne anche predisposta la presenza di due ambulanze.
All'operazione prese parte anche personale dei carabinieri in borghese del
nucleo antiterrorismo. Nel cuore della notte del 28 marzo 1980, sotto una
pioggia torrenziale con tuoni e lampi, alcuni abitanti dello stabile videro
delle ombre muoversi intorno all'edificio; l'irruzione, secondo la relazione
ufficiale ebbe luogo alle ore 04:30 nel buio e con una densa foschia. La notte
del 28 marzo 1980 in via Fracchia 12, interno 1 si trovavano, oltre ad Annamaria
Ludmann, i due brigatisti clandestini provenienti da Torino, Lorenzo Betassa e
Piero Panciarelli, e Riccardo Dura che era il principale dirigente della colonna
genovese e da alcuni mesi era anche uno dei componenti del Comitato Esecutivo
dell'organizzazione, insieme con Mario Moretti e Bruno Seghetti. Dura
generalmente abitava in via Zella 11 a Rivarolo nell'insospettabile appartamento
abitato da Caterina Picasso, una simpatizzante delle Brigate Rosse di 73 anni.
Successivamente ai fatti si ipotizzò che i tre clandestini si fossero riuniti
quella notte in via Fracchia per preparare un imminente attentato contro
l'ingegnere dell'Ansaldo Giobatta Clavarino, forse previsto per la mattina
successiva. Il 4 aprile 1980 la Procura della Repubblica di Genova emise un
comunicato in cui era riportato il resoconto ufficiale dell'Arma riguardo
l'irruzione e i fatti accaduti. Secondo i carabinieri, il nucleo operativo,
equipaggiato in assetto da guerra, entrò nella palazzina, discese le scale,
raggiunse la porta d'ingresso dell'appartamento e intimò ripetutamente agli
occupanti di aprire. Dall'interno dell'appartamento sarebbero giunte
manifestazioni verbali di pronta collaborazione non seguite da fatti concreti,
quindi gli uomini delle forze dell'ordine avrebbe colpito la porta che si
sarebbe aperta dando accesso al corridoio che, immerso nell'oscurità, non
permise di vedere bene. I carabinieri richiesero la resa a cui i brigatisti
avrebbero risposto di rinunciare alla resistenza e dichiarando di essere
disarmati. L'ingresso dell'appartamento: è visibile sul pavimento la macchia di
sangue causata dal ferimento del maresciallo Rinaldo Benà, sulla sinistra si
vedono le braccia e parte della testa del cadavere di Riccardo Dura. Subito dopo
tuttavia dal fondo del corridoio venne esploso un colpo di pistola da uno dei
terroristi che colpì il maresciallo Rinaldo Benà, di 41 anni, che era entrato
per primo oltre il portone e che, forse per vedere meglio, aveva sollevato la
visiera del casco protettivo. Il maresciallo venne seriamente colpito al volto e
cadde a terra. I carabinieri aprirono quindi il fuoco dall'ingresso con le
pistole mitragliatrici e subito dopo il brigatista che aveva sparato fu
abbattuto; a questo punto il capitano Riccio intimò di nuovo la resa e vennero
scorti due uomini e una donna che si muovevano carponi lungo il corridoio;
grazie all'impiego di un faro a disposizione degli uomini del nucleo operativo,
i carabinieri poterono illuminare la scena e vedere i terroristi di cui uno
armato di pistola e la donna con una bomba a mano. I carabinieri riaprirono il
fuoco con tutte le armi a disposizione contro i brigatisti lungo il corridoio
che vennero tutti uccisi. Il racconto del colonnello Bozzo non si discosta dalla
relazione originaria dei carabinieri; secondo l'ufficiale i brigatisti finsero
di collaborare, ma nel momento in cui il maresciallo Benà entrò egli venne
colpito da un proiettile sparato dal corridoio; i colleghi, credendolo morto,
scatenarono un violento fuoco con le pistole mitragliatrici e con il fucile a
pompa, uccidendo tre uomini. Il capitano Riccio diede ordine di cessare il fuoco
ma, alla luce di una torcia, venne individuata una donna che strisciava sul
pavimento con una bomba a mano; quindi si riprese a sparare uccidendo anche
l'ultima terrorista. L'azione sarebbe durata in tutto nove minuti. Infine si
dispone del resoconto del capitano Michele Riccio che guidò l'irruzione; anche
secondo questa ricostruzione i carabinieri avrebbero intimato di aprire la
porta, quindi, non ottenendo risposta, forzarono le serrature ed entrarono; dal
corridoio uno degli occupanti sparò un colpo di pistola che ferì il maresciallo
Benà. I carabinieri aprirono il fuoco e "iniziò l'inferno"; dopo tre minuti di
fuoco con i mitra e il fucile a pompa, gli uomini dell'Arma incominciarono a
perlustrare l'abitazione. Riccio aggiunge il particolare singolare che poco dopo
squillò il telefono dell'appartamento, si sarebbe trattato di un altro
brigatista della colonna genovese, Livio Baistrocchi, che chiamava per
l'appuntamento del mattino. Rispose il capitano ma il terrorista riattaccò
subito. L'operazione era terminata; i carabinieri provvidero a sbarrare
l'accesso allo stabile e ordinarono alle persone che abitavano negli altri
appartamenti, che erano fortemente impressionati dal violento conflitto a fuoco,
di rimanere chiusi in casa; alle ore 06:55 il sostituto procuratore della
Repubblica di Genova, Filippo Maffeo, dopo essere stato accompagnato all'interno
dell'appartamento dai carabinieri, firmò il processo verbale di sopralluogo. Il
maresciallo Rinaldo Benà fu trasportato in ospedale; la grave ferita al capo
causò la perdita di un occhio ma il sottufficiale sopravvisse. Dagli atti
processuali relativi ai fatti di via Fracchia, resi noti da un quotidiano
genovese il 29 marzo 1980 e ripresi da altre testate giornalistiche il 26
gennaio 2000, il sottufficiale dei carabinieri sarebbe stato ricoverato alle ore
06:00 del mattino, quindi circa sessanta minuti più tardi dell'orario riportato
dalla versione ufficiale delle autorità. Il chirurgo di turno sarebbe stato
svegliato alle ore 05:30 e chiamato in servizio per visitare il ferito e
sottoporlo a intervento chirurgico, che poi sarebbe stato effettuato fra le otto
e mezzogiorno. La circostanza del richiamo in servizio del chirurgo all'alba del
28 marzo sarebbe confermata dal foglio di ricovero, reso pubblico venti anni
dopo i fatti insieme con il resto degli atti giudiziari.
Diffusione delle notizie e
identificazione dei brigatisti. Le prime notizie dei cruenti fatti di Genova
vennero diffuse dall'agenzia ANSA che, allertata dal comando generale dei
carabinieri, comunicò alle ore 06:53 che "quattro presunti terroristi sono stati
uccisi in un conflitto a fuoco con i carabinieri... nella sparatoria è rimasto
ferito anche un sottufficiale dell'Arma. Le persone morte sono tre uomini e una
donna"; entro le ore 07:42 l'agenzia diramò altri due comunicati che indicavano
con precisione l'ora ufficiale dello scontro a fuoco e il luogo esatto a Genova
dell'irruzione dei carabinieri. Alle ore 09:00 il comando generale dei
carabinieri diffuse un comunicato ufficiale in cui descriveva rapidamente le
operazioni antiterrorismo in corso a Torino, Genova e Biella e parlava in
termini generali del conflitto a fuoco di via Fracchia dovuto a "colpi di arma
da fuoco" da parte dei terroristi a cui i carabinieri avevano "reagito
prontamente". Per molti giorni questo rimase l'unico resoconto ufficiale
proveniente dall'Arma; il cordone di sicurezza attorno all'edificio rimase molto
stretto, fu proibito l'ingresso ai giornalisti; nel primo giorno le persone
raccolte all'esterno poterono vedere solo le quattro bare in legno dei
brigatisti trasportate fuori dal palazzo e due pulmini dei carabinieri che
furono stipati di sacchi neri e pacchi contenenti il materiale trovato
all'interno dell'abitazione. Anche il personale della DIGOS giunto sul posto
venne fermato e fu impedita ogni interferenza della Questura nelle indagini.
Secondo la documentazione del processo verbale del sostituto procuratore della
Repubblica e la relazione del capitano Riccio, dopo lo scontro a fuoco
nell'appartamento, i carabinieri trovarono i corpi di quattro persone.
Procedendo dalla porta di accesso, videro per primo il cadavere di un uomo di
corporatura robusta con baffi, vestito con slip e maglietta a maniche corte
rossa, disteso ventre a terra tra l'ingresso e l'inizio del corridoio,
apparentemente senza armi; sotto la testa, ruotata verso destra, una grande
chiazza di sangue. Subito dopo lungo il corridoio c'era il cadavere di un altro
uomo ventre a terra con slip e canottiera blu, la testa, sotto di cui si
allargava un'altra chiazza di sangue, rivolta verso il pavimento; a livello del
tronco fu repertata una pistola Beretta 81. Il terzo cadavere era quello di una
donna che giaceva riversa trasversalmente rispetto al corridoio, con le gambe
che si trovavano all'ingresso della stanza ripostiglio; la donna indossava un
maglione avana, sottoveste e slip rosa, scarpe di corda; accanto alla testa
vennero individuati un paio di occhiali da vista e una bomba a mano, dal capo si
estendeva una grande chiazza di sangue. Infine il quarto cadavere si trovava
alla fine del corridoio; si trattava di un altro uomo che giaceva disteso supino
longitudinalmente al corridoio con le gambe che arrivavano fino all'ingresso
della camera da letto. Questo individuo, di alta statura e con barba, era
vestito; indossava maglione di lana e pantaloni, una scarpa era calzata al piede
destro mentre l'altra si trovava vicino al piede sinistro; anche in questo caso
c'era una vasta chiazza di sangue sotto il capo e la parte superiore del torace;
venne repertata accanto al piede sinistro una pistola Browning HP con colpo in
canna percosso ma non esploso. Inizialmente i carabinieri parvero all'oscuro
dell'identità dei quattro brigatisti uccisi; il primo giorno venne divulgato
solo il nome della donna, Annamaria Ludmann, l'insospettabile figlia del
capitano di lungo corso Corrado Ludmann, proprietario deceduto
dell'appartamento; un personaggio minore della colonna genovese del tutto
sconosciuto agli inquirenti, ritenuto solo una militante "legale" unicamente
impegnata a gestire l'abitazione e a metterla a disposizione dei
clandestini[39]. Anche il 29 marzo non furono diffuse notizie precise sui nomi
degli altri brigatisti e i carabinieri diedero l'impressione di aver agito senza
adeguate informazioni preliminari; furono invece le Brigate Rosse che diffusero
un comunicato di commemorazione dei militanti uccisi scritto personalmente da
Mario Moretti[40]. Nel comunicato le Brigate Rosse esaltavano le qualità dei
quattro "militanti rivoluzionari", "avanguardie" decise a "imbracciare il fucile
e combattere"; essi venivano identificati con i nomi di battaglia: "Roberto",
"operaio marittimo" e "dirigente dall'inizio della costruzione della colonna",
"Antonio", operaio Fiat, tutti e due membri della "Direzione Strategica";
"Cecilia", "donna proletaria", e "Pasquale", operaio della Lancia di Chivasso.
Nel volantino si accusavano i carabinieri della loro morte; essi "dopo essersi
arresi, erano stati trucidati". Il comunicato concludeva minacciosamente:
"niente resterà impunito". Nei giorni seguenti i carabinieri, pur permanendo
un'atmosfera di riserbo e incertezza, riuscirono a identificare altri due
brigatisti e fornirono alla stampa i nomi di Lorenzo Betassa, "Antonio" secondo
il volantino diramato dall'organizzazione, e di Piero Panciarelli, "Pasquale".
Il primo, l'uomo ritrovato parzialmente vestito in fondo al corridoio, non era
affatto ricercato dalle forze dell'ordine, nonostante facesse parte secondo le
stesse Brigate Rosse della "Direzione Strategica"; egli venne identificato anche
grazie alla carta d'identità ritrovata sul corpo che riportava i suoi dati
anagrafici reali. Il secondo, Piero Panciarelli, era relativamente più
conosciuto ma non era ritenuto un militante di primo piano; era ricercato dalla
metà del 1978 e considerato coinvolto negli attentati più gravi compiuti
dall'organizzazione a Torino e a Genova. I carabinieri inoltre diramarono un
comunicato con il lungo e dettagliato elenco della grande quantità di armi e
materiali trovati all'interno dell'abitazione di via Fracchia: cinque pistole,
due pistole mitragliatrici Sterling, un fucile Franchi, 2.000 cartucce, due
granate Energa, due mine anticarro; esplosivo al plastico; macchine per
scrivere, registratori, un riproduttore fotografico, drappi con la stella delle
Brigate Rosse, materiale per la falsificazione di documenti, patenti e carte
d'identità contraffatte, targhe di auto rubate, materiale propagandistico
dell'organizzazione, infine un elenco con oltre 3.000 nominativi di persone
verosimilmente individuate come possibili obiettivi della formazione
terroristica. Rimase invece ancora sconosciuta l'identità del quarto brigatista
ucciso, "Roberto", l'uomo caduto all'inizio del corridoio, descritto dalle
Brigate Rosse nel loro comunicato in termini altamente elogiativi e indicato
come un dirigente di primo piano della colonna genovese e un membro della
"Direzione Strategica". Gli inquirenti non sembrarono in grado di identificarlo
e anche l'eventualità, diffusa per breve tempo, che si trattasse di Luca
Nicolotti si rivelò completamente infondata. Furono infine le stesse Brigate
Rosse che il 3 aprile rivelarono con una telefonata il nome del quarto
militante, Riccardo Dura; l'anonimo parlò di "macabra propaganda" e minacciò
rappresaglie contro giudici, carabinieri e giornalisti. Riccardo Dura era un
personaggio sconosciuto agli inquirenti, solo nel mesi successivi grazie alle
informazioni fornite da Patrizio Peci e da altri brigatisti catturati e
collaboranti, si appresero dettagliate informazioni sul suo ruolo importante,
sulla sua partecipazione a gravissimi fatti di sangue, sulla sua personalità
aggressiva e dominante all'interno della colonna genovese.
Aspetti controversi della
vicenda. Perizia balistica e conclusioni giudiziarie. I carabinieri continuarono
a bloccare l'accesso all'appartamento anche dopo l'identificazione dei quattro
brigatisti; la magistratura emise un primo comunicato il 5 aprile insieme con la
relazione ufficiale dell'Arma emessa il giorno precedente con la descrizione
degli eventi accaduti in via Fracchia. Solo l'8 aprile i magistrati poterono
entrare di nuovo nell'appartamento seguiti finalmente anche dai giornalisti, che
furono fatti entrare uno per volta ed ebbero a disposizione tre minuti di tempo
in totale per osservare il luogo del drammatico scontro a fuoco[48]. La visita
non chiarì tutti i dubbi e al contrario alcuni particolari riscontrati
sollevarono perplessità sulla ricostruzione dei carabinieri. I giornalisti
riportarono nei loro resoconti la presenza di fori di proiettili sul
pianerottolo, ad alcuni decimetri da terra, nell'ingresso e all'inizio del
corridoio, alti fino quasi al soffitto; nella relazione dei carabinieri non si
faceva cenno di scontro a fuoco sul pianerottolo e si parlava di colpi sparati
verso persone che avanzavano carponi quasi strisciando. Fu rilevato che la porta
di accesso all'appartamento non sembrava presentare segni evidenti di
effrazione, a differenza della porta esistente tra ingresso e corridoio che
invece apparve forzata. Inoltre ad alcuni cronisti non sembrò chiaro come i
carabinieri fossero potuti entrare nell'edificio attraverso il portone
principale dotato di una serratura; venne ventilata la possibilità che essi
avessero le chiavi d'ingresso dello stabile[49]. Infine sorsero dubbi anche
sull'effettivo responsabile del ferimento del maresciallo Rinaldo Benà che
risultò colpito da un proiettile calibro 9 mm, un tipo utilizzato anche dalle
armi in dotazione ai carabinieri. Per chiarire i particolari dello scontro a
fuoco il Procuratore della Repubblica di Genova richiese l'8 aprile, dopo aver
riportato la relazione dei carabinieri, "indagini peritali di carattere
medico-legale e balistico" che vennero espletate e permisero di accertare con
precisione quali e quante armi avevano sparato nella notte del 28 marzo 1980.
Venne quindi stabilito che tra le armi rinvenute all'interno dell'appartamento,
tutte perfettamente funzionanti, aveva sparato solo la pistola Browning HP
rinvenuta accanto ai piedi di Lorenzo Betassa che aveva esploso un proiettile;
questa pistola presentava inoltre una cartuccia inesplosa all'interno della
camera di scoppio. Tra le armi in dotazione ai carabinieri avevano sparato tre
pistole mitragliatrici Beretta M12 che avevano esploso in totale 44 proiettili e
un fucile da caccia calibro 12 da cui erano stati esplosi cinque proiettili. I
44 proiettili esplosi dai tre mitra M12 si suddividevano tra un'arma che aveva
sparato 28 colpi e le altre due che avevano sparato otto colpi ciascuno. Nel
corpo di Piero Panciarelli infine venne riscontrato un proiettile calibro 38
special "utilizzabile da rivoltella a tamburo"; l'impiego anche di questa arma
era peraltro stato segnalato nel rapporto dei carabinieri. Dopo le perizie
balistiche e medico-legali, le conclusioni definitive della magistratura
genovese giunsero il 29 febbraio 1984; dopo aver riepilogato la ricostruzione
ufficiale dei carabinieri che non si discostava da quella presentata il 4 aprile
1980, il Procuratore della Repubblica descrisse le ferite riscontrate dai periti
sui corpi dei quattro brigatisti, di cui si confermava l'ora del decesso intorno
alle 04:00. Riccardo Dura era stato colpito al capo da un solo proiettile
mortale che era penetrato dalla regione occipitale dal dietro in avanti; Piero
Panciarelli aveva subito ferite mortali encefaliche e toracico-addominali
causate da quattro colpi penetrati in direzione cranio-caudale. Annamaria
Ludmann aveva ricevuto "gravissime lesioni cranio-encefaliche e
toraco-addominali" a seguito di numerosi colpi di arma da fuoco, tra cui alcuni
da proiettili multipli, sparati da distanza superiore a trenta centimetri,
penetrati principalmente da dietro in avanti. Infine Lorenzo Betassa era stato
raggiunto da numerosi proiettili singoli e multipli con lesioni mortali
"cranio-encefaliche, polmonari, cardiache ed epatiche", con direzione da dietro
in avanti, dall'alto in basso, da sinistra a destra. Dopo questa accurata
descrizione, il magistrato trasse le sue conclusioni: partendo dall'assunto che
i carabinieri "all'atto dell'irruzione nell'appartamento di via Fracchia 12/1
stavano agendo legittimamente nell'ambito dei poteri loro riconosciuti", si
considerava che il comportamento di Lorenzo Betassa che "fraudolentemente", dopo
aver dichiarato la volontà di arrendersi, aveva esploso un colpo di pistola
ferendo gravemente il maresciallo Benà, aveva reso inevitabile, a causa
dell'immediata necessità, l'uso delle armi da fuoco da parte dei carabinieri per
superare la resistenza della parte avversa. La presenza di almeno tre
carabinieri nello spazio angusto dell'ingresso, teoricamente esposti al fuoco
dei terroristi dal corridoio, rese la situazione di grave e "incombente"
pericolo per la vita degli uomini delle forze dell'ordine che quindi non
poterono che contrapporre "una reazione adeguata e proporzionata all'offesa
ricevuta". Il magistrato ritenne pienamente giustificato, dopo l'uccisione di
Betassa, anche il successivo impiego delle armi da parte dei carabinieri che, di
fronte alla presenza di altri brigatisti che avanzavano armati carponi lungo il
corridoio nell'oscurità, tra cui la donna con una bomba a mano, ebbero la
"fondata convinzione di trovarsi nuovamente in imminente pericolo di vita". Dopo
aver ritenuto che la perizia avesse confermato sostanzialmente la relazione dei
carabinieri, evidenziando le traiettorie dei colpi sui corpi prevalentemente da
dietro in avanti e dimostrando che i quattro "terroristi furono colpiti a
distanza, mentre due di essi procedevano carponi e con la testa abbassata", il
magistrato concluse quindi, non essendo "emersi né ravvisabili estremi di
reato", con la richiesta di archiviazione definitiva di tutto il procedimento.
La versione dei brigatisti. La
sanguinosa irruzione di via Fracchia provocò grande emozione nelle file dei
brigatisti e anche nell'ambiente dell'estremismo giovanile; si manifestarono
reazioni di odio e propositi di vendetta. Fin dall'inizio, come risulta dal
documento diffuso il 29 marzo, le Brigate Rosse non diedero alcun credito alla
relazione dei carabinieri e ritennero che si fosse trattato di una vera
rappresaglia militare orchestrata dalle forze dell'ordine per dimostrare la
potenza dello stato e intimorire con un brutale atto di sangue militanti e
simpatizzanti. In ricordo dei brigatisti rimasti uccisi nell'appartamento le
Brigate Rosse denominarono poco dopo la loro colonna veneta "Annamaria
Ludmann-Cecilia" mentre la colonna romana divenne la "28 marzo"; alcuni giovani
estremisti costituirono anche autonomamente a Milano nel maggio 1980 una
"Brigata XXVIII marzo" che si rese responsabile del tragico omicidio del
giornalista Walter Tobagi. Nel documento del 29 marzo le Brigate Rosse
accusavano i carabinieri di aver "trucidato" volontariamente i militanti
dell'organizzazione, che a loro dire, di sarebbero arresi; tra i brigatisti
apparve inizialmente inspiegabile come avessero fatto i carabinieri a entrare
nell'appartamento cogliendo completamente di sorpresa i loro compagni che non
avrebbero avuto modo di reagire. Fu dopo la diffusione delle notizie sulla
collaborazione di Patrizio Peci con i carabinieri che i brigatisti ritennero di
aver compreso la reale dinamica degli eventi. Mario Moretti ritenne che le forze
dell'ordine disponessero delle chiavi dell'abitazione sottratte a Rocco
Micaletto, che le avrebbe avute con sé al momento dell'arresto e che Peci avesse
fornito precise indicazioni sul luogo e l'edificio; i carabinieri avrebbero
quindi sorpreso i brigatisti aprendo con le chiavi l'abitazione e cogliendoli
nel sonno. Nelle loro memorie Mario Moretti, Anna Laura Braghetti, Barbara
Balzerani, Vincenzo Guagliardo e Prospero Gallinari sostengono tutti la versione
dell'atto deliberato da parte dei carabinieri che sarebbero entrati agevolmente
grazie alle chiavi e alle informazioni di Peci e avrebbero agito con la precisa
volontà di uccidere i terroristi. Le disposizioni previste dall'organizzazione
in caso di scoperta di una delle sue abitazioni, prevedevano che gli occupanti
non opponessero resistenza di fronte a soverchianti forze dell'ordine e si
arrendessero; i brigatisti ritengono probabile che i compagni sorpresi in via
Fracchia avessero tentato di arrendersi ma fossero stati ugualmente uccisi dai
carabinieri; secondo Moretti e altri il maresciallo Rinaldo Benà sarebbe rimasto
ferito a causa di un proiettile esploso per errore nella concitazione del
momento dagli stessi colleghi dell'Arma. Anche Patrizio Peci nelle sue memorie
esprime sorpresa per il cruento esito dell'irruzione in via Fracchia ma egli
imputa la responsabilità degli eventi in gran parte alla probabile decisione dei
quattro brigatisti all'interno dell'abitazione di tentare di resistere. Egli
ritiene che soprattutto i tre clandestini, aggressivi e determinati, forse
pensarono di essere in grado di sfuggire ai carabinieri con le armi. Il
brigatista collaborante, che era amico di Panciarelli e Betassa, esprime il
proprio dispiacere per la morte dei quattro ma nega ogni responsabilità negli
eventi ed esclude di aver fornito le chiavi dell'appartamento.
Le foto ventiquattro anni
dopo. Nel 2004, a distanza di ventiquattro anni dai fatti, il quotidiano
genovese Corriere Mercantile, è riuscito a venire in possesso delle foto
scattate dai carabinieri subito dopo lo scontro a fuoco e le ha pubblicate, a
cura del giornalista Andrea Ferro, dal 12 al 15 febbraio, insieme con una nuova
analisi della vicenda. Queste foto pongono nuovi dubbi sullo svolgimento reali
dei fatti. Le immagini mostrano i corpi dei quattro brigatisti lungo lo stretto
corridoio sostanzialmente nelle posizione descritte nel processo verbale del
magistrato genovese: Dura, Panciarelli e la Ludmann sono allineati uno dietro
l'altro, scalzi, svestiti e in posizione supina. In fondo al corridoio giace
invece prono Betassa, che è vestito ma con le scarpe slacciate e senza calze; è
verosimile che anche lui stesse dormendo, forse nel sacco a pelo disteso nella
sala da pranzo, e che abbia affrettatamente calzato le scarpe dopo aver sentito
i primi rumori o le ingiunzioni dei carabinieri. Secondo alcuni autori, la
posizione delle braccia dei primi tre terroristi solleva dubbi sulla
ricostruzione ufficiale; Dura, Panciarelli e la Ludmann nelle foto hanno le
braccia distese in avanti e nessuno impugna delle armi; se i brigatisti fossero
avanzati carponi come riportato nel documenti dei carabinieri, questa posizione
dei cadaveri sarebbe poco congruente; se Panciarelli e la Ludmann avessero
impugnato rispettivamente una pistola e una bomba a mano queste armi
verosimilmente sarebbero rimaste nelle loro mani o accanto ai cadaveri. Nella
foto che ritrae la Ludmann si vede una bomba a mano a terra nel piccolo spazio
compreso tra il volto e il braccio destro parzialmente addotto; la posizione è
sembrata piuttosto singolare. Il fatto che i quattro brigatisti siano caduti in
fila lungo il corridoio e che tre di loro fossero con le mani e le braccia
parzialmente distese in avanti, ha fatto ritenere poco probabile che i
terroristi volessero opporre resistenza e avessero la volontà di ingaggiare un
conflitto a fuoco; allineandosi lungo lo stretto corridoio, invece di ripararsi
nelle stanze laterali, si sarebbero fatalmente esposti ai colpi dei carabinieri.
Alcuni autori ritengono possibile che i quattro intendessero arrendersi,
sfilando uno dietro l'altro lungo il corridoio con le braccia alzate o forse
dietro la nuca. Anche l'orario dell'irruzione è stato messo in dubbio; mentre la
relazione dei carabinieri indica le ore 04:00, l'orologio portato al polso
sinistro dalla Ludmann segna le ore 02:42. Infine è stato evidenziato come il
primo cadavere della fila dei terroristi sia quello di Riccardo Dura, in teoria
il dirigente più esperto e quello considerato più aggressivo; egli è a terra
scalzo e senza alcuna pistola in mano o vicino al corpo, sicuramente non sparò.
È possibile che egli sia stato il primo ad alzarsi e a avanzare lungo il
corridoio verso l'ingresso dove egli sarebbe stato raggiunto da colpi sparati a
distanza ravvicinata attraverso la porta di separazione. Dopo la diffusione
delle foto, il brigatista dissociato e collaborante Adriano Duglio, componente
della colonna genovese, ha ritenuto che questa documentazione fotografica
confermi i dubbi sulla vicenda. Egli ha ripreso la versione brigatista che i
carabinieri disponessero delle chiavi dell'appartamento e che i brigatisti
fossero in procinto di arrendersi come sarebbe dimostrato dalla posizione delle
braccia dei corpi di tre terroristi. Il giornalista Giuliano Zincone,
intervistato nel 2004 dal Corriere Mercantile, ha affermato che già all'epoca
dei fatti aveva manifestato, insieme con altri giornalisti entrati
nell'appartamento, perplessità sulla dinamica degli eventi e aveva ritenuto
probabile che i carabinieri avessero voluto imporre una prova di forza militare
escludendo tecniche operative idonee a permettere una cattura incruenta dei
brigatisti.
Conseguenze e conclusione.
Crollo della colonna genovese. La sanguinosa irruzione in via Fracchia ebbe
importanti conseguenze: insieme con le contemporanee operazioni dei carabinieri
del generale dalla Chiesa in Piemonte, a seguito delle rivelazioni di Peci,
provocò un indebolimento sostanziale della struttura delle Brigate Rosse in
Italia settentrionale e dal punto di vista psicologico sembrò dimostrare in modo
inequivocabile che le strutture dello stato erano decise a impiegare mezzi
militari per interrompere la continua crescita dell'attività terroristica di
estrema sinistra. Secondo l'avvocato Giannino Guiso l'azione dei carabinieri era
soprattutto un impressionante monito rivolto ai più irriducibili brigatisti e
anche una rappresaglia contro la colonna genovese responsabile di molti fatti di
sangue. L'irruzione di via Fracchia diffuse lo sconcerto e la paura tra le
colonne brigatiste, favorendo la perdita della coesione tra i militanti e anche
fenomeni sempre più ampi di collaborazione; il generale dalla Chiesa aveva
parlato in precedenza di à la guerre comme à la guerre, e i fatti del 28 marzo
sembrarono la concretizzazione reale di questo avvertimento del comandante della
divisione carabinieri "Pastrengo". In realtà paradossalmente nella fase iniziale
dopo l'irruzione molti giovani dell'estrema sinistra decisero di passare alla
lotta armata nella colonna genovese spinti dal desiderio di vendicare i
militanti uccisi, ma questi nuovi elementi mancavano di disciplina e
preparazione e inoltre ormai l'organizzazione della colonna era in disfacimento.
Dopo la morte di Riccardo Dura, Francesco Lo Bianco cercò di organizzare i
superstiti ma nuove operazioni dei carabinieri e il moltiplicarsi del fenomeno
della collaborazione e della delazione provocarono il crollo definitivo; entro
la fine del 1980 in pratica la colonna genovese si dissolse. La maggior parte
dei militanti vennero arrestati e le strutture logistiche individuate e
smantellate; alcuni dei più aggressivi brigatisti, come Livio Baistrocchi
e Lorenzo Carpi, invece espatriarono all'estero e fecero perdere le loro tracce.
I carabinieri individuarono anche persone insospettabili come l'anziana Caterina
Picasso e l'avvocato Edoardo Arnaldi che in realtà era solo un simpatizzante in
contatto con alcuni capi della colonna ed era stato avvocato difensore dei
brigatisti; egli tuttavia, coinvolto dalle rivelazioni di Peci e in precarie
condizioni di salute, si suicidò, mentre stava per essere arrestato, per timore
della detenzione in carcere.
Conclusioni. Giorgio Bocca fu
tra coloro che espressero fin dall'inizio la convinzione che gli eventi di via
Fracchia derivassero anche dalla volontà dei carabinieri di infliggere una
clamorosa sconfitta militare alle Brigate Rosse; egli alcuni mesi dopo ebbe un
colloquio direttamente con il generale Carlo Alberto dalla Chiesa che, pur
negando che i terroristi fossero stati uccisi deliberatamente senza dargli
possibilità di arrendersi, si dimostrò freddo e molto duro, evidenziando come i
brigatisti avessero agito per primi ferendo gravemente il maresciallo Benà. Dal
colloquio e dal tono risentito della replica del generale, Bocca ritenne che in
ogni caso gli avvenimenti in via Fracchia non si fossero svolti esattamente
secondo la ricostruzione ufficiale dell'Arma. Permangono peraltro ancora dubbi
sulle reali finalità dei carabinieri nell'azione di via Fracchia; accanto
all'interpretazione che considera l'irruzione e la sua metodica connessa alla
volontà di dimostrare la potenza dell'Arma, di rinsaldare il suo prestigio
presso il mondo politico per favorire anche l'adozione di una "legge sui
pentiti" già preparata dal Presidente del Consiglio Francesco Cossiga e di
vendicare i colleghi uccisi dalla colonna genovese nei mesi precedenti, si è
ventilata anche un'altra ipotesi. L'eventualità che il generale dalla Chiesa
fosse convinto di trovare nell'appartamento, sede di una recente "Direzione
Strategica", documenti di grande importanza sul caso Moro, forse l'originale del
cosiddetto "Memoriale" o le bobine degli interrogatori, da mantenere
strettamente riservati. Da questo fatto deriverebbe in parte lo stretto riserbo
iniziale e il rifiuto per molti giorni di permettere l'accesso di magistrati e
giornalisti. Di questi documenti tuttavia non c'è alcuna traccia nel materiale
sequestrato. Lo storico Marco Clementi ha presentato nel 2007 una sintesi
equilibrata che tiene conto di tutta la documentazione disponibile. Egli
considera come in linea generale fosse vero che le disposizioni delle Brigate
Rosse prevedessero di non opporre resistenza e di arrendersi nel caso si fosse
stati sorpresi all'interno di appartamenti, ma rileva che in precedenti
occasioni si erano ugualmente scatenati conflitti a fuoco, anche con morti e
feriti dalle due parti, nel corso di irruzioni delle forze dell'ordine, a causa
del tentativi dei militanti di evitare l'arresto. Egli segnala inoltre come
tutti i brigatisti risultarono colpiti, secondo la perizia medico-legale, dal
dietro in avanti e dall'alto in basso, il che sarebbe stato possibile solo se
effettivamente essi si fossero mossi carponi lungo il corridoio. L'unico
brigatista che avrebbe sparato fu Lorenzo Betassa che esplose un solo colpo
dalla fine del corridoio prima dell'inceppamento della sua pistola. Questo
proiettile avrebbe raggiunto all'occhio il maresciallo Benà; Clementi ritiene
questa azione del brigatista illogica ma in linea teorica, considerando l'ora,
le circostanze e l'estrema tensione, possibile. Le ricostruzioni dei carabinieri
riferiscono in modo sostanzialmente concorde di una reazione generale con tutte
le armi a disposizione dei quattro o cinque uomini presenti all'ingresso in
risposta all'azione ostile di Lorenzo Betassa. L'autore ritiene in conclusione
che è verosimile che non sia trattato di una premeditata eliminazione fisica dei
quattro terroristi per rappresaglia, ma che la metodica scelta per l'irruzione e
la violenta e generale reazione dei carabinieri, farebbero ritenere che le
disposizioni operative delle autorità superiori prevedessero la possibilità di
un conflitto a fuoco e non si curassero molto di catturare vivi gli occupanti
dell'appartamento in via Fracchia 12, interno 1.
L'inchiesta del 2017.
Nel 2017 la procura di Genova, a seguito dell'esposto presentato dal ricercatore
universitario Luigi Grasso (nel 1979 accusato di terrorismo e
successivamente prosciolto con formula piena), ha aperto un fascicolo di
inchiesta con l'ipotesi di omicidio in riferimento ai fatti relativi alla morte
del brigatista Riccardo Dura.
Br “imprendibili”,
il commento di Giuliano Galletta dell'8 dicembre 2013 su "Il Secolo XIX". Il 24
gennaio del 1979, otto mesi dopo l’omicidio di Aldo Moro, la colonna genovese
delle Brigate Rosse uccide il sindacalista Guido Rossa. All’attentato
partecipano Riccardo Dura, Lorenzo Carpi, Vincenzo Guagliardo. Dura, 29 anni, è
il capo del gruppo e ha già partecipato agli omicidi del magistrato
Francesco Coco e del commissario Antonio Esposito, morirà un anno dopo, il 28
marzo 1980, sotto il fuoco dei mitra dei carabinieri del generale Dalla Chiesa
nel blitz in un appartamento di via Fracchia a pochi metri di distanza dal luogo
in cui è stato assassinato Rossa. Con Dura perdono la vita altri tre terroristi:
Annamaria Ludmann, 32 anni, Lorenzo Betassa, 27 anni, e Piero Panciarelli, 25
anni. Intorno a queste due date, per molte ragioni fatidiche, si costruisce il
racconto degli anni del terrorismo a Genova che Andrea Casazza, giornalista del
Secolo XIX, ha disegnato nel suo libro “Gli imprendibili. Storia della colonna
simbolo delle Brigate Rosse” (DeriveApprodi, 25 euro), da mercoledì in libreria.
Quattrocentonovanta pagine in cui con una acribia al limite dell’iperrealismo
Casazza ricostruisce quegli anni scegliendo un punto di vista preciso e
(relativamente) limitato, quello degli atti giudiziari: verbali di
interrogatori, perquisizioni, arresti, rinvii a giudizio, sentenze, atti
parlamentari messi a confronto con le cronache giornalistiche dell’epoca e con
importanti inserti biografici dei protagonisti della lotta armata. Nel libro il
linguaggio burocratico di poliziotti e magistrati, lo stile ripetitivo e spesso
agghiacciante dei comunicati Br, le metafore melodrammatiche dei cronisti di
nera, i mea culpa e le autocritiche, a volte sinceri, dei brigatisti dal
carcere, ci restituiscono un microcosmo, in fondo composto da non più di un
centinaio di persone, che agisce in uno scenario che probabilmente, oggi, agli
occhi di un ventenne, appare di un altro pianeta. Su quel tragico palcoscenico
recitano la loro parte i terroristi, vertici e manovalanza, i cattivi maestri, i
fiancheggiatori, i simpatizzanti, i militanti dell’estrema sinistra estranei
alla lotta armata ma stritolati nel meccanismo delle leggi speciali, i pentiti,
i dissociati, i pentiti di essersi pentiti, le spie, gli infiltrati, gli agenti
provocatori. Di ciascuno Casazza racconta, a oltre trent’anni distanza, la
storia, grande o piccola, miserabile o dignitosa. Il libro copre un arco
temporale di circa un ventennio, dal caso della banda XXII Ottobre (1969) alla
conclusione dei processi alla colonna genovese negli anni Ottanta, passando
attraverso i rapimenti Sossi e Costa. Ma gli anni centrali sono quattro, dal
1977, quando la colonna genovese si costituisce, al 1980, quando inizia a essere
smantellata grazie alle dichiarazioni dei pentiti. Sul filone principale della
storia della colonna genovese si innesta un’altra vicenda, contigua e parallela,
che coinvolge un gruppo di militanti dell’area dell’Autonomia genovese (fra cui
Giorgio Moroni, Luigi Grasso. Mauro Guatelli e Massimo Selis) arrestati nel
blitz del 17 maggio 1979, con l’accusa di essere la struttura portante delle Br
a Genova, assolti, in primo grado, con la sentenza che Dalla Chiesa
stigmatizzerà con il celebre commento “l’ingiustizia che assolve”, condannati in
Appello e infine totalmente scagionati, nel 1993, dopo che fu dimostrato che le
prove a loro carico erano state costruite ad arte per “incastrarli”. Lo Stato li
risarcirà, per ingiusta detenzione, con un miliardo di lire. «La principale
critica che mi attendo è che nel libro si parla molto dei “carnefici” e poco
delle vittime - spiega Casazza - il che è, in buona sostanza, vero. Credo però
che la storia di quel periodo sia già stata da più parti raccontata, come dire,
dalla prospettiva delle vittime. Il tentativo del mio libro, è diverso: è quello
di raccontare l’epoca del terrorismo non come una “semplice” deriva criminale ma
come un periodo che ha avuto per protagonisti uomini e donne mossi da ragioni
politiche su una strada che si sarebbe ben presto macchiata di troppo, inutile e
ingiustificabile sangue».
Per chi ha vissuto quegli anni
la lettura del libro riporterà alla luce gli stessi schieramenti e
contraddizioni dell’epoca, per gli altri c’è il rischio che l’enorme mole di
dettagli, a volte microscopici, facciano smarrire la visione d’insieme. Casazza
non ha la pretesa di sostituirsi agli storici ma mette sotto i nostri occhi, da
buon giornalista, una lunga teoria di fatti. E non è poco.
Br e via Fracchia: Gad
Lerner tra i possibili testimoni,
scrive il 28 Agosto 2017 Levante News. Il 28 marzo 1980 irruzione delle forze
dell’ordine nel covo dei brigatisti di via Fracchia a Genova: restarono uccisi
quattro terroristi tra cui Riccardo Dura; il maresciallo dei carabinieri Rinaldo
Benà, sorpreso dal fuoco dei brigatisti, perse un occhio. Fu un durissimo colpo
inferto ai Br che secondo una teoria non confermata erano nate a Chiavari ed
avevano due covi a Recco e nelle cui fila era Baistrocchi, un camogliese tuttora
latitante che sembra si sia rifatto una vita a Cuba. Sulla morte dei quattro ci
fu un’inchiesta, chiusa il 29 febbraio del 1984, senza che i giudici rilevassero
irregolarità nel blitz. Solo nel febbraio del 2004 dagli archivi della polizia
giudiziaria saltano fuori le immagini dell’irruzione che pubblica il Corriere
Mercantile. Oggi un esposto ha riaperto l’inchiesta perché Riccardo Dura, ex
“garaventino” tormentato da una situazione familiare difficile, fu ucciso con un
colpo alla nuca. Ne parla oggi sul Secolo XIX, il giudice Luigi Carli (che a
Chiavari indagò l’ex sindaco Vittorio Agostino) che si occupò dell’inchiesta
seguita al blitz di via Fracchia. Testimone della nuova inchiesta potrebbe
essere il giornalista Gad Lerner, all’epoca cronista politico de “Il Lavoro”
(diretto da Giuliano Zincone) che si recò in via Fracchia riportandone
un’idea ben precisa.
Blitz di via Fracchia,
inchiesta per omicidio. Esposto ai pm per riaprire il caso,
scrivono Alessandra Costante e Tommaso Fregatti su "Il Secolo XIX" il 27 agosto
2017. Via Fracchia, 28 marzo 1980: grazie alle prime “confidenze” del brigatista
Patrizio Peci, i carabinieri del nucleo antiterrorismo fanno irruzione in un
appartamento al civico 12. A terra restano quattro terroristi della Brigate
Rosse. Sono: i torinesi Lorenzo Betassa e Pietro Panciarelli; e i genovesi
Annamaria Ludmann, che è anche la padrona di casa, e Riccardo Dura. A 37 anni di
distanza da quel blitz, la Procura della Repubblica di Genova ha aperto un
fascicolo per omicidio “in danno di Dura Riccardo”. Inchiesta affidata ai
magistrati genovesi dell’antiterrorismo ai quali, nei giorni scorsi, è stato
trasmesso un esposto contro ignoti. “Quello di Dura è stato un omicidio
volontario (...) venne ucciso con un solo colpo alla nuca” si legge nella
denuncia presentata da Luigi Grasso, ricercatore che nel 1979 venne accusato di
terrorismo e negli anni successivi completamente prosciolto. Un “cold case” per
il quale la Procura di Genova si muove con circospezione. Per il momento
l’apertura del fascicolo è un atto dovuto in seguito ad un esposto: nei prossimi
giorni i magistrati valuteranno come e se procedere.
Nei primi anni del Duemila
dagli archivi giudiziari di Genova, Luigi Grasso riesce ad ottenere il fascicolo
di via Fracchia. Insieme ad altri tre genovesi nel 1979, Grasso era stato
accusato di terrorismo, arrestato, inquisito, mandato a processo e infine
assolto e pure indennizzato per il lungo calvario giudiziario. Ma come “imputato
in un procedimento collegato” alla fine riesce a mettere le mani sulle carte.
C’è tutto. Ci sono i referti delle autopsie giudiziarie eseguite dai professori
Renzo Celesti e Aldo Franchini. C’è la ricostruzione dei fatti spiegata da
Michele Riccio, il capitano che guidò l’assalto e che era uomo di fiducia del
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa al quale era stato affidato il compito di
condurre la battaglia contro le Br e che stava raccogliendo le dichiarazioni del
terrorista Patrizio Peci. E c’è la richiesta di archiviazione che il 29 febbraio
1984 venne firmata dal sostituto procuratore della Repubblica Luigi Carli e che
convalida le indagini del giudice istruttore. Per la Procura dunque, come aveva
testimoniato Riccio, è un blitz finito male: i carabinieri intimano la resa, i
brigatisti fingono di arrendersi e invece sparano. Il maresciallo Rinaldo Benà
resta ferito ad un occhio e nell’appartamento si scatena un inferno di fuoco.
Ma è sui referti delle
autopsie che Grasso si ferma: Ludmann, Betassa e Panciarelli furono falciati da
numerosi colpi di arma da fuoco. Riccardo Dura, allora trentenne, no: lo uccide
un solo proiettile alla testa, «penetrato in regione occipitale sinistra».
Quanto alla distanza da cui viene esploso il proiettile, Franchini e Celesti
parlano di «una distanza superiore ai 30 centimetri».
Il resoconto dei carabinieri
confermato dall’inchiesta della magistratura, in verità non fu mai accettato dai
reduci della lotta armata. Troppi fatti contribuirono ad alimentare in quei mesi
e negli anni successivi interpretazioni differenti. Subito dopo il blitz, i
carabinieri strinsero un cordone di sicurezza intorno all’appartamento di via
Fracchia: per giorni nessuno potè entrare nell’alloggio in cui vennero trovate
armi e documenti delle Br (volantini e risoluzioni, in tutto oltre 700 reperti)
e per giorni l’identità di Riccardo Dura restò ignota anche ai militari finché
non furono le stesse Br a renderne noto il nome. Il 29 marzo un documento delle
Br accusava i carabinieri di aver «trucidato» volontariamente i militanti
dell’organizzazione. Per Mario Moretti, addirittura, i militari avevano a
disposizione le chiavi dell’alloggio trovate in tasca a Peci.
Un’inchiesta risveglia i
“fantasmi” di Via Fracchia, crocevia della nostra democrazia,
scrive Fabrizio Cerignale il
27 agosto 2017 su "Genova 24". “Che era stata una specie di esecuzione lo
dicevano tutti nei giorni dopo il massacro”. Chi in Via Fracchia vive da sempre
ricorda così quel blitz dei carabinieri, 37 anni fa, che portò alla morte di
quattro brigatisti rossi e alla prima vera dimostrazione di forza dello stato
nei confronti della lotta armata. D’altra parte come dimenticare un quartiere
messo sotto assedio per buona parte della notte, un strada praticamente
militarizzata, gli accessi al palazzo bloccati per diversi giorni. E così
nessuno dei residenti si stupisce se oggi, anche se a 37 anni di distanza dal
blitz nel covo Br, la procura della repubblica di Genova, in seguito alla
presentazione di un esposto denuncia di un cittadino, Luigi Grasso, ricercatore
universitario che nel 1979 venne accusato di terrorismo e negli anni successivi
completamente prosciolto, ha aperto un fascicolo per omicidio “in danno di
Riccardo Dura”, uno dei terroristi uccisi. Secondo l’esposto, frutto di una
minuziosa ricerca tra gli atti giudiziari, quello di Dura, che viveva
nell’appartamento in clandestinità con il nome di battaglia di Roberto, sarebbe
stato un omicidio volontario: “Venne ucciso – si legge nell’esposto – con un
solo colpo alla nuca”. La riapertura dell’inchiesta, però potrebbe finalmente
ricostruire una pagina importante della nostra storia facendo luce, sulla
colonna genovese delle Brigate Rosse, considerata una delle più importanti.
L’eventuale inchiesta, che sarà affidata dai magistrati ai poliziotti
dell’antiterrorismo, potrebbe quindi chiarire i tanti interrogativi, e i tanti
silenzi, attorno a questa vicenda. Dalla vera ricostruzione di quanto accaduto
durante il blitz, guidato dal Maresciallo Riccio, fino agli eventuali
ritrovamenti di materiale nel covo, sui quali si è ciclicamente fantasticato ma
non si è mai avuto una parola definitiva. Un’inchiesta che, forse, permetterà
anche di far tacere i “fantasmi” di via Fracchia, una strada semplice, in un
quartiere della Genova operaia diventata crocevia dei destini della nostra
democrazia. Proprio a “cento passi” dal covo, in un parcheggio poco lontano dai
giardini dove e’ stata collocata la stele in memoria, c’era l’auto dove e’ stato
trovato il corpo di Guido Rossa. E sarebbe stato proprio Riccardo Dura, il
terrorista per il quale si riapre l’inchiesta, a schiacciare il grilletto e a
sferrare il colpo fatale che uccise il sindacalista.
A Via Fracchia ci fu uno
scontro a fuoco come dichiarato ufficialmente dai Carabinieri del Generale Dalla
Chiesa o venne eseguita la condanna a morte di quattro brigatisti? Scrive
Valerio Lucarelli autore di "Buio Rivoluzione".
Diario di viaggio. Il
Disertore. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io
armi non ne ho. Boris Vian›› [Ascoltala da Ivano Fossati]
28 marzo 1980. Ore 2.42.
All’interno 1 del civico 12 di via Fracchia Riccardo Dura, Annamaria Ludman,
Lorenzo Betassa e Piero Panciarelli stanno dormendo. La colonna genovese delle
BR sta per essere annientata. Da giorni i carabinieri sono sulle loro tracce
grazie alle rivelazioni del pentito Patrizio Peci. Dalla Chiesa non vuole più
attendere e ordina il blitz. Una trentina tra uomini del reparto antiterrorismo,
carabinieri e personale del Nucleo operativo irrompe nell'appartamento. Giù la
porta, i primi spari. Il maresciallo Rinaldo Benà viene ferito alla testa,
colpito forse da fuoco amico. Ai brigatisti, sorpresi nel sonno, non viene dato
il tempo per pensare. Molta parte dell'opinione pubblica ebbe l'impressione si
fosse trattata di una esecuzione. Giuliano Zincone, editoralista del “Corriere
della sera”, direttore nel 1980 del quotidiano genovese “Il Lavoro”: "Quel
giorno il giornale titolò: “Non è una vittoria”. Sostenevo la teoria che lo
Stato non doveva rispondere sullo stesso piano dei terroristi. Giorgio Bocca:
"Intervistai il generale Dalla Chiesa alcuni mesi dopo il blitz. Gli chiesi se
ai quattro brigatisti fu data la possibilità di arrendersi o furono uccisi
subito. Non mi disse chiaramente che li avevano ammazzati ma il tono usato per
parlare rivelava intransigenza, durezza. Per me, al di la delle parole, non andò
come era stato raccontato nella versione ufficiale". Nei mesi precedenti a
Genova le BR avevano ucciso quattro carabinieri. Forse Via Fracchia fu la
risposta decisa dal Generale Dalla Chiesa. Lo Stato gridava: "Ora in guerra ci
siamo anche noi".
Ringrazio il Corriere
Mercantile per avermi concesso di pubblicare l'inchiesta di Andrea Ferro sui
fatti di Via Fracchia. Documenti straordinari e interviste che lasciano al
lettore il compito di formarsi una libera interpretazione dei fatti.
Giovedì 12 Febbraio 2004
Corriere Mercantile. LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI CON LA NOTIZIA DEL BLITZ.
Sui giornali una città sotto shock.
Il mistero della bomba a mano,
scrive Andrea Ferro. L’orologio fermo alle 2,42, l’ora del conflitto a fuoco
«Quattro terroristi uccisi in un covo vicino alla casa di Rossa», strillava così
la prima pagina del Corriere Mercantile nell’edizione del pomeriggio di venerdì
28 marzo 1980. Sotto due grandi foto: il palazzo dove c’era il covo dei
terroristi e una bara con all’interno uno dei quattro terroristi uccisi.
Nell’occhiello, in alto, le altre notizie principali della cronaca: Stanotte
alle 4.30 i carabinieri hanno fatto irruzione in un appartamento di via
Fracchia. Sotto, nel sommario: ferito gravemente nel conflitto a fuoco un
maresciallo. Gigantesca perquisizione casa per casa al Carmine, centro storico e
Prà. Il resoconto del blitz era raccontato freddamente, come si fa sempre quando
le notizie sono così importanti e chiare da non avere bisogno di aggettivi
superflui: «Quattro terroristi sono rimasti uccisi in un appartamento covo
situato in via Fracchia, nel quartiere di Oregina. E’ la stessa strada dove,
all’alba del 19 gennaio dello scorso anno, venne assassinato il sindacalista
Guido Rossa. Nel corso della sparatoria è rimasto ferito il maresciallo Rinaldo
Benà». Nelle pagine successive altri titoli a tutta pagina: «Sembravano
marziani, poi il crepitio dei mitra...». Poi un titolo sulla morte della donna
brigatista: «Quella professoressa la vedevo spesso. Era una donna
tranquilla...». «La gente sbigottita ricorda Anna Ludmann terrorista
insospettabile». Spazio anche al ritratto del maresciallo ferito e a un
particolare che tutti avevano subito notato: Dalla finestra di casa Rossa a
guardare il blitz dei carabinieri è spuntata la moglie di Guido Rossa che poi,
accortasi della presenza dei giornalisti, si è rifugiata nell’abitazione.
Annamaria Ludman aveva 32
anni. L’appartamento-covo di via Fracchia era intestato alla sua famiglia. Nella
foto, agghiacciante, che pubblichiamo in questa pagina il corpo della donna è in
posizione prona, nel corridoio. Tra il volto e l’avambraccio destro si nota una
bomba a mano, una lente e la stanghetta degli occhiali. In corrispondenza della
testa c’è una lunga striscia di sangue che corre parallela al muro e copre
completamente il pavimento “alla genovese”. Da altre immagini si evince che le
gambe erano distese nel ripostiglio e il cadavere era in posizione
perpendicolare rispetto al corridoio. Ma c’è un altro elemento, molto
importante, per la ricostruzione “storica” dei fatti. Al polso destro Annamaria
Ludman portava un orologio con il cinghino d’acciaio. Da un semplice
ingrandimento della foto si vede, chiaramente, che le lancette sono ferme alle
due e quarantadue. E’ la prova inequivocabile che il blitz scattò in quegli
istanti. Nella scarna ricostruzione ufficiale non fu mai specificata l’ora
esatta dell’irruzione.
LA BORSA ARSENALE - Nell’altro
foto che pubblichiamo in questa pagina è ritratta una borsa (presumibilmente di
tela) con la cerniera completamente aperta. All’interno si nota la canna di
un’arma lunga, presumibilmente un mitra. Sotto si intravedono altre armi e
munizioni (ma lo si deduce più chiaramente dalla nota posta a margine della foto
inserita nel dossier dei carabinieri). La borsa si trovava in fondo al corridoio
all’altezza dell’ingresso del salotto. Così come è stata “repertata” dai
carabinieri si evince che qualcuno dei quattro brigatisti l’avesse trascinata in
fondo al corridoio e aperta con l’intento di impugnare le armi e fare fuoco
contro il commando dei militari.
LA STORIA DELLA LUDMAN -
Annamaria Ludman nasce a Chiavari il 9 settembre 1947, si trasferisce a Genova
nel 1963 dove si iscrive alla Scuola Svizzera. Figlia di un capitano di lungo
corso in pensione, si diploma alle “Magistrali” e poi si iscrive a vari corsi di
lingue. Per un’estate lavora anche come interprete all’hotel “Regina Elena” di
Santa Margherita. Nel 1970 si sposa nella chiesa di Oregina, ma il matrimonio
dura pochi mesi. Dopo la separazione torna a vivere con i genitori. Nel
frattempo lavora come segretaria in una ditta di spedizione di Carignano e nel
’71 passa all’Italimpianti dove resta impiegata meno di due anni. Poi, per un
breve tempo, gestisce con la famiglia una tabaccheria in via Siffredi, a
Cornigliano. Per alcuni mesi si trasferisce a Como, sempre come segretaria.
Torna a Genova. E’ il 1978, trova un impiego al Centro culturale italo-francese
Galliera, in via Garibaldi. Il padre, Corrado Ludman, muore.
IL RITORNO A CHIAVARI -
Annamaria e la madre tornano a vivere a Chiavari. La giovane è costretta a fare
la pendolare tra Genova e la Riviera di levante. Nel giugno del ’79 si licenzia
dal Centro Galliera nonostante godesse di grande stima da parte dei colleghi e
dei dirigenti. Motiva la sua decisione per ragioni economiche, stipendio troppo
basso. Ma da quel momento si sa più poco di lei. Alle amiche che incontra parla
genericamente di un lavoro in porto, come segretaria in una ditta di spedizioni.
Poi la mattina del 28 marzo il suo nome è il primo a trapelare tra quelli degli
occupanti del covo. Di lei parlano con affetto i vicini di casa che mai
avrebbero immaginato la verità. Nel gergo dei brigatisti Annamaria Ludman era
rimasta fino all’ultimo una militante “irregolare”, cioè non era entrata in
clandestinità.
IL RICORDO DELL’AMICA - In una
lettera pubblicata sul “Il Manifesto” alcuni giorni dopo il blitz Liliana
Boccarossa aveva ricordato così l’amica Annamaria Ludman: «Certi ti vedranno
come un mostro, altri ti hanno già messo sull’altare insanguinato dei
“combattenti comunisti”. Io non so se hai ammazzato; so solo che ti hanno
ammazzato e che questo poteva essere evitato. Ho pensato, ho sperato che tu non
sapessi niente di quello che succedeva nella casa di Oregina. Mi si dice che è
impossibile, che c’era un arsenale, che sei morta con una bomba in mano. Allora?
Allora non capisco, come non capiscono quelli che ti hanno conosciuto... Io ti
ricorderò sempre per quella che eri: una brava e simpatica donna incasinata,
fregata dal perbenismo del tuo ambiente, in quella maledetta città, fregata
dall’ultima moda in fatto di perbenismo totale e rassicurante: il terrorismo».
ANDREA FERRO
Tessandori: «Fu la fine delle
Brigate Rosse» Vincenzo Tessandori, inviato de “La Stampa”, ha seguito sin dagli
albori degli anni di piombo la storia delle Brigate rosse. E’ l’autore di “Br,
Imputazione: banda armata”, una ricostruzione certosina degli anni di piombo
firmati dalla stella a cinque punte. Cosa accadde in via Fracchia quel 28 marzo
di ventiquattro anni fa? «Dobbiamo, forzatamente, accettare la ricostruzione
ufficiale. D’altronde non ci sono testimoni o elementi sui quali riscrivere i
fatti». Ma non hai avuto dubbi? «Qualche perplessità è inevitabile, è il nostro
mestiere sospettare. Certamente quattro morti ammazzati pesano e inducono
interpretazioni di vario tipo». Per esempio? «L’interrogativo di fondo è questo:
che obiettivo avevano i carabinieri? Mi spiego: Dovevano prenderli vivi o morti?
E secondo lei? «Impossibile stabilirlo, tantopiù adesso. E’ indubbio che quella
fu un’operazione ad altissimo rischio. Dentro c’erano uomini armati. Gente che
aveva sparato, ammazzato. Pensare ad una loro reazione non è certo pura
fantasia». E infatti all’interno del covo i carabinieri sequestrarono parte del
micidiale arsenale della colonna genovese delle Brigate rosse. Resta il fatto
che quel blitz segnò la sconfitta militare, decisiva, del “partito armato” «Da
anni le Brigate rosse avevano dichiarato guerra allo Stato. E fino al sequestro
Moro lo Stato aveva risposto in maniera blanda. Se l’affaire-Moro fu una
vittoria politica delle Br, contemporaneamente scatenò una vera controffensiva.
Efficace sul piano investigativo e repressivo «I fatti di via Fracchia
presentarono uno scenario nuovo. Lo Stato adesso può uccidere per difendersi,
conduce sul serio una guerra. Cioè brigatisti, potete morire». E infatti da quel
momento le Brigate rosse colarono a picco «Finché il terrorismo era “vincente”
erano più facile attirare nuove leve verso la lotta armata. Quando invece si
inizia a perdere, i più scappano. E per le Brigate rosse dopo via Fracchia andò
così. Sul piano del reclutamento le conseguenze di quel blitz furono più forti
della notizia della cattura e della successiva “collaborazione” di alcuni capi
brigatisti». Tornando alla ricostruzione dei fatti e ai dubbi che accompagnarono
la versione ufficiale. Prima di quell’irruzione e poi dopo altre operazioni di
polizia furono portate a termine con un minore spargimento di sangue. Invece in
via Fracchia... «Mi viene in mente un’operazione, diciamo così analoga, finita
però in maniera diversa. Penso al sequestro Dozier, un anno dopo. Quando la
polizia fece irruzione nel covo-prigione di Padova non fu sparato nemmeno un
colpo» Ma neppure da parte dei brigatisti... «Talvolta è una questione di
addestramento. Esistono tradizioni operative e armi diverse. Ma poi c’è il caso.
Qualcuno ha scritto “in amore e in guerra non esistono regole”. Penso che avesse
ragione». [Andrea Ferro]
Carabinieri e cronisti nei
pressi del portone del caseggiato di via Fracchia Zincone: «Pensammo subito a
un’esecuzione» Giuliano Zincone, editoralista del “Corriere della sera”, nell’80
era direttore de “Il Lavoro”, voce della sinistra genovese e quotidiano molto
attento ai fenomeni dell’eversione. Cosa ricorda di quella mattina di
ventiquattro anni fa? «Ricordo che un confidente mi informò di quello che era
successo in via Fracchia. Invia sul posto due cronisti di razza, Gad Lerner e
Manlio Fantini. Quando tornò in redazione Gad era sconvolto». Quale fu la prima
impressione? «Ci convincemmo subito che era stata un’esecuzione. In redazione
era l’interpretazione prevalente». Ma su quali elementi ne foste così certi?
«Quattro morti, tutti brigatisti, ci sembrarono subito troppi. Non era possibile
pensare al conflitto a fuoco come invece sostenevano i carabinieri». E infatti
il suo fondo quel giorno suscitò grande scalpore. «Titolammo: “Non è una
vittoria”. Sostenevo la teoria che lo Stato non doveva rispondere sullo stesso
piano dei terroristi. Una posizione che suscitò critiche pesanti all’interno di
una certa sinistra, tra i nostri lettori. Non mancarono le polemiche». Però
all’interno del covo fu sequestrato un autentico arsenale, alcuni dei brigatisti
uccisi vennero indicati come i responsabili di numerosi fatti di sangue.
«D’accordo ma nostra convinzione era che i carabinieri avrebbero potuto agire in
maniera diversa. Scoprimmo infatti che la zona attorno al covo era presidiata da
giorni da un esercito di carabinieri. Ritenevamo che potevano esserci altri
modi, meno cruenti, per portare a termine quel blitz. Non potevano credere che
una forza armata moderna, come l’arma dei carabinieri, non avesse la capacità e
i mezzi per intervenire in un altro modo». In sostanza per i carabinieri era
meglio ucciderli che prenderli vivi? «Il sospetto che le cose fossero andate in
maniera diversa rispetto alla versione ufficiale derivava dal fatto che a Genova
nei mesi precedenti i brigatisti avevano ucciso quattro carabinieri». Una
vendetta rabbiosa? «Non potevano non pensarla così. Quando Gad Lerner ebbe la
possibilità di entrare in quella ci raccontò di aver visto fori di proiettile
ovunque. Una carneficina, insomma. In seguito alla posizione assunta dal nostro
giornale Dalla Chiesa si rifiutò di incontrarmi per tanto tempo, continuò a
negarmi interviste». Ma la lotta alle Brigate Rosse non fu contrassegnata solo
da blitz sanguinosi. «Certamente. Al di là di quello che accadde in via Fracchia
l’operato di Dalla Chiesa e dei suoi uomini fu frutto di un grande lavoro di
intelligence. Penso all’opera diplomatica per convincere i pentiti a
collaborare. Dimostrarono un’indubbia capacità investigativa».
Quella telefonata nel cuore
della notte, scrive Mimmo Angeli. La telefonata arrivò nel cuore della notte.
L’apparecchio di casa squillò alle tre. Una voce chiara dall’altra parte del
filo disse: «Direttore, c’è stata una strage di brigatisti in via Fracchia». Poi
il clic metallico interruppe il contatto. Era l’alba del 28 marzo 1980. Rimasi
di sasso. Per un attimo pensai a uno scherzo di cattivo gusto. Qualche minuto
dopo telefonai ai colleghi Attilio Lugli, Alfredo Passadore e al fotografo
Luciano Zeggio, trasmettendogli testualmente il contenuto del messaggio
telefonico. Tutti eravamo scettici ma, nel dubbio, diedi disposizione di andare
a vedere. Erano i tempi delle Br scatenate in città, con i loro messaggi e gli
attentati sanguinosi. I giorni della paura, in cui vivevo con la scorta e
l’incubo delle minacce telefoniche, scritte, sussurrate da chi aveva
intercettato misteriosi dialoghi al bar. I giorni in cui uscivi di casa e non
eri sicuro di tornare vivo in famiglia. Quella telefonata con l’interlocutore
preciso, calmo, telegrafico poteva essere una bufala come una tremenda verità.
Quando i colleghi arrivarono per primi si trovarono di fronte a una scena
impressionante. Dappertutto carabinieri in borghese e in divisa. I colleghi non
ebbero nemmeno il tempo di dire «Siamo giornalisti» che si trovarono faccia al
muro con i mitra spianati. «Fermi, non muovetevi» ripeteva un tipo alto, con i
capelli biondi che gli arrivavano alla schiena, l’abbigliamento da tupamaro, gli
occhi gelidi. Era uno degli uomini del generale Dalla Chiesa protagonisti della
tragica irruzione nell’appartamento di via Fracchia. Un cordone ferreo attorno
al palazzo. L’ordine perentorio: «Nessuno può entrare» veniva ripetuto
seccamente con monotonia quasi ossessiva dai carabinieri in borghese. Neppure il
vicequestore Arrigo Molinari riuscì a entrare; anzi, con decisione, venne
invitato ad allontanarsi. Quel “muro” davanti alla casa della strage venne
incrinato dieci giorni dopo quando, per soli tre minuti, i giornalisti furono
ammessi a entrare nell’appartamento dove erano stati uccisi i quattro
brigatisti. Un sopralluogo preparato per evitare l’impatto con la cruda realtà
di quella notte. A distanza di ventiquattro anni, quello che accadde durante
l’irruzione degli uomini del reparto speciale è testimoniato dalle foto inedite
che il nostro giornale pubblica oggi. Questo documento è l’epilogo di uno
scontro tra i brigatisti e lo Stato. La parola finale dopo lunghe indagini fatte
anche di clamorosi insuccessi. Quella notte, ci sembra ovvio, gli uomini di
Dalla Chiesa andarono a colpo sicuro. Quando fecero irruzione nell’appartamento,
erano preparati alla reazione di brigatisti armati fino ai denti e decisi a
vendere cara la pelle. Il maresciallo Bennà, componente il commando, perse un
occhio colpito da da una pallottola. Non si è mai riusciti a capire se fosse
partita dalla pistola di un brigatista o invece rimbalzata dal mitra di un
carabiniere. Un fatto è certo: i quattro terroristi erano armati fino ai denti e
uno aveva persino una bomba a mano che, evidentemente, non ha avuto il tempo di
usare. Queste foto servono a non dimenticare quei giorni pieni di rabbia e
sangue. Sì, perché nel nostro Paese sono in molti ad avere la memoria corta.
Quegli anni di piombo hanno lasciato una lunga scia di sangue. La nostra città
ha pagato un forte tributo di vite umane, di attentati, persino il rapimento di
un magistrato. Di Riccardo Dura, per esempio, si disse che aveva la sua lunga
lista di “condannati”, che era deciso a continuare a colpire, uno dopo l’altro.
L’irruzione dei carabinieri venne preparata con molta cura e fu il frutto di
lunghe indagini, appostamenti e di qualche “dritta” ricevuta. Quella nonnina,
intestataria dell’appartamento, in realtà risultò poi una basista lucida e
spietata. Quel covo nascosto tra un pugno di case popolari sulle alture della
città, a due passi dall’abitazione del sindacalista Cgil Guido Rossa, ucciso dai
terroristi, nascondeva il gruppo di fuoco delle Br genovesi. La strage rimane un
fatto drammatico: una risposta a un atto di guerra, come avevano rivendicato i
brigatisti nei loro proclami. In queste drammatiche immagini, la fine di quella
guerra. Forse. Mimmo Angeli
Le foto di un blitz storico
che vennero tenute nascoste, scrive Andrea Ferro. La pubblicazione delle foto
scattate dopo il blitz di via Fracchia rappresenta un documento storico.
Ventiquattro anni dopo, per la prima volta, vengono mostrate le immagini del più
discusso blitz compiuto dai carabinieri contro le Brigate rosse. La morte dei
quattro terroristi, i lunghi silenzi prima della ricostruzione ufficiale
indussero sospetti ed interpretazioni diverse. Non è nostra volontà proporre
questo eccezionale documento con la presunzione di riscrivere un tragico
capitolo di storia contemporanea, cercare elementi che possano avvalorare dubbi
o confermare, pedissequamente, la verità di Stato. Siamo consapevoli che queste
foto (alcune agghiaccianti e simboliche al tempo stesso) possano essere “lette”
con occhi diversi schiacciando l’angolo di visuale su posizioni preconcette. Non
ci interessa inseguire il sensazionalismo con l’ansia di trovare il particolare
capace di infiammare lo scoop a tutti i costi. L’unico intento che ci spinge a
riaprire questa pagina è raccontare con il supporto, inedito, delle immagini i
fatti inserendoli nel contesto di vita e di morte entro i quali sono maturati.
Succedeva ventiquattro anni fa, ma forse sembra passato già un secolo, in una
città squassata dal piombo, dall’odio, dalla disperazione di decine di famiglie.
In queste pagine speciali (la pubblicazione delle foto proseguirà nei prossimi
giorni) ospitiamo ricordi, testimonianze, commenti, interpretazioni. [Andrea
Ferro.]
COSÌ VENNE “ANNIENTATA”
VENTIQUATTRO ANNI FA LA COLONNA GENOVESE DELLE BR. Una fila di cadaveri a terra.
L’immagine choc che riassume l’orrore di un’epoca, scrive Andrea Ferro. Quattro
cadaveri lungo un corridoio, quattro morti in fila indiana. Quattro vite
spezzate, la colonna genovese delle Brigate “annientata”, polverizzata dal
piombo dei carabinieri. E’ l’immagine-choc che riassume l’orrore di un’epoca e
l’inizio della sua fine anche se altro sangue scorrerà ancora e la campana a
morto rintoccherà tante, troppe, volte nel buio della notte della Repubblica. La
fotografia che il “Corriere Mercantile” pubblica in esclusiva insieme ad altro
materiale inedito, fu scattata all’alba del 28 gennaio del 1980
nell’appartamento di via Fracchia 12/1, a Oregina, poche ore dopo il blitz
compiuto dagli uomini del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Era la base
strategica della colonna genovese delle Br, qualcosa di più di un covo. La
fotografia ritrae i corpi (nell’ordine) di Riccardo Dura, Piero Panciarelli,
Annamaria Ludman e Lorenzo Betassa. L’istantanea fa parte di un dossier
riservato custodito negli archivi dell’Arma dei carabinieri e della polizia. Il
rapporto venne redatto dai carabinieri della Sezione rilievi del Nucleo
operativo di Genova (in sostanza la squadra di polizia scientifica dell’Arma).
E’ la ricostruzione “fotografica” dell’operazione, in tutto una sessantina di
immagini, del “conflitto a fuoco” . Copia del dossier venne successivamente
inviata all’autorità giudiziaria.
SOPRALLUOGO DEI PM - Il
sopralluogo dei magistrati avvenne l’8 aprile, quindi undici giorni dopo il
blitz. Nel frattempo l’appartamento fu “sigillato” dai carabinieri e presidiato
in forze dai Reparti speciali. Solo dopo il sopralluogo di due sostituti
procuratori i giornalisti, per tre minuti, furono accompagnati all’interno del
covo “in visita guidata”, tre minuti in tutto. Il tragico epilogo del blitz
(testimonianze e commenti sono riportati in altri articoli pubblicati su questa
edizione del “Corriere Mercantile”), la “blindatura” dell’appartamento, i mezzi
silenzi ufficiali, alimentarono il mistero e la sensazione di trovarsi di fronte
ad una pagina tanto decisiva quanto ambigua della lotta al terrorismo. Ma ecco
l’analisi delle prime due foto che compaiono a corredo di questo articolo (le
altre saranno pubblicate domani e dopodomani).
IL CORRIDOIO - Tre dei quattro
corpi sono in posizione prona (Dura, Panciarelli, Ludman). Il cadavere di
Betassa (quello ritratto più lontano) è invece supino. Secondo la prima
ricostruzione dei fatti trapelata sui quotidiani dei primi giorni successivi al
blitz sarebbe stato quest’ultimo a sparare contro i carabinieri. Accanto al suo
corpo fu “repertata” una pistola, una calibro nove dalla quale sarebbero partiti
numerosi colpi. Un’altra pistola fu trovata sotto il cadavere di Panciarelli,
mentre accanto al corpo della Ludman compare una bomba a mano (articolo a pagina
2).
LA PIANTINA DEL COVO -
L’appartamento di via Fracchia 12/1 è situato al piano terra del caseggiato. E’
un alloggio composto da ingresso, tre camere, bagno, cucina e ripostiglio. Come
documenta il dossier fotografico al momento dell’irruzione dei carabinieri, tre
dei quattro brigatisti si trovavano all’interno della camera da letto. Dormivano
su una rete matrimoniale e su una brandina-armadio. Il quarto occupante del covo
(presumibilmente Betassa) riposava invece nel salotto (il vano più grande
dell’appartamento) in un sacco a pelo disteso accanto al divano. Il sospetto che
fosse Betassa deriva da una circostanza precisa. Come testimoniano le foto
scattate dai carabinieri, era l’unico a indossare un maglione e un paio di
pantaloni. Gli altri tre avevano slip e magliette. Panciarelli e Dura erano
scalzi, la Ludman calzava un paio di pantofole. Betassa invece portava mocassini
con i lacci (non stretti). L’impressione è che svegliato nel sonno dai rumori
abbia fatto in tempo a calzare le scarpe a mo’ di ciabatte e poi raggiungere il
corridoio. I corpi dei tre uomini sono in posizione parallela al lato lungo del
corridoio mentre quello della Ludman è perpendicolare rispetto agli altri
cadaveri con le gambe distese nel ripostiglio. I corpi dei quattro terroristi
rimasti uccisi nel covo di via Fracchia. Andrea Ferro
NEL RAPPORTO UFFICIALE SI
PARLA DI FRAGOROSI COLPI ALLA PORTA INTIMANDO LA RESA. Una doppia verità
sull’irruzione in via Fracchia. I fori dei proiettili sul muro della scala dello
stabile. Sabato 5 aprile 1980. Dalla sanguinosa irruzione nel covo delle Brigate
Rosse di via Fracchia - nata dalle rivelazioni del pentito Patrizio Peci - è
passata una settimana. Nel muro alzato dall’Arma su quanto accaduto alle 2 e 30
di venerdì 28 marzo ’80 si apre una breccia. La magistratura rende pubblico il
comunicato ufficiale in cui i carabinieri ricostruiscono l’irruzione nel covo
brigatista. Poche righe, la cui stesura ha richiesto diversi giorni. Una pagina
per descrivere la prima vera risposta alla guerra civile intentata dai
terroristi contro lo Stato. «Dalla ricostruzione riferita dai carabinieri sul
conflitto a fuoco avvenuto venerdì scorso, 28 marzo - scrivono i vertici
dell’Arma - nel corso del quale hanno perso la vita Anna Maria Ludman, Lorenzo
Betassa, Pietro Panciarelli, Riccardo Dura ed ha riportato gravi lesioni il
maresciallo Rinaldo Benà, è emerso che i medesimi portatisi all’esterno
dell’appartamento interno 1 di via Fracchia n. 12, dopo ripetute intimazioni ad
aprire rimaste senza esito, nonostante la dichiarata accettazione di resa, senza
effetto, colpivano la porta di accesso, che cedeva spalancandosi». I militari,
seguendo il protocollo, avrebbero bussato fragorosamente, intimato agli
inquilini dell’appartamento di arrendersi. Quindi avrebbero fatto irruzione.
Altra lettura dei fatti è stata data nel corso degli anni da vari esponenti di
area politica della sinistra, secondo cui i militari fecero irruzione senza
annunciarsi, entrando, sparando, uccidendo. Guerra, insomma. «(I militari)
Potevano così intravvedere, al di là di una tenda, un corridoio buio, dal quale
non proveniva alcun rumore - prosegue la nota dei carabinieri - Intimavano
allora agli occupanti la resa ed una voce maschile rispondeva: “Va bene, siamo
disarmati”». I militari avrebbero per una seconda volta chiesto ai brigatisti di
arrendersi. Lorenzo Betassa avrebbe accettato la resa. Di fatto, sempre secondo
i carabinieri, sarebbe stato armato di una calibro nove. Vediamo: «Subito dopo,
però, dal fondo del corridoio veniva esploso un colpo di pistola che colpiva al
capo il maresciallo Benà» si legge nel comunicato. Il passaggio è drammatico. Lo
scontro a fuoco entra nel vivo. «I carabinieri aprivano il fuoco e udivano il
tonfo di un corpo che cadeva a terra - scrive l’Arma - Intimata nuovamente la
resa, essi potevano notare due uomini e una donna avanzare carponi nel corridoio
provenendo da una stanza laterale». Si tratta di Ludman, Panciarelli e Dura (due
di loro indicati come sicari delle BR, tra cui autori dell’uccisione
dell’operaio Guido Rossa). Si spiegherebbe perché i cadaveri sono stati
fotografati in fila nel corridoio. E’ a questo punto che un fascio di luce
taglia il buio del covo. «A questo punto era possibile far luce con un faro in
dotazione - prosegue la nota - Seguiva, immediatamente, da parte dei tre una
brusca reazione, ed i carabinieri, hanno notato che uno dei due uomini impugnava
una pistola e la donna una bomba a mano, riaprivano il fuoco con tutte le armi».
I brigatisti sono stati freddati. «Cessato il fuoco si constatava che i tre
erano stati colpiti a morte». Poi una fredda e stringata analisi del sito: «La
pistola dalla quale è partito il colpo che ha colpito il maresciallo Benà è
stata trovata con un proiettile in canna percosso, ma non esploso - chiudono i
militari - Nell’appartamento, oltre a vario materiale documentale e a strumenti
per la falsificazione di carte di identità e patenti, sono stati rinvenuti
fucili mitragliatori, bombe da fucile e anticarro, pani di esplosivo plastico e
numerose munizioni». L’analisi dell’artiglieria e delle armi leggere effettuata
successivamente dimostrerà che furono usate in vari attentati genovesi, tra cui
quello contro i carabinieri Tosa e Battaglinia Sampierdarena, Esposito e, come
detto, Rossa. [r.c.]
Venerdì 13 Febbraio 2004
Esclusivo Corriere Mercantile. CON LE FOTO DEL CORRIERE MERCANTILE, AL CIVICO 12
SI RIVIVONO I GIORNI PRECEDENTI IL BLITZ E LA NOTTE DI TERRORE. Via Fracchia,
ricordi indelebili: «Quella donna in giardino, l’uomo col piccone. Poi gli
spari», scrive Simone Traverso. LA TELEFONATA DI ZORA LUDMAN A UN’INQUILINA
DELLO STABILE: «E’ mia figlia, lo sapevo» «E’ la casa di mia figlia? E’
l’appartamento di Anna Maria?». «Sì, Zora, è successo qualcosa, non so...
forse... sì, è lei». «E’ mia figlia, quella disgraziata, lo sapevo». Sono le
9,30 di venerdì 28 marzo 1980. In via Fracchia, al civico 12, i carabinieri del
generale Dalla Chiesa, alle 2,40, hanno fatto irruzione nel covo delle brigate
rosse all’interno 1. Lorenzo Betassa, Riccardo Dura, Piero Panciarelli e
Annamaria Ludman sono morti, colpiti dai proiettili dei militari. I loro corpi
sono riversi nel corridoio dell’appartamento, nel sangue. Gli inquilini dello
stabile sono invece chiusi nelle loro case, terrorizzati. E una signora di
mezz’età riceve una telefonata dalla mamma della Ludman, Zora. Il tono della
donna è teso, la voce rotta dall’impazienza e dalla paura. Il giornale radio ha
appena divulgato la notizia dell’irruzione e della sparatoria. La mamma di
“Cecilia” (il nome di battaglia della brigatista uccisa in via Fracchia) sa. O
almeno ha intuito qualcosa. L’inquilina che rispose alla telefonata di Zora
Ludman ricorda con assoluta nitidezza quella drammatica conversazione. «Mi
chiese cos’era capitato, ma non sapevo cosa risponderle. Eravamo “prigionieri”
nelle nostre abitazioni e sapevamo pochissimo. I carabinieri sorvegliavano
l’ingresso e l’atrio, il giardino e le strade del quartiere. Dissi alla mamma di
Annamaria che era accaduto qualcosa di brutto nell’alloggio di sua proprietà e
lei rispose: «Lo sapevo, è mia figlia, quella disgraziata». Un mese dopo
entrammo nell’appartamento e Zora pianse. La sostenni quando stava per svenire,
le impedii di vedere la biancheria intima della figlia ancora stesa in bagno.
Trenta giorni dopo il blitz tutto era ancora uguale, immutato, congelato. E
l’odore del sangue e della morte riempiva la gola e i polmoni, insopportabile».
[Simone Traverso]
Le porte in legno sono sempre
le stesse, uguali a quella che i carabinieri del generale Dalla Chiesa
sfondarono a calci e pallottole la notte del 28 marzo 1980, scrive Simone
Traverso. A cambiare semmai, nel palazzo di via Fracchia che ospitò il covo
delle Brigate Rosse, sono stati il portone (allora era in legno, oggi è in
acciaio scuro) e la tinta alle pareti, passata da un “crema” anonimo a un
raffinato impasto di graniglia in marmo. Ventiquattro anni dopo quel drammatico
blitz in cui trovarono la morte Annamaria Ludman, Riccardo Dura, Lorenzo Betassa
e Piero Panciarelli, la gente del civico 12 sfoglia il Corriere Mercantile
attonita, quasi senza parole. Le fotografie pubblicate in esclusiva dal nostro
giornale risvegliano antichi ricordi: il ticchettio della macchina da scrivere
(sentito «anche a notte fonda»), quella ragazza bruttina ma con un corpo da
pin-up che prendeva il sole in giardino, un uomo misterioso, forse Dura, che
scavava con un piccone nell’erba alta delle aiuole, eppoi il fumo dei
lacrimogeni, l’odore della polvere da sparo, un carabiniere portato via
sanguinante, le urla e i tonfi sordi, «non come quelli dei film, diversi, ma
inequivocabilmente spari».
“CECILIA”. La prima immagine
che restituisce la memoria degli anni Settanta è quella di Annamaria Ludman
(nome di battaglia Cecilia). Ai suoi genitori era intestato l’appartamento in
via Fracchia divenuto covo delle Br. Lei vi si stabilì prima da single, poi in
compagnia di un giovane: «Credo fosse Luca Nicolotti - racconta uno degli
inquilini che chiede, come tutti i suoi vicini, di restare anonimo -. Restarono
assieme a lungo, poi lui sparì e lei rimase nuovamente sola. Era una ragazza
tranquilla, non proprio bella, ma con un corpo davvero notevole. Ogni tanto si
sdraiava in giardino a prendere il sole. La madre ci disse spesso che sua figlia
collaborava con istituti scolastici esteri e che ospitava studenti provenienti
dalla Francia e dalla Svizzera».
FANTASMI. La gente che oggi
abita in via Fracchia non è più la stessa del 1980. Alcuni inquilini sono morti,
altri si sono trasferiti. Chi è rimasto è comunque cambiato e sa di vivere
accanto ai fantasmi della “rivoluzione fallita”. Fantasmi che quand’ancora erano
in vita trascorrevano le notti a scrivere documenti, volantini, rivendicazioni.
I condomini di oggi ricordano il racconto di un’anziana signora che pochi giorni
dopo la sanguinosa irruzione delle forze dell’ordine disse: «Li sentivo la notte
battere a macchina. Scrivevano, scrivevano, sempre. Il mio appartamento era
proprio sopra il loro, sopra un salotto adibito a camera da letto, ma pure a
pensatoio, perché lì dentro passavano notti e giorni e il ticchettio dei tasti
della macchina da scrivere non mi faceva dormire. “Chissà che avranno da mettere
nero su bianco”, mi dicevo».
LE VACANZE. Eccezion fatta per
la Ludman, i condomini del civico 12 di via Fracchia non videro mai i
brigatisti. «Solo in un paio di occasioni - ricorda una signora - vidi un uomo
scavare in giardino. Era armato di piccone e stava preparando una buca grossa
così». Dalla descrizione, «abbastanza massiccio, senza barba, ma con i capelli
mossi e un tatuaggio sul braccio», pare trattarsi di Riccardo Dura, “Roberto”.
Tre giorni prima della tragica sparatoria del 28 marzo, un’altra inquilina vide
“Cecilia” assieme a “Roberto”: «Li incrociai nell’androne delle scale. Portavano
borse pesantissime, quasi le trascinavano. Tenni loro aperto il portone e
chiesi: «Si parte per le vacanze?”. La risposta fu un laconico “Eh, sì...”, ma
lo sguardo non era certo quello di due amici che s’apprestano a godersi un
periodo di riposo».
SIGARETTE. I primi giorni di
marzo dell’80 sono quelli in cui gli uomini del generale Dalla Chiesa iniziarono
gli appostamenti. Un anziano che vive al 12 di via Fracchia da almeno trent’anni
dice di esserne sicuro: «Una mattina andai alla mia auto, ma trovai le portiere
aperte, anzi forzate. Dentro, nell’abitacolo, un puzzo di sigarette
insopportabile. Ma io non fumavo... dopo il blitz nel covo compresi che i
carabinieri avevano usato la mia utilitaria per sorvegliare il palazzo tutta una
notte».
L’ASSALTO. Il ricordo più vivo
per tutti gli abitanti dello stabile è certamente quello della notte del 28
marzo 1980. Nessuna ricostruzione dettagliata, per carità. Bensì tanti
frammenti, ricchi di dettagli, di suoni, rumori, immagini strazianti. «Sentimmo
tonfi assordanti, una gran confusione nelle scale, molte urla. Fuori, di fronte
al giardino (quello asservito al covo delle Br, ndr), c’erano un sacco di
carabinieri con i mitra puntati e di fronte all’ingresso dell’interno 1 altri
militari, in borghese. Dalla porta usciva fumo, forse lacrimogeni. C’era puzza
di polvere da sparo e sentimmo distintamente i colpi delle armi da fuoco. Poi
portarono fuori un uomo. Era disteso su una coperta, perdeva sangue (era il
maresciallo Rinaldo Benà, ferito a un occhio da un proiettile, ndr). I suoi
colleghi ci dissero di chiamare un’ambulanza. Poi tutto finì e per un giorno
intero fummo “prigionieri” nelle nostre case. Vennero Dalla Chiesa e altri pezzi
grossi. Non potevamo uscire, ci dicevano ch’era meglio non vedere. L’odore del
sangue era pungente e invadeva tutto il palazzo».
BRIVIDI. Gli inquilini del
civico 12 seppero che quell’appartamento al primo piano era un covo di
brigatisti solo un paio di giorni dopo l’irruzione dei carabinieri. «Un militare
venne nella mia casa - dice una condomina -. Mi chiese se poteva fare una
telefonata. Chiamò la moglie, rassicurandola: “Tutto bene, amore. Sto bene, non
preoccuparti”. Mi fece effetto, gli offrii un caffè ma quello rifiutò,
spiegando: “Devo calmarmi, allentare la tensione. Signora - ammise passandosi
una mano sul cuore - se non fossimo stati così lesti, noi, voi e loro saremmo
tutti quanti saltati per aria”. Compresi che non si trattava di criminali
comuni, ma di gente pronta a tutto. E oggi, a distanza di ventiquattro anni,
ripensando a quelle parole, mi vengono ancora i brividi». Simone Traverso
L’INTERVISTA. PARLA UN
BRIGATISTA CONDANNATO PER ATTENTATI A GENOVA: «Ecco cosa sapevano i
carabinieri», scrive Matteo Indice. Adriano Duglio: «Ma queste foto rischiano di
esasperare ancora gli animi» Dice che davanti alle pagine del Mercantile ha
sgranato gli occhi: «Sono uscito di casa ieri mattina verso le undici, ho preso
il giornale e ho avuto come una fitta allo stomaco». Adriano Duglio, 51 anni -
oggi vive a Bogliasco dove gestisce un circolo ricreativo - ha fatto parte della
colonna genovese delle Brigate Rosse. Arrestato nell’80 dopo le rivelazioni di
un pentito, è stato successivamente processato e condannato a undici anni di
carcere: tra le azioni a cui ha preso parte anche l’assassinio del commissario
capo di polizia, Antonio Esposito, ucciso su un bus in via Pisa, ad Albaro. -
Allora Duglio, che effetto fanno queste foto, ventiquattro anni dopo?
«Terribile, lo dico chiaramente. Ho provato a sfogliare un po’ il quotidiano, ma
poi mi sono come bloccato e vorrei sapere innanzitutto se i tempi di questa
pubblicazione sono casuali». - Perché? «Perché la situazione politica è in
fermento, tra poco ci sono le elezioni europee e servizi del genere creano
tensione». - In che senso? «Nel senso che rischiano di estremizzare le posizioni
contrapposte. Mi spiego meglio: chi è orientato a destra, non farà altro che
pensare “hanno fatto bene a ridurli così”. Dall’altra parte, i giovani dei
centri sociali o del movimento potrebbero interpretare la brutalità del blitz in
via Fracchia come una specie di provocazione lanciata con molti anni di ritardo,
non so...». - Ma non credi che questo materiale costituisca uno straordinario
documento storico, e contribuisca a chiarire la dinamica di un’azione oscura
fornendo al contempo un monito per non ripiombare nel buio? «Perdonatemi, ma non
credo che sulla cosiddetta dinamica ci fosse molto da scoprire. Leggo oggi
un’intervista a Giuliano Zincone che parla di “esecuzione”. Ebbene, la condivido
in tutto e per tutto, anche perché le informazioni in mio possesso sono
abbastanza precise». - Ovvero? «Sappiamo che i carabinieri arrivarono a Oregina
grazie alle dichiarazioni del pentito Patrizio Peci. Per quanto ne so io, Peci
aveva accesso al covo e pure le chiavi, dato che lassù si tenevano le riunioni
della direzione strategica. Non credo le avesse tenute per sé...Inoltre,
pregherei di osservare la posizione delle mani nell’immagine che ritrae i
quattro cadaveri in fila nel corridoio. E’ come se i morti fossero caduti mentre
le tenevano dietro la testa, pronti ad arrendersi». - Quanti brigatisti
conoscevi di quelli uccisi? «Con Riccardo Dura avevamo partecipato ad alcune
azioni, lo conoscevo bene. Betassa e Panciarelli non li avevo mai visti,
Annamaria Ludman l’avevo incrociata di sfuggita alla facoltà di Magistero, dove
lavoravo, ma non avevamo mai avuto contatti all’interno dell’organizzazione». -
Sapevi del covo di via Fracchia? «Quando ci fu l’irruzione io ero già fuori
dalle Br da almeno due anni. Però, appena appresa la notizia non ebbi dubbi su
com’era andata: le Brigate Rosse dovevano pagare l’uccisione dei carabinieri a
Sampierdarena, l’attentato del 21 novembre 1979 nel quale morirono il
maresciallo Vittorio Battaglini e il militare Mario Tosa. Non dimentichiamo che
in quell’episodio erano stati coinvolti terroristi poi pentiti, i quali
misteriosamente non hanno mai pagato con un giorno di carcere. D’altronde, la
guerra era stata scatenata con l’uccisione di Mara alla Cascina Spiotta
(Margherita Cagol, detta “Mara” e moglie di Renato Curcio, morì in un conflitto
a fuoco con i carabinieri il 5 giugno 1975 ad Arzello d’Acqui, durante il
sequestro dell’imprenditore Vallarino Gancia)». - Concludendo secco: che effetto
può sortire, nel più ampio dibattito sugli anni di piombo, la diffusione delle
foto finora inedite? «Sono solo un pezzo di verità. Ma per fare chiarezza
davvero, i protagonisti di allora dovrebbero, in senso figurato, sedersi intorno
a un tavolo e confrontarsi sul serio. E tutti, ma proprio tutti, dire quello che
ancora non hanno avuto il coraggio di dire, non solo sul terrorismo». - Non
solo? «Perché invece di rievocare fatti oscuri risalenti a decine di anni fa non
ci concentriamo su eventi più freschi, sfoderando documenti importanti? Penso al
g8, e a tutto quello che si è taciuto sulla repressione di polizia e
carabinieri. Lì sì che ci sono cose da scoprire». Ma questa, per ora, è un’altra
storia. Matteo Indice
Il più veloce a uscire nel
corridoio al momento dell’irruzione, scrive Andrea Ferro. IL GIORNALISTA RICORDA
L’INTERVISTA AL GENERALE SU VIA FRACCHIA. Bocca: «Dalla Chiesa mi fece
capire...» «Intervistai il generale Dalla Chiesa alcuni mesi dopo il blitz per
il mio libro “Noi terroristi”. Gli chiesi: “Ai quattro brigatisti fu data la
possibilità di arrendersi o furono uccisi subito?”. Non mi disse chiaramente che
li avevano ammazzati ma il tono usato per parlare rivelava intransigenza,
durezza. Per me, al di là delle parole, non andò come era stato raccontato nella
versione ufficiale». Giorgio Bocca sfoglia i ricordi della memoria di un’epoca
con la chiarezza del linguaggio e le frasi nette, precise, del testimone.
Raccontò le Brigate Rosse da grande inviato e da scrittore. Ha studiato i
fenomeni dell’eversione scandagliando nella vita dei protagonisti e delle
vittime e tra le pieghe di una società sulla quale attecchì l’odio di classe
fino a sbocciare nel piombo. «Non era la prima volta che il generale Dalla
Chiesa aveva usato un certo metodo militare. Ricordo la rivolta nel carcere di
Alessandria (il maggio del ’74). Fu stroncata dagli uomini dei reparti di Dalla
Chiesa, ci furono morti e feriti. Il generale aveva ordinato ai suoi di
sparare». Ma quale fu la prima sensazione dopo la notizia del sanguinoso blitz
di via Fracchia? «Mi fece impressione il fatto che dentro quella casa ci fossero
i cadaveri di due operai torinesi della Fiat (Lorenzo Betassa e Piero
Panciarelli, ndr). Fino a quel momento credevo di trovarmi di fronte ad un
terrorismo strutturato su base locale, a brigatisti legati alla loro fabbrica,
alla loro città. Fu invece il segnale che il terrorismo era in crescita, si
ramificava sul territorio». L’altro segnale, quella mattina, venne dallo Stato.
«Sì, lo Stato diceva: “Ora in guerra ci siamo anche noi”. Un messaggio
chiarissimo: “Adesso possiamo condurre la lotta senza fare prigionieri”». E lo
Stato da questo momento poteva contare su un’arma in più: i pentiti. Infatti fu
Peci a rivelare l’indirizzo di via Fracchia ai carabinieri. «Sui pentiti Moretti
sostiene una tesi politica. Cioè che furono la conseguenza e non la causa della
fine delle Brigate rosse. Cioè segnarono il fallimento di un progetto politico
più che militare». Si sostiene che i quattro brigatisti morti valevano un monito
per tutti gli altri. Della serie arrendetevi, altrimenti farete la stessa fine.
«E’ discutibile. Quando la repressione arriva a questi punti le reazioni possono
essere anche di segno opposto. Soprattutto quando il senso di ribellismo è già
alto» Che ricordo ha di Genova in quegli anni? «Certamente all’epoca in città
c’era un terreno fertile per i terroristi che ebbero un forte impatto sul
proletariato. Ma non mi riferisco solo al periodo delle Brigate Rosse. Già anni
prima dell’esplosione del terrorismo partecipai a Genova ad alcuni riunioni di
ex partigiani. E c’era già chi teorizzava il ritorno alla lotta armata». E le
ultime leve dei brigatisti? «Sono penosi. Hanno sparato a due uomini indifesi
dopo indagini durate mesi, pedinamenti infiniti». Proprio come facevano le
vecchie Br... «Allora correvano molti più rischi sotto il profilo militare». Ma
oggi esistono le condizioni per una nuova stagione di piombo? «Questi fenomeni
hanno un’evoluzione misteriosa. Le Brigate rosse si affermarono negli anni
Settanta quando la fase più dura della lotta di classe era stata superata. Oggi
stiamo entrando in una nuova fase di conflittualità sociale. Ma non mi sento di
fare pronostici». [Andrea Ferro]
Giorgio Bocca ha studiato il
fenomeno del terrorismo in Italia tra gli anni ’70 e ’80, scrive Andrea Ferro.
Nell’irruzione di via Fracchia, sostiene, venne adottato il metodo militare I
corpi del quattro terroristi nell’appartamento di via Fracchia Il corpo di
Riccardo Dura è il primo nella fila di cadaveri che si allunga nel corridoio
dell’appartamento diventato la fossa comune della colonna genovese delle Brigate
rosse dopo l’irruzione dei carabinieri e il conflitto a fuoco. Il cadavere è in
posizione prona. Le gambe si allungano nel corridoio mentre dalla vita in su il
corpo occupa una porzione del pavimento del corridoio. Dalla foto che
pubblichiamo oggi si evince che Dura sarebbe stato il primo ad andare incontro
ai carabinieri. E’ scalzo, non ha pantaloni, indossa slip e maglietta. Questa la
probabile sequenza degli ultimi suoi istanti di vita. Quando i carabinieri
sfondano la porta, è il primo ad alzarsi dal letto. Presumibilmente era uno dei
tre a dormire nella stanza, il quarto (quasi sicuramente Betassa) riposava in un
sacco a pelo trovato nel salotto. I due vani sono in fondo al corridoio. Dura si
affaccia nell’ingresso, o più probabilmente), si ripara dietro la porta che
(forse) chiude di scatto (altre foto mostrano numerosi fori di proiettile di
medio e grosso calibro). E’ armato? Accanto al cadavere non c’è alcuna pistola
(come documentano altre foto del dossier pubblicato in esclusiva dal “Corriere
Mercantile”). Le armi saranno infatti “repertate” sul pavimento accanto ai corpi
di Panciarelli (il secondo) e Betassa (il quarto).
IL CARABINIERE FERITO - Il
cadavere è lontano un paio di metri dalla macchia di sangue contrassegnata dalla
lettera A (vedi almtra foto). Il cartellino indica il punto nel quale il
maresciallo Rinaldo Benà rimase ferito al volto (perderà un occhio). Ma al di là
del fatto che nessuna arma è stata trovata accanto al cadavere di Dura non si
può escludere che possa essere stato lui stesso a sparare. La pistola sarebbe
successivamente scivolata verso il centro del corridoio. Un’ipotesi, precisiamo.
All’epoca qualcuno avanzò il sospetto che in realtà Benà sarebbe stato ferito da
“fuoco amico” (cioè dai suoi colleghi) anche se la successiva perizia balistica
confermò la versione diramata nei giorni successi dalla Procura con un
comunicato ufficiale. Tornando alla foto dell’ingresso si evince che l’unica
macchia di sangue è quella riferibile al ferimento di Benà. Per il resto la
parte del pavimento vicina alla porta d’ingresso è “pulita”. Significa che
nessuno dei brigatisti è mai arrivato fin lì, tantomeno vi era appostato nel
corso della notte per il “turno di guardia” (come ipotizzavano alcune cronache
dell’epoca).
FERITE ALLA TESTA - La macchia
di sangue inizia in corrispondenza della testa e si estende, allargandosi, per
almeno un metro (prosegue oltre il margine della foto). Riccardo Dura è stato
raggiunto alla testa presumibilmente a distanza piuttosto ravvicinata da più
colpi. Ingrandendo al computer la foto scopriamo che vicino all’angolo formato
dal muro d’ingresso con la mini parete di sostegno della porta del corridoio ci
sono tre bossoli esplosi da un’automatica di medio calibro. Tra il gomito destro
e la parete dell’ingresso spunta un ombrello pieghevole.
“ROBERTO” - E’ il nome di
battaglia di Riccardo Dura. La sua storia. Nasce a Roccalumera, in provincia di
Messina, il 12 settembre 1950. Si trasferisce a Genova giovanissimo. Nel ’66
viene iscritto al “Garaventa”, la nave-scuola per ragazzi in difficoltà. Dopo il
Militare in Marina Riccardo Dura si imbarca sui mercantili, “di coperta”.
Successivamente, è il ’71, lavora per alcune ditte che operano in appalto
all’interno dell’“Italsider” di Cornigliano. In quegli anni inizia la sua
militanza in Lotta Continua fino ad approdare alle Brigate rosse.
GLI OMICIDI - “Roberto” venne
indicato dai pentiti come uno dei killer più spietati delle Brigate Rosse. E’
ritenuto l’esecutore materiale dell’assassinio del commissario capo della
polizia, Antonio Esposito (ex funzionario dell’Antiterrorismo e all’epoca
dirigente del commissariato di Nervi), ucciso il 21 giugno del 1978 su un bus
della linea “15”. Secondo la ricostruzione dei giudici fu sempre Dura a sparare
e uccidere Guido Rossa, l’operaio e sindacalista, freddato sulla sua “Fiat 850”
il 24 gennaio del ’79 in via Fracchia, a duecento metri dal covo. Il nome di
Dura compare poi agli atti dei processi per gli agguati ai carabinieri Vittorio
Battaglini e Mario Tosa, freddati il 21 novembre del ’79 al bar “Da Nino” di via
G. B. Monti, a Sampierdarena. E sempre Dura fece parte del commando che il 25
gennaio dell’80 in via Riboli (Albaro) sparò contro un’altra auto dei
carabinieri. Sotto il piombo brigatista morirono il colonnello Emanuele
Tuttobene e l’appuntato Antonino Casu. Nell’agguato rimase gravemente ferito il
colonnello dell’Esercito Luigi Ramundo. ANDREA FERRO
Guagliardo: «Strage decisa per
spingere al pentitismo» Dal libro “Sguardi Ritrovati” della collana Progetto
Memoria edito da “Sensibili alle foglie” pubblichiamo la testimonianza scritta
nel 1994 dal carcere di Opera, Vincenzo Guagliardo, esponente della colonna
genovese delle Br. «Non è facile ricordare Riccardo in poche parole, dato il
modo in cui morì, le cose che allora su di lui stampa e pentiti dovettero
inventare per giustificare la strage e sbiadirne il senso all’opinione pubblica,
e l’amarezza rabbiosa che tutto questo suscitò in quelli come me. La strage di
via Fracchia non fu affatto, come disse a caldo un primo comunicato delle Br in
preda all’emozione, il risultato di uno scontro, ma una fredda esecuzione
comandata dal generale dei CC Dalla Chiesa per ottenere – credo –, a partire
dalla delazione di Patrizio Peci, l’inizio della politica del “pentitismo”.
Riccardo ed io ci chiamavano “compari” per ironizzare sulla nostra comune
origine siciliana. Quando dovevamo incontrarci in questa o quella città, quello
di noi che combinava l’incontro cercava il posto migliore dove pranzare assieme
come meglio potesse piacere all’altro, nell’ambito del possibile. Credo che in
cuor suo individuasse, giustamente, la solitudine umana come il grande nemico,
come la più grave contraddizione di questa società. Per lui dunque la militanza
brigatista diventava una condizione totale in cui si faceva quel che era
“giusto”; e poi si sarebbe visto come andava a finire... Come un nuovo Pisacane,
vedeva le Br come un piccolo reparto delle masse oppresse che cominciava a fare
la sua parte nel comune destino. Io ero più “politico”, individuavo me e lui in
una comunità più vasta e contraddittoria delle Br, e citando Mao dicevo che il
nostro cammino era un governo della contraddizione all’interno di questa più
sconfinata realtà. Alla fine però, convenivo con lui che personalmente non
sapevamo quanto noi avremmo visto, quanto sarebbe durata. Insomma, dopo lunghe
discussioni trovavamo sempre l’accordo. Il paradosso brigatista era proprio
questo: che in esso era sempre possibile la convergenza finale di esperienze
umane diverse. In quella dimensione, come sappiamo, quella potente allusione a
una superiore e vivace concordia è stata confitta, ha incontrato dei limiti.
Dove e come far rivivere questa convergenza delle singole esperienze umane in
nuove dimensioni è quello che si vedrà. Esse comunque richiedono un cammino che
ha bisogno di verità: a partire dal passato.
Lorenzo Betassa e Piero
Panciarelli, i “bierre” venuti da Torino Il corpo di Lorenzo Betassa è in fondo
al corridoio, scrive Andrea Ferro. Era l’unico dei quattro che al momento del
blitz dei carabinieri era vestito. Presumibilmente riposava nella sala da
pranzo, in un sacco a pelo disteso sul pavimento, accanto al divano (le altre
foto del covo scattate negli altri vani saranno pubblicate sull’edizione in
edicola domani). C’è un particolare che escluderebbe, almeno secondo la
ricostruzione più verosimile, l’ipotesi che Betassa fosse di guardia. I
mocassini sono slacciati, è senza calze: addosso ha una sola scarpa, l’altra è
scivolata sul pavimento all’interno della camera da letto. E’ più probabile che
dopo aver avvertito i primi rumori sospetti Betassa abbia frettolosamente
indossato i mocassini a mo’ di ciabatte. Tra il piede e la scarpa c’è una
pistola di medio calibro dalla quale (secondo la perizia balistica) sarebbero
partiti alcuni colpi.
IL SANGUE - E’ l’unico
cadavere in posizione supina, la testa è piegata sulla destra in una pozza di
sangue. Oltre a quella, mortale, alla testa lungo il corpo non si riscontrano
altre ferite o tracce ematiche. Al polso sinistro porta un orologio. Pur
ingrandendo l’immagine non si riesce a leggere sul quadrante l’ora che segna
(nella foto del cadavere di Annamaria Ludman pubblicata giovedì l’orologio segna
le due e quarantadue).
UN ALTRO CADAVERE - E’ di
Piero Panciarelli. Il corpo è in posizione prona, lungo il corridoio tra i
cadaveri di Riccardo Dura e di Annamaria Ludman. Anche in questo caso la macchia
di sangue si estende vicino alla testa e “scende” fino alla parte alta del
torace. La freccia indica il “cane” della pistola che, presumibilmente, ha usato
per sparare contro i carabinieri. Come Dura (si evince da altre foto) è scalzo,
indossa una canottiera e un paio di slip. Evidentemente stavano dormendo quando
i carabinieri hanno sfondato la porta.
LA LORO STORIA - Lorenzo
Betassa nasce a Torino il 30 marzo 1952. Frequenta le scuole Medie a Torino e
fino al ’69 lavora come operaio alla Italimpianti e successivamente è assunto
alla Fiat (sezione Carrozzerie) diventando anche rappresentante sindacale per la
Fim-Cisl. La sua militanza politica inizia in Potere Operaio. Poi passa alle
Brigate rosse ma gli inquirenti scopriranno la sua militanza solo dopo il blitz
di via Fracchia. “Antonio” era il suo nome di battaglia. Piero Panciarelli nasce
a Torino il 29 agosto 1955. Dopo il diploma di Scuola Media è assunto come
operaio alla “Lancia” di Chivasso. Rispetto a Betassa era conosciuto dalle
Sezioni antiterrorismo di polizia e carabinieri già prima dell’irruzione in via
Fracchia nell’ambito di una serie di indagini condotte tra militanti e
fiancheggiatori della colonna torinese delle Br. Nel maggio del ’78 entra in
clandestinità. Il nome di Panciarelli (“Pasquale”) compare in più inchieste dei
giudici genovesi per fatti di sangue avvenuti all’ombra della Lanterna. Insieme
a Riccardo Dura avrebbe preso parte all’assassinio dei carabinieri Vittorio
Battaglini e Mario Tosa freddati al bar “Da Nino” di via G.B. Monti a
Sampierdarena il 21 novembre del ’79. Panciarelli è indicato anche come uno
degli autori dell’attentato contro la sede della Finligure, compiuto il 14
giugno del 1979. Andrea Ferro.
“Antonio”, il terrorista che
somigliava a Battisti Il ricordo di Lorenzo Betassa (nome di battaglia Antonio)
tratto da Testimonianze al Progetto memoria - Ernesto Amato, Torino 1994,
pubblicato su “Sguardi Ritrovati”, casa editrice “Sensibili alle Foglie”. «L’ho
conosciuto in fabbrica nel 1973, siamo diventati amici, molto amici, ho
conservato in tutti questi anni un ricordo vivo di lui, della sua grande
generosità, giovialità e disponibilità umana... In fabbrica lo chiamavano
“Lucio” a causa dei suoi capelli crespi e lunghi a cespuglio che lo rendevano
simile a Lucio Battisti; la sua militanza politica non è mai stata di quelle
finalizzate ad emergere sugli altri, il suo rapporto con i compagni di lavoro
era di assoluta normalità e cordialità, oppure di giusta contrapposizione
qualora ne sussistessero i motivi. Fare politica per Lorenzo significava vivere
la vita di tutti i giorni in mezzo agli altri, cogliendo le contraddizioni e
cercando una strada per migliorare le proprie condizioni e quelle degli altri.
Mi ricordo che ai picchetti eravamo quasi sempre i primi ad arrivare, ci si
trovava ai cancelli arrivando da strade diverse, quasi sempre erano le 2 o le 3
del mattino e le porte erano quasi sempre quelle degli impiegati. La sua scelta
politica l’ha fatta in piena libertà e convinzione, facendola soprattutto per
sé, infatti mi ricordo una sua frase ricorrente, mi diceva: “Caro Ernesto, la
rivoluzione va fatta innanzitutto per noi stessi e di conseguenza per gli altri,
devi rivoluzionare prima al tuo interno ciò che non ti va e poi fuori...” Non
credo comunque che avesse preventivato, nelle sue scelte, una fine così cruenta.
La sua semplicità, il suo atteggiamento “normale” lo avvicinano molto agli
altri... «È sparito dalla fabbrica e dalla vita civile alla fine del 1979 e solo
alcuni mesi più tardi è stato ucciso, quindi ha fatto una breve militanza da
clandestino; sinceramente, conoscendolo bene, non credo che quel ruolo da
“regolare” si confacesse molto al suo carattere e alla sua personalità, anche in
termini di rinunce. Al suo funerale eravamo in molti, grande era la rabbia, la
commozione, il senso d’impotenza, l’angoscia. Fummo tutti, per quanto possibile,
vicino alla famiglia che, come tutti noi, vide arrivare la bara chiusa e
sigillata; questo rese faticoso prendere coscienza della morte di Lorenzo. A me
successe, poi, diverse volte, di vedere, per strada, delle persone che gli
assomigliavano e cercare di avvicinarle per vedere se era lui o meno.
IL RICORDO DI UN AMICO CHE POI
LO AVEVA RITROVATO IN UN’ORGANIZZAZIONE EXTRAPARLAMENTARE. «Pasquale, con lui
quanti concerti» Il ricordo di Piero Panciarelli (nome di battaglia Pasquale)
tratto da un brano scritto da un amico e pubblicato su “Sguardi Ritrovati”,
Progetto Memoria, casa editrice “Sensibili alle foglie”. «O dalla cantina si
partiva per i concerti di allora (’70-’73) con il minimo necessario per la
“sopravvivenza” e via a prenderci quello che ritenevamo nostro e di tutti, la
musica come espressione di un certo linguaggio ed immaginario collettivo. E
quanti stratagemmi (anche scontri) per riuscire nell’obiettivo. Non voleva
essere “padrone” né avere “padroni” di nessun tipo e non voleva che gli
rubassero il tempo di vivere e il suo spazio. Quando ci incontrammo nella stessa
organizzazione, dopo un periodo che si erano percorse strade diverse, esperienze
diverse, ci sentimmo particolarmente ed intensamente emozionati e ricordo una
sua curiosissima espressione di gioia per esserci ritrovati nuovamente. Era
fatto così! E l’ultima volta che ci siamo incontrati in quartiere, anche come
militanti, sapendo che poteva succedere che non ci saremmo più visti, decise che
dovevamo salutarci a modo nostro, con i nostri riti... Piero è sepolto nel
cimitero di Staglieno a Genova, vicino a un gruppo di alberi e così capitando in
quella città, quando non mi fermo da lui, osservo da lontano gli alberi e lo
saluto a modo nostro».
IL RICORDO DI MORETTI:
«SCRISSI IL VOLANTINO IN UNA CASA DI SAMPIERDARENA». Mario Moretti fu l’ultimo
leader indiscusso delle Brigate rosse. Alla guida dell’organizzazione sostituì
Curcio e Franceschini dopo la loro cattura. Gestì l’operazione Moro, interrogò
il presidente delle Dc nei 55 giorni del sequestro, lo fulminò col colpo di
grazia prima di far ritrovare il cadavere nello statista in via Caetani. Fu
arrestato il 4 aprile dell’81 alla stazione “Centrale” di Milano insieme a
Enrico Fenzi, genovese, “il professore”, e altri due militanti delle Br. In
“Brigate Rosse una storia italiana”, intervista di Carla Mosca e Rossana
Rossana, Milano 1994, Anabasi Editore, Mario Moretti ricorda così Riccardo Dura.
«Ho scritto il volantino per commemorare quei nostri quattro morti, in una casa
di Sampierdarena Oregina, Ndr), dove abitava una compagna operaia e una sua
figlia, allora diciottenne. Eravamo in tre generazioni intorno a quel tavolo e
certo per la mente ci passavano cose diverse, a mala pena saprei dire quello che
passava nella mia. Ma dovevamo avere qualcosa di molto forte in comune per stare
tutti e tre a guardare in faccia la morte di quattro che sentivamo come
fratelli. «Un dolore terribile, che non vogliamo neppure che si veda. “Mia
figeû, semo ne ’a bratta, ma u sciû Costa ha già pagoû” (Senti, noi siamo nella
merda fino a collo, ma il signor Costa ha già pagato), avrebbe detto Roberto, un
marinaio comunista come ne ho conosciuti tre nella vita, che dopo l’azione Costa
ci ripeteva questo tormentone ogni volta che ci trovavamo nei guai. Lo immagino
anche stavolta».
VIAGGIO NELL’APPARTAMENTO
ALL’INTERNO 1 DEL CIVICO 12 DI VIA FRACCHIA. Nella “casa dei fantasmi” Il covo
delle Br è uguale a 24 anni fa, ma con un dobermann in più, scrive Simone
Traverso. Entrare nell’appartamento che fu il covo delle Brigate Rosse a Genova
è come fare un salto indietro nella storia. Negli angoli dell’appartamento dove
si consumò il blitz dei carabinieri del generale Dalla Chiesa, tra quelle pareti
oggi linde si respira l’aria di un dramma, si percepisce il peso di un’epoca
insanguinata. Eppure c’è una signora che da ventun’anni vive in quella stessa
casa, dorme nella stanza che ospitò Lorenzo Betassa, Piero Panciarelli, Riccardo
Dura e Annamaria Ludman, pranza lì dove i brigatisti consumarono la loro ultima
cena, ripone le bevande e i cibi della spesa nello sgabuzzino che i militanti
usavano come laboratorio fotografico. «Nessun timore reverenziale, nessuna paura
dei fantasmi, quella storia è acqua passata». La donna che abita l’ex covo
chiede di restare anonima, ma ammette: «Nel mio appartamento nulla o quasi è
cambiato dal 1980. E’ stato abbattuto un muro, ma un altro è stato innalzato. Il
giardino è tale e quale, alle pareti è stata solo modificata la tinta. Il
sangue? I fori di proiettile? Quando ho acquistato la casa era tutto sparito».
Eppure la forza della storia è ancora percepibile e colpisce duro, proprio come
le fotografie pubblicate dal Corriere Mercantile in esclusiva.
LA TRATTATIVA. La donna che
oggi vive all’interno 1 del civico 12 di via Fracchia acquistò l’appartamento
tre anni dopo l’irruzione dei reparti speciali Antiterrorismo. «Trattammo con la
signora Ludman, Zora - dice oggi - ma non sapevamo cosa fosse accaduto, tant’è
che cademmo dalle nuvole quando ci rivelarono di quel dramma. Ero incinta e non
volli sapere nulla, per non subire traumi. Le foto? Be’, oggi posso anche
guardarle, ma allora mi sarei rifiutata». Non manca il dettaglio curioso,
colorito, per quanto drammaticamente allucinante: «La proprietaria era convinta
che sapessimo, che fossimo al corrente del blitz delle teste di cuoio. Ci disse
che volevamo “tirare sul prezzo”, che “volevamo approfittare della disgrazia”
capitata alla figlia. Quando finalmente ci dissero la verità decidemmo
ugualmente di acquistare l’abitazione». Nonostante chi condusse le trattative
non fu del tutto corretto, almeno secondo l’attuale proprietaria: «Ci spiegarono
che il covo fu scoperto cinque anni prima, invece erano passati soltanto tre
anni... chissà, magari fu un errore in buona fede».
LA MALASORTE. Prendere
possesso di quell’alloggio signorile non fu comunque facile. «Dovemmo vincere
anche l’“ostruzionismo” di mia suocera - racconta la proprietaria -. Diceva che
portava iella abitare nella casa dov’erano morte delle persone, quasi che i
fantasmi potessero perseguitarci. Non so se sono stata fortunata o colpita dalla
malasorte, ma io avevo bisogno di quell’appartamento. La mia famiglia cresceva,
avevamo bisogno di spazi e di un giardino, pur non allontanandoci troppo dal
quartiere dov’eravamo cresciuti. L’ex covo delle Br era l’abitazione giusta e
poco importa cosa avvenne prima lì dentro».
I FIORI. I primi anni di
convivenza con la Storia non furono però facili. «A marzo, in prossimità
dell’anniversario del blitz, veniva sempre un poliziotto. Il 27 marzo 1983 un
agente mi disse: “Domani signora non esca di casa, resti qui, al sicuro. Forse
verrà qualcuno a deporre dei fiori... usano fare così. Nel caso, non faccia
nulla, non apra la porta”. Non accadde nulla e col passare degli anni fu facile
dimenticare anche quei frammenti».
IL CORRIDOIO. A distanza di
ventiquattro anni, comunque, il corridoio dove i brigatisti trovarono la morte è
sempre lo stesso: «Il pavimento è identico, le pareti sono state ripulite, i
fori delle pallottole tappate. Non si vede più nulla». La signora che oggi vive
in quelle stanze guarda alle foto del Corriere Mercantile e cerca di orientarsi.
«La porta dove è caduto il primo terrorista (Riccardo Dura, ndr.) non c’è più.
La donna (Annamaria Ludman, ndr.) sembra essere appena uscita dallo
sgabuzzino... quello è cambiato. Non c’è più la rientranza che faceva da
laboratorio fotografico, ma è più ampio, più spazioso.
IL SALOTTO. L’ultima camera in
fondo al corridoio, quella dove i brigatisti scrivevano a macchina e
trascorrevano, ore e ore a pensare ed elaborare testi, documenti e
rivendicazioni è l’unica ad essere stata stravolta. «C’era un arco, ora c’è una
parete. Il muro in fondo, invece è stato abbattuto per acquisire anche un paio
di cantine. Ora è una camera da letto». Lo era anche allora, almeno stando al
divano letto con sacco a pelo ritrovato dai carabinieri del generale Dalla
Chiesa la notte dell’irruzione.
IL GIARDINO. Lo spazio verde
all’esterno della casa oggi è curato, l’erba tagliata bassa, un tratto è
piastrellato e ricoperto da un gazebo. «Ho letto che la donna, la Ludman
prendeva il sole qui, in questo giardino. E che forse i brigatisti passavano da
qui per entrare in casa, così da non farsi vedere dagli altri condomini. Mi pare
francamente impossibile... non c’è modo di scendere dalla strada senza farsi
notare, senza contare che bisognerebbe fare un salto impressionante». In un
angolo del terrazzino spiccano i segnali che fanno intuire quanto i tempi siano
davvero cambiati per questa casa di fantasmi: una cuccia e una ciotola.
Appartengono a un dobermann alto così. Quello, ai tempi delle Br, non c’era. I
“mastini”, quelli dell’Antiterrorismo, erano fuori, pronti ad entrare nel covo e
cambiare la storia. Simone Traverso
PER LA PRIMA VOLTA L’UFFICIALE
DEI CARABINIERI CHE GUIDÒ IL BLITZ IN CUI VENNERO UCCISI I QUATTRO BRIGATISTI
RACCONTA. Riccio: «Spararono per primi» «Rispondemmo al fuoco, per tre minuti fu
l’inferno». Intervista di Andrea Ferro. Michele Riccio, 55 anni, è l’ufficiale
dei carabinieri che guidò il blitz. Dopo 24 anni racconta al “Corriere
Mercantile” come venne individuato il covo di via Fracchia e ricostruisce
minuziosamente tutte la fasi dell’irruzione nell’appartamento e del conflitto a
fuoco in cui rimasero uccisi i quattro brigatisti. Il colloquio (durato un’ora e
mezza) è avvenuto ieri mattina in un bar del centro. Riccio ha tenuto a
precisare che mai aveva rilasciato un’intervista-ricostruzione sui fatti di via
Fracchia. «Venimmo a sapere dell’esistenza di un covo in via Fracchia
quattro-cinque giorni prima dell’irruzione. Patrizio Peci (il primo grande
pentito delle Br, ndr.) aveva fornito elementi piuttosto vaghi. Aveva detto di
aver dormito una notte in quella casa, circa sette-otto mesi prima. Secondo le
sue rivelazioni l’abitazione era una sorta di “pensione” per terroristi
latitanti. L’intestataria ufficiale dell’appartamento era una donna abbastanza
giovane, della quale però non sapeva il nome. Dell’appartamento ricordava con
grande precisione che era situato al piano terra. Dell’indirizzo conosceva solo
la via, Fracchia appunto, ma non il numero del civico, tantomeno l’interno.
Insomma c’erano tre elementi dai quali partire: un appartamento al piano terra
di uno stabile di via Fracchia abitato da una donna, piuttosto giovane. Peci ci
fornì le chiavi? Falso. «All’epoca dipendevo dal tenente colonnello Nicolò Bozzo
(responsabile per il nord-Italia del reparto antiterrorismo di Dalla Chiesa). La
mia squadra era formata da dieci uomini. Il primo accertamento fu al catasto.
Sequestrammo tutte le piantine degli appartamenti situati ai piani bassi dei
caseggiati di via Fracchia. Le sottoponemmo all’attenzione di Peci.
Contemporaneamente mandai alcuni uomini per le strade della zona, a sentire la
gente. Ufficialmente dicevamo che eravamo sulle tracce di una gang di
trafficanti di droga. E per questo chiedevamo se attorno a via Fracchia qualcuno
aveva notato movimenti sospetti, facce strane. Ci rivolgemmo anche al parroco di
Oregina. Alcune vecchiette ci indicarono decine di sospetti, chiaramente
tossicodipendenti, sbandati. Noi immagazzinavamo tutti i dati, anche i più
insignificanti nella speranza di un’indicazione che potesse indirizzare la
nostra indagine. Patrizio Peci riconobbe l’appartamento da una piantina «Quando
non più di 48 ore dopo Peci riconobbe dalla piantina l’appartamento al 12
interno 1 arrivammo alla prima conferma importante. I vicini di casa dissero in
che quella casa abitava una donna sola e piuttosto giovane (Annamaria Ludman,
fino a quel momento completamente sconosciuta agli inquirenti, ndr.). E
aggiunsero: “Qualche tempo fa abbiamo notato un certo via via di persone, gente
perbene, tutti molto educati”. Informammo il generale Dalla Chiesa degli
sviluppi dell’indagine, ci sentivamo a buon punto. Lui ci ordinò di fare presto.
Il motivo era strettamente operativo. A Torino erano ormai pronti a far scattare
una serie di blitz nei covi e nelle basi della colonna locale. Peci aveva
fornito infatti elementi molto più precisi sulla colonna torinese, con
indirizzi, nomi, cognomi. L’operazione doveva quindi scattare simultaneamente
tra Genova e Torino. In sostanza ci aspettavano. Fosse stato per me avrei atteso
ancora qualche giorno, tenuto sotto osservazione la base con l’obiettivo di
raccogliere più elementi possibili per sviluppare le indagini sulla colonna
genovese. Invece da quel momento iniziò una corsa contro il tempo. Individuato
al novanta per cento il covo, bisognava capire quanta gente avremmo potuto
trovarci dentro. Pedinammo la donna per due giorni, ci appostammo intorno alla
casa ma non ricavammo indicazioni sul numero degli occupanti. Contemporaneamente
controllammo i consumi del gas e della luce, i contatori erano praticamente
fermi da giorni. Evidentemente i terroristi sapevano che potevano essere spiati
anche così e per questo limitavano al minimo indispensabile i consumi. Provammo
con la spazzatura. Per due sere bloccammo lo spazzino che ritirava i sacchetti
davanti alle porte. Quello dell’interno 1 era sempre piuttosto pieno, segno che
dentro la casa c’era vita, ma non trovammo tracce utili per quantificare il
numero degli abitanti. Il tempo era scaduto. «Il 27 marzo insieme ad altri
uomini della “squadra” cenai a casa del maresciallo Rinaldo Benà, l’anziano del
gruppo (rimarrà ferito nel conflitto a fuoco, ndr.), nella abitazione casa di
San Fruttuoso. In serata il tenente colonnello Bozzo convocò una riunione in
caserma, in via Ippolito D’Aste. Bisognava decidere quando e come intervenire,
Dalla Chiesa non voleva più aspettare. Io ero per farlo la mattina successiva:
“Aspettiamo che esca la donna, la fermiamo, saliamo in casa con lei”, suggerii.
Ma da Torino il generale non fu d’accordo. E ordinò: “Alle 4”. Il colonnello
Bozzo informò il prefetto e le altre autorità. Un’ora prima dell’ora x eravamo
già tutti in via Ippolito d’Aste. Noi dieci, più il personale del Nucleo
operativo, altri del comando di Torino ma anche carabinieri in divisa. L’azione
fu studiata così. Il tenente colonnello Bozzo rimaneva nella sala operativa per
coordinare i collegamenti. Le “gazzelle” dovevano essere posizionate a qualche
centinaio di metri. Il personale in divisa sarebbe intervenuto per
tranquillizzare la popolazione se qualcuno degli abitanti della zona si fosse
allarmato di fronte a tutti quegli uomini in Michele Riccio, l’ufficiale dei
carabinieri che guidò il blitz Rinaldo Benà, il maresciallo rimasto ferito nel
conflitto a fuoco. Colpito alla testa, resterà a lungo in ospedale e perderà un
occhio I corpi dei quattro brigatisti nel corridoio dell’appartamento-covo Il
sangue di Benà sul pavimento dell’ingresso La borsa con le armi per un nuovo
agguato borghese, armati, con il rischio di scatenare il panico. Attorno alla
casa varie squadre in borghese. Poi noi. Per entrare nel portone giocammo sulla
complicità della signora anziana che abitava al piano di sopra. Le
preannunciammo il nostro blitz facendole credere che sarebbe stata un’operazione
antidroga. Le chiedemmo di tenersi pronta ad aprirci, nel cuore della notte, non
appena avesse sentito suonare il citofono. «Ci presentammo nel portone in sei.
Suonammo, la signora ci aprì subito. Eccoci nelle scale. Rispetto agli altri
avevo il giubbotto antiproiettile ma non il casco perché mi avrebbe impedito di
percepire i rumori. A quel punto ci dividemmo in due gruppi. Tre davanti, tre
dietro. In prima fila io, Benà e un altro maresciallo. Imbracciavo un fucile a
pompa, gli altri avevano i mitra. Salimmo una breve rampa di scale,
l’appartamento era situato ad un piano rialzato. La porta, non blindata, era
chiusa con tre serrature. Per l’epoca era un po’ strano. «Suonai il campanello
“Aprite, è una perquisizione”» «Suonai il campanello. “Carabinieri, aprite, è
una perquisizione”, ordinai. Dall’interno sentimmo dei passi, pensammo che
qualcuno ci avrebbe aperto. Invece chi si avvicinò diede altri giri alla
serratura. Allora impartii a Benà e all’altro maresciallo l’ordine di sfondare
la porta. Non usammo alcun attrezzo, lo fecero a calci, portavano stivaloni. Una
volta saltata la serratura ci trovammo di fronte ad una spessa tenda nera, da
cinema che ci coprì subito la visuale dell’ingresso. La spostammo subito,
all’interno iniziò a filtrare la luce delle scale. “Arrendetevi”, gridai. Benà
sollevò la visiera del casco, era appannata dal sudore. Fu un attimo. Sentiì gli
spari, poi vidi il maresciallo Benà cadere all’indietro, lentamente come al
rallentatore. In quegli attimi ribollirono nella mia testa paura e stupore. Per
il mio uomo ferito e per la reazione di chi si trovava nella casa. Mi sembrò
incredibile che qualcuno pensasse di ingaggiare un conflitto a fuoco all’interno
di un piccolo appartamento. Benà cadde sul pavimento al centro dell’ingresso, a
mezzo metro dalle mie gambe. Ricordo ancora il getto di sangue alto un metro che
saliva dalla sua testa. Nonostante fosse stato colpito (il proiettile gli
perforò un occhio, ndr.) riusciva ancora a muovere la mano, come per tastare il
pavimento, e a parlare. Ricordo le sue parole: “Dov’è il mitra? Non mi sono
fatto niente, non dite niente a mia moglie”. Nel frattempo sparai col fucile a
pompa, cinque colpi in rapida sequenza. Gli altri due colleghi avevano armi
caricate con più proiettili. Iniziò l’inferno. Dal pianerottolo i tre uomini del
secondo gruppo balzarono all’interno della casa e iniziarono a sparare pure
loro. Uno me lo ritrovai alle spalle, disteso sul pavimento, le raffiche
sfioravano le mie gambe. Tutto avveniva alla luce solo di una torcia imbracciata
da un sottufficiale: noi attestati nell’ingresso sul pavimento o accanto ai
muri, loro nel corridoio. Terrorizzato dagli spari, un maresciallo non più
giovanissimo che era appostato all’esterno del caseggiato fece fuoco in aria per
avvertire gli altri. Le radio portatili non funzionavano. I bossoli finirono in
giardino. Un altro del mio gruppo iniziò a gridare a quelli che erano fuori:
“Hanno colpito Benà, al capo”. La frase fu pronunciata balbettando, per la
concitazione il nome del maresciallo non fu afferrato. Mi raccontarono che i più
capirono che era stato colpito “il capo”, cioè io. «Sentii la voce di un
carabiniere “Attenti hanno una bomba”» «Dentro intanto si continuava a sparare.
Sparavano tutti, all’impazzata. Ad un certo punto gridai. “Venite avanti,
arrendetevi”. Sentì una voce. “Hanno una bomba”, era un mio uomo. Riprendemmo a
sparare, ricaricai un’altra volta il fucile a pompa. Un inferno, un inferno. «In
tutto, dall’esplosione del primo colpo, passarono tre minuti. I miei uomini
entrarono nel corridoio dove c’erano i corpi di quattro persone, una bomba a
mano, le pistole. Io mi precipitai al telefono. Saranno state le 4,35. Chiamai
la centrale: “Mandatemi subito un’ambulanza”. Bozzo mi rispose che aveva già
saputo, che l’ambulanza stava arrivando. Riattaccai e il telefono squillò subito
dopo. Dall’altro capo una voce maschile. Era Livio Baistrocchi, lo accertammo
successivamente: “Roberto (nome di battaglia di Riccardo Dura, ndr.), state
pronti, tra mezz’ora...”, disse. Pensava di parlare con Dura. Compresi che era
un messaggio, replicai: “No, vieni qui, ti aspettiamo”. Lui capì, riattaccò.
Baistrocchi infatti non cadde nella trappola. Scappò, è tuttora latitante.
Quella telefonata, anche questo lo stabilimmo dopo, era l’ultimo segnale prima
dell’agguato che i brigatisti avrebbero dovuto compiere all’alba. In fondo al
corridoio trovammo infatti una borsa contenente due mitra e due parrucche. Erano
pronti per un agguato contro un dirigente dell’Ansaldo. Il telefono squillò
ancora Era il generale Dalla Chiesa «Il telefono squillò ancora. Questa volta
era Dalla Chiesa. “So tutto, sto arrivando, dimmi cosa c’è”. Voleva sapere quali
documenti avevamo trovato. Mirava a quelli, obiettivo primario dell’operazione
era acquisire nuove informazioni. Gli risposi che dentro la casa c’erano dei
morti, che dovevamo ancora fare la perquisizione. Nell’appartamento, sangue
dappertutto. Entrai in cucina e iniziai a stilare il primo inventario del
materiale che i miei uomini di volta in volta mi portavano dalle stanze. Ordinai
che in casa non entrasse più nessuno. Ebbi il tempo di dare un’occhiata in
strada. C’erano lampeggianti azzurri, auto di servizio, uomini in divisa,
giornalisti, fotografi, un mare di gente. Diedi disposizione di allontanare
tutti con modi spicci, poliziotti compresi. Nessuno doveva avvicinarsi. «Il
sopralluogo dei magistrati non avvenne quattro giorno dopo (come è sempre stato
scritto, ndr.). Già in mattinata il dottor Di Noto (all’epoca sostituto
procuratore, ndr.) e un altro pubblico ministero entrarono nel covo. Rimanemmo
in via Fracchia fino a sera con il pensiero fisso rivolto a Benà e a sua moglie.
Avrei voluto essere al suo posto. Per un anno io e miei uomini ci alternammo a
passare le notti accanto a lui. E fummo costretti a fare pressioni affinché
ottenesse i giusti riconoscimenti. «Ho raccontato al “Corriere Mercantile” per
onore della verità. Mi permetta di aggiungere solo due considerazioni. Il
generale Dalla Chiesa è stato un capo eccezionale. Insieme a lui ho lavorato per
anni con abnegazione e grande fiducia reciproca. E pensando a via Fracchia
ricordo che ho eseguito un ordine, che non era certo quello di uccidere. Se si
fossero arresi sarebbe stato meglio per tutti. Anche per noi».
LE ARMI E IL MATERIALE
SEQUESTRATO DOPO L’IRRUZIONE DEGLI UOMINI DI DALLA CHIESA. Nella base l’arsenale
della colonna genovese. Ecco l’arsenale sequestrato il 28 marzo del 1980 nella
base brigatista di via Fracchia, scrive Andrea Ferro. L’elenco delle armi è
tratto dagli atti al processo istruito contro la colonna genovese delle Brigate
rosse. - due mitra Sterling cal. 9 para. matricola KR23161 e 21882 con
complessivi 4 caricatori; - un fucile a ripetizione Franchi cal. 20; - una
pistola Browning H.P. 35 cal. 9 para. matricola 71464-1 con due caricatori
contenenti 23 cartucce; - una pistola Walter P. 38 cal. 9 para. con due
caricatori contenenti 16 cartucce; - una pistola Beretta modello 81 calibro 7,65
matricola D-25204W con due caricatori contenenti 23 cartucce; - una pistola
Beretta modello 70 calibro 7,65 con matricola punzonata; - una pistola Beretta
calibro 7,65 para. matricola G-00257 priva di canna e caricatore; una canna per
pistola cal. 7,65 para. senza matricola; - un castello per pistola Walther P. 38
matr. 9658-F; - due caricatori per pistola cal. 7,65; - due bombe a mano M.K.2.;
- due bombe da fucile contro carro a carica cava mod. Strim-FM M 32 2A; - due
bombe da fucile ad azione polivalente mod. Fren Rifle n. 103; - un tubo in
plastica per il lancio di bombe; - due pani di esplosivo tipo SemtexH per kg. 4
circa; mt. 6,20 di miccia impermeabile; - dieci spezzoni di miccia detonante;
cinque detonatori; - n. 665 cartucce cal. 9 para; n. 149 cartucce cal. 9; - n.
683 cartucce cal. 7,65; n. 75 cartucce cal. 7,65 para; - n. 140 cartucce cal.
7,62 Nato; - n. 32 cartucce cal. 357 magnum; - n. 145 cartucce cal. 22. Ma nel
covo delle Brigate rosse non furono trovate solo armi. L’appartamento di via
Fracchia è considerata la vera e propria base logistica e operativa della
colonna genovese. Altrettanto lungo infatti è l’elenco dell’altro materiale
sequestrato dai carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. In
particolare nell’abitazione erano custodite 17 carte di identità in bianco
risultate rubate nel gennaio del ’69 negli uffici comunali di Quarto Flegreo, in
provincia di Napoli. L’elenco comprende anche 5 patenti di guida rubate un anno
prima (in due tempi diversi) all’Ispettorato della Motorizzazione di Cremona e
altre 7 sottratte negli uffici della Ripartizione generale della motorizzazione
di Catanzaro (furto consumato nel febbraio del ’79). Nel covo i carabinieri
sequestrarono un’altra trentina di documenti (carte di identità, patenti e
passaporti) intestati a cittadini e rubati prevalentemente a Genova e provincia
tra il ’77 e il ’79. I brigatisti erano pure in possesso del tesserino di una
guardia di pubblica sicurezza intestato ad un agente regolarmente in servizio
sottrattogli sul treno Napoli-Salerno e di una tessera del Circolo ufficiali del
presidio di Genova rubata nel ’77. [Andrea Ferro].
Il 18 settembre 1980 fu
sventato un attentato al sindaco Cerofolini. La geografia dei covi genovesi
delle Brigate rosse è una serie di puntini sparsi sulla piantina della città. In
questo articolo proviamo a ricostruire dove erano le basi della “colonna”. La
ricostruzione è fondata su una ricerca di archivio e sulla lettura degli atti
del processo avviato nell’aprile dell’81 nei confronti di una trentina di
imputati, tra militanti regolari (cioè entrati in clandestinità), irregolari,
fiancheggiatori di vario “spessore”. Per esigenze editoriali il materiale è
stato analizzato in poche ore. Siamo consapevoli che si tratta di una
“ricomposizione” forzatamente parziale della mappa delle Br.
IL BLITZ DI VIA PESCHIERA - Le
foto che qui pubblichiamo si riferiscono alla cattura di due brigatisti avvenuta
il 18 settembre del 1980 in via Peschiera,nei pressi della casa dell’allora
sindaco Fulvio Cerofolini. In manette finirono due terroristi Secondo la Digos
stavano per compiere un attentato. Un terzo uomo riuscì rocambolescamente a
scappare. Fu successivamente identificato per Leonardo Bertulazzi. Dopo una
lunga latitanza il br fu catturato dalla Digos genovese il 3 novembre di due
anni fa a Buenos Aires (è stato successivamente rilasciato per motivi
procedurali). Quella operazione consentì polizia e carabinieri di scoprire
quattro basi brigatiste.
VIA ZELLA - Il covo era
nell’abitazione della nonnina delle Br. Caterina Picasso aveva 73 anni quando i
poliziotti della Digos fecero irruzione nella sua casa di via Zella 11/2, nel
quartiere di Rivarolo. Era il 10 ottobre del 1980. L’anziana custodiva un
autentico arsenale, secondo in ordine di importanza solo alla base di via
Fracchia scoperta sei mesi e mezzo prima. Su tutte spicca la pistola CZ calibro
9 matr. 276754 con relativo caricatore: fu usata per uccidere Aldo Moro in via
Montalcini la mattina del 9 maggio 1978. Queste le altre armi trovate a casa
della “nonnina”. «Un mitra Sterling M.K. 4 cal 9 para, matr. KR- 27401, con
cinque caricatori, moschetto Sterling 95, cal 8 matr. 9839- G/9586-M; la pistola
Colt cal. 22 L.R. matr. 1092021, con relativo caricatore; una pistola Beretta
mod. 35 cal. 7,65 con relativo caricatore e matr. punzonata; una pistola Beretta
mod. 1915 cal. 7,65 priva di matr. e con relativo caricatore; una pistola
lanciarazzi “Modern”; cinque caricatori per pistola di cui 4 cal. 7,65 e 1 cal.
9; la canna per la pistola cal. 7,65 matr. T-34121; n. 12 cartucce a salve
cal.7,62 Nato, n.160 cartucce cal. 7,62 Nato, n. 26 cartucce cal 9; n. 30
cartucce cal. 38 Special; n. 138 cartucce cal. 9 para; n. 26 cartucce cal. 7,65
para; n. 10 cartucce cal. 38 Special; ; una bomba da fucile contro carro a
carica cava mod.Strim-FN MM 32 2A:una bomba da fucile ad azione polivalente mod.
Cren Rifle n. 103; due bombe da fucile di fabbricazione artigianale; gr. 400
circa “gelatina - dinamite”; un ordigno incendiario formato da una tanica
contenente benzina e nafta con attaccato un contenitore con gr. 100 di clorato
di potassio; 11 detonatori elettrici; 9 detonatori a miccia; 2 congegni per
esplosione a telecomando; 60 accendimiccia; 2 bombolette di gas paralizzante».
VIA PALESTRO - Il covo era
situato nell’appartamento situato al civico 19 interno 1. La base fu scoperta il
4 ottobre del 1980. Il locale fu definito dagli inquirenti
“appartamento-laboratorio-magazzino. All’interno furono sequestrati «un mitra
Sterling M.K.4. cal 9 para matr. KR.-29531 con due caricatori; una Browning cal.
7,65 abrasa con relativo caricatore n. 18 cartucce cal. 7,65; parti di pistola
cal. 4,5 mod; Mondial - Oklaoma; canna e parte del carrello di pistoAgenti e
carabinieri armati alla ricerca del terrorista sfuggito alla “trappola” di via
Peschiera Documenti sequestrati nel box di via Montallegro Folla in via
Peschiera: il blitz in diretta Un carabiniere mostra alcuni documenti rinvenuti
nel covo di via Palestro.
APPARIZIONE - Il 28
settembre1980 in località Poggio agenti della Digos e carabinieri trovarono nei
pressi di una casa colonica il mitra Beretta m. 12 cal. 9 para, matr. E-9730,
sottratto a Vittorio Battaglini, il maresciallo dei carabinieri freddato il 21
novembre del ’79 al bar “Da Nino” di via G. B. Monti a Sampierdarena insieme al
collega Mario Tosa. Oltre al mitra furono sequestrati una pistola monocolpo a
due canne cal. 6 mm Flobert matr. 11334; n. 300 cartucce cal. 22; n. 15 cariche
lancio per fucile mitragliatore F.A.L. cal 7,62 Nato; n. 100 cartucce cal. 6
Flobert; n. 1 tromboncino per F.A.L.. Alcuni ritagli di giornali trovati tra le
armi indicarono che quel deposito era stato individuato da tempo.
VIA MONTALLEGRO - Più che un
covo era un magazzino. Nel box di via Montallegro 8 i poliziotti fecero
irruzione il 25 settembre sempre del 1980. Dentro trovarono: «un mitra M.A.B.
cal. 9 para matr. KR-30010 con due caricatori; due caricatori per fucile
mitragliatore F.A.L. la pistola Beretta mod. 81 cal. 7,65 matr. D-18349 munita
di due caricatori e silenziatore, una pistola Franchi - Lama cal. 22 l.R; munita
di caricatore con matricola punzonata; il revolver Arminius HW3 cal. 22 con
matricola abrasa e sul tamburo matr. 4063; una canna per pistola cal. 7,65, cm
12 di miccia colore rosso; n. 13 cartucce cal. 9 corto; n. 42 cartucce cal. 9
para; n. 100 cartucce cal. 7,65 n. 36 cartucce cal. 22 LM.R.; una bomba a mano
M.KI.2.; n. 15 detonatori elettrici; n. 13 detonatori ed un telecomando per
brillamento».
SALITA SAN FRANCESCO DA PAOLA
- Sempre negli stessi giorni in un’abitazione al numero 53/11 furono rinvenute
una pistola lanciarazzi Mondial e n. 6 cartucce cal 6 mm Flobert; un pezzo di
miccia; un caricatore per pistola con n. 6 cartucce cal. 9.
SAMPIERDARENA - In corso
Martinetti, sempre intorno a metà ottobre, furono sequestrati 35 chili di
esplosivo. Un autentico arsenale (non siamo in grado di indicare le armi che vi
erano custodite) fu scoperto nei pressi del forte Crocetta, sulle alture di
Sampierdarena.
NERVI, VIA CASOTTI - Fu una
delle ultime operazioni condotte dai carabinieri contro i resti della colonna
genovese. Risale infatti al 20 dicembre 1981. Il covo era in un magazzino al 142
rosso di via Casotti.All’interno furono trovati i “fascicoli” relativi ad alcune
inchieste su nuovi obiettivi da colpire. Nel mirino c’erano un politico con
incarichi nazionali e un economista.Il primo avrebbe dovuto essere ucciso, il
secondo gambizzato. Andrea Ferro.
GRAZIANO MAZZARELLO DEPUTATO
DIESSINO RICORDA GLI ANNI DI PIOMBO NELLA NOSTRA CITTÀ. «Facemmo un lavoro
capillare per impedirne l’accesso in fabbrica», scrive Paolo De Totero. «In
quell’epoca ero il responsabile delle fabbriche del ponente. Conoscevo bene
Guido Rossa» Graziano Mazzarello, cinquant’anni, deputato diessino, un passato
come consigliere regionale e come segretario della federazione comunista ricorda
bene quel periodo, “gli anni di piombo a Genova”: il blitz di via Fracchia, la
spietata esecuzione di Guido Rossa, il sindacalista dell’Italsider ucciso
proprio da Riccardo Dura (il terrorista che trovò la morte un anno dopo proprio
nel covo di Oregina). Mazzarello, allora operaio dell’Italcantieri, iscritto al
Pci, nel 1980 era il responsabile delle fabbriche del ponente. «Ricordo - spiega
il parlamentare diessino - che ebbi immediatamente la sensazione che qualcosa
stesse cambiando. Come se si trattasse di una vera e propria svolta nella guerra
che lo Stato stava combattendo contro la lotta armata dei brigatisti rossi. La
consideravo anche una nostra vittoria perché in quel momento noi pensavamo che
le “Bierre” fossero nemici della classe operaia. Tanto - confida Mazzarello -
che fra noi e la polizia esisteva una sorta di collaborazione, seppure
riservata». E il momento della consapevolezza piena e generale che i brigatisti
non erano più “Compagni che sbagliano” ma come ricorda Mazzarello “Nemici della
classe operaia” era stato proprio quello dell’uccisione di Guido Rossa. «Dopo
quella efferata esecuzione - conferma il deputato dei Ds - ebbi la
consapevolezza che la fase stesse cambiando. Insomma, che i brigatisti fossero
nemici della classe operaia era diventato un assunto ben presente nella
coscienza dei lavoratori e un’idea condivisa dalla generalità dei nostri
iscritti e degli iscritti al sindacato». «Sotto questo aspetto a Genova -
afferma ancora Mazzarello - c’era meno ambiguità nel tessuto operaio, rispetto
ad altri centri industriali dell’Italia del Nord. C’era una maggior attenzione,
una vera e propria partecipazione militante per impedire che qualcuno di loro
potesse introdursi nelle fabbriche. Noi stessi avevamo una coscienza
particolarmente sviluppata sotto questo punto di vista. A capo di tutto questo
lavoro di vigilanza a livello nazionale c’era Ugo Pecchioli, una sorta di
ministro dell’interno del Pci. E dopo Rossa, quando la polizia otteneva dei
risultati, il successo era come se fosse stato anche nostro». Ma c’è ancora un
luogo comune che Graziano Mazzarello intende sfatare ed è quello più volte
ripetuto nel corso di ogni commemorazione, ossia che Guido Rossa fosse isolato.
«Non è vero, io stesso lo conoscevo e ho lavorato insieme a lui. Probabilmente
non si poteva supporre che i brigatisti potessero arrivare a tanto, che ci
sarebbe stato un simile salto di qualità nella lotta armata». Paolo De Totero.
Una partita a scacchi
iniziata, brandine e tanto disordine, scrive Andrea Ferro. Le ultime tracce che
sanno di vita nella casa prima che si scateni l’orrore sono inquadrate alla luce
dei flash dei carabinieri durante la “ricognizione” fotografica avvenuta nelle
prime ore del mattino di quel maledetto 28 marzo di ventiquattro anni fa. Le
foto che pubblichiamo nell’edizione di oggi sono le ultime immagini, inedite, in
nostro possesso dopo quelle comparse sulle edizioni del “Corriere Mercantile” in
edicola giovedì, venerdì e ieri. E con oggi si chiude la nostra rievocazione di
quella pagina, tragica, discussa, molto probabilmente decisiva, della lotta
ingaggiata dallo Stato contro le Brigate rosse che lo avevano attaccato al
cuore, come recitava il proclama che rivendicò la prima strage: l’agguato contro
il procuratore generale Francesco Coco, il brigadiere di polizia, Giovanni
Saponara e l’appuntato dei carabinieri, Antioco Dejana compiuto dalle Br l’8
giugno del 1976.
L’ULTIMA CENA - In cucina si
accede direttamente dall’ingresso. E’ un vano di pochi metri quadrati, il più
piccolo. La foto è stata scattata all’altezza della porta, sul lato destro
dell’ingresso rispetto al pianerottolo. Di fronte appare il lavabo. Si
intravedono una padella, un “colapasta”, lasciati da lavare. A fianco il forno
con pentole, una teglia, mestoli. Il tavolo è piccolo e quadrato con la mensola
allungabile. Si vede la spalliera di una sedia, poi due sgabelli, uno
rettangolare (basso), l’altro rotondo. I piatti sono tre, tutti fondi, uno per
lato. Contengono i resti dell’ultima cena consumata nel covo. Si intravedono
distintamente una caffettiera, un fiasco coperto da un cartone. La sensazione è
di un pasto frugale. La cucina è l’unico vano all’interno del quale non si
notano tracce della sparatoria. Nell’intervista pubblicata nella nostra edizione
di ieri Michele Riccio, l’ufficiale dei carabinieri che guidò il blitz, racconta
che dopo il conflitto a fuoco e la constatazione della morte dei quattro si
fermò a lungo in cucina per eseguire l’ordine impartito telefonicamente dal suo
capo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: compiere l’inventario del
materiale che di volta in volta i suoi uomini trovavano negli altri vani della
base di Oregina. Sempre secondo le dichiarazioni rese da Riccio al nostro
giornale i brigatisti avrebbero cercato di manifestare segnali precisi che
potessero indicare il numero degli occupanti dell’abitazione. Consapevoli delle
tecniche investigative dell’avversario avrebbero infatti ridotto al minimo
indispensabile i consumi di luce, gas e acqua. «Constatammo che i contatori
erano quasi fermi», ha ricordato Riccio.
LA CAMERA DA LETTO - La foto è
stata pubblicata già nella prima pagina di ieri. Ritrae la camera da letto. Il
vano si allarga in fondo al corridoio. La prima sensazione è di un grande
disordine. Evidentemente i carabinieri dopo aver percorso il corridoio sul quale
giacevano i corpi dei quattro brigatisti si precipitarono armati in tutte le
stanze alla ricerca di altre persone che nel frattempo avrebbero potuto
nascondersi in ogni angolo della casa. Secondo la ricostruzione di Riccio il
conflitto a fuoco avvenne praticamente al buio fatta eccezione del faro
impugnato da uno dei suoi uomini. Dopo essersi assicurati che dentro la casa non
c’era nessun altro i carabinieri iniziarono la perquisizione alla ricerca del
“materiale”: armi, documenti, schede e tutto quanto potesse avere “valenza
investigativa”. Su questo punto Dalla Chiesa si raccomandò già nella riunione
avvenuta nelle ore precedenti il blitz (la sera del 27 marzo) negli uffici
dell’Arma di via Ippolito d’Aste e alla quale il generale intervenne
telefonicamente riferendo al tenente colonnello Nicolò Bozzo, suo braccio destro
per il Nord Italia (lo ha raccontato ancora Riccio, il brano ieri è stato
parzialmente omesso nella ricostruzione pubblicata ieri per ragioni di spazio).
UNA BRANDA E UN LETTO - La
foto è scattata frontalmente, dal lato destro rispetto alla porta d’ingresso. I
due lati del muro sono tappezzati con carta da parati che richiama una fantasia
tipica dell’epoca. In primo piano c’è la rete matrimoniale sulla quale,
evidentemente, dormivano due dei quattro occupanti dell’appartamento. L’altro
letto è un mobile-branda reclinabile sul quale è rimboccata una coperta
“scozzese”. C’è grande disordine sul pavimento accanto alla branda. Sulla
mensola superiore ci sono una pistola e un sacchetto di cellophane all’interno
del quale c’è un’altra arma. A occhio nudo il particolare non si nota. Lo
abbiamo stabilito dopo l’ingrandimento al computer dell’immagine e la lettura
degli atti processuali. I documenti si riferiscono al procedimento avviato un
anno dopo nei confronti di una trentina di imputati finiti davanti ai giudici
della Corte d’Assise perché indicati come i componenti della colonna genovese
delle Brigate rosse.
IL TAVOLO - Il televisore è di
colore bianco, con le antenne sollevate parallelamente; si intravede il filo.
Sul tavolo le carte sono ammucchiate. Si evince che prima dello scatto qualcuno
abbia rovistato, piuttosto freneticamente, tra il materiale. Presumibilmente sul
tavolo erano custodite carte, documenti, schede, “atti” delle indagini condotte
dai brigatisti su altri possibili obiettivi della lotta armata: da uccidere, da
gambizzare. Si intravede la copertina di un libro sul quale è stampata una
fotografia. Accanto c’è una targa automobilistica, primo modello, risultata
rubata. Inizia con la sigla della città “GE”. Dagli atti processuali deduciamo
che i numeri seguenti sono: 49909. La targa apparteneva ad una “Fiat 200-B/F
850”. I brigatisti erano in possesso anche della relativa carta di circolazione
(nell’edizione di ieri abbiamo pubblicato l’inventario di tutti i documenti
sequestrati nel covo).
LA VALIGETTA - E’ una
cartella, presumibilmente di pelle. Sembra chiusa. A pochi centimetri c’è il
piede di una sedia con il sedile e lo schienale imbottiti.
LA MENSOLA - Del mobile-branda
pubblichiamo una seconda fotografia. Ritrae la mensola inferiore. In uno spazio
ridottissimo c’è un po’ di tutto. Il particolare più “suggestivo” è costituito
dal denaro. E’ una mazzetta da centomila alta almeno un centimetro. Le banconote
sembrano uscite direttamente dalla zecca. Sono impilate alla perfezione. Una
mazzetta appunto. Quasi sicuramente il denaro faceva parte del bottino di
qualche rapina compiuta nei mesi precedenti dall’organizzazione e costituiva la
“riserva di cassa” della base. All’interno del covo (da quanto possiamo
stabilire) non fu sequestrato altro denaro.
LA SCACCHIERA - La mazzetta è
sopra una scacchiera, i pezzi (bianchi e neri) sono ammucchiati verso la parete.
Sotto la scacchiera si intravedono alcuni fascicoli. Sulla mensola sono
appoggiati un vaso di vetro, un cappello (una coppola) e un paio d’occhiali da
vista. Andrea Ferro.
IN UN LIBRO L’AUTORE
RICOSTRUISCE LE CONSEGUENZE DEL BLITZ NEL COVO DI OREGINA. Bocca: «Si
infiltrarono nelle fabbriche prima della fine» Così Giorgio Bocca ricostruisce
le conseguenze politiche e militari del blitz di via Fracchia con l’uccisione
dei quattro brigatisti nel libro “Noi terroristi, dodici anni di lotta armata
ricostruiti e discussi con i protagonisti” edito da CDE e pubblicato nel gennaio
del 1986. Il brano è tratto dal capitolo “BR genovesi, il mito della
imprendibilità”. «La strage provoca un’“esplosione ritardata”. Decine di giovani
sull’onda della emozione chiedono di entrare nelle Br e Lo Bianco, rimasto solo
a guidarle, li accetta. «Ai primi arresti», dice Fenzi - «arrivarono in questura
le madri, abbracci e baci con i ragazzini piangenti, l’invito materno subito
accolto a vuotare il sacco e in pochi giorni finirono tutti in galera, le BR
genovesi erano finite e finite per sempre. Ci fu anche un caso patetico
dell’avvocato Arnaldi, per certi aspetti simile a quello di Feltrinelli, due che
dovevano recuperare la loro resistenza mancata. Arnaldi si sentiva orfano di
antifascismo e di rivoluzione, voleva fare il brigatista. Se incontrava uno di
noi chiedeva ansioso: «Dici che mi apprezzano? Che mi stimano? Sembra
incredibile, ma sperava che suo figlio studiasse da brigatista». Ebbene la
certezza di essere scoperto quando seppe che Peci parlava. Pochi giorni prima,
durante un colloquio con Micaletto, presente Peci gli aveva detto di essere
entrato nella colonna genovese. Peci era lì a due passi, aveva certamente
sentito. Era anche malato, gravemente, ma non voleva farsi operare perché aveva
l’ossessione dei servizi segreti: «Quelli mi fanno parlare sotto anestesia»,
diceva. Ma aveva pochissimo da dire. Quando la polizia suonò alla porta di casa
sua, sentì che era la fine e forse pensò che il suicidio avrebbe risolto tutti i
suoi problemi. Chiese di andare nella toilette e si sparò. A mio avviso anche la
sua scomparsa totale, irrimediabile nelle BR genovesi testimonia della loro
genovesità. Il partito guerriglia, il cavalcamento di tutte le trasgressioni a
Genova era impensabile: o si trovava un rapporto con le fabbriche oppure si
chiudeva bottega. Per ironia della sorte le prime infiltrazioni brigatiste nelle
fabbriche ebbero successo pochi giorni prima della fine, eravamo riusciti a
portare a casa nostra tre o quattro sindacalisti veri, importanti. Che resta da
dire? Che anche a Genova come a Milano, ci fu il rigetto della Balzarini,
mandata da Moretti a reggere la colonna. Era, nel privato una donna bella e
gentile, lei e Moretti si scambiavano piccoli doni, tenerezze. Ed era amica
piacevole, colta. Ma come dirigente si trasformava in una capetta dogmatica,
intrattabile», Ma questi sono i misteri della psicologia guerrigliera. Città
dura Genova: la sua borghesia ha pagato senza recriminare dal rapimento Costa al
ferimento dell’ingegner Sibilla, senza alzare pianti scomposti, senza uscire dal
suo riserbo. C’è un doppio pudore comunista a Genova: quello della classe
operaia e quello della genovesità. Di certe cose non si parla né fuori dalla
classe né con i foresti.
NESSUN MISTERO DIETRO LA
PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI ESCLUSIVE. In quelle foto c’è la storia, scrive
Mimmo Angeli. La rievocazione storica della strage di via Fracchia, con la
pubblicazione delle foto inedite del blitz, ha suscitato una serie di commenti,
illazioni, critiche. E’ bene chiarire subito che il collega Andrea Ferro ha
semplicemente fatto - molto bene - il suo mestiere di cronista. Il nostro
giornale ha svolto la sua funzione di informare. Quelle foto, indubbiamente
crude, costituiscono una novità per i lettori e rappresentano un documento
storico. Perchè vengono pubblicate dopo 24 anni? Semplice la risposta: perchè
soltanto oggi chi le aveva cercate è riuscito ad averle. Niente dietrologia in
questa vicenda, nessun scopo recondito, nessuna intenzione di sposare tesi
precostituite in favore di nessuno. Lo testimoniano i servizi che hanno
corredato le immagini. Chiunque fosse stato interpellato ha espresso, in piena
libertà, il suo punto di vista sulla vicenda. La storia è ricca di “se” e “ma”,
interpretazioni, giudizi, analisi. Non era certo nostra intenzione riaprire
polemiche ma, semplicemente, integrare la ricostruzione fin qui nota di quella
tragica notte. Non tutti hanno approvato la nostra scelta. Sono opinioni libere
e come tali le rispettiamo. A noi però preme ribadire che, dietro quelle
immagini, c’è soltanto il lavoro, la volontà, il desiderio del giornale di
offrire ai propri lettori un documento di storia contemporanea. Mimmo Angeli
A UN SETTIMANALE Le fotografie
“cedute” solo per beneficenza. Le immagini che abbiamo pubblicato nelle nostre
ultime quattro edizioni costituiscono un eccezionale documento storico. Come
abbiamo scritto più volte in questi giorni, le foto furono scattate dai
carabinieri poche ore dopo il blitz. Materiale inedito, insomma. Di un valore
storico ma anche “commerciale”. I diritti per la pubblicazione delle foto sono
stati ceduti (esclusivamente per sette giorni) ad un noto settimanale nazionale
che le pubblicherà nel numero in edicola venerdì prossimo. Ma nè l’autore di
questo servizio, nè il giornale hanno mai pensato di trarne un vantaggio
economico. Si è deciso di concedere i diritti esclusivamente in cambio di
un’offerta, generosa, a favore delle attività assistenziali del Reparto di
Chemioterapia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna diretto dal professor
Gaetano Bacci.
Brigate Rosse - La verità
negata. Quindici domande di Valerio Lucarelli senza risposta. Solo
una parte di quelle che la storia infinita delle Brigate Rosse ha seminato
dietro di sé. Un abisso insostenibile per un paese che non avrà mai un futuro se
non farà luce sul proprio passato. Nessuna affannosa dietrologia, solo la
ricerca di una Verità chiara e definitiva. Ma la domanda che è urgente porsi
oggi è una sola. Le Br sono state definitivamente debellate o per miracolo
sapranno rigenerarsi? Azzardo una risposta: all'occorrenza.
Marco Pisetta, Silvano
Girotto, Francesco Marra. Nei primi anni 70 le forze dell'ordine sono state in
grado di infiltrarsi almeno tre volte nelle BR. Possibile che tale fenomeno non
si sia più verificato di fronte a BR più vaste e sanguinarie? Perché Frate
Mitra è stato bruciato subito anziché approfittare del ruolo che si stava
ritagliando all'interno delle Brigate Rosse? Non le si voleva annientare del
tutto?
Alla Cascina Spiotta, dove era
imprigionato l'industriale Vallarino Gancia, Mara Cagol cadde in un conflitto a
fuoco o bisogna credere all'autopsia che parlò di colpo sparato per uccidere?
Chi consegnò all'agente
G.71 Antonino Arconte, alcuni giorni prima del sequestro di Moro, il plico
diretto ai servizi segreti israeliani con la richiesta di aiuto per salvare lo
statista democristiano?
Cosa conosceva Mino
Pecorelli per fargli annunciare che il 15 Marzo 1978 sarebbe accaduto qualcosa
di gravissimo in Italia? Era entrato in possesso del memoriale di Moro? Fu
ucciso per le verità che minacciava di portare allo scoperto?
Perché Andreotti aveva l'auto
blindata e l'analoga richiesta fatta da Oreste Leonardi, capo della scorta di
Moro fu rifiutata?
L'istituto
francese Hyperion era realmente una scuola di lingue o la stanza di
compensazione di diversi servizi segreti?
Che fine hanno fatto le borse
di Aldo Moro? Il leader democristiano le portava sempre con sé. Contenevano
documenti compromettenti? Il memoriale scritto durante la prigionia era
completo? Perché non fu mai trovata la copia originale?
Chi ha commissionato a Toni
Chicchiarelli della Banda della Magliana il falso comunicato n°7 che annunciava
la morte di Aldo Moro? Quale era il messaggio trasversale che voleva lanciare?
È lecito credere che
personaggi dello spessore di Romano Prodi, Mario Baldassarri e Alberto Clò, in
una tranquilla domenica trascorsa in famiglia, decidano di fare una seduta
spiritica e che proprio in quella circostanza esca il nome di Gradoli? Da dove
proveniva realmente quell'informazione?
Chi e perché ha voluto far
scoprire il covo di Via Gradoli dove si nascondeva Mario Moretti? Possibile che
Barbara Balzerani fosse distratta al punto da lasciare una scopa nella doccia
causando un'infiltrazione (scusate il gioco di parole...) al piano inferiore?
Perché si diede immediata evidenza della scoperta del covo consentendo a Moretti
di svignarsela tranquillamente?
Mario Moretti: spia o puro
rivoluzionario?
Cosa si nasconde dietro
l'omicidio di Guido Rossa? È plausibile che Riccardo Dura non abbia rispettato
il compito di gambizzare il sindacalista, inferocito per la denuncia che aveva
portato all'arresto del postino Belardi?
A Via Fracchia ci fu uno
scontro a fuoco come dichiarato ufficialmente dai Carabinieri del Generale Dalla
Chiesa o venne eseguita la condanna a morte di quattro brigatisti fra cui lo
stesso Dura?
Un'informativa redatta da un
ufficiale dell'Arma, nome in codice Ciondolo, descriveva come imminente un
attentato a Walter Tobagi, indicando persino l'area in cui quel delitto stava
maturando. Perché venne tralasciata, di fatti condannando a morte il
giornalista?
Perché fu revocata la scorta
a Marco Biagi nonostante le continue minacce ricevute e una relazione dei
servizi segreti, pubblicata da "Panorama", che lo identificava come un chiaro
obiettivo delle BR? Cosa si stava per scoprire riguardo la mail di
rivendicazione dell'omicidio?
MAI DIRE DEPISTAGGIO…
Alla scoperta del
"Collettivo" che cerca la verità sul caso Moro. Emergono nuovi importanti
elementi prima sfuggiti.
Intervista a Franco Martines, membro del "Collettivo
Sedicimarzo", che da alcuni anni indaga sul rapimento e uccisione di Aldo Moro.
Le loro ricerche sono tutte pubblicate su un sito internet, scrive Michele Metta
su "L’Antidiplomatico" il 26/01/2018. Ho avuto modo di conoscere una realtà che
mi ha colpito in maniera estremamente favorevole. Sto parlando del Collettivo
Sedicidimarzo, il quale, come intuibile dal nome, è un gruppo di individui che
hanno deciso, nobilmente, di mettere a disposizione le proprie abilità, le
proprie conoscenze, il proprio tempo, alla ricerca della verità sia sul
rapimento di Aldo Moro, allo straziante costo dello sterminio della sua scorta,
il 16 marzo del 1978, sia sulla uccisione di Moro, sopraggiunta il maggio
successivo. Ho, qui con me, Franco Martines, che farà da portavoce del gruppo.
Franco, grazie per aver
accettato questa intervista. Partirei proprio dal chiederti, per favore, come
nasce il vostro gruppo, da chi è composto, e come mai avete deciso di darvi la
struttura di Collettivo, forma che ha il sapore – lo dico in positivo – di altri
tempi, dato che Collettivo era la maniera aggregativa della Sinistra degli anni
Settanta.
«Michele,
grazie a te. Be’, è stata, la nostra, una lunga gestazione. Ci incontrammo – il
passato remoto è d’obbligo – ormai agli inizi del 2014, o forse alcuni mesi
prima, sul forum del sito di Manlio Castronuovo, che prendeva il nome
dall’omonimo suo libro, da noi tutti letto e apprezzato: vuotoaperdere.org.
Abbiamo iniziato lì a porci domande e a cercare, reciprocamente, risposte. È
venuta poi da sé, dopo un annetto, l’esigenza di avere uno “spazio” nostro e più
privato, creando noi pure un sito web e, successivamente, pure una
pagina Facebook, al nostro sito collegata. Venendo, invece, al chi siamo,
rispondo che, accanto a me, ormai architetto e insegnante in pensione in quel di
Tivoli, dato che sono del ’51 e, quindi, ahimè, il decano del gruppo, abbiamo:
Alberto Gentilini, che è un ingegnere cinquantunenne di Cagliari; Andrea Guidi,
che di anni ne ha 53, è di Roma, ma vive ad Imperia, dove fa il notaio; Domenico
D’Avanzo, 49 anni, di Avella, dove esercita la professione di biologo; Francesco
Velocci, poco più che trentenne, anche lui di Roma, ma che vive e fa il
consulente di marketing in America, nel Missouri. Questo, insomma, è il nostro
quintetto che, come hai giustamente sottolineato, ha voluto effettivamente
richiamarsi, nel nome, alle strutture aggregative di quegli anni».
Sono rimasto davvero
ammirato dalla qualità del vostro lavoro. Adottando il metodo della analisi
meticolosa e puntuale della mole documentale accumulatasi negli anni
sul Caso Moro, siete riusciti a scoprire elementi importantissimi, prima
sfuggiti. Mi riferisco, ad esempio, a quanto avete messo in rilievo circa
l’agente Di Leva presente in via Fani. Ce ne vuoi parlare?
«Sì,
certo. Quella fu una ricerca iniziata appunto su Vuoto a Perdere, e poi
proseguita e conclusa una volta creato il nostro Collettivo. In pratica, ci
siamo accorti di parecchie stranezze ed incongruenze relative alle vicende di
questo signore. Il che, ovviamente, non significava nulla di per sé, ma ci
sembrava opportuno che venisse approfondita la sua posizione. In breve, ci siamo
resi conto che lui, pur presente negli istanti dopo la strage, in 40 anni non
era mai stato sentito da nessuno; e questo, malgrado il fatto che Imposimato,
già nel ’78, interrogando altri, avesse chiesto di lui. Inoltre, il verbale
firmato dal Di Leva, presentava una serie di inesattezze, come se il suo
redattore non fosse stato realmente presente sui luoghi, ma lo avesse compilato
basandosi su racconti altrui. Nei faldoni, abbiamo a quel punto rintracciato una
seconda copia dello stesso verbale. Seconda copia con una firma palesemente
diversa. A quel punto, approfondiamo, e ci accorgiamo pure che gli era stato
attribuito un premio in denaro, per lo spirito di iniziativa dimostrato in via
Fani appena un mese dopo i fatti. Una cosa, questa, che avrebbe dovuto, di
norma, accendere i riflettori su Di Leva. E invece, niente: non un magistrato
ebbe a convocarlo. Infine, ancor di più approfondendo, ecco capitare sotto i
nostri occhi un trafiletto de La Stampa. Trafiletto da cui risultava che il Di
Leva era stato arrestato nel 1980 per gravi atti contro la persona! Ovvio che, a
quel punto, abbiamo ritenuto doveroso inviare un nostro documento riepilogativo
e dettagliato di tali nostre scoperte all’on. Gero Grassi, affinché lo
trasmettesse alla Commissione Moro. Dopo alcuni mesi dalla presentazione del
nostro documento, ecco il Di Leva finalmente audito formalmente in Commissione.
Audizione, a dire il vero, un po’ kafkiana, e dove il Di Leva fece a suo modo
uno show, come chiunque si può rendere conto andando ad ascoltare l’audio di
tale audizione, disponibile sul nostro sito. Audizione dove, comunque, tutto
quanto avevamo ipotizzato deducendolo dalle carte, fu dal Di Leva confermato: il
verbale, effettivamente, non l’aveva fatto lui; una delle due firme era falsa;
era stato effettivamente arrestato. Comunque, sia 40 anni fa che adesso, ha
testardamente mantenuto un punto che sembra inverosimile; sostiene di aver visto
al suo arrivo l’ultima auto dei brigatisti in fuga ma, come dicevo, la cosa è
inverosimile! A meno che, ma risulta un po’ difficile come ipotesi, non sia
errato, viceversa, tutto il quadro testimoniale altrui! Resta la curiosità di
capire, ma la Commissione, purtroppo, non glielo ha chiesto, come mai
Imposimato, che aveva mostrato intenzione di convocare il Di Leva, alla fine non
l’abbia più convocato. Data la recente morte di Imposimato, è qualcosa che non
sapremo più».
Eccellente lavoro, il
vostro, anche sulle incongruenze circa il proiettile che fora il parabrezza
dell’auto su cui viaggiava Moro al momento del suo sequestro. Che anomalie avete
riscontrato?
«Sì.
Anche qui abbiamo fatto una segnalazione e, per la verità, ci auguriamo prima o
poi giunga, direttamente o indirettamente, una risposta al quesito. In pratica,
la Polizia Scientifica di oggi ha fatto una nuova ricostruzione della dinamica,
ipotizzando che il tiro sia iniziato con la 130 ancora in movimento, perché la
traiettoria del foro sul parabrezza – così come da loro ipotizzata sulla base di
un impatto rilevato all’interno – non era compatibile, a differenza degli altri
colpi, con la posizione dell’auto nella fase di arresto in cui fu ritrovata.
Bene, c’è però un piccolo problema: andando a rileggere i rilievi della Polizia
Scientifica dell’epoca, si scopre che, in base alle caratteristiche dell’impatto
sul vetro – tieni presente che nella faccia di fuoriuscita i margini sono sempre
slabbrati, in quella di entrata sono sempre più netti – si valutò, all’epoca,
che il proiettile fosse penetrato dall’interno del parabrezza e uscito dalla
faccia esterna. Insomma: in verso opposto a quello ipotizzato oggi. Solo che, se
si rivelasse esatta la versione del 1978, questo significa inevitabilmente che
non è più dimostrato che l’auto, all’inizio della sparatoria, fosse ancora in
movimento! E allora? Chi ha ragione e chi ha sbagliato? Non vorremmo, visto che
la Scientifica di oggi non fa cenno alla vecchia Relazione, che si sia dato oggi
frettolosamente per scontato, senza andare ad esaminare le caratteristiche del
foro sul parabrezza, che anche quel colpo, come tutti gli altri, fosse di
entrata. Intendiamoci: non voglio certo dire che qualcuno all’interno
della 130 abbia esploso un colpo verso il parabrezza; si tratterebbe ovviamente
di un colpo sempre esploso dall’esterno a destra dell’auto, direzione obliqua, e
però con verso dietro-avanti, che penetra nell’abitacolo e impatta il parabrezza
dall’interno, uscendone. Certo potrebbe pure essere tutto originato da un refuso
di chi batté a macchina la relazione e poi sfuggito alla revisione. Però,
onestamente, le foto che abbiamo a disposizione sembrerebbero confermare quanto
fu detto nella relazione del ’78, e solo un esame diretto da parte di un
esperto, di un Perito, potrebbe risolvere la questione».
C’è poi la storia della
targa della famosa Renault rossa.
«È
una delle tantissime stranezze del Caso Moro. La targa applicata sulla R4 rossa,
corrispondeva a quella di un’auto di una Società con sede a Roma, la ATI, che ne
trasferì la proprietà ad una di Napoli. Poiché, all’epoca, le targhe riportavano
la sigla della provincia di residenza del proprietario, l’auto fu
obbligatoriamente ritargata. La stranezza è, quindi, che quella targa
originaria, in realtà, doveva essere distrutta. E allora, ci siamo domandati, e
abbiamo domandato, se la targa ritrovata sulla R4 in via Caetani fosse
semplicemente contraffatta, o se si trattasse proprio di quella targa che –
ipotesi ancora più inquietante – invece che distrutta, sarebbe finita, non si sa
come, in mano ai brigatisti. Tra i documenti pubblicati da noi, c’è la
dichiarazione dell’impiegato della Motorizzazione di Napoli. Ricordo, per la
cronaca, che la targa che si vede oggi nelle foto recenti, è un fac-simile.
Quella a suo tempo rinvenuta sull’auto, dovrebbe essere archiviata da qualche
parte come corpo di reato».
Nelle maglie della vostra
acuta investigazione, è incappata anche la palazzina al civico 117 di via
Stresa.
«Certo.
Lì, lo stimolo che ci ha mossi è stato l’ascolto dell’audizione, presso la
Commissione d’Inchiesta, del Generale Inzerilli. Audizione nella quale Grassi
gli faceva presente, desumendolo da elenchi del telefono degli anni ’70, che il
colonnello Guglielmi aveva abitato nella famosa palazzina a 150 metri
dall’incrocio maledetto. Dato che tutta la palazzina era abitata da alti gradi
militari e dei Servizi, e non risultava accatastata, siamo andati alla ricerca
di qualche ulteriore riscontro. E allora, come abbiamo documentato in un
articolo sul sito, le nostre ricerche ci hanno fatto imbattere in una conferma
importante. Sono due lettere, pubblicate dalla rivista Demanio Militare. Lettere
da cui si evince che effettivamente quella palazzina era del Demanio Militare, e
che era, e forse è tutt’ora, uso dello stesso Demanio non accatastare le sue
proprietà. A quel punto, abbiamo pure noi messo sul nostro sito tali lettere.
Inoltre, grazie alla cortesia dello storico Giacomo Pacini, che nuovamente
ringrazio, abbiamo anche messo in rete un documento che dimostra che Guglielmi
era un habitué dei Servizi fin dai tempi del SIFAR, e poi ufficialmente in pausa
dal ’74 fino a riprendere questa attività giusto nel giugno o luglio 1978.
Certo: ci sarà chi obietta che sono solo coincidenze, ma quando, in una vicenda,
di cosiddette coincidenze se ne accumulano così tante, forse dovremmo smetterla
di chiamarle coincidenze».
Tornando agli spari in via
Fani, avete svolto una controanalisi sui bossoli. Ce la puoi descrivere?
«Difficile
sintetizzare in poche parole. Ci provo. Il Perito dell’epoca non riuscì – lungo
adesso spiegare perché – ad accoppiare tutti i 93 bossoli che furono rinvenuti
con la loro posizione a terra. Ben 10 rimasero senza localizzazione precisa, con
un riferimento generico: cad. La Polizia Scientifica di oggi, nella sua
relazione alla Commissione, non ha fatto progressi in questo, perpetuando,
quindi, queste indeterminatezze e, soprattutto, incorrendo in quelli che, a noi,
sembrano evidenti errori di attribuzione dei bossoli alle armi. Quel che
occorreva fare, invece, era confrontare con la dovuta pazienza le foto di ogni
singolo bossolo con la corrispondente descrizione fatta nella relazione dei
rilievi tecnici del 16 marzo 1978. Noi, questa pazienza l’abbiamo avuta, e
abbiamo costruito una nuova piantina, con la distribuzione dei bossoli a terra,
e distinguendoli per colore in base alle armi attribuite. Un lavoro che ha
permesso l’emergere, appunto, di alcuni dati molto diversi da quelli viziati
dagli errori accumulatisi in tutti questi anni. In particolare, sulla
pistola Smith&Wesson. Tale arma, nella distribuzione e attribuzione da noi
compiuta, sembra proprio suggerire una dinamica più complessa, con almeno un
quinto sparatore in contemporanea ai quattro noti e riconosciuti. Anzi, lasciami
sinceramente dire che, in base a quanto abbiamo determinato, viene da pensare
che alcuni degli inceppamenti di armi raccontati dai Bierre siano in realtà
serviti ad occultare la presenza di uno o più sparatori aggiuntivi, che agirono
in contemporanea agli altri. Anche perché quegli asseriti problemi alle loro
armi stonano non poco con la fin troppo incredibile fortuna che, secondo quanto
da loro stessi affermato, avevano avuto fino a quel momento. Infatti – così
dicono loro – ad incepparsi sarebbero state tutte, e sottolineo tutte, le
loro machine-pistole! Ma torniamo alla Smith&Wesson: approfondendo il nostro
lavoro, ci siamo a quel punto accorti che, chissà perché, c’erano due bossoli di
tale arma che, dalla Polizia Scientifica del 2015, erano stati tagliati fuori
dalla scena. Ci mettiamo allora a ricontare e riverificare e, con un po’ di
sconcerto, scopriamo che, comunque, di bossoli ne erano stati raffigurati 93: il
numero giusto, insomma. Come poteva essere? La spiegazione è che erano stati
raffigurati e conteggiati tra i bossoli due reperti ben diversi: un proiettile e
un frammento di proiettile in vicinanza dell’Alfetta!»
Più in generale, avete
smontato alcune perizie scientifiche riguardanti la balistica di via Fani.
«Oddio,
“smontato” è una parola grossa, davvero grossa. Diciamo che abbiamo notato e
rilevato delle criticità mai emerse prima. Quanto debbano pesare queste
criticità nell’economia generale delle valutazioni conclusive nelle Perizie
balistiche che si succedettero negli anni a partire dal ’78, lo dovrebbero dire
altri. Ed infatti, proprio per questo, le avevamo segnalate alla Commissione,
sinceramente sperando che venissero valutate. Speranza che si è rivelata errata,
perché, invece, il nostro lavoro, per quanto ci è stato dato di capire, non è
stato esaminato. Come mai? Forse, una sottovalutazione di quel che avevamo
ricostruito? Sinceramente, non lo so. So, però, che avevamo elencato – sempre
dando tutti i riferimenti – una serie di incongruenze interne alle singole
Relazioni peritali sui proiettili, perché di incongruenze dobbiamo parlare se in
un punto si affermava una cosa, e successivamente un’altra. Incongruenze interne
cui si somma pure una serie di incongruenze esterne, e cioè tra una Perizia e
l’altra. Per tacere del fatto che, dall’analisi comparativa delle varie Perizie,
tra l’altro emesse nell’arco di ben una quindicina d’anni, ci sono, da un lato,
alcuni reperti che scompaiono e, dall’altro, nuovi che compaiono all’improvviso!»
Cosa puoi dirmi del
singolare tamponamento avvenuto il giorno prima del rapimento di Moro?
«Già.
Singolare anche quello, in effetti; tanto per cambiare. Guarda, noi siamo andati
direttamente alle fonti; vale a dire: gli incartamenti della
prima Commissione Moro e, via via che venivano pubblicati da Gero Grassi, quelli
della seconda. E abbiamo sgranato gli occhi quando, scorrendo uno dei 130 volumi
della prima Commissione, ci siamo imbattuti in un verbale, riguardante il giorno
15, che descriveva – fatto per noi del tutto nuovo – una dinamica pressoché
identica a quella che si sarebbe verificata il giorno dopo. Infatti, verso
mezzogiorno del 15 marzo, dalle parti di piazza Galeno, un’auto davanti
alla 130, condotta quella mattina da Otello Riccioni, fa una manovra maldestra,
costringendo la 130 a inchiodare. Ma l’autista dell’Alfetta di scorta viene
colto di sorpresa, e va a tamponare la 130. L’Alfetta, che fra le due auto aveva
avuto la peggio, verrà poi sostituita durante la pausa per il pranzo e, infatti,
nella seconda parte della giornata, farà servizio quella che il giorno dopo
verrà crivellata. Tra l’altro, nella seconda parte della giornata del 15,
la 130 la guiderà il Ricci carabiniere perito il giorno dopo, durante il
sequestro di Moro, come attestato dal figlio Giovanni Ricci. Preciso, per
completezza, che, probabilmente, quel giorno – sempre il 15, dico – ci fu uno
scambio di mezzo turno, per una cortesia di uno all’altro, come avviene in tutti
gli ambienti di lavoro. Concludo dicendo che non si può tacere che, proprio
perché si tratta di un episodio singolare, è ancora più singolare che Riccioni,
interrogato pochi mesi dopo sul punto – la vedova di Moro lo aveva in precedenza
raccontato in dibattimento – , neghi che sia avvenuto, ricordandosi solo di un
altro tamponamento, di anni prima, e in tutt’altra zona della città».
E circa la vicenda
della 132 blu?
«La 132 è
stata oggetto di un recente nostro articolo, cui ne seguirà un altro, entrambi
riguardanti complessivamente il nodo di via Licinio Calvo. La parte già
pubblicata, riguarda principalmente la fase del suo ritrovamento, a tempo
di record, da parte della pattuglia Squalo4. Anche qui ci sono stranezze. Come
si può vedere andando a leggere l’articolo, già alle 9:05 viene diramato
l’invito a ricercare l’auto 132 blu, con l’esatta indicazione della targa. Chi
fornì quest’indicazione? Non si sa. Nessuno dei testimoni verbalizzati l’ha mai
detto. Per certo, tra tali testimoni ce n’è uno il cui nome mette un brivido,
dato che si tratta del notissimo fascista Pino Rauti. Rauti racconta d’aver
visto l’auto dall’alto, stando su un balcone a via Stresa. Posizione dalla quale
afferma di essere pure riuscito a prendere la targa. Presa la targa, chiama.
Solo che la sua telefonata risulta essere di 10 minuti dopo: delle 9:15. Dunque,
probabilmente, esiste in realtà un testimone mai verbalizzato, di cui però non
c’è traccia nelle comunicazioni delle autopattuglie giunte sul posto, e in
quelle della sala operativa. Bene, andiamo avanti. Nel frattempo, uditi i primi
drammatici appelli, la pattuglia Squalo4 si dirige verso il luogo indicato dalla
Sala Operativa, e cioè via Fani, ma giunta nei pressi di tale strada, apprende,
anche qui non si sa e non si saprà mai da chi, che la 132 con uomini
incappucciati a bordo era stata vista dirigersi verso la Balduina. E come faceva
mai un eventuale informatore nei pressi di via Fani a poter dire che la 132 si
dirigeva verso la Balduina? Semplicemente, non avrebbe potuto. Guardando la
piantina della zona, che abbiamo inserito nell’articolo, ci si può rendere conto
sia di questo che di altro, sempre supportato da stralci dei documenti. Vicenda
che si conclude come segue: la Squalo4 trova l’auto, alle 9:23, nella poi famosa
via Licinio Calvo, e chiama a sua volta la pattuglia Digos4. Tale pattuglia
prende il comando delle operazioni, chiama la Scientifica per i rilievi, redige
un verbale che, omettendo di dire di essere stati lì chiamati dai colleghi, fa
intendere che siano stati proprio loro a trovare l’auto. E infatti, saranno i
componenti della Digos4 ad essere convocati in Tribunale nei Processi, mentre i
4 componenti l’equipaggio Squalo4 scompariranno definitivamente dalla scena. E
non gli si poté chiedere, ammesso che qualcuno oltre noi ne avesse maturato la
“curiosità”, chi e come li avesse informati e come fecero a trovare
l’auto 132 in così breve tempo».
In sintesi, credo di poter
affermare che il vostro, oltre ad essere un lavoro encomiabile, è altrettanto un
lavoro che sopperisce a quanto, di norma, avrebbero dovuto svolgere già da tempo
le Istituzioni. Concluderei la nostra intervista chiedendoti, per favore, della
tua visita al box di via Montalcini. Cosa è accaduto?
«Le
cose andarono così. Ero in contatto con una giovane avvocato: Benedetta Piola
Caselli, che all’epoca attraversava un momento di forte interesse per
il Caso Moro. Mi comunicò che sarebbe andata a dare un’occhiata alla palazzina
di via Montalcini insieme ad altre persone, e ci invitò ad unirci; essendo
l’unico vicinissimo a Roma, potei andarci solo io, pensando che potesse essere
comunque interessante guardare, oltre che la palazzina, i luoghi circostanti.
Alle volte, in un certo senso, i luoghi ci parlano. Avevo però sottovalutato le
capacità di Benedetta, che riuscì ad un certo punto, andando appresso ad un
fattorino, ad entrare, accedere al garage e, a quel punto, fare entrare anche
noi altri. Mentre ci aggiravamo nella penombra, ecco la bascula
del garage aprirsi. Qualcuno era arrivato per parcheggiare. Inutile dire che ho
davvero temuto che quel qualcuno ci avrebbe cacciati, e anche in malo modo. E
invece, Benedetta, dimostrando una volta di più la sua bravura, avvicinati i due
signori che occupavano l’auto appena entrata, riuscì a conquistarne la
disponibilità in pochi secondi. Non solo: scoprimmo pure di avere avuto un colpo
di fortuna clamoroso, perché i due si rivelarono essere addirittura i
proprietari proprio del box in questione! È così che, con nostra grandissima
emozione, siamo riusciti a entrare, guardare, fotografare, e capire, sia pure ad
occhio, che qualcosa nelle dimensioni non tornava. Quando, mesi dopo, pure la
Commissione parlamentare fece il suo sopralluogo, con foto, misurazioni,
simulazioni con una R4 identica, prove di sparo e prove audiometriche connesse,
e dopo che il RIS presentò le sue risultanze provvisorie, notammo, proprio nelle
foto allegate, un dettaglio perfino più ragguardevole. Oltre alle foto fatte
dalla Commissione, la stessa aveva infatti accluso pure quelle fatte dalla
Polizia negli anni ’80. È stato così che ci siamo accorti che, in passato,
il box era, con tutta evidenza, ancora un po’ più corto di oggi».
L'ENIGMA DI VIA MONTALCINI
8. Qualcuno
dirà: "Ci sono dei rei confessi che hanno dichiarato di aver tenuto segregato
Moro in quell'appartamento in via Camillo Montalcini 8 all'interno 1 e di averlo
ucciso nel box di pertinenza. Perché parlare di un enigma?". Scrive giovedì 11
gennaio 2018 "Sedicidimarzo.org". Dubbi su questa questione, in realtà, ne sono
stati sollevati tanti già in passato ma, a prescindere dalle perizie autoptiche
che contrastano con l'asserzione di un Moro ristretto in una angusta
intercapedine per due mesi, vogliamo soffermarci, attraverso la consueta analisi
delle carte, sulla genesi dell'attribuzione della qualità di "prigione di Moro"
a quell'appartamento. In breve i fatti salienti:
1) L'appartamento e la sua
proprietaria (ma anche su questo termine ci sarebbe qualcosa da ridire) furono
"sotto osservazione" dell'UCIGOS già nell'estate del 1978. Un'osservazione
nemmeno troppo discreta ma al tempo stesso "distratta" se è vero, come è vero,
che la Braghetti se ne accorse e tuttavia potè anche vendere l'appartamento e
traslocare tranquillamente nel giro di alcuni mesi.
2) Di questa "osservazione"
non fu riferito alla Magistratura per due anni e anche dopo la notizia rimase
molto circoscritta.
3) Della ubicazione della
prigione in via Montalcini si inizierà a parlare solo nell' '82 in base ad
indizi derivati dalle confessioni di Savasta. E comunque solo a dieci anni dai
fatti la cosa prenderà corpo.
4) Che una abitante del
condominio abbia detto di aver visto in quel box proprio una R4 rossa è, come
vedrete, un falso mediaticamente diffuso e basato sulla forzatura di quanto
realmente affermato dalla testimone, quasi per confermare a quell'appartamento
la "qualità" di vera prigione di Moro. Ma lasciamo spazio appunto a questo primo
articolo-inchiesta sulla questione.
NEI MEANDRI DELLA PRESUNTA
“PRIGIONE DEL POPOLO” (A cura di: Andrea Guidi). Tra l'estate e l'ottobre del
1978, L'Ucigos (acronimo di Ufficio Centrale Investigazioni Generali e
Operazioni Speciali, sintetizzando, l'"Ufficio politico" della Polizia) di Roma
svolse continuate indagini sull'appartamento situato in Via Montalcini 8,
interno 1, che poi solo in seguito si rileverà essere stato, stando alla verità
"ufficiale" stabilita in sede giudiziaria e raccontata dagli ex
brigatisti, l'unica "prigione" di Aldo Moro. Quelle indagini, rimaste ignote
alla Magistratura fino al 1980 cioè subito dopo l'arresto della Braghetti
avvenuto alla fine di maggio, avevano riguardato tanto l'appartamento che i suoi
occupanti, in particolare la formale proprietaria, Anna Laura Braghetti
(all'epoca non ancora "clandestina" e il cui nome sarebbe stato appunto per
questo utilizzabile), e colui che risultò apparire quale convivente di costei,
quel "Luigi Altobelli" risultato in realtà di falsa e sconosciuta identità,
finchè nella prima metà degli anni '90, come noto, venne ufficialmente
identificato in Germano Maccari. Ma se fino al 1980 quelle indagini erano
rimaste ignote, va detto che addirittura l'intera ricostruzione della vicenda,
dalla segnalazione che originò quelle indagini agli sviluppi poi presi, verrà
disvelata e ricostruita, come si vedrà tra breve, solo a partire dal maggio
1988. Si verrà così a sapere che le indagini dell'Ucigos a carico della
Braghetti e dell'appartamento di Via Montalcini 8 erano iniziate a seguito di
una segnalazione fatta pervenire, a quanto sembra in un periodo variabile tra
due settimane e un mese dopo l'omicidio dell'On. Moro, da due condomini
dell'edificio di Via Montalcini all'avvocato Martignetti, loro cognato. I due
condomini, coniugi Piazza-Ciccotti, stando alle loro stesse parole, che essi
peraltro difenderanno e ribadiranno sempre pervicacemente nel corso degli anni
in ogni sede processuale, avevano riferito all'Avv. Martignetti un insieme di
generici sospetti già maturati sulla coppia di inquilini dell'appartamento
interno 1 (la Braghetti e il suo convivente) in ragione di una serie di
"stranezze" o presunte tali riscontrate negli atteggiamenti della coppia; nel
corso degli sviluppi successivi e a seguito delle varie deposizioni nel corso
del 1988, e successivamente in dibattimento nel 1993, era altresì emerso che,
in virtù di un processo mentale ovviamente fatto a posteriori, cioè dopo il
ritrovamento dell'On. Moro in Via Caetani, la signora Ciccotti aveva collegato
ai precedenti sospetti generici già maturati da ben prima, e solo quale
ulteriore elemento di sospetto, la circostanza di avere notato, la mattina
presto di un giorno collocabile tra una settimana e poco prima del 9 maggio
(data dell'omicidio di Aldo Moro), mentre era intenta a prendere la propria
auto, la parte anteriore di un'auto rossa nel garage della Braghetti. Fermo
restando il fatto quindi, stando alle costanti e convinte deposizioni dei
coniugi in ogni sede in cui essi vennero ascoltati, della marginalità, rispetto
ai sospetti già maturati, e nella stessa segnalazione fatta a Martignetti,
dell'osservazione da parte della signora della porzione anteriore dell'auto, va
comunque rilevato che quest'auto venne sempre indicata, dai testi e specialmente
dalla signora Ciccotti, solo quale una generica auto rossa, dunque, e non già
una specifica "Renault rossa", cioè il tipo di auto- o la stessa auto- nella
quale la mattina del 9 maggio venne ritrovato il corpo dell'On. Moro in Via
Caetani. A quanto pare, invece, nei successivi passaggi di questa segnalazione
verso gli organi competenti, il contenuto centrale dell'informazione divenne,
non si sa come né perché, non solo proprio l'auto, ma soprattutto proprio
una "Renault rossa". La sintesi dei successivi passaggi della trasmissione della
segnalazione è la seguente: per la precisione, L'Avv. Martignetti trasmise la
segnalazione ricevuta dai cognati all'On. Gaspari, che abitava nello stesso
palazzo dove egli aveva il proprio studio legale. L'On. Gaspari aveva poi
informato immediatamente l'allora ministro dell'Interno, On. Virginio Rognoni,
subentrato all'inizio di giugno di quell'anno al posto del predecessore Cossiga,
dimessosi il giorno dopo l'omicidio di Moro. Il ministro Rognoni aveva quindi
riferito a sua volta di quella segnalazione al suo capo di Gabinetto, Prefetto
Coronas, il quale attivò a cascata i dirigenti operativi dell'Ucigos, Noce e De
Francisci, per avviare le indagini sui luoghi cui quella segnalazione faceva
riferimento. Quelle indagini, conclusesi senza nessun esito concreto e con il
tranquillo trasloco della Braghetti dall'appartamento il 4 ottobre
1978, rimarranno come detto ignote alla magistratura e all'opinione pubblica per
circa due anni. Fu infatti solo a seguito dell'arresto della terrorista,
avvenuto a Roma a fine maggio del 1980, e di alcune bene informate indiscrezioni
di stampa subito apparse, che emerse con certezza ed adeguato risalto pubblico,
nel giugno 1980, il fatto che la terrorista fosse proprietaria, all'epoca del
sequestro e dell'omicidio dell'On. Aldo Moro, dell'appartamento in Via
Montalcini. Incuriositi da questa vicenda e del perché la Braghetti non fosse
stata arrestata subito, prima del suo trasloco, in quella fine estate del 1978,
abbiamo affrontato lo studio delle fonti di libera consultazione disponibili
(non solo il testo dell'On. Flamigni "Il covo di Stato e la prigione fantasma",
ed. Kaos, 2016; ma soprattutto l'archivio pubblico dell'On. Gero Grassi,
disponibile sul sito gerograssi.it, e il materiale disponibile sui volumi della
prima Commissione parlamentare di inchiesta. Nel corso dello studio, ricostruiti
sistematicamente tutti i documenti rinvenuti (appunti degli uffici di Polizia,
deposizioni varie, passaggi di alcune sentenze, ecc.), abbiamo maturato forti
dubbi sulla storia di quelle indagini e sul loro esito totalmente
inconcludente. Nonostante l'avallo giudiziario recato all'operato degli organi
di Polizia e segnatamente dell'Ucigos dalla sentenza-ordinanza del giudice
Priore del 1990 nel corso del così detto processo "Moro Quater", la vicenda
delle indagini compiute da questo organo di Polizia nell'estate 1978 senza alcun
esito immediato e soprattutto senza alcun intervento in danno della Braghetti,
costituisce un aspetto fondamentale nella complessiva vicenda del covo di Via
Montalcini, e la questione della ragionevolezza o meno del comportamento inerte
dell'Ucigos e delle giustificazioni addotte per la mancata adozione di una
qualche alcuna azione concreta è una questione a nostro avviso ancora aperta ed
è un grosso punto debole della versione ufficiale cristallizzatasi sulla
vicenda. La mancata adozione di interventi immediati e concreti a carico della
Braghetti, quali il suo arresto e l'irruzione tempestiva nell'appartamento prima
che costei traslocasse in tutta tranquillità (irruzione che pure era stata
riservatamente preannunciata, come si vedrà, agli altri condomini dell'edificio
proprio pochissimi giorni prima che la Braghetti poi traslocasse), è
riassumibile, sintetizzando gli elementi desumibili dalle fonti, con
l'affermazione reiterata dalle varie strutture di polizia (dai funzionari
dell'Ucigos fino al Ministro dell'Interno) della supposta carenza di sufficienti
elementi di sospetto, in quanto nel corso di quelle indagini nulla sarebbe
emerso a carico della Braghetti e del suo convivente, l'evanescente “Ing.
Altobelli”. A nostro parere invece i fondati elementi di sospetto non solo
esistevano, ma furono persino espressamente manifestati dagli stessi agenti
dell'Ucigos agli altri condomini dello stabile, nel corso della riunione tenuta
con alcuni di essi in casa dei coniugi Manfredi-De Seta intorno alla fine del
settembre 1978. In esito al nostro studio, infatti, ci pare di poter concludere
che emerga invece con sufficiente chiarezza che la tesi sostenuta dalle
Autorità e dagli organi di Polizia a giustificazione del proprio operato, alla
fine delle indagini inerte, si impernia sostanzialmente su vari elementi, dei
quali quello a nostro giudizio divenuto il principale e per certi versi il più
ambiguo, è proprio la circostanza già accennata della apparente mutazione
dell'oggetto principale della segnalazione originaria non solo nella supposta
presenza di una certa auto, ma, ancor più, nel salto qualitativo da una
generica "auto rossa" alla specifica "Renault rossa". Infatti da un certo punto
in poi nella rendicontazione degli esiti delle indagini partite dalla
trasmissione della segnalazione, si assiste alla reiterazione dell'affermazione,
da parte delle autorità di Polizia, del fatto che nulla fosse emerso, durante
gli accertamenti in Via Montalcini, in merito alla presenza nei luoghi di
una “Renault rossa”, che finirà addirittura per essere qualificata, in un
successivo documento prodotto, come si vedrà, dalle autorità stesse nel febbraio
1982 alla prima Commissione parlamentare di inchiesta, come “l'oggetto
principale della segnalazione” ricevuta a suo tempo. Come se, in sostanza,
divenuto addirittura "oggetto principale della segnalazione", nella trasmissione
di mano in mano dell'informativa, proprio una "Renault rossa", ma non avendo
evidentemente avuto riscontro dai condomini di Via Montalcini in merito alla
presenza o meno di un'auto del genere sui luoghi, per gli agenti dell'Ucigos
dovette finire con l'essere del tutto consequenziale non rilevare alcun elemento
di sospetto sulla Braghetti e sul suo convivente misterioso. Cosa che avrebbe
dunque giustificato la mancanza di qualunque intervento tempestivo degli agenti
nei confronti della Braghetti e di quell'appartamento. Come accennato, infatti,
è' in sostanza solo nel maggio 1988 che, a seguito del rinnovato interesse
suscitato sul “caso Moro” dalla pubblicazione del libro-inchiesta del Sen.
Sergio Flamigni della prima edizione del “La tela del ragno”(Edizioni
Associate) in occasione del decennale dei tragici fatti – testo fondamentale
per l'indubbio merito di avere riportato ad una generale e da allora mai scemata
attenzione l'analisi e lo studio dell'intera vicenda- emersero con compiutezza
la cronistoria della segnalazione e degli altri fatti in questione, e i
nominativi di alcuni dei protagonisti di questo specifico aspetto della vicenda,
primi tra tutti i coniugi Piazza- Ciccotti come autori dell'originaria
segnalazione, l'avv. Martignetti, l'On. Gaspari, quest'ultimo quale tramite tra
gli originari segnalanti e il Ministro Rognoni, il quale nella sua veste
istituzionale conferì l'impulso decisivo per la trasmissione dell'ordine
esecutivo, tramite il prefetto Coronas, ai dirigenti dell'Ucigos, per
l'attivazione delle indagini effettuate nel 1978. La pur complessa articolazione
dei fatti può, in sintesi, riassumersi nei termini seguenti. Ai primi di maggio
di quel 1988, il Sen. Sergio Flamigni nel citato suo primo libro-inchiesta sulla
vicenda appena edito, tra l'altro chiedeva: "Perchè il ministro Rognoni non ha
mai riferito il nome dell'uomo politico del suo partito che poco dopo
l'uccisione di Moro fece la segnalazione sulla Renault rossa vista a casa della
Braghetti (in Via Montalcini 8), del tutto simile a quella su cui si trovava il
cadavere (di Moro) in via Caetani?" (per il testo riportato, cfr. S. Flamigni,
"Il covo di Stato e la prigione fantasma", ed. Kaos, 2016, pagg 289-290). In
esito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal ministro Rognoni al quotidiano "Il
Manifesto" a commento del libro di Flamigni appena pubblicato, che lo tirava in
ballo per la vicenda delle indagini del 1978, nelle quali il ministro confermava
ai giornalisti la veridicità delle affermazioni contenute nel libro circa il suo
ruolo avuto nell'attivazione delle indagini nel 1978, ma rifiutandosi tuttavia
di fare il nome del suo collega di partito che gli aveva trasmesso una certa
segnalazione su Via Montalcini, il 13 maggio 1988 il ministro stesso deponeva
spontaneamente innanzi al magistrato titolare in quel momento dell'inchiesta,
raccontando la propria versione della sequenza dei fatti e facendo in quella
sede il nome dell'On. Ramo Gaspari, suo collega di partito, quale latore, nel
giugno o luglio 1978, della segnalazione in questione (per il verbale della
deposizione di Rognoni, cfr. faldone On. Grassi 320_01, pag. 31 e seg.). E' in
questa occasione che il ministro dichiara che nel 1978, precisando subito "direi
intorno ai primi di luglio", si era recato da lui al Viminale il ministro Remo
Gaspari per segnalargli, a dire di Rognoni stesso, che era stata vista
precedentemente all'omicidio di Moro, in Via Montalcini, una "macchina rossa del
tutto simile a quella ritrovata in via Caetani...". Le parole del ministro, si
deve osservare, riprendevano in sostanza, nel 1988, lo stesso concetto già
utilizzato da De Francisci (Dirigente dell'Ucigos) nella su accennata risposta
alla Commissione parlamentare di inchiesta del febbraio 1982, e già fatto
proprio dallo stesso Rognoni nella sua audizione innanzi la Commissione
parlamentare stessa del 1983, nella corso della quale egli aveva tra l'atro
affermato (CM-1, Vol. 11, pag. 159). Tornando alla deposizione di Rognoni del
1988, come si vede a questo punto l'equiparazione, sia pure fatta a posteriori,
tra la generica “auto rossa” di cui parleranno due settimane dopo di lui invece
i coniugi Piazza, e la specifica “Renault di Moro” (per usare le stesse parole
usate dal ministro 5 anni prima) diviene un fatto compiuto anche in sede
giudiziaria. Il ministro Rognoni aggiunge quindi: "Ricordo di aver preso un
breve appunto della segnalazione...che trasmisi subito al Capo di
Gabinetto (nda: Coronas), dicendogli anche il nome della persona che mi aveva
dato l'informazione. Qualche tempo dopo ho chiesto a Coronas quale riscontro
aveva avuto l'informazione e ne ebbi risposta negativa. Gaspari mi riferì la
notizia oralmente. Ho parlato pochi giorni fa nuovamente con Gaspari, dopo che
sulla stampa erano apparsi articoli con diverse valutazioni concernenti la
segnalazione pervenuta alla Polizia dal Gabinetto del Ministro sulla macchina
rossa e conseguenti sopralluoghi. Il collega mi ha confermato la sua visita al
Viminale e il contenuto della segnalazione. Mi ha riferito inoltre che la sua
fonte era un medico". Tuttavia il ministro Gaspari, se conferma la visita al
Viminale, rettifica invece, e non di poco al di là delle espressioni e del tono
utilizzato, le affermazioni di Rognoni quanto al contenuto della segnalazione
che egli avrebbe trasmesso a quest'ultimo. Il giorno successivo alla deposizione
di Rognoni, infatti, Gaspari - tirato in ballo per la prima volta nella vicenda
- emette un “comunicato stampa” nel quale afferma invece di non ricordare a
distanza di dieci anni dai fatti, se tra i particolari che l'avvocato
Martignetti (di cui però Gaspari ancora non fa il nome) gli ebbe a riferire (e
che il Ministro ha affermato di avere appuntato su un foglietto) “ci fosse
quello della macchina rossa. Ricordo solo che Rognoni mi ascoltò e prese
appunti” (cfr. faldone On. Grassi 320_01, pag. 1). Una notazione va fatta
immediatamente: tenuto conto della unicità delle circostanze storiche per le
quali quell'auto assurse a tanta sinistra fama, appare poco plausibile che
Gaspari non ricordasse se tra i particolari della segnalazione da lui ricevuta e
poi trasmessa a Rognoni ci fosse quello dell'”auto rossa”; pare in altre parole
che in qualche modo il Ministro Gaspari abbia voluto smentire o quanto meno
affievolire le dichiarazioni resa al giudice il giorno prima dal suo collega
Rognoni, circa l'elemento dell'auto rossa e in particolare della sua
corrispondenza (o quasi) a quella nella quale era stato lasciato il corpo di
Moro in Via Caetani affermata invece da Rognoni stesso. La dichiarazione
del ministro Gaspari alla stampa dava poi conto, prima di tutto, di come egli
fosse venuto a conoscenza della segnalazione: “Una mattina, scendendo dalla mia
abitazione (nda: in Viale delle Milizie), ho incontrato un collega avvocato, il
quale, con grande cautela e circospezione, disse che doveva darmi qualche
notizia di particolare interesse. Mi fece presente che aveva avuto elementi in
base ai quali riteneva che la prigione di Aldo Moro potesse trovarsi in una
certa zona di Roma”. Con quel chiaro riferimento al luogo dell'incontro e alla
professione svolta, l'individuazione del latore della segnalazione fu in pratica
immediata, anche da parte dei mezzi di informazione. Infatti, già il 16 maggio,
alle ore 12.10, inizia, davanti al giudice Priore, la deposizione dell'Avv.
Mario Martignetti, subito identificato (cfr. faldone On. Grassi 320_01, pag. 33
e seg.). L'avvocato consegna al giudice una lettera, allegata al verbale, che
aveva predisposto quel giorno stesso allo scopo di consegnarla ai giudici. Nella
missiva (cfr. faldone On. Grassi 320_01, pag. 2), l'avvocato, riferendosi “alle
notizie oggi diffuse dalla radio e dalla stampa”, rende noto in particolare
che: “E' vero che a causa di una prestazione professionale da me svolta
all'epoca del rinvenimento del corpo dell'on.le Aldo Moro, mi convinsi della
opportunità che le ricerche della sua prigione fossero estese anche a Via
Montalcini”. Quanto alla sua deposizione vera e propria, l'avvocato Martignetti,
da quanto risulta nel verbale, afferma, in sintesi:
- di avere incontrato l'On.
Gaspari successivamente all'omicidio dell'On. Moro;
- i fatti gli erano stati
riferiti dalle sue fonti - che egli non rivela- nell'ambito di una prestazione
professionale occasionale, e, a suo dire, certamente dopo la morte dell'On.
Moro;
- di avere detto a Gaspari
che, a seguito di un colloquio con un "cliente", era opportuno estendere la
ricerca della prigione di Moro a Via Montalcini (la circostanza è peraltro anche
riferita da Gaspari nel suo comunicato stampa di 2 giorni prima, anche se, come
si è visto, con generico riferimento, da parte del ministro, a "una certa zona
di Roma");
- che lo stesso Gaspari ancora
in epoca recente o recentissima gli aveva ricordato l'episodio del loro incontro
e l'indicazione datagli nel 1978 da Martignetti stesso circa la necessità di
estendere le indagini sulla prigione a Via Montalcini;
- di non avere "punti di
riferimento per collocare più esattamente nel tempo" la sua segnalazione,
così "come la dichiarazione del cliente", in quanto non procedette a redigere
alcun atto giudiziario; ma che comunque il colloquio con Gaspari avvenne la
mattina successiva al suo colloquio con il "cliente".
Al di là di alcune evidente
incongruenze sulle modalità di acquisizione delle informazioni dalle sue "fonti"
(in realtà non un cliente, bensì semplicemente il cognato, stando a quanto
risulta ufficialmente), la menzionata lettera da lui predisposta e allegata al
verbale testimoniale contiene, inoltre, un'affermazione che si pone in sostanza
in perfetta analogia con quanto riportato da Gaspari in merito al suo colloquio
con Rognoni in merito ai dettagli sul contenuto della segnalazione originaria,
poiché in sostanza in quella lettera Martignetti afferma in sostanza di non
ricordare il contenuto preciso del colloquio avuto con il "cliente" nel 1978,
sia pure motivandolo in base a due ragioni ben poco verosimili, e cioè " forse
perchè di scarsa importanza e certamente a causa del tempo da allora
decorso oltre che a causa della mancanza di un riscontro obbiettivo della sua
rispondenza al vero". Circostanze, ovviamente, entrambe smentite dal successivo
arresto della Braghetti quale militante delle Brigate Rosse e ufficialmente
compartecipe attiva nella fase di gestione del sequestro dell'On. Moro.
L'avvocato Martignetti viene nuovamente ascoltato, quindi, il giorno successivo,
17 maggio 1988, alle ore 20.10, dal giudice Priore (cfr. faldone On. Grassi
320_01, pag. 3 e seg.), deposizione nel corso della quale – a parte una serie
di doglianze per il fatto che la vicenda, a cominciare dal suo nome, fosse
emersa sui mezzi di informazione, i quali erano arrivati tra l'altro ad
occuparsi della sua pregressa militanza in un partito politico di destra oltre
che della sua attività di difensore di militanti del movimento neo fascista
"Ordine Nuovo" – ai fini che qui rilevano ciò che più conta è che egli non
menziona affatto neppure una generica "auto rossa", né alcuna domanda in merito,
a quanto si deduce, gli viene posta dal giudice. Vale la pena rilevare
incidentalmente come rimarranno sempre privi di qualsiasi approfondimento le
modalità e gli elementi in virtù dei quali egli avrebbe maturato la propria
convinzione, poi riferita a Gaspari, del fatto che a Via Montalcini si potesse
trovare addirittura proprio la “prigione” di Moro, nonostante questa ipotesi non
sia mai stata neppure solo ventilata dai suoi referenti Piazza e Ciccotti.
Depongono quindi innanzi ai giudici, il Prefetto Coronas, il dr. Noce e,
finalmente, ormai individuati quali latori dell'originaria segnalazione del
1978, in data 1° giugno 1988 anche i coniugi Piazza e Ciccotti. Nella sostanza,
i funzionari di Polizia Coronas e Noce ribadiscono la centralità, già acquista
negli anni precedenti dalle varie autorità di polizia stando agli ordini e
segnalazioni impartiti e ricevuti, dell'avvistamento in Via Montalcini di
una Renault rossa: in ultima analisi, Coronas e Noce confermano le parole
espresse dal Ministro dell'Interno Rognoni, a definitiva consacrazione del
mutamento dell'oggetto della segnalazione e della centralità asseritamente
assunta ex novo in suo seno proprio dalla specifica "Renault rossa", rispetto
invece al suo contenuto originario, ben più generale o generico, sempre
ribadito dai coniugi Ciccotti e Piazza e di fatto concorde con i ricordi di
Gaspari e Martignetti, a dir poco "freddi" in merito alla questione dell'auto.
Vale tuttavia soffermarsi più in dettaglio sulla deposizione, del 18 maggio
(1988) del Dr. Noce. Vi sono in verità anche alcuni altri elementi, che meritano
un successivo approfondimento, delle parole utilizzate dal teste, in particolare
i dubbi che suscita il riferimento nelle sue parole a potenziali "altri"
soggetti che per ipotesi si sarebbe dovuto verificare, da parte dell'Ucigos, se
avessero notato l'auto in questione: "altri" rispetto a chi, se l'identità
specifica degli originari segnalanti - coniugi Piazza e Ciccotti - emergerà solo
nei giorni successivi? Ma a parte questo, e alla rivelazione - finalmente, dopo
la richiesta del giudice Imposimato che risaliva al luglio 1980 - dell'identità
di almeno un paio degli agenti dell'Ucigos che operarono in via Montalcini
durante le indagini del 1978 in questione, il dr. Noce, nelle sue conclusioni,
elabora infine una mirabile sintesi di quegli indici di presunta mancanza di
sospetto che avrebbero spinto l'Ucigos a non proseguire oltre, elementi
testualmente reiterati come un costante filo conduttore, in tutti gli appunti ed
altri documenti prodotti sulla vicenda dall'Ucigos, da Uffici di Polizia e dal
Ministero, a partire dal'8 agosto 1978, fino a quello stesso maggio 1988.
Dichiara, infatti, il dr. Noce (la suddivisione per capi numerati e le
sottolineature sono nostre):
1) "Gli investigatori
riferirono di avere interpellato gli inquilini …e che nessuno aveva dichiarato
di avere notato la presenza nel garage dell'auto in questione";
2) "Gli investigatori
mostrarono anche degli album di fotografie agli inquilini di quel palazzo, album
di terroristi noti, tra cui Gallinari, ma nessuno trovò rassomiglianze tra
Altobelli e alcuno dei personaggi rappresentati nelle fotografie";
3) "Ricordo che furono fatti
anche numerosi pedinamenti sulla Braghetti, ma da essi non risultò alcun
elemento meritevole di ulteriore sviluppo investigativo".
Dopo di che, evidentemente
individuati a seguito in particolare delle pressioni che, pare, l'autorità
giudiziaria dovette esercitare sull'Avv. Martignetti – che in un primo momento
aveva opposto il segreto professionale - per fargli rivelare le sue fonti, i
coniugi Piazza- Ciccotti, autori dell'originaria segnalazione, vengono dunque
finalmente ascoltati sullo specifico punto in questione (l'auto rossa) entrambi
il 1° giugno 1988, dal giudice Cudillo, alla presenza del giudice Priore e del
P.M. Sica. Alle ore 14.20 del 1° giungo 1988 depone per primo il marito (faldone
On. Grassi 320_001, pag. 23 e seg.), Giorgio Piazza. Il signor Piazza racconta,
tra le altre cose, appunto, che fu la moglie a vedere, “qualche giorno
prima” dell'uccisione dell'On. Moro, un'auto di colore rosso, attraverso la
serranda basculante del box della Braghetti, senza riuscire tuttavia ad
identificare con precisione quest'auto. Dopo “una settimana o quindici
giorni” dall'omicidio, egli ne parla con suo cognato, Avv. Martignetti, al
quale, afferma, già in precedenza aveva chiesto un colloquio per manifestargli i
propri sospetti. Il verbale della deposizione del signor Piazza prosegue poi con
questa affermazione (le sottolineature sono nostre): "Evidentemente riferii che
nel box mia moglie aveva visto una macchina rossa e presumo di avere aggiunto
che il box era di pertinenza dell'appartamento della signora Braghetti". Come si
desume, la precisazione segue a specifica domanda sia pure
inespressa ("Evidentemente..."), in quanto con tutta evidenza per il teste la
questione dell'auto non aveva assunto un ruolo centrale nel suo colloquio con
Martignetti. Quindi Piazza dichiara appunto che l'avvocato Martignetti lo aveva
sul momento tranquillizzato, data la genericità dei sospetti manifestati, senza
aggiungere nulla circa sue eventuali iniziative. Alle ore 14.50 dello stesso
giorno depone la moglie, signora Graziana Ciccotti, e, tra le altre cose,
dichiara appunto: “in un tempo variante da tre giorni a una settimana
prima della morte dell'on. Moro, ho intravisto, attraverso la serranda
basculante della Braghetti e mentre costei era intenta a chiudere il garage,
il parafango anteriore destro di una autovettura di colore rosso”. (ibid., pag.
21 e segg.). (Sul punto, il più volte citato testo di S. Flamigni "Il covo di
Stato…", pag. 288, reca un'inesattezza, poiché attribuisce questa dichiarazione
alla precedente deposizione della signora del 15 dicembre 1987, che invece, come
si è tratteggiato, verteva esclusivamente su altro). La signora dichiara prima
di tutto in modo generico (le sottolineature sono nostre): "Ho notato nel
comportamento della coppia degli atteggiamenti che davano adito a sospetti".
Proseguendo, poi, la signora, narrato l'episodio della vista dell'auto rossa –
da lei genericamente individuata - nella settimana antecedente l'omicidio,
aggiunge: "Io ho successivamente manifestato a mio marito il sospetto che si
potesse trattare di brigatisti e questi, di sua iniziativa, ne ha parlato con
l'avv. Martignetti. Successivamente alla morte dell'On. Moro non sono stata
mossa da alcuna curiosità per esaminare i luoghi pertinenti al box, anche perchè
non avevo elementi per affermare che si trattasse sicuramente di brigatisti che
avessero partecipato all'omicidio Moro." Prosegue, la signora, dichiarando che
il marito, a seguito del colloquio dal lui avuto con l'Avv. Martignetti, le
riferì che quest'ultimo lo aveva tranquillizzato. Sono queste, a dieci anni dai
fatti, le prime fondamentali dichiarazioni dei due protagonisti dell'origine
delle indagini sul contenuto delle loro osservazioni e segnalazioni a
Martignetti. In definitiva, dunque, della questione dell' “auto rossa”, tra
tutti i testi, ne parleranno espressamente e in modo specifico solo i coniugi
Piazza-Ciccotti, solo nel 1988, e in ben diversi termini, rispetto a quanto sin
qui visto promanante dalle Autorità e dalle forze di Polizia, quanto alla
sua presuntapuntuale identificazione con una “Renault 4”. Questa essenziale
differenza qualitativa nei riferimenti a quell'auto, pone la necessità di
interrogarsi sul fatto che se è vero quanto pervicacemente affermato dai
coniugi circa la genericità di quanto visto dalla signora Ciccotti nel box della
Brgahetti, allora ci si deve conseguentemente chiedere da dove, in quale
momento e perchè , in sede politica e di Uffici di Polizia, si afferma che
l'oggetto principale della segnalazione fosse costituito proprio da una “Renault
rossa” (anziché una generica “auto rossa”). In realtà, come si vede, proprio la
ricostruzione e la delimitazione del contenuto della segnalazione originaria da
parte della coppia di condomini di Via Montalcini che ne fu artefice, da un
lato, e il diverso contenuto con il quale invece pare essa fosse stata trasmessa
dal ministro Rognoni a cascata alle autorità di Polizia, dall'altro,
costituiscono nel loro insieme uno dei maggiori punti critici dell'intera
vicenda. Si tratta di una divergenza di contenuto che caratterizza in modo
costante le rispettive dichiarazioni e deposizioni dei coniugi, da un lato, e
delle autorità, dall'altro. Ci è parso di constatare in particolar modo, a
nostro avviso, il fatto che l'espressa qualificazione, a partire da quel
documento già citato dell'Ucigos del febbraio 1982, di una "Renault rossa" quale
elemento centrale della segnalazione ricevuta, sembra proprio avere proceduto
quasi di pari passo con la sua sussunzione a elemento cardine della tesi auto
assolutoria affermata in sostanza dagli organi di polizia e dalle autorità
politiche, stando in particolare alle deposizioni sopra riportate del maggio
1988 dal ministro Rognoni e dai dirigenti di Polizia Coronas e Noce. Sintesi
mirabile ne è appunto la deposizione del Dr. Noce nella parte conclusiva che si
è riportata in dettaglio.
Viceversa, come si è visto,
nelle deposizioni o dichiarazioni tanto dei coniugi latori dell'originaria
segnalazione, che in quelle dell'avv. Martignetti e dell'On. Gaspari- passaggi
intermedi della sequenza informativa prima dell'arrivo a Rognoni- sembra
proprio che si fosse parlato prima di tutto di generici e antecedenti sospetti
maturati dalla coppia di condomini di Via Montalcini, e solo incidentalmente, a
tutto concedere, di una generica "auto rossa", quale cioè ulteriore e postumo
(rispetto al 9 maggio) mero elemento di sospetto, uno tra altri in quanto
ricollegato solo a posteriori dai due condomini, cioè dopo il fatto di Via
Caetani, ad un complesso di sospetti già in precedenza da loro covati e
maturati sugli occupanti dell'appartamento interno 1 Braghetti e "Altobelli".
Riassumendo, in sintesi questo è quanto accadde. I due, coniugi Piazza-Ciccotti,
furono in effetti il punto di partenza di tutta la non chiara vicenda. La
signora Ciccotti dichiarerà infatti - finalmente individuata solo nel 1988 come
originaria fonte dell'informazione- che in un tempo da circoscrivere tra due
giorni ed una settimana prima dell'omicidio dell'On. Moro, aveva intravisto nel
box della Braghetti la parte anteriore di una generica ed imprecisata “auto
rossa”. Dopo il ritrovamento del cadavere dell'On. Moro in Via Caetani, il 9
maggio 1978 dentro la tristemente famosa Renault 4 rossa, la signora aveva
esternato al marito il collegamento da lei fatto ovviamente a posteriori con i
generici sospetti sulla coppia occupante l'appartamento interno 1 maturati già
in precedenza dai due (nonché dagli altri condomini) in ragione della presunta
“stranezza” di atteggiamenti della coppia stessa. Nonostante le perplessità del
marito - signor Piazza - costui si era infine risolto, un po' di tempo dopo (che
egli quantificherà come visto in circa due settimane dopo l'omicidio dell'uomo
politico) a rivolgersi a suo cognato, l'avv. Martignetti, per manifestargli
nulla più che questi generici sospetti, comprensivi forse - ma la cosa non è
nemmeno certa, stando ai rispettivi ricordi di Piazza, Martignetti e Gaspari -
del riferimento all'auto rossa avvistata a suo tempo dalla moglie nel box della
Braghetti; auto rossa che, come si evince, non fu dunque di certo “l'oggetto
principale della segnalazione” come definita dalle autorità nel menzionato
documento del 1982. Eppure, come risulta dai documenti esaminati, se la
relazione più volte citata del febbraio 1982 ricostruendo la vicenda del 1978
per la Commissione parlamentare aveva per l'appunto definito la “Renault rossa”
quale “oggetto principale della segnalazione”, stando alla deposizione del
ministro Rognoni innanzi al giudice istruttore del 1988 ci è parso di poter
rilevare che è proprio solo a partire dalla successiva trasmissione
dell'informativa da parte dell'ex ministro ai suoi sottoposti in linea
gerarchica che questa generica “auto rossa” diventò ex novo "elemento
principale della segnalazione" e soprattutto venne improvvisamente individuata o
indicata in modo specifico come una “Renault rossa”, nonostante i coniugi
Piazza – Ciccotti ribadiranno sempre, in ogni sede, di non avere mai parlato di
una “Renault rossa” (né, peraltro, di alcuna altra specifica auto). In
definitiva, la tesi degli Organi di Polizia, appare suggestiva ed ha in effetti
avuto pregio anche in sede giudiziaria. Ed è suggestiva al punto, ci sembra, da
avere perfino indotto a nostro parere (come tale ovviamente passibile di
fallacità) ad una esiziale petizione di principio anche uno dei più profondi
studiosi del “caso Moro”, l'ex Sen. Sergio Flamigni, di certo non tacciabile,
per usare un eufemismo, di particolare accondiscendenza verso le acquisizioni
ufficiali sul sequestro dell'On. Moro e in special modo sulla vicenda di Via
Montalcini. Scrive, infatti, Flamigni (cfr. “Il covo di Stato e la prigione
Fantasma" ed. Kaos, 2016, pagg. 293-294), commentando le testimonianze rese nel
1988 dai coniugi Piazza-Ciccotti in sede istruttoria: “...non si comprende
perchè la semplice vista di un “parafango anteriore destro di una vettura di
colore rosso” li abbia poi indotti a sospettare che l'auto intravista fosse la
Renault rossa contenente il cadavere di Moro in Via Caetani”. In realtà i
coniugi non "si indussero" mai a parlare di un specifica "Renault rossa", ma
rimasero per l'appunto sempre fermi all'avvistamento di una porzione limitata
del lato anteriore di una generica "auto rossa". Essi inoltre tanto meno
affermeranno mai di avere neppure lontanamente ipotizzato che in
quell'appartamento vi fosse addirittura “la prigione” di Aldo Moro, come si
espresse testualmente – lo si è visto- il loro interlocutore diretto,
Martignetti, nel trasmettere le proprie personali convinzioni all'On. Gaspari.
Donde Martignetti, poi, avesse tratto questa sua convinzione, che andava ben al
di là delle parole dei coniugi Piazza, è peraltro circostanza che non risulta
essere mai stata approfondita. La domanda che allora di necessità ci siamo
posti, di fronte per così dire a due pervicaci e reiterate manifestazioni di
contenuto diametralmente opposto, è perchè da un certo momento in poi della
catena informativa quella generica “auto rossa” sia stata indicata proprio come
una specifica “Renault rossa”, ed a che tipo di ricostruzione giudiziaria e
storica dei fatti, semmai, questo cambiamento di identità di quell'auto, e la
sua sussunzione ad elemento centrale della segnalazione, abbiano finito
eventualmente con l'essere stati oggettivamente funzionali. In ogni caso, che
quella "trasformazione" da generica "auto rossa" a specifica "Renault rossa"
abbia oppure no finito per costituire un oggettivo parafulmine a fronte dei
dubbi accumulatesi in sede parlamentare, giudiziaria e pubblicistica sulle cause
del mancato arresto immediato della Braghetti nella tarda estate 1978, resta il
fatto, di agevole percezione ad un sistematico studio dei documenti disponibili,
che l'Ucigos di elementi di sospetto ne aveva, o avrebbe dovuto averne, più
d'uno. Ci limitiamo ad elencarne alcuni, senza particolari commenti per esigenze
di sintesi:
a) gli stessi agenti
dell'Ucigos rilevarono in sostanza la falsa identità di colui che si presentava
quale "Luigi Altobelli", occupante con la Braghetti dell'appartamento-covo; già
questo avrebbe dovuto essere un pregnante elemento di sospetto, in un'epoca in
cui si sfondavano porte per molto meno;
b) poco prima che la Braghetti
traslocasse indisturbata, dunque verosimilmente nel settembre 1978 (ma potrebbe
essere anche prima), su iniziativa della stessa Ucigos si tenne in casa di altri
due condomini, coniugi Manfredi-De Seta, un riunione alla quale oltre ai due
funzionari dell'Ucigos parteciparono sei condomini dell'edificio, tra i quali
gli stessi Piazza e Ciccotti. Nel corso della riunione, le testimonianze
concordi dei sei condomini raccolte negli anni successivi in sede giudiziaria
affermano chiaramente che venne loro mostrato una sorta di album di fotografie
di sospetti terroristi, nell'ambito del quale venne mostrata anche la foto della
Braghetti: per quanto dunque non ancora "clandestina" e apparentemente
insospettabile secondo la versione ufficiale, è evidente che l'avere mostrato
anche la foto di costei, persona che i condomini conoscevano bene per essere
coinquilina del palazzo, non può che trovare giustificazione nel fatto che al
contrario di quanto affermato la Braghetti era invece persona già sospettata;
c) nel corso di quella stessa
riunione, venne preannunciata ai condomini presenti una imminente perquisizione
e anzi, secondo le versioni di alcuni di loro, una vera e propria irruzione, con
tanto di raccomandazioni per la loro incolumità; perquisizione che rimase
lettera morta e la cui mancanza lasciò di stucco i condomini di via Montalcini;
d) nei rapporti dell'Ucigos
disponibili, tra l'agosto e l'ottobre 1978, si dà ripetutamente atto del fatto
che la Braghetti avesse sottoscritto il contratto preliminare di acquisto per
l'appartamento di Via Montalcini – poi acquistato con rogito definitivo il 3
agosto, tempestivamente trascritto dal notaio rogante il giorno 10 di quello
stesso mese, senza che però né L'Ucigos, né i Carabinieri di Dalla Chiesa
riuscissero mai ad individuare l'avvenuta stipula dell'atto notarile;
circostanza, questa, meritevole in sé di ulteriore prossimo approfondimento-
impegnandosi ad acquistarlo per Lire 45.000.000, e che la stessa avrebbe
dichiarato (non sia bene a chi, peraltro) che la somma proveniva da eredità
paterna. Eppure, negli stessi rapporti, si dà parimenti atto del fatto che
l'eredità del padre della Braghetti ammontava a somme nel complesso ammontanti a
circa Lire 1.300.000.
Quest'ultima circostanza
avrebbe potuto e dovuto costituire, a nostro giudizio, uno dei massimi indici di
sospetto su Anna Laura Braghetti, in sede di quelle indagini. Si deve inoltre
aggiungere che ai primi di luglio 1980 – a seguito delle menzionate
indiscrezioni di stampa dalle quali era emerso che la brigatista arrestata aveva
la disponibilità anche di questo appartamento- vennero chiamati a deporre a
quel punto innanzi il giudice istruttore, dott. Imposimato, recentemente
scomparso, i condomini dell'edificio in questione, per quanto, tuttavia - quali
che furono le cause di questa carenza (variamente attestate dallo stesso
magistrato negli anni seguenti) - non vennero invece ascoltati in quel momento i
principali autori della segnalazione originaria, i già citati coniugi
Piazza-Ciccotti, nonostante che i loro nomi fossero comunque emersi subito
davanti al giudice nel corso delle deposizioni degli altri condomini, quali
compartecipanti alla suddetta riunione tenutasi in casa Manfredi con i due
agenti dell'Ucigos. Comunque sia, da queste prime deposizioni dei condomini
(coniugi Manfredi-De Seta, signor Signore) dell'estate 1980, emerse infatti con
chiarezza che l'Ucigos aveva svolto indagini reiterate nel corso
dell'estate-autunno 1978, organizzando anche la riunione condominiale in casa
dei coniugi Manfredi, poc'anzi citata. Il 5 luglio 1980 il giudice Imposimato
richiese all'Ucigos dettagliate informazioni sulle indagini svolte. Il 30 luglio
quell'ufficio di Polizia rispose inviando un “unito appunto”, non firmato,
datato 16 ottobre 1978, recante in sostanza una mera sintesi delle operazioni
svolte e dell'esito negativo raggiunto dalle indagini. Fermo restando l'avallo
che l'operato e le giustificazioni addotte dall'Ucigos riceveranno con la
sentenza-ordinanza del giudice Priore nel Moro-quater nel 1990, è comunque
necessario tentare di comprendere l'importanza centrale, nell'ambito di tutta la
vicenda del sequestro e dell'omicidio dell'On. Moro, assunta dalla questione
dell'accertamento di quanto accaduto a Via Montalcini nell'estate-autunno 1978,
e cioè delle indagini ad opera dell'Ucigos, e il disorientamento che
indubbiamente l'intricato susseguirsi dei fatti, dell'acquisizione di dati e
notizie in merito, può avere generato e genera tutt'oggi; a tale scopo, può
essere utile fare rinvio anche ad alcune parole espresse verosimilmente più in
libertà dal giudice Imposimato in alcune dichiarazioni di stampa attorno alla
metà degli anni '80, poco prima e durante l'iter scaturito alle varie
interrogazioni parlamentari proprio su questa specifica vicenda che si stavano
susseguendo in quegli anni. Ne segnaliamo pertanto alcune, che appaiono
caratterizzate da toni rammaricati che tuttavia ci appaiono oggettivamente
difficilmente giustificabili a fronte della sostanziale carenza di
approfondimento in sede giudiziaria del contegno dell’Ucigos e soprattutto del
fatto che le motivazioni avanzate da quell’ufficio e dalle autorità politiche
del mancato intervento immediato nei confronti della Braghetti vennero in
sostanza recepite e fatte proprie anche dalla stessa magistratura. Il 24 maggio
1986 – siamo nel corso della sequela di interrogazioni parlamentari, indagini
amministrative e risposte dei ministri, che avevano toccato in parte anche
l'operato della magistratura, sopra accennate- poi, il giudice Imposimato
rilascia un'intervista a “L'Unità”, nella quale in sostanza
esclude “misteri” nel caso Moro, dicendo – stando al testo dell'intervista
trascritto da Sergio Flamigni- che semmai si dovrebbe parlare di “punti oscuri,
forse ombre. Noi giudici abbiamo lavorato bene, credo scientificamente. Per me
il il grosso punto oscuro, il vero mistero, resta uno solo: è la storia di Via
Montalcini, la prigione di Moro, e di quello strano rapporto Ucigos che io
sollecitai. Non si è mai capito chi fece quel rapporto falso, e perchè non fu
detta la verità su quel covo.” (cfr. Flamigni, op. cit., pag. 279, testo e nota
15 in calce). Anche queste affermazioni, di certo non sfumate, e che palesano un
ruolo dell’ufficio istruzione del Tribunale di Roma quasi di impotente soggetto
passivo di quel “rapporto” dell'Ucigos, per essere giustificabili avrebbero
ovviamente dovuto poter presupporre l’avvenuto compimento di approfonditi
accertamenti e riscontri da parte del giudice e dei suoi colleghi, in merito
alla fondatezza dei vari elementi posti a base dell’asserita carenza di sospetti
riscontrata dall’Ucigos nel corso delle proprie indagini. Non si vede cioè su
che basi il giudice nel 1986 potesse lamentarsi della – diciamo - lacunosità –
di quell’ “unito appunto” inviatogli nel 1980, posto che almeno fino al 1988 non
consteranno neppure generiche deposizioni giudiziarie dei funzionari
responsabili (fatta eccezione per l’audizione innanzi alla Commissione
parlamentare del ministro Rognoni nel 1983, rimasta peraltro anch’essa senza
alcun seguito immediato neppure in quella sede). Basti ricordare che, ad
esempio, fu tra l'altro anche una scelta istruttoria del giudice Imposimato
quella di non far ripetere alcuna ricognizione fotografica ai condomini sulle
foto dei sospettati, e a non chiarire subito quale “album fotografico” fosse
stato mostrato ai condomini dai due dell'Ucigos nella riunione in casa Manfredi,
pur avendo egli in mano, sin dalle prime deposizioni dei testi Manfredi, De Seta
e Signore, praticamente la certezza che l'Ucigos, invece, sospettava eccome, al
punto di prefigurare la perquisizione nell'appartamento della Braghetti poi mai
avvenuta. Per inciso: queste pur di per sé stesse dure parole, espresse dal
giudice alla stampa nel 1986, rendono poi tanto più difficili capire, a
posteriori, la sentenza-ordinanza del Moro-quater (cfr. faldone On. Grassi
318_01, pag 17 e segg.) del 1990 ad opera del suo collega istruttore giudice
Priore, il quale ribadirà in sostanza che in base alle circostanze emerse nel
1978 come attestate dall'Ucigos, fu del tutto giustificata l’affermazione della
mancanza di sospetti da parte dei membri di quell'ufficio di Polizia. In ogni
caso, quale che fu la causa reale del fatto che i coniugi Piazza-Ciccotti non
deposero a caldo, già nel 1980, innanzi a sé, a differenza degli altri
condomini, l'ex giudice Imposimato renderà su questa circostanza, negli anni,
due versioni apparentemente in contrasto. Infatti, il 25 marzo 2015, ascoltato
dalla Commissione parlamentare di inchiesta attualmente in carica l'ex giudice
affermò sul punto: "Come ultima cosa vorrei dire – credo sia importante – che,
quando io ho ritenuto di trovare la prigione, ho sentito tutti gli inquilini. Ho
chiamato un funzionario dell'UCIGOS e gli ho detto che intendevo sentire tutti
gli inquilini dell'edificio di via Montalcini. Se quella era la prigione, ho
pensato, gli inquilini non potevano non aver visto delle persone entrare e
uscire dall'appartamento all'interno 1 del palazzo. A questo punto le cose si
sono complicate. Mentre io pensavo di aver fatto una cosa che poteva essere
gradita agli investigatori, così non è stato. Quando ho chiesto di avere la
presenza di tutti gli inquilini, sono venuti tutti, tranne il più importante,
ossia la professoressa Ciccotti Piazza, che poi sarebbe stata sentita, a
distanza di anni, da Priore e Sica." E' ovvio che un'affermazione del genere,
anche a prescindere da un'eventuale omissione di collaborazione da parte
dell'Ucigos nella convocazione e traduzione dei testi innanzi al giudice o da un
eventuale atteggiamento ostativo da parte dei due coniugi, implica di necessità
l'affermazione che il giudice istruttore fosse carente del potere di reiterare
d'imperio la convocazione, se del caso anche con l'ausilio della forza pubblica,
nonchè, in caso di eventuale reiterata mancanza di ausilio, di adottare i
provvedimenti del caso per ogni eventuale ipotesi di reato riscontrabile nei
confronti di chiunque fosse responsabile della mancata presentazione innanzi a
sé dei due coniugi. Ma anche prescindendo dalla verifica degli effettivi poteri
di cui fosse o non fosse munito il giudice, resta il fatto che in precedenza,
sulla stessa questione, ascoltato dalla "Commissione Stragi" il 24 novembre
1999, l'ex giudice aveva, tra l'altro, affermato: "La cosa abbastanza grave, che
noi cercammo di sapere in tutti i modi, era come e quando la polizia era
arrivata a via Montalcini n. 8; ma questo per molti anni non fu possibile
saperlo. Poi ho letto sugli atti, dieci anni dopo, che ci sarebbe stata una
signora Piazza che avrebbe segnalato la presenza della Renault rossa."
L'affermazione ci appare oggettivamente poco o nulla coordinabile con quella
sopra riportata: insomma, a differenza di quanto dichiarato nel 2015, nel 1999
parrebbe doversi capire che l'ex giudice fosse proprio all'oscuro dell'esistenza
stessa della signora Ciccotti (e di suo marito). Ma se così fosse, questa
affermazione lascerebbe trasparire quanto meno il fatto che l'ex giudice
evidentemente non ricordava che l’esistenza dei due coniugi Piazza e Ciccotti,
quali compartecipi di quella riunione in casa Manfredi, era emerso chiaramente e
verbalizzato proprio innanzi a lui, già in quel luglio 1980, dalle deposizioni
degli altri condomini. Come che siano andate le cose, resta il fatto che la
mancata deposizione a caldo, cioè già nel luglio 1980, dei due coniugi Piazza e
Ciccotti, rimane a tutt'oggi con ogni evidenza un rebus di difficile soluzione.
In conclusione, rinviando per maggiori approfondimenti e dettagli ad un
successivo e più ampio documento, con riferimento alla vicenda di Via Montalcini
e alle indagini che la riguardarono nel 1978, verrebbe da dire vicenda quasi
paradigmatica dell'intera storia del sequestro dell'On. Moro, riteniamo si possa
affermare, in esito alla complessiva esposizione oggetto di questo documento,
che quanto meno qualcosa, per certi versi, oggettivamente ancora oggi non
quadra. Sta di fatto, lo aggiungiamo per completezza della cronaca dei fatti,
che Anna Laura Braghetti ebbe ancora modo pochi mesi prima del suo arresto, nel
1980, di rendersi compartecipe dell'omicidio del Prof. Vittorio Bachelet
avvenuto all'Università “La Sapienza” di Roma.
L'ENIGMA DI VIA MONTALCINI
8 - seconda parte - giovedì 18 gennaio 2018.
Continua in questa seconda parte su "Sedicidimarco.org" il nostro
approfondimento su via Montalcini e le zone d'ombra che si affollano anche qui
come in quasi ogni aspetto del caso Moro. Abbiamo anticipato nella prima parte,
fatti salvi i successivi approfondimenti futuri, la completa differenza di
descrizione, ruolo ed importanza assunti nella segnalazione originaria di due
condomini (concernente generici sospetti sull'interno 1 di Via
Montalcini): dall' "auto rossa", da un lato - nelle parole degli stessi
testimoni - e dall'altro nella ricostruzione della vicenda che sarà invece
adottata dagli organi di polizia e dal Ministro Rognoni. Prima di passare
all'esame degli ulteriori elementi che ci portano nella direzione di poter
dubitare fortemente che non vi fossero sufficienti elementi di sospetto tali da
condurre all'immediata perquisizione dell'alloggio e all'arresto della Braghetti
già nell'estate del 1978, vogliamo dar comunque conto conto di quelli , pur
quantitativamente minori , che porterebbero però a pensare che addirittura vi
possa essere stata da parte degli inquirenti un'attenzione a quell'appartamento
già nei 55 giorni. Il che non significa necessariamente che gli inquirenti
sospettassero di quell'appartamento come di una prigione di Moro. Come abbiamo
visto, e vedremo anche successivamente, tutto ciò appare più frutto di forzature
posteriori. Tornando alla questione di questi indizi di attenzione al covo da
parte degli inquirenti già nei 55 giorni, vogliamo sottolineare che quanto segue
non ha nulla a che fare, sia chiaro, con le tesi di Imposimato, enunciate nel
suo libro "I 55 giorni" e basate sui racconti - invero apparentemente fantasiosi
- di persona poi finita indagata per falsa testimonianza in quanto, tra l'altro,
si era presentato allo scomparso giudice anche sotto mentite spoglie per
confermare ciò che egli stesso in precedenza gli aveva raccontato, presentandosi
con la sua vera identità. Si tratta qui di piccoli indizi e contraddizioni in
alcune dichiarazioni di cui, prima di proseguire, riteniamo opportuno dare conto
e che, se confermati, renderebbero ancora più incomprensibile e inquietante la
libertà con cui la Braghetti poté muoversi durante e dopo i 55 giorni.
VIA MONTALCINI ERA
SORVEGLIATA GIA' DURANTE IL SEQUESTRO? (a cura di: Andrea Guidi ). Dalle
deposizioni riportate nel primo capitolo del nostro documento su questa vicenda,
si evince pacificamente come punto fermo della complessiva ricostruzione il
fatto che la signora Ciccotti – come ormai noto, la condomina di Via Montalcini
che in un imprecisato giorno antecedente il delitto avrebbe visto nel garage
della Braghetti la parte anteriore di un'imprecisata "auto rossa"- non
parlò mai di “Renault 4 rossa” (né di nessuna altra auto specifica). Su questo
aspetto, abbiamo rilevato altresì la sintonia dell'Avv. Martignetti e del
Ministro Gaspari, riscontrata nelle loro rispettive dichiarazioni, nel non dire
nulla, o non ricordare nulla, in merito ad un'auto rossa. Eppure non si
trattava certo di un'auto qualsiasi, né di un contesto storico qualsiasi.
Sembrerebbe cioè poco comprensibile una vera e propria rimozione da parte di
costoro proprio del ricordo di un elemento del genere. Forse si sarebbe dovuta
approfondire tempestivamente questa carenza di memoria da parte di Martignetti e
di Gaspari su un aspetto delle segnalazione (l'auto rossa) che di certo, se
effettivamente la “fonte” ne avesse parlato in termini tali da farne il cardine
dei propri sospetti, non sarebbe potuto essere facilmente dimenticato dai due
interlocutori; fatto sta che, come si è visto, nel maggio 1988 Gaspari stesso
nel suo "comunicato stampa" quanto meno affievolirà non di poco le presunte
certezze che il ministro Rognoni, deponendo davanti al giudice istruttore, aveva
manifestato appena il giorno prima in merito alla presunta centralità del ruolo
rivestito dalla “Renault rossa” nella segnalazione da lui ricevuta da parte
dello stesso collega di partito. La ricostruzione più probabile dei fatti,
pertanto, in quanto concilierebbe lo scarso o nullo rilievo dell'auto
rossa nei ricordi di Martignetti e Gaspari e, in senso conforme alle amnesie
dei due su questo punto, le costanti dichiarazioni dei coniugi Piazza nella
direzione della assoluta secondarietà di questo elemento nei loro sospetti, da
un lato, con le deposizioni del Ministro Rognoni, di Coronas e di Noce
imperniate invece sulla presunta centralità della vera e propria “Renault
rossa” nell'ambito della segnalazione, dall'altro, pare possa essere quella
secondo la quale molto semplicemente quell'auto rossa, come che siano andate le
cose, non costituì affatto, l'"elemento centrale" della segnalazione trasmessa
al ministro Rognoni prima, e all'Ucigos poi. Questa ipotesi, lo rileviamo
incidentalmente, manterrebbe inoltre la propria validità anche nell'ipotesi che
l'Avv. Martignetti abbia per avventura avuto informazioni anche da qualche altra
fonte sua propria, parallela ma diversa dai coniugi Piazza, ipotesi che tra
l'altro porterebbe a dover rovesciare completamente la prospettiva in quanto
imporrebbe di chiedersi di riflesso se per caso la segnalazione di coniugi
Piazza (che non intendiamo mettere di certo in dubbio) non avrebbe potuto finire
per costituire oggettivamente, semmai, un utile diversivo idoneo a sviare
l'attenzione da altre segnalazioni da parte di eventuali altre fonti.
Eventualità, quella di altri “contatti” avuti da Martignetti ulteriori rispetto
ai suoi cognati, che purtroppo non venne neppure prospettata in sede giudiziaria
e che di conseguenza, allo stato delle conoscenze acquisite, si deve ritenere
sia destinata a rimanere ormai priva di risposta. Tuttavia, pur in mancanza di
approfondimenti giudiziari e quindi di dati oggettivi diversi e/o maggiori
sull'effettivo ruolo di Martignetti nell'impulso sia pure indiretto alle
indagini dell'Ucigos, ricordiamo che costui in un certo senso disse perfino
qualcosa "di più", se non "di troppo", e comunque qualcosa di diverso dai
coniugi Piazza, in quanto nella lettera consegnata ai giudici nel corso della
sua prima deposizione (faldone On. Grassi 320_01, pag. 2, cit.) come si è visto
affermava, confermando in sostanza le parole del comunicato stampa di Gaspari
del 14 maggio 1988, di avere maturato personalmente la specifica "convinzione"
che a Via Montalcini avrebbero dovuto essere estese le ricerche non già solo di
qualche persona sospetta, bensì proprio della prigione di Moro; affermazione,
come si comprende, ben diversa da ciò che, come abbiamo visto, i coniugi
Piazza-Ciccotti si limiteranno sempre a riferire in tutte le sedi senza per di
più mai fare neppure in via ipotetica alcun cenno ad un'eventuale prigione del
Presidente della D.C. Sarebbe stato dunque ben meritevole di approfondimento,
come si può facilmente intuire, tentare di capire donde l'avvocato avesse
tratto questa sua specifica e personale convinzione, la cui portata era
ovviamente tale da oltrepassare, aggirare, rendere del tutto superflua e
irrilevante, la stessa questione se in Via Montalcini fosse stata vista oppure
no un'auto rossa (o una Renault rossa). Fermo restando il limbo di mancanza di
qualunque considerazione e a maggior ragione di possibili sviluppi, in cui
questi spunti rimasero, come probabilmente ormai rimarranno, confinati,
l'indagine che ci occupa rimane dunque di necessità limitata all'importanza a
nostro avviso fondamentale che riveste il tentativo di individuare le ragioni
in forza delle quali, stando ai documenti e alle deposizioni delle autorità
politiche e di polizia emersi negli anni successivi, la generica auto
rossa diviene da un certo momento in poi, e precisamente, a quanto pare, solo a
partire dagli ulteriori impulsi di indagine dati dal ministro Rognoni in poi,
una vera e propria "Renault rossa" nonché il presunto “elemento centrale” della
segnalazione. Torneremo nella terza parte di questo studio ad esporre in
dettaglio la cronistoria delle varie relazioni ed appunti dell'Ucigos; possiamo
tuttavia anticipare che ci pare di avere riscontrato un netta cesura
terminologica e qualitativa tra la forma e il modo in cui la questione della
“Renault rossa” viene trattata nei rapporti in senso stretto sulle indagini in
corso, redatti tra l'agosto e l'ottobre 1978, tutto sommato posta in modo
equivalente e confuso con gli altri elementi affrontati dagli agenti, da un
lato, e viceversa l'improvvisa e conclamata centralità che quell'auto viene ad
assumere nella già menzionata relazione del 1982 del capo dell'Ucigos De
Francisci in risposta alla Commissione parlamentare, dall'altro. E' per la
precisione solo da quest'ultimo documento che la “centralità” del riferimento a
quell'auto viene attestata dalle autorità, documento – ci limitiamo a dare qui
atto del mero fatto “storico”- rispetto al quale, ed è un fatto, si
conformeranno costantemente di lì in poi e prontamente le successive
dichiarazioni, scritte o in audizioni, delle autorità, a cominciare dallo stesso
Ministro Rognoni fin dalla sua prima deposizione del 1983 davanti alla
Commissione di inchiesta, nel corso della quale egli manifesterà espressamente
(come si è già visto nella prima parte) per quanto lo riguardava per la prima
volta lo stesso concetto: la “Renault rossa”, per la polizia e per il Ministro,
era “l'oggetto principale” della segnalazione. Prescindiamo per ora, comunque,
da questi aspetti su cui per l'appunto torneremo in quanto in sostanza
costituenti l'oggetto specifico del nostro studio, per affrontare in sintesi
preliminarmente in questa sede l'eventualità – variamente ventilata nella
pubblicistica e sulla stampa nel corso degli scorsi decenni- che appostamenti e
controlli, in una parola le indagini, su Via Montalcini, possano in realtà
essersi svolte già durante il sequestro, e non solo a partire dall'estate 1978
cioè dopo la sua tragica conclusione avvenuta il 9 maggio. In quest'ottica, è
chiaro – è un dato desumibile con la pura logica - che, ragionando in
linea puramente teorica, l'affermazione e la successiva consacrazione anche sul
piano giudiziale del fatto che “oggetto principale” della segnalazione fosse
proprio una “Renault rossa” avrebbe potuto costituire (anche) un elemento
perfettamente funzionale, dal punto di vista delle autorità, a stroncare alla
radice qualunque illazione su presunte indagini, per definizione segrete,
risalenti a data anteriore al 9 maggio 1978. Prima di questa data, infatti,
sarebbe stato semplicemente impossibile che un qualsiasi comune cittadino
segnalasse come elemento di sospetto una “Renault rossa” in sé e per sé, e che
quindi una qualche indagine potesse attivarsi su questa base; questo per
l'evidente ragione che fino al tragico epilogo e al risalto anche “mediatico”
del ritrovamento del corpo dell'On. Moro in quell'auto (avvenuti come noto il 9
maggio), per un qualsiasi cittadino quell'auto sarebbe stata di per sé sola
perfettamente insignificante ed irrilevante; in altre parole, un'auto come
milioni di altre circolanti per Roma. Se la segnalazione – in tesi - proveniente
da due comuni cittadini aveva avuto come oggetto principale la “Renault rossa”,
dunque, le uniche indagini svolte non potevano che avere avuto luogo solo dopo
la conclusione del sequestro, e non durante. Tuttavia va pur detto che,
nonostante la nostra opinione che quell'auto- comunque si siano svolti i fatti e
che cosa, e da chi, abbia appreso Martignetti - non costituì affatto un
elemento centrale dell'originaria segnalazione, e sempre ammesso che di
segnalazioni vi sia stata solo quella ufficialmente nota dei coniugi Piazza, e
nonostante dunque che cadendo, per ipotesi, la centralità di quell'auto
nell'impulso alle indagini si aprirebbe in linea teorica la possibilità dello
svolgimento di indagini in epoca ben anteriore a quelle accertate ufficialmente,
bisogna pur dire che, allo stato delle conoscenze di dati oggettivi, diretti o
desumibili con la logica da quelli noti, non risultano al momento particolari e
decisivi elementi che possano spingerci in modo sufficientemente provato ad
affermare che altre indagini ed appostamenti su Via Montalcini fossero in realtà
avvenuti già in pieno sequestro. Per mera completezza espositiva, diamo però
conto di alcuni fatti, in ogni caso per l'appunto non sufficientemente probanti
nella direzione che qui si sta ipotizzando, ma che magari potrebbero contenere
spunti meritevoli di ulteriori approfondimenti. In primo luogo, una “Renault
bordeaux” era ricercata sin dal giorno dell'agguato di Via Fani, 16 marzo, come
risulta dai brogliacci delle comunicazioni dei Carabinieri (CM-1, Vol. 110, pag.
20), nei quali si legge che già il pomeriggio del 16 marzo, alle 17.15, il
colonnello Varisco comunicava di ricercare riservatamente quest'auto (targa
Roma-T 75812; la targa è tuttavia un dettaglio, essendo nota e conclamata la
costante mutazione di targhe false da parte dei brigatisti sulle auto in loro
possesso). A prescindere dall'esito delle ricerche, che non ci consta,
evidentemente un'auto di quel modello e di colore analogo era già stata oggetto
di specifica attenzione sin dalle prime ore del 16 marzo successive all'agguato.
La circostanza è confermata da un altro rapporto del Reparto Operativo dei
Carabinieri di Roma (CM-1,Vol. 35, pag. 594) a firma del Ten. Col. Cornacchia,
del giorno 8 febbraio 1979 e indirizzato al giudice Priore, nel quale si dà
conto del fatto che “fonte attendibile” aveva riferito “tempo fa”che un
testimone, tale Vasco Bertini, sarebbe stato in grado di fornire elementi utili
alla ricostruzione dell'agguato, e che immediatamente dopo si era messo
all'inseguimento, o conoscerebbe chi si era messo all'inseguimento, di “una
Renault 4 di colore rosso”che era immediatamente partita al seguito delle auto
del commando in fuga. A prescindere dalle perplessità suscitate dal fatto che
avendo appreso queste notizie dalla fonte “tempo fa” il Reparto Operativo, in
persona del suo comandante, si sia risolto a informare il giudice Priore solo
l'8 febbraio 1979, dalle due segnalazioni appena viste deve necessariamente
farsi scaturire che se, come abbiamo detto, prima del 9 maggio per un qualsiasi
cittadino romano la “Renault rossa” costituiva un'auto tra milioni, forse per
“fonti attendibili” o per le stesse forze dell'ordine allertate nei termini di
cui sopra, una “Renault rossa” non era più un'auto qualsiasi. In altre parole,
non si può escludere almeno in linea teorica la possibilità che eventuali
segnalazioni “qualificate” concernenti quell'auto (almeno come tipo e colore)
siano avvenute già prima del 9 maggio 1978 (pur non risultando agli atti
elementi che indichino che, ad esempio, quell'auto fosse stata per avventura
rintracciata e pedinata anche fino ad eventuali soste in Via Montalcini). La
qual cosa parrebbe confermata anche dalla recente audizione innanzi alla
Commissione parlamentare attualmente in carica dell'ex agente di polizia del
Commissariato Monte Mario, Adelmo Saba (artefice con un suo collega del
ritrovamento della Fiat 128 bianca dei rapitori in Via Licinio Calvo nella notte
tra il 16 e il 17 marzo), nel corso della quale l'ex agente di polizia ha
espressamente – anche con toni di una certa durezza- confermato che si ricercava
una “Renault rossa” ben prima del 9 maggio. Oltre a queste circostanze,
segnaliamo anche quanto segue. Ascoltato dalla Commissione parlamentare di
inchiesta attualmente in carica il 22 settembre 2015, il Prof. Achille Lucio
Gaspari, figlio dell'ex ministro e uomo politico DC, richiesto espressamente di
fornire, tra l'altro, un suo ricordo o comunque quanto di sua conoscenza sulla
vicenda delle indagini del 1978 su Via Montalcini, ha narrato appunto
dell'incontro avuto dal padre con l'avv. Martignetti (cfr. in particolare il
resoconto stenografico della seduta, pag. 5). Ebbene, nella descrizione fatta
dal figlio delle circostanze che avrebbero spinto Martignetti ad attivare suo
padre, non viene minimamente menzionato alcun riferimento ad un'auto rossa, nè
tanto meno ad una “Renault”. Martignetti, secondo il figlio dell'ex uomo
politico DC, avrebbe soltanto fatto riferimento all'osservazione da parte di suo
cognato (Piazza), definito come un tipo curioso, di movimenti sospetti: per la
precisione, a detta del Prof. Achille Lucio Gaspari - che si è detto certo di
ricordare bene- Martignetti avrebbe detto a Remo Gaspari, parlando di suo
cognato (Piazza): "..il quale è un tipo curioso, osserva, guarda dalla finestra
e ha notato dei movimenti e ha visto delle cose che gli hanno dato la sensazione
che quello potrebbe essere il covo dove Moro è detenuto. A questo punto
Martignetti ha fornito a mio padre l’indirizzo, che io non ricordo». Il
predicato "è detenuto" si collega strettamente con la circostanza riferita dal
Prof. Gaspari (parliamo sempre del figlio dell'ex uomo politico) a parere del
quale Martignetti avrebbe detto a suo padre: "«Credo di sapere dove è
detenuto Moro». Non disse «Dove era detenuto», ma «Dove è detenuto ». Secondo
quanto io ricordo, l’episodio si è verificato prima del ritrovamento del
cadavere di Moro, credo diversi giorni prima, non nell’imminenza del fatto." A
prescindere ovviamente dalla certezza o meno dei ricordi del prof. Gaspari sulla
tempistica su riferita (sulla quale qualche elemento di dubbio può rinvenirsi
nella incerta indicazione da parte sua quale ministro dell'Interno, al quale il
padre subito riferì, ora in Rognoni, ora in Cossiga, con tutte le evidenti e
diverse implicazioni cronologiche nell'uno ovvero nell'altro caso, essendo
Rognoni subentrato solo nel giugno 1978), ci è sembrato quanto meno opportuno
evidenziare questo aspetto della recente audizione del Prof. Gaspari. Sempre per
completezza dell'esposizione, si deve poi parimenti rilevare che nel comunicato
stampa del 16 maggio 1988, più volte menzionato ed esaminato nella prima parte
già pubblicata di questo documento, l'allora Ministro Gaspari riferendo per
l'appunto in ordine al colloquio avuto con Martignetti in un comunque
imprecisato giorno del 1978, scrisse testualmente: "(Martignetti) Mi fece
presente che aveva avuto elementi in base ai quali riteneva che la prigione di
Moro potesse trovarsi in una certa zona di Roma". Per quanto poi lo stesso
Gaspari (padre) nel prosieguo del comunicato stampa del 1988 confermi di essersi
recato da Rognoni (e non da Cossiga), tuttavia volendo estrapolare il mero dato
testuale e comparandolo con la terminologia utilizzata dal figlio nell'audizione
del 2015, si rileva che dire"potesse trovarsi" è cosa diversa, ad esempio, da
“potrebbe essersi trovata”(o equivalenti coniugazioni più idonee a meglio
collocare "la prigione" in un passato definitivamente compiutosi, anziché, come
potrebbe apparire dalle parole usate, idonee piuttosto ad individuare un fatto o
un'azione ancora in essere). Insomma, la sintassi di Gaspari (padre) del 1988
sembra sicuramente più idonea a riferire un fatto raccontatogli mentre il
sequestro era in corso, cioè un fatto collocato dall'interlocutore nel tempo
presente al momento del colloquio, e non già terminato e dunque collocabile nel
passato, sia pure recente, rispetto al colloquio stesso tra i due. Piuttosto,
come unici dati oggettivi, se così li si può definire, circa l'eventualità dello
svolgimento di indagini a sequestro ancora in corso, ci sono poi gli articoli e
le indiscrezioni di stampa, ed alcuni elementi processuali emersi nel corso
dell'istruttoria del processo per la vicenda "Argo 16" e rilevati a suo tempo
dal giudice istruttore di Venezia, Carlo Mastelloni. Quanto alle notizia di
cronaca, c'è infatti – tra l'altro- un articolo del quotidiano romano “Il
Messaggero” del 2 giugno 1980 (faldone On. Grassi 318_002, pag. 49) secondo il
quale già a marzo del 1978, cioè appena avvenuto il sequestro, sarebbe già
esistito un rapporto di polizia sulla coppia (Braghetti e Altobelli) e
sull'appartamento (via Montalcini). Quanto invece all'inchiesta sulla vicenda
"Argo 16", stando a Sergio Flamigni (già ne "La tela del ragno", cit., pagg.
232-233, testo e note in calce, e poi ne "Il covo di Stato…" cit), che riporta
stralci della sentenza-ordinanza del giudice Mastelloni, il maresciallo Mango
(passato all'Ucigos dopo vari incarichi tra i quali circa venti anni all'Ufficio
Affari Riservati e poi all'antiterrorismo con Santillo) ha dichiarato (cfr.
stralcio della sentenza-ordinanza suddetta come riportato ne "La tela del
ragno", quinta edizione, 2003, Ed. Kaos, pag. 233 e note 29 e 30): " Durante il
sequestro Moro ho saputo dal dottor Schiavone e dall'assistente di polizia Paola
Carraresi che furono fatti accertamenti a seguito di segnalazioni fiduciarie
pervenute alla Squadra anche nella zona dove era ubicata Via Montalcini a
seguito, in particolare, di indicazioni avute sulla Braghetti". Nel corso di
altri due interrogatori, sempre stando ai passaggi riportati da Flamigni, egli
ha poi ulteriormente dichiarato:"...che fu proprio durante il sequestro, e non
dopo, che fu pedinata Anna Laura Braghetti da parte di un elemento della
squadra, e cioè dalla Carraresi Paola". Tuttavia, nel quarto interrogatorio, il
maresciallo Mango dichiarò (cfr. S. Flamigni, op. cit.): " Non intendo
confermare, visto il tempo trascorso, la circostanza da me più volte riferita,
secondo cui fu durante il sequestro che la Carraresi mi parlò di Via Montalcini
in relazione a indicazioni o segnalazioni fiduciarie pervenute alla squadra
sulla Braghetti". Risulta sempre dall'Autore citato, in merito a quanto appena
illustrato, che il giudice Mastelloni trasmise gli atti alla procura di Roma.
Non ci risulta null'altro, sul punto. Mancando ulteriori elementi, non possiamo
che astenerci sul prendere una posizione di merito circa le affermazioni del
maresciallo Mango. Di sicuro, però, solo una di esse è vera: o egli era certo-
come ribadito in tre interrogatori- della tempistica ben anteriore delle
indagini rispetto a quella ufficialmente emersa, o al contrario questa certezza
egli non l'aveva, come dichiarò alla fine. Sarebbe interessante poter
approfondire nuovamente questo aspetto, ove possibile. Nella stessa
sentenza-ordinanza del giudice Mastelloni, si riscontra inoltre (sempre
Flamigni, “Il covo di Stato...” cit., pag. 359-360) un ulteriore contrasto tra
il maresciallo Attilio Di Maio e la Carraresi. Di Maio aveva infatti dichiarato
nel corso di quel procedimento: “Durante i pedinamenti avvenuti, lo ribadisco,
nella fase immediatamente successiva al rapimento di Moro, la Paoletta (nda:
Carraresi) mi riferì di avere individuato il brigatista Seghetti come soggetto
che spesso si accompagnava alla Braghetti. Io Suggerii di riferire ai funzionari
che era anche possibile bloccarli e arrestarli, ma la cosa non ebbe seguito.
Prendo atto che il Giuseppe Mango ha riferito che si pervenne a via Montalcini e
alla Braghetti sulla base di “segnalazioni fiduciarie pervenute alla squadra”.
Escludo di essere stato io a ricevere tale segnalazione: probabilmente le
segnalazioni pervennero in precedenza <ad altri colleghi>. All'esito adduco
che non mi è mai andato giù il fatto che non si fosse proceduto subito
all'arresto della Braghetti e del Seghetti”. Di diverso avviso la Carraresi, che
dichiarò invece di essersi attivata con i pedinamenti ai primi di settembre,
affermando che in quelle occasioni non vide mai la Braghetti insieme a Seghetti.
Tuttavia, la Carraresi pare a sua volta smentita sul punto dallo stesso dott.
Noce, il quale, nello stesso processo, dichiarò che la Carraresi gli aveva
parlato di Seghetti, aggiungendo: “Comunque la Braghetti era nota come
appartenente all'estrema sinistra”. Siamo a questo punto, è bene rilevarlo, al 2
ottobre 1997 (Flamigni, op. cit. pag. 360, nota in calce n. 10) cioè oltre nove
anni dopo le dichiarazioni di Noce rese al giudice istruttore nel 1988,
esaminate nella prima parte che abbiamo già pubblicato. A quanto pare, va
osservato incidentalmente, a distanza di nove anni, e a distanza di sette dalla
sentenza-ordinanza del giudice Priore (1990), sono proprio alcuni componenti
degli stessi organi di polizia a smentire se stessi sulla mancanza di sospetti
asserita in precedenza in ordine alla Braghetti e a Via Montalcini ed avallata
da quella sentenza-ordinanza di Priore. Ritornando con la mente alla deposizione
del dott. Noce del 1988 (alla quale si rinvia), non pochi dubbi sorgono sul
mancato approfondimento – a quanto risulta dalle pubbliche fonti documentali a
nostra disposizione più volte menzionate - di questa sua particolare
contraddizione tra la mancanza di sospetti da lui affermata nella prima
occasione, e le sue affermazioni del 1997, dalle quali si dovrebbe dedurre
esattamente il contrario, perché se fosse vero che la Carraresi gli aveva
parlato già nel 1978 di Seghetti (e ciò, evidentemente, come persona in contatto
con la Braghetti, dato l'oggetto delle sue indagini) , non si vede come, essendo
Seghetti persona già ampiamente sospetta, Noce avesse potuto concludere innanzi
ai magistrati di Roma, nel maggio 1988, nei termini viceversa
"tranquillizzanti" riportati nella sua deposizione e analizzati nella prima
parte di questo lavoro. Tornando alle affermazioni della Carraresi nel processo
“Argo 16” , è opportuno riportare anche le parole di un altro dei protagonisti
della vicenda delle indagini del 1978, autore quanto meno degli “appunti”
preliminari redatti dall'Ucigos il 14 ottobre di quello stesso anno (e che
esamineremo in dettaglio in un prossimo capitolo), cioè il dott. Pasquale
Schiavone, il quale, nell'interrogatorio in pari data di quello della Carraresi
(25 settembre 1997; Flamigni, op. cit., pag.360-361, nota in calce n. 11),
dichiarò tra l'altro:”...Circa il Seghetti – che mi viene detto, secondo una
deposizione raccolta, fu segnalato assieme alla Braghetti- io ricordo che fu il
predetto effettivamente segnalato come persona che si era incontrata una volta
con la stessa”. A parte le considerazioni di analogo contenuto a quelle poc'anzi
svolte con riferimento al dott. Noce che le affermazioni di Schiavone suscitano
con riferimento alle proprie conclusioni degli appunti a sua firma del 1978
attestanti – come si vedrà in apposita parte di prossima pubblicazione- il
presunto esito negativo delle indagini sulla Braghetti, ed a parte poi i
riflessi di queste ultime dichiarazioni del 1997 sulla tempistica di
effettuazione di indagini e pedinamenti, che oggettivamente non ne risulta
chiarita, rimane il fatto che anche il dott. Schiavone, dunque, a distanza di
anni, pare smentire radicalmente le conclusioni affermate dall'Ucigos negli
appunti del 1978 e poi riaffermate come si è visto dalle altre autorità
politiche, di polizia e della magistratura fino alla sentenza ordinanza del
giudice Priore del 1990, in ordine ad una del tutto presunta mancanza di
sufficienti sospetti per agire tempestivamente nei confronti della Braghetti e
dell'appartamento di Via Montalcini. Come anticipato, sospendiamo tuttavia al
momento ogni valutazione di merito in ordine all'ipotesi che la Braghetti e Via
Montalcini fossero stato oggetto di indagini già in pieno sequestro, e non già
solo dopo il 9 maggio. Certo che se non vi furono indagini o appostamenti
anteriori al 9 maggio, resta a maggior ragione poco spiegabile quella
perquisizione, apparentemente isolata e fine a sé stessa, eseguita in Via
Benucci, ovvero sia dietro l'angolo di Via Montalcini, il 12 aprile 1978, cioè
in pieno sequestro, sulla quale torneremo comunque più avanti, in un apposito
capitolo dedicato ad analisi e commenti.
SQUALO 4, LA VOLANTE
(DIMENTICATA) CHE QUASI BLOCCO` LA FIAT 132 IN FUGA DA VIA FANI,
scrivono Andrea Guidi e Francesco Velocci martedì 19 dicembre 2017 su "Il
Sedicidimarzo.org". Il 23 febbraio del 1978 l'avvocato Giorgio Bruno, non si
aspettava che, scendendo dal suo studio in via dei Gracchi, non avrebbe più
ritrovato la sua Fiat 132 GLS 1600 cc di colore blu. Per la fretta aveva
dimenticato le chiavi nel cruscotto (CM-1 vol. 31 pag. 226). Soprattutto –
l'avvocato - non sapeva che quell'auto sarebbe di lì a poco finita tra le carte
dell'inchiesta sul rapimento di Aldo Moro. Esattamente ventuno giorni dopo il
furto - il 16 marzo alle ore 9:03 - dalle autoradio della Polizia gracchiò
l'annuncio: “via Mario Fani, si sono uditi colpi di arma da fuoco”.
CM-1 Vol. 29 pag. 1001 -
Brogliacci di Polizia, canale 13 - distretti e commissariati. Dopo appena 2
minuti dalla comunicazione della Sala Operativa della Questura, alle ore
9:05 pervennero da via Fani le prime drammatiche notizie: “inviare subito
ambulanze sono della scorta di Moro e hanno sequestrato l'onorevole i
responsabili sono scappati a bordo di auto 128 bianca Roma M53995, sono in
numero di quattro e vestono divise da marinai o poliziotti”. Fa seguito, sul
canale 13, una comunicazione della Sala Operativa rivolta a tutti i
commissariati: “si ricerca anche 132 blu Roma P79560".
CM-1 Vol. 29 pag. 1001 -
Brogliacci di Polizia, canale 13. Alle 9:10 sul canale 23, la Sala Operativa
informa tutte le volanti che in “via Balduina si è allontanata 132 blu Roma
P79560 e una 128 bianca Roma M53995 – quattro giovani a bordo armati allontanati
zona Monte Mario”.
CM-1 Vol. 29 pag. 1016 -
Brogliacci di Polizia, canale 23 volanti. Eccola! E` la Fiat 132 GLS 1600 cc di
colore blu dell'avvocato Bruno. La targa è diversa, si scoprirà da qui a poco
che fu sostituita. Esattamente nel giro di pochi minuti dall'ultimo annuncio
della Sala Operativa, l'auto “civetta” Squalo4 ne comunica il ritrovamento. Ore
“9:23 Via Licinio Calvo è stata abbandonata la 132 blu tg Roma P79560”.
CM-1 Vol. 29 pag. 1016 -
Brogliacci di Polizia, canale 23 volanti. Secondo la versione ufficiale, l'on.
Aldo Moro venne prelevato in via Fani e fatto entrare in questa Fiat 132 blu;
l'auto avrebbe preso via Stresa verso via Trionfale; sarebbe transitata per le
stradine via Belli e via De Bustis; avrebbe superato un cancelletto chiuso con
catenella e sarebbe, infine, stata abbandonata in via Licinio Calvo, n. 1.
L'auto fu individuata dalla “civetta” - auto civile della Polizia - Squalo 4, il
cui equipaggio era composto dall'appuntato (?) Mammoliti Saverio - capo
pattuglia - e le guardie Celestini Tommaso, Valvona Aldo e Sapia Gerardo. Non
risulta che essi siano stati auditi in sede giudiziaria, né che la loro
relazione sia stata acquisita agli atti dei processi. Fortunatamente una copia
della relazione di servizio è contenuta negli atti della prima Commissione
parlamentare d'inchiesta sul caso Moro.
(CM-1 Vol. 31 pag. 219). Vi si
legge che verso le ore 9.05 la pattuglia avrebbe appreso dalla Sala Operativa di
una "sparatoria" in atto in via Fani. La volante, quindi, si sarebbe lì diretta.
“Giunti "nei pressi" di questa via i componenti della Squalo 4 venivano
informati "che un'auto Fiat targata Roma P79560 pochi istanti prima si era
allontanata in direzione della Balduina con a bordo delle persone
incappucciate".
CM1 - Vol. 31 pag. 219 -
Relazione di servizio Squadra Speciale Squalo 4 del 16 marzo 1978. Appare
evidente come la formula utilizzata nella relazione sul luogo e sulle modalità
di ottenimento delle informazioni sull'auto in fuga siano quanto meno molto
generiche. In particolare si pongono tre importanti questioni:
a) chi fornì le informazioni
agli agenti della Squalo 4? Nessuno dei testimoni della strage (cfr. Vol 30,
CM-1) indicò in modo preciso la presenza di una Fiat 132: non vi è traccia di
testimoni che ne indichino né marca e modello né la targa;
b) dove esattamente la Squalo
4 ricevette le informazioni? Nella relazione si legge “nei pressi di via Fani”,
ci si chiede come fosse possibile che un qualche testimone negli intorni di via
Fani abbia potuto indicare, come direzione di fuga, la Balduina. Realisticamente
nessuno intorno a via Fani avrebbe potuto avere la certezza della direzione di
fuga una volta che l'auto si infilò in via Stresa;
c) come mai si descrivono le
persone a bordo della Fiat 132 come "incappucciate"? Alla lettura delle
testimonianze risulta che nessuno dei testimoni parlò mai di una circostanza del
genere. Gli assalitori di via Fani vennero descritti generalmente come
indossanti delle divise.
La relazione di servizio
dell'appuntato Mammoliti continua, infine, affermando che "del fatto ne davamo
immediata notizia alla Sala Operativa, mentre noi ci ponevamo alla ricerca della
132, rinvenendola in Via Lucinio (sic!) Calvo altezza civico 1". Questa
affermazione, di fatto conclusiva, è quella che apre il campo ad altri dubbi e
riflessioni. Innanzitutto non risulta nei brogliacci una comunicazione
proveniente dalla Squalo 4 in cui si informa la Sala Operativa della Fiat 132 in
fuga: la prima comunicazione da parte di Squalo 4 è quella relativa al
ritrovamento dell'auto alle ore 9.23. Mentre, in orario precedente al
ritrovamento, risulta che la Sala Operativa diramò i due comunicati di ricerca
della Fiat 132 già citati. Un primo alle ore 9:05 circa, sul canale 13 destinato
a tutte le questure con cui “si ricerca anche 132 targata Roma P79560”.
E unsecondo sul canale 23, alle ore 9:10 destinato a tutte le volanti, “via
Balduina si è allontanata 132 blu Roma P79560 e una 128 bianca Roma M53995 –
quattro giovani a bordo armati allontanati zona Monte Mario”. Non si può non
notare come molti elementi tra la comunicazione appena trascritta e la relazione
della Squalo 4 non siano coincidenti: la Sala Operativa parla di una Fiat 128
insieme alla Fiat 132 e, inoltre, non si accenna al fatto che i passeggeri siano
incappucciati. Ciò che più colpisce, invece, è come sia la relazione della
Squalo 4 sia la comunicazione della Sala Operativa forniscano come zona della
fuga la Balduina o con maggior precisione via della Balduina. Da dove arrivò
questa informazione? La risposta, sfortunatamente, non è reperibile tra gli atti
disponibili, eppure ci resta difficile ipotizzare l'esistenza di un soggetto che
a quell'ora, trovandosi in via della Balduina, avesse potuto riconoscere le due
auto come in fuga da un fatto delittuoso e, di conseguenza, ne avesse informato
la Polizia. Altra questione centrale che la relazione di Mammoliti pone, è sulle
azioni che permisero alla Squalo 4 di ritrovare, in modo praticamente immediato,
la Fiat 132. Si trattò di un caso fortuito? Non lo sapremo mai, perché, di
fatto, la relazione è priva di qualunque concreta informazione sul percorso
seguito dall'equipaggio dal suo arrivo nei “pressi di via Fani” fino a via
Calvo. Da quanto fin qui esposto, appare evidente che le due principali
questioni di interesse riguardano la tempistica della segnalazione sulla Fiat
132 in fuga: fu Squalo 4 a comunicarlo alla Sala Operativa, come afferma nella
relazione, o viceversa? L'altra questione riguarda il soggetto che fornì la
segnalazione. In questa ricerca ci imbatteremo, come si vedrà in seguito, in un
altro elemento che non si esita a dire sconcertante: non vi è tra i testimoni
oculari escussi il 16 marzo alcuno che abbia riferito con precisione né della
presenza di una Fiat 132 tra le auto utilizzate nella azione di via Fani, né
della targa Roma P79560, e, soprattutto, non ve ne è alcuno che abbia riferito
che l'on. Moro sia stato condotto su un'auto di questo modello. Le
testimonianze, nella prima verbalizzazione del 16 marzo, sono disponibili nel
vol.30 CM-1 ed è facilmente verificabile quanto qui affermato (Tabella delle
testimonianze di via Fani). Ulteriore elemento a riprova della nostra tesi è
riscontrabile nelle due relazione di servizio del 16 marzo una degli agenti Di
Berardino e Sapuppo e l'altra del maresciallo Abbondandolo relative ai primi
accertamenti compiuti in via Fani.
CM-1 Vol. 30 pag. 40 -
Relazione di servizio della guardia di P.S. Di Berardino del 16 marzo 1978.
L'unica auto indicata è la Fiat 128 targata Roma M53095, qui definita di colore
blu. Si noti che il colore dell'auto (blu) non coincide con quello indicato nei
brogliacci che e` bianco. La Fiat 128 di colore bianco con targa Roma M53055 (si
noti che il 9 era un 5) fu rinvenuta anch'essa in via Calvo nella primissima
mattinata del 17 marzo.
CM-1 Vol. 30 pag. 41 -
Relazione di servizio M.llo Abbondandolo del 16 marzo 1978. Nei verbali di
interrogatorio dei testimoni identificati dal Mareciallo Marini, Pistolesi,
Proietti - nessuno indica tra le auto in fuga una Fiat 132. (CM-1 Vol. 30).
Solo il rapporto redatto in data 17 marzo - cioè il giorno dopo i fatti - dal
capo della Digos Spinella per il sostituto Procuratore Infelisi, indicherà la
Fiat 132 targata Roma P79560 come l'auto sulla quale venne trasportato l'on.
Moro. Che la Fiat 132 fosse ricercata già dai primi minuti successivi alla
strage è un dato accertato, come ampliamente fin qui esposto. Resta oscuro il
soggetto che la segnalò alla Polizia, così come rimane incerto se su questa auto
vi fosse stato trasportato l'on. Moro. Una testimonianza che, per prima, fa
pensare che l'on. Moro fosse stato trasportato con la Fiat 132, è quella di
Antonio Buttazzo, verbalizzata il 17 marzo, quando - bisogna dirlo - il
ritrovamento della Fiat 132 e la targa erano già stati resi noti a mezzo
stampa. Antonio Buttazzo raccontò che mentre era in attesa dell'Ing. Pellegrini
di cui era autista, resosi conto del rapimento in corso si sarebbe posto
all'inseguimento del convoglio in fuga per un tratto di strada che va da via
Stresa angolo Via Molveno fino all'intersezione di via Trionfale con via della
Camilluccia. Buttazzo riferì che all'altezza di questo incrocio, dove interruppe
l'inseguimento, fermò una sopraggiunta auto della polizia; nel corso del tempo,
sottoposto a più deposizioni, descrisse l'auto ora come “civetta” ora come
“volante”. Ai poliziotti Buttazzo indicò targa e tipo di auto che stava
inseguendo: la Fiat 132 blu targata Roma P79560. Alcune coincidenze potrebbero
far ritenere che Buttazzo sia proprio l'informatore della Squalo 4. Eppure altri
elementi sembrerebbero non confermare questa ipotesi: la Squalo 4 nella
relazione fa riferimento alla sola Fiat 132, mentre Buttazzo dichiarò di aver
notato anche una seconda auto di complici - una Fiat 128 di colore blu -,
inoltre, Buttazzo riferì ai poliziotti che le auto si sarebbero allontanate in
direzione di villa Stuart, quindi in direzione opposta a via della Balduina e, a
dire il vero, anche opposta a via de Bustis - la strada attraversata dalle auto
in fuga secondo la versione ufficiale-. Di queste due versioni ci sembrano più
rilevanti gli aspetti divergenti e pertanto possiamo affermare con una certo
livello di convinzione che Antonio Buttazzo sia da escludere come fonte.
(CM-1 - Vol. 30 pag. 78 - Vol.
40 pag. 84 - Vol. 41 pagg. 412, 435, 631, 938). L'altra ipotesi percorribile è
quella relativa alla telefonata in Questura - sul “canale 2400” - da parte
dell'on. Pino Rauti. Alle ore 9.15 l'onorevole del MSI - abitante in via Stresa,
133 - comunicò che si era “allontanata una Fiat 132 blu targata Roma P79560 con
dei giovani a bordo due vestiti da ufficiali dell'aeronautica”.
CM-1 Vol. 29 pag.994 -
Chiamata dell'on. Rauti in questura del 16 marzo 1978 alle ore 9:15. Va notato
che questa informazione arriverebbe alle ore 9:15, quindi in un momento
successivo – di almeno 5 minuti - dalla comunicazione di ricerca diramata dalla
Sala Operativa. Inoltre, nella chiamata dell'on. Rauti non si fa riferimento
alla direzione di fuga, tantomeno, quindi alla zona della Balduina o di via
della Balduina. Non possiamo, inoltre, non osservare che questa segnalazione
telefonica abbia dei tratti problematici; innanzitutto perché è la sola
testimonianza scritta del 16 marzo in cui un cittadino indichi, tra le auto in
fuga da via Fani la Fiat 132 blu con targa Roma P79560, e lo faccia con estrema
precisione. In secondo luogo le caratteristiche dell'auto sarebbero state
raccolte da una certa distanza – da un balcone - in un punto in cui via Stresa
compie una curva repentina. Inoltre, nel corso degli anni l'on. Rauti, in alcune
interviste, aggiunse ulteriori particolari, come la visione del corpo
dell'agente Iozzino a terra, cosa sulla quale è lecito avanzare più di un dubbio
data la posizione reciproca dell'osservante e del corpo. A prescindere dai dubbi
appena esposti, va rilevato che la relazione dell'appuntato Mammoliti è
inequivocabile. Vi si afferma che l'equipaggio apprese della Fiat 132 "nei
pressi" di via Fani e che abbia, quindi, comunicato questa notizia alla Sala
Operativa, non il viceversa. Le domande che ci siamo posti restano inevase. Chi
è il soggetto che per primo segnalò la Fiat 132? Chi disse che quest'auto si
fosse allontanata in direzione della zona Balduina o di via della Balduina? Chi
comunicò della presenza dell'on. Moro su quell'auto? Con rammarico ammettiamo
che ci sfiora anche l'idea che qualcuno, tra le forze dell'ordine, abbia potuto
inseguire questa auto in fuga da via Fani. Di sicuro sui brogliacci della Sala
Operativa da Squalo 4 abbiamo solo due comunicazioni. La prima, quella del
ritrovamento delle 9:23, la seconda delle 9:27 in cui si informa che “da via
Calvo si sono allontanati due giovani a piedi di cui una donna e un uomo
armati”.
CM-1 Vol. 29 pag. 1017 -
Broglicci di Polizia sul canale 23, volanti. E poi Squalo 4 sparisce dai
brogliacci di giornata, come sparisce in generale dall'inchiesta: la relazione
di servizio che redigono non chiarisce i molti dubbi fin qui discussi e non ci
risulta che i quattro componenti dell'equipaggio siano stati escussi in altre
sedi. Se si vuole aggiungere un'altra piccola riflessione sulla Squalo 4 vale la
pena ricordare che la Sala Operativa comanda in via Fani quattro volanti: V12,
B4, V. Zara e SM91, come si vede non la Squalo 4 che tuttavia si recherà “nei
pressi” del luogo della strage. Cosa è la sezione Squali? Nel libro “Giorgiana
Masi: indagine su un mistero italiano” di Concetto Vecchio (link) si apprende
che il"gruppo Squalo” sarebbe “una squadra di super addestrati che viene
utilizzata solo per contrastare reati in svolgimento, ovvero quando c'è la
possibilità di scontri a fuoco. Poliziotti che dipendono dalle sezioni sportive
della PS, che fanno molti ritiri, i migliori tiratori scelti della polizia …".
Se erano “nei pressi” di un conflitto a fuoco della portata di via Fani, perché
la Sala Operativa non comandò anche loro? Se provassimo a riassumere in poche
righe quanto sin qui esposto, potremmo dire che Squalo 4 si trovò “nei pressi”
di via Fani casualmente; che trovò da quelle parti un soggetto – il cui nome non
venne verbalizzato - che li mise all'inseguimento della Fiat 132 di colore blu
fornendo loro anche la targa; che Squalo 4 trovò nel giro di pochi minuti l'auto
abbandonata in via Calvo. Di stranezze ne abbiamo messe insieme un bel po', ma,
a dire il vero, non finisco qui. Perche` intorno alle ore 10:00 in via Calvo
interviene Digos 4, auto con a bordo il commissario capo Mario Fabbri e il
brigadiere di P.S. Vittorio Faranda. E si badi bene, l'auto compare sulla scena
senza che dai brogliacci si legga che questa fosse stata comandata dalla Sala
Operativa. La prima cose che colpisce nella relazione di servizio è che in essa
non si fa cenno a Squalo 4: non si dice che il ritrovamento della Fiat 132 sia
da addebitare ad essi.
CM-1 Vol. 30 pag. 106 -
Relazione di servizio di Digos 4 del 16 marzo 1978. Sorvolando su alcune
imprecisioni contenute nella relazione (come ad esempio la posizione di
rinvenimento dell'auto) su cui torneremo in un prossimo articolo, ciò che piu`
ci lascia perplessi è il modo in cui viene descritto il ritrovamento dell'auto.
Non si indica il motivo per cui la Digos 4 si fosse recata in via Calvo; non si
dice che il ritrovamento sia avvenuto ad opera di Squalo 4, si ha quasi
l'impressione che a rinvenire l'auto fossero stati gli stessi agenti della
Digos; si indica come orario di abbandono dell'auto le 9:30-9:40, quando
sappiamo che l'auto fu individuata alle ore 9:23. Perchè queste imprecisioni?
Che la Fiat 132 fu trovata da Squalo 4 alle ore 9:23 lo si legge negli atti: nei
brogliacci e nella relazione di servizio a firma del capopattuglia Mammoliti.
Tuttavia le notizie che da essa si ricavano sono scarne e frammentarie, regna
una vaghezza estrama. Squalo 4, non viene citata nella relazione della Digos
appena detta e scompare dalle carte dell'inchiesta, come se quel ritrovamento
fosse un fatto naturale. Una considerazione finale è a questo punto d'obbligo.
Da quanto fin qui esposto e dalla documentazione disponibile il ritrovamento
della Fiat 132, in particolare la sua tempistica, priva di ogni fondatezza la
versione sostenuta dagli ex brigatisti in ordine alle modalità della fuga e in
particolare del presunto trasbordo dell'On Moro dalla 132 sul furgone in Piazza
Madonna del Cenacolo, prima di condurre l'auto in Via Calvo. La Commissione
di inchiesta sul caso Moro presieduta dall'on. Fioroni che si appresta a
concludere i lavori, pare che abbia rilevato alcune delle incongruenze del
racconto brigatista sulla fuga. I lavori sembrano conclusi, eppure alcune
risultanze non sono ancora state rese pubbliche. Tra queste le analisi del DNA
sui reperti. Facciamo presente che anche su su tutte e tre le vetture
comunemente accertate quali componenti del convoglio di fuga del commando - Fiat
132, Fiat 128 bianca e Fiat 128 blu (anche nella Fiat 130 su cui viaggiava Moro)
- furono individuate macchie di sangue. Auspichiamo che gli esiti delle indagini
sui reperti biologici vengano resi quanto prima di pubblico dominio perché, se
vi sono gli elementi per appurarlo, che si renda noto come minimo su quale auto
fu trasportato l'on. Moro.
Di seguito l’inchiesta di
Marianna Gianna Ferrenti pubblicata su “L’Indro” il 17 maggio 2016. “La storia
della Repubblica tra gli anni Settanta e Ottanta, fino al 1993, è stata
macchiata da alcuni clamorosi depistaggi che hanno alterato, con modalità
diverse, il percorso delle indagini riferite ad alcuni eccidi più sanguinari.
Una macchia oscura che con le sue metastasi si estende all’Italia di oggi. Dalle
stragi di Bologna e di Piazza Fontana a Milano, fino a quella di Piazza della
Loggia a Brescia. Dall’omicidio di Aldo Moro a quello di Peppino Impastato, sino
al mistero che avvolge il ritrovamento dell’Agenda Rossa di Paolo Borsellino e
alla Trattativa Stato-Mafia, tanti sono stati i tentativi di inquinare le prove
o di occultare la documentazione che avrebbe potuto rappresentare un tassello
importante per scoprire tutta la verità, senza strascichi o zone d’ombra.
Antonio Giangrande, sociologo e presidente dell’Associazione Contro Tutte le
Mafie, autore di numerosi libri sulle più grandi stragi del passato, tra cui
“‘Aldo Moro. Quello che si dice e quello che si tace’ esprime numerose
perplessità sul Disegno di Legge in questione. “Dopo tanti anni ancora non
sappiamo la verità su una vicenda storica che ha cambiato l’Italia. L’esigenza
della verità su un fatto storico, induce le persone offese dal reato, da singoli
o in associazione, a pretendere più la punibilità dell’ostracismo, che la
conoscenza della stessa verità. Il legislatore, da parte sua, prima o poi,
questa esigenza la soddisfa”. È risaputo, infatti, che molti lati oscuri di
queste inchieste, che hanno portato alla decelerazione, affievolimento o
addirittura al fermo delle indagini derivano proprio dalla mancata
collaborazione di pubblici ufficiali con l’autorità giudiziaria, come
testimoniano numerosi dossier (dossier mitrokhin, dossier Ustica, i documenti
sui depistaggi nella strage di Bologna e molti altri ancora). L’11 maggio è
stato approvato in Commissione Giustizia un DDL che predispone le condizioni per
introdurre nell’ordinamento giuridico il reato di depistaggio e di inquinamento
processuale. Il provvedimento prevede l’introduzione di pene detentive dai 6 ai
12 anni per chi, con modalità diverse, depista le indagini, e si arriva 20 anni
di carcere, con applicazione della pena massima, nel caso in cui intervengano
particolari aggravanti, come il coinvolgimento di persone innocenti. Saranno
considerate inoltre tutte le aggravanti che vanno dal traffico illegale di armi
o del materiale nucleare, chimico o biologico, fino al favoreggiamento di
attività terroristiche. L’attuale relatore del provvedimento, Felice Casson (Pd)
annuncia che il provvedimento sarà calendarizzato sicuramente per la fine del
mese e puntualizza che dovrà comunque tornare alla Camera perché sono state
apportate alcune sostanziali modifiche al testo originario. Per esempio
l’inasprimento delle pene se a commettere il reato è un pubblico ufficiale.
Eppure Giangrande non è affatto convinto che il Disegno di Legge apporterà dei
cambiamenti significativi, soprattutto in relazione alla scoperta della verità
sulle stragi passate e presenti, ma neppure configura degli elementi di
chiarezza in una prospettiva futura. “Non è una norma aggiuntiva a quelle già
esistenti ad indurre l’autore del depistaggio o dell’inquinamento processuale a
cambiare comportamento o a far conoscere l’agognata verità. Il Codice Penale
italiano prevede già la calunnia, la falsa perizia, la falsa testimonianza, la
falsa informazione al Pubblico Ministero od al difensore, la frode processuale o
il favoreggiamento processuale. La novella speciale si aggiunge alle precedenti,
affidandosi all’interpretazione delle toghe per la sua applicazione. Inoltre,
applicata all’autore del reato primario, come concorso del reato, potrebbe in
alcuni casi aggravare la pena, tanto da farla diventare non proporzionale al
fatto commesso” chiarisce il sociologo. Tra gli aspetti preminenti del
provvedimento vi è anche la reclusione fino a quattro anni per chiunque
impedisca, ostacoli o svii un’indagine o un processo penale, anche attraverso
l’occultamento delle prove o l’alterazione della documentazione, con un
inasprimento della pena (da un terzo alla metà) se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale. La pena invece è diminuita dalla metà a due terzi nei
confronti di coloro che si adoperano a ripristinare lo stato originario dei
luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, o ad evitare che il delitto
commesso comporti d ulteriori conseguenze. In pratica, la riduzione della pena è
prevista per coloro che collaborano con la Polizia o l’autorità giudiziaria per
ricostruire il fatto che ha causato l’inquinamento processuale e per
identificarne gli autori. L’Indro su questo Disegno di Legge ha interpellato
anche uno dei relatori del provvedimento, il senatore Nico D’Ascola (AP), che ha
seguito gran parte del percorso legislativo conclusosi con l’approvazione del
testo in Commissione Giustizia. Gli abbiamo chiesto le motivazioni che hanno
allungato i tempi di approvazione, tenendo conto che si tratta di un
provvedimento già approvato alla Camera nel settembre 2014. Sembrava aver subito
un blocco dei lavori al Senato, fino a quando non è stato assegnato alla
Commissione competente nel luglio 2015. D’Ascola riferisce la difficoltà di
dover intervenire su una materia così complessa come quella che riguarda norme
del diritto penale incriminatrici e fortemente limitative della libertà
personale. Ma ammette che una volta superati gli ostacoli tecnico-giuridici, il
proseguo dell’iter parlamentare è stato in discesa. Non ci sarebbe stato quindi
alcun conflitto di natura politica, tant’è che l’11 maggio il provvedimento è
stato approvato all’unanimità. Tra gli aspetti che il provvedimento prende in
considerazione vi è la proporzionalità del reato in relazione sia alla sua
gravità sia allo stato di luogo, di cose o di persone. “Il depistaggio nasce
sostanzialmente da una sommatoria tra le falsità processuali e la falsa
testimonianza. Si punisce separatamente la condotta di chi abbia commesso
depistaggio durante l’attività processuale, ovvero abbia reso falsa
dichiarazione o taciuto con falsa testimonianza circostanze rilevanti, con
attività di inquinamento durante la fase di accertamento del giudice. Il
depistaggio, inoltre, è aggravato se commesso in relazione a procedimenti
dedicati all’accertamento di reati particolarmente gravi” aggiunge D’Ascola. In
pratica, viene punita soltanto la fattispecie in cui vi è l’intenzionalità a
compiere un reato, magari per favoreggiare persone o organizzazioni criminali. È
proprio su questo, secondo Giangrande, che il Disegno di Legge non interviene
adeguatamente per punire, in proporzione alla gravità del fatto commesso, chi
colposamente commette delle gravi imperizie che ostacolano, impediscono o
fuorviano il proseguo delle indagini. “ Il provvedimento non aggiunge niente di
nuovo all’effetto sperato. D'altronde si dà sempre per scontato che l’opera
degli inquirenti e degli investigatori sia meritoria. La carenza strutturale è
che non si prevede la punibilità del responsabile delle indagini che durante le
sue funzioni abbia trascurato per "Colpa" degli elementi probatori essenziali e
non rinnovabili alla soluzione del caso ed alla conoscenza della verità. Questo
affinché l’impunità dello stragismo non sia impunità di Stato” commenta il
presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie. Su questo aspetto, però,
D’Ascola obietta che “punire una sottovalutazione per colpa, cioè di un soggetto
che non si è reso conto dell’importanza dell’elemento investigativo, magari
sulla base d elementi intervenuti successivamente ai fatti contestati, creerebbe
un circuito mostruoso di presunzioni. Francamente, mi sembrerebbe fortemente
limitativo della libertà dell’investigatore. Non credo che nessun ramo del
Parlamento avrebbe avallato una impostazione di questo genere. Poi, nel caso in
cui si verificano gravi imperizie, imprudenze o negligenze da parte di un
investigatore, un Pubblico Ministero o un giudice c’è già la responsabilità
disciplinare o civile, che interviene a seconda del contesto, del tipo di
antigiuridicità, valutando se ci sono degli elementi illeciti rispetto ai quali
commisurare una sanzione. In certi casi, la sottovalutazione può essere del
tutto incolpevole” precisa il senatore. Arriviamo quindi all’aspetto politico
della vicenda legata all’occultamento delle prove o all’universo delle
omissioni, delle bugie o alla distruzione di materiale che poteva essere utile
allo svolgimento delle indagini. Pur non essendoci elementi che facciano pensare
ad un coinvolgimento diretto di influenze politiche nel depistaggio delle
indagini, esistono delle comprovate connivenze, per esempio, tra alcune frange
estreme della politica e alcune associazioni criminali o terroristiche. La
vicenda del rapimento di Aldo Moro e della conseguente uccisione ne è la
dimostrazione lampante, ma anche la strage di Piazza Fontana a Milano su cui “le
indagini si susseguiranno nel corso degli anni, con imputazioni a carico di vari
esponenti anarchici e neo-fascisti; tuttavia alla fine tutti gli accusati sono
stati sempre assolti in sede giudiziaria” argomenta Giangrande. O ancora, sulla
Strage di Piazza della Loggia a Brescia, le indagini si protrarranno a lungo,
per ben 41 anni. “Nella strage dalla stazione di Bologna, il 2 agosto 1980, si
giunse ad una sentenza definitiva della Corte di cassazione il 23 novembre 1995.
Vennero condannati all'ergastolo, quali esecutori dell'attentato, i neofascisti
dei NAR Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, che si sono sempre
dichiarati innocenti (mentre hanno ammesso e rivendicato decine di altri
omicidi, con l'eccezione di quello di Alessandro Caravillani, di cui la Mambro
si dice innocente” chiosa il sociologo. Per Giangrande la vera falla di questo
provvedimento è che interviene semplicemente per punire coloro che depistano le
indagini, ma non contribuisce in alcun modo alla scoperta della verità. Inoltre
non interviene sulle complicità istituzionali, che non sono quelle strettamente
legate al mondo politico, come si potrebbe pensare, ma sono ad esempio legate ai
Servizi Segreti. “I politici nel tempo cambiano e se fossero loro gli
influenzatori o gli occultatori, prima o poi uno di loro canterebbe. Credo che
si debba intervenire di più sulla capacità investigativa e sulle complicità
istituzionali ed avere diritto a dirlo quando questi sono carenti o devianti e
porvi rimedio. Cosa diversa è il mea culpa che la stampa dovrebbe farsi. Un buon
cane da guardia della democrazia, se fosse all’altezza della sua
autocelebrazione, la verità la scoverebbe al posto degli inquirenti incapaci o
delle istituzioni deviate, come fosse un osso nascosto. Senza partigianeria”
sottolinea il presidente dell’associazione Contro Tutte le Mafie. All’interno
del provvedimento non è prevista la retroattività che, come sostiene il relatore
Nino D’Ascola, sarebbe incostituzionale. Tuttavia se fosse stato introdotto
molti anni fa, secondo il presidente dall’associazione ‘Tutte le mafie’, non
sarebbe cambiato molto nel proseguo delle indagini sulle più grandi stragi del
passato. “Non sono le aspettative della piazza a far cambiare le cose, ma la
consapevolezza che le norme sono solo frasi in nero su foglio bianco. Quando
qualcuno sarà veramente libero di scrivere o parlare e gli sarà permesso di
farlo senza ritorsioni, allora la verità verrà a galla. Perché oggi viviamo in
un mondo dove se parte la legittima critica, scatta immediata la querela per
diffamazione o per calunnia. E purtroppo il potere probatorio è solo in mano
alle toghe: giudicanti, ingiudicate” conclude Giangrande.” Marianna Gianna
Ferrenti.
Esempio lampante di “colpa”
degli investigatori. Le stragi di Parigi e Bruxelles? Colpa di una faida tra
poliziotti.
Un'ispettore belga aveva consegnato un dettagliato dossier sui terroristi con le
mappe dei bersagli. Ma il suo capo lo ignorò per un'antipatia personale, scrive
Luigi Guelpa, Lunedì 16/05/2016, su "Il Giornale". La polizia belga disponeva da
settembre delle mappe degli obiettivi dei gruppi di fuoco di Parigi e Bruxelles,
ma per mesi nessuno le ha consultate. Neppure il tempo di metabolizzare la
vicenda dei sessanta militari radicalizzati che il Belgio finisce ancora una
volta nella bufera per l'ennesima falla dei servizi di sicurezza. Protagonista
in negativo della storia è Yves Bogaerts, il capo della polizia di
Malines-Willebroek (località a metà strada tra Bruxelles e Anversa), che non
avrebbe preso sul serio un dossier su Salah Abdeslam e i suoi «compagni di
merenda». Un carteggio nel quale uno zelante ispettore aveva segnalato tutti gli
spostamenti del gruppo jihadista. Non solo, secondo ambienti vicini al ministero
degli Interni tra i documenti consegnati a Bogaerts c'erano anche mappe di
obiettivi da colpire a Parigi e a Bruxelles e rapporti sugli spostamenti di Abid
Aberkan, l'uomo che ha nascosto Salah nella sua casa di Molenbeek fino alla
cattura del 18 marzo. Il tutto corredato anche da indirizzi «di possibili covi»,
compreso quello del civico 79 di rue des Quatre vents, dove venne arrestata la
primula rossa delle stragi di Parigi. Il commissario della stazione di Malines
avrebbe di proposito dato poco peso al fascicolo redatto dal suo ispettore
perché quest'ultimo non avrebbe voluto rivelare le fonti. In realtà, sottolinea
il presidente del sindacato di polizia Vincent Gilles, «Bogaerts aveva chiuso
ogni tipo di rapporto col suo collaboratore» per vicende sindacali che
risalivano all'anno precedente, quando «l'ispettore aveva prolungato il periodo
di convalescenza dopo un intervento chirurgico». La matassa è passata al
«Comitato P», l'organo di controllo dei servizi di polizia che dovrà
pronunciarsi nelle prossime settimane e, con molta probabilità, sollevare
dall'incarico il comandante della caserma di Malines. «Non capisco come una
relazione informativa così delicata non sia stata letta o trasmessa
all'antiterrorismo - spiega il sindaco Bart Somers, confermando la storia - non
posso però esprimere ulteriori giudizi. Quando è scoppiato il caso ho
manifestato sostegno al comandante Bogaerts, ma la nostra comunità merita
maggiore attenzione. L'integralismo anche qui è una minaccia concreta». Nella
cittadina fiamminga (80mila abitanti) ci sono stati infatti cinque arresti dopo
gli attentati all'aeroporto di Zaventem e alle due linee della metropolitana.
Tutti «fiancheggiatori» dei kamikaze dei tragici fatti del 22 marzo. Dall'inizio
dell'anno almeno una ventina di giovani originari del Marocco si sono
radicalizzati, andando a combattere in Siria e Iraq per il Califfato. Malines
dista da Molenbeek (quartiere jihadista per eccellenza) appena 24 chilometri. I
problemi sono più o meno gli stessi. Sulle falle della polizia è intervenuto
ieri anche Olivier Vanderhaegen, direttore dei mediatori culturali di Malines,
gettando ulteriore benzina sul fuoco. «Lavoriamo in situazioni critiche e sotto
minaccia. É inconcepibile che la polizia si permetta di giocare con la nostra
vita non prendendo sul serio denunce, segnalazioni o, peggio ancora, rapporti di
funzionari». Ironia della sorte circa un mese fa i borgomastri di Molenbeek,
Francois Schepmans, e di Malines, Bart Somers, avevano firmato un accordo per
scambiarsi i funzionari di polizia, in modo che potessero accedere a più
informazioni possibili. Alla luce di quanto accaduto le due municipalità hanno
deciso per un opportuno passo indietro.
Esempio lampante di “colpa”
degli investigatori. Aldo Moro e l’articolo di “Repubblica” del 16 marzo 1978,
scrive Giovanni Terzi il 15 marzo 2016 su "Il Giornale". Domani 16 marzo 2016
saranno passati trentotto anni dalla data del rapimento e dell’omicidio di Aldo
Moro avvenuto nel 1978. Trentotto anni in cui la verità su chi e perché ha
ucciso il presidente della democrazia cristiana stenta a farsi luce nonostante i
grandi sforzi prodotti anche dalla ultima commissione parlamentare d’inchiesta
presieduta dal l’onorevole Gero Grassi che con grande abnegazione sta cercando
di riportare alla luce la verità storica fino ad oggi troppo spesso volutamente
dimenticata. Dal 16 aprile 1978 per cinquantacinque giorni Aldo Moro rimase
nelle mani delle Brigate Rosse fino a quel maledetto 9 maggio in cui il corpo
del politico italiano venne ritrovato a Roma all’interno di una Renault 4 rossa
in via Caetani. In questi giorni voglio ripercorrere, come in un diario, ciò che
è accaduto nei 55 giorni di sequestro di Moro; scriverò sia la cronaca del
tempo come veniva raccontata nel 1978, sia ciò che negli anni seguenti è emerso
dagli atti processuali, dalle commissioni d’inchiesta e dalle molteplici
testimonianze. Oggi, il giorno prima del rapimento voglio riportare un documento
a mio avviso importante che fa comprendere quale fosse il clima politico nel
nostro paese in quegli anni. Questo documento riguarda la prima pagina del
quotidiano “La Repubblica” in cui si dava lettura degli atti depositati
riguardanti lo scandalo “Lockheed” dove si registravano tangenti pagate a
politici di mezza Europa per vendere i propri aerei. Il giorno della strage di
via Fani “La Repubblica ” usciva con questo titolo ” Antelope Cobbler?
Semplicissimo è Aldo Moro presidente della DC”. Antelope Cobbler doveva essere
colui che faceva da testa di ponte tra l’azienda aereonautica statunitense ed il
governo italiano ricevendo in cambio tangenti. Potete ben immaginare come quel
titolo e , soprattutto quella dichiarazione , potesse essere devastante per il
politico italiano. L’articolo rendeva noto le dichiarazioni di un teste, Luca
Dainelli un ex diplomatico che visse molto negli Stati Uniti. Suggestivamente
possiamo immaginare che proprio pochi istanti prima del rapimento Aldo Moro
stesse leggendo quell’articolo di “Repubblica”. Insomma mentre Aldo Moro stava
per varare un “governo di solidarietà nazionale” un clima non certo benevolo
aereggiava sulla sua testa quasi a far capire come quella scelta politica fosse
non gradita a molti.
Esempio lampante di “colpa”
degli investigatori. Per la Nato Moro non possedeva segreti che mettessero a
rischio la sicurezza atlantica,
scrive Marco Clementi il 3 gennaio 2016 su “Insorgenze”. Prosegue la nostra
inchiesta che prende spunto dall’attività della nuova commissione d’inchiesta
parlamentare sul rapimento e l’uccisione del presidente della Dc Aldo Moro. La
storia del sequestro del leader democristiano da parte delle Brigate rosse è
costellata di diversivi, false piste, intossicazioni, disseminate per fare
confusione. L’ultima drammatica telefonata che Mario Moretti fece alla famiglia
Moro è la migliore risposta alla domanda che viene continuamente riproposta: il
sequestro avebbe potuto avere un esito diverso? Per sbloccare la situazione il
30 aprile 1978 le Br rinunciano persino a quanto indicato nel loro precedente
comunicato, il numero 8: fanno sapere che sarebbe bastata una presa di parola,
un segnale per sospendere l’uccisione del prigioniero. Ma la Democrazia
cristiana continuò a tacere fino alla mattina del 9 maggio. Perché questo
silenzio? Perché la Dc restò immobile anche difronte ai segnali di
ammorbidimento della posizione brigatista? Oggi ci dicono che il presidente
della Repubblica Leone, informato della chiamata fatta dalle Br avrebbe risposto
alla stessa signora Moro, «tengo la penna in mano», pronto a firmare la grazia
per la liberazione di Paola Besuschio, militante delle Br incarcerata; sembra
anche che la mattina del 9 maggio 1978Amintore Fanfani dovesse pronunciare un
discorso davanti ai vertici del partito, riuniti nella sede nazionale di piazza
del Gesù, ma l’intervento alla fine sarebbe stato rinviato a dopo le elezioni
amministrative del 14 maggio per evitare di avvantaggiare gli avversari
politici… E perché il Pci si mostrò tanto ostile verso il prigioniero Moro, suo
referente fondamentale nella strategia del compromesso storico, decretando
l’inautenticità delle sue lettere e addirittura considerandolo «già morto» dopo
lo scritto su Taviani (Lettera al sen. Paolo Emilio Taviani allegata al
comunicato n. 5 del 10 aprile 1978)? Un Pci che il 18 aprile 1978 vide uno dei
suo massimi dirigenti, il futuro presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
ottenere il visto e partire per la prima volta verso gli Stati uniti dove avrà
incontri molto importanti con l’establishement a cui avrà modo di esporre la
posizione del partito comunista sul rapimento Moro e trovare ampia comprensione
e condivisione per la scelta della «linea della fermezza» (affronteremo meglio
questo capitolo in una delle prossime puntate). La mancata trattativa e l’esito
del sequestro trovano una buona dose di spiegazioni nell’atteggiamento tenuto
dalle due maggiori forze politiche dell’epoca. Proprio per evitare di indagare
le ragioni di queste scelte, con il loro portato di conseguenze e
responsabilità, si sono diffuse le dietrologie più diverse: tra queste spicca la
teoria del «doppio ostaggio», un cervellotico scenario alla Le Carré. Secondo
questa ipotesi, elaborata del senatore Pellegrino presidente della precedente
commissione che si occupò del caso Moro, ad un certo punto del sequestro per le
Br come per la loro controparte avrebbe perso importanza la persona di Moro. La
sorte del prigioniero sarebbe passata in secondo piano rispetto ai segreti
contenuti nelle carte (il «secondo ostaggio») che su indicazione di Moro le Br
avrebbero ricevuto da emissari a lui vicini e barattato con i Servizi segreti
(un’altra variante ipotizza una intercettazione da parte dei Servizi delle
carte) di non meglio specificate potenze straniere (che in questa teoria si
equivalgono senza particolari differenze tra Est e Ovest). La morte di Moro,
anzi la decisione di rinunciare alla sua liberazione dalla prigione, «già
individuata» secondo i propugnatori di questa suggestiva trama noir, sarebbe
stata la diretta conseguenza del soggiungere sulla scena del sequestro delle
carte segrete tenute da Moro nel suo studio di via Savoia. Ed è propio sul
contenuto delle carte dell’archivio Moro, depositate da qualche tempo presso
l’Archivio centrale dello Stato, che si è incentrata l’attenzione di Marco
Clementi. E così l’approccio diretto alle carte ci dimostra che ogni qualvolta i
documenti riemergono sulla scena le narrazioni noir devono lasciare in tutta
fretta il posto alla storia. Una delle ipotesi che circolano ancora oggi sul
rapimento e l’uccisione di Aldo Moro riguarda la possibile consegna di documenti
custoditi da Moro nel suo studio di Roma alle Brigate rosse o, per loro, a
entità diverse, diciamo straniere. Si tratta, per estensione, della teoria del
doppio ostaggio, formulata dal presidente della Commissione Stragi sen. Giovanni
Pellegrino, per la quale le Br, acquisiti i documenti riservati, ebbero la
possibilità di trattare sia per Moro, sia per le carte. L’ipotesi non ha mai
trovato riscontri oggettivi, ma continua a circolare. Oggi, a differenza del
passato, si è in grado di illustrare il contenuto dell’archivio di Aldo Moro di
via Savoia e di come fu gestito dopo l’uccisione dell’uomo politico. Per la Nato
e i Servizi Moro possedeva informazioni riservate ma non sensibili. Siamo, com’è
noto, nel 1978. La situazione politica italiana è complessa. Il partito che ha
governato il paese per 30 anni non ha più il controllo del Parlamento e solo un
concreto aiuto del Pci può consentire il governo del paese. Si tratta del
“compromesso storico”, se visto da Botteghe oscure, o della “solidarietà
nazionale”, se si usa l’espressione coniata dai democristiani. La Nato,
ovviamente, temeva l’ingresso del PCI al governo (fatto indicato specialmente da
ambienti dell’ex partito comunista come il movente del rapimento), ma non perché
avrebbe portato i cosacchi ad abbeverare i cavalli in Vaticano. Il problema era
l’accesso di un partito finanziato da Mosca ai segreti militari dell’Alleanza
Atlantica. Quando Moro cadde nelle mani di una entità sconosciuta a Bruxelles,
la situazione si complicò ancora di più. Appurato che nessun italiano all’epoca
fosse a conoscenza del targeting Nato e che il Pci non avrebbe mai avuto accesso
a informazioni sensibili, la situazione si chiarì nel corso di pochi giorni. La
nota dell’Autorità nazionale per la sicurezza. Ecco cosa riporta un documento
contenuto inACS, MIGS b. 23 C parte A, dispacci MAE, f. 18 cartella 1: «Appunto
autorità nazionale per la sicurezza siglata il 31 marzo 1978 da Ambasciatore
Malfatti, segretario generale MAE per la politica estera, dall’ammiraglio
Mainini, sottocapo di stato maggiore della difesa, per la parte militare. Per le
questioni Nato è stato sentito l’ambasciatore presso l’alleanza atlantica
Catalano. Il rischio di sicurezza connesso al rapimento dell’on. Moro va
considerato rispetto ad alcuni temi che potrebbero essere argomento di
interrogatorio e che sono ipotizzabili anche attraverso comunicazioni contenute
nei messaggi delle Br numeri 2 e 3… Il segretario Generale del nostro Ministero
Affari Esteri, interpellato sulla possibilità che all’on. Moro possono essere
strappati segreti connessi alla politica estera italiana o ai rapporti
internazionale del nostro paese, esclude l’esistenza di fatti riservati di
rilevante importanza, in quanto tutto è praticamente noto attraverso la stampa
normale e specializzata. In effetti il ruolo dell’Italia non è tale da poter
influire sugli equilibri internazionali e quindi, da necessitare una specifica e
così clamorosa azione di ricerca da parte di altra nazione. Nel settore militare
di interesse esclusivamente nazionale non esistono elementi a conoscenza dello
On. Moro che possono costituire un rischio di sicurezza. L’uomo di stato era
indubbiamente a conoscenza di cose riservate nelle loro linee generali ma
evidentemente non poteva scendere nei dettagli operativi. Per quanto riguarda i
nostri rapporti con la Nato può essere ripetuto il discorso precedente, in
quanto nessun uomo politico scende nei dettagli operativi… L’unico punto debole
potrebbe essere quello che l’Italia è membro permanente del Nuclear Planning
Group ma il nostro ambasciatore presso la Nato esclude che l’on. Moro fosse a
conoscenza di fatti capaci di incrinare la sicurezza dell’alleanza. Inoltre va
rilevato che la parte più riservata della strategia nucleare è rilasciata solo
alle nazioni in possesso di proprio armamento nucleare e che pertanto il
targeting completo e le norme di impiego non sono a conoscenza di nessun
elemento nazionale». Le carte dell’ufficio di via Savoia. Chiarito che Moro non
aveva informazioni sensibili, se ne può dedurre logicamente che nel suo Archivio
non conservasse neanche documenti in tal senso. Altre informazioni, diverse dal
targeting Nato, davvero non valevano l’uccisione di 5 uomini e il rapimento di
Moro. Comunque, vediamo quale fosse la consistenza del fondo di via Savoia. Si
tratta di sei armadi blindati contenenti documentazione di varia tipologia, in
parte proprietà dello Stato (e che, dunque, non doveva trovarsi lì), in parte
privata, che richiese mesi di lavoro alle Commissioni incaricate della stesura
di un inventario e che, infine, venne acquisita dallo Stato italiano,
comprandola, per la parte privata, dalla famiglia Moro. È altamente, per non
dire certamente, improbabile che Moro conoscesse l’ubicazione di documenti
specifici, visto il loro alto numero (229 faldoni). Tuttavia, sono presenti
documenti segreti e riservati. Essi furono acquisiti dalla Pubblica
amministrazione nel 1983 e custoditi presso la Segreteria speciale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Riguardavano due casi importanti per
Moro: il processo De Lorenzo e lo scandalo Lockheed. Il dossier De Lorenzo.
Nella prima vicenda sulla quale, com’è noto, Moro aveva posto il segreto di
Stato, lasciando che fossero condannati per diffamazione due giornalisti come E.
Scalfari e L. Jannuzzi (condanna poi non confermata in secondo grado per la
remissione della querela del generale De Lorenzo e del colonnello Mario
Filippi) [Elenco dei documenti contenuti nel pacco n. 1 ora in ACS, fondo Moro,
Carabinieri, busta 174]. I documenti riguardanti questioni militari e la Nato
risalgono al periodo 1963-1969, mentre sono molto più recenti, ossia del 1977,
due documenti su forze di polizia e ordine pubblico. Il carteggio sullo scandalo
Lockheed. Il carteggio sullo scandalo Lockheed per lo più proviene dal
Parlamento, sebbene alcune carte siano state prodotte da Ovidio Lefevre, uno
degli uomini coinvolti nello scandalo, e dal senatore Luigi Gui, uno dei
ministri della Difesa coinvolti nello scandalo con Mario Tanassi. Qui va fatto
un inciso. Lo scandalo, infatti, che riguardava la vendita all’Italia di aerei
forniti dalla ditta Lockheed, costrinse il Parlamento a formare una commissione
inquirente. La seconda, in particolare, che operò nel 1976-77, fu presieduta dal
senatore Mino Martinazzoli, coadiuvato da due vice, uno del Pci e uno del Psi e
composta da 8 Dc, 7 Pci, 2 Psi, un membro di Sinistra Indipendente, uno di
Democrazia Nazionale e uno del Gruppo Misto-Union Valdotaine. Il voto di
Martinazzoli fu decisivo per non incriminare l’ex primo ministro coinvolto,
Mariano Rumor, mentre Gui e Tanassi vennero incriminati. Durante la seguente
discussione in aula, Moro pronunciò un discorso divenuto famoso per questo
passaggio: «…Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi che ci avete
preannunciato il processo sulle piazze, vi diciamo che noi non ci faremo
processare…». Le commissioni Dainotto e Serra. Tornando all’archivio di Moro, la
documentazione riservata e segreta successiva riguarda l’attività del presidente
democristiano quando era ministro degli Esteri, dunque fino al 1974. Della metà
degli anni Sessanta sono un consistente numero di documenti riguardanti la
“società Cogne”, attiva in Val d’Aosta nel comparto energetico (1965-1968). La
prima commissione incaricata di inventariare l’Archivio e valutarne il contenuto
fu istituita nel 1983, presieduta dal prefetto Aldo Dainotto. Fu questa a
individuare la serie di documenti coperti da segreto (una porzione «assai
esigua» rispetto al contesto archivistico, scrisse nella sua relazione), serie
trasferita presso la Segreteria speciale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Una seconda commissione, istituita nel 1992 e presieduta dal prof.
Enrico Serra, concluse i suoi lavori affermando che «non esistevano documenti
rilevanti sotto il profilo del segreto di Stato oltre a quelli già acquisiti
alla Pubblica Amministrazione dalla Commissione Dainotto». Arrivo in Acs e
commissione Porpora. Nel 1995 l’archivio Moro fu acquisito dall’Archivio
centrale di Stato e venne ad affiancarsi agli archivi personali di altri uomini
politici come Giolititi, Orlando, Parri, Sforza e altri. Si diede inizio a un
lavoro di lettura e inventario delle carte in vista della apertura alla
consultazione del fondo, rispettando la sequenza dell’ordinamento dato da Moro
(o da suoi collaboratori). Le carte, oltre a quelle segrete e riservate già
citate, sono relative all’attività del presidente come ministro di Grazie e
giustizia (1955-1957), della Pubblica Istruzione (1957-1959) di segretario della
Dc (1959-1963), di ministro degli esteri (in più fasi dal 1964 al 1974) e di
presidente del Consiglio (1963-1968 e 1974-1976) [Archivio centrale dello Stato,
fondo Moro, CC, b. 174]. Le prime 32 buste sono oggi liberamente consultabili.
Contengono documenti degli anni 1959-1978 costituiti da minuti di testi e
discorsi, molti dei quali pubblici. Le buste 33-37 sono parzialmente
consultabili. Contengono note biografiche, appunti, rassegne stampa, fotografie,
interventi parlamentari, messaggi di saluto. Le buste 38-58 non sono
consultabili. Contengono carte sull’ordine pubblico e la sicurezza interna
(1971-1977), carte dell’Ufficio del capo di Gabinetto di Moro ministro degli
Esteri e del presidente del Consiglio. Le buste 60-196 contengono documentazione
varie relativa all’attività di Moro in qualità di ministro di Grazia e
giustizia, della Pubblica istruzione ecc., questioni Onu, Nato e Cee. Le altre
buste contengono interventi parlamentari, documenti sulle visite di Stato di
Moro e di personalità straniere in Italia. L’ultima commissione, istituita nel
2003 e presieduta dal Consigliere di Stato, prof. Giuseppe Porpora, fu
incaricata di verificare l’eventuale permanenza di motivi che impedivano il
trasferimento della documentazione conservata presso la Segreteria speciale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Archivio centrale dello Stato.
Alla fine dell’esame, una parte venne declassificata (159 fascicoli), mentre su
7 fascicoli è stato mantenuto il segreto. Senza conferme il teorema del “doppio
ostaggio”. Alla luce di questa breve ricognizione del fondo Moro, appare molto
difficile credere a un passaggio di carte da via Savoia a via Montalcini o
Rapallo, in Liguria, dove si riuniva permanentemente l’esecutivo brigatista.
Andiamo per logica. Se Moro fosse stato rapito da un servizio occidentale, non
esistevano segreti che egli conoscesse e non conoscessero i suoi eventuali
rapitori. Se a farlo fosse stato un servizio dell’Est, allora questo avrebbe
sbagliato persona. Molto più semplice e meno vistoso sarebbe stato operare come
di solito agiscono i servizi, ossia ricattando, infiltrando o corrompendo. Se,
infine, furono le Br, come noi crediamo, in questo caso nessuno dei pentiti o
dei dissociati ha mai ricordato la circostanza. Né, se consegna di documenti ci
fu, nessuno dell’eventuale canale di ritorno ha mai detto una parola in
proposito, neanche oggi a distanza di 37 anni, né le eventuali carte sono mai
saltate fuori, nemmeno dal luogo dove in questo caso sarebbero dovute
naturalmente finire, ossia la base di via Monte Nevoso a Milano. Non che quei
documenti non potessero suscitare l’interesse delle Br, specialmente
considerando che l’uomo di potere Aldo Moro aveva nel suo studio Dossier,
conservava segreti che potevano essere usati in politica, dandogli potere di
intervento in determinate situazioni. E, come vedremo in uno dei prossimi
interventi, proprio nei giorni precedenti il sequestro, Moro si era attivato per
far mettere sotto controllo il proprio studio di via Savoia, ma solo “quando era
assente”. Eppure, il Memoriale redatto da Moro in via Montalcini smentisce
qualsiasi ipotesi di consegna. Se, infatti, ci fosse stato un passaggio di
documenti, a cosa sarebbero servite le memorie di Moro sugli stessi argomenti,
senza peraltro incontrare un solo riferimento a eventuali carteggi? Se le Br
avessero saputo che Moro conservava le carte degli scandali, del Sifar o della
Lockheed, e che Moro era stato prima di tutto interessato a salvare, o
salvaguardare, il suo partito e se stesso, allora avrebbero potuto usarli
davvero come mezzo di pressione per rompere il muro della fermezza. Ma non lo
fecero. Semplicemente perché non avevano in mano alcuna di quelle carte. Infatti
annunciò: «Forse rapiscono Moro» pochi minuti prima del sequestro del politico
Dc.
Rapimento Moro, nuove carte
mostrano che l’allarme lanciato dai palestinesi non riguardava il presidente
della Dc,
scrivono il 16 marzo 2016 Marco Clementi e Paolo Persichetti su “Insorgenze”. Il
20 aprile 1978, in pieno rapimento Moro, un ex appartenente ai Servizi di
sicurezza del Venezuela fornisce al Sismi informazioni su due riunioni segrete
tenute a Madrid e poi a Parigi nei primi mesi del 1978 sotto la direzione di una
«Giunta di coordinamento rivoluzionario», la JCR (Junta coordinadora
revolucionaria). La notizia, esposta in questi termini, era già nota alla prima
commissione d’inchiesta parlamentare sul rapimento Moro (presieduta tra gli
altri dal senatore Libero Gualtieri nel corso dell’VIII legislatura, 1979-1983).
Il Sismi ne aveva scritto all’interno di una Relazione (pag. 21-22) inviata alla
commissione, dove forniva «elementi specifici di risposta in funzione dei
quesiti posti alla Commissione Parlamentare d’inchiesta». Oggisiamo in grado di
presentarvi nella sua versione integrale quell’appunto del 20 aprile citato dal
Sismi. Si tratta di un testo di due pagine redatto senza intestazione, data,
numeri di protocollo e altri riferimenti (lo potete visionare qui accanto)
ritrovato tra le carte della direttiva Prodi depositate presso l’Archivio
centrale dello Stato (Direttiva Prodi, “Caso Moro”, Fondo Ministero Interno
Gabinetto Speciale, busta 11). Perché questo documento è importante?
Recentemente si è tornati a parlare, contro ogni evidenza, di segnali che
avrebbero anticipato il progetto di sequestro del presidente della Democrazia
cristiana e messo addirittura in allarme il caposcorta e lo stesso Moro. Lo ha
fatto la nuova commissione d’inchiesta parlamentare, presieduta da Giuseppe
Fioroni, mischiando episodi diversi, in passato ampiamente indagati e rivelatisi
infondati, che suscitarono una certa preoccupazione da parte del leader
democristiano, non per la sua persona ma per le carte riservate presenti
nell’archivio personale di via Savoia (oggi sappiamo – leggi qui – che vi erano
conservati documenti di Stato, in particolare le carte del caso Sifar e dello
scandalo Lockeed, di cui si discuteva molto in quel periodo). La preoccupazione
per la tutela di quei dossier era tale che Moro chiese alle forze di polizia «un
servizio di vigilanza a tutela dell’ufficio di via Savoia» nelle ore della
giornata in cui non era presente, richiesta che mostra quanto fosse poco
allarmato per la sua persona. Altro spunto utilizzato dalla commissione per
rilanciare la pista dell’allarme preventivo è stato il cablo pervenuto da Beirut
il 18 febbraio 1978 (in realtà comunicato al Sismi il giorno precedente), dove
la fonte 2000 (presumibilmente il colonnello Giovannone capocentro in Libano)
riferiva la notizia fornitagli dal capo del FPLP George Habbash di una possibile
azione terroristica che avrebbe potuto coinvolgere l’Italia. Il documento è
stato rinvenuto da chi scrive nella scorsa primavera tra i files depositati
dall’Aise presso l’Archivio centrale dello Stato, nell’ambito delle Direttive
Prodi e Renzi, e reso pubblico nel corso dell’audizione tenuta il 17 giugno 2015
davanti alla nuova commissione d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo
Moro. Poiché il colonnello Giovannone era un uomo vicino a Moro e per suo conto
svolgeva un ruolo centrale nella gestione del cosiddetto “Lodo Moro”, la
commissione ha ipotizzato che Moro stesso fosse stato informato di quell’allarme
senza tuttavia aver trovato conferme che l’informazione di Habbash facesse
riferimento a un progetto di attacco contro il presidente della Dc. La ratio che
sta dietro il tentativo ostinato di voler a tutti i costi dimostrare l’esistenza
di un preallarme che avesse anticipato la preparazione di un attentato contro
Aldo Moro, nella migliore delle ipotesi condurrebbe a denunciare la colpevole
negligenza dei Servizi di intelligence e delle forze di Polizia per aver
trascurato i segnali premonitori del pericolo imminente; in realtà serve ai
fautori delle tesi complottiste, e delle narrazioni dietrologiche che
imperversano sulla storia del sequestro Moro, per dimostrare il ruolo
connivente, se non addirittura attivo dei Servizi, e di “forze oscure dello
Stato”, nella organizzazione, esecuzione e gestione del sequestro. L’appunto del
20 aprile assume dunque una rilevanza particolare perché dal raffronto
incrociato con le indicazioni contenute nel cablo di Beirut si riscontra la
presenza di due informazioni sovrapponibili: L’incontro avvenuto non molto tempo
prima in un Paese europeo: «progetto congiunto discusso giorni scorsi in
Europa», riferisce il cablo di Beirut; due riunioni segrete, una a Madrid e
l’altra a Parigi, secondo l’appunto del 20 aprile. Il contenuto della riunione:
progetto di una «operazione terroristica di notevole portata» per il cablo
proveniente da Beirut; «l’esecuzione di azione clamorosa contro un’eminente
personalità politica pubblica dell’Europa Occidentale», riferita nel documento
del 20 aprile. Entrambi i documenti si riferivano a Moro? La domanda è più che
logica alla luce di quanto avvenuto il 16 marzo in via Fani, ma la risposta è
negativa. Come vedremo meglio nella seconda puntata il Sismi svilupperà una
intensa attività informativa per verificare la portata e il significato della
informazione del 18 febbraio, sia precedentemente che successivamente all’azione
di via Fani. Ripetutamente interpellate e sollecitate le varie organizzazioni
palestinesi non solo ribadirono di non aver mai avuto notizia del progetto
brigatista di sequestro, ma si mostrarono incapaci di instaurare un qualsiasi
contatto, diretto o indiretto con i rapitori, e di riuscire a influenzarne
politicamente, anche a distanza, l’azione. Come già sottolineato nell’audizione
del 17 giugno 2015, il cablo proveniente da Beirut, in realtà, porta ad
escludere ogni riferimento all’imminenza di un’azione delle Br in Italia, perché
l’interlocutore del FPLP, ossia George Habbash, sembra voler rassicurare il
Sismi che l’Italia ne sarebbe stata fuori. Altre informative e indagini svolte
dal Servizio – su cui ci soffermeremo sempre nella seconda puntata – corroborano
piuttosto l’ipotesi di un attentato nei confronti di un obiettivo riguardante
l’area mediorientale, che avrebbe potuto coinvolgere l’Italia al massimo come
luogo di transito. Nel successivo appunto del 20 aprile si precisa con molta
nettezza che il progetto di esecuzione di una clamorosa azione contro
un’eminente personalità politica dell’Europa Occidentale «non è riferita all’On.
Moro, come da recente precisazione della fonte». Sempre nello stesso appunto,
tra i gruppi politici rivoluzionari indicati come partecipanti alle riunioni
segrete della «Giunta», non sono mai menzionati gruppi combattenti europei come
Eta, Raf, Br, Pl. L’appunto del 20 aprile 1978. Il documento, suddiviso in tre
punti, riferisce di una prima riunione segreta della “Giunta di coordinazione
rivoluzionaria” tenutasi a Madrid nel gennaio 1978, nella quale avrebbero
partecipato i rappresentati di formazioni politiche rivoluzionarie, in
prevalenza sudamericane: il Mir cileno, l’Erp e i Montoneros argentini, l’Eln
boliviano, i Tupamaros uruguaiani, il Mrp brasiliano, Baniera roja e la Liga
socialista venezuelani. Insieme a loro viene segnalata la presenza di
rivoluzionari di sinistra di altri Paesi (formulazione che lascia pensare ad una
partecipazione di tipo individuale), dalla Colombia al Centroamerica, Usa,
Germania occidentale, Giappone, Singapore. Avrebbero partecipato anche i
guerriglieri del Fplp di George Habbash (il che fornirebbe una spiegazione sul
possesso delle informazioni riferite nel cablo del 18 febbraio), il Fronte
polisario, il Pcte spagnolo, una formazione francese d’ispirazione trotzkista
che nel punto successivo è indicato tra i gruppi iberici e Lotta Continua.
Preciso nel riferire delle realtà politico-rivoluzionarie del Sudamerica, che
evidentemente la fonte, vista l’origine geografica, conosce direttamente, le
informazioni diventano molto più lacunose quando si tratta di riportare la
composizione dei gruppi degli altri continenti ed è ipotizzabile un errore per
quanto riguarda LC. Nella seconda riunione segreta tenutasi a Parigi si sarebbe
decisa una strutturazione per aree regionali del coordinamento: sezione
latino-americana; iberica; europea, nordamericana e asiatica. Il punto tre
affronta i contenuti operativi di questo secondo incontro:
la finalizzazione di un piano
per il trafugamento di equipaggiamento altamente sofisticato (armi portatili,
laser con congegni di mira di nuovo tipo ecc);
l’esecuzione di un’azione
clamorosa contro un’eminente personalità politica pubblica dell’Europa
Occidentale (non riferita all’On. Moro, come da recente precisazione della
Fonte);
la creazione di una centrale
in Europa per la produzione di documenti personali falsi;
l’istituzione di un comitato
tecnico-scientifico per lo studio di armamenti atomici;
l’addestramento dei
guerriglieri in campi angolani da parte dei cubani;
l’incremento della lotta
armata, soprattutto in Argentina, Brasile e Cile;
lo sviluppo di azioni
terroristiche in occasione del campionato di Calcio in Argentina;
una nuova riunione in Svezia.
L’ex agente dei servizi
venezuelani viene sentito a rapimento in corso e si offre per organizzare
un’azione di infiltrazione utilizzando un nucleo di propri informatori. Offerta
in seguito esclusa dopo una serie di trattative – spiega il Sismi nella
relazione inviata alla commissione – per le «scarse garanzie offerte dagli
interlocutori» che tentano di accreditarsi millantando «il possesso di primizie
informative» al momento del rinvenimento del cadavere di Moro, «giocando sulla
differenza dei fusi orari rispetto all’immediata diffusione della notizia sul
piano mondiale». Oltre alla coincidenza con i contenuti del cablo del 18
febbraio, è proprio questa mancanza di informazioni sulle Brigate rosse e il
rapimento in corso che paradossalmente rafforza quanto riferito sulle riunioni
della “Giunta” che, palesemente, nulla hanno a che vedere con quanto stava
avvenendo in Italia. La Junta coordinadora revolucionaria. Qualche informazione
in più va spesa sulla JCR. Sorprende, infatti, ritrovare nel 1978, e per giunta
in Europa, la sigla di questa organizzazione internazionalista nata nel 1974
dalla decisione delle formazioni rivoluzionarie dell’America Latina di stringere
un’alleanza dopo il golpe cileno dell’anno precedente e coordinare le proprie
forze e strategie per combattere le dittature militari del Cono Sud ispirate e
sostenute dagli Stati Uniti. La JCR, soprattutto tramite l’ERP argentina, ha
avuto relazioni intense con la Quarta internazionale, in particolare con i
francesi della Ligue communiste révolutionnaire che appoggiarono l’opzione
armata in Argentina. Gli storici più accreditati spiegano come la JCR, che le
feroci dittature militari affrontarono dispiegando il piano Condor, entrò in
crisi nel 1977 a seguito delle divisioni emerse all’interno dell’Erp e alle
relazioni stabilite dal Mir con Cuba in vista di un rientro in Cile. Un colpo
molto duro arrivò nel 1975 con l’arresto e la tortura in Paraguay, da parte
della polizia segreta di Alfredo Stroessner, di due dei suoi maggiori dirigenti:
Jorge Fuentes soprannominato “El Trosko”, membro del Mir cileno, e Amilcar
Santucho esponente dell’Erp argentino. Nella metà degli anni 70, la JCR che
aveva il suo massimo radicamento in America latina, aprì delle sedi in Messico,
ad Algeri e in Europa, dove per un periodo stabilì il suo segretariato centrale.
E’ probabile che nel 1978, grazie alla rete degli esuli, si sia tentato di
rilanciare la struttura internazionalista. Questo spiegherebbe le riunioni di
Madrid e Parigi, anche se sembra che in questa fase la JCR non avesse più alcuna
operatività reale. Aldo Marchesi, ritenuto uno degli studiosi più competenti
delle vicende di questa organizzazione rivoluzionaria, scrive che in alcuni
rapporti dei Servizi dei regimi Sud dittatoriali Americani si riferiscono
riunioni tenute in Europa, dopo il 1977, con formazioni rivoluzionarie locali da
coordinamenti indicati con la sigla JCR, che tuttavia non avevano più
l’estensione organizzativa della prima JCR. La nota del 15 aprile 1978. Il 5
aprile 1978 un’agenzia di stampa di destra, l’Aipe, dirama un dispaccio (n°
1640) in cui si riporta un allarme dei servizi di sicurezza francesi sul rischio
di un nuovo gesto spettacolare. «Il servizio segreto francese, cioè lo SDECE, –
riferisce l’agenzia – è in stato di preallarme. Ha informazioni in base alle
quali i terroristi comunisti europei stanno preparando spettacolari imprese,
questa volta contro impianti e servizi, in alcuni Paesi dell’Europa Occidentale.
Questo allarme è stato comunicato anche alle autorità di sicurezza dell’Italia,
che oggi è il Paese più esposto al terrorismo comunista». La nota d’agenzia
suscita una richiesta di verifiche e spiegazioni all’interno del Sismi. Il 15
aprile il Servizio redige un appunto di particolare interesse, in «Visione per
il signor Capo Reparto», in cui nonostante la presenza di alcuni omissis (di cui
sarebbe necessario provvedere alla rimozione) emergono ulteriori informazioni,
per esempio un allarme del mese di Gennaio 1978 che avrebbe interessato le città
di Londra e Parigi, e dal quale si scopre la presenza di altri documenti non
ancora resi pubblici. Dispaccio Aipe. L’estensore precisa che «nessun preallarme
relativo ad attentati terroristici in Europa Occidentale è recentemente
pervenuto daOmissis. Siamo stati invece noi, nel gennaio scorso ad estendere
inOmissis [nel testo sono appuntati a mano i numeri di protocollo di documenti
ancora non versati in Acs, nel fondo della direttiva Prodi, 361=2 pal 38 (1512 +
1514)] un allarme (all. 2) pervenutoci da “R” ed interessante in particolar modo
Londra e Parigi. Poiché in tale messaggio si fa riferimento ad “organizzazioni
terroristiche europee” non è da escludere che si tratti proprio di quello cui fa
riferimento la nota d’agenzia». «Altro Stato d’allarme – prosegue sempre la
precisazione del Sismi – esteso più recentemente in Omissis» è quello in
allegato 2 [numero aggiunto a penna insieme ai protocolli 1526 + 1527 + 1528,
rispettivamente il cablo proveniente da Beirut, e la stessa informazione girata
al Sisde, Ministero interni e Servizi alleati] sempre originato da “R”. E anche
tale messaggio ha qualche assonanza con la nota d’agenzia poiché si parla di una
“operazione di notevole portata” e nella nota si dice “spettacolari imprese”.
Non si dispone di elemento utile a risalire al responsabile della diffusione
delle notizie di cui alla nota successiva». L’allarme dello Sdece francese
sarebbe stato – almeno stando a quanto sostiene il Sismi – soltanto un’eco delle
informative diffuse dal Servizio italiano presso quelli alleati. Ma quel che
appare ancora più interessante in questo documento, con il beneficio del dubbio
degliomissis, è l’indicazione di Londra e Parigi come sedi possibili degli
attentati.
A fronte di quanto pubblicato
da "Insorgenze" scopriamo che Radio Città Futura sapeva di Moro. Il
direttore Rossellini disse che era una voce che girava, scrive Francesco Damato
su "Formiche.net". Non trascorsero inutilmente, per il povero Aldo Moro e quanti
avrebbero dovuto proteggerlo, soltanto i 26 giorni seguiti alla segnalazione del
18 febbraio 1978 dalla «fonte 2000» di Beirut dei servizi segreti italiani,
informati dai palestinesi di un'operazione nel nostro paese, concordata, o a
conoscenza, a livello terroristico internazionale. Purtroppo trascorsero
inutilmente anche gli ultimi, sessanta minuti- come vedremo - che precedettero
il tragico sequestro del presidente della Dc, avvenuto il 16 marzo fra le 9 e 3
minuti e le 9 e 5 minuti, dopo 93 colpi d'armi da fuoco di cui 49 sparati da una
sola fonte e 2 soltanto da uno degli agenti di scorta di Moro: il poliziotto
Raffaele Iozzino. Gli altri quattro della quadra non ebbero neppure il tempo e
il modo di tentare una reazione armata. Pochi minuti dopo le ore otto, quando
Moro era ancora a casa e la scorta si accingeva a raggiungerlo per accompagnarlo
alla Camera, lungo un percorso rivelatosi - ahimè - troppo abituale,
nell'abitazione romana del senatore moroteo Vittorio Cervone la domestica Clara
Giannettino trasecolò ascoltando alla Radio Città Futura, diretta da Renzo
Rossellini e appartenente all'area extraparlamentare di sinistra non certamente
ignota alle forze dell'ordine, che «forse rapiscono Moro». A sequestro avvenuto,
e su segnalazione di Cervone, il capo della Polizia incaricò il vice questore
Umberto Improta di ascoltare la signora. Che fu interrogata nel pomeriggio e
risultò senza precedenti sfavorevoli e sana di mente, «in un appunto redatto su
carta intestata del Ministero dell'Interno, senza destinatario né protocollo»,
come si legge nella relazione del presidente della nuova commissione
parlamentare d'indagine sul caso Moro, il deputato Giuseppe Fioroni, pubblicata
il 10 dicembre scorso nell'apposito bollettino della Camera. L'appunto tuttavia
conteneva anche «osservazioni aggiuntive» che, secondo la relazione di Fioroni,
minavano alla radice l'attendibilità della signora, ritenuta «di livello
culturale molto scadente, se non inesistente, abituata ad ascoltare soltanto
canzonette e, quindi, di scarsissima ginnastica mentale». Pertanto la donna,
secondo l'impressione del dottor Improta riferita nella relazione di Fioroni «in
buona fede e sotto la spinta emotiva della drammatica notizia avrebbe frainteso
il significato di un comunicato radio riguardante Moro». E la cosa, in mancanza
di una registrazione delle trasmissioni di quella radio da parte dei centri
autorizzati di controllo, finì nella nebbia, anche giudiziaria, fra le inutili
proteste levate dopo qualche mese da Cervone in una intervista a Famiglia
Cristiana. La nuova commissione parlamentare d'inchiesta ha giustamente riaperto
e approfondito la vicenda. La relazione di Fioroni dice: «Eppure Improta
conosceva personalmente Rossellini» il direttore cioè della radio ascoltata
dalla collaboratrice di Cervone. «Esisteva da tempo un contatto, riconosciuto da
entrambi anche nel corso di audizioni parlamentari. Si trattava anzi di un
rapporto privilegiato, secondo quanto riferito a collaboratori della Commissione
dall'allora funzionario della Digos, Vittorio Fabrizio». Che «lasciò il servizio
poco dopo la strage di via Fani, rimase del tutto estraneo all'inchiesta e non
fu mai ascoltato dai magistrati inquirenti», ha tenuto ad annotare Fioroni
mostrando uno stupore condivisibile. Inoltre, Improta «circa due settimane prima
dei fatti di via Fani, secondo una dichiarazione del tutto attendibile, avrebbe
ricevuto da Rossellini significative informazioni su eventi eclatanti in vista».
Ma non è finita. La relazione Fioroni fa rilevare che «Rossellini conviveva con
Giovanna Francesca Chantal Personè, militante di sinistra, sospettata all'epoca
di essere vicina alle Brigate Rosse, coinvolta in indagini per reati
associativi», per cui «tale circostanza rende possibile l'ipotesi ch'egli
potesse disporre di elementi di conoscenza tali da consentirgli di formulare,
sia pure in forma dubitativa, previsioni affidabili circa iniziative di tipo
terroristico». Previsioni, d'altronde, confermate dallo stesso Rossellini
davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi presieduta
dall'allora senatore Giovanni Pellegrino ammettendo di avere già riferito
nell'autunno del 1978 ad un giornalista del francese Le Matin che «nel suo
ambiente si parlava molto di un eventuale attentato delle Brigate Rosse in
coincidenza con la votazione alla Camera del governo e con l'entrata del Partito
Comunista nella maggioranza». No. Non è finita neppure con questo. Il presidente
della Commissione ha voluto inserire nella sua relazione il testuale racconto
fatto di quella tragica mattina del 16 marzo 1978 nella Questura di Roma, e non
solo in via Fani, da Vittorio Fabrizio: «Già nelle prime ore della mattinata
circolava la notizia, nell'ambiente dell'Ufficio politico della Questura, che il
rapimento fosse stato annunziato da Radio Città Futura» prima dell'evento. «Nel
corso della giornata – ha riferito sempre l'ex funzionario della Digos – ho
commentato riservatamente questo dato con i miei colleghi dottor Infelisi – da
non confondere, osservo, con l'omonimo magistrato inquirente, Luciano – e dottor
De Stefano, entrambi a conoscenza della stessa circostanza. Si è trattato di un
colloquio molto cauto perché eravamo tutti consapevoli» dell'abnormità della
situazione «meritevole di approfondimento». «Mi resi immediatamente conto -
continua il racconto - che se la notizia fosse stata rappresentata al dirigente
dell'ufficio politico, dottor Spinella, in tempo reale, come la rilevanza
dell'evento lasciava presumere, ciò avrebbe avuto conseguenze colossali».
Avrebbero potuto quanto meno allertare telefonicamente la scorta di Moro, e
sventare l'operazione, par di capire. Il caso – o solo il caso? – volle tuttavia
che proprio il dirigente dell'ufficio politico della Questura, Domenico
Spinella, corresse sul posto del sequestro in tempi così rapidi da precedere di
poco l'allarme della sala operativa, secondo orari e tempi su cui la commissione
ha attentamente indagato ascoltando, fra gli altri, l'allora autista del
dirigente di polizia, Emilio Biancone.
Caso Moro, il leader
democristiano temeva l'agguato,
scrive Andrea Piccoli su “Pontile News” il 20 gennaio 2016. Un giorno prima,
Moro chiese il rafforzamento della protezione. La rivelazione è contenuta nella
prima relazione depositata dalla Commissione Parlamentare presieduta da Giuseppe
Fioroni. Aldo Moro aveva avvertito il pericolo incombente. La sera del 15 marzo
1978, poche ore prima dell'agguato delle Brigate Rosse in via Fani, il
presidente della Democrazia Cristiana chiese «un servizio di vigilanza a tutela
dell'ufficio di via Savoia», dove si trovava lo studio privato del politico.
Alla luce dei fatti, la protezione si sarebbe rivelata inutile, ma il
particolare è significativo del clima di quei giorni e della distanza che ancora
ci separa dalla verità completa sul caso Moro. È solo una delle scoperte che
emergono dalla relazione della Commissione Parlamentare presieduta da Giuseppe
Fioroni. Il documento è stato approvato da tutte le forze politiche presenti,
compreso il M5s. Il particolare è emerso dagli archivi della Polizia, contenuto
in una relazione firmata da Domenico Spinella, dirigente della Digos che Moro
incontrò proprio nello studio di via Savoia la sera precedente all'agguato. La
relazione di Spinella reca la data del 22 febbraio 1979, cioè 11 mesi dopo il
rapimento. Perché? La risposta è in un articolo uscito proprio quel giorno sul
quotidiano di Genova Il Secolo XIX, che alludeva a un non meglio
precisato timore di Moro per un eventuale agguato nei suoi confronti.
«Trentasette anni dopo abbiamo scoperto questa relazione “post-datata”, dalla
quale apprendiamo con certezza che Moro, poche ore prima di essere colpito,
aveva chiesto tutela. Nella relazione è scritto che non avrebbe chiesto aiuto
per sé e per la sua scorta ma per il suo ufficio. Ma oramai sappiamo che Moro
era preoccupato per sé e non per le sue carte. Come confermato da altri dati:
per esempio abbiamo appreso che in quei giorni il maresciallo Leonardi chiese
improvvisamente più caricatori e altri particolari emergeranno prossimamente». A
conferma dei timori di Moro, c'è anche la decisione del leader Dc di non portare
con sé quel giorno il nipotino, come invece faceva abitualmente. Le sorprese non
finiscono qui. Il 18 febbraio 1978, vale a dire 25 giorni prima dell'azione
delle Br, un agente dei Servizi segreti di stanza a Beirut spedì un cablogramma
ai superiori di Roma. Una fonte interna al Fronte per la liberazione della
Palestina gli aveva rivelato che «organizzazioni terroristiche europee si
[erano] riunite per pianificare un'operazione terroristica di notevole portata
che [avrebbe potuto] coinvolgere l’Italia». Non c'è riferimento diretto a Moro,
ma la Commissione pensa che a spedire il cablogramma sia stato Stefano
Giovannone, uomo di fiducia di Moro in Medio Oriente. In questo caso, è
presumibile che Giovannone abbia avvertito non solo i suoi superiori, ma anche
lo stesso Moro. Altri particolari riguardano la dinamica degli eventi avvenuti
la mattina del 16 marzo 1978 in via Fani. La Commissione ha scoperto ad esempio
che una delle automobili di cui per anni non si era potuta accertare la
proprietà, apparteneva in realtà a Spinella, cioè proprio il dirigente della
Digos che aveva ricevuto la richiesta di protezione da parte di Moro la sera
prima. Spinella arrivò sul luogo dell'agguato fra i primi, tanto presto che la
Commissione sospetta «una partenza anticipata». Secondo quanto dichiarato
dall'autista, la macchina partì dalla Questura alle 8:30, più di mezz'ora prima
dell'inizio dell'azione dei brigatisti, che cominciarono a sparare alle 9:03. La
Commissione pensa che Spinella fosse in preda all'ansia o al senso di colpa per
aver sottovalutato l'allarme di Moro. Il bar Olivetti, davanti al quale si
svolse l'attentato, è un'altra fonte di dettagli interessanti. Il suo
amministratore, Tullio Olivetti, era «noto agli atti della polizia di
prevenzione per essere stato coinvolto in una complessa vicenda di traffico
internazionale di armi, nonché citato in una corrispondenza con la questura di
Bologna relativa alla presenza nei giorni antecedenti la strage alla stazione
del 2 agosto 1980». «La gravità di simile omissione non risulterebbe attenuata
anche se si dovesse accertare che nessun legame esiste tra il caso Moro e il
complesso intreccio di interessi, tra intelligence, criminalità organizzata,
ambienti dell’eversione, massoneria e terrorismo internazionale che ruotava
attorno alla figura di Olivetti e alle sue frequentazioni», aggiunge la
Commissione. Un quadro che rende ancora più inquietante ciò che disse il
deputato Dc Benito Cazora: «Dalla Calabria mi hanno telefonato per informarmi
che in una foto presa sul posto quella mattina si individua un personaggio a
loro noto». Per «loro» Cazora intendeva persone affiliate alla 'ndrangheta. La
Commissione continuerà ora a lavorare anche tenendo in considerazione le
testimonianze oculari ritenute poco attendibili all'epoca, nella speranza di
riuscire a fare chiarezza su uno degli eventi più drammatici nella storia del
nostro paese.
La rivelazione. «Un mese
prima del sequestro Moro ho dato io l’allarme a Roma».
Parla Abu Sharif, l’ex portavoce del Fronte popolare: una donna misteriosa è
stata mandata dall’Italia a Beirut, scrive Davide Frattini su “Il Corriere della
Sera” del 15 maggio 2016. Di dita ne ha perse quattro dopo averle appoggiate
sulla copertina delle Memorie di Che Guevara, l’occhio destro è cristallizzato
in uno sguardo di stupore. Quel regalo del Mossad serve a Bassam Abu Sharif per
riordinare i ricordi, c’è un prima e un dopo il 25 luglio del 1972, «doveva
essere passato un anno dalla bomba, sì era la fine del 1973», mormora sotto al
gracidare elettrico dell’apparecchio acustico. A 70 anni qualche nome l’ha
dimenticato, le facce invece sono ancora lì davanti a lui, soprattutto il
sorriso di quella bella italiana che bussa al suo ufficio a Beirut e chiede di
parlare con George Habash, il leader del Fronte popolare per la liberazione
della Palestina. Finito sulla copertina di Time come il «volto del terrore»
durante i dirottamenti di Dawson’s Field, Bassam allora dirige la rivista Al
Hadaf(il Bersaglio) e si occupa della politica estera dell’Fplp. «Mi dice di
essere la moglie di un ufficiale italiano e di voler vedere il capo. Le spiego
che se l’avevano mandata per conquistare Habash con la bellezza, non avrebbe
funzionato, era un monaco. Mi ha risposto: no, sono qui perché sostengo la
vostra causa». L’«accordo» tra i palestinesi e l’Italia. La donna misteriosa si
ripresenta il giorno dopo — «da bionda era diventata castana» — e nell’incontro
chiede ad Habash dettagli sull’intesa siglata dal gruppo marxista-leninista
palestinese con l’Italia, quello che sarebbe il Lodo Moro: nel 2008 Bassam ha
già raccontato al Corriere dell’accordo che permetteva all’organizzazione di
muovere uomini e armi lungo la Penisola. In quest’altro pomeriggio nella sua
villa di Gerico, circondata dalle rocce del Monte delle tentazioni, rivela altri
dettagli. «Il presidente della Dc era in pericolo». «Non ho mai capito a quale
pezzo degli apparati appartenesse. Qualcuno a Roma voleva verificare i resoconti
di Stefano Giovannone (capocentro del Sid e poi del Sismi a Beirut, ndr):
avevamo discusso i dettagli del patto con lui e con l’Ammiraglio. La signora
voleva assicurarsi che l’avremmo rispettato, che non avremmo commesso attentati
in Italia. In cambio ci offrì perfino di inviare istruttori dell’esercito per i
nostri combattenti». Avete avvertito dell’intesa le nazioni arabe che vi
appoggiavano? «La Libia, lo Yemen, l’Iraq, l’Algeria, la Siria. Muammar Gheddafi
si mise a ridere: “Ricordate agli italiani che ci sono debitori per l’epoca
coloniale, il vostro accordo non risolve le faccende tra noi e loro”». In Italia
una commissione parlamentare sta indagando sul rapimento di Aldo Moro. È emerso
un cablogramma del 18 febbraio 1978 spedito da Beirut, molto probabilmente da
Giovannone. Scrive di aver incontrato «il suo abituale interlocutore» nel Fplp
che lo ha avvertito: gruppi europei stanno organizzando «un’operazione
terroristica di notevole portata» e potrebbe coinvolgere l’Italia. «L’allarme
riguarda Moro?». È quello che i parlamentari stanno cercando di capire. «Io
lanciai un allarme: Moro era in pericolo. Credo un mese prima del sequestro
(avvenuto il 16 marzo del 1978, ndr). In quei giorni Giovannone non era a
Beirut, incontrai un suo giovane assistente e gli riferii quel che mi aveva
raccontato una delle ragazze di Carlos. Era tedesca e aveva partecipato a una
riunione dov’era stata discussa l’idea di colpire Moro. Le feci capire che il
Fronte lo considerava un errore: Moro era contro l’egemonia americana, non
andava toccato». Avevate influenza sui gruppi europei? «Fin dal 1968 in
Giordania e poi in Libano il mio incarico è stato quello di gestire i campi di
addestramento per gli occidentali, anche italiani. Lì ho conosciuto Andreas
Baader e Ulrike Meinhoff (i fondatori della Rote Armee Fraktion, ndr). Ho
reclutato io Ilich Ramirez Sanchez e gli ho dato Carlos come nome di battaglia.
Lo Sciacallo, quello ci è diventato da solo».
Sequestro Moro, il capo
della Digos che arrivò “troppo presto” in via Fani. La Commissione vuole sentire
l’autista.
L'Alfasud di Domenico Spinella sfrecciava verso il luogo dell'agguato già prima
che il centralino della Questura ne desse la comunicazione. La vicenda ripropone
il tema degli allarmi che precedettero l'azione delle Brigate rosse. Alcuni
parlamentari chiedono l'audizione di di Emidio Biancone, al volante quella
mattina, scrive Stefania Limiti il 17 febbraio 2016 su “Il Fatto Quotidiano”. 16
marzo 1978, ore 9.02. Il centralino della Questura di Roma dà l’allarme:
“Agguato in via Fani, rapito Moro, ammazzati gli uomini della sua scorta”. Ma in
quel momento il capo della Digos della capitale, Domenico Spinella, è già
sull’Alfasud targata S88162 che lo porta a tutta velocità nel luogo
dell’agguato. E’ andata davvero così? E chi lo avvisò? Sono due pesanti
interrogativi ai quali stanno cercando di rispondere gli investigatori della
Commissione parlamentare d’inchiesta guidata da Giuseppe Fioroni. La faccenda è
piuttosto seria perché coinvolge uno degli organismi più direttamente impegnati
nelle indagini di quelle ore e dei mesi seguenti. L’ipotesi assai consistente è
che Spinella – nel frattempo deceduto – si sia precipitato sul luogo della
strage perché aveva appreso che stava per scattare l’azione. Forse sperava di
arrivare per tempo, di riuscire a bloccarla, sperava di salvare tutti,
eroicamente. Invece, arrivò comunque tardi, non deludendo solo le sue intrepide
aspettative: se davvero Spinella si mosse prima dell’allarme, c’è da pensare
che, dopo il massacro di via Fani, ogni particolare di quei primi momenti sia
stato poi coperto, tenuto segreto. Che figura avrebbe fatto la Digos di Roma
davanti a quei morti? L’autista di Spinella, Emidio Biancone, al terzo
interrogatorio cui lo hanno sottoposto i collaboratori della Commissione, ha
ammesso che partì dall’ufficio centrale alla volta di via Trionfale, e di lì
verso via Fani, subito dopo le ore 8,30. “Insisto perché questa storia sia
chiarita, chiedo l’audizione di Biancone, che venga a dire come andarono le
cose”, ha detto il senatore Federico Fornaro seguito dal collega Gero Grassi:
entrambi avevano già avuto modo nei mesi scorsi di affrontare l’argomento,
sostenendone l’assoluta rilevanza. L’audizione di Biancone potrebbe essere
dunque molto utile, anche se non è affatto detto che l’ex autista sappia
qualcosa dell’eventuale fonte della notizia di Spinella. Ma qui gli elementi
investigativi non mancano. Ne ricordiamo solo alcuni. E’ noto che prima del 16
marzo erano giunti vari segnali sull’imminenza di un sequestro di una
personalità dello Stato. Lo stesso Domenico Spinella il 22 febbraio 1979 scrisse
una relazione per il Questore di Roma spiegando che il 15 marzo 1978 l’allora
Capo della Polizia, contattato da un collaboratore di Moro, Nicola Rana, gli
disse di recarsi presso lo studio di Aldo Moro per concordare l’istituzione di
un servizio di vigilanza dell’ufficio privato del presidente Dc che si trovava
in via Savoia: fu deciso anche il giorno della sua attivazione, il 17 marzo. La
Commissione ha poi acquisito un documento del 18 febbraio proveniente da Beirut
che reca l’intestazione “Ufficio R, reparto D, 1626 segreto”, “fonte 2000”, in
base al quale il colonnello Stefano Giovannone riferiva che il suo “abituale
interlocutore rappresentante Fplp Habbash” gli aveva parlato di una operazione
terroristica di notevole portata che stava per scattare in Italia. E poi si è
tanto parlato dell’annuncio di Radio Città Futura dai cui microfoni il
direttore Renzo Rossellini parlò dell’imminente sequestro di Aldo Moro con circa
tre quarti d’ora di anticipo rispetto al verificarsi dell’evento: ma la
magistratura venne informata della vicenda solo il 27 settembre 1978, quando
essa divenne di dominio pubblico grazie al settimanale Famiglia Cristiana.
Perché la Polizia mantenne sulla vicenda della trasmissione di Radio Città
Futura un così prolungato silenzio, dal 16 marzo al 27 settembre 1978? Eppure il
vice questore Umberto Improta conosceva personalmente Rossellini: esisteva da
tempo un contatto, un “rapporto privilegiato”, secondo quanto ha riferito alla
Commissione l’allora funzionario della Digos Vittorio Fabrizio, fino a oggi mai
sentito da nessun inquirente. E poi le Radio erano attentamente monitorate: è
emersa anche l’esistenza di una struttura informale di ascolto, di cui non si è
mai saputo nulla, delle trasmissioni di Radio Città Futura e Radio Onda Rossa,
le seguitissime emittenti del movimento antagonista romano. Lo stesso questore
De Francesco era estremamente sensibile all’ascolto delle Radio, secondo la
testimonianza del funzionario Riccardo Infelisi, cugino del magistrato, sentito
della Commissione. Davvero impossibile che quella frase di Rossellini non fosse
stata raccolta da tante orecchie vigili. E una notizia del genere, ha detto
Vittorio Fabrizio, “sarebbe stata portata subito a conoscenza del dirigente
dell’ufficio politico”. Cioè Spinella, l’uomo che arrivò troppo presto in via
Fani.
RAPIMENTO DI ALDO MORO. LA
POLIZIA SAPEVA E NULLA HA FATTO.
Dodici ore prima del
rapimento, Aldo Moro chiese aiuto alla polizia,
scrive Fabio Martini su “La Stampa” ed “Il Secolo XIX il 19 gennaio 2016.Più si
scava sul caso
Moro, più
aumentano le scoperte spiazzanti, quelle capaci di riscrivere interi capitoli di
una delle storie più misteriose della Repubblica. Trentotto anni dopo il
rapimento del leader democristiano da parte delle Brigate rosse, la apposita
Commissione parlamentare di inchiesta sta svolgendo un lavoro al “ralenti” su
singoli segmenti, per ingrandire ogni dettaglio. Come dimostrano anche i tempi
di “lavorazione”: dopo un anno d’indagine sono state passate al setaccio le
prime due ore del rapimento, oltre ai tanti segnali che lo precedettero. Un
metodo pragmatico che ha consento diverse scoperte, alcune clamorose e ora
accessibili grazie ad una prima
relazione,
completata nei giorni scorsi. Scoperte favorite dal clima nel quale ha lavorato
la Commissione, «senza la volontà di riscrivere la storia, senza tesi
precostituite, senza clamori», dice il presidente Giuseppe Fioroni. E senza la
pressione di alcuni protagonisti di quella vicenda, ormai scomparsi e anche
senza i partiti allora più “implicati”: la Dc e il Pci. Uno sforzo corale, come
dimostra la prima relazione, approvata all’unanimità da un arco di forze che va
dai Cinque Stelle agli ex missini di Fratelli d’Italia. Il caso Moro, vicenda
piena di enigmi e depistaggi, lungi dall’essere compresa fino in fondo. Come
dimostra una novità: su alcuni filoni scoperti dalla Commissione si sono
riaccesi i riflettori della Procura di Roma. Da decenni l’enigma resta senza
risposte chiare: è mai possibile che non scattò nessun allarme preventivo nelle
settimane che precedettero l’assalto a Moro e alla sua scorta? La Commissione di
indagine ha compiuto diverse scoperte. La prima è un documento, rimasto
secretato per 37 anni. Il 18 febbraio 1978 (l’azione
Br scatterà 25 giorni più tardi, il 16 marzo) un agente dei Servizi di
stanza a Beirut scrive un cablogramma ai superiori di Roma, nel quale riferisce
quanto appreso da un suo «abituale interlocutore» del Fronte per la liberazione
della Palestina Habbash: «Organizzazioni terroristiche europee» si sono riunite
per pianificare «una operazione terroristica di notevole portata che potrebbe
coinvolgere» l’Italia. Scrive nel suo rapporto, la Commissione: «È evidente che
se fosse accertata una relazione con il sequestro Moro, il documento aprirebbe
prospettive allo stato imprevedibili», a partire dal fatto che occorrerebbe
«riconoscere che si era in presenza di un quadro di elevata allerta, i cui
segnali furono probabilmente percepiti dallo stesso Moro». Perché alla
Commissione ritengono che l’autore del cablogramma possa essere stato Stefano
Giovannone, l’uomo di Moro in Medio Oriente. Che evidentemente avvisò, oltre ai
superiori, il suo leader di riferimento. I superiori “sottovalutarono”. E Moro?
E qui scatta la seconda scoperta. La Commissione ha rinvenuto negli archivi
della polizia una relazione di Domenico Spinella, dirigente della Digos, nella
quale si dà conto di un incontro riservatissimo svoltosi nello
studio di Aldo Moro la sera del 15 marzo 1978 (mancano
12 ore all’azione brigatista) e in quella occasione il presidente della Dc fece
sapere di ritenere urgente l’attivazione di «un servizio di vigilanza a tutela
dell’ufficio di via Savoia». Ma la relazione del dottor Spinella al questore -
ecco un altro punto oscuro - è datata 22 febbraio 1979, ben undici mesi dopo
l’attentato, e oggi se ne capisce la ragione: è stata scritta d’urgenza,
dopo un
articolo uscito quel giorno sul Secolo XIX e
relativo a un generico timore di Moro per un attentato. Sostiene il presidente
della Commissione Fioroni: «Trentasette anni dopo abbiamo scoperto questa
relazione “post-datata”, dalla quale apprendiamo con certezza che Moro, poche
ore prima di essere colpito, aveva chiesto tutela. Nella relazione è scritto che
non avrebbe chiesto aiuto per sé e per la sua scorta ma per il suo ufficio. Ma
oramai sappiamo che Moro era preoccupato per sé e non per le sue carte. Come
confermato da altri dati: per esempio abbiamo appreso che in quei giorni il
maresciallo Leonardi chiese improvvisamente più caricatori e altri particolari
emergeranno prossimamente». Per esempio che la mattina del 16 marzo Aldo Moro
non volle portare con sé il nipotino, come faceva quasi sempre? La Commissione
ha scoperto che un’Alfasud
presente in via Fani dopo
l’attentato e della quale per decenni non si era individuata la proprietà,
apparteneva allo stesso dirigente della Digos che il giorno prima aveva raccolto
l’allarme di Moro. La Commissione ha scoperto che la mattina del 16 marzo il
dottor Spinella fu tra i primi ad arrivare in via Fani. Ma con qualche
probabilità (anche se non con certezza), l’arrivo tempestivo sulla scena
dell’attentato è determinato da quella che viene definita «una partenza
“anticipata”». L’attentato scatta in via Fani alle 9,03, ma come ha raccontato
alla Commissione Emilio Biancone, che allora svolgeva il compito di autista, l’Alfasud
della Digos parte dalla Questura alle 8,30,
più di mezzora prima dell’assalto brigatista. Perché tanto presto? Ansia? Senso
di colpa? Consapevolezza di una sottovalutazione? Le indagini della Commissione
hanno scoperto che il bar Olivetti, davanti al quale si svolse l’assalto a Moro,
era un luogo ricco di “ambiguità”. Scrive la Commissione: «Suscita sconcerto la
totale assenza di indagini
sul bar e sul suo amministratore Tullio Olivetti»,
«noto agli atti della polizia di prevenzione per essere stato coinvolto in una
complessa vicenda di traffico internazionale di armi», «nonché citato in una
corrispondenza con la questura di Bologna relativa alla presenza nei giorni
antecedenti la strage alla stazione del 2 agosto 1980». E «la gravità di simile
omissione non risulterebbe attenuata anche se si dovesse accertare che nessun
legame esiste tra il caso Moro e il complesso intreccio di interessi, tra
intelligence, criminalità organizzata, ambienti dell’eversione, massoneria e terrorismo
internazionale
che ruotava attorno alla figura di Olivetti e alle sue frequentazioni». Alla
luce di questo quadro assume una luce diversa quanto disse al telefono, il primo
maggio 1978, il deputato dc Benito Cazora: «Dalla Calabria mi hanno telefonato
per informarmi che in una foto presa sul posto quella mattina, si individua un
personaggio a loro noto». E «loro» sarebbero personaggi legati alla ’ndrangheta.
E sarebbero state preziose per gli inquirenti anche tutte
le foto che furono scattate sul
luogo dell’attacco, ma la Commissione denuncia che diversi rullini «sono
scomparsi». In particolare quello consegnato ad uno dei magistrati inquirenti,
che secondo una testimone tagliò cinque negativi e restituì il resto, senza
«redarre verbale».
E ancora: «Numerosi testimoni oculari sono stati del tutto ignorati dagli
inquirenti dell’epoca e le loro dichiarazioni sono state messe a verbale per la
prima volta dalla Commissione».
ALDO MORO ED IL
COMPLOTTISMO.
I documenti UK che fanno
gelare il sangue: da Enrico Mattei ad Aldo Moro,
scrive il 12 novembre 2015 Claudio Messora su Bioblu. Ho intervistato Giovanni
Fasanella, giornalista che da anni scava in quella storia italiana che nessuno
vi racconta, autore di oltre 21 libri. Insieme a Mario José Cereghino ha scritto
“Colonia Italia. Giornali, radio e tv: così gli inglesi ci controllano. Le prove
nei documenti top secret di Londra”.
Sono cose che dobbiamo
sapere.
«Quando
si pensa alle ingerenze dall’estero nei confronti del nostro Paese si pensa
sempre agli Stati Uniti d’America. Basta aprire una cartina geografica e vedere
dov’è l’Inghilterra, un’isola del Nord Europa, dove sono stati per molti decenni
– a ancora oggi – i suoi interessi economici, strategici, militari. In Nord
Africa, nel Medio Oriente e in Estremo Oriente. E cosa c’è tra la Gran Bretagna
e i suoi interessi? C’è il Mediterraneo e, al centro del Mediterraneo, l’Italia.
Quindi già dai tempi del Risorgimento, l’Italia per la Gran Bretagna era una
postazione di fondamentale importanza, attraverso la quale poteva controllare i
suoi domini e le sue rotte marittime.
Che cosa succede dalla
seconda guerra mondiale in poi?
«L’Italia
perde la guerra e, tra Gran Bretagna e Stati Uniti, c’è una visione molto
conflittuale sul problema Italia: per gli Stati Uniti noi eravamo un paese
cobelligerante, cioè che si era autoliberato dal nazifascismo combattendo al
fianco degli alleati. Per la Gran Bretagna invece noi eravamo un paese sconfitto
tout-court. Punto e basta. Quindi un paese soggetto ai vincoli, imposti
attraverso trattati internazionali, dalle potenze vincitrici alle nazioni
sconfitte. Questo ha determinato il corso degli eventi della storia successiva,
praticamente fino ai giorni nostri. Al tavolo della pace, quando le grandi
potenze vincitrici cominciarono a spartirsi il mondo in aree di influenza,
all’interno del campo atlantico la Gran Bretagna pretese e ottenne, dagli Stati
Uniti e dall’Unione Sovietica, una sorta di diritto di supervisione
sull’Italia. Quindi l’Italia, dalla seconda guerra mondiale in poi, è paese che
appartiene all’area di influenza britannica.
Questa influenza come si è
esplicata?
«C’è
una differenza importante tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Gli Stati
Uniti hanno combattuto anche in Italia una guerra contro il comunismo. La Gran
Bretagna non ha combattuto solo quella, ma anche una guerra contro l’Italia, in
modo particolare contro quella parte della classe dirigente italiana del secondo
dopoguerra – penso ai De Gasperi, ai Mattei, ai Fanfani, ai Vanoni fino agli
Aldo Moro – sovranista, cioè che pur nel contesto di un’alleanza internazionale,
l’alleanza atlantica, si muoveva con una propria visione sulla base di un
proprio interesse nazionale. Era l’Italia del dopoguerra, uscita a pezzi, che
però voleva crescere, riprendersi, ricostruire le proprie istituzioni, il
proprio sistema economico e per poterlo fare aveva bisogno di quella materia
prima che è il sangue, l’ossigeno per ogni sistema, e cioè il petrolio,
l’energia. Questo è stato all’origine di un conflitto con la Gran Bretagna che
dura ancora oggi.
Facciamo dei nomi: Enrico
Mattei…
«La Gran
Bretagna, che ha esercitato un controllo pressoché assoluto sul nostro sistema
di informazione, ha usato la stampa, i giornali, gli opinion leader, gli
intellettuali per orientare l’opinione pubblica e tentare di condizionare le
scelte politiche dei partiti e dei governi. Una di queste grandi scelte su cui
la Gran Bretagna ha tentato di condizionarci è stata la politica mediterranea,
la politica energetica, petrolifera dell’Italia. De Gasperi, Presidente del
Consiglio nel 1953, aveva il mandato britannico di sciogliere l’AGIP. Mattei,
nel 1953, era stato messo alla presidenza dell’Agip per scioglierla. E invece di
sciogliere l’AGIP lui fondò l’ENI, grazie anche a un decreto di De Gasperi. E
dopo aver fondato l’ENI, Mattei cominciò ad attuare una propria politica. Non
era accettata l’Italia di Mattei, dell’ENI, al tavolo delle grandi compagnie
internazionali, in modo particolare di quelle britanniche, con pari dignità. Era
ammessa a sedersi, tutt’al più, su uno strapuntino, ma Mattei e l’Italia di
quegli anni non volevano assolutamente dipendere dal punto di vista energetico
dalla Gran Bretagna. Per cui cercarono autonomamente le fonti di
approvvigionamento, offrendo ai paesi produttori di petrolio, che erano quasi
tutti controllati dalle compagnie britanniche, condizioni più favorevoli. C’era
la famosa regola del fifty-fifty: 50% ai produttori, 50% alle compagnie
petrolifere straniere. Questa era una regola imposta dalle sette sorelle. Mattei
cambiò le regole dello scambio, proponendo il 25% alle compagnie e il 75% ai
produttori: i paesi produttori trovarono più conveniente fare affari con
l’Italia che non con la Gran Bretagna. Questo disturbò parecchio gli inglesi. La
rivelazione di questo libro è l’esistenza di una vera e propria macchina della
propaganda occulta britannica. E questa macchina venne scagliata contro De
Gasperi e contro il suo erede politico Attilio Piccioni, attraverso la macchina
del fango. De Gasperi venne coinvolto in uno scandalo, il famoso scandalo
Guareschi – De Gasperi delle lettere che poi risultarono false, fabbricate dalla
propaganda occulta inglese, e Piccioni venne coinvolto in un altro scandalo,
quello famosissimo di Wilma Montesi, la ragazza trovata morta su una spiaggia di
Tor Vaianica. Il figlio, Piero Piccioni, venne coinvolto in quello scandalo e il
padre, Ministro degli Esteri, sodale di De Gasperi e protettore di Enrico
Mattei, venne travolto da quell’ondata di fango. E poi lo scandalo si rivelò
infondato, perché le responsabilità del figlio di Piccioni non erano quelle
che la campagna ispirata dalla macchina occulta britannica gli aveva attribuito,
tant’è che Piero Piccioni qualche anno dopo fu prosciolto, risultò innocente.
Questo è solo un esempio di come la Gran Bretagna è intervenuta pesantemente
nelle nostre vicende interne, e adesso ho citato due episodi che sono collegati
alla guerra specifica energetico-petrolifera. L’Iran di Mohammad Mosaddegh,
primo ministro iraniano, aveva nazionalizzato il petrolio britannico. La Gran
Bretagna reagì imponendo l’embargo e l’Italia dell’ENI e di De Gasperi violarono
quell’embargo. Winston Churchill, allora premier britannico – nel libro ci sono
dei documenti desecretati inglesi – ordinò ai suoi apparati di dare una lezione
agli italiani, perché avevano osato violare l’embargo imposto dagli inglesi
contro l’Iran.
E quindi, la morte di
Mattei?
«Sono
emersi nuovi documenti sulla guerra scatenata dalla macchina della propaganda
occulta contro Enrico Mattei. Mattei, attraverso la sua politica, emarginò
progressivamente le compagnie che curavano gli interessi britannici, in aree che
gli inglesi consideravano, per importanza – sto citando testualmente un
documento -, seconde soltanto alla Gran Bretagna stessa. Aree come la Libia,
come l’Egitto, come l’Iran, come l’Iraq che per gli inglesi erano di vitale
importanza. Mattei andò a ficcare il naso, con la sua politica, in queste zone,
disturbando, anzi emarginando addirittura nel corso degli anni la presenza
britannica. In questi documenti Mattei venne definito dagli inglesi – cito
testualmente – “un pericolo mortale per gli interessi britannici nel mondo”. E
c’è un altro documento che fa venire la pelle d’oca. E’ del 1962. Gli inglesi
dicono: “[Mattei] è una verruca, è un’escrescenza da rimuovere in ogni modo.
Abbiamo tentato di fermarlo in tutti i modi e non ci siamo riusciti: forse è
giunto il momento di passare la pratica alla nostra intelligence”. Sei mesi dopo
Enrico Mattei morì in un incidente aereo che oggi sappiamo con certezza, anche
sul piano giudiziario, essere stato causato da un atto di sabotaggio.
E Aldo Moro?
«La
vicenda di Aldo Moro si colloca esattamente nello stesso contesto della vicenda
di Enrico Mattei. Aldo Moro è stato l’erede della politica mediterranea di
Enrico Mattei. Tra il 1969 e il 1975, Aldo Moro è stato l’ispiratore della
politica estera italiana. Era Ministro degli Esteri in diversi Governi, e riuscì
a mettere a segno ulteriori colpi contro gli interessi inglesi. Certo, non è che
gli italiani scherzassero, a loro volta. In Libia nel 1969, con Moro ministro
degli esteri, ci fu un colpo di stato che rovesciò la monarchia filo britannica
e portò al potere il colonnello Muammar Gaddafi, addestrato nelle accademie
militari italiane. E’ vero che Gheddafi cacciò via gli italiani, ma subito dopo
nazionalizzò il petrolio che era controllato dalle compagnie britanniche,
espulse dalla Libia le basi militari britanniche e iniziò un rapporto
privilegiato con gli italiani, grazie al quale l’Italia conobbe un periodo di
grande benessere economico. E poi, negli anni successivi, ci furono altri colpi
messi a segno, come in Iraq, dove il regime nazionalista aveva espropriato,
nazionalizzato il petrolio controllato dalle compagnie britanniche e l’ENI era
riuscita a penetrare anche lì, grazie ovviamente ai successori della politica
energetica di Mattei, ma soprattutto grazie alla politica estera di Aldo
Moro. Tra i documenti di “Colonia Italia”, ce n’è uno che veramente fa venire i
brividi, riportato con tutti i suoi riferimenti archivistici, per cui chiunque
voglia andare a controllare può farlo. Nel gennaio del 1969 il responsabile
della macchina della propaganda occulta a Roma dice: “Attraverso la macchina
della propaganda occulta non abbiamo ottenuto grandi risultati contro questa
classe dirigente italiana”. Quindi invita il suo Governo: “Dobbiamo adottare
altri metodi”. Quali metodi? Questa parte del documento è oscurata ancora
oggi. E’ ancora oggi coperta dal segreto. Io chiedo continuamente agli
opinionisti, ai direttori dei giornali, alla stampa: “Ma perché non chiedete al
Governo britannico la desecretazione di quella parte del documento in cui sono
spiegati gli altri metodi da utilizzare contro l’Italia a partire dal 1969?”.
Nel 1969 ci fu la strage di piazza Fontana e iniziò una stagione di sangue, lo
stragismo, il terrorismo, che toccò il suo punto più alto con il sequestro e
l’assassinio di Aldo Moro. E anche qui c’è da dire qualcosa a proposito
dell’intervento britannico. Nel 1976 – questo è provato, perché lo dicono gli
stessi documenti inglesi desecretati e conservati nell’archivio di Stato di Kew
Gardens, a disposizione di tutti – ci fu un tentativo di colpo di stato
organizzato o progettato dagli inglesi nei primi sei mesi del 1976 per bloccare
la politica di Aldo Moro. Quel progetto venne sottoposto all’attenzione degli
alleati francesi, tedeschi e americani. I francesi aderirono immediatamente,
perché l’Italia era un concorrente temibile anche per i francesi, non solo per
gli inglesi, mentre americani e tedeschi si mostrarono mostro più scettici, e
dissero agli inglesi: “Ma voi siete pazzi! Un colpo di stato in Italia, a parte
i contraccolpi negativi nell’opinione pubblica per l’alleanza atlantica, ma poi
c’è una sinistra forte, c’è una organizzazione sindacale molto radicata, cioè ci
sarebbe una reazione e quindi un bagno di sangue!”. Gli inglesi allora misero da
parte il progetto di un colpo di stato vero e proprio, classico. Però c’è un
altro documento, pubblicato nel libro. Scrivono: “Visto che non è possibile
attuare un colpo di stato militare classico, per l’opposizione di Germania, e
Stati Uniti d’America, passiamo al piano B”. Qual era questo piano B? Purtroppo
anche in questo caso, come nel documento che ho citato prima, c’è soltanto il
titolo. E il titolo è agghiacciante. Testualmente: “Appoggio a una diversa
azione sovversiva per bloccare Aldo Moro”. Quale poteva essere questa azione
sovversiva, naturalmente io non lo so, perché anche questa parte del documento è
ancora oggi secretata, protetta dal segreto. A suo tempo venne oscurata persino
agli americani e ai tedeschi. E anche in questo caso non mi trattengo dal
chiedere agli opinionisti italiani, alla stampa italiana: “Siamo in un paese in
cui rivendichiamo tutti i giorni verità e giustizia, beh: quando ci troviamo di
fronte a documenti di questo tipo, ma che ci vuole a chiedere agli inglesi di
desecretare anche questo documento per capire quale poteva essere la diversa
azione sovversiva contro Moro?”. Magari non c’entra nulla con il sequestro e
l’assassinio di Aldo Moro, le cui responsabilità ovviamente ricadono sulle
brigate rosse italiane. Magari, attraverso la desecretazione di quel documento,
scopriamo che la diversa azione sovversiva con cui gli inglesi volevano bloccare
Aldo Moro era una scampagnata soltanto una scampagnata della regina Elisabetta
in Italia. Ci sono due documenti drammatici, che segnano due fasi drammatiche
della nostra storia: Piazza Fontana e l’assassinio di Aldo Moro. Entrambi questi
documenti sono incompleti. Sono ancora oggi secretati. E visto che la Gran
Bretagna è un paese nostro amico, addirittura nostro alleato, sarebbe utile per
noi sapere se questo paese amico ha avuto un qualche ruolo, oppure no, nella
strage di Piazza Fontana e nell’assassinio di Aldo Moro.
La manipolazione
dell’opinione pubblica italiana da parte della Gran Bretagna è ancora in essere,
oppure nel tempo si è attenuato?
«Allo
stato delle nostre ricerche, che ovviamente continuano – non posso fare
riferimenti precisi, per il momento, a documenti sui quali stiamo ancora
lavorando -, sulla base di quello che abbiamo letto e pubblicato finora, ho
ragione di ritenere che oggi il controllo britannico sul nostro Paese sia ancora
più forte di prima.
ALDO MORO TRA BUFALE E
DEPISTAGGI.
Ferdinando Imposimato:
"Aldo Moro ucciso dalle Br per volere di Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e
Nicola Lettieri",
scrive L'Huffington Post il 10 luglio 2013. "L'uccisione di Moro è avvenuta per
mano delle Brigate Rosse, ma anche e soprattutto per il volere di Giulio
Andreotti, Francesco Cossiga e del sottosegretario Nicola Lettieri". Ferdinando
Imposimato, al tempo giudice istruttore della vicenda del sequestro e
dell'uccisione di Moro, interviene sul Caso Moro. E lo fa da Reggio Calabria,
sul palco della rassegna Tabularasa dell'associazione Urba/Strill.it. "Se non mi
fossero stati nascosti alcuni documenti - ha aggiunto - li avrei incriminati per
concorso in associazione per il fatto. I servizi segreti avevano scoperto dove
le Br lo nascondevano, così come i carabinieri. Il generale Dalla Chiesa avrebbe
voluto intervenire con i suoi uomini e la Polizia per liberarlo in tutta
sicurezza, ma due giorni prima dell'uccisione ricevettero l'ordine di
abbandonare il luogo attiguo a quello della prigionia". "Quei politici - ha
detto Imposimato - sono responsabili anche delle stragi: da Piazza Fontana a
quelle di Via D'Amelio. Lo specchietto per le allodole si chiama Gladio. A
Falcone e Borsellino rimprovero soltanto di non aver detto quanto sapevano,
perché avevano capito e intuito tutto, tacendo per rispetto delle istituzioni.
Per ucciderli Cosa Nostra ha eseguito il volere della Falange Armata, una
frangia dei servizi segreti". Lo stesso Imposimato all'inizio di giugno ha
presentato un esposto alla Procura di Roma. Secondo il giudice le forze
dell'ordine sapevano dov'era la prigione di Moro. Così i magistrati di Roma
hanno aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati aperto per valutare
se esistano nuovi indizi per riaprire le indagini sulla morte di Aldo Moro.
"Massima fiducia nella volontà dei giudici di accertare la verità sulla morte di
Moro". Nel testo le rivelazioni di 4 appartenenti a forze dell'ordine e armate
secondo cui il covo Br di via Montalcini fu monitorato per settimane. Ma non è
l'unica indagine che "riapre" il Caso Moro. Le dichiarazioni di Imposimato
arrivano dopo che la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo
alle dichiarazioni di due artificieri che spostano alle 11 l'ora del
ritrovamento della Renault 4 con il cadavere di Aldo Moro e la presenza
dell'allora ministro degli Interni, Francesco Cossiga, in via Caetani. Già,
perché Vitantonio Raso e il suo collega Giovanni Circhetta non sono mai stati
interrogati. E nei giorni scorsi hanno deciso di raccontare la propria verità.
Gli antisabotatori, che per primi arrivarono all'R4 rossa, con il corpo di Moro
nel bagagliaio, in via Caetani, il 9 di maggio di 35 anni fa, spostano l'ora del
ritrovamento dell'auto e del cadavere dello statista a prima delle 11, mentre
era delle 12.30 la famosa telefonata delle Br che annunciava l'uccisione di Moro
ed il luogo dove trovarne il corpo.
Caso Moro, spunta audio
inedito,
scrive Francesco Saita su "L'ADNKronos" del 30/09/2015. "Attenzione, messaggio
numero 13 delle Brigate Rosse, Aldo Moro è stato giudicato dal tribunale del
Popolo, questa mattina alle ore 12 è stato giustiziato, potete trovare il suo
corpo attorno al forte di San Martino. Fine messaggio". E' questo il testo
dell'audio che il Ris ha recuperato da uno dei nastri rinvenuti nel covo
brigatista di viale Giulio Cesare, a Roma, dove furono arrestati Valerio Morucci
e Adriana Faranda, nel maggio del 1979. Nell'audio un presunto brigatista sembra
fare le prove della telefonata di rivendicazione dell'omicidio di Moro, che
nella realtà, venne fatta da Valerio Morucci il 9 maggio del 1978, indicando in
Via Caetani, il luogo dove era stato abbandonato il corpo di Moro. Nell'audio,
su cui hanno lavorato i carabinieri su incarico della Commissione parlamentare
di inchiesta sull'omicidio di Aldo Moro, la voce maschile che registra il
comunicato "numero 13", dice che il corpo dello statista Dc si trova nella zona
del Forte San Martino, riferendosi probabilmente all'omonimo quartiere di
Genova. Il Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri ha consegnato
alla Commissione di inchiesta sull'omicidio di Aldo Moro oggi i risultati delle
ricerche fatte con le nuove metodologie, che - come dichiarato dal comandante
dei Ris di Roma Luigi Ripani - "ha riguardato 1115 reperti provenienti da
diversi covi romani delle Br, da quello di Via Gradoli a quello di via Ugo
Pesci, a quello di Viale Giulio Cesare". L'audio con la rivendicazione
recuperata dai Ris, della durata di 38 secondi, è ascoltabile in esclusiva sul
sito dell'Adnkronos. Dai reperti analizzati da Ris, provenienti dal covo
brigatista di Via Gradoli, dove si nascondevano Mario Moretti e Barbara
Balzarani, non è emerso Dna compatibile con quello di Aldo Moro, ha rivelato il
colonnello Luigi Ripani, comandante del Ris di Roma. Secondo Ripani
"confrontando i profili con quello dell'onorevole è emerso che sono diversi".
"Questi profili ignoti potranno essere eventualmente confrontati con persone
sospettate per vedere a chi appartengono", ha detto riferendosi ad eventuali
riscontri possibili con i brigatisti che hanno partecipato al sequestro e
all'omicidio di Moro. "Abbiamo trovato due profili maschili - ha spiegato ancora
il capo romano del Ris - ignoto A e Ignoto C e due profili femminili, Ignoto B e
Ignoto D. tutto relativo a materiale "isolato, tra l'altro, su due spazzolini,
su un rasoio, su alcune paia di scarpe e su una pinzetta. Si tratta, per la
quasi totalità, di dna "da contatto", depositato dal sudore". Da esami emerge
che Moro non morì subito: "Sugli indumenti indossati da Moro quando fu ritrovato
cadavere - ha detto Ripani, parlando dei risultati degli esami sulla canottiera,
sulla camicia e sul cappotto dello statista Dc - è stato cercato dna di altre
persone, come accade di solito in questi casi". Inoltre "sul bavero sinistro
della giacca dell'onorevole Moro erano presenti delle macchie biancastre. Dagli
accertamenti fatti è emerso che si trattava di saliva, compatibile con la
posizione in cui è stato trovato il cadavere dell'onorevole e con la circostanza
che la morte non sia arrivata nell'immediatezza".
MORO PER SEMPRE - CHI HA
MANOVRATO LA FONTE TAROCCA DI IMPOSIMATO AL DILETTO SCOPO DI SPUTTANARE COSSIGA
E ANDREOTTI?
Nel 2008 l’ex brigadiere delle
Fiamme gialle Giovanni Ladu raccontò che le forze dell’ordine, vicine alla
liberazione di Moro, furono “fermate” - Ora si scopre che Oscar Puddu, “nuova”
fonte di Imposimato, in realtà è lo stesso Ladu - E la pista si sgonfia…, scrive
Giovanni Bianconi per il "Corriere della Sera" del 6 novembre 2013. Tra i
misteri veri e presunti sul «caso Moro» che hanno suggerito addirittura
l'istituzione di una nuova commissione parlamentare d'inchiesta, ce n'è almeno
uno che rischia di evaporare anzitempo. È quello intorno alla prigione del
presidente democristiano messa sotto sorveglianza da non meglio identificati
servizi segreti italiani e stranieri, che controllavano i terroristi ed erano
pronti a liberare l'ostaggio ma inspiegabilmente furono rimandati a casa l'8
maggio 1978, alla vigilia dell'omicidio. La Procura di Roma, che in passato
s'era limitata a chiedere l'archiviazione delle indagini aperte su queste
«rivelazioni», ora cambia strategia per provare a scoprire che cosa c'è dietro:
l'ex sottufficiale della Guardia di finanza da cui tutto è scaturito è indagato
per calunnia, accusato di aver «falsamente incolpato, pur sapendoli innocenti, i
vertici istituzionali e militari nonché le autorità di polizia giudiziaria
dell'epoca», di conoscere il luogo dove Moro era segregato ma di non essere
voluti intervenire, lasciandolo uccidere. La storia risale al racconto dell'ex
brigadiere delle Fiamme gialle Giovanni Ladu, il quale nel 2008 raccontò che
trent'anni prima, in pieno sequestro del leader dc, lui appena ventunenne fu
spedito a Roma per una missione segretissima: il controllo di un appartamento
alla periferia di Roma, con tanto di telecamere e microspie, che in seguito si
rivelò la «prigione del popolo» in cui le Br tenevano rinchiuso Aldo Moro. Ma la
liberazione sfumò perché il giorno prima dell'esecuzione della condanna a morte,
tutti i militari e agenti segreti impegnati ricevettero l'ordine di abbandonare
il lavoro e rientrare alle rispettive basi. Le dichiarazioni di Ladu,
sottoscritte in alcuni verbali giudiziari, finirono pure in un libro dell'ex
giudice istruttore Ferdinando Imposimato, finché nel 2011 il pubblico ministero
Pietro Saviotti chiese e ottenne l'archiviazione del fascicolo poiché «ogni
tentativo di dare un contorno di attendibilità all'allarmante versione del
dichiarante ha dato esito univocamente negativo, senza che sia emersa alcuna pur
frammentaria conferma di una missione per liberare l'onorevole Aldo Moro
deliberatamente annullata». Un falso mistero, insomma. O quantomeno
indimostrato. Quest'anno però un nuovo volume firmato da Imposimato - che come
avvocato rappresenta Maria Fida Moro, primogenita dello statista assassinato
dalle Br, e in questa veste ha sollecitato gli inquirenti a riaprire l'indagine
- ha rilanciato la questione. Nei 55 giorni che hanno cambiato l'Italia, libro
che ha scalato le classifiche delle vendite ed è uno degli elementi che hanno
convinto decine di deputati di tutti gli schieramenti a proporre una nuova
commissione d'inchiesta, l'ex magistrato torna su quella storia grazie a
un'ulteriore testimonianza: un ex appartenente a Gladio, tale Oscar Puddu, che
ribadisce i particolari svelati da Ladu e ne aggiunge altri, conditi con nomi
altisonanti di politici e generali. Da Andreotti a Cossiga, passando per
sottosegretari e leader di partito come Zaccagnini e Donat Cattin; e poi i
vertici del servizio segreto militare, da Maletti a Musumeci e Santovito.
Aggiungendo particolari che sovrappongono mistero a mistero, fino a segnalare
che l'esplosivo utilizzato per le stragi mafiose del 1992 proveniva da un
arsenale clandestino di Gladio. Per l'autore del libro è la riprova della tesi
precedente: Aldo Moro «doveva morire». E nella prefazione a I 55 giorni il
giudice Antonio Esposito (divenuto famoso in estate per aver presieduto il
collegio della Cassazione che ha reso definitiva la condanna di Silvio
Berlusconi per frode fiscale) avvalora le clamorose ricostruzioni che «trovano
oggi definitiva conferma e certezza» grazie alle «dirompenti dichiarazioni di
due dei numerosi militari» coinvolti nell'operazione. Uno è Ladu, l'altro il
sedicente Oscar Puddu, che attraverso quasi cento messaggi di posta elettronica
ha risposto alle domande di Imposimato (sempre negandogli un incontro)
avvalorando la «storia vera» del delitto Moro: i servizi segreti italiani e
stranieri sorvegliavano la prigione, conoscevano i brigatisti e le loro auto, ne
registrarono i colloqui, ma anziché liberare l'ostaggio smantellarono la
vigilanza e lo fecero ammazzare. Per verificare questo secondo capitolo della
storia il pubblico ministero Luca Palamara ha affidato ai carabinieri del Ros di
Roma un'ampia delega, con lo scopo di identificare il secondo «testimone». E
l'analisi tecnica dei messaggi di posta elettronica consegnati agli inquirenti
da Imposimato, attraverso le intestazioni che permettono di scoprire la
provenienza della corrispondenza inviata e ricevuta via computer, ha portato a
una clamorosa conclusione: Oscar Puddu non esiste, è solo un nome di fantasia
dietro il quale si nasconde Giovanni Ladu, il primo «testimone» che aveva visto
archiviate le sue precedenti propalazioni. L'ipotesi investigativa è che l'ex
finanziere abbia raggirato Imposimato per insistere sulle teorie rimaste senza
conferma, proponendosi come un ulteriore protagonista sotto mentite spoglie.
Resta da capire il movente dell'invenzione, se ci siano mandanti e scopi
reconditi dietro il falso mistero. È ciò che si cercherà di capire nel seguito
dell'indagine. A cominciare dall'analisi dei documenti e del materiale
informatico sequestrato ieri nella perquisizione a casa di Ladu.
Aldo Moro, don Mennini:
“Mai entrato in prigione Br. Ma confessione è segreta”.
Audizione in Commissione parlamentare per il sacerdote che, secondo Cossiga,
visitò lo statista sequestrato prima che fosse ucciso dalla Br. L'attuale nunzio
apostolico in Regno Unito smentisce, ma ricorda che la riservatezza intorno al
sacramento non può essere messa in discussione neppure dal Papa. Grassi (Pd):
"Non mi convince", scrive "Il Fatto Quotidiano" del 9 marzo 2015. Non ha
confessato Aldo Moro. E non gli ha mai fatto avere documenti e oggetti nel
“carcere” delle Br. Così l’Arcivescovo Antonio Mennini, nunzio apostolico del
Regno Unito, che a quanto scrisse Cossiga visitò lo statista sequestrato prima
che fosse ucciso dalla Brigate rosse, ha testimoniato oggi di fronte alla
Commissione parlamentare d’inchiesta. Ma il sacerdote ricorda anche che le
circostanze e i luoghi della confessione sono coperti “dalla legge divina” su
cui nessuno può intervenire, nemmeno il Papa. È stato infatti proprio Papa
Francesco a prendere la decisione di far testimoniare don Mennini, scegliendo di
rompere le regole dell’immunità diplomatica di cui godono i nunzi, per
cercare dopo 37 anni di fare luce sui giorni di prigionia dello statista
democristiano rapito dalle Brigate Rosse e trovato morto il 9 maggio 1978. “Mai
confessato Aldo Moro nella prigione delle Brigate rosse”, ha affermato Mennini
di fornte ai parlamentari. “Purtroppo non ho avuto questa possibilità, ma nella
coscienza dei miei doveri sacerdotali sarei stato molto contento di farlo. Non
avrei difficoltà ad ammettere che sarei andato nel covo delle Br”. E se si fosse
presentata un’opportunità del genere, ha aggiunto, “credete che sarei andato lì
dove tenevano prigioniero Moro senza tentare di fare niente? Mi sarei offerto di
prendere il suo posto, avrei tentato di intavolare un discorso o come minimo
ricordare il tragitto fatto”. “Ma poi – ha continuato – di che si doveva
confessare il povero Moro?”. Mennini ha precisato che sulla confessione in ogni
modo “non solo non si può dire nulla sui contenuti ma neppure sulle circostanze
temporali e logistiche”, ha concluso. La figura di don Mennini è cruciale in
quanto considerata “ponte fra le Br e la Santa Sede, con l’obiettivo di salvare
il prigioniero”. L’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, ministro
dell’Interno all’epoca del rapimento Moro ha raccontato che “Don Antonello
(come molti lo chiamavano, ndr) Mennini raggiunse Aldo Moro nel covo delle
Brigate Rosse e noi non lo scoprimmo. Ci scappò don Mennini”. Ma le
dichiarazioni dell’arcivescovo non convincono Gero Grassi,
deputato Pd e vicepresidente della commissione d’indagine: “Non era quello che
mi aspettavo, non mi convince che lui non ci sia stato nel carcere brigatista”.
Non ci sono elementi per smentire la versione di Mennini ma “il percorso di
questi anni ci spingeva a pensare che ci fosse stato un canale di ritorno e che
qualcuno fosse stato da Moro. E ritenevamo fosse lui. Ora lui smentisce, dicendo
che potrebbe essere stato un altro sacerdote, amico dei brigatisti. Ne prendiamo
atto. Oggi viene fuori che è stata altra persona, la cercheremo”.
ALDO MORO, LE CARTE
SEGRETE. I DOCUMENTI ESCLUSIVI di ALBERTO CUSTODERO
su "La Repubblica" del 16
maggio 2012.
Erri de Luca, i comunisti e la
P2. Il rapimento Moro secondo i servizi segreti.
Gli 007 italiani, dieci giorni
dopo la strage di via Fani, avevano nel mirino Erri De Luca, il responsabile del
servizio d'ordine di Lotta Continua. Lo consideravano un "elemento irregolare
delle Brigate Rosse". Tirano fuori anche un elenco di esponenti del Pci,
"schedati" dal Sismi perché sarebbero andati alla scuola-Kgb di Mosca. Su Moro
fu scritto di tutto. Nulla sulla sua liberazione, solo un unico cenno alla
loggia P2.
"Il mandarino è marcio": gli
appunti dei servizi. I servizi segreti, durante il sequestro Moro, avevano
tirato fuori dai loro cassetti anche un vecchio elenco di 507 politici (quasi
tutti esponenti del Pci) che, a detta loro, avrebbero partecipato dal 48 al 73 a
corsi organizzati a Mosca dal Kgb. Nelle carte anche la lettera di Gheddafi, la
sala operatoria in via Gradoli, i sospetti su un sacerdote e le accuse alle
indagini del Pci.
In via Fani il sosia di Erri
De Luca: "elemento irregolare" delle Br. I servizi segreti, dieci giorni dopo la
strage di via Fani, avevano nel mirino Erri De Luca, il responsabile del
servizio d'ordine di Lotta Continua che loro consideravano "elemento irregolare
delle Brigate Rosse". In una velina, si legge che "una fonte aveva riferito di
avere visto subito dopo l'eccidio, in via Mario Fani, un suo sosia".
I servizi segreti citano la
loggia segreta P2 di Licio Gelli - nonostante le sue oscure trame golpiste ed
eversive fossero ben conosciute molto prima del sequestro Moro - solo sei giorni
dopo l'uccisione dello statista. Non come oggetto di una loro indagine,
s'intende, o come l'imbeccata di una loro "fonte". Bensì riportando, in un
appunto del 15 maggio, i malumori dei vertici del partito comunista, in
particolare di Emanuele Macaluso, a proposito della conduzione delle indagini.
"Secondo i responsabili del Pci - annotavano gli 007 - dietro il rapimento Moro
si nasconde una trama ordita, fra l'altro, dai massoni della P2".
I servizi segreti, 10 giorni
dopo la strage di via Fani, avevano nel mirino Erri De Luca, oggi scrittore
all'epoca responsabile del servizo d'ordine di Lotta Continua. Lo consideravano
"elemento irregolare delle Brigate Rosse": in una velina, si legge che "una
fonte aveva riferito di avere visto subito dopo l'eccidio, in via Mario Fani, un
suo sosia". I servizi segreti riferivano poi che le bierre volevano costruire
una sala operatoria in via Gradoli: durante la perquisizione del 18 aprile 1978,
in quel covo brigatista furono sequestrati i progetti per la realizzazione della
struttura di emergenza sanitaria. I servizi segreti, durante il sequestro Moro,
avevano tirato fuori dai loro cassetti un vecchio elenco di 507 politici (quasi
tutti esponenti del Pci) che, a detta loro, avrebbero partecipato dal 48 al 73 a
corsi organizzati a Mosca dal Kgb. Oppure in Cecoslovacchia dai servizi cechi.
Oppure a Cuba o in Albania. Fra chi avrebbe frequentato la scuola-Kgb di Mosca,
(stando al Sismi), anche Claudio Petruccioli, Pio La Torre e Luigi Longo,
segretario del Pci dalla morte di Togliatti nel 1964 al 1972, quando sarà
sostituito da Berlinguer. Ma perché durante il sequestro Moro riesumare quel
vecchio brogliaccio, peraltro poco realistico? Roma, Archivio centrale dello
Stato, primo piano, sala consultazioni. Dopo due mesi di attesa per ottenere dal
ministero dell'Interno la necessaria e indispensabile autorizzazione, finalmente
le carte dei servizi segreti relative al sequestro Moro, rese pubbliche per
volontà dell'ex capo del Dis Gianni De Gennaro, dell'ex sottosegretario di Stato
Gianni Letta, e del presidente del Copasir Massimo D'Alema, sono finalmente
accessibili a un ristretto pubblico di studiosi. Finora i permessi accordati
sono 5. Uno di questi, al cronista di Repubblica, un altro al giornalista
inglese Philip Willam autore di un libro sulla morte di Calvi. Decine di faldoni
di documenti, migliaia di pagine, sono contenuti in un Dvd consultabile solo su
un solo computer dell'Archivio appositamente dotato di un programma in grado di
decriptarne il codice di lettura riservato. La consultazione appare subito
complicata e laboriosa. Un esempio. Dopo aver digitato il nome in codice e una
password segreta, si clicca "esplora dvd", e si apre l'indice dal codice
numerico 73-2-50-6-180. Si ri-clicca, e si presentano dunque due cartelle. In
quella di destra c'è il materiale dei 55 giorni del sequestro. A questo punto si
decide di studiare il fascicolo 16 che contiene al suo interno un centinaio di
documenti pdf. Li si apre uno ad uno, e, dopo qualche ora di ricerca, si fissa
l'attenzione sui numeri 1017, 1018, 1019 e 1020. Si pigia il tasto stampa e poi
si torna indietro e si ricomincia da capo. Ore e ore, giorni e giorni di
paziente e certosino lavoro. Ma se uno avesse il retropensiero di trovare là
documenti che rispondano finalmente, a 34 anni dal sequestro, ai numerosi
interrogativi rimasti tuttora senza risposta, ben presto si rende conto che in
quella mole di carte l'unica cosa che si scopre con certezza, è la confusione
che regnava sovrana nei giorni del sequestro all'interno della nostra
intelligence. Confusione voluta o meno, non è dato sapere. Ma confusione. Se uno
si aspettava di trovare la carta a dimostrazione del sospetto che le bierre
fossero eterodirette dai servizi segreti deviati nostrani, o sovietici o financo
filopiduisti argentini. Oppure la prova regina per dimostrare la presenza di
infiltrati della Cia o del Mossad. Insomma, se uno si aspettava di trovare lo
zampino, la manina o la manona di qualche Gladio, o la prova di una fronda
fratricida democristiana, sarebbe ben presto rimasto deluso. Gli 007, in pieno
sequestro rispolverano un documento datato cinque anni prima coi nomi di
politici della sinistra che avrebbero partecipato a corsi "con denominazioni
ufficiali dei copertura" organizzati nei Paesi dell'Est dal Kgb. "Scopo" di quei
corsi, "specializzazione politica" e "istruzioni di carattere militare". Erano
quasi tutti esponenti del Pci quelli "schedati" dal Sismi che risultavano
essersi in effetti recati in Unione Sovietica, ma non certo per seguire lezioni
dai potenti servizi segreti sovietici. Ma che c'entravano Pio La Torre o Luigi
Longo o Petruccioli coi sequestratori di Moro? Va detto che in una parte
dell'intelligence era in voga una corrente di pensiero (ben tratteggiata in un
articolo di Pecorelli su OP del 17 ottobre del 1978) secondo la quale le bierre
avevano "un'unica matrice, il Pci". Le bierre, in sostanza, sarebbero "nate del
cuore di questo partito, nel cuore dei suoi rapporti con i Paesi del Patto di
Varsavia. "116 brigatisti - svelava Pecorelli su OP - iniziarono la loro milizia
nei Gap di Feltrinelli" addestrandosi in campi militari in Cecoslovacchia. Si
spiega forse così il motivo per cui il Sismi decide, a rapimento in corso, di
rimestare quelle carte ingiallite: per accreditare quell'equazione tanto cara ad
alcuni ambienti dell'intelligence anticomunista:
Br=Pci=Urss=Feltrinelli=Gap=Cecoslovacchia. Evidentemente agli 007 faceva comodo
in quel momento tirare in ballo, in qualche, i sovietici. Fra quei 507 nomi,
c'erano Pio La Torre, segretario regionale del Pci in Sicilia, protagonista
delle lotte contro l'aeroporto militare di Comiso. Lauro Casadio, ex partigiano,
segretario del Comitato regionale della Cgil e consigliere regionale in
Lombardia. Claudio Petruccioli, ex presidente del consiglio d'amministrazione
Rai, e ex segretario nazionale della Fgci. Lia Cigarini, destinata a diventare
una delle protagoniste intellettuali del movimento delle donne. Lanfranco Turci,
presidente della regione Emilia Romagna, uno dei comunisti dell'ala estrema
della corrente migliorista-riformista, poi presidente della Lega delle
cooperative. Paolo Ciofi Degli Atti, deputato esponente del Pci di Roma e suo
fratello Claudio, fisico. Dina Mascetti, (probabilmente Nascetti), attuale
presidentessa di una organizzazione di cittadini benemeriti per la tutela del
centro storico "Vivere Trastevere". Filippo Maone, giornalista de "il
manifesto". Carla Pasquinelli, femminista e antropologa. Lovrano Bisso,
presidente del Consiglio regionale Liguria e deputato. Antonio Rubbi,
responsabile Esteri del Pci con Alessandro Natta. Giovanni Cervetti, migliorista
milanese membro della segreteria con Berlinguer e responsabile organizzazione
del Pci. Rocco Curcio, deputato della Basilicata. Olivio Mancini, senatore del
Pci romano. Fosco Dinucci, uno dei fondatori del pcd'i, il Partito comunista
d'Italia filocinese (e, dunque curiosamente, antisovietico). Fra chi, sempre
secondo i nostri servizi segreti, avrebbe "partecipato in Cecoslovacchia a corsi
di attivismo politico o di addestramento al terrorismo", Rodolfo Mechini, a
lungo alla sezione Esteri del Pci (segretario Berlinguer) proprio ai tempi dalla
presa di distanza dai russi. E Renato Pollini, tesoriere Pci dall'82 al 90,
sindaco di Grosseto dal 51 al 70, senatore due volte, arrestato maggio 93 per
Tangentopoli, inquisito 8 volte, ma sempre assolto. Dopo aver rievocato gli
"allievi" del Kgb e dei servizi cecoslovacchi, la nostra intelligence passa al
setaccio la vita di Erri De Luca, considerato oltranzista e rivoluzionario,
analizzando i suoi dissidi all'interno di Lc con la linea moderata del leader
Adriano Sofri. Poi passano dalle considerazioni sui deliri di un radioamatore
austriaco che millantava di avere intercettato con le sue antenne notizie sul
sequestro. Al ruolo di mediatore con la sinistra extraparlamentare svolto da
padre Davide Turoldo, dell'ordine dei servi di Maria, esponente del clero
cattolico di sinistra. Quindi si dilungano su una fonte che li avvisa che Moro
sarebbe stato tenuto prigioniero in una cella frigorifera in un capannone alla
periferia di Roma. Catalogano gli articoli di Mino Pecorelli che su Op lancia
messaggi cifrati, e monitorano pure il settimanale satirico il Male, che aveva
pubblicato un oroscopo di Moro forse ritenuto sospetto. Registrano minacce
bierre alla Svp di Bolzano e ascoltano radio Rosa Giovanna. Quindi tengono
d'occhio i commenti sul sequestro della stampa sovietica. Annotano che a un
posto di blocco viene fermata una vettura intestata a Marco Donat Cattin e
fotocopiano la lettera che Franca Rame scrive al noto brigatista Paroli Tonino,
in carcere. Si procurano la lettera di solidarietà che Gheddafi scrive alla
moglie di Moro e stilano un elenco di latitanti brigatisti. Quindi lanciano
l'allarme su un possibile atto terroristico che potrebbe essere realizzato di lì
a poco da Marina Petrella. Prendono in considerazione le dritte di un medium e
quelle di una veggente parapsicologa olandese, e si arrovellano per decifrare
frasi misteriose intercettate come "Moro rapito, rivediamo i piani". Oppure "il
mandarino è marcio", il che sarebbe, secondo la sezione Crypto dei servizi
segreti, l'annuncio della sua imminente morte, essendo l'anagramma de "il cane
morirà domani". Riferiscono infine delle iniziative del nunzio apostolico di
Beirut e spiano discretamente il via vai di persone che frequentano la famiglia
dell'esponente Dc. Insomma, di tutto e di più su tutto e il contrario di tutto.
Ma nulla che porti alla liberazione del rapito. Da sottolineare l'assordante
silenzio sulla P2: nonostante fosse notissima prima del sequestro la sua matrice
eversiva in chiave anticomunista, i servizi segreti (diretti, manco a farlo
apposta, da piduisti) finsero di ignorarla. Limitandosi a citarla quasi di
straforo in un appunto che, all'indomani della scoperta del cadavere di Moro,
riferiva gli "errori" che, secondo il Pci, sarebbero stati compiuti durante le
indagini. "Queste forze oscure come la P2 - era la tesi dei comunisti ripresa
e riferita dagli 007 - possono anche non avere creato il terrorismo. Ma
certamente in questo momento se ne servono per i loro obiettivi, che sono
anti-Pci".
L'ANALISI di FEDERICO
IMPERATO. E' la politica che cerca di recuperare "Il sequestro Moro come l'8
settembre". Il ritrovamento del cadavere dell'onorevole Moro. Era il 9 maggio
1978. "Ad accomunare il sequestro dell'onorevole e la Resistenza è
l'inadeguatezza delle istituzioni, alla ricerca disperata di recuperare le basi
di una convivenza civile disgregata dal duro colpo sferrato al sistema politico
e istituzionale". Le carte dei servizi segreti sul "caso Moro" reperite e
analizzate da "Repubblica" confermano in pieno i giudizi storici che su quel
tragico avvenimento sono stati formulati dagli studiosi. Agostino Giovagnoli,
autore di una molto ben documentata storia politica del "caso Moro", ha proposto
un parallelismo tra la situazione politica italiana durante i 55 giorni del
sequestro dello statista pugliese e quella esistente all'indomani dell'8
settembre 1943. Ad accomunare quei due tragici momenti della storia d'Italia è
l'inadeguatezza delle istituzioni, alla ricerca disperata di recuperare le basi
di una convivenza civile disgregata dal duro colpo sferrato al sistema politico
e istituzionale. In questo senso, non stupisce l'attenzione rivolta dai servizi
segreti al PCI e a presunti corsi di politica per militanti comunisti svoltisi
in diversi Paesi dell'Est europeo e comprendenti anche esercitazioni di
carattere militare. L'immagine dell'"album di famiglia", usata da Rossana
Rossanda, per indicare una certa contiguità o derivazione politica tra le BR e
il PCI, poteva aprire un filone di indagini per i servizi segreti o gli
inquirenti, ma più per verificare se esponenti delle BR avessero in passato
usufruire di un addestramento militare all'estero che per coinvolgere esponenti
del partito comunista come Pio La Torre, Claudio Petruccioli o Luigi Longo. Il
PCI doveva respingere le insinuazioni che provenivano da questi settori
dell'estrema sinistra e, in quest'opera, Emanuele Macaluso fu uno dei dirigenti
comunisti più attivi. La critica alla DC, svolta dal partito comunista in tutto
il periodo repubblicano, non aveva mai avuto, secondo Macaluso, come obiettivo
la ricerca dello scontro frontale con il partito cattolico, mirando, invece, a
far emergere le sue contraddizioni, in modo da spingerla alla collaborazione con
le forze della sinistra, PCI compreso. Il sequestro Moro era, secondo
l'esponente comunista, un complotto di vaste dimensioni, che, oltre alla BR,
vedeva coinvolti ambienti politici e di potere reazionari, contrari all'ingresso
del PCI nel governo di solidarietà nazionale. Macaluso fa riferimento, in
particolare alla P2 di Licio Gelli, il cui ruolo nella vicenda non è mai stato
chiarito. Gli accenni al "caso Moro" contenuti nel memoriale che Gelli presentò,
nel 1984, alla commissione bicamerale d'inchiesta sulla loggia P2, dimostrano,
come ha scritto lo storico Piero Craveri, la "profonda intelligenza che egli
aveva degli avvenimenti". Rimane da chiarire, però, il ruolo che la P2 ebbe in
quei 55 giorni: se abbia fatto quasi le veci dei servizi segreti, considerato il
fatto che a capo delle strutture di intelligence e di sicurezza erano stati
posti molti uomini aderenti alla P2, o abbia avuto addirittura un ruolo di regia
occulta nella pianificazione e nella conduzione dell'"affaire Moro", grazie ai
numerosi contatti e collegamenti internazionali, dall'ovest all'est, di cui
poteva godere Gelli, e che erano, in molti casi, rafforzati dall'affiliazione
massonica. Il coinvolgimento di elementi dei servizi segreti stranieri è un
altro dei punti oscuri dell'"affare Moro". Non è mai stato chiarito se ci sia
stato effettivamente un rapporto tra i gruppi terroristici delle Brigate Rosse e
i servizi segreti stranieri, specialmente dei paesi comunisti dell'Europa
orientale, o se le nostre strutture d'intelligence abbiano ricevuto aiuto dai
loro omologhi stranieri. Anche sui rapporti che le BR intessevano con gruppi
armati del terrorismo palestinese o con la Libia, le notizie sono troppo
frammentarie per arrivare a misurare il grado di influenza che queste relazioni
avevano sul fenomeno terrorista di casa nostra. Il messaggio di solidarietà
inviato da Gheddafi alla moglie di Moro, arrivato pochi giorni prima della morte
dello statista pugliese, fu interpretato, dalla stampa dell'epoca, come una
sorta di excusatio non petita. Rimangono oscuri, però, i motivi che avrebbero
potuto indurre il dittatore libico ad appoggiare, direttamente o indirettamente,
l'azione eversiva contro Aldo Moro, che, specialmente nel periodo in cui detenne
la carica di ministro degli Esteri, quasi ininterrottamente tra il 1969 e il
1974, impresse una forte spinta alla politica mediterranea dell'Italia. Il
governo italiano fu, tra le altre cose, il primo governo non arabo a riconoscere
il regime del colonnello libico, pochi giorni dopo la sua presa del potere,
avvenuta il 1°settembre 1969. Una disposizione favorevole che rimase tale anche
dopo l'esproprio dei beni degli italiani in Libia, decisa da Gheddafi nel luglio
del 1970 e a cui il governo italiano reagì con misura e moderazione, evitando di
rompere le relazioni diplomatiche bilaterali. Un'ultima considerazione
sull'attenzione riservata dai servizi segreti ai gruppi extraparlamentari
dell'estrema sinistra. Esisteva di sicuro una certa permeabilità tra le BR e
altri gruppi armati dell'estrema sinistra e l'ampia galassia dell'Autonomia
operaia. Più difficile appare ipotizzare un coinvolgimento di Lotta Continua,
che aveva già rotto con i movimenti extraparlamentari all'epoca del I Congresso
Nazionale, tenutosi a Roma dal 7 al 12 gennaio 1975. In quell'occasione, la
dirigenza di LC decise di votare, alle successive elezioni regionali, per il
Partito Comunista Italiano. L'anno successivo LC si presentò alle elezioni
politiche, indette per il 20 giugno, all'interno di liste comuni con il PdUP per
il comunismo, con Avanguardia Operaia e con il Movimento Lavoratori per il
Socialismo. Questa svolta verso il parlamentarismo segnò, in qualche modo, la
fine di LC, che, di fatto, si sciolse dopo il II Congresso Nazionale, svoltosi a
Rimini tra il 31 ottobre e il 5 novembre 1976. Anche l'ala dura del movimento,
rappresentata a Roma, secondo i documenti in possesso da "Repubblica", dal
servizio d'ordine del gruppo capitolino di LC, di cui faceva parte Erri De Luca,
non volle mai intraprendere la strada della clandestinità, come ha rivelato lo
stesso scrittore napoletano.
Federico Imperato è dottore di
ricerca in storia delle relazioni e delle organizzazioni internazionali e
collabora all'attività scientifica e didattica della cattedra di Storia delle
Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro". E' autore del volume "Aldo Moro e la pace nella
sicurezza. La politica estera del centro-sinistra 1963-68" (Bari, Progedit,
2011).
Lo scrittore Erri De Luca, con
un passato importante in Lotta Continua, spiega cosa c'è dietro all'elenco di
nomi di presunte spie dei servizi segreti russi in Italia: "Dopo il sequestro
Moro c'era una grande confusione all'interno dell'intelligence e quel documento
ne è la prova".
Petruccioli: ''Mai partecipato
ad alcun corso in Urss''. Carlo Petruccioli, ex segretario della Federazione
Giovanile Comunista Italiana negli anni Settanta, è presente nella lista di
nominativi stilata dai servizi italiani di politici e attivisti che avrebbero
effettuato viaggi 'sospetti' in Unione Sovietica, ma nega qualsiasi rapporto con
il Kgb. "Penso che nei giorni del sequestro Moro - spiega l'ex presidente della
Rai -, nel disordine e nell'ansia causati dalle pressioni che arrivavano
dall'alto per raccogliere il maggior numero di informazioni utili sul rapimento,
i servizi abbiano recuperato questo documento - vecchio di cinque anni - in cui
erano stati inseriti semplicemente nomi noti di giovani che erano allora alla
guida della Fgci, ma senza riscontri approfonditi"
Macaluso: ''Nessuna
infiltrazione nel Pci''. Il racconto dell'ex senatore Emanuele Macaluso, autore
di un articoli su "Rinascita" che spiegava quali fossero i "santuari" del
terrorismo: "Erano altre le forze in campo per destabilizzare l'ordinamento
democratico del Paese. In primis la P2, infiltrata nei vertici di tutte le
maggiori istituzioni statali". Diverso il caso del partito comunista. "La scuola
di Mosca era una sorta di università della politica, non c'era nulla di
clandestino".
Turci: ''Mai avuto rapporti
con il Kgb''. Il racconto di Lanfranco Turci, ex presidente della Regione Emilia
Romagna: "Sono andato per la prima volta in Russia in terza liceo con una gita
organizzata e poi ci sono tornato da governatore. Mi sembra difficile che in
qualcuna di queste due vesti possa avere avuto contatti con i servizi segreti
russi". E su come sia finito il suo nome nelle liste spiega: "Non ne ho idea, mi
viene da pensare che chiunque si recasse a Mosca in quegli anni venisse
monitorato".
Le trame "eversive" della
P2 erano già note ma nessuno la indagò durante il sequestro,
continua Alberto Custodero su "La Repubblica". "Dietro il caso Moro uomini
intoccabili" quelle trame indicate da Macaluso. Nelle indagini non si parla mai
di P2. Se non in questo appunto del 15 maggio dove si registrano i malumori dei
vertici del partito comunista, in particolare di Emanuele Macaluso, a proposito
della conduzione delle indagini. "Secondo i responsabili del Pci - annotavano
gli 007 - dietro il rapimento Moro si nasconde una trama ordita, fra l'altro,
dai massoni della P2". "In nome della loggia" nel 1976 già si scriveva di P2.
Quattro anni prima il sequestro degli elenchi nel bunker di Gelli di Castiglion
Fibocchi da parte dei magistrati milanesi (17 marzo 1981), e due anni prima del
rapimento di Aldo Moro, della P2 si sapeva già tutto. O quasi. Ma nessuno,
durante i 55 giorni del sequestro Moro, ha pensato di metterla sotto inchiesta.
La magistratura, che pur la conosceva bene, non lo fece. E si guardarono bene
dal farlo le forze dell'ordine e, soprattutto, i servizi segreti. Eppure,
l'influenza della P2, nei giorni del sequestro, fu tutt'altro che secondaria. La
mattina del 16 marzo 1978 al Comitato di crisi del Viminale tra i convocati
c'erano molti affiliati alla loggia. Se i nomi dei piduisti erano ancora
segreti, le trame di Gelli erano già note. L'unico che la denunciò fu il Pci.
Quattro anni prima il sequestro degli elenchi nel bunker di Gelli di Castiglion
Fibocchi da parte dei magistrati milanesi (17 marzo 1981), e due anni prima del
rapimento di Aldo Moro, della P2 si sapeva già tutto. O quasi. Ma nessuno,
durante i 55 giorni del sequestro Moro, ha pensato di metterla sotto inchiesta.
La magistratura, che pur la conosceva bene, non lo fece. E si guardarono bene
dal farlo le forze dell'ordine e, soprattutto, i servizi segreti. Eppure,
l'influenza della P2, nei giorni del sequestro, fu tutt'altro che secondaria.
Basti considerare il numero delle alte cariche dello Stato che appartenevano
alla loggia di Gelli. La mattina del 16 marzo, giorno del sequestro di Moro, si
riunisce al Viminale un Comitato di crisi. Tra i convocati, molti sono affiliati
alla P2: il generale Santovito, capo del Sismi, il servizio segreto militare
(tessera P2 1630), il generale Giulio Grassini, capo del Sisde, il servizio
segreto civile (tessera P2 1620), il generale Raffaele Giudice, capo della
guardia di finanza (tessera P2 1634), il generale Donato Lo Prete, capo di stato
maggiore della Gdf (tessere P2 1600), l'ammiraglio Giuseppe Torrisi, capo di
stato maggiore della Marina (tessera P2 1825), l'ammiraglio Marcello Celio,
vicecapo di stato maggiore della Marina (tessera P2 815). Fanno parte della
loggia di Gelli anche il segretario generale del Cesis (coordinamento Sismi e
Sisde), Walter Pelosi. Il generale dei carabinieri Giuseppe Siracusano, cui
saranno affidate le prime indagini, il comandante del nucleo investigativo
dell'Arma di Roma, colonnello Antonio Cornacchia, il vicecapo della Mobile
romana, Elio Cioppa, chiamato, dopo il tragico epilogo del sequestro, alla
vicedirezione del Sisde, il commissario Antonio Esposito, che, quel 16 marzo
1978, prestava servizio alla centrale operativa della Questura di Roma. E il cui
nome, indirizzo e numero di telefono fu trovato in una agendina di Valerio
Morucci, uno dei capi della colonna romana delle Brigate rosse. Se quei nomi di
piduisti nel marzo del 1978 erano segreti, l'esistenza della P2, e soprattutto
le sue trame, erano invece ben conosciute dalla metà degli anni Settanta. E alla
loggia di Gelli si attribuiva un qualche ruolo, già in quel periodo,
nell'incredibile catena di colpi di stato pensati, tentati, rinviati, a
cominciare da quello di Junio Valerio Borghese (dicembre 1970), per passare a
quello fallito dell'estate del 1974. E per finire con le iniziative eversive
della Rosa dei Venti. È forse una nemesi storica, va osservato, che proprio la
massoneria, che nel 1923 fu perseguitata dagli squadristi fascisti mandati da
Mussolini, negli anni Settanta, grazie proprio alla P2, sia stata sospettata
come cabina di regia di una strategia della tensione eversiva di matrice
fascista. Sui giornali tra il 1976 e il 1977 già trapelava qualche nome di
iscritti alla P2, in particolare quelli coinvolti in inchieste giudiziarie. Si
leggeva, ad esempio, che "tesoriere della Rosa dei Venti era il piduista
avvocato De Marchi". E che della loggia segreta facevano parte "Adelino Ruggeri
del gruppo eversivo Mar, Loris Civitelli del "golpe bianco" di Edgardo Sogno,
Agostino Coppola coinvolto in storie di mafia, l'avvocato Minghelli accusato di
riciclare i soldi dei sequestri di persona dell'anonima romana", combine,
quella, tra banda della Magliana e clan dei Marsigliesi. È però quasi una
certezza che nei vari tentativi golpisti più o meno credibili, o poi, nelle
varie fase più critiche della Repubblica - compreso il sequestro Moro - si
ritrova sempre, in ordine sparso, ma mai troppo casuale, un gruppetto di
iscritti alla P2. Il primo magistrato a occuparsi della P2, nell'aprile del 1976
(cinque anni prima, dunque, del sequestro di Castiglion Fibocchi), fu il pm
Vittorio Occorsio che indagò sui rapporti tra terrorismo neofascista, massoneria
e apparati deviati del Sifar. L'ex ufficiale dei Parà Sandro Saccucci, ad
esempio, interrogato in carcere, gli confidò di appartenere alla massoneria e
gli parlò di Licio Gelli e della Loggia P2. Sui giornali d'epoca, si legge che
Occorsio, indagando sulla P2, aveva scoperto "un documento datato 22 marzo 1975
nel quale si parlava di presunte attività illecite, dalla corruzione di
esponenti politici e sindacali, al pagamento di tangenti per ottenere licenze
edilizie, dalle presunte attività golpiste della P2 a un grosso traffico d'armi
scoperto a Livorno". In precedenza Occorsio si era occupato anche del golpe
Borghese. E aveva diretto le indagini sul boss dell'anonima sequestri romana
(Albert Bergamelli), e, per riciclaggio, sul suo legale, avvocato Minghelli, che
risultò essere iscritto alla P2. Il convincimento maturato in Occorsio al
termine di quelle indagini è sintetizzato in una significativa dichiarazione
fatta all'amico e collega giudice istruttore Ferdinando Imposimato: "Sono certo
che dietro i sequestri ci siano delle organizzazioni massoniche deviate, e
naturalmente esponenti del mondo politico. Tutto questo rientra nella strategia
della tensione: seminare il terrore tra gli italiani per spingerli a chiedere un
governo forte, capace di ristabilire l'ordine". L'illegalità in nome della
legalità, destabilizzare con attentati terroristici per stabilizzare, vecchia
storia d'Italia. Occorsio fu ucciso da Pierluigi Concutelli di "Ordine nuovo" il
10 luglio del 1976. Ma fu proprio dopo l'omicidio Occorsio, nel 1977, che la
magistratura di mezza Italia si scatenò contro la P2. Licio Gelli fu interrogato
per tre volte dal pm di Firenze Pier Luigi Vigna e il procuratore generale
Giulio Catelani che poi si avocò l'inchiesta. Ma indagarono anche il giudice di
Bologna Angelo Vella. E poi il pm Domenico Sica e ancora il giudice Ferdinando
Imposimato. A Vigna, Gelli ammise di essere stato repubblichino, di essere
consigliere economico dell'ambasciata argentina a Roma, ammise che Miceli faceva
parte della P2, consegnò un imponente materiale sulla loggia da allora andato
misteriosamente scomparso. Lino Salvini, il gran maestro del grand'Oriente
d'Italia, l'Obbedienza massonica nel cui seno si annidava la P2, anch'egli
interrogato da Vigna, disse che Gelli aveva come amici, in particolare,
"Andreotti, Piccoli e Mariotti". In alcune lettere anonime indirizzate ai
giudici, Gelli era indicato come "capo del servizio di spionaggio argentino in
Italia e nel contempo membro influente del Sid". Fabio Isman, sul Messaggero,
scrisse che "fu persecutore di partigiani inquadrato fra le truppe tedesche
d'occupazione, dopo la Liberazione finì in Sudamerica dove divenne amicissimo di
Peron e, pare, anche del nero Lopez Reca". Le indagini allora furono agevolate
da una faida fratricida che si consumava sotto le volte stellate del Goi. A
contendersi il controllo della potente obbedienza massonica, da una parte, il
gran maestro Salvini, dall'altra Gelli, che non faceva mistero di avere dossier
per mandarlo in carcere in mezz'ora. A dare impulso a quelle inchieste fu in
effetti un "fratello" espulso dal grand'Oriente perché in rotta di collisione
con Gelli, tal Francesco Siniscalchi, ingegnere. In un dossier esplosivo
consegnato alla procura e pubblicato nel 1976 sul numero 562 di Panorama, l'ex
massone svelò le oscure manovre politiche di quel gruppetto oltranzista e
piduista collegato, secondo le sue accuse, a mafia, magistratura, finanza e
mondo militare. Siniscalchi denunciò l'attività eversiva della P2 alla
magistratura e rilasciò numerose interviste. In un articolo di Panorama del 13
dicembre del 1977 intitolato "Dietro tutto, la P2", ad esempio, l'ex fratello
dichiarò essere "ampiamente dimostrata" l'appartenenza di Vito Miceli -
coinvolto nel golpe Borghese - alla P2, la loggia che lo raccomandò al vertice
del servizio segreto Sid. "Cominciarono dal 1953 - disse in un'altra intervista
- a crearsi forti commistioni tra la massoneria e il mondo militare, soprattutto
i servizi segreti. Si creò così un altro anello tendenzialmente più oltranzista
disposto e disponibile a portare avanti operazioni politiche spericolate. La P2,
negli anni successivi, è divenuto il ricettacolo segreto di questo potere
militare che secondo me ha avuto per lungo tempo capofila Miceli in contatto
attraverso il maestro venerabile Gelli con personaggi come Michele Sindona,
Carmelo Spagnuolo e così via. A legarli era un acceso anticomunismo". "Non
dimentichiamoci che la maggior parte degli ufficiali coinvolti nell'inchiesta
sulle trame eversive della Rosa dei Venti appartengono proprio alla P2". La P2
era legata alla Cia, svelava ancora Siniscalchi. Per difendersi dalle accuse
della magistratura, dei giornali e dell'ex fratello Siniscalchi, Gelli fu
costretto, per la prima volta, a uscire allo scoperto. E contrattaccò ribattendo
che tutti quei veleni su di lui e sulla P2 "nascevano da lotte intestine interne
alla massoneria", fomentate da "qualche fratello, o ex fratello, espulso". La
faida all'interno del grand'Oriente aveva raggiunto una tensione talmente
elevata che c'era chi, a gran voce, invocava lo scioglimento della loggia
segreta P2. Ma Salvini si guardò bene dal farlo. Prima del sequestro Moro, tra
il 1975 e il 1978, circolavano alcuni nomi di presunti appartenenti alla P2,
puntualmente smentiti dal gran maestro Salvini secondo cui alla P2 erano
affiliati solo 62 fratelli. Tra i nomi pubblicati dai giornalisti, "il generale
di Ps Osvaldo, i generali Miceli e Maletti, Saccucci, il capitano La Bruna, l'ex
procuratore generale Carmelo Spagnuolo". Interrogato dal giudice istruttore
Imposimato, Salvini disse che la loggia Propaganda 2 esisteva già ai tempi di
Garibaldi. In effetti, la storia della P2 è antica. Fu inventata dal gran
maestro Lemmi alla fine dell'Ottocento, dopo che la P1 (Propaganda 1), aveva in
qualche modo esaurito il suo compito di loggia che raccoglieva deputati e
ministri italiani, numerosissimi. La P2 conservò il carattere di segretezza
della P1 continuando a raccogliere al suo interno ministri, deputati, militari,
magistrati, industriali, funzionari che non ritenevano di far conoscere
pubblicamente la loro qualità di massoni. Nel 1966 l'allora gran maestro
Giordano Gamberini affidò a Gelli la sua riorganizzazione. La loggia decollò tra
il 1969 (l'anno della strage di piazza Fontana) e il 1970 e da quel periodo si
diceva che, sotto la direzione Gelli, fossero confluiti i cosiddetti
"fascipisti", ovvero i golpisti di destra. Il "manifesto" della loggia, prima
del sequestro Moro, del resto, non era affatto segreto. Anzi. Nel giugno del
1976 fu divulgato l'editto politico di Licio Gelli (che lui disse essergli stato
richiesto dal Quirinale, nei cui ambienti era stato introdotto dai fratelli
Lefebvre). Dopo una premessa sconsolata sulla "scomparsa politica di uomini
della levatura di uno Scelba, di un Pella e di un Tambroni", Gelli accusava il
centrosinistra, colpevole secondo il Venerabile "di aver determinato
l'instabilità politica, lo sfacelo economico e l'insofferenza sociale, favorendo
lo sviluppo di formazioni criminali che hanno assunto, forti della protezione
del Pci, atteggiamenti da quasi potere". Tre capitoli ("Propaganda", "Aspetti
del comunismo russo", "Aspetti e strategia del Pci") erano diretti a dimostrare
la consistenza del pericolo rosso in Italia "dal momento che il vero artefice
della crisi attuale non è altro che lo stesso Pci che, pur sconfessandole, ha
istruito organizzato e finanziato frange estremiste di sinistra di cui ha il
pieno controllo". A chi si riferiva il venerabile Gelli? Ma il caso Gelli-P2
deflagra proprio a ridosso del sequestro Moro, quando le cronache riportano le
notizie dell'inchiesta sul dissesto delle banche di Sindona. Era l'11 febbraio
del 1978, un mese prima del sequestro. Paolo Guzzanti, in un articolo su
Repubblica intitolato "E in mezzo al gioco la loggia P2", attacca Gelli. "Quello
massonico non è solo un coté dell'affare Sindona, ma molto più probabilmente il
buio centro di tutta la storia. Mario Barone ha fatto finora solo pochi nomi tra
quelli dei 500 esportatori di capitali. Ma sono comunque sufficienti per
azzardare le linee di una mappa che promette di coincidere con quella del più
occulto luogo di potere parallelo del nostro Paese: la loggia massonica P2".
Continua Guzzanti: "Che non si tratti di tenebrose fantasie o della mania di chi
vede trame occulte dappertutto, sembra indicato da pochi, ma incontrovertibili
fatti. Primo fra tutti il nome indicato da Mario Barone, di Licio Gelli capo
della P2 emerso già in decine di occasioni legate alla cronaca del golpismo,
della fuga dei capitali, del traffico delle armi, dei movimenti fra gli altri
gradi delle Forze Armate e dei servizi segreti". La lotta fratricida
Salvini-Gelli ebbe il suo epilogo finale proprio in pieno sequestro Moro. Il 18
marzo 1978, quando Roma era setacciata dalle forze dell'ordine, il grand'oriente
si riunì all'Hotel Hilton di Roma. Di fronte ai maestri venerabili delle 496
logge (fra queste, la P2), molti dei quali riverivano Gelli, Salvini si dimise
con un anno di anticipo. E lasciò il passo a una istanza di Gelli secondo la
quale la futura giunta dell'Obbedienza non sarebbe più stata costituita in base
alle rappresentanze regionali. Bensì chiamandovi a fare parte fratelli di alto e
indiscusso prestigio, guarda caso in gran parte della P2: generali, alti
magistrati, importanti burocrati di stato, banchieri, industriali,
professionisti illustri. Insomma, di Gelli, della P2 e delle trame oscure di
quella loggia, prima del sequestro di Aldo Moro, si sapeva già tutto. Perché,
allora, continuò ad agire indisturbata durante tutto il periodo del rapimento
dello statista Dc? E poi ancora per tre anni agì indisturbata?
IL COMPLOTTO
INTERNAZIONALE.
Aldo Moro ucciso per un
complotto internazionale,
scrive "Il Tempo" l'1/11/2009. E' quanto afferma Sergio Flamigni, parlamentare
del Pci dal 1968 al 1987 ed ex componente della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul caso Moro. Flamigni, 84 anni, è intervenuto venerdì sera ad un
dibattito pubblico organizzato a Sezze in occasione della presentazione del
film-documentario «Se ci fosse luce - I misteri del caso Moro», scritto e
diretto da Giancarlo Loffarelli e realizzato in collaborazione con le «Teche
Rai». Nel corso dell'incontro, cui hanno preso parte anche Agnese Moro, figlia
dello statista, e lo storico Giuseppe De Lutiis, Flamigni ha detto di essere
«oggi ancor più convinto che in molti, in Italia e all'estero, hanno voluto la
morte di Moro per bloccare l'accordo tra Dc e comunisti». Forse anche una
risposta indiretta al Presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga,
che di recente aveva dichiarato al nostro giornale che «Moro è stato ucciso
dalle Brigate Rosse e le Brigate Rosse sono un fatto tutto italiano». L'ex
parlamentare ha dichiarato anche di «avere inviato una richiesta al ministro
Maroni, senza avere risposta, per avere accesso ad alcuni documenti sul caso
Moro coperti da segreto di stato, segreto che è caduto con l'apposita legge del
2007». Tra le carte a cui Flamigni ha chiesto di avere accesso, ce n'è una, in
particolare, redatta dal Ministero dell'Interno, che nei 55 giorni del rapimento
Moro (dal 16 marzo al 9 maggio 1978) era retto da Cossiga, in cui il Viminale
indicava «un sito nell'area aeroportuale di Fiumicino» quale prigione dello
statista. «Non capisco perché Maroni non risponda ai miei solleciti», dice
Flamigni, cui ha fatto eco De Lutiis che si è augurato che anche in Italia si
possa avere libero accesso ai documenti dopo trenta anni dai fatti. E ancora
Flamigni, tra gli argomenti toccati, ha riferito della famosa seduta spiritica a
cui partecipò anche Romano Prodi, il 2 aprile 1978, a Bologna, a casa del
professore Alberto Clò (futuro ministro) in cui uscì il nome di Gradoli. E' la
via a nord di Roma in cui la polizia aveva già fatto un controllo, senza esito,
perché nessuno aprì la porta in un appartamento al civico 96, due giorni dopo la
strage di via Fani. Flamigni ha detto di aver assistito alle deposizioni davanti
alla commissione di tutti i partecipanti alla seduta, di averli visti «sinceri
nelle loro dichiarazioni ma sono convito che il nome Gradoli sia uscito perché,
comunque, qualcuno dei presenti aveva già sentito quel nome in relazione alla
vicenda Moro».
Sequestro Moro, La Torre e
Piersanti Mattarella. La pista siciliana,
scrive Alberto Di Pisa il 21 marzo 2016 su "Sicilia Informazioni". La mattina
del 16 marzo 1978, allorquando il nuovo governo, guidato da Giulio Andreotti,
stava per essere presentato in Parlamento, per ottenere la fiducia, un nucleo
armato delle Brigate Rosse intercettava in via Mario Fani, a Roma, l’autovettura
a bordo della quale vi era Aldo Moro che si accingeva a raggiungere la Camera
dei deputati. Furono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco automatiche e
nell’agguato rimasero uccisi i due carabinieri che si trovavano a bordo
dell’auto in cui viaggiava Moro e tre poliziotti che si trovavano sull’auto di
scorta. Moro venne sequestrato dai Brigatisti e il nove maggio, dopo una
prigionia durata 55 giorni, venne ucciso e il suo cadavere fatto ritrovare a
Roma nel bagagliaio di una Renault 4 parcheggiata in via Caetani, ubicata tra la
sede della DC e quella del PCI. Numerose furono le ipotesi che si fecero sui
motivi e sugli esecutori e mandanti del sequestro e della uccisione
dell’onorevole Moro. Si ipotizzò un possibile coinvolgimento della P2 e dei
servizi segreti, dell’URSS, degli Stati Uniti, di Israele e persino della mafia.
Si arrivò alla fine alla conclusione che tutto era chiaro, il grave delitto era
riconducibile esclusivamente alle Brigate rosse, soprattutto dopo il c.d.
“memoriale” scritto in carcere dal brigatista Valerio Morucci, avallato dall’ex
capo delle BR Mario Moretti e da una parte della magistratura che ricostruì la
vicenda Moro basandosi prevalentemente su ciò che Morucci aveva scritto. Nel
memoriale e nelle dichiarazioni rese agli inquirenti nella primavera del 1984 e
nel processo di appello, Morucci descrisse dettagliatamente tutte le fasi
dell’agguato e le attività delle Brigate rosse. Il memoriale, in un primo
momento non conteneva i nomi degli altri brigatisti. Successivamente, nel 1986,
Morucci inviò dal carcere a Francesco Cossiga, allora Presidente della
Repubblica, una versione “aggiornata” del memoriale in cui invece faceva i nomi
dei terroristi. Il processo di appello si concluse nel 1985 e la condanna
all’ergastolo, riportata da Morucci nel giudizio di primo grado, fu ridotta a 30
anni di reclusione. Morucci, che nel giudizio di appello aveva letto un
documento con cui, insieme ad altri 170 detenuti formalmente si dissociava dalla
lotta armata, vide ulteriormente ridotta la pena a 22 anni e mezzo di reclusione
in virtù della applicazione della legge sulla dissociazione. Grazie poi al
regime della semilibertà e alla concessione della libertà condizionale, ha
finito di scontare la pena nel 1994. Nel libro “Patto di omertà” il senatore
Flamigni ha denunciato la assoluta inattendibilità del cosiddetto “memoriale
Morucci”, affermando di non credere alla veridicità di quanto sostenuto da
quest’ultimo, secondo cui l’omicidio Moro sarebbe stato un delitto maturato
esclusivamente all’interno della organizzazione terroristica senza nessuna
complicità o input da parte di soggetti estranei all’ organizzazione. In tale
libro Flamigni (che ha fatto parte della prima Commissione di inchiesta sul
delitto Moro) sostiene la tesi secondo cui il memoriale di Morucci altro non
sarebbe se non il punto di arrivo di “un patto di omertà” stipulato dagli ex
terroristi con settori politici, statali ed istituzionali. Lo scopo del
memoriale sarebbe stato quello di non rendere possibile una ricostruzione
completa e veritiera del sequestro e omicidio di Aldo Moro. In altri termini si
tratterebbe di una versione di comodo che, se da un lato salvaguardava “la
purezza rivoluzionaria” delle Brigate rosse, dall’altro faceva comodo alla DC
(soprattutto Cossiga ed Andreotti) perché serviva a giustificare lo scarso
impegno posto in essere dal governo per salvare la vita di Moro. In effetti è
sospetto e fa riflettere il fatto che il memoriale Morucci venne scritto a
seguito di una serie di colloqui intervenuti tra quest’ultimo e Remigio Cavedon,
direttore allora del quotidiano DC “Il Popolo” e consulente personale di
politici quali ad esempio Mariano Rumor. Ma la parte più interessante del libro
di Flamigni è quella in cui l’autore esamina il contesto internazionale in cui
maturò il delitto Moro. Ed è questo il punto su cui voglio soffermarmi anche per
le analogie che tale delitto presenta, almeno per quanto riguarda il possibile
movente, con alcuni delitti “eccellenti” verificatisi in Sicilia. E’ un fatto
notorio che negli anni 70 Moro perseguiva una politica volta a fare partecipare
i comunisti alle responsabilità di governo cosi come è altrettanto noto come,
negli USA, tanto l’amministrazione repubblicana che quella democratica erano
manifestamente contrarie a questa politica. Allorquando nel 1974, Moro, allora
ministro degli esteri, si recò, insieme al Presidente della Repubblica Leone,
negli Stati Uniti, ebbe un confronto se non uno scontro, su tale tema, con
l’allora segretario di Stato Henry Kissinger il quale minacciò di tagliare gli
aiuti economici all’Italia se i comunisti fossero andati al governo. La
posizione dell’amministrazione americana non mutò nemmeno allorquando
Napolitano, recatosi in America, diede ampie assicurazioni al governo americano.
Io credo che nessuna persona di buon senso penserebbe che gli Stati Uniti, a
fronte della possibilità che in Italia i comunisti andassero al governo,
sarebbero rimasti a guardare. Ciò non significa certamente che l’ordine di
sequestrare ed uccidere Moro sia venuto da Kissinger o da chi per lui, ciò
sarebbe assurdo pensarlo. Ma il discorso è più sottile e bisogna comprendere
come funziona e come si muove la politica. Negli Usa non vi fu certamente
qualche politico o esponente di governo a ordinare esplicitamente il sequestro
di Moro, ma fu lanciato un messaggio del seguente tenore: “I comunisti stanno
per impossessarsi del potere; la situazione è grave”. Questo messaggio proveniva
dal livello politico più alto e venne recepito da un livello inferiore e diverso
che non aveva nessun contatto con il livello superiore. Il livello inferiore
comprese la preoccupazione del vertice politico per rischi che correva la
democrazia e trasmise questa preoccupazione al livello successivo. Alla fine si
arriva al livello che dice: “Ho capito cosa devo fare”. E’ un meccanismo che ho
avuto modo di riscontrare anche in alcuni delitti di mafia. Ricordo che il
pentito Calderone, parlando dell’omicidio del Generale Dalla Chiesa, ci disse
che alcuni imprenditori catanesi, rivolgendosi a lui gli avevano detto: “ma a
Palermo non fanno nulla?”. Osservò Calderone in proposito che se l’imprenditore
non poteva essere considerato, per questa sola frase, il mandante dell’omicidio,
era tuttavia evidente che, rivolgendo una tale domanda ad un esponente mafioso,
ciò significava indurre l’organizzazione mafiosa ad agire eliminando Dalla
Chiesa che aveva rivolto la propria attenzione sugli appalti in Sicilia. A mio
avviso è da escludere che le BR abbiano fatto tutto da sole. Ciò costituirebbe
una lettura superficiale del delitto Moro. Qualcuno fece pervenire loro il
messaggio proveniente dagli USA e loro eseguirono gestendo sostanzialmente “un
appalto”. Non è infatti senza significato il fatto che Moro viene ucciso proprio
quando la DC, con il Presidente del Senato Fanfani, si apriva alla trattativa
con il partito comunista. Avvalora la tesi qui sostenuta quanto dichiarato da
Giovanni Galloni in una intervista rilasciata, il 5 luglio 2005, nella
trasmissione NEXT, di Rai News 24, secondo cui Moro gli aveva confidato di
essere a conoscenza del fatto che sia i servizi americani che quelli israeliani
avevano degli infiltrati nelle BR, circostanza questa di cui, tuttavia, venivano
tenuti all’oscuro i servizi italiani. Galloni aggiungeva che, durante il
sequestro Moro, vi erano state notevoli difficoltà a mettersi in contatto con i
servizi statunitensi. E sempre Galloni, nel luglio 1988, nel corso di una
audizione dinanzi alla Commissione stragi, affermò che in occasione di un suo
viaggio negli Stai Uniti, nel 1976, gli fu detto che per motivi strategici gli
Stati uniti erano contrari ad una apertura ai comunisti, politica questa
perseguita da Moro. I motivi strategici erano costituiti dal timore degli
americani di perdere le basi che gli Stati Uniti avevano sul suolo italiano che
costituivano una importante linea di difesa in caso di invasione dell’Europa da
parte dell’Unione Sovietica. Dichiarò in particolare Galloni alla Commissione:
“Quindi, l’entrata dei comunisti in Italia nel Governo o nella maggioranza era
una questione strategica, di vita o di morte, “life or death” come dissero, per
gli Stati Uniti d’America, perché se fossero arrivati i comunisti al Governo in
Italia sicuramente loro sarebbero stati cacciati da quelle basi e questo non lo
potevano permettere a nessun costo. Qui si verificavano le divisioni tra colombe
e falchi. I falchi affermavano in modo minaccioso che questo non lo avrebbero
mai permesso, costi quel che costi, per cui vedevo dietro questa affermazione
colpi di Stato, insurrezioni e cose del genere.» (Dichiarazioni di Galloni alla
Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia, 39° seduta, 22
luglio 1998). Si ricorderà come una pista per l’uccisione di Pio la Torre fu
quella della sua campagna contro la realizzazione della base americana a
Comiso che certamente si poneva in contrasto con gli interessi americani come
riferiti da Galloni. Che Moro fosse inviso al Governo degli Stati Uniti a causa
della sua politica che mirava ad un ingresso del Partito comunista al Governo, è
circostanza riferita esplicitamente dalla vedova, Eleonora Chiavarelli, al primo
processo contro il nucleo storico delle BR. In questa sede dichiarò che il
marito più volte era stato “ammonito” da esponenti politici americani a non
violare la cosiddetta “logica” di JALTA e che nel 1974, in occasione di una di
lui visita negli Stati Uniti, Kissinger lo aveva esplicitamente avvertito della
pericolosità di un “legame” con il PCI. Riferì poi la signora Moro che nel 1976,
allorquando gli avvertimenti erano divenuti più espliciti, il marito era stato
avvicinato da un alto personaggio americano che ancora una volta lo aveva
duramente ammonito. Questo episodio fu poi riferito dalla vedova dinanzi alla
commissione parlamentare di inchiesta in questi termini: “È una delle pochissime
volte in cui mio marito mi ha riferito con precisione che cosa gli avevano
detto, senza svelarmi il nome della persona. […] Adesso provo a ripeterla come
la ricordo: "Onorevole (detto in altra lingua, naturalmente), lei deve smettere
di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo Paese a
collaborare direttamente. Qui, o lei smette di fare questa cosa, o lei la
pagherà cara. Veda lei come la vuole intendere"».
Non c’è dubbio che l’ipotesi
che si potesse realizzare in Italia un compromesso tra i partiti di governo e il
partito comunista non piaceva agli americani, perché si poneva in contrasto con
gli interessi USA. L’eliminazione di Moro sarebbe risultata vantaggiosa sia
Oltreoceano che per alcuni settori della politica italiana, scrive ancora
Alberto Di Pisa il 23 marzo 2016 su "Sicilia Informazioni". In un articolo
pubblicato sull’Unità il 26 settembre 1982 scrisse Emanuele Macaluso: “Noi siamo
tra coloro che non hanno mai creduto che a rapire e ad uccidere il presidente
della DC siano state solo le Brigate rosse che organizzarono l’infame impresa.
Abbiamo sempre pensato che gli autonomi obiettivi politici delle BR
coincidessero con quelli di potenti gruppi politico-affaristici, nazionali ed
internazionali che temevano una svolta politica in Italia”. C’è una circostanza
che avvalora l’ipotesi di Macaluso: che il sequestro e l’omicidio Moro non fosse
riconducibile alle sole Brigate rosse e che queste avessero dei collegamenti con
i servizi segreti, lo faceva sospettare una circostanza: la stampatrice trovata
nella tipografia di via Foà a Roma, dove le Brigate rosse avevano stampato,
durante i 55 giorni del sequestro i comunicati, e che era stata ivi portata da
Morucci, proveniva da un reparto unità speciali dell’esercito, sigla RUS, che
altro non era, come si accertò, se non uno dei compartimenti segreti di Gladio.
Ed ancora più inquietante è la vicenda del famoso comunicato numero 7 delle BR e
cioè quello in cui il 18 aprile del 78 i brigatisti annunciavano l’esecuzione di
Moro e indicavano un laghetto ghiacciato in provincia di Roma il luogo dove era
stato abbandonato il cadavere. Ebbene, si accertò che questo comunicato era
stato redatto da Chicchiarelli, pregiudicato e confidente dei servizi segreti;
il che porta alla conclusione che la stessa macchina per scrivere era
utilizzata, nello stesso periodo di tempo sia dai brigatisti rossi che da un
soggetto della malavita romana e dai servizi segreti. Questa, che poteva essere
soltanto una ipotesi, ha trovato conferma in quanto dichiarato il 7 novembre
1980 alla Commissione Parlamentare d’indagine sul delitto Moro, dall’ex capo
dell’Ucigos Fariello. Questi, allorquando, in Commissione, gli venne mostrato il
comunicato numero 7 affermò: “…era autentico, lo do per scontato…io mi baso sui
miei collaboratori tecnici, i quali hanno riconosciuto che la battuta e la
testina erano le stesse (di quelle usate per gli altri comunicati brigatisti
(n.d.r)”. Non sono mai stati approfonditi i motivi per cui Chicchiarelli,
confidente dei servizi segreti, avrebbe compilato e diffuso falsi comunicati
delle BR. Pur non avendo giudiziariamente valenza di prova vi è un ulteriore
fatto che forse meritava un approfondimento. Nell’estate del 1978 pervenne al
direttore dell’istituto di criminologia dell’università di Roma, Semerari, una
lettera a firma di tale “Mister Brown” nella quale si diceva che il sequestro e
la morte di Moro erano da attribuire ad un complotto della Cia. La lettera, che
venne aperta dal Semerari alla presenza del collega Antonio Mottola, fu da
entrambi inviata al generale dei carabinieri Ferrara. Nel luglio 1981 Mottola
venne ucciso dopo essere stato prelevato in casa da tre uomini, mentre Semerari
venne trovato decapitato il 1° aprile del 1982 ad Ottaviano, regno di Raffaele
Cutolo il quale, al processo Cirillo, dirà che Semerari era stato eliminato da
Enzo Casillo (luogotenente di Cutolo) ma per conto dei servizi segreti. Chi era
Aldo Semerari? Un docente universitario, simpatizzante di destra, iscritto alla
Loggia P2 e amico di Licio Gelli, in contatto con il Sismi. Ma la circostanza
più rilevante che induce a ritenere, nel sequestro Moro, un qualche collegamento
con i servizi americani, ci è data dallo psichiatra Franco Ferracuti che faceva
parte degli esperti del Comitato tecnico operativo costituito al Viminale
durante il sequestro Moro. Era iscritto alla P2 (tessera numero 2137) e fu
coinvolto nelle indagini sulla strage di Bologna. Ebbene, il generale Giulio
Grassini, ex capo del Sisde, iscritto alla P2 e componente anche lui del
suddetto Comitato, al processo per la strage di Bologna dichiarò che il
Ferracuti aveva rapporti con elementi del FBI e della Cia. Nel medesimo processo
il Ferracuti dichiarava di conoscere Cossiga e di essere stato introdotto da lui
nel Sisde. Ve ne è abbastanza, quantomeno, per sospettare che il sequestro Moro
non sia stato gestito esclusivamente dalle BR, tesi questa sostenuta
dai magistrati inquirenti e avallata dal presidente Cossiga. Voglio ricordare
che quando Andreotti, allora Presidente del Consiglio, il 4 aprile, a tre
settimane dal sequestro, si recò alla Camera per riferire sulla situazione,
dichiarò di essere certo del fatto che le lettere di Moro fossero false. Senza
volere trarre conclusioni e indicare colpevoli del sequestro e uccisione
dell’onorevole Moro, mi limito a costatare come questo grave delitto presenti
degli elementi che lo accomunano, quanto alle possibili motivazioni, ad alcuni
“delitti eccellenti “verificatisi negli anni 70-80 in Sicilia, a Palermo. Mi
riferisco agli omicidi del segretario provinciale della DC, Michele Reina, del
Presidente della Regione Piersanti Mattarella, del segretario regionale del
partito comunista Pio la Torre. Reina aveva aperto al partito comunista,
Mattarella era stato portatore di una linea di rinnovamento e di apertura alla
sinistra, Pio la Torre si era opposto tenacemente alla realizzazione della base
di Comiso e confliggeva con quei soggetti che volevano impedire che la sinistra
andasse al governo. Solo coincidenze? Alberto Di Pisa
Moro, Pertini, Berlinguer e
i tempi degli animali nobili. Italian Farm e il passaggio in politica dagli
animali alle bestie,
scrive venerdì 23 settembre 2016 Gabriele Della Rovere su
"L'Indro". Il primo, il più giovane dei due, era un castoro. Costruiva, gli
distruggevano l’opera e lui ricominciava a costruire. Ha avuto contro la
peggiore destra italiana, e la destra italiana era ed è una delle peggiori al
mondo, oltretutto per mediocrità di struttura e comportamenti. E contro la
politica (quasi) tutta, sia italiana (anche, e a volte specialmente, della sua
parte) che internazionale (anche, e a volte specialmente, statunitense),
l’economia (anche, e a volte specialmente, petrolifera), la religione (anche, e
a volte specialmente, chi gli era stato e si professava sodale),
la comunicazione (anche e specialmente quasi tutta), la massoneria… A fare
il lavoro sporco ha provveduto gente che si credeva di sinistra, molto di
sinistra, preda di concezioni e comportamenti che più di destra non potevano
essere. Il secondo, quasi esattamente venti anni di più e avrebbe quindi potuto
essergli tranquillamente padre, era un lupo. Solitario e allo stesso tempo
amante dei suoi simili, protettivo e appassionato. Severo ma giusto. Giunto ai
vertici dello Stato in maniera inaspettata riuscì a fare amare le Istituzioni,
oltre che se stesso, come nessuno prima e dopo. Il terzo era un muflone. Solido,
paziente, testardo e buono. Animale in via di estinzione, causa caccia dei
nemici e decadimento sociale. Aldo Moro è nato a Maglie, Lecce, il 23 settembre
1916. Sandro Pertini è nato a Stella, Savona, il 25 settembre 1896. Enrico
Berlinguer è nato a Sassari, Sassari, il 25 maggio 1922. L’anagrafe, il giorno
di nascita a venti anni di distanza, accomuna i primi. La storia, anzi la
Storia, fa sì che anche il terzo sia pienamente della stessa partita. E della
stessa razza. «Noi fummo i Gattopardi, i Leoni, chi ci sostituirà saranno
gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti, gattopardi, sciacalli
e pecore, continueremo a crederci il sale della terra» diceva il Principe di
Salina, don Fabrizio, ne ‘Il Gattopardo’ di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Raccontando questa nostrana postorwelliana fattoria degli animali, Animal Farm
appunto, e quindi l’Italian Farm, partiamo ricordando quando ancora vivevano tra
noi, e ci guidavano, ed era bello farsi guidare, nobili animali. Adesso, in gran
parte, soprattutto bestie. Aldo Moro è morto a Roma, Prigione del Popolo, il 9
maggio 1978. Sandro Pertini è morto a Roma, Roma, il 24 febbraio 1990. Enrico
Berlinguer è morto a Padova, Padova, l’11 giugno 1984. Ma ne siamo proprio
sicuri?
Gli Anni 70 dell’omicidio
Moro Primo Levi: “È il buio del Paese”.
Così il giornale, già ferito dall’uccisione di Casalegno, racconta i 55 giorni
di prigionia. La scena dell’agguato delle Brigate Rosse ad Aldo Moro in via Fani
a Roma il 16 marzo 1978: vennero uccise cinque guardie del corpo, scrive il
02/10/2016 Marco Neirotti su "La Stampa". Il 16 marzo 1978, poco prima delle
9,30, irrompe la notizia del rapimento di Aldo Moro e del massacro di cinque
uomini di scorta. La vita della Stampa è ancora insanguinata dall’agguato al
vicedirettore Carlo Casalegno quattro mesi esatti prima (morirà in ospedale il
29 novembre 1977) e la redazione sta scrivendo sull’assassinio del maresciallo
Rosario Berardi, freddato sei giorni prima a una fermata del tram a Torino. La
Stampa, per tutti i 55 giorni di prigionia di Moro, racconta e analizza senza
lasciarsi deviare dall’orrore che l’ha da poco colpita. Scrive il direttore
Arrigo Levi nel primo editoriale: «Con i terroristi non si tratta», ma
ammonisce: «Sono frutto di comprensibili reazioni emotive le ipotesi di
proclamazione della legge marziale, o di instaurazione della pena di morte». La
cronaca è racconto e indagine: l’agguato attimo per attimo, stranezza per
stranezza (i dodici uomini del commando usano una 128 con targa diplomatica
venezuelana, armi particolari), la blindatura immediata della capitale, le
perquisizioni a raffica, ma anche la vedova Moro china sui corpi degli agenti
che accompagnavano il marito, poi lo Stato che si compatta, le reazioni nei
palazzi del potere, il Paese in lutto con cinema e negozi chiusi,
manifestazioni, 200 mila persone in piazza nella sola Roma. Liliana Madeo si
addentra in vita e morte, ideali e sacrificio delle cinque vittime, colleghi
sorvegliano le indagini e le vane ricerche di Moro prigioniero a Roma, fino al 9
maggio, quando in via Caetani, vicino alla sede del Pci, è segnalata una R4
rossa con un cadavere nel bagagliaio. In un’area subito resa inaccessibile Marco
Tosatti si infila tra gli sbarramenti incollato al ministro dell’Interno Cossiga
ed è lì quando aprono il portellone su quegli occhi semiaperti. Scrive Tosatti:
«Sembra assopito, ma un’aria sofferente è sul volto, coperto dalla barba lunga
di qualche giorno». Accanto ai fatti via via accertati si vuol trasmettere al
lettore la tensione dei passi che portano alla notizia e l’indomani, anticipando
- seppur in un unico blocco - gli aggiornamenti in tempo reale di Internet, si
pubblicano in fila le agenzie che minuto dopo minuto da un’auto ancora chiusa
con un corpo ripiegato si avvicinano alla verità. C’è, nelle pagine del 10
maggio, l’orrore di fronte a quella lotta armata, ma ci sono la pietà per l’uomo
e l’omaggio allo statista. Giovanni Spadolini racconta l’ultimo incontro: «Lo
inquietava il terrorismo, ma più ancora lo inquietavano le radici e i consensi
giovanili». Vittorio Zucconi analizza la strategia del sangue passo dopo passo:
«E adesso uomini delle Brigate rosse?», domanda e, indagando quali strade siano
aperte, scrive: «La lezione del massacro non riguarda la natura del terrorismo
ma la sua condizione attuale, che è massicciamente di crisi
ideologica». La scure di Norberto Bobbio tronca l’immagine degli assassini: «Che
parlino per il proletariato, vindici di quelli che soffrono e hanno sete di
giustizia, ci riempie di disgusto e di orrore». Ed è Primo Levi a puntare contro
il mistero che accompagna spari e vittime, parlando di «buio del Paese
cominciato nel ’69 e sul quale non si è voluto o saputo fare luce». E delinea
«un gioco cinico e spietato che è incominciato a Dallas e che forse non ci sarà
mai dato di capire».
Moro avrebbe impedito
l'implosione del sistema,
scrive Carlo Valentini su "ItaliaOggi" Numero 232 pag. 2 del 30/09/2016. Le
Brigate Rosse sono state sconfitte sul piano militare ma hanno del tutto
modificato il cammino della politica italiana e anche per questo c'è chi
continua a ipotizzare occulte complicità in chi dentro e fuori l'Italia voleva
questa inversione di rotta che aveva un unico protagonista: Aldo Moro. Certo, la
sua strategia era intrecciata a quella di Luigi Berlinguer ma il passo decisivo,
quello di portare la Dc all'incontro col Pci in un governo d'unità nazionale, lo
stava compiendo lui. Sarebbe stato un bene o un male l'incontro tra le due
maggiori forze politiche? Le opinioni, ovviamente, divergono. Ma è indubbio che
quel «governo della nazione» avrebbe fatto scrivere una storia politica diversa
da quella che si è verificata. Bettino Craxi non avrebbe trovato con tanta
facilità la porta aperta verso il governo e i partiti della prima repubblica non
sarebbero crollati in quel modo disastroso. L'occasione per ricordare un delitto
politico fondamentale per capire e interpretare la storia italiana del
dopoguerra è il centenario della nascita di Moro, avvenuta il 23 settembre 1916,
a Maglie, provincia di Lecce. Un anniversario offuscato dalla lettera inviata
dalla figlia primogenita, Maria Fida Moro, al presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in cui lamenta di non essere stata coinvolta nelle iniziative
ufficiali di ricordo perché, scrive, unica a difendere la memoria del padre
cercando quelle che considera le verità nascoste dietro il sequestro, un
intreccio di interessi per far fallire il suo disegno politico. Al di là della
dietrologia, è vero che il compromesso storico fu tumulato insieme ad Aldo Moro,
strenuo combattente, dentro e fuori la Dc, ma sempre ispirato da visioni
lungimiranti, guardava al domani e non alla legge finanziaria del giorno dopo.
Era uomo di fede ma in dialettica con la gerarchia, tanto da riuscire a far
superare, almeno a una parte di essa, le perplessità sull'apertura al Pci. La
preghiera funebre di Papa Paolo VI in San Giovanni in Laterano in un certo senso
ufficializzò lo stretto legame che era intercorso tra loro anche quando egli
prese la decisione non facile di quella che chiamò la «strategia
dell'attenzione» verso quel mondo comunista che vedeva non consanguineo ma di
supporto a un cambiamento che i «tempi nuovi» (concetto che ripeteva spesso)
rendevano indispensabile per evitare quello che poi, senza di lui, avvenne:
l'implosione del sistema politico.
«Moro non fu ucciso nel
bagagliaio della Renault 4».
Gero Grassi rivela le ultime
novità su un caso che lo vede impegnato in prima persona, scrive "Terlizzi Viva"
Giovedì 13 Ottobre 2016. Il parlamentare terlizzese Gero Grassi continua la sua
indagine su Aldo Moro. Uno studio che dura ormai da anni, tra i misteri che
avvolgono ancora il caso del rapimento e dell'assassinio dello statista rapito e
ucciso nel 1978. L'onorevole Grassi, componente della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul rapimento e l'uccisione dello statista pugliese da parte delle
Brigate Rosse, ha fatto di questa storia quasi un centro della sua attività
politica e forse anche della sua vita stessa. Pubblicazioni e convegni in giro
per l'Italia, l'ultimo dei quali l'altro giorno in consiglio regionale davanti a
davanti a numerosi studenti delle scuole superiori baresi. "Siamo ormai all'80%
della verità e stiamo per ricostruire anche il 20% che manca: ad esempio Moro
non è mai stato nella prigione di via Montalcini a Roma, e non è stato ucciso
nel bagagliaio della Renault 4, secondo le nuove perizie balistiche" ha
dichiarato Grassi. Insieme con lui anche Giovanni Pellegrino, già componente
della Commissione Stragi del Parlamento fra il 1994 e il 2001. Grassi da diversi
anni ha dato impulso a nuove ricerche sulla vicenda del rapimento, poi della
detenzione e infine dell'omicidio di Aldo Moro, riassumendo in favore dei
giovani presenti le numerose novità che stanno emergendo, grazie alla
desecretazione dei documenti riservati promossa dal Governo nel 2016. "Sul caso
ci sono ben 4 milioni e mezzo di pagine processuali e delle diverse Commissioni
che se ne sono occupate - ha ricordato Grassi - e oggi sappiamo che sul luogo
del rapimento non c'erano solo i terroristi delle Brigate Rosse ma anche altre
persone. Lo sappiamo dopo aver indagato, ad esempio, sul Bar Olivetti, che
sorgeva alle spalle della siepe di via Fani da cui i terroristi avrebbero
sparato, e di cui mai nessuno si era occupato prima. Anche le circostanze
dell'esecuzione sono totalmente diverse da come gli esecutori le hanno
raccontate, così come è accertato che Aldo Moro non sia morto subito, secondo
analisi fatte oggi con moderni strumenti di rilevazione dai Ris dei Carabinieri.
Dobbiamo ricostruire oggi la verità come debito che abbiamo verso le future
generazioni". "L'Italia di quegli anni era su una tragica frontiera nel pieno
della Guerra Fredda - ha detto a sua volta il senatore Pellegrino - e Moro è
stato vittima di una sorta di 'patto di indicibilità' fra le due parti in
guerra. La Prima repubblica è stata una democrazia difficile dove tante cose si
sapevano, ma semplicemente non si potevano dire. Moro era visto come il fumo
negli occhi sia dagli Usa che dall'URSS con la sua politica tesa a voler
spostare in avanti gli equilibri politici del Paese aprendo al Partito
Comunista". "Moro fu ucciso dalle Brigate Rosse -ha ribadito - ma anche
dall'altra parte della barricata si fece un calcolo costi/benefici tra Moro
libero e Moro morto: si decise che se lo statista fosse tornato libero avrebbe
fatto più danni all'equilibrio internazionale".
Mafia, organizzazioni
segrete, Stati Uniti: il caso Moro non finisce mai.
Il Presidente della Democrazia Cristiana poteva essere salvato: lo Stato
conosceva il luogo della prigione e aveva i contatti per trattare, ma Moro era
una figura scomoda per molti, in Italia e all'estero, scrive Federico Fornaro il
15 Ottobre 2016 su “L’Inkiesta”. Nel marzo del 1978 quando nella capitale si
perpetrò il più drammatico e sconvolgente omicidio politico della storia
dell'Italia repubblicana, con il rapimento e l'assassinio del Presidente della
Democrazia Cristiana, Aldo Moro, e dei cinque uomini della sua scorta, Antonio
Cornacchia comandava il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma.
Cornacchia, pugliese, classe 1931, ha recentemente dato alle stampe per
l'Editoriale Sometti di Mantova un libro sulla sua lunga carriera di servitore
dello Stato, prima nell'arma dei Carabinieri e poi nei servizi segreti militari,
dal titoloAirone 1 Retroscena di un'epoca, a cura di Angelo Giannelli Benvenuti.
Nei giorni scorsi, inoltre, il generale Cornacchia è stato ascoltato dalla
Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo
Moro; un'audizione che ha arricchito di alcuni particolari sia il racconto sia i
giudizi espressi nel libro. Nel suo libro Cornacchia, ad esempio, è tornato sui
viaggi che Mario Moretti avrebbe fatto «in compagnia di Giovanna Currò (Barbara
Balzarani?)» in Sicilia e in Calabria tra il novembre 1975 e il febbraio 1976,
ricordando come il pregiudicato calabrese Aurelio Aquino, al momento del suo
arresto, fosse stato trovato in possesso di «banconote appartenenti al riscatto,
versato alle BR proprio di Moretti, per la liberazione dell'armatore Costa». Una
pista, quella dei rapporti tra BR e criminalità organizzata a cui gli
investigatori dell'epoca non dettero mai troppa importanza, nonostante una voce
indicasse tra i presenti in via Fani il mattino del 16 marzo 1978 un esponente
della famiglia Nirta, il giovane Antonio "due nasi", classe 1946. Una presenza
tra la folla di curiosi che il lavoro della Commissione parlamentare d'Inchiesta
consente oggi di poter confermare con ragionevole certezza, anche se è ancora in
via di accertamento se e quale ruolo Nirta potrebbe aver avuto nella dinamica
dell'agguato. Sia nel libro sia nell'audizione in Commissione, Cornacchia ha
confermato, inoltre, che nei giorni immediatamente successivi furono molteplici
i tentativi di contatto per trovare la prigione di Moro in particolare con «i
mafiosi Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, Pippo Calò; Franco Giuseppucci,
Danilo Abbruciati, Nicolino Selis della banda della Magliana; Francis Turatello,
figlio naturale di Frank Coppola, collegato alla stessa banda». Si scelse di non
intervenire, lasciando le cose al loro destino. Lasciando che Moro venisse
ucciso. Chi fa fuori Moro? Le BR? Mah... Non lo so. Come noto, poi, arriverà un
contrordine e Cornacchia si spinge a scrivere che «la malavita, dunque aveva
avuto il compito di eseguire quella sentenza (conseguenza della linea della
fermezza ndr), di gestire, cioè, il piano d'azione così come mutato e
programmato». Cornacchia conferma, poi, autorevolmente che sul teatro romano si
mosse anche l'organizzazione supersegreta, detta Noto Servizio, o Anello, di cui
verrà scoperta l'esistenza solo nel 1996. «C'è una organizzazione segreta e
clandestina italiana - si legge nel libro Airone 1 - composta da ex-ufficiali
della RSI, ex-ufficiali badogliani, imprenditori, industriali, soggetto del
mondo politico ed economico, della malavita e della criminalità comune
organizzata che funge da collegamento tra gerarchie politiche e civili, e tra
gerarchie militari e servizi segreti, usata in funzione anticomunista». A capo
dell'Anello, nel 1978, c'era Adalberto Titta, che a detta di Michele Ristuccia,
altro esponente dell'organizzazione, «è a conoscenza del luogo ove Moro è
detenuto per essere riuscito ad avere contatti con esponenti delle BR»; ma anche
lui, secondo Cornacchia, «viene fortemente ostacolato dal potere politico da cui
dipende, e cioè dalla Presidenza del Consiglio», leggi Andreotti. Altro
esponente dell'Anello che si diede da fare per liberare Moro fu il francescano
Padre Enrico Zucca, che era balzato agli onori della cronaca, nel maggio 1946,
per aver nascosto a Milano, la salma di Mussolini, trafugata da un gruppo di
neofascisti. Cornacchia racconta di un suo viaggio, la sera del 6 maggio 1978,
in compagnia di Padre Zucca e dell'ispettore dei cappellani delle carceri
italiane dell'epoca, don Cesare Curioni, con destinazione la sede estiva
pontificia di Castel Gandolfo: «Alle 7.30 del 6 sera (...) vedo il segretario
del Papa rispondere al telefono, convinto, forse, sia il segnale per la
conclusione delle trattative e la consegna del cofanetto pieno di soldi, ma
quando depone la cornetta, pallido in volto, ci informa che "Tutto è andato a
monte". Le parole di circostanza non servono a sapere niente di più, ma non è
questo il problema, il dramma è che anche a Sua Santità viene preclusa la
possibilità di liberare Moro». Ancora più enigmatica è la dichiarazione
all'Ansa, riportata da Cornacchia, di un altro personaggio di rilievo
dell'Anello, il professor Petroni: «Eravamo pronti a liberare Moro senza
problemi. La politica ci ha sbarrato la strada affinché non
intervenissimo. C'era l'ordine superiore di non intervenire. Moro, d'altra parte
se l'è proprio cercata. Nel '62 a Napoli vara il centro-sinistra per isolare i
comunisti e nel '78 li porta al governo. Un dato è certo: alle cancellerie
internazionali Moro non piaceva per nulla. Kissinger non lo poteva vedere. Aveva
espressioni durissime per Moro, il quale dava fastidio in Italia, ma anche
all'estero. Si scelse di non intervenire, lasciando le cose al loro destino.
Lasciando che Moro venisse ucciso. Chi fa fuori Moro? Le BR? Mah... Non lo so».
E dire che c'è chi sostiene che la nuova Commissione d'Inchiesta sul caso Moro
sia solo una perdita di tempo, perché è tutto chiaro, nessun mistero.
TRENTOTTO ANNI SENZA UNA
VERITÀ SULLA MORTE DI MORO O CON TROPPE VERITÀ.
Le commissioni parlamentari verso la verità su Moro, scrive “Stato Quotidiano”
il 10 ottobre 2016. Dopo quasi quarant'anni tante domande restano senza
risposta. Trentotto anni senza una verità sulla morte di Moro o con troppe
verità. Un patto omertoso tra brigatisti e pezzi dello Stato ha fatto calare una
cortina di segreti, depistaggi, bugie. Oggi, grazie al lavoro di due commissioni
parlamentari – una tuttora in attività – si comincia ad avere la sensazione di
poter venire a capo di quanto è successo, dove, come e perché è stato compiuto.
Si comincia a vedere la luce nel buio di uno dei più grandi misteri della storia
d’Italia: il direttore di Telenorba, Enzo Magistà, lo ha fatto presente aprendo
nella sua veste di moderatore del convegno che la Presidenza del Consiglio
regionale ha voluto organizzare a conclusione delle celebrazioni del centenario
della nascita dello statista di Maglie, assassinato nel 1978. Un evento promosso
con l’Associazione consiglieri regionali e la Federazione centri studi Moro, in
un’Aula consiliare gremita di studenti, dello scientifico “Amaldi” di Bitetto e
dei commerciali “Giordano” di Bitonto e “Salvemini” di Molfetta. Dopo quasi
quarant’anni tante domande restano senza risposta. “Abbiamo deciso di completare
il ricordo di Moro – ha introdotto il presidente del Consiglio regionale Mario
Loizzo – parlando dei tanti misteri e reticenze che ancora circondano i fatti di
via Fani e mettendo a confronto due personalità autorevoli che alla ricerca
sulla tragedia e sulle trame oscure continuano a dedicare un impegno ammirevole
e nello stesso tempo utile nel percorso verso la verità”, il sen. Giovanni
Pellegrino, già presidente della Commissione stragi e il deputato Gero Grassi,
componente dell’attuale Commissione di inchiesta sul caso Moro. Un’iniziativa
“coraggiosa”, quella del parlamento pugliese, ha sottolineato l’on. Grassi,
perché “è importante discutere dell’uccisione di Moro in una sede istituzionale
qual è il Consiglio regionale della Puglia. In una realtà distonica come quella
italiana è una scelta forte parlare del mistero Moro, mentre si preferisce
parlare solo del pensiero di Moro”. Il sen. Pellegrino ha ricostruito lo
scenario in cui è maturata la vicenda è stato, rendendo pienamente la “tragicità
della situazione italiana dell’epoca”. Il Paese era una frontiera della Guerra
Fredda, diviso politicamente a metà tra due grandi partiti: la DC, espressione
del blocco occidentale e il PCI di quello sovietico. Il tentativo di farli
collaborare non poteva passare: Moro per questo era visto come fumo negli occhi
da entrambi gli schieramenti internazionali opposti, ha osservato il senatore.
“Rischiava di far saltare gli equilibri precari su cui si reggeva la democrazia
della prima Repubblica. Il “patto reciproco di indicibilità” che vigeva allora
ha fatto il resto, occultando ogni verità. La sua sorte, secondo Pellegrino, “è
stata segnata da un calcolo costi-benefici tra Moro libero e Moro ucciso,
condotto da una parte e dall’altra della barricata”. Il lavoro della bicamerale
stragi si è scontrato contro veti incrociati, quello della commissione di cui fa
parte l’on. Grassi ha dalla sua però tecniche inedite d’investigazione
scientifica e si avvale della desecretazione degli atti disposta dal Governo
nazionale. “La verità l’avremmo già avuta se tutti avessero fatto il loro dovere
per intero”, ha sostenuto Grassi. “Ora siamo all’80%, i lavori precedenti erano
stati costretti a fermarsi al 20%, ma grazie all’impegno passato e presente del
Parlamento (4 milioni e mezzo di pagine) Moro sta finalmente uscendo dalla
Renault rossa in cui il potere ha voluto lasciarlo”. Ed oggi, ha concluso, “nel
Consiglio regionale della sua Puglia, abbiamo raccontato un pezzo di storia non
senza qualche pugno nello stomaco, in attesa di poterla raccontare tutta”.
Commissione Moro,
coordinamento con Procura generale per ricostruire strage di via Fani. Arriva pm
che indagò su Brescia.
Francesco Piantoni ha lavorato tenacemente per individuare le responsabilità
sulla bomba di piazza della Loggia. A fine ottobre le audizioni del capo della
Procura di Reggio, Federico Cafiero de Raho, e del suo sostituto, Giovanni
Lombardo, per capire se c'è stato un coinvolgimento della 'ndrangheta, scrive
Stefania Limiti il 29 settembre 2016 su “Il Fatto Quotidiano”. La scorsa
settimana il capo della Procura generale di Roma, Giovanni Salvi, ha trascorso
parecchio tempo nell’ufficio del presidente della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul caso Moro, Giuseppe Fioroni. Scopo dell’incontro il
coordinamento delle azioni investigative finalizzate a scoprire quel che non è
ancora chiaro (tanto) della dinamica della strage di via Fani e dell’assassinio
del presidente della Dc. La collaborazione tra i due uffici è avviata da tempo
ma ora la novità è l’arrivo alla Procura generale di Roma di una grande
professionalità come quella assicurata da Francesco Piantoni che lascia la
Procura di Brescia dove ha testardamente e incessantemente lavorato per
ricostruire le responsabilità della strage di Piazza della Loggia. Piantoni
trova a Roma il collega Otello Lupacchini, grande esperto di eversione di destra
e criminalità organizzata, oltre allo stesso Salvi e alla dottoressa Laura
Tintisona, della Polizia di Stato, ufficiale di collegamento con la Commissione
parlamentare. Quest’ultima continuerà ad avere uno sguardo anche alla
ricostruzione storica del caso, terreno estraneo al lavoro dei magistrati della
Procura che cercando di scavare, in particolare, da quel che si apprende, dentro
i segreti delle strutture occulte come Gladio e del loro possibile
coinvolgimento nel caso Moro. Dove porterà tutto questo lavoro? Se non mancano
osservatori critici che lamentano la scarsa concretezza delle acquisizioni fin
qui ottenute dal lavoro dell’organismo parlamentare, occorre tuttavia ricordare
che numerose dichiarazioni dei commissari e dello stesso presidente evidenziano
la certezza di aver smantellato tutto il falso raccolto dei fatti proposto dal
Memoriale di Valerio Morucci, avallato dal capo brigatista Mario Moretti e dal
protagonista democristiano della ‘narrazione’ (taroccata) del caso Moro, Remigio
Cavedon, all’epoca della stesura del Memoriale (1984) vice direttore de Il
Popolo. Punto per punto, a cominciare dal numero dei partecipanti all’agguato di
via Fani, quel racconto sarà oggetto della prossima relazione della Commissione
attesa per fine anno (l’altra è stata fatta lo scorso dicembre). Del resto, per
chi voglia esercitarsi nelle critiche, suggeriamo di non scegliere il terreno
dei costi: la legge istitutiva della Commissione (82/2014) stanzia 17.500 euro
per l’anno 2014, 35.000 per il 2015 e 17.500 per il 2016 – metà a carico del
bilancio interno del Senato, metà a carico di quello della Camera. Le spese
sostenute dalla Commissione nel 2015 ammontano a circa 7.500 mentre nel 2016,
fino ad oggi, a circa 12.300 euro. Non molto se si considera che la posta in
gioco è la ricostruzione del delitto politico più importante del Novecento
italiano. Il compito di una Commissione parlamentare è quello di contribuire
alla comprensione dei fenomeni oggetto della propria ricerca: ad esempio, il
precedente organismo guidato dal senatore Giovanni Pellegrino, noto come
Commissione Stragi, non riuscì a votare un documento conclusivo ma scrisse
pagine fondamentali per la nostra attuale conoscenza della strategia della
tensione.
Vedremo, dunque, se l’attuale
Commissione Moro saprà essere all’altezza del suo importante mandato. A
proposito di novità, sarà molto interessante ascoltare le audizioni del capo
della Procura di Reggio, Federico Cafiero de Raho, e del suo sostituto, Giovanni
Lombardo, previste per la fine di ottobre: si parlerò di ‘ndrangheta e il caso
Moro. Il 27 torna a parlare Alberto Franceschini, l’ex Br arrestato nel 1974 che
ha dato un grande contribuito di analisi e comprensione del fenomeno brigatista,
delle sue origini e dei suoi torbidi inquinamenti.
L'indagine infinita. Dopo
38 anni rispunta via Gradoli,
scrive Paolo Persichetti il 21 ottobre 2016 su "Il Dubbio". I membri di palazzo
san Macuto vogliono sapere chi di loro è disponibile a fornire il proprio
profilo genetico per effettuare delle indagini comparative su alcuni reperti.
Convocati anche alcuni membri dell'esecutivo brigatista dell'epoca, come il
semilibero Mario Moretti. Da alcuni giorni gli uffici Digos della maggiori città
italiane stanno convocando molti ex brigatisti su mandato della commissione
parlamentare che indaga ancora, dopo quasi 39 anni, sul rapimento e la morte di
Moro. I commissari di san Macuto vogliono sapere chi di loro è disponibile a
fornire il proprio profilo genetico per effettuare delle indagini comparative su
alcuni reperti: molto probabilmente si tratta di quelli rinvenuti nella base di
via Gradoli, nella Fiat 128 giardinetta con targa diplomatica che la mattina del
16 marzo bloccò in via Fani l'auto di Moro e della scorta e delle tracce
ematiche e di alcuni bossoli rinvenuti nella Renault 4 rossa, dove il presidente
della Dc venne ucciso, trasportato e fatto ritrovare in via Caetani, a metà
strada tra i palazzi della Dc e del Pci che lo avevano decretato morto dopo le
sue prime lettere. Non tutti i nomi che fino ad ora sono trapelati risultano
coinvolti nelle inchieste che in passato hanno riguardato il rapimento e
l'uccisione del leader democristiano. Tra questi ci sono Giovanni Senzani e
Paolo Baschieri, il che fa pensare al tentativo di dare vita ad una pista
toscana. Sono stati convocati anche alcuni membri dell'esecutivo brigatista
dell'epoca, come il semilibero Mario Moretti; l'autista della 132 che caricò
Moro in via Fani, Bruno Seghetti; Barbara Balzerani che il 16 marzo controllava
la parte inferiore di via Fani; il responsabile della tipografia di via Pio Foà,
Enrico Triaca, arrestato una settimana dopo il 9 maggio 1978 e torturato la sera
stessa dal professor De Tormentis, quel Nicola Ciocia, funzionario dell'Ucigos,
esperto di waterboarding, la tortura dell'acqua e sale, a cui nessuno chiederà
mai il profilo del dna. Pare che il presidente della Commissione Giuseppe
Fioroni confidi molto nelle indagini scientifiche. Almeno così dichiara in
pubblico. Eppure stando ai risultati prodotti dalla sua commissione non sembra
proprio. Nella relazione sul primo anno di attività, il lavoro svolto dalla
polizia scientifica e dallo Servizio centrale antiterrorismo non è stato tenuto
in grande considerazione. La ricostruzione tridimensionale dell'attacco
brigatista in via Fani, i nuovi studi balistici sugli spari avvenuti quel
giorno, non sono stati apprezzati dalla stragrande maggioranza dei commissari,
che hanno ritenuto il lavoro dei poliziotti troppo "filobrigatista". Risuonano
ancora i commenti sorpresi di fronte alle relazioni dei funzionari Giannini,
Tintisona e Boffi: «Ma state confermando la ricostruzione fatta dalle Brigate
rosse!». Sergio Flamigni, il grande vecchio della dietrologia, non riesce a
trattenere la stizza per un errore così infantile a suo avviso commesso dalla
Commissione, come quello di aver chiesto nuovi accertamenti; lui che è rimasto
affezionato ad un'unica perizia, la prima, quella di Ugolini, la più incerta e
inesatta di tutte, la perizia "cieca" per definizione perché fatta quando ancora
non erano state recuperate le armi impiegate in via Fani, e dunque la più
manipolabile, quella che meglio si addice alle invenzioni dietrologiche del
"superkiller" e dello "sparatore da destra". In via Gradoli la Commissione non
ha trovato tracce biologiche di Moro, con buona pace di chi ha sostenuto (e
sostiene ancora) che fosse stato tenuto almeno per un periodo in quella base, ma
ha isolato quattro profili di dna: due femminili e due maschili. Non è un
mistero che in quella che fu la prima casa delle Br a Roma, hanno risieduto
stabilmente almeno tre coppie di militanti: Carla Maria Brioschi e Franco
Bonisoli all'inizio, Adriana Faranda e Valerio Morucci dopo, Barbara Balzerani e
Mario Moretti fino al 18 aprile 1978. Nella 128 con targa diplomatica vennero
trovati ben 39 mozziconi di sigaretta. I responsabili del Ris che hanno in
carico le analisi dovranno scoprire chi furono i fumatori: i proprietari
effettivi del mezzo rubato dai brigatisti e/o i brigatisti stessi? Quali e
quanti? L'informazione, ammesso che giunga, comunque non ci dirà nulla di certo
sulla mattina del 16 marzo, perché quel mezzo venne usato nelle settimane
precedenti. Il dna non ha data e ora. E dunque a cosa serve tutto questo
dispendio di energie e soldi pubblici (l'estrazione del dna e la sua
comparazione è una procedura di laboratorio che costa molto) quando sulla
vicenda Moro si continua a non vedere la storia politica di quella vicenda, le
ragioni che spinsero Dc e Pci a rifiutare la trattativa? Forse più che cercare
nuovi brigatisti, con il dna qualcuno sogna in cuor suo di trovare il non
brigatista. Fioroni, che ha auspicato «un contributo alla corretta ricostruzione
dei fatti» anche da parte di chi è stato condannato, non troverà la
disponibilità degli ex militanti, i più hanno già declinato la richiesta. Perché
mai dovrebbero accettare? Nella relazione del dicembre scorso, la Commissione ha
dovuto riconoscere, foto alla mano, che nessuna moto sparò al testimone Marini,
che il suo parabrezza non venne colpito da proiettili ma si ruppe nei giorni
precedenti per una caduta del motorino dal cavalletto. Non risulta che Fioroni
abbia chiesto alla procura di Roma di attivare la revisione della condanna per
tentato omicidio, emessa contro gli imputati del primo processo Moro. Da oltre
un anno pende una richiesta di audizione di Enrico Triaca e di Nicola Ciocia per
la vicenda delle torture, ma il presidente Fioroni fa ostruzionismo e
provocatoriamente manda a chiamare Triaca per chiedergli il dna. Forse vorrà
scoprire in quale caserma venne torturato la notte del 17 maggio 1978? Questa
commissione ha ripetutamente dimostrato di non possedere alcuna credibilità, nei
due anni che ha avuto per guadagnarsela ha dato spazio solo ai peggiori
cialtroni. Per chi dovesse nutrire ancora delle aspettative, vale quanto scrisse
Mario Moretti lo scorso anno in risposta ad una missiva inviatagli dal
presidente Fioroni: «Esauriti definitivamente da decenni tutti gli aspetti
giudiziari - sebbene la mia prigionia perduri da oltre 34 anni, in mancanza di
decisioni liberatorie e conclusive doverose nell'ambito politico - la vicenda
delle Brigate rosse appartiene ormai solo alla riflessione storica. [..] In un
ambito storico-politico e con quanti si sono accostati all'argomento con onesta
intellettuale, la mia disponibilità è stata sempre totale. [?] Per contro, mi
sento estraneo e a disagio nell'ambito delle ricostruzioni faziose che hanno la
loro giustificazione solo nell'interesse politico di chi pensa di trarne
vantaggio».
Sequestro Moro, il
colonnello Cornacchia: “Rapporti Br-‘ndrangheta? Diedi tutto al pm Infelisi”.
In
commissione l'audizione dell'ufficiale dei carabinieri, iscritto alla P2:
"Un'informatrice ci rivelò tra Mario Moretti e i capi della criminalità
calabrese", scrive Stefania Limiti il 12 ottobre 2016 su "Il Fatto Quotidiano”.
Nadia era una tipa esuberante, faceva la redattrice di Controinformazione: era
proprio lei – “assomigliava tanto ad Anna Magnani” dice a
ilfattoquotidiano.it Antonio Cornacchia al termine della sua testimonianza
in commissione Moro – l’infiltrata che gli fece scoprire già tra il 1976 e il
1977 le audaci relazioni del capo delle Br, Mario Moretti, con gli uomini della
‘ndrangheta. Di quelle informative fatte realizzare da Cornacchia, allora
comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri, poi braccio destro di dalla
Chiesa, si perse poi ogni traccia – in Sicilia si mise alle calcagna del capo
brigatista un investigatore di prim’ordine, il colonnello Giuseppe Russo,
ammazzato dalla mafia nei pressi di Corleone il 20 agosto del ’77. Cornacchia,
presunto piduista (“generale le dice niente il numero 871?”, gli dice il
commissario Gero Grassi rinfrescandogli la memoria della sua tessera di
appartenenza alla Loggia), aveva del resto realizzato un importante indagine in
quello stesso periodo sul traffico di armi che coinvolgeva un certo Luigi
Guardigli e Tullio Olivetti, proprietario del bar che si trovava di fronte al
luogo dell’agguato ad Aldo Moro e alla sua scorta e che sempre più
pressantemente emerge come la base usata dal commando brigatista. Tuttavia,
Olivetti incredibilmente fu sottratto a ogni indagine, il suo nome cancellato, e
il suo bar fu fatto miracolosamente uscire dalla ‘scena del crimine’ con due
parole magiche: era chiuso. Punto. In realtà, era un luogo nevralgico, come sta
emergendo dalle indagini in corso alle quali, da quanto si apprende, partecipa
anche il procuratore di Roma Pignatone, oltre che la Procura generale della
Capitale, dove si vendevano armi di tipo ‘scenico’, apparentemente armi
giocattolo con un corpo centrale in plastica che venivano poi adattate dentro
laboratori clandestini. Ma di tutto questo per quale motivo durante i 55 giorni
non si tenne conto? “Ma non so… io avevo dato tutto al Procuratore Infelisi, era
lui che seguiva le indagini sul rapimento di Moro”, ha sostenuto Cornacchia.
“Per quel che sia sa, Infelisi durante la prigionia di Moro si recò in Calabria,
disse che doveva scegliere la sua casa per le vacanze estive” fa notare il
presidente Fioroni che attorno alle novità sul ruolo della ndrangheta e sul bar
Olivetti fa ruotare una parte della ricostruzione fino ad ora negata del caso
Moro. “Certamente si tratta di un aspetto importante, nella relazione di
dicembre dimostreremo che le Br usarono gli appoggi e le armi della ‘ndrangheta,
ma non è questo il cuore del caso Moro”, fa notare un commissario che preferisce
restare anonimo. Il prossimo 3 novembre Cornacchia tornerà a dire la sua. Sarà
la tappa finale di una lunga audizione piena di non detti, anche se il generale
si è fatto scappare un particolare che non aveva mai rivelato: padre Zucca, una
figura di notevole spessore, cappellano del servizio segreto clandestino
chiamato l’Anello (le informative che lo svelarono si riferiscono al Noto
Servizio) aveva preso parte attivamente alla trattativa svolta dal Vaticano. Una
circostanza cruciale, di cui padre Zucca parlò pubblicamente in due intervista a
L’Espresso subito dopo il 9 maggio, completamente inabissata, non considerata né
dalla magistratura né dalle precedenti Commissioni parlamentari e il motivo è
semplice: l’argomento era top secret, non si poteva parlare dell’Anello, di cui
il generale Cornacchia, ci confida al margine dell’audizione, aveva anche
conosciuto anche la figura centrale, Adalberto Titta, il fac totum di un
servizio segreto che ha ripulito gli affari sporchi della Repubblica .
Terrorismo e crimine
organizzato, la joint venture ultrasegreta,
scrive Alberto Di Pisa il 15 ottobre 2016 su "Sicilia Informazioni". Il generale
Antonio Cornacchia, oggi ultraottantenne, iscritto alla P2 di Licio Gelli
(tessera numero 871) e nel 1978 comandante del Nucleo investigativo dei
carabinieri, sentito di recente in commissione Moro, ha riferito di rapporti tra
le Brigate rosse e la ‘Ndrangheta e in particolare, come da lui riferito al
“Fatto Quotidiano”, al termine della sua audizione, di avere appreso, da una
informatrice, tale Nadia (redattrice di Controinformazione) di rapporti tra il
capo delle BR Mario Moretti ed esponenti della n’drangheta. Su tali collegamenti
sembra siano attualmente in corso indagini da parte della Procura della
Repubblica di Roma. Il generale Cornacchia fu il primo, il 9 maggio del 1978, ad
arrivare in via Caetani dove era parcheggiata la Renault rossa all’interno della
quale si trovava il corpo di Aldo Moro. Sul posto arrivò insieme a Francesco
Cossiga e al capo dell’Ufficio politico Domenico Spinella. Il coinvolgimento
della ‘ndrangheta così come della mafia o di altre organizzazioni criminali come
ad esempio la banda della Magliana, nel sequestro Moro, costituì all’epoca dei
fatti e negli anni successivi, oggetto di indagini anche a seguito delle
dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Tale ipotizzato
coinvolgimento, risultato controverso, non portò però a risultati concreti o
forse non furono le indagini adeguatamente approfondite. Il primo a parlare del
coinvolgimento della ‘ndrangheta nel sequestro Moro fu il boss Saverio Morabito,
esponente di spicco di tale organizzazione. Divenuto collaboratore di giustizia,
tra le altre propalazioni riguardanti la mafia e la ‘ndrangheta, parlò anche del
sequestro Moro affermando che nel commando di via Fani era presente Antonio
Nirta, capocosca della n’drangheta ed infiltrato dei Servizi segreti, cosa che
avrebbe appreso da Domenico Papalia e Paolo Sergi. Entrambi esponenti di rilievo
di una potente ndrina calabrese originaria di Plati e secondo i quali il Nirta
era un informatore del Generale dei carabinieri Francesco Delfino. Si legge
infatti nei verbali del Morabito: “Nirta era da sempre un suo informatore (di
Delfino n.d.r.), l’aveva aiutato a risolvere molti sequestri di persona. Quel
giorno in via Fani c’era anche Antonio “Due Nasi, si Antonio Nirta”. Ma il
Morabito disse di più e cioè che il Nirta si trovava in via Fani il giorno del
rapimento di Moro non perché richiesto dalle Brigate Rosse bensì perché
richiesto dal generale Delfino. A tale affermazione quest’ultimo rispose: “C’è
senz’altro un errore. Non ero io quello che aveva infiltrati nelle Brigate
Rosse”. Che il Nirta fosse un confidente del Generale Delfino lo disse anche il
collaboratore di giustizia Ubaldo Lauro:”….a dire del Palamara, Antonio Nirta
era un infame e confidente del Generale Delfino”. Ed ancora: “Nirta e i Di
Stefano erano infami tragediatori e legati ai servizi segreti dice Pasquale
Condello…E Pasquale dice realtà”. A confermare poi la presenza del Nirta sul
luogo dell’agguato vi sarebbe stata anche una foto, scattata nei minuti
immediatamente successivi al sequestro, quando in via Fani non era ancora
arrivata la prima volante della Polizia, foto che testimonierebbe della presenza
del Nirta. La foto venne scattata direttamente dalla strada da Gherardo Nucci
che abitava al numero 109 di via Fani. Il Nucci dichiarò inoltre che, dopo avere
scattato le fotografie dalla strada, era tornato a casa dove, dal terrazzo,
aveva fatto altre foto mentre cominciavano ad arrivare le prime auto della
Polizia. Aveva quindi consegnato, lo stesso giorno, il rullino da sviluppare
alla moglie, una giornalista dell’ASCA, agenzia vicina alla DC, che recatasi in
Procura le aveva consegnate al Sostituto Luciano Infelisi che coordinava le
indagini sul sequestro Moro, Tali foto finirono nel dimenticatoio. Sembra
peraltro che dal rullino sviluppato mancassero i negativi relativi alle foto di
via Fani che non furono più ritrovati. Luciano Infelisi, sentito in proposito
dalla Commissione Fioroni, riferì che quelle foto non furono acquisite agli atti
perché prive di un qualsiasi valore probatorio. Ma il collaboratore Ubaldo
Lauro, dopo avere spiegato che “Nirta era uomo dei servizi” lo riconobbe nella
foto, l’unica esistente (oltre quella negli uffici della Questura) acquisita
dall’archivio del Messaggero dai giudici di Perugia che indagavano sull’omicidio
Pecorelli e scattata dal Nucci in via Fani il giorno dell’agguato. Tuttavia il
sospetto della presenza in quelle foto di esponenti della ‘ndrangheta è
avvalorato da una conversazione intercettata l’1 maggio 1978 tra Benito Cazora,
parlamentare della Democrazia cristiana e Sereno Freato. Cazora era stato
incaricato dalla Dc di cercare di contattare elementi della n’drangheta nel
tentativo di avere informazioni sul luogo in cui si trovava prigioniero
l’onorevole Aldo Moro e la ndrangheta gli aveva promesso di aiutarlo ad
individuare la prigione di Moro. La conversazione fu del seguente tenore:
CAZORA: “Un’altra questione,
non so se posso dirtelo.”
FREATO: “Si, si, capiamo”.
CAZORA: “Mi servono le foto
del 16, del 16 marzo".
FREATO: “Quelle del posto,
lì?”
CAZORA: “Si, perché loro
(nastro parzialmente cancellato)…perchè uno stia proprio lì, mi è stato
comunicato da giù”.
FREATO: “E’ che non ci
sono…ah, le foto di quelli, dei nove”.
CAZORA: “No, No! Dalla
Calabria mi hanno telefonato per avvertire che in una foto presa sul posto
quella mattina lì, si individua un personaggio…noto a loro”.
FREATO: “Capito. E’ un po’ un
problema adesso”.
CAZORA: “Per questo ieri sera
ti avevo telefonato. Come si può fare?
FREATO: “Bisogna richiedere un
momento, sentire”.
CAZORA: Dire al ministro”.
FREATO: “Saran tante!”
Certamente quando Cazora parla
di un personaggio a loro noto si riferisce alla ‘ndrangheta e probabilmente a un
loro affiliato e si intuisce dalla conversazione che la ‘ndrangheta aveva
interesse a che quelle foto non circolassero. Dopo questa telefonata Freato si
rivolse al ministro dell’interno Cossiga per cercare di recuperare le foto che
gli aveva richiesto il Cazora, ma inutilmente. Si comprende l’importanza che
tali foto avrebbero rivestito per le indagini, non soltanto per individuare
eventuali falle nelle indagini stesse effettuate nelle ore immediatamente
successive al sequestro, ma soprattutto per accertare la presenza in via Fani,
il 16 marzo del 1978 di esponenti della ‘ndrangheta. Un cronista dell’Unità poi,
come scrive Antonio Giangrande nel suo libro sul sequestro Moro, avrebbe notato
nelle stanze della Questura una gigantografia di quelle foto appese “con i volti
dei personaggi sullo sfondo cerchiati in rosso anche se negli archivi non ce n’è
traccia. Un cerchio rosso avrebbe indicato proprio Antonio Nirta” I magistrati
di Milano, non avendo trovato riscontri alle dichiarazioni del Morabito
archiviarono la vicenda. Lo stesso pubblico ministero del processo Moro quater,
Antonio Marini, si mostrò scettico sulla possibilità che la ‘ndrangheta avesse
avuto un ruolo attivo in via Fani e in particolare sulla presenza di Antonio
Nirta sul luogo dell’agguato. Sostenne che le dichiarazioni di Morabito non
erano da ritenersi attendibili e che forse si trattava di una azione di
depistaggio. In ogni caso si trattava di dichiarazioni che non avevano avuto un
riscontro processuale. Certo il Morabito dovette trovare una notevole
credibilità presso i giudici se la sua collaborazione che si protrasse per circa
un anno riempiendo circa 1200 pagine di verbali, coinvolgendo avvocati,
magistrati, carabinieri, massoni e politici, sfociò nella emissione di 221
ordini di cattura nei confronti di altrettanti imputati, 85 dei quali arrestati
e sedici rimasti latitanti. Il generale Delfino, che l’anno precedente aveva
arrestato Balduccio Di Maggio (che consentì l’arresto di Totò Riina) ricevette
una informazione di garanzia perché indagato per favoreggiamento e occultamento
di documenti nei confronti proprio di Antonio Nirta che sarebbe stato un suo
informatore. In particolare veniva contestato al Generale di avere favorito
Antonio Nirta, sottraendo da un fascicolo processuale una sua fotografia con i
complici mentre stavano telefonando alla famiglia di un sequestrato.
Intervistato da un giornalista del Corriere della Sera escluse categoricamente
di avere mai avuto tra i suoi confidenti il Nirta affermando di potere
dimostrare che quest’ultimo non era mai stato un suo informatore e dichiarava:
“Mi chiedo a chi giova che io venga screditato. La mafia e la ‘ndrangheta hanno
subito durissimi colpi. Alla Commissione antimafia (…) ho consegnato proprio
nelle mani del presidente Luciano Violante la mappa delle cosche del Piemonte e
della Val d’Aosta collegate con la Calabria e con la Sicilia. Alcune di esse,
anzi quelle che fanno capo ai Nirta sono in rapporto col “cartello di Medellin.
Il collegamento sarebbe quindi plausibile. Ma è la magistratura a dovere
chiarire tutto. Io posso solo ribadire, ora, che non ho mai avuto un confidente,
né ho mai conosciuto alcuno di nome Nirta…” Va tuttavia evidenziato come nel
corso dell’interrogatorio svoltosi per circa cinque ore nell’ufficio del Pm di
Milano Alberto Nobili, il generale Delfino finì per fare una mezza ammissione in
quanto, pur escludendo di avere utilizzato il Nirta come suo confidente, disse
di non essere in grado di escludere che il Nirta potesse essere stato utilizzato
da altri come confidente e pur non dicendo nulla su chi potessero essere “gli
altri”, affermò che qualche risposta ai dubbi di Morabito avrebbe potuto darla
il Generale Dalla Chiesa. Nel maggio del 2008 Delfino venne rinviato a giudizio
con l’accusa di concorso nella strage di piazza della Loggia. Sia in primo grado
che in appello venne assolto ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., formula con
cui l’imputato viene assolto allorquando le prove raccolte a suo carico non sono
sufficienti per addivenire ad una condanna. Ma che le Brigate Rosse non abbiamo
avuto niente a che fare con la criminalità organizzata lo sostenne anche l’ex
brigatista rosso Franco Bonisoli che partecipò all’agguato di via Fani: “Basta,
non ne posso più. Ormai si va dietro a chiunque dica qualsiasi cosa sul
sequestro di Aldo Moro. Non si finisce mai. Ma la nostra storia è diversa. E
tutto questo con la nostra storia non c’entra niente”. Bonisoli, condannato
all’ergastolo, si è dissociato dalla lotta armata beneficiando degli sconti di
pena previsti dalla legge. Non si vede quindi quale vantaggio avrebbe potuto
avere nel rivelare i rapporti eventualmente intercorsi tra le BR e la
‘ndrangheta o tra Nirta e il Generale Delfino. Ma anche tra i politici fu
controversa la fondatezza del coinvolgimento di organizzazioni criminali nel
sequestro Moro. Francesco Cossiga, che ai tempi del sequestro Moro era ministro
degli interni, venuto a conoscenza delle dichiarazioni di Morabito, dichiarò al
Tg1: “Se la notizia fosse vera si potrebbe pensare ad un coinvolgimento dello
Stato nell’agguato. Sarebbe spregevole scoprire che ci furono istituzioni al
servizio della mafia. Andrebbe riscritta la Storia d’Italia”. Cossiga non
credette comunque ad infiltrazioni della criminalità nella vicenda Moro. Per lui
la notizia non era neppure verosimile e se si fosse rivelata falsa disse,
significherebbe che “abbiamo organismi investigativi ed inquirenti che hanno
agito con estrema leggerezza”. Di segno opposto la convinzione dell’allora
segretario del Pds Achille Occhetto il quale, alla notizia del coinvolgimento
della criminalità mafiosa nel sequestro dell’on. Aldo Moro dichiarò: “...affiora
la validità delle tesi che noi sosteniamo da tempo e cioè che su quella vicenda
c’è stata la confluenza di corpi separati e deviati dello Stato, di depistaggi”.
Più cauta la presa di posizione di Mino Martinazzoli il quale dichiarò:
“Suggerirei una attesa paziente. C’è bisogno di certezze quindi occorre che
alcune cose siano verificate”. Ed aggiungeva: “C’è un eccesso di dietrologia. Se
qualcosa non va bene subito si pensa ad un complotto. In Italia ci sono più
congiurati che congiure”. Alberto Di Pisa
Caso Moro, l'ex br
Franceschini: "Moretti una spia? Riduttivo, si sentiva Lenin".
Il fondatore br alla Commissione Moro: "Hyperion 'parlamento' degli 007
internazionali". "Dalla Chiesa fu fermato a un passo dalla sconfitta dei
brigatisti". "All'Asinara temevamo di essere uccisi". Fioroni: "Strano il salto
di capacità militare e culturale dopo il suo arresto", scrive Alberto Custodero
il 27 ottobre 2016 su “La Repubblica”. "Spia? Una definizione troppo riduttiva
per Mario Moretti. Io sono convinto che abbia giocato le sue carte in un certo
modo, c'è un livello psicologico da tenere presente, lui crede di essere Lenin,
lui era per alcuni compromessi su cui io non ero d'accordo". In tre ore di
audizione, Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse che fece
poi autocritica, autore, tra l'altro, del libro 'Mara, Renato e io' di Franco
Giustolisi e Pier Vittorio Buffa (in carcere all'Asinara durante il caso Moro),
parla così dell'ex tecnico della Sit-Siemens a capo delle Br che hanno gestito
il sequestro dello statista democristiano. La sua audizione lascia agli atti
della Commissione parlamentare d'inchiesta Moro presieduta da Giuseppe
Fioroni nuovi dubbi su Hyperion, la scuola di lingue francese fondata
da Simioni, Berio e Mulinaris, dopo la rottura con le Br, nella prima metà degli
anni '70. Franceschini avverte: "I dietrologismi non mi interessano, io faccio
una critica politica a Moretti, deve ancora giustificare il fatto che ha
distrutto un'ipotesi politica, in base a una linea politica sballata". "Senza
copertura dei servizi esteri si regge la storia dei 55 giorni?", gli chiedono i
parlamentari della Commissione. "Sono pensieri che ho, ma è importante la
riflessione politica della nostra esperienza", risponde. L'ipotesi che ci
fossero altri personaggi, rispetto a quelli conosciuti e processati, a gestire
l'operazione militare di via Fani e, soprattutto, l'interrogatorio di Aldo Moro,
durante i 55 giorni resta forte. Franceschini, in particolare, ricorda come
seppe dal generale Inzerilli, uomo di Gladio, del "ruolo chiave che
svolgeva Hyperion, (scuola fondata da brigatisti fuoriusciti a Parigi, nel
'77, ndr) una specie di parlamento degli 007, che poneva ai palestinesi le
regole dei servizi internazionali, dai francesi ai tedeschi". Poi un riferimento
al Mossad: "Gli israeliani ci cercarono chiedendoci cosa ci servisse, 'a noi
interessa che voi ci siate, non vogliamo indicare obiettivi, ci dissero. Ma noi
rifiutammo". "I servizi potrebbero aver condizionato il superclan - sottolinea
il fondatore delle Br - . Noi nel '76 siamo finiti, a seguito delle operazioni
del generale Dalla Chiesa. Ma va rilevato come proprio a Dalla Chiesa" a un
passo dalla sconfitta definitiva del brigatismo "gli tolgono il gruppo speciale.
Nel giugno del '76 viene sciolto quel gruppo che teneva insieme magistratura,
intelligence e carabinieri e dava fastidio a tanta gente". "Dal '76 al '78-79
non avviene un arresto. Poi Dalla Chiesa viene richiamato in servizio da
Rognoni, da ottobre del '78 e in due mesi riarresta un sacco di gente. Il
generale non 'chiuse gli infiltrati nel periodo in cui era stato estromesso,
evidentemente", dice ancora Franceschini. Parlando del fondatore di Hyperion,
Corrado Simioni, Franceschini dice che "era personaggio interessante
intellettualmente, uno degli esponenti di punta del Psi a Milano, espulso per
indegnità morale, amico di Craxi. Per anni a Monaco di Baviera a lavorare a
radio libertà, con noi parlava in latino". "Nel '68 aveva fondato comitati di
base del giornalismo, girava il movimento proponendo di fare un quotidiano del
movimento - ricorda Franceschini - facendo capire che i soldi li aveva. Loro
erano borghesi, rampolli della borghesia di destra e sinistra, noi venivamo
dalle fabbriche, invece". Franceschini ricorda ancora come "alcuni di loro
giravano con tesserini delle questure locali e se venivano fermati non avevano
problemi". Il fondatore delle Br dice poi che loro sapevano "degli strani
rapporti di Corrado, lui diceva per esempio che aveva soldi in banca nella
Grecia dei colonnelli, per fare la rivoluzione dovete fare compromessi, ci
diceva". "Nel novembre del '70 ci fu la rottura con noi - aggiunge Franceschini
- lui e altri scomparvero" creando una rete, la Dip, diffusione italiana
periodici, che si occupava di giornali della polizia. "Dopo la rottura con lui
andarono Ivan Maletti, Prospero Gallinari e tanti altri". Franceschini ricorda
che dopo la morte di Feltrinelli "rimaniamo come gattini ciechi, perché lui
gestiva i rapporti con l'esterno. Ci saltarono le relazioni, mentre i rapporti
ora li coltivavano Simioni e gli altri di Hyperion". E si torna a Moretti, che
inizialmente andò con Simioni: "Lui e Corrado avevano rapporto anche
conflittuale, ma Simioni lo stimava capace, penso fosse un suo uomo". Altro
episodio oscuro l'arresto di Curcio e Franceschini l'8 settembre del '74. "Il
giovedì arrivò una telefonata che avvertiva dell'imminente arresto di Curcio,
organizzato per domenica. Levati avverte Moretti, che da giovedì a domenica, non
avverte della soffiata, bastava piazzarsi lì vicino e fermare la nostra macchina
- sottolinea Franceschini - E lui non l'ha fatto". Franceschini poi parla di
Valerio Morucci e di Giovanni Senzani. Per il primo, che disse che sapeva come
Franceschini lo volesse morto dice: "A Nuoro abbiamo fatto insieme la rivolta in
carcere, se volevamo ucciderlo era l'occasione e non l'abbiamo fatto. Sa che le
ha fatto sporche e teme sempre vendette, rispetto alla verità le sue
affermazioni sono sempre molto 'complesse'". Loro cattura, con Faranda nel '79,
una autoconsegna? "Morucci fuggì con 80 milioni delle br romane, lui temeva per
la sua vita, nessuno di noi ha mai rubato". "Altro personaggio interessante è
Senzani - dice parlando del criminologo forlivese - che per me era un perfetto
sconosciuto, viene 'immesso nelle Br, sono personaggi che fanno riferimento a
certe reti". Sulla vicenda della trattativa per la liberazione di Moro,
Franceschini spiega come "noi eravamo per la trattativa, Renato (Curcio, ndr)
per tenersi fuori, ma sapevamo che se ammazzavano Moro avrebbero ucciso anche
noi in carcere, per questo ruotavamo in cella con Curcio, poiché per noi era il
primo che avrebbe fatto quella fine". Franceschini ricorda come fu lo stesso Ugo
la Malfa a dichiarare che se Moro moriva, sarebbe giusto fare come i tedeschi
Stammheim (con alcuni dei capi della Raf, trovati suicidati in carcere, il
giorno dopo l'assassinio del presidente degli industriali tedeschi Hanns-Martin
Schleyer, ndr). "Noi volevamo la chiusura dell'Asinara, come punto di partenza
per trattare la liberazione. Volevamo lo stesso schema del sequestro Sossi, che
per noi era stata una vittoria politica", spiega Franceschini a San Macuto.
Sulla dinamica di Via Fani restano i dubbi: "Per fare operazione Sossi, che era
senza scorta e viaggiava da solo, impiegammo 18 compagni. A via Fani erano in
nove, come dice Morucci, di cui 4 sparatori, affrontarono una scorta che non
credo fosse incapace di difendere Moro. Allora ci si domanda come hanno fatto? I
compagni mi dissero 'l'abbiamo fatta noi, addestrandoci nel cortile di casa,
diceva Gallinari". Il commento di Fioroni. "Sottolineo il richiamo di
Franceschini a non semplificare la complessità del fenomeno eversivo di cui fu
fondatore - ha commentato il presidente della Commissione, Fioroni - ma ad
osservarlo all’interno del contesto geo-politico che ne ha influenzato le
scelte. Inoltre, trovo utili le riflessioni sull’utilizzo degli infiltrati e sul
ruolo del gruppo Hyperion, come l’analisi sulla rapida trasformazione del gruppo
brigatista che, nel volgere di pochi anni, dal '74, anno dell’arresto di
Franceschini, al ’78, acquisisce una sorprendente capacità militare ed anche
culturale, se si pensa agli interrogatori cui fu sottoposto Aldo Moro.
Franceschini ci fa capire esplicitamente che le persone che aveva conosciuto
durante la sua militanza, in sostanza, non avevano quei livelli di operatività”.
I dubbi di Grassi. "Di estremo interesse - sottolinea Gero Grassi, componente
della Commissione - il racconto della nascita del gruppo brigatista e il
passaggio oscuro alla gestione morettiana. Resta una domanda che certamente non
può essere rivolta a lui: perchè gli toccò scontare 18 anni di galera, 21 a
Renato Curcio? Erano accusati di banda armata, non avevano reati di sangue. I
brigatisti condannati come responsabili dell'uccisione di Aldo Moro e della
strage di via Fani se la sono cavata con molto meno". Il parere dello storico.
"Non mi sembra che Franceschini faccia rivelazioni inedite - è il parere dello
storico Federico Imperato, autore di due libri su Aldo Moro, ricercatore in
Storia delle Relazioni e delle Organizzazioni Internazionali - Di Hyperion,
Franceschini aveva già parlato in una audizione in Commissione stragi, nel 1999.
Hyperion era ufficialmente una scuola di lingue a Parigi, in realtà un centro di
collegamento tra gruppi del terrorismo internazionale, ritenuta in contatto
anche con i servizi segreti. Hyperion fu fondata nel 1970 da tre esponenti della
sinistra extraparlamentare italiana: Corrado Simioni, Vanni Mulinaris e Duccio
Berio. I tre ebbero un ruolo agli albori della storia delle Br. Parteciparono,
infatti, nel 1969, ad un convegno del Collettivo Politico Metropolitano, che
decise il passaggio alla lotta armata e la nascita ufficiale delle Brigate
Rosse. Secondo Franceschini, Simioni, Mulinaris e Berio, staccatisi dalle Br,
fondarono prima il Superclan, di cui avrebbero fatto parte Mario Moretti e
Prospero Gallinari, e poi, nel 1970, in Francia, l'Hyperion. Secondo
Franceschini, ancora, il padre di Berio era un famoso medico milanese, legato ai
servizi israeliani. "Il nome di Simioni fatto da Craxi". "Corrado Simioni -
spiega Imperato - è un personaggio interessante. Il suo nome viene fatto per la
prima volta da Craxi a Montecitorio, forse nel 1980: "Non cercate i terroristi
sulla luna, guardatevi intorno, magari tra i vostri compagni di scuola". E
ancora: "Quando si parla del "Grande Vecchio" bisognerebbe riandare indietro con
la memoria, pensare a quei personaggi che avevano cominciato a far politica con
noi e che poi improvvisamente sono scomparsi". Simioni, infatti, aveva militato,
negli anni Cinquanta e Sessanta, nel Psi, faceva parte della corrente
autonomista, ed era in stretti rapporti di collaborazione con Craxi e Silvano
Larini. Poi viene espulso dal Psi, nel 1965; si trasferisce a Monaco di Baviera,
dove collabora con Radio Free Europe. Quindi il ritorno in Italia e l'impegno
nella sinistra extraparlamentare di cui ho già detto. In quegli ambienti,
tuttavia, inizia presto a farsi la fama di doppiogiochista. Secondo Lotta
Continua è un confidente della polizia, mentre in una scheda ritrovata
nell'archivio segreto di Avanguardia operaia si legge: 'Entra tra i primi in
clandestinità anche se all'epoca non ha alcun mandato di cattura a suo carico
(...) era un pezzo grosso a livello di Curcio. Espulso come poliziotto,
probabilmente è del Sid. Secondo Dalla Chiesa 'È un'intelligenza a monte delle
Brigate Rosse'". "Senzani gestì la regia del sequestro". "Anche Giovanni Senzani
è un personaggio interessante - continua Imperato - . Criminologo, docente
dell'Università di Firenze. Secondo Giovanni Pellegrino sarebbe stato lui, da
Firenze, a gestire la regia politica dei 55 giorni del rapimento Moro.
Pellegrino cita anche documenti che confermerebbero i legami tra Senzani e
apparati di sicurezza italiani e stranieri. In particolare, un documento,
anonimo, quindi inutilizzabile nel corso delle indagini, consegnato dal generale
Lee Winter al giornalista Ennio Remondino, secondo cui la stazione di Roma
(della Cia, ndr) ha dato assicurazione al Sops (Special Operation Planning
Staff) che il nuovo collegamento con Parigi, Giovanni Senzani, è sotto
contratto. Probabilmente a lui si riferisce Morucci, in Commissione Stragi,
quando accenna agli irregolari: 'Bisogna chiedersi se c'era un anfitrione o no,
chi era il padrone di casa, chi era l'irregolare, chi batteva a macchina i
comunicati del comitato esecutivo, che poi erano distribuiti in tutta Italia,
sul caso Moro. Certo, ritengo che siano cose che non cambino radicalmente la
questione, ma penso che andrebbero dette".
SEQUESTRO
MORO: LA PISTA DELLA ‘NDRANGHETA.
Che ruolo ha avuto davvero
Giustino De Vuono in via Fani nel caso Aldo Moro?
Scrive Simona Zecchi il 12 luglio 2017 su "Formiche.net". Il sequestro dell’uomo
che poteva cambiare il corso della politica italiana, così come la strage
compiuta della sua scorta e la “consegna” del corpo senza vita in via Caetani il
9 maggio 1978, sono tutte parti complesse di un quadro a oggi, dopo 39 anni di
distanza dai fatti, incompleto. Esistono fatti ed elementi interconessi tra loro
(come a esempio il ruolo internazionale giocato il 16 marzo ’78 e i 55 giorni
seguenti) i quali nel loro insieme sono certo più rilevanti della figura
di Giustino De Vuono sulla quale sin dal maggio scorso Formiche.net ha puntato
indagini e ricerche svelando fatti concreti, incluso il suo volto presente in
via Fani. Non necessariamente De Vuono avrebbe partecipato all’azione del
sequestro, bastava essere lì per supervisionare: un ruolo appunto. L’ex
legionario prestato alla criminalità e all’estremismo politico (che nel 1975
partecipò insieme a elementi di Autonomia Operaia al sequestro
dell’ingegner Carlo Saronio) è un grosso nodo sul quale si stringono più
dinamiche: a partire da via Fani – dove un testimone, Rodolfo Valentino, lo
riconosce – passando per via Gradoli e finendo in via Caetani dove il cerchio si
chiude. Sciogliendolo, l’intero bandolo andrebbe a unire più filamenti.
– Esiste un rapporto di
polizia giudiziaria inviato alla Procura generale che indicava Giustino De Vuono
come l’assassino di Moro. Lo citavano i giornali del tempo in modo dettagliato:
quelle notizie che soltanto inquirenti o forze dell’ordine possono rivelare ai
cronisti. Perché questo rapporto non è agli atti tutti della inchiesta Moro?
– Durante i 55 giorni, un
altro testimone riconobbe De Vuono a bordo di una R4 insieme a una donna (la
stessa R4 di via Caetani?). Da quella testimonianza, come racconta tra le altre
cose l’inchiesta “Morte di un presidente”, emerge un fotofit con il ritratto di
Giustino De Vuono. Perché non ci fu alcun raffronto fra quel fotofit, l’altro
dell’uomo e della donna scesi dalla R4 alle 8,10 della mattina del 9 maggio,
sparito anch’esso dagli atti, con suoi ritratti e foto diffusi e già allora
disponibili? Per compiere un raffronto non servivano particolari tecniche allora
non disponibili.
– Un addetto alle pulizie
riconosce nel palazzo di via Gradoli 96 un uomo “in divisa da spazzino”
fortemente rassomigliante allo “scotennato”. Ne dà conto un libro edito nel 1984
“Operazione Moro” dell’avvocato Giovanni Zupo e di V. Marini Recchia. Di quel
ritratto cosa ne è stato, quali le conclusioni investigative?
– Tra gli elementi che
confermavano in De Vuono l’assassino di Moro (quindi via Caetani), gli
investigatori dell’epoca indicarono una particolare tecnica di sparo a raggera
attorno al cuore, tecnica da lui appresa nella legione straniera. Don Fabio
Fabbri, il braccio destro del cappellano delle carceri Cesare Curioni, nel corso
del 2016 in Commissione Moro, ha ricordato questa stessa tecnica come elemento
che aveva dato la certezza a don Curioni dell’identità dell’omicida calabrese.
Della tecnica ne mostra le evidenze sull’autopsia sempre l’inchiesta “Morte di
un Presidente”. Così don Fabbri alla Commissione: “Io ero lì con lui, come
sempre, le guardammo insieme (le foto della perizia nda.), in tutto erano 5, 6,
forse 8. Si vedeva in modo chiaro che sei colpi erano stati sparati attorno al
cuore di Moro, fotografato separatamente. Curioni ebbe un sussulto, ‘io conosco
il killer, è un professionista, quella è la sua firma”.
– Nel libro “La Borsa di Moro”
(Iuppiter edizioni, 2016) Marcello Altamura riferisce in modo certosino della
testimonianza di Lina Cinzia De Andreis che fa un identitkit di un uomo fermo
davanti al bar Olivetti mentre guarda un orologio e la cui fisionomia richiama
proprio De Vuono: “Alto e con corporatura massiccia, occhi a mandorla molto
grandi e neri, labbra carnose, basettoni, un naso grosso e pronunciato e
orecchie sporgenti. In testa, la coppola di pelle nera con la visiera alzata.”
Identikit presente negli atti Moro ma ignorato.
– Perché le foto di via Fani
dei Gualerzi pubblicate da Formiche.net per la prima volta dopo 39 anni, foto
che ritraevano De Vuono a pochi metri di distanza dal luogo dove era con ogni
probabilità appostato anche Antonio Nirta, il boss di San Luca, sono sparite per
39 anni dagli atti?
– Perché i Carabinieri
consegnano una informativa secretata sulla morte di De Vuono alla Commissione
Moro quando un certificato di decesso ufficiale si sarebbe potuto ottenere così
come da noi ottenuto dopo 39 anni? E dov’è – se esiste – la tomba dell’ex
criminale la cui registrazione stando alle nostre indagini non compare nei
luoghi dove sarebbe deputato?
– Perché Mino Pecorelli fa
riferimento a De Vuono in un suo articolo dal titolo “Vergogna Buffoni”
pubblicato nel gennaio ’79 sulla rivista da lui diretta OP: “Non diremo che il
legionario si chiama “De” e il macellaio Maurizio”?
– Perché il 14 maggio 1978
persino il quotidiano spagnolo El País parlò dell’ex legionario come del
presunto esecutore materiale dell’uccisione di Aldo Moro secondo fonti
ufficiali?
Sono le domande che a forza
emergono e che puntellano il caso Moro tutto. Le domande, come scrisse 40 anni
fa Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera riguardanti altri tragici fatti
di questa nostra Repubblica, le cui risposte “gli italiani vogliono
consapevolmente sapere”.
Caso Aldo Moro, la
commissione Fioroni acquisirà i documenti su De Vuono svelati da Formiche.net,
scrive Andrea Picardi il 7 luglio 2017 su "Formiche.net". La commissione
bicamerale d’inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro acquisirà il
materiale inedito svelato da Formiche.net nelle ultime settimane. Secondo le
indiscrezioni raccolte in ambienti parlamentari, la commissione presieduta
da Beppe Fioroni (Pd) ha deciso di aggiungere agli atti le foto e gli articoli
pubblicati da Formiche.net che – a 39 anni di distanza dall’omicidio dell’ex
leader della Democrazia cristiana – ha ricostruito con dovizia di particolari la
presenza in via Fani a Roma di un uomo vicinissimo alla ‘ndrangheta. Eccola la
foto inedita che ha avvolto ancora più di giallo la vicenda – ancora da
decifrare nei suoi aspetti più segreti – del rapimento e l’assassinio di
Moro. Nel primo articolo a firma di Simona Zecchi – cui, poi, sono seguiti altri
approfondimenti – viene infatti certificata la presenza sul luogo della strage
di Giustino De Vuono, detto lo “scotennato”: criminale e aspirante
‘ndranghetista che però non si affiliò mai ufficialmente all’organizzazione. A
scattare la foto fu un ottico di zona – Gennaro Gualerzi – il cui negozio si
trovava nella vicinissima via Stresa. In base a quanto emerso, Gualerzi si
presentò sul luogo del rapimento pochissimi minuti dopo le ultime raffiche
sparate dai brigatisti sull’auto di Moro alle 9,02. Qualche istante dopo – alle
9,15 – arrivò in via Fani dove scattò alcune foto, i cui negativi furono
consegnati ai carabinieri di via Trionfale. Com’è però spesso accaduto nella
misteriosa storia dell’Italia repubblicana, di quelle foto si è con il tempo
perso traccia tanto da essere tralasciate nell’inchiesta sul rapimento e il
successivo omicidio del presidente della Dc. Non solo De Vuono, peraltro, si
trovava quella mattina del 16 marzo ’78 in via Fani. Accertata anche la presenza
di un altro ‘ndranghetista, Antonio Nirta. Come ha ricostruito Stefano Vespa in
questo articolo, la conferma su Nirta è arrivata lo scorso anno dai carabinieri
del Ris che lo hanno individuato ufficialmente analizzando una fotografia
pubblicata dal Messaggero. E lo stesso adesso potrebbe accadere per De Vuono,
sul cui ruolo nella vicenda Moro si era già esposto Fioroni nel comunicato del
luglio 2016 con il quale confermò l’esito della perizia su Nirta. In
quell’occasione il parlamentare del Pd sottolineò, infatti, come fosse in corso
“un’analoga perizia sul volto di un altro personaggio legato alla malavita e che
comparve tra le foto segnaletiche dei possibili terroristi il giorno dopo il 16
marzo: si tratta di Giustino De Vuono, killer spietato, morto nel 1993 in un
carcere italiano”. Come Formiche.net è riuscita ad accertare, però, De Vuono non
risulta deceduto nel ’93, bensì nel ’94. In questo articolo, sempre Simona
Zecchi è riuscita a ricostruire l’ultima fase di vita dell’aspirante
‘ndranghetista. Il quale morì il 13 novembre del 1994 all’ospedale civile di
Caserta nel quale venne trasferito dal carcere di Carinola. Almeno questo è ciò
che recita il certificato di morte di De Vuono rilasciato dall’ufficio anagrafe
del capoluogo di provincia campano. Nessuna notizia, però, sul luogo in cui il
suo corpo venne seppellito. Che, al momento, risulta completamente sconosciuto.
Un dettaglio che, ovviamente, sta generando voci e congetture e alimentando
sospetti e dubbi. Sui quali a breve si concentrerà la commissione bicamerale
d’inchiesta sul caso Moro, che si accinge ad allegare agli atti quanto svelato
da Formiche.net.
Aldo Moro, via Fani, De
Vuono e la ‘ndrangheta. Ecco le ultime novità dopo lo scoop di Formiche.net,
scrive Stefano Vespa il 2 giugno 2017 su "Formiche.net". I lavori della
commissione d’inchiesta sul caso Moro vanno avanti raggranellando altre tessere
di un quadro molto complesso: le foto inedite pubblicate da Formiche.net
contribuiranno probabilmente ai lavori e non è escluso che vengano acquisite. La
presenza degli ‘ndranghetisti Antonio Nirta e Giustino De Vuono a via Mario Fani
subito dopo l’agguato, infatti, era considerata certa dalla commissione da molto
tempo: nel caso di Nirta la conferma è arrivata l’anno scorso dal Ris dei
Carabinieri che lo hanno individuato ufficialmente analizzando una fotografia
pubblicata dal Messaggero. Ora le foto scattate il 16 marzo 1978
dall’ottico Gennaro Gualerzi, consegnate ai Carabinieri e scomparse come tanti
altri rullini, confermerebbero anche la presenza di De Vuono, un killer che
potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella vicenda. Il presidente della
commissione Moro, Giuseppe Fioroni (Pd), nel comunicato del luglio 2016 con il
quale confermò l’esito della perizia su Nirta, aggiunse che “è in corso
un’analoga perizia sul volto di un altro personaggio legato alla malavita e che
comparve tra le foto segnaletiche dei possibili terroristi il giorno dopo il 16
marzo: si tratta di Giustino De Vuono, killer spietato, morto nel 1993 in un
carcere italiano”. Nel corso dei lavori è emersa la certezza che le Brigate
rosse fossero in contatto con la criminalità organizzata per procurarsi le armi,
ma l’anno scorso l’audizione di monsignor Fabio Fabbri regalò un retroscena di
importanza fondamentale, che confermava quanto si pensò già 39 anni fa. Fabbri
all’epoca era uno stretto collaboratore di monsignor Cesare Curioni, ispettore
generale dei cappellani carcerari e impegnato nella trattativa per liberare il
leader dc, e nell’audizione del 4 febbraio 2016 raccontò di essere stato la
prima persona a ricevere le foto dell’autopsia del corpo di Aldo Moro perché
evidentemente si voleva che fossero consegnate subito a Curioni. Questi, appena
le vide, disse: “So chi l’ha ucciso” e al suo sorpreso collaboratore aggiunse
che la rosa di sei fori di proiettile che non toccava il muscolo cardiaco era la
tecnica di un giovane conosciuto nel carcere minorile Beccaria di Milano e che
era un killer della ‘ndrangheta. Secondo il giornalista Paolo Cucchiarelli,
autore di “Morte di un presidente”, si trattava proprio di De Vuono e anche un
rapporto degli investigatori del 1978 lo indicava come l’esecutore materiale
dell’omicidio. C’è poi un dettaglio nella ricostruzione dell’ottico Gualerzi che
alimenta i dubbi sul bar Olivetti: nel suo articolo su Formiche.net, Simona
Zecchi riferisce la versione dell’ottico secondo il quale all’epoca del
sequestro l’esercizio commerciale svolgeva una normale attività mentre su questo
la commissione d’inchiesta ha raccolto testimonianze opposte. Dettaglio
tutt’altro che secondario, visto che con un bar aperto un’azione militare di
quel genere sarebbe stata quasi impossibile. Nella relazione annuale presentata
nello scorso dicembre dal presidente Fioroni si ricordò che quel bar era stato
chiuso per uno “strano” fallimento qualche mese prima del sequestro e che sul
titolare, Tullio Olivetti, sono emerse prove di favoritismi da parte degli
investigatori dell’epoca. Secondo la commissione “non è stato ancora chiarito in
maniera definitiva il significato di tali omissioni investigative. Tuttavia,
occorre rilevare che la vicenda fa emergere un possibile intreccio tra il caso
Moro e una corrente di traffico d’armi che coinvolgeva sia la criminalità
organizzata che l’area mediorientale e sul quale occorre compiere ulteriori e –
si auspica – definitivi approfondimenti”. Da un’attenta lettura degli atti fatta
dalla commissione emergono anche superficialità senza le quali la storia del
sequestro sarebbe stata molto diversa. Il 2 maggio scorso è stato audito Elio
Cioppa, funzionario di polizia che tra gli anni Settanta e i Novanta è stato tra
l’altro alla Squadra mobile di Roma, al Sisde e questore di Nuoro. Nella
pubblicistica sul caso Moro, Cioppa è stato indicato spesso come responsabile
della mancata perquisizione del covo di via Gradoli 96 dove si nascondevano
Mario Moretti e Barbara Balzerani. Invece all’epoca lavorava alla Mobile e non
alla Digos e non fu lui a presentarsi in quel condominio. Fioroni,
nell’audizione, spiega che “leggendo semplicemente gli atti, che quelli che
hanno scritto libri potevano almeno leggersi, la storia che è andata in onda
stasera, non raccontata da Cioppa ma dagli atti, è diversa. Poi uno fa le
dietrologie che vuole, però credo che, per verità, ci sia un limite alle
sciocchezze che possono essere scritte. Cioppa non ha mai bussato. Stava alla
Squadra mobile. Non ha mai bussato, non c’entrava niente con la Digos”. Chi
bussò il 18 marzo all’appartamento intestato “all’ingegner Borghi” fu il
brigadiere Domenico Merola al quale una condomina, Lucia Mokbel, aspirante
“informatrice” di Cioppa, rivelò di aver sentito rumori simili a segnali Morse
provenire da quell’appartamento. Si trattava del rumore della testina rotante
Ibm di una macchina per scrivere elettrica in uso alle Br. Merola bussò tre
volte, ma non sfondò la porta come pure le direttive dell’epoca gli avrebbero
consentito, non fece subito una relazione di servizio su quanto appreso e anni
dopo smentì di aver avuto la segnalazione. Dietro la porta di quell’appartamento
c’erano Moretti e Balzerani i quali, avrebbero spiegato anni dopo in un
processo, avrebbero sparato se qualcuno fosse entrato. Se Merola l’avesse fatto,
probabilmente le forze dell’ordine avrebbero avuto altre vittime da commemorare
e altrettanto probabilmente la storia del sequestro Moro avrebbe imboccato
subito una strada diversa.
Aldo Moro e via Fani, le
foto inedite e l’altro volto della ‘ndrangheta,
scrive Simona Zecchi il 28 maggio 2017 su "Formiche.net". A 39 anni
dall'agguato, Formiche.net svela alcune foto scattate sul luogo della strage e
poi scomparse. Un rapporto dei Carabinieri ne riporta la testimonianza con il
solo riferimento agli allegati. Ecco le immagini inedite. Tra la folla il volto
del calabrese Giustino De Vuono...16 marzo 1978, Roma: sequestro di Aldo Moro e
strage della scorta. L’esistenza di un’altra serie di rullini scomparsi spunta
dopo 39 anni e si va ad aggiungere alla lista già lunga dei segreti che
riguardano via Fani. Si tratta di 11 fotografie inedite lì scattate da un ottico
di via Stresa, Gennaro Gualerzi, il cui esercizio, attivo sin dal 1974, si
affaccia a metà della stradina che si snoda a gomito sull’incrocio-scena della
sparatoria. La loro esistenza è indicata in un rapporto del Nucleo Operativo dei
Carabinieri di Via Trionfale presente negli atti della Prima Commissione Moro
(voll.30-39). È un breve sommario del verbale rilasciato la mattina del 16 marzo
dall’ottico (il nome indicato è sbagliato: “Gualersi”). Circa il numero di
queste foto appare una correzione a mano che lo porta a 16 ma quelle effettive
sono solo 11. L’attuale Commissione Moro aveva ricevuto nel 2016 una
segnalazione sull’ottico. Tra le foto sino a oggi inedite – qui pubblicate per
la prima volta – una rivelerebbe la presenza di un volto: quello di Giustino De
Vuono lo “scotennato”. Il volto su questa immagine inedita sembra perdersi tra
la folla ma di seguito si può vedere il suo ingrandimento a confronto con le
poche immagini ufficiali che lo riguardano, inclusa quella che lo raffigura su
alcuni documenti del Paraguay nei quali compare il riferimento all’accusa per i
reati di sequestro e omicidio della scorta di Moro. Il signor Gennaro Gualerzi
insieme con la figlia allora sedicenne confermano i contenuti del verbale e
aggiungono alcuni elementi. Pochi minuti prima di apprendere la notizia della
strage da un conoscente titolare di un esercizio loro vicino, Gualerzi aveva
imprecato contro un’auto scura, una Fiat 128, che a forte velocità sfrecciava
davanti al negozio con alcune persone a bordo che si cambiavano velocemente
d’abito. Saputo degli spari, Gualerzi accorre poi in via Fani scattando così le
foto: sono le 9.15, le ultime raffiche in via Fani contro la scorta di Moro
segnano le 9.02 circa. Le Fiat 128 presenti quella mattina sono due: una blu,
l’altra bianca con targa diplomatica. I negativi furono dai Gualerzi prontamente
consegnati dall’ottico ai carabinieri di Via Trionfale, e una copia delle
immagini il signor Gualerzi le inviò anche all’allora direttore de L’Ora di
Palermo, da lui conosciuto personalmente, che non le pubblicò mai visto che per
quanto concerneva Roma L’Ora si appoggiava a Paese Sera. Nello stesso rapporto i
carabinieri infatti scrivono: “I negativi sono stati sviluppati e si accludono
le pose relative – all. nr. 16”. Allegati che non compaiono nemmeno negli atti
di che riguardano i processi Moro e in special modo il Moro Uno e il Bis (né
tanto meno in quelli delle commissioni 1 e 2) in cui si registrarono le entrate
dei verbali e dei rapporti, con nomi e cognomi. Compaiono invece tra il 16 e il
17 marzo altri testi presenti nello stesso rapporto dei CC di via Trionfale,
sentiti anche dalla Digos. Tutti nomi che però non avevano nulla da dire
sull’eccidio di quel giorno. Le foto rinvenute ritraggono i momenti più
significativi successivi alla mattanza: alcuni noti, ma l’elemento più
importante che emerge è quel volto che sembra confondersi tra la folla. Secondo
i Gualerzi, inoltre, il bar Olivetti – ulteriore oggetto di indagine della
Commissione – che appare con la saracinesca abbassata alle spalle del
presunto Antonio Nirta svolgeva attività normale in quel periodo sebbene secondo
loro non vi fosse traffico sospetto di personaggi oscuri. La posizione del boss
Nirta detto ‘due nasi’, intervistato dopo 24 anni da “Le Iene” nei giorni
scorsi è stata archiviata nel ‘93. La lista dei rullini di via Fani scomparsi
dalle evidenze dei fatti è inarrestabile: si va da una parte di materiale
relativa alla foto pubblicata dal Messaggero il 21 gennaio 2016 (scovata questa
tra le carte del processo Pecorelli) rullini consegnati all’allora
magistrato Luciano Infelisi da un carrozziere e sua moglie giornalista; per
passare poi ad alcune foto a loro volta sparite dagli uffici della procura che
ritraevano parte del commando mentre sparava alla scorta; altri rullini furono
rinvenuti poi da un’abitante della zona nel proprio giardino e da questa
consegnate a un agente in borghese mai ritrovate in seguito; ulteriori rullini
ancora di cui ha riferito il giornalista Diego Cimara alla Commissione e infine
un’altra serie, mai più ritrovata, di cui ha riferito sempre alla
Commissione Antonio Ianni, il primo fotografo Ansa di Roma arrivato sul posto.
Il materiale (tre rullini) da lui scattato quella mattina sarebbe stato in gran
parte trafugato dall’archivio fotografico dell’agenzia. Giunto in Via Fani
quando ancora i corpi non erano stati coperti, troverà la sera stessa la propria
abitazione sottosopra. Di questa lunga serie, qui si mostrano le uniche foto
rinvenute, con particolare focus sul volto che è possibile indicare almeno
giornalisticamente come il volto di Giustino De Vuono: il volto dell’altra
‘ndrangheta.
Giustino De Vuono (il volto
individuato tra le foto inedite): Criminale e aspirante ‘ndranghetista mai
affiliato ufficialmente perché fra il 1958 e il ’63 aveva vestito la divisa di
legionario (un militare dunque per loro), De Vuono si “politicizza” in carcere.
Il teste Rodolfo Valentino azzarda un suo riconoscimento dalle foto diffuse sui
giornali (verbale del 19 aprile 1978). Quello di De Vuono è un ruolo che via via
sparisce dalle indagini e dai processi. Di lui attualmente non si conosce
l’esistenza in vita né la sua morte. Arrestato e condannato insieme ad altri nel
1981 per l’omicidio di Carlo Saronio (’75), la sua pena verrà ridotta a sei mesi
per un condono (cfr. libro di Antonella Beccaria Pentiti di Niente 2008).
Apparirà e scomparirà fra il 1977 e il 1981 dal Paraguay durante la dittatura di
Alfredo Stroessner e il suo nome emerge già nel volantino diramato insieme a
quello di altri BR il 18 marzo ’78. A dicembre dello stesso anno viene spiccato
un mandato di cattura nei suoi confronti che cessa di essere attivo ai confini
della Svizzera. I suoi movimenti sempre tracciati si perdono solo nel 78 fino ad
agosto, dunque per tutto il periodo del sequestro e l’omicidio Moro.
Aldo Moro e via Fani,
misteri e segreti di De Vuono.
Cosa ha scoperto Formiche.net, scrive Simona Zecchi il 18 giugno 2017 su
"Formiche.net". Resta introvabile il corpo dell’altro volto della ‘ndrangheta
che Formiche.net ha mostrato in queste foto inedite. Da tempo, nonostante la
notizia della sua morte sia stata affermata da più parti, si nutrono dubbi sul
fatto che il criminale della ‘ndrangheta eventualmente prestato alle Br sia
davvero morto. Il legionario Giustino De Vuono (nella foto), lo “scotennato” del
caso Moro, scagionato per sempre sin dal primo procedimento grazie alla
testimonianza del collaboratore Patrizio Peci e, successivamente, da una
informativa del Sismi che ne negava la presenza in Italia durante la strage, è
morto il 13 novembre del 1994, come recita il certificato di morte originale
che Formiche.net ha visto, rilasciato dall’ufficio anagrafe del Comune di
Caserta. Il ruolo dell’uomo nel sequestro di Aldo Moro, nella uccisione della
scorta e persino nel tentato omicidio del testimone Alessandro Marini lo stesso
16 marzo 1978 prima del ‘Moro Uno’ (come indica il documento dell’Interpol nr.
193F0462) è uno dei protagonisti da sempre di questo caso ed è sempre andato
oltre l’incrocio tra Via Fani e Via Stresa a Roma, dove si compirono strage e
sequestro. Una presenza, quella di de Vuono, che passa anche per Via Gradoli e
arriva fino a Via Caetani, dove fu rinvenuto il corpo del Presidente DC il 9
maggio di 39 anni fa. Nonostante quella prima sentenza che lo scagiona, “per non
aver commesso il fatto”, sia le attuali indagini della Commissione Parlamentare
d’Inchiesta sia le più recenti inchieste giornalistiche – una su tutte ‘Morte di
un Presidente’ di Paolo Cucchiarelli- ne hanno fatto riemergere ruolo e
presenza. Ma in tutto questo manca una cosa fondamentale: il corpo, il luogo di
sepoltura effettivo. L’inchiesta di Formiche.net attesta proprio questo: una
mancanza, forse la più importante del caso Moro. Perché se confermata,
difficilmente poi si potrà negare che le Br si servirono di altri per poter
gestire e poi uccidere anche contro il loro intento Aldo Moro. Inoltre, nel caso
di conferma, porrebbe la questione più grave: dove sarebbe finito e da chi
sarebbe protetto De Vuono, il killer di professione? In questa inchiesta, in cui
ci siamo imbattuti in vari personaggi e anche funzionari comunali gentili e
disponibili, abbiamo scoperto tra le altre cose che cercare in Italia una salma
da poter salutare o sulla quale poter andare magari a pregare non è cosa
semplice, non sempre. A Carinola, in provincia di Caserta, il carcere in cui De
Vuono ha passato gli ultimi anni, sanno soltanto che il detenuto prima
trasportato all’ospedale civile di Caserta è morto poi lì di morte naturale.
L’ufficio matricole della struttura carceraria non conosce il luogo di
sepoltura. A Scigliano, il comune in provincia di Cosenza in cui è nato De Vuono
l’8 maggio del 1940, confermano via e-mail che l’uomo è deceduto a Caserta e che
il corpo non ha mai fatto ritorno al paese. Nei comuni lì vicini, così come
nello stesso paese, non sembrerebbero rimasti suoi parenti, secondo le verifiche
che abbiamo potuto svolgere. Dal cimitero principale di Caserta, città in cui De
Vuono sarebbe morto a leggere l’atto inviato dal Comune, ci confermano che lì
l’uomo non è sepolto. Nel registro del deposito del cimitero, infatti, non è
presente né il nome in generale, né il nome in riferimento alla data di morte
indicata. Infatti, era anche possibile che, deceduto alla fine del 1994, il
corpo potesse essere rimasto in attesa dell’arrivo dei parenti e sepolto magari
mesi dopo: dunque nel ’95. Così non è. Il certificato di morte, come è noto,
riporta solo il luogo in cui è avvenuto l’evento. Giustino De Vuono avrebbe
dovuto essere sepolto – così come è ancora norma oggi, ci dicono, per i detenuti
che passano a miglior vita a prescindere dalla città in cui questi si spengono –
presso il cimitero centrale di Carinola. Ma la salma non si trova né lì, né
presso secondo cimitero, come ci confermano dagli uffici di questo comune. Alla
nostra richiesta presso l’ufficio demografico del comune di Caserta dell’atto di
permesso di seppellimento sul quale, come può essere verificato anche sul web,
vi deve essere normalmente indicato il reale luogo di sepoltura, ci è stato
inviato un documento che afferma la non obbligatorietà del loro ufficio a
conservare questo tipo di atti, e soprattutto, aggiungono al telefono, è
possibile non trovarvi l’indicazione del luogo della tumulazione. A Carinola
invece ci dicono il contrario: quegli atti devono essere archiviati e conservati
e il luogo è sempre indicato. Qual è la verità? È possibile, riferiscono poi dal
Comune di Caserta, che nel caso di detenuti – per ragioni di sicurezza – si sia
deciso di occultare il luogo di sepoltura (la parola precisa usata è stata
“depistare”) per ovviare a eventuali atti di devastazione e danneggiamento o per
altri motivi. Quali possono essere questi “altri motivi”? Forse la Commissione,
che non sembrerebbe passata a Caserta per svolgere indagini (né lo è alcuna
altra autorità di polizia giudiziaria) in tal senso potrebbe approfondire al
riguardo. Perché l’altro problema che si porrebbe a questo punto sarebbe la
eventuale falsificazione di atti pubblici. Alla Commissione parlamentare
d’inchiesta è pervenuta una informativa dei Carabinieri nella quale si affermava
l’avvenuta morte di De Vuono. Una informativa coperta da segreto non
accompagnata da alcun certificato, come è a tutti gli effetti l’atto di morte da
noi reperito. La Commissione sta svolgendo diverse indagini sulla persona di De
Vuono e il suo eventuale ruolo nel caso Moro, e alcuni atti che le riguardano
sono giustamente secretate come emerge dall’elenco pubblico degli atti segreti.
Non si comprendeva dunque la necessità di tenere oscurata una informazione che
si poteva reperire come un qualsiasi atto pubblico via posta certificata. La
Commissione alla fine l’ha giustamente desecretata. Gli ambienti investigativi,
così è la voce che serpeggia in merito, non crederebbero all’effettiva morte del
De Vuono né al fatto che il corpo possa essere il suo. Le voci possono restare
tali, ma la ricerca da noi effettuata racconta dei fatti che andrebbero in
questa direzione. Una ricerca che ci ha portati lungo un percorso infinito, a
slalom, dove di sicuro direbbe forse oggi il giornalista Tommaso Besozzi, che si
occupò della morte di Salvatore Giuliano, ‘c’è solo che è sparito’. E’ la
Commissione Moro a questo punto che dovrebbe individuare il luogo reale di
sepoltura di Giustino De Vuono e la sua tomba, se esiste.
Caso Moro, Fioroni: "In via
Fani anche il boss della 'ndrangheta Nirta".
La rivelazione del presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta si basa
sull'esito degli accertamenti su una foto del giorno del sequestro, ritrovata
nell'archivio del quotidiano romano il Messaggero, scrive il 13 luglio 2016 “La
Repubblica”. Una panoramica dall'alto scattata il 16 marzo 1978 durante i
rilievi tecnici sulla scena dell'agguato in via Fani, dove venne rapito Aldo
Moro e tratta dal fascicolo del primo processo Moro (ansa)ROMA - "Grazie alla
collaborazione del Ris, possiamo affermare con ragionevole certezza che il 16
marzo del 1978 in via Fani c'era anche l'esponente della 'ndrangheta Antonio
Nirta, nato a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, l'8 luglio del '46". E'
quanto rende noto il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
caso Moro, Giuseppe Fioroni. Nipote del capo clan suo omonimo, morto a 96 anni
nel 2015, di Antonio Nirta - che nel 1978 aveva 32 anni - parlò per la prima
volta il pentito della 'ndrangheta Saverio Morabito, collaboratore altamente
attendibile e secondo il quale Nirta, detto 'l'esaurito' o 'due nasi' per la sua
confidenza con la doppietta, sarebbe stato confidente del generale dei
carabinieri Francesco Delfino e uno degli esecutori materiali del sequestro di
Aldo Moro. Le prime dichiarazioni del Morabito sono datate 1992 e la procura di
Roma non le riceve che dopo un anno. Fioroni aggiunge che "il comandante Luigi
Ripani, che ringrazio per la collaborazione, ha inviato in questi giorni l'esito
degli accertamenti svolti su una foto di quel giorno, ritrovata nell'archivio
del quotidiano romano il Messaggero lo scorso gennaio - spuntata da un altro
procedimento penale: quello sull’omicidio del giornalista Mino Pecorelli
avvenuto il 20 marzo 1979 -, nella quale compariva, sul muretto di via Fani, una
persona molto somigliante al boss Nirta. Comparando quella foto con una del boss
- aggiunge - gli esperti sostengono che la statura, la comparazione dei piani
dei volti e le caratteristiche singole del volto mostrano una analogia
sufficiente per far dire, in termini tecnici, che c'è 'assenza di elementi di
netta dissomiglianza'". Fioroni afferma che "è in corso una analoga perizia sul
volto di un altro personaggio legato alla malavita e che comparve tra le foto
segnaletiche dei possibili terroristi il giorno dopo il 16 marzo: si tratta di
Antonio De Vuono, killer spietato, morto nel 1993 in un carcere italiano". "Le
informazioni che abbiamo fin qui acquisito - conclude - ci consentono di dire
che la relazione di fine anno sulla nostra attività sarà di grande interesse per
tutti coloro che chiedono di conoscere la verità sul delitto di via Fani".
Sequestro
Moro, spunta la pista della 'ndrangheta: una foto del Messaggero svela l'uomo
con la sigaretta,
scrive Italo
Carmignani il 21 gennaio 2016 su “Il Messaggero”.
L'uomo con la sigaretta, nella foto in bianconero destinata a incorniciare la
tragedia di via Fani, rilegge la storia e riaccende un dubbio: quale ruolo hanno
avuto la 'ndrangheta e i servizi segreti deviati nel sequestro e omicidio di
Aldo Moro? L'immagine risale al 16 marzo 1978, ritrae la Fiat 130 del presidente
della Dc, l'Alfa Romeo della scorta, i corpi dei carabinieri uccisi dai
brigatisti rossi, i curiosi e, in alto a destra, l'uomo con la sigaretta e la
sua aria di falsa indifferenza. A 38 anni da quello scatto firmato dal reporter
Gherardo Nucci, la commissione parlamentare, presieduta da Giuseppe Fioroni,
cerca di dare un profilo all'uomo misterioso comparandolo con la faccia di
Antonio Nirta, calabrese, esponente della 'ndrangheta, confidente del generale
Francesco Delfino, già implicato nelle stragi di terrorismo, già raccontato
vicino ai servizi segreti deviati. E senza alzare i toni, la commissione si
chiede: perché l'uomo con la sigaretta era sul luogo della strage e chi l'aveva
mandato? La foto arriva dall'archivio della Procura di Perugia, dopo essere
transitata in quello del Messaggero. Nella città dei baci, l'immagine arriva
quando il pool dei magistrati, coordinati dall'allora sostituto procuratore
Fausto Cardella, cerca di dare un autore (venne indagato e assolto Carminati) e
un mandante (venne indagato e assolto Andreotti) all'omicidio di Mino Pecorelli,
giornalista a conoscenza, come Moro, di tanti segreti italiani. Anche per
Pecorelli si segue per un po' la pista dei calabresi. E così si arriva
all'interrogatorio di Ubaldo Lauro, collaboratore di giustizia. Lauro non porta
acqua al giallo Pecorelli, ma parla tanto di Nirta. Dice: «...a dire del
Palamara, Antonio Nirta era un infame e confidente del Generale Delfino». E
aggiunge: «Nirta e i De Stefano erano infami, tragediatori e legati ai Servizi
Segreti dice Pasquale Condello...E Pasquale Condello dice realtà». L'ipotesi di
Nirta coinvolto nel rapimento di Aldo Moro e addirittura infiltrato nelle
Brigate rosse era circolata negli anni '90, quando nell'ambito del processo
“Moro quater”, il pm Antonio Marini interrogò il pentito di 'ndrangheta Saverio
Morabito circa quello che l'organizzazione criminale calabrese aveva saputo sul
delitto. E Morabito confermò a modo suo, annuendo e spiegando: «Nirta fu
fisicamente presente al rapimento Moro». Ora parla la foto. Immagine
travagliata, con dentro altri misteri. Al tempo fu lo stesso Nucci a presentarsi
in procura a Roma per consegnare tutto al pm che coordinava le indagini del
sequestro Moro, Luciano Infelisi. Ma la contraddizione è in agguato: alla
commissione di Fioroni, Infelisi ora racconta che gli scatti non avevano
particolare importanza. Ma un cronista dell'Unità dell'epoca spiega il contrario
con un dettaglio: aver notato nelle stanze della questura delle gigantografie di
quelle stesse foto appese, con i volti dei personaggi sullo sfondo cerchiati in
rosso, anche se negli archivi non ce n'è traccia. Un cerchio rosso avrebbe
indicato proprio Antonio Nirta. Già allora, quindi, correva il sospetto. E
ancora. Il primo maggio del 1978, Benito Cazora, deputato Dc vicino alla
famiglia Moro disse al telefono: «Dalla Calabria mi hanno chiamato per
informarmi che in una foto presa sul posto quella mattina, si individua un
personaggio a loro noto». A chi si riferisce Cazora? Sicuramente alla
'ndrangheta e probabilmente a un loro affiliato. Il doppiogiochista Antonio
Nirta, detto Toni “Due Nasi”. Chissà perché.
La
'ndrangheta dietro al sequestro Moro: alla Dc sapevano tutto,
scrive Italo
Carmignani il 22 gennaio 2016 su “Il Messaggero”.
La foto dell'uomo con la sigaretta scattata nello scenario della strage di via
Fani nel giorno del rapimento di Aldo Moro, il 16 marzo del 1978, doveva sparire
per sempre. Nessuno avrebbe dovuto riconoscere l'uomo dai capelli scuri e mossi,
l'aria di finta indifferenza che gli sfilava il ruolo di spettatore semplice.
Perché se l'uomo con la sigaretta è Antonio Nirta, esponente della 'ndrangheta,
doppiogiochista dei servizi segreti, uno dei favoriti di Francesco Delfino (il
generale dei carabinieri finito più volte nei peggiori misteri italiani), allora
non erano solo le Br a muovere le fila del sequestro-omicidio, ma anche il
crimine organizzato calabrese spinto da una parte deviata dello Stato. Ma chi
aveva paura di quella foto che ora avvalora le parole del pentito Saverio
Morabito («Nirta partecipa al rapimento Moro»)? A 37 anni dalla più politica
delle esecuzioni brigatiste, tocca alla commissione d'inchiesta presieduta da
Giuseppe Fioroni chiarire il dubbio. E oltre alla comparazione tra l'uomo nella
foto e la faccia di Nirta, ora grazie all'immagine s'incastrano una serie di
tasselli di un nuovo quadro della vicenda Moro. A cominciare da
un'intercettazione a pochi giorni dal rapimento. L'apparecchio è quello di
Sereno Freato, uomo della Dc vicinissimo a Moro, dall'altra parte del filo c'è
Benito Cazora, incaricato dalla DC di tenere i rapporti con la malavita
calabrese per avere notizie sulla prigione di Moro. Cazora: Mi servono le foto
del 16, del 16 Marzo. Freato: Quelle
del posto, lì? Cazora: Si,
perchè loro...perché uno stia proprio lì, mi è stato comunicato da giù. Freato:
E' che non ci sono... ah, le foto di quelli, dei nove. Cazora:
No, no! Dalla Calabria mi hanno telefonato per avvertire che in una foto preso
sul posto quella mattina lì, si individua un personaggio... noto a loro. Freato:
Capito. E' un po' un problema adesso. Cazora:
Per questo ieri sera ti avevo telefonato. Come si può fare? Freato:
Bisogna richiedere un momento, sentire. Cazora:
Dire al ministro. Freato:
Saran tante! Perché “loro”, probabilmente la 'ndrangheta, non volevano
circolasse quella foto? Perché Nirta aveva avuto il ruolo di supervisore
dell'operazione, o sarebbe dovuto intervenire se qualcosa fosse andato storto?
Una certezza: da più parti si è sempre detto che il rapimento Moro, l'uccisione
bestiale e precisa della scorta, non potevano essere stati eseguiti solo da
brigatisti male addestrati alle armi. Altro tassello che porta alla 'ndrangheta
e a Nirta sono i pentiti. A riconoscere per primo Nirta nella foto è la
magistratura perugina che nel 1996 acquisirà la foto dall'archivio del
Messaggero inserendola nel fascicolo dedicato all'omicidio di Mino Pecorelli,
giornalista che sapeva, come Moro, tanti segreti italiani. L'uccisione di
Pecorelli porta gli inquirenti a interrogare il pentito Ubaldo Lauro che spiega:
«Nirta era uomo dei servizi». Per poi riconoscerlo (come già gli investigatori),
nella fotografia. Qualche mese fa, a ricordare alla commissione Fioroni di
quella foto a Perugia è l'avvocato Walter Biscotti che assiste le famiglie degli
agenti uccisi. Biscotti rammenta anche la sparizione di tutto un rullino
impresso il giorno della strage dalla macchina fotografica di Gherardo Nucci,
dal quale si salva solo l'immagine del Messaggero. Un rullino consegnato dalla
moglie di Nucci prima all'Asca, agenzia vicina alla Dc, e tre giorni dopo a chi
investigava sul rapimento Moro. E che, misteriosamente, smarrì tutto. Ascoltando
inconsapevolmente un'invocazione telefonica.
IL SEQUESTRO
MORO E LA CAMORRA.
Camorra, si pente Scotti e
parla di Cutolo. Si riapre il fascicolo sul delitto Ammaturo,
scrive Conchita Sannino il 13 luglio 2016 su “La Repubblica”. «Non cerco alibi e
non cerco scuse. Ma ora sono un altro uomo». Pasquale Scotti, l’ex
superlatitante, il criminale e braccio destro di Raffaele Cutolo negli anni
della sanguinaria guerra tra la Nco di ‘o Professore e la Nuova Famiglia di
Carmine Alfieri, da oltre un mese è ufficialmente un collaboratore di giustizia.
Sta parlando. E molto. Con la Procura antimafia di Napoli. Non solo della
camorra - ormai preistorica - di Cutolo, e dei tantissimi cadaveri seminati a
quel tempo, nei territori di Napoli e provincia. Il boss Scotti sta parlando
soprattutto della trattativa tra lo Stato e i terroristi delle Brigate Rosse,
sul ruolo di mediazione della camorra nella liberazione dell’ex assessore
regionale rapito dalle Br, Ciro Cirillo. Sta parlando dei suoi rapporti, dei
legami fitti che ebbe con Vincenzo Casillo, l’uomo che da latitante portò i
Servizi segreti italiani a parlare in carcere con Cutolo, proprio in occasione
della trattativa. E soprattutto, le sue dichiarazioni e le domande dei pubblici
ministeri toccano anche un caso doloroso che potrebbe essere riaperto:
l’assassinio dell’allora (instancabile) commissario di polizia Antonio Ammaturo,
ucciso dalle Br il 15 luglio 1982 in piazza Nicola Amore. Con lui cadde anche
l’agente Pasquale Paola. Scotti era inseguito dalle forze dell’ordine italiane
da oltre sei lustri. Per molti segugi della polizia e dei carabinieri era
diventato, ormai, un’ossessione o un fantasma. Sembrava scomparso per sempre.
Poi la svolta, oltre un anno fa. Grazie a un’intuizione della squadra Mobile di
Napoli, e alla collaborazione dello Sco con l’Interpol. Scotti viene catturato
dopo ben 31 anni di latitanza, dalla polizia, in Brasile. Ma lui si chiama
Francisco de Castro Visconti e ha documenti in regola. Ma ovviamente non ha più
quel volto, non mette piede più in Italia, ha lasciato che sua madre morisse -
nell’hinterland napoletano - davanti alla sua immagine in fotografia, non ha più
rivisto i familiari «ma non è che avevo proprio reciso tutti i legami. In realtà
li sentivo solo per telefono - è il riassunto delle sue parole - ogni tanto, a
distanza di mesi, entrando in qualche cabina telefonica, mai la stessa, dal
Brasile». Viene poi estradato e atterra in Italia nel marzo scorso. Scotti era
apparso subito come un ex padrino tormentato. In lacrime, la barbetta e gli
occhiali che potevano simulare l’identikit di un calmo uomo d’affari, aveva
subito detto ai poliziotti: «La mia vita è distrutta, io non sono più quello che
cercate voi». Da subito era apparso deciso a valutare l’idea di offrire i suoi
ricordi, la sua memoria di killer, faccendiere, oggi mega imprenditore sud
americano, alla giustizia italiana. Ma dopo molti boatos, ora la conferma: i
suoi familiari a Casoria, e nell’hinterland napoletano, sono stati raggiunti
dalla comunicazione di dover cambiare luogo e vita. Non tutti hanno accettato.
Un altro problema da gestire. Mentre ciò che di prezioso può offrire Scotti,
stando alla visione della Procura antimafia, è soprattutto «il legame tra il
mondo criminale e quello del terrorismo», oltre che della politica inquinata. Ha
raccontato subito anche della sua evasione dall’ospedale Civile di Caserta nel
1984. Dichiarazioni secretate. Il boss Scotti ha parlato molto, in carcere,
stando alle indiscrezioni, dinanzi alla pm Ida Teresi e al procuratore aggiunto
antimafia Giuseppe Borrelli. «Io non ho giustificazioni per quello che ho fatto
negli anni Ottanta», questo è in estrema sintesi il suo incipit. E questo il
senso delle sue prime parole: «Io non cerco alibi e non cerco scuse. Sono stato
un uomo, in quel tempo con Cutolo. Ma ora sono un’altra persona. Ho fatto
un’altra vita, mi sono dedicata a un lavoro, ho una moglie, una famiglia e mille
altri interessi. Ma non voglio sfuggire a nessuna delle mie responsabilità».
Fino a che punto? Questo sarà lo Stato italiano a valutarlo. La partita, con una
delle menti più astute e abili - non a caso sopravvissuta a tante Repubbliche -
è appena cominciata.
Moro, l’ultima verità di
Cutolo: «Potevo salvarlo, Gava ci fermò».
Il boss camorrista ai pm: «Era pronta un’irruzione con uomini armati poi da Roma
arrivò un contrordine. La verità su Moro non si saprà mai», scrive Giovanni
Bianconi il 26 giugno 2016 su “Il Corriere della Sera”. «Non per fare il
buffone, ma Aldo Moro lo potevo veramente salvare. Allora, con la mia
organizzazione, eravamo fortissimi, anche su Roma». Poi però, proprio da Roma,
arrivò il contrordine, recapitatogli da Enzo Casillo, il «braccio destro»
latitante che circolava con una tessera dei servizi segreti in tasca: «Mi disse
che i suoi amici avevano detto di farci i fatti nostri, di non interessarci di
Moro... Erano politici di alto grado... La Democrazia cristiana, comunque...».
Ma chi, in particolare? «Mi sembra di parlare male, adesso che è morto. Gava,
comunque». Il salto all’indietro di Raffaele Cutolo, settantacinquenne boss
della Nuova camorra organizzata detenuto dal 1979, si arricchisce di nuovi
particolari. E nell’ultimo interrogatorio, reso tre mesi fa ai pubblici
ministeri di Roma, sostiene che a bloccare l’intervento per liberare il
presidente della Dc sequestrato dalle Brigate rosse, nella primavera del 1978,
fu nientemeno che Antonio Gava, leader democristiano di sangue partenopeo e
futuro ministro dell’Interno. Glielo rivelò Casillo in persona, «che a me mi
doveva dire tutto, ogni virgola». A seguito di quell’avvertimento, il progetto
messo a punto dal capo camorrista si bloccò: «Era un piano semplice, uomini
dell’organizzazione si sarebbero portati, armati, presso l’appartamento, visto
che solo 4-5 persone vigilavano sul covo di Moro». Un’irruzione «di forza...
stavano al pianterreno», afferma Cutolo. La strategia l’aveva studiata insieme a
Nicolino Selis, un malavitoso della banda della Magliana conosciuto in carcere e
in seguito promosso a suo capozona su Roma. Era stato proprio lui a fornirgli le
prime informazioni sulla prigione del presidente democristiano: «È venuto a
trovarmi ad Albanella (paese in provincia di Salerno dove Cutolo s’era rifugiato
e fu arrestato nel 1979 ndr), e mi disse se mi interessavo a Moro perché lui,
non volendo, stava proprio latitante, con la sua fidanzata, dove stava Moro.
Nello stesso palazzo». È una storia già raccontata oltre vent’anni fa, sulla
quale non sono mai stati trovati riscontri attendibili, che il boss ribadisce
dopo che nel settembre scorso un paio di collaboratori della nuova commissione
d’inchiesta sul caso Moro sono andati a trovarlo in carcere. In quell’occasione
Cutolo avrebbe aggiunto di poter chiarire altri misteri sul sequestro e
l’omicidio del presidente dc, e così il procuratore aggiunto di Roma Michele
Prestipino e il sostituito Eugenio Albamonte sono andati a sentirlo nel carcere
di Parma, il 25 marzo scorso. Ne è venuto fuori un verbale, ora a disposizione
dei commissari, nel quale il boss ripete la stessa versione, comprensiva del
fatto che poco dopo la notizia avuta da Selis, il suo avvocato Francesco Gangemi
(democristiano) gli chiese di acquisire notizie sulla prigione di Moro. Cutolo
replicò di voler incontrare l’allora ministro dell’Interno Cossiga, che declinò
l’invito: «Fu l’unico a comportarsi bene, nel senso che disse “io non lo posso
incontrare perché sennò lo devo fare arrestare, però se si interessa vediamo
quello che si può fare”» . Poi arrivò Casillo a fermare tutto, e Cutolo dovette
spiegarlo a Gangemi: «Piangeva, diceva se potevo fare qualcosa, ma io non ho
fatto più niente. Questa è tutta la situazione». Un copione che più o meno
coincide con ciò che hanno raccontato i pentiti di mafia, da Tommaso Buscetta in
giù, sull’intervento di Cosa nostra: richiesta di liberare Moro fermata da un
successivo ripensamento in casa democristiana. Tre anni più tardi, durante il
sequestro dell’assessore campano della Dc Ciro Cirillo, con Cutolo già in
carcere, le cose andarono diversamente: trattativa e rilascio dell’ostaggio,
senza blitz ma grazie a un sostanzioso riscatto. «L’ho salvato, e per premio mi
mandarono all’Asinara», si rammarica ora Cutolo. Secondo il quale per liberare
Cirillo andò a trovarlo in galera anche Adalberto Titta, un misterioso ufficiale
dell’Aeronautica, ex repubblichino, considerato il capo di un servizio segreto
parallelo e clandestino: «Mi disse anche il fatto dell’aereo di Ustica... “Lì,
dice, è successa una guerra stellare”... Ma più che altro veniva per Cirillo, a
implorarmi, perché dice che Cirillo, se stava ancora prigioniero, parlasse di
tante cose della Dc». Gli emissari della commissione Moro l’avevano sollecitato
su altri particolari, ma il boss risponde solo con qualche «sentito dire», ad
esempio sui contatti tra brigatisti e ’ndranghetisti «per avere armi». Di
ulteriori segreti non c’è traccia, Cutolo non ne ricorda: sebbene «allora io ero
all’apice, mi dicevano tutto, ogni cosa che succedeva... Se sapessi altre cose
le direi, perché non ho niente da perdere né da guadagnare. Anzi, da guadagnare
per aiutare la famiglia Moro a scoprire la verità, ma penso che non si scoprirà
mai... Perché, come si dice, quando ci sono implicate persone molto in alto...
la puzza più in alto è e più si sente. Non l’hanno voluto salvare, questo ve lo
posso dire».
La verità di
Cutolo: "Pronto a collaborare, vi svelerò i segreti del sequestro Moro".
L'ex capo
della Nuova camorra organizzata, 13 ergastoli, da 23 anni in regime di 41 bis,
ha iniziato a parlare da due mesi. E le sue rivelazioni si annunciano esplosive,
scrive Paolo Berizzi il 17 novembre 2015 “La Repubblica”.
Nessun
pentimento ("solo davanti a Dio"). Nemmeno una dissociazione. Ma, per la prima
volta dopo oltre mezzo secolo dietro le sbarre - 34 anni in isolamento, 23 in
regime di 41 bis -, Raffaele Cutolo ha deciso di collaborare con lo Stato. Una
scelta clamorosa che Repubblica è
in grado di rivelare e di ricostruire. Una scelta maturata recentemente, in gran
segreto, nel carcere di Parma, dove l'ex capo della Nuova camorra organizzata ha
appena compiuto 74 anni. Qui, due mesi fa, Cutolo ha chiesto - a sorpresa - di
essere interrogato sul rapimento
e la morte di Aldo Moro. E ha parlato. Le sue rivelazioni - il verbale è stato
secretato - le hanno raccolte in cella un luogotenente dei carabinieri e un
magistrato. Collaborano entrambi con la Commissione parlamentare di inchiesta che
indaga sulla complessa, e ancora oscura vicenda, dello statista democristiano
rapito e ucciso dai terroristi delle Brigate Rosse il 9 maggio 1978. Ma vediamo,
con ordine, quello che è successo nel carcere di Parma. Siamo all'inizio di
settembre: l'Italia e l'Europa sono alle prese con il caos migranti. Cutolo,
come da routine, incontra la moglie Immacolata Iacone nell'unico colloquio
mensile previsto per i detenuti sottoposti al regime del carcere duro (41bis).
Piccolo ma non irrilevante passo indietro: sei mesi prima. È il 2 marzo. L'ex
boss della camorra si sfoga in un colloquio riportato sulle colonne di questo
giornale: "Mi hanno sepolto vivo in cella, se parlo crolla lo Stato", dichiara
Cutolo. A stretto giro arriva la replica del procuratore nazionale antimafia,
Franco Roberti. "Cutolo dica quello che sa e sarà valutato, siamo pronti a
indagare", lo incalza il 10 marzo. Un invito, più che eloquente, rivolto a "don
Raffaele" affinché potesse prendere in considerazione l'idea - sempre parole di
Roberti - di fare "seguire alle dichiarazioni contro lo Stato anche delle
dichiarazioni concrete". Perché, è il ragionamento, "la possibilità di uscire
dalla condizione del 41bis dipende soltanto da lui...". Lui, Cutolo. Torniamo
dunque a settembre. Non si sa se e quanto le parole di Roberti abbiano
instillato nel vecchio padrino della camorra lo spunto per una riflessione (a
parte una breve parentesi nel '94 - morta sul nascere - l'ex boss di Ottaviano
è sempre stato un muro di silenzio). Ma adesso Raffaele Cutolo vuole parlare. Di
Moro, sicuramente. Forse anche di altro. Chiede di essere ascoltato da chi sulla
morte del politico Dc sta cercando di fare chiarezza. In questi casi la prassi
prevede due possibilità: o il detenuto scrive - di persona o attraverso il
proprio legale - al magistrato (o ai magistrati) che indagano. O affida la sua
richiesta al direttore del carcere. Sta di fatto che la seconda metà di
settembre, Giuseppe Boschieri, luogotenente dei carabinieri, consulente della
Commissione Moro, contatta uno dei legali di Cutolo, l'avellinese Gaetano
Aufiero. Il carabiniere chiede se all'interrogatorio richiesto dal detenuto
eccellente volesse prendere parte anche il suo difensore. Ma non trattandosi di
un interrogatorio di garanzia, il legale ritiene superflua la propria presenza.
Lunedì 14 settembre 2015. Nel carcere di via Burla - dove sono reclusi tra gli
altri anche i super boss Totò Riina e Leoluca Bagarella (quest'ultimo appena
trasferito in Sardegna), il "Nero" Massimo Carminati e Marcello Dell'Utri -
Cutolo parla. Dichiarazioni spontanee. Che finiscono in un verbale. È uno dei 41
documenti raccolti dalla Commissione Moro e annunciati all'ufficio di
presidenza. Si legge nell'elenco: "Verbale di riversamento di files audio su
supporto informatico relativi all'escussione del detenuto Cutolo Raffaele,
avvenuta il 14 settembre 2015". Mittente del documento 316/1, protocollo 1027,
data 21-09-2015, è il luogotenente Boschieri. Leggendo le carte che mettono in
ordine i documenti c'è un particolare che balza all'occhio: il verbale relativo
all'interrogatorio di Cutolo è segreto. Di più. Dei 41 documenti raccolti da
parlamentari, magistrati, poliziotti, carabinieri che collaborano con la
commissione, il 316/1 è l'unico secretato. Gli altri sono tutti liberi o, al
massimo, riservati. Perché? Che cosa ha rivelato sulla fine di Moro l'ex capo
della Nco? Ha riferito circostanze e particolari che non devono o non possono
essere resi pubblici? E, soprattutto, perché a 74 anni, dopo mezzo secolo al
gabbio, e 34 anni di totale isolamento, Cutolo decide di parlare accettando, di
fatto, di collaborare con quello Stato da cui si è sentito "usato e
abbandonato"? Il riferimento è al suo coinvolgimento nella vicenda dell'ex
assessore regionale Dc Ciro Cirillo, sequestrato dalle Br a Torre del Greco nel
1981 e poi liberato - secondo una sentenza passata in giudicato - "alla fine
di una lunga e serrata trattativa tra apparati dello Stato e il boss Raffaele
Cutolo, a cui si è chiesto di intervenire presso le Br per ottenere la
liberazione di Cirillo". Tredici ergastoli, record italiano di lungodegenza
carceraria, sposato con Immacolata Iacone da cui ha avuto (inseminazione
artificiale) la figlia Denise di 7 anni. Disse Cutolo in un'intervista a Repubblica nel
2006: "Mi sono pentito davanti a Dio, non davanti agli uomini. È immorale fare
arrestare persone innocenti per avere soldi e protezione dallo Stato.
Riabilitarsi significa pagare gli errori con dignità. La dignità è più forte
della libertà, non si baratta con nessun privilegio... ".
Moro, Cutolo
e le BR, quanti dubbi.
Le nuove
rivelazioni di Raffaele
Cutolo sul
caso Moro si aggiungono a cataste di fascicoli contenenti particolari e
testimonianze raccolte in quasi 40 anni di storia italiana, scrive Marzio Di
Mezza il 21 novembre 2015 su
blastingnews.com. Gero
Grassi,
parlamentare Pd e componente della Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro,
sgombra subito il campo da dubbi: “Siamo
stati noi a volerlo interrogare”,
cosa che è avvenuta il 14 settembre scorso, nel carcere di Parma. Grassi e la
commissione parlamentare, tassello dopo tassello, stanno cercando di ricomporre
il mosaico che dovrebbe restituire una immagine un po’ più chiara di ciò che
avvenne prima, durante e
dopo il rapimento dello statista
italiano. “Nell'interrogatorio
di Parma –
riferisce -,
Cutolo ha detto delle cose ma il contenuto di qualche articolo
che è stato pubblicato in questi giorni è parzialmente falso”.
Cosa ha detto l’ex boss? “Sostanzialmente
che il rapporto tra Br e Ndrangheta era precedente al caso Moro e ci fu un
passaggio di armi, dalla organizzazione mafiosa a quella terroristica. E questa
cosa è veritiera perché nel corso delle nostre indagini sulla vicenda Moro, la
presenza della Ndrangheta si riproduce più volte”.
Cutolo parla, poi, del ruolo di Giuliano
Granata,
scomparso qualche anno fa, all'epoca dei fatti avvocato e sindaco di Giugliano,
il quale “gli
avrebbe detto per nome e per conto di qualcuno, forse Gava, di cercare Moro.
Cutolo,
sempre secondo la sua versione, tramite Enzo Casillo e Nicolino Selis, lo
avrebbe trovato Moro nella prigione di via Montalcini e si sarebbe preparato
all’attacco per liberarlo ma sarebbe stato fermato dai due che gli avrebbero
detto ‘lascia stare perché non lo vogliono vivo’. Al di là di queste cose che
dice, la cosa seria, reale, è che uno dei suoi uomini fidati, Casillo, era un
uomo dei Servizi, infatti qualche anno dopo, quando fu ritrovato morto, aveva
addosso la tessera dei Servizi”.
Sui presunti rapporti tra criminalità organizzata e Servizi deviati c'è anche
una pagina su Wikipedia. Intanto nella seduta del 17 novembre, 3 giorni dopo
l'interrogatorio di Cutolo, la commissione presieduta da Giuseppe
Fioroni,
verbalizza l'invio di documentazione segreta alla DNA
e alla Procura di Roma.
Ma quale può essere la qualità delle rivelazioni di un uomo dal profilo
criminologico tendente all'egocentrismo, al fanatismo? Per la criminologa Caterina
De Falco,
il profilo di personalità di Cutolo si presta a varie riflessioni. “Megalomane,
narcisista, va a vivere in un castello, impone una rottura nelle dinamiche della
gestione degli affari criminali. Anche la guerra con Alfieri rappresenta il suo
voler sfidare e voler affermare il proprio potere, su territori sempre più vasti
e su affari sempre più importanti. La criminalità organizzata è molto cambiata a
partire da lui, un personaggio che ha voluto molto apparire e che ha avuto un
continuo bisogno di specchi umani in cui riflettersi”.
Caterina De Falco è Responsabile dell'area di Scienze
criminologiche della Scuola bruniana di
formazione e di aggiornamento forense dell'Ordine
degli Avvocati di Nola.
Premette che le sue considerazioni si basano su ciò che si conosce di Cutolo,
che è pubblico. “Chiaramente
la mia conoscenza del soggetto è limitata –
precisa -penso
che una anamnesi familiare potrebbe definire l’origine della sua personalità
narcisistica. Anche questa dichiarazione potrebbe rappresentare la sua necessità
di farsi notare, ogni tanto dice qualcosa, pur essendo consapevole che da quel
regime detentivo non potrà uscire, rompe il silenzio per attirare l’attenzione
mediatica. E’ pur vero che nel periodo a cui si riferisce, c’è stata una
commistione tra poteri criminali e Servizi deviati, lo abbiamo visto per la
Banda della Magliana ed è probabile che questo possa essere accaduto anche con
la Camorra e, dunque, ci fa apparire un po’ più credibile l’ipotesi che Cutolo
possa effettivamente sapere qualcosa del rapimento Moro".
Ma altri
elementi alimentano dubbi
sulle sue affermazioni.
Raffaele Cutolo, i segreti
del boss.
Cutolo è una bomba pronta a esplodere. Dal caso Cirillo fino al sequestro Moro.
Sullo sfondo i contatti con la Dc. I ricordi occulti che fanno tremare la
politica, scrive Enzo
Ciaccio su "Lettera 43" il 03 Marzo 2015. Ha ribadito che se lui
raccontasse i segreti che sa «ballerebbero
le scrivanie di mezzo parlamento». Perché, ha aggiunto, «molti di quelli
che in parlamento ci stanno adesso ce li hanno messi quelli che allora venivano
a pregarmi». E ancora, quasi in un grido: «Mi hanno tumulato vivo: sanno che, se
parlo, cade lo Stato». Parole di cemento. Anatemi al veleno. Ma quanto c’è di
vero, allarmante, pericoloso nelle sue minacce? E quanto di quel che dice,
invece, è frutto di una frustrazione profonda, sedimentata e imbarbarita nei
decenni di reclusione e spietato isolamento? Per alcuni, Raffaele
Cutolo, 73 anni, licenza elementare, ex vinaio, falegname,
autonoleggiatore ed ex boss indiscusso della cosiddetta Nuova camorra
organizzata (la banda di malavita che tra gli Anni 70 e 80 spadroneggiava in
Campania), è solo «un uomo ormai anziano e psichicamente svanito», con 13
ergastoli da scontare, in carcere a regime di 41 bis dal 27 aprile 1963 (tranne
una breve evasione dal manicomio giudiziario di sant’Eframo a Napoli), fiaccato
nel fisico, nel morale e nella mente «e non più in grado di ragionare con
giudizio e serenità»: per i suoi denigratori, insomma, Cutolo è ridotto a una
sorta di larva umana, «uno che spesso non sa neanche più quel che dice».
Per altri, invece, ‘O professore (come era chiamato dai suoi affiliati, che
raggiunsero negli Anni 80 la dimensione di un vero e proprio esercito da 7 mila
unità, armato, compatto, pronto alle stragi ma anche a una sorta di welfare
ante-litteram che garantiva stipendi e servizi sociali) non è affatto un relitto
umano che va delirando, ma «un capo criminale in piena efficienza, che conserva
nella mente lucidissima la memoria di molte tra le malefatte che la classe
politica di quegli anni avrebbe consumato in tema di business da dopo-terremoto,
rapporti inconfessabili con la malavita organizzata, patti irriferibili con le
organizzazioni terroristiche dell’epoca, le Brigate rosse più di tutte». Cutolo,
secondo chi lo ha ben conosciuto, non possiede da qualche parte a Ottaviano (il
suo paese natale, nel cuore dell’area vesuviana) o altrove archivi segreti né
esplosivi elenchi “dei cattivi e dei buoni”. «Ma», fanno notare gli
inquirenti, «il fatto di non aver conservato mai carte che scottano non vuol
dire che il boss non ricordi eventi, malefatte, nomi e cognomi specie di coloro
che gli hanno procurato del male o gli hanno in passato elargito promesse che
poi non sono state mantenute». «Il film della sua vita», ricorda chi lo ha
conosciuto, «è come se ce lo avesse stampato nella testa, anzi nella memoria che
- nonostante la prigionia - si mantiene viva e in salute». Al contrario di altri
boss, grafomani fino al parossismo, don Raffaele non ha mai esagerato con
lettere, pizzini, diari, memoriali o altro. Le parole scritte le ha riservate -
con pudore - ai dialoghi con la moglie Immacolata, sposata quando era già in
carcere, o con la figlia Denise, avuta grazie all’inseminazione artificiale. Il
boss, da uomo di campagna diffidente e introverso, ha sempre nutrito inimicizia
istintiva per la parola scritta, tranne quando l’ha utilizzata per scrivere le
sue poesie d’amore di cui è orgoglioso (e - dicono - assai geloso). Per il
resto, ha sempre evitato il più possibile di mettere nero su bianco, ritenendo
la parola scritta «arma che tradisce» e dalla quale - una volta vergata - non è
possibile recedere. Una sola eccezione l’ha fatta per le lettere spedite a una
giornalista di Ottaviano, Gemma Tisci, nel corso della prigionia, da cui è
scaturito un libro. «Per il resto», raccontano in Paese, «Cutolo tiene tutto a
mente e ha sempre consigliato ai suoi, e perfino alla sua amatissima sorella
Rosetta, che gli ha tenuto per decenni il controllo degli affiliati e degli
affari, di scrivere il meno possibile, compresi gli elenchi (cifrati) dei
detenuti amici cui spedire i soldi per l’assistenza alle famiglie». Secondo gli
inquirenti, è proprio tale connotazione «tutta orale» ma capace di rimandare a
prove e inconfutabili riscontri a rendere un «fantasma» come Cutolo
particolarmente «pericoloso» per chi ha tramato con lui e ora ha da temere dalle
sue eventuali accuse: il boss è in carcere da decenni, ma fuori del carcere (o
dentro) non esistono archivi da sequestrare, elenchi in cui spulciare, documenti
riservati da far scomparire, carte in cui rubare verità mai rese note. Nulla.
Contrariamente a Francesco
Schiavone, il boss pentito dei Casalesi morto il 22 febbraio di cui i
magistrati stanno
ora sequestrando le carte segrete, non c’è nulla di scritto su quello che
il boss Cutolo ha combinato nella sua vita o su quello che gli altri hanno
combinato con lui né su ciò che lui sa e può decidere di dire ad alta voce su
coloro che lo hanno incrociato nel tempo, malviventi, manager e uomini politici
di basso, medio e altissimo livello compresi. La vicenda “politica” più
rilevante in cui Cutolo ha di sicuro svolto un ruolo illegale ma di primaria
importanza (come ha dimostrato il giudice Carlo Alemi) è la cosiddetta
trattativa avvenuta nel carcere di Ascoli Piceno nei giorni del sequestro
dell’assessore regionale campano all’urbanistica Ciro Cirillo, consumato nel
1981, cioè nel periodo più incandescente del business da dopo-terremoto. In quel
carcere, in visita al detenuto Cutolo - ritenuto in grado di far da mediatore
tra lo Stato e le Brigate rosse per l’eventuale liberazione dell’assessore
rapito - si recarono numerosi esponenti di spicco della Democrazia cristiana
dell’epoca, nonché parecchi personaggi minori che parlavano (e trattavano) con
il capo camorra a nome di leader del calibro di ministri come Antonio Gava,
Giulio Andreotti, Enzo Scotti e tutto il gotha del Potere politico e partitico
dell’epoca. Con loro, a suggellare i dettagli e le modalità del “patto”, erano
presenti esponenti dei Servizi segreti nonché alti gradi delle Forze
dell’ordine, rigorosamente non in divisa. Il nome di Cutolo, però, è comparso
anche in relazione a presunte trattative tra lo Stato e le Br che sarebbero
avvenute ai tempi del sequestro di Aldo Moro, nel tentativo di giungere alla sua
liberazione. Si sta raccontando di vicende, come è noto, che risalgono a più di
30 anni fa: molti, ma non tutti, fra i personaggi dell’epoca non ci sono più.
Altri sono ormai scomparsi dalla scena politica nazionale e locale. Ma è vero -
come Cutolo ha ribadito più volte - che rigagnoli di bugie e di sangue,
omissioni, ombre e misteri collegano quei giorni di trame, scambi e promesse
mancate all’attualità politica che invece preferirebbe ignorarne i contorni: «In
parlamento», fa notare più di un osservatore, «oggi siedono molti figliocci,
nipoti e nipotini ideologici di quei leader che nel segreto del carcere di
Ascoli (e nei giorni del sequestro Moro) patteggiarono con il ras di Ottaviano
pur di salvare la vita all’assessore Cirillo e al leader Dc». Che cosa
patteggiarono? Quante delle promesse fatte a Cutolo e ad altri malavitosi sono
state poi mantenute? Di quante la comunità ne paga, senza saperlo, ancora oggi
il prezzo? A proposito di Cirillo, l’ex assessore è un altro dei protagonisti
dell’epoca che finora si è ben guardato - nel corso delle centinaia di
interviste concesse - dal raccontare qualcosa dei suoi segreti e della torbida
vicenda del sequestro. Cirillo, però, ha di recente fatto sapere di aver
consegnato a un notaio un dossier che racconterebbe la sua verità. Per il resto,
silenzio, connivenze, distrazioni, misteri. E bocche cucite. Cutolo, che di
scritto non lascia nulla (tantomeno nelle mani di un notaio) ma ricorda e fa
capire di avere le prove di tutto, fa paura proprio per la sua estrema,
spaventosa volatilità. ’O professore è come una bomba, che può esplodere quando
vuole, ed è senza disinnesco. Oppure, può restare lì: immota, inerte, silente,
in apparenza innocua. Ma fino a quando, chi può saperlo?
La versione Cutolo sul caso
Moro: "Rapito con le armi della 'ndrangheta".
Le rivelazioni dal 41 bis dell'ex capo della Nuova camorra organizzata: "Patto
in carcere tra le Br e le cosche calabresi", scrive Paolo Berizzi su “La
Repubblica” il
18 novembre 2015.
Nessun
pentimento ("solo davanti a Dio"). Nemmeno una dissociazione. Ma, per la prima
volta dopo oltre mezzo secolo dietro le sbarre - 34 anni in isolamento, 23 in
regime di 41 bis -, Raffaele Cutolo ha deciso di collaborare con lo Stato. Una
scelta clamorosa che Repubblica è in grado di rivelare e di ricostruire.
Una scelta maturata recentemente, in gran segreto, nel carcere di Parma, dove
l'ex capo della Nuova camorra organizzata ha appena compiuto 74 anni. Qui, due
mesi fa, Cutolo ha chiesto - a sorpresa - di essere interrogato sul rapimento
e la morte di Aldo Moro. E ha parlato. Le sue rivelazioni - il verbale è stato
secretato - le hanno raccolte in cella un luogotenente dei carabinieri e un
magistrato. Collaborano entrambi con la Commissione parlamentare di inchiesta
che indaga sulla complessa, e ancora oscura vicenda, dello statista
democristiano rapito e ucciso dai terroristi delle Brigate Rosse il 9 maggio
1978. Ma vediamo, con ordine, quello che è successo nel carcere di Parma. Siamo
all'inizio di settembre: l'Italia e l'Europa sono alle prese con il caos
migranti. Cutolo, come da routine, incontra la moglie Immacolata Iacone
nell'unico colloquio mensile previsto per i detenuti sottoposti al regime del
carcere duro (41bis). Piccolo ma non irrilevante passo indietro: sei mesi prima.
È il 2 marzo. L'ex boss della camorra si sfoga in un colloquio riportato sulle
colonne di questo giornale: "Mi hanno sepolto vivo in cella, se parlo crolla lo
Stato", dichiara Cutolo. A stretto giro arriva la replica del procuratore
nazionale antimafia, Franco Roberti. "Cutolo dica quello che sa e sarà valutato,
siamo pronti a indagare", lo incalza il 10 marzo. Un invito, più che eloquente,
rivolto a "don Raffaele" affinché potesse prendere in considerazione l'idea -
sempre parole di Roberti - di fare "seguire alle dichiarazioni contro lo Stato
anche delle dichiarazioni concrete". Perché, è il ragionamento, "la possibilità
di uscire dalla condizione del 41bis dipende soltanto da lui...". Lui, Cutolo.
Torniamo dunque a settembre. Non si sa se e quanto le parole di Roberti abbiano
instillato nel vecchio padrino della camorra lo spunto per una riflessione (a
parte una breve parentesi nel '94 - morta sul nascere - l'ex boss di Ottaviano
è sempre stato un muro di silenzio). Ma adesso Raffaele Cutolo vuole parlare. Di
Moro, sicuramente. Forse anche di altro. Chiede di essere ascoltato da chi sulla
morte del politico Dc sta cercando di fare chiarezza. In questi casi la prassi
prevede due possibilità: o il detenuto scrive - di persona o attraverso il
proprio legale - al magistrato (o ai magistrati) che indagano. O affida la sua
richiesta al direttore del carcere. Sta di fatto che la seconda metà di
settembre, Giuseppe Boschieri, luogotenente dei carabinieri, consulente della
Commissione Moro, contatta uno dei legali di Cutolo, l'avellinese Gaetano
Aufiero. Il carabiniere chiede se all'interrogatorio richiesto dal detenuto
eccellente volesse prendere parte anche il suo difensore. Ma non trattandosi di
un interrogatorio di garanzia, il legale ritiene superflua la propria presenza.
Lunedì 14 settembre 2015. Nel carcere di via Burla - dove sono reclusi tra gli
altri anche i super boss Totò Riina e Leoluca Bagarella (quest'ultimo appena
trasferito in Sardegna), il "Nero" Massimo Carminati e Marcello Dell'Utri -
Cutolo parla. Dichiarazioni spontanee. Che finiscono in un verbale. È uno dei 41
documenti raccolti dalla Commissione Moro e annunciati all'ufficio di
presidenza. Si legge nell'elenco: "Verbale di riversamento di files audio su
supporto informatico relativi all'escussione del detenuto Cutolo Raffaele,
avvenuta il 14 settembre 2015". Mittente del documento 316/1, protocollo 1027,
data 21-09-2015, è il luogotenente Boschieri. Leggendo le carte che mettono in
ordine i documenti c'è un particolare che balza all'occhio: il verbale relativo
all'interrogatorio di Cutolo è segreto. Di più. Dei 41 documenti raccolti da
parlamentari, magistrati, poliziotti, carabinieri che collaborano con la
commissione, il 316/1 è l'unico secretato. Gli altri sono tutti liberi o, al
massimo, riservati. Perché? Che cosa ha rivelato sulla fine di Moro l'ex capo
della Nco? Ha riferito circostanze e particolari che non devono o non possono
essere resi pubblici? E, soprattutto, perché a 74 anni, dopo mezzo secolo al
gabbio, e 34 anni di tolale isolamento, Cutolo decide di parlare accettando, di
fatto, di collaborare con quello Stato da cui si è sentito "usato e
abbandonato"? Il riferimento è al suo coinvolgimento nella vicenda dell'ex
assessore regionale Dc Ciro Cirillo, sequestrato dalle Br a Torre del Greco nel
1981 e poi liberato - secondo una sentenza passata in giudicato - "alla fine
di una lunga e serrata trattativa tra apparati dello Stato e il boss Raffaele
Cutolo, a cui si è chiesto di intervenire presso le Br per ottenere la
liberazione di Cirillo". Tredici ergastoli, record italiano di lungodegenza
carceraria, sposato con Immacolata Iacone da cui ha avuto (inseminazione
artificiale) la figlia Denise di 7 anni. Disse Cutolo in un'intervista a Repubblica nel
2006: "Mi sono pentito davanti a Dio, non davanti agli uomini. È immorale fare
arrestare persone innocenti per avere soldi e protezione dallo Stato.
Riabilitarsi significa pagare gli errori con dignità. La dignità è più forte
della libertà, non si baratta con nessun privilegio... ".
Il lato oscuro del Paese
nei segreti del professore. Cutolo riapre il caso Moro,
scrive il
18/11/2015 Bruno De Stefano su “Metropolisweb”. Perché non
ha mai collaborato con lo Stato? Perché non ha voluto contribuire a sciogliere
quel grumo di misteri che ha accompagnato prima la sua irresistibile ascesa e
poi il suo rapido declino? Perché si è negato la possibilità di trascorrere la
vecchiaia lontano dal 41 bis per godersi la moglie e la figlia? Perché, restando
in silenzio, ha consapevolmente allungato il collo sotto quella ghigliottina
rappresentata da 13 ergastoli? Da sempre Raffaele Cutolo si porta appresso un
grappolo di interrogativi quasi tutti senza risposta. Almeno fino a ieri, quando
il quotidiano “la Repubblica” ha raccontato che l’ex boss di Ottaviano, feroce
capo della Nuova camorra organizzata attualmente al carcere duro nel
penitenziario di Parma, ha aperto il suo scrigno di segreti per svelare ciò che
sa sul sequestro di Aldo Moro, lo statista democristiano rapito dalle Brigate
Rosse il 16 marzo del 1978 e poi assassinato 55 giorni dopo, all’alba del 9
maggio. Il “professore”, così come lo chiamavano in tanti, non sarebbe però
diventato un collaboratore di giustizia, categoria che ha sempre disprezzato
perché, parole sue, «è immorale fare arrestare persone innocenti per avere soldi
e protezione dello Stato», aggiungendo di essersi «pentito davanti a Dio e non
davanti agli uomini». Non è la prima volta che il nome di Cutolo cammina
parallelamente a quello di Moro, anzi. Negli anni scorsi proprio l’ex boss aveva
sostenuto di essersi interessato, su sollecitazione del suo avvocato Francesco
Cangemi, alla trattativa per la liberazione dello statista democristiano.
Attraverso esponenti della Banda della Magliana sarebbe venuto a conoscenza del
covo in cui le Br tenevano Moro prigioniero; dopo aver ottenuto rassicurazioni
da alcuni esponenti politici - avrebbero alleggerito la sua detenzione in cambio
dell’indirizzo del covo - Cutolo aveva dichiarato di aver ricevuto un
avvertimento dal suo braccio destro, Vincenzo Casillo: «C’è chi non vuole la
liberazione di Moro, i nostri referenti politici hanno detto che devi farti gli
affari tuoi». Dettaglio non trascurabile: Casillo è morto dilaniato da
un’autobomba nel 1983, l’avvocato Cangemi ha sempre negato di aver palato di
Moro con il suo cliente. Quindi non ci sono conferme a questa versione. Ora si
scopre che il fondatore della Nco ha fornito nuovi elementi che sarebbero stati
secretati. Dunque, almeno stavolta le sue parole vengono ritenute attendibili.
Detto questo, è il caso di porsi delle domande. Quesiti suggeriti
dall’imperscrutabile comportamento che Cutolo ha tenuto da quando è finito in
galera. Come mai, ad esempio, ha deciso di parlare proprio ora che ha 74 anni e
un fisico sfibrato da una serie di malanni? Per quale oscura ragione ha deciso
di sbriciolare quel muro del silenzio dietro il quale si è nascosto per decenni,
irrobustendolo ogni tanto con ambigue allusioni, tipo “se esco e parlo, crolla
il Parlamento»? Addentrarsi in suggestive dietrologie è tempo perso, meglio
affidarsi a fatti concreti, ad uno in particolare. Non è la prima volta che
Cutolo compie un passo in avanti verso lo Stato. Più di vent’anni fa, infatti,
il camorrista di Ottaviano aveva deciso di collaborare con i magistrati ed aveva
anche verbalizzato alcune dichiarazioni. A raccontarlo è stato Franco Roberti,
attuale capo della Direzione nazionale antimafia e per lungo tempo pubblico
ministero a Napoli. Cinque anni fa, il magistrato svelò che l’ex boss aveva
deciso di vuotare il sacco, ma che poi innestò la marcia indietro proprio mentre
era pronto il trasferimento in una località protetta. Sostenne di non voler più
pentirsi perché le sue donne, cioè la moglie Immacolata Iacone e la sorella
Rosetta, gli avevano detto di non farlo. Una spiegazione che non hai mai
convinto Roberti, secondo il quale «Cutolo indietreggiò sulla strada del
pentimento perché fu minacciato dai servizi segreti». Un’affermazione piuttosto
impegnativa pronunciata da un magistrato di primissimo piano. E allora, dunque,
come mai proprio adesso l’ex boss è tornato, seppur parzialmente, suoi passi? E
perché, infine, non parlare invece della trattativa per l’assessore regionale
democristiano Ciro Cirillo, rapito dalle Br nell’aprile del 1981 e poi liberato
al termine di un oscuro e ripugnante mercanteggiamento tra Dc, pezzi dello Stato
e camorristi?
Raffaele Cutolo voleva pentirsi, ma fu minacciato dai servizi
segreti,
scrive il 06/03/2010 “Metropolisweb”. Si era aperta una crepa nella coscienza di
Raffaele Cutolo, era stato ad un passo dal raccontare i retroscena degli orrori
della faida degli anni Ottanta, poi, la
decisione di tirarsi indietro quando era già stato avviato un imponente servizio
di protezione. “Le mie donne mi hanno detto di
non pentirmi”, disse allora il professore della Nco, “in realtà Cutolo ebbe
pressione da parte dei servizi segreti”. A
raccontarlo è il procuratore capo della Repubblica di Salerno, Franco Roberti.
Allora, il pm Efra magistrato in servizio alla Dda
di Napoli. Era quasi riuscito nell’impresa più ardua degli ultimi trent’anni,
far parlare il boss che fondò una delle organizzazioni criminali
più potenti della storia del Mezzogiorno. Cutolo, secondo il racconto che
Roberti affida alla stampa questa mattina, era pronto
a vuotare il sacco, partendo dalle trattative per la liberazione di Aldo Moro.
L’impresa stava riuscendo grazie anche al lavoro del
pubblico ministero Alfredo Greco, al quale il superboss aveva sussurrato:
“Dottore, da dove dobbiamo cominciare?”. In quei giorni,
Cutolo è formalmente indagato per la morte di Salvatore Alfieri, fratello del
boss Carmine. E’ recluso nel carcere di Belluno, ma
per i primi colloqui è stato trasferito nel penitenziario di Carinola. Non
basta, per ascoltare i segreti e gli orrori della cruenta faida degli
anni Ottanta si decide che è meglio trasferire il professore di Ottaviano in una
struttura militare nel salernitano. Il viaggio è già programmato,
ma poche ore prima Cutolo torna sui suoi passi. “Non voglio più collaborare”. Il
Pm Greco parte alla volta del carcere di
Carinola, viene seguito da un’auto e una moto di grossa cilindrata e capisce che
qualcosa non va. Arriva nel penitenziario, ma prima
di lui sono arrivati decine di uomini funzionari del ministero. A quel punto, è
impossibile convincere il superboss. E quella crepa
nella coscienza di Cutolo torna magicamente a richiudersi.
Denyse, 7 anni, scrive al
papà Raffaele Cutolo: «Chiedi scusa, così ti fanno uscire»,
scrive il
18/11/2015 Giovanna Salvati su “Metropolisweb”. «Qualsiasi testo gli venga
portato in carcere viene cestinato». Tutto. Tranne quella lettera che ha scritto
Denyse, sette anni e due occhi che brillano come stelle. Lei si chiede
ingenuamente: «Se papà ha sbagliato basta che chieda scusa, e tutto si risolve».
Non è così. E Immacolata Iacone lo sa. L’innocenza della figlia del boss
Raffaele Cutolo sta tutta in una considerazione. La speranza della madre,
invece, sta nel desiderio di poter invecchiare accanto al suo uomo. Uno che
negli anni Ottanta guidava l’esercito di morte della Nuova Camorra Organizzata.
Lei sceglie di parlare solo per raccontare un uomo «stanco». Dice Immacolata
Iacone: «Ho la possibilità di incontrarlo solo ogni due mesi, ma solo per dieci
minuti». Una boccata di ossigeno per il boss che dura seicento brevissimi
secondi, nei quali l’ex capo della camorra appare spesso in vestaglia e capelli
grigio ben pettinati. «Dieci minuti nella sala dei colloqui per ritrovare la
voglia di vivere, o meglio, di sopravvivere». Quando la porta si spalanca,
Cutolo incontra sua figlia ed è - racconta Immacolata - una delle poche ragioni
di vita». «Il sorriso della piccola gli ridona colore e calore, allora si alza
dal letto dove ormai passa le sue intere giornate e il sorriso torna sul suo
volto. Raffaele non va nemmeno più a passeggio nell’area riservata ai detenuti
al carcere duro, e Denise resta l’unica cosa che gli toglie il respiro. La sua
principessa, come dice lui». Denyse ovviamente non sa nulla del passato. Della
camorra, del sangue, dei processi, dell’ergastolo, del carcere duro. Non sa del
Cutolo da tredici ergastoli, che da 34 anni vive in isolamento e che da 23 vive
è al 41 bis. «Le ho raccontato che suo padre è in quell’istituto perchè ha
commesso degli errori e lì le persone lo aiutano a non sbagliare più», racconta
Immacolata Iacone. «Per Denyse allora tutto diventa un gioco: dai cancelli alle
guardie penitenziarie che sorvegliano ogni colloquio». Mentre racconta i suoi
brevi incontri con il marito Immacolata china spesso il capo quasi sotto un peso
insopportabile. Ottaviano-Parma, e ritorno. Tutto per quei dieci minuti. Ogni
due mesi. «Per Raffaele, Denyse è l’unica cosa che conta, però è stanco. Il suo
cuore è stanco e malato. Quando andiamo a trovarlo non vuole nemmeno più
parlare, vuole solo trascorrere del tempo con la figlia. Io per questo mi
sacrifico: non importa che io ci sia, preferisco che stia più tempo con sua
figlia, che se la goda, perché è la sua unica medicina che funziona». Immacolata
racconta di un uomo stanco e ammalato, che rinuncia anche all’ora d’aria, che
«non scrive più una lettera», che non vede da mesi sua sorella Rosetta, che
chiede di respirare, che dice di essersi pentito solo davanti a Dio, e che
avrebbe raccontato nuovi particolari del rapimento di Aldo Moro. Verbali che,
secondo alcuni, potrebbero far tremare i polsi a molti potenti. Ancora oggi.
Raffaele Cutolo ha spento le sue 74 candeline in cella il 4 novembre scorso, in
isolamento in quella cella dove ormai ha consumato la sua vita da «sepolto vivo»
come lui stesso ha dichiarato lo scorso 2 marzo. «Ci sono altri detenuti che
sono nel suo stesso regime di detenzione ma a loro almeno è concesso di stare in
compagnia, perchè a Raffaele ancora no?», si chiede Immacolata, la moglie del
boss della Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo. Un marchio che ancora
pesa. In città e fuori. A Ottaviano, a Napoli, in Campania, in Italia. Lei non
si meraviglia. Lei questa vita l’ha scelta. E non si è mai lamentata. Tranne per
una cosa: «Raffaele Cutolo è stanco, malato, non ha più la forza di combattere
contro la sofferenza dell’isolamento. Non ha mai chiesto sconti, semplicemente
umanità».
IL SEQUESTRO
MORO E COSA NOSTRA.
Sequestro Moro e trattative
Stato-mafia: «Quando i servizi segreti ringraziarono il “papa” Michele Greco»,
scrive Roberto Galullo su “Il Sole 24ore”. E’ di ieri la notizia che il
procuratore generale di Roma, Luigi Ciampoli, ha chiesto alla Procura di
procedere formalmente a carico di Steve Pieczenik, funzionario del Dipartimento
di Stato Usa ai tempi del sequestro di Aldo Moro, il politico assassinato dalle
Br il 9 maggio 1978. Un lancio Ansa delle 14.26 spiega che nei confronti
dell’americano Steve Pieczenik, vi sono «gravi indizi circa un suo concorso
nell’omicidio dello statista democristiano». Le presunte responsabilità di
Pieczenik vengono messe in luce dal procuratore generale Ciampoli nella
richiesta di archiviazione, inoltrata ieri al gip del tribunale di Roma,
dell’inchiesta sulle rivelazioni dell’ex ispettore di polizia Enrico Rossi che
aveva ipotizzato la presenza di agenti dei servizi segreti, a bordo di una moto,
in via Fani, a Roma, quando Moro fu rapito dalle Brigate Rosse. Il pg ha quindi
disposto la trasmissione della richiesta di archiviazione – un documento di 100
pagine – al procuratore della Repubblica di Roma «perché proceda nei confronti
di Steve Pieczenik in ordine al reato di concorso nell’omicidio di Aldo Moro,
commesso in Roma il 9 maggio 1978». La figura dell’esperto Usa – consulente
dell’allora ministro dell’Interno Francesco Cossiga nel comitato di crisi
istituto il 16 marzo 1978, giorno del rapimento di Moro e dell’uccisione degli
uomini della scorta – è da molto tempo, e da molti, considerata centrale nella
vicenda del sequestro e dell’omicidio del presidente della Dc. La procura
generale di Roma sottolinea che «sono emersi indizi gravi circa un suo concorso
nell’omicidio, fatto apparire, per atti concludenti, integranti ipotesi di
istigazione, lo sbocco necessario e ineludibile, per le Br, dell’operazione
militare attuata in via Fani, il 16 marzo 1978, ovvero, comunque, di
rafforzamento del proposito criminoso, se già maturato dalle stesse Br». Secondo
Luigi Ciampoli, anche un ufficiale del Sismi, il servizio segreto militare
dell’epoca, il colonnello Camillo Guglielmi, avrebbe dovuto essere indagato con
l’accusa più grave di concorso nel rapimento di Moro e nell’uccisione della sua
scorta. Nei suo confronti, rileva il Pg, non si può promuovere l’azione penale
perché è morto. Guglielmi era finito nelle inchieste sulla strage perché non
aveva dato spiegazioni ritenute plausibili dai magistrati sulla presenza in via
Fani al momento in cui scattò l’agguato delle Brigate rosse. Del rapimento di
Aldo Moro, nel passato, parlarono (e a profusione) anche due pentiti di
‘ndrangheta: Francesco Fonti e Saverio Morabito. Francesco Fonti, nato a
Bovalino il 22 febbraio 1948 e morto il 5 dicembre 2012, era un uomo legatissimo
alle cosche Romeo e Nirta. Nel 1994 divenne collaboratore di giustizia (seppur
tra mille avventure). Nel 2003 consegnò all’allora sostituto procuratore
nazionale antimafia Enzo Macrì un memoriale di 49 pagine. Nel 2009 pubblicò il
libro “Io Francesco Fonti pentito di ‘Ndrangheta e la mia nave dei veleni, Falco
editore”, all’interno del quale un lungo capitolo era proprio dedicato a quel
rapimento e al ruolo della ‘ndrangheta. Ma è importante anche ricondursi a
quanto ruota intorno all’ex parlamentare Dc Benito Cazora. Tra coloro che ne
parlano c’è anche Francesco Di Carlo, pentito di mafia di Altofonte del quale,
da giorni, vi sto parlando attraverso le sue dichiarazioni nelle audizioni del
processo sulla trattativa Stato-mafia che sta conducendo il pool palermitano
(Vittorio Teresi, Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia). Nella
sua deposizione del 27 febbraio 2014, Di Carlo parla del sequestro Moro
sollecitato dal legale del Centro studi e iniziative Pio La Torre, l’avvocato
Ettore Barcellona, che ricorda come Di Carlo accennò, in altro procedimento
penale, a una riunione della Commissione provinciale sul caso Moro. Di Carlo
risponde senza problemi: «Mi ricordo che c’è stato subito un movimento per
vedere se potevano fare qualcosa, se ai politici ci interessava. Tutto questo
nell’interesse che poi uno li cerca… Che poi se uno fa… Cosa Nostra non fa
niente per niente. Una volta che si interessavano, gli avrebbero risolto il
problema, poi li avrebbero cercato per tantissime cose. Che già si cercavano,
quando era possibile, se noi vediamo nel passato cosa era i processi, se
arrivano in Cassazione, se ci arrivavano o meno. E per Moro mi ricordo che sono
stati chiamati…A quei tempi c’era Gioia, Lima e qualche altro. Avevamo pure noi
il senatore …omissis… che faceva parte della famiglia di Bontate, democristiani
tutti, per fare sapere a Roma se avevano bisogno di intervenire per fare
liberare Moro. Michele Greco a me personale, perché non lo poteva dire, mi aveva
fatto parlare con Peppino, Peppino Santovito, che già dirigeva i servizi a Roma,
per vedere se aveva bisogno. I politici avevano fatto sapere che a Roma non ci
interessava, perché si voleva fare tramite le Brigate Rosse una pressione dentro
il carcere. Ma quando io parlo con il generale Santovito, mi dice: la cosa è più
complicata, è un’altra situazione, mi ringrazi a Michele Greco e a tutti. È
un’altra cosa, poi un giorno ti spiegherò. Questi i risultati,
l’interessamento». Insomma, per come racconta Di Carlo, lo Stato fece a meno
anche dell’aiuto di Cosa nostra (come del resto fece con la ‘ndrangheta per come
la raccontano i due pentiti calabresi) per salvare Aldo Moro. Solleva l’anima e
il cor sapere che non lo fece bruscamente ma con educazione. Ringraziando
Michele Greco, detto il “papa” di Cosa nostra.
Roma “Capitale corrotta =
Italia nazione infetta”. A 60 anni di distanza dalla prima grande inchiesta
giornalistica sulla speculazione edilizia a Roma e gli intrecci con la finanza
vaticana e il “generone capitolino” (pubblicata sull’Espresso l’11 dicembre
1955, a firma di Manlio Cancogni), siamo ancora ad interrogarci sulle cause e la
diffusione di quel virus che ha nel suo DNA un intreccio perverso tra malaffare,
politica e “poteri forti” dello stato. Quel “generume”, come lo ribattezzò il
grande Giorgio Bocca, che viveva e vive all’ombra del Cupolone, che si ritrova
in circoli esclusivi, che frequenta salotti di anziane “signore” vedove di
esponenti della destra romana, che si genuflette nelle ovattate stanze vaticane,
che sfoggia abbigliamenti d’altri tempi per omaggiare gli ospiti illustri nei
cortili vaticani come “maggiordomi d’ancien regime”, che si divide solo allo
stadio Olimpico tra le due opposte tifoserie, che sopravvive alle intemperie
economico-politiche e ai rivolgimenti delle amministrazioni capitoline,
continuando a mungere affari e stringere alleanze. Quel generone comprendeva un
tempo i rampolli della nobiltà decaduta, “papalina e nera”, esponenti di primo
piano del mondo politico e governativo, specie democristiano, massoni più o meno
“coperti”, ecclesiasti di peso nella Curia, alti ufficiali, dirigenti dei
servizi segreti, palazzinari, vertici di alcuni quotidiani. Erano gli anni del
“Sacco di Roma”, quando i politici del centrosinistra di allora e gli affaristi
in corsa per cementificare ovunque, in barba alle leggi urbanistiche, dovevano
comunque passare per le stanze cardinalizie della Società Generale Immobiliare,
il nucleo dorato della finanza vaticana, che negli anni Settanta passò nelle
grinfie di Michele Sindona. A quel generone, dalla fine degli anni Settanta si è
aggiunta una “Cupola” criminale, dalle fattezze mafiose, ma che ha tratto spunto
nei modi di operare dai primi e vi ha aggiunto una spregiudicatezza e una
efferatezza sconosciuta. Una Cupola che ha di fatto soppiantato i modi felpati
di un tempo con l’arroganza e la violenza da “Romanzo criminale”. Ma a bloccare
ogni indagine giornalistica e a stroncare qualsiasi denuncia c’era allora la
Casta giudiziaria raccolta nel “Porto delle nebbie” del Palazzaccio, che veniva
in soccorso alla classe politica e affaristica del momento, “sopendo e
troncando”, fino alle avocazioni e ai trasferimenti in procure minori.
1978 – 1979: gli anni della
“svolta”. Un giorno forse si scopriranno i fili che tennero insieme nel ‘78
personaggi delle Brigate Rosse, esponenti della Banda della Magliana, apparati
deviati dei servizi e massoni “piduisti” durante e dopo il rapimento e
l’uccisione del presidente della DC, Aldo Moro, l’uomo dell’apertura governativa
al PCI. Una brutta fine la fece anche il giornalista Mino Pecorelli, perché si
vantava si saperne molto e di rivelare nomi e cifre, che avrebbero squarciato il
velo dell’ipocrisia che coprivano gli intrecci perversi. Moro e Pecorelli furono
dunque le vittime ancestrali che segnano il confine della “Terra di mezzo”: il
punto di convergenza e di non ritorno tra malavita organizzata, ambienti
dell’estrema destra terroristica e del brigatismo rosso, settori dei servizi
deviati, massoneria coperta, mondo degli affari e della politica che conta.
Qualcuno che ne sapeva più degli altri è purtroppo morto, portando con sé i
segreti inconfessabili di quel “delitto di stato”. Si era battuto per
liberazione di Moro, aveva perso e si era dimesso dal governo. Più tardi salì al
Colle, con un accordo bipartisan e un’unanimità mai più ripetuta. Le sue carte e
le sue registrazioni non sono mai state ancora lette né decifrate. E forse non
sarà sufficiente neppure aprire gli “armadi della vergogna” di Forte Braschi per
decrittarne i segreti tra gli impolverati faldoni. Ma una concomitanza salta
agli occhi: da quel periodo, i reduci della Banda della Magliana estendono i
loro tentacoli mafiosi e, nonostante sanguinarie vendette personali ed alcune
coraggiose indagini, il sistema di quei balordi si è andato affermandosi e
incuneandosi negli sulla vita politica e affaristica della Capitale. Durante il
periodo epico e di rottura col passato della seconda metà degli anni Settanta,
grazie alla Rinascita democratica, sociale e culturale avviata dalle
“amministrazioni rosse” con i sindaci comunisti (Argan, Petroselli e Vetere),
Roma sembrava aver chiuso per sempre con l’epoca dei palazzinari, con le
periferie “accattone” (850 mila abitanti reclusi in quartieri fuorilegge per il
Piano Regolatore, senza servizi primari e trasporti), con la malavita rozza e
“pastasciuttara”. La città fu restituita ai suoi abitanti, le periferie
divennero parte integrante del sistema urbanistico, l’integrazione generò un
circuito virtuoso di convivenza e di drastica diminuzione dell’allarme sociale e
criminale. Ma sotto, sotto, covavano i prodromi degli epigoni del “Signore degli
anelli”. In realtà i “Signori delle tenebre” cominciavano ad uscire dal mondo
dei morti per conquistare la “Terra di mezzo” e volare verso le vette rarefatte
di Valinor, utilizzando i mostri della “Terra di sotto” per stroncare qualsiasi
opposizione. Una mitologia, creata dallo scrittore inglese Tolkien, cara ai
giovani della destra più nostalgica e violenta che, abbandonati i pestaggi e gli
assalti ai “rossi”, negli anni Ottanta s’infilano i golfini di cachemire,
indossano cappotti loden e si introducono negli ambienti del generone romano.
La mafia non doveva
intercedere per la liberazione di Moro,
scrive Rainews24 Martedì 12
Gennaio 2010. Esponenti dei Servizi Segreti fecero pressioni sull'ex sindaco
mafioso di Palermo Vito Ciancimino perchè, qualora alla mafia fosse stato
chiesto di intercedere per la liberazione dell'onorevole Aldo Moro, lui
convincesse il boss Bernardo Provenzano a non intervenire. E' una delle
rivelazioni contenute nei verbali di interrogatorio di Massimo Ciancimino,
figlio di don Vito, depositate agli atti del processo al generale dei
carabinieri Mario Mori, ex vicecomandante del Ros accusato di favoreggiamento
alla mafia. Interrogato dai pm della dda di Palermo il 21 giugno del 2008,
Ciancimino racconta dei rapporti tra il padre ed esponenti dei Servizi. "I
rapporti con i Servizi - spiega il teste - mio padre li ha sempre avuti". E
prosegue: "I Servizi hanno avuto un ruolo sempre chiave, specialmente dopo il
sequestro Moro. La prima volta che si è parlato di Servizi, realmente,
all'interno di Cosa Nostra, avvenne nel sequestro di Aldo Moro. Perchè, una
volta sempre in occasione di appunti che prendevo per la stesura di questo mio
ipotetico libro, mio padre mi disse che era stato pregato per ben due volte, di
non dar seguito a delle richieste pervenute per fare pressione su Bernardo
Provenzano perchè si attivassero per potere interferire, per quantomeno aiutare
lo Stato nella ricerca del rifugio di Moro". Poi spiega meglio: "Mio padre
diceva che tali richieste potevano pervenire al suo paesano Riina da altri
gruppi o esponenti politici, se ciò fosse avvenuto, mio padre doveva convincere
il Provenzano a non immischiarsi in questo affare". Ad ulteriore chiarimento il
pm domanda: "Dunque per ben due volte sarebbe stato chiesto a suo padre di
intervenire su Provenzano a impedire o ad evitare che vi fossero interventi di
Cosa Nostra per liberare Aldo Moro, giusto?". "Perfetto", risponde Massimo
Ciancimino. "Un momento in cui ci fu un grande movimento dei Servizi Segreti
con mio padre - racconta Massimo Ciancimino - fu nel 1980. Non mi posso
scordare: 19 giugno 1980. Mi ricordo che proprio quella sera ci fu la strage di
Ustica". "Mio padre - spiega - fu chiamato subito e si incontrò uno o due giorni
dopo col ministro Ruffini. Mi disse che era successo un casino e che doveva
vedere, fece andare a chiamare l'onorevole Lima, fece andare a chiamare altre
situazioni, altri personaggi, e quando ho chiesto a mio padre realmente cosa
fosse successo, mi raccontò che già allora, il primo momento, si seppe della
storia dell'aereo francese che per sbaglio aveva abbattuto il DC9 e che
bisognava attivare un'operazione di copertura nel territorio affinchè questa
notizia non venisse per niente". "E qualora ci fosse stato bisogno di interventi
di qualsiasi tipo - conclude - loro dovevano poter contare su mio padre". "Loro
chi?", chiede il pm al teste. "I Servizi", risponde Ciancimino.
Andreotti, potere e
misteri. Dai nastri di Aldo Moro ai processi di mafia.
Nel 1990 vengono ritrovate nel covo milanese delle Brigate rosse 400 pagine
risalenti al sequestro che confermano le accuse di Pecorelli. All'interno, la
conferma dell'esistenza di una struttura anti-guerriglia segreta e duri attacchi
contro l'ex senatore a vita. Una fitta trama di intrighi e omissioni che
proseguono lungo tutta la vita del sette volte presidente del Consiglio, dallo
scontro con Cossiga alla morte, avvenuta il 6 maggio scorso, scrive Peter Gomez
l'11
maggio 2013 su "Il Fatto Quotidiano".
Dai primi passi dentro le mura vaticane (con accesso diretto all’appartamento di
Pio XII) ai rapporti con Sindona. Dal caso di Wilma Montesi ai presunti contatti
con Licio Gelli. E poi Salvo Lima e i boss, Ciarrapico e gli appalti. Una storia
politica lunghissima, tutta vissuta nei più importanti palazzi del potere,
vedendo scorrere i più clamorosi e misteriosi eventi della storia del Paese. Dal
dopoguerra agli anni ’90. Ecco il primo degli appuntamenti con “Andreotti,
potere e misteri”: la storia e i segreti del Divo raccontati in quattro puntate
dal direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez. Nell’ottobre
del 1990, durante i lavori di ristrutturazione di un covo milanese delle
Brigate rosse,
perquisito 12 anni prima dagli uomini del generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa,
vengono ritrovate 400 pagine di documenti risalenti all’epoca del sequestro
di Aldo Moro.
Si tratta di una ventina di lettere inedite scritte dallo statista assassinato
e, soprattutto, di una copia di un suo
memoriale già
consegnato alla magistratura dai carabinieri nel ’78. A quell’epoca la rivista
Op aveva quasi subito ipotizzato che quel documento fosse incompleto. Aveva
denunciato la scomparsa
delle bobine su
cui i terroristi avevano inciso gli interrogatori del democristiano, e aveva
intensificato, partendo dal caso
Caltagirone,
gli attacchi contro Andreotti. Le carte, misteriosamente ritrovate nel ’90,
confermano parte delle
denunce di Pecorelli.
Nella nuova copia del memoriale sono, infatti, presenti brani nei quali viene
affrontata la questione dell’esistenza in Italia di una struttura
anti-guerriglia segreta(Gladio)
e, soprattutto, ci sono alcuni durissimi passaggi riguardanti Andreotti. Moro
per esempio parla dello scandalo
Italcasse-Caltagirone e
sostiene, tra l’altro, che la nomina del nuovo presidente dell’istituto di
credito era “stata fatta da un privato, proprio l’interessato Caltagirone che ha
tutto sistemato…”. Come era già avvenuto nel caso delle bobine sul golpe
Borghese
registrate dal capitano La
Bruna,
insomma, ai magistrati nel ’78 era stato consegnato solo il materiale ritenuto
più innocuo. Non è chiaro chi abbia materialmente omissato i memoriali e nemmeno
si sa che fine abbiano fatto le bobine con gli interrogatori di Moro. E’ certo,
invece, l’assassinio di Dalla Chiesa da parte di Cosa
nostra.
Una volta andato in pensione il valoroso generale viene, infatti, inviato a
Palermo come prefetto
antimafia.
E lì, abbandonato da tutti e attaccato pubblicamente dagli andreottiani
(definiti proprio da Dalla Chiesa in lettera indirizzata a Giovanni Spadolini,
“la
famiglia politica più
inquinata del luogo”), crolla, con la moglie, sotto i colpi dei killer mafiosi.
E’ il 3
settembre del 1982.
La sua cassaforte sarà trovata vuota. Prima di accettare quell’incarico Dalla
Chiesa aveva incontrato, tra gli altri, anche Andreotti. Subito dopo, nel
proprio diario aveva annotato: “Andreotti mi ha chiesto di andare e,
naturalmente, date le sue presenze
elettorali in
Sicilia si è manifesta per via indiretta interessato al problema; sono stato
molto chiaro e gli ho dato però la certezza che non avrò riguardo per quella
parte di elettorato cui attingono i suoi grandi
elettori […]
sono convinto che la mancata conoscenza del fenomeno lo ha condotto e lo conduce
a errori
di valutazione […]
il fatto di raccontarmi che intorno al fatto Sindona un certo Inzerillo morto
in America è giunto in una bara e con un biglietto da 10 dollari in bocca,
depone nel senso…”. Il 12 novembre del 1986, Giulio Andreotti sarà interrogato
come testimone al primo maxi-processo alla
mafia. Al centro della sua deposizione ci sarà ovviamente il contenuto del diario dell’eroico
generale. Che, incredibilmente, Andreotti tenterà di smentire.
Per lui Dalla Chiesa si è, infatti, confuso. Andreotti negherà, così, di aver
fatto con lui nomi di Inzerillo e
di
Sindona.
E soprattutto sosterrà che il generale non gli disse mai che non avrebbe avuto
riguardi per il suo elettorato compromesso con la mafia. Quel giorno,
continuando a difendere
Lima e
tutti i suoi accoliti, Andreotti dimostra però che almeno su un punto Dalla
Chiesa davvero sbagliava. Il suo non era stato un errore di valutazione. Era qualcos’altro.
Il 27 luglio del ’90, il magistrato veneziano
Felice Casson,
è autorizzato dal presidente del Consiglio Giulio Andreotti ad acquisire nella
sede del Sismi,
documenti relativi a un’organizzazione segreta antiguerriglia destinata ad
entrare in azione in caso d’invasione dai paesi del blocco sovietico. Il 3
agosto davanti alla Commissione
stragi Andreotti
spiega che la struttura è rimasta attiva fino al 1972. Il 12 ottobre viene
ritrovato a Milano la copia del memoriale Moro in cui si fanno cenni
all’organizzazione. Mentre montano le polemiche sulla strana scoperta, il 19
ottobre Andreotti fa arrivare in commissione un documento, sul frontespizio del
quale compare per la prima volta la
parola “Gladio”.
Leggendo le dodici cartelle i parlamentari scoprono, però, che nel ’72
l’organizzazione non era stata sciolta, solo smilitarizzata e fatta rientrare
nei servizi. Bettino
Craxi
intanto mette apertamente in dubbio le versioni ufficiali sul ritrovamento del
secondo memoriale Moro. Parla di “manine
e manone” e
fa chiaramente intendere che i documenti dello statista (senza omissis)
potrebbero essere stati fatti ritrovare apposta. L’indagine della Commissione
stragi prosegue. I capi dei servizi rivelano che Gladio è nata almeno nel ’51,
quando era presidente del consiglio De
Gasperi.
Nel ’56 venne firmato un accordo segreto
tra Cia e il Sifar in
seguito al quale, tre anni dopo, Gladio entrò nelle strutture Nato. Tutti questi
passaggi, ovviamente, avvennero all’insaputa del parlamento. Come campo di
addestramento dei gladiatori veniva utilizzata la base militare di capo
Marrangiu.
E’ la stessa struttura dove, nel ’64, il capo del Sifar De Lorenzo aveva
progettato di trasferire, in caso di colpo di Stato, tutti gli oppositori
politici di sinistra. Andreotti in più interventi difende la legalità della
struttura. E lo stesso fa il presidente della Repubblica
Francesco Cossiga,
molto coinvolto nell’organizzazione di questi “patrioti”. Cossiga però ipotizza
che Andreotti abbia reso nota l’esistenza di Gladio per screditarlo e
costringerlo alle dimissioni. Ad avviso del presidente-picconatore, Andreotti ha
in mente un solo obiettivo: mandarlo a casa in anticipo e farsi eleggere al suo
posto con l’appoggio del partito comunista. Tra Andreotti e Cossiga è scontro
aperto. A
seguito delle polemiche, nella primavera del ’91, il sesto governo Andreotti
cade. Una settimana dopo si arriva al suo settimo
e ultimo governo,
dal quale escono però i repubblicani. In giugno Andreotti, va in Sicilia per due
giorni. Qui sostiene, al fianco di Salvo
Lima, i
propri candidati alle elezioni regionali. Cosa Nostra è inquieta. La prima
sezione della Corte di Cassazione deve decidere le sorti del primo
maxi-processo. La presenza di un giudice come Corrado
Carnevale,
secondo i collaboratori di giustizia, aveva fatto fino allora dormire sonni
tranquilli agli uomini d’onore. Ma il nuovo ministro di Grazia e Giustizia, il
socialista Claudio
Martelli,
adesso aveva accanto a sé al ministero un giudice come Giovanni
Falcone.
Per le sorti del processo, nella mafia, si cominciava a temere. E non era un
errore. Nell’ottobre
del ’91,
infatti, il presidente della corte di cassazione cambia d’autorità il collegio
che giudicherà il maxi. Di lì a tre mesi gli imputati di rispetto saranno tutti
condannati. Andreotti invece, a sorpresa, si riappacifica con Cossiga. Il
presidente in novembre lo nomina senatore
a vita.
Il suo governo, cosa mai accaduta prima, adesso combatte seriamente la mafia. Il 12
marzo del ’92,
Salvo Lima, il cugino di Sicilia, cade sotto i colpi di Cosa Nostra. Dopo mezzo
secolo troppa gente in Italia aveva cominciato a non
rispettare i patti.
Esplodono di nuovo le bombe. Muore
Giovanni Falcone.
Muore Paolo
Borsellino.
La mafia scopre il 41 bis. Piegati dal carcere
duro,
gli uomini d’onore cominciano a raccontare. Alcuni di loro diranno di aver visto
Andreotti da vicino. Altri parleranno per sentito dire. In aula al processo,
contro l’ex presidente del Consiglio vengono prodotti e ripetuti decine
e decine di verbali.
Un fiume di ricordi, un mare di testimonianze che ora è inutile star qui ad
analizzare. Perché alla fine, confermato dalla Cassazione, arriveranno un
attestato di colpevolezza “fino
alla primavera del 1980” e un’assoluzione per
i fatti successivi. Abbastanza per salvare l’imputato Andreotti Giulio dalle
pene comminate tribunale
degli uomini.
Troppo poco per evitargli di comparire, da lunedì 6 maggio 2013, davanti a
quello della storia.
Un uomo biondo “con gli
occhi di ghiaccio”… Novità sul caso Moro?
Scrive Nicola Tranfaglia
il 13 agosto
2015 su “Articolo 21.
A mano a mano che la nuova commissione parlamentare di inchiesta sul caso
riguardante il misterioso rapimento di 55 giorni (seguito dal barbaro
assassinio) di Aldo
Moro,
va avanti nel suo lavoro, emergono particolari e contraddizioni nella complessa
storia di quei giorni e di quei mesi che creano nuovi problemi all’insoluta storia
dei terrorismi italiani (con
forti interventi di altri Stati e di entità più o meno statuali, o di
associazioni come la P2 di Licio
Gelli e
simili) o a quella sempre aperta del rapporto tra le associazioni mafiose e la
politica attuale e non c’è quindi da stupirsi più di tanto che, persino in
queste calde giornate di metà agosto, si trovino ogni tanto nei lavori
parlamentari, e successivamente su alcuni settimanali o in trasmissioni
televisive, accenni a storie che riguardano, da una parte, la difficile (o
impossibile?) cattura dell’ultimo boss di
prima grandezza ancora libero di Cosa Nostra, Matteo
Messina Denaro, signore
e padrone
del circondario di Trapani, in Sicilia. Per quanto riguarda, il
caso Moro due
testimonianze di inquiline di via Fani 96, la via del tragico agguato, la
signora Armida
Chamoun e
la signora Franci hanno
spiegato al magistrato Antonio
Giammaria che
ha presentato pochi giorni una relazione alla commissione parlamentare di
inchiesta che nei giorni precedenti il rapimento c’era un continuo controllo da
parte di diverse persone e che un uomo e una donna entrarono più volte nel
palazzo e nel covo delle Brigate
Rosse indossando
caschi da motociclisti . E le due testimoni videro un
uomo biondo “con gli occhi di ghiaccio” vestito da aviere.
Ma dagli atti giudiziari precedenti non risulta che nessuno dei BR arrestati per
il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro aveva i capelli biondi e gli occhi
azzurri come affermano le due testimoni. In via
Gradoli peraltro
fu ritrovato l’elenco con gli acquisti per vestire un aviatore con
l’intestazione “Fritz” e il RIS dei
carabinieri sta indagando su alcuni reperti della base BR e sul DNA del
presidente della DC ucciso. Della signora Franci si sta cercando il verbale
della sua prima testimonianza del 1978 che si ha difficoltà a ritrovare e si
pensa a un confronto tra le due testimoni e gli altri abitanti di allora perché
molto forti restano le contraddizioni che le BR non hanno mai risolto su quei
giorni. Il 5 novembre 1995, ad esempio, una delle persone che avevano in
precedenza abitato nell’appartamento usato dai brigatisti,
Barbara
Balzerani,
sostiene che la base fu sgomberata il giorno stesso del rapimento ma che non
avvenne totalmente: “Ci siamo rientrati soltanto dopo la fine del sequestro,
cioè il 9 maggio”. Circostanza peraltro impossibile se si parla dello stesso
appartamento scoperto il 18 aprile precedente. Peraltro, sembra riemergere da
altre testimonianze che, per un certo periodo, Moro sia stato tenuto prigioniero
in via Gradoli, come negli anni medesimi si era ipotizzato, e le ipotesi si
collegano a una serie di riscontri che riguardano il camorrista Raffaele
Cutolo,
Alessandro Ortenzi (vicino
alla banda della Magliana) e il medico-nefrologo Giovanni
Pedroni,
il medico dell’Anello,
servizio segreto clandestino. Le altre rivelazioni che riguardano la latitanza
del boss di
Castelvetrano riguardano i viaggi e gli affari di Messina
Denaro e
che sono emersi da recenti indagini giudiziarie. “Certamente Messina Denaro può
recarsi più facilmente in Sudamerica e in Paesi in cui sono ancora rapporti
criminali interni. Penso ai paesi produttori di coca, in particolare Perù e
Colombia e non si può affatto escludere che il boss possa contare su alleati e
nei servizi e nelle forze dell’ordine, avendo di fronte a noi la storia di un
depistaggio su stragi di via d’Amelio e di Capaci che in Italia dura da più di
vent’anni. Sembrerebbe azzardato escludere che in Italia ci possano essere forme
di tutela attraverso depistaggio o attraverso altre complicità.” Il
vicepresidente della commissione, guidata da Rosy
Bindi,
non esclude anche le complicità in altri paesi europei come la Germania, la
Francia e la Spagna. “Denaro ha una proiezione di sé stesso poco tradizionale,
molto internazionale e imprenditoriale. Sicuramente i suoi interessi e
spostamenti riguardano almeno tre continenti.”
IL SEQUESTRO MORO E LA MASSONERIA.
Dalle carte
Moro spunta un dossier sul gran maestro di Piazza del Gesù.
Nell'archivio
delle carte di Aldo Moro presso l'Archivio centrale dello Stato di Roma, è
conservato un appunto riservato del Viminale che dimostra due cose, scrive
Alberto Custodero su “La Repubblica il 14 agosto 2014. La prima, l'attenzione
che lo statista ucciso dalle Br aveva nel tenere sotto osservazione la
massoneria. La seconda, che il ministero dell'Interno vigilava con estrema
attenzione le obbedienze. Al punto da redigere un documentato dossier nei
confronti del più noto dei gran maestri della massoneria italiana, Giovanni
Ghinazzi. Il questore di Bologna ne fa un ritratto inedito, che noi pubblichiamo
integrale, dal quale emerge una personalità forse poco conosciuta di quello che
è stato per anni il riferimento della massoneria francese al punto che ancora
oggi i fratelli di piazza del Gesù vengono soprannominati "ghinazziani". Da
allora altre inchieste hanno coinvolto in qualche modo la massoneria, o i
fratelli, al punto da indurre i magistrati a battezzare le loro inchieste
evocando la loggia di Licio Gelli. Dopo il 2010, ci sono state in particolare le
indagini P3 e P4 che hanno in qualche modo chiamato in causa ancora il ruolo
delle "obbedienze". Nella vicenda P3 erano stati coinvolti anche il parlamentare
del Pdl, Denis Verdini e l'ex senatore Marcello Dell'Utri. Il procuratore
aggiunto Giancarlo Capaldo e il pm Rodolfo Sabelli ipotizzarono che avevano
costituito una "super loggia segreta" divenuta punto di riferimento di
imprenditori e politici per "influenzare decisioni politiche, a pilotare
processi e a decidere le nomine dei componenti di organi dello Stato di rilievo
costituzionale".
Ufficialmente è stato
ucciso dalla mafia, come almeno altri due personaggi noti che si occuparono del
caso:
Boris Giuliano
e
Carlo Alberto Dalla Chiesa, scrive Gea Ceccarelli su “Articolo 3” dell’aprile
2013.
Quest’ultimo, nel particolare, prima di essere ucciso da Cosa Nostra, si era
occupato, tra gli altri casi, del sequestro e dell’omicidio di
Aldo Moro,
il quale aveva sollevato seri dubbi su ciò che Gladio compieva in Italia, tanto
da citare l’organizzazione nei suoi memoriali. E non stupirà sapere che le carte
relative al sequestro del politico, che Dalla Chiesa aveva portato con sé a
Palermo, sparirono inspiegabilmente dopo l’attentato che gli strappò la vita.
Dopo Moro e Dalla Chiesa, un altro personaggio si interessò all’unità “stay
behind” italiana:
Giovanni Falcone.
Il magistrato voleva
approfondire l’incidenza di Gladio nei delitti politici di Palermo degli ultimi
anni, tra cui quello di
La Torre,
di Reina
e di
Mattarella.
Aveva inoltre supposto che dietro la morte del giornalista
Mauro Rostagno
potessero
celarsi gli agenti segreti, visto e considerato che, durante le sue indagini, il
cronista si era imbattuto in verità scottanti riguardo il
contrabbando di droga e di
armi
con l’Africa.
Verità talmente sconvolgenti da aver persino richiesto, prima di morire, un
colloquio con Falcone, presumibilmente riguardante la base operativa
Centro
Scorpione,
una propaggine di Gladio, a Trapani, creata nell’87. Per l’omicidio di Rostagno,
avvenuto nell’88, fu sospettato come mandante il boss trapanese
Vincenzo Virga,
colui che, pochi anni dopo, fu incaricato dal boss Riina di procurare gli
esplosivi per le stragi e da Marcello Dell’Utri di trattare il recupero di un
credito di Publitalia con la Pallacanestro Trapani. Lo stesso mafioso è anche
mandante della
strage di Pizzolungo.
E’ interessante notare come Rostagno avesse scoperto casualmente i traffici
verso il Continente Nero, laddove, pochi anni dopo, nel marzo 1994, sarebbe
stata uccisa in circostanze misteriose
Ilaria Alpi.
Inviata in Somalia a seguire in prima persona la guerra civile e per indagare
sul
traffico d’armi e di rifiuti tossici illegali, probabilmente scoprì che nella
questione erano coinvolti anche i servizi segreti, come confermato
successivamente da alcuni pentiti. Altresì, riveste i contorni di oscuro
presagio il fatto che, nel
novembre precedente, era stato ucciso, sempre in
Somalia,
l’informatore della stessa Alpi sul traffico illecito di scorie tossiche nel
paese africano, il sottufficiale del SISMI
Vincenzo Li Causi,
capo del Centro Scorpione. Scrisse Alfio Caruso: “Che bel mistero quel Centro
Scorpione, ufficialmente incaricato di contrastare dal basso Mediterraneo
l’arrivo dell’Armata Rossa, viceversa invischiato in combinazioni poco chiare,
talmente cieco – ma è possibile? – da non accorgersi che da Trapani per otto
anni sono transitati tutti i carichi di missili, di esplosivo, di mine, di
granate diretti verso l’Iran e l’Iraq, impegnatissimi a scannarsi
vicendevolmente.” Falcone iniziò a sospettare qualcosa. Ritenne che esistessero
strutture segretissime all’interno di Cosa nostra “con finalità ancora ignote ma
certamente di enorme portata”. Trovò prove inoppugnabili di come la mafia fosse
stata interpellata per salvare Aldo Moro, nonché collegamenti tra omicidi
celebri e massoneria: su tutti Pierluigi Concutelli, assassino di Occorsio,
tessera 4070 della Loggia Camea di Palermo. Ma, quando il giudice provò ad
indagare sul Centro Scorpione di Trapani, gli venne impedito. Il procuratore
Pietro Giammanco gli comunicò che avrebbe preferito condurre lui quell’inchiesta
e il magistrato si trasferì a Roma, divenendo direttore degli affari penali,
accettando il posto offerto da Martelli. Non per questo smise di interessarsi a
Gladio e al Centro Scorpione. Fu la sua ultima indagine, sebbene non ufficiale.
Conservò tutti gli appunti sul suo computer, forse arrivò veramente vicino alla
verità. Così tanto che divenne impellente la necessità di eliminarlo. Il 23
maggio 1992, a Capaci, Falcone venne ammazzato e, con lui, la moglie e alcuni
uomini della scorta. Nei cieli volava anche un piper sconosciuto, probabilmente
dei Servizi. Poche ore dopo, qualcuno s’introdusse nell’ufficio del magistrato e
manomise i dati su Gladio.
P2 E DINTORNI. CHI ERA
LICIO GELLI?
Chi era Licio Gelli, l'ex
"venerabile" della P2. Il gran maestro della loggia massonica, morto ieri, è
stato protagonista di una lunga stagione di trame e misteri della storia
italiana, scrive "Panorama" il 16 dicembre 2015. Il "burattinaio", "Belfagor",
"il venerabile". Ovvero, Licio Gelli. L'ex gran maestro della loggia
massonica P2, che tante volte è tornato nella storia della prima e della seconda
Repubblica tra rapporti occulti con il potere, vicende giudiziarie, arresti,
fughe e guai col fisco, è morto a 96 anni nella sua dimora storica Villa Wanda,
alle porte di Arezzo.
La vita.
Nato a Pistoia il 21 aprile 1919, a 18 anni si arruolò come volontario nelle
camicie nere di Franco in Spagna. Fu fascista, "repubblichino" e poi
partigiano. Il 16 dicembre 1944 sposa Wanda Vannacci dalla quale ebbe quattro
figli. Dopo la guerra si trasferisce in Sardegna e in Argentina, dove si lega a
Peron e Lopez Rega. Tornato in Italia comincia a lavorare nella fabbrica di
materassi Permaflex e diventa direttore dello stabilimento di Frosinone. Poi
diventa socio dei fratelli Lebole e proprietario dello stabilimento Gio. Le di
Castiglion Fibocchi.
La massoneria.
Nel 1963 Gelli si iscrive alla massoneria. Nel 1966 il Gran maestro
Gamberini lo trasferisce alla loggia "Propaganda 2", nata a fine Ottocento per
permettere l'adesione riservata di personaggi pubblici. Nel 1975 si decide lo
scioglimento della P2, che però grazie a Gelli, che da segretario diviene gran
maestro, rinasce più forte e allarga i suoi tentacoli in ogni ramo del potere.
Quando, il 17 marzo 1981, i giudici milanesi Turone e Colombo, indagando sul
crack Sindona, arrivano alle liste, per il mondo politico italiano è un
terremoto. Negli elenchi ci sono quasi mille nomi tra cui ministri,
parlamentari, finanzieri come Michele Sindona e Roberto Calvi, editori,
giornalisti, militari, capi dei servizi segreti, prefetti, questori, magistrati.
C'è anche il nome di Berlusconi.
I guai con la giustizia.
La P2 risulta coinvolta direttamente o indirettamente in tutti i maggiori
scandali degli ultimi trent'anni della storia italiana: tentato golpe Borghese,
strategia della tensione, crack Sindona, caso Calvi, scalata ai grandi gruppi
editoriali, caso Moro, mafia, tangentopoli. Il 22 maggio 1981 scatta il primo
ordine di cattura, ma Gelli è irreperibile. Verrà arrestato a Ginevra il 13
settembre 1982. Rinchiuso nel carcere di Champ Dollon, evade il 10 agosto 1983.
Il 21 settembre 1987 si costituisce a Ginevra. Torna a Champ Dollon, che lascia
il 17 febbraio 1988 estradato in Italia.
La condanna.
L'11 aprile ottiene la libertà provvisoria per motivi di salute. Il 16 gennaio
1997 c'è un nuovo ordine di arresto, ma il ministero della Giustizia lo revoca:
il reato di procacciamento di notizie riservate non era tra quelli per cui era
stata concessa l'estradizione. Il 22 aprile 1998 la Cassazione conferma
la condanna a 12 anni per il Crack del Banco Ambrosiano. Il 4 maggio Gelli è di
nuovo irreperibile: la fuga dura più di quattro mesi. Gli vengono concessi i
domiciliari, che sconterà a Villa Wanda, la residenza dove è morto e che
nell'ottobre 2013 gli venne sequestrata a conclusione di una indagine per un
debito col fisco; la magione - nella quale tuttavia continuò a vivere - è
rientrata nella sua disponibilità pena nel gennaio scorso per la dichiarata
prescrizione dei reati fiscali. Nell'aprile 2013 i pm di Palermo dell'inchiesta
Stato-mafia lo hanno sentito per gli intrecci tra P2, servizi ed eversione.
(ANSA)
A 96 muore Licio Gelli. In
Italia non ha mai fatto un giorno di carcere.
Scompare l'ex venerabile della loggia P2. E' deceduto a Villa Wanda, ad Arezzo.
Condannato per depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna, dopo essere
stato detenuto in Francia e Svizzera era tornato a vivere in Toscana, scrive
R.I. su "L'Espresso" il 16 dicembre 2015.
E' morto Licio Gelli, l'ex venerabile della loggia P2, coinvolto nei misteri più
oscuri dell'Italia del dopoguerra. Si è spento alle 23 del 15 dicembre a Villa
Wanda, la casa sulle colline di Arezzo. Nato a Pistoia il 21 aprile del 1919,
Gelli fu condannato per depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna del
1980, dopo essere stato detenuto in Svizzera e Francia e coinvolto in varie
inchieste, era tornato a vivere a Villa Wanda. Gelli lascia la seconda moglie
Gabriela (la prima Wanda è scomparsa da tempo) e i tre figli Raffaello, Maurizio
e Maria Rosa, la quarta figlia Maria Grazia è morta nel 1988 in un incidente
stradale. I funerali sono previsti giovedì a Pistoia, mentre la camera ardente
potrebbe essere allestita nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo a
pochi metri da Villa Wanda. Il «burattinaio», «Belfagor», «il
venerabile». Ovvero, Licio Gelli. L'ex gran maestro della P2, che tante volte è
tornato nella storia della prima e della seconda Repubblica tra rapporti occulti
con il potere, vicende giudiziarie, arresti, fughe e guai col fisco, a 18 anni
si arruolò come volontario nelle «camicie nere» di Franco in Spagna. Fu
fascista, repubblichino e poi partigiano. Il 16 dicembre 1944 sposa Wanda
Vannacci dalla quale ebbe quattro figli. Dopo la guerra si trasferisce in
Sardegna e in Argentina, dove si lega a Peron e Lopez Rega. Tornato in Italia
comincia a lavorare nella fabbrica di materassi Permaflex e diventa direttore
dello stabilimento di Frosinone. Poi diventa socio dei fratelli Lebole e
proprietario dello stabilimento Gio.Le di Castiglion Fibocchi. Nel 1963
Gelli si iscrive alla massoneria. Nel 1966 il Gran maestro Gamberini lo
trasferisce alla loggia «Propaganda 2», nata a fine Ottocento per permettere
l'adesione riservata di personaggi pubblici. Nel 1975 si decide lo scioglimento
della P2, che però grazie a Gelli, che da segretario diviene gran maestro,
rinasce più forte e allarga i suoi tentacoli in ogni ramo del potere. Quando, il
17 marzo 1981, i giudici milanesi Turone e Colombo, indagando sul crack
Sindona, arrivano alle liste, per il mondo politico italiano è un
terremoto. Negli elenchi ci sono quasi mille nomi tra cui ministri,
parlamentari, finanzieri come Michele Sindona e Roberto Calvi, editori,
giornalisti, militari, capi dei servizi segreti, prefetti, questori, magistrati.
C'è anche il nome di Berlusconi. La P2 risulta coinvolta direttamente o
indirettamente in tutti i maggiori scandali degli ultimi trent'anni della storia
italiana: tentato golpe Borghese, strategia della tensione, crack Sindona, caso
Calvi, scalata ai grandi gruppi editoriali, caso Moro, mafia, tangentopoli. Il
22 maggio 1981 scatta il primo ordine di cattura, ma Gelli è irreperibile. Verrà
arrestato a Ginevra il 13 settembre 1982. Rinchiuso nel carcere di Champ
Dollon, evade il 10 agosto 1983. Il 21 settembre 1987 si costituisce a Ginevra.
Torna a Champ Dollon, che lascia il 17 febbraio 1988 estradato in Italia.
L'11aprile ottiene la libertà provvisoria per motivi di salute. Il 16 gennaio
1997 c'è un nuovo ordine di arresto, ma il ministero della Giustizia lo revoca:
il reato di procacciamento di notizie riservate non era tra quelli per cui era
stata concessa l'estradizione. Il 22 aprile 1998 la Cassazione conferma la
condanna a 12 anni per il Crack del Banco Ambrosiano. Il 4 maggio Gelli è di
nuovo irreperibile: la fuga dura più di quattro mesi. Gli vengono concessi i
domiciliari, che sconterà a Villa Wanda, la residenza dove è morto e che
nell'ottobre 2013 gli venne sequestrata a conclusione di una indagine per un
debito col fisco; la magione - nella quale tuttavia continuò a vivere - è
rientrata nella sua disponibilità pena nel gennaio scorso per la dichiarata
prescrizione dei reati fiscali. Nell'aprile 2013 i pm di Palermo dell'inchiesta
Stato-mafia lo hanno sentito per gli intrecci tra P2, servizi ed eversione. Con
la morte di Licio Gelli scompare uno dei protagonisti degli anni più bui della
storia d’Italia. L’ex venerabile porta con se nella tomba alcuni dei segreti,
destinati, salvo colpi di scena, a restare tali. A capo di una loggia massonica
P2 (Propaganda 2), sconfessata solo dopo lo scoppio dello scandalo dal Grande
Oriente, Gelli era riuscito a tessere una trama di relazioni internazionali e
nazionali che ne hanno fatto a lungo il burattinaio occulto del Paese. Gelli
aveva creato con la P2 nel corso degli anni ’70 un centro di potere di cui, si
scoprì, facevano parte alti vertici delle forze armate, dei servizi segreti,
politici, imprenditori e giornalisti. La P2 è stata chiamata in causa in tutti i
più grandi scandali della storia d’Italia, dal tentato golpe del principe
Borghese, il crack Sindona, il caso Calvi, il controllo del Corriere della Sera
(Bruno Tassan Din, direttore generale della Rizzoli aveva la tessera 534). Fu
condannato, tra l’altro, a 10 anni per depistaggio delle indagini della strage
di Bologna del 1980. Dopo essere stato detenuto in Svizzera e Francia, è vissuto
a Castiglion Fibocchi, a nord di Arezzo, a Villa Wanda, sequestrata il 10
ottobre 2013 dalla Guardia di Finanza per frode fiscale (17 milioni di euro).
Dopo varie aste andate deserte è stata affidata a Licio Gelli come custode
giudiziario. Qui dal 2001 Gelli viveva in detenzione domiciliare dove ha
scontato la pena di 12 anni per la bancarotta fraudolenta dell’Ambrosiano.
L’Italia scoprì l’esistenza di una sorta di Stato parallelo il 17 marzo 1981,
quando gli allora giudici istruttori Gherardo Colombo e Giuliano Turone,
nell’ambito di un’inchiesta sul finto rapimento del finanziere Michele Sindona,
fecero perquisire Villa Wanda e la fabbrica di sua proprietà - Giole - sempre a
Castiglion Fibocchi, subito a nord di Arezzo. Qui venne scoperta una lunga lista
di alti ufficiali delle forze armate e di ’grand commis’ aderenti alla P2 resa
pubblica dall’allora presidente del Consiglio Giovanni Spadolini il 21 maggio
1981. La lista includeva 962 nomi tra cui anche l’intero gruppo dirigente dei
servizi segreti italiani, 2 ministri (Gaetano Stammati e Paolo Foschi, entrambi
Dc), 44 parlamentari, 12 generali dei Carabinieri, 5 della Guardia di Finanza,
22 dell’Esercito, 4 dell’Aeronautica e 8 ammiragli. Imprenditori come Silvio
Berlusconi, giornalisti come Roberto Gervaso e Maurizio Costano e Vittorio
Emanuele di Savoia Nel maggio del 1981 Gelli è già irreperibile. Scappò in
Svizzera dove fu arrestato nel 1982 e rinchiuso nel carcere di Champ Dollon da
cui, nel suo stile, misteriosamente riuscì a scappare, l’anno dopo, ad agosto
del 1983. Trovò rifugio in Sudamerica dove resto a lungo tra Venezuela e
Argentina prima di costituirsi nel 1987, però sempre a Ginevra. Solo nel
febbraio del 1988 venne estradato in Italia ma resta in carcere pochi giorni: ad
aprile ottiene la libertà provvisoria per motivi di salute. Licio Gelli è stato
condannato, tra l’altro, a 12 anni per il crack del Banco Ambrosiano di Calvi;
calunnia nei confronti dei magistrati milanesi Colombo, Turone e Viola; calunnia
aggravata dalla finalità di terrorismo per aver tentato di depistare le indagini
sulla strage alla stazione di Bologna, vicenda per cui è stato condannato a 10
anni Nel corso della sua movimentata storia Gelli aveva coltivato buoni rapporti
con i militari golpisti argentini che nel 1976 avevano deposto Isabelita Peron:
il generale Roberto Eduardo Viola e l’ammiraglio Emilio Massera. Si è spesso
parlato di suoi legami con la Cia, mai provati, o quanto meno con personaggi
legati indirettamente a Langley come lo storico conservatore Michael Ledeen.
Cia, golpe, esercito e
crac: tutti i torbidi segreti che Licio Gelli si porta nella tomba,
scrive “Libero
Quotidiano” il 16 dicembre 2015. Con la morte di Licio Gelli scompare uno dei
protagonisti degli anni più bui della storia d’Italia. L’ex "venerabile "porta
con se nella tomba alcuni dei segreti più torbidi d’Italia, destinati, salvo
colpi di scena, a restare tali. A capo di una loggia massonica P2 (Propaganda
2), sconfessata solo dopo lo scoppio dello scandalo dal Grande Oriente, Gelli
era riuscito a tessere una trama di relazioni internazionali e nazionali che ne
hanno fatto a lungo il burattinaio occulto del Paese. Nato a Pistoia il 21
aprile del 1919, Gelli aveva creato con la P2 nel corso degli anni ’70 un centro
di potere di cui, si scoprì, facevano parte alti vertici delle forze armate, dei
servizi segreti, politici, imprenditori e giornalisti. La P2 è stata chiamata in
causa in tutti i più grandi scandali della storia d’Italia, dal tentato
golpe del principe Borghese, il crack Sindona, il caso Calvi, il controllo del Corriere
della Sera (Bruno Tassan Din, direttore generale della Rizzoli aveva la
tessera 534). Fu condannato, tra l’altro, a 10 anni per depistaggio delle
indagini della strage di Bologna del 1980. Dopo essere stato detenuto in
Svizzera e Francia, è vissuto a Castiglion Fibocchi, a nord di Arezzo, a Villa
Wanda, sequestrata il 10 ottobre 2013 dalla Guardia di Finanza per frode fiscale
(17 milioni di euro). Dopo varie aste andate deserte è stata affidata a Licio
Gelli come custode giudiziario. Qui dal 2001 Gelli viveva in detenzione
domiciliare dove ha scontato la pena di 12 anni per la bancarotta fraudolenta
dell’Ambrosiano. L’Italia scoprì l’esistenza di una sorta di Stato parallelo
allignato dentro e dietro quello ufficiale il 17 marzo 1981 quando gli allora
giudici istruttori Gherardo Colombo e Giuliano Turone, nell’ambito di
un’inchiesta sul finto rapimento del finanziere Michele Sindona, fecero
perquisire Villa Wanda e la fabbrica di sua proprietà - Giole - sempre a
Castiglion Fibocchi, subito a nord di Arezzo. Qui venne scoperta una lunga lista
di alti ufficiali delle forze armate e di "grand commis" aderenti alla P2 resa
pubblica dall’allora presidente del Consiglio Giovanni Spadolini il 21 maggio
1981. La lista includeva 962 nomi tra cui anche l’intero gruppo dirigente dei
servizi segreti italiani, 2 ministri (Gaetano Stammati e Paolo Foschi, entrambi
Dc), 44 parlamentari, 12 generali dei Carabinieri, 5 della Guardia di Finanza,
22 dell’Esercito, 4 dell’Aeronautica e 8 ammiragli. Imprenditori come Silvio
Berlusconi, giornalisti come Roberto Gervaso e Maurizio Costano e Vittorio
Emanuele di Savoia. Nel maggio del 1981 Gelli è già irreperibile. Scappò in
Svizzera dove fu arrestato nel 1982 e rinchiuso nel carcere di Champ Dollon da
cui, nel suo stile, misteriosamente riuscì a scappare, l’anno dopo, ad agosto
del 1983. Trovò rifugio in Sudamerica dove resto a lungo tra Venezuela e
Argentina prima di costituirsi nel 1987, però sempre a Ginevra. Solo nel
febbraio del 1988 venne estradato in Italia ma resta in carcere pochi giorni: ad
aprile ottiene la libertà provvisoria per motivi di salute. Licio Gelli è stato
condannato, tra l’altro, a 12 anni per il crac del Banco Ambrosiano di
Calvi; calunnia nei confronti dei magistrati milanesi Colombo, Turone e Viola;
calunnia aggravata dalla finalità di terrorismo per aver tentato di depistare le
indagini sulla strage alla stazione di Bologna, vicenda per cui è stato
condannato a 10 anni. Nel corso della sua movimentata storia Gelli aveva
coltivato buoni rapporti con i militari golpisti argentini che nel 1976 avevano
deposto Isabelita Peron: il generale Roberto Eduardo Viola e l’ammiraglio Emilio
Massera. Si è spesso parlato di suoi legami con la Cia, mai provati, o quanto
meno con personaggi legati indirettamente a Langley come lo storico conservatore
Michael Ledeen.
È morto Licio Gelli.
L'ex
venerabile della loggia P2, 96 anni, è deceduto nella sua dimora di Villa Wanda
a Arezzo, scrive Luca Romano Mercoledì 16/12/2015 su "Il Giornale". È
morto Licio Gelli. L'ex venerabile della loggia P2, 96 anni, è deceduto nella
sua dimora di Villa Wanda a Arezzo. Gelli era stato ricoverato recentemente in
ospedale. L'ex imprenditore divenuto famoso per la vicenda legata alla loggia
massonica P2 si è spento poco prima delle 23 di martedì a Villa Wanda dove
risiedeva da anni. Da due giorni le condizioni di salute di Licio Gelli, già
precarie, erano fortemente peggiorate tanto da indurre la moglie Gabriela Vasile
a ricoverarlo nella clinica pisana di San Rossore da dove era stato dimesso alla
fine della scorsa settimana perché giudicato ormai in fin di vita. Dopo un
rapido check up all'ospedale di Arezzo che aveva dato lo stesso esito, la
famiglia aveva deciso di riportarlo a Villa Wanda dove è spirato. Nato a Pistoia
il 21 aprile del 1919, Gelli è stato condannato per depistaggio delle indagini
sulla strage di Bologna del 1980, dopo essere stato detenuto in Svizzera e
Francia e coinvolto in varie inchieste, si era ritirato nella sua abitazione
sulle colline di Arezzo dove è morto. Gelli lascia la seconda moglie Gabriela
(la prima Wanda è scomparsa da tempo) e tre figli Raffaello, Maurizio e Maria
Rosa, la quarta figlia Maria Grazia è morta nel 1988 in un incidente stradale. I
funerali si svolgeranno probabilmente giovedì a Pistia, mentre la camera ardente
dovrebbe essere allestita nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo a
pochi metri da Villa Wanda.
Licio Gelli e la P2.
Le liste
segrete loggia P2 (Propaganda due) furono scoperte il 17 marzo 1981, continua
Luca Romano. Condannato per depistaggio delle indagini della strage di Bologna
del 1982, è stato l'uomo dietro ai grandi misteri d'Italia, il nome dell'ex
venerabile - gran maestro della loggia deviata - è legato a decine di inchieste
giudiziarie e a vari lati oscuri della storia dello scorso secolo: tentato golpe
Borghese, strategia della tensione (strage alla stazione di Bologna in testa),
crac Sindona, caso Calvi e Moro, mafia, tangentopoli. Classe 1919, si è spento
nella sua villa Wanda (ribattezzata in onore della prima moglie Wanda Vannacci)
sulle colline di Arezzo, dove era rientrato dopo un breve ricovero in ospedale.
Definito "il burattinaio d'Italia", faccendiere e imprenditore, fu fascista
durante il regime e la Repubblica di Salò e, poi, partigiano, quando la vittoria
della guerra cominciò a rivelarsi impossibile per i nazi-fascisti. Le liste
segrete loggia P2 (Propaganda due) furono scoperte il 17 marzo 1981. I giudici
istruttori Gherardo Colombo e Giuliano Turone, nell'ambito di un'inchiesta sul
finto rapimento del finanziere Michele Sindona (banchiere coinvolto nell'affare
Calvi e mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli), fecero perquisire la villa
di Gelli e la fabbrica di sua proprietà (la Giole di Castiglion Fibocchi,
Arezzo), che portò alla scoperta di una lunga lista di alti ufficiali delle
forze armate e di funzionari pubblici aderenti alla P2. La scoperta di un potere
parallelo, di un altro Stato che controllasse ogni intrigo di potere, fu un
terremoto politico, che travolse un pezzo della classe dirigente italiana. Tra
le 962 persone inserite nell'elenco vi erano i nomi di 44 parlamentari, 2
ministri dell'allora governo (Enrico Manca, Psi e Franco Foschi, Dc), un
segretario di partito, 12 generali dei carabinieri, 5 generali della guardia di
finanza, 22 generali dell'esercito italiano, 4 dell'aeronautica militare, 8
ammiragli, vari magistrati e funzionari pubblici, i direttori e molti funzionari
dei vari servizi segreti, diversi giornalisti ed imprenditori. Tra i nomi più
noti, oltre a Vittorio Emanuele di Savoia, anche il futuro premier Silvio
Berlusconi. Nel 2008, in un'intervista a Klaus Davi per Klauscondicio, l'ex
venerabile dichiarò: "Con la P2 avevamo l'Italia in mano. Con noi c'era
l'esercito, la guardia di finanza, la Polizia, tutte nettamente comandate da
appartenenti alla Loggia". Il presidente del Consiglio Arnaldo Forlani attese il
21 maggio 1981, prima di rendere pubblica la lista degli appartenenti alla P2.
Fu istituita, per volontà della presidente della Camera Nilde Iotti, una
commissione parlamentare d'inchiesta, guidata dalla deputata democristiana Tina
Anselmi, ex partigiana e prima donna a diventare ministro. La commissione
affrontò un lungo lavoro di analisi venendo a scoprire come la P2 fu anche un
punto di riferimento in Italia per ambienti dei servizi segreti americani,
intenzionati a tenere sotto controllo la vita politica italiana fino al punto,
se necessario, di promuovere riforme costituzionali apposite o di organizzare un
colpo di Stato. La commissione denunciò la loggia come una vera e propria
organizzazione criminale ed eversiva. Fu sciolta con un'apposita legge, la
numero 17 del 25 gennaio 1982.
Gelli e i misteri d'Italia.
Oltre che
alla vicenda della loggia P2 il nome di Licio Gelli, l'ex venerabile della
loggia P2 è legato a decine di inchieste giudiziarie e a vari lati oscuri della
storia recente d' Italia, conclude Luca Romano. Oltre che alla vicenda della
loggia P2 il nome di Licio Gelli, l'ex venerabile della loggia P2 scomparso
nella serata di martedì 15 a 96 anni nella sua casa di Arezzo, è legato a decine
di inchieste giudiziarie e a vari lati oscuri della storia recente d' Italia:
dal tentato golpe Borghese a tangentopoli, dalla scalata a gruppi editoriali al
caso Moro.
Questo un elenco dei
principali fatti che lo hanno visto coinvolto e indagato negli ultimi anni.
- STRAGE DI BOLOGNA (2 agosto
1980 - 85 morti e 200 feriti): assolto definitivamente dall' accusa di
associazione eversiva Gelli nel 1994 è stato condannato per calunnia (10 anni)
al processo d'appello-bis. Nell'ambito del processo l'ex "venerabile" fu
protagonista anche della misteriosa rinuncia all'incarico da parte di uno dei
legali di parte civile Roberto Montorzi che abbandonò il collegio dopo due
incontri con Gelli a villa Wanda.
- BANCO AMBROSIANO: al
processo di primo grado a Milano, Gelli è stato condannato a 18 anni di
reclusione per il ruolo avuto nella bancarotta dall'istituto di Calvi (che aveva
la tessera n.519 della P2). Il suo nome è da sempre anche al centro delle
indagini sulla morte del "banchiere di Dio". Nel processo di secondo grado la
pena venne ridotta a 12 anni. Il 6 maggio 1998 Gelli, che doveva scontare la
condanna divenuta definitiva, fugge da villa Wanda e si rende irreperibile. Il
10 settembre viene fermato e arrestato a Cannes. Gelli entrò anche
nell'inchiesta sull'omicidio del banchiere, ma il procedimento venne archiviato
il 30 maggio 2009.
- CONTO "PROTEZIONE": il 29
luglio 1994 Gelli è stato condannato a Milano a sei anni e mezzo, in primo
grado, per la vicenda del conto 633369 di Silvano Larini all'Ubs di Lugano, del
quale fu trovata traccia nel 1981 a Castiglion Fibocchi con riferimenti a soldi
destinati al Psi di Craxi e Martelli. La pena fu ridotta a 5 anni e 9 mesi in
appello. La Cassazione decise l'annullamento della condanna per Gelli per
improcedibilità dell'azione penale, essendo stata la sua posizione definita nel
processo per il crac del Banco Ambrosiano.
- ATTENTATI AI TRENI IN
TOSCANA: accusato di aver finanziato le organizzazioni eversive "nere" per gli
attentati degli anni Settanta, Gelli è stato prima condannato a 8 anni e poi
dichiarato non processabile.
- MAFIA-POLITICA-AFFARI: Gelli
era uno dei 126 imputati al processo a Palmi sui presunti collegamenti tra mondo
politico ed imprenditoriale e organizzazioni mafiose. Secondo l'accusa, si
sarebbe adoperato per "aggiustare" un processo in Cassazione a due presunti
mafiosi di Taranto. Venne assolto il 3 marzo 1995 dall' accusa di concorso
esterno in associazione mafiosa. Nel 1998 è chiamato in causa dal procuratore
capo di Palermo Giancarlo Caselli nell'inchiesta Sistemi criminali poi
archiviata nel 2000.
- INCHIESTA OPERAZIONI
FINANZIARIE: tra il 1993 ed il 1994, Gelli è stato al centro dell'attenzione dei
magistrati di Arezzo e Roma per una serie di operazioni finanziarie miliardarie
che avrebbe disposto in varie banche. Le indagini sono legate in particolare al
fallimento della holding Cgf del gruppo Cerruti. Un ruolo di primo piano nelle
vicende è rivestito dall'ex vicepresidente del Csm Ugo Zilletti.
- LEGAMI CON LA CAMORRA: la
Dda di Napoli ha indagato sui rapporti tra Gelli ed alcuni esponenti della
camorra.
- INCHIESTA CHEQUE TO CHEQUE:
Gelli venne iscritto nel registro degli indagati, insieme al figlio Maurizio,
nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla procura di Torre Annunziata (Napoli)
in relazione ad un presunto traffico internazionale di armi e valuta. Una
trentina le persone arrestate. L'inchiesta venne poi trasferita a Milano.
- CASO BRENNEKE: le presunte
rivelazioni fatte al Tg1 dal sedicente ex agente della Cia Richard Brenneke sui
rapporti tra servizi segreti Usa e P2, duramente smentite da Gelli, estate del
1990 provocarono tensioni e polemiche, anche per il coinvolgimento dell'allora
presidente della Repubblica Francesco Cossiga.
- FALLIMENTO DI NEPI: Il 10
giugno 1997 la procura di Roma emette 9 ordini di arresto per il fallimento
della holding Di Nepi e di numerose società legate al gruppo. Per Gelli scatta
l'obbligo di dimora a Arezzo. Il 18 aprile 2005 venne condannato a 2 anni e 3
mesi di reclusione per associazione a delinquere e bancarotta insieme ad altre 9
persone.
Licio Gelli, quel
megalomane di provincia diventato potente per caso.
Un uomo bugiardo. Che solo le circostanze, la guerra fredda, l'essere l'Italia
un paese di frontiera tra l'Ovest e l'Est, in un brulichio di spie, affaristi e
politicanti, avevano potuto trasformare in un uomo capace di infilarsi ovunque,
dai partiti ai servizi segreti. E all'ombra delle grandi stragi di questo Paese,
scrive Marco Damilano il 16 dicembre 2015 su “L’Espresso”.
Gli ho parlato una sola volta, al
telefono, più di dieci anni fa. Chiamai il numero della casa ad Arezzo per
un'intervista, l'apparecchio suonò un paio di volte, poi qualcuno rispose.
«Pronto, vorrei parlare con Licio Gelli», dissi. Dall'altra parte un lungo
silenzio, poi quella voce: «Non è in casa». Io, stupito: «Ma scusi, Gelli è lei,
la riconosco!». E lui: «No, guardi, non sono io». E mise giù. A me venne in
mente che l'attore Alighiero Noschese, il primo imitatore della tv italiana, era
stato affratellato alla loggia P2, si diceva che falsificasse le voci nelle
telefonate del Venerabile, fingeva di essere un ministro o il presidente del
Consiglio. E anche lui all'epoca si era inventato un'altra identità, al telefono
si faceva chiamare dottor Luciani, per paura delle intercettazioni. E
pensai che questo era, prima di tutto, Licio Gelli. Un bugiardo. Un
megalomane di provincia che solo le circostanze - la guerra fredda, l'essere
l'Italia un paese di frontiera tra l'Ovest e l'Est, in un brulichio di spie,
affaristi e politicanti - avevano potuto trasformare in un uomo potente. In
vecchiaia si era messo a scrivere versi di dubbio valore letterario ma di sicuro
impatto per le cronache: ««Passano gli anni e il tempo affresca le rughe, /
scalfisce i segreti remoti che durano nel cuore…». Untuoso, anzi viscido, ogni
parola un soffio di ricatto. «Sono il confessore di questa Repubblica», amava
vantarsi ai tempi della sua ascesa. Quando arrivava all'hotel Excelsior in via
Veneto, si rinchiudeva nelle sue tre stanze, dalla 127 alla 129, e riceveva. I
suoi seguaci. I candidati alla loggia. «Il braccio sinistro appoggiato su una
scrivania con molti cassetti. Ogni tanto ne apriva uno e tirava fuori qualche
fascicolo ben conservato in copertine di cartoncino rosa. Era il suo archivio.
Lo faceva intravedere, ora ammiccante ora minaccioso, ai suoi ospiti costretti a
sedersi su una poltrona più bassa, tanto per far notare la differenza. Quasi
sempre, dopo ogni visita, le cartelline rosa si arricchivano di altri fogli,
nuovi segreti», scrivevano Maurizio De Luca e Pino Buongiorno, due giornalisti
che non ci sono più, nell'instant-book a più mani "L'Italia della P2" uscito
subito dopo la pubblicazione degli elenchi della loggia nel maggio 1981, a
tutt'oggi il libro più bello su Gelli e i suoi cari. Generali, ammiragli,
direttori di giornale, ministri, segretari di partito. Piccoli
uomini, ridicoli e sinistri. Questa era la loggia massonica P2. Nella
lista ritrovata a Castiglion Fibocchi erano 962, sfilarono uno a uno a palazzo
San Macuto, davanti alla commissione parlamentare di inchiesta presieduta da
Tina Anselmi. Nei diari della parlamentare democristiana ci sono gli appunti di
quelle audizioni, dove tutti negavano e insieme confermavano. «Enrico Manca: nel
1980 il 4 aprile entro come ministro del Commercio estero nel governo
Cossiga. A fine aprile conosco Gelli a un ricevimento all'ambasciata
argentina. Visita di Maurizio Costanzo, che disse di essere massone, e a nome di
Gelli mi chiese se ero disponibile a aderire alla massoneria. Quando mi vidi
negli elenchi di Gelli telefonai a Costanzo, ma questi mi confermò di aver
telefonato a Gelli la non disponibilità...».
La carriera di Gelli era cominciata nel biennio 1943-45, nel passaggio di
regime, al trapasso del fascismo, con la penisola occupata da eserciti
stranieri, l'ideale per cominciare una lunga trafila di doppiogiochista. Il
giovane repubblichino resta in forza alle SS ma traffica con i partigiani, è un
fascista che trama con gli antifascisti, per lui a guerra finita garantisce il
presidente comunista del Cln di Pistoia Italo Carobbi: «Il Gelli Licio di
Ettore, pur essendo stato al servizio dei fascisti e dei tedeschi, si è reso
utile alla causa dei patrioti». Due righe che valgono un'intera biografia,
ricordate dallo storico Luciano Mecacci nel volume-inchiesta sull'assassinio di
Giovanni Gentile, intitolato "La ghirlanda fiorentina". Quella pianta
intrecciata di fiori secchi, appassiti, putridi che soffoca ogni raggio di luce.
La Ghirlanda massonica e piduista cresce negli anni della democrazia,
come una radice marcia di un albero rigoglioso, una cellula malata in un corpo
sano, nell'oscurità. Gelli entra nella segreteria di un deputato democristiano,
diventa dirigente di una nota ditta di materassi, la Permaflex, e in questa
veste accoglierà Giulio Andreotti all'inaugurazione dello stabilimento di
Frosinone (il Divo lo ricorderà sempre così: «Era uno che vendeva materassi», e
via sminuzzando),
giura fedeltà alla massoneria, il Grande Oriente.
Prospera negli anni Settanta dei misteri e delle stragi, si infila
dappertutto: nei partiti, al Quirinale, a Palazzo Chigi, a Montecitorio, tra gli
alti gradi delle forze armate, al comando dei servizi segreti. Controlla le
scalate bancarie più prodigiose, da quella di Michele
Sindona a quella di Roberto Calvi, destinati a morti tragiche e mai
chiarite. È un'ombra
nelle più grandi tragedie italiane: la strage della stazione di Bologna
del 2 agosto 1980, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. Si allarga al Sud
America, nell'Argentina di Peron e dei generali golpisti. Sogna di riscrivere la
Costituzione: il piano di rinascita democratica, i partiti da chiudere, la tv
privata da diffondere, lo statuto dei lavoratori da stracciare, la separazione
delle carriere dei magistrati, «l'obbligo di attuare i turni di festività per
sorteggio, per evitare la sindrome estiva che blocca le attività produttive».
Cede alla vanità e si fa intervistare dal "Corriere della Sera" di cui alla fine
degli anni Settanta ha il pieno controllo. Il verbo gelliano va nella
prestigiosa terza pagina del quotidiano di via Solferino domenica 5 ottobre
1980. Titolo in ginocchio: «Parla, per la prima volta, il signor P2 Licio
Gelli». Incipit genuflesso: «Capo indiscusso della più segreta e potente loggia
massonica, ha accettato di sottoporsi a un'intervista esponendo anche il suo
punto di vista...», scrive felice l'intervistatore Maurizio Costanzo, iniziato
alla loggia due anni prima. «Una brodaglia disgustosa, con il burattinaio che
(tronfio, allusivo, arrogante, ricattatorio) pontifica su tutto e tutti,
dispensando ridicole ricette economiche dietro le quali s'intravedono speranze
di nuovi affari», scrive Giampaolo Pansa.
Silvio Berlusconi giurò da fratello il 26 gennaio 1978 nella sede romana
della P2 in via Condotti, con il grado di apprendista, tessera numero 1816. E in
quel sodalizio tra il Gran Maestro e il Cavaliere c'era un'intuizione potente:
che per attuare il piano di rinascita e conquistare l'Italia non servivano le
bombe sui treni ma il Mundialito, il mini-mondiale di calcio in Uruguay
strappato alla Rai dalla tv del Biscione grazie alla mediazione di Gelli. Non ci
voleva il colpo di Stato, bastava "Colpo grosso". Tra i due personaggi distanti
in tutto, uno dedito ai segreti, l'altro all'immagine, c'è in realtà la stessa
concezione del mondo. In cui le relazioni valgono più delle regole, le lobby
occulte e trasversali contano di più delle appartenenze visibili, la fedeltà
alle istituzioni va scavalcata da doppie, triple fedeltà non dichiarate. Gelli
se ne va e a leggere le cronache di questi giorni si direbbe che abbia vinto
lui. Le vicende bancarie di questi giorni, con la ghirlanda di relazioni
intrecciata attorno alla Banca Etruria, fiore all'occhiello di Arezzo, la città
del Venerabile. Lo scandalo vaticano di ricatti incrociati e millanterie. Il
ritrovato attivismo di Luigi Bisignani, il più giovane tra i nomi comparsi nella
lista dei piduisti (lui ha sempre negato, naturalmente: «Non avevo neppure l'età
per iscrivermi»). La P3, la P4, numerate con scarsa fantasia, per certificare il
marchio di origine, il logo di successo. Quante volte, in questi ultimi anni, in
questi ultimi mesi, ci siamo sorpresi ad avvertire in alcune carriere improvvise
l'inconfondibile odore della P2, gli stessi metodi, a volte le stesse persone. I
burattinai o presunti tali si sono moltiplicati nei palazzi, solo che la posta
in gioco è più meschina, non c'è il grande gioco della guerra fredda che serviva
a nascondere i piccoli affari. E ancora più avvilenti sono i protagonisti:
banchieri di provincia, monsignori allupati, ragazze esibizioniste, faccendieri
invecchiati... «Se la loggia P2 è stata politica sommersa, essa è contro tutti
noi che sediamo in questo emiciclo. Questo è il sistema democratico che in
questi quaranta anni abbiamo voluto e costruito con il nostro quotidiano
impegno: non può esservi posto per nicchie nascoste o burattinai di sorta». Con
queste parole, il 9 gennaio 1986, Tina Anselmi presentava nell'aula della Camera
le conclusioni della commissione parlamentare di inchiesta sulla P2 da lei
presieduta. Trent'anni dopo Gelli se ne va. Ma ancora c'è tanto da fare per
custodire la Repubblica e le sue istituzioni, la trasparenza della democrazia,
dai suoi eredi, i suoi imitatori, i suoi fratelli. I tanti Gelli d'Italia che si
aggirano tra di noi.
Quando Licio
bocciò Silvio,
scrive
Gianfrancesco Turano il 16 dicembre 2015 su "L'Espresso".
È morto Licio
Gelli, 96 anni, fascista vertical che
passerà alla storia per avere legittimato in quasi un secolo di vita il sistema
del potere oligarchico attraverso l'associazionismo segreto. Che si chiamasse loggia
P2 o altrimenti, per l'Aretino non faceva grande differenza purché
depotenziasse la democrazia nell'unico modo ammesso dai sistemi politici
dell'Occidente: l'oligarchia,
appunto. L'unica cosa che Gelli non poteva tollerare, da ex fautore del sistema
autocratico, erano le imitazioni. Per questo, cinque anni fa, sconfessò il suo
ex iscritto e Nostro Caro Leader Silvio
Berlusconi in un'intervista all'Espresso. La malattia e una sua certa
vicinanza, puramente territoriale, con elementi del governo in carica hanno
forse impedito al Venerabile
Maestro di esprimersi compiutamente sulla squadra di Matteo Renzi. In
modo alquanto compassato, Gelli ha criticato come goffe le riforme, poco più di
un anno fa, e ha usato il termine "bambinone" per il primo ministro senza
chiarire chi siano i genitori dell'infante.
Il paleocraxiano Rino Formica, felice inventore dell'espressione
"sinistra ferroviaria", ha attribuito la paternità del renzismo proprio a Gelli
e al suo Piano
Rinascita in un'interemerata risalente al marzo 2014. Esagerato? Di certo
l'Istituzione, cioè la massoneria, ha continuato fino a oggi ad avere un
rapporto contrastato amore-odio verso il "fratello che sbaglia" Licio. La sua
influenza reale è però stata continua, costante, a dispetto dei proclamati
rinnovamenti di grembiuli e cappucci. La morte di Gelli arriva quasi
contemporanea alla dipartita verso l'Oriente Eterno di Armando
Cossutta e della Popolare
dell'Etruria e del Lazio. Il primo ha rappresentato per anni l'Urss
all'interno del Pci. La seconda è la banca aretina appena fallita dopo decenni
di gestione del massonissimo Elio Faralli, scomparso a 91 anni nell'aprile 2013.
La morte è trasversale. Una specie di massoneria. Il Raguno invernale è
intitolato, ovviamente, al Venerabile. Si invitano i partecipanti a vestirsi in
modo adeguato. In attesa di comunicare gli indirizzi delle migliori boutique di fashion massonica,
vorrei pregare GLU di
interrompere i servizi di Discovery Channel che ama accompagnare all'iniziativa.
La scelta del luogo è di pertinenza del Venerabile
BM, clonato e seviziato dalle suore nel Raguno Gaetano di semifausta
memoria. Propenderei per Roma dove si trovano i migliori grembiuli in pelle
d'agnello. Se no Abruzzo, dove abbondano i suscuoiati agnelli. PS Mi sono appena
accorto che questo è il post numero 333 di RdC.
Ça ne s'invente pas.
Gelli: "Sono le mie brutte
copie". "Il
governo Berlusconi si è abbeverato al mio Piano di Rinascita nazionale. Ma il
premier non è in grado di realizzarlo". Parla l'ex capo della Loggia P2, scrive Gianfrancesco
Turano il 20 giugno 2010 su “L’Espresso”.
"La democrazia è
una brutta malattia, una ruggine che corrode. Guardi quello che accade in
Grecia, in Spagna, in Portogallo: anarchia completa". In partenza, Licio Gelli è
coerente con il credo di una vita giunta al traguardo dei 91 anni: ordine e
disciplina. Eppure no. Il Venerabile della poco disciolta loggia P2 non può
godere appieno del successo della sua creatura, quel Piano di Rinascita che per
Antonio Di Pietro e molti altri oppositori è la stella polare dell'esecutivo. "È
vero", sostiene Gelli: "Gli uomini al governo si sono abbeverati al mio Piano di
Rinascita, ma l'hanno preso a pezzetti. Io l'ho concepito perché ci fosse un
solo responsabile, dalle forze armate fino a quell'inutile Csm. Invece oggi vedo
un'applicazione deformata".
Non è contento dell'esecutivo?
"Ho grandi
riserve. Ci sono gli stessi uomini di vent'anni fa e non valgono nulla. Sanno
solo insultarsi e non capiscono di economia. Tremonti è un tramonto. Il
Parlamento è pieno di massaggiatrici, di attacchini di manifesti e di indagati.
Chi è sotto inchiesta deve essere cacciato all'istante, al minimo sospetto".
Almeno il suo ex iscritto Silvio Berlusconi ha la sua
benedizione?
"Io sono un
laico. Non do benedizioni ma certamente non condivido ciò che accade per sua
volontà. Anche certe questioni private si risolvono in famiglia. Deve essere
meno goliardico".
Vede in lui il realizzatore del Piano Rinascita?
"Non è adatto.
Inoltre, non ha molti collaboratori di valore".
Pensa che sia vittima della pressione leghista?
"La Lega per me
è un pericolo. Sta espropriando la sostanza economica dell'Italia. Le bizzarrie
di Umberto Bossi hanno già diviso il Paese. Bisogna dire basta".
Altri segnali di crisi?
"I partiti non
esistono più e i leader attuali passano il Rubicone con tre tessere in tasca.
Non bisogna riformare solo la giustizia, ma prima di tutto l'economia e la
sanità".
Ci tranquillizzi, dottor Gelli. Lei non sta diventando di
sinistra?
"Io sono per il
buon senso. Sono per il benessere al popolo che oggi patisce, non arriva al 20
del mese. Qui siamo oltre i margini della rivolta. Siamo alla Bastiglia".
Filippo Facci il 17 luglio
2014 su “Libero Quotidiano”: "Aveva ragione Gelli". Se Hitler era vegetariano
(che poi non lo era) non è che allora ci strafoghiamo di carne. Del resto Hitler
fece la prima campagna antifumo: non è che allora ci ammazziamo di canne. A
Stalin piaceva Mozart: non è che allora ascoltiamo tutti Peppino di Capri.
Eccetera. Il discorso è demenziale ma serve a dire che persino Licio
Gelli poteva aver ragione in alcune cose: non perché fosse un genio visionario,
ma perché il suo Piano di Rinascita democratica sosteneva anche dei progetti in
parte banali e in parte condivisi da democrazie di tutto il mondo. Ecco perché
esorcizzare i tentativi di riforma paragonandoli a quanto scriveva Gelli nel
1976 - vedi Il Fatto di martedì - resta di un livello intellettuale
annichilente, minestra riscaldata persino per un pubblico para-grillino. Un
Parlamento semplificato, un Senato regionale, un premier eletto dalla Camera, i
decreti legge non emendabili, dei limiti all'ostruzionismo, l'abolizione delle
province, riduzione dei parlamentari: la verità è che certi propositi piduisti
erano di assoluta usualità; oppure, come nel caso dell'Italicum, erano delle
oasi di democrazia se paragonati alle liste bloccate che ci vanno cucinando.
Altre proposte di Gelli, poi, non sono né banali né moderate: sono dei sogni.
Tipo "dissolvere la Rai in nome della libertà di antenna" o ancora la chimera
della "responsabilità civile dei magistrati": quella vera, non l'inapplicabile
legge Vassalli o il consommè che il ministro Andrea Orlando va preparando.
Licio Gelli al Fatto: “Il
bambinone Renzi e gli ex lacchè di Berlusconi”.
Il Venerabile della Loggia P2 dice la sua sulle ultime mosse del governo: "Le
riforme sono goffe". E sull'Italia di oggi: "Sono felice che vengano a galla le
responsabilità della cattiva politica", scrive di Marco Dolcetta il 23 maggio
2014 su “Il Fatto Quotidiano”. Di questi tempi sia la schiena che il cuore
stanno dando qualche problema a Licio Gelli. Il 96enne Venerabile della Loggia
P2, nonostante la voce affaticata, mantiene una certa energia verbale: “Lei deve
sapere che sono entrato nei Servizi di intelligence dello Stato italiano dopo un
incontro con Mussolini che voleva conoscermi. Io, il volontario ‘Licio Gommina’
della guerra civile di Spagna, nella quale aveva perso la vita mio fratello. Il
Duce mi chiese quale poteva essere la ricompensa che lo Stato italiano poteva
dare alla mia famiglia. In quella occasione, gli dissi che senz’altro mi sarebbe
interessato conoscere il mondo dei Servizi segreti… Da allora non ne sono più
uscito”.
Ma che ne pensa
dell’attualità italiana e di Renzi?
Renzi è un bambinone, visto il
suo comportamento che è pieno di parole e molto ridotto nei fatti: non è
destinato a durare a lungo… Comunque, non è mai stato (né lui né i suoi
familiari) nella massoneria. Vedo che nel suo governo ci sono molte giovani
donne che io personalmente vedrei molto meglio a occuparsi d’altro…”.
E le riforme del premier?
Quelle di Renzi, per la legge
elettorale e il Senato, sono goffe. Per quanto riguarda Palazzo Madama, mi fa
piacere pensare che, nonostante tutti mi abbiano vituperato, sotto sotto mi
considerano un lungimirante propositore di leggi; una quarantina di anni fa, con
Rodolfo Pacciardi, scrivemmo, su invito dell’allora presidente Giovanni Leone,
il cosiddetto Piano R., di Rinascita nazionale. Prevedeva una serie di norme e
riforme che avrebbero potuto creare i fondamenti per uno Stato più efficace.
Leone fu eletto presidente della Repubblica grazie ai voti della massoneria: lui
mi ringraziò e poi mi chiese questo contributo. Così gli facemmo avere il testo
del Piano R., cui lui non diede mai alcun riscontro e, anzi, da allora evitò di
incontrarmi… Riguardo al Piano di Rinascita democratica, sfogliando le pagine di
quel testo, si ritrova – nella parte riguardante le riforme istituzionali – una
quasi totale abolizione del Senato. Riducendone drasticamente il numero dei
membri, aumentando la quota di quelli scelti dal presidente della Repubblica e
attribuendo al Senato una competenza limitata alle sole materie di natura
economica e finanziaria, con l’esclusione di ogni altro atto di natura politica.
L’intento era ed è ancora oggi chiaro. Dare un taglio effettivo a un ramo del
Parlamento che, storicamente, ha maggiore saggezza e cultura non solo politica,
a favore di una maggiore velocità nel fare leggi e riforme. Ricordo di averne
parlato in seguito, quando veniva a trovarmi ad Arezzo, anche con la mia amica
Camilla Cederna”.
In tema di amici, che ne
pensa della carriera letteraria di Luigi Bisignani?
Più che mio amico, Luigi è mio
figlioccio. Quando era ancora giovane, dopo la scomparsa di suo padre, sia io
che Gaetano Stammati ci prendemmo cura di lui. Avevo e ho sempre avuto una
grande stima di Luigi. Tanto che, quando nacque il progetto dell’Organizzazione
Mondiale del Pensiero e dell’Assistenza Massonica, a Roma, il 1 gennaio 1975,
decidemmo di affidargli l’incarico di addetto stampa, perché eravamo certi di
poter fare pieno assegnamento sulla sua preziosa collaborazione…”.
Lei con la Svizzera ha un
rapporto particolare, conosce bene le galere ma anche le banche di quel Paese…
Sì, soprattutto quando mi sono
stati sottratti dai giudici milanesi diversi milioni di franchi che risultavano
il frutto lecito di mia mediazione internazionale e che furono destinati a
risarcire piccoli azionisti del Banco Ambrosiano dopo le note vicende che mi
videro ingiustamente coinvolto. Ma nonostante tutto, ho accettato questo
risarcimento forzato. La cosa più sorprendente, però, è che quei soldi non sono
stati mai destinati a piccoli azionisti, tanto che da tempo io, assieme al loro
legale, l’avvocato Gianfranco Lenzini di Milano, ho presentato richiesta di
chiarimenti in tutte le sedi, ma senza alcun risultato”.
Come spiega il caso Renzi,
la sua veloce ascesa, e cosa prevede per il futuro?
Beh, Renzi è un fenomeno
parzialmente italiano, e mi risulta che fra i suoi mentori politici ci siano
persone che vivono a Washington. È circondato, però, da mezze tacche: gli ex
lacchè di Berlusconi. Fini, che ho conosciuto bene, quando faceva l’attendente
ossequioso di Giorgio Almirante cui prestavo denari per il Msi. Soldi sempre
resi… quello sì che era uomo di parola. E poi Schifani, Alfano: personaggi non
certo di livello. Berlusconi ha sbagliato con le giovani donne, ma soprattutto
circondandosi di personaggi di bassa levatura… Penso a Verdini, un mediocre uomo
di finanza; è un massone… credo, ma non della nostra squadra. Il più alto
livello di maturità politica in Italia c’è stato con Cossiga e Andreotti che
avevano entrambi dei sistemi di controllo politico, uno con ‘Gladio’ e l’altro
con Anello, cosa che Berlusconi non è mai riuscito a ripetere. E si sono visti i
risultati di questa sua incapacità…”.
Per concludere, che ne
pensa dell’Italia, e del suo futuro?
Non le nascondo che vedo, con
una certa soddisfazione, il popolo soffrire. Non mi fraintenda: non sono felice
di questa situazione. Sono felice, invece, che vengano sempre più a galla le
responsabilità della cattiva politica. Perché, probabilmente, solo un tributo di
sangue potrà dare una svolta, diciamo pure rivoluzionaria, a questa povera
Italia”. Da Il Fatto Quotidiano del 23 maggio 2014
Quando i magistrati
prendevano ordini dalla P2…,
scrive Ilario Ammendolia su “Il Garantista”. Non so se in Italia vi sia più
corruzione rispetto al passato ma certamente lo scandalo “mafia capitale” non è
lontanamente comparabile con quello della Banca di Roma. Carminati non è
Giolitti e Buzzi non è Crispi. L’effetto però è stato completamente diverso. In
quel caso dinanzi alle accuse del presidente del Banco di Roma Tanlongo che dal
carcere aveva fatto i nomi di Giolitti e Crispi, una classe politica, certamente
conservatrice, ma dotata di quello che la borghesia ha chiamato per decenni
“senso dello Stato” non indietreggiò ma si assunse tutte le responsabilità. Il
primo ministro di Rudinì si presentò in parlamento arginando chi avrebbe voluto
travolgere la classe politica per prenderne il posto e lo fece con fermezza in
nome dei «supremi interessi del Paese e della Patria». Non si comportò
diversamente Aldo Moro che, durante lo scandalo Lockheed, dinanzi al Parlamento
riunito in seduta congiunta, invitò i parlamentari a guardare alla giustizia
«non in senso tecnico-giuridico, ma politico, consapevoli che la valutazione dei
fatti. Non riguarda una dichiarazione astratta di giustizia ma un’attuazione
concreta di essa». Moro concluse il suo intervento con queste parole «…ci avete
preannunciato il processo sulle piazze, vi diciamo che noi non ci faremo
processare». Flaminio Piccoli da presidente del consiglio dei ministri, dinanzi
all’arbitrario debordare di alcuni magistrati, non esitò ad ammonire «…l’Italia
non si farà governare dai pretori». Era un corrotto Aldo Moro? Molti dicono sia
stato l’unico statista del dopoguerra a parte De Gasperi. Certamente la statura
dello statista la ebbe Antonio Giolitti mentre nessuno dubita dell’onestà di
Flaminio Piccoli. C’è un antico detto che predice che il giorno in cui il leone
si metterà a belare, gli sciacalli prenderanno il suo posto. Quando si pretende
di avere un ruolo dirigente senza essere eletti dal popolo, la democrazia
reclina il capo, aprendo le porte all’avventura. Basterebbe riflettere sugli
scandali falsi costruiti con la complicità di alcuni magistrati per capire cosa
diventerebbe l’Italia qualora non si mettesse un argine alla deriva
giustizialista. Cito solo due esempi: Felice Ippolito era uno scienziato
autorevole quanto onesto ma venne arrestato con grande clamore sui giornali ed
in televisione. Era completamente innocente. Lo scandalo è stato ordito dai
petrolieri, per impedire l’uso, su vasta scala, dell’energia nucleare in Italia.
La procura fu l’arma per fermarlo. Si può discutere nel merito dell’uso
dell’energia nucleare, ma certamente quell’arresto è la dimostrazione di cosa
sarebbe l’Italia «governata dai pretori». Non meno grave è il falso scandalo
della Banca d’Italia che coinvolse il governatore Baffi ed il suo vice
Sarcinelli. A Baffi venne risparmiato l’onta della galera per l’età avanzata
mentre Mario Sarcinelli, studioso di chiara fama, venne arrestato e tenuto in
carcere. Si scoprì in seguito che la magistratura romana aveva concepito gli
arresti su stimoli della P2 indispettita dai controlli che la Banca d’Italia
aveva operato su alcuni istituti di credito. Potremmo continuare per così tante
pagine da fare un enciclopedia! Ovviamente, non accuso i magistrati in quanto
tali proprio perché sono assolutamente consapevole che non sono né peggiori, né
migliori degli altri cittadini. Dinanzi alla corruzione, che deve essere
combattuta e sconfitta, una Politica degna di questo nome non balbetta, non
piagnucola, non impreca e soprattutto non tenta di gabbare i gonzi, elevando le
pene. Con queste misure la corruzione non diminuirà di un solo milionesimo.
Conoscete meglio di me le inutili “grida” contro i bravi di cui Manzoni parla
nei Promessi Sposi. La corruzione è figlia di questo sistema ammalato dove il 5%
della popolazione possiede il 50% della ricchezza. Un sistema in cui il
privilegio e le caste calpestano quotidianamente il bisogno. Combattere la
corruzione significa mettere in campo un grande progetto politico capace di
riaccendere passioni e speranze collettive. Non ha senso essere complici di chi
trova comodo mettere l’aureola sulla testa di singoli personaggi filtrati dai
media e farne dei numi tutelari e per eludere i problemi reali da cui scaturisce
la corruzione. Il caso dell’ex pm Antonio Di Pietro è da manuale ma non è il
solo. Il dottor Nicola Gratteri è arrivato a due passi dalla nomina a ministro
della Giustizia, l’onorevole Nitto Palma ha tagliato il traguardo, mentre il
dottor Pietro Grasso, con un solo salto, è stato “eletto” alla seconda carica
dello Stato. Un magistrato al pari di tutti i cittadini può essere eletto a
qualsiasi incarico politico senza però, saltare a piè pari la fatica, le
umiliazioni, le ansie di chi ha fatto politica tra la gente, si è nutrito delle
loro speranze, ha respirato le loro frustrazioni ed i loro bisogni. Le
scorciatoie stanno portando verso avventure autoritarie e contro queste occorre
resistere con coraggio qualsiasi sarà il prezzo da pagare.
IL SEQUESTRO MORO ED I SERVIZI SEGRETI ITALIANI.
Fabio Martini per “la Stampa”
il 31 ottobre 2019. Tanti segreti italiani, a cominciare dall' inesauribile caso
Moro, si sono puntualmente incagliati sul segreto di Stato che per decenni ha
coperto il patto di non belligeranza tra i Servizi italiani e quelli
palestinesi. Basato su uno scambio indicibile: la promessa palestinese a non
realizzare attentati in Italia, in cambio della libertà di trasporto di armi sul
territorio nazionale. Ma a forza di scavare, si sta scoprendo che all' ombra di
quel patto si sono consumati alcuni misteri italiani: la scomparsa in Libano di
due giornalisti italiani, la strage alla Stazione di Bologna, ma anche il ruolo
delle fazioni palestinesi nella trattativa per liberare Moro, prima disponibili
ad attivare la propria "rete", poi dileguate in un batter di ciglia. I documenti
desecretati Un contributo decisivo nel focalizzare gli effetti di quel patto,
passato alla storia come "lodo Moro", lo ha dato la Commissione Moro 2, che in
quattro anni di lavoro (conclusi con irrituale voto unanime della Camera) ha
scelto di avvalersi di migliaia di documenti desecretati dagli archivi dei
Servizi italiani, di nuove prove di Polizia scientifica e Ris dei Carabinieri,
di testimonianze mai attivate. Una gran quantità di "fili scoperti" sono ora
riconnessi nella seconda edizione del libro "Moro, il caso non è chiuso. La
verità non detta", scritto da Giuseppe Fioroni, già Presidente della Commissione
e da Maria Antonietta Calabrò, per molti anni giornalista di giudiziaria al
Corriere della sera. Durante un' audizione davanti alla Commissione Moro sul
tema dei traffici di armi tra palestinesi e Br, l' ex pm Giancarlo Armati ha
lasciato "esterrefatti" i commissari, raccontando gli intrecci occulti tra lo
Stato italiano e i palestinesi. Armati ritiene esista la "prova" che sia stato
il Fronte di Liberazione della Palestina di George Habbash ad uccidere a Beirut
i due giornalisti italiani Italo Toni e Graziella De Palo, che in un articolo
aveva scritto: «La strage di via Fani è stata compiuta con armi italiane
destinate all' Egitto e rientrate per vie tortuose in patria». Nel 1980 i due
giornalisti arrivano a Beirut per indagare sui traffici di armi e scompaiono
immediatamente. In un rapporto scritto per Armati, l' allora ambasciatore in
Libano Stefano D' Andrea indicò fatti e ricostruì come nella sua ambasciata
telex cifrati venissero passati al colonnello Giovannone, che da garante del
patto con i palestinesi, li avvisava su ogni grana che li riguardasse. Ma non
basta. Armati ha rivelato che dopo aver raccolto indizi per emettere un mandato
di cattura contro Habbash, si presentò dal giudice istruttore Squillante, «che
cominciò a saltare sulla sedia» e disse: «No, gli elementi non sono
sufficienti!».
Dopo il rapimento dello
statista. Dopo il rapimento di Moro, marzo '78, i palestinesi offrono
collaborazione alle autorità italiane. Il canale individuato è Wadi Haddad, un
capo palestinese a Berlino est, organico a Stasi e Kgb. Ma Haddad è ucciso senza
che i Servizi dell' Est lo proteggano. Il ministro dell' Interno Cossiga -
conoscendo il "lodo Moro" - capisce che una collaborazione troppo stretta con i
palestinesi può diventare pericolosa e lascia cadere una richiesta di incontro
avanzata da Nemer Hammad, uomo di Arafat in Italia. Ma il 21 giugno, con Moro
appena ucciso, comunicazione «segretissima» di Giovannone: le Br hanno
consegnato «personalmente ad Habbash» copia delle dichiarazioni rese dal leader
Dc in prigionia su questioni di interesse palestinese. Si trattava del famoso
Lodo, che i palestinesi volevano a tutti i costi secretare? E' molto probabile.
Anni dopo Arafat ha scritto nelle sue memorie: il "Lodo", nel 1973, lo
sottoscrisse Andreotti, non Moro. In merito alla strage alla Stazione di Bologna
del 1980 (attribuita a terroristi neri e servizi deviati), di recente, tra
macerie dimenticate per anni, è stato scoperto un «interruttore artigianale»
possibile innesco per l' esplosione, «simile a quello dei tergicristalli di un'
auto», incompatibile con attentatori professionali come i Servizi, pur deviati.
Una scoperta che fa tornare d' attualità la tesi di Francesco Cossiga di un
«trasporto finito male della "resistenza" palestinese». Nel libro di Calabrò e
Fioroni - edito da Lindau e che punta a superare quella "verità accettabile"
frutto di un compromesso tra gli apparati dello Stato e i brigatisti - un
capitolo riguarda Alessio Casimirri, «figlio del numero due della Sala stampa
vaticana per 30 anni, l' unico brigatista, che pur condannato a sei ergastoli,
non ha scontato un giorno di carcere. Da anni vive indisturbato in Nicaragua, il
Paese nel quale approdò un miliardo di dollari sottratti al Banco Ambrosiano» e
dove Maurizio Gelli, figlio di Licio, è stato nominato chargé d' affaires dell'
ambasciata nicaraguense in Uruguay. Casimirri ha confidato alcune delle sue reti
di protezione a un agente dei Servizi italiani che lo aveva agganciato. Raccontò
che la sua fuga dall' Italia fu aiutata dal Kgb. Questo e altro stava
raccontando Casimirri, quando tutto precipitò. Il 16 ottobre 1993, l' Unità
sparò la notizia dell' intenzione di Casimirri di vuotare il sacco. Come ha
raccontato alla Commissione Carlo Parolisi, allora agente Sisde: «Eravamo a un
passo dal farlo rientrare in Italia, quel maledetto scoop fece saltare tutto».
Antonino Arconte.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Antonino Arconte (Oristano, 10
febbraio 1954) è uno scrittore, ex militare e agente segreto italiano. Nato
a Oristano da una famiglia di militari di carriera, all'età di sedici anni si
arruola come allievo sottufficiale nell'Esercito Italiano nel 1970 e frequenta
il 14º Corso AS della Scuola Allievi sottufficiali di Viterbo. Nel settembre
dello stesso anno, durante la frequenza del corso, viene selezionato insieme ad
altri allievi per far parte dei nuovi quadri del Servizio Informazioni Difesa,
il SID, il servizio segreto italiano con struttura militare nato nel 1965 e
comandato da quell'anno dal generale Vito Miceli. Questi aveva ricevuto
l'incarico da Aldo Moro di organizzare la struttura paramilitare segreta
italiana di tipo stay-behind nota con il nome in codice di Organizzazione
Gladio e integrata con le altre organizzazioni simili sorte negli altri paesi
della NATO. Arconte venne inserito nel Nucleo G (identificato dal Presidente
della Commissione Difesa, Amm. Falco Accame e alcuni giornalisti come "Gladio
delle Centurie", perché suddivisa in tre centurie), la parte militare
dell'Organizzazione Gladio e una delle 12 branche in cui era stato suddiviso il
SID e fatto transitare nella Marina Militare. Nel 1997 pubblica sul web una
pagina dal titolo "The Real History of Gladio" e inizia una campagna di
divulgazione dei documenti sull'Organizzazione Gladio rimasti in suo possesso in
risposta a un attentato alla sua vita subito nel febbraio del 1993. Il 26 luglio
1998, rilascia un'intervista a New York al giornalista Stefano Vaccara che la
pubblica su "America Oggi", quotidiano in lingua italiana diffuso negli Stati
Uniti d'America. L'intervista, pubblicata in due parti su nove pagine, contiene
rivelazioni sulla struttura dell'Organizzazione Gladio e riporta alla luce delle
esperienze operative dell'agente di Gladio Antonino Arconte, noto con il nome in
codice G-71, una panoramica su molti episodi oscuri della recente storia
italiana e internazionale. Le rivelazioni creano l'interessamento di alcuni
parlamentari e del Senatore Giulio Andreotti che sollecita un'inchiesta
Ministeriale al Ministro della Difesa per appurare l'autenticità o meno dei
documenti d'epoca pubblicati da numerosi quotidiani italiani e americani.
L'inchiesta del SISMI accerta che le accuse di falsità sono solo
indizi/informazioni e pone il divieto di divulgazione. Le inchieste conseguenti
della procura militare e civile di Roma si concludono il 7 maggio 2004 con
l'archiviazione perché i fatti non sussistono e il GIP di Roma lo riconosce
Parte Offesa da ignoti. Nello stesso tempo subisce delle ritorsioni da alcuni
giornali che lo diffamano gravemente e che querela il 12 luglio 2005. In seguito
a questa L'Unione Sarda, in persona del suo Direttore e del cronista, vengono
condannati con Sentenza passata in giudicato in Cassazione il 21 dicembre 2012,
per diffamazione aggravata perché hanno pubblicato false notizie tendenti a far
credere che Antonino Arconte e l'altro sopravvissuto dell'Organizzazione Gladio,
Pier Francesco Cancedda, fossero due falsari. I media italiani non hanno
pubblicato, pur informati, la notizia di queste tre condanne e la stessa Unione
Sarda non ha pubblicato il dispositivo di condanna, come ordinato dal Tribunale
il 1º dicembre 2010. L'ordine dei giornalisti della Sardegna non ha proceduto
con le sanzioni disciplinari come stabilito dal codice deontologico della stampa
e A. Arconte ha rivolto un esposto all'autorità competente anche contro questi
comportamenti lesivi delle norme previste dalla legge istitutiva degli ordini
professionali del 1963. Prosegue l'impegno dell'ex Gladiatore in sede civile per
ottenere le sanzioni e il risarcimento dei danni, intanto pubblica sul suo blog,
l'unico luogo dove si possono leggere verità su questi argomenti,
g-71.blogspot.com le sentenze di condanna in giudicato che i media nazionali
hanno ignorato. Sullo stesso blog ha pubblicato anche i verbali di testimonianza
al processo nell'aula bunker Giovanni Falcone di Trapani, nel quale depone sulle
basi di Gladio a Trapani e rende noti i comportamenti di alcuni Ministri che in
un paese normale sarebbero stati sanzionati. Sulla sua azione di verità sono
stati pubblicati centinaia di articoli, in Italia ed America, decine di Speciali
TV, decine di interpellanze parlamentari a risposta scritta, sono stati ripresi
da altre pubblicazioni, anche ad opera di magistrati quali il Ferdinando
Imposimato nel suo libro "I 55 giorni che hanno cambiato l'Italia" e la RAI TV è
stata condannata, ad aprile 2013, alla restituzione di materiale video e
documentale che gli aveva sottratto con l'inganno e che costituiscono prova
fondamentale all'identificazione di alcuni mandanti e complici delle stragi di
Via Fani e dell'assassinio dell'On. Aldo Moro. Il 16 gennaio 2015 l'Ufficiale
Giudiziario ha preso atto dell'ammissione di responsabilità dei vertici RAI che,
in Viale Mazzini 14 a Roma, sede della RAI-TV, hanno ammesso che la
documentazione autentica sulla strage di Via Fani e sequestro e omicidio
dell'on. Aldo Moro, è stata sottratta dolosamente dagli archivi RAI dov'era
custodita dal settembre 2002, dopo averla ricevuta da Antonino Arconte per la
perizia scientifica e la trasmissione "VERO o FALSO" di RAI 3 Primo Piano,
andata in onda il 12 marzo 2003. Un'inchiesta della Procura di Roma sulla
sottrazione di quella documentazione in seguito a regolare denuncia, è
attualmente in corso alla data del 2 giugno 2015. Nel dicembre 2001 pubblica la
sua autobiografia in "L'Ultima Missione. G-71 e la verità negata" ISBN
88-900678-2-9 che riepiloga le rivelazioni e i casi giudiziari connessi e
illustra le operazioni da agente segreto alle quali l'Arconte ha partecipato. In
allegato all'opera un CD Rom contenente l'intero archivio superstite
dell'Organizzazione Gladio, che non è stato distrutto nel 1990, come ordinato
dal Governo in carica del Sen. Giulio Andreotti. Lo stesso si può scaricare
gratuitamente da amazon.it per i possessori del lettore kindle. Nel giugno 2010
pubblica il sequel dell'Ultima Missione, intitolato "Bengasi e dintorni", con il
quale aggiorna la sua vicenda che continua con nuovi risvolti, nuove rivelazioni
e le conclusioni delle ultime vicende giudiziarie di cui è stato vittima dal
1991 al 1993, concluse a suo favore con le quattro condanne comminate dalla
Commissione Europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo nel maggio 1998, dello
Stato Italiano per il ritardo con cui le Corti d'Appello hanno riconosciuto la
sua innocenza. Di queste, altre due sono ancora all'esame delle autorità
europee. Attualmente collabora con la Mursia Editore alla diffusione dell'opera:
"L'Ultima Missione di G-71", una nuova edizione aggiornata della vera storia di
Gladio e d'Italia, sempre dedicata alle sue passate esperienze nel Nucleo G
dell'Organizzazione Gladio, pubblicato da Mursia editore, il 13 novembre 2013,
nella collana "le Nuove Guerre" ISBN 978-88-425-4823-2 pagg. 632.
Moro, G71 e l'attesa per la
verità,
scrive Stefano Vaccari il 10-05-2008 su "America Oggi". Cari lettori, questa
settimana, a trent'anni dall'omicidio di Aldo Moro, riprendiamo il contatto con
Nino Arconte, il "gladiatore" che operava negli anni settanta e ottanta in
missioni internazionali con il nome in codice G71 e la cui storia voi conoscete
fin dall'estate del 1998 (per chi segue America Oggi/Oggi7 da tempi più recenti,
consigliamo di andare in internet: scrivendo nel motore di ricerca Arconte
Vaccara troverete diversi articoli). Quindi da dieci anni più volte su questo
giornale abbiamo seguito la vicenda di G71, l'agente segreto della marina
militare italiana appartenente ad una delle cosiddette "Centurie" della Gladio
denominata anche "Stay Behind" (dietro le linee nemiche), che dopo aver servito
la sua Patria durante la Guerra Fredda, improvvisamente si ritrovò non
riconosciuto dallo Stato italiano mentre alcuni dei suoi commilitoni cadevano
come birilli in sempre più misteriosi "suicidi" o morti giudicate accidentali.
Arconte, o meglio G71, cinque anni dopo quella prima intervista, ci mostrò un
altro documento, il più esplosivo di tutti che questo giornale, questa volta
insieme ad altri due (Famiglia Cristiana e Liberazione) pubblicò immediatamente.
In quel documento, che apparentemente sembrava essere del Ministero della Difesa
italiano e che G71 nel marzo del 1978 era stato incaricato di portare a Beirut
al capo dei servizi italiani nella capitale libanese che allora, come del resto
ora, era sconvolta dalla guerra civile. Nel documento si faceva riferimento al
rapimento di Aldo Moro e si chiedeva ai servizi italiani nella regione di
attivarsi per la sua liberazione ma con un particolare sconcertante: la data in
cui era stato scritto, 2 marzo 1978, precedeva quella del rapimento avvenuto il
16 marzo in via Fani a Roma. G71 doveva consegnare il documento a Beirut
all'agente G-219 (identificabile nel colonnello Ferraro, rimasto poi vittima nel
1995 di uno strano suicidio), dislocato e dipendente dal capocentro G-216 (il
colonnello Stefano Giovannone e che poi Moro menzionerà proprio in una delle sue
lettere dal carcere delle BR), affinché prendesse contatti con i movimenti di
liberazione del Medio Oriente, perché questi intervenissero sulle Brigate Rosse,
ai fini della liberazione dello statista democristiano. È grazie al "gladiatore"
G71 che questo documento a "distruzione immediata" è invece ancora qui. E prima
di lui grazie al colonnello Ferraro che, secondo Arconte, prima di morire
misteriosamente impiccato nel suo bagno di casa, gli ha consegnato il documento
che lui non aveva distrutto. Cinque anni fa, all'uscita di quel documento, ci
furono delle interrogazioni parlamentari. Anche l'ex capo del governo ai tempi
del rapimento Moro e ora senatore a vita Giulio Andreotti, chiese espressamente
al governo Berlusconi allora in carica di far subito luce sulla vicenda, perché
se quel documento fosse stato provato autentico ovviamente avrebbe riscritto (e
in che modo!) la storia d'Italia, se invece fosse stato un falso allora chi lo
spacciava per vero avrebbe dovuto essere ovviamente perseguito. Invece Arconte
non venne affatto perseguito anzi fu lui a denunciare chi lo discreditava. Il
ministero della Difesa di allora, senza portare alcuna prova definitiva, si
limitò a delle comunicazioni in cui sosteneva che Nino Arconte non era
attendibile e poi aggiunse qualcosa che ci insospettì. Nel cercare di screditare
il racconto di G71, le autorità italiane scrissero che era priva di ogni
fondamento la tesi di Arconte che sosteneva il coinvolgimento degli Usa e della
Cia nella vicenda del rapimento... Ma Arconte aveva sempre sostenuto il
contrario! E cioè che secondo lui dietro al rapimento Moro si nascondeva la
lunga mano dei servizi segreti di oltre cortina sovietica, e quindi quell'accusa
ci apparve a dir poco stramba per non dire depistante. Il 7 giugno del 2006 il
presidente del Senato Franco Marini, rispondendo ad una lettera di Arconte in
cui chiedeva almeno delle scuse ufficiali, ha scritto che "ho valutato la
complessità della vicenda e posso rendere conto del suo punto di vista" ma che
come presidente del Senato, non ha il potere di imporle a nessuno quelle scuse.
Marini concludeva dicendo di aver fatto acquisire agli atti del Senato la
lettera di Arconte. Cinque anni sono passati dall'emersione di quel documento,
ma sembra che a Roma nessuno abbia fretta di chiarirne definitivamente
l'autenticità o che si debba quindi perseguire Arconte. Noi aspettiamo e intanto
ecco le nostre domande per G71. Cinque anni fa uscì la nostra seconda
intervista, questa volta sullo straordinario documento del Ministero della
Difesa che ti fu ordinato di portare nel marzo del 1978 a Beirut e che
annunciava il rapimento di Moro prima che avvenisse...
Cosa è successo da quelle
rivelazioni e dopo le interrogazioni parlamentari di Andreotti e di altri
legislatori? Che fine ha fatto quel documento? Il governo Berlusconi prima e
quello Prodi dopo, hanno comunicato qualcosa, lo hanno spiegato? Sono state
fatte indagini? E' stato smentito? Ti hanno denunciato o ti hanno ridato gli
onori militari?
«Quel documento è stato fatto
oggetto di dibattiti parlamentari; in Senato sono state presentate 23
interpellanze a risposta scritta ed è stato risposto di tutto e il contrario di
tutto. Molte di queste risposte sono state pubblicate da America Oggi ed Oggi7
nel 2003. Ricorderai l'articolo su Martino, Ministro della Difesa dell'epoca,
che dichiarava cose non vere, come il tuo giornale poté benissimo testimoniare
in proposito dell'inchiesta per falso avviata contro di me e che due anni dopo,
il 7 maggio 2004, fu archiviata per infondatezza della notizia di reato, mentre
il GIP di Roma mi riconosceva "parte offesa da ignoti" perché nessuno di coloro
che mi avevano accusato pubblicamente, di fronte all'infondatezza di esse,
confermava le sue accuse. Ricorderai che quel documento fu anche sottoposto a
perizia scientifica per l'interessamento del settimanale Famiglia Cristiana, la
RAI e il quotidiano Liberazione, organo del Partito di Rifondazione Comunista e
che tale perizia diede esito di autenticità. Nel senso che risultò che carta,
inchiostri e caratteri di stampa, come bolli e sigilli usati, erano quelli
normalmente in uso al Ministero della Difesa, Marina Militare, Ufficio X°, negli
anni '70. Conformi ad altri documenti di raffronto che indubitabilmente
provenivano da quelle sedi e in quelle date. Gli stessi giornalisti che
parteciparono a quelle operazioni di verifica e controllo hanno anche
testimoniato queste cose sotto giuramento nel Tribunale di Oristano, dove ho
dovuto citare la RAI 1 e RAI 3, per avere offeso la verità a cui avevo accettato
di collaborare effettuando tagli alle trasmissioni che non avevo autorizzato.
Scelte non dei giornalisti, ma delle redazioni politiche che li controllano».
Hai altri documenti che non
hai ancora mostrato? E se sì, quando li renderai pubblici e che cosa
rivelerebbero?
«Si, ho altri documenti che
però non riguardano il caso Moro, ma la mia vita in servizio dietro le linee
della Guerra Fredda Italiana e non solo Italiana. Vorrei evitare di renderli
pubblici, ma questo non dipenderà da me, ma dal comportamento del Governo
Italiano. Sto per spedire al nuovo Governo la solita richiesta di Congedo che
invio ad ogni nuova legislatura ricevendo risposte dei più svariati generi:
Alcune le hai smentite anche tu nel tuo giornale. A volte persino divertenti,
altre vergognose, da parte di Ministri della Difesa che mostravano di non
conoscere nemmeno la storia Patria, alcune altre nessuna risposta! Ora vedremo
cosa risponderà il nuovo Governo Berlusconi. Io sono sempre sereno e fiducioso
come chi sa di essere dalla parte del giusto e nel suo pieno diritto. Mi auguro
sempre che finalmente si faccia giustizia anche di questa storia, sarebbe buon
segno, non solo per me, ma per tutta l'Italia e, addirittura, senza voler
esagerare, credo che sarebbe buon segno per tutto l'Occidente Democratico che
sembra aver smarrito la via!»
Sono stati fatti tanti film
sul caso Moro, ora uno anche con Michele Placido nella parte dello statista si
vede in questi giorni in tv. Qualche regista - o sceneggiatore o produttore - ti
ha mai contattato per avere da te una collaborazione? C'è un film la cui
ricostruzione ti ha soddisfatto?
«Si, tantissimi sono venuti
qui a trovarmi per convincermi, ma sono bastate poche parole per capire che
c'era incompatibilità di vedute. Sono tutti troppo politicizzati e vedono la
storia, soprattutto la storia d'Italia, attraverso i filtri colorati ed i
paraocchi della politica. Dovrebbero occuparsi solo di fiction senza pretendere
patenti di autenticità storiche che non hanno. Così ho sempre rinunciato. A
parte per il film di Carlo Infanti "La verità negata" per il quale ho scritto
una sceneggiatura per la parte da girare in Sardegna che ho interpretato con la
protagonista qui nel Sinis di Cabras, perché mi è sembrato che cercasse di dare
una visione dei fatti storici di cui si occupa e relativi al caso Moro che più
si avvicinava alla mia testimonianza. Inoltre ho collaborato perché non mi ha
parlato di tagli e devianze su ciò che dovevo fare nel suo film.
Ho anche scritto io
un'altra sceneggiatura. Sono impegnato proprio in questi giorni a trovare, con
produzioni europee, un possibile accordo per finanziare il primo dei tre film di
cui si compone l'opera cinematografica tratta dal libro L'Ultima Missione!»
Con la tua rivelazione del
documento di Beirut, si confermavano i contatti tra terrorismo rosso e ambienti
del terrorismo mediorientale. Oggi l'Italia è sempre più invischiata nella
regione, in Libano, in Afghanistan... I gruppi terroristi mediorientali legati
ad Al Qaeda, Hamas, Hezbollah, potrebbero cercare ancora di avere legami in
Italia con terroristi locali? Cosa facevate voi allora per scongiurare queste
"alleanze" e cosa si dovrebbe fare adesso?
«Nell'ultimo speciale su Moro
a cui ho collaborato e che si intitola "Moro: se ci fosse luce sarebbe
bellissimo", il magistrato del caso Moro Dr. Imposimato fa alcune dichiarazioni
che si avvicinano alla verità. Dice che secondo alcuni suoi riscontri in Via
Fani c'erano stati anche terroristi della RAF tedesca che era collegata alla
Stasi, servizi segreti della Germania comunista che a sua volta era collegata al
KGB sovietico. Ebbene Imposimato si avvicina molto alla verità, ma non
abbastanza, perché gli mancano le basi della conoscenza della rete terroristica
filo sovietica che comprendeva tutte queste organizzazioni, IRA, ETA, RAF, BR,
OLP tutte orchestrate da Mosca attraverso la Separat comandata dallo Sciacallo,
che aveva basi a Tripoli, in Libia e a Damasco, in Siria, ma anche in Germania
Est ed in Cecoslovacchia. Tutti paesi controllati direttamente dal KGB
sovietico. Ma la vera storia anche di quella parte la descrivo meglio e la
documento nella sceneggiatura del primo film dal titolo provvisorio "L'Isola dei
combattenti". Il mondo è cambiato, ma certe strategie sono le stesse. Cosa
facevamo noi? Eravamo in mezzo a loro! L'Italia era presente anche a quel tempo
in Nord Africa, in Afghanistan, in Libano ... Ieri come oggi, solo che all'epoca
non si poteva dire, né mostrare... Lo racconto e documento nelle mie opere
autobiografiche e adesso anche al cinema. Ma per poter raccontare davvero questa
storia, anzi queste storie, devo riuscire a realizzare il progetto di film
seriale tratto dall'Ultima Missione e di cui ho già pronta la sceneggiatura per
il primo. In questo ci sarà, per onore al vero, anche il nostro primo incontro a
New York, nel giugno 1998, che fu descritto poi dal tuo articolo su America
Oggi/Oggi 7 di quell'estate. Da allora sono stati centinaia, ma il tuo fu il
primo e penso che contribuì a salvarmi la vita. Per vedere realizzata
quest'opera vera sulla Guerra Fredda servono solo i finanziatori e li sto
cercando anche in Europa, soprattutto in Europa, perché in Italia è impossibile
che qualcuno accetti di finanziare un film di questo genere senza voler mettere
sotto controllo la storia dal punto di vista politico e io questo non lo posso
fare e non lo farò.»
Ti senti ancora in pericolo
di vita? Se attraverso questa intervista volessi mandare un messaggio al premier
Berlusconi e ai nuovi ministri degli Esteri Frattini, degli interni Maroni e
della Difesa La Russa, cosa diresti?
«Sono prudente in maniera del
tutto naturale e sentirmi in pericolo è la mia condizione abituale, non mi pesa.
Gli chiederei di fare qualcosa di serio per cambiare il destino della nostra
Patria. E la prima cosa da fare è quella di dare giustizia agli italiani. Oggi
abbiamo uno Stato dei privilegi e di privilegiati che è riuscito a distruggere
tutto, anche l'amor di Patria. Il compito che si trovano davanti non è certo
facile. Non sono il solo a parlare di sfascio generale: della Giustizia, della
scuola, della sanità delle Istituzioni e non è certo a suon di chiacchiere che
si può risanare tutto questo. Io faccio la mia piccola parte, basterebbe che
ognuno facesse la sua. Ho visto l'elenco dei Ministri del Governo Berlusconi...
staremo a vedere».
L’agente segreto G-71,
l’On. Gero Grassi e la verità su Moro: appuntamento all’ONU.
L'ex agente segreto Antonino Arconte, il G-71 della Gladio, autore di L'ultima
missione, alla VOCE rivela a quali condizioni sarebbe disponibile a testimoniare
davanti alla Commissione parlamentare sulla strage di Via Fani e l'assassinio di
Aldo Moro: "Risponderò all'On. Gero Grassi, ma dentro al Palazzo dell'ONU...",
scrive Stefano Vaccara il 16 marzo 2015 su "La Voce di New York". Aldo Moro,
leader della Democrazia Cristiana ed ex capo del governo e più volte ministro,
venne sequestrato 37 anni fa in via Fani a Roma. Per rapirlo, le Brigate Rosse
massacrarono tutti gli uomini della scorta. Un lavoro da professionisti, come in
un film con James Bond. In meno di tre minuti, si spararono quasi cento colpi
che uccisero i due carabinieri, Oreste Leonardi e Domenico Ricci, a bordo della
Fiat 132 in cui viaggiava anche Moro, e i tre poliziotti, Raffaele Iozzino,
Giulio Rivera e Francesco Zizzi, che viaggiavano sull'Alfetta di scorta. Il
tutto senza mai colpire Moro. Professionisti appunto. Ma c'erano solo le BR in
via Fani, alle dieci del mattino, ad aspettare Moro e la sua scorta quel 16
marzo 1978? Gero Grassi, deputato del Partito democratico e componente di spicco
della nuova Commissione parlamentare sul caso Moro, è convinto che ci
fossero altri uomini oltre le BR quel giorno in via Fani ad aspettare
Moro: "Certamente queste persone non erano lì a prendersi un caffè". Ma se gli
uomini "segreti" non fecero nulla per impedire il sequestro di Moro e il
massacro della scorta, allora erano lì per aiutare i terroristi, magari anche
sparando? "Lo sospettiamo fortemente, ma non siamo ancora in grado di
dimostrarlo. Quello che però possiamo dire con assoluta certezza – ha
detto Grassi alla rivista Oggi– è che le Brigate rosse non agirono da sole, ma
furono quantomeno “accompagnate”". Dallo scorso maggio il Parlamento italiano ha
stabilito una nuova commissione d'indagine per far luce sul caso Moro. Non sono
bastate quindi le precedenti commissioni e i precedenti processi per la verità
sulla "matrigna" di tutti i misteri della Repubblica, dove ricatti e depistaggi
continuano a incrociarsi mantenendo così all'oscuro i cittadini italiani sulla
vera storia degli anni di piombo in Italia. Ma questa nuova commissione, di cui
l'On. Grassi appare una personalità determinata ad andare fino in fondo,
è veramente pronta a scoperchiare la storia d'Italia? Oppure si
tratterebbe ancora una volta di una "mossa" propagandistica, sulla scia della
dichiarazione di Renzi di togliere il segreto di stato, ma pronta a fermarsi in
tempo? Frasi ad effetto buone per dei titoli sui giornali, ma poi al momento di
illuminare il buco più nero della Repubblica, la cosiddetta "ragione di stato"
farà ragionare che è meglio continuare a non ragionare…Quando da New York
leggiamo dell'On. Grassi che in giro per l'Italia racconta dei servizi segreti
che sanno, prima che accadesse, del rapimento di Moro, sorridiamo di rabbia. La
prova di ciò fummo proprio noi da qui, da New York, a pubblicarla, ma
tanti, troppi anni fa. I lettori più affezionati, ricorderanno forse una prima
pagina di Oggi7, il settimanale di America Oggi, intitolata: "Italia, spiega
questo documento!" Si trattava di un ordine della Marina italiana, in cui si
istruiva l'agente di Gladio G71, sigla che apparteneva ad Antonino Arconte, a
recarsi in Libano con una nave commerciale per consegnare un documento top
secret per il colonnello Stefano Giavannone. In quel documento, si chiedeva a
Giovannone di adoperarsi con i suoi contatti in Libano con i gruppi di
terroristi mediorientali per attivare canali utili alla liberazione del
Presidente della DC Aldo Moro. La bomba in quel documento? La data: 2 marzo
1978. 14 giorni prima della strage di via Fani. Quando noi pubblicammo
quel documento che ci aveva fornito Nino Arconte, seguito da tanti altri servizi
in cui G71 raccontava storie e coincidenze e non solo su Moro, il tutto
rimbalzava sul muro di gomma dell'informazione italiana. Ogni tanto qualche
lancio d'Ansa, due righe, ma la grande stampa italiana come se nulla fosse.
Quando poi in Parlamento, grazie all'ammiraglio Falco Accame, non si potè
evitare di rispondere alle interrogazioni sulla storia e la validità di questo
documento, cercando invano risposte dai ministri della Difesa di allora (tra i
tanti, pure un certo Sergio Mattarella), qualche scossa comunque si verificò: il
Senatore Giulio Andreotti, che con Francesco Cossiga nel '78 condivise le
maggiori responsabilità della cosiddetta "linea della fermezza" che condannò a
morte Moro, disse ad un certo punto questo: bisogna fare subito luce su quel
documento di Arconte, perché se è vero, processate chi era allora al governo. Se
risultasse falso, processate Arconte! Bene, il documento fu analizzato, portato
pure ad una trasmissione Rai, e quindi dichiarato dai periti compatibile con i
documenti della marina militare italiana in uso nel '78. Che accadde?
Arrestarono forse Andreotti e Cossiga? Macché. Niente. Non accadde proprio
nulla. Nessuno ne parlò più, anche perché la grande stampa italiana di quel
documento in realtà non ne scrisse neanche quando se ne lamentava Andreotti…Così
Arconte ora si ritrova ancora a combattere una battaglia legale con la Rai che
non gli ha mai restituito i documenti consegnati, che ora sarebbero scomparsi…
Lo stesso onorevole Grassi, che è anche vicepresidente dei deputati PD in
Parlamento, ha recentemente riconosciuto le ragioni di Arconte dichiarando
all'Ansa: "L'ex gladiatore Antonino Arconte denuncia da tempo le responsabilità
della Rai nella scomparsa di materiali molto importanti sulla strage di via
Fani. Il Capitano di Vascello Antonino Arconte, che si è rivolto anche alla
magistratura, merita una risposta da parte dei vertici di viale Mazzini ai quali
chiediamo noi oggi di intervenire sul caso". E torniamo quindi allo
scoperchiamento della vera storia della Repubblica d'Italia durante la Guerra
fredda. Nino Arconte, ha pure scritto un libro sulle sue avventure da gladiatore
a servizio dell'Italia e della Nato durante la Guerra Fredda. In L'ultima
missione (Mursia 2014), in un capitolo G71 racconta per esempio di quando per la
prima volta parlò a New York con il cronista che vi scrive queste righe, era
l'estate del 1998. Per Arconte pubblicando la sua storia a New York, allora gli
salvammo la vita: i suoi commilitoni delle centurie di Gladio, che avevano
convissuto con lui quegli anni tra missioni segrete e il caso Moro, in un modo o
nell'altro venivano in quei giorni, ad uno a uno, "suicidati". Ora Nino Arconte
torna spesso a New York, ha un figlio che vive qui, è un manager di successo.
Così nell'ultimo suo viaggio, G71 è venuto a trovarci nel nostro ufficio al
Palazzo di Vetro dell'ONU, ma questa volta non aveva voglia di parlare di quello
che aveva già raccontato. Aveva semmai voglia di poter dire quello che finora
non ha mai detto, e avrebbe voglia di raccontarlo alla nuova Commissione Moro.
Arconte ci ha infatti raccontato di aver ricevuto una telefonata dell'On. Grassi
che ha cercato di convincerlo ad andare a testimoniare di fronte alla
commissione Moro. Ma Nino si rifiuta. Perché è sicuro che per quello che
direbbe, per le accuse che farebbe, sarebbe querelato. Arconte dice di poter
provare quello che vorrebbe dire, ma si è stufato di dover difendersi in un
sistema giudiziario che ritiene lento e inaffidabile. Alla fine anche quando lo
portano in tribunale, devono dargli per forza ragione, ma G71 non vuol perdere
più anni della sua vita nelle corti di giustizia. Allora Nino Arconte, il
gladiatore sopravvissuto, ha una proposta per l'On. Grassi e la commissione Moro
e ci ha pregato di diffonderla in questo giornale: G71 non solo risponderebbe a
tutte le domande della Commissione sul quel documento, ma avrebbe tante altre
cose da raccontare, cose inedite a quanto pare. Però a Roma o in qualunque altra
parte d'Italia questa testimonianza non la rilascerebbe mai, data la mancanza
di una totale immunità. Quindi vorrebbe essere interrogato dalla Commissione
Moro qui a New York, dentro l'ONU, nell'ufficio della VOCE. Perché, dice
Arconte, sarebbe protetto dall'immunità delle Nazioni Unite, e saprebbe che
poi la sua testimonianza potrebbe essere letta da tutti i cittadini
italiani. Sentite che ci dice Arconte: "Io, purtroppo penso che solo
internazionalizzando l’inchiesta sul colpo di Stato del marzo 1978 in Italia si
potrà arrivare alla verità e salvare l’Italia dai golpisti ed eredi dei golpisti
che l’hanno distrutta. Per questo sono disponibile a testimoniare il vero a New
York". Qui potete ascoltare Arconte che nel nostro ufficio parla della sua
volontà di testimoniare e del suo attaccamento alla patria. Ecco un particolare
del pensiero di G-71: “La Patria non è mai lo Stato. Lo Stato è una struttura
amministrativa che i popoli si danno per gestire la cosa pubblica. La sanità, la
giustizia, le forze armate, i servizi segreti, la pubblica istruzione. Questi
sono gli Stati. Se funzionano allora i popoli che sono le patrie, li mantengono.
Se non funzionano più, i popoli hanno il dovere di scioglierli e farsene un
altro. Ma quando è caduto lo stato fascista l’Italia non è morta… E quando si è
sciolta l’Unione Sovietica, la Russia non è morta. E quando è caduto lo stato
delle colonie inglesi, ecco è nata la patria americana…” Allora onorevole
Grassi, che si fa? Lo vogliamo accontentare G71 e andare a verificare se con la
sua testimonianza si potrà ricostruire un tassello fondamentale di storia
d'Italia? On. Grassi, la sua trasferta e quella di alcuni suoi colleghi della
commissione Moro a New York potrebbe rivelarsi opportuna: potrebbe far spiegare
ad Arconte chi diede a G71 quel documento che avvertiva del sequestro Moro prima
che avvenisse e come poi sia riuscito a conservarlo… Forza On. Grassi, chissà
quante domande avrebbe lei per Arconte, che non vede l'ora di parlare qui a New
York, dentro il Palazzo di Vetro. Chissà che non tocchi a G71 riuscire a svelare
chi ci fosse in via Fani, chi fosse a sparare così bene da dietro una Austin
Morris parcheggiata al posto giusto e al momento giusto. E magari anche chi ci
fosse sopra una motocicletta Honda… E ancora, chissà, magari G71 potrebbe aver
saputo qualcosa anche su quella bomba scoppiata sul treno Italicus partito da
Roma il 3 agosto del 1974, un treno in cui avrebbe dovuto viaggiare, ma guarda
che coincidenza, anche l'On. Aldo Moro…
Stefano Vaccara: «Sono nato e
cresciuto in Sicilia, la chiave di tutto secondo un romantico tedesco. Infanzia
rincorrendo un pallone dai Salesiani e liceo a Palermo, laurea a Siena, master a
Boston. L'incontro col giornalismo avviene in America, per Il Giornale di
Montanelli, poi tanti anni ad America Oggi e il mio weekly USItalia. Vivo a New
York con la mia famiglia americana e dal Palazzo di Vetro racconto l’ONU per
Radio Radicale. Amo insegnare: prima downtown, alla New School, ora nel Bronx,
al Lehman College della CUNY. Alle verità comode non ci credo e così ho scritto
Carlos Marcello: The Man Behind the JFK Assassination (Enigma Books 2013 e
2015). Ho fondato e dirigo La VOCE di New York, convinto che la chiave di tutto
sia l’incontro fra "liberty & beauty"».
Aldo Moro compie 100 anni:
le polemiche.
La figlia dello statista Dc scrive una lettera aperta al
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scrive Domenico Camodeca il 23
settembre 2016 su "It.blastingnews.com". Non c’è pace nemmeno da morto per Aldo
Moro, il politico di fede democristiana rapito e poi ucciso da un commando delle
Brigate Rosse nel 1978. La strage di via Fani, la geometrica potenza
delle #Br (con la complicità, forse, della mano dei servizi segreti), l’attacco
al cuore dello Stato, sono ferite profonde per il tessuto democratico
dell’Italia repubblicana che ancora fanno fatica a rimarginarsi. In questo clima
di sospetti e veleni si inserisce la lettera aperta, pubblicata dal Fatto
Quotidiano, inviata dalla figlia primogenita, Maria Fida Moro, al presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella. In essa, la Moro si lamenta di essere stata
fatta fuori, di fatto, dal "gioco della memoria" che ha toccato gli affetti, i
sentimenti, ma anche il portafoglio dei familiari dell’uomo politico
scudocrociato. Forte anche l’accusa lanciata contro i cosiddetti ‘morotei’
(Mattarella compreso) che non avrebbero fatto nulla per salvare il padre. Nel
giorno del centenario della nascita di #Aldo Moro, il 23 settembre del 1916,
fanno scalpore il tono ed il contenuto della pubblica missiva che Maria Fida (la
prima dei quattro figli di Moro) ha indirizzato al presidente Mattarella. Non
c’è gioia e nemmeno serenità in quelle righe, ma una profonda amarezza per il
silenzioso ostracismo ordinato nei suoi confronti dalle autorità istituzionali.
La signora Moro, in pratica, si lamenta del fatto di essere stata esclusa
dall’organizzazione delle cerimonie per il giorno del centenario della nascita
del padre. Opportunità che, accusa la Moro, sarebbe stata concessa solo ai due
fratelli minori proprio da Mattarella che li ha ricevuti al Quirinale
consegnando loro, di fatto, la chiave della cassaforte dei “fondi stanziati
dallo Stato per le suddette celebrazioni”. Una guerra fratricida favorita dal
più alto rappresentante della Repubblica quella che emerge dalle parole di Maria
Fida. A detta della Moro, sono tre le cause principali che hanno contribuito ad
innalzare un muro di gomma per arginare lei e il figlio autore del libro Mio
nonno Aldo Moro. La prima è che solo lei, unica tra i quattro fratelli, ha
“firmato per ben due volte la riapertura delle indagini” per chiarire i tanti
punti oscuri dell’agguato di via Fani (ad esempio, la presenza in quel luogo
della motocicletta Honda e del colonnello del Sismi Camillo Guglielmi il 16
marzo del ’78). La seconda ragione, collegata alla prima, è la posizione
favorevole da lei dimostrata “ad ogni commissione di inchiesta”. Mentre
l’ultima, all’apparenza di minor conto delle precedenti, riguarda la proposta di
beatificazione del padre (profondamente credente, come noto), anche in questo
caso firmata solo da lei in famiglia. Il j’accuse della Moro prosegue con un
attacco diretto a Mattarella, paragonato prima al suo illustre predecessore
Sandro Pertini e poi additato di non poter essere un “moroteo” perché, ecco
l’accusa, “Io non credo che siano mai esistiti dei morotei, altrimenti mio padre
non sarebbe morto in solitaria in quella maniera terribile”. La conclusione a
cui giunge l’autrice della missiva è, se vogliamo, ancora più amara perché Maria
Fida si ritiene, forse a ragione, “quella che ha difeso da sola suo padre lungo
gli ultimi 39 anni”.
Caso Moro, audizione ex
ministro Signorile.
Grassi (Pd): "Ci aspettiamo uno sforzo eccezionale di memoria",
scrive Antonio Maiellaro il 12 luglio 2016 su “Norba On Line”. La strage di via
Fani e l'assassinio di Aldo Moro. Questa sera è in programma un'importante
audizione davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta. Sarà sentito,
infatti, l'ex vice segretario del partito socialista, il pugliese Claudio
Signorile, che ebbe un ruolo importante all'epoca dei fatti. Fu crocevia di
contatti ed incontri per cercare di liberare lo statista democristiano,
prigioniero della Brigate Rosse. Per l'onorevole Gero Grassi, componente della
commissione, Signorile darà sicuramente un contributo di alto profilo. Proprio
la mattina in cui fu annunciato l'assassinio di Moro, Signorile incontrò il
ministro dell'interno Cossiga. Vorremmo capire, precisa Grassi, se andò al
Viminale all'ora del caffè, come disse in un primo momento, o più tardi, come
invece sostenne successivamente. Da signorile, conclude Gero Grassi, ci
aspettiamo uno sforzo eccezionale di memoria.
Moro: Signorile rivela,
morte decisa l'ultima notte.
"Vorremmo sapere cosa è successo quella mattina". "vorrete dire quella notte"!
"tutto si giocò nelle ultime 48 ore e poi nell'ultima notte". E’ questa la
rivelazione che fa Claudio Signorile, all'epoca vice segretario socialista, che
si attivò per salvare il leader della DC in una lunga intervista ad Alessandro
Forlani il 23/01/2010 che può essere ascoltata sul sito rai di
grparlamento. "Quando mi occupavo della trattativa con le BR, per il tramite di
Pace e Piperno, avevo il telefono sotto controllo ed ero pedinato; se avessero
voluto utilizzare le informazioni raccolte, avrebbero potuto fare qualcosa;
servizi e forze dell'ordine sapevano tutto, ma l'immobilismo di cui furono
protagonisti nei 55 giorni del sequestro Moro, fu una scelta". Signorile, che
avvertì la Commissione Stragi di quanto fosse importante considerare il ruolo
dei servizi segreti internazionali nei 55 giorni, traccia un'interpretazione
generale del sequestro con diverse novità. "Le BR rapirono Moro in autonomia,
secondo una loro logica, ma senza l'intenzione di ucciderlo: ne é prova il fatto
che lo interrogassero a volto coperto". "dopo pochi giorni però il sequestro
cambiò di significato, natura e quindi anche conclusione".
Moro: Signorile, si giocò
tutto la notte tra 8-9 maggio
Su rapimento immobilismo
servizi e forze ordine fu una scelta,
scrive Paolo Cucchiarelli. Per il rapimento di Aldo Moro "tutto si giocò nelle
ultime 48 ore", anzi "nell'ultima notte", quella tra l'8 e il 9 maggio del 1978.
É questa la rivelazione che fa Claudio Signorile, all'epoca vice segretario
socialista, che si attivò per salvare il leader della DC, rapito dalle Brigate
Rosse, in una lunga intervista ad Alessandro Forlani che può essere ascoltata
sul sito rai di grparlamento. Quindi, per Signorile tutto precipitò nella notte
tra l'8 e il 9 di maggio. "quando mi occupavo della trattativa con le BR, per il
tramite di Pace e Piperno, avevo il telefono sotto controllo ed ero pedinato; se
avessero voluto utilizzare le informazioni raccolte, avrebbero potuto fare
qualcosa; servizi e forze dell'ordine sapevano tutto, ma l'immobilismo di cui
furono protagonisti nei 55 giorni del sequestro moro, fu una scelta". Signorile,
che avvertì la Commissione Stragi di quanto fosse importante considerare il
ruolo dei servizi segreti internazionali nei 55 giorni, traccia
un'interpretazione generale del sequestro con diverse novità. "Le BR rapirono
moro in autonomia, secondo una loro logica, ma senza l'intenzione di ucciderlo:
ne é prova il fatto che lo interrogassero a volto coperto". "Dopo pochi giorni
però il sequestro cambiò di significato, natura e quindi anche
conclusione". Molti i particolari che Signorile racconta sulla trattativa da lui
condotta, per fermare l'esecuzione. "Il 9 maggio il presidente della Repubblica
Leone doveva firmare un provvedimento di clemenza a favore di Alberto
Buonoconto, che sarebbe stato trasferito in un carcere più vicino ai familiari".
"Quella stessa mattina il presidente del Senato Fanfani avrebbe pronunciato un
discorso alla direzione DC, che di fatto avrebbe aperto una crisi politica e
forse anche di governo, perchè dalla linea della fermezza, condivisa col PCI, la
DC passava a quella della trattativa, proposta dal PSI". "So per certo che l'8
maggio due importanti uomini politici salirono al Quirinale, per convincere
Leone a non firmare". Come é noto, non ci fu bisogno di nessuna di queste mosse,
perché la mattina del 9 Moro fu ucciso. "Non credo che ci fosse bisogno di dare
a Moretti l'ordine di agire, perché i brigatisti sapevano già cosa fare; certo
c'erano delle persone sopra Moretti, che non sono mai state scoperte". "Il mio
più grande rimorso é quello di non aver insistito di più con Fanfani nel nostro
incontro del 6 maggio, perché facesse subito una dichiarazione netta, che
ponesse fine alla linea della fermezza". Signorile rivela anche, per la prima
volta, un importante particolare, cioè il fatto che la notizia della morte di
Moro si diffuse prima della telefonata di Morucci al professor Tritto, a
mezzogiorno e dieci. "Cossiga mi chiamò al Viminale, per prendere un caffé
insieme, e io mi stupii, perché non avevamo un rapporto di grande consuetudine".
"Dopo pochi minuti che ero nella sua stanza, erano le 10 e mezzo- 11, sentiamo
l'altoparlante della centrale operativa, annunciare che la nota personalità era
stata ritrovata al centro di Roma". Signorile però ritiene capziosa la
ricostruzione fatta da alcuni giornalisti, che attribuiscono in quell'occasione
a Cossiga la frase: "mi hanno fregato". Fonte ANSA
Aldo Moro, Claudio
Signorile: "Ero con Francesco Cossiga per un caffè e non per una aperitivo",
scrive "L'Ansa" il 29/06/2013. "Andai da Cossiga nella seconda parte della
mattinata. Alle 12 si va a prendere un aperitivo non certo un caffè". Claudio
Signorile ricorda la mattina del 9 di maggio e si rammarica che queste novità
emergano ora che l'ex capo dello Stato non c'è più. E conferma la versione degli
artificieri, che dicono che sono arrivati prima della telefonata delle Br.
Quella mattina mentre era a colloquio con Cossiga al Viminale Signorile senti
"l'altoparlante in presa diretta che annunciava che c'era un'auto in via Caetani
con dentro un corpo e che andavano a verificare. Poi una seconda comunicazione
che diceva, la 'nota personalità'..." L'orario? A microfoni spenti tempo fa
Signorile disse "tra le 10 e le 11". "Ero lì per un caffè non un aperitivo",
chiosa oggi come a ribadire quell'orario detto in totale controtendenza con la
versione ufficiale della telefonata delle Br alle 12,13 a casa del Professor
Tritto. Il problema è che proprio in quei minuti è in corso la seduta della
direzione Dc che sta accettando la proposta di scambio uno contro uno avanzata
dai socialisti e sostenuta da Amintore Fanfani. "Andai dunque da Cossiga - ha
detto Signorile nel '93 - aspettando qualche novità e quali conseguenze
potessero eventualmente scaturirne. Mentre ne stavamo parlando arrivò la
telefonata del capo della Polizia che annunciò a Cossiga l'avvenuta uccisione di
Moro. Lo vidi sbiancare. Ricordo che Cossiga esclamò: "Debbo dimettermi". Io gli
dissi: "Fai bene, è un dovere morale". Sarebbe utile che le carte che parlano di
questa telefonata a Parlato, ancora segrete, e conservate all'Archivio di Stato
e presso il Senato (carte della Commissioni stragi) potessero essere rese
pubbliche per capire i tempi e i modi della comunicazione della avvenuta
esecuzione di Moro. Tra i documenti segreti a 35 anni dai fatti c'è tra l'altro
un foglio manoscritto con note informative e mappe della zona di via Caetani
(dell'11 maggio), una lettera del primo distretto di polizia, sempre dell'11
maggio, e un "appunto informale su una telefonata ricevuta dal capo della
polizia" (del 12 maggio). Incrociando gli elementi s'intuisce che quei documenti
possono dirci qualcosa su tempi e modi dell'annuncio allo Stato della morte di
Aldo Moro.
Aldo Moro, Vitantonio Raso:
"In via Caetani noi artificieri siamo arrivati due ore prima della telefonata
delle Br",
scrive "L'Ansa" il 29/06/2013. Non sono mai stati interrogati e se ne lamentano
perché hanno molto da raccontare gli antisabotatori che per primi arrivarono
all'R4 rossa, con il corpo di Moro nel bagagliaio, in via Caetani, il 9 di
maggio di 35 anni fa. Uno di loro, Vitantonio Raso, ha scritto un libro, "La
bomba Umana", nel quale dà dettagli che modificano la storia per come finora
nota. Lui ed il suo collega Giovanni Circhetta - sentiti dall'Ansa e dal sito
vuotoaperdere.org - spostano l'ora del ritrovamento dell'auto e del cadavere
dello statista a prima delle 11, mentre era delle 12.30 la famosa telefonata
delle Br che annunciava l'uccisione di Moro ed il luogo dove trovarne il corpo.
Alle 11, infatti, gli artificieri arrivarono in via Caetani per controllare che
l'R4 non fosse una trappola esplosiva. Fu Raso il primo ad entrare nella
macchina ed a trovare sotto la coperta il corpo di Moro. Poco dopo arrivò anche
Francesco Cossiga, che finora si sapeva essere giunto in via Caetani solo poco
prima delle 14 e quando Raso, sceso dalla macchina, comunicò che dentro il
bagagliaio c'era Moro, non vi fu alcuna reazione da parte Cossiga e da chi lo
circondava. "Sembrava che sapessero già tutto", dice Raso. Dal Maresciallo
Giovanni Circhetta l'altra novità: sul sedile anteriore della R4 c'era una
lettera. Circhetta è sicuro e si chiede che fine abbia fatto. In un suo recente
libro ("La bomba umana") Raso aveva lasciato indeterminata la questione degli
orari che ora chiarisce dopo 35 anni. La questione è rilevante perchè la
telefonata delle Br (Morucci e Faranda) che avvertiva dell'uomo chiuso nel
bagagliaio della macchina è delle 12.13. Non solo: Francesco Cossiga e un certo
numero di alti funzionari assistettero, ben prima delle famose riprese di Gbr
che sono state girate a cavallo delle 14, alla prima identificazione del corpo
fatta proprio da Raso. Cossiga si recò quindi due volte in via Caetani. La R4 fu
ripetutamente aperta dai due sportelli laterali come testimoniano le foto a
corredo di questa inchiesta. "Quando dissi a Cossiga, tremando, che in quella
macchina c'era il cadavere di Aldo Moro, Cossiga e i suoi non mi apparvero nè
depressi, nè sorpresi come se sapessero o fossero già a conoscenza di tutto",
dice Raso. "Ricordo bene che il sangue sulle ferite di Moro era fresco. Più
fresco di quello che vidi sui corpi in Via Fani, dove giunsi mezz'ora dopo la
sparatoria". Raso fornisce la prova che le cose il 9 di maggio non andarono come
finora si è raccontato: "Sono ben consapevole. La telefonata delle Br delle
12.13 fu assolutamente inutile. Moro era in via Caetani da almeno due ore quando
questa arrivò. Chi doveva sapere, sapeva. Ne parlo oggi per la prima volta, dopo
averne accennato nel libro, perchè spero sempre che le mie parole possano
servire a fare un pò di luce su una vicenda che per me rappresenta ancora un
forte shock. Con la quale ancora non so convivere". Raso non è mai stato
interrogato.
Aldo Moro, Antonio
Cornacchia: "Sono giunto in Via Caetani alle 13,20. Gli artificieri sono
arrivati dopo",
scrive Andrea Purgatori su "L'Huffington Post" il 30/06/2013. “Me lo ricordo
perfettamente quel 9 maggio del 1978. Quando mi dissero di andare in via Caetani
erano le 13,20. La voce via radio era del colonnello Gerardo Di Donno, che
comandava la sala operativa. Io ero in piazza Ippolito Nievo. Non sapevo dove
fosse via Caetani. Ci pensò il mio autista, Di Francesco. Quando arrivammo, non
c’era nessuno. Vidi la Renault rossa parcheggiata e bloccai la strada chiedendo
a Di Donno due auto di rinforzo che piazzai all’angolo con via delle Botteghe
Oscure e in fondo, verso via dei Funari. La Renault era chiusa. Da fuori non si
vedeva niente. Per me poteva anche esserci una bomba, quindi dissi agli
artificieri di aprire prima di tutto il cofano. Poi tirai fuori dalla mia auto
un piede di porco. Lo so che non avrei dovuto avere quell’arnese ma a via
Gradoli, quando scoppiò quel casino del covo delle Brigate Rosse su cui ci
attaccarono da tutte le parti, ci avevo aperto tutte le porte chiuse. E ci aprii
anche il portabagagli della Renault…”. Il generale Antonio Cornacchia ha un’età,
81 anni. E un passato di successi e di guai, dall’arresto di Renato Vallanzasca
alla tessera numero 871 della P2 di Licio Gelli. Nel 1978 comandava il Nucleo
investigativo dei carabinieri. Secondo i due artificieri che oggi sostengono di
essere giunti in via Caetani un’ora prima della telefonata con cui il brigatista
Valerio Morucci comunicava al professor Francesco Tritto l’avvenuta esecuzione
di Aldo Moro e il luogo in cui la famiglia avrebbe trovato il suo corpo,
Cornacchia arrivò con Francesco Cossiga e col capo dell’ufficio politico
Domenico Spinella. “Ma lasciamo stare queste storie…”, sbuffa Cornacchia. Che
però aggiunge: “Se quelli erano già stati lì prima di me, non lo so. Ma quando
sono arrivato io, la Renault era chiusa e non c’era ancora nessuno. Su questo
non ci piove”.
- Siamo al piede di porco…
“Eh, già. A un certo punto
presi il coraggio a due mani e decisi di aprire quel portabagagli col piede di
porco. Altro che artificieri, il cadavere di Moro lo vidi per primo io. Era
raggomitolato. Sul pianale vidi anche cinque teste di proiettile che gli avevano
trapassato il corpo fermandosi sulla lamiera”.
- C’erano tracce di sangue?
“Per quello che vidi, no. Poi
seppi che era morto per una emorragia interna. E contrariamente a quello che
hanno raccontato i brigatisti, non fu Gallinari ad ucciderlo con la mitraglietta
Skorpion. Fu Moretti. Sparò il primo colpo con una Walter PPK, poi la pistola si
inceppò e la mano gli cominciò a tremare. Allora Maccari prese la Skorpion e
sparò una raffica di dieci colpi. Ma Moro era già nel portabagagli, perché sul
pianale sono rimaste le impronte delle ogive”.
- E gli artificieri?
“Si occuparono del cofano
anteriore. Intanto era arrivata un sacco di gente. Giornalisti, ma non solo.
Vennero anche Giancarlo Pajetta e Miriam Mafai, me li ricordo. Ma a quel punto
io andai ad interrogare quelli che stavano in via Caetani”.
- Cosa venne fuori dalle
testimonianze?
“C’era una signora bionda, di
mezza età, che lavorava alla biblioteca di Stato. Mi disse che era uscita alle
otto e dieci di mattina per andare a prendere un caffè e aveva notato la Renault
rossa, perché di solito in quel posto parcheggiava un suo collega”.
- Quindi la Renault alle otto
di mattina era già in via Caetani.
“Esatto”.
- Ma non potrebbe giurare che
gli artificieri fossero già stati lì due ora prima del suo arrivo.
“Io dico quello che so e che
ricordo. Ho avuto la segnalazione via radio alle 13,20, sono arrivato verso
l’una e mezza e il portabagagli della Renault l’ho aperto io, col mio piede di
porco. Io e il mio autista sono stati i primi, gli artificieri sono arrivati
dopo”.
Vitantonio Raso: "Ero in via
Caetani, da Aldo Moro, un'ora prima della telefonata delle Br. C'era Francesco
Cossiga", scrive "L'Ansa" il 29/06/2013. Vito Antonio Raso proprio in via
Caetani, a 35 anni di distanza. Ha da poco pubblicato un libro di memorie (“La
bomba umana” ed. Seneca) nel quale ripercorre tutta la sua vita, a partire
dall'infanzia trascorsa in un tranquillo paesino del salernitano per giungere
alle sue missioni di artificiere durante le quali ha convissuto con il pericolo
rischiando, più di una volta, la vita.
Dopo l’uscita del tuo libro
hai rilasciato molte interviste. Ma quello che stai per aggiungere oggi è una
novità importante ai fini della comprensione di cosa sia successo quella mattina
in via Caetani…
«E’
vero. Ma voglio precisare che con il mio racconto non intendo accusare nessuno e
non mi spinge nessun desiderio di rivalsa o di protagonismo. Sono stato un
servitore dello Stato per tanti anni e rifarei tutto ciò che ho fatto, con la
stessa abnegazione e con lo stesso spirito di sacrificio. Intendo solo
aggiungere alcuni particolari che, dopo aver studiato meglio la vicenda, ritengo
possano essere utili».
Non ti sei mai documentato
sul caso Moro?
«No.
Ed è stata una mia precisa scelta. Non sono mai più ripassato nemmeno da via
Caetani nonostante sia stato a Roma sino al 2008. Oggi ho accettato il vostro
invito per l’importanza di ciò che voglio aggiungere. Ma posso assicurarvi che
per me è una enorme sofferenza».
Vito, cominciamo da quei 55
giorni…
«Ero
già intervenuto la mattina del 16 marzo in via Fani. Mi chiamarono perché
qualche testimone aveva raccontato che gli assalitori prima di fuggire avevano
gettato nelle macchine coinvolte nell’agguato degli oggetti. Si temeva che
potessero essere ordigni. Da allora, il Ministro Cossiga, pretese che fosse
richiesta la presenza di un artificiere in ogni occasione ci si fosse trovati di
fronte a materiale proveniente dalle BR. Ed in effetti intervenni anche in più
occasioni in via Licinio Calvo (dove furono rinvenute in tre momenti diverse le
auto utilizzate dai brigatisti per la fuga, nda), in via Gradoli ed, infine, in
via Caetani. Me ne occupai sempre io per il semplice motivo che in via Fani
avevo lasciato le mie impronte…»
Che ricordo ne porti
dentro?
«Come
accennavo prima, anche se sono passati tanti anni, quando torna questo periodo
per me è sempre un trauma. E’ un rivivere lo choc ed il dispiacere di aver visto
morire dei colleghi e di un’ulteriore morte che non credevo mai si fosse si
sarebbe consumata».
Il 9 maggio mattina eri in
ufficio quando…
«Da
premettere che io lavoravo in borghese mentre quella mattina mi ero recato in
ufficio in divisa perché alle 11 mi sarei dovuto recare a colloquio dal mio
superiore nel COMMILITER, il Gen. Santovito, che aveva chiesto di parlarmi».
Il Gen. Santovito era,
all’epoca, anche a capo del neocostituito SISMI. E di cosa avrebbe dovuto
parlarti?
«Dato
gli eventi che si susseguirono l’appuntamento fu annullato ed io non ho più
saputo quale fosse l’argomento oggetto della sua richiesta di colloquio. Sta di
fatto che io a quell’appuntamento non potetti andare».
Come si evolsero gli
eventi?
«Ero
in attesa di essere accompagnato in Piazza Ungheria (sede del COMMILITER) quando
in ufficio si presentarono i “ragazzi” della volante 23 della Polizia, che
conoscevo benissimo e che di solito mi passavano a prendere per portarmi sui
luoghi ove era necessario il mio intervento di artificiere».
Quindi prima delle 11?
«Sicuramente.
Quanto prima?
«A
distanza di anni è difficile ricordare un orario preciso, ma credo tra le 10.30
e le 10.45».
E ti portarono in via
Caetani…
«Questo
lo seppi solo al mio arrivo. Quando salii in macchina mi resi subito conto che
la situazione era strana. In genere il capo equipaggio dell’auto che mi veniva a
prelevare, mi dava le prime indicazioni sull’intervento che mi era richiesto.
Insomma le classiche informazioni che a me servivano per iniziare a prepararmi.
Quella mattina, però, non fu così. Nessuno apriva bocca e allora iniziai a fare
domande: “Dove andiamo? Di che tipo di segnalazione si tratta?”. Ma le risposte
erano vaghe tanto da farmi irritare e quasi prendermela con quei ragazzi che poi
non c’entravano nulla. “Andiamo in centro… Ci hanno detto di portarti li…”»
Quanto tempo impiegaste per
arrivare a destinazione?
«Non
molto. Da Piazza San Giovanni in Laterano saranno 5-6 Km, non di più.
Considerando che in genere procedevamo ad andatura elevata (e questo mi ha
comportato anche 4 incidenti durante il servizio) potremmo averci impiegato un
quarto d’ora venti minuti. Arrivammo su via delle Botteghe Oscure e ci fermammo
all’imbocco di via Caetani. La situazione era tranquilla: non c’erano
transennamenti o un blocco del traffico che facessero pensare ad un pericolo
bomba. Il capo equipaggio mi fece scendere e mi indicò di avviarmi nella
stradina dove mi stava aspettando un funzionario di Polizia che mi avrebbe dato
le indicazioni del caso».
Chi era?
«Mi
si fece incontro un uomo che si presentò con un “Salve, sono il Commissario
Federico Vito. Vito è il cognome…”. Al che a me venne spontaneo ricambiare la
battuta con “Piacere. Vito Raso. Vito è il nome”».
Quindi il commissario
Federico Vito era già in via Caetani nei pressi della R4. Da quanto tempo era
li?
«Questo
non lo so, non gliel’ho chiesto. Di sicuro prima di me, da un bel po’ visto che
il capo pattuglia della volante 23 ne era al corrente».
C’era qualcun altro assieme
a lui?
«Lui
era solo, di questo sono sicuro. E la strada era deserta, non c’era gente
attorno alla Renault».
Attorno alle 11.15, quindi,
incontrasti il Commissario Vito? Cosa ti disse?
«Anche
lui fu molto vago. Mi disse che c’era da controllare la R4 perché era stata
ricevuta una telefonata anonima e si riteneva che dentro potesse esserci una
bomba. Al che io mi misi subito ad analizzare dall’esterno la vettura, facendo
un giro di ispezione attorno all’auto e scrutando anche attraverso i finestrini.
Nella parte anteriore notai subito qualcosa che rendeva pericolosa l’auto: oltre
a della sabbia nera, dei bossoli esplosi erano posti sul tappetino anteriore sia
dal lato guidatore che passeggero. Questa cosa mi allarmò e quindi usai molta
accortezza nell’avvicinarmi. Dato che era un’auto che conoscevo molto bene
iniziai a studiare una strategia per riuscire ad entrarvi con il minimo rischio.
Mentre ero li che, sempre sotto il controllo del funzionario di Polizia, giravo
attorno alla macchina si avvicinò una ragazza vestita in un modo che definirei
“alternativo” che mi chiese a bruciapelo: “E’ vero che in quella macchina c’è il
cadavere di Aldo Moro?”. Cercai di mantenere la calma per evitare di mandarla a
quel paese anche perché, conoscendo bene il bagagliaio e sapendo che Moro era di
statura non certo piccola, non avrei mai pensato che sarebbe potuto entrare in
quel piccolo spazio. Ma tant’è».
Una ragazza…Saresti in
grado di riconoscerla?
«Ritengo
di sì. Era alta, magra, capelli scuri. Ricordo che comparve all’improvviso in
strada e pochi secondi prima avevo udito il rumore di un portone che sbatteva.
Come se fosse uscita da un palazzo all’inizio di via Caetani (lato Botteghe
Oscure nda)».
L’Unità, un paio di giorni
dopo il 9 maggio, parlò di un testimone che aveva visto, verso le 8 del mattino,
parcheggiare la R4 da un uomo ed una donna. L’uomo basso e tarchiato, la donna
magra e slanciata. Potrebbe trattarsi della stessa ragazza?
«E
chi può dirlo questo…»
Quindi la ragazza si
allontanò e tu iniziasti ad entrare nella macchina.
«Non
subito. Mentre ero lì che guardavo l’auto dubbioso, vidi avvicinarsi un
gruppetto di persone che da via delle Botteghe Oscure si dirigevano verso
l’auto. Li riconobbi subito ed era evidente fossero interessati anche loro alla
Renault».
Di chi si trattava?
«Riconobbi
il capo della Digos romana Domenico Spinella, il comandante del nucleo
investigativo dei Carabinieri Colonnello Cornacchia, ed il Ministro Cossiga».
Mi rendo conto che è
passato molto tempo, ma sarebbe importante collocare questo incontro
temporalmente…
«Non
era passato molto tempo da quando ero arrivato sul luogo, una decina di minuti».
Quindi erano passate da
poco le 11.30...
«Si,
più o meno. E ricordo due particolari che ho ancora impressi nella mente. Il
Colonnello Cornacchia mi rimproverò con un “Lei che è un militare, non si
vergogna ad andare in giro così?” alludendo ai miei capelli che non erano
proprio cortissimi. Avrei voluto rispondergli che venivo da due mesi in cui
avevo dormito poco, fatto gli straordinari e rischiato la vita ogni giorno, ma
lasciai stare. Il Ministro Cossiga, invece, mi chiese a bruciapelo: “Raso, che
ne pensa di questa macchina?” Io lo guardai e con aria preoccupata risposi:
“Ministro, si tratta di un’auto molto pericolosa. Ho notato al suo interno dei
bossoli. E’ necessario lavorarci con molta attenzione ma alla svelta.” “Bene –
mi rispose – Mi tenga informato.”. E nel dire questo si riallontanò assieme alle
persone con le quali era arrivato dando ordine di far transennare la via da
entrambe le direzioni per non far avvicinare nessuno, come da procedura».
Un momento Vito. Stai
dicendo che quella mattina tu hai visto il Ministro Cossiga in via Caetani molto
prima delle immagini ufficiali che sono collocate ben oltre le 13.30 e che
mostrano i vari politici accorsi dopo la notizia data dalle agenzie quando, tra
l’altro, la strada era già affollata e transennata?
«Assolutamente
sì. Io vidi il Ministro Cossiga due volte. Poco dopo il mio arrivo in via
Caetani e poi dopo un’ora e mezza due, quando terminai il mio lavoro di
ispezione dentro la macchina».
Cossiga va via assieme agli
altri personaggi che lo accompagnavano e tu inizi il tuo lavoro…
«Per
prima cosa mi pongo il problema di come entrare in auto. Con molta attenzione
forzo il finestrino anteriore sinistro e sblocco la serratura. Inizio
l’ispezione dell’auto che, per fortuna, conoscevo molto bene in quanto mio padre
possedeva proprio una R4 e con essa feci le prime esperienze di guida. Sempre
muovendomi con molta cautela, controllai i tappetini anteriori, il cruscotto,
frugai sotto i sedili alla ricerca di qualche elemento che mi desse conferma
della presenza di un ordigno a bordo. L’operazione durò molto tempo in quanto
ogni movimento era studiato ed effettuato con la massima delicatezza. Dopo aver
terminato di controllare la parte anteriore della macchina, sempre dall’interno,
mi spostai sul sedile posteriore e, dopo una breve ispezione, la mia attenzione
fu catturata dal vano bagagli che, nella R4, è un tutt’uno con l’abitacolo».
Cosa notasti?
«Mi
resi conto che c’era una coperta che copriva qualcosa, e lì la mia
preoccupazione salì. Essendo sconsigliato spostare la coperta perché poteva
essere collegata ad un ordigno a strappo, provai a metterci una mano sotto.
Toccai qualcosa, una “peluria” che in un primo momento attribuii al pelo di un
cane. Non capivo, ero disorientato. Poi notai che, appoggiato sulla coperta,
c’era un borsello e lo presi. Non fidandomi troppo, con un taglierino troncai la
cinghia che lo teneva chiuso e, oltre ad un orologio ed una catenina, trovai un
assegno di 27.000 lire dell’allora Banco di S. Spirito intestato ad Aldo Moro.
Fu in quel momento che capii che sotto quella coperta c’era il Presidente della
DC».
Pensasti allora che la
ragazza aveva ragione?
«No,
non subito. Sia perché ero convinto che le Brigate Rosse avrebbero rilasciato il
loro prigioniero vivo sia perché non lo riconobbi subito. Aveva un volto più
magro di quello che ero abituato a vedere in TV, quella barba piuttosto folta,
la posizione rannicchiata, quasi fetale. Dopo qualche secondo notai
l’inconfondibile segno che identificava Moro e cioè la ciocca di capelli bianca,
la sua caratteristica “frezza”. Era immobile ed il mio primo pensiero fu che lo
avevano narcotizzato. Poi notai tre cose: molta sabbia nera, delle ampie macchie
di sangue fresco sul petto in corrispondenza di fori di arma da fuoco e un
fazzoletto di carta sotto al bavero della giacca posto come a voler tamponare le
ferite. Fu la vista di quel sangue a darmi la certezza che in quell’auto le
Brigate Rosse ci avevano riconsegnato il cadavere di Aldo Moro».
Che ora si era fatta?
«Non
so collocare i singoli momenti nel tempo. In auto ero stato un’ora, un’ora e
mezza. Dopo aver fatto la scoperta, mi appoggiai al sedile posteriore e rimasi
qualche minuto ad osservare il volto di Moro, da solo con i miei pensieri. Fu
anche un modo per scaricare la tensione che si era accumulata. E fu allora che
notai un particolare».
Quale?
«Come
dicevo prima, il 16 marzo ero intervenuto in via Fani. Ero arrivato non troppo
tempo dopo la conclusione dell’agguato (mezz’ora massimo tre quarti d’ora) e i
cadaveri dei poveri agenti erano ancora scoperti. Mentre mi occupavo del
presunto ordigno che fu trovato ai piedi dell’autista di Moro, Appuntato Ricci,
mi sporcai del suo sangue che era ancora fresco e che colava dalle sue ferite.
Ebbene, il sangue che ebbi modo di vedere sul petto di Moro, era dello stesso
colore e fluidità di quello visto in via Fani».
Come se fosse stato
ammazzato da non più di un’ora, insomma…
«Si,
ebbi proprio quell’impressione».
A chi comunicasti la
notizia?
«Aprii
lo sportello posteriore destro ed uscii dalla macchina. Il gruppetto di
personaggi assieme a Cossiga era in fondo alla strada e io gli feci cenno di
avvicinarsi. Quando furono abbastanza vicini, parlando a voce bassa per non
farmi ascoltare da orecchie indiscrete dissi: “Ministro, dentro quell’auto c’è
il cadavere di Aldo Moro”».
Cossiga e gli altri che
reazione ebbero?
«Assolutamente
nessuna. Restarono impassibili. Nessun segno di sgomento o stupore, nè lui e
neppure gli altri funzionari che gli erano accanto. Come se già sapessero».
Come se già sapessero o
come se fossero stupiti, increduli, della notizia?
«Non
avevano l’aria di essere stupiti. Ho avuto la netta sensazione che per loro non
fosse una novità».
Dopo avergli dato la
notizia, Cossiga ti chiese altro?
«Mi
fu chiesto di controllare tutte le auto parcheggiate lì vicino prima di aprire
il portellone posteriore. Ma la mia risposta fu secca: “Non se ne parla nemmeno,
Ministro…” Ero stremato, sia per lo stress di quella mattina sia per la fatica
delle settimane precedenti. Chiesi rinforzi. E fu così che furono richiamati
altri due colleghi che stavano disinnescando un ordigno a Cassino per darmi una
mano. Finchè non giunsero anche loro, la gente fu tenuta a distanza dalla
macchina e io tirai un po’ il fiato».
Casertano e Circhetta, come
si legge nei verbali…
«Si. Casertano
si occupò delle altre auto in sosta mentre Circhetta mi aiutò ad aprire il
portellone. Infilando una lastra nella fessura del portellone, mi ero infatti
accorto che era chiuso a chiave. Utilizzando una grossa tronchese (una specie di
maxi-apriscatole) iniziai a tagliare la lamiera della R4 attorno alla serratura».
Questo è anche documentato
dalle immagini.
«Infatti.
Dopo alcuni minuti, assieme al collega riuscimmo a procurarci un varco nella
lamiera e, dopo aver controllato che nei pressi della serratura non vi fossero
fili elettrici che facessero pensare ad un congegno di innesco, aprimmo il
portellone. E’ il momento in cui la storia si svela in tutta la sua
drammaticità. Molti erano li perché si era sparsa voce di un’auto-bomba, altre
voci parlavano di Moro, ma ciascuno, in cuor suo, nutriva ancora un lume di
speranza. Poco dopo l’apertura si avvicinò un prete che poi seppi essere Don
Damiani, prete personale di Moro. Mi chiese se poteva benedire la salma e,
naturalmente, acconsentii. Essendo un credente, anche io mi raccolsi in
preghiera».
C’è un verbale del
Commissario Vito che indica il tuo intervento alle 12.30, un altro verbale dei
periti nel quale siete citati anche voi artificieri. Ma non ho trovato nessuna
relazione di servizio a tuo nome.
«Ciascuno
di noi al rientro da un intervento scriveva un resoconto dei fatti e lo
consegnava al capoufficio. Quel pomeriggio, al termine dell’intervento in via
Caetani, rientrai in ufficio e scrissi il mio resoconto. Nel consegnarlo il mio
capoufficio ebbe una reazione insolita. “Ma che cavolo hai scritto?” alludendo
al mio italiano o forse alla forma complessiva del mio scritto. Forse a causa
della stanchezza non ero stato molto chiaro, ma non mi era mai successo che un
“rapporto di servizio” mi venisse strappato in faccia».
Quindi del tuo intervento
di quella mattina non esiste traccia?
«Il
Maresciallo Circhetta era accanto a me e si propose per farne uno cumulativo
dell’intervento di tutti e tre. E così fu fatto».
E cosa c’era scritto nel
rapporto? Si parlava dei due momenti distinti di arrivo sul luogo?
«Questo
non lo so. Non l’ho mai letto. A distanza di 35 anni hai deciso di scrivere un
libro che hai intitolato “La bomba umana”. Anche se nel testo parli solo
marginalmente della mattina del 9 maggio, immagino che fossi consapevole che
qualcuno avrebbe potuto chiederti degli orari… Ho deciso di scrivere un libro di
memorie anche perché negli anni ho ascoltato di tutto. Persone che non ne
sapevano nulla (non avendo vissuto in prima persona la vicenda) ma che sentivano
il bisogno di parlare, dicendo un sacco di inesattezze. Ho voluto raccontare la
mia storia consapevole del fatto che, in questo mio racconto, ci sia un ordigno
a tempo che prima o poi esploderà. E’ un titolo, in qualche misura,
autobiografico…»
Questa tua storia
rappresenta la prova fattuale che alcune ipotesi sono fondate. Che quella
mattina lo Stato seppe molto presto (con grande anticipo sugli orari ufficiali)
che Moro era stato ucciso e che il suo cadavere era in via Caetani, che qualcuno
si occupò di controllare che la notizia non venisse divulgata e che solo nella
tarda mattinata si espose al mondo la scena del delitto. Come mai? Che idea ti
sei fatto?
«A
questa domanda non so rispondere. E’ chiaro che c’è una enorme discordanza con
quanto affermano le ricostruzioni. La telefonata delle 12.13 fu assolutamente
inutile in quanto Moro era lì da oltre due ore ed evidentemente chi doveva
saperlo ne era al corrente. Mi sono sempre detto che qualcosa non quadrava, ma
non ho mai voluto approfondire, non me ne sono mai interessato. La decisione di
scrivere il libro, forse, nasce anche dalla speranza che qualcuno riesca a dare
una risposta a questi interrogativi. Io ho raccontato quella che è la mia
testimonianza, che nessun magistrato e nessuna commissione d’inchiesta mi hanno
mai chiesto. So che a 35 anni di distanza sarà difficile ma spero lo stesso che
le mie parole possano servire a fare un po’ più di luce su una vicenda che,
ancora oggi, rappresenta per me un forte shock. Con il quale non ho ancora
imparato a convivere».
Aldo Moro, Giovanni
Circhetta: "Qualcuno aprì l'R4 prima del nostro intervento",
scrive "L'Ansa" il 29/06/2013. A Poggiardo (Le), incontriamo Giovanni Circhetta,
il Maresciallo Capo che era il superiore diretto di Vito Raso, che conferma la
versione del “suo” Sergente Maggiore ed aggiunge due particolari molto
importanti: qualcuno aprì quell’auto prima del loro intervento e in macchina
c’erano due lettere delle quali non ha mai trovato alcun riferimento nei verbali
di sequestro…
Maresciallo Circhetta, cosa
ricorda di quella mattina?
«Avevo
lasciato l’ufficio molto presto per un intervento a Nettuno. Rientrato in
ufficio seppi che il Sergente Maggiore Raso era stato portato in centro per un
intervento. Dopo pochi minuti ricevemmo una telefonata in cui ci venne chiesto
di raggiungere Raso che aveva trovato su una R4 il cadavere di Moro. Io ero il
Capo Nucleo e pensai che Raso chiese il mio aiuto perché non se la sentiva di
procedere da solo».
Quindi lei si precipitò sul
posto?
«Come
prima cosa chiamai il Col. Masciarelli per informarlo dell’importante novità
chiedendogli di rientrare in ufficio per seguire le operazioni a distanza.
Ricorda che ora poteva
essere?
«Erano
le 11.00 del mattino, l’orario lo ricordo con certezza. Minuto più minuto meno.
Portai con me l’altro Sergente, Andrea Casertano, in modo da avere qualche
braccia in più che, in simili situazioni, si sarebbe rivelata sicuramente utile».
Quando arrivaste in via
Caetani c’era già molta gente?
«Per
niente. Oltre a raso c’erano alcuni poliziotti in borghese, un commissario che
aveva uno spiccato accento sardo ed un alto ufficiale dei Carabinieri che mi
pare fosse il Col. Antonio Cornacchia. C’era anche qualche curioso, ma non
saprei dire se fossero semplici passanti o agenti dell’antiterrorismo che
osservavano la scena da lontano. La zona era stata parzialmente delimitata».
Le operazioni, a quel
punto, erano in mano sua, immagino.
«Certo.
Feci una prima analisi della situazioni e decisi che il rischio minore era
quello di agire dal portellone posteriore. L’operazione, però, non fu molto
rapida perché prima di far intervenire i due colleghi, fui costretto a parlare
con i membri delle Forze dell’Ordine per convincerli ad allontanarsi. Nel loro
interesse. Finalmente Raso e Casertano si misero all’opera e riuscirono a
tagliare il portellone con la cesoia».
E poco dopo fu aperto.
«Non
subito. Prima di agire sulla serratura, attraverso il varco, introdussi il mio
capo per osservare l’interno della macchina per capire se sul retro ci fossero
dei fili che facessero sospettare un congegno di innesco. Ma non notai nulla, se
non una coperta con qualcosa sotto che però non rimossi per evitare che fosse
collegata ad ordigni a strappo. Sapevo che sotto c’era il cadavere dell’On.
Moro, ma in quel momento avevo il dovere di interessarmi della sicurezza…»
Aperto il portellone, cosa
fa?
«Ero
piccoletto di statura e piuttosto agile e quindi mi puntellai sul bordo del
bagagliaio per sporgermi verso l’interno della macchina ed avere la certezza che
non ci fossero altri scherzetti. In quei casi si deve fare attenzione alle
guarnizioni lungo gli sportelli. Ma non c’era nulla. Sui sedili posteriori
c’erano degli oggetti (catene, triangolo) che credo siano stati spostati dal
bagagliaio per far posto. Il sedile posteriore era sganciato e leggermente
reclinato verso l’interno della vettura. Questo non era casuale in quanto quando
Moro fu fatto salire, per evitare che chiudendo il portellone questo sbattesse
contro il suo corpo, la testa sfruttava quell’ulteriore spazio facendo
allontanare dal portellone il resto del corpo».
Ha notato bossoli, o altri
particolari di interesse?
«A
dir la verità si. Ho scorto delle carte sul sedile anteriore. Sembravano proprio
delle lettere. E mi sono incuriosito in quanto in quei giorni si era parlato
delle famose lettere di Moro».
Lettere?
«Non
mi sembra una novità da poco. Può descrivercele meglio? Si vedeva,
distintamente, una busta da lettera chiusa il cui contenuto era poco spesso,
lasciava intendere fossero pochi fogli piegati similmente a come si fa per
spedire una lettera. Non vi erano segni distintivi, né scritte. Non saprei dire
se le buste fossero una o due. Ma di sicuro sopra c’era poggiato un foglietto
che ad un’osservazione più accurata si rivelò essere un assegno bancario.
Ovviamente non le toccai (come previsto dalle procedure) ma mi sono sempre
chiesto cosa contenessero. Ma è una domanda a cui non ho mai potuto dare
risposta in quanto di quelle buste, che io sappia, non si è mai saputo nulla».
Quindi lei non ha avuto
modo di vedere da vicino il cadavere dell’On. Moro?
«Si,
certo. Dopo aver ispezionato l’interno della macchina scesi dal pianale e mi
occupai della coperta. La sollevai con molta cautela e scoprii il cadavere che
riconobbi subito dalla frezza bianca (e anche perché appena arrivato, Raso mi
aveva raccontato del suo intervento). Vidi il sangue e i fori dei proiettili.
Infilai le mani sotto il corpo di Moro per verificare che non ci fossero ordigni
a pressione e mi accorsi di alcuni bossoli che erano proprio sul piano del
bagagliaio. Alle mie spalle sentivo le voci di due uomini delle Forze
dell’Ordine, uno della Polizia e uno dei Carabinieri che discutevano
animatamente su chi dovesse incaricarsi di portar via il corpo. Appena mi
allontanai dal bagagliaio per dare la possibilità ai presenti di verificare il
contenuto dell’auto ormai messa in sicurezza fui allontanato dal retro dell’auto
con un forte risucchio causato dagli uomini dei due funzionari che si stavano
spingendo a ridosso del bagagliaio (si vede nelle immagini). Proprio in quel
momento, poiché dovetti alzare la testa, mi accorsi che sull’impalcatura accanto
alla R4 c’era un fotografo che stava scattando molte foto. E pensai a come fosse
potuto arrivare fin lassù. Credo si trattasse di qualcuno della scientifica… Si.
Questo lo seppi dopo. Fatto sta che il portellone fu richiuso e fu chiamata
un’ambulanza. E mi stupì vedere che alla fine, tra i due litiganti, il terzo
gode. Perché furono i Vigili del Fuoco a trasportare Moro all’obitorio».
Terminato il vostro
intervento rientraste in ufficio. Fu fatto un verbale?
«Dopo
lo spostamento del cadavere tornammo in sede dove c’era il Col. Masciarelli al
quale, ovviamente, raccontammo della mattinata. Poiché il capo nucleo ero io,
scrissi la relazione di servizio nella quale non specificai nessun orario in
quanto si trattava di un dato di pubblico dominio. Ricordo bene le parole che
utilizzai: “Sono intervenuto in via Caetani per un’operazione antisabotaggio su
una macchina Renault 4. I due ragazzi Raso e Casertano hanno lavorato a tagliare
il portellone posteriore. Una volta ispezionata la macchina nei minimi
particolari ho trovato dentro il bagagliaio l’Onorevole Moro, morto. Firmato:
maresciallo Circhetta”».
Il primo del vostro nucleo
a giungere sul posto fu Vito Raso, che trovò sul posto un commissario di
Polizia. Possiamo sospettare che qualcuno prima di voi artificieri aprì la
macchina?
«È
un sospetto fondato. Le BR dopo aver abbandonato l’auto, hanno sicuramente
avvisato qualcuno che a sua volta ha informato la polizia. Di conseguenza un
commissario di zona si sarà recato sul posto per verificare la fondatezza della
notizia. Solo dopo averne la certezza, come era nelle procedure, hanno chiamato
noi artificieri».
Quindi non ci fu nessuna
telefonata anonima che parlava di un’auto-bomba?
«No,
di questo ne sono sicuro. Perché se così fosse stato in ufficio ne avremmo avuto
notizia».
Un funzionario ci ha
parlato di “uomo dello spadino”.
«Si,
possibilissimo. Ma lo spadino, trattandosi pur sempre di operazione di scasso,
lascia traccia nella serratura. Se la R4 è ancora disponibile basterebbe un
pennellino per fare una verifica…»
In alcune foto si vede la
R4 senza gente intorno e con gli sportelli aperti. Sono scatti effettuati in sua
presenza, cioè dopo le 11.30?
«No.
Di questo ne sono sicuro al 100% perché quando arrivai sul posto non ci fu alcun
via vai di persone che entravano ed uscivano dall’auto utilizzando lo sportello
posteriore aperto. Se così fosse stato, non ci avrei avuto alcun motivo di
perdere un’altra ora e mezza di tempo per creare un varco nella lamiera del
portellone con l’obiettivo di verificare se sotto il cadavere potesse esserci
una carica esplosiva. Avrei comodamente effettuato la verifica dal sedile
posteriore, abbassando lo schienale ed infilando le mani sotto il corpo».
Nessun magistrato l’ha mai
convocata?
«No,
anche se me lo aspettavo. E per tanti anni ho creduto che qualcuno mi chiamasse.
Poi col passare del tempo mi sono rassegnato. La cosa che mi sembra strana è che
i magistrati mi chiamavano spesso, addirittura per sentirmi dopo un sequestro di
fuochi artificiali».
È un ricordo che si porta
dentro?
«Si,
anche perché ebbi modo di avere una gratifica professionale. Il funzionario che
parlava sardo, che poi seppi essere il commissario Corrias, aveva apprezzato il
nostro intervento e aveva telefonato nei giorni successivi al Col. Seccia,
nostro superiore, di congratulazioni per il lavoro svolto con precisione e
professionalità, in una situazione così difficile».
E la sua storia non l’ha
mai raccontata?
«Ho
accennato qualcosa al mio amico Giovanni D’Aco, fotografo de “Il Messaggero”.
Lui mi seguiva sempre. Quando sapeva che ero partito per un intervento, mi
raggiungeva. Lei si chiederà come mai non l’abbia raccontata anche ad altri.
Semplicemente perché nessuno me l’ha mai chiesto».
Le rivelazioni di un
poliziotto. Sequestro Moro. "Le Br coperte dai servizi segreti italiani".
Parla Enrico Rossi, il poliziotto al quale fu tolta l’indagine Br-servizi
segreti, scrive “Il Secolo XIX il 23 marzo 2014. Due uomini dei servizi
segreti sulla moto Honda, presente in
via Fani il 16 marzo 1978 mentre le Brigate Rosse (da sole?)
rapivano Aldo Moro e
massacravano la sua scorta. Da quella moto partirono colpi
di mitraglietta contro un testimone e fu quella moto che bloccò il
traffico. La confessione post mortem di qualcuno che sapeva e le rivelazioni di
un poliziotto riaprono i dubbi su uno dei passaggi
più oscuri della storia italiana. E infatti nel racconto diEnrico
Rossi, ispettore di pubblica sicurezza in pensione, si parla anche di
prove distrutte dopo una breve indagine della magistratura romana. Rossi ha
parlato con Paolo Cucchiarelli, un giornalista dell’agenzia Ansa. «Tutto è
partito - ha spiegato - da una lettera anonima scritta dall’uomo che era sul
sellino posteriore della Honda in via Fani. Diede riscontri per arrivare
all’altro, quello che guidava la moto». Rossi, che vive a Torino spiega con
puntiglio e gentilezza sabauda che, secondo colui che inviò la lettera anonima -
che si qualificava come uno dei due sulla moto - gli agenti avevano il compito
di «proteggere le Br da disturbi di qualsiasi genere. Dipendevano dal colonnello
del Sismi Camillo
Guglielmi che era in via Fani la mattina del 16 marzo 1978».
LA LETTERA ANONIMA.
Tutta
l’inchiesta è nata da una lettera
anonima inviata al quotidiano
torinese La Stampa nell’ottobre 2009. Eccola: «Quando
riceverete questa lettera, saranno trascorsi almeno sei mesi dalla mia morte
come da mie disposizioni. Ho passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di
quanto non ho fatto e cioè raccontare la verità su certi fatti. Ora è tardi, il
cancro mi sta divorando e non voglio che mio figlio sappia. La mattina del 16
marzo ero su di una moto e operavo alle dipendenze del colonnello Guglielmi, con
me alla guida della moto un altro uomo proveniente come me da Torino; il nostro
compito era quello di proteggere le Br nella loro azione da disturbi di
qualsiasi genere. Io non credo che voi giornalisti non sappiate come veramente
andarono le cose ma nel caso fosse così, provate a parlare con chi guidava la
moto, è possibile che voglia farlo, da allora non ci siamo più parlati, anche se
ho avuto modo di incontralo ultimamente...».
LE INDAGINI.
L’anonimo
forniva elementi per rintracciare il guidatore
della Honda: il nome di una donna e di un negozio di Torino. «Tanto io
posso dire, sta a voi decidere se saperne di più». Il quotidiano all’epoca
passò alla questura la
lettera per i dovuti riscontri. A Rossi, che ha sempre lavorato nell’antiterrorismo,
la lettera arriva sul tavolo nel febbraio 2011 in modocasuale.
Non è protocollata e non sono stati fatti accertamenti, ma ci vuole poco a
identificare il presunto guidatore della Honda di via Fani che secondo un
testimone ritenuto molto credibile era a volto scoperto e aveva tratti del viso
che ricordavano Eduardo
De Filippo. «Non so bene perché ma questa
inchiesta trova subito ostacoli. Chiedo di fare riscontri ma non sono
accontentato. L’uomo su cui indago ha, regolarmente registrate, due pistole. Una
è molto particolare: una Drulov cecoslovacca; pistola da specialisti a canna
molto lunga, di precisione. Assomiglia ad una mitraglietta». «Per non lasciare
cadere tutto nel solito nulla predispongo un controllo amministrativo
nell’abitazione. L’uomo si è separato legalmente. Parlo con lui al telefono e mi
indica dove è la prima pistola, una Beretta, ma nulla mi dice della seconda.
Allora l’accertamento amministrativo diventa perquisizione e in cantina, in un
armadio, ricordo, trovammo la pistola Drulov poggiata accanto o sopra una copia
dell’edizione straordinaria cellofanata de La Repubblica del 16 marzo». Il
titolo era: «Aldo Moro rapito dalle Brigate Rosse».
I DEPISTAGGI.
«Nel frattempo - continua Rossi - erano arrivati i
carabinieri non si sa bene chiamati da chi. Consegno le due pistole e gli
oggetti sequestrati alla Digos di Cuneo. Chiedo subito di interrogare l’uomo che
all’epoca vive in Toscana. Autorizzazione negata. Chiedo di periziare le due
pistole. Negato. Ho qualche `incomprensione´ nel mio ufficio. La situazione si
`congela´ e non si fa nessun altro passo, che io sappia». «Capisco che è meglio
che me ne vada e nell’agosto del 2012 vado
in pensione a 56 anni. Tempo dopo, una `voce amica´ di cui mi fido - dice
l’ex poliziotto - m’informa che l’uomo su cui indagavo è morto dopo l’estate del
2012 e che le due armi sono state distrutte senza effettuare le perizie
balistiche che avevo consigliato di fare. Ho aspettato mesi. I fatti sono più
importanti delle persone e per questo decido di raccontare l’inchiesta
`incompiuta». Rossi ricorda, sequestrò una foto, che quell’uomo aveva un viso
allungato, simile a quello di De Filippo: «Sì, gli assomigliava». Fin qui l’ex
ispettore, che rimarca di parlare senza alcun risentimento personale ma solo
perché «quella è stata un’occasione persa. E bisogna parlare per rispetto dei
morti».
I RISCONTRI.
Il signore
su cui indagava Rossi è effettivamente morto - ha accertato l’ANSA - nel
settembre del 2012 in Toscana. Le pistole sembrerebbero essere state
effettivamente distrutte, ma il fascicolo che contiene tutta la storia dei due
presunti passeggeri della Honda è stato trasferito
da Torino a Roma dove
è tuttora aperta un’inchiesta della magistratura sul caso Moro. Per una volta
sono tutti d’accordo: magistrati e Br. La
Honda blu presente in via Fani il 16 marzo del 1978 è un mistero.
I capi brigatisti hanno sempre negato che a bordo ci fossero due loro uomini, ma
da quella moto si spararono - sicuramente - gli unici colpi verso un `civile´
presente sulla scena del rapimento, l’ingegner Alessandro
Marini, uno dei testimoni più citati dalla sentenza del primo processo
Moro. Mario Moretti e Valerio
Morucci sono stati sempre chiarissimi su quella moto blu di grossa
cilindrata: «Non è certamente roba nostra». L’ingegner Marini si
salvò solo perché cadde di lato quando una raffica partita da un
piccolo mitra fu scaricata contro di lui `ad altezza d’uomo´ proprio da uno dei
due che viaggiavano sulla moto. I proiettili frantumarono il parabrezza del suo
motorino con il quale l’ingegnere cercava di `passare´ all’incrocio tra via Fani
e via Stresa. Marini fu interrogato alle 10.15 del 16 marzo. Il conducente della
moto - disse - era un giovane di 20-22 anni, molto magro, con il viso lungo e le
guance scavate, che a Marini ricordò «l’immagine dell’attore
Edoardo De Filippo». Dietro, sulla moto blu, un uomo con il passamontagna
scuro che esplose colpi di mitra nella direzione dell’ingegnere perdendo poi il
caricatore che cadde dal piccolo mitra durante la fuga. La sera a casa Marini
arrivò la prima telefonata di minacce: “Devi
stare zitto”. Per giorni le intimidazioni continuarono. Si rafforzarono
quando tornò a testimoniare ad aprile e giugno. Poi l’ingegnere capì l’aria, si
trasferì in Svizzera per tre anni e cambiò lavoro. Il caricatore
cadde certamente dalla moto e Marini, dicono le carte, lo fece ritrovare ma
questo non sembra essere stato messo a raffronto con i tre mitra (ritrovati in
covi Br) che spararono in via Fani (ce ne è anche un quarto, mai ritrovato).
LE IPOTESI.
Di certo da
quella moto si sparò per uccidere Marini, tanto che i brigatisti sono stati
condannati in via definitiva anche per il tentato omicidio dell’ingegnere.
Marini d’altra parte confermò più volte durante i processi il suo racconto e
consegnò il parabrezza trapassato dai proiettili. A terra in via Fani rimasero
quindi anche i proiettili sparati dal piccolo mitra ma le
perizie sembrano tacere su questo particolare. Sarebbe questa l’ottava
arma usata in via Fani: 4 mitra, 2 pistole, oltre alla pistola dell’agente
Zizzi, che scortava Moro, e quella in mano all’uomo della Honda: il piccolo
mitra. Su chi fossero i due sulla Honda tante ipotesi finora: due autonomi
romani in `cerca di gloria´ (ma perché allora sparare per uccidere?); due uomini
della `ndrangheta (ma non si è andati oltre l’ipotesi); o, come ha ventilato
anche il pm
romano Antonio Marini che ha indagato a lungo sulla vicenda, uomini
dei servizi segreti o della malavita. I Br negano ma, ha detto il
magistrato, «una spiegazione deve pur esserci. Io vedo un solo motivo: che si
tratti di un argomento
inconfessabile». Uomini della malavita o dei servizi? «Allora tutto si
spiegherebbe». Certo che quella mattina a pochi passi da via Fani c’era, per sua
stessa ammissione, Camillo Guglielmi, indicato alternativamente come addestratore
di Gladio o uomo dei servizi segreti, invitato a pranzo alle 9.15
di mattina da un suo collega. E Guglielmi è proprio l’uomo dei servizi chiamato
in causa nella lettera anonima che ha dato il via a Torino agli accertamenti sui
due uomini a bordo Honda, poi trasferiti a Roma. A Guglielmi si è addebitata
anche la guida di un gruppo clandestino del Sismi incaricato di gestire il
rapimento Moro secondo un’inchiesta che è anche nell’archivio della Commissione
stragi, in Parlamento.
Gli attacchi
agli aeroporti di Roma e Vienna, 30 anni fa. Breve storia di uno degli ultimi
grandi attacchi terroristici compiuti da organizzazioni palestinesi in Europa,
il 27 dicembre 1985, scrive “Il Post”. Alle 8 e 15 del 27 dicembre 1985, due
commando palestinesi formati da sette terroristi attaccarono gli aeroporti di
Roma e Vienna con armi automatiche e granate, in quello che diventò uno degli
ultimi attacchi compiuti dal terrorismo internazionale in Italia e un punto di
svolta nel conflitto israelo-palestinese. I due commando riuscirono a uccidere
19 persone e a ferirne più di 130 prima di essere uccisi o catturati a loro
volta. I terroristi cominciarono ad agire a Roma, alle otto e un quarto in
punto, quando quattro uomini armati entrarono nella grande sala dell’aeroporto
dove centinaia di persone erano in fila per il check-in della compagnia aerea
israeliana El Al e dell’americana TWA. I quattro uomini spararono sulla folla
con armi automatiche e lanciarono alcune granate. Le guardie di sicurezza
israeliane, alcune in borghese e mischiate tra i passeggeri, risposero al fuoco.
La compagnia aerea israeliana era oggetto di attacchi da anni e oramai in tutti
gli aeroporti del mondo si era dotata di guardie di sicurezza, spesso
ex-militari o poliziotti. La sparatoria durò un minuto. Tre palestinesi furono
uccisi dalle guardie armate, mentre il quarto fu ferito e catturato dalla
polizia italiana. Mentre la sparatoria terminava a Fiumicino, altri tre uomini
iniziarono a sparare contro le persone in coda davanti agli uffici di El Al
nell’aeroporto di Vienna. Tre persone furono uccise da una granata e altre 39
rimasero ferite. I tre assalitori fuggirono in macchina, ma furono inseguiti e
fermata dalla polizia austriaca. Uno di loro rimase ucciso nello scontro a
fuoco, mentre altri due furono catturati. Durante il processo, i terroristi
catturati dissero di appartenere ad Abu Nidal, un’organizzazione palestinese che
nel 1974 si era separato da Fatah, il gruppo guidato da Yasser Arafat e la
principale delle molte fazioni che lottavano per la liberazione della Palestina.
Abu Nidal era uno dei gruppi più cruenti e, nel corso degli anni Ottanta e dei
primi anni Novanta, uccise più di 900 persone in una serie di attentanti ed
assassinii mirati, spesso nei confronti di altri palestinesi. Il doppio attacco
di Fiumicino e Vienna fu il più ambizioso degli attentati che l’organizzazione
provò a compiere in Europa e rappresentò un punto di svolta nella lotta per la
liberazione della Palestina. L’opinione pubblica europea, che fino ad allora
aveva adottato un atteggiamento cauto nei confronti del terrorismo palestinese,
reagì con durezza agli attacchi. Pochi mesi prima, nel novembre del 1985, Arafat
aveva dichiarato in un famoso discorso al Cairo che gli attacchi terroristici
contro obiettivi israeliani all’estero servivano solo a danneggiare la causa
palestinese. La reazione dell’opinione pubblica dopo gli attacchi sembrò in
parte confermare le sue parole e negli anni successivi il terrorismo palestinese
in Europa praticamente sparì. Le indagini successive e le confessioni dei
terroristi catturati indicarono che il regime siriano, guidato da Hafez al
Assad, padre dell’attuale dittatore Bashar, aveva fornito aiuto logistico e
ospitalità agli organizzatori dell’attentato. Gli Stati Uniti all’epoca
accusarono anche il regime libico di Muammar Gheddafi. I servizi segreti
tunisini dimostrarono che la Libia aveva fornito passaporti falsi ad alcuni dei
terroristi, ma giudici e investigatori europei rimasero convinti che l’appoggio
maggiore all’attacco fu fornito dai siriani. L’organizzazione Abu Nidal esiste
ancora oggi, ma la sua forza politica e militare è andata scomparendo.
Assalto a Fiumicino. Il
terrore 30 anni prima di Parigi,
scrive Luca Laviola
su “L’Ansa”, “America Oggi”, ecc. il 21-12-2015.
Doveva finire come l'11 Settembre a New York - ma 16 anni prima -, con un aereo
a schiantarsi su Tel Aviv. Invece fu la seconda strage dell'aeroporto di
Fiumicino, con modalità che ricordano quella di Parigi a novembre. Era il 27
dicembre 1985 - 30 anni fa -: un gruppo di terroristi palestinesi assaltò con
bombe a mano e kalashnikov i banchi della compagnia israeliana El Al e della
statunitense Twa, sparando sulla gente in fila o al bar. Nello scontro a fuoco
con i poliziotti e la sicurezza israeliana morirono 16 persone: 12 passeggeri, 3
terroristi e un addetto israeliano; 80 i feriti. Secondo alcune fonti, avallate
dal giudice Rosario Priore che indagò, il commando doveva prendere un aereo e
farlo precipitare su Israele. Come avrebbero poi fatto nel 2001 i kamikaze di
Osama Bin Laden in America. Ma i terroristi furono scoperti e scatenarono
l'apocalisse in aeroporto. "Sapevamo che nessuno di noi sarebbe uscito vivo", ha
detto anni fa Ibrahim Khaled, l'unico dei quattro a essere catturato. Condannato
a 30 anni, ha collaborato, chiesto perdono e di recente è tornato libero. Il
massacro dell' '85 arrivò 12 anni dopo quello del 17 dicembre 1973, sempre a
Fiumicino e da parte di arabi armati, con 34 vittime e modalità ancora più
cruente: due bombe incendiarie gettate dentro un aereo pieno fermo sulla pista.
A seguito di quella strage Aldo Moro avrebbe stretto un accordo con i gruppi
palestinesi, che si impegnavano a non compiere azioni in Italia a patto di poter
transitare per il Paese con armi ed esplosivi. Ma l'intesa segreta voluta dal
ministro degli Esteri democristiano sarebbe emersa solo molti anni dopo. Il
mandante dell'attentato dell' '85 era Abu Nidal, capo di una fazione palestinese
contraria alla linea più moderata a cui si era deciso il leader
dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) Yasser Arafat.
Condannato all'ergastolo in contumacia, Abu Nidal è stato ucciso nel 2002 a
Bagdad. Il commando arrivò a Roma un mese prima, in un periodo in cui stava
saltando il cosiddetto Lodo Moro (lo statista Dc era stato ucciso nel '78), che
aveva risparmiato per 12 anni attentati palestinesi all'Italia. In poche
settimane, un colpo di bazooka sull'ambasciata Usa, una bomba al Cafè de Paris
in via Veneto, un'altra alla compagnia British Airways. Ad ottobre il
dirottamento della nave Achille Lauro e l'uccisione di un passeggero americano
sulla sedia a rotelle, Leon Klinghoffer. E si arriva al 27 dicembre 1985. Sono
le 9.05 quando i quattro, che si trovano vicini ai check-in El Al e Twa, vengono
individuati dalla security israeliana - probabilmente corpi speciali - e scoppia
la sparatoria. Un minuto di terrore, i palestinesi mirano ai passeggeri in fila.
Tra le vittime italiani, statunitensi, messicani, greci e un algerino. Tre
terroristi vengono uccisi. Khaled, 18/enne, viene catturato. In simultanea a
Vienna un altro gruppo attacca l'aeroporto, uccide 3 persone, decine i feriti.
Due fedayn vengono presi, uno muore. L'ammiraglio Fulvio Martini, nell' '85 capo
del Sismi (intelligence militare), ha scritto che dal 10 dicembre si sapeva di
un possibile attentato in Italia. Il 19 i servizi informarono che sarebbe
avvenuto tra il 25 e il 31 dicembre a Fiumicino. Gli israeliani, scrive Martini,
misero tiratori scelti a difesa della postazione El Al. Furono loro i primi a
reagire. Le forze dell'ordine italiane erano impreparate. Nel 1992 i capi della
sicurezza di Fiumicino sono stati assolti. Il 17 dicembre '73 era andata perfino
peggio: un gruppo di terroristi arabi arrivato dalla Spagna in aereo con le armi
nei bagagli a mano gettò bombe al fosforo dentro un Boeing Pan Am sulla pista,
uccidendo 30 persone. Quindi dirottò un aereo su Atene, altri morti prima di
arrendersi in Kuwait. Un massacro quasi dimenticato. Stragi di civili, come
quelle dell'Isis oggi.
Strage di
Fiumicino, parla il fotografo che visse quei momenti in diretta.
Vergati: "Ero lì, la gente stava al bar e un attimo dopo era morta", scrive
Luca Laviola su
“L’Ansa” il 20
dicembre 2015.Il 13
novembre ha ripensato a quella strage avvenuta, trent'anni fa, a poche decine di
metri da lui. "E' una cosa incredibile, a Parigi quelle persone stavano sedute
al bar e un attimo dopo una sventagliata di mitra le ha uccise. Come il 27
dicembre dell'85 a Fiumicino". Elio Vergati aveva 46 anni e faceva il fotografo.
Lo fa ancora oggi che ne ha 76 e vanta un secondo posto al premio Pulitzer e al
World Press Photo. Sempre nella mitica agenzia Telenews che da decenni racconta
quello che accade negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino. "Ero nel
nostro ufficio e sentimmo dei botti - racconta -. Si capì subito che erano bombe
a mano e la gente scappava da tutte le parti. Ho preso la macchina fotografica e
ho fatto di corsa i 100, 150 metri di distanza dai check-in dell'El Al e della
Twa. Una sparatoria tremenda, ma sarà durata un minuto, non di più". E' la
strage di Fiumicino: 4 terroristi palestinesi tirano bombe e sparano sulla gente
in fila all'imbarco o al bancone del bar, prima che tre di loro vengano uccisi
dalla sicurezza della compagnia israeliana. "Sono intervenuti subito - ricorda
Vergati -, il quarto terrorista è stato catturato da un poliziotto italiano e ha
rischiato il linciaggio". Una foto del reporter mostra il diciottenne Khaled
Ibrahim portato via da un agente. Una delle tante esclusive scattate quel giorno
da Vergati. "C'erano tanti feriti in terra, sangue, gente che chiedeva aiuto e
si lamentava, una scena pazzesca - racconta -. Mentre scattavo le foto cercavo
di rassicurarli, che i soccorsi sarebbero arrivati. Ma ti senti impotente. I
primi feriti li hanno portati via con i carrelli dei bagagli. Ricordo una donna
con il ginocchio aperto, poi ho saputo che è morta. Tra le vittime una ragazzina
di 12 anni figlia di un giornalista americano". "Gli israeliani erano preparati,
come sempre, loro difendevano i loro voli - dice il fotografo - due agenti
italiani sono arrivati poco dopo. Dell'allarme lanciato dai servizi italiani si
è saputo in seguito". Secondo alcune fonti gli addetti alla sicurezza dell'El Al
- in realtà corpi speciali - avrebbero finito i tre palestinesi con un colpo
alla nuca e poi sarebbero subito partiti per Israele. "Non lo so. Può darsi. Non
li abbiamo più visti", dice Vergati che ricorda però che un palestinese aveva un
foro sulla nuca e un rivolo di sangue. "La cosa più incredibile è che dopo la
strage hanno chiuso l'aeroporto una mezz'ora massimo, poi è stata messa una
paratia per non far vedere quel settore e hanno ripreso a fare biglietti - dice
Vergati -. E la gente si lamentava che perdeva l'aereo". "Eravamo così vicini
alla sparatoria, abbiamo trovato dei proiettili nel vetro dell'ufficio - ricorda
-. La paura non la senti quando fai le foto, ti viene dopo, ti tremano le gambe
e pensi 'ma che so' matto?'". Quella del resto era la seconda strage a cui
Vergati assisteva in diretta al Leonardo Da Vinci. Il 17 dicembre 1973, 12 anni
prima, un commando arabo gettò bombe incendiarie dentro un aereo della Pan Am
fermo sulla pista: 30 morti bruciati. "Anche allora ero in ufficio e sentimmo le
esplosioni - racconta -. Corsi dietro un agente con il mitra e mi piazzai dietro
una colonna a fotografare. I terroristi erano a 40 metri e le pallottole
fischiavano vicine". Vergati scattò la foto di un finanziere morto sulla pista
"che arrivò seconda al Premio Pulitzer". Oggi Elio Vergati è ancora lì, lavora
all'aeroporto di Fiumicino che nei decenni è molto cambiato, ma non è cambiato
il modo in cui lui lavora. Con il suo compagno di lavoro di sempre Nevio
Mazzocco, insieme allo storico direttore Lamberto Magnoni e a un collaudato
gruppo di giornalisti sono conosciuti da tutti e conoscono tutti. Rimangono un
punto di riferimento fondamentale per Fiumicino. Oggi come allora.
27 dicembre 1985, Abu
Nidal attacca in aeroporto: 30 anni fa le stragi di Fiumicino e Vienna.
Alle 9.15 due
assalti simultanei di due gruppi armati palestinesi seminarono il terrore negli
scali di Roma e della capitale austriaca: 17 vittime in Italia, 3 allo
Schwechat, scrive di Antonio
Ferrari su “Il Corriere della Sera” del 27 dicembre 2015. Fu una mattina di
terrore in due aeroporti internazionali, Fiumicino e Vienna, quella del 27
dicembre 1985. Esattamente trent’anni fa, il gruppo che allora era il più
estremista della galassia palestinese, guidato da Sabri el Banna detto Abu
Nidal, decise di compiere con perfetta sincronia due simultanei e sanguinosi
attentati, anche se all’epoca non esistevano il web e i cellulari. Bisognava
fidarsi degli orologi da polso. Abu Nidal, che lo stesso presidente dell’Olp
Yasser Arafat aveva condannato a morte per i suoi crimini, si opponeva a
qualsiasi alito di trattativa, a qualunque cenno di disgelo con gli odiati
israeliani, con gli americani e i loro alleati europei. Alle 9 e 15 minuti,
secondo più o meno, di quel mattino due commando entrarono in azione negli scali
delle due capitali con un unico obiettivo: uccidere il maggior numero possibile
di persone. Quelle assiepate davanti ai banchi per l’imbarco in vista del
Capodanno, o magari al bar per un caffè: famiglie serene, bambini sorridenti con
i giocattoli ricevuti in dono a Natale, immigrati che tornavano a casa. Quattro
terroristi, con i mitra nascosti sotto i giubbotti, presero posizione a
Fiumicino, controllando da una ventina di metri di distanza i banchi della
compagnia di bandiera israeliana El Al, e quelli dell’adiacente compagnia
americana TWA (ndr. Uno degli attentatori, l’unico sopravvissuto, condannato e
incarcerato in Italia, poi si pentì: leggi l’intervista sul Corriere del 2008
sfiorando l’icona blu). Altri tre fecero altrettanto in Austria, nello scalo
Schwechat di Vienna. In pochi attimi, l’inferno, e due stragi: 17 morti a
Fiumicino, compresi gli attentatori, e 3 morti a Vienna. Doveva finire come l’11
Settembre a New York - ma 16 anni prima - con un aereo a schiantarsi su Tel
Aviv. Invece fu la seconda strage dell’aeroporto di Fiumicino, con modalità che
ricordano quella di Parigi a novembre. Era il 27 dicembre 1985 - 30 anni fa -:
un gruppo di terroristi palestinesi assaltò con bombe a mano e kalashnikov i
banchi della compagnia israeliana El Al e della statunitense Twa, sparando sulla
gente in fila o al bar. Nello scontro a fuoco con i poliziotti e la sicurezza
israeliana morirono 17 persone: 12 passeggeri, 3 terroristi e un addetto
israeliano; 80 i feriti. Secondo alcune fonti, avallate dal giudice Rosario
Priore che indagò, il commando doveva prendere un aereo e farlo precipitare su
Israele. Come avrebbero poi fatto nel 2001 i kamikaze di Osama Bin Laden in
America. Ma i terroristi furono scoperti e scatenarono l’apocalisse. Mentre is
spara a Fiumicino, altri complici compiono lo stesso massacro all’aeroporto di
Vienna. ll massacro dell’’85 arrivò 12 anni dopo quello del 17 dicembre 1973,
sempre a Fiumicino e da parte di arabi armati, con 34 vittime e modalità ancora
più cruente: due bombe incendiarie gettate dentro un aereo pieno fermo sulla
pista. A seguito di quella strage Aldo Moro avrebbe stretto un accordo con i
gruppi palestinesi, che si impegnavano a non compiere azioni in Italia a patto
di poter transitare per il Paese con armi ed esplosivi. Ma l’intesa segreta
voluta dal ministro degli Esteri democristiano sarebbe emersa solo molti anni
dopo. Il mandante dell’attentato dell’’85 era Abu Nidal, capo di una fazione
palestinese contraria alla linea più moderata a cui si era deciso il leader
dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) Yasser Arafat.
Condannato all’ergastolo in contumacia, Abu Nidal è stato ucciso nel 2002 a
Bagdad. Il commando arrivò a Roma un mese prima, in un periodo in cui stava
saltando il cosiddetto Lodo Moro (lo statista Dc era stato ucciso nel ‘78), che
aveva risparmiato per 12 anni attentati palestinesi all’Italia. In poche
settimane, un colpo di bazooka sull’ambasciata Usa, una bomba al Cafè de Paris
in via Veneto, un’altra alla compagnia British Airways. Ad ottobre il
dirottamento della nave Achille Lauro e l’uccisione di un passeggero americano
sulla sedia a rotelle, Leon Klinghoffer (Ansa) E si arriva al 27 dicembre 1985.
Sono le 9.05 quando i quattro, che si trovano vicini ai check-in El Al e Twa,
vengono individuati dalla security israeliana - probabilmente corpi speciali - e
scoppia la sparatoria. Un minuto di terrore, i palestinesi mirano ai passeggeri
in fila. Tra le vittime italiani, statunitensi, messicani, greci e un algerino.
Tre terroristi vengono uccisi. Khaled, 18/enne, viene catturato. In simultanea a
Vienna un altro gruppo attacca l’aeroporto, uccide 3 persone, decine i feriti.
Due fedayn vengono presi, uno muore. L’ammiraglio Fulvio Martini, nell’’85 capo
del Sismi (intelligence militare), ha scritto che dal 10 dicembre si sapeva di
un possibile attentato in Italia. Il 19 i servizi informarono che sarebbe
avvenuto tra il 25 e il 31 dicembre a Fiumicino. Gli israeliani, scrive Martini,
misero tiratori scelti a difesa della postazione El Al. Furono loro i primi a
reagire. Le forze dell’ordine italiane erano impreparate. Nel 1992 i capi della
sicurezza di Fiumicino sono stati assolti. Il 17 dicembre ‘73 era andata perfino
peggio: un gruppo di terroristi arabi arrivato dalla Spagna in aereo con le armi
nei bagagli a mano gettò bombe al fosforo dentro un Boeing Pan Am sulla pista,
uccidendo 30 persone. Quindi dirottò un aereo su Atene, altri morti prima di
arrendersi in Kuwait. Un massacro quasi dimenticato. Stragi di civili, come
quelle dell’Isis oggi. Fu una fine d’anno di orrore e di angoscia. L’attrice
Sandra Milo, che stava per imbarcarsi, si gettò a terra e riuscì a salvarsi. I
giornali raccontarono le storie delle vittime e dei familiari sopravvissuti.
Come si sarebbe scoperto in seguito, la strage di Fiumicino poteva forse essere
scongiurata. Infatti i servizi segreti italiani avevano ricevuto, da un Paese
arabo amico, l’informazione (risultata attendibilissima) che vi sarebbe stato un
attentato nello scalo aereo romano tra il Natale e il San Silvestro di
quell’anno. Fu avvisata anche la sicurezza israeliana, che da sempre controlla e
vigila sulle partenze dei propri aerei, e i tiratori scelti si piazzarono in
posizione strategica. Riuscirono a colpire e a uccidere tre degli attentatori,
limitando il numero delle vittime (ndr. Oltre 50 i feriti, nella foto Ansa, qui
sotto, uno dei passeggeri colpiti davanti al banco delle linee aeree
israeliane). Ma, come affermarono i vertici del Sismi, la nostra intelligence
militare, qualcosa non funzionò. Eppure vi erano tante ragioni per ritenere che
vi fosse un’allerta da codice rosso. Il primo ottobre di quell’anno, gli
israeliani avevano bombardato il quartier generale dell’Olp a Tunisi, dove
vivevano in esilio, dopo la partenza coatta dal Libano, Yasser Arafat e i suoi
fedelissimi. Fu una strage, ma il leader palestinese si salvò grazie a un
provvidenziale avvertimento. Allora, infatti, gli americani avevano imposto un
limite al loro alleato israeliano: che non si uccidessero i leader. Sei giorni
dopo — il 7 ottobre 1985 — era cominciata l’odissea, finita in dramma, della
nave italiana «Achille Lauro», in balia di due estremisti palestinesi del gruppo
di Abu Abbas. Ci fu l’assassinio dell’ebreo americano disabile Leon Klinghofer,
e la vicenda di Sigonella, con il muro contro muro tra i nostri soldati e i
marines, e la decisione del presidente del consiglio Bettino Craxi di sfidare
apertamente il presidente-Usa Ronald Reagan. Alla fine, tutto si ricompose tra i
due alleati. Non certo nel mondo palestinese, dove Arafat stava cercando di
trovare la strada per intavolare una trattativa con il suo storico nemico:
Israele. E’ chiaro che la strage di Fiumicino fu un attacco diretto anche ad
Arafat da parte degli estremisti palestinesi, che avevano trovato rifugio
nell’accogliente Siria di Hafez el Assad, padre di Bashar. A Damasco vi era
persino un pubblico ufficio del gruppo di Abu Nidal, guidato dal suo vice e
portavoce Walid Khaled. Appena arrivato a Damasco, all’inizio di quel gelido
1986, andai subito a cercare Khaled, per chiedergli ragione di quei massacri. Il
giovane guerrigliero, che si vantava delle imprese terroristiche della sua
organizzazione, fu gentile e insieme sprezzante. In realtà, noi italiani in
Siria avevamo nel Paese canali privilegiati. Assad padre aveva stima
incondizionata per il presidente Giulio Andreotti, e il suo ministro degli
esteri Farouk al Shara non mancava mai di ricordare i bei tempi in cui aveva
servito come ambasciatore a Roma. I giornalisti americani che riuscivano ad
ottenere il visto per la Siria faticavano non poco a ottenere interviste e
notizie interessanti dalle fonti locali. Un giorno incontrai la collega Elaine
Sciolino, una delle firme più prestigiose del New York Times. Bravissima, colta,
notevole grinta e grande coraggio. Dopo avermi ricordato l’origine italiana del
suo cognome, mi chiese la cortesia di aiutarla ad incontrare, in mia compagnia,
Walid Khaled. Organizzammo l’intervista, che si concluse in maniera quasi
drammatica. Elaine, sensibilissima, domandò, cercando invano di trattenere le
lacrime: «Ma come potete ammazzare donne, bambini, persone che non vi hanno
fatto nulla. Non ascoltate mai la voce della vostra coscienza?». L’uomo di Abu
Nidal, per nulla turbato, rispose gelidamente: «Per colpire il cuore bisogna
tagliare le vene».
30 anni dalla strage di
Fiumicino: quando il terrorismo palestinese colpì l’Italia,
scrive Simone Cosimelli il 27 dicembre 2015. La storia dell’Italia del
dopoguerra è costituita da un vortice di avvenimenti strazianti e convulsi,
frutto delle spinte politiche e sociali che dagli anni successivi all’Assemblea
Costituente – con le sue speranze e le sue illusioni – culminarono nello
scandalo dell’inchiesta Mani
Pulite del 1992, che di fatto segnò il limite di un epoca (la così
detta Prima
Repubblica) per aprirne una nuova, non meno discutibile. Il ricordo
di quel periodo, carico di circostanze oscure e casi irrisolti, è eredità e
condanna di tutti. Ma non solo vicende interne hanno plasmato il Paese, e spesso
è il tempo ad offrire l’occasione per volgere lo sguardo indietro: esattamente
30 anni fa in due attacchi terroristici di matrice palestinese, uno
all’aeroporto di Fiumicino e l’altro a Vienna,
morirono 16 persone e
oltre 100 rimasero ferite. Il 1985 era stato un anno difficile. Il
dirottamento della nave da crociera italiana
Achille Lauro (con
oltre 500 persone a bordo) da parte di un commando di palestinesi pronti ad un
azione offensiva sulle coste Israeliane, e la conseguente crisi di Sigonella, in
cui l’allora capo del Governo Bettino
Craxi si oppose al Presidente statunitense Ronald Reagan, avevano
intorpidito la situazione internazionale. Craxi andò fino in fondo e non
trattenne l’emissario di Arafat (Presidente dell’OLP) Abu
Abbas, a sua volta leader del gruppo paramilitare FLP (Fronte per la
Liberazione della Palestina) e presunto promotore del tentato attacco, in cui un
cittadino americano invalido, Leon Klinghoffer, perse la vita dopo essere stato
gettato in mare. Abu Abbas lasciò indenne l’Italia, ma fu subito giudicato
colpevole grazie alle prove schiaccianti addotte dalla Cia e condannato
all’ergastolo in contumacia. L’Italia non fece in tempo ad attenuare le tensioni
sorte con gli USA, che, nonostante l’atteggiamento comprensivo mostrato nella
vicenda verso i palestinesi, fu
duramente colpita due mesi più tardi: e questa volta, al Leonardo da
Vinci di Roma, si dovettero contare i morti. Alle nove del mattino del 27
dicembre quattro uomini entrano nell’atrio dell’aeroporto e si posizionano di
fronte ai banchi accettazione delle compagnie aeree El
Al e Twa (l’una
israeliana e l’altra americana). Armati di kalashnikov cominciano a lanciare
bombe a mano e a sparare sulla folla davanti ai banchi del check-in e nel bar
vicino. Gli agenti della sicurezza israeliani e le forze dell’ordine italiane
rispondono al fuoco: in pochi minuti tre attentatori sono uccisi e il quarto è
catturato. L’attentato
nella capitale conta tredici morti e settantasette feriti (tra italiani,
americani, messicani, greci, e un algerino). Contemporaneamente, in Austria, un
commando terroristi mette in atto lo stesso tipo di azione all’aeroporto Schwechat di
Vienna, provocando tre
morti e quaranta feriti. Secondo alcune fonti, avallate dal giudice
Rosario Priore che all’epoca indagava, il piano doveva concludersi con la
requisizione di un aereo da far precipitare, in stile 11
settembre, in una città di Israele. Per l’ammiraglio Fulvio Martini,
al tempo capo del Sismi,
dal 10 dicembre si sapeva di un possibile attentato. I servizi informarono che
sarebbe potuto avvenire tra il 25 e il 31 a Fiumicino. Gli israeliani misero
infatti tiratori scelti a difesa della postazione El
Al: furono loro i primi ad intervenire, mentre
le forze dell’ordine italiane si trovarono sostanzialmente impreparate.
“Sapevamo che nessuno
di noi sarebbe uscito vivo”. Confermò in seguito l’unico degli
attentatori rimasto illeso nello scontro a fuoco, Ibrahim Khaled, condannato poi
a 30 di reclusione e recentemente liberato. Non era la prima volta che si
spargeva sangue sul suolo del Bel Paese: c’era stata nel 1973 la “prima” strage
di Fiumicino (una delle più cruente d’Europa), dove su un Boeing 707 della Pan
Am, diretto a Beirut, furono fatte esplodere due bombe, con un bilancio finale
di 32 vittime, tra cui 4 italiani. Nel 1982, invece, l’attentato alla sinagoga
di Roma sconvolse la comunità ebraica causando 37 feriti e la morte di un
bambino di due anni, Stefano Gaj Taché.
Il mandante dell’85 fu Abu Nidal, capo di una fazione palestinese
contraria alla linea più moderata perseguita da Arafat in quegli anni. Anche lui
– come successo ad Abu Abbas – fu giudicato colpevole in contumacia, e,
riconosciuto coinvolto in circa 90 attentati a livello internazionale, perse la
vita nel 2002 a Bagdad su ordine del dittatore Saddam Hussein, liberatosi di una
presenza “ingombrante”.
Eventi del genere seguono logiche difficile da percorrere ma doverose da
ricostruire: fu l’eccessiva compiacenza, o negligenza, del Governo a permettere
che i palestinesi considerassero l’Italia un porto sicuro da dove far partire, o
verso cui finalizzare, gli attacchi terroristici? Si sarebbero dovuti condannare
con più veemenza certi fatti internazionali di quegli anni (Guerra
del Kippur, Invasione del Libano, massacro di Monaco alle Olimpiadi),
deplorando tanto le azioni palestinesi quanto le continue vessazioni israeliane?
Perché non si combatté concretamente, mettendo da parte la retorica e i
protocolli, l’indigenza e la precarietà politica del Medio Oriente? Se il mondo
si trova ancora nel mezzo di una guerra asimmetrica, qual è quella che
imperversa in Siria e porta avanti lo Stato Islamico, o che ogni giorno rischia
di deflagrare sulla striscia di Gaza e in Cisgiordania, significa
che un tipo di politica ha fallito: la
politica dell’interesse. E con essa, come si è visto, non sono mai
mancati coinvolgimenti diretti, e drammatici, di nazioni distanti sulla carta
geografica dai conflitti mediorientali ma poi duramente colpiti: ieri è toccato
all’Italia, oggi al Mali, alla Tunisia e alla Francia.
E domani?
Tante sono le proposte, troppi gli incontri conclusi con sterili promesse, poco,
invece, è l’impegno profuso senza che il proprio tornaconto prevarichi quello
collettivo. Da quando la mano dell’Occidente ha cercato di cogliere i frutti
(avvelenati) del Medio Oriente, il
terrorismo è stata una costante e si è fatto finta di non capire che
dalle guerre nasce e delle guerre si alimenta. Questi conflitti, sobillati e
finanziati dalle stesse forze che poi si impegnano nel debellarli, arriveranno,
presto o tardi, ad un punto di non ritorno. Quel punto troppe volte sembra
essere un obbiettivo da raggiungere piuttosto che evitare.
Se la storia non insegna, quanto meno invita a riflettere. Soprattutto oggi.
Fiumicino, strage
inevitabile.
Raid del 1985, assolti tutti i responsabili della sicurezza. Assolti dall'
accusa di strage colposa Casagrande Raffaele, ex dirigente dell'aeroporto; D'
Agostino Francesco, responsabile del centro di Polizia; Jovinella Carlo, capo
del commissariato; Carlino Antonio, ispettore generale della polizia di
frontiera. Secondo l'accusa avevano ignorato gli allarmi sul pericolo di
attacchi. La strage all'aeroporto di Fiumicino del 27 dicembre di sette anni fa
non poteva essere evitata. A questa conclusione sono giunti i giudici del
Tribunale che, al termine di una breve camera di consiglio, hanno assolto
"perchè il fatto non costituisce reato" le quattro persone che dovevano
garantire la sicurezza nello scalo. Una sentenza destinata a far discutere, che
costituisce una sorta di caposaldo sul fronte dell'accertamento delle
responsabilità per il funzionamento delle misure anti-attentati. Il processo e'
andato avanti per parecchie udienze. Sul banco degli imputati l'ex dirigente del
"Leonardo da Vinci", Raffaele Casagrande, gli allora responsabili del centro di
polizia e di prevenzione del Dipartimento di sicurezza del ministero
dell'Interno, Francesco D' Agostino, e del commissariato "Polaria", Carlo
Jovinella, e l'ispettore generale con funzioni di coordinamento dei servizi di
polizia della frontiera, Antonio Carlino. Al termine della requisitoria, il
Pubblico ministero Giuseppe Geremia aveva chiesto la condanna di Casagrande a
due anni di carcere e degli altri imputati a un anno e mezzo. La sparatoria tra
terroristi e forze dell'ordine provocò tredici morti e ottanta feriti. La tesi
sostenuta dalle famiglie delle vittime fu che non erano stati tenuti nella
dovuta considerazione i suggerimenti dei servizi segreti: l'avvocato Lepore era
riuscito ad avere un fonogramma della Twa (la compagnia statunitense che venne
presa di mira insieme alla israeliana El Al dal commando palestinese del gruppo
di Abu Nidal) col quale si lanciava un preciso avvertimento ai dipendenti. I
servizi segreti americani avevano saputo che erano stati messi a punto piani per
eseguire attentati terroristici negli aeroporti europei. Non basta. L'avvocato
Lepore aveva appreso che il fonogramma era in possesso del Sismi, il quale lo
aveva ricevuto prima della strage. E l'allora responsabile dei nostri servizi
segreti, Fulvio Martini, sentito come testimone nel corso dell'inchiesta,
confermò anche che nel documento riservato veniva indicato il periodo entro il
quale doveva essere compiuto l'attentato, dal 25 al 31 dicembre del 1985. Da
qui, l'incriminazione e il successivo rinvio a giudizio dei responsabili dei
servizi di sicurezza. Agli imputati venne contestato il reato di strage colposa.
Secondo l'accusa, avevano avuto un comportamento negligente: Casagrande non
attuò accorgimenti per evitare che i terroristi arrivassero ai banchi
dell'accettazione, dove poi avvenne il conflitto a fuoco. Jovinella e Carlino
non diedero un giro di vite ai servizi di sorveglianza, D' Agostino non trasmise
agli organi di polizia circolari con le quali venivano imposte precise
disposizioni di prevenzione. Insomma, il peggio sul fronte della prevenzione. Ma
i giudici hanno sconfessato questa impostazione. Flavio Haver
Pagina 14 (31 marzo 1992) - Corriere della Sera
Uccise 13 persone a
Fiumicino. Esce di cella e fa il
giardiniere.
Mahmoud nell'85 guidò il
commando palestinese all'aeroporto. Portò la guerra a Roma, ha tredici morti
sulla coscienza e raccoglie foglie secche in un prato. Khaled Ibrahim Mahmoud
oggi ha 41 anni. Ne aveva 18, il 27 dicembre 1985, quando guidò il commando
della strage di Fiumicino. «Ci penso sì, a quei morti. Ci penso ancora e ci
penserò sempre. E penso anche che l'aver seminato il terrore, come abbiamo fatto
noi, non è servito a niente. Non è servito al mio popolo, non è servito alla
pace. Anzi, il contrario...». Il 27 dicembre 1985, all'aeroporto di Fiumicino,
il commando di terroristi palestinesi uccise tredici persone e ne ferì più di
80, sparando contro il banco delle linee aeree israeliane. Il fuoco della
sicurezza in pochi secondi annientò gli assalitori, tre morirono all'istante,
Khaled rimase ferito, unico superstite. Poi è stato in carcere 23 anni, fino a
tre giorni fa. Oggi è un detenuto semilibero (la sera torna a Rebibbia) e da
giovedì ha cominciato a lavorare all'esterno per una cooperativa sociale:
giardinaggio, facchinaggio, pulizie nei mercati e nei parchi di Roma (come Pino
Pelosi, l'assassino di Pier Paolo Pasolini). La prima cosa che ha chiesto è
stato il permesso di acquistare un telefonino cellulare («Per chiamare mio
fratello e i miei genitori ormai anziani», dice in buon italiano, appreso in
questi anni leggendo e guardando in cella la televisione). Gli altri detenuti
che lavorano con lui non conoscono la sua storia. Khaled, in fondo, preferisce
così: «Il dolore che provo — dice — non potrebbe essere condiviso, sono venuto
al mondo durante la guerra, una lunga scia di sangue e di orrori mi accompagna
da sempre, da Sabra e Chatila a Fiumicino. Ma allora avevo 18 anni, ero
completamente indottrinato, non ragionavo. Il carcere, almeno, mi è servito a
questo: a farmi pensare con la mia testa, a farmi capire tante cose». Lui faceva
parte del gruppo di Abu Nidal, il feroce leader della lotta armata palestinese,
mandante del massacro di Fiumicino, trovato morto in un appartamento di Bagdad
nell'agosto 2002 («È stato ammazzato, ne sono certo», dice oggi Khaled,
condannato a 30 anni per la strage dell'85). Il Garante dei diritti dei detenuti
del Lazio, Angiolo Marroni, è la persona che in questi anni l'ha seguito più da
vicino: «Di sicuro — dice il Garante — Khaled ha maturato una critica profonda
rispetto al suo passato. In carcere ha studiato, ha fatto il bibliotecario, è
stato un detenuto modello, perciò ha ottenuto la liberazione anticipata. Il
nostro è un sistema premiale, dunque non c'era motivo perché lui non ottenesse i
benefìci previsti dalla legge. Il primo permesso gli fu accordato un anno fa, lo
accompagnai io stesso ad Ostia, a vedere il mare...». Il giorno che andarono al
mare, però, pioveva e faceva freddo: del resto, dopo 23 anni di carcere, diventa
difficile far tornare i conti. Se n'è andato un pezzo di vita perché tu hai
distrutto quella degli altri e anche andare avanti fa paura. «Il mondo da allora
è completamente cambiato — sospira l'ex terrorista, con i capelli ingrigiti —. È
caduto il muro di Berlino, non c'è più l'Unione Sovietica, non c'è più il
comunismo. Noi stavamo coi russi, all'epoca, io stesso ero comunista-stalinista,
oggi però sono in via di guarigione...». L'anno prossimo Khaled finirà di
scontare la sua pena, nel frattempo si è laureato in Scienze politiche con una
tesi sui Diritti umani e, malgrado tutto, sembra avere fiducia nel futuro del
Medio Oriente: «Prima o poi tutti i muri cadono. Ma la pace non s'impone, la
pace bisogna volerla». Fabrizio Caccia
22
novembre 2008 "Il Corriere della Sera".
7 ottobre 1985: dal
sequestro dell’Achille Lauro alla lunga notte di Sigonella,
scrive “Il Corriere della Sera”. Sono da poco passate le 13 del 7 ottobre del
1985, la nave da crociera Achille Lauro della Mediterranean Shipping Company sta
percorrendo la tratta al largo delle coste egiziane, a bordo ci sono 101
passeggeri e 344 membri dell’equipaggio, quando un commando composto da quattro
militanti del Fronte per la Liberazione della Palestina, saliti a bordo a Genova
con dei passaporti falsi, dà inizio a un dirottamento che diventerà un caso
diplomatico internazionale, con conseguenze fatali per il passeggero americano
di origine ebraica Leon Klinghoffer. L’Italia reagisce inviando la sera stessa
60 incursori del reggimento d’assalto paracadutisti Col Moschin alla base
militare di Cipro, pronti all’intervento in quella che verrà chiamata
l’Operazione Margherita. Nella foto di repertorio l’Achille Lauro lascia il
porto di Napoli. I terroristi vengono sorpresi da un componente dell’equipaggio
mentre maneggiano delle armi, ne nasce un conflitto a fuoco, dopo il quale viene
immediatamente inviato un SOS dalla nave che verrà captato in Svezia. Nella foto
i quattro terroristi autori del sequestro, da sinistra: Ibrahim Fatayer
Abdelatif, Youssef Al Molqi, Al Ashker Bassam, Marrouf Al Assadi. I dirottatori
chiedono la liberazione di cinquanta palestinesi detenuti in Israele a Nahariya,
si dichiarano esponenti dell’OLP, e minacciano di far saltare in aria la nave in
caso di mancata risposta alle loro richieste. Il Governo italiano si attiva non
appena ricevuta la notizia del dirottamento: agli Esteri c’è Giulio Andreotti,
forte di buoni contatti con il mondo arabo, alla Difesa c’é Giovanni Spadolini
che convoca immediatamente l’intelligence, mentre alla Presidenza del Consiglio
c’é Bettino Craxi, che spinge per una risoluzione diplomatica della crisi. I
nostri ministri sono in contatto telefonico con il governo egiziano di Hosni
Mubarak, con il leader palestinese Yasser Arafat, che in un comunicato stampa fa
sapere di essere estraneo alla vicenda, e con la Tunisia, allora sede dell’OLP.
Nella foto d’archivio, Andreotti con Arafat. Dopo una frenetica serie di
colloqui internazionali, l’Egitto e Arafat comunicano all’Italia l’invio di
alcuni emissari per gestire la situazione: tra loro Hani El Hassan, braccio
destro del leader dell’OLP, e Abu Abbas, che solo in seguito si rivelerà
coinvolto nell’attentato in qualità di ispiratore e di capo del fronte
terroristico palestinese filosiriano. Nella foto, Abu Abbas. Il Presidente
americano Ronald Reagan si oppone a qualsiasi trattativa con i terroristi,
mentre l’Achille Lauro si dirige verso il porto di Tartus in Siria e chiede un
negoziato mediato dalla Croce Rossa Internazionale. Nella foto, Maxwell Rabb,
all'epoca ambasciatore USA a Roma. Sulla nave intanto la tensione sale
vertiginosamente con i terroristi che minacciano ripetutamente di iniziare a
uccidere i passeggeri, in primis i cittadini americani. Nella foto i familiari
dei marinai dell’Achille Lauro in attesa di notizie. Gli Stati Uniti decidono di
intervenire rompendo le trattative diplomatiche in corso, mentre Bettino Craxi
insiste nel voler evitare un’azione di forza, e nel caso, vuole che sia guidata
da forze armate italiane. Nella foto Giulio Andreotti e Bettino Craxi. La
Achille Lauro abbandona la costa siriana e raggiunge Port Said, mentre le
trattative, non appoggiate dagli americani, riescono a convincere alla resa di
terroristi, grazie alla mediazione di Abu Abbas e alla promessa di fuga
diplomatica verso la Tunisia. Una soluzione che trova l’appoggio del Governo
italiano e che apparentemente sembra portare a un epilogo non drammatico della
vicenda, fino a quando non arriva la notizia dell’uccisione a bordo del
cittadino americano Leon Klinghoffer, nella foto. La situazione si aggrava
tragicamente e la tensione con gli Stati Uniti assume dei contorni molto
preoccupanti anche per lo Stato italiano, che sta vivendo da protagonista
l’intricata vicenda. Dopo la liberazione della nave si decide per l’immediato
trasferimento dei quattro attentatori e dei diplomatici egiziani e palestinesi
in Tunisia, a bordo del boeing 737 delle linee aeree egiziane. Nella foto il
comandate della nave Gerardo De Rosa. Oltreoceano Reagan dispone di intercettare
l’aereo egiziano facendo partire dalla portaerei Saratoga quattro caccia F-14 e
spingendo diplomaticamente affinché gli aeroporti di Tunisia, Grecia e Libano
rifiutassero l’atterraggio. Nella foto Caspar Weinberger, segretario alla difesa
americano, durante la riunione al Pentagono illustra dove i jet US F14 hanno
intercettato l’aereo egiziano che trasporta i dirottatori dell’Achille Lauro.
Senza possibile luogo d’atterraggio l’aereo egiziano viene così intercettato dai
velivoli americani e costretto ad atterrare alla base statunitense di Sigonella,
in territorio italiano. «Perché in Italia?» chiederà Craxi durante una
telefonata con il consulente CIA Michael Leeden, come racconterà poi Michael K.
Bohn nel suo libro sulla vicenda di Sigonella e dell’Achille Lauro. Nella foto
la nave liberata, i passeggeri e i marinai guardano le strisce di sangue
lasciate dal corpo dell’americano Leon Klinghoffer, ucciso e gettato in mare.
Contrariato dall’improvvisazione degli americani, l’allora presidente del
Consiglio italiano Bettino Craxi rivendica la competenza territoriale,
appellandosi al diritto internazionale e schiera a difesa del velivolo egiziano
uomini dei Carabinieri di stanza all’aeroporto e del comando di Catania. Nella
foto la gioia dei passeggeri dell’Achille Lauro sulla nave liberata. Il
controllore di torre dell’aeroporto militare di Sigonella e il suo assistente,
inizialmente all'oscuro dell'identità dei passeggeri a bordo del boeing
egiziano, saranno decisivi e indispensabili alla gestione dei momenti concitati
sulla pista e alla cattura dei terroristi da parte delle autorità italiane.
Nella foto Edward Casey, dell'ambasciata degli Stati Uniti, sull'’Achille Lauro
con i passeggeri americani. Sulla pista di Sigonella, poco dopo la mezzanotte,
atterrano a luci spente e senza autorizzazione due Lockheed dei Navy Seal, da
cui scendono militari americani armati con l’intento di ottenere il controllo
dell’aereo e soprattutto di prendere in consegna i terroristi e Abu Abbas. Nella
foto la moglie del cittadino americano ucciso, Marilyn Klinghoffer. L’Italia e
gli Stati Uniti vivono ore di tensione fortissima, il cui apice sarà la
telefonata di Reagan a Craxi per chiedere la consegna dei terroristi, ma Craxi
non si muoverà dalle sue posizioni, attestandosi sulla linea che in assenza di
richiesta di estradizione non era consentito a nessuno sottrarre alla giustizia
italiana persone sospettate di reati punibili ai sensi della legge italiana.
Dopo ore interminabili, con l’invio di altri Carabinieri e di mezzi blindati, le
forze armate americane ricevono l’ordine di ritirarsi. Nella foto il presidente
americano Ronald Reagan. Si dirà poi che a vincere questo pericoloso braccio di
ferro fu soprattutto il socialista Bettino Craxi, anche se poi vedrà cadere
proprio su questa vicenda il proprio gabinetto di governo, ma le conseguenze di
questo intricato affaire internazionale non termineranno con l’arresto dei
quattro terroristi. Nella foto il carcere di Siracusa dove sono stati rinchiusi
i terroristi palestinesi. I due dirigenti palestinesi e il diplomatico egiziano
restano a bordo del boeing, che parte alla volta di Ciampino, protetto da un
velivolo del SISMI e quattro caccia italiani F-104S, mentre un caccia americano,
senza autorizzazione e senza aver comunicato il piano di volo, decolla subito
dopo con l’intento di prendere in consegna il boeing con a bordo Abbas,
considerato responsabile del dirottamento. L’aereo riuscirà ad atterrare a
Ciampino, ma in un continuo crescendo di tensione, un secondo jet militare
statunitense fingendo un guasto otterrà di poter atterrare proprio sulla stessa
pista, davanti al boeing egiziano per impedirne la ripartenza. L’ammiraglio
Fulvio Martini, protagonista diretto di tutta la vicenda, intimerà di liberare
la pista, e per altri minuti l’Italia e gli Usa saranno a un passo dallo scontro
armato. Nella foto il boeing 737, atterrato all’aeroporto di Ciampino, con a
bordo i palestinesi. La crisi si sposta dalla pista dell’aeroporto alle stanze
di Governo, dove è in corso un braccio di ferro sulla gestione e l’eventuale
fermo in Italia dei due dirigenti dell’OLP a bordo del boeing egiziano: da un
lato Craxi, Andreotti e Martinazzoli, nella foto, contrari all’arresto dei due
funzionari palestinesi, dall’altro Giovanni Spadolini che chiede una
consultazione collegiale della decisione. Il 12 ottobre Abu Abbas e l’altro
funzionario palestinese ripartono a bordo di uno volo delle linee aeree
jugoslave verso Belgrado, senza che Spadolini sia stato informato. L’intera
vicenda porterà alla caduta del governo Craxi poche settimane dopo e a una
rottura personale tra Craxi e Spadolini, esponenti rispettivamente delle due
correnti filopalestinese e filoamericana. Nella foto la prima pagina del
Corriere della Sera del 17 ottobre 1985 che annuncia le dimissioni del Governo
Craxi. Solo nei giorni successivi verranno raccolte informazioni e
intercettazioni dei servizi segreti israeliani e americani che proveranno con
certezza il coinvolgimento diretto nel dirottamento di Abu Abbas, nella foto,
che sarà condannato all’ergastolo in contumacia. I quattro dirottatori saranno
poi rinchiusi nel carcere di Siracusa, trasferiti a Genova, processati e
condannati dalla magistratura italiana, mentre l’Achille Lauro farà ritorno a
Napoli dopo un breve scalo in Grecia e dopo che un’informativa della CIA sulla
possibile presenza di esplosivo sulla nave su alcune casse, gettate poi in mare
dal comandante. Nella foto Al Ashker Bassam durante il processo. Quanto ai
rapporti Usa-Italia, gli attriti rientreranno qualche tempo dopo con l’invito
dal famoso incipit “Dear Bettino” rivolto da Reagan a Craxi a recarsi negli Usa,
un viaggio già programmato, ma annullato a causa della vicenda Achille Lauro.
Nella foto la vedova di Leon Klinghoffer, ricevuta dal presidente Ronald Reagan.
A proposito di prevenzione.
Un magistrato la arresta l'altro la rimette in libertà. Qual è il pericolo a
piede libero? Scrive Salvatore Tramontano Giovedì 24/12/2015 su "Il Giornale".
Qual è il pericolo a piede libero? Una terrorista con l'obbligo di dimora, ma
con la possibilità di contattare via Internet i suoi compagni di fede e di
terrore, pianificando eventuali azioni di guerriglia e attentati oppure il pm
che voleva marchiare e sbattere in galera un'innocente? Oppure è il gip che ha
scarcerato la donna, che dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4 al largo di
Palermo, avrebbe affermato: «Questa è la vendetta divina»? Nulla è come prima.
La guerra invisibile dello Stato islamico sgretola le nostre certezze, i
capisaldi del diritto, fa sponda sulle paure e gioca a scacchi con la fede nella
libertà e il desiderio di sicurezza. La storia della ricercatrice libica di 45
anni, accusata di istigazione a commettere atti di terrorismo, che per il pm è
così pericolosa da essere rinchiusa in carcere mentre per il gip al massimo
merita l'obbligo di dimora, mostra quale sia la nostra realtà: noi non siamo in
grado di capire se questa donna sia davvero una terrorista. Questo caso incarna
tutte le nostre paure e segna le fragilità di questa stagione. Come mai il pm,
convinto che la donna sia pericolosa, non è riuscito a trovare le prove per
tenerla in carcere? Non è stato abbastanza bravo? O la legge non fornisce a chi
indaga gli strumenti adeguati? E il gip è stato troppo fiscale o davvero non
poteva fare altrimenti? Certo che se per aiutare i magistrati a «formarsi»
meglio sul fenomeno jihadista, come ha raccontato alcuni giorni fa Fausto
Biloslavo su questo Giornale, la Scuola superiore della magistratura organizza
un solo corso, allora tutto diventa più difficile. Il motivo spiegato nella
presentazione è chiaro: «Scandita dagli attentati, la disciplina antiterrorismo
costituisce un vero e proprio sottosistema della giustizia penale». Purtroppo la
prestigiosa Scuola offre poco altro sull'argomento. Di terrorismo, infatti, si
parlerà brevemente soltanto nel corso su «Religione-Diritto-Satira». Questo
nonostante al sistema di formazione dei magistrati concorra anche il ministero
della Giustizia. In compenso, però, ha raccontato sempre Biloslavo, viene
ripetuto, dopo il grande successo dello scorso anno, il corso sull'«immagine
della giustizia nell'arte, nel cinema, nella letteratura». La questione è seria
e forse il guaio maggiore è che non siamo pronti ad affrontare una situazione
come questa. Se c'è un punto dove siamo più vulnerabili, questo è il versante
della giustizia: l'Italia, le sue leggi, si confrontano con un nemico nuovo,
diverso perfino dal terrorismo rosso e nero degli anni '70, con integralisti
fanatici che non temono la morte e sono pronti a farsi saltare in aria o sparare
sulla folla come martiri. Come ci si difende da nemici così assoluti e
imprevedibili? Quante garanzie si possono concedere? È il paradosso della
società aperta: fino a che punto si può essere tolleranti con gli intolleranti?
La risposta è che una società aperta non è suicida, non è spalancata. Non può
essere tollerante fino alla morte. È arrivato il momento di difendersi dal
terrore islamico con tutti i mezzi. E servono nuove leggi. Per non morire o
sopravvivere nella paura.
Moro, spuntano di nuovo
Servizi e criminalità dietro al sequestro,
scrive Paolo giovedì 10 dicembre 2015 su “Il Secolo d’Italia”. C’è la
possibilità che si scelse proprio via Mario Fani a Roma per
portare a compimento il sequestro di Aldo
Moro perché
il Bar
Olivetti,
davanti al quale si dislocò il commando
Br, era
sede di un inedito intreccio di interessi che la Commissione
Moro sta
cercando ora di ricostruire. Il dubbio è fondato e supportato da molti elementi
nuovi riportati nella relazione approvata oggi. La Commissione sta scandagliando
l’ipotesi che il titolare del bar possa essere stato in relazione con i Servizi
Segreti o
con le forze
dell’ordine.
Un’ipotesi, questa, che costringerebbe a riscrivere del tutto la vicenda di
via Fani per
come è conosciuta fino ad oggi. Una vicenda densa di misteri mai
compiutamente chiariti e sulla quale aleggiano aspetti a dir poco inquietanti
che lasciano immaginare un’eterodirezione del sequestro e della sua gestione
fino al tragico epilogo finale. Alcuni testimoni hanno riferito che il bar
Olivetti non
era affatto chiuso in quelle settimane, come, invece, si era sempre ritenuto e
come hanno riferito tutte le indagini nel corso di questi 37 anni e di
conseguenza la sterminata pubblicistica esistente. Alcuni testi, come il giornalista
Paolo Frajese, dichiarano
di aver preso il caffè o di aver usato il telefono proprio nella mattina del 16
– quindi il giorno del sequestro
Moro –
o di essere clienti abituali. La possibilità che il bar
Olivetti fosse,
invece, effettivamente aperto al pubblico dopo la strage, nonostante la
situazione giuridica formale fosse di attività in liquidazione, pone seri
interrogativi sulla dinamica dell’agguato, per come è stata sempre ricostruita
sulla scorta delle dichiarazioni degli stessi brigatisti,
i quali hanno asserito di aver atteso nascosti dietro le fioriere prospicienti
il bar
Olivetti l’arrivo
delle auto al servizio di Aldo
Moro.
Questa ricostruzione – non del tutto convincente, tenuto conto che le fioriere
potevano offrire un riparo ben poco efficace a più persone destinate a
stazionare in attesa per un lasso di tempo non trascurabile – deve essere quanto
meno riconsiderata alla luce dei nuovi elementi acquisiti dalla Commissione
Moro.
Tuttavia alcune ricostruzioni confermano, invece, la chiusura del Bar
Olivetti tanto
che fu il portiere del civico 109, che ne aveva le chiavi, ad aprire ai
carabinieri che vollero fare un frettoloso quanto inutile sopralluogo
all’interno. Ma c’è un altro aspetto che ha catturato l’attenzione dei
commissari dell’organismo parlamentare di inchiesta. Il titolare del Bar Olivetti,
Tullio Olivetti,
socio e proprietario di ben 24 società diverse, era un personaggio molto noto
agli ambienti investigativi per essere stato coinvolto in
una complessa e stranissima vicenda relativa ad un traffico
internazionale di armi,
ma più volte è stato “sfilato” da tutte le indagini, contrariamente ai suoi
presunti complici, tanto da far ipotizzare che la sua posizione sembrerebbe
essere stata quasi “preservata” dagli inquirenti e che egli possa avere agito
per conto di apparati istituzionali ovvero avere prestato una erta forma di
collaborazione che ora la Commissione Moro intende meglio definire. Formalmente
l’indagine che coinvolge Tullio
Olivetti,
il cui nominativo figura, peraltro, anche negli elenchi – predisposti dalla Questura
di Bologna –
delle persone presenti in quella città nei giorni antecedenti la strage
alla stazione del 2 agosto 1980,
iniziò il 29 gennaio 1977, con un rapporto a firma del tenente
colonnello Antonio Cornacchia,
ed aveva al centro le attività di un certo Luigi
Guardigli,
amministratore della società
RA.CO.IN che
si occupava, tra l’altro, di compravendita
di armi per Paesi stranieri.
Tullio
Olivetti venne
subito indicato da Guardigli come trafficante
d’armi e di valuta falsa (aveva
riciclato 8 milioni di marchi tedeschi, provento di un sequestro avvenuto in Germania)
che vantava alte aderenze politiche, era in contatto con ambienti della criminalità
organizzata.
In una circostanza, nella villa di una persona presentatagli proprio da Tullio
Olivetti, Guardigli aveva
trovato ad attenderlo il mafioso
Frank Coppola (indicato
come persona che intervenne per dissuadere alcuni elementi della criminalità
organizzata –
in precedenza sollecitati da uomini politici ad attivarsi – dal fornire notizie
utili a localizzare il luogo dove era tenuto prigioniero Aldo
Moro)
che gli aveva chiesto di dare seguito ad una richiesta di armi fattagli da tale Vinicio
Avegnano,
in rapporti con ambienti di destra e con quelli, non meglio precisati, dei Servizi,
anch’egli indicato come amico di Olivetti.
Ma le indagini su Olivetti non
vanno avanti: sottoposto a perizia
psichiatrica eseguita
dal professor Aldo
Semerari,
che verrà poi ucciso e fatto ritrovare, attraverso una singolare messinscena, la
testa mozzata e lasciata in un catino all’interno di un’auto, Guardigli fu
definito «una personalità mitomane, con una condizione psicopatica di vecchia
data, e, allo stato, permanente. I suoi atti e le sue dichiarazioni sono
espressioni sintomatologiche di tale anomalia». Il complesso di queste
circostanze. Secondo la Commissione
Moro,
anche in considerazione dei rapporti tra
Olivetti e Avegnano impone
ulteriori accertamenti sull’ipotesi che il primo fosse un appartenente o un
collaboratore di ancora non meglio definiti ambienti istituzionali o dei Servizi
Segreti o
delle forze dell’ordine. E a rafforzare questo sospetto c’è un altro elemento
emerso. Dopo aver gestito il Bar
Olivetti per
proprio conto, ad un certo punto Tullio
Olivetti si
mise in società nella
Olivetti SpA con Maria
Cecilia Gronchi,
figlia dell’ex-presidente
della Repubblica Giovanni Gronchi e
con il di lei marito, Gianni
Cigna.
IL SEQUESTRO MORO E GLI STATI UNITI.
Il caldo lunedì della
commissione Moro. Su Aldo Moro (e sull'Isis) il palestinese Bassam Abu Sharif ha
le idee chiare: "E' tutta colpa degli americani",
scrive Massimo Bordin il 27 Giugno 2017 su “Il foglio”. Emozioni internazionali
ieri per gli onorevoli indagatori della ennesima commissione parlamentare sul
caso Moro: a intrattenerli è stato il palestinese Bassam Abu Sharif, che prima
di entrare nell’inner circle di Arafat nell’Olp, era stato un dirigente del più
estremista Fronte Popolare di liberazione. I rapporti del Fplp con le Br e le
informazioni raccolte dai palestinesi sul rapimento Moro sono stati l’oggetto
delle domande. Sul primo tema la risposta è stata articolata, forse anche
troppo. Da un iniziale: “Noi e le Br? Nulla a che vedere”, a un: “Certo molti di
loro si sono addestrati nei nostri campi, ma io sono certo – ha proseguito Abu
Sharif, venendo alla seconda domanda – che con il rapimento di Moro non
c’entrano. Sono state forze speciali Usa a sparare in via Fani. Per colpire un
bersaglio in movimento e lasciare indenne l’ostaggio ci voleva una preparazione
militare che le Br non avevano”, ha sentenziato il vecchio guerrigliero. Gli
onorevoli indagatori lo hanno ascoltato incantati, tranne chi per scrupolo una
occhiata a via Fani deve pure averla data. Una strada stretta, in discesa con
parcheggi ai lati, dove anche una scorta non può tanto correre e in ogni caso a
un certo punto, quando, finita la discesa, c’è una curva a gomito, deve quasi
fermarsi. Se poi c’è una macchina che la blocca, deve proprio fermarsi. Lì hanno
sparato, a un bersaglio fermo distante meno di un metro. Non ci volevano i Delta
Force. Ma Abu Sharif è molto convinto della pista Usa e a riprova ha aggiunto:
“Del resto noi sappiamo che anche l’Isis è una creatura americana”. Mentre
queste righe vengono spedite i lavori della Commissione continuano e il caldo
non accenna a diminuire.
Caso Moro, la verità va
riscritta: Abu Sharif conferma le incongruenze,
scrive Michele Bollino il 26 giugno 2017 su "Dire". Una colpo perfetto, forse
troppo. Dietro alla strage di via Fani che portò al rapimento di Aldo Moro e
all’uccisione dei 5 agenti della sua scorta “non c’erano le Brigate Rosse, ma
gli Stati Uniti”. A rilanciare la tesi di un coinvolgimento di forze diverse da
quelle delle BR è Bassam Abu Sharif, ex leader del Fronte Popolare per la
Liberazione della Palestina (FLPL), in audizione in Commissione parlamentare di
inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Le dichiarazioni di Abu
Sharif, storico collaboratore di Arafat negli anni ’70 e ’80, potrebbero non
essere solo frutto di fantasia ma, anzi, sembrano confermare le novità scoperte
dalla Commissione parlamentare di inchiesta. Sharif, infatti, non crede che “le
Brigate Rosse avessero la possibilità di uccidere cinque guardie del corpo senza
nemmeno ferire Moro”. L’ex esponente della resistenza palestinese ha combattuto
sul campo e conosce le difficoltà che comporta un’azione come quella compiuta in
via Fani. “So di cosa parlo - ribadisce - so quanto sia difficile colpire un
bersaglio mobile e quanta precisione serva per colpire cinque guardie del
corpo. Questa è professionalità di alto livello, serve un addestramento molto
elevato e chi ha rapito Moro si è addestrato a colpire almeno 10mila bersagli
mobili: le BR non erano così professionali”. Secondo Sharif, quindi, il commando
che è riuscito a fermare le due auto della polizia ed eliminare 5 agenti senza
neanche ferire Aldo Moro era composto da corpi specializzati, quindi “Cia o
Gladio, magari uomini dell’intelligence o da un team di forze speciali”. A 39
anni di distanza, sulla strage di via Fani restano più ombre che luci. La
commissione parlamentare di inchiesta è stata riaperta nel 2014, dopo le
rivelazioni di un agente del Sismi che testimoniava la presenza dei servizi
segreti italiani durante l’attacco. Da quel momento, i nuovi fatti emersi hanno
portato la commissione d’inchiesta a riscrivere la verità storica. Le
incongruenze sono tante, a partire dal numero dei terroristi del commando: nove,
secondo le contraddittorie testimonianze dei brigatisti, almeno venti secondo la
relazione della Commissione approvata sia dalla Camera che dal Senato. Una scena
del crimine piuttosto affollata, che trova però conferma nella relazione del
Procuratore della Repubblica Luigi Ciampoli che, nella sua ricostruzione dei
fatti del 16 marzo 1978, parla della presenza di “elementi dei servizi segreti
deviati dello Stato, uomini della mafia romana e di servizi segreti stranieri”.
Secondo il procuratore Ciampoli, inoltre, in via Fani vi erano almeno due
persone che parlavano in tedesco. A finire sotto la lente di ingrandimento della
Commissione è, in particolare, la dinamica dell’agguato. Secondo i brigatisti,
infatti, i colpi diretti alle macchine sarebbero stati esplosi solo dal lato
sinistro, mentre le ricostruzioni balistiche hanno ormai accertato che gli
assalitori hanno sparato anche da destra. Proprio da quel lato di via Fani era
presente il bar Olivetti, punto di ritrovo della malavita romana, frequentato
dai maggiori esponenti della Banda della Magliana e dei Nar, Renatino de Pedis e
Massimo Carminati, ma anche dal boss italoamericano Tano Badalamenti e
da Camillo Guglielmi, vice comandante generale di Gladio. Stando alle
ricostruzioni ufficiali, il giorno dell’attacco il bar risulta chiuso per
fallimento. Ma secondo l’onorevole Gero Grassi (PD), membro della Commissione
d’Inchiesta sul Caso Moro, non è così: c’erano dei testimoni, infatti, “che
affermavano che il locale fosse aperto, che non avrebbe mai tolto le fioriere,
l’arredamento e che dopo 15-20 giorni dal rapimento Moro il bar avrebbe riaperto
tranquillamente”. Un’ultima novità inquietante è quella che riguarda il ruolo
del consulente inviato dal Dipartimento di Stato Usa per affiancare le autorità
italiane nella gestione del sequestro, Steve Pieczenik. Contro di lui, il
procuratore Ciampoli ha infatti chiesto di procedere per “concorso nell’omicidio
di Aldo Moro, commesso in Roma il 9 maggio 1978” per aver contribuito a far
apparire la morte dell’ostaggio come “lo sbocco necessario e ineludibile, per le
Br, dell’operazione militare attuata in via Fani”. Se la verità sulla strage di
via Fani va riscritta, allora calano pesanti ombre anche sulle motivazioni che
portarono all’uccisione di Aldo Moro. Davanti alla Commissione, Abu Sharif dice
la sua: “Moro aveva una visione strategica per l’Italia, l’Europa e il mondo.
Dopo De Gaulle, Moro è stato il punto di svolta per tutta l’Europa. Chi lo ha
ucciso ha dunque voluto uccidere la visione e l’idea di Moro”. Dalla seconda
guerra mondiale in poi, continua Abu Sharif, “gli Stati Uniti hanno sempre
sventolato la bandiera della libertà dei popoli, ma ben presto s’è capito che
dietro era in corso una lotta essenzialmente economica. Da una parte gli Stati
Uniti proclamavano l’indipendenza di tutti gli Stati e dall’altra, attraverso il
piano Marshall, si creava un nemico, ovvero l’Unione Sovietica, per poter così
sottomettere l’Europa al dominio americano. Ora Trump va nei Paesi arabi e firma
contratti per 500 miliardi dollari mentre i bambini arabi sono sotto la soglia
di povertà. Moro invece voleva contratti equi e questo non piaceva ad una
superpotenza che ha voluto fermare la corrente del cambiamento”, termina l’ex
leader FLPL.
Caso Aldo Moro, cosa (non)
ha detto Abu Sharif,
scrive Stefano Vespa il 27 giugno 2017 su "Formiche.net. Forse i membri della
commissione Moro, presieduta da Giuseppe Fioroni, si aspettavano di più
dall’audizione di quattro ore di Bassam Abu Sharif, già consigliere di Yasser
Arafat e portavoce del Fronte popolare di liberazione della Palestina (Fplp). Si
cercava di avere conferme dirette su quegli anni, sui rapporti tra gruppi
palestinesi e terroristi europei e su quanto avvenne prima, durante e dopo il
sequestro e l’omicidio di Aldo Moro. Abu Sharif, 71 anni, ha insistito su due
punti essenziali: le Brigate rosse erano infiltrate dagli Stati Uniti che
volevano Moro morto e se fosse stato chiesto aiuto ai palestinesi per salvare il
presidente della Dc l’avrebbero certamente dato per gli eccellenti rapporti con
lo stesso. Ma si profila una seconda puntata perché l’esponente palestinese si è
impegnato a fornire alla commissione due elementi di enorme importanza: il testo
del cosiddetto Lodo Moro, cioè il documento firmato da George Habash con il
quale si garantiva che l’Italia sarebbe stata al riparo da attentati, e i nomi
dei brigatisti che sarebbero stati in realtà infiltrati americani, fatto che per
i palestinesi è assolutamente certo. La lunghezza delle risposte, spesso
argomentate con riferimenti non attinenti al caso (si sa che i mediorientali non
amano la sintesi…), alla terza ora di audizione ha costretto un esausto Fioroni
a “imporre” risposte secche (sì o no) a due quesiti. Così Abu Sharif ha detto
che non è stato mai chiesto l’intervento palestinese per salvare il leader Dc e
che avrebbero certamente avvertito l’intelligence italiana se avessero avuto
notizia di attentati in preparazione in Italia. Ciò in base a quanto era
previsto dal Lodo Moro. Abu Sharif ha insistito anche sulle modalità del
sequestro e dell’uccisione della scorta quel 16 marzo 1978: veri professionisti,
ha detto, “della Cia, di Gladio, di intelligence o un team di forze speciali”.
“Quelli che hanno sparato – ha poi aggiunto – non sono stati gli stessi che
l’hanno tenuto prigioniero”. Alcuni passaggi lasciano dei dubbi. Fioroni ha
ricordato l’ormai famoso messaggio del colonnello Stefano Giovannone, capo
centro del Sismi a Beirut e amico di Moro, che il 17 febbraio 1978 (un mese
prima del sequestro) inviò a Roma notizie su un’operazione terroristica in
preparazione. Giovannone non aveva contatti diretti con Abu Sharif, che pure
conosceva perfettamente, bensì con un altro palestinese oggi morto. È chiaro
però che le fonti del colonnello facevano parte di quell’ambiente e quindi non
si capisce come Abu Sharif possa negare che i palestinesi abbiano mai avuto
notizie di possibili attentati. Su altri passaggi l’ex consigliere di Arafat è
parso sfuggente. Fioroni ha ricordato un documento redatto da Giovannone il 21
giugno 1978 secondo il quale le Br avrebbero inviato a Habash copia delle
dichiarazioni fatte da Moro durante la prigionia su temi palestinesi: lo scopo
era di riallacciare rapporti con quel mondo. La risposta vaga è stata che i
rapporti con le Br erano stati interrotti da qualche anno una volta accertata
l’infiltrazione statunitense. Altrettanto curioso che Abu Sharif non abbia mai
sentito nominare l’organizzazione terroristica “Giugno nero” di Abu Nidal, della
quale si parla da decenni, e dei legami che avrebbe avuto con le Br come risulta
da un documento dell’allora vicedirettore del Sisde risalente all’11 agosto
1978. Fioroni ha insistito sul fatto che, in base a documenti di intelligence
appena desecretati, Abu Nidal fosse a conoscenza dei piani delle Br. Per Abu
Sharif, invece, “era fuori dalla rivoluzione palestinese” essendo ormai con Al
Fatah, accampando l’ipotesi che fosse un bugiardo riguardo alla vendita di armi
ai brigatisti. È troppo generico parlare di “palestinesi”, si è poi lamentato:
il presidente della commissione aveva citato il fatto che, dopo la morte di
Moro, Avanguardia Operaia ottenne da gruppi palestinesi armi che sarebbero state
distribuite anche ad altri gruppi terroristici e che nel 1979 le stesse Br
ottennero armi da palestinesi. Ovvia la domanda di Fioroni: “Come mai prima del
sequestro Moro le Br erano inaffidabili e dopo non lo sono state più?”. La
risposta è stata un classico depistaggio: “Anche oggi nei Territori occupati ci
sono palestinesi che sono in realtà agenti israeliani…”. La promessa di
informarsi presso la propria intelligence su chi fossero i brigatisti infiltrati
dagli Usa è stata fatta in risposta all’insistenza di Gero Grassi (Pd) mentre
dopo un’analoga domanda di Marco Carra (Pd) se l’era cavata col fatto che è un
comandante e non un agente dei servizi segreti. Invece Abu Sharif ha negato più
volte l’esistenza di campi di addestramento nei quali si sarebbero esercitati
brigatisti. In ogni occasione ha ribadito il ruolo a suo avviso determinante
degli Stati Uniti, invitando la commissione a procurarsi il documento che
l’allora segretario di Stato americano, Zbigniew Brzezinski, consegnò al
presidente Jimmy Carter insistendo sul “no” alla trattativa, “che avrebbe
significato la morte di Moro”. Se manterrà gli impegni, le notizie che fornirà
alla commissione saranno piccanti, sperando che non vengano secretate.
“Italiani nei campi
profughi palestinesi addestrati a combattere contro Israele”.
La deposizione di Abu Sharif
alla Commissione sulla morte di Moro: “Negli Anni 70 c’era un patto scritto con
Roma per non fare attentati”, scrive Francesca Paci il 27/06/2017 su “La
Stampa”. «Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (Fplp) aveva
rapporti particolari con alcuni dei gruppi rivoluzionari emersi in Europa dopo
il ’68. Queste forze non sapevano come opporsi al capitalismo e noi glielo
insegnammo, era parte della lotta contro l’imperialismo che sosteneva Israele.
Migliaia di giovani donne e uomini italiani vennero nei campi profughi
palestinesi ad aiutare in tanti modi diversi, nelle scuole, negli ambulatori o
nel combattimento, ma sempre e solo contro l’occupante israeliano». A raccontare
questo ulteriore tassello del controverso puzzle “Italia Anni 70” è Bassam Abu
Sharif, storico membro della formazione marxista-leninista Fplp e poi influente
consulente di Arafat ascoltato ieri dalla Commissione bicamerale d’inchiesta
sulla morte di Aldo Moro, l’ennesimo organo d’indagine sul rapimento del
presidente della Dc la cui durata teoricamente biennale è stata prolungata dalla
fine del 2016 al termine della legislatura. È la prima volta che si parla in
modo così esplicito della presenza di nostri connazionali nei campi profughi
palestinesi di 40 anni fa, giovani, uomini, donne, un po’ volontari e un po’
foreign fighters ante litteram. Una nuova angolazione che amplierebbe il quadro
delle “relazioni pericolose” dell’epoca in cui s’inserisce anche il cosiddetto
Lodo Moro, il patto segreto di non belligeranza tra gli 007 italiani e i fedayn
palestinesi sempre menzionato ma mai ammesso. E non è escluso che ora la
Commissione presieduta da Fioroni possa avviare altre indagini oltre a quelle di
sua stretta competenza per le quali ha già inviato alla procura generale di Roma
il lavoro di oltre un anno di accertamenti. E non è escluso neppure che possano
riaprirsi altri dossier sulle presunte connivenze passate, a partire dalla
vicenda degli autonomi Pifano, Nieri e Baumgartner, arrestati nel 1979 a Ortona
perché trovati in possesso di missili portatili di proprietà della resistenza
palestinese. Sebbene interpellato nello specifico sui rapporti tra il Fplp e le
Br alla data del 16 marzo 1978, Bassam Abu Sharif, anche autore del volume «The
Best of Enemies» scritto con il giornalista israeliano Uzi Mahnaimi, riapre il
capitolo Lodo Moro parlandone come di qualcosa di storicamente acquisito, un
fatto. Secondo Abu Sharif, definito a un tratto da Time «face of terror»,
sarebbe stato proprio quel rapporto privilegiato con il Medioriente in generale
e con i palestinesi in particolare a mettere l’Italia sotto sorveglianza da
parte di chi, come gli Stati Uniti, non apprezzava, e a condannare Moro, la
mente del compromesso storico. Siamo nei mesi precedenti al sequestro del leader
democristiano, il cupo ’77, il ’78, gli anni in cui, sostiene Abu Sharif, il
Fplp ha già interrotto i rapporti con le Br perché sospetta che, con i capi in
prigione, le seconde linee siano state infiltrate: «All’epoca le fazioni
palestinesi sotto l’ombrello dell’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina (Olp) avevano rapporti con tutti i paesi arabi e, in modo non
ufficiale, con molti di quelli europei, dove gli uffici locali della Lega Araba
ospitavano i nostri rappresentanti. E parlo di rapporti anche a livello di 007.
In questo quadro di aiuto e collaborazione, alcuni paesi - segnatamente il
vostro - volevano un documento firmato da George Habash in cui il Fplp si
impegnasse a non partecipare ad azioni in Italia. E infatti da allora non è mai
successo niente qui». Abu Sharif insiste sui buoni rapporti tra i suoi e il
governo di Roma per provare l’estraneità del Fplp al rapimento Moro ma finisce
per ipotizzare di più: «Il Fplp e l’Italia avevano un dialogo particolare sulla
politica e la sicurezza sin dal ’72, attraverso noi l’Italia mandava ambulanze e
medici ai campi profughi e noi in cambio vi aiutavamo molto. Fu così che
l’Italia ci chiese di risparmiarla, di non usarla per fare operazioni o per
compiere attentati contro Israele. Me ne parlò il colonnello Giovannone, disse
che doveva rassicurare i suoi. Habash firmò questo documento, portai il nostro
impegno a mettere l’Italia al sicuro, il colonnello Giovannone lo ricevette per
scritto. E quando passai dal Fplp ad Arafat continuammo sulla stessa linea».
Il giorno dopo l'audizione
di Bassam Abu Sharif davanti alla Commissione bicamerale d'inchiesta sulla morte
di Aldo Moro, il presidente Giuseppe Fioroni mette in ordine quelle che
definisce «importanti novità» per la ricostruzione dell'Italia di quegli anni,
scrive Francesca Paci il 28 giugno 2017 su “la Stampa”. Secondo l'ex del Fronte
Popolare per la Liberazione della Palestina (Fplp) che Fioroni ha ascoltato per
ore, nel 1978 i palestinesi diffidavano delle Brigate Rosse, riferivano
all'intelligence di Roma qualsiasi informazione ricevessero circa potenziali
attentati in Italia nel quadro dell'impegno unilaterale firmato da George
Habash, accoglievano nei loro campi numerosi nostri giovani connazionali
disposti a curare i malati ma anche a combattere per la loro causa.
Abu Sharif cita un accordo
scritto in cui Habash s'impegnava a risparmiare l'Italia. È la conferma del
cosiddetto Lodo Moro?
«Abu Sharif ha ammesso che
dopo l'attentato di Fiumicino del 1973 le intelligence italiana e palestinese
avviarono una serie di contatti sfociati in un documento unilaterale firmato da
George Habash a nome del Fplp e consegnato al colonnello Giovannone affinché lo
portasse a Roma. In quella lettera, che Abu Sharif inquadra nella politica
estera di Moro centrata allora sui Paesi arabi e sul Mediterraneo, c'è l'impegno
a impedire attentati in Italia e a considerarci solo un Paese di transito. Se
Abu Sharif ne troverà copia negli archivi del Fplp lo avremo presto in mano».
A chi rispondeva
Giovannone?
«Da un punto di vista tecnico
al capo dei servizi italiani, il Sismi. Ma sul piano politico era il referente
di Moro per la politica estera in Medioriente».
L'Italia sapeva che nel '78
il Fplp non si fidava più delle Br?
«È la prima volta che viene
fatta questa distinzione. Abu Sharif sostiene che nel 1976 il Fplp, allertato
dal capo operativo Wadie Haddad, ritiene già da tempo le Br inaffidabili. Haddad
intanto ha rotto con il Fplp perché è in dissenso con l'input di Mosca che
chiede la fine dei sequestri aerei, ma i contatti sono stretti. E qui c' è un
riscontro importante sul caso Moro, perché già nei primi giorni dopo il
rapimento il Sismi cerca tra i fuoriusciti palestinesi. In più, a giugno,
Giovannone segnala a Roma rapporti tra ex Fplp e BR aggiungendo che i brigatisti
hanno fatto avere ad Habash copia delle dichiarazioni di Moro prigioniero per
ripristinare collaborazione e assistenza. Significa che Moretti prova a
riallacciare con i palestinesi usando le carte che ha».
Riusciranno le Br
nell'impresa?
«Anche qui abbiamo riscontri
alle affermazioni di Abu Sharif. A noi risultano transiti di armi tra
palestinesi, Br e autonomi nel 1979, ma Abu Sharif sostiene che il Fplp non
c'entri (di altre sigle non risponde ndr.) e dice che se avesse ricevuto dai
propri 007 informazioni di possibili attacchi in Italia lo avrebbe riferito a
Roma. In effetti il 17 febbraio 1978 Giovannone avverte i suoi di un attentato
in preparazione e Moro ne parla il 15 marzo, la sera prima del sequestro.
Inoltre, il 30 marzo 1978 l'allora uomo dell'Olp in Italia Nemer Hammad assicura
a Cossiga che sta facendo il possibile e cita Abu Anzeh Saleh, legato al fronte
del rifiuto e in contatto con Wadie Haddad. Un mese dopo, il 24 e 25 aprile,
Giovannone annuncia un contatto valido con le Br e dice che verrà a Roma.
Sapremo poi che Moro in una lettera del 23 aprile menziona la liberazione di un
palestinese a Ostia avvenuta via Giovannone e chiede di averlo a Roma, come se
sapesse che si è attivato un canale palestinese».
Come si inquadrano in
questo scenario gli italiani addestrati nei campi profughi palestinesi?
«È una conferma. A parlarne la
prima volta fu l'ex responsabile esteri del Fplp Taysir Qubaa che in
un'intervista del 1980 spiegò come non volesse esportare la rivoluzione in
Italia ma potesse contare su "compagni" italiani addestrati nei campi per
combattere contro i nemici dei palestinesi. Sapevamo di campi in Yemen, Iraq,
Siria, Libano ma ora Abu Sharif torna su questi italiani pronti ad aiutare la
resistenza palestinese».
Vede un collegamento con i
due giornalisti di Paese Sera De Palo e Toni, spariti a Beirut nel 1980?
«La loro storia ruota intorno
al traffico di armi che tra il '78 e il '79 esisteva intorno ai campi
palestinesi. Abu Sharif smentisce che fosse gestito dal Fplp ma a noi risulta
che c'era. E sapevamo da alcuni pentiti che i palestinesi affidavano armi alle
Br. Ora sappiamo che degli italiani si addestravano lì».
Lodo Moro. Quei patti
inconfessabili tra Sismi e terrorismo palestinese,
scrive Gea Ceccarelli su “Articolo 3”. Con l'imperversare della crisi di Gaza,
tutti hanno imparato a conoscere Hamas. Chiunque, adesso, sa che si tratta di
un'organizzazione paramilitare e terrorista, contro cui si è scatenata la furia
di Israele con quello che ne è conseguito: un vero e proprio genocidio di
innocenti, arabi colpevoli semplicemente di essere non ebrei. Quello che in
pochi sanno è come, Hamas, abbia una storia lunga e travagliata: come la stessa
sia stata probabilmente vista di buon occhio per lungo tempo, dagli israeliani,
a causa della sua rivalità con un'altra organizzazione palestinese, l'Olp,
fondato, tra gli altri, da Yasser Arafat. Nell'aprile scorso, Hamas e l'Olp
hanno firmato un accordo, un'alleanza. Un patto che ha istantaneamente fatto
allertare Israele, la quale, da parte sua, ha tuonato chiaramente come esso
avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile per la pace tra i due paesi.
Pochi mesi dopo, il rapimento di tre ragazzi ebrei s'è configurato come la
scintilla in grado di scatenare l'inferno, con Netanyahu che giurava vendetta,
pur sapendo, come è stato confermato da alcuni funzionari di polizia, che la
responsabilità non era stata di Hamas. Ogni scusa, però, era valida per
intervenire. Così, riconoscendo in Hamas il nemico supremo, si dimentica l'Olp.
La cui storia sta per tornare a galla, fra pochi giorni, in Italia. Il motivo è
semplice: fu proprio questa organizzazione a scendere a patti con il Sismi
italiano, nell'ambito del cosiddetto "lodo Moro", i cui dossier relativi stanno
per diventare pubblici. Erano gli anni '70-'80. Anni di stragi, nel nostro
Paese. Anni di ombre incombenti e alleanze inconfessabili. Una di queste sarebbe
proprio quella intercorsa tra la nostra intelligence e i terroristi palestinesi:
un patto, firmato dall'allora Presidente del Consiglio Aldo Moro, che garantiva
agli islamici la possibilità di far passare fiumi d'armi nel nostro paese,
destinati a cellule terroriste sparse in tutto il continente, e la liberazione
dei prigionieri palestinesi. In cambio, i militanti non avrebbero colpito gli
italiani, avrebbero lasciato il nostro Paese tranquillo, pur non inserendo negli
accordi l'incolumità per gli ebrei residenti nel Belpaese. Tanto più che,
nell'82, venne attaccata la Sinagoga di Roma. Fu quella, forse, a squarciare il
velo di misteri che avvolgeva gli accordi. Il 3 ottobre del 2008, in occasione
del 30esimo anniversario dell'attentato, l'ambiguo ex presidente della
Repubblica Francesco Cossiga, rivelò chiaramente l'esistenza del lodo in
un'intervista rilasciata al quotidiano israeliano Yediot Aharonot. “Vi abbiamo
venduti”, dichiarava in essa Cossiga. “Lo chiamavano ‘Accordo Moro’ e la formula
era semplice: l’Italia non si intromette negli affari dei palestinesi, che in
cambio non toccano obiettivi italiani”. “Per evitare problemi, l’Italia assumeva
una linea di condotta tale da non essere disturbata o infastidita”, continuava
l'uomo nell’intervista “Poiché gli arabi erano in grado di disturbare l’Italia
più degli americani, l’Italia si arrese ai primi." Ma non solo: Cossiga rivelava
anche l'esistenza di simili accordi con l'Hezbollah libanese, "per cui le forze
UNIFIL chiudono un occhio sul processo di riarmo, purché non siano compiuti
attentati contro gli uomini del suo contingente”. Nonostante secondo Giovanni
Pellegrino, ex presidente della Commissione Stragi il patto risalga all'autunno
del 1973, Cossiga dichiarava di esserne a conoscenza soltanto dal 1976, da
quando, cioè, divenne ministro dell'Interno. "Mi fecero sapere che gli uomini
dell’OLP tenevano armi nei propri appartamenti ed erano protetti da immunità
diplomatica", raccontava nell'intervista. "Mi dissero di non preoccuparmi, ma io
riuscii a convincerli a rinunciare all’artiglieria pesante ed accontentarsi di
armi leggere”. Anni dopo, quando divenne Presidente del Consiglio, ebbe la
certezza dell'esistenza di tali accordi: “Durante il mio mandato, una pattuglia
della polizia aveva fermato un camion nei pressi di Orte per un consueto
controllo”, raccontava. “I poliziotti rimasero sbigottiti nel trovare un missile
terra-aria, che aveva raggiunto il territorio italiano via mare”. In pochi
giorni, una sua fonte del Sismi gli fece sapere dell'esistenza di un telegramma,
arrivato da Beirut, nel quale era "scritto che secondo l’accordo, il missile non
era destinato ad un attentato in Italia, e a me fu chiesto di restituirlo e
liberare gli arrestati”. “Col tempo", aggiungeva ancora Cossiga nell'intervista,
"cominciai a chiedermi che cosa potesse essere questo accordo di cui si parlava
nel telegramma. Tutti i miei tentativi di indagare presso i Servizi e presso
diplomatici si sono sempre imbattuti in un silenzio tuonante. Fatto sta che Aldo
Moro era un mito nell’ambito dei Servizi Segreti”. Secondo Pellegrino, il patto
fu stilato dal Sismi, e solo firmato da Moro, che pure ne faceva riferimento in
alcune missive inviate durante la seconda metà degli anni Settanta. Numerose le
testimonianze che confermano tale versione. Come quella, rilasciata al Corriere
della Sera, di Bassam Abu Sharif, portavoce del Fronte popolare per la
liberazione della Palestina, "costola" dell'Olp, da cui successivamente si
separò. "Ho seguito personalmente le trattative per l'accordo", ricorda Abu
Sharif. "Aldo Moro era un grande uomo, un vero patriota. Voleva risparmiare
all'Italia qualche mal di testa", ma "non l'ho mai incontrato. Abbiamo discusso
i dettagli con un ammiraglio, gente dei servizi segreti, e con Stefano
Giovannone (capocentro del Sid e poi del Sismi a Beirut, ndr). Incontri a Roma e
in Libano. L'intesa venne definita e da allora l'abbiamo sempre rispettata".
Grazie a questa, prosegue, "ci veniva concesso di organizzare piccoli transiti,
passaggi, operazioni puramente palestinesi, senza coinvolgere italiani. Dovevamo
informare le persone opportune: stiamo trasportando A, B, C… Dopo il patto, ogni
volta che venivo a Roma, due auto di scorta mi aspettavano per proteggermi. Da
parte nostra, garantivamo anche di evitare imbarazzi al vostro Paese, attacchi
che partissero direttamente dal suolo italiano". C'è però altro: quando, il 2
agosto del 1982, Bologna fu sconvolta dalla strage alla stazione, Cossiga puntò
dapprima il dito contro i neofascisti e, successivamente, contro i palestinesi.
Secondo lui, a compiere l'incredibile attentato erano stati proprio i terroristi
arabi, dopo che il "patto" era stato tradito. Un'ipotesi venuta a crollare nelle
settimane scorse, quando i pm di Bologna hanno depositato la richiesta di
archiviazione per le posizioni di Thomas Kram e Margot Christa Frohlich, due
terroristi tedeschi indagati e legati ai palestinesi. Secondo i magistrati, la
presenza dell'esperto di esplosivi Kram a Bologna la notte prima dell'attentato
è accertata, ma “quel solo e sorprendente fatto non è tuttavia sufficiente per
ipotizzare in assenza di altri elementi” sul suo conto “una partecipazione alla
strage della stazione”. Per i pm, poi, è tutta la teoria a non reggere, in
quanto, secondo tale ipotesi, il legame tra terrorismo palestinese e Kram
avrebbe dovuto essere il terrorista venezuelano "Carlos". Rapporto non solo
indimostrabile, ma pure confutato dal diretto interessato. Fu lui, Carlos, a
sottolineare infatti come, non solo ai tempi della strage avesse già rotto da
anni i ponti con il Fplp, ma che inoltre non vi sarebbero stati motivi, per gli
arabi, di colpire degli innocenti italiani: avrebbero solo rischiato di
danneggiare i rapporti tradizionalmente buoni tra la Palestina e il nostro
paese. Secondo lui, dunque, a Bologna a colpire furono piuttosto la Cia e il
Mossad, così da punire l'Italia e distoglierla dai propri interessi
“antiatlantici” e “filoarabi”. Ipotesi, questa, supportata da Abu Sharif: "Non
c'entriamo niente", ha infatti spiegato. "Nessuno ordine è venuto da me. Il
massacro non ha niente a che vedere con organizzazioni palestinesi. Neppure un
incidente. Non c'era nessuna ragione per farlo, soprattutto a Bologna". L'unica
possibilità è che "la Cia o il Mossad abbiano usato un palestinese, un loro
agente. E' stato fatto esplodere, senza che lo sapesse, per accusare noi."
D'altronde, sottolinea, "Gli americani non erano affatto felici della nostra
cooperazione con l'Italia. Soprattutto perché passavamo agli italiani
informazioni top secret su quello che gli americani stavano facendo nel vostro
Paese". Ma l'Olp e il Flpl avevano contatti anche con le Br: "Solo
cooperazione", chiarisce l'ex portavoce. "Qualcuno di loro faceva parte dell'"
Alleanza" che venne stabilita nel 1972, assieme a organizzazioni di tutto il
mondo." "Erano", spiega, "le "operazioni speciali" guidate da Wadie Haddad.
Questi gruppi stranieri non sono mai stati ai nostri ordini, c'era solo
coordinamento". Per questo, quando, nel '78 venne rapito il segretario della Dc,
i palestinesi avrebbero potuto intervenire. Ma, prosegue Abu Sharif, "ho
chiamato un numero, ho lasciato un messaggio dopo l'altro. Nessuna risposta.
Davvero strano: una linea speciale e nessuno risponde". Certo è che, del lodo
Moro, l'opinione pubblica seppe in seguito, e sempre a spezzoni. Dopo la
sparizione dei due giornalisti De Palo e Toni, che indagavano sul traffico
d'armi, si alzò subito un impenetrabile muro di silenzi e depistaggi atto a
oscurare l'esistenza stessa degli accordi che, nell'ambito delle indagini sulla
loro scomparsa, sarebbero inevitabilmente emersi. Nell'84, poi, l'ufficiale del
Sismi Giovannone invocò il segreto di Stato su tali patti, ottenendolo grazie a
Bettino Craxi. Un sigillo poi ribadito da Silvio Berlusconi per due volte tra il
2009 e il 2010. Il 28 agosto prossimo, però, scadono i trent’anni previsti dalla
recente riforma sui servizi come limite massimo per il segreto di Stato. Non c'è
più niente che possa esser nascosto ancora. Circa un'ottantina di faldoni
verranno alla luce e riconsegnati agli inquirenti. In essi, si potrà trovare la
verità su numerosi misteri italiani e non solo: stragi e rapimenti, accordi
inconfessabili. Potrebbe, altresì, esser compresa una volta per tutte l'attuale
situazione di equilibri tra le potenze in gioco a Gaza, dove "buoni" e "cattivi"
non esistono, e dove l'Italia ha una sua, enorme, colpa.
Si apre una breccia nel muro
di gomma. I rapporti inconfessabili tra palestinesi e Sismi. Occhi chiusi sul
fiume di armi destinate alle cellule dell'Olp. In cambio niente attentati. E' il
patto tra servizi segreti, Dc e Yasser Arafat. Un quadro già emerso in un
processo menomato dai veti politici. Fino a ora: i documenti decisivi stanno per
essere desecretati, scrive Andrea Palladino su “L’Espresso”. Una doppia
politica. Un lodo - firmato da Aldo Moro - che garantiva tutti. Niente
attentati, ma occhi chiusi sul fiume di armi da far passare nel nostro paese,
destinate alle cellule internazionali palestinesi sparse in tutta Europa.
Accordi per tre decenni coperti dal segreto di Stato, l’omissis tutto politico.
Un sigillo che neanche la magistratura può violare. Ancora per poco. Perché i
dossier sui rapporti tra la nostra intelligence e l’Olp di Yasser Arafat che
hanno marcato la politica estera italiana tra gli anni ’70 e ’80 stanno per
diventare pubblici. Ed è la prima volta nella storia repubblicana. Scade il 28
agosto il termine ultimo del segreto invocato nel 1984 dall’ufficiale del Sismi
Stefano Giovannone - confermato da Bettino Craxi il 5 settembre dello stesso
anno e ribadito da Silvio Berlusconi per due volte tra il 2009 e il 2010 - di
fronte alla domanda del pm romano Giancarlo Armati, che indagava sulla scomparsa
in Libano dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni. Che rapporti avevate
con i palestinesi? Era questa la questione chiave per capire non solo che fine
avessero fatto i due reporter arrivati a Beirut nell’agosto del 1980, ma
soprattutto i motivi del sistematico depistaggio attuato dall’intelligence
italiana per coprire gli autori del rapimento e della successiva esecuzione.
Ovvero la fazione più dura dei palestinesi, quella di George Habbash, detto
al-akīm, il dottore. Per le famiglie dei due giornalisti, che hanno lanciato una
petizione per togliere il segreto di Stato e pubblicare on line tutti i
documenti disponibili, i prossimi giorni saranno cruciali. Potrebbero essere il
punto finale di una battaglia che dura da 34 anni. La verità sostanziale è nota
e certificata dalla carte processuali, che hanno portato alla condanna di un
brigadiere dei carabinieri addetto all’ufficio cifra dell’ambasciata italiana a
Beirut (gli altri indagati, Giovannone e Santovito, alti ufficiali dei servizi,
nel frattempo sono deceduti). Graziella De Palo, giovane freelance -
collaboratrice di Paese Sera e dell’Astrolabio - e Italo De Toni, giornalista di
esperienza di Diari con la passione sfrenata per il jazz, erano partiti per
Beirut con idee precise. La capitale libanese godeva in quegli anni della fama
di città più pericolosa del Medio Oriente, forse del mondo. Crocevia di spie,
terroristi di ogni matrice, trafficanti di armi e di droga, faccendieri arrivati
da ogni dove, gente pronta a sfruttare le opportunità di una guerra civile
infinita, in una città divisa in due, tra i cristiani maroniti del partito
falangista di Bashir Gemayel e le fazioni filo palestinesi. Toni e De Palo
avevano contatti buoni, presi in Italia prima della partenza, direttamente con
l’Olp di Arafat. Cosa cercavano? Tante le ipotesi. Di certo non si
accontentavano del semplice racconto di una città in guerra. Graziella De Palo
seguiva ormai da mesi il filo del traffico di armi. La sua agenda e i suoi
quaderni erano pieni di annotazioni precise, nomi di società legate alla nostra
difesa. Partono tre settimane esatte dopo l’attentato alla stazione di Bologna,
quando in Italia si viveva la stagione delle bombe e dei misteri di Stato. Un
anno prima a Ortona i carabinieri avevano fermato un gruppo di terroristi, una
cellula composta dall’esponente dell’Autonomia Daniele Pifano, dal militante del
Fplp di George Habbash (Fronte popolare per la liberazione della Palestina)
Saleh Abu Anzeh, da Giuseppe Nieri e Giorgio Baumgartner, con un lanciamissili.
Solo più tardi si scoprirà che quell’arma micidiale apparteneva all’Olp, e che
l’Italia era solo un punto di transito, come spiegarono gli stessi palestinesi
del Fplp in una lettera inviata al Tribunale di Chieti, competente per il caso.
La prova dei rapporti inconfessabili tra l’intelligence militare italiana e
l’organizzazione palestinese è arrivata - per il pm Armati che indagò sul caso -
dal muro di silenzi e depistaggi alzato immediatamente dopo la scomparsa di De
Palo e Toni. Scrive il magistrato nella sua richiesta di rinvio a giudizio per
George Habbash, Stefano Giovannone (ufficiale del Sismi a capo degli uffici di
Beirut) e Damiano Balestra (brigadiere dei carabinieri addetto all’ufficio cifra
dell’ambasciata italiana in Libano): “L’istruttoria finora compiuta avrebbe
certamente consentito di fare piena luce sulla complessa vicenda della scomparsa
all’estero dei due giornalisti”. Ma troppi sono stati gli ostacoli che hanno
bloccato la procura di Roma: “In primo luogo l’atteggiamento completamente
negativo delle autorità libanesi; in secondo luogo le difficoltà frapposte dalle
autorità elvetiche (coinvolte per il caso del depistaggio sulla strage di
Bologna attuata da Elio Ciolini, ndr); in terzo luogo la conferma da parte
dell’autorità di governo del segreto di Stato opposto dal Giovannone, (…) che ha
avuto l’effetto non voluto di coprire anche le ragioni della condotta
dell’ufficiale del Sismi nei confronti dell’Olp”. Per il pm Armati la condotta
dei nostri servizi nella vicenda “presenta aspetti oscuri certamente estranei ai
suoi fini istituzionali”. Con un coinvolgimento - ipotizzato dalla procura -
dello stesso direttore del servizio, il generale Giuseppe Santovito. Il primo
novembre del 1980 - due mesi dopo la scomparsa dei giornalisti - il capo del
Sismi incontrò Arafat. Il leader dell'Olp chiese alla nostra intelligence di
“stendere un velo pietoso sulla vicenda”. Circostanza che lo stesso Santovito
ammise davanti al pm Armati. Da quel momento - si legge nelle carte del processo
- l’ambasciatore italiano D’Andrea, intenzionato a chiarire quello che era
accaduto, si trovò davanti il classico muro di gomma, metafora che il nostro
paese stava imparando a conoscere molto bene. Gli ufficiali del Sismi iniziarono
a monitorare le indagini condotte dall’ambasciata, convincendo il brigadiere
Balestra - poi condannato in via definitiva - a passare all’intelligence i
messaggi scambiati con la Farnesina. Stefano Giovannone, a quel punto,
intervenne direttamente con la famiglia, chiedendo il silenzio stampa, accusando
i Falangisti di Beirut, giocando sulla speranza dei parenti dei giornalisti di
poter risolvere il rapimento. Nonostante i depistaggi, la Procura di Roma riuscì
a ricostruire almeno il contesto della scomparsa, attribuendone la
responsabilità ai palestinesi: “I due erano stati uccisi dal gruppo di Habbash,
subito o quasi”, spiega il magistrato romano citando una nota dell’ambasciata
italiana a Beirut. Il mistero nasce sui motivi del rapimento e dell’omicidio,
con un’ipotesi inquietante: “Forse i palestinesi avevano ricevuto qualche
indicazione errata”, era l’indicazione arrivata dalle forze di sicurezza
libanesi. Una trappola, un mandante esterno. Italiano? Chissà. Il 28 agosto
scadono i trent’anni previsti dalla recente riforma sui servizi come limite
massimo per il segreto di Stato. Già il 10 marzo del 2010 - attraverso
l’intervento del Copasir presieduto da Francesco Rutelli - le famiglie dei due
giornalisti avevano ottenuto un primo accesso a 1.161 documenti classificati.
Mancavano all’appello un’ottantina di fascicoli, per i quali fu confermato il
segreto di Stato da Silvio Berlusconi. Fabio De Palo, fratello minore di
Graziella, oggi giudice civile a Roma, ha catalogato con cura le migliaia di
pagine consultate (che ha potuto copiare solo dopo un ricorso al Tar).
All’Espresso spiega che dal 29 agosto è pronto a chiedere l’accesso alle carte
mancati al premier Matteo Renzi, che - secondo le norme attuali - non potrà più
autorizzare gli omissis. “Gli interessi economici prevedevano lucrosi affari
nella vendita delle armi - spiegano in un appello i familiari di Graziella De
Palo e Italo Toni - a quei paesi nei confronti dei quali vigevano embarghi
economico militari”. Una politica che Paolo Emilio Taviani sintetizzò nella
formula “della moglie americana e dell’amante libica”. Sintesi di quel lodo
“Moro” che l’ufficiale del Sismi Stefano Giovannone (uomo di stretta fiducia del
leader Dc) attuò con meticolosità, e che Vincenzo Parisi citò in parlamento “per
spiegare il movente di tante stragi ancora oggi inspiegabili e coperte da
inquietanti aloni di mistero”, come ricordano i familiari dei due giornalisti
uccisi nel 1980. “Ci aspettiamo di riavere i resti degli scomparsi e la
riapertura di un processo” che era stato interrotto, bloccato dal segreto di
Stato confermato da Bettino Craxi, trent’anni fa. Verità e giustizia, al posto
dell’eterno muro di gomma italiano.
L'accordo con l'Olp degli anni
70'. In questi giorni di fervore patriottico per il caso Battisti proviamo a
riesaminare alcuni degli episodi altrettanto irrisolti della storia del nostro
Paese. Vi propongo un articolo che fà riflettere, fatti irrisolti di cui si
preferisce ancora tacere. Decidete voi se significa qualcosa o significa nulla.
Tratto da “L’accordo Moro e la
strage di Bologna del 2 agosto 1980” di Matteo Masetti su “Vietato Parlare”.
Negli anni Settanta il governo italiano siglò un accordo segreto con l’Olp per
evitare atti di terrorismo nel nostro Paese. In cambio l’organizzazione di
Arafat ottenne la libera circolazione dei fedayn palestinesi nella penisola.
L’intesa sarebbe stata pensata da Aldo Moro. Ma tra la fine del 1979 e i
l’agosto del 1980 qualcosa andò storto. L’attentato alla stazione di Bologna
potrebbe essere maturato in quel clima. Una delle pagine più oscure e tragiche
nella storia della nostra Repubblica è quella dell’attentato alla stazione
ferroviaria di Bologna il 2 agosto 1980. Questa strage fu un fatto di una
violenza terroristica mai apparsa fino ad allora nel nostro paese e avvenne poco
tempo dopo il misterioso incidente al DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo
il 27 giugno di quell’anno, inabissatosi con 81 passeggeri nel mar Tirreno nei
pressi dell’isola di Ustica. Ecco dunque la breve cronaca di quel tragico 2
agosto: alle ore 10,25 nella sala d’aspetto della stazione di Bologna Centrale
circa 23 kg di esplosivo di fabbricazione militare vennero fatti saltare con un
comando a tempo. Assieme alle vittime – 85 morti e 200 feriti – andarono
distrutti gran parte della stazione, il parcheggio antistante e il treno
Ancona-Chiasso in sosta. Tre giorni dopo l’attentato, a seguito di una riunione
del comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, il presidente
del Consiglio Francesco Cossiga dichiarò: “La strage è di chiara marca
fascista”. Le indagini porteranno all’arresto tra il 1981 e il 1982 di due
estremisti di destra dei NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari), Giuseppe Valerio
Fioravanti e la sua fidanzata Francesca Mambro, i quali dopo un processo che era
stato annullato, verranno condannati in modo definitivo all’ergastolo con
sentenza del 23 novembre 1995. A questo riguardo l’ex presidente della
Commissione Stragi, Giovanni Pellegrino, ha sostenuto che il movente attribuito
ai condannati per quell’eccidio, “non ha alcun senso”. Mambro e Fioravanti hanno
ammesso altri delitti assai gravi per i quali hanno ricevuto condanne
pesantissime; ma si sono sempre professati innocenti per quella bomba alla
stazione di Bologna. Da notare che Cossiga, in una lettera inviata all’on. Enzo
Fragalà – membro della Commissione d’inchiesta sul dossier Mitrokhin – e letta
nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio il 20 luglio 2005 aveva
scritto: “Premetto che non ho mai ritenuto la Francesca Mambro e Giusva
Fioravanti responsabili dell’eccidio di Bologna. L’ultima, assai debole sentenza
di condanna è da ascriversi alle condizioni ambientali, politiche ed emotive
della città in cui è stata pronunziata, nonché alle teorie allora largamente
imperanti nella sinistra e nella cosiddetta magistratura militante “. Il 30
maggio 2005, cioè due mesi prima di questa importantissima dichiarazione – che
quindi smentiva quanto il presidente emerito della Repubblica aveva affermato
quando la strage era stata appena compiuta – l’ANSA dava una notizia riferita al
1980, secondo la quale il giorno 11 luglio di quell’anno, il prefetto Gaspare De
Francisci, direttore dell’UCIGOS (Ufficio centrale per le investigazioni
generali e per le operazioni speciali), scriveva al direttore del SISDE generale
Grassini che il FPLP (Fronte Popolare Liberazione Palestina) minacciava
ritorsioni contro il nostro paese a causa della vicenda di un giordano arrestato
e condannato il 25 gennaio 1980 dal Tribunale di Chieti. De Francisci avrebbe
poi coordinato le indagini sul sequestro Dozier, l’alto ufficiale statunitense
rapito da un commando delle Brigate Rosse il 17 dicembre 1981 e liberato da una
brillante operazione dei Nocs il 28 gennaio 1982. Il direttore dell’UCIGOS di
quegli anni era quindi un grande professionista. Ma perché De Francisci aveva
parlato del terrorismo palestinese che minacciava da vicino l’Italia?
L’intricata vicenda è stata ben ricostruita da un dossier apparso sul numero di
luglio/agosto 2005 del mensile “Area” e firmato da un brillante giornalista
investigativo, Gian Paolo Pellizzaro. Consulente della commissione di inchiesta
parlamentare sulle stragi e sul terrorismo, oltre ad avere svolto lo stesso
incarico per la commissione Mitrokhin, presieduta tra il 2001 e il 2006 dal
senatore Paolo Guzzanti, Pellizzaro si è occupato delle ricerche inerenti la
strage di Bologna, citata infatti nel capitolo conclusivo del documento della
commissione Mitrokhin. Secondo questa ricostruzione ampiamente documentata le
origini dell’attentato sono da far risalire all’episodio dei “missili di
Ortona”, ovvero all’arresto avvenuto il 7 novembre 1979 nei pressi di Ortona
(Chieti) di tre rappresentanti dell’Autonomia Operaia di Roma. Baumgartner,
Pifano e Nieri – questi i nomi degli arrestati – stavano infatti trasportando
due lanciamissili di fabbricazione sovietica del modello SAM-7 Strela con
relativo munizionamento avuti da un contrabbandiere di armi, il quale le aveva
sbarcate quel giorno da una motonave presso il porto di Ortona al Mare. Ecco
come vengono descritti i missili Sam-7 Strela nel capitolo conclusivo della
relazione di maggioranza sul dossier Mitrokhin (pag. 285): “I missili [.]
possono essere impiegati per un solo colpo e il missile è dotato di una testa
auto cercante che consente di manovrare in modo automatico per colpire
l’obiettivo, con una gittata massima di 6-7 chilometri. Il sistema è destinato
contro aerei a bassa quota ed è idoneo a lanci contro aerei in allontanamento,
in fase di decollo e di atterraggio”. Nello svolgimento della vicenda è
fondamentale il successivo arresto operato a Bologna il 13 novembre 1979 del
giordano Abu Anzeh Saleh, ovvero del responsabile del FPLP in Italia. E’ quindi
importante ricordare che il capoluogo romagnolo era il luogo di residenza del
giordano e che in questa ricostruzione la scelta del luogo dell’attentato – al
di là delle motivazioni che vedremo – sia da ricondurre a questo fatto. Saleh
avrebbe infatti dovuto essere presente alla consegna delle armi ma quel giorno
aveva avuto un impedimento e quindi aveva delegato i tre autonomi romani per
assolvere questo compito. Oltre ad essere una figura di spicco in Italia del
FPLP, comandato dal noto terrorista palestinese George Habbash, A. A. Saleh era
anche un uomo legato all’organizzazione del venezuelano Ilich Ramirez Sanchez,
noto anche come “Carlos”, ora condannato all’ergastolo e detenuto in Francia.
Comunque la vicenda dei missili, lungi dal risolversi con l’arresto delle
persone coinvolte, cominciò invece a diventare una questione molto spinosa per
la magistratura e la politica italiana. Infatti il 2 gennaio 1980 il Comitato
Centrale del Fronte popolare per la liberazione della Palestina inviava una nota
ufficiale al presidente del Tribunale di Chieti, presso il quale si stava
svolgendo il processo. Ecco alcuni passaggi di quella nota: “I missili trovati
ad Ortona sono dell’FPLP [.] Non c’è mai stata intenzione da parte del Fronte di
usarli in Italia [.] E quindi il passaggio-chiave: “Noi richiedemmo che queste
informazioni fossero trasmesse al governo italiano. Alcuni giorni dopo,
l’ambasciata italiana ci confermò che il governo italiano era stato informato in
modo esatto e completo”. Tutto il documento venne letto in aula durante il
dibattimento ma a questo punto è opportuna una precisazione importante, perché
la missiva era stata affidata a Damasco al colonnello Stefano Giovannone, il
quale era subito partito per l’Italia senza informare l’ambasciatore a Beirut
del motivo del viaggio. Questo alto ufficiale era stato designato nel 1972 come
capo centro del SISMI a Beirut e lì rimase fino al 1981. Ecco cosa scrisse di
lui l’ammiraglio Fulvio Martini – ex direttore del SISMI – nel suo libro “Nome
in codice: Ulisse”: “Penso che l’Italia debba qualcosa a questo ufficiale dei
carabinieri; in centrale [.] avevano scelto per lui il nome in codice Maestro e
questo è già di per sé indicativo. Pochi riuscivano a capire con quali
difficoltà il colonnello Giovannone avesse a che fare nello svolgimento della
sua missione di capo centro a Beirut. Il compito principale di Giovannone era
quello di mantenere il SID informato con continuità sull’evoluzione degli
avvenimenti. Il Servizio, come era suo dovere istituzionale, aveva necessità di
conoscere esattamente la situazione, non solo per poterla analizzare e fare
delle previsioni utili alla politica estera del nostro governo, ma anche al fine
di provvedere alla difesa dell’Italia da eventuali operazioni di terrorismo che
avrebbero potuto coinvolgerla. [.] Era un maestro della cosiddetta diplomazia
parallela – quella che ti scarica se non riesci e che ha come solo scopo
l’interesse superiore del tuo Paese. Il suo successo fu completo. L’Italia fu
molto ingrata con lui. Rientrò da Beirut nel 1980 e morì nel 1985, di tumore,
dopo un calvario giudiziario che durò a lungo e durante il quale non fu difeso
da quei politici che l’avevano utilizzato”. Poco prima di morire rilasciò
un’intervista nella quale dichiarò: “Il mio dialogo con i palestinesi ha dato
sette anni di pace all’Italia”. Possiamo a questo punto evidenziare nella lunga
citazione tratta dal libro dell’ammiraglio Martini il termine di “diplomazia
parallela”, quindi credo sia lecito domandarsi che tipo di agreement esistesse
tra il nostro paese e i palestinesi per lasciare in pace l’Italia in quegli
anni. Esistono infatti tutti gli indizi per ricostruire l’esistenza di un patto
per assicurare al nostro paese un livello di tranquillità in cambio di una
specie di salvacondotto per gli estremisti arabi. Nel saggio “Fratelli d’Italia”
uscito nel 2007, l’autore Ferruccio Pinotti scrive: “Come è emerso
successivamente, il governo italiano aveva siglato negli anni Settanta un
accordo segreto con l’Olp mirato a evitare atti di terrorismo: in cambio della
possibilità degli attivisti palestinesi di circolare sul territorio italiano,
l’organizzazione di Arafat si sarebbe impegnata affinché non avvenissero
attentati sul suolo nazionale. L’intesa sarebbe stata pensata già da Aldo Moro”.
A questo proposito Rosario Priore, il magistrato che ha indagato nel corso della
sua carriera su casi come la strage di Piazza Fontana, “l’incidente” di Ustica e
l’attentato a Papa Giovanni Paolo II, ha affermato nel corso della trasmissione
“Omnibus” su LA7 del 14 maggio 2007: “Io vorrei solo fare un piccolo riferimento
a questo patto, questo è un patto di cui parla Moro in quattro importantissime
lettere [.] Questo è un patto, diciamo la verità, che ha determinato la nostra
storia per oltre trent’anni.” Le lettere di cui parla Priore sono evidentemente
quelle che lo statista democristiano scrisse durante la sua prigionia nelle mani
delle Brigate Rosse e i riferimenti a questo patto dovevano servire a
giustificare uno scambio per la sua liberazione. Ecco il passaggio della lettera
inviata alla Democrazia Cristiana: “in moltissimi casi scambi sono stati fatti
in passato, ovunque, per salvaguardare ostaggi, per salvare vittime innocenti.
Ma è tempo di aggiungere che, senza che almeno la DC lo ignorasse, anche la
libertà (con l’espatrio) in un numero discreto di casi è stata concessa a
palestinesi, per parare la grave minaccia di ritorsioni e rappresaglie capaci di
arrecare danno rilevante alla comunità”. In un’altra lettera indirizzata a
Flaminio Piccoli Moro farà preciso riferimento al colonnello Giovannone affinchè
venga in Italia ed influisca per la sua liberazione. Ma allora a quando risale
la data di questo patto? Probabilmente una data precisa di stipula non esiste,
ma le condizioni perché esso si realizzasse avvennero attraverso una serie di
incontri e successivamente ad azioni terroristiche di “stimolo”. Ad esempio a
seguito della strage all’aeroporto di Fiumicino operato da un commando
palestinese di Settembre Nero, che il 17 dicembre 1973 provocò 32 morti e decine
di feriti: fu così che il governo italiano nella persona dell’allora ministro
degli Esteri Aldo Moro si decise a condurre le trattative per una “tregua”
mantenendo il colonnello Giovannone dislocato a Beirut in qualità di garante
affinchè potesse controllare e monitorare costantemente la situazione. Di fatto
un accordo tutto sulla parola ma senza nulla di scritto. In pratica, a fronte
della “distrazione” delle autorità italiane per il transito di materiale
esplosivo e armi attraverso il nostro paese, l’Italia sarebbe stata risparmiata
dalle cruente azioni del terrorismo palestinese e dai pericoli di ritorsione
israeliana: e ciò in effetti accadde. Il nostro paese infatti, per la sua
posizione geografica in mezzo al Mediterraneo era considerato un punto
strategico ed inoltre proprio in quel periodo si verificò lo scontro
arabo-israeliano del Kippur (6-22 ottobre 1973), con le dovute ripercussioni
nell’area. Trattandosi comunque di un patto non scritto e a causa della cronica
instabilità della situazione politica italiana, le condizioni andavano di volta
in volta riviste a seconda dei vari accadimenti del nostro scenario politico. E
sicuramente la morte di Moro (9 maggio 1978) dovette creare non poche
complicazioni. Questa lunga digressione per spiegare cosa aveva innescato il
sequestro dei missili – che durante il processo si scoprì essere solo in
transito nel nostro paese – e l’arresto del responsabile del FPLP in Italia alla
fine del 1979. Sempre Cossiga nella lettera inviata alla commissione Mitrokhin
nel 2005 scriveva: “La richiesta avanzata dall’FPLP di restituzione dei missili
faceva forse parte dell’accordo mai dimostrato ‘per tabulas’, ma notorio,
stipulato sulla parola tra la resistenza ed il terrorismo palestinese da una
parte, e dal governo italiano dall’altra, quando era per la prima volta
Presidente del Consiglio dei Ministri l’on. Aldo Moro. La totale fedeltà e
conseguente riservatezza che i collaboratori sia del Ministero degli esteri sia
del Sifar e poi Sismi nutrivano per lui, impedì sempre a me, benché
autoritariamente curioso, di sapere alcunché di più preciso sia da ministro
dell’Interno, che da Presidente del Consiglio dei Ministri e da Presidente della
Repubblica”. Inoltre nel corso della trasmissione “La storia siamo noi” su Rai
Due del 24 maggio 2007 l’ex presidente della Repubblica ha affermato: “Arrivò
attraverso Giovannone, un messaggio del capo di un’organizzazione terroristica,
a me diretto, molto cortese che diceva: Ma qui stiamo violando i patti, il
missile è mio, voi me lo dovete restituire “. Vi fu in quell’occasione un vero e
proprio braccio di ferro tra la posizione dell’allora premier Cossiga e il
nostro servizio segreto militare – i cui vertici risulteranno iscritti alla
loggia massonica P2 – che riteneva ancora in vigore quell’accordo nonostante
Moro non fosse più in vita. Tra l’altro, proprio in quel periodo il nostro paese
era impegnato in una fase di importante riavvicinamento agli interessi degli
Stati Uniti, di Israele e della NATO. Ma la posizione palestinese verso il
governo italiano andò peggiorando nei mesi successivi, anche perché, come
abbiamo accennato, il giordano Saleh, del Fronte popolare per la liberazione
della Palestina, era anche un uomo che faceva parte dell’organizzazione
terroristica di Carlos, con il quale si era incontrato in più di un’occasione a
Bologna e di certo non per dei briefing di tipo culinario. Il gruppo Carlos
denominato Separat dalla Stasi dell’ex DDR ed attivo tra il 1976 e il 1989 ha
avuto al suo attivo una serie di azioni terroristiche soprattutto sul territorio
francese. Quindi la vicenda del sequestro dei missili Strela si stava
intrecciando pericolosamente anche a questo gruppo che tra l’altro non era solo
una variabile rischiosa ma altamente imprevedibile per gli sviluppi che poteva
provocare. L’organizzazione terroristica di Carlos, detto anche lo Sciacallo,
godeva inoltre della protezione dei governi dell’Est Europa e del Medio Oriente
ed era in contatto con altri gruppi eversivi in Italia, Francia, Germania,
Spagna, ecc. Da una ricerca della Digos di Bologna del marzo 2001 su
segnalazione dell’allora capo della Polizia Gianni De Gennaro è emerso che
Thomas Kram, membro di spicco delle Cellule Rivoluzionarie (RZ) e facente parte
a tutti gli effetti del gruppo Carlos, alloggiò a Bologna la notte del 1° agosto
1980, cioè proprio il giorno prima dell’attentato. Kram, cittadino tedesco
qualificato negli atti giudiziari come un grande esperto di esplosivi, si rese
poi irreperibile la mattina del 2 agosto rimanendo latitante fino al 2006 quando
si costituì in Germania. Va quindi annotato che, come indicato nell’ultimo
capitolo dalla Commissione Mitrokhin, la Procura di Bologna ha aperto un
procedimento a carico di ignoti per l’ipotesi di strage e successivamente ha
chiesto, con rogatoria internazionale, di interrogare Kram come persona
informata dei fatti. Tra l’altro lo stesso Carlos, nel corso di un’intervista in
carcere rilasciata al “Corriere della Sera” il 23 novembre 2005 ha affermato che
“un compagno tedesco era uscito dalla stazione pochi istanti prima
dell’esplosione. Ho ricordato il suo nome leggendo il Corriere: Thomas Kram”. Se
ciò non fosse ancora sufficiente a seguire questa pista, vorremmo anche
ricordare che lo stesso tipo di esplosivo utilizzato nell’attentato di Bologna è
stato rintracciato al momento dell’arresto nella valigia della terrorista
tedesca Christa Margot Froehlich, anch’essa legata al gruppo Carlos, avvenuto il
18 giugno 1982 all’aeroporto di Fiumicino: purtroppo però gli esperti non lo
hanno mai accertato con sicurezza assoluta e questo rimane un interrogativo
ancora aperto di quella vicenda. L’attentato di Bologna venne poi a legarsi
anche alla improvvisa sparizione, avvenuta a Beirut il 2 settembre 1980, di due
giornalisti italiani, Italo Toni e Graziella De Palo. Ecco cosa scrive ancora
Ferruccio Pinotti nel suo libro “Fratelli d’Italia”: “Lo stato, il governo, i
servizi segreti avrebbero coperto i veri responsabili della strage di Bologna
per rispettare l’accordo coi palestinesi. Si tratterebbe di una verità
sconvolgente. E se Italo Toni e Graziella De Palo, attraverso le loro fonti
palestinesi in Libano, avessero messo le mani su una simile “lettura” della
strage di Bologna, si giustificherebbe la loro sparizione e si spiegherebbero le
coltri di fumo e i depistagli posti in essere da Giovannone e dal generale
Santovito sulla loro morte, tanto da essere rinviati a giudizio. Soprattutto si
capirebbe il motivo dell’imposizione, sull’intera vicenda, del ‘segreto di
Stato’, che permane tutt’oggi.” Se quindi l’ipotesi dell’attentato di matrice
medio-orientale, finora senza esiti processuali, può comunque essere considerata
una traccia molto credibile, considerando l’intreccio di motivazioni, connivenze
e interessi – oltre alla sentenza molto dubbia nei confronti degli imputati
Mambro e Fioravanti -, aggiungiamo un altro elemento che ha contribuito in
questi anni all’offuscamento della verità processuale. Infatti il 13 gennaio
1981 sul treno Taranto-Milano in sosta alla stazione di Bologna veniva rinvenuta
una valigia contenente esplosivo simile a quello utilizzato per la strage oltre
ad armi ed altro materiale compromettente. Le indagini fecero scoprire che
questo ritrovamento costituiva una vera e propria sceneggiata operata dal SISMI
che, sempre fedele al “patto”, tentò il depistaggio verso elementi neo-nazisti e
ciò spiega perché ufficiali del SISMI vennero condannati per questo episodio.
Tornando invece alla condanna degli imputati al processo di Chieti per
l’episodio dei missili, il giordano Saleh venne rimesso in libertà il 17 giugno
1981 per decorrenza dei termini di custodia, mentre gli altri complici italiani
continuarono a rimanere in carcere. E’ quindi evidente la disparità del
trattamento degli imputati. E ciò non può non essere stata una coincidenza
casuale in seguito all’attentato avvenuto meno di un anno prima. Un’ultima nota
crediamo sia doverosa per le vittime di quel tragico 2 agosto: persone ignare
del proprio destino che vide 85 vittime o che avrebbero visto la propria vita
completamente cambiata per un grave ferimento così come per la perdita di un
familiare o di un caro amico. La perdita di fiducia nella giustizia e nelle
istituzioni di cui oggi dobbiamo constatare la drammatica attualità è dovuta
anche – ovviamente non solo – a situazioni irrisolte come quella di Bologna che,
a distanza di quasi 30 anni, chiede una chiave di lettura diversa rispetto a
quella finora rivelata. Mi sembra infatti che gli elementi oggi a nostra
disposizione richiedano quindi un nuovo impegno da parte degli organi inquirenti
e giudiziari per arrivare ad una memoria processuale condivisa che possa
cominciare a ridare credibilità al nostro panorama istituzionale. Allo stesso
tempo è certo che continuerà l’azione di sbarramento dei “guardiani della
verità”, cioè di coloro che non vogliono che queste rivelazioni diventino di
ampia diffusione, poiché si ha quasi l’impressione che la nostra opinione
pubblica non sia ancora preparata alla lettura di fatti che accaduti da troppo
poco tempo per essere completamente metabolizzati. Oltre alle inevitabili
ripercussioni che simili verità possano divenire fonte di attrito con i vicini
medio-orientali e i nostri interessi nell’area.
Rapporti Italia-OLP, segreti
svelati!, scrive “Liberali per Israele”.
FRANCESCO COSSIGA: « Vi sono
sempre delle cose, delle verità che è meglio che in certi momenti non si
sappiano. Le faccio un esempio: quando io da Ministro dell'Interno o presidente
del Consiglio mi vedevo con gli esponenti dell' Olp, non era bene che si
sapesse, o quando abbiamo trattato con l'Urss per coprire un caso di spionaggio
che aveva portato all'arresto di alcuni italiani e un brillante ufficiale del
sevizio militare sovietico; all'arrivo di Gorbaciov facemmo in modo che questo
funzionario fosse scarcerato.
Cari giudici girotondini, vi
svelo una cosa. Io e Moro i terroristi li abbiamo sequestrati, cacciati,
incastrati con la droga. E abbiamo vinto. Voi invece...
Caro dottor Spataro, io ho per
Lei una grande simpatia, anche se l'ho denunziata e spero che di quella denunzia
Lei debba rispondere, a onore degli uomini dei servizi segreti italiani e delle
potenze alleate e amiche che ci difendono dal terrorismo (pardon, dalla
"resistenza"). Stia certo che io andrei a trovare in carcere chiunque, anche se
fosse un giudice, e porterei le arance siciliane e le ciliegie di Vignola
prodotte da un mio amico, che non è né della Cia né del Sismi. Dicevo: io ho per
Lei una grande simpatia perché siamo entrambi dei politici. Io lo sono in panni
normali e combatto con la parola e lo scritto; Lei lo è nei panni del magistrato
che lotta con l'esercizio dell'azione penale e con gli ordini di custodia
cautelare. Da ragazzino io per la Repubblica e la Democrazia Cristiana facevo a
botte; Lei non ho ben capito per che cosa, ma forse già allora faceva i
girotondi. ::: Voglio raccontarLe alcune istruttive cose. Aldo Moro molto si
preoccupava di tenere al riparo i cittadini italiani dagli attacchi del
terrorismo arabo-medio orientale e palestinese: l'Olp di Arafat non aveva ancora
rinunciato a compiere "azioni di convinzione" all'estero contro obiettivi
ebraici e occidentali. Si operava nell'ambito del più generale accordo segreto
chiamato il "patto Giovannone", dal nome del residente del Sismi a Beirut.
Quando terroristi palestinesi tentarono - con missili terra-aria piazzati nei
dintorni all'Aeroporto di Fiumicino - di abbattere un aeromobile civile
israeliano dell'El-Al e furono arrestati, Moro intervenne personalmente sul
presidente del tribunale, con la cortesia e la fermezza che gli erano proprie, e
fece concedere ai terroristi la libertà provvisoria. All'uscita dal carcere vi
erano agenti dell'allora Sid che prelevarono i terroristi appena scarcerati, li
portarono in un aeroporto militare, li imbarcarono su un aeromobile DC 3 dello
stormo dello Stato Maggiore, sigla "Argo", quello di cui normalmente si serve la
V Divisione e cioè "Gladio" (mamma mia, "Gladio!") e li spedì a Malta, da dove
raggiunsero la Palestina. Arafat ringraziò. Fortunatamente Lei, dottor Spataro,
era impegnato in un girotondo! Gli israeliani anni dopo ci risposero e fecero
saltare in aria l'Argo: pari e patta. Nella "guerra sporca" dei servizi si fa
così! Altra storia. Un magistrato arrestò un giorno il capo del Sid, uomo fedele
ad Aldo Moro che era allora presidente del Consiglio dei ministri, e arrivò
vicino a scoprire la struttura di Gladio. Moro convocò un giovane ministro che
ero io, e gli diede istruzioni di prendere contatto con la famiglia, e di
esprimere ad essa e tramite essa la solidarietà del governo al generale. Moro mi
diede le indicazioni per impartire all'arrestato le istruzioni su ciò che doveva
e su ciò che non doveva dire al magistrato. Il generale fu messo in libertà e
delicati segreti di Stato non furono rivelati al magistrato, con e senza
password! E Lei, il dottor Spataro non c'era, perché si allietava a fare già i
girotondi contro i futuri Ds, quando il Pci si fosse trasformato in essi! Quando
diventai ministro dell'Interno, il capo dell'Ispettorato Antiterrorismo mi disse
che potevamo fare un "colpo" catturando un terrorista (pardon, un "resistente
rosso"!), rapendolo con la forza da un Paese confinante. Diedi l'autorizzazione,
i nostri ragazzi penetrarono in "territorio amico", localizzarono il "rapendo",
ebbero con lui un conflitto a fuoco e lo trasportarono di forza in territorio
nazionale. Al processo il terrorista tacque perché su nostra richiesta il
magistrato gli aveva promesso un trattamento di favore. Lei, dottor Spataro
fortunatamente non c'era, perché si riposava dai girotondi. Sempre io giovane e
spregiudicato ministro dell'Interno, mi feci consegnare da un mio più giovane
collega straniero in un aeroporto militare di quel Paese un gruppetto di
terroristi di destra (questi "delinquenti", e non "resistenti"), e li feci
riportare in Italia senza le complicazioni di domande di estradizione e simili.
Sempre ministro dell'Interno, escogitai un sistema per far fermare e interrogare
sospetti terroristi o loro fiancheggiatori, per i quali i magistrati proprio non
ci potevano concedere mandati di arresto e cattura o confermare fermi di polizia
giudiziaria (solo dopo un paio d'anni riuscii infatti a far reintrodurre il
fermo di polizia, con l'aiuto dei comunisti). E Le racconto un'altra cosa
ancora, dottor Spataro. Nella calca delle grandi città, nostri ragazzi dell'Arma
o della Polizia facevano scivolare buste di cocaina o di altra droga (in modica
quantità!) nelle tasche del ben-capitato di turno. Qualche metro dopo una
squadra della Guardia di finanza in divisa, che si trovava per caso di passaggio
per servizio antidroga, fermava il sopraddetto, lo perquisiva, gli trovava la
droga e lo portava in caserma dove, dopo un sommario interrogatorio sul possesso
di droga, insieme a carabinieri o agenti di polizia dell'antiterrorismo in
borghese il bencapitato veniva interrogato su fatti di terrorismo... con minor
dolcezza! Gli Spataro non c'erano: erano i tempi degli Occorsio, dei Sica e dei
Di Matteo..., quelli che con seri politici, soprattutto democratico-cristiani e
comunisti, sconfissero il terrorismo (perdono! La "resistenza"!). Chissà quanti
ostacoli alla lotta contro il terrorismo rosso ci avrebbe messo il girotondino
Spataro, allora con baffi meno bianchi! Andiamo avanti con i ricordi. Dopo un
devastante attacco terrorista contro obiettivi israeliani a Fiumicino (il "patto
Giovannone" non venne violato!), dopo che gli "steward" e le "hostess" della
El-Al fecero fuori tre o quattro terroristi la polizia italiana riuscì a
catturarne uno, ferito. Il sostituto procuratore e il capo di una sezione
antiterrorismo che mi incontrarono nell'obitorio dove ero andato a rendere
omaggio alle salme dei cittadini israeliani (mi scusi, qualche girotondino
direbbe "sporchi sionisti"!) uccisi, mi chiesero se ritenessi opportuno che, con
l'aiuto degli anestesisti, gli agenti dessero una "strizzatina" al ferito per
farlo parlare, in presenza del magistrato della procura di Roma, che
naturalmente non era girotondino ma della sinistra vera. Il consiglio di dare
strizzatine ai terroristi detenuti mi era stato dato anche da un grande capo
partigiano, "icona" del Pci e leninista di ferro. Risposi che mi sembrava
un'ottima idea. Così fu fatto: e la magistratura "mise dentro" un bel po' di
complici dei terroristi (pardon, di resistenti contro il sionismo). Il
"resistente" fu condannato all'ergastolo e fu poi oggetto di uno scambio. Lei,
dottor Spataro non c'era, perché aveva ripreso gli allenamenti di girotondo!
Avendo avuto forti insegnanti di diritto costituzionale e di diritto penale (sì,
mi sono laureato in diritto penale ottenendo il voto di 110 su 110 e lode, con
dignità di stampa!) conosco che cosa sia la legalità ordinaria e la legittimità
istituzionale dei tempi di guerra. Non si affanni a fare indagini, dottor
Spataro, perché è tutto prescritto... In conclusione: io, democratico,
antifascista e antiterrorista, ringrazio gli agenti del Sismi, quelli della Cia
(sì, anche quelli della Cia con le "extraordinary rendition") del Security
Service, quelli della BND, quelli dell'SFB che hanno fatto (complimenti!) il bel
colpo contro il capo terrorista ceceno. Li ringrazio per il contributo che
danno, anche con metodi spicci, alla lotta contro il terrorismo islamico
(pardon, la resistenza islamica!) Spero che Clemente Mastella riesca a salvarsi
dalla stretta della lobby politicosindacale dell'Associazione Nazionale
Magistrati e a rifiutarsi di inoltrare la domanda di estradizione degli agenti
Cia che Lei - insieme al non girotondino conoscitore delle "carte di
Montenevoso" - inoltrerete agli Stati Uniti. Spero che Mastella riesca ad
evitare che dall'altra parte dell'Atlantico ci arrivi una pernacchia imperiale!
Sa che cosa mi duole di tutta questa vicenda, dottor Spataro? Che né il governo
né il Sismi abbiano dato una mano alla Cia, come quasi tutti gli altri Stati e
servizi di intelligence europei hanno fatto! Con sincera cordialità.»
FRANCESCO COSSIGA: «Adesso le
dico un segreto, quando venne in Italia Arafat per i funerali di Berlinguer, nei
suoi confronti c'era un ordine di cattura emesso dal giudice Mastelloni. Avevamo
paura che ci arrestassero Arafat, e io allora ero presidente del Senato lo
nascosi insieme ai suoi all'interno dell'allora mio appartamento al Senato, e
depistammo i carabinieri che avevano avuto l'ordine dal giudice Mastelloni di
eseguire il mandato di cattura. Adesso lo si può dire».
Lo sa che Cossiga per far
partecipare Arafat ai funerali di Berlinguer lo nascose al Senato?
CARLO MASTELLONI - Procura di
Venezia: «Non mi meraviglio perché si mosse tutta una macchina, in maniera
abbastanza violenta, virulenta. Io ricevetti perquisizioni per scoprire quali
fossero le mie idee politiche, fu un episodio molto doloroso. Da una parte si
può anche capire le motivazioni politiche che spingono un parte politica ad
intervenire, dall'altra bisogna andare sempre dritti per fare il proprio
dovere.»
BERNARDO IOVENE:
«Tra
l'organizzazione per la liberazione della Palestina e l'Italia c'era un accordo
segreto che aveva fatto Aldo Moro. Un accordo ancora oggi sconosciuto».
FRANCESCO COSSIGA: «Non si è
mai saputo, io non ho mai conosciuto i termini reali dell'accordo che fece Moro
con l'OLP, ma tale accordo prevedeva che quando furono arrestati dei
guerriglieri arabi con dei lanciamissili terra-aria destinati ad abbattere un
aereo di linea israeliano a Fiumicino, questi su richiesta dell'OLP furono
portati a Malta e liberati».
BERNARDO IOVENE:
«In pratica furono
beccati dei terroristi palestinesi con dei missili terra aria per abbattere un
aereo israeliano e in barba alle leggi italiane furono riaccompagnati a casa».
E ritorniamo al segreto di
Stato, quanto dura?
GIUSEPPE DE LUTIIS -
Consulente Commissione Stragi: «Attualmente i segreti dei servizi sono eterni a
meno che un presidente del Consiglio non decida di farne decadere qualcuno in
specifico».
Da spararsi un colpo in testa,
ragazzi!
Il super-consulente Usa di
Cossiga che
voleva la morte di Aldo Moro,
scrive il 13 novembre 2014
“Bergamo Post". Un coinvolgimento del governo americano nell’uccisione di Aldo
Moro, precisamente nella persona di Steve Pieczenik. Sembra la trama di un libro
giallo di fantapolitica, in realtà è quanto emerso dalla richiesta di
archiviazione di un nuovo filone su via Fani, redatta dal procuratore generale
della Corte d’appello di Roma Luigi Ciampoli. Nelle cento pagine del documento,
il magistrato ha chiamato in causa Pieczenik – ex funzionario del Dipartimento
di Stato Usa e superconsulente del governo italiano e in particolare del
ministro dell’Interno Cossiga, ai tempi del sequestro di Moro – chiedendo alla
procura l’apertura di un procedimento formale a suo carico per “concorso
nell’omicidio del presidente della Democrazia Cristiana, commesso a Roma il 9
maggio 1978″. A carico di Pieczenik, secondo Ciampoli, ci sarebbero “gravi
indizi” di colpevolezza. Il funzionario americano, nei 55 giorni del sequestro
Moro sedeva al tavolo del Comitato di crisi come inviato informale degli
Usa. Pieczenik in un libro aveva già “confessato” il suo ruolo nello spingere le
Brigate Rosse ad assassinare il leader Dc.
Il coinvolgimento di Pieczenik. Durante
quei quasi due mesi di febbrili trattative, arrivarono da tutto il mondo esperti
di antiterrorismo per coadiuvare il governo italiano nel tentativo di liberare
Aldo Moro. Fra questi professionisti figurava anche Pieczenik, esperto di
terrorismo che ottenne in breve tempo un ruolo di assoluta rilevanza nelle
trattative, vista sicuramente la sua esperienza nonché per il fatto di non
conoscere personalmente Moro e di non essere parte del sistema politico
italiano, cosa che lo sollevava da qualsiasi tipo di possibile faziosità o
pregiudizio. Come ben noto, nulla si riuscì a fare, e Aldo Moro venne ucciso
dalle Brigate Rosse. Ma è proprio nel periodo delle trattative che la figura di
Pieczenik assume un ruolo primario: secondo quanto asserito dal procuratore
generale Ciampoli. Gli Stati Uniti avrebbero invitato Pieczenik in Italia non
tanto per collaborare nel tentativo di ottenere la liberazione di Moro, quanto
per capire cosa fosse meglio che accadesse in seguito al rapimento: le Br, e in
generale il terrorismo rosso, stava prendendo sempre più piede in Italia, la DC
appariva debole e divisa al suo interno, cosa che avrebbe potuto portare ad una
ascesa al governo del Pci. Gli Usa intendevano scongiurare in ogni modo questa
eventualità, e colsero l’occasione per portare direttamente sul territorio un
uomo di fiducia. In breve tempo, Pieczenik capì che l’unico modo per mettere le
Br definitivamente con le spalle al muro e far capire agli italiani la
pericolosità del comunismo, fosse che Moro venisse ucciso. Sempre secondo il
fascicolo di Ciampoli, Pieczenik, oltre a non prodigarsi con particolare impegno
nelle ricerche e nelle indagini, pare che fosse anche in contatto diretto con le
Br, nel tentativo di persuadere i terroristi a non liberare Moro.
Pieczenik, ma non solo. Quella
del funzionario americano, benché estremamente rilevante, non è l’unica figura
oscura coinvolta nell’omicidio di Aldo Moro: pare che, con l’intento di
destabilizzare la situazione già tesa in Italia, fossero coinvolti anche agenti
segreti di vari Paesi, addirittura dello stesso governo italiano. Uno di questi
è il colonnello Camillo Guglielmi, all’epoca in forza al Sismi (il servizio
segreto militare italiano), che il giorno della strage di via Fani, il 16 marzo
1978, pare fosse presente sulla scena del sequestro, a cavallo di una moto
Honda. Più volte negli anni gli era stato chiesto di dar ragione della sua
presenza, e sempre aveva risposto di essere passato di lì per caso, diretto a
pranzo da un collega; versione smentita proprio dal collega, che confermò la
visita ma negò il pranzo. La strage avvenne alle 9 del mattino. Guglielmi è
morto, e non è quindi nemmeno più possibile, oltre che carpire nuove e decisive
informazioni, aprire nei suoi confronti un procedimento penale. Secondo
Ciampoli, per Guglielmi avrebbe potuto ipotizzarsi il concorso nel rapimento e
nell’omicidio degli uomini della scorta. Tantissimi i dubbi quindi, esistenti
ancora oggi, circa la vicenda che ha portato all’assassinio del presidente della
Dc e degli uomini della sua scorta. Ora riprende quota la pista internazionale e
più si aggiungono tasselli, più la questione si fa inquietante, con tante
persone e governi impegnati nel raggiungere qualsiasi obiettivo tranne che, a
quanto pare, quello di salvare la vita di Aldo Moro.
Il sequestro e la
morte di Aldo Moro. Presidente della
Democrazia Cristiana, protagonista della vita politica italiana nel Dopoguerra,
fautore del dialogo con il Partito comunista italiano, Moro venne sequestrato a
Roma il 16 marzo 1978, mentre si trovava a bordo di una Fiat 1500 insieme alla
sua scorta, diretto alla Camera dei Deputati. In prossimità dell’incrocio fra
via Fani e via Stresa, un commando delle Brigate Rosse intercettò l’automobile,
uccise tutte le guardie del corpo, e sequestrò lo statista. Da quel momento in
poi, per 55 giorni, si tentò in ogni modo di trovare una via di mediazione con
le BR, che fin da subito rivendicarono l’accaduto, ma l’esito della vicenda fu
tragico: il 9 maggio 1978, il corpo senza vita di Aldo Moro venne trovato nel
portabagagli di una Renault 4 rossa presso via Caetani, a pochi passi dalla sede
romana della DC.
Sequestro
Moro, l'ombra di Mossad e Cia. Trovati gli appunti inediti di Spadolini: nelle
carte spuntano i servizi israeliani e statunitensi,
scrive
Fabrizio Colarieti il
13 Ottobre 2015 su “Lettera
43”. Riguarderebbero anche il
coinvolgimento del Mossad e dell’intelligence americana nel sequestro Moro i
documenti acquisiti a Firenze, nella sede della Fondazione Giovanni Spadolini,
dalla Commissione parlamentare d’inchiesta che indaga sul rapimento e l’omicidio
dello statista democristiano. Si tratta di appunti inediti, annotati su diversi
block notes dallo stesso Spadolini nel corso di alcuni colloqui privati con l’ex
presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Gli appunti, che risalirebbero
all’ottobre del ‘90, a quanto riferiscono fonti parlamentari, sono stati
scoperti prima dell’estate dal magistrato Antonia Giammaria, consulente della
stessa Commissione Fioroni, e conterrebbero importanti elementi sul contesto in
cui si consumò la tragedia di Aldo Moro e sul possibile coinvolgimento dei
servizi segreti israeliani e statunitensi. Tutti gli appunti sono stati perciò
acquisiti dalla Commissione e saranno digitalizzati e restituiti alla Fondazione
Spadolini. La circostanza che i documenti in questione fossero custoditi
all’interno di un armadio blindato, anziché tra i fondi dell’archivio personale
di Spadolini, lascia intendere che il contenuto di quelle carte fosse stato in
quale modo classificato o comunque soggetto a restrizioni, pare per un periodo
di 50 anni. A quanto riferisce l’agenzia Ansa, che ha dato la notizia del
ritrovamento, tra le carte acquisite c’è anche una lettera di Cossiga, già nota,
che ricostruisce l'atteggiamento del Pci subito dopo la diffusione della prima
lettera di Moro, con il passaggio di Ugo Pecchioli: «L'onorevole Moro sia che
muoia sia che torni dalla prigionia per noi è morto». Ma anche riferimenti ai
rapporti tra alcuni politici italiani e le intelligence straniere. Gli appunti,
da una prima lettura di cui dà conto l’Ansa, sintetizzano il disappunto di
Spadolini rispetto alla nomina di Moro a capo del governo. L’esponente
repubblicano, che durante il sequestro era il segretario del Pri, aveva
sostenuto che oltre alle lettere scritte da Moro durante la prigionia e
successivamente rese note ve ne fossero sicuramente delle altre. Spadolini
riporta anche la posizione socialista che ipotizzava nella scoperta delle carte
di Moro un’iniziativa dei servizi americani o israeliani. «Ci sono molte carte
segrete perché riguardanti aspetti delicati della politica. Non memorie o altro
ma corrispondenza oppure, come in questo caso, resoconti sbobinati di colloqui
registrati», ha spiegato all’Ansa Cosimo Ceccuti, responsabile della Fondazione
Spadolini. «Spadolini è morto da 21 anni ma stiamo ancora ordinando alcune carte
e stiamo messo in ordine i 100 mila volumi della sua biblioteca. Il magistrato
ha esaminato il settore delle carte segretate e a sua discrezione ne ha estratte
alcune. La selezione è stata fatta tra le carte che erano in cassaforte».
''Aldo Moro, patto con i palestinesi per evitare attentati in
Italia'',
scrive il 16 Ottobre 2015
Stefania Limiti.
''La Cia impedì le trattive e ordinò la sua morte''.
Intervista
esclusiva a Bassam Abu Sharif, ex leader del Fronte popolare per la liberazione
della Palestina. Negli anni Settanta, sostiene, lo statista voleva liberare il
Paese dalla "subdola dominazione statunitense". E almeno una volta "incontrò i
vertici dei nostri servizi" per avere rassicurazioni che non saremmmo stati
colpiti da attentati. Dopo il sequestro da parte delle Brigate rosse, "fummo
contattati da Roma e facemmo ogni tentativo per salvarlo. Ma una terza parte lo
impedì".
Ancora oggi va su e giù per il Medio
Oriente il
vecchio capo del Fronte
popolare per la liberazione della Palestina, Bassam
Abu Sharif.
Tu sai che è a Beirut, arrivi lì ma lui parte. Poi vai a Gerico, dove abita, ma
lui scappa in un’altra delle città infuocate di questo pezzo di terra devastato:
però alla fine accetta, grazie agli auspici di un comune amico, alto dirigente
del Comitato nazionale per il Diritto al ritorno, e risponde alle domande di
ilfattoquotidiano.it in una lunga conversazione telefonica che si snoda in varie
tappe per un mesetto circa. Gli spiego che voglio riportarlo indietro nel tempo,
quando lui era uomo chiave dei rapporti internazionali dei palestinesi, e che
qui da noi il dibattito sull’amicizia dell’Italia per il suo Paese è sempre
aperto e ruota attorno a una figura chiave, quella di Aldo
Moro.
“Eh sì … ovvio …”, mi dice interrompendomi, “Moro è stato un vero patriota”.
Dunque, per favore, ci aiuta a capire meglio cosa accadde tra l’uomo del
compromesso storico e i dirigenti palestinesi? “Lo faccio volentieri” dice, ma
subito premette: “Non insista troppo sulle date… ah le date! Sapesse quante
carte sono andate perdute a Beirut durante la guerra civile, e poi i nostri
spostamenti. Tutto è successo troppo tempo fa e i segni della guerra sul mio
corpo sono ben chiari”. Mr Sharif è incappato in un pacco bomba che gli fu
recapitato nel 1972 a Beirut e gli sfigurò il volto, portandogli via la mano
destra. “Moro – mi spiega – voleva rendere l’Italia più forte economicamente,
politicamente e anche, in un certo senso, tecnologicamente. Voleva rendere
l’Italia libera dalla subdola
dominazione statunitense.
Era consapevole che nel vostro paese venivano fatte azioni
illegali alle
spalle degli stessi ufficiali italiani. Era perfettamente informato di cosa
accedeva nelle basi aeree e navali della Nato e
degli Usa che voi ospitavate. Gli americani arrivarono al punto di avere le loro
prigioni segrete in Italia. Mi pare che recentemente la cosa è diventata
pubblica, non è così?”. Solo in parte, gli dico, pregandolo di ritornare
indietro nel tempo: “Sì, sì ha ragione, Aldo Moro. Era un italiano orgoglioso,
provò a rafforzare i servizi segreti che considerava una istituzione
fondamentale per sostenere l’azione dei governi: credeva che le scelte
dell’Italia, nel rispetto degli interessi nazionali degli italiani, spettassero
solo ai suoi governi. E noi lo rispettavamo moltissimo per questo suo
temperamento”.
I vostri rapporti con Moro passavano solo attraverso il
colonnello Giovannone (dal 1972 referente dei Servizi, o almeno di una parte di
essi, in Libano)?
“E’ noto che il ruolo di
Stefano Giovannone fu centrale ma l’approccio di Moro alla questione palestinese
fu il risultato di una serie d’iniziative coraggiose prese da alcuni ufficiali
della vostra intelligence che conoscevano molto bene Beirut negli anni ’70.
All’inizio erano contatti tesi a realizzare iniziative di carattere umanitario:
l’invio di aiuti sanitari, di medici volontari o di farmaci. Poi si stabilirono
relazioni politiche più complesse. Ci furono moltissimi incontri tra esponenti
palestinesi e rappresentati dell’Italia, a Beirut e nella vostra capitale Roma.
L’Olp,
per rafforzare la collaborazione, inviò in modo permanente un nostro uomo a
Roma, Abu
Iyad (il
suo nome era Salah Khalaf), il capo dei servizi segreti dell’Olp e una delle
figure preminenti della dirigenza palestinese, anche se Moro …” – Bassam Sharif
non tradisce l’orgoglio della sua vecchia appartenenza – “si rese conto
rapidamente che era necessario intrecciare rapporti con il Fronte popolare di
George Habash per rafforzare la sicurezza italiana. Abu Iyad incontrò diversi
ufficiali e gli diede la sua parola d’onore. Una sola volta anche Aldo Moro
incontrò i vertici dei nostri servizi, insieme a Abu Iyad, per mettere a punto
l’accordo (Lodo
Moro)
che firmò George Habash. Moro sapeva che la strada migliore e più breve per
evitare il coinvolgimento dell’Italia in fatti che non la riguardavano passava
attraverso il Fronte popolare. Così nacque quell’accordo senza precedenti con il
quale noi ci impegnavamo a evitare operazioni militari in Italia. Infatti, da
allora nessuna azione da parte nostra fu condotta sul suolo italiano. L’accordo
guardava anche al futuro”.
In che senso?
“Prevedeva una fase 2,
un’evoluzione dei nostri rapporti; in pratica erano state programmate iniziative
per il rafforzamento della cooperazione sulla base del sostegno italiano al
diritto di autodeterminazione del popolo palestinese. Si pensava a un futuro
nuovo per il Mediterraneo. Fu una vittoria di Moro che gli americani e gli
israeliani non gradirono affatto. Anzi, erano davvero molto arrabbiati, per loro
l’accordo con i palestinesi era un sostegno ai ‘terroristi’. Gli israeliani
volevano usare l’Europa per la loro caccia ai palestinesi: figuratevi se
potevano accettare la politica di Aldo Moro. Di fatto avviarono una guerra
contro di lui e contro l’Italia”.
Lei cosa sa delle trattative condotte per salvare la vita di Aldo
Moro? Qualcuno vi chiese di mediare?
“Di certo so che le Brigate
rosse volevano trattare e liberarlo. Quando Moro fu rapito noi fummo davvero
sorpresi. E lo fummo ancora di più quando apprendemmo della rivendicazione delle
Brigate rosse. Eravamo increduli, davvero le Brigate rosse? Non potevamo
crederci. Nessuno ufficialmente ci chiese qualcosa. Noi ci sentimmo obbligati a
fare ogni tentativo per salvare la vita di Moro, cercammo di fare quanto era in
nostro potere, lo abbiamo sempre detto pubblicamente. La prima telefonata arrivò
nel mio ufficio di Beirut. Qualcuno ci chiese di intervenire e trattare. Non so
chi fosse la persona dall’altra parte, ci diede un numero per tenere i contatti
che fino ad allora non avevamo mai usato. Non so francamente a chi appartenesse
quell’utenza, non so se dall’altra parte ci fosse un agente dei servizi o un
funzionario del ministero, non posso davvero dirlo perché non lo so. Certamente
l’argomento delle nostre conversazioni era la salvezza di Aldo Moro. Per noi
liberare Moro era fondamentale, avevamo di lui un’altissima opinione come uomo e
come politico ed era a favore della nostra autodeterminazione, disapprovava la
politica di Israele ed era molto simile a uno dei leader europei che sentì il
dovere di condannare l’occupazione della Palestina, penso a De Gaulle”.
Quante telefonate ci furono?
“Diverse, l’uomo che chiamò
l’ultima volta ci disse espressamente che i rapitori di Moro lo volevano
liberare, aveva una gran fretta, si sentiva che era sotto pressione, che era in
uno stato di grande ansia, “hurry up, we don’t know what to do”, disse,
sbrigatevi, non sappiamo più che fare”.
E’ vero che all’aeroporto di Beirut era pronto un aereo? Anche
Carlos lo ‘Sciacallo’, il famoso terrorista di nome Ilich Ramirez Sanchez,
reclutato e poi ripudiato da Sharif, parlò di un estremo tentativo di salvare
Aldo Moro che ebbe come scenario la pista dell’aeroporto di Beirut dove un
executive dei servizi segreti italiani attese invano, l’8 e il 9 maggio del
1978, che a Roma si sbloccasse qualcosa: brigatisti liberi contro la vita di
Moro.
“Certamente, l’aereo a Beirut
era pronto. Le Brigate rosse chiesero un accordo che comprendesse l’uso
dell’aereo. Ma tutto fu improvvisamente interrotto nonostante la loro volontà di
rilasciare Moro. Una terza parte, fortemente contraria, anzi intenzionata a
liberarsi di Aldo Moro e della sua politica d’indipendenza, riuscì ad impedire
le trattative. Per questo quel telefono non squillò più”.
Lei sostiene che qualcuno si mise in mezzo, dunque che c’erano
interferenze dirette, infiltrati o contatti in grado di avere notizie su quanto
si stava muovendo?
“La situazione era perfetta
per la penetrazione di un gruppo come le Brigate rosse. In giro per l’Europa
c’erano militanti brigatisti legati a Carlos che stavano cercando di organizzare
un suo gruppo autonomo, dopo la famosa azione di Vienna (l’incredibile assalto
al quartiere generale dell’Opec organizzato da Carlos nel 1975) e la spaccatura
con Wadi Haddad (un attivista espulso dall’Olp nel 1973). La situazione di quei
gruppi era porosa e offriva l’opportunità di forti, fortissime infiltrazioni. La
Cia giocò un ruolo eccezionale nella penetrazione di questi gruppi in Europa,
era una partita che giocava in proprio, senza avvisare i governi europei,
ovviamente. Insisto: ordinarono la morte di Moro. Intervennero per interrompere
le trattative che erano ancora in corso, erano quasi fatte. Certamente chi ha
ammazzato Moro non era amico della nostra lotta di liberazione. Ed ora mi scusi,
devo salutarla, ho troppo da fare, qui siamo dentro una nuova Intifada. Gli
israeliani stanno diventando selvaggi: sparano direttamente sui bambini, qui da
noi c’è l’orrore”.
IL SEQUESTRO MORO E
L’UNIONE SOVIETICA.
Il KGB che spiava Aldo
Moro, il Sismi che lo sapeva ma non avvertì la magistratura,
i due «fronti di ...scrive "Il Tempo" il 10/03/2003. Un quarto di secolo dopo il
rapimento e l'assassinio dello statista democristiano e il massacro della
scorta, sul «caso Moro» continuano ad aleggiare molti, troppi
misteri. L'ufficiale del Kgb. Sergej Fedorovic Sokolov, ufficiale del servizio
segreto sovietico, spiava Moro alla Sapienza già un mese prima del sequestro,
spacciandosi per studente. A sua volta era controllato dagli 007 del Sismi. Il
suo nome emerse dal dossier Mitrokhin nel '98 anche se l'assistente del
presidente Dc Franco Tritto denunciò la sua presenza sospetta intorno allo
statista già il 16 marzo 1978. Sokolov chiese informazioni sulla scorta di Moro
nel febbraio di quell'anno. Poi scomparve nel nulla e, il 23 marzo rientrò
precipitosamente in Unione Sovietica per tornare in Italia nell'81. Per lui la
procura di Roma ha chiesto l'archiviazione non essendo «possibile dimostrare il
coinvolgimento» dell'uomo nella vicenda. «Perché il Sismi - si chiede oggi
Ferdinando Imposimato, giudice istruttore nelle inchieste sulla strage e il
rapimento - ha taciuto alla magistratura l'esistenza di un fascicolo su Sokolov
mentre era in corso il sequestro?». La dinamica della sparatoria. Il consulente
balistico della procura sostenne fin dall'inizio la tesi del fuoco incrociato di
cui restarono vittima gli uomini di scorta in via Fani. Gli ex Br sostennero il
contrario. «Sia nella prima consulenza per la procura nell'immediatezza del
fatto, sia nelle perizie balistiche eseguite successivamente in sede
dibattimentale e istruttoria scrissi che nell'agguato di via Fani per rapire
Moro, vi fu un fuoco incrociato da parte delle Brigate Rosse. Lo dimostravano i
fori dei proiettili e il numero delle armi», spiega il professor Antonio
Ugolini. Almeno sull'auto del presidente, il fuoco fu aperto da destra e da
sinistra della strada. Per Ugolini, inoltre, i famosi 49 colpi «con
verosimiglianza furono sparati da una sola pistola mitragliatrice utilizzando
due caricatori, mettendo a segno buona parte dell'operazione. Tanto che sul
posto venne trovato un caricatore con alcune cartucce, dimostrando che l'arma si
era inceppata». Aggiunge Ugolini: «i caricatori della pistola mitragliatrice Fna
43 erano da 32 o 36 colpi ed uno, come noto, fu estratto perchè l'arma si era
inceppata». Invece, ancora nel 1997, in commissione Stragi, Valerio Morucci,
affermò che gli «Fna a sparare erano due», aggiungendo quindi che «la perizia
balistica ha accomunato i colpi sparati da entrambe le armi». I covi. Per
Alfredo Carlo Moro, fratello della vittima e magistrato, si è tuttora in
presenza di «elementi dubbi» e la versione dei brigatisti è «fantasiosa e
illogica». La Renault 4 nella quale venne rinvenuto il cadavere di Moro era in
via Montalcini, dove fu vista da un'inquilina, e «raggiunse la sede della vera
prigione, che era fuori Roma ma vicina alla Capitale. In questa sede - sostiene
Carlo Moro - avvenne l'uccisione e la Renault tornò in via Caetani verso
mezzogiorno». Per quanto riguarda via Gradoli, invece, la scoperta del covo
viene definita da Carlo Moro un fatto «enigmatico».
Delitto Moro: spunta la
pista russa,
scrive Natalia Poggi il 3/04/2013 su "Il Tempo". Dopo 35 anni la morte dello
statista dc è ancora un mistero Perché le Br poche ore prima del rilascio lo
uccisero? Sono passati trentacinque anni dal tragico 9 maggio 1978 quando il
corpo senza vita dello statista democristiano Aldo Moro, rapito 55 giorni prima
da un commando delle Brigate Rosse, fu trovato senza vita nel portabagaglio di
una Renault 5 parcheggiata in via Caetani. In tutti questi lunghi anni sono
venute a galla tante verità, oltre a quella ufficiale che vede nel drammatico
epilogo il triste e ineluttabile esito della linea della fermezza propugnata dal
governo d’allora, ma ancora nessuna certezza. Un libro appena uscito «La zona
franca» (ed. Castelvecchi) del giornalista Rai Alessandro Forlani le ha
raccolte, analizzate, confrontate nel tentativo di dipanare la matassa del
giallo e dei misteri che ancora lo ammantano. Il libro di Forlani è il frutto di
dieci anni di certosino e appassionato lavoro durante il quale ha raccolto
documenti, libri, articoli di giornali, i preziosi racconti dei testimoni di
allora. Alcuni di loro nel frattempo sono scomparsi. Come Corrado Guerzoni,
portavoce storico di Moro e Sereno Freato, uno dei segretari. «L’ho saputo per
caso proprio ieri - dice Alessandro Forlani - Freato è morto il 18 marzo scorso
ma la famiglia non ha divulgato la cosa».
Un preambolo: il 16 marzo
scorso (nello stesso giorno di 35 anni fa Aldo Moro fu rapito in via Fani dalle
Brigate Rosse che trucidarono i 5 uomini di scorta) lei è stato visto
all’udienza di Papa Francesco, unico tra i giornalisti presenti a stringere la
mano del neopapa direttamente sul palco, per esplicita richiesta di Bergoglio
che ha anche accarezzato il suo cane guida Asia. Che vi siete detti?
«Solo un saluto affettuoso. Mi
ero messo in prima fila perché sono non vedente e per Asia non c’era spazio
dietro. Però la coincidenza del giorno mi ha fatto pensare che Moro mi stesse
guardando da lassù e che approvasse il mio lavoro».
Nel quale le Br appaiono
più come comparse che non protagoniste. E si ribadisce l’incongruenza degli
eventi. Infatti nonostante le tre, quattro trattative imbastite per salvare
Moro, la situazione precipitò all’improvviso la mattina del 9 a poche ore dal
previsto rilascio.
«È uno dei tanti misteri della
vicenda. Cosa fece cambiare idea ai brigatisti? Il Vaticano aveva raccolto un
riscatto miliardario (si parla di 25 miliardi). Moro doveva essere rilasciato in
Vaticano nelle prime ore del pomeriggio. Si è detto che i terroristi non
volevano soldi ma non è vero perché il precedente rapimento, quello di Costa,
era basato proprio sui soldi. I servizi segreti italiani avevano imbastito
accordi internazionali di tutto rispetto. Il maresciallo Tito s’apprestava a
riconoscere le Br come un soggetto politico, degli 007 erano volati in
Yugoslavia per prelevare tre esponenti della Raf e trasportarli a Beirut dove un
altro 007 li attendeva su un aereo con altri guerriglieri palestinesi. C’era
pure la volontà del presidente Leone, avallata dalla Dc per scopi umanitari, di
firmare la grazia dei rapitori...»
Invece?
«Quella mattina tra le 9 e le
10 Moro viene assassinato. Io penso non a via Montalcini ma a via Caetani dove
lo statista Dc era stato trasportato qualche giorno prima. Era nascosto dentro
palazzo Caetani. Lo testimoniano anche dei fili di stoffa colorati trovati nelle
suole delle scarpe. C’era un negozio di stoffe là davanti. È probabile che fu
nascosto nel deposito del negozio».
Nel suo libro si sottolinea
anche il ruolo della famiglia Caetani?
«In particolare del pianista
Igor Markevitch, finto rivoluzionario in realtà garante di Jalta per conto del
Kgb, sposato con la principessa Topazia Caetani e abitante nel palazzo.
Markevitch è il classico profilo dell’agente doppio. Inoltre si sa che durante
la prigionia Moro sia stato nascosto per un certo periodo in una casa vicino al
mare molto aristocratica e piena di statue antiche. Penso che si tratti di un
palazzo a Palo Laziale disabitato all’interno di un parco di pertinenza del Wwf
e legato a Markevitch. I Caetani sono sempre stati dei mecenati e di sinistra. I
servizi segreti avevano a suo tempo rilevato anche contatti tra gli
aristocratici e i brigatisti».
Si delinea una spy-story
con servizi deviati, Cia e Kgb. Ma a chi faceva comodo la morte di Moro?
«Secondo il sottosegretario
dell’epoca Franco Mazzola ci fu una convergenza di interessi. La Russia non
poteva accettare che un partito comunista salisse al potere con elezioni
democratiche rinunciando al sogno della rivoluzione. Per gli americani era
inaccettabile che i comunisti avessero accesso alla stanza dei bottoni in un
paese occidentale. Tuttavia se Moro fosse uscito vivo dalla sua prigione avrebbe
abbandonato il compromesso storico visto che il Pci si era opposto alla sua
liberazione. È un mistero chi e cosa Moro abbia visto durante la prigionia. Di
sicuro sarebbe diventano una mina vagante per gli equilibri interni e
internazionali». Natalia Poggi
A Mosca la verità sulla
morte dello statista. Stretti legami tra le Br e gli agenti del KGB,
scrive su "Il Tempo" il 17/03/2015 Antonio Selvatici. "Nel luglio del 1977 c’è
stato un incontro tra le Br e il KGB a Mosca": sono gli archivi dell’Est che
parlano. "Nel luglio del 1977 c’è stato un incontro tra le Br e il KGB a Mosca":
sono gli archivi dell’Est che parlano. La nuova inchiesta voluta dai familiari
delle vittime di via Fani ed ora sulla scrivania del Procuratore generale presso
la corte di Appello del Tribunale di Roma Antonio Marini riguardante il
rapimento di Aldo Moro e l’uccisione degli uomini della scorta non può e non
deve concentrarsi solamente su quanto in quegli anni è accaduto in Italia. Il
recinto del terrorismo era più ampio. Allora, quando la fumante P38 era un
simbolo ed uno strumento di morte gli investigatori per cercare di arginare il
fenomeno non si sono molto concentrati sulle ricerche oltre confine. Ora, dopo
la caduta del Muro e la conseguente apertura degli archivi, sappiamo che uomini
delle Brigate Rosse hanno avuto frequenti rapporti sia con altri gruppi
terroristici, sia con agenti dell’Est comunista, sia con uomini del Pci conviti
che la Resistenza del dopoguerra li «aveva traditi» non compiendo l’atto finale.
Negli anni passati «sprovincializzare» le inchieste del terrorismo degli Anni di
Piombo poteva significare affrontare o scontrarsi con noti ostacoli ideologici.
Oggi i tempi sono cambiati. Sarebbe quindi un buon gesto se gli investigatori
italiani che indagano per conto del procuratore Antonio Marini ritrovassero il
testo di una richiesta di rogatoria internazionale partita da un reparto
speciale della polizia di Praga che chiedeva a Roma delucidazioni riguardanti la
mitraglietta Skorpion: la micidiale arma utilizzata per ammazzare Aldo Moro.
Sembra proprio che gli investigatori d’Oltralpe fossero riusciti a mappare il
percorso della Skorpion. Cinque giorni prima che Aldo Moro venisse ucciso il
noto dirigente del Pci Giorgio Amendola consigliò a Vladmir Koucky, l’allora
ambasciatore cecoslovacco in Italia, di essere prudenti nel trafficare con i
terroristi italiani. Era una questione di possibile imbarazzo politico: se si
fosse venuto a sapere che un Paese amico trafficava con i terroristi rossi
italiani, la cosa avrebbe creato difficoltà in casa Pci. Già nella primavera del
1976 il dirigente del Pci Salvatore Cacciapuoti si recò a Praga per comunicare
ai cecoslovacchi che due brigatisti avevano raccontato al loro legale che erano
stati addestrati in Cecoslovacchia. La figlia Alba di Salvatore Cacciapuoti ha
successivamente confermato l’accaduto: «mio padre era stato incaricato da Enrico
Berlinguer di denunciare al governo cecoslovacco l’appoggio del suo servizio
segreto alle Brigate rosse». I documenti custoditi negli sterminati archivi
suggeriscono scenari poco considerati. Ad esempio, un documento della Stasi ci
dice che nel settembre del 1978 si tenne a Dubrovnik in Jugoslavia il «Congresso
segreto internazionale» dove erano presenti i rappresentanti di alcune
organizzazioni terroristiche tra cui Settembre nero, FPLP di Wadi Haddad, le RAF
e, naturalmente, le Brigate Rosse. Un altro documento: «nel luglio del 1977 c’è
stato un incontro fra le Br e il Kgb a Mosca». Gli uomini della Stasi
raccoglievano informazioni sui brigatisti italiani. Alcuni di loro (Renato
Curcio, Lauro Azzolini, e Barbara Balzerani) sono intestatari di schede che ho
potuto visionare. Su alcune di queste (allora non si usava il computer) vi è una
nota, talvolta vergata a penna altre scritta a macchina, il cui testo è chiaro:
«Album di amici sul terrorismo internazionale». Tale album è un elenco di
terroristi compilato dal Kgb in forma di libro. Ma allora, chi era amico di chi?
Poi un mistero, vi è un documento scomparso. È quello dell’«Archivio Moro» che
troviamo citato nel retro della scheda di Valerio Morucci. Lo stesso archivio di
Berlino suggerisce anche che Giorgio Bellini «in base alle nostre conoscenze
manterrebbe un collegamento continuativo con Carlos per conto delle Brigate
Rosse». Carlos, vale a dire Ilich Ramìrez Sànchez, noto terrorista
internazionale una volta a capo del gruppo «Separat», oggi è detenuto in Francia
dove sta scontando l’ergastolo. Ed a Bettola, piccolo paese dell’Appennino
piacentino noto per essere il luogo in cui è nato Pier Luigi Bersani, ha vissuto
per molti anni sotto falso nome Antonio Expedito Carvalho Perera, poi
riconosciuto come un fiancheggiatore di Carlos. Sappiamo che le Brigate Rosse
venivano rifor nite di armi dai palestinesi. Non dimentichiamo i rapporti tra
Mario Moretti e Abu Iyyad, la collaborazione è stata così descritta in un testo
di terrorismo internazionale: «l’Olp consegna armi alle Br; membri delle Br
hanno il permesso di addestrarsi nei campi palestinesi in Medio Oriente; l’Olp
offre assistenza ai membri Br fuggitivi; le Br immagazzinano armi in Italia
perché possono essere usati dall’Olp; le Br parteciperanno ad attacchi contro
individui israeliani in Italia». Il 9 marzo 1982, durante un’udienza del
processo al rapimento del generale americano James Lee Dozier, il brigatista
Antonio Savasta ammise: «il rappresentante dell’Olp chiarì che il contatto con
noi era stato richiesto per costruire un fronte di lotta contro Israele da noi,
e con la Raf, in Germania. In seguito a ciò l’Olp ci inviò armi e esplosivo
plastico». Antonio Selvatici
PARLA ELEONORA CHIAVARELLI
IN MORO.
16 marzo 2010 – Le lettere di
Aldo Moro a sua moglie. È morta Eleonora Moro, che cercò di salvare la vita a
suo marito. Lui le scrisse lettere dolorose e bellissime, scrive “Il Post" del
19 luglio 2010. L’altro ieri è
morta Eleonora Chiavarelli Moro: si è saputo ieri sera. Aveva 94 anni, era stata
la moglie di Aldo Moro, protagonista privata di tutta la vita del politico
democristiano fino al suo assassinio da parte delle Brigate Rosse il 9 maggio
1978, e protagonista pubblica dei quasi due mesi del suo sequestro con i suoi
disperati tentativi di ottenere aiuto per salvare la vita di suo marito. E con
le emozionanti lettere che Aldo Moro le scrisse in quei giorni. La Stampa oggi ripubblica un’intervista
a Eleonora Moro di due anni fa, il Post ripubblica alcune lettere scritte da
Aldo Moro sotto sequestro.
"Mia carissima Noretta,
Desidero farti giungere nel giorno di Pasqua, a te ed a tutti, gli auguri più
fervidi ed affettuosi con tanta tenerezza per la famiglia ed il piccolo in
particolare. Ricordami ad Anna che avrei dovuto vedere oggi. Prego Agnese di
farti compagnia la notte. Io discretamente, bene alimentato ed assistito con
premura. Vi benedico, invio tante cose care a tutti e un forte abbraccio. Aldo".
"Mia Carissima Noretta, vorrei
dirti tante cose, ma mi fermerò alle essenziali. Io sono qui in discreta salute,
beneficiando di un’assistenza umana ed anche molto premurosa. Il cibo è
abbondante e sano (mangio ora un po’ più di farinacei); non mancano mucchietti
di appropriate medicine. Puoi comprendere come mi manchiate tutti e come passi
ore ed ore ad immaginarvi, a ritrovarvi, ad accarezzarvi. Spero che anche voi mi
ricordiate, ma senza farne un dramma. E’ la prima volta dopo trentatré anni che
passiamo Pasqua disuniti e giorni dopo il trentatreesimo di matrimonio sarà
senza incontro tra noi. Ricordo la chiesetta di Montemarciano ed il semplice
ricevimento con gli amici contadini. Ma quando si rompe così il ritmo delle
cose, esse, nella loro semplicità, risplendono come oro nel mondo. Per quanto mi
riguarda, non ho previsioni né progetti, ma fido in Dio che, in vicende sempre
tanto difficili, non mi ha mai abbandonato. Intuisco che altri siano nel dolore.
Intuisco, ma non voglio spingermi oltre sulla via della disperazione.
Riconoscenza e affetto sono per tutti coloro che mi hanno amato e mi amano, al
di là di ogni mio merito, che al più consiste nella mia capacità di riamare. Non
so in che forma possa avvenire ma ricordami alla Nonna. Cosa capirà della mia
assenza? Cose tenerissime a tutti i figli, a Fida col marito, ad Anna col marito
ed il piccolino in seno, ad Agnese, a Giovanni, ad Emma. Ad Agnese vorrei
chiedere di farti compagnia la sera, stando al mio posto nel letto e
controllando sempre che il gas sia spento. A Giovanni, che carezzo tanto, vorrei
chiedessi dolcemente che provi a fare un esame per amor mio. Ogni tenerezza al
piccolo di cui vorrei raccogliessi le voci e qualche foto. Per l’Università
prega Saverio Fortuna di portare il mio saluto affettuoso agli studenti ed il
mio rammarico di non poter andare oltre nel corso. Ricordami tanto a fratelli e
cognati ed a tutti gli amati collaboratori. A Rana in particolare vorrei
chiedere di mantenere qualche contatto col Collegio e di ricordarmi a tutti. Mi
dispiace di non poter dire di tutti, ma li ho tutti nel cuore. Se puoi, nella
mia rubrichetta verde, c’è il numero di M.L. Familiari, mia allieva. Ti prego di
telefonarle di sera per un saluto a lei e agli amici Mimmo, Matteo, Manfredi e
Giovanna, che mi accompagnano a Messa. Ed ora alcune cose pratiche. Ho lasciato
lo stipendio al solito posto. C’è da ritirare una camicia in lavanderia. Data la
gravidanza ed il misero stipendio del marito, aiuta un po’ Anna. Puoi prelevare
per questa necessità da qualche assegno firmato e non riscosso che Rana potrà
aiutarti a realizzare. Spero che, mancando io, Anna ti porti i fiori di
giunchiglie per il giorno delle nozze. Sempre tramite Rana, bisognerebbe cercare
di raccogliere 5 borse che erano in macchina. Niente di politico, ma tutte le
attività correnti, rimaste a giacere nel corso della crisi. C’erano anche vari
indumenti da viaggio. Ora credo di averti stancato e ti chiedo scusa. Non so se
e come riuscirò a sapere di voi. Il meglio è che per risponderne brevemente usi
giornali. Spero che l’ottimo Giacovazzo si sia inteso con Giunchi. Ricordatemi
nella vostra preghiera così come io faccio. Vi abbraccio tutti con tanto tanto
affetto ed i migliori auguri. Vostro Aldo. P.S. Accelera la vendita
dell’appartamentino di nonna, per provvedere alle necessità della sua malattia".
La prima intervista di
Eleonora Moro Dall'archivio de La Stampa.
A trent'anni dalla morte dello statista ucciso dalle Br la vedova ne parlò con
il giudice Imposimato, scrive "La Stampa" il 19 luglio 2010. Questa, a
trent’anni dall’uccisione di Aldo Moro, è la prima intervista rilasciata dalla
moglie Eleonora su quei tragici momenti. Lo sfogo della vedova dello statista
democristiano è stato raccolto da Ferdinando Imposimato, magistrato, docente,
parlamentare, che lo pubblica nel volume “Doveva morire - Chi ha ucciso Aldo
Moro. Il giudice dell’inchiesta racconta”.
Aldo Moro ha scritto: «Le cose saranno chiare, saranno chiare
presto». Lo ha scritto in una delle sue lettere più belle. È una lettera che
rileggo spesso...
«Non lo faccia perché è troppo
triste...»
Quando ho riletto le dichiarazioni che lei ha fatto alla
Commissione Moro, sono rimasto sconvolto. Lei afferma fatti e circostanze con
precisione e verità assolute. Lei denuncia le inerzie del potere.
«Quella gente desiderava
eliminarlo perché era scomodo. La gente scomoda sta dalla parte della giustizia
e della verità. E poi c’è da dire che tutti avevano una paura terribile perché
lui sapeva tutto di tutti, e quindi si sentivano sotto un riflettore che li
inquadrava. Purtroppo non avevano capito che Aldo non avrebbe mai fatto del male
a qualcuno se non fosse stato necessario per il bene comune...».
Nelle sue testimonianze, davanti alla Commissione Moro e alla
Corte di Assise di Roma, lei fa un’affermazione che mi ha colpito. Dice che la
tipografia delle Brigate rosse di via Pio Foà era stata scoperta molti giorni
prima...
«Certo».
Lei domanda: perché, se questa tipografia era stata individuata,
non è stata fatta alcuna perquisizione? E aggiunge: perché i documenti trovati
nell’appartamento brigatista di via Gradoli non sono stati esaminati? Perché
nessuno li ha letti? Perché sono rimasti imballati per tanto tempo? A lei chi
aveva detto tutto questo?
«Erano cose che sapevano
tutti. Le conoscevo io perché ero in contatto con la segreteria di Aldo. E le
conoscevano quelli che avevano potere nel governo. Vede, Aldo Moro era un uomo
che non aveva paura. Camminava verso la sua morte tranquillo, come se andasse a
fare una passeggiata. Quando una persona non la si può corrompere, né
spaventare, l’unica possibilità è quella di eliminarla perché troppo pericolosa.
Aldo conosceva fatti che risalivano a dieci, vent’anni prima. Loro si rendevano
conto di essere i veri prigionieri. E che c’era un’unica cosa da fare:
ucciderlo. Anche perché, conoscendo la profonda onestà di Aldo Moro, erano certi
che egli non aveva lasciato scritto la storia di ognuno di loro su dei pezzi di
carta, consegnandoli a un notaio».
Moro, dopo gli episodi avvenuti in via Savoia, davanti al suo
studio, disse: «Questa è la prova generale».
«Anche gli uomini della sua
scorta, che erano ragazzi buoni, dicevano: “Noi siamo i bersagli di un tiro a
segno”. Lo dicevano continuamente. Quindi Moro e i suoi custodi avevano la
sensazione di essere sotto tiro. Era una sensazione che aveva anche il portiere
di casa nostra. Erano tutti sorvegliati».
Ma perché non ci fu alcun controllo da parte dello Stato?
«Perché lo Stato voleva la
morte di Aldo Moro. Quelli che erano nei vari posti di comando lo volevano
eliminare». Può indicare qualche persona? «Io non posso indicare nessuno. Non li
ho visti operare. Io sono una cristiana e se non ho la prova sicura che quello è
un mascalzone, io non lo accuso. Prego Dio per lui. Prego affinché gli tenga la
Sua santa mano sul capo».
Comunque in quei giorni prima del sequestro c’era una percezione
di pericolo imminente.
«Gli uomini della sua scorta,
e soprattutto l’autista, vivevano con l’idea chiara che un giorno o l’altro li
avrebbero ammazzati. Perché Moro doveva essere ammazzato. Gli uomini della
scorta erano sicuri di essere nel mirino di qualche gruppo, ma non erano
intimoriti. Mi dicevano: “Signora, noi siamo certi del pericolo, ma non morirà
da solo, noi siamo pronti a sacrificarci con lui”».
A un certo punto della sua audizione davanti alla Commissione
Moro, usa questa espressione: «Quei poverini mi hanno detto che era stata
trovata la tipografia delle Br molti giorni prima dell’uccisione di Aldo Moro e
che non era stato fatto nulla». Chi erano quei poverini?
«Credo gli autisti e anche la
sua segreteria. Ad Aldo la gente voleva bene. E tutti quelli che gli volevano
bene non hanno mai smesso di interessarsi alla sua sorte in quei terribili
giorni. Vede, a coloro che lo hanno fatto uccidere non posso stringere la mano.
Se li incontro, li saluto da lontano e filo via rapidamente».
Non riesce a dar loro la mano?
«Io non sono una cristiana
così santa. Sono una cristiana molto semplice...».
E questo accade quando ci sono le cerimonie commemorative?
«Sì. Ma succede anche quando
li incontro per strada».
Quindi quando ci sono le cerimonie lei è costretta a incontrarli?
«Non vado mai alle cerimonie.
Non ci volevo andare quando Aldo era vivo, ma lo dovevo fare come moglie di mio
marito. Figuriamoci adesso. Ma il mondo è piccolo. Incontri la gente quando meno
te l’aspetti. Per esempio: vado al funerale di una mia amica dell’Azione
cattolica, ed ecco che me li trovo lì. Vede, dopo la morte di mio marito mi sono
messa a studiare, dal punto di vista cattolico, la difficoltà del perdono.
Perché uno può dire: li voglio perdonare. E io, nel profondo, li ho perdonati.
Ma quando li vedo, attraverso la strada e vado dall’altra parte. Più che la
morte di mio marito, mi ferisce il fatto che sia morto un innocente a causa
delle perverse mire di quattro stupidi mascalzoni. Se solo fossero stati
modestamente intelligenti avrebbero capito che al potere non si arriva mai
attraverso il delitto».
Aldo Moro si è sacrificato per tutti.
«Io glielo dicevo: guarda come
cammini verso la tua morte. E lui lo sapeva benissimo. Era il suo abito mentale,
il suo modo di vivere. Era un uomo che amava il merito, la pulizia morale,
l’onestà delle persone, la bontà. È un dato di fatto che Aldo, arrivato al
potere, non lo abbia usato per fare del male a qualcuno. Continuamente il male
gli cadeva sotto gli occhi: il tale aveva rubato, quell’altro aveva imbrogliato,
l’altro ancora aveva messo nei guai tutta la famiglia. Lui cercava sempre di
riparare, ma poi cercava di mettere chi aveva sbagliato in un angolino, in modo
che non potesse nuocere più di tanto. In un paese come l’Italia, con la voglia
di fare carriera che hanno tutti, non era poco».
L'Ultima lettera della
vedova Moro,
scrive Flavia Amabile l'8 settembre 2011 su "La Stampa". Scrive ai figli,
rimprovera duramente Anna, Agnese e Giovanni: non avete rispettato la volontà di
vostro padre. Sono cinque fogli protocollo, di quelli usati per i contratti di
acquisto e vendita di una casa. Proprio come in un contratto, o in un atto
legale, le pagine sono numerate a mano e firmate sui lati da lei, Eleonora
Chiavarelli vedova Moro come annota con la sua precisione. Le pagine sono
scritte fitte, con calligrafia spigolosa e sicura, come è stata lei fino
all'ultimo. Le parole sono durissime. La lettera è del 9 gennaio 2006. Se ne
fece fare alcune fotocopie, consegnò l'originale ad un avvocato, e distribuì le
copie a figli ed alcune persone accuratamente scelte. Qualche tempo dopo me la
fece arrivare con la promessa di pubblicarla solo almeno un anno dopo la sua
morte. La considerava una sorta di compensazione per quella che le era parsa
un'ingiustizia subita da me a proposito di un articolo. E anche una naturale
conclusione di un discorso iniziato con il nipote Luca quando avevo raccolto la
sua prima intervista. Eleonora Moro è morta il 19 luglio dello scorso anno e io
della lettera racconterò solo una parte, la meno privata. Il resto appartiene ai
rapporti interni di una famiglia che la vita ha messo a dura prova. I punti che
la vedova Moro ritiene "giusto puntualizzare" sono quattro. Non vale la pena
riportarli per intero ma ruotano tutti intorno ad un'accusa molto pesante: i
figli non hanno rispettato la volontà del padre, Aldo Moro. Nemmeno quella
espressa durante la prigionia attraverso le lettere inviate dal carcere.
Un'accusa è rivolta in modo diretto all'unico figlio maschio, Giovanni,
responsabile di "un gravissimo danno morale", spiega Eleonora Moro. "Si è
ritenuto possessore di un bene di grande valore", ovvero l'ex studio del padre
in via Savoia a Roma. Ma "in quelle stanze doveva trovare sede, come poi è
accaduto, l'"Accademia di Studi Aldo Moro", e ciò ha provocato, con l'esclusione
di gran parte dei componenti della famiglia Moro, un gravissimo danno morale,
con la impossibilità di prendere visione dei documenti contenuti nell'archivio".
Un'altra parte rilevante di accuse riguarda il comportamento di Anna, Agnese e
Giovanni nei confronti del nipote Luca, figlio di Maria Fida, il nipote
amatissimo a cui Aldo Moro scriveva dalla prigionia. Il ricavato dell'archivio
privato ceduto all'Archivio di Stato, "stando al testamento, anzi ai testamenti
redatti da mio marito, doveva andare al nipote Luca per garantirgli la
possibilità di studiare. Invece i miei figli si sono divisi l'importo e se le
sono tenuto a dispetto dell'espressa volontà paterna, volontà di un condannato a
morte con una valenza, quindi, etica di gran lunga superiore". "Inopinatamente i
miei figli - continua la vedova Moro - si sono anche opposti all'aggiunta del
cognome Moro legittimamente richiesta da Luca e che poi lo Stato gli ha concesso
ugualmente". E aggiunge: "Era desiderio di mio marito, come emerge dalle lettere
scritte nel carcere del popolo, concedere il cognome Moro a Luca, il quale
veniva da lui considerato "suo figlio", poiché aveva deciso di adottarlo.
Purtroppo non ha fatto in tempo. Questa circostanza è stata sempre conosciuta da
tutti i miei figli e da tante altre persone vicine alla famiglia". Arrivata alla
fine della quinta pagina, Eleonora Moro conclude con amarezza: "Mi sono sentita
in dovere di precisare questi fatti, sicuramente gravi e spiacevoli, per puro
amore di verità e di giustizia, anche perché ritengo che solo nella verità vi
sia pace. Nella mia vita ho sofferto molti dolori, ma sicuramente nessuno così
grande come quello di vedere la mia famiglia non unita come avrei voluto e
vorrei".
PARLA AGNESE MORO.
Quando la
vittima dice al carnefice: tu stai peggio di me.
Franco Insardà il
15 Dicembre 2019 su Il Dubbio. “Un’azalea in via Fani”, di Angelo Picariello, è
un viaggio nella riconciliazione tra gli ex terroristi e i parenti di chi, come
Moro, è morto negli anni della lotta armata. «Il merito di questo libro è di
aver avuto il coraggio di alzare il velo sui conflitti della nostra storia.
Un’operazione che finora hanno fatto solo l’autore e la vedova Calabresi. In
tanti anni dalla morte di mio padre molti si sono interessati alla vicenda, alla
sua vita, un po’ troppo alla sua morte, spesso in modo sguaiato, però nessuno si
è interessato del dolore che rimane da una parte e dall’altra, quando si chiude
un conflitto. Si tratta di una ferita che nessuno ha mai curato. Mi chiedo:
perché non curiamo il nostro passato?». Lo dice Agnese Moro presentando, insieme
con Marco Follini, “Un’azalea in Via Fani. Da Piazza Fontana a oggi: terrorismo,
vittime, riscatto e riconciliazione” ( San Paolo edizioni, 344 pagg. 25 euro),
il libro di Angelo Picariello, quirinalista di Avvenire. La figlia di Aldo Moro
sottolinea: «Questo libro è costato anni di lavoro, riflessione, ripensamenti,
scrupoli, prudenze e delicatezze. Facendo, soprattutto attenzione che l’esigenza
di raccontare non creasse altro dolore. Restituisce i sentimenti e il clima di
tutte le persone che partecipano a questo gruppo di dialogo ( da cui è nato “Il
libro dell’incontro” ndr) tra ex appartenenti alla lotta armata, familiari delle
vittime, giovani e altri che ci hanno aiutato. Il merito, però, è di chi ci è
venuto a cercare, perché le nostre sono state vite molto solitarie, molto
isolate. È stato sorprendente che qualcuno venisse a interessarsi al mio dolore.
I conflitti della nostra storia diventano favolette che poi passano alla storia:
nella Resistenza ci sono stati i buoni e i cattivi, anche durante il terrorismo
c’era una società buona e dei gruppetti di cattivi, usciti dal nulla, che a un
certo punto hanno deciso di prendere le armi, con lo Stato incapace di
fronteggiarli. Però in un guizzo di democrazia alla fine abbiamo sconfitto il
terrorismo. Questa è la favoletta che passerà alla storia. Si tratta,
sottolineo, di una favoletta, perché le persone che hanno scelto la lotta
armata, come documenta molto bene questo saggio, facevano parte integrante della
società e c’erano fior fior di intellettuali che hanno predicato la bontà della
scelta di prendere le armi». E Agnese Moro continua: «Nei miei incontri in giro
per l’Italia ci sono tante persone che vengono non solo per capire come mai io,
Giovanni Ricci e altri familiari delle vittime siamo insieme agli ex terroristi,
ma tanti anche per curare la loro memoria, feriti per aver tifato per la morte
di mio padre e lo raccontano vergognandosi di se stessi, altri che erano bambini
e hanno vissuto quel periodo avendo paura. È stato sorprendente che dopo tanti
anni qualcuno venisse a interessarsi del mio dolore». E Giovanni Ricci, figlio
di uno dei poliziotti assassinati a via Fani, che insieme ad Agnese Moro ha
stabilito un rapporto con gli ex terroristi confida: «Si portano addosso una
croce più grande della mia, per il peso di ciò che hanno fatto” e “nulla
attenuerà mai questo». Quello di Angelo Picariello è un viaggio nelle pagine più
nere del terrorismo italiano: dalla strage di Piazza Fontana alla morte del
commissario Calabresi, dalla storia di Prima Linea e delle Brigate Rosse fino al
rapimento di Aldo Moro. Un percorso difficile, fatto di testimonianze, racconti
ed esperienze personali che traccia il quadro di un periodo complicato della
nostra democrazia, nel quale una generazione percorsa e dilaniata da un forte
malessere in alcuni casi ha trovato uno sbocco nella lotta armata. Il lavoro del
giornalista di Avvenire, pur mantenendo una rigorosa ricostruzione storica, si
focalizza sui protagonisti senza distinzioni preconcette tra vittime e
terroristi e, grazie alla formazione professionale, politica e religiosa
dell’autore, ne restituisce la loro umanità e i loro sentimenti. La figura di
Aldo Moro è il filo conduttore di “Un’azalea in via Fani”. Una delle lezioni del
presidente della Dc è testimoniata da Nicodemo Oliverio, suo allievo alla
cattedra di diritto e procedura penale alla Sapienza proprio nell’anno
accademico del rapimento: «Aveva incredibile attenzione umana per la persona che
traspariva dalla passione con cui spiegava il ruolo emendativo della pena».
Oliverio, alla presentazione del libro, ha ricordato che «l’ultima lezione, il
15 marzo 1978, fu proprio sulla rieducazione dei detenuti. Senza dimenticare i
suoi dubbi sull’ergastolo, una posizione che restituisce appieno la
contemporaneità del pensiero di Moro. E non sfugge a nessuno come l’articolo 27
della Costituzione sia stato ispirato proprio da lui». Picariello ricorda anche
la figura di padre Adolfo Bachelet, fratello di Vittorio ucciso il 12 febbraio
1980 alla Sapienza, che ha avuto un ruolo fondamentale nelle scelte e nei
pentimenti di tanti ex terroristi sia di destra che di sinistra, come Maurice
Bignami, ex capo di Prima Linea. Storica, a proposito di questa formazione
armata, la conversione “laica” al congresso Radicale del 1987 di Sergio D’Elia,
diventato poi animato dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”. Storie che hanno
un comune denominatore: quella umanità emersa in molti di coloro che hanno
scontato la loro pena, maturando anche un sincero pentimento, come l’ex
brigatista Franco Bonisoli che ha ispirato il titolo del libro. Sì perché è
proprio Bonisoli, con il quale Picariello ha da anni un rapporto di amicizia,
che nel 2013 arriva a Roma, e chiama il giornalista. Si danno appuntamento in
via Fani, dove lui 35 anni prima nel 1978 aveva partecipato al commando che rapì
Moro. “Quando arrivai in zona- scrive Picariello – scoprii che c’era appena
stato, aveva preferito, alla fine, andarci da solo. Era da poco passato
mezzogiorno. Gli chiesi però di tornarci un attimo insieme. Imboccammo così a
piedi la strada e subito scorsi a terra, sul marciapiede un vasetto con una
piantina, davanti alla lapide in ricordo delle vittime dell’agguato,
all’incrocio con via Stresa. «Franco» gli dissi, «è bello che qualcuno ancora si
ricordi, dopo tanto tempo…». «Veramente» fu la risposta bruciante, «l’ho appena
messa io». Un gesto che testimonia in modo netto la sua lontananza da quella
violenza che aveva caratterizzata la prima parte della sua vita. Una violenza
che ha accompagnato l’Italia per oltre un decennio, quella che Sergio Zavoli ha
battezzato come “La notte della Repubblica”, e che Angelo Picariello fa iniziare
il 19 novembre 1969, quando a Milano fu ucciso l’agente di Polizia Antonio
Annarumma, originario di Monteforte Irpino ( in provincia di Avellino). Il
giornalista di Avvenire ricorda anche i funerali di Annarumma in cui era stato
proprio il commissario di polizia Luigi Calabresi, assassinato il 17 maggio
1972, «a intervenire, ingaggiando un corpo a corpo drammatico, in questura, per
sottrarre Mario Capanna al linciaggio degli agenti, furiosi per la sua presenza
alle esequie». Per tanti, in quel pomeriggio l’Italia perse la sua «innocenza»,
si legge nel saggio storico, frutto di una lunga ricerca curata dall’Istituto di
Studi Politici “S. Pio V” di Roma, con la prefazione di Agostino Giovagnoli,
storico della “Cattolica’”, e i contributi dell’ex presidente della Camera,
Luciano Violante e dell’ex capo dell’antiterrorismo, ed ex sottosegretario
all’Interno, Carlo De Stefano che ha collaborato alla ricerca. Un lavoro che
parte da Giorgio Semeria, tra i fondatori delle Brigate Rosse, che «si avvicinò
alla lotta arma- ta frequentando proprio sia il Movimento di Cl che il
Pontificio istituto missioni estere a Milano, prendendo anche parte con padre
Pedro Melesi a un’esperienza missionaria in Brasile». Semeria, uscito di
prigione, «si è sposato in chiesa e ha devoluto i doni di nozze alla missione
che da ragazzo visitò con quel religioso che suo malgrado lo avvicinò alle
ingiustizie, facendo in qualche modo pace con se stesso e potendosi impegnare
ora per quegli stessi ideali giovanili in una maniera che non prevede la
violenza». E poi ancora Renato Curcio, Alberto Franceschini e tanti altri fino
alla colonna avellinese delle Br. Sì, perché Angelo Picariello va a fondo su
quello che è un pezzo di storia del terrorismo che ha vissuto da vicino. Lui,
militante di Comunione e Liberazione, studente prima e poi giovane consigliere
comunale, vive nell’Avellino della metà degli anni Settanta, inebriata dai
successi sportivi della squadra di calcio e dall’ascesa politica di Ciriaco De
Mita e della Dc di Base. Una città, come si intitola il capitolo dedicato alla
sua Avellino, “fra evasione pallonara ed eversione politica”. Dove Maurizio
Montesi, un calciatore sui generis arrivato da Roma e tra i protagonisti della
promozione in serie A, che Picariello descrive come “legato alla sinistra
estrema, tanto regolare in campo quanto sregolato nella vita privata”, alla
vigilia di Natale 1978 in un’intervista a Lotta Continua dichiara: “Il tifoso è
uno stronzo. Fa il gioco del sistema. Fa il tifo per undici persone con le quali
non ha nulla a che spartire». Un mese prima, l’ 8 novembre 1978, la borghesia
avellinese era stata scossa dall’assassinio a Patrica, in provincia di
Frosinone, del procuratore della Repubblica di Frosinone, Fedele Calvosa. La
rivendicazione è delle “Formazioni comuniste combattenti” e gli autori sono tre
giovani studenti avellinesi: Nicola Valentino, Maria Rosaria Biondi e il suo
fidanzato Roberto Capone. Quest’ultimo rimarrà sul campo, ucciso dal “fuoco
amico”. Un’altra ragazza irpina, Maria Teresa Romeo compagna all’epoca di Nicola
Valentino, sarà tra gli autori, il 19 maggio 1980, dell’assassinio
dell’assessore regionale Pino Amato. Ma oltre a loro tre altri irpini hanno
conosciuto la lotta armata. Alfredo Buonavita, operaio emigrato a Torino vicino
a Renato Curcio sin dall’inizio e fondatore delle Br nel capoluogo piemontese.
Gianni Mallardo, coetaneo e compagno di scuola di Picariello, tra i primi a
dissociarsi, reclutato dall’altro avellinese Antonio Chiocchi, figura di spicco
delle Br campane e braccio destro di Giovanni Senzani, tra i protagonisti del
rapimento di Ciro Cirillo e dell’omicidio del commissario Antonio Ammaturo, che
ha avviato un percorso di dissociazione nel carcere di Nuoro nel 1983. Ma a
mezzo secolo dall’esplosione di Piazza Fontana, che voleva far precipitare il
Paese nello scontro e portare, attraverso la strategia della tensione, a una
svolta autoritaria, ecco affermarsi, alla fine di un percorso lungo e
drammatico, un vasto movimento di riconciliazione fra vittime, ex protagonisti
della lotta armata e uomini delle istituzioni. Ed è ancora Franco Bonisoli il
protagonista del viaggio di Angelo Picariello. L’occasione è quella della
presentazione all’Istituto Sturzo de “Il libro dell’incontro”, nel luglio del
2016, sull’esperienza del gesuita padre Guido Bertagna. Franco Bonisoli è vicino
a Giovanni Ricci, figlio di Domenico morto in via Fani. Con loro ci sono anche
Agnese Moro e Alexandra Rosati, figlia di Adriana Faranda, la “postina” delle
Br. E quel valore emendativo della pena che Aldo Moro aveva voluto nella
Costituzione conforta oggi Agnese nel vedere i carcerieri di suo padre cambiati:
«Sono stati una sorpresa perché nella mia mente loro sono dei mostri senza
cuore, senza pietà. E lo sono anche stati». Ma poi ha scoperto in loro «un
dolore infinitamente peggiore del mio che li fa essere totalmente disarmati nei
nostri confronti. Ho imparato da loro che se tu vuoi ascoltare qualcuno e poi
parlare ti devi disarmare da pregiudizi e rabbia. Incontrare chi ha fatto del
male è un atto di amore verso se stessi, perché trovarsi faccia a faccia con chi
ha compiuti atti tremendi di violenza è l’unico modo possibile per uscirne:
perché quella è la realtà. Guardi in faccia dei vecchietti come me, cadenti o
meno, ognuno ha sul viso la storia di quello che gli è successo e sono storie
terribili. Perché quando hai pensato di salvare il mondo, ma alla fine scopri
che hai ucciso solo delle brave persone che non possono tornare indietro, e
quella giustizia che volevi l’hai solo tradita è davvero terribile. Ecco perché
è importante fare un percorso insieme». E Agnese Moro ribadisce che suo padre
avrebbe approvato questo cammino di riconciliazione e il fatto che «queste due
realtà “ex giovani” feritesi reciprocamente, possano oggi incontrarsi e sanare
qualcuna di quelle ferite io sono certa che per lui sia motivo di contentezza».
INTERVISTA "UN UOMO COSÌ", IL
DIARIO INTIMO DELLO STATISTA SCRITTO DALLA FIGLIA AGNESE. ALDO MORO ERA MIO
PADRE.
Un uomo concreto, mite, ricco di senso dell’umorismo, che ascoltava tutti. A 25
anni dalla morte, un ritratto inedito ce lo restituisce in tutta la sua
dimensione umana, scrive Francesco
Anfossi su “Famiglia Cristiana”. Nell’album della storia d’Italia e nella
memoria visiva di gran parte degli italiani l’immagine di Aldo Moro è nelle foto
del suo calvario. Una di queste è certamente la polaroid scattata dai suoi
rapitori: il fondale con la stella a cinque punte, la camicia bianca, quello
sguardo docile e opaco attraverso il quale Leonardo Sciascia, alludendo alle sue
radici meridionali, diceva di leggervi «secoli di scirocco». Come se quella
persona avesse finito per dissolversi nell’affaire Moro, ossia nel
tragico epilogo della sua vita, perdendosi nei labirinti dei processi,
scindendosi nei mille teoremi e misteri, congiungendosi idealmente alla sua
immagine di simbolo democristiano, alle celebri "convergenze parallele" e alle
altre astrattezze del suo freddo linguaggio politico. Venticinque anni dopo la
sua morte, un libricino scritto dalla figlia Agnese (Un uomo così,
Rizzoli editore) ce lo restituisce nella sua più profonda dimensione umana.
Immagini, episodi e pensieri persi nel bianco della pagina, improvviso
schiudersi di palpebre nel buio della memoria: il pacchettino fragrante dei
formaggi, «quasi una traccia del suo legame con la Puglia», la saponata davanti
allo specchio, l’acqua per la figlioletta nel cuore della notte, la passione per
i film di cow-boy, l’orso di peluche comprato a Parigi, l’amore di padre, la
tenerezza di un nonno. In quelle parole vive e semplici, in quei piccoli gesti
quotidiani, Aldo Moro ritorna persona, ritrova la sua essenza e la sua intimità,
viene deposto dalla croce di quelle foto terribili. C’è anche la lettera al
nipotino Luca scritta dalla "prigione del popolo": «Caro Luca, sono il nonno del
casco, il nonno degli scacchi, il nonno della Spagna, del vestito di torero, dei
tamburelli. Il nonno, forse ricordi, che ti portava in braccio come il SS.
Sacramento, che ti faceva fare la pipì all’ora giusta, che tentava di metterti a
posto le coperte e poi ti addormentava con un lungo sorriso...». Tutta quella
felicità sacrificata dai brigatisti a un’ideologia e a un progetto paranoici.
Questo libricino testimonia lo spreco di quella vita, di qualunque vita umana
interrotta, fa capire «quello che è stato portato via». Perché venticinque anni
dopo? «Perché ci voleva del tempo, bisognava avere il coraggio di fermarli e di
riguardarli, quei ricordi», risponde Agnese Moro, la terza dei quattro figli di
Aldo e Nora (gli altri sono Maria Fida, Anna Maria e Giovanni, che Agnese ritrae
da piccolo, addormentato beatamente sopra i giornali di papà). «Se fosse
vissuto, mio padre la gente l’avrebbe incontrato così», spiega Agnese, che oggi
ha 51 anni, tre figli e lavora come sociopsicologa, davanti a un mazzetto di
foto dell’album di famiglia. «Ho scritto quei pensieri di getto, a penna, in
foglietti sparsi. Spero che chi l’ha conosciuto lo possa ritrovare e chi non
l’ha conosciuto se lo ritrovi come persona, non come simbolo. I simboli sono
irraggiungibili. Invece mio padre era un uomo normale, concreto, che può essere
imitato nel suo modo di concepire la vita. I simboli non hanno bisogno che sia
resa loro giustizia. Sono gli uomini che hanno bisogno di giustizia». «Padre
perdona loro perché non sanno quello che fanno»: c’è questa frase del Vangelo
come epigrafe del libro. «Io credo proprio che sia così, che i suoi carnefici
non sapessero quello che facevano». Si è mai fatto vivo qualcuno con lei?
«Nessuno», è la risposta. «Che Luca non faccia i miei errori generosi e
ingenui», aveva scritto alla moglie Nora in un’altra lettera citata. «Generosi,
perché tutta la sua vita era stata un’offerta: lui non voleva far politica,
glielo aveva chiesto il vescovo di Bari. Accettò quella chiamata solo per senso
di responsabilità. Concepiva il potere come servizio. Ingenui, perché sapeva che
era in pericolo. E così la sua famiglia. L’unica volta in tutta la sua vita in
cui si impose fu nel dotarci della scorta». Aldo Moro, si evince dalle sue
lettere e da questa specie di diario intimo, era tutto nell’amore della sua
famiglia. Un amore incondizionato e totale. Le accuse di codardia che molti maître
à penser gli
hanno scagliato da dietro le loro comode scrivanie citando le lettere dalla
"prigione del popolo" non tengono conto di questo. Aldo Moro non aveva paura di
morire: aveva paura di mancare alla sua famiglia. «Si sentiva responsabile della
felicità di ognuno di noi. Ricordatevi di chiudere il gas, ci ripeteva ogni
sera. Lo dice persino in una lettera dalla prigione». Agnese ha con sé una delle
cartoline spedite dal padre in uno dei suoi viaggi. Dietro c’è l’inconfondibile
augurio scritto con calligrafia minuta: «Tante cose care». La stessa frase
compariva nelle lettere scritte dalla "prigione brigatista": «Vi benedico, invio
tante cose care a tutti e un forte abbraccio». In quelle lettere, dice Agnese,
«c’era tutto lui, noi non abbiamo mai avuto dubbi». Quanto alla trattativa,
«avemmo da subito l’impressione non solo che non avrebbero trattato, ma che
avevano rinunciato a cercarlo». Il giorno della strage di piazza Fontana, Agnese
era a Parigi con lui: «Lo vidi invecchiare in un istante. Anni dopo mi dirà che
a suo parere nelle stragi si verifica una coincidenza di interessi tra servizi
segreti diversi, in un tacito accordo tra chi fa e chi lascia fare». Di aneddoto
in aneddoto: «È un giorno importante, torna a casa contento. Per la prima volta,
mi dice, ci sarà un presidente del Senato comunista. Ma scusa, gli dico, sei
sicuro che gli americani saranno contenti? Se il presidente della Repubblica si
ammala, subentra un presidente comunista. Non dice una parola e va al telefono.
Parla, discute». E così finì che il designato al Senato, il comunista Ingrao,
andò a presiedere la Camera. A Palazzo Madama andò Fanfani. «Ero una ragazzetta,
ma mi ascoltò. Lo faceva con tutti. Se gli chiedevi una cosa non ti rimandava a
un altro momento: ti ascoltava subito. Era un uomo gentile, mite, credo di
averlo sentito alzare la voce una sola volta». La mattina del 16 marzo 1978
Agnese aveva 26 anni. «Papà si stava facendo la barba in bagno. Gli dissi ciao
dalla porta chiusa, lui ricambiò e corsi via». Le chiedo se qualche volta lo ha
mai immaginato camminare libero per le strade di Roma, come nel film Buongiorno,
notte di
Bellocchio. «Io lo aspettavo al balcone», risponde. Metaforicamente? «No, non
metaforicamente. Sono stata al balcone per tutti i 55 giorni del sequestro.
Stavo lì, aspettavo che lui comparisse, solo, in fondo alla strada, suonasse al
portone e salisse per riabbracciare noi e mamma». Francesco
Anfossi.
PARLA GIOVANNI MORO.
Intervista di Silvana
Mazzocchi del 14 marzo 1998 su “La Repubblica” al figlio dello statista,
Giovanni Moro. Che accusa il "partito della fermezza" di aver ucciso suo padre.
"Ma la verità vera ancora non c'è". "Da allora, ci ho pensato tante volte, e
con rammarico: Quel mattino avrei potuto salutarlo meglio, parlare un po' con
lui... invece - saranno state le otto, le otto meno un quarto - passai dinanzi
al bagno distrattamente, lo vidi che si stava facendo la barba, con sapone e
pennello, come sempre. Dissi appena un ciao e uscii". Un'ora dopo, Aldo Moro
sarebbe stato rapito e gli uomini della scorta massacrati. Era il 16 marzo 1978.
Giovanni Moro, suo figlio, aveva vent'anni. Adesso ne ha quaranta e s'immerge
nei ricordi con qualche riluttanza: "Era un giovedì, mia madre era andata a
tenere la sua lezione di catechismo nella parrocchia lì vicino... in famiglia
solo mio padre si alzava tardi, del resto a casa non tornava mai prima di
mezzanotte e dunque...". Dalla strage sono ormai trascorsi due decenni e sono
arrivati i giorni delle memorie e dei bilanci. Giovanni Moro accusa: "Non c'è
ancora verità, nè quella storica, neè quella giudiziaria, e tantomeno quella
politica. Moro non fu colpito perché era un simbolo, come si disse, ma per fare
un'operazione chirurgica sulla politica italiana, per fermare il suo progetto.
Anche i brigatisti non hanno detto la verità: perché non hanno reso pubblico
tutto ciò che ha raccontato mio padre? E perché lo uccisero proprio quando nella
Dc si era aperto uno spiraglio? E, infine, perché lo Stato non fece nulla per
salvarlo?... Andreotti era il capo del governo, il responsabile politico ... E
Cossiga? In qualsiasi paese, un ministro dell'Interno a cui fosse capitata una
disgrazia del genere, sarebbe finito a coltivare rose... lui invece divenne due
volte presidente del Consiglio e una volta capo dello Stato".
Come venne a sapere, quel
16 marzo, che suo padre era stato rapito?
"Ero arrivato da poco nella
sede del Movimento Febbraio '74, in via Gregorio VII, avevamo appena traslocato
e non c'era ancora il telefono. Verso le 9 e 30 qualcuno me lo venne a dire di
persona. Ma le notizie erano incerte, confuse. Non si sapeva che cosa gli fosse
successo, nè dove fosse, nè si sapeva dei morti. No, non ricordo chi fu ad
avvertirmi, forse un uomo della mia scorta. Tutti noi della famiglia eravamo
scortati".
Perché?
"Noi... ce l'aspettavamo prima o poi".
Riprenda il filo del suo
ricordo.
"Mi avviai verso casa, con la
mia macchina. Quando arrivai all'angolo di via Fani, vidi tutto bloccato, la
polizia, le volanti... compresi che era successo qualcosa di veramente grave. A
casa trovai mia madre. L'aveva saputo subito, in parrocchia. E di lì a piedi si
era precipitata in via Fani. Aveva visto la scena, il sedile di dietro che non
era sporco di sangue... capì che lo avevano rapito. Ma solo ad un certo punto
della mattinata se ne ebbe la certezza... venimmo a sapere che gli uomini della
scorta erano stati uccisi. Fu un grande dolore, eravamo tutti molto legati.
Loro, le loro famiglie, stavano spesso con noi, la domenica, in vacanza...".
La prima rivendicazione
delle Br delle 10.10...
"Non ricordo cosa disse mia
madre... in casa c'erano anche le mie sorelle. La nostra impressione fu comune:
tutti insieme sentimmo che non si era voluto colpire un simbolo, come poi si
disse. Ma che si stava facendo un'operazione chirurgica sulla politica italiana.
Moro era l'artefice dell'incontro con i comunisti, era un soggetto a rischio. E
del resto basta guardare agli anni delle bombe... e fare una considerazione. Che
quando Moro si marginalizza, anche le bombe si marginalizzano. La sua politica è
strettamente collegata a questo pezzo di storia italiana".
Quella mattina, il progetto
di suo padre doveva andare in porto con il governo di solidarietà nazionale,
temevate qualcosa?
"Non si era mai parlato
esplicitamente dei rischi. Ma lui, già qualche mese prima, aveva insistito
moltissimo perché tutti noi fossimo scortati. Aveva cominciato a preoccuparsi
soprattutto dopo il rapimento del figlio di De Martino, l'anno precedente... lui
non diceva mai niente di concreto, ma in quel periodo in famiglia c'era una
grande tensione, un clima che si tagliava con il coltello. Infine, accadde".
Che cosa ricorda di quelle
prime ore?
"Eravamo tutti un po'
sbandati, soprattutto non riuscivamo a capire fino in fondo che cosa fosse
davvero successo. Ci sentivamo nell'occhio del ciclone, ma separati. Intorno a
noi succedevano le cose più incredibili. E noi lì, insieme, in calma apparente a
leggere i giornali, a vedere i telegiornali".
Dalle lettere di Moro
traspare un forte legame con la moglie....
"Sì, ma era un rapporto
molto... insomma, nella vita famigliare, Moro non era granché presente. Lui
usciva la mattina, e magari tornava alle due di notte. Non c'era la domenica, nè
le feste... Non ricordo che fossimo andati, neanche una volta a mangiare fuori.
Se si voleva chiacchierare con lui, lo si faceva da mezzanotte in poi, e per
cena lo si doveva aspettare. Non esisteva la dimensione quotidiana".
In una lettera a
Zaccagnini, suo padre accennò a gravi problemi famigliari...
"In famiglia c'erano i normali
conflitti. Ma, al di lè di questo, lui era molto preoccupato per tutti noi e
probabilmente aveva le sue ragioni... mia sorella Anna stava aspettando un
bambino, insomma un insieme di preoccupazioni, anche per la nostra sicurezza".
A lei, suo padre scrisse
mai dalla prigione?
"Due lettere per me vennero
ritrovate a Milano, solo nel '90, in via Montenevoso. In una mi avvertiva sul
che cosa fosse la politica... forse voleva dire che dentro la politica c'era
anche quello che gli stava capitando".
Che cosa ricorda dei giorni
precedenti all'agguato?
"In quel periodo sembrava
molto stanco, provato. Aveva 62 anni, pensava di aver avuto già tutto dalla
politica. Io non so se lui pensasse alla presidenza della Repubblica. Credo che
lui non lo desiderasse. Ma ritengo anche che sarebbe stato pronto a farlo... ed
era nell'ordine delle cose. E forse anche questa stata una delle cause
scatenanti di questa vicenda. Insomma in quei giorni era scocciato, irritato
dalle difficoltà... dalle risse tra quelli che volevano entrare nel governo. E
poi convincere la Dc a quell'operazione, convincere il Pci, era stato davvero
duro. Durante la conduzione di quella crisi c'era stato uno scambio di battute
molto pesanti con Andreotti".
Moro prendeva molte
medicine? E' vero che le teneva in una borsa, tra quelle che si portava dietro?
A proposito, quante erano veramente le borse? I brigatisti dissero di averne
prese due.
"Un
po' lui aveva la tendenza a preoccuparsi per le malattie, un po' aveva anche dei
reali problemi di ansia e di stress. Sì, aveva una borsa piena di medicine, ma
quante borse si portasse dietro, non lo so. Ce ne era una con i materiali
dell'Università, e poi aveva altre carte. Che riguardavano, per esempio, lo
status dei servizi segreti. Faccio notare che quelli erano i giorni caldi dello
scandalo Lochkeed. Proprio quella mattina Repubblica era uscita con un
titolone: Moro Antelope Cobbler. Si cercava di buttare addosso a Moro lo
scandalo... Lui non c'entrava niente, ma il punto era che la vicenda veniva
usata per ostacolare il processo politico che aveva avviato".
Moro era un democristiano,
ma anche un uomo nuovo, di frontiera...
"Per questo, forse, al di là
della sua appartenenza, era considerato pericoloso. Mi sono spesso chiesto
perché non sono mai stati ritrovati gli elenchi completi del piano Solo, dello
scandalo Sifar del '64. E mi rispondo che, probabilmente, la ragione è che non
c'erano solo i comunisti, i sindacalisti e i socialisti, ma perché era pieno di
democristiani amici di Moro che dovevano essere presi. Lui aveva intuito che la
guerra fredda era destinata a diventare marginale, era stato per anni ministro
degli esteri... Dall'interpretazione di quello che accade nel '68 da noi e nel
mondo, lui capisce che le società civili tendenzialmente diventano autonome dai
poteri politici... E forse capisce troppo".
Suo padre aveva un buon
rapporto con Berlinguer?
"Sì, stima e rispetto, anche
se Moro aveva un disegno politico diverso. Berlinguer guardava al confronto tra
due grandi potenze che si dovevano in qualche modo impegnare per salvare la
democrazia. Moro credeva che si dovessero creare le condizioni sociali,
culturali e politiche della democrazia dell'alternanza. Lo voglio ripetere: mio
padre era l'uomo del superamento della guerra fredda. E c'era un sacco di gente,
in Italia e fuori di Italia, che lo considerava un pericolo. Questa è una
spiegazione che rende conto di tanti possibili coinvolgimenti".
Nel '78, il terrorismo già
era molto diffuso, Moro ne parlava?
"Era preoccupato. Anzi, credo
sia stato il primo a coniare l'espressione 'partito armato' per definirne la
complessità. Per lui significava una forza politica, con una intenzionalità e
con delle strategie. Non solo un agire politico. Ricordo che rimase molto
colpito dall'omicidio di Casalegno. Disse di avere la percezione che costituiva
il salto di qualità del terrorismo".
Torniamo ai 55 giorni,
Cossiga era il ministro dell'Interno, guidava le ricerche di suo padre. Venne
mai in casa vostra?
"Due volte, mi pare.
Sicuramente il 17 marzo e poi il giorno in cui fu scoperta la base brigatista di
via Gradoli, il 18 aprile. Ne ricavammo la sensazione che non sapessero dove
sbattere la testa. Anzi, sin dall'inizio, si ebbe l'impressione che fosse in
atto una strategia della rappresentazione, un conflitto simbolico. Che usava le
forze dell'ordine per mettere in scena una lotta simbolica alle Br. E cinque
processi non sono riusciti a chiarire questo aspetto della vicenda".
Il 18 aprile, poco dopo la
scoperta della base di via Gradoli, arrivò il falso comunicato di Lago della
Duchessa che annunciava la morte di Moro. Vi sembrò attendibile?
"Ci venne detto che si era
tardato ad andare in via Gradoli, dopo la segnalazione, perché la strada non era
sulle pagine gialle. Si era andati al paese Gradoli... soltanto in seguito si
apprese che in quella via c'erano stati, ma che, avendo bussato alla porta e non
avendo trovato nessuno, se ne erano andati. Quanto al falso comunicato, no...
non ci credemmo, si ebbe l'immediata impressione che non fosse autentico. Non lo
interpretammo come una prova generale, come poi si disse, ma genericamente come
un'interferenza, come un tentativo di qualcuno di forzare la situazione".
La Dc (ma non solo la Dc),
sostenne che le lettere che venivano dalla prigione non potevano essere state
scritte da Moro, lei riconosceva suo padre?
"Sì, completamente. E senza
alcuna ombra di dubbio. Addirittura dal punto di vista linguistico ... e poi la
continuità del pensiero, dell'espressione. Era lui, non c'è discussione".
In quei giorni, lei, voi
credeste davvero che Moro poteva tornare libero?
"Pensammo fino alla fine che
potesse essere salvato, lo abbiamo sempre creduto, e ci siamo battuti con tutti
i mezzi e fino all'ultimo. Certo non era una speranza fondata su chissà cosa. Ma
abbiamo sempre agito in questa direzione, fino alla fine. Ed eravamo uniti.
Capivamo che la situazione era grave. La lettera del Papa era stata terribile,
quel 'liberatelo senza condizioni..."
Il 30 aprile le Br al
telefono sollecitano l'intervento di Zaccagnini. E' vero che lei lo chiamò e fu
lei a darsi da fare?
"Sì, lo chiamai dalla casa del
portiere, perché il nostro telefono si era bloccato. Gli riferii l'ultimatum dei
brigatisti, fu una conversazione piuttosto tumultuosa... noi avevamo una
sensazione di impotenza. Altro che canali privilegiati... Di recente Cossiga ha
dichiarato alla commissione stragi che la famiglia Moro, all'epoca, ebbe
informazioni che non ha messo a disposizione... ma quando mai... la storia che
noi avevamo un canale di ritorno privilegiato, è una sciocchezza. E in ogni caso
di noi si sa tutto, perché eravamo microfonati".
Qualche giorno dopo il
rapimento fu diffusa la foto di suo padre nella prigione, in camicia, con la
stella a cinque punte alle spalle. Che impressione le fece?
"La guardai a lungo. Mio padre
lo rivedevo lì, vestito come Aldo Moro non si sarebbe mai mostrato in pubblco,
la camicia aperta, la canottiera. Sul suo volto lessi una sottile smorfia di
ironia, ma soprattutto rabbia. Forse per la natura della vicenda, un po' da
commedia tragica, tragicissima. Gli è stato rimproverato di non essersi
comportato come un eroe della Resistenza. Ma lo si capiva anche dalle lettere:
lui era consapevole che quella non era la resistenza, che si trattava di una
faccenda molto meno seria. E le Br non erano l'esercito di Hitler".
In quei giorni in casa
vostra venne spesso Tina Anselmi, in seguito andò a presiedere la commissione
P2. Che cosa vi diceva, che cosa vi disse in seguito?
"Lei si convinse molto della
correlazione tra i due eventi: il caso Moro e la Loggia di Gelli. Del resto, a
parte le dietrologie, leggendo certi storici, come Franco De Felice, viene fuori
che la realtà del doppio Stato ha attraversato decenni di storia repubblicana
del nostro paese".
Suo padre aveva delle
verità democristiane che avrebbe potuto rivelare ai brigatisti?
"Certamente nella prigione br,
Moro non dice tutto quello che sa. Dice quello che gli interessa dire. E porta
avanti anche una riflessione politica. Ma di Gladio parla per la prima volta e
racconta molte altre cose. Perché non sono state rese pubbliche? I brigatisti
hanno diffuso episodi ben meno pregnanti: quelli che pure avrebbero potuto
creare imbarazzo alla Dc, li tennero segreti. Guardando le carte ritrovate nel
'90 in via Montenevoso, viene spontaneo chiedersi il perché. Con la rivelazione
di Gladio, le Br avrebbero distrutto l'immagine dello Stato che si voleva saldo
e integro. Sono sicuro che su questo punto i brigatisti mentono ancora oggi".
Lei ha mai avuto interesse
a incontrarli?
"Per carità... Non ci tengo.
Mi sono arrivate varie richieste, negli anni. L'ultimo è stato Maccari, ma non
mi interessa".
Lei continua a chiedere
verità. Vent'anni dopo, qual è il pezzo di verità che ancora lei cerca?
"La verità è un fenomeno
complesso. E' a strati. C'è una verità storica e riguarda il perché Moro.
Abbiamo detto che si volle sventare un progetto politico, ma non basta essere
d'accordo in tre o quattro, deve diventare la verità di tutti. Molti dicono che
Moro era un simbolo. No, era il catalizzatore, per non dire il demiurgo di
un'operazione politica. E l'hanno fermato per questo, altro che simbolo... Poi
c'è una verità politica. Che riguarda il comportamento dei partiti. In
particolare della Dc e del Pci, d'accordo nella decisione di darlo morto fin dal
primo giorno. Ed è la questione principale, ancora tutta aperta. Se non si
riconosce questo, se non si riflette su questo, non arriveremo mai veramente
alla seconda Repubblica. Non c'è stata alcuna autocritica all'interno della Dc
sui comportamenti di allora, nè c'è stata riflessione all'interno del mondo che
all'epoca era il Pci. Ormai i comunisti chiedono scusa di tutto, perfino di aver
sternutito nel 1921, ma di questo... non se ne parla. Non hanno ceduto neanche
di un millimetro".
Lei parla di verità
politiche. C'è chi sostiene che le Br non fornirono il bandolo che avrebbe
potuto salvare Moro, è così?
"Non vero. Alla fine sarebbe
bastata una semplice presa di posizione, un comunicato chiaro. Invece, si è
voluto dare per morto Moro dal primo momento".
Si rende conto che è
un'accusa gravissima?
"Per interesse, per cinismo,
qualcuno per calcolo. O perché si pensò che non ci fosse più nulla da fare. E
anche per paura, per viltà. Credo che, finalmente, sarebbe giusto distinguere
fra quelli che credettero veramente nella linea della fermezza con disperazione
e tormento e fecero appunto una scelta disperata. E quelli che invece
cominciarono da subito a calcolare quanto avrebbero potuto guadagnare alle
prossime elezioni sul cadavere di Moro. In fondo poteva essere un buon affare,
togliere di mezzo un personaggio tanto fantasioso.... Insomma la verità è ancora
lontana. Se non fosse così, il caso Moro sarebbe chiuso. Invece Moro è un
fantasma che continua a inseguirci. E non ci lascia in pace".
Lei ha fatto queste
distinzioni? I capi dell'interpartito della fermezza erano Berlinguer,
Zaccagnini, uomini interessati alla politica di Moro. Dunque?
"Chi contava a quei tempi
erano Zaccagnini, Donat Cattin, Piccoli, Andreotti. Quanto al Pci, penso che dal
primo minuto, i comunisti abbiano dato per persa la partita. E abbiano valutato
che, se si fossero spostati di un solo centimetro, si sarebbe detto che c'era
connessione tra loro e l'area dei combattenti. Vede, io mi sono detto tante
volte che la storia del Novecento è piena di omicidi politici che hanno reso la
vittima ancor più ingombrante che da viva. Basti pensare a Martin Luther King o
a Kennedy, due casi in cui l'immagine rimase ancor più importante... Allora,
ecco, forse c'era bisogno anche di distruggere l'immagine di Moro, evitare che
potesse essere utilizzata come un simbolo positivo: per questo la sua
demolizione attraverso le lettere".
Dal suo elenco di misteri e
di verità lacunose, manca quella giudiziaria...
"Cinque processi, due
commissioni parlamentari non sono serviti a dare risposta ad alcune domande
fondamentali: perché le br non pubblicizzarono tutto il memoriale di Moro? E
perché lo uccisero proprio mentre si apriva uno spiraglio all'interno della Dc?
Infine, perché agirono proprio quel giorno che mio padre passò in via Fani? Come
facevano a saperlo? Lui cambiava spesso itinerario... invece loro erano sicuri
che quel giorno Moro sarebbe passato proprio di lì. E poi: la metà dei colpi
esplosi in via Fani vengono da un'unica arma che non è mai stata trovata. E
restano i misteri della Honda e del camioncino presenti sul luogo dell'agguato.
Fin qui ciò che manca dal versante dei terroristi. E per quel che riguarda le
forze di polizia: perchè tante omissioni, tante superficialità?".
Lei ha detto che non vuole
incontrare i terroristi, ma i leader Dc di allora li incontrerebbe?
"In questi giorni ho rifiutato
di partecipare ad una trasmissione televisiva su mio padre, insieme con Cossiga,
Andreotti e altri. Io non accetto un piano di parità con i responsabili politici
del caso Moro. O con i responsabili delle forze di polizia. Piuttosto sarebbe
necessario sottolineare la disparità. Si deve ricordare che qualcuno morto e
qualcun altro no. Che qualcuno ci ha rimesso, mentre qualcun altro ha costruito
carriere. Per amore della memoria".
E il partito della
trattativa? Suo padre ringraziò Craxi...
"Craxi si era dato da fare, e
dunque... Anche se bisogna dire che per Craxi quello era un passo positivo,
comunque fosse andata a finire. Si metteva in questione l'egemonia Pci-Dc. Era
in ogni caso, una questione che valeva la pena affrontare".
Cerchi di spersonalizzare.
Lei non ritiene che, se all'epoca si fosse trattato con le br, le istituzioni ne
sarebbero state danneggiate?
"Faccio un ragionamento
generale e brutale. Quando c'è un rapimento, lo Stato - che ha il dovere di
tutelare la sicurezza e la vita dei cittadini - ha due possibilità: o libera il
prigioniero o tratta. Se non fa né l'una né l'altra cosa, è corresponsabile di
quel che accade dopo. E' una valutazione eccessiva? Può darsi. Resta il fatto
che dal sequestro Sossi a Soffiantini, passando per Dozier e Cirillo, lo Stato o
ha liberato il prigioniero o ha trattato. L'unico caso in cui non ha né trovato
il prigioniero, né ha trattato, è stato Moro. Non farei nessun'altra
considerazione. E poi, durante i 55 giorni, nel nostro Paese dove si litiga
continuamente, si ebbe la sensazione che ci fosse una straordinaria, inedita,
inspiegabile unità tra le forze politiche. Le voci di dissenso erano pochissime
e ci si sentiva veramente impotenti".
In una delle sue lettere,
Moro si era rivolto a Zaccagnini, lo aveva indicato come il responsabile
morale...
"Quando Zaccagnini venne
eletto segretario della Dc, costrinsero mio padre ad assumere la carica di
presidente del partito. Mia madre si oppose, aveva con Moro un enorme contrasto
sul fatto che lui continuasse a fare politica. Del resto l'ostilità nei
confronti di papà era evidente... come le minacce".
Dalle lettere, specie dalle
ultime, sparisce il Moro paludato. Va giù duro con Cossiga Piccoli,
Zaccagnini...
"Mio
padre non era un muro di gomma. Era un uomo forte, deciso, quando doveva
esserlo. Ma le lettere devono essere lette anche sotto il genere letterario
della profezia".
Che vuol dire? Che lui sa
di scrivere profezie, di scrivere per il domani? In una parola sa che
l'uccideranno?
"Lui lotta fino alla fine.
Certo, man mano, in successione, diminuisce la capacità di resistenza. Arrivano
botte. Basti pensare alla lettera del Papa. A quel 'liberatelo senza
condizioni'. Il Papa fece la sua parte. Ma quello che produsse... diciamo che
sarebbe stato meglio che non l'avesse prodotto. Anche se quell'espressione
'senza condizioni', dicono che gliel'abbiano imposta".
Andreotti?
"Era il capo del governo, il
responsabile politico della gestione di questa vicenda. Credo che ci si possa
limitare a questo".
Siamo alla fine, il
comunicato numero 9 del 5 maggio, annuncia: "Concludiamo la battaglia,
eseguendo..."
"No, non pensai che lo
stessero uccidendo. Interpretammo quel gerundio come l'inizio dell'ultima fase.
Capimmo che c'era un messaggio, uno spiraglio per agire. La mattina del 9 maggio
ci sarebbe stata la direzione della Dc e il dissenso di Fanfani e dei suoi
sarebbe stato rappresentato, manifestato. In quel momento non abbiamo cognizione
diretta che le cose stiano proprio così, ma lo intuiamo. La telefonata delle Br,
in cui si chiedeva l'intervento di Zaccagnini, l'avevamo letta in questo senso.
Avevamo sentito i compagni di corrente, i colleghi della dc, avevamo fatto
pressioni. Senza grandi risultati. Ma neanche i suoi pochi compagni di corrente
furono in grado di fare di più. Certo, alcuni si attivarono per chiedere tramite
Misasi la convocazione del Consiglio nazionale. Ma insomma non è che si siano
dati fuoco nelle piazze... E tuttavia qualcosa nella Dc si stava muovendo".
Il 9 maggio, invece lo
uccisero.
"Io rimasi... non me
l'aspettavo. Per due mesi, certo sapevo che sarebbe potuto succedere in
qualsiasi momento. Invece accadde proprio quando le Br stavano ottenendo
qualcosa..."
Dove si trovava quel
giorno?
"A casa. Non ci chiamò nessuno
di quelli che avrebbero dovuto farlo, né dal ministero dell'Interno, né da
qualsiasi altra parte. Ci telefonarono amici, forse Gianfranco Quaranta, il capo
del nostro Movimento. Ma è pazzesco che nessuno si volle prendere la
responsabilità ufficiale di comunicarcelo. Appena saputo, andammo all'obitorio,
mia madre, le mie sorelle ed io, per l'autopsia. No, non voglio parlare di
quello che provai".
Moro era l'espressione
della grande tragedia italiana, lei quel giorno vide anche questo o solo suo
padre?
"Non è facile rispondere.
Tutto insieme. Mi colpì qualche tempo fa un signore anziano che mi disse: 'Quel
9 maggio per me fu come l'8 settembre'. Mi ha fatto pensare: interpretava bene
l'idea del tutto che crolla, lo sbandamento".
Alla fine, la famiglia ha
chiesto il silenzio, non è andata ai funerali di Stato.
"Si, e non solo perché erano
le ultime volontà di mio padre. Eravamo in perfetta consonanza con lui".
Vent'anni dopo ha ancora la
speranza che si possa arrivare alla verità?
"Mi conforta che, pur tra
tentativi di trovare scorciatoie o versioni di comodo, ritorni sempre fuori la
voglia di raggiungere la verità. E' nell'interesse del Paese liberarsi di questo
fantasma. Vede, io ho due figli, di dieci e otto anni. Mi hanno chiesto tante
volte del nonno. Ho tentato di rispondere e ho spiegato che non è un problema
nostro privato, è un problema della democrazia, un problema insoluto che
riguarda il nostro paese".
PARLA MARIA FIDA MORO.
La figlia di Aldo Moro: "Il
Papa fermi la beatificazione di mio padre".
L'appello di Maria Fida: "Ci sono delle infiltrazioni anomale e ributtanti da
parte di persone alle quali non interessa altro che il proprio tornaconto". La
Repubblica 6 maggio 2019. "Santità, La prego dal profondo del cuore di
interrompere il processo di beatificazione di mio padre Aldo Moro, sempre che
non sia invece possibile riportarlo nei binari giuridici delle norme
ecclesiastiche. Perché è contro la verità e la dignità della persona che tale
processo sia stato trasformato, da estranei alla vicenda, in una specie di
guerra tra bande per appropriarsi della beatificazione stessa
strumentalizzandola a proprio favore". E' l'appello che Maria Fida Moro ha fatto
a Papa Francesco, in una lettera da lei stessa letta in un video postato sul
web. Aldo Moro è stato proclamato "servo di Dio" (il primo passo verso la
beatificazione) il 16 luglio 2012. Già nell'aprile del 2015 si erano avute delle
proteste di "ingerenze" da parte dell'allora postulatore, l'avvocato Nicola
Giampaolo. Nel 2018 al postulatore generale dei Domenicani, padre Gianni Festa,
era stato affidato l'incarico di occuparsi del processo di beatificazione di
Moro (che era un laico domenicano). Il religioso aveva precisato che per si
trattava ancora di una fase iniziale del "processo". "A me risulta - spiega la
figlia dello statista ucciso 41 anni fa dalle Brigate Rosse - che il postulatore
legittimo sia Nicola Giampaolo al quale ho consegnato due denunce, che sono
state protocollate ed inserite nella documentazione della causa nonché inoltrate
per via gerarchica a chi di dovere. Ma non ho avuto alcuna risposta e sono
passati anni. Nell'ambito dello stesso processo ci sono delle infiltrazioni
anomale e ributtanti da parte di persone alle quali non interessa altro che il
proprio tornaconto e per questo motivo intendono fare propria e gestire la
beatificazione per ambizione di potere. Poi è spuntato un ulteriore postulatore
non si sa a quale titolo.
"Vorrei proprio che la Chiesa
facesse chiarezza nella forma e nel merito". "Mio padre - prosegue la
lettera-appello è stato tradito, rapito, tenuto prigioniero ed ucciso sotto
tortura. Dal 9 maggio di 41 anni fa è cominciato il 'business' della morte e lo
sciacallaggio continuativo per sfruttare il suo nome a fini indebiti. Mi viene
in mente la scena, narrata nei Vangeli, dei soldati romani che si giocavano a
dadi, ai piedi della Croce, il possesso della tunica di Gesù tessuta in un solo
pezzo. I soldati erano, in qualche misura, inconsapevoli di quanto stavano
facendo invece costoro sanno di compiere un'azione abbietta e lo fanno
ugualmente in piena coscienza". "Il mio nome significa fede e sono assolutamente
certa della Comunione dei Santi e della vita eterna. E so che mio padre è in
salvo per sempre nella perfetta letizia dell'eternità e nessuna bruttura può
ferirlo. Ma preferire mille volte che non fosse proclamato Santo - tanto lo è -
se questo deve essere il prezzo: una viscida guerra fatta falsamente in nome
della verità. Paolo VI descriveva mio padre così: uomo "buono, mite, giusto,
innocente ed amico". Regali, se può, a mio figlio Luca ed a me una giornata di
pace in mezzo alla straordinaria amarezza di una non vita. Che il Signore la
benedica. Mio padre, dal luogo luminoso in cui si trova ora, saprà come
ringraziarla. Sono mortificata di aver dovuto disturbare Lei. Con rispettoso
ossequio, stima e gratitudine", conclude Maria Fida Moro. L'appello alla vigilia
del 9 maggio, quando la memoria dello statista dc ucciso dalle Brigate Rosse nel
1978, sarà onorata in via Fani, dove avvenne il rapimento di Moro e della
scorta, e alla Camera dei deputati, per la Giornata delle vittime del
terrorismo, a cui presenzierà anche il presidente Mattarella.
Beatificazione Moro, prof.
Coppola replica a Maria Fida: «Processo mai avviato».
Il giurista che vanta incarichi Oltretevere interviene sulla lettera inviata
dalla figlia dello statista al papa con cui chiedeva di interrompere la
beatificazione. Leonardo Petrocelli l'08 Maggio 2019 su La Gazzetta del
Mezzogiorno. «Il processo di beatificazione di Aldo Moro in questo momento non
esiste. E non esiste da parecchio tempo». Abbassa i toni della polemica Raffaele
Coppola - avvocato, accademico e direttore del Centro di ricerca «Renato
Baccari» dell’Università di Bari - dopo la durissima lettera-appello inviata al
Papa da Maria Fida Moro, figlia dello statista di Maglie, per chiedere
l’interruzione del processo di beatificazione del padre, evocando
«strumentalizzazioni e infiltrazioni anomale e ributtanti». Coppola - che
ricopre un incarico di grande rilievo in Vaticano -ricuce i fili di una storia
complessa, su cui molto si è detto e scritto, non sempre in omaggio alla verità.
Lo intercettiamo subito dopo la chiusura del seminario di studio su «Aldo Moro
politico e cristiano», svoltosi ieri a Venosa. «Un appuntamento - precisa
Coppola, fresco cittadino onorario della città lucana - che non deve spaventare
nessuno ma qualificarsi solo come momento di approfondimento».
Professor Coppola, da dove
facciamo partire il racconto?
«Tutto ha inizio anni fa con
l’introduzione della causa attraverso la presentazione del libello. Dal giorno
dopo, però, ecco scatenarsi una intensa pubblicità che ha messo sul chi vive
l’autorità ecclesiastica».
Quale l’effetto del battage
mediatico?
«Il cardinale Augusto Vallini,
al tempo vicario del Santo Padre, dà la possibilità di andare avanti. Ma non nel
senso del processo, bensì nella direzione dell’approfondimento della figura del
Moro religioso».
In altre parole?
«L’approfondimento non porta
alla beatificazione ma spinge a comprendere se ci sono le condizioni per avviare
il percorso. Per di più, sul caso non è intervenuta l’approvazione di tutti i
vescovi della regione Lazio, lì dove il processo si svolgeva. Dunque, Moro non è
figlio di Dio».
Da quel momento in poi cosa
accade?
«Il postulatore (cioè colui
che si occupa delle pratiche fino alla beatificazione, ndr) ha cercato di
ottenere appoggi e consensi che ci sono stati, ma non al punto da poter avviare
il processo».
La figlia di Moro ha evocato,
con durezza, la questione dei due postulatori, parlando del secondo come di una
figura «spuntata non si sa a quale titolo».
«L’attore principale, cioè la
Federazione dei centri studi “Aldo Moro” ha revocato il mandato al primo
postulatore per affidarlo a un’altra figura che però non ha ricevuto
l’approvazione della Santa Sede. Quindi, ne abbiamo uno revocato e uno nominato
ma non approvato».
Professore, come andrà a
finire questa vicenda?
«Siamo solo agli inizi, la
Chiesa ha tempi lunghi che, nel caso di un politico, si moltiplicano
ulteriormente. Tommaso Moro fu canonizzato a 400 anni dalla morte. Ripeto, il
processo non è iniziato (come confermato ieri anche dal cardinale Angelo Becciu,
prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ndr)».
E quanto alle polemiche?
«Vorrei precisare una cosa.
Moro, figura gigantesca di grande cattolico, appartiene a tutti. Coloro che
hanno promosso il congresso di Venosa tendono la mano anche a chi non la pensa
come loro. Vogliamo dare un messaggio di pace e ricordare che, per arrivare a un
obiettivo condiviso, bisogna essere uniti».
In tutto questo, infine, qual
è la posizione del Pontefice?
«Il Santo Padre credo sia
informato di tutto ma lascia ai competenti organismi ecclesiastici ogni
decisione in proposito. È in particolare il cardinale Angelo De Donatis, vicario
del Papa nella diocesi di Roma, a dover decidere se avviare o meno il processo».
Maria Fida
Moro.
Primogenita del leader democristiano Aldo (1916-1978, assassinato dalle
Brigate Rosse).
Ex senatore (1987-1992, prima gruppo democristiano, poi Rifondazione comunista,
infine gruppo Misto). Nel 1993 si candidò a sindaco di Fermo con il Movimento
sociale italiano, ma non venne eletta. «Nessun partito mi ha mai voluto
veramente e di conseguenza la mia vicenda politica è
stata giudicata negativamente in molti modi da coloro che scrivono, ma la gente
comune ne ha colto, nella grandissima maggioranza dei casi, la linearità
nascosta». Nel 2006, infastidita dagli esibizionismi degli ex terroristi (chi in
Parlamento come Sergio D’Elia, chi a scriver
libri e a presentarli con l’aria dei maestri), scrisse una lettera aperta ad
Adriana Faranda, che aveva appena pubblicato un’altra
sua opera ispirata all’esperienza della clandestinità: «Tu hai finito e sei
fuori, noi resisteremo nel carcere della disperazione a contemplare le nostre ex
vite per sempre». Nel 2007 ha attaccato l’ex presidente della Repubblica
Francesco Cossiga additandolo tra i responsabili della
morte del padre. Nel 2008 annunciò l’intenzione di lasciare l’Italia,
«Paese che ho amato tanto, ma è un Paese diverso da quello in cui sono
cresciuta, è diventato privo di memoria e compassione». In maggio si scontrò
con Gianni Alemanno a proposito della Renault 4
nella quale venne ritrovato il corpo del padre: «Andrebbe in un museo», aveva
detto il sindaco di Roma. «Per noi andrebbe
bruciata», rispose lei. Nel maggio 2014 in una lettera aperta pubblicata sul
blog di Beppe Grillo indirizzata a politici e
intellettuali si dichiarò contraria all’ipotesi dell’abolizione del Senato. Le
sarebbe piaciuto interpretare la madre Noretta (Eleonora) nella fiction di
Canale 5 Aldo Moro (in tv nel maggio 2008): il produttore le chiese se
fosse disponibile, lei accettò ma poi non se ne fece niente. Nel 1998, con il
figlio Luca, era stata protagonista dello spettacolo teatrale L’ira del sole,
un nove di maggio, dedicato a Moro a vent’anni dalla scomparsa. Ai funerali
della madre (morta il 19 luglio 2010) non
presenziò. Nel maggio 2012 mise all’asta l’ultima lettera scritta ai figli dalla
madre. «Se hanno messo all’asta i volantini delle Br,
non posso fare la stessa cosa con l’ultima lettera di mia madre? Voglio farlo
per provocare le coscienze, visto che non abbiamo ancora la verità». «Segnata
dalla tragedia familiare con 26 tumori in 34 anni e con tre preinfarti negli
ultimi due mesi. “La mia indennità parlamentare fu completamente bruciata per
pagare i debiti della famiglia, che era rimasta senza reddito finché la mamma
non ricevette la sua pensione. Ho dovuto vendere i miei regali di nozze e la mia
stessa casa, per aiutare mamma e i miei fratelli. Una vita terrificante. Per le
conseguenze subite sul piano emotivo, economico e persino fisico. Ma soprattutto
a causa di un terribile, lacerante senso di colpa per non essere riuscita a fare
quello che papà ci chiedeva”». È laureata in Scienze politiche.
Vive in Trentino con il figlio: il cantante Luca Bonini (il
carissimo nipote citato nelle lettere dalla prigionia dello statista, avuto da
Demetrio Bonini). Insieme gestiscono il sito internet “Moro nella verità”, con
l’obiettivo di ricordare la figura di Aldo Moro.
Giorgio Dell’Arti
Catalogo dei viventi 2015 scheda aggiornata al 9 giugno 2014 da Lorenzo
Stellini
Lettera aperta di Maria
Fida Moro, figlia di Aldo Moro del 9 maggio 2011.
Scrivo questa mia dolorosa
lettera su un vecchio quaderno dove qualcuno ha copiato, anni fa, L'Infinito di
Leopardi. Poesia che bene si addice al mio stato d'animo sconfitta come sono
dalla vita. Una volta ancora, ahimè, sono condannata a chiedere aiuto ed
ospitalità a gentili persone per inviare nei popolosi cieli di internet il mio
ennesimo Sos. Almeno sul limitare della esistenza terrena mi piacerebbe davvero
tanto essere lasciata in pace e poter finalmente smettere di battermi invece –
come al solito – sono relegata in trincea e devo combattere in favore della
verità e del giusto significato. Il nocciolo del mio appello è il seguente. C'è
chi, fin dalla scorsa primavera, ha posto in rete una specie di specchietto per
le allodole, tramite il quale chiede e riceve soldi promettendo la mia presenza
in eventi vari. Il paradosso è che l'unica condizione che io pongo per
presenziare ad eventi che riguardino mio padre e la sua memoria è di farlo a
titolo gratuito e senza nemmeno il rimborso spese. È immorale dunque gravemente
scorretto e lesivo della mia immagine che qualcuno in malafede ed in modo falso
e mendace guadagni indebitamente millantando il credito e offuscando la mia
onorabilità. Io non ho uno staff, né una segreteria e faccio tutto da sola
quindi se devo prendere un impegno lo faccio personalmente. Nessuno dunque è
autorizzato o ha titolo per parlare a mio nome e tantomeno impegnarsi al posto
mio. Invito chi fosse interessato a diffidare dai falsi profeti, dai sepolcri
imbiancati, dai truffatori. Sono amareggiata e stufa di dovermi difendere mentre
non sto facendo niente di male e cerco soltanto di esistere in pace vivendo ai
margini e traversando la vita in punta di piedi. Nel nostro mondo marcio, che
tutto inghiotte, sembra non esserci più posto per la gentilezza, la bontà, la
comprensione e la ragionevolezza. Ciò non di meno, facendo appello ai buoni
sentimenti, esprimo profonda gratitudine per chi ha ospitato questa disadorna
segnalazione. È etico cercare di distinguersi dal male e fare il bene. Non
voglio neppure immaginare di guadagnare un centesimo dalla tragica morte di mio
padre Aldo Moro ed a maggior ragione non intendo che altri guadagnino, ma il
termine esatto sarebbe rubino, a mio nome. Se intendono truffare ed operare
furti lo facciano in proprio e lascino in pace mio padre e me. Abbiamo già
pagato mio padre con la morte io con una vita orribile il diritto di esistere.
Mi piacerebbe di più rinunciare a vivere ma mi perderei l'avvento
dell'Apocalisse e la fine di questi tempi. Invece devo restare perché voglio
vedere i nuovi cieli e la luce che illuminerà il mondo nuovo. Intendo essere
presente per applaudire la sconfitta delle tenebre e di coloro che perseguono, a
vario titolo, il male. “Il male fiorisce dove chi può non fa il bene” ha
lasciato scritto un anonimo del '600. E' ora, straora, di rinnegare il buio ed
avanzare verso le stelle. Maria Fida Moro
Maria Fida Moro "Se papà per
miracolo tornasse vivo, lo ucciderebbero ancora e ancora e ancora". Bellissimo
ed appassionato racconto della figlia dello statista democristiano a Giovanni
Fasanella e Antonella Grippo. Sono Maria Fida, la primogenita di Aldo Moro. La
mattina del 16 marzo 1978, in via Fani a Roma, le Brigate rosse sequestrarono
papà, dopo aver massacrato gli uomini della sua scorta. Vorrei ricordare i nomi:
Domenico Ricci – Oreste Leonardi – Giulio Rivera – Raffaele Jozzino – Francesco
Zizzi. Lo tennero in una << prigione del popolo>> per cinquantacinque giorni. Il
9 maggio, poco dopo le 10, il suo corpo senza vita fu ritrovato nel bagagliaio
di una Renault 4 rossa, parcheggiata in via Caetani. L’assassinio di mio padre
fu un colpo di Stato. L’ho sempre pensato e l’ho sempre detto. E ne ho pagato il
prezzo. Avevo compiuto trentuno anni da qualche mese, quando sequestrarono papà.
Luca, mio figlio, aveva solo due anni. La settimana prima di quel maledetto 16
marzo, passai tutte le notti a piangere. Senza sapere un perché. Avevo il
presentimento che stesse accadendo qualcosa di catastrofico, di irreparabile. Se
dovessi descrivere con un ‘immagine il mio stato d’animo…ecco, direi che ero
sovrastata da una nube rosso sangue. Si una nube rosso sangue, questa è
l’associazione che mi viene spontanea. In realtà, in famiglia pensavamo che un
evento terribile fosse nell’ordine delle cose. Era come se ce lo aspettassimo,
soprattutto dopo il rapimento del figlio di Francesco De Martino, Guido... Erano
tre i personaggi politici che, negli anni precedenti, avevano contribuito a
rimettere in gioco il Partito Comunista: il socialista De Martino, il comunista
Enrico Berlinguer e il democristiano Aldo Moro. Berlinguer non era molto
tranquillo, e di recente si è scoperto che nel 1973 avevano tentato di
ammazzarlo in Bulgaria, simulando un incidente stradale. A De Martino,
nell’aprile 1977, avevano sequestrato il figlio per impedire al padre di essere
eletto Presidente della Repubblica. E papà, anche se non lo lasciava trasparire,
era molto preoccupato. Noi, in famiglia, lo eravamo più di lui. Forse fu per
esorcizzare quella sensazione di inquietudine, di catastrofe incombente, che un
giorno mi decisi chiedergli se lui ipotizzava di poter essere rapito. Ricordo
che mi rispose: << Nella vita non si può mai sapere>> Tradotto dal suo
linguaggio ermetico, voleva dire di sì. Non ero preoccupata solo per mio padre,
ma più in generale, per il clima politico che si respirava in quegli anni.
Vivevo nell’incubo di una terza guerra mondiale, che sembrava potesse scoppiare
da un momento all’altro. Ma, ripeto, un po’ tutti, in famiglia, erano allarmati.
Nel 1974, mia madre era riuscita a strappare a papà la promessa che avrebbe
lasciato la politica. Glielo aveva chiesto più volte in modo pressante, erano
arrivati perfino a litigare, cosa che tra loro non succedeva mai. Alla fine mia
madre era riuscita a spuntarla. L’anno seguente, però, nel settembre del 1975,
era nato luca. E papà, di fronte alla nursery, disse alla mamma che gli
dispiaceva, ma non poteva mantenere la promessa: << Per ricordare la catastrofe
che pende sulla testa dei bambini>>, disse proprio così. Continuò a far
politica, perché credeva davvero che un mondo migliore fosse possibile.
Ricevevamo minacce continue. Non solo mio padre, ma tutta la famiglia era
esposta a intimidazioni e pressioni. Ricordo il 3 agosto del 1974, altra data
infausta della storia italiana. Papà allora era ministro degli Esteri e avrebbe
dovuto raggiungervi in treno a Bellamente, sulle montagne del Trentino, dove di
solito trascorrevamo insieme le vacanze estive. Era già salito sulla sua
carrozza, alla stazione Termini, e il treno stava per partire, quando all’ultimo
momento arrivarono dei funzionari e lo fecero scendere perché doveva tornare per
firmare delle carte- A causa di quell’imprevisto, perse il treno e fu costretto
a raggiungerci in macchina. Un ritardo provvidenziale, perché quel treno era
l’Italicus. Non ho alcuna prova per dirlo con certezza, però ho avuto il
sospetto che la bomba esplosa poche ore dopo nella galleria di San Benedetto Val
di Sambro avesse come obiettivo proprio lui. Anche perché già altre volte,
un’infinità di altre volte, si era salvato per il rotto della cuffia. Un giorno
esplosero le gomme della sua auto, che andò fuori strada. A bordo c’ero anche
io, ma le conseguenze furono lievi Qualche tempo dopo accadde di nuovo, e papà
non si fece male a un ginocchio. Dissero che erano ruote da neve usate per
camminare u strada, per questo erano scoppiate. Ma è proprio difficile crederlo.
Qualche tempo dopo, papà soffriva di un malanno da diverse settimane, e stava
peggiorando sempre più. Poi un giorno la mamma, che era infermiera della Croce
rossa, scoprì che alcune medicine con le quali papà veniva curato erano non solo
inefficaci, ma addirittura pericolose, tanto che forse lo stavano avvelenando.
Fece sospendere la cura e papà si riprese. Potrei citarvi davvero tanti altri
episodi strani, ma ci vorrebbe forse un libro intero….Vi basti pensare, per
capire quale era il clima negli anni che precedettero il sequestro, a un
episodio del 12 dicembre 1969, altra data della nostra tragica storia italiana.
Dopo l’esplosione della bomba di piazza Fontana, a Milano, quella sera stessa,
Luciano Beca, uno dei più stretti collaboratori di Berlinguer, telefonò a mio
padre, che era in visita ufficiale a Parigi, per invitarlo a rientrare in Italia
in treno, invece che in aereo. Era stato proprio Berlinguer , preoccupato per la
sua sorte, a dirgli di telefonare a papà, come lo stesso Barca ha rivelato in
tempi più recenti, nella audizione della Commissione parlamentare d’inchiesta
sulle stragi e sul terrorismo. Il segretario del Pci era convinto che il treno
fosse più sicuro dell’aereo. Piazza Fontana, piazza della Loggia, l’Italicus. E
dopo le stragi, il terrorismo brigatista. Ricordo mio padre dire alla mamma:<<
Noretta, siamo in guerra>>. Dal 1974, dopo la strage dell’Italicus, papà volle
che avessimo una scorta anche noi figli. La sensazione era che si fosse con
tutti e due i piedi nel baratro, solo i talloni rimanevano sulla terra ferma:
sarebbe bastato un nulla per caderci dentro. Quella sensazione la conoscevamo
benissimo. Perché l’avevamo vissuta tante altre volte, anche prima di quel 1974.
Ad esempio, nel luglio 1960 durante i moti di piazza contro il governo Tambroni
appoggiato dal Msi. E ancora nell’estate del 1964, all’epoca del <>, il
tentativo di colpo di Stato attribuito al generale Giovanni De Lorenzo. Ma
quelle date erano soltanto dei picchi di tensione. In realtà, la normalità della
nostra famiglia era vivere costantemente nell’attesa di precipitare nel burrone.
Vivevano così i miei genitori, innanzitutto. E poi noi figli, io in particolare
che ero primogenita. Mi sentivo responsabile e volevamo proteggerlo. Facevamo di
tutto per non farlo uscire di casa. Ricordo mia sorella Agnese, piccolissima,
nascondeva la sua tessera parlamentare sotto la cenere fredda del caminetto:
aveva capito che, senza quella, papà non sarebbe potuto partire in treno. E mio
fratello Giovanni, anche lui piccolissimo spesso si addormentava, sdraiato alla
porta d’ingresso, per impedirgli di uscire. Proprio Giovanni! Un giorno carpii
spezzoni di una conversazione concitata dei miei genitori, che si parlavano in
francese. Quella era la lingua che usavano, insieme al tedesco, quando volevano
esser sicuri che noi non capissimo. Io invece qualcosa afferrai, e ne rimasi
sconvolta. Qualcuno aveva minacciato papà di portare via Giovanni, il mio
fratellino adorato, e di rimandarlo indietro, tagliato a pezzi, in una valigia.
Quell’episodio ha sconvolto la mia infanzia, la mia giovinezza e la mia età
adulta. Avevamo piena coscienza che papà fosse in pericolo. Tutti quanti, da
sempre. Ma c’era una specie di tacito accordo con la mamma, per cui noi non
parlavamo mai di cose pericolose con papà. E a loro volta, papà e mamma non
parlavano mai davanti a noi dei pericoli incombenti. Ricordo che mamma mandava
noi bambine, me Anna, la secondogenita, ai convegni annuali della Dc, a San
Pellegrino. Voleva che vigilassimo su papà, perché si fidava di noi più di
chiunque altro. Una delle due rimaneva in sala, seduta in prima fila, a
controllare che non accadesse nulla a papà mentre parlava; l’altra, nel
frattempo, perquisiva la sua stanza in cerca di eventuali esplosivi o altro.
Saremmo state in grado di riconoscerle, le bombe, perché mamma, reduce dalla
guerra, ce le aveva descritte. E l’ordine che avevamo era che, se avessimo
trovato qualcosa, avremmo dovuto subito avvertirla. Papà non ha mai saputo che
noi abbiamo fatto questo per anni, Una volta, non avevamo ancora finito di
perquisire la sua stanza, quando lui arrivò: ci inventammo un la essere, per
costringerlo ad andare in farmacia a comprare le medicine. Eravamo la sua
scorta, eravamo della sua vigilanza. Mamma mi insegnò anche a sparare. Si,
proprio nel luglio del 1960, durante la crisi del governo Tambroni: ero talmente
terrorizzata che mamma mi regalò un flobert, un fucile ad aria compressa e mi
insegnò ad usarlo. Mi ero spaventata perché, una notte, Sereno Freato e altri
collaboratori di papà, mandati da lui a Torrita Tiberina, dove trascorrevamo
l’estate, per portarci via di lì. Ma la mamma in quel momento non c’era. Ci
dicevano di fare in fretta, la mamma non tornava, e io non sapevo cosa fare.
Intuivo un pericolo enorme e imminente. E quando finalmente tornò mamma ci
portarono a Roma, nella nostra casa di Salita di Poggio San Lorenzo e dormimmo
ognuno con un carabiniere davanti alla porta della nostra camera. Il rischio
doveva essere proprio serio. Perché mamma mi diceva:<< Se senti dire che è
successo qualcosa di pericoloso o di strano, non ti spaventare, vieni diritta a
casa>>. Lei è persona molto serena e gioiosa, ma quando da degli ordini, sono
secchi e perentori. E quello non era un consiglio, ma proprio un ordine. Dal suo
tono capivo che era una situazione grave. Tanto che, come ho già ricordato, dal
1974, papà impose a tutti noi una scorta. E fu forse l’unica volta che ci ha
imposto qualcosa. Certo non è facile vivere con una scorta, ma diventa
sopportabile se si diventa amici di chi si occupa della tua sicurezza. Per
sdrammatizzare, tra fratelli ci si salutava dicendo: << Se ti rapiscono,
citofona>> E infatti, la mattina del 16 marzo andò proprio così: seppi del
sequestro dal citofono. Che papà fosse un personaggio scomodo era indubbio. In
molti gli rimproveravano la sua politica di apertura ai comunisti di Berlinguer,
la sua lungimiranza. Lui non si arroccava mai su posizioni conservatrici,
guardava oltre. Nella vita in casa invece, era timidissimo, riservato, discreto,
ma anche molto divertente. Il rapporto con me era fatto di sguardi, di sintonia
d’intenti, di parole non dette. Cercava solo di dissuadermi dalla carriera
giornalistica, perché conosceva bene la mia sensibilità e il cinismo di quel
mondo, come ho sperimentato poi sulla mia pelle, qualche anno più tardi. Non
aveva nessun senso pratico, risolvere dei banali problemi quotidiani, persino
aprire un pacchetto, con lui diventava un’esperienza surreale. Ci metteva a
volte delle ore, e capitava persino che si facesse male. Un vero tenerissimo
disastro. Una settimana prima del rapimento, papà era a letto con un raffreddore
fortissimo, e io passavo notti insonni, turbata da quella sensazione di minaccia
incombente. Speravo tanto che il raffreddore lo costringesse a letto e che
quindi non potesse uscire. Abitavamo nella palazzina di fronte ai miei genitori.
Io stavo talmente male, tra l’altro ero provata anche fisicamente a causa di una
dolorosissima ernia al disco, che Luca, mio figlio, quella notte era rimasto a
dormire dai nonni. La mattina del 16 marzo, volevo alzarmi dal letto a tutti i
costi, ma non ci riuscivo per il dolore alla gamba, e mi feci aiutare da mio
marito, che mi alzò di peso. Ero terrorizzata dall’idea che papà portare Luca
con sé, come faceva spesso. Non so perché proprio quel giorno avevo l’imperativo
categorico che non lo dovesse fare. Arrivai appena in tempo a fermarlo. Vidi mia
madre uscire rapidamente per andare, come ogni giovedì, a insegnare catechismo
in parrocchia. Mio padre era già sulla porta d’ascensore, con Luca in braccio.
Purtroppo, quasi sgarbata:<< Luca oggi deve stare con me!>>. Lui provò
timidamente a resistere, visto che io non potevo nemmeno camminare. Ma fui
irremovibile. Lui si rassegnò, e lessi nei suoi occhi che aveva capito i miei
timori. Entrò nell’ascensore, lo guardai con la consapevolezza che non l’avrei
più rivisto. L’ultimo ricordo che ho di lui vivo, è il suo sorriso mesto, e il
cigolio dell’ascensore che se lo portava via. Rimasi sola in casa con Luca. Il
tempo era incerto, piovigginava e tirava molto vento. Avrei voluto portare mio
figlio a Capannelle, alla scuola centrale antincendio dei vigili del fuoco, per
assistere alla prova generale del saggio ginnico-sportivo, e aspettavo una
telefonata di conferma. Il telefono squillò. Risposi. Ma non erano i vigili del
fuoco. Sentivo, dall’altro capo del filo, una perdona piangere, farfugliare
parole incomprensibili, non capivo nulla. Era la signora Ricci, la moglie di
Domenico, il carabiniere autista di mio padre che era in servizio quel giorno.
Non accesi la televisione, né la radio per non spaventare Luca. Telefonai al
ministero dell’Interno per sapere cosa fosse successo. Mi dissero che era
accaduto qualcosa, ma non sapevano cosa. Quella risposta mi fece immediatamente
pensare che lo sapessero e che non me lo volevano dire. Una conferma, insomma,
dei miei peggiori timori. Erano circa le 9.15 del mattino. Suonò il citofono, il
poliziotto di servizio alla vigilanza che c’era un passante che desiderava
parlare con me. Era assolutamente anomalo che dalla vigilanza ci chiedessero se
volevamo parlare al citofono con degli sconosciuti. Ma se il poliziotto lo aveva
fatto, significava che aveva un motivo serio. Perciò risposi subito di sì. Un
signore, non so chi fosse, mi disse: << hanno trucidato tutta la scorta e hanno
portato via suo padre>>. Tutto quello che avevo paventato da sempre, era
successo. Percepivo chiaramente che la situazione era perfino peggiore di quanto
avessi mai temuto: un padre rapito è molto più spaventoso di un padre ucciso, è
un’agonia rimandata. Mia madre fu tra le prime persone ad arrivare in via Fani.
Era in parrocchia quando qualcuno chiamò un sacerdote per portare l’estrema
unzione ai caduti della scorta. Ed era andata anche lei. Resasi conto che non
c’era più modo di aiutarli, si era inginocchiata per terra, tra il sangue e i
bossoli, a pregare. In quel momento, io ero a casa, sola con Luca. Quando mamma
rientrò, riuscì a mostrarsi straordinariamente serena, straordinariamente
coraggiosa, com’era il suo solito, e perfino rassegnata. Mi disse, e mi colpi
che, rivolgendosi solo a me, usasse il plurale, come se parlasse a tutta la
famiglia: << Mi dispiace, ragazzi, è colpa mia. Non dovevo permettergli di fare
politica>>. Io le risposi: << Non è colpa tua, si vede che doveva comunque
accadere>> C’era del fatalismo in quella mia risposta. D’altra parte, avendo
fino a quel momento sempre vissuto nell’attesa della caduta nel baratro, non
poteva esserci reazione diversa. Cercai di rintracciare il resto della famiglia.
E intanto, la casa cominciava a riempirsi di amici e parenti, in evidente stato
di choc. Chi piangeva, chi si sentiva male, chi sveniva. Toccò a noi soccorrerli
e consolarli, farli sedere, dargli i fazzoletti per asciugarsi le lacrime, il
caffè, gli ansiolitici e le gocce per la pressione…Capivo benissimo il loro
stato d’animo, anche perché noi eravamo in qualche misura preparati, loro no.
Tuttavia, mi sembrava troppo e me ne andai con Luca. Non sapevo, in quel
momento, quanto il comportamento delle persone che erano venute a farci visita
fosse emblematico dell’atteggiamento dello Stato nei nostri confronti da quel
giorno in avanti: la pretesa assurda e arrogante di escluderci persino dal
dolore, non solo dal diritto di parola sulle vicende legate al caso Moro. Le
vittime devono entrare nella tomba insieme al loro congiunto e non apparire mai
più, come le vedove indiane sulla pira funebre. Non devono piangere, né
tantomeno parlare E’ l’ingiustizia esponenziale, il massimo dell’orrore. Sin dal
primo dei cinquantacinque giorni, avevo come la sensazione che la mamma fosse
consigliata da personaggi non sempre e non tutti in buona fede. Era solo la mia
sensazione, naturalmente. Alcune persone davano l’impressione di essere
state…come dire?...non saprei…ecco …si <>. Proprio questa forse è la parola
giusta:<< infiltrate>> in casa Moro con lo scopo preciso di dividere la
famiglia, e di conseguenza impedire tutta una serie di iniziative volte alla
salvezza di papà. La famiglia Moro unita era invincibile, per questo, la prima
cosa da fare era dividerla. Ne sono sempre stata convinta. Però per favore, su
questo specifico punto non fatemi altre domande, non voglio dire di più.
Aggiungo solo questo. Il giorno dei funerali della scorta, per esempio, mi fu
impedito di partecipare. Alcuni miei familiari decisero per me che io non
dovessi esserci e mi lasciarono a casa. Io ci andai ugualmente, ma non essendo
con altri, quelli del servizio d’ordine non mi riconobbero e non mi fecero
entrare nella chiesa. Rimasi dunque fuori con la folla. Poi vidi passare un
anziano poliziotto che a suo tempo era stato scorta di papà, e lui mi fece
entrare. Mi chiedo ancora oggi perché diavolo non avessi il diritto di
partecipare ai funerali di persone che erano care a me quanto agli altri membri
della famiglia. Questa è la mia verità. Dicano quello che vogliono, ma questa
resta la verità: il compimento dell’orrore del caso Moro non è stato il 16 marzo
ma il giorno dei funerali della scorta, perché quel giorno sono rimasta davvero
orfana e senza famiglia. Se lo Stato o chi per esso voleva avere carta bianca
nella mia famiglia, doveva togliere me di mezzo. Perché io sono battagliera,
coraggiosa, determinante, incurante dei giudizi altrui e del pericolo. E
soprattutto fedele, come il mio nome, quindi avrei fatto tutto il possibile per
impedire che papà venisse ucciso. Sarei andata tutti i giorni in televisione, mi
sarei incatenata al cavallo di viale Mazzini per avere udienza in Rai e dire la
nostra opinione pubblica. Avrei fatto entrare in casa un giornalista perché
assistesse dalla prima linea agli sviluppi della vicenda Moro, e poi lo
raccontasse. Avrei organizzato dei sit-in di giovani davanti al Parlamento e
alla sede del governo. Avrei promosso fiaccolate, corte
manifestazioni….Qualsiasi cosa. Ma non il silenzio. Perfino mio padre, che non
amava la televisione, in una lettera a mia madre le aveva chiesto espressamente
di non dare retta a nessuno e di andare in tv per fare un appello. Dalla <>,
aveva capito – e io con lui – che l’unica speranza di salvezza era coinvolgere
l’opinione pubblica. Dopo i funerali della scorta, me ne tornai a casa. E dal
quel momento rimasi in disparte, per aderire a un espresso e pressante desiderio
di mia madre di non aprire fronti esterni alla famiglia. Oggi, a distanza di
tanti anni sono sempre più convinta che la gestione << silenziosa >> dei
cinquantacinque giorni fosse sbagliatissima. In quel periodo, oltre alla
tragedia di mio padre nella mani dei sequestratori, dovevo fare i conti anche
con altre emergenze. L’ernia del disco. La difficoltà oggettiva di tenere un
bambino piccolo abituato a uscire imprigionato in casa, con le serrande
abbassate, tipo coprifuoco, per paura che ci sparassero. E soprattutto un senso
di impotenza portata allo spasimo. Stare a guardare le cose sbagliate fatte
dagli altri e non poterne fare neppure una giusta, può darti, infatti, una
devastante sensazione di impotenza. Comunque, ogni volta che ci penso, pur
rimanendo della mia opinione, mi sforzo di capire anche le ragioni di mia madre.
E giungo alla conclusione che probabilmente lei avesse scelto il male minore,
che non potesse fare altrimenti. Arrivo persino a convincermi che, al suo posto,
nei suoi panni di madre, forse anch’io avrei agito così. In ogni caso, la morte
di papà non ha purtroppo segnato la fine di un incubo, ma l’inizio dell’incubo
per eccellenza. Tutte le certezze erano andate perdute, la mia famiglia non
c’era più. E io a trentun anni, quanti ne avevo il 9 maggio 1978, mi sono
ritrovata da sola su un campo di battaglia, sotto un bombardamento, vittima e
protagonista, mio malgrado, di una guerra che non avevo voluto, né provocato.
Quella della mia famiglia, e delle persone che le giravano intorno, contro la
Dc, accusata di non aver fatto nulla per salvare mio padre. L’accusa, per certi
aspetti, era anche giustificata e ragionevole. Ma credo che mio padre non
avrebbe voluto che la guerra venisse combattuta dalla sua famiglia, e oltretutto
in modo frontale. Perciò, pur non assolvendola, ho cercato di mediare perché i
Moro non rompessero totalmente con la Dc. Ma alcuni miei familiari non erano
d’accordo. Quando Ciriaco De Mita, allora segretario del partito, mi chiese di
candidarmi, rifiutai perché mia madre mi disse che << sarei stata il chiodo
della sua bara>>. Qualche tempo dopo, nel 1986, fu la base democristiana a
propormi la candidatura al Senato in un collegio difficile in Puglia, e io
accettai. Anche perché alcuni avvocati mi avevano vivamente consigliato di farlo
per motivi di sicurezza: una carica istituzionale vale come deterrente. La mia
scelta non piacque alla famiglia e fu vissuta come uno sgarbo anche dai vertici
democristiani. L’unico a inviarmi un biglietto di felicitazioni per la mia
elezione, fu Giulio Andreotti. La guerra alla Dc, anche se aveva un suo
fondamento, durante il sequestro non era servita a papà; e dopo, quando c’erano
ben altre tragedie da combattere, ha isolato noi. Dalla morte di mio padre in
poi, io ho vissuto in una trincea virtuale. Perché non volevo lasciarlo solo.
Era iniziata immediatamente una campagna di stampa per denigrare,anche dopo
morto, la figura di Aldo Moro. Io non volevo permettere che venisse abbandonato
e la sua memoria negata, che lui continuasse a essere ucciso di giorno in
giorno. Ma così facendo, ho preso tutte le bombe, tutto il livore, tutto lo
schifo che era la risposta di quanti si sentivano attaccati dal disprezzo della
mia famiglia e dalla verità. Durante il sequestro, tutti avevano fatto di tutto,
io avrei voluto fare solo poche cose utili e non potei farle, e dopo mi ritrovai
da sola a subire le conseguenze di azioni non mie e che non condividevo. La
conseguenza più immediata? Sono stati ventisei tumori….mi mancano sei organi..
Già, è così. E’ stupefacente che io sia ancora viva. L’altra è che mi hanno
messa nella condizione di non vita. Io sono esule nel mio paese, per non dire
apolide. Hanno creato di me un immagine che non corrisponde assolutamente al
vero: quella di una persona volubile, vulnerabile e anche un po’ tocca, nella
migliore delle ipotesi non razionale, nella peggiore inaffidabile. Ed è
paradossale, perché proprio la mia affidabilità mi ha permesso di restare a
fronteggiare da sola, per quasi trent’anni, il tentativo del potere di uccidere
perfino l’idea che sia esistito un Aldo Moro. Da sola e con un fardello di
inesprimibile sofferenza. La subdola versione ufficiale della mia presunta non
sanità mentale. La mancanza di lavoro – si, perché ho perso anche il lavoro – e
quindi la mancanza di denaro. E poi, il dolore insopportabile dell’ingiustizia
conclamata e quotidiana nei confronti di papà e della verità. E ancora, la
perdita migliore delle famiglie possibili. Ma su tutto, l’insopportabile dolore,
per me, di mio figlio Luca. Un giornalista, una volta, ha scritto parole
straordinariamente giuste: mio padre, di fronte alla morte, ha messo per la
prima ed unica volta davanti allo Stato la famiglia; e davanti alla famiglia,
Luca. Il dolore di Luca è inenarrabile. Ed è atroce per me non poterlo sanare in
alcun modo. La stessa impotenza vissuta nei giorni del sequestro. Questa è stata
la mia esistenza dopo la morte di mio padre. E come se non bastasse, non voglio
dimenticare – anche se non gli do nessun peso e nessuna valenza – le
intimidazioni e le minacce che costellano in varia misura la vita di alcuni, più
che di altri membri della famiglia Moro. Minacce e intimidazioni iniziate da
quando io ho memoria e proseguite anche dopo il 9 maggio del ’78, e a tutt’oggi,
come se Aldo Moro dovesse essere ucciso una seconda volta. Sono convinta che se
papà per miracolo dovesse tornare vivo, sarebbe ucciso ancora e ancora. Il suo
progetto politico dava talmente tanto fastidio da risultare pericoloso perfino
in assenza di colui che lo aveva pensato. Secondo me, i sentimenti di colpa
inconfessabili e la relativa rimozione di responsabilità da parte del potere si
riverberano sulla nostra vita, la mia in particolare, chiudendo ancora una volta
porte e finestre e impedendoci di vivere allo stesso livello di un clandestino.
A mio avviso la verità non può essere e non è solo quella conclamata dalle
trombe prezzolate del solito potere. I delitti politici avvenuti nel nostro
Paese dal dopoguerra in poi andrebbero riesaminati come vere e proprie
esecuzioni di persone da far tacere per sempre. Io avrei fatto di tutto per
salvare papà. Ma oggi sono sempre più convinta che anche l’impossibile non
sarebbe bastato. Ripensando a quei 55 giorni, ripercorrendo ogni fotogramma di
quella vicenda, mi rendo sempre più conto di quanto fossero potenti quelli che
volevano Moro morto. La mia opinione è che dietro il sequestro ci fosse un
potere, una volontà troppo più forte di ogni tentativo che si potesse mettere in
atto per salvarlo. L’Onu, la Caritas, la Croce rossa internazionale, lo stesso
papa Paolo VI, chiunque tentasse di salvare la vita a Moro veniva bloccato a un
certo punto. Era come se, a un certo livello, a un livello talmente alto da
risultare più potente di qualunque altro, esistessero delle <> a cui dava
fastidio Moro vivo. << Entità>>forse non riconducibili a una sola persona, ma a
poteri e lobby. E credo che mio padre, dalla prigione in cui era detenuto, lo
avesse ben compreso. Le lettere che mandava all’esterno erano più che vere, e
non estorte con la minaccia delle armi o scritte sotto l’effetto di qualche
droga, come qualcuno a suo tempo insinuò. Nei suoi messaggi, papà non solo
parlava in coscienza, sapendo quello che diceva, ma parlava su più livelli.
Almeno quattro: la famiglia, il potere politico, i brigatisti e un misterioso
quarto livello che si intuisce dalle indagini, ma sul quale, forse per la ragion
di Stato, non si è arrivati a ricerche più approfondite. Appena sequestrato,
papà deve aver capito immediatamente chi erano i suoi veri interlocutori e con
loro ha cercato di parlare. E’ doloroso pensare che Aldo Moro non abbia avuto
dei veri amici. Di questo titolo, infatti, si potrebbero fregiare meno di cinque
persone. Altrimenti non sarebbe stato abbandonato e tradito da tutti. Persino da
molti suoi ex allievi, ai quali papà aveva dedicato tantissimo tempo togliendolo
a noi: lo hanno tradito anche dopo non difendendone la memoria. Mi dà inaudito
dolore. Come mi perseguita l’eterno confronto tra il prima e il dopo. Ogni cosa
mi ricorda papà e mi da dolore. Una sofferenza a cui si aggiunge infine quella
esponenziale e profondamente gratuita che scaturisce da un’ingiustizia: perché
non solo noi non abbiamo voce, ma altri, personaggi che non sanno nulla sulla
vicenda Moro o denigratori della figura di mio padre o ex brigatisti, invece si,
parlano come oracoli in televisione e sui giornali. E forniscono delle versioni
che, guarda caso, arrivano tutte sulla stessa conclusione: non c’è più niente da
sapere, dietro il sequestro Moro non c’era nessuna entità. E’ un’ingiustizia
troppo grande, per essere sopportata. Il 9 maggio del 2006 ho scritto al
Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano e ai presidenti delle due Camere,
Fausto Bertinotti e Franco Marini. Chiedevo, anche a nome degli altri firmatari
della lettera, che i familiari delle vittime venissero almeno equiparati agli
assassini nella possibilità di dar voce ai propri sentimenti e nel ricordo dei
propri cari. Risultato? Napoletano ha immediatamente risposto e mi ha assicurato
di aver trasmesso la mia richiesta alla Commissione parlamentare di vigilanza
sulla Rai. Bertinotti mi ha ricevuto con cortesia e celerità. Marini invece, non
ha risposto. Almeno fino a questo momento. Sarà perché è un ex democristiano? In
effetti, quell’area sembra non aver ancora metabolizzato la vicenda Moro.
D’altro canto, finchè il Paese non si sarà fatto carico di questo fardello, non
potrà riprendere il suo cammino. Tutti rimarranno inchiodati sul posto fino a
quando ognuno non si sarà assunto sulle proprie spalle il peso della sua parte
di responsabilità. Ma non sarà così per sempre. Anche se il potere continua a
creare terra bruciata interno a noi e a fabbricare versioni di comodo, non c’è
niente da fare: prima o poi, tutti, anche i mandanti, si dovranno confrontare
con la verità. Questa è una legge cosmica. Maria Fida Moro.
La figlia di Aldo Moro: i
brigatisti che sanno non parlano per paura,
scrive martedì 5 maggio 2015 “Il Secolo d’Italia”. «Non tutti i brigasti conoscono
la verità. E chi sa preferisce tacere. Per paura. Ma non per loro, per i loro
cari». Sono parole pesanti pronunciate dalla figlia di Aldo
Moro, Maria
Fida,
in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi in
edicola mercoledì 6 maggio. La figlia dello statista democristiano trovato
ucciso il
9 maggio 1978 spiega:
«Se non si farà chiarezza a livello collettivo sulle reali responsabilità della
morte di Aldo Moro questo Paese resterà nel fango». Maria Fida Moro racconta
anche che il padre tradì una promessa fatta alla moglie Eleonora: «Nel ’74,
durante le massime minacce, mia madre si era fatta promettere che avrebbe
lasciato la politica attiva. Ricordo che avevano litigato a morte per questo…
Mamma non gli aveva parlato per giorni. E lui non sopportava il suo silenzio:
per questo decise che avrebbe continuato a fare il professore universitario. E
che al massimo avrebbe fatto il presidente della commissione giustizia della
Camera». La figlia di Moro quindi rigetta l’ipotesi più volte avanzata dai
brigasti secondo la quale fu scelto Moro come obiettivo perché Andreotti godeva
di una protezione più alta: «È falso. È una menzogna reiterata! Mio padre non è
stato ucciso per sbaglio. Non è stata un caso la sua morte. Ma è stata voluta,
ordinata. Aldo Moro aveva, in Italia e in Europa, una funzione di mediazione, di
scomoda pacificazione. È stato eliminato perché si voleva arrivare a dove siamo
arrivati adesso. A una non politica. A un mondo di soli affari».
La figlia di Aldo Moro:
“Reintegriamo i brigatisti, hanno già pagato i loro sbagli”,
scrive Ilaria Giupponi
il 24
gennaio 2012 su “Il Fatto Quotidiano”. “Li guardo con affetto. Portano dentro un
peso perché sanno che non possono rimediare a ciò che hanno fatto. Dopo 34 anni,
io sto meglio di loro perché ho un dolore del quale non sono colpevole”.
Descrive così, Agnese
Moro,
le
Brigate rosse,
parlando degli esecutori dell’omicidio di suo padre, lo statista Aldo
Moro ucciso
il 9 maggio
del 1978.
Ospite del Comune di Monghidoro (Bologna)
in occasione della rassegna “La
verità rende liberi”, la più piccola dei figli del presidente della Dc dialoga
con Paolo
Bolognesi,
presidente dell’Associazione vittime dei familiari della strage alla stazione di
Bologna del 2 agosto 1980, sugli interrogativi della storia italiana. “Aldo Moro
fu lasciato morire”. Su questo non c’è ombra di dubbio per la figlia del
“cavallo di razza” della Dc, secondo la quale ci fu “un’inerzia
attiva per
far sì che lui non tornasse”. Eppure non c’è rancore quando parla di quelle
responsabilità che per lei sono di chiarissima attribuzione. “Penso che i
terroristi non vadano guardati come pazzi, ma come persone. Hanno capito che ciò
che hanno fatto era assolutamente sbagliato, e alcuni di loro hanno pagato per
questo. Ma in questo paese, se qualcuno ha fatto qualcosa di male, noi non lo
riprendiamo. Anche se la Costituzione vorrebbe e recita il contrario. Dobbiamo
continuare a negargli dei diritti?” Certo, chi ha premuto il grilletto e
organizzato il sequestro di Moro non è in discussione: “Io non credo a una
volontà al di fuori delle Br”, dice Agnese Moro. “Sicuramente ognuno ha giocato
la sua partita sfruttando l’occasione”. “Un formicaietto”,
così chiama l’intreccio di poteri che univa servizi segreti italiani a quelli
americani, la P2 e i vertici del potere della prima Repubblica fino alle bande
armate, “che si agitava intorno a un uomo che combatteva la sua battaglia umana
e politica da solo”. E che dal ‘76 stava lavorando all’idea di un governo di
solidarietà nazionale col Pci di Enrico Berlinguer,
per “rendere la democrazia effettiva. E questo non piaceva a tutti. Mio padre è
stato ucciso da quelli che non credono che la democrazia equivalga alla
giustizia”. Per quel “formicaietto”, Moro doveva morire, come ricostruisce l’ex
giudice istruttore e ora avvocato di Maria Fida Moro Ferdinando
Imposimato nel
suo omonimo libro, scritto con il giornalista Sandro Provvisionato ed edito
Chiarelettere. L’ex magistrato è oggi pronto ad andare a Strasburgo pur di fare
luce sulle parole inserite nel 2008 in un fascicolo archiviato della procura di
Roma da un
militare che
avrebbe sorvegliato il covo-prigione di via
Montalcini nei
15 giorni precedenti all’uccisione. Non dimentica Agnese Moro, oggi
sociopsicologa e ricercatrice: “Noi sappiamo tutto: sappiamo che c’era
l’attività esplicita della loggia massonica P2 di
cui allora non si conosceva ancora l’esistenza, e sappiamo che il comitato
di crisi,
il gruppo che governava le indagini sul rapimento, era tutto di appartenenti
alla loggia. Quello che non facciamo è trarne le conseguenze”. Ma non prosegue
quando Bolognesi ribadisce: “Non dobbiamo dimenticare che pochi mesi prima del
sequestro furono cambiati tutti i vertici dei servizi segreti da Francesco
Cossiga e Giulio
Andreotti,
i Dc allora rispettivamente ministro degli Interni e presidente del Consiglio
democristiani”.
Per la figlia dello statista assassinato, la ricerca delle responsabilità non
avviene solo seguendo la pista giudiziaria. E ricorda: “Ci sono altre verità che
non sono state neanche toccate. Come quella politica, certo, ma anche quella
sociale. Davvero possiamo considerare le Br gruppetti isolati?”. “La
contestualizzazione aiuta a capire più della criminalizzazione. E soprattutto,
permette una presa di responsabilità
individuale”,
spiega Agnese Moro. “Noi italiani ci siamo disabituati a pensare che ciascuno
può fare la differenza. Ci hanno convinti che arriverà sempre qualcuno che ci salverà.
Ma la ricostruzione di una democrazia non è una cosa che va avanti da sola: è
una gigantesca lotta contro poteri che non la vogliono. Siamo disponibili a
sacrificare qualcosa, perché questo cammino riprenda?” Durante la serata con
Paolo Bolognesi, vengono letti stralci delle lettere che il politico scrisse
dalla “prigione del popolo” brigatista di
via Montalcini alla
sua “Noretta”, la moglie, e la domanda arriva proprio dalle parole dell’uomo
assassinato: “Io mi chiedo in coscienza: Zaccagnini (Benigno,
allora segretario della Dc, ndr)
come fa a rimanere al suo
posto? E Cossiga che non ha saputo immaginare nessuna difesa?” Come uomo, oltre
che come un pilastro della storia italiana, lo ritrae la figlia. Parla di un
Moro tenero, “buffo”. “Un maledetto secchione”, lo definisce la figlia nel libro Un
uomo così (Rizzoli),
“che andava in spiaggia con giacca e cravatta perché gli italiani dovevano
essere rappresentati con dignità”. E conclude: “A casa avevamo due avversari: la
politica e i suoi allievi.
Tanto che dal carcere scrisse un biglietto al suo assistente pregandolo di
scusarsi con gli studenti perché quell’anno non avrebbe potuto portare a termine
il corso”. Infine pronuncia un frase che sulla figura di Moro dice tutto: “Gli
italiani erano come un membro della nostra famiglia”.
Maria Fida Moro: «Le
divisioni in casa non aiutarono mio padre».
A 34 anni dal sequestro delle
Br, la figlia del leader Dc accusa: il movimento Febbraio 74 seminò zizzania in
famiglia, scrive Giovanni Fasanella su “Panorama”. «Mia
madre scrisse quella lettera prima di morire per rimediare ad alcune sue
decisioni sbagliate. Non è un documento privato, è un testamento
storico-politico, perché tocca un aspetto del caso Moro rimasto in ombra: i
conflitti in famiglia durante i 55 giorni del sequestro. È giusto che ora venga
messo agli atti ed entri a fare parte della storia pubblica». A 34
anni esatti dalla strage di via Fani, molte di quelle ferite non si sono ancora
rimarginate. Una sanguina più di tutte: quella che lacerò sin dall’inizio la
famiglia del leader dc, rapito dalle Brigate rosse il 16 marzo 1978 e
assassinato dopo 55 giorni di prigionia, il 9 maggio. Che in casa Moro qualcosa
non fosse andato per il verso giusto lo si era appena intuito. Ma adesso è Maria
Fida,
primogenita di Aldo ed Eleonora,
a sollevare il velo, commentando una lettera scritta nel 2006 dalla madre e mai
resa pubblica per l’opposizione degli altri due fratelli, Agnese e Giovanni.
Qualche brano della lettera è apparso tempo fa, sul sito online della Stampa.
Ma poi sul documento è calato di nuovo il silenzio. Segnata dalla tragedia
familiare con 26 tumori in 34 anni e con tre preinfarti negli ultimi due mesi,
Maria Fida oggi è in convalescenza. E in questa intervista con Panorama parla
del movimento
politico Febbraio 74,
della presenza di suoi esponenti in casa Moro nei 55 giorni e del
«condizionamento» esercitato sulle decisioni della famiglia.
Nella lettera, sua madre Eleonora accenna al movimento Febbraio
74. Perché?
«La
storia va raccontata dall’inizio. Durante i primi giorni del sequestro, una
giornalista di un settimanale importante, mi pare fosse Dina Luce dell’Europeo,
ci chiese di venire a casa per seguire la vicenda Moro accanto alla famiglia. Io
dissi di sì, ma gli altri membri si opposero. Ecco, i problemi cominciarono
proprio quel giorno».
Perché si opposero?
«Devo
supporre che non volessero testimoni, che non volessero far sapere all’esterno
quello che accadeva nella famiglia».
Ma che cosa avrebbe potuto mai raccontare, d’imbarazzante per la
famiglia Moro, la giornalista Dina Luce?
«È
un tasto molto delicato, ma provo a spiegarmi. Qualche giorno dopo il sequestro,
i miei fratelli non volevano che io partecipassi ai funerali degli uomini della
scorta. Il motivo? Poteva essere pericoloso per mio figlio Luca... Io ci andai
lo stesso, ma fui bloccata all’ingresso della chiesa. Per fortuna un agente mi
riconobbe e mi fece entrare. Quell’episodio fu l’inizio della guerra in famiglia
contro di me e costituì uno dei punti di svolta dell’intera vicenda Moro. La
tensione era tale che un giorno mia madre si gettò in ginocchio e, in lacrime,
mi supplicò di andarmene via di casa».
Perché lei non poteva rimanere in casa?
«Il
nodo è tutto qui. Io mi sarei battuta per fare esattamente quello che papà ci
chiedeva dalla «prigione del popolo». Voleva che ci mobilitassimo, che facessimo
qualcosa per tirarlo fuori da lì. E probabilmente io sarei riuscita a convincere
anche la mamma. Ma forse era quello che qualcuno temeva».
Ma, scusi, la liberazione di Moro non era proprio l’obiettivo
della famiglia?
«È
ovvio che fosse così. Ma a giudicare dai fatti, chi dava suggerimenti al resto
della famiglia doveva essere proprio un pessimo consigliere. Un gruppo esterno
aveva «occupato» casa nostra sin dal giorno del sequestro: quelli del movimento
Febbraio 74 diretto dall’avvocato Giancarlo Quaranta, cui aveva aderito mio
fratello Giovanni».
Quindi, lei in casa avrebbe infastidito?
«Molto.
Ma perché?
«Bisognerebbe
capire come ragionavano i leader di quel movimento, dove volevano andare a
parare e se a loro volta erano consigliati da altri. Certo è che avevano la
pretesa di «gestire» l’atteggiamento della famiglia: loro, non Aldo dalla
prigione, non Eleonora dall’esterno, e tanto meno la figlia primogenita Maria
Fida che era stata cacciata di casa. Papà, nonostante la sua condizione, se
n’era accorto».
Come fa a esserne sicura?
«In
due lettere inviate a mamma le diceva di non ascoltare i consigli di nessuno,
tanto meno di estranei, e di andare in televisione per invocare una trattativa.
Non si fidava di nessuno. E voleva che fosse lui dalla prigione, e noi da casa,
a gestire la situazione».
Suo padre conosceva il movimento Febbraio 74?
«Certo
che lo conosceva. E lo detestava. I suoi collaboratori mi avevano raccontato
che, nelle elezioni del 1976, Febbraio 74 aveva fatto campagna contro la Dc con
un manifesto in cui si accusavano i democristiani di essere tutti ladri, e che
tra i primi firmatari c’era anche mio fratello Giovanni. Mamma poi riferì che
papà si era talmente offeso che, da quel momento, non aveva più voluto rivolgere
la parola a mio fratello: comunicava con lui soltanto tramite lei».
Quali consigli dava Febbraio 74?
«Indirizzava
la mamma e i miei fratelli verso un atteggiamento che, a mio avviso, non avrebbe
potuto mai portare a risultati positivi. Un atteggiamento di chiusura, di astio
nei confronti di tutto e tutti. Riuscirono a mettere la famiglia persino contro
la Dc. Rimanemmo completamente isolati».
Era a questo che si riferiva Francesco Cossiga, quando diceva che
all’interno della famiglia c’era chi si comportava come se non volesse la
liberazione di Moro?
«Sembrerebbe
un paradosso, ma ho ragione di ritenere che Cossiga si riferisse proprio a
questo. Tra le persone che giravano in casa in quei giorni, oltre a tanti cari
amici, c’era anche chi sembrava essersi introdotto esclusivamente per dividerci.
Di questo io sono sempre stata convinta. Se fossimo rimasti uniti e avessimo
seguito i consigli di papà, avremmo fatto tutto il possibile per salvarlo
rivolgendoci direttamente all’opinione pubblica. Papà ci diceva che sarebbero
bastate le firme di 100 parlamentari per costringere lo Stato a trattare. Ma
invece eravamo divisi, isolati, troppo deboli. Inevitabile che finisse com’è
finita».
Ma perché sua madre lasciava fare? Possibile che non si rendesse
conto?
«Si
illudeva che in quel modo potesse limitare i danni mantenendo almeno un’unità
formale della famiglia. Sapeva che io avrei comunque rispettato le sue
decisioni. Pur non condividendole e sapendo che cosa diceva papà di quel
movimento. Pensi che, sin dal 16 marzo, i suoi capi si comportavano come se la
nostra casa fosse la loro, sentendosi in diritto persino di spostare cose».
Neppure i suoi fratelli si rendevano conto?
«Erano
in simbiosi con quel gruppo. Io cercavo di farlo capire a mia madre. Ma non
c’era niente da fare: se fossi rimasta in casa, sarebbe stata guerra continua.
Per questo mi chiese di andarmene».
In seguito ha avuto modo di parlarne con sua madre?
«Sì.
E lei ha ammesso in lacrime di avere fatto «un macello». L’isolamento esterno
della famiglia e le divisioni interne provocate da elementi estranei concorsero
a determinare il tragico epilogo del sequestro».
Dopo la morte di suo padre, lei è potuta tornare a casa?
«Sì,
ma dopo tanto tempo. Intanto avevo perso il lavoro di giornalista alla Gazzetta
del Mezzogiorno,
conseguenza dei pessimi rapporti tra la famiglia Moro e la Dc. La mia elezione
in Parlamento mi aiutò poi a risalire la china. Tornai a casa perché avevano
bisogno di me. La mia indennità parlamentare fu completamente bruciata per
pagare i debiti della famiglia, che era rimasta senza reddito finché la mamma
non ricevette la sua pensione. Ho dovuto vendere i miei regali di nozze e la mia
stessa casa, per aiutare mamma e i miei fratelli. Una vita terrificante. Per le
conseguenze subite sul piano emotivo, economico e persino fisico. Ma soprattutto
a causa di un terribile, lacerante senso di colpa per non essere riuscita a fare
quello che papà ci chiedeva. E che tutti insieme avremmo dovuto e potuto fare,
se esterni ritenuti pericolosi dallo stesso papà non avessero controllato ogni
mossa della famiglia. Ancora oggi non riesco a capire come sia potuto succedere».
ALDO MORO: FU VERA GLORIA?
Da Sciascia alle Br: la
verità (vera) su Moro.
A 100 anni dalla nascita dell’ex presidente Dc, Veneziani va ancora
controcorrente, scrive "Il Tempo" il 23 Settembre 2016. L’articolo su Aldo Moro
a cent’anni dalla nascita ha suscitato un vespaio di polemiche ma vorrei
tornarci per ricordare stavolta l’epilogo tragico del Caso Moro, il ruolo delle
Br, della Dc e del Pci e cosa scrissero Sciascia e Pasolini di lui. Leonardo
Sciascia dedicò all’Affaire Moro un celebre e controverso saggio che fu
stroncato su la Repubblica dal suo Direttore, Eugenio Scalfari, già prima che
vedesse la luce. Di quella polemica resta uno slogan attribuito a Sciascia: né
con lo Stato né con le Brigate rosse. Ma è un’eco sommaria e non veritiera. Il
dibattito su Moro fu pirandelliano: cominciò infatti un anno prima
dell’assassinio Moro. E nacque dal defilarsi di sedici giudici popolari di
Torino di far parte d’un processo alle Brigate rosse. Sciascia, come Montale e
in parte Bobbio, comprese la loro paura e la loro sfiducia nello Stato. Ma il
Pci, impegnato a presentarsi come il partito dell’ordine e della difesa della
Repubblica, considerò queste obiezioni come defezioni. Quando Amendola lo accusò
di disfattismo e di nikodemismo (ricevendo il plauso di molti intellettuali, tra
cui Lucio Colletti), Sciascia replicò che Amendola rischiava di essere come
Liborio Romano, il ministro dell’Interno che passò dai Borboni a Garibaldi senza
smuoversi dalla sua poltrona. Poi notò l’uso capovolto delle parole coraggio e
viltà da parte dei comunisti: «Se ti conformi a quello che noi facciamo sei un
coraggioso, se osi dissentire sei un vile». In un altro scritto Sciascia arrivò
a sottolineare l’utilità funzionale delle Br nel quadro del compromesso storico:
dopo aver ridotto il dissenso dal Pci al rango criminale e dopo aver
destabilizzato il Paese, le Br finiranno quando la loro azione «si rovescerà in
una solida stabilizzazione». Non so se la dietrologia arabesca di Sciascia fosse
fondata, ma vero fu l’esito da lui previsto dell’azione brigatista: la loro
destabilizzazione rafforzò l’establishment, spezzò le aspirazioni al cambiamento
e bruciò ogni ipotesi di alternanza. L’intreccio dialettico tra corruzione e
violenza è la chiave di lettura dell’Affaire Moro e degli anni di piombo: per il
Partito Armato le azioni terroristiche servivano a colpire il Partito dei
Corrotti; ma il Partito dei Corrotti a sua volta trovava nel Partito Armato
l’alibi per restare sempre al potere: meglio i ladri che i terroristi. Nessun
vero cambiamento era possibile: o il compromesso storico o la guerra civile. È
il pendolo italiano che Sciascia rifiutava e che ritrovò in Moro e nei suoi
carnefici. Perché Moro viene colpito dalle Br? Perché appare ai loro occhi come
il Grande Corruttore. Non il Gran Corrotto, si badi bene; anche Pasolini che
aveva scritto il primo grande processo alla Dc e al Palazzo, precedendo le Br e
i giudici di Mani Pulite, giudicava Moro lo stratega principe e perfino il
filologo del Palazzo e delle sue trame, ma non personalmente coinvolto nel
malaffare. Allora in che senso Moro era ritenuto il grande Corruttore? In un
triplice senso. Grande corruttore perché Moro era stato il più autorevole
difensore del Palazzo, della partitocrazia e della Dc nel memorabile discorso
(allusivo anche al processo di Pasolini) su Gui, Tanassi e l’affare Lockheed.
Non si processa la Dc, disse Moro, gettando le basi per il processo che poi subì
da parte delle Br. Moro divenne così agli occhi dei rivoluzionari come il
Teologo del Palazzo e dei suoi misteri. Ma Moro era ai loro occhi Grande
Corruttore in un altro senso: perché con la sua strategia avvolgente e
aperturista corrompeva il Pci nell’abbraccio mortale del Compromesso storico.
Dunque andava eliminato, anche per salvare l’anima al Pci, oltre che il destino
della sinistra e della classe operaia. L’eliminazione di Moro era anche un modo
per decapitare la Dc e consegnarla all’egemonia del Pci che assumeva il ruolo di
garante dell’ordine e della stabilità. Congetture, che ebbero uno strascico
pesante per Sciascia perché fu querelato per diffamazione da Berlinguer quando
riferì una sua opinione, poi smentita, circa le responsabilità dei servizi
segreti cechi nel caso Moro. C’era infine una terza ragione per cui Moro
appariva come il Grande Corruttore. Una ragione intellettuale, filologica, colta
da Pasolini e da Sciascia. Moro inventò un linguaggio incomprensibile di cui fu
depositario in vita ma anche vittima (perché nessuno colse i messaggi cifrati
delle sue lettere dal carcere delle Br), che secondo Sciascia serviva a tenere
oscura e impenetrabile la chiave del potere, Arcana Imperii. La lingua di Moro
era per lo scrittore siciliano come il latino usato dalla Chiesa per rendersi
incomprensibile al volgo e indurlo in devozione. Una lingua che corrompeva la
democrazia perché rendeva i percorsi della politica inaccessibili al popolo
sovrano. Sciascia non teorizzò l’equidistanza dallo Stato e dal terrorismo ma
criticò questo tardivo e poco credibile conato di fermezza sul caso Moro dopo
anni di cedimenti: «dopo trent’anni di corruzione e incompetenza», di violenza e
mafia tollerate, di «scuole occupate e devastate» e di trattative con la
criminalità. Sciascia si rifiutò di considerare Moro uno statista, ritenendolo
privo di senso dello Stato e definendolo «un grande politicante». A Moro
rimproverò pure di non aver speso una parola nelle sue numerose lettere dal
carcere per la sua scorta che aveva perso la vita in via Fani. Sciascia denunciò
la rete larga di connivenze intorno al terrorismo rilevando già nel 1977 che «è
in atto un’espansione del partito armato che sta trovando insediamenti sociali».
Egli fu il primo a denunciare da sinistra l’ipocrisia sulle Br che per
intellettuali, politici e media erano cripto-fasciste: «Le Brigate rosse - lo
ribadì in Nero su Nero - erano rosse e non nere come tutti i partiti del
cosiddetto arco costituzionale desideravano che fossero». Sciascia poi rivelò la
contraddizione del 25 aprile: «la marea della retorica sale», dal Pci e dai
partiti dell’arco antifascista nei giorni del sequestro Moro ma «il guaio è che
quella Resistenza è un valore indistruttibile anche per le Brigate rosse:
credono di esserne i figli». La repubblica italiana e i suoi nemici delle Br si
appellavano l’uno contro l’altro alla stessa origine e legittimazione, la
Resistenza, ritenendosi entrambi prosecutori. Sciascia poi notava a proposito
degli attacchi che riceveva dai paraggi del Pci: «Questa specie di terrorismo
verbale è stato battezzato nella stessa parrocchia in cui è stato battezzato
quello che spara: la parrocchia dello stalinismo» (Corriere della sera, 21 marzo
1978). Si fronteggiano due stalinismi, aggiungerà nell’Affaire Moro. Sulla
vicenda Moro avvenne un tragico gioco delle parti: i partiti che usufruirono
della strategia morotea, che spingevano per il compromesso storico, furono gli
stessi che decretarono la sua morte, rifiutando la trattativa con le Br; invece
il partito che intendeva scardinare la strategia morotea incentrata sull’asse
Dc-Pci, vale a dire il Psi di Craxi, si adoperò per salvarlo. Moro fu
sacrificato sull’altare del moroteismo. Ma oggi non ci sarà spazio per la storia
e la riflessione sul caso Moro, prevarrà come sempre il conformismo celebrativo,
e chi si sottrae a quest’orgia disgustosa è bollato di «livore». Figuratevi se
un mite teorico, ucciso dalle Br, possa suscitare tanti anni dopo, «livore». Nel
paese dei codini e degli accodati, viene scomunicato come livoroso chi esprime
dissenso e giudizio critico per amor di verità.
Ripensando a Moro
attraverso Sciascia,
scrive Valter Vecellio su "L’Opinione” il 24 settembre 2016. Piaceva, a Leonardo
Sciascia, “frugare” nelle cataste di libri degli antiquari, alla “caccia” di
quella preziosa edizione francese, o di quell’acquaforte ritratto di uno
scrittore ammirato e amato. Capitava di accompagnarlo in quel suo girovagare,
come quella volta che, felice, aveva recuperato una ventina di volumi de “La
Scala d’Oro”, libri che aveva letto e gustato da ragazzo, e che voleva
leggessero e gustassero gli amati nipoti. E a dispetto dell’immagine-cartolina
che lo vuole taciturno, immusonito, guardingo, era un parlare di tutto e su
tutto, e con grande spirito di divertita e paziente ironia. Ma, anche,
naturalmente, discorsi e conversare molto serio; come quella volta che, già
nella Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro, eletto deputato del
Partito Radicale, racconta perché aveva voluto scrivere “L’Affaire Moro” che
tante polemiche aveva sollevato; e poi perché aveva accettato di entrare nella
Commissione d’inchiesta: “Volevo e voglio smascherare quello che mi pareva e mi
pare un delitto. Perché Moro è stato ucciso due volte: dalle Brigate Rosse e da
coloro che lo hanno negato, che lo hanno disconosciuto, che hanno detto cioè di
non riconoscere nel prigioniero delle BR il Moro di prima”. E ancora: “Quelli
che lo hanno negato, non possono restare nascosti dietro la ragione di Stato. La
ragione di Stato potevano anche difenderla, ma non dicendo che Moro era
diventato un altro. Moro era rimasto indefettibilmente fedele a se stesso, a se
stesso cristiano, soprattutto democristiano. Presentarlo come impazzito di paura
è stato, cristianamente, umanamente, un delitto”. Nel ripensare a quelle parole,
come non riconoscere che dobbiamo farli, eccome, i conti con Aldo Moro; e più
propriamente, forse, si deve anche dire che Moro aspetta dal 16 marzo del 1978,
che tutti noi si faccia i conti con lui. E sono tanti, a partire proprio dai
suoi ultimi cinquantacinque giorni di vita, da quel 16 marzo quando viene rapito
dalle Brigate Rosse, al 9 maggio, quando viene ritrovato morto a Roma, dentro la
famosa Renault rossa, in via Caetani. In che senso fare i conti: nel senso che
ne dà Leonardo Sciascia in una lunga intervista al settimanale francese “Le
Nouvel Observateur” nel giugno del 1978: “Moro morendo, nonostante tutte le sue
responsabilità storiche, ha acquistato un’innocenza che rende tutti noi
colpevoli, dunque anche me. Sono rimasto molto scosso dalle sue ultime volontà,
che mi rammentano quelle di Pirandello. Il fatto è noto... Pirandello era
fascista, ma ha voluto essere sepolto completamente nudo per paura che lo
vestissero con la divisa fascista, come avevano allora l’abitudine di fare per i
dignitari del regime. Morendo, Aldo Moro si è, per così dire, spogliato della
tunica democristiana. Il suo cadavere non appartiene ad alcuno, ma la sua morte
ci mette tutti sotto accusa”. Per “L’Affaire Moro”, che ancora oggi è di
preziosa lettura, Sciascia patisce una delle innumerevoli “lapidazioni” che di
volta in volta gli sono riservate da destra e da sinistra. Il punto centrale
della questione è questo: si accredita, si è accreditato, un Moro di prima,
“grande statista”; poi un Moro prigioniero che non ha il senso dello Stato. Moro
uno e due, insomma. Una grande mistificazione. Aver accreditato, aver
letteralmente inventato un Moro “grande statista” (mentre è stato un grande
politico, ma senza il senso dello Stato, che ne aveva, per esempio, un Alcide De
Gasperi), è quello che, per Sciascia, è il secondo delitto consumato; da chi,
appunto, lo ha disconosciuto. Il punto centrale, il nodo del dramma: Moro anche
in quei 55 giorni di prigionia è lucido e continua a pensare come ha sempre
pensato; e lo si riduce a un “pazzo”, un “plagiato”. Ci è stata offerta in quei
giorni quella terribile mistificazione. Moro è solo, negato, tradito. È in quei
55 giorni, e attraverso le lettere che Moro può scrivere e far recapitare, che
abbiamo il ritratto più autentico del personaggio: politico con due soli
princìpi: la sua radicata fede cattolica e lo spirito di libertà. Per il resto,
come osserva Sciascia, “c’erano la trattativa, la mediazione, la duttilità
continua. Non era un uomo da cozzare contro la realtà. Era un uomo che qualsiasi
realtà si proponeva di far ingoiare nelle sabbie mobili del cattolicesimo
italiano”. Per quel che riguarda il dover fare i conti con noi stessi: si tratta
appunto di quel pantano, quella micidiale sabbia mobile fatta di mistificazione
e conformismo che si muove contro il Moro senza più potere, e avvolge l’intero
Paese, tutti noi. Innegabile, per esempio, che i principali mezzi di
informazione si siano comportati ignobilmente, in quei giorni; per non parlare
della classe politica, con pochissime eccezioni; e per tutti quei pochissimi
faccio tre nomi: Bettino Craxi, Marco Pannella, Umberto Terracini, il Partito
Socialista, il Partito Radicale, un comunista “eretico”, per il quale la verità
contava sempre più e prima del partito. Sciascia comincia sempre i suoi lavori
con una frase emblematica che è un po’ il simbolo-guida di quello che vuole
scrivere. “L’Affaire Moro” si apre con un paio di righe tratte da “La provincia
dell’uomo” di Elias Canetti: “La frase più mostruosa di tutte: qualcuno è morto
‘al momento giusto’”. Agghiacciante e terribile. Più oggi, forse, di allora.
«Vi racconto la storia
dimenticata del giovane Aldo Moro di destra».
Gli anni de La Rassegna raccontati da Marcello Veneziani alla vigilia del
centenario, scrive Michele De Feudis il 22 settembre 2016 su “Il Corriere della
Sera”. La storia dimenticata del giovane Aldo Moro, intellettuale «di destra»,
ostile al Cln e agli eccessi dei partigiani, con sensibilità riconducibili al
reazionarismo dell’Uomo Qualunque. Questo è il ritratto tracciato da Marcello
Veneziani, scrittore e filosofo barese, nel dialogo con il Corriere del
Mezzogiorno alla vigilia del centenario della nascita dello statista pugliese.
Veneziani, dal 1998 a Maglie c’è una statua di Moro con l’Unità sotto il
braccio.
Si può ridurre il suo
itinerario politico-culturale alla prospettiva del compromesso storico Dc-Pci?
«Quel ritratto scultoreo si
presta ad una volgare mitologia: Moro come una sorta di comunista di
complemento. C’è invece da riprendere un tassello sconosciuto della sua
biografia che ribalta tanti stereotipi».
Da dove partiamo?
«Da un articolo scritto da
Giuseppe Tatarella, negli anni Sessanta, intitolato “Quando Moro non era Moro”.
Allora Pinuccio era un giovane avvocato, giornalista del combattivo periodico
“Puglia d’Oggi””.
Su cosa si fondava la
polemica del politico missino?
«Risaliva alle idee di Moro
nel periodo 1943-46, a Bari. Allora era destrorso, scriveva sul settimanale “La
Rassegna”».
Il capoluogo pugliese al
tempo era un vero laboratorio nazionale, fucina di idee e futuri leader.
«C’era “Radio Bari”, un
fiorire di pubblicazioni come “l’Avanti” di Eugenio Laricchiuta, l’azionista
“Italia del popolo” e il primo giornale non clandestino del Pci, “Civiltà
proletaria” diretto da Michele Pellicani. Si stampava anche “il Manifesto”,
primo giornale neofascista, diretto da Pietro Marengo, e “L’Italia liberale” di
Giuseppe Perrone-Capano».
Che orientamento aveva La
Rassegna a cui collaborò Moro?
«Vi scrivevano accademici che
oggi si direbbero di centro-destra: Pasquale Del Prete, Francesco Maria De
Robertis…».
Dei trascorsi giovanili nei
Guf dello statista pugliese ne scrisse già nel dopoguerra Nino Tripodi nei saggi
“Italia fascista in piedi” e “Intellettuali sotto due bandiere”.
«Su La Rassegna, invece,
emerge un Moro sottilmente antipartitocratico, che sferza anche la Dc e fa
trasparire sintonie con l’Uomo Qualunque».
Un Moro di “destra”?
«L’8 maggio del 1945 Moro
scrive: “Le destre come consapevolezza storica, come visione realistica della
vita umana, come misura vigile contro le tentazioni dell’entusiasmo, non possono
e non debbono essere sconfitte”».
A che categoria si
riferisce?
«A una destra come mentalità o
fattore prepolitico che si caratterizza per realismo».
Come declina questa
sensibilità?
«Distingue così tra destre e
sinistre: “le prime pronte a riconoscere valore all’ideologia avversaria, finché
non diventi esclusiva, le seconde portate invece a negarle del tutto, se pure si
adattano per ragioni tattiche, al compromesso della convivenza”. Evidenzia la
tentazione illiberale di certe sinistre».
Cosa temeva il giovane
intellettuale della sinistra nel 1943?
«Moro condivise la battaglia
de “La Rassegna” contro gli eccessi del Cln. Scriveva nel 12 marzo del ’45 che
“la milizia irregolare” dei partigiani richiamava “spiacevoli ricordi della
rivoluzione permanente e del suo presidio armato… noi guardiamo con tanto timore
l’esercito dei partigiani… e certe spavalderie da bravi”. Intuì i rischi di una
guerra civile nella quale i gruppi partigiani più estremisti “si facciano
persino giustizia da sé. E di che giustizia si tratti si può bene immaginare”.
Per un uomo mite e prudente come Moro, questi scritti furono una rilevante presa
di posizione in un periodo nel quale si andavano definendo gli spazi d’azione
tra le varie forze politiche democratiche».
Come fu accolta questa
posizione nell’Italia del tempo?
«Per La Rassegna, notava
Tatarella, fu coniata da “Civiltà Proletaria” e da “Italia del popolo” la nuova
parola “neofascismo”: Moro e l’intera redazione furono tacciati di avere origini
fasciste mal celate e di carrierismo e opportunismo».
Poco dopo entrò nella Fuci.
«Un percorso in polemica con
la Dc ciellenista guidata a Bari da Troisi e Calcaterra. Poi le vicende della
storia, il realismo politico e forse il cinismo, portarono Moro verso sinistra».
La fatalità del destino ha
dato forma alla preveggenza dei suoi timori giovanili.
«Conservò sempre l’indole
moderata, un orientamento di destra sociale, figlio della dottrina sociale della
Chiesa come formula efficace per superare gli scontri di classe. Purtroppo non
aveva fatto i conti con la “giustizia armata” delle “milizie irregolari”, le
Br…».
L’improbabile
santificazione dell’ex "fascista" Aldo Moro,
scrive il 20/09/2016 Marcello Veneziani su "Il Tempo". Giovedì sarà il
centenario della nascita di Aldo Moro e al Quirinale sarà celebrato solennemente
come grande statista. È in corso pure un processo per canonizzarlo. Con tutto il
rispetto che si deve a una vittima delle Brigate rosse e a una fine intelligenza
politica, Moro non fu né un santo né un grande statista. E non lo dico perché
Moro fu il teorico dell’apertura a sinistra e poi del compromesso storico, ma
perché in lui il senso dello Stato e ancor più della Nazione fu sempre
subordinato al senso del Partito e del Potere democristiano. Le sue esperienze
di governo non furono molto significative per l’Italia, non si ricordano grandi
riforme e grandi opere legate al suo nome. Non paragonabili, non dico a De
Gasperi ma neanche a Fanfani. Di lui si ricordano le ambiguità e i teoremi, i
funambolismi e le fumosità lessicali, sferzate anche da Sciascia e Pasolini. Da
Ministro degli Esteri si ricordano pagine amare per il nostro Paese, la sua
dignità e la sua integrità, con Tito e con Gheddafi, con l’est comunista e gli
Stati Uniti. Mai l’amor patrio fu così flebile e avvilito in Italia come al
tempo di Moro (non solo a causa sua). La sua tragica fine nelle mani sanguinarie
delle Br suscita ancora dolore e pietà. Ma alcune sue lettere dalla prigionia
non spiccarono affatto per senso dello Stato. Per non dire dell’affare Loockeed,
la sua difesa della partitocrazia e lo scandalo dei petroli che coinvolse suoi
stretti collaboratori. La sua biografia rivela una brillante carriera politica e
accademica ma non è quella di un santo o di un grande statista. Per cominciare,
imbarazza quel che il professor Moro scrisse nel corso universitario del ’43
sullo Stato circa la razza, considerato «elemento costitutivo della nazione».
«La razza - scrisse Moro - è l’elemento biologico che creando particolari
affinità, condiziona l’individuazione del settore particolare dell’esperienza
sociale, che è il primo elemento discriminativo delle particolarità dello
Stato». Nel periodo che va dal 1943 e il 1946, Moro fu tra i fondatori del
settimanale barese La Rassegna, che fu accusato di neofascismo e qualunquismo
dalla sinistra. Nei suoi scritti di allora, Moro diffida dei partiti, Dc
inclusa, si appella agli apolitici e agli indipendenti, guarda con simpatia
all’Uomo qualunque di Giannini e al governo Badoglio e non disdegna di
dichiararsi a certe condizioni «uomo di destra». L’8 maggio del ’45 Moro scrive:
«Le destre come consapevolezza storica, come visione realistica della vita
umana, come misura vigile contro le tentazioni dell’entusiasmo, non possono e
non debbono essere sconfitte». Moro si riferisce a una destra come temperamento,
come mentalità; rispetto ad esse «noi siamo di destra limitatamente a questa
serena realistica considerazione». In precedenza, Moro aveva notato la
differenza di stile tra destra e sinistra: «le prime pronte a riconoscere valore
all’ideologia avversaria, finché non diventi esclusiva, le seconde portate
invece a negarle del tutto, se pure si adattano per ragioni tattiche, al
compromesso della convivenza». Quasi proiettando i tratti del proprio carattere
nella destra, Moro notava che «la ragione della debolezza delle destre» fosse in
quella «timidezza cauta» che non incendiava le masse «galvanizzate dalla
irruenza veemente della intransigenza di sinistra». Di destra sociale, si
potrebbe dire, perché Moro impiantava i suoi valori di libertà e di realismo
sulla dottrina sociale cristiana. Del resto, la sua stessa iscrizione alla Dc
nel ’46 avvenne su spinta dell'arcivescovo Mimmi di Bari, un conservatore che lo
aveva nominato segretario nazionale dei laureati cattolici e poi lo aveva
sostenuto alla guida della Domus Mariae per frenare le aperture a sinistra nella
Dc di un altro ex-fascista e dossettiano, Amintore Fanfani. Moro condivise la
battaglia de La Rassegna contro il Cln, contro le epurazioni e l’egemonia dei
partigiani. Scriveva il 12 marzo del ’45 che «la milizia irregolare» dei
partigiani richiamava «spiacevoli ricordi della rivoluzione permanente e del suo
presidio armato... noi guardiamo con tanto timore l’esercito dei partigiani... e
certe spavalderie da bravi». E temeva soprattutto che le armate partigiane,
godendo di perfetta autonomia, «si facciano persino giustizia da sé. E di che
giustizia si tratti si può bene immaginare». Per un intellettuale dal linguaggio
paludato come Moro era già un significativo esporsi. E infatti fu accusato dai
giornali baresi di sinistra, Civiltà Proletaria e Italia del popolo, di
«neofascismo» e «attendismo carrierista». L’accusa era questa: questi redattori
già fascisti, fanno ora gli indipendenti, perché non hanno ancora capito a quale
partito convenga oggi affiliarsi. Moro si staccò dal giornale qualunquista alla
fine del '45 per dedicarsi alla Fuci, in polemica con la Dc troppo legata al
Cln. Ma conservò l’indole moderata di chi voleva narcotizzare l’avversario e
sedare i conflitti. Tentò la stessa così decenni dopo col Pci, ma non fece di
fatto i conti con la «giustizia armata» delle «milizie irregolari», di cui aveva
scritto nel ’45... È grottesco pensare che nella sua città natale, Maglie, fu
eretta la statua di Moro con l’Unità sotto il braccio. Intanto prosegue il
processo di santificazione di Aldo Moro, servo di Dio, promosso da due suoi
fedelissimi, Luigi Ferlicchia, presidente del centro studi Moro e Nicola
Giampaolo, postulatore della canonizzazione. Ferlicchia è pure convinto che Moro
sia stato vittima del Kgb sovietico: ricorda un borsista che seguiva le lezioni
di Moro, Sergeij Sokulov, agente del Kgb, che avrebbe condotto Moro per braccio
nel rapimento di via Fani. Una tesi condivisa da due stretti collaboratori di
Moro, Franco Tritto e Renato Dell'Andro. Misteri, come la sua prigionia e la
linea dura della Dc e delle istituzioni nelle trattative. L'uccisione di Moro
brucia ancora, ma come diceva Sant’Agostino, non è la pena ma la causa a fare i
martiri. I veri santi si sacrificano nel nome della fede cristiana (non
democristiana), dedicano la loro vita a opere di carità, compiono miracoli,
avvicinano a Dio. Moro rientra in questi canoni? Un San Moro politico c’è già: è
San Tommaso Moro, primo martire della Brexit, perché cinque secoli fa si oppose
allo scisma anglicano dall’Europa cattolica e pagò con la vita. Aldo Moro fu
ucciso perché cercò il compromesso storico, che non piaceva a tanti, tra cui gli
Usa, l’Urss e i brigatisti rossi. Il suo era un disegno politico, non della
Divina Provvidenza. Marcello Veneziani
Su Aldo Moro dette troppe
cose sbagliate,
scrive il 22/09/2016 Giuseppe Fioroni su “Il Tempo”. Giuseppe Fioroni Presidente
della Commissione d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Devo
dire con rispetto, ma in spirito di verità, che Marcello Veneziani mi ha deluso.
Non discuto il diritto di sfidare l’opinione di quanti - e sono la stragrande
maggioranza - considerano Aldo Moro una figura eminente della nostra Repubblica;
viceversa discuto la semplificazione che porta addirittura a denigrare le
qualità politiche e morali dell’uomo, tanto da negare che gli si possa
attribuire la qualifica di statista (sulla santità, chiaramente, non mi
pronuncio). Perché tanto livore su Moro? Nell’articolo apparso martedì scorso su
queste colonne Veneziani, appunto, adombra la mancanza di visione e
l’insufficienza di leadership. Eppure Moro, artefice nel 1962-1963 del primo
centrosinistra organico, seppe offrire alla Nazione una prospettiva di crescita
democratica, allargando la base della partecipazione popolare alla vita dello
Stato. Cattolici e socialisti, rimasti fuori dal processo risorgimentale,
finalmente ritrovavano la loro funzione attiva nella cornice di un comune
impegno patriottico. Questa è stata, in politica interna, la grande
trasformazione degli anni ’60. Ed essa esprime esattamente il contrario di
quello che Veneziani afferma a proposito del rapporto di Moro con il potere. In
Moro il senso della collettività nazionale (e della persona) prevale di gran
lunga sull’appartenenza di partito e non viceversa. Moro lo aveva del resto già
dimostrato nei lavori della Commissione preparatoria per la Costituzione,
quando, dialogando e confrontandosi con socialisti, comunisti e azionisti,
contribuì...
Quella destra che non ha
mai capito le aperture di Moro,
scrive Luciano Lanna il 21 settembre 2016 su "Il Dubbio". Una risposta
all'articolo di Marcello Veneziani sul "Tempo". In realtà il processo di
canonizzazione non c'entra proprio niente. Perché la polemica contro la presunta
"santificazione" di Aldo Moro, contro cui si scagliava l'intervento di Marcello
Veneziani di ieri sul quotidiano romano Il Tempo, non è altro che la
riproposizione del giudizio che una certa area (in realtà trasversale) della
politica di questo Paese ha da sempre riservato all'ex statista e leader
politico pugliese. Ripetere, infatti, che Moro non espresse significative
esperienze di governo, che «non si ricordano grandi riforme e grandi opere
legate al suo nome», che anzi emergerebbero di lui «ambiguità» nei confronti di
Tito o di Gheddafi, che la sua figura sarebbe simbolo della deriva democristiana
nei confronti di una politica di respiro nazionale, significa non solo
confondere le acque ma soprattutto non affrontare tutti i nodi irrisolti che - a
nostro avviso - appaiono in tutta evidenza attraverso la lettura del ruolo
svolto nella politica italiana del secondo dopoguerra da Aldo Moro. Il quale,
invece, resta come uno dei principali "avatar" dell'interpretazione complessiva
della storia politica del nostro Novecento. Il tragico destino, sia umano sia
politico, di Moro insieme a quello di altri due statisti significativi dello
stesso secolo come Mussolini e Craxi - ferma restando la differenza di epoca e
di scenario - è a nostro avviso un capitolo ancora tutto da chiarire nelle sue
implicazioni generali, soprattutto di ordine internazionale e geopolitico. Non
c'è infatti bisogno di scomodare i lavori di Giovanni Fasanella, che restano
comunque estremamente utili, per avvicinarsi alla complessità di azione di
politica estera nazionale che i tre statisti succitati esercitarono più o meno
direttamente e di cui, in buona parte, finirono anche vittime. Non si può, in
altre parole, parlare di Aldo Moro - e del suo centrosinistra - senza far
riferimento, soprattutto, alla sua politica estera. Che si poneva in continuità
con quella vocazione nazionale italiana che, partendo da Crispi e Giolitti, e
passando per Balbo e Mussolini, arriva in linea diretta sino all'episodio di
Sigonella con il governo Craxi. È una politica terzaforzista e d'indipendenza
nazionale che, all'epoca di Moro, di concerto con le strategie dell'Eni di
Enrico Mattei, approfondisce una nostra linea autonoma nel Mediterraneo tra Nord
e Sud e tenta un'intesa con i Paesi arabi anche oltre la logica di Yalta
Est/Ovest. Una politica che, tra l'altro, puntava ad affrancare l'Italia
dall'egemonia francese e britannica e sosteneva una nostra indipendenza
energetica. Dentro questo c'è, ovviamente, quello che sarà chiamato il "lodo
Moro" nei confronti dei palestinesi, ma anche una certa distensione nei
confronti dell'Est comunista. Una scelta geopolitica che cozzava contro le forze
- traversali - che erano schierate per altre opzioni: la preferenza per le Sette
Sorelle petrolifere, l'occidentalismo spinto in politica militare, la
Confindustria come alleanza economia collaterale interna. Stava insomma in
queste scelte il cuore di quel centrosinistra Moro-Nenni che, sin dall'inizio,
scatenerà contro di esso tutti i suoi avversari interni allo schieramento
politico e parlamentare nazionale. Tanto che, per guardare agli ambienti da cui
proviene l'articolo di ieri sul Tempo, anche lì, d'altronde nei primi anni
Sessanta, ci fu chi si pose il problema di dove collocarsi. Tra questi Luciano
Lucci Chiarissi, un ex repubblichino che "rompe" con il Msi e crea un soggetto
in cui si aggregano postfascisti che, a sorpresa, guardavano con simpatia alle
politiche di Aldo Moro, Pietro Nenni ed Enrico Mattei. «Si stava costruendo -
racconterà Lucci Chiarissi in un libro degli anni Settanta - un vero miracolo
economico, c'era un'Italia viva, malgrado ogni apparenza ufficiale, per la
prepotente energia costruttiva degli italiani. I quali, proprio attraverso tanti
avvenimenti, guai e vicissitudini, avevano aperto gli occhi sul mondo, e più non
si accontentavano della meschina realtà che per secoli li aveva tenuti
prigionieri, nei borghi e nelle loro case, di una società fossile. Erano sorti
dovunque cantieri, fabbriche, centri di lavoro. Forse a modo loro gli italiani
tentavano così di riscattare le ore della disfatta bellica... ». Ma nonostante
ciò buona parte degli ambienti della destra italiana, rilevava amaro Lucci
Chiarissi, non solo non seppero comprenderlo ma, in realtà, si posero dall'altra
parte. L'Italia di Aldo Moro venne infatti snobbata con la banale battuta di
"Repubblica fondata sulle cambiali". Proprio contro questo, Lucci Chiarissi,
insieme a chi la pensava come lui, aveva fondato, nel 1963, la rivista
L'Orologio: «Annibale non è alle porte. E comunque - vi si leggeva - non lo è a
causa del centrosinistra». Tanto più che, solo per fare esempio, la riforma
della scuola media attuata allora ricalcava il modello di quella mai attuata da
Bottai nell'ultimo periodo dell'esperienza fascista. Al contrario, negli anni
del moroteismo, la destra missina (e non) sceglie altre intese, come racconterà
un eretico quale Giano Accame: «Nella venerazione per l'ectoplasma dello Stato,
nelle alleanze di questo Stato e del suo establishment, con delle professioni di
occidentalismo che parevano a tratti la ripetizione maniacale di scenari del
passato, con gli americani messi al posto dei tedeschi; nel coinvolgimento in
tante battaglie di ritardo, per le quali ha poi incontrato di volta in volta
compagni di strada in interessi economici o posizioni mentali che non trovavano
più altrove copertura, e così sarà per le Sette Sorelle contro l'Eni di Enrico
Mattei, con l'establishment contestato contro la protesta giovanile, con
l'elezione di Leone alla presidenza della Repubblica». Di contro, le vicende di
quegli anni dimostrano un Aldo Moro, fine politico cattolico, teso soprattutto
al superamento delle lacerazioni della società italiana, finalizzato a
ricomporre un tessuto nazionale unitario in cui tutte le componenti sociali e
culturali, finanche politiche, si potessero ritrovare insieme. Non a caso, di
lui si ricorda l'accorato discorso alla Camera, da premier, per commemorare con
grande rispetto il parlamentare missino Filippo Anfuso. Così come ieri sul Tempo
si ricordava l'impegno giovanile di Moro contro le epurazioni e per la
pacificazione nell'immediato dopoguerra. Perché, in sostanza, di Aldo Moro il
dato centrale sarà sempre la tensione verso l'aggregazione di tutte le
componenti politiche del Paese in un progetto ampio e unitario. E se non è
questa politica nazionale, che cos'è? D'altra parte, come mai dalle lettere
dalla sua prigionia l'ultimo Aldo Moro si rivolse più volte direttamente al
generale Vito Miceli, che oltre a essere uomo di sua fiducia e capo
dell'intelligence italiana negli anni del suo governo fu anche parlamentare del
Msi? Ma c'è un episodio, riportato nel libro di un altro postfascista, Luigi
Battioni, uno dei più stretti collaboratori di Pino Romualdi - il vero fondatore
del Msi - che mai valorizzato come dovrebbe è forse la migliore replica
all'atteggiamento espresso, anche ieri sul Tempo, da buona parte della destra.
Racconta infatti Battioni in Memorie senza tempo (Fergen, 2009) che -
plausibilmente nel 1977 - una domenica sera Moro si imbatte in Romualdi,
personaggio che lui stimava e con cui interloquiva - su un traghetto tornando
dalla Sardegna. Riferì testualmente l'esponente missino a Battioni: «Il pensiero
di Moro è come una matassa aggrovigliata, ma se hai la pazienza di cercare il
bandolo, tutto si snoda perfettamente e il pensiero diventa lucido, preciso come
un teorema. Moro è veramente - questo era il giudizio di Romualdi - la testa
pensante della Dc, una buona testa…». L'argomento principale del colloquio,
comunque, fu sulla necessità di costruire in Parlamento una maggioranza davvero
nazionale vasta, per consentire al Paese di affrontare al meglio anni di crisi e
di terrorismo. «Inevitabile - spiegò Moro a Romualdi, il quale, pur da uomo
dell'opposizione di destra, comunque capiva - che occorre vincere le resistenze
popolari e di una certa opinione pubblica per portare nella maggioranza di
governo anche il Pci, ovviamente insieme ai socialisti, e così realizzare una
coalizione in grado di disporre di oltre il 70 per cento dei consensi e delle
forze parlamentari». Stando al resoconto, Romualdi non si scompose affatto,
mostrando di comprendere, mentre Moro aggiunse: «Sarà inevitabile ma proficuo
per il Paese. Io non mi nascondo le difficoltà per convincere gli elettori
moderati e, quelle ancora maggiori, per tenere al passo i comunisti nel governo,
affidando loro responsabilità precise, senza possibilità di smagliature, di
slabbrature, di sfondamenti a favore di ciò che a loro interessa. Io conosco
quello che è accaduto a Praga e conosco il metodo. Ma l'unico all'altezza di
tale compito sono io, e io solo…». Una strategia, quella che poi conosceremo
come "compromesso storico", la quale tendeva a inglobare, "sdoganare" come si è
detto poi, il Pci, disinnescandone le residue pulsioni antisistema e
responsabilizzandone la classe dirigente all'interno di un progetto nazionale
che - stando a questa ricostruzione - Moro avrebbe voluto, forse, che fosse
compreso anche dalla destra. Poi, come è andata la storia lo sappiamo. Con il
solo Craxi e i radicali a cercare di salvare Moro, durante il suo sequestro da
parte delle Br, attestati sulla cosiddetta "linea della trattativa". E gli
altri, inclusa la destra almirantiana, tutti barricati sul fronte della
fermezza. Con il risultato, guardando all'area destra dello schieramento
politico e culturale, che ancora oggi a fronte della permanenza di una
"strategia dell'equivoco" sull'intera parabola morotea non si registra neanche
una voce critica nei confronti, per restare al campo democristiano, di figure
oggettivamente controverse come Andreotti o Cossiga. E qualcosa deve pur
significare.
I posteri pronunciano l’ardua sentenza: fu una vergogna! Morte (e
vita pubblica e privata) poco cristiana, parecchio anarchica e per niente eroica
di un pover’uomo di Stato, che si credeva lo Stato, ma senza alcun senso dello
Stato. Per tacer del “santo”…, scrive
Antonio Margheriti
“Il Mastino” su “Papale Papale” del
16/05/2012.
Parte 1: La “famiglia pasticciata” del presidente.…mi
ha molto colpito scoprire una cosa sulla famiglia Moro. Qualcosa che non la fa
proprio corrispondere al santino di sacra famiglia che in contemporanea alla
canonizzazione laica di Moro, quale presunto santo dottore e martire (e a
momenti pure vergine) di una sorta di res-publica christiana immaginaria, gli è
stato dipinto addosso. Viene fuori una famiglia Moro lacerata, con figli
contestatori, con la madre che un giorno sì e l’altro pure veniva alle mani con
le figlie, di una moglie che aveva pessimi rapporti col marito, di un Moro che
ogni sera cercava ogni scusa per non rientrare a casa prima dell’una di notte,
di modo da trovare moglie e figli già a letto; che non trovava neppure un piatto
coperto, tanto che si faceva un uovo al tegamino da sé nottetempo… Francesco
Cossiga, facendomi rimanere di stucco, racconta del periodo che precedette il
sequestro Moro: “Io e Andreotti conoscevamo la vera situazione della famiglia,
una famiglia pasticciata… con le moglie Eleonora le cose non andavano bene…”
Guardo adesso, l’ho qui davanti, la sezione della mia biblioteca
destinata agli studi sui 54 uomini che governarono l’Italia: i nostri capi del
governo, da Cavour a Monti.
Le ho collezionate non per fancazzismo, ma per una ragione seria. Un tempo,
infatti, avevo deciso di dedicarci la tesi di laurea ai nostri (allora) 53 primi
ministri, tanto più che mi dovevo laureare alla sezione storico-politica di
Scienze Politiche, alla Sapienza. Emblematico luogo accademico quello: da lì,
fin dagli albori ad oggi, ma ai miei tempi soprattutto, di capi del governo hai
voglia quanti ne erano passati, se ne erano fatti, ci avevano bivaccato, persino
governato da quel mio dipartimento. Per tacere della mole di ministri e
presidenti di qualcosa che ancora vi pullulavano: nei miei anni di studente
ricordo
Giuliano Amato e
moglie, la Diana
Vincenzi (che
a un esame di diritto privato quasi mi fece piangere, e come non bastasse mi
bocciò tre volte in un mese); ricordo Giovanni
Caravale che
nessuno sopportava da ministro ma che era peggio da professore, e poi Antonio
Marzano ministro
di Berlusconi,
mezzo governoDini,
l’antico Giovanni
Galloni,
il presidente Capotosti, Fisichella,
tanti altri notabili. Spesso avevamo in comune aule e professori con
Giurisprudenza, e del resto i locali delle due facoltà si fondevano insieme.
Poco tempo prima, sotto le nostre finestre era stata ammazzata Marta
Russo,
poco dopo era toccato a un altro dell’ambiente: Massimo
D’Antona.
Anni prima, sulle scale di questa mia tormentata Facoltà avevano assassinatoBachelet,
che era accompagnato dalla sua allora giovane (e già brutta) assistente: Rosy
Bindi,
che lo vide morire; ancora più tardi un altro della nostra Facoltà fece la
stessa fine:
Ruffilli.
Andando ancora indietro con la memoria, c’era stato negli anni ’70 lo scandaloso
omicidio-suicidio dei Casati
Stampa:
il ragazzo che si scopava la marchesa con la benedizione del marchese guardone,
era un nostro “collega” di Scienze Politiche. Una Facoltà un po’ maledetta,
insomma. Per concludere: mi piaceva l’idea di scrivere la tesi su capi del
governo italiani che, a decine, in quei corridoi avevano lavorato: da Salandra a
Orlando a Luzzatti, da Amato ad
Antonio Segni,
da Giuseppe
Pella aLeone.
E Moro.
Sì, Aldo Moro è stato forse il più assiduo e appassionato frequentatore di
quelle stanze, non solo come professore ma specie come “maestro”. Ossia: gli
piaceva moltissimo il rapporto diretto con gli studenti, circondarsene, fare
seminari con loro, persino in case private: si sentiva allora al suo stato
naturale, il
Maestro per
diritto divino e i suoi
discepoli per
legge di natura. Si rilassava a fare il prof, quasi un hobby. Negli ultimi mesi
della sua vita, conscio dell’amore appassionato che una studentessa dell’alta
borghesia romana nutriva per lui, che certamente aveva un suo anomalo fascino,
aveva cominciato ad accettare di tenere cenacoli accademici con i suoi studenti
in casa di questa ragazza. Sequestrato, indirizzò alla ragazza che lo amava ben
due lettere, che per motivi immaginabili, e la famiglia Moro e le istituzioni,
avevano tenute lontane dai riflettori. Sì, lui che in vita sua, in qualsiasi
contesto sempre in
cattedra era
stato e mai ne era sceso, alla cattedra universitaria ci rimase attaccato
ostinatamente anche quando impegni maggiori avrebbero dovuto allontanarlo. E’ di
Moro che voglio parlare. No no, mica per fare un’analisi storico-politica del
personaggio, Dio me ne scampi: ne sarei capace, sia chiaro, ma la pigrizia me lo
impedisce. Oltretutto non servirebbe a una mazza su questo sito. E per giunta mi
annoierei da morire: in caso, ci sono tanti libri seri sull’argomento che
potreste consultare. Gli stessi che ho qui davanti a me: decine di volumi
biografici e analitici, la metà dei quali con la stessa dignità scientifica
delle agiografie di santi del primo millennio, pessimi, se escludiamo la prima
analisi critica e acida post-mortem, quella di Italo
Pietra Moro:
fu vera gloria?;
libro coraggioso e facondo di un antico cavallo di razza del grande e perduto
laicissimo giornalismo d’inchiesta all’italiana, del quale riparleremo. Anche se
direi che l’opera più profonda, seria, lunghissima, puramente politologica, e
per tutte queste succitate qualità, pedantissima e noiosissima, è quella scritta
da don
Gianni Baget Bozzo.
Teologo mirabile, politologo stimabile, prete malamente, uomo peggiore. Non
voglio analizzare né psicoanalizzare Moro, non voglio ricostruire una ceppa di
niente. Dice: che
scrivi a fa’ allora?, ma statte zitto e nun fa’ perde’ tempo alla ggente! Sì,
dovrei chiudere qui il discorso, anche perchè alcuni mi ricordano che Moro ha
lasciato al mondo una famiglia assai suscettibile, dalla querela facile, come è
anche facile alle recrimininazioni. Per esempio (vi dirò in seguito), l’unico
maschio di Moro, il figlio
Giovanni,
or sono un quattro anni, querelò nientemeno Cossiga,
così stimato dal padre, per “diffamazione”. E l’ex presidente, come suo costume,
se la legò al dito per poi vendicarsi: da allora, infatti, non perse occasione
di sputtanare i Moro, raccontando in pubblico, nelle interviste, nei libri,
particolari intimi piuttosto imbarazzanti della famiglia del leader DC. Cossiga
era così: se lo provocavi, se lo sfidavi, stante la sua lunga consuetudine
questurina con il lerciume degli incartamenti degli italici servizi più o meno
segreti più o meno veritieri e più spesso no, dei quali dal Viminale sempre si
era occupato, stante questa sua mal-forma mentis, pigliava carte o ricordi con
cose riservate su di te, foss’anche una cartella clinica con dentro i cazzi ed
emorroidi tua (se eri fortunato), e li gettava sornione in mezzo la strada in
pasto al pubblico. Poi, magari pentito o simulando contrizione, porgeva le sue
scuse: a buoi scappati, naturalmente… se no che vendetta è? In effetti molte
cosette delle quali vorrei dire, dove la gola profonda è proprio manco a dirlo
il Picconatore, pure quelle le lascerò cadere: qua non stiamo oltretutto su
Dagospia, sito che fra le altre cose pare avesse proprio Cossiga fra i suoi
principali cobra soffiatori.
E sia chiaro: manco per niente voglio discettare della tipologia di
cattolicesimo di Moro, se fosse dossettiano o meno (e non lo è, secondo me, non
del tutto). Dice: non vuoi parlare di Moro politico, non di quello cattolico,
non vuoi parlare manco di Cossiga cobra, non vuoi parlare de ‘na pippa e
nonostante ciò stai blaterando da mezzora… ma
de che voi parlà nzomma?
Ma di niente. Bazzecole, pinzellacchere, quisquilie. Spunti, ecco, cosette che
ho trovato qua e là su Moro, da quel lettore e bibliofilo onnivoro e compulsivo
che sono. Cosette che però mi hanno fatto riflettere a lungo. Su questo statista
che ho sempre avuto sullo stomaco. E prima di dire perchè non lo
reggo, fia cosa laudabile soffermarci un secondo sul termine “statista”. Lo era
il Moro? No, direi. Se a questo termine, pomposa Treccani a parte, devo dare la
definizione che ne ha dato un uomo attendibile stante il suo curriculum. Tal
prof. Francesco Cossiga, sempre lui: “E’ uno statista colui che governa avendo
come vero e unico criterio lo Stato. Anche per Mussolini il
fascismo era una pseudocostruzione ideologica ma tutta basata sul primato dello
Stato. E infatti i grandi statisti italiani sono stati soltanto Cavour, Giolitti,
Mussolini e De
Gasperi”.
Moro no, sostiene questo suo allora giovane prediletto. “Non fu uno statista né
un grand’uomo di governo. Fu un grande leader politico-ideologico. Forse il più
grande. Laico. Non come Andreotti.
Andreotti era il segretario di Stato permanente della Santa Sede. Moro era laico
nell’agire”. A proposito di questa sua “laicità” e più ancora del suo essere
“leader politico-ideologico”. Ascoltavo qualche mesotto fa Giuseppe
De Rita al
convegno romano pieno di dinosauri che celebrava il non so più quanti “secoli”
della DC – certo è che se li portava malissimo a giudicare dai 2/3 d’ospizio che
c’era in sala, e per il restante comunisti scudocrociati, De Mita e Bindi in
primis –. Ebbene, il dinosauro di Stato, arcivescovo del dossettismo e dottore
serafico del cattocomunismo, De Rita, racconta questo episodio. Anni ’70, Moro e
Andreotti aprono una polemica a distanza, sulle illeggibili e anestetizzanti
riviste di solfa ideologico-omiletica democristiana, ciascuno su quella della
sua corrente o spiffero politico. Moro con dolorante sicumera da abate Faria
dice: “La politica ha il compito di orientare e dirigere la società”. Un
programma decisamente e radicalmente rivoluzionario, leninista. Risponde
Andreotti con gelida cattolica-romana saggezza di alta sacrestia d’altri tempi:
“No, la politica non ha il compito di orientare né dirigere un bel niente.
Tantomeno la società. Ha semmai il dovere di accompagnarla, sostenerla,
assecondarla, seppure in modo vigile, nella strada che ha intrapreso”. Qui si
vede l’astrattezza ideologica del primo – pensavo fra me e me – e la concretezza
scettica del secondo. Qui, pensavo sempre, si vede quanto la Dc fosse utile,
nell’uno e nell’altro caso, al cattolico: almeno quanto a me è utile una cirrosi
o un carcinoma. Qui si vede pure, mi dicevo, come Moro abbia potuto teorizzare e
realizzare il per nulla casto
connubio con
i socialisti, la stessa cosa che stava per fare con i comunisti; e, dal canto
suo, Andreotti, teorico dell’assecondare la
società nel suo cammino, firmare la legge sul divorzio e guidare un governo, il
primo, sostenuto dai comunisti. E nonostante ciò, sentirsi la coscienza a posto.
Ma non rischiamo di fare della politologia, altra scienza amena gentile omaggio
del secolo passato, maledettissimo. Stiamo alle bazzecole-pinzellacchere, come
promesso. Da “studioso” della storia dei governi italiani mi sono sempre
meravigliato di una cosa. Mentre durante il Regno d’Italia la presidenza del
consiglio era il vertice delle aspirazioni e anche del potere dei notabili
liberali, poi, con la prima repubblica, le cose son cambiate. Un po’ perchè
comunisti e democristiani alla Costituente, diffidenti gli uni degli altri e
incerti sull’esito che avrebbero avuto le prime elezioni repubblicane, ancora
ossessionati dai fantasmi del governo autoritario fascista, erano interessati,
chiunque avesse prevalso, a dar vita a governi di gracile costituzione, anemici
di poteri, paralitici nelle articolazioni, rachitici da cadere come foglia secca
al primo venticello. Un po’ perchè i democristiani, poi, superata l’era
degasperiana, del governo se ne strafottevano. Non erano uomini di stato, erano
uomini di potere, talora ideologi, intellettuali, o gente di sacrestia che da
perfetti chierici avevano imparato l’arte di non essere ossessionati dalle
cariche, smania indecorosa, appariscente, vanitas vanitatis, e anche perché
spesso altro non erano che gusci vuoti. Sapevano infatti i giovani marpioni da
sacrestia DC, che il potere spesso era altrove, nella sfera magica delle
indefinibili alchimie che li raccordavano alle masse dalle quali promanava la
potenza che essi avrebbero incarnato come sacerdoti austeri e terribili. Nei
partiti, per esempio, nei posti più grigi e apparentemente meno gallonati e
appetibili. Ma i DC non erano dei vanitosi, erano uomini di geometrico realismo.
Apro qui adesso un libro di storia repubblicana a caso… una Storia
dell’Italia Repubblicana di
un allora giovane Giorgio
Bocca…
sfoglio… ecco un esempio: ennesimo governo Moro negli anni ’70, Forlani è
chiamato agli interni, il più nobile dei ministeri, ma scocciato e sbadigliante
lo rifiuta. Misteri democristiani! Oggi non accadrebbe: magari succede che
abbandonano il partito se non hanno ottenuto il ministero. Forlani, da vecchio
chierico DC, sapeva però che non stava rinunciando al potere: sapeva di
rinunciare soltanto a un potere formale per uno sostanziale; sapeva, da vecchio
residuato di sacrestia, che molte volte il vicario generale di una diocesi dal
suo posto riesce a contare più del vescovo. È gusto del potere allo stato puro,
è roba da intenditori sopraffini. Dunque, cosa mi meraviglia? Voglio ancora
insistere sul concetto di prima. Conosco più o meno tutti gli uomini che sono
stati ministri della prima repubblica, e conosco tutti i primi ministri di
quell’epoca. E mi sono sempre meravigliato (ma fino a un certo punto) di come
questi qui talora rifiutassero con assoluta leggerezza se non indifferenza
cariche che altri avrebbero ucciso per ottenere. Per una cazzata banalissima
rifiutavano di essere ministri degli esteri, per scetticismo e pigrizia
rinunciavano al ministero della giustizia, con svogliatezza salivano al
Quirinale per essere incaricati di formare il governo, e alla prima scusa se ne
lavavano le mani rinunciando e rifilando ad altri l’incarico, che con eguale
apatia sì e no l’accettavano. Ma come, mi chiedevo, ma possibile che un figlio
di operai, di contadini, di maestri di scuola gli capita l’occasione più unica
che rara di essere il successore di Cavour, di Crispi,
di sedere sulla poltrona che fu di Giolitti e
Mussolini, e se ne sbatte altamente? Probabilmente, mi rispondo, partito di
governo senza alternativa la DC, carriere politiche che diventavano al suo
interno a vita, per loro non era affatto un’occasione unica e nemmeno rara una
poltrona del genere: prima o poi gli sarebbe ricapitata. O più realisticamente,
uomini di potere puro, sapevano benissimo che presidenza del consiglio e
ministri non contavano davvero quasi una cippa. Il potere era altrove, nel
partito, lì era anche il segreto della loro longevità politica. Significa anche
che mentre avevano il senso del potere, al contempo mancavano di senso dello
Stato. Non è un caso che tutti i democristiani che avevano più senso dello Stato
che non del potere, prendi Scelba,
videro cessare la loro sfolgorante carriera già negli anni ’50, agli albori
della repubblica cioè, mentre evaporavano anche i ricordi del degasperismo,
altro uomo tutto senso dello Stato e zero del potere. In questo c’è anche
un’altra qualità del chierico democristiano: le virtù da sacrestia della
pazienza e della temperanza. O come diceva Machiavelli,
“dell’essere golpi per sbigottire i lupi”. Ecco, Moro questo, tutto questo lo
aveva capito. Moro era così. Tutti erano concordi nel dire che del governo non
gliene fregava nulla. A meno che questo non fosse stato veicolo per realizzare
in potenza, come disegno nell’aria, il contesto per un mutamento ideologico,
parafulmine terreno di astrattezze speculative, “ragionamenti” che fluttuavano
impalpabili lassù nel cielo, nella speranza che presto, non sapendo come e
quando, s’abbattessero sulla testa degli uomini, delle cose, della nazione
mutandone la forma e la sostanza, polverizzando in un attimo quello che era
prima. Sistema di pensiero moroteo, che in soldoni poteva così sintetizzarsi:
mutare i massimi sistemi con la forza d’urto dell’inerzia. Con lo scetticismo
del “servir non credendo”. E in definitiva accontentarsi del “disegno” soltanto,
anche perchè già fare il “disegno” maledetto, per il Moro corrispondeva all’aver
assolto al 99% del compito… e questo è quanto! Cose da intellettuali della Magna
Grecia appunto, da ideologi, e Moro ideologo era. Un teorico fumoso. Quando nel
1963 gli fu, giovane com’era, consegnata la guida del governo, succedendo al
ducetto Fanfani che
aveva messo tutti in allarme, non solo per i suoi trascorsi di “mistico
fascista”, per la quadrata mascella, le mani sui fianchi, il concionare
metallico, isterico e ducesco, ma soprattutto per il suo strafare attivista,
nevrotico e alacre, per essersi autoincoronato con la tiara dalla triplice
corona di capo del governo, ministro degli esteri e segretario della Dc, ebbene
succedendo al Mezzo
Toscano sapete
quale fu l’atteggiamento di Moro? Di svogliatezza, stanchezza, indifferenza. Era
diventato il successore di Cavour e lui non se ne fregava niente, nemmeno ci
pensava. Viveva il governo, l’amministrazione concreta del potere, come un
impiccio, una faccenda futile. Erano le idee, e più che le idee i disegni fatti
col dito ad altezze incommensurabili, fra le nuvole che contavano per lui. Il
quotidiano, che è la realtà del governo – gli spazi angusti e delimitati di
legalità entro cui si muove, – non lo interessava: le sue astrattezze dai
contorni sfumati dovevano fare a meno dello spazio e del tempo, della
quotidianità appunto. Lui era già oltre la terra, nel limbo semantico di
iniziati angelicati, ancora di forma umana ma già stemperati in essenza
acorporale, asessuata, in ogni caso ormai mondati dalle passioni umane e
liberati dal destino dei comuni mortali. Creature sospese, a metà fra cielo e
terra, semidei. Ecco, così moralmente, politicamente e intellettualmente si
percepiva Moro. Era una teologia del potere la sua. La legittimazione a
permanere sulla scena a un così svogliato e pessimo governante era data non dai
risultati della sua vaporosa azione di governo, ma da una giustificazione per sola
fide nella
politica come sinfonia di idee astratte, e più che dalle idee dai “disegni”
morotei; che poi altro non erano che un “ragionar” allo sfinimento purchessia,
disegnar ragionando. Al di là dello spazio e dei tempi, al di là del bene e del
male. Per diritto divino, volontà degli arcana imperia, rassegnazione devota
della nazione, paralisi provvidenziale del sistema, forza dell’inerzia di Moro
stesso. Un simile fancazzista cervellotico in qualsiasi paese normale non
sarebbe stato cacciato a pedate dal Palazzo: non ci sarebbe mai entrato a
Palazzo: in Inghilterra sarebbe rimasto un direttore delle poste a Liverpool, a
Mosca un campione di giochi agli scacchi, in Germani non avrebbe avuto neppure
il fegato di essere un burocrate dello sterminio. De
Mita era
uguale: pur mancando della sottigliezza di Moro, era egualmente incomprensibile:
in più aveva la volgarità, fisica, di stile, morale, linguistica anche… mentre
Aldo era pur sempre un gran signore; come Moro, De Mita era privo di senso dello
Stato, più di Moro però aveva il senso del potere, ma un senso terragno,
territoriale, aggressivo, animale, cagnesco, da guappo assessore al bilancio
vita natural durante del comune di Nusco. De Mita era un anticlericale e un
agnostico, non aveva nessuna reale fede se non come dato culturale, nominale:
Moro ci credeva sul serio. Pure le mogli dei leader democristiani erano così…
come dire?…donnone de casa, matrioske russe come quelle dei leader sovietici. Se
si esclude la signora Leone,
la bella e giovane
donna Vittoria,
della quale però ci si accorse solo dopo l’elezione al Quirinale del marito che
pure aveva cariche ininterrottamente dagli albori della repubblica, le altre
mogli di notabili DC non solo mostravano totale indifferenza e spesso fastidio
per la carica altissima conquistata dal marito; ma questa loro apatia era
visibile anche fisicamente, nella sciatteria con la quale si vestivano, si
conciavano, si comportavano. Dalla ostinata vocazione all’invisibilità, alla
repulsione per i teleobiettivi. E onestamente, massaie rurali e provinciali come
erano rimaste, non era manco decenza presentarsi o presentarle in pubblico.
Qualcuno dirà che i leaders democristiani sembravano perennemente “vedovi e
senza prole”, e forse fu Pansa a
dire che in un congresso DC si respirava ferale aria “vedovile” ma al maschile.
Tutti indici che ci indicano di quanto poco incidesse, rispetto, che so, alle
first ladies americane, il potere, le cariche istituzionali sulla vita privata
dei capi democristiani, su mogli e figli. Eleonora
Moro gli
italiani la conobbero soltato all’uccisione del marito: solo in un’occasione
ufficiale in cui era obbligatorio l’accompagnatrice fu vista e fotografata, con
un fazzoletto in testa come una contadina marchigiana, accanto al marito. Non
mise mai piede in alcun palazzo del potere. Così le altre signore della
repubblica. C’è qualcosa di molto curiale, di celibato ecclesiastico figurato in
questi atteggiamenti, di monacale e di sacrestanesco. Dopotutto i notabili della
DC non abbiamo detto si percepivano come austeri sommi sacerdoti del potere?
Dunque, le loro “perpetue” non c’era bisogna salissero sull’altare: la canonica
bastava e avanzava. A proposito della famiglia Moro. Difficilmente i grandi
leader italiani sono fortunati con i figli. Del resto è difficile competere con
padri tanto ingombranti. Se questi padri riescono a mettere al mondo dei figli
mediocri è già un successo. Se non ne mettono proprio al mondo, è grasso che
cola. Più spesso hanno famiglie penose in tutti i sensi, per mogli e figli. Fin
qui parlo in generale. Andando nel caso specifico mi ha molto colpito scoprire
una cosa sulla famiglia Moro. Qualcosa che non la fa proprio corrispondere al
santino di sacra famiglia che in contemporanea alla canonizzazione laica di
Moro, quale presunto santo dottore e martire (e a momenti pure vergine) di una
sorta di res-publica christiana immaginaria, gli è stato dipinto addosso. Viene
fuori una famiglia Moro lacerata, con figli contestatori, con la madre che un
giorno sì e l’altro pure veniva alle mani con le figlie, di una moglie che aveva
pessimi rapporti col marito, di un Moro che ogni sera cercava ogni scusa per non
rientrare a casa prima dell’una di notte, di modo da trovare moglie e figli già
a letto; che non trovava neppure un piatto coperto, tanto che si faceva un uovo
al tegamino da sé nottetempo. Chi racconta tutto questo è sì uno che si è legato
al dito le insolenze e le eccentricità di alcuni figli di Moro, che “giocano a
fare i figli della vittima”; è anche un amico stretto di Moro, col quale il
leader si confidava per sfogarsi di tutte le amarezze che subiva in famiglia; è
persino un uomo potente, che a sua volta ha anch’egli una tristissima e
desolante, nonché fallimentare, storia coniugale alle spalle: è Francesco
Cossiga.
Il quale, facendomi rimanere di stucco, in un libro con Sabelli
Fioretti racconta
del periodo che precedette il sequestro Moro:
“Io
e Andreotti conoscevamo
la vera situazione della famiglia, una famiglia pasticciata… con le moglie
Eleonora le cose non andavano bene… Se Moro ti incontrava alle dieci di sera eri
fottuto perchè ti teneva a discorrere fino a mezzanotte pur di non tornare a
casa presto. Lui tornava a casa all’una e si faceva un uovo al tegamino. Quando
lessi [nelle lettere dalla prigionia] ‘Dolcissima
Norina…’ Andai
da Andreotti e gli dissi: ‘Qui
c’è qualcosa che non funziona… dolcissima Norina? Ma quale dolcissima Norina?’. Pensi
che quando fu pubblicata la prima fotografia da sequestrato lui aveva un cerotto
in faccia. Noi dicemmo, mentendo, che tirandolo fuori dalla macchina i
brigatisti lo avevano fatto sbattere contro la portiera ferendolo. E non era
vero. La verità è che lui era andato a sbattere contro un comodino e si era
fatto male cercando di separare la moglie e la figlia”… che se le davano di poco
santa ragione. Probabilmente è di Maria
Fida Moro che
si parla. Vedremo come i figli di Moro prenderanno nella loro vita strade
politiche (e non solo) del tutto divergenti dall’indole e dalle idee di Moro. Il
guaio più grosso, però, è che cominciarono a imboccarle già a babbo non ancora
morto. Sbattendogliele in faccia. E per giunta, nei momenti più difficili e
sofferti della carriera del padre. Ora, non c’è cosa più brutta e umiliante
nella storia domestica di un padre di famiglia, che ha dato tanto lustro alla
famiglia col suo solo lavoro, che ritrovarsela compatta e all’unisono
recriminante, tutta contro, nei momenti in cui avrebbe più bisogno del sostegno
di ciascuno. È così che Cossiga racconta
a Renato
Farina
questa amara storia familiare dell’amico Aldo: “Non accetto il
ruolo di Eleonora Moro come sposa innamorata. Gli rese la vita infernale. Lui
resisteva in casa solo perchè tornava tardi la notte. Non voleva mai rientrare,
sperava che la moglie dormisse. Altrimenti erano litigi con lei o con i figli da
lui amatissimi. Lo ricordo una volta scendere dall’aereo in arrivo da Bari da
dove era giunto con la famiglia. Era rabbuiato: gli avevano detto in coro
(moglie e figli) che non avrebbero votato Democrazia Cristiana. In quel momento
in cui si decideva tutto quanto il loro padre avesse a cuore…”. A proposito di
Eleonora, un amico, attivista pro-life, su facebook mi ha raccontato una cosa,
che spero (anzi, no) sia vera. Questo amico, dunque, Fabrizio, abitando come la
moglie di Moro all’EUR, frequentava anche la sua stessa messa domenicale. Una
volta, all’uscita, l’ha voluta salutare. E le ha posto delle domande a tema…
cattolico, su divorzio e aborto. Ora non ricordo i termini esatti, però in
soldoni la vecchia gli rispose: “Noi dobbiamo molto al femminismo, e a questo è
dovuta l’emancipazione. La donna ha il diritto di poter scegliere. Anche se
portare avanti una gravidanza”. Se è vero, la Bonino non avrebbe saputo dir di
meglio. Il peggio è che si era all’uscita dalla messa. Ma del resto pure il
figlio di Vittorio
Bachelet,
cattocomunista, appena fuori il portone della chiesa, dopo la comunione, si
dedicava a esternazioni pro-aborto e pro-ogni-porcheria. E per la verità alla
domanda di un giornalista – “dalle lettere di Moro traspare un forte legame con
la moglie….” – il figlio Giovanni ha risposto dicendo e non dicendo: “Sì, ma era
un rapporto molto… insomma, nella vita famigliare, Moro non era granché
presente. Lui usciva la mattina, e magari tornava alle due di notte. Non c’era
la domenica, nè le feste… Non ricordo che fossimo andati, neanche una volta a
mangiare fuori. Se si voleva chiacchierare con lui, lo si faceva da mezzanotte
in poi, e per cena lo si doveva aspettare. Non esisteva la dimensione
quotidiana”. Che grossomodo conferma le confidenze di Cossiga. Se non fosse che
la stessa Maria Fida Moro a sua volta, a conferma dei cattivi rapporti
famigliari, proprio sul fratello Giovanni poco tempo fa ha fatto insinuazioni
terribili:
Qualche giorno dopo il sequestro, i miei fratelli non volevano che io
partecipassi ai funerali degli uomini della scorta (…) Quell’episodio fu
l’inizio della guerra in famiglia contro di me e costituì uno dei punti di
svolta dell’intera vicenda Moro. La tensione era tale che un giorno mia madre si
gettò in ginocchio e, in lacrime, mi supplicò di andarmene via di casa (…) Io mi
sarei battuta per fare esattamente quello che papà ci chiedeva dalla «prigione
del popolo». Voleva che ci mobilitassimo, che facessimo qualcosa per tirarlo
fuori da lì. E probabilmente io sarei riuscita a convincere anche la mamma. Ma
forse era quello che qualcuno temeva. La liberazione di Moro non era proprio
l’obiettivo della famiglia? È ovvio che fosse così. Ma a giudicare dai fatti,
chi dava suggerimenti al resto della famiglia doveva essere proprio un pessimo
consigliere. Un gruppo esterno aveva «occupato» casa nostra sin dal giorno del
sequestro: quelli del movimento Febbraio 74 diretto dall’avvocato Giancarlo
Quaranta, cui aveva aderito mio fratello Giovanni. Quindi io in casa davo molto
fastidio. Ma perchè? Bisognerebbe capire come ragionavano i leader di quel
movimento, dove volevano andare a parare e se a loro volta erano consigliati da
altri. Certo è che avevano la pretesa di «gestire» l’atteggiamento della
famiglia: loro, non Aldo dalla prigione, non Eleonora dall’esterno, e tanto meno
la figlia primogenita Maria Fida che era stata cacciata di casa (…) Mio padre
conosceva il movimento Febbraio 74. E lo detestava. I suoi collaboratori mi
avevano raccontato che, nelle elezioni del 1976, Febbraio 74 aveva fatto
campagna contro la Dc con un manifesto in cui si accusavano i democristiani di
essere tutti ladri, e che tra i primi firmatari c’era anche mio fratello
Giovanni. Mamma poi riferì che papà si era talmente offeso che, da quel momento,
non aveva più voluto rivolgere la parola a mio fratello: comunicava con lui
soltanto tramite lei. Questo movimento indirizzava la mamma e i miei fratelli
verso un atteggiamento che, a mio avviso, non avrebbe potuto mai portare a
risultati positivi. Un atteggiamento di chiusura, di astio nei confronti di
tutto e tutti. Riuscirono a mettere la famiglia persino contro la Dc. Rimanemmo
completamente isolati. Era a questo che si riferiva Francesco Cossiga, quando
diceva che all’interno della famiglia c’era chi si comportava come se non
volesse la liberazione di Moro? Sembrerebbe un paradosso, ma ho ragione di
ritenere che Cossiga si riferisse proprio a questo. Tra le persone che giravano
in casa in quei giorni, oltre a tanti cari amici, c’era anche chi sembrava
essersi introdotto esclusivamente per dividerci. Di questo io sono sempre stata
convinta. Se fossimo rimasti uniti e avessimo seguito i consigli di papà,
avremmo fatto tutto il possibile per salvarlo rivolgendoci direttamente
all’opinione pubblica. Papà ci diceva che sarebbero bastate le firme di 100
parlamentari per costringere lo Stato a trattare. Ma invece eravamo divisi,
isolati, troppo deboli. Inevitabile che finisse com’è finita. Ma perché mia
madre lasciava fare? Possibile che non si rendesse conto? Si illudeva che in
quel modo potesse limitare i danni mantenendo almeno un’unità formale della
famiglia. Sapeva che io avrei comunque rispettato le sue decisioni. Pur non
condividendole e sapendo che cosa diceva papà di quel movimento. Pensi che, sin
dal 16 marzo, i suoi capi si comportavano come se la nostra casa fosse la loro,
sentendosi in diritto persino di spostare.
Così Maria Fida, la figlia “ribelle”. Non più la “sola”… a quanto pare. InFida?
Bah: qui pare molto lucida e sincera.
Certe volte mi verrebbe da sospettare – e per la verità, qui pure, è Cossiga che
fa filtrare l’insinuazione – che quando i media si scordano del clan dei Moro,
questi poi per rinfrescare la loro memoria e finire sui giornali, si inventino
un altro nome da aggiungere alla lunga lista di quelli che già hanno accusato di
come minimo “omicidio colposo” (e magari pure “premeditato”) nella persona del
padre. Tutti, tutti hanno accusato: tranne i comunisti, e Berlinguer,
che fu il più granitico e persino leninista spietato assertore della linea della
fermezza a qualsiasi costo, a cominciare dalla pelle di Moro. Confessa Cossiga
nel suo commovente libro-testamento a Renato
Farina proprio
a proposito di Giovanni
Moro che
definisce “matto”: “Devo dirla questa banale verità. Ci si dimentica sempre
questo: che gli assassini sono i brigatisti. E che tra coloro che hanno deciso
la condanna a morte c’è, e in una posizione decisiva, di intransigenza estrema,
Enrico Berlinguer con il suo Partito Comunista (…) Perchè gli assassini di Moro,
secondo i suoi familiari, siamo io, Zaccagnini e
Andreotti? Avete mai sentito parlare uno della famiglia Moro dire che la linea
della fermezza era voluta innanzitutto da Berlinguer e
dai suoi? Perchè i comunisti fanno ancora paura (…). Nel suo ultimo libro, quel
matto di Giovanni Moro indica queste persone come gli assassini del padre: me,
Andreotti, Zaccagnini e… papa Paolo VI! Ancora una volta Berlinguer lo lascia
fuori. Nessuno della famiglia l’ha mai lontanamente indicato anche solo come
appena appena responsabile. O i comunisti sanno su di loro cose per cui li
minacciano oppure la realtà è metafisica e fanno paura in sè”.
Paolo VI mò
a sentire il clan (Giovanni specialmente) incorreggibile dei Moro, è l’ultimo
loro acquisto per completare la collezione già affollatissima di preziosi pezzi
da 90, insigniti graziosamente del titolo di “assassini” del padre. Prima o poi
tireranno in ballo pure il “destino cinico e baro”. Se non fosse che… a sentire
Maria Fida (leggi intervista sopra), pare invece che qualche responsabilità
nella gestione confusa della faccenda ce l’avrebbero proprio loro. Il fratello
Giovanni in primis. Qualche critico esame di coscienza per ogni membro della
vivace famiglia Moro, forse, giunti a questo punto, sarebbe consigliabile.
Personaggio curioso assai, questa figlia di cotanto padre. Che si ostina a
impicciarsi di politica senza capirne assolutamente nulla – com’è destino dei
figli dei grandi politici, specie quelli morti in tragico odor di “santità”
laica – facendo solo pasticci. Non capendo che non si fa politica con i
sentimenti domestici o con le nevrosi domestiche, che non la si può fare per
vendetta, né in memoria del caro estinto, memoria assai
spesso travisata da figli stessi non di rado viziati e incapaci di comprendere
la reale portata politica dei genitori. Che si tratti di Stefania
Craxi o
di Maria Fida Moro. Semmai di un vizio dei genitori, quello sì, sono portatori
sani (ma non troppo): considerare il potere, le cariche, in una parola la cosa
pubblica, come un bene immobile, di famiglia, una proprietà privata, da
ereditare pari pari. Per diritto divino e meriti sul campo, assai presunti, dei
genitori. Ma dicevo di Maria Fida Moro, già madre di Luca che
ha aspirazioni di cantante e, va da sé, qualche testo (e man mano tutti) lo ha
“ispirato” al celebre nonno. Ebbene, Maria Fida ha avuto una fulminea e infausta
esperienza parlamentare nella X legislatura, dove si è segnalata più che altro
per le polemiche inutili e a vuoto ma soprattutto per essersi girata in un solo
mandato tutto l’arco costituzionale e oltre: eletta in Puglia, terra del padre,
al senato per la DC nel 1987, nel 1990 è già passata al gruppo di Rifondazione,
nel 1991 – e qui c’è da ridere! – in quello del MSI candidandosi pure a sindaca
fascista di Fermo. Ma mica si è fermata, no! È arrivata a essere fra i fondatori
di Alleanza Nazionale, ma l’acqua di Fiuggi deve averle procurato impropri
effetti diuretici se è vero che poco più tardi si è candidata alle europee per
Rinnovamento Italiano-Dini: un plebiscito: 900 voti, ultima dei non eletti. Nel
frattempo aveva trovato pure il tempo di scrivere una commedia teatrale insieme
al figlio (io l’ho vista per caso: per carità di patria… fia laudabile
tacerci!), naturaliter intitolata “Un 8 maggio”, cioè data della morte di Moro,
che a me sembrò una trovata di cattivissimo gusto, come un voler spremere
l’ultima goccia di sangue da un cadavere. E probabilmente ha ritenuto di non
aver spremuto abbastanza se allo scoccare del Terzo Millennio si è scoperta –
dopo essere stata democristiana, fascista, comunista, diniana – fiammeggiante
pasionaria del Partito Radicale. Qui pure, alle solite: ha fondato
[leggo da wikipedia] l’Associazione
Radicale “Sete di verità – che attraversa le nostre vite”, che si propone di
affrontare le verità che asserisce negate dal caso Moro ed episodi quotidiani di
informazione non veridica, “disattenzioni” delle istituzioni, di impossibilità
per le vittime e per gli ultimi di avere voce ed ascolto”.
Ovverossia, in termini meno vittimistici, un modo di passare la giornata ad
accusare ora questo ora quello, ora Cossiga ora Andreotti, di correità o
premeditazione o colposità nel sequestro e uccisione del padre da parte delle
BR. Ancora una volta, avrebbe detto Cossiga (lo ha detto al fratello di Maria
Fida, Giovanni, l’unico maschio di Moro), il professionismo del “figlio della
vittima”. E nonostante tutto questo pandemonio, alla fine non ha neppure
partecipato al funerale della madre Eleonora, morta ultranovantenne nel 2010.
Funerale, del resto, com’è giusto celebrato dal più vieto clero
cattocomunistizzato. Poco prima, il figlio Luca aveva sfornato una canzone blues
per il nonno,
Se ci fosse luce, avendo
il “buongusto” di ricavarne il testo dalle lettere del nonno prigioniero: ospite
d’onore in platea, Valerio
Morucci,
il terrorista delle Br che partecipò al sequestro del nonno e all’uccisione
degli agenti di scorta. Tutte le lagne finiscono in blues. E in omaggio alla
logica la signora Maria Fida per l’occasione denuncia che non può parlare del
padre in televisione perchè “nella tv pubblica di recente hanno rievocato il
povero Domenico
Ricci,
autista di Moro, ed è giusto ricordare le persone non note, però a noi non è
stato consentito ricordare Aldo Moro. Inoltre lo Stato in questi anni ha
delegato agli ex brigatisti il compito della memoria”. E tutto questo con
invitato speciale, allo spettacolino canoro-familista, proprio il sequestratore
del padre e l’uccisore della scorta: sempre il Morucci (che plaudente ma
spocchioso, per l’occasione s’improvvisa critico musicale, storico, politologo e
persino moralista, rievocando proprio l’affaire Moro). Senza contare anche la
poltrona d’onore riservata ai terroristi Fioravanti
e D’Elia:
a momenti dentro quella sala dei Radicali sembrava essere ripiombati negli anni
di piombo. Ma come fai a no ride? Leggo ancora: “Maria Fida Moro vorrebbe che
l’anniversario della strage fosse l’occasione per ricordare l’umanità dello
statista, il
padre, il nonno, non c’interessano i misteri. Spesso invece è stato ridotto ad
un oggetto nel portabagagli di una Renault”.
Ci manca poco che non si precipiti dal “portabagagli” al Bagaglino, seguendo
questo andazzo. E ci è andata vicino quando ha detto che vorrebbe fare un film
su “com’era mio padre Aldo Moro e vorrei Clint
Eastwood come
regista”. Anzi, è andata già oltre. Se è vero come è vero che ha aggiunto: ““Questo
film surreale comincerà in una buca di quelle usate per la ginnastica artistica
piena di palle di gommapiuma e l’attore che impersonerà papà parlerà con un
ragazzo a proposito del senso dell’essere. Così comincerà”.
”Per ora – spiega Maria Fida Moro – ho sul tavolo sette ipotesi di
sceneggiatura”: quanto i peccati capitali. “Tutte scritte da me”, precisa: una
garanzia! ”Luca, mio figlio e nipote adorato da Aldo Moro, scriverà la colonna
sonora del film: questa è l’unica condizione che porrò. Nel caso ci servisse un
Moro giovane, a interpretarlo sarà proprio Luca, che oggi ha 32 anni”. E siamo
già alla seconda, e fatti bene i conti alla decima pretesa: si sa, la mamma è
mamma e i figli so
piezz e core.
Sarà un caso se ancora stiamo aspettando questo capolavoro del kitchs
all’amatriciana cinematografica. Mentre non stiamo nelle mutande per l’ansia di
assistervi, magari accanto a Moretti: sono passati già 3 anni. Auguriamoci ne
passino altri 30. Ma siccome la signora (a cercare su google è una fonte
inesauribile la Maria Fida) ama smodatamente la logica, così conclude
l’intervista: “Mio padre non era un pacco ma una persona che va ricordata nel
giusto modo. Oggi preferisco il silenzio, che è più rispettoso”. Queste furono
le ultime parole famose. Ma non le ultime parole. Purtroppo. Ma ora basta, me
so’ scocciato de ‘sta lunga premessa de bazzecole-pinzellacchere-quisquiglie.
Veniamo al nocciolo della questione. E ancora una volta il casus belli me lo
offre la logorroica Maria Fida Moro. “La verità è che se Aldo Moro tornasse, lo
ucciderebbero ancora. Lo metterebbero a morte tutti coloro che hanno voluto la
sua fine e non parlo solo dei brigatisti. C’è ancora oggi un rancore – nota la
signora Maria Fida, autore de ‘La casa dei cento Natali’ – che serpeggia sottile
nei confronti di mio padre. Interrogarsi sulla sua morte è come interrogarsi
sulla morte di Cristo: come il Nazareno lui dava scandalo perché era buono.
Questa era la caratteristica della sua politica: la bontà. Questo
era il modo di essere di Aldo Moro: non un debole, ma un grande maestro di
coraggio e di pace”.
Ci risiamo col santino. Ci risiamo con l’ennesimo gesucristo laico.
Oggi per tutti tale è: per la famiglia che certo non addolcì i suoi ultimi anni;
per i democristiani che pure fra mille tormenti si erano rassegnati al male
minore, salvare lo Stato invece di Moro; per i comunisti per i quali il bene
maggiore era non essere assimilati ai brigatisti, costasse anche la vita di
Moro; per Paolo VI e il suo “amico buono, giusto, fedele” che proprio così
giusto e fedele non doveva essere stato stante la sua freddezza sul referendum
divorzista e prima ancora permettendo il compromesso con i socialisti, tramando
per l’alternativa con i comunisti, favorendo la progressiva comunistizzazione
dei movimenti politici cattolici e della DC stessa alla faccia dell’amico Montini
che condannava; per tutti quelli che abbisognano di questo santino come foglia
di fico per coprire le proprie vergogne o nascondercisi dietro o per benedire le
più immonde alchimie da bassa cucina politica cattocomunista mignon in nome
degli “alti volori dei quali sono portatori Moro-Sturzo-De Gasperi”, non capendo
manco le enormi differenze fra i tre; per gli appassionati di commemorazioni
necrofile ufficialissime, afflitti dalla sindrome comica del “santo subito” e da
quella del “santo del giorno dopo” fosse anche un cane ma che è suscettibile di
essere sbandierato per ogni verso specie per laddove tira il vento; per tutti i
retori della repubblica che magari in quegli anni avversarono Moro e qualcuno,
so, brindò persino alla sua morte. Per gli ipocriti. Per quelli che “uccidono i
morti”. Per quelli che non li lasciano riposare. Per quelli che addirittura li
fanno votare. Moro come il Nazareno, dice la primogenita. E per dimostraci la
Maria Fida che è la figlia di Gesucristo,
non ha trovato di meglio da fare che partecipare alla marcia della giornata
dell’Orgoglio
Laico in
contrapposizione alla contemporanea marcia della giornata del Family
Day,
promossa dai laicisti e anticattolici più bavosi e da pederasti assatanati
d’ogni risma. Come ci informa, in una aggiornatissima lista dei “promotori”, il
forum di lesbiche
e bisessuali orgogliosi,
che classifica la Maria Fida come “comitato promotore ed esponenti politici”.
Quando la Nostra accusa l’universo mondo di ogni sozzura e di fare qualsiasi
torto alla memoria e al pensiero, alla vita e alla morte del padre, con un
sorriso vorrei mostrarle questa lista, ricapitolarle i suoi più recenti
rocamboleschi trascorsi politici e domandarle: “Maria Fida, tesoro, dolce e
aspra Maria Fida: tuo padre sarebbe contento di tutto quel che fai per – a tuo e
solo TUO dire – onorare la
sua memoria? Non ti è venuto il sospetto che così non stai facendo altro che
travisarne, svilirne e offenderne quella stessa
memoria che
credi di magnificare? Non pensi di oltraggiare così facendo, frequentando certe
compagnie, anche la fede che fino all’ultimo istante fu quella di tuo
padre? Perchè fai tutto questo? Cui prodest?”. Dulcis in fundo, proprio una
settimana fa. Maria Fida Moro, annunciano i giornali, mette all’asta l’ultima
lettera-testamento che “con le lacrime” la madre Eleonora, morta nel 2010, ha
vergato e le ha consegnato nel 2006. E dove, specifica la Fida figlia, non si sa
se per dovere di cronaca o per incrementare il valore del povero manoscritto, la
madre “ha scritto ai suoi quattro figli per dire cose privatissime”. Restando
gli altri 3 figli del tutto contrari a quest’ultima penosa trovata della sorella
maggiore. Ma tant’è! Perchè lo fa? Naturalmente – e che te pare! – per “onorare”
la memoria del padre, perchè “non abbiamo ancora la verità” (mettendo all’asta
le lettere private dei suoi, arguiamo, sarà più facile ottenerla) e soprattutto
per “provocare le coscienze”. Di chi? Per cosa? A me m’ha provocato: ma non la
coscienza, la nausea. Complimenti! Dopo che ha “onorato” la memoria del padre…
adesso è passata a “onorare” per bene la “memoria” della madre.
Aveva detto di Aldo la moglie Eleonora: “In politica mio marito era vedovo e
senza prole”. E mò abbiamo pure capito perchè.
Moro, dunque, in definitiva era la “bontà”. Un cavallo di razza,
un padrone dell’Italia del boom, il regista del centrosinistra, un capo
indiscusso e inamovibile di quel partito di equilibri fragili, terribili e
cattivissimi, la Dc, nucleo incandescente, principio e fine di ogni potenza, il
cinque volte primo ministro Aldo Moro, quindi, altri non era che la “bontà”; ad
altro non mirava che alla “bontà”. Alla “pace” anche: tutto fa brodo e oggi è
pure chic [i comunisti erano specializzati in premi “Per la Pace Giuseppe
Stalin” che poi, quando fu sputtanato, divenne “Premio per la Pace Nicola
Kruscev”: davano il nome di “pace” alle loro porcherie più innominabili]. Uno
che ha conquistato il potere, l’ha mantenuto sempre e l’ha aumentato volta per
volta, con aria imbambolata e pigra, petto flaccido e carni lasse quanto volete
ma con pugno di ferro; ebbene, ha fatto tutto questo per “bontà”. Almanco per la
“pace”… e “l’amore”…Siete dei bambini, ragazzi! Siamo alle altezze intellettuali
di un Fraccazzo da Velletri! Siamo allo zecchino d’oro! Al coro dell’Antoniano!
Siete nati bambini e morirete bambini… se avete queste fantasie da fresconi e da
gonzi. Gente che pensa così se non è in malafede, è minchiona, non sa nulla del
mondo, e non lo saprà mai: non hanno raggiunto neppure quel minimo di malizia
prepuberale sufficiente all’autoerotismo come prima scoperta delle proprie
pudenda. Ancora una volta si è scambiato un ideologo per un asceta; uno stratega
del teorico a lunga gittata per un profeta; uno disinteressato alle cariche
istituzionali perchè il potere era altrove, ossia nel partito generalista, la
DC, e non al governo, lo si è preso per un missionario; uno tutto concentrato in
disegni politici e dunque al nocciolo del potere stesso, per mistico senza
secondi fini. Il suo linguaggio fumoso e anestetizzante – soporifero così fatto
proprio per non farsi comprendere essendo al fondo convinto il Moro essere la
politica roba per grandi iniziati e sommi sacerdoti del potere – si è scambiato
quel linguaggio oscuro dunque, per linguaggio “ispirato”, dasapitore
delle secrete cose;
il suo andare a messa la mattina per un segno di santità personale, e la sua
politica stessa di riflesso come esercizio della santità, e allora non si
capisce perchè non possa esserlo anche per uno persino più assiduo come Andreotti (del
quale ho grande stima) e per tutto il gotha democristiano. E questa olezzo di santità
veniva sottolineato quando nei fatti si allargava sempre più, in
contemporanea con la sua Azione Cattolica, il fossato che lo divideva dal
Magistero sociale e morale della Chiesa; si è scambiata la sua mollezza, il suo
scetticismo, per mitezza, carità e pazienza cristiane… mentre invece era il
totale disinteresse dell’ideologo e dell’intellettuale per la gestione pratica
della quotidianità istituzionale, per il quotidiano politico, dei bisogni umani
immediati dello Stato. Dal momento che certi tipi così percepivano la politica
come organizzatrice e suscitatrice di “pensiero”, anche contorto e inutile ma
sempre “pensiero”, purchè alieno dall’azione, “pensiero” che poi altro non era
che rinuncia, astensione dall’agire. Alibi alla pigrizia e stitichezza etica, in
fine. Cazzeggio. Il cazzeggio del “ragionamento” politico, con cui ci hanno
macerato per decenni l’anima e i coglioni i Dc di sinistra. Pensieri e parole,
cazzeggi, che per questi qui erano già “azione”, la forza invincibile
dell’inerzia che sfinisce. Estranea all’oggi, tutta proiettata in un futuro che
era di là da venire ma che però esisteva nel loro “pensiero”… senza
immaginazione. E a questo “pensiero” inerte e nato morto, anzi mai nato, doveva
essere soggetta, piegata, sottomessa, si doveva adeguare la realtà. In Moro non
era il pensiero che si adattava alla realtà, come poteva essere nel duttile
Andreotti, anti-ideologo per eccellenza, ma la realtà che doveva adattarsi al
“pensiero”. Possibilmente, secondo Moro, l’unico che potesse dirsi tale, che
avesse dignità e sostanza politica: il suo. Infine, si è scambiato il suo
sequestro e la sua esecuzione, come un volontario andare incontro alla croce,
per un martirio di redenzione. E così non è stato. Prima di tutto perchè i
brigatisti non erano gli antichi romani, e nemmanco il sinedrio se non nel
fanatismo, ma una manica di imbecilli. Secondo, perchè Moro incontro a
quell’inutile destino non aveva alcuna voglia di andarci, e quando ci si è
ritrovato dentro ha fatto di tutto per uscirne, costasse quel che costasse anche
lo sfondamento dello Stato e lo sputtanamento di tutti i suoi amici. Non
esattamente un martire. Né tanto meno uno che per il semplice fatto di essere
stato ucciso (come tantissimi in quegli anni) dalle Br è degno di essere, come
pure fin troppi pazzi hanno sostenuto, beatificato financo con regolare processo
canonico. Tanto più che le Br uccisero proprio lui non in quanto cattolico, ma
in quanto ideologo e stratega del patto d’alleanza in prospettiva
dell’alternanza fra la Dc e il Pci. Pci che allora, badate bene, stando ancora
in piedi l’Urss faceva davvero paura: fu un messaggio trasversale delle Br a un
Pci che reputavano in fase di “imborghesimento” invece che guerrigliero e
partigiano,
stante la sua smania di piazzarsi al governo di un paese “borghese”. E avevano
rettamente individuato, in Moro, il mallevadore di questa operazione: fu l’unica
volta in vita loro che i brigatisti non peccarono di cretinismo. E in questo
Moro fu persino doppiamente cieco, non avendo captato quanto fosse putrescente e
oramai in agonia l’Urss come tutto il sistema comunista ovunque disperso. Veniva
a patti con un moribondo, invece d’avere santa e politica pazienza ad attenderne
il collasso finale… Perchè al pari di Montini, Casaroli,
di tutto il gotha democristiano, vaticano e dei tromboni dell’intellighenzia
laica, credeva che il comunismo avesse vinto la sua partita, non avesse altro
dinanzi a sé che magnifiche sorti e progressive. E tutti quanti insieme
reputavano persino ineluttabile – tanto li avevano impressionati gli ultimi
successi elettorali del Pci alle amministrative – che comunque da sé il Pci
avrebbe più prima che poi vinto le elezioni. Tanto valeva quindi andarci a
braccetto, adeguandosi, per attutire il colpo. La più colossale cantonata che
uno statista italiano, dopo il Patto d’Acciaio Mussolini-Hitler,
avesse preso nell’ultimo secolo: nessuno fu più cieco e meno profeta politico di
Moro. Appunto perchè era un intellettuale, un ideologo, uno che viveva di
fumisterie. In pratica Moro non solo era un mediocre politico, un pessimo
governante, ma era anche un pessimo pensatore politico, un disastroso stratega.
Si è scambiata la sua astrattezza per superiore strategia, che infatti la storia
di lì a pochi anni avrebbe dimostrato del tutto sballata e avventata, tutto meno
che profetica. Anacronistica semmai. Ma quando mai, del resto, sono stati buoni
profeti intellettuali e ideologici? La storia dimostra che non ne azzeccano una
da almeno due secoli. Moro uguale. E in questo è stato un intellettuale
tout-cout: nella cecità. Nell’ostinarsi sul proprio schema superficiale, che
aveva la priorità sugli elementi di realtà. Del resto è il sintomo principe
dell’ideologite: l’idea è tutto, la realtà è niente. Sebbene, ripeto, l’idea,
era proprietà intellettuale dei socialcomunisti: i democristiani la degradavano
a “ragionamento”. Che era se non più dannoso certamente più contorto e
soprattutto inutile della prima.
Atturoncoli di stato mentre interpretano dozzinali copioni di stato, scritti da
mano cattocomunista di boiardi di stato (leggi: tutto il giro del fanfaniano
Ettore Berbabei, ex padrone della rai per conto terzi… cioè di Fanfani), per
finalità di propaganda ulivista di stato. Rai che ha sostituito la chiesa nelle
canonizzazioni: basta che sei stato cattocomunista, meglio ancora se “prete
ribelle” (e cioè sempre comunista) e che sei morto, e il soviet supremo
Rai-M-in-cul-pop, ti prepara un film di stato e ti canonizza per direttissima.
In questo filmetto propagandistico Rai, i due attori (uno figlio dell’ex
segretario generale del Quirinale) interpretano goffamente Paolo VI e Moro.
Ridotti a Stallio & Ollio di sacrestia.
Dunque Moro all’improvviso divenne un “martire” per i signori della politica e i
bamboccioni dell’antipolitica. Poi fu “sola bontà”. Quindi per i residuati di
sacrestia e di sezione (o la risultante della fusione di entrambe: l’Azione
Cattolica) si andò oltre: era già un “beato” per i primi; forse un “santo”
azzardarono i secondi, e per chiarirlo, conclusero entrambi, era opportuno “un
regolare processo canonico”. E siccome nessuno si dava una mossa, osarono
l’inosabile: “Se risorgesse, sarebbe come Gesù Cristo”. A parte il fatto che
(forse) in quanto anima cristiana è già “risorto” in Cristo (e non “come”
Cristo) appena morto, per il resto, poco male: a Gesù capitò di peggio, il
processo mondano inverso: lo fecero diventare prima tutta “bontà”, poi un
martire a causa solo della sua “bontà”, quindi dedussero che questa “bontà” era
in realtà la coscienza di un “liberatore dall’oppressione”, chè dopotutto “pure”
Gesù era un “proletario” [credevano loro: e invece no, era benestante, borghese
e amico di ricchi borghesi], e in quanto tale era finito in croce: perchè altro
non era che un “socialista”, il “primo socialista” precisarono; anzi, no:
“comunista”, si corressero più tardi, essendo mutati i rapporti di forza nel
mondo operaio. Tutto, tranne quel che era veramente: il figlio di Dio morto in
croce e risorto per salvare gli uomini dall’oppressione sì, ma del peccato.
Ipocriti, falsi profeti, razza di vipere, teste di pietra! Pietà di loro,
Signore, secondo la tua misericordia! Altro che “comunista”!!…Qui oltre che
ignoranza e malafede, nella secolarizzazione generale si è dimenticato
completamente cosa è e a cosa serve non solo un processo canonico, ma anche la
santità stessa. Perchè hanno dimenticato persino chi era e a cosa era servito
Cristo. E se per caso lo sanno ancora, il chi
è stato e
il a
cosa è servito,
evidentemente, lo ritengono del tutto irrilevante ai fini della religione
civile. Avendo perso ogni fede e ogni autentica cristianità, invece di
cristianizzare la società che governano, mirano a sacralizzare elementi di
società: il passo successivo è secolarizzare il cristianesimo. Io lo so da
quand’è che ho cominciato a maltollerare Aldo Moro. Da molto prima che
diventassi anticomunista. Già quando ero nel PPI e partecipavo ai congressi
nazionali, sempre più cattocomunista. Sì, già da allora non reggevo Moro, il
laicissimo, il rivoluzionario a piccola
marcia,
il teorico fumoso del piano
inclinato:
sul quale lentamente ma inesorabilmente il democristiano scivolava verso il suo
letto naturale, il cattocomunismo, la comunistizzazione, per finire infine più a
sinistra dei comunisti mezzi rinnegati per la vergogna, secondo la ben nota
teoria gramsciana. Quel Moro per il quale il cattolico in nome dell’alternanza,
dei grandi disegni, dei compromessi storici, delle convergenze parallele e altre
minchionerie stravaganti accolte come nuova Rivelazione per i gonzi, doveva
rinunciare alla sua identità per farsi comunista, credendo veramente che i
comunisti in cambio si sarebbero fatti più democristiani. E il paradosso era che
tale esigenza di inseguire i comunisti, di farsi come loro, persino andando
oltre, quanto a progressismo, a costo di una apostasia silenziosa e che non
osava dire il suo nome, si manifestava in modo più insistente quando l’Urss
stava putrefacendosi, ovunque il comunismo era alle corde, palesi i suoi
inappellabili crudeli fallimenti. La psiscologia di Moro, come di tutti i
democristiani, era la stessa, almeno nelle sue nevrosi e fobie,
dell’establishment vaticano di quei decenni, della sua razza padrona in talare
con a capo ora Montini,
ora Benelli,
ora Casaroli.
La loro ostpolitik fu
proprio questo. E a questo travisamento, l’invincibilità del
comunismo, segno di scarso senso politico e di scarsa fede, sacrificarono una
chiesa, quella dell’Est, che ridussero al silenzio prima
e poi ebbero pure la sfrontatezza di battezzarla ufficialmente Chiesa
del Silenzio,
come fosse una cosa edificante, come si fosse trattato di chissà che geniale
trovata diplomatica: le persecuzioni comuniste contro i cattolici continuarono
come prima, più di prima, si acuirono, soltanto che adesso nessuno più le poteva
denunciare. Neppure le stesse vittime. E al silenzio cruento
di quelle chiese s’aggiunse la solitudine. Neppure i giornali vaticani di quegli
anni, per ordine dall’alto, osavano più fare il nome del comunismo, né per dirne
bene né male: il silenzio assordante
era diventato nella chiesa di allora ciò che, al contempo, nel moroteismo era
spostare una montagna con la forza dell’inerzia. La logica della ostpolitik con
i comunisti dell’Est, era la stessa del moroteismo con i comunisti italiani. Ma
vi dicevo delle scaturigini infantili della mia insofferenza per Moro. Sì, già
da prima del mio anticattocomunismo ero se non anti-moroteo, almeno
antipatizzante di Moro. In pratica da quando ero bambino. Bambino del tutto sui
generis: invece di sfogliare le figurine dei calciatori sfogliavo le “immagini
del potere”: mi piaceva guardare le foto dei potenti, capi del governo, di
partito, di stato (i monarchi no: ero antipatizzante pure di quelli). Mi
piacevano soprattutto i potenti democristiani e comunisti: per me erano loro il
potere che immaginavo, e pur bambino non mi sbagliavo affatto. Entrambi, capi
comunisti e democristiani, erano figure clericali, monacali, casta sacerdotale,
volti d’uomini sacralizzati, immagini sacre di grandi liturghi del potere (i
democristiani) e di sommi teologi della morale civile (i comunisti), ossia del
moralismo ipocrita. In questa mia mania, mi aiutava spesso Famiglia
Cristiana,
che collezionavo, assai prodiga di foto di potenti democristiani e soprattutto
di “santi” laici della DC, purchè “di sinistra”. Una volta, sarà stato sui 13
anni, incappai in una foto di Moro che me lo rese antipatico a vita, io che amo
l’informalità e la praticità: era ritratto in bianco e nero, in pieno agosto,
seduto su una sdraio in spiaggia. Vestito (è questo che mi fece saltare i nervi…
ma un nervoso che non vi dico!!) non solo tutto di nero, ma in giacca e
cravatta… sulla spiaggia!.. in agosto! col sole a picco sulla sua testa! Lo
detestai. Una faccenda solo “estetica”, apparentemente. E invece no. Di poi,
infatti, cominciai a detestare tutto il resto… Come il fatto di capire da simili
indizi che questi qui come Moro si consideravano degli iniziati, uomini di una
razza diversa rispetto alla restante umanità, viventi in un mondo a parte, sommi
sacerdoti di un potere che stava altrove, in alto, laddove stanno anche “i
farisei” (A. Merini), ad altezze intellettuali incommensurabili, sopra tutti.
Ragion per cui non dovevano rendere conto né chiarire ad alcuno il di
coloro giacular sancto et lustro; e
proprio quel formulare frasisecrete
et ignote tipico
del moroteismo, quale lingua liturgica della
potestà, stava lì a ribadirlo. Erano “diversi”. Parlavano lingue diverse.
Vestivano diversi. Un destino speciale, fatale e ineluttabile, come voluto da un
capriccio di divinità oscure che ne faceva stirpe sacra e unta. Un’investitura:
eletti, dall’alto più che dal basso. E come sacerdoti vestivano: i quali nel
farlo, rispondono a un tempo solo loro, quello liturgico, e non alle esigenze
delle stagioni dei comuni mortali; come i sacerdoti, a prescindere dalla
meteorologia, vestivano alla stessa maniera o che stessero a dir messa in
cattedrale o in piazza, in montagna o sulla spiaggia: casula d’ordinanza in ogni
caso. Così Moro: giacca e cravatta neri, anche sulla spiaggia. Anche sotto il
sole. D’agosto. Nu
me ce posso rassegnà!…
E’ una vita che non sopporto Aldo Moro, dunque. Così come non ho mai sopportato
i santini laici, e certe volte neanche quelli consacrati. Stante l’andazzo, in
presenza di morti travagliate o inattese di qualche personaggio della cronaca,
magari all’auge del suo quarto d’ora di celebrità, foss’anche nient’altro che un
motociclista, un attimo dopo il trapasso gli si cuce addosso il santino.
Iniziano i media, concludono strafacendo, e non di rado col tipico cattivo gusto
clericale odierno, i preti – peggio è se capita un vescovo: e se sa esserci una
telecamera “capita” lì di certo – nelle esequie. Cattivo gusto che diventa
apocalittico se fuso col telegiornalismo d’assalto e straccione. Questi
“santini” laici a scoppio ritardato, qualunque cosa abbiano detto o fatto nella
loro vita, foss’anche la più immonda, nelle esequie sono dall’ambone catapultati
per direttissima in indecorose beatificazioni post-mortem seduta stante: corte
d’assise celeste composta da prete, giornalisti, amici, amici degli amici e non
di rado nemici dichiarati del “caro estinto che vivrà sempre nei nostri ricordi:
un esempio da imitare e seguire, un maestro”. Alla faccia degli ammonimenti di
Cristo “non giudicare” né in bene né in male e “uno solo chiamate Maestro”. O
come più prosaicamente avrebbe detto
Alberto Arbasino:
“La carriera di uno scrittore o di qualsiasi altro uomo illustre, conosce solo
tre tappe: brillante promessa, solito stronzo, venerato maestro”. Assai spesso
questi preti ed episcopi canonizzatori spontanei, stampatori abusivi di santini
laici senza approvazione
ecclesiastica,
parlano in ‘sì ferale sede proprio alla porcavacca: senza cognizione di causa,
dei tempi, della storia, della decenza, e del catechismo cattolico persino. E
quasi sempre senza sapere davvero una beata mazza della personalità alla quale
si infligge la coatta “beatificazione” clerico-giornalistica. Dove giornalisti
nevrotici e logorroici dalla professionalità di un “pazzariello” napoletano,
concelebrano con questo clero in crisi di identità ormai terminale, questo rito
sociale idolatrico e religioso, pagano e vagamente cristiano insieme, questo
rito di santificazione del morto celebre. Che talora – succede pure questo – è
un notorio agnostico, un anticattolico, o ateo finanche. E anche in questi casi
finita la messa, comunque vada sarà un successo: se non ne esci dottore della
chiesa, sicuro ne esci almeno “martire”, e, va da sé, “uomo di pace”, anche se
sei Goebbels.
Così è stato anche per Moro, santo della chiesa democristiana, e “scismatico di
quella comunista” (sostiene qualcuno). E per la verità, clericalmente, fu
proprio Paolo
VI a
iniziare la sarabanda, il circolo vizioso, sebbene in ben più alte sfere
letterarie, in un linguaggio aulico e drammatico da cultura vera con
quell’inquietante “Rimprovero a Dio” (così la videro almeno giornalisti e retori
di stato), non da ampollosità appiccicose da necrologio sul Gazzettino di
Catanzaro. Tutto questo, questa caligine di retorica, che pesante cala dall’alto
inibisce ogni analisi seria del personaggio (ed è proprio a questo che serve la
retorica, il trombonismo). E probabilmente confonde e cancella per sempre ogni
responsabilità e colpa, prima ancora che del defunto di chi ha contribuito al
suo decesso in un qualche modo. E nell’affaire Moro sembra esserci tutto
l’interesse a dissolvere la realtà di quelle “colpe” di un’intera casta
politica che portarono Moro alla tomba: quasi un rito di autogiustificazione di
massa, penitenziale e autoassolutorio insieme. I figli di Moro, quando reclamano
ancora oggi la “verità”, dovrebbero convincersi che è lo stesso circo retorico
che sull’affaire Moro si è costruito, che la ostacola. E al quale non poco
contribuiscono da un trentennio loro stessi.
Che cosa poteva venirne mai fuori da quella sceneggiata vuota e imbarazzante,
proprio perchè fasulla, di tanto di uomini di stato che ogni anno andavano a
inginocchiarsi, a telecamere di stato spiegate (appena si accendevano, è
chiaro), davanti al portone in anticorotal di un comune condominio romano come
fosse la porta santa, l’altare del sacrificio supremo di Cristo? Che senso aveva
prostrarsi in diretta tv nel punto dove fu trovato il corpo di Moro, a
piagnucolare, far finta di contrirsi, mettersi le mani sulla faccia quasi a
nascondere lo sforzo non sai se di simularsi affranti o dissimulare un conato di
risa? Sceneggiate farsesche e indecorose sulle quali si sono costruite e unte
scintillanti carriere politiche. Lo stesso
Cossiga,
abbonato a questi pellegrinaggi laici, a queste esibizioni di lacrime da
coccodrillo, quel Kossiga che gestì in maniera pietosa e ciò non di meno
spietato nella sua sguaiatezza la vicenda Moro, si inventa da vecchio volpone
quale è persino un particolare postumo palesemente falso, quello che gli son
“venuti i capelli bianchi nei giorni del sequestro”. Mentre invece gli piove
addosso come manna un diluvio di fortuna; costruisce sui falsi sensi di colpa la
sua resurrezione politica fulminea. E una carriera inarrestabile. Che lo porterà
quasi subito a occupare tutte e tre le massime cariche dello stato in un solo
quinquennio: presidenza del consiglio, del senato, della repubblica. E per
giunta, alla fine, quando ormai non aveva nulla da perdere, essendosi già
puppato tutto, si permette pure il lusso di fare il “picconatore” circense di
quello stesso sistema che lo ha partorito, allattato, ingrassato e al quale in
tutto era organico. Quello stesso sistema sclerotico che fece dire alla famiglia
Moro, nei giorni del sequestro, “sì, il ministro Cossiga venne a casa nostra: e
aveva tutta l’aria di uno che non sapeva che pesci pigliare”. “Distrutto dalla
vicenda Moro”, dice Cossiga. Quanti vorrebbero essere “distrutti” così!
Ritualità civili, da sacralizzazione non più solo della politica ma dei politici
stessi. Culti profani a immagine e somiglianza di quelli sacri, che hanno però
un vago sapore idolatrico, paganeggiante, e che se a cedervi sono dei vecchi
politici cattolici è prima che indecoroso, inopportuno e improbabile. Farsesco.
E più ancora peccaminoso. Ma come se dice a Napoli: chiagne
e fotti!
Se guardate alla vita pubblica di Moro, noterete presto che è il politico in
assoluto più laico di tutti, non solo dei democristiani. Quando ha ricevuto
ingiunzioni dal Vaticano a non praticare una determinata strada politica,
incompatibile con l’essere cattolici in politica e, in prospettiva, deviante per
la fede, Moro, se riteneva di ricavarne vantaggi pratici, proseguiva invece per
la via intrapresa. Come il centro-sinistra, che varò e guidò contro i fulmini di
mezzo mondo cattolico. Prospettando di rendere finalmente possibile l’alternarsi
al governo coi comunisti, imperterrito iniziò al stessa operazione, sfidando il
Vaticano e la dottrina sociale della Chiesa, che è vincolante per ogni
cattolico. In situazioni simili, egli se ha ritenuto di averne i voti e di non
perderne, ha in tutta tranquillità disobbedito, sentendosi la coscienza a posto.
La questione “laicità” e “autonomia del cattolico” in politica, la vedeva in
questi termini: siamo al “cattolico adulto” di prodiana memoria, sebbene qui ha
ancora i brufoli. Emblematico l’episodio della riunione in Piazza del Gesù per
evitare il referendum sul divorzio e modificare in senso restrittivo la legge
che lo liberalizzava, arrivando in tal senso a un compromesso coi comunisti, che
a tal proposito, del resto, erano d’accordo, essendo nel fondo, in certe cose,
più conservatori dei democristiani. Arrivò Fanfani con
un biglietto autografo di Paolo
VI che
diceva “si vada al referendum!”. Era una pazzia, si sarebbe perso sicuro, mentre
invece si potevano limitare i danni trovando un accordo coi comunisti. Rumor,
presente, si ribella al papa, grida furibondo “è una follia! Se andiamo al
referendum saremo distrutti!”. Interviene Moro a calmarlo: “Mariano, ma a noi
chi ce li dà i voti?”. Glieli davano in teoria il Vaticano, i preti, i
cattolici. “I voti”, ancora una volta. Strano però che lo stesso patema non gli
venne al momento di varare il centrosinistra, nonostante pure allora i “voti”
glieli desse il Vaticano. Semplicemente la questione del divorzio, ai suoi fini
politici, elettorali e di potenza, era indifferente, anzi, reputava dannoso
andarsi a impelagare. Meglio lasciare ogni responsabilità al Vaticano. E al
povero Fanfani, lasciato solo dal “partito cattolico” a combattere contro il
divorzio: Moro non spese una sola parola che non fosse di circostanza, in quella
circostanza. Non gli interessava. Non gli conveniva. Era laico dentro. E fuori.
Guardando ancora alla sua carriera politica, noterete che mai parlò, non in
pubblico, di cose che riguardassero il cattolicesimo, la fede, nemmeno la sua. E
il suo primo biografo (e primo biografo di Scelba), il vecchissimo
Corrado Pizzinelli,
che andai a trovare qualche anno fa nella sua casa a Fontana di Trevi, mi ripetè
una cosa che già aveva scritto nel suo libro edito negli anni ’60 sul giovane
Moro, pure questa indicativa della sua profonda laicità: “I suoi più cari amici,
affermano tutti concordemente che mai parlava dei suoi problemi religiosi, di
Dio”. La verità è che Moro fu democristiano per caso, perchè calcolò sarebbe
stato provvido (per usare una parola cara ai dorotei) aderire alla DC e scendere
in politica con questa, da Bari dov’era, piuttosto, come pure aveva intenzione
di fare, con i socialisti. Avete capito bene: prima delle elezioni per la
Costituente era incerto se optare per la Dc o per il Psi, che allora, badate
bene, era rigidamente marxista, aveva la falce e martello, ed era completamente
schierato con l’Urss e con Stalin,
e Nenni (con
quella sua infallibile idiozia politica che fu la sua più fedele compagna, sino
alla fine) ne era il massimo patetico cantore, completamente orbo e disastroso
com’era politicamente: Saragat fu
costretto a fare la famosa scissione per poter stare dalla parte dell’Occidente,
stante i deliranti entusiasmi orientali del compagno faentino. Allora ti spieghi
perchè è proprio questo laicissimo socialista mancato – che certamente sarebbe
diventato capo del Psi lo avesse scelto – perchè è Moro ad essere l’ideologo, il
mallevadore e il duce del governo insieme ai socialisti… perchè sarà proprio lui
il padre-padrone del primo centrosinistra nonostante
il parere della Chiesa, a prescindere da questa. Perchè sarà più tardi
l’inventore del governo di unità
nazionale col
Pci. E perchè era sempre colui che aveva meditato l’alternanza con i comunisti
al governo (la qual cosa morì con Moro… e c’è da interrogarsi se questo non sia
stato un “segno”). Il vizio ce
l’aveva già dalle origini.
Giorgio Bocca lo
leggevo all’inizio della mia carriera di lettore: quando ancora era razzista e
trombone, ma non ancora rincoglionito e ugualmente trombone. Lo leggevo con
l’ingenuità degli adolescenti, è chiaro, credendolo – essendo il mio primo
“scrittore” – un oracolo; che poi, specialmente alla fine della sua vita,
nell’estrema vecchiezza, quando si perdono i freni inibitori, si rivelerà per
quello che era sempre stato: uno sprezzante nevrotico, più di altri trombone, e
più d’altri recalcitrante a ogni verità storica anche quanto era diventata
lapalissiana, se al Giorgio quella “verità”, quell’evidenza andava di traverso.
Ebbene, per un mio compleanno, su mia insistenza, avrò avuto 13 anni, mi
regalarono l’ultimo successo di Bocca, il più grande forse: L’Inferno,
un’inchiesta sul Sud alla maniera sua, di un razzismo e un pregiudizio
antimeridionali, che prima ancora d’essere tutto piemonte e antropologico, era
molto più da crasso pregustatore di ottimi vini. E pensare che io avevo voluto
quel libro (santa ingenuità infantile!) che per me costava un patrimonio (32mila
lire) perchè pensavo parlasse del diavolo [senza contare che i miei si
preoccuparono: un
pischello che domanda un libro?...
bah… non s’era mai visto in casa… né sentito in tutto il paese… Fosse malato?
Magari è gay? Strano è strano ‘sto ragazzino… Bocca poi!].
Quando aprii gioioso l’agognato volume boccaccesco, fui saturo di amarezza:
parlava di tutt’altro (o quasi) che del diavolo. Però lessi, sempre per caso,
queste cose su Moro in
questo libro che, malgrado tutto, mi segnerà per tutta la vita:
“Poi
c’è la Bari dei notabili, di Moro e
di Lattanzio.
La differenza fra i due era questa, cheLattanzio nella
merda di Bari ci stava felice e contento, inaugurava lapidi, partecipava a
raduni, faceva affari (…) e non chiedeva di più alla vita che fare un comizio ad
Altamura e poi mangiare con gli amici un piatto di panzarotti. Moro invece era
triste e morigerato. Lui la vedeva la merda e sapeva che su essa galleggiava la
sua delega parlamentare e ministeriale, ma era come se non la vedesse: arrivava
qui da Roma, andava a porgere omaggio ai carmelitani, faceva i suoi comizi anche
dopo che era scaduto il termine e se i rossi protestavano la Celere li legnava.
Intanto il fedele Lattanzio lo aspettava all’aeroporto e si tardava a partire
con l’aereo di linea di mezzora perchè il segretario di Moro era andato a
Taranto a salutare la madre. Questa prona disposizione dello stato alla sua
persona, Aldo Moro la considerava un dovuto omaggio. Ricordava l’avvocato
Pasquale Calvario:
“Un giorno nell’università si parlava di uno scandalo romano e gli chiesi come
mai anche nella Democrazia cristiana c’era corruzione. Da quel momento mi tolse
il saluto”. Quando ci fu il colera e La Gazzetta del Mezzogiorno si decise ad
essere un giornale che dava le notizie, Moro arrivò in visita alla redazione,
volle vedere le rotative, le spedizioni. L’amministrazione come se fossero una
sua proprietà e prima di accomiatarsi mormorava al direttore: “Me l’avete
ridotta proprio una fogna questa Bari”.
Attenti a questa frase del Bocca: “Questa prona disposizione dello stato alla
sua persona. Aldo Moro la considerava un dovuto omaggio”. Fra i tanti libri che
ho su Moro, alcuni di questi non sono agiografie. Sono prudentemente critici: si
sa, non
si sollevano impunemente gli occhi a una dea…
specie se è morta ammazzata. Fra questi ce ne sta uno particolarmente prezioso,
stimolante. La prima vera biografia critica di Moro. Scritta coraggiosamente nei
primi anni ’80 quando, ancora caldo il cadavere, Moro era al vertice
dell’empireo di cartapesta degli intoccabili, dei semidei semidivinizzati a
furor di opinion-maker e retori del giorno dopo. L’autore è un valoroso
giornalista di parte ma di razza: Italo
Pietra,
il glorioso direttore del Il
Giorno degli
anni d’oro, un socialista. Il titolo del libro è ‘na figata: Moro:
fu vera gloria?.
Il sottotitolo è pure meglio: Sa
e non fa. Ha il senso della storia, non quello dello Stato né quello delle
cifre”. Epigrafe
perfetta. Ebbene, piglio ‘sto libro letto negli anni universitari e che mi
lasciò un ricordo sgradevolissimo di un Moro insopportabile, e lo apro a caso, e
a caso leggo un paragrafo. Dove si parla del discutibilissimo capo della
segreteria politica e tuttofare di Moro:Sereno
Freato,
un avventuriero, un imbroglione, un avanzo di galera. Che più volte rischiò di
inguaiare lo stesso Moro, che dal canto suo se ne guardò bene dal cacciarlo: gli
serviva. Ebbene, dopo che ne aveva combinate di tutti i colori questo Freato,
incappa nelle attenzioni -oltre che di tutte le polizie nazionali e
internazionali- della magistratura. Ma è un’altra faccenda che mi colpisce.
Leggo dal libro:
“Salvatore
Giallombardo,
che indelicatamente turba un’ora del Natale 1955 di Moro, è un magistrato
siciliano dalla testa troppo dura (…) Si faceva scrupolo di non guardare in
faccia a nessuno. Prediligeva le pagine di Guicciardini,
ma non gli andava giù l’esortazione a tenersi bene coi potenti”. Alla procura di
Roma, dove è pm, incappa in un grosso e losco affare di imprese fittizie,
capitali in fuga, protezioni eminenti… insomma, il solito mangime dei potenti.
Dove questo pm ha l’imprudenza di volerci mettere la lente. L’avesse mai fatto.
Viene immediatamente trasferito a Venezia. Casca dalle nuove, implora il csm di
bloccare il trasferimento, in lacrime si reca dal guardasigilli De
Pietro perchè
intervenga per una tregua “almeno fino alla catastrofe imminente”, e cioè a dopo
la morte della moglie ormai agonizzante per un cancro, chè a pure dei figli
piccoli. Il ministro tace, nessuna pietà, il trasferimento avviene. Morta la
moglie, una campagna di stampa fa sì che venga richiamato a Roma, a riprendere
il processo dal quale era stato allontanato. La sua requisitoria è durissima,
dura 15 giorni, chiede 62 condanne, che coinvolgono anche le partecipazioni
statali. I superiori lo richiamano in servizio a Roma. Riprende casa, riporta i
figli… ma subito dopo arriva un’ordinanza di Moro nuovo guardasigilli: lo
destina a Ravenna, a debita distanza. Il magistrato così sbatutto, scrive una
lettera di rimostranze a Moro. “Passano giorni e giorni di silenzio. Il 25
dicembre 1955 “l’Avanti” pubblica la lettera di Giallombardo. Moro è
notoriamente uomo dai tempi lunghi e ha un vero e proprio culto per il Natale,
per quell’atmosfera di pace e di buona volontà tra gli echi delle zampogne,
delle campane, degli inni sacri. Usa dedicare ore e ore alla preparazione del
presepio; nella notte del 24 dicembre pone personalmente Gesù nella mangiatoia.
Ebbene alcune ore del Natale 1955 sono diverse dal solito; di punto in bianco,
Moro non sembra più quello. A dispetto dell’eccezionale clima festivo e dalla
caratteristica inclinazione al rinvio, si mette in moto con grande
determinazione (…) Il baleno del giorno di santo Stefano tiene dietro al fulmine
del giorno di Natale. L’Ansa dà notizia dei provvedimenti disciplinari proposti
dal ministro a carico del magistrato, il quale è ben presto raggiunto da censura
(…) Uno degli interventi più severi e più risoluti della carriera governativa di
Moro è fatto nel giorno di Natale, e nei confronti di Giallombardo (…) Ma
pensate un po’, è quella la pecora nera nel bianco gregge del buongoverno DC”.
“Come
un bene privato trattava lo stato”, così parlò Bocca.
E aveva, almeno in questo caso, ragione. Così sarà durante il sequestro: egli si
sente l’unico legittimo intestatario dell’autorità, la fonte primaria del
diritto stesso, il custode della profezia, il dispensato speciale dalla ragion
di stato, il titolare della salvazione della patria nonché della politica;
perchè diritto patria potere e politica, va da sé la profezia, la ragion di
stato, tutte queste belle cose, le identificava con la sua stessa persona: l’etat
c’est moi!
E con questa psicologia Moro si comporta durante la sua prigionia. Frigna,
protesta, minaccia, quasi ricatta, condanna: tutto pur di essere liberato e…
andasse anche a morire ammazzato tutto il resto. Non esattamente l’eroe civile e
politico che ci hanno dato a credere le trombe mediatiche democristiane e no.
Anche per purificarsi dal senso di colpa feroce dell’unica volta che si erano
comportati con senso dello Stato, che poi era purissimo realismo politico:
scegliendo fra un politico e lo Stato tutto, scelsero di salvare lo Stato. Ho
scolpite in mente le immagini di un summit internazionale fra ministri degli
esteri, e Moro lo era. In questi contesti nessuno poteva soffrirlo, temendo come
la morte il suo prendere la parola: non solo per la perdita di tempo stante
l’irrilevanza politica dell’Italia, ma per le cose bizantine e contorte che il
Moro sciorinava per ore, senza che nessuno ne capisse niente, e chi lo capiva
che niente aveva in effetti detto… mosaici di fumo… macerando di noia mortale i
colleghi. Ebbene, in uno di questi summit, dopo che Moro da mezzora stava
anestetizzando i suoi pari con “ragionamenti” leziosi e inutili, uno che
contava, il sanguigno Kissinger lì
presente, platealmente si strappò dalle orecchie le cuffie della traduzione
simultanea e le scaraventò sul tavolo. Come dire: all’estero avevano capito da
un pezzo che questo era uomo dalla testa fra le nuvole, vivente nel mondo a
parte degli ideologi fumosi all’italiana, teologi dell’astrattismo, che vivono
imbambolati in una dimensione atemporale, che hanno il gusto del bizantino, cioè
dell’inutile, del secondario, del dettaglio. Avendo in sommo disgusto ogni
praticità, la preziosità del tempo che perciò dilapidavano, la realtà nel suo
complesso… così umana, così vera… così plebea e satura di passioni e bisogni da
comuni mortali invece che da iniziati al nulla cosmico. Moro durante la
prigionia è la prima volta in vita sua che parla in modo comprensibile. E in
quella prima volta che lo fa, in cui tutti capiscono che dice, è un uomo che fa
pena. E penose sono le cose che dice: finalmente nude e crude, decriptate, tali
si dimostrano. E fa indignare e accapponare la pelle, per la sua totale mancanza
di senso di responsabilità, della collettività e dello stato. Un egotismo e un
egoismo senza pari nella storia d’Italia e del mondo stesso, almeno per uomini
tanto importanti caduti in simili sventure. Quantomeno il re Vittorio
Emanuele III scappando
a Brindisi durante l’occupazione tedesca della Capitale, cercava di salvare le
insegne dello stato trasferendole altrove. Moro pretese che le insegne dello
stato venissero trasferite nel suo tugurio e lì lasciate dare pubblicamente alle
fiamme dagli stessi terroristi. Per cosa? Per se stesso, per la sua pelle, e
magari per la sua “famiglia”, ché pure lui, da italiano quasi come gli altri,
infine, “teneva famiglia”. E fu la sola e unica volta che pubblicamente se ne
ricordò e lo ammise, mentre gli italiani sin lì erano stati quasi convinti del
contrario; perchè sin poco prima, a piede libero, si era sempre considerato, da
sommo sacerdote del potere, dentro la politica, “vedovo e senza prole”, e così
lo vedeva pure la stessa moglie. E gli italiani. Se ne ricordò e lo ricordò a
tutti che invece aveva moglie e prole, solo giunto al capolinea: ancora una
volta quando gli era (ed è umanamente comprensibile) utile. Utile in questo caso
ad avere un’ulteriore arma di ricatto morale verso quello stato che come aveva
detto Bocca, vedeva in “prona disposizione alla sua persona” come un “dovuto
omaggio”. E che perciò, per lesa maestà, ormai disilluso, senza remora alcuna
ora trascinava nello scorno, nella vergogna, nell’oltraggio. Si era reso conto
che, superato un certo limite, quello stesso Stato, che aveva creduto essere
solo e solamente lui, non era disposto ad essergli “prono” sino a tal punto. Non
al punto da suicidarsi e consegnare le insegne della nazione nelle mani invitte
e insanguinate dei brigatisti. Come Moro, certamente sconvolto, va detto,
avrebbe desiderato. “Un collega
[Fini] che ci permette di respirare un’aria depurata dall’ipocrisia, dalla
banalità, dall’ossequio ai nuovi feticci che rischiano di inquinare anche parte
del mondo cattolico. E proprio a questo nostro mondo mondo, Fini rivolge una
provocazione particolarmente bruciante. Se davvero, dice, i cristiani non hanno
paura della verità, dovrebbero avere il coraggio di affrontare una buona volta
la domanda Aldo
Moro: statista insigne o pover’uomo? E
prosegue poi: peccato
poi che Moro abbia scritto le lettere che ha scritto, che sono ciò che di più
triste e miserevole un prigioniero politico abbia mai inviato dal fondo della
sua prigione. Ma i giornali stettero zitti, tutti, pur di fronte all’evidenza.
[Dopo questo articolo] il direttore de Il
Giorno di
allora gli sospese per quattro mesi la rubrica, con la motivazione che ciò che
Fini aveva scritto era vero, ma non si poteva scrivere. Adesso, cocciuto,
ritorna alla carica. Rilanciando la rischiosa sfida confida almeno nel
superstite amore dei cattolici per la verità, nel rifiuto evangelico del
fariseismo, dell’ipocrisia. Oltretutto, ricorda, i credenti sono qui
particolarmente coinvolti: la vittima essendo infatti un cattolico da comunione
quotidiana e il papa stesso essendo intervenuto a suo favore, con quella
sconcertante ‘Lettera
agli uomini della Brigate Rosse’, dove, ‘in ginocchio’, chiedeva la liberazione
di ‘un uomo buono e giusto’. Riconosciuto che Moro
scrive nelle condizioni più terribili, il
giornalista prosegue: Ma
è proprio in quelle condizioni limite che si vede quanto vale un uomo, quanto
profondo sia ciò in cui crede e a cui ha chiesto, e spesso imposto, agli altri
di credere. Invece, nelle sue lettere, Moro, a cui per trent’anni è stata
attribuita fama di statista insigne, sconfessa tutti i principi dello Stato di
diritto, sembra considerare lo Stato e i suoi organismi un proprio patrimonio
privato, invita gli amici del suo partito a i principali rappresentanti della
Repubblica a fare altrettanto, chiede pietà per sé, ma non ha una parola per gli
uomini assassinati della sua scorta. Si dirà che Moro fa questo per avere salva
la vita e che a nessuno può essere chiesto di essere un eroe, di conservare
anche in pericolo di vita coerenza e dignità. Ma, allora, si fa un mestiere
diverso da quello che Moro ha fatto per tanti anni, non si pretende di guidare
la vita di sessanta milioni di persone, non si chiede loro di rispettare le
leggi che tu stesso hai fatto e, magari, di sacrificare anche la vita per il
rispetto di quelle leggi.
Come si vede, il problema che Fini ci pone è drammatico. Eppure, insiste, non si
può da tanti anni far finta di niente, intitolare a quel nome vie, monumenti,
scuole. Ai cattolici, poi, Fini chiede che il coraggio della verità evangelica
si manifesti affidando la memoria dell’ucciso -nel suffragio- al Dio che solo
può giudicare; ma anche non cooperando a proporre come esempio ciò che tale non
gli sembra essere stato. Una triste storia, questa di Moro, che, a suo avviso,
umilia il coraggio degli
umili che seppero morire con ben altra coerenza e dignità”.
Da dentro la prigione “del popolo”, dunque, Moro piagnucola, minaccia, maledice,
accusa, ricatta, invia centinaia di lettere in tutte le direzioni, e che per la
metà tutti vedevano per quello che effettivamente erano: vergognose. Ma che solo
la prudenza politica, la carità cristiana, l’umana comprensione, spinsero
lettori e vittime delle missive ad avere la signorilità di far finta di non
accorgersi della loro miseria politica se non umana, del degrado etico che ne
esalava, del loro essere uno svergognamento più per lui che non per loro.
“Massì”,
disse uno stremato
Fanfani,
“sia quel che sia, trattiamo, facciamolo liberare, costi quel che costi, tanto
Moro, dopo tutto quello che ha scritto è un cadavere politico, è finito: non
barattiamo lo stato, perchè qui non è questione di salvare uno statista, ma un
pover’uomo finito politicamente, un già cadavere politico…”. E fu un moto
sincero, quello del ruspante nano aretino, che tradiva quel che tutti pensavano
senza osar dire: Moro stava comportandosi da irresponsabile, era un cadavere
politico che voleva trascinarsi nella tomba lo Stato. Basta leggere le lettere.
Moro invita lo stato a una resa a una capitolazione senza condizioni e senza
senso, assurda; a trattare con le br, a liberare brigatisti e assassini, a un
suicidio di massa di un intero sistema con classe dirigente annessa, a una
sconfitta politica senza eguali e quindi a una vittoria senza eguali, seguita da
riconoscimento politico, di una banda di pazzi sadici e sanguinari e per giunta
terroristi. Non si fa minimo scrupolo a infangare in modo osceno gli amici, che
per una volta in vita loro stanno facendo il loro dovere e stanno comportandosi
da statisti pur rodendosi il fegato e inghiottendo lacrime amare… e tutto
questo, in nome della sua liberazione. Non si ricorda – lo dicevo poco su –
nella storia un uomo di stato che in situazioni tanto estreme si sia comportato
in modo tanto vergognoso, inadeguato, da coniglio mannaro, e tutto sommato
anarchico… semmai ci fu caso di individualismo più esasperato e portato alle
estreme conseguenze fu proprio il suo. O
lo Stato o la mia vita: non
aveva avuto dubbi: la sua vita. Eppure da quello Stato in vita sua aveva avuto
tantissimo, tutto, in gloria e potenza, e pochissimo gli aveva sempre reso in
cambio, niente quasi… ma tant’è! E non riusciva proprio a capire perchè i suoi
colleghi e amici la pensassero diversamente… dovevano pensarla così, non v’era
scelta: sulla bilancia il piatto “Stato” pesava 60 milioni di volte più del
piatto “Moro”. Anche se ebbero sempre il buon cuore e la signorilità di non
farlo notare mai di che cosa veramente pensassero, che poi era una
constatazione, dell’atteggiamento inqualificabile di Moro. Si lasciarono
sfuggire qualcosa, ma adoperando un linguaggio obliquo: “Fosse la sindrome di
Stoccolma?”, “ma possibile che Moro dica davvero quelle cose?!”, “capace lo
abbiano obbligato a scriverle”, “forse sono lettere false”. Increduli,
stupefatti, disorientati dicevano – per trovare coraggio in quei momenti
terrificanti che prigioniero e famiglia non facevano che aggravare – “ma forse
non è davvero Moro”. Cercavano di convincersene. E si sbagliavano alla grande,
perchè quello era un Moro purissimo, era proprio lui allo stato naturale, senza
più indosso i paramenti del gran chierico di Stato. Che diceva stavolta in
maniera diretta e persino divulgativa quanto prima sosteneva in modo articolato
e fumoso fra le righe. Anarchia e potere; immobilismo ed egocentrismo: lo Stato
era lui, e lo Stato era “prono” a lui. Lo Stato era soltanto, per come egli
l’aveva sempre vista, il riverbero, pallido e innocuo, della sua ombra
giganteggiante nelle nebbie plumbee della notte della repubblica. E dulcis in
fundo, a coronamento di questa vicenda orribile, persino il suo omologo
religioso, Montini, tratta la Chiesa come un bene privato; così come lo Stato
fin lì, pure questa “prona” alla persona di Moro “come un dovuto omaggio”; e,
infine, con un unicum nella storia papale, come un’agenzia di pompe funebri per
“l’amico Moro”, a sua disposizione sino in fondo, oltre la morte. E non è
finita. Paolo addirittura interpella e “rimprovera” Dio, per non aver “esaudito”
la sua supplica. Proprio come Moro aveva interpellato e “rimproverato” (e
qualcosa di più e peggio: infangato e ricattato) la classe politica, i suoi
stessi amici, lo Stato tutto affinchè “esaudisse” la sua “supplica” per salvare
un “uomo giusto, buono, onesto, amico”. Ossia se stesso. Non solo non è un
santo, ma neppure un eroe. E, Dio mi perdoni, nemmanco un uomo semplicemente
coraggioso. Forse era solo e solamente un uomo, che pretendeva di non essere
trattato come tutti gli altri uomini le cui comuni leggi per lui soltanto
dovevano non valere, sebbene le avesse firmate e insegnate egli stesso. Sì, era
davvero un uomo. Comune, come tutti, con le sue miserie, egoismi, debolezze,
paure: un uomo
senza qualità.
Un pover’uomo. Soltanto che nessuno se ne era accorto prima. Neppure lui.
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA PER
UNA MEMORIA CONDIVISA.
IL LIBRO DELL'INCONTRO.
Militanti della lotta armata e famigliari delle vittime a confronto. «Il libro
dell’incontro» per il Saggiatore. Un lavoro durato anni e curato con rigore da
Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato. Nessuno doveva pentirsi o
chiedere perdono. Ma spiegare i perché di un conflitto «irriducibile», scrive
Niccolò Nisivoccia il 24.12.2015 su “Il Manifesto”. Guido Bertagna, Adolfo
Ceretti e Claudia Mazzucato (rispettivamente un teologo gesuita, un criminologo
e una docente di diritto penale) sono i tre curatori di un libro destinato a
squarciare la memorialistica e la storiografia della lotta armata in Italia (e
forse non solo), aprendovi inediti orizzonti di senso, illuminandole di una luce
nuova: lo ha appena pubblicato il Saggiatore, il titolo è Il libro
dell’incontro, il sottotitolo Vittime e responsabili della lotta armata a
confronto” (Il Saggiatore, pp. 466, euro 22). Dov’era riposto infatti, almeno
fino ad oggi, il senso di quegli anni, degli anni Settanta e ottanta del secolo
scorso? Era in un pugno di verità contenute nelle sentenze dei tribunali, ma la
verità processuale è cosa diversa dalla verità storica, come si sa, e perdipiù
su molti di quei fatti è perfino un accertamento processuale a mancare (basti
pensare alle tante stragi ancora prive di colpevoli); era nelle appropriazioni
fattene dai partiti politici, ma ciascuno in funzione esclusiva dei propri
obiettivi; ed era infine nelle testimonianze ora degli uni ora degli altri dei
protagonisti. Le vittime o i loro famigliari, da una parte (si pensi, negli
ultimi anni, ai libri di Mario Calabresi o a Benedetta Tobagi); i responsabili
dall’altra (e qui si pensi ad esempio all’intervista di Carla Mosca e Rossana
Rossanda a Mario Moretti, Brigate rosse. Una storia italiana, risalente ormai al
1994). Ne è sempre derivata una memoria frammentaria, divaricata,
strumentalizzata (lo ha spiegato forse meglio di tutti Giovanni De Luna, nel
suo Le ragioni di un decennio); una memoria non a caso ancora dolorante e che
ancora brucia, come se – per usare le parole di una poesia di Mario Luzi, Presso
il Bisenzio – fosse ancora vivo il «fuoco della lotta/quando divampava e
ardevano nel rogo bene e male». Dentro questo «fuoco» sono entrati ora Bertagna,
Ceretti e Mazzucato, per cercare di costruire una memoria che sia invece
condivisa, per quanto corale e policentrica. È il frutto di un lavoro di anni,
Il libro dell’incontro, durante i quali i suoi curatori, a partire dal 2009,
hanno fatto appunto incontrare, nella veste di mediatori, alcune vittime o loro
famigliari e alcuni responsabili della lotta armata fra gli anni Settanta e
Ottanta. Le persone coinvolte sono state circa sessanta, gli incontri
continuativi e talvolta anche residenziali. Bertagna, Ceretti e Mazzucato hanno
lavorato per propria iniziativa; e pochi erano al corrente di quanto stavano
facendo. Fra queste il Cardinale Carlo Maria Martini, un gruppo di esponenti
della società civile definiti «Primi Terzi» e uno di autorevoli «garanti», quali
ad esempio Gherardo Colombo e Valerio Onida. Ciascun incontro trovava in se
stesso il proprio significato e il proprio fine: vittime e responsabili si
ritrovavano faccia a faccia, e potevano guardarsi, parlarsi, ascoltarsi, o anche
solo rimanere in silenzio. Le loro «voci» costituiscono adesso il cuore pulsante
del Libro dell’incontro: attorno a loro, prima e dopo, il libro è fatto anche di
molti necessari contributi scientifici ed è arricchito da una Postfazione di
Luigi Manconi con Stefano Anastasìa, ma rimangono le «voci» il suo più ardente
«fuoco». Nella maggior parte dei casi non sappiamo neppure a chi attribuirle,
perché anonime; in altri, appaiono le firme in calce (ad esempio di Agnese Moro,
o Adriana Faranda, o Manlio Milani). Lette, come devono essere, in un continuum
narrativo, queste «voci» sembrano quasi una Spoon River dei vivi, dove nessuno
però potrebbe aver fiato da solo, perché la «voce» di ciascuno ha bisogno di
quella che la precede come di quella che la segue. Ed è questa la potenza anche
storiografica del libro: a parlare di quegli anni non sono le vittime o i
responsabili della lotta armata, in racconti solipsistici, ma sono le une e gli
altri insieme, e le loro parole sono parole nuove e mai sentite proprio perché
scaturiscono dal loro intrecciarsi. Sono parole che aspettavano di salire alla
superficie, ma occorreva che qualcuno gliene offrisse un tempo e uno spazio.
L’aver immaginato questo tempo e questo spazio è il più grande merito da
attribuire a Bertagna, Ceretti e Mazzucato, i quali dichiarano apertamente di
riconoscere il proprio modello nella giustizia riparativa, che a sua volta trova
la propria espressione più nobile nell’esperienza della Commissione Sudafricana
per la Verità e la Riconciliazione. La giustizia riparativa, infatti, non si
accontenta delle sentenze bensì ha l’ambizione di offrire qualcosa di più, in
primo luogo alle vittime dei reati ma anche ai loro autori: un’occasione per
superare insieme, aldilà dei ruoli processuali e nella relazione dialogica, le
conseguenze generate dal reato. Nel caso del confronto fra i protagonisti della
lotta armata l’ambizione era ancora più alta, perché a contrapporre le parti in
gioco non era e non è semplicemente un conflitto, ma un «dissidio» vero e
proprio, vale a dire un conflitto «irriducibile». Nessuno era in cerca di
perdono, non interessava ai curatori del libro procurarlo né i responsabili lo
chiedevano; e neppure la riconciliazione, a ben vedere, doveva essere per forza
l’esito degli incontri, il cui fine ultimo risiedeva piuttosto in una
«ricomposizione» delle memorie e dei punti di vista in virtù della quale a
ciascuno fosse dato quantomeno di essere ritenuto legittimato a parlare e di
essere ascoltato. Sembra forse poco, ed è invece moltissimo: un «compromesso»
virtuoso, un equilibrio fondato sull’apertura di nuove possibilità, «fragile» e
«insicuro» come tutto ciò che richieda cura e come ogni proiezione sul futuro lo
è per definizione (nelle parole di Claudia Mazzucato e di Federica Brunelli,
quest’ultima in un testo contenuto in Giustizia riparativa, a cura di Grazia
Mannozzi e Giovanni Angelo Lodigiani, di recente pubblicazione dal Mulino). Solo
il futuro, dunque, potrà dire se questo equilibrio, che il lavoro testimoniato
dal Libro dell’incontro è riuscito a creare, saprà anche perdurare. Il libro
dell’incontro dimostra che un’esperienza di giustizia, diversa quella ordinaria,
è sempre possibile; e costituirà un precedente di enorme valore anche politico.
"Il libro dell'incontro",
l'abbraccio possibile tra vittime e carnefici, scrive Stefano Jesurum su "Il
Corriere della Sera" il 27 novembre 2015. "Il libro dell'incontro. Vittime e
responsabili della lotta armata a confronto", a cura di Adolfo Ceretti, Guido
Bertagna e Claudia Mazzucato. Editore "Il Saggiatore". Gli incontri tra i
terroristi degli anni di piombo e le famiglie degli uccisi, raccontati n in un
libro, dimostrano che riconciliarsi è possibile. Ecco. Noi testimoniamo che
un'altra strada è possibile, ma adesso non tocca più a noi. Tocca a voi che
incontrate e ascoltate". Già, ma... "Quanta verità siamo disposti ad
ascoltare?". Poche righe pescate nell'oceano di emozioni e ragionamenti
contenuto nelle quasi 500 pagine de "Il libro dell'incontro" (il Saggiatore).
Sette anni di colloqui/confronti nel senso più profondo - accompagnati finché è
stato in vita dal cardinale Carlo Maria Martini - tra chi ha subìto un male
terribile e chi quel male lo aveva causato. Vittime e responsabili della lotta
armata nell'Italia del piombo e dell'odio, uniti da "qualcosa di tanto
misterioso, e per molti versi inspiegabile, quanto forte, ineludibile,
decisivo": ovvero la domanda, o la ricerca, di giustizia. Giustizia riparativa.
Un flash. Domenica 17 giugno 2012, cimitero alle porte di Roma, davanti alla
tomba di Aldo Moro un gruppo di persone, c'è Agnese la figlia dello statista
ucciso dalle BR, familiari di ammazzati dal terrorismo rosso e nero, tre ex
brigatisti tra cui due killer della strage di via Fani. Una preghiera, poi
Agnese li abbraccia. Per chi ha fede un miracolo. Di sicuro qualcosa (come il
tragitto che questo libro racconta) di difficile, impensabile, per alcuni
indigesto, per altri scandaloso. Comunità della memoria. All'inizio - lo narrano
i tre "mediatori" - tutti sapevano unicamente con chi e da che cosa volevano
fuggire, "detto senza paura: dall'idea, di cui abbiamo constatato il fallimento,
che una esperienza di giustizia significhi per i responsabili soltanto "pagare"
le proprie colpe con anni di carcere; e per le vittime e i loro parenti trovare
invece conforto e soddisfazione, in primo luogo, nell'espiazione di quella
pena". Anni tenuti gelosamente lontani dai riflettori, secondo il metodo e le
regole, appunto, della giustizia riparativa: volontarietà di partecipazione,
riservatezza, confidenzialità, gratuità. A volte faccia a faccia, a volte in più
d'uno, altre in molti, fino a ciò che non sono riusciti a chiamare in altro modo
che "il Gruppo", una sorta di comunità di memoria. Ricordo, perdita,
irreparabilità, verità, responsabilità, colpa, giustizia, pena,
risocializzazione, riconciliazione.
"Dobbiamo confrontare le due
verità-la vostra, di ex, e la nostra, di vittime. È l'unico modo per arrivare a
comprenderci tutti come vittime. Noi della violenza, voi della storia". Una
esperienza davvero importante. Che non vuole spiegarci alcunché. A noi lettori
immaginare (provare a vivere) le voci, i silenzi, le lacrime e la speranza, i
climi interiori, la potenza dei volti, degli sguardi. Con la speranza che possa
segnare una svolta nelle coscienze individuali e in quella collettiva e, perché
no?, magari nell'ordinamento giuridico.
“Il libro dell’incontro”,
dialogo tra ex terroristi e vittime. “Così le nostre vite sono cambiate”. Nel
volume del Saggiatore il racconto di un gruppo "autofinanziato" nato sette anni
fa seguendo il metodo della giustizia riparativa, che prende a modello la
Commissione per la verità e la riconciliazione del Sudafrica post apartheid.
Partecipano ex membri di gruppi di lotta armata e famigliari delle vittime degli
anni di piombo. Un percorso che il 17 giugno 2012 li ha portati insieme sulla
tomba di Aldo Moro, scrive Eleonora Bianchini il 25 ottobre 2015 su "Il Fatto
Quotidiano". Giorgio Bazzega – figlio di Sergio, poliziotto ammazzato insieme
al vicequestore di Sesto San Giovanni Vittorio Padovani - e Mario Ferrandi - ex
di Prima Linea condannato per concorso in omicidio del
vicebrigadiere Antonio Custra a Milano il 14 maggio 1977 - escono sul balcone
del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, quasi al buio, e riescono a
recuperare un microfono per una “presentazione alternativa” de “Il libro
dell’incontro” (Saggiatore), davanti a decine di persone rimaste fuori
dall’auditorium. Perché dentro la sala è piena, non si può più entrare. Adriana
Faranda – ex Br – Manlio Milani – presidente del comitato delle vittime della
strage di Piazza della Loggia a Brescia, 1974 – e Agnese Moro sono già sul
palco. Fuori, l’incontro “parallelo” e inaspettato. Bazzega e Ferrandi, insieme
a Giovanni Ricci – figlio dell’autista di Moro, crivellato da nove colpi in
via Fani il 16 marzo 1978 – raccontano la storia di un gruppo nato sette anni
fa, fatto dai responsabili della lotta armata e dalle vittime di quegli anni
Settanta di sangue. Proprio come Faranda, Milani e Moro stanno facendo in sala.
Il filone è quello della giustizia riparativa, che prende a modello la
Commissione per la verità e la riconciliazione nata nel Sudafrica post
apartheid. Una strada percorribile solo con la consapevolezza che la pena non
basta senza riconciliazione, dove è centrale il danno “umano”, “l’ascolto
attento che mette da parte l’impulso a voler avere tutto chiaro e la tentazione
del giudizio”. Tutto autofinanziato, dove lo Stato e le istituzioni sono i
convitati di pietra, e in cui chi partecipa – volontariamente – è convinto che
“fare giustizia non possa, e non debba, risolversi solamente nell’applicazione
di una pena”. Bazzega ricorda l’incontro con Ferrandi, prima su internet “dove
scazzavamo, e gli facevo un sacco di domande”. Poi di persona. Mi è venuta
voglia di conoscerlo, in lui ho trovato molta disponibilità. Una sera l’ho
tenuto sveglio fino alle quattro per parlare. E’ un amico, gli voglio bene”.
Prima, però, la sua è una storia di rabbia, di periodi “che mi facevo
di cocaina senza ritegno”, dove “mi ero fatto anche una lista con nomi e cognomi
per andarli a prendere a casa e ammazzarli. Tutti quelli che facevan parte
dell’organizzazione. Tutti quelli che mi avevan privato di mio papà”. Che aveva
identificato Curcio come il male assoluto “perché era quello che aveva
indottrinato Alasia, che ha ucciso mio papà”. E che poi decide di vederlo di
persona, in un centro sociale alla Barona, a Milano, dove era stato chiamato da
alcuni ragazzi. “Gli ho dato una pacca sulle spalle e ho detto: ‘Stai
tranquillo: io abito a cinquanta metri, sai chi sono io, sai chi era mio padre.
Venivi a parlare qua a casa mia, volevo solo che mi guardavi in faccia,
fine'”. L’incontro decisivo per Bazzega è con Milani, “un signore che si è visto
esplodere la moglie di fronte, durante la strage di Brescia. Io sembravo
un animale uscito dalla gabbia, arrabbiato nero, e mi sono trovato davanti
questo signore che aveva vissuto una tragedia forse anche più scioccante,
traumatica della mia, e invece affrontava le cose con una serena determinazione.
Per me è stata la chiave di volta. E poi altri, fra cui alcuni ex. E be’, la mia
vita è cambiata, è cambiata veramente”. Con la consapevolezza “anche che mio
padre era morto per difendere la vita”, cioè quella dei famigliari di Alasia,
presenti durante la sparatoria del ’76. “Quindi non potevo buttare via la mia”.
“Rispetto a Milani, che si è visto esplodere la moglie di fronte a piazza della
Loggia, sembravo un animale uscito dalla gabbia”. Vivere, e non sopravvivere,
anche per Ferrandi, che pensa “ai figli”, alle generazioni di oggi e di domani,
a uomini e donne cristallizzati in un passato pesante per il quale hanno già
saldato il debito con la giustizia. Alla sua immagine – come quella di altri ex
– che rispunta, strumentalmente, sui giornali e dove “siamo ancora identificati
come quelli con la P38. Ma sono passati quarant’anni”. Tanti, troppi anche
per Giovanni Ricci, figlio dell’autista di fiducia di Aldo Moro. “La mia vita è
stata rovinata dall’immagine del volto di mio padre crivellato di colpi. L’ho
vista in tv. Ma chi ha ucciso in quegli anni ha una ferita ancor più grande
della mia. Lo vedo. E lo sanno anche loro”. Inizia a pensare che forse quel
“gruppo” – dopo tutti i tentativi falliti – possa essere una via per darsi una
possibilità e andare oltre il tormento del passato. E gli anni, fatti anche di
confronti aspri, hanno portato quel gruppo fatto di ex e vittime il 17 giugno
2012 sulla tomba di Aldo Moro, insieme. “Consideriamo questo percorso soltanto
un primo passo”, spiega la giurista Claudia Mazzucato (a sinistra), curatrice
del volume e mediatrice insieme al padre gesuita Guido Bertagna e al
criminologo Adolfo Ceretti. Ma c’è ancora chi “soffre talmente tanto” da
rifiutare ancora l’idea del confronto. “Ricordo una volta di avere incontrato
una persona per strada che, saputo del mio ruolo di mediatore, ha indietreggiato
fino a rischiare di finire sotto una macchina”. Alcuni, poi, “hanno chiesto di
essere dimenticati, altri di non essere citati, altri ancora di non essere
riconoscibili”. Gli ex che partecipano sono “terroristi rossi”. Il confronto
coi “neri” non è ancora possibile. “La distanza e il conflitto tra le due parti
sono ancora irriducibili. Soltanto una volta hanno partecipato alcuni dei gruppi
armati di destra. Poi basta”. “Abbiamo condiviso la quotidianità. Poi magari
c’era chi insegnava agli altri a pulire bene i corridoi ‘a lisca di pesce che si
fa prima’ perché l’aveva imparato a San Vittore”. Un’esperienza di un dialogo a
più voci dove, consapevolmente, la “verità storica di quegli anni non è stata
toccata”, e dove al centro c’è il singolo in quanto persona. “Siamo arrivati a
condividere la quotidianità. A passare prima qualche weekend e poi una
settimana, d’estate, in montagna. Si lavavano i piatti insieme, si dormiva in
stanze l’una vicina all’altra. Poi magari c’era chi insegnava agli altri a
pulire bene i corridoi ‘a lisca di pesce che si fa prima’ perché l’aveva
imparato a San Vittore”. Per alcuni ex il desiderio sarebbe quello
di avviare una vera Commissione verità e riconciliazione anche in Italia, di
coinvolgere Parlamento e istituzioni. Il timore è che l’opinione pubblica non
sia ancora pronta, che al Paese sia ancora funzionale la memoria di un conflitto
latente, esasperato allora e mai risolto dopo. Se le centinaia di persone dentro
e fuori dall’auditorium a Milano possono significare qualcosa, forse i tempi
sono cambiati.
Scrive “Nebrodi e Dintorni” il
24/10/2015. “Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a
confronto”, a cura di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato. Se ne
parla con Adriana Faranda, Manlio Milani, Agnese Moro, figlia dello statista
ucciso dalle Brigate Rosse e altri protagonisti. Adriana Faranda è nata a
Tortorici il 7 agosto 1950. Militante rivoluzionaria negli Anni di piombo, entrò
a far parte delle Brigate Rosse, insieme al suo compagno Valerio Morucci,
nell'estate 1976, dirigendo la colonna romana e svolgendo un ruolo importante
durante il sequestro Moro. Sabato 24 ottobre 2015 al Museo della Scienza e della
Tecnica di Milano, alle ore 19, Gad Lerner presenta "un’esperienza straordinaria
condotta lungo sette anni in riservatezza da persone segnate dal dolore,
protagonisti degli anni di piombo e loro vittime o parenti di esse". Lo stesso
Lerner definisce questo un esperimento di “giustizia riparativa orizzontale”,
condotto con la mediazione di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia
Mazzuccato, con il coinvolgimento di garanti e testimoni, "assieme a sempre più
numerosi protagonisti diretti che si sono incontrati decine di volte, fino a
sperimentare momenti estivi di vita comune". "Vicende cruciali della nostra
storia, la scia di sangue degli anni Settanta, vengono rivissuti in cerca di una
“verità curativa”, senza edulcorarle, ma sapendo che “ci sono dolori non
cancellabili ma che possono essere trasformati”. Avendo il coraggio di guardarsi
in faccia e riconoscersi, nell’elaborazione del lutto e della colpa, rafforzati
dal constatare che, alla lunga, “Il volto non mi può ingannare”. “Il libro
dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto” (Il
Saggiatore), a cura di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato. Questo
libro cambia la storia d'Italia. L'incontro di cui parla - fra vittime e
responsabili della lotta armata degli anni settanta - è infatti destinato ad
avviare un radicale cambio di paradigma storico: non si potrà più guardare agli
"anni di piombo" con gli stessi occhi; né si potrà tornare a un'idea di
giustizia che si esaurisca nella pena inflitta ai colpevoli. Le prime pagine
ancora oggi dedicate alla lotta armata e alle stragi, le centinaia di libri
pubblicati, i film, le inchieste dimostrano non tanto un persistente desiderio
di sapere, ma anche e soprattutto un bisogno insopprimibile di capire, di fare i
conti con quel periodo, fra i più bui della nostra storia recente. È proprio
muovendo dalla constatazione che né i processi né i dibattiti mediatici del
conflitto sono riusciti a sanare la ferita, che un gruppo numeroso di vittime,
familiari di vittime e responsabili della lotta armata ha iniziato a
incontrarsi, a scadenze regolari e con assiduità sempre maggiore, per cercare
con l'aiuto di tre mediatori: il padre gesuita Guido Bertagna, il criminologo
Adolfo Ceretti e la giurista Claudia Mazzucato - una via altra alla
ricomposizione di quella frattura che non smette di dolere; una via che,
ispirandosi all'esempio del Sud Africa post-apartheid, fa propria la lezione
della giustizia riparativa, nella certezza che il fare giustizia non possa, e
non debba, risolversi solamente nell'applicazione di una pena. Postfazione di
Luigi Manconi e Stefano Anastasia. In un articolo del Corriere della Sera del 24
ottobre 1993, i figli dello statista - Agnese e Giovanni Moro - commentano le
ultime confessioni di Adriana Faranda sul rapimento e omicidio del padre e
aggiungono di avere ancora dubbi e interrogativi fondati su punti essenziali
dell'intera vicenda: "Abbiamo dato troppo credito ai pentiti e non lo
meritavano, come viene dimostrato in questi giorni". Così affermano Agnese e
Giovanni Moro, figli dello statista ucciso dalle Brigate rosse. Esprimono "dubbi
e interrogativi seri e fondati su molti punti essenziali della vicenda". E
aggiungono: "Non sappiamo dire quali siano le ragioni per cui nelle ultime
settimane sono emerse circostanze inedite a proposito della vicenda del
rapimento e dell'assassinio di Aldo Moro. Non crediamo nemmeno che l'argomento
sia di grande interesse, mentre ciò che è davvero importante è sottoporre ad
attenta verifica quanto si sta venendo a sapere, accertandone la consistenza
senza alcun pregiudizio". I figli di Moro trovano poi "inaccettabile" il modo in
cui alcuni "importanti commentatori e opinionisti" minimizzano la portata dei
"fatti emersi in questi giorni". Non hanno gradito la lettura di alcuni commenti
secondo cui i nuovi episodi che stanno affiorando sono, "anche una volta
provati, dettagli irrilevanti". Non credono, come scrivono alcuni osservatori,
che "il quadro di insieme è' chiaro". Dopo le dichiarazioni di Adriana Faranda,
intervennero "anche i familiari degli uomini della scorta di Moro, uccisi nell'
agguato di via Fani. Sono "indignati", disse l'avvocato Luigi Ligotti, legale di
parte civile, per "l'ipocrisia di molti giornali che fingono di essere commossi
per le lacrime del killer Prospero Gallinari prima che Moro venisse ucciso, e
non hanno mai ricordato la morte dei cinque uomini che proteggevano il
presidente della Democrazia cristiana". Ma la storia può davvero cambiare la
storia? Nel «Libro dell'incontro» curato da Guido Bertagna, Adolfo Ceretti,
Claudia Mazzucato, nell'ambito «Bookcity Milano», nell'auditorium del Museo
nazionale della Scienza e della Tecnologia, quello che di certo si può dire è
che si è rivelato uno spazio insufficiente per le tantissime persone che
desideravano prendere parte all'incontro. L'evento è stato moderato da Gad
Lerner e vi hanno preso parte Manlio Milani, Adriana Faranda e Agnese Moro. Una
storia che continua a rivelarsi "stretta", in tutti i sensi.
Adriana Faranda (Tortorici, 7
agosto 1950) è un'ex terrorista italiana, militante delle Brigate Rosse durante
gli Anni di piombo. Dopo aver militato in alcune formazioni minori di lotta
armata attive a Roma, entrò a far parte delle Brigate Rosse, insieme al suo
compagno Valerio Morucci, nell'estate 1976, dirigendo la colonna romana e
svolgendo un ruolo importante durante il sequestro Moro. Si distaccò dalle
Brigate Rosse per contrasti sulle scelte strategiche dell'associazione
terroristica nel gennaio 1979. Arrestata il 30 maggio 1979 insieme a Morucci,
durante gli anni ottanta si è dissociata dal terrorismo beneficiando delle
riduzioni di pena previste dalla legge e uscendo dal carcere nel 1994.
Inizialmente entrata in Potere Operaio, nel 1973 insieme ad altri (fra i quali
Bruno Seghetti e il suo compagno Valerio Morucci) fu tra le persone fondatrici
del gruppo estremistico LAPP (Lotta Armata Potere Proletario); in seguito entrò
nelle Brigate Rosse, nelle quali fece parte dei suoi vertici direttivi. Fu una
componente della colonna Romana (insieme a Mario Moretti, Prospero Gallinari,
Bruno Seghetti, Valerio Morucci, Germano Maccari e Barbara Balzerani), che
organizzò il sequestro di Aldo Moro. Abbandonò questa organizzazione
terroristica dopo l'assassinio di Aldo Moro, durante il cui rapimento agiva come
"postina", nel giugno del 1978. Fu infatti tra i pochissimi ("due compagni che
dissentono non sono nemmeno un'eccezione, sono un'eccentricità", commentò Mario
Moretti), insieme a Morucci e a Maccari, a opporsi all'omicidio del politico e
questo l'avrebbe portata a una rapida estromissione dall'organizzazione, che
lasciò per seguire formazioni legate a Franco Piperno. Tentò, senza successo, di
creare una nuova formazione di lotta armata.
Scrive Luca Doninelli per “il
Giornale” il 17 dicembre 2015. Il Saggiatore ha pubblicato, il mese scorso, un
testo di grande importanza, Il libro dell'incontro (pagg. 470, euro 22) a cura
di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato, che rimarrà nel tempo
come un punto di riferimento fondamentale per chiunque desideri ripercorrere
quel periodo oscuro della storia che va sotto il nome di «Anni di piombo»: anni
che furono la matrice di tutti i misteri e i segreti di un Paese che, oggi, non
è più capace di guardarsi e di pensarsi, ossia di trovare un luogo - come la
ginestra leopardiana - dove poter dire: «qui mira e qui ti specchia». Avendo
anche il sottoscritto partecipato, sia pure in modo marginale, all' avventura
umana che ha portato all' esistenza di questo libro - una storia di incontri, di
faccia-a-faccia talora meravigliosi ma altre volte quasi intollerabili - trovo
scorretto proporre una vera e propria recensione. Mi limito a un'osservazione:
la raccolta di testi che compone il volume - taluni anonimi altri firmati, sia
da ex-terroristi, sia da vittime che da giuristi o intellettuali o semplici
cittadini - non riguarda il passato, la guerra che fu, ma continua a riguardare
il presente perché le motivazioni umane che generarono quei fatti continuano a
esistere e ad agire in ciascuno. Per quanto attiene a me, mi voglio limitare a
commentare una pagina sola del libro, a firma di Adriana Faranda, che fu (come
tutti sanno) una delle protagoniste della strage di via Fani. Parlando di quegli
anni, Faranda rivendica i motivi della propria azione: nessuno agisce senza
motivi, il problema è «piuttosto il modo in cui si affermano». Non nega i propri
gravi errori, e aggiunge che «per fare questo ho dovuto rimuovere e mutilare
parte di me stessa, quella che di me era la migliore». Insomma, nell'
agghiacciante grido di Paolo VI - «uomini delle Brigate Rosse!» - non c'era solo
un'improbabile speranza. Gli uomini c' erano, erano lì. Faranda nega tuttavia
che a muovere lei e gli altri verso il peggio sia stata semplicemente una
«deriva irrazionalistica». Certo, dice, c' era molto di irrazionale in quelle
azioni e più ancora in quel modo di vivere e di pensare, soprattutto nel rifiuto
di ogni «confronto delle idee». Un' attitudine di chiusura, insomma: pensiamo a
quanti delitti si consumano oggi allo stesso modo. In una cultura in cui (oggi
più che ieri) tutto sembra voler definire la personalità umana come un mondo
organizzato intorno a un ego (pensiamo anche a certe pubblicità) ad esclusione
di qualsiasi intruso - be', c'è da chiedersi in che senso possiamo dirci fuori
da questa dinamica: sono cambiate solo le opinioni, non la struttura. Ma questa
è solo la premessa della vera domanda: «perché - si chiede l'ex-brigatista - a
quei tempi mi sembrava tutto così maledettamente razionale? (...) E perché anche
chi vedeva così irrimediabilmente nemiche le nostre domande, le nostre istanze,
il nostro desiderio di cambiamento, ci sembrava così crudelmente razionale?».
Questa domanda dovrebbe riguardare tutti, e il fatto che sia un'ex-terrorista a
porla non ne limita la sostanza. La mia personale impressione è che non bisogna
mai confondere la storia con il passato. La persuasione che le nostre azioni
seguano una linea razionale dipende in gran parte dalle strategie che mettiamo
in atto per sentire di essere «qualcosa», e per sentire di essere «qualcosa»
dobbiamo affermare un certo senso di differenza: noi ci differenziamo da loro,
noi siamo fuori dal coro. Chi vorrebbe dire di sé «io sono uno del coro»? Ma tra
quel tempo e questo, affinché la storia non scada in un banale labirintico
archivio del passato, è necessario segnare un punto di passaggio: l'idea della
guerra. I brigatisti si consideravano in guerra con lo Stato, e avevano una
strategia (razionale) da contrapporre a un'altra strategia, altrettanto
razionale. I brigatisti si sentivano portatori di una storia migliore, perché
con la loro razionalità agivano le «istanze». Sicuramente lo Stato era a loro
modo di vedere una compagine razionale capace di esercitare un controllo
esattamente sulle istanze, sui luoghi e sulle dinamiche in cui il desiderio
diventava parola, ragione, azione. La guerra contro lo Stato era la forma del
confronto, era il presente della storia, la premessa del futuro. Oggi noi
diciamo «io sono fuori dal coro», ma il coro che cos' è? Dove sono quelli che
dicono «io sono del coro?». Saliamo sulla nostra Jeep Renegade o sulla nostra
Mercedes e andiamo via, ma via da dove? Da chi? Verso la libertà, ma qual è il
luogo della libertà? Nelle scelte sanguinarie e disumane compiute da quegli
uomini e da quelle donne era presente una domanda che non si è più estinta.
Pensiamoci. Siamo circondati da guerre di cui siamo in parte noi stessi i
responsabili - noi, intesi come civiltà alla quale apparteniamo per libero
consenso - e ci pensiamo in pace. Mi viene allora da chiedermi che guerra fu
mai, quella, e se i morti di quella guerra si possono limitare soltanto a quelli
lasciati sulle strade dai terroristi; se, al di là delle teorie, dei calcoli e
delle strategie, la posta in gioco non fosse ben più alta. I quarant' anni
trascorsi dalla morte di Pasolini sospingono il nostro pensiero verso un
sospetto: che a morire, in questa guerra, sia stata quell' Italia diciamo così
«guareschiana», popolare, alimentata da fedi diverse ma da un senso naturale del
bene comune, che mai si sarebbe sottomessa ai calcoli degli intellettuali, alle
mode culturali, ai diktat di chiunque volesse trasformare la sua cultura in un
mercato. Fu il mercato a vincere quella guerra, la riduzione della cultura a
proprietà di qualcuno; a vincere fu la possibilità di riformulare un'idea di
società più permeabile agli indirizzi dei maîtres à penser, che da sempre
conoscono e spesso servono le vere centrali del potere. Io non so né mai saprò
se le BR volessero combattere quelle centrali (in questo mi sembrano molto
ingenue) oppure entrare in qualche modo a farne parte, in nome di un «desiderio»
magari non irrazionale, ma senza dubbio confuso. Quello che so è che le domande
che quell' epoca pose all' Italia sono le stesse alle quali non abbiamo mai
risposto, ed è forse anche per questo che, oggi, l'Italia ci appare un Paese
fatto di (poco affascinanti) segreti.
Faranda: ho il dubbio di non
aver fatto abbastanza per salvare Moro. L’ex brigatista rossa parla degli anni
di piombo a Radio Uno: «La violenza va tenuta fuori da qualsiasi forma di
conflitto». E aggiunge: «Avrei dovuto forse uscire immediatamente dalle Br»,
scrive Valeria Palumbo il 28 aprile 2016 su "Il Corriere della Sera”. Adriana
Faranda, 65 anni, la “postina” delle Br, tra i responsabili del sequestro del
presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro da parte dei terroristi rossi
che, il 16 marzo 1978 uccisero anche i cinque uomini della scorta, ribadisce di
aver fatto di tutto per convincere i compagni a non uccidere il politico. Lo
dice a Carla Manzocchi di Radio Uno: Moro «era ormai una persona diversa,
indifesa e lasciata sola dai compagni di partito». L’ex terrorista, arrestata
nel 1979, si è dissociata negli anni Ottanta e ha goduto delle progressive
riduzioni di pena: nel 1994 è uscita dal carcere. A Radio Uno ha detto: «Io
credo che l’odio irrisolto e la violenza non possano partorire un mondo più
giusto, un mondo migliore. Il bilancio è estremamente amaro». La Faranda parla
soprattutto dell’incontro con i familiari dello statista ucciso dalle Br: «sono
momenti difficili, sai che è impossibile mettere rimedio a ciò che è stato
fatto». In particolare l’ex brigatista ha incontrato Agnese Moro, la figlia di
Aldo: insieme, nell’ottobre 2015, hanno affrontato il palco di Bookcity per la
presentazione de Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta
armata a confronto(ilSaggiatore). Faranda ribadisce: «Rispetto il dolore dei
familiari di chi è stato ucciso in quegli anni terribili» ha precisato. E ha
spiegato che l’incontro con Agnese Moro, figlia dello statista dc, è stato
«emozionante e difficile dal punto vista emotivo. Sono momenti intensi in cui
c’è timore, perché sei davanti a una persona che sai di aver ferito in maniera
irrimediabile». Agnese Moro, a sua volta, aveva detto di «aspirare a essere una
ex vittima. Io amerò per sempre mio padre, ma voglio andare avanti». «Ho sempre
il dubbio— ha aggiunto Adriana Faranda — di non aver fatto abbastanza per
evitare la condanna a morte di Moro. Avrei dovuto forse uscire immediatamente
dalle Br. Credo di aver usato tutti gli argomenti possibili per fare una
battaglia politica all’interno: per esempio dicendo che Moro era indifeso, che
non era più l’uomo politico che avevamo sequestrato perché era ormai una persona
lasciata sola dai suoi compagni di partito che si rivelava in tutta la sua
umanità». Quando all’aspetto storico e giudiziario, Faranda ha sostenuto a Radio
Uno: «Oggi posso affermare di aver detto tutto ciò che sapevo del delitto Moro,
non ho altro da aggiungere». E, in particolare, rispetto alle ipotesi che le Br
fossero “eterodirette”, che ci fossero degli infiltrati: «di questo non ho avuto
alcuna percezione. Le ipotesi lasciano il tempo che trovano».
APUZZO E FALCETTA: STRAGE
DI ALCAMO: NON FU GLADIO (NEMMENO GULOTTA).
FU UN ASSASSINIO SU
COMMISSIONE? Forse una svolta nel barbaro eccidio di Alcamo.
Da indiscrezioni confermata
questa ipotesi -1 due CC sarebbero stati uccisi per caso dai malviventi che
preparavano un sequestro. Sembra che il personaggio preso di mira fosse l’on.
Sinesio, grosso esponente DC - Lo strano comportamento di «Dino u pazzu».
Vincenzo Vasile martedì 17 febbraio 1976, pag. 5, L’Unità. C’è una svolta nelle
indagini sul barbaro eccidio dell'appuntato Salvatore Falcetta e dell'allievo
Carmine Apuzzo, trucidati a pistolettate la notte del 27 gennaio dentro la
casermetta di Alcamo Marina: così sembra, stando alle indiscrezioni che
circolano alla vigilia della presentazione al magistrato del rapporto elaborato
sulla vicenda dal nucleo investigativo dei carabinieri, prevista per domani.
Naturalmente, visti i precedenti. bisogna prendere tutto co' beneficio
dell'inventario. Però — a quanto sembra — sarebbe innanzitutto ormai i accertato
che non era semplicemente «dimostrativo» lo scopo prefissato dal commando
composto da Giuseppe Vesco, Giuseppe Ferratelli, Gaetano Sant' Angelo, Giovanni
Gulotta e Giovanni Mandala, con l'uccisione dei due militari e l'irruzione.
quella tragica notte, nel posto fisso della frazione balneare semideserta di
Alcamo. Circola voce. anzi, che il massacro dei due carabinieri sarebbe avvenuto
praticamente «per caso» e che cioè uccidere i due militari sarebbe divenuto
necessario, una volta che uno dei due carabinieri, svegliatosi di soprassalto,
aveva riconosciuto alcuni degli intrusi. La banda — si dice — nella stazione di
Alcamo Marina, in realtà, cercava armi, bandoliere, divise e pilette
rifrangenti. Quanto occorreva ad un regista accurato — con tutta probabilità
esterno al gruppo di « mezze figure » che «sinora sono state individuate — per
predisporre un tranello, un sequestro. Dal formicaio di voci che sembra essersi
scoperchiato, è uscito anche un nome, quello di un esponente democristiano, il
sottosegretario ai trasporti, Giuseppe Sinesio, che sarebbe il « grosso
personaggio » da rapire, di cui si è insistentemente parlato in queste ore. In
serata, comunque, questa circostanza è stata « fermamente smentita » dagli
investigatori. Nel rapporto che sarà consegnato domani all'autorità giudiziaria,
figurerebbero. comunque, oltre ai nomi dei cinque, anche altre due o tre persone
sulla cui identità, per non intralciare l'inchiesta, vice il riserbo. Ed il
fatto è che. indiscutibilmente, delle svariate versioni interpretative che sono
circolate in questi giorni sul massacro di Alcamo, nessuna ancora soddisfa e
convince pienamente. C'è financo chi ha parlato, a proposito dell'eccidio, di un
«delitto gratuito ». Ma come pensare che un «raptus» » inconsulto abbia condotto
questi quattro ragazzi e questo botta-sofìsticatore di vini dentro la casermetta
di Alcamo Manna ad uccidere, con tecnica da professionisti i due carabinieri? Le
«arance meccaniche » non crescono facilmente in una zona di solidi equilibri
mafiosi come questa. «La Mafia non c’entra» ha sostenuto qualcuno degli
inquirenti all'indomani dell’eccdio. con una fretta ed una sicumera che appare
eccessiva, pensando solo a questo scenario che è, come testimonia anche
l'inconfondibile « identikit » del p:ù anziano dei banditi, il 34enne
sofisticatore di v.ni di Partinico. Giovanni Mandalà, lo scenario ben noto di
una zona dove arricchimenti rapidi, violenza criminale, equilibri politici,
fortune elettorali recano spesso un'unica matrice mafiosa. I dubbi non sono
affatto dissipati: tre delie quattro confessioni, come si ricorderà sono state
ritrattate. I giovani arrestati hanno addirittura lanciato accuse contro i
carabinieri. Hanno detto di essere stati picchiati, costretti a firmare. Al
verbale che è all'esame del magistrato, è stata aggiunta questa dichiarazione di
Vincenzo Ferrandoli: « E" tutto falso: mi hanno messo in testa un cappuccio.
m'hanno condotto fuori della caserma e hanno detto: ora ti fuciliamo ». I
carabinieri hanno replicato sostenendo che gli interrogatori si sarebbero svolti
alla presenza dei difensori d'ufficio. Ma rimane ancora da spiegare come e
perché, se il fermo di Vesco — quello che ha confessato per primo — e avvenuto
mercoledì, la procura e stata lasciata all'oscuro di tutto sino al giorno dopo.
« C'è una banda — commenta stupito un investigatore — che si macchia d'un
delitto casì infame correndo rischi terribili. E poi. tutto all’improvviso, uno
di loro, il Vesco, si fa trovare praticamente con le mani nel sacco; indica i
nomi dei complici, infine conduce gli inquirenti quasi per mano nel luogo dove
essi troveranno tutti i riscontri obiettivi, tutte le prove; un garage di
Partinico, dove c'è mezzo milione in contanti, la refurtiva, rimasto pressoché
intatto, e poi le bandoliere e le divise». Un particolare singolare che fa
pensare ad un cervello esterno alia banda Vesco Mandalà: Dino u pazzu, custode
del garage deposito di Partinico, aveva utilizzato una piccolissima parte del
bottino (tremila lire in tutto) per le piccole spese ed aveva annotato il fatto
in una specie di «libro mastro». come se, all'occorrenza. esso avesse dovuto
essere esibito ad un regista dietro le quinte. Di simili mister è stato
contrassegnato anche tutto il complicato e contraddittorio svolgersi delle
indagini. Cosi e nata l'inquietante ridda di notizie contraddittorie; di nervose
e polemiche smentite e controsmentite a distanza, che le vane polizie che si
occupano di questo tragico caso sono andate diramando in questi giorni, malgrado
le violente e pubbliche reprimende ad uso interno che sono state fatte dal
comandante generale dell'Arma, e dal questore di Trapani, a proposito di
presunte, e a tuttora imprecisate « piste terroristiche. Vincenzo Vasile
È doveroso puntualizzare , che
le persone, i cui nomi sono citati nell’articolo, che furono accusate all'epoca,
sono state tutte assolte.
Apuzzo e Falcetta. Strage
Alcamo Marina: non fu Gladio (e nemmeno Gulotta).
Francesca Scoleri su themisemetis.com il 12 Luglio 2019. Riceviamo e
pubblichiamo: Era la notte del 27 gennaio del 1976 , quando un commando fece
irruzione nella casermetta di Alcamo Marina, in provincia di Trapani e uccise i
carabinieri Apuzzo e Falcetta. Le indagini furono condotte dal Colonnello
Russo, ucciso un anno dopo a Ficuzza da un commando agli ordini di Totò Riina.
Dopo circa quindici giorni dal duplice omicidio, una volante dei carabinieri,
fermò un giovane di Alcamo, tal Giuseppe Vesco, monco di una mano, alla guida di
una Fiat 127. Era in possesso dell’arma che aveva ucciso i due carabinieri e di
una pistola di ordinanza, di uno dei due carabinieri uccisi nell’agguato. Vesco
fu interrogato e confessò. Indicò agli inquirenti il covo dove era nascosta la
refurtiva, e accusò i suoi complici, tre giovanissimi ragazzi, suoi amici di
Alcamo e un suo conoscente di Partinico. Tutti condannati nei processi che
seguirono nei successivi anni. Vesco però non arrivò mai al processo, perché un
anno dopo, fu trovato impiccato nel bagno dell’infermeria del carcere San
Giuliano di Trapani. Nel 2008 il colpo di scena. Un ex carabiniere Renato Olino,
che aveva partecipato alle indagini, raccontò che Vesco confessò tutto sotto
tortura. Gli avvocati di Giuseppe Gulotta, uno dei quattro condannati, chiedono
e ottengono il processo di revisione e alla fine, vengono assolti tutti, inclusi
Ferrantelli e Santangelo che, dopo la sentenza in cassazione, erano scappati in
Brasile con l’aiuto di Padre Mattarella, cappellano del carcere di Trapani, che
a suo dire, illuminato dal Signore, era certo della loro innocenza. Tutto da
rifare dunque per gli inquirenti, anche se sono passati 36 anni. Nel frattempo
si susseguono le piste sui possibili moventi e mandanti. Un ex poliziotto di
Alcamo, Federico Antonio, racconta al sostituto procuratore di Trapani, che nel
1992, un suo confidente, gli raccontò che Apuzzo e Falcetta furono uccisi il
pomeriggio del 26 Gennaio, esattamente alle 15.30 perché fermarono un furgone
carico di armi, condotto da appartenenti alla Gladio. Dopo un breve controllo, i
due carabinieri, invitarono i passeggeri del furgone all’interno della
casermetta, e li furono uccisi. Il movente Gladio è stato ripreso da più organi
di stampa, inclusa la trasmissione Blu Notte di Lucarelli, ma nessuno ha mai
fatto i dovuti riscontri. Stefano Santoro operatore video free lance residente a
New York, ha prodotto un lungo video dossier sulla vicenda e ha dimostrato che
in realtà, l’ipotesi tanto declamata dagli organi di stampa, dell’omicidio alle
15.30 è irreale. La sorella di Carmine Apuzzo ricorda la telefonata del fratello
alle 18.30 , mentre i familiari di Falcetta hanno ricostruito le ultime ore
dell’appuntato che nel pomeriggio, dopo aver trascorso alcune ore con i
familiari, si recò al comando provinciale di Trapani, poiché doveva ultimare il
suo imminente trasferimento a Buseto, per essere più vicino alla madre
sofferente. Altro tassello che esclude il posto di blocco all’equipaggio Gladio,
con l’immediato duplice omicidio, è la testimonianza a poche ore dalla strage,
di due persone che raccontarono agli inquirenti di essere stati insieme ai due
militari all’interno della casermetta di Alcamo Marina fino a mezzanotte circa,
per giocare a carte. Inoltre i due carabinieri furono trovati in pigiama, Apuzzo
ancora a letto sotto le coperte, mentre Falcetta, dopo un tentativo di reazione,
rimase incastrato tra il letto e il muro, con le gambe attorcigliate alle
lenzuola. Una scena raccapricciante che non lascia spazio a ricostruzioni false
e artificiose, di riproduzioni della scena del delitto. Nonostante ciò nessuno
ha mai smentito questo inconcepibile teorema, accostato suggestivamente più
volte anche al ritrovamento, nel 1992, di un deposito di armi, custodito da
due carabinieri . Il professore Romano Davare, noto scrittore, regista teatrale
e all’epoca dei fatti corrispondente del Secolo D’Italia, racconta che la sera
precedente alla strage, si trovava nei pressi di Trapani, per un convegno del
Msi, con ospite il segretario Giorgio Almirante. Il professore Davare scrisse
della strage, ma il direttore del Secolo D’Italia gli proibì di parlare del
possibile movente, da lui ipotizzato alla luce dei fatti. Sul gruppo Facebook
Giustizia per Apuzzo e Falcetta, Stefano Santoro ha approfondito questa ipotesi
e scrive “L’assalto alla casermetta a quattro ore dal passaggio di Almirante, in
un arco di 365 giorni, e sotto una pioggia torrenziale, fu solo una casualità ?
No a mio parere. Gli ingredienti per un sequestro ci sono tutti. Covo pronto a
Partinico, divise, (non quelle in grande uniforme lasciate invece a terra nella
casermetta) armi, cibo, (preso dalla casermetta) indumenti intimi, soldi,
passamontagna, materasso, lenzuola, guanciale, soldi di altri sequestri, stralci
di giornali relativi ai sequestri Corleo e Campisi e ancora, cavi di telefono e
ruote tagliate dell’auto di Falcetta, per isolarli e avere un vantaggio di
tempo, al loro risveglio prima che potessero avvisare i colleghi (Vesco scrisse
nelle lettere che non era prevista la loro esecuzione, evidentemente perché
dovevano essere sedati), e ancora, la scorta di Almirante non comunicò al
segretario del Msi della tragedia, ed infine, la parola fine ai sequestri, in
provincia di Trapani ,dopo l’episodio di Alcamo Marina, come se qualcosa si
ruppe. Insomma, cosa altro serve, per dimostrare che ci fu un tentativo di
sequestro di Almirante.
La domanda è: chi fu il
mandante e a quale scopo?” Il professore Davare, sostiene nell’intervista che
il direttore del Secolo D’Italia declinò il tentativo di scrivere sul possibile
sequestro di Almirante, per evitare uno scontro sociale. Dopo 43 anni è
difficile smascherare la verità, ma intanto alla vicenda si è aggiunto un altro
enigma. La sorella di Giuseppe Vesco, il giovane trovato impiccato all’interno
del carcere, sostiene di avere visto suo fratello nel corso principale di
Alcamo, ma aggiunge altri particolari. Racconta, in esclusiva ai microfoni di
Stefano Santoro, che al momento del riconoscimento del cadavere, suo fratello
non aveva segni di impiccagione al collo , che il corpo del fratello giaceva su
una normale barella, che non fu permesso ai familiari di avvicinarsi per un
ultimo abbraccio e che, al padre e allo zio del giovane, non gli fu autorizzato
di assistere alla saldatura della bara. La sorella ha presentato regolare
denuncia al commissariato di Alcamo, ha fatto richiesta per l’apertura della
bara, ha appeso per le vie di Alcamo, la foto di suo fratello, per denunciarne
l’esistenza in vita, ma non ha ancora ricevuto nessuna risposta. Una persona in
cerca di verità e giustizia.
La strage di Alcamo Marina.
Premessa. Vi sto raccontando
in queste pagine le storie che hanno riempito di mistero la nostra storia
recente. Alcune di queste sono conosciutissime, come quella relativa ad Ilaria
Alpi, allo scandalo Lockheed, l’incendio della Moby Prince e così via. Altre
invece sono poco conosciute, spesso del tutto sconosciute al grande pubblico,
perfino a quello nella cui zona le vicende si sono verificate. Un esempio è
l’abbattimento dell’elicottero della Guardia di Finanza Volpe 132 e un altro
esempio è il fatto di cui vi voglio parlare adesso. É conosciuto come la strage
di Alcamo Marina. Ci sono stati due morti, due carabinieri, ma il caso è
estremamente intricato e quindi vi consiglio di seguire tutta la puntata con
attenzione. In ogni caso potrete riascoltarla con calma visitando il mio sito
noncicredo.org, dove trovate tutte le puntate trasmesse negli ultimi anni da
questa emittente. E adesso possiamo cominciare. Alcamo è un paese a metà strada
tra Trapani e Palermo. Si affaccia sul mar Tirreno. Oggi parleremo di un fatto
avvenuto il 27 gennaio 1976 nella frazione Alcamo Marina, località balneare
grazie ad una bella spiaggia sabbiosa sul golfo di Castellamare, quella in
provincia di Trapani. Nella caserma dell’arma, la Alkamar, quella notte stanno
dormendo due militari, l’appuntato Salvatore Falcetta di Castelvetrano (TP) e un
ragazzo di 19 anni, il carabiniere Carmine Apuzzo, di Castellamare di Stabia
(NA). É una notte di temporale con tuoni e molta pioggia. Del resto siamo in
pieno inverno e la località balneare è praticamente deserta di turisti. Verso le
7 della mattina del 27 gennaio, la scorta di Giorgio Almirante, che passava di
là, si accorge che qualcosa non va nella caserma. Il portoncino è stato
scassinato, usando la fiamma ossidrica. Fanno intervenire i carabinieri di
Alcamo, i quali, entrando, si trovano di fronte ad una scena raccapricciante.
Carmine è steso nella sua branda crivellato di colpi: non si è neppure accorto
di quello che stava accadendo. Salvatore invece i rumori li sente, cerca di
prendere la sua pistola, ma non fa in tempo: viene assassinato come il suo
collega. Dalla caserma sono sparite pistole, divise e altri oggetti. Perché
dedicare un articolo ad un fatto che con ogni probabilità nessuno ricorda, forse
nemmeno conosce se non chi è rimasto coinvolto direttamente: i familiari delle
vittime, quelle uccise e quelle ritenute colpevoli? In fondo – si potrà dire -
si tratta di due morti che non hanno nomi importanti e quindi passano
inosservati nell’insieme delle storie che vi sto raccontando. Ma questa vicenda
è allucinante per le conseguenze che ha avuto e per il fatto che, ancora oggi a
così tanti anni di distanza nessuno sa chi sia stato né il motivo di questo
eccidio. Certo, si sono fatte ipotesi e qualche racconto è emerso ed è proprio
di questo che voglio parlare questa sera, perché qualche colpevole è stato
riconosciuti e sbattuto in galera con sentenze durissime. Peccato che quelle
persone fossero innocenti.
I fatti. Cominciamo con il
racconto formale dei fatti, quello che scrive Wikipedia, una fonte semplice, ma
che può essere controllata dai diretti interessati. Poi entreremo nelle pieghe
della storia e cercheremo di capire meglio. Prima di cominciare è bene ricordare
in che clima vive il paese in quel periodo a metà anni ’70. Sono anni difficili,
anche e soprattutto in Sicilia: il pericolo terrorismo, le brigate rosse, la
mafia, i servizi segreti “deviati” presenti in provincia. E poi d’inverno non
c’è nessuno su quelle spiagge del Golfo di Castellammare proprio dove si trova
la casermetta di Alkamar: un luogo ideale per interi sbarchi di sigarette di
contrabbando, di droga e forse anche di armi. Il primo sospetto cade sulle
Brigate Rosse, anche se, a dire il vero, c’è una rivendicazione di un gruppo mai
sentito prima. Poche ore dopo l’eccidio, infatti, il Nucleo Sicilia Armata,
diffonde questo messaggio telefonico con una voce priva di inflessioni al
centralinista de La Sicilia. “La giustizia della classe lavoratrice ha fatto
sentire la sua presenza con la condanna eseguita alle 1.55 ad Alcamo Marina. Il
popolo e i lavoratori faranno ancora giustizia di tutti servi, carabinieri in
testa, che difendono lo stato borghese. Il bottone perso da uno dei componenti
del nostro commando armato che ha operato ad Alcamo Marina è una traccia inutile
perché l’abbiamo preso da una giacca tempo addietro a Orbetello. Carabinieri e
polizia fanno meglio a difendersi e a dedicare le loro energie ad altro. Fanno
meglio a difendersi assieme ai loro padroni fascisti e americani. Sentirete
ancora molto presto parlare di noi. Possiamo agire ad Alcamo, a Roma, ovunque”.
Di questo fantomatico gruppo, di evidente matrice rossa, nessuno sentirà mai più
parlare, segno che il messaggio aveva una funzione di depistaggio. Ma è
altrettanto certo agli inquirenti che chi telefonava era stato sulla scena del
crimine o, quanto meno, ne era molto ben informato. Del resto in quegli anni ad
Alcamo erano stati ammazzati due altri personaggi pubblici: l’assessore ai
lavori pubblici di Alcamo Francesco Paolo Guarrasi (ex sindaco DC) viene ucciso
nel maggio del 1975 con 4 colpi di pistola, mentre scende dalla sua auto proprio
sotto casa. La pistola che lo uccide è la stessa calibro 38 che soltanto un mese
prima aveva ucciso ad Alcamo il consigliere comunale Antonio Piscitello. E poi
di spari contro i carabinieri in piena notte ce n’erano già stati, ma senza
provocare feriti. Anche in quell’occasione il responsabile non era stato
trovato. Passano solo tre giorni quando, il 30 gennaio, le Brigate Rosse
emettono un comunicato, negando con fermezza di aver partecipato ai due
assassinii. Nonostante questo la pista che viene seguita è sempre quella del
terrorismo rosso. Le indagini sono guidate da Giuseppe Russo, allora capitano
del nucleo operativo di Palermo, braccio destro del generale Dalla Chiesa.
Mentre si cerca tra i vari gruppi e gruppuscoli dell’estremismo di sinistra,
ecco il colpo di scena.
Il colpevole? Qualche
settimana più tardi, è il 13 febbraio, ad un posto di blocco viene fermato
Giuseppe Vesco, di Alcamo su una fiat 127 verde. É un tipo stravagante, tanto
che in paese lo chiamano “Giuseppe il pazzo”. La targa della sua automobile è
falsa. Gli manca la mano sinistra, amputata dopo che, un paio di anni prima,
aveva fatto brillare un ordigno esplosivo forse trovato in un prato. Lo
perquisiscono: ha addosso una pistola calibro 7,65, dello stesso tipo di quella
usata per l’eccidio dei due carabinieri. Poi, salta fuori un’altra pistola: una
Beretta in dotazione ai carabinieri. La conclusione è quasi immediata: è una
delle armi rubate dalla casermetta: Il colpevole è stato trovato. Giuseppe, o
Pino, come molti lo chiamano, si chiude in un silenzio ostinato, rotto solo da
frasi del tipo: “Mi considero un prigioniero di guerra”, giocando il ruolo del
terrorista come quelli veri delle Brigate Rosse. Si dichiara colpevole, ma al
processo ritratta. I giornali dell’epoca non danno risalto a questo cambiamento
di strategia. Cosa è accaduto tra l’arresto e il processo? Abbiamo la
possibilità di usare due fonti. La prima è l’insieme di lettere che Pino scrive
dal carcere, anche se a volte non si conosce l’identità dei destinatari. la
seconda è la deposizione di un ex carabiniere, che aveva partecipato
all’interrogatorio dopo il quale Vesco aveva confessato tutto. Cominceremo ad
esaminare la prima fonte. Trovare quelle lettere non è facile. Un paio di esse
vengono pubblicate nel 1978 dalle riviste “Controinformazione” e “Anarchismo” e
vengono poi raccolte da un’associazione, alla quale si rivolge Roberto Scurto,
giornalista che tiene un blog chiamato “Liberi di informare”. Ho già detto
all’inizio che seguiamo la vicenda con le informazioni che sono state
pubblicate. In ogni caso si tratta di una storia scottante, a volte cruda e
pesante, in cui intervengono sevizie e torture e altre questioni poco chiare. Il
racconto del carabiniere, avvenuto nel 2007, a 32 anni dai fatti, coincida in
larga misura con il contenuto delle lettere non fa che confermarne la
veridicità.
Dunque cominciamo. Nella prima
lettera Pino assume l’atteggiamento di un guerrigliero che fa della lotta di
classe a difesa del proletariato la sua bandiera. Inneggia alla lotta armata ed
è chiaro che l’eccidio di Alcamo in questa lotta armata ci starebbe benissimo.
Dunque è giustificato che gli inquirenti seguano la pista del terrorismo rosso.
Ma il ragazzo ha anche a preoccupazione che vogliano farlo passare per pazzo e
rinchiudere in un manicomio, per poi eliminarlo fisicamente. Quello
dell’eliminazione è un chiodo fisso come vedremo tra poco. La parte più dura
degli scritti di Giuseppe è quella in cui descrive la tortura subita perché si
decida a far sapere dove si trova il materiale rubato nella casermetta e a dire
i nomi dei suoi complici. La descrizione è di una lucidità estrema, descrivendo
non solo il male subito, ma anche gli stati d’animo che mano a mano egli ha
attraversato. Immobilizzato su due casse gli viene versato con un imbuto in gola
un liquido che lui, perito chimico, stabilisce essere acqua con molto sale, olio
di ricino e terra. L’effetto è quello del soffocamento. Resiste un po’ ma poi
deve cedere. Tra l’altro non è uno con un fisico bestiale e non ci vuole molto
perché quella tortura produca i suoi effetti. Così i carabinieri riescono a
trovare quello che cercano: pistole, divise e quant’altro. Poi ritornano e
adesso vogliono i nomi dei complici. La tortura riprende e Pino a quel punto fa
dei nomi a caso, coinvolgendo quattro amici con i quali è solito passare parte
del suo tempo libero. Dalle lettere non si capisce bene se Giuseppe sia
coinvolto o meno negli omicidi. Da un lato c’è tuttavia il ritrovamento della
refurtiva, dall’altro il fatto che lui continui a dichiarare di non aver avuto
niente a che fare con quel fattaccio. Già al processo Giuseppe Vesco dichiarerà
che tutte le confessioni gli sono state estorte con la tortura, il che, per la
legge, rende inutile qualsiasi deposizione. I nomi coinvolti da Pino sono:
Giovanni Mandalà, fabbricante di fuochi di artificio: Vincenzo Ferrantelli,
Getano Santangelo, Giuseppe Gullotta. Quattro amici, un paio ancora minorenni
che di politica e di lotta armata non sanno proprio nulla. Eppure anche loro
confessano. Poi al processo diranno che le loro deposizioni sano il risultato di
torture pesanti subite durante gli interrogatori. Si va verso il processo, ma
Pino Vesco non fa in tempo a raccontare la sua storia. Lo trovano impiccato
nella sua cella. “Suicidio” sentenziano gli inquirenti, ma come abbia fatto a
fare il nodo scorsoio con una sola mano resta davvero un grande mistero. Proprio
di questo scriveva alla madre: il timore di essere suicidato. La prima sentenza
è di assoluzione. Nell’attesa dell’appello, i due minorenni, Ferrantelli e
Santangelo fuggono in Brasile, chiedono e ottengono asilo politico. L’appello
darà sentenze durissime: ergastolo per i due rimasti in Italia, 20 anni per gli
altri. Nel 1995 Santangelo tornerà in patria a disposizione della magistratura,
mentre l’altro rimarrà latitante. Mandalà muore in carcere nel 1998 di malattia,
mentre Gullotta sconta l’ergastolo, finché …
Io c'ero...Prima di continuare
con la storia, passiamo alla seconda fonte, l’ex brigadiere Giuseppe Olindo, che
nel 2008 si presenta ai magistrati per fare le dichiarazioni che tra poco
ascolteremo. Quelle che ascolteremo di seguito sono le voci tratte da un
documento filmato che è facilmente reperibile in rete. Si tratta, tra l’altro
anche di alcune deposizioni durante il processo per la revisione della posizione
dei condannati, oltre che di interviste e filmati su altri temi che toccheremo.
Derivano anche da trasmissioni radiofoniche e televisive, come ad esempio Blu
Notte e La storia siamo noi. Ringrazio gli autori di questi documenti che sono
fondamentali se non altro per dubitare di quello che viene passato per verità e
ci induce ad indagare ancora per cercare di capire, anche se spesso purtroppo
non ne siamo oggettivamente capaci. Dunque nel 2008 l’ex brigadiere dei
Carabinieri Giuseppe Olindo si presenta alla magistratura e racconta quanto
segue.
Insomma in quella caserma
vengono inflitte tremende torture e vengono condannati all’ergastolo degli
innocenti; la vita di quattro ragazzi, privati della libertà e condannati ad
atroci sofferenze, è rovinata per sempre. Perché i carabinieri usano tanta
violenza e tanta ingiustizia? Da chi hanno l’ordine di procedere in quel modo?
Perché la squadra antiterrorismo ha così fretta di chiudere il caso?
Lo stesso Olino riferisce che
quando arrivano ad Alcamo, non hanno alcuna idea di come muoversi, non hanno una
pista da seguire. Ma ad essi viene imposto di indagare nei gruppi dell’estrema
sinistra e solo in quelli. Lo stesso Peppino Impastato si interessa della
vicenda e raccoglie documentazioni importanti, ma di questo parleremo tra poco.
Adesso ascoltiamo di nuovo Olindo.
Peppino Impastato. In effetti
Peppino Impastato si occupava in quel periodo delle molte illegalità che
avvenivano in Sicilia e quell’omicidio non era certo cosa da poco. Fa uscire un
volantino molto duro nel quale sostiene che i carabinieri stavano cercando di
depistare l’azione investigativa e che a lui sembrava strano questo accanirsi
contro le organizzazioni di sinistra, non prendendo neppure lontanamente in
considerazione un’origine mafiosa della strage.
Che i depistaggi di cui
Peppino parla ci siano stati è abbastanza evidente. I carabinieri che conducono
le indagini vengono dal nucleo anti-crimine di Napoli. Li comanda il capitano
Gustavo Pignero, che diventerà generale e dirigerà una sezione dei Servizi
segreti militari (il SISMI). Quando il caso viene riaperto, i carabinieri che
avevano partecipato alle torture e che facevano capo al colonnello Giuseppe
Russo, finiti tutti sotto inchiesta, sono ormai ottantenni e si avvalgono della
facoltà di non rispondere. Resta in piedi la domanda senza risposta: chi ha
guidato i depistaggi e per quale motivo? Cosa è successo realmente quella notte
di gennaio ad Alcamo?
I dubbi e le nuove inchieste.
Le ipotesi sono diverse, alcune coinvolgono direttamente lo stato, altre la
mafia, altre ancora dei contrabbandieri di armi o di altra merce. Ma quello che
emerge è che in tutta la storia ci sono tante, troppe cose che non tornano o che
sono, quanto meno, molto, ma davvero molto strane. In effetti c’è il suicidio di
Pino Vesco che suona di falso lontano un miglio. C’è il ritrovamento dei corpi
che fa storcere in naso. Come è possibile che le guardie del corpo di Almirante
passino per caso la mattina seguente l’eccidio e si fermino in una stradina di
nessun conto, vedano il portoncino divelto e scoprano i cadaveri? Come mai il
tribunale condanna senza mezzi termini quattro balordi che non hanno precedenti
di un delitto così atroce e, a ben vedere, effettuato con estrema efferatezza e,
passatemi l’espressione, mestiere. Eh già, Gullotta, dopo aver passato 21 anni
in carcere, viene riconosciuto innocente, viene liberato e il fatto di aver
passato gran parte della vita dietro le sbarre viene compensato con 6 milioni e
mezzo di euro. Credo non sia difficile immaginare quanto poco quel denaro abbia
alleviato le sofferenze di un uomo che non aveva fatto niente e si è trovato
privato del bene più prezioso che abbiamo, la propria libertà. E questa
assoluzione si porta dietro altre conseguenze importanti. Prima di entrare nel
merito mi sento di fare una considerazione. É curioso che serva un riesame di
questa portata per capire che le conclusioni su molti delitti, dei quali la
storia del nostro paese è piena, sono state falsate. La gente lo sa, ma servono
sempre prove e documentazioni per poter procedere e soprattutto ci volgliono
decenni per venirne a capo, le rare volte in cui questo succede. Ecco dunque che
la sentenza Gullotta spinge il sostituto procuratore Antonino Ingroia, che
lavora nella procura di Trapani, a riaprire due inchieste: quella sulla strage
di Alcamo Marina e quella su Peppino Impastato, ucciso il 9 maggio 1978. E, di
conseguenza, salta fuori anche una terza inchiesta, quella sul suicidio di Pino
Vesco. Secondo la procura tutto quello che è avvenuto è stato fatto con il
preciso scopo di evitare che le indagini arrivassero a svelare l’esistenza e
soprattutto le opere (certo non benemerite) di un esercito segreto, la struttura
segreta Gladio. Certo, Peppino è stato ucciso dalla mafia, dal clan Badalamenti.
Per questo il processo ha condannato Tano Badalamenti all’ergastolo e il suo
vice, Vito Palazzolo, a 30 anni. É il 2002 e Tano muore due anni più tardi. Il
corpo di Peppino viene ritrovato lo stesso giorno in cui le BR (o chi per loro)
riconsegnano quello di Aldo Moro. La sentenza è immediata. Per i carabinieri si
tratta di suicidio o quanto meno di un incidente mentre il giovane sta mettendo
dell’esplosivo sui binari. Un’ipotesi assurda per chiunque conosca Peppino. Lui
è un militante di Democrazia Proletaria e soprattutto è responsabile di una
radio di denuncia contro la mafia, la radio Aut. Quello che qui interessa è che,
in quell’occasione, viene eseguita una nuova perquisizione nella casa di
Impastato. Si trova un dossier, con scritto sulla copertina “Giuseppe Vesco”.
Questa notizia è certa, perché il ritrovamento dell’incartamento compare nel
rapporto redatto dai carabinieri. Ma del dossier o di notizie sul suo contenuto
non c’è alcuna traccia, da nessuna parte. Il materiale è semplicemente sparito.
E torniamo ancora e sempre alle stesse domande su chi è stato e perché. Sappiamo
che sono domande che restano senza risposta. Nel caso appena esaminato è anche
evidente come la mafia abbia partecipato direttamente alla strategia.
Carabinieri, Servizi segreti, mafia, probabilmente Gladio … ecco la strada
indicata da Peppino. I due carabinieri, secondo la sua ipotesi, avevano fermato
quella sera un carico di armi che la mafia doveva consegnare a Gladio o
viceversa. Per questo vengono fatti fuori e poi viene inscenata tutta la
faccenda della casermetta ad Alcamo Marina. E c’è anche la scorta di Almirante
che, per caso, passa per una stradina di nessun conto, sperduta nel nulla e
scopre il portoncino divelto e tutto il resto … ma dai!
Gladio ... che roba è? Ho
accennato a Gladio. Di cosa si tratta? Quando è nato? Come è organizzato e,
soprattutto, a cosa serve? Di questo parleremo dopo una breve pausa. A partire
dall’esplosione di una bomba nella banca dell’agricoltura in piazza Fontana a
Milano nel 1969 si susseguono una serie di attentati che spesso non hanno alcuna
ragione, come quello in Belgio dove un commando perfettamente addestrato fa una
strage di clienti sparando senza alcuna remora anche sui bambini. Non esiste
ancora una matrice di terrorismo pseudo-religioso come ai giorni nostri e non si
era mai visto prima un bandito uccidere senza pensarci su dei bambini. Gli occhi
degli inquirenti, di quelli che riescono a capirci qualcosa, puntano su
un’organizzazione militare segreta, che ha sedi in tutta Europa e negli Stati
Uniti e ci chiama “Stay behind”, che significa sostanzialmente di rimanere
dietro, ma dietro a che cosa? Dopo la seconda guerra mondiale il mondo si spacca
in due: da una parte l’Occidente, guidato (il verbo è un eufemismo) dagli Stati
Uniti e dall’altro il blocco orientale socialista guidato (anche questo è un
eufemismo) dall’Unione Sovietica. Le due superpotenze si fronteggiano in ogni
settore della vita pubblica e si armano come se stesse per cominciare una nuova
guerra, la terza guerra mondiale, di cui in quel periodo si parla continuamente
con grande terrore. Noi italiani viviamo nel blocco occidentale e, anzi, siamo
un paese di confine e per questo da tutelare in modo particolare contro il
pericolo più grande: l’invasione delle truppe comuniste che arriveranno per
mangiare i nostri bambini e fare delle nostre chiese stalle per i cavalli dei
cosacchi. Detta così è certamente sarcastica, ma il fatto è che l’esercito
sovietico è probabilmente il più potente in quel momento e quindi arrestarne una
eventuale avanzata sarà impossibile. Ecco allora l’idea. Creare dei gruppi di
specialisti che operino dietro le linee nemiche (di qui il nome Stay behind =
stare dietro) e servano da appoggio per azioni da parte delle forze alleate
inglesi o americane che arriveranno a salvarci come nei film americani sui
cowboy. L'organizzazione di questo esercito è della NATO, l’alleanza atlantica.
Ci sono mezzi enormi messi adisposizione sia come addestramento (che avviene a
Sud di Londra) che come mezzi in ogni senso: trasporto, armi, e qualsiasi altra
cosa. Le formazioni assumono nomi diversi a seconda della nazione. In Italia
Stay Behind si chiama Gladio. É chiaro che qualcuno degli ascoltatori a questo
punto si chiederà cosa diavolo c’entri Gladio con Alcamo Marina, gli eserciti
segreti con i due carabinieri ammazzati nella casermetta siciliana. Arriveremo a
rispondere anche a questa domanda: ci vuole solo un po’ di pazienza. Ci sono
sicuramente indizi che lasciano pensare che non sia poi così assurdo pensare ad
un coinvolgimento di Gladio. I depistaggi e le modalità con cui i carabinieri
eseguono le indagini non sono quelle solite dell’arma. E poi, negli anni ’90,
viene scoperto ad Alcamo un nascondiglio di armi dentro un seminterrato di una
villa. Lo custodiscono due carabinieri. Siano in Sicilia, si può pensare ad un
covo della mafia, ma il deposito è davvero molto particolare. La quantità di
armi presenti è impressionante e anche la loro tipologia lascia perplessi gli
inquirenti. Non solo: c’è anche il materiale e gli strumenti per fabbricare
proiettili di vario genere. La procura si affida ad un consulente esterno, il
quale certifica che la possibilità della costruzione di munizioni da guerra è la
stessa che potrebbe rifornire la polizia di un intero piccolo stato. I due
guardiani, Vincenzo La Colla e Fabio Bertotto, si giustificano con la loro
passione per le armi e per esercitarsi al tiro, giustificazione del tutto
improbabile visto il tipo di arsenale. Tra l’altro il Bertotto faceva parte
(anche mentre si occupava dell’arsenale) dei Servizi segreti, come responsabile
della sicurezza delle ambasciate estere. Le armi sequestrate sono 422, tra cui
un centinaio di armi da guerra, mitra statunitensi, armi degli eserciti dell’Est
europeo, duecento pezzi da assemblare, perfino una munizione per contraerea. É
piuttosto ingenuo pensare a semplici collezionisti. L’indagine deve adesso
scoprire a quale rete tutto questo fa riferimento. In quel periodo è procuratore
aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. Anche lui indaga su questi fatti ed esclude
categoricamente che quell’arsenale sia in qualche modo legato alla mafia. Quelli
della mafia – dice Ingroia – non solo sono molto diversi come tipologia di armi,
ma vengono protetti da profili completamente diversi di guardiani. Insomma c’è
dell’altro, ci sono organizzazioni nascoste, come si evidenzierà con l’omicidio
Rostagno, di cui parleremo tra poco. Che poi ci siano interazioni tra queste
organizzazioni e la mafia è molto probabile ma che sia la mafia ad agire ad
Alcamo è, per Ingroia, del tutto fuori discussione.
Mauro Rostagno, Li Causi, la
Somalia, le armi e ancora Gladio. E adesso entra in scena un nuovo personaggio,
morto ammazzato nel 1993 in Somalia in un agguato per motivi mai accertati. Si
chiama Vincenzo Li Causi, trapanese di nascita, militare di carriera e
appartenente ai servizi segreti militari. É un nome importante: partecipa alla
liberazione del generale Dozier, sequestrato dalla BR a Padova; viene inviato in
molte missioni che richiedono abilità e competenza. Insomma è uno che conta. Dal
1987 al 1990 è a capo del Centro Scorpione, una sezione di Gladio a Trapani. Dal
1991 viene mandato più volte in Somalia. In una di queste missioni viene
ammazzato nel novembre 1993. La cosa più strana è che il giorno dopo è atteso a
Roma per testimoniare su Gladio e sui traffici di armi e rifiuti tossici e
radioattivi provenienti da mezzo mondo e di cui abbiamo parlato a lungo nelle
puntate di Noncicredo. Tutto questo pochi mesi dopo la scoperta dell’arsenale
vicino ad Alcamo. Il nome di Li Causi emerge un anno più tardi quando si indaga
sull’uccisione di Ilaria Alpi, di cui egli sarebbe stato un informatore che ben
conosceva i traffici sui quali la giornalista romana stava conducendo da anni la
sua inchiesta. Un ex appartenente a Gladio, protetto dall’anonimato ci dice
quanto segue. La sua voce è contraffatta. I compiti di Gladio in Sicilia non
sono tuttora molto chiari. Probabilmente fungeva da collegamento con la Gladio
all’estero, che operava nei Balcani, nel Nord Africa e nel Corno d’Africa. C’è
anche la questione del traffico di armi che avviene nell’aeroporto militare di
Chinisia, località a Sud di Trapani. Qui si trova il giornalista torinese Mauro
Rostagno, uno dei fondatori di Lotta Continua, che in Sicilia vive e lotta
contro la mafia nell’ultima parte della sua breve vita. Trasmette servizi
importanti contro il potere di Cosa Nostra dall’emittente Radio Tele Cine. Uno
di questi lo realizza proprio a Chinisia, quando atterra un aereo militare che
viene subito circondato da camion militari e molti uomini in mimetica. Torna
rapidamente in studio per montare il servizio che quella sera dovrà fare un
botto. In effetti quell’aereo trasportava armi da consegnare evidentemente non
tanto alla mafia quanto ad una organizzazione militare. Quelle immagini
spariranno la sera del 26 settembre 1988, giorno in cui Mauro Rostagno viene
ammazzato nella sua auto. Chi è stato? La pista seguita è quella della mafia. Ma
i dubbi sono enormi, soprattutto a causa dei modi di procedere con le indagini e
degli evidenti depistaggi che avvengono. Questa è un’altra storia che si
intreccia con quelle fin qui raccontate. Molte indagini sono state fatte e molte
ipotesi sono state avanzate sulla morte di Mauro: la mafia, Gladio, i servizi,
la massoneria deviata. Restiamo semplicemente agli atti più recenti, che dicono
che, nel maggio 2014, la Corte d'Assise di Trapani condanna in primo grado
all'ergastolo i boss trapanesi Vincenzo Virga e Vito Mazzara. I legami tra mafia
e Gladio vengono rivelati in diverse indagini, di recente è saltato fuori che
l’ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, avrebbe potuto far parte della
struttura segreta. Lo ha detto il figlio Massimo durante le rivelazioni sulla
trattativa tra Mafia e Stato. Giovanni Falcone, mentre sta seguendo piste in
merito all’uccisione di Pio La Torre da parte della mafia nel 1982, crede che
sia importante confrontarsi con i colleghi romani, che stanno indagando su
Gladio, ma si trova davanti un muro posto dal Procuratore Capo. Non si può e non
si sa perché.
I pentiti di mafia.
Sull’eccidio della casermetta nel tempo ci sono altre voci che intervengono.
Quella, ad esempio, di Giuseppe Ferro, un pentito della famiglia di Alcamo, che
conferma che la strage non fu certo eseguita dai ragazzotti accusati e
incarcerati. Nella sua testimonianza si legge: “Li ho conosciuti in carcere quei
ragazzi arrestati. Erano solamente delle vittime, pensavamo che era una cosa dei
carabinieri, che fosse qualcosa di qualche servizio segreto.” C’è poi Vincenzo
Calcara, altro pentito di mafia di Castelvetrano, il quale racconta di essere
stato compagno di cella di Pino Vesco. Quando arriva l’ordine da parte di
Antonio Messina, boss di Campobello di Mazara del Vallo, di lasciare da solo il
ragazzo senza una mano. “Fu ucciso da un mafioso con la complicità di due
guardie carcerarie” dichiara il pentito. É lo stesso Messina a spiegare la
situazione a Calcara. Vesco deve morire perché è stato uno strumento e deve
sparire. I due carabinieri sono stati ammazzati perché hanno visto cose che non
dovevano vedere e è stato impedito loro di fare cose che potevano danneggiare
non personaggi di cosa nostra ma anche collegati ad essa. É dunque questa la
pista: una connivenza tra mafia e Gladio (o comunque organizzazioni segrete
all’interno dello stato) che nel trapanese si sono sempre incrociate e
frequentate in un anomalo scambio di favori. Ma l’invasione sovietica, come ben
sappiamo, non c’è mai stata e quindi negli anni l’organizzazione Gladio viene
utilizzata per scopi diversi. Tra questi un piano elaborato dalla CIA,
l’intelligence statunitense, chiamato Demagnetize (Smagnetizzare). Il suo scopo
è quello di togliere ossigeno e depotenziare il Partito Comunista Italiano, che
negli anni ’70 comincia ad assumere l’importanza di un partito di governo.
Questo coinvolge diversi movimenti di estrema destra, che diventano attivi nella
strategia della tensione con numerosi attentati in tutta Italia. Abbiamo
ricordato quello di Gorizia, per fare un esempio. Ci sono stati anche tentativi
di golpe, a dire il vero piuttosto velleitari, in uno dei quali interviene anche
una delle famiglie mafiose di Alcamo, la famiglia Rimi. É il 1970 e il fallito
attentato alle istituzioni italiane è quello di Junio Valerio Borghese, ex
fascista, ex presidente del Movimento Sociale, frequentatore di Pinochet e del
suo capo della polizia segreta … insomma un personaggino tutto pepe. Dopo la
guerra viene condannato a due ergastoli, ma l’intervento dei servizi segreti
americani fa sì che quella condanna si riduca a 12 anni, di cui nove condonati.
Sfruttando l’amnistia voluta da Palmiro Togliatti viene rilasciato
immediatamente. Muore nel 1974 in circostanze abbastanza strane in Spagna, dove
si è rifugiato. Nella provincia di Trapani le organizzazioni segrete sono ben
radicate in quel periodo. In un ambiente in cui conta molto più la mafia dello
stato, le attività sommerse sono all’ordine del giorno e può quindi accadere che
due carabinieri in servizio si imbattano in un trasporto strano, in qualcosa di
più grande di loro. La presenza di Gladio nel trapanese viene certificata
ufficialmente solo nel 1990, ma i vertici dell’organizzazione continueranno a
ribadire la propria estraneità ai fatti di Alcamo Marina, e a tutte le
nefandezze che la popolazione ha dovuto subire in quegli anni. Di questo parla
Paolo Inzerilli, responsabile di Gladio dal 1974 al 1986. Un altro personaggio,
al quale ha accennato il giudice Casson nel suo primo intervento ha avuto una
storia notevole. Si tratta di Vincenzo Vinciguerra, condannato all’ergastolo per
la strage di Peteano, quella in cui sono rimasti uccisi tre carabinieri e feriti
altri due. Vinciguerra non si è mai tirato indietro, considerandosi un “soldato
politico”, facendo rivelazioni e non chiedendo mai uno sconto di pena, anzi
volendo rimanere in carcere per tutta la sua durata, ritenendolo un mezzo di
protesta. Durante il processo, che vedeva come giudica Felice Casson, lo scontro
è durissimo. Il giudice cerca in ogni modo di dimostrare che l’esplosivo usato
nell’attentato proviene da un deposito di armi di Gladio, trovato vicino a
Verona. Si tratta di C-4, il più potente esplosivo disponibile all’epoca, in
dotazione alla NATO. Nel 1984, a domanda dei giudici sulla strage alla stazione
di Bologna, Vinciguerra dice: « Con la strage di Peteano, e con tutte quelle che
sono seguite, la conoscenza dei fatti potrebbe far risultare chiaro che esisteva
una reale viva struttura, segreta, con le capacità di dare una direzione agli
scandali... menzogne dentro gli stessi stati... esisteva in Italia una struttura
parallela alle forze armate, composta da civili e militari, con una funzione
anti-comunista che era organizzare una resistenza sul suolo italiano contro
l'esercito russo ... una organizzazione segreta, una sovra-organizzazione con
una rete di comunicazioni, armi ed esplosivi, ed uomini addestrati all'utilizzo
delle stesse ... una sovra-organizzazione, la quale mancando una invasione
militare sovietica, assunse il compito, per conto della NATO, di prevenire una
deriva a sinistra della nazione. Questo hanno fatto, con l'assistenza di
ufficiali dei servizi segreti e di forze politiche e militari.» Una posizione
personale, ma molto chiara, come quella che esprime a parole. Ma Gladio è stato
davvero il demonio responsabile di ogni nefandezza che nel paese si veniva
compiendo? Adesso ascoltiamo due testimonianza. La prima, brevissima, è di
Francesco Gironda, capo della rete Gladio di Milano, mentre la seconda è ancora
di Felice Casson, magistrato chioggiotto e più tardi politico dell’Ulivo e poi
del Partito Democratico. Ascoltiamoli, poi chiuderemo il nostro racconto.
Conclusioni. Siamo partiti da
un fatto particolare, quello dell’uccisione di due carabinieri nella casermetta
di Alcamo Marina e siamo finiti a parlare di strategia della tensione, di
attentati come quello di Bologna che apparentemente non hanno nulla a che fare
con l’inizio della nostra storia. Questo dimostra quello che in questi mesi ho
sempre cercato di sottolineare e cioè che le storie sono tutte legate tra loro,
perché è periodo in cui esiste una strategia ben precisa che coinvolge lo stato
e le sue istituzioni, per mantenere il potere e fare profitti. Oggi Gullotta è
un uomo libero e ricco, libero perché non ha commesso quel reato infamante, così
come i suoi amici, quelli sopravvissuti per lo meno. Ma non è libero dagli
incubi che nessuno di noi credo possa neppure immaginare di aver passato un
terzo della sua vita rinchiuso in un carcere dove non doveva stare. Rinchiuso
mentre altre persone e non una sola sapevano perfettamente che era innocente.
Prima di chiudere un’ultima osservazione su Gladio. Nell’estate del 2014 viene
proposta una legge intitolata: “Riconoscimento del servizio volontario civile
prestato nell’organizzazione nordatlantica Stay Behind”. La firma Luca Squeri di
Forza Italia. In essa si sostiene che i volontari che hanno prestato servizio
all’interno di Gladio devono essere trattati come i partigiani e quindi meritano
una legittimazione per aver difeso la patria dal nemico. Nessun riconoscimento
in denaro, si intende, un riconoscimento sotto il profilo politico e anche
militare. Quindi nessun legame con le trame nere, con brandelli impazziti
dell’eversione di stato. Sotto sotto la proposta porterebbe dritto al
finanziamento pubblico dell’associazione. Il fatto che, una volta capito che il
patto di Varsavia non aveva intenzioni di invadere l’Occidente, questa
organizzazione si sia mossa in segreto, sfruttando le risorse dei servizi
segreti semplicemente per impedire l’accesso al governo del Partito Comunista
Italiano è un fatto riconosciuto anche da due dei politici più dentro le
questioni delle segrete stanze, come Andreotti e Cossiga. Del resto quella di
Squeri non è la prima volta di una simile richiesta strampalata. La prima in
assoluto è del 2004 e porta la firma, guarda caso, di Cossiga. Iniziativa
seguita, pochi mesi dopo alla Camera, da un testo identico presentato dal
forzista Paolo Ricciotti. Ma Cossiga torna alla carica ancora altre volte: nel
2006, nel 2007, nel 2008 e nel 2009. Sempre nel 2009 un testo identico viene
presentato a Montecitorio da Renato Farina, quello famoso per aver partecipato
coi servizi segreti alla diffusione di notizie false contro Romano Prodi.
Condannato per vari reati e radiato dall’ordine dei giornalisti, oggi collabora
con Il Giornale e sarebbe difficile pensare il contrario. Insomma per la destra
istituzionale (Forza Italia, PDL e tutte le altre sigle berlusconiane) Gladio è
una organizzazione di eroi positivi, che hanno cercato di fare il bene del
nostro paese. Non mi sembra il caso di aggiungere alcun commento. Termino qui. É
stato un articolo forse più faticoso del solito, che ha cercato di raccontare
una storia poco conosciuta in cui, ancora una volta, si mescolano affari loschi,
mafia e reparti deviati della repubblica, ma, in questo caso, ben conosciuti e
sostenuti dallo stato. Alcamo Marina in fondo non è stata nulla come tributo di
sangue rispetto a molte altre tragedie di cui vi ho raccontato: penso alle bombe
della strategia della tensione: piazza Fontana, Brescia, l’Italicus, Bologna o
alle tragedie di cui sappiamo poco o nulla perché occorre che non si sappia chi
andava coperto, come nel caso dell’elicottero Volpe 132, della Moby Prince, di
Ustica. Purtroppo si potrebbe continuare l’elenco. Purtroppo ...
Strage alla caserma
“Alkamar”, ecco come venne riaperto il caso.
Il racconto del cronista trapanese Maurizio Macaluso, la sua inchiesta portò
alla revisione del processo. Michele Caltagirone su Blasting News Italia il 27
gennaio 2016. Il giornalista Maurizio Macaluso lavorava nella redazione del
settimanale “Il Quarto Potere”, diretto da Vito Manca. Nel 2007, in una rubrica
da lui curata su fatti di cronaca ancora avvolti nel mistero, iniziò ad
occuparsi della strage alla caserma “Alkamar” del 27 gennaio 1976, sollevando
dubbi sulla reale colpevolezza di Giuseppe Gulotta, Vincenzo Ferrantelli,
Gaetano Santangelo e Giovanni Mandalà, i quattro giovani condannati per il
duplice omicidio dei carabinieri Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo. “Mi recai
anche ad Alcamo – ricorda Macaluso, contattato dalla redazione di Blasting News
Italia – ad intervistare Marta Ferrantelli, sorella di uno dei presunti
colpevoli. Tra i miei obiettivi c’era ovviamente quello di contattare
direttamente Vincenzo Ferrantelli, tanto lui quanto Gaetano Santangelo all’epoca
si trovavano in Brasile. Entrambi, a qualche settimana di distanza, fecero
pervenire una e-mail in redazione raccontando la loro versione dei fattiche
venne pubblicata sul nostro settimanale. In risposta ricevetti anche un’altra
e-mail con parole di fuoco da parte dei familiari di Salvatore Falcetta che
contestarono il contenuto dell’articolo. Per quasi un anno non ci furono altre
novità sul caso”.
Contattato dall’ex brigadiere
Olino. “A quasi un anno di distanza – prosegue Maurizio Macaluso – ricevetti una
mail anonima. Qualcuno sosteneva di essere a conoscenza della verità, affermando
che erano stati condannati quattro innocenti. Si faceva riferimento anche alla
mail dei familiari di Falcetta, ‘chissà cosa direbbero se sapessero la verità’,
tra le parole che mi vennero scritte. Il misterioso mittente rivelò
successivamente la sua identità, si trattava dell’ex brigadiere Renato Olino che
aveva assistito agli interrogatori dei giovani arrestati nel 1976. Ci
incontrammo successivamente a Trapani, venne in redazione e mi espose ifatti ai
quali aveva assistito. Si trattò di confessioni forzate; ad esempio, nel caso
di Giuseppe Vesco, le confessioni gli vennero estorte nel corso
dell’interrogatorio con latorture. Da quel momento la stragedi Alcamo Marina
divenne un tormentone del nostro giornale, mi sforzavo settimana dopo settimana
per mettere insieme nuovi elementi. La Procura, che conservava anche le copie
dei miei articoli, raccolse poi elementi a sufficienza per riaprire il caso”.
C'è un altro segreto.
Maurizio Macaluso Linea Rossa 12 anno 3 - numero 45. Un giovane alcamese,
Giuseppe Tarantola, fu ucciso nel 1976 nel corso di un conflitto a fuoco con i
Carabinieri. Si disse che era in possesso di una pistola ma un ex brigadiere
rivela che non era armato. Un altro morto che attende giustizia. Un'altra storia
scomoda che riemerge dal passato. Si chiamava Giuseppe Tarantola. Aveva
venticinque anni ed era di Alcamo. Morì trentuno anni fa durante una sparatoria
con i carabinieri. Si disse che era armato, che voleva uccidere i militari, che
era pronto a compiere una strage. Un testimone rivela però ora che in realtà
Giuseppe Tarantola non era armato. Che la pistola sequestrata sarebbe stata
apposta dai carabinieri per coprire le responsabilità di colui che aveva
sparato. A rivelare il nuovo sconvolgete episodio è un ex brigadiere, lo stesso
che, due mesi fa, ha parlato dell'uccisione dell'appuntato Salvatore Falcetta e
del carabiniere Carmine Apuzzo. Lo stesso che ha sostenuto che Giuseppe Vesco e
gli altri giovani coinvolti nelle indagini sull'uccisione dei due carabinieri
furono picchiati e seviziati e costretti a confessare. Giuseppe Tarantola fu
ucciso nel corso della notte tra il 10 e l’11 febbraio del 1976 alla periferia
di Alcamo nel corso di un conflitto a fuoco con i carabinieri. Erano trascorse
due settimane dall'uccisione di Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo. L'assassino
dei due carabinieri aveva destato grande scalpore. La vicenda era arrivata anche
in Parlamento. Qualche giorno prima, nel corso di una seduta parlamentare,
l'onorevole Giomo aveva presentato un'interrogazione ai ministri dell'interno e
della difesa. "Chiedo di conoscere - aveva detto il parlamentare - se ritengano
rendere edotta l'opinione pubblica ed il Parlamento sull'offensiva che si sta
attuando da parte di forze extraparlamentari contro i carabinieri, offensiva
culminata nel selvaggio agguato contro la caserma di Alcamo Marina dove hanno
perso la vita due giovani militari. È ormai noto a chi segue la cronaca
quotidiana che nei soli mesi di dicembre e gennaio nelle città di Milano, Roma e
Genova sono state attaccate più volte caserme di carabinieri con bombe a mano,
bottiglie incendiarie e raffiche di mitra, che hanno portato alla distruzione di
automezzi militari e danneggiamento di edifici pubblici. Si è passati ora in
questa escalation di guerriglia contro l'Arma, che ha il difficile compito della
tutela dell'ordine pubblico, all'assassinio. L'interrogante chiede se di fronte
alla brutale e violenta campagna istigatrice di odio contro i carabinieri
organizzata dalla stampa extraparlamentare con le conseguenti offensive di
guerra che in questi ultimi mesi sono state scatenate, il governo intenda
intervenire con tutti i mezzi a sua disposizione rendendo note all'opinione
pubblica tutte le informazioni in suo possesso sull'attività dei mandanti e
degli esecutori di questi gruppi sovversivi paramilitari che operano nel paese".
L'uccisione di Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo aveva generato preoccupazione
nella popolazione di Alcamo. La gente era allarmata. Temeva che la morte dei due
carabinieri potesse essere soltanto l'inizio di una lunga serie di omicidi. Gli
investigatori erano intenzionati a chiarire al più presto il contesto in cui era
maturato il delitto. Bisognava fare presto e restituire serenità ai cittadini.
Interrogatori e perquisizioni si susseguivano giorno e notte. Tutte le persone
sospette venivano fermate. La notte tra il 10 e l'11 febbraio una pattuglia dei
carabinieri intercettò un'auto sulla quale viaggiavano quattro giovani. Alla
vista dei militari il conducente proseguì la corsa senza fermarsi. Dopo un lungo
inseguimento per le vie della città, l'auto sbandò finendo contro un edificio. I
quattro giovani, inseguiti dai carabinieri, scesero dalla vettura e tentarono di
fuggire a piedi. Scoppiò un conflitto a fuoco. Giuseppe Tarantola fu colpito da
una raffica di mitraglia. Il giovane, gravemente ferito alla gola ed al petto,
morì mentre veniva trasportato in ospedale. Gli investigatori sostennero che,
dopo essere stato bloccato, Giuseppe Tarantola era sceso dall'auto e si era
lanciato contro i carabinieri con una pistola in pugno pronto a far fuoco.
L'arma, una pistola calibro trentotto, era stata rinvenuta dopo la sparatoria
sull'asfalto. L'auto sulla quale viaggiavano i quattro giovani era rubata. Due
dei tre sopravvissuti, interrogati dagli investigatori, confessarono di avere
rubato, qualche giorno prima, anche un'altra vettura. Le auto erano destinate ad
un meccanico di Alcamo che avrebbe dovuto smontarle e rivendere i pezzi. I tre
giovani furono arrestati. La morte di Giuseppe Tarantola destò grande scalpore
ad Alcamo. Ventiquattro ore dopo però i carabinieri arrestarono Giuseppe Vesco.
Nella città si diffuse immediatamente la notizia che il giovane aveva
confessato. Che aveva ammesso di avere ucciso i due carabinieri. Che aveva
indicato i nomi dei complici. La gente si precipitò dinanzi la caserma. La morte
di Giuseppe Tarantola fu presto dimenticata. Trentuno anni dopo, però, c'è però
chi sostiene che c'è un'altra verità. Che Giuseppe Tarantola non era armato. Che
non voleva compiere alcuna strage. Che la sua morte va inserita nel clima di
tensione che in quei giorni si respirava ad Alcamo. "Non si fermò all'alt",
racconta l'ex brigadiere, che in quei giorni si trovava ad Alcamo per
partecipare alle indagini sull'uccisione di Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo.
"Dopo un breve inseguimento finì contro un muro. Scese dall'auto e tentò di
fuggire. Un brigadiere esplose alcuni colpi di mitra uccidendolo. Dopo la
sparatoria fu rinvenuta sotto l'auto una pistola a tamburo. La magistratura
archiviò il caso ritenendo che il brigadiere avesse operato legittimamente. Ma
in realtà quel giovane non era armato. Fui io a collocare la pistola su ordine
di un ufficiale prima dell'arrivo del magistrato". La clamorosa rivelazione
getta nuove ombre sull'operato dei carabinieri. L'episodio è stato riferito
dall'ex brigadiere nel corso dell'intervista rilasciata al nostro giornale due
mesi fa. Avevamo deciso di non pubblicarla in attesa di effettuare le necessarie
verifiche. La ricerca si è rivelata più lunga del previsto. Ad Alcamo nessuno
ricorda più questa storia. Tutte le persone interpellate non hanno saputo
fornirci alcuna informazione in merito alla vicenda. La tragica morte di
Giuseppe Tarantola è stata rimossa dalla memoria collettiva. Abbiamo quindi
effettuato una ricerca negli archivi della biblioteca di Paceco ed abbiamo
accertato che l'episodio riferito dall'ex brigadiere è realmente avvenuto. Il 12
febbraio del 1976 il Giornale di Sicilia pubblicò un articolo in prima pagina
nel quale era riportata la cronaca degli avvenimenti che avevano condotto
all'uccisione di Giuseppe Tarantola. "Alcamo - Tragica fine di un giovane ladro.
Scappa all'alt. Ucciso dal mitra di un carabiniere - Arrestati i tre ragazzi che
erano con lui in auto". Nell'articolo si riferiva che Giuseppe Tarantola non si
era fermato all'alt dei carabinieri e che dopo essere stato bloccato era sceso
dalla vettura con una pistola in pugno pronto a far fuoco contro i militari. Una
raffica di mitra lo aveva fermato uccidendolo. La rivelazione dell'ex brigadiere
potrebbe ora riaprire il caso. Intanto le dichiarazioni dell'ex sottufficiale
sui presunti pestaggi subiti da Giuseppe Vesco e dagli altri giovani alcamesi
coinvolti nelle indagini sull'uccisione dell'appuntato Salvatore Falcetta e del
carabiniere Carmine Apuzzo hanno aperto un ampio dibattito. Numerosi alcamesi si
sono ricordati della tragica fine dei due militari. Tanti sono tornati ad
interrogarsi. Anche numerosi giovani stanno seguendo con grande attenzione gli
sviluppi della vicenda. Roberto Scurto ha ventuno anni. "Sono passati tantissimi
anni, è ora che finalmente si faccia giustizia", scrive in un articolo
pubblicato sul portale Alcamo.it. "Chi sa qualcosa parli! È incredibile come
questa storia possa ancora dare fastidio a qualcuno dopo tutto questo tempo. E
se qualcuno pensasse che non interessa a nessuno si sbaglia". Il suo appello è
stato accolto da tanti concittadini che sono intervenuti nel blog. C'è chi pone
domande, chi avanza dubbi. C'è chi, come Anna, chiede di sapere perché l'ex
brigadiere si è deciso soltanto ora a parlare. Perché per trentuno anni è
rimasto zitto. L'ex sottufficiale ha voluto chiarire, intervenendo personalmente
sul blog, la sua pozione. "Per motivi di opportunità al momento molte domande
restano senza risposta. Grazie al giornalista Maurizio Macaluso oggi, dopo
trentuno anni, qualcuno mostra finalmente interesse su questa brutta storia.
Quando venni a conoscenza che Giuseppe Vesco si era impiccato portando con sé
tutti i segreti di questa tragedia, rimasi profondamente ferito e ritenni di non
essere più degno di portare la divisa. Lasciai l'Arma dei Carabinieri senza
alcuna spiegazione. Ho sempre pensato che la tortura non porta alla vera verità.
Mi rivolgo a tutti quei colleghi che quella notte erano presenti a sostenere la
mia testimonianza. Voglio ricordare che il giuramento di fedeltà alla
Repubblica, alle Leggi di questo Stato, alla Costituzione vennero quella notte
calpestate da chi era posto dalle stesse alla difesa ed al rispetto. Gli stessi
militari che quella notte, ritenendo di fare Giustizia usarono metodi cileni,
sono gli stessi che nel corso dei successivi trent'anni hanno dato la vita per
combattere la mafia. Questo mio appello, questa mia decisione di contribuire
alla ricerca della verità può solo dare dignità all'Arma dei Carabinieri ed a
coloro che hanno pagato con la vita il loro impegno per il rispetto della
legalità". Tra coloro che scrivono c'è però anche chi va controcorrente. Chi non
si scandalizza, chi invita a riflettere, a considerare il contesto in cui maturò
la vicenda. "Non mi scandalizzerei più di tanto.... anche perchè chi uccide, chi
ruba chi estorce non si fa di certo scrupoli", scrive un ex carabiniere. "Con
questo non voglio dire che voglio difendere l'operato delle forze dell'ordine,
però vorrei evidenziare come ogni qual volta succede qualcosa di negativo
operato dalle forze dell'ordine si strumentalizzi.... Io penso che bisogna
considerare i contesti storici, politici del momento che spingono a certi
comportamenti. Sicuramente nella strage citata, ci sono molti risvolti oscuri,
ma non credo che si sia volutamente operato per non far emergere la verità....
Ps. Sono un ex carabiniere e sono orgoglioso di esserlo stato". "Questa
equazione mi sconcerta", risponde Zagor. "Se i delinquenti non si fanno
scrupoli... neanche le forze dell'ordine se ne debbono fare!!! Sicuramente non
gli sarà mai capitato di essere dall'altra parte della scrivania, quando con
metodi da boia - questa è la giusta definizione - si estorcono le verità che
perseguono gli inquirenti, non certamente la verità assoluta. Potrebbe essere
vero che non si voleva occultare la verità in quel caso, questo però non esclude
che si volessero trovare velocemente dei colpevoli a caso e non i reali
colpevoli!". "Poveri ragazzi, loro hanno perso la vita, hanno sacrificato
l'unica vita che avevano per garantire lo Stato e proteggere noi cittadini, e
noi anziché pensare a loro parliamo dei metodi poco ortodossi che usano a volte
le forze dell'ordine nei riguardi dei delinquenti", scrive Caterina, invitando
tutti a non dimenticare il sacrificio dell'appuntato Salvatore Falcetta e del
carabiniere Carmine Apuzzo, vittime di questa tragedia. "Non dico che si
dovrebbe fare dente per dente, ma certo non riesco a provare tutto questo falso
buonismo su chi non rispetta le leggi. A mio avviso noi stiamo confondendo il
perdono dalla giustizia, perdonare non significa che non venga fatta giustizia,
e chi sbaglia paga o in questa o nell'altra vita". C'è anche chi scrive alla
nostra redazione. Chi pone altre domande, chi avanza altri sospetti. "Come mai
ancora oggi si sentono casi di barbare torture per estorcere confessioni, come
in certi paesi incivili?", chiede Lydia Adamo "Come mai uno Stefano Santoro
s'indigna per le foto da lei pubblicate e non batte ciglio per "lo stupro della
legalità" commesso dai carabinieri? La tortura è illegale in Italia, giusto?
Ultimo ma non meno importante, Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo sono morti
si, ma siamo certi che fossero davvero innocenti? O forse erano incappati in
qualcosa più grande di loro e andavano eliminati? Poi, come la storia ci ha
dimostrato, tutto viene messo a tacere torturando quattro sventurati.... ". Un
altro dubbio, un altro inquietante sospetto di questa torbida storia. Maurizio
Macaluso
Alcamo e la strage della
casermetta.
Rino Giacalone il 14 luglio 2008 su liberainformazione.org. Si negano
continuamente, e invece ecco che spuntano sempre i misteri e le deviazioni,
mischiati alla storia di una Sicilia che non è possibile leggere in modo chiaro,
per questi gialli irrisolti, per delle pagine se scritte sono state fatte
sparire, o inghiottite negli archivi del «segreto di Stato», come è accaduto per
la storia del bandito Giuliano (forse primo vero esempio di accordo tra mafia e
settori dello Stato). Ci sono le commistioni che accompagnano la Sicilia da
sempre, da quando Garibaldi sbarcò a Marsala e cercò subito i «picciotti» per
sbarazzarsi dei Borboni, e la stessa cosa fecero gli americani che per occuparci
fecero accordi con i «mammasantissima» di Cosa Nostra degli States e poi fecero
ancora più potenti i mafiosi consegnando loro le città, continuando un rapporto
fino ai giorni nostri se è vero come è vero che il super latitante Matteo
Messina Denaro cercò sino agli anni ’90 aiuto negli Usa, attraverso i «re» del
narcotraffico, come Rosario Naimo, per far diventare la Sicilia stato
americano. In mezzo ci sono anche le storie dei tentativi di golpe, dei mafiosi
che dovevano essere alleati della destra eversiva, di principi e generali, ma
non se ne fece nulla perchè qualcuno a Roma dei capi del golpe chiese i nomi di
chi avrebbe fatto parte dell’esercito dei mafiosi che avrebbero partecipato al
colpo di stato del principe Borghese. In questa «pentola» ogni tanto ci sono
episodi che emergono, che chiedono di essere riletti. Uno di questi è quello
della strage della casermetta dei Carabinieri di Alcamo Marina. Era la notte del
26 gennaio 1976, la mattina successiva due agenti dell’allora «squadra politica»
della questura di Palermo di scorta al segretario Msi Giorgio Almirante passando
da Alcamo Marina videro il cancello aperto e la porta della stazione sfondata,
diedero l’allarme dentro furono trovati i corpi di Carmine Apuzzo, carabiniere
semplice, e Salvatore Falcetta, appuntato, crivellati a colpi di pistola. Al
delitto di mafia pensò subito la Polizia, i Carabinieri con le loro indagini
presero altre direzioni, inquadrarono il movente nella vendetta di una sorta di
anarchico, Giuseppe Vesco, lo arrestarono, lui accusò altre 4 persone, poi
ritrattò e disse che altri erano stati i suoi complici, prima di uccidersi in
carcere. Vesco aveva fatto i nomi di Giovanni Mandalà, Giuseppe Gulotta e due
minorenni, Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo. Secondo il racconto di
Vesco Mandalà avrebbe forzato la porta della caserma con la fiamma ossidrica, a
sparare sarebbero stati Giuseppe Gulotta e Gaetano Santangelo, Ferrantelli
avrebbe solo messo a soqquadro le stanze. I 4 arrestati confessarono dopo
estenuanti interrogatori successivi al loro arresto avvenuto il 13 febbraio
successivo all’eccidio dei carabinieri della «casermetta», ma davanti al
procuratore ritrattarono, raccontarono delle torture subite e delle confessioni
estorte. Vesco nel frattempo cambiava versione e assumeva ogni colpa su di se
rilevando che «altri soggetti erano stati suoi correi». Fu trovato morto,
suicida, in carcere. Erano trascorsi pochi mesi dalla strage e dall’arresto.
Privo di una mano Vesco riuscì ad impiccarsi con una corda sistemata in una
finestra della cella a due metri da terra. Erano dei balordi, questa la
conclusione di un tormentato iter giudiziario, concluso da condanne, scaturite
da una serie di atti contenuti in faldoni dove oggi le indagini riaperte non
hanno tardato a riconoscere che ci sono elementi più per assolvere che per
condannare. Giovanni Mandalà di Partinico, è uscito da questa storia perchè
deceduto,Vesco come si diceva si è suicidato prima ancora di presenziare al
processo di primo grado (che si era concluso con le assoluzioni per tutti tranne
che per Mandalà), Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo sono fuggiti via
dall’Italia e sono in Brasile al sicuro dall’estradizione (condanne definitive
rispettivamente a 14 e 22 anni anche per la loro minore età all’epoca del
duplice delitto), unico a finire a scontare la pena, l’ergastolo, Giuseppe
Gulotta: lui ha presentato istanza di revisione del processo (con l’avvocato
Pardo Cellini), indicando la persona che lo (li) scagiona, un ex brigadiere dei
carabinieri che ha svelato che in quei giorni a tavolino fu deciso di incolpare
quei ragazzi della morte dei due carabinieri, torturati e minacciati, costretti
a confessare. È stato il quotidiano «La Stampa» e il giornalista Francesco La
Licata a raccogliere il suo racconto dopo che una puntata della serie «Blu
Notte» di Carlo Lucarelli, ha rilanciato i misteri di quella strage «Nel 1976 –
raccontò l’ex brigadiere a La Licata – facevo parte del Nucleo Anticrimine di
Napoli e fui mandato ad Alcamo per indagare sull’uccisione dei due militari. Mi
porto dentro un peso che non sopporto più. E’ vero che i giovani fermati furono
torturati. Io stavo lì e ho visto. A Vesco, che poi accusò gli altri, gli fecero
bere acqua e sale e lo seviziarono. Fece ritrovare anche alcuni oggetti e due
pistole. Ma non bastò, volevano i nomi dei complici. Anche le confessioni di
questi furono ottenute in quel modo». «Ci sarebbe – svela La Licata in un suo
articolo riprendendo ancora la confessione dell’ex brigadiere dell’Arma – anche
una registrazione audio dove è impressa la voce dell’ufficiale che quella notte
dirigeva le operazioni». Giuseppe Gulotta da tempo ormai vive in Toscana, con
moglie e un figlio, ha trascorso 17 anni in carcere, da poco ha ottenuto il
regime di semi libertà. la sua storia e complessivamente quella della strage è
stata anche ripresa e ricostruita da una settimanale locale a Trapani, «QP» e
dal giornalista Maurizio Macaluso. Gulotta pochi giorni addietro hanno riferito
i quotidiani «La Stampa» e «La Sicilia» è stato sentito in procura a Trapani: ha
detto ai magistrati che hanno riaperto le indagini sulla strage di non avere mai
ucciso nessuno. «Mi sono commosso – ha raccontato Gulotta a La Licata per “La
Stampa” – quando ho riproposto il film del mio arresto. Io che non capivo perchè
mi mettevano le manette, io che venivo picchiato per confessare quello che non
avevo fatto. Mi sono commosso quando ho ricordato la sentenza definitiva, coi
carabinieri di Certaldo che mi sono venuti a prendere a casa. Piangevano pure
loro, perchè mi conoscevano e sapevano che non avrei mai potuto commettere quei
crimini. Piangevano, quando hanno dovuto strapparmi dal collo il mio bambino,
che allora aveva un anno e mezzo». È partita una sorta di caccia – investigativa
– su chi può avere ucciso i due carabinieri. Sui depistaggi e le torture,
svelati dall’ex carabiniere, niente si può più fare, reati prescritti, ma su chi
ha sparato, ancora è possibile indagare. Si stanno rileggendo vecchi atti
giudiziari, ma anche verbali non proprio antichi, ce ne sono anche risalenti al
1999. Pentiti che parlando di quegli anni ’70 hanno confermato l’esistenza di
piani di attacco allo Stato concordati tra mafia, eversione di destra, settori
deviati dello Stato. Circostanze che non sono nuove raccontando di quell’Italia
del 1976, travolta dalla cosiddetta «strategia della tensione», anni dopo si
scoprirà che c’erano «poteri forti» come la massoneria, servizi segreti che
servivano infedelmente lo Stato, a disposizione di politici rimasti nell’ombra,
avevano stretto «patti» con uomini del terrorismo, della mafia, delle
organizzazioni criminali. Uno «scambio di favori» per il quale tantissima gente
è finita vittima innocente di bombe e attentati. La mafia fece parte di quel
piano, dove comparve pure la figura di un principe «nero», Junio Valerio
Borghese che chiamò i mafiosi per un golpe rimasto tentato. Ciò che avvenne in
quei giorni di gennaio ad Alcamo sembra proprio frutto di una strategia. Vennero
dapprima uccisi un sindacalista socialista, Antonio Piscitello e poi il
democristiano Francesco Guarrasi; la notte dell’omicidio Piscitello, in una
strada di Alcamo furono trovati anche 14 candelotti di dinamite che non
esplosero per caso. Nella notte del 26 gennaio vennero trucidati i due
carabinieri. Per gli omicidi Piscitello e Guarrasi nel 1977 la polizia avrebbe
arrestato tre personaggi che diventeranno famosi anche per altro, Armando
Bonanno, Giacomo Gambino e Giovanni Leone che nel giro di qualche anno si
sarebbe scoperto essere uomini d’onore, legati a quelle cosche invischiate in
delitti ancora più gravi. Leone si trovò coinvolto nel sequestro dell’esattore
Luigi Corleo, imparentato con i Salvo di Salemi, i potenti esattori, rapito e
mai restituito alla sua famiglia. La banda Vannutelli si scoprì essere bene in
contatto con ambienti della destra eversiva. Un quadro esatto di quello che
accadeva in quegli anni in provincia di Trapani lo scrisse in un rapporto, del 2
dicembre 1976, il capo della squadra Mobile Giuseppe Peri: mafia ed eversione di
destra alleate, colpevoli dei crimini del tempo, forse anche dell’incidente
aereo del Dc9 caduto a Montagna Longa. Nella vicenda della strage della
casermetta spunta anche il nome di Peppino Impastato, il giornalista ucciso nel
1978 dalla mafia a Cinisi. I carabinieri andarono anche nella sua abitazione a
fare perquisizioni cercando prove di un coinvolgimento della sinistra
extraparlamentare in quella strage e da Impastato fu trovato un volantino sulla
strage della casermetta e che raccontava altro, denunciava che le indagini erano
apposta pilotate verso ambienti politici della sinistra, un volantino scomparso,
nei faldoni del processo per la uccisione dei carabinieri Falcetta e Apuzzo non
se ne trova traccia, c’è il verbale di perquisizione in casa Impastato, ma quel
volantino non c’è. In fin dei conti in questa vicenda questo sembra essere il
passaggio più marginale. Ce ne sono di altre cose strane, anomale, alle quali la
procura di Trapani oggi sta provando a fare chiarezza. Muovendosi doppiamente in
maniera cauta, per il riserbo investigativo ma anche perchè i protagonisti di
questa storia sono ancora «operativi». Ci sono indagini che in questi anni hanno
riproposto scenari aggiornati rispetto a quelle commistioni del 1976, il
«sistema» è rimasto in piedi, magari ha cambiato funzionamento e addentellati,
si può anche essere chiamato «Gladio» o qualcos’altro, può avere avuto trovato
utili riferimenti nelle logge massoniche di Palermo e Trapani o anche di Mazara
del Vallo, dove c’erano comunque dei «punciuti» o per i riti esoterici o per
quelli mafiosi, o per tutte e due le cose. Mentre Giuseppe Gulotta è tornato in
Toscana alla sua semilibertà, e Ferrantelli e Santangelo stanno in Brasile.
L’ultima volta furono rintracciati dai carabinieri, alcuni anni addietro: i
militari partiti apposta da Trapani pedinando un sacerdote che faceva il
fattorino per conto delle loro famiglie avevano, annunciato il loro arresto poi
però negato, niente estradizione. Anche allora Ferrantelli e Santangelo dissero
che loro non hanno mai ucciso nessuno.
Le memorie dal carcere di
Giuseppe Gulotta, "mostro" d'innocenza.
Accusato ingiustamente dell'omicidio di due carabinieri, ha passato vent'anni in
galera. E ora li racconta in un libro. Matteo Sacchi, Venerdì 03/05/2013, su Il
Giornale. È una storia da brividi. Uno strano incrocio tra gli eventi narrati ne
La colonna infame di Manzoni e il caso Dreyfus. Eppure non è accaduto nel Secolo
di Ferro o nella Francia dell'Ottocento. È accaduta in Italia, in Sicilia, in
pieno regime di democrazia. Ed è costata più di un ventennio di galera a un
innocente, come ha stabilito una sentenza della Corte d'Appello di Reggio
Calabria il 13 febbraio 2012. Ora Giuseppe Gulotta che a lungo ha dovuto
convivere con l'infamia di essere considerato il mostro di Alcamo, ha deciso di
raccontare (con Nicola Biondo) la propria storia in un libro prossimo
all'uscita: Alkamar. La mia vita in carcere da innocente (Chiarelettere). Ecco i
fatti. Il 27 gennaio 1976 ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani, la stazione
dei Carabinieri viene attaccata. Agli inquirenti la scena si presenta così: la
porta della casermetta è stata abbattuta usando una fiamma ossidrica. Nelle loro
brande giacciono, freddati, due giovani carabinieri, Carmine Apuzzo e
l'appuntato Salvatore Falcetta. Sembra siano stati colti nel sonno, soltanto uno
ha avuto un accenno di reazione. Da subito le indagini si rivelano complesse.
L'attacco sembra un lavoro da professionisti, il fatto che i carabinieri siano
colti nel sonno è poco spiegabile. Per non parlare del movente. Due le piste
battute: quella mafiosa (l'anno prima erano stati uccisi l'assessore ai lavori
pubblici di Alcamo, Francesco Paolo Guarrasi, e il consigliere comunale Antonio
Piscitello) e quella dell'attacco terroristico (arrivò un comunicato di
rivendicazione, subito dopo smentito dalle stesse Br). Viene spedita sul posto
in maniera piuttosto informale una squadra investigativa dei carabinieri
comandata da Giuseppe Russo (colonnello dei carabinieri poi ucciso dalla mafia
il 28 agosto 1977 e insignito della medaglia d'oro al valor civile). Poi finisce
nelle mani degli inquirenti un certo Giuseppe Vesco. È un carrozziere della
zona, monco di una mano, viene trovato in possesso di armi e oggetti che
sembrerebbero provenire dalla Stazione di Alcamo. La pista sembra buona e gli
uomini di Russo si fanno prendere la mano. Come rivelerà, troppi anni dopo, uno
di loro, Renato Olino, usano le maniere forti, molto forti. Vesco per sfuggire
al dolore fa i nomi di una serie di ragazzi di Alcamo tra cui Giuseppe Gulotta.
Olino non è convinto, vorrebbe attendere i riscontri della scientifica, gli
altri vogliono giustizia subito, portano in caserma quelli nominati da Vesco.
Secondo Gulotta, all'epoca manovale diciottenne che aveva appena fatto il
concorso per entrare in Finanza, anche a loro tocca la linea dura. Ecco che cosa
racconta nel libro: «Schiaffi, tre, quattro, a mano aperta... Mani coperte di
guanti neri continuano a colpirmi... Il ferro freddo mi scortica la parte
sinistra della faccia: è una pistola. Il clic del cane che si alza e si abbatte
a vuoto». L'interrogatorio per cui non è stato fatto nessun verbale e a cui non
presenzia l'avvocato dura diverse ore. Alla fine Gulotta cede: «Vi dico tutto
quello che volete, basta che la smettete». Nella testa di questo ragazzino
terrorizzato ciò che conta è farli smettere. Non capisce che firmare una
confessione può distruggergli la vita. Quando arriva al carcere di Trapani e
finalmente incontra i magistrati prova a dire la sua verità: «Lei conferma
quello che ha detto a verbale?. Se ho fatto quelle dichiarazioni è perché sono
stato picchiato tutta la notte». Secondo Gulotta gli rispondono: «È impossibile
che per le botte si confessi un omicidio». Gli fanno una visita medica,
risultano delle contusioni, ma secondo i Carabinieri purtroppo è caduto...E da
questo punto in poi la storia giudiziaria di Gulotta oscilla fra la sua
testimonianza iniziale, le prove labili, e la modalità in cui si sono svolti gli
interrogatori. Anche perché Vesco, il testimone chiave che ha coinvolto gli
altri, in carcere si suicida. Pur essendo monco riesce a impiccarsi a una grata
altissima e, per non disturbare, si posiziona anche un fazzoletto in bocca. La
prima sentenza della corte di Assise di Trapani assolve Gulotta per
insufficienza di prove. Però è vaga sulle violenze. Per ciò che è avvenuto nella
caserma di Alcamo si limita a un «critico giudizio» e parla di «maltrattamenti e
irregolarità». Nel 1982 si passa alla Corte d'Appello di Palermo che ribalta la
sentenza: Gulotta è condannato all'ergastolo. Si accumuleranno i processi, sino
a che il 19 settembre 1990 la sentenza diventa esecutiva. Gulotta deve entrare
in prigione, per lo Stato è un assassino. Per un attimo ha la tentazione di
fuggire, poi rinuncia. Entra in carcere, affronta il calvario cercando di essere
un detenuto modello, per uscire il prima possibile. Nel 2010 arriva la libertà
vigilata. Intanto qualcuno ha dei terribili rimorsi di coscienza. È l'ex
brigadiere Renato Olino. Aveva già provato a raccontare di quegli interrogatori,
soprattutto di quello di Vesco. Non trovò sponda istituzionale e nemmeno in
certi giornalisti, che non vollero saperne delle sue verità. Poi però sul caso
torna la televisione con la trasmissione Rai Blu notte - Misteri italiani,
ricostruisce la storia anche se con alcune inesattezze e Olino via web si fa
avanti per raccontare. Così la magistratura di Trapani apre un'inchiesta e
arriva anche il processo di revisione: il 26 gennaio 2012 il procuratore
generale della Corte d'Appello di Reggio Calabria ha chiesto il proscioglimento
di Giuseppe Gulotta da ogni accusa; proscioglimento raggiunto in via definitiva
il 13 febbraio 2012. Sulle cause di un'indagine condotta così male si indaga
ancora. Giuseppe Gulotta, che ha chiesto allo Stato un risarcimento di 69
milioni di euro, racconta di essere tornato sul luogo dove c'era la stazione dei
carabinieri di Alcamo Mare. Ora li c'è un cippo per i due carabinieri morti. A
loro nessuno ha ancora dato giustizia, a lui l'hanno data con 36 anni di
ritardo. Anni che non torneranno più.
Stefano Santoro pagina
Facebook 15 novembre 2019 alle ore 22:20 ha condiviso un link. Vesco in contatto
con Curcio .Fogli con stemma delle Br trovati nelle perquisizioni ad Alcamo nel
76., lo stato maggiore delle Br a Catania un mese prima della strage di Alcamo
Marina, ovvero gli uomini del sequestro Moro. Una autovettura intercettata a
Cefalù con dei brigatisti. Un tentativo di attentato con uomini vestiti da
carabinieri, nei pressi di Messina, dopo la strage. Puzza di Br a Cinisi. Vesco
disse nelle sue lettere, che chi fece quella incursione, non aveva esperienza di
guerriglia.....Fossero stati estremisti di destra ,oggi ne parlerebbero tutti i
giornali e si aprirebbero fascicoli contro ignoti. Viva la democrazia
sinistriota!
MISTERI CATANESI. Aureliano
Buendìa Sud Press 9 Luglio 2013. Lentamente, le timide scoperte delle indagini
della Magistratura da una parte e il contributo di vari autori storici
dall’altra, viene emergendo il ruolo strategico della città di Catania in alcuni
Misteri italiani. Una città affidabile la nostra, che tiene per decenni i
segreti nel suo ventre molle, un po’ come la lava che sembra inghiottire tutto
ma che talvolta invece conserva in una sorta di bolla senza distruggere. Allo
stesso modo alcuni ambienti hanno saputo nascondere, coprire e ricattare grazie
a verità insopportabili. D’altra parte, Catania è periferia, persino rispetto a
Palermo, e qui l’afa soffoca tutto, qui lo Stato, salvo qualche episodico
errore, manda funzionari levantini, annoiati, preoccupati di passare indenni
sotto l’Etna per poi incassare il premio alla loro omertà.
Quali sono questi ambienti e
cosa nascondono e cosa hanno avuto in cambio? Si tratta di fatti delicatissimi,
per alcuni dei quali non sarebbe ancora intervenuta alcuna prescrizione, ma noi
del resto ce ne occupiamo per quel piacere della verità che coltiviamo non come
esteti ma come cittadini che non dimenticano, come debito che manteniamo nei
confronti di quanti hanno pagato con la vita. In questo pezzo ci occuperemo
del delitto Moro e prima ancora dei contatti delle Brigate Rosse a Catania.
Pochissimi sanno che il 12 dicembre del 1975 presso il centrale Hotel Costa – in
via Etnea – alloggiavano Giovanna Currò con il suo compagno. In verità si
trattava di Mario Moretti, capo storico delle BR, e della sua compagna Barbara
Balzerani.
Cosa facevano i due brigatisti
a Catania? Sono oramai centinaia i documenti che attestano come gli esponenti
delle BR abbiano in diverse occasioni “preso un caffè” con i rappresentanti di
Cosa Nostra e Catania aveva la sua influente Famiglia, della quale non a caso si
ricorderà il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa riprendendo la sua attività
svolta come Generale e come responsabile delle carceri italiane. Sempre Moretti
tornerà a Catania, nelle settimane successive, questa volta alloggiando
all’Hotel Jolly di Catania, e cioè a 200 metri dal Palazzo di Giustizia e dal
Comando provinciale dei Carabinieri. A Catania operava già un Nucleo di Lotta
Continua, che era stato organizzato fino al 1976 da Franca Fossati,
appositamente trasferitasi nella nostra città appunto per organizzare il gruppo
etneo ed è noto che alcuni militanti di Lotta Continua passeranno alle Brigate
Rosse proprio in quegli anni. Allo stesso modo sono più o meno noti gli
spostamenti che la Faranda, storica carceriera brigatista, poi dissociatasi e
che pare si sia opposta alla sentenza di morte nei confronti di Aldo Moro,
effettuava da e verso Catania, godendo di una certa libertà. Nei 55 giorni del
rapimento di Aldo Moro a Catania succedeva qualcosa di particolarmente grave, su
cui non si è mai fatta piena luce, e cioè, mentre gli uomini di Dalla Chiesa si
occupavano di prendere contatto nelle carceri con quei detenuti, anche
appartenenti a Cosa Nostra, che potessero collaborare con lo Stato per dare
informazioni utili alla liberazione dello statista e la Mafia da parte sua non
vedeva l’ora di rendersi utile, agli uni (chi trattava) e agli altri (che
volevano morto l’On. Moro), il 3 aprile – 16 giorni dopo la strage di via Fani
ed in pieno rapimento – ignoti gambizzavano il Comandante delle guardie
carcerarie di piazza Lanza. Qualcuno, ed anche chi scrive, ricorda nitidamente
l’arrivo dei Carabinieri in assetto antisommossa entrare in forze dentro la Casa
circondariale mentre altri uomini cinturavano letteralmente piazza Lanza e le
vie limitrofe.
Cosa era accaduto? Cosa si
cercava? Chi era detenuto a Catania in quel momento? Qualcuno voleva
interrompere quel tentativo trattativista? Non risulta, di contro, che mai
collaboratore di giustizia abbia chiarito la circostanza, probabilmente
trattandosi di questione troppo alta e delicata per essere trattata da pentiti
comunque di piccolo cabotaggio ed in ogni caso terrorizzati per le conseguenze.
A Catania, si vivevano gli anni dello splendore dei Cavalieri mentre la
Democrazia Cristiana – sul libro paga dei primi – era targata Andreotti, con il
suo luogotenente l’on. Nino Drago, ed era fermamente contraria alla trattativa.
Erano gli anni in cui un capomafia in piazza Università, alla fine di un comizio
si era permesso, e si poteva permettere, di schiaffeggiare ostentatamente il
rappresentante andreottiano e ciò accadeva senza che alcuno tra le forze
dell’ordine osasse intervenire. Santapaola completava la sua scalata, eliminando
di lì a poco proprio quel capomafia schiaffeggiatore. Pippo Fava osservava e
scriveva, e sarebbe interessante indagare anche in questa direzione, su cosa
cioè il coraggioso giornalista avesse scoperto della complicità tra mafiosi e
settori dello Stato, in quella che sarebbe stata la madre di tutte le trattative
ed anche di quella più scellerata che si sarebbe consumata 15 anni dopo.
L’omicidio di Fava fu un fatto eclatante che non portò bene ai mafiosi e quindi
non si può escludere che in quel 5 di gennaio del 1984 – siamo a meno di 6 anni
dall’omicidio Moro, in piena celebrazione di uno dei tanti processi su quel
mistero della Repubblica (il processo era cominciato il 14 aprile 1982), ad
appena due anni dalla eliminazione “mafiosa” (la pista catanese?) del Prefetto
Dalla Chiesa – qualcuno abbia fatto un favore a qualcun altro, secondo la teoria
dei cosiddetti cerchi concentrici. I Siciliani di Fava, di Orioles e degli altri
"ragazzi", scrivevano di Ciancimino, degli esattori di Salemi, dei rapporti con
i Cavalieri del Lavoro; Calogero Mannino diventava segretario regionale della
DC, Rocco Chinnici insisteva sul terzo livello. Il cav. Costanzo e Mario Ciancio
Sanfilippo nel 1981 acquistavano il 16% del Giornale di Sicilia. Incredibile,
quanti uomini della trattativa si incontrino già in quegli anni. Tornando
all’anno del sequestro Moro – il 1978 – dobbiamo registrare un altro episodio
inquietante, che assume i contorni di un messaggio probabilmente indirizzato
alle alte sfere della Politica nazionale: il 14 di settembre di quell’annus
orribilis diversi colpi di pistola attingono il segretario della federazione
socialista di Catania. I socialisti di Craxi erano stati favorevoli alla
trattativa per liberare l’on. Aldo Moro e Craxi aveva ricevuto dal Gen. Dalla
Chiesa informazioni riservatissime sul rapporto delle BR a Catania con ambienti
malavitosi organizzati e con i potentati cittadini che si apprestavano a
conquistare l’Italia. Qualche mese dopo Salvo Andò veniva eletto per la prima
volta alla Camera dei Deputati, rompendo il predominio democristiano che in
Sicilia aveva visto fino ad allora i socialisti di Capria subalterni agli
andreottiani. Interessante, sulle relazioni pericolose mafia-terrorismo, saranno
anche le rivelazioni di un funzionario di polizia come Giovanni Palagonia,
mentre più di tutti al cerchio magico catanese si avvicinerà, dopo
Chinnici, Falcone e Borsellino, il PM Carlo Palermo, scampato all’attentato in
cui persero la vita una mamma con i suoi due bambini trovatisi nel momento
sbagliato nel luogo sbagliato. Catania, quindi, in quei giorni del rapimento
Moro aveva il suo ruolo e le inconfessabili trame di quei giorni testimoniano il
livello dei contatti catanesi, la commistione tra apparati dello Stato e crimine
organizzato, il ruolo di alcuni imprenditori che avevano mostrato appoggi ed
ambizioni smisurate, osservatori che avevano forse intuito tutto e che sarebbero
caduti negli anni successivi sotto i colpi di quell’Anti Stato mentre altri
avrebbero fatto e, pensiamo, alcuni continuano a fare carriera nelle
Istituzioni. D’altra parte sono passati appena 35 anni, un tempo breve per i
nostri longevi politici. Certi segreti, fino a tanto che rimangono tali, pesano
sulla coscienza di una città e sul suo futuro come macigni, ciclopi di lava che
tutto coprono ma non distruggono, perché i segreti come la lava si ingrottano. E
tutto scorre. Le Brigate Rosse a Catania, i contatti con la Mafia, i Cavalieri e
Dalla Chiesa…Autore Aureliano Buendìa
Stefano Santoro pagina
Facebook 14 novembre 2019 alle ore 19:20 ha condiviso un post. Fabio Lombardo è
il figlio del maresciallo Lombardo trovato morto nella sua auto, all'interno del
cortile, del comando regionale dei carabinieri a Palermo. Alcuni giorni prima
era stato attaccato dal sindaco Leo Luca Orlando, nello stesso modo, come era
stato fatto con Falcone. Nell'auto del sottufficiale non c'era traccia di
polvere da sparo. Si parlò di suicidio.
Fabio Lombardo pagina facebook
14 novembre 2019 alle ore 15:15. Negli ultimi 24 anni ho incontrato tanti
giornalisti, la stragrande maggioranza dei lecchini e vigliacchi. Tra questi, 3
palermitani sono stati codardi: Salvo Palazzolo (La Repubblica ), una volta ha
scritto un pezzo sulla borsa di mio padre scomparsa dall'auto. Ricordo di averlo
incontrato dopo qualche mese e gli dissi: Salvo, perché non hai più scritto?
Perché non ti sei fatto più sentire? Risposta: "Da quando ho scritto
quell'articolo, i giudici non mi fanno più entrare negli uffici....quindi DEVO
LAVORARE. Ah bene!
Salvo Sottile, dopo il 4 marzo
95 chiamava decine di volte al giorno perché voleva notizie, dicendo che era un
amico e che il caso lo aveva toccato tanto....Infatti! Qualche anno fa ha
inviato un suo giornalista per fare un servizio sulle irregolarità del caso
Lombardo. La puntata non andò mai in onda. Perché? Un mistero.
Infine la nostra iena
palermitana Ismaele La Vardera, direi più un gattino che gioca a fare il
giornalista. Quest'estate mi contatta dicendo che vuole realizzare un servizio
sul caso Lombardo, come quello Cucchi o Rossi. Intanto quando parlavo con lui mi
sembrava di avere di fronte un bambino, perché, vista l'età, non conosceva i
personaggi e diceva sempre: ma vero? Stai scherzando? Io penso che la redazione
delle Iene non sapeva nulla su questa sua iniziativa. Chiedeva documenti
particolari, nomi particolari...per fare cosa? Mi viene da ridere quando mi
trovo giornalisti come questi. Un altro giornalista palermitano mi ha
intervistato ma, prima di iniziare la conversazione gli chiesi se potevo parlare
di Orlando. Risposta: No perché a Palermo ci devo lavorare....e Minchia! I
giornalisti che hanno seriamente affrontato questa storia hanno dovuto pagare
con la giustizia italiana... E ci tengo a ricordare Daniela Pellicanò, Giammarco
Chiocci e Roberta Ruscica.
Stefano Santoro 13 novembre
2019 alle ore 06:10 pagina Facebook ha condiviso un link. Ecco chi è NICOLA
BIONDO, colui il quale chiama bestie in divisa i carabinieri di Alcamo , ecco a
chi ha affidato Giuseppe Gulotta, la stesura del suo libro. Leggete l'articolo.
Mitrokhin, “palestra” per manipolatori occulti Il caso Nicola Biondo di Gabriele
Paradisi – Gian Paolo Pelizzaro – Sextus Empiricus il 24 ottobre 2011. La
Commissione parlamentare d’inchiesta sul dossier Mitrokhin ha fatto da palestra
ad alcuni manipolatori più o meno occulti. Come abbiamo più volte scritto, il
caso più eclatante di manipolazioni multiple riguarda il “Documento conclusivo”
di minoranza, presentato il 23 marzo 2006 dai commissari di centrosinistra. A
quella relazione lavorò un agguerrito pool di consulenti, composto da
magistrati, storici, ricercatori, giornalisti e aspiranti tali, fra cui tale
Nicola Biondo. Durante i lavori della Commissione, Biondo ha vissuto in una
sorta di totale anonimato. Raramente è uscito allo scoperto, mai è stato
delegato a svolgere attività istruttorie come ricerche d’archivio, in Italia o
all’estero, rare le sue comparsate durante le audizioni, sporadiche le sue
presenze a Palazzo San Macuto per lo svolgimento di quelle attività di studio e
lettura degli atti. Questa sorta di apatia, però, ha subito uno scossone nel
luglio del 2005 quando Gian Paolo Pelizzaro, dopo 25 anni di totale segreto, ha
trovato negli atti della Questura di Bologna il nome di Thomas Kram, ossia del
terrorista tedesco presente in città il giorno della strage. Da quel momento,
Biondo ha ritrovato il fuoco sacro del lavoro di ricercatore, vestendo
immediatamente i panni di un inflessibile e zelante investigatore. Ha iniziato
ad estrarre copia degli atti depositati in Commissione, ha fatto le ore piccole
a leggere, studiare e congetturare. Si è documentato, a modo suo, facendo una
sorta di corso accelerato sulla storia del superterrorista Carlos e della sua
organizzazione “Separat”, scaricando da internet intere rassegne stampa e
quant’altro. Da un giorno all’altro, si è trasformato in un “grande esperto” di
terrorismo internazionale e in particolare di quello di matrice
arabo-palestinese (per il quale ha tradito una “passione” molto speciale),
capace di dispensare – a destra e a manca – patenti e certificati di
attendibilità di questo o quel documento, su questa o quella ricostruzione dei
fatti. Il personaggio, dall’alto della sua profonda conoscenza e suprema
competenza, ha iniziato ad esprimere giudizi e a sparare sentenze su questo o
quell’argomento: l’importante è che si parlasse di Carlos e del suo ipotetico
ruolo (come capo di “Separat”) nell’organizzazione della strage alla stazione di
Bologna. Obiettivo: demolire, anche con informazioni e notizie fasulle, ogni
ipotesi di collegamento tra il gruppo del terrorista venezuelano, il terrorismo
di matrice arabo-palestinese e l’attentato del 2 agosto 1980. Lentamente, ma
inesorabilmente Biondo, da anonimo e svogliato collaboratore della Mitrokhin, si
è tramutato in un infaticabile censore e castigatore. Uno dei più severi e
spietati. Meglio tardi che mai, si potrebbe obiettare. Il suo nome è venuto
fuori prepotentemente un anno dopo la scoperta del nome e del ruolo di Kram a
Bologna e quattro mesi dopo la formale chiusura dei lavori della Commissione
Mitrokhin, in due articoli-fotocopia pubblicati il 28 luglio del 2006 dai
quotidiani di sinistra Liberazione e l’Unità, basati su un medesimo elaborato,
proprio a firma Biondo. Gli articoli erano titolati “2 agosto strage di Bologna:
smentita la pista araba” (Saverio Ferrari, Liberazione”) e “Quanti depistaggi
per coprire la strage fascista” (Vincenzo Vasile, l’Unità) e cercavano, partendo
proprio dalle avventurose “ricostruzioni” di Biondo, di dimostrare l’esistenza
di un fantomatico piano da parte di alcuni esponenti di An per depistare (non si
sa cosa, visto che su Bologna dal 1995 c’è il giudicato della Cassazione), dalla
matrice fascista della strage. In uno degli articoli si leggevano frasi di
questo tenore: «Smascherato l’ultimo depistaggio di Alleanza nazionale costruito
con documenti mai esistiti». Non solo temerari, ma pericolosamente superficiali.
Ebbene, grazie a Biondo e alle sue teorie, i direttori responsabili dei due
quotidiani, così come gli estensori degli articoli, sono stati tutti querelati e
rinviati a giudizio per diffamazione aggravata dal mezzo stampa. C’è un processo
in corso davanti al Tribunale Penale di Roma e la prossima udienza
dibattimentale è fissata al 7 novembre 2011 (per un approfondimento sulla
vicenda, si veda anche l’articolo “Un omicidio senza colpevoli”, LiberoReporter,
febbraio 2011). Anche con un certo coraggio (vista la palese violazione delle
norme e delle regole sulla tenuta del segreto e sulla riservatezza alle quali si
devono attenere coloro che hanno fatto parte delle commissioni d’inchiesta),
Biondo è citato come teste da parte degli imputati. Vedremo cosa dirà, sotto
giuramento, il nostro castigatore. Intanto, abbiamo scoperto un altro prezioso
riscontro al metodo scientifico impiegato da Biondo per svolgere il suo lavoro
di ricercatore attento e scrupoloso. Abbiamo così preso in esame l’edizione
italiana del libro di Emmanuel Amara, “Abbiamo ucciso Aldo Moro. Dopo 30 anni un
protagonista esce dall’ombra” (Cooper, febbraio 2008, pp. 205), con introduzione
di Giovanni Pellegrino, traduzione di Alice Volpi e curato proprio da Nicola
Biondo. Per apprezzare la qualità e la raffinatezza dei suoi interventi, è però
necessario procurarsi l’edizione originale francese del libro di Amara, “Nous
avons tué Aldo Moro” (Patrick Robin Éditions, novembre 2006, pp. 175). Mettendo
a confronto i due testi si rileva una serie impressionante di modifiche che
spesso cambiano il senso del discorso. Interventi, questi, che non possono certo
essere imputati alla traduzione. Volendo farne una dettagliata classificazione,
possiamo riconoscere:
1. L’aggiunta di 46 note a
pie’ di pagina, intervento in apparenza migliorativo, ma non segnalato come tale
(nel testo originale francese non vi è infatti alcuna nota).
2. L’eliminazione di brani
(significativa ci sembra la soppressione delle cinque pagine di testo con le
dichiarazioni di Giulio Andreotti sul caso Gladio dell’ottobre 1990).
3. Traduzioni modificate
mediante aggiunte o sottrazioni di parole o manipolazioni di testo.
4. Trasformazioni di parti di
testo virgolettate (ossia citazioni degli intervistati) in brani apparentemente
attribuiti all’autore (ossia Amara).
Va dato atto che Biondo, a
pagina 14, ha avuto l’accortezza di preavvisare i lettori con una dichiarazione
pedagogico-programmatica: «La versione originale di questo volume ha subito
alcune modifiche nell’edizione italiana. Ciò è dipeso dalla necessità di rendere
il testo quanto più comprensibile a coloro che non hanno vissuto direttamente
quella storia e a chi l’ha dimenticata. Altre modifiche si sono rese necessarie
a causa dell’emergere di documenti e testimonianze successive alla pubblicazione
dell’opera in Francia». Il lettore dell’edizione italiana non è tuttavia in
grado di identificare nessuna delle modifiche apportate dal curatore. Volendo
anche seguire il ragionamento di Biondo (excusatio non petita?), non si capisce
nemmeno quali siano i nuovi documenti emersi tra la pubblicazione in Francia del
lavoro di Amara (novembre 2006) e la pubblicazione in Italia dell’edizione
curata da Biondo (febbraio 2008). Ad ogni modo, veniamo al dunque per fare
apprezzare alcuni eclatanti e macroscopici esempi di “chirurgia giornalistica”,
veri e propri “trapianti multipli” eseguiti da quel ligio e solerte “gendarme
della memoria” di Nicola Biondo. Cerchiamo ad esempio di verificare cosa c’era
nel testo originale francese di così poco fruibile per il pubblico italiano.
Presto detto: c’erano alcuni “organi” decisamente corrotti e impresentabili che
andavano assolutamente e tempestivamente rimossi e sostituiti con organi “sani”.
Qui di seguito alcuni esempi.
Testo originale edizione
francese
Testo manipolato edizione
italiana
[p. 15] “L’OLP de Yasser
Arafat fournit des armes de tous calibres aux Brigades rouges et le magistrat
[Ferdinando Imposimato] y voit également une connexion entre le KGB et les
brigadistes.”
[traduzione] “L’OLP di Yasser
Arafat fornisce armi di tutti i calibri alle Brigate rosse e il magistrato
[Ferdinando Imposimato] vede anche una connessione tra il KGB e i brigatisti.”
[p. 31] “Una fazione dell’Olp
di Yasser Arafat riforniva le Brigate rosse di armi di ogni calibro e il
magistrato [Ferdinando Imposimato] si chiede se attraverso questi rapporti
accertati le Br siano entrate in contatto con i servizi segreti di altri Paesi.”
Subdolo intervento di sublime
maestria. L’Olp di Yasser Arafat, icona della sinistra fin dagli anni Sessanta,
non poteva certo essere citata e messa sul banco degli imputati come
responsabile dei traffici di armi con le Brigate rosse. Quindi era meglio
coinvolgere qualche imprecisata fazione palestinese, magari eretica ma pur
sempre in termini generici, senza calcare la mano su Arafat. Poi, la certezza di
un magistrato [“che vede connessioni”] si trasforma in una semplice domanda [“si
chiede se esistano connessioni”]. Ma il finale indubbiamente ha qualcosa di
straordinario, di funambolico. Il famigerato Kgb, che però dobbiamo ricordare è
stato pur sempre il potente servizio segreto della Grande Madre Sovietica “sol
dell’avvenire”, è eliminato dal testo e soppiantato da più rassicuranti e
imprecisati “servizi di altri Paesi” (quali poi? non è dato saperlo), con la
speranza che nella testa di un lettore qualsiasi possa spuntare anche l’idea
della Cia, perché no. Ora viene da domandarsi se l’autore del libro, Amara, sia
stato consultato e se abbia concordato con Biondo queste manipolazioni che, da
un punto di vista tecnico, alterano in profondità il significato originale.
Biondo nello stesso libro si è adoperato anche in difesa di un’altra “sacra
icona” della sinistra, ovvero il mitico Sessantotto. In questo caso il trapianto
ha comportato anche un leggero spostamento temporale.
Testo originale edizione
francese
Testo manipolato edizione
italiana
[p. 29] “Depuis la fin des
années 60, L’Italie est plongée dans le chaos”.
[traduzione] “Sin dalla fine
degli anni Sessanta, l’Italia è immersa nel caos”.
[p. 50] “Dalla metà degli anni
Settanta l’Italia è piombata nel caos”. Tutto questo non può essere derubricato
come un banale caso di (scorretta o errata) esegesi. È qualcos’altro. Nasconde
dell’altro. Ha altre e più inquietanti implicazioni. Il mettere mano ai testi,
ai documenti, manipolare il contenuto, alterare il loro significato è
un’attività non casuale, non banale, non innocente. È un’attività che ha delle
finalità. Tutto questo nasconde una volontà e un movente. Tutto questo deve
avere un perché. Ciò che stupisce e inquieta è l’assoluta mancanza di rispetto
del dato reale. In Italia, c’è un piccolo esercito di “gendarmi della memoria”
che lavora per imbrogliare, occultare e manipolare i fatti. C’è ancora chi, a
distanza di 22 anni dalla caduta del Muro di Berlino e dal crollo dei regimi
dell’Est, teme la verità come fosse un morbo mortale per la coscienza
collettiva. Per questi signori, cresciuti nelle menzogne della propaganda
ideologica, la verità deve essere funzionale al dato politico. Altrimenti va
estirpata come una pianta malata.
Pillole di saggezza «La
cultura, la lingua, la forma mentis del falsario finiscono sempre per fare
capolino, anche nelle più sagaci fabbricazioni». (Luciano Canfora, “Il viaggio
di Artemidoro”, Rizzoli, Milano 2010, pp. 313). (Dal nostro portale tematico
segretidistato.it)
Stefano Santoro pagina
facebook 27 ottobre 2019 alle ore 15:09. Il movente, solo il movente resta il
mistero sulla morte di Salvatore e Carmine. Di recente ho appreso ,da fonte
autorevole, che in Calabria la stessa notte, in una casermetta di campagna , un
plotone di carabinieri era pronto ad affrontare una incursione di alcuni
terroristi. Non accadde nulla, o meglio, una strage avvenne ad Alcamo Marina, e
quei carabinieri si spostarono ad Alcamo per i rastrellamenti. Rimane il mistero
sulla figura di Giuseppe Vesco, i suoi rapporti con i Nap, le sue lettere
inviate al più grande anarchico italiano, Alfredo Maria Bonanno, che non solo
pubblicò le lettere sulla rivista Anarchismo, ma commentò il "fatto" . Perché
Bonanno le pubblica , e ne trae spunto per esprimere le sue idee , e perché
Vesco fa riferimento a Sansone ,ex brigatista e ai compagni ? Chi conosceva
Vesco, nell'ambiente anarchico? Siamo certi che non aveva una preparazione
letteraria, anarchica ideologica, tale , da non poter scrivere quelle lettere ?
Perché Giuseppe Vesco , tentò di arruolare ad Alcamo, suoi coetanei , proponendo
una lotta di classe (vedi intervista nel dossier Ammazzaru du sbirri) . È chiaro
che i carabinieri non approfondirono all'epoca, la figura di Vesco . Quali
soggetti , quali mandanti, o quali complici Vesco coprì durante le sue
rivelazioni ? Perché i carabinieri si spinsero fino a Cinisi, a casa di Peppino
Impastato , dopo aver perquisito attivisti di sinistra e di destra , nel
territorio tra Alcamo e Castellammare ? Chi aveva l'interesse di "suicidarlo" ?
Esiste ancora oggi qualcuno, che potrebbe dare risposte a queste domande ? Voi
che leggete come al solito rimarrete muti , si dice in gergo alcamese..."mi
fazzu lu me filaru". Siamo un popolo a cui hanno imposto una cultura del
mutismo, dinanzi a certe situazioni. La libertà di ogni uomo, è anche
partecipazione, senza la paura di dover esprimere la propria opinione. Questa
società d'altronde, ci ha lasciato solo la libertà di opinioni, e poco,
pochissimo potere decisionale sulla vita pubblica. Grazie per la lettura.
GLI SCHELETRI DELLA DC.
Quando Moro bocciò i due
ministri del Pci e rifiutò di sostituire Bisaglia e Donat Cattin.
Erano le richieste di
Berlinguer per votare la solidarietà nazionale, ma la Dc rifiutò. Francesco
Damato il 21 Settembre 2019 su Il Dubbio. Nella ricerca ormai ossessiva delle
discendenze o analogie politiche si è cercato di scavare nel passato anche a
proposito della scissione del Pd consumata questa volta da Matteo Renzi, come
due anni e mezzo fa dai suoi nemici ormai per la pelle Pier Luigi Bersani,
Massimo D’Alema e compagni. Che avevano brindato alla sua sconfitta referendaria
sulla riforma costituzionale, dopo averla apertamente osteggiata. Ho sentito da
qualche parte evocare persino il povero Aldo Moro, già scomodato durante la
crisi d’agosto come anticipatore di Giuseppe Conte, per usarne il ricordo
stavolta contro Renzi. Che si sarebbe comportato con la stessa irrazionalità e
assurdità di un Moro che nel 1976, dopo avere spinto la Dc verso l’intesa di
carattere eccezionale col Pci di Enrico Berlinguer, nonostante la
contrapposizione elettorale, se ne fosse andato dal suo partito. Il paragone,
sia pure rovesciato – ripeto- in negativo, fatto per deplorare e non per
giustificare l’iniziativa di Renzi, è di una evidente esagerazione per l’abisso,
più che per la differenza, fra i due personaggi, anche se l’ex segretario del Pd
e fondatore di “Italia Viva” è in qualche modo riconducibile alla storia della
Dc: più a quella però del suo corregionale Amintore Fanfani che a quella di
Moro, l’altro “cavallo di razza” dello scudo crociato. Eppure, scavandoci sotto
o riflettendoci sopra, il riferimento a Moro potrebbe diventare meno stravagante
e assurdo di quanto non abbia pensato chi vi ha fatto ricorso in funzione
antirenziana. E spero che quanto sto per scrivere, ove mai letto
dall’interessato, non lo imbaldanzisca troppo facendolo molto, troppo
paradossalmente sentire un nuovo Moro. Cui Renzi potrebbe paragonarsi davvero se
solo volesse esprimere pubblicamente eventuali riserve sulla natura strutturale,
persino a livello locale, che la dirigenza del Pd vorrebbe dare all’accordo con
i grillini da lui proposto, a sorpresa, in via del tutto eccezionale, e con una
prospettiva non di legislatura. Moro fu certamente l’artefice dell’intesa del
1976 con Berlinguer, al quale però fece ingoiare persino un governo monocolore
democristiano presieduto da Giulio Andreotti: uno degli esponenti della Dc fra i
più lontani, obiettivamente, dal Pci. E che proprio per questo costituiva un
elemento di riequilibrio e di garanzia oltre Tevere e Oceano Atlantico. Il guaio
fu, per l’allora presidente ella Dc, che ad un certo punto la gestione di
quell’intesa da parte di Andreotti a Palazzo Chigi e del suo amico ed estimatore
Benigno Zaccagnini a Piazza del Gesù, come segretario del partito, andò ben
oltre i suoi progetti o intenzioni. Se ne accorse, poveretto, un anno e mezzo
dopo, verso la fine del 1977, quando Berlinguer non ce la fece più a trattenere
i mal di pancia nel Pci e provocò la crisi reclamando un passo avanti sulla
strada di nuovi equilibri politici. Il leader comunista chiese ad Andreotti e a
Zaccagnini per via riservata, ma non tanto da sfuggire alle orecchie e
all’intuito di Moro, di fare entrare nel governo almeno due indipendenti di
sinistra eletti nelle liste del Pci. Quando Moro se ne accorse non si lasciò
certo tentare – figuriamoci, col suo carattere- di minacciare e tanto meno di
preparare e realizzare un’uscita dalla Dc, come ha appena fatto Renzi col Pd.
Egli lavorò con pazienza e ostinazione per impedire che la richiesta di
Berlinguer fosse accettata da Andreotti e da Zaccagnini, che ne erano molto
tentati pur di non chiudere anzitempo la stagione politica della cosiddetta
“solidarietà nazionale” e trattare un nuovo centrosinistra col Psi passato nel
frattempo dalla guida di Francesco De Martino a quella di Bettino Craxi. Che era
disponibile a riprendere la collaborazione con lo scudo crociato, e ricacciare
il Pci all’opposizione, ma non a buon mercato, diciamo così. Moro afferrò nelle
sue mani le trattative, dietro e davanti alle quinte, e convinse Berlinguer
della impraticabilità politica della sua richiesta, sul piano interno per i
rischi di rottura dell’unità democristiana e sul piano internazionale per i
rapporti con gli Stati Uniti. Dove già avevano storto il muso per la mezza
partecipazione del Pci alla maggioranza, astenendosi nelle votazioni di fiducia
al governo Andreotti, e avrebbero storto qualcosa di più e di diverso in caso di
nomina a ministri di eletti nelle liste comuniste. Berlinguer si acquietò
ripiegando su un programma di governo da concordare più dettagliatamente e
incisivamente di quanto non fosse stato fatto nel 1976. E ciò per consentire al
Pci di passare dall’astensione al voto di fiducia vero e proprio, dalla mezza
maggioranza alla maggioranza intera, dall’anticamera alla camera della
spartizione del potere e sottopotere, perché esistevano già allora enti
pubblici, consigli d’amministrazione, cariche di alta burocrazia e quant’altro
da assegnare con criteri politici. A trattativa conclusa, tuttavia, Berlinguer
tentò, con un altro approccio diretto ad Andreotti e a Zaccagnini, di ottenere
qualcosa in più da spendere sul terreno della propaganda: la testa di qualche
ministro uscente. Furono individuate, in particolare, quelle di Antonio Bisaglia
e di Carlo Donat- Cattin, distintisi nella Dc durante la crisi per le resistenze
opposte ad una maggiore apertura al Pci. Ma quando Moro se ne accorse, leggendo
la lista dei ministri portata di sera da Andreotti a un vertice democristiano
alla Camilluccia, prima di salire al Quirinale per sottoporla alla firma del
capo dello Stato, il presidente del partito disse no. E impose la conferma di
entrambi i democristiani dicendo che la Dc sarebbe finita se avesse accettato di
farsi selezionare la classe dirigente dagli altri. Alcune decine di migliaia di
copie del giornale ufficiale del Pci già stampate con la lista dei ministri
promessa a Berlinguer dal presidente del Consiglio furono ritirate dalla
spedizione e macerate. Nei gruppi parlamentari comunisti il malumore crebbe sino
alla minaccia di non votare più la fiducia al governo che stava per presentarsi
alle Camere. Lo stesso Zaccagnini nella Dc voleva dimettersi da segretario.
Tutto rientrò solo perché la mattina del 9 marzo 1978, andando proprio alla
presentazione del governo a Montecitorio, Moro fu sequestrato dai brigatisti
rossi fra il sangue della sua scorta, decimata. Dopo 55 giorni di drammatica
prigionia, e di convulsa gestione governativa e partitica della cosiddetta linea
della fermezza imposta dal Pci ad una Dc a dir poco sconvolta dagli eventi,
sarebbe stato ucciso pure Moro. Meno di un anno dopo sarebbe finita anche la
maggioranza di “solidarietà nazionale”, o di “compromesso storico”, come
preferiscono chiamarla persone di cattiva memoria o storici improvvisati. Il
compromesso storico proposto da Berlinguer era tutt’altra cosa dall’operazione
concepita e gestita da Moro.
·
Aldo Moro e la sua idea di centro.
Il genio politico di Aldo
Moro e la sua idea di centro: la persona perno di un cambiamento reale e
duraturo.
Sergio Carlini il 24 luglio 2019 su Il Dubbio. Un genio politico che, dal
carcere brigatista, profetizza, dopo la sua morte, “un altro ciclo più terribile
e parimenti senza sbocco” per il nostro Paese. Giuseppe Genna ha svolto
sull’ultimo numero de L’Espresso una riflessione mirabile. Tanto che chi volesse
cimentarsi con essa – come in questo momento fa il sottoscritto – corre il serio
rischio di una semplificazione o peggio di una banalizzazione. Credo che la
questione fondamentale posta da Genna sia la seguente: che cosa sostiene
un’azione giusta, soprattutto da parte di un uomo politico? Un uomo politico che
si trova di fronte e alle prese con le forze spurie, primordiali, caotiche e
drammatiche della società e della storia. L’azione giusta è sempre e comunque
giustificata e motivata da principi morali oppure è quella che, guidata
dall’intuito del genio politico e dalla conoscenza del “tempo giusto per ogni
cosa”, conduce a sminare i pericoli e aprire prospettive nuove? Machiavelli ha
risposto una volta per tutte a questa domanda, dimostrando non solo che il fine
giustifica i mezzi, ma che l’azione politica è volta, soprattutto, a ristabilire
le condizioni in cui le leggi morali e la retta coscienza dell’individuo possono
reggere autonomamente una società armonica. Giuseppe Genna conduce questa
riflessione fino alla realtà italiana, individuando giustamente in Aldo Moro
l’artefice di un genio politico capace di “tenere unito il molteplice,
rallentare, accelerare, comporre”. Nel contesto di un Paese, l’Italia,
attraversato da drammatiche tensioni internazionali, segnato da arretratezze
storiche, dilaniato da forze oscure e dalla presenza del più potente partito
comunista dell’Occidente. Un genio politico che, dal carcere brigatista,
profetizza, dopo la sua morte, “un altro ciclo più terribile e parimenti senza
sbocco” per il nostro Paese. La linea di condotta di Aldo Moro, “fare della Dc
una forza di mediazione di tutta la realtà politica e sociale italiana ivi
compresa la sinistra”, è stata per lo più fraintesa, anche dai suoi
interlocutori comunisti più avveduti, i quali si piegarono, anzi imposero
l’infausta linea della fermezza. A questo punto Giuseppe Genna introduce il
concetto di centro, non come punto intermedia di una linea retta, bensì come
centro di un cerchio. Mi ha fatto piacere che Genna abbia citato Gianni Baget
Bozzo, che pochi oggi ricordano come una figura davvero importante del dibattito
religioso, della cultura e della politica in Italia, il quale concepiva il
centro in termini dinamici, come mediazione. Certo, si potrebbe dire che questo
concetto e soprattutto la pratica della mediazione, sottratta dal rigore
intellettuale e morale di Aldo Moro e affidata al doroteismo democristiano, ha
condotto anche alla piega del clientelismo, del consociativismo più deteriore e,
infine, ad accumulare un enorme debito pubblico, che oggi pesa come un macigno
sul nostro futuro. Così come si potrebbe affermare con ragione che questo
concetto di mediazione, di cui peraltro Franco Cassano, nel volume “Il teorema
democristiano”, metteva in luce gli aspetti di autonomia rispetto alla sfera
dell’economia, confligge alla lunga con un’autentica visione liberale dello
Stato, del sistema politico e dell’economia. Ma qui tocchiamo con mano le
caratteristiche dell’Italia del dopo Moro, l’Italia violenta di tangentopoli,
l’Italia volgare del berlusconismo, l’Italia della speranza fulminea
rappresentata da Renzi e, in ultimo, l’Italia del governo più populista e
sovranista d’Europa. Evidentemente se siamo finiti in questa situazione qualcosa
non ha funzionato. Di Aldo Moro rimane, però, come ricorda Genna, l’ispirazione
“di una politica condotta, se non dal centro, in nome del centro stesso. E quel
centro è la persona: il valore dell’inalienabilità della persona da se stessa e
da tutto ciò che il fenomeno umano produce”. La vera rivoluzione per Aldo Moro è
la metanoia, una rivoluzione interiore attraverso cui l’umano si arricchisce e
di trasforma, diventando il perno solido di un cambiamento reale e duraturo. In
fondo, ciò che auspicava anche Machiavelli, anche se quando cadono queste solide
strutture morali diventa imprescindibile farsi guidare dal dovere, di cui ha
parlato Marco Damilano, che consiste in qualcosa di “trascendente che supera
anche le leggi dell’uomo, imparziali o addirittura ingiuste”.
·
Chi amò e chi odiò Aldo Moro.
Vittoria Leone: «Un anonimo
mi scrisse dov’era il covo di Moro, la lettera fu ignorata».
Pubblicato sabato, 05 ottobre 2019 su Corriere.it da Aldo Cazzullo. La moglie
del presidente Leone: «Ogni sforzo di mio marito per liberarlo fu inutile.
Venivo definita l’ambasciatrice della moda italiana, ne ero orgogliosa.
Andreotti? Un ingenuo»
Lei si sente donna Vittoria,
come la chiamavano i giornali, o la signora Leone?
«Per me non ha mai fatto
differenza. La mia vita privata ha sempre coinciso con quella pubblica di mio
marito. Avevo 28 anni quando divenne presidente della Camera, 36 quando fece per
la prima volta il presidente del Consiglio, 44 quando fu eletto capo dello
Stato. Ora non ci sento così bene come prima; e mi piace pensare di essere
chiamata semplicemente Vittoria dalle persone più vicine».
Qual è il suo primo ricordo?
«La mia bicicletta Wolsit di
Legnano. Andavamo a scuola a piedi o in bici, con qualsiasi tempo. Mio padre,
medico, aveva una macchina; ma non veniva messa a disposizione dei bambini.
Allora non si cresceva viziati. Avevo anche un cane. Mi morse, ma non lo dissi:
temevo che lo punissero. Ero sicura di aver preso la rabbia, la notte pregavo di
morire in fretta».
Come finì?
«Feci la cura antirabbica».
La sua famiglia è di origine
inglese?
«Un trisavolo, Andrea Graefer,
architetto botanico, fu chiamato dai Borbone per progettare i giardini inglesi
della reggia, che ancora oggi portano il suo nome. Si innamorò di una casertana.
La mia famiglia viene da lì».
Quando ha visto per la prima
volta l’uomo che sarebbe diventato suo marito?
«Giovanni venne a casa nostra
con mio fratello Luigi. La guerra era appena finita. Era professore
universitario, e tenente colonnello alla procura militare di Napoli: aveva
liberato tutti i prigionieri per sottrarli alla vendetta nazista, poi era
scappato travestito da prete. Mio fratello era tenente. Divennero amici. Così me
lo vidi comparire a casa».
È vero, come ha scritto
Vittorio Gorresio, che si offrì di raccomandarla per l’esame di maturità?
«È vero, e io pensai: ma che
invadenza! Alla fine l’esame non lo diedi. Mi sposai prima, il giorno del mio
diciottesimo compleanno».
Lo sa cosa viene da pensare
nel vedere le vostre fotografie? Lei era bellissima; lui no. E aveva vent’anni
di più. Com’è potuto nascere il vostro amore?
«Me lo sono chiesto anch’io.
Non esistono spiegazioni razionali. Accadde. Certo lui mi aveva affascinato con
fiumi incessanti di parole. Mi aveva stordito con la sua testa».
Cosa l’ha colpita di Giovanni
Leone?
«Un carattere fuori dagli
schemi, un’immensa cultura, una rara capacità di ragionare e convincere. E un
grande senso dell’umorismo. Era molto curioso, di mente aperta, di una
lungimiranza fuori dal comune, di un’umanità straordinaria. Non mi dette il
tempo di capire quello che stava succedendo, ed eravamo già sposati».
Com’era la vita quotidiana al
suo fianco? È vero che lui di notte leggeva, mangiava, accendeva e spegneva la
luce di continuo?
«Giovanni ha sempre sofferto
di insonnia. Libri e discorsi li scriveva di notte. Era il terrore delle
dattilografe che dovevano trascrivere blocchi interi partoriti nottetempo. A un
certo punto abbiamo deciso di dormire in stanze separate, ma comunicanti. Non
era facile reggere i suoi ritmi forsennati. Amava stare in compagnia, spesso mi
trovavo ospiti a casa senza preavviso. Una cosa è certa: con lui non ci si
poteva annoiare».
Leone era presidente del
Consiglio quando incontraste Kennedy. Che impressione le fece?
«Volendomi fare un complimento
galante, mi disse, in inglese: “Ora capisco il successo di suo marito”. Risposi
che all’evidenza gli sfuggivano le doti di Giovanni».
In sostanza, ci provò...
«Ma no, voleva essere
simpatico. Era una persona affascinante, nello stesso tempo educata e concreta.
Adorava Napoli, dove fu accolto da due milioni di persone. Ho ancora la lettera
che scrisse a Giovanni. Vuole vederla? Guardi qui in fondo. Kennedy scrisse
“Viva Napoli” di suo pugno. È datata luglio 1963. Gli restavano quattro mesi».
E Jackie?
«Bella. Elegante. Altera».
Fanfani e Moro: i cavalli di
razza democristiani. Chi erano veramente?
«Moro era molto legato a mio
marito, era stato suo assistente di diritto penale all’università di Bari. Il
destino li volle entrambi candidati della Dc al Quirinale: votarono i gruppi
parlamentari; Giovanni vinse per otto voti, e Aldo fu leale, non armò i soliti
franchi tiratori».
Com’era Moro?
«Un uomo triste. Veniva a
trovarci nella nostra casa di Roccaraso, si sedeva, e stava zitto. Non parlava
quasi mai, ma quando parlava non smetteva più; e non si capiva niente. Avevamo
un barboncino nero e l’avevamo chiamato Moro. Suonarono alla porta e lui si
agitò, io lo rimproverai: “Moro piantala, Moro stai buono!”. Poi andai ad
aprire: era Moro, quello vero. Ci era rimasto malissimo».
Come ricorda i giorni del suo
rapimento?
«Mio marito è l’unico
democristiano che Moro non abbia maledetto nelle sue lettere. Fece
disperatamente e inutilmente di tutto per farlo liberare. Ma avemmo la
sensazione che fosse un destino segnato».
Perché dice così?
«Arrivò una lettera anonima,
indirizzata a me, che segnalava il covo brigatista. La portai al ministero
dell’Interno. La ignorarono. Quando la chiesi indietro, mi dissero che era
sparita. E le Br lo uccisero poche ore prima che Giovanni firmasse la grazia per
una terrorista malata che non aveva sparso sangue, Paola Besuschio».
Anche Fanfani era per la
trattativa.
«Fanfani era uomo di partito,
oltre che delle istituzioni, mentre mio marito incarichi di partito non ne volle
mai, per non trovarsi a gestire troppi compromessi e giochi di potere. Questo
talvolta li allontanava, nonostante avessero un ottimo rapporto personale. Io
ero molto amica di sua moglie Biancarosa, che scomparve prematuramente. Poi lo
sono stata di Mariapia».
Su cosa Leone e Fanfani si
trovarono lontani?
«Il referendum sul divorzio.
Lo scontro fu duro e lungo. Fanfani lo volle a tutti i costi. Giovanni era
contrario: “Servirà solo a sancire che siamo minoranza” diceva. E questo non lo
fece amare da Papa Montini».
Che opinione si è fatta di
Andreotti?
«L’ho sempre considerato un
amico di famiglia. Adorava giocare a carte con me e alcuni amici comuni.
Giovanni condivideva la sua apertura a Mosca e al Medio Oriente. Lo considerava
un grande politico che, a dispetto di quel che si crede, alternava all’astuzia
anche momenti di ingenuità».
Ingenuo, Andreotti?
«A volte si fidava troppo
degli altri».
Come ricorda i leader che
incontrò? Ford, lo Scià, Pompidou...
«Pompidou e la moglie erano
due persone straordinarie: lei simpatica e cordiale, lui statista con una
visione. Ford era una persona schiva e sincera, però la sensazione era che
comandasse Kissinger: uomo brillante, di apparente bonomia, ma dagli occhi
cattivi. Anche al Cremlino si faceva notare di più Gromyko, che parlava un
ottimo inglese, che non Breznev, uomo timido, introverso. Lo Scià era un leader
illuminato ma taciturno: sapeva molte lingue e non ne parlava nessuna».
Franco lo incontrò mai? E
Peron?
«Franco mai. Ho un bel ricordo
di Juan Carlos, che conversava amabilmente in un ottimo italiano. Peron venne
con Isabelita e propose che il nostro governo comprasse un pezzo di Argentina,
per risanare il loro debito pubblico. Mio marito e io ci guardammo imbarazzati;
poi lui con le sue doti diplomatiche sbrogliò la situazione».
E tra le mogli chi la colpì di
più? Farah Diba?
«Una donna dolcissima e
intelligente. A Teheran parlammo in inglese a lungo e ci trovammo d’accordo su
molte cose, dall’educazione dei figli alla moda. Volle sapere chi era il mio
stilista. Quando le dissi Valentino, non si stupì: sapeva riconoscere
l’eleganza. Erano gli anni in cui mi definivano l’ambasciatrice della moda
italiana nel mondo, ne ero così orgogliosa... Mi colpì molto anche la regina
Fabiola. Lei e Baldovino erano visceralmente legati al loro popolo».
La regina Elisabetta era
ancora giovane.
«La prima volta che la
incontrai aveva 35 anni, mio marito era presidente della Camera. I nostri figli
avevano una governante inglese, miss Bertha. Elisabetta la volle conoscere. Miss
Bertha svenne in avanti per l’emozione. Ci spaventammo».
E la regina?
«Imperturbabile».
Con suo marito andaste da
padre Pio.
«Non amava i politici e ci
trattò con durezza. Però mi diede tre rosari: “Per i suoi figli”. “Ma io ne ho
solo due, Mauro e Paolo”. “Ne prenda tre” disse. L’anno dopo nacque Giancarlo».
Lei è considerata la prima e
ultima first-lady italiana. Perché siamo allergici a questo ruolo?
«La prima fu Ida Einaudi. Si
affezionò molto a me. Anche troppo, voleva sempre che la accompagnassi...
Saragat, presidente prima di Giovanni, era vedovo. Gli altri predecessori erano
molto più anziani. Il Paese non era abituato a vedere al Quirinale una famiglia
al completo, con moglie giovane e figli piccoli. Del resto, né Mussolini né i
Savoia hanno evidenziato figure femminili accanto a loro, per scelta. Veniamo da
un passato maschilista. E restiamo il Paese dove la maldicenza primeggia e il
rispetto delle istituzioni è dote rara».
Da sinistra foste accusati di
aver trasformato il Quirinale in una reggia. Poi venne il libro della Cederna.
Cosa provò nel leggerlo?
«Ero troppo impegnata a
sostenere mio marito per avere il tempo di metabolizzare quelle ingiurie.
Eravamo una famiglia normale, che conduceva una vita normale in un contesto
eccezionale. La campagna denigratoria del gruppo Espresso e il libro della
Cederna furono palesemente un’orchestrazione per colpire il cuore dello Stato,
il cui presidente veniva dalla Democrazia cristiana, e un’ambigua operazione
anche commerciale, per accreditarsi come la vera controinformazione. La fonte
principale della Cederna era OP di Mino Pecorelli, agenzia ricattatoria e legata
ai servizi segreti deviati e ai poteri occulti dell’epoca. La maldicenza trovò
terreno fertile anche nel Pci e nei radicali».
Un capitolo era intitolato «I
tre monelli»: i suoi figli. Come reagì?
«I tre monelli era il nome
della nostra casa di Roccaraso. Neanche i ragazzi, nonostante fossero
giovanissimi, furono risparmiati dalle diffamazioni della Cederna: talmente
ridicole da non poter essere prese sul serio. E così fu. Io però capii che si
stava aprendo una voragine nel nostro Paese: in nome della faziosità e di
interessi di varia natura, nessuno sarebbe stato più risparmiato».
Chi costrinse suo marito a
lasciare, i democristiani o i comunisti? Leone era un intralcio sulla via del
compromesso storico?
«Lo scopo era favorire un
cambio nella gestione del Paese a favore della sinistra, spostando il baricentro
democristiano. Alla campagna si unirono altri soggetti interessati: la P2, già
in azione ma ancora ignota ai più; politici e ministri Dc in odore di
corruzione; membri del governo contrari all’apertura di mio marito per salvare
Moro. Quell’immenso polverone riuscì per un po’ a distrarre l’opinione pubblica
dai veri scandali, destinati comunque a esplodere. Leone si dimise perché la Dc
non lo difendeva dagli attacchi interessati del Pci. Proprio quella Dc che
qualche mese prima lo aveva implorato di non dimettersi come lui avrebbe voluto,
per potersi difendere meglio. Tutto cambiò con la terribile morte di Moro».
Perché?
«Quella tragedia, che si
poteva evitare se gli avessero lasciato firmare la grazia, spinse Dc e Pci a
forzare un ricambio, una ripartenza scioccante, fornendo al Paese un capro
espiatorio. Così uccisero anche Giovanni Leone, psicologicamente e umanamente».
Lei provò a convincerlo a non
dimettersi?
«Non dovevo, perché lui era
determinato da tempo a lasciare. Voleva farlo già nel 1975, quando il suo
messaggio alle Camere rimase ignorato. La politica gli chiese di restare e lui,
galantuomo fino in fondo, aderì fino a quando la politica gli chiese il passo
indietro. In questo dimostrò di essere molto diverso dal suo partito, per
correttezza e onestà. Come quando disse no a Togliatti...».
Togliatti?
«Quando Giovanni era
presidente della Camera, il leader comunista gli disse riservatamente che
avrebbe fatto convergere voti del Pci su di lui per il Quirinale, se avesse
preso tempo prima di indire una nuova votazione. Lui declinò l’offerta, e
convocò subito la votazione che elesse Segni. Quanti altri politici si sarebbero
comportati così?».
È vero che cadde in
depressione?
«Era amato e popolare; una
campagna infondata lo precipitò nel mondo che aveva sempre combattuto, quello
dell’illegalità e del sospetto. Fu come essere colpito da un fulmine. Non era
preparato, non poteva esserlo. Non aveva gli strumenti di difesa tipici dei
corrotti, che sono sempre pronti a tutto. Lui era del tutto indifeso. Sì, cadde
in una depressione da cui non si riprese più. Gli sono stata accanto per altri
23 anni, e con me i figli. Ma non era più lui. Era la testimonianza vivente e
dolente del sacrificio di una persona troppo perbene».
Però lei conosceva il dolore.
Aveva perso un figlio, Giulio, a 5 anni, per la difterite.
«Dopo aver visto la guerra, la
morte di Giulio, la malattia di Mauro, che da piccolo fu colpito dalla
poliomelite, non potevo impressionarmi di fronte alla meschinità e alla falsità.
Per il nostro bambino, Giovanni scrisse allora un libro per pochi, Dialoghi con
Giulio. Non riesco a rileggerlo perché ancora oggi mi commuove. Penso a lui
sempre. Era di una dolcezza senza confini».
Come si comportò con voi il
successore, Pertini?
«Rapporti formali. Giovanni
non se ne meravigliò. Lo conosceva troppo bene».
Molti anni dopo i radicali
chiesero scusa.
«Ne fui sorpresa. Mi ero fatta
un’idea molto diversa di Pannella. Con la Bonino fece un atto di onestà
intellettuale, scusandosi per le accuse ingiuste di anni prima. Mi commossi:
Giovanni lo meritava. Il Pci invece non si è mai scusato. Anche se Napolitano da
presidente ebbe parole durissime contro quella campagna».
Suo marito però fu al centro
di altre polemiche: dalla difesa della Sade nel processo sul Vajont, alla famosa
foto delle corna agli studenti di Pisa. «Da avvocato ha sempre sostenuto le
cause giuste. La difesa della Sade non andava contro le vittime; serviva per
stabilire la verità dei fatti. Lasciò presto l’incarico per impegni
istituzionali. Da penalista amava difendere i più deboli, gratis. Quel gesto
delle corna fu istintivo: era il suo modo di rispondere ai contestatori violenti
che gli urlavano “a morte Leone!”. Apparteneva al suo spirito napoletano. Anche
in questo non era un politico di professione; era un grande giurista prestato
alla politica».
Lei come immagina l’aldilà?
«Sono credente, ma proprio per
questo vivo incertezze che tengo per me. Nella nostra cappella di famiglia a
Napoli è scolpita una frase di san Paolo: Vita mutatur, non tollitur».
Virginio Rognoni, quando
Andreotti lesse (o rilesse?) il Memoriale di Aldo Moro.
Pubblicato giovedì, 11 luglio 2019 da Walter Veltroni su Corriere.it.
Virginio Rognoni, tu sei stato
uno dei massimi dirigenti della Dc e il ministro dell’Interno succeduto a
Francesco Cossiga dopo la morte di Moro. Che cosa era la Democrazia Cristiana?
Che cosa è stata nella storia italiana?
«Non si capisce la Democrazia
Cristiana se non con riferimento alla storia politica e civile del Paese. Non è
un partito che nasce dal nulla. Durante il fascismo i cattolici antifascisti,
per tradizione familiare e radicata convinzione, erano assoluta minoranza; la
gran parte del mondo cattolico faceva massa intorno a Mussolini; erano gli anni
Trenta; giusto gli anni del grande consenso; un patrimonio ingannevole che porta
Mussolini definitivamente nelle braccia di Hitler. Finita la guerra, ma già
prima, a ridosso del 25 luglio, c’è l’incontro dei vecchi “popolari” del partito
di Sturzo, con De Gasperi in testa, e i giovani professori che venivano dalla
Fuci e dai Laureati cattolici; queste due realtà si incontrano, vi confluiscono
altri gruppi già clandestini, come i neoguelfi di Milano, e nasce il partito.
Oggi si racconta che quella politica era in mano a vecchi, ma perché non
ricordare che Aldo Moro arriva alla Costituente a 29 anni e Dossetti a 33, e che
entrambi sono stati tra i costituenti più ascoltati e apprezzati?».
La Dc era un arcobaleno che
copriva posizioni reazionarie e il loro contrario. Nella Dc poterono convivere
Lima e Tina Anselmi, Sbardella e persone come te o Zaccagnini. Esclusivo
prodotto della Guerra fredda?
«L’unità politica dei
cattolici non era certamente un dogma e neppure una sorta di obbligazione
morale; era semplicemente un fatto politico inevitabile in quel determinato
momento. L’Italia è stata subito segnata da due grandi questioni, la questione
cattolica e quella comunista; due realtà che contrapponendosi radicalmente hanno
irrigidito il sistema, quasi bloccato. La questione comunista, con il richiamo
allora fortissimo all’Unione Sovietica, al mito della Rivoluzione ha finito per
arroccare la Dc ben oltre la sua cultura di partito. La Dc era diventata argine,
diga contro il comunismo: un problema. Il contrasto tra De Gasperi e Dossetti
circa il modo di interpretare la grande vittoria del 18 aprile mi è sempre parso
come la denuncia di questo problema e giusta mi è sempre parsa la soluzione
presa da De Gasperi. D’altro canto, il Pci non era semplicemente l’emanazione
dell’Urss; non era il Partito comunista tedesco (tra l’altro messo fuori legge)
e neppure quello francese o spagnolo; aveva alle spalle diverse culture e
soprattutto era il partito che aveva contribuito alla rinascita della democrazia
con un ruolo rilevantissimo nella Resistenza. Ma eravamo in quegli anni. E il
mondo era separato in blocchi e aree di influenza. C’erano vincoli
internazionali, appartenenze, alleanze militari, insomma la “Guerra fredda”. Per
la Democrazia cristiana, il Pci doveva essere combattuto e allo stesso tempo
cooptato nel gioco democratico: da qui il riconoscimento di un’area, il
cosiddetto “arco costituzionale”, dove palese fosse la continuità di un legame
tra tutti i partiti che avevano scritto la Costituzione. Un equilibrio non
semplice, ma necessario, in un Paese di frontiera come l’Italia».
La Dc muore con la morte di
Moro?
«Con Moro finisce la prima
Repubblica. Ferma la pregiudiziale antifascista, Moro, con un’azione di
carattere quasi pedagogico, era diventato protagonista del progressivo
allargamento della base democratica del Paese. Esaurita la formula centrista,
ecco i socialisti al governo, poi la solidarietà nazionale con i comunisti nella
maggioranza parlamentare; a quel tempo, una vera e propria sfida alla stessa Dc
e in campo internazionale. Moro non è mai stato vicino al compromesso storico di
Berlinguer, una strategia che prevedeva l’unità al governo dei partiti popolari,
quasi un ritorno all’alleanza dell’immediato dopoguerra prolungata nel tempo.
Moro invece riteneva che per il Pci stare fuori dal governo, ma dentro la
maggioranza, fosse un passaggio necessario di legittimazione democratica così da
arrivare, senza strappi, all’alternanza. Un percorso confermato nell’intervista
postuma a Scalfari. Moro sarebbe diventato presidente della Repubblica e avrebbe
accompagnato questa transizione per uno o due anni. Alle elezioni successive i
due partiti si sarebbero presentati in conflitto. Una sorta di 18 aprile purgato
di tutte le scorie, le durezze e le anomalie, nazionali e internazionali, del
’48. Ma il Pci sarebbe stato così legittimato a governare, se avesse avuto i
voti. Era un grande progetto, che avrebbe completato il disegno costituzionale.
La morte di Moro ha impedito che si realizzasse».
Conosco la tua tesi e la
condivido: il rapimento di Moro e il suo assassinio sono stati compiuti dalle
Brigate rosse. Però Moro viene ucciso per far saltare il suo disegno. Quindi uno
di quegli omicidi politici che cambiano il destino di un Paese...
«Ero convinto e lo sono ancora
che il terrorismo delle Brigate rosse fosse nazionale, italiano, non
eterocomandato da un “grande vecchio”. Ho spesso discusso con Pertini; il
Presidente riteneva che ci fosse una centrale straniera in ragione della
posizione geopolitica italiana, al confine tra patto di Varsavia e Nato. Tanto è
vero che quando fu sequestrato il generale Dozier mi telefonò preoccupatissimo:
“Hai visto? Hai visto? Un generale americano”. Come ministro dell’Interno io
avvertivo l’assoluta necessità di seguire ogni congettura, nessuna esclusa; il
mio compito, dopo via Fani e la tragedia di Moro, era che il Paese rimontasse la
china, sconfiggesse il terrorismo senza uscire dalla democrazia e senza
imbarbarire lo Stato. Il clima era pesantissimo, avevamo avuto un ’68 diverso
dagli altri Paesi. Il ’68 italiano è stato una cosa eccezionale. Sia chiaro: il
’68 esprimeva un bisogno di modernità, postulava uno sbocco politico che però
non c’è stato. Il ’77, con tutte le sue violenze, in fondo è la manifestazione
drammatica di quella delusione. Dico questo anche perché quando sono arrivato al
Viminale sentivo dentro di me quel grido, nato giusto in ambienti
“sessantottini”, “né con le Brigate rosse, né con lo Stato”. Era un grido
spaventoso, che poneva sullo stesso piano negativo le Br e lo Stato, uno Stato
vissuto come lontano, sempre uguale, torbido».
Durante la Guerra fredda
quelli che erano considerati nemici in un fronte non dovevano partecipare al
governo dell’altro. Credo che questo abbia detto con rudezza Kissinger a Moro e
anche Berlinguer viene messo nel mirino dai sovietici, fino all’attentato in
Bulgaria. Moro e Berlinguer, ciascuno nei due campi, erano un’anomalia
pericolosa. Ribadito che il rapimento Moro lo hanno fatto le Br tu non pensi che
nei cinquantacinque giorni ci sia stato l’intervento di questi soggetti per
evitare che Moro fosse liberato?
«Cominciamo col dire che nei
cinquantacinque giorni probabilmente la linea della fermezza è stata
inevitabile. Se fosse avvenuto il contrario le istituzioni non avrebbero retto.
Ma la cosa grave non è stata la scelta della “fermezza”. Lo scandalo — come
qualcuno lo ha chiamato — è stato che per cinquantacinque giorni non si sia
riusciti a trovare la prigione di Moro. Il Presidente non era prigioniero, che
so io, in Alaska, era a Roma, nella capitale, e dalla prigione mandava continui
messaggi, accorati e struggenti. Che poi questa incapacità sia stata in qualche
modo “aiutata” da chi era contro la politica di Moro e il suo ruolo nel concerto
internazionale non è affatto da escludere; troppo fitto era il bosco di
personaggi inquietanti e pericolosi che giravano intorno all’intera vicenda».
Tu vieni nominato ministro
dopo questo inaccettabile fallimento.
«La proposta è venuta da
Zaccagnini e gli altri leader della maggioranza l’hanno condivisa. Al Viminale
non volevo e non potevo fare “rivoluzioni”. Tuttavia ero fermamente convinto che
fosse necessario introdurre elementi di netta discontinuità rispetto alla
passata gestione. Perché — mi domandavo — Cossiga aveva chiamato esperti
stranieri sul terrorismo internazionale, americani o di altro Paese che fossero?
Molto meglio, innanzitutto, rifarsi alla memoria di Polizia e Carabinieri. Di
qui la scelta del generale dalla Chiesa, che bene già aveva conosciuto le prime
Br di Curcio e Franceschini. Non bisognava perdere tempo. C’erano anche da
governare l’ansia, le aspettative, la paura, la rabbia, la speranza della gente.
Era impresa difficile; mai come in quel momento mi sono sentito ministro della
convivenza civile: ministro “terzo” rispetto alle fortune e alle sfortune del
proprio partito».
Tu mettesti alla porta Ledeen
e Pieczenik. Perché erano stati chiamati?
«Veramente non è così; al
Viminale da pochissimi giorni, sento trillare il telefono, d’istinto prendo la
chiamata; chi era? Ledeen; mi diceva che vi erano ancora parcelle insolute per
sue consulenze; per tutta risposta l’ho mandato a quel paese. Pieczenik non l’ho
mai visto e conosciuto. Entrambi erano stati chiamati da Cossiga; purtroppo
scelte sbagliate, prima ancora che inconcludenti».
Pieczenik ha detto
testualmente: «Mi aspettavo che le Br si rendessero conto dell’errore che
stavano commettendo — con il rapimento — e che liberassero Moro, mossa che
avrebbe fatto fallire il mio piano. Fino alla fine ho avuto paura che
liberassero Moro».
«Liberato dalle Br, dalla
prigione dove era detenuto, Moro, libero, fa paura. È la sua parola che fa
paura; la paura — l’immagine me la concedo — dei mercanti di essere cacciati dal
tempio».
Nel comitato che ai tempi di
Cossiga seguiva le indagini, erano quasi tutti iscritti alla P2. Undici su
dodici.
«Pensare che intorno a
Cossiga, nel comitato dei cinquantacinque giorni, ci fosse questa gente, forse
la peggiore, è veramente doloroso, ma soprattutto inquietante».
Di Gladio tu sapevi?
«No; non ne sapevo nulla; l’ho
saputo quando, verso la fine di luglio del ’91, Andreotti andò in Parlamento a
parlarne; a parlarne e a dichiararne senza mezzi termini lo scioglimento. Gladio
era l’espressione italiana di una segretissima organizzazione denominata Stay
behind che, in piena Guerra fredda, i Paesi della Nato avevano creato
nell’ipotesi che l’Europa potesse essere invasa dalle truppe sovietiche: un
primo punto di resistenza contro l’invasore. Cessata la Guerra fredda, con il
superamento definitivo dei blocchi, simile organizzazione non aveva alcuna
ragione per sopravvivere: così Andreotti. Subito scoppia il finimondo, l’ira di
Cossiga è incontenibile, tutta la segretezza di Gladio è in frantumi, le
polemiche non cessano. La mattina precedente il 4 novembre — da pochi giorni ero
ministro della Difesa — mi telefona Cossiga: “Domani a Redipuglia devi difendere
Gladio”. Gli rispondo: “Francesco, a Redipuglia di Gladio non voglio parlare”.
Per me era inaccettabile che Gladio fosse stata tenuta nascosta a uomini di
governo che avevano il diritto di conoscerne l’esistenza. Mi risulta che anche
Fanfani non ne sapesse niente».
Ricordi l’attentato del ‘73
alla questura di Milano? A tirare la bomba fu quell’anarchico, che invece era
stato in Gladio.
«Sì: anarchico e gladiatore e,
se ben ricordo, informatore del Sismi».
Gladio è stata usata per
condizionare la vita italiana?
«Escludo un impiego del
genere. Il vero condizionamento è stato lo stragismo di destra: colpire nel
mucchio per provocare una reazione autoritaria dello Stato». Quindi non ritieni
credibile che Gladio sia dietro e dentro alcune delle pagine di sangue di quegli
anni?
«A parte il caso di Bertoli,
con la bomba alla questura di Milano, non mi risulta la compromissione di altri
esponenti di Gladio».
Il vero colpo di Stato in
Italia fu l’assassinio di Moro?
«Le Br pensavano che il
rapimento di Moro, il cosiddetto processo che ne è seguito e la sua uccisione
avrebbero portato alla “rivoluzione”, ritenuta ormai imminente, dietro l’angolo;
i brigatisti erano rivoluzionari senza rivoluzione. Tuttavia un colpo di Stato
c’è stato, perché con l’uccisione di Moro si ferma e si ribalta l’intera vicenda
politica del Paese».
Descrivimi due personaggi che
per me sono shakespeariani: Cossiga e Andreotti.
«Cossiga era un uomo politico
di elevata e vasta cultura, una personalità singolare dalle analisi acute come
certamente lo era, nel suo complesso, il messaggio inviato alle Camere
immediatamente dopo la caduta del Muro di Berlino. Un messaggio che avrebbe
dovuto essere preso in seria considerazione. Gli è nuociuto l’insieme delle sue
debolezze e stravaganze che, ripetute, diventavano manie e ossessioni
insopportabili. Mi ha sempre colpito e addolorato la sua solitudine». E
Andreotti?
«Andreotti non lo so
descrivere, e questa credo sia la risposta più onesta. Come ministro di alcuni
dei suoi tanti governi devo dire che ha sempre rispettato le proposte che gli
venivo facendo: così la nomina del generale dalla Chiesa; non ha opposto alcuna
riserva, pur sapendo io dei rapporti tutt’altro che buoni che egli aveva con il
generale. Non una piega, ancora, quando, dovendo cambiare il capo della Polizia,
scelsi un prefetto diverso da quello che mi aveva suggerito, e scelsi bene
perché il candidato che mi proponeva è poi risultato appartenere alla P2. Era un
uomo algido, di una freddezza impressionante. Quando gli portai le carte che gli
uomini del generale dalla Chiesa avevano trovato il 1° settembre del 1978 in via
Montenevoso, carte contenenti giudizi severissimi su di lui, egli le lesse
imperturbabile; una lettura tranquilla, una trentina di minuti. Una volta
finito, ha alzato gli occhi e ha detto solamente: “Eleonora era una Fucina come
noi, una donna di straordinario valore”. Nessun altro commento. Sembrava quasi
che quelle pagine le avesse già lette: se fosse così sarebbe stato un vero e
proprio uomo di teatro con il copione pronto per il caso che gli stava
davanti...».C’è qualcuno che ti manca, tra le persone che hai incrociato nella
tua vita pubblica?
«Sì, Pietro Scoppola e
Leopoldo Elia, cattolici democratici di straordinario spessore. Sono stati dalla
parte giusta ma hanno sempre lavorato perché i democratici, dopo l’ottantanove,
si ritrovassero insieme. E per liberare la democrazia dalle serrature, politiche
e istituzionali, della Guerra fredda. Mi mancano, ma soprattutto mancano a
questo Paese che pare si accontenti di uomini casuali».
Vittorio Feltri: "Vi dico
chi era davvero Berlinguer". Il bluff della sinistra: così smonta il mito
comunista.
Libero Quotidiano l'11 Luglio 2019. Walter Veltroni è diventato un editorialista
del Corriere della Sera. Normale che scriva articoli sul Pci facendolo passare
per un partito morbido e tollerante quanto la Dc. Egli infatti disse di essere
più kennediano che comunista, pur rimanendo fedelmente inchiodato a Botteghe
Oscure. Le contraddizioni in politica sono all' ordine del giorno. Ma rileggere
le vicende dei marxisti italiani è un esercizio stupefacente che insegna molte
cose. E Veltroni è capace di presentare Enrico Berlinguer sul quotidiano di via
Solferino come un super democratico. La mia opinione è diversa. Penso che il
famoso segretario rosso non fosse affatto rosso. Neppure lui sapeva di quale
colore fosse, forse era bianco, cioè innamorato della Dc a capo della quale
avrebbe voluto ergersi. Egli era un tipo tranquillizzante, come Rumor e come
Piccoli, uomini miti e furbi, praticamente volpi in grado di muoversi con
disinvoltura nel ginepraio capitolino. È un fatto che Berlinguer, pur
dichiarandosi bolscevico, tale non era per mancanza di fede e di adesione alla
folle ideologia sovietica. Tanto è vero che a un certo punto, egli si inventò il
compromesso storico, ossia una possibile alleanza tra Pci e Democrazia cristiana
ovvero un matrimonio spurio, non compatibile, tra pauperisti di centro e di
sinistra, allo scopo di spartirsi il potere. Il nobile Enrico si illuse di
realizzare simile progetto non calcolando che la Dc era un partito-mamma,
strutturalmente identico al fascismo nel senso che inglobava chiunque, purché
non rompesse i coglioni. Il cosiddetto compromesso storico rimase una sterile
teoria, suggestiva e tuttavia irrealizzabile. Cosicché il politico sardo, di
fronte alle difficoltà tecniche di realizzare il proprio piano, ripiegò su un'
altra formula altrettanto astrusa: l' eurocomunismo che nessuno capì mai in che
cosa consistesse. L' unico Paese in Europa che avesse una parentela stretta con
Mosca e dintorni era l' Italia che non aveva certo la forza di persuadere il
continente a sposare i sogni berlingueriani. Ogniqualvolta un giornalista, per
esempio Scalfari, chiedeva al segretario come intendesse l' eurocomunismo e con
quali tecniche trasformarlo in realtà, non riceveva che risposte fumose, prive
di connotati credibili. Enrico era un sognatore bravo nel marketing ma fuori dal
mondo. Probabilmente neppure lui sapeva che desiderare per la falce e martello.
Gli piaceva comandare e arringare le folle ciononostante ignorava dove portarle.
Se aggiungiamo che il nostro a un dato momento tirò fuori dal cilindro la
questione morale, il quadro confuso si completò. In effetti tutte le formazioni
della prima Repubblica rubavano a mani basse, incluso il Pci, attraverso il
sistema degli illeciti finanziamenti, eppure Enrico accusò chiunque tranne se
stesso e il suo gruppo. Semplicemente ridicolo. Costui in sostanza, pur in buona
fede, fu un grande bluff e proprio per questo è ricordato quasi fosse un
fenomeno di onestà. Mentre all' epoca sua, Botteghe Oscure riceveva montagne di
rubli dall' Urss per stare a galla. Ora che Veltroni lo santifichi non ci
stupisce, la nostalgia fa brutti scherzi, però il comunismo rimane una porcheria
che Walter dovrebbe risparmiarsi di santificare. Vittorio Feltri
Rino Formica e il caso
Moro: «La prigione delle Br? Lo Stato non ha voluto trovarla».
Pubblicato domenica, 07 luglio 2019 da Walter Veltroni su Corriere.it. Rino
Formica, cominciamo con te, autorevole dirigente socialista, una serie di
incontri per ricostruire la fine della prima Repubblica, assai più certa della
nascita della seconda. Cos’ era la prima Repubblica? «L’Italia è stato un Paese
di frontiera, ma di più frontiere. Frontiera Est-Ovest e poi Nord-Sud. È stato
luogo di scambio tra due imperi, quello sovietico e quello americano. E aveva
una frontiera in più, quella dello Stato del Vaticano. Infine vi era una
frontiera tutta interna del sistema politico: quella tra forze politiche che
dovevano stare insieme necessariamente per ragioni costituzionali, ma erano
divise per appartenenza a due campi ideologici diversi. Come hanno risolto i
problemi della frontiera le classi dirigenti della prima Repubblica? Con un
miracolo di equilibrismo in tutti i campi. Sulla frontiera Est-Ovest sono stati
un Paese fedele all’alleanza, ma contemporaneamente coltivavano aperture al
dialogo con il campo dell’Est. Poi c’erano ragioni commerciali. Insomma era un
miracolo di equilibrio: un po’ di Helsinki, un po’ di Tangeri».
E sul fronte interno?
«La frontiera interna era tra
i partiti del campo occidentale ed il Partito Comunista, che aveva un legame
ideologico con l’Est. Lo regolava con il patto costituzionale e con la grande
intuizione del partito di massa del Partito Comunista, un partito che si doveva
non isolare come partito minoritario di avanguardia, ma doveva entrare
all’interno della società nelle aree più ramificabili dall’influenza politica.
Si saldava così un legame costituzionale. Il legame del compromesso patriottico.
Nessuna forza politica del campo occidentale avrebbe messo fuori legge il
Partito Comunista e il Partito Comunista non sarebbe mai stato un partito
falange armata in caso di attacco all’Italia dei Paesi dell’Est».
Quel patto muore con la morte
di Moro e tutto il sistema comincia uno squilibrio che esploderà con la caduta
del muro? Che idea ti sei fatto di quel grumo di anni che c’è tra il golpe in
Cile, il rapimento Moro volto a far saltare il compromesso storico, l’assassinio
di Falcone?
«Tra il 1948 e il 1989,
quaranta anni, in un Paese di frontiera come l’Italia, si è combattuta una
guerra fredda. I due campi ideologici non erano in condizione di poter dialogare
senza misurarsi costantemente sul piano della forza. Ma non più la forza
militare. Ogni volta che si stava per arrivare al punto dello scontro, del
passaggio dalla guerra fredda alla guerra calda, i due imperi frenavano. Questa
guerra di aggiustamento delle condizioni di squilibrio che si andavano a creare
nelle due aree non poteva non avvenire che con mezzi occulti, coperti, non
visibili. Ho letto un tuo articolo sulla strage di Brescia. Ti sembra possibile
che in un Paese di frontiera non si sappia cosa c’era nell’uso del terrorismo di
destra e di sinistra? Noi pensiamo: il terrorismo di sinistra ha una base
ideologica. E quindi ha un retroterra anche idealistico, pazzoide, quello che
vuoi, ma c’era idealismo, sporco di sangue. Il terrorismo di destra non aveva
nulla di ideologico, è stato strumentalizzato ed utilizzato a fini di
manovalanza. Non esisteva una centrale del fascismo che utilizzava il terrorismo
di destra per ragioni ideologiche, c’era una centrale di farabutti che dovevano
dare una veste ideologica allo stragismo. Il terrorismo di destra è assimilabile
alle bande criminali della mafiosità. Perché è roba da criminali, da mafiosi».
Cos’era Gladio? Tu sapevi che
esisteva?
«Gladio, nella sua
manifestazione plateale, appare nel ‘90-91 con le dichiarazioni di Andreotti.
Delle organizzazioni parallele fuori dell’ordinamento costituzionale, parla lo
stesso Andreotti in un articolo sul Sifar pubblicato sul giornale Concretezza
nel febbraio del ’68. “Ma di che cosa si sta parlando qui? Qui è tutto noto,
tutti sanno. I rapporti, anche le forme clandestine”. Fa accenno esplicito ad
organizzazioni, all’interno del nostro sistema di sicurezza e del nostro sistema
di alleanze, non costituzionalmente rispettabili, o compatibili
costituzionalmente. Andreotti era uno che non si faceva coinvolgere nei
problemi, ma era informato. Lui non si immischiava. Sapeva e tesaurizzava.
Quando, nell’84, feci l’intervista sulla questione dell’attentato al treno...»
La strage del rapido 904,
diciassette morti all’antivigilia di Natale.
«Sì. Dissi: “Ci hanno mandato
un avvertimento”. Dissi che c’erano forze che volevano ledere la nostra
sovranità. Spadolini fece un casino. C’era il governo Craxi, voleva fare una
crisi per la mia intervista. Craxi mi telefonò: “Vieni ad una riunione a Palazzo
Chigi”. Vado, ci sono Craxi, Forlani, Andreotti ministro degli Esteri, Spadolini
ministro della Difesa e Amato che stava lì come sottosegretario ai Servizi.
Spadolini fa uno sproloquio: “Tu vuoi rovinare questo governo tu, così come hai
fatto cadere il mio governo, vuoi far cadere anche il governo di Craxi!”. Io
dissi: “No, io ho semplicemente espresso il mio pensiero. Non voglio far cadere
nessun governo”. Andreotti, che ce l’aveva con Spadolini e che voleva darmi una
dritta, dice col suo modo: “La sovranità limitata è un problema sempre aperto,
un problema antico. La sovranità limitata con l’America noi l’abbiamo sancita
con un atto amministrativo, la circolare Trabucchi”. Silenzio. Mette lì queste
cose: circolare Trabucchi, sovranità limitata, atto amministrativo. Spadolini
non capisce perché è disorientato da questa cosa. Forlani guarda l’orologio e
dice: “Ho un appuntamento”, si alza e se ne va. Due minuti dopo Amato dice a
Craxi che ha un impegno e se ne va. Restiamo Spadolini, Andreotti, io e Craxi.
Craxi vede l’imbarazzo generale e dice: “Va bene, ci siamo chiariti”. Andreotti
mi stringe la mano come per dire: approfondisci. E in effetti Trabucchi nel
giugno 1960, durante i fatti di Genova con il governo Tambroni, accettò una
richiesta degli americani, evidentemente molto preoccupati, che ottennero, con
una circolare del ministro delle Finanze, che negli uffici doganali delle basi
americane venissero sostituiti i doganieri italiani con quelli statunitensi. Di
lì passò tutto l’armamento in Italia. Passò attraverso le basi militari
americane. Entrava ed usciva. E la circolare Trabucchi non fu mai abolita».
C’è stato un momento in cui
Moro stava per essere liberato?
«Io credo di sì. Noi
socialisti, gli amici di Moro e persone spinte da una preoccupazione umanitaria,
come Vassalli, cercammo di spingere per la liberazione del presidente dc. La
nostra azione era alla luce del sole e gli incontri con le persone che pensavamo
potessero essere tramite con le Br avvenivano all’aperto. Insomma ti pare
possibile che Pace, esponente dell’estrema sinistra che dialogava con le Br
attraverso Morucci, si incontra con i socialisti alla luce del sole, si vede più
volte nei bar con Morucci e Faranda... E tutti questi non sono controllati? Non
sono ascoltati? Seguendo lui sarebbero arrivati alla prigione».
Ci si è sempre chiesti se voi
informaste il governo dell’epoca...
«Non è vero che non
informavamo, tutti erano informati, Cossiga era informato, il Quirinale era
informato, il Quirinale e chi stava al Quirinale oltre il Presidente, erano
informati, tutti erano informati. Ora come è possibile che ci sia stata tanta
voluta trascuratezza? A mio modo di vedere il covo era conosciuto. Se poi metti
in connessione che oramai è quasi certo il fatto che Mennini il prete, andò a
confessarlo e poi andò via dall’Italia, fu mandato lontano dalla Chiesa...».
Chi è che voleva Moro morto?
«Questa è una domanda che non
va fatta perché non otterrai mai la risposta. Devi fare un’altra domanda. Chi
non lo voleva operante? I comandi militari della guerra fredda. Perché lui stava
innovando le regole del passato. Sapeva che, nella guerra fredda, non potevano
stare nei governi nazionali del campo occidentale quelli che erano considerati i
nemici internazionali. Ma Moro, negli anni settanta, fece un ragionamento
inedito. Stava nascendo un nuovo rapporto Est-Ovest, andava avanti una politica
di distensione, di dialogo tra le grandi potenze. Questo, pensava, permetteva un
superamento, sul piano nazionale, della logica derivata dalla guerra fredda. Non
per fare governi tra Dc e Pci, ma per realizzare una legittimazione di governo
delle masse popolari anti-Stato in Italia. Che erano i cattolici, i socialisti e
i comunisti. E la legittimazione avviene attraverso il governo del Paese. Dei
cattolici è avvenuto, dei socialisti anche, doveva avvenire pure dei
comunisti».
In Italia c’è stato il rischio
di un colpo di Stato negli anni ’70?
«In Italia dal 1948 in poi
hanno convissuto due tendenze di fondo. La tendenza alla soluzione autoritaria
dei problemi difficili a risolversi e la scelta difficile, faticosa, della via
democratica. Questo nasce dal fatto che non è stato risolto in via definitiva
l’appartenenza toto corde delle masse alle ragioni dello stato democratico. La
maturazione democratica delle masse in Italia è stato un processo sempre
interrotto. È continuato sempre, ma ha avuto sempre delle interruzioni perché ,
anche nell’opinione pubblica, talvolta ha prevalso la suggestione della
semplificazione. Tanto è vero che oggi la vera questione non è rievocare regimi
passati o rischi di regimi passati, il problema sempre aperto in Italia è quello
della opzione tra la soluzione autoritaria e quella democratica».
La prima Repubblica si spegne
per sempre con l’attentato a Falcone, nei giorni di Tangentopoli e con il
parlamento che non riesce a eleggere il Capo dello Stato...
«Falcone aveva accumulato
nella sua vita tante ostilità perché aveva saputo agire sempre senza domandarsi:
“Mi giova o non mi giova?”. Ad un certo momento c’è un vuoto politico e
istituzionale che apre spazio ad uno o a più di quelli che sono stati colpiti da
quell’agire indipendente. La responsabilità, quando avviene qualcosa di questo
genere, è sì di chi ha colpito, è sì di chi ha fornito l’arma, ma è anche di
coloro, e possono essere moltissimi, che sapevano e si sono voltati dall’altra
parte. Che Falcone andasse incontro a qualcosa di terribile c’era più di uno che
lo sapeva. E si è voltato».
La fase finale di Cossiga, le
picconate e il resto... Come la spieghi?
«È un dramma shakespeariano.
Cossiga era uno che ha rappresentato veramente il dramma politico italiano nel
suo unicum, cioè il dilemma tra autoritarismo e democrazia. Quello è stato ed è
il dramma vero. Soluzione autoritaria o soluzione democratica».
Cossiga le aveva tutte e due
dentro?
«Sì».
Ed è per questo che dopo la
vicenda Andreotti perde il controllo?
«Sì».
1956. Cosa sarebbe stata la
sinistra italiana se allora il Pci avesse avuto il coraggio di una secca
condanna?
«Nel ’56 Togliatti sferra un
attacco violento contro il revisionismo. È rivolto a Nenni che pone il problema
dei socialisti e alla dissidenza interna, quella di intellettuali come Giolitti,
Fabrizio Onofri che poi rompono con il Partito. Pongono il problema che non è
una crisi nel sistema, ma è una crisi del sistema. Il socialismo reale è lo
Stato che diventa Stato del partito. Il revisionismo rompe questo assunto. Il
partito politico non può essere Stato, perché, se diventa Stato, ha dentro di sé
gli elementi della oppressione. Se nel ‘56 il Pci avesse condannato la
repressione ungherese cosa sarebbe successo? Sarebbe stato lacerato da una
scissione. E avrebbero prevalso i filosovietici. Ecco perché insisto sul tema
dell’assenza di cultura istituzionale da parte della Sinistra. La Sinistra e i
cattolici, la stragrande maggioranza delle masse italiane nascono anti-Stato. I
cattolici per la questione vaticana, i socialisti e i comunisti per ragioni
sociali, economiche, ideologiche».
Neanche dopo il 1989 la
sinistra riesce a unirsi.
«Dopo il 1989 Craxi va a
Praga. Su un muro trova scritto “viva il Comunismo”. Allora lui cancella e
scrive “abbasso il Comunismo, viva il Socialismo”. Passa un giovane ceco, legge
e gli dice, facendogli il segno del taglio della testa, “Socialismo Kaputt”.
Comunismo e Socialismo, nell’immaginario generale, erano identificate. Craxi
dopo l’89 doveva compiere una grande operazione politica: chiedere, dopo la
Bolognina, che Partito Comunista e Partito Socialista si sciogliessero e
riunificassero superando la scissione di Livorno del 1921. Ma non andando a
prima di Livorno, andando più avanti. Si doveva sapere che si sarebbe aperta
nelle nuove generazioni una crisi di rigetto nei confronti anche della
socialdemocrazia e di ogni forma di socialismo. Realizzato o realizzabile.
Bisognava andare oltre. Craxi invece fa una sola operazione distensiva, nei
confronti del Pci. Dice: vi do tempo, cioè non vado alle elezioni anticipate
sulla vostra crisi, vi do tempo per riorganizzarvi e riconvertirvi. Ora secondo
me questa era una linea totalmente sbagliata perché la riconversione affidata
semplicemente all’iniziativa interna del Partito Comunista avrebbe avuto tempi
lunghi, e abbiamo visto che, ancora oggi, in aree del Partito Comunista, dopo
trent’anni, non è maturata ancora questa consapevolezza».
Qual è l’ultima volta che hai
sentito Craxi?
«Prima che partisse».
Dopo non lo hai più sentito?
«Non l’ho più sentito. Io ebbi
con lui un dissenso finale. Ho sempre ritenuto che, andando via, sbagliasse. Un
errore forse inevitabile per le ragioni di un profondo dolore . Al culmine del
suo dramma personale e politico, alla fine della legislatura nel ‘94, io gli
dissi: «Non andare all’estero, noi abbiamo tutti il dovere di stare qui.
All’inizio sarà dura, sarà difficile, tutto sarà pieno di amarezze e di
sofferenze, ma il tempo fa maturare le ragioni, si spengono le passioni più
aspre. Le passioni sono naturalmente ingovernabili solo in due casi: quando il
soggetto è ancora sul piedistallo e quando il soggetto è scappato». Quando tu
scendi dal piedistallo e non scappi, la ragione ti arriva non dico subito, ma in
tempi ragionevoli».
E lui questo non lo accettò?
«Non lo accettò perché sentiva
forte l’ingiustizia, l’offesa ricevuta, l’inaccettabilità della selezione per
decimazione. Credo che ci fosse anche una ragione di sofferenza fisica, morale,
personale. Temeva di non farcela».
Delle persone che hanno fatto
politica con te chi ti manca di più?
«Matteo Matteotti. Era una
persona splendida: aveva un profondo distacco dal suo dramma umano e la ragione
della sua lotta politica era sicuramente l’incarnazione di un ideale e di una
sofferenza. La sinistra non esiste senza la sofferenza. Io ricordo sempre una
frase che la Kuliscioff aveva pronunciato nel 1926 , intervistata da Giovanni
Ansaldo allora ancora antifascista, che le chiese: “Ma dove avete sbagliato?”
Una domanda che si può, si deve, fare sempre quando un grande patrimonio viene
improvvisamente distrutto. Si può fare anche oggi, a chi lo ha distrutto. Lei
rispose: “Non vi esercitate in grandi elucubrazioni, cercate di capire una cosa:
alla base di una sconfitta vi è sempre una dirigenza che non ha sofferto”».
Chi amò e chi odiò Aldo
Moro, scrive
Renato Moro il 9 maggio 2018 su Tempi. Questi tempi sono lontani. Il fatto che
Moro sia stato un leader politico odiato come pochi non va però dimenticato. Nel
quarantennale della morte di Aldo Moro, pubblichiamo un articolo tratto
dall’Osservatore romano – Tre anni prima della strage di via Fani, Pier Paolo
Pasolini, nel celebre articolo dedicato nel 1975 alla scomparsa delle lucciole,
denunciava il «drammatico vuoto di potere» di un paese governato non da una
classe dirigente ma da «maschere». Tra di esse la più emblematica gli appariva
proprio Aldo Moro, l’uomo dal «linguaggio incomprensibile come il latino». Pochi
mesi dopo lo scrittore propose pubblicamente un vero «processo penale» contro
gli esponenti democristiani del «Palazzo», per trascinarli, «come Nixon» (erano
gli anni dello scandalo Watergate), «sul banco degli imputati». E aggiunse:
«Anzi, no, non come Nixon, restiamo alle giuste proporzioni: come Papadopulos»,
cioè come il dittatore greco che era allora stato processato e condannato a
morte. L’anno dopo un regista vicino alla sinistra extraparlamentare, Elio
Petri, trasformava in un film il giallo politico di Leonardo Sciascia Todo modo.
Vi si vedeva, impersonato da Gian Maria Volonté, il presidente «M», leader di un
partito cattolico corrotto e che governava da decenni un paese in ginocchio. Era
un politico viscido, dall’eloquio complesso e dalla sempiterna attitudine a
mediare, giunto a orchestrare, in un albergo per ritiri spirituali, la
carneficina dei suoi complici di partito, per la loro manifesta inadeguatezza e
al solo scopo di sancire la propria supremazia. Nell’ultima scena, in un
grottesco sacrificio di redenzione, «M» offriva se stesso al boia e, recitando
il Padre nostro, attendeva in ginocchio il proprio destino. Questi tempi sono
lontani. Il fatto che Moro sia stato un leader politico odiato come pochi non va
però dimenticato. Sin dai primi anni sessanta, a destra si denunciava il
«comunismo moroteo» e accusava Moro di essere una sorta di complice “attivo” del
Partito comunista italiano (Pci). A sinistra il quotidiano comunista ne bollava
il sistema di «ricatto» mascherato «sotto il velo delle parole dette e non
dette, delle ambiguità, delle polivalenti interpretazioni». Sarebbe stato così
Eugenio Scalfari ad attribuire a Moro la celeberrima formula delle «convergenze
parallele», che lui, in realtà, non aveva mai usato: perché aveva semplicemente
parlato di «convergenze democratiche»; ma la leggenda era più vera della realtà,
e, nonostante le sue smentite, Moro era stato coperto da un coro di ironia.
Insomma, negli anni settanta Pasolini e Petri esprimevano un topos
interpretativo già largamente diffuso: quello del “gattopardo levantino”,
trasformista perché nulla cambiasse. E Sciascia stesso, nel suo pamphlet
sull’affaire Moro, l’avrebbe di lì a poco definitivamente codificato scrivendo
di «un grande politicante: vigile accorto, calcolatore, apparentemente duttile
ma irremovibile». Naturalmente, Moro venne anche profondamente amato.
Innanzitutto, dai suoi elettori: va ricordato che nel 1968 fu il politico che
ottenne il record delle preferenze. Poi, intorno a lui, da una parte, il
cattolicesimo di sinistra e, dall’altra, la cultura comunista costruirono
l’immagine, speculare e non meno distorta, del principale ideatore dell’accordo
con il Pci. Sarebbe stato così facile, dopo la sua morte, farne il martire di
questa causa: nel 1998, non certo a caso, la città natale, Maglie, ha scelto di
porre a suo ricordo una statua che lo rappresenta con in mano una copia
dell’«Unità». Quei tempi sono lontani. Ancora oggi, però, non è facile un
discorso su Moro: non è facile evitare il peso di tante passioni; non è facile
nemmeno evitare il peso della sua stessa tragedia. Eppure, continuando a
focalizzare esclusivamente lo sguardo su di essa, non solo rischiamo di mettere
quei cinquantacinque giorni avanti a quasi 62 anni di vita pienissima, ma
rischiamo una sorta di paradossale proiezione interpretativa all’indietro che
legga Moro dalla fine, come se quest’ultima fosse la chiave rivelatrice di
tutto. Eppure, di lui si deve parlare. Per “liberarlo” una volta per tutte dal
carcere delle Brigate rosse e riconoscergli il ruolo di protagonista di quasi
vent’anni di storia della democrazia italiana che certamente merita. Formatosi
nella nidiata montiniana dei giovani intellettuali cattolici della Fuci, la
Federazione universitaria cattolica italiana, e del Movimento laureati, educato
a una fede pensante, Moro non aveva scelto la politica: avrebbe sempre
dichiarato di sentire lo studio e l’insegnamento universitario come la propria
vera vocazione. Se non l’aveva seguita, era stato solo per senso di
responsabilità, verso la chiesa e il paese. Fu così che, giovanissimo (non aveva
ancora compiuto trent’anni), Moro divenne uno dei costituenti, e con un ruolo
decisivo: per l’attitudine a suggerire formule di mediazione e di sintesi; per
il fermo sostegno alla necessità di collocare i principi fondamentali nella
costituzione, e non in un limitativo preambolo; per il ruolo nella scelta
dell’espressione «fondata sul lavoro» dell’articolo 1; per l’accoglimento
dell’istituto del referendum; per la rivendicazione di una democrazia sociale,
basata su una forte presenza dello Stato; per l’affermazione della valenza
«antifascista» della nuova democrazia. Moro fu il primo ministro della giustizia
(1955-1957) a visitare sistematicamente le carceri, il primo ministro della
pubblica istruzione (1957-1959) a istituire l’educazione civica. Soprattutto, fu
colui che, con un paziente lavoro di convincimento e di rassicurazione, riuscì a
portare il suo partito, il mondo cattolico e la Chiesa ad accettare l’apertura
ai socialisti, e cioè la formula politica che avrebbe regalato agli italiani la
maggiore crescita economica e civile della loro storia. Il centro-sinistra è
sempre rimasto per Moro il vero orizzonte di riferimento: nel 1968 fu sensibile
a capire i «tempi nuovi» della contestazione giovanile, dell’emancipazione
femminile, della protesta del mondo del lavoro, ma avrebbe voluto continuare a
governare coi socialisti. Furono gli anni settanta, con la crescita
inarrestabile dei voti al Pci e l’indisponibilità socialista, a rendere il suo
disegno impossibile. Fu ancora lui, tuttavia, a farsi perno e garante di una
soluzione difficilissima, quasi acrobatica, per fare andare avanti, e non
indietro, la democrazia italiana: governi democristiani con l’ingresso comunista
nella maggioranza e con l’avvio di un complesso processo di legittimazione
reciproca che avrebbe potuto favorire il superamento degli invalicabili muri
della Guerra fredda. Quei tempi sono lontani. Il centenario della nascita di
Moro nel 2016 e il quarantennale della sua morte hanno visto un numero davvero
straordinario di commemorazioni, di celebrazioni, di documentari, di interventi
a ogni livello. È un caso che tutto questo interesse mediatico coincida con un
momento di profonda incertezza, di crisi, forse addirittura di tramonto
dell’Italia? Certo, Moro pare oggi venire da un altro pianeta. In un’epoca di
leadership fortemente personalistiche, lui è, come scrisse allora un
giornalista, un uomo «che non vuole essere fotografato, che non vuole essere
intervistato, che non vuole essere citato, che non vuole essere nemmeno lodato».
In un’epoca in cui tutte le forze politiche ripetono insistentemente ai loro
elettori che le soluzioni sono semplicissime ed evidenti e che, se i loro
avversari non lo riconoscono, è solo per malafede o corruzione, Moro è il
politico convinto che la realtà è sempre complessa, che un elemento profondo di
verità esiste in ogni posizione sincera, che occorre studiare seriamente e
mettersi dal punto di vista degli altri. In un’epoca di politica esclusiva e
intollerante, che ha creato il termine “inciucio” per bollare come cedimento
corruttivo ogni forma di accordo politico, Moro è convinto che compromesso
significa esattamente quello che la sua etimologia latina dice: cum promittere,
“promettere insieme”, e dunque l’atto più alto che si possa compiere in
politica. Forse, proprio perché gli italiani sembrano non sapere più chi sono
essi sentono l’interesse (e, chissà, la nostalgia) di una leadership non della
forza, non del decisionismo, non della delegittimazione, ma dell’intelligenza e
del dialogo.
La sinistra morì con Aldo
Moro. Il
nuovo libro di Giovanni Bianconi, scrive giovedì, 07 marzo 2019, Il Corriere.it.
Il 16 marzo del ’78 finì il ’68. L’euforia rivoluzionaria che aveva dominato il
decennio affogò nel sangue dei cinque uomini della scorta uccisi dalle Br, e
poi, 55 giorni dopo, di Aldo Moro. Si chiuse così la lunga stagione in cui una
sinistra che si chiamava ancora comunista poté realisticamente sperare di
vincere in un Paese occidentale; e non solo sul piano politico, ma anche su
quello sociale e culturale, quasi inverando l’idea gramsciana di egemonia. Dalla
morte del leader democristiano, che voleva metabolizzare quella sinistra e
assorbirla in una «terza fase» della democrazia italiana, cominciò il decennio
che l’avrebbe invece espulsa dalla storia, con Craxi e Canale 5, con Forlani e
il pentapartito, per finire poi con la sua sepoltura definitiva sotto le macerie
del Muro di Berlino, nel 1989. Quando ci si confronta con una data storica, si
tende a fare ragionamenti del genere che avete appena letto. Si assume cioè il
punto di vista, un po’ pomposo, della profezia che si autoavvera, come se gli
eventi di allora, osservati quarant’anni dopo, contenessero già in sé, in nuce,
le tracce di ciò che hanno prodotto. E invece una giornata storica è
innanzitutto una giornata del suo tempo, non del nostro. E se la riguardi da
vicino per com’era, non con il senno di poi, ti accorgi di due cose. La prima è
l’incredibile forza che esercita, nelle vicende umane, l’eterogenesi dei fini: i
protagonisti compiono azioni di cui non possono veramente prevedere l’esito,
tentano di influenzarlo ma agiscono in realtà sotto un velo di ignoranza: per
questo talvolta appaiono «sonnambuli» mentre si dirigono verso il ciglio di un
burrone. La seconda è che ogni giornata storica poteva andare in un altro modo,
anzi, in mille altri modi; e che ciò che ne risultò fu solo la combinazione di
comportamenti individuali contraddittori e fallaci, di errori e omissioni. È
questo il valore di testi come quello che ha scritto Giovanni Bianconi per
Laterza. Un lavoro quasi virtuosistico di ricostruzione di tutto ciò che accadde
davvero quel giorno, un libro così da cronista da diventare un libro di storia.
Perché del rapimento di Moro si sa quasi tutto, e lo si sa anche grazie a ciò
che ne ha scritto negli anni Bianconi. Però ogni volta c’è qualcosa che ti
colpisce come se non fosse nota. La vicenda di Antonio Spiriticchio, per
esempio, il fioraio ambulante che si era piazzato da un paio di anni tra via
Mario Fani e via Stresa, proprio dove era progettato l’agguato. La notte prima
due brigatisti, Seghetti e Fiore, andarono sotto casa sua, in tutt’altra zona di
Roma (erano risaliti all’indirizzo fingendosi avvocati al Pra), e gli bucarono
tutte e quattro le gomme del Ford Transit che usava. Un dettaglio, certo. Ma che
al fioraio salvò la vita; e che a leggerlo oggi basta a render chiaro quanto
superiore fosse il livello di preparazione e di organizzazione del gruppo armato
rispetto alla risposta che le forze dello Stato riuscirono a dare quel giorno e
nei successivi due mesi. Giovanni Bianconi (Roma, 1960) Oppure la vicenda di
Tullio Ancora, l’ex alto funzionario della Camera, che lo statista democristiano
usava come messaggero segreto con il Pci, attraverso Luciano Barca, allora
membro della direzione comunista. La sera prima di esser rapito, Moro chiese ad
Ancora di pregare il Pci di non fare scherzi. Il 16 marzo avrebbe dovuto votare
la fiducia al governo Andreotti. Si sarebbe trattato del primo monocolore dc con
il voto favorevole del Pci, dopo due anni di governi delle astensioni e della
non sfiducia. Ma le correnti democristiane imposero una lista di ministri
impresentabile per i comunisti, e questi non erano più così sicuri di fare il
grande passo. L’azione delle Br fu dunque decisiva nello spingere il Pci a
votare a favore del governo Andreotti (perfino nella direzione che si riunì
subito dopo l’attentato, Pajetta espresse i suoi dubbi su quella che chiamò «una
fiducia listata a lutto»). I brigatisti colpirono dunque per affondare il
connubio Dc-Pci, ma in effetti lo accelerarono. Fu di nuovo Tullio Ancora, un
mese dopo il rapimento, a portare al Pci una lettera dell’ostaggio che chiedeva
aiuto: «Ricevo come premio dai comunisti, dopo la lunga marcia, la condanna a
morte. Non commento». Ma stavolta Barca non poteva più nulla. «Di fatto»,
scriverà poi, «dipendiamo in tutto e per tutto da ciò che Cossiga dice e non
dice a Pecchioli. Ma io (…) sono escluso anche da queste comunicazioni». È stata
decisa la linea della fermezza, e non verrà più smentita, né dallo Stato, né
dalle Br, che alla fine uccisero Moro, come forse avevano già deciso di fare fin
dall’inizio, dopo la discussione critica che aveva aperto al loro interno la
liberazione senza condizioni del giudice Sossi, anch’egli rapito quattro anni
prima. Persero le Br? Sicuramente sì. Dopo l’uccisione di Moro non era più
possibile alzare ulteriormente il livello dello scontro, per scatenare una
guerra civile che gli italiani non volevano e che non ci fu. La sconfitta
politica del terrorismo rosso cominciò proprio con la vittoria della «geometrica
potenza» di via Fani. Ma forse un po’ vinsero. Perché la morte di Moro fu
l’inizio della fine della collaborazione tra Dc e Pci, che infatti si interruppe
nel 1979, dieci mesi dopo, quando i comunisti fecero cadere il governo
Andreotti, e tornarono all’opposizione. Berlinguer annunciò la decisione della
rottura (presa col voto contrario di Napolitano, Chiaromonte, Macaluso, Perna,
Trivelli, Bufalini) il 17 gennaio del 1979, sette giorni prima che le Br
uccidessero Guido Rossa, l’operaio del Pci e sindacalista Cgil dell’Italsider di
Genova che aveva denunciato un brigatista infiltrato in fabbrica. Così che, in
quello spazio temporale tra il sacrificio della più celebre vittima
democristiana e quello della più celebra vittima comunista del terrorismo rosso,
si compì nei fatti il disegno dell’estremismo che aveva contrastato fin
dall’inizio l’evoluzione democratica del Pci. Dalla morte di quel progetto di
compromesso non nacque però una nuova sinistra rivoluzionaria, tutt’altro. Il
‘79 fu anzi il canto del cigno della sinistra in tutte le sue manifestazioni.
Quattro mesi dopo in Inghilterra vinse Margaret Thatcher. Un altro anno e alla
Casa Bianca arrivò Ronald Reagan. Di tutti i calcoli e le macchinazioni del 16
marzo 1978, nota con implicita e amara ironia Bianconi chiudendo il libro, alla
fine la previsione più azzeccata resta quella metereologica, diramata
regolarmente alla fine della giornata: «Sull’Italia settentrionale e su quella
centrale molto nuvoloso o coperto. Nevicate sull’arco alpino. Attività
temporalesca in Sardegna. Sulle regioni meridionali nuvolosità in graduale
intensificazione. Venti forti. Mari generalmente agitati». Brutto tempo in
arrivo. Il libro di Giovanni Bianconi sarà presentato a Roma presso la fiera
Libri Come sabato 16 marzo alle ore 18, in sala Studio 2, con Gianni Cuperlo,
Marco Damilano, Monica Galfré. Un secondo incontro si svolgerà a Roma il 29
marzo alle ore 17 presso la Treccani, con Giuliano Amato, Pier Ferdinando Casini
e Massimo D’Alema.
L’archivio segreto della Dc,
scrive "Il Tempo" il 20/09/2016. Riemerge ad Avellino il carteggio sui conti
della Democrazia Cristiana Spuntano lettere di Moro, raccomandazioni,
contabilità in nero e guerre tra correnti. Migliaia di faldoni impolverati,
tutta la leggenda della Dc. Per la prima volta vedono la luce dopo 30 anni di
oblio. Conti correnti, movimenti bancari per 30 miliardi di lire solo nel '92,
lettere di raccomandazioni, report dei servizi segreti, litigi fra vecchi
segretari, contabilità in nero. Un volume immenso di carta ingiallita che
racconta un pezzo di storia italiana.
La signora che custodì
(senza saperlo) quarant’anni di politica italiana,
scrive Daniele Di Mario su "Il Tempo" il 20/09/2016. Iole scomparsa a giugno di
due anni fa a novant'anni, ha ospitato nella sua casa faldoni e documenti. La
signora Iole se n’è andata all’inizio del giugno di due anni fa, poco dopo aver
portato a termine una missione di cui non era a conoscenza ma che pure le era
stata affidata, consegnando questa donna irpina in qualche modo alla storia di
questo Paese. La signora Iole si è spenta il 3 giugno del 2014, dopo aver
custodito, senza saperlo l’archivio della Democrazia Cristiana. Migliaia di
faldoni, documenti, appunti, ricevute, note spese messi in salvo da Gianfranco
Rotondi e da Rocco Buttiglione, grazie a un furgoncino rimediato mentre in
piazza del Gesù si consumava l’abbandono della storica sede della Balena Bianca
ormai sciolta e il prezioso archivio rischiava di andare perduto per sempre. Era
il 1993. La Democrazia Cristiana - liquidata dall’ultimo segretario Mino
Martinazzoli, sconvolta da Tangentopoli e fiaccata da vent’anni di crisi di un
partito che non aveva saputo rinnovare il cattolicesimo politico dopo le novità
portate dal Concilio del Vaticano II nell’impegno del laicato - esauriva la sua
storia in una scissione che avrebbe finito col generare una diaspora infinita
dei cattolici democratici. La Democrazia Cristiana divenne Partito Popolare, non
senza fratture importanti: la frangia cattolico-sociale guardò a sinistra; il
Centro Cristiano Democratico (Ccd) ruppe gli argini verso il centrodestra che si
andava aggregando attorno alla discesa in campo di Silvio Berlusconi. Il
patrimonio della Dc restò al Ppi, il simbolo seguì invece il Cdu. Nel 1995 poi,
il segretario del Ppi Rocco Buttiglione lasciò il partito per fondare i
Cristiano Democratici Uniti (Cdu). Nel 2002 Ccd e Cdu si fusero per fondare
l’Udc; nello stesso periodo il Ppi - rottamato nel 1999 alle elezioni europee
dai Democratici di Romano Prodi - confluì nella Margherita. Ma questa è un’altra
storia. Torniamo al 1993. Mentre la Dc moriva Rotondi e Buttiglione, con un
furgone, misero in salvo l’archivio. Migliaia di faldoni, documenti, appunti,
ricevute che coprono un arco temporale dal 1946 al 1993 presero la via di
Avellino, dove vennero conservate in tre stanze di un appartamento il cui canone
di locazione e utenze venivano pagate dagli eredi della Balena Bianca. In quella
casa viveva la signora Iole, che conservò per vent’anni un archivio tenuto
rigorosamente sotto chiave e che rappresenta un pezzo di storia della nostra
Repubblica. La gente passava davanti a quella casa - racconta divertito Rotondi
- e sentiva l’odore della divina pasta e fagioli o del fantastico ragù che la
signora Iole sapeva cucinare e non immaginava che lì dentro ci fosse un archivio
tanto importante. L’accordo era che quei documenti non potessero essere resi
pubblici per vent’anni, dal 1993 al 2013. Un embargo finito pochi mesi prima
della scomparsa della novantenne irpina. All’indomani della morte della signora
Iole, Rotondi annunciò la propria intenzione di voler trasferire l’intero
archivio della Dc all’Istituto Sturzo, a condizione che anche il simbolo fosse
consegnato alla Fondazione sottraendolo alla contesa elettorale. Lo Scudo
Crociato non fu ovviamente consegnato a via delle Coppelle. Così Rotondi si
tenne l’archivio e oggi, a tre anni dalla fine dell’embargo ventennale che lo
teneva celato, lo regala in esclusiva ai lettori de Il Tempo.
Documenti, lettere e conti
in nero. Ecco l’archivio della Dc,
scrive Daniele Di Mario su "Il Tempo" il 20/09/2016. Riemergono ad Avellino
migliaia di volumi che raccontano la storia della Democrazia Cristiana. Migliaia
di faldoni impolverati, tutta la leggenda della Dc. Per la prima volta vedono la
luce dopo 30 anni di oblio. Conti correnti, movimenti bancari per 30 miliardi di
lire solo nel '92, lettere di raccomandazioni, report dei servizi segreti,
litigi fra vecchi segretari, rapporti su società immobiliari, contabilità in
nero, finanziamenti a giornali, associazioni, sindacati. Un volume immenso di
carta ingiallita che racconta un pezzo di storia italiana a testimonianza dei
cinquant'anni di vita della Democrazia Cristiana, dal 1946 al 1993, anno del suo
scioglimento. Si tratta dell'archivio amministrativo della Balena Bianca,
documenti che non hanno nulla a che fare con il patrimonio immobiliare finito
poi al Partito Popolare. L'archivio, portato ad Avellino con un furgone da
Gianfranco Rotondi e Rocco Buttiglione, che così lo salvarono dal macero, è
stato coperto da embargo per vent'anni. Ora Il Tempo ha potuto visionarlo in
esclusiva nella sede della Fondazione Sullo, ad Avellino, dov'è conservato. In
quelle carte c'è la vita del partito che ha governato l'Italia dal secondo
dopoguerra alla fine della Prima Repubblica. In fin dei conti c'è un pezzo
consistente della storia di tutti noi. Tutto si può dire della Democrazia
Cristiana, fuorché che non fosse trasparente. Tutt'altro, i democristiani che
nel tempo si sono succeduti nell'amministrazione del partito annotavano
qualsiasi cosa. Cambiavano i segretari politici, cambiavano i segretari
amministrativi, cambiavano i tesorieri, ma la rendicontazione del fiume di
denaro che entrava e usciva dai conti correnti della Dc restava sempre la
stessa, annotando anche i contributi in nero sotto diverse locuzioni, ad esempio
“contributi non formalizzati”. Così orientarsi in quel mare di numeri è la cosa
più facile del mondo, indipendentemente dall'anno che si prende in
considerazione. Parliamo naturalmente di cifre miliardarie. Ovviamente in lire.
Peschiamo a caso dalle migliaia di cartelline usurate dal tempo. Le spese
sostenute da piazza del Gesù nell'Anno Domini 1961 furono di oltre 4 miliardi e
650 milioni di lire. Un'enormità, considerando che stiamo parlando di oltre 55
anni fa. Le spese indivisibili ammontavano a oltre 439 milioni. C'erano poi i
contributi ai vari movimenti: 123 milioni al giovani, 97 al femminile, 23 ai
reduci di guerra, 22 alla polisportiva Libertas e mille altri. Gli Uffici
Gestionali rappresentavano invece il cuore operativo della Balena Bianca. Piazza
del Gesù assorbiva il grosso dei costi. La segreteria politica, ad esempio,
costava 169 milioni l'anno, quella amministrativa 139 e quella organizzativa, su
cui pendeva l'onere del tesseramento, dei comizi, delle campagne elettorali,
arrivava a pesare per quasi 270 milioni di lire dell'epoca sui conti del partito
tra stipendi, spese logistiche, stampe, noleggio automobili. Le sole spese di
preparazione del congresso nazionale ammontarono a 4,8 milioni, mentre di
manifestazioni elettorali furono spesi oltre 320 milioni. Le manifestazioni
straordinarie pesarono in bilancio per oltre 139 milioni. Nel 1961, ad esempio,
in televisori la Balena Bianca spese 22 milioni, per la cancelleria 3 milioni.
Tornando alle articolazioni di Piazza del Gesù, nei conti di quell'anno si
riscontrano anche 114 milioni per l'ufficio Spes, 35 per le attività culturali,
48 per l'ufficio enti locali, 25 per l'elettorale, 72 milioni erano invece
appannaggio del centro studi e formazione. La Dc destinava anche 21 milioni per
l'anno 1961 ai problemi assistenziali. Un fiume di milioni anche alla stampa di
partito: un miliardo al Popolo, 84 milioni alla Discussione fondata da De
Gasperi, 10 milioni a Civitas, 368 al Giornale del Mattino, 74 al Corriere del
Giorno, 60 all'Avvenire d'Italia e 22 all'Adige. I contributi ordinari ai
comitati provinciali e regionali ammontavano a 667 milioni di lire. Le società
collegate – come l'Immobiliare, la Società Edilizia Romana, la Sari Camiluccia e
la Affidavit – pesavano per 274 milioni. Gli interessi passivi sullo scoperto di
conto corrente erano di 103 milioni. La situazione debitoria generale invece era
di oltre 4,3 miliardi. Il volume dei movimenti bancari della Dc crebbe a tasso
d'inflazione. Aumentavano i prezzi, si svalutava la lira e la mole di denaro nei
conti correnti di Piazza del Gesù cresceva nonostante la scala mobile fosse
stata abolita da qualche anno. Tra il 1991 e il 1992 la Dc aveva sei conti
correnti presso altrettanti istituti di credito: Banca Nazionale
dell'Agricoltura, Banco di Santo Spirito, Monte dei Paschi di Siena, Banca
Popolare di Bergamo, Banco Roma e Banco di Napoli. Nei movimenti bancari si
notano entrate mensili tra contributi non meglio specificati – probabilmente
tangenti o altri contributi in nero – e versamenti per il tesseramento. Nelle
uscite c'è di tutto. Gli stipendi ogni mese pesavano per oltre 850 milioni di
lire. Ma a venire finanziate erano anche agenzie di pubblicità che beneficiavano
di erogazioni periodica mensili per 200, 600 o 800 milioni ognuna. Nel maggio
del 1991 Il Popolo, il quotidiano Dc che riceveva ogni mese 580 milioni di lire,
versò 3,9 miliardi alla Dc che ne rigirò altrettanti pochi giorni dopo per
ripianare delle uscite. Registrati anche i contributi previdenziali: rate da 519
milioni all'Inps. Gli stipendi delle società immobiliari ammontavano a 20
milioni al mese, mentre quelli della Camilluccia a 5. Annotati anche prelievi di
cassa per conto di Ciriaco De Mita, alcuni dei quali ammontano a oltre 30
milioni. Daniele Di Mario
Raccomandazioni, liti e
tante lettere anonime,
scrive Daniele Di Mario su "Il Tempo" il 20/09/2016. Tra le carte anche i
rapporti dei servizi segreti su diverse persone. Miliardi di vecchie lire,
certo. Ma non solo. Perché la vita della Dc era fatta anche di altro. Nelle
migliaia di faldoni custoditi nella sede della Fondazione Sullo, spuntano anche
migliaia di lettere di raccomandazione, di assunzione e persino rapporti dei
servizi di sicurezza rigorosamente anonimi. Spulciando nelle carte del 1958
emerge la lettera di assunzione del direttore amministrativo del quotidiano Il
Popolo. Germano Bodo ricevette una lettera dalla segreteria amministrativa della
Dc firmata da Renato Barzi in cui veniva informato dell’assunzione. Ma quanto
guadagnava il direttore amministrativo del quotidiano della Dc? Nel 1958
percepiva 4 milioni e 800mila lire l’anno. Per l’epoca un signor stipendio.
Nelle carte spunta anche altro. Ad esempio piccole beghe interne. Nel 1960 negli
uffici di Piazza del Gesù ci si interroga su un assegno da 200mila lire recante
le firme di Guglielmoni e Gonella, probabilmente contraffatte. Ci sono poi i
rapporti dei servizi segreti, vere e proprie informative chieste dal partito per
cercare di capire chi fossero i personaggi che si avvicinavano al partito, che
magari lo finanziavano, che chiedevano o ricevevano una raccomandazione. E le
informazioni richieste puntualmente venivano rese sotto forma di «promemoria»
anonimi, ma molto dettagliati che raccontavano fedine penali, sentenze pendenti
o passate in giudicato, professione e stato civile della persona di cui si
chiedevano informazioni. Così si apprende che nel 1959 nella segreteria di un
senatore lavorava un uomo sposato con un figlio, denunciato e arrestato per
appropriazione indebita, poi rilasciato e denunciato di nuovo per omicidio
colposo in seguito a un incidente stradale, poi condannato a 4 mesi di
reclusione con pena condonata e quindi riarrestato proprio nel 1959 per
bancarotta fraudolenta. Un altro che non andando a donne e nemmeno a uomini
meritava «un approfondimento investigativo». Nell'archivio Dc non potevano
mancare le lettere riservate. Come quella che nel 1960 l'onorevole Nocentini
riceveva da parte di Renato Branzi, della segreteria amministrativa, per conto
di Aldo Moro: «Ci siamo domandati come manifestare gratitudine che ambedue
proviamo per la illuminata e assidua assistenza dataci in questo anno. Siamo
così giunti alla conclusione di chiedere di accettare una piccola somma, la cui
stessa modesta misura, esclude che la si possa considerare un compenso». E poi
nell'archivio ci sono centinaia, ma centinaia davvero, raccomandazioni. Nel 1960
se ne occupava lo stesso Branzi, che con riservate personali rigorosamente
protocollate, scriveva ai top manager delle aziende pubbliche per chiedere. Dan.
Dim.
«Io, avvocato Dc derubato
durante i processi Moro»,
scrive Daniele Di Mario su "Il Tempo" il 20/09/2016. Il legale che difendeva il
partito denunciò una serie di furti nel suo studio. Nell’archivio della Dc non
poteva mancare Aldo Moro, lo statista ucciso dalle Brigate Rosse di cui
quest'anno ricorre il centenario della nascita. Decine di fascicoli, su
correnti, amici e nemici. L'ex presidente della Democrazia Cristiana spunta un
po' dappertutto, per la sua attività di presidente del Consiglio e di segretario
politico. Ma Moro figura nelle carte della Dc soprattutto dopo la sua morte, per
i numerosi processi celebrati sul suo rapimento e sul suo assassinio. I
fascicoli sulle spese legali custoditi nell'archivio riguardano per larga parte
i processi legati all'omicidio di Moro. Con particolari a volte inquietanti. Un
avvocato, ad esempio, scrive a Piazza del Gesù per informare che, da quando ha
accettato l'incarico di difensore della Dc nel processo Moro, ha subìto ben
sette furti nel proprio studio legale, veri e propri blitz che hanno distrutto
gli uffici. Ruberie che il legale attribuisce alla sua attività di difensore del
partito dell'ex presidente del Consiglio assassinato. Incursioni notturne
sospette e ripetute, cominciate proprio nel momento in cui il professionista ha
iniziato a occuparsi del caso Moro con alcune iniziative particolarmente
delicate. Pertanto il principe del Foro spiega ai responsabili della segreteria
amministrativa della Democrazia Cristiana di voler rinunciare all'incarico e di
non avere nulla a pretendere dal partito, chiedendo in cambio solo la
ristrutturazione dei propri uffici a carico della Balena Bianca. Lo stesso
avvocato arrivò a intentare una causa per vedersi riconosciuto il diritto ad
aver ristrutturato il proprio studio, chiedendo 350 milioni di vecchie lire. La
rinuncia all'onorario da parte dell'avvocato non è cosa di poco conto, visto che
le spese legali per i processi Moro sono state davvero esorbitanti. Nel Moro
Ter, solo di copie atti, la Dc ha dovuto onorare una fattura di 78 milioni di
lire. Lo stesso avvocato che inviò quella nota di pagamento non era tuttavia
stimato dallo stato maggiore democristiano. Giulio Andreotti, ad esempio – si
legge in alcune lettere – «è tornato alla carica» per il «comportamento non
edificante» del legale e lagnandosi del fatto che il professionista in questione
«lavora male» e «si comporta in maniera strana e insolita». Al Divo Giulio
risponde Flaminio Piccoli, spiegandogli di aver discusso a lungo con l'avvocato
e rassicurandolo che la situazione sarebbe stata risolta. E così fu, con una
classica pax democristiana a sei zeri che mise d'accordo tutti: l'avvocato,
Andreotti che voleva sostituirlo e il partito. Dan. Dim.
L’immobiliare Dc finisce in
procura. Caccia al patrimonio scomparso,
scrive Valeria Di Corrado su "Il Tempo" il 10/02/2016. Il segretario Sandri e
gli iscritti del 1993 presentano una nuova denuncia STORIA Sedi e miliardi
svaniti tra vendite e scissioni. Chi ha fatto sparire l’immenso patrimonio
immobiliare della Democrazia cristiana? È questo il nuovo fronte d’indagine
della Procura di Roma, che potrebbe rivelare sorprese interessanti. Lo scorso 27
novembre è stato presentato negli uffici di piazzale Clodio un esposto firmato
da Angelo Sandri, segretario nazionale pro tempore della Dc, Franco De Simoni,
segretario ragionale della Dc Lazio e Raffaele Cerenza, presidente
dell’Associazione degli iscritti al partito della Dc del 1993. «Sussiste il
fondato timore – si legge nell’esposto – che buona parte dei beni e delle
risorse patrimoniali della storica e vivente Dc siano confluiti nei partiti di
successiva formazione, i cui dirigenti hanno così potuto disporre d’ingenti
cespiti, senza dichiararli né riportarli nei rispettivi rendiconti/bilanci».
Stiamo parlando di un patrimonio di beni mobili e immobili, partecipazioni
societarie e sedi in tutte le città italiane, il cui valore oggi ammonterebbe a
un miliardo di euro. Tutto è cominciato quando, con una delibera del 18 gennaio
1994 adottata dall’ Assemblea della Democrazia cristiana, la Dc ha cambiato nome
ed è diventata il Partito popolare italiano. «Il processo modificativo della
denominazione – spiega l’esposto – ha determinato un’evidente distorsione tra il
soggetto che poteva disporre dei beni e il soggetto che ne ha effettivamente
disposto». In effetti, la sentenza della Corte d’appello di Roma dell’11 marzo
2009, poi confermata dalla Corte di Cassazione l’anno successivo, ha accertato
«l’insussistenza di una dimostrata continuità tra la "storica" Democrazia
cristiana, attiva con questa denominazione e il noto simbolo dello scudo
crociato con la scritta "Libertas" fino al 18 gennaio 1994, e il partito della
Democrazia cristiana di Giuseppe Pizza». Questo significa che i partiti politici
che negli anni si sono proclamati eredi della Democrazia cristiana (con le sigle
Ppi, Ppi ex Dc, Ppi Gonfalone, Cdu, Ccd e Udc), l’hanno fatto a fronte di «una
continuità ideale certamente non coincidente – spiega la sentenza d’Appello –
con una continuità associativa giuridicamente rilevante». In ballo, però, non
c’era solo un’eredità di valori o ideali, bensì quella più ambita di decine e
decine di immobili sparsi per l’Italia. «Tali beni – si legge sempre nella
documentazione depositata in Procura – sono stati illegittimamente alienati e
sottratti al patrimonio della Democrazia cristiana storica. Alcune delle società
intestatarie sono state addirittura sottoposte a procedure fallimentari ancora
non definite davanti al Tribunale di Roma, relativamente all’Immobiliare spa e
alla Ser spa». Viene definita «gravissima» l’operazione con la quale il
patrimonio e l’organizzazione della Dc è stata fatta confluire nel 2001 nella
formazione politica «La Margherita», che quello stesso anno ha partecipato alle
elezioni politiche, percependo il relativo contributo statale. Ma c’è di più,
perché dal 1995 al 2015 Ppi e Cdu non avrebbero dichiarato anno per anno le
variazioni patrimoniali e ipotecarie dei beni della Dc, «in grave violazione
della legge sul finanziamento pubblico dei partiti». L’ultima traccia di questo
patrimonio immobiliare si ha nel bilancio-rendiconto della Dc del 1993,
confluito nel Ppi, come conferma il bilancio di quel partito, relativo al 1994.
Sandri, De Simoni e Cerenza hanno inviato anche una lettera alla presidente
della Camera Laura Boldrini per chiedere di ricostruire i bilanci della Dc dal
’94 a oggi e dei partiti ai quali è stato trasferito il suo patrimonio
immobiliare che «deve essere restituito alla Dc e ai suoi iscritti del 1993». Ma
nessuno finora ha risposto. Valeria Di Corrado
Sedi e miliardi svaniti tra
vendite e scissioni. Oltre 120 gli appartamenti sparsi in tutta Italia,
scrive il 10/02/2016 Daniele Di Mario su "Il Tempo". Dell’«unità politica dei
cattolici», la fusione tra il Partito popolare di Alcide De Gasperi e il
Movimento Guelfo d’Azione di Piero Malvestiti che nel 1942 diede la vita alla
Democrazia Cristiana, oggi rimane l’idea del cattolicesimo democratico. Il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ad esempio, è moroteo. Ma anche
una diaspora che ha portato i suoi esponenti moderni a frammentarsi un po’ i
tutti i partiti e una pletora di sigle che negli anni hanno dato vita a
scissioni ed evoluzioni. Dall’ultima Dc del segretario «liquidatore» Mino
Martinazzoli, al Ppi e alla prima scissione del Ccd datate 1994 passando per la
scissione dal rinato Partito popolare del Cdu del 1995. Dal 1942 al 1994 la Dc
ha governato l’Italia per cinquant’anni, frutto dell’intuizione dell’allora
assistente spirituale della Fuci Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, che
mise insieme l’elité cattolica del tempo. Prossima la caduta del fascismo, in
casa dell’imprenditore milanese Giorgio Maria Flick, presero a incontrarli
Alcide De Gasperi, Mario Scelba, Attilio Piccioni, Camillo Corsanego e Giovanni
Gronchi provenienti dal disciolto Partito Popolare Italiano di don Luigi Sturzo;
Piero Malvestiti e il suo Movimento Guelfo d’Azione; Aldo Moro e Giulio
Andreotti dell’Azione Cattolica; Amintore Fanfani e Giuseppe Dossetti della
Fuci; i leader della Resistenza Paolo Emilio Taviani, Giovanni Marcora ed Enrico
Mattei e Giuseppe Alessi. Nacque così la Dc che elesse come simbolo lo storico
scudo crociato scelto da Sturzo e finito al Cdu con la scissione del ’95.
Ricostruire la geografia attuale del cattolicesimo politico vuol dire
ripercorrere tutta la storia della Seconda Repubblica. Una frammentazione che ha
portato, dalla crisi dei primi anni Novanta, alla nascita di una miriade di
sigle confluite poi in partiti più grandi. La prima scissione all’assemblea di
scioglimento del 1994. I Cristiano Sociali di Ermanno Gorrieri e Dario
Franceschini scelsero di andare a sinistra con il Pds di Occhetto. Rinacque il
Partito popolare italiano, da cui si staccò anche il Centro cristiano
democratico (nato il 18 gennaio 1994, nell’anniversario dell’appello ai liberi e
ai forti di Sturzo, che avviò subito contatti con Silvio Berlusconi) di Pier
Ferdinando Casini e Clemente Mastella (che nel 1999 fonderà l’Udeur dopo una
ennesima scissione). Il Ccd rimase in vita fino al 2002 quando fondendosi con il
Cdu divenne Udc. Nel 1995 un nuovo trauma, con la frattura tra il Ppi (simbolo
«gonfalone») e il Cdu di Rocco Buttiglione che tenne lo scudo crociato. Nodo del
contendere le alleanze: il Ppi nel 1994 si presentò alle politiche da solo, poi
la rottura con Buttiglione che scelse l’alleanza con Berlusconi e i popolari di
Gerardo Bianco con Prodi nel 1996. Il nuovo Ppi del gonfalone, incardinato
nell’area dei centrosinistra, restò in vita fino al 2002 quando si sciolse nella
Margherita di Francesco Rutelli e poi confluì nel Partito democratico. Nel
frattempo nascevano nuovi movimenti parademocristiani: la Dc di Flaminio Piccoli
(1997-2002), i Cristiani Democratici per la Repubblica, i Cristiani Democratici
per la Libertà di Roberto Formigoni (1998-2001), il Partito Democratico
Cristiano di Giovanni Prandini (2000), la Dc di Giuseppe Pizza (2002-2013), la
Dc di Angelo Sandri (2004), la Dc per le Autonomie di Gianfranco Rotondi (2005),
Rinascita Popolare di Publio Fiori (2006), la Federazione dei Cristiano Popolari
di Mario Baccini (2008-2013), i Popolari Liberali di Carlo Giovanardi (2008),
l’Alleanza di Centro di Francesco Pionati (2008), la Dc di Gianni Fontana
(2012), il nuovo Cdu di Mario Tassone (2012), la Dc di Annamaria Ciammetti
(2014). Nel frattempo il patrimonio della Dc, circa un miliardo di euro tra
soldi e immobili, svaniva con la scissione tra Ppi e Ccd prima e tra Ppi e Cdu
poi. Gli immobili (circa 120 in tutta Italia di cui 7 a Roma, 9 nella sua
provincia, 5 a Firenze, 6 a Trieste, 5 ad Arezzo, 4 a Bologna e altrettanti ad
Ancona) venivano conferiti a quattro società immobiliari (tra cui la Ser Spa e
l’Immobiliare Spa). Alcuni furono venduti, altri addirittura finirono a
improbabili personaggi in Croazia. Di debiti e contributi elettorali non c’è più
traccia nei bilanci dei partiti. Così come del patrimonio immobiliare. Padre
Bartolomeo Sorge, storico direttore de La Civiltà Cattolica, ebbe a dire nel
1992: «Se dovesse fallire l’ennesimo tentativo di rinnovamento della DC, dalla
tradizione cattolico-democratica gemmerà spontaneamente, come partito rinnovato,
il vero Partito popolare di Sturzo». Una previsione ottimista finita in diaspora
e tesori scomparsi. Daniele Di Mario
LA SANTIFICAZIONE DI ALDO
MORO.
Aldo Moro, avviato il
processo di beatificazione,
scrive il 29 settembre 2016 "Blitz Quotidiano". La notizia è stata diffusa, in
diretta da Radio Vaticana, dall’avvocato Nicola Giampaolo, promotore della causa
di beatificazione di Aldo Moro: il “supplice libello sulla fama di santità”, il
documento d’avvio della causa, è stato accolto dal tribunale della diocesi di
Roma. La causa di beatificazione è iniziata quattro anni fa: era il settembre
2012. Secondo l’avvocato Nicola Giampaolo, ad appoggiare la causa, oltre alla
primogenita di Moro, Maria Fida, c’è anche il giudice Ferdinando Imposimato,
all’epoca giudice istruttore del processo Moro. Come ricorda Antonio D’Anna di
Italia Oggi, qualche mese fa la causa ha rischiato di arenarsi. «Colpa», si fa
per dire, della Commissione d’inchiesta sul caso Moro guidata da Giuseppe
Fioroni. Che nel marzo 2015 ha sentito l’arcivescovo Antonio Mennini, Nunzio
apostolico (ambasciatore vaticano) a Londra e confessore di Moro, autorizzato da
Papa Francesco a farsi interrogare. Tema dei quesiti: Mennini incontrò o no lo
statista scudocrociato durante la sua prigionia nel 1978, per giunta
confessandolo? La risposta fu lapidaria: «Io purtroppo non sono mai stato nella
prigione di Aldo Moro, né ho confessato il presidente». Ma aggiunse: «La stessa
signora Moro commentò con me che se ciò fosse davvero accaduto sarebbe avvenuto
tramite un amico di questi mascalzoni». Un prete vicino ai Br? E chi? Polemiche
a non finire e Giampaolo costretto a chiedere a tutti di calmare le acque
temendo che la causa potesse subire uno stop. Adesso c’è da capire su quale base
si continuerà nel cammino di beatificazione. Le strade sono due. Aldo Moro potrà
diventare Beato perché martire o per qualche miracolo a lui
attribuito. Secondo Andrea Venezia, canonico della basilica di San Giovanni in
Laterano “la sua fine fu anche la conclusione di una testimonianza ed è per
questo che nel suo caso possiamo parlare di martirio”. Nel secondo caso – scrive
ancora Antonio D’Anna di Italia Oggi – “il miracolo potrebbe esserci. Sempre nel
2012 la Gazzetta del Mezzogiorno ricordò quanto accaduto a monsignor Francesco
Colasuonno, tra il 1974 e il 1981 Delegato Apostolico in Mozambico. Quando
attorno al 1980 la Nunziatura in cui risiedeva venne presa d’assalto da un
gruppo di guerriglieri, egli si rinchiuse in una stanza nella quale c’era una
foto di Moro e si mise a pregarlo, salvandosi. Da allora lo considera il suo
Santo”.
"Aldo Moro Santo":
l'annuncio da Carlentini e Sortino: "l’avvio del processo di Beatificazione e
Canonizzazione è vicino",
scrive il 2 Ottobre 2016 "Siracusa News". "Se i politici cercano un santo cui
votarsi, forse tra non molto lo avranno davvero: per Aldo Moro, lo statista
democristiano ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978, dopo 55 giorni di
prigionia, presto, dopo la consegna dei documenti e firme per la “fama di
santità” potrebbe aprirsi il processo vero e proprio che si aprirà dopo il
nullaosta della Conferenza episcopale. Una data precisa ancora non c’è, ma siamo
vicini". Lo ha detto il dottore Nicola Giampaolo, il postulatore che da quattro
anni, per conto del Vaticano, coordina la raccolta delle testimonianze per la
beatificazione e canonizzazione dello statista della Democrazia cristiana,
giovedì e venerdì in Sicilia a Sortino e Carlentini in occasione della
presentazione del libro “Aldo Moro, un cristiano verso l’altare” per Giuseppe
Laterza editore. I due eventi sono stati promossi e organizzati dall’Unione
cattolica della Stampa Italiana, sezione di Siracusa con il sostegno
dell’associazione “Argomenti 2000”, il patrocinio dei comuni di Carlentini,
Sortino, di Radio Una Voce Vicina e del settimanale cattolico “Cammino” di
Siracusa. Nella due giorni in Sicilia, il postulatore accreditato alla Santa
Sede Nicola Giampaolo ha partecipato, giovedì mattina, a Lentini alla
celebrazione eucaristica nella chiesa dell’Immacolata presieduta dal Rettore don
Enzo Salemi, canonico dell’ex cattedrale di Lentini. Nel pomeriggio a Sortino,
nella sala conferenze del convento dei Cappuccini l’incontro con il postulatore
moderato dalla giornalista Pia Parlato. “Per noi è un momento intenso di storia
e di ricordi – ha detto il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato – parlare di Aldo
Moro, uomo, politico e padre di famiglia. Aldo Moro è stato nel nostro paese
negli anni settanta quando l’allora sindaco Mario Giardino lo ospitò in un
momento intenso di confronto politico”. Nicola Giampaolo, venerdì mattina, ha
incontrato l’arcivescovo di Siracusa monsignor Salvatore Pappalardo con il quale
ha avuto un lungo colloquio privato. Nel pomeriggio a Lentini, in piazza Aldo
Moro, davanti alla lapide che ricorda il 34 anniversario della scomparsa, alla
presenza del sindaco Saverio Bosco ha deposto un mazzo di fiori. Alla sobria
cerimonia hanno partecipato l’onorevole Luigi Boggio, il comandante della
polizia municipale Alfio Vacanti e l’ex presidente del Consiglio comunale ed ex
assessore Salvatore Di Mari. A Carlentini è stato ricevuto dal sindaco Giuseppe
Basso, dal vice sindaco Angelo Ferraro, dal presidente del consiglio Salvatore
Genovese a Palazzo di Città. Poi nell’aula consiliare la presentazione del
libro, moderato dalla giornalista Maria Chiara Catalano e la relazione del vice
presidente diocesano dell’Azione cattolica Alfio Castro, docente di Storia e
Filosofia al liceo “Megara” di Augusta e del giornalista Luca Marino. Poi la
testimonianza del sindaco Giuseppe Basso su Aldo Moro. “Dopo il nulla osta del
cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa, che ha proclamato Moro servo di
Dio - ha detto Nicola Giampaolo - in breve tempo il presidente del Tribunale
diocesano di Roma, sede competente perché lì s’è svolta la tragica vicenda, ha
introdotto la causa, acquisendo gli atti del supplice libello sulla fama di
santità. Alla raccolta di firme per la “fama di santità” di Moro hanno d’altra
parte aderito 50 vescovi e 25 cardinali, oltre a personalità del mondo civile e
politico, soprattutto di matrice democristiana ma non solo. Lo statista Dc,
quindi, si avvicinerebbe il momento in cui verrà proclamato beato. Ma anche
martire, perché caduto, addirittura, in odio alla fede cristiana. E questo è un
passaggio molto importante, che attribuisce alla figura di Moro uno spessore
ancor più evidente. Del resto, non bisogna dimenticare che la figura e la
vicenda di Moro, con tutta la loro tragicità, ma anche grandezza rientrano nel
terzo segreto di Fatima”. E poi c’è la presa di posizione dei vescovi, per i
quali andrebbe dichiarata l’opportunità della causa per la beatificazione di
Moro come “modello di vita per la politica italiana. Per la beatificazione
occorre un miracolo, o una grazia. Non però se si parla di martirio, come nel
caso di Moro. I miracoli ci sono, li metteremo in campo per la canonizzazione”,
per quando cioè si tratterà di fare un ulteriore passo in avanti verso la
santità di Moro. Le segnalazioni non mancano, come quella di un presunto
miracolo, una guarigione. Un altro requisito è quello di una fede cristiana e
cattolica forte e inconfutabile, e ciò spiega perché sia stato già aperto un
analogo procedimento nei confronti di Giorgio La Pira e Alcide De Gasperi in
fama di virtù, per il giurista Vittorio Bachelet, come Moro giustiziato dalle
Br, s’è in attesa del nulla osta. Aldo Moro assieme a Paolo VI fu protagonista
del disegno, poi realizzato compiutamente da Giovanni Paolo II, di un
allargamento della fede alla Russia e a tutti i Paesi dell’Est europeo. Risiede
qui la ragione profonda del suo assassinio. E la Populorum progressio è
l’Enciclica più politica fatta da Paolo VI, si vocifera che la parte iniziale
sia stata redatta proprio da Moro. “Abbiamo – ha detto il presidente dell’Ucsi
di Siracusa Salvatore Di Salvo – contribuito a far conoscere, tramite il
postulatore, la figura di Aldo Moro, comunicatore, uomo, cristiano, padre di
famiglia, in questo momento che l’avvio del processo di Beatificazione e
Canonizzazione del Servo di Dio Aldo Moro è vicino”.
FRANCESCO COSSIGA.
In ricordo del Presidente
Francesco Cossiga.
Stefania Craxi su Il Corriere del Giorno 17 Agosto 2019. Il 17 agosto di 9 anni
fa veniva a mancare Il Presidente Francesco Cossiga. La senatrice Stefania Craxi
lo ricorda con questo testo, uscito come speciale per l’Adnkronos. La Fondazione
Craxi pubblica nel giorno in cui si celebra il nono anniversario della morte di
Francesco Cossiga, una lettera inedita, custodita nei suoi archivi, che il
leader socialista Bettino Craxi scrisse all’allora presidente del Consiglio
durante gli anni del suo esilio ad Hammamet. A quasi un decennio dalla sua
scomparsa, Francesco Cossiga resta una delle figure di maggior spessore politico
e di altro profilo istituzionale della nostra storia repubblicana. Una
personalità enigmatica, le cui scelte e decisioni sono state spesso di difficile
lettura, a tratti incomprensibili, e mai definitive. Era anche questa una delle
cifre caratterizzanti del rapporto con Bettino Craxi. Dalle dimissioni
anticipate dalla Presidenza della Repubblica alle oscure vicende di
“Tangentopoli“, passando alla sua mutevole relazione con il “giudice” e il
“politico” Di Pietro – senza tralasciare le vicende degli anni ’80 come
Sigonella, in cui i due gestirono la vicenda l’uno dal Quirinale l’altro da
Palazzo Chigi – sono molti i momenti che congiungono due personalità diverse ma
con sensibilità comuni. Su tutto, basti pensare al tema delle riforme
istituzionali che mai come in questi giorni, segnati da una crisi che più di
governo potremmo definire l’ennesima crisi di sistema, si presenta come
questione aperta. Infatti, dopo il saggio “VIII legislatura” vergato
da Craxi sulle colonne de “L’Avanti” nel settembre del 1979 in cui il leader
socialista invocava una "grande riforma" che abbracciasse insieme l’ambito
istituzionale, amministrativo, economico-sociale e morale, fu proprio Cossiga a
recuperare con forza il tema delle riforme in un messaggio alle Camere del
giugno ’91. È sufficiente rileggersi le cronache del tempo per comprendere il
clamore, l’isolamento e la portata riformatrice di quel messaggio presidenziale
che evidenziava la necessità, un anno e mezzo dopo la caduta del muro di
Berlino, di adeguare il dettato costituzionale, specie alla vigilia del varo di
Maastricht. Cossiga come sappiamo fu bersagliato e isolato. Il suo messaggio
trovò di fatto, non a caso, il solo Craxi come sostenitore, vista la freddezza
di una parte della DC e, addirittura, la richiesta di messa in stato di accusa
da parte del PCI. Ma quell’atto presidenziale resta ancora oggi un punto di
riferimento, poiché ha il merito di indicare le principali direttrici di una
‘vera’ riforma costituzionale: dalla forma di governo al ruolo delle autonomie,
passando per la disciplina dell’ordine giudiziario, ai nuovi diritti di
cittadinanza, fino agli strumenti di finanza pubblica che, tra l’altro, da lì a
poco le norme europee avrebbero radicalmente modificato. Il messaggio resta
quindi, oggi come ieri, un prezioso vademecum per le riforme’, ignorato quanto
utile, anche perché individuava le procedure possibili ed alternative, seppur
rispettose del 138, per una revisione organica della Carta. Altro che le riforme
"un tanto al chilo" di cui si parla oggi! Ma, il rapporto tra Craxi e Cossiga
continuò, tra diversità e comunanze di vedute, anche dopo la "falsa rivoluzione"
di "Mani pulite" e negli anni dell’esilio tunisino. Craxi si chiese spesso il
perché di quelle dimissioni anticipate dalla Presidenza che, guardate a
posteriori, cambiarono e influirono molto sugli accadimenti successivi. Viste i
suoi legami internazionali e la nuova geopolitica che si schiudeva, era
conoscenza di qualcosa? Viveva un altro dei suoi contrasti interni come negli
anni del delitto Moro? Molto c’è ancora da capire e su molto c’è ancora da
indagare e studiare. Ad ogni modo ricordo la sua visita ad Hammamet pochi mesi
prima della morte di Bettino. È un incontro che ancora oggi mi emozione modi e
intensità. Fu un pranzo tra due vecchi amici, con poche parole e molti sguardi,
un incrocio tra due combattenti, duri e franchi, con due stili diversissimi, con
alcune domande di Bettino e alcuni silenzi di Cossiga. Fu proprio l’ex
Presidente a chiedere in quella occasione a Craxi di raccontare la verità sulla
vera natura del finanziamento irregolare del PSI e sul suo principale impiego,
ossia il sostengo a quanti, da Est a Ovest, in Medioriente come in Sudamerica,
lottavano per la democrazia e la libertà. Ma in quella circostanza la
perseveranza di Cossiga non ebbe la meglio. Craxi gli rispose che non avrebbe
mai e poi mai mischiato le cause di libertà di mezzo mondo con le miserie
italiane. Chissà, nell’opportunismo e nella confusione delle contingenze,
nell’incapacità di leggere e agire nel quadro internazionale, quanti sarebbero
oggi coloro disposti a farlo! Nel giorno in cui si celebra il nono anniversario
della morte di Francesco Cossiga, la Fondazione Craxi pubblica una lettera
inedita, custodita nei suoi archivi, che il leader socialista scrisse all’allora
presidente del Consiglio durante gli anni del suo esilio ad Hammamet.
La lettera di Bettino Craxi a
Francesco Cossiga. “Caro Presidente, mi auguro che tu stia bene e leggo con
piacere ciò che scrivi a proposito di questa Araba Fenice chiamata ‘riforma
costituzionale’. Leggo però anche cosa scrivi riguardo a Di Pietro: ‘Poveretto
ha tanti guai. Lasciate in pace Di Pietro’. Ti confesso che sin dall’inizio non
ho mai capito la tua posizione a proposito di questo signore. Mi sono chiesto
tante volte a che cosa fosse dovuta” si legge nell’incipit della missiva. Gran
parte della lettera è dedicata all’ex pm di Mani pulite, definito un
“avventuriero” ma l’ex leader del Psi assicurava a Cossiga: “In ogni caso non
starò zitto io. Sino ad ora subendo quello che ho subito e subisco, ivi compresa
una sentenza della Cassazione che si è messa sotto i piedi anche una pronuncia
chiarissima della Corte Costituzionale, senza che un’ombra di costituzionalista
levasse una parola di protesta, mi sono imposto una condotta di estrema
responsabilità. Aspetto ancora con pazienza una soluzione politica”. “Se non
verrà e se mi convincerò che è inutile farsi illusioni –
proseguiva Craxi – credo che la mia reazione, peraltro molto documentata, non
mancherà, e renderà un buon servizio all’Italia e alla storia. Quanto al Di
Pietro, come un suo libro, certo non scritto da lui, non meritava una tua
prefazione, la sua attuale situazione non merita proprio quello che dici. Io mi
auguro ancora che tu stesso riprenda il tema della ‘operazione verità’ di cui si
è parlato e si parla. Ricordo, di tanto in tanto, i tempi passati e ti invio un
fraterno saluto. Bettino Craxi”.
Br, l'intervista a Cossiga
del 2003: "Terroristi come partigiani".
Le Iene 20 gennaio 2019. Dopo il caso Battisti e la nostra intervista all'ex
brigatista latitante Alvaro Lojacono, vi riproponiamo una nostra intervista del
2003 all'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga sugli "anni di
piombo". Dopo la cattura e l’estradizione di Cesare Battisti e la nostra
intervista all’ex brigatista Alvaro Lojacono (scovato e intervistato da Gaetano
Pecoraro in Svizzera, dove è latitante, mentre in Italia è stato condannato
all’ergastolo), ci sembra importante riproporre questa nostra intervista del
2003 all’ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Cossiga, nemico
giurato dei terroristi rossi, si era fatto promotore di un’iniziativa per
l’amnistia sugli anni di piombo. Sulla base di un concetto, a cui fa riferimento
lo stesso Lojacono e che l’ex Capo dello Stato, scomparso nel 2010, ribadisce
anche davanti alle nostre telecamere: “Fu il tentativo di innescare una guerra
civile: chi combatté lo fece non con l’animo del terrorista ma con l’animo del
partigiano”.
Cesare Lanza per “la Verità”
il 2 ottobre 2019. Tutto cominciò quando dirigevo La Notte, alla fine degli anni
Ottanta. Mi urtavano i continui attacchi, le perfidie, le malizie e i sottintesi
da cui Francesco Cossiga - presidente della Repubblica - era tormentato: in
particolare le allusioni alla sua salute mentale. L' intento dei suoi critici
era evidente, a volte esplicito, dichiarato: indurlo alle dimissioni. E così un
giorno scrissi un fondino, per esprimergli simpatia e stima. Non ricordo con
precisione il contenuto del mio breve articolo, ma il titolo sì, che mi inventai
lì per lì: «Uno, due, dieci, cento, mille Cossiga». In breve sostenevo che un
uomo come Cossiga bisognava tenerselo caro, e peccato che non ce ne fosse un
migliaio di altri simili, nella vita politica del nostro Paese. Cossiga mi
ringraziò con una formula affabile, ma convenzionale: pensai che non fosse di
suo pugno, sapevo che aveva l' abitudine di scrivere biglietti estrosi,
bizzarri, spontanei. Non avevo avuto questo onore, e invece nacque un rapporto
reciprocamente corretto e cortese, oserei dire amichevole. Qualche volta andai a
trovarlo al Quirinale, gli attacchi contro di lui non erano affatto cessati,
anzi l' accanimento era diventato più feroce. Una volta gli chiesi: «Cosa
avresti fatto al posto di Leone, quando i delegati del Pc e della Dc gli
chiesero, o ingiunsero, di dimettersi?». Cossiga replicò con uno sguardo
beffardo e disse: «Semplice, avrei chiamato i carabinieri!» (Leone invece,
sgomento, si dimise subito e lasciò il Quirinale. Era innocente di fronte a
tutte le accuse che gli erano rivolte, ma cedette alla arrogante violenza degli
alleati comunisti e democristiani). In seguito, lessi risposte più o meno uguali
di Cossiga, quando gli rivolsero una domanda come la mia. Il Presidente però non
ebbe mai la necessità di chiamare i carabinieri. Leone era un personaggio
timido, uno studioso estraneo ai veleni della politica. Cossiga aveva un
carattere forte, risoluto, sbeffeggiava perfino i suoi avversari. Era detestato,
ma temuto. Qualche anno dopo commisi un errore professionale molto grave.
Lasciai La Notte, dove mi trovavo benissimo anche se i popolari giornali del
pomeriggio erano destinati a sparire, e accettai un' offerta principesca di un
finanziere temerario e spregiudicato, Gianmauro Borsano. Si trattava di fondare
e dirigere un nuovo giornale, La Gazzetta del Piemonte, nelle sue intenzioni
erede di un quotidiano, La Gazzetta del Popolo, molto amata non solo a Torino, e
purtroppo scomparsa, da tempo, dalla scena. Borsano aveva acquistato la squadra
del Torino e astutamente, conoscendo la mia passione per il calcio, mi offrì la
vicepresidenza, per superare le mie esitazioni. Per mia fortuna l' incarico non
fu mai formalizzato: in seguito infatti tutti i consiglieri di amministrazione
furono indagati, coinvolti - a prescindere - dai disastri che Borsano aveva
combinato. Portai Borsano con me al Quirinale e fummo accolti con cordialità,
alla vigilia dell' uscita della Gazzetta. Chiesi a Cossiga di promettermi di
farci visita a Torino, in redazione, e lui me lo promise. Sinceramente, non me
l' aspettavo. E invece, promessa mantenuta! Qualche settimana dopo, il Quirinale
ci inserì nel quadro di una visita di Cossiga a Torino: c' eravamo noi, un
giornalino neonato, e non c' era La Stampa, uno dei più grandi quotidiani
italiani, di proprietà della famiglia Agnelli! Con Cossiga non ne parlai mai, ma
intuii il retroscena: il risentimento che nutriva verso il grande giornale
torinese, che non gli risparmiava critiche pungenti e frecciate. Ad accogliere
il Presidente c' erano non solo i giornalisti e tutto il personale della
Gazzetta, ma anche tutti i calciatori del Torino e il loro allenatore, Emiliano
Mondonico. Devo dire che l' esperienza con la Gazzetta fu tormentosa e infelice,
ma con il calcio mi divertii moltissimo: quarto posto in campionato e
finalissima in Coppa Uefa (oggi Europa League): risultato mai più raggiunto
dalla gloriosa squadra granata.
La visita di Cossiga si svolse
secondo tradizione. Fotografie, discorsi, scambi di regali...Ma c' è un episodio
che merita di essere ricordato, per il divertimento dei lettori. All' arrivo di
Cossiga, un suo timido ammiratore, agricoltore ad Alba, si era fatto avanti e
aveva offerto al Presidente un gigantesco cesto di tartufi. Cossiga aveva
ringraziato e benignamente aveva fatto cenno a un suo collaboratore di posare
quel ben di Dio sul mio tavolo... Dopo un' ora, finita la visita, Borsano e io,
insieme con la scorta, avevamo accompagnato il Presidente fino alla sua
automobile. Tornai nel mio ufficio e notai subito che i tartufi erano spariti.
Chiesi alla mia segretaria... «Direttore, è arrivato Borsano di corsa e se li è
portati via!». L' attrazione che Cossiga esercitava su di me era incentrata, tra
altri aspetti, sulla sua meravigliosa qualità di esprimersi controcorrente,
secondo i casi con audacia e impertinenza, sempre con ironia. Una volta mi disse
che la strage di Bologna era nata da un fortuito incidente, gli attentatori non
avevano l' Italia nel mirino. Mi ero abituato a credere a tutto ciò che diceva,
a rispettare battute e rivelazioni. Perciò scrissi tranquillamente di ciò che mi
aveva detto. Nessuna reazione. C' erano argomenti di cui il nostro mondo
preferiva non occuparsi. E fu così anche, tranne qualche eccezione, quando fu
pubblicato un suo straordinario libro, La versione di K. Sessant' anni di
controstoria (Rizzoli, Rai Eri). «Anche se talvolta misteri inestricabili si
sono addensati in alcuni passaggi della vicenda italiana - scriveva - la mia
impressione è che ormai nessuno creda più alla realtà così come è. E dunque c' è
sempre una seconda realtà da ricercare. Non credo che sia un principio
sbagliato, e non posso certo dirlo io che ancora non ho smesso di scavare,
chiedere, provocare. Ma aspirare sempre alla quadratura del cerchio fa sì che
spesso ombre riottose sfidino le leggi della percezione e affollino impazzite la
scena fino a oscurarla del tutto». Come dire: attenzione che le cose sono più
semplici di come si crede, ma proprio perché sono semplici non vogliamo crederci
e andiamo alla ricerca del retroscena e del mistero, infilandoci in un tunnel
senza via d' uscita. È così che la verità, a portata di mano, finisce per
allontanarsi per sempre.
Tragedie come Ustica, Piazza
Fontana, il caso Moro, la strage di Bologna, andrebbero rilette senza frequenti,
artificiosi scenari dietrologici. Molte facili convinzioni e vecchie
ricostruzioni giornalistiche, e persino giudiziarie, potrebbero mostrare tutta
la loro inconsistenza. Cossiga: «Ci si accanisce sulla strage di Bologna, si
chiedono a gran voce giustizia e verità. Capisco. Come potrei non capire il
vuoto e la disperazione prodotti da quell' esplosione del 2 agosto 1980?
Ottantacinque morti, oltre 200 feriti: un bilancio insopportabile. Ma perché non
credere a Giusva Fioravanti e a Francesca Mambro che si dicono innocenti per
quello che è successo a Bologna, pur dichiarandosi responsabili di altri atti
criminali? [] Per me fu un incidente, un drammatico incidente di percorso. Una
bomba trasportata da terroristi palestinesi che non doveva essere innescata in
quell' occasione e che invece, chissà perché, per un sobbalzo, una minaccia, un
imprevisto, scoppiò proprio in quel momento». Questa audacia di analisi, mi
attrae. Cossiga offre anche una interessante rilettura del rapporto
mafia-politica, di quella contiguità fra Cosa nostra e la Democrazia cristiana
siciliana della quale «molto si è detto e molto si è immaginato. Forse troppo».
Argomento di grandissima attualità. La ricostruzione di Cossiga parte dallo
sbarco alleato in Sicilia, e arriva alle prime elezioni amministrative, per
ricordare ai troppi che lo hanno dimenticato che la mafia si presentava come
apertamente antifascista e fece convergere i voti sulla più antifascista delle
forze politiche: il Partito comunista. La circostanza mise in allarme i
moderati. Allora, ecco Cossiga: «Fu il cardinale Ernesto Ruffini, arcivescovo di
Palermo, a mettere in guardia la Dc. "Se volete i voti dovete andare a cercare
quelli lì" disse. E con "quelli lì" intendeva i mafiosi. L' ingrato compito
toccò a Bernardo Mattarella, vicepresidente dell' Azione cattolica». Cossiga è
convinto che non esistano «politici mafiosi», mentre «esistono uomini vicini
alla mafia, collusi, ma non mafiosi». La spiegazione: Cosa nostra può ammettere
nelle sue fila professionisti, medici, avvocati, ma non politici, rappresentanti
cioè di un altro potere organizzato. Cossiga tante volte mi ha detto quanto sia
impervio spazzare via i «luoghi comuni». Sia per pigrizia, comunque sono duri a
morire. E concordo con chi ha scritto che nei libri «forniva il suo punto di
vista, la sua visione sui cosiddetti "misteri italiani". In troppi, superficiali
e altezzosi, lo liquidarono come "le solite cose del picconatore"».
Eppure cose da leggere e
rileggere. E proprio in omaggio a Cossiga, uno che di intelligence se ne
intendeva, va proposto ai lettori questo scritto, uno degli ultimi. «L' Italia
dei misteri. O forse l' Italia senza misteri. Siamo abituati da sempre a cercare
un grande burattinaio, anzi "il grande vecchio", dietro spezzoni della nostra
storia, dietro le tragedie che hanno travagliato il nostro Paese, dal dopoguerra
a oggi. [...] Il fatto è che nessuno fino a oggi ha saputo dare una risposta a
domande-chiave: perché l' Italia dal 1969 è stata funestata dal terrorismo e
dalla violenza politica con centinaia di morti e migliaia di feriti? Perché le
inchieste giudiziarie hanno dato finora molta importanza al ruolo dei Servizi
segreti definiti "deviati", della P2, della Cia, con il risultato di non
approdare ad una verità giudiziaria e ad una verità storica condivisa? Forse è
ancora presto per parlare di Storia, in un Paese che non ha ancora superato il
trauma e la lacerazione dell' 8 settembre e soltanto adesso comincia a fare i
conti con il Risorgimento».
Cossiga, le lettere agli ex
Br: “Ormai la giustizia contro di voi è vendetta”.
Alice De Gregoriis su
meteoweek.com il 7 agosto 2020. Il Corriere pubblica stralci di lettere segrete
tra Cossiga e gli ex Brigate Rosse. Tra i nomi al centro della corrispondenza
epistolare: Renato Curcio, Toni Negri, Prospero Gallinari, Paolo Persichetti e
Fabrizio Melorio. A Paolo Persichetti, ad esempio, scrive: “Ormai la cosiddetta
giustizia che si è esercitata e ancora si esercita verso di voi, anche se
legalmente giustificabile, è politicamente o vendetta o paura”. Siamo nel 1992,
precisamente il 25 novembre, nel carcere di Rebibbia: l’ormai ex presidente
della Repubblica Francesco Cossiga incontra Renato Curcio, uno dei fondatori
delle Brigate Rosse. L’incontro tra i due avviene l’anno dopo il tentativo di
Cossiga di concedere la grazia a quello che lui stesso definiva “un sovversivo
di sinistra”. Un tentativo non andato a buon fine. Durante il colloquio, tra i
tanti temi toccati (come il caso Moro), Cossiga spiega che quell’atto di
clemenza (fallito) doveva rappresentare un primo passo verso il superamento di
leggi di emergenza alla cui creazione lui stesso aveva partecipato. Ma quella
manovra raccolse l’opposizione dei parenti delle vittime e di alcune forze
politiche, come l’ex Pci. A fornire i dettagli dell’incontro, riportati dalle
parole degli stessi partecipanti, sarebbe un resoconto conservato nell’archivio
privato del presidente emerito, oggi riportato dal Corriere. Nel resoconto
Curcio avrebbe scritto: “Il senatore Cossiga ha commentato che, in effetti, la
nostra esperienza, per molti di quel partito, rappresenta ciò che essi hanno
segretamente desiderato e mai apertamente osato fare“. Poi ancora: “Ho sentito
la nostra stretta di mano come segno di una nuova maturazione personale… Il
colloquio mi ha lasciato una visione più chiara dei sentieri percorsi e anche di
me stesso, e di ciò le sono grato”. Ma Cossiga non avrebbe intrattenuto rapporti
epistolari esclusivamente con Curcio. A dimostrarlo è il suo archivio donato
alla Camera dei deputati. Tra gli altri brigatisti al centro dello scambio di
lettere ci sarebbero anche: Prospero Gallinari, Mario Moretti e Germano Maccari,
e anche esponenti dell’Autonomia operaia fuggiti in Francia come Toni Negri.
Significativa la lettera che Cossiga scrisse a Prospero Gallinari, ex carceriere
di Moro. Gallinari fu scarcerato per motivi di salute, e subito arrivarono gli
auguri di Cossiga: “Sono lieto che Lei sia rientrato a casa e formulo gli auguri
più fervidi per una vita normale e serena”. Importante anche la lettera che nel
2002 Cossiga invia a Paolo Persichetti, ex Udcc appena estradato dalla Francia e
arrestato: “Ormai la cosiddetta giustizia che si è esercitata e ancora si
esercita verso di voi, anche se legalmente giustificabile, è politicamente
o vendetta o paura, come appunto lo è per molti comunisti di quel periodo, quale
titolo di legittimità repubblicana che credono di essersi conquistati non col
voto popolare o con le lotte di massa, ma con la loro collaborazione con le
forze di polizia e di sicurezza dello Stato”. Non manca anche qualche lettera a
Fabrizio Melorio, che partecipò all’omicidio del generale Licio Giorgieri.
Cossiga scrive: “Ho letto con attenzione, trepidazione e commozione la sua
lettera… perché in fondo mi sento anche un po’ ‘colpevole’ della Sua prigionia,
essendo stato uno di quelli che hanno combattuto quella guerra, e per di più per
essermi trovato dalla parte dei vincitori”.
Giovanni Bianconi per il
“Corriere della Sera” il 9 agosto 2020. Un anno dopo il fallito tentativo di
concedergli la grazia nell'estate 1991, l'ormai ex presidente della Repubblica
Francesco Cossiga incontrò Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate rosse.
Il colloquio avvenne a quattr' occhi, nel carcere romano di Rebibbia, il 25
novembre 1992, quando Cossiga aveva lasciato il Quirinale da sei mesi. Parlarono
di molte cose, dal «carattere sociale e politico del fenomeno armato», che l'ex
capo dello Stato non definiva terrorismo bensì «sovversivismo di sinistra», al
caso Moro, alla vicenda della grazia abortita. Cossiga spiegò che nelle sue
intenzioni quell'atto di clemenza unilaterale doveva essere un primo passo per
superare le leggi di emergenza a cui lui stesso aveva contributo, prima da
ministro dell'Interno e poi da presidente del Consiglio, quando le Br avevano
lanciato il loro «attacco al cuore dello Stato». I vertici delle forze di
sicurezza erano d'accordo, ma i parenti delle vittime no, al pari di alcune
forze politiche; in primo luogo l'ex Pci divenuto Partito democratico della
sinistra. «Il senatore Cossiga ha commentato che, in effetti, la nostra
esperienza, per molti di quel partito, rappresenta ciò che essi hanno
segretamente desiderato e mai apertamente osato fare», ha scritto Curcio in un
resoconto dell'incontro conservato nell'archivio privato del presidente emerito.
Insieme e a un biglietto inviato al fondatore delle Br per ringrazialo
dell'incontro che «è stato per me di grande interesse politico, culturale, e
soprattutto umano». Risposta dell'ex brigatista: «Debbo dirle che dopo anni di
fuoco, non solo metaforico, e di K (nell'estrema sinistra il ministro
dell'Interno del '77 veniva chiamato Kossiga, con la doppia S stilizzata come il
simbolo delle SS naziste, ndr ), ho sentito la nostra stretta di mano come segno
di una nuova maturazione personale... Il colloquio mi ha lasciato una visione
più chiara dei sentieri percorsi e anche di me stesso, e di ciò le sono grato».
Curcio comincerà a uscire dal carcere solo l'anno successivo, in un periodo in
cui Cossiga (non più Kossiga bensì il «picconatore» del sistema di cui era stato
parte) ha intrattenuto rapporti epistolari e diretti con molti ex terroristi. In
prevalenza di sinistra, ma non solo. Nel suo archivio donato alla Camera dei
deputati, oltre al carteggio con Curcio ci sono le lettere inviate ad altri
brigatisti come Prospero Gallinari, Mario Moretti e Germano Maccari, militanti
dell'Unione dei comunisti combattenti, pentiti come Marco Barbone e l'ex di
Prima linea Roberto Sandalo, esponenti dell'Autonomia operaia fuggiti in Francia
per evitare il carcere, a cominciare da Toni Negri. Il quale, una volta
rientrato in Italia per finire di scontare la pena, si rivolse all'ex presidente
per chiedere una buona parola con un dirigente della Digos. Su sollecitazione di
Cossiga, in virtù di un'antica conoscenza personale e «come primo effetto della
reciproca smobilitazione ideologica», Negri gli dava del tu, e il 12 aprile
1998, giorno di Pasqua, gli scrisse per fargli gli auguri e «per chiederti di
intervenire eccezionalmente in mio favore». Dopo un primo diniego, il professore
detenuto aspirava a ottenere un permesso per «una brevissima vacanza», però
serviva che la polizia «dichiarasse insussistente, come in realtà è, il pericolo
di fuga». Così Negri s' era rivolto al presidente emerito: «Mi permetto di
insistere con te perché, se ti è possibile, tu faccia questo intervento. Ti
ringrazio fin d'ora per quello che potrai fare». All'ex carceriere di Moro
Prospero Gallinari, scarcerato per motivi di salute, Cossiga scrisse il 5 maggio
'94: «Sono lieto che Lei sia rientrato a casa e formulo gli auguri più fervidi
per una vita normale e serena». Aggiungendo il rammarico perché nell'ex Pci
c'era chi considerava le Br «uno strumento della Cia e della P2! Che vergogna e
che falsità, che viltà e che malafede! Ma non se la prenda. Se viene a Roma me
lo faccia sapere». In una lettera a Mario Moretti, il «regista» del caso Moro,
l'ex presidente lo ringrazia per il libro sulla storia delle Br scritto nel
1994, e ribadisce la sua idea di un fenomeno «radicato socialmente e
radicalmente nella società e nella sinistra italiana, e collegata alla divisione
ideologica dell'Europa». È per questa sua analisi che Cossiga, morto dieci anni
fa, è stato e continua ad essere pressoché l'unico politico apprezzato dagli ex
militanti della lotta armata di sinistra. Compresi i giovani aderenti alla
fazione brigatista che nel 1987 uccisero il generale Licio Giorgieri, come
Francesco Maietta e Fabrizio Melorio. «Le sue esternazioni hanno avuto per me lo
stesso effetto di rottura e di nuovo punto di partenza delle considerazioni del
professor De Felice in materia di fascismo e resistenza», gli scrive Maietta
dalla cella nel 1993; cinque anni dopo Cossiga sarà ospite al matrimonio dell'ex
brigatista, uscito dal carcere. E al suo compagno di cella Melorio, che all'ex
presidente aveva raccontato il passaggio dall'essere suo nemico giurato nel '77
a «condividere molte delle cose che lei sostiene», Cossiga confida: «Ho letto
con attenzione, trepidazione e commozione la sua lettera... perché in fondo mi
sento anche un po' "colpevole" della Sua prigionia, essendo stato uno di quelli
che hanno combattuto quella guerra, e per di più per essermi trovato dalla parte
dei vincitori». Nel 2002 il «picconatore» manda una lettera a Paolo Persichetti,
altro ex dell'Udcc appena estradato dalla Francia e chiuso in prigione: «Ormai
la cosiddetta "giustizia" che si è esercitata e ancora si esercita verso di voi,
anche se legalmente giustificabile, è politicamente o "vendetta" o "paura", come
appunto lo è per molti comunisti di quel periodo, quale titolo di legittimità
repubblicana che credono di essersi conquistati non col voto popolare o con le
lotte di massa, ma con la loro collaborazione con le forze di polizia e di
sicurezza dello Stato». In un altro faldone, insieme a documenti e atti
parlamentari e giudiziari sulla strage di Bologna di quarant' anni fa, sono
conservate alcune lettere inviate a Cossiga da Valerio Fioravanti e Francesca
Mambro, quando ancora erano sotto processo per la bomba alla quale si sono
sempre proclamati estranei. Dopo la condanna nell'appello bis, a luglio '94, gli
scrisse pure la mamma di Francesca Mambro: «Io e i miei figli Le chiediamo aiuto
per la ricerca della verità, perché chi è dalla parte della Giustizia si senta
anche dalla parte della difesa di Francesca e Valerio». Ma un anno dopo arrivò
l'ergastolo definitivo».
Paolo Guzzanti per “il
Giornale” il 25 luglio 2020. Gli sarebbe piaciuto. Il «Premio Cossiga per
l'Intelligence» promosso dalla Società italiana di Intelligence, assegnato al
prefetto Carlo Mosca dalla giuria presieduta da Gianni Letta, con vicepresidenti
Giuseppe Cossiga e Mario Caligiuri, lo avrebbe molto divertito. La prima
edizione si svolgerà in modalità virtuale il 17 agosto, in occasione del
decennale della scomparsa di Francesco Cossiga. Avrebbe voluto certamente
premiare lui il Prefetto Carlo Mosca, ma c'è suo figlio. L'ultima volta che lo
andai a trovare a casa sua, Cossiga era un po' malandato, ma mi avvertì subito
che il mio telefonino Sony non eravamo ancora agli smart e gli iPhone, era un
modello superato. La sua casa era piena di soldatini, di truppe sarde di piombo,
di carabinieri in alta uniforme, ma non era un museo, era piuttosto la casa di
un grande piccolo patriota. Quando mi chiamò per avvertirmi che avrebbe lasciato
il Quirinale, lo andai a trovare con la mia compagna di allora e il suo bambino
Andrea. A lui consegnò, con estrema solennità, la bandiera di combattimento: «A
te che rappresenti le nuove generazioni». Poi io lo seguii fino in Irlanda. Ma
la sua passione per i giocattoli dell'Intelligence era molto più di una mania da
collezionista. Cossiga aveva imparato già negli anni Cinquanta che cosa
significasse far parte dell'Intelligence Community, e per giunta di lingua
inglese. Non so quanto fluente fosse in inglese, ma lo capiva bene e scherzavamo
sul fatto che in inglese per dire «rapporto sessuale» si dica sexual
intercourse. Lo faceva ridere. Ma era un lettore scaltro di informazioni
diplomatiche e aveva protetto e difeso con le unghie e coi denti
l'organizzazione della Nato Stay behind (dietro le linee) che in Italia era
stata curiosamente ribattezzata «Gladio» ma che esisteva tale e quale in tutti i
Paesi della Nato. Era una organizzazione partigiana che si sarebbe dovuta
attivare nel caso di occupazione sovietica. Quello fu il suo vero war game che
finì malissimo quando Giulio Andreotti, presidente del Consiglio, consegnò le
chiavi dell'organizzazione segreta al giudice Casson, sicché tutto finì in
piazza e in uno scontro politico rovente. Come sardo, si sentiva più vicino agli
irlandesi che agli inglesi, ma era molto bravo nell'usare i codici, decifrare un
rapporto diplomatico e saper trattare le materie di intelligence anche con gli
ambasciatori. Ricordo la sua grande amicizia con l'ambasciatore sovietico e poi
russo Adamishin che gli dette informazioni essenziali sulla più grande
operazione di riciclaggio del tesoro sovietico di cui si occupò poi Falcone, non
più procuratore, ma suo delegato personale e subito prima di essere ucciso.
Cossiga mi diceva sempre che il suo vero maestro di Intelligence era stato Aldo
Moro: il criptico intellettuale e professore che si sentiva perennemente tenuto
d'occhio dal Kgb in Italia. Cossiga era il supervisore italiano del passaggio di
denaro fra Mosca e il Partito comunista italiano, come ministro o rappresentante
del governo, in compagnia di due agenti del Tesoro americano che controllavano
soltanto la genuinità dei dollari che da Mosca arrivavano a Roma e che Cossiga
(sue personali confidenze) faceva cambiare in lire alla banca dello Ior vaticano
(Istituti Opere Religiose) da Monsignor Marcinkus. Che non era proprio uno
stinco di santo. Conosceva perfettamente gli schieramenti di missili europei di
media gittata sovietici, gli SS20 e quelli di teatro americani Pershing e
Cruise. Adorava, letteralmente adorava gli avversari sovietici con un sentimento
che lo accomunava a John LeCarré: «Quei distinti signori che erano i grandi
comunisti di quei tempi», mi diceva. E poi, sì, c'era anche l'apparato giocoso:
le microspie, i rivelatori di microspie (gli portai un detector che avevo
comprato a New York che faceva molti ronzii quando lo accostavamo ai suoi muri,
cosa di cui era orgoglioso). Il suo amore possessivo per l'Arma dei Carabinieri
dipendeva anche dal fatto che i Carabinieri sono sia polizia militare che
civile, forza combattente e di intelligence, all'occorrenza polizia stradale.
Che è anche il motivo per cui i Carabinieri sono stati sempre molto apprezzati
anche dagli americani per le operazioni di peace keeping all'estero. Adorava le
uniformi, i gradi, le mostrine e mi regalò solennemente un maglione blu della
Marina militare che conservo come una reliquia. Non aveva per natura un
portamento militare, ma aveva una passione per la Storia e i suoi dettagli. Non
si trattava solo di soldatini di piombo, ma di combattenti cibernetici. Mi
regalò anche un grande album dell'intelligence con tutte le armi che si usavano
trent' anni fa, introvabile nelle librerie. Da vero uomo di intelligence,
ascoltava con piacere anche i pettegolezzi e si informava con curiosità dei
particolari piccanti delle relazioni amorose nel mondo politico. Aveva una
straordinaria collezione delle bandiere di combattimento di reggimenti e
divisioni del passato, ma anche lettere che certificavano la sua competenza
anche tecnica che gli permetteva di riconoscere una operazione mediatica da una
«fabbricazione» che è una sostituzione del falso con il reale. Sapeva molto di
più di quello che possiamo immaginare e tutti speriamo che abbia lasciato
scritto da qualche parte ciò che ancora ci manca per ricostruire quel che
accadde, come e agito da chi, perché e quando. Lui lo sapeva, Andreotti anche e
oggi il teatro politico è molto disadorno senza questi due personaggi.
Specialmente senza Cossiga.
Francesco Cossiga, un
cattolico liberale in un partito di affaristi.
Paolo Guzzanti de Il Riformista il 28 Febbraio 2020. Era ancora l’altra Italia,
quella precedente. Sì, c’era stato il muro di Berlino, molto rumore e accesi
dibattiti, ma ancora non si sapeva dove si sarebbe aperta la crepa. Un indizio
c’era, ma non andava molto oltre l’aspetto in apparenza buffo, aneddotico e
magari leggermente psichiatrico del solo fatto degno di nota: il signor
presidente della Repubblica in carica, Francesco Cossiga, che per anni se ne era
stato buono e tranquillo anzi invisibile e misterioso dietro le tende del
Quirinale, improvvisamente era diventato matto. Fu creato un verbo per indicare
le sue azioni verbali: «Esternava». Mandava all’esterno del suo corpo e della
sua mente ciò che vi albergava da tempo, represso come in un fucile ad aria
compressa. Da mite e ossequioso, istituzionale e quasi invisibile, si era fatto
aggressivo, e diceva che doveva togliersi i sassi che aveva nelle scarpe e
menava botte da orbi a destra e a manca, più a manca che a destra. Io ero appena
approdato a La Stampa diretta da Paolo Mieli, condirettore Ezio Mauro che sei
anni dopo sarebbe diventato direttore di Repubblica, da cui io provenivo dal
giorno della fondazione. Questa è la storia di come, per puro caso, diventai non
soltanto il confidente del presidente della Repubblica ma colui che, con pochi
altri, difese persino la sua follia e vide che – a parte qualche eccesso in
liquerizia e qualche compressa di litio – il primo cittadino era non soltanto
sano di mente, ma probabilmente vedeva più lontano di tutti gli altri. E che
aveva tirato l’allarme facendo suonare tutte le sirene e quasi sbandare il
convoglio istituzionale. Erano dunque i primi di gennaio del 1990, nei giorni in
cui ogni anno le singole Procure inaugurano l’anno giudiziario. Mi chiamò Ezio
Mauro e mi disse: «Perché non vai a Gela? Domani Cossiga inaugura l’anno
giudiziario e probabilmente farà il matto anche lì». Per puro caso la sera prima
era andata in onda, ma non lo sapevo, la registrazione di una puntata di Harem
di Catherine Spaak. In quella trasmissione Catherine mi aveva chiesto notizie di
mia figlia Sabina che muoveva i suoi primi e gloriosi passi nella satira
televisiva. Io non lo sapevo, ma Cossiga, che era un animale televisivo
informatissimo, sì. A Gela un servizio d’ordine poliziesco piuttosto brusco
aveva confinato la fastidiosa massa dei cronistacci e dei paparazzi in un
androne dell’ingresso, mentre la macchina del presidente della Repubblica e
della sua scorta arriva con stridore di gomme e luci lampeggianti. Io non avevo
mai visto Cossiga e dunque quando lo vidi dirigersi a passo di carica verso di
me, mi chiesi se ci fosse qualcosa di molto strano. Cossiga mi afferrò per un
braccio portandomi via dalla mischia, dicendomi col suo accento sardo che gli
raddoppiava tutte le consonanti: «Non sapevo che lei avesse una figlia attrice.
Mi sembra anche molto bella e molto brava». Capii allora che aveva visto la mia
intervista dalla Spaak e risposi con parole di circostanza, mentre il presidente
mi trascinava sui gradini di una scala con tutto il codazzo di guardie del corpo
e dignitari, fra cui il sindaco di Gela disperato per essere stato estromesso
dal suo posto di accompagnatore ufficiale con fascia tricolore del presidente,
il quale lo ignorava e invece seguitava a parlarmi. Il sindaco, furibondo, si
aggrappò allora alla giacca della mia grisaglia e la aprì verticalmente in due
lasciandomi in maniche di camicia e brandelli come in un film di Charlie
Chaplin. Cossiga non mi mollò e il sindaco mi prese a gomitate molto decise
all’altezza dello stomaco. E non mollai neanche io. Arrivammo nell’aula e io
restai incollato a Cossiga in una ressa senza ossigeno, ma colma di rancori. Il
presidente fece il suo discorso e senza alcun preavviso attaccò Giorgio Bocca,
uno dei principi del giornalismo italiano. Erano i tempi dei delitti della banda
detta della “Uno Bianca” in cui erano stati implicati alcuni carabinieri. Bocca
aveva scritto quel giorno un articolo in cui sosteneva più o meno che i
carabinieri erano storicamente degli eversori (alludendo al famoso “Piano Solo”
ai tempi del generale De Lorenzo, accusato di propositi golpisti) e Cossiga
diventava una belva se qualcuno gli toccava i “suoi” carabinieri di cui si
considerava il supremo protettore. Dunque, fra l’altro, pronunciò una invettiva
contro Bocca molto dura, accusandolo di vilipendere. Io prendevo nota su un
piccolo notes. Il punto su cui ero chiamato a render conto ai miei lettori era:
Cossiga è matto o no? Sembrava davvero preda di un delirio fuori controllo,
oppure diceva semplicemente cose che molti consideravano sgradevoli? Fra pazzia
e divergenze d’opinione, c’è un abisso. Così, ricordo che mi dedicai al suo body
language, i movimenti minimi che potevano suggerire segni di agitazione e
scompostezza e potevo farlo perché ero attaccato a lui come una cozza, in una
ressa irrespirabile. Ricordo in particolare i suoi radi capelli bianchi che
erano composti e immobili. La voce era alta, ma secca, con un tono sprezzante
costante. Non isterico. Poi ci salutammo, ci separammo e corsi in albergo per
scrivere un pezzo in cui facevo la cronaca dell’accaduto dando conto di parole e
fatti (non della mia sventurata giacca) ignorando di compiere in questo modo un
gesto eversivo. Il giorno successivo infatti quasi tutti i giornali titolavano
sulla follia presidenziale, l’evidente patologia mentale e il fatto – che di lì
a poco sarebbe emerso come fatto istituzionale – che Cossiga non sarebbe stato
nelle condizioni mentali per reggere il suo ufficio: «Not fit» per l’Economist e
una celebre giornalista inglese lo definì matto come le lepri di marzo quando
vanno in amore, un’espressione ripresa da Lewis Carroll nel Tè del Cappellaio
matto (una lepre) in Alice in Wonderland. Tutti avevano scritto che Cossiga era
matto, tranne me. Ero forse matto io? Fu così che mi accorsi per la prima volta
(ne sarebbero seguite molte altre) che alcune persone preferivano cambiare
marciapiede quando mi incontravano per strada. Cossiga non usava ancora il verbo
«picconare» (l’avrebbe inaugurato alla presentazione del mio libro su di lui
Cossiga uomo solo) ma assestava colpi micidiali al suo partito e ai partiti che
lo avevano eletto quasi all’unanimità. Che cosa gli era preso? Me lo spiegò man
mano che il nostro rapporto si trasformava in amicizia. Ma fu un processo lento.
Dopo alcuni giorni dal mio primo articolo mi telefonò all’alba allarmando il
bambino della mia compagna il quale mi svegliò scuotendomi: «Che cosa hai fatto
a Bush?». A Bush?, chiesi «Sì, c’è il presidente al telefono e ti vuole parlare
subito». Per un bimbo di cinque anni l’unico presidente noto era quello
americano. Andai al telefono e mi sentii chiedere: «Che cosa sa lei dei
cattolici liberali?». E mi impartì una dottissima lezione il cui significato
era: io sono l’unico cattolico liberale in Italia, sono solo come un cane in un
partito di affaristi o integralisti. Gli mandai per corriere (non esistevano
ancora le e-mail) un articolo in cui ricostruivo la nostra conversazione
chiedendogli l’autorizzazione a pubblicarlo. Mi rispose: «No, ma venga domattina
alle sette a fare colazione al Quirinale». Andai e trovai la crème de la crème
della sinistra italiana: Andrea Barbato, Sandro Curzi, Valentino Parlato e mezza
redazione de il manifesto con qualche scampolo de l’Unità. Tutta gente
intelligentissima, un po’ anarchica ed eretica impegnata fra cappuccini,
cornetti e uova strapazzate con cui Cossiga aveva una familiarità molto giocosa.
Quello sì, che sembrava il Tè del cappellaio matto. Ma allora erano tutti matti,
o così sembrava. Lo stesso Cossiga che veniva scudisciato sulla carta stampata,
era il beniamino di un bel gruppo di intelligentissimi e spiritosissimi
pensatori e giornalisti. Non c’era Eugenio Scalfari, che era in quel momento uno
dei suoi principali avversari e questo faceva soffrire molto Cossiga perché per
anni – mi diceva – era stato a pranzo da Eugenio una volta alla settimana.
Eugenio stesso mi aveva raccontato di aver lui stesso suggerito a De Mita il
nome di Cossiga per succedere come presidente del Senato ad Amintore Fanfani che
si era giocato la poltrona pur di fare un governicchio estivo. Poi, dopo mille
premesse, promesse ed emozioni, venne il momento della prima intervista ed era
allora un vero scoop, perché tutti speravano di poterlo intervistare. Mi spiegò
il senso della sua azione, che era la semplice presa d’atto di quel che stava
per accadere: «L’Italia, con la fine della Guerra Fredda – disse – ha perso il
suo potere di ricatto sugli americani e gli altri alleati. Non contiamo più
niente e coloro che ci hanno dovuto sopportare con tutti i nostri tradimenti,
ricatti, ruberie e arroganze, stanno per presentarci il conto e sarà
salatissimo. Sto cercando di fare capire ai democristiani e ai comunisti (che
considerava come i carabinieri, dei suoi parenti, vista la cuginanza con Enrico
Berlinguer il quale gli rispondeva che «con i parenti si mangia l’agnello a
Pasqua» e lo mise in stato d’accusa) che nel nuovo mondo tutte le regole sono
cambiate ed è mio compito traghettare l’Italia nella nuova realtà storica».
Vaste programme, avrebbe detto de Gaulle. Ma la Dc di Ciriaco De Mita, e non
solo, non aveva alcuna intenzione di farsi rieducare da Cossiga, il quale
vantava – con parecchia millanteria – una frequentazione nelle altissime sfere
dell’intelligence mondiale delle segrete ruote che governavano il pianeta. Aveva
un caratteraccio, questo è indubbio. Era certamente un po’ paranoico (la
paranoia consiste nel vedere complotti e veleni, ma è una sindrome utile se si
vive in un’epoca di complotti e veleni), era soggetto ad accessi di collera che
erano però più di natura sarda che psichiatrica: il codice cavalleresco dei
gentiluomini sardi impone delle furie di facciata che soltanto i veri sardi
possono capire. Ed è una furia fredda, che non fa salire la pressione, anche se
siamo nell’antropologia e nel nazionalismo sardo, perché Cossiga era anche un
nazionalista sardo più o meno come lo sono i corsi. Fu così che le mie
interviste con il presidente della Repubblica, da formali e in pompa magna si
fecero frequenti e convulse. Decise di darmi del tu e di chiamarmi “A Guzzà”.
Recalcitravo alla richiesta di fare altrettanto ma non fu contento finché non
passai a un improbabile “A Francé”. Si palpava benissimo il desiderio della
nomenklatura italiana di levarselo dalle scatole e rimuoverlo con acrobazie
procedurali accompagnate da comitati di psichiatri che avrebbero dovuto
proclamare un reggente finché il Parlamento non avesse eletto un successore. Per
fortuna non ero solo nel difendere il presidente che aveva previsto Mani Pulite
e l’assalto alla cittadella e che senza pensarci due volte, aveva mandato una
legione di carabinieri in assetto anti-sommossa a Palazzo dei Marescialli per
mandare un segnale inequivocabile al Consiglio superiore della Magistratura
riunito nel Palazzo dei Marescialli, di cui lei era il presidente, anche se
nel Csm chi governa è il vice presidente, ai tempi Giovanni Galloni. Dovetti a
un certo punto scoraggiarlo dalla sua pretesa di affidare a me tutte le sue
punzecchiature contro gli altri politici. Ma era un’impresa quasi disperata. Un
giorno pretese di farmi scrivere che Achille Occhetto era «Uno zombie coi
baffi». E io mi rifiutai: «Non è da te, presidente, io non lo scrivo». Poco
male: il giorno dopo «Occhetto è uno zombi coi baffi» era un titolo de il
Messaggero. Mi aveva bypassato senza tragedie e meglio così. Quando si dimise mi
volle al Quirinale fra le sue scartoffie, consegnò la bandiera di combattimento
al bambino che gli aveva risposto al telefono raccomandandogli di custodirla per
la generazione dei futuri patrioti e mi chiese di accompagnarlo in esilio in
Irlanda. Mi mandò al 33mo Stormo di Ciampino dove lo attendeva il jet
presidenziale e gli fui accanto mentre il pilota metteva la prua sull’Irlanda.
Parlammo poco e lui si lasciò vincere da una lacrima o due. Io gli detti una
goffa pacca sulla spalla. Poi andammo in taxi fino al monastero dove lo
attendevano e dove il bibliotecario era sulla soglia a braccia aperte per
discutere con lui i libri dei pensatori cattolici irlandesi. La porta si
richiuse e finì così la mia straordinaria avventura giornalistica con un
presidente molto speciale che poi ho sentito solo poche volte per telefono e che
visitai una sola volta nella sua casa al quartiere Prati, ormai abbandonato da
tutti.
Quando Cossiga mandò i
carabinieri al Csm.
Paolo Guzzanti de Il Riformista il 29 Novembre 2019. “Ma certo
che mandai i carabinieri!”. Mi disse Cossiga quando diventammo amici: “Mandai un
generale di brigata con un reparto antisommossa, pronti a irrompere nel palazzo
dei Marescialli”. Oggi fa impressione riascoltare nelle registrazioni la voce
del “matto” Cossiga quando attaccava lo strapotere di alcuni magistrati e lo
faceva spavaldamente come un Cyrano de Bergerac, odiato da tutti nel 1985 –
trentaquattro anni fa – quando invece aveva ragione. Il Consiglio superiore
della magistratura si è recentemente infangato con l’inchiesta di Perugia che ci
ha fatto assistere in diretta al mercato delle procure, alla vendita del
diritto.Tutto già parte di un vizio d’origine contro cui oggi pochi hanno il
fegato di combattere. Cossiga mi aveva invitato a fare colazione al Quirinale.
C’era il meglio del giornalismo di sinistra a inzuppare il cornetto nel
cappuccino di quelle stanze mentre Cossiga raccontava. A quei tempi era ministro
dell’interno Oscar Luigi Scalfaro, che sarebbe diventato il suo successore e il
suo principale nemico. Ricorderemo ancora Scalfaro quando, assestando il colpo
dell’asino a Cossiga dimissionario, urlò stentoreamente in aula “Viva il
Parlamento!” come se lui fosse stato il Parlamento. Allora era ministro degli
interni e quando Cossiga decise di far intendere chi comandasse sugli abitanti
del Palazzo dei Marescialli (di stile fascista, curiosamente decorato con teste
di Mussolini con l’elmetto), il ministro del Viminale disse di sì. Dissero di sì
anche i comunisti che poi si scatenarono contro Cossiga. Erano con lui il
giudice costituzionale Malacugini e il senatore Perna, capo del gruppo comunista
al Senato. I membri del Csm allora pretendevano di comandare come terza camera
dello Stato, in barba della Costituzione. Volevano colpire il presidente del
Consiglio Bettino Craxi che aveva polemizzato sulle inchieste seguite
all’assassinio del giornalista socialista del Corriere della Sera Walter Tobagi,
ucciso dalla Brigate Rosse, che Craxi considerò sempre interne ai salotti
milanesi di sinistra. Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo di
autogoverno dei magistrati, i quali godono di una autonomia prossima
all’extraterritorialità, salvo poi trasformare tanta autonomia in un mercato di
interferenze e abusi talmente terrestri da produrre fatti come quelli messi a
nudo dall’inchiesta di Perugia che hanno inferto alle istituzioni delle ferite
probabilmente non rimarginabili. L’organo di autogoverno fu concepito come
massimo baluardo del servizio pubblico della giustizia- e non come privilegio
degli operatori togati della giustizia – allo scopo di garantire ai cittadini un
servizio di assoluta indipendenza da poteri esterni a cominciare da quelli
politici. Il presidente del Csm è il Capo dello Stato, ma è una carica solo
formale perché chi comanda è il vicepresidente del CSM. Cossiga ingaggiò nel
1985 un braccio di ferro istituzionale in cui, malgrado i suoi colpi, alla fine
fu lui ad essere disarcionato. La sua battaglia contro il
vicepresidente Giovanni Galloni (un radicale rappresentante storico della
sinistra cattolica che detestava apertamente tutto ciò che Cossiga
rappresentava) espose Cossiga ad un vero massacro mediatico. Le camionette dei
carabinieri erano a piazza Indipendenza. I carabinieri in assetto antisommossa,
con gli elmetti calati in testa, pronti a sfondare il portone se solo il
presidente Cossiga, in quanto Capo dello Stato, lo avesse ordinato. La carica
non avvenne, il portone restò integro, ma lo schieramento delle forze che
rappresentavano lo Stato – i carabinieri in questo caso – contro un ridotto
nelle mani di chi si riteneva di essere separato dallo Stato, in quanto organo
separato dello Stato, rappresentò uno schieramento concreto, militare, non
diverso – per qualità istituzionale – a quello che lo Stato rinunciò ad opporre
nel 1922 alla marcia su Roma di Mussolini. Non che esista una comparazione tra
la marcia su Roma e il conflitto affrontato da Cossiga, ma restano i comuni
termini di una difesa anche militare contro l’eversione. Cossiga individuò
nell’arroganza di un ristretto gruppo di magistrati la formazione di un potere
insurrezionale “ultroneo” rispetto a quelli previsti dalla Costituzione e dunque
un nucleo eversivo. Il punto allora era politico: il Csm usurpava il diritto –
non contemplato tra le sue funzioni – di muovere critica o censura alle parole o
alle azioni del presidente del Consiglio dei ministri. Cossiga sospese la delega
a Galloni, cioè lo degradò sul campo strappandogli le spalline, sia pure
temporaneamente. E dopo aver disarmato quello che riteneva il leader di una
corrente eversiva, impose che si prendesse atto di un punto fermo: l’organo di
autogoverno dei magistrati è soltanto l’organo di autogoverno dei magistrati e
mai, in alcun modo, un potere dello Stato. Come invece pretendevano allora le
correnti politiche dell’Anm che Cossiga accusava di usurpazione contro lo Stato.
FILMOGRAFIA SUL CASO MORO.
PIAZZA DELLE CINQUE LUNE: STORIA O FINZIONE?
Quello che la fiction può
raccontare senza ritorsioni.
RECENSIONE PIAZZA DELLE
CINQUE LUNE (2002)
di Claudia Catalli del 5 marzo 2005. Un film sugli intrighi di
potere, sulle mezze verità, sui dati occultati, sulla sete di ideali, che fra
fotogrammi sgranati stile documentario e flashbacks in bianco e nero, si cimenta
in un'interessante ipotesi storico-politica sul sequestro di Aldo Moro.
Storia d'una ragnatela letale.
Colpisce, questo film di Enzo Martinelli, distribuito dall'Istituto Luce.
Colpisce per l'impeccabile precisione della sceneggiatura, per l'efficace resa
fotografica, per la meticolosa quanto fedele ricostruzione storica, nonché per
la buona interpretazione degli attori e non ultima la grande regia, capace di
far scivolare la pellicola lungo piani diversi, dal giallo al thriller al film
d'azione al drammatico allo storico al sentimentale. Rosario Saracini,
magistrato senese fresco di pensione, riceve all'improvviso da uno sconosciuto
un misterioso pacchetto, il cui contenuto si rivela un vecchio film girato
in super8 sul sequestro di Aldo Moro in Via C. Fani, datato 16 Marzo 1978. Da
qui ha inizio una lunga e appassionata indagine, (non ufficialmente) condotta
proprio dall'anziano Saracini che, consultandosi costantemente con due dei suoi
più fedeli colleghi, tali Branco e Fernanda, impegna tutto se stesso in questa
ricerca quasi ossessiva di una verità sepolta da un silenzio colpevole da ben
venticinque anni...Tralasciando di dibattere sulla convenienza della scelta del
soggetto -scelta senza dubbio rischiosa quanto forse provocatoria: nel film si
dice che il sequestro di Moro fu deciso in realtà dalla CIA, colpevole per altro
di aver manipolato le Brigate Rosse-, c'è da dire che Piazza delle cinque
lune vanta una discreta potenza suggestiva non solo grazie all'architettura
minuziosa che da filmica si fa in ultimo urbanistica, per così dire, ma anche
per merito di interpreti mediamente (e si sottolinei mediamente) convincenti. A
parte Stefania Rocca, che resta in bilico fra sì e no (molto meno espressiva
rispetto al suo solito, fatta eccezione per l'incisiva scena in ospedale coi
figli), Giancarlo Giannini si dimostra attore degli sguardi, più che delle
parole, e riesce a reggere il confronto con Donald Sutherland - da non perdere
il faccia a faccia finale. Se è vero che in alcuni tratti la vicenda si fa
scontata e prevedibile, è anche vero d'altra parte che i difetti comunque
presenti nella pellicola vengono presto perdonati grazie ai titoli di coda, che
regalano l'emozione di un Luca Moro che, chitarra alla mano, inveisce contro
tutti coloro che sapevano e non sapevano, che vedevano e non vedevano, complici
anche inconsapevoli della tragica fine del nonno: "Maledetti voi!"
Il film risulta, infine, di
fatto suddiviso in due parti - nella prima si assiste ad una scrupolosa
ricostruzione storica del sequestro, studiata e sviscerata dai magistrati in
ogni minimo dettaglio, mentre nella seconda, decisamente più intrigante, la
macchina da presa segue attentamente tutte le mosse dell'arguto Saracini,
spiando silenziosamente al tempo stesso il contrattacco dell'avversario, come in
un'avvincente partita a scacchi, dove però non c'è nessun vero vincitore. O
meglio, vince chi bara, chi riesce a camuffare la propria identità fino
all'ultimo istante; vincono i sotterfugi, le menzogne, le ragnatele d'una
politica malvagia. Alla schermata finale è consegnato il messaggio del film,
messaggio indimenticabile per la sua maledetta, cruda verità: "La giustizia è
come una tela di ragno: trattiene gli insetti piccoli, mentre i grandi
trafiggono la tela e restano liberi" (Solone)
Quando si è fuori dal coro, si
han contro tutti…
Da destra. Film su Moro con
polemica,
scrive il 9 maggio 2013 “La Repubblica”. Esce oggi in 200 sale Piazza delle
Cinque Lune, il film di Renzo Martinelli sul caso Moro, a 25 anni esatti di
distanza dal ritrovamento del cadavere dello statista ucciso dalle Br, dentro
un'automobile parcheggiata a due passi dalle sedi del Pci e della Dc.
Interpretato da Donald Sutherland, Giancarlo Giannini e Stefania Rocca, il film
ha ricevuto la "benedizione" della famiglia Moro ed è stato realizzato con la
consulenza dell'ex senatore Sergio Flamigni, che all' argomento ha dedicato per
anni approfondite inchieste. «Questa non è la verità ma si avvicina molto alla
verità» dice il regista, riferendosi ai molti lati ancora oscuri del caso Moro.
E, insieme ai coautori del film, si aspetta polemiche. Che non tardano ad
arrivare: un deputato di An, Enzo Fragalà, chiede al ministro Urbani di
«verificare la congruità e i requisiti del progetto finanziato con i soldi
pubblici dell'Istituto Luce», sostenendo che «da sinistra si è fatta una nuova
indecente azione di disinformazione con i soldi pubblici». Allarga le braccia
Flamigni: «Quando si dice la verità la querela bisogna aspettarsela. Polemico,
d' altronde, lo stesso Martinelli, che se la prende con Bruno Vespa: «Mi chiedo
come mai non ospiti a Porta a porta questo Piazza delle cinque lune. Vespa ha
detto che è un argomento che non fa audience, ma mi chiedo: di cosa ha paura?».
Pronta la replica di Vespa, che afferma di non aver mai detto niente del genere,
e che Porta a porta ha dedicato una puntata al caso Moro l'11 marzo, vigilia del
25esimo anniversario della strage di via Fani.
Da sinistra. "Piazza delle
Cinque Lune",
scrive Renzo Martinelli il 12 maggio 2003 Fulvio Baglivi su "Sentieri
selvaggi". Si può vivere senza Rossellini. Il cinema italiano lo ripete da anni
e Piazza delle Cinque Lune lo afferma senza esitazioni; forte dei 9 milioni
incassati dal precedente film di Renzo Martinelli, Vajont, della presenza di un
cast con Donald Sutherland e Giancarlo Giannini affiancati da Stefania Rocca,
del suo "linguaggio moderno, accattivante, pieno di suspense e di ritmo"
(Martinelli). Il titolo è il nome di una piazza romana, dove sembra che Mino
Pecorelli fosse venuto a conoscenza del "Memoriale Moro", e nel film diventa la
chiave d'accesso di un dischetto (contenente appunto il mai interamente
ritrovato memoriale che Aldo Moro avrebbe scritto durante la sua prigionia) che
un brigatista, prossimo alla morte, consegna al procuratore Saracini
(Sutherland) appena andato in pensione. La verità? (permetteteci di interrogarci
ancora…) proviene dai libri di Sergio Flamigni, in particolare La tela del
ragno, che legge il "casomoro" in chiave antiPCI, con gli statisti democristiani
(in particolare Andreotti, capo del governo e il ministro degli interni Cossiga)
a coprire una manovra di CIA, P2 e SISDE con le BR di Mario Moretti semplice
braccio armato al servizio dello spionaggio internazionale (questa parte nel
film è spiegata con il cameo di F. Murray Abraham, chiamato Entità, con cui
Saracini si incontra a Parigi). Il fine del film è dire tutto questo e per due
volte i protagonisti si ritrovano intorno ad un tavolo a snocciolare dati e
date. Intorno al "messaggio" Martinelli e il cosceneggiatore Campus costruiscono
un giallo-spy-thriller d'ambientazione senese, con il procuratore Saracini
affiancato dalla giovane collaboratrice Doni (Rocca) e dal capo della scorta
Branco (Giannini), che indaga a partire da un Super8 con le immagini del
rapimento di Moro in via Fani consegnatogli da un ex-brigatista ammalato di
tumore. Intorno ai tre protagonisti, che incarnano l'uomo che non si arrende
all'età (trascurando i consigli della figlia) pur di fare luce sui fatti, la
donna in carriera che sacrifica la sua famiglia (nonostante i litigi col marito)
sull'altare del vero e della patria a cui Branco è asservito, vi sono le figure
del brigatista e del "potere" che agiscono in direzioni opposte e di cui vediamo
i volti soltanto alla fine. Schema applicato alla lettera, Hollywood è il
riferimento di Martinelli che "omaggia" il "giallo" JFK di Oliver Stone, la
saga 007 e l'ultimo thriller di Fincher Panic Room con la mdp che attraversa i
corpi (tutto con il digitale) dimostrando quanto sia irrisorio il Caso Moro
nella colonizzazione statunitense. Piazza delle Cinque Lune è il rovesciamento
di pensiero e opere di Rossellini, qui la verità non è qualcosa da ricercare
attraverso la forma, è già data all'inizio (la frase di Solone La giustizia è
come una tela di ragno: trattiene gli insetti piccoli mentre i grandi trafiggono
la tela e restano liberi) e il film ne è una spiegazione (che finisce appunto
con l'immagine della ragnatela). Martinelli continua a credere che falso su vero
è uguale a vero (come già in Porzus e Vajont), con tecnica pubblicitaria (e la
macchina che corre nella campagna senese svela le sue origini) sa qual è il
prodotto a cui vuole arrivare e ci costruisce intorno improbabili fiction,
svilendo il cinema a mero linguaggio/mezzo con cui giocare a piacimento. Finché
resterà questo lo Stato del cinema italiano noi continueremo a stare con le
Brigate Rosse(llini).
Aldo Moro nel labirinto di
fantasmi. Un
volume curato da Marco Clementi, Paolo Persichetti ed Elisa Santelena per
DeriveApprodi percorre la parabola delle Brigate Rosse, scrive su “Il Manifesto"
Andrea Colombo il 16 marzo 2017. Il tempo non è stato galantuomo. A 39 anni di
distanza dall’agguato di via Fani e dal sequestro di Aldo Moro la verità, invece
di avvicinarsi, si è allontanata, almeno agli occhi dell’opinione diffusa. La
verità sul caso Moro è affondata in una palude di coincidenze spacciate per
prove, di sospetti sconfinanti nei territori della psicopatologia, di dicerie
elevate a fatti. La vittoria di quella che uno dei più brutti neologismi in
circolazione ha battezzato «dietrologia» non consiste tanto nell’aver affermato
la sua confusa e sgusciante «verità» quanto nell’aver imposto il proprio terreno
di confronto: quello in cui ci si deve misurare sempre su voci e ipotesi
fantasmagoriche, sino a che dalla storia dell’organizzazione politica Brigate
rosse, del sequestro del leader politico Aldo Moro e del braccio di ferro
proseguito per 55 giorni con l’intero establishment politico italiano vengono
espunti proprio i due elementi fondamentali, la storia e la politica,
sostituititi da una frenetica caccia al mistero. Almeno per quanto riguarda il
versante storico un passo avanti decisivo è segnato dalla pubblicazione
di Brigate rosse, (DeriveApprodi, pp. 550, euro 28), di Marco Clementi, Paolo
Persichetti ed Elisa Santelena. È il primo volume di una storia delle Br
tracciata con gli strumenti propri della ricerca storica. Ne dovrebbero seguire
altri due, forse con l’apporto di nuovi o diversi autori, anche se non è escluso
che il progetto si riduca solo a un secondo volume. Clementi, da questo punto di
vista, è un pioniere. È stato il primo, nel libro del 2001 La pazzia di Aldo
Moro, a cimentarsi da un punto di vista rigorosamente storico con gli scritti di
Moro dal carcere del popolo, poi con la Storia delle Brigate rosse, del 2007.
Nei dieci anni trascorsi dall’uscita di quel libro, però, si sono aperte molte
nuove fonti per la ricerca storica, e i tre autori le hanno esplorate tutte con
incredibile minuzia. Pur trattandosi di un libro sulle Br e non sul caso Moro,
l’operazione Fritz, come fu definita in codice dai brigatisti stessi, occupa ben
411 pagine su 550. È una scelta editoriale che veicola un preciso taglio
storico: una costruzione del genere, infatti, mette in prospettiva l’intero
percorso delle Br sino a quel momento come progressivo avvicinamento al culmine,
rappresentato appunto dalla loro azione più clamorosa. Inevitabilmente i tre
autori sono costretti a confrontarsi con la ricostruzione della verità storica,
sfatando molte leggende: dalla insufficiente protezione assicurata dallo Stato
al presidente della Dc, alle minacce di cui sarebbe stato oggetto sin dal 1975;
dalle diverse versioni offerte dal presunto «super-testimone» Marini alla ormai
leggendaria Honda di via Fani. Ma la parte più interessante riguarda la
politica, sia nel senso di esplorare le motivazioni politiche che muovevano le
Br sia in quello di esaminare dallo stesso punto di vista le scelte dello Stato
e dei partiti. La politica, ancora più della Storia, è la grande rimozione nel
dibattito pluridecennale sul caso Moro. Da questo punto di vista la
«dietrologia» è la prosecuzione con altri mezzi di quella che all’epoca fu
definita «linea della fermezza». Quella linea non significava affatto rifiuto di
trattare. Lo Stato era pronto a trattare, però come si faceva d’abitudine con i
banditi comuni: senza dirlo e offrendo in cambio della vita dell’ostaggio soldi.
Nel caso specifico moltissimi soldi. Fermezza voleva dire negare l’identità
politica e non criminale delle Br. Le fantasie che impazzano da decenni sul caso
Moro fanno lo stesso, trascinando tutto sul terreno di un complotto oscuro, nel
quale le Br fanno più o meno la figura dei burattini. Proprio la scelta di
negare quella identità politica portò come conseguenza inevitabile, almeno nel
solco dell’analisi brigatista, all’uccisione dell’ostaggio. Il riconoscimento di
quella identità, secondo gli autori, avrebbe avuto conseguenze enormi. Tanto, si
direbbe, da giustificarne in pieno il rifiuto da parte dello Stato. Sia il
sequestro che la scelta di uccidere Moro furono decisioni dettate da un’analisi
politica che non si può liquidare come «delirante», secondo l’aggettivo più in
voga all’epoca. L’analisi della fase del capitalismo contenuta nelle Risoluzioni
strategiche del 1975 e del 1978 risulta in effetti tutt’altro che delirante,
mentre certamente superficiale è il ruolo che le Br assegnavano alla Dc
all’interno di quel processo globale. Si può discutere su alcune delle analisi
elaborate dagli autori, come il carattere deflagrante del riconoscimento
politico. Ma fino a che la ricostruzione storica e politica non si snoderà sul
terreno posto con questo libro, un momento essenziale della storia repubblicana
resterà ridotto a un labirinto di fantasmi.
Aldo Moro, una
contro-inchiesta rivela nuovi elementi,
scrive Angela Mauro, Giornalista politica, su "L'Huffington Post" il 16/03/2017.
I postini delle Brigate Rosse durante i 55 giorni del sequestro Moro erano tre e
non due: Bruno Seghetti, Valerio Morucci e Adriana Faranda. L'agguato in via
Fani, di cui oggi ricorre il 39esimo anniversario, costò circa 700mila lire, e
furono impiegati in totale 10 mezzi. Soprattutto la 127 bianca, parcheggiata da
Morucci e Franco Bonisoli all'alba di quel 16 marzo dietro al mercato di via
Trionfale, ebbe un ruolo strategico: i brigatisti la usarono come deposito
temporaneo per le armi lunghe. E ancora: fu nella base di via Chiabrera e non in
via Gradoli che i brigatisti tennero la riunione decisiva, quella dell'8 maggio
1978, che decretò la morte di Aldo Moro. Sono solo alcuni dei particolari
ricostruiti nel libro 'Brigate rosse - Dalle fabbriche alla 'campagna di
primavera' (Derive Approdi), scritto dagli storici Marco Clementi ed Elisa
Santalena e da Paolo Persichetti, ricercatore indipendente che aderì alle
Br-Unione dei comunisti combattenti, per questo estradato dalla Francia,
arrestato, ha scontato la pena. Il libro è il risultato di un lungo lavoro di
ricerca nell'Archivio di Stato, dove per effetto della direttiva Prodi (2008) e
della direttiva Renzi (2014) è stata trasmessa tutta la documentazione degli
apparati di sicurezza sui tragici eventi che hanno segnato la storia della
Repubblica dal 1969 al 1984, dalla strage di piazza Fontana alla strage del
rapido 904 nel 1984, passando per il sequestro Moro, oggetto particolare della
direttiva Prodi. E in più nel testo ci sono le testimonianze inedite di alcuni
ex brigatisti. E così a 39 anni di distanza dai fatti, una nuova pubblicazione
sul sequestro e l'assassinio del presidente della Dc aggiunge altri elementi
alla storia. La particolarità è che va a confutare molte delle tesi cui è giunta
di recente la commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro presieduta dal
deputato del Pd Giuseppe Fioroni. Per esempio, secondo la ricerca di Clementi,
Santalena e Persichetti, non è vero che le armi usate in via Fani furono
custodite in un garage in via Licinio Calvo. Invece erano in un borsone nella
127 bianca parcheggiata dietro il mercato da Morucci e Bonisoli e furono
recuperate alcune ore più tardi da Barbara Balzerani e Seghetti che per
trasportarle le misero in un carrello della spesa, nascoste sotto ortaggi appena
acquistati. E poi c'è il particolare dell'auto parcheggiata dai brigatisti la
sera dell'8 maggio in via Caetani, per bloccare il posto dove poi fu invece
lasciata la Renault 4 con il cadavere di Moro. C'è la ricostruzione del percorso
compiuto dalla Renault 4, la descrizione del piano di emergenza della polizia
messo in atto dopo il ritrovamento del corpo di Moro: triplo anello concentrico
a chiudere la capitale. Ci sono le domande sulle carte del Nucleo speciale del
generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Stando alla documentazione consegnata
dall'Arma dei Carabinieri all'Archivio di Stato, il generale ha coordinato
un'attività di indagine sul sequestro Moro molto approfondita. Risultano "16.161
fascicoli e 19.780 schede personali che però oggi non risultano consultabili
(potrebbero anche essere andati distrutti"), concludono i tre autori. Nel libro
c'è il racconto dei luoghi che servirono da base alle Br. Per esempio, il libro
confuta la tesi giudiziaria secondo cui la base centrale dei brigatisti durante
il sequestro Moro su quella di via Gradoli 96. Invece, sostengono gli autori, si
trovava in via Chiabrera 74 e fu usata per le riunioni decisive, come quella
della sera dell'8 maggio 1978 che decretò la morte di Moro e le modalità di
trasporto del corpo in via Caetani. La cornice storica, il Vaticano e il Pci,
l'Italia degli anni di Piombo e una tesi che scorre nel libro dall'inizio alla
fine. E cioè che il sequestro Moro fu l'epilogo di una campagna messa in atto
dalle Br dagli inizi degli anni '70: dalle fabbriche al sequestro del presidente
della Dc. Un'inchiesta indipendente destinata a far discutere.
Il golpe di Via Fani svela
le sue ombre,
scrive Gino Gullace Raugei su "Oggi.it" il 7 maggio 2010. Si è sempre creduto
che il nodo inestricabile dei mille misteri che hanno caratterizzato una delle
vicende più oscure d’Italia fosse nei 55 giorni di prigionia di Aldo Moro.
Invece, la chiave del giallo è nei poco più di 55 secondi che si impiegano per
percorrere 400 metri di alcune anonime strade di Roma: chi ha avuto interesse ad
eliminare dalla scena il presidente della Democrazia cristiana che con la forza
delle sue idee turbava pesantemente i delicati equilibri politico-militari
dell’Alleanza atlantica e la logica del mondo diviso in due blocchi, proprio qui
lascia la sua firma. E le Brigate rosse? Non furono che uno strumento, più o
meno inconsapevole, di una inquietante trama molto più grande di loro? La nostra
è stata un’inchiesta lunga, faticosa e difficile. Alla fine, siamo riusciti a
ricomporre secondo un rigido ordine logico tutte le tessere del puzzle. Ecco che
cosa abbiamo scoperto.
LA MATTINA DELL’AGGUATO.
Giovedì, 16 marzo 1978, è una mattina di cielo plumbeo e aria frizzantina: la
dolce primavera romana si fa attendere. La Fiat 130 blu ministeriale di Aldo
Moro e l’Alfetta bianca di scorta spuntano invece puntuali, alle 9.01, da un
largo curvone di Via Trionfale, nel quartiere di Monte Mario. Il presidente
della Dc, che abita lì vicino, e i cinque uomini della sua scorta (il
maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, l’appuntato Domenico Ricci, le
guardie di Pubblica sicurezza Raffaele Iozzino e Giulio Rivera e il brigadiere
Francesco Zizzi) sono diretti alla Camera dei deputati dove quel giorno si vota
per la nascita della controversa creatura politica di cui lo statista pugliese è
il padre storico: il governo Andreotti IV, un monocolore Dc con l’appoggio
esterno - per la prima volta nella storia della Repubblica - del Partito
comunista. «Via Trionfale», come si legge sul quotidiano Il Tempo, in un
articolo del 17 marzo 1978, «è il percorso più diretto verso il centro
dell’Urbe». Eppure, Moro e la sua scorta rallentano all’improvviso e svoltano a
sinistra, sulla stretta Via Mario Fani, correndo ignari all’appuntamento con la
morte. «Infinite volte, mi sono chiesta come potevano essere le Brigate rosse
così sicure che quel giorno, a quell’ora, in quel punto, l’onorevole Moro
sarebbe passato da Via Fani», dichiarò la signora Eleonora Chiavarelli, vedova
dello statista, alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage della
scorta, sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, nell’udienza del 1° agosto
1980. Un dubbio atroce che, tra indagini lacunose, reticenti, frammentarie o,
addirittura, inesistenti, non ha avuto mai una risposta. Eppure in quel
chilometro scarso che separa Via del Forte Trionfale 79 (dove al tempo abitava
la famiglia Moro) e l’incrocio di Via Trionfale con Via Fani c’è qualcosa di non
trascurabile importanza che proprio non torna. In quei mille passi, come direbbe
un giallista, c’è probabilmente la traccia decisiva per identificare i complici
di quel gravissimo delitto. E, attraverso di loro, identificare probabilmente il
mandante. Tra le quattro o cinque alternative di itinerario possibile, qualcuno
insospettabile indirizzò Aldo Moro sul percorso meno conveniente, ma fatale.
Senza il concorso di questo qualcuno l’agguato delle Brigate rosse non avrebbe
probabilmente mai avuto luogo.
BASTAVA PEDINARLO?
Dal punto di vista della verità ufficiale, cioè giudiziaria, le deposizioni
fondamentali per ricostruire le dinamiche del clamoroso agguato brigatista
furono rilasciate tra il 13 e il 26 settembre 1978 dai cinque agenti superstiti
della scorta di Moro (che il giorno della strage erano di riposo o in licenza)
interrogati uno per volta dai giudici istruttori Ferdinando Imposimato e Achille
Gallucci. «Ogni mattina il presidente Moro si recava sempre alla messa delle ore
9 nella chiesa di Santa Chiara, in Piazza dei Giuochi delfici», dicono, parola
più, parola meno, l’appuntato dei carabinieri Otello Riccioni, il maresciallo di
Pubblica sicurezza Ferdinando Pallante, il brigadiere Rocco Gentiluomo e gli
agenti Vincenzo Lamberti e Rinaldo Pampana. «Il percorso seguito era sempre lo
stesso, il più breve e il più veloce: via del Forte Trionfale, via Trionfale,
via Fani, via Stresa, via della Camilluccia fino a piazza dei Giuochi delfici».
L’agente Pampana, nella sua deposizione, aggiunge un particolare molto preciso:
«L’onorevole Moro usciva, costantemente, salvo rare eccezioni, intorno alle ore
9. Era precisissimo nell’orario, nel senso che poteva anticipare o posticipare
l’ora di uno o due minuti». Stando così le cose, tutto sembra sufficientemente
chiaro: alle Brigate rosse - come racconteranno in seguito i vari Moretti,
Morucci, Faranda e compagnia - è bastato pedinare neanche troppo a lungo Moro e
la scorta per avere una precisa contezza delle loro abitudini e quindi per
scegliere il punto più adatto dove posizionare la trappola mortale.
LA VERSIONE DI ELEONORA.
Eppure, il 23 settembre 1978, la signora Eleonora Moro, interrogata dal giudice
istruttore Achille Gallucci, smentisce clamorosamente le deposizioni dei primi
tre agenti (Gentiluomo, Pallante e Riccioni, ascoltati il 16 settembre). «Non
posso affermare», dice la signora Eleonora, «che mio marito sia stato un
abitudinario. Per quanto attiene all’orario di uscita del mattino, non è esatto
quanto affermato dai superstiti della scorta. Essi, come la Signoria vostra mi
precisa, sostengono che l’onorevole Moro era solito uscire di casa verso le ore
9. Invece, particolarmente negli ultimi tempi, a causa della crisi di governo,
egli non aveva mai un orario fisso di uscita poiché bastava una telefonata per
fargli cambiare il programma della giornata. Era solito andare a messa tutti i
giorni, anche nel pomeriggio, a seconda dei suoi impegni. Egli, fra l’altro,
cambiava spesso le chiese, frequentando quella di Santa Chiara, a Piazza dei
Giuochi delfici, ma anche quella di San Francesco, sulla Via Trionfale, oppure
quella del Gesù, in viale Regina Margherita ed altre ancora. «Faccio altresì
presente», aggiunge la vedova di Moro, «che mio marito non faceva di solito la
stessa strada e ciò per motivi di sicurezza. Ritengo di dover affermare che il
percorso veniva deciso al momento da mio marito e dal maresciallo Leonardi, il
caposcorta. La sua auto percorreva alle volte Via Cortina d’Ampezzo, alle volte
Via Fani, alle volte Via Trionfale». Malgrado gli altri due agenti superstiti
della scorta, Pampana e Lamberti, vengano convocati dallo stesso Giudice
Gallucci tre giorni dopo la signora Moro, non vi è traccia nei verbali dei loro
interrogatori di alcun contraddittorio mirato a far luce su testimonianze tanto
divergenti.
“PARTICOLARI” TRASCURATI.
A 32 anni di
distanza dal fatto ci rechiamo dall’ex giudice istruttore Ferdinando Imposimato
con i verbali di quegli interrogatori che lui stesso contribuì a raccogliere.
«Non c’è dubbio», dice Imposimato, scorrendo le carte, «che le deposizioni
fotocopia degli agenti sembrano concordate. Qualcuno, evidentemente, gli avrà
ordinato di dire quelle cose. Perché non ce ne siamo accorti subito? Perché in
violazione del codice di procedura penale del tempo, gli atti del rapimento Moro
non furono trasmessi all’ufficio del giudice istruttore entro 40 giorni dal
fatto, ma ben 64 giorni dopo, esattamente il 19 maggio. A quella data Moro era
già stato ucciso e l’obiettivo era assicurare alla giustizia i brigatisti
colpevoli. Un particolare come quello degli orari e dei percorsi della scorta è
sembrato minore».
PARLA LA FIGLIA.
Sempre a proposito
degli orari e degli itinerari seguiti da Moro e la sua scorta, ecco ciò che
dichiarò sua figlia Agnese ai giudici della corte d’Assise di Roma che stavano
processando i brigatisti assassini nell’udienza del 20 luglio 1982: «Vorrei
sottolineare che mio padre non faceva sempre gli stessi percorsi, che Via Fani
non era che una delle strade che potevano essere percorse la mattina come nel
corso della giornata, anche perché è una strada stretta, disagevole, spesso
trafficata. I percorsi si cambiavano spesso perché c’erano delle preoccupazioni
da parte di mio padre, inerenti al suo ruolo politico, preoccupazione per sé e
per i familiari». «Vorrei sapere dalla teste se sa chi decideva il cambio dei
percorsi nel trasferimento del padre dall’abitazione nei vari posti dove doveva
recarsi», chiede l’avvocato Enzo Ciardulli, dell’Avvocatura di Stato. «Io ho
sentito abbastanza frequentemente non delle discussioni in senso polemico, ma
delle conversazioni fra Ricci e Leonardi al momento di uscire di casa sul
percorso da scegliere. A volte mi è capitato anche di sentir dire: mi hanno
detto che lì c’è traffico, passiamo da un’altra parte. I percorsi credo che poi
venissero stabiliti anche a seconda del ritardo in cui era mio padre per
arrivare a destinazione, cioè anche alla messa della mattina: spesso non ci
andava più perché magari era in ritardo, cosa che gli capitava in maniera
frequentissima. Quindi, voglio dire che c’era anche questa variabile di quello
che poi succedeva realmente la mattina, cioè quale era l’orario effettivo di
uscita di casa di mio padre». «Poteva capitare», chiede il presidente della
giuria, «che il percorso da fare la mattina veniva stabilito la sera
precedente?». «Non credo proprio», dice Agnese. «Mi pare veramente impossibile
anche perché mio padre era un tipo veramente ritardatario, quindi, magari,
usciva con tre quarti d’ora di ritardo rispetto all’orario previsto e magari
avevano deciso di andare prima in un posto eppoi non ci potevano più andare
perché l’orario era passato. Sono sicura che i percorsi venivano stabiliti la
mattina stessa». «Quindi il percorso di Via Fani la mattina del 16 marzo venne
stabilito casualmente quella mattina stessa?», chiede l’avvocato Ciardulli.
«Credo proprio di sì», risponde Agnese Moro. «Questa Via Fani era uno dei
percorsi che si facevano?», domanda il presidente. «Sì, ma ce n’erano parecchi»,
precisa Agnese Moro. «Altre volte era passato da Via Fani suo padre?», dice il
presidente. «Sì», spiega Agnese Moro, «però non è che il percorso di Via Fani
corrispondeva all’andare, poniamo, sempre per fare un esempio concreto, alla
Chiesa di Santa Chiara perché per andare in Piazza dei Giuochi delfici passava
indifferentemente da lì oppure da via Cortina d’Ampezzo. Questo per rendere
l’idea, non è che per andare in un posto abituale c’era sempre quella strada.
Anche per andare in un posto abituale ci potevano essere vari percorsi».
CAMBI DI PERCORSO.
«Nelle settimane
precedenti l’agguato di Via Fani mio padre era preoccupato per il continuo
cambio dei percorsi per raggiungere le varie destinazioni di Moro», ci dice oggi
Giovanni Ricci, figlio dell’appuntato Domenico Ricci, autista della Fiat 130
dello statista pugliese. «“Devo guidare a velocità elevata perché il presidente
è sempre in ritardo”, spiegava papà, “e siccome transitiamo a volte per strade
che non conosco, finirò prima o poi per fare un incidente».
LA NOSTRA PROVA COL GPS.
A titolo
puramente indicativo abbiamo sottoposto gli itinerari del presidente Moro alla
prova del Gps o navigatore satellitare, uno strumento di precisione che allora
non esisteva e che oggi serve per determinare la strada più breve e veloce che
conviene fare per andare in un certo posto. Parcheggiamo dunque la nostra auto
davanti al numero 79 di Via del Forte Trionfale, dove abitava lo statista, e
chiediamo al Gps di guidarci verso Piazza dei Giuochi delfici. Lo strumento dice
di proseguire per Via Cortina d’Ampezzo, svoltare a destra su via Cassia e poi
andare diritti fino alla piazza. In totale sono 4 chilometri che percorriamo in
5 minuti e 42 secondi. Torniamo a Via del Forte Trionfale, 79, e raggiungiamo
Piazza dei Giuochi delfici passando stavolta per Via Trionfale, Via Mario Fani,
Via Stresa, Via della Camilluccia. L’incrocio tra Via del Forte Trionfale e Via
Trionfale non è oggi transitabile nella direzione che ci interessa poiché sono
intervenuti dei notevoli lavori di modifica della planimetria viaria che
allungano il percorso di circa un chilometro. Sottraendo questa distanza e il
tempo che impieghiamo a percorrerla dal dato finale si ottiene che passando per
quelle strade si arriva a Piazza dei Giuchi delfici dopo 5 chilometri e 500
metri e quasi 9 minuti a causa delle numerose svolte e incroci con stop. A
titolo puramente indicativo, come dicevamo, possiamo affermare che il percorso
per Piazza dei Giochi delfici passando per Via Fani, oggi, come allora, non è il
più breve né il più veloce.
IL DOCUMENTO SCOMPARSO.
Per tagliare
la testa al toro, come si suol dire, servirebbe un documento inoppugnabile: il
diario della sala operativa del Viminale, relativo al giorno 16 marzo 1978 e
precedenti, dove venivano annotati tutti i contatti radio con le auto di scorta
e quindi tutti gli orari e tutti i percorsi. A quanto dichiara il dottor Guido
Zecca, dirigente dell’ispettorato generale (l’ufficio responsabile dei servizi
di scorta) presso il Viminale alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso
Moro, nella seduta del 7 novembre 1980, «tutti i movimenti venivano sempre
controllati dalla nostra sala operativa che segnava su un brogliaccio tutti gli
spostamenti. Gli agenti di scorta dicevano: siamo partiti, siamo arrivati in
questo punto, siamo qui fermi». Peccato però che questo fondamentale documento
sembra misteriosamente scomparso: «Lo abbiamo chiesto ripetutamente», ricorda il
senatore Sergio Flamigni, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta, «ma
non ci è stato mai trasmesso».
IL FIORAIO AMBULANTE.
Per saperne
di più, non resta che tentare di rintracciare alcuni testimoni, peraltro mai
prima d’oggi interrogati. Il primo è Antonio Spiriticchio, il famoso fioraio
ambulante di via Fani a cui, nella notte tra il 15 e il 16 marzo 1978, furono
squarciate le gomme del furgone per impedirgli di trovarsi, al momento
dell’agguato, proprio nel punto cruciale: in prossimità dello stop all’incrocio
con Via Stresa. «Quella mattina dovevo recarmi al mercato generale per
rifornirmi di fiori e piante», ricorda Spiriticchio, che oggi ha 82 anni,
«perciò uscii di casa verso le 6.30. Quando vidi tutt’e quattro le gomme del mio
Transit a terra pensai all’atto vandalico di qualche teppista. La mia prima
preoccupazione fu quella di andare comunque al lavoro, rimettendo il furgone in
condizioni di circolare: nel cassone, infatti, c’erano molti fiori invenduti il
giorno precedente che si sarebbero rapidamente deteriorati aggiungendo danno al
danno. Perciò mi detti da fare con un amico gommista che venne a sostituirmi nel
più breve tempo possibile le quattro ruote. Ero quasi arrivato a Via Fani,
quando la radio dette la notizia dell’agguato». Spiriticchio ricorda Aldo Moro
in Via Fani come una presenza abbastanza familiare. «Qualche volta passava in
auto col solo Leonardi», dice, «qualche volte scendeva addirittura a piedi con
la moglie che si fermava a comprare dei fiori». Ricorda, chiediamo, se Moro e la
scorta passavano ogni giorno da Via Fani, più o meno alla stessa ora, verso le 9
del mattino? «No, su questo non ci potrei proprio giurare», risponde
Spiriticchio. «Passava spesso, ma non sempre. Dopo l’agguato delle Br mi hanno
interrogato un mucchio di volte, ma una domanda del genere non me l’hanno mai
fatta».
GLI ALTRI TESTIMONI.
I signori Ferrando e Santina, che avevano una rivendita di frutta e verdura sul
tratto iniziale di Via Fani, confermano i ricordi del signor Spiriticchio. «Il
presidente Moro e la sua scorta passavano frequentemente, ma non possiamo
mettere la mano sul fuoco che passassero sempre e alla stessa ora», spiegano.
«Quando il presidente passava, io ero intento a sistemare la merce in vetrina»,
racconta Bruno Marocchini, titolare di una gioielleria. «Me lo ricordo ancora,
sul sedile posteriore della Fiat 130, intento a sfogliare i giornali. Passava
sempre da Via Fani? Diciamo che passava spesso, ma se non passava non è che mi
mettevo a piangere!».
IL PARROCO ATTUALE.
A questo punto ci rechiamo alla Chiesa di Santa Chiara, in Piazza dei Giuochi
delfici, dove incontriamo don Giuseppe, uno dei parroci attuali. «Sto qui da
appena sei anni e non sono dunque un testimone diretto dei fatti che vi
interessano», premette. «Però sono molto legato alla figura di Aldo Moro perché
anche io sono pugliese, di Castellaneta». Don Giuseppe ricorda il bailamme che
turbò i ritmi parrochiali quando, circa tre anni fa, la chiesa fu invasa dalla
troupe cinematografica che girava la fiction di Canale 5 Aldo Moro, il
presidente con Michele Placido nei panni dello statista. «I parrocchiani, specie
i più anziani, erano un po’ infastiditi e ricordavano che Aldo Moro, in fondo,
frequentava abbastanza saltuariamente la nostra chiesa. Comunque, per saperne di
più, dovete cercare il parroco di allora, Gianni Todescato».
IL PARROCO DI ALLORA.
Don Gianni,
attuale rettore della chiesa di Sant’Agnese a Piazza Navona è un anziano parroco
vicentino, molto disponibile e cortese. Infatti accetta volentieri di riceverci.
«Sono stato parroco di Santa Chiara per quarantuno anni», dice, «e certo non
posso dimenticarmi di Aldo Moro. Proprio il 15 marzo, il giorno prima di essere
rapito, gli detti io il sacramento della comunione. Quella mattina, certo prima
delle 9, orario di inizio della messa, venne il maresciallo Leonardi a chiedermi
la cortesia di somministrare in privato l’eucarestia al presidente che, dovendo
tenere di lì a breve un importante discorso, non aveva tempo di assistere alla
funzione religiosa». Don Gianni ricorda l’assidua presenza di Aldo Moro anche se
ammette: «In tutti gli anni che è venuto alla mia chiesa non abbiamo mai
stabilito un rapporto particolare. Riservato sono io e riservatissimo era lui».
Gli chiediamo se si ricorda come si disponeva la scorta del presidente fuori
dalla chiesa. «Me lo ricordo benissimo: due agenti lo accompagnavano dentro e
gli altri tre aspettavano con le auto fuori. Parcheggiavano proprio davanti
all’ingresso. Alcune volte arrivavano da Via della Camilluccia; altre volte
venivano invece da Via Cortina d’Ampezzo». Ne è sicuro, padre? «Assolutamente:
alcune volte venivano da sopra, da Via della Camilluccia; altre volte venivano
da sotto, dalla parte di Via Cassia su cui sbocca Via Cortina d’Ampezzo. «Io non
sono stato mai interrogato dagli inquirenti», dice don Gianni. «Altrimenti gli
avrei detto che per circa due anni, tutte le volte che Moro entrava in chiesa,
appariva un giovane sconosciuto in fondo al sagrato. Dopo il rapimento del
presidente, quel giovane non si fece più vedere. Secondo me, era un brigatista».
Gino Gullace Raugei
Caso Moro, ex poliziotto:
“Il giorno dell’agguato in via Fani furono sospesi i controlli di bonifica nelle
strade vicine”.
Ascoltato in Commissione l’ex agente di Pubblica Sicurezza Adelmo Saba. Senatore
Federico Fornaro: "Per la prima volta abbiamo appreso che esisteva questa prassi
e che sicuramente quel giorno non fu garantita", scrive Stefania Limiti il 9
giugno 2016 su "Il Fatto Quotidiano". Sedici marzo 1978: in via Mario
Fani nessuna delle auto civetta del commissariato di zona svolge le consuete
operazioni di ‘bonifica’ del territorio. Il servizio di controllo, che precede
il passaggio di personalità importanti, viene misteriosamente sospeso. Lo ha
detto davanti alla commissione d’inchiesta sul caso Moro l’ex agente di Pubblica
Sicurezza Adelmo Saba che quella mattina si trova inaspettatamente libero perché
il suo capo, Enrico Marinelli, ha deciso, senza avvisarlo, di metterlo in ferie
forzate. L’audizione di Saba rompe la serie dei non ricordo ascoltata troppo
spesso nelle recenti audizioni e riporta al centro dell’interesse della
Commissione il tema piuttosto insidioso delle strane circostanze che precedono
l’assalto del commando brigatista – come quello del capo della Digos Spinella
che arrivò troppo presto in via Fani (leggi). “Dopo la testimonianza di Saba
senz’altro aumentano le coincidenze”, ha detto il senatore Federico Fornaro che,
per niente distratto dalla sua ormai nota passione e competenza per i dati
elettorali, coglie la novità dell’audizione: “Oggi per la prima volta abbiamo
appreso che esisteva un servizio di bonifica, una prassi di cui nessun documento
dell’epoca parla, e che sicuramente quel giorno non fu garantito”. Saba ha poi
ricordato le parole del suo collega che faceva parte della scorta di Moro: era
il più esperto, molto affidabile con le armi ma quel giorno viene anche lui
esentato dal servizio senza un motivo. “Mi disse che qualcuno
evidentemente aveva voluto salvargli la vita”. Un altro aspetto dell’audizione –
nella quale non mancano spunti di riflessione sulle incertezze e sulle fragilità
delle ricostruzioni che si affidano ai ricordi lontani – riguarda il
ritrovamento della Fiat 128 bianca in via Licino Calvo. Saba ha confermato che
quell’auto per tutto il giorno del 16 marzo non c’era nel punto in cui lui e il
suo collega Antonio Pinna la ritrovarono nella notte del 17: il rilascio delle
auto usate dal commando fu dunque controllato, cioè realizzato in fasi
successive.
Una modalità che richiama
l’esistenza di un ‘garage compiacente’, come lo definì il giornalista Mino
Pecorelli, cioè di una base brigatista proprio in prossimità dell’agguato. E,
ovviamente, sempre negata dalle Br. Ultimo aspetto della testimonianza riguarda
il ricordo di una enorme pozza di sangue non coagulato sul sedile anteriore a
fianco del guidatore della 128 blu – nel loro rapporto Saba e Pinna fecero una
descrizione meno enfatica. Le perizie fatte all’epoca dalla Scientifica rilevano
genericamente schizzi di sangue: a chi apparteneva? Certamente non ad Aldo Moro
– l’autopsia lo esclude – e le Br non hanno mai parlato del ferimento di uno dei
loro. Vedremo se gli esperti guidati da Giuseppe Fioroni riusciranno a trovare
risposte a questi pesantissimi interrogativi.
Quel 16 marzo Moro e la sua
scorta non dovevano passare per via Fani,
scrive Martedì, 4 maggio 2010 "Affari Italiani". “Ogni giorno Aldo Moro usciva
puntualmente di casa alle nove di mattina e si recava sempre alla chiesa di
Santa Chiara, in Piazza dei Giuochi delfici, transitando con la scorta sempre
sullo stesso percorso: Via del Forte Trionfale, Via Trionfale, Via Fani, Via
Stresa, Via della Camilluccia fino alla chiesa”, dichiararono ai magistrati i
cinque agenti superstiti (che quel giorno erano in ferie o in turno di riposo)
della scorta del presidente della Democrazia cristiana. Otello Riccioni,
Ferdinando Pallante, Rocco Gentiluomo, Vincenzo Lamberti o Rinaldo Pampana. “No,
Aldo Moro non usciva mai di casa allo stesso orario, era solito frequentare
chiese diverse e cambiava continuamente gli itinerari per motivi di sicurezza”,
dichiararono invece i parenti dello statista rapito e poi ucciso dalle Brigate
rosse. A 32 anni dall'agguato di Via Fani, un'inchiesta di OGGI ricostruisce in
due puntate le dinamiche degli attimi precedenti l'attacco terroristico al cuore
dello Stato e svela il mistero delle deposizioni chiave che pur clamorosamente
contraddittorie non furono mai chiarite né dagli inquirenti, né durante i vari
processi. Alcune testimonianze inedite consentono inoltre di ipotizzare un
nuovo, inquietante scenario: Aldo Moro e la sua scorta, il 16 marzo del 1978,
non dovevano passare per Via Fani; eppure il commando terrorista tese proprio lì
la sua complicata trappola, certo che invece sarebbero passati.
Il precedente-fotocopia nel
film «Piazza delle Cinque Lune».
Quanto raccontato dall’agente
era già stato documentato nella pellicola di Martinelli sul rapimento dello
statista Dc, scrive il 26 Marzo 2014 “Il Tempo”. Un misterioso uomo sta per
morire a causa di un tumore. Non vuole portarsi nella tomba alcuni segreti, di
cui è al corrente, sul rapimento di Aldo Modo e decide, prima di passare a
miglior vita, di rivelare che il 16 marzo 1978, in via Fani, a bordo di una
Honda, c’erano due agenti dei servizi segreti: uno era lui, seduto sul sellino
posteriore della moto. Può sembrare la storia svelata, nei giorni scorsi,
dall’ex ispettore di polizia Enrico Rossi, sulla base di una lettere anonima di
cui è entrato in possesso nel 2011. E invece no. È la trama di Piazza delle
Cinque Lune, un film del 2003 diretto da Renzo Martinelli, ispirato proprio alla
vicenda del rapimento e l’omicidio dello statista democristiano da parte delle
Br. Una ricostruzione fantasiosa, quella di Martinelli, priva di qualsiasi
ancoraggio alla realtà, ma identica, in quel passaggio, alla versione rivelata
dall’ex poliziotto. Nella lettera anonima inviata nel 2009 a La Stampa, su cui
Rossi ha indagato, si legge: «Quando riceverete questa lettera, saranno
trascorsi almeno sei mesi dalla mia morte (…). Ho passato la vita nel rimorso di
quanto ho fatto e di quanto non ho fatto e cioè raccontare la verità su certi
fatti. Ora è tardi, il cancro mi sta divorando (…). La mattina del 16 marzo ero
su di una moto e operavo alle dipendenze del colonnello Guglielmi, con me alla
guida della moto un altro uomo (…); il nostro compito era quello di proteggere
le Br». Ed ecco, invece, il dialogo, tratto dal film di Martinelli, fra un
componente del commando di via Fani, misterioso pure lui, e il giudice Rosario
Saracini, interpretato da Donald Sutherland: «Ricorda la moto Honda? Quello
dietro che spara con il mitra? Quei due non li avete mai trovati. Io ero seduto
dietro». E quando il giudice chiede il perché di quella «confessione», dopo
tanti anni, l’uomo risponde: «Ho un tumore, mi hanno dato due mesi, forse meno.
Non voglio portarmi la verità nella tomba. Sono state dette così tante bugie».
Sia nel film che nella lettera, lo 007 è seduto sul sellino posteriore; la
malattia terminale è alla base della «lettera confessione» che ha scatenato
nuove teorie sul rapimento Moro, e della «confessione verbale» rilasciata, nel
film, al giudice Saracini. C’è dell’altro. In Piazza delle Cinque Lune al
giudice viene consegnata una pellicola inedita con impressi i momenti drammatici
del rapimento del presidente della Dc. Nel filmato compare un uomo con un
impermeabile: è Camillo Guglielmi, il colonnello del Sismi che nella realtà, la
mattina del 16 marzo 1978, si trovava in via Stresa, nei pressi di via Fani. Ed
è lo stesso Guglielmi citato nella lettera che ha dato il via all’ennesimo
mistero sul caso Moro. Un’incredibile similitudine tra fiction e «presunta»
realtà.
Caso Moro: via Fani, quello
che già sapevamo,
scrive Rita Di Giovacchino, Giornalista e scrittrice, il 24 marzo 2014 su "Il
Fatto Quotidiano". Sono passati quasi 36 anni dal 16 marzo 1978 e
finalmente arriva la testimonianza, post mortem, di uno degli agenti del Sismi
presenti in via Fani. Non per proteggere la vita di Moro (quelli sono stati
uccisi), ma le Brigate rosse che, come già sapevamo, non erano in grado di
gestire un’operazione militare di tale livello e pertanto andavano aiutate, anzi
“protette da disturbi di qualsiasi genere”. L’obiettivo? Eliminare dalla scena
politica il leader Dc favorevole al compromesso storico, ovvero al
coinvolgimento del Pci a livello di governo. C’era la “guerra fredda” e l’Italia
non si poteva permettere un simile strappo. Per una strana coincidenza la
rivelazione arriva nei giorni in cui il film di Veltroni su Berlinguer ci fa
sapere che, nonostante la linea della “fermezza” proclamata dal più amato dei
segretari comunisti, il Pci cominciò a morire durante il sequestro Moro. In
realtà cominciò a morire anche la Dc ma ci vollero altre 5 stragi, quelle degli
anni Novanta, perché uscisse di scena. La verità è affidata a una lettera
anonima, ingrediente d’obbligo in ogni spy story, di cui si occupò senza venirne
a capo un ex ispettore dell’antiterrorismo, Enrico Rossi, 56 anni, che seguendo
i sassolini indicati nella missiva era quasi arrivato alla soluzione del giallo
quando una mano (superiore) lo ha bloccato. L’indagine è durata un anno, dal
2011 al 2012, poi l’ex ispettore è stato costretto a fermarsi e ha chiesto di
essere collocato anticipatamente in pensione. Nel frattempo era riuscito a
identificare i due agenti a bordo sulla misteriosa moto Honda, che entrò in
azione all’incrocio tra via Fani e via Stresa: seduto sul sellino posteriore era
l’autore della lettera anonima, nel frattempo morto di cancro, aveva il volto
coperto dal casco e sparò una raffica di mitra contro l’ingegnere Marini, che
intralciava la scena del delitto. Alla guida c’era invece un giovane dal volto
scavato che assomigliava in modo impressionante a Eduardo De Filippo.
L’ispettore Rossi fece a tempo a scoprire che il secondo agente del Sismi era
separato dalla moglie, ma nel frattempo era prematuramente deceduto, perquisì la
cantina, trovò due pistole, una Beretta e una Drulov cecoslovacca, chiese che le
armi fossero periziate e cercò di rintracciare gli elenchi degli appartenenti a
Gladio nel 1978. Ma gli fu impedito e le armi furono distrutte, lui capì che era
meglio uscire di scena non senza informare la procura di Roma per dovere di
ufficio. Tanto in 40 anni non aveva scoperto niente. C’è un passaggio
significativo nella lettera che ha sollecitato il mio amor proprio: “Non credo
che voi giornalisti non sappiate come andarono le cose”, scrive l’anonimo
divorato dal cancro e dai rimorsi. Ha ragione, qualcosa abbiamo scoperto nel
corso degli anni nonostante il giornalismo investigativo in Italia non aiuti a
fare carriera. Ad esempio già sapevamo che il colonnello del Sismi Camillo
Guglielmi, diretto superiore degli agenti sulla Honda, anche lui deceduto (ma è
un’epidemia!), non era un passante in via Fani, come ha cercato di far credere a
Santiapichi, presidente del primo processo Moro. Guglielmi addestrava truppe di
sbarco e assalto a Capo Marrargiu, la base militare Nato vicina ad Alghero, dove
venivano istruiti anche i capi scorta di alte personalità. In via Fani Guglielmi
era nell’esercizio delle sue funzioni, dirigeva un’operazione militare. E
pensare che siamo stati accusati di dietrologia, quando ci eravamo limitati a
sospettare che era lì per prelevare le borse di Moro! Molto probabilmente, ma è
soltanto un’ipotesi, il colonnello Guglielmi e il maresciallo Oreste Leonardi,
caposcorta di Aldo Moro, si conoscevano. La sottoscritta, in un libro di qualche
anno fa, sosteneva che il nodo di molti misteri di via Fani andava cercato
proprio nel rapporto gerarchico tra Guglielmi e Leonardi. Se cliccate su
Internet scoprirete che mi viene attribuita la tesi, cui non credo fino a prova
contraria, che Moro sia stato rapito nella chiesa di Santa Chiara dove era
andato a messa prima di recarsi in Parlamento per varare il governo sostenuto
dal Pci. Penso però che nella chiesa di Santa Chiara qualcosa di importante sia
accaduto: bisognava convincere il caposcorta a imboccare via Fani, dove erano in
attesa brigatisti e altri ancora, dove erano state tagliate le ruote del Fiorino
per impedire al fioraio di aprire il chiosco, dove tutto era stato predisposto.
Leonardi sceglieva all’ultimo momento la strada da fare, senza comunicarlo a
nessuno per motivi di sicurezza, e via Fani era soltanto uno dei tre possibili
percorsi. La logica conclusione è che sia stato il colonnello Guglielmi a trarlo
in inganno, magari adducendo motivi di sicurezza, era l’unico che poteva
impartirgli ordini. A proposito chi ha ucciso Leonardo, Zizzi e tutti gli altri?
Le Brigate rosse? No, sembra si trattasse di uno ‘ndranghetista, tal Gustino De
Vuono, il legionario “De”, come scriveva Mino Pecorelli, uno che sparava come un
dio e che, al centro della scena con un giubbetto azzurro e una mitraglietta
Scorpio, ha esploso 84 proiettili. Gli unici che hanno colpito gli agenti, ma
per averne conferma dobbiamo aspettare la prossima lettera anonima. p.s.:
qualcuno di voi dirà, ma chissenefrega di una storia di mezzo secolo fa, non
eravamo manco nati. Attenti, magari non lo sapete, ma quella di Moro è una
ferita ancora aperta e c’è un filo che lega questa strage a quelle del 1992-93.
Quasi fosse un’unica operazione, in due tempi, che ha sottratto ai cittadini
italiani la possibilità di decidere sul proprio futuro.
"La nuova verità del caso
Moro? Era già raccontata nel mio film".
Parla il regista Renzo
Martinelli che girò "Piazza delle Cinque Lune", scrive il 27 Marzo 2014 “Il
Tempo”. La trama del film Piazza delle Cinque Lune «ispiratrice» delle nuove
rivelazioni sul rapimento di Aldo Moro? La lettera anonima su cui ha indagato
l’ex agente Enrico Rossi, che parla della presenza di due agenti dei servizi
segreti in via Fani, a bordo di una Honda, è solo una «patacca» camuffata da
nuova verità? Le similitudini fra il film, del 2003, e il contenuto della
lettera che risale al 2009 e che è stata scritta da un misterioso 007, sono
impressionanti. E se è vero che Piazza delle Cinque Lune va oltre nella
fantasia, mettendo in scena delle Br infiltrate anzi comandate dalla Cia, è
altrettanto vero che molti particolari presenti nel film e nella lettera, sono
praticamente indistinguibili. Una coincidenza? Oppure una storia quantomeno
«orientata» dal film? Ne parliamo con il regista di quel film, Renzo Martinelli.
Allora, le analogie tra il
film e la lettera anonima sono impressionanti. Cos’ha pensato quando l’ha letta?
«Sono rimasto sconcertato
perché confermano quanto abbiamo sostenuto dieci anni fa nel film. Solo che
all’epoca tutti ci hanno ignorato. Ciò che avevano messo in scena con Piazza
delle Cinque Lune trova oggi un’incredibile conferma».
L’autore della lettera dice
di essere un agente segreto in fin di vita che vuole «confessare» prima di
morire. Anche l’uomo che nel film consegna al giudice il filmato inedito su via
Fani ha una malattia terminale. Una coincidenza?
«La nostra era un’invenzione
drammaturgica. L’uomo che avvicina il magistrato era un brigatista che faceva
parte del commando e che prima di morire vuole rivelare la verità sulla dinamica
dell’agguato. Ora la realtà supera la fantasia. Quanto alla malattia, beh, la
gente muore di tumore tutti i giorni. Probabilmente si tratta di una
coincidenza».
Nel film l’uomo che
confessa dice che la mattina della strage era seduto sul sellino posteriore
della Honda. La stessa versione di colui che ha vergato la lettera.
«Credo sia un’altra
coincidenza. D’altronde la moto aveva una funzione indispensabile per la
perfetta riuscita dell’operazione».
Ancora un’altra
similitudine. Lei nel film parla del ruolo del colonnello del Sismi Camillo
Guglielmi; l’autore della misteriosa missiva afferma di essere stato al suo
servizio in via Fani. Un’altra coincidenza? Che Guglielmi fosse presente
all’angolo tra via Fani e via Stresa, da dove assiste all’agguato, è un dato di
fatto. Guglielmi, poi, non è un colonnello qualunque, è uno che insegna agli
uomini di Gladio le tecniche d’imboscata. Dunque per lei è verosimile anche,
come scritto nella lettera, che sulla moto fossero presenti due agenti dei
servizi segreti italiani?
«Non è solo verosimile, è la
realtà. È questa la verità. Sono assolutamente convinto che quanto scritto nella
lettera sia vero».
Ritiene, quindi, che dopo
tutti questi anni si stia andando verso la verità su quella tragica pagina della
storia italiana?
«Nessuno conosce la verità sul
caso Moro, ma sono sicuro che quell’operazione avesse delle coperture ad alto
livello. Come sempre, però, col tempo si creano delle smagliature. Questa
lettera può rappresentare la prima. Magari fra 30 anni scopriremo che
probabilmente la nostra ricostruzione era tutta corretta».
Nel suo film, però, lei va
oltre, teorizzando che dietro le Br ci fosse la Cia.
«Quando parlo della Cia come
"regista" dell’agguato di via Fani è perché l’intuito mi porta là. In via Fani
c’è stata una manovra d’attacco militare perfetta. Oltre ai brigatisti c’erano
degli specialisti. Sì, le Br erano eterodirette».
Non pensa che l’autore
della lettera possa essersi lasciato suggestionare, o addirittura guidare, dal
suo film?
«Lo escludo. Credo che chi ha
messo nero su bianco quelle parole è solo un uomo che ha raccontato un pezzo di
verità coincidente con un altro pezzo di verità che noi avevamo già svelato».
Martinelli: "Contro tutti,
al servizio della verità: vi racconto il mio cinema".
Dai comunisti alla Lega
"alle cantanti che fanno film": intervista di Dario Crippa senza peli sulla
lingua al regista Renzo Martinelli il 26 giugno 2016 su “Il Giorno”. Era
ancora un ragazzo quando uscì nelle sale Effetto notte di Truffaut. "E
innamorandomi di quel film, come tanti della mia generazione, decisi che un
giorno avrei voluto fare il regista". Ci è voluta però molta gavetta, anni a
girare documentari, spot pubblicitari, video musicali. Ma alla fine, Renzo
Martinelli da Cesano Maderno – già 10 film all’attivo - è diventato pure lui un
cineasta. Massacrato spesso dalla critica, discusso, rompiscatole, ma un
cineasta.
Partiamo dall’inizio.
"Nasco a Seveso il 4 ottobre
1948, ma cresco a Cesano Maderno".
Cosa faceva la sua
famiglia?
"Papà era falegname, mamma
faceva le pulizie, ho un fratello più piccolo".
Origini umili.
"Mi hanno insegnato a essere
consapevole delle mie radici e mi hanno costretto a lavorare. Sempre. D’estate
facevo il cameriere in un ristorante di Varedo, e dopo la maggiore età sono
diventato istruttore di guida per pagarmi gli studi...".
Gli studi li fa a Milano.
"Tre lauree: Lingue e
letterature straniere, Comunicazione sociale e Scienze politiche".
E poi?
"Ho fatto il documentarista
col grande direttore della fotografia Lamberto Caimi: con lui ho imparato sul
campo a fare il regista...".
Cosa significa?
"Oggi tutti fanno i registi,
anche comici, cantanti, mignotte... ma in pochi conoscono la tecnica,
occuparsene – curiosa eredità del Neorealismo - è considerato plebeo, quando
invece pittori come Vermeeer o il Perugino impastavamo personalmente i colori:
questo era essere un Maestro e questo ho sempre tentato di essere io. La mia
fortuna è stata quella di andare a bottega come nel Rinascimento. Un aneddoto?".
Prego.
"Una volta sul set feci una
scommessa con l’attore Harvey Keitel: avrei girato dieci primi piani diversi di
lui senza muovere la macchina. Con suo grande stupore (ride) dovette darmi i 100
euro in palio!".
Vantaggi di questo modo di
girare?
"Risparmi decine di migliaia
di euro... i miei colleghi danno il primo ciak di pomeriggio, prima devono
attendere che il set sia preparato. Io invece faccio tutto da solo e inizio alle
8 di mattina. E anche con gli attori...".
Cosa?
"Il tipico regista italiano
sta sotto un tendone davanti a uno schermo a 50 metri di distanza dal set, e per
ogni scena l’aiuto regista deve andare a dare istruzioni all’attore...
Risultato? Perdi ogni volta in adrenalina. Se invece conosci bene la tecnica,
hai un rapporto più carnale con l’attore, non ti sente distante, con spreco di
energie ed emozioni continuo... insomma, quando si gira io sono in macchina,
vicino al set".
Si dovrebbe fare sempre
così?
"I più grandi registi, da
Kubrick a Spielberg, stanno in macchina”.
Quali sono i suoi modelli?
"Oliver Stone, autore di film
di grosso impegno civile e coraggio".
In Italia?
"Il cinema civile di Rosi,
Petri, Damiani. In tanti dopo il ‘68 pensavamo si potesse finalmente indagare
anche con i film, c’era un grosso interesse sociale...".
E invece?
"Poi però la paghi in sala. Un
proverbio arabo dice che gli uomini somigliano al loro tempo più che ai loro
padri. E oggi interessa solo l’immediato: io invece tento di affrontare momenti
della storia di questo Paese".
Perché?
"In settant’anni di Repubblica
non c’è un solo episodio che non sia rimasto un mistero, in cui la verità non
sia stata manipolata, da Portella della Ginestra alla strage di Piazza Fontana o
Ustica. La ragion di Stato interviene sempre pesantemente. Borges, il grande
scrittore argentino, diceva: “La storia è un atto di fede”. Ecco, credo che la
forza maieutica del cinema invece possa avvicinare alla verità...".
Il 27 giugno ci sarà
l’anniversario di un’altra strage, quella di Ustica (1980, un aereo si squarciò
in volo, 81 morti). Lei gli ha dedicato il suo ultimo film, Ustica appunto.
"Quando decido di lavorare a
una storia faccio un lavoro di documentazione enorme, ho avuto la fortuna di
conoscere il giudice Priore, che mi ha consegnato un dischetto con le 5mila
pagine della sua sentenza. E mi resi conto che già a pagina 118 si parlava di
pezzi di un caccia americano rinvenuti in mare che facevano pensare a una
collisione in volo...".
Su quel disastro vennero
fatte tre ipotesi: il cedimento strutturale dell’aereo, una bomba nella toilet,
un missile francese che l’avrebbe colpito per errore. Lei ne avanza una quarta:
un caccia americano che inseguiva un Mig libico...
"Solo dopo 8 anni si andò a
cercare nel fondale, la Dc aveva fatto in modo che non lo si facesse prima, ma
si scoprì che qualcuno era già andato di nascosto a recuperare i rottami".
Lei ha toccato temi
scottanti: le violenze partigiane, il Vajont, il delitto Moro, il terrorismo
islamico... La critica spesso però l’ha demolita.
"In Italia se non appartieni a
una parrocchia, te la fanno pagare... ho subito critiche impietose e a tratti
offensive".
Lei a quale parrocchia
appartiene?
"A nessuna... e non voto da
anni. Cerco solo di fare film che mi interessano: con Porzûs sono andato contro
i comunisti, con Vajont-La diga del disonore contro la Dc... Lo storico francese
Marc Bloch diceva che il giudice e lo storico hanno un dovere in comune,
“l’onesta sottomissione alla verità”. Il mio dovere di cineasta, come in Ustica,
era di comunicare la verità che ho scoperto".
“Regista uscito dalla
pubblicità” è uno dei marchi malevoli che le hanno affibbiato.
"Anche perché col mio cinema
cerco di far convivere impegno civile e spettacolarità e i critici non me lo
perdonano".
Prima di approdare al cinema,
è vero però che ha fatto tanta pubblicità...
"E non me ne pento: l’ho fatto
per 10 anni e ho imparato il lavoro di sintesi, un’esperienza che mi ha aiutato
molto a curare l’immagine e il ritmo".
E...
"Ho girato anche sigle
televisive come La Notte Vola con Lorella Cuccarini e tanti video musicali, da
Battiato ad Alice".
Divertente?
"(ride) I Van Halen (gruppo
hard rock, ndr) prima del ciak pretesero due casse di whisky!".
Dice che non apparteneva a
nessuna parrocchia, però girò Barbarossa, film fortissimamente voluto dalla Lega
Nord.
"Me lo propose la Rai: mi
incuriosiva fare un film d’azione con grandi scene di battaglia e accettai...
tutto qui".
Non andò tanto bene.
"In Italia fui massacrato, ma
è stato il film che è stato venduto di più all’estero, 60 Paesi! Lì delle nostre
polemiche non interessava niente".
Fece fare una comparsa
anche a Umberto Bossi.
"Compare in una scena da
fermo, ma non ho mai avuto nessuna richiesta o intromissione, non mi è stato
chiesto nemmeno di far recitare qualche raccomandato come accade quando c’è di
messo un partito. Però...".
Però?
"La Lega fagocitò quel film e
fu un danno, perché scatenò critiche feroci".
Lei insegna anche cinema.
Per fare un buon film, cosa conta di più: soggetto, sceneggiatura, attori?
"Da una buona sceneggiatura
può uscire un buon film, senza no... è la base di una macchina molto complessa
in cui ti trovi a muovere molto denaro".
Quanto costano i suoi film?
"In media, dai 3 ai 6 milioni
di euro. Ma il confronto con altri Paesi è impietoso... Solo la scena della
lotta con l’orso nel recente Revenant è costata 3 milioni di dollari, la stessa
cifra che mi ci è voluta per girare tutto Ustica!".
Il suo attore feticcio?
"Murray Abraham: a lui mi lega
un’amicizia vera, affetto, mi invita spesso a New York a trovarlo... lavorare
con lui è come guidare un purosangue, è talmente bravo che fa subito scene
perfette. Con lui spesso basta un solo ciak... trovo stupido chi ne fa 200 per
una scena, non puoi spremere un limone per ore".
Il film a cui è più legato?
"Vajont, esperienza umana
irripetibile. Quando andai la prima volta a Longarone, la gente aveva ostilità e
rancore nei miei confronti. Quando però videro l’impegno che ci mettevo, le ore
passate sul set, alla mattina cominciai a trovare cesti di frutta e salami
davanti a casa".
E dopo il film?
"Ebbi la folle idea di
organizzare l’anteprima davanti alla diga del disastro, c’era una tensione da
tagliare col coltello e migliaia di persone sedute lì davanti a vederlo. Andò
bene. Oggi mi adorano e mi hanno anche dato la cittadinanza onoraria".
Progetti?
"Mi piacerebbe fare un film
sulla morte di Mussolini, altro evento su cui non è mai stata fatta luce. Ho già
fatto uno studio approfondito scoprendo verità molto scomode, ma l’Italia è un
Paese di pavidi... e per ora non trovo nessuno che mi appoggi. Intanto conto di
farne comunque un libro".
La felicità per il regista
Renzo Martinelli?
"È il momento in cui vedi
proiettato per la prima volta la tua pellicola, punto di arrivo di un percorso
costato magari anni di lavoro, con la consapevolezza che il tuo film rimarrà
nella storia. Con Piazza delle Cinque Lune, dedicato al caso Moro, andò così:
contestato all’uscita, oggi è oggetto di studio nelle università".
Piazza delle 5 lune: la
sfuggente verità sul caso Moro,
scrive Nicola Cappelli il 19 agosto 2010 su "Orizzonte Universitario". Piazza
delle Cinque Lune: qui fu ammazzato da ignoti il giornalista Mino Pecorella,
direttore della rivista Osservatorio Politico, famosa per i suoi scoop e la
pubblicazione di notizie riservate. Pecorella aveva promesso ai suoi lettori per
il giorno successivo lo svelamento di un fascicolo in suo possesso, che avrebbe
illuminato il caso Moro, dissolvendo la sua nebbia grazie al memoriale dello
statista democristiano. Non potè mai il povero giornalista rivelare ciò che
sapeva, dei suoi documenti non si trovò mai più traccia. Il film Piazza delle
Cinque Lune, unico film “approvato” dalla famiglia Moro (le altre riduzioni sono
state tutte senza scampo stroncate dai familiari del presidente DC, contestando
inoltre il fatto che i registi si siano sempre serviti di ex brigatisti come
consulenti), narra la storia di Rosario Sarracini, piccolo procuratore di
provincia: la vita sua e dei suoi collaboratori sarà sconvolta quando – mentre è
ormai prossimo al pensionamento – un brigatista ignoto lo avvicina e gli
consegna un microfilm con le riprese della strage di via Fani, rivelandogli di
possedere il memoriale di Aldo Moro. Scatenerà così la curiosità dell’ex
procuratore, la quale finirà per diventare morbosa, ossessiva, irrefrenabile e
quasi irrazionale pulsione verso la Verità. E’ proprio sul motivo della ricerca
della Verità che si incunea tutto il film, simboleggiata dal memoriale
introvabile. La Verità è il filo conduttore, la vera protagonista del film; ma
il rapporto con lei è conflittuale: da una parte la si desidera ardentemente,
con tutte le proprie forze, ci si tende verso di lei in uno spasmo, tentando
disperatamente di raggiungerla, ma d’altra parte lei si cela a noi e si sottrae
ai nostri sguardi; è il senso stesso che muove la vita umana. La Verità è ciò
che cerca il giudice Saracini. Ma la meta sembra lontanissima, anzitutto perché
si presenta come una catena di dubbi e di interrogativi, nella quale non appena
verrà sciolto un anello subito altri cento se ne troveranno collegati; in
secondo luogo per il travaglio che il percorso comporta, per la sofferenza e il
dolore che continuamente rallentano il passo del giudice e dei suoi
collaboratori; in terzo luogo per la complessità inconcepibile del disegno che
sta sotto il mistero da svelare, per lo shock inevitabile che ogni nuova
scoperta porta. Alla fine, non si potrà tuttavia che rimanere delusi: proprio
mentre Sarracini sta per aprire la porta della Verità, dopo essere riuscito con
molte peripezie a procurarsi la chiave, quella porta gli si richiuderà addosso.
Perché questo è l’insegnamento del film: non è vero che il tempo è sufficiente a
dissolvere la nebbia del mistero, a squarciare il velo del segreto. In mezzo a
tutto questo, il regista ripercorre tutte le ipotesi, tutte le sconvolgenti
scoperte, le incredibili coincidenze e le tremende scoperte, facendo incarnare
in Sarracini tutti i magistrati che si sono spesi per gettare luce sul caso.
Ecco dispiegarsi allora davanti a noi la nebulosa del caso Moro. Il risultato di
tutto ciò? Poveri illusi: la Verità rimarrà chiusa dietro una porta che non
potremo aprire, eterno supplizio di Tantalo. D’altra parte, non è forse vero che
la giustizia è come una ragnatela, che cattura gli insetti piccoli, ma finisce
rotta dagli individui più grossi? Un film tremendo nelle sue conclusioni e nei
suoi insegnamenti, condito da un’atmosfera di ansia e tensione, quella stessa
provata da Sarracini. Colpi di scena a ripetizione, rivelazioni di realtà (o
meglio, di ipotesi coerenti e verosimilissime) che vanno di pari passo con lo
svolgersi cronologico della vicenda: un brivido lungo la schiena e un rivolo di
sudore sulla fronte non vi abbandoneranno mai mentre guarderete questo film. Il
quale sarebbe troppo semplice definire poliziesco, troppo riduttivo definire
inchiesta. La conclusione, pessimista, ci lascia intendere che troppi hanno
interesse che la vicenda rimanga insabbiata, troppi lavorano per gettare altre
ombre. Non ci resterà, quindi, che unirci al grido di Luca Moro, e rivolgendoci
contro gli sconosciuti burattinai, urlare: «Maledetti voi, signori del Potere!».
Giovanni Pigozzo
PIAZZA DELLE CINQUE LUNE:
FILM STORICO O RACCONTO DI FINZIONE?
ANALISI DEL FILM DI RENZO MARTINELLI ALLA LUCE DI NUOVI ELEMENTI STORICI.
Relazione di Andrea Lomartire del 2005 pubblicata su "L'Archivio".
INTRODUZIONE.
Un film è sempre un fatto narrativo, un racconto formato da un intreccio
destinato alla soluzione finale, composto di eventi e di esistenti. Lo statuto è
in primo luogo estetico e non politico o storiografico. Tuttavia esiste una
narrazione cosiddetta “impegnata” che ambirebbe a divenire cinema politico e che
si riferisce ad una serie di opere profonde e minuziose, le quali
rifletterebbero, ineccepibilmente, il contesto storico sociale da cui
provengono. Si tratta di racconti legati agli uomini della contemporaneità. In
questo ambito si può affermare che il primo film politico della cinematografia
italiana è quello di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano che partendo da un
piccolo fatto di cronaca, la morte di Turiddu, il re di Montelepre, inizia
un’indagine del contesto politico del periodo, attraversando circostanze e nomi
che hanno preso realmente parte in quella intricata vicenda. Da Salvatore
Giuliano a all’ultimo Piazza delle Cinque Lune, il cinema italiano ha proposto
una serie di opere “politiche” che hanno contribuito fortemente alla formazione
di una coscienza storica, morale e nazionale del pubblico italiano. Il fruitore
dell’opera cinematografica, lo spettatore, è colui che assume un ruolo
importante ancora prima di entrare nella sala e vedere un film. Tale definizione
riguarderebbe proprio il film politico, in quanto, l’atto stesso di raccontare
una storia si completa nella mente dello “spettatore civile”. Non è soltanto un
atto percettivo, un puro meccanismo formale, di relazione tra significato e
significante. È molto di più: è in questo modo che lo spettatore dilata la sua
consapevolezza sociale, e acquisisce una coscienza critica della modernità in
cui egli si trova. Appartenere ad una comunità democratica e civile significa,
prima di tutto, vivere coscientemente il ruolo di cittadino. Esisterebbe,
quindi, un cinema politico, un cinema che guarderebbe senza troppe velature,
alla società in cui viviamo. Lo scopo di questo cinema è quello di ampliare e
approfondire la visione storica di quegli eventi che hanno caratterizzato la
vita pubblica e civile del paese tentando, al tempo stesso, una
interpretazione-sensibilizzazione su alcuni temi scottanti ancora oggi
irrisolti: il caso Mattei, l’omicidio di Pasolini, il sequestro Moro, la
scomparsa di Matteotti, lo stragismo, il terrorismo, la bancarotta di Michele
Sindona, la vicenda di Ambrosoli, la strage di Ustica. Il cinema di questo
genere avrebbe, per tanto, una funzione sociale e politica nel senso più
filosofico del termine: diverrebbe specchio e memoria di un percorso storico
fondamentale per il cittadino e che altrimenti rischierebbe di essere travolto
dal magma indistinto e, molto spesso, confuso dell’informazione. Senza la
possibilità di studiare il passato, non esisterebbe quella di realizzare un
futuro psicologico, sociale e politico. Dunque il cinema è la memoria, il
supporto storico e sociale, è la possibilità di sviluppare una coscienza storica
e culturale, necessaria per il progresso di una Nazione o Paese, che dir si
voglia. Tuttavia, come affermavo all’inizio, non bisogna dimenticare che il
cinema è prima di tutto un fatto narrativo, una finzione scenografica, formata
da attori e stampata su di una pellicola e riprodotta a 24 fotogrammi al
secondo. Nondimeno non si può negare una sorta di autentico impulso di ricerca
storica che costituisce uno dei suoi aspetti peculiari: se il cinema è svago,
spettacolo, emozione, è anche ricerca storica, indagine, proprio come i film
summenzionati, proprio come Piazza delle Cinque Lune, film quasi passato in
sordina all’interno del panorama cinematografico italiano. A tale proposito, il
regista afferma: «Quando sento parlare di "rinascita del cinema italiano" mi
viene da ridere. Su 50 film italiani prodotti, 45 sono commedie. Noi viviamo in
un paese che ha avuto 18 anni di terrorismo con 540 morti. Ci sono stati 3 film.
Tangentopoli ha prodotto un film. La società e il cinema seguono binari
differenti, mentre il tanto criticato cinema americano affronta ogni segmento
del sociale: la Cia, Kennedy, la Corea, le multinazionali del tabacco... Io sono
cresciuto stimando il cinema di Petri, Rosi, Vancini, Pontecorvo, Damiani,
decine di registi che attraversavano il sociale come delle locomotive. Perché è
difficile fare un buon cinema civile in Italia? Io spero che questo film serva
ai giovani per riflettere». Dunque un cinema la cui funzione è ricordare,
sviscerare il passato rimosso, tentando di creare un dibattito acceso e
produttivo. Da questo punto di vista il cinema di Martinelli, si veda l’esempio
di Porzus o di Vajont, è certamente un alto contributo alla ricerca della verità
storica, giudiziaria e al tempo stesso, opera di alto impegno civile e
“politico”. Nel caso specifico, come metterò in evidenza attraverso l’ausilio di
documenti giudiziari e il confronto semantico narrativo del film, l’impegno
civile viene fortemente evidenziato dall’indagine proposta: i misteri di via
Fani, le dichiarazioni ambigue di alcuni brigatisti, la dinamica balistica del
sequestro. Si tratta di elementi specificatamente giudiziari che finiscono per
avvalorare l’ipotesi investigativa del film. Il valore civile emerge nel
tentativo di spazzare via la menzogna, l’occulto, e mostrare il possibile
complotto. Al centro del film c’è la vicenda di Aldo Moro, la cui storia ha
continuato a ispirare alcune opere cinematografiche: Il caso Moro di Giuseppe
Ferrara, quello grottesco e profetico di Elio Petri, Todo Modo, e in fine, anche
se con un tono assai diverso, quello di Marco Belloccio, Buongiorno Notte.
Tuttavia, soltanto nell’ultimo film di Martinelli si può iniziare a parlare di
indagine giudiziaria in cui vengono rappresentati, con tanto di nome e cognome,
i principali protagonisti di questa tragica vicenda. La verosimiglianza della
narrazione costituisce un alto contributo del cinema di indagine, da divenire,
un importante esempio di ricerca storica. Da qui, come analizzerò, prenderanno
forma due racconti: quello dei personaggi che compiono l’indagine sul sequestro
Moro e quello specifico del caso Moro. Si tratta di due racconti sovrapposti, da
cui emerge la particolare struttura del film. Anche da questo, mi preme
ricordare, che l’efficacia di un film, e di questo film, è data dalla
costruzione narrativa ed estetica del racconto. Tale costruzione è il vero
obiettivo del film, il compito di suggerire elementi inquietanti attraverso uno
stile specifico e particolare. Solo se si comprende il valore estetico e
semantico del film, possono emergere gli indizi inquietanti che lo stesso
regista Martinelli ha messo in scena. Il trattamento di eventi storici, riferiti
a circostanze esatte e documentate, offrono, indubbiamente, l’idea di un cinema
impegnato e “politico”; ma è soprattutto la forma estetica del racconto, il
montaggio, l’intreccio, la costruzione narrativa, la sua realizzazione che
costituisce la fonte inesauribile del cosiddetto cinema politico e poetico.
1. PIAZZA DELLE CINQUE
LUNE, UN FILM POLITICO.
«Quando si dice la verità, non bisogna dolersi di averla detta. La verità è
sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi». Si tratta della didascalia
iniziale del film, una citazione dello stesso Aldo Moro. E Martinelli, sembra
averla presa alla lettera: con questo film ha voluto «tentare un avvicinamento
onesto alla verità […] il caso Moro rappresenta un mistero in assoluto […] gli
anni di piombo hanno prodotto in questo paese, in 18 anni, più di 500 morti.
Questa galassia del terrorismo ha prodotto 3 o 4 film. Quindi vuol dire che la
cinematografia italiana è malata. Quando un cinema non interpreta il sociale,
non lo vive attraverso i suoi cineasti è un brutto segno». La didascalia, in
primo luogo, assume un ruolo fortemente “ideologico”: non soltanto attraverso il
racconto che sta per svelarsi al pubblico, ma anche attraverso la scelta di un
tema particolare e spinoso come il caso Moro. Il regista è inevitabilmente
presente sin da questo livello verbale: la «verità» non è soltanto un punto di
vista storico e giudiziario, ma è anche un punto di vista estetico e ideologico,
che preme contro l’altro cinema italiano, quello che inconsapevolmente rimuove
il dovere di descrivere la storia del paese, quello che dimentica il compito
civile e sociale di un arte indirizzata verso l’impegno costruttivo della
società. In questo preambolo, il regista introduce lo spettatore all’interno
della storia e, al tempo stesso, gli indica una direzione precisa: la ricerca
della verità. In oltre, la didascalia si riferisce, inevitabilmente, ad un
contesto storico e ad un contesto narrativo. La funzione storica è indicata
dalla ricerca di un difficile equilibrio politico sostenuto da Aldo Moro, spinto
da un’opera di mediazione e di equilibrio tra le diverse forze del paese.
Durante la sua prigionia, lo statista avrebbe analizzato, attraverso le sue
lettere, l’assurdo comportamento di uno Stato che si era trovato lui stesso a
servire e ad incarnare. Moro tenterà di trattare i suoi “segreti”, elaborando,
in più di un’occasione uno scambio con altri prigionieri brigatisti. Sarà un
tentativo inutile, scartato in principio dal suo stesso partito. L’unico esito
della trattativa sarà quello del 9 maggio: Moro, il suo corpo, verrà ritrovato
dentro il cofano di una Renault 5 senza che egli abbia potuto comprendere,
probabilmente, la forza oscura di un certo livello della “politica” che lui
stesso si era trovato a praticare e poi a interrogare. Dunque la «verità» della
didascalia scelta dal regista Martinelli tende a ribadire il significato di
ricerca, di mediazione e di accordo che ha caratterizzato l’attività politica di
Aldo Moro, fuori e dentro la sua prigionia. Insieme alla funzione
storico-biografica, si può rintracciare la funzione narrativa che il film si
propone di portare a compimento secondo la migliore tradizione cinematografica
italiana. Il film può tranquillamente essere inserito in ambito del cosiddetto
cinema politico. Si tratta di osservare come il film tenti di raccontare il
“caso” Moro anche attraverso gli “indizi” giudiziari, evitando di limitare la
narrazione soltanto al puro intreccio. Il film, mentre racconta la storia del
Giudice Saracini, un personaggio inventato, tratta la verità giudiziaria del
misterioso sequestro dello statista, avvalendosi di una precisa e dettagliata
documentazione e della consulenza del senatore Sergio Flamigni. Dunque, il film
argomenta la sua storia intorno alla ricerca di una verità possibile, di una
verità giudiziaria tentando di mettere insieme i vari tasselli del caso e trarne
un’immagine d’insieme quanto più vicina alla drammatica vicenda dello statista.
La ricerca della verità è presente anche attraverso il linguaggio verbale che
culmina in molti dialoghi: l’esclamazione di Branco (Giancarlo Giannini),
guardia del corpo del giudice, il quale considera il Memoriale un’ossessiva
ricerca della verità; attraverso il misterioso agente segreto a Parigi (F.
Murray Abraham) che imposta un discorso piuttosto sibillino sulla verità e il
corso della storia; o ancora, caso più drammatico, attraverso il marito di
Fernanda Doni (Stefania Rocca) che ironizza piuttosto pesantemente sulla ricerca
di una verità impossibile che rischia di sfaldare tutta la famiglia. Dunque, da
questo punto di vista, il film presume di raccontare la verità sul caso Moro. Le
inquadrature, i tasselli del puzzle Moro, sono gli indizi che tentano di ridare
il senso di quella verità perduta e attraverso l’ausilio delle immagini girate:
il caso estremo, ma verosimile si ha con il sequestro di Via Fani, o ancora
attraverso i frammenti di flashback che si palesano improvvisamente sullo
schermo durante l’indagine dei tre protagonisti (si pensi all’arresto di Curcio
e di Cagol, alle scene di Via Gradoli, l’uccisione di Pecorelli, l’esecuzione
del colonnello Varisco). In questa prospettiva, la verità, quella costruita
dalla finzione scenica, finisce per divenire l’unico elemento storico
giudiziario che mostra il crimine come oggettivamente avvenuto. In tal senso si
può scorgere l’ambizione implicita del film, e cioè quella di divenire una sorta
di resoconto giudiziario, la versione più verosimile degli eventi che dettero
vita al caso Moro. Da un punto di vista narrativo, quello che Seymour Chatman ha
definito come la forma del discorso, si può osservare come sia fondamentale il
rapporto che si stabilisce tra l’evento raccontato e il punto di vista della
macchina da presa. Il film ricorre molto spesso all’inquadratura dall’alto (la
panoramica) quasi ad indicare l’importanza di una visione globale che possa
mostrare i tasselli del racconto, altrimenti non visibili. Non è certo un caso
che il film si chiude con l’ennesima inquadratura dall’alto, la quale, oltre a
schiacciare il personaggio del giudice colto di sorpresa dall’incontro con
Branco, ribadisce il fatto che “sopra” alla visione provinciale del giudice, o
“oltre” il punto di vista ideologico e terroristico delle famigerate Brigate
Rosse, vi sarebbe stata una strategia più ampia, di livello internazionale che
spiegherebbe la possibilità di un complotto ordito contro il fautore della
politica di Solidarietà Nazionale. Il giornalista Willan descrive, nel suo bel
volume, I burattinai, tutte le incongruenze dell’affaire: «e, infine, va
sottolineata la profonda differenza che esiste – anche a livello psicologico –
tra i due modi di muovere l’ “attore di legno”: il burattinaio costituisce un
prolungamento della mano del burattinaio, una amplificazione dei suoi movimenti
compiuta in positivo; esso prende corpo e vita dal braccio e dalle dita di chi
lo manovra: la marionetta invece viene mossa come in negativo, in un modo
indiretto, che da qualche marionettista ho sentito paragonare all’atto di
suonare uno strumento musicale a corde: richiede dunque un attenzione di tipo
razionale». L’interpretazione è presto data: i brigatisti sono stati delle
marionette, mosse a loro insaputa da una serie di interessi nazionali e
internazionali. Il punto di vista, la veduta su Siena, la visione di Roma,
spiega questa fondamentale impostazione narrativa del film. La teoria del
complotto prende forma attraverso un’attenta analisi storica e giudiziaria, con
precisi riferimenti collusivi tra Stato, servizi segreti e apparati militari.
Per Willan il complotto esiste, non è soltanto una teoria, ed è quel movimento
“negativo” che appartiene alle diverse marionette che hanno occupato la scena.
Lo stesso Sciascia, nel suo acuto scritto L’affaire Moro, aveva osservato che la
“verità” e il “punto di vista” sono, in qualche modo, coincidenti: il lettore
comprende che tutti i suoi sospetti sono erronei e per questo, sul finire del
racconto (il punto di vista) è costretto a ri-iniziarlo, «il lettore, inquieto,
rivede i capitoli sospetti e scopre un'altra soluzione, la vera». Dunque, il
film nasce come ricerca della verità non più metaforica o simbolica, ma immagine
diretta e immediata, come l’organigramma dei Comitati di sicurezza istituiti
subito dopo il sequestro Moro, esibito all’interno di un’inquadratura, con i
nomi degli affiliati alla Loggia Propaganda Massonica P2. La verità non è più
allegorica o sottesa come avveniva in certe opere italiane. Si pensi a Salvatore
Giuliano in cui Francesco Rosi evita di citare il nome del ministro degli
Interni Mario Scelba che lo stesso Gaspare Pisciotta aveva chiamato in causa
durante il processo di Viterbo. Nel 1986 Il caso Moro di Giuseppe Ferrara fa un
accenno, se pur minimo, alla loggia P2, ma evita di citare nomi importanti. Il
racconto di Piazza delle cinque lune mostra con estrema chiarezza la trama che
ha generato l’affaire Moro, evitando di costruire il suo racconto attraverso
complicate allusioni storiche o con l’ausilio di complesse forme simboliche. Il
film parla chiaro e non risparmia accuse e sospetti. Dove esiste un margine per
l’indagine, il racconto penetra la materia storica e tenta di approfondire gli
eventi e i comportamenti degli uomini politici che, volenti o nolenti, hanno
preso parte alla tragica vicenda.
2. I PRIMI INDIZI.
Il film costruisce il suo inizio con due elementi fondamentali: il sequestro di
Via Fani e il Memoriale Moro. Si tratta di due aspetti estremamente importanti
che, a livello narrativo, servono a ricostruire le circostanze storiche della
vicenda Moro e di cui, ancora oggi, persiste un’imbarazzante ambiguità sulla
loro dinamica. Sono i primi due “indizi” dell’indagine che il film si propone.
Il giornalista fiorentino Marcello Coppetti ricorda come lo stesso Licio Gelli,
il capo venerabile della Loggia P2, facesse riferimento ad un filmino relativo
al sequestro Moro: «loro erano abituati a filmare tutto, l’avranno anche filmato
quando l’hanno ucciso, io credo. Non credo che lui si aspettasse di morire,
almeno così mi hanno detto». Lo stesso Willan cita Flaminio Piccoli il quale
aveva osservato la scomparsa della “pizza” delle riprese televisive a circuito
chiuso che avrebbero registrato ogni attimo delle giornate del sequestro, «tale
patrimonio è in possesso di non più di due o tre persone che lo renderanno
pubblico, si presume, quando lo riterranno, per loro, più politicamente
opportuno». Tale materiale, secondo quanto scrive Il Borghese (17 febbraio 1985)
sarebbe stato recuperato in un baule durante l’arresto del terrorista Giovanni
Senzani. Forse i servizi segreti ne ebbero una prima visione onde farne un
numero di copie. Il giornale ipotizza tre soluzioni:
1. i servizi decidono di
tenere il film nei loro archivi senza informare il governo dandone una copia ai
servizi di un paese alleato (CIA?);
2. i servizi mostrano il film
ad un “personaggio” importante che lo mostra alla corrente politica e ai suoi
dirigenti i quali decidono di nasconderlo;
3. i servizi informano
l’ufficio della Presidenza del Consiglio della scoperta, e il video è tenuto
nascosto come segreto di stato. A presumere tale circostanza è anche lo stesso
ex-brigatista Bonisoli durante l’intervista con Sergio Zavoli.
Bonisoli ricorda che tutti gli
attimi della prigionia di Moro venivano filmati da una «telecamera a circuito
chiuso», ma non da un «videoregistratore». Si è parlato anche del nastro
magnetico con la voce di Moro, anche questo mai trovato. Adriano Sofri cita la
possibile esistenza del film che ritrarrebbe Moro durante la prigionia e
dichiara «che i documenti dell’impresa contro Moro siano stati distrutti “per
ragioni di sicurezza” è difficile da credere, per il feticismo brigatista di
allora…». Tuttavia, ancora oggi non è dato sapere a chi siano state consegnate
le presunte bobine audio e video. Il silenzio di Moretti, come ricorda Flamigni,
non fa che ostacolare la ricerca di una verità giudiziaria e storica
fondamentale. Tuttavia nessuna di queste testimonianze comproverebbe l’esistenza
reale del filmato relativo al sequestro del 16 marzo. Per la realizzazione del
film, il regista Martinelli è stato colto da una circostanza simile e in
particolare dalla frase sibillina di Gelli relativa al «rapimento del secolo» il
quale molto probabilmente era stato filmato dalle stesse Br[20]. Questa ipotesi
non fa che avvalorare la soluzione narrativa adottata dal regista, ovvero la
messa in scena del rapimento di Moro come documento oggettivo e reale, realmente
esistito. Le immagini sono lì presenti e colpiscono tanto il giudice quanto lo
stesso pubblico che si sente violentemente catapultato nella tenebrosa atmosfera
di via Fani e nella feroce esecuzione: gli eventi visivi, in questo senso,
vengono percepiti come veri, come il reale resoconto di quel giorno. Tale
funzione narrativa viene descritta eccellentemente da Lotman, attraverso la
sovrapposizione di due codici: il livello cinematografico (quello della sala in
cui si trova il pubblico o quello della finzione) e il livello filmico (quello
della proiezione del super8 di via Fani). Questo fatto fa percepire come “vita
reale” o “non-finzione” le immagini della strage proprio perché lo stesso
personaggio della storia, il giudice Rosario, guarda quelle immagini proiettate
sul muro della sua abitazione. Si tratta della rappresentazione all’interno
della stessa rappresentazione, il cinema nel cinema, “lo scherno nello schermo”,
per cui lo spettatore è indotto a percepire tutto il filmato del sequestro Moro
come realmente accaduto. Tutto il film si baserà sul “ritrovamento” di questo
filmato e sull’indagine che i tre protagonisti, il giudice Rosario, la sua
assistente Fernanda Doni e il caposcorta Branco, effettuano nelle diverse
circostanze del racconto. Questo materiale visivo, inteso come documento storico
all’interno della narrazione si basa soprattutto sullo studio di questo filmato,
tanto da poter dire che il film Piazza delle cinque lune nasce e si costruisce
su questa idea “estetica” particolarmente forte. Il secondo elemento riguarda il
misterioso Memoriale Moro di cui si hanno ufficialmente due versioni. Si tratta
di analizzare le misteriose rivelazioni che Moro fece ai suoi carcerieri durante
l’interrogatorio del “popolo”. Il primo Memoriale venne ritrovato in via
Montenevoso a Milano nel 1 ottobre del 1978; il secondo verrà ritrovato nello
stesso luogo il 9 ottobre del 1990. Colpisce la strana coincidenza, due
memoriali ritrovati nello stesso luogo a distanza di 12 anni: responsabilità dei
carabinieri o manovra politica (?), «un muro alzato a regola d’arte», ricorda
Sofri proprio mentre ne cadeva un altro, quello di Berlino. Si parlò, ma senza
prove, di una consegna da parte del generale Alberto dalla Chiesa al ministro
Andreotti. L’elemento più importante riguarderebbe la differenza esistente tra i
due memoriali. Nel secondo Memoriale risaltano le parti mancanti: sono
evidenziati chiaramente i paragrafi relativi a Gladio (la segretissima struttura
militare pronta per un intervento armato contro una probabile invasione
dell’Unione Sovietica), i rapporti Andreotti-Sindona (i cosiddetti «pranzi
americani» a cui seguiva l’esplicito disappunto di Moro) e i finanziamenti degli
Stati Uniti diretti alla corrente democristiana attraverso la Cia. Ovviamente i
due “indizi” summenzionati non entrano in scena in modo autonomo, ma sono
incastrati nella struttura narrativa attraverso la vicenda del giudice Saracini.
Il film è dunque iniziato quando il giudice viene assalito fuori la sua
abitazione: «non si tratta di una rapina […] voglio solo che dia un’occhiata a
questo», dice l’aggressore che gli consegna un misterioso microfilm. Rosario
tenta una prima visione manuale, ma senza riuscire a distinguere gli elementi
all’interno del fotogramma. La scena passa immediatamente alla proiezione del
Super8, dove prendono forma le immagini della strage del 16 marzo 1978 (ancora
una volta l’inquadratura dall’alto). Lo straordinario documento cinematografico
ricostruito da Martinelli (in realtà girato in 16mm e in seguito rielaborato in
postproduzione digitale) ripropone con particolare minuzia i particolari di quel
tragico giorno: la macchina bianca dietro a quella della scorta, l’assalto da
sinistra, un altro terrorista che attacca la scorta da destra, la presenza di un
misterioso uomo con l’impermeabile e tutta la dinamica del prelevamento di Moro.
L’argomento centrale del film è dunque Aldo Moro e la sua apertura al partito
comunista di Enrico Berlinguer, iniziata sin dal 1964 attraverso la
conciliazione con il partito socialista. Dietro la genesi di un nuovo corso
politico che va sotto il nome di Solidarietà Nazionale, i gruppi eversivi di
sinistra vedono la minaccia del Potere “imperialista”. Per l’estrema sinistra
rivoluzionaria, Moro è il nemico del “popolo” e del progresso sociale di tutto
il proletariato. Moro è bersaglio della rivoluzione comunista: «dopo il suo
degno compare De Gasperi, è stato fino ad oggi il gerarca più autorevole, il
"teorico" e lo "stratega" indiscusso di quel regime democristiano che da
trent'anni opprime il popolo italiano», per i brigatisti Moro è il fautore della
«controrivoluzione», artefice delle politiche «sanguinarie» degli anni ’50, «il
padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle
centrali imperialiste». E nel secondo comunicato si legge «chi meglio di Aldo
Moro potrebbe rappresentare come capo del SIM (Stati Imperialisti delle
Multinazionali, ndr) gli interessi della borghesia imperialista? Chi meglio di
lui potrebbe realizzare le modifiche istituzionali necessarie alla completa
ristrutturazione dello SIM? La sua carriera però non comincia oggi: la sua
presenza, a volte palese a volte strisciante». Al momento del sequestro Moro non
era certo un politico particolarmente popolare, osserva Willan, poiché
rappresentava trent’anni di governi corrotti e incapaci, guidati da un partito
criticato. Moro era in oltre definito mister omissis per i suoi numerosi segreti
di Stato imposti ai rapporti sugli abusi dei servizi segreti e per le dubbie
attività dei compagni di partito per lo scandalo Lockheed. Le attività
finanziarie del partito non l’avevano arricchito, poiché egli era effettivamente
interessato più al bene pubblico che all’ottenimento del potere fine a se
stesso. La sua politica di mediazione lo fece salire al centro della politica
italiana da divenire il principale obiettivo dell’eversione rossa e,
contemporaneamente, politico poco gradito dalle correnti atlantiche. Se
l’argomento centrale del racconto è Aldo Moro, il film pone al centro della
scena la storia di un giudice che in un altro tempo e in un altro spazio viene a
contatto con il caso Moro. Il racconto è filtrato da un contesto narrativo
“estraneo” alla peculiarità del caso Moro e per questo tutti gli elementi che
entrano in contatto sono “indiretti” a differenza, per esempio, del film di
Ferrara che tratta specificatamente il rapimento Moro dall’inizio alla fine, con
tanto di nomi e cognomi seguendo una precisa ricostruzione temporale. Tuttavia
il racconto di Martinelli finisce per avere una forte valenza “storica” proprio
perché i protagonisti storici della vicenda sono ancora oggi presenti sulla
scena giudiziaria e istituzionale del paese. Di fronte ad un evidenza così
prorompente, come la strage di via Fani, si presenta il problema principale, lo
scopo narrativo, del giudice Saracini. Attraverso il suo “problema”, si gettano
le basi per l’intreccio della narrazione: se lo scopo del personaggio sarà
quello di indagare sul misterioso filmato, lo scopo della narrazione sarà quello
di analizzare tutti i misteri esistenti nell’affaire. La formalità e il rigore
che seguono nella scena del discorso commemorativo, fanno da contrasto allo
stato d’animo del giudice. In tal senso le sue parole sembrano essere ancora più
“vuote” e distanti da quel potere che fino all’ultimo giorno aveva servito, un
potere che probabilmente nasconde ancora molti misteri. Sono parole che rivelano
un presagio sinistro e oscuro: «oggi entro, ufficialmente nella categoria dei
pensionati», un mondo, sembra dire il giudice, insidioso e pericoloso in cui si
è soli. La citazione del poeta russo Joseph Brodsky, non è soltanto una semplice
affermazione di copione; e non è soltanto funzionale alla struttura del
racconto: la ricerca della verità e la necessità della passione sono
l’espressione più vitale e civile della partecipazione al mondo e rappresentano
un dichiarato “testamento spirituale” del regista: «solo il cercando la verità,
solo comunicando la verità si dà senso alla propria esistenza». Tale discorso,
inizia il percorso investigativo del giudice, e avvia definitivamente l’indagine
del film. L’ulteriore incontro con il misterioso aggressore, ha la funzione di
chiarire gli obiettivi di questo secondo personaggio. Egli si identifica come
ex-brigatista che prese parte alla strage di via Fani (dietro alla moto Honda)
che a causa di un tumore giunto allo stadio terminale ha deciso di consegnare il
filmino al giudice. L’ex terrorista si fa portavoce di un importantissimo
indizio relativo al Memoriale di cui sono state dette molte «bugie» e in cui «i
punti cruciali non si conoscono ancora». In sostanza, attraverso il personaggio
brigatista, di cui il pubblico non vedrà mai il volto, il racconto rivela che
esisterebbe una versione integrale e originale del Memoriale Moro. Qui nasce una
sorta di rapporto dialettico tra realtà e finzione. Il filmato e il Memoriale
sono chiaramente due elementi narrativi, di fiction, ma finiscono per essere
percepiti come elementi storici e reali. La loro presenza determina la
narrazione, genera il racconto del film (finzione) e produce l’indagine sul caso
Moro (analisi storiografica). È la caratteristica tematica del film, il quale
nasce e si sviluppa su elementi immaginari, trattando al tempo stesso la storia
reale di Moro. Su tale costruzione fa leva la verosimiglianza dell’opera. Da
questo punto prende avvio la parte del film in cui si analizzerà la dinamica del
sequestro di via Fani, in cui emergeranno alcuni elementi giudiziari
delicatissimi che non si limiterebbero soltanto alla finzione del racconto.
3. LA VISIONE DEL SUPER8.
Una delle caratteristiche narrative del film è quella di trattare gli elementi
giudiziari del caso Moro attraverso l’ausilio di un filmato completamente
inventato per il racconto. Da questo confronto, tra la realtà oggettiva del caso
e la fiction narrativa, emerge il valore tematico del film. La forza del
racconto è offerta da un filmato di finzione che riesce a descrivere con
esattezza storica gli eventi del sequestro Moro, senza modificare o alterare la
presunta veridicità dei fatti. La realizzazione del filmato, costituisce un
fondamentale esempio di costruzione “filologica” della strage di via Fani, da
divenire la fonte principale non soltanto del racconto, ma anche della detection
proposta dal film. Gli elementi evidenziati in questa prima parte sono tre: il
mancato tamponamento, l’uccisione di Leonardi attraverso un misterioso quinto
uomo e la misteriosa presenza di un superkiller. La visione del filmato debutta
con la descrizione di quella mattina del 16 marzo 1978. I vari indizi, oltre ad
essere chiaramente visibili sullo schermo, sono evidenziati dal commento del
giudice Saracini, Fernanda Doni e il caposcorta Branco. La scelta formale del
regista è quella di supportare il linguaggio visivo del filmato con quello
verbale, permettendo di far emergere più chiaramente gli elementi indiziari.
Rosario fa notare una Fiat 128 familiare, con targa diplomatica posteggiata
all’angolo di via Stresa, guidata dal capo brigatista Mario Moretti. Quando la
Fiat 130 di Moro arriva da via Trionfale verso Via Fani insieme alla Alfa della
scorta, una moto Honda li supera, dando così il segnale a Moretti. Quest’ultimo
fa marcia indietro parcheggiando la sua auto a circa 30 metri dello stop di Via
Fani. Vedendo poi arrivare la Fiat 130 di Moro, riesce dal parcheggio
ostacolando il suo arrivo. La prima novità emerge proprio in questa circostanza.
La versione ufficiale dei fatti, riferita da Morucci, riferisce che la macchina
di Moro fu costretta a tamponare quella di Moretti. Ma il filmato mostra una
circostanza assai diversa: la macchina di Moro non tampona affatto quella di
Moretti, ma si ferma poco prima, costretta dagli spari provenienti dal lato
destro della strada. Durante la loro deposizione (osserva il personaggio di
Fernanda) Moretti e Morucci avevano dichiarato una dinamica completamente
differente: il primo aveva affermato che lo scontro con la macchina di Moro era
stato violento e che egli aveva dovuto tirare il «freno a mano» per fermare
l’avanzata della macchina; il secondo aveva affermato che il tamponamento era
ripetuto. Il filmato mostra inequivocabilmente che le due macchine si erano
appena sfiorate (circa 20 cm), senza «nessun graffio […] nessun segno di frenata
sull’asfalto», come osserva Rosario. Se ne deduce che rallentarono e poi si
fermarono senza toccarsi. La forza semantica della scena, la descrizione
minuziosa dei diversi momenti, rappresenta il punto più alto del film e forse il
più riuscito. Le immagini sembrano uscite dalla cronaca di quei giorni per
divenire storia. I gesti e le azioni raccontano con estrema precisione quelle
drammatiche circostanze. Il filmato sembra essere, al di là della finzione
scenica, un documento di altissimo valore storico. Ma questo avviene anche per
la rigorosa costruzione dell’agguato, basato su un precisa documentazione e
sulla logica consequenzialità degli eventi. La forza estetica del filmato è
quindi supportata da una ragione filologica fondamentale. Morucci dichiarerà di
essere stato il quinto uomo sul lato destro della strada, quello che doveva
colpire mortalmente il maresciallo Leonardi. In quello stesso frangente, un
gruppo di quattro brigatisti, posti sul lato sinistro della strada, avrebbero
avuto il compito di eliminare la scorta. Fu questo fatto a causare il
tamponamento. Ma il film mostra un'altra dinamica, e non lo fa attraverso un
atto deliberato e parziale, ma attraverso la stessa fenomenologia dell’evento.
Il regista conosce bene questa circostanza. L’uccisione di Leonardi sarebbe
avvenuta in un tempo incomprensibilmente lungo, in cui il maresciallo sarebbe
stato seduto ad osservare l’impatto: da questo si deluciderebbe già una strana
dinamica balistica che forse si riferisce agli stessi attentatori. La 128 di
Moretti, frena bruscamente allo stop: seguirebbe l’ipotetico tamponamento della
130 di Moro e dell’Alfetta della scorta. Dalla 128 sarebbero scesi due
brigatisti, mentre quasi contemporaneamente, dal lato sinistro della colonna
sarebbero giunti altri quattro terroristi preposti all’eliminazione di tutta la
scorta. L’unico a reagire sarà Iozzino che, infatti, verrà trovato ucciso con 17
colpi sull’asfalto. E in tutto questo tempo, cosa fa il maresciallo Leonardi?
Ricorda Martinelli: «lo stunt che è seduto nella posizione del maresciallo
Leonardi, mi blocca l’azione… Renzo, ma io che ci faccio qui? Me ne sto seduto
ad aspettare che quelli mi arrivino addosso?». Si tratta di una perplessità
scenica che riflette quella della dinamica e lascia pensare sulle veridicità
delle versioni. Probabilmente l’evento traumatico che avrebbe bloccato Leonardi
in quella posizione non è l’impatto tra le macchine (falso) ma qualcos’altro.
Leonardi venne ucciso da destra e quindi c’era un quinto sparatore oltre ai
quattro di sinistra, un killer solitario. Leonardi viene trovato in una
posizione rilassata e serena, come mostra la foto scattata dopo l’attentato,
come se stesse parlando con Ricci. Il capo scorta sarebbe stato ucciso senza
accorgersi di cosa stesse succedendo. Sei pallottole lo colpiscono dietro la
schiena, provenienti dalla destra da uno sparatore che ha saputo muoversi in
perfetto sincrono con l’incidente. Subito dopo, due pallottole avrebbero colpito
il petto di Leonardi. Soltanto attraverso questa dinamica è stato possibile
giare la scena: volendo anche seguire la versione di Moretti o di Morucci,
sarebbe stato impossibile. Da questo punto di vista, la costruzione della scena,
assumerebbe il valore di una perizia giudiziaria senza precedenti. Si tratta di
un caso formidabile in cui l’impegno civile dell’arte cinematografica si
concilia con quello della verità storica: è l’esempio in cui il cinema, come
immagine movimento può intervenire nella realtà sociale per rappresentare il suo
più alto contributo etico ed estetico. La costruzione della scena costringe il
film, per forza di cose, ad ipotizzare un'altra dinamica dell’evento e per
questo scorge senza imbarazzo brigatisti e istituzioni dietro una versione
troppo spesso superficiale. Dopo l’eliminazione di Leonardi, il quinto uomo si
toglie dall’azione per dare la possibilità agli altri quattro terroristi di
continuare l’assalto. Ed è in questo punto del film che emerge il secondo
indizio: il misterioso superkiller. Il personaggio di Fernanda ricorda che
secondo le deposizioni, il misterioso killer sarebbe giunto in via Fani insieme
a Moretti. Qui si sarebbe appartato con gli altri tre brigatisti, sul lato
sinistro della strada. Dopo l’esecuzione di Leonardi da parte di Morucci,
sarebbe entrato in azione. Il commento del giudice descrive la perizia
balistica. I bossoli ritrovati dimostrano che il lavoro militare fu di «alta
specializzazione»: i brigatisti spararono da punti contrapposti e soltanto un
brigatista, sembrerebbe, ne uscì ferito. Il gruppo riesce ad uccidere la scorta,
senza colpire Moro pur essendo da mezzo metro dal maresciallo Leonardi. Saracini
osserva che in via Fani furono sparati 93 colpi in soli 90 secondi provenienti
da sette armi diverse. I colpi furono soprattutto dei brigatisti. Soltanto 20
furono quelli della scorta mentre 49 colpi, andati tutti a segno, furono sparati
da un arma unica, una pistola mitra calibro 9 Parabellum Stern o forse FNA 1943,
appartenente al misterioso superkiller. Il teste Pietro Lalli, benzinaio di via
Fani, esperto di armi, descrive l’agguato e la tecnica di questo superkiller con
“autentica ammirazione”. Il terrorista spara con un’arma a recupero di gas, ha
la mano guantata sulla canna per evitare i sobbalzi e colpisce con precisione:
la prima raffica contro Leonardi e Ricci, poi un salto indietro per allargare il
raggio di tiro e sparare contro l’Alfetta di scorta: «la professionalità
criminale dell’attentatore è talmente elevata, a giudizio degli stessi periti,
da non potersi ragionevolmente inquadrare in nessuna delle figure dei brigatisti
noti». Rispetto a questo superkiller gli altri brigatisti fanno ben poco:
sparano 4 colpi con un arma, 5 con un'altra, 3 con quella di Raffaele Fiore, 8
con la Smith & Wesson poi sequestrata a Prospero Gallinari. In tutto sei armi.
Il racconto introduce le testimonianze oculari del tragico giorno e,
naturalmente, lo fa secondo un criterio oggettivo e storico senza alterare la
veridicità dei fatti. Pietro Lalli, racconta delle «raffiche complete contro la
Fiat 132». Alessandro Marini, l’ingegnere civile in motorino viene addirittura
bloccato da una mitragliata dall’uomo dietro la moto Honda. Egli vede Moro
salire in macchina con un andamento passivo, dimesso e soprattutto illeso. Luca
Moschini studente di medicina a bordo di una Fiat 500 vede la moto Honda e due
uomini in divisa. Quella mattina era presente anche l’agente di polizia del
settimo reparto celere di Roma, Giovanni Intrevato che vede distintamente il
prelevamento di Moro. Per raccontare la scena, il film adotta un montaggio
alternato tra la ricostruzione delle testimonianze e la fiction degli eventi
descritti. Tale commistione di tempi e spazi diversi, che il cinema conosce come
flashback, sono potenziati dallo stile “sporco” e mosso della macchina da presa.
Le inquadrature sembrano rubate da un archivio storico. Tuttavia il film evita
di trattare l’identità del superkiller in maniera dettagliata e precisa. Uno
stranissimo elemento, non inserito nel film, costituisce un importane indizio.
Questo si riferisce ai proiettili dell’agguato coperti da una speciale vernice
impermeabile, adatta alla conservazione di munizioni in nascondigli sotterranei
e normalmente in dotazione alle forze speciali. Questo elemento, se provato,
dimostrerebbe la possibilità di un’oscura strategia tra Moro e i suoi
sequestratori e la possibilità di un intervento straniero o comunque estraneo al
contesto rivoluzionario del partito armato. In sede processuale emerge, poi,
un'altra ipotesi inquietante: l’eliminazione di Leonardi sarebbe avvenuta non
soltanto per l’attacco improvviso sul quel lato, ma anche perché nel commando
terrorista vi sarebbe stato qualcuno che egli conosceva. Questo fatto,
evidenziato dall’avvocato di parte civile della famiglia Moro, non è però
trattato dal film, per ragioni prettamente narrative. Tuttavia il resoconto di
Rosario ricorda l’azione di questo brigatista il cui obiettivo è stato
principalmente quello di eliminare l’autista e il maresciallo Leonardi: «lo
fredda e si defila». A partire da questo elemento, il film inizia un’operazione
investigativa che non collima con la versione ufficiale. Lo spettatore è colto
dal dubbio: alcuni indizi discreditano le versioni dei brigatisti a tal punto
che «le diverse verità potrebbero voler nascondere la partecipazione al blitz di
uomini diversi dai brigatisti comunemente intesi».
4. VIA FANI: INDIZI E
MISTERI.
Dopo aver trattato la dinamica del tamponamento, il film continua la sua
indagine giudiziaria. Attraverso il dialogo incalzante del giudice Saracini e di
Fernanda, il racconto fa emergere i nodi cruciali dell’eccidio di via Fani.
Questi si possono riassumere in quattro punti fondamentali, non ancora chiarite
dalle stesse indagini: le borse di Moro; la strage violenta e deliberatamente
“spettacolare”; l’organizzazione del sequestro; il colpo di grazia alla scorta.
Il giudice Saracini ricorda che Moro possedeva cinque borse: una conteneva
documenti riservati; una seconda, medicinali ed effetti personali; le altre tre
contenevano articoli di giornali e tesi di laurea (Moro era professore di
Diritto Penale). Come facevano i brigatisti a sapere quali erano le borse
giuste, ammesso che siano stati loro ad effettuare il prelevamento? Durante la
deposizione in Commissione, Eleonora Moro aveva dichiarato; «loro (i brigatisti
[N.d.R.]) dovevano sapere quali e dove stavano nella macchina perché c’era una
bella costellazione di borse, messe così, così e così, prendere a colpo sicuro
quella…». Tuttavia Eleonora ricorda che quella mattina quando arrivò in via Fani
si accorse che la borsa da cui Moro non si staccava mai era stata prelevata (se
ne accorge attraverso il rivestimento pulito della automobile quando
tutt’intorno era macchiato dal sangue delle vittime). Due borse, la
ventiquattrore e una borsa diplomatica, saranno poi consegnate nelle mani
dell’agente di pubblica sicurezza Otello Riccioni (uno degli autisti della
scorta che quel giorno era in ferie). Riccioni a sua volta le consegnò alla
signora Moro. Una terza borsa piena di libri viene ritrovata cinque giorni dopo
nel baule della Fiat di Moro all’interno della questura. Un fatto piuttosto
inquietante che rivela in ultima analisi le modalità di indagine in via Fani.
Borsa “insignificante”, ma estremamente importante per comprendere quale giro
strano avesse fatto, se di questo si è mai trattato. In Commissione Parlamentare
il mistero delle borse occuperà gran parte dei dibattimenti. Secondo le
testimonianze, emerse che i brigatisti ne presero soltanto due: quella personale
e quella con i documenti riservati. Dentro quest’ultima si sa di certo che
contenesse una nota dello stesso Moro sulla crisi di governo, una nota
sull’ordine pubblico, una nota sul terrorismo e una delicata relazione sul
coordinamento tra polizia e carabinieri. Forse vi era quel documento sui
collegamenti dei servizi dell’interno della NATO. Dichiarerà il generale Dalla
Chiesa: «io penso che ci sia qualcuno che possa avere recepito tutto questo…
dobbiamo pensare anche ai viaggi all’estero che faceva questa gente, Moretti
andava e veniva…». Il film di Giuseppe Ferrara, Il caso Moro, racconta tale
episodio attraverso l’appropriamento della borsa da parte di un misterioso
funzionario dei servizi segreti, che si scoprirà in seguito un esponente della
Loggia Massonica P2. E’ in questa circostanza che la signora Moro inizia un
colloquio piuttosto teso con il militare. Si tratta della trascrizione del vero
dialogo, relativo alla mattina del 18 marzo 1978, che Eleonora Moro depone in
Commissione. Il generale Dalla Chiesa avrebbe affermato che la strage e il
sequestro sarebbero state opera delle Brigate Rosse. Qui emergerebbe un altro
elemento: Moro non era a conoscenza del “destino” di quelle borse: «bisognerebbe
cercare di raccogliere le 5 borse che erano in macchina», scrive nella quarta
lettera a sua moglie; ovviamente ignorava che le valigette erano nelle mani dei
suoi sequestratori; nella lettera a Rana (suo segretario) scrive: «sono state
recuperate delle borse in macchina? O sono sequestrate come corpo di reato?».
Una curiosità viene dall’intervista a Bonisoli nel documentario televisivo di
Zavoli: egli non sa chi ha preso le borse, «forse la colonna romana», afferma.
La storia delle borse di Moro e del loro contenuto rimane quindi avvolta nel
mistero, tanto nel film, quanto nella storia ufficiale del caso Moro. L’altro
mistero riguarda la modalità della “strage” che lascia pensare, senza ombra di
dubbio, ad un episodio che vuole far parlare di se. Il personaggio di Fernanda
si domanda perché è stato realizzato un colpo così spettacolare, quando vi
sarebbe stata la possibilità di fare tutto più tranquillamente allo Stadio dei
Marmi, dove Moro era solito fermarsi per fare una passeggiata insieme al
maresciallo Leonardi. Il personaggio di Fernanda, con questa sua osservazione
finisce per divenire una sorta di alter ego della vedova Moro che riguardo alla
strage di via Fani affermò: «mi sono chiesta infinite volte perché li abbiano
uccisi tutti, quando mio marito potevano prenderlo tranquillamente in altri
posti… questa è una delle cose che la Commissione la scopre, secondo me scoprirà
una grossa parte della verità». Le Br erano sicure del percorso che avrebbe
fatto la scorta (si tratta di un ulteriore indizio di Fernanda) che il giorno
prima erano andati in via Brunetti a tagliare le gomme di un furgoncino, di
proprietà di un fioraio, che ogni mattina parcheggiava tra via Fani e via Stresa
e che di fatto avrebbe costituito un ostacolo per le manovre di attacco delle
Br. Anche questo episodio è raccontato nel film di Ferrara. Secondo le
testimonianze dei brigatisti il giorno prescelto per il sequestro non fu affatto
previsto con precisione: un «giorno probabile» affermò Morucci, una
«coincidenza» dichiarò Moretti, «casuale» disse Bonisoli. L’ultima osservazione
di Fernanda riguarda il colpo di grazia inferto agli uomini della scorta che
ripropone in maniera drammatica la necessità di eliminare ogni prova e ogni
testimonianza di quel tragico giorno e, al tempo stesso, dimostrare la violenza
e la determinazione di quell’atto “politico”. Nessuno doveva rimanere in vita
perché nessuno doveva raccontare cosa fosse accaduto quella mattina. Si tratta
di un’ipotesi portata avanti dal racconto. Nel numero del 2 maggio, Mino
Pecorelli dava una chiara allusione al sequestro Moro. L’articolo era intitolato
«Yalta in via Mario Fani» e analizzava il sequestro: «[…] l’agguato di via Fani
porta il segno di un lucido superpotere. La cattura di Moro rappresenta una
delle più grosse operazioni politiche […] L’obiettivo primario è senz’altro
quello di allontanare il Partito Comunista dall’area del potere nel momento in
cui si accinge all’ultimo balzo, alla diretta partecipazione al governo del
Paese. È un fatto che si vuole che ciò non accada. Perché è comune interesse
delle due superpotenze mondiali modificare l’ascesa del Pci, cioè del leader
dell’eurocomunismo, del comunismo che aspira a diventare democratico e
democraticamente guidare un Paese industriale». Il giornalista continuava
affermando che la partecipazione governativa del Pci sarebbe stata «ancor meno
gradita ai sovietici […] la dimostrazione storica che un comunismo democratico
può arrivare al potere grazie al consenso popolare, rappresenterebbe non
soltanto il crollo del primato ideologico del Pcus sulla Terza Internazionale,
ma la fine dello stesso sistema imperialista moscovita». Si tratta in sostanza
della logica di Yalta, la logica di guerra e di potere che decise il destino
della politica italiana e le sorti di Aldo Moro. Nello stesso numero di OP, ma
in un diverso articolo dal titolo «E anche Renato Curcio fa il suo dovere»,
Pecorelli affermava: «i rapitori di Aldo Moro non hanno nulla a che spartire con
Brigate rosse comunemente note. Curcio e compagni non hanno nulla a che fare con
il grande fatto politico-tecnicistico del sequestro Moro». In tal senso
Pecorelli prospettava un allargamento dell’affaire Moro. Nell’articolo del 12
settembre 1978, dopo aver ricordato l’interesse di Washington e Mosca nel porre
fine all’eurocomunismo, scrive: «per essere sicuri che le Br hanno agito per
conto di terzi, italiani o stranieri, italiani e stranieri». L’abilità
comunicativa di Pecorelli, i codici linguistici e giochi verbali, attribuiscono
al giornalista una profonda forza storica. Egli era in grado di predire fatti e
avvenimenti grazie al suo inserimento nei centri nevralgici del potere e dello
spionaggio. Si tratta del punto di vista del film, che insiste sull’aspetto
segreto e internazionale della guerra di cui sarebbe stato vittima Moro.
Alle quattro evidenze, si
aggiungerebbe quella della divisa di avieri che si ricollega alla presenza del
superkiller: si sarebbe trattato di un modalità di riconoscimento utile agli
stessi brigatisti. Ma forse, tra loro, vi era qualcuno che non li conosceva
personalmente e questo espediente avrebbe rappresentato un ottimo sistema di
identificazione. Attraverso questa ipotesi, il film riprende il tema del
superkiller. Egli sarebbe giunto a via Fani con la macchina di Mario Moretti,
avrebbe attraversato la strada, e sarebbe andato verso il bar Olivetti, per
incontrare il resto del comando, riconoscibili poiché tutti vestiti da avieri.
Questo comportamento presume che il misterioso personaggio, che spara da solo 49
colpi, non conoscesse affatto il comando terrorista. E’ in tale circostanza,
implicherebbe, secondo il personaggio di Branco, la possibilità che si trattasse
di un «professionista» assoldato dalle Br. Con la divisa di avieri sarebbe stato
più facile essere avvistati e riconosciuti. La testimonianza del giornalista
Ernesto Viglione, depositata agli atti della Commissione Parlamentare, evidenzia
la possibilità di gruppi militari presenti quella mattina in via Fani. Egli
aveva contattato le Br per intervistare Aldo Moro durante la sua prigionia. Un
anonimo brigatista gli avrebbe confidato che tutta la vicenda Moro sarebbe stata
guidata «da due parlamentari e da una persona legata al Vaticano» e che in via
Fani vi avrebbero partecipato uomini dei carabinieri e della polizia. Tale
indizio, tuttavia, è apparso debole e ricco di lacune. Un elemento
importantissimo, non raccontato nel film, è rappresentato da una testimonianza
diretta. La giornalista Cristina Rossi occupata presso l’Asca (agenzia stampa
Dc) aveva scattato delle foto dalla finestra del suo appartamento sito in via
Fani 109: «il 18 marzo consegnai al giudice Infelisi, nel suo ufficio a piazzale
Clodio, il rollino dei negativi che il 16 marzo mio marito [Gherardo Nucci
N.d.T.] aveva scattato pochi minuti dopo il tragico fatto… la cosa gli era stata
possibile abitando proprio nel palazzo di fronte al quale viene consumato
l’eccidio… ritenni che i sette-otto fotogrammi riguardanti la vicenda, uno in
particolare avrebbe potuto essere di qualche utilità per le indagini: infatti,
sebbene nel fotogramma si vedesse che già sul posto si trovava un’autovettura di
PS… vi era un capannello di una decina di persone tra le quali gli inquirenti
avrebbero potuto individuare la presenza di qualche terrorista nella eventualità
che questi, invece di allontanarti, si fosse mischiato tra i primi curiosi». La
giornalista affermò che il giudice Infelisi tagliò con una lametta i fotogrammi
interessati, ma in futuro quei stessi fotogrammi sparirono. Il giudice fece
sapere che i negativi erano stati «riconsegnati alla proprietaria», quando lei
stessa non avrebbe saputo più niente. Quelle foto scompariranno misteriosamente
e il tutto fu reso più complicato da strane incomprensioni tra la Rossi, il
dottor Infelisi e il capo delle Digos Spinella che aveva convocato la testimone
il 26 maggio 1978. Willan ricorda che quelle foto vennero ingrandite per
identificare i primi passanti e di come, probabilmente, si finì per identificare
qualche personaggio scomodo. Un’intercettazione telefonica, trascritta da
Willan, datata il 1 maggio del 1978, tra Benito Cazora e Sereno Freato
evidenzierebbe la presenza di un presunto uomo “scomodo”. Dalla telefonata
traspare la preoccupazione di certi ambienti malavitosi calabresi per quelle
foto. Forse avrebbero potuto portare gli inquirenti su di un sentiero piuttosto
pericoloso sia per gli stessi ambienti calabresi, sia per la precisa
ricomposizione dello scenario di quella tragica mattina. Tuttavia, per quanto
riguarda questo episodio, il film non ne fa accenno. Come si vedrà il
coinvolgimento della malavita nel sequestro Moro avverrà, con il personaggio
piuttosto ambiguo di Antonio Chichiarelli.
5. PEDINAMENTI E MINACCE
FUORI DAL FILM.
L’inseguimento costituisce un elemento narrativo e cinematografico di altissima
tensione. Attraverso la costruzione tecnica dell’inseguimento, il cinema
classico ha prodotto un vero e proprio tema narrativo che va sotto il nome di
thriller. Si tratta di uno schema narrativo che ha delle regole precise. In
primo luogo, l’inseguimento o pedinamento, inteso come azione fisica e
narrativa, deve essere realizzato da almeno due personaggi in chiaro
antagonismo. In secondo luogo, questi stessi personaggi, o esistenti, debbono
essere plasmati dalla forma del discorso o se si preferisce dall’estetica
stessa: un montaggio serrato e veloce, inquadrature strette e rapide. In terzo
luogo, deve emergere il senso di paura e di tensione psicologica degli stessi
personaggi. Questa costruzione è finalizzata alla suspense. Si tratta di un
momento peculiare del racconto filmico, in cui si concentra l’intreccio
narrativo e costringe lo stesso spettatore ad una maggiore attenzione. Da questo
momento emotivo dipende il destino stesso dei personaggi e di tutto il racconto.
Tale costruzione è presente anche nel film di Martinelli, a livello di racconto
filmico, ovvero attraverso il rapporto che si stabilisce tra il punto di vista
dei personaggi (soggettivo) e quello della macchina da presa (oggettivo del
narratore). Ma gran parte degli eventi raccontati dal film, l’inseguimento in
metropolitana, l’inquadratura all’interno del garage, la scena dell’attacco
aereo, costituiscono un fatto narrativo ed esclusivamente di finzione: sono gli
eventi che costringono il racconto verso una determinata direzione e portano i
personaggi verso un determinato destino. Questa impostazione è data anche dal
trattamento particolare che la vicenda storica di Moro subisce in ambito
narrativo, per il solo fatto di dover essere raccontata. Ed è proprio per questo
motivo che molti eventi storici non possono essere inseriti nel film. La vicenda
di Moro è costellata da eventi particolarmente inquietanti, che tuttavia non
sono inseriti nel film, ma che potrebbero evidenziare maggiormente alcune
circostanze storiche molto gravi. Si tratta di certi episodi, precedenti al
sequestro di via Fani, che descrivono il clima teso di quei giorni e offrono una
chiara descrizione del contesto politico in cui si sarebbe trovato Moro. Una
serie di strani episodi costringono Moro a ipotizzare di essere pedinato. Lo
statista era stato particolarmente impressionato per il sequestro del figlio
dell’ex segretario del Partito socialista, Francesco De Martino nell’aprile
1977, da temere il peggio per i suoi stessi figli. Secondo la vedova Leonardi,
il marito era stato particolarmente in ansia durante il periodo precedente il 16
marzo a causa di un’informativa che segnalava la presenza di elementi brigatisti
a Roma provenienti da paesi stranieri. La cosa sconcertante, affermò Leonardi ad
Eleonora Moro, è che gli stessi organi di polizia avevano avuto l’ordine di non
occuparsi di questa cosa e di lasciare stare. Questo fatto costituisce un primo
indizio storico. Particolarmente grave è il caso della richiesta della macchina
blindata. L’istanza risulta agli atti ufficiali e indicherebbe che lo stesso
Sismi avrebbe consegnato la domanda al ministro dell’interno Cossiga. Scarano –
De Luca scrivono che questi avrebbe negato di aver mai ricevuto una tale
richiesta direttamente da Moro come invece sembra sostenere Eleonora. Tuttavia
la scorta e lo stesso Moro non ebbero mai una risposta e, cosa molto più
importante, non ebbero mai una macchina blindata. Particolarmente significativi
furono gli eventi accaduti in Via Savoia 86, la strada in cui c’era lo studio di
Moro dove lo stesso Moretti avrebbe acquistato delle armi. La porta dello studio
di Moro venne forzata mentre la sua macchina venne manomessa almeno una decina
di volte. Ma anche in questo caso, le indagini non aprirono nessuna pista
rilevante. Due vicende, non ancora chiarite, descriverebbero la situazione di
tensione che avrebbe caratterizzato l’atmosfera in quella via. Si tratta del
caso Franco Di Bella e del caso Francesco Moreno. Nel novembre del 1977,
Francesco Di Bella, direttore del Corriere della Sera, si era recato in via
Savoia per un appuntamento con Moro. Alla sua macchina (una Fiat 125)
improvvisamente si affiancarono due motociclisti armati. Leonardi denunciò il
fatto. Il 15 marzo 1978, Spinella, capo della polizia, fece sapere che i
motociclisti erano soltanto dei «volgari scippatori». Ma forse, la formulazione
è troppo sicura: due scippatori in via Savoia che attirano l’attenzione della
scorta di Moro e del giornalista Francesco Di Bella, indicherebbe, in qualche
modo, una circostanza che andava quanto meno approfondita. L’evento è fatto
passare senza particolari provvedimenti. Secondo il lavoro di Scarano - De Luca,
il caso Moreno è un elemento assai inquietante a causa di strani collegamenti
legati al soggetto. Gli inquilini dello stabile avevano notano per più giorni
una Bmw sostare troppo a lungo davanti allo studio di Moro. Dopo la
segnalazione, si apre un’indagine e si scopre che il giovanotto a bordo è
Francesco Moreno. Si tratta di un individuo misterioso, in contatto con i
servizi segreti libanesi, imputato nel 1973 per spionaggio politico, vicino agli
ambienti dell’estremismo di destra (in particolare con la Società Radiofonica
dove sembra si producessero informazioni a scopo spionistico, frequentata da un
certo Schuller «ex nazista in rapporti stretti con servizi tedeschi e svizzeri,
ma soprattutto arabi»). Il suo contatto con il caso Moro avviene anche per una
strana coincidenza. Scarano – De Luca affermano che la sirena, destinata
all'auto di Moreno, era del tipo di quella usata da un'auto che partecipò al
rapimento Moro. Tuttavia una delle due è risultata acquistata soltanto nella
mattina del 16 marzo 1978. Osserva De Luca: «in via Savoia non sembra che
Francesco Moreno stesse per controllare Moro, ma proprio i brigatisti che
controllavano Moro. Per contro di chi?». Si tratta di un ipotesi particolarmente
grave, che è, tuttavia, in sintonia con il racconto filmico. Alcuni elementi
indiziari avevano in qualche modo anticipato l’eccidio che si sarebbe compiuto
in via Fani. Il primo riguarda un rapporto (6 marzo 1978) che giunge al Sismi da
parte della Securpena, la struttura che gestisce la supervisione delle carceri:
«comunicare subito che ci sarà un altro attentato, a grossa personalità di
Roma». Ma obiettivamente rappresenta soltanto un indizio e per di più molto
vago. Santovito, allora capo del Sismi si pronunciò argomentando le vie
burocratiche: «la legge 108 stabilisce che noi Servizi informazioni arriviamo
fino a un certo punto… una volta prodotta l’informazione e data all’organo
operativo non possiamo nemmeno domandare che cosa ne fanno di questa
informazioni». Un'altra informazione venne dal carcere di Matera da un certo
Salvatore Senatore (16 febbraio 1978): «è possibile il rapimento di Moro». La
velina viene passata al Sisde e li si ferma. Un’altra informativa giunse da
Silvano Maestrello, un informatore già conosciuto dai servizi, che venne ucciso
il 12 maggio del 1978 durante una rapina a Venezia. Anche in questo caso il
Sismi accolse l’informativa senza dare origine ad azioni preventive ed
investigative. Questi eventi sono di fatto indicativi per l’atmosfera che
circolava intorno alla sorte di Aldo Moro. Ma gli elementi non si esauriscono
qui. Particolarmente sinistre erano state le dichiarazioni raccolte da
un’assistente, Giuseppe Eusebi presso la facoltà di filosofia a Roma, testimone
di un dialogo tra due studenti: «hai messo tu la bomba all’Università?». La
risposta: «queste cose io non le faccio, tanto rapiremo Moro». Giuseppe Marchi,
altro testimone, sente in una piazza di Siena, un dialogo, con forte accento
straniero tra due individui che dichiarano di aver rapito Moro e la sua scorta
(siamo nel 18 marzo). Gian Gustavo D’Emilia, studente di 17 anni, dice ai
compagni della scuola romana Merry Del Val: “oggi sequestriamo Moro e ammazziamo
la scorta”, una confidenza che viene fatta prima dell’attacco terrorista.
Dunque, tante informative, molti nomi e testimonianze dirette che citano il nome
di Moro. Ma nessuno che voglia ascoltare: «davvero troppi sapevano per non
pensare a una lunga, inerte attesa, rispetto a un fatto che “doveva” accadere»,
scrivono gli autori Scarano e De Luca. Il caso più eclatante si ha con la
trasmissione radiofonica in diretta su Radio Città futura la mattina del 18
marzo. Renzo Rossellini parlerà in trasmissione della preparazione di un
attentato e di una delle sue possibili vittime tra cui Aldo Moro. Quarantacinque
minuti dopo, Moro veniva rapito. Si parlò di «supposizione metafisica», ma in
seguito lo stesso Rossellini affermò che si era trattato di un ipotesi più che
probabile: «noi sapevamo che il 16 marzo doveva presentarsi alle Camere il primo
governo sostenuto dal Pci… Era evidente per noi che questa era l'occasione
sognata dai brigatisti». L’ipotesi circolava già da tempo nei circoli
dell’estrema sinistra, dichiarò in seguito Rossellini. Egli ricorre ad un
elemento prettamente induttivo. Il Sismi, che solitamente registrava tutte le
trasmissioni, dichiarò attraverso il suo generale Santovito che dall’archivio
mancava proprio quella mezz’ora in cui Rossellini avrebbe fatto quella
dichiarazione. Il nastro poi risulterà tagliato. La presenza di strane
convergenze è dato direttamente da un evento che il film mette nelle parole di
Branco. Si tratta di un elemento storico evidenziato da un personaggio di
finzione. Durante la visione del Super8, il capo scorta osserva: «c’è qualcosa
che non avete notato […] il tipo con l’impermeabile non si muove e si limita ad
osservare». È un elemento fondamentale del caso Moro che si ricollega con la
presenza dei servizi segreti durante la mattina del 16 marzo. Il nome dell’uomo,
come rivelerà la scena seguente, è Camillo Guglielmi, colonnello dei servizi
segreti, appartenente alle rete clandestina della Nato, responsabile
dell’addestramento e della preparazione dei “gladiatori”. Anche in questo caso
il film si riferisce alla ricostruzione giudiziaria di quel giorno. Nella
Relazione della Commissione Parlamentare si legge che la presenza in via Fani di
un colonnello del Sismi, Camillo Guglielmi, «non ha mai ricevuto una accettabile
spiegazione […] il Guglielmi riferì di aver ricevuto un invito a pranzo presso
un collega; quest'ultimo confermò di averne ricevuto la visita, ma non la
circostanza dell'invito a pranzo, che comunque non avrebbe potuto giustificare
la presenza del Guglielmi in via Fani alle nove del mattino». Tutti questi
elementi costituiscono nell’insieme una sorta di disegno eversivo che
probabilmente poteva essere debellato sul nascere. Tuttavia, soltanto a
posteriori di questi eventi si riesce a comprendere il filo rosso che avrebbe
descritto il progetto di destabilizzazione: l’eliminazione della politica di
Moro che inevitabilmente sarebbe coincisa con l’eliminazione fisica dello stesso
statista. La presenza di un colonnello del Sismi, dopo i pedinamenti avvenuti in
via Savoia, i strani passaggi del Moreno, i misteriosi “scippatori”,
costituiscono una complessa struttura di rapporti strani e non ancora chiariti.
Spie, poliziotti, servizi segreti e militari costituiscono la colonna portante
dell’enigma Moro e contribuiscono ad ispessire il segreto. Ad aumentare il senso
di mistero, contribuisce la figura di Antonio Chichiarelli, un personaggio
appartenente alla malavita romana, che Martinelli decide di inserire nella scena
seguente. Si tratta di un affiancamento non soltanto narrativo, ma molto
probabilmente anche allusivo, riferito alle strane alleanze che avrebbero
favorito il tragico destino di Moro.
6. ANTONIO CHICHIARELLI.
All’interno del sequestro Moro esiste un giorno, forse il più problematico di
tutti, che costrinse le parti in causa, investigatori e brigatisti a
confrontarsi con alcuni eventi particolari e piuttosto ambigui. Si tratta del 18
aprile, anniversario trentennale della Democrazia Cristiana, giorno in cui venne
scoperto il covo di via Gradoli e consegnato il settimo comunicato dei
brigatisti, poi risultato falso. Il compito narrativo del film è quello di
analizzare la strana traccia che si era delineata in quel giorno e lo fa
attraverso la figura misteriosa di Antonio Chichiarelli, oscuro manipolatore,
falsario della banda della Magliana. Si tratta di un punto nevralgico della
narrazione, in cui il regista tenta di analizzare le collusioni che avrebbero
caratterizzato la perpetuazione del sequestro Moro, attraverso linguaggi
criptati, molto spesso in codice e oscuri personaggi non meglio definiti. La
scoperta del covo di via Gradoli avviene in maniera piuttosto strana da mettere
in dubbio la stessa verosimiglianza dell’evento. Uno sciacquone difettoso
avrebbe causato l’intervento dei pompieri e quindi delle forze dell’ordine.
Quando la polizia entrò nell’appartamento, trovò in bella mostra una serie di
documenti scottanti. Perché i brigatisti avrebbero commesso una tale ingenuità?
È possibile che Moretti e Balzerani abbiano trascurato così superficialmente un
guasto nel loro appartamento, rischiando di far saltare il sequestro di Moro? Si
tratta di domande legittime che secondo alcuni giornalisti, i cosiddetti
dietrologi, e secondo lo stesso Martinelli, troverebbero una risposta soltanto
in un contesto più complesso. L’ipotesi accreditata è quella del messaggio in
codice. È possibile che i servizi segreti abbiano “bruciato” il covo per
permettere di recuperare alcune carte di Moro legate ai segreti Nato (P2,
Gladio) e forse sulla stessa rete italiana del Kgb. L’operazione sarebbe stata
fatta in modo particolarmente evidente da permettere a Moretti e alla Balzerani
di essere informati da radio e televisione e continuare così il loro sequestro,
ma in modo sempre vigilato. In questo modo i brigatisti sarebbero stati
avvertiti: possiamo prendervi quando vogliamo. In questa prospettiva il falso
comunicato, quello del lago della Duchessa, è servito a creare un potente
diversivo per catalizzare l’attenzione sulla prigionia di Moro, piuttosto che
sulla scoperta del covo di via Gradoli. L’autore del comunicato è Antonio
Chichiarelli, personaggio ambiguo, falsario, pittore, il quale sembra occupare
un ruolo di mediazione tra servizi segreti e malavita romana. Secondo Willan,
Chichiarelli conosce e frequenta Luciano Del Bello (informatore del Sisde) ed è
in possesso di numerose informazioni relative al sequestro Moro, all’omicidio
Pecorelli e del sottufficiale dei carabinieri Antonio Varisco. Come racconta il
film, fu Chichiarelli a scrivere il settimo falso comunicato. Chi aveva
commissionato il falso comunicato a Chichiarelli? Gladio? I servizi segreti? E
perché? Sono le domande che offrono la pista investigativa del film. Attraverso
le parole di Fernanda, il racconto inizia la sua indagine. Fernanda ricorda che
ad un giorno di distanza dall’omicidio Pecorelli, Chichiarelli “dimentica” su di
un taxi un misterioso borsello. Questo conteneva una Beretta 9 mm, una serie di
documenti, alcuni oggetti collegati alla vicenda di Aldo Moro da suggerire
strane complicità tra servizi militari e civili. Probabilmente si trattava di un
messaggio criptato, rivolto a chi poteva comprendere: undici proiettili calibro
7.65 e uno di calibro maggiore, una testina ruotante Ibm simile a quella usata
dalle Br per scrivere i loro comunicati (light Italia numero 12), un portachiavi
con nove chiavi (possibile riferimento ai possibili terroristi che avevano
collaborato all’agguato), due flash Silvania (due come le Polaroid scattate
durante la prigionia), un pacchetto di tovagliolini di carta Palma (tipo per
tamponare le ferite del prigioniero), e tre piccole pillole bianche, forse
un’allusione alle medicine di Moro. Il film descrive direttamente questi
elementi e relaziona tutti gli oggetti con il caso Moro. I documenti della borsa
includevano dieci pagine dell’elenco telefonico di Roma riguardanti alcuni
ministeri governativi, in cui comparivano messaggi in codice, simili a quelli
usati dalle Br per il comunicato consegnato a Roma il 20 marzo 1978. In oltre,
vi erano quattro documenti che trattavano un piano d’attacco a personaggi di
rilievo (Pietro Ingrao, il figlio del magistrato romano Achille Gallucci,
l’avvocato milanese Giuseppe Prisco). Sorprende l’appunto sulla morte di
Pecorelli in cui si leggeva, “da eliminare”, con data martedì 6 marzo 1979, con
alcune indicazioni di depistaggio. Probabilmente lo scopo del messaggio era
quello di collegare l’omicidio di Pecorelli con quello di Moro suggerendo che lo
stesso Pecorelli era in possesso di documenti riservatissimi. In questa
circostanza compare un ulteriore indizio che fornisce il titolo alla storia. Si
tratta del messaggio che descriveva il rinvio dell’omicidio di Pecorelli, causa
«intrattenimento prolungato», presso Piazza delle Cinque Lune. Qui, il 6 marzo
del 1979, come racconta il film, Pecorelli avrebbe partecipato ad un incontro
segreto con alcuni esponenti del servizio segreto militare, il colonnello
Antonio Varisco ed un altro altissimo carabiniere, probabilmente il generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa, mentre fuori dall’edificio, alcuni killer avrebbero
atteso la sua uscita. Ma il delitto venne rinviato per fine marzo, anche perché,
come si legge nei documenti lasciati da Chichiarelli, «sarebbe problematico
concedergli tempo». Dunque, la piazza rappresenta un passaggio obbligato nella
vicenda di Pecorelli, di Varisco e inevitabilmente di Moro. Pecorelli doveva
incontrare i servizi segreti. Ma chi aveva commissionato l’attentato? I stessi
servizi segreti che Pecorelli stava incontrando? Probabilmente no. Il film
precisa che Pecorelli voleva incontrare il conoscente Antonio Varisco,
colonnello dei carabinieri, l’uomo che il 16 marzo 1978 aveva avvisato i servizi
di sicurezza di cercare una Renault 4 rossa. Egli venne ucciso il 13 luglio 1979
per mano delle Br, ma la scelta dell’arma, un fucile a canne mozze, lascia
pensare ad un esecuzione di tipo mafiosa. Uno dei colleghi di Varisco, il
capitano Antonio Straullu, fece una fine analoga per mano dei Nar e anche lui
aveva affermato, di saperne abbastanza per far saltare il “palazzo”. Molto
probabilmente gli attentatori non erano soltanto legati ad un “semplice” gruppo
malavitoso. Il film ricorda che fu lo stesso Pecorelli ad aver collegato il
falso comunicato del Lago della Duchessa con la scoperta del covo di via
Gradoli. E per queste sue “rivelazioni” aveva probabilmente infastidito più di
qualche “potere forte”, appunto la loggia di Gelli. E in questi termini si
spiegherebbe l’eliminazione del colonnello Varisco. Tutti questi cadaveri
eccellenti, sono legati da un unico destino: il legame con il Memoriale di Moro.
Inizialmente, attraverso alcuni articoli sibillini, Pecorelli aveva il compito
di scoraggiare la politica di Moro. Per questo motivo, quasi sempre, il nome del
segretario della Dc veniva associato a quella di “morte”. Osserva Willan: «è
possibile che la cosa facesse parte di un piano orchestrato dalla P2 per mettere
Moro sotto pressione e forzarlo ad abbandonare il suo programma politico». In
seguito Pecorelli assume un comportamento contraddittorio, di allontanamento
dagli ambienti dei servizi segreti e dalla stessa P2. La posizione di Pecorelli
si fa ambigua: da uomo facente parte del presunto complotto (iscritto alla P2,
amico di militari, politici e alta finanza), sembra improvvisamente chiamarsi
fuori da questo coinvolgimento. È questo comportamento, il tentativo di trattare
le sue informazioni con i servizi segreti e altri gruppi occulti, che sancisce
la sua condanna. Nel numero del 18 marzo 1977 di OP, scrive una lettera
indirizzata a Gelli per informarlo della sua intenzione di dimettersi dalla P2.
Una decisione che sembra derivare dalle difficoltà economiche del giornalista.
Da questo momento in poi la figura di Pecorelli sembra divenire particolarmente
fastidiosa per la stessa Loggia. Negli articoli di OP, la struttura di Gelli è
descritta come macchinosa, misteriosa, pericolosa e potente. In un articolo
datato una settimana prima della sua morte, Pecorelli scriveva: «attentati,
stragi, tentativi di golpe, l’ombra della massoneria ha aleggiato dappertutto:
da piazza Fontana al delitto Occorsio, dal golpe Borghese all’Anonima sequestri,
alla fuga di Sindona dall’Italia». Si tratta dell’ultimo articolo di Pecorelli,
in cui aveva promesso importanti notizie sul caso Moro. Tre giorni dopo, proprio
quando doveva incontrare Gelli, come era appuntato nella sua agenda, Pecorelli
veniva eliminato (20 marzo 1979). Sotto il suo ufficio in via Tacito, nel
quartiere Prati, Pecorelli è colpito in bocca: «la punizione mafiosa per chi
aveva parlato troppo». Tra gli appunti trovati sul taxi c’erano dei paragrafi
relativi ai segreti Nato (il film cita i paragrafi 162, 168, 174 e 177) che
corrispondevano alle pagine mancanti del Memoriale Moro in possesso di Pecorelli
il giorno della sua morte. Con questa spiegazione il film collega
inequivocabilmente l’uccisione di Pecorelli al sequestro Moro, e lo fa
attraverso quegli indizi che Chichiarelli avrebbe intenzionalmente lasciato sul
taxi. Questa informazione finisce per essere un indizio piuttosto compromettente
per i presunti personaggi che avrebbero preso parte all’affaire Moro. Gli eventi
descritti dal film, che corrispondono perfettamente al livello delle indagini
fatte fino ad oggi, finiscono per descrivere il gruppo brigatista in maniera
misteriosa e complessa. Ed è la strada scelta dal racconto, la domanda
assillante che percorre tutto il film. Osservano Scarano e De Luca: «la strage
di Via Fani, il sequestro di Aldo Moro e infine l’assassinio sono stati
“gestiti” a più mani. Sotto il drappo con la stella a cinque punte, accanto alla
folta e più forte componente terroristica, si sono nascosti i maneggi e gli
interventi di altre due componenti ugualmente aggressive: quella di una
delinquenza organizzata tipo camorra e mafia, e quella più occulta di spezzoni
di vecchi servizi segreti». Da questo punto di vista, la figura di Chichiarelli
fungerebbe da collante tra la legalità e l’illegalità, in una situazione in cui
non si è mai chiarita del tutto la relazione esistente tra i diversi elementi
dei servizi segreti e alcuni esponenti della malavita organizzata. Il film
prosegue con un ulteriore evento che riguarda la biografia di Chichiarelli e che
sembra apparentemente sganciato dall’affaire Moro. Si tratta della rapina Brinks
Securmark, il 23 marzo 1984, dove sono lasciati, ancora una volta, alcuni
oggetti che alludono ad un messaggio in codice. La sua funzione, come si potrà
osservare, è quella di chiudere il cerchio e dare un senso preciso alla presenza
di Chichiarelli all’interno del caso Moro. I rapitori, identificati come
brigatisti, prelevano dall’edificio 35 miliardi di lire. Prima di legare le
guardie, i terroristi enfatizzarono l’aspetto politico e rivoluzionario del loro
gesto, fotografando una delle guardie davanti una bandiera rossa con la famosa
stella a cinque punte. I rapitori abbandonarono un certo numero di oggetti di
chiaro significato simbolico: una granata fumogena Energa (riferimento
all’omicidio Varisco), sette proiettili Nato calibro 7.62, sette piccole catene
e sette chiavi. Le chiavi e le catene vennero poi interpretate come riferimento
al rapimento di Moro. Il giudice Saracini afferma che il ricorrente numero sette
rimanda al falso comunicato del lago della Duchessa. Le granate erano di
provenienza americana ed erano state originariamente conservate, secondo quanto
scrive Willan, da Egidio Giuliano nel deposito del ministero della Sanità.
Afferma Willan che le armi erano servite per l’operazione “Terrore sui treni”
come depistaggio per la strage di Bologna. L’abbandono delle granate Energa
avrebbe rappresentato una sorta di linguaggio cifrato: sappiamo chi ha ucciso
Varisco e perché. Un ulteriore elemento, un documento politico redatto dal
vertice delle Br, chiarisce la relazione con i terroristi. Come afferma il
personaggio di Fernanda, la mente della rapina è Antonio Chichiarelli, che dopo
aver scritto il falso comunicato, e aver lasciato del materiale scottante in un
taxi, riappare attraverso una rapina, lasciando strani indizi, quasi
un’intimidazione a chi gli aveva garantito la libertà. Il film sostiene la tesi
dello scambio: la rapina, consistente e molto facile, sarebbe stata una
ricompensa per il lavoro svolto fino a quel giorno. Ma pochi mesi dopo la
rapina, come ricorda il giudice Saracini, un killer munito di pistola con
silenziatore uccide Chichiarelli. È il 28 settembre 1984. E’ l’ennesimo cadavere
eccellente che articola l’affaire Moro e lo ammanta di un ulteriore mistero. A
collegare il caso Moro a quello di Chichiarelli esistono altri elementi che per
motivi di narrazione il film non può raccontare. Willan ricorda che il 25 marzo
Pecorelli avrebbe telefonato a Il Messaggero comunicando che in un cestino di
piazza Gioacchino Belli, lo stesso luogo del falso comunicato numero 7, si
troverebbero alcuni proiettili dello stesso calibro usato per la rapina della
Brinks. Vi era, in oltre, un documento definito “allarmante”: c’era il
riferimento alla presenza finanziaria di Sindona nella banca Brinks, cosa che
non era affatto di pubblico dominio. Chiunque si addossasse la responsabilità
della rapina del 1984 era indubbiamente l’autore del comunicato in codice del
1978 o gli era molto vicino. Tra i documenti ritrovati in piazza Belli c’erano
anche gli originali dei rapporti su Pecorelli, Gallucci e Ingrao, lasciati da
Chichiarelli nel taxi. Il film non si sofferma, però, su un ipotesi inquietante:
Chichiarelli aveva spedito sempre a Il Messaggero due frammenti originali di
Polaroid fatte risalire alle due foto fatte a Moro durante la sua prigionia. Ne
consegue che Chichiarelli, o qualcuno molto vicino, era venuto in contatto con
la prigionia di Moro. Si tratta di un fatto gravissimo: un membro della malavita
romana in contatto con i servizi segreti si sarebbe introdotto nella prigione di
Moro mentre questi era ancora vivo; dal che si deduce che i servizi segreti
conoscevano l’ubicazione della prigione di Moro (e Pecorelli l’aveva detto) ma
anche, nonostante questo, non avevano fatto nulla per assicurarne il rilascio. È
un’ipotesi inquietante che si collega nuovamente agli oggetti lasciati sul taxi.
Il primo elemento riguarda la patente intestata a Luciano Grossetti priva di
foto che probabilmente, secondo Willan, si riferiva all’informatore Luciano Del
Bello. Il secondo riguarda un biglietto per Messina (Villa San Giovanni), che
indicherebbe una possibile relazione con il mondo mafioso siciliano e che si
riferirebbe alla presenza dei carabinieri nell’affaire Moro. Con questa manovra,
Chichiarelli sembra voler evidenziare tutta il lavoro svolto da Pecorelli. Anche
Chichiarelli sembra spinto da una volontà “strana”: quella di svelare i
collegamenti già descritti dal giornalista. Ma il suo vero obiettivo non sembra
essere molto chiaro e forse, anche per questo, sarà eliminato in circostanze
misteriose. La morte di Chichiarelli, il falso comunicato e l’episodio della
borsa finiscono per assumere, come sottolinea lo stesso giudice, un chiaro
significato collusivo: la rapina di Chichiarelli era la ricompensa che i servizi
segreti, legati agli interessi della P2, avevano offerto allo stesso falsario
per la collaborazione al settimo comunicato. L’evento collusivo spiega, per
tanto, la complicata alleanza che si era creata dietro l’affaire, dove servizi
segreti e criminalità sembrano convergere sull’obiettivo di eliminare in ogni
modo la presenza “politica” di Moro. Dunque il film, trattando il personaggio di
Chichiarelli, costruisce un'altra pista indiziaria che si affianca al caso Moro
e allude alle possibili collusioni: sono coinvolti Pecorelli, Varisco,
Chichiarelli stesso, servizi segreti deviati e gruppi potenti e oscuri che fanno
gli interessi di qualcosa che nel film ancora non si capisce chiaramente[99].
Fino a questo punto lo scopo del racconto filmico è quello di sollevare quanti
più dubbi sulle versione ufficiale del sequestro Moro. E’ soltanto in questo
momento che il film inizia ad affrontare il motivo del suo racconto, ovvero
fornisce una prima spiegazione del suo titolo Piazza delle Cinque Lune. La
Piazza è il luogo che spiegherebbe le strane alleanze che avrebbero dato origine
all’eliminazione di Moro, che spiegherebbe la collusione tra terroristi, servizi
segreti deviati e gruppi internazionali: le “cinque lune” possono assurgere al
valore simbolico della vicenda di Moro, incastonata in una sorta di zona grigia
che ancora oggi, malgrado i cinque processi, rimarrebbe misteriosa e irrisolta.
Attraverso l’inserimento di immagini brevi e verosimili (il bianco e nero dei
Super8) e la descrizione di elementi indiziari riservati e compromettenti per la
politica nazionale e internazionale, il film minaccia la fruizione passiva dello
spettatore, portandolo ad un coinvolgimento emotivo e razionale. Rispetto alla
struttura narrativa di Rosi, o ancora di Oliver Stone (si pensi a JKF) il film
mantiene le unità di luogo e di tempo, concedendosi brevi flashback di forte
impatto percettivo e storico, senza lasciare il “presente storico” dove si
svolgono le indagini. I due livelli del film, l’indagine degli esistenti e
l’affaire Moro, finiscono per sovrapporsi da dare l’illusione di un unico tempo
storico. In realtà di tratta di due momenti ben distinti, sia per quanto
concerne la collocazione temporale degli eventi, e sia per quello che concerne
la costruzione estetica dei vari momenti. Tuttavia questa sovrapposizione di
tempi diversi, può giustamente considerarsi un unico tempo narrativo, in quanto
sono tematicamente legati al tema dell’indagine. Probabilmente è quello che
intende Deleuze, quando tratta l’argomento “tempo”: si scopre un tempo interno
all’avvenimento, fatto di simultaneità di tre tempi, passato, presente e futuro,
contemporanei, e dunque «arrotolati», «simultanei», «inesplicabili». La
narrazione consisterebbe, da questo punto di vista, nel distribuire i differenti
presenti a seconda delle circostanze. Tuttavia, il film di Martinelli non
costituisce una narrazione particolarmente destrutturata per quanto concerne
l’ordine del tempo, come invece avviene nel film Salvatore Giuliano di Francesco
Rosi o in JFK di Oliver Stone.
7. INDAGINI E MASSONERIA.
Dopo la prima indagine sul caso Moro scaturita dalla visione del Super8, il
racconto punta l’attenzione sui protagonisti, Rosario, Branco e Fernanda.
Qualcuno li sta spiando. La scena della metropolitana di Milano informa
chiaramente che i personaggi sono al centro di un misterioso pedinamento. La
conferma viene dallo stesso Branco che attraverso il vecchio trucco del cerino,
incastrato nella portiera della macchina, scopre che qualcuno è stato li.
Qualcuno ha aperto la macchina. Le immagini in bianco e nero fanno da
contrappunto alla scena nel garage: l’inquadratura riprende gli stessi
personaggi, ma cambia la qualità e il punto di vista di chi osserva. Se prima
era il racconto del film a mostrarci il loro movimento, adesso è un punto di
vista diverso, estraneo all’oggettività narrativa della macchina da presa. Quel
punto di vista sembra indicare la presenza di un altro esistente, di un altro
personaggio, che il racconto non ha ancora presentato. Il movimento “sporco”
dell’inquadratura contiene una sorta di terzo senso, è offre un ulteriore
significato semantico: è il punto di vista di qualcuno che sta spiando i tre
personaggi, che li controlla in ogni piccola mossa. Questo evento ha due
significati narrativi: il primo, evidentemente, è di ordine informativo, cioè
dice che qualcuno o qualcosa sta controllando le azioni del procuratore
(brigatisti? servizi segreti? malavita?). Il secondo è di ordine prettamente
narrativo in quanto tende a rafforzare l’intreccio del racconto: attraverso
queste misteriose minacce, il film “ri-attualizza” il clima che aveva
caratterizzato il caso Moro. Il “potere” è dunque sempre in agguato,
intollerante e spietato. Chiunque ha che fare con il caso Moro, come ricordano
le parole di Fernanda, è inevitabilmente coinvolto in un gioco molto più grande
che sembra non avere scrupoli sull’incolumità delle persone e delle rispettive
famiglie. È proprio questo tipo di intreccio che rafforza l’ipotesi del
“complotto” contro Moro e quindi contro chi tenta di indagare sullo stesso
affaire. Da questo punto di vista il tempo storico sembra non essere trascorso:
il potere è costantemente presente, onnisciente, determinato, spietato, come
racconta lo stesso film. La morte del marito di Fernanda, che il film racconta
attraverso un “incidente” creato a regola d’arte, mostra l’estrema conseguenza
di questo potere: uccide le persone, distrugge le famiglie, sopprime la società
civile. La scena della recita risorgimentale, impersonata dai figli di Fernanda,
assume un valore simbolico. La bandiera dell’Italia che copre il corpo caduto
del soldato oltre ad essere un evento narrativo, la recita scolastica appunto, è
anche una rappresentazione simbolica di tutto quello che coinvolge il caso Moro.
Durante la recita, Rosario viene raggiunto da un nuovo messaggio dall’anonimo
terrorista (si tratta del quarto contatto all’interno del film): «controllate i
rogiti di via Gradoli 96». L’espressione indica chiaramente la mancanza di
chiarezza sul covo brigatista sito in via Gradoli. Il biglietto provoca una
furibonda reazione di Fernanda, la quale inizialmente si scaglia contro Rosario
nel tentativo di dissuaderlo da questa folle indagine, ma subito dopo è lei
stessa che si immerge nei fascicoli del caso Moro. Tale costruzione del
personaggio è senza dubbio contraddittoria. Se la sua funzione narrativa è
quella di alimentare la “paura” che aleggia intorno alle indagini, che di fatto
si tradurranno con la perdita del marito, e pur vero che l’integrità del
personaggio, la sua costruzione, è poco chiara e sostanzialmente ambigua.
Fernanda preme affinché la famiglia debba restare fuori, ma poi si lascia
trasportare dal vortice delle indagini ed è lei stessa a conoscere l’esito delle
indagini e dei vari processi. Da un punto di vista diegetico, il suo scopo
narrativo è particolarmente debole o, comunque, subisce un’evoluzione che resta
un tantino forzata. La scoperta del presunto covo di via Gradoli 96 (scala A
interno 11), nella zona nord di Roma, costituisce uno degli elementi più
misteriosi del caso Moro in cui si può intravedere una sorta di “collusione” tra
malavita, brigatisti e servizi segreti. Il covo, come ho accennato nel paragrafo
precedente, viene scoperto durante la prigionia di Aldo Moro, esattamente il 18
aprile: la data coincide con il trentesimo anniversario della democrazia
cristiana e con la diffusione del settimo “falso” comunicato. Il film evidenzia
che nella stessa via, al numero 89, sarebbe vissuto il sottufficiale dei
carabinieri Arcangelo Montani, agente del Sismi e originario di Porto San
Giorgio, luogo di nascita del capo brigatista Mario Moretti. Si tratta di una
coincidenza significativa. Durante il sequestro Moro, l’agente Arcangelo Montani
ufficialmente “non faceva parte del Sismi”, ma il 31 marzo 1978 lo stesso
contrammiraglio Fulvio Martini (allora vice direttore del servizio segreto
militare) era intervenuto a favore del Montani in seguito a un esposto
presentato al comando dei carabinieri da alcuni inquilini del condominio di via
Gradoli 89, i quali avrebbero lamentato di aver subito vessazioni da parte del
sottufficiale. Si tratta di un primo elemento misterioso a cui seguiranno una
serie di “indizi”. Attraverso uno scorcio veloce sul personaggio di Rosario, il
film mostra una serie di nomi di società immobiliari di coperture del Sisde,
presenti in via Gradoli ad incominciare dagli appartamenti della palazzina dove
si trovava il covo. Le società sono l’immobiliare Gradoli, l’immobiliare Case
Roma srl e l’immobiliare Monte Valle Verde srl. Flamigni si chiede, come sia
possibile che il Sisde, che aveva in locazione gli appartamenti accanto e di
fronte al covo brigatista, non si sia accorto di niente. Come è possibile che il
Sisde non abbia saputo della presenza dei brigatisti in una delle sue proprietà
immobiliari? Questa parte del film è chiaramente ispirata al lavoro d’indagine
del senatore Flamigni, il quale si è basato su due ricerche principali:
«…1) ho voluto concentrare
l’attenzione su uno degli aspetti principali del caso Moro, le vicende del covo
di via Gradoli, da cui emerge che i nostri servizi segreti hanno controllato i
brigatisti, ma li hanno lasciati agire indisturbati fino al 18 aprile 1978,
quando hanno fatto scoprire il covo in concomitanza con il comunicato falso del
lago della Duchessa.
2) Dato che alcune notizie
pubblicate nel mio libro “Convergenze parallele” erano state contestate in
particolare da Francesco Cossiga che aveva presentato una interrogazione
parlamentare al ministro dell’Interno, ho voluto rendere noto che lo stesso Capo
della Polizia, dott. Masone, ha ammesso la veridicità di quanto avevo scritto
nel precedente libro Convergenze parallele a proposito dei legami con fiduciari
del Servizio segreto civile di società immobiliari proprietarie di appartamenti
in via Gradoli 96 (nello stesso palazzo dove vi era il covo delle Br), e a
proposito del fatto che Vincenzo Parisi, già direttore del Sisde e capo della
polizia, era proprietario di diversi appartamenti in via Gradoli».
La tesi portata avanti dal
film è quella della collusione tra servizi segreti, apparati della polizia e
brigatisti: insieme, controllati da un’organizzazione per ora non meglio
definita, avrebbero contribuito a determinare lo svolgimento degli eventi.
Rosario ricorda come il ministro degli interni Cossiga aveva istituito tre
Comitati con una rapidità senza precedenti i quali, però, non produssero
risultati determinanti. Questi furono il Comitato tecnico-operativo (presso il
gabinetto del Ministero dell’Interno), il Comitato informativo (Sismi, Sisde,
Cesis e Sios) e il Comitato “esperti”, di tipo informale composto da
intellettuali, aggregato intorno al professor Vincenzo Cappelletti. Il film non
può “raccontare” ogni indizio giudiziario (non è il suo compito precipuo), ma
tra le righe tenta di dare valore ad alcuni eventi. In effetti la questione
relativa alla formazione e alla funzione dei Comitati è piuttosto recente: del
Comitato di “esperti” si è avuta ufficialmente notizia solo il 15 maggio 1991,
quando Francesco Cossiga, che lo istituì, ha deciso di renderlo noto, senza
peraltro chiarirne fino in fondo, l’attività e le decisioni. Di questo gruppo
parallelo facevano parte: Stephen Pieczenik del Dipartimento di Stato Usa e uomo
di fiducia di Kissinger, e i professori Franco Ferracuti, Stefano Silvestri,
Cappelletti, Conte Micheli, Dalbello, Mario D’Addio, Ermentini. Su questa
struttura di consulenza, ha reso testimonianza uno degli appartenenti, Stefano
Silvestri, ascoltato in Commissione Stragi nel giugno 1998. Secondo Silvestri
non fu mai tenuta una riunione di questo organismo, ma ai singoli componenti
venivano chiesti pareri su alcune questioni senza alcun coordinamento con
strutture operative. Il dato più importante riguarda il lavoro relativo al
Comitato di esperti che risulterebbe, tutt’oggi, inesistente: mancherebbero i
verbali e una precisa documentazione. La stessa Commissione ha concluso: «la
mancanza dagli archivi del Viminale di tutta la documentazione concernente il
periodo di prigionia dell’On. Moro e dei tentativi di liberarlo da parte delle
forze dell’ordine non trova alcuna plausibile spiegazione». Le ipotesi in merito
possono essere tre: «La soppressione dei documenti stessi, la loro sottrazione
da parte di ignoti, ovvero il loro trasferimento dalla sede propria. Si conferma
così una costante dell’affaire Moro: prove importanti sulla gestione della crisi
sono state sottratte agli organi istituzionali, ma non è escluso che altri ne
dispongano e le utilizzino, o minacci di farlo, nel momento più conveniente».
L’elemento di spicco del Comitato “esperti” è senza dubbio Steve Pieczenik,
fautore di una precisa linea strategica: occorreva dimostrare che Moro non era
indispensabile alla vita del Governo e della nazione. Per il comitato, Aldo Moro
è affetto dalla sindrome di Stoccolma e quindi è inaffidabile. Tutto il
contributo del consulente americano è quella di rafforzare la decisione del
governo italiano a non negoziare la liberazione di Moro. Si tratta di una
strategia che entra fortemente in relazione con la tesi portata avanti dal film
di Martinelli. Ad occuparsi del consulente americano è Pecorelli, nel suo ultimo
articolo (16 gennaio 1979) intitolato Vergogna buffoni. Il giornalista
minacciava di tornare in futuro su alcuni aspetti dell’oscura vicenda:
«Parleremo di Steve R. Pieczenick vicesegretario di Stato al governo Usa, il
quale, dopo aver partecipato per tre settimane alle riunioni di esperti al
Viminale, ritornato in America prima che Moro venisse ucciso, ha riferito al
Congresso che le disposizioni date da Cossiga in merito alla vicenda Moro erano
quanto di meglio si potesse fare». Willan ricorda che la stessa presenza del
consulente americano era stata tenuta nascosta alla stampa e perfino, come
afferma Rosario, alla stessa ambasciata Americana. La sua presenza a Roma è
dunque segretissima. Se fosse vero, questo fatto proverebbe la particolare
ambiguità del Comitato in cui faceva parte lo stesso Steve Pieczenik. Ma non
basta. Un altro comitato, quello tecnico operativo, dimostra strane
incongruenze. Questo è composto dal Sismi, dal Sisde, dall’Ucigos, più i vertici
dell’esercito e della marina. La struttura si rivelerà quasi subito impotente,
perfino depistante: i verbali del 3 aprile, data che coincide con la presenza
dell’amico americano di Cossiga e della nuova strategia relativa al sequestro
Moro, spariranno misteriosamente. Tutto il lavoro delle indagini è
caratterizzato da un imponente sforzo investigativo basato sul movimento di
mezzi logistici e posti di blocco. Come aveva osservato Sciascia, si aveva
l’impressione di assistere ad una parata che voleva impressionare l’opinione
pubblica. E si tratta di una tesi che il film sviluppa ulteriormente: tutte le
indagini, secondo il giudice Saracini, sarebbero state manovrate da un
misterioso gruppo di potere, la Loggia «ultrasegreta e clandestina» P2. La
Loggia Massonica, come evidenzia il giudice, ebbe una funzione di collegamento
tra l’esito delle indagini e il lavoro dei Comitati con lo scopo di impedire la
realizzazione della politica di Moro e «l’ingresso del partito comunista nel
governo italiano». È la prima volta che un film italiano tratta in maniera
approfondita la funzione specifica e strategica di questo gruppo massonico
deviato. Da questo momento in poi il film costruisce il caso Moro in relazione a
questo gruppo di potere; per la prima volta nella storia del cinema fa il nome
del suo capo e dei suoi appartenenti in relazione al caso Moro. L’inserimento
della P2 all’interno del film è quindi un evento importante anche da punto di
vista strettamente narrativo. Giuseppe Ferrara aveva tentato l’inserimento della
Loggia nel suo film con tanto di luogo fisico, un elegante salone dove gli
affiliati si sarebbero riuniti (compreso l’uomo che avrebbe preso alcune valigie
di Moro). Tuttavia il racconto di Ferrara rimane circoscritto in questo evento e
non allarga l’indagine come invece fa il film di Martinelli. Lungi dal fare un
confronto diegetico tra i due film, i quali se pur trattando lo stesso argomento
sono film diversissimi, è doveroso osservare che Piazza delle cinque Lune è un
racconto basato sull’ipotesi del complotto a partire dal compito che la stessa
Loggia avrebbe perpetuato all’interno del caso Moro. Martinelli non esita a fare
il nome del capo venerabile Licio Gelli compiendo un ulteriore passo verso il
cinema cosiddetto impegnato, rompendo il muro di omertà e di autocensura che ha
caratterizzato la cinematografia politica.
8. VIA GRADOLI.
Tutte le indagini portate avanti sembrano essere determinate da un potere che le
gestisce, e al tempo stesso, ne impedisce lo sviluppo in senso definitivo.
L’evento più indicativo, in questo senso, è il caso di via Gradoli, che
costituisce uno dei punti fermi del racconto di Martinelli. La via nasconde
molte contraddizioni. Una piccola via di città, sconosciuta, persa nella
periferia nord di Roma, trova una collocazione “giudiziaria” che la pone al
centro di un contesto internazionale complesso e delicato. Le strane modalità di
indagine avvenute in via Gradoli sono argomentate da Fernanda. Il 18 marzo del
1978, gli agenti di pubblica sicurezza erano già stati nella via senza
conseguire risultati. Gli agenti del commissariato Flaminio capeggiati dal
brigadiere Domenico Merola non apriranno la porta dove, in seguito, verrà
scoperto uno dei covi delle Br. Fernanda evidenzia un fatto estremamente strano,
un indizio inequivocabile. Si tratta della relazione firmata da Merola riguardo
a quella perquisizione intestata su carta con il bollo Polizia di Stato. La
nuova sigla, pero, è adottata con la riforma della pubblica sicurezza nel 1981.
E’ una relazione “falsa” che mette in dubbio l’operato della polizia e delle
perquisizioni. Il dirigente del commissariato, il dottor Costa, fornirà una
versione dell’evento: la relazione era stata riscritta e fatta firmare al
brigadiere Merola poiché l’originale era stato consegnato alla Corte. Per gli
appartamenti non perquisiti lo stesso Costa affermerà che erano state prese
«opportune informazioni» sugli inquilini occupanti. Un ulteriore indizio viene
dalla dichiarazione-denuncia di Lucia Mokbel datata 18 marzo, la quale sente
provenire dall’appartamento in cui si sarebbe trovato il prigioniero Moro alcuni
segnali morse, denuncia che consegnerà al suo amico vicequestore e funzionario
del Sisde Elio Cioppa (P2) uno degli uomini del generale Giulio Grassini. In
Corte d’Assise gli agenti sarebbero caduti dalle nuvole, e non avrebbero
ricordato nessuna denuncia della Mokbel. Altri fatti strani offrono uno spunto
investigativo. Delle segnalazioni riguarderebbero alcune automobili viste
passare nella via. Vengono annotate targhe automobilistiche e si pedinano
persone come riporta un rapporto della Digos riscritto il 18 agosto 1978. In
particolare viene osservato un furgone Volkswagen targato Roma 589133
appartenente ad un certo Giulio del Petra, il quale si recherà in Calabria con
il furgone stesso. In Calabria c’è nello stesso periodo (1975) anche Mario
Moretti in circostanze mai chiarite. In una testimonianza di Enrico Triaca, si
afferma che un furgone simile è utilizzato dalle Br per portare la stampatrice
presso la tipografia in via Foa. Il numero di De Petra verrà trovato nell’agenda
di Morucci. Ma tutto questo si scoprirà più tardi. Un'altra informazione sul
covo di via Gradoli era giunta anche dal parlamentare democristiano Benito
Cazora in data 25 marzo 1978 da un misterioso emissario appartenente alla
malavita calabrese di nome “Rocco”. Lo stesso Cazora afferma di essere stato
portato sulla Cassia all’altezza dell’incrocio di via Gradoli dove gli sarebbe
stato detto che questa era la “zona calda”. Cazora riportò immediatamente
l’informazione al questore di Roma, dove si fermò. Ma l’elenco delle
segnalazioni non finisce qui. Altre informazioni sarebbero giunte all’ex
ufficiale del Sid Antonio La Bruna attraverso un suo informatore, un certo
Benito Puccinelli in una notte di fine marzo 1978: in via Gradoli c’era un
appartamento interessante che si nota anche per un “antenna” radio sul tetto.
Francesco Solimeno pentito ed esponente di Guerriglia comunista afferma di
essere stato informato su via Gradoli da un certo Fritz (4 aprile 1978) durante
un giro dalle parti di via Cassia. Secondo un appunto trovato nel covo, un certo
“Fritz” aveva consegnato alle Br la mitraglietta Skorpion usata per il rapimento
Moro. E naturalmente come ogni indagine che si rispetti non poteva mancare
l’elemento metafisico. Il nome di via Gradoli uscì durante una seduta spiritica
a cui aveva partecipato il futuro presidente dell’Iri Romano Prodi. Tuttavia
Andreotti e Cossiga hanno sempre affermato che l’informativa a Prodi gli sarebbe
giunta, probabilmente, attraverso l’area dell’Autonomia Operaia di Bologna. Lo
stesso Cossiga, in chiara polemica con le modalità delle indagini, ha poi
dichiarato in un’intervista a Radio Radicale del 18 aprile 2001: «nessuno di
coloro che hanno partecipato alla seduta spiritica e che lo hanno ammesso, e che
mi hanno passato l’informazione, sono stati minimamente incriminati, io sono
stato sentito 68 volte, il presidente Prodi che mi passò l’informazione, non è
stato mai chiamato di fronte alla Commissione Stragi, questo perché non è vero
che tutti siamo uguali davanti alla legge». Malgrado le moltissime segnalazioni,
l’appartamento verrà scoperto soltanto il 18 aprile del 1978 in seguito ad un
evento definito accidentale: una perdita d’acqua provocata dal rubinetto della
doccia appoggiato contro le screpolature del muro. Ciò nonostante Moretti dirà:
«la scoperta di via Gradoli fu normale: io sapevo che c’era un sifone che
perdeva in un alloggio vicino al nostro e l’amministratore ne era informato,
dunque niente P2 ma la disonestà dei palazzinari romani». il contratto
sottoscritto da Mario Borghi alias Mario Moretti, è datato il 31 dicembre 1975.
I primi inquilini brigatisti sono Lauro Azzolini e Carla Brioschi. Dal gennaio
all’estate del ’77 ci abitano Valerio Morucci e Adriana Faranda. Le indagini di
Sergio Flamigni, descritte nei diversi volumi (La tela del ragno, Il covo di
Stato e la Sfinge delle Brigate Rosse), puntano l’attenzione su un elemento
extrafilmico: la figura dell’ingegner G. F, locatore dell’appartamento.
L’ingegnere, che secondo Flamigni sarebbe stato il proprietario dell’immobile
affittato a Mario Moretti, avrebbe visto avanzare la sua carriera negli anni
consecutivi al caso Moro. Flamigni ricostruisce le vicende a partire dallo
stranissimo contratto d’affitto, a suo dire, stipulato in fretta e furia, senza
date di stipula e decorrenza. Flamigni evidenzia come non sia stato possibile
dimostrare quanto l’inquilino Borghi-Moretti pagasse di canone d’affitto, e
neppure se lo pagasse regolarmente. Per Flamigni, la strana dinamica che si
sarebbe generata dietro la figura dell’ingegnere, rappresenta un valido elemento
di indagine da gettare un ombra di sospetto sugli eventi di via Gradoli. Ma si
tratta di supposizioni e di indagini che non hanno trovato, per ora, una
conferma giudiziaria e storica. È ancora Pecorelli (aprile 1978) a puntare
l’attenzione sulle strane circostanze relative alla scoperta del covo di via
Gradoli: «l’allagamento è soltanto un pretesto di comodo inventato dalla
polizia, allo scopo di depistare l’interesse della stampa da chi per ben due
volte, da Roma e da Torino, fornì l’informazione sul covo. Informazione che
usata meglio avrebbe potuto essere risolutiva». Nello stesso articolo Pecorelli
non esita a inserire alcuni strani “errori”. Primo fra tutti il numero civico
che è indicato erroneamente con il numero 92. Nello stesso articolo, Pecorelli
chiama Mario Borghi con il nome di Vincenzo Borghi. Sarà proprio il film a
risolvere questi misteri. Questo nome era stato preso dal rapporto ufficiale
redatto dal colonnello dei carabinieri, nonché amico dello stesso Pecorelli,
Antonio Cornacchia. Riguardo il numero “92” il film chiarisce immediatamente il
significato di quel messaggio: presso quel civico c’era un appartamento del
Sisde. Fernanda afferma che Pecorelli stava collegando il sequestro Moro e le
attività delle Br con i servizi segreti. Un altro articolo di Pecorelli
affermava «la scoperta del covo si doveva ad una soffiata della malavita romana,
malgrado Infelisi e la polizia abbiano sostenuto che l’allagamento fosse stato
accidentale». Si scoprirà in seguito, come scrive Flamigni, che all’interno del
covo Br era stato trovato il numero di telefono dell’immobiliare Savellia,
società di copertura del Sisde e che in via Gradoli (civico 96 e 75) c’erano
intestati alcuni appartamenti all’ex capo della polizia Vincenzo Parisi
(Flamigni osserva che l’immobiliare Savellia risulta di proprietà del Sovrano
militare Ordine di Malta). In tale contesto, è lo stesso personaggio di Fernanda
che cita il nome di Vincenzo Parisi come destinatario del rogito del box al
numero civico 75 di via Gradoli, «esattamente dove un anno prima il capo della
Brigate Rosse parcheggiava le auto dei terroristi» e dei due «appartamenti al
numero 96, esattamente dove si trovava il covo brigatista». Non solo:
l’amministratore dello stabile (a cui evidentemente si rivolgevano le Brigate
Rosse per la normale gestione delle spese), è un certo Domenico Catracchia
«professionista di fiducia del Servizio segreto civile» come ricorda il
personaggio di Fernanda. Il documento storico o l’indagine filmica, che dir si
voglia, è quindi prevista in sceneggiatura con un’impostazione del racconto che
non ha certamente precedenti nel cinema di inchiesta italiano. Anche da questo
di evince il coraggio civile del film di Martinelli che si espone,
probabilmente, a non pochi problemi giudiziari. In questo ambito è doveroso
ricordare che il senatore Flamigni riporta due documenti “riservati” che
comprovano inequivocabilmente la presenza del Sisde in via Gradoli: una
relazione e un appunto, datati entrambi il 7 maggio 1998, firmati
rispettivamente dal capo della polizia Fernando Masone e dal capo del Sisde
Vittorio Stelo, e inviati al ministro dell’Interno e al Cesis in seguito alla
pubblicazione del libro Convergenze parallele. La relazione firmata dal dottor
Masone, conferma che la Fidrev srl, società di consulenza del Sisde era a sua
volta controllata dall’immobiliare Gradoli. Ma non basta. Flamigni continua le
sue indagini e scopre che il prefetto Parisi avrebbe acquistato, con atto
notarile del 10 settembre 1979, un appartamento al civico 75 di via Gradoli e,
successivamente, sempre al civico 75, altri due appartamenti e un box. Secondo
lo studio di Flamigni, Parisi acquistò, altri due appartamenti nel 1987.
L’appunto del prefetto Stelo precisa inoltre che «la società Fidrev, azionista
di maggioranza dell’immobiliare Gradoli, risulta aver svolto assistenza
tecnico-amministrativa per la Gus e la Gattel [società di copertura del Sisde,
ndr], dalla loro costituzione fino al 14 ottobre 1988. Strane convergenze,
dunque, per parafrasare l’inchiesta di Sergio Flamigni, strani accostamenti che
lasciano il sospetto che qualcosa di strano sia avvenuto in quella zona di Roma.
Le ambiguità che gravano in un luogo frequentato dalla polizia, dai brigatisti e
dai servizi segreti, portano nel cuore del Ghetto romano. Willan ricorda che
Elfino Mortati, arrestato per l’omicidio del notaio Gianfranco Spighi (Prato, 10
febbraio 1978), chiede di essere ascoltato per alcune informazioni relative a
questo covo. Ricorda il giudice istruttore Ferdinando Imposimato: «Io e il
collega Priore caricammo Mortati su un pulmino dei carabinieri e girammo in
lungo e in largo, anche a piedi, per il Ghetto, ma senza alcun risultato. Pochi
giorni dopo il mistero s’infittì quando mi vidi recapitare in ufficio una foto
scattata quella sera, e nella foto c’eravamo io, Priore e Mortati»; la foto, che
ritraeva i tre mentre erano in via dei Funari angolo via Caetani, venne scattata
da un osservatorio dei servizi segreti italiani. Di quell’intimidazione non
venne informata la Commissione d’inchiesta sul caso Moro, né le foto risultano
agli atti del processo Moro trasmessi alla Commissione. Dalle dichiarazioni di
Mortati, dagli accertamenti svolti dai vigili urbani, dalle notizie delle fonti
confidenziali trasmesse, gli inquirenti arrivarono a individuare un covo
brigatista situato nel Ghetto ebraico di Roma durante il sequestro Moro in via
Sant’Elena n° 8, interno 9. Ma a quel punto tutto si fermò: una speciale
immunità protesse le Brigate rosse anche nel Ghetto ebraico. Il film non trova
spazio per inserire tale elemento ma il collegamento con il Ghetto, come ricorda
Flamigni, continua. Nel covo Br di via Gradoli il 18 aprile 1978 venne trovata
la chiave di un’auto con un talloncino di cartone sul quale c’era scritto su un
lato «Jaguar 2,8 beige H 52559 via Aurelia 711», e sull’altro «FS 915 FS 927
porte Sermoneta Bruno». Era una traccia che portava nuovamente nel Ghetto
ebraico, dove c’erano alcune basi e punti d’appoggio delle Br che tenevano
prigioniero Moro, ma le indagini vennero avviate solo a partire dal 12 ottobre
1978 (cioè 5 mesi dopo l’uccisione del presidente Dc). A tale proposito la
signora Moro ricorda una circostanza piuttosto inquietante. Quando Eleonora Moro
suggerì che la parola “Gradoli” poteva riferirsi ad una strada romana, si sentì
rispondere dal ministro degli Interni Cossiga che lo stradario di Roma non
registrava quel nome. In realtà la strada esiste ed esisteva anche all’epoca. La
signora Moro e altri membri della sua famiglia riferirono questo episodio nel
corso del processo, ma Cossiga smentì recisamente la circostanza durante la sua
testimonianza. Nel covo vengono trovati volantini delle BR, numerose armi,
esplosivo ed altri documenti. Vengono rinvenute patenti automobilistiche, carte
di identità e tessere per concessioni ferroviarie per impiegati dello Stato in
bianco, centinaia di volantini delle Brigate Rosse, rivendicanti attentati, tra
cui quello al Procuratore Generale di Genova, dott. Francesco Coco (Genova, 8
giugno 1976), e quello al Maresciallo Rosario Berardi (Torino, 10 marzo 1978).
Inoltre vengono sequestrati, una divisa da Guardia di PS; una divisa da aviatore
di linee aeree, una tuta da operaio della SIP, un camice da impiegato delle
PP.TT., nonché numerosi manoscritti, una piantina di un carcere imprecisato,
matrici di ciclostile ed altro. Ma la cosa più allarmante come ricorda Fernanda
e che non venne fatto nessun rilevamento delle impronte, cosa che si fa nelle
procedure più semplici relative ai furti d’appartamento. Insomma, la scoperta di
via Gradoli come afferma Rosario è stata una «scoperta pilotata». Sul
collegamento del Sisde con Borghi-Moretti, emergono le conclusioni portate
avanti dall’indagine di Flamigni. Fra il materiale trovato nel covo c’era un
appunto manoscritto di Moretti: «Marchesi Liva – 659127 – mercoledì 22 ore 21 e
un quarto» (la data corrispondeva a mercoledì 22 marzo 1978, sei giorni dopo la
strage di via Fani e il sequestro), e un altro «foglietto manoscritto con
recapito telefonico n° 659127 dell’immobiliare Savellia». Ancora la Savellia! La
sede della Savellia si trovava in palazzo Orsini nella zona del ghetto romano a
pochi passi da via Caetani. Il segretario della Savellia secondo Flamigni,
risulta essere il ragioniere commercialista G. C. Ma perché il manoscritto
appuntava Marchesi Liva, marchesa Valeria Rossi in Litta Modigliani, nobildonna
romana che si firmava anche Liva residente in palazzo Orsini? Flamigni evidenzia
che il commercialista risulta essere responsabile di altre società immobiliari
(Proim srl, immobiliare Palestrina III e l’immobiliare Kepos) tutte collegate al
Sisde. Altri nomi, altri individui e altre società immobiliari quasi sempre di
copertura collegate al servizio segreto civile finiscono per rendere ancora più
complesso l’affaire Moro. Si tratta di eventi che gettano un’oscura ombra su
tutta la vicenda di Via Gradoli e pongono conseguentemente domande urgenti:
quale alleanze trasversali si sarebbero formate dietro l’affaire Moro? A favore
di chi? Perché Moretti avrebbe dovuto incontrare Liva? Che legame sarebbe
esistito tra Moro, i brigatisti e il ghetto ebraico? Quale funzione avrebbe
dovuto avere lo schizzo planimetrico di palazzo Orsini attribuito a Valerio
Morucci, trovato nel materiale di via Gradoli? Sono domande, ancora oggi, in
attesa di una chiara risposta. De Luca – Scarano ricordano che il 20 aprile, due
giorni dopo la scoperta del covo, il perito balistico Ugolini avrebbe scritto al
magistrato una lettera “riservata”, relativa alle possibili connessioni tra il
materiale trovato nel covo di via Gradoli e la strage di via Fani. Il perito
avrebbe puntato l’attenzione sul calibro delle pallottole: un bossolo 7.65
parabellum marca Sako con capsula percossa e un bossolo, anch’esso esploso, di
calibro 30 M Winchester (carabina in dotazione ai carabinieri). Il bossolo Sako
risulta essere uguale a quelli trovati a via Fani, probabilmente sparati dalla
MAB P 15 e quindi testimonierebbe il legame tra via Gradoli e via Fani. Ma,
inspiegabilmente, non vengono approfondite le indagini. E siamo all’evento più
complesso di tutto il sequestro: il settimo comunicato delle Br. In esso reso,
noto lo stesso giorno del ritrovamento di via Gradoli, viene annunciato il
«suicidio» di Aldo Moro e il recupero della salma nei fondali limacciosi («ecco
perché si dichiarava impantanato» si legge) del lago della Duchessa. In seguito
si scoprirà essere un comunicato falso, elaborato dal già citato Antonio
Chichiarelli. Il 20 aprile giungerà alla stampa il vero comunicato numero sette
che smentirà categoricamente quello precedente, definito come «una lugubre mossa
degli specialisti della guerra psicologica». Nella sua Relazione,
l’intellettuale Leonardo Sciascia aveva visto giusto: il falso comunicato poteva
essere indistintamente assegnato sia alle Br e sia al Governo. Il falso
comunicato «serviva ed è servito ad entrambi: come ballon d’essai, come prova
generale, come ovvio sistema per far scaricare su una notizia falsa – che
sarebbe poi stata dichiarata falsa – quelle tensioni, emozioni e giudizi che si
sarebbero scaricati sulla vera; e di rendere quindi la vera, che a distanza più
o meno calcolata sarebbe esplosa, come ridotta, come devitalizzata». La notizia
dell’esecuzione doveva avere una funzione strategica: annunciando la morte di
Moro, avrebbe dovuto abituare l’opinione pubblica e le stesse istituzioni a tale
evento. In relazione al falso comunicato, emergono altri elementi indiziari non
meno importanti. Enrico Paghera (già incontrato per il caso Ronald Stark)
spiegherà alla Commissione Moro che si è trattato di uno stratagemma per
distogliere l’attenzione delle forze dell’ordine dalla città di Roma, in modo da
consentire la fuga indisturbata dei suoi compagni. Tale ipotesi è avvalorata
anche da Mario Moretti il quale è sempre pronto ad allontanare dal caso Moro
ogni possibilità di complotto e negando ogni “altra” interpretazione. Willan
ricorda che lo stesso avvocato di Curcio, Giannino Guiso, ipotizzò persino che
Licio Gelli fosse implicato nel depistaggio del lago della Duchessa: «quella fu
la prova generale della morte di Moro… il fatto che un falso fosse stato
considerato autentico, quando in realtà era palese la sua in autenticità, deve
pur significare qualcosa. Di certo Chichiarelli non lo preparò di sua spontanea
volontà». Una testimonianza del terrorista di destra Massimo Sparti, secondo
Willan, dichiarò ai magistrati che Chichiarelli gli aveva raccontato di aver
preparato per scherzo e divertimento il comunicato, versione poi confermata
anche dalla moglie di Chichiarelli, Chiara Zossolo. Come si è visto, la funzione
di Chichiarelli all’interno del caso Moro era stata quella di distrarre
l’opinione pubblica sulla scoperta del covo di via Gradoli. Ma il film non si
limita a questa spiegazione: la figura di Chichiarelli serve ad ipotizzare
legami più profondi tra la malavita organizzata e i servizi segreti, da alludere
ad uno scenario più inquietante e più complesso. Tutto quello che accade in via
Gradoli, inevitabilmente, grava ulteriormente l’affaire Moro, da divenire essa
stessa luogo di strani incontri e oscure collusioni. Da questo punto di vista,
si rinforza la traccia proposta dal film, ovvero la possibilità che la teoria
del complotto non sia soltanto una teoria.
9. MORETTI E HYPERION.
L’incontro del giudice con il misterioso aggressore costituisce la continuazione
del racconto. La scena si svolge nel duomo di Siena, all’interno di un
confessionale. Da un punto di vista narrativo, molto probabilmente, la scelta
della scena coincide con una sorta di sottotesto, di codice tematico che accosta
il caso Moro con un ambiente principalmente ecclesiastico. Se questo elemento
sia voluto o accessorio poco importa. Di fatto il regista sembra aver scelto
questa traccia narrativa. A rendere più misteriosa la scena è indubbiamente il
cammeo del bravo scrittore e archeologo Valerio Manfredi, nella parte del
vescovo nel confessionale. Ma ovviamente si tratta di una presenza scenica
limitata soltanto a questa parte del film. È in questa circostanza che prende
forma l’identità piuttosto ambigua del temibile capo delle Br, Mario Moretti.
L’anonimo terrorista definisce Moretti un «capo anomalo» giocando con un
sillogismo evidente, quello con il covo di via Gradoli. Se Gradoli è stato un
covo singolare, contiguo alle attività del Sisde, anche il ruolo di Moretti
potrebbe indicare uno strano contatto “esterno” con altri gruppi di potere.
Rosario è invitato ad andare dietro all’altare. Il terrorista prima di sparire
allude alle simbologie misteriose del caso Moro. A questo punto Rosario si
accorge di essere rimasto solo e trova un floppy per computer. La consultazione
del file si rivela carica di tensione. Il giudice clicca sul file Memoriale, ma
non possiede la password per entrare. In un secondo momento clicca sul nome di
Moretti. Come un videogioco, prende forma una catena di associazioni: la torre
“Eiffel”, che allude chiaramente alla città parigina, e in fine una strada, Quai
de la Tornelle 24, numero 7. E’ il luogo dove risiede la scuola di lingue
Hyperion. Dopo qualche secondo compare il nome Entità. Da questo evento Rosario
decide di partire per Parigi per incontrare tale “entità” e comprendere quale
relazione vi sia tra Moretti e Parigi. Cosa sia questa Hyperion è subito
spiegato dal misterioso intermediario contattato da Rosario: Hyperion è una
compagnia, una scuola di lingue, di centro di assistenza dove sono presenti un
grandissimo numero di marxisti, quasi tutti collegati con gruppi eversivi e
terroristici come l’OLP, l’ETA, l’IRA e le stesse Br. La vera essenza della
società è quella della «lotta tra bande». Ma in realtà, continua l’entità,
questa organizzazione faceva parte della Cia, infiltrata all’interno dei stessi
gruppi eversivi per poterli strumentalizzare e manipolare a seconda delle
necessità politiche. Obiettivo: cooptare i gruppi violenti e fornirgli aiuti e
organizzazione. Attraverso una battuta esemplificativa di Rosario, il film
prende dunque una chiave narrativa inedita attraverso un percorso storico
giudiziario diverso da quello ufficialmente conosciuto: «trovo stupefacente il
grado di infiltrazione, l’insidiosità della presenza americana nelle nostre
azioni, incredibile». È il momento in cui il film incomincia ad allargare il
caso Moro, elevandolo ad un contesto internazionale che ha come riferimento il
trattato di Yalta. Il trattato, che sanciva la divisione politica del mondo in
due grandi blocchi, ha avuto l’effetto di determinare la politica nazionale e le
scelte economiche di ogni governo del pianeta. In Italia, come osserva l’ex
terrorista, esisteva il partito comunista più forte di tutta l’Europa
occidentale e questo poteva rappresentare una seria minaccia per l’equilibrio
mondiale. La nozione inserita nel film è offre una visione inedita e fino ad ora
ignorata della vicenda di Moro e confermerebbe, in questo senso, una prima prova
del complotto dietro la sua eliminazione. Ma l’ipotesi portata avanti dal film,
non sembra essere soltanto un’evidenza. La Commissione d’inchiesta parlamentare
sulla strage di via Fani aveva evidenziato che la scuola di lingue disponeva «di
locali di un certo tono, per la cui locazione viene corrisposto un canone di
notevole importo che, aggiunto alle spese di gestione, comporta un impegno
costante di spesa». Le entrate dichiarate dalla scuola, come rivela Flamigni,
non potevano certo compensare gli impegni finanziari assunti. In relazione a
questa scuola, secondo un rapporto della polizia evidenziato da Flamigni, si
legge il nome di Duccio Berio (addetto alle pubbliche relazioni), Francoise
Tuscher (presidente dell’Hyperion) e Corrado Simioni (consigliere culturale).
Tutti avrebbero un reddito superiore alle loro entrate. Nelle fila della scuola
si registrano nomi importanti e molti viaggi in Europa che evidenzierebbero una
fitta rete di rapporti a livello internazionale. Il coinvolgimento di questa
struttura, che aveva sede in un prestigioso ufficio di Qua de la Tornelle, a
pochi passi da Notre Dame, era stata analizzata dal giudice Pietro Calogero come
organizzazione che avrebbe dettato le direttive strategiche a diversi gruppi
terroristici. Hyperion sarebbe stata creata per dare rifugio e protezione ai
latitanti di tutta Europa, secondo la deposizione del brigatista veneto Michele
Galati. Per quest’ultimo le Br si sarebbero fornite dalla scuola Hyperion
attraverso la figura di Moretti. Si tratta di un ulteriore elemento indiziario
che mette in discussione la figura del capo delle Br, Mario Moretti. Il film,
per motivi specificatamente narrativi non può inserire troppe nozioni e per
questo si limita ad evidenziare la funzione proteiforme e sostanzialmente
ambigua di questa organizzazione. Tuttavia esisterebbero delle prove sconcertati
riguardo alla strana identità del gruppo brigatista. L’Hyperion aveva altri
protettori, ancora più potenti e sinistri come suggerisce il giudice Calogero
attraverso le indagini su Toni Negri e l’autonomia operaia francese. L’indagine
del magistrato Carlo Mastelloni, incentrata sul traffico d’armi tra l’Olp e le
Brigate rosse aveva analizzato l’insolita posizione della scuola Hyperion. La
vicenda salì agli onori della cronaca nel 1984 con la clamorosa emissione di un
mandato di cattura per Yasser Arafat, con l’accusa di aver autorizzato la
vendita alle Br di numerosi carichi d’armi, un procedimento che non ebbe, però,
conseguenze giudiziarie. Tuttavia il giudice affermò, anche se con una certa
cautela, che tale traffico era, molto probabilmente, avvallato e protetto dai
servizi segreti italiani e dalla stessa Cia. Il volume di Willan evidenzia come
all’interno di questa vicenda si possano individuare eventi particolarmente
gravi. In particolare emerge il ruolo del colonnello Stefano Giovannone,
ufficiale del Sismi, la cui attività si sarebbe inserita tra alcune
organizzazioni terroristiche come l’Olp, o le stesse Br e la Cia, sempre pronto
a mantenere un costante equilibrio tra le parti. Secondo Willan, l’ufficiale
sarebbe stato coinvolto nel traffico di armi con lo stesso Moretti sul noto
incontro sulla nave Papago. Sempre Willan ricorda un'altra strana circostanza:
la funzione di un non meglio specificato “gruppo speciale” creato dal direttore
del Sismi Giuseppe Santovito, sin dal’79 quando Moretti organizzava la consegna
delle armi dal Libano che avrebbe sorvegliato tale operazione. Ambigua è anche
la presenza del colonnello Silvio Di Napoli le cui missioni sarebbero rimaste
coperte dal Segreto di Stato. Willan ricorda il caso sconcertante dell’archivio
del generale Maletti in cui si leggerebbe con data 25 marzo 1975, di uno strano
contatto tra brigatisti e Olp: «coordinamento Br – Olp, nostra brillante azione,
relazionare». Nel dicembre del 1990 la corte d’Assise di Venezia assolse tutti i
quattordici imputati accusati di complicità nel traffico d’armi. Il pubblico
ministero minimizzò la tesi del giudice Mastelloni, chiedendo la condanna solo
per quattro degli accusati. Tuttavia, come osserva Willan, «per la prima volta
ufficiali dei servizi segreti e terroristi di sinistra si trovavano assieme in
un processo, imputati per gli stessi fatti». Se tutte queste ipotesi giudiziarie
fossero in qualche modo storicamente rilevabili, per quale motivo la Cia o i
servizi segreti italiani, avrebbero lasciato campo libero alle azioni
terroristiche dei brigatisti? Hyperion dunque corrisponderebbe ad un disegno
strategico assai complesso, con un preciso obiettivo politico. Duccio Berio,
incaricato delle pubbliche relazioni della scuola, aveva affermato che dietro
gli attentati della sinistra in realtà si sarebbe nascosto un disegno di destra.
Per una strana coincidenza, come ricorda l’Entità, la scuola aprì una sede anche
a Roma, in via Nicotera 26 poco prima del rapimento di Aldo Moro (nello stesso
edificio dove sono domiciliate alcune società di coperture del Sismi) e una a
Milano. Entrambe le scuole saranno poi chiuse l’autunno seguente. Dopo l’arresto
di Moretti, avvenuto nel 1981, i contatti con Parigi furono affidati a Giovanni
Senzani, un altro brigatista sospettato di essere in contatto coi servizi
segreti, proprio come lo stesso Moretti. Il compito narrativo del film è quello
di scavare sotto il velo ufficiale e definitivo della storiografia, innescando
un’indagine complessa e difficilissima. Tuttavia, se quanto detto corrispondesse
ad una verità storica, sarebbe inevitabile pensare alle estreme conseguenze
storiche e politiche di una simile organizzazione. Da questo presupposto,
verrebbe spontaneo dubitare sui reali obiettivi di Moretti, che con i suoi
comportamenti strani, quasi mai giustificati chiaramente, finisce per spiazzare
i suoi stessi compagni di lotta. «Dove c’è Moretti, ci sono i servizi segreti»,
afferma il personaggio dell’ex terrorista, spingendo il ragionamento oltre a
qualsiasi interpretazione scontata. E così facendo provoca una strana
possibilità di costruzione del racconto, non solo nel giudice, ma soprattutto
nel pubblico, che sin dall’inizio è costretto a mettere in dubbio tutte le
versioni “ufficiali” delle indagini giudiziarie. Lo sconcerto di Rosario è
placato dalla consegna di uno strano opuscolo: «se vuole sapere la verità, legga
questo». Quando il giudice Saracini arriva a Parigi, scoprirà il filo rosso che
lega Moretti alla scuola Hyperion. Da questo punto di vista il film rivela la
portata internazionale delle Br italiane. Il compito narrativo spetta all’Entità
(F. Murray Abraham), di cui non viene fatto il nome e ne si mostrano indizi
anagrafici da far pensare a qualcuno realmente esistito. Da qui, la peculiarità
della scena. Si tratta di una scelta narrativa precisa che attraverso un
personaggio di finzione racconta chiaramente il “quarto livello” di questa
vicenda. In questo modo la fiction viene a contatto con i documenti storici in
modo da non tradire la veridicità dei fatti. Se il personaggio è inventato, è un
esistente, lo stesso non si può dire dei contenuti che riferisce e del suo ruolo
all’interno della vicenda. L’Entità, questo è il suo nome, è dunque un
personaggio inventato, ma con una funzione narrativa e storica che poco si
allontanerebbe dalla verità dei fatti proposta da Martinelli. La sua funzione è
quella di spiegare, appunto, la vera ragione “politica” delle Br, sconosciuta ai
stessi aderenti della lotta armata. Nel 1980 il giornalista Guido Passalacqua
sollevò la questione della vera identità dei capi delle Br in un articolo su La
Repubblica (12 aprile 1980): «c’è qualcuno più in altro, una, due, tre persone,
che decide le “campagne del terrorismo”… Una direzione decisamente impenetrabile
se si pensa che, stando alle indiscrezioni, l’unico collegamento con gli
operativi era costituito da Moretti». Il 7 maggio, Passalacqua venne gambizzato
perché nemico di classe. Fortemente sospettosi sulla funzione di Moretti sono
gli stessi compagni di partito: secondo Curcio, Moretti è sicuramente una spia;
anche per Giorgio Semeria, appartenente alla colonna milanese, Moretti è una
spia. E probabilmente Moretti non era l’unico elemento “anomalo”. Secondo una
dichiarazione allusiva di Bettino Craxi, dietro la Brigate rosse e dietro la
stessa Hyperion si sarebbe nascosto un “grande vecchio” ovvero, il già citato
Corrado Simioni. Flamigni ricorda che Corrado Simioni aveva catturato
l’attenzione degli investigatori italiani per i suoi esili guadagni e le
moltissime spese della scuola Hyperion. Il mistero di questa scuola si
infittisce per una strana vicenda relativa ad un sequestro di persona. Un uomo
di affari italiano (non viene specificato il nome) aveva donato circa 20 milioni
di lire alla scuola poco dopo che il fratello era stato rapito dalla ‘ndrangheta
calabrese. Avvicinarsi alla villa di campagna di Simioni, forse di proprietà
della stessa scuola, era impossibile a causa del grande numero di guardie armate
da cui era presidiata. Flamigni ricorda che il protettore ufficiale di questa
scuola era un certo Henri Groues, conosciuto come Padre Pierre, un prete
cattolico che aiutava in senzatetto, eroe della Resistenza, deputato e candidato
nel ’89 al Nobel per la pace. Secondo la polizia italiana nel ’72, Padre Pierre
si teneva in contatto con Renato Curcio e altri brigatisti che sosteneva come
vittime della “persecuzione politica” (anche sua nipote, Francoise Tuscher, era
un attivista politica che aveva militato nella Sinistra proletaria). Quando nel
’65 Simioni è espulso dal Psi, entra a far parte del Usis (servizi di
informazione Usa), con un ruolo di provocatore e di indebolimento del Partito
comunista e di rafforzo del sentimento filoatlantico. Una delle strategie
proposte dall’Usis prevedeva la formazione di una nuova corrente socialista che
avrebbe dovuto rompere con la linea marxista filosovietica e occidentalizzarsi.
Funzione, secondo Flamigni, che ebbe il suo amico e compagno di partito Bettino
Craxi. Nel 1969, Simioni aveva fondato e diretto il Cip, Centro informazione
politica, composto su un doppio livello, uno ufficiale e uno riservato. Secondo
la Commissione controinformazione di Avanguardia operaia, Simioni avrebbe avuto
collegamenti con l’intelligence statunitense e sarebbe stato addestrato dalla
stessa Cia in Francia. Sono circostanze importanti che tuttavia non possono
essere trattate nel film, per ovvi motivi di narrazione. Il racconto sceglie di
puntare su Moretti, sui suoi comportamenti strani e molto spesso superficiali.
Molto spesso Moretti commette errori madornali, ma subito dopo non perde
occasione per scusarsi, senza essere chiaro nelle spiegazioni date. Le
circostanze sono diverse. Nel 2 maggio 1972 la polizia scopre l’appartamento di
via Boiardo e arresta Giorgio Semeria e Marco Pisetta. Gli altri terroristi
riescono a fuggire grazie anche al sorprendente numero di giornalisti che si era
appostato sul luogo con netto anticipo rispetto alla polizia. Moretti, secondo
il suo resoconto, riesce a fuggire perché una “vecchietta” lo avrebbe informato
sulla scoperta del covo pieno d’armi. Il noto giornalista Enzo Tortora,
collaboratore del mensile Resistenza Democratica, si era appoggiato proprio alla
macchina della moglie di Moretti, una 500 blu. La macchina, che verrà
sequestrata dalle forze dell’ordine quello stesso giorno, è uno dei primi indizi
dello strano comportamento di Moretti. La polizia risalirà alla moglie di
Moretti. Tuttavia anziché arrestare la banda al completo, Curcio, Cagol e lo
stesso Moretti, l’operazione di via Boiardo può considerarsi un reale
insuccesso. Ma un fatto è certo: siamo nel maggio del 1972 e «il futuro capo
delle Br al momento è dunque conosciuto, latitante e ricercato e tutti –
polizia, carabinieri, apparati di sicurezza, ministero dell’Interno,
magistratura – ne sono informati, a Milano così come a Roma». Nel covo vennero
trovati i negativi scattati all’ingegner Macchiarini, fotogrammi che avrebbero
permesso di riconoscere uno dei terroristi, Giacomo Cattaneo detto il Lupo.
Afferma Franceschini che quei negativi non dovevano stare lì, «Moretti ci aveva
garantito di averli distrutti […] si giustificò di essersi sbagliato in quanto i
negativi si erano incollati tra di loro […] Giacomo Cattaneo, arrestato si era
convinto che Moretti era una spia». Ma non basta. La polizia troverà una foto di
Renato Curcio. Moretti si era dimenticato di distruggere la foto dopo aver
preparato il falso passaporto al brigatista. Si tratta di un'altra dimenticanza
del capo brigatista. Ogni volta, Moretti è pronto a chiedere scusa per le sue
“sbadataggini” e a tergiversare immediatamente su altre questioni. Durante il
sequestro Mincuzzi (28 giugno 1973), dirigente tecnico dell’Alfa Romeo, Moretti
lascia un comunicato con una stella a sei punte, la stella di David. Moretti
disse di essersi sbagliato. Per pura combinazione il Mossad prenderà contatto
con lo stesso Moretti e lo aiuterà a trovare l’informatore Pisetta nascosto a
Friburgo. Ricorda Franceschini che il Mossad offrì, senza volere niente in
cambio, armi e munizioni a patto che gli stessi brigatisti continuassero a
destabilizzare il paese in modo che gli «Usa fossero costretti a far riferimento
a Israele per il mantenimento delle posizioni nell’area del Mediterraneo […]
avevano assicurato che avrebbero comunque sostenuto la lotta armata in Italia».
Si tratta di un'altra ipotesi inquietante, molto spesso sorvolata dalle diverse
versioni storiche del caso Moro, ma che costituisce un importantissimo
riferimento dell’affaire, come ricorda lo stesso senatore Pellegrino. Scarnado -
De Luca ricordano il comportamento anomalo di Moretti. Primo fra tutti la
misteriosa partenza per la Calabria, in una strana missione di cui non avrebbe
offerto giustificazioni plausibili ai compagni di lotta. Il 12 e il 15 dicembre
Moretti e la Balzerani sono a Catania. Il 6 febbraio 1975 è al Jolly Hotel
Excelsior di Reggio Calabria. In questa città, come in buona parte del sud
italiano, non ci sono colonne brigatiste da fondare come non ci sono progetti
“rivoluzionari”. Semmai è l’epoca della nuova mafia. Eppure Moretti e la
Balzerani se ne stanno in alberghi di lusso, senza informare il resto
dell’organizzazione. Tra i due viaggi, Moretti stipula il contratto di affitto
per il covo di via Gradoli, in una via ricca di strane convergenze. Tutto questo
confermerebbe un comportamento ambiguo e poco chiaro da far insospettire gli
stessi compagni di lotta. «È il tempo a determinare la verità della storia»,
afferma l’Entità. Di fronte allo sbigottimento del giudice Saracini, l’uomo
incalza la dose, e attraverso questa frase sibillina, rende concreta la
possibilità del complotto. Una frase che ha una forte valenza storiografica e al
tempo stesso investigativa. Soltanto da una precisa prospettiva storica si
possono comprendere certi eventi e giungere alla verità. Un’affermazione che
sembra ribadire il punto di vista di chi conosce il retroscena dell’affaire. Il
tempo e lo spazio, dunque, sono le coordinate del caso Moro raccontato da
Martinelli. Il tempo che aggiunge nuove nozioni, piccoli indizi che gettano
inquietanti dubbi sull’ultimissima costruzione dell’affaire; e
contemporaneamente lo spazio, quello storico e quello scenico, rappresentato
dalla scena finale della torre di Siena come metafora del punto di vista
narrativo. Più si sale in alto e più il “complotto” e il suo obiettivo, prendono
forma. All’interno di un contesto tutto interno e nazionale, il caso Moro appare
come un episodio di importanza internazionale. Allargando la prospettiva, le
cose prendono un significato diverso: la torre, la salita dei personaggi, le
scale, sono la metafora di un allargamento dell’affaire ad un livello
internazionale che avrebbe riguardato gli interessi e l’equilibrio dei governi
mondiali. Da questo punto di vista, il film non solo sostiene la possibilità del
complotto, ma diventa un primo abbozzo di tutte quelle dinamiche politiche e
finanziarie che saranno decise a livello mondiale dai governi più potenti,
attraverso una politica molto spesso oscura e belligerante, che sembra
determinare gli interessi del cosiddetto Nuovo Ordine Mondiale. Se il film di
Martinelli può infastidire, e perché mira senza troppe scuse al cuore del
problema storico e politico del mondo, inquadrando gli interessi delle potenze
economiche e internazionali in un contesto dettato della legge del dominio e del
controllo finanziario, e definendo, così, la necessità di mettere in pratica le
perfide strategie militari e geopolitiche. Eventi molto spesso sottaciuti o
nascosti alla maggioranza del mondo civile che, per forza di cose, non riesce e
ne può comprendere la spietata strategia degli Imperi.
10. LA FAMIGLIA DENTRO E
FUORI IL FILM.
Un aspetto in cui il film costruisce la sua narrazione è quello del contesto
familiare. La famiglia è il gruppo elementare dove l’individuo nasce, si forma e
cresce. Si tratta di un punto di riferimento particolarmente importante per le
persone che la compongono, dove si formano le basi psicologiche e affettive del
gruppo. In oltre, la famiglia è la struttura basilare su cui si costruisce la
società, cellula fondamentale per lo stesso Stato. Ne consegue che sia da un
punto di vista sociologico e sia da un punto di vista psicologico è un
fondamentale snodo dell’individuo. In tal senso la famiglia riveste un ruolo
centrale nel racconto, sia attraverso il caso Moro e sia attraverso i
protagonisti che portano avanti l’indagine. Il film costruisce una parte
dell’intreccio sulla famiglia di Fernanda e, considerando lo stesso caso Moro,
tale scelta narrativa non è data unicamente da questa necessità. Aldo Moro, come
viene evidenziato nelle sue lettere, scriveva costantemente alla sua famiglia,
con un calore e un affetto esemplare. I suoi interventi sono sempre mirati a
tranquillizzare i suoi cari e la “dolcissima Noretta”, richiamandosi alle prove
dure della sua vicenda. Per lo statista la famiglia assume un ruolo fondamentale
come interlocutore intimo e a volte perfino poetico. Una famiglia che non ha
smesso di soffrire la perdita del caro congiunto, ancora oggi incredule del
tradimento di amici e del suo partito. Il film, a suo modo, tenta la descrizione
di questa sofferenza attraverso lo stato d’animo la famiglia di Fernanda. Quando
suo marito viene a conoscenza degli eventi in cui sta indagando la moglie,
minaccia di portare via i figli. È la parte narrativa del film che insiste
sull’importanza degli affetti familiari e sulla loro incolumità e che bilancia
il racconto dell’indagine. La libertà individuale rischia di essere messa in
discussione a causa degli impegni improrogabili del lavoro, le indagini portate
avanti dalla moglie. Il privato viene usurpato dalle necessità “pubbliche”
(Fernanda è un magistrato) mettendo a rischio la cosa più importante: la
famiglia e gli stessi figli. Tuttavia qui devo riscontrare una contraddizione
sulla costruzione del personaggio di Fernanda, già summenzionata, la quale
inizialmente fa di tutto per bloccare l’entusiasmo e le indagini private dello
stesso Rosario e poi, in seguito, è mostrata nell’atto di studiare le carte
processuali e i documenti delle varie Commissioni Parlamentari. Dunque, il
personaggio di Fernanda si divide, con non poche contraddizioni diegetiche tra
la famiglia e la carriera, tra la sfera privata (i figli e il marito) e la pista
investigativa. Un dualismo sembra forzare un pochino le varie sfaccettature del
personaggio e non sembrano offrire una sua perfetta costruzione narrativa e
psicologica. Tuttavia si può tentare un confronto tra la scelta narrativa del
film e del personaggio di Fernanda con l’uomo Moro, che agisce tra l’importanza
della sua famiglia politica e l’affetto della famiglia naturale. L’ultima
lettera di Moro a Noretta, recapitata il 5 maggio, rivela tutta la sua intensità
umana e intellettiva, una sorta di componimento poetico, un testamento che tocca
il cuore e che confermerebbe l’importanza del fattore umano dietro l’affaire.
Verso l’epilogo, verso la consapevole fine fisica del prigioniero, cruda e
razionale, c’è spazio per una lucida analisi di quello che sta per avvenire,
annuncio del «momento conclusivo»: Mia dolcissima Noretta, dopo un momento di
esilissimo ottimismo, dovuto forse ad un mio equivoco circa quel che mi si
veniva dicendo, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Non mi pare il caso
di discutere della cosa in sé e dell'incredibilità di una sanzione che cade
sulla mia mitezza e la mia moderazione. Certo ho sbagliato, a fin di bene, nel
definire l'indirizzo della mia vita. Ma ormai non si può cambiare. Resta solo di
riconoscere che tu avevi ragione. Si può solo dire che forse saremmo stati in
altro modo puniti, noi e i nostri piccoli. Vorrei restasse ben chiara la piena
responsabilità della D.C. con il suo assurdo ed incredibile comportamento. Essa
va detto con fermezza così come si deve rifiutare eventuale medaglia che si
suole dare in questo caso. E' poi vero che moltissimi amici (ma non ne so i
nomi) o ingannati dall'idea che il parlare mi danneggiasse o preoccupati delle
loro personali posizioni, non si sono mossi come avrebbero dovuto. Cento sole
firme raccolte avrebbero costretto a trattare. E questo è tutto per il passato.
Per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi, il ricordo
di tutti e di ciascuno, un amore grande grande carico di ricordi apparentemente
insignificanti e in realtà preziosi. Uniti nel mio ricordo vivete insieme. Mi
parrà di essere tra voi. Per carità, vivete in una unica casa, anche Emma se è
possibile e fate ricorso ai buoni e cari amici, che ringrazierai tanto, per le
vostre esigenze. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi,
capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue
mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono
le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto ed
a te e tutti un caldissimo abbraccio pegno di un amore eterno. Vorrei capire,
con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce,
sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e tienmi stretto. Bacia e
carezza Fida, Demi, Luca (tanto tanto Luca) Anna Mario il piccolo non nato
Agnese Giovanni. Sono tanto grato per quello che hanno fatto. Tutto è inutile,
quando non si vuole aprire la porta. Il Papa ha fatto pochino: forse ne avrà
scrupolo. L’affetto e l’emozione con cui Moro scrive le ultime parole alla
moglie, lasciano comprendere quanto egli fosse premuroso e protettivo nei
confronti della sua famiglia. In oltre emerge, senza troppe velature, l’intensa
umanità dell’uomo Moro, che smentirebbe chiaramente la definizione di un uomo
duro e freddo, come qualcuno lo avrebbe descritto. La lettera si comunica
attraverso due livelli, quello famigliare e quello politico, dimostrando una
sorta di inseparabilità, di coerente continuità tra la vita privata e la vita
politica, un’integrità etica e morale, di “fare” politica e di “essere”
politico. Tuttavia, quello che mi preme evidenziare è la presenza di un
elemento, in un certo senso, estraneo al contesto familiare, che si riferirebbe
ad una serie di indizi cifrati, che lo stesso Sciascia non aveva esitato a
prendere in considerazione. Questo aspetto avrebbe dovuto attirare l’attenzione,
se non della narrazione, che non può raccontare tutto, almeno degli
investigatori. Adriano Sofri aveva posto l’attenzione su quella strana
espressione di Moro, «vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci
si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo». La frase indicherebbe,
probabilmente, una sorta di luogo chiuso in cui lo statista sarebbe stato
rinchiuso, luogo in cui era privato della luce del sole. Da questo prenderebbe
corpo l’ipotesi che lo statista avrebbe inserito dei messaggi in codice nelle
sue lettere. La trasmissione televisiva di Enigma (Rai Tre, martedì 22 marzo
2004) ha messo in evidenza la particolare propensione di Moro per l’enigmistica
e la possibilità che lo stesso abbia inserito alcuni anagrammi in alcuni passi
“strani” nelle sue lettere. Il giornalista Gianni Gennari, ospite delle
trasmissione, riferisce della passione di Aldo Moro per l’enigmistica attraverso
la testimonianza degli amici del politico, il professor Filippo Sacconi, Giorgio
Bachelet (fratello di Vittorio), Alberto Malavolti. Fu proprio questo gruppo di
amici che si sarebbe accorto della possibile esistenza di messaggi cifrati
all’interno delle lettere di Moro attraverso frasi non molto chiare, le stesse
frasi che aveva preso in esame Leonardo Sciascia. La prima lettera è quella
rivolta a Zaccagnini, del 4 aprile. Si legge «se non avessi una famiglia
bisognosa di me sarebbe un po’ diverso». Giocando sull’anagramma, di cui Moro è
sarebbe stato un esperto conoscitore, gli amici di Moro avrebbero individuato
«son fuori Roma, dove la Cassia in basso forma un asse, vedo pini e bimbi»
(rimane fuori la lettera “g”). L’altra lettera è quella del 29 aprile che
risalterebbe agli occhi per una strana caratteristica visiva. Improvvisamente
dopo aver scritto a Misasi, Moro salta un quarto di pagina iniziando una frase
strana. Si tratta forse di un'altra indicazione: «è noto che i gravissimi
problemi della mia famiglia sono le ragioni fondamentali della mia lotta contro
la morte». Anagrammando uscirebbe: «le Br mi tengono prigioniero nel Cottage a
mattoni a somma della valle di Formello tra Flaminia e Cassia» (rimangono fuori
“h”, “i” e “u”). Secondo la testimonianza di Gennari si tratta di una tesi che
aveva una sua forza comprovata anche da un importante enigmista, Ennio Peres, il
quale aveva notato la forte presenza della lettera “s” e la costante indicazione
della parola “famiglia”. L’uscita di questo articolo presso il giornale Paese
Sera (1983) non ebbe ripercussioni. Un evento stranissimo però accadde: un
signore anziano, ex pilota della Raf, grafico e pittore si presentò alla
redazione del giornale, raccontando allo stesso Gennari e all’allora direttore
Claudio Fragassi, di aver conosciuto e visitato la prigione di Moro, in una
cantina di un noto magistrato, escluso dal suo ruolo proprio da Moro poiché
coinvolto nella vicenda Sindona. L’anziano pittore evidenziò le strane parole
del magistrato in relazione a questo scantinato: «da qui salveremo l’Italia».
L’anziano signore, racconta Gennari, venne trovato morto (morte naturale) 20
giorni dopo nella sua abitazione di Vertica di Amalfi. Il mistero si infittisce
quando nel 1987 esce la nuova rivista Giochi in cui viene pubblicato l’articolo
sull’enigmistica di Moro e le lettere anagrammate: la rivista viene fatta
chiudere il giorno dopo. Si tratta di una storia che andrebbe presa con tutte le
riserve del caso e su cui si dovrebbe fare più chiarezza. Satta, da parte sua,
ricorda che lo stesso fratello dello statista, Alfredo Carlo Moro, aveva fatto
presente che lo statista non sarebbe stato un enigmistam. L’autore ritiene
improbabile che Moro abbia inserito dei messaggi segreti nelle sue lettere.
Attraverso la famiglia, Moro tenta di stabilire un canale di comunicazione
privilegiato e probabilmente sotto forma di codice. Per Sciascia, Moro darebbe
due significati diversi al termine “famiglia”. Il bisogno di protezione e di
affetto che porta alla sua famiglia non coincide con lo stato sociale della
stessa: «peraltro, da meridionale, non credo potesse vedere come bisognosa – di
denaro e di protezione – una famiglia come la sua. Un meridionale ai cui figli
non manca il lavoro e le cui figlie hanno, oltre al lavoro, un marito; che
lascia alla moglie una casa e una pensione e all’intera famiglia un buon nome,
si considera come sciolto dal problema della famiglia e in regola con la vita e
con la morte. È da pensare, dunque, che appunto perché trovavano immediata e
oggettiva smentita, Moro continuasse, insomma, che voleva dire altro». Per cui
Moro non avrebbe trattato la famiglia nel «sentimento, nella sentimentalità, nel
pietismo in cui gli italiani lo usano», poiché questo fare «torto alla sua
intelligenza, alla sua misura, alla sua lucidità». Dunque nel messaggio preso in
esame da Sciascia, la lettera datata 29 aprile, Moro allude ad un’altra
famiglia: «è noto che i gravissimi problemi della mia famiglia sono la ragione
fondamentale della mia lotta contro la morte». Con il termine “noto” Moro
intende sottolineare «quel che noto non è: e che dunque un'altra ragione bisogna
riconoscere nella sua lotta contro la morte». Sciascia allude ad un'altra
famiglia, probabilmente quella politica, quella all’interno del partito stesso,
che si sarebbe trasformata durante il suo sequestro, e che forse è condizionata
da altri eventi esterni. Probabilmente l’allusione dello statista è rivolta a
chi dentro il partito conosce le priorità dell’altra politica. Nel caso Moro, la
famiglia assume in todo un aspetto importantissimo. E probabilmente grande
importanza hanno i sentimenti, al di là dei possibili codici inseriti nelle
comunicazioni. Tuttavia, questo aspetto non ha ancora smesso di incoraggiare
un’indagine seria e rigorosa che possa far emergere qualche elemento importante.
Insomma, anche nella chiara possibilità di vedere un uomo segnato dal suo
destino, pronto a comunicare il suo dolore ai suoi cari, esisterebbe spazio per
un Moro “diverso”, preciso, puntuale, che avrebbe cercato di comunicare in
codice alcuni elementi utili alla sua liberazione. Si tratta naturalmente di
un’ipotesi, ma ciò costituisce inevitabilmente un fatto storico importante che
lo stesso Sciascia aveva indicato all’indomani della scomparsa di Moro e che non
può essere dimenticato. Di fronte al Moro emotivo, debole, forse colpito dalla
sindrome di Stoccolma, esisterebbe un Moro lucido, razionale pronto ad
utilizzare con abilità e precisione qualsiasi spiraglio di comunicazione per
tentare la sua liberazione. Sono due immagini quasi opposte, diverse che non
coincidono affatto e che dovrebbero suggerire in qualche modo una possibile
soluzione. Da una parte c’è la perfezione del sequestro, dell’azione militare di
via Fani; dall’altra esiste una strana imperfezione dei terroristi, dei
comportamenti di Moretti, degli arresti improvvisi, dove addirittura emerge il
fattore umano e debole dei stessi brigatisti, come ricorda Sciascia. Nella
perfezione del caso Moro, nell’ipotetico scenario del complotto, esiste la
faccia imperfetta e debole del sentimento degli stessi personaggi che vi
prendono parte, proprio come nella palese imperfezione dei protagonisti reali
della drammatica vicenda. Il film Buongiorno Notte di Marco Belloccio, tratto
dallo scritto della Braghetti, Il prigioniero, insiste molto su questa lettura
del caso Moro, anche se si tratta di un’interpretazione legittima, storica e
soggettiva. Probabilmente il caso Moro con le sue implicazioni politiche e
strategiche è più complesso di quello che la Braghetti, dal suo punto di vista,
ha descritto nel suo bel libro. E affermando questo, vorrei evitare di cadere
nella facile dietrologia storica. E’ opportuno ricordare, che Anna Maria
Braghetti ha continuato a rifiutare la tesi del complotto e senza troppi
misteri, ha sostenuto che dietro le stesse Brigate Rosse «non c’erano potenze
nazionali o internazionali che potessero influire sulla situazione, o aprire
canali coperti di comunicazione e di trattativa». Si tratta di una visione
semplice e lineare della vicenda Moro, che entra chiaramente in contrasto con le
conclusioni sostenute dal film. Una recente trasmissione televisiva, L’infedele
di Gad Lerner (20.9.2003), trattando l’argomento Moro, ha glissato su tutti i
misteri che avrebbero generato l’affaire. Il programma ha invece scelto di
argomentare altre questioni, come il rapporto tra gli intellettuali e il
terrorismo, la militanza del marxismo – leninismo, la rivoluzione fallace e
illusoria di molti giovani, brigatisti compresi. Nemmeno una parola sulla
possibilità che gli stessi brigatisti potessero essere stati strumentalizzati,
nemmeno una parola su Hyperion, o su Moretti. Nessuna parola è stata proferita
per i misteri del caso Moro. In parte, questo dimostrerebbe che il tabù Moro sia
piuttosto diffuso all’interno del panorama culturale e politico italiano. Dalla
trasmissione è emersa un’immagine delle Brigate Rosse ingenua, lacerata,
inconsapevole, edulcorata proprio come la racconta la Braghetti e come lo ha
raccontato, seppur in modo diverso, il film di Marco Bellocchio. Tuttavia,
esiste un’imperfezione costante in tanti aspetti dell’affaire, una sorta di
sviluppo illogico di alcuni eventi che, proprio per questo, finiscono per
incrementare l’incerto sviluppo del caso. Un’imperfezione che inevitabilmente
suggerisce un'altra pista investigativa, una serie di fatti che affiancati l’uno
all’altro, suggeriscono un'altra immagine del sequestro. Da questo punto di
vista, la strage di via Fani finisce per essere la fine di un lungo percorso che
sembra partire molto prima. Il sequestro Moro rappresenterebbe, alla luce di
questi eventi, una sorta di cappello conclusivo. Sciascia osserva che non è
soltanto l’incongruenza di alcuni indizi ad essere messa in discussione, ma
esiste un’umanità che traspare negli eventi del sequestro che finiscono per
ribadire la fragilità degli stessi terroristi di fronte ad un piano preciso e
portato a termine. Un’imperfezione che Moro ribadisce alla «unanimità fittizia»
della linea della fermezza, in riferimento ad un possibile scambio con i
brigatisti: «…applicare le norme del diritto comune non ha senso. E poi questo
rigore in un paese scombinato come l’Italia». La telefonata a Franco Tritto del
brigatista Nicolai è uno degli esempi di questa umanità involontaria presente
nel caso Moro. La telefonata, secondo Sciascia, è costretta alla terribile
necessità del caso e, al tempo stesso, è intrisa di un’emotività incontrollata:
la freddezza e la passione del terrorista indicano, nel suo divenire evento
storico, un terzo senso, un significato nascosto, che richiederebbe una nuova
valutazione dell’affaire. Attraverso la telefonata si comunicano dei piccoli
particolari, forse insignificanti per un magistrato, ma fondamentali per uno
scrittore: la titubanza del figlio del professore che inizia a piangere per
telefono, l’esitazione del freddo Nicolai che in più di un’occasione si ripete
perdendo l’obiettivo di quella comunicazione, una modalità anomala per una
telefonata lunga più di tre minuti che si scoprirà fatta dalla Stazione Termini:
«che cosa dunque trattiene il brigatista a quella telefonata, se non
l’adempimento di un dovere che nasce dalla militanza ma sconfina ormai nella
umana pietà? La voce è fredda; ma le parole, le pause, le esitazioni tradiscono
la pietà […] forse ancora oggi il giovane brigatista crede di credere si possa
vincere di odio e contro la pietà: ma quel giorno, in quell’adempimento, la
pietà è penetrata in lui come il tradimento in una fortezza. E spero che lo
devasti». La telefonata ricalca un’anomalia italiana, l’imperfezione di una
organizzazione, quelle delle Brigate rosse che lasciano continuamente tracce e
commettono errori madornali. Al di la della straordinaria lucidità di Sciascia,
viene da chiedersi ancora oggi, come è possibile che le Brigate rosse, ragazzi
con qualche idea rivoluzionaria e un armamento piuttosto ridotto, abbiano potuto
realizzare un attacco così preciso e determinante nel cuore dell’Europa. Osserva
Sofri: con Moro, qualcuno ha ancora sorriso della piccineria italiana e
democristiana, del “tengo famiglia”. Tuttavia, attraverso le lettere di Moro, è
la famiglia – e proprio la famiglia del più esemplare leader cattolico e
democristiano – a contrapporsi fino alla rottura alla ragione di stato e di
partito». Da questa spaccatura sono poi seguite le famiglie delle vittime delle
altre stragi Ustica, Bologna, famiglie che ancora aspettano, nella loro dura
lotta quotidiana, la verità sulla morte dei loro congiunti, figli e mariti,
mogli e madri. Il coinvolgimento della famiglia è dunque una scelta narrativa ma
è anche un dato storico, un fatto reale. Sarà proprio la famiglia di Moro ad
entrare in scena dimostrano la commistione tra vita privata e vita pubblica del
presidente, attraverso un duro comunicato stampa del 27 aprile diretto al mondo
politico italiano e alla stessa Democrazia Cristiana. Si tratta di un atto di
accusa rivolto alla Dc per la liberazione di Moro, in riferimento al
«comportamento di immobilità e di rifiuto di ogni iniziativa proveniente da
diverse parti» che ratificherebbero la condanna a morte di Aldo Moro. Il
contatto tra il pubblico e il privato è quindi tanto inevitabile quanto
evidente. La famiglia è tutto. Sarà proprio da questa comunicazione che prenderà
origine la risposta di “pugno” di Andreotti, autore dell’incomprensibile
fermezza. Così traduce Sciascia il comunicato di Andreotti: «il governo ha
deciso di non trattare in nessun modo con le brigate rosse, per il rispetto che
si deve alle famiglie i cui congiunti sono stati uccisi dai brigatisti». Inizia
un lungo processo di deresponsabilizzazione che finirà con l’esplodere con la
definitiva condanna a morte fine del prigioniero. Ma la condanna a morte siglata
da chi? La stessa domanda percorre il film in relazione alle indagini di
Rosario, Fernanda e Branco: qualcuno li segue segretamente, li spia, li
minaccia. Ma chi è? Quale scopo avrebbe? Perché? Da un punto di vista
prettamente narrativo, il pedinamento dei personaggi indicherebbe che il caso
Moro nasconderebbe dei dettagli importanti, alcuni campi inesplorati che
riaprirebbero il caso e metterebbero in discussione l’attuale verità
giudiziaria. Questa struttura narrativa è basata, per tanto, sull’analisi
critica delle versioni ufficiali, e sulla possibilità di delineare una vicenda
assai diversa. Si tratta del compito narrativo delle prossime scene del film.
11. LA MORTE DI ALDO MORO.
Il racconto è giunto al punto finale, la morte di Moro. Il regista sceglie la
nota telefonata del brigatista Nicolai al professor Franco Tritto, per narrare
le circostanze relative all’eliminazione e all’ubicazione del cadavere di Moro.
Anche in questa situazione il film utilizza uno stile particolare: attraverso il
supporto sonoro originale, il film inserisce dei spezzoni di fiction che
descrivono gli eventi drammatici di quella telefonata: c’è spazio per un
inquadratura mossa in cui si intravede il presunto brigatista al telefono con il
professor Tritto. Più avanti il film ricorre alle immagini del 9 maggio di Via
Caetani, immagini indubbiamente vere, girate dai cineoperatori, cui vengono
affiancante quelle di fiction dell’esecuzione di Moro dentro la Renault rossa.
Questo tipo di linguaggio utilizza la commistione tra il materiale di
repertorio, storico e autentico, e il repertorio di finzione, girato dallo
stesso regista per supportare visivamente la descrizione che i protagonisti
fanno degli eventi. L’effetto di una simile impostazione è di certo molto forte,
ma forse potrebbe creare una qualche confusione nel pubblico. Dov’è la verità
storica e oggettiva rispetto a quella proposta dal regista? Credo che si tratti
di una questione di non poco conto su cui si giocherebbe il valore narrativo del
film, il suo valore “investigativo”. Tale costruzione richiama inevitabilmente
l’attenzione intellettiva e culturale dello spettatore, il quale deve saper
scindere e analizzare il testo filmico, riconoscere il repertorio storico da
quello “inventato” dal regista e, al tempo stesso, deve riuscire a comprendere
quali sono le novità investigative proposte dal film, rispetto a quelle
ufficiali e giudiziarie. Si tratta di un lavoro impegnativo che, in un certo
senso, può essere facilitato dal presente studio, in cui si tenta di porre una
linea di demarcazione tra la versione ufficiale e quella “nuova” proposta dal
regista Martinelli. Tuttavia un fatto è certo. L’eliminazione di Moro nasconde
molte incongruenze e il film lo mostra con straordinaria lucidità, argomentando
chiaramente il momento che avrebbe preceduto l’uccisione di Moro. Tutte le
contraddizioni esistenti sono enumerate e analizzate dalle indagini portate
avanti da Fernanda e il giudice Rosario. Esiste una versione dei brigatisti che
non sembra essere molto esaustiva. Per i brigatisti Moro venne ucciso nel covo
di via Montalcini con una raffica di mitra Skorpio (l’immagine di fiction
ribadisce piuttosto violentemente l’evento) e in un secondo momento da una
pistola Walther Ppk modificata a calibro 9. I brigatisti dichiararono che la
morte dello statista sarebbe avvenuta tra le 6 e le 6.30 del mattino. Ma per
Rosario si tratta di una menzogna palese. In questo punto interviene l’energica
relazione di Fernanda che evidenzia le incongruenze della deposizione dei
brigatisti. Che Moro sia stato ucciso in via Montalcini è assai improbabile
considerando che il tratto di strada da fare fino a via Caetani, luogo del
ritrovamento del cadavere, sarebbe stato piuttosto lungo (7-8 km), rischioso e
pieno di posti di blocco. Un rischio che le Br probabilmente non erano abituate
a correre. Dal rapporto della scientifica, in oltre, emergerebbe che la vittima
sarebbe deceduta dopo l’ultimo colpo della pistola calibro 9. Considerando il
tratto di strada tra via Montalcini e via Caetani e il traffico esistente, è
quasi impossibile sostenere che il corpo della vittima, sia rimasto immobile
fino alla fine del percorso. In relazione alla balistica, Fernanda ricorda che
le pallottole entrate sul fianco sinistro del prigioniero sono state sparate da
dentro la macchina e non dall’esterno come invece sostengono Moretti e Maccari.
È per questo motivo che si sono trovati tre bossoli all’interno della macchina
sotto il sedile ribaltabile. Fatto che non viene affatto citato nelle versioni
di Moretti e di Maccari. Emerge il quarto elemento: che via Montalcini fosse
stata l’unica e duratura base in cui Moro era stato recluso per tutti i 55
giorni è un'altra menzogna. L’elemento indiziario di questa incongruenza è
evidenziato dalla presenza di sabbia e bitume nei risvolti dei pantaloni di
Moro, il quale probabilmente avrebbe camminato in una zona costiera, in
«bagnasciuga». I brigatisti hanno sempre sostenuto che il bitume, cosparso da
loro, abbia avuto lo scopo di depistare le indagini. Insomma, e si tratta del
quinto elemento, l’esecuzione di Moro sarebbe stata compiuta nel pieno centro di
Roma, dove erano presenti i servizi segreti. Come afferma il procuratore
Saracini dal rapimento fino all’uccisione compaiono i servizi segreti, «in via
Fani, dove avviene il sequestro del Presidente… in via Gradoli, dove hanno il
covo …in via Caetani, dove viene fatto ritrovare il cadavere». Dopo il delitto,
il corpo di Moro non sarebbe stato spostato, ma sarebbe rimasto esattamente in
quel luogo. Si tratta di un’ipotesi inquietante che confermerebbe una diversa
ricostruzione delle ultime ore di Moro. Tuttavia il film non tratta l’argomento
di chi avrebbe ucciso Aldo Moro. Molti elementi indiziari, oltre alle
contraddizioni degli stessi brigatisti descriverebbero un contesto estremamente
diverso e porterebbero nel cuore del ghetto ebraico, dove fu rinvenuto il corpo
di Moro. Nel covo di via Gradoli la polizia aveva trovato alcuni elementi che
avrebbero portato nella zona del ghetto ebraico: un mazzo di chiavi di una
Jaguar con un talloncino con su scritto Sermoneta Bruno, un telefono (grafia di
Moretti) che portava il nome di Marchesi Liva con tanto di appuntamento, un
altro recapito telefonico dell’immobiliare Savellia, altra sede di copertura del
Sisde, uno schizzo planimetrico, attribuito a Morucci, di palazzo Orsini. Quale
interesse avrebbero avuto i brigatisti per questo palazzo? Perché Moretti
avrebbe dovuto incontrare Marchesi Liva, ovvero la marchesa Valeria Rossi in
Litta Modigliani, nobildonna romana? Che legame sarebbe esistito tra il
sequestro Moro, i brigatisti e il ghetto ebraico? Si tratta di alcune questioni
fondamentali che il film non può trattare per una ragione essenzialmente
narrativa. Tuttavia, emergono alcuni elementi essenziali che indicherebbero la
strana tendenza di quelle indagini. Le ricerche partirono in ritardo: soltanto
il 15 maggio, il consigliere istruttore Achille Gallucci ordinò
l’identificazione dell’immobiliare Savellia e i necessari accertamenti. Il tutto
porterà al già citato commercialista G. C., che come scrive Flamigni, è il
presidente e amministratore della società, in contatto con altre immobiliari
tutte collegate al Sisde (l’immobiliare Palestrina III, la Kepos, e la Proim
srl). Ma la relazione a quanto pare non produsse conseguenze giudiziarie. Il già
citato Sermoneta Bruno, (talloncino di via Gradoli) porta nel cuore del ghetto
ebraico: è un commerciante di tessuti e possiede diversi automezzi tra cui
alcuni autofurgoni. Quale collegamento esiste con Moretti e le Brigate Rosse? Le
indagini vengono, inspiegabilmente avviate in ritardo (12 ottobre 1978) e senza
soluzione di continuità. Flamigni osserva che un gruppo di fiancheggiatori delle
Br venne individuato in via Sant’Elena, proprio nel Ghetto Ebraico, abitato dai
coniugi Raffaele De Cosa e Laura Di Nola, militanti della sinistra
extraparlamentare. Emergerà poi che la stessa Di Nola, deceduta nel luglio 1979,
figlia di un commerciante di tessuti, sarebbe stata legata all’intelligence
israeliana. Si tratta di una figura oggettivamente strana, che pur non
costituendo un elemento giudiziario, va situata in una strana zona di confine la
zona il Mossad e l’estrema sinistra armata. Il ghetto ebraico ritorna attraverso
la figura di Igor Markevich, il “misterioso intermediario”, esponente della
nobile famiglia Caetani, indicato da alcune informative come possibile capo
delle Br, nonchè il possibile inquisitore che avrebbe interrogato Moro. Le
indagini sul direttore d’orchestra non offriranno nessun riscontro
significativo. Tuttavia Flamigni osserva che il nome di Igor Markevich finisce
per essere legato a Palazzo Caetani, sede di altre organizzazioni come
l’ambasciata del Sovrano ordine dei Cavalieri di Malta, un ordine religioso-
militare che ospitava diversi iscritti al P2 nonché il direttore del Sismi il
generale Santovito. Altro elemento riguarda palazzo Mattei, confinante con
palazzo Caetani, ideale luogo per ricetto di autovetture: «la Renault delle Br
avrebbe potuto entrare e uscire dallo spazioso passo carraio collocato in via
dei Funari», forse quel misterioso passo carraio di cui parla lo stesso
Pecorelli. O forse questo passo carraio è quello di un edificio di via Paganica,
adiacente con tre entrate. Una di queste porterebbe ai magazzini di Guglielmo Di
Nola, padre della citata Laura. I tessuti rappresentato un elemento importante
nell’indagine poiché vengono trovati sotto la suola delle scarpe di Moro, sui
parafanghi e nel pianale delle Renault 4 e definiti come «strutture
filamentose». Questo fatto potrebbe provare gli spostamenti che venivano imposti
al prigioniero, indicando un’altra verità. Tuttavia il film preferisce
evidenziare la sola presenza di “bitume” e del «materiale sabbioso misto a una
formazione vegetale tipo cardo, con aculei non essiccati» piuttosto che
allargare l’indagine su ulteriori elementi indiziari. In oltre, palazzo Mattei è
ricco di sotterranei con vari magazzini di tessuti, è sede di entri culturali e
accoglie una sede del Sisde (quarto piano). Insomma la conclusione del sequestro
Moro ha come scenario il ghetto ebraico circondato da strane coincidenze,
personaggi misteriosi, di cui non si è fatta piena chiarezza: ma secondo il film
e il senatore Sergio Flamigni, è anche molto probabilmente il luogo
dell’uccisione di Moro. Le perizie effettuate sul corpo di Moro, smentiscono la
versione di Morucci, confermata da Moretti, dalla Braghetti e da Maccari. I
brigatisti hanno sostenuto che il prigioniero sarebbe stato rinchiuso in una
stanza di 90 centimetri per 3 metri in via Montalcini per tutti i 55 giorni del
sequestro. Ma le risultanze peritali affermano che il corpo di Moro era in buone
condizioni igieniche, senza nessun segno di anchilosi muscolare e che
probabilmente il corpo di quell’uomo avrebbe vissuto in un luogo spazioso. Il
materiale sabbioso presente nei risvolti dei pantaloni, giustificato dai
brigatisti come depistaggio, potrebbe indicare il possibile luogo dove il
prigioniero avrebbe trascorso una parte della prigionia. In effetti, ricorda
Flamigni, che un covo brigatista era stato individuato nella zona Fregene –
Focene. Secondo Flamigni, alcuni volantini trovati il 26 marzo confermerebbero
tale ipotesi. Particolarmente rilevante è la testimonianza relativa all’episodio
avvenuto il 6-7 maggio, in cui un certo Sergio Cardinaletti avrebbe visto lo
stesso Mario Moretti, in zona Focene, riconosciuto subito dopo in una foto
segnaletica. Tutto questo getterebbe una luce sinistra sulle dinamiche del
delitto e insisterebbe sulla necessità di riaprire il caso Moro. Lo scambio di
battute tra Branco e Fernanda sintetizza la tesi portata avanti dal film:
«dunque, stando a quanto dite, il Presidente sarebbe stato ucciso non nel covo
di via Montalcini, ma nel centro di Roma, a poche centinaia di metri dal luogo
del ritrovamento del cadavere». Si tratta di un’ipotesi inquietante e
rivoluzionaria, presa in considerazione da un articolo di Massimo Caprara,
pubblicato presso la rivista Pagina (25 febbraio 1982), in cui si faceva
riferimento al dubbio assassinio di Moro. Caprara aveva osservato come i pochi
soldi trovati in tasca allo statista, avessero avuto una precisa utilità: «una
somma pari a quanto occorre… per pagare un taxi dalla periferia urbana,
dall’Ostiense, la Magliana, la Cassia o poco più là». Ma forse i soldi erano un
trucco per illudere lo stesso Moro di un suo imminente rilascio. Tuttavia,
osserva ancora Caparra, che «la famiglia Moro non ha mai rinunziato a
sottolineare questo dettaglio inquietante che porta ad una conclusione
altrettanto torbida: Moro fu liberato dagli uni e trucidato da altri?». E come
ricorda il senatore Dc, Giovanniello, probabilmente «Moro stava per essere
affidato a criminali comuni per il terribile atto conclusivo». Si tratta di
un’ipotesi che ravviserebbe la presenza di altri esecutori materiali, di altri
gruppi misteriosi di cui ancora oggi non si conosce la vera identità. Per la
notissima immagine in cui Moro veniva fotografato con la stella a cinque punte,
il film elabora una nuova location, modificando ancora una volta la versione
ufficiale. Il racconto mostra la circostanza in cui sarebbe stata scattata
quella foto, “ricreando” gli ultimi istanti prima di quell’evento: si vede il
prigioniero (ricreato in post produzione), si sentono le voci fuori campo dei
terroristi. Ma quello che colpisce è la costruzione di una location molto più
ampia che sembra ribadire, attraverso un codice iconico, che il prigioniero non
fu rinchiuso sempre e soltanto in un unico luogo stretto e inospitale come viene
dichiarato dai brigatisti. Lo spazio di questo luogo, che appare attraverso un
flashback per pochissimi secondi, evidenzia un’ipotesi diversa. L’autopsia fatta
sul corpo di Moro, aveva evidenziato, come ho già summenzionato, la mancanza di
anchilosi e contratture che avrebbero potuto testimoniare la costrizione in cui
si sarebbe trovato il prigioniero: «il cadavere risulta curato, con indumenti in
buono stato, le unghie non debordano dai polpastrelli e ne si rileva materiale
ematico. È evidente, osserva il regista, che il prigioniero fu tenuto in un
locale ampio, dotato di servizi igienici, che gli consentì di lavarsi, di
scrivere e di radersi. Si tratta di una ipotesi avvallata anche dalla perizia
calligrafica che riferisce una situazione comoda e rilassata e non stando
sdraiato a letto con i gomiti sulle gambe come, invece, dichiarano le
deposizioni dei brigatisti e di cui si può vedere una chiara rappresentazione
nel film di Giuseppe Ferrara. Anche in questo caso ci si troverebbe di fronte ad
un resoconto che non coincide con la versione ufficiale degli eventi. Si tratta
di una sorta di ricostruzione spaziale che assurge ad una nuova dinamica del
dopo sequestro e diverge dalla versione ufficiale. Il valore figurativo
dell’inquadratura ha il potere di mettere in discussione la versione ufficiale
della prigionia di Moro. Le evidenze enumerate da Fernanda, continuano a
smontare la versione ufficiale. Il luogo del ritrovamento del cadavere di Moro è
contiguo a via Foa dove lo stesso Moretti aveva preso un immobile presso Via Foa
per redigere i comunicati brigatisti. Si tratta del sesto indizio inserito nella
scena. La vicinanza tra il luogo del delitto e via Foa indicherebbero una
importante relazione tra le attività dei brigatisti e il ghetto ebraico di Roma.
Ma il film punta l’attenzione sulla macchina topografica utilizzata dalle Br, la
quale proveniva da un reparto definito Rus (raggruppamento unita speciale)
dell’ufficio Sismi, in via di Forte Bravetta, sotto il comando del Generale
Giuseppe Santovito. Si trattava di un reparto d’addestramento responsabile
dell’allora organizzazione paramilitare Gladio. Questo è un fatto certo, come
afferma Fernanda: «una stampatrice appartenente ad un ufficio del
controspionaggio militare viene usata per redigere tutti i comunicati relativi
al rapimento del presidente all’interno di una topografia gestita
clandestinamente dalle Br». È il momento in cui il film ammette la strana
collusione che sarebbe esistita tra i brigatisti di Moretti e i servizi segreti
militari. È quindi la conclusione di un percorso investigativo estremamente
grave che espone i protagonisti a non pochi rischi. La sentenza di Corte
d’assise racconta che la Rotoprint A.B. Dych matricola 938508 era stata fornita
il 31 gennaio 1972 dalla stessa ditta RUS del ministero della Difesa. Dichiarata
“fuori uso” era stata venduta come rottame ad un commerciante di vecchi
strumenti grafici, un certo Noto Stefano, il quale aveva trovato un acquirente
nel brigatista Sebregondi Stefano per tre milioni di lire. Quel giorno risulta
essere presente anche Triaca Enrico. È l’inizio di una vicenda contorta. Per il
Sid esiste un'altra storia, declassata nel 1975, per la quale la stampante
sarebbe stata venduta a Bentivoglio, il quale, però in Corte d’assise avrebbe
negato. Affermerà Eleonora Moro: «quando hanno scoperto la tipografia, mio
marito era ancora vivo. E si doveva fare questa cosa prima della data che era
stata fissata. La data stabilita per andare e prendere le persone della
tipografia era molto interiore alla data in cui mio marito morì. Perché fu poi
rimandata al 9 e poi rimandata ancora? Perché?». Risponde Sciascia: «tanta
lentezza crediamo dovuta principalmente a quello che il dottor Fariello
(dell’Ucigos) chiama “pedinamento a intervalli”: che sarebbe il pedinare le
persone sospette, a che non si accorgano di essere pedinate, quando sì e quando
no. Il che, afferma Sciascia, sarebbe come non pedinarle affatto, poiché
soltanto il caso e la fortuna possono dare senso ad una simile pratica
investigativa, «come se il recarsi in luoghi segreti, gli incontri clandestini e
tutto ciò che s’appartiene all’occulto cospirare e delinquere, fosse regolato da
abitudini ed orari». È sempre Fernanda a ricordare che in data 28 marzo, dodici
giorni dopo la strage di via Fani, al Viminale era giunta un importante
informativa riguardo Teodoro Spadaccini. L’informazione è precisa ma viene
tenuta in “sonno” per oltre un mese. Verrà trasmessa alla questura soltanto 32
giorni dopo, il 29 aprile: «da questa data inizia il pedinamento del brigatista
Teodoro Spadaccini, che faceva parte della brigatista universitaria che gestiva
la custodia della Renault rossa utilizzata per l’uccisione di Aldo Moro. Ebbene
nove giorni dopo la morte del Presidente, il pedinamento di Spadaccini porterà
alla localizzazione della tipografia di via Pio Foà». Ma si tratta del giorno in
cui Moro viene trovato morto. La detection viene interrotta dalle necessità
narrative, che pure fanno parte del racconto complessivo. L’indagine avanza
vorticosamente e pericolosamente e gli effetti sui propri cari, sulla famiglia
sono quasi immediati. Fernanda è avvisata da suo marito che i loro figli non
sono ancora tornati a casa e questo è naturalmente fonte di preoccupazione per
tutti, Rosario compreso, il quale sa benissimo che la sua indagine non è ancora
autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura. L’intreccio del racconto
porta a confronto il valore investigativo del film e quello umano dei
personaggi, realizzando un pericoloso corto circuito. Come avevo osservato nei
paragrafi precedenti si tratta di una scelta narrativa ma anche molto precisa
che ha a che vedere, probabilmente, con l’inevitabile pericolosità dell’affaire
che come una piovra stringe nei suoi tentacoli chiunque si lascia coinvolgere
dal caso, colpendo gli stessi familiari. L’uccisione di Moro trova un drammatico
riscontro con un fatto: probabilmente nessuno era interessato a liberare un uomo
che presumibilmente aveva parlato dei numerosi segreti di Stato, di un uomo che
rappresentava la diretta testimonianza sul suo stesso sequestro e degli strani
avvenimenti relativi al covo. La sua liberazione avrebbe avuto un effetto
destabilizzante. Ricorda Pecorelli che lo stesso Cossiga era stato avvisato
della presenza dei brigatisti in via Montalcini, alludendo, attraverso
espressioni simboliche, alla presenza della P2 in tutta la vicenda. Con i suoi
scritti e il possibile Memoriale che gli sarebbe stato estorto, Moro annunciava
cose gravi da non poter essere tollerate da un sistema politico fragile come
quello italiano. Il messaggio di Pecorelli indicava chiaramente che il sequestro
Moro rappresentava l’ulteriore continuazione di una strategia della tensione,
attraverso mezzi nuovi. Per questo motivo la liberazione e il reinserimento di
Aldo Moro all’interno della politica italiana era pressoché impossibile. Moro
conosceva il comportamento finanziario e politico del suo partito, il potere di
Governo che dal dopoguerra fino agli anni ’70 aveva dominato la scena sociale e
civile. La sua politica filoaraba era in chiaro contrasto con la politica
americana. Durante la guerra dei Sei Giorni, Moro si sarebbe opposto alla
concessione delle basi militari, provocando le animose lamentele di Kissinger.
Moro sapeva e parlava del coinvolgimento americano nella strategia della
tensione che aveva lo scopo di ricondurre alla “normalità” l’Italia, dopo la
destabilizzazione del ’68. Moro, nel suo Memoriale, aveva rivelato dei
finanziamenti Cia alla Dc e faceva riferimento a Gladio. Aveva descritto
negativamente i suoi colleghi di partito, Andreotti, Taviani, Zaccagnini, e
molti altri. Era divenuto da vittima a pubblico ministero della politica
italiana e della stessa Dc dei quali conosceva tutti i segreti. Come aveva
osservato Pecorelli (24 ottobre 1978), Moro rappresentava una «bomba ad
orologeria che avrebbe ancor più minato le già cotte strutture della
repubblica». E per questo motivo non si sarebbe potuto tornare indietro, il
prigioniero doveva essere eliminato. Esisteva un gruppo di potere contro Aldo
Moro e la sua politica di solidarietà nazionale. Qualcun altro avrebbe poi
pensato, inevitabilmente, alla sua “eliminazione”. La genesi della linea della
fermezza potrebbe trovare una valida interpretazione alla luce di quanto detto:
la liberazione di Moro avrebbe potuto significare la fine di altri personaggi
politici a livello di partito e forse anche a livello internazionale. Tuttavia
all’opinione pubblica, veniva descritto un Moro influenzato, alterato, drogato.
Il culmine della linea di fermezza si sarebbe raggiunto con la notizia che lo
statista starebbe scrivendo sotto l’influsso di un potente psicofarmaco,
l’aloperidolo, «una medicina insapore e inodore che rende la persona facilmente
dominabile e che modifica la scrittura rendendola incerta». I politici
confermarono incredibilmente la tesi di scienziati e neurologi: Cossiga, «…
missiva completamente estorta», Rognoni, «Moro è ormai uno strumento delle
Brigate Rosse», Colombo, «non c’è niente del pensiero di Aldo, cose infantili,
assurde». La linea della fermezza si sarebbe espressa anche attraverso questi
particolari e non soltanto attraverso una logica politica e giustizialista. Così
la spiegherà Andreotti «i rapitori hanno posto il preciso tema del cosiddetto
“scambio di prigionieri”. L’inaccettabilità di un tale disegno è palese… Ancora:
se gli agenti dell’ordine e ancor più le guardie carcerarie, che quotidiane
soffrono disagi e dileggi e purtroppo in parecchi casi hanno pagato con la vita
il difficile servizio di vigilanza e di prevenzione; se questi umili servitori
dello Stato vedessero che per liberare un uomo politico si calpestano le leggi e
si aprono le prigioni, la reazione sarebbe immediata, con conseguenze
gravissime. E che dire delle vedove e degli orfani degli uccisi?» Sofri ricorda
che Andreotti aveva più volte ribadito questa intenzione della linea della
fermezza. Nella relazione finale della Commissione Moro si legge che «la
liberazione, anche di uno solo dei tredici, avrebbe imposto un gravissimo
strappo alla legalità, incrinando profondamente le ragioni stesse della
resistenza del Paese contro il terrorismo e offeso i valori di fondo di
giustizia e di uguaglianza del nostro ordinamento». Ironicamente aggiunge Sofri:
«tutto questo disastro sarebbe stato provocato dalla liberazione, per esempio di
Paola Besucchio?». Il ritrovamento del cadavere di Moro è commentato dallo
stesso Pecorelli attraverso uno dei suoi scritti più criptici. Il 23 maggio 1978
pubblicò qualcosa di molto simile a una telecronaca: oltre il muro dove sarebbe
stato trovato il cadavere, «ci sono i ruderi del teatro di Balbo, il terzo
anfiteatro di Roma». E continua «ho letto in un libro che a quei tempi gli
schiavi fuggiaschi e i prigionieri vi venivano condotti perché si massacrassero
tra loro. Chissà cosa c’era nel destino di Moro perché la sua morte fosse
scoperta proprio contro quel muro? Il sangue di allora e il sangue di oggi».
Pecorelli parlava dei gladiatori riferendosi alla morte di Moro, ma fino a poco
tempo fa pochissimi avrebbero capito il senso del messaggio. Sembrerebbe, però,
che Pecorelli si riferisse anche a delle precise responsabilità dei gladiatori
nella morte di Moro. Per Pecorelli, Gladio è certamente presente dietro
all’affaire Moro come una delle organizzazioni che avrebbe determinato l’esito
del sequestro. L’esecuzione di Moro, l’abbandono tra la sede nazionale della Dc
(piazza del Gesù) e quella del Pci (via delle Botteghe Oscure) confermerebbe la
strana guerra in cui si trovò lo statista e il motivo per il quale fu eliminato.
Da questo punto di vista la sua eliminazione avrebbe significato la sconfitta
violenta e traumatica della stessa democrazia, e affermato il valore subliminale
di una guerra che si combatteva soprattutto sul piano psicologico e non più
propriamente militare. Scriveva nel 1944 il giovane Moro: «ciascuno accetti in
pace, quando è la sua ora, di uscire dalla scena del mondo, con la gioia di
avere costruito qualcosa per gli uomini e con la certezza di finire». Contro la
sua stessa volontà, prematuramente, lo statista uscì drammaticamente di scena,
senza aver potuto realizzare il suo progetto solidarietà nazionale, senza poter
completare la sua missione. Come una marionetta «dai fili spezzati, come un
fagotto», il cadavere di Moro è stato collocato all’interno di un’anonima
automobile, ucciso insieme alla sua stessa idea di ricostruzione di una società
probabilmente diversa.
12. LA SCENA DELLA TORRE.
In una lettera datata tra il 27 e il 30 aprile e indirizzata a sua moglie
Eleonora, Moro scriveva: «si trattava in fondo di uno scambio di prigionieri
come si pratica in tutte le guerre (e questa in fondo lo è) […]».
L’interpretazione non lascia scampo e sottolinea fortemente lo stato di «guerra»
in cui il mondo politico italiano si sarebbe trovato. Moro parla di scambio di
prigionieri, come possibile “oggetto” della trattativa. Analizzando tutto il
contesto del sequestro, colpisce ineccepibilmente l’espressione «guerra» usata
dallo statista. Nella ricerca effettuata sulle lettere di Moro, il termine
“guerra” e “guerriglia” compare in tutto nove volte e quasi sempre ad indicare
la possibilità di scambio tra prigionieri. Moro cita esempi internazionali, il
caso Lorenz, gli eventi Palestinesi, la Croce Rossa. Particolarmente sibillina è
l’ultima lettera in cui compare il termine “guerriglia”: si tratta di quella
indirizzata a Riccardo Misasi in cui le parole di Moro descrivono la triste
constatazione di questa guerra. Appellandosi al diritto umanitario, alla stessa
Croce Rossa, alle procedure adottate in caso di scambio di prigionieri, Moro
scrive che «c’è un rifiuto […] un allineamento su posizioni esterne», quasi a
rilevare la presenza di una forza esterna che controllerebbe gli eventi e che
impedirebbe la sua liberazione. Dunque, anche questo elemento insiste sul
contesto bellico in cui il paese è coinvolto. In altre lettere Moro richiama
l’attenzione sulle potenze straniere, evidenziando una possibile patologia della
sovranità nazionale dello Stato Italiano: «vi è forse, nel tener duro contro di
me, un’indicazione americana o tedesca?». Scrive Sofri: «la sensazione che fra i
terroristi agisse una mano straniera, quella ossessione di una perfezione e di
una ferocia “tedesca”, si ritrova nel sospetto che assilla Moro, che i
democristiani siano a loro volta ispirati nella “fermezza” da una volontà
esterna». Moro sapeva perfettamente che la sua vicenda non poteva limitarsi ad
un ambito personale e privato. Sapeva che le sue scelte politiche avrebbero
avuto un importante effetto sull’equilibrio nazionale e da poter alterare
l’equilibrio politico di tutto il mondo e per questo, sarebbe stato inviso a
molti capi di Stato. Sapeva, quindi della “guerra” che gli si sarebbe rivolta
contro e intuiva, forse, che sarebbe stato colpito da una manovra politica di
altissimo livello. Ma come sarebbe stato attuato il “colpo”? Chi sarebbe stato
l’esecutore materiale di tale manovra? Quali interessi sarebbero entrati in
gioco? Gli interrogativi sono sviluppati in questa parte del film. La guerra può
essere definita come il conflitto violento scaturito tra società e gruppi armati
organizzati. Essa presuppone lo scontro tra due o più blocchi militari e
politici fino alla sua estrema conclusione, dove una delle due parti, o
schieramenti, sancisca la propria impossibilità di continuare il conflitto, e
iniziando, così, il primo passo verso il trattato di pace. Questa definizione
indicherebbe in primis la chiarezza degli obiettivi che scatenerebbero la
guerra, e la presenza chiara e distinta di un nemico da combattere. Nell’affaire
Moro, non si possono riconoscere questi elementi bellici. Per tanto, la guerra
che avrebbe combattuto Moro non conserverebbe nessuno di questi tratti
essenziali. Ma allora, di quale guerra sta parlando lo statista? Moro è oggetto
di una guerra strana, di un conflitto simbolico e criptato, una guerra
invisibile, una guerra fatta tra idee e strutture politiche non proprio evidenti
di fronte alla storia e alla stessa opinione pubblica. Si tratta di una guerra
che, in primo luogo, si compie sul piano psicologico, quello personale, di una
guerra che può essere compresa soltanto da chi aveva scritto quelle lettere. Si
tratta della tesi sostenuta nel film. La scena della torre di Siena argomenta il
livello “occulto” della presunta guerra in cui sarebbe coinvolto lo statista, il
cosiddetto quarto livello internazionale. Le scelte narrative e stilistiche del
film convergono sulla descrizione di un livello politico avanzato, in cui
prenderebbero vita segreti rapporti politici e finanziari tra governi e lobby
internazionali. Si tratta della teoria del doppio Stato, assai avversata dagli
storici accademici secondo la quale, oltre allo Stato trasparente, fatto di
istituzioni, di un governo e di un parlamento eletto dal popolo, esisterebbe in
ogni Nazione, uno stato occulto, segreto composto di famiglie finanziarie, di
massonerie e di potenti gruppi economici che possono determinare il ciclo
storico. Al di la di ogni possibile veridicità sull’esistenza di questo livello,
che per altro precluderebbe da questo lavoro, bisognerà ammettere che il
racconto di Martinelli avanza una serie di elementi giudiziari e probanti, assai
imbarazzanti per le stesse istituzioni. Il film adotta uno stile storico e
scenografico: molti elementi architettonici, edifici, chiese, palazzi e torri,
divengono il luogo candidato per affrontare l’argomento Moro. Questa scelta,
probabilmente, risponde a due ragioni narrative. Da una parte, la scenografia
rifletterebbe una certa tradizione storica italiana, caratterizzata da
un’imponente architettura bellica e politica, composta da torri, chiese,
castelli in cui le potenti Signorie hanno esercitato il loro specifico potere
temporale e militare. Da questo punto di vista, l’ambientazione risponde ad
un’esigenza analitica che tenta di comprendere il corso storico degli eventi.
Dall’altra, evidenzierebbe la stessa vicenda di Moro, la quale coinciderebbe con
il tentativo di stabilire un equilibrio tra le diverse spinte politiche italiane
e internazionali, di porre una sorta di pace, di compromesso. La frammentazione
della politica italiana, l’eccessivo partitismo e una vivacissima attività
governativa, evidenziano la particolare instabilità della storia politica e
civile dell’Italia. La scena iniziale del famoso palio di Siena, potrebbero
assumerebbe questo significato. Le immagini sono veloci, strette su dettagli e
montate con un ritmo serrato e brevissimo. Suggeriscono una forte conflittualità
tra gli elementi. La funzione semantica del particolare chiuso all’interno
dell’immagine, l’inquadratura specifica che sottrae lo spazio intorno
all’oggetto, destruttura e mette in conflitto tutta l’integrità dell’oggetto e
della stessa scena. Attraverso un montaggio rapido, concentrato sulla brevità
dell’inquadratura e sulla specificità dei dettagli, emerge un significato
conflittuale tra gli elementi mostrati. Tale struttura suggerirebbe la forza
rituale del palio di Siena, ma anche la tradizione storica della cavalleria, dei
soldati, e in una parola della guerra: il film si apre attraverso la messa in
scena di una guerra. Attraverso il rituale storico del palio, come paradigma
degli eserciti e della conquista, emerge l’idea di un conflitto permanente che
attraversa tutto il racconto filmico e che ha determinato la vicenda storica
dell’Italia e dello stesso Aldo Moro. Ma esiste anche un altro aspetto
importante che emerge dalla scena della Torre e che posso definire di valore
squisitamente cinematografico. Si tratta del valore simbolico che assume lo
spazio scenico in cui avviene il racconto. Questo valore spaziale è propriamente
la dimensione dell’altezza della Torre. L’altezza della Torre corrisponde al
punto di vista di chi nell’insieme analizza l’affaire Moro; più si va in alto e
più sono chiare le strategie del Potere. Questa scena ha lo scopo di svelare lo
scenario internazionale dietro l’episodio prettamente nazionale, contro chi,
fino ad oggi, ha insistito per far prevalere l’interpretazione del sequestro
Moro solo e soltanto attraverso le Brigate rosse. Lo scopo precipuo della scena
è quindi di dare una risposta al significato particolare che Moro dava alla
parola guerra. La metafora adottata per questa scena è quindi il punto di vista
dei protagonisti, una metafora che viene realizzata dal basso verso l’alto. Il
punto di vista spaziale corrisponde al punto di vista narrativo e
conseguentemente al punto di vista storico. La finzione cinematografica e
narrativa è il presupposto per una possibile verità storica che avrebbe generato
la drammatica vicenda di Aldo Moro: questa, a mio avviso, sarebbe la forza
semantica di questa scena. Martinelli afferma che si è trattato di una metafora
per dare corpo all’idea del complotto: «dalla cima della Torre, molti fatti
apparentemente slegati tra loto tradiscono così il filo sotterraneo che li
lega». Ogni piano della torre corrisponde ad un nuovo e inquietante livello del
caso Moro, dove si svelerebbero i tasselli dell’indagine. Rosario accosta tutte
le conclusioni raggiunte fino ad ora: quello di via Fani è un sequestro anomalo,
come anche quello di via Gradoli è un covo anomalo. Ancora una volta emerge
l’idea di una situazione strana, non chiara, esattamente come la «guerra» di cui
scriveva Moro. Il film raggiunge il suo scopo puntando l’attenzione sulla figura
anomala e ambigua del presunto capo delle Brigate rosse, Mario Moretti, un «capo
anomalo». Il giudice rivela le ultime informazioni avute a Parigi dalla
cosiddetta entità. Tutta la strana vicenda del sequestro Moro è fatta risalire
alla scuola di lingue Hyperion, il cui scopo nascosto era quella d’impedire
l’ascesa del partito comunista italiano. Un obiettivo che coincideva con quello
della Loggia Massonica P2. Rosario conclude affermando che dentro le Brigate
rosse vi erano gli infiltrati di presunti e misteriosi servizi segreti che
dovevano convogliare gli interessi dei terroristi con gli interessi delle
potenze internazionali: in una parola l’impraticabilità del compromesso storico.
Questo aspetto emerge in maniera piuttosto diretta attraverso le parole di
Saracini: «il programma della P2 era diametralmente opposto alla politica di
Moro, la loggia di Gelli avversava il partito comunista come un esiziale nemico…
proprio in quegli anni nel nostro Paese era nato un fenomeno nuovo, le Brigate
Rosse, appunto». In questo punto del film si tratta l’ennesima anomalia
dell’affaire Moro. L’esempio è fornito da Frate Mitra, meglio conosciuto come
Silvano Girotto. La sua biografia può essere equiparata a quella dell’agente
provocatore: studente, ladro, rapinatore, legionario in Algeria, disertore,
frate francescano, guerrigliero in Bolivia, resistente in Cile. Sempre salvo
mentre chi gli sta intorno viene arrestato. Si ha l’impressione di vedere un
infiltrato di altissimo livello, agli ordini di un servizio segreto che
determina gli eventi storici, «usato dagli strateghi della tensione che
procedono alternando attentati di destra e attentati rossi». Il primo incontro
tra Curcio e Girotto avviene il 28 luglio 1974. L’incontro è fotografato dai
carabinieri del generale Dalla Chiesa. Il secondo incontro è del 31 agosto.
Curcio e Moretti sono insieme. Girotto aveva offerto la sua conoscenza di
guerrigliero andino. Moretti trasse l’impressione che Girotto fosse sincero. Ma
Curcio e Cagol non ne erano affatto convinti, ricorda Franceschini. Il terzo
incontro è fissato per l’8 settembre. Il 6 settembre una telefonata anonima
giunge ad Enrico Levati, medico già presente nell’incontro di Pecorile,
arrestato e poi rilasciato in merito alle indagini sui Gap di Feltrinelli.
Flamigni ricorda che Levati avrebbe ricevuto l’informazione di avvisare Curcio
che l’incontro di settembre sarebbe stato una trappola. Ma la notizia non
arriverà mai a Curcio, ma soltanto a Moretti. Gli incontri tra il gruppo armato
e Girotto sono di fatto una trappola gestita dal Nucleo speciale dei carabinieri
del generale Dalla Chiesa. Ma questa operazione si rivela, comunque, gravida di
enigmi e di ambiguità a partire dallo strano comportamento di Moretti e dalla
misteriosa fuga di notizie che avrebbe avvisato Enrico Levati. L’otto settembre
del 1974 Girotto partecipa all’operazione organizzata dai carabinieri del
Generale Dalla Chiesa, che si concluderà con l’arresto di Franceschini e Curcio,
in località Pinerolo. Si tratta di un evento che muta radicalmente l’attività
delle Brigate rosse e tutti gli obiettivi politici della lotta armata contro il
“regime”. Il film evidenzia i lati oscuri dell’arresto di Pinerolo a partire da
un fatto strano: perché Curcio e Franceschini sono stati arrestati così in
anticipo da bruciare la stessa copertura di Girotto? Se Girotto avesse potuto
continuare le sue indagini, avrebbe sgominato l’intera organizzazione e
impedito, probabilmente, lo stesso sequestro Moro. Il generale Dalla Chiesa, in
Commissione Parlamentare, diede una risposta poco esaustiva, affermando che una
volta identificati i criminali dovevano, nell’obbligo della legge, intervenire
nell’arresto. Ma non basta. Tra il materiale che i carabinieri raccolsero non
risulta, stranamente, nessuna immagine di Moretti. Fino a quel 8 settembre,
Moretti era già stato pedinato, fotografato e quindi era un elemento
classificato come pericoloso dalle stesse Forze dell’Ordine. Eppure nei suoi
confronti, come ricorda Flamigni, non vennero fatte ulteriori fotografie
comprovanti la sua presenza a Pinerolo. Questo spiegherebbe, ricorda Fernanda,
«come mai in nessuna foto agli atti del processo torinese delle Brigate Rosse
non compare Moretti». Cosa più strana è che Mario Moretti non è arrestato. Ne
consegue che la presenza di Girotto, non solo comproverebbe l’ingerenza dei
servizi segreti dietro gli stessi Brigatisti, ma evidenzierebbe che la retata
sarebbe stata organizzata con lo scopo preciso di arrestare soltanto una parte
della Brigate rosse e lasciare poi spazio al nuovo capo Mario Moretti. Moretti è
il vero beneficiario dell’arresto. Egli cambia strategie e obiettivi del gruppo
armato, dando una svolta violenta e bellicosa: il film mostra le immagini del
telegiornale relative al 6 giugno del 1976, quando le Br uccisero il magistrato
Francesco Coco e i due carabinieri della scorta. Come ricorda Saracini, «è a
partire da questo preciso momento che le Br adottano l’omicidio come metodo di
lotta». Quando Moretti assume il comando, le Brigate Rosse stanno progettando il
sequestro dell’onorevole Giulio Andreotti, «Moretti invece, convince
l’organizzazione a spostare il tiro su Aldo Moro… nel momento in cui quelli che
manovrano Moretti decidono il sequestro di Moro, il presidente della Democrazia
Cristiana è un uomo morto». Ricorda Franceschini, che nel ’74 si era deciso di
organizzare il sequestro Andreotti con il quale i brigatisti avrebbero chiesto
in cambio i compagni della XXII Ottobre e di Maurizio Ferrari (arrestato dopo la
liberazione di Sossi). Nel ’76, dopo il reclutamento di Morucci, i brigatisti
iniziarono un’inchiesta su Moro, spingendo verso la realizzazione del suo
sequestro. Moretti, spiegherà che molto probabilmente le Br non avevano compreso
in pieno la differenza tra Moro e Andreotti. Ma appunto, ricorda Flamigni,
«perché Moro e non Andreotti?», perché il leader democristiano vicino alla
sinistra, progressista, filoaraba, inviso agli americani e allo stesso Mossad?
Perché non Andreotti, capo della destra anticomunista accusato dalle stesse Br
di essere il regista politico della svolta “neo-gollista” di Sogno? Sono domande
che Moretti evade con sfrontata ambiguità. Sofri ricorda una dichiarazione di
Moretti: «non mi risulta che si sia pensato ad altri per la grande campagna di
primavera del ’78 […] la nostra attenzione e il nostro impegno si concentrarono
su Moro». Dunque, strane contraddizioni. Rosario illustra le nuove priorità
delle Br, il cambiamento di rotta. Moretti è l’unico brigatista importante
ancora libero: trasforma l’obiettivo delle Br attraverso un’opera di propaganda
per sequestrare il vero nemico del proletariato e del partito armato,
l’esponente di spicco dei Stati Imperialisti Multinazionali: Aldo Moro. Da
adesso in poi, Moro è il vero responsabile del regime democristiano. Rosario
ricorda che intorno ad Aldo Moro esisteva già una «cortina di ferro» anche
nell’area di partito, di governo e nel mondo politico internazionale. La
realizzazione del suo progetto politico, attraverso l’entrata del partito
comunista nell’area di governo, avrebbe rappresentato un serio pericolo per le
forze democratiche e per lo stesso regime comunista. Si tratta del punto più
delicato e fondamentale del film. La politica di Moro era destabilizzante,
avrebbe permesso ad un partito “nemico” di accedere ai segreti militari della
Nato. L’entrata del Pci nel Governo avrebbe significato svelare tutti i segreti
Nato al nemico. Di contro, avrebbe significato che un partito comunista poteva
partecipare al processo democratico attraverso un consenso popolare ed
elettorale, senza il bisogno di costruirsi su di una solida impalcatura
burocratica come poteva essere l’Unione Sovietica di Breznev. Dunque, il
compromesso storico rappresentava oggettivamente un problema geopolitico e
strategico-militare tanto per Washington, quanto per Mosca. È il punto chiave
del film. Lo stesso Pecorelli aveva evidenziato il carattere internazionale del
sequestro Moro attraverso un articolo intitolato Yalta in via Mario Fani:
«l’agguato di via Fani porta il segno di un lucido superpotere. La cattura di
Moro rappresenta una delle più grosse operazioni politiche compiute negli ultimi
decenni in un Paese industriale, integrato nel sistema occidentale». Più avanti
aggiunge che l’obiettivo principale di questo sequestro è l’allontanamento del
partito comunista dall’area di governo, e al tempo stesso, l’allontanamento di
una prospettiva troppo democratica per lo stesso comunismo o «eurocomunismo». Il
film diviene la descrizione narrativa di questo articolo: il fattore Yalta e la
divisione del mondo in due blocchi. Pecorelli insiste in questa prospettiva: la
partecipazione del Pci non era gradita nè a Washington e ne a Mosca, «la
dimostrazione storica che un comunismo democratica può arrivare al potere grazie
al consenso popolare, rappresenterebbe non soltanto il crollo del primato
ideologico del Pcus sulla Terza Internazionale, ma alla fine dello stesso
sistema imperiale moscovita». L’apertura al “quarto livello” è da identificare
con la logica di Yalta, «è Yalta che ha deciso via Mario Fani». Da questo
presupposto il film introduce il dubbio sulla identità organica e unitaria delle
stesse Brigate rosse e su alcuni suoi componenti, proprio come aveva fatto lo
stesso Pecorelli attraverso un altro articolo: E anche Renato Curcio fa il suo
dovere. Si tratta di un articolo sibillino che allude al fatto che i rapitori di
Moro non avrebbero niente a che vedere con le Brigate rosse, con il «grande
fatto politico – tecnicistico del sequestro Moro». La scelta di Moretti di
puntare l’attenzione su Aldo Moro coincide “stranamente” con la volontà
internazionale dei due blocchi di scongiurare a tutti i costi la realizzazione
del compromesso storico in un paese, l’Italia, in cui esisteva il partito
comunista più forte sotto giurisdizione Nato. Da qui, il film, spinge
ulteriormente sulle strane anomalie del brigatista Moretti: la sua straordinaria
fortuna nell’evitare gli arresti, fino all’aprile 1981, i suoi misteriosi
viaggi, i contatti con Hyperion, i suoi evasivi resoconti sulla dinamica del
sequestro Moro, versioni non sempre chiare e soddisfacenti. Tanto che, in
carcere Moretti verrà emarginato da tutti gli altri brigatisti, come ricorda
Galati, perché considerato spia. Il film mostra l’opuscolo che il giudice
avrebbe avuto dall’Entità a Parigi. L’opuscolo definisce i piani d’intervento
militare da adottare in caso di vittoria elettorale del partito comunista o in
caso d’invasione dell’Armata Rossa, attraverso l’azione di agenti infiltrati. Si
tratta, afferma Rosario, della direttiva FM 30/31 B che prevedeva azioni di
provocazione e reazione di alti esponenti della sinistra comunista e azioni di
sequestro, fino all’assassinio di leader politici. Il dato più significante è
quello che riguarda i piani d’intervento militare presenti nell’opuscolo in mano
a Rosario sono incredibilmente simili ai piani di intervento politico e
finanziario in programma per le elezioni politiche del 18 aprile 1948. Si tratta
dei piani di Gladio, di cui Moro stesso era a conoscenza, e della struttura
segreta Stay Behind, nata per lo stesso motivo: osteggiare il pericolo di
un’avanzata politica e militare comunista[256]. Ed è probabilmente a questa
guerra che Moro si sarebbe rivolto nelle sue lettere. Aspetti militari e
politici che in quel periodo ancora erano del tutto sconosciuti all’opinione
pubblica e a buona parte del mondo politico, ma di cui Aldo Moro, noto anche con
il nomignolo di Signor Omissis, ne conosceva gli interessi e la gestione. Da un
punto di vista narrativo la scena della torre assume un’importanza fondamentale
per risolvere definitivamente l’indagine. Rosario, si rivolge a Branco,
affermando che forse conosce l’ubicazione del presunto vero Memoriale Moro. Ed è
in questa direzione che il film tenta il suo percorso investigativo. Il
Memoriale che tutti conoscono quello riscoperto nel ’91 sarebbe dunque
incompleto e il giudice Saracini starebbe per raggiungere quello vero e
definitivo.
13. LA FINE DEL RACCONTO.
Nella ricorrenza della strage di Via Fani del 16 marzo 1988, Il Messaggero
pubblicò alcune dichiarazioni del pubblico ministero Domenico Sica. Il
magistrato affermava: «non ci sono verità nascoste sul caso Moro... tutto quello
che poteva essere scoperto è stato scoperto… sono convinto che ciò che resta da
sapere è assolutamente irrilevante ai fini dell’individuazione del nucleo
terroristico responsabile». È un punto di vista condiviso dalla maggior parte
delle Istituzioni e dalla politica italiana: nel caso Moro non c’è più niente da
scoprire e per questo sono da escludere tutti quei misteri che continuerebbero a
destabilizzare la verità giudiziaria. Tutte le indagini personali portate avanti
da un certo settore dalla pubblicistica apparterebbero, quindi, ad una
dietrologia speculativa e fantastica. Quella di De Sica è un’affermazione molto
forte che stride con l’idea narrativa del film di Martinelli e con le ipotesi
proposte da altri scrittori, giornalisti e intellettuali. Lo stesso Moretti,
ancora oggi, è fermamente convinto che le Br, di fatto, furono un gruppo
rivoluzionario armato che voleva attuare una lotta contro il Potere. Tuttavia,
molti sono i buchi neri che confermerebbero le strane circostanze del sequestro
Moro. Ci si trova di fronte ad uno strano bivio, un doppio percorso che
descriverebbe i due approcci del caso Moro. Da una parte esiste la versione
ufficiale, divulgata in ogni dove, di cui si fanno portavoce maggiori
rappresentati della cultura e della politica italiana. È il caso dell’Odissea
del caso Moro, di Vladimiro Satta, ricordato polemicamente dallo stesso
Flamigni, o ancora di alcuni interventi giornalistici di Pierluigi Battista o
ancora di Paolo Mieli che avrebbero sminuito il lavoro investigativo di Flamigni
o criticato lo stesso film di Martinelli. Dall’altra esiste una “strana”
minoranza, che continuerebbe il personale percorso investigativo, molto spesso
solitario e difficoltoso, cercando di portare alla luce gli elementi poco
definiti della vicenda. Due tendenze che, effettivamente, sembrano rispecchiare
un divario storico e politico tutto italiano e che rappresentano due tendenze
opposte e contrarie che sembrano andare molto al di là della semplice ricerca
storiografica. Forse, come ha osservato il presidente della commissione stragi
Giovanni Pellegrino «la classe politica italiana non ha un reale interesse
all'accertamento della verità sulle stragi in quanto ciascuna forza politica
punta ad una verità che giovi al proprio interesse». Sopra le due tendenze,
sembra esistere un potere molto più ampio, che gestirebbe la verità storica e
giudiziaria: è la tesi narrativa proposta dal film e che colpirà direttamente i
familiari di Fernanda e lo stesso procuratore Saracini. Si tratta, almeno da un
punto di vista filmico, della conferma della tesi del complotto, e di come
esista un potere che convive con gli eventi quotidiani della società civile, che
gestisce gli eventi della storia. La morte del marito di Fernanda, in
circostanze che il film presenta chiaramente delittuose, e la scoperta della
vera identità di Branco, indicherebbero la presenza di un potere insidioso
dedito al controllo delle informazioni, proteso ad un incessante spionaggio.
Martinelli racconta che il caso Moro nasce in un contesto storico e politico
determinato da una guerra di spie di altissimo livello internazionale. Gli
eventi incalzano tutti verso il finale: l’inseguimento di un misterioso
elicottero che tenta di eliminare il giudice[263]; la visita intimidatoria nella
casa del giudice che viene messa a soqquadro[264]; la strana telefonata che
Rosario riceve dal capo della magistratura che lo invita a presentarsi
immediatamente a Roma. Si tratta, ineccepibilmente, di un superpotere che esiste
e convive concretamente con la vita del procuratore, che controlla segretamente
tutti gli eventi privati e pubblici della vita del singolo cittadino. Quando
Rosario scoprirà la chiave per accedere al programma informatico, comprenderà
che si tratta del nome di una nota zona romana, prossima a piazza Navona, dal
nome piazzadellecinquelune: è la password che gli consentirà di svelare il
mistero intorno al memoriale Moro. Piazza delle Cinque Lune è anche il luogo
dove Varisco, Pecorelli e il generale Dalla Chiesa si sarebbero incontrati in
più riprese e dove, molto probabilmente, sarebbero venuti a conoscenza, già
durante il 1978, dei passi censurati del memoriale Moro. Piazza delle Cinque
Lune sarebbe la chiave per accedere al Memoriale, il luogo dove si sarebbe
creata una strana collusione tra servizi segreti e occulti superpoteri. Ma
sarebbe anche lo spazio scenico del finale narrativo del racconto, il telos
della storia. Quindi il livello storico si sovrappone al codice narrativo,
delineando una nuova possibilità investigativa. Il titolo del film spiegherebbe
tale circostanza complottistica e insidiosa, la rappresentazione di “poteri” non
meglio definiti. Piazza delle cinque lune è il luogo fisico carico di misteri, è
l’elemento narrativo che scioglie l’intreccio e spiega la logica del racconto.
Un luogo che sosterrebbe il significato storico e storiografico di tutta la
vicenda: il caso Moro nasconderebbe un’intricata matassa da districare, resa
contorta dalla mancanza di documenti troppo spesso confusi o addirittura
scomparsi. Se il giudice Saracini scopre di essere stato spiato sin dal primo
momento, lo spettatore scopre che tutto il caso Moro è controllato da un
superpotere nascosto e onnisciente. Tutta la storia raccontata è quindi travolta
dal poderoso dubbio finale che travolgerebbe tutta la storiografia riferita al
caso Moro. Tutta la finzione narrativa, quindi, corrisponderebbe ad un reale
livello storico ancora da esplorare. Nell’incontro con Branco si assiste allo
svolgimento dell’intreccio narrativo che però non risolve quello storico: anzi
lo ammanta di un dubbio maggiore. Chi si nasconderebbe dietro il caso Moro? È
l’invisibilità dell’evidenza, per dirla con Sciascia. Il potere dentro il
sistema è onnicomprensivo, onnisciente e onnipresente. Convive a fianco della
magistratura, della politica, nell’esecutivo e per poi intervenire quando crede.
L’inquadratura dall’alto assume anche questo significato: il controllo. Il punto
di vista rappresenta la visione complessiva degli eventi e come un potere più
grande che controlla gerarchicamente quelli più in basso. Il film, come ho
osservato precedentemente, adotta questo linguaggio semantico per evidenziare
questo aspetto del racconto, ovvero la relazione esistente tra il punto di vista
narrativo (la macchina da presa) e il punto di vista storico (lo svelamento di
alcuni indizi giudiziari). Il Memoriale non sarà scoperto nemmeno alla
conclusione del racconto: «il film ha una conclusione amara, ovvero che la
verità è destinata a rimanere nascosta in questo paese. Il famoso Memoriale non
verrà fuori neanche nel film […] in Italia certi misteri sono destinati a non
essere svelati mai, come è successo per i fatti di Ustica, per la strage di
Bologna e in tanti altri tragici episodi della nostra storia». Il Memoriale Moro
fa riferimento ad espressioni tipo «come dirò più avanti» oppure «come ho già
detto altrove». Nelle 229 pagine fotocopiate, trovate nel covo di via
Montenevoso il 9 ottobre del ’90, mancherebbero tali rimandi. Perché i
brigatisti non hanno divulgato il Memoriale, pur avendo affermato che “niente
doveva essere nascosto al popolo”? Dov’è finito l’originale scritto a mano del
Memoriale Moro? Dove sono finite le pagine mancanti? Dove le bobine registrate?
Dove sono le trascrizioni degli interrogatori? Il regista sceglie la strada del
finale aperto. L’impossibilità narrativa di trovare il Memoriale è la triste
constatazione di una storia politica e giudiziaria ancora da risolvere. Da
questo punto di vista, il film raggiunge il suo scopo narrativo. Il discorso
della storia e il discorso della forma coincidono nell’impossibilità di non
poter chiudere il film. Si tratta di un film che inquieta lo spettatore, il
quale non riesce a trovare un finale perché non esisterebbe, secondo Martinelli,
nemmeno nella storia ufficiale, perché nessuno è ancora riuscito a trovare la
versione definitiva del Memoriale Moro. Il collante di questi misteri è
rappresentato da una location virtuale, un luogo che per tutto il film non
esiste, se non nell’indagine che compiono i protagonisti, e compare soltanto nel
finale del film, nella soluzione amara dell’intreccio: Rosario non troverà il
Memoriale, ma scopre la doppia faccia dello Stato. Il Memoriale, è molto
probabilmente dietro a questo superpotere. Cercare di scoprire l’ubicazione del
Memoriale, significherebbe affrontare la presunta identità di uno Stato che si
muove nel segreto, con tutte le conseguenze che questo comporterebbe. Il punto
di vista è confermato anche dalla scelta stilistica del regista, dalla
costruzione scenica e narrativa della scena finale. L’ending shot, è realizzato
attraverso il ritorno della forma elicoidale della rampa delle scale e dalla
panoramica sulla mappa della città. Tutto richiamerebbe alla rete in cui è
caduto il giudice. La forma essenziale di questi due elementi, già presenti
durante la narrazione, sono esasperati attraverso l’utilizzo di un piano
sequenza che partendo dall’interno del palazzo, in cui si trova il giudice,
arriva a coinvolgere una zona enormemente più grande e più complessa. La
violenza del zoom out non indica soltanto lo stato d’animo del giudice, sorpreso
e spaventato della presenza di Branco, ma è anche l’espressione diretta,
tangibile ed estetica del complotto. Il film, attraverso questo finale,
offrirebbe un’ulteriore spiegazione sull’utilizzazione semantica del punto di
vista. Lo svelamento del reticolo delle strade, visto dall’alto, indica
chiaramente l’incastro diabolico e perfido di tutta la storia, quella del
giudice che tenta l’indagine e quella stessa di Moro, ricca di contraddizioni
irrisolte. La figura ellittica, come ho già evidenziato precedentemente, è la
metafora di una ragnatela che circoscrive l’affaire, la stessa che fa
riferimento alla citazione in esergo al film: «la giustizia è come una tela di
ragno: trattiene gli insetti piccoli, mentre i grandi trafiggono la tela e
restano liberi». Si tratta di una conclusione inquietante che entra nettamente
in contrasto con quella garantista e risoluta delle istituzioni. Ce lo ricorda
Franceschini. Per lui Moretti era un infiltrato di terzo livello: il primo
livello era il movimento rivoluzionario; il secondo livello erano le stesse Br;
e il terzo era rappresentato da chi «utilizzava anche la lotta armata per
garantire gli equilibri del mondo sanciti a Yalta nel 1945». D’altra parte, è lo
stesso Moretti a ricordare la valenza storica dell’affaire Moro sarebbe rimasta
ancora aperta, «perché questa storia che politicamente è finita non è una storia
giuridicamente finita». E Franceschini parla apertamente di trattative: «nelle
galere c’è stata la contrattazione su quello che si doveva e non si doveva dire,
e il silenzio è stato pagato con la libertà o i benefici di legge a favore degli
ergastolani». Flamigni, a suo modo giunge ad alcune conclusioni simili a
Franceschini, in totale disaccordo con gli esiti giudiziari: la verità ufficiale
raccontata dai brigatisti e sancita dai tribunali come tale è, in più punti,
inverosimile; non crede alla purezza rivoluzionaria delle Brigate rosse
morettiane e tanto meno a quella di Moretti; egli è convinto che nel delitto
Moro vi siano state implicazioni dei servizi segreti e collusioni “atlantiche”.
Si tratta di tesi soggettive e per tanto opinabili, afferma Flamigni, ma libere
di essere espresse e di essere argomentate. Ed è, al contempo, il filo rosso che
percorre tutto il film di Martinelli, nel racconto di finzione e nell’indagine
giudiziaria. Un film, come ricordavo all’inizio è prima di tutto un fatto
narrativo, che rientra di diritto nel campo estetico. Ma non per questo deve
essere necessariamente destinato al mondo della finzione e dell’invenzione
intellettuale. Da questo punto di vista, il film di Martinelli può essere
definito come un fondamentale esempio di impegno civile e sociale interessato
all’analisi e allo studio della verità storica. Non si tratta di puntare
l’attenzione sul fattore spettacolare che tenta di trarre il massimo dai tanti
misteri che esistono nella prima repubblica. E ne si può accusare il film di
Martinelli di faziosità politica o giudiziaria. Gli elementi presentati nel
film, sono in primo luogo indizi, tracce reali, segni oggettivi che messi
insieme definiscono una possibile pista investigativa, una possibile
interpretazione storica che non può essere tacciata come difettosa o paranoica.
Il film è l’esempio in cui il cinema, come immagine movimento, possa intervenire
nella realtà sociale per rappresentare il suo più alto contributo etico ed
estetico. La costruzione della trama, il rifacimento delle scene, costringe il
film, per forza di cose, ad ipotizzare un'altra dinamica degli eventi a tal
punto da scorgere, senza imbarazzo, brigatisti e istituzioni dietro una versione
troppo spesso superficiale. Così accade nella ricostruzione della strage di via
Fani dove due elementi giudiziari non hanno permesso, a rigore di logica, lo
svolgimento drammatico e fattivo dell’incidente: l’impatto della macchina di
Moro, che non c’è mai stato e l’uccisione del maresciallo Leonardi. Qui il film
insinua il dubbio e lo fa secondo una base oggettivamente riscontrabile nei
resoconti giudiziari e nelle versioni fornite dai stessi brigatisti.
Probabilmente, come afferma il regista, se brigatisti hanno potuto mentire
sull’azione di via Fani e su un aspetto evidente come il mancato tamponamento,
forse hanno mentito su tutto il resto. Dunque, il film non è esclusivamente un
fatto finzione o di invenzione. Da questo punto di vista il racconto ribadisce
continuamente il suo sforzo di costruzione semantica e al tempo stesso
storiografica, degna di un cinema della migliore tradizione italiana, del cinema
di Rosi, di Petri, del cosiddetto cinema politico. In oltre, il film ha un altro
primato: per la prima volta all’interno del cinema italiano viene trattato senza
troppi formalismi l’argomento P2. Non solo. Nel film esiste una vera e propria
struttura gerarchica, un organigramma, che si mostra chiaramente in tutta la sua
forza storica e giudiziaria, attraverso alcune inquadrature chiare e distinte in
un contesto storico preciso. Prima di questo film, nessuna opera aveva osato
tanto, nessun racconto aveva tentato di presentare i nomi di uomini politici,
militari e civili per inserirli in un racconto. Da questo punto di vista, il
film di Martinelli ha effettivamente rotto un muro di omertà e per questo,
volenti o nolenti, bisogna dargliene atto. Ma la conclusione spetta proprio allo
spettatore, poiché il film è creato soprattutto per stimolare la sua conoscenza
e la sua intelligenza. Allo spettatore spetta il compito di unire i spezzoni
proposti nel film, di operare un scelta tra le tante versioni esistenti, di
creare un unico percorso narrativo unendo i diversi tempi e i diversi spazi
proposti nel film: il flashback, il repertorio, le immagini di finzione, le
telefonate dei brigatisti, il filmato di via Fani, i nuovi elementi indiziari.
Tutto questo deve essere necessariamente contestualizzato se si vuole dare un
senso al racconto narrativo e al racconto storiografico. Per dirla insieme a
Deleuze, l’attività dello spettatore finisce per coincidere con quella «falda di
trasformazione» che inventa una sorta di continuità, di comunicazione
trasversale, liberando così la stessa narrazione dall’impaccio del racconto e
operare un senso compiuto. Percezione, ricezione e riflessione: la sintesi deve
essere data e offerta proprio dallo spettatore, che completa il finale aperto
del film. Ma forse «è un lavoro che rischia lo scacco, talvolta produciamo
soltanto una polvere incoerente fatta di prestiti giustapposti, talvolta
formiamo soltanto generalità che prendono in considerazione solo delle
somiglianze» e in tutto questo, lo spettatore comune può perdersi, confondendo
ulteriormente la ricerca della verità. Ma si tratta, inevitabilmente, di un
rischio che il cinema deve correre se vuole intervenire positivamente nei gangli
dello sviluppo sociale e civile, modificare i punti nevralgici del Potere e
incentivare la crescita degli individui. La costruzione finale del racconto
indica inequivocabilmente l’allargamento del caso Moro: l’affaire è «una vicenda
di intelligence internazionale, non circoscritta solo all’Italia e nella quale
molti sono i punti oscuri». Il film propone dunque l’idea di questa storia e non
pretende, secondo la più alta ambizione del cinema politico italiano, di
risolvere la vicenda e nè tanto meno di schierarsi su di un fronte interessato e
partitico: «vorrebbe sollecitare gli spettatori a riflettere su tutte le
incongruenze e le menzogne che da venticinque anni ruotano intorno a questo
evento epocale». Lo scopo dell’arte impegnata del cinema cosiddetto politico è
quello di incitare allo studio della propria storia, stimolare la curiosità e
comprendere le cause e gli effetti del proprio paese, significa crescere e
costruire il futuro. Lo scopo del cinema verità è quello di impedire l’oblio,
provocare l’indignazione non per il gusto estetico di provocare emozioni forti e
violente: semplicemente per non dimenticare la propria storia e gli strani
revisionismi che non collimano tra loro, molto spesso forzati e interessati.
L’indignazione è il gesto rivoluzionario dello spettatore, è una delle
possibilità per acquisire coscienza critica. È uno dei modi per poter
raggiungere la verità. E la verità è sempre illuminante e ci aiuta a essere
coraggiosi, come scriveva Moro. Il film di Martinelli è un film coraggioso
proprio perché cerca una verità senza tornaconti. Andrea Lomartire




 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: