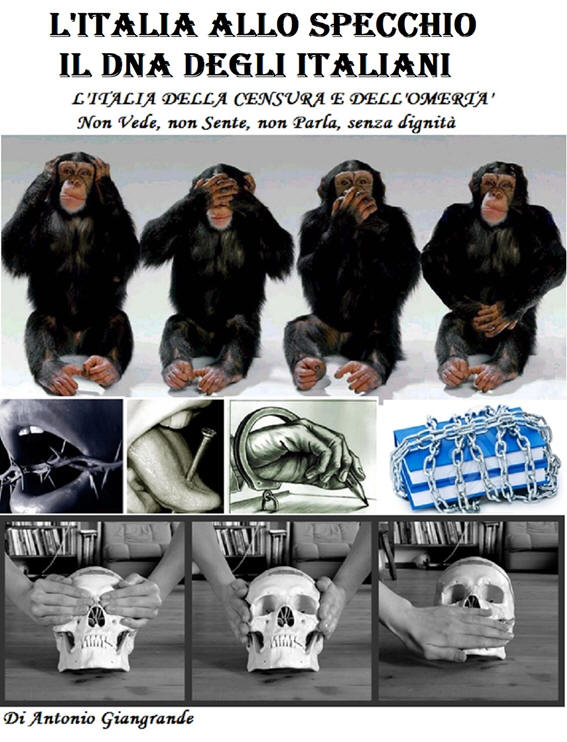Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
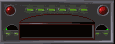
 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
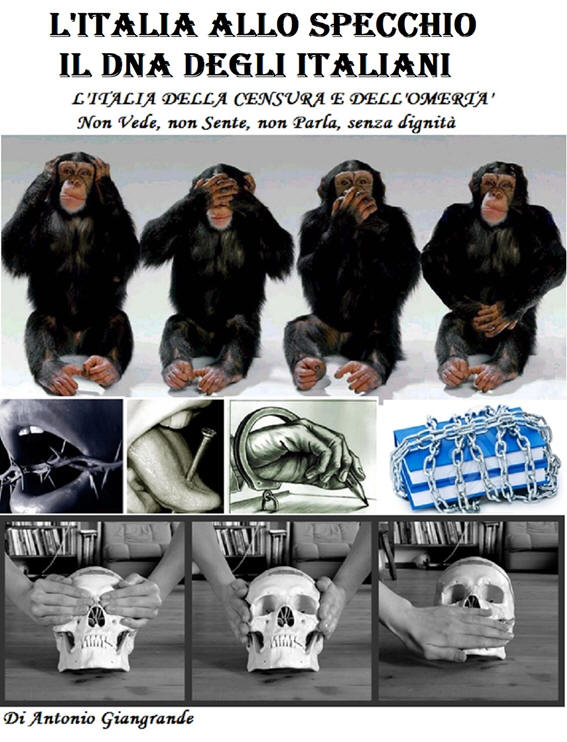
ANNO 2023
IL GOVERNO
TERZA
PARTE
DI ANTONIO
GIANGRANDE
L’APOTEOSI
DI UN POPOLO
DIFETTATO
Questo saggio è un aggiornamento temporale,
pluritematico e pluriterritoriale, riferito al 2023, consequenziale a quello del
2022. Gli argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati
ed approfonditi in centinaia di saggi analitici specificatamente dedicati e già
pubblicati negli stessi canali in forma Book o E-book, con raccolta di materiale
riferito al periodo antecedente. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a
tesi di laurea ed inchieste giornalistiche.
Si troveranno delle recensioni deliranti e
degradanti di queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando
del nulla, ma dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio
che l'offeso si ribelli con la denigrazione del palesato.
IL GOVERNO
UNA BALLATA
PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE SIAMO.
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande). L’AVETRANA CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
LA SOLITA INVASIONE
BARBARICA SABAUDA.
LA SOLITA ITALIOPOLI.
SOLITA LADRONIA.
SOLITO GOVERNOPOLI.
MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’.
SOLITA APPALTOPOLI.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED
ESAMI DI STATO TRUCCATI.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE
TRUCCATA.
SOLITO SPRECOPOLI.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE
SPECULAZIONI.
L’AMMINISTRAZIONE
SOLITO DISSERVIZIOPOLI. LA DITTATURA DEI
BUROCRATI.
SOLITA UGUAGLIANZIOPOLI.
IL COGLIONAVIRUS.
SANITA’: ROBA NOSTRA.
UN’INCHIESTA DA NON FARE. I MARCUCCI.
L’ACCOGLIENZA
SOLITA ITALIA RAZZISTA.
SOLITI PROFUGHI E FOIBE.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI.
GLI STATISTI
IL SOLITO AFFAIRE ALDO
MORO.
IL SOLITO GIULIO ANDREOTTI. IL DIVO RE.
SOLITA TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI. LE
MANI SPORCHE DI MANI PULITE.
SOLITO BERLUSCONI. L'ITALIANO PER ANTONOMASIA.
IL SOLITO COMUNISTA BENITO
MUSSOLINI.
I PARTITI
SOLITI 5 STELLE… CADENTI.
SOLITA LEGOPOLI. LA LEGA DA LEGARE.
SOLITI COMUNISTI. CHI LI
CONOSCE LI EVITA.
IL SOLITO AMICO TERRORISTA.
1968 TRAGICA ILLUSIONE
IDEOLOGICA.
LA GIUSTIZIA
SOLITO STEFANO CUCCHI &
COMPANY.
LA SOLITA SARAH SCAZZI. IL DELITTO DI AVETRANA.
LA SOLITA YARA GAMBIRASIO. IL DELITTO DI
BREMBATE.
SOLITO DELITTO DI PERUGIA.
SOLITA ABUSOPOLI.
SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI.
SOLITA GIUSTIZIOPOLI.
SOLITA MANETTOPOLI.
SOLITA IMPUNITOPOLI.
L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.
I SOLITI MISTERI ITALIANI.
BOLOGNA: UNA STRAGE
PARTIGIANA.
LA MAFIOSITA’
SOLITA MAFIOPOLI.
SOLITE MAFIE IN ITALIA.
SOLITA MAFIA
DELL’ANTIMAFIA.
SOLITO RIINA. LA COLPA DEI PADRI RICADE SUI
FIGLI.
SOLITO CAPORALATO. IPOCRISIA E SPECULAZIONE.
LA SOLITA USUROPOLI E
FALLIMENTOPOLI.
SOLITA CASTOPOLI.
LA SOLITA MASSONERIOPOLI.
CONTRO TUTTE LE MAFIE.
LA CULTURA ED
I MEDIA
LA SCIENZA E’ UN’OPINIONE.
SOLITO CONTROLLO E MANIPOLAZIONE MENTALE.
SOLITA SCUOLOPOLI ED IGNORANTOPOLI.
SOLITA CULTUROPOLI. DISCULTURA ED OSCURANTISMO.
SOLITO MEDIOPOLI. CENSURA, DISINFORMAZIONE,
OMERTA'.
LO SPETTACOLO E LO SPORT
SOLITO SPETTACOLOPOLI.
SOLITO SANREMO.
SOLITO SPORTOPOLI. LO SPORT COL TRUCCO.
LA SOCIETA’
GLI ANNIVERSARI DEL 2019.
I MORTI FAMOSI.
ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONI O CENTO DA AGNELLI?
L’AMBIENTE
LA SOLITA AGROFRODOPOLI.
SOLITO ANIMALOPOLI.
IL SOLITO TERREMOTO E…
IL SOLITO AMBIENTOPOLI.
IL TERRITORIO
SOLITO TRENTINO ALTO ADIGE.
SOLITO FRIULI VENEZIA GIULIA.
SOLITA VENEZIA ED IL VENETO.
SOLITA MILANO E LA LOMBARDIA.
SOLITO TORINO ED IL PIEMONTE E LA VAL D’AOSTA.
SOLITA GENOVA E LA LIGURIA.
SOLITA BOLOGNA, PARMA ED EMILIA ROMAGNA.
SOLITA FIRENZE E LA TOSCANA.
SOLITA SIENA.
SOLITA SARDEGNA.
SOLITE MARCHE.
SOLITA PERUGIA E L’UMBRIA.
SOLITA ROMA ED IL LAZIO.
SOLITO ABRUZZO.
SOLITO MOLISE.
SOLITA NAPOLI E LA CAMPANIA.
SOLITA BARI.
SOLITA FOGGIA.
SOLITA TARANTO.
SOLITA BRINDISI.
SOLITA LECCE.
SOLITA POTENZA E LA BASILICATA.
SOLITA REGGIO E LA CALABRIA.
SOLITA PALERMO, MESSINA E LA SICILIA.
LE RELIGIONI
SOLITO GESU’ CONTRO MAOMETTO.
FEMMINE E LGBTI
SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.
IL GOVERNO
INDICE PRIMA
PARTE
UNA BALLATA
PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE SIAMO.
LA POVERTA’
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande). L’AVETRANA CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE. (Ho scritto un
saggio dedicato)
LA SOLITA INVASIONE BARBARICA SABAUDA. (Ho
scritto un saggio dedicato)
Storia d’Italia.
INDICE
SECONDA PARTE
LA SOLITA ITALIOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
L’Italianità.
Gli Antifascisti.
Italiani scommettitori.
Italioti
Retrogradi.
Gli Arraffoni.
INDICE TERZA
PARTE
SOLITA LADRONIA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Italioti
corrotti e corruttori.
La
Questione Morale.
Tangentopoli Italiana.
Tangentopoli Europea.
INDICE
QUARTA
PARTE
SOLITO GOVERNOPOLI.
MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’. (Ho scritto un saggio dedicato)
Il
Potere.
La Geopolitica.
Nazi-fascismo e Comunismo: Economia pianificata.
I Conservatori.
Il Capitalismo.
Il Sovranismo.
Il
Riformismo.
I Liberali.
I
Popolari.
L’Opinionismo.
Il Populismo.
Il Complottismo.
Politica e magistratura, uno scontro lungo 30 anni.
Una Costituzione Catto-Comunista.
Democrazia:
La Dittatura delle minoranze.
Democrazia: Il potere oscuro ed occulto. I Burocrati.
Il Partito dello Stato: Deep State
e
Spoils system.
Il Presidenzialismo.
L’astensionismo.
I
Brogli.
Lo
Stato di Emergenza.
Quelli che…la Prima Repubblica.
Quelli che…la Seconda Repubblica.
Trasformisti e Voltagabbana.
Le Commissioni Parlamentari.
La Credibilità.
I
Sondaggisti.
Il finanziamento pubblico.
I
redditi dei politici.
I
Privilegiati.
I Portavoce.
Servi di…
Un Popolo di Spie.
INDICE
QUINTA PARTE
SOLITA APPALTOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
La Resistenza Morale.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED
ESAMI DI STATO TRUCCATI. (Ho scritto un saggio dedicato)
Impuniti.
Ignoranti e
Magistrati.
ESAME DI AVVOCATO.
LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE TRUCCATA. (Ho scritto un saggio dedicato)
Ignoranti
ed avvocati.
SOLITO SPRECOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Le Auto: blu e
grigie.
Le
Regioni.
L’Alitalia.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE
SPECULAZIONI.
L’Oro.
La Ricchezza.
I Ricconi alle
nostre spalle.
I
Bonus.
La Partita Iva.
Quelli che…Evasori Fiscali: Il Pizzo di Stato.
Il POS.
Il Patto di Stabilità.
Il MES.
Il PNRR.
Il ricatto del gas.
La Telefonia.
Bancopoli.
Sommario
SOLITA LADRONIA. (Ho scritto un saggio
dedicato).
Italioti corrotti e
corruttori.
I controllori.
Il primo atto di
Tangentopoli.
La questione morale.
Tangentopoli Italiana.
Tangentopoli fu
un colpo di Stato.
Antonio Dipietro.
Gherardo Colombo.
Gianni De
Michelis.
Giorgio Ruffolo.
Enzo Carra.
Gabriele Cagliari.
Sergio Moroni.
Raul Gardini.
Mafia Appalti.
Tangentopoli europea.
IL GOVERNO
TERZA PARTE
SOLITA LADRONIA. (Ho
scritto un saggio dedicato)
·
Italioti corrotti e corruttori.
I controllori.
Il primo atto di
Tangentopoli.
Estratto
dell’articolo di Federica Pozzi per "Il Messaggero" il 29 Marzo 2023
Si scambiavano i
badge, anche se non erano in servizio, per maturare il diritto all'indennità
speciale. Peccato che i tre "furbetti" del cartellino, finiti a processo per
truffa davanti al Tribunale di Roma, lavoravano proprio alla Corte dei conti,
dove si perseguono i dipendenti pubblici accusati di danno erariale.
Sembra un
paradosso in termini. Gli imputati, infatti, hanno avuto l'ardire di realizzare
il raggiro proprio nel palazzo di giustizia contabile che si trova a Roma, nel
quartiere Prati. E ora, oltre al procedimento penale, rischiano di finire
imputati nelle aule dell'edificio nel quale lavoravano per rispondere del danno
arrecato all'amministrazione.
A processo per il
presunto raggiro è finito Fabio Zambelli, 62 anni, funzionario della Corte dei
conti e fratello di Gianfranco Zambelli, ex consigliere regionale del Lazio in
quota Pd e tra gli organizzatori della "lista Rocca".
Insieme a
Zambelli, sono stati "pizzicati" Antonella Pizzella, 58 anni, collaboratore
amministrativo della Corte dei conti, e Maurizio Vaccaro, 69 anni, impiegato e
tesoriere di un'organizzazione sindacale interna al palazzo di via Baiamonti.
[…]
Nello specifico,
tra marzo e aprile del 2018, Fabio Zambelli aveva utilizzato il badge di
servizio assegnato al fratello Gianfranco «per svariate entrate e uscite» dagli
uffici di via Baiamonti (angolo viale Mazzini), dove lavorava, e «faceva così
risultare di essere in servizio».
L'ex consigliere
della Regione Lazio, infatti, è un funzionario amministrativo della Corte dei
conti in aspettativa non retribuita. Così facendo, Fabio Zambelli «si procurava
un ingiusto profitto, valutato in 969 euro, con pari danno per
l'Amministrazione», si legge nel capo di imputazione firmato dal sostituto
procuratore Laura Condemi.
Gli altri due
imputati, invece, si scambiavano i badge tra di loro. Questo escamotage, grazie
alla complicità del collega Vaccaro, serviva ad attestare la presenza al lavoro
di Pizzella per il raggiungimento delle ore necessarie per poter ottenere
un'indennità speciale.
Lo scambio
avveniva sia in entrata che in uscita, ed è stato collocato dalla Procura
capitolina nel lasso temporale compreso tra il 7 marzo e il 10 aprile del 2018.
L'ingiusto profitto in favore della donna è stato quantificato dai carabinieri
in oltre 2.200 euro.
[…] Fabio
Zambelli nel 2013 era già finito a processo per falso, truffa e peculato. […]
L’inaugurazione
del Petruzzelli, il primo atto di Tangentopoli.
Ad essersi
aggiudicati, alcuni anni prima, il suolo comunale da destinare a nuovo
Politeama, erano stati proprio i fratelli Antonio e Onofrio Petruzzelli.
ANNABELLA DE ROBERTIS su La Gazzetta del Mezzogiorno il 18 Febbraio 2023.
È il 15 febbraio
1903. Centoventi anni fa un trafiletto in terza pagina riportava una notizia
dalla portata epocale per la storia della città di Bari e di tutto il territorio
pugliese: «La grande inaugurazione del Teatro Petruzzelli». Il critico del
«Corriere delle Puglie» così racconta quella storica serata: «Quando il
pubblico, il gran pubblico, il pubblico aristocratico e democratico, borghese e
lavoratore, che affollava la immensa sala è rimasto colpito dalle onde di luce,
dal fulgore dell’oro, dai colori smaglianti, dai quadri rivelatori di tutto un
superiore criterio di arte; quando quel pubblico ha visto schiuso innanzi a sé
il meraviglioso ambiente, in cui il livello teatrale cittadino era innalzato
alle vette di un teatro, che è uno dei più belli d’Italia, ha avuto come una
esplosione di questa meraviglia, di riconoscenza verso chi ha dato un’opera
monumentale a Bari, di entusiasmo delirante per l’opera creata e portata a fine,
dall’ingegnere Messeni con una costanza infaticabile, dai fratelli Petruzzelli
con una persistenza che si spiega soltanto col sentimento di uomini che si
prefiggono una meta e tutto sgombrano per raggiungerla. E costoro l’hanno
raggiunta anche oltre l’aspettativa, l’hanno raggiunta nell’ammirazione anche
dei diffidenti e degli increduli; l’han raggiunta dando a Bari un teatro
Petruzzelli, che mette Bari tra le città che possono inorgoglire di avere un
grande, un bello, uno splendido teatro».
Ad essersi
aggiudicati, alcuni anni prima, il suolo comunale da destinare a nuovo
Politeama, erano stati proprio i fratelli Antonio e Onofrio Petruzzelli,
commercianti baresi di lenzuola, asciugamani e fazzoletti, i quali avevano
affidato il progetto al cognato, l’ing. Angelo Cicciomessere, che qualche tempo
dopo avrebbe cambiato il suo cognome in Messeni. «Non è comune il caso di
privati, i quali soltanto dal lavoro han tratto e traggono la loro fortuna, e
che impiegano più di un milione per un concetto artistico, per adorazione
dell’arte, per la incarnazione del bello in una sublime espressione estetica»,
commenta il giornalista.
Già autore di uno
dei primi piani regolatori della città, Messeni, prendendo spunto dai più grandi
teatri europei, progetta una sala grandiosa da circa 2000 posti che comprende
platea, palchi, galleria e loggione, realizzando così uno spazio continuo
dall’acustica perfetta. A Raffaele Armenise, un pittore barese della scuola
napoletana di Domenico Morelli, viene affidata l’esecuzione del telone della
scenografia che riproduce la liberazione di Bari dai Saraceni, avvenuta per
opera dei Veneziani nel 1002, la cui riproduzione fotografica si può ammirare
oggi sul pannello che ricopre il cantiere di palazzo Starita su via Venezia.
Armenise affresca
magistralmente anche la volta, una superficie di oltre 500 metri. Quella sera la
rappresentazione de Gli Ugonotti di Giacomo Meyerbeer, interpretata dal tenore
Carlo Cartica e dai soprani Carmen Bonaplata e Tina De Spada, inaugura la prima
stagione del Petruzzelli. «La sala di una splendidezza d’incanto. Innumerevoli
le signore di eleganza squisita. Non un palco, non una poltrona, non una sedia,
non un posto di loggione vuoto».
Di tutt’altro
tenore, invece, la notizia che compare il 19 febbraio 1992 a pagina 8 de «La
Gazzetta del Mezzogiorno»: «L’ingegner Mario Chiesa, 48 anni, socialista, da sei
presidente del Pio albergo Trivulzio, noto ai milanesi come la “Baggina” e del
non meno noto istituto per orfanelli “Martinitt”, arrestato lunedì sera dai
carabinieri nel suo ufficio, aveva intascato una tangente di 10 milioni. “Lo
abbiamo preso con le mani nella marmellata”, ha dichiarato ieri il procuratore
della Repubblica Saverio Borrelli nel corso di un incontro coi giornalisti».
Trentuno anni fa si compiva il primo atto dell’inchiesta che passerà alla storia
con il nome di «Mani pulite»: quello che in quei primi giorni viene raccontato
come un isolato caso di corruzione si trasforma ben presto in una valanga che
travolgerà non solo il Partito socialista, ma l’intero sistema partitico
italiano.
“Il centro non
esiste più. L’Italia giustizialista è più corrotta di prima”.
Edoardo Sirignano su
l’Identità il 21 Febbraio 2023
“Il giustizialismo
ha fallito. Italia più corrotta di prima”. È quanto sostiene Stefano Andreotti,
figlio dello statista Giulio.
Sono passati diversi
anni dalla scomparsa di suo padre. Il ricordo è ancora vivo?
È certamente tra le
figure che vengono ricordate più spesso.
C’è un partito che
richiama più alla sua Dc?
La politica, ai
tempi di mio padre, era diversa. Siamo in un altro periodo storico e le cose
sono cambiate. Andreotti ha sempre fatto parte della Dc e oggi questo partito
non c’è in nessuna delle formazioni in campo. Sono tutti movimenti o partiti
molto diversi, sia come organizzazione che per le persone che ne fanno parte.
Spesso si condanna
a prescindere la Prima Repubblica. È giusto?
Ha subito una vera e
propria demonizzazione. Con l’andare avanti, però, ci si si è resi conto dei
tanti lati positivi che ha avuto. Per un giudizio più sereno e pacato, dobbiamo
ancora attendere. Quando la cronaca lascerà il passo alla storia, cominceremo a
capire i tanti pregi che hanno avuto i suoi esponenti.
Più di qualcuno
sostiene che Meloni, dal momento in cui ha abbandonato i panni della sovranista,
tanto somiglia ai grandi leader dello scudocrociato. Può essere l’erede dei
dorotei?
Non farei paragoni.
Detto ciò, vedo la Meloni una moderata. Basta osservare come si sta comportando
da quando è premier. Tra i suoi pregi ci sono i toni sempre pacati, modi di
comportarsi diversi da quelli che aveva qualche anno fa. Vedo bene chi cerca di
migliorarsi.
In un momento di
crisi, le persone forse hanno più paura degli estremismi?
L’elettorato
italiano è da sempre moderato. A parte i momenti, la gente vuole una certa
serenità, tranquillità, che forse ci auguriamo tutti.
Esiste ancora la
possibilità di un grande centro?
Il mondo della
politica ci ha fatto assistere a diversi fenomeni, che nascono all’improvviso e
poi con la stessa rapidità si ridimensionano. Quando si vanno a creare due poli
contrapposti, lo spazio non c’è per il centro, soprattutto se il sistema
elettorale è quello vigente. Detto ciò, ovunque, sento l’esigenza di tornare a
certi valori, ideali.
Cosa ne pensa del
dibattito sulla giustizia. Sarebbe opportuna una riforma più garantista?
Sono pienamente
d’accordo. Uno dei grandi guai d’Italia è quella magistratura che ha seguito la
linea chiamata giustizialista. Una riforma vera è indispensabile per la certezza
e rapidità del diritto. Solo per i tempi che occorrono per arrivare a sentenza,
possiamo parlare di sistema di giudizio deprimente.
È stata, intanto,
distrutta un’intera classe dirigente, che tra l’altro è stata artefice di atti
gravi, ma forse meno rispetto a quelli commessi dai protagonisti di Qatargate…
Quanto avvenuto, ai
tempi di Tangentopoli, è particolare. A distanza di decenni, si comincia a
capire la differenza tra finanziamento illecito e corruzione. Bisogna separare
ciò che viene fatto per far andare avanti i partiti, indubbiamente con degli
eccessi, come quelli verificatisi allora, con la gente che si mette il denaro in
tasca. Considerando gli scandali che leggo sui giornali, mi sembra diventato
comune l’arricchimento personale.
Si parla del
ritorno degli anarchici. Sono davvero un pericolo?
Sono sempre stati
presenti nella vita del Paese. Mi auguro che non arriviamo a quello che erano
negli anni terribili. Il terrorismo, allora, aveva un substrato diffuso. Non
tutti lo condannavano in modo netto. Ora è un fenomeno molto più circoscritto,
ma comunque da tenere sotto controllo.
La sinistra di un
tempo, pur essendo all’opposizione, riusciva a distinguersi per idee. Cosa ne
pensa del Pd?
La storia della
Prima Repubblica è stata di un governo che ha visto sempre dentro la Dc, la
quale però condivideva le grandi decisioni con l’opposizione. Le cose, allo
stato, sono cambiate. La politica viene fatta più con le urla, con le accuse
all’altro e non con le proposte. La sinistra italiana da diversi anni è in crisi
per questa ragione.
Si ricorda di un
particolare interlocutore di suo padre nel campo progressista…
Pajetta, pur essendo
uno dei grandi esponenti del Pci, aveva con mio padre un grandissimo rapporto.
Non andavano in vacanza insieme, ma si frequentavano. Stesso discorso vale per
il presidente Pertini, con cui c’era amicizia. Anche con lo stesso Berlinguer,
molto più chiuso come carattere, c’era un rapporto di stima, soprattutto ai
tempi del compromesso storico. Era un modo di contrapporsi agli avversari
diverso da quello attuale. Non c’era una lotta assoluta, ma una considerazione
dell’altro, che travalicava gli schieramenti di appartenenza.
Finito al centro
delle cronache l’arresto dell’ultimo grande boss stragista. Spesso il nome di
Andreotti è stato collegato alla malavita siciliana?
Mio padre,
purtroppo, ci è finito dentro. Si tratta di un discorso molto lungo da fare.
Troppo spesso viene data un’interpretazione distorta di come si sono svolte
realmente le cose. Da cittadino, sono felice che sia finita la latitanza per
Matteo Messina Denaro.
La mafia, però,
ancora non è finita. Stesso discorso vale per i rapporti con la politica, che
non riguardano solo una parte…
Per chi vive in
Sicilia c’è molta difficoltà a non aver rapporti con certi mondi. Detto ciò, in
molto casi, sono stati anche inventati. Se si conosce bene la storia di mio
padre, si potrebbe arrivare alla conclusione che con Cosa Nostra non solo non ha
avuto niente a che vedere, ma che è stato anche il politico che quando era al
governo ha preso i provvedimenti più forti contro di essa. Ciò, purtroppo, non
viene mai ricordato.
Cosa ne pensa,
infine, dell’Autonomia voluta dalla Lega di cui tanto si discute?
Ha pregi e difetti,
vantaggi e svantaggi. Se terrà conto del divario, se avrà come priorità una
migliore organizzazione, nonché una crescita del Mezzogiorno, ben venga. Se
favorisce, invece, un Nord, che è già avanti, non ritengo sia un buon progetto.
Dare una maggiore autonomia alle Regioni, comunque, non mi pare qualcosa di
negativo, anzi può creare sviluppo.
“I partiti hanno
degenerato e questa è l’origine dei malanni d’Italia”. Cos’è la Questione
Morale: da Berlinguer al Qatargate, il significato dell’espressione in politica.
Redazione su Il Riformista il 23 Dicembre 2022
Enrico Berlinguer ci
parla ancora. Con tutte le sfumature e le cautele del caso. Berlinguer e non
solo lui, a dirla tutta. Da quando è esploso il caso del Qatargate si è tornato
a parlare di “Questione Morale”, un’espressione che ha indicato, dalla sua
affermazione nel dibattito negli anni Settanta, la necessità che i partiti
tornassero a principi di onestà e correttezza nella gestione delle istituzioni,
dei poteri dello Stato e del denaro pubblico. Il segretario del Partito
Comunista Berlinguer ne parlò in questi termini in una direzione straordinaria
di partito: “La ‘questione morale’ è divenuta oggi la questione nazionale più
importante”. E sul tema ritornò in un’intervista rilasciata ad Eugenio Scalfari
per La Repubblica. Come spiegò anni dopo in un editoriale su L’Espresso lo
stesso Scalfari, Berlinguer con quell’espressione si riferiva a “l’occupazione
delle istituzioni da parte dei partiti”. Il segretario comunista disse che era
“necessario difendere le istituzioni dalla partitocrazia che le ha invase”.
La “Questione
Morale” entrò nel dibattito politico il 27 novembre del 1980, a pochi giorni
dal terremoto che colpì l’Irpinia, in una riunione straordinaria del Partito
Comunista Italiano a Salerno. Il segretario Berlinguer tenne un discorso
diventato emblematico e chiuse definitivamente la stagione del compromesso
storico con la Democrazia Cristiana. L’espressione era stata già utilizzata da
Giuseppe Mazzini in uno scritto del 1886 e da Pietro Ingrao in un intervento sul
quotidiano sul caso di Wilma Montesi, la ragazza 21enne trovata in spiaggia
a Torvajanica nel 1953.
Berlinguer riadattò
quell’espressione in un’Italia profondamente cambiata. Gli Anni di Piombo, la
lottizzazione del potere, il Manuale Cencelli, lo “scandalo Lockheed”, il
sequestro e l’omicidio di Aldo Moro. Alle elezioni politiche del giugno 1976 il
Pci aveva ottenuto il suo massimo storico, 34,4%, che comunque non bastò a
superare la Dc, al 38,7%. Gli accordi portarono a un governo monocolore, della
Dc, e a Pietro Ingrao Presidente della Camera. La crisi di governo esplosa tra
fine 1977 e inizio 1978 portò a un quarto esecutivo Andreotti, con il voto
favorevole dei comunisti tramite “appoggio esterno”.
Berlinguer ruppe
quel patto dopo il terremoto che colpì l’Irpinia il 23 novembre del 1980. A
Salerno, in quella riunione straordinaria, il segretario nel suo discorso parlò
delle “risposte deludenti e negative del governo di fronte alla catena di
scandali, di deviazioni negli apparati dello Stato e di intrighi di potere” che
“chiama in causa non semplicemente le responsabilità di uno o più ministri, o
dell’attuale governo, ma un sistema di potere, una concezione e un metodo di
governo che hanno generato di continuo inefficienze e confusioni nel
funzionamento degli organi dello Stato, corruttele e scandali nella vita dei
partiti governativi, omertà e impunità per i responsabili. La questione morale è
divenuta oggi la questione nazionale più importante”.
Qualche giorno dopo
Berlinguer rilasciava un’intervista ad Alfredo Reichlin per L’Unità, in cui
descriveva il cambio di passo dal compromesso storico. “Mi fanno un po’
sorridere tutti questi becchini del ‘compromesso storico’. Perché sarebbe
fallito? È fallita la caricatura che ne hanno fatto presentandolo come una pura
formula di governo: peggio, come un accordo di potere tra noi e la DC. L’abbiamo
detto cento volte che non era questo, bensì la ricerca di una convergenza tra le
componenti diverse della storia italiana, della società nazionale, anche,
quindi, tra classi diverse, tale da rendere possibile una profonda
trasformazione democratica (un secondo 1945, si è detto) nel rispetto del
pluralismo e della Costituzione repubblicana”. Il segretario comunista nella
stessa (da enricoberlinguer.it) avvertiva, in merito al sisma in Irpinia, che
“il problema più grave non sarà il reperimento delle risorse da destinare al
Sud, ma il loro impiego: a quale fine, attraverso quali strumenti, con quali
garanzie che non si ripeterà un Belice moltiplicato per cento, con quali forme
di partecipazione popolare e di controllo democratico? E con quali mezzi di
prevenzione e di repressione dell’assalto clientelare e mafioso alla greppia
degli stanziamenti pubblici?”.
Qualche mese dopo,
il 28 luglio del 1981, Berlinguer rilasciava una lunga intervista, entrata nella
storia, a Eugenio Scalfari in cui esordiva senza mezzi termini: “I partiti hanno
degenerato e questa è l’origine dei malanni d’Italia”. Alla degenerazione dei
partiti – “hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni, a partire dal
governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le
aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai
TV, alcuni grandi giornali” – il segretario comunista riconduceva le radici
della crisi italiana. “Per noi comunisti la passione non è finita. Ma per gli
altri? Non voglio dar giudizi e mettere il piede in casa altrui, ma i fatti ci
sono e sono sotto gli occhi di tutti. I partiti di oggi sono soprattutto
macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e
dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi,
sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più
contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le
esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il
bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai conformata su
questo modello, e non sono più organizzatori del popolo, formazioni che ne
promuovono la maturazione civile e l’iniziativa: sono piuttosto federazioni di
correnti, di camarille, ciascuna con un ‘boss’ e dei ‘sotto-boss’. La carta
geopolitica dei partiti è fatta di nomi e di luoghi. Per la DC: Bisaglia in
Veneto, Gava in Campania, Lattanzio in Puglia, Andreotti nel Lazio, De Mita ad
Avellino, Gaspari in Abruzzo, Forlani nelle Marche e così via. Ma per i
socialisti, più o meno, è lo stesso e per i socialdemocratici peggio ancora …”.
Un
passaggio sull’atteggiamento dei cittadini in merito: “Molti italiani, secondo
me, si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle
sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è
sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi (magari dovuti, ma ottenuti solo
attraverso i canali dei partiti e delle loro correnti) o sperano di riceverne, o
temono di non riceverne più. Vuole una conferma di quanto dico? Confronti il
voto che gli italiani hanno dato in occasione dei referendum e quello delle
normali elezioni politiche e amministrative. Il voto ai referendum non comporta
favori, non coinvolge rapporti clientelari, non mette in gioco e non mobilita
candidati e interessi privati o di un gruppo o di parte. È un voto assolutamente
libero da questo genere di condizionamenti. Ebbene, sia nel ’74 per il divorzio,
sia, ancor di più, nell’81 per l’aborto, gli italiani hanno fornito l’immagine
di un paese liberissimo e moderno, hanno dato un voto di progresso. Al nord come
al sud, nelle città come nelle campagne, nei quartieri borghesi come in quelli
operai e proletari. Nelle elezioni politiche e amministrative il quadro cambia,
anche a distanza di poche settimane”.
Berlinguer fu
criticato, accusato per aver messo in alcuni passaggi il Pci al di sopra degli
altri partiti da un punto di vista morale. “La questione morale, nell’Italia
d’oggi, fa tutt’uno con l’occupazione dello stato da parte dei partiti
governativi e delle loro correnti, fa tutt’uno con la guerra per bande, fa
tutt’uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro,
che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la
questione morale è il centro del problema italiano. Ecco perché gli altri
partiti possono provare d’essere forze di serio rinnovamento soltanto se
aggrediscono in pieno la questione morale andando alle sue cause politiche”. Le
posizioni di Berlinguer raccolsero ostilità tuttavia anche all’interno dello
stesso partito. E da esponenti autorevoli come Giorgio Napolitano e Alessandro
Natta. Il segretario comunista ribadì i suoi concetti fino all’ultimo, fino
all’ultima sua intervista televisiva rilasciata poche ore prima il malore che lo
colpì mortalmente durante il comizio di Padova del 7 giugno 1984.
Le 10 conseguenze
della corruzione.
Gian Antonio Stella
su Il Corriere della Sera il 13 Dicembre 2022
La percezione di
vivere in un Paese corrotto, tra gli italiani, cala e cresce, ma neppure una
volta il nostro è riuscito a entrare tra i trenta Paesi più virtuosi
Ammesso che siano
stati i disinvolti nababbi quatarioti a svuotare barili di banconote nei sacchi
di juta di vari italiani, italo-belgi per emigrazione e italo-greche per amore
tutti nel giro dell’Europarlamento, chi mai avrà messo in testa ai corruttori
che i nostri connazionali potevano essere più aperti rispetto ai danesi o ai
finlandesi nei confronti degli aspiranti distributori di mazzette? C’è poco da
buttarla sull’ironia: chi odia gli stereotipi razzisti contro gli italiani (la
pistola sul piatto di spaghetti di una rivista tedesca, la prima pagina
del Süddeutsche Zeitung con un vecchio e malconcio stivale da donna intitolata
«Stivale puzzolente», le malignità sul comandante Schettino additato a simbolo
della superficialità di tutti noi?) vive con fastidio intollerabile il
coinvolgimento di tanti politici e para-politici e lobbisti nostrani in queste
oscene vicende di tangenti. E si chiede fino a che punto tanti connazionali non
abbiano contribuito a far crescere questo osceno stereotipo dando sempre minore
importanza alla corruzione al punto di scandalizzare Papa Francesco che pochi
anni fa attaccò frontalmente il corruttore: «Dio ci ha comandato di portare il
pane a casa col nostro lavoro onesto! Ma quest’uomo, amministratore, come lo
portava? Dava da mangiare ai suoi figli pane sporco! E i suoi figli forse
educati in collegi costosi, forse cresciuti in ambienti colti hanno ricevuto dal
loro papà, come pasto, sporcizia, perché il loro papà, portando pane sporco a
casa, aveva perso la dignità!».
La classifica di
Transparency dal 1995 a oggi, del resto, dice tutto: la percezione di vivere in
un Paese corrotto, tra gli italiani, cala e cresce, cala e cresce ma neppure una
volta il nostro è riuscito a entrare nella trentina dei Paesi più
virtuosi. Neppure una. Con danni pesanti per tutti i cittadini perché, come
scrive ne L’Atlante della corruzione Alberto Vannucci, «La corruzione 1)
demolisce la fiducia dei cittadini e la coesione sociale, 2) lede il principio
di uguaglianza, 3) distrugge la giustizia sociale, 4) contraddice il principio
di trasparenza e non crea allarme sociale, 5) mina la decisione pubblica e
orienta i procedimenti legislativi, 6) distorce la competizione
politico-elettorale, 7) espone il politico al ricatto, 8) favorisce
l’incompetenza a scapito del merito, 9) rafforza le mafie, 10) uccide». Ce la
meritiamo, la pioggia di battutine insultanti di questi giorni? Mah... Certo non
basta indignarsi contro chi ridacchia ...
Qatargate. Se
l'incompetenza fa danni peggiori.
La corruzione a
Bruxelles fa scalpore, ma l'incompetenza e l'autoreferenzialità ideologica fanno
molti più danni. Pier Luigi del Viscovo il 15 Dicembre 2022 su Il Giornale.
La corruzione a
Bruxelles fa scalpore, ma l'incompetenza e l'autoreferenzialità ideologica fanno
molti più danni. Certo, il malaffare non l'avevamo messo in conto. Per noi
italiani, cresciuti con tangentopoli e calciopoli, è strano vedere implicati nel
Qatargate i vertici di quelle istituzioni da cui spesso veniamo bacchettati.
Sarà che ci portiamo dietro quel complesso di essere noi i furbi, anzi
furbastri, che cercano le scorciatoie, mentre non è che siamo i soli a cercarle,
quanto magari i più svegli a trovarle. Sarà anche che per decenni la politica
italiana ha pompato l'autorità economica e morale di Bruxelles, per usarla come
scusa per imporre qualche freno alla spesa, non avendo la forza di dire che meno
debito è nel nostro interesse. Fatto sta che non ce l'aspettavamo. Invece
avremmo dovuto ipotizzare che la competenza, seppur concorrente con gli Stati
Membri, in settori importanti, dall'agricoltura alla pesca, dai trasporti
all'energia, potesse dar luogo a fenomeni corruttivi.
Nella transizione
energetica, ad esempio, l'Europa sta imponendo all'economia, all'industria e
alla società dei limiti e dei costi assolutamente sproporzionati, alla luce
della non autosufficienza nelle materie prime e nell'energia, del ritardo
dell'industria nelle tecnologie avanzate e, in ultimo, del peso irrisorio delle
emissioni europee sui cambiamenti climatici. Forse adesso sarà più agevole per
tutti fare la domanda fatidica: cui prodest? Certe decisioni, nell'interesse di
chi?
Tuttavia, è anche
possibile che tante decisioni incomprensibili non siano frutto di interessi
vergognosi di pochi, quanto di incompetenza e inefficienza di tanti. Ideologie
scollegate dai fatti e calate in un enorme apparato burocratico, entro cui si
muovono figure professionali non sempre all'altezza, ma sempre inebriate da
autoreferenzialità, tipica dei contesti dove stanno insieme il potere e la
distanza dalle cose reali. Noi italiani abbiamo sempre sottovalutato il potere
che sta a Bruxelles, cercando anzi di tenerlo fuori dai confini il più
possibile. Per questo, abbiamo spedito in quelle posizioni coloro di cui la
politica domestica proprio non sapeva che farne, illudendoci di essere i soli a
comportarci così. Sbagliato. Avendo l'occasione di lavorare con gli organismi
comunitari, si scopre che anche dagli altri Paesi non arrivano dei fenomeni,
anzi. Inoltre, col sistema uno-vale-uno, capita che in una riunione la decisione
penda da una parte grazie al parere del maltese che, con tutto il rispetto, vale
quanto quello del tedesco.
Sì, la corruzione,
in Italia come ovunque, fa notizia e fa arrabbiare. Ma proprio noi dovremmo
sapere che al funzionamento del sistema fa più male l'incompetenza e l'arroganza
del potere, e pure che c'è un filo rosso che tiene tutto insieme. Quando interi
apparati possono operare senza il riscontro di un risultato apprezzabile da
parte dei cittadini, allora diventa anche più facile dare ascolto alle sirene
che girano con i trolley pieni di soldi.
Fara: «Col
Qatargate trionfa il racconto fasullo dell’Italia corrotta…»
Intervista al
presidente Eurispes: «Sui media europei il caso è definito italian job. Colpa
nostra...». Errico Novi su Il Dubbio il 15 dicembre 2022.
«Sa qual è il
paradosso? Che persino i giornali italiani hanno concentrato l’attenzione sui
connotati italianistici, per così dire, del Qatargate. Ci facciamo del male da
soli, come se non bastasse la distorsione in corso nel resto d’Europa».
Perché alla fine,
presidente Fara, negli altri Paesi dell’Ue se la cavano così? Liquidano le
presunte eurotangenti come una macchia lasciata dalla solita Italia
sporcacciona?
«Perché, lei aveva
dei dubbi?».Ieri, su queste pagine, abbiamo ricordato l’analisi che Gian Maria
Fara, presidente dell’Eurispes, propone da anni, col suo lucido disincanto, a
proposito della corruzione e soprattutto delle terrificanti posizioni che il
Belpaese occupa in tutte le graduatorie internazionali sul fenomeno: a
complicare la faccenda, è la tesi del sociologo, è lo scarto fra realtà e
obiettività. Nello specifico, fra corruzione percepita e reale. «Che in Italia»,
ripete ancora una volta il fondatore dell’Eurispes, «ci sia una percezione
ingigantita della corruzione è evidente, ed è spiegabile. Il paradosso è che ora
la nostra distorsione percettiva ci ritorna come un boomerang attraverso i media
degli altri Paesi europei».
Ma quindi lei dice
che in realtà, tra le opinioni pubbliche del Vecchio Continente, non ci sarà
alcun particolare crollo di fiducia nei confronti delle istituzioni comunitarie?
Ma intanto mi viene
da pensare che il caso delle presunte eurotangenti potrebbe confermare una
semplicissima verità: diversamente da quanto noi italiani pensiamo, non sono le
istituzioni ma gli uomini a essere inaffidabili. E poi, per parafrasare
Shakespeare, potremmo dire che c’è del marcio persino a Strasburgo e a
Bruxelles, così come nella Danimarca dell’Amleto. Ma al di là delle battute, la
diversa percezione che abbiamo del malaffare nel nostro Paese rispetto al resto
d’Europa influisce tantissimo sulla reazione che il cosiddetto Qatargate potrà
suscitare, e in realtà già suscita, da noi e in altri Paesi.
Anche stavolta noi
ingigantiremo e gli altri vedranno viceversa assai meno di quello che esiste?
Allora, partiamo
dalla condizione oggettiva dell’Italia comparata al resto del continente. Noi
abbiamo vissuto Mani pulite, un trauma che trent’anni non sono riusciti a
sanare. Si è affermata, da lì, l’idea di un sistema deviato, in cui è tutto
marcio, da condannare. Tutto quanto è politica è cattivo, e non funziona. Nel
nostro immaginario collettivo quel paradigma è insuperabile. Altrove, non hanno
certo avuto una Mani pulite come la nostra. E anzi hanno coltivato la
compiaciuta convinzione di vivere, se non proprio nel migliore dei mondi
possibili, certamente in un mondo migliore della corrotta Italia.
Insomma, ci siamo
procurati da soli questo tremendo stigma.
Be’, da soli… ce lo
siamo procurati anche per virtù specifiche del nostro sistema giudiziario.
Ricordiamoci come il fattore decisivo, rispetto all’idea che un certo Paese è
corrotto, sia essenzialmente uno: la trasparenza. È un meccanismo che riguarda
qualsiasi fenomeno sociale: esiste in base a come lo racconti, lo denunci.
Prendiamo la Francia: ecco, i cittadini francesi ritengono di vivere nel
migliore dei mondi possibili perché da loro non esiste un giornalismo
giudiziario ficcante come il nostro, né una magistratura autonoma, indipendente
e dunque efficace come la nostra. Più indagini vengono aperte, più i media ne
parlano, più corruzione si crea, quanto meno dal punto di vista della
rappresentazione sociale.
Chiarissimo. Ma
quindi lei dice che all’estero c’è un atteggiamento in fondo più sereno, sul
Qatargate, rispetto alla reazione verificatasi da noi?
In generale non
credo che l’aggettivo “sereno” sia il più adatto a descrivere l’atteggiamento
che, nella maggior parte dei Paesi europei, è diffuso rispetto alla corruzione.
Casomai c’è una differenza, come detto, di disponibilità dell’informazione e,
sul piano strettamente giudiziario, anche di esercizio dell’azione penale, che
da noi è obbligatorio ma che funziona diversamente altrove. Poi è chiaro che in
tutte le opinioni pubbliche europee ci sarà un innalzamento dell’attenzione nei
confronti delle istituzioni comunitarie, ma da quanto si legge sui media
stranieri, si parla essenzialmente di corruzione all’italiana.
L’italian job.
Esatto. Siamo noi,
brutti, sporchi e cattivi, ad aver infettato, con i nostri soliti e corrotti
metodi, persino la linda e pinta Europa. Non mi pare di intravedere un tracollo
di credibilità, all’estero, per le istituzioni dell’Ue. Hanno trovato il modo di
scaricare il problema addosso a noi.
Siamo il capro
espiatorio persino del Qatargate.
Siete arrivati e
siete stati capaci di contagiare la pulita e tranquilla Europa, persino il
Parlamento di Stasburgo, la più democratica delle istituzioni europee.
Davvero si risolverà
tutto così?
Ci sono due
possibilità, legate al racconto dei media: se prevarrà l’interpretazione secondo
cui sì, potrebbe anche essere esistito, come sostengono i giudici titolari
dell’inchiesta, un giro di corruzione sull’asse Doha-Strasburgo, ma non si
tratta di un dato che segna l’intera dimensione eurocomunitaria, allora saremo
su un piano probabilmente di realtà e ci sarà pure maggiore equilibrio rispetto
alla connotazione italiana della vicenda. Ma considero più probabile che si
affermi quell’altra semplicistica interpretazione: l’Italia ha corrotto
l’Europa.
Ma in tutto questo
le statistiche sulla corruzione continuano a essere basate sulle interviste ai
cittadini?
E altrimenti come
potrebbe spiegarsi il fatto che in queste classifiche l’Italia viaggia a
braccetto col Botswana? Nell’analisi di un fenomeno come la corruzione sarebbe
ora di passare dalla percezione alla rilevazione oggettiva. In incontri
organizzati con l’Anac ne abbiamo parlato anche ai vertici di Transparency:
ancora una volta le vostre statistiche relative alla presenza della corruzione
si sono basate su alcune migliaia di interviste ai cittadini, ma gli indicatori
oggettivi dove sono?
E che vi hanno
risposto?
Non sanno cosa
rispondere, sono in difficoltà: provano a dare il contentino, pensi un po’, per
cui l’Italia nel 2021 è riuscita a scalare dalla 52esima alla 42esima posizione…
ma possiamo mai essere paragonati a Paesi del Centrafrica? È attendibile una
fotografia del genere?
In realtà noi siamo
più attivi nelle azioni di contrasto, giusto?
Oltre ad avere una
magistratura libera di indagare su tutto, disponiamo anche di forze di polizia
efficientissime, dotate di sistemi di verifica che in altri Paesi neppure
immaginano.
La coincidenza
temporale con la fase clou dei Mondiali ha amplificato il Qatargate?
Le faccio io una
domanda: l’assegnazione dei Mondiali al Qatar è un fatto singolare o quel Paese
presentava tutti i requisiti per ottenere l’assegnazione?
Be’, sembra che le
istituzioni calcistiche mondiali si siano fatte pesantemente condizionare dal
potere finanziario dello sceicco.
Ecco: e mi scusi, ma
le risulta che le organizzazioni calcistiche internazionali siano tutte
italiane? Non è così, ovviamente.
Paghiamo la nostra
solerzia nel contrastare la corruzione.
E la mafia, che i
tedeschi hanno scoperto improvvisamente con la strage di Dusseldorf: la verità è
che le organizzazioni criminali seguono la pista dei soldi. Da noi è impossibile
che non siano tracciate, visti i nostri pm e la nostra polizia. Ah, un’ultima
diversità del sistema italiano: in Francia per esempio, il ministro dell’Interno
ha il comando diretto delle forze di polizia, in Italia rispondono invece a una
magistratura assolutamente autonoma e libera. Ecco, una cosa del genere credete
che conti zero, in quella capacità di rendere visibile la corruzione che da noi
è tanto più sviluppata che altrove?…
Mondiali e
mazzette, mix terribile che amplifica la “corruzione percepita”.
Da anni L’Italia
paga l’attivismo dei pm col primato negativo nelle classifiche del malaffare.
Ora, per l’Ue, la suggestione si lega alla coppa di DOHA. Errico Novi su Il
Dubbio il 14 dicembre 2022.
Prendete i Mondiali
di calcio, evento mediatico per eccellenza. Ai Mondiali associate un’inchiesta
deflagrante sulla presunta corruzione a cui si sarebbero abbandonati soggetti a
vario titolo riconducibili all’Europarlamento. Metteteci pure che il mix si
produce contestualmente alla fase decisiva dei campionati in Qatar, semifinali e
finali. La tempesta è perfetta. Nel suo potenziale distruttivo, ovviamente.
Alcuni anni fa il
Dubbio ospitò le considerazioni di Gian Maria Fara presidente dell’Eurispes,
istituto di ricerca particolarmente attento al tema della giustizia, tra gli
altri. Ebbene, Fara spiegò con lucida precisione il fenomeno della “corruzione
percepita”. In Italia, disse, abbiamo un record negativo, rispetto ai partner
europei, nelle graduatorie sulla corruzione, ma pochi sanno che le statistiche
di questo tipo, diffuse regolarmente dalle organizzazioni internazionali, si
basano non sulle risultanze processuali, ma appunto sulla percezione dei
cittadini, e cioè su semplici interviste. Interpellati, gli italiani denunciano
una pervasività del malaffare, nel loro Paese, assai superiore al feedback che
arriva da francesi, tedeschi e britannici.
Ma a sua volta la
percezione è enormemente influenzata, spiegò ancora il presidente dell’Eurispes,
dall’intensa attività investigativa e processuale che la magistratura italiana
assicura nel contrasto della corruzione. Paradossalmente, il fatto che le nostre
Procure siano così vigili sul malaffare – al punto da inseguire, cosa
impensabile in Paesi come la Francia ad esempio, persino ipotesi di corruzione
consumata dai grandi stakeholders dell’energia in favore di Paesi in via di
sviluppo, vedi il caso Eni – ecco, questo fatto alimenta fra i cittadini
italiani l’impressione di essere immersi in una selva di furfanti perennemente
impegnati a concutere, estorcere, corrompere, deviare le risorse
pubbliche.Paradossale, sì. Ma pure inevitabile, dopo trent’anni di
sovraesposizione dei pm, a partire da Mani pulite.
Ora, l’uragano che
ha improvvisamente travolto Strasburgo, Bruxelles e in generale la credibilità e
l’immagine delle istituzioni comunitarie ha in apparenza poco a che vedere con
l’estenuante stillicidio di cronache giudiziarie che ha investito l’Italia negli
ultimi trenta lunghi anni. Eppure un nesso c’è, e riguarda appunto quella parola
fatale: percezione. Dove finisce la realtà dei fatti, nella loro dimensione
effettiva, e dove inizia invece l’immagine ingigantita e deformata che se ne
diffonde nell’opinione pubblica? Se c’è un allarme da lanciare a proposito
dell’Europa, della sua forza di “tempio” dei diritti, improvvisamente degradata
a presunto “mercato” di tangenti, è proprio in questa percezione che può
diffondersi, e che da tre giorni anzi già si diffonde tra i cittadini
dell’Unione.
Anche se si tratta
di una vicenda che coinvolge pochissimi esponenti politici e alcuni loro
assistenti, e anche se le responsabilità sono tutte ben lontane dall’essere
accertate nell’unica sede possibile, ossia il processo, il mix mediatico evocato
all’inizio fra Mondiali e presunte mazzette qatariote già altera abbondantemente
quel feedback restituito dai cittadini. Lo ingigantisce, lo esaspera. Anche se
non sappiamo ancora con certezza se la presunta rete organizzatasi, secondo il
giudice belga Michel Claise, attorno all’ex eurodeputato italiano Antonio
Panzeri può davvero essere paragonata a un enclave di corrotti incistatasi negli
organismi dell’Ue, e anche se non vi è alcuna prova, alcun nesso evidente, fra i
giudizi indulgenti con Doha espressi da qualche parlamentare europeo, italiano e
non, e il teorizzato giro di sacchi di banconote, l’opinione pubblica
continentale già tira le somme, già chiude il bilancio: da anni si parla di
corruzione da parte della monarchia qatariota in direzione dei vertici del
calcio mondiale, che avrebbero assicurato l’assegnazione a Doha dei campionati
prossimi alla loro conclusione; bene, pensano i cittadini a cui presto si andrà
a chiedere quanta corruzione “percepiscono” in seno all’Unione, abbiamo allora
la prova che l’Europa, intesa come istituzioni comunitarie, è il più corrotto
dei consorzi, il meno credibile degli avamposti di democrazia e civiltà, il più
ingannevole dei miti del progresso globale.
E quanto credete
risulterà difficile approfittarne, di fronte a uno scenario simile, a governi e
partiti populisti/euroscettici come quello di Orban, rilanciare questa
“percezione” e trasformarla in attacco distruttivo? È presto per misurare fino
in fondo i danni di una vicenda che, a prescindere dall’effettiva consistenza
della corruzione, risente, non ci stanchiamo di dirlo, anche di un effetto
mediatico “booster” che solo i Mondiali di calcio potevano assicurare. Ma in
attesa di raccogliere i cocci lasciati dalla deflagrazione, timidamente osiamo
rivolgere un auspicio, e cioè che per il futuro si faccia quanto meno un ricorso
più prudente alle interviste come misura della corruzione. E che ci si
riferisca, almeno da parte di autorevoli organizzazioni internazionali, a dati
quantitativi più chiari, più oggettivi, anche se più difficili da raccogliere. E
che insomma, la realtà cominci non solo in Italia ma ovunque a prevalere sulle
suggestioni.
·
La questione morale.
Estratto dell'articolo di Samuele Finetti
per corriere.it venerdì 28 luglio 2023.
Galeotti sono stati un paio di occhiali da sole di
una nota griffe. Che il parlamentare norvegese Bjørnar Moxnes, leader del
partito di sinistra Rodt da un decennio, si è infilato in valigia nel duty free
dell’aeroporto di Oslo dopo aver strappato l’etichetta col codice a barre. Il
tutto sotto gli occhi di una telecamera di sicurezza: presto fatto […]
Moxnes ha provato a giustificarsi con un
inverosimile «è stato un incidente». Poi ha dovuto ammettere la verità in un
post su Facebook: «Molte persone mi hanno chiesto come ho potuto fare una cosa
così stupida. Me lo sono chiesto molte volte nelle ultime settimane. Non ho una
spiegazione adeguata». Oltre alla faccia, Moxnes ha perso anche il posto: il 24
luglio ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico nel partito. […]
L’inglese e i video hard
Il parlamentare conservatore inglese Neil Parish
meriterebbe un posto sul podio delle scuse più assurde. Lo scorso anno, in
aprile, fu pizzicato mentre guardava un video hard sul telefonino nel bel mezzo
di una seduta della Camera dei Comuni. Prima lo giudicò «un momento di pazzia»,
poi s’inventò di essere finito su quella pagina mentre stava cercando
informazioni sui trattori su Google. Alla fine cedette e ammise che
l’agricoltura non c’entrava nulla e che aveva davvero cercato quel video. E
addio al seggio a Westminster.
Francesi, jet e sigari
Spendere 116mila euro per affittare un jet privato
che ti porti in un Paese appena devastato da un terremoto? Ad Alain Joyandet,
allora ministro della Cooperazione francese, non sembrò una cattiva idea quando
fu invitato per una conferenza ad Haiti poche settimane dopo il catastrofico
sisma del gennaio 2010.
Joyandet (che oggi è senatore) fu costretto a
dimettersi, come anche il sottosegretario Christan Blanc, quando si scoprì che
aveva speso 12mila euro (pubblici) in sigari cubani. […]
L’antievasori con la società alle Seychelles
Fare i paladini della lotta all’evasione fiscale e
finire condannato per frode. Il destino è cinico e baro e l’ex ministro del
Bilancio francese Jérôme Cahuzac ne sa qualcosa. Dopo essersi fatto una
reputazione come uno dei più fermi critici di evasori e paradisi fiscali, nel
2012 finì nello scandalo quando si scoprì che aveva da venti anni un conto in
banca in Svizzera. Come se non fosse abbastanza, nel 2016 i Panama Papers
rivelarono che gli era pure intestata una società alle Seychelles. Dal governo
finì in cella, condannato a due anni per frode fiscale e riciclaggio.
Il candidato fedifrago
Abbiamo citato il caso di Neil Parish. Quello di
Benjamin Griveaux, stretto collaboratore di Emmanuel Macron nonché candidato di
La République En Marche alla carica di sindaco di Parigi nel 2020, appartiene
allo stesso filone.
Al voto Griveaux non è neppure arrivato. Ad
affossarlo sono stati i messaggi e le foto esplicite che aveva inviato a una
donna (un dettaglio: Griveaux era sposato e ha tre figli) e che nel febbraio di
quell’anno diventarono virali sul web dopo che il blogger russo Piotr Pavlenski
le aveva condivise. Nel 2021, Griveaux lasciò anche il seggio al parlamento e da
allora si è rifatto una carriera nel settore privato.
L’austriaco e la nipote dell’oligarca
Diede la colpa all’alcol Heinz-Christian Strache,
vicecancelliere austriaco al tempo dello scandalo poi passato alla storia come
«Ibiza-Gate». La questione era piuttosto seria: nel 2017, nel pieno della
campagna elettorale, Strache volò ad Ibiza per una vacanza.
Una sera incontrò una giovane donna russa che si
presentò come la nipote di un’oligarca e promise di investire in un quotidiano
per poi spostarlo su una linea vicina a quella di destra del partito del suo
interlocutore. Che, in cambio, le assicurò che l’avrebbe favorita
nell’assegnazione di appalti pubblici. Solo che la donna era in realtà una
giornalista, ma Strache non se ne accorse perché era annebbiato dai drink (così
sostenne poi).
Il caso saltò fuori nel 2019: Strache fu costretto
a dimettersi e a ritirarsi dalla politica, il cancelliere Sebastian Kurz a
sciogliere il governo e convocare elezioni anticipate.
L’ungherese e la festa gay
In questa lista di episodi assurdi, quello che ha
come protagonista József Szájer merita un posto d’onore. Europarlamentare,
membro di lunga data del partito ungherese Fidesz — guidato da Viktor Orbán —,
noto per le sue posizioni conservatrici specie sul tema Lgbtq, la sua carriera
finì per colpa di una festa piuttosto insolita. La sera del 27 novembre 2020, in
pieno lockdown, la polizia di Bruxelles trovò 25 uomini che si intrattenevano in
un incontro sessuale di gruppo.
Si scoprì che Szájer era fuggito calandosi da una
grondaia e quando fu fermato per strada gli agenti trovarono della droga nel suo
zaino. Orbán lo silurò in un nulla: «Inaccettabile e indifendibile».
La spagnola ladra «involontaria»
Fatale per Cristina Cifuentes fu una crema per il
viso da 40 euro. Nel 2018 l’allora presidente della Comunità di Madrid fu
costretta a lasciare il suo ruolo dopo la pubblicazione di un video del 2011 nel
quale era ripresa mentre rubava il prodotto cosmetico in un supermercato. «Un
errore involontario» sostenne lei, che poi pagò il dovuto. […]
Lo sloveno tradito da un panino
Di furto non si sono macchiati solo Cifuentes e
Moxnes, ma pure il parlamentare sloveno Darij Krajcic, reo di aver rubato un
panino nel 2019. In realtà, spiegò lui, stava conducendo un esperimento sociale:
seccato dal fatto che i commessi lo ignoravano, sentì l’impulso di testare in
prima persona quanto fosse efficace la sicurezza del supermercato. Il furto non
venne scoperto sul posto, ma i colleghi lo spinsero a dimettersi (e a pagare il
tramezzino trafugato).
[...]
Il maltese e il lobbista
Sessanta milioni di euro: tanto si era fatto
promettere da un’azienda svedese del tabacco un collaboratore di John Dalli,
allora (era il 2012) commissario europeo per la Salute, in cambio dell’impegno a
far abrogare una legge che vietava la vendita e l’uso dello snus, tabacco umido
in polvere che si consuma non fumandolo ma per via orale.
Dalli sostenne di essere stato costretto alle
dimissioni dal presidente della Commissione José Manuel Barroso e lo citò in
giudizio. Nel 2019, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto l’istanza e con
questa la richiesta di risarcimento danni. […]
Qatargate. E l'ex
Pci manda in soffitta la questione morale.
Pure D'Alema
archivia, in nome degli affari, la lezione di Berlinguer. Roberto Chiarini il 19
Dicembre 2022 su Il Giornale.
Vi immaginate
Antonio Gramsci o Palmiro Togliatti che lasciano la politica per consacrarsi
alla consulenza di società (capitalistiche) internazionali? Quella del
consulente è invece l'attività che Massimo D'Alema, comunista non pentito, si
vanta di aver intrapreso. Al giornalista che gli chiede se non convenga con lui
sulla dubbia compatibilità tra la sua originaria passione politica e l'odierna
attività di consulente di governi stranieri e di multinazionali risponde che non
va confusa l'attività di «consulente» con quella dell'«affarista». È
improponibile ogni accostamento tra le sue collaborazioni con società
internazionali con i traffici dell'ex compagno di partito Antonio Panzieri,
nella cui abitazione di Bruxelles sono stati trovati sacchi sospetti di
banconote.
È inoppugnabile - ci
mancherebbe - la distinzione tra le due attività sul piano della legalità e pure
su quello della moralità. La distinzione regge meno però (ma forse ci sbagliamo)
sul piano dell'opportunità. Non è comunque su questo punto che ci sembra
essenziale puntare l'attenzione, ma piuttosto su quanto questa mutazione di
destini professionali sia rivelatrice di un'altra mutazione in atto nella
sinistra italiana e europea. Vorrà pur dire qualcosa il fatto che il mestiere di
manager e di procacciatore d'affari stia diventando la vocazione principe di
molte figure di ex leader della sinistra - da Tony Blair a Gerhard Schroeder
fino a Massimo D'Alema: tutti ex primi ministri che a fine carriera abbracciano
l'attività di business man, pronti a concedere la loro consulenza anche a uomini
di stato che non vantano una coscienza democratica propriamente immacolata.
Contrapponendo
l'affarismo alla consulenza, come fa il già lider maximo della sinistra
italiana, ha voluto far intendere che è l'onestà ciò che fa la differenza. Con
ciò, salva inequivocabilmente la sua personale onorabilità. Non coglie però il
punto politico chiave della questione che sta alla base dell'impasse in cui s'è
incagliata la sinistra ex comunista dopo l'abbandono dell'originaria fede
anticapitalista. Politici e intellettuali di sinistra cercano di ridurre lo
scandalo delle mazzette all'europarlamento solo a un fatto (indubitabile) di
disonestà personale indicando la soluzione al richiamo della lezione di Enrico
Berlinguer sulla «questione morale» quando l'allora segretario del Pci
denunciava la degenerazione dei partiti ridotti a «macchine di potere» che
«hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni».
La sua era certo una
meritoria denuncia del malcostume politico ormai imperante. Era però anche un
atto d'accusa rivolto all'intero sistema dei partiti su cui si era retta la vita
pubblica nazionale dalla caduta del fascismo in poi contro cui veniva
contrapposto il popolo tradito.
Non s'è mai prestata
adeguata attenzione al fatto che con l'elevazione da parte del Pci della
«questione morale» a stella polare della sua futura azione politica il Pci
consumava il cambio di due suoi storici paradigmi culturali.
Il primo. Berlinguer
superava l'idea del primato della politica che lo aveva permeato il partito per
tutto il lungo dopoguerra conferendo al confronto politico un carattere
«gladiatorio sui valori» e alla politica una connotazione «alta». Accantonava
l'idea che sia la politica a determinare i grandi movimenti della storia, che
«la persona venga giudicata in base all'ideologia cui ispira le sue azioni, non
per la moralità o immoralità di quelle».
Il secondo paradigma
con cui il Pci rompeva era con la precedente valorizzazione del partito a
architrave di sostegno della democrazia. Ora individuava la lotta alla
partitocrazia quale essenza del suo conclamato nuovismo. Portava acqua con ciò
al mulino della tesi, allora popolare, di una società civile sana contrapposta a
una società politica malata, e con ciò disarmandosi nei confronti dell'ordine di
idee e di comportamenti propri della società capitalistica di cui «la
consulenza» finisce per essere la fisiologia e «l'affarismo» la patologia.
Per queste ragioni,
la perdita degli anticorpi dall'infezione affaristica che oggi la sinistra
lamenta non può limitarsi ad attribuirla al venir meno della tensione morale che
contraddistingue ormai la vita di tutti i partiti. Una responsabilità a monte va
ricercata nell'aver sostituito di fatto la questione morale alla questione
sociale come orizzonte strategico della sinistra.
La superiorità
morale del Pci, storia di un tragico equivoco.
Giovanni Vasso su
L’Identità il 15 Dicembre 2022
“I partiti di oggi
sono soprattutto macchina di potere e di clientela: scarsa o mistificata
conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali,
programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero”. No, non è un post
social di uno dei tanti populisti del web che si scagliano contro ciò che è
diventata la sinistra. No, questa frase, che oggi farebbe suonare le sirene
democratiche, è stata pronunciata da Enrico Berlinguer e raccolta da Eugenio
Scalfari in quell’intervista, ormai mitologica, sulla “questione morale” nella
politica italiana. Era il 28 luglio del 1981. “La loro stessa struttura
organizzativa si è ormai conformata su questo modello, non sono più
organizzatori del popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e
l’iniziativa: sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con
un boss e dei sotto-boss”. Forse sono parole troppo dure, eppure la descrizione
che Berlinguer fece quarantadue anni fa della Dc e (soprattutto) del Psi, che
stava erodendo consensi ai comunisti, non è molto lontana dalla percezione che
gli italiani hanno del (fu?) maggior partito della sinistra italiana che oggi
sprofonda, letteralmente, nei sondaggi. La superiorità morale dei comunisti, più
che un fatto politico è stato un dogma, una verità di fede, un preciso schema
strategico. Tutti rubano, tranne il Pci. Tangentopoli avrebbe dovuto
dimostrarlo, la sinistra italiana venne soltanto lambita dall’ondata di avvisi
di garanzia che, invece, travolse il Psi di Bettino Craxi. “Ora legale, panico
tra i socialisti”, fu il titolo non solo di un giornale ma di una stagione
politica. Di Primo Greganti si parlò poco, così come del dossier Mitrokhin e dei
rubli da Mosca, mentre infuriava, sulla parte avversa, la polemica Gladio.
Achille Occhetto per un attimo ci aveva creduto: i Progressisti avrebbero
portato, finalmente, l’onestà al potere. Arrivò Berlusconi nel ‘94, e vinse lui.
Aprendo una nuova stagione in cui la sinistra, con il pio e dimesso Romano
Prodi, si poneva come argine morale alla decadenza tele-bizantina di cui il Cav
sarebbe stato simbolo e causa insieme. Finì anche quella stagione. E gli ex
comunisti col santino di Berlinguer in tasca e la Santa alleanza con i
democristiani (“buoni”, come scrive Paolo Cirino Pomicino) della Base, si
scordarono di badare alla profezia di un grande socialista, Pietro Nenni: “A
fare i puri, prima o poi, si trova uno più puro che ti epura”. Arrivò Beppe
Grillo e il Vaffa day nel 2008. Fu respinto. Nacque il M5s su gentile (e
auto-jettatorio) invito di Piero Fassino. Raccolse l’eredità dei puri, degli
onesti, appropriandosi, nel 2018, di tutte le roccheforti che furono rosse.
Cinque anni dopo, la parabola era già finita. Ma Giuseppe Conte, piuttosto che
rintanarsi sulla questione morale, è sceso in campo agitando le ragioni dei ceti
più poveri e del Sud. Gli fecero il funerale, ridacchiando di lui. Oggi si
ritrova la possibilità di diventare lui il maggior partito di sinistra in
Italia. Enrico Letta, puntando tutto sull’antifascismo, vecchio richiamo della
foresta e insieme tentativo di aggiornare la questione morale inquadrandola su
base ideologica, ha fallito. Il Pd deve cambiare ma con Bonaccini e la sua vice
Schlein già è sotto il 15% dei sondaggi.
Mozione Qatar. Il
grande imbarazzo sulla nuova questione morale della sinistra.
Mario Lavia su
L’Inkiesta il 14 Dicembre 2022
Prima di trarre
conclusioni bisogna aspettare le sentenze, ma la storia dei politici
progressisti di Bruxelles merita comunque un chiarimento da parte dei leader
vecchi e futuri del Pd e di Articolo 1
Nel tardo 1989, in
una drammatica riunione del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana,
Oscar Luigi Scalfaro, all’epoca uno degli esponenti più autorevoli di quel
partito, intervenne senza giri di parole: «Ligato è un uomo nostro, non possiamo
tacerne». Ludovico Ligato era il presidente del Ferrovie, democristiano, ucciso
nell’agosto di quell’anno per motivi mai chiariti.
Scalfaro contestava
il silenzio dei suoi amici democristiani perché «è un uomo nostro» ma non ebbe
successo e il silenzio perdurò. Ecco, la cosa che certe volte fa più paura è
questo, il silenzio. Che può significare due cose: o è vergogna o è
instupidimento.
Enrico Letta ha
chiesto doverosamente chiarezza e annunciato che il Partito democratico si
costituirà come parte lesa. Bene. Ma non ci ha detto minimamente come sia stato
possibile uno schifo del genere nella sua famiglia politica. Qualcuno anzi si
scoccia pure e si dice «incazzato».
Se sono incazzati
loro figuriamoci gli elettori. Ci fosse uno che abbia chiesto scusa (premettendo
alle scuse l’estenuante ma giusto richiamo al garantismo), che abbia detto una
cosa tipo «non ce ne siamo accorti, era una così brava persona», come dicono
quelli del piano di sotto quando arrestano l’inquilino del piano di sopra.
E allora: Antonio
Panzeri è stato un esponente del Pci-Pds-Ds-Partito democratico e infine
Articolo Uno per decenni. «È un uomo nostro»: la frase di Scalfaro non l’ha
detta nessun dirigente. È possibile, per quanto inquietante, che nemmeno uno si
sia accorto della personalità di costui, forse di un probabile cambio del suo
tenore di vita, che so, di un qualche cosa che non quadrasse con il cliché di ex
sindacalista votato alla causa dei lavoratori di tutto il mondo, segnatamente,
da ultimo, del mondo arabo.
I vari
europarlamentari del Partito democratico di questi anni non lo hanno
frequentato? Gli assistenti, che a Bruxelles lavorano ora per uno ora per
l’altro, non hanno notato nulla? Così come è possibile, anche se allucinante,
che i socialisti europei, e in particolare greci, non si siano mai accorti di
che tipetto fosse Eva Kaili, una compagna talmente capace da essere eletta
vicepresidente dell’Europarlamento su designazione dei socialisti. È possibile,
anzi è probabile, che nessuno avesse sospettato alcunché. Ma allora sono tutti
degli sprovveduti, dei tontoloni, degli addormentati.
Tra tante persone
intelligenti e oneste non uno che avesse rizzato le antenne: un tempo, dispiace
dirlo, a sinistra non funzionava così. C’erano gli anticorpi. A partire dalla
sensibilità dei dirigenti.
Si dice: le mele
marce ci sono sempre. Sì, ma qui sta emergendo un sistema, una rete che
probabilmente è stata pazientemente intessuta per anni. Al di là dei luoghi
comuni, che dice Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito democratico e
leader morale di Articolo Uno che si appresta a rientrare nel Partito
democratico? L’arrestato non era un uomo suo? Ha parlato Matteo Renzi, come al
solito polemico: Panzeri «se ne andò dal Partito democratico perché diceva che
io ero contro i valori della sinistra. Ma quali erano questi valori?».
Renzi era segretario
del Partito democratico quando nel 2014 Panzeri venne ricandidato, ma giova
ricordare che le liste elettorali sono lottizzate tra le correnti ed è difficile
che una corrente metta il becco sulle scelte delle altre: e anche questo nel
Partito democratico ci sarebbe da correggere. E Articolo Uno, un partito così
piccolo, non si accorge che c’è del marcio a Bruxelles che origina da un suo
esponente? Nessuno se n’è accorto ma è proprio questo che sotto il profilo
politico preoccupa.
Si aspettano i
risultati delle indagini, com’è giusto, e poi dei processi, ma pare veramente
difficile a questo punto pensare che si tratti di un errore giudiziario, visto
che ci sono personaggi, come il padre della ex vicepresidente greca, che
scappano con il bottino; e va sempre ricordato che le responsabilità penali sono
personali.
Le responsabilità
politiche però no, sono collettive. Sono dei partiti, Partito democratico e
Articolo Uno che ormai è nel Partito democratico. Stefano Bonaccini ha ricordato
Enrico Berlinguer e la questione morale: solo che ora la questione morale è un
problema della sinistra. Quella sinistra che ha il dovere di capire e di
spiegare come sia stata possibile questa roba soprattutto per rispetto dei suoi
elettori, già frastornati dalla crisi di questi mesi a cui si aggiunge adesso la
vergogna di «un uomo nostro» al centro di uno scandalo internazionale. Il grande
silenzio è la risposta peggiore.
La lezione del
teorico sardo. Gramsci e la questione morale: non è un valore ma strumento di
lotta politica.
Michele Prospero su Il Riformista il 29 Dicembre 2022
Dinanzi ad ogni
scandalo politico, da ultimo quello dei contanti del Qatar, i commentatori
recuperano l’intervista di Berlinguer sulla “questione morale”. E se invece si
interrogasse di più un analista della crisi come Gramsci? La cosiddetta
questione morale è, per il teorico sardo, una “arma ideologica”, come le altre,
che può servire in maniera “eccellente” in vista di obiettivi contingenti. Però
un uso demagogico della lotta alla “corruzione” è sconsigliato poiché essa, da
strumento occasionale per resistere o approfittare di una situazione favorevole,
si tramuta così in una maschera che confonde, manipola.
La questione
morale, per Gramsci, costruisce una bolla ideologica che impedisce di cogliere i
processi reali. “Che gli interessati a che la crisi si risolva, dal loro punto
di vista, fingano di credere e reclamino a gran voce che si tratti
della «corruzione» e della «dissoluzione» di una serie di «principi» (immortali
o no), potrebbe anche essere giustificato: ognuno è il giudice migliore nella
scelta delle armi ideologiche che sono più appropriate ai fini che vuol
raggiungere e la demagogia può essere ritenuta arma eccellente. Ma la cosa
diventa comica quando il demagogo non sa di esserlo ed opera praticamente come
fosse vero nella realtà effettuale che l’abito è il monaco e il berretto è il
cervello”. Non serve la lamentela sulla decadenza morale, che è solo un aspetto,
non la causa, della degenerazione. È essenziale, nella lente
di Gramsci, comprendere le ragioni per cui “tutto l’organismo politico è
corrotto dallo sfacelo della funzione egemonica”.
La crisi è un
fenomeno complesso che appare con le sue “manifestazioni teatrali”, con
la “crescente instabilità dei governi”. Si produce una sorta di governismo per
cui partiti, fazioni e singole personalità danno luogo a “contrattazioni
cavillose e minuziose”. Anche gli accordi personalistici più “scandalosi” sono
recuperati per “formare il governo per salvare il paese”. In tutto ciò si
avverte l’impatto di una “moltiplicazione dei partiti parlamentari”, con il
rincorrersi di “crisi interne permanenti di ognuno di questi partiti”. Secondo
Gramsci, “le forme di questo fenomeno sono anche, in una certa misura, di
corruzione e dissoluzione morale”. Ma, oltre le immagini della compromissione
individuale, esistono le ragioni più durevoli di una questione che presenta
molteplici strati. Di là dalla dimensione provinciale della micro-corruzione,
quella che procede “sotto forma di pagliettismo meschino e di mania di bassi
intrighi”, i Quaderni esplorano la corruzione come espressione di
un “marasma”, cioè di una crisi di sistema che viene mascherata dalle calde
accuse di slealtà che le parti politiche reciprocamente si scambiano.
“I libri
dei «destri» dipingono la corruzione politica e morale nel periodo della
sinistra, ma la letteratura degli epigoni del Partito d’Azione non presenta come
molto migliore il periodo del governo della destra”. L’uso strumentale degli
scandali, che ogni partito rinfaccia all’altro rivendicando per sé un’immunità
morale, rientra nella fisiologia della schermaglia politica. All’alternanza di
governo, di fatto, non corrisponde un “cambiamento essenziale” e durevole delle
pratiche che incida nel modo di essere della democrazia. E per questo, invece di
cogliere le implicazioni generali della “debolezza generale della classe
dirigente”, si accumulano demonizzazioni del regime parlamentare o rimpianti per
la “crisi del principio di autorità”, da recuperare con qualche forma
di “superstizione” politica. La radice della crisi, però, risiede non nella
decadenza morale in quanto tale (“forse, nella realtà, la corruzione personale è
inferiore di quanto appare”) o nella dimenticanza di “immortali princìpi”, bensì
nella “assurda situazione politica” che raccoglie una dissolvente giuntura
storico-critica a seguito della quale “l’apparato egemonico si sgretola”.
Dietro i toni
scandalistici, nella lettura di Gramsci, esistono dati di sistema. Spicca, a
destra, la mancanza di “un vasto partito conservatore” capace di arginare le
variegate forze antisistema, “che negano in tronco tutta la civiltà moderna e
boicottano lo Stato”. Al centro, si avverte la latitanza di una credibile
aggregazione di tutte “le gamme liberali, dai moderati ai repubblicani, sui
quali operano tutti i ricordi degli odi dei tempi delle lotte e che si dilaniano
implacabilmente”. A sinistra, infine, affiora solo “in forma sporadica una serie
di tendenze sovversive anarcoidi, senza consistenza e indirizzo politico, che
mantengono uno stato febbrile senza avvenire costruttivo”. Agli occhi
di Gramsci, in una politica a forti tinte personalistiche, la mancanza di
partiti-società determina processi decompositivi. “Non esistono «partiti
economici» ma gruppi di ideologi déclassés, galli che annunziano un sole che mai
vuole spuntare”. Le parole si sganciano dalle cose, le formule anche più
radicali si estraniano dai processi.
La radice di una
tipologia di corruzione è connessa all’industrializzazione e alla
sua civiltà. La crescita disordinata del moderno apparato produttivo
determinò “una formidabile disoccupazione di intellettuali, che provocò tutta
una serie di fenomeni di corruzione e di decomposizione intellettuale e morale,
con riflessi economici non trascurabili. Lo stesso apparato statale, in tutte le
sue manifestazioni, ne fu intaccato assumendo un particolare carattere”. Si
tratta, per certi versi, di una corruzione connessa ai processi di
modernizzazione che, nelle sue forme esteriori, è destinata ad essere
riassorbita dalla crescita della società civile, dalla diffusione di una
burocrazia affidabile e di un’etica individuale più matura.
Le manifestazioni
di corruzione che i servizi segreti hanno smascherato nel caso qatarino, però,
non riguardano i processi molecolari dello Stato in formazione, ma si
riferiscono alle crepe dello Stato moderno, ridimensionato al cospetto delle
trame mondiali di influenza. La scuola marxista di relazioni internazionali di
Amsterdam, nelle analisi dedicate alle compenetrazioni potere-denaro, ripercorre
alcuni passaggi di Gramsci. La suggestione che Kees van der Pijl (Class
formation at the international level) recupera è soprattutto quella del concetto
di corruzione da intendersi come degenerazione che esplode nelle fasi di crisi
di egemonia, quando i regimi politici vedono eroso l’equilibrio storico di forza
e consenso maturato nel governo efficace dei processi e nella capacità di
direzione dell’opinione pubblica.
Si può leggere
nei Quaderni: “Tra il consenso e la forza sta la corruzione-frode (che è
caratteristica di certe situazioni di difficile esercizio della funzione
egemonica, presentando l’impiego della forza troppi pericoli), cioè lo
snervamento e la paralisi procurati all’antagonista o agli antagonisti con
l’accaparrarne i dirigenti sia copertamente sia in caso di pericolo emergente,
apertamente, per gettare lo scompiglio e il disordine nelle file
antagoniste”. Secondo van der Pijl, la crisi attuale della democrazia è visibile
nell’usura storica della mediazione politica novecentesca. Per dirla
con Gramsci, essa si manifesta con l’alterazione dei “normali” meccanismi
vigenti “nel terreno divenuto classico del regime
parlamentare”, risultante “dalla combinazione della forza e del consenso che si
equilibrano variamente”. L’ordine mondiale definito nel dopoguerra ha perso
validità, e sulla scena delle influenze irrompono nuove potenze regionali,
emirati e Stati falliti, mentre fioccano offerte di consulenze, arbitraggi
speculativi. Emergono trame nuove di potere, con le manovre di banche ombra e
l’attivismo di frazioni di élite e centri di corruttela espressi da entità
transnazionali (politiche, finanziarie, affaristiche, militari).
I grumi di potere
scavalcano la mediazione dello Stato e vedono in movimento gli agenti del
capitale internazionale. La corruzione diventa così uno strumento per agire
nelle pieghe dell’economia e superare le difficoltà del consenso (per i costi
sociali della globalizzazione e la privatizzazione dei servizi) e le scorciatoie
della forza. Quello che Gramsci chiamava “l’esercizio «normale» dell’egemonia” è
superato da intrecci denaro-potere che coinvolgono sia i paesi centrali che
quelli periferici. La ricerca di van der Pijl ricorda che nella top 20 dei
finanziatori miliardari di Obama figurano Soros, il gestore di hedge fund Paul
Tudor Jones, le banche di investimento di Wall Street, insieme a Google,
Microsoft e Time Warner, alcune università della Ivy League, la Goldman Sachs,
JP Morgan Chase, Citigroup, la svizzera UBS e Morgan Stanley. La stessa
presidenza reazionaria del “miliardario anticonformista” Trump si configura come
una coalizione di super ricchi aggregatasi per spremere il potere e conseguire
opportunità di accumulazione. In essa la Goldman Sachs è rappresentata in modo
preminente, con Steven Mnuchin come segretario al Tesoro e Gary Cohn come capo
consigliere economico. Altri quattro esponenti sono attivi in dipartimenti
importanti per inseguire la deregolazione finanziaria e la promozione di
“mercati liquidi e vivaci” (ivi).
Sul piano storico,
in America la crisi della forma politica si presenta con l’attivismo di imprese
commerciali, società di consulenza, banchieri, fiduciari d’affari, responsabili
di servizi finanziari che entrano nei ruoli direttivi delle amministrazioni.
In Europa, invece, la crisi mobilita la funzione surrogatoria di banche ombra,
dell’arbitrato finanziario, delle consulenze. Sorgono ministri tecnocratici,
la Bce con la ricetta Trichet si tramuta in una sorta di ufficio del programma
dei governi alle prese con la crisi. Il fenomeno delle porte girevoli tra
politica e affari, con consigli di amministrazione ospitali per le élite
politiche, assume risvolti evidenti: “Il presidente uscente della Commissione Ue
Barroso non ha dovuto pensare a lungo a dove trasferirsi ed è succeduto a Peter
Sutherland come presidente di Goldman Sachs International nel 2016” (van der
Pijl).
La redistribuzione
del potere si attua, nelle parole di Gramsci, “senza che la forza soverchi di
troppo il consenso, anzi cercando di ottenere che la forza appaia appoggiata sul
consenso della maggioranza, espresso dai cosí detti organi dell’opinione
pubblica -giornali e associazioni- i quali, perciò, in certe situazioni, vengono
moltiplicati artificiosamente”. Se i media corrompono le coscienze con le
manipolazioni della “politica della paura”, i giri del denaro e delle
mediazioni, le manovre degli emirati e degli emissari transnazionali del
capitale cercano di occupare il vuoto che la crisi della forma politica ha
lasciato. Magari bastasse ripassare l’intervista del 1981 al segretario
comunista per fornire una risposta alla privatizzazione della politica. Servono
attori e culture per superare la crisi della democrazia, che nel populismo
antipolitico trova alleati, non certo argini.
Michele Prospero
Fu l’ultimo
Berlinguer che rese giustizialista il Pci: nacque così il partito delle procure.
Fabrizio Cicchitto su Il Riformista il 5 Dicembre 2021
Sulla vicenda
di Mani Pulite il dibattito è sempre aperto e probabilmente non si chiuderà mai,
malgrado gli appelli melensi ad una impossibile “memoria condivisa”: e poi
“condivisa” fra chi? Fra chi ha fatto un autentico colpo di mano
mediatico-giudiziario e chi lo ha subìto? Dopo un’autentica, anche se atipica
guerra civile (gli avvisi di garanzia, gli arresti, i titoli dei giornali, i
telegiornali, Samarcanda, gli editti in diretta del pool dei pm di Milano che
sono stati il corrispettivo dei carri armati e dei paracadutisti per cui Curzio
Malaparte potrebbe scrivere una nuova edizione del suo libro: Tecnica di un
colpo di Stato) la memoria condivisa è impossibile, a meno che la storia non sia
scritta solo dai vincitori. Ma su questo terreno invece i vinti si sono fatti
sentire e continueranno a farlo.
Gli ultimi
significativi contributi sull’argomento sono costituiti da due saggi sul Foglio,
uno di Luciano Violante (Casellario dei veleni che hanno intossicato la
giustizia), l’altro di Paolo Cirino Pomicino (Le conversioni di Violante), da un
libro assai vivace, con intenti giustificazionisti, di Goffredo Buccini (Il
tempo delle Mani Pulite) e un altro di Pier Camillo Davigo, L’occasione mancata
(ma la principale occasione mancata è costituita proprio dal libro di Davigo che
invece di impegnarsi in una riflessione critica porta avanti, fra minacce e
rinnovate condanne, una esaltazione di tutti gli atti del pool e dei suoi
protagonisti ). I due saggi sul Foglio si pongono su piani totalmente diversi.
Luciano Violante colloca il suo saggio in una dimensione che, per usare una
espressione cara a Gramsci, è “fur ewig”, quasi che negli anni cruciali dal 1970
al 2000 egli sia stato uno studioso indipendente. Invece dagli anni ’70 agli
anni ’90 Violante è stato uno dei fondatori del giustizialismo sostanziale, ha
operato a monte del Parlamento nella costruzione di un rapporto profondo fra
il Pci e alcune procure, e poi dalla presidenza della Commissione Antimafia ha
contribuito ad elaborare testi assai importanti.
Invece Paolo
Pomicino ha scritto il suo saggio con il cervello, con la memoria storica, e
anche con la partecipazione di chi da un certo uso politico della giustizia è
stato colpito in modo molto duro. Alla luce di tutto ciò Pomicino, nel suo
saggio assai polemico, finisce con l’attribuire a Violante il ruolo di deus ex
machina di tutto quello che è accaduto. Invece, a nostro avviso, se si vuole
andare davvero al fondo della questione, bisogna fare i conti con la storia
del Pci dal 1979 in poi. Se li facciamo vediamo che è “l’ultimo Berlinguer” ad
essere alle origini di tutto, compresa l’involuzione giustizialista dal Pds.
L’azione politica sviluppata dal gruppo dirigente che ha cambiato nome al Pci e
ha fondato il Pds (Occhetto, D’Alema, Veltroni, Fassino e, appunto, Violante) è
in assoluta continuità con quel lascito berlingueriano. “L’ultimo Berlinguer”
(descritto in modo magistrale in un saggio di Piero Craveri sulla rivista XXI
secolo – marzo 2002) ha prodotto due guasti.
In primo luogo ha
accentuato, non ridotto, le divisioni verificatesi fra il Pci e il Psi dai tempi
dell’invasione sovietica dell’Ungheria: certamente Togliatti era un sofisticato
stalinista e anche dopo il XX Congresso lavorò per ricostruire su nuove basi il
legame di ferro con l’Urss. Però Togliatti non fu mai un giustizialista (la sua
scelta per l’amnistia ebbe un significato profondo) e dal 1944 al 1964 mantenne
sempre ferma la scelta strategica fatta dall’Internazionale comunista nel VII
Congresso (I fronti popolari, il rapporto preferenziale con i partiti
socialisti, la linea gradualista in Europa) e quindi non regredì mai verso il
settarismo del VI Congresso (1928) fondato appunto “sul socialfascismo”. In
secondo luogo Berlinguer con la sua enfatizzazione della questione morale e con
la sua damnatio degli “altri partiti” (quasi che il Pci fosse davvero “diverso”
da essi sul terreno del finanziamento irregolare) ha rappresentato una delle
fondamentali scuole di pensiero (quella di sinistra), che hanno ispirato la
successiva affermazione della demonizzazione dei partiti e dell’antipolitica.
Le altre scuole su
questo terreno sono state tutte di destra o di ispirazione confindustriale e poi
sono state anche quelle che hanno drenato più consensi. Di fronte all’ascesa
di Craxi alla presidenza del Consiglio Berlinguer scartò nettamente la proposta
del segretario della Cgil Luciano Lama che era quella di dare una sponda
politica e sindacale alla novità costituita dal fatto che per la prima volta un
socialista diventava presidente del Consiglio. Anzi Berlinguer fece la scelta
del tutto opposta, quella della contrapposizione frontale. Ciò derivava da
un’analisi totalmente negativa su Craxi e sul gruppo dirigente socialista
sviluppata nel ristretto laboratorio cattocomunista che assisteva Berlinguer
nella definizione della politica interna (invece in politica estera egli aveva
una autonomia assoluta e faceva tutto di testa sua). In una lettera del 18
luglio 1978 Antonio Tatò, uno dei due consiglieri di Berlinguer in politica
interna, scriveva “Craxi è un avventuriero, anzi un avventurista, un abile
maneggione e ricattatore, un nemico dell’unità operaia e sindacale, un nemico
nostro e della Cgil, un bandito politico di alto livello”.
Di lettere su questa
falsa riga ce ne stanno altre. Partendo da un’analisi siffatta in una riunione
della direzione Berlinguer sostenne che il Psi puntava ad acquisire la direzione
del paese con la presidenza del Consiglio addirittura “sulla base di uno
spostamento a destra” dell’asse politico. Berlinguer ammonì “di non dimenticare
il periodo del cosiddetto “socialfascismo” in cui le socialdemocrazie avevano
aperto la strada alla reazione e al nazismo con le loro posizioni antipopolari e
antioperaie (attorno agli anni ‘30) per cui si potevano controllare i toni della
polemica ma sarebbe stato un errore non mettere in chiaro la pericolosità della
posizione del Psi”. Per chi conosce il valore di certe espressioni “simboliche”
del linguaggio comunista la frase usata da Berlinguer a proposito di Craxi sul
“socialfascismo” aveva un significato profondo. Da qui una scelta politica di
fondo: il nemico da battere era il Psi di Craxi. Per altro verso l’alternativa
lanciata a Salerno era contro tutto e tutti. Gli unici alleati possibili erano
la sinistra cattolica e quella democristiana. Arriviamo così al 1989.
Cossiga capì subito
che il crollo del comunismo avrebbe avuto conseguenze non solo per il Pci ma
anche per la Dc, per il Psi e per i partiti laici. Egli sostenne l’esigenza di
una profonda autocritica da parte di entrambi gli schieramenti contrapposti che
duranti gli anni della guerra fredda avevano messo in atto molte illegalità.
Questo invito fu nettamente respinto prima dal Pci di Berlinguer poi dal Pds e
anzi Cossiga fu addirittura criminalizzato. A quel punto i cosiddetti poteri
forti (dalla Confindustria a Mediobanca alla Fiat alla Cir, ad altri grandi
gruppi) ritirarono la loro delega alla Dc e al Psi e anzi manifestarono forti
propensioni per l’antipolitica e ancor di più una netta repulsione per la
“repubblica dei partiti” e per le imprese pubbliche. Di conseguenza il Pds fu di
fronte ad una scelta di fondo.
I miglioristi
proposero di rispondere a tutto ciò con la formazione di un grande partito
socialdemocratico e riformista e comunque con l’unità fra il Psi e il Pds.
Invece sulla base dell’analisi e della linea politica di Berlinguer la risposta
di coloro che Folena appellò in un suo libro I ragazzi di Berlinguer fu di segno
opposto e fu espressa in modo lucido da Massimo D’Alema: “Che cosa dobbiamo
fare? Dobbiamo cambiare nome. Volevamo entrare nell’Internazionale socialista,
dunque non potevamo continuare a chiamarci comunisti. Craxi aveva un indubbio
vantaggio su di noi, era il capo dei socialisti in un paese occidentale, quindi
rappresentava la sinistra giusta per l’Italia, solo che aveva lo svantaggio di
essere Craxi.
Mi spiego. I
socialisti erano storicamente dalla parte giusta, ma si erano trasformati in un
gruppo affarista avvinghiato al potere democristiano. Allora avevamo una sola
scelta: diventare noi il partito socialista” (Fasanella-Martini: D’Alema). Qui è
il punto cruciale. Quando in seguito alla presa di distanza dai partiti
tradizionali da parte dei poteri forti decollò il cosiddetto circo
mediatico-giudiziario alle origini il Pds non ne faceva parte, tant’è che tremò
sapendo bene di essere inserito a suo modo nel sistema del finanziamento
irregolare dei partiti. Questa fu la ragione per cui Occhetto si recò per la
seconda volta alla Bolognina per chiedere scusa agli italiani.
A sua volta per una
fase Borrelli accarezzò l’idea che a un certo punto “il presidente della
Repubblica come supremo tutore” avrebbe “chiamato a raccolta gli uomini della
legge e soltanto in quel caso noi potremmo rispondere. Non basterebbe certo una
folla oceanica sotto i nostri balconi, ma un appello di questo genere del capo
dello Stato”. Quando fu chiaro che ciò non sarebbe avvenuto il vice procuratore
capo Gerardo D’Ambrosio, da sempre militante del Pci, ebbe buon gioco a
convincere Borrelli e gli altri che il pool aveva bisogno di un partito di
riferimento e che esso avrebbe potuto benissimo essere il Pds, visti gli ottimi
rapporti che il Pci aveva avuto con alcune procure strategiche (Milano, Torino,
Palermo). Ecco che così il Pds ebbe un rapporto speciale con il pool di Milano e
attraverso di esso poté procedere alla occupazione dello spazio storicamente
coperto dal PSI distruggendolo per via mediatico-giudiziaria. In una prima fase
questo disegno non fu contrastato dalla Dd perché Antonio Gava si illuse che
consegnando Craxi e il Psi “ad bestias” tutta la DC si sarebbe salvata.
Le cose non andarono
così: quando la ghigliottina si mette in moto essa non si arresta facilmente: in
quel caso essa fu interrotta solo per la sinistra democristiana. A proposito di
tutto ciò valgono le osservazioni fatte da un personaggio al di sopra di ogni
sospetto come Giovanni Pellegrino, del Pds, già presidente della Commissione
Stragi: “l’innesto di alcuni magistrati come Luciano Violante nel gruppo
dirigente aveva finito col cambiarne (del Pds, n.d.r.) la cultura. Comincia a
nascere un “partito delle procure” e si forma una corrente di pensiero secondo
cui i problemi politici si risolvono con i processi. Il gruppo dirigente del
partito era convinto che cavalcando la protesta popolare e con una riforma
elettorale maggioritaria un partito del 17%, quale era allora il Pds, avrebbe
conquistato la maggioranza assoluta dei seggi […]. Occhetto e parte del gruppo
dirigente pensavano di avere il monopolio della astuzia […]. La nostra astuzia
era al servizio di un disegno fragile che alla fine ha prodotto
Berlusconi. Berlusconi è nato perché a sinistra in tanti erano convinti che la
magistratura poteva essere la leva per arrivare al governo” (in G. Fasanella, G.
Pellegrino, La guerra civile, Bur). Questi a nostro avviso sono gli elementi
fondamentali di una vicenda che ha segnato in modo profondo la storia del nostro
paese.
Comunque fra i
protagonisti di quella stagione Violante è l’unico che negli anni 2000 ha
portato avanti una riflessione critica e sostanzialmente autocritica. A parte il
suo lungo articolo sul Foglio Luciano Violante ha il merito di aver fatto una
battuta fulminante per commentare la situazione in cui si trova attualmente la
magistratura italiana: “la prima riforma della giustizia da fare è quella della
divisione delle carriere fra pm e cronisti giudiziari”. Quella battuta ci porta
direttamente al libro di Goffredo Buccini. Nel 1992 Buccini era un giovanissimo
giornalista del Corriere della Sera. Egli ricostruisce dal lato dei cronisti
giudiziari quella che non fu una rivoluzione, ma una confusa guerra civile. Le
rivoluzioni sono cose serie e producono anche una nuova classe dirigente di
livello, una nuova cultura, nuovi valori. Le cose invece con Mani Pulite non
sono andate così: sul mucchio selvaggio dai giovani cronisti descritti da
Buccini, sugli avvocati accompagnatori, sugli imprenditori e su alcuni politici
presi dalla sindrome di Stoccolma, si innestò una operazione politica fondata
sulla scelta di due pesi e di due misure, uno adottato a favore del Pci-Pds e
della sinistra democristiana, l’altro per colpire Craxi, i segretari dei partiti
laici e l’area di centro-destra della Dc.
Ciò è avvenuto, come
abbiamo già visto, perché i poteri forti dopo il 1989 hanno ritenuto di
interrompere il loro rapporto globale (compresi i finanziamenti) con i
tradizionali partiti di governo (Dc, Psi, partiti laici) per cui hanno dato
licenza di uccidere agli organi di stampa da loro condizionati anche andando
incontro nell’immediato ad alcune difficoltà di immagine e anche a vicende
giudiziarie risolte come fecero Romiti e De Benedetti con alcune
confessioni-genuflessioni fatte al pool dei pm di Milano. Di conseguenza un
nucleo ben assortito di pm della procura di Milano non ha avuto più alcun
condizionamento e si è scatenato “sulla politica”. A quel punto però se la
razionalità e specialmente l’equanimità avessero prevalso sarebbero stati
ipotizzabili due grandi operazioni. Una ipotesi era quella della grande e
reciproca confessione (visto che il Pci era finanziato in modo ancor più
irregolare della Dc e del Psi) come sostennero in modo diverso da un
lato Cossiga, dall’altro lato Craxi nel suo discorso in parlamento del luglio
1992. Ciò avrebbe dato luogo a nuove procedure, a nuove regole, a una vera
amnistia (non quella del 1989 che servì solo a mettere a riparo il Pci da
conseguenze penali per il finanziamento del Kgb) e a un nuovo sistema politico
di stampo europeo.
L’altra ipotesi sul
terreno della equanimità era invece quella di una totale rottura per una
ipotetica palingenesi con i magistrati assunti al ruolo di “angeli sterminatori”
nei confronti di tutti i peccatori, vale a dire i partiti senza eccezione alcuna
e i grandi gruppi imprenditoriali privati e pubblici. Avvenne esattamente il
contrario, Mani Pulite fu gestita in modo del tutto unilaterale con i due pesi e
le due misure a cui ci siamo riferiti precedentemente. Il libro
di Buccini costituisce una straordinaria conferma di questa unilateralità. Tutti
i cronisti giudiziari erano di sinistra e nessuno di essi ha mai contestato la
grande mistificazione su cui si è fondata Mani Pulite. I segretari della Dc,
del Psi, dei partiti laici “non potevano non sapere” e invece, per non far
nomi, Occhetto, D’Alema, Veltroni “potevano non sapere” anche quando Gardini si
recava a via delle Botteghe Oscure per incontrare uno o due di loro portando con
sé una valigetta con dentro un miliardo. Buccini rimane all’interno del
paradigma su cui si è fondato Mani Pulite quando sottovaluta il discorso
di Craxi alla Camera del 1992, liquidandolo con la battuta: “tutti colpevoli,
quindi nessun colpevole”: la sostanza era proprio quella; il finanziamento
irregolare riguardava tutti da tempo immemorabile e a loro volta magistrati e
giornalisti sapevano tutto benissimo. Solo che, indubbiamente in seguito a un
fatto storico come il 1989, ad un certo punto qualcuno (in primo luogo i poteri
forti) decise che le regole del gioco all’improvviso cambiavano.
Parliamoci chiaro:
con i metodi adottati dalla procura di Milano Togliatti, Secchia, Amendola,
Longo, lo stesso Berlinguer per interposti amministratori del partito, De
Gasperi, Fanfani, i dorotei, Marcora, De Mita e Donat-Cattin si sarebbero venuti
a trovare in condizioni analoghe a quelle di Bettino Craxi, di Forlani,
di Altissimo e di Giorgio La Malfa. Buccini descrive anche quali erano i
rapporti reali dei cronisti con il nucleo leninista dei pm: “Davigo mi ha preso
a ben volere – riservatissimo e un po’ misantropo mi lascia intravedere a volte
uno spiraglio di amicizia […] passeggiandomi accanto fra le file di uffici
semideserti a quell’ora mi dice che quando nasceranno le Commissioni di
epurazione dei giornalisti io dovrei proprio farne parte perché sono un ragazzo
perbene: lo guardo e naturalmente deve stare scherzando” (Buccini, Il tempo
delle Mani Pulite, pag. 145). “È un pezzo che mi sto curando Borrelli, Alfonso,
suo segretario, mi guarda con il compatimento di uno zio affettuoso […]. La
scena è abbastanza umiliante, devo ammetterlo, ma nel mestiere la sostanza conta
più del talento” (idem, pag. 166) e “Borrelli mi dice […] in un’ennesima
intervista, i colleghi in sala stampa mi sfottono acidi definendomi la penna
preferita del procuratore, ma starebbero volentieri al mio posto” (idem, pag.
186). Infine, ma questa è invece un’osservazione assai seria perché va al fondo
della questione: “l’indagine si è avvalsa e nutrita dell’uso smisurato delle
manette” (idem, pag. 178).
A ciò va aggiunto
che ci fu un unico Gip, cioè Ghitti, del tutto allineato, che addirittura parlò
della liquidazione di un intero “sistema”. Infine, quanto al libro
di Davigo, c’è un punto fondamentale che per molti aspetti è sorprendente e
disarmante perché tratta con argomenti puramente giuridici una decisiva
questione politica: “le successive indagini fecero emergere l’esistenza di un
sistema nazionale in cui le principali imprese che avevano rapporti prevalenti
con la pubblica amministrazione pagavano imponenti somme di danaro ai segretari
amministrativi dei partiti di maggioranza mentre le cooperative rosse pagavano
il Pci (dal 1991 Pds). La questione è stata oggetto di polemiche infinite
sull’assunto che il Pci-Pds non sarebbe stato perseguito con la stessa energia
con cui sarebbero state svolte le indagini nei confronti degli altri partiti,
per poi trarvene l’accusa di politicizzazione agli inquirenti”.
In queste poche
righe Davigo liquida una questione fondamentale perché dietro questo pretesto
(quello che i segretari del Pci-Pds ignoravano l’apporto delle cooperative rosse
mentre a loro volta i pm hanno volutamente ignorato che ad esempio la
percentuale fra il 20 e il 30% riservata alle cooperative in sede Italstat, dove
tutti gli appalti erano manipolati, era il modo con cui al Pci in quanto tale
erano indirizzate enormi tangenti) è stata realizzata la manipolazione che ha
portato a un uso politico della giustizia molto mirato. Se poi a questo si
aggiunge che quando è stato provato che Gardini si era recato in via delle
Botteghe Oscure per vedere i massimi dirigenti del Pds portando con sé una
valigetta con dentro un miliardo si è trovato il pretesto per evitare di inviare
ad essi un avviso di garanzia e in sede di processo Enimont il presidente
Tarantola addirittura ha rifiutato di accogliere la richiesta dell’avvocato
Spazzali di sentire Occhetto e D’Alema come testimoni perché quello era un
processo totalmente dedicato a sputtanare i segretari dei partiti di governo,
ecco che la misura è colma e l’unilateralità della operazione Mani Pulite è
assolutamente evidente.
Infine non bisogna
mai dimenticare che per due volte il pool fece una sorta di “pronunciamiento”
contro proposte di legge del governo. Addirittura una volta, dopo aver fatto
saltare il decreto Biondi, a Cernobbio il pool presentò una propria proposta di
legge per la sistemazione di tutta la vicenda. Infine, ben due esponenti del
pool, cioè il vice procuratore D’Ambrosio e il protagonista dell’operazione di
“sfondamento” cioè Antonio Di Pietro sono stati eletti per più legislature nelle
liste del Pds. Dopodiché oggi il risultato finale di un colpo di mano senza
rivoluzione è del tutto evidente: leaders effimeri, che durano lo spazio di un
mattino, partiti liquidi e movimenti privi di spessore politico e culturale. La
conseguenza è netta. Nel momento più drammatico del nostro paese dal 1945 il
destino dell’Italia dipende da due persone: Sergio Mattarella e Mario Draghi.
Fabrizio Cicchitto
·
Tangentopoli Italiana.
Tangentopoli fu
un colpo di Stato.
Antonio Di
Pietro.
Gherardo Colombo.
Gianni De
Michelis.
Giorgio Ruffolo.
Enzo Carra.
Gabriele Cagliari.
Sergio Moroni.
Raul Gardini.
Mafia Appalti.
«Verrà il giorno
in cui i pm si arresteranno tra loro». La cupa profezia di Craxi.
Ora che persino Davigo è stato condannato in primo grado,
quelle parole tornano alla mente. Paola Sacchi su Il Dubbio il 22 giugno 2023
«Verrà il giorno in cui i magistrati si
arresteranno tra di loro». Ora che Piercamillo Davigo, magistrato in pensione, è
stato condannato in primo grado per rivelazione d’atti di ufficio, e il
garantismo deve valere per tutti, quindi anche per lui dalle posizioni estreme
sui politici, non può non risuonare in testa quella tagliente profezia di
Bettino Craxi, nei giorni di Hammamet. Lo statista socialista, che aveva fatto
esposti contro Davigo, per il quale usò parole durissime difendendosi da quelle
altrettanto trancianti che l’esponente del pool di Mani pulite aveva usato per
lui, quella cupa profezia la ripeteva spesso fin dal 1994, quando iniziò il suo
esilio.
Quelle parole le diceva ai pochi ormai che lo
andavano a trovare e gli stavano vicini, oltre alla sua famiglia, come l’ex capo
dei giovani socialisti, Luca Josi, e pochi altri del suo stesso Psi.
Giustificava solo Gianni De Michelis per non averlo lì con lui. Disse alla
cronista: «Povero Gianni, lo capisco, lo hanno messo in croce sul piano
giudiziario, però lui come può mi chiama sempre da una cabina telefonica».
Erano gli anni in cui lui diceva, preoccupandosi
quasi più degli altri: «Attenzione, chi tocca i fili muore». E questo persino
per riguardo dei pochi giornalisti, come la sottoscritta, che pur scrivendo
allora per un giornale avversario, l’Unità, durante i periodi di ferie lo andava
a trovare in forma privata per un libro-intervista sulla mancata unità a
sinistra, I conti con Craxi (MaleEdizioni con prefazione di Stefania Craxi).
Erano i giorni in cui già stavano emergendo le prime crepe nel pool milanese,
Craxi aveva denunciato in uno dei suoi libretti clandestini, diffusi da Critica
social”, dal titolo Giallo, grigio, turchino, la violazione allo stato di
diritto che era stata fatta per la sua persona, il suo partito e la sua
famiglia. E sperava che qualche verità emergesse dal processo di Brescia contro
Di Pietro. Craxi non piangeva, lo fece platealmente in un’intervista a Carlotta
Tagliarini, per la tv tedesca, solo per il suicidio di Sergio Moroni. Ma, quando
lo incontravamo sul terrazzo dello Sheraton hotel si vedeva che i suoi occhi
trattenevano dignitosamente e con fierezza le lacrime dell’amarezza per la sua
fine. Per il fatto di essere stato trattato «peggio dei peggiori criminali,
mentre io ho sempre servito solo il mio Paese e spero di averlo fatto bene».
«Ma, non mi hanno neppure lasciato fare il pensionato», è scritto in uno degli
appunti notturni di Hammamet, raccolti dallo storico Andrea Spiri, nel
libro L’ultimo Craxi- Diari di Hammamet, per Baldini e Castoldi. Sempre Spiri
nel libro
Io parlo e continuerò a parlare (Fondazione Craxi
per Mondadori) ricorda le denunce ai colpi dati allo stato di diritto:
«Giustizieri, protagonisti, forcaioli mostreranno tutta la corda della loro
falsità». Craxi fu il primo a denunciare il perverso circuito mediatico-
giudiziario. Lo stigmatizzò più esattamente così: «Clan politici, mediatici,
giudiziari». Ma guardava lontano, non si fermava al suo personale calvario
giudiziario, tragedia politica per un intero Paese, guardava al futuro
dell’assetto tra i poteri, denunciava il colpo inferto al primato della politica
da quell’uso politico della giustizia sotto il quale cadde un’intera, storica
classe dirigente che aveva ricostruito il Paese nel dopoguerra, fatto importanti
riforme e raggiunto successi, come i suoi, dalla scala mobile al nuovo
Concordato, all’Italia nel G7. Il terremoto di quella che definì «la falsa
rivoluzione» salvò solo gli ex Pci poi Pds e Ds e la sinistra della
Dc. Dall’archivio della Fondazione Craxi, in suo schema autografo, riportato da
Spiri in Nell’ultimo Craxi, emergono in modo spietatamente chirurgico tutti i
nodi di quella stagione, alcuni dei quali ancora oggi irrisolti: «L’uso violento
del potere giudiziario. Gli arresti illegali ( le modalità ingiustificate agli
arresti), per esempio l’uso illegale delle manette. Gli incredibili Tribunali
della Libertà. Il ruolo del Gip. Le detenzioni illegali. I trucchi adottati per
allungare le detenzioni. Le discriminazioni negli arresti. La orologeria
politica rispetto alle scadenze politiche. Il rapporto con il potere
legislativo, con l’istituzione parlamentare. Esibizionismo logorroico.
Politicismo nelle valutazioni e nella condotta».
Infine, uno dei punti più dolenti, ancora oggi
alla ribalta: «Rapporto illegale e perverso con la stampa». Conclusione:
«Violazioni sui diritti dell’uomo». Forse, Craxi aveva ben intuito con la sua
profezia che un sistema politico, schiacciato e che aveva in parte avallato «la
falsa rivoluzione», gioco forza, per contraccolpo, avrebbe prima o poi generato
spinte e controspinte tra aree in lotta in quella stessa parte di magistratura
allora dominante. «Verrà il giorno in cui i magistrati si arresteranno tra di
loro». Craxi azzeccò anche la profezia su di sé: «Io parlo e continuerò a
parlare» .
Estratto dell'articolo di Mattia Feltri per “La
Stampa” il 22 giugno 2023.
All'inizio del millennio, al Foglio, dove allora
lavoravo, avevamo oltrepassato il centinaio di querele ricevuto dal Pool di Mani
pulite. Poi assolti in blocco ma mica male come intimidazione […].
In una di esse […] Piercamillo Davigo aveva
individuato una prova di dileggio in un banale refuso – mi uscì un "Pircamillo"
– e lì si si consolidò il sospetto che il Dottor Sottile si stesse lasciando un
po' prendere la mano, quanto a sottigliezze.
Ma ieri, dopo la condanna in primo grado per
rivelazione di segreto d'ufficio, sono stato contento di […] leggere anzi
qualche articolo nel quale si osservava che l'onestà di Davigo rimane fuori
discussione.
Infatti non ho mai pensato che l'onestà delle
persone sia misurabile coi codici e le sentenze […]. Altrimenti non avrebbe
nessun senso i Miserabili, il capolavoro di Victor Hugo nel quale Jean Valjean è
un pregiudicato latitante eppure sta moralmente tre spanne sopra a Javert, il
poliziotto da cui è braccato, l'incorruttibile che pretende da sé il rigore
preteso dagli altri poiché crede nella perfetta coincidenza fra legge e morale,
ed è questa la sua condanna.
Tra l'altro Javert nel romanzo non ha nome,
soltanto il cognome, come se fosse soltanto un ruolo, una maschera: Javert. E a
distanza di tanti anni confermo il refuso: se avessi voluto irriderlo, non avrei
scritto "Pircamillo", avrei scritto semplicemente Davigo.
Davigo, Colombo e Di Pietro? Giardinetti,
trattori e processi: che brutta fine. Libero
Quotidiano il 22 giugno 2023
Gherardo Colombo porta il cane a spasso nel centro
di Milano e va in giro dicendo, nonostante abbia firmato quando era in servizio
decine di richieste di custodia cautelare, che il carcere «non serve a nulla e
rende la società pericolosa». Antonio Di Pietro, dopo aver gettato la toga alle
ortiche ed essere stato candidato nel 1996 da Massimo D’Alema nel collegio
blindato del Mugello, ha fondato e chiuso un partito, l’Italia dei valori.
Adesso è su un trattore in Molise e prepara il terreno per la semina delle
patate. Francesco Greco, pur sotto scorta anche quando andava in bagno, è
riuscito nell’impresa di perdersi il telefono che i colleghi di Brescia gli
avevano chiesto per verificare se si fosse scritto con il pg della
Cassazione Giovanni Salvi a proposito della condotta del pm Paolo Storari. Per
la cronaca anche Salvi si era perso il telefono nello stesso giorno. Nonostante
questa distrazione, il sindaco di Roma, il piddino Roberto Gualtieri, lo ha
nominato responsabile della legalità del Campidoglio. Davigo, il più famoso di
tutti, ha cercato di far passare come massone il collega antimafia Sebastiano
Ardita, con cui aveva scritto libri e fondato- addirittura- una corrente della
magistratura italiana che solo il nome mette timore: Autonomia&indipendenza.
È una fine quanto mai impietosa quella degli idoli
di Mani pulite che vollero fare la rivoluzione spalancando le porte al
giustizialismo più becero e volgare. Per trent’anni, come le vecchie rock band
che propongono sempre lo stesso repertorio, i magnifici pm di Mani pulite sono
riusciti nell’impresa di monopolizzare tv e giornali per raccontare quella
stagione eroica. Scomparsi da tempo i procuratori dell’epoca, Gerardo
D’Ambrosio e Francesco Saverio Borrelli, Davigo, Di Pietro, Colombo e Greco,
come un disco incantato, hanno descritto un’Italia dove si rubava su tutto.
Sconfinata l’aneddotica. Chi potrà dimenticare gli interrogatori “multitasking”
di Di Pietro? Per evitare che gli indagati comunicassero fra loro, anche tramite
i loro avvocati, egli era solito convocarli tutti insieme in una stanza del
Palazzo di giustizia di Milano dove erano presenti 11 postazioni con dei
computer. Alla tastiera e al mouse personale delle Forze di polizia,
carabinieri, finanzieri, vigili urbani. Un gioioso mix di divise al servizio di
Tonino da Montenero di Bisaccia. Qui, come Garri Kasparov senza gli scacchi ma
con la toga, si alternava di postazione in postazione interrogando i vari
malcapitati, politici o membri di consigli di amministrazione di società
sospettate di pagare le mazzette.
Questo stratagemma sarebbe servito ad impedire che
venissero concordate le deposizioni. Una volta, come nei migliori film
polizieschi degli anni ’70, Di Pietro prese invece dei faldoni, li fece riempire
con carta di giornale per fare spessore e li posizionò sulla scrivania. Quando
entrò l’imputato disse: «Queste sono le contestazioni alle quali deve
rispondere. Da dove cominciamo? Ne prendo una caso?». Cosi facendo terrorizzò
l’indagato che confessò tutto. La gente, ascoltandolo, rideva, ma non c’era
nulla da ridere. Davigo, che venne eletto anche presidente dell’Associazione
nazionale magistrati, non perdeva occasione per affermare che la magistratura
italiana è la migliore del mondo occidentale e i magistrati italiani sono i più
produttivi ed efficienti. «Citofonavamo e già cominciavano a confessare le
tangenti», ripeteva Davigo.
Di quel periodo che ha cambiato la storia, però,
nessuno tranne un paio di anni fa il giudice Guido Salvini, ha raccontato il
“trucco” escogitato dal pool per evitare incidenti di percorso. Si trattava del
fascicolo che in realtà non era tale ma era un “registro” che riguardava
centinaia e centinaia di indagati che nemmeno si conoscevano tra loro e vicende
tra loro completamente diverse unificate solo dall’essere da gestite dal pool.
Il numero con cui iscrivevano qualsiasi novità che riguardasse tangenti in tutti
i settori della Pubblica amministrazione era sempre lo stesso, il 8655 del 1992,
quello del Pio Albergo Trivulzio, un fascicolo estensibile a piacere, tra
l’altro anche a vicende per cui la competenza territoriale dell’autorità
giudiziaria di Milano non esisteva. Questo espediente dell’unico numero impediva
la rotazione e consentiva di mantenere quell'unico gip iniziale, quello
dell’indagine sul Trivulzio, Italo Ghitti, che evidentemente soddisfaceva le
aspettative del pool. Un paio gli anni dopo, nel 1994, Ghitti divenne
consigliere del Csm. «Un’elezione e un prestigioso incarico propiziati quasi
esclusivamente dall’essere stato il “gip di Mani pulite” senza rivali». Adesso è
calato il sipario.
3 Luglio ’92, l’ultimo discorso di Craxi:
«Nessuno è innocente». Bettino Craxi, ex presidente
del Consiglio dei Ministri ed ex segretario del Partito socialista italiano.
L’intervento del leader socialista alla Camera dei Deputati sul problema del
finanziamento illecito ai partiti. E non solo...Il Dubbio il 19 giugno 2023
Il celebre discorso che Bettino Craxi pronunciò
alla Camera il 3 luglio 1992 «È tornato alla ribalta, in modo devastante, il
problema del finanziamento dei partiti, meglio del finanziamento del sistema
politico nel suo complesso, delle sue degenerazioni, degli abusi che si compiono
in suo nome, delle illegalità che si verificano da tempo, forse da tempo
immemorabile. In quest’Aula e di fronte alla Nazione, io penso che si debba
usare un linguaggio improntato alla massima franchezza. Bisogna innanzitutto
dire la verità delle cose e non nascondersi dietro nobili e altisonanti parole
di circostanza che molto spesso, e in certi casi, hanno tutto il sapore della
menzogna. Si è diffusa nel Paese, nella vita delle istituzioni e delle pubbliche
amministrazioni, una rete di corruttele grandi e piccole che segnalano uno stato
di crescente degrado della vita pubblica. Uno stato di cose che suscita la più
viva indignazione, legittimando un vero e proprio allarme sociale e ponendo
l’urgenza di una rete di contrasto che riesca ad operare con rapidità e con
efficacia. I casi sono della più diversa natura, spesso confinano con il racket
malavitoso, e talvolta si presentano con caratteri particolarmente odiosi di
immoralità e di asocialità».
«Purtroppo, anche nella vita dei partiti molto
spesso è difficile individuare, prevenire, tagliare aree infette, sia per la
impossibilità oggettiva di un controllo adeguato, sia, talvolta, per l’esistenza
ed il prevalere di logiche perverse. E così, all’ombra di un finanziamento
irregolare ai partiti, e ripeto, al sistema politico, fioriscono e si
intrecciano casi di corruzione e di concussione, che come tali vanno definiti,
trattati, provati e giudicati. E tuttavia, d’altra parte, ciò che bisogna dire,
e che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è
irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su appartati grandi,
medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali e associative,
e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e
ricorrono all’uso di risorse aggiuntive in forma irregolare od illegale. Se gran
parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale,
allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia
nessuno in quest’Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che
possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo:
presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. E del
resto, andando alla ricerca dei fatti, si è dimostrato e si dimostrerà che tante
sorprese non sono in realtà mai state tali. Per esempio, nella materia tanto
scottante dei finanziamenti dall’estero, sarebbe solo il caso di ripetere
l’arcinoto “tutti sapevano e nessuno parlava”. Un finanziamento irregolare ed
illegale al sistema politico, per quanto reazioni e giudizi negativi possa
comportare e per quante degenerazioni possa aver generato, non è e non può
essere considerato ed utilizzato da nessuno come un esplosivo per far saltare un
sistema, per delegittimare una classe politica».
Giustizia e politica: quei leader alla
sbarra da Craxi a Trump passando per il Cav...Con un
po' di approssimazione si può dire che l'epicentri del terremoto che ha
destabilizzato il rapporto tra politica e magistratura è rintracciabile nel
nostro paese con l'inchiesta di Mani Pulite che, nel 1992, spazzò via i partiti
della Prima Repubblica. Daniele Zaccaria su Il Dubbio il 19 giugno 2023
È da oltre trent’anni che il romanzo della
politica si intreccia senza soluzione di continuità con quello della giustizia,
un conflitto quasi “ontologico” che ha visto decine di leader, capi di Stato e
di governo finire alla sbarra a ogni latitudine. L’azione dei giudici non sempre
si è rivelata immune da faziosità e pregiudizio, a volte ha ribaltato gli esiti
elettorali e favorito improvvisi cambi di regime, in altri casi è stata
chiaramente persecutoria guidata dall’idea che la magistratura possa in qualche
modo sostituirsi alla stessa politica, sospinta dal giustizialismo dell’opinione
pubblica e dalla grancassa dei processi mediatici.
L’ultimo a finire nel mirino è stato l’ex
presidente Usa Donald Trump, incriminato nei giorni scorsi dalla procura di
Miami con l’accusa di aver trafugato documenti top secret dagli uffici della
Casa Bianca, messo in stato di arresto per diverse ore dal procuratore Jack
Smith che pare seriamente intenzionato a sbatterlo in prigione. «È un sicario
mandato da Joe Biden, è un complotto», ha tuonato il tycoon come al solito
esagerando e passando la misura. Ma che il suo accusatore sia un simpatizzante
dem (la moglie regista è un’amica di Michelle Obama e donatrice del partito) è
un fatto accertato e a suo modo destabilizzante visto che Trump è anche il capo
dell’opposizione repubblicana e rischia di non poter partecipare alle
presidenziali del prossimo anno.
Ma al di là delle storie personali, degli
accanimenti o degli interessi di parte, la rotta di collisione continua tra
toghe ed eletti sembra di natura sistemica, il frutto di una “rivoluzione
culturale” avvenuta negli ultimi decenni che ha allargato in modo significativo
il perimetro di azione della magistratura.
Oggi un intero governo può tranquillamente finire
sotto inchiesta per “strage colposa” come è accaduto all’ex premier Giuseppe
Conte e all’ex ministro Speranza accusati dalla procura di Bergamo addirittura
per le vittime della pandemia di Covid. Va da sé che l’inchiesta è stata
archiviata ma il solo fatto di pensare a un’incriminazione del genere mostra
l’idea estensiva che le procure hanno oggi del proprio potere.
Con un po’ di approssimazione si può dire che
l’epicentro di quel terremoto e cambio di paradigma fu proprio la nostra piccola
Italia con l’inchiesta di Mani Pulite che, nel 1992, spazzò via la prima
repubblica, proiettando procuratori e sostituti sulla ribalta mediatica e
mettendo all’angolo l’intera classe politica, sepolta sotto le macerie dei
partiti. L’onda d’urto di quella stagione ha dato luogo a una vera e propria
saga giudiziaria con lo scontro senza esclusione di colpi tra Silvio Berlusconi
e i pm, una guerra che si è disputata lungo 36 processi penali, con una sola
condanna ai danni Cavaliere, recentemente scomparso.
Che i vecchi equilibri si siano spezzati in
parallelo con la dissoluzione del socialismo reale e del mondo diviso in blocchi
non è stata certo una coincidenza: la fine dell’Unione sovietica ha “stappato”
energie dormienti, innescando nuovi rapporti di potere, mentre l’azione dei
giudici si smarcava progressivamente dalla ragion di Stato e dalle logiche
deterrenti della Guerra Fredda. Italia, Francia, Stati Uniti, Argentina,
Brasile, Perù, Israele, Corea del sud, Pakistan, Sudafrica, sono solo alcune
delle nazioni che hanno visto incriminare e spesso condannare ex presidenti e
capi di governo nell’ultimo trentennio.
Prendiamo un paese simile al nostro per tradizioni
e cultura, la Francia. E iniziamo con un evento traumatico: il suicidio dell’ex
primo ministro socialista Pierre Beregoy, finito al centro
dall’affaire Pechiney-Triangle (uno scandalo finanziario di insider trading),
che si toglie la vita il primo maggio del 1993 sparandosi alla testa con una
pistola che aveva sottratto a un agente della sua scorta.
Beregoy si era sempre dichiarato innocente, entrò
in depressione denunciando l’accanimento nei suoi confronti, in particolare del
giudice Thierry Jean-Pierre che qualche anno dopo si farà eleggere
all’europarlamento per il centrodestra. È invece dichiaratamente di gauche, al
punto da essersi candidata alle presidenziali per i Verdi nel 2012, l’ex
magistrata Eva Joli, titolare dell’inchiesta che ha raggiunto l’ex presidente
Jacques Chirac accusato e poi condannato per abuso d’ufficio, reati che avrebbe
commesso nel periodo in cui è stato sindaco di Parigi, distribuendo posti chiave
agli amici di partito. Dopo il maresciallo Pétain, processato per
collaborazionismo, Chirac è stato il primo ex Capo di Stato francese a subire un
verdetto di condanna.
Un filone che si è allungato nelle inchieste su un
altro ex inquilino dell’Eliseo, Nicolas Sarkozy, condannato in primo grado nel
2012 a tre anni di prigione per corruzione e traffico di influenze per aver
promesso una nomina a un magistrato in cambio di informazioni su un altro filone
di indagine che lo riguarda; l’inchiesta condotta dalla Procura nazionale per i
reati finanziari con metodi «da spioni» per citare il ministro della
giustizia Dupond-Moretti ha visto le accese proteste della difesa che ha
denunciato le intercettazioni illegali delle conversazioni telefoniche tra
Sarkozy e il suo avvocato e le perquisizioni selvagge all’interno degli studi.
Il paese democratico che in assoluto ha visto più
ex presidenti subire una condanna è la corea del sud, almeno cinque dall’inizio
degli anni 90, mentre un sesto, Roh Moo- hyun, si è tolto la vita lanciandosi
nel vuoto prima che iniziasse il processo. Tutti con pene oltre i 20 anni come
ad esempio Park Geun- hye, prima presidente donna del Paese finita alla sbarra
per corruzione e abuso di potere, e poi generalmente graziati dal presidente
successivo.
Un altro caso emblematico in cui il conflitto sta
investendo la natura stessa delle istituzioni, è quello che riguarda il premier
israeliano Benjamin Netanyahu, accusato dai giudici di Tel Aviv di corruzione,
frode e abuso di fiducia, processi ancora in corso. Ritornato al potere lo
scorso anno Netanyahu sta provando a imporre a colpi di maggioranza una riforma
della giustizia che di fatto terrebbe al guinzaglio l’odiata Corte suprema a cui
vuole togliere il diritto di veto sulle leggi e l’autonomia delle nomine.
L’operazione è talmente flagrante che ha scatenato la protesta di milioni di
israeliani scesi in piazza per difendere l’indipendenza dell’alta Corte
dall’esecutivo. E che dire del Brasile, autentica fucina di guerre politico-
giudiziarie, in cui l’attuale presidente Inacio Lula da Silva ha trascorso un
anno e mezzo dietro le sbarre di una prigione federale per delle accuse che si
sono rivelate false?
Le quattro sentenze di condanna a carico di Lula
emesse nel 2017 dal Tribunale di Curitiba sono state annullate nel 2021 dal
Supremo Tribunale Federale. Il giudice che lo aveva incastrato è quel Sergio
Moro che venne poi nominato ministro di giustizia dal successore di Lula e suo
peggior nemico, Jair Bolsonaro. Lo stesso che aveva ammesso di essersi ispirato
al pool milanese di Mani Pulite, in particolare al suo grande amico Pier Camillo
Davigo.
Prima di Lula la scure si era abbattuta sulla
presidente Dilma Rousseff che nel 2015 ha subito un procedimento di
impeachment in seguito all’accusa di aver di aver truccato i dati sul deficit di
bilancio annuale dello Stato, accusa che due anni dopo, quando si era già
dimessa e la sua carriera politica era finita, si è rivelata infondata Ora
invece tocca a Bolsonaro difendersi dalle toghe: appena rientrato in patria dopo
un “esilio” americano di due mesi dovrà affrontare le accuse di aver aizzato gli
assalti ai palazzi del governo compiuti dai suoi seguaci a Brasilia lo scorso 10
gennaio. Avanti il prossimo
Le origini dello strapotere delle toghe
rivelate in “La repubblica giudiziaria” di Ermes Antonucci.
Molti credono che nasca col terremoto di Mani pulite, ma non è così. Frank
Cimini su L'Unità il 6 Giugno 2023
Vale davvero la pena di leggere La Repubblica
Giudiziaria. Una storia della magistratura italiana (Marsilio) frutto del lavoro
di Ermes Antonucci soprattutto per un motivo spiegato nella controcopertina:
“Molti credono che la preminenza della magistratura sulla politica sia stata
innescata dal terremoto provocato da Mani pulite, ma solo un ingenuo può pensare
che questa rottura sia avvenuta all’improvviso”.
“Lo strapotere della magistratura è il risultato
del sommarsi di tensioni tra diverse faglie istituzionali” si spiega. Chi scrive
queste poche righe per invogliare a leggere il libro di Antonucci aggiunge che
tutto comincia con la madre di tutte le emergenze, quella rubricata
con l’etichetta di terrorismo ma che fu in realtà un tentativo di rivoluzione
fallito. Decine di migliaia di persone passate per le carceri rappresentarono un
problema politico che la politica non volle affrontare direttamente delegando la
questione della sovversione interna alla magistratura che ne approfittò per
aumentare il proprio potere e per andare a riscuotere il credito acquisito
nel 1992.
Le leggi premiali utilizzate per risolvere il
problema furono pretese e ottenute dalla magistratura sempre storicamente
interessata alle scorciatoie come poi andrà in epoca successiva con l’utilizzo
smodato delle intercettazioni fino al trojan che continua a fare danni
irreparabili ai diritti dei cittadini. Con le leggi premiali non vale più quello
che un imputato ha fatto ma ciò che pensa delle sue azioni e soprattutto se fa
l’autocritica agli altri.
La catena di Sant’Antonio delle chiamate di correo
finirà per fare danni agli stessi politici in occasione della falsa rivoluzione
di Mani pulite. Quando la politica si suicida abolendo l’immunità parlamentare
sotto la forma dell’autorizzazione a procedere. E con quella scelta la politica
non ha mai voluto fare i conti fino in fondo, salvo lamentarsi che la
magistratura ha un potere eccessivo che esercita tuttora.
Con la differenza che in passato lo faceva
soprattutto svolgendo indagini e ora, quando le conviene, lo fa evitando di
compiere gli accertamenti che sarebbero doverosi secondo il codice. Basta
ricordare il caso di Expo quando l’allora presidente del Consiglio Matteo
Renzi ringraziò la procura di Milano per avere dimostrato responsabilità
istituzionale.
E a questo proposito basta riportare il passaggio
in cui nel libro si ricorda “il lungo percorso culturale, politico e ideologico
di una istituzione divisa fra la fedeltà a valori comuni e visioni della
giustizia contrastanti. In una accurata ricostruzione storica che svela luci e
ombre di un ‘ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere’, la parabola
di un sistema controverso, tra interessi personali e rappresentanza delle
istanze collettive”. Frank Cimini 6 Giugno 2023
Ma la Repubblica giudiziaria nasce prima
di tangentopoli. Nel suo libro, Antonucci spiega che
il potere che hanno ora i magistrati, soprattutto che esercita funzioni
requirenti, ha origini assai lontane. Giovanni Maria Jacobazzi su Il Dubbio il
15 giugno 2023
La Repubblica giudiziaria. Una storia della
magistratura italiana (Marsilio, 288 pp. 19 euro) scritto dal giornalista del
Foglio Ermes Antonucci è il primo libro sulla storia della magistratura nel
periodo repubblicano. «Uno strumento utile per capire le varie tappe che hanno
portato allo strapotere delle toghe», ricorda l'autore che si è cimentato in
questa inedita ricerca storica». «La maggior parte delle persone pensa che la
magistratura abbia sostituto la politica dopo Tangentopoli. Ma non è così. Il
potere che hanno ora i magistrati, soprattutto chi esercita funzioni requirenti,
ha origini lontane», prosegue Antonucci che ha suddiviso il suo libro in
capitoli, uno per ogni decennio, dall'entrata in vigore della Costituzione, agli
anni del terrorismo, alla P2, a Tangentopoli, alle picconate di Cossiga, al
berlusconismo. Grande spazio nel libro hanno, ovviamente, le correnti delle
toghe. Nate come centri di elaborazione culturale, le correnti, sulla carta
delle associazioni di carattere privato, condizionano (vedasi il Palamaragate)
in maniera profonda il Consiglio superiore della magistratura.
Va ricordato che in nessun altro Paese occidentale
esistono, come in Italia, le correnti dei magistrati. «Il primo gruppo
all'interno dell'Anm fu, nel 1957, Terzo potere ( Tp) che sostenne le domande di
cambiamento dei magistrati più giovani contro la struttura gerarchica
dell’ordinamento giudiziario e il sistema di carriera», sottolinea Antonucci.
Per contrastare il progressismo di Tp, nel 1962 nacque Magistratura indipendente
(Mi), la corrente conservatrice, poi in contrapposizione con Magistratura
democratica (Md), nata nel 1964. Md fin da subito influenzerà il dibattito sulla
giustizia dentro e fuori la magistratura. Di Md si ricorda la giurisprudenza
alternativa, fondata su una visione marxista della giustizia come lotta di
classe contro lo Stato borghese. I magistrati di Md ritenevano che il «diritto
avesse natura discrezionale e che la decisione giudiziaria era un atto
politico». L’interpretazione della norma doveva essere a favore della classe
deboli Nel convegno 1971, Giovanni Palombarini, uno dei padri fondatori di Md,
propose il diritto “diseguale' finalizzato proprio ad interpretare le norme per
le classi subalterne.
Era necessario partecipare insieme ai lavoratori
al processo di formazione della coscienza di classe, con l'obiettivo finale di
rovesciare la struttura capitalistica «attraverso l'affermazione dell'egemonia
proletaria nella società, la crisi dell'ideologia dominante e degli apparati
repressivi». Negli anni successivi i collegamenti con i partiti della
sinistra parlamentare ed extraparlamentare si fecero sempre più intensi,
favoriti anche da un diverso atteggiamento del Pci nei confronti della
magistratura a seguito di un ricambio generazionale. Il collegamento
magistratura- politica era fondamentale nel quadro di una strategia unitaria
«per sconfiggere il disegno reazionario e di ristrutturazione neocapitalista”.
Una immagine rende bene il clima di quegli anni. Ed è quella durante i funerali
di Ottorino Pesce, pm romano, toga di Md, morto d'infarto a gennaio del 1970. Al
termine della cerimonia, militanti comunisti e magistrati di Md, fra lo
sventolio delle bandiere rosse, decisero di salutare il feretro con il pugno
chiuso.
Nel 1972 il segretario generale di Md Generoso
Petrella venne eletto in Parlamento nel liste del Pci. Qualche anno più tardi
toccò ad un altro esponente di punta di Md, Luciano Violante, essere eletto,
aprendo così la strada delle toghe che dalle aule di giustizia andavano in
Parlamento con il Pci- Ds- Pds- Pd.
Dopo le
rivelazioni dell'ex Mani Pulite. “Di Pietro propose a Craxi un patto: lasciare
la politica in cambio dell’uscita dall’inchiesta”, la rivelazione di Bobo Craxi.
Aldo Torchiaro su il Riformista il 14 Aprile 2023
Bobo Craxi, ha
letto le parole di Gherardo Colombo? “I politici che avessero accettato di
collaborare e si fossero fatti da parte, rispetto alla vita pubblica, sarebbero
usciti dalle indagini”, ha scritto nel libro che ha pubblicato con Enzo
Carra. Siamo davanti alla prova generale di colpo di Stato? Il potere
giudiziario ha tentato di sopraffare il potere politico e di sostituirvisi. È
nelle carte. Il Procuratore Capo Francesco Saverio Borrelli a un certo punto
uscì allo scoperto. Con un messaggio pubblico rivolto all’allora presidente
della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, fece sapere di essere pronto. “Sono a
disposizione”. Mentre mettevano fuori gioco la classe politica, si candidavano a
sostituirla.
Attuarono un
golpe bianco, e neanche tanto bianco, se pensiamo al “tintinnar di manette”…
C’è stato un
meccanismo preciso con cui il colpo di Stato ha provato ad avere successo:
quando hanno provato ad attuare una “rivoluzione morale”, evocando la piazza,
surriscaldando gli animi. Il sovvertimento può avvenire attraverso le armi, con
la presa del potere militare. Oppure con la politica, come nelle rivoluzioni
gentili. Oppure, ed è una via di mezzo, con l’arma giudiziaria. Una rivoluzione
in parte armata e in parte gentile. Questo meccanismo si palesò ad un certo
punto delle inchieste.
Quale fu la
dinamica?
Fu un’escalation.
La trattativa tra l’accusa e la difesa prima del processo, nella fase
istruttoria, avvenne in un momento in cui la cupola giudiziaria si era arrogata
poteri straordinari. Questo le ha consentito di parlare di politica con i
politici, trascendendo dal ruolo naturale del giudice per ergersi a elemento
regolatore dell’ordine istituzionale. In quella fase mio padre, Bettino Craxi,
incontrò una serie di volte Antonio Di Pietro. In maniera assolutamente
irrituale e informale.
Fu Di Pietro a
chiedergli di incontrarlo?
Sì. In maniera
del tutto extra legem.
Dove?
Mai al Palazzo di
Giustizia, sempre in modo informale, discreto, in territorio neutro. Alla
presenza dell’avvocato di mio padre, Nicolò Amato, senza altri testimoni; non vi
sono eloquenti tracce verbali riprodotte nei processi a suo carico.
Quanti furono
quegli incontri?
Furono una serie.
Almeno tre. Tutti lontano da occhi indiscreti.
In quale fase
dell’indagine di Mani Pulite avvennero?
Nel 1993, prima
del processo Cusani.
Sa cosa si
dissero? Suo padre gliene avrà parlato…
Certo, ne rimase
particolarmente interdetto. Mi ricordo che tra le prime cose mi raccontò di un
Di Pietro diverso da quello che si vedeva in pubblico, più accomodante, perfino
mite. D’altronde i rumori su di lui si erano fatti assordanti.
Cosa gli chiese?
Di Pietro chiese
a mio padre di restituire i denari illecitamente percepiti dal Psi, facendogli
capire che se avesse collaborato con le indagini e fatto un passo indietro
rispetto alla politica, il suo coinvolgimento nell’inchiesta penale sarebbe
finito lì.
Cosa rispose suo
padre?
Lo mandò a
stendere. Per la procedura irrituale, inaccettabile. E per la premessa stessa,
che lo offendeva: i finanziamenti illeciti non finirono mai nella disponibilità
personale di mio padre. Non li aveva lui, non li aveva mai avuti. E dunque non
poté che rifiutare quell’approccio, quell’apertura di trattativa.
Finanziamenti che
pure vi furono, come disse lui stesso alla Camera, in quel discorso del 29
aprile ’93…
Non negó mai la
conoscenza di finanziamenti illeciti. Né tantomeno si è mai negato il suo
utilizzo nella maggioranza dei casi palese anzi palesissimo visto che un partito
nazionale affrontava elezioni a rotta di collo, che le sue strutture
territoriali erano ben evidenti ed altrettanto evidente il collateralismo
politico. Un po’ più occulto era il finanziamento in direzione di partiti o
movimenti politici esteri sovente in lotta per la libertà e la democrazia;
pratica che continuo a considerare ancora molto nobile.
Fece delle
ammissioni, rispetto ai reati contestati, in camera caritatis?
Craxi diede una
serie di elementi di natura sistemica. Come poi fece in pubblico, parlando
quell’ultima volta in Parlamento, chiarì come tutti i partiti avevano pattuito
un finanziamento non lecito, al fine di tenersi in piedi. Lo ribadì anche a Di
Pietro, che però aveva una missione unica: non quella di capire il fenomeno in
generale, ma quella di recuperare quello che definiva “bottino”.
Dal rifiuto di
arrendersi di suo padre nacque la necessità di arrestarlo, di metterlo a tacere
con l’arma delle manette. Iniziò quella che Vittorio Feltri aveva chiamato
“caccia al Cinghialone”, espressione di cui poi si è pentito.
Già, serviva un
trofeo di caccia. E il trofeo più importante da esibire per le carriere di
ciascuno degli attori. Questo accadde più tardi, quando si capì che mio padre
non sarebbe stato al gioco. Quando rifiutò la resa. E allora inforcarono le
armi, provando ad arrestarlo. Siamo dopo il 30 aprile 1993. Ci provò un Pm di
Roma, Misiani. Ne incaricarono un ufficiale di polizia, il maggiore Francesco
D’Agostino, che venne a fare delle incursioni anche ad Hammamet, senza riuscire
a portare a casa il trofeo. Ed è poi finito sotto inchiesta a sua volta…
Torniamo al Di
Pietro della trattativa. Era latore di una direttiva, era parte di una
strategia?
Da parte della
Procura di Milano ci fu una duplice tentazione. Quella di incidere sulla
politica e sulle istituzioni, costituendo una barriera tra il vecchio e il
nuovo, ma anche quella di trovare una onorevole via d’uscita per una inchiesta
che si estendeva a macchia d’olio ogni giorno di più. A un certo punto fu chiaro
agli inquirenti che se avessero applicato con metodo quella indagine a tutti,
partiti, aziende, enti pubblici, si sarebbero dovute celebrare infinite serie di
maxiprocessi.
E provarono a
tirare una riga?
Provarono a
offrire una sorta di indulto coperto per chi avesse accettato di cambiare vita,
rinunciando alla politica. Lo hanno dovuto proporre a tanti, se non a tutti, se
sono arrivati a parlarne perfino con Bettino Craxi.
C’è stato un
precedente giudiziario?
C’è stato
nell’ambito della stessa inchiesta Mani Pulite. Nella prima parte, dal 1992
all’inizio del 1993. La formula aveva funzionato con alcune delle aziende
coinvolte, dove i manager si erano dimessi, avevano collaborato dando
informazioni ed elementi e avevano accettato di ritirarsi e di non proseguire
nelle rispettive carriere, o di andare a vivere per un periodo all’estero. Ci
sono molti casi.
Ma chiedere la
stessa cosa ad un politico eletto democraticamente, ad un rappresentante delle
istituzioni è ben diverso…
Ed emerge oggi in
tutta la sua gravità. Ma all’epoca a quei magistrati doveva sembrare
normalissimo. La classe dirigente viene rimossa quando c’è una rivoluzione o
quando arriva un esercito invasore. Quei giudici si comportarono così: come
rivoluzionari di piazza o meglio, come un esercito armato che conquista la
capitale, entra nei palazzi e spodesta con la forza chi guida le istituzioni.
La politica ha
provato a resistere. Suo padre Bettino non si consegnò mai, da vivo.
Mio padre aveva
un senso delle istituzioni che non gli consentiva di scendere a patti sulla
tenuta democratica, sulla legittimità degli eletti. Denunciò da subito gli
eccessi della barbarie giustizialista.
Il golpe riuscì,
però, in parte.
Sul piano
politico di fatto imposero un ricambio forzato di classe dirigente. Diedero
all’avviso di garanzia la valenza della condanna, impallinando questo e quello
fino a smontare il Parlamento e a distruggere cinque partiti. Quando costrinsero
Scalfaro a sciogliere le Camere si capì che per un verso stavano vincendo loro.
E per altri
versi?
Beh, dal punto di
vista tecnico l’inchiesta Mani Pulite fu un fallimento. Non portò mai ad una
conclusione chiara, accontentandosi di seminare il panico. Alcuni indagati si
suicidarono. Altri se la cavarono con l’abiura. Alcuni processi sono durati
dieci anni e oltre, portando anche a tante assoluzioni.
Aldo Torchiaro.
Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003.
Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.
Facciamo un
gioco. Cosa avremmo detto se a guidare Mani pulite cinfosse stata una junta e
non il pool?
Iuri Maria Prado su L’Inkiesta il 14 Aprile 2023
I protagonisti di
quell’epopea erano dei signori intabarrati di seta nera, le loro ambizioni erano
acclamate dai girotondi e i giornalisti erano embedded. Ma le loro parole
d’ordine erano una pericolosa compromissione dello stato di diritto
Facciamo un
gioco. Siamo sempre negli anni ’90 del secolo scorso e siamo sempre in Italia.
Solo che a convocare i giornali e le televisioni per contestare un provvedimento
legislativo non sono quattro pubblici ministeri in toga, in un Palazzo di
giustizia: ma quattro militari, in divisa, nel piazzale di una caserma. Fuori
c’è la stessa folla, ma appunto non sta sotto al balcone della procura: sta
oltre i cancelli di quella caserma, e urla a quei militari impettiti di far
sognare il popolo onesto mettendo in prigione gli indagati finché non
confessano. I giornalisti sono sempre embedded, ma in fureria anziché in
cancelleria, e da lì quotidianamente riportano le gesta della junta che
ripulisce la società di tutto il marciume che la soffoca. Quello ritratto a
cavallo in una fotografia pubblicata dal magazine del primo quotidiano d’Italia
non è un magistrato del cosiddetto Pool che coordina la cosiddetta inchiesta
Mani Pulite, ma un colonnello, lo stesso che non davanti a un Tribunale, ma
ancora davanti a una caserma, dice che se il presidente della Repubblica lo
chiama per riporre in riga l’Italia corrotta lui si mette a disposizione.
Che cosa si
sarebbe detto a proposito della vicenda in quello scenario trasfigurato? Che
cosa si sarebbe detto se a rendersi protagonisti di quell’epopea non fossero
stati dei signori intabarrati di seta nera, ma un manipolo di soldati in
mimetica, con pistola alla cintola e con i girotondi che ne acclamavano le
ambizioni? Si sarebbe detto probabilmente, e probabilmente con appropriatezza,
che quella era una vicenda di pericolosa compromissione dello Stato di diritto,
e chi avesse denunciato il clima eversivo di quel periodo non sarebbe passato
per una specie di bestemmiatore.
Non fu mai in
discussione, almeno da parte degli osservatori spassionati e giudiziosi, il
lavoro per così dire curricolare di quei magistrati, insomma il fatto che i loro
provvedimenti fossero buoni o cattivi, corretti o sbagliati, legittimi o no. Fu
in discussione, almeno da parte dei pochi che lo denunciarono, il pubblico
straripamento di quel corso giudiziario, il fatto che esso aberrasse in una
pretesa moraleggiante e di riordino sociale che non compete alla magistratura e
che alla magistratura non può essere consentito di esercitare.
Dire, come disse
uno di quei pubblici accusatori, che il compito del magistrato è di «far
rispettare la legge», significa fraintendere la funzione del potere
giurisdizionale e, ciò che è peggio, significa istigare il pubblico a quel
fraintendimento: perché a far rispettare la legge è comandato il poliziotto, o
appunto il militare con funzioni di polizia, non il magistrato, il quale è
chiamato al compito del tutto diverso di applicarla.
Disporsi al
governo del Paese, come fece qualcuno, dopo aver diffidato i partiti politici
dal candidare gente con gli scheletri negli armadi, significa credere che il
potere di arrestare le persone costituisca un’arma diversissima, mentre è solo
succedanea, rispetto al fucile imbracciato dal militare che reclama investitura
civile.
E attenzione. Il
fatto che i protagonisti di quella vicenda, e i tanti che ne celebravano il
comportamento indebito, potessero essere in buona fede, se possibile
aggraverebbe la loro responsabilità. Perché la loro presunzione di operare a fin
di bene avrebbe reso più facile commettere il male che hanno fatto al Paese.
Estratto
da ilfattoquotidiano.it il 6 aprile 2023.
“Negli anni ’90
Draghi ha svenduto l’argenteria del nostro Paese”. Domenico De Masi, ospite de
La Confessione di Peter Gomez, [...] ripercorre la storia dell’Iri, l’Istituto
per la ricostruzione industriale [...].
[...] Dal punto di
vista storico [...], secondo De Masi, “l’Iri era una bestemmia economica. Non
solo molte aziende erano di Stato, non solo l’80% delle banche erano di Stato,
ma c’era il più grande partito comunista d’Occidente. Quindi, l’Italia era
un’eresia, non solo in Europa, ma in tutto l’Occidente”.
E cosa accadde
quindi? Qui il sociologo colloca l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi
[...]. “Fu mandato un giovane economista, un brillantissimo italiano, che aveva
studiato al Mit, si era specializzato lì, fior fiore del neoliberismo. – ha
spiegato De Masi – Fu mandato lì dal ’91 al 2001.
Per dieci anni fu il
segretario generale del ministero del Tesoro, poi presidente della Commissione
per le privatizzazioni. Il 2 giugno del 1992 arrivò a Civitavecchia il Britannia
della regina Elisabetta con sopra il fior fiore dei finanzieri mondiali. – ha
proseguito lo studioso –Il nostro giovane segretario generale del Tesoro salì
sullo yacht, fece un discorso bellissimo in cui in sintesi disse: ‘Avete
l’argenteria del nostro Paese a vostra disposizione. Approfittatene‘.
L’astuzia di questo
giovane, che io ammiro proprio per la sua astuzia quasi luciferina, è che fece
fare la cosa più di destra, cioè le privatizzazioni, a quattro governi di
sinistra: il governo Amato, due governi D’Alema, un governo Prodi”, ha concluso
De Masi.
La vittima
dimenticata del pool. Riccardo Misasi fu vittima del pool, così fu fatto fuori.
Ilario Ammendolia su Il Riformista l’11 Aprile 2023
Il Riformista ha
riportato a tutta pagina la notizia secondo cui la cosiddetta stagione di “Mani
pulite” fu in realtà un golpe. A svelare ciò non sono gli archivi dei servizi
segreti ma lo si deduce dalla prefazione dell’ex pm Gherardo Colombo al libro
dell’on. Enzo Carra. La tesi mi sembra suggestiva e bisognerebbe trovare “prove”
significative su tutto il territorio nazionale. Mi è capitato di riflettere su
ciò che in quegli anni successe in Calabria ed in particolare sulla storia
dell’uomo politico più importante di quel momento storico: l’on. Riccardo
Misasi.
Un politico
intelligente, brillante e potentissimo che occupò incarichi nazionali importanti
come quello di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ministro alla Pubblica istruzione e sottosegretario alla Giustizia. Per oltre
trenta anni Misasi fu parlamentare della Repubblica eletto in Calabria con
vagonate di voti. Nelle elezioni del 1968 affrontò la “concorrenza” manciniana
da sottosegretario alla Giustizia e sembra che proprio in quel periodo molti
detenuti siano stati messi in libertà provvisoria. Potrebbe essere questa una
cattiveria della stampa di estrema sinistra di allora o dei partiti concorrenti
ma quello che è certo che le basi strategiche di quella campagna
elettorale di Misasi furono appunto i tribunali disseminati in tutto il
territorio calabrese nei quali il sottosegretario alla Giustizia incontrava
magistrati, forze dell’ordine e capi elettori.
È superfluo
aggiungere che molti tra quest’ultimi non erano proprio degli stinchi di santo.
La storia corre veloce e i rapporti di forza cambiano radicalmente con l’arrivo
della stagione di “mani pulite” tanto che nel giro di qualche mese avviene la
trasfigurazione di Misasi che da uomo politico più potente della Calabria si
trasforma in preda inseguita dai “segugi” e su cui le procure aprono un fuoco
concentrico. Quello che era stato un intoccabile diventa un malfattore. Viene
chiesta l’autorizzazione a procedere per associazione a delinquere di stampo
mafioso, gli viene arrestato un figlio, viene indagato come capo del sistema
delle tangenti in Calabria e addirittura indicato come mandante dell’omicidio
dell’ex presidente delle Ferrovie dello Stato, on.Vico Ligato. Misasi è ancora
parlamentare, la Camera con l’astensione del Pds nega l’autorizzazione ma è
ormai un uomo braccato. Il 17 marzo del 1993 Misasi rilascia un’intervista al
giornalista del Corriere della Sera Paolo Graldi che viene pubblicata col titolo
“Don Riccardo in lacrime”.
Il “don” richiama
quello di don Calò registrato all’anagrafe come Calogero Vizzini capo della
mafia siciliana e non era stato affatto stato messo a caso. Molti magistrati,
già alleati e subalterni al potere democristiano, assunsero su di loro il
compito si seppellire il cadavere politico di don Riccardo che piange a dirotto
e quelle lacrime non erano un segnale di umana debolezza ma di resa
politica. Misasi conosceva molto quel mondo torbido già subalterno al potente
ministro calabrese e affamato di potere che dominava nei tribunali e comprendeva
che, anche se innocente, per sfuggire alle accuse che gli venivano mosse, le
“lacrime” sarebbero state il viatico del “perdono”.
E perdono è
stato! Doveva piangere ed ha pianto perché Lui sapeva meglio d’ogni altro di
cosa sarebbe stato capace quel “potere” di cui era stato sicuro punto di
riferimento. Così Misasi si allontanò dalla politica e dalla Calabria e per
rendere plastico il suo disinteresse per le vicende calabresi scrisse un bel
libro sulla storia di Orvieto. Non della Calabria e non di Cosenza ma
di Orvieto. Un libro che oggi potrebbe apparire come un messaggio in bottiglia
che venne subito “apprezzato” e recepito perché scritto con il linguaggio che i
poteri utilizzano parlando fra di loro, soprattutto in Calabria. Misasi cede il
posto che, nel bene e nel male, era frutto d’un consenso popolare che gli
consentiva di essere protagonista sulla scena nazionale.
Ilario Ammendolia
I veri
obiettivi e la regia internazionale. Tangentopoli fu eversione: partiti
distrutti, beni svenduti.
Fabrizio
Cicchitto su Il Riformista l’11 Aprile 2023
Come ha già messo
in evidenza Il Riformista con la sua prima pagina del 5 Aprile dedicata al
sostanziale colpo di Stato avvenuto in Italia attraverso Mani Pulite, quasi
tutte le vicende giudiziarie di maggior rilievo avvenute in Italia in questi 30
anni, hanno un forte rilievostorico-politico. In questo quadro è stato del tutto
fuorviante e paradossale che da parte di Di Pietro, Colombo e Davigo ci sia
stata la tendenza a ridurre in una sorta di grottesca partita a guardie e ladri
sminuzzate in tante vicende processuali la storia di Mani Pulite del
‘92-’94 attraverso la quale proprio loro hanno addirittura provocato un totale
rivolgimento del sistema politico italiano con la distruzione di ben 5 partiti
fondamentali nella vita politica italiana.
Il fatto è che
tutta la storia del finanziamento irregolare dei partiti non può essere
banalizzata sotto la fattispecie della corruzione individuale come purtroppo ha
fatto anche Luigi Zanda nella sua peraltro interessante intervista resa
al Riformista. È avvenuto invece qualcosa di molto rilevante non appena
fra l’89 e il ‘91 è finito il pericolo comunista. Allora in Italia i cosiddetti
poteri forti, cioè quelli che detengono il potere finanziario e editoriale hanno
valutato che i partiti non servivano più e anzi, poiché la Dc e il Psi erano i
proprietari di fatto delle industrie a partecipazioni statali che invece
dovevano essere smantellate e privatizzati a prezzi stracciati, allora proprio
questi partiti (e quindi il loro leader Craxi, Andreotti, Forlani, andavano
messi fuori gioco). Prima che l’operazione partisse, Cuccia fece,
tramite Salvatore Ligresti, l’offerta a Craxi di prendere la guida della
operazione neogollista, presidenzialista, antipartitocratica. Craxi rifiutò di
svolgere questo ruolo, ritenendo che i partiti rimanevano un elemento essenziale
per la democrazia italiana.
Allora, stando a
quanto ha raccontato Massimo Pini, amico e biografo del leader socialista,
quando Cuccia seppe che Craxi respingeva l’ipotesi di svolgere quel ruolo
affermo’: “Peccato, era la sua ultima occasione”. Così nello spazio di un anno e
mezzo Craxi da candidato a premier divenne “il cinghialone”, da braccare e
sbranare. L’antipolitica, il populismo, l’antiparlamentarismo nascono da lì,
altro che quegli untorelli dei grillini, arrivati molto dopo che molte cose
erano già accadute. A quel punto dai poteri forti venne un input che arrivò ai
magistrati di Milano, cuore del potere economico ai quattro giornali
fondamentali, alle tv, in primo luogo quelle di Berlusconi che pensava così di
mettersi al riparo: e infatti nel ‘92-’93 il Cavaliere non fu neanche sfiorato
da un avviso di garanzia ma l’uragano è arrivato dopo, quando egli ha deciso di
scendere in politica.
Non è che
precedentemente fino ad allora magistrati e giornalisti non sapessero niente:
fra l’altro dagli anni Cinquanta in poi don Sturzo ed Ernesto Rossi avevano
riempito giornali e pubblicato libri in cui parlavano dei finanziamenti
irregolari dei partiti. Né i magistrati né gran parte dei giornalisti accolsero
allora quelle denunce perché, a monte di tutto il finanziamento irregolare dei
partiti, c’era la divisione del mondo in due blocchi. Ora in Italia De
Gasperi e Togliatti esclusero che lo scontro fra i partiti filo-occidentali e
il Pci potesse finire con una guerra civile. Di conseguenza tutti sapevano come
era combinato il finanziamento irregolare della Dc (a partire dalla Cia fino ai
soldi provenienti dal “Quarto partito” di carattere confindustriale) e quella
del Pci (a partire dal KGB, alle società di import-export alle cooperative
rosse). Invece, finito il pericolo comunista, la musica cambiò totalmente. Ad
opera del pool di Mani Pulite, dei quattro principali giornali, delle
televisioni, la denuncia del finanziamento irregolare fu il grimaldello per far
saltare il sistema politico e per realizzare l’operazione rivoluzionaria-
eversiva di cui ha parlato Il Riformista qualche giorno fa.
A un certo punto
si pensò anche, come risulta da una dichiarazione del procuratore
generale Borrelli, che il presidente della Repubblica Scalfaro potesse dare ai
magistrati anche una diretta investitura politica. Questa operazione però
risultò impraticabile e allora il pool ebbe bisogno di un “braccio
politico” identificato nel Pds e nella sinistra democristiana. All’interno del
Pds i miglioristi sostenevano l’alleanza o addirittura l’unità socialista con il
Psi per lanciare un’alternativa riformista. I “ragazzi di Berlinguer” che
avevano la maggioranza del partito scartarono però quell’ipotesi sia perché essi
erano stati allevati dallo stesso Berlinguer all’antisocialismo e
all’anticraxismo sia perché essi erano terrorizzati dalla possibilità di finire
che anch’essi sotto il tritacarne del pool visto che il Pci-Pds aveva il
finanziamento più irregolare di tutti i partiti. Così, a quel punto, rivelatosi
del tutto velleitario, il sogno di Occhetto di fuoriuscire da sinistra dal
comunismo reale cavalcando l’ingraismo, in nome della Real Politik, sia pure con
sfumature diverse, D’Alema e Veltroni fecero del Pds il “braccio politico” delle
procure e dei poteri forti.
Il
cosiddetto “governismo” del Pds e poi del Pd nasce da qui, da questa piena
subalternità ad alcune procure e ad alcuni poteri, venendo ripagato con una
totale impunità (limitata al nucleo ristretto del gruppo dirigente del vertice
del partito, non certo da un inesistente neo liberismo). Così al centro Nord il
circo mediatico giudiziario penetrò come un coltello nel burro delle imprese
comprese le cooperative, dei partiti e delle loro correnti mentre a loro volta
Fiat e Debenedetti contrattarono un compromesso fondato su lettere che
contenevano parziali confessioni, profonde genuflessioni al pool (vedi le
lettere di Romiti e di Debenedetti) ricambiate con il sostanziale salvataggio
del sistema Fiat, di quello Mediobanca, di quello Cir, di una parte di
quello Iri (Prodi) e di quello Eni (Bernabè), mentre interi settori industriali
come l’edilizia e la farmaceutica e Gardini venivano massacrati.
Invece ben altra
musica è stata suonata in Sicilia. Il fascicolo mafia-appalti messo insieme dal
Ros di Mori, De Donno e altri (che per questo sono stati perseguitati nel corso
di almeno 20 anni), qualora fosse stato tradotto in indagini giudiziarie del
tipo di quelle svolte al Nord, avrebbe messo allo scoperto la versione siciliana
di Tangentopoli diversa da quella esistente nel settentrione del Paese. Infatti,
mentre al Nord il sistema di Tangentopoli riguardava questi soggetti: le
imprese, comprese le cooperative, le istituzioni locali e nazionali, i partiti,
in Sicilia il sistema aveva un altro soggetto, un convitato di pietra costituito
dalla mafia. Ebbene, lì, prima la strage di Capaci e poi quella di Borsellino a
via d’Amelio hanno avuto questo obiettivo di fondo: liquidare sul nascere una
versione siciliana di Mani Pulite.
Tutto si è svolto
con agghiacciante rapidità. Cosi non appena la mafia ha liquidato il principale
pericolo rimasto su pizza dopo Falcone costituito da Paolo Borsellino, subito il
procuratore Giammanco, con la controfirma di Scarpinato, ha archiviato le
indagini sul filone mafia-appalti. Ovviamente, avendo questo retroterra, il
processo Borsellino è stato depistato ad opera in primis del questore La
Barbera, ma per ben altre ragioni di quelle citate nelle motivazioni del
processo che parlano dell’obiettivo di un avanzamento di carriera. La Barbera
non aveva problemi di carriera tant’è che lo ritroviamo qualche anno dopo al G8
di Genova come punta di diamante del capo della polizia De Gennaro. Come si
vede, quindi, le cose presentano aspetti assai seri che vanno molto al di là
delle mistificazioni orchestrate da alcuni gestori di talk show che concentrano
la loro attenzione sul dito e non sulla luna. Fabrizio Cicchitto
Come nasce Mani
Pulite. Tutte le tappe di Tangentopoli: dall’arresto di Mario Chiesa alle
elezioni del ’94.
Redazione su Il
Riformista il 5 Aprile 2023
17 febbraio 1992 –
Il giorno dell’arresto di Mario Chiesa, presidente della casa di cura Pio
Albergo Trivulzio di Milano ed esponente del Partito socialista italiano. A
breve ci sarebbero state le elezioni e il segretario del Psi Bettino Craxi nega
l’esistenza di pratiche e condotte fraudolente all’interno del suo partito.
5 e 6 aprile 1992
– L’Italia va al voto. Alta l’astensione, in calo i democristiani, che restano
comunque il primo partito, stabile il Psi. La rivelazione è la Lega, partito
nascente che accusa il “governo ladro” di Roma. Gli avvisi di garanzia arrivano
a Carlo Tognoli e a Paolo Pillitteri, ex sindaco e sindaco in quel momento di
Milano, tutti e due socialisti. Il 12 maggio è il turno di Severino Citaristi,
tesoriere della Dc. Il 16 maggio viene arrestato il segretario milanese
Pds, Roberto Cappellini. L’inchiesta prende ufficialmente il nome di Mani
Pulite.
23 maggio 1992 –
Strage di Capaci, sono uccisi il giudice Giovanni Falcone con la
moglie Francesca Morvillo e tre agenti di scorta.
25 maggio
1992 – Oscar Luigi Scalfaro eletto presidente della Repubblica.
28 giugno 1992 – Si
insedia il governo Amato I: il 49esimo esecutivo della Repubblica Italiana e
primo dell’XI legislatura.
23 agosto 1992 –
Craxi comincia su l’Avanti! i corsivi contro Mani Pulite e preannuncia un
dossier su Di Pietro.
2 settembre 1992
– Si uccide il parlamentare socialista Sergio Moroni, coinvolto nelle indagini.
Uomo vicino a Craxi, prima del suicidio lascia una lettera a Napolitano che la
legge in aula. Il segretario del Psi attacca la magistratura e la stampa. Il 15
dicembre Craxi riceve un avviso di garanzia, accusato per la tangente Enimont,
che lo porta a dimettersi l’11 febbraio 1993.
5 marzo 1993 –
Palazzo Chigi vara il Decreto Conso che prevede la depenalizzazione del
finanziamento illecito ai partiti. Il capo dello Stato Luigi Scalfaro si rifiuta
di firmare e il decreto viene ritirato.
21 aprile 1993 – Il
governo Amato si dimette e una settimana dopo nasce l’esecutivo guidato da Carlo
Azeglio Ciampi, il primo non politico alla guida dell’Italia repubblicana.
29 aprile 1993 – Il
Parlamento vota contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Craxi. Si
scatenano proteste in tutta Italia. Rimane nella storia dei linciaggi, il lancio
di monetine contro Craxi mentre esce dall’Hotel Raphael di Roma. Una delle
pagine più buie.
20 luglio
1993 – Gabriele Cagliari, presidente Eni precedentemente arrestato, si suicida.
Tre giorni dopo, venerdì 23, si toglie la vita anche Raul Gardini, presidente
del gruppo Ferruzzi-Montedison, informato dal suo avvocato dell’avvio delle
indagini su di lui. Vengono successivamente arrestati l’ad di Montedison Carlo
Sama e il manager Sergio Cusani, consulente finanziario di Gardini accusato di
falso in bilancio e di violazione alla legge sul finanziamento dei partiti.
17 dicembre 1993 –
Nell’ambito del processo Cusani si tiene l’interrogatorio pubblico di Bettino
Craxi e dell’ex presidente del Consiglio Arnaldo Forlani.
1994 Elezioni
politiche – È la prima volta in cui il popolo italiano vota senza il simbolo
della Democrazia Cristiana sulla scheda. La stessa tornata elettorale è
caratterizzata dalla discesa in politica di Silvio Berlusconi annunciata il 26
gennaio di quell’anno.
La scalata della
magistratura. Mani Pulite non fu una rivoluzione ma guerra civile: le verità di
Facci.
Paolo Liguori su Il Riformista il 6 Luglio 2022
Guerra dunque,
non rivoluzione, quella di Mani Pulite. Nessuna rivoluzione. Perché tutto nel
potere giudiziario è rimasto come prima, anzi tra i rapporti tra i poteri,
secondo il racconto che ne ha fatto Palamara, sono diventati ancora più confusi
e torbidi. Quanto è stato scritto, detto, spiegato sull’epopea di Mani Pulite e
i suoi protagonisti? Moltissimo, anche troppo. Sembra niente, a leggere il libro
di Filippo Facci dedicato al tema.
“La Guerra dei
Trent’anni” è il titolo e fa impressione per la scelta, il volume, la densità
dei fatti narrati, la ridefinizione dei personaggi. Stiamo parlando di
un’enciclopedia, di un lavoro monumentale, perfino sorprendente da parte di un
giornalista, vista l’abitudine della categoria a scrivere instant-book, opere
veloci, dedicate ad un singolo argomento, superficiali. In questo caso, si
perdoni il paragone forte e irriverente, il contenuto ricorda più alcuni libri
di Montanelli, che però scriveva in collaborazione con Gervaso e poi con Biazzi
Vergani e Mario Cervi.
Filippo Facci, uno
dei giornalisti più eclettici, ma apparentemente disordinati, ha fatto tutto da
solo, anche per evidente mancanza di sodali. Ed ha scritto la sua Storia (di
questo si tratta) con un lavoro impressionante di ricostruzione di fatti,
dettagli e persone. Non abbiate paura della mole di informazioni, vale la pena
prendersi il tempo per leggere 7oo pagine scritte bene, anche per rendere
omaggio all’autore che solo per le note divise per anno dal 1992, le fonti e
l’indice dei nomi, pur con l’aiuto del computer non può averci messo meno di un
mese. Come nella prima metà del ‘600 (1618-1648), una delle guerre più
sanguinose si concluse con un riequilibrio precario dei poteri tra principi
protestanti impero cattolico, così Mani Pulite viene definita da Facci
una Guerra Civile tra i poteri dello Stato. Ma tanti cambiamenti significativi
ci furono eccome: «la magistratura debordò e le Procure si attribuirono un ruolo
di potere assoluto, l’informazione debordò e se ne attribuì un altro, l’opinione
pubblica debordò di conseguenza».
Facci ha
scandagliato tutte le crepe di quel terremoto, senza risparmiare nessuno, sulla
base dell’archivio del proprio lavoro di giornalista e collaboratore
dell’Avanti. E l’aspetto più interessante è proprio quello che riguarda
l’informazione, qui descritta con una lapidaria e assolutamente vera citazione
di Indro Montanelli: «Gli storici avranno un serio problema. Non potranno
attingere da giornali e telegiornali, perché i cronisti durante Tangentopoli
hanno seguito il vento che tirava, il soffio della piazza. Volevano il rogo e si
sono macchiati di un’infame abdicazione di fronte al potere della folla».
Per chi, come me, ha
vissuto nel fuoco delle polemiche quei primi anni, dalla direzione del Giorno, è
una citazione da sottoscrivere senza riserve. E Facci ha il merito, con un lungo
e certosino lavoro, di ricostruire una base di verità. Intanto, è l’unico, con
una tesi inedita a mostrare come questa guerra di poteri inizia in Sicilia,
prima che a Milano. E poi ripercorre la scalata delle Procure con minuziosa
attenzione. Senza Facci, risulta poco spiegabile l’ascesa del modesto Palamara
ai vertici di Csm e Anm.
Significativa la
citazione di Piercamillo Davigo in una delle sue battute: «Con la Riforma, vi
aspettavate Perry Mason e invece è spuntato Di Pietro». Di Pietro come simbolo
ha funzionato per qualche anno, finché non si è schiantato in politica, ma
intanto la Guerra dei Trent’anni continuava, proprio come quella reale: e
gli Slovacchi e i Danesi e gli Svedesi e i Francesi. Gli episodi ricostruiti da
Facci sono decine e affrontano la questione più interessante: il silenzio o,
peggio, le menzogne interessate e servili dell’informazione. Per ogni episodio,
potrete facilmente confrontare la ricostruzione di Facci con quanto credevate di
conoscere e capirete.
Ma, tra tutti, un
episodio vale la pena di citare, giudicato “minore” per il protagonista, ma per
me gravissimo, perché si tratta di un suicidio e di una persona che ho
conosciuto: Renato Amorese, segretario del Psi di Lodi. Fu accusato falsamente
sui giornali di aver preso una tangente di 400 milioni, si trattava di
tutt’altro e Di Pietro faceva pressione per costringerlo a coinvolgere
l’architetto Claudio Dini. Lui non resse e si uccise.
Scrive Facci, in
sintesi: «Pareva complicata, ma era semplice. Renato Amorese, pur da morto, era
divenuto la chiave per tenere in galera Claudio Dini. La dinamica era
raggelante: Di Pietro aveva dato la notizia (falsa) secondo la quale Amorese era
un semplice teste e non indagato; venti giorni dopo aveva dato la notizia
(falsa) del ritrovamento di 400 milioni nelle cassette, mentre nello stesso
giorno i giornali davano la notizia (falsa) dell’apertura delle cassette che in
realtà erano ancora sigillate. E quei soldi, neppure trovati, erano diventati la
giustificazione di un suicidio. Le cassette di sicurezza di Amorese vennero
aperte il 16 e il 23 luglio, ma i soldi non c’erano. La notizia non comparve sui
giornali. Neanche sul Corriere della Sera, che pure aveva scritto in prima
pagina il contrario». “Mani Pulite, vite spezzate”, titolò il Giorno, dopo il
suicidio di Primo Moroni. Filippo Facci spiega bene anche il senso di quel
titolo. Paolo Liguori
Tangentopoli fu
un colpo di Stato fatto dai Pm.
Piero Sansonetti su
Il Riformista il 16 Febbraio 2022
Il 17 febbraio del
1992 – domani sono trent’anni – fu arrestato Mario Chiesa, socialista milanese,
e iniziò la sconvolgente avventura di mani Pulite. Un piccolo gruppo di Pm,
spalleggiati da un Gip, guidati dal Procuratore Francesco Saverio
Borrelli, impiegarono circa un anno di lavoro per smantellare la prima
Repubblica, frenare lo sviluppo economico del paese, annientare i vecchi partiti
e i loro riferimenti sociali e acquistare un enorme potere, mettendo in scacco
il Parlamento, il governo, l’opinione pubblica, sorretti dall’appoggio pieno e
incondizionato di quasi tutti i giornali e le televisioni.
In un tempo
piuttosto rapido furono eliminati prima i leader di secondo piano dei partiti,
poi i loro massimi esponenti. L’obiettivo numero 1 era Bettino Craxi, perché lui
era considerato, giustamente, il più robusto e indipendente dei capi della
politica italiana.
Craxi aveva due
difetti considerati imperdonabili: credeva nel socialismo democratico e credeva
nell’autonomia della politica. Erano quelli i nemici. Il pool dei Pm agì
velocemente e in appena due anni rase al suolo tutto l’impianto della democrazia
italiana. Braccò Craxi, lo costrinse ad espatriare e poi fece in modo che
morisse, in Tunisia, senza poter rientrare a curarsi in Italia. Ci furono
migliaia di arresti, molti poi risultarono innocenti. Alcuni suicidi. Morti in
carcere.
Il risultato? Lo
vediamo oggi, la politica si è arresa senza condizioni. È nata la repubblica
giudiziaria nella quale tutti viviamo e nella quale il potere delle Procure è
praticamente assoluto. L’economia italiana, che era la più fiorente d’Europa e
aveva portato l’Italia al quarto posto tra le potenze economiche del mondo, si è
accartocciata su se stessa. Hanno pagato soprattutto i poveri. Sia in termini
economici sia di perdita della libertà.
Oggi non sappiamo
neppure se esiste la possibilità di reagire. E sappiamo che, certo, viviamo
ancora in un regime democratico, ma che ha divorziato dallo stato di diritto.
Piero Sansonetti.
Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di
cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004
al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per
poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre
2019.
Una rivoluzione
che impose lo Stato etico. Da chi era composto il pool di Mani Pulite, i
paladini del bene contro i politici corrotti.
Tiziana Maiolo su Il
Riformista il 16 Febbraio 2022
Francesco Saverio
Borrelli – L’aristocratico feroce
L’unica volta in cui
il Procuratore capo di Milano degli anni di mani Pulite si era veramente offeso,
fu quando l’avevo descritto in un articolo come persona per bene ma scialba, una
sorta di omino “in grigio”. Era prima di Tangentopoli e lui appariva così, in
ufficio o alla prima della Scala. Ma aveva ragione a non riconoscersi in quella
definizione, perché “dopo” si manifestò completamente diverso. E divenne colui
che non arrossiva nel dire: «Ma in fin dei conti è proprio così scandaloso
chiedersi se lo choc della carcerazione preventiva non abbia prodotto dei
risultati positivi nella ricerca della verità?».
Se poi questo tipo
di choc abbia lasciato sul campo morti e feriti, fa parte del gioco per cui il
fine giustifica sempre il mezzo. E non si versa mai una lacrima per i 40 e più
morti suicidi di Tangentopoli, così come il non consentire a Bettino Craxi di
venire a curarsi e farsi operare a Milano, e lasciarlo morire esule. E poi
assumere il ruolo di capo dell’opposizione politica al leader che non piace,
Silvio Berlusconi. Prima consigliargli di non candidarsi in presenza di
“scheletri nell’armadio”, e poi offrire se stesso al presidente Scalfaro per
governare l’Italia “come servizio di complemento”. E infine passare dal vero
corpo a corpo con il nemico di sempre con quel “resistere, resistere” gridato
con il piglio del capopopolo nell’aula magna del Palazzo di giustizia, fino al
melanconico addio politico della sconfitta, quando chiede «scusa per il disastro
seguito a Mani Pulite. Non valeva la pena di buttare all’aria il mondo
precedente per cascare poi in quello attuale».
Piercamillo Davigo –
Sottile? Macché
Di sottile, colui
che fu indebitamente definito “dottor sottile” (mentre era piuttosto uno bravo
ad “aggiustare”) dai soliti giornalisti laudatores, non ha mai mostrato neppure
l’ombra. Al contrario è sempre stato piuttosto muscolare nelle sue apparizioni
pubbliche, manifestando senza timore la sua cultura da Santa Inquisizione, a
disagio con le regole e le procedure. Cosa che ha dimostrato anche di recente.
Era quello non di sinistra del pool, ma non meno politico degli altri.
Fin da quando parlò
della necessità di “rivoltare l’Italia come un calzino” e poi stese il testo
(pare sia stato proprio lui) di quella clamorosa protesta del gruppetto che andò
in televisione a protestare contro un provvedimento del governo, il
famoso “decreto Biondi” sulla custodia cautelare. Teorizzò il proprio diritto
all’”obiezione di coscienza” quando “vengono toccati i fondamenti etici del mio
mestiere”. In che cosa consiste la sua etica? Nel teorizzare che l’indagato A
non esce dal carcere finché non denuncia B e C, i quali a loro volta devono
denunciare altri. Tutti in galera. Ci dicono che arrestiamo troppo? La verità è
che qui si scarcera troppo, disse un giorno. Può tornare a essere libero solo
chi fa i nomi di altri, perché “diventa inaffidabile per il sistema del
malaffare”. Sottile?
Gherardo Colombo –
Fonzie tormentato
Proprio come Fonzie,
non riesce a dire “ho sbagliato”. Nel suo percorso di oggi, che lo ha portato a
capire l’inutilità del carcere e persino l’eccesso dell’intervento penale su
problemi sociali o economici, c’è un abisso di vuoto di memoria su quel che lui
stesso ha detto e fatto negli anni di Mani Pulite. Proprio sull’uso del carcere.
Non riesce, come Fonzie, a dire più di “ho sb..”, anzi neanche quello. Fa fatica
persino a riconoscere le palesi violazioni di legge, come quella, per esempio,
sulla predeterminazione del giudice naturale e la competenza territoriale. Pure
lo sapeva di essere fuori legge, quando, in una discussione con il suo
amico Francesco Misiani, pm a Roma che gli contestava «..e poi non è che ogni
volta possiamo fare finta che non esistano il codice e le regole sulla
competenza..», rispondeva disinvoltamente «…se esiste una sola possibilità di
arrivare in fondo a Tangentopoli, questa possibilità ce l’abbiamo noi».
E intanto il pool di
Milano teneva in carcere l’ex ministro Clelio Darida e il presidente
dell’Iri Franco Nobili, che saranno in seguito assolti, quando le inchieste in
cui erano imputati saranno tornate all’alveo della competenza territoriale, cioè
a Roma. Una certa spregiudicatezza Gherardo Colombo la ebbe ancora, in due
diverse circostanze. Quando mandò i finanzieri in Parlamento per sequestrare i
bilanci del Psi, grave sgrammaticatura istituzionale, come disse uno
scandalizzato Giorgio Napolitano, cosa di cui il procuratore Borrelli fu
costretto a scusarsi (lui sì). Non sapeva neanche che i bilanci dei partiti sono
pubblici? E ancora quando –erano ormai passati tremila giorni
da Tangentopoli e Mani pulite– tirò un vero siluro politico e affossò la
Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema con un’intervista sparata a tutta
pagina dalla prima del Corriere, in cui denunciava “Le riforme ispirate dalla
società del ricatto”. E raccontava la storia d’Italia come storia criminale. Le
riforme morirono allora, mille giorni dopo Mani Pulite. Per mano di uno che oggi
non crede più neanche nell’uso del diritto penale come soluzione dei problemi
sociali.
Tiziana Parenti –
L’intrusa
L’intrusa era
l’ultima arrivata, veniva da Genova e pareva, a occhio, una di sinistra. Forse
per quello fu accolta nel pool e le fu affidato il filone che avrebbe potuto
(non necessariamente dovuto) portare al Pci-Pds. Nessuno aveva fatto i conti con
la caparbietà di Tiziana Parenti. La sua storia nel gruppo di Mani Pulite
comincia e finisce con un’informazione di garanzia che la giovane pm osò inviare
all’amministratore del Pds, il senatore Marcello Stefanini. Quel che era parso
normale finché si erano turbati i sonni dei dirigenti della Dc e del Psi,
provocò il terremoto quando si arrivò a toccare il partito
di D’Alema e Occhetto. Il partito gridò alla “strategia della tensione”.
Ma nel frattempo
a Milano due pezzi da novanta come Maurizio Prada, tesoriere della Dc e Luigi
Carnevale, che svolgeva lo stesso ruolo nel Pci, avevano rivelato con molta
precisione il sistema della spartizione delle tangenti fra i tre principali
partiti, Dc, Psi e Pci, sulle grandi opere. Come finì? Con il famoso intervento
del procuratore D’Ambrosio in favore di Primo Greganti e con la cacciata di
Tiziana Parenti dal pool in quanto “fuori linea”. L’anno dopo la pm entrò in
politica, candidata in Forza Italia. E oggi svolge, felicemente, il ruolo di
avvocato a Roma.
Francesco Greco – Il
rivoluzionario pigro
Uno scritto in cui
lo avevo definito “frivolo” ( l’introduzione al libretto di Giancarlo
Lehner “Borrelli, autobiografia di un inquisitore”) aveva suscitato l’interesse
di Bettino Craxi, che da Hammamet mi aveva mandato un messaggio, dicendosi
interessato a capirne il significato. La prevista telefonata poi non ci fu,
diversamente gli avrei spiegato che a mio parere Francesco Greco era
semplicemente diventato magistrato un po’ per caso. Così ne parlava il suo (ex)
amico Francesco Misiani: «Francesco, come molti di noi, invitava nei congressi
all’abbattimento dello Stato borghese..». La toga indossata per caso, ma poi il
mancato rivoluzionario, quello delle riunioni “del mercoledi” con Primo Moroni,
il libraio più trasgressivo d’Italia, ha finito per prenderci gusto proprio con
Mani Pulite, arrivando a definire quello il periodo “più bello della mia vita” .
Sarà anche stato
bello, ma qualcosa di brutto ci fu, quando lui stese quella relazione di
servizio con cui mandò il suo amico di Magistratura Democratica, il suo maestro
e mentore Francesco Misiani davanti al plotone del Csm a farlo processare per
incompatibilità ambientale a causa della sua amicizia con il procuratore di
Roma Renato Squillante. È strano che questo magistrato per caso sia poi
diventato lui stesso il capo della procura più famosa d’Italia. E che
l’incendiario sia diventato più che pompiere. Con tutto quel che ne segue, fino
all’inchiesta dei magistrati di Brescia sulla procura ormai la più disastrata
d’Italia e lo stesso Greco in pensione con una finale di carriera non proprio
brillante.
Gerardo D’Ambrosio –
Soccorso rosso
Era stato per tutti
noi cronisti giudiziari lo “zio Gerri”, il simpatico bonario giudice istruttore
di Piazza Fontana e della morte di Pino Pinelli, inchiesta chiusa con qualche
nostra delusione. Poi in Procura, nella veste di vice di Borrelli, divenne il
militante difensore d’ufficio del Pci-Pds. Neppure lui negò a se stesso qualche
stilla di cinismo, quando dopo il tragico suicidio di Sergio Moroni, che fece
commuovere anche il presidente della Camera Giorgio Napolitano che nell’aula di
Montecitorio aveva letto la sua lettera in lacrime, aveva commentato: «Si può
morire anche di vergogna». Senza vergognarsi a sua volta. Neanche di continuare
la carriera per due volte come senatore di quel partito che gli doveva tanto.
Fin da quando, nella
sua veste di procuratore, aveva preso per mano l’imputato Primo
Greganti, funzionario comunista tutto d’un pezzo, trovandogli prove a discarico
meglio di qualunque difensore di fiducia. Aveva scoperto che Greganti, nella
stessa giornata in cui aveva prelevato 621 milioni di lire dal conto
svizzero Gabbietta, aveva anche acquistato una casa a Roma. «Ecco la prova
-aveva detto- che il funzionario rubava per sé e non per il partito». Inchiesta
chiusa. Ma due anni dopo, quando il ministro Mancuso, guardasigilli del governo
Dini, manderà gli ispettori al pool di Milano, si scoprirà la relazione di un
graduato della guardia di finanza che aveva rivelato come la Procura di Milano
avesse rifiutato di ricevere un documento che attestava come il famoso rogito
per l’acquisto della casa a Roma fosse stato stipulato in banca alle 9,30 del
mattino, e non in seguito al prelievo nella banca svizzera. I 626 milioni
avevano preso un’altra strada, quindi. Le casse del Pci-Pds? Del resto lo stesso
D’Ambrosio aveva definito chiuse le inchieste di Tangentopoli con le
responsabilità della Dc e del Psi. Tertium non datur, aveva detto, anche se non
in latino.
Antonio Di Pietro –
Il testimonial
Non è mai stato il
Capo del pool Mani Pulite. Ne è stato l’esecutore e anche l’immagine, il
Testimonial. Amato dagli italiani, anche con le sue debolezze che lo rendevano
simile a tutti quelli che facevano i cortei intorno al Palazzo di giustizia
gridando ”facci sognare”. E mentre lui, chiuso nel suo ufficio in ciabatte
agitava le manette e gli imprenditori milanesi facevano la fila per farsi
interrogare, diventare delatori e mandare in carcere gli altri per non finirci
loro, i suoi colleghi si trastullavano vendendo all’opinione pubblica la sua
immagine come figurina sacra. L’origine contadina con il trattore rosso e la
mamma con il foulardino nero in testa facevano proprio sognare.
Ma proprio le sue
debolezze e una sentenza in cui era stato parte lesa ma che le aveva rese palesi
e lui era descritto come un avventuriero (e contro cui lui non fece appello) e
il timore fondato di una brutta fine nel procedimento disciplinare aperto al
Csm, ne determinarono l’uscita dalla magistratura. E la caduta del personaggio,
non sanata dal successivo suo ingresso in politica come ministro e come
fondatore del movimento moralistico “Italia dei valori”. La vera storia di Di
Pietro è finita con la “sentenza Maddalo”.
Tiziana Maiolo.
Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella
XI, XII e XIII legislatura.
Sentire dai
protagonisti come andarono i fatti. Mani Pulite e il ricatto ai politici: i
magistrati a chi proposero quel patto scellerato?
Tiziana Maiolo su
Il Riformista il 6 Aprile 2023
Nessuno sarebbe
andato in carcere, a partire dal 1992, se il mondo della Prima Repubblica avesse
accettato il ricatto degli uomini di Mani Pulite: resa incondizionata, consegna
delle armi e uscita dai processi. La rivelazione sconvolgente di Gherardo
Colombo, uno degli uomini che nel luglio del 1992 avrebbero avanzato la proposta
ai leader dei partiti di governo di allora, parla oggi di un progetto politico
mai realizzato che avrebbe cambiato il corso della storia.
Lo avevamo già
intuito dalla dichiarazione di Saverio Borrelli, quando, dopo la quarta vittoria
elettorale di Silvio Berlusconi, aveva detto candidamente: “Non valeva la pena
di buttare all’aria il mondo precedente per cascare poi in quello
attuale”. L’ammissione del fatto che Mani Pulite era stata un’operazione
politica e solo politica. Niente moralizzazione, niente obbligo dell’azione
penale. Ma oggi Gherardo Colombo non solo conferma, ma aggiunge qualcosa di più
drammatico. Un ricatto che equivale a un moto rivoluzionario. Qualcosa di
violento e immorale come un push, preparato da toghe anziché da divise militari.
Questa sarebbe stata l’attività di Mani Pulite. Tanto che, qualora si fosse
arrivati a un accordo, la proposta del 1992 di cui parla Gherardo Colombo
avrebbe comportato la rinuncia da parte dei pm all’obbligatorietà dell’azione
penale in cambio di una trasformazione della politica nell’esercito dei
“pentiti” e il riconoscimento del nuovo assetto di potere, quello giudiziario.
La dittatura delle toghe. Sarebbe stata questa dunque la “soluzione politica”
per uscire in modo indolore da Tangentopoli, lo “scambio tra ricostruzione dei
fatti ed estromissione dal processo”.
Non c’è motivo di
dubitare della sincerità di Gherardo Colombo, che sta vivendo il successo della
sua terza vita, dopo quella di magistrato garantista di sinistra e poi quella
della passione per le manette fino alla scoperta dell’inutilità del carcere. Se
quel che dice oggi corrisponde alla realtà dei fatti, vuol dire che c’è stato da
parte del pool di Milano un tentativo segreto di avvelenare i pozzi. Cioè che
fin da subito, da prima ancora che i leader politici del tempo, il segretario
della Dc Arnaldo Forlani e del Psi Bettino Craxi ricevessero un’informazione di
garanzia, i pubblici ministeri non avevano a cuore il trionfo della giustizia,
ma solo la presa del potere.
E proprio perché
lo dice una persona molto stimata come Gherardo Colombo, e se la proposta ci fu,
vorremmo sapere non solo da chi, ma anche a chi il pactum sceleris fu avanzato.
Perché tutti gli accadimenti di quell’anno sono stati distillati e centellinati
in ogni angolatura, in ogni sospiro, per trent’anni in libri e giornali. E
ripensandoci, e con angoscia, vien da dubitare che se l’accordo non ci fu è solo
perché provvidero gli uomini di Totò Riina a portare altrove l’attenzione del
mondo politico. Così l’omicidio di Salvo Lima del 12 marzo precede di appena un
mese le elezioni politiche del 5 aprile che segneranno il primo segnale politico
dell’influsso di tangentopoli sul pentapartito di governo. E poi tutto quel che
seguì, con le dimissioni del Presidente Cossiga e subito dopo l’assassinio
di Giovanni Falcone. E poi in sequenza la prima informazione di garanzia al
tesoriere della Dc Severino Citaristi e la sorte di Bettino Craxi con la sua
invettiva in Parlamento mentre si votava la fiducia a un governo che non sarà
presieduto da lui perché nel frattempo la sua immagine dalle parti del palazzo
di giustizia di Milano non era del tutto cristallina.
Da una parte
c’erano le bombe di Cosa Nostra, dall’altra i siluri di Mani Pulite. Questo era
il 1992. Con Scalfaro alla Presidenza della repubblica al posto di Cossiga, due
giorni dopo la strage di Capaci, e anche questo fu un cambiamento storico, e non
certo positivo. Mentre a commento dei primi tre suicidi di Tangentopoli il
procuratore aggiunto di Milano Gherardo D’Ambrosio diceva “A volte si muore
anche di vergogna”. Ma il patto, almeno in quell’anno, non ci fu. E loro
andavano avanti. E ci vorrebbe una sorta di grande Csm della storia per sentire
da Gherardo Colombo come andarono i fatti e quali fossero le loro intenzioni.
Per esempio, la domanda pare legittima: volevano solo un ricambio di classe
politica, mandando semplicemente un D’Alema al governo (cosa poi accaduta negli
anni successivi), come pensano alcuni, o volevano invece fare loro direttamente
le valigie e prendere l’aereo per Palazzo Chigi? Non l’aveva del resto detto lo
stesso procuratore Borrelli “se il Presidente ci chiama” siamo a disposizione?
Ma questo della
resa della politica, della consegna delle armi, resterà sempre un tarlo nella
mente del gruppo dei magistrati coraggiosi. Lo dimostra tutto il loro modo di
procedere, lo sprezzo con cui trattavano i politici negli interrogatori, le
minacce, il tono ricattatorio, l’uso del carcere preventivo. Orpelli non
indispensabili nelle normali procedure della giustizia. Importanti invece nel
clima di vera guerra che il Pool aveva dichiarato. I primi ad arrendersi furono
comunque gli imprenditori. Non solo Romiti e De Benedetti, che evitarono il
carcere con trattative condotte nei principali studi legali italiani, che
diedero ai magistrati niente di più che piccole mance, una paginetta di modeste
ammissioni di colpevolezza in cambio dell’impunità. Ma anche gli altri, quanto
meno a partire dal 1993, quando il Presidente di Assolombarda Ennio
Presutti indisse l’assemblea generale degli industriali, con la presenza
dei Moratti, dei Pirelli e i Tronchetti Provera ma anche dei
tanti Brambilla esasperati, e disse “Occorre chiudere con tangentopoli” e
infine “Dobbiamo rassegnarci”, e fu l’inizio della resa.
Anche il mondo
della politica ci provò. Ma l’interlocutore – era ormai nato il circo mediatico
giudiziario – pareva insaziabile, assetato del sangue di partiti ormai in
ginocchio. Due ministri per bene come Giovanni Conso e Alfredo Biondi furono uno
dopo l’altro messi alla berlina come delinquenti. E intanto gli uomini del pool,
quelli che contavano davvero, mandavano avanti un Tonino Di Pietro tutto
elegante in abito fumo di Londra e cravatta berlusconiana a piccoli pois, a
presentare una vera proposta di legge in quella cornice da “liberté égalité jet
privé” che è sempre stato l’incontro promosso ogni anno dallo Studio Ambrosetti
a Cernobbio sul lago di Como. Era la solita proposta capestro per umiliare la
politica e l’imprenditore Berlusconi – si era ormai nel 1994 – l’unico del mondo
industriale a non essersi mai piegato, mentre la Confindustria di Luigi
Abete aveva dato subito il proprio consenso.
Il ceto politico
seppe allora ribellarsi, il mondo era cambiato e nessuno, compreso il
Presidente Scalfaro, accettò quello stravolgimento della Costituzione che si
sarebbe avverato se l’ordine giudiziario si fosse impadronito del potere
legislativo. Velenoso fu in quei giorni il pm Gherardo Colombo, mentre molti
politici avevano accusato la proposta dei magistrati di voler creare un mondo
di ”pentiti”. “Non vorrei – aveva sibilato – che chiamare delatore chi fa il suo
dovere svelando la corruzione sottintendesse la convinzione che rubare ai
cittadini non è così grave”. Ipse dixit. Ieri come oggi.
Tiziana Maiolo.
Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella
XI, XII e XIII legislatura.
“Colombo ha avuto
grande onestà intellettuale".
Mani Pulite, il
racconto di Giulio Di Donato: “Sconti ai politici, a me fu chiesto di convincere
Craxi a consegnarsi”. Aldo Torchiaro su Il riformista l’8 Aprile 2023
Le rivelazioni
che Gherardo Colombo, ex pm del pool Mani Pulite, ha fatto a Enzo Carra fanno
discutere. Alcuni magistrati avrebbero offerto un salvacondotto ai loro
inquisiti, a cui avrebbero promesso l’immunità penale in cambio di informazioni
e di qualcosa di più: della promessa di “uscire dalla vita pubblica”. Da
Gherardo Colombo, che d’altronde lo ha scritto nero su bianco, nessuna smentita.
Arrivano invece le conferme. I protagonisti di quegli anni iniziano a parlare, a
ricordare le irricevibili proposte che alcuni magistrati gli formulavano.
«Pentitevi e saltate un turno dalla politica, avrete la fedina penale
pulita»: Giulio Di Donato, a lungo parlamentare socialista e oggi presidente
dell’associazione Socialismo Oggi, conferma nella sostanza quella che definisce
“una prassi, una offerta regolare”.
E sottoscrive le
parole di Gherardo Colombo, «cui va dato atto di una grande onestà
intellettuale. Ha capito gli errori e anche gli orrori di una inchiesta che ha
sommerso di fango la storia del Paese, e ha iniziato a scavare nel fango per
rimettere qualche cosa a posto». Di Donato, napoletano, è stato l’ultimo vice
segretario del Psi di Bettino Craxi, dal 1990 al 1992. Ed in quanto tale è
rientrato in una trentina di procedimenti per un totale di 44 capi di
imputazione. A Milano lo chiamarono in causa per una questione di
sponsorizzazioni al Festival de L’Avanti. «Mi dissero che lo sapevano, che io
non ne sapevo niente. Ma che da vice segretario del partito avevo delle
responsabilità. E giù ore a interrogarmi, certe sere fi no allo sfi nimento». I
modi sono quelli che solo l’eloquenza di Antonio Di Pietro ha saputo restituire
fedelmente: “Io a quello lo sfascio”, disse di Silvio Berlusconi. I primi
arrestati confessavano, denunciavano il denunciabile. Poi il clima cambiò, e
mutò lo scenario.
Prima c’era Di
Pietro che martellava, mentre agli altri pm, come dirà Francesco
Greco, «competeva un lavoro di ricostruzione successivo agli interrogatori… ma
la situazione si è modifi cata nel corso del 1994 quando le collaborazioni
diminuirono fi no a cessare. Fu lo stesso Di Pietro a dire che non arrivava più
acqua al suo mulino, la tecnica investigativa cambiò». A quelli che consegnavano
la propria carriera politica, annunciando pubblicamente di uscire dalle
istituzioni, dai partiti, dalla pubblica amministrazione “almeno
provvisoriamente”, come scrive Colombo, si iniziavano a fare sconti anche molto
importanti. Perdonando alla fi ne anche tutto. Giulio Di Donato rievoca quegli
anni e un episodio in particolare. Finisce un interrogatorio – siamo nel 1994 –
e gli sequestrano il passaporto. Così, per fargli capire che non può lasciare il
Paese, sospeso in quel limbo tra attesa di giudizio e attesa di giustizia in cui
vengono messi a rosolare, ogni anno, mezzo milione di italiani.
“Poi successe una
cosa strana: l’allora Pm di Milano, Francesco Greco, mi fece chiamare in via
informale. Disse ai miei legali di voler fare una chiacchierata amichevole con
me. Ero a Napoli, presi il treno con i miei legali, Greco mi incontrò nel suo
ufficio senza più usare i toni dei due anni precedenti. Un pacchetto di
sigarette aperto sul tavolo richiama la sua attenzione: erano Gitanes senza
filtro”. Che strano, proprio le sigarette abituali di Di Donato. Una
coincidenza. E quando l’ex numero due di Craxi si siede, voilà, dal primo
cassetto del Pm Greco ecco che salta fuori il passaporto di Di Donato. “Eccolo,
glielo volevo riconsegnare io stesso”, gli dice il magistrato. Quanta premura. E
gli allunga l’accendino. Si parla di politica, di famiglia. “Pensa di fare un
viaggio, adesso che può?”, gli chiede l’inquirente. E l’esponente socialista:
“Non so ancora, non ci ho pensato. E a dire la verità non ricordavo neanche di
non avere il passaporto”.
“Allora mi permetta
di darle un suggerimento”, incalza Greco. “Perché non va ad Hammamet a trovare
Bettino Craxi? Lei ci parla, gli fa capire che faremo un giusto processo, che la
cosa migliore è farsi vedere in aula, e se lo convince a tornare in Italia
gliene saremo tutti grati”. Non serviva aggiungere altro. Di Donato ha intuito
il senso, l’obiettivo delle cortesie riservategli. E ha capito che i magistrati
hanno nel mirino Bettino Craxi, “il Cinghialone”. Vogliono il trofeo di caccia
da esporre. Varrebbe oro, quel trofeo. Di Donato quel viaggio lo farà, andando a
salutare il leader socialista in esilio, ma si guarderà bene dal farsi
messaggero delle Procure.
Né rivedrà quel Pm,
al ritorno. «Una cosa però me la faccia aggiungere: c’era un disegno politico
ben preciso, nell’operazione Mani Pulite. Non è vero che si voleva colpire tutta
la politica. Si voleva colpire il Pentapartito, che rappresentava il nodo di
potere stabile del nostro sistema politico. Si indagarono con particolare
pervicacia quelli vicini a Forlani e a Andreotti, nella Dc, risparmiando quasi
del tutto la sinistra democristiana. Si indagò con il microscopio fi n nelle
piccole federazioni provinciali del Psi. Da noi misero a soqquadro tutto,
ripetutamente». Un capitolo a parte riguarda Berlusconi. «Le Procure guardavano
con simpatia a Berlusconi che ne ossequiava il lavoro con i suoi inviati di
Mediaset a documentare il lavoro febbrile al Palazzo di giustizia di Milano.
Nel 1994, quando entra lui in politica, sconfi ggendo Occhetto, ecco che le
Procure dirigono tutte le indagini su di lui. All’improvviso. Dimostrando una
regìa politica che dirigeva senza esitazioni le sue armi sul nemico di volta in
volta da abbattere».
Aldo Torchiaro.
Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003.
Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.
Tangentopoli fu
un colpo di Stato, la rivelazione del Pm Colombo del pool di Mani Pulite.
Piero
Sansonetti su Il Riformista il 5 Aprile 2023
Gherardo
Colombo, l’ex Pm che è stato nei primi anni novanta uno dei cinque grandi
protagonisti dell‘inchiesta “Mani Pulite” – quella che rase al suolo la prima
Repubblica – ha scritto una introduzione al libro di Enzo Carra (uscito postumo
in libreria in questi giorni) nella quale ci svela un aspetto finora sconosciuto
di quella stagione. Sconosciuto e sconvolgente. Ci dice che nel luglio del
1992, quando le indagini erano ancora alle prime battute, fu suggerito ai
politici di confessare i propri delitti e di uscire dalla vita pubblica in
cambio dell’impunità.
Colombo dice
esattamente che se i politici avessero accettato le condizioni dei Pm, in cambio
non avrebbero avuto “a che fare con la giustizia penale”. In pratica fu proposta
una trattativa segreta Stato-Tangentopoli . Ovviamente del tutto illegale. Dal
punto di vista del codice penale, se Colombo racconta il vero, il pool commise
un reato piuttosto serio. Violò l’articolo 338 che punisce severamente
la “minaccia a corpo politico”. Nella sua ricostruzione dei fatti, Colombo non
parta di singoli politici, o di imputati: parla di “politica”, al singolare,
cioè si riferisce esattamente del “soggetto collettivo” al quale, evidentemente,
fu proposta la trattativa con la minaccia del carcere. L’articolo 338 del codice
penale prevede pene fino a sette anni di reclusione. Ovviamente i reati sono
caduti in prescrizione, però resta la ferita allo Stato.
Se davvero
la procura di Milano chiese a quella che allora era la classe dirigente,
legittimamente eletta, di farsi da parte, minacciando altrimenti l’arresto e
il carcere, compì un atto che è difficile non considerare un vero e
proprio colpo di Stato. Non in senso metaforico, simbolico: nel senso pieno e
letterale della parola. L’accordo non ci fu. La politica si dimostrò migliore
della magistratura. Il ricatto non funzionò. E però la Storia ci dice che il
disegno politico della Procura di Milano – sempre se è vero quello che dice il
dottor Colombo – fu comunque portato avanti, con gli arresti sistematici, con
l’aggiramento del Gip, con i mandati di cattura a rate, col sistema delle
delazioni ottenute in cambio di scarcerazioni o con nuovi mandati di cattura,
con una lunga scia di suicidi. Ed eliminò dalla scena tutta la classe politica
di governo, più o meno come succedeva spesso in America Latina.
Naturalmente dal
punto di vista strettamente politico, le ammissioni di Colombo non cambiano
niente. La prima repubblica è morta sotto le picconate della procura di Milano e
poi di altre procure. Nessuno la risusciterà. La democrazia cristiana non esiste
più, non esiste più il vecchio e glorioso partito socialista, non esiste
il Psdi, né il Pri, né i il partito liberale. Però è importante ricostruire
quegli avvenimenti. Sapere che almeno una parte della magistratura si mosse
violando in modo clamoroso la legalità. Ed è importante accertare come nella
storia della repubblica c’è stata una rottura determinata non dal normale
svolgimento democratico ma da un Putsch.
Piero Sansonetti.
Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di
cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004
al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per
poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre
2019.
Il tentato golpe
nel 1992. Cosa ha rivelato Gherardo Colombo su Tangentopoli, il ricatto dei Pm
ai politici.
Aldo Torchiaro su Il Riformista il 5 Aprile 2023
Un tentato golpe nel
1992 tentò di rovesciare la democrazia. A denunciarlo oggi è Enzo Carra. Sì,
perché Enzo Carra parla. Parla ancora. A tutti. L’oscenità delle manette con cui
lo volevano umiliare non lo ha messo a tacere. È morto lo scorso 2 febbraio,
l’ultimo portavoce della Democrazia Cristiana. Ma poco prima di morire ha
affidato all’amico Vincenzo Scotti, patron della Link Campus e della casa
editrice Eurilink, un testo. Un manoscritto denso di rivelazioni, informazioni,
ricostruzioni. Un memoriale inestimabile, soprattutto perché costruisce un
terreno di confronto con la controparte – i magistrati della Procura di Milano –
che ci permette di leggere anche i disegni dei Pm senza più tanti filtri. Senza
infingimenti.
L’Ultima
Repubblica – è il titolo che ha dato Carra – ricorda tutto, con una lucidità
puntuale. E per puntellare il suo racconto di quel periodo di legalità sospesa
ha invitato a dialogare uno dei suoi accusatori. Una figura sui generis: quella
di Gherardo Colombo. Integrato nel gruppo di punta e dunque tra i Pm più
direttamente coinvolti nel clamoroso arresto di Carra, Colombo è stato anche tra
i pochi protagonisti di quegli anni a saperli rileggere con sguardo critico. Fu
senz’altro sua una delle firme che condussero dietro le sbarre l’allora
portavoce di Arnaldo Forlani, appunto Enzo Carra, a nome del pool milanese di
Mani Pulite il 19 febbraio 1993. Bisognava celebrare il primo anniversario
di Tangentopoli. Ci voleva più di un brindisi. Un brindisi “col botto”. Fu
allora che la storia di quell’inchiesta assunse i contorni di qualcosa d’altro.
Di più oscuro. Ed è lo stesso Gherardo Colombo a rivelarlo. A scriverlo.
Rispondendo al dialogo con Carra, l’ex Pm rievoca gli eventi di quei giorni
di Mani Pulite, gli errori e gli eccessi.
Quello in epigrafe:
quando il colto, acuto, placido Carra venne arrestato (e ammanettato, come se
fosse socialmente pericoloso e aggressivo) per essere mostrato come un trofeo di
caccia davanti allo sguardo famelico delle telecamere. Un arresto insostenibile,
gratuito. Come quello di molte altre vittime di quella furia giacobina. Che si
può meglio interpretare con una dichiarazione disarmante di Gherardo Colombo,
che nella sua introduzione squarcia il velo sul segreto dell’operazione Mani
Pulite: “Eppure non una persona sarebbe andata in carcere se, come suggerito nel
luglio 1992, ben prima (data la rapidità dell’evolversi di quegli eventi) della
nomina di Martinazzoli, la politica avesse scelto di seguire la strada dello
scambio tra ricostruzione dei fatti ed estromissione dal processo. Chi avesse
raccontato, restituito e temporaneamente abdicato alla vita pubblica non avrebbe
più avuto a che fare con la giustizia penale”. Lette queste parole, abbiamo
chiuso gli occhi e inspirato. Poi abbiamo riletto: e sì, è tutto vero. A pagina
13 del libro di Enzo Carra il giornalista fa dire a Colombo come funzionava il
meccanismo del golpe. Lo spinge ad un controinterrogatorio gentile che lo porta
ad ammettere.
Veniamo a sapere che
il meccanismo dello scambio – come lo definisce lo stesso Colombo – funzionava
con il do ut des tra due poteri: gli eletti che avessero ricostruito notizie
eventualmente possedute e avessero fatto oltre alla delazione anche un’abiura,
disconoscendo il proprio mandato democratico e accettando di dimettersi
“temporaneamente” (sic) nelle mani del potere giudiziario, avrebbero ricevuto
dai Pm di Mani Pulite un salvacondotto capace di farli attraversare indenni
l’Acheronte di Tangentopoli. Nessun problema avrebbero più avuto con la
giustizia coloro i quali avessero accettato di “abdicare” alla vita pubblica. E
che cos’è, la vita pubblica, se non la partecipazione democratica, il confronto
elettorale, il dibattito culturale che secondo la Costituzione viene organizzato
con il mezzo principale di quei pilastri della democrazia che sono i partiti? I
sospetti tratteggiati nei discorsi di Bettino Craxi e nelle lettere di alcuni
dei condannati a morte dal pool parlano chiaro. “Non mi è estranea la
convinzione che forze oscure coltivino disegni che nulla hanno a che fare con il
rinnovamento e la pulizia”, scriveva Sergio Moroni all’allora presidente della
Camera, Giorgio Napolitano, prima di spararsi.
Ne L’Ultima
Repubblica quei fantasmi prendono forma, assumono le sembianze umane di quel
pool che abbiamo imparato a conoscere bene. Come a dover aderire a un disegno
sinistro, i Pm provano a buttare giù un sistema, un architrave democratico
composto di partiti. Di scuole politiche. Colombo prova poi, nel testo, a
rifiutare la responsabilità della storia: “I partiti sono morti da soli”, glossa
a pagina 13. Poi ci torna a pagina 17: “Abbiamo pensato che la fine dei partiti
italiani, avvenuta tra il 1993 e il 1994, sia stata una condanna della storia e
non dei tribunali. Abbiamo pensato che la cancellazione del nostro quadro
politico, creatura della guerra fredda, fosse la conseguenza positiva dello
spegnersi di un lungo dopoguerra. Sì, certo, c’era stata anche la Grande
Inchiesta a rendere impresentabili partiti corrotti o addirittura covi di
personaggi dediti a pratiche previste come reati dalla legge italiana.
‘Finalmente ce ne siamo liberati’, gli italiani salutarono così l’insperato
addio dei partiti”. Ci sarebbe da fare un’analisi filologica attenta, su tutto
il passaggio di Colombo: “la politica”, sempre tra virgolette, a sminuirla.
La cancellazione del
quadro politico definita solo come “positiva”. La Grande Inchiesta con le
iniziali maiuscole, a sottolinearne la sacralità. Torniamo a Carra: il talento
giornalistico, il fiuto politico, l’umanità profonda dell’ultimo portavoce della
prima repubblica – da qui L’Ultima Repubblica – tornano a far parlare i suoi
amici, riuniti per un ennesimo saluto fatto di idee e di rinnovate intese. Al
primo evento di presentazione del libro, ospitato lunedì scorso dalla Lumsa a
Roma, a moderare c’erano i due più grandi confidenti di Carra, i
giornalisti Paolo Franchi e Stefano Folli. Riformista il primo, repubblicano il
secondo. Sono loro a rievocare gli anni in cui il potere politico dovette cedere
l’egemonia al potere giudiziario. Davanti agli occhi lucidi del giovane Giorgio
Carra, che ha assistito suo padre nel portare a termine questo suo memoriale,
sfilano i ricordi di un pezzo di storia. Vincenzo Scotti “quasi commuove”, come
chiosa Franchi.
In prima fila, Mario
Segni e Luigi Zanda. Dietro di loro c’è Flavia Piccoli Nardelli, appena nominata
a capo dell’Associazione delle istituzioni culturali italiane, accanto a Michele
Anzaldi (Iv). Uomini e donne che hanno contribuito con senso dello stato a
costruire quell’ossatura della democrazia, i partiti politici, le istituzioni
democratiche, che qualcuno forse avrebbe preferito vedere morte. “I corpi
intermedi… esisteranno ancora i corpi intermedi?”, si chiede Gherardo Colombo a
pagina 18 dell’introduzione. “Chissà che non si arrivi a una forma assai più
diretta di democrazia o all’affermazione di una forma di dittatura della massa,
sulla falsariga di quel che accadeva ai tempi di Ponzio Pilato”. Per ora, il
potere è nelle mani degli elettori. Il pool non colpisce più. E non c’è più Enzo
Carra, ma rimangono le sue parole a illuminarci: il golpe armato di toga e
maglietto ha disarcionato una classe dirigente e l’ha provata a sostituire con
populisti e giustizialisti. Prenderne atto è essenziale per farsi gli anticorpi.
Aldo Torchiaro.
Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003.
Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.
Antonio Di Pietro, Vittorio Feltri: "I 3
cadaveri dietro al muro. Diede la notizia a me..."
Vittorio Feltri su Libero Quotidiano il 12 agosto 2023
Ho conosciuto Antonio Di Pietro nel 1983: io ero
direttore di “Bergamo Oggi”, lui era Sostituto Procuratore nella mia città. Di
Pietro è sempre stato un personaggio. Di origini molisane, è nato a Montenero di
Bisaccia, ha modi abbastanza burini ed è arrivato alla magistratura dopo una
disparata serie di lavori: è stato operaio in una segheria, lucidatore in
un’azienda metalmeccanica in Germania. Infine, dopo la laurea in Giurisprudenza,
è stato commissario di Polizia e poi responsabile di un distretto alla Questura
di Milano. Insomma, Di Pietro è arrivato a Palazzo di giustizia a forza di
braccia, facendo uno a uno tutti gli scalini. Forse per questo, in un ambiente
snob come quello delle toghe, i colleghi lo detestavano, sostenevano che fosse
inadeguato. Ma si sbagliavano. Mi sono detto: «Io divento suo amico».
Lui era stato abbandonato da tutti e in me aveva
trovato una sponda, un giornalista che lo prendeva in considerazione, così ha
cominciato a darmi notizie interessanti. Ricordo un fatto di cronaca eclatante,
a quarant’anni di distanza ancora se lo ricordano tutti: il caso del mostro di
Leffe, un piccolo Comune bergamasco della Val Seriana. Un bancario del paese,
Giovanni Bergamaschi, aveva ucciso la suocera, la moglie e la figlia.
La suocera, Annunciata Brignoli, l’aveva ammazzata
nel 1978 e l’aveva sepolta sul Monte Croce, mentre tre anni dopo era toccato
alla moglie Giannina Pezzoli e alla figlia Aurora di quattro anni, che poi
l’uomo aveva murato dietro una parete eretta appositamente nel sottoscala di
casa. Bergamaschi se n’era poi andato in Germania e per anni aveva inviato a
casa cartoline falsificando la firma della moglie e della figlia, lasciando
intendere che tutta la famiglia era emigrata e viveva là felicemente.
GLI OMICIDI - I tre omicidi furono scoperti solo
il 13 febbraio del 1984: nel paese si parlava della vicenda, ma la popolazione
era sospettosa, Annunciata Brignoli non si vedeva più da anni, era difficile
ricostruire i fatti. Di Pietro seguì il caso e andò a perquisire la villetta
della famiglia scomparsa: c’erano tracce di sangue sulla scala ma si accorse che
le gocce si interrompevano nel sottoscala, che era stato murato. Notò subito che
la parete era stata tirata su malamente, di fretta. Bussò e sentì che dietro
suonava il vuoto. Gli agenti sfondarono a picconate la parete e trovarono due
sacchi dell’immondizia, dentro i quali si trovavano i corpi della moglie e della
figlia di Bergamaschi.
Di Pietro diede la notizia solo a me. Mandai un
cronista a Leffe, ma al tempo in provincia non si era abituati a trattare fatti
di questo rilievo, così quando tornò scrisse un pezzo, me lo portò e io mi
accorsi che era un articolo breve, nel quale non dava valore alla vicenda: gli
tirai dietro la mia Lettera 22 e mi misi a riscrivere di mio pugno la storia.
Facemmo un titolone in prima pagina e il giorno successivo andammo in Val
Seriana con i tir pieni di giornali, in edicola non se ne trovava più una copia:
Bergamo è piccola, se capita qualche cosa nei paesi è come se succedesse in
città e la provincia vibra subito per i fatti di sangue, perché le persone si
conoscono o sanno per sentito dire, una notizia del genere chi non la legge?
Due settimane dopo mi chiamò Gian Antonio Stella,
che era stato mio collega al Corriere della Sera: mi diede la notizia che
stavano arrestando Bergamaschi a Roma, alla stazione Termini, mentre si recava a
trovare il fratello, docente universitario. Lo scongiurai di scrivermi trenta
righe, dovetti insistere perché lui lavorava ancora per il Corriere. Alla fine
produsse le trenta righe che volevo e io le pubblicai: di nuovo fui l’unico a
Bergamo ad aver pubblicato l’avvenuto arresto e, con mio sommo godimento, L’Eco
di Bergamo bucò la notizia. Di nuovo vendemmo tutto il vendibile. Mi telefonò il
direttore dell’Eco, monsignor Andrea Spada, e mi disse: «Te Vittorio, quando te
ne vai fora da i bal? Te me fe diventà mat». Non ne poteva più di avermi al
giornale concorrente.
Bergamaschi ammise tutto, fece ritrovare il corpo
della suocera che aveva seppellito in montagna, confessò di aver ucciso la
moglie perché lei aveva sospetti sulla morte della madre e di aver ucciso anche
la figlia perché sarebbe stata testimone. Poi si era trasferito in Germania Est,
dove era rimasto per oltre due anni. «Quel caso resta l’emblema delle indagini
tradizionali», racconterà poi Di Pietro, «Oggi dominano gli algoritmi, allora
invece era fondamentale l’intuito. Fu quella la chiave di tutto». L’ex bancario
scontò dieci anni in un manicomio giudiziario, come persona «incapace di
intendere e di volere».
La mia strada incrociò di nuovo quella di Di
Pietro quando lui stava lavorando nel pool di Mani Pulite, era stato traferito
alla Procura di Milano e io ero direttore dell’Indipendente. Mi fece chiamare da
comuni amici di Bergamo e disse che avrebbe voluto rilasciarmi un’intervista. Mi
precipitai al quarto piano del palazzo di Giustizia, era il 5 giugno del 1992:
Tonino era già un eroe popolare, l’angelo sterminatore di Tangentopoli, un
“marchio” il cui valore venne valutato, secondo Gavino Sanna, al tempo uno dei
massimi esperti pubblicitari, dieci miliardi di lire.
TANGENTOPOLI - Di Pietro era adorato dall’opinione
pubblica, tra scritte sui muri (“Forza Di Pietro”, “Signore, dacci un Di
Pietro”), striscioni (“Di Pietro sei meglio di Pelé”) e poesie di Alda Merini
(“Conosce benissimo Di Pietro/ le cose vinte dalla nostra Italia”). Era adorato
pure dai giornalisti della cronaca giudiziaria milanese, che gli affibbiarono
decine di soprannomi: “Belva”, “Zanzone”, “Padrepio”, “La Madonna”, “Dio”,
“L’Onnipotente”.
Indro Montanelli diceva che Di Pietro era “uomo
della provvidenza” e questa mansione il magistrato la svolgeva con gusto. Quando
lo incontrai nel suo ufficio di via Freguglia, il pm lavorava in una stanza
ingombra di faldoni, con una luce triste, da film neorealista. Viveva lì dieci,
dodici ore al giorno. Davanti al suo tavolo c’erano due sedie, una era occupata
da una pila di documenti. Mi sedetti. Mi raccontò come aveva preso l’avvio il
procedimento: «Nulla di romanzesco», mi disse, «da due anni studiavo il
fenomeno, diciamo che ero abbastanza preparato in materia di tangenti. E quando
mi è capitata fra le mani una querela per diffamazione sporta da Chiesa, è
partita la macchina. Un passo dopo l’altro siamo andati lontano». Si lasciò
andare sulle sue impressioni: «Mandare un uomo in carcere provoca sempre
angoscia, a me ne provoca molta. Quando sono ricorso alle manette è stato perché
esisteva il rischio effettivo di inquinamento delle prove, mai per
spettacolizzare l’indagine».
Da quel momento ebbi da Di Pietro tutte le notizie
su Tangentopoli, navigammo sulla marea di sdegno che inondò quei due anni.
L’inchiesta infuriava, mezza Milano tremava, tutti i politici italiani
tremavano. Quel magistrato inviso ai colleghi era riuscito a fare in tre mesi
ciò che a loro non era riuscito in quarant’anni. Alla fine litigammo perché
aveva eseguito indagini su tutti i partiti e le uniche infruttuose erano state
quelle sul Partito Comunista. «Ho seguito la tangente fin sul portone di
Botteghe Oscure», si giustificò il magistrato, ma per me non bastava. Alcuni,
fin troppi, di coloro che furono risucchiati dalle indagini non ressero alla
pressione, oppure si videro senza scampo, e si uccisero. Ho sempre avuto
l’impressione che a Di Pietro non importasse nulla, nonostante una volta abbia
detto che la morte di Raul Gardini sia stata per lui una sconfitta terribile e
che lo avrebbe potuto salvare. Raccontò infatti che la sera prima del suicidio i
carabinieri lo chiamarono a casa, a Curno, per chiedergli se dovessero
arrestarlo: «Dottore, che facciamo, lo prendiamo?».
Tonino però aveva dato la sua parola agli avvocati
dell’imprenditore che non avrebbe fatto scattare le manette, a patto che Gardini
la mattina seguente si fosse presentato in Procura spontaneamente. Quindi ai
militari rispose di lasciar perdere. «Se l’avessi fatto arrestare subito»,
racconta Di Pietro, «sarebbe ancora qui con noi». Di Pietro si disse convinto
che quello del finanziere fosse stato un «suicidio d’istinto, un moto d’impeto,
non preordinato». Io sono invece dell’idea che Gardini non premette il grilletto
all’improvviso, ma dopo aver covato il proposito per almeno 36 ore. Di Pietro
avrà certamente fatto il suo mestiere secondo coscienza, ma al tempo si usava la
galera come scorciatoia per arrivare in fretta a una confessione. Si rivelò un
sistema spesso efficace. Ma la coercizione, in persone che non sono delinquenti
abituati a passare attraverso le porte del carcere, può provocare disastri. E
infatti ne ha provocati.
Gherardo Colombo:
«Da ragazzino mi bocciarono due volte. Agli inizi della mia carriera giravo con
un revolver».
Luca Mastrantonio su il Corriere della Sera il 23 febbraio 2023
L’ex magistrato, 76
anni: «Prima di Mani Pulite ero un milanista accanito, poi mi sono calmato»
Nel salotto della
casa milanese di Gherardo Colombo, un golden retriever (Luce) ci osserva dal
divano, la testa poggiata sul bracciolo coperto da un lindo fazzoletto bianco.
Colombo ha l’aria di aver finito da poco un esercizio di fatica domestica (un
rubinetto da sistemare). L’occasione del nostro incontro è l’uscita del nuovo
libro Anti Costituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della
nostra società (Garzanti).
Lei è classe 1946,
brianzolo, mamma casalinga, papà medico. Primo ricordo?
«La scossa di
corrente elettrica, per le dita in una presa elettrica. Da lì sono venuti i
capelli ricci... (ride). Ero piccolo e sperimentavo. I miei non si arrabbiavano,
erano accoglienti».
A scuola come
andava?
«Bocciato in seconda
media e quarta ginnasio, ho recuperato l’anno in entrambe le occasioni. Avevo
difficoltà a entrare in relazione con gli altri. Ero obeso... Finalmente al
liceo ho capito che la libertà passa per lo studio. Poi scelsi
Giurisprudenza...».
Si immaginava già
giudice?
«Mio padre faceva il
medico generico, girava di giorno e di notte, curava, faceva partorire. Volevo
essere utile come lo era lui, e a mio parere verificare il rispetto delle regole
lo era. A differenza del medico non avrei dovuto mettere le mani sulle persone.
L’alternativa era Fisica, mi piace capire il perché dei fenomeni».
Nella Giustizia ha
individuato qualche legge fisica?
«Non è una legge
fisica, ma poco ci manca. L’importanza dell’ambiente nelle scelte che le persone
fanno anche nel campo della trasgressione. Sa, la storia in cui l’imputato è
davanti al giudice, chiuso nel posto degli imputati e dice: “Signor giudice, se
lei fosse nato dove sono nato io e io dove è nato lei, qui ci starebbe lei e io
sarei lì”. Una regola che soffre poche eccezioni».
Ci sono ambienti in
cui uno sceglie di stare. La P2. Cosa ricorda di quando nel 1981 con Giuliano
Turone scopriste le liste di Licio Gelli?
«Stupore e
indignazione. C’erano i capi dei servizi segreti, c’era chi aveva inquinato le
indagini sulle stragi, ministri, imprenditori, giornalisti, magistrati, la
catena di comando del Corriere della Sera ... C’erano buste sigillate che
contenevano inquietanti notizie di reato...».
Quale fu la prima
reazione?
«Preoccupazione, che
i servizi segreti potessero venire a riprendersi le carte. Fotocopiare 5 mila
fogli era impossibile, allora incominciammo a selezionare, fotocopiarne le più
importanti, descriverle accuratamente, nasconderle in un fascicolo che
riguardava altre indagini».
Lei agli inizi della
sua carriera girava armato.
«Qualche volta mi
capitava di portare la pistola. Il 19 marzo 1980 venne ucciso Guido Galli, con
cui lavoravo. E nei gironi immediatamente precedenti erano stati ammazzati altri
due giudici. Prima linea rivendicò l’omicidio di Guido. Alcuni colleghi
scapparono nei Paesi di origine. Io sono rimasto, ma per una settimana ho
dormito fuori casa, finché la mia moglie di allora mi ha aiutato a riprendermi.
Ma ogni volta che mi fermavo con la moto ad un semaforo e qualcuno attraversava
dietro, mi aspettavo il colpo. Nonostante le armi non mi siano mai piaciute mi
sono obbligato ad andare in armeria, ma a comperare una pistola non ce l’ho
fatta. Ci ho sono tornato un’altra volta, niente. Alla terza volta mi sono
costretto ed ho preso un revolver».
Cos’ha provato?
«Quando mi sembrava
d’essere più esposto dava una sensazione di sicurezza. Ma è irrazionale. Un
antidoto, un’esorcizzazione della paura e basta. L’anno dopo, scoperta la P2,
m’hanno assegnato la scorta, e l’arma l’ho messa in cassaforte, in ufficio.
Dimessomi dalla magistratura nel 2007, l’ho consegnata in Questura chiedendo
venisse distrutta. Non volevo che qualcuno usasse contro qualcun altro l’arma
che era stata mia».
Molto cauto. Lei si
è mai sentito tradito da qualcuno?
«Durante Mani Pulite
avevamo scoperto un grande giro di corruzione nella Guardia di finanza di
Milano, un corpo con cui avevo lavorato tanto e bene. Un imprenditore,
interrogato, coinvolse un colonnello con cui avevo lavorato e di cui mi fidavo,
temevo potesse fare un gesto estremo. La lettera che Sergio Moroni aveva scritto
decidendo di suicidarsi mi aveva colpito profondamente, per cui ho disposto che,
una volta arrestato, il colonnello venisse portato subito da me per
l’interrogatorio, per evitare che potesse compiere atti insani, precisando che
lo avrei atteso fino al giorno dopo. Arrivò alle 4 di notte e mentre aspettavamo
il suo avvocato mi chiese: “Dottore mi dice lei cosa fare? Patteggio la pena?
Dico che sono innocente o confesso? Mi dica lei...” Mi sono stupito, pensavo
fosse disperato, non era nemmeno imbarazzato».
Lei non si arrabbia
mai?
«Con le parole
reagisco al momento, se percepisco un’ingiustizia. Ma conto fino a dieci e non
vado oltre. Comunque mi arrabbio».
L’ultima volta?
«L’altro giorno,
attraversavo sulle strisce pedonali con Luce, un’auto quasi ci ha investito. Che
caspita!»
Ha urlato «che
caspita»?
«Purtroppo a volte
mi scappa anche qualche parola “turpe”».
Difficile
immaginarla.
«Allo stadio, fino
agli anni '90, ero un tifoso accanito del Milan».
Smise durante Mani
Pulite?
«È che allo stadio
qualche volta mi lasciavo coinvolgere, e magari dietro di me qualcuno non la
prendeva bene».
È restato tifoso?
«Sì, ormai all’acqua
di rose. Mi ha fatto ricordare che quando interrogammo Adriano Galliani, ad del
Milan, sul caso di Lentini, per il possibile falso in bilancio, lui a un certo
punto, vedendo che eravamo Davigo, Di Pietro ed io disse: “Addirittura in tre
per questa vicenda?”. E Davigo: “Sa, l’indagine l’ha fatta Colombo, ma siccome è
milanista non ci fidiamo tanto”. Era ovviamente una battuta, ma Piercamillo non
sa resistere».
Nel 2022, a 30 anni
da Mani Pulite, ha fatto un incontro pubblico con Sergio Cusani, che fu
condannato.
«Ci conoscevamo
anche prima della vicenda. Ci vediamo con una certa frequenza, ci sentiamo
spesso».
Sente più Cusani dei
suoi ex colleghi del pool?
«Sicuramente. Con
una certa costanza vedo e sento Piercamillo Davigo, abbiamo un rapporto di
amicizia. Però sento più frequentemente Sergio Cusani, del quale pure sono
amico».
Un colpevole redento
le dà più soddisfazione?
«Non è questione di
soddisfazione, è questione del riconoscersi, di riconoscere le persone,
distinguere le persone dai loro atti. E magari considerare, cosa che vale
particolarmente per Sergio, il percorso che hanno fatto».
Gianni De
Michelis, la politica e il ballo di un "avanzo di balera".
Storia di Tommaso
Giacomelli su Il Giornale il 5 febbraio 2023.
Con lo sguardo ti
fulmina, ma con la parola ti tramortisce. Gianni De Michelis dietro a quegli
occhiali spessi nasconde un occhio vivace e arzillo, la sua faccia paffutella e
la sua corporatura sgraziata non devono trarre in inganno. Lui è un uomo
potente, padroneggia bene ogni campo dell'ingegno umano, spazia dalla filosofia
alla letteratura, dalle scienze alla fisica, con una disinvoltura
impareggiabile. Si è fatto le ossa in una città romantica e intrisa di cultura,
ha bagnato i piedi nella Laguna di Venezia fin dalla tenera età e,
all'Università Ca' Foscari, detiene con orgoglio una cattedra in Chimica. De
Michelis ha la propensione al comando e all'intrigo, la politica lo stuzzica e
lo affascina. Negli anni diventa un baluardo del Partito Socialista Italiano e
una figura di spicco del Pentapartito.
Quando l'Italia esce
dal grigiore e della morsa degli Anni di piombo, il veneziano si prende la
poltrona di ministro del Lavoro, quando a dirigere il governo c'è Bettino Craxi,
poi, fai il vicepresidente del Consiglio quando il primo ministro è il profeta
di Nusco, Ciriaco De Mita, infine, nei turbolenti primi anni '90 ricopre la
carica di ministro degli Affari Esteri. Quando gli chiedono cosa lo abbia spinto
a gettarsi tra le braccia della politica, lui risponde così: "Perché sono brutto
ed è l'unico modo che conosco per essere ammirato, amato o temuto". Dentro
all'animo, ciò che lo smuove di più, quel motore che gli fa vibrare le corde più
intime, sono quei vizi tipici dell'uomo comune. De Michelis è un patito del
ballo, fa le ore piccole nei club, ama conversare e danzare con un bicchiere in
mano. Le sale da ballo, le discoteche sono un suo chiodo fisso. Spesso si fa
immortalare dai flash intento a muovere le gambe sotto a una palla stroboscopica
e, perché no, in compagnia di qualche conquista del gentil sesso.
Quando l'Italia si
fa bella e traina l'Europa con la sua economia galoppante, sfoggiando un PIL
superiore alla Gran Bretagna, sembra di assistere a una nuova impennata di
benessere, che si riversa in ogni categoria. Ovviamente tutto è effimero, lo
scopriremo ben presto, ma la popolazione ignara, nel frattempo, si dedica con
tanta passione alla mondanità. Milano toglie l'abito austero del giorno per
indossare quello delle notte, più trasgressivo e frizzante. De Michelis non ha
paura a mischiarsi coi giovani e con chi ama spassarsela sotto al chiarore della
Luna. Egli crede che le discoteche siano un grande spazio di aggregazione,
forse, il migliore del periodo. "I locali notturni sono, dopo la famiglia e la
scuola, il più importante luogo di socializzazione per le nuove generazioni. Per
dirla con una battuta, nell’Italia di fine secolo le discoteche stanno
sostituendo il servizio militare dell’Italia dell’inizio del secolo come prima
grande scuola di vita e di comportamento per i giovani". Bizzarra e scherzosa
affermazione che, per lui, possiede una punta di verità.
Il ballo per lui è
un momento di evasione, di svago dalla routine quotidiana, dalle fatiche di
tutti i giorni. Guardando quello che succede con i ristoranti e gli alberghi,
pensa bene di realizzare di suo pugno una guida esplorativa per chi vuole
spendere il proprio denaro andando a ballare nei molteplici locali che si
possono incontrare lungo lo Stivale. Lui, ça va sans dire, li conosce bene e,
nel 1987, fa pubblicare questo libro dal titolo esplicativo: "Dove andiamo a
ballare questa sera? Guida a 250 discoteche italiane". Si tratta di una raccolta
semi-seria, indirizzata a chi vuole divertirsi in luoghi raccomandabili, a tutti
coloro che desiderano spendere bene il tempo e il denaro. Si spazia da Rimini,
capitale della movida italiana, alla Toscana, fino agli avamposti di Sud e Nord
Italia. Insomma, De Michelis non tralascia nulla. Tratta con dovizia di
particolari la cura degli ambienti, del servizio, della musica, la composizione
della platea, la qualità del bar e dei servizi di ristorazione. Lo fa con garbo,
con classe e con un rigore scientifico. Sembra sciocco, ma lo scafato
protagonista della politica italiana sa che chi frequenta quei luoghi, poi,
andrà a votare. Inoltre, introduce il suo libro snocciolando dati e analisi
economiche, dandogli una dignità ben precisa. Il settore della vita notturna,
all'epoca, portava un indotto alle casse statali di millecinquecento miliardi di
lire. Un'industria vitale per il Bel Paese.
A proposito della
curiosa opera letteraria sopra citata, Enzo Biagi ebbe modo di dire la sua,
apostrofando De Michelis come "un avanzo di balera". Un'etichetta sgradevole, ma
che saggiamente mostrava le due facce della medaglia di un uomo, che quando
l'inchiesta "Mani Pulite" si infranse sull'Italia con la forza di un tornando,
scoperchiando i tetti e gettando fuori il marcio della politica e
dell'establishment nazionale, finì inevitabilmente per coglierlo in fallo.
Il viveur, il dotto accademico, l'abile politico terminava la sua corsa nella
morsa dei tribunali. L'Italia gaudente si spegneva nelle aule della giustizia.
Sulla testa del doge veneziano pendeva una condanna definitiva di un anno e sei
mesi patteggiati per corruzione nell'ambito delle tangenti autostradali del
Veneto, e, di sei mesi patteggiati nell'ambito dello scandalo Enimont. La pena
complessiva di due anni fu, però, sospesa con la condizionale. De Michelis ebbe
modo di rifarsi nella sua seconda vita politica, trovando rifugio tra i vari
partiti risorti dalle ceneri del PSI, guadagnando anche una poltrona al
Parlamento Europeo. Morì di Parkinson all'età di 78 anni, nel 2019, nella sua
Venezia. Gianni De Michelis è stato una figura simbolo di un'Italia
spregiudicata, rampante, ma corrotta nelle viscere. Tenere in mano la sua opera,
a oltre tre decadi di distanza, ci offre lo spaccato su una società vivace ed
effervescente nella sua dissimulante facciata.
È morto Giorgio
Ruffolo, ex ministro del Psi in quattro governi. Antonio
Carioti su Il Corriere della Sera il 16 febbraio 2023
È scomparso a Roma a
96 anni. Con i socialisti militò nella corrente di Antonio Giolitti e nella
sinistra lombardiana
Per Giorgio Ruffolo
le parole socialismo e riformismo non era mai divenute etichette vuote. L’ex
ministro dell’Ambiente, scomparso all’età di 96 anni, si era sempre sforzato di
riempirle con idee e progetti, perché riteneva che il capitalismo non potesse
essere lasciato allo stato brado, se ci si proponeva di assicurare all’umanità
condizioni di vita meno crudeli e sperequate. Senza indulgere all’utopia, non si
era mai rassegnato all’accettazione dell’esistente. Per questo si era impegnato
direttamente in politica nel Psi, ricoprendo cariche importanti, anche se la sua
vocazione più autentica lo indirizzava piuttosto verso la riflessione
intellettuale.
Nato a Roma nel
1926, fratello di due partigiani, Nicola e Sergio Ruffolo, catturati dai
fascisti e sfuggiti di poco alla morte, già nel 1944 era entrato nella gioventù
socialista (all’epoca collocata su posizioni rivoluzionarie, ma antistaliniste)
e aveva vissuto anche un periodo di vera a propria militanza trotskista al
fianco di Livio Maitan. Benché laureato in Giurisprudenza, si era presto
dedicato allo studio dell’economia e aveva trascorso anche un periodo presso
l’Ocse, a Parigi, prima di approdare, nella seconda metà degli anni Cinquanta,
all’Eni di Enrico Mattei, di cui ricordava con ammirazione il forte carisma, e
poi al Psi di Pietro Nenni, ormai svincolato dalla sudditanza nei riguardi dei
comunisti.
Nel 1962, dopo la
misteriosa morte di Mattei, Ruffolo era stato chiamato da Ugo La Malfa al
ministero del Bilancio, dove aveva assunto un ruolo di vertice. Nel 1964 aveva
elaborato un rapporto sulla programmazione economica, presentato dal ministro
Antonio Giolitti, che venne liquidato sbrigativamente come «libro dei sogni».
Qualcosa del sognatore in effetti c’era, nella personalità di Ruffolo, anche se
non perdeva mai il contatto con la realtà.
Negli anni Settanta,
da esponente della corrente giolittiana, aveva partecipato all’opera di
aggiornamento culturale del socialismo italiano avviato dalla rivista
«Mondoperaio», ma era sempre rimasto abbastanza critico verso Bettino Craxi, pur
senza diventarne mai un oppositore accanito. Però non è casuale che nel 1986
avesse scelto di fondare un altro periodico, «MicroMega», insieme a Paolo Flores
d’Arcais, che invece con il Psi aveva rotto in maniera aspra. D’altronde i due
direttori erano collocati su posizioni assai diverse: capitò anche, nel 1991,
che firmassero editoriali contrapposti e alla fine il sodalizio si sciolse con
l’addio di Ruffolo, che aveva sperato fino all’ultimo nel rinnovamento delle
forze politiche tradizionali, mentre Flores d’Arcais puntava su una prospettiva
nettamente antipartitocratica.
Parlamentare del Psi
dal 1979 al 1994 (prima in Europa, poi alla Camera e quindi al Senato) e
ministro dell’Ambiente dal 1987 al 1992 (governi Goria, De Mita, Andreotti VI e
Andreotti VII), Ruffolo non aveva mai rinunciato a interrogarsi sulla necessità
di fornire alla sinistra nuove chiavi d’interpretazione del presente. In
particolare fu tra i primi a sottolineare, nel saggio La qualità sociale
(Laterza, 1990) l’insufficienza di una visione quantitativa della crescita
rispetto ai nuovi bisogni che si andavano manifestando. E se venne scelto come
ministro dell’Ambiente, fu perché aveva sviluppato precocemente un’acuta
sensibilità per le questioni ecologiche.
Dopo il naufragio
del Psi determinato dal ciclone di Mani pulite, Ruffolo aveva aderito al Pds
(poi Ds), nei cui ranghi aveva trascorso dieci anni al Parlamento europeo. Ma
soprattutto, nella fase successiva, aveva approfondito in una serie di saggi
l’analisi dell’attuale modello di sviluppo e delle alternative possibili, senza
risparmiare critiche alle posizioni troppo generiche del Partito democratico,
che a suo avviso rischiavano «di perdersi nella retorica della chiacchiera».
In un testo il cui
titolo rifletteva il suo spiccato senso dell’umorismo, Il capitalismo ha i
secoli contati (Einaudi, 2008), Ruffolo aveva evidenziato i rischi insiti nella
finanziarizzazione galoppante dell’economia e lanciato un vigoroso allarme sul
fronte ambientale: «Fermare la distruzione del capitale naturale — scriveva — è
il primo comandamento della sopravvivenza umana». Con Stefano Sylos Labini, nel
saggio Il film della crisi (Einaudi, 2012), aveva invocato «un’azione politica
di livello internazionale per contrastare la mutazione finanziaria del
capitalismo», ripristinando le condizioni del precedente compromesso tra potere
economico e istanze democratiche, a cominciare dal controllo sui flussi della
finanza globale.
Per quanto riguarda
specificamente l’Italia, Ruffolo aveva manifestato le sue preoccupazioni per il
destino dell’unità nazionale nel libro Un Paese troppo lungo (Einaudi,
2009). Non temeva tanto una frattura traumatica, quanto quella che chiamava
«decomposizione», dovuta da una parte alle spinte «bizzarramente provocatorie»
del leghismo e, dall’altra, alla «secessione criminale delle mafie, che
sequestrano zone intere della Repubblica». Anche se non aveva mai cessato di
sperare in un rilancio dell’idea di solidarietà, negli ultimi tempi prevaleva in
lui una tendenza pessimista. «L’attaccamento ai piccoli e grandi privilegi» di
molti italiani gli appariva «profondamente inemendabile».
I funerali si
svolgeranno sabato 18 febbraio alle ore 15 presso la Chiesa Valdese di Piazza
Cavour.
La morte dell'ex
ministro. Chi era Giorgio Ruffolo: socialista, ambientalista e laico che credeva
nella politica.
Valdo Spini su Il Riformista il 19 Febbraio 2023
Spiegare oggi ad un
giovane che non l’ha conosciuto chi era Giorgio Ruffolo non è cosa facile,
perché la sua azione va contestualizzata nel periodo politico in cui si trovò a
vivere, ma il suo pensiero presenta tratti importanti di modernità che ci
possono aiutare anche oggi. Ruffolo era l’uomo del piano, della programmazione,
del progetto.
Oggi siamo in una
fase di transizione economica e produttiva e se non vogliamo andare avanti
disordinatamente, senza un progetto, incuranti di chi se ne avvantaggerà e di
chi invece rimarrà sotto le macerie della vecchia economia, rischiamo il
populismo se non peggio. Ministro socialista dell’ambiente, ebbe la sorte di
partecipare nel 1992 alla conferenza di Rio sul futuro della terra, una delle
pietre miliari dell’ambientalismo ecologista. Il suo lungo curriculum
professionale e istituzionale, parte addirittura dalla collaborazione con Enrico
Mattei all’Eni. Successivamente, Segretario Generale della Programmazione
economica, deputato europeo, deputato italiano e poi senatore, ministro
dell’Ambiente per tutta la legislatura ’87-’92, e ancora deputato
europeo, Giorgio Ruffolo ha percorso tutto l’iter di un’importante vicenda
istituzionale.
Lo ha fatto con la
competenza dell’economista di alto livello, ma anche con l’impegno di militante
politico. Socialista fino dai tempi della sua militanza nella Federazione
Giovanile Socialista Italiana, che a Palazzo Barberini ne 1947 andò
con Saragat per ripulsa dello stalinismo frontista. Rientrato nel Psi militò
nella corrente di Antonio Giolitti e poi nella sinistra di Riccardo
Lombardi. Insieme partecipammo alla fondazione dei Democratici di sinistra,
formazione politica che vide la collocazione del simbolo del Partito Socialista
Europeo alla base della Quercia del Pds al posto di quello del Pci.
LEGGI ANCHE
Su quest’ultima
esperienza vorrei soffermarmi. A quell’epoca avevamo fondato la Federazione
Laburista che fu una delle componenti essenziali degli Stati Generali della
sinistra che nel febbraio 1998 portarono alla formazione dei Ds. Il nostro
intento era quello di non disperdere l’importante impiantazione sociale e
territoriale di quello che era stato il Pci e, per quello che se ne poteva
salvare, anche del Psi, ma ristrutturarlo culturalmente e organizzativamente in
un moderno partito socialdemocratico o forse ancor meglio laburista. Purtroppo,
questa linea venne sconfitta. In nome della formazione di un Partito
Democratico a vocazione maggioritaria, si optò invece per un partito “leggero”
(e quindi debolmente organizzato sul territorio), che andasse aldilà
del socialismo europeo ma in questo modo dotandosi di riferimenti ideali e
valoriali troppo tenui per costituirne un efficace collante. Fu la famosa
“fusione a freddo” tra postcomunisti italiani e postdemocristiani di sinistra,
di cui gli stessi protagonisti ebbero poi a lamentarsi.
Quando questa
ipotesi si delineò facemmo con Ruffolo un’ultima battaglia. Al congresso
dei Ds del 2005, presentammo un “documento integrativo” a sei firme. Quella
di Giorgio Ruffolo e di Alfredo Reichlin, di Giorgio Benvenuto e di Bruno
Trentin, di Pasqualina Napoletano e mia. Volevamo andare oltre lo stesso simbolo
adottato a Firenze che aveva solo una lillipuziana sigla Pse, per scrivervi a
tutto tondo, Partito del Socialismo Europeo. Quando il documento integrativo
cominciò ad essere approvato in molte federazioni, il vertice del partito decise
di adottarlo e fu quindi approvato in congresso all’unanimità. Salvo che, meno
di due anni dopo, pur di imbracciare la strada della formazione del Pd, uscire
addirittura dal Pse. (In cui poi, ironia della storia, ve lo ricondusse Matteo
Renzi).
Rievoco queste
vicende, non per inutili rimpianti, ma per sottolineare come,
il centro-sinistra, la sinistra riformista, per ricucire un rapporto con
l’elettorato e in particolare con le classi lavoratrici che si è così
deteriorato, debba oggi ripartire da fondamenta politico-ideali come quelle che
animarono Giorgio Ruffolo. Da socialisti dobbiamo riaffermare il valore del
lavoro, sia quello subordinato che quello dell’impresa, da ambientalisti
affrontare con metodo programmatico i problemi della transizione ecologica, da
laici in politica affermare le regole di una società pluralistica ed
aperta. Giorgio Ruffolo credeva nella politica e quindi nel pubblico e voleva
che nel potere pubblico si affermasse una logica al tempo stesso di razionalità
e di partecipazione in un quadro capace di far esprimere al meglio l’iniziativa
privata su grandi obiettivi collettivi. Una lezione che consideriamo viva ed
attuale.
I ricordi che si
affollano nella mia mente sono tanti, alcuni molti belli, qualcuno più amaro
come la lotta politica inevitabilmente comporta. Dovrò forzatamente sceglierne
uno, e sarà l’ultimo. Quella telefonata che mi rivolse all’inizio di un gennaio
di tanti anni fa per chiedermi di sistemare le cose perché, quando fosse venuto
il momento, si potesse celebrare il suo funerale in Chiesa Valdese. Lui che era
un laico, aveva sentito il bisogno di un saluto, nel suo passaggio ad un’altra
vita, in quella che è forse la più laica delle Chiese Cristiane, in questo modo
arricchendo il messaggio politico militante e di uomo di profonda cultura che ci
lascia. Valdo Spini
Quell’
“accanimento funerario” di Travaglio contro Enzo Carra...Carra
è stato un esemplare di doppiogiochista, reticente, falso testimone o piuttosto
la vittima di chissà quali altri doppi giochi, reticenze e false testimonianze
giocate magari all’interno del suo stesso partito? Francesco Damato su Il Dubbio
il 6 febbraio 2023
In un prevedibile e
perciò puntuale accanimento persino funerario – trattandosi di un morto
– al Fatto Quotidiano non hanno gradito la generosità o l’ignoranza, o entrambe,
di quanti scrivendo nei giorni scorsi di Enzo Carra, l’ex portavoce di Arnaldo
Forlani alla segreteria della Dc, hanno scambiato per assoluzione
la riabilitazione da lui ottenuta dal tribunale di sorveglianza di Roma il 26
marzo del 2004, una ventina d’anni fa..
Essa, in effetti,
non annullò né capovolse la condanna definitiva ricevuta da Carra per false
dichiarazioni nel 1995, a conferma della condanna in appello, dell’anno prima, a
un anno e 4 mesi correttiva dei due anni comminatigli in primo grado, nel 1993,
con la sospensione condizionale della pena. La riabilitazione si limitò a
cancellare completamente dal casellario giudiziale gli effetti della condanna, a
fargli riacquistare le capacità perdute e ad ottenere l’estinzione delle
pene accessorie. Già nel 2001, del resto, Enzo era stato eletto deputato nelle
liste della Margherita, confermato nel 2006, rieletto nel 2008 nelle liste
del Pd, dove la Margherita di Francesco Rutelli era confluita.
Come ho già
ricordato scrivendone dopo la morte, Enzo – nel frattempo uscito dal Pd
per collocarsi più propriamente al centro con l’omonima Unione di ex o
post-democristiani praticamente offertasi alle improvvise ambizioni
politiche dell’allora presidente “tecnico” del Consiglio Mario Monti – sarebbe
stato probabilmente rieletto ancora se non fosse incorso nel veto opposto dal
senatore a vita alla candidatura di chiunque avesse avuto pendenze giudiziarie
negli anni di Tangentopoli, anche se riabilitato. Enzo si aspettava una difesa
di Pier Ferdinando Casini che mancò. O non avvenne con la convinzione, la forza
e soprattutto il risultato ch’egli si aspettava.
Oltre a contestare
il Carra “assolto” e “innocente” di troppi articoli scritti in sua memoria,
al Fatto Quotidiano hanno voluto riassumerne almeno il primo processo: quello al
quale l’imputato fu portato con gli schiavettoni ai polsi contestati persino da
Antonio Di Pietro, che lo prelevò personalmente dalla gabbia per portarselo
accanto a mani libere. «Nel 1993 – ha raccontato testualmente il giornale ancora
convinto, temo per altri passaggi del pezzo, della opportunità di
quegli schiavettoni – Graziano Moro, manager dc dell’Eni, racconta a Di Pietro
che il suo amico Carra, portavoce del segretario Forlani, gli ha raccontato una
stecca di 5 miliardi della maxitangente Enimont alla Dc. Di Pietro lo sente come
teste. Lui nega sotto giuramento. Di Pietro lo mette a confronto con Moro, che
arricchisce il racconto con altri dettagli. Carra nega ancora. Davigo gli
ricorda l’obbligo di dire la verità. Carra si contraddice, cambiando due o tre
versioni. L’articolo 371 del codice penale, voluto da Falcone e approvato nel
1992 solo dopo la sua morte, prevede l’arresto in flagranza dei falsi testimoni.
Carra viene arrestato e processato per direttissima».
Sembra di capire,
insomma, che Carra fosse stato arrestato e persino portato con gli schiavettoni
al processo, attraversando così i corridoi del tribunale di Milano, anche per
onorare la memoria di Falcone, trucidato l’anno prima con la moglie e quasi
tutta la scorta a Capaci. Poiché non dispongo – lo confesso senza vergogna o
disagio – degli archivi del Fatto Quotidiano e della memoria specialistica di
quanti vi scrivono, mi sono limitato a navigare per qualche minuto in internet
ed ho trovato di quella vicenda giudiziaria una cronaca
dell’insospettabile Repubblica. Che faceva parte del giro dei giornali di cui
l’amico Piero Sansonetti, allora all’Unità, ha onestamente raccontato che si
scambiavano informazioni e titoli su Mani pulite per uscire all’unisono a favore
degli inquirenti e contro gli imputati.
Ecco il racconto
di Repubblica: «Processo in tempi rapidi per l’ex portavoce di Arnaldo Forlani.
Enzo Carra, l’unico imputato di Tangentopoli arrestato con l’accusa di aver
mentito davanti al pubblico ministero (il dottor Di Pietro), entrerà in aula
giovedì mattina. L’udienza, per direttissima, è stata fissata davanti alla
prima sezione penale e, quasi certamente, sfileranno testimoni d’accusa
d’eccezione, come i democristiani Graziano Moro, ex presidente
dell’Eni Ambiente, e Maurizio Prada, “raccoglitore” delle mazzette per lo
Scudocrociato a Milano da più di dieci anni. L’arresto di Carra era scattato
quando Moro era insorto: “Voi lo sapevate benissimo, delle tangenti per l‘affare
Enimont”, aveva detto al forlaniano doc. Ma se quel “voi” indicasse la corrente
o la Dc nazionale, non si è mai appreso con certezza. Gli avvocati di Carra, che
è in carcere da oltre dieci giorni, hanno annunciato che rinunceranno a chiedere
“i termini a difesa” per consentire l’immediata celebrazione del processo».
Da questa cronaca
giudiziaria, ripeto, dell’insospettabile Repubblica non risulta il
Carra del Fatto Quotidiano che si procura l’arresto con non so quante versioni
delle rivelazioni attribuitegli da Graziano Moro, peraltro collega di partito.
Nei cui riguardi, peraltro, nella sentenza d’appello si riconosce al pur
condannato Carra “un raro senso della dignità” non avendo mai rinnegato,
anzi confermando sentimenti di amicizia. Vi sembra questo Carra del 1993 un
esemplare di doppiogiochista, reticente, falso testimone? O non piuttosto la
vittima di chissà quali altri doppi giochi, reticenze e false testimonianze
giocate magari all’interno del suo stesso partito?
La guerra di
Travaglio non finisce mai: si accanisce su Carra.
Il direttore del
"Fatto" più manettaro dei pm. Nessuna pietà per l'ex dc persino da morto. Marco
Gervasoni su Il Giornale il 5 febbraio 2023
Leo Longanesi amava
dire che in Italia le rivoluzioni cominciamo in piazza ma finiscono a tavola ma
forse l'animo degli italiani non è così benevolo come credeva il grande
romagnolo. Al contrario, essi tendono a non dimenticare e a riprodurre quasi in
eterno le loro piccole guerre civili. Niente pietà, anche per i vecchi
protagonisti che, quando defungono, continuano a essere trattati senza alcuna
misericordia e soprattutto senza alcuna distanza. Forse la premessa è troppo
aulica per parlare di Marco Travaglio ma calza a pennello per il suo ricordo di
Enzo Carra, il giornalista ed ex parlamentare scomparso il 2 febbraio,
pubblicato sul Fatto quotidiano di ieri.
Per Travaglio, come
per la «signora» di Loredana Berté in una famosa canzone di Ivano Fossati, «la
guerra non è mai finita». Anzi, i nemici, i corrotti, spuntano da ogni dove e
dopo trent'anni siamo punto daccapo perché la rivoluzione giudiziaria non è
andata fino in fondo, la ghigliottina non ha lavorato abbastanza e i «contro
rivoluzionari» hanno rialzato la testa. Per questo, non bisogna avere pietà
alcuna, né verso i reduci vivi, né tanto meno per i morti. Così Carra,
giornalista, portavoce di Forlani, arrestato da Di Pietro nel 1993 e esposto in
manette, può ben essere definito una delle tante vittime di Tangentopoli. E non
solo per quel trattamento da gogna. Come ricorda Gherardo Colombo, autore della
introduzione all'ultimo libro di Carra, Ultima repubblica (Eurilink University
press) le cui bozze sono state consegnate pochi giorni prima della morte, il
pool di Mani pulite poteva evitare di incarcerarlo. Colombo, pubblico ministero
di quel gruppo, negli anni successivi era diventato amico di colui che aveva
fatto arrestare. E oggi, su quella vicenda di Tangentopoli, ha uno sguardo
lucido. «Anche la magistratura (meglio, qualche magistrato)», scrive Colombo,
«anche inconsapevolmente ha dato allora una mano a scaricare sulla sua categoria
responsabilità non sue», cioè è stato tentato di svolgere un ruolo politico. Ma
Travaglio, no, resta tetragono nelle sue certezze di allora e inneggia ancora e
sempre al Di Pietro, alle manette, contro un Carra defunto, che per lui resterà
in eterno corrotto. Carra ebbe una seconda vita: fu parlamentare della
Margherita e poi del Pd. Ma per Travaglio questo non fu un merito; anzi, lascia
intendere, fu piuttosto un premio elargito tra politici conniventi. E quindi
niente, ecco cancellata tutta la vita successiva all'arresto, ecco Carra
fotografato in eterno con gli schiavettoni, con le manette, che per Travaglio
era giusto si stringessero ai suoi polsi. Non serve che Carra sia stato un fine
giornalista, prima e dopo l'arresto, se abbia scritto dei libri, se sia stato in
definitiva una persona, resta il simbolo della santità della rivoluzione
giudiziaria: il politico ai ceppi, il massimo dell'orgasmo. Capirà il lettore
che quando noi garantisti parliamo di «manettari», non è quindi un linguaggio
figurato. Colpisce un altro aspetto nel ritratto al veleno di Travaglio, un
termine che appare alla fine, l'evocazione della «giustizia di classe». Carra,
spiega il direttore del Fatto quotidiano, si meritava le catene perché in catene
finiscono anche i normali arrestati, i poveracci. Invece di essere coerente, e
di scrivere che gli schiavettoni erano e sono umilianti, e quindi chiederne un
uso moderato, Travaglio lancia il suo slogan: manette per tutti, che siate
tossici o politici, imprenditori o clandestini, finanzieri o ladruncoli da
strada. Tutti in manette, tutti in galera, come da tormentone di Giorgio
Bracardi. In galera anche i defunti e, non potendoli più tenere in cella, almeno
incarcerare la loro memoria.
Enzo Carra e la
toccante celebrazione del suo funerale. Il racconto di Anzaldi.
Di Michele
Anzaldi il 05/02/2023 su Cultura/formiche.net.
“I morti non fanno
la guerra”, come dice il proverbio, ma in questo caso verrebbe da dire che hanno
trasmesso dei valori. Lettera di Michele Anzaldi sui funerali di Enzo Carra
“Mortui non mordent”
(un uomo morto non fa più la guerra). Mai come in quest’occasione si è rivelato
appropriato il proverbio latino. Oggi, sul Giornale di Augusto Minzolini, Marco
Gervasoni risponde al fondo infamante – non dimentichiamo la tempistica –
pubblicato ieri dal Fatto quotidiano giornata dei funerali di Enzo Carra.
Tralasciando gli
aspetti umani e il rispetto del dolore dei suoi cari e delle persone amiche, per
capirne l’inappropriatezza e infondatezza invito a leggere Gervasoni. O forse
sarebbe meglio leggere l’ultimo libro scritto da Carra (l’ok alla pubblicazione
è stato dato dal letto dell’ospedale Gemelli), uscito proprio in queste ore col
il titolo “Ultima Repubblica”, edito da Eurilink University Press.
A dimostrazione di
come è stata superata e rivalutata la vicenda rievocata in maniera inutilmente
polemica da Travaglio, il libro si apre con un dialogo tra Carra e proprio uno
dei magistrati del pool di Mani pulite, Gherardo Colombo, conseguenza di un
rapporto che si è creato e consolidato dopo la il dibattito nato anche dalla
famosa foto degli schiavettoni.
Ma lasciando da
parte queste risposte giornalistiche, rimane il dolore per la perdita
inaspettata di Carra.
E allora vorrei
pubblicamente fare i complimenti alla moglie, la signora Olga, e al
figlio Giorgio per il toccante funerale che si è svolto nonostante la
situazione: la moglie costretta su una sedia a rotelle per la frattura di femore
e anca, ricoverata a Torino e giunta a Roma di notte appena in tempo per
l’ultimo saluto; il figlio colpito non solo dal dolore ma anche dalla burocrazia
funeraria. La bellissima chiesa di Sant’Andrea al Quirinale, progettata da
Lorenzo Bernini, grazie alla pianta ellittica ha trasmesso ai tanti partecipanti
la sensazione di vicinanza o addirittura di una riunione di redazione, come le
tante presenziate da Carra nella sua lunga carriera giornalistica. Un
ringraziamento al parroco Alessandro Manaresi, che nell’erudirci sulla bellezza
della chiesa museo e dell’eccezionalità di celebrare un funerale in quel luogo,
ha spiegato che ciò era possibile perché era il luogo abituale di incontro e di
confronto tra lui ed Enzo.
Una celebrazione
bella e toccante, che a causa della grande partecipazione ha dovuto limitare gli
interventi solo a tre. Il primo fatto dal giornalista Francesco Giorgino, in
rappresentanza dei numerosi allievi giornalisti cresciuti in redazione con Enzo.
Il secondo in rappresentanza dei colleghi giornalisti fatto da Paolo Franchi.
L’ultimo, il più toccante, dell’artista, cantautore, poeta, intellettuale e
tanto altro David Riondino, che letteralmente ha rapito tutti recitando una
poesia di Antonio Machado, Retrato, da “Campos de Castilla”.
Poesia molto bella e
toccante che nella parte finale dice: “Al mio lavoro adempio con i miei soldi,
pago l’abito che mi copre e la dimora che abito, il pane che mi nutre e il letto
dove giaccio. E quando giungerà il dì dell’ultimo viaggio, e salperà la nave che
non ritorna mai, mi troverete a bordo leggero di bagaglio, quasi svestito, come
i figli del mare”.
Caro Giorgio, devi
essere orgoglioso di tuo padre e dell’ultimo saluto che sei riuscito a
organizzare.
Anzi mi permetto di
proporti, alla luce di certe miserie, di rendere pubblico il “Libro delle
Condoglianze”. Non avevo mai visto una partecipazione così ampia di grandi
giornalisti, direttori, opinionisti, editorialisti di sinistra e di destra,
politici, rappresentanti delle più alte istituzioni e belle e oneste persone
normali.
È stato veramente un
bel funerale, tutti in semi cerchio intorno a quell’inaspettata bara. “I morti
non fanno la guerra”, come dice il proverbio, ma in questo caso verrebbe da dire
che hanno trasmesso dei valori.
Sul carro di
Carra
– Il Fatto Quotidiano Pubblicato il 4 Febbraio 2023
La scomparsa di Enzo
Carra a 79 anni e i coccodrilli della stampa italiana che lo dipinge come un
martire della malagiustizia, addirittura un “assolto”, sono un’ottima cartina al
tornasole del “Paese di Sottosopra” (Giorgio Bocca). Nel 1993 Graziano Moro,
manager dc dell’Eni, racconta a Di Pietro che il suo amico Carra, portavoce del
segretario Forlani, gli ha raccontato una stecca di 5 miliardi della
maxitangente Enimont alla Dc. Di Pietro lo sente come teste. Lui nega sotto
giuramento. Di Pietro lo mette a confronto con Moro, che arricchisce il racconto
con altri dettagli. Carra nega ancora. Davigo gli ricorda l’obbligo di dire la
verità. Carra si contraddice, cambiando due o tre versioni. L’articolo 371 bis
del Codice penale, voluto da Falcone e approvato nel 1992 solo dopo la sua
morte, prevede l’arresto in flagranza dei falsi testimoni. Carra viene arrestato
e processato per direttissima.
Il mattino
dell’udienza viene tradotto dal carcere al tribunale in fila con altri 50
detenuti, tutti ammanettati e legati a una catena: i famosi “schiavettoni”,
previsti dalla legge (voluta tre mesi prima dai socialisti) per evitare
evasioni. L’aula è gremita e i carabinieri lo sistemano nella gabbia degli
imputati. Di Pietro e Davigo lo fanno uscire e sedere accanto agli avvocati.
Carra stringe la mano a Di Pietro e a Moro. Ma la sua foto in manette scatena la
bagarre in Parlamento con urla e strepiti contro gli aguzzini di Mani Pulite: le
manette si addicono agli imputati comuni, non ai signori. L’indomani alcuni
detenuti del carcere di Asti scrivono alla Stampa: “Siamo tutti ladri di
galline, eppure in tutti i trasferimenti veniamo incatenati ben stretti, per
farci male, e restiamo incatenati in treno, in ospedale, al gabinetto, sempre.
Anche noi appariamo in catene sui giornali prima di essere processati, ma
nessuno ha mai aperto un dibattito su di noi. Oggi ci siamo domandati quali
differenze esistano fra noi e il signor Carra. Al quale, in ogni caso,
esprimiamo solidarietà”. Carra viene condannato a 2 anni per false dichiarazioni
al pm, poi ridotti in appello a 1 anno e 4 mesi per lo sconto del rito
abbreviato e confermati in Cassazione. Il Tribunale ritiene che, avendo
depistato le indagini sulla più grande tangente mai vista in Europa, “furono
quantomai opportuni il suo arresto, la direttissima e la pena non confinata ai
minimi di legge”. I giudici d’appello censurano il suo “poco apprezzabile
sentimento di omertà”. Nel 1995 destra, centro e sinistra cancellano la legge
Falcone sull’arresto dei falsi testimoni. Carra, che da incensurato non era
deputato, lo diventa da pregiudicato nel 2001 con la Margherita. E, oggi come
trent’anni fa, la legge uguale per tutti fa scandalo: meglio la vecchia, lurida
giustizia di classe. Sorgente: Sul carro di Carra – Il Fatto Quotidiano
Estratto
dell'articolo di Alberto Giannoni per “il Giornale” il 7 febbraio 2023.
Giorgio Carra,
giornalista, 39 anni, 5 giorni fa è scomparso suo padre Enzo, portavoce Dc alla
fine degli anni Ottanta.
«Sono stordito.
Nell’ultimo anno aveva avuto problemi, ma niente faceva presagire un precipizio
così rapido» […]
Com’era Enzo Carra
privato?
«[…] Colto, era
abbonato a due teatri, leggeva sempre. Quando ha avuto la crisi, gli avevo
portato lo zainetto con i-pad e cellulare per leggere. Era una biblioteca
vivente. Amava la politica e conservava molte amicizie. Gli chiedevano consigli,
la politica per lui era visione».
Che idee aveva?
«Era e restava un
giornalista, notista politico del Tempo, poi portavoce Dc, non deputato, quello
dopo, con la Margherita, nel 2011. Era profondamente credente, ma aveva idee
molto moderne».
La foto del suo
arresto in catene è rimasta nella storia.
«Avevo 9 anni.
Quella foto è l’emblema di come non devono andare le cose. Poche settimane prima
era stato arrestato Riina, che se la rideva, non certo con quegli schiavettoni a
favore di camera».
E poche settimane
fa Messina Denaro, senza manette. «È civiltà» è stato detto.
«Giusto. E Carra
invece sì. Un giornalista, messo alla gogna per uno show, a mio avviso per far
sì che si capisse chi comandava, chi aveva il potere in quel momento. Era il
simbolo della politica vinta dal pool. Ed era uno che non poteva dire niente, se
non inventandoselo. Accusato da qualcuno che al momento dell’accusa è stato
liberato. Trattato come una bestia».
Ne parlava?
«Tranquillamente,
sì, si era tolto qualche sassolino ma non era capace di rancori. Una
consolazione ora è che sia morto dopo aver visto, anche se solo on line, il suo
ultimo libro, L’Ultima repubblica. Il cartaceo è uscito il giorno della morte.
L’introduzione è un
dialogo con Gherardo Colombo, del pool, che si era pentito di alcune cose. Sono
diventati amici, una delle ultime telefonate che ha ricevuto era sua».
Era un episodio
chiuso.
«Il 99% delle
persone ha capito. E che il Capo dello Stato abbia usato quelle parole dice
tutto. Era tornato a fare il giornalista, aveva intervistato Madre Teresa.
L’ultima cosa che voglio è che resti inchiodato a quella foto».
Il giustizialismo
[…] C’è ancora.
«Ha avuto seguito,
pensi a Grillo, e al suo fedelissimo che si è distinto anche stavolta, non lo
cito neanche, è stato l’unico».
Marco Travaglio?
«Non scendo su certi
livelli. Non l’ha mai fatto mio padre e non lo farò nemmeno io» [...]
Estratto
dell'articolo di Filippo Ceccarelli per “la Repubblica” il 7 febbraio 2023.
Ecce Carra, ecce
homo. Perché non si vorrebbe esagerare, né farla troppo complicata, però
riguardandosi la foto di Enzo Carra trascinato con le catene ai polsi al Palazzo
di Giustizia di Milano fra due ali di giornalisti, fotografi e telecamere, ecco,
solo ora si capisce come in epoca post-moderna certe icone paiono destinate a
sostituire le figure di un immaginario religioso che nella loro potenza
simbolica, così come nella concretezza, non sono affatto lontane da un contesto
religioso ravvivato dai tanti Cristi ritratti con le mani.
Enzo Carra, che
ieri se n’è andato a 79 anni, era certamente un credente, ma siccome nel ricordo
resta un uomo simpatico e spiritoso, ci avrebbe fatto su una risata. Eppure, nel
ricordare quella sequenza di flash ha scritto: “In quel momento ho capito
perfettamente di essere un simbolo; io ero la Dc trascinata in catene e
processata”.
Era il marzo del
1993, poco prima che venisse giù tutto. Fu una passerella tanto orchestrata
quanto avvilente. Ammutolito dai giornalisti che gli chiedevano se quegli
arcaici schiavettoni gli facevano sanguinare i polsi, il portavoce del
segretario della Dc Forlani fu trainato nella gabbia degli imputati. Quando in
aula s’intensificò la bolgia, Di Pietro platealmente ebbe l’intuito di
accompagnarlo in prima fila, vicino agli avvocati, ma l’immagine destinata a
rimanere impressa restò per sempre quella di Carra ammanettato con un
carabiniere a destra e uno a sinistra.
(…)
E davvero qui
dispiace inchiodare Carra a quelle foto che sanno di vergogna e martirio. Anche
perché da esse Enzo ebbe poi la fortuna di trarre sapienza e coraggio per
rifarsi una vita (fu condannato non per corruzione ma per falsa testimonianza),
pure come senatore della Margherita e imprescindibile conoscitore della Prima e
della Seconda Repubblica. Ma come accade per i simboli, l’immaginario non fa
sconti, nemmeno dopo la morte. Così vale ricordare che la scena delle manette
suscitò le più contraddittorie emozioni: «Anche la Gestapo» disse Forlani; non
moltissimi protestarono, fra cui Boato, Biondi, Anna Finocchiaro; Occhetto si
disse turbato; il ministro della Giustizia Conso fu drastico: «È stata tradita
la giustizia, l’episodio disonora il Paese».
Dei telegiornali il
Tg1, il Tg3 e il Tg4 censurarono le immagini, il Tg2 coprì il volto e i ferri,
il Tg5, ammiraglia Mediaset, fece vedere tutto. Ma “la gente” non dovette
disapprovare gli schiavettoni ai polsi di Carra se, secondo un sondaggio, 63
milanesi su cento li giudicarono “una cosa giusta”. Tacquero, come chi
acconsente, leghisti, missini e repubblicani. Fu in quell’occasione che il
professor Miglio, padre putativo del modello presidenzial- federalista portato
avanti dall’odierna maggioranza di governo, affermò: «Il linciaggio è la forma
di giustizia nel senso più alto della parola». Da lassù, Enzo saprà compatirlo,
o almeno speriamo.
(ADNKRONOS il 2
Febbraio 2023) - È morto nella notte a Roma Enzo Carra, giornalista, portavoce
della Dc tra il 1989 e il 1992, poi deputato prima della Margherita e poi del
Pd. Era ricoverato da una settimana nel reparto di Terapia intensiva del
Policlinico Gemelli a causa di una crisi respiratoria. Avrebbe compiuto 80 anni
il prossimo 8 agosto.
Da
www.cinquantamila.it
- la storia raccontata da Giorgio Dell'Arti
Enzo Carra, nato a
Roma l’8 agosto 1943. Politico. Giornalista. Leader teodem. Eletto deputato con
la Margherita nel 2001, l’Ulivo nel 2006 e il Partito democratico nel 2008,
passato all’Udc il 14 gennio 2010. Non è stato ricandidato per le elezioni
politiche di febbraio 2013 «Casini nel darmi la notizia della mia esclusione
l’ha motivata con il no di Monti il quale non ha ammesso eccezioni al codice
etico, ma la mia condanna di vent’anni or sono per false o reticenti
dichiarazioni al pm riguardava vicende della Dc alle quali ero totalmente
estraneo».
• Nel 1993, da
portavoce dell’allora segretario della Dc Arnaldo Forlani, fu chiamato a
testimoniare sulla tangente Enimont alla Democrazia cristiana (vedi Sergio
Cusani): accusato per «dichiarazioni reticenti» dal pubblico ministero Antonio
Di Pietro, processato per direttissima e tradotto in aula con schiavettoni e
catene, la drammatica immagine fece il giro del mondo e suscitò i primi dubbi su
certi metodi del pool Mani Pulite.
• «Ti chiedevano
una cosa, gli rispondevi che non ne sapevi nulla, ma loro volevano comunque che
tu accusassi qualcuno. Io mi rifiutai di partecipare a questo gioco al massacro
e pagai a caro prezzo, anche se tutti i condannati per Enimont, da Cusani a
Severino Citaristi, confermarono che non ne sapevo nulla. Vissi quel dramma come
la prova della mia vita. E se riuscii a superarla fu perché, anche grazie alla
violenza che mi fu riservata, il clima nel Paese cominciò a migliorare e i
garantisti trovarono finalmente spazio sui media».
• È favorevole a una
riforma della giustizia: «In Italia si è creato un corto circuito che è dato
dall’assenza di immunità, dal fatto che non si possono sospendere i processi per
le alte cariche e che i magistrati hanno l’obbligo dell’azione penale. Questo è
un problema obiettivo, che rende debole la politica rispetto alla magistratura.
Discutiamone».
• «Da portavoce di
Arnaldo Forlani entrava in Transatlantico chiedendo: "Ahò, che gli faccio dì
oggi ad Arnaldo?". Mitico» (Luca Telese) [Grn 19/10/2007].
• «Di amici politici
vedo solo Enzo Carra, di razza e surreale» (Carlo Degli Esposti, produttore
televisivo).
• «Con Tremonti è
tra i miei clienti più esigenti. Chiede tagli pettinabili e pratici» (Riccardo
Balestra, parrucchiere).
Addio al
portavoce Dc. Chi era Enzo Carra, il forlaniano ridotto in schiavettoni.
Paolo
Guzzanti su Il Riformista il 3 Febbraio 2023
Ciò che gli avevano
messo ai polsi, a Enzo Carra, quel giorno di marzo del 1993 in
piena Tangentopoli per esporlo alla gogna dei giornalisti, erano gli
schiavettoni, non le manette. Attrezzi del genere usato sulle navi negriere: due
pezzi di ferro con anelli per tenere i polsi legati da una catena. Un oggetto
che si poteva usare per i briganti dell’Aspromonte, i celebri mafiosi.
E invece si trattava
di un innocente catturato dal gruppo dei procuratori di “Mani Pulite”, nome
originario dell’operazione “Clean hands”.
Più tardi,
quando Enzo Carra e Antonio di Pietro si incontrarono, il famoso procuratore
negò di avere chiesto per lui l’uso di questo strumento medievale che aveva come
unico scopo quello di umiliare e rendere l’imputato penoso, ridicolo, e
certamente colpevole di fronte a un’opinione pubblica e un giornalismo incline
al linciaggio in un’epoca assetata di simboli carcerari. Mancavano soltanto le
palle al piede con la catena e il pigiama a strisce degli ergastolani.
E onestamente non è
vero affatto che a quei tempi un fremito d’indignazione spingesse tutti
i giornali e i giornalisti ad aver cura o almeno rispetto dei diritti
dell’accusato sottoposto alle umiliazioni più cocenti non perché fosse
certamente colpevole, ma perché l’ideologia del gruppo di magistrati precedeva
l’umiliazione simbolica della politica e dei politici, anzi aprendo la strada al
vilipendio sistematico delle istituzioni attraverso il vilipendio dei singoli
imputati. Enzo Carra era innocente, fu riconosciuto innocente, nessun indizio e
nessuna prova, ma gli fu detto che non era in questione la sua innocenza ma il
suo ruolo politico. L’umiliazione degli imputati politici era stata già usata
con successo nei processi staliniani e poi in quelli nazisti, in cui si faceva
largo uso di abiti e strumenti di detenzione che mettessero in ridicolo
l’accusato. Così, quando Enzo Carra fu arrestato ed esposto ai fotografi con una
messinscena degna della polizia franchista in Spagna, veramente in pochi si
indignarono, mentre i più risero o almeno sorrisero.
In fondo, il
giornalista Enzo Carra faceva ridere messo ai ferri ed esposto in catene. Faceva
ridere quell’uomo con la barba, vecchio giornalista passato alla politica dalla
parte sbagliata: quella di Arnaldo Forlani e accusato a causa di quello
schieramento. Secondo molti, dietro la disgrazia di Carra c’era stato il ritorno
nella corsa al Quirinale di Giulio Andreotti, il quale però si trovò la porta
sbarrata da Forlani e Craxi con cui prima aveva formato una sorta di triumvirato
detto “Caf” dalle iniziali dei protagonisti. Ma il terzetto si era rotto,
Andreotti era rimasto indietro e voleva tornare in prima linea a Forlani gli
sbarrava la strada. E Enzo Carra era forlaniano.
Tutta la stampa
liberal era schieratissima contro il Caf per avversione radicale
contro Craxi che aveva finito con assorbire anche Andreotti. E quindi acciuffare
un giornalista come Carra che era considerato un portavoce del “Coniglio
mannaro” (nomignolo corrente per Arnaldo Forlani) e dunque un perfetto bersaglio
per una operazione politica che troncasse gli eventuali progetti di Craxi. Più
tardi Carra fu tra i fondatori della Margherita e poi partito unico fatto di
democristiani e comunisti da cui però si scostò. Ma ai tempi di Forlani, Carra
fu eletto deputato nelle file della Dc dove ebbe l’importantissimo ruolo di
portavoce della segreteria del partito diventò dunque un uomo di peso rilevante.
Quale moto di
indignazione volete che portasse un democristiano per di più “forlaniano” cioè
aderente membro attivo del gruppo di Craxi Andreotti e Forlani. Oggi è tutto
dimenticato. Restano solo gli schiavettoni contro i quali protestò
anche Francesco Cossiga. Ma non dimentichiamo che più di metà del paese di
fronte a quello spettacolo immondo si sentì rallegrata e mormorò: “Ben gli sta,
forlaniano di merda”.
Paolo Guzzanti.
Giornalista e politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della
Fondazione Italia Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza
Italia e deputato nella XVI per Il Popolo della Libertà.
Estratto
dell'articolo di Filippo Ceccarelli per “la Repubblica” il 3 Febbraio 2023.
Ecce Carra, ecce
homo. Perché non si vorrebbe esagerare, né farla troppo complicata, però
riguardandosi la foto di Enzo Carra trascinato con le catene ai polsi al Palazzo
di Giustizia di Milano fra due ali di giornalisti, fotografi e telecamere, ecco,
solo ora si capisce come in epoca post-moderna certe icone paiono destinate a
sostituire le figure di un immaginario religioso che nella loro potenza
simbolica, così come nella concretezza, non sono affatto lontane da un contesto
religioso ravvivato dai tanti Cristi ritratti con le mani.
Enzo Carra, che
ieri se n’è andato a 79 anni, era certamente un credente, ma siccome nel ricordo
resta un uomo simpatico e spiritoso, ci avrebbe fatto su una risata. Eppure, nel
ricordare quella sequenza di flash ha scritto: “In quel momento ho capito
perfettamente di essere un simbolo; io ero la Dc trascinata in catene e
processata”.
Era il marzo del
1993, poco prima che venisse giù tutto. Fu una passerella tanto orchestrata
quanto avvilente. Ammutolito dai giornalisti che gli chiedevano se quegli
arcaici schiavettoni gli facevano sanguinare i polsi, il portavoce del
segretario della Dc Forlani fu trainato nella gabbia degli imputati. Quando in
aula s’intensificò la bolgia, Di Pietro platealmente ebbe l’intuito di
accompagnarlo in prima fila, vicino agli avvocati, ma l’immagine destinata a
rimanere impressa restò per sempre quella di Carra ammanettato con un
carabiniere a destra e uno a sinistra.
(…)
E davvero qui
dispiace inchiodare Carra a quelle foto che sanno di vergogna e martirio. Anche
perché da esse Enzo ebbe poi la fortuna di trarre sapienza e coraggio per
rifarsi una vita (fu condannato non per corruzione ma per falsa testimonianza),
pure come senatore della Margherita e imprescindibile conoscitore della Prima e
della Seconda Repubblica. Ma come accade per i simboli, l’immaginario non fa
sconti, nemmeno dopo la morte. Così vale ricordare che la scena delle manette
suscitò le più contraddittorie emozioni: «Anche la Gestapo» disse Forlani; non
moltissimi protestarono, fra cui Boato, Biondi, Anna Finocchiaro; Occhetto si
disse turbato; il ministro della Giustizia Conso fu drastico: «È stata tradita
la giustizia, l’episodio disonora il Paese».
Dei telegiornali il
Tg1, il Tg3 e il Tg4 censurarono le immagini, il Tg2 coprì il volto e i ferri,
il Tg5, ammiraglia Mediaset, fece vedere tutto. Ma “la gente” non dovette
disapprovare gli schiavettoni ai polsi di Carra se, secondo un sondaggio, 63
milanesi su cento li giudicarono “una cosa giusta”. Tacquero, come chi
acconsente, leghisti, missini e repubblicani. Fu in quell’occasione che il
professor Miglio, padre putativo del modello presidenzial- federalista portato
avanti dall’odierna maggioranza di governo, affermò: «Il linciaggio è la forma
di giustizia nel senso più alto della parola». Da lassù, Enzo saprà compatirlo,
o almeno speriamo.
Enzo Carra, solo
poco prima di morire ha visto la copertina del suo libro su «L'ultima
Repubblica». Paolo
Franchi su Il Corriere della Sera il 2 Febbraio 2023
Da uomo della Prima
Repubblica, ingiustamente additato a simbolo vivente delle nequizie della
medesima, ha provato a ricostruire dall’interno i perché e i come della caduta
dell’Antico Regime, rievocandone grandezze e miserie
Del suo ultimo
desiderio non mi aveva mai parlato esplicitamente, Enzo Carra, nonostante
fossimo amici più che fraterni. Ma ci giurerei su lo stesso. Sperava di vivere
abbastanza a lungo – sto parlando di mesi, di settimane, di giorni – per vedere
pubblicato il suo ultimo libro, e godersi il dibattito pubblico (lui lo avrebbe
voluto impietoso e serrato) che avrebbe suscitato. Ci aveva lavorato per anni,
scrivendo, correggendo, tagliando, e poi riscrivendo, ricorreggendo e
ritagliando ancora. Poi, finalmente, si era convinto di aver portato a
compimento il lavoro.
In non so più quale
convegno sui rapporti tra politica e magistratura aveva conosciuto Gherardo
Colombo. Non posso dire che cosa l’ex Pm di Mani Pulite pensasse e pensi di
Carra, l’ex portavoce di Arnaldo Forlani arrestato e trascinato in aula con gli
schiavettoni ai polsi a dimostrazione che un’intera classe politica era stata
sgominata dai magistrati: penso che ne abbia stima. Ma so per innumerevoli
testimonianze dirette che, per Enzo, Colombo era stato una scoperta politica,
intellettuale e soprattutto umana. Si erano visti e sentiti molte volte, in
pubblico e in privato. E da questa frequentazione era nata l’idea di far
precedere il testo del libro da un dialogo tra i due, fitto, ricco e, per quanto
è soprattutto sereno. L’idea si è realizzata, l’ultimo desiderio di Carra
no: Enzo ha fatto appena in tempo ieri, poche ore prima di andarsene, a farsi
passare dal figlio Giorgio il cellulare per vedere la copertina del libro, che
sta per arrivare in libreria, pubblicato da Eurilink, e ha per titolo «L’ultima
Repubblica». È già qualcosa, ma l’autore avrebbe meritato di più.
Non capita spesso
(anzi, per essere più precisi, fin qui non è capitato mai) che un uomo della
Prima Repubblica, a suo tempo sbrigativamente e del tutto ingiustamente additato
a simbolo vivente delle nequizie della medesima, provi sulla scorta della sua
esperienza non solo a ricostruire dall’interno i perché e i come della caduta
dell’Antico Regime, rievocandone grandezze e miserie, ma pure i perché e i come
del disastro cui il Nuovo ha consegnato, nel trentennio successivo, il
Paese. Carra ci ha provato, secondo me con successo, restando uomo di parte
anche quando la sua parte non c’era più, ma senza cedere per questo
all’indulgenza e all’autoindulgenza: di questo, credo, gli va dato atto e
merito.
Carra è stato un
giornalista raffinato e colto, i suoi primi passi nel mestiere li ha fatti
occupandosi di cinema e di teatro, ma non è mai stato, come si dice, «prestato
alla politica». La politica, quella interna come quella internazionale, sono
stati da sempre, ben prima di entrarvi in primissima persona, e ben oltre il
momento in cui la ha lasciata, o è stato costretto a lasciarla, il suo pane
quotidiano. Della politica (quella vecchia e, sempre che sia mai esistita,
quella nuova) conosceva a menadito la scena e i retroscena, i piani alti i piani
bassi e pure i sottoscala, anche perché li aveva praticati tutti. Senza politica
(politica fatta, non solo pensata) non sapeva stare, o almeno stava molto male.
Finché gli fu
possibile, appena gli si presentò l’occasione continuò a farla, prima nella
Margherita, poi nel Pd e infine, per qualche tempo, nell’Udc. E coltivò pensiero
politico senza disdegnare, anzi, la cosiddetta politique politicienne. Dei tempi
antichi ricordo un verbo, «accarrarsi», coniato da noi giovani cronisti
parlamentari che gli chiedevamo lumi sulle manovre interne alla Dc, e ne avevamo
in cambio oscure metafore e dotte citazioni. Di tempi più recenti l’amicizia con
Francesco Cossiga. Dei tempi nostri, la cena quasi settimanale con Olga e
Gabriella. E un’infinità di interminabili telefonate, zeppe di chiacchiere
giornalistiche, politiche e calcistiche (era un uomo di stadio come me, Enzo, ma
tutto all’opposto di me di incrollabile fede laziale). Già mi mancano, e ancora
più mi mancheranno nei giorni a venire.
Addio a Carra,
vittima di Mani Pulite. Quelle manette come arma di tortura.
Fu fatto sfilare in
tribunale con gli schiavettoni ai polsi per un reato poi cancellato. Di Pietro
voleva che accusasse Forlani. Stefano Zurlo il 3 Febbraio 2023 su Il Giornale.
Quell'immagine
borbonica di un uomo sfilacciato è una delle foto simbolo di Mani pulite.
L'icona di una stagione in cui le manette venivano prima della giustizia e la
giustizia si misurava col metro del pentimento. È il 4 marzo 1993 e Enzo Carra,
potente portavoce della ormai moribonda Dc, sfila con le manette ai polsi
attraverso i grandi saloni del Palazzo di giustizia di Milano.
Antonio Di Pietro e
il Pool gli contestano un reato cucito come un abito di sartoria su di lui: le
false informazioni al pubblico ministero. Un illecito per cui dal 94 sarà
impossibile arrestare.
Di Pietro l'ha
interrogato come persona informata sui fatti, più o meno nel primo anniversario
della rivoluzione giudiziaria cominciata il 17 febbraio 1992 con la cattura di
Mario Chiesa, e gli ha chiesto spiegazioni su una tangente da 5 miliardi di lire
incassata dal partito: il nome che tutti si aspettano è quello di Arnaldo
Forlani, uno dei tre lati del Caf, il triangolo che comanda l'Italia.
Bettino Craxi in
quel momento è già nel mirino della magistratura ambrosiana e viene bersagliato
da avvisi di garanzia, uno dopo l'altro; Giulio Andreotti invece sembra schivare
i colpi, che gli arriveranno da Palermo, e sul perché di quel galleggiamento
girano nel Paese infinite leggende, tutte più o meno di matrice complottistica.
Resta quell'obolo sostanzioso che potrebbe portare al segretario della Dc, ma
Carra dice di non saperne nulla e finisce a San Vittore.
Il 4 marzo va in
scena quello spettacolo avvilente: il prigioniero con i ferri, gli schiavettoni
che diventeranno un'icona, fissati con una lunga catena stretta nelle mani di un
carabiniere.
È tutto feroce, è
tutto senza umanità, è tutto sproporzionato ma quella è la metrica di Mani
pulite, forse all'apogeo in quei mesi.
«Prima dell'udienza
- mi raccontó un giorno - mi tennero una mezz'ora in una stanza dei sotterranei,
poi finalmente si decisero a spedirmi in aula. Stavano per mandarmi con le mani
libere, ma ci fu una telefonata e mi misero gli schiavettoni».
Carra, che ieri è
scomparso a 79 anni, riviveva quei giorni cupi cercando di descrivere tutti i
dettagli, come fa un giornalista, e lui era nato con la penna in mano: dopo un
esordio nella critica cinematografica, approda al Tempo dove rimane fino al
1987, firma di punta della cronaca politica; nell'89 diventa lo speaker del
partito e dunque l'ombra del potere ma la caduta del Muro e l'esplosione di
Tangentopoli mandano in pezzi quel mondo.
L'inverno 93 è
quello decisivo: ormai il Pool è sulle tracce della tangente Enimont, la
maxitangente che segnerà i suicidi di Gabriele Cagliari e Raul Gardini.
La procura di Milano
è una catena di montaggio: arresto, confessione, scarcerazione. Detenzioni
lampo, spesso, o addirittura nemmeno quelle: basta un avviso di garanzia per
correre a vuotare il sacco con un effetto domino che coinvolge imprenditori e
politici.
Però non sempre va
così, anche se obiettivamente è difficile resistere alla pressione che spinge
sempre nella stessa direzione: c'è chi contesta quei metodi, ma i provvedimenti
sono spesso confermati dai giudizi nei gradi successivi.
Succede anche con
lui: Carra viene condannato a 2 anni, poi ridotti a 1 anno e 4 mesi, pena
confermata in cassazione. E peró quel fotogramma scioccante e umiliante segna un
punto di non ritorno: molti Tg si rifiutano di trasmettere quella sequenza così
umiliante e le standing ovation per le toghe si affievoliscono.
«Io - spiegava lui -
mi rimisi in carreggiata solo grazie a un amico psichiatra e ricominciai a
lavorare solo dopo due anni, grazie a Minoli».
Alla Rai, Carra
confeziona alcune clamorose interviste: a Gheddafi e a Madre Teresa, forse
l'ultima prima della sua morte. Ma il demone della politica lo riafferra di
nuovo: sta con la Margherita e il centrosinistra nell'Italia bipolare e per tre
legislature è parlamentare, colto e ironico, mai cinico, con quella ferita
sempre pronta a riaprirsi.
Alla fine torna al
suo primo amore: ci siamo incrociati l'ultima volta tre anni fa a Radio3, nel
programma di Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà Tutta l'umanità ne parla: in un
gioco semiserio io impersonavo Craxi e lui Andreotti. Anche quella volta si
rivelò rigoroso, come sempre.
Il mio amico Enzo
Carra, vittima di quella sua grande passione politica.
Dell’ex portavoce
della Dc, morto a 79 anni, si continuerà a ricordare non tanto la lunga e
apprezzata attività giornalistica, saggistica e politica, quanto quella
maledetta foto in manette nel tribunale di Milano. Francesco Damato su Il Dubbio
il 2 febbraio 2023.
Di Enzo Carra, del
mio amico Enzo Carra, morto a 79 anni, temo che si continuerà sfortunatamente a
ricordare non tanto la sua lunga e apprezzata attività giornalistica, saggistica
e politica, quanto quella maledetta fotografia che negli anni terribili di
Tangentopoli - o di Mani pulite, come i magistrati di Milano vollero chiamare le
loro indagini sul finanziamento illegale dei partiti- lo riprese barbaramente in
manette nei corridoi del tribunale ambrosiano mentre raggiungeva l’aula del suo
processo.
Egli era stato
accusato, e infine condannato, non di corruzione o simili ma di reticenza: per
non avere detto della Dc e del suo segretario politico Arnaldo Forlani, di cui
era portavoce, ciò che gli inquirenti si aspettavano. O -come lui poi mi
raccontò- pretendevano che dicesse per stringere ancora di più al collo della Dc
e di Forlani il cappio gemello di quello che stavano stringendo attorno al Psi e
a Bettino Craxi. Del quale Forlani era amico ed alleato avendone favorito negli
anni 80 la scalata a Palazzo Chigi, ed avendo collaborato con lui come vice
presidente del Consiglio: veste nella quale, fra il 1983 e il 1987, il mio amico
Arnaldo si trovò spesso, volente o nolente, a proteggerlo dagli agguati non
tanto della forte e dichiarata opposizione comunista quanto dell’altrettanto
forte ma non del tutto esplicita avversione dell’allora segretario della Dc
Ciriaco De Mita. Che era salito anni prima al vertice del partito proponendosi
come argine all’avanzata del pur alleato leader socialista, giunto ad un palmo
da Palazzo Chigi già nel 1979, incaricato dal presidente socialista della
Repubblica Sandro Pertini ma fermato dalla direzione della Dc all’ultimo momento
con una votazione alla quale Forlani aveva partecipato astenendosi, cioè non
approvando lo stop.
Proprio a Palazzo
Chigi da vice presidente del Consiglio di Craxi, dopo un turno elettorale nel
quale la Dc guidata da De Mita aveva perso in un colpo solo ben sei punti
percentuali, Forlani chiamò Enzo Carra a fargli da portavoce. Nel dirimpettaio
palazzo dell’Inps, in Piazza Colonna, affittato al Tempo, Enzo aveva seguito
sino ad allora la politica con meticolosità e convinzioni moderate in linea con
quella testata.
La lunga
collaborazione con Forlani, tornato alla guida della Dc nel 1989, dopo averla
già guidata fra il 1969 e il 1973, rafforzò in Enzo Carra la simpatia per lo
scudo crociato, tanto da tentare l’elezione a deputato nelle sue liste a Roma,
purtroppo inutilmente. Ma né la delusione per quella mancata elezione, né il
coinvolgimento del partito nel terremoto giudiziario e politico di Tangentopoli,
o -ripeto- Mani pulite, né il suo personale impatto con quella tragedia da
imputato di reticenza, trattato con quegli schiavettoni ai polsi come un
criminale peggio che comune, lo distolsero da quella che era ormai diventata una
sua passione politica. Al contrario -sia detto a suo merito- la rafforzarono.
Una volta passati,
davvero o a parole, dalla cosiddetta prima Repubblica alla seconda, Enzo non si
lasciò scappare nessuna occasione per partecipare ai tentativi di salvaguardare
la memoria della Dc e di raccoglierne valori e tradizioni nei movimenti dove ciò
era possibile: per esempio, nella Margherita, dove alla fine confluirono i resti
della Dc contrari o impossibilitati, secondo le circostanze, a intrufolarsi nel
centrodestra berlusconiano. E Carra riuscì, nella sua ostinata passione
diventata ormai militanza, anche ad essere finalmente e ripetutamente eletto
deputato grazie anche alle nove leggi elettorali che risparmiavano ai candidati
il pesantissimo onere di cercarsi i vecchi voti di preferenza della prima
Repubblica. Egli segui la Margherita nel 2007 anche nella pur controversa
confluenza nel Pd, nelle cui liste fu rieletto nel 2008 ma da cui tuttavia uscì
per aderire all’Unione di Centro nel 2010.
La sua esperienza
parlamentare sarebbe continuata anche dopo le elezioni del 2013 se, fra i
candidati post-democristiani, chiamiamoli così, raccoltisi sostanzialmente
attorno alle liste improvvisate da Mario Monti non fosse incorso nello
sbarramento posto dallo stesso Monti contro chiunque avesse avuto pendenze
giudiziarie risalenti a Tangentopoli. Il colpo fu durissimo per lui, pur
riabilitato dal tribunale di sorveglianza di Roma nel 2004. Da quella delusione
praticamente non si riprese più, prendendosela tuttavia più che con Monti, in
pubbliche dichiarazioni, con Casini. Dal quale, nel ricordo della comune
collaborazione avuta con Forlani nella penultima segreteria della Dc, prima di
Martinazzoli, Enzo si aspettava una difesa a oltranza dalle forbici
giustizialiste del presidente del Consiglio succeduto a Berlusconi nell’autunno
del 2011.
Addio, Enzo, amico
mio. O arrivederci, nella nostra comune fede religiosa, pur dopo le
incomprensioni che non sono mancate fra di noi all’epoca, per esempio, della mia
direzione al Giorno. Dove mi rimproveravi, a tuo modo, tra telefonate e
bigliettini, di privilegiare nella linea politica i socialisti e Craxi rispetto
ai democristiani e a Forlani. Del quale, a un certo punto, volli verificare
personalmente gli umori scoprendo che non erano quelli del suo portavoce.
L’ultima
intervista a Enzo Carra, il giornalista simbolo degli orrori di Mani Pulite.
Aldo Torchiaro su Il Riformista il 2 Febbraio 2023.
E’ morto oggi a Roma
il giornalista ed ex deputato Enzo Carra. Arguto, brillante, coltissimo, è stato
un maestro per i giornalisti che hanno avuto la fortuna di frequentarlo. Sempre
gioviale, aveva per il suo lavoro e per il dovere della corretta informazione un
rispetto rigoroso. Divenuto, suo malgrado, l’immagine di una delle pagine più
buie dell’inchiesta ‘Mani pulite’, nel 1993 venne arrestato e trascinato in
tribunale con gli schiavettoni ai polsi a favore di fotografi e cameramen,
simbolo dei danni che può procurare il perverso circuito mediatico-giudiziario.
Enzo Carra ha
raccontato la politica come giornalista per vent’anni, prima di diventarne un
protagonista come portavoce della Dc e quindi come parlamentare di area
centrista, eletto nel 2001 con la Margherita di Rutelli.
Quella di Carra,
lucidissimo interprete della politica – inventò la comunicazione politica
moderna, negli anni Ottanta – fu una carriera interrotta dalla brutalità di
una inchiesta giudiziaria dissennata: gli vennero ascritte colpe di cui non era
responsabile usando l’atroce sillogismo del “non poteva non sapere“. Ha pagato
un prezzo altissimo sull’altare della condanna mediatica.
Riabilitato dalla
giustizia nel 2004, faticherà a reinserirsi nel mondo dell’informazione, a parte
una collaborazione con la Rai richiestagli da Giovanni Minoli. L’ultima
intervista pubblica di Enzo Carra è stata con il Riformista Tv. A margine
dell’intervista rivelò di aver scritto un memoriale sulle vicende misteriose e
irrisolte della prima repubblica, viste da dietro le quinte della Democrazia
Cristiana. Quel manoscritto è rimasto inedito: nessun editore lo ha voluto
pubblicare.
Aldo Torchiaro.
Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003.
Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.
"Così il Pci ha
approfittato di Tangentopoli..."
Edoardo Sirignano il 25 Febbraio 2022 su Il Giornale.
Enzo Carra, protagonista
dell'arresto più celebre di Mani Pulite, ribadisce come il giustizialismo di
quel periodo storico servì a cancellare solo una parte di storia politica del
nostro Paese.
“Il Partito Comunista
approfittò di quel periodo per rigenerarsi”. A rivelarlo è Enzo Carra, già
portavoce della Democrazia Cristiana e protagonista dell’arresto più celebre di
Mani Pulite, a margine di un convegno sull’anniversario di Tangentopoli, che
ribadisce come il giustizialismo di quel periodo, nei fatti, è servito a
cancellare una parte di storia del nostro Paese.
Che ricordo ha di quegli anni?
“E’ stata una fase in un certo
senso rivoluzionaria. Tutti quanti, politici, partiti, magistratura e
giornalisti, avevano perso un po' la testa. Ciò non vuol dire impazzire, ma che
alcuni credevano davvero nella possibilità di un processo rigeneratore. Altri,
invece, inerti, mi riferisco ai politici, cercavano di frenare, ma quando uno
corre come un ossesso è difficile stopparlo. C’è stato, quindi, uno scontro
violento. E’ chiaro, però, che chi andava a piedi non poteva sconfiggere
carrarmati possenti, come quelli di una certa magistratura”.
Non sono stati, quindi, tempi
semplici?
“A trent’anni di distanza,
avendola conosciuta bene quella stagione e sulla mia pelle, non come altri,
posso dire che non è stata una passeggiata, né per una parte, né per l’altra.
Insistere su quel periodo come se fosse ancora pagina a parte della storia
italiana è un errore. Ancora non abbiamo, direbbe qualcuno più saggio di me,
storicizzato quella stagione, frutto di difficoltà, paura, terrore, assassini e
criminalità”.
Da cosa ritiene sia venuto
fuori tutto ciò?
“Mani Pulite non è sbocciata
come un fiore nel deserto o un veleno, ma è stata generata dalla grande paura,
dal degrado che c’era stato in precedenza nel nostro paese e che in molti
avevano ignorato”.
Chi è stato più penalizzato?
“Le parti politiche più
colpite sono state quelle che avevano ancora qualche carta da spendere ed erano
i socialisti, che avevano il problema Craxi e una certa parte della Dc”.
Possiamo, quindi, dire che i
Ds allora furono risparmiati dai giudici?
“Ho rivisto tutte le carte. I
Ds già avevano messo in conto l’esigenza di cambiare. Non erano più il partito
comunista di un tempo. Non dimentichiamo che Mani Pulite avviene a ridosso della
caduta del muro di Berlino, avvenimento di cui si sono accorti in pochi. Anzi
tutti hanno finto che fosse successo niente per continuare un po'. Questo è
stato il guaio. Tutto ciò, quindi, è stata una riscossa per il Partito Comunista
che ha trovato una via d’uscita. Diciamo che ha approfittato di quel periodo per
rigenerarsi”.
Quali sono state le
conseguenze?
“L’Italia, quando è scomparsa
la Dc, che metteva insieme la tradizione dei cattolici, ha perso un pezzo della
sua storia”.
Una certa magistratura, però,
ancora oggi tende a cancellare chi la pensa in modo diverso, come accaduto prima
con Berlusconi, poi con Renzi, Salvini…
“Stiamo parlando di parti in
conflitto tra loro. Non sempre la politica ha dimostrato di saper combattere ad
armi pari con la magistratura. Un dibattito come quello dell’altro ieri al
Senato che ha votato non per Renzi, ma a favore della politica, della
democrazia, può essere la strada. Si tratta di un caso sintomatico di come
spezzettando i problemi a volta la stessa politica sbaglia. Sul singolo episodio
chi dice che il magistrato non possa aver ragione”.
Parla il portavoce della Dc
al tempo di Mani pulite. Il dramma di Enzo Carra: “Mostrato in manette per dare
un segnale di sottomissione alla politica ma ero innocente”.
Aldo Torchiaro su Il
Riformista il 18 Febbraio 2022.
Trent’anni dall’inizio di Mani
Pulite. E poco meno da quando il terremoto giudiziario arrivò a Roma,
travolgendo – con il colpo di cannone della maxi tangente Eni Montedison – anche
il cuore della politica. Enzo Carra ne fu, suo malgrado, protagonista. Era il
portavoce della Dc. Un professionista che di tangenti non ne aveva mai viste. Ma
che fu prescelto dal pool della Procura di Milano per farne una vittima
sacrificale sull’altare dei simboli. Era pur sempre il portavoce del partito che
teneva le relazioni tra il mondo dei media e il partitone del potere, “non
poteva non sapere”. Andava colpito, quasi per educarne cento.
All’epoca era il portavoce
della Dc, come ci arrivò?
Ero giornalista da quando
avevo 22 anni. La mia passione all’inizio era il cinema, la critica
cinematografica. Fondai un giornale, Il Dramma.
Un nome profetico…
Sì, quello fu un dramma vero.
Non solo mio, collettivo.
Torniamo a quando diventa
giornalista politico.
Avevo ridato fiato alle pagine
di politica del quotidiano Il Tempo, a Roma. Avevo reinventato la nota politica,
rinnovando il modo di informare i lettori. A un certo punto Forlani, nel 1989,
mi chiese di diventare portavoce della Dc, accettai. Era un momento vibrante,
che sentivo carico di sfide.
Nell’ 89 cambiava il mondo.
E però molti tardavano ad
accorgersene. Come pure fu per Tangentopoli. La politica era gerontocratica, non
percepiva velocemente i cambiamenti in arrivo.
Come fu l’arrivo di
Tangentopoli, con l’arresto di Mario Chiesa?
Nessuno fece caso. Sembravano
questioni milanesi, secondarie. L’atteggiamento era “‘a da passà ‘a nottata”.
Una sottovalutazione generale. E invece fu l’inizio di un passaggio da un’epoca
a un’altra.
Viene in mente Gramsci: il
vecchio tramonta ma il nuovo stenta a nascere.
E guardi che siamo ancora in
quel guado. Tangentopoli fu l’abbattimento di una classe dirigente, senza un
progetto vero di sostituzione. Uno sconquasso che ha creato il vuoto della
politica che si vede anche oggi.
Veniamo a lei. Lambito dalle
indagini sulla supposizione del “non poteva non sapere”. Scoppia lo scandalo
della maxi tangente Eni Montedison e Di Pietro chiama a testimoniare tanti. Tra
cui anche lei.
Esatto. Vado a Milano, Di
Pietro mi interroga. Gli spiego che non so quasi nulla, tranne quel che leggo
dai giornali. Il mio era un ruolo tecnico, da comunicatore. Mi dice: “Ma sa,
andando al bagno in quei palazzi del potere uno le cose le viene a sapere”.
Lei non frequentava i bagni
giusti, Carra. E come costruiscono l’imputazione su di lei?
Mi dà appuntamento al venerdì,
tre giorni dopo. “Perché dobbiamo fare dei riscontri”. Al mio ritorno, venerdì,
mi trovo davanti a una sceneggiatura, per quanto fantasiosa, già scritta. Un
tipo mai visto, un faccendiere che doveva uscire di prigione, gli avrebbe detto
di essersi riunito con me a Roma. E io gli avrei parlato della maxi tangente. Io
lo guardo negli occhi, gli chiedo in quali circostanze. Quello farfuglia: nel
suo ufficio a Roma, c’erano diverse segretarie… e alla fine della frase si mette
a piangere. Doveva recitare la parte per uscire di galera, lo compatisco. Di
Pietro sorride e mi stampa addosso l’accusa di aver mentito al Pm. Mi difendo ma
non mi dà retta. Aveva bisogno di imputati freschi, e io che ero il portavoce
del segretario Forlani ero succulento, per lui.
Poi come accadde che la fece
comparire ammanettato con gli “schiavoni”?
Dovevo comparire davanti ai
giudici, ero al pianterreno del Palazzo di Giustizia. Due Carabinieri si
apprestavano ad accompagnarmi tenendomi per il braccio, poi arrivò una
telefonata. Non seppi mai di chi. Li vedi consultarsi: era arrivato l’ordine di
mettermi in ceppi. Dovevo comparire davanti al ‘muro’ delle telecamere e dei
fotografi ammanettato, come simbolo della vittoria dei magistrati sulla
politica. Ero molto colpito ma rimasi, per fortuna, lucido.
Quell’immagine suscitò per
fortuna anche un sussulto di risposta, un minimo di sdegno.
E fu per il pool di Mani
Pulite un segnale. Non potevano affondare le persone e umiliarle senza fine.
Tornato in cella, vidi alla tv diverse dichiarazioni di tutti gli schieramenti
che chiedevano più rispetto.
Un anno e quattro mesi, la
condanna. Per “non aver sentito niente, andando al bagno”. Li ha perdonati?
Non ho né il potere del
perdono, né la voglia di vendetta. Ciascuno di loro, del pool, ha dovuto
rivedere le sue posizioni. Io no, non ho mai avuto niente di cui pentirmi. I
bilanci, sa, si fanno alla fine.
Aldo Torchiaro. Ph.D. in
Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di
attualità e politica con interviste e inchieste.
Trent’anni fa un’inchiesta
sull’Eni distrusse i partiti, oggi colpisce la procura più importante d’Italia.
Enzo Carra
su tpi.it il 20 Settembre 2021. “I politici non riusciranno a cambiare la
giustizia.” Non ha dubbi il vecchio cronista che negli anni di Mani Pulite
batteva i corridoi della Procura di Milano a caccia di poveri cristi tramortiti
dagli interrogatori del Pool e spulezzava quando quelli non gli rispondevano. Ha
ragione Andrea Pamparana (Libero del 20 settembre), fin qui la politica ha fatto
poco, in compenso il caso e la necessità hanno provveduto al resto. Il caso si
chiama Eni. Sono state infatti due inchieste intitolate alla stessa
multinazionale a innalzare prima la procura milanese a Sancta sanctorum del
diritto e a quartier generale nella lotta alla corruzione in politica, per
trasformarla adesso nel luogo dove si sta consumando un’incredibile vicenda che
divide e annebbia gli eponimi di Mani Pulite. Prima viene la tangente Enimont,
“la madre di tutte le tangenti”: una “provvista” di 140 miliardi di lire, oltre
70 milioni in euro, per partiti di governo e d’opposizione e per faccendieri
sciolti e in pacchetti. La scoperta rappresenta il punto di svolta, definitivo,
di Mani Pulite, il suo trionfo. Antonio Di Pietro e Francesco Greco sono i due
sostituti che hanno lavorato su Enimont, ma il merito è di tutto il pool e il
risultato è che le mura già pericolanti di un sistema politico figlio della
Resistenza crollano tra le lacrime di pochi e la gioia di tanti. La Magistratura
italiana ha sconfitto il malaffare politico. Corsi e ricorsi. Poco meno di
trent’anni dopo, alla Procura di Milano torna a bussare l’Eni. È il processo
Eni-Nigeria, ovviamente per corruzione. Se ne occupa Francesco Greco, il quale
si avvale delle dichiarazioni di un dipendente dell’Eni e di un ex legale
“esterno” – qualunque cosa voglia dire “esterno” – della nostra multinazionale,
Pietro Amara. Questi, secondo il pm Paolo Storari è troppo importante per quel
processo, la procura “lo tiene in palmo di mano” e quindi non si procede per
appurare se ha detto o no la verità anche su altre questioni: affari, logge
segrete, promozioni, insomma il paroliere italiano. Storari quindi decide di
tirare le orecchie a Greco e, in modo quantomeno “irrituale”, muove le carte che
giacciono in procura a Milano e le consegna a Davigo, che a quel tempo è ancora
componente del Csm. Lui ne parla con alti rappresentanti delle Istituzioni,
contando forse sulla loro collaborazione nella sua campagna contro Greco e
comunque sul loro silenzio: ma come fai a tenere a lungo un segreto così a Roma?
A far casino ci pensa la sua ex segretaria la quale, per impedire il
pensionamento del suo capo, diffonde le carte ad alcuni giornali “amici”. Lo
scandalo, si illude, potrebbe prolungare la permanenza di Davigo al Palazzo dei
marescialli. E che scandalo, a tanti anni dalla P2 ecco a voi un’altra loggia,
più piccola, esclusiva, ma potente, parola di Amara. La nuova loggia si chiama
Ungheria, ma ha sede in Roma ed è responsabilità di Greco aver tenuto nascoste
quelle preziose informazioni per tanto tempo. Eppure, lì per lì, niente: i
giornali non pubblicano le carte della ex segretaria, chissà perché. Mesi dopo,
però, uno di loro, Il Fatto quotidiano, ci ripensa ed esce. Nel consueto “c’era
questo e c’era quello” di ogni rubrica mondana: tanti bei nomi.
Prevedibilissimi, sembra la short list di un ricevimento per “pochi ma buoni” in
un palazzo del potere. I fratelli di Amara. Certo però se trent’anni prima
un’inchiesta targata Eni aveva distrutto i partiti, oggi un processo che assolve
l’Eni colpisce duramente la procura più importante d’Italia e l’immagine della
magistratura italiana. Perché Amara può aver raccontato qualche verità in mezzo
a un sacco di balle, ma le querele tra Greco e Davigo, l’affanno televisivo di
quest’ultimo e lo smarrimento dell’opinione pubblica restano, e pesano. Corsi e
ricorsi.
ENZO CARRA. Enzo Carra è un
giornalista e politico italiano. Redattore capo del mensile "Il Dramma" ha
successivamente lavorato per molti anni al quotidiano romano "Il Tempo" e ha
scritto per il cinema e la TV. Ha realizzato alcuni reportage per la TV, tra
questi un ritratto di Gheddaffi e uno di Madre Teresa di Calcutta. Dal 2021
collabora con TPI
Il suicidio dell'ex presidente. Marco
Travaglio è un contraffattore: Gabriele Cagliari non era in cella “perché
rubava”. È un’impostazione volgarmente plebea e
irrispettosa del dovere elementare di non stuprare i diritti e la memoria delle
persone. Che bassezza. Iuri Maria Prado su L'Unità il 25 Luglio 2023
Le polemiche tra giornali costituiscono un genere
classico, tuttavia frequentato molto da chi li scrive e molto poco da chi li
legge. Roba noiosa e perlopiù, come si dice, autoreferenziale. A volte, però,
non si tratta di “cicca cicca”, “non mi hai fatto niente faccia di serpente, non
mi hai fatto male faccia di maiale”, e cioè della desolante tigna tra colleghi
buona a riempire una colonna altrimenti vacua.
A volte c’è sostanza: di quale pasta, è un altro
discorso. Ma c’è. Vedi, per esempio, un titolo di questo quotidiano
nell’edizione di qualche giorno fa: “Gabriele Cagliari, mio padre, morto in
cella perché non volle denunciare Craxi”. Che ti fa Marco Travaglio? Ieri, sul
suo giornale (Il Fatto Quotidiano), smozzica quel titolo e, virgolettandolo, lo
riporta così: “Gabriele Cagliari morto in cella perché non volle denunciare
Craxi” (scompare quel “mio padre”, e cioè l’elemento che denunciava la fonte
dell’affermazione: vale a dire il figlio di Cagliari, non il
giornale, l’Unità, che semmai ne raccoglieva le dichiarazioni).
Il taglio da magliaro adempie a due scopi,
entrambi vigliacchi. Il primo: lasciare intendere, appunto contro il vero, che
l’affermazione fosse de l’Unità, mentre in realtà era del figlio intervistato.
Il secondo: consentire all’articolista e contraffattore, cioè Travaglio stesso,
di attenuare l’impatto della porcata immediatamente successiva, lì dove questo
impudente si abbandona a scrivere che Gabriele Cagliari non è morto in carcere
per quel motivo, ma “perché rubava”. Dire direttamente al figlio che il padre si
è ammazzato perché era un ladro avrebbe fatto schifo lo stesso, ma almeno la
sfrontatezza sarebbe stata piena: invece no, falta de huevos.
Che poi Gabriele Cagliari, raggiunto da tre ordini
di custodia cautelare in carcere, due dei quali revocati (il terzo no: parere
negativo del pm in partenza per le ferie), non fosse indagato per “furto”, è un
dettaglio fastidiosamente incompatibile con la retorica macellaia di questo
disinvolto violentatore della verità. Il quale, ne siamo certi, invocherebbe il
diritto alla sintesi delle piazze del vaffanculo di cui è punto di riferimento
fortissimo se qualcuno gli facesse osservare che Cagliari neppure se fosse stato
condannato avrebbe meritato quella definizione, ladro: e figurarsi ricordare
a Travaglio che Cagliari stava in galera e si ammazzava prima del processo,
dunque quando le sue responsabilità (non per aver “rubato”) dovevano ancora
essere accertate.
Il dramma è che piace un sacco questa impostazione
volgarmente plebea, e irrispettosa del dovere elementare di non stuprare i
diritti e la memoria delle persone. E il fatto che piaccia, che abbia tanto
riscontro, racconta bene la bassezza di chi vi ricorre. Perché è ancora
ammissibile ascoltare la plebe violenta, è ammissibile persino mischiarvisi: ma
farsene forza, no, questo è imperdonabile.
Ed esattamente questo si fa quando si scrive
che un uomo si è suicidato in carcere perché era un ladro: si stimolano le
trippe della turba che reclama onestà sfilando sotto ai balconi delle procure
della Repubblica, lì dove i pubblici ministeri lavorano di manette nell’attesa
delle collaborazioni con il Fatto Quotidiano e delle vacanze sotto l’ombrellone
con il direttore.
Iuri Maria Prado 25 Luglio 2023
30 anni dal suicidio. “Ecco perché
Gabriele Cagliari si è tolto la vita”, la verità del figlio Stefano.
«Dava fastidio ai suoi concorrenti di tutto il mondo, alle multinazionali del
petrolio, a partire da quelle americane. Bisognava fermarlo, togliergli il
potere che stava esercitando». Graziella Balestrieri su L'Unità il 20 Luglio
2023
Il 20 Luglio del 1993 Gabriele Cagliari, allora
presidente dell’Eni, si toglie la vita in carcere. Siamo all’inizio
di Tangentopoli. Gabriele Cagliari ammette le sue colpe ma si rende conto che
quella condizione a cui lui viene sottoposto e alla quale sono sottoposti gli
altri detenuti non è una condizione umana. Scriverà in una delle sue numerose
lettere che in carcere si è “come cani in un canile”. E allora un gesto estremo,
calcolato, quando ormai capisce che la speranza gli viene tolta
dall’atteggiamento dei magistrati.
Il figlio Stefano, dopo aver pubblicato
nel 2018 il libro Storia mio padre (edito da Longanesi, curato da Costanza
Rizzacasa d’Orsogna e con prefazione di Gherardo Colombo) continua a portare
avanti una missione che per lui è un impegno civile, anche se dolorosissimo, sul
sito gabrielecagliari.it, ricordando le numerose lettere di suo padre, i fatti,
i personaggi e quel tempo di Tangentopoli che ancora rimane una ferita aperta
per tutti nel nostro paese.
Tangentopoli. Che momento era quello in Italia?
L’Italia era in una situazione difficile dal punto
di vista economico e finanziario. Nel 1992 i tedeschi ci avevano abbandonato e
c’era stata la svalutazione della lira, il malcontento cominciava a crescere. La
Lega Nord interpretava questo malcontento, era un fenomeno assolutamente nuovo,
anche per l’uso aggressivo e finanche volgare del linguaggio nel discorso
politico. Era un paese che si era abituato a vivere di mazzette, di favori, di
tangenti, un sistema diffuso a tutti i livelli, mentre il grande mito di
Tangentopoli è che solo il ceto politico ne fosse coinvolto.
Tangentopoli travolse sostanzialmente una buona
parte della classe dirigente, anche di quella imprenditoriale non solo quella
politica, con tutte le conseguenze che ci sono state successivamente, che devo
dire un po’ stiamo ancora pagando. Era un’Italia in cui, come ho scritto in
Storia di mio padre, tutti incitavano all’uso delle manette, come se mandare in
galera i politici risolvesse il problema della corruzione nel paese. All’asilo i
bambini si inseguivano urlando “in galera, in galera!”
Non più giustizia ma giustizialismo dunque?
Certo, a quel punto si è scatenato il
giustizialismo.
Il suo libro parte da un sogno (suo padre che in
realtà non si era suicidato ma era fuggito fuori dall’Italia e comunicava solo
con lei). Fa ancora quel sogno dopo 30 anni?
No. Ho sognato spesso mio padre ma non più in
quella situazione. In realtà alla fine chi voleva fuggire ero io, come se
volessi nascondermi per non dover continuamente ritornare a quella situazione
così dolorosa. Con il libro e le molte interviste non mi sono più nascosto e
ora, quando sogno mio padre, sono in situazioni diciamo così di serena vita
familiare.
Se dovesse raccontare suo padre a chi non ha
vissuto quegli anni e a chi ignora completamente la sua vicenda che cosa
direbbe?
Quello che posso dire è che era un uomo
estremamente intelligente, estremamente generoso, molto corretto, molto
ambizioso. E tutte queste sue qualità mi sono state manifestate in parte anche
dopo la sua morte. Per esempio, sul sito gabrielecagliari.it continuiamo a
caricare contenuti e ultimamente abbiamo caricato le lettere dei detenuti che lo
avevano conosciuto in carcere: emerge la personalità di un uomo che aiutava
tutti quelli che ne avevano bisogno, chi non aveva i soldi per l’avvocato, chi
non aveva strumenti per difendersi. Ed è stato un uomo di una visione
straordinaria dal punto di vista della politica industriale. All’Eni aveva fatto
cose che nessuno aveva fatto prima e che per venticinque anni nessuno ha più
fatto. In questi mesi in Europa sono in corso degli studi sulla sua presidenza
da cui risulta che allora l’Eni era l’unica società petrolifera che si occupava
di sviluppo sostenibile. Fu l’unica major che partecipò a Rio, alla conferenza
del 1992, e che mise nel suo piano strategico la difesa dell’ambiente e lo
sviluppo sostenibile. Una società che era all’avanguardia nello studio delle
tecnologie di difesa ambientale. Dopo di lui si è fermato tutto, è come se
avessero cancellato lui e tutto quello che stava cercando di fare e che stava
proponendo. Immagini: che cosa sarebbe stata l’Eni e l’Italia se quella politica
fosse andata avanti? Ma era una politica che evidentemente dava un fastidio
enorme alle grandi multinazionali del petrolio, che in quel momento negavano il
problema dell’esaurimento delle risorse, negavano i problemi ambientali,
negavano il riscaldamento climatico. Adesso questi temi sono quasi una moda, ma
questo le fa capire che mio padre aveva una visione strategica lungimirante e
unica. D’altronde quelle lettere che lui ha scritto, dove già descrive quello
che sarebbe successo a causa di Tangentopoli vedono lontanissimo: tutto quello
che lui ha scritto poi è successo.
In famiglia vi aspettavate che venisse arrestato?
Un po’ me l’aspettavo, perché avevo visto dei
segnali sui giornali e diciamo che in quel periodo, ma diciamo non solo in quel
periodo, c’era un filo diretto tra magistratura e determinati quotidiani. Il
fatto che avevano cominciato a tirar fuori il suo nome voleva dire che c’era
burrasca nell’aria. E anche papà se lo aspettava. L’ultima volta che ha visto
suo nipote, mio figlio di tre anni, quando l’ha preso in braccio, il bambino ha
cominciato ad urlare “in galera, in galera!”. Mesi prima erano telefonate
continue, gente che voleva favori, perché in questo paese i favori erano
all’ordine del giorno, mentre in quelle ultime settimane era calato il silenzio,
tutti gli stavano alla larga.
Anche l’Eni lo ha abbandonato?
Il personale, i dipendenti, hanno amato mio padre
come presidente, probabilmente come, se non più, di Enrico Mattei, perché mio
padre era uno di loro, era cresciuto con loro, era un tecnico, era un uomo che
conosceva tutti e che aveva qualità straordinarie. Il problema dell’Eni era
quello di essere una società presente sui mercati mondiali, una società che non
si poteva permettere di vedere il proprio nome infangato e su questo lui si è
arroccato. Ha avuto questo tipo di atteggiamento: è riuscito, come ha scritto, a
salvare il middle management e a far sì che tutte le responsabilità ricadessero
su di lui, questo ha fatto sì che l’Eni non venisse coinvolta.
Nelle lettere suo padre descrive la condizione del
carcere come quella di “cani in un canile”.
Il suo gesto è stato un gesto di denuncia della
situazione carceraria. Ormai per sé aveva perso ogni speranza, visto
l’atteggiamento dei magistrati nei suoi confronti, un atteggiamento che leggeva
come un tentativo di annientarlo dal punto di visto umano, di farne un capro
espiatorio. Chi restava fuori non si rendeva conto della condizione carceraria.
Resistette alla prigionia durante la Seconda
guerra mondiale e non al carcere durante Tangentopoli. Perché mai secondo lei?
No, in realtà lo ha sostenuto benissimo, ma anche
lì aveva una strategia: il suicidio, un gesto drammatico, ne ha fatto parte. Non
solo quest’anno, ma ogni anno, ci sono decine e decine di suicidi in carcere, ma
sui giornali non finisce niente. La notizia va sui giornali se il presidente
dell’Eni si suicida in carcere, dopo quattro mesi e mezzo di detenzione, che lui
ritiene ingiustificata. Il suo è stato un gesto di grande impatto, anche se mio
padre non era un uomo da copertina come lo era Gardini, e questo gesto è stato
capito non solo a San Vittore dove lo avevano conosciuto bene, ma anche nelle
altre carceri e fuori dalle carceri.
La prefazione del suo libro è stata affidata a
Gherardo Colombo.
Gherardo Colombo è uscito dalla magistratura e
sostiene con forza che non è il sistema giudiziario che può risolvere i problemi
della corruzione in Italia, come Tangentopoli ha dimostrato. Il mio libro non ha
voluto essere di parte né essere “targato”, è un documento storico e come tale
spero che sia letto. La partecipazione di Gherardo Colombo è stato un modo per
mostrare il nostro tentativo di essere equilibrati.
I magistrati che allora si occuparono del caso di
suo padre, anni dopo, visto il drammatico epilogo, si sono fatti sentire in un
qualche modo?
No. Nulla.
Perché suo padre ha accettato quel sistema?
Mio padre ha ammesso di aver sbagliato, lo ha
anche scritto. C’è una lettera che ha scritto a Scalfari da San Vittore, in cui
dice che pagare i partiti era l’unico modo per poter lavorare tranquilli.
Soffriva questo sistema, come più volte ha scritto, ma ne aveva bisogno perché
altrimenti non avrebbe potuto fare quello che voleva fare. C’è un’intervista a
Newsweek, che si trova tradotta nel sito, da cui si capisce che mio padre fuori
dall’Italia, senza i vincoli della politica, si muoveva in modo completamente
diverso. Già allora aveva strategie verso i paesi che oggi sono considerati
emergenti che nessuna delle major petrolifere aveva. Offriva collaborazione:
tecnologie in cambio di risorse, aveva un approccio che spiazzava tutti:
evidentemente mio padre dava fastidio.
Sua moglie muore, suo fratello scopre di avere
l’Aids, suo padre in carcere, che momento è stato quello per lei?
Avevo un bambino di 3 anni, la cosa più importante
era andare avanti per lui. Ho avuto un momento di sconforto, forse di rabbia,
solo quando abbiamo aperto quella lettera (una lettera dove Gabriele Cagliari
annuncia il suo suicidio ma che chiede alla moglie di aprire solo al “suo
ritorno”, ndr.) perché anche in quel caso aveva anteposto i suoi ideali alla
famiglia. Anni dopo ho capito da tutto quello che è venuto fuori e dalle sue
lettere che forse ci ha risparmiato tanti e tanti di quei problemi, di quelle
delusioni, tante di quelle sofferenze che il metterlo sotto processo per decenni
avrebbe significato.
Che sentimento ha provato nei confronti della
magistratura di allora?
Hanno commesso degli errori tragici, sono stati
degli ingenui, pensando di fare del bene hanno fatto invece molto male.
Ingenui è diverso da dire che erano “ambiziosi”,
come li definiva suo padre.
Diciamo che sicuramente Di Pietro era molto
ambizioso. Poi di quasi tutti si è visto di che pasta sono fatti. Perché uno
dopo l’altro sono caduti, scivolando su bucce di banana varie, e hanno
cominciato a litigare tra di loro. Degli illusi, perché pensavano di cambiare il
paese, quando in realtà stavano usando in maniera strumentale il loro potere.
Pensando di eliminare la corruzione in Italia, hanno invece favorito un
peggioramento drammatico della situazione politica e hanno decapitato una parte
del sistema imprenditoriale italiano.
Come mai non avete incontrato Martelli (ma solo
sua zia, come viene scritto nel libro)?
Io quel giorno non ero a casa di mia madre. Il
partito… il sistema politico era il principale responsabile di quello che stava
succedendo (non solo il partito socialista ma tutti i partiti, compreso il
partito comunista). Mio padre era un socialista e la nostra sensazione era che
il partito lo avesse abbandonato. Io l’ho vissuta come se Bettino Craxi fosse
fuggito abbandonando i suoi colonnelli. Martelli in quel momento era una figura
piuttosto ambigua perché stava cercando di scalare a sua volta il partito
socialista sostituendosi a Craxi. Il problema è che tutti quanti sono stati poi
tirati dentro. Il problema non era più questo o quel partito, il problema era il
sistema, almeno così veniva venduto a livello mediatico, e quel sistema politico
è crollato, tanto è vero che al governo poi è salito un populista che di
politico faceva finta di non avere niente.
Il comportamento della stampa?
Il comportamento della stampa fu vergognoso, sono
stati senza pietà anche nei confronti di mio padre. Il loro problema era vendere
e cavalcare l’inchiesta, lo hanno fatto tutti, a partire dalle reti di
Berlusconi.
Di Pietro lo ha mai rincontrato?
L’ho visto a Napoli, in un autobus che ci portava
da un aereo all’aeroporto, ma non ho avuto il coraggio di parlargli, non mi è
sembrato proprio il caso. Eravamo uno di fronte all’altro: ci siamo guardati a
lungo, ma in silenzio.
Nessuno dei magistrati di allora l’ha mai cercata?
Scusarsi sarebbe stato ammettere che hanno
compiuto cose fuori dai binari dalla legalità, come scrive mio padre.
Suo padre che cosa si aspettava?
Durante gli interrogatori ha ammesso quello che
pensava fosse utile ai magistrati, però nelle lettere scrive che i magistrati
chiedevano informazioni su vicende che erano completamente avulse dai capi
d’accusa, e non se la sentiva anche perché il giorno dopo qualunque cosa avesse
detto sarebbe finita sui giornali. L’Eni che figura ci avrebbe fatto a livello
internazionale? Che fine avrebbero fatto tutti i contratti che l’Eni aveva in
piedi? Che fine avrebbero fatto gli accordi sul gas? In carcere mio padre ha
difeso l’Eni e ha messo in evidenza quelle che sono le carenze drammatiche del
sistema carcerario in Italia, anzi, la funzione anticostituzionale del sistema
carcerario perché, se usi il carcere come tortura psicologica, è chiaro che
siamo esattamente dalla parte opposta della rieducazione.
A chi dava fastidio suo padre?
Ho sempre pensato che il problema fosse che non ha
voluto denunciare Craxi, ma ultimamente mi gira in testa un pensiero che mi
spaventa. Mi sto rendendo conto che quest’uomo dava fastidio ai suoi concorrenti
in tutto il mondo. Tutte le settimane Di Pietro era all’ambasciata americana,
che cosa si dicevano non lo sapremo mai. Però se mio padre dava fastidio alle
multinazionali del petrolio, a partire da quelle americane, allora bisognava
fermarlo, togliergli il potere che stava esercitando.
Si sente che ce l’ha un po’ con Craxi…
Diciamo che è stato un grandissimo politico,
straordinario, un uomo che tra l’altro stava cercando di ridare dignità politica
all’Italia in campo internazionale, e forse per questo è stato punito, però
umanamente si è comportato come un codardo. Quel discorso alla Camera – quando
disse a tutti di guardarsi in faccia e che nessuno era escluso da quel sistema,
e tutti quanti hanno fatto finta di niente – è stato probabilmente un errore, in
quanto ha delegittimato la politica tout court. Fallito quel tentativo, capisci
che il problema sei tu: e allora trasforma il processo in una denuncia! Non
scappare, non andartene! Il suo era un ruolo politico fondamentale, ma è stato
troppo umano, quando avrebbe dovuto comportarsi da politico. Mio padre non è
stato umano altrimenti non si sarebbe ammazzato. Ma ha rispettato il suo ruolo.
Craxi no.
Graziella Balestrieri 20 Luglio 2023
Estratto dell’articolo di
Chiara Baldi per corriere.it il 19 maggio 2023.
[…] Chiara Moroni, classe
1974, figlia di Sergio Moroni, deputato socialista
che si tolse la vita nel settembre 1992 per aver ricevuto due avvisi di garanzia
nell’inchiesta Mani Pulite, è originaria di Iseo, uno dei comuni della Bresciana
in cui Fratelli d’Italia ha preso alle Politiche circa il 30%. La sua uscita di
scena dalla politica italiana risale al 2013, quando il partito in cui militava
da poco meno di tre anni – Futuro e Libertà (Fli), di Gianfranco Fini – non
raggiunse il quorum. […] Oggi Moroni […] è una manager della multinazionale
farmaceutica Bristol Myers Squibb e vive a New York […]
Moroni, suo papà si tolse la
vita nel 1992 per aver ricevuto due avvisi di garanzia. Lei all'epoca stava per
compiere diciott'anni. Prima di andarsene scrisse molte lettere, una anche a
Giorgio Napolitano, all'epoca presidente della Camera. Sergio Moroni si
professava innocente e scrisse che «quando la parola è flebile, non resta che il
gesto». Sono trascorsi quasi 31 anni: quel gesto è servito?
«[…] Gran parte del mio
impegno politico ha avuto l'obiettivo di tenere viva la sua memoria e quella del
suo gesto. Che era un gesto politico. Non posso dire che sia servito perché
dovrei dire che era giusto farlo e non potrei mai. Ma sono convinta che papà è
riuscito a raggiungere l’obiettivo che si era dato di generare un dibattito,
almeno in parte».
Cosa vuol dire che «in quel
momento non è servito»?
«La violenza in quegli anni di
Mani Pulite era talmente forte che nonostante il gesto di mio padre avesse avuto
un impatto molto significativo, non fu abbastanza per cambiare le modalità con
cui veniva gestita l’inchiesta. Cionondimeno, la lettera di papà è sempre stata
al centro di un dibattito sul garantismo. Quindi in quel momento quel suo gesto
non è servito abbastanza, perché avrebbe potuto - ed era quello che papà voleva
- innescare una riflessione più seria e critica».
[…] «[…] alla fine i media
hanno contribuito molto a rendere l'inchiesta di Mani Pulite un'inchiesta di
piazza».
[…] E con Berlusconi che
rapporto ha avuto? Lei uscì nel 2010 dal Popolo della Libertà per seguire la
sfida interna al centrodestra lanciata da Fini.
«Non ci siamo mai più sentiti
da allora. Io gli ho scritto un paio di volte […] ma non ho mai avuto risposta.
Nei suoi confronti conservo una vicinanza affettiva perché, pur contestando una
serie di questioni legate alla politica e alla modalità in cui lui ha fatto
politica, mi ha dato anche un sacco di opportunità. Mi spiace molto vedere che
non sta bene, gli auguro di guarire presto».
Cosa imputa alla gestione
berlusconiana del partito?
«Lui ha sempre fatto il "dopo
di me il diluvio", quindi non capisco quale futuro possa avere Forza Italia
visto che lui non ha mai permesso la costruzione di una successione. Berlusconi
non ha mai avuto nessuna forma di democrazia interna al partito».
Ora è in corso uno scontro tra
donne in Forza Italia e una sorta di ricambio nei rapporti di forza interni...
«Non mi sorprende, ci sono
sempre stati lì dentro, sia tra donne che tra uomini. La cosa che però mi fa
sorridere e trovo interessante è che chi rimane vittima di questo ricambio gridi
allo scandalo per il metodo che viene utilizzato, dimenticandosi che è lo stesso
metodo di cui si era precedentemente agevolato».
Lei era presente il giorno del
«Che fai, mi cacci?» di Fini a Berlusconi. Cosa ricorda?
«(Ride) Ero seduta lì tra le
prime file, mi ricordo molto bene ogni passaggio. Fu l'esempio plastico del
fatto che Berlusconi ha un concetto proprietario del partito e questa non è
un'opinione, ma un fatto. Lui è un imprenditore e così come le aziende sono sue,
anche il partito lo è. Fini invece viene da una cultura politica in cui le
leadership si costruiscono e poi si affermano. Che poi è la stessa cultura
politica in cui è cresciuta e si è formata Giorgia Meloni».
[…] Elly Schlein, segretaria
del Pd. Le piace?
«[…] non penso che potrei
votare il Pd oggi. Ma nella vicenda Schlein c'è una cosa che mi piace molto: il
fatto che una outsider prende la tessera e vince il congresso del partito.
Significa che il Pd è un partito scalabile […] Dopodiché io sono socialista
riformista quindi io e Schlein non la pensiamo uguale quasi su niente […]». […]
«Antonio Di Pietro è il primo a lasciare
l'ufficio di Borrelli. È irriconoscibile. Cammina come
un ubriaco, quasi appoggiandosi ai muri». Così scrive Goffredo Buccini sul
Corriere della Sera del 24 luglio 1993, il giorno dopo il suicidio di Raul
Gardini.
«Per me fu una sconfitta terribile - racconta oggi
Antonio Di Pietro ad Aldo Cazzullo su “Il Corriere della Sera” -. La morte di
Gardini è il vero, grande rammarico che conservo della stagione di Mani pulite.
Per due ragioni. La prima: quel 23 luglio Gardini avrebbe dovuto raccontarmi
tutto: a chi aveva consegnato il miliardo di lire che aveva portato a Botteghe
Oscure, sede del Pci; chi erano i giornalisti economici corrotti, oltre a quelli
già rivelati da Sama; e chi erano i beneficiari del grosso della tangente
Enimont, messo al sicuro nello Ior. La seconda ragione: io Gardini lo potevo
salvare. La sera del 22, poco prima di mezzanotte, i carabinieri mi chiamarono a
casa a Curno, per avvertirmi che Gardini era arrivato nella sua casa di piazza
Belgioioso a Milano e mi dissero: "Dottore che facciamo, lo prendiamo?". Ma io
avevo dato la mia parola agli avvocati che lui sarebbe arrivato in Procura con
le sue gambe, il mattino dopo. E dissi di lasciar perdere. Se l'avessi fatto
arrestare subito, sarebbe ancora qui con noi».
Ma proprio questo è il punto. Il «Moro di
Venezia», il condottiero dell'Italia anni 80, il padrone della chimica non
avrebbe retto l'umiliazione del carcere. E molte cose lasciano credere che non
se la sarebbe cavata con un interrogatorio. Lei, Di Pietro, Gardini l'avrebbe
mandato a San Vittore?
«Le rispondo con il cuore in mano: non lo so.
Tutto sarebbe dipeso dalle sue parole: se mi raccontava frottole, o se diceva la
verità. Altre volte mi era successo di arrestare un imprenditore e liberarlo in
giornata, ad esempio Fabrizio Garampelli: mi sentii male mentre lo interrogavo -
un attacco di angina -, e fu lui a portarmi in ospedale con il suo autista... Io
comunque il 23 luglio 1993 ero preparato. Avevo predisposto tutto e allertato la
mia squadretta, a Milano e a Roma. Lavoravo sia con i carabinieri, sia con i
poliziotti, sia con la Guardia di Finanza, pronti a verificare quel che diceva
l'interrogato. Se faceva il nome di qualcuno, prima che il suo avvocato potesse
avvertirlo io gli mandavo le forze dell'ordine a casa. Sarebbe stata una
giornata decisiva per Mani pulite. Purtroppo non è mai cominciata».
Partiamo dall'inizio. Il 20 luglio di vent'anni fa
si suicida in carcere, con la testa in un sacchetto di plastica, Gabriele
Cagliari, presidente dell'Eni.
«L'Eni aveva costituito con la Montedison di
Gardini l'Enimont. Ma Gardini voleva comandare - è la ricostruzione di Di Pietro
-. Quando diceva "la chimica sono io", ne era davvero convinto. E quando vide
che i partiti non intendevano rinunciare alla mangiatoia della petrolchimica
pubblica, mamma del sistema tangentizio, lui si impuntò: "Io vendo, ma il prezzo
lo stabilisco io". Così Gardini chiese tremila miliardi, e ne mise sul piatto
150 per la maxitangente. Cagliari però non era in carcere per la nostra
inchiesta, ma per l'inchiesta di De Pasquale su Eni-Sai. Non si possono
paragonare i due suicidi, perché non si possono paragonare i due personaggi.
Cagliari era un uomo che sputava nel piatto in cui aveva mangiato. Gardini era
un uomo che disprezzava e comprava, e disprezzava quel che comprava. Il miliardo
a Botteghe Oscure lo portò lui. Il suo autista Leo Porcari mi aveva raccontato
di averlo lasciato all'ingresso del quartier generale comunista, ma non aveva
saputo dirmi in quale ufficio era salito, se al secondo o al quarto piano: me lo
sarei fatto dire da Gardini. Ma era ancora più importante stabilire chi avesse
imboscato la maxitangente, probabilmente portando i soldi al sicuro nello Ior.
Avevamo ricostruito la destinazione di circa metà del bottino; restavano da
rintracciare 75 miliardi».
Chi li aveva presi?
«Qualcuno l'abbiamo trovato. Ad esempio Arnaldo
Forlani: non era certo Severino Citaristi a gestire simili cifre. Non è vero che
il segretario dc fu condannato perché non poteva non sapere, e lo stesso vale
per Bettino Craxi, che fu condannato per i conti in Svizzera. Ma il grosso era
finito allo Ior. Allora c'era il Caf».
Craxi. Forlani. E Giulio Andreotti.
«Il vero capo la fa girare, ma non la tocca. Noi
eravamo arrivati a Vito Ciancimino, che era in carcere, e a Salvo Lima, che era
morto. A Palermo c'era già Giancarlo Caselli, tra le due Procure nacque una
stretta collaborazione, ci vedevamo regolarmente e per non farci beccare
l'appuntamento era a casa di Borrelli. Ingroia l'ho conosciuto là».
Torniamo a Gardini. E al 23 luglio 1993.
«Con Francesco Greco avevamo ottenuto l'arresto.
Un gran lavoro di squadra. Io ero l'investigatore. Piercamillo Davigo era il
tecnico che dava una veste giuridica alle malefatte che avevo scoperto: arrivavo
nel suo ufficio, posavo i fascicoli sulla scrivania, e gli dicevo in dipietrese:
"Ho trovato quindici reati di porcata. Ora tocca a te trovargli un nome".
Gherardo Colombo, con la Guardia di Finanza, si occupava dei riscontri al mio
lavoro di sfondamento, rintracciava i conti correnti, trovava il capello (sic)
nell'uovo. Gli avvocati Giovanni Maria Flick e Marco De Luca vennero a trattare
il rientro di Gardini, che non era ancora stato dichiarato latitante. Fissammo
l'appuntamento per il 23, il mattino presto». «Avevamo stabilito presidi a
Ravenna, Roma, a Milano e allertato le frontiere. E proprio da Milano, da piazza
Belgioioso dove Gardini aveva casa, mi arriva la telefonata: ci siamo, lui è lì.
In teoria avrei dovuto ordinare ai carabinieri di eseguire l'arresto. Gli avrei
salvato la vita. Ma non volevo venir meno alla parola data. Così rispondo di
limitarsi a sorvegliare con discrezione la casa. Il mattino del 23 prima delle 7
sono già a Palazzo di Giustizia. Alle 8 e un quarto mi telefona uno degli
avvocati, credo De Luca, per avvertirmi che Gardini sta venendo da me, si sono
appena sentiti. Ma poco dopo arriva la chiamata del 113: "Gardini si è sparato
in testa". Credo di essere stato tra i primi a saperlo, prima anche dei suoi
avvocati». «Mi precipito in piazza Belgioioso, in cinque minuti sono già lì.
Entro di corsa. Io ho fatto il poliziotto, ne ho visti di cadaveri, ma quel
mattino ero davvero sconvolto. Gardini era sul letto, l'accappatoio
insanguinato, il buco nella tempia».
E la pistola?
«Sul comodino. Ma solo perché l'aveva raccolta il
maggiordomo, dopo che era caduta per terra. Capii subito che sarebbe partito il
giallo dell'omicidio, già se ne sentiva mormorare nei conciliaboli tra
giornalisti e pure tra forze dell'ordine, e lo dissi fin dall'inizio: nessun
film, è tutto fin troppo chiaro. Ovviamente in quella casa mi guardai attorno,
cercai una lettera, un dettaglio rivelatore, qualcosa: nulla».
Scusi Di Pietro, ma spettava a lei indagare sulla
morte di Gardini?
«Per carità, Borrelli affidò correttamente
l'inchiesta al sostituto di turno, non ricordo neppure chi fosse, ma insomma
un'idea me la sono fatta...».
Quale?
«Fu un suicidio d'istinto. Un moto d'impeto, non
preordinato. Coerente con il personaggio, che era lucido, razionale, coraggioso.
Con il pelo sullo stomaco; ma uomo vero. Si serviva di Tangentopoli, che in
fondo però gli faceva schifo. La sua morte per me fu un colpo duro e anche un
coitus interruptus».
Di Pietro, c'è di mezzo la vita di un uomo.
«Capisco, non volevo essere inopportuno. È che
l'interrogatorio di Gardini sarebbe stato una svolta, per l'inchiesta e per la
storia d'Italia. Tutte le altre volte che nei mesi successivi sono arrivato
vicino alla verità, è sempre successo qualcosa, sono sempre riusciti a fermarmi.
L'anno dopo, era il 4 ottobre, aspettavo le carte decisive dalla Svizzera, dal
giudice Crochet di Ginevra: non sono mai arrivate. Poi mi bloccarono con i
dossier, quando ero arrivato sulla soglia dell'istituto pontificio...».
Ancora i dossier?
«Vada a leggersi la relazione del Copasir relativa
al 1995: contro di me lavoravano in tanti, dal capo della polizia Parisi a
Craxi».
Lei in morte di Gardini disse: «Nessuno potrà più
aprire bocca, non si potrà più dire che gli imputati si ammazzano perché li
teniamo in carcere sperando che parlino».
«Può darsi che abbia detto davvero così. Erano
giornate calde. Ma il punto lo riconfermo: non è vero, come si diceva già
allora, che arrestavamo gli inquisiti per farli parlare. Quando arrestavamo
qualcuno sapevamo già tutto, avevamo già trovato i soldi. E avevamo la fila di
imprenditori disposti a parlare».
Altri capitani d'industria hanno avuto un
trattamento diverso.
«Carlo De Benedetti e Cesare Romiti si assunsero
le loro responsabilità. Di loro si occuparono la Procura di Roma e quella di
Torino. Non ci furono favoritismi né persecuzioni. Purtroppo, nella vicenda di
Gardini non ci furono neanche vincitori; quel giorno abbiamo perso tutti».
Dopo 20 anni Di Pietro è senza: pudore: «Avrei
potuto salvarlo». Mani Pulite riscritta per autoassolversi. L'ex pm: "Avrei
dovuto arrestarlo e lui avrebbe parlato delle mazzette al Pci". La ferita brucia
ancora. Vent'anni fa Antonio Di Pietro, allora l'invincibile Napoleone di Mani
pulite, si fermò sulla porta di Botteghe Oscure e il filo delle tangenti rosse
si spezzò con i suoi misteri, scrive Stefano Zurlo su “Il Giornale”. Per questo,
forse per trovare una spiegazione che in realtà spiega solo in parte, l'ex pm
racconta che il suicidio di Raul Gardini, avvenuto il 23 luglio '93 a Milano, fu
un colpo mortale per quell'indagine. «La sua morte - racconta Di Pietro ad Aldo
Cazzullo in un colloquio pubblicato ieri dal Corriere della Sera - fu per me un
coitus interruptus». Il dipietrese s'imbarbarisce ancora di più al cospetto di
chi non c'è più, ma non è questo il punto. È che l'ormai ex leader dell'Italia
dei Valori si autoassolve a buon mercato e non analizza con la dovuta brutalità
il fallimento di un'inchiesta che andò a sbattere contro tanti ostacoli.
Compresa l'emarginazione del pm Tiziana Parenti, titolare di quel filone. E non
s'infranse solo sulla tragedia di piazza Belgioioso. Di Pietro, come è nel suo
stile, semplifica e fornisce un quadro in cui lui e il Pool non hanno alcuna
responsabilità, diretta o indiretta, per quel fiasco. Tutto finì invece con quei
colpi di pistola: «Quel 23 luglio Gardini avrebbe dovuto raccontarmi tutto: a
chi aveva consegnato il miliardo di lire che aveva portato a Botteghe Oscure,
sede del Pci; chi erano i giornalisti economici corrotti, oltre a quelli già
rivelati da Sama; e chi erano i beneficiari del grosso della tangente Enimont,
messo al sicuro nello Ior». E ancora, a proposito di quel miliardo su cui tanto
si è polemizzato in questi anni, specifica: «Il suo autista Leo Porcari mi aveva
raccontato di averlo lasciato all'ingresso del quartier generale comunista, ma
non aveva saputo dirmi in quale ufficio era salito, se al secondo o al quarto
piano: me lo sarei fatto dire da Gardini». Il messaggio che arriva è chiaro: lui
ha fatto tutto quel che poteva per scoprire i destinatari di quel contributo
illegale, sulla cui esistenza non c'è il minimo dubbio, ma quel 23 luglio cambiò
la storia di Mani pulite e in qualche modo quella d'Italia e diventa una data
spartiacque, come il 25 luglio 43. Vengono i brividi, ma questa ricostruzione
non può essere accettata acriticamente e dovrebbero essere rivisti gli errori, e
le incertezze dell'altrove insuperabile Pool sulla strada del vecchio Pci. Non
si può scaricare su chi non c'è più la responsabilità di non aver scoperchiato
quella Tangentopoli. Di Pietro invece se la cava così, rammaricandosi solo di
non aver fatto ammanettare il signore della chimica italiana la sera prima,
quando i carabinieri lo avvisarono che Gardini era a casa, in piazza Belgioioso.
«M avevo dato la mia parola agli avvocati che lui sarebbe arrivato in procura
con le sue gambe, il mattino dopo». Quello fatale. «E dissi di lasciar perdere.
Se l'avessi fatto arrestare subito sarebbe ancora qui con noi. Io Gardini lo
potevo salvare». La storia non si fa con i se. E quella delle tangenti rosse è
finita prima ancora di cominciare.
Pomicino: il pm Di Pietro tentò di farmi
incastrare Napolitano. L'ex ministro Cirino Pomicino: "Inventando una
confessione, cercò di spingermi a denunciare una tangente all'attuale capo dello
Stato, poi spiegò il trucco", scrive Paolo Bracalini su “Il Giornale”. E mentre
la truccatrice gli passa la spazzola sulla giacca, prima di entrare nello studio
tv di Agorà, 'o ministro ti sgancia la bomba: «Di Pietro mi chiese: "È vero che
Giorgio Napolitano ha ricevuto soldi da lei?". Io risposi che non era vero, ma
lui insisteva. "Guardi che c'è un testimone, un suo amico, che lo ha
confessato". "Se l'ha detto, ha detto una sciocchezza, perché non è vero"
risposi io. E infatti la confessione era finta, me lo rivelò lo stesso Di Pietro
poco dopo, un tranello per farmi dire che Napolitano aveva preso una tangente.
Ma si può gestire la giustizia con questi metodi? E badi bene che lì aveva
trovato uno come me, ma normalmente la gente ci metteva due minuti a dire quel
che volevano fargli dire". "In quegli anni le persone venivano arrestate,
dicevano delle sciocchezze, ammettevano qualsiasi cosa e il pm li faceva subito
uscire e procedeva col patteggiamento. Quando poi queste persone venivano
chiamate a testimoniare nel processo, contro il politico che avevano accusato,
potevano avvalersi della facoltà di non rispondere. E quindi restavano agli atti
le confessioni false fatte a tu per tu col pubblico ministero», aveva già
raccontato Pomicino in una lunga intervista video pubblicata sul suo blog
paolocirinopomicino.it. La stessa tesi falsa, cioè che Napolitano, allora
presidente della Camera, esponente Pds dell'ex area migliorista Pci, avesse
ricevuto dei fondi, per sé e per la sua corrente, col tramite dell'ex ministro
democristiano, Pomicino se la ritrovò davanti in un altro interrogatorio,
stavolta a Napoli. «Il pm era il dottor Quatrano (nel 2001 partecipò ad un
corteo no global e l'allora Guardasigilli Roberto Castelli promosse un'azione
disciplinare). Mi fece incontrare una persona amica, agli arresti, anche lì per
farmi dire che avevo dato a Napolitano e alla sua corrente delle risorse
finanziaria». La ragione di quel passaggio di soldi a Napolitano, mai
verificatosi ma da confermare a tutti i costi anche col tranello della finta
confessione di un amico (uno dei trucchi dell'ex poliziotto Di Pietro, "altre
volte dicevano che se parlavamo avremmo avuto un trattamento più mite"), per
Cirino Pomicino è tutta politica: «Obiettivo del disegno complessivo era far
fuori, dopo la Dc e il Psi, anche la componente amendoliana del Pci, quella più
filo-occidentale, più aperta al centrosinistra. Tenga presente che a Milano fu
arrestato Cervetti, anch'egli della componente migliorista di Giorgio
Napolitano, e fu accusata anche Barbara Pollastrini. Entrambi poi scagionati da
ogni accusa». I ricordi sono riemersi di colpo, richiamati dalle «corbellerie»
dette da Di Pietro al Corriere a proposito del suicidio di Raul Gardini,
vent'anni esatti fa (23 luglio 1993). «Sono allibito che il Corriere della Sera
dia spazio alle ricostruzioni false raccontate da Di Pietro. Ho anche mandato un
sms a De Bortoli, ma quel che gli ho scritto sono cose private. Di Pietro dice
che Gardini si uccise con un moto d'impeto, e che lui avrebbe potuto salvarlo
arrestandolo il giorno prima. Io credo che Gardini si sia ucciso per il motivo
opposto», forse perché era chiaro che di lì a poche ore sarebbe stato arrestato.
Anche Luigi Bisignani, l'«Uomo che sussurra ai potenti» (bestseller
Chiarelettere con Paolo Madron), braccio destro di Gardini alla Ferruzzi,
conferma questa lettura: «Raul Gardini si suicidò perché la procura aveva
promesso che la sua confessione serviva per non andare in carcere, ma invece
scoprì che l'avrebbero arrestato». Processo Enimont, la «madre di tutte le
tangenti», l'epicentro del terremoto Tangentopoli. «La storia di quella
cosiddetta maxitangente, che poi invece, come diceva Craxi, era una maxiballa, è
ancora tutta da scrivere. - Pomicino lo spiega meglio - Alla politica andarono
15 o 20 miliardi, ma c'erano 500 miliardi in fondi neri. Dove sono finiti? A chi
sono andati? E chi ha coperto queste persone in questi anni? In parte l'ho
ricostruito, con documenti che ho, sui fondi Eni finiti a personaggi all'interno
dell'Eni. Ma di questo non si parla mai, e invece si pubblicano false
ricostruzioni della morte tragica di Gardini».
Ieri come oggi la farsa continua.
Dopo 5 anni arriva la sentenza di primo grado:
l'ex-governatore dell'Abruzzo Ottaviano del Turco è stato condannato a 9 anni e
6 mesi di reclusione dal Tribunale collegiale di Pescara nell'inchiesta riguardo
le presunti tangenti nella sanità abruzzese. L’ex ministro delle finanze ed ex
segretario generale aggiunto della Cgil all’epoca di Luciano Lama è accusato di
associazione per delinquere, corruzione, abuso, concussione, falso. Il pm aveva
chiesto 12 anni. Secondo la Procura di Pescara l’allora governatore avrebbe
intascato 5 milioni di euro da Vincenzo Maria Angelini, noto imprenditore della
sanità privata, all’epoca titolare della casa di cura Villa Pini.
«E' un processo che è nato da una vicenda
costruita dopo gli arresti, cioè senza prove - attacca l'ex governatore
dell'Abruzzo intervistato al Giornale Radio Rai -. Hanno cercato disperatamente
le prove per 4 anni e non le hanno trovate e hanno dovuto ricorrere a una specie
di teorema e con il teorema hanno comminato condanne che non si usano più
nemmeno per gli assassini, in questo periodo. Io sono stato condannato
esattamente a 20 anni di carcere come Enzo Tortora». E a Repubblica ha poi
affidato un messaggio-shock: «Ho un tumore, ma voglio vivere per dimostrare la
mia innocenza».
Lunedì 22 luglio 2013, giorno della sentenza, non
si era fatto attendere il commento del legale di Del Turco, Giandomenico
Caiazza, che ha dichiarato: «Lasciamo perdere se me lo aspettassi o no perchè
questo richiederebbe ragionamenti un pò troppo impegnativi. Diciamo che è una
sentenza che condanna un protagonista morale della vita politica istituzionale
sindacale del nostro paese accusato di aver incassato sei milioni e 250 mila
euro a titolo di corruzione dei quali non si è visto un solo euro. Quindi penso
che sia un precedente assoluto nella storia giudiziaria perchè si possono non
trovare i soldi ma si trovano le tracce dei soldi».
Nello specifico, Del Turco è accusato insieme
all’ex capogruppo del Pd alla Regione Camillo Cesarone e a Lamberto Quarta, ex
segretario generale dell’ufficio di presidenza della Regione, di aver intascato
mazzette per 5 milioni e 800mila euro. Per questa vicenda fu arrestato il 14
luglio 2008 insieme ad altre nove persone, tra le quali assessori e consiglieri
regionali. L’ex presidente finì in carcere a Sulmona (L'Aquila) per 28 giorni e
trascorse altri due mesi agli arresti domiciliari. A seguito dell’arresto, Del
Turco il 17 luglio 2008 si dimise dalla carica di presidente della Regione e con
una lettera indirizzata all’allora segretario nazionale Walter Veltroni si
autosospese dal Pd, di cui era uno dei 45 saggi fondatori nonchè membro della
Direzione nazionale. Le dimissioni comportarono lo scioglimento del consiglio
regionale e il ritorno anticipato alle urne per i cittadini abruzzesi.
Del Turco condannato senza prove. All'ex
presidente dell'Abruzzo 9 anni e sei mesi per presunte tangenti nella sanità. Ma
le accuse non hanno riscontri: nessuna traccia delle mazzette né dei passaggi di
denaro, scrive Gian Marco Chiocci su “Il Giornale”. In dubio pro reo. Nel dubbio
- dicevano i latini - decidi a favore dell'imputato. Duole dirlo, e non ce ne
voglia il collegio giudicante del tribunale di Pescara, ma la locuzione dei
padri del diritto sembra sfilacciarsi nel processo all'ex presidente della
Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco. Processo che in assenza di prove certe s'è
concluso come gli antichi si sarebbero ben guardati dal concluderlo: con la
condanna del principale imputato e dei suoi presunti sodali. Qui non interessa
riaprire il dibattito sulle sentenze da rispettare o sull'assenza o meno di un
giudice a Berlino. Si tratta più semplicemente di capire se una persona - che su
meri indizi è finita prima in cella e poi con la vita politica e personale
distrutta - di fronte a un processo per certi versi surreale, contraddistintosi
per la mancanza di riscontri documentali, possa beccarsi, o no, una condanna
pesantissima a nove anni e sei mesi (non nove mesi, come ha detto erroneamente
in aula il giudice). Noi crediamo di no. E vi spieghiamo perché. In cinque anni
nessuno ha avuto il piacere di toccare con mano le «prove schiaccianti» a carico
dell'ex governatore Pd di cui parlò, a poche ore dalle manette, l'allora
procuratore capo Trifuoggi. Un solo euro fuori posto non è saltato fuori dai
conti correnti dell'indagato eccellente, dei suoi familiari o degli amici più
stretti, nemmeno dopo centinaia di rogatorie internazionali e proroghe
d'indagini. E se non si sono trovati i soldi, nemmeno s'è trovata una traccia
piccola piccola di quei soldi. Quanto alle famose case che Del Turco avrebbe
acquistate coi denari delle tangenti (sei milioni di euro) si è dimostrato al
centesimo esser state in realtà acquistate con mutui, oppure prima dei fatti
contestati o ancora coi soldi delle liquidazioni o le vendite di pezzi di
famiglia. Non c'è un'intercettazione sospetta. Non un accertamento schiacciante.
Non è emerso niente di clamoroso al processo. Ma ciò non vuol dire che per i pm
non ci sia «niente» posto che nella requisitoria finale i rappresentanti
dell'accusa hanno spiegato come l'ex segretario della Cgil in passato avesse
ricoperto i ruoli di presidente della commissione parlamentare Antimafia e di
ministro dell'Economia, e dunque fosse a conoscenza dei «sistemi» criminali
utilizzati per occultare i quattrini oltre confine. Come dire: ecco perché i
soldi non si trovano (sic !). Per arrivare a un verdetto del genere i giudici, e
in origine i magistrati di Pescara (ieri assolutamente sereni prima della
sentenza, rinfrancati dalla presenza a sorpresa in aula del loro ex procuratore
capo) hanno creduto alle parole del re delle cliniche abruzzesi, Vincenzo Maria
Angelini, colpito dalla scure della giunta di centrosinistra che tagliava fondi
alla sanità privata, per il quale i carabinieri sollecitarono (invano) l'arresto
per tutta una serie di ragioni che sono poi emerse, e deflagrate, in un
procedimento parallelo: quello aperto non a Pescara bensì a Chieti dove tal
signore è sotto processo per bancarotta per aver distratto oltre 180 milioni di
euro con operazioni spericolate, transazioni sospette, spese compulsive per
milioni e milioni in opere d'arte e beni di lusso. Distrazioni, queste sì,
riscontrate nel dettaglio dagli inquirenti teatini. Da qui il sospetto, rimasto
tale, che il super teste possa avere utilizzato per sé (vedi Chieti) ciò che ha
giurato (a Pescara) di avere passato ai politici. Nel «caso Del Turco» alla
mancanza di riscontri si è supplito con le sole dichiarazioni dell'imprenditore,
rivelatesi raramente precise e puntuali come dal dichiarante di turno pretendeva
un certo Giovanni Falcone. Angelini sostiene che prelevava contanti solo per
pagare i politici corrotti? Non è vero, prelevava di continuo ingenti somme
anche prima, e pure dopo le manette (vedi inchiesta di Chieti). Angelini giura
che andava a trovare Del Turco nella sua casa di Collelongo, uscendo al casello
autostradale di Aiello Celano? Non è vero, come dimostrano i telepass, le
testimonianze e le relazioni degli autisti, a quel casello l'auto della sua
azienda usciva prima e dopo evidentemente anche per altri motivi. Angelini dice
che ha incontrato Del Turco a casa il giorno x? Impossibile, quel giorno si
festeggiava il santo patrono e in casa i numerosi vertici istituzionali non
hanno memoria della gola profonda. Angelini porta la prova della tangente
mostrando una fotografia sfocata dove non si riconosce la persona ritratta? In
dibattimento la difesa ha fornito la prova che quella foto risalirebbe ad almeno
un anno prima, e così cresce il giallo del taroccamento. Angelini corre a
giustificarsi consegnando ai giudici il giaccone che indossava quando passò la
mazzetta nel 2007, e di lì a poco la casa produttrice della giubba certifica che
quel modello nel 2007 non esisteva proprio essendo stato prodotto a far data
2011. Questo per sintetizzare, e per dire che le prove portate da Angelini, che
la difesa ribattezza «calunnie per vendetta», sono tutt'altro che granitiche
come una sana certezza del diritto imporrebbe. Se per fatti di mafia si è
arrivati a condannare senza prove ricorrendo alla convergenza del molteplice (il
fatto diventa provato se lo dicono più pentiti) qui siamo decisamente oltre:
basta uno, uno soltanto, e sei fregato. «Basta la parola», recitava lo spot di
un celebre lassativo. Nel dubbio, d'ora in poi, il reo presunto è autorizzato a
farsela sotto. Del Turco: "Ho un cancro, voglio vivere per provare la mia
innocenza". «Da tre mesi so di avere un tumore, da due sono in chemioterapia.
Domani andrò a Roma a chiedere al professor Mandelli di darmi cinque anni di
vita, cinque anni per dimostrare la mia innocenza e riabilitare la giunta della
Regione Abruzzo che ho guidato». A dichiararlo in una intervista a Repubblica è
Ottaviano Del Turco, condannato a nove anni e sei mesi per presunte tangenti
nella sanità privata abruzzese. «Mi hanno condannato senza una prova applicando
in maniera feroce il teorema Angelini, oggi in Italia molti presidenti di corte
sono ex pm che si portano dietro la cultura accusatoria. Il risultato,
spaventoso, sono nove anni e sei mesi basati sulle parole di un bandito. Ho
preso la stessa condanna di Tortora, e questo mi dà sgomento». Il Pd? «Ha così
paura dei giudici che non è neppure capace di difendere un suo dirigente
innocente», ha aggiunto Del Turco.
Raul Gardini, la vera storia del
"Corsaro" tra scommesse azzardate e faide familiari.
Luigi Bisignani su Il Tempo il 30 luglio 2023
Caro direttore, un popolo di santi, eroi, poeti e
naviganti. Mai come in questi giorni queste parole sono state così calzanti nel
sentire la narrazione di una certa stampa e Tv su Raul Gardini, in occasione dei
30 anni dalla morte del manager ravvenate. Non è stata da meno la Rai, con
l’apologetico docufilm «Raul Gardini» - andato in onda il 23 luglio - nel
rappresentare la vicenda umana e professionale del «Corsaro», così
soprannominato per le sue scorribande in borsa. Un protagonista temerario e
certamente con idee innovative, ma anche uno spericolato «gambler» con il gusto
dell’azzardo che è riuscito a distruggere uno dei più grandi player
agro-industriali al mondo nello spazio di pochi mesi.
Anche nella tv di Stato la vicenda viene fatta
passare per una faida di famiglia, una sorta di Dynasty «acchiappa audience»
che, peraltro, proprio sul terreno degli ascolti è stata un flop. Mentre il
Gruppo Ferruzzi era in realtà il progetto di una vita del patriarca Serafino,
lui sì visionario e all’avanguardia, che si era sempre tenuto ben lontano da
politica e finanza e che aveva costruito un megapolo integrato con una filiera
rigorosamente “homemade” di trasporti, logistica, stoccaggio. Solo per dare
qualche numero, parliamo di circa 170 chiatte da 1.000 tonnellate per il
trasporto fluviale, di una flotta di 16 navi per 752mila tonnellate di carico e
di enormi stoccaggi in silos giganteschi alla foce del Mississippi. Tant’è che
alla Borsa di Chicago, come si fa con i «grandi», quando entrava il cavalier
Ferruzzi, veniva suonata la campanella. Il patrimonio di Serafino Ferruzzi è
stata la migliore «dote» in mano a Gardini, utilizzata per l’acquisto non solo
della Montedison, ma di tante altre realtà come Central Soia, Koipe, Carapelli
ed anche per la celebrata avventura de Il Moro di Venezia.
Tornando al docufilm, bastano i primi minuti per
capire la follia dello storytelling celebrativo a senso unico non appena, al
bravo Bentivoglio/Gardini, mettono in bocca una falsità storica: gli fanno dire
che non si sa chi sia più ricco tra suo padre Ivan e Serafino Ferruzzi. La
verità è che da una parte abbiamo Ivan Gardini, un piccolo imprenditore che
aveva come microcosmo Ferrara, una famiglia che coltivava pesche e, quale
attività complementare, quella del «sabiunat», ovvero dragava il fiume per
raccogliere la sabbia. Dall’altra parte abbiamo Serafino Ferruzzi, una leggenda
che per orizzonte aveva il mondo intero e con una liquidità in tasca di migliaia
di miliardi di lire. La «pietas» per il tragico destino di Gardini non deve però
farci dimenticare la verità e dunque la sua distruttiva arroganza. E questa
volta chi postula «ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e
diventerà una verità» resterà deluso perché un’altra verità sta emergendo da una
domanda spontanea: perché, dopo tutto questo tempo, si continua a rappresentare
epicamente la storia di Gardini, oramai smentita da carte e testimoni, come
quella di un eroe senza macchia e peccato?
Le risposte possono essere molteplici: forse per
evitare di parlare del ruolo nefasto e malefico di Mediobanca e di alcuni poteri
forti che contribuirono in modo sostanziale a spolpare il gruppo Ferruzzi a
beneficio della Fiat.
O, più semplicemente, per spostare l’attenzione
nei giorni tragici di Mani Pulite su partiti come il Pci e personaggi finiti nel
mirino della magistratura, come gli Agnelli, i De Benedetti e i Falck,
sfruttando e approfittando, con un grimaldello perfetto quale era il carattere
impetuoso di Gardini, delle divisioni nella famiglia di Ravenna. O, forse, anche
per evitare di aprire uno squarcio in seno alla stessa Procura di Milano, che
aveva bisogno di «crocifiggere» Sergio Cusani e i Ferruzzi per lavarsi la
coscienza dai suicidi dei vari Castellari, Moroni, Cagliari e dello stesso
Gardini, portando così avanti la tesi della corruzione nella vicenda Enimont.
Ricostruzioni e verità giudiziarie che tuttavia non sempre collimano con le
verità reali. Più che una corruzione sta diventando palese che si trattò
dell’ennesimo sciagurato finanziamento illecito ai partiti - un habitus a quei
tempi di tutti i grandi gruppi industriali - per mettere fine alla guerra
personale che Gardini aveva dichiarato alla politica, lanciando in campo
provocazioni di ogni genere.
Leggendaria fu quella di mandare sotto la casa del
ministro dell’epoca delle partecipazioni statali, Carlo Fracanzani, truppe
cammellate urlanti «la chimica sono io». Oppure, ed è un mio ricordo personale
ancora vivo, quando accompagnai il dottor Gardini dal presidente Andreotti per
perorare un beneficio fiscale osteggiato da parte della sinistra Dc e dal Pci.
Gardini spiegò le sue ragioni in maniera entusiasmante ma uscendo, con un ghigno
arrogante dei suoi, si congedò dicendo testualmente «Se non me lo accordate, io
i soldi me li faccio dare dai francesi». Il Divo, allora, commentò sagacemente:
«Questo è matto, che se li facesse dare dai francesi, cosa è venuto a fare».
Enimont durò neanche due anni. Nel ‘90 Montedison cedette il settore «chimica»
all’Eni anche perché tutto il mondo politico voleva Gardini fuori per favorire
quello che veniva definito il partito degli appalti e degli appaltatori
all’ombra del cane a sei zampe. Vennero pagati 2.800 miliardi di lire per
costringere Gardini alla resa. Ma potevano essere anche di più, come sosteneva
all’epoca l’imperituro Franco Bernabè, in forza all’Eni e incaricato di una
valutazione, pur di cacciare il «Contadino».
Gardini, affogato nel suo ego, era rimasto quello
spregiudicato giocatore di poker che Serafino mal sopportava. Spesso i geni sono
incontenibili nelle loro pretese e gesta, ma comunque i fratelli Ferruzzi,
Arturo, Alessandra e Franca gli accordarono fiducia, supporto e sostegno.
Tuttavia, riguardo a Enimont, certamente la vicenda più mediatica, la famiglia
ha sempre affermato che la decisione della vendita della quota della società a
Eni fu presa dal solo Raul, in totale autonomia e comunicata solo a cose fatte
ai familiari i quali, basiti di fronte a tanta prepotenza, gli chiesero invano
spiegazioni, così come avvenne per l’acquisto a debito della Montedison,
portando ovviamente in garanzia il patrimonio Ferruzzi. Gardini non si smentiva
mai e aveva manie di grandezza, anche perché il suo sogno nascosto era quello di
diventare il nuovo Gianni Agnelli.
Solo una volta è venuto meno a sé stesso,
solleticato nell’ego ipertrofico da quel venditore di sogni di Silvio
Berlusconi, che ben sapeva interpretare i suoi interlocutori. L’occasione fu
l’acquisto della Standa, che Gardini aveva giurato di non vendere mai e
invece... Berlusconi si recò in pellegrinaggio a Ravenna e, giunto sulla soglia
d’ingresso della villa di Gardini, si inginocchiò in stile Wojtyla. Davanti a
quel gesto, Gardini rimase esterrefatto e così Silvio cominciò ad incantarlo,
rimarcando che loro due erano gli unici indipendenti: «Abbiamo figli giovani.
Abbiamo tutti contro. Ci vogliono far litigare. Ci scatenano contro i loro
giornali». E così si prese la Standa. La lucida follia di Gardini raggiunse il
suo apice quando pretese di mettere come presidente della Ferruzzi Finanziaria,
la cassaforte del Gruppo il giovane figlio Ivan, in un consiglio di
amministrazione dove sedevano, tra gli altri, giganti come Giuseppe Garofano,
Italo Trapasso, Renato Picco e Sergio Cragnotti. Un bravo ragazzo che,
nonostante l’aiuto del comandante generale dei Carabinieri, non riuscì neanche
ad essere ammesso nell’Arma.
La conseguenza per la gloriosa «Ferruzzi
Finanziaria» è che quel Cda divenne una farsa come l’Enrico IV di Pirandello,
dove ogni consigliere doveva leggere un foglio pre-compilato in modo che il
rampollo, fatto re, non facesse brutta figura. Fu l’inizio della fine per Raul,
che voleva cancellare la Ferruzzi per farla diventare la Gardini. Voleva
condizionare e tenere sotto controllo ogni cosa, anche la vita dei suoi
collaboratori. Non gli piaceva, ad esempio, la moglie di Sergio Cragnotti, la
Signora Flora, che poi si è dimostrata una donna eccezionale. E così architettò
di creare le condizioni per il loro divorzio. Aveva addirittura scelto la futura
compagna di Cragnotti: l’attrice e modella Marisa Berenson, che peraltro non
aveva mai conosciuto. Nel «Colosseo Ferruzzi», come un imperatore romano, Raul
voleva avere potere di vita e di morte, anche in nome di tutti gli eredi,
perfino dei piccoli in arrivo come il bimbo di Alessandra, la più tenace dei
figli di Serafino, l’unica che aveva compreso la fatale deriva verso cui stava
trascinando il Gruppo. La debolezza della famiglia sotto scacco di Gardini,
portò ad un certo punto alla decisione di liquidare il Contadino con 500
miliardi di lire. E da lì a poco entrò maleficamente in campo la Mediobanca di
Cuccia che non permise alla famiglia Ferruzzi di farsi assistere dalla Goldman
Sachs di Claudio Costamagna - che al contrario apprezzava il piano di
risanamento portato avanti da Arturo Ferruzzi e Carlo Sama per poterla così
spingere nell’abisso. Decisamente una storia tristissima per il capitalismo
italiano. Ed è struggente l’ultima frase della prima lunga “intervista-verità”
che ha rilasciato poche settimane fa Alessandra Ferruzzi, ricordando anche
Gardini. Due sole parole eloquenti: «Scusa papà».
Gardini, 30 anni fa la morte. L’avvocato
che passò con lui le ultime ore: «Ecco perché si uccise». Andrea
Pasqualetto su Il Corriere della Sera il 23 luglio 2023.
Marco De Luca, l’avvocato che passò le ultime ore
con l’imprenditore: «Nel suo volto una tristezza profonda». Oggi il 30mo
anniversario della morte
Il 23 luglio di trent’anni fa Milano si svegliò
con uno sparo. A palazzo Belgioioso, nel centro cittadino, veniva trovato il
corpo senza vita di Raul Gardini. L’eco fu planetaria perché il personaggio era
planetario: partendo dall’eredità del suocero Serafino Ferruzzi, Gardini aveva
creato in dieci anni un gruppo agroindustriale e chimico, Ferruzzi-Montedison,
di dimensioni mondiali, con oltre 90 mila dipendenti; e nel contempo aveva
scalato, come armatore e velista, le vette della Coppa America.
La magistratura non ebbe dubbi: suicidio. E nessun
dubbio ebbero i familiari, nonostante le ombre allungate sul caso da varie
inchieste giornalistiche. Com’è possibile che la pistola, trovata dalla
Scientifica, fosse sullo scrittoio anziché accanto a lui? «Qualcuno nel
frattempo l’ha spostata», tagliò corto il pm. E l’assenza di polvere da sparo
nelle mani di Gardini? «Sono state lavate al pronto soccorso». La strage di via
Palestro di quattro giorni dopo attribuita alla mafia? «Nessun nesso».
Il suicidio squassò il mondo della finanza e la
famiglia. Da allora i Gardini e i Ferruzzi, già ai ferri corti per via del suo
siluramento dalla guida del gruppo, non si parlano. Ma al di là delle vicende
familiari, erano giorni neri per Gardini: la mattina del suicidio, dopo
che quella settimana l’ex presidente dell’Eni Gabriele Cagliari si era tolto la
vita in carcere, sapeva di dover essere arrestato su richiesta del pool Mani
Pulite che lo accusava delle tangenti pagate ai politici per la joint
venture Enimont. Il giorno prima, a palazzo Belgioioso, con Gardini c’erano il
figlio Ivan, la moglie Idina, il dirigente Roberto Michetti e i suoi avvocati,
Marco De Luca e Giovanni Maria Flick.
Avvocato De Luca, ci racconta l’ultimo giorno di
Gardini?
«Il 22 luglio ero andato da lui nel pomeriggio per
rivedere il possibile interrogatorio del giorno dopo, visto che doveva essere
arrestato e ne avevo parlato con Di Pietro. E ciò anche alla luce delle
dichiarazioni del manager Giuseppe Garofano, rispetto alle quali stavano uscendo
delle anticipazioni di agenzia. Flick ed io restammo con lui quasi tutto il
pomeriggio e la sera. Io me ne andai più o meno alle undici dopo che Idina era
ripartita per Ravenna dicendo che sarebbe tornata la mattina successiva».
Come trovò Gardini?
«Mi sembrava un uomo molto provato, aveva nel
volto una profonda tristezza».
Che cosa lo preoccupava?
«La sua prima preoccupazione riguardava la
documentazione delle attività di Montedison di cui non disponeva ma che riteneva
necessaria per difendersi dalle accuse. Essendo ormai fuori dal gruppo da un
paio d’anni, da quando c’era stata la rottura in famiglia, non aveva quelle
carte, in particolare sulla vicenda Enimont e sulle dazioni di denaro».
Doveva essere arrestato per le tangenti ai
politici. Lei aveva trattato a lungo con Di Pietro, cosa aveva ottenuto?
«Io avrei voluto che Di Pietro sentisse Gardini
per rendersi conto della sua posizione effettiva, di responsabilità nella fase
decisionale, non però in quella esecutiva. Ma Di Pietro non volle. Alla fine
riuscii a ottenere un arresto senza passaggio dal carcere. Gardini si sarebbe
dovuto presentare il giorno 23 alle 11 di mattina in una qualche caserma della
Guardia di Finanza, lì Di Pietro l’avrebbe interrogato a lungo, probabilmente
fino a notte fonda, e Gardini sarebbe rimasto con noi fino a che il gip non
avesse concesso i domiciliari. Il 24 poteva essere a casa».
(Ascolta qui i 5 episodi della serie podcast
«Chiedi chi era Gardini», di Carlo Annese)
Gardini che cosa disse?
«Temeva che dall’interrogatorio di Garofano
emergesse una realtà molto diversa da quella che pensava di rappresentare. Aveva
paura cioè che gli gettassero la croce addosso».
La mattina dopo come andò?
«Dovevamo vederci alle 10 nel mio studio. Flick
l’aveva cercato alle 7.30 per rinfrancarlo. Gli voleva offrire un caffè prima di
venire da me. Ma non è riuscito a parlargli e quando è arrivato in piazza
Belgioioso era già tutto successo».
Ha dei dubbi sul suicidio?
«Nessuno».
Che idea si è fatto sul movente?
«Io credo che l’abbia fatto per tutelare la sua
famiglia e l’immagine. Non dobbiamo dimenticare che accanto alle vicende di
Tangentopoli era maturato in quel momento il dissesto della Montedison che
avrebbe potuto ripercuotersi su di lui e su molti altri con azioni riparatorie
importanti dal punto di vista economico. Penso abbia considerato il fatto che
senza di lui la sua famiglia sarebbe stata in qualche modo tutelata. In quegli
anni Gardini era l’imprenditore per eccellenza in Italia. Il suo nome era
straordinario, a Ravenna era considerato un re. Forse voleva evitare che le
vicende di Tangentopoli potessero turbare tutto questo: lui e il suo mondo, nato
accanto a Serafino Ferruzzi».
Se questo era il suo obiettivo l’ha raggiunto?
«Il suo ricordo, che condivido, è rimasto quello
di un uomo di grandi capacità e vedute che ha portato molto onore a Ravenna e
all’imprenditoria italiana. Quindi sì, credo abbia raggiunto l’obiettivo».
Trent'anni fa la scomparsa. Il ricordo di
Gardini: Raul e Serafino gli inizi dell’avventura.
“Voleva convincere i commissari europei sul bioetanolo ma aveva contro la lobby
del petrolio”. Marco Fortis su Il Riformista il 18 Luglio 2023
Sono trascorsi trent’anni dalla tragica morte
di Raul Gardini, con cui ho avuto il piacere e l’onore di collaborare agli inizi
della mia attività professionale. Gardini mi chiamò a Ravenna per dare vita
all’Ufficio Studi del Gruppo Ferruzzi nel 1986. Fu per me una scelta non facile.
Perché avrei dovuto abbandonare l’attività di condirettore della rivista
“Materie Prime” di Nomisma che era stata co-fondata nel 1981 da me con il mio
maestro accademico Alberto Quadrio Curzio, ma anche con il sostegno di Romano
Prodi.
La rivista “Materie Prime” aveva diversi sponsor,
tra cui il Gruppo Ferruzzi e si creò subito una sintonia ed una complementarità
di competenze tra Gardini e me. Ciò fu determinante per la proposta che mi fece
Gardini: lui imprenditore innovatore ed io economista con l’angolatura sulla
economia reale ed internazionale. Per questo anche Quadrio Curzio, con cui
collaboravo intensamente, mi incoraggiò nella mia decisione.
Così accettai, perché mi affascinavano le idee e i
progetti che Gardini e suoi più stretti collaboratori stavano portando avanti e
fui attratto dalla possibilità di lavorare in un grande gruppo industriale
internazionale come la Ferruzzi, dove avrei comunque potuto continuare a fare
ricerca economica ad alto livello, in parallelo con la mia attività
universitaria, come poi è effettivamente successo fino ad oggi, prima con
Ferruzzi-Montedison e poi con la Fondazione Edison.
Ricordare Gardini è, a mio avviso, molto
importante. Non solo per tributare un omaggio alla memoria di un grande uomo. Ma
anche per non perdere il “filo della storia”, di quella storia del nostro Paese
e della sua economia i cui contorni spesso sembrano confondersi nel tempo. Per
capire chi è stato Gardini occorre innanzitutto capire chi è stato prima di lui
Serafino Ferruzzi, il fondatore del Gruppo, la cui figlia Idina era moglie di
Gardini. Il “dottor” Ferruzzi fu, come Enrico Mattei nell’energia, un uomo di
grande intraprendenza, capace di rendere l’Italia del Secondo Dopoguerra
indipendente per i cereali e la soia dalle grandi multinazionali del settore.
Ferruzzi sfidò le società di trading americane costruendo propri silos per i
cereali sul Mississippi. Si diversificò geograficamente negli approvvigionamenti
andando a comprare le materie prime agricole anche dalle cooperative argentine,
si dotò di una propria flotta per trasportare le derrate in Italia, acquistò
immensi possedimenti terrieri negli Stati Uniti e in Sudamerica.
Divenne così importante ed autorevole nel mondo
del commercio mondiale dei prodotti agricoli che quando egli arrivava alla Borsa
dei cereali di Chicago le contrattazioni venivano temporaneamente interrotte per
tributargli un deferente saluto. Prima di morire in un incidente aereo in una
notte nebbiosa a Forlì mentre stava tornando a casa a Ravenna col suo
jet, Serafino Ferruzzi aveva accumulato uno dei più importanti patrimoni
d’Italia, stimato da Cesare Peruzzi in un articolo su “Il Mondo” del febbraio
1980 in circa 3 mila miliardi di lire, ed era riuscito a comprare dal cavalier
Attilio Monti l’Eridania, la principale società italiana produttrice di
zucchero. Furono così create le solide basi per lo sviluppo agro-industriale del
Gruppo Ferruzzi che fu poi portato avanti dopo la sua scomparsa dal genero Raul
Gardini.
La storia di Raul Gardini è certamente più nota di
quella di Serafino Ferruzzi ma anch’essa è conosciuta solo in parte. Ed è
probabilmente conosciuta più per le tragiche vicende finali di Enimont e le
imprese veliche in Coppa America che non per il ruolo che Gardini ha avuto
nell’industria italiana e mondiale. Ho avuto la fortuna di condividere con
Gardini gli anni di lavoro che credo siano stati per lui i più belli: anni
emozionanti e travolgenti, ma ancora sereni, diversamente da quelli successivi
dell’avventura tormentata nella chimica, che gli avrebbe riservato fama ma anche
tante amarezze. Un periodo, quello centrale degli anni ‘80, in cui Gardini era
tutto proiettato verso il futuro ed era circondato da uomini fidati: dirigenti
storici che aveva “ereditato” dal suocero Serafino ed altri emergenti, come
Renato Picco, a capo dell’Eridania. La Ferruzzi a quell’epoca era veramente una
grande squadra di manager preparati, chi a capo del trading, chi degli olii, chi
dello zucchero, chi del calcestruzzo, chi delle navi, chi dei silos: tutti
compatti attorno a Gardini. Una squadra che lo aiutò molto a muovere i suoi
primi passi da leader, nel solco di Serafino.
Inoltre, era entrato a far parte dei vertici
anche Mauro De André, fratello del noto cantautore, che era diventato l’avvocato
del Gruppo, della famiglia Ferruzzi e di Gardini. Un uomo di straordinaria
professionalità, De André, un autentico baluardo per la Ferruzzi. Forse, se non
fosse morto prematuramente, avrebbe saputo consigliare Gardini in taluni
successivi momenti difficili della sua vita e la storia della Ferruzzi stessa
sarebbe andata diversamente.
Lavoravo con Gardini nell’ufficio che egli aveva
posto a piano terra nella sua casa, a Palazzo Prandi a Ravenna, in via Massimo
d’Azeglio, assieme a Carlo Sama, suo più stretto assistente, con un mio giovane
collaboratore e due segretarie. Tutti in un unico stanzone. Dietro l’ufficio,
attraverso una serie di piccole porte comunicanti, si accedeva a una stanza
privata di Gardini, dove lui amava leggere e riposarsi, circondato da
suppellettili di caccia e di vela. Un’altra porta accedeva al giardino sul retro
e a una piccola piscina. Un grande scalone portava al primo piano dove talvolta
salivamo per il pranzo Gardini, Sama ed io, in compagnia della moglie di Raul,
Idina, una donna straordinaria, semplice e molto religiosa, come la sorella
Alessandra. Con Idina ho avuto la possibilità di rimanere sempre in contatto
anche negli ultimi anni della sua vita, sia per dei consigli sia per organizzare
eventi in memoria di Raul.
Il lavoro a Ravenna trascorreva tra Palazzo Prandi
e il moderno edificio di vetro che ospitava le sedi della Italiana Oli e Risi e
della Calcestruzzi. Con Gardini e Sama ci spostavamo a piedi per le vie della
città da un ufficio all’altro. Nel week end cercavo spesso di rientrare a casa,
in Piemonte. Viaggiavo tra Ravenna e il lago d’Orta a passo di lumaca con la mia
vecchia Renault 4 bianca che raggiungeva appena i 90 all’ora e il lunedì mattina
ripartivo alla volta della Romagna prima che albeggiasse, per poter arrivare in
tempo in ufficio. Quando Gardini venne a sapere di questi miei faticosi
spostamenti mi fece affidare una più confortevole e veloce Mercedes aziendale.
Erano giorni febbrili, quelli del 1986. Gardini
voleva convincere i Commissari europei a dar vita al progetto del bioetanolo,
alcol da miscelare alla benzina ricavato dalle eccedenze cerealicole europee di
quegli anni, che erano enormi e molto costose da mantenere. Ma aveva contro
tutta la potente lobby dei petrolieri. Inoltre, Gardini voleva portare la soia
in Italia: un altro progetto coraggioso. Da poco la Ferruzzi aveva preso il
controllo del primo produttore di zucchero della Francia, la Béghin-Say, di cui
Eridania deteneva già una importante partecipazione.
Una operazione difficilissima, quella di scalare
un gruppo industriale francese, in cui però Gardini fu aiutato dallo
straordinario lavoro di lobbying di un giovanissimo Sergio Cusani, che aveva
rapporti consolidati col mondo saccarifero e finanziario transalpino. E ora,
dopo quel successo, la Ferruzzi puntava a scalare la British Sugar, con
l’appoggio dei bieticoltori inglesi ma con l’opposizione del governo britannico,
che aveva più a cuore gli interessi coloniali dello zucchero di canna della
Tate&Lyle. L’operazione British Sugar fu l’unica di quegli anni che Gardini non
riuscì a portare a termine, forse per non aver tessuto lo stesso paziente lavoro
diplomatico che caratterizzò la scalata vincente di Béghin-Say. La sconfitta di
British Sugar fu però subito riscattata dall’introduzione della soia in Italia,
che invece fu un enorme successo. Marco Fortis
Il ricordo dell'imprenditore scomparso 30
anni fa. Il ricordo di Gardini e lo sviluppo della
Ferruzzi: “Era diventato l’interlocutore degli agricoltori italiani e francesi”.
Marco Fortis su Il Riformista il 19 Luglio 2023
In quei giorni passavo ore con Gardini in ufficio
o in giardino ad ascoltare le sue idee e i suoi progetti
sull’agricoltura, sull’ambiente e sull’Europa, mentre egli, instancabile,
tracciava appunti e schemi su fogli e agendine, e discutevamo su come poter
trasferire questa narrativa alle istituzioni europee, al mondo politico e
all’opinione pubblica.
Buttammo giù praticamente insieme il primo working
paper del gruppo Ferruzzi, “Una nuova agricoltura per vivere meglio”, del
settembre 1986, che fu tradotto anche in inglese e francese, e fu presentato
poco dopo ad un convegno a Bruxelles e ai vertici della Commissione europea. Il
secondo working paper, “La soia. Una coltura alternativa per l’agricoltura
italiana”, fu pubblicato nel dicembre 1986. Va ricordato che il Gruppo Ferruzzi
favorì lo sviluppo della coltivazione della soia in Italia rendendo il nostro
Paese primo produttore europeo di questa importante leguminosa che permette di
fissare l’azoto nel terreno senza l’impiego di fertilizzanti e che quindi favorì
una vera e propria rivoluzione della rotazione agraria. Anche per questo motivo
l’Università di Bologna avrebbe poi conferito a Gardini la Laurea Honoris Causa
in Agraria.
A quei tempi si volava in continuazione con
i Falcon aziendali partendo dall’aeroporto di Forlì, diretti un po’ ovunque, a
New York, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Parigi e Reims, in quest’ultimo caso
ospiti di George Garinois, leader dei bieticoltori francesi, che dopo la scalata
di Béhin-Say divenne amico di Gardini e lo invitava spesso a cena nella sua
fattoria dove venivano cucinati gustosi polli allo spiedo. Intorno al camino
acceso, Gardini e Garinois mi coinvolgevano in interminabili discussioni fino a
notte inoltrata sull’agricoltura, sull’Europa, sulle monete. Ero affascinato da
questi uomini che rappresentavano ai miei occhi il tipo di capitalismo che avevo
sempre giudicato migliore, quello dell’economia reale, dei grandi progetti per
lo sviluppo, in contrapposizione a quello finanziario e del facile
arricchimento. Talvolta rientravamo in aereo direttamente in Italia alla
mattina, appena in tempo per aprire l’ufficio. Nei viaggi più brevi tra Ravenna,
Venezia e Milano ci si spostava invece con il grande elicottero verde della
Ferruzzi.
Gardini era un uomo affascinante ed emanava un
notevole carisma. Loquace con gli amici, era di poche parole in pubblico, spesso
rispondeva a monosillabi, ma aveva improvvise battute fulminanti, come mostra
anche una celebre intervista televisiva rilasciata ad Enzo Biagi. Nei suoi
viaggi all’estero era spesso accompagnato dalla figlia Eleonora. Ricordo che un
giorno a New York, a margine di un appuntamento d’affari, anziché seguire la
segretaria che ci accompagnava, irrompemmo di proposito nella enorme sala di
trading di una importante società di investimento con un centinaio di operatori
sbalorditi ed ammutoliti che interruppero il loro lavoro per ammirare il
passaggio di Raul e di Eleonora, elegantissima in un abito azzurro.
I Ferruzzi e i Gardini erano ovviamente persone
molto benestanti e al centro della cronaca ma anche semplici e aperte. Per
questa ragione erano molto amati e rispettati dai ravennati. Inoltre, sapevano
mettere sempre a loro agio anche giovani collaboratori come me da poco entrati a
far parte del loro mondo. Ricordo che, da poco assunto, in occasione di una
fiera agricola vicino a Birmingham, nel pieno della scalata a British Sugar,
trascorsi quasi un intero pomeriggio con Alessandra Ferruzzi, che mi raccontò la
vita di suo padre e tanti aneddoti della sua famiglia.
Oltre che con Gardini collaboravo molto anche con
Sama, a cui Raul affidò le Relazioni esterne del Gruppo Ferruzzi. In quel
periodo Carlo svolse un lavoro enorme per dare alla Ferruzzi una comunicazione
di livello, fattore essenziale per far conoscere al mondo un gruppo fino a quel
momento poco noto che però stava per entrare in Borsa, cosa che avvenne poco
dopo con la holding Agricola Finanziaria. Un impegno, quello nella
comunicazione, che poi valse a Sama anche la laurea ad honorem in sociologia da
parte dell’Università di Urbino. Sama coordinò la prima campagna istituzionale
della Ferruzzi con l’Agenzia Testa, con lo slogan “Ferruzzi Pianeta Terra”, e
lavorò alla creazione del logo della Ferruzzi, con le sue tre foglioline verdi,
ideato dalla Landor di San Francisco. Ricordo che in uno dei miei primi giorni
di lavoro, raggiunsi direttamente in treno dal Piemonte Raul e Carlo a Torino
presso l’Agenzia Testa per vedere l’evoluzione del progetto di immagine del
Gruppo. C’era anche Alessandra Ferruzzi che Gardini coinvolgeva spesso nelle sue
riflessioni strategiche perché riteneva molto preziosi i suoi pareri. Alessandra
si era laureata con una tesi sul Chicago Board of Trade ed era molto competente
sui temi dell’agricoltura e dell’agro-industria.
Sama fece anche realizzare da Fulvio Roiter uno
splendido libro fotografico sulla Ferruzzi, le cui immagini sarebbero poi finite
sui giornali e sulle riviste di tutto mondo a corredo delle interviste di
Gardini, che andavano via via moltiplicandosi. Negli anni seguenti, assunto
l’incarico di direttore delle relazioni esterne anche della Montedison, Sama
ideò poi una delle campagne pubblicitarie più innovative di quell’epoca,
consistente nella promozione di oggetti costruiti con le nuove plastiche
biodegradabili del Gruppo, tra cui macchine fotografiche ed automobiline,
distribuite in migliaia di esemplari con i numeri settimanali del periodico
“Topolino”. Quei giocattoli, oltre trent’anni fa, furono i precursori degli
odierni sacchetti ecologici della spesa in Mater-Bi. Nel 1990, Sama ed io
avremmo poi lavorato insieme alla sponsorizzazione da parte della Ferruzzi del
primo concerto dei Tre Tenori, José Carreras, Plácido Domingo e Luciano
Pavarotti, che si esibirono in un memorabile concerto alle Terme di Caracalla,
il 7 di luglio.
La Ferruzzi nella seconda metà degli anni ’80 era
intanto diventata il più importante interlocutore diretto degli agricoltori
italiani e francesi, ritirando la maggior parte dei loro raccolti di soia e
barbabietola da zucchero, suscitando anche qualche gelosia tra le rappresentanze
datoriali e sindacali italiane del settore. Memorabili furono le giornate della
soia che la Ferruzzi organizzava presso la Torvis, una delle principali aziende
agricole del Gruppo, oltre 4 mila ettari di terreni in provincia di Udine, con
la partecipazione di migliaia di coltivatori e con in cielo le caratteristiche
mongolfiere multicolori su cui spiccava il nuovo marchio del Gruppo. Nel corso
di tali giornate venivano anche tenute importanti conferenze internazionali con
la partecipazione di importanti personalità, tra cui il ministro
dell’agricoltura Filippo Maria Pandolfi e il vicepresidente della Cee e
commissario europeo all’agricoltura Frans Andriessen. In queste occasioni
Gardini e Sama sovraintendevano personalmente tutta l’organizzazione degli
eventi fino ai minimi particolari.
Quel mio dividermi tra l’Ufficio Studi e le
relazioni esterne del Gruppo e tutti quei viaggi con Raul, Carlo e Alessandra
Ferruzzi mi permisero di conoscere in breve tempo la immensa realtà della
Ferruzzi, del suo know how, delle sue tecnologie, dei suoi siti produttivi e
delle sue sedi nel mondo. In Italia Ferruzzi controllava Eridania, Italiana Olii
e Risi e Carapelli; in Francia Béghin-Say, Lesieur e Ducros; in Spagna Koipe. La
Ferruzzi aveva anche acquisito la divisione europea della statunitense Corn
Product Corporation, che Gardini ridenominò Cerestar, così il Gruppo divenne il
primo produttore europeo di amido e derivati con numerosi stabilimenti in
diversi Paesi. Furono altresì comprate Central Soya negli Stati Uniti e Provimi,
leader europea nei mangimi. La sede di Ferruzzi a Bruxelles divenne il più
imponente ufficio di rappresentanza che un’impresa italiana avesse mai avuto
nella capitale europea. Marco Fortis
Il terzo capitolo sulla scomparsa, 30
anni fa, dell'imprenditore. Raul Gardini e la scalata
di Montedison che lo trasformò da “contadino” a “pirata” e “giocatore di poker”.
Marco Fortis su Il Riformista il 20 Luglio 2023.
Arrivò poi, nel 1987, la conquista di Montedison.
L’acquisizione avvenne in modo quasi casuale, senza una strategia
preordinata. Gardini riuscì ad inserirsi nella lotta tra Mediobanca e Mario
Schimberni, il presidente di Montedison che aveva trasformato la società di Foro
Buonaparte in una public company e aveva sfidato Enrico Cuccia sulla Bi-Invest
dei Bonomi e su Fondiaria. Rastrellando titoli sul mercato, poco a poco Gardini
accrebbe la sua quota in Montedison, peraltro comprando a un prezzo elevato le
azioni di cui nel frattempo era entrato in possesso Carlo De Benedetti, nonché
quelle di Gianni Varasi e di altri azionisti minori.
Alla fine, spiazzando lo stesso Cuccia, Gardini
prese il controllo del gruppo chimico, pur appesantendo significativamente
l’indebitamento della Ferruzzi, probabilmente animato anche dalla volontà di
riuscire in una impresa completamente sua e non legata solo allo sviluppo
dell’impero agro-industriale costruito dal suocero Serafino Ferruzzi.
A seguito della irruente scalata di Montedison, la
stampa italiana, che in precedenza aveva soprannominato Gardini “il contadino”,
prese anche ad indicarlo come “il pirata”. Alcuni media lo paragonarono ad
un giocatore di poker che, con una impresa finanziaria eccessivamente
spericolata, rischiava di mettere a repentaglio il patrimonio di famigliari fin
troppo acquiescenti. E che con quella mossa, rischiava di scontrarsi
irrimediabilmente anche con lo stesso Cuccia.
Sta di fatto che Montedison costituì un’autentica
svolta per la Ferruzzi. Con grandi potenzialità ma anche con rischi enormi.
Gardini si fidò inizialmente di Schimberni ma poi ruppe con lui quando capì che
questi stava ulteriormente indebitando Montedison portando avanti in proprio
progetti non condivisi. E fece piazza pulita di molti dei suoi uomini,
mantenendo in squadra solo un professionista come Giuseppe Garofano e
promuovendo gradatamente Italo Trapasso alla guida delle materie plastiche.
Inoltre, Gardini chiamò Rita Levi Montalcini a far parte del Cda di Montedison.
Liberatosi di Schimberni, si riavvicinò anche a Mediobanca perché aveva bisogno
di Via Filodrammatici per rimettere ordine nei conti appesantiti del Gruppo.
È stato spesso enfatizzato che l’acquisizione
della Montedison da parte della Ferruzzi sarebbe stata finalizzata all’obiettivo
di esplorare un possibile legame tra agroindustria e chimica, un ponte che
avrebbe potuto permettere di realizzare la “chimica verde”, altrimenti detta
bioeconomia: vale a dire plastiche biodegradabili ottenute dal mais, carburanti
ricavati dalle materie prime agricole come l’etanolo o il biodiesel, nuovi
materiali, componenti e inchiostri biodegradabili. Frontiere che indubbiamente
Gardini ha “focalizzato” con 35-40 anni di anticipo e che sono oggi più che mai
di straordinaria attualità, nell’era di Greta Thunberg, delle nuove sfide che ci
attendono con gli obiettivi ambiziosi della transizione ecologica e nel pieno
del nuovo disordine globale innescato dalla pandemia e dall’aggressione russa
all’Ucraina. Uno scenario che ha riproposto ad un Europa non sempre capace di
programmare il proprio futuro la rude realtà di nuove improvvise “scarsità”, dal
gas alle materie prime.
In realtà, il Gruppo Ferruzzi avrebbe potuto
benissimo sviluppare la bioeconomia anche senza la Montedison. La visione della
“chimica verde” di Gardini e del Gruppo Ferruzzi, infatti, era antecedente la
presa di controllo del gruppo di Foro Buonaparte. E dentro la stessa Ferruzzi
c’erano tecnologie d’avanguardia, come quelle dell’amido di Cerestar, che
avrebbero potuto essere autonomamente indirizzate verso la bioeconomia con
importanti prospettive di innovazione.
Il vero valore aggiunto per il nostro Paese
dell’acquisizione di Montedison da parte del Gruppo Ferruzzi era invece
potenzialmente un altro. Quello, cioè, di dare finalmente un azionariato stabile
e un disegno industriale coerente alla società di Foro Buonaparte, dopo tanti
anni tormentati di invadenze politiche e finanziarie, e di proiettarla sempre di
più su scala internazionale. L’Italia avrebbe così potuto disporre non di una ma
di ben due grandi multinazionali per competere sui mercati globali in settori
strategici: la Ferruzzi nell’alimentare e la Montedison nella chimica. Senza
contare che il nostro Paese avrebbe potuto averne in futuro anche una terza,
cioè la Edison.
Furono Carlo Sama e Alessandra Ferruzzi a proporre
a Gardini di ripristinare il vecchio marchio Edison e di ridenominare così le ex
centrali elettriche di autoproduzione ex Edison ed ex Montecatini riunite nella
Selm, che era in pieno sviluppo sotto la guida di un altro capace manager,
Giancarlo Cimoli.
Invece Gardini, forse per eccessiva generosità
verso il suo Paese, forse per troppa ambizione, si “incartò” nell’affare
Enimont. Quando le massime istituzioni politiche italiane, i vertici dell’Eni e
i manager chimici della stessa Montedison proposero a Gardini un progetto per
mettere in comune le attività della chimica di base di Montedison e quelle di
Enichem in unico gruppo industriale, cioè di creare quella che sarebbe poi
diventata la futura joint venture Enimont, l’imprenditore ravennate fu molto
combattuto sul da farsi.
Lo ricordo bene perché ne parlammo insieme tante
volte in quelle settimane. Da un lato, infatti, Gardini vedeva la Montedison
soprattutto proiettata nel mondo, esattamente come la Ferruzzi. Una Montedison
tutta concentrata sulle sue società d’avanguardia come Himont (leader nel
polipropilene), Ausimont (leader nel fluoro) ed Erbamont (leader negli
antitumorali). Gardini avrebbe potuto vendere la chimica di base di Montedison
che non gli interessava, quella dei fertilizzanti, delle fibre, della
raffinazione, del pvc e del polistirene, rientrando così in parte anche dagli
investimenti finanziari fatti per scalare Foro Bonaparte. Questa era pure l’idea
degli eredi Ferruzzi e di Sama.
Ma, dall’altro lato, Gardini era anche un uomo
attratto dalle sfide impossibili. I vertici dello Stato italiano, tra l’altro,
lo invogliarono a creare l’Enimont promettendogli anche dei consistenti sgravi
fiscali per favorire la fusione societaria e lo rassicurarono sul fatto che
Enimont sarebbe stato un gruppo gestito con mentalità privata e senza
intromissioni politiche. Perciò Gardini alla fine accettò e, senza saperlo,
quello fu l’inizio del suo calvario personale così come di quello dei suoi
parenti, che anche in quella partita rovente non gli fecero mai mancare il loro
sostegno, mettendo seriamente a rischio il loro patrimonio.
La storia andò molto diversamente da come Gardini
aveva immaginato. Infatti, nei mesi immediatamente successivi alla nascita di
Enimont apparve subito evidente che la politica e i partiti, nonostante le
promesse che gli erano state fatte, non intendevano mollare per nulla la presa
sulla chimica di base, sugli appalti, sulle rendite clientelari e i relativi
consensi collegati, intromettendosi di continuo negli affari interni di Enimont,
incluse le nomine di alcuni manager. E, per di più, gli sgravi fiscali promessi
alla Ferruzzi dai massimi vertici dello Stato italiano non decollavano, con
continui rinvii politici dal carattere ricattatorio e stop and go del Parlamento
sulla materia. L’Enimont, guidata da Lorenzo Necci e Sergio Cragnotti, era
letteralmente impantanata e in quelle condizioni costituiva una emorragia che
sul piano finanziario rischiava di dissanguare giorno dopo giorno la
Ferruzzi-Montedison.
Gardini si sentì ingannato dalle istituzioni del
suo Paese. E da uomo d’azione e di mercato quale era reagì cercando di scalare
l’Enimont in modo ostile, con l’appoggio di investitori francesi, dando inizio
ad una guerra all’ultimo sangue con lo Stato italiano. Il paradosso di queste
dolorose vicende è che il gruppo Ferruzzi, così poco avvezzo ad avere a che fare
con la politica italiana, alla fine fu coinvolto in quella che è stata definita
la “madre di tutte le tangenti”. Marco Fortis
Il ricordo dell'imprenditore scomparso 30
anni fa. Gardini, l’acquisto a tutti i costi di Enimont, il fallimento e
l’inchiesta Mani Pulite. Marco Fortis su Il Riformista
il 21 Luglio 2023
Messo all’angolo, Gardini alla fine decise di
vendere all’ENI la quota in Enimont e si dimise polemicamente da tutte le
cariche che ricopriva in Italia, nominando il giovanissimo figlio Ivan
presidente del Gruppo. Furono giorni molto difficili quelli, sia per lui sia per
Ivan. Ricordo che spesso la domenica pomeriggio partivo da Linate e li
raggiungevo a Roma nella sede della Ferruzzi-Montedison presso l’Ara Coeli, dove
c’erano anche alcune stanze per dormire. Lì lavoravamo insieme a discorsi e
progetti e poi dopo cena si discuteva a lungo di possibili nuove strategie. Ma
il morale di entrambi era molto basso.
È un peccato che molti dei ricordi storici che
riguardano Raul Gardini imprenditore si riducano, oggi, alla vicenda
di Enimont e ai drammatici episodi che ne seguirono. In altri Paesi un gruppo
come la Ferruzzi-Montedison sarebbe stato giudicato un patrimonio nazionale da
difendere e da valorizzare. Gli Stati Uniti, ad esempio, normalmente fanno così.
Tanti tycoon dell’odierna economia americana sono partiti da poco più che dei
garages o tramite avventurose start up. Ma, grazie ad un ambiente istituzionale,
politico, finanziario e fiscale favorevole, hanno potuto creare delle
multinazionali che oggi dominano i mercati mondiali e le filiere
dell’innovazione tecnologica. In Germania i grandi gruppi industriali storici
dell’auto, dell’elettromeccanica, della chimica e della farmaceutica sono sempre
stati considerati dei patrimoni nazionali strategici così come lo sono in
Francia le grandi imprese del lusso o della microelettronica, quelle
dell’energia, della farmaceutica, della cosmetica o dell’auto.
Con la successiva disintegrazione del Gruppo
Ferruzzi-Montedison, si è perduta invece una fetta importante della storia e del
potenziale di sviluppo economico del nostro Paese. Si sono disperse tutte le
avanguardie della nostra chimica, che sin dai tempi della Montecatini era leader
nel mondo, e aveva vinto anche un premio Nobel con Giulio Natta. E si è anche
disperso lo straordinario patrimonio commerciale e agroindustriale creato in
quarant’anni di lavoro in tutto il mondo dal fondatore della Ferruzzi, Serafino
Ferruzzi, e poi da Gardini.
La vicenda giudiziaria su Enimont, che coinvolse
il Gruppo Ferruzzi-Montedison in Mani Pulite e vide il triste epilogo prima del
suicidio di Gabriele Cagliari (le cui lettere dal carcere sono una delle più
drammatiche testimonianze di quegli anni) e poi di quello di Raul Gardini (un
uomo che probabilmente si sentiva troppo libero e orgoglioso per poter passare
anche una sola notte in prigione), portò alla perdita del gruppo
Ferruzzi-Montedison stesso da parte della famiglia Ferruzzi e alla sua
progressiva vendita a pezzi, una volta passato sotto il controllo di Mediobanca.
Come tutti gli uomini, Gardini ha anche commesso
alcuni errori. E uno dei più gravi è certamente stato proprio quello
di intestardirsi a voler conquistare Enimont a tutti i costi. Per di più in un
Paese come l’Italia, stretto tra vecchi presunti “salotti buoni” della finanza
che certamente non gli erano amici e un sistema politico “invadente” come pochi
altri in economia. Tra l’altro, per guadagnare rapidamente somme di denaro da
mettere sul piatto della bilancia dello scontro Enimont, in quei giorni Gardini
si lanciò anche in una spericolata speculazione finanziaria sulla soia
al Chicago Board of Trade, mal consigliato da alcuni nuovi traders francesi ed
americani che lui stesso aveva promosso ai vertici del trading Ferruzzi, in
discontinuità con gli uomini fidati della vecchia scuola di Serafino.
L’operazione andò molto male, minò il prestigio della Ferruzzi negli USA e costò
alle casse del Gruppo e della stessa famiglia Ferruzzi, secondo le cronache e i
resoconti giudiziari dell’epoca, non meno di 300 milioni di dollari o forse di
più (la cifra esatta non si è mai saputa).
Un altro errore di Gardini, forse dettato
dall’esito frustrante della stessa vicenda Enimont, fu quello di voler
costringere a tutti costi gli eredi Ferruzzi a mettere in pratica un passaggio
generazionale anticipato che lui riteneva innovativo ma che, di fatto, avrebbe
praticamente privato i figli di Serafino delle loro legittime quote azionarie di
controllo. I cognati fino a quel momento non gli avevano mai fatto mancare il
loro più totale appoggio, nemmeno nei momenti più difficili. Ma il suo
irrigidimento su quel progetto di successione portò ad una rottura con Arturo,
Franca e Alessandra Ferruzzi e con Carlo Sama, che nel frattempo aveva sposato
quest’ultima. Ciò indebolì notevolmente il Gruppo e lo espose, nel pieno delle
indagini della magistratura, all’attacco di Mediobanca che, di fatto, portò poi
alla espropriazione della Ferruzzi-Montedison da parte di quest’ultima.
Separandosi dai Ferruzzi, Gardini perse anche quella squadra di fedeli manager
che avevano sempre lavorato con lui, da Picco a Ceroni, da Venturi a Trapasso e
tanti altri, che decisero di rimanere nel Gruppo con gli eredi di Serafino, non
riuscendo a comprendere le ragioni di quella separazione.
Invano, negli ultimi giorni prima dell’escalation
di Mani Pulite, Carlo Sama, che era sempre rimasto in rapporti con Gardini,
cercò con pragmatismo di progettare con Goldman Sachs un disegno di
riunificazione dei gruppi Ferruzzi, Gardini e Cragnotti che avrebbe consentito
di affrontare meglio le difficoltà che si stavano profilando all’orizzonte. Ma
ormai era tardi e l’ondata di arresti del pool del tribunale di Milano era in
arrivo.
Vale la pena di ricordare che il Gruppo
Ferruzzi-Montedison era all’epoca più o meno indebitato come altre importanti
realtà industriali italiane, cioè come Fiat o il Gruppo De Benedetti, ma a
differenza di queste era largamente in utile ed estremamente solido dal punto di
vista industriale. A maggior ragione, quello che è accaduto in seguito è
semplicemente assurdo dal punto di vista dell’interesse nazionale. Infatti, il
sistema politico-istituzionale-finanziario italiano ha colpevolmente assecondato
la dissoluzione di un patrimonio industriale unico al mondo, quello del Gruppo
Ferruzzi-Montedison, che costituiva una delle poche realtà su scala globale che
l’Italia abbia mai posseduto.
Benché avesse messo dei manager indubbiamente
capaci a gestire le società ex-Ferruzzi-Montedison, come Enrico Bondi e Stefano
Meloni, Mediobanca non sembrava avere un disegno industriale preciso per le
realtà produttive di cui si era impossessata. Himont, leader mondiale nel
polipropilene, fu venduta a gruppi stranieri. E, ironia della sorte, morto
Enrico Cuccia nel giugno del 2000, la stessa Mediobanca che a suo tempo,
approfittando dei giorni caotici di Mani Pulite, si era impadronita con un blitz
dell’impero creato dai Ferruzzi e da Gardini, nell’estate del 2001 fu “scippata”
della Ferruzzi-Montedison stessa, che nel frattempo era stata denominata
Compart, con una OPA ostile guidata da Électricité de France e con il
“tradimento” della vecchia e tradizionale alleata Fiat e di alcune banche
italiane che appoggiarono quel colpo di mano contro via Filodrammatici.
Alla francese EdF, ovviamente, non interessava
l’agro-industria dell’ex gruppo Ferruzzi, sicché successivamente Eridania
Béghin-Say fu anch’essa venduta così come altre società chimiche residuali
dell’ex Gruppo Montedison, mentre La Fondiaria sarebbe poi finita al Gruppo
Ligresti. Ed è già tanto che EdF, un soggetto straniero, si sia poi dimostrata
negli anni seguenti un azionista industriale valido per Edison, sostenendola
sempre nei suoi investimenti in Italia e accompagnando i suoi manager fino ai
successi recenti.
Ma il bilancio finale di tutte queste vicende per
il nostro Paese è fallimentare. Perché con la fine di Ferruzzi e
Montedison l’Italia ha perso per sempre la possibilità di essere protagonista in
due settori strategici.
Marco Fortis
Il ricordo
dell'imprenditore scomparso 30 anni fa. Gardini,
la vela del Moro di Venezia e la Coppa America con l’amico Paul Cayard per
dimenticare i tradimenti in politica. Marco Fortis su Il Riformista il 22 Luglio
2023
Negli ultimi anni della sua vita, le fatiche e le
frustrazioni che Raul Gardini aveva accumulato in Italia furono temperate da una
intensa attività di relazioni internazionali. Ma, soprattutto, i suoi giorni
furono illuminati dai grandi successi nella vela del Moro di Venezia, con
l’amico Paul Cayard al timone.
Sentendosi “tradito” dalla politica italiana e
alla ricerca di nuovi stimoli, Gardini già prima del definitivo abbandono
di Enimont si era sempre più concentrato sulle attività fuori dal nostro Paese,
dove godeva di un grande prestigio. Fu chiamato da Michail Gorbačëv a progettare
un immenso investimento agricolo ed agro-industriale in URSS nell’area di
Stavropol. Sempre in quel periodo Gardini incontrò il presidente americano
George Bush e numerosi ministri del governo statunitense. E tenne in America
importanti conferenze, una delle quali all’Università di Harvard.
Uno dei riconoscimenti più significativi tributati
a Gardini fuori dai nostri confini, fu senza dubbio l’invito che gli fece la
Sorbona nel 1990 a tenere una conferenza nell’ambito delle iniziative della Cité
della Réussite, onore riservato prima di lui solo ad un altro italiano, Gianni
Agnelli. Allo scopo realizzammo anche il primo film di presentazione del Gruppo
Ferruzzi-Montedison, che fu proiettato prima della conferenza e che è ancora
oggi possibile vedere su Yutube. Fu, quello, un momento molto importante, con la
presenza di tutti i membri delle famiglie Gardini e Ferruzzi, inclusa la anziana
vedova di Serafino, signora Elisa, nonché dei principali manager del Gruppo.
Intanto, nei cantieri della Montedison di Tencara
si stavano costruendo le avveniristiche imbarcazioni del Moro di Venezia, per
partecipare alla sfida di Coppa America. La passione di Gardini per il mare,
parallela a quella per la caccia, era di vecchia data, così come l’amicizia con
il suo marinaio di fiducia ed intimo amico, Angelo Vianello.
Gardini aveva già armato molte barche nella sua
vita, a cominciare da “Naso Blu” e “Orca 43” fino a “Naif”, e partecipato a
tante regate. Aveva anche avuto altri “Mori”, da giovane. Infatti, per fare un
salto di qualità ed entrare nel mondo dei maxi, già a fine anni ’70 Raul e
Arturo Ferruzzi avevano chiesto al giovane progettista German Frers di disegnare
quella che sarebbe diventata una delle più belle barche a vela da regata del
Novecento.
Costruito dai cantieri Carlini in legno, quel
grande sloop con un solo albero si sarebbe chiamato Il Moro di Venezia. Fu un
regalo di Serafino Ferruzzi ai suoi figli. Questi a loro volta regalarono poi Il
Moro a Gardini in seguito. Era una imbarcazione ammirata ed invidiata anche dal
re di Spagna Juan Carlos di Borbone, che frequentava abitualmente Raul a Palma
di Maiorca. Lo stesso Moro sarebbe poi stato protagonista di un’avventurosa
Fastnet durante una furiosa tempesta nel 1979, quando Gardini e il resto
dell’equipaggio riuscirono a portare a casa la pelle solo grazie al coraggio e
alla forza di Vianello, che rimase per ore legato al timone.
Quel Moro fu il precursore dei Mori successivi,
dal Moro di Venezia III che conquistò nel 1989 il mondiale maxi con al timone
Paul Cayard fino a quelli che in seguito infiammarono la sfida delle sfide: la
Coppa America. Una spedizione che Gardini concepì sin dall’inizio non solo come
una impresa sportiva, capitanata dalla Compagnia della Vela di Venezia, sempre
con Cayard al timone, ma anche come una sfida tecnologica che avrebbe reso
Montedison, con i suoi materiali avanzati impiegati nella realizzazione dello
scafo, ancor più famosa nel mondo. Tant’è che Italo Trapasso, che era a capo
della chimica del Gruppo, fu nominato da Gardini Vicepresidente del Sindacato de
“Il Moro di Venezia”.
Il primo Moro di Coppa America fu varato nel marzo
1990 a Venezia. Fu un evento fastoso con tutta la città e centinaia di ospiti
illustri presenti; un avvenimento di rilevanza mondiale, trasmesso in TV, la cui
regia fu affidata a Franco Zeffirelli, con musiche di Ennio Morricone. Madrina
del varo fu la figlia più giovane di Gardini, Maria Speranza.
In quei mesi, avevo aiutato Gardini a curare i
dettagli e i decori dei Magazzini del Sale, a Venezia, allestiti appositamente
per la sfida alla Coppa America. E insieme lavorammo anche al Libro ufficiale
della sfida del Moro di Venezia, che conteneva i bozzetti del leone simbolo del
Moro e aveva una copertina lucida rosso carminio con il leone in rilievo.
Una sera a Palazzo Dario, dove abitava quando
stava a Venezia, feci ascoltare a Gardini la canzone “Listen to the Lion” del
grande cantante irlandese Van Morrison. Musica e testo gli piacquero molto e
Gardini decise di inserirne le parole, che parlavano dei viaggi per mare dei
vichinghi verso l’America, subito all’inizio della pubblicazione. La stessa
canzone divenne uno dei motivi musicali ufficiali del Moro, le cui imprese
venivano trasmesse tutti i giorni da Tele Montecarlo, con commentatori tecnici
d’eccezione come Cino Ricci, già protagonista della precedente sfida italiana in
Coppa America di “Azzurra”.
Nel 1992 il Moro di Venezia vinse la Louis Vuitton
Cup battendo la Nuova Zelanda e si guadagnò così il diritto a disputare la
finale di Coppa America a San Diego contro gli americani. Timonato da Paul
Cayard, Il Moro eliminò in semifinale Francia e Giappone e in finale sconfisse i
neozelandesi, divenendo così la prima imbarcazione di un paese non anglofono a
poter ambire alla coppa in 141 anni di storia del trofeo.
Nella sfida finale contro il defender, disputatasi
sempre a San Diego, il Moro però fu sconfitto per 4-1 dall’imbarcazione
americana del miliardario petroliere americano Bill Kock, “America Cube”,
capitanata da Harry Buddy Melges. Fu una grande delusione ma era stata comunque
una straordinaria avventura, che aveva fatto innamorare tutti gli italiani
inchiodati davanti alla tv di uno sport come la vela e reso Gardini estremamente
popolare.
La fase finale di quell’avventura era cominciata
esattamente un anno prima, nell’estate del 1991, con il campionato mondiale
degli scafi di Coppa America, disputatosi anch’esso a San Diego. Gardini volle
che lo accompagnassi. Stavo in hotel a dormire ma vivevo praticamente tutto il
resto della giornata con Raul a bordo del suo yacht. Per ingannare il tempo e
anche per stemperare un po’ il nervosismo in attesa delle gare, scrivevamo
appunti sui materiali avanzati e sulle tecnologie di Montedison impiegate sul
Moro in vista della pubblicazione di un vero e proprio documento aziendale
sull’argomento. Il marinaio Angelo talvolta preparava qualcosa da bere o da
mangiare e si univa a noi, prendendoci in giro e dicendoci di smettere di
lavorare.
Durante le regate salivano a bordo dello yacht
d’appoggio diversi parenti ed ospiti e poi seguivamo tutti insieme con
trepidazione le competizioni in mare aperto, con la nostra imbarcazione a motore
ferma ma paurosamente ondeggiante nella marea lunga del Pacifico, mangiando di
continuo banane per combattere il mal di mare e non sentire l’odore acre del
carburante. Gardini di tanto in tanto prendeva un piccolo motoscafo e
raggiungeva il Moro per trasferire a Cayard e compagni tutta la sua
determinazione e il suo incoraggiamento.
Alla fine, il Moro vinse quel mondiale,
dimostrandosi superiore come imbarcazione ed equipaggio a tutti gli altri
contendenti. L’avvicinamento alla sfida di Coppa America era cominciato nel
migliore dei modi. Ricordo molto bene Gardini e Cayard, durante la premiazione,
raggianti, circondati da tutti i membri della squadra del Moro. E fu un’emozione
da brivido quella sera, rientrando tardi in hotel, ascoltare sul lungomare di
San Diego gli altoparlanti in festa che diffondevano ancora a tutto volume
“Listen to the Lion”, con la voce di Van Morrison che ruggiva proprio come il
nostro leone di Venezia. Marco Fortis
“Decido io”, Raul Gardini trent’anni
dopo. Filippo Tabacchi su L'Identità il 22 Luglio
2023
“Decido io”, diceva e così fece anche quella
mattina di trent’anni fa, alle 8:15 del mattino, quando una calda Milano aveva
appena bevuto il caffè e stava ancora sonnecchiando. Si sparò alla tempia con la
Walther PPK, la pistola di James Bond e in fondo lui un po’ Bond lo era stato,
avventuriero e con una vita avventurosa, sempre impeccabile nel vestire, iconico
sapendo di esserlo. Ma Bond non muore mai, Raul invece era morto per davvero. Il
provinciale di Ravenna, Il Contadino, arrivato a Piazza Affari dopo scalate
ostili, sempre all’ attacco, sempre davanti alle sue truppe, sempre in prima
fila, sempre contro tutto e tutti anche quando non era così ma a lui serviva
essere così, un carro armato, fermato da un colpo di 7.65 alla tempia, A Palazzo
Belgioioso esattamente trenta, lunghissimi anni fa. Era già ricco, di una
famiglia di campagna che aveva il proprio capitale nella terra emiliana,
laboriosa e poco godereccia, senza i lussi che la borghesia contadina fatica
appunto a concedersi . Ma lui voleva di più, non voleva tutto, non gli bastava
tutto, ma sempre di più e non si trattava solo di quattrini. Entrò giovane nel
Gruppo Ferruzzi, una creatura strana creata da suo suocero Serafino, un genio
con lo sguardo furbissimo e i baffetti bianchi che era partito vendendo per i
paesini oli e sementi con la bicicletta ed era diventato il leader più grosso
gruppo agroalimentare italiano e uno dei players mondiali, arrivando a possedere
terre ed impianti anche negli USA. Ma Raul volava di più, voleva essere il,
numero uno tra i numeri uno, primus e basta senza inter pares. Morto Serafino
nel 79 in un disastro aereo, le figlie e il figlio di Ferruzzi gli diedero le
deleghe operative del gruppo e lui scateno una tempesta, che sconvolse il
cosicdetto salotto buono della finanza italiana , che non lo digerì mai e di cui
lui non si sentiva parte parte ma sapeva che si sarebbe dovuto sedere con quelli
che lui considerava degli elefanti invecchiati in una savana chiusa da sempre.
Cercò l’ alleanza con chi dava le carte , quel croupier e padrone del casinò
che era il dominus di Via dei Filodrammatici ovvero Cuccia, vero padrone del
capitalismo italiano, come l’ Innominato di manzoniana memoria il quale non
rispondeva a nessuno tranne che a se stesso. L’ accordo ci fu, poi si ruppe
rovinosamente ,poi lo ottenne ancora e alla fine il giocattolo si ruppe. Acquisì
Standa, La Fondiaria, Il Messaggero, migliaia di immobili, investimenti
miliardari nello sport, scalò la Montedison contro il parere di tutti e allora
il Vecchio si arrabbiò davvero senza battere ciglio. Immaginò di creare il più
grande colosso agro alimentare industriale del mondo, partecipando alla
creazione dell’ Enimont, una joint venture con l’ Eni come socia al 40% ed il
restante 20% flottante in Borsa, ma pensava già da mesi come accaparrarsi la
maggioranza assoluta. Decido io, la chimica sono io, disse a Padova. Ma il
colosso pubblico – privato aveva le fondamenta di argilla e i partiti non si
sarebbero fatti sfilare la chimica da sotto il culo e comincio un’ altra guerra
che lo portò alla rovina, era una battaglia persa in partenza e Raul pensava che
pagando , a carissimo prezzo, l’ avrebbe portata a casa anche stavolta. Il
gruppo era carico di debiti e quando in piena Tangentopoli, il procuratore
Borrelli disse un giorno ” abbiamo acceso un faro su Mediobanca”, il salotto
buono capì subito e qualcuno cominciò davvero a preoccuparsi. Il faro non
illuminò mai quella direzione e spostò la sua luce accecante sull’ anello debole
del capitalismo italiano, il Gruppo Ferruzzi, la sua obesità di quattrini spesi
e quella voragine di debiti con le banche. La famiglia gli tolse le deleghe, lui
ricevette una cifra mostruosa pari 505 miliardi cash per togliersi dalla palle:
era diventato ricco oltre ogni immaginazione ma aveva perso. La sconfitta fu
bruciante e non si riprese mai. Tentò di distruggere la sua creatura ma non ci
riuscì e una pallottola trent’ anni fa mise fine a quel sogno proibito, alla
vita di quell’ imperatore ravennate che era ad un passo dal diventare un Dio ma
che cadde come Icaro, accecato non dal sole ma dalla sua stessa figura. Ci
piace ricordarlo al timone del Moro di Venezia, il suo ultimo grande sogno, col
suo berretto e i suoi abiti bianchi, quel miliardo di Winston fumate e spente e
accese, una dietro l’ altra, quel sorriso da eterno ragazzo che ammaliò l’
Italia intera. La sua storia dovrebbe essere raccontata più approfonditamente,
come forse, molto forse farà la docu fiction su Rai1 in onda stasera, ma il suo
ricordo sarà impossibile da dimenticare, mai oblio ci sarà . Non abbiamo più
visionari nel nostro paese ma solo personaggi che pensano a domattina e non ai
prossimi dieci o venti anni. Amo il vento, diceva. Aveva ragione.
Personalmente sono dell’idea che la vita debba
essere vissuta fino in fondo e non per finta, anche se talvolta c’è da farsi
venire il mal di stomaco.»
Raul Gardini moriva trent’anni fa:
nascita e crollo di un impero che ha cambiato Ravenna.
L’impatto sull’economia, i palazzi del centro, il Pala De André, lo scudetto del
Messaggero volley. La mattina del giorno di Sant’Apollinare del 1993 la notizia
del suicidio dell’imprenditore. La nautica, una delle grandi passioni
dell’imprenditore Raul. CARLO RAGGI il 23 luglio 2023 su ilrestodelcarlino.it.
"Non ti dimenticheremo", una promessa, un impegno,
di più, un imperativo, vergato centinaio di volte nei quadernetti sui tavolini
dentro San Francesco, molti con calligrafia incerta, semplice, a testimoniare
come Raul fosse sentito come uno di loro anche dalle classi sociali che nulla
avevano a che spartire con il potere economico.
Lo disse bene Cristina Muti: "Abbiamo perso uno di
noi, un fratello di tutti". Perché in realtà Raul Gardini, per i ravennati doc,
era rimasto ‘il contadino’ di sempre, che giocava a carte, andava a caccia,
aveva la passione per le barche e la velocità.
Anche quando le sue imprese a livello
internazionale riempivano ogni sera i telegiornali, ogni mattina i quotidiani.
Quando quella mattina del giorno di Sant’ Apollinare di 30 anni fa si diffuse la
notizia che si era tolto la vita, a Milano, moltissimi ravennati accorsero a
Marina, davanti al Gran Hotel, luogo di abituale dimora estiva per Idina, la
moglie. Solo poche ore prima si erano salutati a Milano e l’appuntamento era per
l’indomani e invece poco dopo le 8 arrivò la tragica notizia. Una moltitudine
silenziosa, addolorata, incredula, peraltro già scossa da mesi, da quando
quotidianamente l’impero Ferruzzi stava precipitando dalle stelle della finanza
e dell’economia mondiale alla polvere dei ribassi borsistici e dell’inchiesta
giudiziaria.
Una testimonianza sincera di solidarietà, una
moltitudine che si ampliò a dismisura alla domenica, alla camera ardente in San
Francesco e nel pomeriggio di lunedì 26 luglio quando si svolsero i funerali.
Una testimonianza che voleva essere anche un riconoscimento per i traguardi
raggiunti da Gardini negli undici anni in cui era rimasto alla guida del Gruppo
Ferruzzi (fino al novembre 1990) e che enormi ricadute positive avevano avuto
sull’economia ravennate e, quindi, sull’occupazione per moltissime persone: a
Ravenna i dipendenti del Gruppo raggiunsero quota milleduecento. Che
inevitabilmente adesso temevano per il futuro. Ripercorriamo, allora, in questo
trentennale da quel tragico sparo (indotto in Raul dall’inaccettabile
consapevolezza di essere in un vicolo cieco per il fatto che gli era impedito di
accedere ai documenti societari per la propria difesa), gli anni della
costruzione dell’impero, i cui confini andavano dall’Europa agli Usa
all’Argentina.
Un impero le cui fondamenta venivano da lontano,
dagli anni del dopoguerra: Serafino Ferruzzi, senza conoscere una parola di
inglese, divenne uno dei più importanti imprenditori del commercio mondiale dei
cereali, con base a New Orleans, città che gli conferì anche la cittadinanza
onoraria. E quando negli anni Sessanta accolse il giovane Raul, fidanzato con la
giovanissima figlia Idina, nelle file di quell’impero, ben pochi a Ravenna ne
conoscevano l’estensione, la portata finanziaria. Furono scoperte dopo la
tragica morte di Serafino, la notte del 10 dicembre 1979 quando l’aereo su cui
stava rientrando da Londra si schiantò contro un mulino alle porte di Forlì,
cinque le vittime.
Fu allora che la famiglia Ferruzzi consegnò lo
scettro del comando a Raul. Il quale rivoluzionò la gestione puntando, con non
poco azzardo, sulle mirabolanti azioni finanziarie e acquisizioni societarie per
poter raggiungere comunque gli obiettivi che aveva in testa, obiettivi
diversificati, dalla produzione e trading dei cereali al calcestruzzo, dallo
zucchero all’olio di semi, e poi la chimica con la grande scommessa
sul bioetanolo, ricavato dalla soja, "il carburante verde del futuro".
Per quanto Serafino amasse restare nell’ombra,
così non fu per le iniziative, spesso clamorose, del Gruppo Ferruzzi guidato da
Gardini. Iniziative anche benefiche e locali, come nel 1982 il lancio di una
sottoscrizione a livello cittadino per l’acquisito della prima Tac per
l’ospedale di Ravenna: entrò in funzione nel novembre ‘83. Mese dopo mese i
ravennati si accorgevano che il volto della città stava cambiando, a cominciare
dal cantiere a palazzo Prandi, in via D’Azeglio, che Gardini acquistò e fece
ristrutturare per farne residenza e luogo di rappresentanza, un palazzo sempre
più frequentato da nomi illustri della borghesia imprenditoriale italiana
dell’epoca, da Agnelli a De Benedetti, da Romiti a Cefis: eravamo alla fine
degli anni 80, quando Gardini iniziò la scalata alla Montedison.
Via D’Azeglio venne presto occupata dalle grosse
auto di rappresentanza, Mercedes grigie o nere con i vetri fumé e l’antenna del
radiotelefono (a Ravenna a disposizione dei manager se ne contava una trentina)
condotte da autisti guardiaspalle armati addestrati alle tecniche antisequestro
(che sfrecciavano nelle corsie riservate a bus e mezzi di soccorso). E non
mancava la Ferrari F 40 di Carlo Sama, il cognato di Raul che nel frattempo era
andato ad abitare nell’edificio ristrutturato in angolo a via Pasolini davanti a
palazzo Prandi. Un altro cantiere già era spuntato in via Guerrini per la
costruzione del ‘palazzo di vetro’ dove trovò sede la Calcestruzzi guidata da
Lorenzo Panzavolta e a inizio 1990 in via Diaz fu la volta della
ristrutturazione del palazzo che aveva ospitato prima l’Upim poi la Rinascente e
che divenne la sede della Ferfin (Ferruzzi Finanziaria, la holding) un Gruppo
che valeva 25mila miliardi di lire.
In quel tempo Gardini trasferì la residenza a
villa Monaldina, un casolare di campagna appena ristrutturato, sulla strada per
Punta Marina e lì atterrava con l’elicottero. Nel 1987 Raul Gardini acquisì la
maggioranza delle azioni di Montedison e con essa si ritrovò in tasca l’allora
primo quotidiano di Roma, il Messaggero che, passati due anni, nel dicembre ‘89
sbarcò a Ravenna con una frotta di giornalisti e una redazione in via Salara
vicina a quella del Carlino. Seguì l’apertura di altre tre redazioni in Romagna.
Tutte le edicole furono monopolizzate dal nome ‘Messaggero’ e lo stesso nome
comparve sulle magliette dei pallavolisti ravennati.
Gli appassionati di volley non potranno mai
dimenticare lo scudetto del Messaggero Volley Ravenna conquistato il 30 maggio
1991 al ‘Pala Mauro de Andrè’ il Palazzo dello sport e delle arti voluto da Raul
(e da Sama) e che porta il nome del figlio del manager della Ferruzzi (a capo di
Eridania), Giuseppe, costruito fra il 1988 e il 1990. L’espansione del Gruppo
Ferruzzi indusse le banche collegate alle attività finanziarie delle centinaia
di società controllate ad aprire sedi a Ravenna. Questo significò altra
occupazione con ulteriori ricadute per gli esercizi commerciali di qualità e per
bar e ristoranti. L’apice fu raggiunto nel 1990 con la nascita di Enimont,
matrimonio fra Montesidon ed Eni, la più grande impresa pubblico - privata sul
fronte della chimica a livello italiano.
"La chimica sono io" disse Raul, ma poi dovette
cedere ai ricatti dei politici e alle imposizioni della famiglia.
Vendette le azioni Enimont possedute dal Gruppo
con un ritorno di 2.805 miliardi di lire, poi a novembre ‘90 le dimissioni dal
Gruppo e il 30 giugno ‘91 il divorzio dalla famiglia.
Gli rimase l’impresa nella Vuitton Cup - Coppa
America a maggio ‘92 a San Diego e la grande festa in piazza del Popolo. A
gennaio ‘93 ecco il coinvolgimento del Gruppo in Tangentopoli con l’arresto di
Panzavolta. A luglio, il colpo di pistola.
Nel giro di pochi mesi il Gruppo Ferruzzi fu
commissariato e smembrato, tutte le società lasciarono Ravenna, così anche le
banche, Il Messaggero chiuse la redazione. Il velo calò, definitivamente,
sull’impero evaporato.
Dagospia sabato 22 luglio 2023."LA GARANZIA DI
GARDINI PER LA SCALATA A MONTEDISON FU L’IMPERO DI SERAFINO FERRUZZI" – IL
RACCONTO DI SERGIO CUSANI, CONSULENTE FINANZIARIO DI RAUL, CHE FINI’ IN CARCERE
LO STESSO GIORNO (23 LUGLIO 1993) IN CUI IL CAPITANO D’IMPRESA DI RAVENNA SI
SUICIDO’ – "QUANDO GARDINI DIVENTO’ L’AZIONISTA PIÙ IMPORTANTE DI MONTEDISON,
CHIESERO ALLA BANCA DUEMILA MILIARDI DI LIRE. OVVIAMENTE LASCIANDO IN GARANZIA
LE AZIONI MONTEDISON. PER QUALSIASI ALTRA PERSONA AVREBBERO CHIAMATO LA
NEURODELIRI, IN QUEL CASO LE BANCHE SAPEVANO BENISSIMO CHE C’ERANO PIÙ DI 1.200
MILIARDI DI LIQUIDITÀ LASCIATI DA SERAFINO FERRUZZI ALL’ESTERO..."
Trent’anni fa Raul Gardini si toglieva la vita con
un colpo di pistola nella sua casa di Milano. Era il 23 luglio del 1993, un
venerdì. Il capitano d’industria sentiva che gli inquirenti stavano arrivando a
lui e si suicidò il giorno dei funerali di Gabriele Cagliari, il presidente
dell’Eni a sua volta in carcere su richiesta dei magistrati di Mani Pulite.
Anche Cagliari, disperato, aveva deciso di farla finita soffocandosi in cella.
Quel giorno finiva a San Vittore anche Sergio
Cusani, il consulente finanziario che collaborava da anni con la famiglia
Ferruzzi. Gardini aveva potuto portare a termine la scalata della Montedison
grazie alle garanzie economiche che l’impero creato dal nulla da Serafino
Ferruzzi gli aveva messo a disposizione. Il ruolo di questo grande imprenditore
è stato fondamentale.
Perché partendo da Ravenna aveva costruito una
realtà dalle fondamenta solidissime, un gigante di grande affidabilità
economica. Ferruzzi fu tra i primi a costruire un sistema logistico e di
trasporto privato per gestire in autonomia tutta la filiera delle sue attività
industriali.
Estratto dell'articolo di Piero Fachin per “QN –
Quotidiano Nazionale” sabato 22 luglio 2023.
"Accidenti: abbiamo il 14%", disse Raul Gardini.
Era lunedì, il 6 ottobre del 1986, Gardini era insieme a Carlo Sama e parlava al
telefono con Umberto Maiocchi, il responsabile Borsa della Banca di Suez Milano
a cui aveva affidato il compito di comprare, senza definire né il prezzo né la
quantità, le azioni del colosso chimico. Di fatto dava avvio alla scalata non
programmata, non studiata, non preparata.
La telefonata, quella telefonata che tanto cambiò
di molte storie personali e di un pezzo della storia d’Italia, partiva
dall’ufficio di Milano di un giovane manager. Partiva dall’ufficio di Sergio
Cusani, proprio quel Sergio Cusani: il dirigente destinato a diventare l’uomo
simbolo di Mani Pulite, il principale imputato del processo per la maxi-tangente
Enimont, quello che tenne testa ad Antonio Di Pietro e a tutto il pool, il
consulente condannato a 5 anni e 10 mesi scontati a San Vittore fino
all’affidamento in prova, alla piena libertà, alla completa riabilitazione.
L’uomo a cui tutti riconoscono tenacia e coerenza. "Ho le mie colpe, e le colpe
restano", disse una volta davanti a una platea di magistrati.
“Sta iniziando male - sostiene Cusani, con voce
pacata ma decisa - perché io non voglio partire da questo. Io sono qui solo per
ricordare Serafino Ferruzzi, uno dei più grandi imprenditori italiani". Perché
senza di lui, senza Ferruzzi, nessuna cosa sarebbe andata come è andata: Gardini
non avrebbe mai scalato Montedison e nemmeno Enimont sarebbe mai nata. Parla
piano, Cusani. E misura le parole, una a una. Riannoda i pensieri, mette in fila
i ricordi fino a commuoversi.
Serafino Ferruzzi, allora. Partiamo da lui,
dall’imprenditore di Ravenna. Come vi siete conosciuti?
"Facevo apprendistato da Aldo Ravelli, uno dei più
importanti commissionari della Borsa di Milano. Serafino veniva nello stabile
dove lavoravo per incontrare un broker navale che aveva l’ufficio vicino a noi e
che ci presentò Ferruzzi, che nessuno di noi conosceva".
Prima impressione?
"Bella. Una persona gentile. Garbata. Un bel
sorriso. Quei due occhietti con uno sguardo al laser. Soprattutto, una persona
curiosa di quello che avveniva nel mondo della finanza. Iniziai ad andare a
trovarlo il mercoledì nel suo bugigattolo alla Borsa Merci di Milano, e a dargli
la mia opinione sui mercati finanziari".
(...)
Il primo incarico?
"Mi chiama dal Brasile e mi dice: ‘Ho sorvolato
(aveva un Bombardier Learjet transoceanico) in Veneto la Torviscosa, una tenuta
di 4.500 ettari. I sentieri interpoderali dell’azienda sono asfaltati! Mai vista
una cosa così in vita mia in tutto il mondo. Costa 42,5 miliardi di lire, se la
rivendessi frazionata ne prenderei minimo 90. Ma non la venderei mai’".
Voleva comprarla?
"Ci sto arrivando: ‘Per domani mattina - mi disse
- ti ho fissato un incontro con Enrico Cuccia a Mediobanca. Occupati tu della
Torviscosa’. Io per tutta la notte studiai le carte che Ferruzzi mi aveva fatto
avere, elaborai una scheda molto sintetica, una paginetta, con cui la mattina
alle 11 mi presentai in banca.
Cuccia mi disse: cosa ha preparato per me? Io gli
diedi la scheda. Lui commentò: bene, sintetica e chiara. Dica al dottor Ferruzzi
che domani avrà a disposizione 42,5 miliardi. Ma lei domani mi farà avere tutta
la documentazione alla base di questa scheda. Se ci sarà qualcosa che non
corrisponde non dovrà più farsi vedere in questa banca, sarà il portiere a non
farla entrare".
(...)
Chi era allora Ferruzzi per l’Italia?
"Uno sconosciuto. Anche se era ritenuto il maggior
commerciante privato del mondo di prodotti cerealicoli. Alla borsa merci di
Chicago quando entrava suonavano la campanella in segno di omaggio".
Commerciante o industriale?
"Allora commerciava. Ma la sua logica era
industriale".
Cosa vuol dire, nel concreto?
"Oggi si esternalizza tutto. A quei tempi,
Serafino invece aveva un progetto diverso, allora all’avanguardia. Puntava su
logistica, trasporti, silos di stoccaggio. Negli Usa alla foce del Mississippi
aveva una enorme struttura di silos, 170 chiatte da mille tonnellate per il
trasporto fluviale. Aveva una sua flotta di 16 navi per 752mila tonnellate di
carico secco. Il più grande armatore privato d’Europa. Serafino voleva il totale
controllo della filiera produttiva. Una visione quasi profetica: oggi, in un
mondo di guerre e di tensioni, sta ritornando di grande attualità".
(...)
L’ultima volta che lo ha visto?
"Due giorni prima della morte, l’8 dicembre del
1979 a Roma. E per la prima volta con lui c’era il genero, Raul Gardini. Avevo
invitato in Italia il più grande produttore di caffè del mondo, un brasiliano di
origine turca: Atallà".
Quanto valeva l’impero di Ferruzzi alla sua morte?
"Le stime dicono tre, quattromila miliardi di lire
in proprietà. E in più 1.200 miliardi in liquidità, soprattutto all’estero dato
che le sue grandi operazioni di trader internazionale erano estero su estero".
Quando entrò in scena Gardini?
"A metà degli anni Ottanta la finanza italiana, e
in particolare Mediobanca, premeva affinché il gruppo Ferruzzi – che aveva
Gardini come leader assoluto nella gestione – entrasse nel cosiddetto ‘salotto
buono’, con una partecipazione del 2 e 3% in Montedison. C’era pressione su
Gardini, anche dai giornali. Ricorda i titoli?".
Li ricordi lei.
"Il Corsaro entra in Montedison. L’ora di Raul. Il
pirata in azione. Insomma, lo tiravano da tutte le parti perché entrasse.
Gardini venne a parlarne con me".
E lei che gli disse?
"Raul, se devi entrare, tu rappresenti il gruppo
Ferruzzi. Il mio consiglio è di distinguerti per ciò che rappresenti. Prendi il
4, 5 per cento. Primus inter pares".
Come reagì?
"Mi fece una domanda: tu mi sai spiegare cosa c’è
in Montedison? Fammi per favore una scheda, una fotografia della situazione. Io
mi misi a lavorare due o tre giorni, gli feci una bella sintesi. Nella nota
finale gli dissi: escluso il patrimonio immobiliare, comunque notevole, ha un
valore molto superiore a quello di Borsa".
E arriviamo a quel lunedì del 1986, il 6 ottobre.
"Gardini venne da me verso le 11. Aveva appena
dato incarico, un ordine aperto non circoscritto, di comprare azioni Montedison
alla banca di Suez. Gli chiesi: che ordine hai dato, a che prezzo? Lui disse: ho
detto di comprare tutto quello che viene. Poi alzò il telefono, e si mise a
dire, con un mezzo sorriso che era anche un mezzo ghigno: "Accidenti". Gli
chiesi: "Accidenti cosa?" E lui: "Abbiamo il 14%". Era diventato l’azionista più
importante. E non penso assolutamente che i soci Ferruzzi ne fossero informati".
Fine della storia?
"Macché. Andava pagata l’operazione di acquisto.
Subito mi attivai con Carlo Sama per fissare un incontro martedì mattina presto
con Nerio Nesi, presidente della Banca nazionale del lavoro, con Raul Gardini e
Carlo Sama. Chiesero alla banca duemila miliardi di lire. Ovviamente lasciando
in garanzia le azioni Montedison".
Ma se la stessa garanzia l’avessimo proposta lei o
io?
(Cusani sorride)
"Ci avrebbero cacciato o avrebbero chiamato la
neurodeliri perché ci ritenevano pazzi. Ma in quel caso l’impegno era preso da
Raul per il gruppo Ferruzzi. Cioè, il patrimonio di Serafino Ferruzzi è stato la
migliore garanzia per l’affare Montedison. Le banche sapevano benissimo quale
fosse il patrimonio del Gruppo e che c’erano più di 1.200 miliardi di liquidità
lasciati da Serafino Ferruzzi all’estero".
Estratto da Gente giovedì 27 luglio 2023.
Carlo Sama è stato per quasi due decenni al fianco
di Raul Gardini, soprattutto in quegli anni 80 che hanno segnato la grande
cavalcata del top manager della Ferruzzi, dalla conquista della Montedison alla
scommessa di Enimont, dalla creazione di un grande gruppo industriale di portata
internazionale alle sfide veliche in Coppa America con il Moro di Venezia.
Gardini e Sama avevano sposato rispettivamente Idina e Alessandra, due delle
figlie di Serafino Ferruzzi, il fondatore del gruppo (gli altri due figli erano
Arturo e Franca).
Le loro strade si erano separate nei primi anni
90, quando ci fu la rottura tra Raul e Idina da una parte e il resto della
famiglia dall’altro. Di lì a poco, nel 1993, Gardini, travolto dall’inchiesta
Mani pulite, si suicidò. Ora una docufiction, andata in onda domenica scorsa su
Rai1, ripercorre parte di questa storia. Ma con una serie di errori e omissioni
che Sama stesso, come testimone privilegiato, ha voluto ricostruire per Gente
nell’articolo che segue. (u.b.)
Estratti dell’articolo di Carlo Sama per Gente
giovedì 27 luglio 2023.
Il docufilm su Raul Gardini è assai criticabile
perché, anziché ricostruire la sua vera storia, fornisce di lui un’immagine
quasi caricaturale. Il contrasto tra i dialoghi egocentrici, vanesi e logorroici
del Raul Gardini fittizio inventato dalla sceneggiatura e le interviste
contenute nello stesso docufilm al Gardini reale, uomo schivo e di poche parole,
semplici ed efficaci, è abissale. Ne avranno avuta chiara evidenza sin da subito
i telespettatori.
La sceneggiatura, inoltre, anziché esplorare le
ragioni che hanno prima portato allo straordinario successo mondiale e poi alla
crisi del Gruppo Ferruzzi-Montedison e al suicidio di Gardini, si appiattisce
sotto forma di una squallida telenovela sui presunti contrasti tra Gardini e gli
altri membri della famiglia Ferruzzi: una sceneggiatura che appare evidentemente
ispirata esclusivamente dalle testimonianze e dal risentimento, una sorta di
vera e propria regia, di ex manager minori espulsi dal Gruppo Ferruzzi nonché
degli stessi eredi Gardini.
Nonostante il docufilm contenga alcune
testimonianze di notevole valore personale e storico (Muti, Zeffirelli, Cayard,
Fortis), esso si riduce perciò nella sua parte sceneggiata e recitata al rango
di un mero strumento di gossip di quart’ordine e di vendetta mediatica contro
Alessandra (e il sottoscritto, in quanto suo marito), Arturo e Franca Ferruzzi,
rei, secondo il docufilm, di “aver tradito” Gardini. Cosa mai avvenuta nella
realtà. (…)
Immediatamente all’inizio del docufilm appare un
quadro con scritto “Chi ha tradito Raul?” che introduce uno dei temi chiave poi
ripetutamente ripreso nel corso del filmato: Gardini sarebbe stato tradito dalla
famiglia Ferruzzi, la quale, secondo la sceneggiatura, gli avrebbe fatto mancare
il proprio appoggio nei momenti decisivi della sua vita di leader del Gruppo. Si
tratta di un falso storico grave, perché la famiglia Ferruzzi non ha mai fatto
venir meno il suo totale sostegno a Raul (…) Riguardo a Enimont, va subito detto
che la decisione della vendita della quota di Enimont in possesso di Montedison
fu presa dallo stesso Gardini in totale autonomia e comunicata solo in seguito
agli altri membri della famiglia Ferruzzi.
In un solo caso Arturo Ferruzzi e le sorelle
Alessandra e Franca hanno contestato Gardini: in occasione della sua
inaccettabile proposta di redistribuzione immediata e totalmente arbitraria
delle quote azionarie di controllo del Gruppo Ferruzzi-Montedison tra i figli di
Arturo, Alessandra, Franca e Idina, cioè direttamente a favore delle terze
generazioni, con grave pregiudizio patrimoniale per le seconde generazioni
ancora viventi. È su questo unico aspetto controverso, sul quale Raul Gardini si
impuntò in modo ostinato, che maturò la separazione tra la famiglia Gardini e
gli altri figli di Serafino Ferruzzi.
(…)
Dal docufilm emerge una contrapposizione netta tra
la figura di Gardini, presentato come un genio assoluto degli affari,
dell’industria e della finanza, e gli altri membri della famiglia Ferruzzi,
fatti passare in modo irriverente per persone senza alcuna competenza
professionale e conoscenza del mondo del business, nonché come figure pavide o
perennemente dubbiose sulle scelte di Raul. Ciò è estremamente lesivo
dell’immagine dei membri della famiglia, in particolare di Alessandra e Arturo
Ferruzzi, più volte protagonisti negativi, impacciati o ridicoli, di scene del
docufilm. In questi casi, la sceneggiatura rappresenta una distorsione dei fatti
storici, strumentale e priva di fondamento. (…)
In realtà, nella storia economica mondiale vi sono
ben pochi casi in cui una famiglia (come quella dei Ferruzzi) ha messo a
disposizione di un manager (come Gardini) un patrimonio così ingente dandogli
pieni poteri su un lunghissimo arco temporale e sostenendolo sempre con coraggio
anche in fasi complesse e finanziariamente sfidanti come la scalata di
Montedison o le vicende di Enimont.
(…) È indubbio che Gardini sia stato un
personaggio straordinario (…). È altrettanto indubbio, però, che Gardini aveva
anche dei limiti, come tutti gli esseri umani, e che la sua opera come manager è
anche costellata di alcuni errori decisivi che molto hanno pesato sul destino
del Gruppo Ferruzzi e di cui il docufilm non parla affatto. Innanzitutto, dopo
la scalata di Montedison, Gardini non si preoccupò minimamente di ridurre
l’indebitamento della Ferruzzi. (…) Gardini non si rivelò, in Montedison, un
amministratore e un ristrutturatore efficace come lo era stato in Ferruzzi, dove
i suoi manager storici erano di ben altro livello e lo avevano sempre supportato
con successo. Tuttavia, ciò premesso, curiosamente e in modo assolutamente
ridicolo, in alcune scene conclusive del docufilm è invece Gardini a rinfacciare
agli ex famigliari di Ferruzzi di non aver venduto degli asset non strategici in
epoca successiva in modo da ridurre l’indebitamento!
(…)
In un’altra sequenza, di fronte all’opportunità di
comprare o vendere la quota detenuta da Montedison in Enimont la sceneggiatura
si immagina una riunione tra Gardini e i membri della famiglia Ferruzzi in cui
questi ultimi vogliono vendere la quota e mettono in minoranza Raul che invece
vorrebbe comprarla. Gardini si mostra adirato con i famigliari a cui rinfaccia
che “era un rischio che si doveva correre”. Si tratta di una riunione in realtà
mai avvenuta perché la decisione di uscire da Enimont fu presa direttamente da
Gardini in totale autonomia e comunicata solo successivamente ai membri della
famiglia. Non solo. A essi Gardini comunicò anche che intendeva dare le
dimissioni da presidente del Gruppo e da tutte le cariche da egli ricoperte in
Italia, in segno polemico verso il sistema politico italiano che lo aveva messo
con le spalle al muro sulla vicenda Enimont. E i famigliari furono altresì
informati che la presidenza del Gruppo sarebbe stata presa da suo figlio Ivan.
(…)
Maturò in seguito anche la decisione di Gardini di
redistribuire le quote di controllo del Gruppo Ferruzzi detenute dai quattro
figli di Serafino ancora viventi direttamente ai loro figli, mantenendo Ivan
Gardini nel ruolo di presidente della Ferruzzi. Si trattò di un piano forzato,
una proposta di esproprio a dir poco rocambolesca, che non poteva evidentemente
trovare d’accordo Arturo, Alessandra e Franca. L’ostinazione di Gardini nel
portare avanti a tutti i costi questo assurdo piano, senza lasciare ai parenti
alcuna alternativa, generò la rottura con gli altri membri della famiglia. (…)
Un’altra grave distorsione della storia è
rappresentata da come si raccontano le vicende del Moro di Venezia. (…) Nel
docufilm gli sceneggiatori cercano di dimostrare che se il Moro non è riuscito a
vincere la finale di Coppa America è per colpa dei membri della famiglia
Ferruzzi che non avrebbero concesso a Gardini ulteriori finanziamenti per
costruire una imbarcazione tecnologicamente più avanzata e all’altezza della
sfida finale. Vi è addirittura una sequenza del tutto inventata in cui Gardini
incontra Arturo Ferruzzi per chiedergli altre somme di denaro da investire nel
Moro ma Arturo gliele nega a male parole. La Montedison ha invece profuso ogni
energia per sostenere l’avventura di Gardini nell’America’s Cup: 160 miliardi di
lire solo di sponsorizzazione, oltre a decine di milioni di dollari direttamente
dal patrimonio degli eredi Ferruzzi. (…)
Invece gli sceneggiatori del docufilm sono
riusciti a creare un falso storico, totalmente assurdo, secondo il quale Gardini
fu lasciato finanziariamente solo ad affrontare la finalissima.
(…) Appare quindi evidente una volta di più che la
sceneggiatura del docufilm è principalmente imperniata su una denigrazione
reiterata della famiglia Ferruzzi, che avrebbe costantemente “tradito” la
fiducia di Gardini. (…)
Infine, anche nelle vicende finali di Enimont e
dell’inchiesta giudiziaria a esse collegata, il docufilm non perde l’occasione
per far passare Gardini come una “vittima” che non ha potuto difendersi dalle
accuse dei magistrati perché “già fuori dal gruppo”. Come se non avesse presa
lui stesso, prima della separazione dai famigliari, la decisione di vendere
Enimont.
...evidentemente male informata lei stessa dal
marito, dichiara in un passaggio del docufilm che io e Sergio Cusani non avevamo
dato a Gardini la documentazione per potersi difendere, cosa totalmente falsa
perché eravamo regolarmente in contatto e l’abbiamo sempre supportato,
offrendogli perfino la totale disponibilità per la copertura delle sue spese
legali da parte del Gruppo.
(…) In definitiva. Il docufilm ha perso la grande
occasione per raccontare il Gardini “vero”, l’imprenditore, il sognatore, il
velista, coi suoi successi e i suoi errori, dipingendolo invece come un
vincitore mancato per colpa di una inesistente e costante congiura dei
famigliari ai suoi danni. Il docufilm, cioè, è riuscito nella vergognosa impresa
di dipingere Arturo, Alessandra, Franca Ferruzzi e il sottoscritto, come i
principali responsabili di un destino conclusosi male, quello di Raul Gardini,
che è invece sempre stato esclusivamente, nel bene e nel male, nelle sue mani.
Carlo Sama
Carlo Sama: «Il suicidio di mio cognato
Raul Gardini? Un sacrilegio. Ora coltivo soia in Sudamerica».
La maxi tangente Enimont, la condanna, la nuova vita. «Raul era
straordinario. Fu il primo a parlare di auto elettrica, biomasse, energie
alternative. Era avanti su tutto», scrive Stefano Lorenzetto il 13 luglio 2018
su "Il Corriere della Sera". La sua nuova vita è costata a Carlo Sama un occhio
della testa. Il destro. «In Paraguay ho avuto il distacco della retina mentre
aprivo una strada nella tenuta di famiglia, dentro la più vasta foresta pluviale
atlantica del pianeta posseduta da un privato. Sarebbe bastato farmela suturare
là con il laser. Invece ho aspettato 20 giorni perché volevo ricoverarmi in una
clinica europea. Risultato: 14 inutili interventi chirurgici fra Londra, Roma e
Miami. Ed eccomi qua, orbo veggente come Gabriele D’Annunzio». Il protagonista
del processo Enimont, inchiodato dal pm Antonio Di Pietro per aver pagato «la
madre di tutte le tangenti» e riabilitato di recente dal tribunale di
sorveglianza di Bologna, vive fra Montecarlo e il Sudamerica. «Nel bosco mi sono
costruito una casa di legno su un albero, a 20 metri da terra, ma confesso che
non ci ho ancora dormito. Ho paura dei giaguari: quelli s’arrampicano». Eppure
nella sua Ravenna lo considerano l’amico del giaguaro che tradì il proprio
mentore, il cognato Raul Gardini. «Il passato è storia. Fa parte di noi. Pensi
al povero Ubaldo Lay: bravo attore, ma alla fine tutti se lo ricordano solo come
il tenente Sheridan con l’impermeabile». L’accusa gli pesa, e ancor più adesso,
a 25 anni dal colpo di pistola alla testa con cui il 23 luglio 1993 l’arrembante
magnate del gruppo Ferruzzi-Montedison si uccise nel Palazzo Belgioioso di
Milano. «Tra la mia famiglia e Gardini, scelsi la mia famiglia». Cioè la moglie
Alessandra Ferruzzi, che, come i fratelli Franca e Arturo, non condivideva la
successione decisa da Raul, marito della sorella Idina, la primogenita del
fondatore Serafino Ferruzzi. Era il 1991. Gardini fu liquidato con 505 miliardi
di lire. «Quello che nessuno sa, è che l’anno dopo ritornammo a parlarci».
Chi fece il primo passo?
«Io. Ci vedemmo in Svizzera. Ruppi il ghiaccio con
una battuta: Raul, non ci divertiamo più se non stiamo insieme».
Stare insieme per fare che cosa?
«Avevamo il monopolio mondiale del polipropilene.
Ma bisognava investire centinaia di miliardi in ricerca. La Shell era pronta.
Avremmo riportato a casa i pozzi petroliferi in Adriatico. E la Edison.
L’advisor dell’operazione era Romano Prodi, affiancato da Claudio Costamagna,
attuale presidente della Cassa depositi e prestiti. Il principio era banale:
rimettere tutto assieme. Dissi a Raul: facciamo un atto di compravendita della
Ferruzzi per una lira, poi a bocce ferme sarai tu, da padre di famiglia, a
valutarne il vero valore».
Come reagì?
«La proposta gli piacque molto. Ma non se ne fece
nulla, perché commise un errore: cercò l’avallo di Mediobanca, cioè di Enrico
Cuccia».
E che cosa accadde?
«Le azioni furono svalutate da 1.250 a 5 lire. La
Ferruzzi fu oggetto di un trapianto d’organo, con le sue quote di mercato
immesse in corpi malati. Sa di che parlo? Eravamo primi al mondo anche nelle
proteine e nelle lecitine di soia, nelle penicilline; primi in Europa nello
zucchero, negli amidi e derivati, nei semi oleosi, nei mangimi, negli oli di
marca; primi in Italia nel calcestruzzo e nelle assicurazioni danni e secondi
nell’elettricità».
Che uomo era Raul Gardini?
«Straordinario. Aveva una visione così chiara del
mercato che si dimenticava dei tempi. Voleva che le cose fossero fatte per ieri.
Fu il primo a parlare di auto elettrica, biomasse, energie alternative. Il mondo
era il nostro giardino di casa. Fosse ancora vivo, oggi costringerebbe l’Italia
a ridiscutere Maastricht, le quote, tutto».
Perché a 60 anni si uccise?
«Non certo per disonore: non aveva fatto nulla.
Temeva di finire come Gabriele Cagliari, 134 giorni nel canile. Quando il
presidente dell’Eni si suicidò in cella, Raul mi telefonò: “È morto da eroe”.
Pensava solo a quello, all’arresto. Di Pietro lo teneva sulla graticola. Non si
lavora una vita per finire in ginocchio da chi ti accusa. Mi hanno raccontato
un’orribile storia di guerra sui topi».
Quale storia?
«I soldati catturavano una dozzina di topi e li
tenevano a digiuno in gabbia. L’unico che sopravviveva, dopo aver divorato gli
altri, veniva liberato perché desse la caccia ai suoi simili nelle trincee».
Gli innocenti non temono il carcere.
«Efrem Campese, capo della sicurezza di
Montedison, gli aveva parlato di dieci buste gialle con l’intestazione “F” e di
un colonnello della Finanza chiamato da Roma per recapitarle. I destinatari
potevano essere Fiat o Ferruzzi. Si figuri se Raul ebbe dubbi. L’avviso di
garanzia equivaleva a una condanna».
Lei ebbe 146 imputazioni, mi pare.
«Più o meno. Assolto da tutte, a parte il
finanziamento illecito ai partiti e l’inevitabile falso in bilancio».
Fu arrestato il giorno del suicidio.
«Sì. Mi trovavo a Lugano. Telefonai a Palazzo
Belgioioso. Rispose Renata Cervotti, la segretaria di Raul. Lo stavano
soccorrendo. Non morì subito».
Aleggiano misteri sulla tragedia?
«No, fu tutto lineare. Il comandante che affonda
con la sua nave».
Fu dunque un gesto eroico?
«Rispetto la sua decisione e non esprimo giudizi.
Sarebbe fargli torto».
È vero che la vedova ha abbracciato la vita
religiosa?
«Idina è una donna meravigliosa, come lo era il
marito. Oggi non sta bene. La storia dei Ferruzzi non la conosce nessuno. Sono
l’unico a poter dire d’aver visto la luna e l’altra faccia della luna. Serafino
era un genio, ha segnato il secolo scorso. Il giorno in cui arrivò alla Borsa di
Chicago, si fermarono per rispetto le contrattazioni: era entrato Mister Soia,
il trader che faceva il mercato».
Ma che bisogno aveva Enimont di versare tangenti
ai partiti?
«Nessuno. Si pagava perché non rompessero le
balle. Non mi pareva un peccato. Magari una scemata. Ma la politica costa tanto,
sa? Non trovo anormale aiutarla. Si doveva fare alla luce del sole».
Foraggiavate tutti?
«Nella migliore tradizione. Avevano stabilito le
percentuali. I partiti dalle mani pulite? Qualcuno svolgeva il lavoro sporco
anche per conto loro».
Severino Citaristi, tesoriere della Dc, mi
raccontò di quando il segretario Arnaldo Forlani lo spedì da lei per ritirare
una busta con dentro 2 miliardi e 850 milioni di lire in Cct, circostanza che
poi mi fu confermata dallo stesso Forlani.
«In piazza del Gesù ci andai poche volte. E non
chiesi mai nulla a Forlani».
Che mi dice della valigia con 1 miliardo di lire
consegnata al Pci?
«Bisognerebbe poterlo chiedere a Raul. La portò
lui alle Botteghe Oscure».
Centinaia di miliardi in Cct transitarono dallo
Ior, la banca della Santa Sede.
«Sono assolutamente consapevole di questo. Ma non
fui io a smistarli».
Però il vescovo Donato De Bonis, segretario dello
Ior, celebrò le sue nozze nella parrocchia vaticana di Sant’Anna.
«Un caro amico. Aprì il fondo San Serafino per
attività di beneficenza in onore del padre di mia moglie. Ogni anno ci versavo
la mia gratifica natalizia».
Stefano Bartezzaghi, figlio del Bartezzaghi della
«Settimana Enigmistica», la definì «vantaggiosamente inappariscente» e le imputò
la «tendenza a strafare».
(Ride). «Giudichi lei. Ho interesse ad apparire
sul Corriere della Sera?».
Di che cosa si occupa adesso?
«Mi sarebbe piaciuto cimentarmi nello sport, come
mi aveva consigliato Bettino Craxi, magari alla presidenza del Coni. Invece sono
rimasto fedele all’antico amore: la terra. Mi occupo di Agropeco, 12.000 ettari
fra Paraguay e Brasile, vicino alle cascate dell’Iguazú, e di Las Cabezas,
18.000 ettari a Entre Rios, in Argentina. Produco dalla soia all’eucalipto. E
allevo 12.000 capi di bestiame razza Hereford. Ho brevettato un mangime
contenente il 5 per cento di stevia, un’erba dolcificante che funge da
antibiotico naturale. In campagna rido da solo, come i matti».
Investe ancora nel nostro Paese?
«Beh, no, che domande! L’ultimo affare fu la
cessione di un’immobile a Roma, diventato il J.K. Place luxury hotel».
Le restano l’Es Ram resort e il ristorante Chezz
Gerdi, a Formentera. Tra gli ospiti, Veronica Lario con figli e nipoti, Piero
Chiambretti, Paolo Bonolis, Raoul Bova.
«Chiuso il primo, venduto il secondo. Mai ospitato
Bonolis. Però ci venivano Kate Moss e una figlia di Mick Jagger».
Silvio Berlusconi era suo amico.
«Lo è ancora, lo sarà sempre. Fu l’unico a
telefonarmi il giorno dell’arresto. E pensare che avrebbe dovuto odiarmi: con
Telemontecarlo gli fregavo la pubblicità».
Chi altro le è rimasto vicino?
«Luca Cordero di Montezemolo, Carlo Rossella,
Luigi Bisignani. E Sergio Cusani. Il mese scorso si è fatto 400 chilometri,
Milano-Bossolasco e ritorno, per stare mezz’ora con le stampelle al matrimonio
di Francesco, il mio secondogenito».
Come vede l’Italia a trazione
pentastellata-leghista?
«Tutto quello che porta al cambiamento, lo vedo
bene. Pensi che Gardini già negli anni Ottanta voleva risolvere il problema
degli immigrati. Fece predisporre da Marco Fortis, docente della Cattolica
proveniente dalla Nomisma di Prodi, un progetto per rendere coltivabile la
fascia mediterranea del Maghreb. Dall’Africa non sarebbe più partito nessuno. Se
solo avessimo potuto continuare...». (Si commuove). «Il lavoro era il nostro
gioco, la nostra vacanza. È stato commesso un sacrilegio».
Secondo lei i partiti si finanziano ancora in modo
illecito?
«Mi pare di sì. Ma non ho i riscontri».
Allora da che cosa lo deduce?
«Dall’odore».
Estratto dell'articolo di Andrea Pasqualetto per
il “Corriere della Sera” il 30 giugno 2023.
I baffoni gli davano forza e fascino. Oggi,
trent’anni dopo, fanno posto a una barbetta più sale che pepe di tre giorni. Ma
la forza di Paul Cayard è oramai scritta nel libro mastro della vela: campione
del mondo, coppe, trofei, encomi, un nome, una leggenda. Nel 1992 con il Moro di
Venezia di Raul Gardini arrivò lì dove nessuna barca italiana era giunta prima
di allora: la finalissima della Coppa America, l’Everest del mare, che si
disputava in California nelle acque di San Diego. Furono i mesi in cui l’Italia,
incollata alla tv a orari impossibili, si innamorò di lui, lo skipper americano
voluto da Gardini alla guida delle regate ed eletto a super manager sportivo.
Dopo il trionfo, però, la tragedia: la mattina del
23 luglio del 1993, giorno in cui doveva essere arrestato, Gardini si puntò
l’arma alla tempia e schiacciò il grilletto. Cayard era con lui a Milano nelle
stanze di palazzo Belgioioso, teatro del suicidio. E rieccolo in Italia, fra
queste barche oceaniche approdate a Genova per la tappa finale dell’Ocean Race,
il giro del mondo a vela. Nei giorni in cui il dibattito sulla figura di Gardini
è stato riacceso da eventi, incontri e un paio di libri (Solferino pubblica «Di
vento e di terra», il romanzo vero di una vita di sfide), Cayard ha deciso di
parlare del suicidio: «Per ricordare colui che è stato per me come un padre e un
grande amico».
Partiamo dalla fine, da quel colpo di pistola...
«Uno choc totale, non ci potevo credere, quella
settimana ero stato con lui fino a due giorni prima, proprio a palazzo
Belgioioso. Raul aveva letto del suicidio di Gabriele Cagliari e mi diceva che
era una strana cosa, con quel sacchetto di plastica nella testa. Era molto
preoccupato. Non voleva finire in carcere anche lui, secondo me perché lì non si
sentiva più padrone della sua vita e lui non sopportava l’idea che fossero gli
altri a decidergli il destino».
In che senso è stato per lei un padre?
«Avevo 26 anni e non ero nessuno, ha creduto in
me, mi ha aperto le porte di casa sua e mi ha aiutato molto. “Paolino — mi ha
detto — tu vieni a vivere a Milano e io ti do tutto quello che ti serve”. E l’ha
fatto, mi ha dato tutto, soprattutto la fiducia. Quando è morto avevo 33 anni e
una professionalità tale che mi è bastata per il resto della vita».
Perché Gardini scelse proprio lei?
«Lui mi disse che a parlargli di me era stata
Eleonora (primogenita di Raul, ndr ). Mi aveva visto vincere una regata in
Sardegna, dove io ero in sostituzione. Raul ha voluto provarmi e ha deciso
subito. Guarda questa foto — ci mostra una foto ingiallita — è quella della
prima volta con lui sul Moro, questo sono io, questa è Eleonora di spalle, in
bikini, eh, quello è Raul...».
Com’è nata l’idea della Coppa America?
«Siamo a San Francisco per il mondiale Maxi del
1988, nello stesso albergo. Vinciamo la prima regata e la mattina dopo, a
colazione, c’era anche il suo amico marinaio Angelo Vianello, mi dice: “Paolino,
dobbiamo fare la Coppa America”. Io ho detto: “Raul, questa è brutta idea”.
“Perché?” “Costa un sacco di soldi, perdi molto tempo e vince uno solo”. Il
secondo giorno, altra vittoria e altra colazione insieme. “Paolino, pensaci”.
Dopo ogni vittoria me lo ripeteva. Alla fine delle
cinque regate, tutte vinte e vinto il Mondiale, è stato impossibile dirgli di
no. Ci ha portati tutti in Argentina e ha parlato delle sue idee grandiose».
Il varo del Moro a Venezia con la regia di
Zeffirelli, il cantiere Tencara con la tecnologia più avanzata e potente...non
spendeva un po’ troppo?
«Potrebbe sembrare, sì, ma è vero anche che se tu
dai l’impressione di essere vincente il gruppo è motivato e alla lunga questo ti
ripaga delle spese, quel che è successo».
Pregi e difetti del grande capo?
«Era divertente, coraggioso, un grande motivatore,
delegava molto e non avevi mai l’impressione che potesse dubitare di qualcuno,
così tutti davano il massimo e si rimaneva uniti. Difetti? Non sapeva guidare,
una volta siamo andati da Montezemolo a vedere una Ferrari, lui era al volante e
passava dalla prima alla quarta e il contrario, la macchina strattonava e
diceva: non ci sono più le Mercedes di una volta.
Capito? Altro difetto? Fumava troppo, anche in
aereo. Ricordo un viaggio in cui mi sono svegliato tossendo per il suo fumo.
“Sai cosa Paolino, dovresti iniziare anche tu, in modo che hai un filtro
naturale”. E non scherzava».
(…)
Estratto dell'articolo di Gian Antonio Stella
per il “Corriere della Sera” il 23 giugno 2023.
«Una curiosità: quanto fuma?» «Più che posso».
Seduto su uno scalino della Madonna della Salute, sigaretta serrata fra i denti,
mani impegnate ad allacciarsi le scarpe, Raul Gardini fissò l’occhio buono sul
cronista e rise. Schiacciò la sigaretta e ne accese un’altra.
Faceva male ai polmoni? Chissenefrega. Era una
sfida, una delle tante. Come la presentazione, quel giorno, a Venezia, in pompa
magna, un caos di bandiere, gondole, ospiti di spicco, cestini di leccornie
deluxe preparati dal consuocero Arrigo Cipriani, regia di Franco Zeffirelli, del
bellissimo «Moro» col quale voleva andare a vincere la coppa America.
Sfida perduta. Come troppe altre di una vita
conclusa la mattina di venerdì 23 luglio 1993, trent’anni fa, con un colpo alla
tempia sparato con una pistola calibro 7,65 Walther Ppk, la stessa usata anni
prima da Luigi Tenco. Scrisse il Corriere : «Lo aspettava il carcere. Ha
preferito la morte».
Tre giorni prima si era ammazzato il presidente
dell’Eni Gabriele Cagliari. Una settimana prima, come ricordò nel suo editoriale
Paolo Mieli, si era costituito dopo sei mesi di latitanza l’ex presidente della
Montedison Giuseppe Garofano, «raccontando ai magistrati i segreti
dell’avventura chimica del gruppo Ferruzzi, con tutti i dettagli sui passi più
spericolati e gli illeciti più incredibili per accantonare fondi da far affluire
in parte nelle proprie casse segrete e in parte in quelle dei partiti di
governo». Partiti che Gardini pagava e disprezzava.
«Io ho questa mentalità: quando sono in Brasile mi
sento brasiliano, in Argentina argentino, negli Usa americano ed europeo in
Europa», confidò a Enzo Biagi poche settimane prima di andarsene. Ultimo
sospiro: «Non ci sono innocenti. I peccati sono collettivi». «Come uomo aveva
sei marce. Il guaio è che troppo spesso teneva la sesta in curva», spiegò a
l’Unità il celebre fiscalista e consigliere Montedison Victor Uckmar. E
aggiunse: «Non vorrei che qualcuno ora se la pigliasse coi giudici, dimenticando
chi è il responsabile primo di queste cose. Alludo ad una classe politica...»
Trent’anni dopo, sul «Contadino» ribattezzato con
quel nomignolo per l’appartenenza «alla razza terragna» da cui veniva anche se
aveva passato la giovinezza «fra le pinete e le spiagge romagnole», esce un
libro che ripercorre tutta l’irruenta avventura umana, economica, finanziaria,
politica e marinara dell’imprenditore che alla morte del suocero
Serafino Ferruzzi, il re delle granaglie di cui
aveva sposato la primogenita cattolicissima e riservatissima Idina, si ritrovò a
46 anni in pugno un’immensa ricchezza e in tre lustri scarsi, scommettendo
spericolatamente su se stesso, le sue intuizioni, le sue ambizioni, riuscì a
bruciare tutto. Compreso se stesso.
Si intitola Di vento e di terra. Raul Gardini, il
romanzo vero di una vita di sfide , è firmato dal nostro Andrea Pasqualetto e
Lucio Trevisan, è edito da Solferino e in 320 pagine racconta due storie
parallele che si incrociano e confondono l’una nell’altra.
Quella dell’imprenditore di enorme successo
iniziale che a un certo punto «addenta un’azienda dopo l’altra (agroalimentare,
agrochimica, energia, costruzioni e impiantistica, farmaceutica, grande
distribuzione, editoria…)
(...)
E quella del velista appassionato che si fissa su
barche sempre più belle create da designer sempre più famosi con marinai sempre
più competitivi rastrellati in giro per il pianeta senza rinunciare mai, però,
ai consigli di un vecchio uomo di mare di Pellestrina, Angelo Vianello. «L’amico
del silenzio, con il quale Raul sta bene anche tacendo». Quello cui chiede
consiglio anche su cose che non hanno a che fare con la nautica, come
l’improvvisa difficoltà del figlioletto Ivan colpito da un’inspiegabile
difficoltà a camminare e in poche settimane rimesso in piedi. Quello che, «fiol
de pescadori de laguna», si ritrovò una mattina presto davanti il re di Spagna
Juan Carlos, curioso di salire a bordo per vedere il «Moro» e lo accolse così:
«Siòr Re, ghe fasso un cafetin?»
(...)
Ma tutto intorno meritano d’esser raccontate tante
storie che ricostruiscono un’epoca.
L’acquisto a Venezia del «maledetto» Palazzo Dario
per sfidare le leggende della bellissima dimora marcata nei secoli da suicidi,
omicidi, sventure, morti violente... Lo sfizio di impossessarsi dell’arte del
vetro comprando larga parte delle vetrerie di Murano. L’audizione alla Camera
nel 1986 in cui avvertì il Parlamento: «L’Italia deve diventare autonoma sul
piano energetico, altrimenti rimarremo sempre un Paese dipendente da altri.
(...) Ci vuole il coinvolgimento diretto dello
Stato. Quello di cui sto parlando è un sogno, ma è un sogno realizzabile: vedere
l’Italia produttrice di energia verde, grazie all’etanolo. Inquina meno ed è
altamente redditizio a livello di rendimento...» Parlava (anche) pro domo sua,
dato che aveva enormi quantità di cereali giacenti? Sicuro. C’era però, oltre
agli interessi aziendali, qualcosa di più. Che merita forse, tanti anni dopo,
qualche riflessione.
Così come meriterebbe un romanzo a parte il
carteggio, lettera dopo lettera, ora note, che ricostruisce lo sfascio della
Famiglia. Con Alessandra, la più giovane dei figli del vecchio Serafino, che
inizia con parole apparentemente amichevoli a contestare la leadership del
cognato Raul. E lui che, dopo un crescendo di reciproche tensioni, passa
affiancato da Idina alle minacce a tutti i cognati: «Se abbraccerete
definitivamente le teorie di Alessandra contro di me ed Idina sarà una rottura
definitiva che vi costerà molto, molto cara». Come sia finita si sa. Trent’anni
dopo, in famiglia, non si parlano ancora.
Raul Gardini,
il corsaro della Borsa: tra scalate e declivi pericolosi.
Raul Gardini ha
incarnato il sogno del capitalismo italiano, le sue epiche scalate di Borsa lo
hanno portato in cima, prima della tempesta Mani Pulite. Tommaso Giacomelli
il 22
Gennaio 2023 su Il Giornale.
Un trascinatore,
un leader naturale e un uomo dalla visione illuminata. Raul Gardini non riusciva
a fermarsi al presente, non metteva mai l'ancora, seguiva il flusso del mare,
come quello del suo amato Adriatico, e si proiettava con energia instancabile
verso obiettivi futuri, per i più imponderabili. Uno spirito da vero corsaro
quello dell'imprenditore ravennate, classe 1933, che ebbe il suo momento di
massimo fulgore negli anni '80, salendo agli onori della cronaca per le grandi
scalate finanziarie dal sapore temerario, che lo proiettarono nelle stanze dei
bottoni della politica italiana e tra il gotha degli industriali nostrani.
Gardini era orgoglioso della sua origine romagnola, di essere nato in quella
città che fu capitale dell'Impero romano d'Occidente prima e del Regno degli
Ostrogoti poi, non dimenticando mai la bellezza delle cose semplici, dei profumi
del mare e della terra, di quanto sia benefico il calore di una famiglia unita e
l'importanza di una stretta di mano tra gentiluomini. Gardini ha vissuto la vita
a modo suo, seguendo le sue regole, pagando a caro prezzo un orgoglio che lo ha
spinto a togliersi la vita con un colpo di pistola la mattina del 23 luglio
1993, a Milano, nel suo appartamento di Palazzo Belgioioso. Nel mezzo, però,
vale la pena raccontare la vicenda personale di un uomo che ha saputo stupire e
scioccare, nel nome di un capitalismo rampante e senza freno come quello esploso
in Italia nella seconda metà degli anni '80.
Alla guida della
Ferruzzi
Nel 1948 Serafino
Ferruzzi, romagnolo doc, fonda la sua azienda, la Ferruzzi, che in una prima
fase commercializza legname e calce, poi diventa leader nel trattare le materie
agricole. Negli anni '60 l'impresa ravennate si ritaglia spazio come primo
importatore italiano di grano, soia, olio di semi e cemento, diventando uno dei
principali operatori del settore in Europa e, di conseguenza, nel mondo. Raul
Gardini nel 1957 sposa la figlia del patron della Ferruzzi, Idina, e quando il
vecchio Serafino nel 1979 muore in un incidente aereo, la famiglia decide di
affidare le deleghe operative del Gruppo proprio a Gardini. Quest'ultimo, a 46
anni, si ritrova investito del ruolo di capo di una realtà industriale, che lui
guiderà a una vera rivoluzione d'assalto. Ravenna, dopo molti secoli, torna ad
avere un imperatore, diverso da quelli del passato, ma animato dallo stesso
spirito di conquista grazie a delle idee che hanno la forza di colpire il cuore
delle persone. Lui è un visionario, ma concreto, non un sognatore, in più è
animato dalla voglia di ottenere quello che desidera con un fare quasi da
guascone. Alla gente piace, buca lo schermo e cattura le simpatie dei media. In
breve tempo, Raul Gardini è un nome che fa strada all'interno della società
italiana, arrivando ad avere una forte risonanza a livello nazionale. Tutti si
accorgono di lui e nel frattempo il Gruppo Ferruzzi spicca il volo, passando dal
trading all'industria, concentrando le proprie risorse nel business dello
zucchero. Nel 1981 acquista la Eridania, prima azienda produttrice di idrato di
carbonio in Italia, poi nel 1986 passa alla francese Béghin Say. A guidare
Gardini in queste campagne finanziare c'è l'intuito e una capacità di prendere
le decisioni in un breve lasso di tempo. In seguito alle numerose politiche di
acquisizione, l'industriale ravennate capisce che ci sono tutte le carte in
regola per entrare nell'alta finanza con un ruolo da protagonista assoluto.
La Borsa e il
sogno di Raul Gardini
Dopo il lungo
silenzio degli anni di piombo, nel 1985 l'Italia sembra essere rinata. Un'ondata
di benessere cavalcato dal nascente rampantismo inebria gli italiani di una
nuova euforia collettiva. L'arrivo dei fondi di investimento mobiliare fa
quintuplicare gli incassi della Borsa, le quotazioni guadagnano il 20% a
settimana e in un mese si ottengono qualcosa come 300 miliardi di lire. In
questo scenario Raul Gardini mette la Ferruzzi finanziaria sul mercato, i soldi
- dice lui - si trovano in Borsa e basta saperli prendere. Una scelta
all'apparenza spregiudicata che si rivela quanto mai azzeccata, dato che in tre
anni fa entrare nelle casse del Gruppo qualcosa come 3.000 miliardi di lire. Gli
yuppies hanno un nuovo idolo da venerare, Milano diventa la capitale del sogno
che passa attraverso le urla, gli strepitii e la frenesia imperante delle
affollate sale di Piazza Affari. Il sogno nel cassetto di Gardini, però, è
quello di riuscire a costituire un polo della chimica che si proponesse come
baluardo dell'ecologia. Il suo più viscerale desiderio è quello di proporre sul
mercato un carburante che avesse un legame con le materie agricole, il suo primo
amore. A quel punto, il ravennate mette gli occhi sulla Montedison, grande
gruppo industriale italiano attivo nella chimica e nell'agroalimentare.
La scalata a
Montedison
Nel 1985 la
Montedison è al centro di uno scontro molto violento tra gli azionisti, Gardini
fiuta la situazione e intravede la possibilità di entrare in scena per diventare
l'azionista di riferimento. Un'azione facile sulla carta, ma difficile da
realizzare perché a guidare il gruppo industriale c'è un osso duro, Mario
Schimberni. Quest'ultimo è un tipo riservato, enigmatico e impenetrabile, che
non fuma e non beve, tanto che viene chiamato "l'uomo di ghiaccio". Schimberni è
un manager di alto rango che ha come unico obiettivo quello di fare della
Montedison la prima public company italiana. Nel frattempo Gemina, il salotto
buono del capitalismo italiano, prende per la giacchetta Gardini cercando di
spingerlo a tutti i costi a farne parte, ma lui non ne vuole sapere. Il
ravennate è un romagnolo puro, un po' impulsivo, la partita per conquistare la
Montedison la vuole giocare da solo. A lui la chimica serve per trasformare il
prodotto agricolo e creare energia, per questo mettere le mani sulla
quell'industria diventa di capitale importanza. Nessuno, però, immagina che il
numero uno del Gruppo Ferruzzi ha in mente la più clamorosa operazione
finanziaria del secondo dopoguerra.
La prima
fase dell'assalto alla Montedison è rapida e si conclude quasi in un lampo: l'8
ottobre del 1986 Gardini convoca il suo agente di cambio e gli ordina di
acquistare più azioni possibile della Montedison. In un paio d'ore la Ferruzzi
sborsa 1.500 miliardi di lire; alla fine della giornata Gardini blocca l'OPA di
Cuccia e De Benedetti, e ottiene il 10% del pacchetto azionario del Gruppo
operante nella chimica. La seconda fase è intrisa di diplomazia, di tessitura di
rapporti e di dolce seduzione verso quegli azionisti che possiedono pacchetti
importanti della Montedison. L'11 marzo 1987 Gardini ha speso un complessivo di
2.000 miliardi di lire ma in cinque mesi ha ottenuto il 40% delle quote
desiderate. A novembre dello stesso anno, Gardini si issa al comando della
Montedison, subentrando a Schimberni non senza un'aspra disputa tra i due
leader. In appena sette anni, il ravennate diventa il secondo industriale
italiano, contro ogni pronostico.
Il fallimento di
Enimont
Il progetto di
Gardini è in continua evoluzione, un rincorrersi perpetuo di decisioni, vale a
dire che ogni passo stimola il successivo. Quando si conquista un avamposto,
bisogna andare avanti e procedere a passo spedito. Non c'è mai quiete nel suo
spirito. Sul finire del 1987, Gardini è il presidente della Montedison ed è il
leader privato della chimica in Italia. Alla sua porta bussa la controparte
pubblica, l'ENI, che ha bisogno dell'appoggio del ravennate per sopravvivere e
dar vita a un polo chimico in grado di competere coi grandi del settore. Gardini
si convince che l'unione tra le due realtà si può fare, con l'obiettivo di
entrare almeno nei primi dieci del mondo. In poco tempo nasce la Enimont, che
alla Montedison costa la bellezza di 1.200 miliardi di lire di tasse. Una spesa
enorme, ma la parte pubblica promette a Gardini delle garanzie sugli sgravi
fiscali con dei decreti legge. L'accordo viene siglato alla maniera contadina, o
dei sensali, tramite una stretta di mano tra il ravennate e Ciriaco De Mita,
presidente del Consiglio. A fine 1988 la Enimont conta 55.000 dipendenti e
16.000 miliardi di lire di fatturato, con il 40% delle quote a ENI, l'altro 40%
a Montedison e il restante 20% destinato al mercato azionario. La nuova realtà
pubblica-privata è il leader mondiale della chimica, ma per Gardini arriverà
presto la beffa.
La politica
capisce che sta per perdere un ufficio acquisti da 15.000 miliardi di lire
all'anno, così in Parlamento il decreto legge aspettato da Gardini viene
bocciato per due volte fino a decadere definitivamente. Poi, dopo la caduta del
Governo De Mita e il ritorno di Andreotti, grande oppositore dei Ferruzzi fin
dai tempi di Serafino, si mette una pietra tombale sulla questione. La politica
si dimostra per Gardini il più inaffidabile degli interlocutori, inoltre, le
divergenti vedute imprenditoriali tra le due realtà, porta alla rottura
della joint venture con Gardini che si appella alla violazione degli impegni. Si
arriva al "patto del cowboy", con la Montedison che ricopre il ruolo della parte
che fa il prezzo e l'ENI di quella che compra. Dopo un iniziale tentativo di
scalata da parte di Gardini alla Enimont, stoppata dal guidice Curtò con il
congelamento provvisorio delle sue quote da parte del Tribunale di Milano, alla
fine di novembre 1990 l'industriale ravennate abbassa la testa e vende il suo
40% all'ENI per 2.805 miliardi di lire.
Il Moro di
Venezia e la caduta
Dopo il
fallimento di Enimont, la famiglia Ferruzzi - stanca di inseguire le imprese
spericolate - si dissocia da Raul Gardini, luquidandolo da tutti i suoi
incarichi pagando una cifra di 503 miliardi di lire in contanti. L'ultima
romantica impresa del ravennate è quella del Moro di Venezia, l'innovativa barca
a vela che affidata al geniale skipper americano, Paul Cayard, vince la Louis
Vuitton Cup del 1992 battendo in finale New Zeland per 4 a 3 dopo una rimonta
insperata. La barca italiana arriva, dunque, negli Stati Uniti, nella baia di
San Diego, per contendere l'America's Cup all'imbarcazione statunitense
America³. Purtroppo la sfida terminerà 4 a 1 a favore dei padroni di casa,
mentre per il Moro di Venezia rimane il sogno di aver spinto la vela italiana
fino a toccare quasi il cielo, anche se il boccone da digerire è amaro.
I trionfi in mare
vengono oscurati dalle nubi di tempesta che si abbatono a Milano con le indagini
di "Mani Pulite". Uno dopo l'altro politici e manager ricevono avvisi di
garanzia o mandati di cattura. È un effetto domino che non risparmia nessuno e
travolge tutti. Il pool di magistrati milanesi punta alla Enimont, l'inchiesta
viene incuriosita da una falso in bilancio, tra il 1990 e 1991, di 150 miliardi
di lire che sarebbe servito a Gardini, e alla Montedison, per corrompere
funzionari di governo e uscire indenne dalla chiusura della joint venture. Al
ravennate questa cifra non torna e decide di collaborare con la giustizia.
Scosso da un mondo che stava crollando sotto ai suoi piedi, e impotente di
fronte al flusso degli eventi, Raul Gardini la mattina del 23 luglio 1993 si
spara alla testa con un colpo di pistola. Una scelta drammatica e di impeto, un
ultimo atto di volontà per un uomo che ha sempre imposto la sua decisione. Con
lui si chiude la pagina italiana di rampantismo e capitalismo sfrenato, del
sogno della Borsa, delle luci e del divertimento. La sua morte apre un capitolo
più cupo e torbido che ha condizionato il proseguo degli anni '90 fino a segnare
persino i giorni nostri.
Falcone,
Borsellino e le indagini sui grandi appalti in odor di mafia.
SENTENZA DELLA CORTE
D'APPELLO su Il Domani il 07 novembre 2022
Secondo i giudici
d’appello: «Che vi sia stato una sorta di passaggio del testimone da Falcone a
Borsellino quanto all’impegno di seguire e approfondire questo filone d’indagine
è pacifico e la dottoressa Ferraro ebbe modo di constatano personalmente, avendo
assistito ad una telefonata...»
Su Domani prosegue
il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina.
Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in
collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi
stralci delle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo sulla
trattativa stato-mafia.
Questo era dunque la
reale dimensione e natura degli interessi in gioco, sullo sfondo delle due
stragi siciliane, e di quella di via D’Amelio in particolare.
Ma l’obiezione più
calzante e meritevole di attenzione che la sentenza qui impugnata muove alla
tesi difensiva (secondo cui sarebbe stato il timore di un approfondimento
dell’indagine mafia appalti a causare un’accelerazione dell’iter esecutivo della
strage di via D’Amelio: ammesso che tale accelerazione vi sia mai stata) è che
non vi sarebbe prova che Cosa nostra sapesse dell’interesse nutrito dal dott.
Borsellino per quel tema d’indagine; e del suo proposito di riprendere e
approfondire l’indagine a suo tempo curata dal Ros, mettendo a frutto le
conoscenze acquisite e sviluppando le intuizioni e le indicazioni che gli erano
state trasmesse dal collega e grande amico Falcone.
Che vi sia stato una
sorta di passaggio del testimone da Falcone a Borsellino quanto all’impegno di
seguire e approfondire questo filone d’indagine è pacifico e la dott. Ferraro
ebbe modo di constatano personalmente, avendo assistito ad una telefonata con la
quale Falcone rammentava all’amico Paolo che adesso toccava a lui seguire gli
sviluppi dell’indagine compendiata nel rapporto “mafia e appalti” del Ros
È anche vero che
Borsellino ne aveva parlato ripetutamente, e non solo come tema di dibattito
conviviale (come in occasione della cena romana, tre giorni prima che il
magistrato venisse ucciso, di cui hanno parlato il dott. Natoli e l’on Vizzini),
ma come programma di lavoro (con Antonio Di Pietro, con il quale, in occasione
dei funerali di Falcone, si incontrarono ed ebbero uno scambio di idee sul tema,
ripromettendosi di vedersi proprio per mettere a punto un piano di coordinamento
delle rispettive indagini), e come oggetto di una futura delega d’indagine
riservata della quale i carabinieri del Ros avrebbero dovuto riferire soltanto a
lui. E decine e decine di volte, come ricorda l’allora procuratore Aggiunto
Aliquò, avevano discusso in procura della rilevanza di questo tema d’indagine,
ossia l’intreccio tra le attività delle cosche mafiose e il sistema di gestione
illecita degli appalti, e dell’ipotesi che vi potesse essere un nesso con la
causale della strage di Capaci (e poco importa che, a dire dello stesso Aliquò,
non si fossero trovati elementi concreti che la suffragassero, poiché ciò che si
ricava dalla sua testimonianza è che il dott. Borsellino fosse seriamente
interessato a quell’ipotesi investigativa e a verificarne l’attendibilità tale
ipotesi).
E come si vedrà in
prosieguo, in occasione di una tesa riunione tra tutti i magistrati della
procura della Repubblica di Palermo, tenutasi — per volere del procuratore
Giammanco — il 14 luglio ‘92 per fare il punto sulle indagini più delicate (e
per tentare di sopire le polemiche esplose a seguito di velenose campagne di
stampa su presunti insabbiamenti: v. infra), il dott. Borsellino non è chiaro se
già al corrente o ancora ignaro che il giorno prima il procuratore Giammanco
aveva apposto il proprio visto alla richiesta di archiviazione per le posizioni
che restavano da definire nell’ambito dell’originario procedimento n. 2789/90
N.C. a carico di “Siino Angelo+43” (quello oggetto del rapporto “mafia e
appalti” esitato dal Ros Nel febbraio 1991) chiese chiarimenti e ottenne di
aggiornare la discussione sulle determinazioni che l’Ufficio avrebbe dovuto
adottare in merito, a riprova del suo concreto interesse per tale indagine.
Ma che il dott.
Borsellino fosse in procinto di dedicarsi a questo tema d’indagine, partendo dal
dossier mafia e appalti, e che vi annettesse una rilevanza strategica, nella
convinzione che avrebbe potuto condurre fino ai santuari del potere mafioso e
forse anche a fare luce sulla strage di Capaci, non erano certo notizie di
pubblico dominio, né trapelavano in modo esplicito dalle pur frequenti
esternazioni pubbliche alle quali lo stesso Borsellino si lasciò andare nei
giorni e nelle settimane successive al 23 maggio ‘92.
E sarebbe un
rimestare nel torbido se si indugiasse sui sospetti di collusione dell’allora
maresciallo Canale— che certamente era a conoscenza dell’interesse di Borsellino
per quel terna d’indagine così come del fatto che avesse voluto un incontro
riservato con Mori e De Donno per ragioni inerenti a quell’indagine — dopo che
lo stesso Canale è uscito assolto dall’accusa di concorso esterno in
associazione mafiosa, nonostante le infamanti propalazioni di Siino (che da lui,
o anche da lui sarebbe stato informato delle indagini a suo carico e avrebbe
avuto poi una copia dell’informativa del febbraio 1991, secondo quanto Brusca
dice di avere saputo appreso dallo stesso Siino).
LE DICHIARAZIONI DEI
PENTITI
Dal versante interno
a Cosa nostra, ovvero dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia più
addentro agli arcana imperii dell’organizzazione mafiosa, sono venute
indicazioni non sempre chiare e univoche.
Antonino Giuffrè,
interrogato sulle ragioni dell’uccisione di Borsellino, dopo avere ribadito il
discorso stragistico della resa dei conti contro i nemici giurati di Cosa
nostra, sia nel dottore Falcone, che il dottore Borsellino, che risaliva sempre
all’ormai nota riunione di Commissione del dicembre ‘91, ha aggiunto che nella
decisione di uccidere Borsellino ha pesato moltissimo, assieme al discorso della
sentenza del Maxi, anche questo discorso su mafia e appalti: «se il discorso del
Maxi processo è un discorso dove troviamo principalmente dei mafiosi, nel
contesto mafia e appalti troviamo altri discorsi di una cera gravità, cioè che
vengono fuori quei legami appositamente extra dal inondo mafioso, con alti-e
entità, quali imprenditori... Quindi è un discorso abbastanza destabilizzante
perché se è vero come è vero che ho detto è una delle attività più importanti di
Cosa nostra da un punto di vista economico, ma non solo, non solo, perché
permette di creare degli agganci con personaggi che io ho sempre sottolineato
questo discorso, importanti della vita italiana anche da un punto di vista
politico, cioè, si sfruttano anche il contesto imprenditoriale per creare degli
agganci in altri settori dello Stato».
Ed a specifica
domanda (le risulta che in Cosa nostra si ebbe notizia che il dottore Borsellino
forse stava diventando più pericoloso pure del dottore Falcone, specificamente
in questo campo degli appalti?) ha confermato che in effetti «l‘unica persona
che era in grado, o una delle poche, per meglio dire, che era in grado di
leggere il capitolo sull‘uccisione del dottore Falcone, era il dottore
Borsellino. Quindi (....) sono stati messi tutti e due candidati ad essere
uccisi, appositamente già si sapeva che erano, come ho detto in precedenza, dei
nemici giurati di Cosa nostra, e non vado oltre».
In altri termini,
prima di Borsellino già Falcone era stato ucciso non soltanto perché nemico
giurato di Cosa nostra ma anche per una ragione più recondita, legata al suo
impegno nel portare avanti le indagini in materia di mafia e appalti. E di
riflesso, anche Borsellino doveva essere ucciso non solo per vendetta, ma perché
nessuno meglio di lui avrebbe saputo individuare la giusta chiave di lettura
della strage di Capaci, che andava oltre le finalità dichiarata di vendicarsi.
Alla domanda se
risultasse, all’interno di Cosa nostra, che il dott. Borsellino volesse fare
indagini in terna di appalti, dopo la morte di Falcone, Giovanni Brusca,
all’udienza del 12.12.2013, ha dato una risposta evasiva, limitandosi a dire che
«era uno dei temi che più si dibatteva, però notizie così, generiche,
dettagliatamente non ne conosco». Gli è stato contestato quanto aveva risposto
alla stessa domanda fattagli all’udienza del 23.01.1999, nel proc. Borsellino
ter; ma il collaborante, implicitamente confermando le pregresse dichiarazioni,
non ha ritenuto di aggiungere nulla a chiarimento. Resta quindi confermato che,
a suo dire, si seppe all’interno di Cosa nostra che il dott. Borsellino «dopo la
morte del dott. Falcone voleva vedere sia perché era stato ucciso e voleva
continuare quello che il dottore Falcone stava facendo (...) Tra Capaci e via
D'Amelio credo che è saputo e risaputo da tutti che il dottore Borsellino vuole
sapere, vuole scoprire clv ha ucciso, perché ha ucciso il dottore Falcone e
riuscire a capirlo attraverso indagini che stava facendo, su cosa stava
lavorando».
[…] Da queste
tormentate acrobazie verbali sembrerebbe evincersi che solo attraverso
conoscenze acquisite nei vari processi successivi si comprese che le ragioni per
cui furono uccisi Falcone e Borsellino, a parte il fine di vendetta, avevano a
che vedere anche con gli appalti o comunque con le attività giudiziarie che i
due magistrati uccisi stavano portando avanti. Ma sollecitato a chiarire le sue
affermazioni, Brusca, in quella sede, puntualizzava che chi lo aveva interrogava
nel precedente processo (il Borsellino ter) cercava una conferma all’ipotesi che
Falcone e Borsellino fossero stati uccisi per l’attività d’indagine su mafia e
appalti, «cosa che per me non esiste, può darsi magari per altri si».
In realtà, ciò che
vuole dire Brusca non è dissimile da quanto ha dichiarato Giuffré: c’era una
verità ufficiale, all’interno di Cosa nostra, secondo la quale Borsellino doveva
morire, così come Falcone, perché entrambi nemici giurati dell’organizzazione
mafiosa e artefici del mai processo che tanto danno aveva provocato per gli
interessi mafiosi, a cominciare dalla demolizione del mito dell’impunità. Ma
c’era anche una ragione non dichiarata e più profonda, che rimandava proprio al
rilievo strategico che il settore degli appalti aveva per gli interessi mafiosi.
E posto che la
strage di Capaci aveva come finalità recondita anche quella di bloccare le
indagini sul sistema di spartizione degli appalti, o sviarle, il fatto stesso
che Borsellino fosse assolutamente determinato a venire a capo non solo
dell’identità dei responsabili della strage di Capaci, ma anche della sua vera
causale (segno che riteneva che la finalità ritorsiva non fosse l’unica
ragione), come andava dicendo pubblicamente, sicché Cosa nostra ne era a
conoscenza senza bisogno di ricorrere a talpe o infiltrati, ne faceva un
obbiettivo primario da colpire, non meno di Falcone.
E in tal senso al
“Borsellino Ter lo stesso Brusca era stato molto chiaro: «tra Capaci e via
d’Amelio, credo che è saputo e risaputo da tutti che il dottor Borsellino vuole
sapere... vuole sapere, vuole scoprire chi ha ucciso, perché ha ucciso il
dottor... il dottor Giovanni Falcone e riuscire a capirlo attraverso le indagini
che stava facendo, su che cosa stava lavorando (...) io con Salvatore Riina di
questo qua non ne ho più parlato, io lo apprendo dal.. come un normale
cittadino, come tutti gli altri, che lui vuole andare avanti, lo dice
pubblicamente, lo grida, cioè lo esterna... dottor Di Matteo, non è che c’è
bisogno che te lo devono venire a dire a confida... in confidenza».
E sempre in questo
senso si può convenire che l’interesse che il dott. Borsellino nutriva per
l’intreccio mafia e appalti come tema d’indagine da approfondire era motivo di
allarme per Cosa nostra non perché ne fosse venuta direttamente a conoscenza, ma
già per il fatto che egli intendesse scoprire la vera causale della strage di
Capaci (non solo chi ha ucciso, ma perché ha ucciso),e intendeva comunque
ripartire dalle ultime indagini che l’amico Giovanni aveva curato prima di
trasferirsi al Ministero (tra cui proprio quella su mafia e appalti): e questo
proposito era ormai notorio. SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO
Forza Italia non
molla: «Ora “indaghiamo” su Mani Pulite».
Il deputato azzurro
Battilocchio invoca una Commissione d’inchiesta su Tangentopoli, Gotor non ci
sta: «Un’autoassoluzione collettiva». di Giovanni M. Jacobazzi Prado su Il
Dubbio il 13 dicembre 2022.
«Dopo aver letto i
libri dell’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati Luca Palamara mi
pare evidente che in questi anni ci sia stato nel nostro Paese un “uso politico”
della giustizia», afferma il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio.
Il parlamentare azzurro, il mese scorso, ha presentato una proposta di legge per
l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta “sugli effetti delle
inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa,
svolte negli anni 1992 e 1993, sulla successiva evoluzione del sistema politico
italiano”.
«Non ho vissuto il
periodo di Tangentopoli (Battilocchio è nato nel 1977, ndr) ma ritengo che a
trent’anni di distanza ci siano adesso tutte le condizioni per capire cosa sia
successo», aggiunge il parlamentare che è anche coordinatore provinciale a Roma
di Forza Italia. La Commissione parlamentare d’inchiesta sul punto, la cui
istituzione era stata proposta anche nella scorsa legislatura, oltre alla
lettura delle carte processuali, dovrebbe interrogare i “protagonisti”
dell’epoca e chiunque possa fornire utili contributi per far luce su una
inchiesta giudiziaria che cambiò per sempre la storia del Paese. Battilocchio
non lo dice, ma è evidente il riferimento al fatto che la Democrazia cristiana,
il Partito socialista e i tre partiti laici (Pri, Pli e Psdi) furono travolti,
mentre il Partito comunista fu solo sfiorato delle inchieste. La conseguenza di
tale agire fu che il Pci, poi Pds, salvò per intero la sua classe dirigente.
L’incipit della
proposta di legge riporta una intervista del settembre del 2017, durante una
trasmissione televisiva, del pm Antonio Di Pietro. «Ho fatto una politica sulla
paura e ne ho pagato le conseguenze. (…) La paura delle manette, la paura del,
diciamo così, “sono tutti criminali”, la paura che chi non la pensa come me sia
un delinquente. Poi alla fine, oggi come oggi, avviandomi verso la terza età,
bisogna rispettare anche le idee degli altri. (…) Ho fatto l’inchiesta Mani
pulite e con l’inchiesta Mani pulite si è distrutto tutto ciò che era la
cosiddetta Prima Repubblica: il male, e ce n’era tanto con la corruzione, ma
anche le idee, perché sono nati i cosiddetti partiti personali», le parole
dell’ex magistrato, poi eletto in Parlamento proprio nella fila del Pds
. «L’avere messo la
“paura” al centro delle azioni che hanno guidato le dinamiche della stagione
politica e giudiziaria dei primi anni novanta dello scorso secolo necessita un
approfondimento per capire in che misura i risultati elettorali di quegli anni
ne sono stati influenzati. La “paura delle manette”, a cui l’ex magistrato fa
riferimento, potrebbe essere stato uno strumento di “politica giudiziaria” in
mano alla magistratura», sottolinea allora Battilocchio che, comunque, non ha
intenzione con la sua iniziativa legislativa di «cancellare i fatti emersi
nell’ambito dell’inchiesta», limitandosi a voler fare «chiarezza sulle
dichiarazioni di Di Pietro, in quanto per perseguire qualsiasi scopo, anche
fosse il più nobile, fece ricorso alla “paura delle manette”».
Molto critico alla
proposta di Battilocchio è Miguel Gotor, ex parlamentare dem ed ora assessore
alla cultura del Comune di Roma. In un articolo ieri su Repubblica, Gotor
afferma che Battilocchio sarebbe mosso da «intenzioni bellicose» con il ricorso
ad un «armamentario nostalgico e reducista tipico di una certa tradizione
socialista che ritiene Mani pulite il frutto di un golpe mediatico giudiziario».
La commissione d’inchiesta avrebbe allora la funzione di «mera propaganda se non
di disinformazione e intossicazione della pubblica opinione». Su un aspetto,
però, Gotor concorda con Battilocchio, quello dell’uso (abuso) della
carcerazione preventiva che venne fatto dai pm in quegli anni. Per il resto il
mondo stava cambiando ed il finanziamento irregolare ai partiti non era più
tollerato.
Nessun complotto,
insomma. Gotor si lascia andare anche ad una considerazione sui trascorsi
dell’attuale compagine di governo. Quando scoppiò Tangentopoli vi era chi usava
il cappio (Luca Leoni Orsenigo delle Lega Nord, ndr) o chi, i giovani del
Movimento sociale, accerchiava il Parlamento al grido di «arrendetevi siete
circondati». E poi Silvio Berlusconi che nel 1994 sarebbe diventato presidente
del Consiglio e che aveva appoggiato fin da subito l’operato del Pool di Milano
con le indimenticabili dirette di Paolo Brosio. Per Gotor, dunque, il problema
attuale è quella di una «autoassoluzione collettiva» da parte della classe
politica che ha voluto rimuovere il passato nella migliore tradizione
“gattopardesca”. L’Italia, aggiunge l’assessore romano, non ha bisogno di una
commissione d’inchiesta su Tangentopoli ma di una «civica e culturale».
Gattopardi e nostalgici che
vogliono riscrivere la storia di Tangentopoli.
Miguel Gotor
il 12 Dicembre
2022 su La Repubblica.
Fermo restando il diritto di
un singolo deputato a chiedere l'istituzione di qualsivoglia commissione
d'inchiesta sarebbe saggio che il Parlamento non desse seguito a questa istanza
per due buone ragioni
Nelle ore in cui una presunta
vicenda di corruzione si abbatte sul Parlamento europeo, un deputato di Forza
Italia, Alessandro Battilocchio, chiede l'istituzione di una Commissione di
inchiesta su Tangentopoli. A quanto pare non si tratta dell'iniziativa
estemporanea di un singolo parlamentare, legato alla cultura politica socialista
di derivazione craxiana e alla poco fortunata esperienza del Nuovo Psi, dal
momento che il capogruppo di Forza Italia Alessandro Cattaneo avrebbe condiviso
la proposta.
Forza Italia riapre lo
scontro dopo 20 anni: “Commissione d’inchiesta su Mani Pulite”.
Lorenzo De Cicco
il 12
Dicembre 2022 su La Repubblica.
Presentato un ddl in cui si
cita un'intervista di Di Pietro: "Ho fatto una politica sulla paura delle
manette"
Un'altra manina della
maggioranza schiaccia sul tasto rewind. Forza Italia vuole una commissione
d'inchiesta su Tangentopoli. Il nastro scorre veloce a vent'anni fa, allo
scontro fra politica e magistratura. Cavallo di battaglia del berlusconismo
rampante tra gli ultimi anni '90 e i primi 2000. Rieccoci. Dopo le picconate del
Guardasigilli Carlo Nordio sulla separazione delle carriere, le intercettazioni
"inutili", l'obbligatorietà dell'azione penale bollata come "intollerabile
arbitrio", ecco un altro tassello del puzzle: la commissione parlamentare su
Mani pulite.
La proposta di
istituire una Commissione di inchiesta. Commissione di inchiesta su
Tangentopoli: tra suicidi, abusi e diritti perché è giusto indagare.
Tiziana
Maiolo su Il Riformista il 14 Dicembre 2022
Se mai aprirà le sue
porte la Commissione d’inchiesta su Tangentopoli, non ne varcheranno mai la
soglia i testimoni più rilevanti dell’epoca, Severino Citaristi, Vincenzo
Balzamo, Marcello Stefanini. I tre tesorieri dei principali partiti della Prima
repubblica non ci sono più, e uno di loro, il socialista Balzamo, di
Tangentopoli è addirittura morto, di crepacuore, con un infarto che l’ha
annientato un mese dopo la prima informazione di garanzia per finanziamento
illecito del partito.
Era il 2 novembre
del 1992, si era ancora all’inizio. E, caduto il responsabile amministrativo del
partito, tutto il vaso di pandora delle indagini si rovesciò direttamente sul
segretario Bettino Craxi. Il quale non poteva non sapere, gli dissero i pubblici
ministeri. E che subì la sorte peggiore, soprattutto nelle interessate
vociferazioni di certa stampa e di un’opinione pubblica orientata. Forse anche
perché gli mancò quel pungiball che porterà alla morte due anni dopo anche il
tesoriere del Pds Stefanini, distrutto dalle inchieste giudiziarie e che
immolerà per tutta la vita, fino al 2006, il democristiano Citaristi, uomo per
bene morto nella semplicità di una vita sobria, inchiodato al ruolo insano di
collettore di tangenti. Su cui si accaniranno, molti anni dopo, nella loro
voglia continua di sangue, anche i voraci cultori della finta onestà, con la
privazione di una parte del vitalizio.
Se coloro che, come
l’assessore alla cultura del Comune di Roma del Pd Miguel Gotor, autore di un
articolo sarcastico su Repubblica, ritengono che solo la propria categoria sia
degna di mettere le mani sulla storia, vogliono provare a farlo
con Tangentopoli, sanno da dove cominciare. Dalla riabilitazione di tre persone
per bene. Ma non crediamo che ne siano capaci. Prima di tutto perché lo storico
lascia intendere la stravagante convinzione che Forza Italia abbia presentato la
proposta della Commissione per infierire sul Pd, su Panzeri e sull’inchiesta
belga su presunti finanziamenti del Qatar. Nulla di più errato, visto che
l’iniziativa era già stata presentata nella scorsa legislatura. E poi perché,
forse sentendosi virtuoso per l’ammissione, si lascia andare a dire che «si può
serenamente affermare che in quegli anni, in alcuni casi, si registrò un uso
inquisitorio dello strumento e della carcerazione preventiva».
Un’affermazione
gravissima perché lontana dalla realtà. Perché l’uso della custodia cautelare in
carcere non fu una piccola degenerazione isolata di qualche pm eccessivo, ma lo
strumento di vera tortura che portò a quarantun suicidi, oltre che alla
distruzione di vite e carriere. Fu lo strumento che consentì di trasformare una
“normale” inchiesta giudiziaria sul finanziamento illecito dei partiti e su
alcuni casi di corruzione personale nella rivoluzione giudiziaria che ha mandato
al potere toghe e divise. In questo senso un vero golpe. È inutile citare Sergio
Moroni e la straziante lettera letta in aula alla Camera da un
presidente Napolitano con la voce rotta. Pessima abitudine dello storico di
stralciare un caso come fosse un unicum del panorama, quando invece proprio quel
caso clamoroso è la spia di quel che è successo in generale. Come fatto politico
e storico.
Il Pd, erede degli
antenati Pci, Pds, Ds, proprio perché uscito quasi indenne dal “golpe” grazie
all’alleanza strategica con i pubblici ministeri, dovrebbe evitare prima di
tutto di mostrare paura di quella Commissione. Quella delle facce impietrite
di Occhetto e D’Alema quando Bettino Craxi denunciò nell’aula di Montecitorio
l’esistenza di bilanci falsi dei principali partiti. Facce impietrite e bocche
ammutolite. E dovrebbe poi domandarsi, anche alla luce della
propria “normalità” nel finire oggetto, o a volte preda, di una certa voracità
giudiziaria che dal 1992 non è mai tramontata nonostante il terremoto che ha
distrutto il Csm e la Procura di Milano, perché non ha colto l’occasione di fare
propria una cultura riformatrice e costituzionale. Di fare della separazione tra
i poteri la propria bandiera. Di esibire con orgoglio, quasi con spavalderia, la
giustizia sociale anche come luogo dei diritti e delle garanzie, prime tra
tutte, quella della libertà e del principio dell’habeas corpus.
Invece di
scandalizzarsi se al fianco di uno stimato garantista come Nordio, sia nella
difesa dei referendum sulla giustizia che nel suo programma di governo, ci siano
gli uomini di Berlusconi e in parte anche quelli di Salvini e Meloni, si
domandino le donne e gli uomini eredi di Berlinguer perché non ci sono loro.
Perché prima si siano fatti tenere per mano dai pubblici ministeri e poi dai
seguaci di Travaglio. Si diano una risposta decente, poi votino per la nascita
della Commissione su tangentopoli, e ne rivendichino la Presidenza. Questa è la
strada anche per affrontare momenti difficili come questo nato al Parlamento
europeo.
Tiziana Maiolo.
Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella
XI, XII e XIII legislatura.
Dal
centrosinistra a Tangentopoli. Ecco i “testimoni” di Ugo Intini…L’ex
dirigente del Partito socialista racconta in un bel saggio l’ascesa e la morte
della prima Repubblica. Francesco Damato su Il Dubbio il 13 novembre 2022.
Come gli è capitato
di fare nel 2014 con una bella e orgogliosa storia del
suo Avanti!, intrecciandola in 754 pagine con
quella dell’Italia della Monarchia e della prima Repubblica, praticamente
ghigliottinata dalla magistratura a mani cosiddette pulite, così Ugo Intini –
che nel quotidiano socialista ha percorso tutta intera la carriera
giornalistica, da redattore a direttore- ha fatto con i suoi Testimoni di un
secolo, ancora fresco di stampa, edito da Baldini+Castoldi.
In 684 pagine
scritte – come gli ha riconosciuto sul Sole- 24 Ore Sabino Cassese “in maniera
avvincente, con verve e acume, grande attenzione per i particolari” ha
ripercorso la storia del Novecento, non solo italiano, attraverso 48
protagonisti sistemati in una metaforica galleria di ritratti. Protagonisti – ha
avvertito Cassese – “oltre a comprimari e l’autore del libro, auctor e agens”.
Del Psi del garofano
guidato da Bettino Craxi all’insegna dell’autonomia e del riformismo Intini non
è stato solo un dirigente, e portavoce del segretario, ma anche un ispiratore:
per esempio, con il suo saggio, a quattro mani col compianto Enzo Bettiza, sulla
compatibilità fra liberali e socialisti. Era il lib-lab.
Dal centro- sinistra
col trattino degli anni sessanta, che si diede come segno distintivo i liberali
sostituti al governo dai socialisti, si passò negli anni Ottanta, con Craxi in
persona a Palazzo Chigi, al centrosinistra senza trattino – il famoso
pentapartito – comprensivo dei liberali. Fu un’evoluzione pragmatica e
ideologica al tempo stesso.
Vi confesso che la
prima cosa che sono andato a cercare nella galleria dei ritratti del mio
amico Ugo è stata la parte relativa alla tragedia di Tangentopoli gestita
giudiziariamente, mediaticamente e politicamente in modo che diventasse una
tragedia soprattutto socialista, pur essendo arcinota la diffusione generale del
finanziamento illegale dei partiti, all’ombra di una legge a dir poco ipocrita
sul loro finanziamento pubblico. Che stanziava a questo scopo meno della metà di
quanto si sapeva che essi costassero.
Mi ha sorpreso, in
verità, una certa comprensione di Intini verso Oscar Luigi Scalfaro, eletto
al Quirinale nel 1992, cioè all’alba già avanzata di Tangentopoli, grazie alla
preferenza del Pds- ex Pci rispetto alla candidatura del laico Giovanni
Spadolini, ma grazie anche, o ancor più, all’assenso dei socialisti.
Che fu motivato – ha
spiegato Intini- dalla fiducia che Scalfaro da ministro dell’Interno di Craxi si
era guadagnato tirando fuori dagli archivi del Viminale e dintorni un documento
che confermava la convinzione dei socialisti, a cominciare dallo stesso Intini,
che il nostro comune amico Walter Tobagi, del Corriere della Sera, fosse stato
assassinato da aspiranti brigatisi rossi il 28 maggio 1980 per negligenza anche
degli apparati di sicurezza della Repubblica. Ai quali era stato segnalato in
tempo il progetto quanto meno di rapirlo.
Scalfaro che,
consultando inusualmente nella crisi d’inizio della nuova legislatura anche il
capo della Procura di Milano, rifiutò a Craxi il ritorno a Palazzo Chigi pur
proposto dalla Dc di Arnaldo Forlani e dagli altri alleati, secondo Intini “ebbe
certamente un ruolo nel salvare il salvabile” in quegli anni terribili.
Anche se poi,
“almeno sul piano economico – ha aggiunto Intini– il merito è andato al
governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi”, mandato da Scalfaro a
Palazzo Chigi nel 1993.
Ho storto il muso
pensando a quanto quel rifiuto di Scalfaro di conferirgli l’incarico nel 1992
avesse indebolito Craxi nella caccia al “cinghialone”, come lo chiamava il
magistrato simbolo dell’inchiesta Mani pulite: Antonio Di Pietro. Poi ho capito
l’illusione procurata da Scalfaro a Intini con una difesa dei partiti espressa
con queste parole “Demonizzarli, criminalizzarli è terribilmente pericoloso,
poiché senza partiti non c’è democrazia”.
“Credevamo che
questo fosse un argomento decisivo”, ha scritto Intini al plurale. “Ma ci
sbagliavamo di grosso”, ha aggiunto, “perché non sapevamo che sarebbero arrivati
i grillini a teorizzare la democrazia diretta, a individuare i parlamentari come
il vertice della casta e a imporre a titolo punitivo e simbolico il taglio”.
No, Ugo, prima ancora dei tagli grillini al Parlamento abbiamo avuto in Italia
la demonizzazione dei partiti temuta sì da Scalfaro ma da lui non contrastata, o
non contrasta a sufficienza.
I ricordi di Di
Pietro sull’intreccio tra Tangentopoli e Cosa Nostra.
SENTENZA DELLA CORTE
D'APPELLO su Il Domani il 04 novembre 2022
Di Pietro ha
ricordato che Borsellino anche in occasione dei funerali di Falcone gli aveva
manifestato la piena convinzione che le indagini che avessero accertato il ruolo
di Cosa nostra nella gestione degli appalti e nella spartizione delle relative
tangenti pagate dagli imprenditori avrebbero consentito di penetrare nel cuore
del sistema di potere e di arricchimento di quell’organizzazione.
Su Domani prosegue
il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina.
Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in
collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi
stralci delle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo sulla
trattativa stato-mafia.
Il senatore Di
Pietro, sulla cui deposizione si tornerà in prosieguo per gli spunti che ha
offerto alla riflessione sui temi di questo processo, ha confermato che le
indagini della procura di Milano su vicende di corruttela politico-affaristica
che investivano alcuni dei più grossi gruppi imprenditoriali nazionali portavano
(anche) in Sicilia. Così come la ricostruzione di flussi di denaro provento di
tangenti a politici, conduceva a conti di comodo (prevalentemente in banche
svizzere) da cui poi partivano ulteriori flussi verso altri conti nella
disponibilità di faccendieri e personaggi legati ad ambienti mafiosi.
Ma non appena
imprenditori e funzionari d’impresa che facevano la fila davanti alla sua stanza
in procura, mostrandosi disponibili a collaborare alle inchieste, venivano
invitati a parlare degli appalti in Sicilia, ecco che si trinceravano dietro un
assoluto silenzio. E questo muro di omertosa reticenza s’implementò
sensibilmente dopo Capaci e ancor più dopo via D’Amelio.
Alla fine, il pool
di Mani Pulite riuscì, grazie alla mediazione del procuratore di Milano Borrelli
e del nuovo procuratore di Palermo Caselli (ma siamo già nella prima metà del
1993), a coordinare le proprie indagini con quelle istruite dall’omologo ufficio
palermitano sulla base di un riparto di competenze che valse a sciogliere il
grumo di reticenze degli imprenditori del nord che avevano fatto affari in
Sicilia, spartendosi gli appalti con cordate di imprese locali più o meno vicine
o contigue a Cosa nostra e con la mediazione di faccendieri o imprenditori
collusi (e che ottennero in pratica di continuare ad essere processati a Milano,
per connessione con i reati di ordinaria corruzione/concussione ivi commessi;
mentre i loro correi per gli affari in Sicilia venivano processati per il reato
di cui all’an. 416 bis).
Insomma, nel sistema
verticistico e unitario di gestione illecita degli appalti in Sicilia era
risultato a vario titolo coinvolto il Gotha dell’imprenditoria nazionale; e Cosa
nostra era proiettata a giocare un ruolo preminente in questo sistema: cosa che
in effetti avvenne negli anni successivi, come i processi del filone mafia e
appalti avrebbero poi dimostrato.
Ebbene, di queste
problematiche Antonio Di Pietro aveva parlato con il dott. Borsellino — che si
onorava della sua amicizia, come lo stesso magistrato ucciso aveva dichiarato in
un’intervista pubblicata sul Venerdì di Repubblica del 22 maggio 1992: v. infra
- e insieme avevano deciso di rivedersi per definire un programma di lavoro
comune che assicurasse un proficuo coordinamento di indagini che apparivano
sempre più strettamente collegate, come accertato già nel proc. Nr. 29/97
R.G.C.Ass. “Agate Mariano+26”: «Il senatore Di Pietro ha ricordato che
Borsellino anche in occasione dei funerali di Falcone gli aveva manifestato la
piena convinzione che le indagini che avessero accertato il ruolo di Cosa nostra
nella gestione degli appalti e nella spartizione delle relative tangenti pagate
dagli imprenditori avrebbero consentito di penetrare nel cuore del sistema di
potere e di arricchimento di quell’organizzazione. Ha altresì riferito il teste
che mentre a Milano e nella maggior parte del territorio nazionale si stava
registrando in misura massiccia il fenomeno della collaborazione con la
giustizia di molti degli imprenditori che erano rimasti coinvolti nel circuito
tangentizio, ciò non si era verificato in Sicilia e Borsellino spiegava tale
diversità con la peculiarità del circuito siciliano, in cui l’accordo non si
basava solo due poli, quello politico e quello imprenditoriale, ma era
tripolare, in quanto Cosa nostra interveniva direttamente per gestire ed
assicurare il funzionamento del meccanismo e con la sua forza di intimidazione
determinava così l’omertà di quegli stessi imprenditori che non avevano, invece,
remore a denunciare l’esistenza di quel sistema in relazione agli appalti loro
assegnati nel resto d’Italia. Intenzione di Borsellino e Di Pietro era quella di
sviluppare di comune intesa delle modalità investigative fondate anche sulle
conoscenze già acquisite, per ottenere anche in Sicilia i risultati conseguiti
altrove. E Borsellino stava già traducendo in atto questo progetto, come
dimostrano le dichiarazioni rese dai predetti testi Mori e De Donno, che hanno
riferito di un incontro da loro avuto con Borsellino il 25 giugno 1992 presso la
Caserma dei Carabinieri Carini di Palermo».
IL SISTEMA DEGLI
APPALTI E LA MAFIA
In effetti, il
peculiare ruolo di Cosa nostra nella gestione illecita degli appalti in Sicilia
sarà messo a fuoco quando le risultanze dell’originario proc. nr. 2789/90 N.C. a
carico di Siino Angelo e altri saranno integrate con le rivelazioni di quei
collaboratori di giustizia che avevano acquisito — sul campo — una vera e
propria specializzazione nel settore degli appalti pubblici.
Si accerterà così
che Panzavolta, Bini, Visentin e Canepa, ossia il management delle varie società
del Gruppo Ferruzzi consociate della Calcestruzzi Spa di Ravenna per anni si
erano prestati a fare affari con imprenditori siciliani che erano l’interfaccia
del gruppo mafioso egemone.
In particolare, i
Buscemi di Boccadifalco (Salvatore e Antonino) erano tra gli esponenti mafiosi
più vicini a Riina, e da soli non avrebbero avuto, per quanto influenti, la
forza di imporsi all’attenzione di uno dei gruppi imprenditoriali più importanti
dell’economia nazionale, fino a costituire una sorta di monopolio nel settore
degli appalti di grandi opere e nella produzione e fornitura di calcestruzzi. La
loro ascesa fu sponsorizzata dai vertici di Cosa nostra, nell’ambito di un
sistema che finì per ridimensionare e poi emarginare lo stesso Siino Angelo,
confinato nei limiti della “gestione” di appalti di dimensioni medio-piccole,
ossia per importi inferiori a 5 mld. di lire (e su base provinciale: gli appalti
banditi dall’amministrazione provinciale di Palermo: cfr. Brusca e Siino).
Ma è la grande
impresa italiana a fare affari in Sicilia con Cosa nostra, attraverso cordate di
imprenditori collusi o compiacenti verso le imprese mafiose.
E tale sistema, i
cui prodromi s’intravedono sullo sfondo delle prime inchieste del filone mafia e
appalti come quella compendiata nel rapporto del Ros depositato il 20 febbraio
1991 era già giunto a piena maturazione quando si apre la stagione delle stragi,
ma era proseguito anche oltre: come accertato, tra gli altri, nel proc. nr.
1120/97 n.c.- Dda, istruito dalla Dda di Palermo a carico di Buscemi Antonino,
Bini Giovanni, Salamone Filippo, Micciché Giovanni, Vita Antonio,
Panzavolta Lorenzo,
Canea Franco, Visentin Giuliano, Bondì Giuseppe, Crivello Sebastiano per i reati
di associazione mafiosa, turbativa d’asta e illecita concorrenza con violenza e
minaccia (e per fatti commessi fino a tutto il 1991, e anche negli anni
successivi. Procedimento che, avvalendosi delle propalazioni di Angelo Siino,
che nel frattempo si era determinato a collaborare con la giustizia, si
profilava quale naturale prosecuzione e sviluppo di quanto emerso già in altri
procedimenti nell'ambito delle indagini relative all'illecita aggiudicazione di
appalti pubblici ed allo strutturato sistema di controllo degli stessi da parte
dell'associazione per delinquere di tipo denominata Cosa nostra. SENTENZA DELLA
CORTE D'APPELLO
Giustizia fanta-horror. Il
reato di lesa maestà di Mani Pulite e la libertà di parola di chi non è
magistrato.
Carmelo Palma su L'Inkiesta il 31 Ottobre 2022
Tre ex pm si sono offesi per
un articolo di giudizio storico-critico sul carattere eversivo della cultura di
Tangentopoli, ma in passato uno di loro non si è fatto problemi con i
parlamentari della Bicamerale
È passato quasi un quarto di
secolo, ma molti ancora ricordano l’intervista di Gherardo Colombo a Giuseppe
d’Avanzo sul Corriere della Sera del 22 febbraio 1998, in cui il pm della
procura milanese fece esplodere una vera e propria bomba sotto il tavolo della
Commissione Bicamerale per le riforme presieduta da Massimo D’Alema.
La tesi sostenuta da Colombo
era che la riforma della Repubblica, cui la Commissione stava mettendo mano,
fosse figlia della “società del ricatto” che univa in un patto occulto forze
politiche e organizzazioni criminali e dunque che il tentativo di riscrivere la
seconda parte della Costituzione, facendo una serie di riforme in materia di
giustizia, rispondesse alla necessità di quella “società” di occultare gli
scheletri del passato. «La nuova Costituzione può avere come fondamento quel
ricatto».
A D’Avanzo, che gli chiese
esplicitamente se intendesse la Bicamerale come «la strada obbligata per chi,
partecipe degli illeciti di ieri, oggi è obbligato a scegliere l’accordo»,
Colombo rispose in modo molto sincero: «È detto in modo un po’ brutale, ma è
quel che penso. Ecco perché, a mio avviso, la Bicamerale deve anche affrontare
la questione della giustizia».
Non ricordo tutto questo per
discutere se abbia qualche pregio o fondatezza storica la tesi di Colombo sul
filo rosso criminale che legava la mediazione della mafia per facilitare lo
sbarco degli alleati in Sicilia nel 1943, la trattativa con la camorra per la
liberazione di Ciro Cirillo, i fondi neri dell’Iri e la P2 alla proposta di
separazione delle carriere dei magistrati inutilmente negoziata nella Bicamerale
D’Alema. La cosa che mi interessa rilevare è che questi addebiti oggettivamente
pesantissimi non solo rispetto al sistema dei partiti, ma soprattutto rispetto
ai membri della Bicamerale chiamati ad attuare, per così dire, l’estorsione
criminale trasfigurandola e sigillandola in innovazione costituzionale, fossero
da Colombo presentati come un fattivo contributo alla discussione: «Le
mie considerazioni non vogliono (come è ovvio) e non potrebbero (come è giusto)
condizionare il lavoro del Parlamento nella riscrittura della seconda parte
della Costituzione. Le mie sono soltanto osservazioni di carattere generale sul
tema della giustizia e dei modi di amministrarla».
Malgrado le polemiche
politiche, gli imbarazzati distinguo dell’Associazione nazionale magistrati e
l’avvio di un’azione disciplinare, da cui Colombo uscì prosciolto, sul
presupposto che si trattasse di opinioni compatibili con il suo ufficio di
magistrato, la cosa che ai nostri fini importa è che Colombo non fu mai
processato né condannato per avere calunniato o diffamato i parlamentari della
Bicamerale, né i vertici politici impegnati a trovare un accordo dettato dalla
“società del ricatto”.
Allora perché Colombo, insieme
a due ex colleghi del pool milanese, Davigo e Ramondini, si è sentito
personalmente diffamato da un articolo di Iuri Maria Prado su Il Riformista che
descrive l’epopea di Mani Pulite, a partire dalla stessa denominazione, come una
pagina di «terrore giudiziario… civilmente osceno e democraticamente blasfemo» e
dichiara che la «cultura di Mani pulite, la brutalità proterva dei suoi modi e
la buia temperie che li festeggiava furono e rimangono la vergogna della
Repubblica», e che «svergognata» è la magistratura «che ne rivendica la
paternità»? Un giudizio storico-critico sul carattere eversivo della cultura di
Mani Pulite è più penalmente sensibile di un giudizio escatologico sulla
trappola criminale che imprigionava la Bicamerale?
Dopo la querela presentata dai
tre (due ex) magistrati, la Procura di Brescia, territorialmente competente,
aveva chiesto l’archiviazione per Prado, sulla base del pacifico presupposto che
il diffamato non è chi si senta offeso, in quanto parte di una categoria o di un
gruppo sociale, dalle parole di qualcuno, ma quello cui la presunta offesa sia
personalmente e inequivocabilmente rivolta. Insomma, Prado, chiamando in causa
in quei termini l’esperienza di Mani Pulite non ha diffamato i membri del pool
più di quanto Colombo un quarto di secolo fa avesse diffamato i membri della
Commissione Bicamerale o i segretari e i dirigenti dei partiti del tempo,
dicendo che la riforma costituzionale in preparazione era figlia di un ricatto
criminale. Con una differenza rilevante: che Prado, diversamente da Colombo, non
si è mai riferito a questo o quello specifico atto di ufficio di questo o quel
magistrato, ma al clima e alla cultura del tempo e ai pubblici atteggiamenti di
chi, fuori e dentro la magistratura, vi operava.
Il Gip di Brescia, contro la
richiesta del pm, ha invece disposto l’imputazione coatta di Prado ritenendo che
il combinato disposto della dicitura “Mani pulite” contenuta nel titolo (non
scelto dall’autore) e nel testo dell’articolo, il riferimento al «manipolo
meneghino di pubblici ministeri» e un’immagine di repertorio usata dal giornale
a corredo dell’articolo (non scelta dall’autore), relativa a uno dei tre
querelanti, cioè Colombo (l’unico citato per nome da Prado come «ottima
persona»), permettano «in termini di ragionevole certezza di individuare in modo
inequivoco i destinatari delle affermazioni diffamatorie negli odierni
querelanti». In modo inequivoco, eh!
Il Gip inoltre qualifica come
in sé diffamatorio il riferimento a una «eversione giudiziaria organizzata»
(anch’esso si suppone inequivocabilmente riservato ai tre querelanti)
interpretando il termine “eversione” in un senso tecnico-criminale, e non nello
stesso senso figurato e iperbolico per cui è consentito da decenni agli esimi
rappresentanti della magistratura italiana – querelanti compresi – di
qualificare come eversive o direttamente piduiste alcune proposte di riforma
della giustizia, partendo – visto che tutto torna? – dalla separazione delle
carriere di magistrati.
Peraltro, per chi avrà la
pazienza di leggerlo, risulterà chiaro che nell’articolo di Prado l’eversione
contestata alla cultura di Mani Pulite riguarda soprattutto la proiezione
extra-giudiziaria dei magistrati militanti e televisivi e la loro sinistra
postura da soprastanti del potere politico-legislativo e da Consiglio dei
Guardiani della morale della Repubblica.
L’articolo di Prado parla
insomma di una temperie storica isterizzata e fanatizzata, di uno spirito
pubblico avvelenato, di una cultura del chiedere e del fare giustizia che ha, a
parere dell’autore e pure modestamente dello scrivente, irrimediabilmente
corrotto la nozione e pervertito il funzionamento del sistema penale.
Non addita le responsabilità
di nessuno, ma chiama in causa quelle di tutti (non dei soli magistrati), in
quella gigantesca autobiografia nazionale che si iniziò a scrivere nei corridoi
delle procure, dilagò nelle piazze delle monetine contro il delinquente del
Raphael che doveva marcire nelle patrie galere e infine giunse, con il maiosmo
politico-giudiziario del Movimento 5 stelle, ad accomodare i peggiori e ultimi
epigoni della retorica manipulitista ai vertici dello Stato.
Prado scrive di tutto questo
nello stesso modo risentito e scandalizzato con cui il “diffamato” Colombo un
quarto di secolo prima faceva requisitorie in prima pagina, senza paura di
scandalizzare e di diffamare (e senza timore di querele, ipotizziamo),
sull’Italia della Bicamerale.
Il processo che si chiede
contro Prado ha quindi molteplici profili di interesse e altrettanti di allarme.
Sarà interessante verificare se per il giudice di Brescia la libertà di parola,
di iperbole e di metafora dei non magistrati sia almeno pari a quello dei
magistrati e se la diffamazione “categoriale” valga solo per questi ultimi o
magari anche per i politici o per i giornalisti o (Prado non è né un politico,
né un giornalista) per i cittadini civilmente impegnati, così da aprire nuove e
funeste pagine di giurisdizione fanta-horror.
Ma questo processo sarà anche
interessante per capire se quelle cartelline “per una serena vecchiaia”, in cui
Davigo dice di collezionare le querele e le richieste di risarcimento per le
diffamazioni a mezzo stampa, interesseranno anche quella parte dell’informazione
italiana che le querele da Davigo proprio non le rischia, ma farebbe bene
comunque a preoccuparsene. Infatti a funzionare come “querele bavaglio”, con un
effetto, neppure con un proposito, intimidatorio, non sono solo le querele
minacciate dai politici – si pensi al notissimo e recentissimo caso del Ministro
Crosetto – ma, da parecchi anni, anche quelle largamente dispensate dai
magistrati a chiunque metta in dubbio la maestà delle loro persone o
addirittura, come in questo caso, del fenomeno storico-politico di Mani Pulite.
Francesco Melchionda
per perfideinterviste.it il 27 luglio 2022.
“Vuoi pure queste, Bettino,
vuoi pure queste…” Era il 30 aprile del Novantatré, l’Italia sull’orlo del
precipizio, e Craxi, il capro espiatorio di ogni male italicus. Quella sera,
quando il corpo imponente di Bettino lasciò l’hotel Raphael, a pochi passi da
piazza Navona, nel cielo già terso e primaverile della Capitale, il grido dei
manifestanti divenne feroce.
Avevo 13 anni, e a cena il
nonno, vedendo le immagini mandate in onda da mamma Rai, non la smetteva di
dire: ma che sta succedendo a Roma? Capivo nulla di politica, ma quelle urla,
quelle monete sonanti che volavano sulla testa e sul corpo del gran capo
socialista, mi rimasero impresse. Anche dalla provincia povera e, per certi
versi, ignorante e retrograda, si capiva che la slavina stava prendendo forza e
velocità e che avrebbe travolto la vecchia politica e tutti i mammasantissima
del Palazzo.
A distanza di quasi
trent’anni, sembra tutto sbiadito, per certi versi evaporato. La storia ha preso
il sopravvento sulla cronaca. I politici della Prima Repubblica morti e sepolti
e dimenticati. I partiti? Liquefatti. Le sezioni? Chiuse per sempre.
In un Paese che non ha mai
amato coltivare il vizio del ricordo, qualcuno, però, ancora si ostina a
lucidare la recente storia patria…
E così, in un sabato torrido,
decido di lasciare la canicola e la sporcizia romane, per salire dalle parti di
Orbetello, e raggiungere il buen ritiro di Stefania Craxi, la vera combattente
della famiglia.
A pochi metri dalla sua
dimora, la sinistra borghese e noiosa, quella che si dà di gomito nei premi
letterari e nelle stanze del potere capitolino, è sdraiata all’Ultima Spiaggia
di Capalbio.
La chiacchierata comincia
quasi con una colazione e finisce a pranzo.
Stefania Craxi non ha il viso
pacifico, e pacificato, anzi. Quando i ricordi, ineluttabili, salgono su, fin
negli anfratti più resistenti e respingenti della memoria, si rabbuia. I segni
del dolore e della rabbia sono palmari, nonostante il sorriso contagioso.
Con Tangentopoli – o la “falsa
rivoluzione”, come l’ha più volte definita – Stefania Craxi non ha smesso di
fare i conti, anzi. Appena può, prova a richiamare tutti alle loro
responsabilità; appena può, rispolvera e riapre il vaso di Pandora, con i
tradimenti, le colpe, le dimenticanze, le prese di distanze, di tutti, o quasi:
socialisti, comunisti, democristiani, giudici e giornalisti…
Ripensando al suo j’accuse,
una domanda, nei giorni successivi, mi ha accompagnato: riuscirà la Storia, una
volte per tutte, e senza gli occhiali della ideologia, a chiarirci chi è stato
veramente Bettino Craxi, e cosa ha rappresentato per il nostro Paese…?
Stefania, cominciamo subito
questa intervista con il botto: dov’era la sera del 30 aprile 1993, quando suo
padre Bettino fu subissato di monetine dinanzi all’hotel Raphael?
Purtroppo non ero con lui, non
mi trovavo a Roma, ma quella sera me la ricordo perfettamente. Ero a letto, a
casa, perché incinta della mia terza figlia; una gravidanza che mi stava dando
non pochi problemi. In serata, all’ora di cena, accendo la tivù e leggo sul
Televideo di questo episodio assurdo, barbaro, un’aggressione squadrista, come
l’avrebbe definita lui stesso.
A Giuliano Ferrara, che lo
intervista poco dopo, in quello stesso pomeriggio, nel suo programma
L’Istruttoria, e che gli chiede se ha avuto paura, Craxi risponde che no, non ha
avuto paura, che ha provato solo vergogna per loro.
E nonostante il suggerimento
degli uomini della sicurezza, che lo invitano a uscire dal retro, Craxi decide
di varcare il portone principale del Raphael, si infila in macchina, alza lo
sguardo fiero. Alle 10 della sera, riesco finalmente a sentirlo; mi trova
scossa, turbata, in lacrime. Stefania, mi dice, ricordati che una Craxi non
piange. Il suo messaggio era chiaro: sei nata in una famiglia politica, quella
politica che ha a che fare con la vita e con la morte, devi saper affrontare i
momenti difficili che verranno.
Che emozioni provò?
Rabbia, impotenza, un senso di
ingiustizia, rammarico, forse, per non essere stata lì con lui.
Che bambina era?
Una bambina che ha amato
trascorrere tanto tempo con suo padre…
Addirittura.
Da bambina, capii una cosa
importantissima: se volevo relazionarmi con lui, dovevo imparare, e in fretta,
il linguaggio della politica. Per questo amavo ascoltarlo tantissimo. Il fine
settimana, quando tornava da Roma, io non uscivo con i miei amici fino a quando
non capivo che mio padre non mi avrebbe portato con sé. Sentivo il respiro della
Storia. Ma ricordo anche momenti intimi, per esempio, quando prendevamo la
metropolitana e andavamo a San Siro, a vedere le corse dei cavalli.
Perché suo padre scelse di
vivere in un albergo?
Non lo considerava un albergo:
era di proprietà di uno dei suoi più cari amici, Spartaco Vannoni, personaggio
straordinario e uomo coltissimo. Era stato in passato una spia della Stasi, poi
divenne anticomunista. Mio padre ha sempre ritenuto Roma una città provvisoria,
di passaggio, per la sua vita. E anch’io, in realtà, quando scendevo a Roma,
consideravo il Raphael una seconda casa.
Quando le capita di passargli
vicino, cosa prova?
Faccio fatica a spingermi fino
a largo Febo, i ricordi e le emozioni si rincorrono velocemente, sono ancora
molto forti. Oggi, poi, essendo stato ristrutturato, la stanza di papà non c’è
più. Una volta, ricordo, ebbi uno scontro con Filippo Ceccarelli, il quale,
dalle colonne di Repubblica, scrisse che la camera di mio padre fosse lussuosa.
Ma era vero l’esatto contrario. Possibile, gli dissi, che a nessuno dei
giornalisti di Repubblica sia mai venuto in mente di intervistare Craxi nella
sua camera? Solo Giampaolo Pansa, dalle pagine di Libero, rispose dandomi
ragione.
Ha mai provato a mettersi nei
panni e nella testa di quelli che lanciarono le monetine? Non erano mica tutti
facinorosi e pazzi… Lei, giustamente, pensava alle sorti di Bettino, loro,
invece, al bottino e alle mazzette che, ogni giorno, spuntavano fuori.
La campagna mediatica fu
violenta, mistificatoria, denigratoria, e non stento a credere che le persone
comuni possano avere creduto in toto a quello che leggevano sui giornali. Una
cosa, però, ancora me la chiedo: perché da destra mi hanno chiesto scusa, e da
sinistra ancora no? I leader della sinistra dovrebbero porsi una domanda: come
mai l’elettorato socialista è confluito tutto nel centro-destra?
Lo faranno, secondo lei?
Finché c’è vita, c’è
speranza…
Che fine ha fatto il tesoro
del partito socialista? L’ha mai chiesto a suo padre?
Mio padre non si occupava
della gestione amministrativa del Psi. In quel periodo ce n’erano tanti, di
conti; e ogni corrente poteva disporre di denaro; qualcuno, probabilmente, sarà
sparito, altri, invece, riposano in qualche banca, chissà.
È stato un grave errore quello
di aver lasciato fare… Un segretario di partito non può lasciare che fiumi di
denaro scorrano senza lasciare tracce, senza controllo. È d’accordo?
Le rispondo con le parole che
Bettino Craxi consegnò a Sergio Zavoli, che lo andò a intervistare ad Hammamet:
''Io, probabilmente, ho sopravvalutato il mio ruolo, la mia personalità, la mia
capacità di tenere in mano, saldamente, le cose…C’erano circostanze di cui avevo
perso completamente il controllo…Erano situazioni che andavano degenerando, a
volte infracidendo''.
Martelli ha dichiarato
pubblicamente di aver restituito la bellezza di 550 milioni di lire, e suo
padre, invece, no…
Perché non è stato chiesto ai
prefetti di Milano, che non potevano non saperlo, qual era il tenore di vita di
Craxi e dei suoi familiari? Mia madre, con il marito presidente del Consiglio,
andava in Corso Vercelli a fare la spesa in tram. Mio padre non possedeva tutti
quei soldi. Cosa avrebbe dovuto restituire? Tutti sapevano che Craxi aveva uno
stile di vita per nulla sfarzoso e, del resto, sarebbe bastato chiederlo agli
uomini della sua scorta, che gli stavano accanto 24 ore su 24.
Perché non ha mai sopportato
Martelli? Eppure era la punta di diamante del partito… Era invidiosa della sua
brillantezza, intelligenza, dell’ascendente che aveva su suo padre?
Stimo Martelli per la sua
intelligenza e per la capacità di analisi politica che ancora oggi farebbe bene
a questo Paese. Ma a Claudio ho sempre detto, guardandolo negli occhi, che ha
commesso un grandissimo errore, umano prima ancora che politico, ad abbandonare
il segretario nel momento peggiore, quando il Psi stava fronteggiando l’avanzata
di truppe assedianti, quelle giudiziarie e quelle mediatiche in primo luogo.
Una volta ha detto: senza mio
padre, Amato sarebbe ancora un professore universitario. Che cosa le ha fatto il
dottor Sottile? Lo reputa vigliacco, fariseo, arrivista?
Giuliano Amato è un uomo di
grande esperienza, non gli mancano né le qualità e neppure l’intelligenza. E
infatti è stato uno degli uomini più vicini a Craxi, suo sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, nonché fra i massimi dirigenti del partito,
commissario del Psi a Torino o a Milano quando scoppiava qualche grana.
Dopodiché pongo una domanda: come mai il vice di Craxi viene periodicamente
indicato come potenziale candidato alla presidenza della Repubblica, mentre mio
padre dovette seguire la via dell’esilio? O sono manigoldi entrambi o entrambe
sono delle brave persone…
E De Michelis?
Gianni è stato un politico di
grande statura, un uomo di profondo spessore culturale, capace di anticipare con
le sue analisi alcune delle dinamiche geopolitiche che avremmo vissuto negli
anni successivi. E fu una persona vera; quando mio padre morì, le sue lacrime
furono vere…
Quante lacrime di coccodrillo
ha visto cadere alla morte di Craxi?
Tante, tantissime…
Ci faccia qualche nome.
Beh, tutti quelli che, per
esempio, non sono mai venuti ad Hammamet.
Chi erano le troie di regime,
per dirla con De André, che affollavano le cene e i congressi? Se le ricorda?
I congressi, e poi l’Assemblea
Nazionale del Psi, rappresentano il primo tentativo di aprirsi alla società
civile, parola, oggi, tanto abusata. Le ricordo alcune delle figure presenti:
Strehler, Francesco Rosi, Portoghesi, Treu, Pera, Veronesi, Gassman. Ci sono
stati i nani e le ballerine? Ma sicuramente… Vogliamo definire Sandra Milo una
ballerina? Facciamolo pure, ma è stata una grandissima attrice! E Lina
Wertmuller? Vuole che continui…?
Chi sono stati, invece,
politicamente parlando, i nani socialisti?
Il socialista più nano sapeva
suonare il violino con la punta dei piedi, altroché! La classe dirigente
socialista, senza dimenticare quella locale, era composta da gente di
prim’ordine…
Come reagì, sua madre, quando
si venne a sapere che suo padre aveva un’amante?
A mio padre le donne
piacevano, e lui piaceva loro, perché è sempre stato un uomo di grande fascino e
carisma… Mamma, quando seppe delle fughe amorose di mio padre, ha messo in campo
una capacità di comprensione e perdono che ancora le invidio.
Pensò di mollarlo?
Assolutamente no! E men che
meno lui. Era facile sedurlo, difficile tenerlo. Ci è riuscita solo mia madre.
E lei, invece?
Ero gelosissima; appena
potevo, cercavo di fargli terra bruciata, confondendo, a dire il vero, un po’ i
ruoli. Una volta, ora che ci penso, strappai un orecchino a una sua fiamma…
Quali sono state, secondo lei,
le colpe che suo padre ha commesso?
Pensare che i comunisti
potessero cambiare; e dare fiducia a uomini che non la meritavano affatto…
Tipo?
Fare sempre i nomi non è
gradevole. Sa, lui aveva una giustificazione per tutto. Quando qualcuno
sbagliava, o lo tradiva, diceva sempre: poverino. Aveva sempre un atteggiamento
giustificatorio verso le debolezze umane. Una volta, me lo ricordo come fosse
ora, arrivò un caporedattore dell’Avanti, tutto trafelato e contento, e gli
disse:
Bettino, ho scoperto che
alcuni giornalisti dell’Avanti sono a libro paga del Kgb. Mio padre, senza
scomporsi, gli rispose: questo ha una brutta malattia, quest’altro ha un mutuo
sulle spalle, quest’altro ancora ha quattro figli da mantenere… Cambierà la
storia del mondo se li metto da parte? Lasciamoli stare… Ogni tanto, ho provato
a fargli cambiare idea, ma lui niente: mi diceva che ero una bacchettona… Il
tempo, però, mi ha dato ragione.
Come venne a sapere che suo
padre si sarebbe dato alla latitanza? Ne era a conoscenza?
Mio padre non si è dato alla
latitanza…
Ma come, uno che scappa, come
la vuole chiamare…? Viaggio Alpitour?
Mio padre è andato in Tunisia,
a casa sua, con il suo passaporto…
Tecnicamente, e non solo, si
chiama latitanza…
I giudici, tecnicamente, hanno
commesso un abuso; avrebbero potuto emettere un provvedimento di rimpatrio,
perché non l’hanno fatto? Tornando alla sua domanda, lui non mi disse che
sarebbe andato ad Hammamet, ma io sentivo che avrebbe lasciato l’Italia.
Temeva le patrie galere,
Bettino…?
No, non ha inteso
sottomettersi a una giustizia politica, farsi umiliare da chi lo voleva vedere
in ginocchio. Tanti politici, soprattutto quelli che si sono smarcati, farebbero
bene a rileggersi quel famoso discorso che mio padre fece alla Camera, il 3
luglio del 1992, in occasione del dibattito sul voto di fiducia al governo
Amato, che, lo voglio ricordare, non era per niente una chiamata in correità,
bensì il tentativo di affrontare con gli strumenti della politica la crisi della
Repubblica. Quell’invocazione si disperde nel silenzio dell’Aula, più eloquente
di ogni parola, denso di verità, come avrebbe commentato lo stesso Craxi.
Non pensa che, come fece anche
Andreotti, che santo di certo non era, avrebbe fatto meglio a difendersi nelle
aule giudiziarie?
Ma cosa vuol dire, per lei,
essere un santo? Lei lo è?
No, per niente, ma io non sono
un politico…
Andreotti è stato un grande
politico della Prima Repubblica, ma, a differenza di Craxi, aveva lo scudo da
senatore a vita, oltre che l’ombrello protettivo del Vaticano.
Quali giudici del Pool ha
apprezzato? Non erano perfetti, ma, di certo, ispiravano fiducia…
Se quei giudici avessero fatto
un’opera di vera pulizia e giustizia, senza scopi politici, li avrei di certo
apprezzati. Lei mi può dire perché quasi tutti hanno fatto politica? Di Pietro,
Colombo, D’Ambrosio…Non dimenticherò mai quella lettera di Borrelli, scritta in
un orrendo burocratese, indirizzata a don Verzé e agli avvocati, in cui
praticamente vietava a mio padre di curarsi in Italia. Solo D’Ambrosio, eletto
nelle file dei Ds, ammise, anni dopo, in un’intervista rilasciata al Foglio, che
la molla di Craxi era la politica, non l’arricchimento personale, che Craxi per
sé non aveva mai intascato una lira.
Come mai, se se lo è mai
chiesto, il Pci di allora fu, soprattutto nei suoi nomi grossi, salvato? Erano
meno corrotti degli altri? Cosa le disse suo padre, a tal proposito?
Lei fa confusione tra i casi
di corruzione che, disse Craxi in Parlamento, come tali vanno definiti,
trattati, provati e giudicati, e il finanziamento illegale ai partiti. Perché,
quando nel 1989 ci fu l’amnistia, votata anche dal Pci, nessuno osa aprire
bocca? Lei pensa davvero che le tangenti in Italia siano girate solo nel biennio
1992-1994? Oggi pensa davvero che la corruzione sia diminuita…?
Le rifaccio la domanda: perché
il Pci, secondo lei, è stato “salvato”?
Perché un partito di sistema
serviva per mettere in atto la falsa rivoluzione. Da dove passava gran parte del
finanziamento illegale comunista, se non dall’import-export delle Coop; e
ancora, che fine ha fatto il famoso miliardo di cui parla Gardini, portato a
Botteghe Oscure? E l’enorme flusso finanziario proveniente dall’Urss, una
potenza militare nemica dell’Italia? Ci siamo dimenticati di tutto questo?
“La politica è sangue e
merda”, disse Formica. Perché lei, nonostante le sofferenze provate e la
capitolazione invereconda di suo padre, ha deciso comunque di fare politica?
Ostinazione, vanità, follia?
Vengo da una famiglia
politica, per noi la politica è come l’acqua dove nuotano i pesci, non potevo di
certo tirami indietro. Poi volevo, dopo quello che era successo a Craxi e al
Partito socialista, provare a fare un’opera di verità e restituire a quella
storia socialista il posto giusto che merita. Da questo punto di vista, l’essere
stata eletta presidente della Commissione Esteri al Senato ha rappresentato una
piccola rivincita della storia.
Non ha mai avuto paura nel
fare politica?
Se vuoi fare politica, la
paura non può esistere nel tuo vocabolario.
Tra le tante, cosa non amava
di suo padre? L’arroganza, l’attaccamento al potere, la freddezza, la scarsa
empatia…
Mio padre non era né arrogante
né attaccato al potere. Il suo difetto più grande? Che era gelosissimo…
C’è un ricordo che non le dà
pace, di quando suo padre era ad Hammamet?
Più che un ricordo, forse il
rimpianto di non avere fatto abbastanza per la sua vita, soprattutto quando
stava male. Forse sono stata inadeguata…
Quante volte ha messo in
dubbio l’onestà e trasparenza di Bettino, soprattutto nei momenti in cui
fioccavano le inchieste?
Mai!
Quali sono i politici della
Seconda Repubblica che disprezza e perché? Le faccio dei nomi: Rutelli, Fassino,
D’Alema, Veltroni…
Intanto, la parola disprezzo
non appartiene al mio vocabolario. Direi disistima. A Rutelli ho dato del
grandissimo stronzo. Fui querelata. Sono passati vent’anni, col tempo le
arrabbiature passano e, di recente, ci siamo anche riparlati.
Ricordo che una volta, dopo
che fui condannata a pagare una multa di cinquantamila lire per l’epiteto che
gli rivolsi, mio padre commentò sarcastico che, “grazie a mia figlia, tutti
adesso sanno quanto costa dare dello stronzo al sindaco di Roma”.
Fassino, pur essendo stato un
giustizialista feroce, ha provato, a differenza di altri, a fare un po’ i conti
con la storia di Tangentopoli. D’Alema, che ci faceva la morale tutti i giorni,
in quanto ad affari, non penso debba insegnare nulla a nessuno. Veltroni,
invece, ogni tanto prova a raccontare sulle pagine del Corriere la storia a modo
suo. Ma nessuno ha ancora fatto davvero i conti con Craxi.
Come mai, secondo lei, tanti
socialisti, crollato il partito, sono finiti nelle mani di Berlusconi, che con
il socialismo non c’entrava proprio?
Anche per reazione a quello
che era successo. Una domanda che molti dovrebbero porsi! Forza Italia ha
rappresentato l’approdo naturale per sanare la ferita che era stata inferta alla
comunità socialista. O lei pensa che fosse possibile muoversi nell’alveo di
Botteghe Oscure, dove avrebbe continuato a dominare l’antisocialismo viscerale?
Lei si sente più una
socialista o una capitalista, visto il lavoro da imprenditore fatto per anni?
Io mi definisco una socialista
craxiana.
Perché suo padre volle aiutare
un parvenu come Berlusconi con quel famoso decreto? Re Silvio finanziava il
partito?
No, Berlusconi non ha mai
finanziato il partito e, soprattutto, non ha mai fatto parte dell’establishment
del Paese. Mio padre lo ha aiutato molto perché le televisioni commerciali
rompevano il monopolio della Rai. Fu quella una battaglia di libertà, per il
progresso dell’Italia.
Perché suo padre detestava i
giornalisti? Eppure, nei suoi anni d’oro, c’era la fila per leccargli i piedi…
Non è vero che li detestava,
anzi; con alcuni aveva anche ottimi rapporti personali…
Giulio Anselmi mi ha
raccontato di una telefonata furibonda di suo padre con annessa minaccia di
fargli perdere il posto…
Credo che non si apprezzassero
a vicenda. L’atteggiamento di Anselmi nei confronti di mio padre fu a dir poco
scandaloso, ma comunque Craxi non ha mai fatto cacciare nessuno.
E perché? Scandaloso perché
indipendente? Anselmi è stato uno dei pochi direttori veramente liberi…
La campagna di informazione
fatta da Anselmi e da tanti altri fu denigratoria. Lei forse l’ha dimenticato,
ma mi vengono in mente alcune prime pagine, con le pubblicazioni di
conversazioni private tra me e mio padre. Un grafico importante, tale Muzi
Falcone, colui che inventò il simbolo della Quercia, mandò una lettera ai
giornali in cui affermava che la sottoscritta fosse ricoverata in una casa di
disintossicazione…
Faceva uso di cocaina, o era
schiava della bottiglia?
Ma no! Avevano messo in giro
questa voce solo per gettarmi del fango addosso.
A proposito di grandi
direttori: cosa pensa di Scalfari?
Penso che, da un punto di
vista politico, non ne abbia azzeccata una!
Perché tra Scalfari e Craxi il
rapporto è sempre stato burrascoso?
Semplice: Scalfari imputava a
mio padre la mancata elezione a deputato, sul finire degli anni Settanta. E,
come si è potuto vedere, non gliel’ha mai perdonata.
C’era qualche giornalista,
invece, che lui stimava?
Nonostante i conflitti,
stimava molto Giampaolo Pansa, e tutti i giovani cronisti che lo seguivano nei
viaggi, penso a Massimo Franco, a Marcello Sorgi, a Paolo Mieli. Craxi amava in
modo particolare gli irregolari, i “liberi di testa”: Giampiero Mughini,
Vittorio Sgarbi, Roberto D’Agostino…
Se non erro, anche gli
stilisti, un tempo tutti socialisti, hanno abbandonato suo padre… Dico bene?
Craxi capi’ e seppe
interpretare il Made in Italy, la capacitàla laboriosità degli italiani e se ne
fece ambasciatore nel mondo. E così anche Milano soppiantò Parigi come capitale
della moda. Questo era il motivo della riconoscenza di quel mondo verso Bettino.
Mi ricordo, a onor del vero, una volta in cui Krizia sostenne di non conoscerlo
a cui rispose mia madre con una garbata lettera in cui disse che Krizia, tra gli
altri, le prestava gli abiti durante i suoi viaggi a fianco di Craxi, presidente
del consiglio, e lei aveva pensato fosse un segno di amicizia…
“Io provo un rancore tanto
grande che non ho posto per i piccoli rancori”. Mi ha incuriosito questa sua
riflessione, per certi versi amara…
Una riflessione figlia del
fatto che l’ingiustizia subìta da mio padre è talmente grande, che non riesco a
dimenticare. Ma il mio, voglio chiarirlo, è un rancore politico. Pretendo delle
scuse, in primis dalla sinistra, che, a distanza di tanti anni, ancora non ha
fatto i conti con sé stessa.
Le scuse… ma non arriveranno
mai… E’ un’illusa…
Questo lo dice lei.
Per il cognome che porta, o
che portava soprattutto quando suo padre era all’apice del potere, si è mai
sentita usata?
No, perché ho pochi amici,
quelli di sempre, quelli che non ti tradiscono mai…
Ha mai avuto paura di finire
in miseria, quando stava crollando tutto?
In miseria no, ho sempre
lavorato, ma con mio marito abbiamo passato momenti di grande difficoltà, perché
quando scoppiò Tangentopoli nessuno ci rispondeva al telefono, la nostra azienda
rischiava di fallire…
I nomi, Stefania…
Neanche sotto tortura.
Qual è stato il momento più
doloroso della sua vita?
La morte di Bettino Craxi.
Nel film su suo padre, Gianni
Amelio tratteggia suo fratello Bobo in maniera poco tenera. C’ha visto giusto…?
A naso, penso non si siano
piaciuti…
E il film, le è piaciuto?
Ad Amelio, che stimo molto
come regista, non interessava fare un film “politico”, ma tracciare un parallelo
fra la parabola di Craxi e le grandi tragedie classiche. Nel film c’è quindi
poca politica, e Craxi era un uomo “totus politicus”. Il merito della pellicola
è stato quello di avere acceso i riflettori sulla sua storia.
Al di là dell’affetto, ha
stima per la carriera di Bobo? Eppure c’è chi dice che non abbia nessuna stoffa
particolare e che senza quel cognome sarebbe stato un perfetto sconosciuto?
Penso che mio fratello abbia
fatto un grandissimo errore: quello di essere passato a sinistra, quella stessa
sinistra che il nome Craxi non l’ha mai sopportato e accettato.
Che rapporto ebbe l’Avvocato
con suo padre?
A differenza di tanti politici
di oggi, Craxi non si è mai inchinato dinanzi al gotha dell’imprenditoria, ai
santuari del capitalismo. Lo muoveva la convinzione che la politica dovesse
esercitare il primato sulla finanza e sull’imprenditoria…
Agnelli, da uomo di potere,
chiedeva continui favori a chiunque… Anche a suo padre?
Ricordo che mio padre,
commentando le assoluzioni in casa Fiat, una volta mi disse: cosa andava a fare
Romiti nell’ufficio degli amministratori dei partiti? A parlare del nuovo
modello della 500?
Cosa le disse suo padre prima
di morire? C’è un ricordo che non riesce a dimenticare?
Dopo la sua morte, trovai un
foglietto scritto a mano: “In questo processo, in questa trama di odio e
menzogne devo sacrificare la mia vita per le mie idee. La sacrifico volentieri…”
Ero lì con lui, ad Hammamet, poche ore prima che se ne andasse, e continuava a
parlare di politica e dell’Italia. Una mattina, appena sveglio, mi disse che
aveva sognato Milano, di essersi ritrovato a passeggiare in piazza Duomo. Aveva
nostalgia del suo Paese e dei tanti posti che non era riuscito a vedere. Dopo
pranzo, mi disse: vado in camera a sdraiarmi, portami un caffè. Lo raggiunsi in
stanza e lo trovai riverso sul letto, ormai privo di vita…
Chi fu il primo, dopo la sua
morte, a raggiungere Hammamet?
Yasser Arafat… E poi le
persone a me più care, compresi Casini e Follini…
Dall’Italia, invece?
Dall’Italia mi chiamarono in
tanti. Ricordo che l’allora presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, tramite
il sottosegretario Minniti, offrì i funerali di Stato. Ringraziai, e risposi di
no.
Perché?
Delle due l’una: o Craxi era
uno statista, e allora aveva diritto ad essere curato in Italia da uomo libero,
oppure era un delinquente, e allora non meritava tutti gli onori che gli
venivano offerti in quel momento dalle massime autorità italiane. Scelsi la
coerenza e la dignità.
Quanto conta, per lei, il
denaro?
Nulla, anche perché ho un
rapporto pessimo con i soldi.
È stata una donna fedele?
Abbastanza, ma ho avuto due
mariti…
Una donna noiosamente
monogama…
Questo lo dice lei!
Che gioventù ha vissuto lei in
mezzo a quel circo?
Non lo definirei circo, ma una
comunità, una bellissima comunità…
Le è mancata l’intimità,
però…
Assolutamente sì. Era
difficile poter stare da soli con mio padre, soprattutto quando era a Roma.
Lei ama avere il controllo su
tutti, e tutti si appoggiano a lei, almeno questo è quello che ho notato… Ha mai
voglia di scappare?
Assolutamente sì, mi
basterebbero tre giorni.
E con sua madre, che rapporti
ha?
Fantastici! Ci ha sempre
consentito di vivere una vita normale; quando si trovavano ad Hammamet, e la
tempesta in Italia non si era ancora placata, la sentivo sempre serena,
tranquilla. Probabilmente, per non affrontare il dolore nei suoi risvolti più
spietati, cercava di stare sempre in superficie. Era un modo, il suo, per tenere
botta.
Qual è stato il suo, e ultimo,
giorno spensierato…?
Se vogliamo parlare di
spensieratezza, come tutte le mamme l’ho persa quando sono nati i figli…Se
parliamo di serenità, i giorni precedenti al dramma che si è abbattuto sulla
nostra famiglia e sull’Italia.
Torna ancora volentieri in
Tunisia?
La Tunisia è un Paese che mio
padre ha profondamente amato, che io amo profondamente. Un Paese straniero, ma
non estraneo, diceva Bettino. Lì mio padre ha vissuto i giorni dolorosi
dell’esilio, lì è sepolto nel piccolo cimitero cristiano di Hammamet, di fianco
al cimitero musulmano. Tutto il popolo tunisino ha protetto, amato, difeso e
garantito la libertà del presidente Craxi, nel rispetto delle leggi e del
diritto internazionale, accogliendo la mia famiglia in un momento molto
difficile.
Ha il viso malinconico, a
tratti sofferente; ha mai conosciuto momenti di felicità?
Ho passato periodi difficili,
difficilissimi, con Tangentopoli e tutto quello che poi ne è conseguito per la
mia famiglia. Chiaro che, parlando a lungo di una vicenda ancora dolorosissima,
il mio viso si rabbuia e intristisce. Ma le posso garantire che nella mia vita
la felicità, seppur fuggevole, abita questa casa…
Gli Usa "tifavano" per il
pool. E Borrelli riferiva al console.
Felice Manti e Edoardo
Montolli l'11 Giugno 2022 su Il Giornale.
Il ruolo di diplomatici e 007
americani nel nostro Paese tra il '92 e il '94 in un libro sugli archivi segreti
degli States.
Ai tempi di Tangentopoli
l'attenzione della segreteria di Stato e dei servizi di intelligence degli Stati
Uniti fu particolarmente concentrata nell'assistere alla fine della Prima
Repubblica. «L'America si schiera dalla parte dei giudici che danno fiato alle
inchieste sulla corruzione... Domina, nei resoconti e nelle informative
dell'universo a stelle e strisce, il disinteresse per le sorti del vecchio ceto
di governo, prevale nella narrazione sul regime change l'esigenza di guardare
avanti, di non attardarsi nella salvaguardia dell'esistente. Un approccio, anche
questo, certamente favorito dal mutamento degli equilibri internazionali, e
dalla perdita di centralità geopolitica dell'Italia nel più ampio contesto di
marginalizzazione del ruolo europeo».
Lo scrive Andrea Spiri nel suo
ultimo libro The End 1992-1994 - La fine della prima Repubblica negli Archivi
segreti americani (Baldini + Castoldi) dopo aver spulciato decine di rapporti
confidenziali dell'epoca ottenuti grazie al Freedom of Information Act, la
normativa che regola la declassificazione e l'accesso alle carte ufficiali
conservate negli Archivi federali. Si scopre anzi che vi era un filo diretto tra
la Procura di Milano e il consolato yankee all'ombra del Duomo, che veniva
informato sull'andamento di Mani Pulite, specie nei momenti decisivi. Il 29
aprile 1993, ad esempio, dopo che la Camera aveva respinto le richieste di
autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi, il console
statunitense Peter Semler incontrò «il numero due dei giudici milanesi» il cui
nome è omesso nel rapporto inviato al segretario di Stato americano. Subito dopo
quel diniego il Pds di Achille Occhetto aveva imposto il ritiro dal governo dei
ministri Augusto Barbera, Luigi Berlinguer, Vincenzo Visco e Francesco Rutelli.
E il giudice si lamentava con Semler che «il Pci di Berlinguer non avrebbe mai
commesso un errore politico del genere». Non solo. Il magistrato, andando ben
oltre le prerogative giudiziarie, riteneva che quella di Botteghe Oscure fosse
stata una decisione che «destabilizza l'esecutivo e rischia di trascinare il
Paese verso elezioni anticipate». Prospettiva che era «evitare a tutti i costi»
anche perché Craxi «verrebbe financo rieletto». E la cosa evidentemente stizziva
anche gli americani se si pensa che in un cablogramma del successivo 7 giugno,
Daniel Serwer, incaricato d'affari dell'Ambasciata statunitense a Roma, scriveva
a Washington dopo le amministrative: «Paradossalmente gli ex comunisti del Pds
sono forse gli interlocutori per noi più affidabili in questo frangente storico
che vede il declino inesorabile dei partiti con cui abbiamo lavorato a lungo e
sui quali abbiamo fatto affidamento». Ma a parlare con gli americani non c'era
solo il numero due dei giudici milanesi. C'era forse anche il numero uno degli
inquirenti. In un cablogramma del 12 maggio, solo parzialmente desecretato,
Semler sintetizza l'incontro con un magistrato, sempre coperto da omissis, che
Spiri ritiene di poter individuare nientemeno che nel capo della Procura
milanese, Francesco Saverio Borrelli, perché il console faceva riferimento al
fatto che il padre della misteriosa toga era la persona che aveva convinto Oscar
Luigi Scalfaro a lasciare la magistratura per entrare in politica. E
storicamente è risaputo che Scalfaro fu convinto della scelta da Manlio
Borrelli, papà di Francesco Saverio. Il magistrato annunciava al diplomatico uno
scenario «caratterizzato da un numero di casi ancora maggiore rispetto alle
attuali settecento indagini milanesi», lasciando intendere che «ci saranno pochi
patteggiamenti» e, per il resto, «verranno celebrati processi lunghi» che
«metteranno a dura prova le energie del pool». Ma gli americani guardavano con
attenzione anche a ciò che succedeva al Sud, dove i pentiti trascinavano
nell'abisso i vertici della Dc. Sicché, quando Giulio Andreotti, accusato di
collusione con la mafia, chiese audizione all'ambasciata, partì dopo l'incontro
il cablogramma riservato The Accused. Andreotti speaks, datato 2 luglio 1993. Il
senatore a vita riteneva che dietro le accuse contro di lui ci fossero «mafiosi
americani» e «spezzoni deviati dei Servizi segreti italiani» oltre che dello
United States Marshals Service, ovvero l'agenzia federale che sovrintende alle
operazioni giudiziarie dall'altra parte dell'Atlantico. Ma non il governo
americano. Si lamentava però della diffusione da parte di Washington di un
cablogramma molto particolare: «Ha chiesto informazioni in merito alla
diffusione da parte del governo americano di un cablogramma del 1984 redatto dal
Consolato di Palermo, nel quale veniva riferito che, se i presunti legami di
Lima con la mafia fossero stati confermati, allora sia Andreotti che l'intero
sistema politico italiano sarebbero finiti nei guai». I diplomatici riconobbero
«l'errore», ma anche che gli eventi avevano confermato la profezia. Salvo Lima,
in effetti, fu il primo dei delitti che avevano sconvolto l'Italia tra marzo e
luglio (così come predetto chirurgicamente da una circolare che allertava il
Paese su un pericolo di destabilizzazione orchestrato all'estero) e che frantumò
l'immagine del senatore a vita. Il secondo fu la strage di Capaci. Due giorni
dopo al Quirinale fu scelto Scalfaro. Gli analisti del Dipartimento di Stato di
Washington avevano scritto: «Le ultime speranze di Andreotti» di salire al Colle
«sono svanite con l'assassinio di Falcone, per via dei rapporti che il capo del
governo intrattiene con figure sospettate di essere in odore di mafia».
Lesa maestà.
Mani Pulite non si può criticare, per questo Colombo mi vuole alla sbarra.
Iuri Maria Prado su
Il Riformista il
3 Giugno 2022.
Gentile Gherardo
Colombo,
lei, in sodalizio
con Piercamillo Davigo e Elio Ramondini (quest’ultimo a me, come immagino ai
più, perfettamente sconosciuto), ha deciso di querelarmi per un articolo
pubblicato da questo giornale. L’articolo di cui lei, con i suoi colleghi, si è
doluto, argomenta in modo magari contestabile ma – almeno si spera – non
meritevole di sanzione penale, che l’adozione della dicitura “Mani Pulite”
costituisce in sé un pericoloso segno di inflessione autoritaria, e che la
cultura che vi si richiama ha arrecato grave danno al Paese, al nostro
ordinamento civile, al tenore della nostra democrazia.
Scrivere – come
ho scritto qui – che “La cultura di Mani pulite, la brutalità proterva dei suoi
modi e la buia temperie che li festeggiava, furono e rimangono la vergogna della
Repubblica”, è espressione di un giudizio civile e politico che può non essere
condiviso, ma che soltanto in forza di un gravissimo pregiudizio può ritenersi
vietato. Sostenere – come ho sostenuto qui – che è “civilmente osceno e
democraticamente blasfemo” intestare all’iniziativa di una funzione pubblica un
segno distintivo moraleggiante (“Mani Pulite”, appunto), specie sulla scena
delle acclamazioni popolari e dei suicidi che non saranno stati colpa di
nessuno, ma c’erano, significa manifestare un’inclinazione morale e un
convincimento politico che ancora una volta potranno essere discutibili, ma che
in un assetto di tutela minima dei diritti individuali dovrebbe essere tuttavia
consentito.
Lei,
dottor Colombo, che pubblicamente argomenta di aver lasciato la magistratura
perché era stufo di togliere la libertà alle persone, reclama invece che sia
applicata una sanzione penale a chi, come me, si è reso responsabile d’aver
scritto – contro la maggioranza che ne fa invece apologia – che quello di cui
lei è stato personaggio è uno dei capitoli vergognosi della storia d’Italia, e
che verecondia vorrebbe che i protagonisti giudiziari di quegli eventi si
limitassero semmai a dimostrare di aver solo applicato la legge piuttosto che
impancarsi ad agenti del bene pubblico. Ci vuole la galera, per quelli che
pensano e scrivono queste cose?
Caro dottor
Colombo, grattata la superficie delle vostre recriminazioni, ciò di cui in
realtà vi lamentate è la lesione della maestà di Mani Pulite. Perché
evidentemente non vi identificate nei provvedimenti che voi avete tutto il
diritto di rivendicare quanto gli altri hanno il diritto di criticare, ma
appunto nell’immagine apologetica di quell’esperienza giudiziaria e nella
cultura che l’ha ispirata e vi si è ispirata. Un’esperienza e una cultura che
non soltanto chi scrive, ma chiunque, avrebbe il diritto di considerare pessime.
Iuri Maria Prado
Michele
Santoro, Funari e gli altri: quando il talk show inventò l’indignazione della
gente comune.
Trent’anni fa, ai tempi di Mani
Pulite, si affermarono programmi che secondo Simona Colarizi allevarono i
prototipi degli odierni hater. Ma quello, a differenza di quanto accade con i
social, fu un fenomeno collettivo. Giandomenico Crapis
su L'Espresso il 16 Maggio
2022.
La storica Simona
Colarizi nel saggio “Passatopresente” (editori Laterza ), uscito di recente,
parla dell’azione «devastante» della tv nei primi anni Novanta, che allevò con i
suoi talk i prototipi degli odiatori del ventunesimo secolo. Un giudizio
tranchant e senza appello. Ma davvero i lanciatori di monetine dell’hotel
Raphaël erano gli antenati degli odierni haters? Lo vedremo più avanti, dopo
avere ricordato a trent’anni da Mani Pulite il ruolo che vi ebbe la televisione,
cercando di collocarne l’azione in una prospettiva di più lungo periodo.
·
Tangentopoli europea.
Gli Stati
corruttori, la nuova questione morale.
Ernesto Galli della
Loggia su Il Corriere della Sera il 19 Dicembre 2022.
Unifica il fronte
dei tiranni il profondo disprezzo ideologico verso l’universo dei valori di
libertà e di eguaglianza dove essi giudicano che «tutto è in vendita»
L’eterna rissa
italiana tra destra e sinistra sulla spinosa questione morale da un lato, e
dall’altro la non eccelsa reputazione di cui godono le istituzioni europee hanno
concentrato l’attenzione suscitata dallo scandalo delle tangenti Ue assai più
sul versante dei corrotti che su quello dei corruttori. Sulla miserabile
congrega di politici di serie B residenti a Bruxelles e di sottopancia
intraprendenti e bellocci anziché su chi elargiva loro i quattrini per i suoi
scopi poco puliti. Ma il vero nodo politico è su questo versante, non
sull’altro. Di corrotti, infatti, ce ne sono sempre stati e sempre ce ne saranno
così come sempre ci sono stati e sempre ci saranno, ad esempio, grandi interessi
economici pronti a cercare chi, in cambio di soldi, si metta al loro servizio. È
considerato in un certo senso talmente fisiologico questo ultimo tipo di ricerca
di «influenza» che esso ha trovato anche un nome presentabile, «il lobbysmo»,
con un adeguato corredo di regole come quelle (forse un po’ troppo generose?)
vigenti a Bruxelles.
Il vero fatto nuovo
del Qatargate, invece, è il Qatar. Il vero fatto nuovo, cioè, è la definitiva
scoperta di un genere di corruttore del tutto inedito, e cioè gli Stati: non già
per ragioni di spionaggio ma per ben altro. Negli ultimi anni ne avevamo avuto
sentore (più di un sentore in verità) ma ora è una certezza. Si tratta perlopiù
di Stati africani e asiatici — con l’importante eccezione della Russia — uniti
tutti dalla caratteristica di essere retti da regimi non democratici.
In un certo senso
quanto sta accadendo lo si potrebbe considerare anche una sorta di nemesi
storica. Una sorta di contrappasso per le tante volte in cui, nel corso dei
secoli, avventurieri europei di ogni risma o addirittura rappresentanti delle
stesse potenze europee se ne andarono in giro in Asia e in Africa con qualche
sacchetto di vetri colorati o di qualche vecchio moschetto arrugginito ad
«acquistare» dai capi locali, in cambio di questa paccottiglia, tutto quello che
potevano: dagli esseri umani da ridurre in schiavitù a immense estensioni
territoriali.
Ma oggi la storia ha
cambiato verso ed è l’Occidente che viene preso di mira a suon di euro o di
dollari. Non già però, come ho detto, nel tentativo di corrompere questo o quel
funzionario per carpire qualche informazione, per aver accesso a un piano o a un
documento, non già a fini di spionaggio insomma, come in sostanza avveniva un
tempo, ma per uno scopo ben più ambizioso e grave: per influenzare lo stesso
processo decisionale di vertice di quel Paese (o nell’ultimo caso l’Unione
europea), per determinarne le scelte politiche anche le più importanti. Perfino
per stabilire chi lo governerà. Il mondo dei tiranni, insomma, ha scoperto che
il mondo delle democrazie, delle istituzioni democratiche, dei partiti e dei
parlamenti, non solo è regolato da procedure aperte e perciò permeabilissime
dall’esterno, ma è altresì pieno di donne e uomini fragili, dagli ideali deboli
o inesistenti, avidi di successo personale, di automobili, di sesso, di Rolex; è
popolato di statisti di serie B interessantissimi conferenzieri da 50 mila
dollari a prestazione. E allora non si fa problemi a pagare. A cercare tra
queste persone chi possa servire ai suoi propositi. Non basta, perché al fine di
falsare le consultazioni elettorali oltre i soldi il mondo dei tiranni mette in
campo anche le risorse del progresso tecnico, della suggestione mediatica, della
manipolazione digitale delle informazioni.
Il fatto è che da
qualche decennio viviamo in una congiuntura storica nuova, nella quale si
sommano e s’intrecciano vari fattori più o meno inediti che, insieme, hanno
segnato per l’argomento di cui ci stiamo occupando una vera e propria svolta.
Sul versante dei
corruttori assistiamo innanzitutto a un’esplosione di attivismo sia da parte
della Cina, ansiosa di giungere al potere mondiale con ogni mezzo — non ultimo
la costruzione di una rete d’influenza commerciale, la planetaria «via della
seta», che però necessita della collaborazione/complicità dei governi dei Paesi
interessati —, sia della Russia che, guidata da una leadership dagli accenti
paranoici, cerca con la violenza di mantenere i suoi antichi domini imperiali e
la sua antica influenza servendosi di qualunque élite occidentale «amichevole»
disposta ad aiutarla in cambio delle sue «risorse» d’ogni genere. Accanto a Cina
e Russia si affollano molti altri attori di calibro minore — Turchia, Marocco,
Corea del Nord, Stati del Golfo - ognuno con le sue mire espansionistiche o
egemoniche a carattere più o meno regionale, pronti a impiegare i propri soldi
per due obiettivi congiunti: acquisire il placet dell’Occidente ai propri
disegni (spesso insieme a forniture militari) ovvero impedire che si faccia luce
sul carattere sempre antidemocratico e perlopiù criminale del proprio regime
interno. Unifica il fronte dei tiranni un elemento comune: il profondo disprezzo
ideologico verso l’universo dei valori di libertà e di eguaglianza — dove essi
giudicano che «tutto è in vendita» — nonché verso l’umanità che è frutto di quei
valori.
Sull’altro versante,
quello dei corrompibili c’è per l’appunto questa umanità, ci siamo noi, c’è il
nostro mondo. Con la sua pronta, obbligatoria disponibilità a tutto ciò che
sappia di diverso dall’Occidente, con il proliferare di mille centri decisionali
e la loro facile penetrabilità, soprattutto con la disarticolazione culturale e
morale delle sue élite: non più tenute insieme da forti valori condivisi o da
antiche regole di educazione e di stile, non difese da consapevoli e forti
identità né istruite adeguatamente ai nuovi compiti e alle nuove responsabilità;
c’è infine il mondo della nostra sfera pubblica dove sembrano avere sempre più
la meglio «la gente nova e i sùbiti guadagni».
La corruzione,
quando coinvolge i vertici, non è più un fatto solo penale: è lo specchio dove è
dato leggere il grado di salute dell’organismo a cui quei vertici presiedono e
talvolta, Dio non voglia, anche il destino che l’aspetta.
Tangentopoli
europea: i soldi dal Qatar sarebbero solo la punta dell’iceberg.
Michele Manfrin
su L'Indipendente il 15 Dicembre 2022.
Dopo che vi avevamo
già parlato degli arresti a carico della Vice-Presidente del Parlamento europeo,
Eva Kaili, e del suo compagno Francesco Giorgi, così come di Antonio Panzeri, ex
eurodeputato del Pd e di Articolo 1 del gruppo europeo Socialisti e Democratici
(S&D) e del direttore della ong No Peace Without Justice, Nicolò Figà-Talamanca,
torniamo a parlare dello scandalo denominato Qatargate. Infatti, da come apparso
fin da subito, la questione è destinata ad allargarsi e ciò che è successo fin
oggi potrebbe quindi essere soltanto la punto di un iceberg. Mentre si allarga
la rete delle persone coinvolte, iniziano ad aggiungersi anche altri attori
statali per uno scandalo che va ben al di là del Qatar, che anzi forse non
sarebbe nemmeno il Paese estero maggiormente coinvolto nel giro di tangenti.
Più volte la
deputata europea Manon Aubry, del gruppo della sinistra radicale (GUE/NGL) aveva
chiesto all’Assemblea di adottare una risoluzione di condanna nei confronti del
Qatar. Oltre ad allargarsi ad un maggior numero di persone, l’inchiesta apre ora
verso scenari che coinvolgono altri paesi, come il Marocco. Francesco Giorgi, ex
assistente di Panzeri e oggi nell’ufficio dell’europarlamentare Andrea Cozzolino
(Pd), nonché compagno della Vice-Presidente Eva Kaili, ha confessato circa
l’esistenza di una ancora non meglio descritta organizzazione capeggiata da Pier
Antonio Panzeri e che il suo ruolo in essa era quella di gestire il denaro.
Durante la sua confessione, Giorgi ha spiegato che i soldi per interferire negli
affari europei non arrivano solo dal Qatar ma anche dal Marocco.
Dalle indagini
risulta che anche il Marocco, attraverso il suo servizio di intelligence
estero DGED (Direction générale des études et de la documentation), sarebbe
coinvolto in questo dossier di corruzione. Secondo i documenti, Panzeri,
Cozzolino e Giorgi erano in contatto con il DGED e con Abderrahim Atmoun,
ambasciatore del Marocco in Polonia. Con la mediazione del funzionario politico
marocchino, incontri, colloqui e cene venivano imbastiti tra i tre italiani e i
massimi funzionari dei servizi segreti di Rabat, come Belarace Mohammed,
ufficiale della DGED, e Mansor Yassin, direttore generale di DGED. Panzeri,
Cozzolino e Giorgi hanno ricevuto pagamenti attraverso i conti della ONG Fight
Impunity, anche in contanti, o con un “regalo”.
Ciò che è emerso da
quanto riportato dal quotidiano Le Soir e il settimanale Knack, dipinge uno
scenario di “guerra” tra spie, con il sospetto, ventilato dagli stessi qatarini,
che via sia il coinvolgimento dei servizi segreti degli Emirati Arabi Uniti –
che hanno respinto le accuse – nel disvelare la rete di corruzione. Proprio
grazie alla perquisizione dei servizi segreti belgi nella casa di Antonio
Panzeri, trovandovi 700mila euro in contanti, a quel punto, lo scorso 12 luglio,
il fascicolo è stato desecretato ed è passato alla magistratura. I fiumi di
banconote sequestrate a Bruxelles sarebbero serviti per la distribuzione ad
altri eurodeputati appartenenti al gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D).
Il Marocco avrebbe
interferito con la politica europea per interesse nel settore della pesca e
soprattutto in relazione alla questione del Sahara occidentale e del popolo
sahrawi, quindi sul fronte dei diritti umani e dell’autodeterminazione dei
popoli. Per quanto concerne invece il Qatar le mire sarebbero state ancora più
vaste: prima il dossier relativo ai mondiali di calcio e la violazione dei
diritti umani, un maggiore radicamento in vari settori del mercato europeo e
una politica di liberalizzazione dei visti (che era in discussione) con l’UE.
Intanto,
all’Europarlamento è stata presentata una risoluzione redatta da tutti i
principali gruppi per “sospendere tutti i lavori sui fascicoli legislativi
relativi al Qatar, in particolare per quanto riguarda la liberalizzazione dei
visti e tutte le visite programmate, fino a quando le accuse non saranno state
confermate o respinte”. Il voto in plenaria è previsto per oggi, 15 novembre.
L’Unione Europea
subisce un grave colpo alle proprie istituzioni democratiche proprio mentre
infuria la guerra in Ucraina ove risulta, con la NATO, coinvolta dalle retrovie
e le cui azioni stanno producendo effetti catastrofici in ambito
economico-sociale e per cui mette a rischio la propria tenuta politica,
economica e sociale. Al contempo, il Qatar, che aveva militarizzato l’edizione
del mondiale di calcio, col timore che potesse essere una vetrina succulenta e
su cui si giocavano anche interessi geostrategici, viene colpito al fianco e
forse dove non se lo aspettava. A questo punto ci chiediamo quanto sia realmente
vasta la corruzione nelle istituzioni europee e quale, e da chi, influenza
indebita venga esercita sui politici dell’Unione Europea. [di Michele Manfrin]
Fifa Uncovered.
Il più grande scandalo di corruzione nella storia dello sport.
Alessandro Cappelli su L’Inkiesta il 24 Novembre 2022.
Una docuserie
Netflix in quattro episodi racconta l’evoluzione della federazione calcistica
mondiale del calcio, da «Ong del pallone» a impero in cui la corruzione è
sistemica. La stessa assegnazione dei Mondiali in Qatar è legata al pagamento di
tangenti milionarie
Il principio della
salsiccia dice che se c’è qualcosa di buono o di bello è meglio non sapere com’è
fatto. Di solito si applica alle leggi e alla politica: meglio non investigare
cosa c’è dietro accordi, compromessi e strette di mano. Vale anche per il mondo
del calcio, per la Fifa, le triangolazioni tra i suoi funzionari.
A lungo tifosi e
semplici spettatori hanno fatto finta di niente, hanno scelto di non dare peso
agli scandali che riguardavano il governo del pallone – cioè di uno sport
seguito con trasporto trascendentale, mistico, religioso – anche quando erano al
centro delle cronache e delle indagini giudiziarie. In fondo, se il piatto è
buono meglio non fare troppe domande.
L’inizio dei
Mondiali in Qatar però ha cambiato ogni prospettiva. Le oscenità in serie girate
sui social e poi sui giornali hanno ridimensionato l’interesse per l’evento
calcistico più importante di tutti, seppellendo sotto una montagna di marciume,
corruzione e morti impunite la bellezza sportiva della competizione.
Il Qatar ha
programmato questi Mondiali per quasi due decenni, e comunque non è riuscita a
offrire un’organizzazione paragonabile alle edizioni precedenti. La Fifa invece
sembra arrivata alla chiusura di un cerchio, al termine di un percorso e un
declino – politico, ma anche morale e umano – decisamente più antico.
«Se vuoi gestire la
Fifa con un codice etico, allora buona fortuna», suggerisce Jérôme Valcke, ex
segretario generale Fifa, nelle scene finali della docuserie Netflix “Fifa:
Tutte le rivelazioni”. In quattro episodi, la serie pubblicata poco prima
dell’inizio dei Mondiali dipinge un quadro affascinante e scoraggiante: quattro
ore di interviste a giornalisti, ex funzionari Fifa, agenti sportivi, forze
dell’ordine e persone coinvolte nelle indagini sono una miscela di trasgressione
e ripugnanza che rendono il racconto di una storia calcistica una serie sulla
perversione criminale del potere, sull’inevitabilità del male. «Non sono sicuro
che sia possibile seguire un codice etico», dice Valcke in un misto di sicumera
e inconsolabile accettazione.
Per decenni la Fifa
era stata solo un’ente dedito all’organizzazione dei tornei, con una visione
puramente idealistica di un calcio senza scopo di lucro e l’obiettivo ultimo di
portare in tutto il mondo the beautiful game.
Nel 1974 João
Havelange diventa presidente. È l’anno in cui sbiadisce l’idea romantica dietro
l’organo di governo del calcio mondiale: la campagna elettorale dell’ex
nuotatore brasiliano è ambiziosa, parla di un calcio globale diffuso in maniera
capillare, una bandierina in ogni centimetro del planisfero.
Politicamente è una
strategia geniale. In un sistema in cui ogni federazione nazionale vale uno, le
organizzazioni continentali del Nord America (Concacaf) e dell’Africa (Caf)
hanno un peso elettorale enorme pur avendo mercati marginali rispetto al
movimento calcistico mondiale: bisogna convincere i vertici di quelle
federazioni per garantirsi la continuità al trono.
Il successo di
Havelange inizia proprio con le buste di contanti da distribuire ai presidenti
delle federazioni a cui deve chiedere voti: è il momento della storia in cui la
corruzione nella Fifa si trasforma in un elemento sistemico, il pilastro su cui
poggia l’architrave del potere.
Una visione che non
può concretizzarsi con le scarse risorse di un’organizzazione che fino a quel
momento era paragonabile a una Onu del calcio: il calcio fine a se stesso deve
morire, sostituito da una visione del gioco come prodotto, merce da vendere al
miglior offerente.
Il volto e la mente
dietro questa trasformazione sono di uno svizzero nativo di Visp, settemila
anime tra le valli del Canton Vallese, un uomo innamorato del calcio che non
vede l’ora di avere un ruolo in questa storia. Sono i primi passi nella
costruzione di un impero che poi Sepp Blatter avrebbe governato per molti anni.
L’idea è
rivoluzionaria eppure semplicissima: servono sponsor. Il primo è Coca Cola, che
nel 1976 diventa partner nei progetti calcistici destinati ai giovani. «Due
grandi organizzazioni potevano e dovevano lavorare insieme», pensa Blatter.
Serve un fornitore di attrezzature sportive e il secondo brand a stringere mani
e firmare contratti è adidas. Ne seguiranno altri, Phillips, Canon, Gillette. Se
c’è una ricompensa, i Mondiali li può organizzare chiunque: Havelange appoggia
la candidatura dell’Argentina per la Coppa del Mondo del 1978; significa fare il
gioco di Videla e di tutta la giunta militare, ma nell’ottica del calcio come
prodotto passa tutto in secondo piano.
Possono sembrare
storie di un passato più cupo del presente, in realtà è tutto ancora in piedi,
come se certi principi fossero scolpiti nella pietra: domenica scorsa l’attuale
presidente della Fifa, Gianni Infatino – purtroppo rimasto fuori dalla docuserie
Netflix, ma è uno che in questi anni ha stretto la mano di Vladimir Putin e
degli sceicchi qatarioti – ha detto che tutti possono ospitare i Mondiali, anche
la Corea del Nord.
La chiave di volta
di “Fifa: Tutte le rivelazioni” è nel terzo episodio, quello che racconta sia le
accuse di corruzione dei membri della Fifa per mano del Qatar, sia
l’intersezione tra interessi del calcio e della geopolitica che ha portato
Blatter ad annunciare con un po’ di scoramento l’assegnazione dei Mondiali al
piccolo emirato del Golfo.
L’informatore
Phaedra Almajid, responsabile capo delle relazioni con i media internazionali
della Fifa, rivela di aver assistito al pagamento di tangenti in cambio del voto
per assegnare i Mondiali al Qatar. Hassan Al Thawadi, segretario generale del
Comitato Supremo incaricato della Coppa del Mondo 2022, avrebbe offerto denaro
ai delegati del Camerun (Issa Hayatou), della Costa d’Avorio (Jacques Anouma) e
della Nigeria (Amos Adamu) per assicurarsi il loro voto.
Lo scandalo sembra
così più vero e più crudele in questi giorni in cui i migliori giocatori del
mondo vanno in campo negli stadi in mezzo al deserto, tra tifosi finti e una
generale sensazione «che sia tutto finto, molto, molto finto», come ha detto a
Linkiesta un agente di calciatori – che preferisce rimanere anonimo – sbarcato
in Qatar due giorni prima della partita inaugurale.
L’inchiesta dell’Fbi
ha portato, nel 2015, a quarantasette capi d’accusa tra cui associazione a
delinquere, frode telematica e riciclaggio di denaro; all’arresto di sette
massimi dirigenti; quattro membri del Comitato esecutivo indagati; le dimissioni
di Sepp Blatter. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti – che ha
coordinato le indagini con l’Fbi – l’aveva definita come una fitta rete di
corruzioni concatenate che avrebbe influenzato accordi di marketing, diritti tv
e appunto l’assegnazione dei Mondiali, per cifre che si contano nell’ordine
delle centinaia di milioni di dollari, in un periodo lungo circa due decenni.
Da fanpage.it il 9
dicembre 2022.
La magistratura
Belga ha lanciato un'ondata di perquisizioni a Bruxelles nella mattinata di oggi
nell'ambito di una inchiesta su presunte corruzioni al Parlamento Ue e
l'esistenza di una organizzazione infiltrata nel cuore dell'Europarlamento,
sospettata di ingerenza nella politica dell'Ue e corruzione da parte del Qatar.
Lo rendono noto in esclusiva i quotidiani locali Le Soir e Knack rivelando che
tra gli indagati vi sarebbero anche quattro italiani.
Secondo le ipotesi
degli inquirenti della procura federale belga, riportate dai due giornali, si
sospetta che il Paese del Golfo dove si stanno svolgendo i mondiali di calcio
abbia tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento
europeo corrompendo politici ed europarlamentari
"La polizia
giudiziaria federale ha effettuato 16 perquisizioni (in 14 diversi indirizzi) in
diversi comuni di Bruxelles. In particolare a Ixelles, Schaerbeek, Crainhem,
Forest e Bruxelles-Ville. Queste perquisizioni sono state effettuate nell'ambito
di un'ampia indagine per presunti atti di organizzazione criminale, corruzione e
riciclaggio di denaro" confermano dalla procura belga senza però indicare i nomi
dei coinvolti né quello del Paese del Golfo che, attraverso il pagamento di
"ingenti somme di denaro o offrendo doni significativi a terzi che rivestono una
posizione politica e/o strategica significativa all'interno del Parlamento
europeo", avrebbe interferito sulle politiche Ue.
Secondo le
informazioni della stampa belga, tra gli indagati figurerebbero l'ex deputato
democratico Pier Antonio Panzeri, il neoeletto segretario generale della
Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc) Luca Visentini, nonché un
direttore di una ong e un assistente parlamentare europeo – tutti italiani. Per
loro sarebbero scattati fermi e perquisizioni.
Panzeri è stato
eurodeputato per tre mandati, dal 2004 al 2019. Panzeri è stato eletto
all'Eurocamera nella lista Uniti nell'Ulivo ed è stato riconfermato a Strasburgo
alle Europee del 2009. Nel 2014 è stato eletto eurodeputato una terza volta,
nelle liste del Pd ma nel 2017 ha lasciato i Dem per aderire ad Articolo I.
All'Eurocamera ha ricoperto diversi incarichi ed è stato, tra l'altro,
presidente della sottocommissione dei diritti umani. Luca Visentini è stato per
diversi anni il punto di riferimento dei sindacati europei. Nel 2015 è stato
eletto segretario generale della Etuc, ovvero la confederazione dei sindacati
europei, e nel 2019 è stato riconfermato. Infine è stato nominato come
segretario generale della Ituc (International Trade Uniion Confederation), la
più grande confederazione sindacale del mondo.
Da iltempo.it il 9
dicembre 2022.
Terremoto in Europa.
La vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili è stata arrestata per una
sospetta corruzione con soldi arrivati dal Qatar.
A riferire la
notizia è il quotidiano belga Le Soir, che spiega come l'abitazione della
rappresentante socialdemocratica greca sia stata perquisita e che anche il
compagno sia indagato per corruzione. Il partito socialista greco, Pasok, ha
espulso l’eurodeputata: “A seguito degli ultimi sviluppi e delle indagini delle
autorità belghe sulla corruzione di funzionari europei, l’eurodeputata Eva Kaili
viene espulsa dal Pasok - Movimento per il cambiamento per decisione del
presidente Nikos Androulakis”. L'unico modo per arrestare un parlamentare
protetto dall'immunità è coglierlo in flagrante.
Il 1 novembre, su
Twitter, è stato riportato che Kaili ha incontrato il ministro del Lavoro del
Qatar, Al Marri. L’eurodeputata era inoltre intervenuta il 21 novembre nella
plenaria a Strasburgo, nel dibattito sulla ‘Situazione dei diritti umani nel
contesto della Coppa del Mondo Fifa in Qatar’, con parole positive nei confronti
del paese del Golfo: “Oggi i Mondiali in Qatar sono la prova, in realtà, di come
la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un Paese
con riforme che hanno ispirato il mondo arabo. Il Qatar è all’avanguardia nei
diritti dei lavoratori, si sono aperti al mondo. Tuttavia, alcuni qui stanno
chiedendo di discriminarli. Maltrattano e accusano di corruzione chiunque parli
con loro. Ma comunque, prendono il loro gas. E hanno le loro aziende che
guadagnano miliardi lì”.
Tangenti del
Qatar, è coinvolta la Ong fondata da Emma Bonino: “Non so niente, non ricordo”.
Guido Liberati su Il Secolo d’Italia l’11 Dicembre 2022.
Nessun tg lo ha
detto, nessun quotidiano lo ha pubblicato in prima pagina, ma nello scandalo
delle tangenti del Qatar al Parlamento europeo, figura anche la Ong«No Peace
Without Justice» (“Non c’è pace senza giustizia”), fondata da Emma Bonino. Al
momento, una delle persone in stato di fermo in Belgio è il segretario generale
della Ong, Niccolò Figà Talamanca, considerato da sempre un fedelissimo della
leader di Più Europa.
Al Corriere della
Sera, l’esponente radicale ha risposto con delle risposte molto vaghe,
costellate da “Non so” e “non ricordo”. La giornalista che la interpella
telefonicamente riesce a strapparle pochissime ammissioni. Chiede Alessandra
Arachi: Lei ha fondato a Bruxelles la Ong “Non c’è pace senza giustizia”? «Sì,è
successo nel 1994 se non ricordo male. Forse era il 1993». L’Ong è finita
nell’inchiesta sul presunto tentativo da parte del Qatar di corrompere alcune
autorità europee. Sa niente di questo? «No, non so niente, aspetto la
magistratura che si deve esprimere, credo che lo farà nel giro di pochi giorni».
Niccolò Figà
-Talamanca, il segretario generale della sua Ong, è implicato direttamente in
questa inchiesta. «Ho letto, ma non ho potuto parlare con Niccolò, lui adesso è
in stato di fermo. Immagino che gli abbiano dato un avvocato d’ufficio». Ancora
più vaga la risposta su Antonio Panzeri, uno dei principali indagati di questa
inchiesta. «Non mi ricordo di lui – dice la Bonino al Corriere – può essere che
l’abbia incontrato qualche volta quando ero al Parlamento europeo».
Chi è il fedelissimo
della Bonino fermato per le tangenti del Qatar
Niccolò Figà
Talamanca, nato a Genova nel 1971 è uno degli indagati ed è considerato un
fedelissimo di Emma Bonino. Ha un curriculum accademico che passa dal Tribunale
penale internazionale per l’ex-Jugoslavia dell’Aia alla Comitato degli avvocati
per i diritti umani di New York City.
Nello stesso
edificio dove ha sede la sua Ong, a Bruxelles hanno sede anche i Radicali
Italiani, Più Europa, l’Associazione Luca Coscioni, l’Euro-Syrian Democratic
Forum, Al Wefaq (un partito di opposizione del Bahrein) e altre realtà. Più,
appunto, Fight Impunity di Panzeri, che ha una targa separata, probabilmente
perché è di costituzione più recente.
L’associazione “Non
c’è pace senza giustizia” è una presenza fissa su Radio Radicale. Sulla home
page dell’associazione campeggia una foto di Emma Bonino e un suo messaggio di
benvenuto. Non è improprio quindi definire l’organizzazione umanitaria la Ong
della Bonino. Eppure pochissimi la tirano in ballo, almeno per avere una
dichiarazione ufficiale. Fosse capitato uno scandalo del genere con un politico
di centrodestra i media sarebbero stati così delicatamente cauti?
Da open.online il 10
dicembre 2022.
Eva Kaili,
vicepresidente del Parlamento Europeo, è una degli europarlamentari arrestati
nell’inchiesta sulla corruzione dal Qatar. L’arresto ha seguito segue il fermo
di altri quattro sospetti avvenuto nella mattinata. Tra questi l’ex eurodeputato
socialista Antonio Panzeri e il segretario generale della Confederazione
internazionale dei sindacati Luca Visentini. Kaili è stata espulsa dal partito
per decisione del presidente Nikos Androulakis. Il gruppo dei Socialisti e
Democratici l’ha sospesa. La polizia ha apposto i sigilli ai suoi uffici, così
come a quelli di Tarabella. Il suo compagno, Francesco Giorgi, è stato fermato
nello stesso filone d’indagine.
Le accuse
Secondo la procura
di Bruxelles un paese del Golfo avrebbe tentato di influenzare le decisioni
economiche e politiche del Parlamento europeo. «Versando ingenti somme di denaro
o offrendo regali di grande entità a terzi che ricoprono posizioni politiche o
strategiche di rilievo all’interno del Parlamento europeo», ha spiegato la
procura senza fornire né il nome del Paese coinvolto né quello di indagati e
persone fermati. Le accuse per tutti sono corruzione, criminalità organizzata e
riciclaggio di denaro.
Le 16 perquisizioni
condotte in sei delle municipalità che costituiscono la regione di Bruxelles
capitale – Ixelles, Schaerbeek, Crainhem, Forest e Bruxelles città – hanno
permesso il recupero di circa 600 mila euro in contanti. Sono stati inoltre
sequestrati computer portatili e telefoni cellulari. Kaili, nata a Salonicco il
26 ottobre 1978, fa parte del Movimento Socialista Panellenico. È entrata
all’Europarlamento nel 2014. Dal 2004 al 2007 era stata giornalista per Mega
Channel. È stata la più giovane deputata del Pasok eletta nel 2007.
Eva Kaili e il
discorso sul Qatar
L’agenzia di stampa
Agi ha riportato un intervento di Kaili nella plenaria di novembre in cui
difendeva in aula i progressi del Qatar nell’ambito dei diritti. «Oggi i
Mondiali in Qatar sono la prova, in realtà, di come la diplomazia sportiva possa
realizzare una trasformazione storica di un paese con riforme che hanno ispirato
il mondo arabo. Io da sola ho detto che il Qatar è all’avanguardia nei diritti
dei lavoratori. Nonostante le sfide che persino le aziende europee stanno
negando per far rispettare queste leggi, si sono impegnati in una visione per
scelta e si sono aperti al mondo.
Tuttavia, alcuni qui
stanno invitando per discriminarli. Li maltrattano e li accusano di corruzione
chiunque parli con loro o si impegni nel confronto. Ma comunque, prendono il
loro gas. Tuttavia, hanno le loro aziende che guadagnano miliardi lì», aveva
detto a Strasburgo.
Il compagno
Francesco Giorgi
E ancora: «Ho
ricevuto lezioni come greca e ricordo a tutti noi che abbiamo migliaia di morti
a causa del nostro fallimento per le vie legali di migrazione in Europa.
Possiamo promuovere i nostri valori ma non abbiamo il diritto morale di dare
lezioni per avere un’attenzione mediatica a basso costo. E non imponiamo mai la
nostra via, noi li rispettiamo». Il Corriere della Sera specifica che la sua
elezione a vicepresidente è stata favorita anche dal sostegno dei socialisti
rimasti vicini a Panzeri.
Kaili ha deleghe
dalla responsabilità sociale d’impresa all’informatica e alle telecomunicazioni.
E sostituisce la presidente Roberta Metsola nei contatti con le associazioni
imprenditoriali europee, anche con il Medio Oriente. Repubblica fornisce oggi
altri dettagli sul compagno di Kaili, Francesco Giorgi. L’assistente
parlamentare è costantemente “eletto” come il più bello tra le deputate e le
funzionarie di Bruxelles. Nella scorsa legislatura era l’assistente di Panzeri,
fermato nella stessa inchiesta. Poi è diventato il collaboratore di Andrea
Cozzolino.
Da repubblica.it il
10 dicembre 2022.
Eva Kaili,
vicepresidente del Parlamento europeo arrestata in Belgio, ha trascorso la notte
in stato di detenzione, poiché a casa sua sono stati trovati "sacchi di
banconote".
Lo riferisce il
quotidiano belga L'Echo. Secondo l'agenzia di stampa greca Ana-Mpa anche il
compagno di Kaili, Francesco Giorgi, è stato arrestato. Giorgi in passato è
stato assistente parlamentare di Antonio Panzeri, anch'esso arrestato. Fino a
pochi giorni fa la vice presidente del Parlamento europeo Kaili ha difeso in
aula i progressi del Paese del Golfo nell'ambito dei diritti in vista dei
Mondiali di calcio in corso.
"Oggi i Mondiali in
Qatar sono la prova, in realtà, di come la diplomazia sportiva possa realizzare
una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato il mondo
arabo. Io da sola ho detto che il Qatar è all'avanguardia nei diritti dei
lavoratori, abolendo la kafala e riducendo il salario minimo. Nonostante le
sfide che persino le aziende europee stanno negando per far rispettare queste
leggi, si sono impegnati in una visione per scelta e si sono aperti al mondo.
Tuttavia, alcuni qui stanno invitando per discriminarli. Li maltrattano e
accusano di corruzione chiunque parli con loro o si impegni nel confronto. Ma
comunque, prendono il loro gas. Tuttavia, hanno le loro aziende che guadagnano
miliardi lì", ha detto nel suo intervento a Strasburgo.
"Ho ricevuto lezioni
come greca e ricordo a tutti noi che abbiamo migliaia di morti a causa del
nostro fallimento per le vie legali di migrazione in Europa. Possiamo promuovere
i nostri valori ma non abbiamo il diritto morale di dare lezioni per avere
un'attenzione mediatica a basso costo. E non imponiamo mai la nostra via, noi li
rispettitamo, anche senza Gnl", ha aggiunto. Sono una nuova generazione di
persone intelligenti e altamente istruite. Ci hanno aiutato a ridurre la
tensione con la Turchia. Ci hanno aiutato con l'Afghanistan a salvare attivisti,
bambini, donne. Ci hanno aiutati. E sono negoziatori di pace. Sono buoni vicini
e partner. Possiamo aiutarci a vicenda per superare le carenze. Hanno già
raggiunto l'impossibile", ha concluso.
Kaili, come le altre
quattro persone arrestate, sarà ascoltata entro 48 ore da un giudice che
deciderà su eventuali mandati di cattura. La procura federale belga non ha
confermato i nomi degli arrestati, ma sottolinea che si tratta di "personalità
con posizioni strategiche".
Claudio Tito per la
Repubblica l’11 Dicembre 2022.
«Il Qatar è sulla
strada giusta per le riforme in diversi settori, il Paese può essere considerato
un riferimento per i diritti umani. Si tratta di sforzi encomiabili. Il Qatar ha
avviato uno sviluppo positivo». Era il 2019. Ormai tre anni fa. Ma
l'organizzazione dei mondiali di calcio era in pieno svolgimento. E Antonio
Panzeri, che aveva da poco lasciato la presidenza della sottocommissione del
Parlamento europeo per i diritti umani, usava proprio queste parole per
descrivere la situazione nel Paese del Golfo Persico.
La lunga marcia di
avvicinamento a Doha, dunque, parte da quel momento. E da quel momento la
"conversione" di molti esponenti del gruppo S&D, i socialisti europei, diventa
quasi un segno distintivo. Almeno di quelli del "circolo" più stretto
organizzato dall'ex eurodeputato e che fa perno su italiani o di origine
italiana.
E così di
conversioni ce ne sono diverse. E tutte pubbliche. Perché l'esigenza è
soprattutto comunicativa. Basti pensare a Luca Visentini, capo del sindacato
europeo e di recente "promosso" alla guida di quello mondiale. «Il Qatar - ha
detto in una intervista di pochi mesi fa - dovrebbe essere visto come una storia
di successo. La Coppa del Mondo è stata un'opportunità per accelerare il
cambiamento e queste riforme possono costituire un buon esempio da estendere ad
altri Paesi che ospitano grandi eventi sportivi». Nell'inchiesta dei magistrati
belgi, del resto, il ruolo di Visentini emerge con chiarezza: l'obiettivo
qatarino era dimostrare che anche i sindacati apprezzavano i presunti passi
avanti sulla tutela dei lavoratori.
Ma è il 22 novembre
il giorno in cui si illuminano le luci sul palco e chi deve, si presenta. A
Strasburgo, nella seduta plenaria del Parlamento europeo, si discute e si vota
una risoluzione sul Qatar. Il testo unico Ppe-Pse viene bloccato. I socialisti
si dividono. Durante la riunione del gruppo vengono presentati diversi
emendamenti. Alcuni di loro si astengono, in dissenso con i colleghi (ad esempio
l'italiano Cozzolino il cui assistente è Francesco Giorgi, uno dei fermati). Il
dibattito pubblico mostra chi tra il gruppo S&D ha cambiato opinione sul Qatar.
La più clamorosa è
Eva Kaili, vicepresidente greca del Parlamento: «Il Qatar è all'avanguardia nei
diritti dei lavoratori, nell'abolizione della kafala (un sistema per cui il
datore di lavoro è anche il tutore legale del lavoratore straniero). Alcuni qui
chiedono di discriminarli. Li bullizzano e accusano di corruzione chiunque parli
con loro o si impegni. Ma ancora, prendono il loro gas. Sono buoni vicini e
partner. Hanno già raggiunto l’impossibile».
È il turno di Mark
Tarabella (al momento non coinvolto nell'inchiesta ma molto vicino a Panzeri),
deputato belga di origini italiane. «Restano ancora molti progressi da fare -
spiega - ma è un Paese che ha intrapreso la via delle riforme. E
l'organizzazione della Coppa del Mondo è stata probabilmente la molla che ha
accelerato queste riforme. Bisogna riconoscere oggi, l'abbandono della kafala,
questo sistema di dipendenza dei lavoratori. Così oggi, il discorso
unilateralmente negativo mi sembra dannoso per l'evoluzione dei diritti in
futuro in Qatar.
Perché ciò che è
importante è che, quando le luci della Coppa del Mondo si spengono, lo sviluppo
positivo continui non solo in Qatar, ma in tutta la penisola arabica». Un'altra
parlamentare belga di origini italiane e in buoni rapporti con Panzeri, Maria
Arena (coinvolto nelle indagini un suo collaboratore, non lei), senza i toni
entusiastici degli altri due colleghi ha cercato di fissare un punto di
equilibrio. «Sì, come lei ha detto signor Commissario, il Qatar ha compiuto
progressi. Oggi non c'è la kafala». Arena sottolinea però che «in alcuni
settori, la kafala esiste ancora in un modo piuttosto speciale. E ci sono state
violazioni, morti e il risarcimento è necessario. Dobbiamo lavorare con il Qatar
per garantire che queste compensazioni abbiano luogo». La nemesi del "circolo"
di Panzeri è fatta.
Da ilfattoquotidiano.it il 9 dicembre 2022.
Mazzette e regali
dal Qatar per influenzare le decisioni del Parlamento europeo e della più
importante federazione sindacale del mondo, la Confederazione sindacale
internazionale (Ituc). È quanto emerge da un’inchiesta svolta dalle autorità
belghe e citata da un articolo pubblicato dal quotidiano Le Soir e dal
settimanale Knack, secondo cui tra i vertici di quella che i media definiscono
una “organizzazione criminale infiltrata nel cuore del Parlamento” c’erano due
personaggi italiani di spicco a Bruxelles:
l’ex deputato dei
Socialisti per Articolo 1, Antonio Panzeri, al quale sono stati anche trovati
500mila euro in contanti all’interno della residenza brussellese, e Luca
Visentini, segretario generale di Ituc che rappresenta più di 200 milioni di
lavoratori. Entrambi risultano essere stati fermati nel blitz delle forze
dell’ordine belghe che hanno svolto 14 perquisizioni. I vertici dei
Socialisti&Democratici, di cui Panzeri ha fatto parte fino ad alcuni anni fa, si
riuniranno d’urgenza nelle prossime ore.
Quella iniziata a
luglio 2022 dalle autorità belghe e coordinata dalla procura federale è
un’inchiesta che potrebbe provocare un terremoto senza precedenti all’interno
dei palazzi delle istituzioni europee. Un caso di corruzione e riciclaggio di
denaro che, se venissero dimostrati legami ben più ramificati con altri
esponenti politici seduti tra gli scranni dell’Eurocamera, rischierebbe di
minare la credibilità delle istituzioni stesse. Secondo quanto si legge, “la
polizia giudiziaria federale ha effettuato 14 perquisizioni in diversi comuni di
Bruxelles. In particolare a Ixelles, Schaerbeek, Crainhem, Forest e
Brussels-City. Queste perquisizioni sono state effettuate nell’ambito di
un’ampia indagine con le accuse di organizzazione criminale, corruzione e
riciclaggio di denaro”.
Gli inquirenti
“sospettano che un Paese del Golfo stia cercando di influenzare le decisioni
economiche e politiche del Parlamento europeo pagando ingenti somme di denaro o
offrendo doni significativi a terzi che rivestono una posizione politica e/o
strategica significativa all’interno del Parlamento europeo. L’accusa, precisano
i giornali, non menziona il Qatar, ma diverse fonti ben informate hanno riferito
che a pagare le mazzette sia stata proprio Doha. Il loro obiettivo, mentre sono
ancora in corso le partite della Coppa del Mondo, sarebbe stato proprio quello
di difendere la legittimità della competizione dalle accuse di violazione di
diritti umani e dei diritti dei lavoratori, sottolineando i presunti progressi
della monarchia qatariota.
Tra gli arrestati,
oltre a Panzeri e Visentini, i media riferiscono esserci anche il direttore di
una ong e un assistente parlamentare, anch’essi di origine italiana. Si tratta
di personalità molto attive nelle associazioni per i diritti umani. Panzeri è
anche presidente di Fight Impunity che promuove “la lotta all’impunità per gravi
violazioni dei diritti umani” e la giustizia internazionale. Tra le sedi
perquisite ci sarebbe infatti anche quella dell’associazione.
Maggiori
informazioni sull’architettura dell’organizzazione potrebbero emergere dalle
analisi delle apparecchiature informatiche e dei telefoni sequestrati dagli
inquirenti nel corso dei blitz che hanno riguardato soprattutto gli assistenti
parlamentari legati al gruppo Socialisti e Democratici e, in un caso, al Partito
Popolare Europeo.
Inchiesta a
Bruxelles, sequestrati 600 mila euro in contanti. Le accuse all’ex eurodeputato
del Pd Antonio Panzeri.
Francesca Basso su
Il Corriere della Sera il 10 Dicembre 2022.
Coinvolta anche la
vicepresidente dell’Europarlamento Eva Kaili. Le perquisizioni in casa dell’ex
esponente del Pd: sono stati trovati 600 mila euro in contanti
Bufera al Parlamento
europeo e sgomento per un affare di corruzione legato al Qatar, che sta
scuotendo il gruppo socialista. Sono stati fermati ieri mattina dalla polizia
belga l’ex eurodeputato del Pd Antonio Panzeri, poi passato ad Articolo Uno, il
suo assistente nella passata legislatura Francesco Giorgi, Luca Visentini che è
da poco stato eletto segretario generale della Confederazione internazionale dei
sindacati (Ituc) e Niccolò Figà-Talamanca direttore della Ong No Peace Without
Justice che opera a Bruxelles. La notizia è stata anticipata dai giornali
belgi Le Soir e Knack, che in serata hanno allungato la lista dei fermati
aggiungendo Eva Kaili, compagna di Giorgi, socialista greca e una dei
quattordici vicepresidenti del Parlamento europeo.
Un parlamentare per
essere arrestato deve essere colto in flagranza di reato, l’abitazione di Kaili
è stata perquisita come i suoi uffici al Parlamento Ue. In un comunicato stampa
la procura federale belga ha spiegato che la polizia giudiziaria ha condotto 16
perquisizioni in 14 indirizzi in diversi quartieri di Bruxelles nell’ambito di
un’indagine di ampio respiro su una presunta organizzazione criminale, casi di
corruzione e riciclaggio di denaro.«Da diversi mesi gli inquirenti della polizia
giudiziaria sospettano che uno Stato del Golfo abbia cercato di influenzare le
decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo», spiega il comunicato
aggiungendo che sono stati sequestrati contanti per 600 mila euro oltre a
materiale informatico e telefoni cellulari. I giornali belgi riferiscono che il
Paese del Golfo sarebbe il Qatar, dove sono in corso i tanto discussi mondiali
di calcio e il contante sarebbe stato sequestrato a casa di Panzeri.
Secondo altre fonti
i quattro sono stati fermati per corruzione di funzionari e membri degli organi
delle comunità europee e di Stati esteri, riciclaggio e associazione a
delinquere. Da alcune intercettazioni sarebbero emersi anche riferimenti a fondi
europei destinati al nord Africa. Sono stati perquisiti anche gli uffici al
Parlamento europeo degli assistenti dei deputati belgi Marie Arena e Marc
Tarabella. Il comunicato della procura belga, che non indica i nomi dei fermati
ma solo le date di nascita (1955, 1969, 1971 e 1987) , spiega che «l’operazione
ha riguardato in particolare gli assistenti parlamentari» e cita anche un ex
eurodeputato che sarebbe appunto Panzeri. Sempre ieri è stato eseguito il MAE,
mandato di arresto europeo, nei confronti della moglie di Panzeri Maria
Colleoni, che abita a Carlusco (Bergamo) e della figlia Silvia, residente invece
nel Milanese. Tra le 16 perquisizioni c’è anche Fight Impunity, la ong fondata
nel settembre 2019 da Antonio Panzeri, una volta terminata la sua esperienza al
Parlamento Ue, per combattere le violazioni dei diritti umani. Alla ong era
legato anche Visentini.
L’ex segretario
della Camera del Lavoro di Milano ha comunque sempre mantenuto i legami e una
certa influenza soprattutto nella componente più a sinistra del gruppo S&D. Il
gruppo dei socialisti è «sconvolto dalle accuse» e fa sapere di avere chiesto
«la sospensione dei lavori su eventuali fascicoli e votazioni in plenaria
riguardanti gli Stati del Golfo, in particolare la liberalizzazione dei visti e
le visite programmate». A Strasburgo, alla Plenaria dello scorso novembre, si è
tenuto un dibattito sulla situazione dei diritti umani e dei lavoratori in
Qatar dopo le polemiche sul trattamento dei dipendenti stranieri che hanno
contribuito alla costruzione degli stadi per il Mondiale e per diversi
parlamentari avrebbe potuto essere più severa. La Lega va all’attacco: «Dopo
anni di accuse ai rivali, il Pd che deve chiarire immediatamente agli italiani».
L’ex giornalista
Kaili e il velista Giorgi, i «belli» di Bruxelles.
Storia di Francesca
Basso, da Bruxelles su Il Corriere della Sera il 10 dicembre 2022.
È una di quelle
coppie che non passa inosservata perché sono entrambi molto belli. Lei è di
Salonicco e ha 44 anni. Lui viene dall’hinterland di Milano e ha 35 anni . Eva
Kaili e Francesco Giorgi sono stati fermati (lei in flagranza di reato)
nell’ambito dell’inchiesta belga su una presunta corruzione al Parlamento Ue
legata al Qatar che sta scuotendo il gruppo socialista . Lei è uno dei 14
vicepresidenti del Parlamento Ue (ma gli S&D dopo averla espulsa ne hanno
chiesto e ottenuto la destituzione), lui è attualmente assistente parlamentare
dell’eurodeputato Andrea Cozzolino (non coinvolto nell’inchiesta) ed è stato
nella passata legislatura assistente di Antonio Panzeri, a sua volta fermato.
A casa della coppia,
che ha una bambina di due anni che ogni tanto si portavano al Parlamento
Ue, sono state trovate borse con del denaro e venerdì sarebbe stato fermato
anche il padre di Kaili. La famiglia fa parte della buona borghesia di
Salonicco, il padre è ingegnere e si è sempre mosso con successo nell’ambito del
pubblico. Eva ha una laurea in architettura messa da parte per diventare
giornalista. Per un breve periodo ha presentato il tg e poi è entrata in
politica. È stata molto vicina al primo ministro socialista George Papandreou,
che ha guidato la Grecia dal 2009 al 2011 (fu lui nell’ottobre del 2009 ad
annunciare che i bilanci di Atene erano stati truccati per entrare nell’euro).
Poi l’esperienza europea dal 2014. I rapporti con il Pasok si erano però
deteriorati da un po’ di tempo. Fonti greche riferiscono che il presidente del
Movimento socialista panellenico Nikos Androulakis avesse detto a Kaili già nel
settembre scorso, con largo anticipo, che non sarebbe stata ricandidata nel
2024. E venerdì sera, appena apparsa la notizia del fermo, l’ha espulsa.
Francesco Giorgi
gode di fama di bello al Parlamento Ue ma anche con un carattere un po’
arrogante. Chi lo conosce dice che facesse pesare la sua esperienza di
assistente parlamentare di lungo corso, iniziata nel febbraio del 2009. È anche
istruttore di vela a Caprera dal 2007. In quel contesto chi lo ha incrociato lo
descrive come una persona disponibile. Dai sui profili social è evidente che la
vela sia la sua passione ma c’è anche chi aggiunge la pesca. L’ambiente degli
assistenti parlamentari è altamente competitivo, il confronto è tra persone
molto preparate che ad ogni legislatura rischiano il proprio posto. E questo può
scatenare degli odi. Alle ultime Europee la delegazione del Pd ha quasi
dimezzato i parlamentari, che hanno diritto a tre assistenti a testa, quindi
circa una quarantina si è trovata a spasso. Giorgi, specializzato nel Maghreb,
era assistente di Panzeri e nella nuova legislatura lo è diventato di Cozzolino
per la sua specializzazione, perché l’eurodeputato napoletano è il presidente
della Delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb del Parlamento
europeo. Questo «cadere in piedi senza troppa fatica» ha creato però qualche
malumore nel mondo degli assistenti. Per il resto chi li conosce li descrive
come una coppia dalla grande bellezza ma normale. È generale lo stupore per
l’inchiesta e i suoi contenuti.
Eva Kaili
arrestata e sospesa da vicepresidente: per europarlamentari niente immunità se
colti in flagranza.
Storia di Giuseppe
Guastella Bruxelles su Il Corriere della Sera il 10 dicembre 2022.
È una Bruxelles
attonita che, stordita dallo schiaffo dell’arresto per reati pesantissimi di uno
dei 16 vice presidenti del Parlamento europeo, Eva Kaili si chiede cosa succede
all’ombra del palazzo dell’Unione. In serata la presidente Metsola ha deciso
sospendere Kaili dal ruolo di vicepresidente. A casa della parlamentare
socialista greca, la 44 enne ex presentatrice televisiva, gli agenti della
polizia giudiziaria avrebbero trovato «borse di banconote», scrive il giornale
belga L’Echo: è l’elemento decisivo che ha fatto scattare il fermo della
Kaili. Un europarlamentare, infatti, non gode di immunità se viene sorpreso
in , se viene, come letteralmente è accaduto con la Kaili, preso con le mani nel
sacco.
Per evitare che il
reato si protragga, la polizia deve fermare il sospettato, salvo poi l’avvio
delle procedure di autorizzazione a procedere da parte della magistratura. Con
la Kaili, nell’ambito dell’, sarebbe stato fermato anche il padre, anche lui
sorpreso in flagranza di reato mentre maneggiava le banconote. L’arresto della
parlamentare è stato ordinato dal giudice istruttore (Magistrato di prima
istanza) di Bruxelles Michel Claise. I reati contestati sarebbero gli stessi di
cui è accusato l’ex parlamentare europeo del Pd Panzeri, anche lui arrestato con
la moglie e la figlia, ma in questo caso su richiesta di arresto europeo al
termine della prima fase delle indagini preliminari: associazione per delinquere
finalizzata alla corruzione e al riciclaggio connessi all’ intensa attività di
lobbing compiuta a favore dello stato del Qatar e di quello del Marocco che, a
leggere la scarna documentazione notificata, avrebbero evidentemente pagato
tangenti per ottenere corsie preferenziali a loro favore nei rapporti con la
Unione Europea. Panzeri, la moglie e la figlia rischiano un massimo di 5 anni di
carcere, il primo per «essere intervenuto politicamente su membri del parlamento
europeo a favore del Qatar e del Marocco dietro pagamento».
Dalla documentazione
emerge che la famiglia sta organizzando una vacanza per Natale. Alla moglie che,
però, non vuole che sul suo conto siano addebitati 35 mila euro, Panzeri
risponde «che lui sarebbe andato in vacanza il primo gennaio usando “l’altra
soluzione” e che avrebbe addebitato 10 mila euro nel conto bancario “qui”»,
riferendosi al Belgio. Quindi la donna aggiunge che non può «permettersi di
spendere 100 mila euro per le vacanze come l’anno scorso». Panzeri, moglie e
figlia avrebbero partecipato anche ad un «trasporto dei “regali” ricevuti in
Marocco attraverso Abderrahim Atmoun», il 67 enne «ambasciatore del Marocco in
Polonia» ed avrebbero beneficiato di una «carta di credito intestata ad una
terza persona che loro chiamavano in francese “géant”, il “gigante”».
Emergerebbe anche che Panzeri aveva intenzione di aprire in Belgio una “nuova
attività”, ma che la moglie lo avrebbe rimproverato perché «non voleva che lui
facesse cose e operazioni di ogni genere» senza il suo controllo, che lei pare
voler esercitare, suggerendogli di «aprire un conto con l’Iva», cosa che per il
magistrato suggerisce che Panzeri intenda «aprire una nova attività
commerciale». La donna, infine, avrebbe usato in una telefonata la parola
«intrallazzi in riferimento ai viaggi e agli affari» usando la parola francese
«combines» «che suggerisce che il marito usa ingegnosi e spesso scorretti mezzi
per ottenere i suoi scopi», chiosa il giudice.
Maddalena Berbenni
per corriere.it il 10 dicembre 2022.
Si muoveva con
«metodi ingegnosi e spesso scorretti per raggiungere i suoi scopi», Antonio
Panzeri . Così scrivono di lui gli inquirenti di Bruxelles, che lo hanno
arrestato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e al
riciclaggio. Tra doni e vacanze da 100 mila euro, emersi nelle intercettazione
delle indagini e citati nelle accuse, di mezzo ci sono andate anche la moglie
Maria Dolores Colleoni e la figlia Silvia Panzeri , portate in carcere in
esecuzione di un mandato di arresto europeo disposto dalle autorità belga.
Nella tarda mattina
di oggi (sabato 10 dicembre 2022), sono comparse davanti alla Corte d’Appello di
Brescia per l’udienza di convalida dell’arresto. Secondo le accuse, sapevano dei
favori che l’ex eurodeputato del Pd ed ex sindacalista, 67 anni, avrebbe
ricevuto da Qatar e Marocco in cambio di pressioni politiche.
L’arresto nella casa
di Calusco
Le due donne
rispondono di favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta di Bruxelles per
corruzione e riciclaggio , con vincolo di associazione per delinquere che ha
portato agli arresti lo stesso Panzeri e altre persone. I carabinieri le hanno
accompagnate in carcere, a Bergamo, nel primo pomeriggio del 9 dicembre, la
moglie raggiunta nella casa di Calusco d’Adda (Bergamo) e la figlia, che vive
nel Milanese ed è avvocatessa, rintracciata in un secondo momento. Sono
assistite da due legali, uno è l’avvocato Nicola Colli del Foro di Bergamo.
Nelle
intercettazioni si parla di doni
L’ex eurodeputato
del Pd, passato ad Articolo Uno (che lo ha sospeso dopo l’arresto), è sospettato
di essere intervenuto politicamente, «dietro pagamento», presso alcune persone
che lavorano al Parlamento Europeo, a beneficio non solo del Qatar, ma anche del
Marocco. Emergerebbe da uno degli atti trasmessi dalle autorità belghe
all’Italia, in relazione alla richiesta di arresto della figlia. Ufficialmente
le autorità belghe non hanno confermato neppure che le pressioni riguardavano il
Qatar: il Parquet si è limitato a parlare di un «Paese del Golfo».
Nel documento viene
precisato che vige comunque la «presunzione di innocenza». La figlia e la moglie
di Panzeri apparirebbero agli occhi degli inquirenti «pienamente consapevoli»
delle attività di Panzeri, persino «del trasporto di doni». Le due sono
menzionate «nella trascrizione di intercettazioni telefoniche» durante le quali
il capofamiglia «ha commentato la consegna dei doni» di cui sarebbe stato «a
quanto pare» il beneficiario.
Le vacanze da 100
mila euro
Nelle carte
dell’inchiesta si farebbe riferimento anche a vacanze da 100 mila euro per
Panzeri e la moglie. Colleoni, riferiscono gli inquirenti belgi, «ha detto» al
marito «che non poteva permettersi di spendere 100 mila euro per le vacanze come
l’anno scorso e che pensava che l’attuale proposta, 9 mila euro a persona solo
per l’alloggio, era troppo costosa».
Panzeri, i regali
dell’ambasciatore e il viaggio della figlia Silvia a Doha.
Storia di Fabio
Paravisi Bruxelles su Il Corriere della Sera il 10 dicembre 2022.
Il dubbio era venuto
anche alla moglie: «Non possiamo permetterci di spendere 100mila euro per le
vacanze come l’anno scorso», ha detto Maria Dolores Colleoni ad Antonio Panzeri.
E anche quando ha visto il progetto del marito per le vacanze di Natale aveva
obiettato che il preventivo di 9 mila euro a persona solo per l’alloggio «era
troppo costoso».
I partono, spendono,
si fotografano e postano tutto sui social, incuranti del fatto che a qualcuno
potesse avere sospetti. Basta guardare i profili della figlia dell’ex
europarlamentare. Silvia Panzeri, 38 anni, avvocato da undici, casa e ufficio
nel Milanese, da un lato sfoggia sul curriculum attività legate alla violenza di
genere, la tutela delle donne vittime di violenza e il cyberbullismo (oltre a
una fresca specializzazione in diritto dell’Unione Europea). Ma, insieme, si
mostra con gli amici sui bordi di una piscina di Miami Beach lamentandosi che la
vacanza era ormai finita, solo per andare due settimane dopo a spasso per
Montreal. E lo scorso 27 novembre, a proposito di diritti delle donne, ha
postato immagini del Souq Waqif di Doha. Cioè la capitale del Qatar, il Paese
che sta ospitando i Mondiali di calcio, coinvolto nelle accuse di corruzione con
denaro versato a suo padre. Con quelle che la madre definisce al telefono
«combines». E per chiamare «intrallazzi» i viaggi e gli affari del marito,
secondo gli inquirenti, significa che la donna fosse al corrente di «mezzi
ingegnosi e spesso scorretti».
Mezzi di cui
peraltro le due donne, per le autorità belghe, «sembrano essere pienamente
consapevoli», tanto da avere «persino partecipato nel trasporto dei “regali”
dell’ambasciatore del Marocco in Polonia». Nonostante il curriculum del marito,
pare che Maria Colleoni non fosse poi molto convinta delle sue competenze
finanziarie, tanto che avrebbe più volte sottolineato di non volere che lui
facesse «operazioni senza che lei fosse in grado di controllarlo». Anzi, a volte
è lei che gli suggeriva come usare il denaro, per esempio spiegando che per
pagare la vacanza di Capodanno si poteva usare una non meglio chiarita «altra
soluzione», addebitando poi le spese su un conto belga. O usando la carta di
credito, insieme al marito, di una terza persona, soprannominata «The Giant»,
non identificata negli atti.
«Noi leggiamo queste
cose e siamo sconvolti», dicevano ieri i vicini di casa della coppia a Calusco
d’Adda (Bergamo). Dove sono pochi ad avere rapporti stretti con Antonio Panzeri.
Chi lo conosce bene, come l’ex sindaco Alfredino Cattaneo, che aveva avuto il
fratello di Panzeri come vice, si dice «incredulo: non corrisponde all’uomo che
conosco». E gli esponenti storici della sinistra e del sindacato anche di più:
«Per noi Antonio era un bravo sindacalista e un riferimento in Europa — dice
l’ex segretario provinciale della Cgil Luigi Bresciani —. Queste cose sono un
fulmine a ciel sereno, mi fanno sentire tradito e deluso, e mi fanno venire una
grande rabbia».
L’ex eurodeputato
Antonio Panzeri indagato a Bruxelles per corruzione. Fermate anche sua moglie e
la figlia.
Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 9 Dicembre 2022.
L’uomo politico
sospettato di aver agito per conto di autorità del Qatar al fine di «influenzare
le politiche del Parlamento Europeo» dice una nota della procura federale belga.
Con lui sotto indagine altri tre italiani
L’ex eurodeputato
della sinistra italiana Pier Antonio Panzeri e altri tre cittadini italiani
sono stati indagati ed arrestati dalla magistratura di Bruxelles in una
inchiesta internazionale per corruzione che vede coinvolte anche le autorità del
Qatar. Panzeri, terminato il mandato di europarlamentare ha continuato
a lavorare a Bruxelles come lobbista. Fermato ed interrogato
anche Francesco Giorgi, ex assistente parlamentare di Panzeri. L’indagine
riguarderebbe anche Luca Visentini , eletto a novembre segretario generale
dell’Ituc l’organizzazione internazionale dei sindacati e in passato dirigente
della Uil. L’ Ituc è una confederazione di sindacati di tutto il mondo, comprese
le organizzazioni belghe, che rappresentano in totale più di 200 milioni di
lavoratori.
Lo rivelano le
testate belghe Le Soir e Knack secondo i quali Panzeri e gli altri tre sono
stati “trattenuti per un interrogatorio” e sono stati sottoposti a perquisizioni
domiciliari. Nel corso di questi controlli sono stati sequestrati 600.000 euro
in contanti scoperti nella residenza di Bruxelles dell’ex eurodeputato. Il
fascicolo è stato aperto nel luglio scorso dal pubblico ministero Michel Claise,
specializzato in reati finanziari. Il giudice belga deciderà entro 48 ore se
emettere un mandato di arresto.
Tra le persone
interessate dalle perquisizioni, i media belgi Le Soir e Knack individuano
quattro assistenti parlamentari, persone “nate nel 1955, 1969, 1971 e 1987”
vicini al gruppo S&D. Uno di questi assistenti è legato anche al gruppo PPE (a
destra). Gli inquirenti hanno nuovamente “perquisito” le abitazioni di due
consiglieri e di un funzionario del Parlamento europeo. Per non parlare dei
direttori dei gruppi di lobbisti attivi nell’Ue.
Panzeri, è stato
componente anche della direzione dei Ds nel 2004 era stato eletto a Bruxelles
nelle liste degli allora «Uniti per l’Ulivo» ; in passato aveva rivestito a
lungo il ruolo di sindacalista ed era stato segretario della Camera del Lavoro
di Milano. Nel 2014 Pier Antonio Panzeri è stato rieletto all’assemblea Ue in
quota Pd, partito che ha lasciato nel 2017 aderendo ad Articolo Uno. Nel 2019 ha
fondato nella capitale belga una Ong denominata “Fight Impunity” di cui è
attualmente presidente, che promuove “la lotta all’impunità per gravi violazioni
dei diritti umani” e la giustizia internazionale. Stamattina , secondo le nostre
informazioni, è stata perquisita la sede di Fight Impunity situata in Rue Ducale
nel cuore di Bruxelles . Fino al 2019, Panzeri ha guidato la sottocommissione
del Parlamento europeo sui diritti umani, che si è occupata anche delle
condizioni dei lavoratori e più in generale dei diritti umani nel Qatar.
La procura federale,
che nella sua nota non cita nomi, avrebbe fatto luce su un flusso di denaro che
avrebbe raggiunto alcuni assistenti parlamentari al lavoro nei palazzi della Ue:
“La polizia giudiziaria federale ha effettuato 16 perquisizioni (a 14 diversi
indirizzi ) in diversi comuni di Bruxelles. In particolare a Ixelles,
Schaerbeek, Crainhem, Forest e Brussels-City. Queste perquisizioni sono state
effettuate nell’ambito di un’ampia indagine per presunti atti di organizzazione
criminale, corruzione e riciclaggio di denaro“. Dell’indagine sono state
informate anche le autorità italiane. Nel pomeriggio, a Bergamo sono state
fermate anche la moglie e la figlia di Panzeri. sono state fermate Maria
Colleoni, di 67 anni moglie di Panzeri, e la figlia Silvia Panzeri, 38anni.
Panzeri è originario
di Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo dove ha ancora la casa. È lì, secondo
le poche informazioni che è stato possibile raccogliere, che si trovava la donna
quando i Carabinieri hanno consegnato il Mae, che dispone il carcere. La figlia,
invece, è stata rintracciata. Le due donne sono state associate al carcere di
Bergamo.
Fermata ed
interrogata anche la vicepresidente del Parlamento europeo Eva
Kaili socialdemocratica greca , una dei 14 vicepresidenti dell’emiciclo europeo,
che è stata perquisita. L’unico modo per arrestare un parlamentare protetto
dalla sua immunità è coglierlo in flagrante, la vicepresidente Kaili è stata
sospesa dal gruppo dei Socialisti e Democratici ed espulsa dal partito
greco Pasok. Il suo compagno Francesco Giorgi, 44 anni, ex assistente
parlamentare di Panzeri, ed attuale collaboratore legato al gruppo S&D era stato
intercettato in mattinata. Entrambi sono indagati per corruzione. Indagato
anche Niccolò Figà-Talamanca, segretario generale della ong “No Peace Without
Justice“.
Il gruppo dei
Socialisti al Parlamento europeo si è detto “sconcertato dalle accuse di
corruzione nelle istituzioni europee”. “Data la gravità delle accuse, fino a
quando le autorità competenti non forniranno informazioni e chiarimenti
pertinenti, chiediamo la sospensione dei lavori su tutti i dossier e delle
votazioni in plenaria riguardanti gli Stati del Golfo, in particolare la
liberalizzazione dei visti e le visite previste”.
L’accusa, precisano
i giornali belgi, non menziona il Qatar, ma fonti ben informate hanno riferito
che a pagare le mazzette sia stata proprio Doha. Il loro obiettivo, mentre sono
ancora in corso le partite dei Mondiali di calcio, sarebbe stato proprio quello
di difendere la legittimità della competizione dalle accuse di violazione di
diritti umani e dei diritti dei lavoratori, sottolineando i presunti progressi
della monarchia qatariota. Maggiori informazioni sull’architettura
dell’organizzazione potrebbero emergere dalle operazioni di “criminal forensics”
sulle apparecchiature informatiche e telefoniche sequestrate dagli inquirenti
nel corso dei blitz che hanno riguardato soprattutto gli assistenti
parlamentari. Redazione CdG 1947
Mazzette dal
Qatar al Parlamento Ue: arrestata anche la vicepresidente.
Valeria Casolaro su
L'Indipendente il 10 Dicembre 2022.
È in corso una maxi
operazione della polizia belga, eseguita nell’ambito di un’indagine aperta a
metà luglio 2022 su presunti casi di corruzione all’interno del Parlamento
europeo, che sta portando in queste ore alla perquisizione delle abitazioni di
diversi eurodeputati e all’arresto di alcuni di questi, tra i quali l’ex
europarlamentare italiano Antonio Panzeri la deputata greca, nonché
vicepresidente del Parlamento Ue, Eva Kaili. Le accuse, a vario titolo, sono di
corruzione e riciclaggio di denaro: i soggetti coinvolti avrebbero infatti
ricevuto ingenti somme dalla monarchia qatarina per promuovere i supposti
miglioramenti in materia di diritti umani messi in campo da Doha e ripulirne
l’immagine di fronte al mondo, mentre nei cantieri dei Mondiali gli operai
morivano a centinaia per le pessime condizioni lavorative.
Le perquisizioni
fino ad ora condotte dalla polizia federale belga sono almeno 17: a muovere le
indagini il sospetto “che un Paese del Golfo stia cercando di influenzare le
decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo“, secondo
quanto confermato dalla Procura federale al quotidiano belga Le Soir, che ha
condotto l’inchiesta insieme ad un’altro quotidiano belga, Knack. Il tentativo
di corruzione avrebbe avuto luogo “versando somme di denaro consistenti o
offrendo regali importanti a terzi con una posizione politica e/o strategica
significativa all’interno del Parlamento europeo”. Non viene menzionato
esplicitamente il Qatar, ma entrambe i giornali citano fonti che avrebbero
confermato come dietro al versamento di mazzette vi sarebbe proprio il Paese
arabo. Tutti i soggetti fermati afferiscono al gruppo socialista europeo, primo
tra tutti l’ex deputato Antonio Panzeri e il suo ex assistente parlamentare
Francesco Giorgi, e, ad eccezione di Eva Kaili, sono di nazionalità italiana e
molto attivi nel mondo delle ONG a tutela dei diritti umani e dei sindacati.
A quanto risulta,
Panzeri è stato fermato e indagato a seguito di una perquisizione del suo
appartamento di Bruxelles, dove sono stati trovati tra i 500 e i 600 mila euro
in contanti. Confermato anche l’arresto in Italia, in esecuzione di un Mae
(Mandato di arresto europeo), di Maria Colleoni, moglie dell’ex eurodeputato, e
della figlia Silvia Panzeri, le quali si trovano ora in carcere a Bergamo. Nella
mattina di venerdì 9 sono stati perquisiti anche i locali di Fight Impunity, la
ONG presieduta da Panzeri dedita a promuovere “la lotta all’impunità per gravi
violazioni dei diritti umani” e la giustizia internazionale. Risulta inoltre
indagato a seguito della perquisizione del suo appartamento anche Francesco
Giorgi, ex assistente parlamentare di Panzeri e compagno di Eva Kaili.
Il nome della Kaili
è quello che forse ha suscitato il maggior scalpore, dato il ruolo di estremo
rilievo ricoperto (vice presidente del Parlamento europeo). Il Movimento
socialista panellenico, per il quale la Kaili era eurodeputata, ne ha annunciato
l’espulsione poco dopo l’annuncio di un suo possibile coinvolgimento. Era stata
proprio la Kaili a schierarsi a favore della decisione della FIFA di far
ospitare i mondiali in Qatar, in quanto questi «testimoniano come la diplomazia
sportiva possa realizzare la trasformazione storica di un Paese, con riforme che
hanno ispirato il mondo arabo. Si sono impegnati e si sono aperti al mondo» e
definendo il Paese «pioniere nei diritti dei lavoratori». Kaili si era persino
recata a Doha per incontrare i funzionari del Paese ed elogiare i tentativi di
miglioramento in materia di diritti umani, facendo anche uno sforzo verso
l’abolizione delle restrizioni sui visti Schengen per i cittadini quatarini.
Le sue dichiarazioni
erano state rilasciate in vista della risoluzione presentata il 21 novembre dal
Gruppo della Sinistra al Parlamento europeo per chiedere una presa di posizione
in merito alla vicenda dei Mondiali, poi approvata con 182 voti a favore, 165
contrari e 32 astenuti e osteggiata dalla pressoché totalità dei deputati
socialisti. Contrari alla risoluzione erano anche alcuni esponenti del Pd quali
Andrea Cozzolino, secondo quanto riporta ilFattoQuotidiano, che aveva dichiarato
come «il Parlamento europeo non dovrebbe accusare un Paese senza prove emerse da
indagini delle competenti autorità giudiziarie». Guardacaso, tra i nomi degli
assistenti di Cozzolino figurava proprio quello di Francesco Giorgi.
Tra i fermati vi
sono inoltre Luca Visentini, per undici anni a capo della Confederazione dei
sindacati europei (ETUC) ed eletto lo scorso novembre segretario generale della
International Trade Union Confederation (confederazione mondiale dei sindacati),
e Niccolò Figà-Talamanca, segretario generale della ONG fondata da Emma Bonino
No Peace Without Justice. Nè il Parlamento europeo né l’ambasciata del Qatar in
Belgio, riporta Le Soir, hanno per ora risposto alle richieste di commento.
Di quale sia la
realtà dietro allo sfarzo dei Mondiali che si stanno svolgendo nel Paese arabo
abbiamo ampiamente discusso all’interno dell’ultimo numero del Monthly Report. E
non si può non cogliere una certa amara ironia nel constatare che le operazioni
della polizia belga hanno avuto luogo nella giornata di venerdì 9 e sabato 10
dicembre, rispettivamente la Giornata internazionale contro la corruzione e
quella per i diritti umani. Concetti dei quali, evidentemente, le istituzioni si
riempiono la bocca in modo sfacciatamente strumentale. [di Valeria Casolaro]
Lobby ingolfata.
Cosa sappiamo dell’indagine sulla presunta corruzione del Qatar al Parlamento
europeo.
Linkiesta il 9 Dicembre 2022.
Gli inquirenti della
procura di Bruxelles hanno sequestrato cinquecentomila euro dalla abitazione
dell’ex eurodeputato di Articolo 1 Antonio Panzer, fermato assieme al
sindacalista Luca Visentini. Tra gli indagati c'è anche la vicepresidente
dell’Eurocamera, la socialdemocratica greca Eva Kaili
L’ex eurodeputato di
Articolo 1 Antonio Panzeri e il segretario generale dell’organizzazione
internazionale dei sindacati (Ituc) Luca Visentini sono stati fermati venerdì
dalla polizia di Bruxelles nell’ambito dell’indagine sul presunto tentativo di
uno Stato del Golfo di influenzare le decisioni economiche e politiche del
Parlamento europeo. Entro 48 ore un giudice deciderà se convalidare o meno il
loro arresto e quello di altri due italiani, un direttore di una organizzazione
non governativa e un assistente parlamentare europeo. Secondo il quotidiano
belga Le Soir il Paese del Golfo in questione sarebbe il Qatar, dove si sta
svolgendo in questi giorni la seconda fase del Campionato mondiale di calcio e
già al centro di indagini sulla presunta corruzione per la assegnazione del
torneo.
La tesi degli
inquirenti dell’Ufficio Centrale per la Repressione della Corruzione belga
(OCRC) è che delle ingenti somme di denaro e doni significativi sarebbero stati
regalati a persone che rivestono un ruolo strategico all’interno del Parlamento
europeo. Con questa motivazione la procura di Bruxelles ha ordinato
perquisizioni in diverse zone della capitale belga tra cui Bruxelles-Ville,
Crainhem, Forest, Ixelles e Schaerbeek.
Tra le sedici
abitazioni perquisite c’è anche quella della vicepresidente del Parlamento
europeo, la socialdemocratica greca Eva Kaili che come riportato su Twitter dal
giornalista David Carretta, il 21 novembre aveva dichiarato in un dibattito
all’Eurocamera sulla situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del
mondo FIFA nel Paese del Golfo: «Il Qatar è all’avanguardia nei diritti dei
lavoratori, abolendo la kafala e riducendo il salario minimo. Nonostante le
sfide che anche le aziende europee stanno negando per far rispettare queste
leggi, (i qatarioti) si sono aperti al mondo. Tuttavia, alcuni qui li stanno
discriminando, li maltrattano accusando di corruzione chiunque parli con loro o
si impegni».
Un’altra delle
abitazioni perquisite è la sede di Fight Impunity una organizzazione che lotta
contro la violazione dei diritti umani, il cui presidente è Panzeri. Anche
nella casa a Bruxelles dell’ex deputato del Parlamento europeo per tre
legislature (dal 2004 al 2019, le prime due con l’Ulivo, la seconda nelle liste
del Partito democratico che lasciò nel 2017 per aderire ad Articolo 1) gli
inquirenti hanno sequestrato cinquecentomila euro in contanti.
Visentini è stato
dal 2011 al 2022 membro della Confederazione dei sindacati europei (Etuc), prima
come segretario confederale e poi come segretario generale. A novembre aveva
lasciato l’Etuc per diventare segretario dell’International Trade Union
Confederation, la più grande confederazione sindacale del mondo che rappresenta
oltre 200 milioni di lavoratori.
Nella stessa
indagine, con un mandato d’arresto europeo sono state fermate a Calusco d’Adda,
in provincia di Bergamo, la moglie e la figlia dell’ex eurodeputato. Secondo i
giornali locali, le due si troverebbero ora nel carcere di Bergamo.
"Corruzione dal
Qatar". Fermati la numero due dell'Europarlamento, un ex deputato Pd e un
sindacalista Uil.
Due arresti, 5 fermi
e 600mila euro in casa: l'ipotesi di tangenti per ammorbidire l'UE verso il
Paese del Golfo. Luca Fazzo il 10 Dicembre 2022 su Il Giornale.
«La questione dei
lavoratori morti durante la costruzione delle infrastrutture che ospiteranno i
Mondiali di calcio va guardata in controluce e statisticamente relativizzata»:
così Antonio Panzeri, ex segretario della Cgil di Milano ed ex eurodeputato del
Pd, nel febbraio di quest'anno difendeva il governo del Qatar in un lungo,
imbarazzante intervento sulla home page di Fight Impunity, la Ong di cui è
presidente. Un report che oltre a minimizzare i morti nei cantieri dei Mondiali
indicava il Qatar come l'unico paese dell'area ad avere fatto «passi avanti»
anche sul terreno dei diritti umani.
Non era
disinteressato, a quanto pare, l'appoggio dell'ex sindacalista alla dittatura di
Doha nei corridoi e nelle aule dell'Europarlamento. Ieri mattina la gendarmeria
belga arresta quattro cittadini italiani: insieme a Panzeri c'è Luca Visentin,
ex segretario lombardo della Uil del commercio, oggi segretario mondiale della
potente confederazione sindacale Ituc; insieme a loro vengono arrestati il
direttore di una Ong e un assistente parlamentare dei Socialisti. I quattro sono
tutti accusati di corruzione, avrebbero ricevuto ingenti finanziamenti dal Qatar
per condizionare l'atteggiamento dell'Unione Europea nei confronti del paese del
Golfo, prima e dopo i Mondiali di calcio. Vengono perquisite le abitazioni degli
arrestati e la sede Fight Impunity, nella centralissima rue Ducale; in una
cassaforte a casa di Panzeri saltano fuori 600mila euro in contanti. E nella
Bergamasca è stato eseguito un mandato di arresto europeo anche nei confronti
della moglie e della figlia di Panzeri, che risulta avere ancora casa a Calusco
d'Adda, paese di cui è originario dove sono state rintracciate la moglie Maria
Colleoni, 67 anni, e la figlia Silvia. Ora si trovano in carcere a Bergamo.
Il caso Panzeri si
abbatte come una tempesta su Strasburgo, dove l'attività delle lobby è una
presenza costante: ma in questo caso, secondo la magistratura belga, si è andati
ben aldilà. Scattano sedici perquisizioni, quattro a carico di altri tre
assistenti parlamentari cui vengono sequestrati computer e telefoni: due
lavorano per il gruppo dei Socialisti e democratici, il quarto per i Popolari.
Secondo Le Soir, il quotidiano che ha reso noti gli arresti e le indagini, sono
stati perquisiti anche due consiglieri e un funzionario. Ma il colpo più
eclatante è l'interrogatorio con perquisizione di Eva Kailli, vicepresidente
socialista del Parlamento, il cui compagno Francesco Giorgi è l'ex assistente
parlamentare.
Panzeri e gli altri
arrestati verranno interrogati entro oggi da un giudice che deciderà se
confermare il loro arresto o rimetterli in libertà. Di sicuro c'è che sulla loro
strada gli italiani hanno incontrato un mastino: il giudice istruttore Michel
Claise, uno specialista in criminalità economica e finanziaria. É stato lui a
raccogliere le prime notizie di reato sulla attività della Ong di Panzeri e a
scavare per quattro mesi sui rapporti occulti col Qatar, arrivando a ricostruire
nei dettagli l'attività di quella che Le Soir definisce «una organizzazione
criminale infiltrata nel cuore del Parlamento europeo». Braccio operativo di
Claise è l'Ocrc, l'ufficio centrale per la repressione della corruzione.
«Siamo sconvolti
dalle accuse di corruzione nelle istituzioni dell'Ue», è il primo commento
dell'eurogruppo dei Socialisti, mentre il Pd si dichiara «sconcertato in
particolar modo a fronte delle persone coinvolte». Il problema è che se Fight
Immunity poteva presentare nel suo board personaggi di tutto rispetto - da Emma
Bonino al premio Nobel per la pace Denis Mukwege - la sua attività di lobbying a
favore del Qatar avveniva in modo tanto scoperto quanto disinvolto, e avrebbe
potuto spingere gli eurocompagni di Panzeri a interrogarsi sui veri motivi che
portavano uno stimato rappresentante dei lavoratori a trasformarsi nel cantore
di una dittatura dove i diritti sindacali non esistono. Eppure nel suo lungo
intervento del febbraio scorso Panzeri affermava che «dalla prospettiva dei
diritti umani» il Qatar è l'unico paese dell'area a «imprimere un movimento e
una direzione evolutiva», oltre a indicare il regime come «il più affidabile
alleato» della Nato nell'area, elogiandone «la disponibilità» nella crisi del
gas. Ma a Bruxelles queste cose non le leggevano?
(Adnkronos il 10
dicembre 2022) - Fight Impunity, la ong perquisita dalla polizia belga
nell'ambito dell'inchiesta che ha portato al fermo di quattro persone per
presunta corruzione, è stata fondata nel settembre 2019 da Antonio Panzeri, già
eurodeputato del gruppo S&D ed ex presidente della sottocommissione Diritti
umani del Parlamento Europeo.
Il consiglio dei
membri onorari della Ong, impegnata "contro l'impunità" per le violazioni dei
diritti umani che ha sede in Rue Ducale, è composto da personalità di assoluto
rilievo. Tra loro Federica Mogherini, ex ministro degli Esteri e Alto
Rappresentante dell'Ue, che oggi ha annunciato di essersi dimessa dal board,
oltre a Dimitris Avramopoulos, già commissario europeo agli Affari Interni,
candidato all'incarico di inviato speciale dell'Ue per il Golfo.
L'oro
del Qatargate: ferie da 100mila euro e sacchi di banconote. Panzeri si prodigava
pure per il Marocco.
Luca Fazzo l’11
Dicembre 2022 su Il Giornale.
Una specie di
Soumahoro in giacca e cravatta, un alfiere dei diritti dei poveri che garantiva
a sé e alla famiglia un invidiabile tenore di vita.
Una specie di
Soumahoro in giacca e cravatta, un alfiere dei diritti dei poveri che garantiva
a sé e alla famiglia un invidiabile tenore di vita. Nelle carte delle indagini
della magistratura belga su Antonio Panzeri, ex leader della Cgil milanese e già
eurodeputato del Pd, emergono col passare delle ore dettagli sempre più
sconcertanti. Se i meccanismi attraverso i quali Panzeri conquistava adesioni a
Bruxelles agli interessi del regime del Qatar e - si scopre ieri - anche del
Marocco rimangono ancora un po' indefiniti, a emergere con chiarezza disarmante
sono i benefit che l'esponente piddino ritagliava per sé dall'attività di Fight
Impunity, la Ong con sede nel centro della capitale belga, protagonista di
nobili battaglie - dal caso Regeni ai morti sul lavoro - ma anche sponsor
prezzolata degli interessi del regime di Doha, a partire dai Mondiali di calcio.
L'udienza di
convalida dell'arresto per favoreggiamento di Maria Colleoni e Silvia Panzeri,
moglie e figlia dell'ex sindacalista, catturate vicino Bergamo su richiesta
delle autorità belghe, si è svolta ieri. Ed è dalla carte trasmesse in Italia da
Bruxelles che emergono gli aspetti più incresciosi del lato familiare dello
scandalo che ha messo a rumore l'Europarlamento. Le due donne erano «pienamente
consapevoli» dei retroscena dell'attività svolta da Panzeri, e «persino del
trasporto di doni» che l'uomo riceveva dal Qatar. Del trasporto di altri regali,
provenienti dal governo del Marocco attraverso l'ambasciata a Varsavia, si
occuparono direttamente le due. In una intercettazione la Colleoni brontola
perché «non poteva permettersi di spendere centomila euro per le vacanze come
l'anno scorso e che pensava che l'attuale proposta, 9mila euro a persona solo
per l'alloggio, era troppo costosa». La Corte d'appello di Brescia ieri sera ha
confermato il mandato di cattura per le due donne e ha concesso loro gli arresti
domiciliari.
Panzeri, intanto,
viene scaricato praticamente da tutti. Articolo 1, il partito dove era approdato
dal Pd, lo espelle. L'ex ministra Federica Mogherini si dimette da Fight
Impunity, seguita dall'intero board. Eppure anche prima degli arresti, di ombre
sulla Ong per il suo appoggio al governo del Qatar ne erano emerse. Ma ora
Panzeri viene ufficialmente accusato di avere utilizzato «metodi ingegnosi e
spesso scorretti per raggiungere i suoi scopi». Il tesoretto di seicentomila
euro in contanti trovato durante la perquisizione in casa sua ne è la prova
tangibile. E ora l'arresto di Panzeri rischia di essere solo l'innesco di un
terremoto pronto a investire l'intero Parlamento europeo, finora restato
pressocché incolume dalle inchieste giudiziarie, in quella che i giornali belgi
definiscono una Mani Pulite in versione comunitaria.
Accuse simili a
quelle mosse a Fight Community vengono contestate anche a un'altra Ong gestita
da un italiano ma operante da Bruxelles, la No Peace without Justice fondata da
Emma Bonino, con sede allo stesso indirizzo della Figh Impunity e stesso
programma di lotta alle ingiustizia su scala globale: il suo segretario Niccolò
Figà Talamanca sarebbe, secondo alcune agenzie, tra gli arrestati. E soprattutto
desta scalpore il coinvolgimento della socialista greca Eva Kaili,
vicepresidente del Parlamento europeo, a casa della quale secondo la stampa
belga sarebbero stati trovati «sacchi di banconote». Il collegamento tra la
Kaili e Panzeri è il compagno della donna, Francesco Giorgi, assistente
parlamentare di Panzeri a Bruxelles. Quella che si intravede in controluce è
insomma una rete di politici-affaristi insediata nel cuore delle istituzioni
europee, in grado di condizionarne le scelte grazie ai fondi quasi illimitati
messi a disposizione dai paesi-clienti. E ora forse qualcosa verrà alla luce.
Le accuse per
Panzeri e gli altri arrestati, tra cui il sindacalista Luca Visentini, sono
«corruzione e riciclaggio, con vincolo di associazione per delinquere». Oggi il
giudice preliminare di Bruxelles, che li ha interrogati dopo l'arresto, deciderà
sulla convalida del provvedimento del giudice istruttore Mchel Claise che accusa
i cinque di avere condizionato le decisioni della Ue «versando somme di denaro o
offrendo regali importanti a terzi avendo una posizione politica e/o strategica
rilevante in seno al parlamento». Le Soir, il quotidiano belga che ha dato per
primo la notizia degli arresti, ha già segnalato una anomalia: il 9 dicembre in
un intervento a Strasburgo Eva Kaili si è dissociata dal coro di critiche al
Qatar. «La coppa del Mondo - disse - è la prova di come la diplomazia può
realizzare la trasformazione storica di un paese». Anche questa farina del sacco
di Panzeri?
Giordano Stabile per la Stampa l’11 Dicembre 2022.
I nostri cari emiri.
Il titolo di un saggio di qualche anno fa, 2016, ora di bruciante attualità.
Autori due giornalisti francesi, Georges Malbrunot e Christian Chesnot. La
guerra in Siria era all'apice, Bashar al-Assad usava tutte le armi, anche
proibite, per massacrare i ribelli. Le accuse contro le monarchie del Golfo, in
quel momento i principali sostenitori della rivoluzione siriana, valgono agli
autori anche accuse di "assadismo".
Ma l'inchiesta
guardava lontano e lo scandalo nel cuore della democrazia europea conferma tutte
le loro preoccupazioni. L'alleanza tra Occidente e Paesi del Golfo, che vede la
Francia fra i principali protagonisti, ha il suo lato oscuro, fatto soprattutto
di corruzione. «Da una parte c'è lo scambio irrinunciabile - conferma Malbrunot
- tra forniture energetiche e sicurezza, con gli Stati Uniti come garante
supremo dell'esistenza stessa dei ricchissimi ma piccoli emirati, minacciati
dall'Iran. Dall'altra un flusso di investimenti gigantesco verso l'Europa,
sempre più spesso opaco».
È il Qatar, il Paese
con il reddito pro capite più alto al mondo, 70 mila dollari all'anno, a esserne
la fonte. Con la Francia il rapporto è simbiotico.
Sboccia negli anni
Novanta, ma è nel 2009, dopo la mediazione qatarina per la liberazione delle
infermiere bulgare prigioniere di Gheddafi, che il presidente Nicolas Sarkozy
impone una convenzione fiscale a misura dell'allora emiro Hamad bin Khalifa
al-Thani, compresi famigliari e amici, senza ritenute alla fonte.
In pratica, la
Francia diviene un paradiso fiscale per i ricchi qatarini. Lo shopping è
gigantesco. L'Hôtel Lambert sull'Ile Saint-Louis, nel cuore di Parigi, il casinò
di Cannes, quote nei principali gruppi del lusso, fino alla perla, la squadra di
calcio del Psg, che sarà una delle porte d'ingresso per arrivare
all'assegnazione dei Mondiali di Calcio.
Ma il trattamento
privilegiato si accompagna a «innaffiatura» di uomini politici. «La maggior
parte dei francesi sono stati "innaffiati" dal Qatar durante la presidenza
Sarkozy - precisa Chesnot -. Doha però ha anche finanziato le campagne sia dei
laburisti che dei conservatori britannici nel 2015. Mentre negli Stati Uniti la
penetrazione è soprattutto emiratina e saudita: Mohammed bin Salman si è vantato
si aver contribuito per il 20 per cento della campagna di Hillary Clinton nel
2016», salvo poi diventare uno dei più stretti alleati di Donald Trump. Un altro
esempio di come non ci siano «preferenze di campo».
L'importate è
l'obiettivo, cioè influenzare le società occidentali. Con tutti i mezzi.
Ne hanno in
abbondanza.
Qatar ed Emirati
hanno sviluppato una strategia di soft power, che ha come pilastri
«l'educazione, la cultura e lo sport», conferma Malbrunot: «Hanno i mezzi per
comprarsi tutto o quasi: i quadri più preziosi, i club più prestigiosi, come il
Manchester City, ma anche i politici. Quando c'è un problema, un ostacolo, la
loro reazione può essere riassunta in una frase: "Compralo". Il risultato è che
la classe politica europea ha spesso difficoltà a resistere a queste sirene». E
se noi vediamo i miliardari in turbante ancora come «beduini ignoranti», loro ci
percepiscono come gente che si vende facilmente «per un libretto degli assegni o
un Rolex». O soldi in contanti in una valigia. Lo scandalo che ha coinvolto il
patron del Psg, Nasser al-Khelaïfi, ne è un esempio. Che seguono quelli sulle
mazzette alla Fifa o il finanziamento a moschee estremiste.
È dal fronte
culturale che forse arrivano le minacce più insidiose. Come ancora Malbrunot ha
documentato in un altro saggio, Qatar Papers, Doha è anche la principale
finanziatrice di imam vicini alla Fratellanza musulmana, che diffondono una
visione integralista dell'islam nelle diaspore dei Paesi arabi in Europa.
L'altro volto scuro dell'Emirato. L'alleanza con i Fratelli musulmani è
suggellata dall'accoglienza al loro leader Yusuf al-Qaradawi, condannato a morte
in Egitto, e rifugiato a Doha fin dal 1977, dove fonda la facoltà di Studi
islamici all'Università e diventa dagli anni Novanta in poi uno dei volti di
Al-Jazeera in arabo. L'Emirato ha protetto il controverso imam jihadista fino
alla sua morte, il 26 settembre scorso. «La soluzione è il Corano», era il suo
motto. Soprattutto se oliato di petrodollari, si potrebbe aggiungere.
Antonio Bravetti
per la Stampa l’11 Dicembre 2022.
A fine giornata, a
rompere il silenzio imbarazzato di Articolo Uno, arriva Arturo Scotto, netto:
«Il Qatar è un Paese dove i diritti umani non sono rispettati. Prima ancora che
sul piano giudiziario - dice a La Stampa il coordinatore del partito - il punto
è politico. Noi siamo con i lavoratori, non con gli emiri miliardari».
L'arresto di Antonio
Panzeri, l'ex eurodeputato di Pd e Articolo 1 accusato di corruzione,
riciclaggio e associazione per delinquere, scuote il partito di Roberto
Speranza.
Il segretario tace,
così come Pier Luigi Bersani e Sergio Cofferati. Anche nel Pd c'è poca voglia di
commentare. Sbotta Andrea Orlando su Twitter: «Diciamola tutta, garantismo a
parte, se fosse vera anche la metà dell'affaire Qatar-Europarlamento, saremmo
già allo schifo assoluto. Scambiare i diritti fondamentali dei lavoratori con
soldi e regali dei signori feudali del Qatar è tradimento totale dei valori
democratici».
Eppure Panzeri,
racconta un suo ex collega all'Europarlamento, era un uomo potente: «Tra i 10-15
deputati che contavano davvero. Aveva rapporti fortissimi con l'Africa, stava
più lì che a Bruxelles.
Soprattutto il
Maghreb: in Marocco e Tunisia era di casa. Le pareti del suo ufficio erano piene
di foto con re e principi».
Articolo Uno intanto
lo sospende. In una nota il partito esterna «sconcerto per quanto sta emergendo»
in «una vicenda del tutto incompatibile con la sua storia e il suo impegno
politico». Scotto ricorda che l'ex eurodeputato «da tempo non ricopre ruoli
operativi» e sospenderlo è «una decisione a tutela della nostra organizzazione
politica». Poi, sottolinea: «Noi viviamo con i soldi degli iscritti, con il
contributo del 2 per mille e con i versamenti degli eletti a tutti i livelli.
Questa è la nostra garanzia di libertà da qualsiasi condizionamento». Il
centrodestra, ovviamente, affonda il colpo: la Lega chiede una commissione
d'inchiesta all'Europarlamento e Susanna Ceccardi parla di «vergognosa ipocrisia
della sinistra».
Caso vuole che
l'arresto di Panzeri coincida con il lavoro che in questi giorni sta portando
avanti Massimo D'Alema come consulente privato.
L'ex premier sarebbe
il tramite tra il governo italiano e un gruppo di investitori del Qatar pronti a
rilevare la raffineria della russa Lukoil a Priolo. Una coincidenza temporale
che spinge Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd, a una critica amara: «A
proposito di Qatar, una nota a margine. Non c'entra con la vicenda a dir poco
orribile dell'Europarlamento, ma vedere ex leader della sinistra fare i lobbisti
in grandi affari internazionali non è solo triste, dice molto sul perché le
persone non si fidano, non ci credono più». Chi ha condiviso gli anni di
Bruxelles con Panzeri ne parla dietro anonimato come di «un parlamentare
potente, non uno sprovveduto».
Mai sopra le righe:
«Un taccagno esagerato, non buttava soldi, né per vestiti né per locali». Lo
ricordano amico di Gianni Pittella e Andrea Cozzolino. Raccontano di un rapporto
con Massimo D'Alema che si è molto affievolito negli anni «e poi Antonio non ha
bisogno di una casacca per girare, ha la sua. Non è "dalemiano", è sempre stato
un "panzeriano"».
Da open.online l’11
Dicembre 2022.
Lo scandalo esploso
con le gravi accuse all’ex europarlamentare Pd ora Articolo 1 Panzeri di essere
stato corrotto dal regime del Qatar, con tanto di mazzette da centinaia di
migliaia di euro scoperte nella sua casa di Bruxelles, agita la sinistra
italiana.
Per una fatale
coincidenza lo scandalo è esploso all’indomani della notizia che l’ex premier
Massimo D’Alema, ora impegnato sul versante delle grandi consulenze
internazionali, ha propiziato l’interessamento di un ricchissimo imprenditore
proprio del Qatar ad acquisire la raffineria Lukoil di Priolo in Sicilia, in
difficoltà dopo l’embargo alla Russia. Su questo D’Alema viene duramente
attaccato dal vice segretario del Pd Giuseppe Provenzano, citato da La Stampa:
«Vedere ex leader della sinistra fare i lobbisti in grandi affari internazionali
non è solo triste, dice molto sul perché le persone non si fidano, non ci
credono più».
Alessandro Da Rold
per “la Verità” l’11 Dicembre 2022.
Quando ai socialisti
milanesi rimasti si fa il nome di Antonio Panzeri, in tanti mettono subito le
mani avanti: «In Europa sarà stato anche nel gruppo socialista, ma è sempre
stato del Pci, un comunista!». La precisazione è doverosa per chi faceva parte
del Psi, che fu spazzato via dopo Mani Pulite, nel 1992. Anche perché alla fine
degli anni Novanta furono proprio i «comunisti» come Panzeri, oggi accusato di
corruzione e sospeso dal suo partito Articolo 1, a diventare i protagonisti
della politica italiana.
Nato nel 1955 in
provincia di Bergamo, a Riviera D'Adda, ex ala amendoliana (di Giorgio Amendola)
e migliorista del Pci (quella dell'ex presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano), la fortuna politica di Panzeri si è consumata proprio alla fine del
secolo scorso, a cavallo del nuovo millennio, quando Dc e Psi erano stati
spazzati via dalle indagini della magistratura.
All'epoca Massimo
D'Alema era un ruspante segretario del Pds, capace di diventare anche presidente
del Consiglio nel 1998. In quegli anni teneva banco la polemica sulla riforma
del mercato del lavoro e dell'articolo 18. Ogni giorno si accendeva una polemica
tra D'Alema e l'allora segretario generale della Cgil, Sergio Cofferati.
Panzeri, da segretario della Camera del Lavoro di Milano (lo è stato dal 1995 al
2003), avrebbe dovuto in teoria parteggiare per Cofferati.
Invece scelse
un'altra strada, decidendo di appoggiare D'Alema e schierando tutta la Camera
del Lavoro contro il «cinese». La decisione lo premiò, perché grazie a quella
battaglia, Panzeri entrò dalla porta principale del potere politico dalemiano.
Non è un caso, come ricordano le cronache di allora, che a metà del 2000 Panzeri
fosse uno degli invitati di punta a casa di Inge Feltrinelli a Milano, tra i
salotti più rinomati in quegli anni nel capoluogo lombardo. La vedova di
Giangiacomo, infatti, era solita ospitare pezzi della sinistra milanese,
filosofi e anche banchieri, per discutere e immaginare gli scenari politici
futuri.
Nel luglio di
quell'anno, D'Alema, appena uscito da Palazzo Chigi, puntava a rafforzare la sua
Fondazione Italianieuropei. E per farlo aveva deciso di invitare a casa dei
Feltrinelli lo stesso Panzeri, ma anche l'economista Pietro Modiano (ex Sea e
Carige) o un altro politico all'epoca in ascesa come Luca Bernareggi (già Ds e
poi in Legacoop).
Nasce e si afferma
in quegli anni il potere di D'Alema, a livello economico e politico, che passa
chiaramente anche dalla stanza dei bottoni di Bruxelles. Panzeri nel 2004 sarà
eletto in Europarlamento proprio con i Ds, negli anni d'oro della provincia di
Milano di Filippo Penati, poi passerà al Pd; quindi, nel 2017 seguirà ancora il
compagno Max nella formazione di Articolo 1.
In tre legislature,
quasi 15 anni da burocrate europeo che gli hanno assicurato una buona pensione
al compimento dei 63 anni, aveva stretto rapporti soprattutto con i Paesi del
Maghreb, in particolare il Marocco. Infatti, tra gli atti di accusa da parte
delle autorità belghe, oltre al Qatar, c'è anche il Paese nordafricano, per cui
si sarebbe speso in cambio di tangenti.
Chi conosce bene il
mondo dalemiano sostiene, però, che l'europarlamentare preferito dall'ex premier
sia sempre stato Massimo Paolucci. Anche per questo motivo, quando Paolucci e
Panzeri rimasero senza un seggio a Bruxelles, fu il primo a diventare capo della
segreteria del ministero della Salute di Roberto Speranza. Il secondo, invece,
fu costretto a reinventarsi. Su Internet si sprecano le foto che ritraggono
Speranza e Panzeri, futuro e passato del comunismo. Ma è anche per questo,
perché ormai senza un seggio e senza posti nel governo, che l'ex segretario
della Camera del Lavoro aveva deciso di fondare nel settembre 2019 la Ong Fight
Impunity per «contribuire a promuovere la lotta contro l'impunità».
A giudicare dalle
intercettazioni tra Panzeri e la moglie, Maria Dolores Colleoni, di soldi ne
giravano molti, con vacanze da 100.000 euro. Eppure, nella visura della Ong c'è
scritto che Panzeri aveva anche le funzioni di chauffeur: cosa non si fa quando
si perde un posto in Europarlamento
Da ansa.it il 12
dicembre 2022.
E' nell'ordine delle
centinaia di migliaia di euro l'importo in contanti sequestrato nell'abitazione
della vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili e nelle borse che suo padre
trasportava quando è stato fermato dalle autorità.
Il denaro non è
stato ancora contato ma, secondo il quotidiano belga L'Echo le prime stime
parlano di oltre 750mila euro in tagli da 20 e 50 euro: seicentomila euro erano
nella valigia portata dal padre di Kaili e il resto nell'abitazione
dell'eurodeputata greca.
L'autorità ellenica
per l'antiriciclaggio, nel frattempo, ha congelato gli averi della
vicepresidente dell'Eurocamera.
Atene ha congelato
tutti i beni di Eva Kaili: lo ha reso noto il governo greco. Il provvedimento
dell'Autorità greca antiriciclaggio riguarda "conti bancari, casseforti, aziende
e qualsiasi altro bene finanziario", riporta Le Soir citando il presidente
dell'organismo Haralambos Vourliotis. Il congelamento dei beni, secondo la
stessa fonte, colpisce anche i familiari stretti di Kaili, come i suoi genitori.
Nel mirino dell'Autorità c'è anche una società immobiliare di recente
costituzione nel quartiere chic ateniese di Kolonaki, che sarebbe stata creata
dall'eurodeputata 44enne e dal suo compagno italiano, aggiunge il giornale
belga. La procura federale belga ha annunciato una perquisizione negli uffici
del Parlamento europeo nell'ambito dell'inchiesta sul Qatar
Alcune perquisizioni
sono state effettuate fra ieri sera e oggi in abitazioni a Milano e in provincia
riconducibili ad Antonio Panzeri e alla sua famiglia dalla Guardia di Finanzia
in esecuzione di un ordine di investigazione europea nell'inchiesta di Bruxelles
per associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio per favorire Qatar e
Marocco, che hanno portato all'arresto fra gli altri dell'ex europarlamentare,
della figlia, della moglie e della vicepresidente del Parlamento Europeo Eva
Kaili. Da quanto si è saputo, sono stati sequestrati supporti informatici,
documenti e una somma in contanti in euro non significativa.
Intanto la procura
federale belga ha annunciato una perquisizione negli uffici del Parlamento
europeo nell'ambito dell'inchiesta sul Qatar. "Non appaiono sussistere cause
ostative alla consegna" al Belgio. Lo ha scritto il giudice della Corte
d'appello di Brescia Anna Dalla Libera nel provvedimento di convalida
dell'arresto di Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex
eurodeputato Antonio Panzeri, fermate venerdì nell'abitazione di famiglia a
Calusco d'Adda (Bergamo) in esecuzione di un mandato di arresto europeo e poi
poste ai domiciliari. Le due donne sono accusate di corruzione, riciclaggio e
associazione per delinquere per fatti commessi dal 1 gennaio 2021 all'8 dicembre
2022.
Estratto
dell’articolo di Gad Lerner per “il Fatto quotidiano” il 12 dicembre 2022.
[…] Cosa gli è
preso? Difficile trovare una risposta. Ma certo non aiuta il silenzio dei
dirigenti di Articolo 1 che, dopo aver sospeso Panzeri (ci mancherebbe), non
hanno proferito verbo. Forse perché fa loro male riconoscere che la corruzione
spesso è il passo successivo della spregiudicatezza, così come l'affarismo della
intermediazione negli scambi commerciali è un corollario della realpolitik.
So che in quel
partito ha suscitato imbarazzo l'attività professionale di advisor del militante
semplice D'Alema in favore della Colombia o del Qatar. Nessuna relazione, per
carità, con lo scandalo dell'Europarlamento in cui è coinvolto Panzeri. Ma,
parafrasando il vecchio Lenin, possiamo ben dirlo: l'affarismo è la malattia
senile del dalemismo.
Corruzione al
Parlamento Europeo, per il Tribunale di Brescia: “Moglie e figlia di Panzeri si
possono consegnare al Belgio”.
Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 13 Dicembre 2022
Dall'inizio
dell'operazione della magistratura belga che ha portato all'arresto di 6 persone
e a 20 perquisizioni, a partire da venerdì scorso, "i mezzi informatici di dieci
assistenti parlamentari sono stati congelati per evitare che i dati necessari
all'inchiesta non sparissero". È quanto si legge in un comunicato della Procura
belga
La Corte d’appello
di Brescia ha dato semaforo verde alla consegna della moglie Maria Dolores
Colleonie e di Silvia Panzeri, figlia di Antonio Panzeri all’ Autorità
Giudiziaria del Belgio che ha emesso un mandato di arresto internazionale su di
loro. Il giudice della Corte d’appello di Brescia Anna Dalla Libera scrive nel
provvedimento di convalida dell’arresto “Non appaiono sussistere cause ostative
alla consegna” al Belgio, delle due donne di casa Panzeri fermate venerdì
nell’abitazione di famiglia a Calusco d’Adda (Bergamo) e poi poste ai
domiciliari.
Le due donne
rispondono delle accuse di corruzione, riciclaggio e associazione per delinquere
per fatti commessi dal 1 gennaio 2021 all’8 dicembre 2022. Il giudice di
Brescia, disponendo gli arresti domiciliari delle due donne, nel suo
provvedimento ha scritto che “la misura è idonea a garantire la consegna alle
autorità del Belgio“. Nel corso dell’udienza, come riportato dall’ordinanza ,
la moglie e la figlia di Panzeri “non hanno espresso il consenso ad essere
consegnate e non hanno rinunciato al principio di specialità“. La Corte
d’Appello di Brescia, in composizione collegiale, ha fissato l’udienza per
discutere della consegna, il 19 dicembre per la Colleoni e il giorno dopo per
sua figlia Silvia Panzeri.
Tra ieri sera e oggi
sono state effettuate dalla Guardia di Finanza delle perquisizioni nelle
abitazioni a Milano e nella Bergamasca riconducibili ad Antonio Panzeri e alla
sua famiglia in esecuzione di un ordine di investigazione europea nell’ambito
dell’inchiesta di Bruxelles per presunte tangenti da parte di Qatar e Marocco,
in cambio di un appoggio politico all’Europarlamento. Le Fiamme Gialle hanno
rinvenuto e sequestrato nell’abitazione della famiglia Panzeri a Calusco d’Adda,
in provincia di Bergamo contanti per una somma di 17mila euro. Al momento nella
casa si trova agli arresti domiciliari Maria Dolores Colleoni, la moglie
di Panzeri, destinataria insieme alla figlia Silvia Panzeri di un mandato di
arresto europeo.
Le perquisizioni
sono state disposte dalla magistratura belga nell’inchiesta di Bruxelles per
associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio per favorire Qatar e
Marocco, che hanno portato all’arresto fra gli altri dell’ex
europarlamentare Panzeri , della figlia, della moglie e della vicepresidente del
Parlamento Europeo Eva Kaili e del suo compagno Francesco Giorgi. Da quanto si è
appreso, sono stati sequestrati anche supporti informatici e documenti che
potrebbero rivelarsi utili nel corso delle indagini.
Eseguiti anche degli
accertamenti bancari su diversi conti bancari riconducibili all’ex
europarlamentare Panzeri: il decreto di perquisizione è stato firmato dal
procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale, a capo del dipartimento Affari
internazionali, che sta operando in collaborazione con Eurojust, riguarda in
particolare l’abitazione della famiglia Panzeri a Calusco D’Adda (Bergamo), ma
anche un ufficio a Milano e l’abitazione milanese dell’arrestato Francesco
Giorgi, ex collaboratore dell’ex europarlamentare dem Panzeri. Da quanto emerge
sono stati sequestrati anche degli orologi di lusso (ma non si sa al momento a
chi), oltre a supporti informatici e documenti.
Perquisita ieri
dalla Guardia di Finanza anche l’abitazione milanese di Francesco
Giorgi, assistente europarlamentare e compagno della vice presidente del
Parlamento europeo, Eva Kaili, sulla base di un’ordine di investigazione europeo
legato all’inchiesta Qatargate della Procura federale di Bruxelles.
La Camera del Lavoro
di Milano, di cui Antonio Panzeri è stato segretario generale dal 1995 al 2003,
ha espresso “sdegno per la gravità dei fatti denunciati” nell’inchiesta di
Bruxelles sulle tangenti in Qatar. Lo si apprende da una nota in cui
la Cgil milanese sottolinea che “sarà compito della magistratura e dei tribunali
accertare le responsabilità” degli indagati, tra cui lo stesso Panzeri. “Siamo
convinti che i diritti dei lavoratori e le battaglie per la difesa, la dignità e
promozione del lavoro non possono essere oggetto di scambi di qualsivoglia
natura. La Camera del Lavoro di Milano e tutta la Cgil – conclude il sindacato
– continueranno nel loro impegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori per
la difesa dei loro diritti e per il miglioramento delle loro condizioni“.
Erano già stati
posti i sigilli in nel settore G, di Palazzo Spinelli, dove al quindicesimo
piano si trovano gli uffici – tra gli altri – degli eurodeputati Maria
Arena, Alessandra Moretti e Marc Tarabella, mentre al decimo piano sono stati
sigillati almeno altri tre uffici, tra cui quello della vice presidente Eva
Kaili (Socialisti & Democratici). Gli agenti della Polizia federale belga, in
borghese con la fascia della polizia al braccio, si sono spostati verso il
settore Q, dove si sono trattenuti per un’altra mezz’ora almeno.
A quanto constatato
dall’Ansa, gli uffici sigillati negli edifici dell’Eurocamera a Strasburgo
sarebbero legati ad almeno due eurodeputati: Cozzolino ed Alessandra Moretti,
entrambi eletti e militanti nelle file del Pd che non risultano indagati dalla
Procura belga. Si tratta delle stanze dove lavorano gli assistenti parlamentari
dei due esponenti socialisti e i sigilli fanno seguito alle perquisizioni
avvenute negli edifici del Parlamento Europeo a Bruxelles. Nelle scorse ore,
nella capitale belga, è stato perquisito l’ufficio di una delle assistenti
parlamentari di Moretti, Francesca Garbagnati, che al momento non risulta tra
gli indagati.
Procura del Belgio:
“congelati” computer di 10 assistenti. Dall’inizio dell’operazione della
magistratura belga che ha portato all’arresto di 6 persone e a 20 perquisizioni,
a partire da venerdì scorso, “i mezzi informatici di dieci assistenti
parlamentari sono stati congelati per evitare che i dati necessari all’inchiesta
non sparissero”. È quanto si legge in un comunicato della Procura belga. Il
dossier della procura, “gestito da un giudice istruttore di Bruxelles, è stato
aperto da più di quattro mesi per corruzione, riciclaggio e organizzazione
criminale”, spiega la nota.
“Da venerdì, con il
sostegno dei servizi di sicurezza del Parlamento Europeo, i mezzi informatici di
10 assistenti parlamentari erano stati congelati” affinchè i dati che
contenevano non sparissero. La perquisizione di oggi al Parlamento
europeo “aveva quindi come obiettivo quello di ottenere questi dati”. “Altre
perquisizioni – continua la Procura federale – sono avvenute ieri in Italia. In
tutto, dall’inizio delle operazioni, ci sono state 20 perquisizioni: 19 in
residenze e uffici oltre a quella di oggi nei locali del Parlamento europeo.
Sono stati sequestrati, in tre diversi luoghi, diverse centinaia di migliaia di
euro: 600 mila al domicilio di uno dei sospetti, diverse centinaia di migliaia
in una valigia che si trovava in una camera di albergo a Bruxelles e circa 150
mila circa in un appartamento di proprietà di un deputato europeo. Ad oggi, in
questo dossier, sono state arrestate 6 persone. Per quattro, fra cui un
parlamentare europeo, è stato confermato lo stato di arresto“. Nella nota si
conferma senza citarla che l’arresto della vicepresidente Eva Kaili è stato
possibile nonostante l’immunità parlamentare perché ci si trovava dinanzi a un
caso di flagranza di reato.
“L’Italia è un
grande Paese e, se ci sono dei parlamentari o degli assistenti che hanno
commesso dei reati, è una questione che riguarda le singole persone e non il
sistema Italia“. ha commentato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al
termine del Consiglio Affari esteri. “Noi non dobbiamo permettere che la
supposta corruzione di alcuni nella violazione di regole con comportamenti
inaccettabili da parte di alcuni danneggi il ruolo del Parlamento europeo,
l’unica istituzione democratica eletta dai cittadini, e dell’Ue”, ha
aggiunto Tajani. “Fa benissimo la presidente Metsola, che ha tutto il nostro
sostegno, a difendere il ruolo del Parlamento e a insistere sulla trasparenza.
Condividiamo tutte le iniziative che ha annunciato questo pomeriggio a
Strasburgo”, ha concluso il vice premier e ministro degli esteri del Governo
Meloni. Redazione CdG 1947
Arrestata l’
eurodeputata Eva Kaili che difendeva il Qatar: in casa trovati “sacchi di
banconote”.
Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 12 Dicembre 2022
L'eurodeputata
socialista espulsa dal gruppo dopo l'inchiesta per corruzione con tangenti
qatarine per 'ammorbidire' le critiche sui diritti umani. Panzeri, ex
eurodeputato del Pd, successivamente passato ad Articolo Uno, ritenuto un
"fedelissimo" di Roberto Speranza, che dopo l’arresto lo ha sospeso
Eva
Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo dopo che nella perquisizione della
sua abitazione sono stati trovati “sacchi di banconote” è stata arrestata in
Belgio ed ha trascorso la notte in stato di detenzione. Sarebbe stato fermato
anche il padre della politica greca, che stava cercando di partire con una borsa
piena di banconote. Lo rende noto il quotidiano belga L’Echo. La circostanza
del rinvenimento dei soldi spiegherebbe come mai nonostante l’immunità
parlamentare la Kaili sia stata arrestata . Infatti sulla base il regolamento
interno del Parlamento Europeo l’immunità decade in caso di flagranza di reato.
L’agenzia di stampa greca Ana-Mpa ha oggi confermato quanto il CORRIERE DEL
GIORNO aveva reso noto sin da ieri sera, anche il compagno della Kaili, cioè che
è stato tratto in arrestato anche il suo compagno Francesco Giorgi, con il quale
ha avuto una figlia, il quale in passato è stato assistente parlamentare
di Antonio Panzeri, . L’indagine, aperta lo scorso luglio, è stata coordinata
dall’Ufficio centrale per la repressione della corruzione del Tribunale di
Bruxelles.
La vice presidente
greca del Parlamento europeo Kaili aveva difeso in aula, sino a qualche giorno
fa i progressi del Paese del Golfo nell’ambito dei diritti in vista dei Mondiali
di calcio in corso. Nel suo intervento a Strasburgo ha detto: “Oggi i Mondiali
in Qatar sono la prova, in realtà, di come la diplomazia sportiva possa
realizzare una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato
il mondo arabo. Io da sola ho detto che il Qatar è all’avanguardia nei diritti
dei lavoratori, abolendo la kafala e riducendo il salario minimo. Nonostante le
sfide che persino le aziende europee stanno negando per far rispettare queste
leggi, si sono impegnati in una visione per scelta e si sono aperti al mondo.
Tuttavia, alcuni qui stanno invitando per discriminarli. Li maltrattano e
accusano di corruzione chiunque parli con loro o si impegni nel confronto. Ma
comunque, prendono il loro gas. Tuttavia, hanno le loro aziende che guadagnano
miliardi lì” aggiungendo “Ho ricevuto lezioni come greca e ricordo a tutti noi
che abbiamo migliaia di morti a causa del nostro fallimento per le vie legali di
migrazione in Europa. Possiamo promuovere i nostri valori ma non abbiamo il
diritto morale di dare lezioni per avere un’attenzione mediatica a basso costo.
E non imponiamo mai la nostra via, noi li rispettitamo, anche senza Gnl“.
Scandalo
all’Europarlamento, quando Eva Kaili diceva: “Il Qatar è all’avanguardia nei
diritti dei lavoratori”
“Sono una nuova
generazione di persone intelligenti e altamente istruite. Ci hanno aiutato a
ridurre la tensione con la Turchia. Ci hanno aiutato con l’Afghanistan a salvare
attivisti, bambini, donne. Ci hanno aiutati. E sono negoziatori di pace. Sono
buoni vicini e partner. Possiamo aiutarci a vicenda per superare le carenze.
Hanno già raggiunto l’impossibile” ha concluso la Kaili.
Da alcune
intercettazioni sarebbero emersi anche riferimenti a fondi europei destinati al
nord Africa. Sono stati perquisiti anche gli uffici al Parlamento europeo degli
assistenti dei deputati belgi Marie Arena (molto “vicina” alle attività
lobbistiche di Panzeri) e Marc Tarabella. Sarebbe stato perquisito anche
l’ufficio di una funzionaria dell’Europarlamento, anche lei italiana. Un’
assistente che è stata perquisita è anche lei italiana, si chiama Donatella
Rostagno e lavora da circa un anno con l’eurodeputata Arena. Un’altra assistente
coinvolta nelle indagini (come rivela il Fatto Quotidiano) sarebbe Francesca
Garbagnati, 30 anni, la quale in passato ha lavorato per Panzeri mentre adesso
lavora per l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti (che non è indagata in
questa inchiesta) la quale smentisce ad Affaritaliani, che la sua assistente
sia stata interrogata. Ma non smentisce che la procura stia indagando
sulla Garbagnati per i suoi precedenti rapporti con Panzieri . Il
collega Vincenzo Bisbiglia del Fatto rivela infatti che l’ufficio
della Garbagnati all’ Europarlamento sarebbe stato sigillato dalla Polizia
Federale che le avrebbe sequestrato il pc e lo smartphone. Sarà forse per questo
che la Garbagnati ieri pomeriggio ci ha fatto scrivere minacciando querele
attraverso un account di post di una terza persona che è un attivista del Pd.
L’eurodeputata del
Pd Moretti, che abbiamo provato a contattare telefonicamente anche questa
mattina ai suoi recapiti telefonici Bruxelles e Strasburgo dove i telefoni
squillano a vuoto (nonostante abbia ben 7 assistenti retribuiti con denaro
pubblico, senza mai ricevere alcuna risposta, era stata a Doha nel 2020 per un
convegno sui diritti delle donne ed aveva pubblicato un post su Facebook sul
tema. “Qui in Qatar stanno facendo passi in avanti nella tutela dei
diritti anche delle donne e dei lavoratori. Siamo infatti andati a visitare uno
degli 8 stadi che stanno costruendo in vista dei Mondiali di calcio 2022 e
abbiamo verificato le condizioni di vita di chi sta offrendo manodopera per la
realizzazione degli impianti”, si leggeva nel post.
Il comunicato della
procura belga, spiega che “l’operazione ha riguardato in particolare gli
assistenti parlamentari” e cita anche un ex eurodeputato che sarebbe
appunto Panzeri, ex eurodeputato del Pd, successivamente passato ad Articolo
Uno, dove era il “responsabile delle Politiche Europee Internazionali “ ritenuto
un “fedelissimo” di Roberto Speranza, ma che dopo l’arresto lo ha sospeso.
Imbarazzante la nota: “”La commissione di garanzia di Articolo Uno Lombardia
ha sospeso Antonio Panzeri dall’anagrafe degli iscritti. Nell’esprimere
sconcerto per quanto sta emergendo, Articolo Uno esprime fiducia nell’autorità
giudiziaria e auspica che Panzeri possa dimostrare la sua estraneità a una
vicenda del tutto incompatibile con la sua storia e il suo impegno politico“.
Della serie: alla vergogna “rossa” non c’ è mai limite !
A Strasburgo, alla
Plenaria dello scorso novembre, si era tenuto un dibattito sulla situazione dei
diritti umani e dei lavoratori in Qatar dopo le polemiche sul trattamento dei
dipendenti stranieri che hanno contribuito alla costruzione degli stadi per il
Mondiale e per diversi parlamentari avrebbe potuto essere più severa. La Lega va
all’attacco: “Dopo anni di accuse ai rivali, il Pd che deve chiarire
immediatamente agli italiani”.
Nel 2019, quando
Panzeri aveva scelto di non ricandidarsi, Roberto Speranza su Twitter aveva
commentato: “Ringrazio Antonio Panzeri per l’impegno prezioso di questi anni al
Parlamento Europeo. La scelta autonoma di non ricandidarsi merita rispetto. Sono
sicuro che faremo ancora insieme molte battaglie per ricostruire la Sinistra nel
nostro Paese”.
Maria Dolores
Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente la moglie e la figlia (che peraltro
fa l’avvocato) dell’ex eurodeputato del gruppo Socialisti & Democratici Antonio
Panzeri, scrivono gli inquirenti belgi, nei documenti trasmessi alle autorità
italiane per chiedere l’arresto delle due donne “sembrano essere pienamente
consapevoli delle attività del marito/padre” e sembrano “persino partecipare nel
trasporto dei “regali” dati al Marocco da A.A. (Abdesselam
Alem n.d.r.) ambasciatore del Marocco in Polonia”. I reati, spiegano gli
inquirenti, sono menzionati nelle trascrizioni delle intercettazioni
telefoniche, “durante le quali la signora Panzeri ha fatto commenti circa i
“regali”, dei quali ha apparentemente beneficiato“.
La moglie di Panzeri
Maria Dolores Colleoni avrebbe anche detto a al marito “di aprire un conto
bancario in Belgio e aveva apparentemente insistito che non voleva che lui
facesse operazioni senza che lei potesse controllarle. Gli ha detto di aprire un
conto con Iva, cosa che suggerisce che Panzeri potrebbe avviare una nuova
attività commerciale, soggetta a Iva. Questo indica che Maria Colleoni esercita
un qualche tipo di controllo sulle attività del marito o che perlomeno cerca di
mantenere un qualche controllo“. Gli inquirenti belgi evidenziano
che Colleoni “ha usato la parola “combines” per riferirsi ai viaggi e agli
affari del marito. La parola francese “combines” è peggiorativa e suggerisce che
suo marito usa mezzi ingegnosi e spesso scorretti per ottenere i suoi scopi”. Da
quanto emerge dalle carte, la coppia Panzeri-Colleoni usava anche carte di
credito intestate ad altre persone, in particolare ad un prestanome , indicato
con il nome “gèant” (il gigante) per evitare le loro spese con tanti “zero”
potessero essere rintracciate.
Nei documenti
trasmessi all’ Autorità Giudiziaria italiana, con i quali è stato richiesto ed
ottenuto l’arretso delle due donne si ricostruirebbero persino le vacanze della
famiglia Panzeri: apparentemente l’ex eurodeputato italiano della sinistra
italiana poteva permettersi di fare con la moglie, Maria Dolores Colleoni,
vacanze per un costo che “arrivava fino a 100mila euro“. La Colleoni,
riferiscono gli inquirenti belgi, “ha detto al marito che non poteva permettersi
di spendere 100mila euro per le vacanze come l’anno scorso e che pensava che
l’attuale proposta, 9mila euro a persona solo per l’alloggio, era troppo
costosa“. Le due donne sono state prelevate ieri sera dai Carabinieri nelle loro
case di Calusco d’Adda (Bergamo) ed in quella di Milano dove risiede la figlia,
la quale esercita nel foro ambrosiano la professione di avvocato nello Studio
legale Panzeri Ventarola a Locate di Triulzi, (MI)
Maria Dolores
Colleoni e la figlia Silvia Panzeri sono state convocate questa mattina presso
la Corte d’appello di Brescia per l’udienza di identificazione che è iniziata
alle ore 14: entrambe risponderebbero di favoreggiamento nell’ambito
dell’inchiesta di Bruxelles per la presunta corruzione messa in piedi dal
Qatar. Il Gip Anna Dalla Libera ha convalidato l’arresto e concesso la
detenzione domiciliare. “Le mie assistite hanno riferito in aula di non essere a
conoscenza di quanto viene loro contestato“, ha commentato l’avvocato Angelo De
Riso difensore con il collega Nicola Colli, delle due donne. “Siamo soddisfatti
e confidiamo che non venga accolta la richiesta di consegna alle autorità del
Belgio”, hanno affermato i legali. Si ritorna in aula il 19 dicembre.
L’eurodeputata
Kaili, come anche le altre quattro persone arrestate, verrà ascoltata fra 48 ore
da un giudice belga il quale deciderà se confermare i mandati di cattura. La
procura federale belga non ha confermato i nomi degli arrestati, che ormai sono
quasi tutti noti, sottolineando però che si tratta di “personalità con posizioni
strategiche“.
“Il nostro
Parlamento europeo è fermamente contrario alla corruzione. In questa fase, non
possiamo commentare alcuna indagine in corso se non per confermare che stiamo
cooperando e coopereremo pienamente con tutte le forze dell’ordine e le
autorità giudiziarie pertinenti. Faremo tutto il possibile per favorire il corso
della giustizia“. Con questo il tweet la presidente del Parlamento
europeo, Roberta Metsola, ha commentato l’inchiesta per corruzione che ha
portato all’arresto della vicepresidente dell’Eurocamera, la greca Eva Kaili, e
di quattro cittadini italiani, tra cui Antonio Panzeri, ex eurodeputato del Pd e
poi passato con Articolo 1, Luca Visentini, segretario generale dell’Ituc,
organizzazione internazionale dei sindacati, e Francesco Giorgi, assistente
di Panzeri e compagno della Kaili. Redazione CdG 1947
Qatargate,
Panzeri per i giudici era il «manovratore». A Kaili sequestrati 750 mila euro in
contanti.
Storia di Giuseppe Guastella, inviato a Bruxelles, su Il Corriere
della Sera il 12 dicembre 2022.
Un «paravento»
dietro il quale Antonio Panzeri si muoveva «manovrando» come un «capo» in modo
criminale e spregiudicato: secondo la magistratura belga era questa la reale
funzione di Fight impunity, la Ong per la difesa dei diritti umani fondata nel
2019 da Panzeri il quale avrebbe influenzato il Parlamento europeo elargendo,
attraverso la sua nobile creatura, grosse somme di denaro e regali principeschi
provenienti dal Qatar. Cadeaux che avrebbe elargito a coloro che, politici o no,
potevano orientare le decisioni dell’assemblea a favore del Paese del Golfo a
ridosso del Mondiale di calcio, quando emergeva con evidenza che l’emirato
proprio non era in prima linea nei diritti umani e dei lavoratori. E le indagini
si estendono a Milano, alla rete italiana legata a Panzeri e al suo patrimonio
definito «molto consistente».
Le indagini
Gli sviluppi
dell’ inchiesta della procura federale belga puntano in modo marcato al ruolo
dell’ex politico di Pd e poi di Articolo 1 e della sua ong che annoverava nel
consiglio onorario personaggi del calibro degli ex commissari europei Emma
Bonino e Dimitris Avramopoulos e della ex rappresentante Ue per gli affari
esteri Federica Mogherini, tutti dimessisi per lo scandalo che ha portato in
carcere per associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio Panzeri, uno dei
14 vice presidenti del Parlamento europeo, la greca del Pasok Eva Kaili, il
padre e il compagno di questa, il milanese Francesco Giorgi, la moglie e la
figlia di Panzeri, il segretario dell’ong No peace without justice Niccolò Figà
Talamanca. Un ambiente in cui l’italianità crea cameratismo e complicità e che,
ma solo per una questione di assonanza tricolore, si estende al cognome
dell’europarlamentare Marc Tarabella, perquisito sabato scorso davanti al
presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola che è dovuta appositamente
rientrare di corsa da Malta.
Le indagini si
muovono spedite anche sull’asse Bruxelles-Milano per individuare la rete dei
rapporti di Panzeri. Usufruendo di Eurojust, il giudice istruttore Michel
Claise sta ricevendo assistenza giudiziaria dall’aggiunto Fabio De Pasquale che
guida il dipartimento «affari internazionali» della Procura di Milano. È stato
lui ad ordinare la perquisizione dell’abitazione di Panzeri a Calusco D’Adda
(Bergamo) dove moglie e figlia sono ai domiciliari e dove la Gdf ha trovato 17
mila euro in contanti, che si sommano ai 600mila sequestrati all’uomo al momento
dell’arresto in un residence di Bruxelles. Tanti, troppi sono i soldi che girano
in questa storia. Oltre alle banconote, Panzeri e i suoi familiari sembrano
possedere un patrimonio importante fatto di conti correnti, che sono stati
acquisiti insieme, e di immobili che difficilmente può essere giustificato solo
con il pur ricco appannaggio incassato in 10 anni di mandato parlamentare
europeo. Le indagini di De Pasquale (perquisita anche la casa di Giorgi e
sequestrato il suo conto) dovranno contribuire a chiarire flussi di denaro
arrivato dal Marocco e dal Qatar in contanti e bonifici. E poi ci sono i 100
mila euro che sarebbero stati spesi per una vacanza di Natale e i regali
trasferiti in Marocco.
Un trolley di
banconote
Banconote fruscianti
tornano anche nell’arresto di Eva Kaili «causato» dal fermo precedente del
padre. Quando venerdì la polizia lo ha visto lasciare in fretta e furia il
lussuoso albergo nel quartiere «Europeo» di Bruxelles dove era arrivato qualche
giorno prima con la moglie, è bastato un attimo agli agenti per saltargli
addosso e scoprire che nel trolley che si trascinava dietro c’erano la bellezza
di 600 mila euro in banconote da 50 euro. Perché aveva tanta premura? Forse
sapeva che gli investigatori erano sulle tracce dei soldi accumulati dalla
figlia con le tangenti, dicono a Bruxelles, ai quali si aggiungeranno i 150 mila
euro trovati in banconote da 20 e 50 euro nell’abitazione della Kaili assieme a
molti regali di valore, oggetti e medaglie, ricevuti dal Qatar. La scoperta dei
soldi e dei regali è stata considerata la «flagranza di reato» che, facendo
decadere l’immunità parlamentare, ha permesso alla magistratura di arrestare
Kaili. Sono 19 le abitazioni perquisite e 10 gli uffici di collaboratori
sigillati al Parlamento per «congelare» e «prevenire» la manomissione dei dati
dei telefonini e dei pc sequestrati, come spiegano i pm. Sigilli anche negli
uffici di Strasburgo degli assistenti dei parlamentari Pd, non
indagati, Alessandra Moretti e Andrea Cozzolino, l’arrestato Giorgi assiste il
secondo e lavora in uno dei due.
Fermato venerdì e
rimesso in libertà il giorno dopo, Luca Visentini, capo della Confederazione
sindacale internazionale, è ancora scosso dalla esperienza del carcere. «Sono
stato liberato senza accuse formali e con condizioni minime che permettono di
muovermi liberamente» afferma, e aggiunge: «Sono estraneo a qualsiasi forma di
corruzione. Se fossi stato corrotto o se fossi un corruttore le mie posizioni
politiche sarebbero state molto favorevoli al Qatar, invece nei giorni
precedenti avevo dichiarato che le riforme fatte in quel Paese erano del tutto
insufficienti».
Eva Kaili, ascesa
e caduta: da ribelle del Pasok a «musa» degli emiri.
Il Corriere della
Sera il 12 dicembre 2022.
Raccontano che Eva
Kaili debba l’inizio della sua carriera politica alla somiglianza con Eleni
Rapti, deputata di Salonicco per Néa Dimokratia, il partito conservatore. Fu
infatti nella disperata ricerca di un volto nuovo da contrapporre a
quest’ultima, fiammeggiante candidata alle elezioni greche del 2004, che i
dirigenti locali del Pasok appuntarono la loro attenzione sulla giovane
giornalista, popolare anchorwoman di Mega Channel, studi in architettura,
relazioni internazionali ed economia, bionda e telegenica proprio come la Rapti.
Ma non andò bene,
perché Kaili fu la prima dei non eletti nella seconda città della Grecia. E lì
forse iniziò anche la sua ostilità verso Georgios Papandreou, il quale eletto
sia a Salonicco che a Patrasso optò per la prima, lasciando fuori proprio lei,
Eva Kaili.
Probabilmente gliela
giurò, se è vero che quando tre anni dopo, nel 2007, i greci tornarono al voto e
lei questa volta entrò nel Parlamento ellenico sull’onda di oltre centomila
preferenze, sempre per il Pasok, Kaili diventò una specie di bastian contrario
del leader socialista, il quale ha sempre diffidato di lei.
Con qualche ragione,
se è vero che fu proprio Kaili la causa ultima della caduta di Papandreou.
Successe nel 2011, quando al culmine della crisi greca, il premier socialista
decise di accettare le misure dell’austerità imposte dalla Ue, sotto la spinta
di Merkel e Sarkozy, ma annunciò di volerle prima sottoporle a referendum.
Convocatolo al vertice di Nizza, Sarkozy lo prese a male parole, ma soprattutto
il presidente della Commissione José Manuel Barroso giocò sporco, convincendo il
ministro delle Finanze greco, Evangelos Venizelos, a ribellarsi e organizzare la
rivolta dentro il partito. Così fu. Papandreou aveva solo 2 voti di maggioranza
in Parlamento, ma prima che il voto per indire il referendum avesse luogo, gli
arrivò la lettera di una deputata: «Al di sopra dell’interesse personale o di
partito devo mettere quello nazionale. Io voterò contro di te». La firma era
quella di Eva Kaili, subito imitata da altre due colleghe. Papandreou rinunziò
al referendum e pochi giorni dopo si dimise.
Di tutte le prese di
posizione di Kaili in contrasto con il suo partito, rimane celebre quella
ultranazionalista contro l’accordo che mise fine all’annosa battaglia tra Grecia
e Macedonia del Nord, con cui Atene riconobbe il diritto di quest’ultima a
definirsi tale: «Un danno irreparabile per la storia della Macedonia (nel senso
della regione greca n.d.r) e per i greci», disse allora la deputata socialista
sposando in pieno la linea di Néa Dimokratia.
Nikos Androulakis,
leader di quel poco che resta del Pasok, che nel frattempo ha espulso
l’eurodeputata sotto accusa a Bruxelles, ha definito Kaili «il cavallo di Troia»
del governo conservatore dentro il partito socialista, una quinta colonna che
non ha mai perso occasione di sparare fuoco amico. E cita il recente episodio
dello scandalo delle intercettazioni, commissionate dal governo ai danni
dell’opposizione, autentico Watergate greco. Kaili, invece di condannarle, ha
detto che non erano nulla di nuovo o di strano, derubricandole come poco
rilevanti.
Il salto verso la
politica europea era avvenuto nel 2014 con l’elezione all’Europarlamento,
seguita dalla riconferma nel 2019 con l’ascesa alla vicepresidenza
dell’Assemblea, proclamata al primo scrutinio con 454 voti fra i 14 sostituti di
Roberta Metsola, della quale fa le veci nei rapporti con il Medio Oriente. A
Bruxelles e Strasburgo Kaili sembrava ubiqua, attiva in commissioni, organismi
di valutazione, delegazioni parlamentari, intergruppi, missioni speciali, di
tutto di più. Sempre pronta nei suoi discorsi a sostenere cause nobili, come i
diritti umani o la lotta alla corruzione. Il suo forte erano i temi digitali e
l’high-tech, ancora qualche giorno fa aveva spiegato che la Ue deve fare molto
di più per aiutare i cittadini ad acquisire certe competenze digitali».
Poi, o forse prima,
è venuto il Qatar, l’irresistibile leggerezza dell’essere. Un po’ alla volta,
Kaili è diventata il capo riconosciuto del «collegio di difesa» dell’Emirato nel
Parlamento di Strasburgo. Surreale il discorso del 21 novembre scorso, quando la
plenaria ha votato una risoluzione che «deplora la morte di migliaia di
lavoratori migranti». Kaili, contraria, si è fatta aedo del Qatar, che ha
definito «Paese all’avanguardia nei diritti dei lavoratori», forse confondendo
questi ultimi con i morti sul lavoro. Poi, dieci giorni fa, letteralmente si è
intrufolata nella Commissione Giustizia, di cui non fa parte, per votare a
favore della liberalizzazione di visti d’ingresso nello spazio Schengen per i
cittadini qatarioti. Ancora, quando il Qatar aveva rinviato all’ultimo momento
il viaggio della Delegazione parlamentare per i rapporti con la Penisola araba,
che voleva visitare le strutture dei Mondiali e verificare i cambiamenti alla
legislazione sul lavoro sbandierati dai dirigenti di Doha, Kaili era partita da
sola alla volta dell’Emirato dove, accolta in gran fanfara, aveva lodato le
riforme del regime, dicendo di rappresentare 500 milioni di europei. Come ha
commentato la deputata verde Hannah Neumann, che guida la delegazione, «ho
avvertito che qualcosa stesse succedendo alle mie spalle. I qatarioti hanno
disinvitato i parlamentari, sapendo che avrebbero avuto una posizione più
equilibrata, e invitato lei sapendo cosa avrebbe detto».
I titoli di coda
vedono una valigia piena di banconote, 750 mila euro, portata goffamente via da
un padre trafelato e protettivo dall’appartamento, in cui l’onorevole deputata
abitava con il compagno italiano, Francesco Giorgi, ex assistente parlamentare
dell’indagato principale, Pier Antonio Panzeri. Anche Giorgi appassionato di
diritti umani e anche lui ora agli arresti. Belli e dannati? La presunzione
d’innocenza è d’obbligo, ma l’eurodeputata socialista Eva Kaili deve più di
qualche spiegazione.
Da corriere.it il 12
dicembre 2022.
Contanti per una
somma di 17 mila euro sono stati sequestrati ieri sera dalla Guardia di Finanza
nell’abitazione della famiglia Panzeri a Calusco d’Adda La somma è stata trovata
nel corso delle perquisizioni effettuate in esecuzione di un ordine di
investigazione europea nell’ambito dell’inchiesta di Bruxelles per presunte
tangenti da parte di Qatar e Marocco, in cambio di una sponda politica
all’Europarlamento.
Nella casa al
momento si trova agli arresti domiciliare la moglie di Panzeri, Maria Dolores
Colleoni, destinataria insieme alla figlia Silvia di un mandato di arresto
europeo. Anche la figlia Silvia è ai domiciliari ma nella sua casa nel Milanese.
Giuseppe Guastella
per corriere.it il 12 dicembre 2022.
Quando la polizia lo
ha visto lasciare in fretta e furia il lussuoso albergo nel quartiere «Europeo»
di Bruxelles con in mano una valigia, è bastato un attimo agli agenti per
saltare addosso e bloccare il padre della vice presidente del Parlamento europeo
Eva Kaili e trovare nel trolley che si trascinava dietro la bellezza di 600 mila
euro in banconote da 50 euro. Perché l’uomo, che era arrivato nell’albergo
qualche giorno prima con la moglie, aveva tanta premura? Forse sospettava che
gli investigatori erano sulle tracce del denaro accumulato dalla figlia con le
tangenti, dicono i magistrati belgi.
A questi soldi si
aggiungeranno in serata altri 150 mila euro trovati in banconote da 20 e 50 euro
nell’abitazione della Kaili assieme a più regali di valore, come medaglie e
altri oggetti, ricevuti in regalo dal Qatar.
La scoperta dei
soldi e dei regali è stata considerata la «flagranza di reato» che, facendo
decadere l’immunità parlamentare, ha permesso alla magistratura di arrestare
Kaili. Il contante è la caratteristica dell’inchiesta che riguarda un giro di
corruzione per favorire un atteggiamento morbido della politica continentale a
favore del Marocco e del Qatar, il secondo paese al mondo per l’insufficiente
rispetto dei diritti umani.
Un’indagine che sta
colpendo al cuore la massima istituzione rappresentativa europea con l’arresto
della ex giornalista tv greca Kaili al quale venerdì 9 dicembre si è aggiunto
quello di altre 7 persone, tra cui l’ex parlamentare a Bruxelles Pd Antonio
Panzeri, sua moglie e sua figlia (fermate e mandate ai domiciliari in Italia),
oltre a quelli del compagno della Kaili Francesco Giorgio e del segretario
dell’ong No peace without justice, l’italiano Niccolò Figà Talamanca. E infatti,
anche nel residence in cui Panzeri vive a Bruxelles la polizia giudiziaria ha
trovato in due sacchi banconote da 20 e 50 euro per un totale di circa 600 mila
euro. In tutto sono state eseguite 10 perquisizioni in uffici di parlamentari
europei e 19 in abitazioni private.
Soldi, ancora soldi
son stati trovati oggi dalla Guardia di finanza nell’abitazione di Panzeri e
famiglia a Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo, dove sono ai domiciliari la
moglie Maria Dolores Colleoni e la figlia Silvia. Le Fiamme gialle hanno trovato
17 mila euro eseguendo un ordine di investigazione europea partito da Bruxelles
in abitazioni a Milano e in provincia riconducibili a Panzeri e alla sua
famiglia. Nelle carte dell’indagine, il giudice istruttore federale Michel
Claise scrive che per «diversi mesi gli investigatori della polizia giudiziaria
federale hanno sospettato che un paese del Golfo, per influenzare le decisioni
economiche e politiche del Parlamento europeo, ha pagato forti somme di denaro o
offerto importanti regali» e a soggetti che avevano una «significativa posizione
politico e/o strategica nel Parlamento europeo».
Sulla vicenda è
intervenuta la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola durante una
plenaria: «Non ci sarà impunità. Nessuno. I responsabili troveranno questo
Parlamento dalla parte della legge. Sono orgogliosa del nostro ruolo e della
nostra assistenza in questa indagine. Non ci sarà da nascondere la polvere sotto
il tappeto». E ha aggiunto che verrà avviata «un’indagine interna per esaminare
tutti i fatti relativi al Parlamento e per vedere come i nostri sistemi possono
diventare ancora più impermeabili».
Ha poi espresso la
sua delusione al riguardo e si è rivolta al resto dell’assemblea: «So che
condividete tutti lo stesso sentimento. A quegli attori maligni, nei Paesi
terzi, che pensano di poter comprare la loro strada. Che pensano che l’Europa
sia in vendita. Che pensano di poter rilevare le nostre Ong. Lasciatemi dire che
troverete questo Parlamento fermamente sulla vostra strada. Siamo europei».
«Dovevo anche annunciare l’apertura del mandato negoziale per la relazione
sull’esenzione dal visto con il Qatar e il Kuwait. Alla luce delle indagini,
tale relazione dovrà essere rinviata in commissione», ha concluso.
Estratto
dell’articolo di Francesca Basso per il “Corriere della Sera” il 12 dicembre
2022.
È forse il peggiore
scandalo di corruzione che si ricordi nella storia del Parlamento europeo. Ed è
una corsa a prenderne le distanze dai protagonisti dell'inchiesta belga sulla
presunta corruzione da parte del Qatar nei confronti di eurodeputati e
funzionari del Parlamento Ue: sono finiti in carcere la vicepresidente greca Eva
Kaili, il suo compagno Francesco Giorgi, l'ex eurodeputato Antonio Panzeri e il
lobbista Niccolò Figà-Talamanca.
L'ex commissario Ue
all'Immigrazione, il greco Dimitris Avramopoulos di Nea Demokratia (Ppe), che
figurava nel board onorario della Ong Fight impunity , fondata da Panzeri, ha
reso pubblico con un tweet le sue dimissioni: «Dopo aver letto dell'indagine in
corso contro Panzeri venerdì sera - ha scritto - ho immediatamente rassegnato le
dimissioni, per principio, dal comitato consultivo onorario di Fight impunity ».
Avramopoulos è con
Luigi Di Maio uno dei quattro candidati sul tavolo dell'Alto rappresentante Ue
Josep Borrell per l'incarico di inviato Ue nel Golfo Persico e le sue chance
sembravano in salita dopo le polemiche in Italia sull'ex ministro degli Esteri.
Pure il Qatar si è
chiamato fuori con una dichiarazione ufficiale del ministero degli Esteri:
«Qualsiasi associazione del governo qatarino con le accuse riportate è senza
fondamento e gravemente male informata. Lo Stato del Qatar lavora sulla base di
un rapporto da istituzione a istituzione e opera in piena conformità con il
diritto internazionale». […]
Maddalena Berbenni
per il “Corriere della Sera” il 12 dicembre 2022.
A maggio 2019,
Antonio Panzeri lascia il Parlamento europeo dopo tre mandati, nel 2004 eletto
con la lista Uniti nell'Ulivo, poi con il Pd, l'ultimo paio d'anni trascorso tra
le fila del partito che ora lo ha sospeso in fretta e furia, Articolo Uno. Non
abbandona, però, Bruxelles.
Nel giro di
un'estate, in rue Ducale 41, tra il parco principale della città e i palazzi che
contano, fonda l'organizzazione no profit Fight impunity , «combatti
l'impunità». Un nome che certo stride di fronte alle accuse che hanno portato al
suo arresto e a quello della moglie Maria Dolores Colleoni e della figlia Silvia
- quest' ultima avvocato con un curriculum che indica, come ultimo corso di
perfezionamento, una specializzazione in diritto dell'Unione Europea - mentre la
bacheca Facebook è una galleria di cartoline dalle vacanze, anche in Qatar.
Proprio dal Paese
dei Mondiali di calcio e delle accese polemiche sui diritti violati, insieme al
Marocco, sarebbero arrivate le tangenti in soldi e regali al centro
dell'inchiesta per corruzione e riciclaggio, nell'ambito di quella che gli
inquirenti belgi ritengono fosse un'associazione per delinquere.
Delle due donne
hanno chiesto la consegna, che la Corte d'Appello di Brescia valuterà fra una
settimana. Ora, sono ai domiciliari, la figlia nel Milanese, la moglie nella
casa di famiglia a Calusco d'Adda, dove lo stesso Panzeri ha mantenuto la
residenza.
La base in provincia
di Bergamo, la carriera nella Cgil a Milano e la nuova vita da paladino dei
diritti principalmente a Bruxelles, ma poi ovunque lo conducessero gli eventi
promossi da Fight impunity .
Dunque, ad esempio,
il 29 marzo è al Collegio d'Europa a Bruges, nelle Fiandre, per illustrare il
rapporto annuale «sull'impunità e la giustizia transizionale», steso
dall'organizzazione e poi discusso anche al Parlamento europeo: «Sono giorni
difficili quelli che stiamo attraversando - dice Panzeri in un video -. La
guerra in Ucraina, l'invasione russa sta producendo enormi drammi non solo sotto
il profilo umanitario, ma ci sta proponendo con forza le questioni legate
all'impunità e ai diritti umani. Noi siamo fortemente impegnati in questa
direzione».
Il 6 aprile è in
Grecia al Delphi economic forum, il 21 dello stesso mese presenta alla Camera
del lavoro di Milano un libro sulle vittime sul lavoro nel mondo, il 28 giugno
interviene a un convegno internazionale sull'Africa subsahariana a Nouakchott,
la capitale della Mauritania. L'ultimo appuntamento del 2022 segnalato sui
canali social della Ong è un seminario, il 2 e 3 dicembre, nella casa di Jean
Monnet, fuori Parigi, dedicato alla libertà dei media e alla lotta contro gli
attacchi nei confronti di giornali e giornalisti nel mondo.
Dall'articolo di
Giuliano Foschini e Claudio Tito per "la Repubblica" il 12 dicembre 2022.
I magistrati belgi
ormai parlano di una "Italian Connection" dentro il "Qatargate". E lo fanno da
venerdì scorso. Da quando cioè sono entrati negli edifici del Parlamento europeo
per mettere i sigilli agli uffici di una serie di collaboratori e assistenti.
Tutti italiani. Un lungo corridoio al gruppo S&D - ma non solo - con una sfilza
di stanze incerottate e chiuse a chiave. (...) Infine c'è un quarto nome. Davide
Zoggia.
Un pezzo da
"novanta" della sinistra italiana di un quindicennio fa. Ex deputato italiano,
un fedelissimo di Pierluigi Bersani e responsabile organizzativo del Pd durante
la segreteria Epifani. A lui hanno sequestrato il telefonino. Perché? Perché
viveva a Bruxelles in una casa di proprietà di Giuseppe Meroni.
Anzi, con lui ha
condiviso fino a qualche settimana anche l'ufficio. Zoggia è nello staff di
Pietro Bartolo ma anche - spesso gli assistenti sono condivisi - in quello del
capogruppo Dem, Brando Benifei. Tutti questi parlamentari non sono stati
assolutamente toccati dalle indagini.
Tonia Mastrobuoni
per repubblica.it il 12 dicembre 2022.
Poco fa il leader
del Pasok Nikos Androulakis l'ha definita un "cavallo di Troia" del governo, in
sostanza un'agente all'Avana dei conservatori di Nea Dimokratia e del premier
Mitsotakis. Al di là degli imbarazzanti dettagli che stanno emergendo dalla
protagonista del Qatargate, Eva Kaili - a cominciare dai sacchi pieni di
banconote rinvenuti nel suo appartamento brussellese - non è la prima volta che
sulla politica socialista appena sospesa dal ruolo di vicepresidente del
Parlamento Ue si addensano sospetti di intelligenza con il nemico.
Oggi le autorità
brussellesi hanno confermato l'arresto di Kaili. Persino suo padre era stato
sorpreso con una valigia piena di soldi. E tra gli arrestati figura anche il suo
compagno, Francesco Giorgi, con cui ha una figlia. Dall'entourage di Androulakis
trapela enorme irritazione per lo scandalo che ha travolto i socialisti: "Non
tollereremo azioni del genere e ci comporteremo di conseguenza". Da tempo i
rapporti tra i due si erano raffreddati, dopo otto anni di sodalizio di ferro.
Quarantaquattrenne,
originaria di Salonicco, Kaili era considerata da tempo una sorta di Lady
Macbeth dei socialisti greci, un'ambiziosa e popolare ex giornalista della tv
Mega che, in virtù delle sue oltre centomila preferenze incassate nella città
natale aveva fatto una carriera rapidissima nel partito. Nel 2007 era già
deputata, nel 2014 è stata eletta al Parlamento Ue.
Ma negli ultimi
tempi, l'ex numero due dell'Europarlamento si era inimicata l'attuale dirigenza
attorno ad Androulakis. E da dieci anni l'ex premier greco e leader del Pasok,
George Papandreou aveva imparato in modo traumatico a non fidarsi di lei. Nella
fase più drammatica del suo governo e della crisi greca, Kaili gli girò
clamorosamente le spalle. Stava già tramando con il successore di Papandreou,
Evangelos Venizelos.
Ai microfoni della
tv greca, l'attuale leader del Pasok, Androulakis ha ricordato poco fa l'ultimo,
enorme scandalo che ha travolto la Grecia: quello delle intercettazioni ai suoi
danni commissionate dall'attuale governo Mitsotakis. Ebbene, Kaili aveva
minimizzato sull'incidente che aveva messo in grave imbarazzo Mitsotakis a fine
luglio e colpito i vertici del suo stesso partito. E Androulakis aveva "preso le
distanze" già allora dalla sua collega di partito, ha ribadito in tv.
Anche nel 2011 Kaili
si è fatta notare per la sua disinvoltura tattica. Quando George Papandreou
propose di fare un referendum sulla permanenza della Grecia nell'euro, il
presidente francese Nicolas Sarkozy si infuriò e il presidente conservatore
della Commissione Ue José Manuel Durão Barroso convinse segretamente il ministro
delle Finanze greco, Evangelos Venizelos, a bloccare il referendum e costringere
Papandreou alle dimissioni. Così fu: alla vigilia del voto in Parlamento che
avrebbe dovuto approvare il referendum, tre deputate del Pasok gli dissero che
avrebbero votato contro, e che non avrebbe più avuto la maggioranza. Una era Eva
Kaili.
Giuliano Foschini e
Claudio Tito per “la Repubblica” il 12 dicembre 2022.
[…] I sigilli sono
stati così posti all'ufficio di Federica Garbagnati. Al momento è l'assistente
dell'eurodeputata Alessandra Moretti. Che, pur avendo compiuto un viaggio a
Dohaper incontrare il ministro del Lavoro, ha precisato di aver sempre votato
sul Qatar secondo le indicazioni del suo gruppo. Garbagnati, però, in passato
collaborava proprio con il fulcro dell'indagine: Antonio Panzeri. […]
Alessandro Gonzato
per “Libero quotidiano” il 12 dicembre 2022.
Minaccia querele a
raffica l'europarlamentare Dem Alessandra Moretti: non vuole che il suo nome
venga accostato al Qatar, non ora almeno. Dal Belgio arriva anche la notizia che
gli inquirenti hanno sequestrato il pc e il telefono di una delle sue assistenti
accreditate, Francesca Garbagnati, che era stata assistente dell'allora
europarlamentare del Pd Antonio Panzeri- fulcro dell'inchiesta sul "Qatargate" -
ma la Moretti non è inquisita.
Tra gli emiri e
Bruxelles è transitato un mare di denaro sporco - stando alla mega inchiesta
fatta di arresti, valigie colme di banconote, sequestri e tentate fughe - e
dunque quando Il Fatto Quotidiano accenna che l'eurodeputata vicentina «a
Bruxelles ha sempre votato nel blocco della Kaili (la vicepresidente greca
dell'Ue arrestata per i sacchi di soldi in casa, ndr)» la Moretti diffonde un
comunicato di fuoco.
Non «comprende il
significato» delle «presunte votazioni nel blocco della Kaili» e diffida ogni
mezzo d'informazione dall'accostare il suo nome «a ogni illazione sull'indagine
sui presunti casi di corruzione dal Qatar al parlamento europeo». Moretti
aggiunge di aver «dato mandato ai propri legali di procedere» per l'articolo
«altamente diffamatorio» e farà lo stesso con chi «rilancerà simili notizie
destituite di ogni fondamento».
La Dem tiene a
precisare che «riguardo alla risoluzione contro il Qatar» ha sempre votato «in
linea col proprio gruppo politico», i socialdemocratici (S&D), «in qualche caso
votando a favore di alcuni emendamenti presentati dalla sinistra, molto duri sul
Qatar».
Nessuna illazione, e
però se prendiamo la votazione agli emendamenti della sessione plenaria dello
scorso 24 novembre, nella sinistra c'è chi è a favore, chi contro, chi s' è
astenuto: ci arriviamo tra poco.
La Moretti il Qatar
lo conosce, e dalla capitale il 17 febbraio 2020 ha pubblicato un lungo post su
Facebook in cui con gli emiri è stata piuttosto benevola. Eccolo: «Sono di
rientro da Doha dove sono stata relatrice al convegno "Social Media, challenges
and ways to promote freedom". Ho parlato di hate speech e fake news. Ho
incontrato tante giovani che si battono per la parità di genere. Qui in Qatar»,
ecco, «stanno facendo passi in avanti nella tutela dei diritti anche delle donne
e dei lavoratori. Siamo andati a visitare uno degli 8 stadi che stanno
costruendo in vista dei Mondiali di calcio 2022 e abbiamo verificato le
condizioni di vita di chi sta offrendo manodopera per la realizzazione degli
impianti (...)».
Il quotidiano
britannico The Guardian, oltre a diverse associazioni umanitarie, hanno
denunciato che durante la realizzazione delle infrastrutture sono morte quasi 7
mila persone, e dunque vien da chiedersi quali condizioni abbia «verificato» la
Moretti.
Anzi, in
un'intervista, Affaritaliani.it glielo chiede direttamente: possibile che i
visitatori occidentali non si siano resi conto della situazione? «Noi questa
cosa l'abbiamo sempre denunciata.
Non trovo
correlazione tra la partecipazione a un'iniziativa sui diritti delle donne con
la tragedia dei lavoratori». Nel post c'era scritto anche di questo tema... «Sì,
al tema dei diritti. Perché me ne occupo e quindi anche relativamente a quello
della tutela dei diritti dei lavoratori».
Quindi non c'erano
segnali dei numerosi deceduti? «Sì certo, eravamo lì proprio per verificare le
condizioni di lavoro e la fine del sistema della Kafala (istituzione che regola
il mondo del lavoro in molti Paesi arabi, ndr). Io mi sono concentrata di più
sui diritti delle donne». Dicevamo degli emendamenti alla plenaria del 24
novembre: se è vero che il voto finale non era nominale e quindi, come sta
accadendo, chiunque può dire di aver condannato il trattamento degli immigrati
che hanno lavorato in Qatarcome ha fatto il Dem Andrea Cozzolino il cui
principale collaboratore, Francesco Giorgi, il compagno della Kaili, è stato
arrestato nell'indagine per corruzione e riciclaggio- lo è altrettanto che in
diversi emendamenti i Dem si sono divisi, e qui il voto era nominale.
Ad esempio, pagina
134 del documento, punto 65 "Situazione dei diritti umani nel contesto della
Coppa del Mondo in Qatar": la Moretti ha votato contro, Cozzolino e Marie Arena
(l'ufficio della sua assistente, Donatella Rostagno, pure lei ex collaboratrice
di Panzeri, è sotto sequestro), Majorino, Picerno e Variati (di cui la Moretti è
stata vicesindaco) a favore.
Proprio il 24
novembre Cozzolino ha inviato una mail ai colleghi socialdemocratici: «In vista
del voto di oggi sulla situazione dei diritti umani relativi ai Mondiali in
Qatar vorrei ribadire la mia posizione di votare contro la seconda parte che
sostiene che la Coppa del Mondo sia stata assegnata dalla Fifa attraverso
concussione e corruzione. Il parlamento Ue non dovrebbe accusare un Paese senza
evidenze che non siano segnalate dalle autorità giudiziarie. In ogni caso se
vogliamo discutere di corruzione negli eventi sportivi, allora bisognerebbe
riflettere su tutto, compresi i Mondiali in Germania del 2006». Dunque a posto
così?
Da milano.repubblica.it il 12 dicembre 2022.
La Corte d'appello
di Brescia dà il via libera alla consegna della moglie e della figlia di Antonio
Panzeri al Belgio. "Non appaiono sussistere cause ostative alla consegna" al
Belgio, scrive infatti il giudice della Corte d'appello di Brescia Anna Dalla
Libera nel provvedimento di convalida dell'arresto di Maria Dolores Colleoni e
Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, fermate
venerdì nell'abitazione di famiglia a Calusco d'Adda (Bergamo) in esecuzione di
un mandato di arresto europeo e poi poste ai domiciliari. Le due donne sono
accusate di corruzione, riciclaggio e associazione per delinquere per fatti
commessi dal 1 gennaio 2021 all'8 dicembre 2022.
Alcune perquisizioni
sono state effettuate fra ieri sera e oggi in abitazioni a Milano e nella
Bergamasca riconducibili ad Antonio Panzeri e alla sua famiglia dalla guardia di
finanzia in esecuzione di un ordine di investigazione europea nell'ambito
dell'inchiesta di Bruxelles per presunte tangenti da parte di Qatar e Marocco,
in cambio di una sponda politica all'Europarlamento. Contanti per una somma di
17mila euro sono stati sequestrati ieri sera dalla Guardia di Finanza
nell'abitazione della famiglia Panzeri a Calusco d'Adda, in provincia di
Bergamo. Nella casa al momento si trova agli arresti domiciliare la moglie di
Panzeri, Maria Dolores Colleoni, destinataria insieme alla figlia Silvia di un
mandato di arresto europeo. Le perquisizioni sono avvenute nell'inchiesta di
Bruxelles per associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio per favorire
Qatar e Marocco, che hanno portato all'arresto fra gli altri dell'ex
europarlamentare, della figlia, della moglie e della vicepresidente del
Parlamento Europeo Eva Kaili. Da quanto si è saputo, sono stati sequestrati
anche supporti informatici e documenti.
Sono stati anche
eseguiti accertamenti bancari su diversi conti riconducibili all'ex
europarlamentare: il decreto di perquisizione firmato dal procuratore aggiunto
di Milano Fabio De Pasquale, a capo del dipartimento Affari internazionali, che
sta lavorando in collaborazione con Eurojust, riguarda in particolare
l'abitazione della famiglia Panzeri a Calusco D'Adda (Bergamo), ma anche un
ufficio a Milano e l'abitazione milanese dell'arrestato Francesco Giorgi, ex
collaboratore dell'ex europarlamentare dem Panzeri. Da quanto emerge sono stati
sequestrati 17mila euro nell'abitazione in provincia di Bergamo, ma anche (non
si sa a chi) degli orologi di lusso, oltre a supporti informatici e documenti.
Qatargate, il più
grande scandalo della storia dell’Europarlamento.
La procura federale
belga sventa una lobby criminale in seno al gruppo socialista. Puntava a
influenzare le decisioni dell’organo democraticamente eletto a favore del Qatar.
In cambio di montagne di denaro. Federica Bianchi su L’Espresso il 12 Dicembre
2022.
La parola Qatar è
diventata tossica a Bruxelles. Tutto ciò che la riguarda è ormai visto con
paura. Perché è proprio intorno al Qatar e a questi campionati mondiali che da
venerdì sera si sta svolgendo la matassa del più grande scandalo che abbia mai
riguardato l'Europarlamento. Il quotidiano belga "Le Soir" l'aveva definito
sabato "uno scandalo italiano" visto che il perno di questa storia di corruzione
parlamentare è l'ex europarlamentare del PD Pier Antonio Panzeri, che a
Bruxelles continuava a vivere e lavorare, aiutato nei suoi affari dalla
famiglia. Ma giorno dopo giorno la realtà si dimostra molto più complessa,
coinvolge anche cittadini belgi, e non escluderà ulteriori colpi di scena.
I risultato di mesi
di lavoro e intercettazioni da parte della polizia belga hanno portato alla
scoperta di un'organizzazione criminale volta a influenzare il voto del
parlamento europeo a vantaggio degli stati committenti – il Qatar, appunto, e il
Marocco - in cambio di ingenti somme di denaro e regali.
Il cervello
dell'operazione è Panzeri, europarlamentare dal 2004 al 2019, attivista per i
diritti umani, e oggi leader di "Fight impunity", una ong che sembra sempre più
una copertura per attività a scopi personali. «Sì facevo parte dell'advisory
board», dice al telefono Emma Bonino, «ma non sono mai stata consultata. Il
board non è mai stato convocato». Solo bei nomi su un sito web. E la conferma
viene anche dall’ex Alta Rappresentante Federica Mogherini e dall'ex commissario
greco Dimiotris Avramolopoulos, che si sono entrambi immediatamente dimessi dal
board.
Come assistente
parlamentare di Panzeri ha a lungo lavorato Francesco Giorgio, compagno della
vice presidente del parlamento europeo (ce ne sono 14) Eva Kaili, ex giornalista
televisiva. Dopo che il padre di Kaili è stato fermato con un trolley con dentro
600mila euro in banconote da 50, entrambi sono stati arrestati (l'impunità
parlamentare non è più valida in flagranza di reato). A casa della coppia (che
ha una bambina di due anni) sono poi stati trovati altri 150mila euro oltre a
oggetti di valore offerti dal Qatar. «Abbiamo avuto grande fortuna ad arrestare
Kaili in flagranza di reato», hanno detto fonti della polizia a Le Soir. Il
fermo dovrà essere convalidato entro cinque giorni. Kaili è stata immediatamente
dimessa dalla sua carica dalla presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, che
apparentemente sapeva dell'inchiesta da tempo, ed è stata sospesa sia dal
partito socialista greco sia dal gruppo socialista europeo.
Già sabato mattina
però lo scandalo si è allargato: ad essere coinvolti sono anche l'eurodeputato
belga di origine italiana Marc Tarabella, che si proclama innocente, ma il cui
ufficio è stato ispezionato e messo sotto sequestro durante la partita
Francia-Inghilterra, dopo che la polizia belga ha fatto tornare di corsa da
Malta la presidente Metsola per poter eseguire la perquisizione (la sua presenza
era necessaria in assenza di flagranza di reato).
Nel cercare le
complicità in questa storia aiuta seguire gli interventi parlamentari degli
eurodeputati: se inizialmente Tarabella era stato molto critico con
l'assegnazione della coppa in Qatar, le sue posizioni si sono addolcite di pari
passo al moltiplicarsi dei suoi viaggi nello stato del Golfo durante la
costruzione dei cantieri del mondiale. Ultimamente aveva più volte ripetuto che
non era di nessun aiuto continuare a parlare male del Qatar quando il Paese
stava facendo sforzi per migliorare sul piano dei diritti umani e aveva votato
contro una risoluzione sulla risoluzione dei diritti umani in Qatar.
Come Tarabella così
anche Maria Arena, un'altra parlamentare belga di origine italiana, ha adesso il
suo ufficio sotto sequestro: lo scorso 11 ottobre aveva incontrato il ministro
del lavoro del Qatar e il 14 novembre, come presidente della sotto-commissione
dei diritti dell'Uomo, ha organizzato un dibattito in parlamento a cui ha
partecipato anche il ministro qatarino. Entrambi -Tarabella e Arena - avevano
contribuito a l'edizione 2021 del rapporto sullo "stato dell'impunità nel
mondo". «Una situazione ripugnante», commenta al telefono sgomenta
l'eurodeputata e vicepresidente socialista Pina Picerno.
Della stessa
"tossica" commissione fa parte anche l'eurodeputato socialista Andrea Cozzolino
(«oh poveretto coinvolto anche lui? I nostri figli sono a scuola insieme,
commenta una funzionaria della Commissione»), di cui Francesco Giorgi era
attuale assistente. Anche lui recentemente aveva inviato agli altri membri del
partito socialista una email chiedendo di moderare la posizione verso il Qatar e
la Coppa del Mondo perché «il parlamento europeo non dovrebbe accusare un Paese
senza prove da parte dell'autorità giudiziaria». Una seria di atteggiamenti
positivi verso il Qatar che Philippe Lamberts, co-presidente dei Verdi, aveva
notato da tempo e di cui non riusciva a capire il motivo. «Ci sembrava
stranissima questa posizione dei socialisti che sul Qatar hanno cercato di
smorzare ogni tono fino all'ultimo», ha detto al telefono. Parole simili
provengono anche da Manon Aubry, la leader francese del gruppo dell'estrema
sinistra che aveva cercato senza successo di convincere i socialisti a votare
una risoluzione sui diritti umani in Qatar, e che ora chiede una nuova
votazione. Sicuramente non arriverà in plenaria il voto sulla liberalizzazione
dei visti del Qatar, dopo la proposta avanzata in aprile dalla Commissione
europea e caldeggiata dal commissario greco Margaritis Schinas che il 20
novembre aveva incontrato a Doha i ministri qatarini degli affari esteri e del
Lavoro, dopo avere parlato con Kaili. I socialisti (in testa il tedesco Erik
Marquardt) verdi e liberali adesso vogliono mettere la proposta in ghiacciaia.
Non sarà l'unica
cosa a cambiare. In questa seduta di Strasburgo - gli ultimi quattro giorni di
lavoro dell'Eurocamera prima della pausa natalizia - potrebbero portare novità
anche legislative: è chiaro che lo status quo sul livello di trasparenza
dell'Europarlamento non funziona. In particolare sotto accusa è la scarsa
regolamentazione dell'attività di lobbying. «Anche chi lavora per le ambasciate
dovrebbe essere considerato lobbista», sottolinea tra le altre cose Lamberts.
«Abbiamo sempre
pensato che le decisioni del parlamento non fossero determinanti e invece
scopriamo adesso quanto influenzino l'opinione mondiali nei confronti di certi
argomenti o certi stati», commenta un funzionario dell'Eurocamera. Da più parti
si indica nell'ambiente degli assistenti parlamentari, un lavoro faticoso e
precario in seno all'Europarlamento, la nascita dello scandalo: «Qualcuno deve
avere perso il posto e si è vendicato». Dando inizio al più grande terremoto
della storia delle istituzioni europee.
Tra gli assistenti
coinvolti c'è innanzitutto Giuseppe Meroni, collaboratire di Panzeri, passato
poi con Arena e Tarabella, che lavorava ultimamente con Lara Comi, appena
sbarcata a Bruxelles col ripescaggio dopo le elezioni nazionali, e Federica
Garbagnati, oggi assistente di Alessandra Moretti, ieri di Panzeri. Sempre con
Panzeri aveva lavorato anche Donatella Rostagno, esperta di Medio Oriente, oggi
con Arena, e componente del direttivo della ong "Fight Impunity" di Panzeri. Con
Meroni vive invece Davide Zoggia, ex sindaco di Jesolo, adesso assistente di
Pietro Bartolo, a cui hanno sequestrato l'ufficio.
Al di fuori del
Parlamento, tra gli arrestati, c'è poi Niccolò Figa-Talamanca, segretario della
ong "No peace Without Justice", romano, esperto di politica nord africana e
mediorientale, che ha lo stesso indirizzo in 41 rue Ducale, proprio nel
quartiere delle istituzioni, della ong di Panzeri Fight impunity. Sarebbe stato
avvicinato dalle autorità del Qatar per promuoverne l'immagine dei progressi nel
campo della tutela dei diritti umani.
Marco Bresolin
per “La Stampa” il 12 dicembre 2022.
«Dobbiamo perquisire
l'abitazione di un membro del Parlamento europeo e la legge belga prevede la
presenza del Presidente dell'Aula». Quando Roberta Metsola ha ricevuto questo
messaggio si trovava a Malta. La presidente ha subito preso un aereo per
Bruxelles e una volta atterrata ha dovuto percorrere più di cento chilometri.
Destinazione Anthisnes, un paesino di quattromila abitanti a sud di Liegi. Gli
inquirenti sono entrati in azione poco prima delle 21, giusto in tempo prima del
termine massimo oltre il quale la legge belga non consente di fare le
perquisizioni (sì: dalle 21 alle 5 del mattino sono vietate).
La casa in questione
era quella del sindaco del paese, l'onorevole Marc Tarabella, eurodeputato del
partito socialista. Anche lui finito nel tritacarne dell'inchiesta sul
«pagamento di ingenti somme di denaro» da parte del Qatar a persone «aventi una
posizione politica e/o strategica in seno al Parlamento europeo» al fine di
«influenzarne le decisioni».
Il Qatar ha respinto
le accuse, definendole «prive di fondamento», mentre sullo sfondo resta
l'ipotesi che ci siano altri Paesi coinvolti, tra cui il Marocco. Tarabella è il
secondo eurodeputato dell'attuale legislatura a entrare ufficialmente
nell'inchiesta, anche se nei suoi confronti non è stato disposto un
provvedimento di fermo. L'altra è la greca Eva Kaili, compagna di gruppo di
Tarabella, il cui arresto è stato convalidato ieri.
Ma l'indagine sembra
destinata ad estendersi ulteriormente: secondo quanto risulta a La Stampa da
fonti parlamentari, ci sarebbero altri tre eurodeputati coinvolti
nell'inchiesta, anche se nessuno di loro è stato oggetto di provvedimenti
giudiziari. In assenza di flagranza, infatti, i membri dell'eurocamera godono
dell'immunità, che può essere revocata solo dall'Aula. Se le informazioni
fossero confermate, l'autorità giudiziaria dovrà chiedere l'autorizzazione al
Parlamento. Al momento non risulta che siano arrivate richieste in tal senso
all'istituzione presieduta da Roberta Metsola. «Il Parlamento europeo e la
presidente stanno collaborando attiva- mente e pienamente con le autorità
giudiziarie per favorire il corso della giustizia» si è limitato a far sapere il
portavoce della presidente, Juri Laas.. Intanto ieri il giudice Michel Claise ha
convalidato quattro dei sei provvedimento di fermo.
Oltre a Eva Kaili,
fermata venerdì sera dopo che il padre era stato bloccato mentre cercava di
dirigersi verso l'aeroporto con una valigia piena di soldi, restano in carcere
anche l'italiano Antonio Panzeri, ex eurodeputato di Articolo Uno (eletto nelle
fila del Pd) e oggi presidente dell'associazione "Fight Impunity", l'assistente
parlamentare Francesco Giorgi, compagno della Kaili, e Niccolò Figà-Talamanca,
segretario generale dell'associazione "No peace without justice" .
Tutti sono accusati
di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio. È stato invece deciso di
concedere la libertà condizionale a Luca Visentini, segretario generale della
confederazione internazionale dei sindacati, e al padre di Eva Kaili. Gi
eventuali sviluppi dell'inchiesta arriveranno nel bel mezzo dell'ultima seduta
plenaria di quest'anno, che da stasera si riunisce a Strasburgo. Al di là degli
aspetti giudiziari ci saranno sicuramente ripercussioni di tipo istituzionale,
politico e legislativo. La prima è che il gruppo dei socialisti-democratici
chiederà di destituire dall'incarico di vicepresidente l'eurodeputata Kaili,
alla quale Metsola ha già tolto tutte le deleghe.
Poi ci saranno
inevitabilmente conseguenze politiche perché l'Aula intende chiedere un
dibattito sulla vicenda, con i gruppi di destra che sono già sul piede di
guerra, pronti a scatenarsi contro i socialisti-democratici. Infine verranno
congelati tutti i dossier legislativi legati al Qatar, in particolare quello che
prevede la liberalizzazione dei visti per i cittadini.
La plenaria avrebbe
dovuto dare il via libera al mandato negoziale approvato dalla commissione Libe
e invece rimanderà il file in commissione, con la richiesta di tenere in stand
by la parte relativa a Doha e di andare avanti invece con l'iter per Oman,
Kuwait ed Ecuador. «Ripugnante, aberrante e riprovevole»: così ha definito lo
scandalo corruzione la vicepresidente del Parlamento Pina Picierno. E sugli
sviluppi dell'inchiesta è intervenuto anche il commissario all'Economia, Paolo
Gentiloni che l'ha definita «una vicenda vergognosa e intollerabile». Parlando
alla trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai, l'ex premier ha sottolineato
che questa potrebbe diventare «una delle più drammatiche storie di corruzione
degli ultimi anni».
Monica Serra per “la
Stampa” il 12 dicembre 2022.
Dietro a tante
operazioni o meglio, per usare le sue parole, «intrallazzi» di Pier Antonio
Panzeri c'era la moglie, Maria Dolores Colleoni. A metterlo nero su bianco nella
scheda allegata al mandato di arresto europeo (Mae) con cui lei e la figlia,
l'avvocata Silvia Panzeri, sono finite in carcere e, dopo la convalida, ai
domiciliari, sono stati i magistrati belgi. Che hanno annotato come la donna, 67
anni, sempre al fianco dell'ex eurodeputato del Pd, già segretario della Camera
del lavoro di Milano, fosse contraria al fatto che lui potesse gestire attività
«fuori dal suo controllo». In che modo?
È solo accennato al
momento nelle quattro pagine trasmesse all'Italia, in attesa che i fascicoli
relativi a madre e figlia arrivino alla procura generale e alla corte d'Appello
di Brescia che, nelle udienze del 19 e 20 dicembre, dovranno valutare se
concedere l'estradizione delle due donne, mentre la difesa annuncia battaglia:
«Ci opporremo in ogni modo alla richiesta. Da quel che sappiamo, le accuse
appaiono troppo fumose - spiega l'avvocato Angelo De Riso -. Non è neanche
chiaro se le donne siano indagate per concorso o favoreggiamento della presunta
organizzazione criminale».
Nella scheda
allegata al Mae si parla dei consigli di Colleoni, che suggeriva al marito di
aprire un nuovo conto corrente bancario in Belgio, dove la coppia di fatto si
era trasferita dal 2004, quando Panzeri era stato per la prima volta eletto nel
Parlamento europeo.
Intercettata,
Colleoni diceva al marito di aprire un «account con l'Iva» per avviare una
«nuova attività commerciale» su cui lei potesse esercitare il «controllo»,
insistono gli inquirenti.
Che accennano anche
a come la coppia gestisse i propri conti bancari. Quello della donna, che non
accettava le venissero addebitate spese per 35 mila euro. Tanto che Panzeri, in
una conversazione riassunta dagli investigatori, diceva alla moglie che per
andare in vacanza il primo gennaio avrebbero potuto usare «un'altra soluzione» e
addebitare 10 mila euro sul conto corrente «qui», che per gli inquirenti
significa in Belgio. Certo, non si parla di una «vacanza da 100 mila euro» come
quella dello scorso anno che preoccupava la donna: «Troppo costosa».
A incuriosire gli
investigatori è anche la carta di credito di una non meglio precisata terza
persona, il «Giant», il «Gigante» nel vortice degli affari della famiglia
Panzeri sull'asse Italia - Belgio -Qatar - Marocco. Tra viaggi pazzeschi in giro
per il mondo e «doni», il tenore di vita della famiglia era alto. E proprio sul
denaro si concentrano ora le attenzioni degli investigatori che stanno
analizzando, una per una, tutte le operazioni sui conti correnti a disposizione
della famiglia.
E non è escluso che
qualche stralcio di indagine finisca sulla scrivania dei magistrati italiani, se
dovessero emergere eventuali irregolarità commesse su conti aperti in Italia. A
Calusco sull'Adda, 8 mila abitanti nella Bergamasca, l'intera famiglia aveva
mantenuto la residenza, «anche se qui oramai si vedevano poco, soprattutto in
occasione delle elezioni e neanche per le ultime del 25 settembre», precisa
l'assessore Massimo Cocchi. «Mi capitava ogni tanto di incrociare Panzeri
sull'aereo per Bruxelles nei miei viaggi di lavoro - spiega il sindaco Michele
Pellegrini - In paese è successo di rado. Niente di più».
Vacanze da Miami
a Doha. Ma la figlia di Panzeri "cancella" il lusso dai social.
Da Miami Beach a
Montreal, fino a Doha: la trentottenne, professione avvocato, ha documentato
tutto su Facebook, ma ora ha sbianchettato tutto. Massimo Balsamo il 12 Dicembre
2022 su Il Giornale.
Sapevano dei regali
ricevuti da Qatar e Marocco in cambio di pressioni politiche. Questo il giudizio
degli inquirenti belgi circa le presunte responsabilità di Maria Dolores
Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia dell’ex
europarlamentare e sindacalista Antonio. Dopo l’arresto di sabato - rispondono
di favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta di Bruxelles per corruzione e
riciclaggio - le due donne sono ai domiciliari: la prima nella casa di famiglia
a Calusco d’Adda, la seconda nel milanese.
I “doni” legati allo
scandalo Qatar erano ben presenti al centro della vita familiare, secondo gli
investigatori. Entrambe al corrente dei “mezzi ingegnosi e spesso scorretti” del
politico. Tanto da aver addirittura partecipato “nel trasporto dei ‘regali’
dell’ambasciatore del Marocco in Polonia”. Un tenore di vita alto, confermato
anche dagli scatti pubblicati sui social network (ma ora rimossi).
Social network
“sbianchettati”
Dal tanto
discusso Qatar agli Stati Uniti, passando per il Canada: mete di vacanza da
sogno, luoghi straordinari da immortalare e condividere sul web. Silvia Panzeri
sui social network ha spesso documentato le sue giornate di svago e relax, tra
piscine di lusso e spiagge incantevoli. L’ultima visita a Doha risale al 27
novembre, anche in quel caso non manca lo scatto per Facebook dal Souq Waqif, il
mercato più antico della città qatariota oggi teatro dei Mondiali di calcio.
I doni, le vacanze,
i conti: così si muovevano la moglie e la figlia di Panzeri
Come anticipato, il
Qatar non è l’unica destinazione della 38enne. Non mancano post sulle vacanze
con gli amici in quel di Miami Beach o sulle giornate trascorse a spasso per
Montreal. Foto e pensieri ora svaniti: la figlia dell’ex europarlamentare dem ha
rapidamente rimosso tutto dai social network, consapevole del rischio
strumentalizzazione. O più semplicemente per evitare ulteriori polemiche sulla
bufera che ha coinvolto la famiglia.
Silvia Panzeri tra
lusso e battaglie sociali
Oltre alle già
citate foto delle ammalianti vacanze, Silvia Panzeri ha utilizzato i social
network anche per portare avanti battaglie sociali degne di nota. Avvocato da
undici anni con fresca specializzazione in diritto dell’Unione europea, la
trentottenne ha utilizzato Facebook per manifestare il suo impegno contro la
violenza di genere, la tutela delle donne vittime di violenza e il
cyberbullismo. Ora il coinvolgimento nel Qatargate: insieme alla madre,
l’avvocato è menzionata “nella trascrizione di intercettazioni telefoniche”.
Qatargate, blitz
nella villa di Panzeri a Bergamo: trovati altri 17mila euro.
Proseguono le
perquisizioni disposte dalla procura di Bruxelles nell'ambito del Qatargate:
17mila euro e documenti sequestrati a Panzeri. Francesca Galici il 12 Dicembre
2022 su Il Giornale.
La procura belga non
si ferma nell'indagine sulla corruzione che ha coinvolto il parlamento europeo e
ha annunciato nuove perquisizioni negli uffici di Bruxelles e non solo. Altre
perquisizioni quest'oggi sono state effettuate anche in Italia, a Milano e
Calusco D'Adda, in provincia di Bergamo, a carico di Antonio Panzeri. Le nuove
perquisizioni hanno portato al sequestro di supporti informatici e documenti,
oltre alla somma di 17 mila euro in contanti trovati nell'abitazione in
provincia di Bergamo.
Mazzette dal Qatar,
lo strano pass con cui Panzeri aggirava le norme Ue
La procura ha
spiegato che "da venerdì, con il supporto dei servizi di sicurezza del
Parlamento europeo, le risorse informatiche di dieci collaboratori parlamentari
sono state congelate". Una misura presa "per evitare la scomparsa di dati
necessari alle indagini. La perquisizione di oggi al parlamento europeo aveva lo
scopo di sequestrare questi dati". Il dossier della procura, "gestito da un
giudice istruttore di Bruxelles", è stato "aperto da più di quattro mesi per
corruzione, riciclaggio e organizzazione criminale".
Viaggi, convegni,
meeting: tutti gli "affari" della Ong di Panzeri
Le quattro persone
in carcere, delle sei arrestate sabato, compariranno mercoledì davanti al
giudice. "In tutto, dall'inizio delle operazioni, ci sono state 20
perquisizioni: 19 in residenze e uffici oltre a quella di oggi nei locali del
parlamento europeo. Sono stati sequestrati, in tre diversi luoghi, diverse
centinaia di migliaia di euro: 600 mila al domicilio di uno dei sospetti,
diverse centinaia di migliaia in una valigia che si trovava in una camera di
albergo a Bruxelles e circa 150 mila circa in un appartamento di proprietà di un
deputato europeo", spiega la procura belga nella nota.
Intanto arrivano
anche le prime conseguenze politiche, che fanno seguito alla sospensione e
destituzione di Eva Kaili dalla carica di vicepresidente del parlamento europeo
disposta da Roberta Metsola, che ha attivato anche la procedura per la
decadenza, che escluderà per sempre la greca dal suo ruolo. In queste ore, Marc
Tarabella si è autospeso dal gruppo dei Socialisti e Democratici dopo le
perquisizioni condotte dalla polizia belga nel suo ufficio e nella sua
abitazione di Bruxelles in presenza di Roberta Metsola nella giornata di ieri.
Nella stessa
sede, Andrea Cozzolino ha reso noto di rinunciare all'incarico di coordinatore
del gruppo per le emergenze. In più, Maria Arena, eurodeputata italo-belga dei
socialisti europei, ha annunciato le dimissioni dalla presidenza della
Commissione Diritti del parlamento europeo: "A seguito delle rivelazioni di
sospetti di corruzione legati al Qatar ed al Parlamento europeo, ed alla
perquisizione di uno dei miei assistenti nel contesto di questo caso, ho deciso
che non presiederò più temporaneamente le riunioni del sottocomitato peri
Diritti Umani del Parlamento europeo".
In conferenza
stampa, Roberta Metsola ha ribadito il totale impegno della sua carica e del
Parlamento europeo nel risolvere questa situazione, eliminando gli elementi che
l'hanno causata. "Non ci sarà impunità. Nessuno. I responsabili troveranno
questo Parlamento dalla parte della legge. Sono orgogliosa del nostro ruolo e
della nostra assistenza in questa indagine. Non ci sarà da nascondere la polvere
sotto il tappeto. Avvieremo un'indagine interna per esaminare tutti i fatti
relativi al Parlamento e per vedere come i nostri sistemi possono diventare
ancora più impermeabili", ha dichiarato il presidente del parlamento europeo.
"Questi sono tempi
difficili per tutti noi, ma so, ne sono convinto, che se lavoriamo insieme
possiamo uscirne più forti. A voi, colleghi che avete vissuto con me questi
giorni, lasciatemi dire ancora una volta quanto sono profondamente delusa: so
che condividete tutti lo stesso sentimento. A quegli attori maligni, nei Paesi
terzi, che pensano di poter comprare la loro strada. Che pensano che l'Europa
sia in vendita. Che pensano di poter rilevare le nostre Ong. Lasciatemi dire che
troverete questo Parlamento fermamente sulla vostra strada. Siamo europei", ha
concluso Roberta Metsola.
Ammoniva l'Italia
ma elogiava il Qatar. Il caso che imbarazza la Commissione Ue.
Oggi in tanti
chiedono conto, anche alla luce delle inchieste giudiziarie su presunti casi di
corruzione in Qatar, delle posizioni giudicate "morbide" di Schinas
sull'emirato. Mauro Indelicato il 12 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Fino ad oggi
l'inchiesta di Bruxelles sui presunti casi di corruzione di Qatar e Marocco ha
coinvolto il parlamento europeo. L'arresto della vice presidente
dell'europarlamento, Eva Kaili, e il coinvolgimento di altri deputati o ex
deputati ha lasciato il segno. Ma il sospetto è che il lavoro della magistratura
belga sia solo all'inizio. E che, soprattutto, in qualche modo il raggio
d'azione degli emissari di Doha e Rabat sia in realtà esteso anche ad altre
istituzioni europee.
"Corruzione dal
Qatar". Indagini su 4 italiani, fermato ex eurodeputato dem
Per questo nelle
ultime ore, come sottolineato dall'Agi, a Bruxelles sta aumentando la pressione
sulla Commissione europea affinché venga spiegata la posizione del vice
presidente Margaritis Schinas. Quest'ultimo, stando alle ricostruzioni trapelate
dalla capitale belga, negli ultimi mesi avrebbe ammorbidito la sua posizione nei
confronti del Qatar. Circostanza non passata inosservata.
La linea di Schinas
su Doha
È bene precisare che
Schinas non risulta tra gli indagati e non è coinvolto al momento nella vicenda
che ha portato all'arresto della connazionale Eva Kaili. Nel mirino però sono
finite le sue considerazioni politiche sul Qatar alla vigilia dei mondiali di
calcio, evento per il quale Doha non ha badato a spese. E forse qualche soldo,
se le accuse degli investigatori dovessero rivelarsi fondate, lo ha speso per
“ammorbidire” la posizione di alcuni rappresentanti europei nei confronti del
piccolo Stato del Golfo.
Anche dopo il
fischio d'inizio dei mondiali, su una parte della stampa si è infatti continuato
a parlare delle condizioni dei lavoratori in Qatar e degli standard poco
democratici del Paese. Le tangenti potrebbero essere servite proprio per far
parlare in chiave positiva dei progressi fatti da Doha in vista del torneo
iridato.
Cosa ha comprato il
Qatar con i soldi ai deputati corrotti
Ecco perché quindi
alcune recenti dichiarazioni di Schinas sono adesso nel mirino di diversi
europarlamentari. “Il commissario europeo greco di destra Margaritis Schinas –
ha scritto su Twitter Manon Aubry, presidente del gruppo La Sinistra a
Strasburgo – ha moltiplicato riunioni e lodi dall'emirato”.
Un'allusione quindi
al fatto che dal vice presidente della Commissione europea sono arrivate
considerazioni positive sul lavoro fatto dal Qatar. In effetti, scorrendo la
cronologia delle dichiarazioni, più volte Schinas si è soffermato
sull'importanza del ruolo di Doha nella regione, così come sui passi in avanti
compiuti grazie alle riforme del mercato del lavoro.
C'è anche un Tweet
del vice presidente della Commissione europea, datato 11 maggio 2022, in cui è
stata annunciata l'esenzione dai visti per i qatarini. “La nostra proposta di
concedere l'esenzione dal visto per i qatarini – si legge in quel post – è un
riflesso della nostra partnership sempre più profonda. L'imminente Coppa del
mondo è una ragione obiettiva per progredire rapidamente con la sua adozione”.
Eppure Schinas si
diceva preoccupato per le scelte italiane
Come detto, Schinas
non è indagato. Né obbligatoriamente occorre ricondurre le sue dichiarazioni e
le sue posizioni alle vicende di corruzione che hanno interessato
l'europarlamento. Inoltre, andando a vedere le ultime dichiarazioni di gran
parte dei leader politici europei, la ricerca di gas ha spesso condotto molti
politici negli ultimi mesi a ricercare importanti relazioni con Doha.
Tuttavia, sotto il
profilo prettamente politico, stridono e non poco le parole pronunciate da
Schinas sul Qatar con quelle invece pronunciate sull'Italia. Se Doha è stata
presentata come un Paese in grado di fare passi in avanti, nonostante
l'inesistenza di alcuni basilari diritti e l'esistenza di un codice penale
ispirato alla Sharia, l'Italia invece dallo stesso Schinas è stata più volte
criticata per la gestione dei flussi migratori.
“Secondo il diritto
internazionale, la responsabilità è del Paese nelle cui acque territoriali si
trova la nave – scriveva Schinas in un'intervista al Corriere della
Sera rilasciata a novembre, all'indomani del caso Ocean Viking – L'Italia si è
rifiutata di ottemperare pienamente e ha mandato la nave in Francia creando
questa situazione per avere una soluzione europea”.
Sbarchi, nuovo
monito Ue all'Italia: "Niente ritardi"
Desta una certa
sensazione leggere simili dichiarazioni, improntante sul rispetto del diritto
internazionale, dallo stesso esponente politico non così scrupoloso invece
quando si parla di rispetto dei diritti umani in Qatar. Di questa doppia
visione del suo vice presidente la commissione, in primis sotto il profilo
politico, potrebbe essere ben presto chiamata a rispondere. E l'imbarazzo a
Bruxelles viene tenuto faticosamente confinato nelle stanze di Palazzo
Berlaymont.
Da globalist.it il
12 dicembre 2022.
Panzeri arrestato,
grande sconcerto per ciò che è accaduto all’europarlamentare che da sempre si è
distinto per il suo impegno.
Fight Impunity, la
ong perquisita oggi dalla polizia belga nell’ambito dell’inchiesta che ha
portato al fermo di quattro persone per presunta corruzione, è stata fondata nel
settembre 2019 da Antonio Panzeri, già eurodeputato del gruppo S&D ed ex
presidente della sottocommissione Diritti umani del Parlamento Europeo. Dopo
essere stato a lungo segretario della Camera del Lavoro di Milano, dal 1995 al
2003, Panzeri è diventato eurodeputato nel 2004 e lo è stato fino al 2019.
Una volta lasciata
l’Aula, dove si è distinto tra l’altro per l’impegno in favore dei diritti umani
e in particolare per la ricerca della verità sull’uccisione in Egitto del
ricercatore Giulio Regeni, Panzeri ha fondato a Bruxelles Fight Impunity,
organizzazione non profit impegnata «contro l’impunità» per le violazioni dei
diritti umani.
Il consiglio dei
membri onorari della Ong, che ha sede in Rue Ducale, non lontano dall’Ambasciata
americana, dalla missione permanente a Bruxelles della Federazione Russa e dal
Parlamento federale belga, è composto da personalità di assoluto rilievo.
Tra queste, secondo
il sito della Ong, figurano anche Emma Bonino, ex ministra e commissaria
europea, e Federica Mogherini, già ministra degli Esteri e Alto Rappresentante
dell’Ue, oltre a Dimitris Avramopoulos, già commissario europeo agli Affari
Interni, e all’ex primo ministro francese Bernard Cazeneuve. E’ membro onorario
di Fight Impunity anche Denis Mukwege, ginecologo congolese premio Nobel per la
Pace nel 2018.
Terremoto tra
i socialisti, dimissioni di massa.
Paolo Bracalini il
13 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Dopo la sospensione
dalla carica di vicepresidente del Parlamento Ue per la greca Eva Kaili, la
deputata socialista al centro del Qatargate, arriverà a breve il siluramento
formale dal mandato
Dopo la sospensione
dalla carica di vicepresidente del Parlamento Ue per la greca Eva Kaili, la
deputata socialista al centro del Qatargate, arriverà a breve il siluramento
formale dal mandato. La conferenza dei capigruppo è convocata stamattina con
appunto questo unico ordine del giorno: la cessazione del mandato di
vicepresidente Ue. «Provo furia, rabbia e dolore. La democrazia europea è sotto
attacco» ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, aprendo la
plenaria a Bruxelles.
«I nemici della
democrazia non si fermeranno. Questi attori maligni, legati a Paesi terzi
autocratici, hanno presumibilmente armato Ong, sindacati, individui, assistenti
ed eurodeputati nel tentativo di sottomettere i nostri processi. Ma i loro piani
maligni sono falliti», ha spiegato Metsola, annunciando l'avvio di «un'indagine
interna» all'Europarlamento. L'unico procedimento formale riguarda finora la
vicepresidente Kaili, trovata con qualcosa come 750mila euro in contanti, mentre
continuano le perquisizioni a carico degli altri indagati, in primis l'ex
eurodeputato di sinistra Antonio Panzeri, altro protagonista dello scandalo con
la sua ong «Fight Impunity».
Si parla di altri
parlamentari coinvolti, nomi non ancora usciti, mentre altri vengono coinvolti
pur non essendo sotto indagine. É il caso del deputato belga, sempre del gruppo
dei socialisti) Marc Tarabella, la cui casa è stata perquisita, mentre è sotto
sequestro l'ufficio del suo assistente Giuseppe Meroni, trait d'union con
Panzeri, di cui è stato collaboratore, come anche ha lavorato con Pietro
Bartolo, il medico di Lampedusa eletto con il Pd alle europee del 2019. Ieri,
all'unisono, si sono tutti fatti da parte. Tarabella si è autosospeso dal gruppo
dei Socialisti e Democratici (S&D), Bartolo ha rimesso il mandato da relatore di
S&D del testo sulla liberalizzazione dei visti a Kuwait e Qatar.
Altra assistente al
centro della presunta «Italian connection» è Donatella Rostagno, ex
collaboratrice di Panzeri e ora dell'europarlamentare belga di origine italiana,
Maria Arena, anche lei socialista, che ieri si è appunto dimessa dalla
presidenza del «Sottocommissione per i diritti dell'uomo» del Pe. Il deputato Pd
Andrea Cozzolino, che si era dato da fare nei mesi scorsi per invitare i
colleghi a votare contro le mozioni di accusa al Qatar sui diritti umani, si è
sentito in imbarazzo e si è dimesso da coordinatore di S&D per le urgenze. Emma
Bonino si dimette dall'Advisory board di Fight Impunity. Una sfilza di
autodimissioni (spinte anche dal gruppo che ha promesso tolleranza zero) che fa
capire il clima rovente, soprattutto a sinistra, di questo dicembre nella
uggiosa Bruxelles.
Si passano al
setaccio le dichiarazioni pubbliche sospette degli esponenti delle istituzioni
europee. Come quelle di Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Ue,
che in occasione di un bilaterale con Hassan Al Thawadi, segretario generale del
comitato organizzatore dei Mondiali, ha elogiato «i progressi sulla riforma dei
diritti del lavoro e le misure per garantire l'inclusione e la tolleranza per
tutti i partecipanti e i visitatori».
In Italia è evidente
l'imbarazzo del centrosinistra, già reduce dal caso Soumahoro. Il centrodestra
resta garantista, dice Stefania Craxi, «ma pensare che questi ci facevamo la
morale a noi.. Mia nonna diceva anche il più pulito dei moralisti c'ha la
rogna». Monsignor Crociata, delegato della Cei, è contrito: «Il problema più
grave della vita pubblica è la qualità morale delle persone»
Pietro De Leo
per “Libero quotidiano” il 12 dicembre 2022.
Siccome il
garantismo è un esercizio sì culturale, ma anche scientifico, la premessa è che
la responsabilità morale è personale e che, in sede di inchiesta, anche quando
scattano misure cautelari, ogni addebito è sempre presunto.
Dunque la (non)
presa di posizione di Emma Bonino sull’inchiesta che riguarda le presunte
(appunto) pressioni del Qatar su alcuni esponenti politici e di Ong europei
vanno lette in un’ottica espressamente politica. Null’altro. Ed è pacifico che
la senatrice, storica attivista dei diritti umani, in una battuta volante con
l’Ansa ieri pomeriggio abbia detto che per ora, «ad indagine in corso», non
vuole rilasciare dichiarazioni.
Però allora risulta
un bel po’ rovinosa, ribadiamo sempre sul piano del confronto pubblico,
l’intervista rilasciata al Corriere della Sera di ieri. Rileva il fatto che nel
calderone dell’inchiesta sia finita anche la Ong No peace without justice, da
lei fondata nel 1993.
La giornalista del
Corriere le fa notare il coinvolgimento dell’ente. E a domanda se sappia niente
di questo, la risposta è: «No, non so niente. Aspetto la magistratura che si
deve esprimere, credo che lo farà nel giro di pochi giorni». Quanto all’arresto
del segretario generale della Ong, Niccolò Figà-Talamanca, risponde: «Ho letto,
ma non ho potuto parlare con Niccolò, lui adesso è in stato di fermo».
Peraltro, la
senatrice neanche ricorda bene quando ha fondato la Ong: «È successo nel 1994.
Forse era il 1993». Certamente, con una storia come la sua, così ricca di
iniziative politiche e di incarichi, qualche mese può scappare. E però, allora,
questo evidente distacco rispetto all’essenza della Ong (in un’altra domanda
afferma di sapere ben poco anche sulle altre organizzazioni ospitate nella sede
di Npwj a Bruxelles) stride con quanto c’è scritto sul sito.
Sotto la sezione
“The Team”, la squadra, il primo nome che compare è proprio quello dell’ex
ministro degli esteri. E nel profilo l’attacco è piuttosto eloquente: «Emma
Bonino è la fondatrice di No peace without justice, ed è ancora molto impegnata
nelle attività e nelle campagne» della Ong. Allora, forse, alla luce dei “non
so” sarebbe opportuno aggiornare la pagina. Così come, sempre nella breve
intervista al Corriere, è alquanto singolare la risposta che Bonino dà alla
domanda su Antonio Panzeri.
Ex eurodeputato Pd,
in stato di fermo sempre per la stessa inchiesta. Anche la sua Ong, Fight
Impunity (Combattiamo l’impunità) è al centro dell’indagine. Alla domanda se lo
conosca o meno, Bonino risponde: «Non mi ricordo di lui, può essere che l’abbia
incontrato qualche volta quando ero al Parlamento europeo».
E però se si clicca
sul sito della Ong, Emma Bonino compare nel board dei “membri onorari”. Appena
un paio di schede sotto di Panzeri, che è presidente. Chissà, magari davvero
l’avrà incontrato «qualche volta», ma di certo questi «non so» e «non ricordo»
stridono rispetto al tenore dell’impegno pubblico di Emma Bonino, ancora oggi
molto attiva e partecipe al dibattito su molti dossier. Specie considerando il
fatto che il presunto scandalo riguarda un tema che ne ha animato l’attivismo
per una vita, il rispetto dei diritti umani. Un gioco di rimessa che sorprende
assai.
"Potrebbe essere
il caso più significativo di potenziale corruzione dentro al Parlamento".
Scandalo Qatar, cosa è successo: l’indagine e le accuse di corruzione sul
Parlamento europeo.
Elena Del Mastro su
Il Riformista il 12 Dicembre 2022
Del Qatar non si
parla più soltanto per via dei Mondiali, ma anche per il caso di sospetta
corruzione che aleggia nel Parlamento europeo che sarebbe stato proprio da parte
del ricchissimo paese del Medio Oriente. Stata avviata un’indagine che coinvolge
diversi parlamentari europei e persone che lavorano nel Parlamento Europeo
alcuni dei quali italiani.
La Procura Federale
Belga sta conducendo l’indagine da luglio. Sabato 10 dicembre ha fatto sapere
che sono state arrestate quattro persone, fra cui una delle attuali
vicepresidenti del Parlamento Europeo, la greca Eva Kaili, e l’ex parlamentare
europeo italiano Antonio Panzeri, entrambi espressione di partiti del
centrosinistra. Alcune persone a loro vicine sono state interrogate e alcuni
uffici sono stati perquisiti dalle autorità belghe. Le accuse formali sono di
associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione. La procura sospetta che a
“persone dentro al Parlamento Europeo siano state pagate grosse quantità di
soldi o abbiano ricevuto regali significativi per influenzare le decisioni del
Parlamento Europeo” riguardo al Qatar. Ma le indagini sono ancora in corso.
Negli ultimi mesi il
Qatar è stato al centro del dibattito per i mondiali e soprattutto per
le violazioni dei diritti umani relativi ai lavoratori impegnati nella
costruzione di grattacieli e stadi per i Mondiali. La Procura sospetta che il
Qatar abbia coinvolto diverse persone del parlamento Europeo per migliorare la
propria immagine nell’Occidente e nelle istituzioni europee. Nessuna delle
persone coinvolte ha commentato le accuse e il Qatar con un breve comunicato ha
respinto “ogni tentativo di associare lo stato ad accuse di irregolarità”.
Nella mattinata di
venerdì sono stati fermati l’ex eurodeputato del Pd Antonio Panzeri, poi passato
ad Articolo Uno, il suo assistente nella passata legislatura Francesco Giorgi,
e Niccolò Figà-Talamanca, direttore della Ong No Peace Without Justice che opera
a Bruxelles.
In questo elenco si
aggiunge l’ europarlamentare socialista greca Eva Kaili, compagna dell’italiano
Giorgi e soprattutto una dei 14 vicepresidenti del Parlamento europeo. Kaili è
stata sospesa sia dal gruppo socialista europeo che dal Pasok greco. Ma a causa
delle indagini, come comunicato dal portavoce della presidente
dell’Eurocamera Roberta Metsola, quest’ultima “ha deciso di sospendere con
effetto immediato tutti i poteri, compiti e le deleghe di Eva Kaili nella sua
qualità di vicepresidente del Parlamento europeo”
Soltanto due
settimane fa, nel corso di un dibattito parlamentare nell’aula di Strasburgo,
era stata votata una risoluzione di censura del Qatar e in difesa dei diritti
civili in quel Paese. Nel suo discorso Eva Kaili, per essendo il gruppo
socialista S&D a favore della risoluzione, si era espressa a favore del
Paese: “Il Qatar è all’avanguardia nei diritti dei lavoratori”, aveva detto la
eurodeputata greca, sottolineando che “la Coppa del Mondo in Qatar è la prova di
come la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un
Paese con riforme che hanno ispirato il mondo arabo”.
Nel corso della
perquisizione presso l’abitazione della vice presidente dell’Eurocamera Eva
Kaili, scrive il quotidiano belga L’Echo, sarebbero stati trovati addirittura
“sacchi di banconote”. Il dato chiarirebbe anche il perché Kaili sia stata
arrestata nonostante l’immunità parlamentare. Secondo il regolamento interno del
Parlamento europeo l’immunità, infatti, decade in caso di flagranza di reato.
Anche il padre di Kaili è stato arrestato: stava cercando di fuggire portando
con sé una valigia piena di banconote. L’operazione condotta dalla polizia ha
portato a 16 perquisizioni in 14 indirizzi in diversi quartieri di Bruxelles,
oltre al sequestro di 600mila euro in contanti, smartphone e altro materiale
informatica. Il denaro sarebbe stato sequestrato a casa di Panzeri, l’ex
eurodeputato Dem.
Tra gli uffici
perquisiti anche quelli degli assistenti di due deputati belgi, Marie Arena e
Marc Tarabella, così come la sede di Fight Impunity, ong fondata nel settembre
2019 da Panzeri e che si occupa di violazione dei diritti umani. Panzeri “è
sospettato” di essere intervenuto “politicamente con i membri” che lavorano al
Parlamento Europeo “a beneficio di Qatar e Marocco, contro il pagamento”. Lo si
legge in uno degli atti dell’indagine di Bruxelles per “corruzione di funzionari
e membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri, riciclaggio e
associazione per delinquere”.
Indagini sono ancora
in corso per stabilire cosa sia successo. Certo è che il caso ha riaperto il
dibattito sulla permeabilità del parlamento Europeo ai tentativi di influenza
esterna di lobby e paesi stranieri. “Sebbene questo possa essere il caso più
significativo di potenziale corruzione dentro al Parlamento da molti anni a
questa parte, non è un incidente isolato”, ha detto al Financial Times Michiel
van Hulten, capo dell’ufficio di Bruxelles della ong Transparency International,
come cita Il Post. Da tempo circola la proposta di rendere più stringenti le
norme del Parlamento Europeo sulla trasparenza e i rapporti con le lobby.
Proposta che viene sempre bocciata da una maggioranza trasversale di
parlamentari europei.
Elena Del Mastro.
Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È
innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature,
raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli
stereotipi.
Corruzione dal
Qatar. Una persona coinvolta nell’indagine sta collaborando con la procura
belga.
Linkiesta su L’Inkiesta il 13 Dicembre 2022
C’è un «pentito» che
si è fatto avanti per raccontare ai magistrati la «rete Panzeri» e le attività
della ong “Fight Impunity”. Il giudice istruttore Michel Claise sta ricevendo
assistenza giudiziaria anche dal pm di Milano Fabio De Pasquale
C’è un «pentito»
nell’indagine sulla presunta corruzione dal Qatar al Parlamento europeo,
scrive Repubblica. Dopo quattro giorni, sei interrogatori e una sfilza di
sequestri e uffici sigillati, una delle persone toccate dall’indagine – di cui
non si conosce il nome – si è fatta avanti con la procura belga e sta
collaborando con gli inquirenti. Sarebbe una testimonianza decisiva per
illustrare la rete di Antonio Panzeri, spiegare le attività della sua ong “Fight
Impunity” e stilare un elenco di tutto quelli che hanno collaborato con l’ex
parlamentare in quella che ormai chiamano “Italian Connection”.
Nella casa di
Panzeri a Calusco D’Adda, ieri la Guardia di Finanza ha trovato 17mila euro in
contanti e alcuni orologi di valore. E sulla base delle indicazioni del
«pentito», la polizia belga ha fatto partire nuove perquisizioni, inviando un
gruppo di gendarmi anche a Strasburgo durante la sessione plenaria del
Parlamento. Dove sono stati apposti i sigilli ai computer del collaboratore di
Antonio Cozzolino e dell’assistente di Alessandra Moretti. E a quello di una
funzionaria del parlamento: Mychelle Rieu, responsabile di unità della
sottocommissione Diritti Umani.
I deputati con un
coinvolgimento più evidente e con incarichi di rilievo alla fine hanno deciso di
autosospendersi: Andrea Cozzolino da coordinatore delle urgenze, Pietro Bartolo
(“Se le accuse sono vere devono rinchiuderli e buttare le chiavi nella fossa
delle Marianne”) da relatore ombra per il dossier della commissione per le
libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe), la belga Maria Arena
si è dimessa da presidente della commissione per i diritti umani, il suio
connazionale Marc Tarabella dal gruppo stesso. Ma certo non sono mancate lo
scambio di accuse. E il dito finiva sempre contro la delegazione italiana. Oggi
l’Assemblea discuterà il caso e entro giovedì voterà anche sulla destituzione di
Eva Kaili dalla vicepresidenza.
Luca Visentini, il
segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (Etuc) fermato
con tutto il gruppo la settimana scorsa, è il solo a essere stato rilasciato
dopo gli interrogatori. A Repubblica, Visentini dice che «il punto erano proprio
le mie collaborazioni con Fight Impunity che sono state equivocate.
L’associazione era riconosciuta dal Parlamento europeo, aveva nel board
personaggi influentissimi, si occupava di difesa dei diritti umani. A quanto
pare, in base alle indagini in corso, sembrerebbe una organizzazione criminale
finanziata dal governo del Qatar per corrompere in particolare i membri
dell’Europarlamento e per indurli a prendere posizioni più favorevoli nei
confronti del governo del Qatar. Ma io nulla potevo sapere».
Il Corriere della
Sera spiega che il giudice istruttore Michel Claise sta ricevendo assistenza
giudiziaria dal pm di Milano Fabio De Pasquale. Secondo le prime risultanze
investigative, a Panzeri sarebbero intestati alcuni conti correnti con liquidità
importanti. Oltre che immobili difficilmente acquistabili soltanto con il lavoro
di europarlamentare.
Niccolò
Figà-Talamanca e Francesco Giorgi sono gli altri due nomi collegati a Panzeri
nell’inchiesta. E ieri altri quattro italiani hanno visto sigillarsi gli uffici
o sequestrare i telefoni. Tra questi c’è Davide Zoggia, ex sindaco di Jesolo e
fedelissimo di Pier Luigi Bersani. Poi c’è Giuseppe Meroni, ex assistente di
Panzeri. Infine ci sono Donatella Rostagno e Federica Garbagnati. La prima è
un’esperta di Medio Oriente. Collaborava con Panzeri, ora con l’europarlamentare
Maria Arena. Ma soprattutto, è componente del board della Ong “Fight Impunity”.
Garbagnati invece è collaboratrice di Alessandra Moretti.
Ma da Strasburgo è
partito anche un attacco a una parte della Commissione, in particolare a al
vicepresidente greco, Margaritis Schinas. Tutto nasce da un suo viaggio
istituzionale nella scorsa primavera a Doha e di una foto postata su Twitter con
la connazionale Kaili. Verdi e Sinistra hanno chiesto chiarimenti. Il
commissario ha risposto sottolineando che si tratta di una missione
istituzionale con il segretario generale dell’Onu. E anche che la foto con Kaili
non era stata preventivata.
Da ansa.it il 13
dicembre 2022.
Ammonta ad oltre un
milione e mezzo di euro il totale delle banconote trovate dalla polizia belga
nel corso delle perquisizioni alle abitazioni di Antonio Panzeri e dell'ex
vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili, entrambi agli arresti per il
Qatargate.
Nel domicilio di
Kaili viveva anche Francesco Giorgi, anche lui agli arresti.
E' quanto riportano
i media belgi citando la polizia federale. Il computo comprende anche i contanti
trovati nella valigia che il padre di Kaili aveva con sé mentre stava lasciando
un albergo di Bruxelles. (ANSA).
Giuseppe Guastella
per il “Corriere della Sera” il 13 dicembre 2022.
Un «paravento»
dietro il quale Antonio Panzeri si muoveva «manovrando» come un «capo» in modo
criminale e spregiudicato: secondo la magistratura belga era questa la reale
funzione di Fight impunity, la Ong per la difesa dei diritti umani fondata nel
2019 da Panzeri il quale avrebbe influenzato il Parlamento europeo elargendo,
attraverso la sua nobile creatura, grosse somme di denaro e regali principeschi
provenienti dal Qatar.
Cadeaux che avrebbe
elargito a coloro che, politici o no, potevano orientare le decisioni
dell'assemblea a favore del Paese del Golfo a ridosso del Mondiale di calcio,
quando emergeva con evidenza che l'emirato proprio non era in prima linea nei
diritti umani e dei lavoratori. E le indagini si estendono a Milano, alla rete
italiana legata a Panzeri e al suo patrimonio definito «molto consistente».
Le indagini
Gli sviluppi
dell'inchiesta della Procura federale belga puntano in modo marcato al ruolo
dell'ex politico di Pd e poi di Articolo 1 e della sua Ong che annoverava nel
consiglio onorario personaggi del calibro degli ex commissari europei Emma
Bonino e Dimitris Avramopoulos e della ex rappresentante Ue per gli affari
esteri Federica Mogherini, tutti dimessisi per lo scandalo che ha portato in
carcere per associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio Panzeri, uno dei
14 vice presidenti del Parlamento europeo, la greca del Pasok Eva Kaili, il
padre e il compagno di questa, il milanese Francesco Giorgi, la moglie e la
figlia di Panzeri, il segretario dell'ong No peace without justice Niccolò Figà
Talamanca.
Un ambiente in cui
l'italianità crea cameratismo e complicità e che, ma solo per una questione di
assonanza tricolore, si estende al cognome dell'europarlamentare Marc Tarabella,
perquisito sabato scorso davanti al presidente dell'Europarlamento Roberta
Metsola che è dovuta appositamente rientrare di corsa da Malta.
Bruxelles-Milano
Le indagini si
muovono spedite anche sull'asse Bruxelles-Milano per individuare la rete dei
rapporti di Panzeri. Usufruendo di Eurojust, il giudice istruttore Michel Claise
sta ricevendo assistenza giudiziaria dall'aggiunto Fabio De Pasquale che guida
il dipartimento «affari internazionali» della Procura di Milano.
È stato lui ad
ordinare la perquisizione dell'abitazione di Panzeri a Calusco D'Adda (Bergamo)
dove moglie e figlia sono ai domiciliari e dove la Gdf ha trovato 17 mila euro
in contanti, che si sommano ai 600mila sequestrati all'uomo al momento
dell'arresto in un residence di Bruxelles. Tanti, troppi sono i soldi che girano
in questa storia.
Oltre alle
banconote, Panzeri e i suoi familiari sembrano possedere un patrimonio
importante fatto di conti correnti, che sono stati acquisiti insieme, e di
immobili che difficilmente può essere giustificato solo con il pur ricco
appannaggio incassato in 10 anni di mandato parlamentare europeo.
Le indagini di De
Pasquale (perquisita anche la casa di Giorgi e sequestrato il suo conto)
dovranno contribuire a chiarire flussi di denaro arrivato dal Marocco e dal
Qatar in contanti e bonifici. E poi ci sono i 100 mila euro che sarebbero stati
spesi per una vacanza di Natale e i regali trasferiti in Marocco.
Un trolley di
banconote
Banconote fruscianti
tornano anche nell'arresto di Eva Kaili «causato» dal fermo precedente del
padre. Quando venerdì la polizia lo ha visto lasciare in fretta e furia il
lussuoso albergo nel quartiere «Europeo» di Bruxelles dove era arrivato qualche
giorno prima con la moglie, è bastato un attimo agli agenti per saltargli
addosso e scoprire che nel trolley che si trascinava dietro c'erano la bellezza
di 600 mila euro in banconote da 50 euro.
Perché aveva tanta
premura? Forse sapeva che gli investigatori erano sulle tracce dei soldi
accumulati dalla figlia con le tangenti, dicono a Bruxelles, ai quali si
aggiungeranno i 150 mila euro trovati in banconote da 20 e 50 euro
nell'abitazione della Kaili assieme a molti regali di valore, oggetti e
medaglie, ricevuti dal Qatar.
La scoperta dei
soldi e dei regali è stata considerata la «flagranza di reato» che, facendo
decadere l'immunità parlamentare, ha permesso alla magistratura di arrestare
Kaili. Sono 19 le abitazioni perquisite e 10 gli uffici di collaboratori
sigillati al Parlamento per «congelare» e «prevenire» la manomissione dei dati
dei telefonini e dei pc sequestrati, come spiegano i pm.
Sigilli anche negli
uffici di Strasburgo degli assistenti dei parlamentari Pd, non indagati,
Alessandra Moretti e Andrea Cozzolino, l'arrestato Giorgi assiste il secondo e
lavora in uno dei due. Fermato venerdì e rimesso in libertà il giorno dopo, Luca
Visentini, capo della Confederazione sindacale internazionale, è ancora scosso
dalla esperienza del carcere. «Sono stato liberato senza accuse formali e con
condizioni minime che permettono di muovermi liberamente» afferma, e aggiunge:
«Sono estraneo a qualsiasi forma di corruzione. Se fossi stato corrotto o se
fossi un corruttore le mie posizioni politiche sarebbero state molto favorevoli
al Qatar, invece nei giorni precedenti avevo dichiarato che le riforme fatte in
quel Paese erano del tutto insufficienti».
Estratto
dell’articolo di G.F e C.T. per “la Repubblica” il 13 dicembre 2022.
Il Qatargate è a una
svolta. Dopo quattro giorni, sei interrogatori e una sfilza di sequestri e
uffici sigillati, un "pentito" si è fatto avanti con la procura belga. Uno dei
"toccati" dall'inchiesta ha iniziato dunque a collaborare con gli inquirenti.
A illustrare la rete
di Panzeri, a spiegare le attività della sua Ong "Fight Impunity" e a stilare un
elenco di tutti quelli che hanno collaborato con l'ex parlamentare. La "Italian
Connection" è ora qualcosa di più di un semplice teorema giudiziario. Adesso c'è
una geografia delle mazzette.
E ovviamente è
scattato il terrore, soprattutto nel gruppo S&D dell'Europarlamento. Lo
psicodramma è così arrivato anche a Strasburgo. In occasione della riunione
Plenaria. I socialisti hanno fatto autocoscienza. Ma nel frattempo, sulla base
delle indicazioni del "pentito", la polizia belga ha fatto partire nuove
perquisizioni nella sede del Parlamento a Bruxelles e ha inviato un gruppo di
gendarmi anche a Strasburgo.
Hanno ricevuto
l'autorizzazione delle autorità francesi e hanno prima fatto visita in alcuni
uffici, controllato i computer utilizzati dalla "Rete Panzeri" e poi hanno posto
i sigilli.
In particolare alla
stanza di Cozzolino e del suo collaboratore e in quella dell'assistente di
Alessandra Moretti. Sono stati sigillati gli uffici di una funzionaria del
Parlamento, la responsabile di unità della sottocommissione Diritti umani,
Mychelle Rieu. Il passaggio segna un'escalation dell'inchiesta, che irrompe così
nei piani alti della burocrazia. Il tutto, appunto, mentre i socialisti cercano
di mettere riparo all'immagine colpita da uno scandalo senza precedenti. […]
Scandalo
Qatargate. Un pentito (italiano ?) ha iniziato a collaborare con la magistratura
belga.
Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 13 Dicembre 2022
Durante la sessione
plenaria di Strasburgo, gli eurodeputati hanno espresso il desiderio di creare
una commissione parlamentare d'inchiesta per far luce sullo scandalo della
corruzione.
E’ di oltre un
milione e mezzo di euro il totale delle banconote rinvenite e sequestrate dalla
Polizia belga nel corso delle perquisizioni effettuate nelle abitazioni dell’
ex-eurodeputato del Pd-SI Antonio Panzeri e dell’ex vicepresidente (oggi
destituita) dell’EuroParlamento Eva Kaili, entrambi agli arresti per il
Qatargate. Nell’abitazione della Kaili dove l’ eurodeputata greca viveva appunto
anche l’italiano Francesco Giorgi, anche lui agli arresti. Giorgi è stato
assistente parlamentare di Panzeri ed ora lo è dell’europarlamentare Pd Andrea
Cozzolino (non coinvolto nell’inchiesta) che ieri si è visto sigillare l’ufficio
dei suoi collaboratori dalla polizia belga.
E’ stato proprio l
’arresto “in flagranza” del padre della Kaili che ha permesso agli investigatori
di perquisire l’abitazione dell’ormai ex vicepresidente, senza dover rispettare
la sua immunità parlamentare. All’interno dai verbali sono stati riportati ed
elencati i costosi regali dal Qatar ed altri somme di contanti per circa 150
mila euro. Giorgi sicuramente potrebbe avere ancora non poche cose da
raccontare, e molte deve averle raccontate nel suo lungo interrogatorio di
sabato scorso, che hanno costretto il giudice istruttore Michel Classe a
ritardate gli altri interrogatori per raccogliere tutte le sue dichiarazioni.
Il conteggio dei
soldi sequestrati sinora dalla polizia federale comprende anche i 600 mila euro
in contanti trovati nella valigia che il padre di Kaili aveva con sé mentre
stava lasciando insieme a sua moglie l’hotel Sofitel di Bruxelles di Bruxelles.
Probabilmente deve essere stata avvisato in anticipo dell’operazione della
polizia e c’è chi sospetta che potrebbe essere stato lo stesso Giorgi che aveva
saputo qualcosa. Probabilmente una sua telefonata (era intercettato) ha condotto
gli agenti ad appostarsi davanti all’hotel per sorprendere il signor Kaili che
tentava la fuga.
Martedì, l’avvocato
della signora Kaili ha dichiarato di non aver ricevuto tangenti dal Qatar: “La
sua posizione è che è innocente. Non ha nulla a che fare con le tangenti del
Qatar”, ha detto l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos al canale privato
greco Open TV. L’avvocato, però, ha assicurato ai nostri colleghi di non sapere
se il denaro fosse stato effettivamente ritrovato presso il suo assistito e
nelle mani del padre, venuto a trovarlo in Belgio.
Al centro dell’
interrogatorio sicuramente chiarimenti sul movimento di soldi che dalla Ong
Fight Immunity di Panzeri potrebbero essere arrivati alla Kaili e ad altre
persone, ma anche anche il ruolo della Ong fondata nel 2019 da Panzeri, e le sue
attività all’indomani che non era rientrato come deputato nel Parlamento
Europeo. L’inchiesta ha una “tranche” che arriva in Italia, dove in provincia di
Bergamo si trovano ai domiciliari la moglie e la figlia di Panzeri, (che fa
l’avvocato) ed a Milano dove è stata perquisita l’abitazione di Giorgi. Quindi
due distinte Procure competenti in Italia.
Giorgi
immediatamente dopo l’arresto di venerdì scorso quando è finito in carcere è
stato un fiume in piena ed ha parlato per ore, e le sue dichiarazioni stanno
contribuendo ad aprire una voragine che consentirebbe agli investigatori belgi
di ampliare le indagini o, comunque allo stato attuale trovare riscontri
fondamentali su quanto hanno scovato dopo mesi di indagini segretissime avviate
nella scorsa estate e conclusesi per ora nel blitz di venerdì scorso .
Al momento sono
stati perquisiti 19 abitazioni e 10 uffici parlamentari a Bruxelles. I controlli
hanno riguardato anche gli europarlamentari belgi Marc Tarabella e Maria Arena.
Lo scandalo “QuatarGate” ha interessato degli appartenenti al gruppo dei
Socialisti e Semocratici, dove nonostante al momento non siano indagati si
sono autosospesi anche i deputati Andrea Cozzolino e Pietro Bartolo. L’
eurodeputata greca Eva Kaili, è stata trasferita nelle scorse ore nel carcere di
Haren, alla periferia nord-orientale di Bruxelles, nelle vicinanze
dall’aeroporto internazionale di Zaventem, che è stato completato nei mesi
scorsi ed è stato costruito per alleggerire il peso agli altri carceri della
città, in particolare quello di St. Gilles e quello di Forest.
Il Parlamento
europeo oggi ha revocato la carica di Vicepresidente all’europarlamentare
greca Eva Kaili, approvando la destituzione dalla carica di vicepresidente del
Pe dell’eurodeputata L’aula ha votato sì con la maggioranza di oltre due terzi
(625 voti), come previsto dal Parlamento. Il nome del l’eurodeputato
socialista Marc Tarabella è stato tra quelli emersi nei primi interrogatori alle
quattro persone fermate per il Qatargate. Secondo il quotidiano belga L’Echo,
che cita fonti ben informate, il suo nome “è stato fatto da due persone, tra cui
uno dei quattro imputati, durante gli interrogatori effettuati dall’Ufficio
Centrale per la repressione della corruzione“, scrive il quotidiano.
L’eurodeputato belga non risulta indagato e tra l’altro dell’immunità
parlamentare, che viene rimossa solo in caso di flagranza di reato. Contattato
dalla stampa belga, Tarabella ha dichiarato di “non avere assolutamente nulla da
nascondere”.
Ora dopo ora si sta
facendo delicata ed imbarazzante (dal punto di vista politico) dell’
eurodeputato greco Margheritis Schinas, commissario ed attuale vice di Ursula
von der Leyen. L’uomo politico, esponente del partito di centrodestra Nea
Demokratia ha più volte esternato pubblicamente non pochi elogi al Qatar,
esaltandone “i progressi in materia di diritti del lavoro e gli sforzi per
garantire l’inclusione e la tolleranza”. È stata Manon Aubry la capogruppo
socialista a denunciare pubblicamente l’ atteggiamento morbido manifestato
da Schinas verso gli emiri del Golfo usando parole molto morbide ed in linea a
quelle pronunciate da Eva Kaili. Ieri in conferenza stampa la von der Leyen si è
rifiutata di rispondere a domande riguardanti il suo vice. Schinas dal canto suo
ha detto : “Dal Qatar ho ricevuto solo un pallone e una scatola di cioccolatini
. Dopo 32 anni di politica la mia carriera è limpida“. Dicono tutti
così…Redazione CdG 1947
Manon Aubry: «Il
Qatargate è solo all’inizio, spunteranno altri nomi di corrotti in Parlamento».
Parla la leader della sinistra che pubblicamente aveva avanzato dubbi su
possibili infiltrazioni straniere. E da mesi vedeva bloccate le sue risoluzioni
di denuncia sulle violazioni di diritti umani in Qatar. Federica Bianchi su
L’Espresso il 13 Dicembre 2022.
Manon Aubry è
l'eurodeputata francese, leader del gruppo di estrema sinistra “The Left", che
per mesi ha cercato di portare in Parlamento una risoluzione di condanna della
violazione dei diritti dell’uomo da parte del Qatar: durante i lavori di
costruzione delle infrastrutture dei mondiali sono morti migliaia di
lavoratori, secondo una denuncia del Guardian. Ma Aubry si è vista a ogni
sessione bloccare nella sua risoluzione e nei suoi emendamenti dai deputati
socialisti e dai popolari al punto da dire pubblicamente «Sono venduti!» in
tempi non sospetti, adesso non ha dubbi: «Questa è solo la punta dell'iceberg».
E poi aggiunge al telefono. «Andremo avanti a vedere cosa c'è sotto l'iceberg».
La sua certezza è
che nei prossimi giorni verranno alla luce i nomi di altre persone coinvolte
nello scandalo che ha visto un gruppo di parlamentari e assistenti socialisti
oltre a membri di ong legati all'ex eurodeputato Panzeri vendere il proprio
sostegno alla propaganda del Qatar, colpevole di gravi abusi dei diritti umani
durante l'organizzazione del Mondiale di calcio, in cambio di ingenti somme di
denaro. L'11 dicembre ha pubblicato su Twitter un lungo post riepilogativo di
come ha vissuto le influenze del Qatar fin dall'inizio, con tanto di voti degli
europarlamentari sui suoi emendamenti contro il Qatar.
«Era da tempo che
avevo dei chiari sospetti nei confronti dei socialisti e del Ppe perché si
opponevano con una durezza che non avevo mai visto prima a ogni risoluzione
contro il Qatar, usando spesso le stessi tesi dell'ambasciata qatarina», ha
spiegato al telefono da Strasburgo: «Ho visto in prima persona all'opera i
contatti di influenza del Qatar e la maniera in cui socialisti e popolari hanno
difeso gli interessi del Qatar, usando un linguaggio che non condanna mai la
violazione dei diritti dell'uomo e che invece esalta dei presunti miglioramenti
fatti dal Qatar ma di cui non esiste prova, e che sottolinea l’importanza delle
relazioni energetiche tra Europa e Qatar».
Lo ha fatto in tempi
non sospetti…
«Il mese scorso nel
video in cui denunciavo una situazione che non tornava mi sono infatti chiesta
se il Qatar non avesse infiltrato il Parlamento».
Si aspettava
l'estensione della rete qatarina?
«Che fosse stata
addirittura costituita una banda a delinquere con il coinvolgimento della
vicepresidente no. Oltre i miei peggiori sospetti».
Per il momento le
indagini sono concentrate in campo socialista: si aspetta un allargamento ad
altri gruppi?
«Mi aspetto che sia
coinvolto il Ppe sulla base delle votazioni fatte in aula sul Qatar. D'altronde
il vice presidente greco della Commissione europea Margaritis Schinas da mesi
porta avanti la promozione del Qatar e dunque non è scorretto oggi nutrire
sospetti».
E in Parlamento?
«Usciranno altri
nomi, ma a causa dell'immunità parlamentare non sarà facile procedere se non
sono colti in flagrante come nel caso di Eva Kaili. Adesso tutti stanno attenti
però. Non escludo che prima o poi le autorità chiederanno al Parlamento di
toglierla su qualche deputato e noi lo faremo».
Altri stati
potrebbero essere coinvolti in questa compravendita delle influenze esterne?
«A fare lobbying
pesante oltre al Qatar finora sono stati il Marocco e la Russia, ma non ho
prove».
Cosa dovrebbe
cambiare in futuro perché queste situazioni non si ripetano?
«Ovviamente dobbiamo
cambiare le regole. Esiste già un registro della trasparenza in Parlamento ma
non è obbligatorio registrare i propri contati, né per i parlamentari, né per i
lobbisti (ndr: Fight impunity non era registrata). Le regole esistenti non sono
applicate perché manca un'Authority che monitori e possa applicare sanzioni. È
dall'inizio del mandato che chiediamo un'autorità indipendente che abbia i mezzi
per investigare, la Commissione l'aveva appoggiata ma fino ad oggi non se ne è
fatto nulla. Adesso è diventata una necessità. Dobbiamo uscirne dicendo che
giammai i Paesi terzi compreranno i nostri Mep come fossero squadre di calcio.
Le regole dovranno essere molto rigide perché al democrazia non è in vendita».
Lo scandalo.
Perché Eva Kaili è stata arrestata e cosa è il Qatargate.
Salvatore Curreri su
Il Riformista il 13 Dicembre 2022
Lo scandalo che ha
colpito il Parlamento europeo, con l’arresto in flagranza di reato della sua
vicepresidente socialista Eva Kaili, pone – tra gli altri – il problema della
perseguibilità in sede giudiziaria delle opinioni da questa espresse in difesa
del Qatar dalle accuse di violazione dei diritti fondamentali della
persona, specie dei lavoratori che sono stati impegnati nella costruzione degli
stadi.
In altri termini,
può un giudice incriminare la deputata europea sulla base dell’ipotesi di accusa
che le parole da lei espresse siano frutto di corruzione? Oppure quelle opinioni
da lei espresse sono coperte dalla prerogativa parlamentare
della insindacabilità, in base a cui ogni parlamentare non può essere chiamato a
rispondere in nessuna sede, penale inclusa, delle opinioni espresse
nell’esercizio delle sue funzioni, cosicché sia sempre tutelata la sua libertà
di parola e, con essa, l’autonomia del Parlamento cui appartiene da
indebite interferenze giudiziarie?
Si tratta di una
questione, com’è evidente, che induce a riflettere, sotto un punto di vista del
tutto particolare, sul tema della rappresentanza politica del parlamentare e del
suo rapporto con la rappresentanza di interessi. Questione peraltro non nuova,
se è vero che già il 31 gennaio 1893 la Camera dei deputati concesse
l’autorizzazione a procedere contro il deputato De Zerbi, imputato di peculato,
corruzione millantato credito per avere ricevuto somme offerte in cambio della
sua interferenza nell’iter di approvazione di un disegno di legge che ad una
banca interessava vedere approvato. Il tema si è riproposto nelle Camere
repubblicane, dove si è registrato nel tempo un significativo mutamento
d’indirizzo.
Inizialmente,
infatti, la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, chiamata a
pronunciarsi sull’accettazione di una promessa di denaro per presentare e
sostenere due disegni di legge da parte di un deputato per questo accusato di
corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, ritenne che l’attività
parlamentare fosse sempre oggettivamente insindacabile, a prescindere dagli
intenti soggettivi, e coprisse anche quella antecedente rispetto ad essa
inscindibilmente collegata e strumentale. Se così non fosse, concluse allora la
Giunta, il giudice potrebbe sindacare l’attività politica del parlamentare, e
precisamente il processo di formazione della sua volontà, vanificando in tal
modo la prerogativa dell’insindacabilità nelle sue motivazioni. In questo modo,
quindi, si volle evitare un controllo esterno sulla volontà del deputato, a
costo però di rendere possibile il mercimonio dell’attività parlamentare.
Per evitare però
tale indesiderato epilogo, l’indirizzo della Giunta per le autorizzazioni a
procedere della Camera mutò in seguito radicalmente. Nel 1972 la Giunta ritenne
che la prerogativa della insindacabilità non poteva essere sempre e comunque
astrattamente e intrinsecamente data per scontata; piuttosto occorreva
verificarla nei fatti, onde escludere che essa potesse estendersi
all’accettazione di denaro o di altri beni materiali o alla loro relativa
promessa in grado di interferire e/o condizionare il compimento di un atto
tipicamente parlamentare. La stessa Corte costituzionale, nella sua sentenza n.
81/1975 del 27 marzo, ha collegato la irresponsabilità dei parlamentari al “fine
di rendere pienamente libere le discussioni che si svolgono nelle Camere, per il
soddisfacimento del superiore interesse pubblico connessovi”. È in vista di
questo fine che “siffatte eccezionali deroghe all’attuazione della funzione
giurisdizionale, considerate necessarie a salvaguardia dell’esercizio delle
funzioni sovrane spettanti al Parlamento, risultano legittime in quanto sancite
dalla Costituzione”.
La prerogativa
dell’insindacabilità è dunque funzionalmente connessa alla rappresentanza
“nazionale” del singolo parlamentare, chiamato ad esercitare le sue
funzioni “senza vincolo di mandato”. Pertanto essa non può coprire quanto non
strumentalmente funzionale al corretto esercizio del mandato parlamentare ed al
corretto funzionamento dell’istituzione parlamentare nel suo complesso. Ciò
giustifica quindi l’applicazione anche al parlamentare del reato di “corruzione
per l’esercizio della funzione”, previsto dall’art. 318 c.p., come riformato
dalla legge n. 190/2012 (c.d. Severino), che punisce con la reclusione da tre a
otto anni “il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità
o ne accetta la promessa”. Tale reato fu applicato nei confronti dell’ex
deputato dell’Udc Luca Volonté, accusato di aver ricevuto da politici azeri una
tangente di 2 milioni e 390 mila euro per orientare il proprio voto come membro
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.
In quell’occasione,
infatti, la Cassazione (sentenza n. 36769/2017) accolse il ricorso del pubblico
ministero contro la decisione del giudice per l’udienza preliminare di non
procedere nei confronti del suddetto deputato perché riteneva insindacabili le
sue attività. Per la Cassazione, infatti, la garanzia della insindacabilità a
tutela dell’autodeterminazione del singolo parlamentare ne copre gli atti purché
connessi alla funzione parlamentare. Altrimenti prevale la “grande regola”
dello stato di diritto e la parola deve passare alla giurisdizione. L’utilità
percepita, infatti, va qualificata “indebita” quando l’attività parlamentare,
che per sua natura tende alla costante composizione di interessi di parte, viene
condizionata da interessi estranei alla sua natura politica.
Per questo,
nell’ambito dell’attività politico-parlamentare “non può ritenersi rientrare la
ricezione di utilità, anche estremamente rilevante, come ad esempio cospicue
somme di denaro a titolo personale”. In conclusione, quanto dalle ipotesi di
reato si presume sia accaduto nel Parlamento europeo ci richiama ancora una
volta in modo esigente alla nobiltà della funzione parlamentare, marcando il
confine oltre cui si è fuori dai compiti di rappresentanza e anche
di “compromesso” politico e si entra nella logica di uno sfruttamento privato
dell’altissimo ufficio ricoperto. Salvatore Curreri
Documenti
sospetti. A Bruxelles, il Qatar cercava soprattutto l’esenzione dei visti per
entrare in Europa.
Vincenzo Genovese su
L’Inkiesta il 14 Dicembre 2022
Nell’inchiesta sulla
corruzione all’Europarlamento, il dossier più importante riguarda una questione
piuttosto tecnica ma molto significativa, che tocca le persone con passaporto
del Paese mediorientale
La difesa del
Qatar come «Paese all’avanguardia nei diritti dei lavoratori» pronunciata da Eva
Kaili, ex vice-presidente del Parlamento europeo ora arrestata per presunta
corruzione e destituita dalla carica, sembra il prodotto più esplicito
dell’influenza indebita sui processi della democrazia comunitaria di cui è
accusato lo Stato mediorientale. Ma non è il più significativo.
Il dibattito in cui
questo intervento si inserisce ha generato una risoluzione non legislativa sulla
situazione dei diritti umani in Qatar: uno dei tanti «messaggi politici», dalla
discutibile efficacia, che l’Eurocamera manda al resto del mondo durante le sue
sessioni plenarie.
Il file della
discordia
Al governo di Doha
interessava probabilmente di più un’altra procedura, quella riguardante la
liberalizzazione dei visti per i propri connazionali.
Si tratta di una
questione piuttosto tecnica, ma molto significativa. Ad aprile 2022 la
Commissione europea propose un’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini
di Qatar e Kuwait, subordinata a determinate condizioni che i due Paesi
avrebbero dovuto soddisfare.
Trattandosi della
modifica di un regolamento europeo, quello sui visti, il processo legislativo
prevede che Parlamento e Consiglio adottino ognuno una propria posizione sul
tema, prima di negoziarla tra loro.
«Onestamente mi
sarei sorpreso se il Qatar non avesse cercato di influenzare questa decisione»,
dice a Linkiesta l’eurodeputato tedesco dei Verdi/Ale Erik Marquardt, relatore
del file nella commissione parlamentare Libe (Libertà civili, giustizia e affari
interni).
A decidere se la
pressione esercitata rientra nella normale attività di lobbying che esercitano i
funzionari dei Paesi stranieri o se è sfociata nella corruzione sarà
un’inchiesta della magistratura belga ancora in corso, che al momento conta
quattro persone in carcere e circa un milione di euro di contanti sequestrati.
Di certo Marquardt
sottolinea un interesse molto sospetto da parte di Eva Kaili, che nemmeno fa
parte della commissione Libe, ma come sostituta ha partecipato alla votazione
finale sul testo. «Mi ha chiamato più volte, spingendo per accelerare il
processo. A un certo punto ha proposto di procedere con il Qatar senza il
Kuwait, perché in quel Paese la situazione era più problematica».
La relazione si vota
in commissione Libe il primo dicembre e il risultato è una relazione che propone
l’esenzione dal visto per i cittadini di Qatar e Kuwait, Ecuador e Oman,
approvata con quarantadue pareri favorevoli e sedici contrari. Scorrendo la
lista di voto, si nota un appoggio trasversale: Partito popolare europeo,
Socialisti e democratici, Verdi/Ale e persino Conservatori e riformisti europei.
Votano contro solo
Renew Europe, il gruppo della Sinistra e gli esponenti di Identità e democrazia,
oltre a un non iscritto. La posizione favorevole dei Verdi è spiegata a
Linkiesta da Marquardt: «Un accordo sull’esenzione dei visti rappresenta una
leva politica, perché se si inseriscono determinate clausole lo si può
sospendere in caso di arretramenti democratici del Paese in questione. Ad
esempio l’accordo con il Kuwait prevedeva una moratoria sull’applicazione della
pena di morte».
Potrebbero essere le
stesse motivazioni del gruppo S&D, il cui comportamento è ora sotto esame perché
è quello più toccato dallo scandalo: tra gli arrestati ci sono una sua
componente (Eva Kaili), un suo ex deputato (Pier Antonio Panzeri) e un
assistente parlamentare alle sue dipendenze (Francesco Giorgi).
In questi casi è il
«relatore ombra» di ogni gruppo politico a lavorare sul dossier e a dare poi
l’indicazione di voto ai propri colleghi. Sul file in questione, per i
Socialisti e democratici, il ruolo era ricoperto da Pietro Bartolo, che al
momento non intende parlare con la stampa. L’eurodeputato siciliano, conferma la
direzione di S&D, si è dimesso dal ruolo dopo gli arresti che hanno dato il via
al cosiddetto Qatargate.
Che tra le sue
conseguenze politiche annovera anche il rinvio in commissione Libe del dossier
sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini qatarioti. Avrebbe dovuto
essere votato in questa sessione plenaria dall’aula di Strasburgo, che vista la
situazione ha invece deciso di rimandarla indietro per «approfondire la
discussione».
Relazioni con il
Qatar
Come dice a
Linkiesta una fonte parlamentare a Strasburgo, «la tensione si taglia con il
coltello», ed è opinione diffusa che altri eurodeputati appartengano alle rete
su cui la polizia belga sta indagando per «corruzione, riciclaggio di denaro e
partecipazione a un’organizzazione criminale».
Qualcuno lo ha detto
in modo esplicito, come l’eurodeputato finlandese Petri Sarvamaa, in
un’intervista a Euronews: «Dobbiamo cercare ogni singolo deputato che c’entra
qualcosa con quello che sta succedendo. Purtroppo sono sicuro che non è finita:
ci saranno altri casi».
Osservati speciali,
secondo la fonte consultata da Linkiesta, sarebbero i tredici deputati che
appartengono al «Gruppo di amicizia con il Qatar», appena sospeso dal suo
presidente, il liberale spagnolo José Ramón Bauzá Díaz.
Ne fanno parte, tra
gli altri, gli italiani Dino Giarrusso, Luisa Regimenti e Fulvio Martusciello.
Quest’ultimo ha presentato nel giugno 2021 un’interrogazione parlamentare per
denunciare «i tentativi degli Emirati arabi uniti di manipolare le
organizzazioni di giornalisti per boicottare la Coppa del Mondo in Qatar».
Ovviamente si tratta
di una posizione legittima come, fino a prova contraria, tutte le altre espresse
in favore dello Stato mediorientale dai rappresentanti del Parlamento. Ma oggi
chiunque ha intrattenuto buoni rapporti con il governo qatariota è guardato con
sospetto all’interno del Parlamento.
Le minacce via
mail dell’ assistente dell’ Europarlamentare del PD Alessandra Moretti al nostro
giornale.
Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 12 Dicembre 2022
Sono almeno altri
quattro italiani, pur non essendo indagati, finiti tra le maglie dell'inchiesta
ritrovandosi il posto di lavoro inaccessibile e subendo il sequestro di computer
e smartphone.
Ondate di fango
mediatico sulla politica italiana nello scandalo del Quatar che ha visto
coinvolto l’ex-eurodeputato Panzieri ed una serie di lobbisti sotto mentite
spoglie di politici, lobbisti e partaborse. I media ed i magistrati belgi ormai
parlano di una “Italian Connection” presente nell’inchiesta sul “Qatargate“. E
lo fanno dalla scorsa settimana quando la Polizia Federale belga è entrata negli
edifici del Parlamento europeo per mettere i sigilli agli uffici di una serie di
collaboratori e assistenti, tutti “rigorosamente” italiani. Un lungo corridoio
di stanze nel gruppo Socialisti & Democratici sigillate e chiuse a doppia
mandata su disposizione della magistratura belga. il giudice Michel Claise ha
confermato ieri gli arresti per Antonio Panzeri, Eva Kaili, Niccolò
Figà-Talamanca e Francesco Giorgi. La procura ha perquisito la casa
dell’eurodeputato socialista Marc Tarabella, che oggi dovrà fornire le sue
spiegazioni alla commissione di vigilanza del Partito Socialista belga.
Inizialmente
c’era Francesco Giorgi, fermato prima e confermato ieri agli arresti, attuale
assistente dell’eurodeputato Andrea Cozzolino, e fidanzato dell’eurodeputata
greca Eva Kaili nella cui abitazione sono stati trovati borsoni pieni di
centinaia di migliaia di euro in contanti . La procura belga ha deciso di
avviare una sorta di pesca a strascico per scovare e raccogliendo quante più
prove possibile. In queste ore il Partito Democratico ha annunciato di aver
“disposto la sospensione cautelare di Giorgi con effetto immediato“. Nato ad
Abbiategrasso si segnala appena ventenne come “attivista” dei Democratici di
Sinistra, all’epilogo del loro percorso, prima di spiccare il volo con una
laurea in Scienze Politiche ottenuta alla Statale di Milano.
Giorgi si faceva fa
notare nel centrosinistra lombardo ma la sua ambizione superava i confini
regionali puntando all’Europa, destinazione Bruxelles. Collabora con il
Parlamento Europeo e intreccia la sua carriera con quella di Antonio Panzeri di
cui diventa assistente. Un legame che ha portato entrambi agli arresti con
l’accusa di aver ricevuto laute mazzette dal Qatar per ripulire l’immagine del
paese ospitante i mondiali di calcio 2022.
Al momento
dell’arresto Giorgi lavora però per un altro europarlamentare Pd, Andrea
Cozzolino, (che come la Moretti non è coinvolto nell’indagine), come consulente
per i i rapporti dell’Ue con i Paesi del Maghreb (Marocco, Tunisia,
Algeria). Cozzolino, si è dichiarato sopreso per l’arresto del suo assistente,
sostenendo che lo avrebbe scelto perché già lo conosceva come esperto dei Paesi
nordafricani al Parlamento Europeo, nella sua attività precedente. Nessun
“contatto” sospetto quindi fra Cozzolino e Panzeri.
Sono almeno altri
quattro italiani, pur non essendo indagati, finiti tra le maglie dell’inchiesta
ritrovandosi il posto di lavoro inaccessibile e subendo il sequestro di computer
e smartphone.
I sigilli sono stati
così posti all’ufficio di Federica Garbagnati, in passato lavorava all’
Europarlamento con Panzieri, intorno al quale ruota una vera e propria rete di
collocamento e alle conoscenze dell’ex europarlamentare del Pd, passato
ad Articolo Uno, che ieri lo ha sospeso. La Garbagnati che è attualmente
assistente dell’eurodeputata Alessandra Moretti ieri pomeriggio utilizzando un
account di posta di tale “Matteo Cavallo” alle h. 17:04, ci scriveva
testualmente:
“Mi chiamo Francesca
Garbagnati e ho appena notato che un vostro impreciso articolo mi ha appena
definita INDAGATA nell’inchiesta che vede al centro l’ex eurodeputato Pier
Antonio Panzeri. Essendo ciò assolutamente falso, vi chiedo di provvedere a
cancellare immediatamente il mio nome da ogni vostro articolo dal momento
che non sono indagata, non sono una personalità pubblica e che il mio nome non è
essenziale nella descrizione della cronaca. Provvederò immediatamente a sporgere
querela nei confronti del vostro giornale e del vostro giornalista.Mi auguro
correggiate immediatamente il vostro errore. Cordialmente, Francesca
Garbagnati”
Non avendo timore
delle minacce di querela ricevute, nella consapevolezza di aver pubblicato la
verità. le abbiamo così risposto:
Dopodichè la
Garbagnati si è affrettata a far sparire da Internet e dai socialnetwork tutti i
suoi profili (ha dimenticato Facebook….) e le sue foto, e persino qualche
piccola pseudo-intervista dove raccontava la sua esperienza lavorativa all’
Europarlamento . Un comportamento singolare e sicuramente poco “trasparente”,
che si è allineato con le bugie dalle gambe corte della Moretti, come quelle
dichiarate al sito Affari Italiani che sabato scorso scriveva: “in mezzo a tanti
nomi, qualcuno ha tirato fuori anche quello di un assistente parlamentare
dell’eurodeputata Pd Alessandra Moretti. Ma l’assistente, che non risulta essere
indagata, sarebbe coinvolta nell’inchiesta in quanto ex assistente
di Panzeri (così come gli altri suoi ex colleghi). Dato il clamore della
notizia è facile che il “fango” finisca un po’ dovunque, anche se alcune voci
raccontano addirittura di uffici sigillati e telefoni sequestrati.” Sentita
sempre da Affaritaliani, la Moretti ha smentito “che la sua assistente sia stata
interrogata” (circostanza che nessuno, tantomeno il nostro giornale ha mai
scritto !).
Peccato che oggi
sempre la Moretti, parlando con l’ ADN-Kronos , ha ammesso che la sua
assistente Francesca Garbagnati, “ha subito una perquisizione ma non è stata
interrogata”. Probabilmente la Moretti non ha molta esperienza di indagini di
polizia giudiziaria.
Dopo aver chiamato
inutilmente per tutta la mattinata la segreteria dell’ on. Moretti all’
Europarlamento (che conta ben 7 addetti tutti stipendiati con denaro “pubblico”
) dove non rispondeva nessuno, siamo riusciti nel primo pomeriggio a contattarla
via Whatsapp. La Moretti ci ha rilasciato questa dichiarazione “Tutti gli ex
collaboratori di Panzeri hanno subito i sigilli dei propri uffici. Massima
collaborazione con la magistratura su questa vicenda che ci lascia sgomenti”, di
fatto confermando quello che il CORRIERE DEL GIORNO ed il FATTO
QUOTIDIANO avevano rivelato per primi così di fatto smentendo la sua
assistente che ci minaccia legalmente via mail attraverso il suo “cavaliere
bianco” Matteo Cavallo, minaccia che si è trasformata in una denuncia penale per
“tentata estorsione” che il nostro avvocato sta già preparando. Altro che le
querele preannunciate dalla Moretti contro chiunque “pubblichi o diffonda
notizie false e tendenziose o che puntino a minare la propria onorabilità” !
L’ assistente della
Moretti non è l’unica “portaborse” a ritrovarsi senza un ufficio. Sigilli sono
stati apposti anche anche all’ufficio di Giuseppe Meroni, esponente di Articolo
Uno, anche lui con un passato da assistente di Panzeri e attualmente alle
dipendenze dell’ eurodeputata Lara Comi (Forza Italia) che nonostante la
distanza politica hanno sempre avuto una amicizia generata dalla passione comune
per il calcio. La Comi tifosa del Milan e Panzeri dell’Inter, partecipavano
spesso e volentieri in Lombardia a trasmissioni tv dedicate al derby della
Madonnina.
Sigilli sono stati
posti anche all’ufficio di Donatella Rostagno, altra ex collaboratrice
di Panzeri ritenuta un esperta di Medio Oriente e mondo arabo, attualmente alle
dipendenze dell’europarlamentare belga Maria Arena che era componente del Board
dell’Ong Fight Impunity, fondata nel 2019 dall’ex eurodeputato S&D Panzieri.
Il quarto ed ultimo
assistente parlamentare europeo coinvolto è Davide Zoggia, un ex deputato
considerato “vicino” agli amici di Pierluigi Bersani, con un passato di
amministratore pubblico come ex sindaco di Jesolo e presidente della provincia
di Venezia, al quale gli investigatori belgi hanno sequestrato il suo
cellulare. Zoggia è il responsabile degli Enti Locali del PD durante la
“segreteria” Bersani, diventando il capo dell’ organizzazione del partito
con Guglielmo Epifani. Attualmente fa parte dello staff di Pietro
Bartolo e Brando Benifei (nessuno dei due è sotto indagine).
“I Mondiali al Qatar
sono un insulto all’etica, bisogna ritirare l’assegnazione”. E ancora, con una
punta di sarcasmo: “Platini, i parenti di 1.200 operai morti nei cantieri per la
costruzione degli stadi si scusano per aver rovinato i Mondiali“. Poi, a un
certo punto, la posizione è cambiata. Ed allora il boicottaggio si è trasformato
in “un gesto ipocrita” e “chi abbandona i maxi-schermi è un idiota perché la
Coppa del mondo è una festa che bisogna vivere insieme” aggiungendo che in Qatar
i lavoratori “hanno un salario minimo, che viene versato sul loro conto
corrente» e all’interno delle aziende c’è persino «una concertazione sindacale».
Per questo gli altri Paesi del Golfo dovrebbero seguire il modello-Qatar”.
Le prime
dichiarazioni che avete letto sono di Marc Tarabella, eurodeputato belga di
origini italiane con alle spalle quattro mandati al Parlamento Ue. Le ultime
anche. E questa giravolta è tra i motivi che hanno spinto sabato sera gli
investigatori belgi a perquisire la casa del politico socialista folgorato sulla
via di Doha. E’ durata un paio d’anni, dal 2014 fino al gennaio del 2016 la sua
campagna politico-mediatica per annullare l’assegnazione dei campionati di
calcio al Qatar . Interventi in Parlamento, dichiarazioni sui media,
manifestazioni. Poi all’improvviso un lungo silenzio, interrotto a partire dallo
scorso anno, quando la linea dell’esponente socialista ha preso tutt’altra
direzione. Tarabella ha continuato a occuparsi di Qatar, ma questa volta con
toni e dichiarazioni molto più istituzionali. Che coincidenza…
Tarabella è nato in
Belgio nel 1963, figlio di un emigrante italiano originario di Seravezza
(Lucca), dal 1994 è sindaco di Anthisnes , un comune di 4000 abitanti alle porte
di Liegi. Parla perfettamente italiano ed è considerato molto vicino a Panzeri,
al punto tale che un anno fa ha preso la tessera di Articolo Uno.
Le mazzette e le
risultanze investigative che usciranno dai telefoni e computer sequestrati
potrebbero portino altrove: per il governo del Qatar il ruolo dell’ ormai
ex-vicepresidente del Parlamento Europeo, la greca Eva Kaili era un “”badge”
strategico per accedere alle porte dell’istituzione europea. La parlamentare
greca è stata recentemente fotografata ad Abu Dhabi in un weekend con il suo
connazionale, il vice presidente della Commissione, Margaritis Schinas,
esponente del Ppe che guarda caso in un tweet dello scorso 20 novembre aveva
elogiato il mondiale del Qatar, definendolo un “paese che ha attuato riforme e
che merita questo successo mondiale“.
Ecco perché, al
momento, l’indagine belga è soltanto al primo livello. La Polizia ha
voluto accelerare con le perquisizioni temendo che, con la fine del Mondiale, e
lo stop ai lavori del Parlamento Europeo per la pausa natalizia, molto (cioè le
valige di denaro) potesse scomparire. E probabilmente non hanno torto.
Redazione CdG 1947
Le bugie delle
mazzette contro le inchieste libere.
Cristiana Flaminio
su L’Identità il 13 Dicembre 2022
Autocitarsi non è
bello. Ma la cronaca ci costringe a farlo. Per un motivo molto semplice: forse,
ma forse, abbiamo capito perché, mentre tutto il mondo urlava allo scandalo,
c’era qualcuno in Italia e in Europa che tentava di far passare il Qatar come un
Paese proiettato verso le magnifiche sorti e progressive della libertà e della
democrazia. Qualcuno, come la vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili,
addirittura cercava di fare di Doha una sorta di enclave dei diritti del lavoro
(sic!) nel Medio Oriente.
L’Identità ha già
dato, ai suoi lettori, conto e ragione dei dubbi, troppi, che gravavano su certe
ricostruzioni della way of life, o sarebbe meglio dire della way of business,
del Paese del Golfo. Abbiamo scritto, riprendendo inchieste giornalistiche
internazionali e atti del Parlamento europeo stesso, che gli stadi, quelle
meravigliose e autentiche cattedrali nel deserto allestite a tempo di record tra
le dune, grondavano il sangue di migliaia e migliaia di lavoratori migranti, di
stranieri, provenienti dai Paesi più poveri dell’Asia, con il miraggio di
guadagnare un tozzo di pane. Troppi ne sono morti. Ancora di più sono stati
trattati, secondo quanto emerso dai report delle associazioni internazionali e
degli osservatori internazionali, come dei veri e propri schiavi moderni.
Eppure, c’era chi
continuava a predicare calma. A intravedere chissà che gloriose innovazioni che
sarebbero presto arrivate dal Paese qatarino. C’era chi, solitamente
ipersensibile ai diritti, ha fatto orecchie da mercante sulle tante, troppe,
aporie e vere e proprie discriminazioni, sociali e non, dei lavoratori e non
solo loro (ricordate, quella “malattia mentale” dell’essere gay?). Il Parlamento
europeo, ora, deve fare chiarezza al suo interno. Spazzare via la corruzione che
si sarebbe verificata tra le stanze dei vertici, non dei semplici peones, del
luogo principe della democrazia comunitaria. Di un’Europa che si picca di averla
inventata la democrazia, di averla insegnata al mondo. E che oggi, invece, fa
ridere, di gusto, tutti gli avversari geopolitici e internazionali. L’offesa
subita dalle istituzioni è gravissima. E va sanata. Senza la retorica di Metsola
che chiama alle armi contro i “nemici della democrazia” che assedierebbero
l’europarlamento. Ma con il coraggio di scacciare i lobbisti (o presunti tali)
dal parlamento come qualcun altro, ben più grande di ogni istituzione umana,
fece coi mercanti nel Tempio.
Lo scandalo
Qatargate.“Premesso che siamo garantisti”, la nuova moda per linciare gli altri.
Iuri Maria Prado su Il Riformista il 13 Dicembre 2022
È la solita storia
del “premesso che”. Premesso che siamo garantisti, quello è un ladro. Premesso
che siamo garantisti, è una vergogna. Premesso che siamo garantisti, è evidente
che quella è una famiglia di farabutti. Premesso che siamo garantisti, insomma,
garantiamoci il diritto di fare a pezzi un indagato, e la moglie, e la figlia,
arrestate non si sa in base a quali imprescindibili esigenze cautelari, perché
d’accordo che la giustizia deve fare il suo corso ma intanto ci pensiamo noi.
Per il dovere di informare la gente. Per la difesa dell’onestà. Per la
democrazia.
E come Soumahoro va
strattonato tanto più fortemente perché faceva le mostre di difendere i deboli
mentre la moglie si faceva il guardaroba di lusso alle loro spalle,
così Panzeri, l’ex deputato del Pd, l’ex sindacalista, va castigato a reti
unificate e a prime pagine scandalizzate perché il suo profilo progressista
nascondeva in realtà le chat sulle vacanze da centomila euro. Con lo strepito
misurato non sulla ipotetica provenienza illecita dei soldi destinati a quel
lusso, che ancora ancora ci potrebbe stare, ma sulla intrinseca portata
oltraggiosa di tanta spesa. La settimanella nella pensioncina in riviera,
evidentemente, non avrebbe revocato la sua perfetta presentabilità democratica.
Ovviamente la sua
parte politica scaricherà prima del processo, solo sulla base di quel chiasso
mediatico e unicamente sull’onda della retata, questo suo eminente (fino a ieri)
rappresentante, ed è desolante assistere ai gesti vigliacchi di quelli che
rinnegano persino, ora che è finito in disgrazia, di averlo conosciuto
(qualcuno, come Andrea Orlando, è arrivato a rimuovere un proprio messaggio con
il quale si congratulava con Panzeri per non si sa più quale incarico o
iniziativa). Ovviamente non si dice che la notizia dovesse scomparire, o che il
milieu politico e amicale di Panzeri dovesse limitarsi, nell’apprenderla, a fare
spallucce. Ma anche qui, e per l’ennesima volta pur dopo oltre trent’anni di
giustizia giornalistica, il protocollo continua a svilupparsi nel solco
tradizionale della condanna già confezionata: e con quella premessa (“premesso
che siamo garantisti”) chiamata a un ruolo anche più bastardo, cioè a
legittimare i pregiudizi e il verdetto popolar-televisivo che invece dovrebbe
sorvegliare e possibilmente inibire.
Ti sbattiamo in
prima pagina e pubblichiamo le tue chat di famiglia, d’accordo, ma di che cosa
ti lamenti? Non sai che siamo garantisti? La premessa garantista è insomma il
lasciapassare di cui gode ogni nefandezza giustizialista. Il cosiddetto sistema
dell’informazione dovrebbe comportarsi diversamente anche solo in omaggio a una
regola statistica, se non già per un minimo di decenza e rispetto dei diritti
delle persone: e cioè perché troppe volte, troppe, e con il sacrificio della
reputazione, e a volte della vita, di tanti, i presunti scandali avevano di
scandaloso soltanto l’inconsistenza su cui si basavano. Può darsi che questo non
sia il caso, ma tante volte il caso è stato proprio questo. Non basta a
suggerire un po’ di prudenza? E quella premessa farlocca (“premesso che siamo
garantisti”), non dovrebbe supporre il dovere di ascoltare anche, forse prima,
quel che ha da dire a propria difesa l’indagato? O “premesso che siamo
garantisti” significa fare gli equanimi ripetitori dell’accusa? Iuri Maria Prado
Media scatenati
contro "Eurotangentopoli". Caso Qatar, giornalisti scatenati si ‘travaglizzano’
e linciano tutti Panzeri.
Piero Sansonetti su
Il Riformista il 13 Dicembre 2022
Prendevano un nero
(loro dicevano nigger) che immaginavano fosse colpevole di qualcosa di grave,
magari di infame – forse lo era, forse no – lo bastonavano a sangue, gli
sputavano addosso, gli tiravano sacchetti di piscio in faccia, lo ferivano coi
coltelli e con le asce, e poi, mentre agonizzava lo impiccavano a un albero. Si
chiamava linciaggio.
Era frequente negli
stati meridionali degli Stati Uniti. Era una forma primordiale
di giustizia, generalmente esercitata a maggioranza. Nel senso che la
maggioranza o la quasi unanimità della popolazione bianca del borgo, o della
cittadina – ma anche di qualche città più grande – riteneva giusta la condanna e
la punizione. E questo legittimava il linciaggio. Se leggete i giornali
italiani, e scorrete le dichiarazioni dei politici – quelli di ieri e dell’altro
ieri, dico – avete la sensazione netta, quasi visuale del linciaggio. E potete
immaginare il rogo preparato per bruciare vivi i rei. Cioè Antonio Panzeri con
tutta la sua famiglia (anche coi neri, spesso si faceva così: tutta la famiglia
sulla forca), e poi Eva Kaili, la deputata greca, suo padre e qualche altro
funzionario, in genere socialista. Anche in questo caso il linciaggio, che è
scattato pochi minuti dopo la cattura, è giustificato dal consenso dell’opinione
pubblica.
Un altissimo
dirigente del Pd, intervistato, ha detto semplicemente: “Mi fa schifo”. Chi gli
fa schifo? Panzeri? A me no. Considero Panzeri un essere umano come tutti gli
altri esseri umani; perciò non provo schifo per lui ma affetto. Che casomai
cresce, e non decresce, nel momento più difficile della sua vita. Dalle notizie
che leggo (e che sono abituato a non prendere per oro colato) capisco che esiste
la concreta possibilità che abbia commesso un reato. Non so bene quale,
bisognerà indagare e esaminare i codici prima di stabilirlo e prima di gridare
al mostro. Cosa che in genere quasi nessuno fa. Se davvero hanno trovato nella
sua abitazione denaro contante per circa mezzo milione di euro, a occhio
qualcosa non va.
Quantomeno
c’è evasione fiscale, direi. Se poi dalle intercettazioni risulti o no un
rapporto illegale con le autorità del Qatar, e se risulti che questo rapporto
serviva a influenzare il Parlamento europeo sul tema dei diritti umani, o
addirittura a nascondere alcuni orrori commessi dallo Stato del Qatar nei
confronti di cittadini qatarioti o di immigrati, questo credo che ancora non si
possa dire. Ignoro i metodi della polizia e dei magistrati belgi, so che
l’interpretazione delle intercettazioni è sempre una questione molto opinabile,
e che è difficilissimo che dalle intercettazioni esca con chiarezza la
colpevolezza di una persona. Più spesso risulta la sua innocenza, ma in questo
caso di rado vengono adoperate.
Se Antonio
Panzeri risulterà colpevole subirà una condanna penale. Punto. Se risulterà
colpevole risulterà colpevole lui, non il socialismo. Perché l’arresto di
Panzeri ha scatenato, in particolare nella destra, questo riflesso: se Panzeri
trafficava con il Qatar, se Panzeri era esponente di alcune ong per i diritti
umani, se Panzeri era socialista, questo vuol dire che i socialisti e le ong per
i diritti umani sono formazioni di farabutti venduti. Ecco, questa non è
battaglia politica, questa è malafede. Vorrei fare tre osservazioni.
La furia della
destra non solo contro Panzeri e i suoi coimputati ma contro qualunque
organizzazione o esponente di sinistra è davvero impressionante e temibile. Dico
temibile perché travolge ogni regola della lotta politica. E quando le regole
della lotta sono stracciate è difficile tornare indietro. C’è un giornale – non
isolato – che ha messo sullo stesso piano il possibile delitto di Panzeri con
il caso Soumahoro e addirittura con la vicenda di Luca Casarini e della ong
Mediterranea. Possibile che chi scrive queste cose non sappia che Soumahoro non
è presunto innocente ma è del tutto innocente nel senso che nessuno mai lo ha
accusato di niente? Addirittura, quello stesso giornale, ha tirato in ballo la
storia della Mediterranea. Di cosa è accusata? Di aver salvato circa 500
migranti, in condizioni di salute terribili, che da un mese giacevano sul ponte
di una petroliera che li aveva salvati dalla morte e che non riusciva a
riportarli a terra.
Cosa c’entra questo
atto, sicuramente onesto e nobile, con i favori al Qatar? Dice il giornale del
quale vi parlo che però su Casarini c’è un’inchiesta aperta per favoreggiamento
dell’immigrazione (reato folle: come favoreggiamento di soccorso…): vero, va
avanti da due anni questa inchiesta. I termini sono scaduti da tempo ma resta
lì, perché gli inquirenti, evidentemente, non riescono a capire come possano
inventarsi una richiesta di rinvio a giudizio. Mi chiedo fino a quando e dove
(quo usque tandem…) possa arrivare l’amore per la strumentalizzazione politica.
L’idea che lotta delle idee si possa fare solo dopo aver eliminato tutte le idee
e averle sostituite con dei bastoni è terrificante. ma sta prevalendo.
La sinistra deve
smetterla di accettare la subalternità a qualsiasi alito di destra soffi sulla
ribalta. È troppo tempo che fa così. È dal giorno che cadde il muro di Berlino e
la sinistra immaginò che l’errore non fosse stato il bolscevismo e
la dittatura, ma il pensiero socialista, cioè il pensiero politico di gran lunga
più completo, ricco e avanzato della storia dell’umanità. La sinistra si farà
demolire dai suoi sensi di colpa e dalla sua voglia di subalternità
alla destra. È da quando decise che il suo compito fosse quello di dare gruppi
dirigenti alle idee liberiste, è da allora che la sinistra si muove così. Si
muove per non farsi notare, per nascondersi, per negare di essere sinistra. Cosa
c’entra l’eventuale reato di Panzeri con la storia del socialismo? Zero virgola
zero.
Il giornalismo
italiano in questi giorni sembrava interamente nelle mani di Travaglio. Il
forcaiolismo che trasuda dagli editoriali di tutti i giornali, i titoli gridati
ad effetto, la voglia di gogna, di linciaggio, supera le migliori performance
del “Fatto”. È chiaro che su questo piano Grillo e Travaglio hanno stravinto.
Scorrere i giornali della destra, in origine tradizionalmente garantisti, è
stato qualcosa di impressionante. Guardavi le firme e non ci credevi. Sembravano
tutti Scanzi, tutti Travaglio, tutti Grillo, tutti Di Battista. Hanno vinto
loro. Non c’è dubbio, hanno stravinto: hanno in mano l’anima e il cuore del
giornalismo italiano.
Piero Sansonetti.
Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di
cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004
al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per
poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre
2019.
Parla il
difensore di Panzeri. “Panzeri e famiglia già condannati dalla stampa”,
intervista all’avvocato Daniele Colli.
Aldo Torchiaro su Il
Riformista il 14 Dicembre 2022
Il 9 dicembre
2022 Antonio Panzeri viene arrestato a Bruxelles nell’ambito di un’inchiesta
delle autorità inquirenti belghe su casi di corruzione presso il Parlamento
europeo volti a favorire gli interessi qatarioti. Al contempo vengono arrestate
a Bergamo anche sua moglie Maria Colleoni, 67 anni, e la loro figlia Silvia, 38
anni, in base ad un mandato di arresto europeo emesso appunto dall’autorità
giudiziaria belga. Le accuse sono tanto fumose quanto stiracchiate, se allargate
alla cerchia dei famigliari. L’avvocato Daniele Colli rappresenta la famiglia
Panzeri, insieme al collega Angelo De Riso.
Di quali accuse
parliamo?
Non abbiamo ancora
visto gli atti. Sui documenti belgi si parla di un insieme di condotte illecite
che vanno dalla corruzione al riciclaggio con vincolo di associazione per
delinquere. Tutto da provare.
In casa delle sue
assistite la Guardia di Finanza ha trovato 17 mila euro in contante…
È una somma che non
ritengo considerevole per una famiglia benestante.
Come si dichiarano i
suoi assistititi?
La moglie e la
figlia di Panzeri si sono dichiarate innocenti, non a conoscenza delle accuse
rivolte loro dalla magistratura belga che adesso ne chiede anche la consegna.
La consegna, cioè
l’estradizione. In un carcere di Bruxelles?
Il procedimento
incardinato in Italia è volto a valutare quello. Teoricamente, se la
magistratura italiana la concede, sì. La decisione è rimandata all’udienza del
19 dicembre.
Perché scusi, se
sono attinte da misure cautelari c’è il rischio che scappino o che occultino le
prove?
Appunto. Confidiamo
che la richiesta di Bruxelles così com’è non venga accolta.
La moglie di Antonio
Panzeri che cosa fa?
Nulla, è una
pensionata. Vive a Calusco D’Adda, in provincia di Bergamo. E non mi risulta che
abbia mai fatto attività politica o che abbia avuto un ruolo nel lavoro del
marito.
E la figlia?
È una collega,
avvocato civilista attiva qui nella zona. Del tutto sconvolta da queste accuse,
incredula.
Che idea si è fatto
su questa indagine?
Una attenzione a
orologeria, perché curiosamente proprio nella settimana in cui tutto il mondo
guarda al Qatar per le semifinali e la finale del campionato del mondo, ecco
spuntare la pista della corruzione qatarina.
Quando avrà le
carte? Sui giornali le condanne ci sono già tutte.
Questa è la domanda
che rivolgiamo alla magistratura del Belgio, sotto la cui giurisdizione ricade
il Parlamento europeo. Ci faccia avere gli atti, che vanno poi tradotti e
analizzati, altrimenti viene meno il diritto alla difesa.
Aldo Torchiaro.
Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003.
Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.
Estratto
dell’articolo di David Carretta per “il Foglio” il 13 dicembre 2022.
Per gli assetati di
dettagli da buco della serratura, il modo con cui la procura federale belga
comunica sullo scandalo del “Qatar gate” si sta rivelando deludente.
Contrariamente a quanto avviene in Italia, dove gli atti giudiziari e le
intercettazioni finiscono regolarmente sui giornali, il Belgio ha un’ossessione
per la riservatezza a tutela delle indagini e delle persone indagate.
Nei comunicati
stampa pubblicati finora sul più grave scandalo di corruzione che ha colpito il
Parlamento europeo, la procura non ha mai menzionato il Qatar o le persone
coinvolte. Impossibile lanciarsi nel gioco di requisitorie, processi e condanne
sui media: occorrerà aspettare una sentenza di un tribunale, o almeno le
udienze, per capire tutto quel che è successo.
Il Qatar gate non ha
ricevuto un trattamento diverso da altre grandi o piccole inchieste giudiziarie
condotte in Belgio. Che sia sugli attentati di Bruxelles del 2016, la cattura di
terroristi o un accoltellamento, la comunicazione si limita a scarni comunicati
molto generali che contengono una sintesi di perquisizioni, numero di persone
arrestate e reati ipotizzati. Ma niente nomi o dettagli. Nel primo comunicato
sul Qatar gate di venerdì e nel secondo di domenica il nome del Qatar non
compare.
[…] In Belgio le
fonti giudiziarie ci sono e parlano con i giornalisti, ma solo fino a un certo
punto. “Nell’interesse dell’inchiesta, nessun’altra informazione sarà data per
il momento. La stampa sarà informata da eventuali nuovi sviluppi attraverso un
comunicato”, ha spiegato la procura. Le uniche intercettazioni del Qatar gate
che sono finite sui giornali sono quelle contenute negli atti trasmessi alla
Corte d’appello di Brescia per chiedere l’esecuzione del mandato d’arresto
contro la moglie e la figlia di Panzeri. Così i media da buco della serratura
hanno finalmente avuto il loro romanzo su un Gigante, le vacanze e le carte di
credito.
Marcello Sorgi
per “la Stampa” il 13 dicembre 2022.
È davvero singolare
che il solo nel Pd a condannare seriamente il Qatargate sia il commissario per
gli Affari economici Gentiloni, mentre ai vertici del partito si fa strada una
strana teoria: gli scandali e la corruzione prosperano per mancanza di regole
severe. E chi non ha voluto le regole finora è stata la destra. Uno strano modo
di affrontare gli eventi sui quali, alla vigilia del congresso, c'è ben poco da
sorvolare.
Invece è tutto un
voltarsi dall'altra parte, mentre le forze di polizia a Bruxelles sequestrano
valigioni pieni di soldi. Sotto sotto si tratta anche di non infierire sui
"compagni separati" di Articolo 1, i bersaniani-dalemiani a cui apparteneva
Panzeri, il principale arrestato italiano, che stanno per rientrare nella casa
da cui erano usciti per protestare contro Renzi (e hanno continuato a farlo
anche in tempi più recenti, attaccando l'attività di conferenziere dell'ex
premier negli Emirati Arabi).
Com' è stato fino a
qualche giorno fa per il caso Soumahoro, che ha investito Sinistra Italiana e
Europa Verde, alleati della striminzita coalizione che ha perso le elezioni il
25 settembre. È pura illusione sperare di far volare sulla destra qualche
schizzo del fango che al momento sommerge la componente italiana del gruppo
Socialisti e Democratici dell'Europarlamento (oltre alla vicepresidente greca
Kaili). E fermarsi alla questione delle regole, come ha fatto la candidata alla
segreteria Schlein, è quasi un parlar d'altro. Sentiremo Bonaccini.
Ma la domanda da
farsi è semplice: ce li vogliono davvero nel partito che sta entrando in una
fase costituente i lobbisti del Qatar, pagati con centinaia di migliaia di euro
per addolcire le prese di posizione del Parlamento di Strasburgo sul mancato
rispetto dei diritti civili da parte del governo di Doha? Ci saranno o no un
paio di righe, almeno un paio, nella nuova carta dei valori del Pd, per segnare
un confine tra il rispetto e l'assenza di democrazia che riguarda la maggioranza
dei Paesi del mondo arabo? Oltre ai candidati alla segreteria, evidentemente
preoccupati di urtare parte degli iscritti che dovrebbero poi votarli alle
primarie, a parlare, a dire parole chiare, dovrebbe essere il vertice del Pd.
Che al momento invece preferisce prenderla molto alla larga.
Panzeri,
l'indagato è di sinistra? Ecco cosa sparisce dai titoli.
Iuri Maria Prado su
Libero Quotidiano il 13 dicembre 2022.
Non è propriamente
per resipiscenza garantista che la stampa coi fiocchi fatica a mettere in prima
pagina che il presunto colpevole, questo Panzeri, appartiene ai ranghi illustri
della Repubblica Bella Ciao. Sarebbe nobilissimo se si trattasse della doverosa
cautela con cui si tiene basso il profilo dell'indagato, senza indugiare sui
particolari del suo curriculum, fino a che le cose non sono più chiare: ma la
vaghissima impressione è che si tratti di tutt'altro e cioè del ricorso al
bianchetto sulla notizia che imbarazza non per i pacchi di soldi di cui si
parla, ma per il fatto che se ne ipotizzi il maneggio da parte di un
plenipotenziario progressista.
Che non si tratti
di quella cautela è evidentissimo guardando certi titoli: “Choc in Europa”,
“Eurocorruzione”, “La Tangentopoli in Europa”, che sembrano misurati meno
sull’esigenza di descrivere uno scandalo generale, che è tutto da dimostrare, e
ben più sull’urgenza di rendere trascurabile l’identità politica di chi pare
esservi coinvolto. Che andrebbe benissimo un’altra volta, se non fosse che altre
volte l’affiliazione è vigorosamente sottolineata e non è neppure la guarnizione
della notizia, ma la notizia punto e basta. Ora a sinistra faranno il solito, e
cioè lo scaricheranno a prescindere, prima del processo, ma nel frattempo verrà
fuori che sotto le spoglie di comunista sindacalista era in realtà un
ordoliberista.
La morale di Eva.
Storia di Massimo Gramellini su Il Corriere della Sera il 12 dicembre 2022.
Se ti riempiono un
sacco di banconote fino all’orlo per parlare bene del Qatar e tu parli bene del
Qatar, sei una politica corrotta, ma lineare. Invece l’eurosocialista (nel senso
di socialista sensibile agli euro) Eva Kaili ha scelto una strada più contorta,
non limitandosi a tessere l’elogio dei suoi corruttori, ma usandolo per sputare
sull’Europa che le passa lo stipendio, quello regolare. Forse avrete visto anche
voi le immagini del memorabile intervento al Parlamento di Bruxelles in cui la
vicepresidente Kaili proponeva il Qatar come modello sindacale per il nostro
Continente: «Impariamo da loro, lì c’è il salario minimo!». Di sicuro c’è quello
massimo, riservato a lei e ai suoi compari.
Nell’area socialista
è partita la solita corsa a prendere le distanze , come se l’avidità e il
lobbismo a favore dei mostruosamente ricchi fossero incompatibili con la loro
parte politica, che ne ha invece sempre fornito amplissime testimonianze.
L’aggravante di sinistra, se così si può dire, sta in quel non accontentarsi di
adulare il finanziatore, ma nel volere trasformare persino l’adulazione a
pagamento in una caricatura di battaglia progressista. Che consistano in questo
i vantaggi del famoso «multipolarismo» decantato dagli esegeti del modello
arabo, russo, indiano, cinese? Definire bieco e corrotto il capitalismo
occidentale mentre si prendono le mazzette da quello degli altri.
Paolo Bracalini
per ilgiornale.it il 12 dicembre 2022.
Dalle sardine ai
cavallini rampanti, il passo è breve e transita dalla politica. Si tratta di una
battuta sbagliata, ma la foto (e il commento) pubblicata sui social da Mattia
Santori, leader delle Sardine, non è stata particolarmente apprezzata. «Non ho
fatto in tempo a mettermi la camicia che subito Stefano Bonaccini mi ha preso
l'auto aziendale» scrive Santori pensando di essere ironico e postando una foto
di lui, in abito e camicia visto il clima estivo di Dubai, con a fianco il
governatore Stefano Bonaccini e dietro una fiammeggiante Ferrari gialla.
Un simbolo di lusso
che non ci si aspetta dai rivoluzionari alla bolognese, dichiaratamente ispirati
a ideali «di stampo gramsciano» (cit). Ora, a parte il fatto di essere a Dubai
per l'Expo2020 in qualità di consigliere comunale Pd «con delega al turismo», a
parte il fatto di essere a braccetto con il governatore, a parte il fatto di
farsi la foto tamarra con le auto di lusso sullo sfondo, è tutto il quadretto
che stona. I commenti al post glielo fanno notare in massa. «E brava la sardina!
Questo ha capito tutto della vita. Vedrai che presto arriverà pure per te una
poltroncina ben retribuita», «Passare dalle sardine al caviale è un attimo....»,
«Ma come è caduta in basso la sinistra», «Ma non avevi detto che non volevi
entrare in politica?
Ti stai preparando
per accomodarti, giusto? Tra sardine e tonno il posto è già bello che pronto», e
via così. Al netto di alcuni che penseranno davvero che Santori avrà come auto
di servizio una Ferrari, le altre critiche riguardano l'evoluzione (tipica)
della sardina, da movimentisti a politici (ormai organici al Pd emiliano), una
parabola già vista. Già un'altra volta Santori era inciampato in uno scatto
infelice, quando si era fatto fotografare insieme a Luciano Benetton e Oliviero
Toscani, un'immagine che scatenò un mare di polemiche e portò alla scissione di
un gruppo romano di Sardine («Un errore politico ingiustificabile»).
Il movimento nel
frattempo si è sgonfiato, qualche giorno fa all'anniversario del primo famoso
raduno a Bologna, quando riempirono piazza Maggiore, non c'erano migliaia di
persone, ma solo poche decine. «Non saremo mai un partito» ha detto Santori. Al
massimo una corrente del Pd.
I rivoluzionari che pretendono il diritto al lusso.
L'odiosa ipocrisia
di chi predica l'inclusione facendo parte di un mondo esclusivo. Francesco Maria
Del Vigo il 13 Dicembre 2022 su Il Giornale.
C'è una grande
confusione sotto l'altra metà del cielo. E più che quella delle donne,
intendiamo quella delle professioniste del femminismo. Sono successe troppe
cose, tutte insieme e in poco tempo. Troppe cose complicate da decodificare,
digerire e poi spiegare a se stessi e agli altri, siano lettori o elettori. Per
amor di sintesi elenchiamo i tre eventi principali di questa crisi: la vittoria
del centrodestra e quindi l'ascesa di Giorgia Meloni a palazzo Chigi; lo
scandalo che ha coinvolto l'onorevole Aboubakar Soumahoro e la moglie Liliane
Murekatete, trascinando con loro tutto il mondo dell'accoglienza e del suo
apparato ideologico; il Qatar-gate con il coinvolgimento, tra gli altri, della
vice presidente del Parlamento Ue, la socialista greca Eva Kaili. Tre colpi che
hanno fatto tremare anche le più solide certezze della sinistra più convinta
della propria superiorità morale e, appunto, di genere.
Ieri, su Repubblica,
si è esibita Concita De Gregorio, firma di punta della galassia politica che
fonde il progressismo più chic con la difesa più radicale dei diritti delle
donne. L'ex direttrice dell'Unità non si nasconde dietro una borsa di Louis
Vuitton e, con coerenza, ammette subito la sua missione: difendere Liliane
Murekatete. Tentativo più che legittimo, a patto di non sconquassare tutto il
sistema di valori con il quale la sinistra per anni ci ha sconquassato le
scatole. Cosa che puntualmente avviene. I due pilastri del pensiero della De
Gregorio sono le basi della nuova sinistra dei diritti: cioè il diritto al lusso
e il diritto all'esibizione del proprio corpo. Il primo teorizzato - con
invidiabile coraggio - in diretta televisiva dall'onorevole Soumahoro e il
secondo addebitato dalla giornalista a Chiara Ferragni. E potremmo anche
fermarci già qui: perché se parlando di diritti siamo passati da Rousseau e
Locke ai due sopraccitati, beh, qualche problema c'è, ci è sfuggita almeno una
via di mezzo.
E ora, la De
Gregorio, per difendere la passione di lady Soumahoro per borse griffate e foto
sexy, la paragona proprio alla Ferragni, perché anche lei pubblica foto su
Instagram con marchi di lusso e mutande bene in vista. Da queste colonne siamo
sempre stati piuttosto severi con la regina delle influencer, ma cosa c'entra
con Liliane Murekatete? Al netto di un certo insipido buonismo e uno spiccato
qualunquismo vagamente di sinistra, la Ferragni non si è mai occupata di
accoglienza e ha fatto i suoi (tanti) soldi nel nome del più spudorato
capitalismo, senza nascondersi dietro il paravento dell'umanitarismo e
soprattutto senza finire in torbide inchieste su milioni dispensati dallo Stato.
Ma è diventata l'ultimo scudo dietro al quale i dem tentano di occultare le loro
magagne. Un vizio antico, quello del doppiopesismo rosso. Sinistra al caviale,
sinistra da ztl e comunisti col Rolex - per citare solo i più diffusi - non sono
solo modi di dire e luoghi comuni. O meglio, nel tempo lo sono diventati, ma si
basano su solide realtà fattuali. Per capire geograficamente dove vince la
sinistra ormai non serve più consultare gli esperti di flussi elettorali, basta
aprire immobiliare.it e cercare dove costano di più le case al metro quadrato.
Il Pd, e i suoi cespugli sinistri, sono animali che abitano la fauna dei centri
storici. Si sbracciano, dai loro salotti, per il proletariato, ma hanno l'orrore
per le periferie proletarie, veleggiano su comode barche a vela - come il famoso
Ikarus di D'Alema - lontano dai marosi del populismo e sopratutto del popolo.
D'altronde l'ultimo comunista di successo di cui si abbia memoria è Fausto
Bertinotti, uno che somigliava molto di più a un lord inglese che a un operaio
di Mirafiori. E anche Olivia Palladino, compagna di Giuseppe Conte, neo avvocato
degli ultimi, è già finita nel mirino del web per aver sfoggiato borse
firmatissime: perfetta per essere la first lady della gauche.
Tra la sinistra e il
lusso c'è sempre stato un grande feeling. E non ci sarebbe nulla di male, se non
predicassero pauperismo per poi vivere come nababbi, se non detestassero il
capitalismo salvo poi esserne ingranaggi oliatissimi, se non predicassero
inclusività facendo parte di una della caste più esclusive. Il problema è solo
uno: l'ipocrisia. Ultimo vero comune denominatore rimasto alla sinistra.
Alessandro De
Angelis per “La Stampa” il 12 dicembre 2022.
In questa
storiaccia, che annuncia uno scandalo gigantesco, di corruzione gozzovigliante -
soldi nei borsoni che evocano la mazzetta gettata da Mario Chiesa nel water,
padri in fuga col malloppo, mogli e figlie che prenotano vacanze faraoniche -
peggio del denaro c'è solo la reazione balbettante della sinistra. Ed è proprio
questa reazione, che col garantismo non c'entra nulla, a configurare il caso
come un elemento di strutturale collasso politico e morale. Non il mariuolo o la
classica mela marcia in un corpo sano.
Soumahoro e Panzeri,
mutatis mutandis, ognuno con le sue signore, sono due volti dello stesso cinico
modello: la disinvoltura, propria o familiare, agita dietro e grazie
all'immagine pubblica di difesa dei diritti umani. Circostanza tale da rendere
ancora più intollerabili quei comportamenti.
A meno che il
cronista non sia così limitato da non comprendere che non di cedimento morale si
tratta, ma di diabolica e raffinata strategia posta in essere da chi, impegnato
a criticare il capitalismo, quando si discute il Manifesto dei valori, adesso
tace, da Articolo 1 al Pd: chissà, magari sembra corruzione ma è un modo per
dissanguare i ricchi della terra, versione aggiornata al terzo millennio
dell'esproprio proletario di cui Bruxelles è l'avamposto più avanzato.
Scherzi a parte, in
questo assurdo dei principi, c'è chi arriva a consumare il reato senza neanche
l'alibi ipocrita del "rubare per il partito", ma l'assenza di una messa a tema
della questione morale, da parte dei vertici della sinistra, rivela un
meccanismo omertoso generalizzato. Le cui radici sono nel fatto che "può
capitare" a tutti, di ritrovarsi tra colleghi o famiglie altri Soumahoro o
Panzeri, in un partito schiacciato sul governismo affaristico o dove il
tesseramento è affidato ai capibastone.
E dunque, in un
clima di appartenenza allo stesso consorzio politico-morale, nessuno ha la forza
di difendere i valori, parola ridotta solo a chiacchiera nell'ammuina
congressuale sui Manifesti. Accadde lo stesso con Nicola Oddati, responsabile
delle Agorà di Enrico Letta, beccato a gennaio a Termini con 14mila euro in
tasca, controllo non casuale perché da tempo la procura stava indagando per un
presunto giro di favori con imprenditori: si dimise e finì lì. Come finì con la
relazione Barca lo sforzo di rinnovamento del marcio partito romano, dopo Mafia
Capitale.
In questo quadro si
spiega la reazione della destra, tutto sommato misurata. Da un lato, da questa
vicenda incassa il terreno ideale per una campagna contro le Ong; dall'altra
preferisce (a sinistra) un gruppo dirigente condizionabile a una "piazza pulita"
da cui nasca qualcosa di nuovo e insidioso. E non a caso il governo incontra
D'Alema, gran consigliere di Conte e della sinistra Pd, nei panni di consulente
di un gruppo di investitori qatarini pronti a competere per rilevare la
raffineria di Lukoil a Priolo. La destra sa che questi dirigenti sono la sua
polizza a vita.
(ANSA il 13 dicembre
2022) - Gli uffici dell'assistente dell'eurodeputato Pietro Bartolo
all'Eurocamera di Strasburgo sono stati posti sotto sigillo, ha constatato
l''ANSA. I sigilli sono stati apposti questa mattina, ha confermato una persona
del suo staff.
Sandro Iacometti
per “Libero quotidiano” il 13 dicembre 2022.
Da una parte c'è lo
sgretolamento totale e definitivo, sulla scia di Mafia Capitale e dei casi Mimmo
Lucano e Aboubakar Soumahoro, del grande castello di ipocrisia creato dalla
sinistra oltre quarant' anni or sono con la famosa "questione morale" di
Berlinguer. Una roba che, va detto, per essere vista fin dall'inizio con
diffidenza non richiedeva grandi sforzi.
Bastava leggersi non
il libro, ma l'ultima pagina della Fattoria degli animali di Orwell per avere le
idee chiare: «Le creature volgevano lo sguardo dal maiale all'uomo, e dall'uomo
al maiale, e ancora dal maiale all'uomo: ma era già impossibile distinguere
l'uno dall'altro». Dove l'uomo era ovviamente lo spietato oppressore e il maiale
l'intrepido rivoluzionario.
Ma gli effetti del
Qatar gate non si abbatteranno, purtroppo, solo su quel mondo dei buoni e degli
onesti a prescindere in cui la corruzione, il mercimonio e lo sfruttamento dei
più deboli dietro lo scudo della presunta superiorità morale si sono alimentati
e diffusi.
Tra i molti danni
collaterali del clamoroso traffico di mazzette finito nel mirino della giustizia
belga tra lobbisti e parlamentari europei di area socialista, molti dei quali
legati a doppio filo al nostro Pd (e ai suoi cespugli) sta iniziando a
materializzarsi anche quello di una colossale colata di fango sull'intero
Paese.
Per carità, con il
passar delle ore si moltiplicano gli appelli a circoscrivere l'accaduto alle
persone coinvolte, per evitare che il discredito si allarghi a macchio d'olio.
Anche la presidente dell'europarlamento Roberto Metsola ha provato, aprendo la
plenaria di ieri tra le urla e le proteste, a spiegare che «questo scandalo non
è una questione di destra o sinistra, non è questione di nord o sud».
Epperò nei corridoi
dell'europarlamento iniziano a circolare con insistenza espressioni come
"italian connection" o "italian job". Ad alimentare la convinzione che si sia
trattato di «un colpo all'italiana», del resto, ci sono anche le indagini che,
allargandosi, vedono sempre più connazionali coinvolti.
Illazioni e accuse
sicuramente velate e dette a mezza bocca, ma non così trascurabili. Al punto che
ieri sera persino Antonio Tajani ha sentito il bisogno di respingere
pubblicamente l'attribuzione geografica ed antropologica della responsabilità
dello scandalo.
«L'Italia», ha detto
il ministro degli Esteri in un punto stampa al termine del consiglio degli
Affari esteri a Bruxelles, «è un grande Paese: se ci sono dei parlamentari o
degli assistenti che hanno commesso dei reati, sono questioni che riguardano le
singole persone, non il sistema Italia, come non riguardano il sistema
Parlamento».
Insomma, la frittata
è fatta. Dopo il mandolino, la pizza e la mafia ora gli italiani nel mondo
dovranno anche giustificarsi di non andare in giro con borsoni zeppi di
banconote ricevute da Paesi arabi per ripulirgli un po' il pedigree in materia
di rispetto dei diritti civili e sindacali.
E, per ironia della
sorte o, come dicono quelli che parlano bene, per eterogenesi dei fini, a
svergognare l'Italia in Europa alla fine ci hanno pensato proprio gli amici di
quelli che hanno passato gli ultimi mesi a raccontare che a fare figuracce
oltreconfine, mettendo in imbarazzo tutto il Paese, sarebbe stato il nuovo
governo.
Le vicende sono
troppo recenti per essere dimenticate anche da un popolo con la memoria corta
come la nostra. «Questa destra ci porterebbe molto lontano dai valori europei»;
«Meloni lavora per sfasciare l'Europa»; «Noi vogliamo un'Italia che conti in
Europa». Solo per citare alcune dichiarazioni fatte dal segretario dimissionario
del Pd, Enrico Letta, durante la campagna elettorale. Che poi sono le frasi più
innocue.
Già, perché tra
intellettuali, politici e media di area le accuse che volavano erano ben più pe
santi. Comprese quelle sulla imminente demolizione dei diritti civili, a cui
alcuni alti esponenti delle istituzioni Ue hanno persi no abboccato, sostenendo
che avrebbero vigilato sulle azioni del nuovo governo.
E mentre gli occhi
di Strasburgo e Bruxelles erano tutti puntati sul centrodestra postfascista,
nemico degli immigrati, omofobo, anti immigrati, anti Pnrr, anti patto di
stabilità e anti tutto, gli eurodeputati del Pd si riempivano tranquillamente le
tasche di tangenti per difendere il Qatar.
La beffa delle beffe
è degli ultimi giorni, con tutte le opposizioni impegnate a descrivere un
governo amico degli evasori, dei riciclatori di denaro e di chi gira coi
contanti in tasca intenzionato a commettere reati di ogni tipo.
Salvo poi scoprire
che il tetto a 5mila euro inserito in manovra non solo è la metà di quello
proposto dalla Ue, ma anche infinitamente più basso della quantità di contante
con cui circolano normalmente i "sinistri" finiti sotto indagine nell'inchiesta
sul la Tangentopoli Ue.
Ma non è finita.
Della serie il lupo perde il pelo ma non il vi zio, nelle ultime ore i due
contendenti per la segreteria del Pd, Elly Schlein e Stefano Bonaccini, hanno
fatto a gara a prendere le distanze dallo scandalo Qatar.
«La vicenda è
gravissima e ripugnante», ha detto la prima. «Se confermato sarebbe uno scandalo
clamoroso», ha detto il secondo. Il sottinteso è che quella ro ba appartiene al
vecchio e marcio Pd, non al nuovo che si apprestano a guidare e rifondare. In
altre parole, la superiorità morale vale ancora, ma solo per chi li vota.
Mozione Qatar. Il
grande imbarazzo sulla nuova questione morale della sinistra.
Mario Lavia su
L’Inkiesta il 14 Dicembre 2022
Prima di trarre
conclusioni bisogna aspettare le sentenze, ma la storia dei politici
progressisti di Bruxelles merita comunque un chiarimento da parte dei leader
vecchi e futuri del Pd e di Articolo 1
Nel tardo 1989, in
una drammatica riunione del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana,
Oscar Luigi Scalfaro, all’epoca uno degli esponenti più autorevoli di quel
partito, intervenne senza giri di parole: «Ligato è un uomo nostro, non possiamo
tacerne». Ludovico Ligato era il presidente del Ferrovie, democristiano, ucciso
nell’agosto di quell’anno per motivi mai chiariti.
Scalfaro contestava
il silenzio dei suoi amici democristiani perché «è un uomo nostro» ma non ebbe
successo e il silenzio perdurò. Ecco, la cosa che certe volte fa più paura è
questo, il silenzio. Che può significare due cose: o è vergogna o è
instupidimento.
Enrico Letta ha
chiesto doverosamente chiarezza e annunciato che il Partito democratico si
costituirà come parte lesa. Bene. Ma non ci ha detto minimamente come sia stato
possibile uno schifo del genere nella sua famiglia politica. Qualcuno anzi si
scoccia pure e si dice «incazzato».
Se sono incazzati
loro figuriamoci gli elettori. Ci fosse uno che abbia chiesto scusa (premettendo
alle scuse l’estenuante ma giusto richiamo al garantismo), che abbia detto una
cosa tipo «non ce ne siamo accorti, era una così brava persona», come dicono
quelli del piano di sotto quando arrestano l’inquilino del piano di sopra.
E allora: Antonio
Panzeri è stato un esponente del Pci-Pds-Ds-Partito democratico e infine
Articolo Uno per decenni. «È un uomo nostro»: la frase di Scalfaro non l’ha
detta nessun dirigente. È possibile, per quanto inquietante, che nemmeno uno si
sia accorto della personalità di costui, forse di un probabile cambio del suo
tenore di vita, che so, di un qualche cosa che non quadrasse con il cliché di ex
sindacalista votato alla causa dei lavoratori di tutto il mondo, segnatamente,
da ultimo, del mondo arabo.
I vari
europarlamentari del Partito democratico di questi anni non lo hanno
frequentato? Gli assistenti, che a Bruxelles lavorano ora per uno ora per
l’altro, non hanno notato nulla? Così come è possibile, anche se allucinante,
che i socialisti europei, e in particolare greci, non si siano mai accorti di
che tipetto fosse Eva Kaili, una compagna talmente capace da essere eletta
vicepresidente dell’Europarlamento su designazione dei socialisti. È possibile,
anzi è probabile, che nessuno avesse sospettato alcunché. Ma allora sono tutti
degli sprovveduti, dei tontoloni, degli addormentati.
Tra tante persone
intelligenti e oneste non uno che avesse rizzato le antenne: un tempo, dispiace
dirlo, a sinistra non funzionava così. C’erano gli anticorpi. A partire dalla
sensibilità dei dirigenti.
Si dice: le mele
marce ci sono sempre. Sì, ma qui sta emergendo un sistema, una rete che
probabilmente è stata pazientemente intessuta per anni. Al di là dei luoghi
comuni, che dice Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito democratico e
leader morale di Articolo Uno che si appresta a rientrare nel Partito
democratico? L’arrestato non era un uomo suo? Ha parlato Matteo Renzi, come al
solito polemico: Panzeri «se ne andò dal Partito democratico perché diceva che
io ero contro i valori della sinistra. Ma quali erano questi valori?».
Renzi era segretario
del Partito democratico quando nel 2014 Panzeri venne ricandidato, ma giova
ricordare che le liste elettorali sono lottizzate tra le correnti ed è difficile
che una corrente metta il becco sulle scelte delle altre: e anche questo nel
Partito democratico ci sarebbe da correggere. E Articolo Uno, un partito così
piccolo, non si accorge che c’è del marcio a Bruxelles che origina da un suo
esponente? Nessuno se n’è accorto ma è proprio questo che sotto il profilo
politico preoccupa.
Si aspettano i
risultati delle indagini, com’è giusto, e poi dei processi, ma pare veramente
difficile a questo punto pensare che si tratti di un errore giudiziario, visto
che ci sono personaggi, come il padre della ex vicepresidente greca, che
scappano con il bottino; e va sempre ricordato che le responsabilità penali sono
personali.
Le responsabilità
politiche però no, sono collettive. Sono dei partiti, Partito democratico e
Articolo Uno che ormai è nel Partito democratico. Stefano Bonaccini ha ricordato
Enrico Berlinguer e la questione morale: solo che ora la questione morale è un
problema della sinistra. Quella sinistra che ha il dovere di capire e di
spiegare come sia stata possibile questa roba soprattutto per rispetto dei suoi
elettori, già frastornati dalla crisi di questi mesi a cui si aggiunge adesso la
vergogna di «un uomo nostro» al centro di uno scandalo internazionale. Il grande
silenzio è la risposta peggiore.
È fin troppo
facile, vista l'implicazione di una parlamentare greca nel cosiddetto affare
Qatar, evocare la figura della nemesi.
Marco Gervasoni il
14 Dicembre 2022 su Il Giornale.
È fin troppo facile,
vista l'implicazione di una parlamentare greca nel cosiddetto affare Qatar,
evocare la figura della nemesi. Ma così è. Pensiamoci: l'area politica
socialista che, dal crollo del Muro di Berlino in poi, per sostituire una nuova
utopia con quella appena morta, è stata la più fanatica sul piano
dell'europeismo, sposato con i diritti e il secolarismo multiculturalista, è
anche quella che sta danneggiando maggiormente non solo il sogno europeo, come
tale irrealizzabile, ma anche la Unione Europea reale. Le banconote di decine di
migliaia di euro in casa di parlamentari, ex parlamentari, loro collaboratori;
le ong, le sacre ong, utilizzate come organizzazioni di raccolta fondi per spese
sembra personali, le vacanze a 9 mila euro, paiono uno scenario che neppure i
brexiters più scatenati, i Nigel Farage, le Le Pen e i Salvini di un tempo,
avrebbero potuto costruire, nella loro propaganda per l'uscita dalla Ue e
dall'euro. E oggi ancora, a gongolare è Orban, che può accusare di ipocrisia il
Parlamento europeo, promotore, non senza ragione, di mozioni per condannare la
corruzione e la violazione dello stato di diritto in Ungheria. Violazioni certo
presenti, ma se poi paragoniamo Budapest a Doha, Orban ne esce come un seguace
di Soros.
Non ultimo,
l'effetto negativo è anche nei confronti della Russia, la cui propaganda ora
afferma di non voler prendere lezioni da un'entità corrotta come la Ue - benché
un europarlamentare Pd, non indagato, ma lambito, sia anche uno di quelli che
vota regolarmente pro Putin da quando è iniziata la guerra.
Come scriveva
nell'editoriale di ieri il Financial Times, «che regalo agli anti europeisti»,
tanto più che il parlamento si presenta come «la coscienza morale dell'Europa».
Certo, siamo tutti garantisti, anzi lo siamo più noi degli esponenti del Pd, che
fingono di non conoscere figure elette per diverse legislature e prestigiosi
esponenti del loro gruppo, il Pse. Ma certo, i socialisti dovrebbero chiedersi
perché i paesi arabi abbiano puntato soprattutto su di loro: la risposta, tra le
tante, è che mai nessuno, come loro, ha sviluppato un rapporto cosi forte con
l'Islam, con tutto il correlato di tolleranza verso l'immigrazione clandestina e
legami con le ong. E chi ha fatto crescere maggiormente l'Islam nelle società
europee, se non sindaci e premier di partiti del Pse? Insomma, come nell'antica
tragedia, la nemesi non è cieca e finisce sempre per colpire laddove deve.
La superiorità
morale del Pci, storia di un tragico equivoco.
Giovanni Vasso su
L’Identità il 15 Dicembre 2022
“I partiti di oggi
sono soprattutto macchina di potere e di clientela: scarsa o mistificata
conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali,
programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero”. No, non è un post
social di uno dei tanti populisti del web che si scagliano contro ciò che è
diventata la sinistra. No, questa frase, che oggi farebbe suonare le sirene
democratiche, è stata pronunciata da Enrico Berlinguer e raccolta da Eugenio
Scalfari in quell’intervista, ormai mitologica, sulla “questione morale” nella
politica italiana. Era il 28 luglio del 1981. “La loro stessa struttura
organizzativa si è ormai conformata su questo modello, non sono più
organizzatori del popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e
l’iniziativa: sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con
un boss e dei sotto-boss”. Forse sono parole troppo dure, eppure la descrizione
che Berlinguer fece quarantadue anni fa della Dc e (soprattutto) del Psi, che
stava erodendo consensi ai comunisti, non è molto lontana dalla percezione che
gli italiani hanno del (fu?) maggior partito della sinistra italiana che oggi
sprofonda, letteralmente, nei sondaggi. La superiorità morale dei comunisti, più
che un fatto politico è stato un dogma, una verità di fede, un preciso schema
strategico. Tutti rubano, tranne il Pci. Tangentopoli avrebbe dovuto
dimostrarlo, la sinistra italiana venne soltanto lambita dall’ondata di avvisi
di garanzia che, invece, travolse il Psi di Bettino Craxi. “Ora legale, panico
tra i socialisti”, fu il titolo non solo di un giornale ma di una stagione
politica. Di Primo Greganti si parlò poco, così come del dossier Mitrokhin e dei
rubli da Mosca, mentre infuriava, sulla parte avversa, la polemica Gladio.
Achille Occhetto per un attimo ci aveva creduto: i Progressisti avrebbero
portato, finalmente, l’onestà al potere. Arrivò Berlusconi nel ‘94, e vinse lui.
Aprendo una nuova stagione in cui la sinistra, con il pio e dimesso Romano
Prodi, si poneva come argine morale alla decadenza tele-bizantina di cui il Cav
sarebbe stato simbolo e causa insieme. Finì anche quella stagione. E gli ex
comunisti col santino di Berlinguer in tasca e la Santa alleanza con i
democristiani (“buoni”, come scrive Paolo Cirino Pomicino) della Base, si
scordarono di badare alla profezia di un grande socialista, Pietro Nenni: “A
fare i puri, prima o poi, si trova uno più puro che ti epura”. Arrivò Beppe
Grillo e il Vaffa day nel 2008. Fu respinto. Nacque il M5s su gentile (e
auto-jettatorio) invito di Piero Fassino. Raccolse l’eredità dei puri, degli
onesti, appropriandosi, nel 2018, di tutte le roccheforti che furono rosse.
Cinque anni dopo, la parabola era già finita. Ma Giuseppe Conte, piuttosto che
rintanarsi sulla questione morale, è sceso in campo agitando le ragioni dei ceti
più poveri e del Sud. Gli fecero il funerale, ridacchiando di lui. Oggi si
ritrova la possibilità di diventare lui il maggior partito di sinistra in
Italia. Enrico Letta, puntando tutto sull’antifascismo, vecchio richiamo della
foresta e insieme tentativo di aggiornare la questione morale inquadrandola su
base ideologica, ha fallito. Il Pd deve cambiare ma con Bonaccini e la sua vice
Schlein già è sotto il 15% dei sondaggi.
BONIFEI: “Il Pd
ha la schiena dritta da Soumahoro a Panzeri serve pulizia e trasparenza”.
Edoardo
Sirignano su L’Identità il 15 Dicembre 2022
“Siamo i primi a
pretendere chiarezza e trasparenza”. A dirlo Brando Benifei, capodelegazione del
Partito Democratico al Parlamento Europeo.
La vicenda del Qatar
tocca più di qualcuno del Pd. Non Benifei, ma diversi suoi colleghi hanno avuto
rapporti con queste persone. Lei non sapeva nulla di tutto ciò…
No, e non vedo come
avrei potuto saperlo. Come Partito Democratico ci costituiremo parte lesa nel
processo che ora si terrà in Belgio, ed esigiamo la massima chiarezza su una
vicenda dai contorni che appaiono assolutamente vergognosi.
Se i parlamentari
del vostro gruppo non c’entrano niente, è mai possibile che non sapessero cosa
facessero i loro collaboratori?
Gli assistenti
parlamentari sono figure di altissima professionalità, che hanno competenze sul
fronte legislativo e fanno un lavoro di studio e approfondimento sui dossier.
Come potevano alcuni eurodeputati pensare che tra queste figure vi fosse
qualcuno che agiva per interessi particolari o corruttivi?
Tutta questa vicenda
rischia di penalizzare il vostro partito?
Il Partito
Democratico ha dimostrato con i fatti di aver tenuto la schiena dritta sulla
questione dei diritti umani in Qatar. Su questo non possono esserci ambiguità di
giudizio, parlano i nostri voti e le nostre interrogazioni.
De Magistris dice
che non si tratta di qualche mela marcia, ma di un vero e proprio sistema…
Non accetto che
passi l’idea che il Parlamento Europeo si sia lasciato corrompere. Se ci sono
state influenze su qualcuno si faccia luce rapidamente. Proprio noi abbiamo
voluto che il Parlamento Europeo aprisse, anche con una apposita Commissione
Speciale, che ha lavorato in questo anno, una vera riflessione sulle influenze e
gli attacchi alla democrazia europea da parte di Stati esteri, come la Russia di
Putin.
A più riprese ha
detto che è solo colpa delle destre. Perché?
Non ho detto che è
“solo” colpa delle destre, ma è un fatto che i Socialisti e Democratici siano la
forza politica che ha sempre voluto e votato per istituire un organismo
indipendente sulle questioni di etica pubblica nelle istituzioni europee e
maggiori restrizioni per i lobbisti, mentre i gruppi politici di destra si sono
opposti. Ora cambino idea e supportino con noi la richiesta per una commissione
d’inchiesta sui fatti di questi giorni.
Cosa vi distingue
dalle destre?
Oltre a quanto già
detto, ricordo che la destra italiana ed europea non ha votato gli emendamenti
di maggiore condanna al Qatar sostenuti dal Partito Democratico e presentati dal
gruppo della Sinistra. In questi anni quante volte siamo stati solo noi a
spingere per vincolare gli accordi commerciali, a migliori risultati sul tema
della tutela dei diritti umani.
Quanto è importante
la questione morale nella vicenda e soprattutto che idea avete oggi su Doha, i
mondiali e quanto accade a quelle latitudini?
La nostra posizione
è sempre stata la stessa: la delegazione che guido al Parlamento Europeo ha
tenuto, sin dall’inizio, una linea molto dura nelle votazioni sul Qatar,
supportando anche emendamenti fuori dall’accordo principale fra i gruppi
politici per essere ancora più netti sulla condanna delle violazioni dei diritti
dei lavoratori e della comunità LGBTQ, tema su cui ho anche presentato una
successiva interrogazione chiedendo a Borrell di richiamare il nostro
Ambasciatore Ue presso il Qatar.
Non ritiene che il
Pd, così come le altre forze, debba prestare più attenzione quando sceglie
collaboratori e staff?
Mi preoccuperei
piuttosto di regolare in modo più stringente le attività degli ex parlamentari,
di qualsiasi colore essi siano. Dobbiamo mettere fine al fenomeno delle porte
girevoli o di attività usate come paravento. L’ex Presidente della Commissione
Barroso è andato a lavorare dopo pochissimo tempo dal termine del suo mandato
per la Goldman Sachs, su queste storie c’è stato sempre troppo lassismo. E in
questo specifico caso, l’idea stessa che si possa lucrare sulla lotta per i
diritti umani mi suscita un profondissimo sdegno.
Come pensate,
intanto, di interagire con chi ha come unico fine quello di fare chiarezza su
tutto ciò?
Rispondendo nel
merito e con i fatti. Siamo i primi a pretendere chiarezza e trasparenza, è il
nostro lavoro che viene danneggiato da queste vicende.
In politica può
capitare di sbagliare. Occorre, però, determinazione nel prendere le distanze da
certi atteggiamenti. Basti pensare al caso Soumahoro, dove c’è molta ambiguità.
Questa volta sarà tracciata una linea netta?
L’abbiamo già
tracciata e continueremo a farlo, penso che questo scandalo sia l’occasione per
migliorare e rendere molto più forte la nostra democrazia europea, non c’è
alternativa.
Il Pd fiaccato
dagli scandali ora rivuole il finanziamento pubblico.
Carlantonio Solimene
su Il Tempo il 16 dicembre 2022
La teoria ha un
certo fascino: se oggi il finanziamento pubblico ai partiti non c'è più; se i
giornali di partito sono rimasti senza soldi e hanno abbassato le serrande; se
la figura dei funzionari di partito- nell'impossibilità di pagar loro gli
stipendi- si è praticamente estinta; se, in sintesi, per chi fa politica la
poltrona di parlamentare è l'unica possibile fonte di reddito, allora è da
ipocriti scandalizzarsi se c'è qualcuno che, per mettersi in sicurezza, si mette
a fare il lobbista, nella migliore delle ipotesi. O incassa tangenti, nella
peggiore.
Il naturale
corollario della tesi è il seguente: ritorniamo ai contributi statali e non
avremo più scandali come il «Qatargate» che sta facendo tremare la sinistra.
Ragionamento suggestivo, come detto, e finanche condivisibile. Se non fosse per
due particolari. Il primo è che la corruzione c'era anche prima, quando i
partiti erano generosamente foraggiati dal bilancio pubblico. E, d'altronde, il
referendum del 1993 sull'abolizione del finanziamento ottenne un sì
plebiscitario (90%) proprio sull'onda del più celebre di quegli scandali,
Tangentopoli.
La seconda
obiezione, invece, sta nel fatto che fu la medesima sinistra a schierarsi per lo
stop ai fondi statali. Prima cavalcando il referendum del 1993, poi abolendo -
con il governo Letta nel 2013 - anche i rimborsi elettorali che ne avevano preso
il posto.
Eppure sono stati
due esponenti del Pd non certo di secondo piano- il vicesegretario Giuseppe
Provenzano e Gianni Cuperlo, in procinto di candidarsi alla segreteria- a
indicare nella fine del finanziamento pubblico il padre di tutti i mali. Ed è
stato incardinato al Senato un ddl per reintrodurlo firmato dal senatore Dem
Andrea Giorgis. «Se sopprimi ogni forma di finanziamento della politica
argomenta Cuperlo - rimanere nelle istituzioni diventa il traguardo a cui non
puoi rinunciare. I soldi gli strumenti per conservare lo status. Le
responsabilità sono sempre personali, ma paghiamo anche gli errori di questi
anni, a partire dalla selezione dei gruppi dirigenti.
C'è il ritorno a un
accesso patrimoniale alle cariche elettive. Chi non è nelle istituzioni non
esiste». «Se negli anni passati - aggiunge Provenzano all'Huffington Post
un'intera classe dirigente non ha avuto le palle, scusi il termine, per opporsi
al vento populista, se siamo stati noi ad abolire il finanziamento pubblico ai
partiti, allora vuol dire essere pronti a rinunciare al "professionismo della
politica". È un errore, a mio avviso».
Dai rimborsi ai
rimorsi il passo è breve. Male obiezioni restano. La prima: la battaglia
culturale sul finanziamento pubblico non era il caso di farla quando la
decisione di abolirlo fu presa? Ora che i buoi sono scappati non è tardi per
chiudere il recinto? E ancora: come conciliano Cuperlo e Provenzano l'improvvisa
sterzata anti -populista con l'auspicio a riallacciare i ponti col M5S, il
«partito» più populista e anti -casta di tutti? E, infine, dopo giorni di
imbarazzato silenzio, davvero l'unica riflessione arrivata da sinistra sul
«Qatargate» (e sul caso Soumahoro) è sulla necessità di reintrodurre il
finanziamento pubblico? Che fine ha fatto la questione morale? E il tradimento
ideale di chi ha sfruttato il «bene» (le coop e le ong) per fare il «male»
(corruzioni e tangenti)? E il fatto che lo scandalo abbia colpito solo la
sinistra e non la destra? Davvero si può ridurre tutto questo all'assenza di
contributi statali? Davvero si rimetterà tutto a posto con quello che Provenzano
chiama «l'elogio del funzionario di partito»? Per il Pd, evidentemente, sì. Caso
chiuso, compagni.
Da iltempo.it il 15
Dicembre 2022.
Maria Giovanna
Maglie umilia il capo delegazione Pd in Ue Brando Benifei. Rilanciando un post
dell'account non ufficiale della Lega esteri che riporta l'intervista di Benifei
a La Stampa, Maglie esprime il suo parere sulle dichiarazioni rilasciate dal dem
europeo.
"Ridicolo". Il big
Pd finisce nel mirino di Maglie, fucilato con una parola
Nell'intervista al
quotidiano torinese Benifei prova ad accusare la destra sullo scandalo
Qatargate. "Se il Parlamento europeo rischia dei casi di corruzione è colpa
della destra che ha sempre bloccato norme più rigide sul tema" dice
l'eurodeputato nell'attacco dell'articolo. Non solo. Benifei non esprime una
forte condanna nei confronti dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, arrestato con
l'accusa di aver preso soldi dal Qatar per influenzare il Parlamento Ue, e punta
invece il dito sulla destra perché "hanno un numero di persone inquisite e
condannate veramente elevato, anche in Italia". Poi Benifei si lancia in un
surreale attacco frontale alla Lega: "Questa vicenda ci scandalizza, ci poniamo
il problema di risolvere queste cose, mentre a destra non capisco quanto ad
esempio è stata presa con serietà la vicenda dei 49 milioni della Lega o altre
gravi vicende giudiziarie". E di fronte a questo tripudio di assurdità Maglie
risponde a tono, in modo conciso e calzante come è nel suo stile fare: "Che
faccia di..."
Qatargate, "dire
che tutta la sinistra è di mazzettari..." Bocchino sbotta e zittisce Padellaro.
Giada Oricchio su Il Tempo il 15 dicembre 2022
Il Qatargate scuote
il Parlamento europeo e la sinistra. Lo scandalo su un vorticoso giro
internazionale di tangenti, con cui il Paese qatariota ha corrotto esponenti del
Parlamento UE allo scopo di ottenere appalti, interferire e condizionare le
scelte europee, si preannuncia una valanga giudiziaria (sarebbero almeno 60 i
deputati coinvolti, nda). Se ne parla a “Otto e Mezzo”, il talk preserale
condotto da Lilli Gruber su La7, giovedì 15 dicembre.
Il direttore del
Secolo d’Italia, Italo Bocchino, ha condannato senza se e senza ma. “Tutto
questo mi fa schifo tre volte. Mi schifo e basta. Mi fa schifo perché queste
persone sono state trovate con pacchi di soldi a casa in un modo ignobile e mi
schifo perché si sono venduti sui diritti umani, un valore che la sinistra
rivendica”.
Al momento, i
magistrati belgi hanno fatto arrestare per corruzione Antonio Panzeri, ex
parlamentare Pd e Articolo Uno, l'ex vicepresidente dell’Europarlamento, Eva
Kaili, eletta nelle liste del Movimento socialista panellenico e il compagno. E
questo dà modo a Bocchino di affondare il colpo: “E’ la pietra tombale sulla
superiorità della sinistra”.
L’affermazione ha
indispettito l’ex direttore de “Il Fatto Quotidiano”, Antonio Padellaro: “La
storia della superiorità è una fesseria che non so chi ha inventato… siamo di
fronte a una serie di personaggi presi con le mani nella marmellata, ma da qui a
coinvolgere un’intera classe dirigente della sinistra no! I dirigenti sono
onesti e perbene, è inaccettabile dire che a sinistra sono tutti mazzettari”.
L’ex deputato di
Forza Italia ha insistito: “Io non ho detto che sono tutti mazzettari, ho detto
che ci sono mazzettari di sinistra con 600mila euro nei trolley che volevano
spiegare all’Europa che i diritti umani in Qatar erano perfetti. Questo fa
schifo. Ci sarà almeno una ‘culpa in vigilando’? Una sbagliata selezione della
classe dirigente? Almirante e Berlinguer non avrebbero mai permesso a personaggi
simili di varcare la soglia del loro partito”.
Francesca Basso per
il “Corriere della Sera” il 15 Dicembre 2022.
Le risoluzioni
d'urgenza del Parlamento Ue sui diritti umani diventano un caso e si accende un
faro sull'accordo sull'aviazione del 2021 tra Ue e Qatar. Tutte le iniziative
del Parlamento Ue che riguardano i Paesi del Golfo suscitano ormai sospetto.
Il Ppe ha deciso «di
non partecipare a nessuna preparazione, negoziazione, discussione o votazione in
plenaria nel contesto delle risoluzioni d'urgenza» alla luce delle indagini
penali in corso «estremamente preoccupato per l'integrità delle posizioni di
politica estera del Parlamento Ue espresse nelle risoluzioni d'urgenza».
La decisione del Ppe
ha effetto immediato e sarà annunciata in plenaria domani. La decisione non è
stata apprezzata da Renew Europe che su Twitter ha spiegato che «il silenzio del
Parlamento Ue sulle violazioni dei diritti umani è esattamente ciò che le
tangenti del Qatar miravano a ottenere. Noi a Renew Europe siamo determinati a
continuare a gridare le atrocità». La replica sempre via social del Ppe è stata
che «nulla impedisce al Parlamento di denunciare le violazioni dei diritti umani
attraverso la commissione per gli Affari esteri».
Il Ppe è finito ieri
al centro della polemica per il suo eurodeputato ceco Tomá Zdechovský,
presidente del gruppo Friends of Bahrain al Parlamento Ue, che il 13 dicembre ha
presentato una mozione per una risoluzione sul caso del difensore dei diritti
umani Abdulhadi Al-Khawaja in Bahrein.
Su Twitter Maryam
Al-Khawaja, figlia dell'attivista condannato all'ergastolo nel 2011 durante la
repressione delle proteste, ha contestato a Zdechovský «la sua relazione e i
viaggi pagati in Bahrain con il governo». E la danese Karen Melchior ha chiesto
a Zdechovský di farsi da parte.
Nella conferenza dei
presidenti di lunedì il Ppe aveva proposto di non presentare la risoluzione sul
Bahrain, come elemento di garanzia ma dopo un acceso dibattito, dietro pressione
di liberali, socialisti e Left, i gruppi hanno deciso di procedere. C'è chi ha
osservato che la mozione non chiedeva nemmeno la scarcerazione di Al-Khawaja.
Faro acceso anche
sull'accordo firmato nel 2021 tra Ue e Qatar per aggiornare le regole per i voli
tra il Paese del Golfo e l'Unione, che è già applicato ma deve essere ratificato
dagli Stati membri, quindi dall'Ue ma con il consenso del Parlamento Ue (per
completare il processo ci vorranno dai 5 ai dieci anni).
L'intesa prevede per
le compagnie aeree del Qatar la possibilità di operare voli diretti in qualsiasi
aeroporto dell'Ue e viceversa. Ieri l'eurodeputata della Left Leïla Chaibi ha
presentato un emendamento che aggiunge la sospensione dell'accordo Ue-Qatar al
punto 14 della risoluzione che vota oggi il Parlamento in cui si chiede la
sospensione di «tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar,
specie per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti e visite programmate,
fino a quando i sospetti non saranno confermati o respinti».
Eurotangenti, il
ruggito del Ppe: «Non è un Qatargate, ma uno scandalo socialista».
Valerio
Falerni su Il Secolo d’Italia il 15 Dicembre 2022.
Lo scandalo
delle eurotangenti fa scricchiolare la cosiddetta “maggioranza Ursula” in auge
a Strasburgo e a Bruxelles. A rompere la tregua è un ruggente tweet con cui
il Ppe ha deciso di parlare il linguaggio della chiarezza. «Dobbiamo affrontare
questa ipocrisia – vi si legge -: il gruppo dei socialisti, “il più santo dei
santi” è l’epicentro del Qatargate ed è ora che siano ritenuti responsabili. Le
loro lezioni sullo stato di diritto si sono ora dimostrate ipocrite». Della
serie: pane al pane e vino al vino. Il tutto a poche ore dal voto
dell’Eurocamera sul testo unitario di condanna dell’eurocorruzione.
Probabilmente, a consigliare al Ppe di rompere la tregua con i socialisti è
stato il timore di un giudizio forfettario sull’accaduto.
Tweet dei Popolari
incrina la “maggioranza Ursula”
Da qui la decisione
di passare all’attacco. «C’è stato uno sforzo costante per trasformare il
Qatargate in una questione esclusivamente istituzionale – si legge ancora
nel tweet -. Ma questo scandalo non è orfano. Non è apparso dal nulla. Non è
successo da solo. Ha un nome. Ha un indirizzo. E questo è il gruppo S&D». E a
beneficio di chi eventualmente non avesse capito, il Ppe ha allegato una foto
che riporta la scritta «non è il Qatargate ma uno scandalo S&D». La sortita
dei Popolari europei interessa moltissimo anche il nostro Paese, che rischia di
veder classificato come italian job lo scandalo qatariota.
Ma il Qatargate non
è neanche un italian job
Inutile rimarcare
che a tanto contribuisce anche parte della nostra stampa mainstream. Ma è uno
scandalo socialista. Del resto, tutto ruota intorno alle ong. Le stesse che,
come ha spiegato agli inquirenti uno degli arrestati, Francesco Giorgi, «servono
a far girare i soldi». I soldi della corruzione, per l’appunto. Vale per i
diritti umani in Qatar, vale per l’accoglienza dei migranti (vedi suocera
di Soumahoro), vale per le coop (vedi il Buzzi di Mafia Capitale: «Rendono più
della droga»). Un sistema, insomma, da sempre incarnato nella sinistra. Ecco
perché ha ragione il Ppe a dire che il pasticciaccio brutto di Bruxelles «non è
un Qatargate». Né, aggiungiamo noi, un italian job.
Estratto
dell’articolo di Gianni Barbacetto per il “Fatto quotidiano” il 15 Dicembre
2022.
[…] L'arresto di
Antonio Panzeri ha scoperchiato uno scandalo che ha per protagonisti
sindacalisti, politici e persone di sinistra che avrebbero dovuto difendere i
diritti dei lavoratori e invece accettavano (tanti) soldi (dal Qatar e non solo)
per convincere l'Europarlamento che i 6 mila operai morti nei cantieri dei
Mondiali (fonte The Guardian) erano uno scherzo […]
[…] temo che questa
storia di corruzione sia una conseguenza patologica dell'affarismo praticato da
anni da una parte della sinistra italiana.
Panzeri è cresciuto
nel Pci come fedelissimo di Massimo D'Alema ed è politicamente figlio di quel
Filippo Penati che era stato sindaco Pci di Sesto San Giovanni e poi, da
presidente della Provincia di Milano, decise di comprare (con soldi pubblici, e
a caro prezzo) dal costruttore e re delle autostrade Marcellino Gavio la
maggioranza della Milano-Serravalle. Gavio incassò 238 milioni, vendendo a 8,93
euro azioni che solo diciotto mesi prima aveva pagato 2,9 euro e realizzò una
plusvalenza di 176 milioni.
Penati dissanguò le
casse della Provincia per acquistare una autostrada che […] era già a
maggioranza pubblica. […] Gavio utilizzò una parte di quelle plusvalenze (50
milioni) per appoggiare le scalate dei "furbetti del quartierino", sostenendo
Giovanni Consorte, il presidente di Unipol (la compagnia d'assicurazioni delle
coop rosse, legata al vecchio Pci), nella sua scalata alla Banca nazionale del
lavoro.
E Penati fu premiato
da Pier Luigi Bersani che lo chiamò a diventare il capo della sua segreteria
politica. In quella stessa, cruciale estate del 2005, Piero Fassino, allora
segretario dei Ds, telefonò a Consorte (intercettato) e gli pose la domanda
destinata a entrare nella storia politica italiana: "Allora, abbiamo una
banca?". Era la Bnl, che Consorte credeva di aver conquistato.
[…] Bersani chiama
"la Ditta" quel gruppo politico proveniente dal Pci […] "La Ditta" […] connota
un gruppo in cui la lunga pratica del potere e la consolidata abitudine a
governare hanno avuto l'effetto di saldare la politica con gli affari. Con il
rischio di far via via prevalere gli affari sulla politica. […]
Superiorità
morale, così crolla la bugia.
L'opera di
corruzione del Qatar nel Parlamento europeo per favorire una sorta di amnesia
collettiva - e istituzionale - su come i diritti umani vengono calpestati in
quel Paese, ha avuto un unico interlocutore e protagonista: la sinistra. Augusto
Minzolini il 12 Dicembre 2022 su Il Giornale.
A volte si rimuovono
il passato e le proprie convinzioni ideologiche ed etiche in un batter d'occhio.
Con un colpo di spugna si cancella dalla memoria ciò che si è predicato per
mezzo secolo. L'opera di corruzione del Qatar nel Parlamento europeo per
favorire una sorta di amnesia collettiva - e istituzionale - su come i diritti
umani vengono calpestati in quel Paese, ha avuto un unico interlocutore e
protagonista: la sinistra. Questo, almeno per adesso, è un dato di fatto. E solo
ora, in assenza di una linea di difesa credibile, il commissario europeo Paolo
Gentiloni, ex premier del Pd, ammette: «Penso che la sinistra abbia riconosciuto
che comportamenti di corruzione non sono appannaggio della destra o della stessa
sinistra. I corrotti sono di destra e di sinistra».
Ragionamento che non
fa una piega, perché l'onestà, come la corruzione, non ha colore. Purtroppo,
però, la sinistra, in tutte le sigle cangianti con cui si è presentata negli
anni, ha sempre teorizzato il contrario. È sempre vissuta, da Enrico Berlinguer
in poi, nel mito della propria diversità, pardon della propria superiorità
morale. Un totem che ora viene drasticamente meno. Ciò che è avvenuto a
Strasburgo, infatti, mette fine ad una rendita di posizione di cui per decenni
ex-comunisti, cattocomunisti, sinistra democristiana, ds, margherite, ulivi e
partiti democratici o articoli uno, hanno sempre beneficiato, coltivando
un'illusione - o una maleodorante bugia: quella che gli schieramenti politici
non si formano sulle idee, ma sull'etica.
Ora è rimasto solo
qualche Savonarola da strapazzo a teorizzarlo. Anche perché accettare mazzette
da chi considera nel proprio Paese la vita e la libertà delle persone meno di
niente mentre si mettono in piedi Ong per la difesa dei diritti umani, dimostra
che tutto è in vendita: ideologia, coscienza e anima. Qualcuno ha fatto il
paragone con Tangentopoli, ma neppure questo calza, perché la maggior parte
degli indagati e dei condannati di allora fu mandato al «patibolo morale» per
finanziamento illecito ai partiti, cioè le mazzette nella maggior parte dei casi
- non tutti, perché i mascalzoni ci sono sempre stati - servivano a tenere in
piedi un'attività politica, cioè coltivare nella società idee, appunto, di
centro, di destra o di sinistra. Qui, invece, il paravento degli ideali di
libertà e di rispetto della vita umana servono solo a consegnare le vittime che,
sulla carta, si difendono ai carnefici. Appunto, si vende l'anima al diavolo.
Per cui non c'è
alibi, motivazione, ragione che in questo caso possa coprire il marcio. Questa
vicenda è la pietra tombale sulla diversità della sinistra perché la corruzione
investe l'ultima bandiera di quel mondo, cioè la difesa dei diritti umani, delle
libertà e del rispetto dei lavoratori, le battaglie su cui partiti e sindacati
si sono concentrati, dall'immigrazione alla lotta contro le autocrazie. Ma c'è
anche un elemento simbolico da non trascurare. La storiaccia è ambientata in un
posto che la sinistra ormai da anni ha eletto a luogo sacro contro il populismo
e il sovranismo: il Parlamento europeo. E, invece, grazie ai nuovi farisei che
oggi si alimentano di «retorica europeista» come ieri di «questione morale», i
mercanti hanno violato il tempio.
Il bianco e il
nero. "Qatar? A sinistra finalmente sono 'normali'.." "Una vicenda ininfluente"
Il
caso Qatar e il caso Somahoro hanno sconvolto la sinistra. Ecco le opinioni dei
sondaggisti Nicola Piepoli e Antonio Noto. Francesco Curridori il 13 Dicembre
2022 su Il Giornale.
Il caso Qatar e il
caso Somahoro hanno sconvolto la sinistra. Per la rubrica il bianco e il nero
abbiamo raccolto le opinioni dei sondaggisti Nicola Piepoli e Antonio Noto.
La vicenda delle
mazzette arrivate dal Qatar quanto danneggia il Pd e la sinistra?
Piepoli: “Il danno
lo hanno ricevuto dalle elezioni, non dal Qatar. Si sono disfatti, hanno lottato
per perdere e hanno perso. Di questa vicenda mi vien da dire solo questo:
‘Finalmente sono normali, rubano anche loro’. Che, poi, è ciò che pensa anche
l’opinione pubblica. Pensa che sono normali filibustieri, altro che ‘sacre ruote
del carro della vita’. E, in effetti, personalmente, ritengo questa una vicenda
normale e priva di qualsiasi rilevanza politica”.
Noto: “Il Pd è in
calo da mesi. Dalle elezioni a oggi è passato dal 19 al 16%. Non è detto che
subirà un’ulteriore flessione dovuta a questa vicenda. Il vantaggio è che i
parlamentari europei coinvolti sono poco noti. Il problema che si pone in vista
del congresso Pd, casomai, è quello relativo alle regole da darsi per non
incorrere in questi rischi?”
Il caso Somahoro
com’è stato percepito dall’opinione pubblica?
Piepoli: “Non
abbiamo fatto rilevazioni in merito a questo caso, ma posso dire ciò che ho
percepito io. Anche in questo caso si tratta di una normale vicenda che non
appassiona l’opinione pubblica che, in realtà, è molto più interessata all’esito
dei Mondiali di calcio. ‘Panem et circenses’ dell’imperatore Claudio è valido
ora come nel 53 a.C.”.
Noto: “C’è stata una
forte delusione perché Somahoro era diventato un personaggio pubblico. Non sono
i singoli fatti che spostano il consenso però, anche se c’è stata una forte
delusione, non è detto che qualcuno cambi la propria intenzione di voto”.
Minacce alla Meloni.
Il premier passa come vittima oppure ha sfruttato mediaticamente le
intimidazioni ricevute?
Piepoli: “No, la
Meloni è una donna che si fa rispettare. È l’unica donna post-fascista in Italia
ed è riuscita a imporsi in un partito di maschi. Sono convinto che governerà
bene e per cinque anni”.
Noto: “Questi
eventi, invece, colpiscono molto gli italiani che sono molto attenti a queste
cose. Gli italiani si sentono sicuramente vicini al premier e la Meloni ne esce
‘vittima’ in termini politici”.
Alla Meloni
converrebbe elettoralmente ritirare la querela nei confronti di Saviano?
Piepoli: “Ritirare
una querela è sempre un atto d’onore e, se lo facesse, avrebbe la mia
ammirazione. Ma, se non la ritira, fatti suoi. Non è un qualcosa che tocca
l’opinione pubblica. È solo un problema personale. Al Paese interessa che ci
siano più posti di lavoro, non Saviano. Chi è Saviano? Che cosa ha prodotto per
il Paese?”.
Noto: “Il consenso a
un partito politico non cambia come noi cambiamo i programmi televisivi. Il
consenso è più duraturo che cambia in base a più fattori. Dovendo pensare al
proprio elettorato, non dovrebbe ritirare la querela. Se, invece, volesse
rendersi più attraente verso l’elettorato di sinistra che non l’ha votato,
allora dovrebbe ritirarla. Fare una scelta o l’altra non sposta consenso
nell’immediato”.
Regionali nel Lazio
e nella Lombardia. Chi è il favorito?
Piepoli: “I tre
candidati della Lombardia sono tutte persone degne e preparate per governare una
Regione che ha il Pil della Svizzera. Sul Lazio non abbiamo ancora dati. Al
momento, però, posso dire che non c’è alcun favorito certo”.
Noto: “Nel Lazio è
difficile dirlo perché mancano ancora i candidati. Il centrodestra, è avanti, ma
senza il candidato si può dire poco, ma non è certamente un buon segnale. In
Lombardia è avanti Fontana e subito dopo Majorino e la Moratti si contendono il
secondo posto. Secondo i nostri sondaggi il candidato del Pd è un po’ più
avanti, ma per il momento Fontana è avanti in maniera significativa”.
Majorino: "Chi è
Antonio Panzeri", come suicidarsi con una sola frase.
Fabio Rubini su
Libero Quotidiano 15 dicembre 2022
Da quando è
scoppiata "Sinistropoli" è partita la corsa a scaricare le amicizie scomode.
Solo che nell'era della tecnologia sfrenata cancellare foto e video imbarazzanti
è sempre più difficile. Tra queste "riscoperte" c'è anche quella che riguarda
una videoconferenza che ha come organizzatore Pierfrancesco
Majorino eurodeputato del Pd e attuale candidato alla presidenza di Regione
Lombardia - e tra i relatori quell'Antonio Panzeri arrestato nell'ambito del
Quatar-gate, insieme a moglie e figlia. Uno scandalo - e siamo appena all'inizio
- sul quale lo stesso Majorino ha usato parole quasi profetiche: «È un episodio
che riguarda anche noi, non possiamo far finta di nulla».
I fatti. Siamo nel
luglio del 2020, la conferenza è dedicata alla storia di Giulio Regeni e infatti
s' inititola "Giulio fa cose". Nell'ambito della chiacchierata ovviamente si
tocca il nodo dei diritti umani. E proprio in quest' ottica viene introdotto
l'intervento di Panzeri. A presentarlo, anche con una certa enfasi, financo con
un po' di emozione, è Majorino, del quale trascriviamo fedelmente le parole: «La
violazione dei diritti o la capacità di tollerare la violazione dei diritti non
possono in alcun modo non mobilitare al massimo le energie europee. Sono il
contrario dei valori che stanno alla base del progetto politico europeo -
prosegue l'eponente Pd che deve avere al centro la questione dei diritti umani.
Ed è il motivo per cui partiamo con questa nostra chiacchierata chiedendo un
contributo a chi è stato presidente della Sottocommissione dei diritti dell'uomo
al Parlamento Europeo. Innanzitutto chiedendo all'ex presidente ed esperto- e
qui Majorino quasi si entusiasma... mi vien da dire se posso, anche militante in
relazione al grande tema dei diritti umani a livello italiano e non solo,
Antonio Panzeri, di portarci il primo contributo».
È chiaro, lo diciamo
a scanso di equivoci, che Majorino con le mazzette del Quatar non c'entra e che
lo svarione sul «militante dei diritti umani» si può derubricare alla voce
"errore di valutazione". Nulla però ci toglie dalla testa che se al posto di
Panzeri ci fosse stato un esponente di centrodestra, oggi il prode Majorino
sarebbe impegnato nell'organizzazione di una bella manifestazione per chiedere
di fare piazza pulita. Ad oggi, parole a parte, non ci risultano sforzi del
Nostro in tal senso...
Il percorso della
sinistra, da operaia a lobbista.
Federico Novella su
Panorama il 12 Dicembre 2022.
La vicenda Panzeri,
come quelle degli ultimi mesi di altri big italiani del Pd, racconta come sono
sempre più i comunisti che non difendono gli interessi degli ultimi ma
soprattutto i loro stessi Il percorso della sinistra, da operaia a lobbista
Per quanto sia
obbligatorio considerare tutti innocenti fino a prova contraria, lo spaccato che
esce dall’eurotangentopoli in salsa Qatar è desolante per diversi motivi. Il
primo è che tutti i protagonisti politici sono affiliati alla sinistra europea.
A dar retta alle accuse della procura sono loro, i paladini degli ultimi, i
primi a tentare di arricchirsi personalmente. Dal fulcro dell’indagine, Antonio
Panzeri, fino alla vicepresidente del parlamento Kaili, sacchi di denaro volano
sui bei propositi umanitari di chi dice di lottare per i diritti dei più
sfortunati. Attendiamo i dettagli dell’inchiesta, e soprattutto aspettiamo di
vedere se ci sia qualcosa di più grande sotto la punta dell’iceberg. In
particolare dietro quest’ennesima Ong dal nome che è tutto un programma, “Fight
Impunity” , creatura di Panzeri dal quale si sono dimesse in blocco le
eccellenze italiane ed estere che fino a ieri ne abitavano il board: dalla
Bonino al greco Avramoupolos.
In Italia abbiamo
appena finito di indignarci per il caso Soumahoro, ed ecco arrivare la tempesta
di Bruxelles: vicende diverse, ma equivalenti su un punto: occorre prestare
attenzione a chi si professa buono e pio. La bontà può diventare spesso un
paravento per nascondere traffici quantomeno oscuri. L’altra certezza, mentre la
procura indaga, è che il Parlamento Europeo non sembra esattamente quel palazzo
di vetro che vorrebbero raccontarci. Stando a quanto si legge in queste ore,
somiglia più ai corridoi bui delle Nazioni Unite, dove transita gente di ogni
risma, senza controlli e senza grandi slanci morali. Non poteva che essere così,
dal momento che le istituzioni europee , così congegnate, non hanno mai avuto
reale legittimità democratica. E laddove non c’è trasparenza, prima o poi
arrivano soldi e lobbisti. Il quotidiano “Il Giorno” ha ricordato che 485
deputati hanno lasciato l’europarlamento nel 2019: di questi, il 30% lavora oggi
per gruppi di pressione. Panzeri era uno di questi. La politica delle porte
girevoli spesso non è illegale, ma si sviluppa selvaggiamente all’ombra di
regole deboli e oscure. Come si diceva in principio, sulla materia dei diritti
umani sembra essere la sinistra quella più propensa a coltivare rapporti di alto
livello. Sul secondo lavoro di Massimo D’Alema, cioè quello della consulenza
finanziaria, si è detto molto: ultimamente pare abbia fatto da tramite tra una
cordata di sceicchi del Qatar e il governo, per l’acquisizione della raffineria
Lukoil di Priolo. Nulla di male, per quanto ne sappiamo. Ma quest’abitudine ha
fatto dire al vicesegretario del Pd Provenzano che “vedere grandi leader della
sinistra fare i lobbisti la dice lunga sul perché la gente non si fida più”. E
qui arriviamo all’ultima certezza di questa storia, a prescindere dagli esiti
delle indagini: ad essere morta e sepolta è la cosiddetta “superiorità morale”
della sinistra. La sindrome per cui da quella parte politica ci si arroga il
diritto di distribuire agli avversari patenti di onestà e limpidezza morale. Una
sindrome nata con Tangentopoli, e morta con Qataropoli. Nata con la presunta
difesa dei diritti degli sfortunati, e morta con la difesa dei diritti degli
Emirati.
Dall'intervista di
Brando Benifei ad Andrea Bulleri su "Il Messaggero" il 12 dicembre 2022.
L`immagine
dell`Eurocamera esce molto danneggiata da questa storia.
"Per questo bisogna
agire subito con la massima severità, a tutela di chi ogni giorno in quelle aule
si fa il mazzo per ottenere dei risultati. Bisogna irrobustire le difese
democratiche. A cominciare da una stretta sulle cosiddette "porte girevoli":
basta con gli ex parlamentari che il giorno dopo si mettono a fare i lobbisti"
Professione
indignati. Il Qatargate e l’eterno ritorno dello scoop populista e giudiziario.
Cataldo Intrieri su L’Inkiesta il 16 Dicembre 2022.
Ad alcuni bastano le
foto delle banconote sequestrate per gridare alla corruzione. Ma a un tribunale
serve molto di più: capire chi ha dato i soldi a quale funzionario e soprattutto
per fare che cosa. Senza queste risposte può essere una normale attività di
lobbying o al massimo un traffico di influenze
Ogni volta che
esplode un qualsiasi straccio di scandalo, fioriscono articoli densi di sdegno,
reprimende e autodafé. Lo stesso vale anche per l’ultimo arrivato: il Qatargate.
Pensate: un paese semidesertico di poco più di due milioni di abitanti che vuole
papparsi il Parlamento europeo, 705 membri, senza contare assistenti e personale
amministrativo, in rappresentanza di oltre quattrocento milioni di cittadini.
L’indignato speciale
che dorme in ogni animo di benpensante “de sinistra” non va mai in vacanza, al
massimo si appisola in attesa di potersi risvegliare al primo refolo. E che
sollievo, vuoi mettere, liberarsi di certo estenuante garantismo per far sfogare
il forcaiolo dentro di noi, per gridare vergogna (sempre agli altri) e per
minacciare di costituirsi parte civile in un processo che ancora deve iniziare?
E poi diciamo la
verità: cosa vuoi difendere di fronte alle foto di mazzette, debitamente
impilate, alle intercettazioni dove il sapiente dispensatore di verbali si è
preso la briga pure di tradurre il termine combine in intrallazzo, che suona
meglio? Ma anche di fronte alle prime notizie di confessioni come si può
reagire? In fondo sono tutte “voci di dentro”, beninteso, ma sono anche le
uniche che abbiamo finora, e ci si arrangia con quelle.
Vogliamo mettere
l’antropologia criminale che i volti, il tenore di vita, il sito Instagram degli
inquisiti suggeriscono come assolutamente sovrapponibile a quello di un
qualsiasi elettore di destra? E invece è gente “de sinistra”. E addirittura,
come nel caso di Antonio Panzeri, a sinistra della sinistra.
Il can can è sempre
lo stesso, lo abbiamo visto già in altre inchieste, alcune coronate da successo,
altre no, ma tutte accomunate dagli stessi iniziali toni trionfalistici. Il che
dovrebbe far pensare che il garantismo, ancorché vigorosamente sputtanato (è il
caso di dirlo) dal berlusconismo e dalla parentela di una prosperosa ragazza
marocchina (guarda un po’ la coincidenza) col rais Mubarak, altro non è che un
sano smagato scetticismo verso l’eterno ritorno del sempre uguale scoop
giudiziario, uno dei pochi pilastri su cui si regge l’esangue stampa di casa
nostra (sui giornali stranieri come il Financial Times e il Guardian di Qatar e
Marocco non se ne trova traccia se non nelle pagine dedicate al mondiale).
Non si tratta di
negare la realtà quanto di porsi allo stato delle cose qualche domanda e almeno
un preoccupante interrogativo.
Innanzitutto, ferme
restando le vivide immagini delle mazzette impilate, non è dato sapere a che
cosa concretamente servissero i soldi in questione oltre ad arricchire gli
indagati che li percepivano come mediatori di ulteriori illeciti favori che
sarebbero dovuti essere concessi da parlamentari europei. al comprensibile e
nobile moto d’indignazione, le foto dei pacchi di soldi servono a ben poco se
non si individua il pubblico ufficiale quale utilizzatore finale e soprattutto
la specifica attività legata alla sua funzione e oggetto della corruzione.
In Italia si
tratterebbe si è no di “traffico di influenze illecite” (articolo 346 bis del
codice penale) punito con pene assai modeste (fino a quattro anni e sei mesi).
Un reato che non
consentirebbe neanche le intercettazioni e che punisce l’intermediazione tra un
privato che chiede e un pubblico ufficiale che dispone. Inoltre si tratta di un
reato di difficile applicazione perché a mezza strada tra quello più grave di
corruzione (i soldi dati al pubblico ufficiale) e una normale e lecita attività
di lobbying
Qui subentra il
secondo quesito: a chi erano destinati quei soldi e cosa si doveva ottenere
dalle istituzioni europee? Ebbene, un altro mistero allo stato delle cose. Il
Parlamento europeo è un’assemblea che non ha iniziativa legislativa (che è della
assai più potente Commissione), ma è responsabile dell’adozione della
legislazione dell’Unione insieme al Consiglio, l’organo che riunisce i ministri
dei governi dei 27 Stati membro. Cioè può agire in concerto con il Consiglio e
modificare norme europee, ma non può presentarle da sola.
Se, come leggiamo,
con quei soldi così ben impilati, si doveva “modificare una percezione” verso un
qualche illiberale paese arabo, piaccia o meno siamo nell’ambito di un’attività
di lobby, opaca ed eticamente censurabile, ma nulla più di questo. Roba da
indignati in servizio attivo, appunto.
Meriterebbe invece
una più attenta riflessione la singolare modalità dell’indagine originata, a
quanto leggiamo, da un’iniziativa dei servizi segreti belgi, che hanno agito
senza dare notizia all’autorità giudiziaria, intercettando e perquisendo le
abitazioni degli indagati senza alcuna preventiva autorizzazione prima di
investire la magistratura ordinaria.
Il Belgio ha
un’efficiente e dedicata agenzia specificamente destinata alla lotta contro la
corruzione, l’OCRC (l’Ufficio centrale per la repressione della corruzione, una
branca della polizia giudiziaria federale) sicché non è ozioso chiedersi come
mai siano intervenuti i servizi e cosa cercassero per potere giustificare delle
eccezioni così eclatanti allo Stato di diritto (capirei atti di terrorismo ma
avrei difficoltà ad accettarlo, confesso, per una storia di lobbying
prezzolato).
Appartengo a una
generazione abituata a diffidare dei servizi segreti (per capirne i motivi
suggerisco di rivedere su RaiPlay le puntate straordinarie de La Notte della
repubblica di un giornalista vero, Sergio Zavoli). Il segreto non va bene con la
trasparenza della democrazia. Soprattutto rilevo che un’indagine come questa,
condotta da un giudice che è una via di mezzo tra Di Pietro e Carofiglio (e già
questo…) ancor prima di individuare possibili colpevoli singoli, ha già buttato
discredito sulle istituzioni europee, le stesse che hanno mantenuto salda
l’Unione europea negli anni terribili della pandemia e oggi della guerra.
Si cerchino, ci
mancherebbe, le responsabilità singole, si eviti cortesemente, per amore di
scoop, vieto moralismo e rancore politico di fare l’ennesimo favore ai
sovranismi nemici della democrazia. Non ce n’è bisogno, se non per i nemici
dell’Europa libera. Si cessi di alimentare, una buona volta, il populismo
demolitorio che poi ipocritamente si condanna quando ormai è troppo tardi.
Qatargate, tutte
le falle del Parlamento Ue: pochi controlli, molti conflitti d’interesse, tenui
sanzioni.
Franco Stefanoni su Il Corriere della Sera il 15 Dicembre 2022.
Problemi e rimedi
secondo Federico Anghelè di The good lobby. «A fronte di tanta burocrazia
preventiva, le verifiche ex post risultano lasche»
Rendere obbligatorio
il Registro della trasparenza per Parlamento europeo e Consiglio europeo come
già accade per la Commissione europea; poter monitorare l’agenda degli incontri
di lavoro dei parlamentari di Strasburgo; autorizzare controlli indipendenti su
tutte e tre le istituzioni cardine della Ue; regolare il fenomeno delle «porte
girevoli» che consente agli ex eurodeputati di accedere agli uffici delle
istituzioni; bloccare il cortocircuito causato da quel 30% e passa di
parlamentari che, una volta eletti, non lasciano la propria attività
professionale. Sono i suggerimenti di Federico Anghelè, direttore di The good
lobby (Ong impegnata a difendere la cultura partecipativa dei cittadini), per
evitare altri inciampi alle istituzioni Ue alla luce dell’inchiesta belga su
presunte tangenti da parte di Qatar e Marocco in favore di parlamentari disposti
a parlar bene di quei governi. Milioni di euro in cambio di «favori d’immagine».
«Double check»
Frotte di lobbysti
puntano quotidianamente sulle istituzioni Ue poiché per loro è spesso vitale
ottenerne l’ascolto. Tutto fisiologico e consentito, a patto di muoversi nel
rispetto della legge e di essere trasparenti. A Bruxelles e Strasburgo le regole
in tal senso valgono tuttavia solo per alcuni. «La Ue, con oltre 30 mila
lobbysti a Bruxelles (capitale dei gruppi di pressione seconda solo a
Washington, ndr), è considerata un faro della trasparenza», racconta Anghelè,
«ma in realtà esistono ampie falle, specialmente in Parlamento». Il Registro
della trasparenza, a cui sono iscritti oggi oltre 13 mila soggetti (aziende,
società di lobbying, Ong, associazioni di categoria, sindacati, studi legali,
confessioni religiose) e la cui inclusione consente di operare con le
istituzioni, è ritenuto poco efficace. Infatti, da un lato i dati dei soggetti
(fatturati, personale, storia ecc) non sono omogenei rendendoli poco affidabili.
Dall’altro solo la Commissione europea (commissari e alti funzionari), ovvero
l’organo esecutivo, ha l’obbligo di dichiarare le attività e gli incontri avuti
con le lobby. Qui il controllo è a cosiddetto «double check»: quanto
verbalizzato dal lobbysta e quanto dalla Commissione deve coincidere.
Le scelte dei gruppi
Non funziona così
però con i 705 parlamentari che legiferano e votano risoluzioni. Nessun obbligo:
gli incontri restano discrezionali, autonomi e privati. «La mancanza di vincoli
(eccetto la denuncia dei regali ricevuti, ndr) è rivendicata dagli eurodeputati
in base al principio della libertà di azione per chi è eletto», spiega il
direttore di The good lobby, «una indisponibilità tuttora inscalfibile». Anche
se va detto che obblighi sussistono in Parlamento per i relatori dei dossier
seguiti, per i presidenti di commissione e per i cosiddetti «relatori ombra»,
ovvero delle minoranze politiche. Inoltre, per quanto i singoli eurodeputati
siano svincolati dal rendere conto di ciò che fanno, i gruppi parlamentari a cui
appartengono possono decidere diversamente fissando regole autonome. Come
segnala Transparency international Ue, primi nel collaborare sono i Verdi, meno
accade invece con S&D e Ppe, molto meno con le destre.
Porte girevoli
Tra il giugno 2019 e
il luglio 2022 a Bruxelles e Strasburgo gli incontri di lobbysti con il
Parlamento sono stati circa 28 mila, ma solo metà resi pubblici secondo le
regole del registro. I Paesi più virtuosi risultano il Lussemburgo (100%), la
Svezia (95%) e la Danimarca (93%), mentre in fondo alla classifica si trovano
Lettonia (25%), Cipro (17%) e Grecia (10%). Un conto però sono le autorizzazioni
e le dichiarazioni ex ante, un altro le verifiche ex post. «Il punto», conferma
Anghelè, «è che a fronte di una grande mole di burocrazia preventiva, spesso
esagerata, i controlli successivi scarseggiano, sono laschi». Non esistono
organi indipendenti che verifichino il rispetto delle regole da parte di
Consiglio, Commissione e Parlamento europeo. La sola sanzione in caso di
violazione da parte del lobbysta (che dal 2022 può incorrere in verifiche
amministrative) è il ritiro della tessera del registro. In più, mentre per la
Commissione è previsto un «periodo di raffreddamento» da uno a tre anni durante
il quale commissari e alti funzionari che lasciano l’ente non possono operare su
ciò di cui si occupavano - trasformandosi in lobbysti -, questo per i
parlamentari non è previsto. Avviene così il fenomeno delle «porti girevoli»,
come sarebbe accaduto con Antonio Panzeri, ex eurodeputato e poi fondatore della
Ong Fight impunity (cosa che gli permetteva di avere accesso facile alle
istituzioni). «Oggi chi termina con la presenza di un seggio in Parlamento ha
diritto a un’indennità, per ricollocarsi», ricorda il direttore di The good
lobby, «ma io credo che sia necessario, anche per loro, un periodo di
raffreddamento di almeno un anno».
Francia, i dubbi
sui rapporti con gli emiri.
Anche a Parigi
divampa la polemica, l’opposizione chiede chiarezza. Lodovica Bulian il 16
Dicembre 2022 su Il Giornale.
Il Qatargate non più
letto solo come un «italian job». Gli altri Paesi europei accendono i riflettori
su legami con l'Emirato. Tra diffidenze e sospetti reciproci, lo scandalo
all'Europarlamento scuote le assemblee parlamentari degli Stati. Secondo il sito
Politico Eu, le polemiche divampano in Francia. L'opposizione chiede di
accendere un faro sui rapporti stretti e di lunga data tra Parigi e il Qatar.
Affari dalla sicurezza, all'energia alla cultura. Lo stato del Golfo ha
investito molto in Francia e possiede una delle squadre di calcio di punta del
paese: il Paris Saint-Germain, scrive Politico. Martedì, il governo francese si
è confrontato all'Assemblea nazionale con l'opposizione sulle norme nazionali in
materia di lobbismo. Il quadro, ha affermato un parlamentare socialista, non è
adatto a prevenire possibili tentativi di corruzione da parte di paesi
stranieri. «I fatti sono gravi, spetta alle istituzioni europee far luce su di
essi e trarne le conseguenze», ha risposto il sottosegretario Olivia Grégoire,
aggiungendo però che l'esecutivo è aperto a rivedere le regole per renderle più
restrittive. Il Qatar è il quarto paese più visitato da parlamentari e senatori
francesi dal 2019. Di questi, 12 hanno trascorso un totale di 38 giorni
nell'Emirato, rivela il sito. I viaggi sarebbero stati finanziati direttamente
dallo stato del Golfo, come evidenziano alcuni documenti ufficiali citati da
Politico. Documenti che però non forniscono informazioni su budget e spese. Ora
i sospetti dilagano. E del resto la procura finanziaria francese da tempo indaga
su ipotesi di corruzione relative all'assegnazione al Qatar della Coppa del
Mondo 2022 e al ruolo svolto da funzionari francesi di alto rango. Anche in
Francia erano scoppiate violente polemiche sull'assegnazione della Coppa a Doha.
A novembre, alcuni parlamentari di sinistra avevano denunciato pubblicamente le
intense attività di lobbying del Qatar per far cambiare idea sulla tutela dei
diritti nell'Emirato.
Claudio Antonelli
per “la Verità” il 19 dicembre 2022.
Lo scorso settembre,
a meno di due mesi dall'avvio dei Mondiali di calcio in Qatar, un lobbista e
imprenditore franco-algerino, Tayeb Benabderrahmane, ha potuto far rientro a
Parigi dopo quasi due anni di detenzione a Doha. Per la precisione era già stato
rilasciato dal carcere duro a luglio, ma non gli era stato consentito il
rimpatrio prima di firmare un accordo di segretezza e organizzare uno scambio di
chiavette Usb contenenti video e documenti segreti. Difficile sapere che ci
fosse dentro.
Dalle inchieste
giornalistiche di Liberation, le ipotesi emerse sarebbero due. Materiale
ricattatorio nei confronti del presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, nonché
stretto amico dell'emiro del Qatar, oppure informazioni di natura più ampia e
quindi in grado di dipanare una rete incredibile di corruzione partita dal Qatar
e arrivata fino a Parigi, dove avrebbe messo radici stabili.
Le versioni
potrebbero essere entrambe vere. La prima giustificherebbe le accuse del
presidente del Paris Saint-Germain che, tramite gli avvocati, avrebbe denunciato
un ricatto da circa 100 milioni di dollari. La seconda aprirebbe una strada ben
più complicata che andrebbe a intrecciarsi con l'inchiesta che ha già portato in
tribunale l'ex presidente Nicolas Sarkozy, condannato nel 2021 in primo grado di
giudizio a un anno di carcere per presunto finanziamento illecito.
Nel 2010, il 23
novembre per l'esattezza, l'ex capo dell'Eliseo tenne una cena con l'emiro Hamad
Al Thani, Michel Platini e Sebastien Bazin, all'epoca proprietario del Psg. Da
quell'incontro la posizione della Francia è cambiata in sede Fifa. E guarda
caso, dopo il voto a favore dei Mondiali da tenersi in Qatar, il fondo sovrano
di Doha ha portato a casa l'acquisizione della celebre squadra parigina. Non
solo. Da lì è scattata una larga pianificazione di investimenti (quelli
immobiliari tutti defiscalizzati) dalle quote in Total fino al gruppo Lagardere,
passando alla riqualificazione delle banlieue e borse di studio per siriani da
ospitare direttamente alla Sorbona.
A dare il benestare
all'accordo, che come contropartita aveva una forte defiscalizzazione degli
investimenti immobiliari qatarioti in Francia, fu inizialmente Sarkozy. Poi
Hollande mise il sigillo su tutto. «L'Aneld - associazione nata sull'onda della
vittoria di Obama nel 2008, che raggruppava esponenti politici locali di seconda
generazione - oggi tace ma il problema dell'infiltrazione dei fondi qatarioti
rimane.
Quei fondi hanno
penetrato strati che vanno ben oltre quelli superficiali della finanza e dei
conti economici, questo è il problema», si legge in un articolo di
approfondimento di Le Monde. Restano le parole del presidente dell'Aneld, Kamel
Hamza, pronunciate nel 2012, come segno di inadeguatezza e di incapacità di
leggere i tempi, se non peggio: «Il tasso di disoccupazione giovanile in certe
zone urbane sensibili raggiunge il 40%. Non capisco perché il Qatar non ci
dovrebbe aiutare».
Pubblicamente,
nessuno chiese che cosa Doha avrebbe chiesto in cambio. Pubblicamente, nessuno
continua a chiederlo. Nemmeno a Emmanuel Macron, che è andato in scia ai suoi
due predecessori e che è riuscito a sfruttare i rapporti con Doha per piazzare
commesse militari di ingente valore. Alla luce, però, delle inchieste
giudiziarie che in questi giorni stanno toccando i socialisti europei e il
Pd-Articolo Uno italiano, è obbligo chiedersi che cosa succederà alle inchieste
giudiziarie al momento soffocate in Francia.
E, inoltre, è
obbligo chiedersi con quale indipendenza la Francia abbia preso scelte politiche
che hanno cambiato le sorti del Mediterraneo e pure quelle del nostro Paese.
Basta seguire la scansione temporale. Tra marzo e ottobre del 2011 una compagine
internazionale guidata da Sarkozy e sostenuta dal dem Obama depone e poi fa
uccidere Muhammar Gheddafi. Si apre la strada alle cosiddette primavere arabe e
alla corsa della Fratellanza musulmana, la stessa sostenuta da Doha. Mentre si
disgregano i nostri interessi e si rompono gli equilibri storici anche in
Tunisia ed Egitto, l'avanzata qatarina non ha rivali.
Nel frattempo
all'Eliseo cambiano ben due inquilini, ma quando nel 2019 in Libia siamo a un
nuovo punto di svolta e c'è la possibilità di cambiare le carte in tavola, Doha
sfodera un nuovo asso nella manica. L'amicizia nata a partire dal 2014 con gli
esponenti piddini italiani, alias Matteo Renzi. Così, nonostante i progetti di
Khalifa Haftar fossero noti a tutti gli osservatori internazionali, in Europa si
è mossa solo la Francia, che per settimane ha aiutato militarmente l'esercito di
Bengasi alla conquista del Fezzan. L'Italia è rimasta a osservare, e si è
trovata schiacciata tra diverse coalizioni con l'unica possibilità di scegliere
il male minore. Mezzo mondo stava con Haftar e solo la Mogherini e l'Onu
sostenevano Tripoli.
Roma non poteva
certo schierarsi con la Russia, anche se gli Usa si erano defilati e il Qatar
controllava le nostre mosse promettendo altri soldi e investimenti in Italia.
Un'eredità che ci portiamo avanti dai governi Renzi e Gentiloni, ma che nemmeno
i successivi esecutivi sono riusciti a spezzare. Risultato? Gli investimenti di
Doha hanno sicuramente influenzato la storia d'Europa. C'è, quindi, il rischio
che le presunte tangenti alle Ong modello Panzeri siano solo una avvisaglia. Se
così fosse ne sarà travolta anche la Francia e tutta la filiera socialista che
fino a oggi ha sostenuto quella parte di mondo arabo. Vedremo come si muoveranno
gli Usa. Potrebbero anche avere qualche registrazione nel cassetto in grado di
ribaltare l'equilibrio del Parlamento Ue. Più Ecr, una spruzzata di Ppe e per un
decennio socialisti in freezer. E fine della carriera di Macron.
Il Qatargate e le
responsabilità di Sarkozy e della Francia. Armi, aerei, il Psg e molto altro in
cambio del sì ai mondiali?
Massimo Nava su Il
Corriere della Sera il 17 Dicembre 2022
Molti indizi portano
a Parigi, addirittura nei saloni dorati dell’Eliseo. In Francia, il Qatar ha
gettato le basi per un’estesa penetrazione nel mondo della finanza, delle
imprese, dei settori immobiliare e alberghiero, delle commesse militari e dello
sport
Onore alla Francia,
se rivincerà il Mondiale. Onore all’Argentina, se porterà la Coppa a Buenos
Aires. E onore a Mbappé e Messi, campioni e avversari, ma compagni del Paris
Saint-Germain, la squadra di proprietà del Qatar. Insomma, come si dice,
comunque vada sarà un successo. Limpido sul piano sportivo, un po’ meno sul
piano politico e finanziario.
Sul Mondiale del
Qatar, oltre alle note denunce per le condizioni dei lavoratori
immigrati impiegati nella costruzione di stadi e infrastrutture, si allungano da
tempo le inchieste giudiziarie sulle circostanze in cui l’Emirato ottenne la
candidatura. La differenza con la storia di mazzette all’Europarlamento potrebbe
risultare di metodo, di modo di intendere il lobbismo, i rapporti di potere, gli
interessi strategici di un Paese.
Molti indizi portano
a Parigi, addirittura nei saloni dorati dell’Eliseo. In Francia, il Qatar ha
gettato le basi per un’estesa penetrazione nel mondo della finanza, delle
imprese, dei settori immobiliare e alberghiero, delle commesse militari e dello
sport. E ha conquistato la candidatura del Mondiale, grazie ai rapporti con l’ex
presidente Nicolas Sarkozy , con alcuni personaggi vicini all’Eliseo e l’ex
stella del firmamento calcistico francese, Michel Platini. Le Monde ricorda che
la prima pietra per la candidatura fu metaforicamente posata proprio da Sarkozy
in un discorso a Doha del 2010, pronunciato in occasione del Forum dello Sport,
organizzato dall’uomo d’affari Richard Attias, compagno dell’ex moglie del
presidente, Cecilia.
Nove anni dopo, è
stata aperta un’inchiesta per corruzione e riciclaggio sotto il poco edificante
titolo di «lobby di Stato». Tutto nascerebbe da un episodio successivo alla
conferenza, un pranzo all’Eliseo in cui si siedono attorno al tavolo Sarkozy,
Platini, il principe ereditario del Qatar, Al Thani, il suo primo ministro e
Claude Géant, segretario generale dell’Eliseo, poi incriminato per corruzione
nell’ambito di altre inchieste giudiziarie. Secondo Le Monde, esistono prove che
Sarkozy fosse coinvolto nel promuovere la vittoria del Qatar. Sei mesi dopo quel
pranzo, il Qatar compra il Paris Saint-Germain, entra nel capitale del gruppo
Lagardère e sostiene il lancio del canale televisivo sportivo BeinSports. Il
Qatar inoltre acquista 80 Airbus A350, aerei Rafale, elicotteri Tiger, un
sistema di difesa missilistico a lungo raggio Aster 30. Michel Platini, a capo
dell’Uefa, vecchio amico di Sarkozy, fu sempre favorevole alla candidatura degli
Stati Uniti. Ma poi cambiò idea. Platini assicura a Le Monde di aver «preso la
decisione di votare per il Qatar ben prima del pranzo all’Eliseo».
Ma proprio Sepp
Blatter, presidente della Fifa dal 1998 al 2015, ha richiamato l’importanza del
pranzo all’Eliseo. «Platini mi disse che Sarkozy gli aveva raccomandato di
votare per il Qatar», ha dichiarato nel novembre 2021. Il contenuto del famoso
pranzo all’Eliseo è chiuso negli archivi di Stato e protetto dal segreto almeno
fino al 2038. Anche la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
(Cada) ha emesso un parere negativo all’inizio di gennaio 2021, adducendo come
motivazione «la tutela degli interessi fondamentali dello Stato nella sua
politica estera o nella semplice conduzione delle sue relazioni estere».
Il 2 dicembre 2010,
il Comitato esecutivo della Fifa votò, tra lo stupore di tutti, a favore
dell’Emirato come Paese ospitante della Coppa del Mondo 2022. La delegazione
americana, guidata dall’ex presidente Bill Clinton, era furiosa. «Ho votato per
il Qatar - ha poi detto Platini - in nome dello sviluppo del calcio in una
regione che non aveva mai avuto una Coppa del Mondo». Come riporta Le Monde,
Sébastien Bazin, amministratore delegato del gruppo alberghiero Accor e allora
rappresentante europeo di Colony Capital, voleva sbarazzarsi del Psg, un club
fortemente indebitato e la cui reputazione era macchiata da risse tra ultras. E
avrebbe voluto venderlo al Qatar. Per farlo, contò sulla buona volontà del
vecchio amico Nicolas Sarkozy. L’acquisizione del Psg è stata una condizione per
il sostegno della Francia alla candidatura del Qatar? Come rivelato da
Mediapart, Sébastien Bazin, che è stato ascoltato nella primavera del 2022 dai
giudici istruttori come «imputato libero», in un sms assicurò che la cosa fosse
fattibile. Il 10 dicembre 2010, una nota di Olivier Buquen, capo della
delegazione interministeriale per l’intelligence economica, ha illustrato i
numerosi vantaggi che deriverebbero dall’assegnazione del torneo
all’emirato. Tutto doveva ancora essere fatto in Qatar: stadi, alberghi,
trasporti, ecc. «Oltre ai 55 miliardi di dollari di progetti infrastrutturali
già in corso, 45 miliardi di dollari doveva essere assegnati sotto forma di PPP
(partenariati pubblico-privati)», si legge nella nota, che propone di
«sensibilizzare le imprese francesi potenzialmente interessate a questi mercati
e di mettere in atto meccanismi di sostegno per i contratti strategici». « Gli
interessi militari e diplomatici francesi - scrive Le Monde - sembrano aver
pesato a favore della candidatura del Qatar».
Bazin ha dichiarato
a Le Monde che le trattative per il PSG sono state «senza alcuna considerazione
o condizione se non quella finanziaria». Laurent Platini, figlio del campione è
stato assunto «dopo una serie di colloqui» nel dicembre 2011 come «consulente»
per Pilatus Sport Mgmt, una holding di proprietà del fondo qatariota QSI, che
gestisce il marchio di attrezzature Burrda Sport. Michel Platini ha detto a Le
Monde: «Mio figlio prende le sue decisioni sulla sua vita professionale. Non ha
bisogno di me, non mi ha mai chiesto nulla. Non c’era nessuna contropartita
diretta o indiretta... laterale, verticale o spaziale al mio voto. L’Fbi, la
giustizia svizzera e quella francese hanno indagato e stanno ancora indagando:
non hanno trovato nulla. Possono cercare, fare il loro lavoro, non troveranno
nulla, perché io non sono stato corrotto». L’Emirato moltiplicherà i gesti di
affetto verso l’entourage di Nicolas Sarkozy. Come rivelato da Mediapart, il
Qatar accoglierà una richiesta di Claude Géant del 2011, che vuole che l’Emirato
offra un contratto a Znz Group, la società del comunicatore François de La
Brosse, che ha lavorato per la campagna di Nicolas Sarkozy nel 2007, poi come
consigliere dell’Eliseo. Così, 600.000 euro sarebbero stati pagati dal Qatar al
signor de La Brosse a partire da settembre 2011, su oltre 2 milioni di euro
previsti. De La Brosse ha fatto sapere che questo «primo pagamento corrispondeva
al web design e allo sviluppo informatico della piattaforma I love Qatar, che
doveva promuovere i meriti del turismo nell’emirato, oltre al costo dell’invio
di un’équipe per le riprese e il montaggio di “trenta clip di quattro minuti”».
Questo capitolo della vicenda si è sommato a un’altra indagine giudiziaria,
quella sui sospetti di finanziamento libico della campagna elettorale di
Sarkozy, nel 2007.
L’Emirato ha avuto
attenzioni per altri membri della cerchia ristretta di Sarkozy. Nel marzo 2012,
una fondazione di diritto privato, il Centro Internazionale per la Sicurezza
dello Sport (ICSS) ha sovvenzionato, per 150.000 euro all’anno, una cattedra
dedicata a «etica e sicurezza nello sport» presso l’Università di
Paris-I-Panthéon-Sorbonne, dove insegna Sophie Dion, responsabile del master,
consigliera per lo sport dell’ex presidente Sarkozy e presente al famoso pranzo
all’Eliseo. La signora Dion, ex vicepresidente del gruppo di amicizia
Francia-Qatar all’Assemblea nazionale, durante il suo mandato di deputato
dell’Alta Savoia (2012-2017), ha però detto di aver «ricevuto solo 13.000
euro» nel quadro di questo «partenariato» tra Paris-I e l’ICSS. Dopo la
sconfitta del 2012, Nicolas Sarkozy si è praticamente ritirato dalla politica e
si è concesso qualche vacanza in Qatar prima di intraprendere la carriera di
oratore, come rivelato da Le Canard Enchaîné, nell’ottobre 2012.
Secondo Libération nel 2014, sulla base di documenti dell’inchiesta, Sarkozy
intendeva raccogliere finanziamenti per alimentare un fondo di investimento. Nel
2012, il Qatar ha soccorso un altro amico di Sarkozy, Arnaud Lagardère, in
difficoltà alla guida della sua azienda. La Qatar Holding ha acquisito il 12,8%
del capitale di Lagardère. Dopo il tentativo fallito di tornare in politica nel
2016, Sarkozy è entrato nel 2017 nel consiglio di amministrazione del gruppo
Accor, come presidente del «comitato di strategia internazionale». Sarkozy, che
entrerà anche nel consiglio di amministrazione del gruppo Lagardère nel 2020,
arriva al momento giusto nel gruppo alberghiero: Accor, che è già sponsor di
maglia del Psg dal 2019, beneficerà anche di altri succosi spin-off dalla Coppa
del Mondo, fra cui una partnership per gestire l’accoglienza dei tifosi in una
rete di 66.000 camere. Intervistato dal Journal de Dimanche, Sarkozy ha
stigmatizzato il boicottaggio della competizione da parte di alcune municipalità
francesi che hanno deciso di non organizzare maxi schermi pubblici e ha
criticato in particolare il suo successore, il socialista François Hollande e la
sindaca di Parigi, Anna Hidalgo. «Il calcio è uno sport universale e ogni
regione del mondo dovrebbe essere in grado di organizzare una competizione
internazionale. Il calcio non appartiene solo agli occidentali. È uno sport che
unisce le persone. Tutti i Paesi che hanno organizzato grandi eventi
internazionali sono stati oggetto di molte polemiche: Cina, Russia, Brasile e
ora Qatar. Dovremmo dare a ciascuno di questi Paesi ospitanti la possibilità di
dimostrare il proprio know-how e aspettare di vedere come si svolgono questi
eventi prima di giudicarli». «Non sono stato io a vendere i Rafale. Il mio
successore deve aver giudicato che era una decisione corretta. Quanto al
boicottaggio, mi sembra che il Comune di Parigi sia molto contento che i
qatarini siano proprietari e finanziatori del club della capitale. Questa
polemica è piuttosto ipocrita».
"Mondiale in
cambio dell'acquisto del Psg". Il Qatargate e le responsabilità di Sarkozy.
I
legami sospetti tra l'ex presidente Sarkozy e il Qatar sono al centro di
un'indagine per corruzione. Lo scorso settembre Sarkò era stato condannato a un
anno di reclusione per finanziamento illecito. Roberto Vivaldelli il 18 Dicembre
2022 su Il Giornale.
Continua a tenere
banco lo scandalo Qatargate. Alla vigilia delle finali dei Mondiali di Calcio
che vedranno Francia e Argentina contendersi la Coppa, emergono ombre
sull'Eliseo e sui rapporti a tinte fosche tra Parigi e l'emirato. Soprattutto ai
tempi di Nicolas Sarkozy, condannato nel settembre 2021 a un anno di carcere
senza condizionale per "finanziamento illecito". Come riporta Massimo Nava
sul Corriere della Sera, è proprio in Francia che il Qatar ha gettato le basi
per un’estesa penetrazione nel mondo della finanza, delle imprese, dei settori
immobiliare e alberghiero, delle commesse militari e dello sport. Doha si
guadagnò l'assegnazione del Mondiale probabilmente grazie ai rapporti con l’ex
presidente Nicolas Sarkozy. Ecco come.
L'inchiesta di Le
Monde
In un articolo
pubblicato lo scorso 14 novembre, Le Monde ricorda come, l'11 dicembre 2012, nel
suo primo discorso dopo la sconfitta rimediata alle elezioni presidenziali
contro Francois Hollande, Sarkozy si presentò sul podio del Doha Goals, forum
sportivo finanziato dalla Qatar National Bank e organizzato dall'imprenditore
Richard Attias, vantandosi di aver sostenuto la candidatura dell'emirato. Un
decennio dopo questo discorso, il ruolo di Nicolas Sarkozy – che non ha risposto
alle domande di Le Monde – è al centro dei sospetti della giustizia francese,
nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria aperta, nel 2019, dalla Procura nazionale
finanziere (PNF) per "corruzione attiva e passiva", "riciclaggio" e
"ricettazione" in merito alla controversa assegnazione (14 voti contro 8 per gli
Stati Uniti) dei Mondiali 2022 in Qatar.
In questa fase delle
indagini, sottolinea il quotidiano francese, l'ex presidente della Repubblica
non è stato ascoltato dai due giudici Serge Tournaire, che lo ha già incriminato
nel caso Bygmalion, e Virginie Tilmont. Tuttavia, diversi elementi del
procedimento penale in merito a questa gigantesca operazione di lobbying
statale, dimostrerebbero il coinvolgimento dell'ex presidente nella promozione
dell'assegnazione del mondiale a Doha, emirato con il quale l'ex presidente ha
peraltro forgiato stretti legami.
Quel pranzo
all'Eliseo
Gli occhi degli
inquirenti sono puntati sull'oramai famoso pranzo all'Eliseo del 23 novembre
2010, tre settimane prima del voto della Fifa che sancì l'assegnazione della
competizione all'emirato. Il presidente Sarkozy invitò al suo tavolo il principe
ereditario e futuro emiro del Qatar Tamim ben Hamad al-Thani, il presidente
della Uefa Michel Platini (che pesava quattro voti all'interno del comitato
esecutivo della Fifa), Sébastien Bazin, noto imprenditore e allora presidente
del Paris Saint-Germain. Il sospetto è che Parigi abbia barattato il sostegno a
Doha in cambio dell'acquisizione del club da parte dell'emirato. Secondo Sepp
Blatter, ex presidente della Fifa, Platini gli avrebbe confessato più tardi di
aver dovuto votare per Doha. Sei mesi dopo quel pranzo, il Qatar rilevò il club
parigino, investendo milioni di euro per farlo diventare uno dei più forti al
mondo con ingaggi e investimenti da capogiro. Coincidenza? È ciò su cui dovranno
fare luce i magistrati.
Massimo Nava
per corriere.it il 17 dicembre 2022.
Onore alla Francia,
se rivincerà il Mondiale. Onore all’Argentina, se porterà la Coppa a Buenos
Aires. E onore a Mbappé e Messi, campioni e avversari, ma compagni del Paris
Saint-Germain, la squadra di proprietà del Qatar. Insomma, come si dice,
comunque vada sarà un successo. Limpido sul piano sportivo, un po’ meno sul
piano politico e finanziario.
Sul Mondiale del
Qatar, oltre alle note denunce per le condizioni dei lavoratori immigrati
impiegati nella costruzione di stadi e infrastrutture, si allungano da tempo le
inchieste giudiziarie sulle circostanze in cui l’Emirato ottenne la candidatura.
La differenza con la storia di mazzette all’Europarlamento potrebbe risultare di
metodo, di modo di intendere il lobbismo, i rapporti di potere, gli interessi
strategici di un Paese.
Molti indizi portano
a Parigi, addirittura nei saloni dorati dell’Eliseo. In Francia, il Qatar ha
gettato le basi per un’estesa penetrazione nel mondo della finanza, delle
imprese, dei settori immobiliare e alberghiero, delle commesse militari e dello
sport. E ha conquistato la candidatura del Mondiale, grazie ai rapporti con l’ex
presidente Nicolas Sarkozy , con alcuni personaggi vicini all’Eliseo e l’ex
stella del firmamento calcistico francese, Michel Platini. Le Monde ricorda che
la prima pietra per la candidatura fu metaforicamente posata proprio da Sarkozy
in un discorso a Doha del 2010, pronunciato in occasione del Forum dello Sport,
organizzato dall’uomo d’affari Richard Attias, compagno dell’ex moglie del
presidente, Cecilia.
Nove anni dopo, è
stata aperta un’inchiesta per corruzione e riciclaggio sotto il poco edificante
titolo di «lobby di Stato». Tutto nascerebbe da un episodio successivo alla
conferenza, un pranzo all’Eliseo in cui si siedono attorno al tavolo Sarkozy,
Platini, il principe ereditario del Qatar, Al Thani, il suo primo ministro e
Claude Géant, segretario generale dell’Eliseo, poi incriminato per corruzione
nell’ambito di altre inchieste giudiziarie. Secondo Le Monde, esistono prove che
Sarkozy fosse coinvolto nel promuovere la vittoria del Qatar.
Sei mesi dopo quel
pranzo, il Qatar compra il Paris Saint-Germain, entra nel capitale del gruppo
Lagardère e sostiene il lancio del canale televisivo sportivo BeinSports. Il
Qatar inoltre acquista 80 Airbus A350, aerei Rafale, elicotteri Tiger, un
sistema di difesa missilistico a lungo raggio Aster 30. Michel Platini, a capo
dell’Uefa, vecchio amico di Sarkozy, fu sempre favorevole alla candidatura degli
Stati Uniti. Ma poi cambiò idea. Platini assicura a Le Monde di aver «preso la
decisione di votare per il Qatar ben prima del pranzo all’Eliseo».
Ma proprio Sepp
Blatter, presidente della Fifa dal 1998 al 2015, ha richiamato l’importanza del
pranzo all’Eliseo. «Platini mi disse che Sarkozy gli aveva raccomandato di
votare per il Qatar», ha dichiarato nel novembre 2021. Il contenuto del famoso
pranzo all’Eliseo è chiuso negli archivi di Stato e protetto dal segreto almeno
fino al 2038. Anche la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
(Cada) ha emesso un parere negativo all’inizio di gennaio 2021, adducendo come
motivazione «la tutela degli interessi fondamentali dello Stato nella sua
politica estera o nella semplice conduzione delle sue relazioni estere».
Il 2 dicembre 2010,
il Comitato esecutivo della Fifa votò, tra lo stupore di tutti, a favore
dell’Emirato come Paese ospitante della Coppa del Mondo 2022. La delegazione
americana, guidata dall’ex presidente Bill Clinton, era furiosa. «Ho votato per
il Qatar - ha poi detto Platini - in nome dello sviluppo del calcio in una
regione che non aveva mai avuto una Coppa del Mondo». Come riporta Le Monde,
Sébastien Bazin, amministratore delegato del gruppo alberghiero Accor e allora
rappresentante europeo di Colony Capital, voleva sbarazzarsi del Psg, un club
fortemente indebitato e la cui reputazione era macchiata da risse tra ultras. E
avrebbe voluto venderlo al Qatar.
Per farlo, contò
sulla buona volontà del vecchio amico Nicolas Sarkozy. L’acquisizione del Psg è
stata una condizione per il sostegno della Francia alla candidatura del Qatar?
Come rivelato da Mediapart, Sébastien Bazin, che è stato ascoltato nella
primavera del 2022 dai giudici istruttori come «imputato libero», in un sms
assicurò che la cosa fosse fattibile. Il 10 dicembre 2010, una nota di Olivier
Buquen, capo della delegazione interministeriale per l’intelligence economica,
ha illustrato i numerosi vantaggi che deriverebbero dall’assegnazione del torneo
all’emirato.
Tutto doveva ancora
essere fatto in Qatar: stadi, alberghi, trasporti, ecc. «Oltre ai 55 miliardi di
dollari di progetti infrastrutturali già in corso, 45 miliardi di dollari doveva
essere assegnati sotto forma di PPP (partenariati pubblico-privati)», si legge
nella nota, che propone di «sensibilizzare le imprese francesi potenzialmente
interessate a questi mercati e di mettere in atto meccanismi di sostegno per i
contratti strategici». « Gli interessi militari e diplomatici francesi - scrive
Le Monde - sembrano aver pesato a favore della candidatura del Qatar».
Bazin ha dichiarato
a Le Monde che le trattative per il PSG sono state «senza alcuna considerazione
o condizione se non quella finanziaria». Laurent Platini, figlio del campione è
stato assunto «dopo una serie di colloqui» nel dicembre 2011 come «consulente»
per Pilatus Sport Mgmt, una holding di proprietà del fondo qatariota QSI, che
gestisce il marchio di attrezzature Burrda Sport.
Michel Platini ha
detto a Le Monde: «Mio figlio prende le sue decisioni sulla sua vita
professionale. Non ha bisogno di me, non mi ha mai chiesto nulla. Non c’era
nessuna contropartita diretta o indiretta... laterale, verticale o spaziale al
mio voto. L’Fbi, la giustizia svizzera e quella francese hanno indagato e stanno
ancora indagando: non hanno trovato nulla. Possono cercare, fare il loro lavoro,
non troveranno nulla, perché io non sono stato corrotto».
L’Emirato
moltiplicherà i gesti di affetto verso l’entourage di Nicolas Sarkozy. Come
rivelato da Mediapart, il Qatar accoglierà una richiesta di Claude Géant del
2011, che vuole che l’Emirato offra un contratto a Znz Group, la società del
comunicatore François de La Brosse, che ha lavorato per la campagna di Nicolas
Sarkozy nel 2007, poi come consigliere dell’Eliseo. Così, 600.000 euro sarebbero
stati pagati dal Qatar al signor de La Brosse a partire da settembre 2011, su
oltre 2 milioni di euro previsti. De La Brosse ha fatto sapere che questo «primo
pagamento corrispondeva al web design e allo sviluppo informatico della
piattaforma I love Qatar, che doveva promuovere i meriti del turismo
nell’emirato, oltre al costo dell’invio di un’équipe per le riprese e il
montaggio di “trenta clip di quattro minuti”». Questo capitolo della vicenda si
è sommato a un’altra indagine giudiziaria, quella sui sospetti di finanziamento
libico della campagna elettorale di Sarkozy, nel 2007.
L’Emirato ha avuto
attenzioni per altri membri della cerchia ristretta di Sarkozy. Nel marzo 2012,
una fondazione di diritto privato, il Centro Internazionale per la Sicurezza
dello Sport (ICSS) ha sovvenzionato, per 150.000 euro all’anno, una cattedra
dedicata a «etica e sicurezza nello sport» presso l’Università di
Paris-I-Panthéon-Sorbonne, dove insegna Sophie Dion, responsabile del master,
consigliera per lo sport dell’ex presidente Sarkozy e presente al famoso pranzo
all’Eliseo.
La signora Dion, ex
vicepresidente del gruppo di amicizia Francia-Qatar all’Assemblea nazionale,
durante il suo mandato di deputato dell’Alta Savoia (2012-2017), ha però detto
di aver «ricevuto solo 13.000 euro» nel quadro di questo «partenariato» tra
Paris-I e l’ICSS. Dopo la sconfitta del 2012, Nicolas Sarkozy si è praticamente
ritirato dalla politica e si è concesso qualche vacanza in Qatar prima di
intraprendere la carriera di oratore, come rivelato da Le Canard Enchaîné,
nell’ottobre 2012.
Secondo Libération
nel 2014, sulla base di documenti dell’inchiesta, Sarkozy intendeva raccogliere
finanziamenti per alimentare un fondo di investimento. Nel 2012, il Qatar ha
soccorso un altro amico di Sarkozy, Arnaud Lagardère, in difficoltà alla guida
della sua azienda. La Qatar Holding ha acquisito il 12,8% del capitale di
Lagardère.
Dopo il tentativo
fallito di tornare in politica nel 2016, Sarkozy è entrato nel 2017 nel
consiglio di amministrazione del gruppo Accor, come presidente del «comitato di
strategia internazionale». Sarkozy, che entrerà anche nel consiglio di
amministrazione del gruppo Lagardère nel 2020, arriva al momento giusto nel
gruppo alberghiero: Accor, che è già sponsor di maglia del Psg dal 2019,
beneficerà anche di altri succosi spin-off dalla Coppa del Mondo, fra cui una
partnership per gestire l’accoglienza dei tifosi in una rete di 66.000 camere.
Intervistato dal
Journal de Dimanche, Sarkozy ha stigmatizzato il boicottaggio della competizione
da parte di alcune municipalità francesi che hanno deciso di non organizzare
maxi schermi pubblici e ha criticato in particolare il suo successore, il
socialista François Hollande e la sindaca di Parigi, Anna Hidalgo. «Il calcio è
uno sport universale e ogni regione del mondo dovrebbe essere in grado di
organizzare una competizione internazionale.
Il calcio non
appartiene solo agli occidentali. È uno sport che unisce le persone. Tutti i
Paesi che hanno organizzato grandi eventi internazionali sono stati oggetto di
molte polemiche: Cina, Russia, Brasile e ora Qatar. Dovremmo dare a ciascuno di
questi Paesi ospitanti la possibilità di dimostrare il proprio know-how e
aspettare di vedere come si svolgono questi eventi prima di giudicarli». «Non
sono stato io a vendere i Rafale. Il mio successore deve aver giudicato che era
una decisione corretta. Quanto al boicottaggio, mi sembra che il Comune di
Parigi sia molto contento che i qatarini siano proprietari e finanziatori del
club della capitale. Questa polemica è piuttosto ipocrita».
DAGONEWS il 26
gennaio 2023.
Nel raccontare la
ricca consulenza da oltre 3 milioni di euro incassata da Sarkozy per la vendita
di “Ntv” al fondo americano GIP, “il Fatto quotidiano” ha omesso un dettaglio:
quando aveva le chiappe all’Eliseo, Sarkozy concesse numerose regalie fiscali al
Qatar e agli Emirati Arabi Uniti.
I due Paesi, pur
odiandosi, lo “ricompensarono” finanziando, nel 2016, il fondo londinese
“Peninsula capital”, su cui negli anni hanno investito la Qatar Investment
Authority e alcune holding riconducibili a Dubai.
Al “signor Bruni” i
guadagni sarebbero arrivati passando sui conti del suo studio legale, in cui
lavora il figlio Jean, a sua volta managing director di Peninsula.
Come presidente del
fondo Peninsula, fu scelto Borja Prado Eulate, ex capo di Mediobanca Spagna e di
Endesa. Fu Prado a chiamare come partner l’italiano Stefano Marsaglia, oggi
membro del cda di Generali (quota Caltagirone).
Come scrive Stefano
Vergine, oggi sul “Fatto quotidiano”, “Peninsula Capital è stata creata nel
marzo del 2016 da Marsaglia insieme a due manager spagnoli che conoscono bene
l’Italia: Borja Prado e Javier de la Rica. […]
Il registro
commerciale lussemburghese dice che l’11 dicembre 2018, poco dopo aver concluso
l’affare Ntv, Marsaglia e de la Rica cedono le quote detenute in quattro società
di gestione del gruppo Peninsula […] a due imprese costituite nella zona franca
di Sharjah, che oltre ad essere uno dei sette Emirati Arabi è anche un paradiso
fiscale, dove non si pagano imposte sugli utili societari né sul rimpatrio dei
capitali.
Le due società si
chiamano Casan Holding e Mbb Holding. Il prezzo della compravendita non viene
pubblicato sul registro commerciale.
Sempre l’11
dicembre 2018, i due veicoli emiratini rivendono queste azioni alla
lussemburghese Peninsula Holding, controllata con quote uguali dalle stesse
società emiratine.
Prezzo pagato: 19,2
milioni di euro, di cui 16,5 milioni versati cash.
L’operazione sembra
non avere senso economico, a meno che si tratti di uno schema di ottimizzazione
fiscale il cui obiettivo è spostare nell’emirato di Sharjah parte dei profitti
realizzati con Peninsula.
È così? Casan
Holding e Mbb Holding sono di proprietà rispettivamente di Marsaglia e De la
Rica? […] Di sicuro c’è il fatto che il 28 luglio del 2021 Marsaglia ha lasciato
il suo ruolo di amministratore di Peninsula, e lo stesso giorno l’emiratina
Casan Holding ha venduto tutte le sue azioni di Peninsula.
Ora Marsaglia è un
consigliere d’amministrazione di Generali. Ha creato un nuovo fondo
d’investimento, chiamato Azzurra Capital e registrato a Dubai. Secondo un
documento presente sul registro del commercio britannico, da aprile del 2019
risiede negli Emirati”.
Ps. Italo – NTV
oggi è sotto osservazione di Aponte, che avrebbe come consulente Jean Sarkozy.
Stefano Vergine per
il “Fatto quotidiano” il 26 gennaio 2023.
Finora si sapeva che
la vendita di Ntv al fondo americano Gip, avvenuta nel 2018, aveva fatto
arricchire i vecchi azionisti della compagnia dei treni Italo: soprattutto Luca
Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle e Gianni Punzo. Grazie a un’inchiesta
realizzata dal Fatto insieme al consorzio Eic, ora sappiamo che a ricevere
parecchi soldi collegati a quell’affare è stato anche Nicolas Sarkozy. Tre
milioni e 300 mila euro: è quanto incassato dall’ex presidente francese per una
consulenza nella vendita di Ntv.
Il problema?
Documenti e testimonianze raccolte mettono in dubbio che Sarkozy abbia davvero
lavorato all’operazione. Per comprendere la vicenda dobbiamo partire da
Peninsula Capital, un fondo di private equity che a giugno 2017 sborsa 66
milioni per comprare il 12,8% di Ntv. Ad aprile 2018 il fondo americano Gip
compra il 100% di Ntv per 1,98 miliardi. La plusvalenza realizzata da Peninsula
è di 181 milioni. Peninsula incassa il denaro da Gip in due bonifici, tra aprile
e luglio 2018.
Dieci giorni dopo
l’ultimo pagamento, due società del gruppo Peninsula versano 3,15 milioni a
Sarkozy, sul suo conto nella filiale parigina della banca Rothschild, che
diventeranno 3,3 grazie a un ulteriore pagamento datato aprile 2019, come
scritto negli estratti conto della banca. A dire che quei soldi sono collegati
all’operazione Ntv è uno studio legale.
Per giustificare il
pagamento, lo studio lussemburghese Van Campen Liem, consulente di Peninsula,
scrive una lettera a Rothschild: “Dal 2018 – si legge – Nicolas Sarkozy è stato
un consulente esperto di Peninsula Capital II”, la società che ha gestito
l’affare Ntv. Nella lettera si legge poi che “all’uscita dall’investimento in
Ntv, il consulente esperto ha ricevuto parte degli interessi ai quali ha
diritto”. Insomma, i 3,3 milioni derivano dal ruolo che Sarkozy ha svolto per
Peninsula nell’operazione Ntv. Nella lettera, però, gli avvocati aggiungono
un’avvertenza: “Non ci assumiamo alcuna responsabilità sull’accuratezza di
queste informazioni... ricevute da Peninsula Capital II”.
Di strano c’è che
Sarkozy è diventato consulente di Peninsula nel 2018, mentre l’investimento in
Ntv è del giugno 2017. Inoltre Borja Prado, uno dei fondatori di Peninsula, ha
negato che l’ex capo dell’Eliseo abbia mai lavorato per il fondo: “Sarkozy non
ha mai fatto da advisor per Peninsula. Noi non abbiamo mai ingaggiato alcun
advisor per questa né per altre operazioni, dato che il fondo ha un comitato per
gli investimenti che verifica le transazioni”, ha detto Prado al telefono,
aggiungendo che “nessuno ha pagato Sarkozy”.
All’epoca, insieme a
due suoi colleghi, Prado era sia proprietario che amministratore di Peninsula
Capital II, la società che avrebbe ingaggiato Sarkozy come consulente. Significa
dunque che Prado e colleghi hanno fornito informazioni false allo studio legale
Van Campen Liem?
Alle domande su
questo e su altri punti, Peninsula, Prado e gli altri due manager e azionisti
del fondo non hanno risposto. Secondo due fonti che hanno partecipato
all’affare, e che ci hanno parlato a condizione di anonimato, a finanziare
l’operazione Ntv e a pagare Sarkozy sono stati principalmente gli Emirati Arabi.
“Dovevamo comprare una quota maggiore di Ntv, ma alla fine il Qatar si è sfilato
e abbiamo acquistato metà della quota a cui puntavamo”, ha detto un dirigente di
Peninsula. Se non il Qatar, chi ha investito allora in Peninsula Partners II?
“Gli Emirati Arabi Uniti e altri della zona”, ha risposto lo stesso dirigente.
Secondo una seconda
fonte informata sull’operazione, “i soldi sono arrivati dagli Emirati, in
particolare dal family office dello sceicco Mohammed bin Zayed”: è il sovrano di
Abu Dhabi e presidente degli Emirati Arabi Uniti, conosciuto con la sigla di
Mbz.
Coincidenza:
Sarkozy è stato due volte ad Abu Dhabi nel 2018. Invitato a un evento nel marzo
2018, ha fatto un discorso in cui ha elogiato vari autocrati tra cui quello
degli Emirati: “Chi sono oggi i grandi leader mondiali? Il presidente Xi, il
presidente Putin, il Gran Principe Mohammed bin Salman. E cosa sarebbero oggi
gli Emirati senza la leadership di Mbz?”, ha detto l’ex presidente francese. A
dicembre dello stesso anno è tornato nella Capitale degli Emirati per un un
seminario a porte chiuse.
È però improbabile
che i 3,3 milioni siano stati pagati per remunerare la sua presenza a questi
eventi. Secondo gli estratti conto, infatti, Sarkozy non ha mai ottenuto
ufficialmente più di 147 mila euro per un discorso. Perché dunque ha ricevuto
tutti questi soldi?
E come mai il
pagamento è stato motivato con una consulenza a Peninsula sull’operazione Ntv?
Alle domande di Eic, né Sarkozy né il governo degli Emirati né Peninsula hanno
risposto.
Faro sui "cieli
aperti" dell'Ue: l'accordo che ha favorito il Qatar.
Andrea Muratore il
16 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Scopriamo l'accordo
sull'aviazione Ue-Qatar al centro di nuove polemiche. Ma è presto per parlare di
un trattato figlio del Qatargate. Vediamo perché
Tra il 2019 e il
2021 l'Unione Europea ha negoziato un ampio accordo sull'aviazione civile col
Qatar che ha avuto il suo compimento nella formalizzazione dell'intesa avvenuta
il 18 ottobre 2021. Un trattato nello stile open skies paragonabile a quelli che
l'Ue ha formalizzato con Stati Uniti, Canada, Marocco, Georgia, Giordania,
Moldova, Israele e Ucraina è stato applicato all'emirato del Golfo. In sostanza,
ai sensi dell'intesa, si legge sul sito della Commissione Europea, "tutte le
compagnie aeree dell'Ue potranno operare voli diretti da qualsiasi aeroporto
dell'Ue verso il Qatar e viceversa per le compagnie aeree del Qatar".
La genesi
dell'accordo
A parole si potrebbe
leggere come una grande svolta di rilancio dell'aviazione dopo lo stop per il
Covid-19. Fuori dal burocratese, però, parliamo di un'intesa sbilanciata. Come
già la testata Greek City Times faceva notare ad accordo ancora fresco di firma,
essenzialmente le compagnie del Paese mediorientale si riducono a un solo
vettore: Qatar Airways.
L'intesa è iniziata
a venire discussa in una fase in cui l'emirato degli al-Thani era di fatto sotto
assedio per l'embargo imposto da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e
Bahrein che avevano chiuso i confini terrestri e impedito il sorvolo aereo ai
vettori di Qatar Airways, ai tempi ritenuta una delle compagnie migliori al
mondo per qualità del servizio. La compagnia di bandiera del Paese
mediorientale iniziò i negoziati per rompere l'assedio e creare un ponte con
l'Europa in una fase in cui, complice il decollo dell'Asia, il Medio Oriente
diventava l'hub decisivo per i traffici aerei mondiali.
Un servizio
capillare
Fatte queste
premesse, notiamo comunque che, leggendo i contenuti dell'intesa, Qatar Airways
risulta fortemente avvantaggiata: con l'obiettivo di raggiungere e superare
i 6,3 milioni di passeggeri annui portati sull'asse Europa-Medio Oriente e
rafforzare i voli commerciali l'Ue ha programmato un'ampia crescita delle
connessioni con cinque Paesi-chiave: Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi
Bassi.
261 i collegamenti
interessati, si legge sul sito della Commissione: 24 servizi settimanali tra
l'Emirato e il Belgio; 27 servizi settimanali tra il Paese del Golfo e Parigi,
14 servizi settimanali tra il Qatar e Nizza, altrettanti sia per i voli
destinati a Lione e, a parte, per tutti gli altri scali francese; 21 servizi
settimanali tra il Qatar e Francoforte, altrettanti per Monaco Monaco e 14
servizi settimanali tra il Qatar e ciascuno di tutti gli altri punti in
Germania; 84 voli settimanali Qatar-Italia; 14 voli Qatar-Amsterdam e 14 tra
Doha e tutti gli altri hub dei Paesi Bassi. A cui si aggiungono 135 voli
commerciali. Un totale di 396 voli sull'asse Europa-Golfo per i quali, da un
lato, Qatar Airways ha libero accesso agli aeroporti dell'Unoone Europea e,
dall'altro, le compagnie dell'Ue, formalmente garantite nel rispetto della
concorrenza, possono competere tra loro per un solo hub, quello internazionale
di Doha.
Il ruolo di Qatar
Airways
L'accordo,
nell'ultimo anno, è stato criticato dalle principali compagnie aeree e dai
sindacati dell'Europa, ma difeso dalla Commissione Ue che ha affermato che
garantirebbe "opportunità per entrambe le parti". La compagnia di bandiera da
allora ha conquistato una base a Dusserdolf, in Germania, rilanciato la rotta
italiana per Venezia e riorganizzato le strategie per connettere, secondo le sue
priorità, "l'Europa al mondo". I dati compresi tra metà 2021 e metà 2022
mostrano come la compagnia di bandiera sia messa nettamente alle spalle la
crisi: ricavi aumentati del 210% nell'ultimo anno, grazie alla crescita del
network di Qatar Airways e un profitto record nei 25 anni di storia della
compagnia di 1,54 miliardi di dollari, proiettato verso l'alto nel 2022-2023.
L'accordo, che non
prevede che Doha debba adeguarsi alla legislazione sull'aviazione dell'Ue, è
tornato nell'occhio del ciclone dopo lo scoppio del Qatargate. La compagnia
aerea di bandiera non risulta indagata ma Politico.eu ha sottolineato che oltre
a un'operazione di soft power il lobbying dell'Emirato in Europa potrebbe aver
avuto, tra le altre cose, l'obiettivo di favorire un'approvazione
spedita dell'accordo. Per il quale un coinvolgimento diretto di Qatar Airways
del resto non sarebbe necessario: l'Emirato degli al-Thani cura come una grande
corporation i suoi affari: l'ultimo neoassunto dei piloti della compagnia così
come le stelle del Paris Saint Germain sono parimenti considerati "dipendenti"
di Doha, al cui governo spetta la regia politica.
Francesca Basso
del Corriere della Sera ha reso noto che "l'eurodeputata della Sinistra Leïla
Chaibi ha presentato un emendamento che aggiunge la sospensione dell'accordo al
punto 14 della risoluzione che vota oggi il Parlamento in cui si chiede la
sospensione di "tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Paese del
Golfo, specie per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti e visite
programmate, fino a quando i sospetti non saranno confermati o respinti". Dal
nostro punto di vista nel Qatargate ci atteniamo a quanto sappiamo finora, e
cioè che l'accordo sembra fuori dai radar dello scandalo Panzeri-Kaili. Da
analisti, però, non possiamo non avanzare alcune ipotesi e considerazioni sulle
conseguenze politiche di questo fatto.
Tre questioni su cui
fare il punto
Il primo punto da
tenere in considerazione è il fatto che l'esclusione di Qatar Airways dallo
scandalo Qatargate non esclude pressioni politiche di Doha per rilanciare la
compagnia. Fa gioco la comprensibile paura dell'Emirato per l'isolamento
internazionale, l'atteggiamento bilanciato dell'Europa nella diatriba del Golfo
e, soprattutto, il desiderio di accelerare la connessione dell'Ue ai grandi hub
internazionali. Elementi che, assieme all'indubbia eccellenza della compagnia di
bandiera del Paese mediorientale , possono aver giocato un ruolo nel firmare un
accordo ritenuto capace di sfavorire le compagnie ma accelerare il mercato
interno.
In secondo luogo,
c'è da chiedersi chi potrebbe risultare "vincitore" da questo accordo sul fronte
europeo. E pensare che la grande partita dell'aviazione mobilita contesti
industriali complessi che sono competenza diretta dei governi più che di enti
come l'Europarlamento al centro dello scandalo. Simple Flying alcune settimane
fa ha messo in campo la sospetta corrispondenza tra l'acquisto da parte di Qatar
Airways di 80 Airbus A380 nel 2010 e la pressione della Francia, nazione
centrale nel colosso europeo dell'avionica, per l'assegnazione al Paese
mediorientale dei Mondiali 2022. Ebbene, negli anni in cui l'accordo sui voli
era in negoziazione Airbus, che ha il 6,65% della compagnia a trazione
franco-tedesca, ha visto l'avvio delle commesse del Qatar per i nuovi Airbus
A350. L'affare, di recente, è naufragato per dispute sulla sicurezza e il futuro
della commessa dopo la consegna dei primi A350 e il Qatar si è rivolto a
Boeing, nonostante detenga una quota nel gruppo con cui Qatar Airways è in
diatriba. Dunque sicuramente Francia e, in secondo luogo, Germania hanno avuto
tutto l'interesse politico a rafforzare l'asse sull'aviazione con Doha, che tra
2019 e 2021 avrebbe comportato fiorenti affari e commesse miliardarie.
In terzo luogo,
aprire il Vaso di Pandora con la compagnia degli al-Thani imporrebbe la
rilettura ex post di tutte le intese commerciali siglate dall'Ue in materia di
aviazione civile. La peculiarità del "cielo unico" europeo rende il mercato
interno dell'Ue estremamente attrattivo. E questo rende per contrappasso
Bruxelles "svantaggiata" in molte intese che riguardano Paesi singoli.
Dunque, ad oggi non
ci sono elementi per sospettare Qatar Airways coinvolta nel Qatargate. Esistono
però possibilità che pressioni politiche provenienti sia dall'Emirato che
dall'Ue abbiano, per ragioni di opportunità e speranze di floride commesse,
oliato l'accelerazione dell'accordo. E c'è, per ora, un solo vincitore di questa
sfida: Doha. Che ha ottenuto un trattamento privilegiato senza doversi
conformare agli standard europei e "invaso" l'Ue con la sua compagnia a cinque
stelle. Ma questo può anche, di fatto, mostrare l'insipienza dei burocrati di
Bruxelles. Attenti più alle logiche del libero scambio che agli equilibri di
mercato. E se così fosse ciò stupirebbe meno: sarebbe l'ordinaria
amministrazione europea.
Estratto
dell’articolo di Emiiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian per “Domani” - 08
settembre 2022
[…] ad Atene Renzi
non doveva partecipare a cda, né fare conferenze e interviste sul futuro
«rinascimento» dell’Arabia. Non ha preso gettoni né consulenze per eventi
ufficiali.
Il senatore ha
incontrato in segreto il principe, e ha avuto rendez vous con il primo ministro
albanese Edi Rama, con il capo del governo del Montenegro Dritan Abazovic
(recentemente sfiduciato), il ministro dell’Energia saudita, il vicepresidente
della Commissione europea Margaritis Schinas, quello del parlamento di
Strasburgo Eva Kaili e, ovviamente, il premier di casa Mitsotakis. Anfitrione al
Four Seasons era anche il ricchissimo Theodore Kyruakou, classe 1974 e
proprietario del gruppo Antenna, il più grande colosso mediatico della Grecia.
In che ruolo Renzi
ha partecipato agli incontri con personaggi pubblici di questa leva? Di cosa si
è parlato durante i pranzi a tavola con il principe accusato di aver dato
l’ordine di aver ammazzato giornalisti dissidenti (su tutti Jamal Khashoggi,
ucciso dai sauditi su ordine, dice la Cia, di bin Salman), politici e
imprenditori nel bel mezzo della crisi energetica e della guerra tra Russia e
Ucraina? E come mai nessuno dei partecipanti – a parte Mitsotakis – ha dato
notizia della loro presenza nell’albergo di lusso affittato per giorni da bin
Salman?
Emiiliano Fittipaldi
e Giovanni Tizian per “Domani” il 15 Dicembre 2022.
A fine luglio un
pezzo dell’establishment europeo è stato convocato ad Atene. Nelle sale e nelle
suite dell’albergo a cinque stelle Four Seasons di Atene, prezzo medio 2.500
euro a notte. In quei giorni, l’hotel era stato affittato interamente da
Mohammed bin Salman, il principe saudita in visita ufficiale al primo ministro
greco Kiryakos Mitsotakis.
Il capo del regime
di Riad, però, ha approfittato della visita istituzionale per incontrare in via
ufficiosa una ristrettissima cerchi di altri capi di stato, importanti
parlamentari europei, oligarchi russi, tycoon e giornalisti. Un gruppo di una
ventina di eletti, di cui ha fatto parte anche il senatore Matteo Renzi.
Nel bel mezzo della
campagna elettorale, e a pochi giorni dal primo incontro con il leader di Azione
Carlo Calenda prodromico all’alleanza elettorale del terzo polo, l’ex premier ha
preso un aereo ed è atterrato in gran segreto nella capitale greca.
Amico personale di
bin Salman, Renzi è membro del board dell’FII Institute di Riad controllato dal
fondo sovrano saudita (guadagna 80mila dollari l’anno), e siede nella Royal
commission per Alula, antica città del deserto che il dittatore vuole
trasformare in un grande polo turistico. Una poltrona di consulente che gli ha
fruttato finora incassi per circa mezzo milione di euro complessivi.
A differenza dei
precedenti viaggi mediorientali, spesso legati a occasioni propagandistiche
organizzate dai sauditi per il lancio del progetto “Vision 2030” (bin Salman
punta a trasformare entro quella data il regno da una petrolmonarchia a
un’economia basata sui servizi e sul turismo), ad Atene Renzi non doveva
partecipare a cda, né fare conferenze e interviste sul futuro «rinascimento»
dell’Arabia. Non ha preso gettoni né consulenze per eventi ufficiali.
Il senatore ha
incontrato in segreto il principe, e ha avuto rendez vous con il primo ministro
albanese Edi Rama, con il capo del governo del Montenegro Dritan Abazovic
(recentemente sfiduciato), il ministro dell’Energia saudita, il vicepresidente
della Commissione europea Margaritis Schinas, quello del parlamento di
Strasburgo Eva Kaili e, ovviamente, il premier di casa Mitsotakis. Anfitrione al
Four Seasons era anche il ricchissimo Theodore Kyruakou, classe 1974 e
proprietario del gruppo Antenna, il più grande colosso mediatico della Grecia.
In che ruolo Renzi
ha partecipato agli incontri con personaggi pubblici di questa leva? Di cosa si
è parlato durante i pranzi a tavola con il principe accusato di aver dato
l’ordine di aver ammazzato giornalisti dissidenti (su tutti Jamal Khashoggi,
ucciso dai sauditi su ordine, dice la Cia, di bin Salman), politici e
imprenditori nel bel mezzo della crisi energetica e della guerra tra Russia e
Ucraina? E come mai nessuno dei partecipanti – a parte Mitsotakis – ha dato
notizia della loro presenza nell’albergo di lusso affittato per giorni da bin
Salman?
È un fatto che il
principe saudita stia cercando di modernizzare, da un punto di vista economico,
il suo paese.
E stia cercando di
cambiare anche la percezione dell’Arabia saudita nell’immaginario collettivo
occidentale. Patria dell’integralismo musulmano, dove i diritti delle donne e
delle minoranze sono minimi, il regno saudita deve trasformarsi in fretta se
vuole sopravvivere all’età post petrolifera, finora unico core business
dell’economia dello stato.
Bin Salman sta
investendo miliardi a Riad, e contemporaneamente tesse da anni nuove relazioni
internazionali, sfruttando l’enorme liquidità dei fondi governativi come il Pif.
Il viaggio ufficiale in Grecia del 26 e del 27 luglio, il suo primo in Europa
dopo la pandemia, è stata una tappa importante di questo processo.
L’erede al trono ha
portato dall’Arabia un codazzo di 700 persone che hanno viaggiato su 6 aerei,
oltre al cibo personale per sé e i suoi consiglieri, la biancheria della camera
da letto, i piatti e i bicchieri (non si fida né del Four Seasons né dei servizi
d’intelligence di Atene), quasi 200 valigie personali.
«Vorrei
congratularmi con voi per il progetto Vision 2030, e vorremmo esplorare
ulteriori opportunità di cooperazione tra i nostri due paesi», ha detto
Mitsotakis al principe. Mentre bin Salman vedeva il premier greco nella sede del
governo, le due delegazioni hanno firmato accordi commerciali ed economici che
secondo i giornali greci «sono stimati in alcuni miliardi di euro».
Basati quasi tutti
su futuri investimenti sauditi in Grecia, sul settore della difesa e quello
della cultura. Ma soprattutto sull’energia: il principe ha spiegato di voler
collegare le reti elettriche, «per fornire all’Europa, soprattutto quella
meridionale e occidentale, energia rinnovabile molto più economica: oggi
firmeremo un memorandum d’intesa su questo. Siamo anche interessati
all’idrogeno, e a come rendere la Grecia un hub per l’Europa nel campo
dell’idrogeno», si legge in un comunicato.
Le questioni
trattate nel summit ufficiale con i greci sono state dunque strategiche. Ma
probabilmente lo sono state anche quelle discusse durante gli incontri informali
avuti da bin Salman. Il principe ha infatti convocato ad Atene anche due premier
slavi, che sono corsi a omaggiarlo in piena estate: si tratta dell’albanese
Rama, amico di Renzi, e del montenegrino Abazovic.
Con loro bin Salman
ha avuto un incontro riservato, a pranzo, il 26 luglio, presente anche il
premier greco, il ministro dell’Energia saudita e l’ex presidente del consiglio
italiano. «Sono andato ad Atene perché bin Salman è un amico, e perché ha la
grande ambizione di portare energia elettrica prodotta con pannelli fotovoltaici
in Arabia Saudita verso la Grecia, verso i Balcani, e poi l’Europa: sarebbe una
risorsa eccezionale per sostituire il gas russo, e più in generale gli
idrocarburi» dice Rama a Domani.
«Perché Renzi era
lì? Mi è parso molto dentro al progetto di bin Salman di esportare verso
l’occidente dell’energia solare saudita. Un’ipotesi interessantissima. Se
abbiamo parlato anche di portare l’energia saudita in Italia dall’Albania? Sì,
loro vogliono espandersi oltre i Balcani certo. Ma nella prima fase saranno
coinvolti la Grecia e paesi limitrofi».
Al netto
dell’efficacia del disegno industriale ed economico del principe, è possibile
che Renzi da consulente dei presunti valori neo rinascimentali del regime (fu
proprio Renzi a suggerire al principe lo slogan all’evento FII di gennaio 2021,
chiamata la Davos del deserto) sia ora diventato pure una sorta di consigliere
di bin Salman anche in merito al cruciale settore energetico?
Lo staff di Renzi a
Domani spiega che l’ex premier sarebbe stato chiamato ad Atene da Mitsotakis,
suo amico personale, ma ammette che l’invito al Four Seasons potrebbe essere
dovuto anche alla circostanza che i suoi eccellenti rapporti con bin Salman
siano ormai universalmente conosciuti.
Negano che il suo
viaggio, a differenza delle conferenze e dei soldi presi dalle fondazioni e
commissioni saudite, avesse «natura professionale»: «Renzi intrattiene
costantemente rapporti con colleghi che hanno o hanno avuto responsabilità di
governo. L’incontro ad Atene ha visto la partecipazione di vari politici, tra i
quali esponenti della Ue. Renzi non ha alcuna consulenza o interesse economico
nel mondo energetico».
Nessuna risposta
alla domanda se il leader, essendo pagato dai sauditi in merito ad altre
partite, sia anche pagato in modo indiretto. Renzi in persona, contattato, dice
solo che se lui fosse al governo non disdegnerebbe affatto un aiuto da parte di
bin Salman: «Penso che l’Europa debba ridurre il costo delle bollette anche con
l’aiuto dei paesi arabi e del nord Africa. Questa dovrebbe essere la priorità
politica della delicata stagione che stiamo vivendo». Nessun altra dichiarazione
in merito al viaggio estivo.
Se Renzi non ha
alcuna intenzione di chiudere con le consulenze in giro per il mondo o
rinunciare ai soldi di Riad, la vicenda non crea alcun imbarazzo all’alleato
Calenda. «Non sapevo nulla dell’incontro di luglio, ma se non ha preso soldi non
ci vedo nulla di male. E per un politico non è un obbligo pubblicizzare sempre
chi si incontra».
Il numero uno di
Azione che, dopo aver stracciato in 48 ore un accordo già firmato con il Pd, ha
deciso ad agosto di legarsi al senatore di Rignano, fa della «serietà» e della
«coerenza» la sua cifra politica, ma a causa del patto con Renzi ha già dovuto
rimangiarsi quanto detto nel recentissimo passato.
Solo a fine giugno
aveva detto: «Con Renzi, che è una persona che stimo, c’è però un tema
inaccettabile della lobbying internazionale, non si può essere pagati
dall’Italia e dall’Arabia Saudita. Senza una linea retta e coerente non andrà
mai sopra il 3 per cento. È un buco etico».
Poi, di nuovo: «Ho
detto a Renzi: “Scegli se vuoi fare politica o business”». Qualche giorno fa
Calenda giustificava il suo dietrofront così: «Io le consulenze non le prendo,
tanto meno da paesi stranieri. Renzi risponde dicendo che questa cosa
dell’Arabia Saudita è lecita, e in effetti per la legge lo è. Ma io sono
disponibile domani mattina a votare per vietarla».
Il paradosso è che
Calenda, che fa del liberalismo il suo mantra (nulla di più lontano dal regime
saudita) e dell’agenda Draghi la sua stella polare, ha organizzato uno dei primi
incontri con Renzi in vista di un possibile accordo tra Azione e Italia viva
proprio il 25 luglio.
Cioè il giorno
prima che il senatore e lobbista raggiungesse bin Salman ad Atene nelle stanze
del Four Seasons dove si discuteva di energia elettrica saudita e investimenti
con il principe ereditario, il suo ministro dell’Energia e i premier di altri
paesi. «Ripeto: con Matteo siamo in disaccordo sulle consulenze, ma questo
viaggio per me non ha nulla di scandaloso», spiega. Chissà se prima dell’accordo
politico avrebbe usato parole così conciliatorie.
Ma chi erano gli
altri avventori dell’albergo affittato da bin Salman in quei due giorni? Nella
lista degli invitati al Four Seasons che c’è il nome di sir “Len” Blavatnik, il
cui ufficio stampa non ha però risposto alle nostre domande sulla sua effettiva
presenza e sui motivi della visita.
Blavatnik è l’uomo
più ricco d’Inghilterra con un patrimonio che si aggira sui 40 miliardi di
dollari, proprietario della Warner Music e di Dazn. Ha passaporto americano e
inglese, ma le origini della sua fortuna sono simili a quelle degli altri
oligarchi russi poi sanzionati dall’Europa (lui ne è rimasto indenne).
Nato nel 1958 a
Odessa, al tempo Urss, è diventato miliardario sotto le presidenze Boris Eltsin
e Vladimir Putin. Ha lavorato nell’acciaio e poi nel petrolio: qualche lustro fa
ha comprato il 40 per cento della compagnia russa TNK, poi fusa con l’inglese
Bp. Nel 2013 la nuova società è stata comprata dalla Rosneft, multinazionale
legata al Cremlino.
Secondo le cronache
finanziere del tempo l’operazione, benedetta da Putin, ha portato nelle tasche
di Blavatnik la bellezza di sette miliardi di euro. Abbiamo chiesto all’oligarca
come mai era stato invitato al Four Seasons, e se avesse parlato con bin Salman
e i presenti anche di energia o altri business, ma non ci è pervenuta risposta.
Oltre al magnate dei
media Kyruakou e il fondatore del sito Vice Shane Smith, nella lista degli
invitati alla due giorni all’hotel affittato da bin Salman compare anche il nome
di Margaritis Schinas, un liberal conservatore del partito greco Nuova
Democrazia, lo stesso del premier Mitsotakis ora al governo, membro della grande
famiglia del partito popolare europeo.
Schinas è un uomo
che conta a Bruxelles: è uno degli otto vicepresidenti della Commissione europea
guidata Ursula von der Leyen. Ha la delega alla Promozione dello stile di vita
europeo. Schinas è stato membro del parlamento europeo tra il 2007 e il 2009, da
quel momento in poi ha trascorso gli ultimi 13 anni negli uffici della
Commissione, con vari ruoli: da portavoce a vicedirettore generale della
comunicazione fino alla vicepresidenza attuale.
In quest’ultimo
ruolo ha svolto diverse attività collaterali. Per esempio ha coordinato il
lavoro della commissione sullo Sviluppo della sicurezza europea e di quella
istituita per rafforzare le misure di prevenzione, rilevamento e risposta alle
minacce ibride. In una sua recente dichiarazione ha espresso la linea di
fermezza dell’Unione contro l’invasione russa in Ucraina spiegando perché è
necessario limitare il rilascio dei visti ai cittadini della federazione
governata da Putin.
Sui canali social
non c’è traccia della sua presenza ad Atene all’incontro con il principe il 27
luglio. Su Twitter quel giorno ha pubblicato un post per magnificare il progetto
ErasmusPlus e le «nostre università europee campionesse di conoscenza,
educazione e innovazione per il bene degli studenti, educatori e società. Di
certo tra i tanti accordi firmati tra Arabia Saudita e Grecia c’è anche un piano
di partnership commerciali e industriali nel settore marittimo.
I rappresentanti di
questa categoria, riuniti sotto la sigla “Unione armatori greci” (Union of Greek
Shipowers), erano stati ricevuti da Schinas lo scorso marzo, incontro inserito
nell’agenda del vicepresidente seguendo la normativa sulla trasparenza che
obbliga i membri della Commissione a dichiarare i soggetti (aziende,
associazioni, industrie) che incontrano e dove lo fanno. Con gli armatori
ellenici il tema della riunione è stato il settore marittimo e il Green new
deal.
Ma come mai Schinas
è stato invitato al Four Seasonss? Da chi e perché? E come mai non dichiararlo,
visto il livello degli altri invitati? Schinas non ha risposto alla nostra
richiesta di commento sull’incontro con bin Salman, di cui non c’è traccia
nell’agenda ufficiale del vicepresidente.
Neppure Eva Kaili ha
risposto alle nostre domande sul perché il suo nome sia nella lista ristretta di
invitati. A differenza di Schinas, Kaili è una dirigente del Partito socialista,
ma come il suo collega ha fatto carriera in Europa. È attualmente vicepresidente
del parlamento europeo e presiede il Comitato per il futuro della scienza e
della tecnologia. È stata deputata in Grecia tra il 2007 e il 2012 e poi è stata
eletta a Bruxelles, dove è diventata capo della delegazione per le relazioni con
l’assemblea parlamentare della Nato, l’alleanza atlantica.
Sui canali ufficiali
della leader politica non c’è alcun riferimento a incontri o cene ad Atene a
luglio. In quei giorni, tra il 26 e il 27, ha però rilasciato un’intervista alla
tv Mega, dove ha lavorato come giornalista prima di dedicarsi alla politica.
Un’intervista ripresa da vari media: Kaili denunciava infatti che circa due anni
prima era stata oggetto di un tentativo di intercettazione abusivo durante un
viaggio nella penisola arabica. Un tentativo di attacco hacker simile a quello
più noto subito e denunciato a fine luglio dal presidente del Pasok, il Partito
socialista panellenico di cui Kaili fa parte.
Uno scandalo di
spionaggio interno di rilevanza internazionale che ha portato alle dimissioni
del segretario generale del governo Grigoris Dimitriadis, nipote del primo
ministro Mitsotakis, e del capo del National Intelligence Service (EYP) greco,
Panagiotis Kontoleon. Il caso ha portato all’apertura di un’indagine
parlamentare, tuttora in corso.
La vicepresidente
del parlamento europeo Kaili è relatrice per i socialdemocratici europei nella
commissione che si occupa di sicurezza informatica e software di sorveglianza.
Tra i regimi accusati di aver usato il sistema di spionaggio informatico Pegasus
per controllare attivisti e oppositori c’è l’Arabia Saudita di bin Salman, che
ne ha sempre negato l’utilizzo.
Chissà se il
gruppetto di fortunati invitati, tra energia elettrica, affari in Albania e
Peloponneso, memorandum su telecomunicazioni e digitale, ha parlato anche di
sicurezza informatica con il principe saudita, che si presenta ormai ai suoi
interlocutori come uno dei pochi leader mondiali che può aiutare l’Europa di
fronte alla crisi energetica globale.
Andrea Greco e
Giovanni Pons per “la Repubblica” il 17 dicembre 2022.
La tela qatarina.
Tessuta con relazioni e attività ai massimi livelli, con politici come Matteo
Renzi e Massimo D'Alema, funzionari come l'ambasciatore Pasquale Salzano, i
manager Giuseppe Bono, Franco Carraro, Giuseppe Giordo.
Tenuta stretta con
investimenti miliardari, diretti o sollecitati, tanto di soldi ce n'è a iosa.
Così tanti che, qualche volta, prendono le strade sbagliate, come emerge dalle
indagini su Antonio Panzeri e gli altri facilitatori pro-Qatar in Europa.
Ma sarebbe riduttivo
e grossolano ridurre l'avanzata del Qatar in Italia a qualche valigia di
banconote. Si deve partire da una visione geopolitica, dalla proiezione del
piccolo Paese nel mondo, decisa lo scorso decennio e avviata in nazioni
strategiche come Francia e Gran Bretagna, poi estesa all'Italia dal 2012 in
avanti. Una scelta di Stato, per evitare l'isolamento mentre l'Arabia Saudita e
altre nazioni sunnite rompevano le relazioni con il Qatar, accusato di
destabilizzare la regione con il sostegno - politico e finanziario - al
radicalismo musulmano e al terrorismo coperto dai nemici che ruotano attorno
alla galassia sciita, Iran in testa.
La sterzata italiana
sul Qatar ha per mentore Matteo Renzi, presidente del consiglio per tre anni dal
febbraio 2014. Il leader di Italia Viva (allora nel Pd) fu fautore della nuova
amicizia tra i due Paesi, che ha vissuto un magic moment negli anni a cavallo
del suo mandato. Riuscendo a soffiare alla Francia, nel giugno 2016, il
contratto per costruire da zero la flotta militare del Qatar.
Una marina da guerra
istantanea, con ordini per circa 6 miliardi di euro (poi altri, per Leonardo)
per la vendita di sette unità, una mini- portaerei, quattro fregate
portamissili, due pattugliatori, altri due mini-sottomarini per incursioni, più
tanta formazione agli ufficiali da parte della Marina militare. Insieme a Renzi
aveva gestito direttamente la commessa Giuseppe Bono, patron di Fincantieri da
poco scomparso.
Dopo la firma la
commessa fu portata avanti da Giuseppe Giordo, dg di Fincantieri che ha poi
lasciato il gruppo sei mesi fa per il ruolo avuto nella tentata mediazione in
una fornitura di navi alla Colombia.
Quell'affare,
pasticciato e poi sfumato, aveva coinvolto come consulente anche Massimo
D'Alema, ex presidente del consiglio e ministro degli Esteri per il Pd. Fino al
2017, quando fu tra i fondatori di Articolo 1, partito in cui è confluito anche
Panzeri. Giorni fa D'Alema è spuntato come consulente del magnate qatarino
Ghanim Bin Saad Al Saad, la cui conglomerata è in corsa per rilevare da Lukoil
la raffineria Isab di Priolo.
Sugli idrocarburi il
Qatar, terzo Paese per riserve di gas e primo esportatore via nave, ha costruito
le sue ricchezze. E l'Eni vi ha consolidati rapporti, che nel 2022 l'hanno fatta
scegliere come partner al 25% di QatarEnergy nel progetto di 27 anni North Field
East, il più grande terminale Gnl al mondo. Accordo trattato direttamente
dall'ad dell'Eni, Claudio Descalzi, con i vertici dell'emirato.
Nell'Eni si è fatto
le ossa Pasquale Salzano, distaccato nel 2011 dalla Farnesina come capo dei
rapporti istituzionali internazionali e dell'ufficio della major negli Usa; e
che dall'aprile 2017 al dicembre 2019 è stato ambasciatore italiano in Qatar. La
scelta di Salzano fu fortemente voluta da Renzi (anche se il suo amico e
collaboratore Marco Carrai avrebbe preferito Salzano a Tel Aviv), che lo
caldeggiò a Paolo Gentiloni malgrado ambasciatori più esperti e di pieno rango
puntassero al ruolo. Salzano ha cementato così bene l'amicizia tra i due Paesi
da far decollare l'interscambio commerciale. Una missione compiuta per lui,
passato oggi a presiedere la pubblica Simest.
Quasi in sincrono,
tra il 2012 e il 2015 i capitali del Qia, il fondo sovrano locale da 450
miliardi di dollari, planarono sul mercato immobiliare italiano, tra la Sardegna
e Milano. Il passaggio di alberghi e terreni della Costa Smeralda avvenne grazie
ai contatti tra l'emiro e Tom Barrack, l'americano amico di Trump proprietario
del fondo Colony Capital che poco prima gli aveva ceduto anche il Paris Saint
Germain.
Mentre il trait
d'union italiano è stato Franco Carraro, ex ministro, ex sindaco di Roma, già
presidente del Coni e della Figc e molto vicino alla Capitalia di Cesare
Geronzi, in sella alla Costa Smeralda Holding dal 2006 e anche con la nuova
gestione qatarina.
La bandierina
milanese viene invece piantata in due tappe, acquistando per circa 2 miliardi i
25 palazzi del complesso di Porta Nuova che comprende il famoso Bosco Verticale
e la torre Unicredit di Pella. L'affare è facilitato dai rapporti già esistenti
tra la struttura del Qia e quella del fondo americano Hines, allora gestito in
Italia da Manfredi Catella che, in seguito, si avvalse della consulenza del
banchiere d'affari Luigi De Vecchi, ora al vertice di Citi.
Dal “Fatto
quotidiano” il 17 dicembre 2022.
Che schifo questa
sinistra, signora mia. Da Lilli Gruber la predica sulla questione morale ce la
propina Italo Bocchino, direttore del Secolo d'Italia, ex parlamentare del
centrodestra, imputato nel processo Consip per traffico d'influenze illecite
insieme a Tiziano Renzi e Alfredo Romeo relativo alla gara FM4 da 2,7 miliardi
di euro. Bocchino è schifato "tre volte", mica una soltanto.
"Mi fa schifo e
basta". Uno. "Mi fa schifo perché queste persone sono state trovate con pacchi
di soldi a casa in un modo ignobile". Due.
"Mi fa schifo perché
si sono venduti sui diritti umani, un valore che la sinistra rivendica". Tre.
Bocchino non ha tutti i torti, ma se il pulpito è quello dell'ex consulente di
Romeo che comunicava con lui negli uffici di via Pallacorda a Roma attraverso
pezzi di carta scritti al momento per eludere le cimici piazzate dal capitano
Gianpaolo Scafarto, qualche dubbio sulla credibilità della predica ci viene.
La lobby delle
3.500 Ong che spadroneggiano alla Ue.
Le organizzazioni
non governative hanno occupato Bruxelles. E non ci sono controlli sui
finanziatori. Paolo Bracalini il 16 Dicembre 2022 su Il Giornale.
«Le ong? Servono a
far girare i soldi» confessa Francesco Giorgi, l'assistente-faccendiere che
smistava le mazzette insieme alla compagna Eva Kaili, ex vicepresidente del
Parlamento Ue. In effetti si vuol fare affari a Bruxelles aprire una ong è la
via più semplice. Ci si dà un'immagine nobile, ci si ammanta di intenti
umanitari, si sceglie un bel nome impegnato, e poi si fa un po' quel che si
vuole sfruttando l'accredito nei palazzi del potere europeo e le facilitazioni
che ne conseguono. Infatti la capitale della Ue pullula di organizzazioni non
governative, un vero esercito. C'è un numero preciso perché la Commissione Ue ha
previsto un registro per la Trasparenza, una banca dati che registra tutti i
gruppi e le organizzazioni «che cercano di influenzare l'elaborazione o
l'attuazione delle sue politiche e della sua legislazione». Le lobby dunque, e
fra queste anche le ong. Nella categoria «Organizzazioni, piattaforme e reti non
governative e altre organizzazioni analoghe» il registro conta la bellezza di
3488 associazioni accreditate. Tra queste ci sono i colossi della solidarietà,
da Amnesty a Save The Children, e poi una miriade di organizzazioni che si
occupano di tutto, dai diritti umani a quelli degli animali, dal cambiamento
climatico alle questioni legate alla giustizia, come «Non c'è pace senza
giustizia» di Emma Bonino, diretta da Niccolò Figà-Talamanca, indagato
nell'inchiesta belga sul Qatargate. E poi appunto la ong Fight Impunity dell'ex
parlamentare Pd e Articolo Uno, Antonio Panzeri, anche quella depennata dal
Registro dopo lo scoppio dello scandalo.
Le norme
avvantaggiano chi vuole utilizzare le ong e finanziarle per attività di
pressione politica, magari da paesi extraeuropei, mantenendo la privacy. A
differenza delle associazioni che rappresentano interessi industriali, le ong
hanno infatti meno obblighi di trasparenza finanziaria rispetto alla provenienza
dei fondi e delle donazioni che ricevono. Un vero assist per quei finanziatori
che vogliono influenzare le decisioni politica senza avere pubblicità. «Le ong
sono soggette alle stesse regole dei normali lobbisti aziendali. Ma mentre per
un lobbista d'affari sarà difficile nascondere le proprie origini e i propri
interessi, la creazione di una ong per rappresentare interessi d'affari o di un
Paese straniero, può permettere di nascondere le proprie origini. L'attuale
registro fa poco per rimediare a questa situazione. I casi di gruppi di
facciata, non vengono mai scoperti dai funzionari che gestiscono il registro, a
quanto ricordo», spiega a Vita Kenneth Haar, ricercatore di Corporate Europe
Observatory, un gruppo di ricerca sull'attività di lobbying in Ue. Ricorda bene,
in effetti il Registro per la trasparenza ha solo 9 dipendenti, a fronte di
migliaia di associazioni da controllare, in via puramente teorica. Un sistema
opaco, perfetto per «far girare i soldi». L'inchiesta sulle mazzette del Qatar
ha messo in evidenza il ruolo che possono giocare le ong in questi processi
corruttivi. La Lega ha presentato degli emendamenti alla risoluzione sul
Qatargate, per introdurre una revisione più stringente delle norme sulle ong. Ma
non è passata per il veto della sinistra. E sul ruolo delle ong è intervenuto
anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, impegnato a contrastare le
navi ong che fanno da «taxi dei migranti». «Il sospetto che talune formazioni
siano ispirate a creare un meccanismo di condizionamento non lo dico io ma studi
di anni fa. Siamo molto attenti perché non mi stupirebbe se il condizionamento
politico di queste Ong fosse un anello di una catena più grande».
Non chiamateli
lobbisti.
Simone Dattoli su Panorama il 13 Dicembre 2022.
Improvviso come una
valanga è piombato un nuovo scandalo legato al malaffare all’interno delle
istituzioni. Lo hanno chiamato “Qatar Gate” o peggio ancora “The Italian Job” -
il colpo all’italiana - perché nelle vicende di corruzione che fanno tremare la
Commissione Europea e l’intero Parlamento alcuni dei principali protagonisti
sono purtroppo nostri connazionali.
Ma aldilà della
nazionalità e delle istituzioni coinvolte, quello su cui vorrei porre
l’attenzione in questa vicenda di cui al momento pare sia emersa solo la punta
dell’iceberg di un ampio sistema, è che ancora una volta semplicisticamente i
media e l’opinione pubblica hanno pensato di utilizzare il termine lobbista per
fotografare e descrivere coloro che si ipotizza abbiano commesso attività
illecite legate al traffico di influenze. E così ancora una volta ci troviamo a
dover difendere d’ufficio una categoria, quella dei lobbisti appunto, che poco
ha a che vedere con le pratiche di cui si racconta in questi giorni. Simone
Dattoli, ad & founder Inrete Come rappresentante di una delle principali società
di consulenza italiane in ambito public affairs e lobbying più volte negli anni
sono intervenuto in tavoli di lavoro, dibattiti e anche in sedi istituzionali
per portare testimonianze e contributi utili a dare forma e dignità ad un
settore spesso male interpretato come quello delle relazioni istituzionali e
della rappresentanza di interessi.
Negli ultimi
cinquanta anni sono stati presentati in Italia quasi cento disegni di legge
volti a regolamentare questo tipo di rapporti, e anche nella passata legislatura
tutti i principali operatori del settore hanno convintamente sostenuto la
necessità di una regolamentazione che supportasse un settore che ha vissuto
un’evoluzione significativa negli anni, sia sotto il profilo degli strumenti che
delle competenze, diventando sempre più uno strumento a supporto delle
istituzioni e della politica piuttosto che un’attività portatrice di valori
negativi. E allora perché oggi ancora una volta ci ritroviamo a dover
distinguere tra lobbisti buoni e lobbisti cattivi? Perché la mancanza di un
reale riconoscimento della categoria, con precise regole di ingresso e di
ingaggio lascia aperta la possibilità alla creazione di aree grigie in cui
pratiche poco ortodosse possono insinuarsi. Un esempio su tutti è quello delle
cosiddette “revolving doors” e cioè la possibilità di impedire a chi ha
ricoperto nel recente passato incarichi elettivi di poter semplicemente cambiare
la giacca e diventare da decisore a portatore di interessi in un tempo talmente
breve da consentire di poter far pesare il proprio precedente ruolo in maniera
poco trasparente. Una norma di buon senso, che spegnerebbe le aspirazioni
lobbistiche e la voglia di guadagno di molti che, magari non più eletti e quindi
rimasti privi di importanti emolumenti mensili, si improvvisano in un mercato
fatto invece di professionisti e organizzazioni che rispettano e anzi invocano
regole sempre più qualificanti per la determinazione di una categoria che non
merita di essere sempre citata negativamente.
Da “Posta e
risposta” – “la Repubblica” il 13 dicembre 2022.
Caro Merlo, non mi
sorprende che Massimo D'Alema, che ha trovato un compratore qatarino della
raffineria di Priolo, da bravo campione di supercinismo spacciato per super
intelligenza, sia ora diventato un lobbista, un procacciatore d'affari
internazionali. Mi sorprende invece che il vice segretario del Pd Giuseppe
Provenzano glielo abbia finalmente detto, così, sul grugno.
Dai candidati alla
segreteria del Pd Elly Schlein, Stefano Bonaccini, Matteo Ricci, sinora avevo
sentito solo vacuità retoriche: ripartire dal basso, tornare agli operai,
battersi per i diritti: ma va? E invece, evviva, Peppe Provenzano ha detto
qualcosa di sinistra; non le demagogie a 5 stelle (sponsorizzate, guarda caso,
da D'Alema), ma qualcosa di semplice da cui far ripartire la sinistra: "siamo un
partito di governo, ma non un partito di affaristi". Bravo.
Lilly D'Ambrosio -
Bari
Risposta di
Francesco Merlo:
Massimo D'Alema è
diventato un broker - l'archetipo è Michael Douglas nel film Oscar Wall Street -
che si occupa di profitto e di transazioni non maligne, ma coperte e
spregiudicate com' è nella natura del capitalismo internazionale. Non importa a
nessuno se e quanto D'Alema ci guadagni ed è meschino il rancore dei militanti
con le scarpe rotte: "Non c'è nobiltà nella miseria" dice Michael Douglas.
Il broker però gioca
d'azzardo con uno stile e una passione che non consentono più il moralismo di
chi, ad ogni intervista, ancora parla ed è ascoltato come un padre nobile della
sinistra. Non sorprende insomma che D'Alema non si ispiri più alla filosofia
della tombola, che prometteva "ricchi premi" nelle feste dell'Unità, ma alla
filosofia del Monopoli che, attenzione, non è certo il gioco del delinquere
economico.
Meraviglia invece
che, tra tante analisi, astratte e astruse, sulla crisi della sinistra, uno
solo, Peppe Provenzano, abbia indicato la strada giusta che, vedrà, non sarà
seguita: "vedere ex leader della sinistra fare i lobbisti in grandi affari
internazionali non è solo triste, ma dice molto sul perché le persone non si
fidano, non ci credono più".
Provenzano fa
pendant con Paolo Gentiloni sulla corruzione a Bruxelles: "I corrotti sono di
destra e di sinistra. Ma è drammatico che questi episodi di corruzione
riguardino i lavoratori che hanno bisogno di tutela, un valore irrinunciabile
per la sinistra".
Provenzano e
Gentiloni raccontano la sinistra che si è dissipata, estenuata e corrotta
provando a liberarsi e a liberarci dall'ideologia, ma senza riuscire a diventare
moderna restando sinistra. È la sinistra che ha perso perché, come dice Michael
Douglas: "Non mi illudo di vincere un concorso di popolarità. Ho un "amico" che
dice di me: 'Perché onoriamo quest' uomo? Siamo a corto di esseri umani?'".
D’Alema e il
Qatargate: «Quelle banconote sono un’indecenza. Io? Consulente, non affarista».
Tommaso Labate su Il Corriere della Sera il 17 Dicembre 2022.
L’ex premier: «Nel
mio caso non ci sono porte girevoli, ma stagioni diverse. Faccio il consulente,
ma non sono più parlamentare». Panzeri? «Una persona che stimavo».
Presidente D’Alema,
che impressione le fa vedere persone che conosce da anni, come Antonio Panzeri,
coinvolte in uno scandalo come il Qatargate?
«Sono colpito e
addolorato. Anche perché le persone coinvolte hanno una storia tale per cui non
si può che rimanere colpiti e addolorati. Condivido l’intransigenza di Roberto
Speranza e del Pd. Non trovo però accettabile che si prenda questa vicenda e la
si usi come una clava per demolire una storia e una classe dirigente, facendo
confusione tra cose che sono totalmente non assimilabili tra loro».
Panzeri e Cozzolino
in passato sono stati censiti tra i «dalemiani».
«È un aggettivo il
cui utilizzo, com’è noto, ho sempre contestato. Panzeri è uno degli esponenti
che ha aderito ad Articolo 1, Cozzolino no, comunque sia sono persone che
conosco da anni e che ho stimato. Nel caso di Panzeri parliamo dell’ex
segretario della Camera del Lavoro di Milano. Una figura con una storia
sindacale importante alle spalle, non certo l’assistente di D’Alema».
I sacchi con le
banconote nelle case private, negli uffici.
«Non avrei mai
potuto sospettare una cosa del genere e infatti la trovo un’indecenza, che
merita una riposta ferma in difesa del Parlamento europeo. Devo dire che ho
molti dubbi sul fatto che questo tipo di pressioni abbia impedito all’Europa di
prendere le sue decisioni. Infatti a me risulta che il Parlamento europeo si sia
pronunciato in modo molto severo rispetto al tema dei diritti umani in Qatar.
Comunque sia, anche soltanto il tentativo di condizionare le istituzioni
attraverso un’opera corruttiva è inaccettabile».
Si indaga anche
sugli eurodeputati amici del Marocco. Circolano le foto del 2012 di una
conferenza del Mediterraneo organizzata dal Pd e dai Socialisti europei in cui,
tra relatori e ospiti, figuravano Gualtieri, Panzeri, Cozzolino. Il convegno
venne chiuso da un suo intervento.
«Non mi risulta che
parlare a un convegno sia un reato. E comunque, il Partito socialista marocchino
è membro dell’Internazionale socialista, abbiamo sempre avuto tanti rapporti. In
Marocco, in cui è in corso un processo di democratizzazione che non si vede
certo in Qatar, un socialista a un certo punto è arrivato addirittura alla
carica di primo ministro. La nostra azione è sempre in difesa dei diritti umani
e della democrazia, per cui in quel mondo abbiamo avuto sempre relazioni
importanti con le forze che si muovono in queste direzioni».
Il vicesegretario
del Pd, Provenzano, evocando anche la sua attività, ha detto che vedere ex
leader della sinistra fare i lobbisti in grandi affari istituzionali non è solo
triste; ma dice molto del perché la gente non si fida più della sinistra.
«Provenzano ha detto
una cosa giusta. E cioè che non si possono accettare porte girevoli tra politica
e attività economica. Io però non faccio né l’affarista né il lobbista. Da
diversi anni ho un’attività di consulenza prima di avviare la quale, è agli
atti, ho scritto al segretario Speranza una lettera di dimissioni dagli
organismi dirigenti di Articolo 1. Non ci sono nel mio caso porte girevoli; ma
diverse stagioni nella vita che devono essere scandite da un rigido principio di
incompatibilità. Io le ho scandite, diciamo».
Ammetterà che in
tanti non la pensano così.
«Vede, questo tipo
di attività deve essere fatto alla luce del sole. Io non sono più in Parlamento
dal 2013, mi sono dimesso dagli organismi dirigenti del partito a cui sono
iscritto, poi ho creato una società, collaboro con società internazionali,
presento bilanci. Tra l’altro concorro in questo modo largamente a finanziare la
mia fondazione e la rivista. Non faccio un’attività sotterranea. È tutto
trasparente, tutto controllabile. Qualcuno dice che non è opportuno? Be’, in
tutti i Paesi del mondo ci sono persone che hanno avuto un ruolo istituzionale e
che poi continuano a dare un contributo utilizzando le loro competenze al
servizio dello sviluppo economico. Le aggiungo un’altra cosa, visto che ci
siamo. Persino una persona solitamente mite come il sottoscritto arriva al punto
in cui non ne può più di leggere certe menzogne. Infatti mi sono rivolto agli
avvocati per discutere della questione nelle sedi preposte. È falso, tanto per
dirne una, che io abbia fatto da mediatore nella vendita di armi o che abbia
truffato il governo italiano con ventilatori difettosi».
Si riferisce agli
affari con la Colombia?
«Ho dato una mano a
un imprenditore con una qualche imprudenza, lo ammetto. Ma se avessi partecipato
a una compravendita di armi sarei stato oggetto di attività giudiziaria.
Parliamo di reati. Reati che, non a caso, nessuno mi contesta».
E sulla vendita dei
ventilatori difettosi all’inizio della pandemia?
«C’era una corsa
disperata ad acquistare questi prodotti sul mercato cinese, perché si producono
soprattutto lì, e tutti andavano e pagavano in anticipo. E visto che l’Italia
non poteva farlo per le nostre regole amministrative, a me fu chiesto di trovare
qualcuno che comprasse in vece nostra, mettendoci i soldi. Io ho trovato
un’associazione che l’ha fatto. Ma attenzione (mostra l’email di richiesta col
logo della presidenza del Consiglio, ndr): il modello del ventilatore fu scelto,
su indicazione del Comitato tecnico scientifico, dalla Protezione civile
italiana non da D’Alema, che non c’entrava nulla. Presumo, prima di pagarli, che
abbiano verificato che funzionassero. Ma lo presumo, visto che io ho solo fatto
un favore e non ho venduto niente a nessuno».
È impegnato ad
aiutare il Qatar a rilevare la raffineria di Priolo?
«Anche qui (sorride,
ndr), “aiutare il Qatar…”, quante bugie. Una cordata di investitori
internazionali, tra cui è presente un imprenditore qatariota, si è rivolta anche
me per l’acquisizione della raffineria. A loro ho dato un consiglio: vi
interessa? Bene, come prima cosa andate a parlare col governo. Cosa che abbiamo
fatto prima col governo Draghi, attraverso il ministro Cingolani, e ora col
governo in carica. Massima trasparenza. Vogliono mantenere livelli
occupazionali, rilanciare l’area, rispettare i paletti europei della transizione
energetica. Se poi si decide il principio che non si possono accettare
investimenti che provengono da Paesi non democratici, sarò il primo ad
attenermi; naturalmente bisognerebbe smontare circa la metà dell’economia
italiana e anche un bel pezzo del campionato di calcio. Questo è il festival
dell’ipocrisia. Tra l’altro, non ricordo grandi sollevazioni intellettuali
quando Gheddafi, che non era un campione della democrazia, era entrato nel
capitale di grandi aziende italiane, anche dell’informazione...».
Voterà al congresso
del Pd?
«No. Perché ho
sempre pensato che il segretario di un partito debba essere scelto dagli
iscritti. E io non sono un iscritto di quel partito».
Potrebbe tornare a
esserlo presto.
«Seguo con molta
attenzione il dibattito congressuale del Pd. Alla fine di questo percorso, mi
atterrò alle indicazioni del mio segretario, Speranza».
Massimo Gramellini
per il “Corriere della Sera” il 13 dicembre 2022.
Se ti riempiono un
sacco di banconote fino all'orlo per parlare bene del Qatar e tu parli bene del
Qatar, sei una politica corrotta, ma lineare. Invece l'eurosocialista (nel senso
di socialista sensibile agli euro) Eva Kaili ha scelto una strada più contorta,
non limitandosi a tessere l'elogio dei suoi corruttori, ma usandolo per sputare
sull'Europa che le passa lo stipendio, quello regolare.
Forse avrete visto
anche voi le immagini del memorabile intervento al Parlamento di Bruxelles in
cui la vicepresidente Kaili proponeva il Qatar come modello sindacale per il
nostro Continente: «Impariamo da loro, lì c'è il salario minimo!». Di sicuro c'è
quello massimo, riservato a lei e ai suoi compari.
Nell'area socialista
è partita la solita corsa a prendere le distanze dalle Kaili e dai Panzeri, come
se l'avidità e il lobbismo a favore dei mostruosamente ricchi fossero
incompatibili con la loro parte politica, che ne ha invece sempre fornito
amplissime testimonianze.
L'aggravante di
sinistra, se così si può dire, sta in quel non accontentarsi di adulare il
finanziatore, ma nel volere trasformare persino l'adulazione a pagamento in una
caricatura di battaglia progressista. Che consistano in questo i vantaggi del
famoso «multipolarismo» decantato dagli esegeti del modello arabo, russo,
indiano, cinese? Definire bieco e corrotto il capitalismo occidentale mentre si
prendono le mazzette da quello degli altri.
Pier Luigi Petrillo
per “il Domani” il 13 dicembre 2022.
L'indagine sulle
presunte tangenti pagate dal Qatar a esponenti del parlamento tato
all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della regolamentazione dei
rapporti tra lobby e decisori pubblici.
Partiamo da un dato
di fatto: l'azione posta in essere dai gruppi di pressione al fine di
influenzare i processi decisionali è strettamente connessa alla natura
democratica di uno stato.
Lobbying è
democrazia. Un sistema democratico, per essere tale, necessita di un dialogo
continuo e trasparente tra decisore pubblico e lobby consentendo, a queste
ultime, di intervenire nel processo decisionale.
L'aspetto critico di
tale relazione non risiede nella natura "negoziata" dell'atto conseguente al
processo decisionale, ma nel modo in cui i vari interessi sono sintetizzati
nella decisione finale. È proprio in questo "modo" che si cela il rischio
corruzione che, tuttavia, non dipende dall'azione di lobbying di per sé ma
dall'assenza di trasparenza che connota la maggior parte dei processi
decisionali e dall'elevata probabilità che, a intervenire nel processo
decisionale, non siano tutti coloro che ne hanno interesse ma solo i più
potenti. Il paradiso dei lobbisti
Per ovviare a tali
fenomeni degenerativi servono norme puntuali.
A Bruxelles queste
regole ci sono e consentono oggi di conoscere come i lobbisti intervengono su
parlamento, Commissione e Consiglio. Secondo un accordo siglato tra le tre
istituzioni ed entrato in vigore a giugno 2021, i lobbisti che intendano
organizzare incontri o avere contatti con i decisori pubblici al fine di
influenzare le politiche dell'Unione sono tenuti a iscriversi a un registro
pubblico e a rispettare numerose regole di trasparenza. Le medesime regole
valgono per i decisori pubblici europei che incontrano i lobbisti iscritti.
La normativa ha però
due scorciatoie: in primo luogo, gli obblighi di trasparenza non si applicano a
chi rappresenta gli interessi di stati anche di paesi terzi, di partiti politici
e di sindacati coinvolti nel dialogo sociale europeo.
In secondo luogo,
agli ex parlamentari non si applicano le norme che vietano l'assunzione di
incarichi in conflitto di interessi appena cessato il mandato (il così detto
"revolving door"). Sono queste "scappatoie" normative ad avere alimentato -
stando alle ricostruzioni giornalistiche - il terreno della corruzione nello
scandalo emerso in questi giorni.
Il Far west italiano
La vicenda europea
rappresenta un campanello d'allarme per il contesto italiano dove la relazione
tra lobbista e decisore è avvolta da un velo impenetrabile e dove continuano a
mancare, nonostante lo "scandalo" Renzi, norme volte a regolare il rapporto tra
parlamentari in carica e stati esteri. L'Italia è una delle poche democrazie al
mondo a non avere una legge organica in materia; il legislatore è intervenuto
solo in modalità difensiva, introducendo nel codice penale il reato di «traffico
illecito di influenze» che punirebbe chiunque indebitamente si fa dare o
promettere denaro per la propria mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale.
La norma, per come
formulata, ha vizi di incostituzionalità ed è sostanzialmente inapplicabile,
come ha evidenziato l'ufficio studi della corte di Cassazione precisando che, in
assenza di una legge volta a definire i limiti leciti dell'influenza, è
impossibile determinare i casi di influenza illecita. L'assurdità ditale
disposizione è stata ricordata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio in una
intervista al Corriere della sera.
Nella scorsa
legislatura la Camera ha approvato un disegno di legge in materia, presentato da
Francesco Silvestri (M5s), poi arenatosi in Senato sotto i colpi di migliaia di
emendamenti. Tuttavia, quel provvedimento nulla disponeva sul lobbying da parte
di rappresentanti di stati esteri né fissava divieti di assumere incarichi da
parte degli ex parlamentari (molti dei quali si improvvisano lobbisti) o da
parte di parlamentari in carica nei confronti di stati esteri.
Lo scandalo europeo
dovrebbe ora indurre il governo Meloni a colmare le "scappatoie" italiane. Le
direzioni potrebbero essere due: da un lato imporre obblighi di trasparenza in
capo ai decisori pubblici (il che non vuol dire compilare dei moduli assurdi
come previsto inutilmente dal decreto legislativo n. 33 del 2013) e, dall'altro,
disciplinare i diritti dei lobbisti in modo da fissare la cornice entro cui
operare.
Al tempo stesso
serve che il parlamento adotti un codice di condotta dei propri membri che vieti
espressamente rapporti economici con stati esteri e loro rappresentanti. Il
ministro Nordio ha dichiarato che è urgente agire. Speriamo sia di parola.
Annalisa Cuzzocrea
per la Stampa il 14 dicembre 2022.
«Siamo profondamente
scossi e increduli davanti alle ricostruzioni di queste ore. Sono enormità che
non potevo nemmeno immaginare». Solo nel suo ufficio di Montecitorio, Roberto
Speranza – deputato e leader di Articolo 1 – chiede: «Posso dire che sono
incazzato nero?».
Può, ma non basta.
Quello che emerge su Antonio Panzeri – europarlamentare prima del Pd, poi di
Articolo 1 - fa pensare a una rete costruita nel tempo. Possibile non vi siate
accorti di nulla?
«I fatti che vengono
ricostruiti, con tanto di flagranza di reato con cui bisogna fare i conti al di
là di qualsiasi garantismo, sono quanto di più lontano ci possa essere da
Articolo 1. Che è una piccola comunità di militanza vera, di gente che dedica
una vita a tenere aperto un circolo tra mille difficoltà autotassandosi, capendo
come poter risparmiare 5 o 10 euro se c’è da pagare un manifestino o una sala.
Abbiamo avuto oltre 50mila persone che ci hanno dato il loro 2 per mille
raccogliendo in un anno gli stessi soldi di cui si parla in queste ore».
I 600mila euro
trovati nel residence di Bruxelles in cui vive Panzeri?
«Seicentomila euro
raccolti dal versamento volontario di persone che hanno scelto di sostenerci.
Abbiamo candidato alle politiche il nostro segretario della Liguria, un operaio
dell’Ansaldo. Michele Mognato, parlamentare nella scorsa legislatura, adesso è
tornato a fare l’Rsu in fabbrica».
Siete persone che
non fanno politica per arricchirsi, sta dicendo questo?
«La rabbia che ho
dentro è pesante perché il modo in cui intendiamo la politica, la militanza e il
rapporto con le istituzioni è totalmente incompatibile con quel che stiamo
leggendo».
È sicuro non ci
siano altre persone di Articolo 1 coinvolte?
«Lo escludo. Le
risorse che noi prendiamo arrivano dal 2 per mille, dai versamenti dei deputati,
2000 euro ciascuno, e dagli iscritti. Non raccogliamo soldi in altro modo».
Non accettate
donazioni da società o fondi?
«No. I nostri
bilanci sono pubblici».
Non avete fondazioni
del partito?
«Ma no!».
Non crede sia
comunque grave, non accorgersi di nulla?
«Mi sono fatto
questa domanda. Panzeri era un parlamentare europeo autorevole con una storia
sindacale importante alle spalle. È uscito dal Pd per partecipare alla
fondazione di Articolo1. Lo abbiamo seguito nella sua attività istituzionale a
Bruxelles. Quando ha smesso, ha confermato la tessera di Articolo 1, senza
incarichi gestionali».
Non è un dirigente?
«È una personalità
rilevante della sinistra milanese e lombarda, non è l’ultimo arrivato. Si tratta
di una persona che ha fatto per otto anni il capo della Camera del lavoro di
Milano, poi dodici anni europarlamentare, presidente della commissione Diritti
umani di Strasburgo. Come potevamo immaginare? Le attività che ha condotto dopo
non hanno mai avuto a che fare con noi».
Nessun
coinvolgimento con la Ong che presiedeva?
«Mai avuto a che
fare».
È stato perquisito
l’ufficio e sequestrato il cellulare di Davide Zoggia, ex deputato Pd, passato
con lei in Articolo 1, ora collaboratore di due europarlamentari.
«Non è più in
Articolo 1 da molto tempo. A differenza di quello che emerge per Panzeri non ho
elementi per valutare eventuali responsabilità. Personalmente sono per usare la
massima fermezza dinanzi alle responsabilità che emergeranno. Spero che la
magistratura vada avanti con determinazione perché qui è in gioco la credibilità
delle istituzioni europee e delle forze politiche coinvolte. Voglio più di tutti
che si faccia chiarezza. Noi in questa vicenda siamo parte lesa».
Che decisione avete
preso nei confronti di Panzeri?
«La commissione di
garanzia appena sono apparsi gli elementi più gravi lo ha depennato
dall’anagrafe degli iscritti».
La vicenda Soumahoro
ha scoperchiato, come minimo, una grossa dose di ipocrisia. Adesso si trovano
sacchi di soldi di provenienza sospetta in casa di chi diceva di agire per gli
ultimi, i reietti, i perseguitati. Vede l’enorme questione morale davanti alla
quale si trova la sinistra?
«Credo che la
questione morale sia un tema attuale nel nostro Paese. Fa molto più male quando
riguarda la sinistra. Perché a destra negli anni ne abbiamo viste parecchie».
Ma dopo questo, dopo
il caso del dem Nicola Oddati trovato con 14mila euro letteralmente in tasca e
indagato per corruzione, dopo l’inchiesta Mafia capitale, e potrei continuare,
capisce che non si può rivendicare alcuna superiorità morale?
«Lo capisco e so che
a noi fa molto più male perché l’eredità della sinistra è legata alla lezione di
Enrico Berlinguer. Dobbiamo con onestà dirci che non siamo impermeabili e quindi
anche noi dobbiamo avere processi di selezione dei gruppi dirigenti il più
rigorosi possibili. Fatti del genere sono inaccettabili e finiscono per far
perdere la fiducia delle persone nei confronti della politica. Ho speso la mia
vita, da quando avevo 18 anni, a dire che non è vero che siamo tutti uguali, che
tutti rubano alla stessa maniera. Vedere che un’azione individuale così grave
può macchiare la storia di una comunità è inaccettabile».
Provenzano,
vicesegretario Pd, scrive: «Non c’entra con la vicenda dell’Europarlamento, ma
vedere ex leader della sinistra fare i lobbisti in grandi affari internazionali
dice molto del perché le persone non ci credono più». Parla anche di Massimo
D’Alema. Del suo ruolo di intermediario nella vendita di armi alla Colombia e
nella proposta di acquisto di un fondo del Qatar per la raffineria Lukoil in
Sicilia. Tutto lecito, ma non crede ci sia un problema di opportunità politica?
«D’Alema non c’entra
nulla con questa vicenda giudiziaria. Chiamarlo in causa su questo è del tutto
improprio».
Ha un peso politico
e un’influenza che non può negare. Non solo su Articolo 1 ma anche sul Movimento
5 stelle a quanto risulta dai buoni rapporti, confermati, con Giuseppe Conte.
«Ha scelto di
accettare un incarico professionale rilevante in una importante società di
consulenza. Ma non si può non ricordare che è fuori dalle istituzioni da dieci
anni».
Crede ci sia
differenza con Matteo Renzi, attaccato per i suoi contratti di consulenza con
l’Arabia Saudita di Mohammed bin Salman?
«Non credo sia una
differenza da poco se sei tuttora un rappresentante delle istituzioni della
Repubblica. Io sono per la netta separazione delle funzioni politiche e
istituzionali con quelle che hanno a che fare con la gestione di interessi
particolari».
Ue, 11.800 lobby
per influenzare Commissione e parlamentari. I casi di corruzione.
Milena Gabanelli
e Luigi Offeddu su Il Corriere della Sera il 7 aprile 2019.
Bruxelles supera
Washington e si consacra capitale mondiale del lobbismo: sono 11.801 i gruppi di
pressione elencati nel Registro della Trasparenza istituito dalla Commissione
Europea. A Bruxelles si fanno le leggi che riguardano 508 milioni di cittadini
e le lobby lavorano perché non contrastino gli interessi delle imprese e
associazioni che rappresentano: industrie, aziende private, grandi studi legali,
ma anche sindacati, ong, associazioni di consumatori.
Da Google a Eni ad
Altroconsumo: quanto spendono?
Ai primi posti nella
classifica ci sono il Cefic o Consiglio delle industrie chimiche europee (12
milioni di spese minime dichiarate nel 2018), Google (6 milioni nel
2017), Microsoft (5 milioni) BusinessEurope (la Confindustria europea, 4
milioni). C’è anche Huawei, il colosso cinese della telefonia, 2.190.000 di
costi dichiarati nel 2017.
Fra i singoli
Paesi, l’Italia, con 841 lobby, è al quinto posto dopo il Belgio (dove
ovviamente si registrano molti gruppi stranieri), la Germania, la Gran Bretagna,
la Francia. Fra le principali, per costi minimi dichiarati, troviamo:
Altroconsumo (5 milioni di euro), Enel (2 milioni), Eni (1.250.000),
Confindustria (900.000). Tutti insieme, i quasi dodicimila gruppi di pressione
di Bruxelles spendono circa 1,5 miliardi all’anno. A che cosa servono? A
mantenere uffici e personale, a fare convegni e campagne d’opinione in diversi
Paesi. O a comprare voti, leggi, e figure delle istituzioni, questo è il dubbio
spesso evocato.
Cosa fa il lobbista
Il lavoro del
lobbista è quello di contattare commissari ed eurodeputati trasmettendo loro
idee per emendare questa o quella norma. Commissari e deputati, a loro volta,
hanno bisogno di confrontarsi per sapere quanto e come incidono le direttive nei
vari settori dell’impresa e della società. Un’attività legale quindi, purché
avvenga alla luce del sole. Infatti ci sono delle transenne: se vuoi incontrare
un commissario europeo, per esempio, devi essere iscritto nel Registro della
Trasparenza. Ma il problema dei controlli resta: «Mentre la Commissione obbliga
i lobbisti a registrarsi prima che qualsiasi incontro possa aver luogo – spiega
Raphael Kergueno, del sito Integrity Watch legato a Transparency International
–, esercitare il lobbismo con gli eurodeputati e i delegati nazionali al
Consiglio resta invece un’attività largamente non regolata. Solo quando il
registro coprirà tutte e tre le istituzioni potremo verificare i comportamenti
di coloro che a Bruxelles prendono le decisioni politiche».
Il lobbismo soft
Ci sono tanti modi
per fare lobbismo, e a Bruxelles bisogna esserci, altrimenti ci sono solo gli
«altri». L’ong Altroconsumo ha scritto nel 2018 agli eurodeputati italiani,
chiedendo loro alcuni emendamenti a una proposta di direttiva sulle vendite a
distanza. Si voleva che anche ai beni digitali fossero estese ampie garanzie
contro i difetti di funzionamento, e così è stato. Sempre Altroconsumo ha
influenzato le direttive Ue contro l’impiego degli antibiotici negli allevamenti
intensivi. Slow Food ha fatto sentire la sua voce nelle direttive sugli Ogm.
Altronsumo dichiara di essere finanziata al 98,08 % da quote e abbonamenti degli
associati. Slow Food, costi minimi di 800.000 euro per il 2017, riceve
sovvenzioni Ue per 730.285 euro, e il contributo degli aderenti di 816.331 euro.
A volte basta
modificare un verbo
Il lobbismo delle
imprese è più aggressivo. Di norma, ogni proposta di legge raccoglie in
Parlamento 50-100 emendamenti, ma a volte sono molti di più e in questi casi
possono infilarsi quelli proposti, o scritti direttamente, dai lobbisti e
ricopiati pari pari dai deputati.
Quando si discusse
l’ultima riforma della politica agricola, gli emendamenti furono 8.000. Per la
direttiva che avrebbe dovuto regolare meglio gli hedge fund, i fondi di
investimento a rischio, ne piovvero 1600: secondo fonti ufficiose metà erano
stati scritti direttamente dai lobbisti della finanza. Anno 2013, direttiva
sulla protezione dei dati personali firmata dalla commissaria Ue Viviane Reding,
che parlerà poi di «lobbying feroce». Un esempio: l’articolo 35 del testo
originale della direttiva dice: «il controllore e il processore (di certi dati
personali, ndr) devono designare un responsabile della protezione…». La lobby
della Camera di Commercio americana chiede che al «devono» si sostituisca un più
morbido «possono». Il deputato conservatore inglese Sjjad Karim rilancia: nel
suo emendamento, accolto, si legge «dovrebbero». La differenza fra «dovrebbero»
e «devono» non è banale: sparisce l’obbligo tassativo.
La guerra del
copyright
L’ultima guerra fra
le lobby è scoppiata intorno alla direttiva sul copyright, appena approvata
dall’Europarlamento. Da una parte Google e gli altri giganti dell’high tech,
dall’altra musicisti, editori, giornalisti e le società che raccolgono i loro
diritti d’autore, schierate contro il «no» allo sfruttamento gratuito sul web di
opere che hanno diritto a un copyright. Dal novembre 2014 agli inizi del 2019 si
sono avuti 765 incontri fra lobbisti e Commissione, nei cui verbali compare la
parola «copyright». Google ha avuto 3 incontri al mese per tutto il 2018 con i
vertici della Commissione (e le associazioni per i diritti d’autore ancora di
più). In estate i deputati Verdi sono stati bombardati da tremila e-mail pro o
contro le nuove norme. Virginie Rozière, deputata favorevole, ne ha ricevuto 400
mila, tutte contrarie. Alla fine la direttiva ha disposto che i giganti
dell’high tech (nonostante le pesantissime pressioni) ora debbano chiedere le
autorizzazioni, pagare autori ed editori, e intervenire sulle violazioni dei
diritti.
Norme su emissioni,
plastica e farmaci: grande via vai
Un’altra guerra è
stata quella accesa dalle norme sulla plastica monouso. Il Cefic, l’ombrello
delle industrie chimiche (oggi schierato contro la plastica), nel 2010 dichiara
6 milioni di costi di lobbying, che nel 2018 diventano 12. Nel frattempo, dal
dicembre 2014 al febbraio 2019, ottiene 80 incontri con la Commissione Europea,
più o meno uno ogni 23 giorni. Significa che questa è una lobby influente,
ascoltata.
Poi c’è il pianeta
di «Big Pharma». Secondo un rapporto del 2015, le lobby dei farmaci spendono
tutte insieme 40 milioni di euro. Questi investimenti riguarderebbero anche le
decisioni sui diritti di proprietà o i delicati test sui farmaci. Altro settore
caldo è quello dell’automobile. Le spese delle sue lobby a Bruxelles sono
passate dai 7,6 milioni del 2011 ai 20,2 milioni nel 2014. Indizio per azzardare
un perché: nel 2013 si discutevano le norme Ue sulle emissioni di co2 delle
auto, nel 2014 quelle sull’ossido d’azoto.
I casi di corruzione
L’attività delle
lobby è per sua natura opaca e il panorama non è sempre tutto bianco o tutto
nero. A volte è proprio nero. Novembre 2010-marzo 2011, due giornalisti del
«Sunday Times» con telecamera nascosta si presentano come lobbisti a Ernst
Strasser, capogruppo del partito popolare austriaco: «Vorremmo cambiare una
direttiva, ci aiuta?». Lui accetta, loro pubblicano tutto. Strasser finirà in
carcere per corruzione. Come l’eurodeputato sloveno Zoran Thaler e il romeno
Adrian Severin, incastrati dalla stessa telecamera. Stessa disponibilità: 100
mila euro a colpo. Un anno dopo, ottobre 2012, il commissario Ue alla salute, il
maltese John Dalli, viene cacciato per i suoi legami con un lobbista del
tabacco. Per aggiustare una direttiva Ue c’erano in ballo 60 milioni.
Negli ultimi due
giorni sono falliti i negoziati, durati due anni, fra Commissione, Consiglio e
Parlamento europeo per l’istituzione di un registro unico.
Oltre 13mila
lobbisti: cosa succede in Ue.
Storia di Andrea
Muratore su Il Giornale il 12 dicembre 2022.
Diciannove
dipendenti delle lobby per ogni parlamentare europeo: Bruxelles è un crocevia
di portatori d'interesse di aziende, gruppi di pressione e società finanziarie.
Sono 13mila i lobbysti iscritti al registro ufficiale dell'Unione Europea,
diciannove volte il numero totale di parlamentari, che assomma a 705.
Lo
scandalo Panzeri-Kaili, in quest'ottica, rischia di gettare un'ombra sinistra
sul lavoro dei professionisti delle pubbliche relazioni che sono,
legittimamente, portatori di interessi. Più che di lobbying, nel caso, qualora
gli addebiti venissero confermati, dovremmo parlare di una triste storia di
corruzione e degrado morale, come del resto ha sottolineato anche il Commissario
agli Affari Economici Paolo Gentiloni. Ma lo scandalo rischia di gettare
un'ombra sinistra sull'intera galassia delle lobby. Al cui interno - oltre a
Panzeri - si trovano numerosi ex esponenti delle istituzioni.
Il Corriere della
Sera ricorda che "ben 485 ex parlamentari oggi lavorano per gruppi di interesse.
ben 485 ex parlamentari oggi lavorano per gruppi di interesse" e molti
personaggi di spicco delle istituzioni del passato hanno oggi incarichi
importanti in grandi multinazionali. José Manuel Barroso, ex presidente della
Commissione, è da anni un top manager di Goldman Sachs. L'ex Europarlamentare e
vicepremier britannico Nick Clegg è dal 2018 vicepresidente di Facebook. E ci
sono anche molti casi di revolving doors tra apparati amministrativi che
gestiscono cause o processi decisionali e aziende, sia di beni e servizi che di
consulenza, che sostengono gruppi di pressione: nel 2021 ad esempio, Nick
Banasevic, un altro alto funzionario coinvolto in cause contro Google e
Microsoft, ha lasciato l'UE per unirsi a Gibson Dunn, un'importante impresa
legale. L'ex commissario olandese Neelie Kroes, secondo gli Uber Files, avrebbe
rappresentato la compagnia di trasporto privato nella fase di diciotto mesi
compresa tra la fine del suo mandato e il limite legale segnato dalla
Commissione per assumere un ruolo nel privato.
Il Financial
Times riporta che solo sul fronte consulenziale questo problema è stato
affrontato: "Bruxelles sta restringendo la possibilità per i funzionari dell'Ue
che lavorano per le imprese del settore privato sfruttando le porte girevoli tra
l'istituzione e gli studi legali e le società di consulenza". Ma in generale il
mondo del lobbying non ha regole certe e questo, accanto a professionisti
trasparenti, crea un mondo di mezzo di portatori d'interesse che va di pari
passo con l'aumento delle agenzie e degli apparati, oltre che delle decisioni
strategiche prese dall'Ue.
Chi lavora a
Bruxelles ricorda la pioggia di audizioni avvenute ai tempi delle discussioni
sulla Gdpr, quando le compagnie del big tech furono le più critiche verso la
regolamentazione europea. L'European Chemical Industry Council è oggi con 9
milioni di euro il primo investitore nel lobbying presso la Commisisone, seguito
da Google con 6 e Microsoft con 5. Facebook e ExxonMobil sono a 3 milioni a
testa. Mohammed Chahim, europarlamentare socialista, ha sottolineato come a
giugno si fosse intensificato il lobbying dei big dell'auto per fermare
l'opzione del passaggio all'elettrico entro il 2035. E di recente, nota
Politico, molti parlamentari ritengono che "hanno ingannato i legislatori
europei durante i negoziati su due importanti leggi tecnologiche dell'UE, il
Digital Markets Act (DMA) e il Digital Services Act (DSA), nascondendosi dietro
altre organizzazioni: lobby che presumibilmente rappresentano piccole e medie
imprese, a cui hanno fornito finanziamenti e istruzioni. Nel frattempo, le lobby
hanno finto di essere i rappresentanti ufficiali delle Pmi mentre allo stesso
tempo promuovevano e difendevano gli interessi commerciali delle Big Tech",
senza rivelare le loro connessioni. Un altro esempio del fatto che non è il
lobbying il problema, ma l'assenza di regolamentazione verticale e di paletti
precisi sui passaggi di campo che, per ora, riguarda solo nove agenzie dell'Ue.
Le regole sul conflitto d'interesse esistono: basterebbe applicarle. E
distinguere i professionisti degli affari istituzionali dagli arrivisti che
lucrano sul contatto diretto tra esponenti istituzionali e settore privato.
Fate presto. La
migliore risposta al Qatargate è regolamentare i lobbisti dei Paesi extra Ue.
Pier Virgilio Dastoli su L’Inkiesta il 13 Dicembre 2022
Il caso sulla
presunta corruzione deve aprirci gli occhi su un vuoto legislativo da colmare il
prima possibile: non c’è nessuna regola che impedisca l’azione di lobbies
extra-europee su assistenti ed eurodeputati. L’Eurocamera deve creare una
commissione di inchiesta sulla vicenda
Il 10 dicembre è
stata la giornata internazionale dei diritti fondamentali che si celebra ogni
anno per ricordare la Dichiarazione universale proclamata dalle Nazioni Unite
nel 1948. Questa giornata internazionale ha paradossalmente coinciso con
l’esplodere del cosiddetto Qatargate e cioè con le informazioni diffuse dalla
Procura federale belga sull’inchiesta avviata cinque mesi fa per una serie di
azioni criminose secondo cui «gli inquirenti della polizia giudiziaria
sospettano che uno Stato del Golfo abbia cercato di influenzare le decisioni
economiche e politiche del Parlamento europeo». «Sono stati sequestrati contanti
per seicentomila euro oltre a materiale informatico e telefoni cellulari», ha
aggiunto la Procura federale belga.
Nonostante il
carattere molto scarno del comunicato, ambienti alla Procura federale belga si
sono immediatamente attivati per informare i due maggiori quotidiani belgi
francofono e fiammingo sull’identità dei fermati, sul numero e sulle località
delle perquisizioni, sui capi d’accusa e sul nome dello Stato del Golfo che
avrebbe esercitato il tentativo di influenza: ciò in pieno disprezzo – come
avviene purtroppo in molti paesi europei a cominciare dall’Italia nei rapporti
di «buona collaborazione» fra la magistratura o le cancellerie e la stampa –
delle ragioni che dovrebbero essere alla base degli avvisi di garanzia e della
presunzione di innocenza.
L’azione ultra vires
della Procura federale belga ha avuto l’effetto immediato di aprire un processo
mediatico nei confronti non solo degli indagati/fermati ma di tutto il
Parlamento europeo «sécoué – scrive Le Monde – par un Qatargate» o «soldi del
Qatar al Parlamento europeo» (Il Sole 24 Ore) o ancor di più «Eurocorruzione»
aggiungendo che «il Qatar ha corrotto la democrazia europea» (La Repubblica).
A proposito di
presunzione di innocenza vale la pena di sottolineare che la Procura si è
attivata il 9 dicembre perché fossero diffusi sulla stampa i nomi dei fermati
(6) ma che non ha usato la stessa premura e sollecitudine perché fosse diffusa
sulla stampa la notizia che uno dei fermati (Luca Visentini) era stato liberato
seppure sous conditions.
Il Movimento europeo
condanna senza riserve le azioni dei corrotti – quando esse saranno provate – e
ritiene che l’opinione pubblica europea debba essere rapidamente e ampiamente
informata sulle dimensioni non solo finanziarie della corruzione ma anche sugli
effetti delle azioni dei corrotti nelle decisioni “economiche e politiche” del
Parlamento europeo relative alla denuncia delle violazioni del rispetto dei
diritti fondamentali nel Qatar e più in generale negli Stati del Golfo.
Il Movimento europeo
prende anche atto con soddisfazione delle sanzioni prese con estrema rapidità
dal Parlamento europeo attraverso la propria presidente Roberta Metsola, dal
Gruppo S&D e dal Pasok nei confronti della vicepresidente Eva Kaili e si attende
che la stessa fermezza e la stessa rapidità siano adottate nei confronto di
altri eventuali indagati appartenenti a qualsiasi titolo all’istituzione così
come la totale estraneità dell’ETUC alle ipotesi di corruzione su cui indaga la
magistratura belga.
Noi invitiamo a
leggere con attenzione la risoluzione “sui diritti umani nel contesto della
Coppa del Mondo FIFA 2022 nel Qatar” approvata dal Parlamento europeo il 24
novembre 2022 a Strasburgo – nata da una proposta del Gruppo Renew Europe (i
liberali, n.d.r.) che, fin dalla legislatura 2014-2019, è stato il più attivo
nella denuncia delle violazioni dei diritti fondamentali in Europa e nel mondo
nonostante le incomprensibili reticenze di PPE e S&D – frutto di un compromesso
raggiunto fra Renew Europe, PPE, S&D e ECR e dunque con la auto-esclusione per
ragioni opposte di Verdi, Sinistra Europea e Identità e Democrazia.
Nella risoluzione si
condannano le morti (quelle che in Italia vengono chiamate ipocritamente
“incidenti sul lavoro”) e le violenze di cui sono stati vittime i lavoratori
nella preparazione dei campionati del mondo di calcio, le discriminazioni nei
confronti di centinaia di migliaia di migranti, la mancanza di trasparenza e di
responsabilità della FIFA nella scelta del Qatar avvenuta nel 2010, la lunga
storia di corruzione “rampante e sistemica” della FIFA che ha gravemente
danneggiato l’immagine e l’integrità del calcio, l’assenza del rispetto dei
diritti fondamentali e dei principi dello stato di diritto da parte degli
sponsor delle manifestazioni sportive, la mancanza di una riforma profonda delle
regole per l’attribuzione delle sedi dei campionati del mondo di calcio e di una
informazione trasparente sull’attribuzione del campionato 2022 al Qatar e il
mantenimento della pena di morte nel Qatar (dove è in vigore la legge islamica
della Sharia, n.d.r.).
Si deve invece
sottolineare che un approccio più flessibile nel giudicare lo stato della
protezione dei diritti nel Qatar e in particolare dei lavoratori migranti (come
si riscontra dal Testo della Risoluzione) sembrerebbe derivare soprattutto dal
fatto che sia l’ILO che l’ITUC hanno considerato le riforme adottate dal Qatar
come un esempio per gli altri Stati del Golfo.
La magistratura
belga e con essa le magistrature degli altri paesi europei possono e debbono
agire con pene esemplari contro i corrotti europei e le istituzioni europee
possono e debbono accompagnare le pene giudiziarie con sanzioni amministrative
congelando e poi cancellando i diritti finanziari maturati da membri delle
istituzioni così come la Commissione e il Consiglio dovranno indagare per
verificare se ci sono stati tentativi di influenze illegali al proprio interno.
La vicenda del
Qatargate deve permettere tuttavia di lanciare un forte allarme non solo sulla
presenza dei corrotti ma anche sull’azione dei corruttori e cioè delle lobbies
che agiscono da paesi al di fuori dell’Unione europea sapendo che la
regolamentazione e la trasparenza sulle lobbies europee deve essere rafforzata e
completata con un accordo interistituzionale ma che non c’è nessuna regola e
nessuna misura per impedire l’azione e le ingerenze di lobbies extra-europee.
Una pronta reazione
del Parlamento all’accaduto con il varo di misure preventive ed efficaci a
tutela dell’autenticità e dell’autonomia delle procedure di formazione della
volontà collettiva dell’organo a mandato universale dei cittadini europei
sarebbe la prima, doverosa, risposta all’attuale turbamento dell’opinione
pubblica continentale, nell’attesa che la Magistratura chiarisca la reale entità
dei fatti. Il Movimento europeo chiede infine al Parlamento europeo di creare
una commissione di inchiesta sul Qatargate a partire dalla lista di denunce e di
condanne contenute nella risoluzione del 24 novembre 2022.
Gauche Qatar. Le
accuse di corruzione a Bruxelles rivelano le fragilità del socialismo europeo e
della sinistra italiana.
Mario Lavia su
L’Inkiesta il 12 Dicembre 2022
Le istituzioni
restano forti ma l’indagine è un colpo duro all’immagine dell‘Europa, e getta
ombre anche su un’area di ex Pd ora dalemiani. Ma, attenzione, i precedenti
insegnano che è meglio essere garantisti fino all’ultimo
Doverosa e non
formale premessa: sulla vicenda che sta travolgendo esponenti o ex esponenti del
Parlamento europeo bisogna essere garantisti fino all’ultimo, come sempre. Ci
sono stati alcuni arresti, è vero, ma ovviamente non basta a decretare la
responsabilità delle persone in questione. Ci sono già le strumentalizzazioni
politiche tipicamente italiane, con la destra che chiede al Partito democratico
di chiarire.
È vero che la
vicenda tocca ambienti del socialismo europeo (che tristezza, ndr) ma il Partito
democratico in quanto tale non si capisce bene cosa c’entri. Comunque sia, la
questione è molto seria. In primo luogo, c’è il colpo all’immagine delle
istituzioni europee: «Lo scandalo di corruzione all’Europarlamento è una cosa
gravissima. Si tratterebbe di esponenti del Parlamento europeo e di attivisti
che avrebbero ricevuto soldi per chiudere un occhio sulle condizioni di lavoro
in Qatar. È una vicenda vergognosa», ha detto con chiarezza Paolo Gentiloni.
Non da oggi viene
alla luce che il Parlamento europeo e in generale le strutture politiche e
organizzative di Bruxelles sono nella costante attenzione di Stati, potentati,
lobby, forze economiche palesi e occulte che in mille modi tentano di
condizionarne politiche e scelte.
Questa volta è il
Qatar ad aver messo in moto azioni tese ad annullare l’immagine negativa di quel
Paese sotto molteplici aspetti, in primo luogo in relazione agli scarsissimi
diritti dei lavoratori. La domanda sorge spontanea: l’Europa è dunque permeabile
alle manovre di questo o quello Stato, di questo o quel potentato? Bruxelles
come la nuova Bisanzio, nei cui bazar brulicano faccendieri e corrotti? Il
palazzo del Parlamento europeo come un suq arabo?
Probabilmente questo
sarà il nuovo stornello da osteria dei sovranisti che da qualche tempo hanno un
po’ mollato la presa sull’antieuropeismo, ma che sono sempre in agguato nelle
loro tane nazionaliste.
Bisogna rispondere
di no, che quelle europee sono istituzioni forti. «I corruttori sono nemici
della democrazia», dice giustamente Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento
europeo. Ma siccome la struttura è gigantesca, donne e uomini che vi lavorano
sono più esposti alle “tentazioni”: a Bruxelles un consigliere parlamentare ha
spesso più potere di un deputato, personaggi lontani dai riflettori maneggiano
questioni e pratiche di grandissimo rilievo fuori da ogni possibile controllo: è
la tragedia delle democrazie quando si trasformano in grandi tecnocrazie.
E poi, al netto del
garantismo, possono inciampare nelle “tentazioni” parlamentari oscuri ma ben
addentro a certe dinamiche: non è il caso della importante socialista greca Eva
Kaili, vicepresidente dell’Europarlamento prontamente sospesa dalla presidente
Roberta Metsola, figura di primo piano.
Ma Antonio Panzeri,
già Partito democratico poi Articolo Uno, anch’egli subito sospeso, è un ex
deputato, comunque una figura non notissima al pubblico. Panzeri però è stato un
personaggio importante soprattutto nella sinistra milanese, segretario della
Camera del lavoro, poi dirigente Cgil di primo piano, una lunga storia
Pci-Pds-Ds-Pd, sempre annoverato tra i dalemiani di ferro. Amico di Massimo
D’Alema, uno di sinistra, talmente di sinistra da uscire dal Pd per confluire in
Articolo Uno di Pier Luigi Bersani. Il suo partito lo ha sospeso esprimendo
«sconcerto», perché per Panzeri è uno di quei compagni su cui non c’è da
dubitare, anche se era già incappato in una indagine interna dell’Europarlamento
per rimborsi di viaggi legati alla sua Associazione “Milano+Europa” che
l’amministrazione considerava non idonei: 83mila euro.
Essendo da anni
impegnato sulle questioni dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente, il
Qatar deve aver visto in lui un possibile canale per la sua campagna d’immagine,
si vedrà se con mezzi leciti o illeciti – frattanto sono stati arrestati la
moglie e la figlia e il suo ex collaboratore, quel Francesco Giorgi che in
seguito ha stretto una relazione con la Kaili (ricordiamoci sempre che al
momento sono soltanto accusati e di tante persone infangate e uscite alla fine
pulite: ultimi i casi dell’ex presidente dell’Umbria Rita Lorenzetti ma non si
può dimenticare la triste vicenda di Filippo Penati o quella di Calogero Mannino
e tante altre).
Ma è chiaro che
questa storia scuote la famiglia del socialismo europeo, lambisce un pezzo della
sinistra italiana, segnala che il rapporto tra politica e morale si fa
problematico proprio laddove la morale venne elevata a spartiacque tra “noi” e
“loro” – fu un tratto fondamentale del berlinguerismo – ed è davvero una
grottesca ripicca della storia il fatto che in questi giorni sia uscita un’altra
notizia che collega il Qatar ai dalemiani, anzi, proprio a Massimo D’Alema in
persona, che sarebbe uno dei consulenti dell’uomo d’affari qatarino Ghanim Bin
Saad Al Saad, a capo di una cordata per l’acquisizione della raffineria di
Priolo, in Sicilia.
Qui tutto lecito,
nessuno scandalo, non c’è relazione tra le due cose, l’ex capo dei Ds è da tempo
un consulente che agisce in svariate parti del mondo. Però è difficile dar torto
al vicesegretario del Partito democratico Peppe Provenzano quando dice che
«vedere ex leader della sinistra fare i lobbisti in grandi affari internazionali
non è solo triste, dice molto sul perché le persone non si fidano, non ci
credono più». E alla fine il gioco di parole viene facile, dalla gauche
caviar alla gauche Qatar il passo è breve. Sempre al netto del garantismo.
Il silenzio
imbarazzante della sinistra, sindacati compresi, sulle tangenti del Qatar.
Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno l’11 Dicembre 2022
L’arresto di
Panzeri, ex eurodeputato di Pd e Articolo Uno mette in crisi i partiti della
sinistra. L’affondo della Lega: “Siete ipocriti” , chiede una commissione
d'inchiesta all'Europarlamento . Durissimo il commento del vicepremier Matteo
Salvini: "Sul Pd accuse sconvolgenti. Si convochi subito il Copasir".
L’arresto di Antonio
Panzeri, l’ex eurodeputato di Pd e Articolo 1 per tre mandati consecutivi e ha
ricoperto diversi incarichi, tra i quali quello di presidente della
sottocommissione dei Diritti umani, oggi accusato di corruzione, riciclaggio e
associazione per delinquere, scuote il partito di Roberto Speranza. A fine
giornata, il silenzio di Articolo Uno è imbarazzante, come quello del suo
segretario che tace, esattamente come fanno anche Pier Luigi Bersani e Sergio
Cofferati che parlano sempre di tutto e di tutti. L’ex ministra Federica
Mogherini si dimette dalla Ong di Panzeri, la Fight Impunity, seguita
dall’intero board. Eppure anche prima degli arresti, di ombre sulla Ong per il
suo appoggio al governo del Qatar ne erano emerse. Ma ora Panzeri viene
ufficialmente accusato di avere utilizzato “metodi ingegnosi e spesso scorretti
per raggiungere i suoi scopi”. Tutti zitti ed allineati a sinistra, ad
eccezione di Arturo Scotto, che parla chiaro: “Il Qatar è un Paese dove i
diritti umani non sono rispettati. Prima ancora che sul piano giudiziario – dice
il coordinatore di Articolo Uno – il punto è politico. Noi siamo con i
lavoratori, non con gli emiri miliardari“.
Panzeri viene
definito da Luca Fazzo oggi sul quotidiano Il Giornale, “Una specie
di Soumahoro in giacca e cravatta, un alfiere dei diritti dei poveri che
garantiva a sé e alla famiglia un invidiabile tenore di vita. Nelle carte delle
indagini della magistratura belga su Antonio Panzeri, ex leader
della Cgil milanese e già eurodeputato del Pd, emergono col passare delle ore
dettagli sempre più sconcertanti. Se i meccanismi attraverso i
quali Panzeri conquistava adesioni a Bruxelles agli interessi del regime del
Qatar e – si scopre ieri – anche del Marocco rimangono ancora un po’ indefiniti,
a emergere con chiarezza disarmante sono i benefit che l’esponente piddino
ritagliava per sé dall’attività di Fight Impunity, la Ong con sede nel centro
della capitale belga, protagonista di nobili battaglie – dal caso Regeni ai
morti sul lavoro – ma anche sponsor prezzolata degli interessi del regime di
Doha, a partire dai Mondiali di calcio“
Accuse simili a
quelle mosse alla Ong Fight Community vengono contestate anche a un’altra Ong ,
la No Peace without Justice fondata da Emma Bonino, e gestita da un italiano ma
operante da Bruxelles, con sede allo stesso indirizzo (i casi della vita…)
della Figh Impunity e stesso programma di lotta alle ingiustizia su scala
globale. Il suo segretario generale Niccolò Figà Talamanca, secondo alcune
agenzie, sarebbe stato arrestato.
Nel Pd latita la
voglia di commentare. Sbotta Andrea Orlando su Twitter: “Diciamola tutta,
garantismo a parte, se fosse vera anche la metà dell’affaire
Qatar-Europarlamento, saremmo già allo schifo assoluto. Scambiare i diritti
fondamentali dei lavoratori con soldi e regali dei signori feudali del Qatar è
tradimento totale dei valori democratici“. L’ex-ministro della giustizia prima e
del lavoro poi Andrea Orlando dimentica però di essere stato firmatario, nel
2016, della convenzione che affida proprio agli imam dell’Ucoii il compito di
prevenire la penetrazione nelle carceri dell’Islam radicale. Una mossa che
equivale a mettere la volpe nel pollaio.
Un ex collega di
Panzeri all’Europarlamento, parla di lui r lo descrive come un uomo potente:
“Tra i 10-15 deputati che contavano davvero. Aveva rapporti fortissimi con
l’Africa, stava più lì che a Bruxelles. Soprattutto il Maghreb: in Marocco e
Tunisia era di casa. Le pareti del suo ufficio erano piene di foto con re e
principi”. Chi ha condiviso gli anni di Bruxelles con Panzeri ne parla dietro
anonimato come di “un parlamentare potente, non uno sprovveduto“. Un politico
mai sopra le righe: “Un taccagno esagerato, non buttava soldi, né per vestiti né
per locali”.
Lo ricordano amico
di Gianni Pittella e Andrea Cozzolino (per il quale lavora adesso il suo
ex-assistente arrestato Francesco Giorgi) . Parlano di un rapporto che si è
molto affievolito negli anni con Massimo D’Alema anche perche “Antonio non ha
bisogno di una casacca per girare, ha la sua. Non è “dalemiano”, è sempre stato
un “panzeriano“.
L’idillio
ideologico-finanziario che lega il Pd italiano e la sinistra europea all’Islam
della Fratellanza Musulmana sovvenzionato dal “grande fratello” del Qatar dura
da oltre un decennio. E l’Italia ne rappresenta, grazie ai governi Pd, una delle
culle più accoglienti. Per scoprirlo basta sostituire al nome di Fratellanza
Musulmana e Qatar la sigla del loro referente nostrano ovvero quell’Ucoii,
Unione delle comunità islamiche in Italia, che – pur rappresentando un’ala
minoritaria e non proprio moderata dell’Islam italiano – ne è diventato grazie a
governi e amministratori del Pd la voce più ascoltata e autorevole.
Il Qatar da sempre
accoglie e protegge la diaspora della Fratellanza Musulmana, un movimento
integralista giudicato sovversivo e pericoloso da molti paesi arabi e islamici.
Un giudizio non proprio campato in aria visto che tra le fila della Fratellanza
sono cresciuti i leader di Hamas prima e di Al Qaida poi. A Doha, invece, è
vissuto in esilio, fino alla morte sopraggiunta lo scorso settembre, Yusouf Al
Qaradawi, il predicatore simbolo della Fratellanza Musulmana autore di una fatwa
in cui pronosticava “la riconquista di Roma attraverso la predicazione e le
idee“. Predicazione e idee destinate a far assai poca strada senza i soldi
riversati in Italia ed Europa da Doha e dai suoi prestanome.
In Italia grazie
alle “disattenzioni” (soltanto ?) dei governi Pd sono arrivati dopo il 2013,
circa 25 milioni di euro della «Qatar Charity» con cui l’Ucoii conta di
realizzare 45 progetti per la costruzione di moschee, luoghi di preghiera e
centri culturali islamici. Il tutto mentre Al Qaradawi suggerisce di destinare
qualche piccolo contributo anche al Caim, il Coordinamento Associazioni
Islamiche di Milano, Monza e Brianza. Un’intuizione a dir poco lungimirante
visto che subito dopo il sindaco di Milano Giuseppe Sala fa eleggere nelle
liste Pd e accoglie in Consiglio comunale la militante islamica Sumaya Abdel
Qader. Una militante orgogliosamente velata formatasi, guarda caso, tra le fila
del Forum Europeo delle Donne Musulmane, braccio operativo della Fratellanza
Musulmana a Bruxelles. Una mossa che alla luce delle attuali cronache la dice
lunga sui rapporti intessuti dal Pd con l’Ucoii e i suoi referenti
internazionali.
Gli imam dell’Ucoii
sono i principali propagatori del verbo integralista propugnato
dalla Fratellanza Musulmana. Ma il “pollaio” italiano è ben più ampio del
ristretto universo carcerario. E lo dimostra la Firma del «Patto nazionale
sull’Islam» con cui l’Ucoii è diventato nel 2017 un interlocutore ufficiale dei
nostri governi. Mentre l’accusa di «islamofobia» diventa l’anatema con cui
tacitare qualsiasi critica al diffondersi di un islam radicale garantito dal
denaro distribuito all’Ucoii e agli spregiudicati esponenti di un pensiero
progressista modellato sul verbo di Doha.
Il destino vuole che
l’arresto di Panzeri coincida incredibilmente con le attività che Massimo
D’Alema in questi giorni sta portando avanti come consulente privato . L’ex
premier, uno dei leader della sinistra italiana, sarebbe l’intermediario tra il
governo italiano e un gruppo di investitori del Qatar pronti a rilevare la
raffineria della russa Lukoil a Priolo. Una coincidenza che porta Giuseppe
Provenzano , vicesegretario del Pd, a fare una pubblica critica amara: “A
proposito di Qatar, una nota a margine. Non c’entra con la vicenda a dir poco
orribile dell’Europarlamento, ma vedere ex leader della sinistra fare i lobbisti
in grandi affari internazionali non è solo triste, dice molto sul perché le
persone non si fidano, non ci credono più“.
Tutti a sinistra
corrono a disconoscere Panzeri. Articolo Uno lo ha sospeso ed in una nota
esprime “sconcerto per quanto sta emergendo» in «una vicenda del tutto
incompatibile con la sua storia e il suo impegno
politico“. Arturo Scotto sostiene che l’ex eurodeputato “da tempo non ricopre
ruoli operativi” e che quella di sospenderlo è “una decisione a tutela della
nostra organizzazione politica“. L’ufficio dell’eurodeputato socialista belga
(di origini italiane) Marc Tarabella è stato sigillato: nel 2014 aveva dato
a Salvini del “fannullone“. Adesso il centrodestra, chiaramente, attacca, e
la Lega per voce di Susanna Ceccardi parla di “vergognosa ipocrisia della
sinistra” e chiede una commissione d’inchiesta all’Europarlamento . Durissimo il
commento del vicepremier Matteo Salvini: “Sul Pd accuse sconvolgenti. Si
convochi subito il Copasir”. Redazione CdG 1947
Bonino, Mogherini
e le Ong coinvolte nell'inchiesta di Bruxelles. L'ex ministra: "Non so nulla,
voglio capire". A
cura della redazione Politica su La Repubblica l’11 Dicembre 2022.
Entrambe figurano
come consigliere onorarie di 'Fight Impunity' di Panzeri. La ex commissaria Ue
su 'No Peace Without Justice': "Figà-Talamanca? Aspetto la magistratura che si
deve esprimere".
Caso Qatar: le due
Ong finite nel mirino degli inquirenti belgi nell'ambito dell'inchiesta per
sospetta corruzione, Fight Impunity e No Peace Without Justice, hanno sede
entrambe al civico 41 di Rue Ducale, nei pressi del Palais Royal, del Parlamento
Federale e dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America, a Bruxelles.
La prima, Fight
Impunity, è stata fondata il 25 settembre 2019 nello studio del notaio Jean van
de Wouwer, in square de Meeus a Bruxelles, da Antonio Panzeri, già segretario
della Camera del Lavoro di Milano, ex eurodeputato per il Pd prima e poi per
Articolo 1, del gruppo S&D, residente a Calusco d'Adda, fermato venerdì dalle
autorità belghe.
La Ong di Panzeri
'Fight Impunity', la
Ong perquisita dalla polizia belga nell'ambito dell'inchiesta che ha portato al
fermo di quattro persone per presunta corruzione, è stata fondata nel settembre
2019 da Antonio Panzeri, già eurodeputato del gruppo S&D ed ex presidente della
sottocommissione Diritti umani del Parlamento europeo. Dopo essere stato a lungo
segretario della Camera del lavoro di Milano, dal 1995 al 2003, Panzeri è
diventato eurodeputato nel 2004 e lo è stato fino al 2019.
Una volta lasciata
l'Aula, Panzeri ha fondato a Bruxelles 'Fight Impunity', organizzazione non
profit impegnata "contro l'impunità" per le violazioni dei diritti umani. Il
consiglio dei membri onorari della Ong, che ha sede in Rue Ducale, non lontano
dall'Ambasciata americana, dalla missione permanente a Bruxelles della
Federazione Russa e dal Parlamento federale belga, è composto da personalità di
assoluto rilievo.
Tra queste, secondo
il sito della Ong, figurano anche Emma Bonino, ex ministra ed ex commissaria
europea, e Federica Mogherini, già ministra degli Esteri e Alto Rappresentante
dell'Ue, oltre a Dimitris Avramopoulos, già commissario europeo agli Affari
Interni, e all'ex primo ministro francese Bernard Cazeneuve. È membro onorario
di 'Fight Impunity' anche Denis Mukwege, ginecologo congolese premio Nobel per
la Pace nel 2018.
La Ong 'No Peace
Without Justice'
No Peace Without
Justice, invece, ha molti più anni: la sede sociale è stata trasferita nel 2018
in Rue Ducale 41, dove l'associazione ha tuttora sede, in una palazzina a due
piani davanti al Parc de Bruxelles, un giardino urbano quadrangolare. Nello
stesso edificio hanno gli uffici, secondo quanto riporta la targa all'ingresso,
anche i Radicali Italiani, Più Europa, l'Associazione Luca Coscioni,
l'Euro-Syrian Democratic Forum, Al Wefaq (un partito di opposizione del Bahrein)
e altre realtà. Più, appunto, Fight Impunity, che ha una targa separata,
probabilmente perché è di costituzione più recente.
Al Corriere, Emma
Bonino ricorda di aver fondato l'Organizzazione non governativa "nel 1994, forse
nel 1993". Il segretario generale della Ong, Niccolò Figà-Talamanca, è coinvolto
nell'inchiesta corruzione dal Qatar. Dice Bonino: "Non so niente" di questa
vicenda, "aspetto la magistratura che si deve esprimere, credo che lo farà nel
giro di pochi giorni".
Mazzette Ue-Qatar. Lo strano pass con cui Panzeri aggirava le norme di
Bruxelles.
Un lasciapassare a vita, un tesserino che consente la libera
circolazione negli uffici e nei corridoi dell'Europarlamento anche dopo la fine
del mandato di deputato. Luca Fazzo il 12 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Un lasciapassare a
vita, un tesserino che consente la libera circolazione negli uffici e nei
corridoi dell'Europarlamento anche dopo la fine del mandato di deputato. Tra i
privilegi che hanno consentito a Antonio Panzeri di muoversi a suo piacimento
dopo il 2019 - quando ha cessato la carica - nel cuore della democrazia europea
c'è quel badge. Che gli ha permesso di aggirare le norme della Commissione
secondo cui tutti i contatti devono passare per l'albo chiamato «Registro della
trasparenza». Senza iscrizione a quell'albo, non si può fare nulla. L'altra ong
investita dall'inchiesta, «No peace without justice», fondata da Emma Bonino,
risulta iscritta dal dicembre 2012. Di «Fight Impunity» invece nell'albo non c'è
traccia.
Questo non impediva
a Panzeri di muoversi agevolmente. La domanda che circola in queste ore a
Bruxelles è come sia stato possibile che appena dieci giorni fa, il 2 dicembre,
la ong di Panzeri abbia potuto organizzare un seminario a Parigi sulla libertà
dei massmedia in collaborazione con l'Eprs, il Servizio di ricerca parlamentare
dell'Europarlamento, senza far parte del registro. Al seminario insieme a
Panzeri c'erano anche la socialista Marie Arena, il cui assistente è stato
perquisito in questi giorni, e l'ex assistente di Panzeri Francesco Giorgi, ora
compagno della vicepresidente dell'europarlamento Eva Kaili, anche lei del
gruppo Socialisti e democratici, pure lei finita in manette dopo la scoperta a
casa sua di sacchi di banconote che il padre si preparava a fare sparire.
Ieri il padre della
Kaili è stato liberato, mentre l'arresto della ormai ex vicepresidente è stato
confermato. Negli ambienti giudiziari di Bruxelles si è appreso che la Kaili è
ora formalmente indagata per associazione a delinquere finalizzata alla
corruzione e al riciclaggio, gli stessi reati contestati a Panzeri. E come la
Kaili anche l'ex eurodeputato del Pd è destinato per ora a restare in carcere:
al termine degli interrogatori il tribunale belga ha confermato il suo arresto,
come pure quello di Giorgi e di Niccolò Figà Talamanca, segretario generale
della ong di Emma Bonino. È stato invece scarcerato Luca Visentini, ex
sindacalista Uil e oggi a capo della Ituc, la più grande organizzazione
sindacale internazionale. La Ituc era finita nel mirino dell'inchiesta anche per
il suo silenzio sulla violazione dei diritti sindacali in Qatar, uno dei paesi
di cui Panzeri oliava la reputazione internazionale.
E l'indagine sulla
«banda criminale» che si muoveva nell'Europarlamento a favore del Qatar fa ieri
un'altra vittima importante, e anche questa come Panzeri e la Kaili è una figura
di spicco dell'eurogruppo dei Socialisti & democratici: è il secondo gruppo per
dimensioni, e sta venendo investito in pieno dallo scandalo. Il suo nuovo
incriminato è Marc Tarabella, florido socialista belga, che svolge
nell'europarlamento un ruolo cruciale per gli interessi di Panzeri, essendo
vicepresidente della delegazione per i rapporti con la penisola araba (Qatar
compreso). Il suo assistente, fermato venerdì, era in passato l'assistente
parlamentare di Panzeri. Tarabella è stato perquisito sabato sera. E ora
rispuntano i documenti della spettacolare conversione compiuta dall'eurodeputato
belga sul tema dei Mondiali in Qatar: Tarabella contesta aspramente
l'assegnazione da parte della Fifa al regime di Doha, poi si addolcisce
improvvisamente e inizia a assumere posizioni sempre più favorevoli all'evento.
Il 26 ottobre alla rete LN24 definisce «ridicolo e ipocrita» boicottare i
mondiali, e in una intervista dice che «il Qatar ha fatto dei progressi sui
diritti dei lavoratori». Anche in questa conversione, ora gli inquirenti vedono
la mano di Panzeri e dei soldi degli sceicchi.
Gli elogi
all'emirato che hanno attirato i sospetti: "È un punto di riferimento per i
diritti umani..."
Dalla Kaili a
Panzeri, un castello di esternazioni per l'immagine di Doha. Domenico Di Sanzo
il 12 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Sentite questa. «I
mondiali in Qatar sono una prova di come la diplomazia sportiva possa realizzare
una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato il mondo
arabo. Il Qatar è in prima linea per i diritti dei lavoratori, ha abolito la
Kafala e introdotto il salario minimo», parlava così durante l'ultima plenaria
Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo, arrestata e sospesa dalla sua
carica perché coinvolta nello scandalo Qatargate, il caso di corruzione su
presunte mazzette e tangenti ad attuali ed ex membri del Parlamento europeo per
convincerli a parlare bene del Paese del Golfo, ripulendone l'immagine in vista
dei mondiali di calcio.
Kaili, esponente
greca del gruppo dei Socialisti Europei, è stata arrestata sabato a Bruxelles ed
è accusata di corruzione. Secondo gli inquirenti belgi una non precisata nazione
del Golfo Persico - il Qatar stando alle indiscrezioni - avrebbe elargito regali
e versato somme di denaro a una serie di personalità della politica europea con
l'obiettivo di influenzare l'Europarlamento. Da Doha smentiscono ogni accusa, ma
le parole di Kaili aprono una serie di interrogativi. Ed ecco un'altra vecchia
dichiarazione di Kaili: «I qatarioti ci hanno aiutati a ridurre la tensione con
la Turchia, ci hanno aiutati a salvare attivisti, bambini e donne in
Afghanistan, sono negoziatori di pace e buoni vicini. Hanno già ottenuto
l'impossibile». Frasi che stridono con le recenti polemiche sulla trasparenza
dell'assegnazione dei mondiali al Qatar e le denunce sul mancato rispetto dei
diritti umani. E ancora Kaili, profetica: «Qualcuno discrimina i qatarioti, li
bullizza e accusa di corruzione tutti quelli che ci parlano, noi possiamo
promuovere i nostri valori, ma non abbiamo il diritto morale di fare lezioni».
Collegato a Kaili è
il filone «italiano» dell'inchiesta. Nel 2019 l'ex eurodeputato socialista di
Articolo 1 Antonio Panzeri, anche lui arrestato, va a Doha e loda l'Emirato del
Medio Oriente: «Il Qatar è diventato un punto di riferimento per i diritti
umani». Tre anni fa alla «Conferenza internazionale sui meccanismi nazionali,
regionali e internazionali per combattere l'impunità e garantire la
responsabilità ai sensi del diritto internazionale» Panzeri parlava dei
progressi del Qatar in tema di diritti e insisteva: «È un progetto guidato dal
Qatar a livello internazionale, è molto importante e questi sono sforzi
encomiabili». Anche un anno prima, sempre a Doha, Panzeri sottolineava gli
«sviluppi positivi nel campo dei diritti umani» messi in campo dalla monarchia
degli Al Thani. Molto più di recente, il 21 novembre scorso, la maggioranza dei
deputati socialisti ha deciso di non appoggiare una risoluzione sulla situazione
dei diritti umani in Qatar proposta dai «compagni» del Gruppo della Sinistra.
Oltre alla vicenda giudiziaria, il centrosinistra europeo sembra avere un
problema con Doha.
Qatargate,
l'indagine si allarga: perquisita l'abitazione dell'eurodeputato
socialista Tarabella.
Anche l'abitazione
belga di Marc Tarabella è stata perquisita dalla polizia sotto la supervisione
del presidente del parlamento europeo Roberta Metsola. Francesca Galici l’11
Dicembre 2022 su Il Giornale.
Proseguono le
indagini delle autorità di Bruxelles in merito ai sospetti di corruzione attuati
da un Paese del Golfo (che i media belgi indicano come Qatar) e dal Marocco nei
confronti di alcuni esponenti del parlamento europeo, tra i quali il
vicepresidente Eva Kaili. Secondo i media belgi, sabato sera è stata sottoposta
a perquisizione l'abitazione di Bruxelles dell'eurodeputato socialista Marc
Tarabella in sua presenza.
Il tutto è avvenuto
sotto la supervisione della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola,
rientrata appositamente da Malta come confermato da fonti del parlamento
europeo. La Costituzione belga, all'articolo 59, prevede che sia presente il
presidente del parlamento di appartenenza in caso di perquisizione in casa di
eletti nel Paese. Politico ha rivelato anche che la procura ha messo i sigilli
all'ufficio dell'eurocamera di Tarabella, che solo un mese fa aveva dichiarato
che il Qatar era "un buon esempio da seguire per gli altri Paesi del vicinato".
Cosa ha comprato il
Qatar con i soldi ai deputati corrotti
Marc Tarabella è
nato in Belgio ed è iscritto dal 1986 al partito Socialista. Ha origini italiane
e dal 2021 è iscritto anche al partito italiano Articolo Uno al pari di Antonio
Panzeri, per il quale la commissione di garanzia di Articolo Uno Lombardia ha
sospeso l'iscrizione. Nell'esternare "sconcerto per quanto sta emergendo",
Articolo Uno esprime in una nota "fiducia nell'autorità giudiziaria" e auspica
che "Panzeri possa dimostrare la sua estraneità a una vicenda del tutto
incompatibile con la sua storia e il suo impegno politico". Si attendono ora
dichiarazioni in merito alla perquisizione effettuata su Marc Tarabella.
A dare la notizia
della perquisizione sono due giornali belgi, il quotidiano Le Soir e il
settimanale Knack, secondo i quali il materiale informatico dell'eurodeputato
belga è stato sequestrato dagli investigatori ma Tarabella non è in stato di
fermo. Dopo Kaili, arrestata in flagranza di delitto venerdì, si tratta del
secondo eurodeputato formalmente citato nell'ambito della vasta indagine
per presunta corruzione al parlamento europeo. A casa del vicepresidente del
parlamento europeo sono state trovate alcune sacche contenenti centinaia di
migliaia di euro in contanti. Lo scandalo sembra destinato ad allargarsi dopo
l'arresto di alcune persone, tra i quali anche Antonio Panzeri, ex eurodeputato
del Pd non rieletto, che è stato fermato nei pressi di Bergamo insieme alla
figlia e alla moglie.
Secondo le autorità
inquirenti, il Paese del Golfo avrebbe tentato di influenzare le decisioni
economiche e politiche del parlamento europeo versando ingenti somme di denaro
per fare pressioni, soprattutto in vista dei mondiali di calcio. "Lo stato del
Qatar respinge categoricamente ogni tentativo di associarlo ad accuse di cattiva
condotta", ha dichiarato un funzionario del Qatar in una dichiarazione inviata
per e-mail a Politico Eu, in merito allo scandalo di presunta corruzione del
Qatar che ha coinvolto l'Europarlamento. Intanto la procura belga ha confermato
di aver messo in stato di fermo quattro persone, compresa Eva Kaili, delle quali
due sono già state rilasciate nelle ultime ore.
L'inchiesta
dell'euroscandalo. Chi è Michel Claise, lo strano pm del Qatargate che dice: “Il
pil italiano è gestito dalla mafia”.
Nicola Biondo su
Il Riformista il 21 Gennaio 2023
Michel Claise è
il pubblico ministero belga che si occupa del Qatar-gate. Pochi giorni fa, nelle
stesse ore in cui le agenzie di mezzo mondo battevano la notizia dell’arresto
di Matteo Messina Denaro, i lettori italiani potevano conoscere dalla sua viva
voce (intervista su Fq) la sociologia criminale che informa la sua azione da
investigatore. Si scopre così che Claise è un proibizionista che auspica la
galera per chiunque consumi droga, «perché non immaginare, nel caso delle droghe
pesanti, di considerare che anche chi consuma è parte della rete criminale?».
Una posizione che si commenta da sola.
Ma l’affermazione
che più sbalordisce è quando il magistrato afferma che, «in Italia, mafie
ricchissime stanno comprando una dopo l’altra tutte le aziende che stanno
fallendo: il 50% dell’economia è attualmente nelle mani di mafie come Ndrangheta
e Cosa Nostra». I numeri e le analisi più recenti ed autorevoli dicono ben
altro. Un stima è stata fatta dall’Istituto Bruno Leoni secondo cui il PIL
italiano è di circa 1800 miliardi di euro compreso “una componente di circa
l’11% di economia non osservata”. Se fosse come afferma Claise le mafie
gestirebbero circa 900 miliardi l’anno, più del Pil di
Belgio e Austria insieme. Visto che in Italia la metà del PIL – è ancora
l’analisi del Bruno Leoni- «è intermediato dallo Stato, ciò sembrerebbe
implicare che l’intera economia privata (oppure, a scelta, quella pubblica) nel
nostro paese è in mano alle mafie». Il responsabile del Qatar-gate sembra non
conoscere alcuni tra gli studi più recenti commissionati dalla Commissione
europea, secondo cui il giro d’affari delle organizzazioni criminali in Italia
incide per meno dell’un per cento del PIL. Il populismo giudiziario non è solo
una caratteristica italiana, questa sembra essere l’unica buona notizia. Paolo
Borsellino, spesso citato a sproposito, diceva che era necessario parlare di
mafia in ogni luogo della società. Ci permettiamo di aggiungere, parlatene bene,
con precisione.
Nicola Biondo
Qatargate,
ecco chi è il giudice della tangentopoli Ue.
Michel Claise è il
giudice che si sta occupando del Qatargate. Molto conosciuto in Belgio, non
risparmia giudizi severi anche sul suo Paese. Federico Garau l’11 Dicembre 2022
su Il Giornale.
Bruxelles trema dopo
lo scoppiare di quello che è stato già ridenominato Qatargate, e i riflettori
non sono puntati solo sui principali personaggi coinvolti, ma anche sul
giudice Michel Claise che, dopo aver ascoltato le prime testimonianze, domani
dorvà pronunciarsi sulla convalida dell’arresto.
Cosa ha comprato il
Qatar con i soldi ai deputati corrotti
Claise, il
magistrato della tangentopoli
Avvocato per oltre
vent'anni, poi divenuto giudice istruttore, Michel Claise ha 66 anni e una
carriera di tutto rispetto. Il lavoro di Claise consiste nello scovare reati
finanziari e la sua lente di ingrandimento non si è fermata neppure di fronte al
Parlamento europeo. C'è il giudice Claise dietro le indagini, partite a luglio,
che hanno portato allo scoperto le dinamiche del Qatargate, con le mazzette del
Qatar arrivate nelle tasche di eurodeputati e funzionari.
La lotta
alla corruzione è la specialità di Michel Claise, ben conosciuto a Bruxelles.
Nel tempo libero il magistrato si diletta a scrivere romanzi gialli, mentre sul
posto di lavoro è molto stimato. Molti dei casi da lui seguiti sono noti in
Belgio.
Le inchieste più
famose
Fra le inchieste più
celebri condotte da Claise, quella sul flautista e segretario del Consiglio
della Musica della comunità francofona in Belgio, finito sul banco degli
imputati per una serie di spese non rendicontate. Alla chiusura del caso,
Dumortier non poté fare altro che dimettersi. Nel 2011, poi, la condanna per
falsificazione e frode.
Nel mirino del
giudice Claise anche il gruppo belga-olandese Fortis per l'inchiesta
sull'insider trading. A inizio 2000, il magistrato si occupò anche della banca
Belgolaise per riciclaggio. La maxi-inchiesta si chiuse con un mandato d'arresto
per un ex ministro della Repubblica democratica del Congo.
Nessuno sconto
Si dice che Michel
Claise sia un autentico osso duro, uno che non molla, e che non risparmia dal
suo giudizio severo neppure il Belgio, il suo Paese. Recentemente, parlando
proprio del Belgio, ha dichiarato che il paese "non è affatto in regola".
Michel Claise, il
Di Pietro belga che ama la letteratura e le manette.
Ex avvocato, il
procuratore che ha sollevato lo scandalo del “Qatargate” a Bruxelles è una star
amata dalla “gente” e temuta da politici e manager. Daniele Zaccaria su Il
Dubbio il 15 dicembre 2022.
“Il giudice che fa
paura ai banchieri” titolava nel 2014 il settimanale belga Le Vif tratteggiando
un apologetico ritratto di Michel Claise titolare dell’inchiesta sul colosso del
credito HSBC, accusato di riciclaggio aggravato di fondi provenienti dai narcos
sudamericani.
Un’inchiesta che
costò ai vertici della banca due miliardi di euro di multa, di cui 300 milioni
allo Stato belga. E poi l’ex ministro Serge Kubla finito nel mirino con l’accusa
di aver corrotto il governo del Congo per la concessione di un giacimento
minerario a beneficio del gruppo italo- svizzero Duferco. E ancora una banca, la
svizzera Ubs, condannata per frode fiscale a un risarcimento di 3,5 miliardi di
euro.
Insomma, il
procuratore che ha scoperchiato lo scandalo del “Qatargate” un affaire che sta
facendo tremare le fondamenta dell’Unione europea, non è un magistrato
qualunque. In Belgio lo conoscono tutti da almeno un decennio e cioè da quando è
salito sulla ribalta mediatica per non abbandonarla più.
Fieramente affiliato
alla massoneria, autore di una dozzina tra saggi e romanzi storici e
legal-thriller alcuni anche premiati per le qualità letterarie, Claise si
concede con grande facilità ai televisioni e giornali, rilasciando lunghe
interviste con il suo classico abbigliamento casual, jeans, maglietta e
maglioncino a v. Spesso è ospite di trasmissioni letterarie dove presenta e
commenta i suoi libri con estremo talento comunicativo. «Mi ritengo un umanista,
una persona rivolta verso il prossimo», dice di sé con un pizzico di immodestia.
Nato a Bruxelles nel
1956, abbandonato dal padre quando era ancora bambino, Claise è stato cresciuto
dai nonni materni che gestivano un piccolo forno: «Ho ricevuto un’educazione
dura e d’altri tempi, ma è stata molto formativa e ha portato i suoi frutti».
Laureato in diritto all’università libera di Bruxelles, per una ventina d’anni
ha svolto la professione di avvocato all’ordine della capitale belga.
Alla fine degli anni
90 decide però di passare dall’altra parte della barricata, vince il concorso di
stato e diventa giudice istruttore, specializzandosi in crimini finanziari e
amministrativi. E costruendosi in poco tempo la nomea di castigamatti di leader
politici, celebrità dello sport, imprenditori e grandi manager, un cliché
mediatico che piace molto alla “gente” e che gli ha regalato un’ampia
popolarità, proprio come accadde in Italia nel 1992 con l’inchiesta Mani
Pulite e l’ascesa di Antonio Di Pietro.
Claise è in tal
senso una versione “colta” e molto snob del magistrato molisano, uno che in casa
ha una biblioteca con migliaia di libri e che non possiede una televisione ( gli
basta andarci, in tv) ma se lo stile appare meno ruvido i metodi che utilizza
per far parlare gli indagati non sono poi così diversi da quelli di “Tonino”.
«Claise adora
pungolare i potenti, ha le spalle larghe e non ha paura di nessuno, mentre loro
hanno una paura folle di lui», scrive un cronista giudiziario dell’Afp che segue
da anni le sue inchieste. E, visti i precedenti fanno bene a essere spaventati.
Su questo punto non mancano in effetti critici e detrattori. Un avvocato che ha
lo ha affrontato in più di un processo ne parla in modo assai velenoso sulle
colonne del quotidiano La libre Belgique: «È un uomo tronfio e pieno di sé, uno
che ha il mandato di arresto facile, è il suo sistema preferito per far crollare
i sospetti o per aggiungere un nome celebre al suo folto carnet di caccia».
In altre parole
basta far titillare le manette e l’effetto è garantito specialmente con quelle
mammolette di politici, colletti bianchi ricchi imprenditori, per quanto
nell’ordinamento belga la custodia cautelare di un sospetto deve essere
confermata da altri giudici competenti entro cinque giorni. Un lasso di tempo
che Claise ritiene più che sufficiente per ottenere se non per estorcere le sue
confessioni.
Di fronte alle
accuse di non rispettare i diritti degli indagati e di utilizzare metodi
polizieschi alquanto brutali lui replica stizzito: «Non sono uno sceriffo,
faccio semplicemente il mio lavoro che consiste nell’affrontare dossier che
coinvolgono persone potenti, persone che nessuno si aspetta vengano toccate, io
invece lo faccio, non odio la ricchezza, ma la criminalità finanziaria è una
piaga che ci sta divorando e bisogna fermarla a tutti i costi».
Essendo una figura
molto popolare, i media belgi si chiedono da tempo quali siano le sue simpatie
politiche, ma Claise nicchia affermando di non votare per nessun partito. Anche
se, una volta in pensione, non esclude di candidarsi per «trasmettere i miei
valori culturali» .
Cosa
ha comprato il Qatar con i soldi ai deputati corrotti.
Secondo gli
inquirenti belgi, il Paese del Golfo avrebbe puntato su una precisa strategia di
corruzione che ha fatto perno sui deputati di Socialisti e Democratici arrestati
nei giorni scorsi. Mauro Indelicato l’11 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Quando si nomina
il Qatar il pensiero non può andare al mondiale ancora in corso. E in effetti
anche l'indagine condotta a Bruxelles e che ha visto l'arresto di quattro
italiani e della vice presidente del parlamento europeo, ha in qualche modo a
che fare con il torneo iridato.
Il tentativo di Doha
di condizionare i giudizi europei
L'indagine, come
spiegato su IlDomani, è partita questa estate. E i fari, poco dopo, sono stati
puntati su una risoluzione votata dal parlamento europeo alla viglia dell'inizio
dei mondiali in cui, tra le altre cose, veniva espressa soddisfazione per il
miglioramento delle condizioni dei lavoratori in Qatar. Nel documento, in
particolare, come sottolineato sempre dal quotidiano, veniva fatto notare che il
Paese mediorientale in vista dei mondiali aveva fatto passi avanti nella
gestione del mercato del lavoro.
Probabilmente agli
inquirenti belgi questa dichiarazione è risultata “sospetta”. Se è vero infatti
che il governo di Doha negli ultimi anni ha approvato molte riforme che hanno
introdotto il salario minimo e hanno abolito la kafala, una vera e propria forma
di schiavitù moderna, è altrettanto vero che molte organizzazioni internazionali
hanno espresso dubbi sulle condizioni dei lavoratori.
In poche parole, a
Bruxelles hanno voluto verificare, in base all'indagine già aperta e ai sospetti
che aleggiavano su alcuni eurodeputati, se quella mozione era frutto di mere
considerazioni politiche oppure se c'era dell'altro.
Tra i firmatari del
documento spiccava anche il nome dell'europarlamentare italiano Andrea
Cozzolino, del Partito Democratico e iscritto quindi al gruppo Socialisti e
Democratici. Lui non è tra gli indagati, ma ha un ruolo molto importante
nell'inchiesta un suo assistente, Francesco Giorgi. Quest'ultimo è il compagno
di Eva Kaili, la vicepresidente del parlamento europeo.
"Borse piene di
banconote". L'eurodeputata Kaili arrestata in flagranza
Sia Giorgi che Kaili
sono indagati, con la parlamentare greca posta anche in stato di fermo. Nella
propria abitazione i poliziotti hanno trovato valigie piene di banconote. Una
prova scottante secondo gli inquirenti. Quei soldi le sarebbero stati girati dal
Qatar e per l'accusa l'obiettivo degli emissari di Doha era quello di
condizionare i giudizi sul Paese da parte delle istituzioni europee.
Il contesto, secondo
gli investigatori, sarebbe molto chiaro: il Qatar, sotto pressione per la
cattiva nomea mediatica in vista dei mondiali, ha provato a sfruttare soldi e
agganci per condizionare in positivo la propria immagine.
Eva Kaili è stata
sospesa dal gruppo Socialisti e Democratici del parlamento europeo e, inoltre, è
stata espulsa dal Pasok, il partito greco a cui apparteneva fino a pochi giorni
fa. È stato arrestato anche il padre, raggiunto dai poliziotti mentre tentava di
lasciare la propria abitazione.
Gli inquirenti
vogliono anche fare luce sulle 600mila Euro in contanti trovati nell'abitazione
di un altro esponente politico, questa volta italiano. Si tratta di Antonio
Panzeri, ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1, sospeso nelle scorse ore dal
partito. Panzeri è sospettato di avere ottimi rapporti con il Qatar e quei soldi
potrebbero essere frutto di corruzione. Nella scorsa legislatura, l'ex
eurodeputato aveva come collaboratore proprio Francesco Giorgi. Secondo la
procura belga, moglie e figlia dell'indagato erano al corrente della situazione.
I sospetti aleggiano in queste ore anche su Luca Visentini, per diverso tempo a
capo dei sindacati europei.
Corruzione e non
“semplice” attività di lobbying
Quella messa in moto
dal Qatar, almeno stando a quanto fatto trapelare dagli inquirenti, non sarebbe
stata un'attività di promozione o di lobbying. Al contrario, “Il paese del Golfo
– si legge nelle carte della procura di Bruxelles – avrebbe cercato di
influenzare più personalità versando ingenti somme di denaro o offrendo regali
di grande entità a terzi che ricoprono posizioni politiche o strategiche di
rilievo all'interno del parlamento europeo”.
Un quadro quindi
piuttosto grave, in cui emissari vicini a Doha si sarebbero mossi per
influenzare, sotto la promessa di importanti somme, l'attività politica del
parlamento europeo. Non si è quindi all'interno di una “zona grigia”, ma in un
territorio dove la corruzione e i tentativi di corruzione, secondo gli
inquirenti, sarebbero elementi palesi e lampanti. Per la procura di Bruxelles,
il giudizio di alcuni deputati sarebbe stato letteralmente comprato in cambio di
soldi e favori.
"Paura per
l'influenza sulle votazioni. Tutto è iniziato col Mondiale di calcio".
L'europarlamentare: "La Ue non deve cedere sul piano culturale. L'obiettivo del
Qatar è conquistare le popolazioni con il soft power". Francesco Boezi il 10
Dicembre 2022 su Il Giornale.
Il caso giudiziario
dell'ex europarlamentare del Pd Antonio Panzeri rilancia la questione del soft
power del Qatar e di altri Stati arabi in Europa.
Onorevole
Procaccini, europarlamentare di Fdi, si avverte una pesante influenza del Qatar
in Ue?
«Premetto che la
vicenda in sé è inquietante ma che bisogna attendere i risvolti giudiziari.
L'influenza del Qatar non è soltanto sulla politica europea ma sulla cultura
popolare europea. Il che è più pervasivo. Abbiamo avuto un dibattito sui
mondiali in Qatar e su tutto ciò che quella scelta ha comportato. Abbiamo anche
approvato una risoluzione comune. Un dibattito che, peraltro, era stato voluto
con forza dallo stesso partito attorno cui oggi si muovono delle ombre».
Quando ha avuto
inizio questa influenza?
«Proprio con
l'assegnazione del Mondiale al Qatar. E perché il Qatar ha voluto il mondiale di
calcio? Cosa c'è del resto di più popolare dei Mondiali di calcio nel pianeta
terra? Il messaggio è questo: siamo in grado di rappresentare la forza della
nostra economia ma anche quella della nostra cultura, che non ha rispetto dei
diritti umani e dei diritti di libertà. Questo è il soft power: conquistare
popolazioni passando attraverso la cultura popolare. Ricordo un nostro dossier
sull'islamizzazione in Europa in cui dimostrammo come tutte le grandi squadre
delle grandi capitali europee fossero state interessate da finanziamenti del
Qatar e degli Emirati Arabi. Il Real Madrid, squadra più blasonata del Vecchio
continente, ha persino rinunciato alla sua iconica croce nello stemma. Qualcosa
che aveva almeno centodieci-centoventi anni di storia alle spalle. Un simbolo
rimosso magari per vendere meglio o perché la richiesta arrivava dallo sponsor.
Nulla accade per caso. Il Qatar non ha un ritorno economico con i Mondiali ma ha
semmai un ritorno culturale che com'è ovvio interessa anche l'ambito religioso».
Ma in Ue avete
l'impressione che alcune votazioni vengano interessate dal soft power di
quell'area di mondo?
«Più che la
sensazione, la paura. Certo: se la vicenda emersa ieri venisse confermata,
quella paura allora avrebbe più di qualche fondamento».
Quali sono allora
gli strumenti che l'Ue dovrebbe mettere in campo per evitare quella che Michel
Michel Houellebecq ha chiamato «Sottomissione»
«Bisognerebbe porre
dei paletti, dei principi. Non è vietato organizzare i Mondiali in Qatar, a
patto che quello Stato rispetti dei principi. Non voglio fare l'anima candida,
so bene quanto sia importante avere buoni rapporti commerciali con tutti. Ma lo
sport con le sue implicazioni sociali e culturali dovrebbe essere messo al
riparo. Credo sia essenziale non cedere sul piano identitario come avvenuto
invece con il simbolo del Real Madrid».
In Onda, Dino
Giarrusso: “Avvicinato anche io dagli emissari del Qatar ma…”
Libero Quotidiano il
10 dicembre 2022
Nello studio di De
Gregorio e Parenzo a In Onda su La7, si è parlato dell'inchiesta per corruzione
che ha travolto il Parlamento europeo. Al centro delle indagini presunte
mazzette da parte del Qatar per far tacere l'Europarlamento. A offrire la
propria testimonianza è stato proprio un membro di quell'Aula, Dino Giarrusso,
che ha raccontato di essere stato avvicinato anche lui - così come tanti altri
deputati - dagli emissari del Qatar: "In genere gli esponenti diplomatici di
altri Paesi ci fanno offerte di incontri, di solito propongono di promuovere dei
prodotti o di fare scambi commerciali, questo è il classico lavoro del
diplomatico con l'europarlamentare".
Con il Qatar, però,
qualcosa avrebbe subito insospettito Giarrusso: "La cosa che mi è puzzata fin
dall'inizio è che loro cercavano di influenzare la 'reputation'. L'emissario del
Qatar diceva 'noi siamo buoni e democratici', mentre gli osservatori
internazionali e indipendenti parlavano di gravissime violazioni dei diritti
umani in Qatar in vista del Mondiale". "Quando parliamo di emissari del Qatar,
di che figure parliamo?", ha chiesto poi la De Gregorio. E l'eurodeputato ha
risposto: "Sono funzionari di Stato, ben foraggiati perché poi offrivano anche
vacanze".
"Quando tu rispondi
a una mail o vai a un incontro, ci sono cose che vanno bene e cose che invece
danno sensazioni più sgradevoli", ha proseguito Giarrusso. "Quindi non le hanno
mai offerto dei soldi?", ha chiesto la conduttrice. E l'ospite ha replicato,
chiosando: "No, ma sono stato io a non dare modo".
Francesca Del
Vecchio per “la Stampa” il 10 dicembre 2022.
Uno, negli anni del
berlusconismo imperante è stato il volto della sinistra milanese che si opponeva
al cavaliere di Arcore. Oggi la bufera ha travolto lui insieme alla moglie e
alla figlia (arrestate ieri a Bergamo). L'altro, da pochi giorni era diventato
il capo della più grande confederazione sindacale al mondo.
Antonio Panzeri,
uomo della Cgil che nel 2009 voleva «un'Europa in grado di superare gli egoismi
dei governi nazionali», ex eurodeputato del Partito democratico e Luca
Visentini, ex sindacalista Uil del Friuli Venenzia Giulia, sono i due italiani
finiti in manette nell'inchiesta per corruzione del Qatar delle autorità
belghe.
E non è una bella
figura per il Paese e per il sindacato. Panzeri, bergamasco di Riviera d'Adda,
classe '55, un passato nel Pci e nel sindacato, dal '95 al 2003 è segretario
della Camera del Lavoro di Milano. Diventa talmente importante da essere
candidato a guidare la Cgil al posto di Sergio Cofferati. Gli verrà preferito
Guglielmo Epifani. Ma Panzeri si consola velocemente diventando nel 2004 "mister
Preferenze" per l'Ulivo nella circoscrizione Nord Ovest con ben 105 mila voti
che lo fanno entrare per la prima volta al Parlamento Europeo.
Diventa
vicepresidente della commissione Occupazione e affari sociali dell'Eurocamera,
membro supplente della commissione per il Mercato interno e la protezione dei
consumatori e fa parte della Delegazione per le relazioni con Usa e Giappone.
Entra nel Pd nel 2007, anno della sua fondazione, salvo poi lasciare il partito
del Nazareno nel 2017 per iscriversi ad Articolo 1 e poi alla lista elettorale
«Liberi e uguali». Viene riconfermato a Bruxelles nel 2009 per guidare le
relazioni con il Maghreb.
Cinque anni dopo,
con oltre 77 mila preferenze conquista anche la terza legislatura a Bruxelles.
Da qui, nel 2019 fonda la Ong «Fight impunity» di cui è direttore, nel cui board
figurano personaggi della politica italiana ed internazionale come Emma Bonino,
ex ministra e commissaria europea, Federica Mogherini, già Alto Rappresentante
dell'Ue, Dimitri Avramopulos, ex commissario europeo agli Affari Interni e l'ex
primo ministro francese Bernard Cazeneuve.
La sua
organizzazione non profit con sede a Bruxelles promuove «la lotta contro
l'impunità per gravi violazioni dei diritti umani e crimini contro l'umanità».
Luca Visentini invece, 53 anni, poco conosciuto in Italia, ha un passato nella
Uil del Friuli Venenzia Giulia, è diventato nel 2015 segretario generale della
Etuc (Confederazione europea dei sindacati), riconfermato nel 2019. Poi il
grande salto pochi giorni fa, diventando il sindacalista più potente del mondo,
ovvero segretario generale della Ituc, la più grande confederazione sindacale
del pianeta.
Il progressismo
Pd a misura di islam.
La sinistra italiana
ha sempre legittimato gli integralisti dell'Ucoii. Gian Micalessin l’11 Dicembre
2022 su Il Giornale.
Garantisti sì, fessi
no. I sacchi di soldi elargiti alla «sinistra» eurobrigata guidata dalla
socialista greca Eva Kaili e dall'ex eurodeputato dem Antonio Panzeri non
bastano, da soli, per emettere una condanna preventiva. D'altra parte sarà
difficile stupirsi se quelle accuse risulteranno, alla fine, quanto mai fondate.
L'idillio ideologico-finanziario che lega il Pd italiano e la sinistra europea
all'Islam della Fratellanza Musulmana sovvenzionato dal «grande fratello»
qatariota dura da oltre un decennio. E l'Italia ne rappresenta, grazie ai
governi Pd, una delle culle più accoglienti. Per scoprirlo basta sostituire al
nome di Fratellanza Musulmana e Qatar la sigla del loro referente nostrano
ovvero quell'Ucoii, Unione delle comunità islamiche in Italia, che - pur
rappresentando un'ala minoritaria e non proprio moderata dell'Islam italiano -
ne è diventato grazie a governi e amministratori del Pd la voce più ascoltata e
autorevole.
Ma per comprendere
la pericolosità dell'idillio dem-islamista vanno ricordati alcuni retroscena. Il
Qatar da sempre accoglie e protegge la diaspora della Fratellanza Musulmana, un
movimento integralista giudicato sovversivo e pericoloso da molti paesi arabi e
islamici. Un giudizio non proprio campato in aria visto che tra le fila della
Fratellanza sono cresciuti i leader di Hamas prima e di Al Qaida poi. A Doha,
invece, è vissuto in esilio, fino alla morte sopraggiunta lo scorso settembre,
Yusouf Al Qaradawi, il predicatore simbolo della Fratellanza Musulmana autore di
una fatwa in cui pronosticava la riconquista di Roma «attraverso la predicazione
e le idee». Predicazione e idee destinate a far assai poca strada senza i soldi
riversati in Italia ed Europa da Doha e dai suoi prestanome. Da noi, grazie alle
«disattenzioni» dei governi Pd arrivano, dopo il 2013, circa 25 milioni di euro
della «Qatar Charity» con cui l'Ucoii conta di realizzare 45 progetti per la
costruzione di moschee, luoghi di preghiera e centri culturali islamici. Il
tutto mentre Al Qaradawi suggerisce di destinare qualche spicciolo anche al
Caim, il Coordinamento Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza.
Un'intuizione a dir poco lungimirante visto che subito dopo il sindaco di Milano
Giuseppe Sala fa eleggere nelle liste Pd e accoglie in Consiglio comunale la
militante islamica Sumaya Abdel Qader. Una militante orgogliosamente velata
formatasi, guarda caso, tra le fila del Forum Europeo delle Donne Musulmane,
braccio operativo della Fratellanza Musulmana a Bruxelles. Una mossa che alla
luce delle attuali cronache la dice lunga sui rapporti intessuti dal Pd con
l'Ucoii e i suoi referenti internazionali. Legami confermati dalle scelte
dell'ex-ministro della giustizia Andrea Orlando firmatario, nel 2016, della
convenzione che affida proprio agli imam dell'Ucoii il compito di prevenire la
penetrazione nelle carceri dell'Islam radicale. Una mossa che equivale a mettere
la volpe nel pollaio.
Gli imam dell'Ucoii
sono, infatti, i principali propagatori del verbo integralista propugnato dalla
Fratellanza Musulmana. Ma il pollaio italiano è ben più ampio del ristretto
universo carcerario. E lo dimostra la Firma del «Patto nazionale sull'Islam» con
cui l'Ucoii diventa nel 2017 un interlocutore ufficiale dei nostri governi.
Mentre l'accusa di «islamofobia» diventa l'anatema con cui tacitare qualsiasi
critica al diffondersi di un islam radicale garantito dal denaro distribuito
all'Ucoii e agli spregiudicati esponenti di un pensiero progressista modellato
sul verbo di Doha.
Dai diritti
agli affari: la triste parabola di una sinistra che si è venduta.
Tocca a Panzeri
dopo il caso Soumahoro. Quella deriva dietro il paravento delle "lotte". Stefano
Zurlo il 10 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Quasi
cinquecentomila euro in contanti. Mazzette, ipotizzano gli inquirenti. E allora
si resta sbalorditi perché Antonio Panzeri è una delle voci storiche del
riformismo ambrosiano e italiano, un punto di riferimento per la sinistra che a
Milano faticava a toccare palla. Oggi che non è più in prima linea, il suo nome
può suscitare interrogativi sbiaditi, ma Panzeri, classe 1955, è stato il leader
milanese della Cgil e per un certo periodo si pensava a lui come al possibile
successore di Sergio Cofferati, a sua volta per una breve stagione il vero
antagonista di Silvio Berlusconi.
Panzeri ha
interpretato a lungo una linea pragmatica, forse l'unica praticabile nella
metropoli lombarda alla prese con la deindustrializzazione, e certo fa
impressione pensare che oggi si sospetti una deriva oltre il confine della
legalità: la capacità di leggere la realtà senza gli occhiali dell'ideologia
avrebbe lasciato il posto ad altre logiche e altre prospettive. Una parabola
avvilente, se sarà confermata dallo sviluppo delle indagini.
Panzeri è per lungo
tempo una figura di raccordo fra la Cgil e il partito, naturalmente il Pci e poi
le sue evoluzioni. Il tutto in un'epoca in cui le due chiese officiavano lo
stesso rito e incrociavano i percorsi dei loro colonnelli. Panzeri è per due
mandati segretario della Camera del lavoro di Milano, insomma è ai vertici del
sindacato, poi deve lasciare, come da statuto, e inizia la carriera politica.
Nel 2004 viene eletto al Parlamento europeo, con 105 mila preferenze,
naturalmente nella circoscrizione Nord-Ovest, e sembra portare a Bruxelles le
istanze di una sinistra meno legata ai vecchi dogmi ormai in soffitta e pronta a
dialogare con il ceto medio e la borghesia meneghina.
Ma le cose vanno
diversamente; Panzeri viene rieletto la seconda e la terza volta, ma il rapporto
con il Nazareno si consuma: l'europarlamentare esce dal Pd e aderisce ad
Articolo 1, poi si ritrova fuori dall'emiciclo: in realtà continua a frequentare
il mondo della politica. È direttore della Ong Fight impunity che annovera nel
comitato scientifico personaggi come Emma Bonino e Federica Mogherini.
Insomma, l'impegno
anche dopo aver lasciato la prima linea: forse, dietro le quinte, se dobbiamo
dare credito a quel che sta emergendo a Bruxelles, Panzeri transita in quella
fase al partito degli affari. I suoi interlocutori non sono più i lavoratori
milanesi, gli operai costretti a reinventarsi dopo il declino delle fabbriche e
l'esplosione del terziario; no, dai radar di Panzeri sarebbero usciti anche gli
euroburocrati e i funzionari della Ue, o forse no, perché spezzoni dell'apparato
si sarebbero integrati fra Bruxelles e Strasburgo con emiri e mediatori
mediorientali.
Tutto da dimostrare,
in un'inchiesta che per una volta non nasce in Italia. La cronaca giudiziaria ci
ha abituato per lunghi periodi a indagini che colpivano il centrodestra. Quando,
a finire sotto i riflettori sono i protagonisti dell'altro versante, si tende a
catalogarli come un'eccezione. Un'eccezione che ai tempi di Mani pulite tolse
dall'imbarazzo l'allora Pds perché i miglioristi furono equiparati ad una
variante degli allora impresentabili socialisti.
Qui non è facile
cavarsela con le acrobazie semantiche e i distinguo capziosi ma resta il fatto
che la storia gloriosa di Panzeri non può essere cancellata. E mette a disagio
pensare che possa aver virato in altra direzione, privilegiando intrighi e
oboli.
Chissà. La vicenda
di Aboubakar Soumahoro, che peraltro non è indagato, insegna che proclami e
invettive qualche volta sono solo un paravento: dietro si nascondono pasticci, o
peggio rapporti opachi. Certo, sono storie diverse e con differenti profili: fra
l'altro da qualche tempo Panzeri era finito nella penombra e non aveva più la
notorietà del deputato della sinistra radicale, scintillante campione
dell'opposizione al governo Meloni.
Battaglie su
battaglie, manifestazioni, assemblee e cortei, talk e interviste. Poi dietro le
quinte affiora altro. Non proprio edificante. Anche se sarebbe a dir poco
ingeneroso trasformare gli elementi investigativi che arrivano dal Belgio in una
sentenza di condanna.
Estratto
dell'articolo di Lorenzo Vidino per “la Repubblica” il 14 dicembre 2022.
Lo scandalo
corruzione che ha travolto il Parlamento Europeo è l'ennesima conferma
dell'enorme influenza che il Qatar è riuscito a ottenere in tutto il Continente.
[…] Ottenere visibilità e influenza, tessere una rete di contatti che, ognuno in
modo diverso, possano innalzare la posizione del Qatar, una strategia a livello
globale che vede nell'Europa un tassello fondamentale e nell'Italia un Paese di
particolare interesse. Investimenti strategici che vanno dal settore energetico,
fondamentale in questo periodo, all'immobiliare (è loro Porta Nuova a Milano) al
lusso. […]
Ma anche utilizzo
massivo di società di pubbliche relazioni e conseguente ottenimento di copertura
mediatica di favore, e una diplomazia che spesso si spinge ben oltre il lecito,
diventando vera e propria coltivazione di politici "amici," come l'inchiesta
belga pare dimostrare. […]
Qualche anno fa
l'ospitalità qatariota aveva ammaliato anche Salvini. Se nel 2017 il leader
della Lega esortava a «istituire immediatamente blocchi e controlli anche in
Italia e in Europa sugli ingressi, i fondi e gli investimenti provenienti dal
Qatar», pochi mesi dopo, in una diretta Facebook da Doha, si sperticava di elogi
per «un Paese che cresce, che accoglie, che ha voglia di lavorare con l'Italia».
Ma gli investimenti
qatarioti in Italia riguardano anche un altro campo estremamente problematico:
l'islamismo radicale. Da anni il Qatar finanzia la costruzione su larga scala di
centri islamici in tutta Europa. Un fenomeno di per sé non preoccupante se non
fosse che la stragrande maggioranza di questi centri sono gestiti dai Fratelli
Musulmani, movimento supportato dal Qatar a livello globale, e promuovono la
diffusione di un tipo di islam incompatibile coi valori europei e i diritti
umani.
Non a caso negli
ultimi anni l'Unione Europea e vari governi europei hanno più volte sollevato la
questione del finanziamento qatariota all'islam radicale. […] In tutta Europa
aveva fatto scalpore nel 2019 la pubblicazione di Qatar Papers, libro basato su
migliaia di documenti interni della Qatar Charity, la fondazione formalmente
indipendente ma in realtà controllata dall'emiro del Qatar e nodo centrale del
soft power del piccolo emirato. Il libro aveva rivelato 113 progetti finanziati
in tutta Europa nel solo 2014, per un totale di 71 milioni di Euro. Può non
stupire che il Paese dove la Qatar Charity ha speso di più sia l'Italia, più di
22 milioni suddivisi su 45 progetti.
Moschee e centri
islamici, soprattutto nel nord (Saronno, Piacenza, Brescia, Alessandria.), ma
anche centro e sud. Anzi, tra le regioni primeggia la Sicilia con i suoi 11
progetti, nei capoluoghi come in piccoli centri quali Comiso e Vittoria. […]
E se all'estero la
costruzione di moschee qatariote veniva accompagnata da polemiche e talvolta
bloccata dalle autorità, in Italia le strutture sono state spesso inaugurate in
pompa magna da sindaci locali (se per sempre ingenuità o perché "amici" è
difficile dire). […]
Stasera Italia,
Liguori esplode sul Qatar: "Calato un velo, non si può dire nulla”.
Il Tempo
il 09 dicembre 2022
L’ex eurodeputato
Antonio Panzeri è stato arrestato a Bruxelles per corruzione. La notizia viene
commentata nel corso della puntata del 9 dicembre di Stasera Italia, programma
televisivo che vede Barbara Palombelli alla conduzione, da Paolo Liguori,
direttore di Tgcom: “Delle sue responsabilità non so nulla e nemmeno degli
altri, perché la notizia è fresca. Dico però una cosa, un’inchiesta di questo
genere in Europa ha comunque delle fondamenta, se fosse nata in Italia, come
quella Soumahoro, io sarei stato tra quelli a dire ‘mostratemi bene i reati,
sennò mi sembra una cosa non del tutto chiara’. Invece per l’Europa sono serie
queste cose”.
“Io - prosegue
Liguori - faccio un passo indietro e pongo un altro problema. Il soggetto per il
quale, a favore del quale, a vantaggio del quale, si sarebbe, forse, orchestrata
questa lobby è un soggetto che si chiama Qatar. Non so nulla di Panzeri e delle
loro responsabilità, ma qualcosa negli ultimi anni sul Qatar l’ho letta. Non so
se oggi, visto che ci sono i Mondiali, si è creata una zona franca per cui non
si deve dire nulla che riguarda il Qatar, che poco poco chiami in causa reati,
possibili turbative, possibili influenze negative sull’Europa, sui paesi
europei, sulla Francia, sulla Gran Bretagna, sull’Italia. Adesso - si arrabbia
il giornalista - c’è questo velo, abbiamo una confusione delle coscienze”.
Estratto
dell'articolo di Gabriele Rosana per “Il Messaggero” il 14 dicembre 2022.
Il badge che apre
tutte le porte è per sempre. Al termine del mandato da eurodeputati, gli ex
conservano il tesserino identificativo blu notte che continua a mantenere la
propria validità senza scadenza. E a consentire loro di accedere liberamente ai
palazzi dell'Eurocamera, a Bruxelles come a Strasburgo, senza doversi registrare
né dover segnalare il proprio arrivo. [...]
È il destino degli
ex europarlamentari diventati lobbisti, che attraversano le porte girevoli
facendo leva sulla propria rete di contatti. È così che, nei capannelli
bipartisan di fronte all'aula plenaria, al termine del voto di mezzogiorno che
ha destituito la greca Eva Kaili dalla vicepresidenza, c'è chi ricorda le
chiamate con insistenza e le richieste di appuntamento da parte di Pier Antonio
Panzeri. Pressioni in particolare nei confronti di quegli eletti molti italiani
che siedono nelle delegazioni parlamentari con i Paesi del Golfo e del Maghreb,
o che si occupano, a vario titolo, di politica estera e diritti umani.
Insomma, l'inchiesta
della magistratura belga scoperchia il vaso di Pandora di un Parlamento che è
«fisiologicamente iper-penetrabile» (parola di un diplomatico di lungo corso),
un sottobosco popolato da personaggi poco noti ai più. Da lobbisti e
rappresentanti di interessi organizzati, anzitutto, la cui figura è disciplinata
dal registro Ue per la trasparenza.
Più che i deputati
Ue, però, i loro interlocutori privilegiati, quando si abbandonano i convenevoli
e si entra nel vivo della discussione tecnica, sono le schiere di assistenti e
collaboratori parlamentari. Non semplici portaborse come vorrebbe la vulgata, ma
veri e propri consiglieri politici spesso altamente specializzati sui dossier.
E che all'Eurocamera
costruiscono vere e proprie carriere, passando dagli uffici di diretta
collaborazione degli eurodeputati, talvolta anche di diversa appartenenza
politica (è prassi diffusa che siano reclutati direttamente a Bruxelles, senza
arrivare dai territori) fino al segretariato del gruppo politico e, quindi,
all'amministrazione del Parlamento. Insomma, non sorprende che, per il potere
spesso accentrato, alcuni di loro vengano talvolta considerati degli
eurodeputati-ombra.
Ma accanto ai binari
classici ci sono anche contatti meno trasparenti, che fuggono agli stessi
obblighi di pubblicità. Sono i rappresentanti dei governi extra-Ue e gli agenti
stranieri che si aggirano per i corridoi di Bruxelles e Strasburgo facendo leva
sul loro status diplomatico per agire, sostanzialmente, nell'ombra. [...]
Accanto alle lobby
più o meno strutturate si espande anche tutto un universo di piattaforme
informali che servono a fare rete, e che vengono attivate all'occorrenza. È il
caso, ad esempio, del gruppo di amicizia con il Qatar, un raggruppamento di una
dozzina di europarlamentari i cui nomi campeggiano ancora sul sito Internet
dell'ambasciata di Doha a Bruxelles. Costituito nel 2019, a inizio legislatura,
tuttavia, non si sarebbe mai riunito né avrebbe svolto attività in concreto,
anche se non sono mancati inviti a buffet da parte degli emissari qatarioti. Che
a svariati parlamentari avrebbero pure promesso biglietti gratis per assistere
al Mondiale. Ieri mattina il gruppo di amicizia è stato sospeso «finché non sarà
fatta chiarezza sulla vicenda» delle presunte mazzette degli emiri [...]
Da quotidiano.net il
14 dicembre 2022.
Visto lo scandalo
del Qatar (oggi tra l'altro c'è stata la destituzione di Eva Kaili dalla
vicepresidenza dell'Europarlamento) e un tweet di elogio sul progresso del Qatar
in termini di diritti umani, Margaritis Schinas, vicepresidente della
Commissione Europea, ha parlato in conferenza stampa a Strasburgo, rispondendo
ad alcune domande sul Qatargate. In primo luogo ha detto che le sue posizioni
sono sempre state in linea con quelle dell'Unione Europea, che ha rappresentato
anche alla cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar. Ha rivendicato la
limpidezza della sua carriera politica, anche grazie ai tweet che pubblica
regolarmente e con cui comunica idee ed esperienze.
"Ho ricevuto in dono
dal Qatar un pallone e una scatola di cioccolatini, che ho regalato all'autista
andando all'aeroporto, e qualche souvenir legato al Mondiale di calcio", ha
risposto, quando gli è stato chiesto se avesse ricevuto regali dalle autorità
qatariote. "Mi sono recato in Qatar come rappresentante della Commissione
Europea, poiché responsabile dello sport, in piena trasparenza, e in
quell'occasione ho difeso il nostro modello sportivo", ha spiegato.
"Per me, dopo 32
anni di servizio pubblico, c'è solo la limpidezza. Twitto e continuerò a farlo
come segno di trasparenza. E grazie a Dio l'ho fatto. Potete immaginare il
genere di critiche che avrei ricevuto se non avessi twittato tutto quello che ho
fatto e detto alla luce di questo?", ha dichiarato in merito a un suo tweet di
novembre in cui ha elogiato il Qatar sul progresso nell'ambito dei diritti
umani.
E ancora: "Tutti i
miei interventi pubblici, non solo quando ero in Qatar, ma sempre, sono
compatibili al 100% con le politiche della Commissione: non inventiamo cose alla
Commissione, ma ci basiamo sui documenti e le strategie prodotte dagli uffici".
"Voglio che questa istituzione resti un bastione della democrazia e questa non è
stata una buona settimana: sono felice che il Parlamento abbia preso azioni
immediate e si guadagni nuovamente la fiducia dei cittadini".
Vista, in ogni caso,
la corruzione scoperta, non possono non esserci azioni nel prossimo futuro per
riconquistare la fiducia e Schinas auspica in un pacchetto anti-corruzione nel
2023. "Vogliamo ottenere un organismo etico Ue, la piena applicazione del
registro di trasparenza delle Istituzioni europee e il pacchetto anti-corruzione
che presenteremo e fisserà regole molto specifiche".
"Se il sistema ha
bisogno di correzioni, non ci sono dubbi che la Commissione punterà a questi
obiettivi. Ma se gli individui hanno bisogno di correzioni, non sono sicuro che
si tratti di un compito della Commissione", ha aggiunto. "Ricordiamo che la
Commissione ha proposto un registro obbligatorio della trasparenza per tutte le
Istituzioni Ue già nel 2016. Ci sono voluti cinque anni perché il Parlamento e
il Consiglio arrivassero a un accordo. La Commissione è l'unica ad applicare la
regola, 'no registro no incontro'", ha spiegato. "La Commissione proporrà un
organismo etico per tutte le Istituzioni ue. Mi aspetto che questa volta non ci
vogliano 5 anni per metterlo in pratica. Ora è tempo di riforme", ha ribadito
Schinas.
Portavoce Ue:
"Fiducia in Schinas non in discussione"
"Ovviamente la
presidente" Ursula von der Leyen "sostiene l'intero collegio, dal vice
presidente Schinas alla commissaria Johansson" e nella conferenza stampa di ieri
"non c'era assolutamente alcun fatto che richiedesse alla presidente della
Commissione di esprimere la sua solidarietà o sostegno al Collegio o a un membro
del Collegio" dei commissari europei. Questo è quanto ha dichiarato Eric Mamer,
portavoce della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen,
nella conferenza stampa a Strasburgo con i commissari Margaritis Schinas e Ylva
Johansson.
Interrogato sulla
mancata conferma di von der Leyen della sua fiducia in Schinas dopo le polemiche
sui tweet di sostegno del commissario greco al Qatar, Mamer ha risposto che "se
ogni volta che la presidente si trova in conferenza stampa le venisse chiesto di
garantire la sua fiducia ai membri del Collegio ci troveremmo in una situazione
molto bizzarra". "Non c'è assolutamente nulla di nuovo là fuori che giustifichi
che lei debba prendere una posizione pubblica su questo", ha concluso Mamer.
Ivan Cimmarusti,
Sara Monaci per il Sole 24 Ore il 14 dicembre 2022.
Sono i quattro
dossier "bollenti" del Parlamento europeo - soprattutto in materia di diritti
umani e sfruttamento del lavoro - sui cui si sospetta che il Qatar volesse
influire con un presunto «sistema» di tangenti e che ora sono al centro delle
indagini degli inquirenti di Bruxelles. Ma c'è anche una lista con una decina di
europarlamentari su cui si sta cercando di fare chiarezza.
L'inchiesta
"Qatargate" dell'autorità giudiziaria belga presto potrebbe ampliare i propri
perimetri.
L'ipotesi
preliminare di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio ricade,
allo stato, sui sei principali arrestati: l'ex europarlamentare Pd Pier Antonio
Panzeri, oggi lobbista con l'Ong Fight Impunity e ritenuto il presunto trait
d'union tra gli interessi di Doha e i parlamentari Ue, l'ormai ex vice
presidente del Parlamento Ue, la social democratica Eva Kaili - da ieri
destituita e detenuta nel carcere di Haren, alla periferia nord-orientale di
Bruxelles -, il suo compagno Francesco Giorgi, ex collaboratore di Panzeri e
oggi assistente parlamentare di Andrea Cozzolino (Pd, non coinvolto
nell'inchiesta), il segretario dell'Ong No peace without justice Niccolò Figà
Talamanca e la moglie e la figlia di Panzeri.
I primi quattro oggi
compariranno davanti alla Camera di consiglio di Bruxelles per una prima
udienza, mentre per le due donne si attende il provvedimento del Tribunale di
Brescia per trasferirle in Belgio.
Eppure, ragionano
gli investigatori, il presunto ruolo della Kaili - che negli ambienti
parlamentari è definita «Lady Qatar» - potrebbe non essere isolato.
L'ex giornalista
greca, chiamata anche «la portavoce del Qatar», respinge le accuse anche se è
stata arrestata in flagranza di reato perché trovata in possesso di 150mila euro
che non ha saputo giustificare. Suo padre è stato bloccato mentre cercava di
partire con un volo Ryanair con un trolley pieno di soldi: 600mila euro in
biglietti da 20 e 50 euro. Ulteriori 600mila euro sono stati sequestrati a
Panzeri. In tutto il "malloppo" messo sotto sigillo ammonta a 1,5 milioni.
La lista di
eurodeputati L'ipotesi che altro denaro «non tracciato» sia finito nelle tasche
di ulteriori parlamentari Ue, nell'ambito di una più ampia strategia di lobbying
progettata presumibilmente dal Paese del Golfo Persico, non è scartata.
Gli investigatori,
con il coordinamento del giudice istruttore belga Michel Claise, hanno una lista
di almeno una decina di europarlamentari la cui posizione è al vaglio. A partire
dal social-democratico Marc Tarabella, italo-belga, sospeso dal gruppo dei
Socialisti e Democratici (S&D), di cui fa parte anche Kaili. Fonti vicine alle
indagini confermano che il suo nome è stato fatto nel corso dell'interrogatorio
di Francesco Giorgi, cui tra l'altro ieri sono stati sequestrati 20mila euro
trovati nella sua abitazione nella provincia di Milano.
A collaborare con
gli inquirenti ci sarebbe anche Luca Visentini, segretario generale dell'Ituc,
la confederazione sindacale internazionale, fermato nei giorni scorsi ma poi
rimesso in libertà.
I dossier Gli
inquirenti stanno incrociando il contenuto delle indagini con alcuni atti
parlamentari, per individuare conferme alle ipotesi di un più ampio
coinvolgimento di politici Ue, presumibilmente pagati per agevolare gli
interessi qatarini.
Un faro
investigativo riguarda la risoluzione del 24 novembre scorso: l'Europarlamento
ha approvato un testo non legislativo in cui deplora la morte di migliaia di
lavoratori migranti impiegati nei cantieri del Mondiale Fifa in Qatar.
Tuttavia, come
emerge dalle riunioni di quei giorni, ci sarebbero state pressioni dell'area S&D
per ammorbidire il testo allo scopo di non «discriminare il Qatar». Poi ci sono
gli emendamenti al regolamento Ue 2018/1806 che adotta l'elenco dei Paesi terzi
i cui cittadini sono esenti dall'obbligo dei visti per l'attraversamento delle
frontiere europee.
Una modifica a cuore
del Qatar, considerato che è nella lista degli Stati assoggettati all'obbligo
del visto.
A leggere le
documentazioni si scoprono gli emendamenti che elogiano Doha per l'applicazione
del «salario minimo» ai lavoratori, presentanti anche da alcuni deputati
socialisti (l'area politica di cui fa parte anche la Kaili), tra i quali Pietro
Bartolo, al cui assistente hanno messo sotto sequestro l'ufficio a Strasburgo.
Infine, c'è la proposta di regolamento della Commissione Ue che punta a vietare
l'import in Europa di prodotti di Paesi terzi che attuano lo sfruttamento del
lavoro forzato.
Il Qatar è accusato
da anni di promuovere questo tipo di pratiche, anche se dal 2020 ha eliminato la
Kafala, un regime tribale paragonabile a un lavoro forzato per i dipendenti per
i lavoratori migranti. Eppure, ha constatato Amnesty International, lo
sfruttamento sembra essere ancora la regola. Ci sarebbe un ulteriore dossier su
gas ed energia, ma in generale è l'ambito dei diritti umani - che vede coinvolte
molte Ong in Europa - a destare l'attenzione dei magistrati belgi. I diritti
umani come schermo per la corruzione.
Da open.online il 14
dicembre 2022.
Tra i corridoi di
Strasburgo si fa sempre più strada l’ipotesi che all’origine di tutto ci sarebbe
un assistente parlamentare precario di Panzeri che, al mancato rinnovo di
contratto, avrebbe deciso di raccontare degli strani movimenti di denaro a cui
assisteva periodicamente. Secondo la stampa belga, uno dei quattro interrogati
avrebbe invece fatto il nome di Marc Tarabella, l’eurodeputato belga di origini
italiane, accusato di aver cambiato radicalmente la sua posizione sui diritti
umani in Qatar. Tarabella, sospeso dal partito socialista belga e non indagato,
è vicepresidente della delegazione del Parlamento Ue per i rapporti con la
Penisola arabica ed è considerato molto vicino al Marocco.
Da open.online il 14
dicembre 2022.
È Francesco Giorgi
l’indagato nel Qatargate che sta parlando con i magistrati. E l’inchiesta sulla
corruzione dal Qatar arriva a una possibile svolta. L’assistente parlamentare
dell’eurodeputato del Partito Democratico Antonio Cozzolino (non indagato) ha
risposto per ore alle domande degli inquirenti belgi.
Fornendo dettagli
sulla rete dell’ex deputato Antonio Panzeri e della sua compagna, la
parlamentare greca Eva Kaili. Sono state le sue rivelazioni a consentire di
estendere le indagini a Marc Tarabella. Ieri la polizia belga ha sequestrato 20
mila euro nell’abitazione di Giorgi ad Abbiategrasso. In tutto a Giorgi e Kaili
sono stati sequestrati quasi un milione di euro in contanti. Sommati ai 600 mila
ritrovati a Panzeri fanno arrivare a un milione e mezzo di euro il totale della
corruzione dal Qatar.
Le carte
dell’interrogatorio
Nelle carte
dell’interrogatorio di Giorgi ci sono ammissioni deflagranti. Secondo le accuse
di Michel Claise il gruppo formato da lui, Panzeri, Niccolò Figà-Talamanca e
Luca Visentini (che si dice però estraneo all’indagine) si muoveva intorno alla
Ong “Fight Impunity”.
Che aveva
l’obiettivo di favorire due paesi: Qatar e Marocco. Perché le organizzazioni non
governative, scrive Repubblica, «ci servono per far girare i soldi», secondo
l’ammissione dello stesso Giorgi davanti ai magistrati. Il gruppo sarebbe attivo
dal 2021. I magistrati vogliono contestare l’associazione a delinquere. Giorgi è
stato inchiodato anche da alcune intercettazioni in cui faceva riferimenti molto
espliciti. Il ministro del Lavoro del Qatar Ali Bin Samikh Al Marri è il
contatto. Con Kaili si è incontrato il primo novembre in Qatar. Grazie proprio
alla mediazione del gruppo, secondo gli inquirenti.
L’udienza
preliminare
Kaili, Giorgi,
Panzeri e Niccolò Figà-Talamanca comunque si presenteranno oggi in tarda
mattinata in tribunale per l’udienza preliminare. La polizia federale ha diffuso
la prima foto dei contanti trovati all’ellenica, a suo padre e a casa di
Panzeri. Molte le banconote di piccolo taglio, anche da dieci e venti euro. A
parlare in via ufficiale con la stampa, finora, è stato solo il legale
dell’eurodeputata di Salonicco. «La sua posizione è di innocenza. Non ha nulla a
che fare con le tangenti del Qatar», ha dichiarato l’avvocato Michalis
Dimitrakopoulos.
Francesca Basso
per corriere.it il 14 dicembre 2022.
La plenaria del
Parlamento Ue ha rimosso la vicepresidente Eva Kaili, in quota socialisti, con
625 voti a favore, un contrario (Mislav Kolakusic, del Gruppo non iscritti) e
due astenuti (Dorien Rookmaker e Joachim Kuhs di Alternative fuer Deutschland,
gruppo Id).
Kaili è stata
arrestata in flagranza di reato nell’ambito dell’inchiesta belga sulla
corruzione da parte del Qatar nei confronti di deputati e funzionari per
influenzare le decisioni dell’Eurocamera. (Il suo avvocato ha dichiarato che la
sua assistita «non sapeva nulla» del denaro che le è stato trovato in casa).
Ieri si è anche
autosospeso temporaneamente dal gruppo S&D l’eurodeputato Andrea Cozzolino , il
cui assistente Francesco Giorgi — compagno di Kaili — è stato arrestato
nell’ambito della stessa inchiesta. Cozzolino ha spiegato in una lettera al
capodelegazione Brando Benifei e alla capogruppo Iratxe García Pérez, che ha
annunciato che i socialisti si costituiranno parte civile, di avere deciso di
autosospendersi in continuità con la sospensione dalla presidenza della
Delegazione per le relazioni con il Maghreb «per tutelare me stesso, la mia
moralità, la mia integrità politica».
In questi giorni il
ruolo di assistente di Giorgi è stato molto chiacchierato a Strasburgo, a
partire dal suo stipendio a detta di molti assai superiore rispetto alla media
di un assistente.
Dopo lo scoppio
dello scandalo ha creato imbarazzo un’email che Cozzolino, prima del voto del 24
novembre sulla risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel contesto della
Coppa del mondo in Qatar, aveva mandato ai colleghi invitandoli a votare contro
una parte del testo in cui si sosteneva che Doha ha ottenuto i Mondiali
attraverso la corruzione perché «il Parlamento Ue non dovrebbe accusare un Paese
senza prove delle autorità giudiziarie competenti» e a riflettere sulla
corruzione in tutti gli eventi sportivi «inclusa la Coppa del mondo in Germania
nel 2006», passaggio che ha fatto infuriare la delegazione tedesca. Il suo
invito non fu raccolto.
Cozzolino non è
nemmeno tra i firmatari dell’interrogazione all’Alto rappresentante Josep
Borrell sulla grave situazione dei diritti Lgbtqia+ in Qatar presentata il 28
novembre scorso da Benifei, Majorino, Picierno, Smeriglio, Moretti, Bartolo,
Tinagli, Roberti, Laureti.
È finito sotto i
riflettori anche il vicepresidente della Commissione Ue, il greco Margaritis
Schinas, che ha partecipato alla cerimonia inaugurale della Coppa del mondo in
rappresentanza dell’esecutivo, ha parlato dei «progressi considerevoli e
tangibili sulle riforme del lavoro» in Qatar e il 18 novembre ha twittato una
foto con Kaili e il viceministro greco per lo Sviluppo Tsakiris: «Imprevedibile
e piacevole incontro ad Abu Dhabi».
Schinas ha spiegato
che tutti i suoi interventi pubblici «non solo quando ero in Qatar sono
compatibili al 100% con le politiche della Commissione: non improvvisiamo le
posizioni». Ha detto di avere ricevuto in dono «un pallone e una scatola di
cioccolatini, che ho regalato all’autista andando all’aeroporto, e qualche
souvenir dei Mondiali».
Marco Imarisio per
il “Corriere della Sera” il 14 dicembre 2022.
Dammi il cinque.
Quando la sottocommissione ai Diritti umani votò il via libera al libero
ingresso dei cittadini del Qatar in Europa, Francesco Giorgi batté le mani con
il suo amico Mamedov Eldar in segno di reciproca soddisfazione. Era andata bene.
Entrambi presenti in aula, a seguire fino alla fine un provvedimento che avevano
accompagnato sin dalla sua ideazione.
Del primo, ex
assistente parlamentare di Antonio Panzeri e ora di Andrea Cozzolino, ormai si
conoscono molte cose. A quella sessione, come a molte altre, era presente anche
la sua compagna Eva Kaili, una dei 14 vicepresidenti del Parlamento europeo, che
per eccesso di zelo si prese la briga in quella occasione di dare anche lei
parere favorevole al provvedimento, senza per altro avvertire il suo gruppo,
l’Alleanza progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D) che infatti si
ritrovò con un voto in più di quelli dovuti e attesi.
Il misterioso
consigliere
Ma quello del
secondo è un nome nuovo, con una storia particolare. Nel vasto organigramma dei
S&D, «il nostro team» sul sito di riferimento, il cinquantenne Mamedov Eldar, di
passaporto lettone e di origine iraniane e macedoni, è presentato come
consigliere politico per gli Affari esteri. Secondo alcune fonti, il suo ufficio
nel palazzo dell’Unione europea dedicato a Stephen Zweig, l’ex Atrium di
Bruxelles, è stato perquisito e sigillato dalla gendarmeria belga.
I suoi interessi
riguardano però una sola area, da sempre. «Un lobbista iraniano» è la
definizione generale di questo personaggio ben conosciuto a Strasburgo e
Bruxelles. «Sempre pronto a ripetere la propaganda di Teheran», lo fulmina così
un articolo di Aze media, poco lusinghiero nei suoi confronti. «Un promettente
diplomatico e analista politico che negli ultimi quindici anni è diventato un
inutile agente dei Pasdaran».
Gli europarlamentari
del gruppo ricordano come ogni volta che uno di loro si esprimeva in termini
severi sul Qatar, come noto uno degli alleati principali dell’Iran, Eldar
interveniva cercando di ammorbidire la sua posizione. Spesso riuscendo nel suo
intento, come dimostra la proposta della Commissione sui visti di ingresso poi
congelata dopo gli arresti dello scorso venerdì, che riconosceva «i progressi»,
così erano definiti nella bozza finale, fatti dal Qatar sui diritti civili.
Amici e
collaboratori
Tutti i nomi portano
a Panzeri, «sospettato di essere intervenuto politicamente presso alcuni
deputati europei in favore del Qatar e del Marocco in cambio di pagamenti», così
come recita il suo capo di imputazione. Anche quello del diplomatico lettone,
che ha condiviso articoli e prese di posizione con il fondatore della
Organizzazione non governativa Fight impunity, fondata dall’ex eurodeputato
lombardo, lo ha intervistato e si è fatto da lui intervistare. Compagni di idee
e vedute convergenti, definizione agli atti di un convegno sul Maghreb che li
aveva visti insieme. Eldar suggeriva e disegnava scenari ai deputati che si
occupavano dei Paesi del Golfo.
Faceva lo stesso,
nel senso che identico è il ruolo presso i socialisti europei, anche Carlo
Bittarelli, italiano originario di Losanna, pure lui proveniente dagli ex
Democratici di sinistra, dei quali fu membro di segreteria della sezione di
Bruxelles prima di diventare, correva l’anno 2007, assistente di un
europarlamentare di prima nomina, tale Antonio Panzeri. Con il quale ha lavorato
fino al 2014, preparandogli i dossier di politica estera.
Oggi è rimasto nei
dintorni del Parlamento europeo. Sembra che anche il suo ufficio abbia ricevuto
le attenzioni degli investigatori belgi. «Il nostro team» qualifica anche lui
come consigliere politico, ma di quella sottocommissione sui Diritti umani
(Droi) che pare essere il centro di gravità dell’intera inchiesta, il luogo dove
convergevano interessi e spinte per aiutare eventuali amici qatarioti.
La rete
Sia Eldar sia
Bittarelli non risultano indagati. Così come non lo sono Mychelle Rieu,
funzionaria della sottocommissione sui Diritti umani, il cui ufficio è stato
perquisito ieri, e Giuseppe Meroni, anche lui oggetto delle attenzioni dei
gendarmi. Al momento e fino a prova contraria, pagano la vicinanza a Panzeri, la
prima in termini di amicizia personale, cosa nota negli ambienti della politica
comunitaria, il secondo in quanto anche lui suo assistente storico, prima di
passare alle dipendenze di Pietro Bartolo e dell’eurodeputato belga Marc
Tarabella, il Mister T indicato come tale dagli inquirenti belgi.
Gomitolo da dipanare
Ogni filo di questo
intrigo dai contorni ancora poco chiari riporta alla palazzina di rue Ducale,
nel cuore di Bruxelles, a pochi metri dall’ambasciata americana. Perché è dalla
sede di Fight impunity che inizia a dipanarsi questo gomitolo. Dalla telefonata
fatta da un collaboratore di Panzeri, che voleva sporgere denuncia. Era sempre
stato sottopagato, così avrebbe sostenuto. E la circostanza gli sembrava strana,
perché intorno a sé vedeva girare molti soldi, anche e soprattutto in contanti.
Non per una questione di principio, dunque. Ma per denaro. Come tutta questa
storia.
Giuseppe Guastella
per corriere.it il 14 dicembre 2022.
C’è un salto
temporale nell’inchiesta sulla corruzione che sta facendo tremare il Parlamento
europeo, uno scarto di non poco conto in cui i magistrati belgi, che pure
avevano già in mano tutti gli indizi per fare il blitz, hanno deciso di restare
sott’acqua e di rinviare di quasi due mesi gli arresti già programmati. Una
decisione che si spiega solo con nuovi elementi, cruciali ed urgenti che hanno
costretto a modificare i piani all’ultimo momento. Come possono esserlo gli
sviluppi del lungo interrogatorio di Francesco Giorgi, il compagno della vice
presidente Eva Kaili arrestato con lei.
Un milione e mezzo
La coppia più
glamour della politica europea è stata sorpresa con quasi un milione di euro in
contanti che, sommati ai 600 mila trovati ad Antonio Panzeri, fanno salire a un
milione e mezzo il frutto avvelenato della corruzione partita dal Qatar. Venerdì
Giorgi deve essersi sentito crollare il mondo addosso quando la polizia
giudiziaria gli ha messo le manette. Lo tenevano d’occhio e lo intercettavano, e
non è da escludere che siano state proprio le sue parole al telefono con il
padre della compagna a consentire agli investigatori di entrare nella bella casa
della ex giornalista greca e trovare 150 mila euro in mazzette.
A permettere di
superare lo sbarramento dell’immunità parlamentare che proteggeva la residenza è
stata la «flagranza» in cui è stato colto suo padre che usciva in fretta e furia
dal lussuoso Sofitel di Bruxelles dove da alcuni giorni soggiornava con la
moglie. Quando l’hanno bloccato, gli agenti hanno scoperto 600 mila euro in
banconote nel trolley che si trascinava. Bussando a casa della figlia e a quella
di Giorgi e lì hanno trovato gli altri soldi. «Non era a conoscenza dei soldi»
trovati a casa sua, dice l’avvocato della Kaili con una affermazione
sorprendente che lascia presagire lo scaricabarile.
Interrogatorio
L’interrogatorio di
Giorgi sabato si è protratto per una decina di ore con l’indagato che ha
risposto al giudice istruttore Michel Claise il quale nel pomeriggio è stato
costretto a rinviare le audizioni degli altri arrestati (oggi compariranno in
udienza) al giorno dopo per dare libero sfogo al fiume in piena. Quello che
emerge dall’indagine che ha scoperchiato il più grande giro di mazzette nella
storia dell’istituzione europea è che i magistrati stanno cercando conferma al
giro delle tangenti e dei sontuosi regali che dal Qatar, e in parte anche dal
Marocco, sarebbero arrivati all’ong Figth impunity, fondata nel 2019 da Panzeri
e nel cui consiglio onorario sedevano, prima di dimettersi sdegnati, premi
nobel, ex premier e ed ex commissari. Un giro di corruzione che arriva anche in
Lombardia, dove su richiesta di Eurojust l’aggiunto Fabio De Pasquale, che guida
il dipartimento affari internazionali della Procura di Milano, ha acquisito
conti e perquisito abitazioni ed uffici per ricostruire il patrimonio della
famiglia Panzeri e di Giorgi (a casa sua ad Abbiategrasso sono saltati fuori
altri 20mila euro).
L’intreccio
Nel decreto di
perquisizione, però, è indicata una prima data, «il 19 ottobre», in cui i
magistrati belgi avevano pronta la richiesta di arresti che poi è stata tenuta
in caldo fino al «7 dicembre» quando, integrata da altra documentazione, è
arrivata a Milano a due giorni dal blitz di Bruxelles. Questo lascia ipotizzare
che le basi d’accusa gettate due mesi fa ma sono state ulteriormente arricchite
fino alla vigilia degli arresti. Lungo i corridoi ovattati e attoniti della sede
del parlamento di Strasburgo, dove le voci si rincorrono all’impazzata, c’è chi
racconta dell’assistente di un parlamentare che avrebbe fatto partire le
indagini dopo che non le era stato rinnovato il contratto in uno staff contiguo
a quello in cui lavora Giorgi. Questi è attualmente un collaboratore del Pd
Andrea Cozzolino (non coinvolto nell’inchiesta), ma soprattutto ex collaboratore
di Panzeri che, direttamente o attraverso di lui, avrebbe corrotto Eva Kaili .
Questo intreccio, che se provato sarebbe perverso, è un altro dei temi centrali
dell’estenuante interrogatorio in cui il 35enne istruttore di vela ha parlato
anche dei soldi passati dal «manovratore» Panzeri ad altri «membri che lavorano
nel Parlamento Europeo», come li definisce l’accusa con una specificazione che
fa immaginare nuovi sviluppi.
Qatargate, quel
blitz degli 007 belgi a casa Panzeri e la pista degli altri europarlamentari.
Giuseppe Guastella su Il Corriere della Sera il 15 dicembre 2022.
L’inchiesta dei
Servizi nel 2021. I media greci: sono sessanta nomi nel mirino dei pm
Ci sono i servizi
segreti del Belgio dietro lo scandalo dei regali e del milione e mezzo di euro
partiti dal Qatar e dal Marocco, passati attraverso la ong Fight impunity di
Antonio Panzeri e finiti a personaggi che lavorano nel Parlamento europeo. A
dare il via all’inchiesta che ha fatto emergere il più grave caso di corruzione
nella storia della massima istituzione continentale, compromettendone
pesantemente l’immagine, è stata l’agenzia interna per la «Sicurezza dello
Stato» del Belgio che per mesi ha lavorato con i servizi segreti di altri 5
paesi, ma non con quelli dell’Italia che sarebbero stati esclusi dall’operazione
nonostante tutto sembri ruotare intorno a personaggi italiani.
Partito come un caso
di «sicurezza nazionale», il dossier si trasforma in una questione di corruzione
internazionale, altrettanto grave, ma certamente meno allarmante per gli 007
locali che lo passano alla magistratura ordinaria quando si rendono conto che la
minaccia è cessata o forse non è mai esistita. L’operazione Qatar, rivelano
fonti giornalistiche belghe non smentite dalle autorità, comincia nel 2021 come
indagine su un’interferenza da parte di un paese straniero sui processi
decisionali del Parlamento europeo, come quelli sulle posizioni da prendere nei
confronti di paesi accusati di non rispettare i diritti umani quali il Qatar,
molto attivo per raggiungere un’intesa con la Ue sull’aviazione (ora bloccata
dopo lo scandalo). E i pm di Milano che danno assistenza in Italia ai colleghi
greci per le propaggini italiane dell’indagine, parlano di europarlamentari
«libro paga» lasciando immaginare un orizzonte investigativo più esteso di
quello che al momento può essere osservato. Secondo la stampa greca, i pm
avrebbero nel mirino «oltre 60 eurodeputati», la maggior parte del gruppo dei
socialisti e Ppe, ma anche dei «nuovi partiti della destra».
Non si sa quale sia
la fonte della soffiata agli 007 belgi, se si tratti di una assistente
parlamentare che ha denunciato cosa aveva visto per vendicarsi di non essere
stata riconfermata nell’ incarico, come dice qualcuno, o se invece l’allerta sia
arrivato da un paese terzo, come ha scritto il giornale belga De Standaard. Sta
di fatto che le indagini segretissime si concentrano subito su Antonio Panzeri e
sulla Figth impunity. Il suo appartamento in un residence di Bruxelles viene
messo sotto controllo ed imbottito di microspie mentre lui viene pedinato e
intercettato. Sono i poteri speciali dati in Belgio ai servizi a consentire loro
di fare indagini così intrusive senza autorizzazione della magistratura, ma dopo
il via libera di una commissione che ne valuta opportunità e necessità.
Quando a luglio
scorso i servizi hanno avuto il quadro della situazione, l’indagine è stata
passata alla procura federale che ha aperto un fascicolo per i reati di
associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro commessi dal
primo gennaio 2021 all’8 dicembre scorso. Nelle mani dei magistrati ci sono i
contatti di Panzeri, a cominciare da quello stretto che lo lega a Francesco
Giorgi, compagno di Eva Kaili, la vice presidente del parlamento arrestata con i
due uomini. Dal Qatar alla coppia sarebbero arrivati gli oltre 750 mila euro di
cui sono stati trovati in possesso, così come i 600 scovati nel residence di
Panzeri. Le indagini dovranno stabilire in che modo, dato che dai numeri di
serie risulterebbe che la maggior parte delle banconote è stata emessa in Belgio
ed è passata da banche belghe, il che smentirebbe l’ipotesi di valigie arrivate
dall’estero. Gli investigatori hanno anche più di un’idea degli «intrallazzi» di
cui parlava Maria Dolores Colleoni, moglie di Panzeri, come del «trasporto dei
regali» in Marocco attraverso l’ambasciatore del paese nordafricano in Polonia.
Estratto
dell'articolo di G.F. per “la Repubblica” il 14 dicembre 2022.
Un milione e mezzo
di euro, in banconote da 200, 100, 50, 20 e persino una da cinque euro. Eccolo
il tesoro del Qatargate, sequestrato fino a questo momento dalla polizia belga a
casa dell'ex eurodeputato italiano del Partito democratico Pier Antonio Panzeri
e della vice presidente del Parlamento, la greca Eva Kaili. La fotografia
(pubblicata dal quotidiano belga Le Soir) racconta meglio di ogni cosa lo
spaccato di quello che è il più grande scandalo recente che ha travolto
l'Europarlamento.
Che rischia di
allargarsi ogni giorno. […]
Perché una foto come
quella che ieri il giudice istruttore di Bruxelles, Michel Claise, ha deciso di
divulgare per dare il segno e il senso a quello che sta accadendo, assomiglia a
quelle scattate dopo un blitz di narcotraffico. Sembra essere uscita da una
serie televisiva sui corrieri del Sud America e non dagli uffici di una delle
massime istituzioni del Parlamento europeo, quello della vicepresidente greca
Kaili appunto. […]
A leggere gli atti
dell'inchiesta, almeno a casa di Panzeri gli inquirenti sono andati quasi a
colpo sicuro. Dalle intercettazioni telefoniche, effettuate per più di sei mesi,
avevano intuito infatti che l'ex europarlamentare del Pd avesse a casa del
denaro contante. Soldi che non erano l'oggetto della corruzione ma che nel
meccanismo Panzeri avrebbe dovuto utilizzare per "oliare" i meccanismi del
Parlamento e portare a casa quello che il Qatar (e probabilmente anche il
Marocco) chiedeva: dichiarazioni rassicuranti, atti amministrativi amichevoli.
Gli investigatori
sono persuasi che questo sia effettivamente accaduto perché, dal conto che era
stato fatto in sede di indagine, erano convinti di trovare - almeno a casa di
Panzeri - più soldi di quelli che c'erano. Gli altri è possibile quindi che
siano stati consegnati in queste settimane. Non pensavano invece ci fossero a
casa di Kaili, tanto che l'arresto dell'europarlamentare è stato deciso soltanto
in un secondo momento, proprio per via della flagranza di reato.
Francesco Giorgi,
il compagno di Eva Kaili «è uno che crolla sotto stress»: il surfista
dell'Idroscalo nei racconti degli amici.
Andrea Galli su Il
Corriere della Sera il 15 dicembre 2022.
Il 35enne nato ad
Abbiategrasso, alle porte di Milano. Nel suo paese raccontano: sogna di
comprarsi una barca da emiro
Ma dunque, se lei
l’han ribattezzata «Eva Kant», lui chi sarebbe? Davvero (un) «Diabolik»?
Nell’omettere certi indicibili soprannomi correlati ad attitudini se non
ossessioni da gran corteggiatore instancabile, per Francesco Giorgi scegliamo la
seguente definizione d’un amico, che si dichiara sia affezionato, sia devastato:
«Il surfista dell’Idroscalo».
Le due ville
Una definizione che
poi racconta molto del 35enne arrestato insieme alla stessa compagna Eva Kaili:
ovvero uno sì consapevole delle origini da provinciale, nel suo caso
Abbiategrasso, cittadina a mezz’ora da Milano tra noiosi rettilinei e cascine
decadenti, ma col mondo nell’orizzonte, e appunto fruitore del macchinario che
genera onde nel lago artificiale simulando d’essere alle Hawaii. E comunque quel
suo interrogatorio esondante, reso al magistrato con gli abituali pianti e le
abituali crisi di panico dei comuni mortali, dimostra che non si tratta di un
criminale. O meglio, così ci viene ripetuto in via della Noce, dove, una di
fronte all’altra, sorgono due ville. Quella al numero pari, più grande, di mamma
Iole e papà Luciano, un’insegnante e un preside, nascosta da un’alta siepe; e
quella al numero dispari, a schiera, più piccola, e fino all’ottobre 2016, prima
di emigrare a Bruxelles in rue de la Tulipe, residenza di Francesco, laurea in
Scienze politiche e lunga esperienza da assistente parlamentare; più forte degli
avvicendamenti dei partiti, di destra o sinistra che siano, e dei politici per i
quali lavorare. Quasi che mantener l’equilibrio, mai cadere, insomma surfare,
sia l’atteggiamento esistenziale di uno che predica l’ottimismo e detesta quelli
che mugugnano e si arrendono. Bisogna aggiungere che, nel coro di voci, Giorgi
generava invidie diffuse: e la bellezza, e la brillantezza, e la naturale
capacità d’affascinare chiunque ovunque, e l’incredibile abilità a vendere pure
doti che non ha...
Nell’oratorio
Invidia oppure
accanimento, a questo punto conviene menzionare anche gli aneddoti relativi a un
«influente familiare», ugualmente nato nell’ospedale di Rho, che ne avrebbe
indirizzato la carriera presentandolo a quelli giusti. Ma di nuovo: invidia o
puro accanimento, se siamo di fronte a una persona dalla doppia vita, a uno
stratega del male, tutto quanto stride con l’infanzia e la giovinezza di Giorgi,
cresciuto educato e cortese, orgoglio assoluto di papà Luciano, di anni 66, a
capo dell’istituto comprensivo della vicina Cisliano, un dirigente noto per le
battaglie contro i docenti fannulloni e le sterili polemiche sindacali.
Francesco, tipo maniacale nella scelta e nel peso del cibo, nella lettura
mattutina della bilancia e dell’evoluzione dei muscoli, è diventato grande
all’oratorio, e dal padre, volontario sulle ambulanze e in parrocchia, ha
imparato — avrebbe — a pensare al prossimo. Ecco, il signor Luciano esce dalla
porta ma subito si blocca sul vialetto; chiede scusa, «mi hanno ordinato di
tacere e in ogni modo non avrei parlato». China la testa, abbozza un sorriso
doloroso, perfino straziante. Per le coordinate sue e della moglie, le accuse
contro il figlio, le manette, i paesani che scrutano e giudicano, son peggio di
un tradimento.
Il terrore dello
stress
Un residente col
cane, nel giardino con la lapide in ricordo dei deportati e dei caduti di
Abbiategrasso, dice che i genitori è come se li avessero ammazzati, pur essendo
due che, alle prese ogni giorno per mestiere con i ragazzini e i percorsi di
crescita, sanno bene che ogni mente è imprevedibile. Non che, attenzione, negli
anni Francesco non abbia fatto impensierire: egli considera l’avventura un moto
dell’animo, da skipper ha compiuto navigazioni pure in tempesta, adora la
velocità folle, da adolescente combinava azzardi notturni ai limiti del
ricovero — ma sempre si fermava all’ultimo millimetro utile mentre gli amici
intorno crollavano — e, in quella sua, diciamo, attività da gran corteggiatore,
spesso scommetteva che con quella ragazza sarebbe riuscito e si dannava finché
non riusciva...
E il rapporto con i
soldi? Gli hanno beccato sacchi di banconote, anche nella villa. Ora, non
emergono aneddoti di avidità, anzi trattasi di uno che presta il denaro senza
storie, e però si vocifera dell’imminente acquisto di una barca da emiro per
regalarsi maestose traversate con Eva e la figlioletta. Eva. «Scattava a ogni
sua disposizione!»; «Quando mai, è lui che l’ha plagiata!». Chissà chi sia o non
sia, questo Giorgi. Di sicuro ha un famoso limite, svelato dai suoi più intimi:
«Soffre maledettamente le situazioni di stress»; quando ci capita dentro compie
ogni mossa per scappare, scavalcando se necessario chi ha davanti, pure se a
terra e invocante aiuto.
La caduta di
Kaili.
Domenico Pecile su L’Identità il 14 Dicembre 2022.
Il terremoto
abbattutosi sul Parlamento Ue ha già lasciato le prime macerie. Eva Kaili,
numero due dell’Eurocamera, travolta e arrestata nell’ambito dell’inchiesta sul
Qatargate, è stata destituita dall’incarico. La richiesta, avanzata dalla
Conferenza dei presidenti, è stata votata all’unanimità. L’aula l’ha infatti
destituita con un voto a larghissima maggioranza: su 628 voti, 625 sono stati
favorevoli e un solo contrario, il croato Mislav Kolakusic, e due astenuti. La
politica greca è stata anche sospesa dal Pasok. È sospettata di corruzione
operata dal Qatar al fine di influenzare le decisioni del Parlamento Europeo.
Fino ad ora sono stati ritrovati 1,5 milioni in contanti. Eppure, nonostante il
ritrovamento del denaro nascosto anche dentro bustoni di plastica e nonostante
le sue benevoli dichiarazioni in tema di diritti in Qatar, Kaili si dichiara
innocente aggiungendo che non ha nulla a che fare con le tangenti del Qatar. Le
parole sono state riportate dal suo avvocato, Kaili Michailis Dimitrakopoulos.
A casa della donna e
di Antonio Panzeri, ex eurodeputato di S&D, sono stati ritrovati oltre 1,5
milioni di euro in banconote. Sono state diffuse dalla polizia belga le foto di
pile di biglietti sequestrati da 20, 50, 100 e 200 euro. Nei 1,5 milioni è
compresa anche la somma sequestrata al padre della Kaili e nascosta nella
valigia. L’uomo era stato fermato mentre stava lasciando un albergo di
Bruxelles. Ieri, nell’abitazione del convivente della Kaili, Francesco Giorgi,
pure arrestato, sono stati sequestrati 20 mila euro. L’uomo ha parlato per ore
con gli inquirenti, avvalorando, pare, le tesi dell’inchiesta.
Inchiesta che
giocoforza procede a ritmo serrato ed inevitabilmente è destinata ad allargarsi,
mentre nell’europarlamento diviso si registra una ridda di dichiarazioni a metà
tra la dura condanna e lo stupore. Sempre ieri, la procura belga ha deciso di
mettere i sigilli agli uffici a Strasburgo dell’assistente dell’europarlamentare
Pietro Bartolo, eletto con il Pd e pure lui iscritto al gruppo S&D. Bartolo si
era dimesso dal ruolo di relatore sul testo di liberalizzazione dei visti al
Qatar. E nel frattempo si è autosospeso un altro eletto con i Dem. Si tratta di
Andrea Cozzolino, che pure ha rinunciato alla attività di coordinatore delle
emergenze. Ma le indagini hanno coinvolto anche l’italo-belga Maria Arena, che
ha lasciato la presidenza della Commissione per i Diritti umani e Marc Tarabella
la cui abitazione era già stata perquisita sabati scorso. La posizione più
delicata per quanto concerne gli italiani riguarda sicuramente Panzeri. Fonti
della Reuters tra le accuse mosse all’eurodeputato sospeso da Articolo1 ci
potrebbe essere anche quella di avere incassato denaro dal Marocco. In questo
caso la sua posizione è destinata ad aggravarsi ulteriormente. Intanto, si è
saputo che la ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo si troverebbe nel
carcere di Haren, alla periferia Nord orientale di Bruxelles. Gli inquirenti,
invece, non hanno voluto confermare se anche Panzeri, Giorgi e Niccolò Figà
Talamacca (segretario di No Pace Without Justice), si trovino nella stessa
prigione che ospita, tra gli atri, anche Salh Abdeslam, unico sopravvissuto tra
il gruppo dei terroristi dell’attentato al Bataclan.
E tra ipotesi di
altri arresti, la politica europea si interroga. Tra i socialisti europei
prevale la linea dei falchi e dell’intransigenza. A guidarla è il presidente
della commissione per le ingerenze nei processi democratici dell’Eurocamera, il
francese Glucksmann. Ieri ha sottolineato la necessità di istituire una
commissione d’inchiesta sullo scandalo e la sospensione immediata di chi è
coinvolto. L’obiettivo indicato è perentorio: “Ripulire la famiglia socialista”.
Ma le rassicurazioni, le scuse e i propositi di Glucksamm non hanno sopito le
polemiche degli avversari politici che hanno duramente stigmatizzato in aula le
parole di Roberta Metsola secondo cui quanto è stato scoperto dagli inquirenti
non è né di sinistra né di destra. E nella ridda di dichiarazioni spicca anche
quella del premier ungherese, Viktor Orban, che ha contrattaccato con ironia
accusando l’Ue di preoccuparsi della corruzione nel suo Paese. Polemiche e
veleni sono destinati a incendiarsi nei prossimi giorni come dimostrano anche le
parole del primo portavoce della Commissione, Eric Mamer. Il quale, proprio
ieri, rispondendo a una domanda su tweet del vicepresidente Schinas che elogiava
i progressi del Qatar, nel corso della conferenza stampa del resoconto del
Collegio dei commissari, ha riferito che “abbiamo fatto questa dichiarazione
sulle riforme intraprese nell’area dei diritti del lavoro. Ben prima che il
vicepresidente Schinas andasse in Qatar, e questo è di pubblico dominio. Quindi
non c’è assolutamente alcuna discrepanza tra ciò che il vicepresidente ha
twittato in quel momento è ciò che la Commissione ha sempre detto”.
Eurocorruzione.
Così i servizi segreti belgi hanno svelato il sistema di tangenti da Qatar e
Marocco.
Linkiesta il 15 Dicembre 2022
Dopo oltre un anno
di indagini e sei Paesi coinvolti, gli inquirenti seguono le tracce dei soldi
per unire i punti della rete che potrebbe coinvolgere oltre 60 eurodeputati,
soprattutto appartenenti alle famiglie politiche dei Socialisti & Democratici,
del Partito popolare europeo e di altri partiti di sinistra
A svelare la
Tangentopoli del Parlamento europeo è stata un’operazione di spionaggio
internazionale durata un anno, con il coinvolgimento di almeno sei Paesi per
sventare la pesante infiltrazione del Qatar nelle istituzioni di Bruxelles. Gli
apparati di intelligence hanno raccolto e condiviso informazioni sulla base di
una sospetta minaccia alla sicurezza degli Stati con «interferenze nei processi
decisionali» garantite dalla corruzione di deputati e funzionari del Parlamento
europeo. Solo successivamente il Servizio informazioni e sicurezza belga le ha
declassificate, mettendole a disposizione della Procura federale per l’avvio di
una «indagine su larga scala». Un’indagine che, secondo alcuni media greci – tra
cui Mega Tv – coinvolgerebbe una sessantina di europarlamentari, per la maggior
parte appartenenti alle famiglie politiche dei Socialisti & Democratici, del
Partito popolare europeo e di altri partiti di sinistra.
Il “Qatargate”,
insomma, sta diventando una Spy Story – scrive Repubblica. Con un protagonista
principale: il Dged, il servizio segreto marocchino. E una serie di
coprotagonisti: l’Intelligence del Belgio, con la collaborazione di Paesi
alleati dell’Unione europea, e il governo del Qatar. Marocco e Doha nelle parti
dei grandi corruttori dentro le istituzioni dell’Ue, in particolare il
Parlamento.
Tutto nasce cinque
mesi fa. Gli 007 belgi, assistiti da altri servizi europei, vengono a conoscenza
che c’è una rete che lavora «per conto» del Marocco e del Qatar. Lo sfondo è il
ruolo di Rabat nel Sahara Occidentale e i flussi migratori. Il Marocco vuole che
l’Ue non si metta di traverso sull’occupazione di quel pezzo d’Africa e punta ad
avere meno problemi possibili dal punto di vista dei flussi dei migranti.
Il gruppo socialista
di S&D sarebbe quello maggiormente coinvolto. Attraverso una sorta di cricca
composta da tre italiani: Panzeri, Cozzolino (europarlamentare) e Giorgi
(compagno di Kaili). Anche se alcuni media della Grecia, addirittura ipotizzano
che dentro il Parlamento europeo potrebbero essere una sessantina i nomi
coinvolti.
Il più attivo nel
cercare l’influenza è comunque lo Stato del Marocco. Incontri, colloqui, cene
con i più alti dirigenti dei servizi segreti di Rabat sono una costante di
questo sistema. Il gruppo è stato agganciato prima da un ufficiale del Dged di
stanza a Rabat. Si tratta di Belharace Mohammed, il quale ha potuto contare
sulla intermediazione anche di un diplomatico di base a Varsavia: Abderrahim
Atmoun. Tutte informazioni in un primo momento raccolte dai servizi segreti del
Belgio.
Il ruolo del
diplomatico di Rabat che si muove lungo l’asse Varsavia-Bruxelles è centrale. Ma
c’è un anello che è ancora più importante in questa catena: Mansour Yassine,
direttore generale del Dged. I tre lo hanno incontrato. Cozzolino lo ha fatto ad
esempio diverse volte e almeno in una sarebbe andato in Marocco, nel 2019.
Secondo la ricostruzione dei pm belgi, infatti, un ufficiale dell’intelligence
marocchina ha prenotato due biglietti aerei sul volo Alitalia Casablanca-Roma
del 2 novembre 2019 e sulla successiva tratta Roma-Napoli. Gli 007 del Belgio
non sanno con certezza se Cozzolino sia effettivamente salito sull’aereo. Anche
Panzeri è volato verso lo Stato magrebino per incontrare ancora lo stesso
Mansour nel luglio del 2021.
La motivazione che
viene assegnata a questo colloquio è discutere la «strategia» del Parlamento
europeo. Anche in questo caso gli 007 si prendono una prudenza: non confermano
che il colloquio sia effettivamente avvenuto. Ma che sia stato organizzato sì.
Della rete avrebbe fatto parte anche Figà Talamanca, il vertice della Ong “No
Peace without justice”.
L’ufficio di Atmoun
a Varsavia, dunque, era una specie di crocevia. Lì si sono alternati in visita
Panzeri, Cozzolino e anche Giuseppe Meroni, un tempo assistente dell’ex
eurodeputato e ora a disposizione della neo eletta di Forza Italia, Lara Comi.
All’interno di questo quadro, Francesco Giorgi veniva identificato come una
sorta di «agente» di Panzeri. Almeno i Servizi marocchini lo utilizzavano in
quel modo. Ma sarebbero stati Cozzolino e Panzeri a gestire l’accordo per
consentire «l’ingerenza del Marocco».
Il sistema del Qatar
non cambiava molto. Le regole, alla fine, erano le stesse. E gli obiettivi
analoghi. In questo caso gli obiettivi sono quelli di rendere accettabili le
procedure adottate da Doha sui lavoratori. In particolare quelli impegnati nella
costruzione delle strutture dei mondiali di calcio. Le autorità qatarine
sarebbero state persino più dirette di quelle marocchine. Non avrebbero usato
direttamente le spie, ricorrendo direttamente al governo. Gli incontri, infatti,
sono fatti con il ministro del lavoro, Bin Samikh al Marri. E il tutto sarebbe
avvenuto – secondo il mandato di cattura – con l’aiuto di un personaggio
misterioso chiamato Bettahar e soprannominato «l’Algerino».
Gli inquirenti non
hanno dubbi: Panzeri e Giorgi dividevano tutto al 50 per cento. E il resto era
per Figà Talamanca. Il gruppo riceveva pagamenti per le sue attività in due modi
quando venivano Doha: attraverso i conti della Ong “Fight Impunity”, in contanti
o con qualche regalo. Quando il finanziatore era Rabat, allora non si andava per
il sottile: la moneta in contanti veniva trasferita in alcune buste o borsoni
attraverso la intermediazione del diplomatico di stanza in Polonia Atmoun.
Secondo la
magistratura belga, quegli importi venivano impiegati per pagare tutte le spese
che denotavano «un tenore di vita che eccedeva le sue possibilità». E poi per
pagare i «membri della rete» che dentro le istituzioni europee venivano
manipolati come delle vere e proprie teste di legno.
Nella villetta dei
genitori di Francesco Giorgi ad Abbiategrasso i finanzieri hanno trovato la
chiave di una cassetta di sicurezza. In banca hanno trovato altri 20mila euro in
contanti. Sarà difficile rintracciarne la provenienza. Ma per i contanti
sequestrati a Bruxelles la polizia ha trovato una traccia: la fascetta che li
avvolgeva consente di risalire ai conti correnti da cui sono stati prelevati. E
questo potrebbe costituire la svolta dell’inchiesta.
Eva Kaili intanto
continua a dirsi innocente, affermando di non sapere nulla di soldi e accordi di
corruzione e addossando la responsabilità al compagno. Il quale, scrive
Repubblica, avrebbe confermato agli inquirenti di aver lasciato all’oscuro la
donna dell’operazione. «Farò il possibile affinché la mia compagna sia libera e
possa occuparsi di nostra figlia di 22 mesi», avrebbe detto agli inquirenti.
Eurocorruzione.
Le dichiarazioni di Francesco Giorgi svelano il sistema del Qatargate.
Linkiesta
il 15 Dicembre 2022
Il compagno della
vicepresidente Kaili sta collaborando con gli inquirenti belgi. Oggi si tiene
l’udienza preliminare in tribunale. Le organizzazioni non governative «ci
servono per far girare i soldi», si legge nelle carte. I contanti sequestrati
finora ammontano a 1,5 milioni di euro
Francesco Giorgi,
uno dei cinque arrestati nell’inchiesta sulla presunta corruzione per
ammorbidire la posizione del Parlamento europeo sulle violazioni di diritti
umani in Qatar, sta collaborando con gli inquirenti belgi. L’assistente
parlamentare dell’eurodeputato del Partito democratico Antonio Cozzolino (non
indagato) ha risposto per ore alle domande, fornendo elementi sulla rete che
ruotava attorno all’ex deputato Antonio Panzeri (Pd, poi Articolo 1) di cui è
stato assistente fino al 2019, e alla deputata socialista greca Eva Kaili, sua
compagna di vita.
Le sue rivelazioni
hanno consentito alla polizia belga di estendere le indagini a un altro deputato
socialista, il belga Marc Tarabella. «Non ho assolutamente nulla da nascondere»,
replica Tarabella. Su di lui – scrive La Stampa – ci sarebbe anche il riscontro
di un altro testimone. «Temo che saranno coinvolti altri deputati», dice Hannah
Neumann, eurodeputata dei Verdi tedeschi nonché presidente della Darp, la
Delegazione del Parlamento per i rapporti con la Penisola Arabica, il cui
vicepresidente era proprio Tarabella.
Mentre Giorgi
parlava a Bruxelles, la Guardia di Finanza è tornata nella sua casa ad
Abbiategrasso, trovando altri 20mila euro in contanti, che si aggiungono al
milione e mezzo già sequestrato tra Bruxelles e l’Italia. Il denaro è stato
esibito dalla polizia belga in una fotografia destinata a fare storia, diviso in
mazzette con pezzature variabile, prevalentemente in banconote da 50 euro.
In tutto a Giorgi e
Kaili sono stati sequestrati quasi un milione di euro in contanti. Sommati ai
600mila ritrovati a Panzeri, fanno arrivare a un milione e mezzo di euro il
totale della corruzione dal Qatar.
Nelle carte
dell’interrogatorio di Giorgi, ci sono ammissioni deflagranti. Secondo le accuse
di Michel Claise il gruppo formato da lui, Panzeri, Niccolò Figà-Talamanca e
Luca Visentini (che si dice però estraneo all’indagine) si muoveva intorno alla
Ong “Fight Impunity”, che aveva l’obiettivo di favorire due paesi: Qatar e
Marocco. Le organizzazioni non governative «ci servono per far girare i soldi»,
è la frase di Giorgi contenuta nelle carte dell’indagine riportata
da Repubblica.
Il gruppo, per come
è raccontato negli atti, sarebbe attivo almeno dal gennaio del 2021. I reati
contestati sono appunto quello dell’associazione, la corruzione e il
riciclaggio. Il rapporto principale era con il Qatar. Nei documenti si fa
riferimento, per esempio, al ministro del Lavoro Ali Bin Samikh Al Marri che
Kaili ha incontrato il primo novembre in Qatar.
Kaili, Giorgi,
Panzeri e Niccolò Figà-Talamanca comunque si presenteranno oggi in tarda
mattinata in tribunale per l’udienza preliminare. A parlare in via ufficiale con
la stampa, finora, è stato solo il legale di Kaili. «La sua posizione è di
innocenza. Non ha nulla a che fare con le tangenti del Qatar», ha detto
l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos. Ma sulla provenienza dei soldi in contanti
non si sbilancia. Kaili aveva pronunciato un discorso pro Qatar il 21 novembre,
salutandone i progressi nel campo dei diritti dei lavoratori. Dieci giorni dopo,
all’insaputa dei collegi del gruppo socialista, si era presentata nella
commissione libertà civili, di cui non fa parte, chiamata a votare la
liberalizzazione dei visti dal Qatar. Benché non necessario, non aveva fatto
mancare il suo voto favorevole. Con lei c’era anche Giorgi, che aveva
festeggiato l’approvazione con un vistoso “cinque” a un altro funzionario.
Si rafforza intanto
il ruolo degli assistenti parlamentari. Molto più che portaborse, sono segretari
politici dei deputati, di cui gestiscono fino all’80% del lavoro. Giorgi aveva
lavorato come assistente di Panzeri e, dopo la sua mancata rielezione, era
transitato con Andrea Cozzolino, Pd. Altri due assistenti italiani sono stati
perquisiti: Giuseppe Meroni, che in passato lavorava con Panzeri, e Davide
Zoggia, collaboratore di Pietro Bartolo, il medico lampedusano estraneo
all’indagine.
Certo il pressing
del Qatar sui deputati europei è stato insistente. «Anch’io fui avvicinato da
funzionari dell’ambasciata del Qatar», dice tra gli altri Dino Giarrusso,
eurodeputato ex Movimento 5 Stelle. «Mi colpirono i modi melliflui e ambigui, le
allusioni ad associazioni Amici del Qatar e a viaggi da organizzare prima e
durante i Mondiali. Mi puzzava e rifiutai». Ancora giovedì scorso, poche ore
prima degli arresti, molti deputati tra cui diversi del Pd erano ospiti
dell’ambasciata del Qatar a Bruxelles, per un ricevimento.
All’inizio della
prossima settimana davanti alla Corte di appello di Brescia compariranno Maria
Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell’ex eurodeputato. Per evitare
l’estradizione in Belgio dovranno spiegare la provenienza dei 17mila euro in
contanti sequestrati nella loro casa.
Il Qatar ha negato
responsabilità in casi di corruzione in una scarna nota diffusa negli Stati
Uniti. Televisioni e giornali nel Paese che sta ospitando i Mondiali ci calcio
non hanno detto una parola sull’indagine.
Nel Qatargate
naufraga la favola buonista delle Ong.
Federico Novella su
Panorama il 14 Dicembre 2022.
Le frasi di
Francesco Giorgi su «Fight Impunity» e «No Peace Without Justice» dicono molto
di un mondo dove, dietro uno strato di buone intenzioni si celano troppe cose
misteriose
La frase che
potrebbe scoperchiare il vaso di Pandora è tutta qui: “Quelle Ong ci servono per
far girare i soldi”. Le parole di Francesco Giorgi, fidanzato della
vicepresidente del parlamento europeo Eva Kaili e assistente storico di Antonio
Panzeri, ben raccontano ciò che rischia di saltar fuori da questa Qataropoli. La
chiamiamo così, all’italiana, anziché “Qatar-Gate” , perché italiani sembrano,
stando alle accuse, gli uomini chiave attorno ai quali ruota l’inchiesta. Tutti
accomunati da un particolare: l’appartenenza alla sinistra globalista, quella
che lotta per i diritti dei più deboli, e che vive di lezioni morali impartite
all’avversario.
Fatte le dovute
premesse (aspettiamo gli sviluppi delle indagini, accertiamo le responsabilità),
il dato storico-politico è che mentre ai tempi di Tangentopoli si rubava per sé
o per il partito, stavolta, a dar retta agli inquirenti belgi, si ruba
spacciandosi per buoni. Si accumulano sacchi di soldi dietro il paravento dei
buoni sentimenti nei confronti dei più sfortunati. Alla faccia della tanto
sbandierata superiorità morale. E tutto ciò attraverso il cavallo di Troia delle
tanto celebrate Ong, organizzazioni non governative e a quanto pare nemmeno
tanto “gentili” come qualcuno vorrebbe far sembrare. Sempre border line tra
legalità e illegalità, tra propositi di interesse pubblico e cascami di
interesse privatissimo. E’ una (nuova?) forma di corruzione, quella nel nome
della pace e dell’amore, corruzione vera o presunta, che cela tuttavia una
tendenza odiosa. Fare business sulla bontà. Dal caso Soumahoro alla losca
vicenda di Mimmo Lucano, fino alla bufera Panzeri che rischia di portarsi dietro
le macerie delle istituzioni comunitarie, comincia ad essere lunga la lista
degli oscuri accadimenti all’ombra della beneficienza. Cooperative,
associazionismi, galassie oscure che dietro il paravento del bene, nascondono
ipocrisie e malfunzionamenti, nel migliore dei casi, e vere e proprie truffe,
nei casi peggiori. A ulteriore dimostrazione che sono tempi magri, nei quali
occorre guardarsi dalla bontà ostentata, o sventolata politicamente. La vera
bontà, i veri buoni sentimenti, di solito restano discreti e nascosti: quando
risalgono in superficie per essere messi su un piedistallo, quello è il momento
in cui farsi prendere dai sospetti. Gli stessi sospetti che in queste ore, a
Bruxelles, lasciano immaginare l’impensabile.
"Un'ideologia
infame. Ong e sinistra...". La sentenza di Rampini sul Qatargate.
Il giornalista
denuncia l'ipocrisia anti-occidentale che accomuna "sedicenti progressisti" e
"un certo mondo di Ong". Questa ideologia, ha attaccato, "consente tutto, anche
di prendere le mazzette". Marco Leardi il 15 Dicembre 2022 su Il Giornale.
"Questa ideologia
consente tutto, anche di prendere le mazzette". Federico Rampini è entrato a
gamba tesa sul Qatargate e sul retropensiero orientato a sinistra che a suo
avviso farebbe da sfondo alla vicenda. Invitato a esprimersi sull'inchiesta che
ha travolto e imbarazzato le istituzioni europee, su La7 il giornalista ha
puntato il dito contro l'anti-occidentalismo di certi "sedicenti progressiti",
pronti ad autoflagellarsi e a osservare invece senza altrettanta severità il sud
del pianeta.
Qatargate, la
lezione di Rampini
Nel suo ragionamento
Rampini è partito commentando le vicende di Eva Kaili, l'ex vicepresidente del
Parlamento Europeo accusata di aver ricevuto denaro dal Qatar per difendere gli
interessi dell'emirato. "Non è stata cacciata dal suo partito di sinistra quando
disse delle cose infamanti, ignobili, molto prima che le scoprissero i soldi in
casa. Disse che il Qatar è un modello per i diritti umani, cosa vergognosa visto
che prima dei Mondiali sono morti tanti migranti nei cantieri. Quello era già un
buon motivo per cacciarla...", ha affermato il giornalista genovese, biasimando
con forza un'altra e successiva dichiarazione dell'ex socialdemocratica: quella
in cui la donna aggiunse "che noi europei non abbiamo nessun diritto di dare
lezioni agli altri".
"Ideologia
infame..."
Proprio riflettendo
su quella affermazione, Rampini ha esteso il proprio discorso, inchiodato una
parte della sinistra. "Siamo nel bel mezzo di un'ideologia infame che accomuna
certi sedicenti, e sottolineo sedicenti progressisti e un certo mondo di Ong,
per cui noi occidentali siamo colpevoli di tutto, gli altri hanno sempre
ragione, noi siamo l'impero del male, gli altri sono buoni, vittime innocenti",
ha osservato il giornalista, severo con quanti non perdono l'occasione per
attribuire all'Occidente una sorta di peccato originale di natura ideologica.
"Nell'emisfero sud,
del quale simbolicamente fa parte anche il Qatar, sono tutti migliori di noi. E
allora per carità, uno incassa anche le mazzette da quelli lì, perché loro sono
buoni anche se possiedono mezza Milano, il Paris Saint Germain... Però loro sono
il sud del pianeta mentre noi siamo la razza bianca cattiva. Questa ideologia
consente tutto, anche di prendere le mazzette", ha continuato Rampini, ospite
di Coffee Break su La7. Chissà che a qualcuno, anche in Italia, non siano
fischiate le orecchie.
Corruzione al
parlamento europeo, oltre il Qatar ci sono i servizi segreti del Marocco.
YOUSSEF
HASSAN HOLGADO su Il Domani il 15 dicembre 2022
Nella rete dei
funzionari del Marocco implicati nel caso ci sono un diplomatico attivo in
Polonia (Abderrahim Atmoun) e l’ufficiale dei servizi Belharace
Mohammed. L’obiettivo dello stato nord africano è quello di impedire che le
istituzioni europee interferiscano nella questione del Sahara occidentale.
Gli italiani
coinvolti nello scandalo corruzione del Qatar guardavano anche al Marocco.
Inizialmente era soltanto un’ipotesi quella che il caso si allargasse anche ad
altri stati, ma ora, secondo quanto riporta Repubblica, nel mandato di cattura
c’è la certezza.
L’ex
europarlamentare Antonio Panzeri, l’attuale europarlamentare Cozzolino (al
momento non indagato) e Francesco Giorgi, assistente della vicepresidente del
parlamento europeo Eva Kaili, sono stati avvicinati in prima persona dai servizi
segreti marocchini. Cozzolino aveva anche un ruolo politico chiave, era il
presidente della delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e delle
commissioni parlamentari miste Ue-Marocco.
Nella rete dei
funzionari del Marocco implicati nel caso ci sono un diplomatico attivo in
Polonia (Abderrahim Atmoun) e l’ufficiale dei servizi Belharace
Mohammed. L’obiettivo dello stato nord africano è quello di impedire che le
istituzioni europee interferiscano nella questione del Sahara occidentale. Nelle
carte del mandato di cattura si legge che è «fuori di dubbio» che i tre italiani
collaborano con i servizi marocchini.
Gli italiani
avrebbero anche avuto diversi incontri in Europa con Mansour Yassine, direttore
generale del Dged (servizi segreti del Marocco), mentre altri sono stati
organizzati direttamente nel paese magrebino. In questo caso gli inquirenti
belgi non hanno la certezza che alla fine gli italiani si siano recati in
Marocco.
Secondo Repubblica,
la rete quindi si muoveva tra Rabat, Varsavia e Bruxelles con Giorgi che era una
sorta di “agente”, mentre Panzeri si occupava di gestire l’accordo
sulle ingerenze del Marocco all’interno dell’Europarlamento. Nella rete c’è
anche Niccolo Figà Talamanca della Ong No peace without justice.
I RAPPORTI CON IL
MINISTRO QATARINO
Se le relazioni con
il Marocco venivano mediate e filtrate dai servizi segreti marocchini, con il
Qatar, invece, i rapporti erano gestiti dal ministro del lavoro in persona Bin
Samikh al Marri con l’aiuto di un uomo soprannominato «l’Algerino».
Gli obiettivi del
Qatar erano legati a ripulire l’immagine del paese in Europa soprattutto
riguardo i diritti umani e civili. Secondo gli inquirenti belgi i compensi
venivano divisi tra Panzeri e Giorgi in maniera eguale, il resto veniva
consegnato a Niccolo Figà Talamanca. Soldi che venivano ricevuti in contanti o
attraverso le due Ong coinvolte nel caso quella di Panzeri, Fight impunity, e
quella di Figà Talamanca No peace without justice.
Ulteriori novità
emergeranno alla fine degli interrogatori, per il momento Francesco Giorgi sta
raccontando il funzionamento del sistema agli inquirenti e già si ipotizza che
siano coinvolti molti europarlamentari: circa sessanta. YOUSSEF HASSAN HOLGADO
Qatargate.
Tangenti Ue-Qatar. Panzeri in carcere almeno un mese. Adesso nel mirino ci
sono sessanta europarlamentari.
Luca Fazzo il 15
Dicembre 2022 su Il Giornale.
Nei film di una
volta i malavitosi volevano il malloppo in banconote usate e con i numeri di
serie non consecutivi
Nei film di una
volta i malavitosi volevano il malloppo in banconote usate e con i numeri di
serie non consecutivi. Nella storia vera che ha per protagonista Antonio
Panzeri, ex eurodeputato, i quattrini sono ancora impacchettati, fascettati come
se fossero appena usciti dalla stamperia. Gli uomini dei servizi segreti che
sono penetrati di nascosto nella casa di Panzeri a Bruxelles se li sono trovati
davanti. E buona parte dei soldi portava una Z nel piccolo codice che indica il
paese di stampa. Z è la lettera del Belgio. Significa che il malloppo veniva
direttamente da una banca belga. E risalire alla provenienza dei 600mila euro
rischia ora di risultare fin troppo facile.
Sono errori come
questi che ora pesano come pietre sul destino di Panzeri e degli altri arrestati
del Qatargate. Due di loro, Panzeri compreso, sono destinati ad un amaro Natale
dietro le sbarre. Ieri l'udienza preliminare davanti alla Court de Justice di
Bruxelles finisce per l'ex sindacalista nel peggiore dei modi. Panzeri e soci
puntavano alla liberazione, o almeno agli arresti domiciliari. Niente da fare,
carcere confermato per Panzeri e per il suo ex assistente Francesco Giorgi. Esce
invece, ma ai domiciliari e con braccialetto elettronico, Niccolò Figà
Talamanca, segretario della Ong No peace without justice, che secondo i suoi
legali era finito dentro per un equivoco destinato a essere chiarito
nell'udienza di ieri. A quanto pare, c'è riuscito solo in parte.
In carcere per ora
resta anche la socialista greca Eva Kaili, la più alta in grado degli arrestati:
lei e Giorgi hanno insieme una figlia piccola, la donna spera di venire liberata
per poterla assistere ma ieri uno sciopero impedisce il trasferimento della
Kaili dal carcere di Haren a Bruxelles, l'udienza slitta e la decisione viene
rinviata a giovedì prossimo.
Sul tavolo dei
giudici chiamati ieri a valutare la posizione dei quattro c'era un materiale di
prove e di riscontri molto più nutrito di quanto trapelato finora. Le banconote
trovate a casa di Panzeri e della Kaili (sulle quali sarebbero in corso anche la
ricerca delle impronte digitali) sono la «pistola fumante», la prova provata
della operazione di corruzione attuata nel cuore della democrazia europea. Ma
nel dossier raccolto dal giudice Michel Claise c'è molto di più, c'è la
ricostruzione dettagliata della rete di rapporti che aveva consentito a Panzeri
di garantire un trattamento indulgente da parte di numerosi parlamentari verso
il regime del Qatar e verso l'organizzazione dei Mondiali di calcio. Secondo la
stampa greca si parla di ben sessanta eurodeputati nel mirino. É una rete in
buona parte interna al gruppo parlamentare dei Socialisti & Democratici, che ora
- dopo che i nomi di almeno quattro dei suoi componenti sono finiti nelle carte
dell'inchiesta - sembra attonito e incapace di reagire. Se scaricare Panzeri,
ormai privo di ruoli formali nel Parlamento, è stato facile, spiegare come
nessuno si sia accorto in questi mesi del mutato atteggiamento di parte del
gruppo S&D verso il Qatar rischia di essere imbarazzante.
I sigilli apposti
dall'Ocrc - la polizia anticorruzione - a una ventina di uffici di parlamentari
della sinistra sono il segno più vistoso della vastità della rete di Panzeri. Il
tessuto connettivo sono indubbiamente gli assistenti parlamentari, pagati
direttamente dalla Ue usando il budget di 21mila euro mensili di ogni deputato,
ma che rispondono direttamente a quest'ultimo. E anzi ne sono spesso la guida
nel mondo complicato delle istituzioni comunitarie. Ma è inverosimile che questa
vicenda possa chiudersi scaricando le colpe solo sugli assistenti. Anzi, secondo
fonti locali è possibile l'opposto: che l'inchiesta compia un salto di qualità,
e dopo avere scavato sulle offerte della lobby pro-Qatar ai parlamentari vada a
analizzare eventuali contatti nel cuore vero del potere europeo, la Commissione,
il governo dell'Unione.
Panzeri e Giorgi
hanno tempo fino ad oggi per presentare ricorso contro il provvedimento che li
tiene in carcere, e a quel punto a decidere sarà la Corte d'appello entro
quindici giorni. Nel frattempo l'inchiesta va avanti: decine di computer e
telefoni sequestrati nel corso delle perquisizioni vengono frugati in queste ore
dagli inquirenti, e può saltare fuori di tutto.
Qatargate. Spunta
anche la pista iraniana: il nuovo filone del Qatargate.
Qatar e Iran hanno
molti interessi in comune e questo potrebbe aver spinto alcuni emissari di
Teheran a operare in Europa anche per conto di Doha. A dimostrarlo i rapporti
tra un analista di origini iraniane. Mauro Indelicato il 15 Dicembre 2022 su Il
Giornale.
Fino ad
oggi l'inchiesta belga sul presunto giro di corruzione all'interno del
parlamento europeo, definito ad oggi come “Qatargate”, ha fatto prima luce sui
possibili tentativi di Qatar e Marocco di influenzare la politica europea. C'è
però un filone che porta anche all'Iran. E del resto, quello di Doha all'interno
della regione del Golfo è l'unico governo che ha importanti rapporti con
Teheran. Di riflesso quindi, le istanze qatariote potrebbero in alcuni casi aver
coinciso anche con interessi iraniani.
L'analista politico
lettone vicino a Teheran
Così come
sottolineato dal Corriere della Sera, al momento dell'approvazione del via
libera per i visti ai cittadini del Qatar, in una seduta della sottocommissione
per i diritti umani del parlamento europeo c'erano due persone ad applaudire. Da
un lato Francesco Giorgi, dall'altro Eldar Mamedov.
Il nome del primo
oramai è ben conosciuto. Si tratta di uno dei principali indiziati
dell'inchiesta ed è il compagno di Eva Kaili, oramai ex vicepresidente del
parlamento europeo e anche lei sospettata di aver preso mazzette dal Qatar.
L'altro invece è un analista politico con cittadinanza lettone ma di origini
iraniane.
625 voti a favore:
l'Europarlamento destituisce Eva Kaili
Tra i due, dopo
l'approvazione della norma nella sottocommissione, è scattato anche un cenno di
intesa con le mani. Segno quindi di come si conoscevano già da prima di quella
seduta ed erano già in buoni rapporti.
La libera
circolazione dei cittadini qatarioti in Europa è senza dubbio uno degli atti più
favorevoli a Doha degli ultimi anni. Il fatto che, tra il pubblico, Giorgi e
Mamedov erano tra le persone più soddisfatte potrebbe indicare rapporti stretti
tra i due anche sotto la sfera politica.
Mamedov, il cui nome
non risulterebbe al momento nel registro gli indagati ma a cui sarebbe stato
perquisito il proprio ufficio nelle scorse ore a Bruxelles, è da sempre
descritto come un lobbista pro Teheran. Chi lo conosce, all'interno delle sedi
istituzionali europee, ne parla sempre come di un personaggio pronto a
intervenire quando le posizioni di Qatar e Iran venivano attaccate a livello
politico. E dopo i suoi interventi, in effetti alcune dichiarazioni venivano
“ammorbidite”.
A Brxuelles
l'analista di origini iraniane ufficialmente ricopre l'incarico di consigliere
politico per gli Affari Esteri per il gruppo Socialisti e Democratici. Lo stesso
a cui apparteneva, prima della sospensione, Eva Kalili. Nel suo ruolo, è adesso
il sospetto di molti nella capitale belga, potrebbe aver influenzato a favore di
Doha e Teheran alcune delle posizioni del gruppo politico per cui lavorava.
Gli interessi comuni
tra Qatar e Iran
Ecco quindi perché
adesso potrebbe aprirsi il filone iraniano. E non sarebbe una sorpresa. Quando
nel 2017 l'Arabia Saudita ha imposto un ferreo embargo al Qatar, lo ha fatto
proprio perché il piccolo emirato si era rifiutato di interrompere i rapporti
con l'Iran.
Doha e Teheran hanno
molti interessi in comune. A partire dalla condivisione di tratti di mare nei
cui fondali si trovano alcuni dei più importanti giacimenti di gas off shore.
L'Iran ha aiutato il Qatar a sopravvivere alle sanzioni imposte dai Saud e
questo è anche uno dei motivi per cui l'emirato, a differenza di altri vicini,
non ha normalizzato i rapporti con Israele.
Possibile quindi che
alcuni emissari vicini a Teheran hanno lavorato in questi anni in Europa anche
per conto del Qatar? La vicinanza tra Mamedov e Giorgi, così come tra l'analista
pro iraniano e l'altro indiziato dell'inchiesta di Bruxelles, ossia Antonio
Panzeri, potrebbe rappresentare ben più di un semplice indizio. L'inchiesta
inevitabilmente punterà anche sulla pista iraniana: Teheran potrebbe aver avuto
un ruolo importante sia nel Qatargate che, più in generale, nei tentativi di
indirizzare una parte della politica europea verso i propri interessi e verso
quelli di Doha.
Qatargate. Se
l'incompetenza fa danni peggiori.
La corruzione a
Bruxelles fa scalpore, ma l'incompetenza e l'autoreferenzialità ideologica fanno
molti più danni. Pier Luigi del Viscovo il 15 Dicembre 2022 su Il Giornale.
La corruzione a
Bruxelles fa scalpore, ma l'incompetenza e l'autoreferenzialità ideologica fanno
molti più danni. Certo, il malaffare non l'avevamo messo in conto. Per noi
italiani, cresciuti con tangentopoli e calciopoli, è strano vedere implicati nel
Qatargate i vertici di quelle istituzioni da cui spesso veniamo bacchettati.
Sarà che ci portiamo dietro quel complesso di essere noi i furbi, anzi
furbastri, che cercano le scorciatoie, mentre non è che siamo i soli a cercarle,
quanto magari i più svegli a trovarle. Sarà anche che per decenni la politica
italiana ha pompato l'autorità economica e morale di Bruxelles, per usarla come
scusa per imporre qualche freno alla spesa, non avendo la forza di dire che meno
debito è nel nostro interesse. Fatto sta che non ce l'aspettavamo. Invece
avremmo dovuto ipotizzare che la competenza, seppur concorrente con gli Stati
Membri, in settori importanti, dall'agricoltura alla pesca, dai trasporti
all'energia, potesse dar luogo a fenomeni corruttivi.
Nella transizione
energetica, ad esempio, l'Europa sta imponendo all'economia, all'industria e
alla società dei limiti e dei costi assolutamente sproporzionati, alla luce
della non autosufficienza nelle materie prime e nell'energia, del ritardo
dell'industria nelle tecnologie avanzate e, in ultimo, del peso irrisorio delle
emissioni europee sui cambiamenti climatici. Forse adesso sarà più agevole per
tutti fare la domanda fatidica: cui prodest? Certe decisioni, nell'interesse di
chi?
Tuttavia, è anche
possibile che tante decisioni incomprensibili non siano frutto di interessi
vergognosi di pochi, quanto di incompetenza e inefficienza di tanti. Ideologie
scollegate dai fatti e calate in un enorme apparato burocratico, entro cui si
muovono figure professionali non sempre all'altezza, ma sempre inebriate da
autoreferenzialità, tipica dei contesti dove stanno insieme il potere e la
distanza dalle cose reali. Noi italiani abbiamo sempre sottovalutato il potere
che sta a Bruxelles, cercando anzi di tenerlo fuori dai confini il più
possibile. Per questo, abbiamo spedito in quelle posizioni coloro di cui la
politica domestica proprio non sapeva che farne, illudendoci di essere i soli a
comportarci così. Sbagliato. Avendo l'occasione di lavorare con gli organismi
comunitari, si scopre che anche dagli altri Paesi non arrivano dei fenomeni,
anzi. Inoltre, col sistema uno-vale-uno, capita che in una riunione la decisione
penda da una parte grazie al parere del maltese che, con tutto il rispetto, vale
quanto quello del tedesco.
Sì, la corruzione,
in Italia come ovunque, fa notizia e fa arrabbiare. Ma proprio noi dovremmo
sapere che al funzionamento del sistema fa più male l'incompetenza e l'arroganza
del potere, e pure che c'è un filo rosso che tiene tutto insieme. Quando interi
apparati possono operare senza il riscontro di un risultato apprezzabile da
parte dei cittadini, allora diventa anche più facile dare ascolto alle sirene
che girano con i trolley pieni di soldi.
Il Bestiario. Il
Bestiario, l'Eurocorrottino.
Giovanni Zola il 15 Dicembre 2022 su Il Giornale.
L’Eurocorrottino è
un leggendario animale che non si accontenta di uno stipendio da 20mila euro al
mese
L’Eurocorrottino è
un leggendario animale che predica bene ma razzola male e soprattutto non si
accontenta di uno stipendio da 20mila euro al mese.
L’Eurocorrottino
nasce e opera nel cuore del Parlamento Europeo, al centro delle istituzioni UE,
proprio là dove vige l’austera Von der Leyen, colei che rappresenta l’ordine, la
giustizia e la superiorità morale della grande Europa unita. Insomma la
corruzione di alcuni parlamentari europei è come se un enorme albatros con
apertura alare di due metri, l’avesse fatta dritta dritta in testa alla curata e
tersa permanete bionda della presidente.
La peculiarità
dell’Eurocorrottino non è quella di essere accusato di associazione a
delinquere, riciclaggio di denaro e corruzione – di questo sono buoni tutti - ma
di aver fatto affari sporchi proprio in nome della difesa dei diritti umani di
Paesi che i diritti umani li usano, nel migliore dei casi, per pareggiare le
gambe dei tavoli per non farli traballare. L’Eurocorrottino ha l’hobby delle
lobby che pagano ricche tangenti per ottenere ingerenza all’interno della UE. A
questo riguardo chi accusava Salvini di essere al soldo russo senza lo straccio
di una prova, ora potrà occuparsi di una vera e autentica ingerenza.
I fattacci
dell’Eurocorrottino naturalmente sono stati ripresi da tutti i giornali e Tg, ma
senza l’enfasi che avrebbero usato se l’Eurocorrottino fosse appartenuto al
centro destra. In questo caso avremmo assistito a maratone televisive
all’insegna dello stracciar di vesti, ma essendo l’Eurocorrottino di sinistra,
ci si limita ad affermare che si tratta di condotte personali che non hanno
niente a che fare con le appartenenze di partito. Inoltre quando si tratta di
“compagni che sbagliano”, il cattocomunista diventa improvvisamente garantista e
cita Papa Francesco ripetendo: “Chi siamo noi per giudicare”.
Così, a causa delle
malefatte dell’Eurocorrottino, la sinistra si sente addirittura parte lesa.
Alcuni detrattori affermano che sia perché il bottino da un milione e mezzo di
euro non sia stato diviso in parti uguali tra i compagni. In realtà è perché si
tratta di una tremenda figuraccia che ricorda alla lontana l’episodio dei 24mila
euro ritrovati in una cuccia e giustificati, da parte del cane stesso, come
anticipo per l’impianto fotovoltaico della cuccia.
Infine ora
comprendiamo perché tanta insistenza sull’utilizzo del POS da parte della
sinistra. Non si tratta tanto di una questione legata alla lotta all’evasione
fiscale, quanto al fatto che i contanti servono per riempire i sacchi dei
compagni Eurocorrottini.
Pioggia di mazzette, ma la sinistra arrossisce per una battuta
del Cav.
In Europa impazza il Qatargate, ma a sinistra fanno la morale a
Berlusconi perché a una cena ha fatto una battuta ai calciatori del Monza.
Andrea Indini il 15 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Borse piene zeppe di
banconote. Mazzette per ripulire la fedina penale di uno Stato che, quando va
bene, i diritti umani li calpesta. E ancora: Ong che "servivano a far girare i
soldi", lusso sfrenato e vacanze da 100mila euro, un'inchiesta che, stando a
quanto fanno trapelare gli inquirenti, "non sarebbe circoscritta solo ai quattro
fermati ma riguarderebbe diversi europarlamentari a libro paga del Qatar".
Eppure, anziché stare davanti a questo girone infernale di corruzione, a
sinistra sbroccano (ancora una volta) per una battuta, tra l'altro fatta in un
contesto conviviale, di Silvio Berlusconi. C'è chi, come Laura Boldrini, si
strappa i capelli in nome del sessismo e chi, dalle parte di Verdi e Sinistra
italiana, vorrebbe il Cavaliere "fuori per sempre dalla vita pubblica". E c'è
chi chiama in causa persino la Meloni che, dopo aver incassato il via libera di
Bruxelles alla legge di Bilancio, è in partenza per il Consiglio europeo e ha
ben altro di cui occuparsi.
Ma veniamo
alla battuta di Berlusconi che ha lasciato inorridite le anime candide della
sinistra nostra. Parte tutto da un video registrato ieri sera e poi affidato ai
social. Una volta online, la viralità ha fatto il suo corso. Contesto: cena di
Natale del Monza. Nello spezzone incriminato si vede l'ex premier in piedi, in
mezzo ai tavoli, chiacchierare disinvolto. "Abbiamo trovato un nuovo allenatore
che era l'allenatore della nostra squadra Primavera - racconta - è bravo,
simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi". Quindi la
battuta: "Io ci ho messo una stimolazione in più e ai ragazzi ho detto: 'Ora
arrivano Juventus e Milan. Se vincete con una di queste grandi squadre, vi
faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie'". Nessuno ai tavoli si è
stracciato le vesti né se l'è presa. Hanno riso, come è normale che sia.
A dare di matto ci
ha, invece, pensato la sinistra. La grillina Chiara Appendino parla di "concetti
miseri", addirittura "pericolosi". Laura Boldrini ci mette il carico da novanta
("Becero sessismo usato come goliardia") e ovviamente chiama in causa tutto il
centrodestra: "Ricordo che Meloni, Salvini e Tajani volevano Berlusconi
Presidente della Repubblica". È una gara a chi la spara più grossa. "Una
vergogna per tutte le italiane e gli italiani", azzarda Marco Grimaldi (Alleanza
Verdi e Sinistra). E poi +Europa: "Dagli anni Ottanta a oggi il nostro boomer
nazionale attinge allo stesso inventario di insulti con cui ha sempre infestato
le cronache politico-mondane". Su Twitter ci si mette pure Monica
Cirinnà: "Conferma la cultura patriarcale che riduce le donne a oggetti,
anticamera della violenza".
Tutti scandalizzati
per quella che, per quanto possa essere considerata da alcuni sopra le righe,
resta una battuta, tanto più pronunciata in un contesto tutt'altro che
istituzionale. Nemmeno Berlusconi si sarebbe mai aspettato tanto clamore per
quella che lui stesso considera "una semplice battuta 'da spogliatoio',
scherzosa e chiaramente paradossale". E davanti a questo paradossale finimondo
non gli resta che la compassione per i critici di professione. "Forse - azzarda
l'ex premier - è solo la loro assoluta mancanza di humor a renderli così tristi
ed anche così gratuitamente cattivi nell'attaccare i nemici". Ma, dopo tutto,
cos'altro ci saremmo potuti aspettare? Così è la sinistra. Arrossisce quando si
dicono le parolacce, ma quasi non batte ciglio davanti a un milione e mezzo di
contanti.
I servizi segreti
belgi dietro l'inchiesta.
L'indagine è
scattata dopo un ritrovamento anomalo di denaro. Lodovica Bulian il 15 Dicembre
2022 su Il Giornale.
I servizi segreti
del Belgio dietro l'inchiesta sul Qatar gate. Mesi prima dell'arresto, venerdì
scorso, dell'ex eurodeputato socialista Antonio Panzeri, gli 007 belgi avrebbero
trovato somme anomale in cash all'interno del suo appartamento a Bruxelles. I
quotidiani Le Soir e Knack, citando fonti investigative, rivelano quello che
sarebbe stato l'innesco dell'indagine per corruzione, associazione a delinquere
e riciclaggio che sta facendo tremare il Parlamento Ue. Al centro le presunte
mazzette pagate dal Qatar con l'obiettivo di ammorbidire le posizioni delle
istituzioni sulle violazioni dei diritti umani e dei lavoratori nella
costruzione delle opere per i Mondiali di calcio. Ieri i giudici della Camera di
consiglio di Bruxelles hanno confermato il carcere, ancora per almeno un mese,
per Panzeri e per il suo ex assistente Francesco Giorgi, compagno della ex
vicepresidente dell'assemblea Ue Eva Kaili. Per lei la decisione è stata
rinviata al 22 dicembre, mentre per il quarto arrestato, Niccolò Figà Talamanca,
è stato disposto il braccialetto elettronico. Uno dei nodi ancora da chiarire è
proprio l'inizio dell'indagine, cosa avrebbe spinto i magistrati belgi ad
aprire, a luglio, un'inchiesta poi arrivata ai vertici delle istituzioni.
Secondo Le Soir alla
base ci sarebbe una segnalazione dei servizi segreti del Belgio. Già nel 2021,
gli apparati di sicurezza avrebbero aperto un'inchiesta sull'interferenza di una
potenza straniera . Nell'ambito dell'indagine, secondo questa ricostruzione, gli
007 sarebbero arrivati all'ex eurodeputato Panzeri. Tanto che, nell'ambito di
un'operazione segreta di intelligence, avrebbero effettuato una perquisizione
nella sua abitazione e avrebbero trovato circa 700mila euro in contanti.
Elemento che avrebbe fatto scattare la declassificazione del fascicolo e la sua
trasmissione alla Procura federale il 12 luglio 2022. É l'atto che di fatto
avrebbe fatto partire l'inchiesta ora coordinata dal giudice Micheal Claise.
Secondo i quotidiani, il servizio interno avrebbe collaborato con l'intelligence
di altri cinque Paesi europei nelle indagini. Dai servizi segreti non sono
arrivate conferme ufficiali a questa versione né smentite. Ma rimbalzano
sull'asse Bruxelles- Roma anche voci di una presunta gola profonda dietro il
Qatar gate, un collaboratore che avrebbe parlato con la polizia delle due ong
finite sotto la lente degli investigatori, la «Fight for Impunity» di Panzeri e
la «No Peace Without Justice». Gli inquirenti starebbero cercando conferme
sull'utilizzo delle ong - attorno a cuo ruotano nomi riferibili alla galassia
Panzeri - come «veicolo» della presunta corruzione. Uno dei punti ancora non
noti del lavoro dei magistrati riguarda il Marocco e in quale misura la presunta
attività di corruzione sia arrivata anche da lì al cuore di Bruxelles e per
quali fini.
Pietro De Leo
per “Libero quotidiano” il 14 dicembre 2022.
Voi, popolo del b&b,
chirurgici frequentatori dei siti low cost, con la prospettiva mentale tarata
verso il basso (nel senso del risparmio), vi domandate come si possa trascorrere
una vacanza spendendo 100 mila euro? E allora vi aiutiamo noi, in una breve
guida turistica per attivisti extralusso di sinistra.
Passo indietro:
nell’inchiesta Qatargate, uno degli indagati, Antonio Panzeri, ex
europarlamentare del Pd, è stato intercettato dagli inquirenti mentre parla con
la moglie. Tema della conversazione, l’organizzazione di un soggiorno. Ebbene,
ad un certo punto, la signora dice di aver «dato uno sguardo ai prezzi per il
periodo di Natale», anche se non può «permettersi di spendere 100 mila euro per
le vacanze come l’anno scorso».
Certo, siamo ancora
nel campo del presunto, del “da accertare”, e il nostro è un divertissement
ipotetico. Ma dalle foto pubblicate sui social dalla figlia della coppia (anche
lei, come mamma e papà, finita agli arresti), poi prontamente rimosse, si può
ricavare qualche parametro. La pargola ritrae se stessa in luoghi come Doha,
Miami, Montreal. E allora eccolo, il prontuario del progressista con valigia (di
Louis Vuitton, come vuole il soumaoramente corretto di questi periodi).
Per esempio, a Doha,
in Qatar, patria a quanto pare assai cara alla famigliola, c’è da fiondarsi al
Mandarin Oriental. Qui, infatti, ha loco una lussuosissima suite, salita agli
onori delle cronache perché per qualche giorno vi ha trascorso ore liete David
Beckham, arrivato colà per i mondiali in quanto ambasciatore del calcio inglese.
Ebbene, per questo gioiello che prevede palestra, spa e piscina private, oltre
ad una vista mozzafiato, bisogna sborsare 23 mila euro a notte.
Cambiando
destinazione, Miami Beach, ecco la “Penthouse suite” del Faena Hotel. In questo
caso bisogna staccare un assegno di circa 41 mila euro. Vista Oceano, piscina a
sfioro, cinque camere da letto, ognuna delle quali con balcone. Come
alternativa, considerando che il buon Panzeri pare fosse in rapporti assai buoni
anche con il Marocco, si può sempre optare per la “Grand Riad”, dell’”hotel
Royal Mansour”, 40 mila euro a notte. La minireggia ha una sala cinema, un
hamman, palestra e piscina privata.
EMPHATY SUITE PALMS
CASINO RESORT.
E chissà, magari, se
non buttasse male di questi tempi per la vacanza d’élite progressista si
potrebbe sempre puntare al bersaglio grosso, l’Emphaty Suite del Palms Casino
Resort di Las Vegas. Vuoi mettere, per il radicalchic, addormentarsi fra gli
squali immersi in formaldeide del grande Damien Hirst? Da “vacanza intelligente”
per veri intellettuali della gauche. Per il relax spiccio, invece, ci sono bar
personale, sale massaggi e palestra. Costo, 100mila dollari a notte, a meno che
non si tratti di un cliente “pesante” del Casino con 1 milione di dollari di
credito, in quel caso è gratis. Il prezzo è un po’ altino, certo, ma accessibile
con una colletta tra compagni del sodalizio. Considerando le cifre emerse
dall’inchiesta, qualche giorno ci potrebbe scappare.
Qatargate,
l'ombra di George Soros: quel filo che lega tutti gli arrestati.
Libero
Quotidiano il 15 dicembre 2022.
C'è un filo che lega
gli arrestati e chi è stato solo sfiorato e non indagato per il Qatargate: sono
tutti "alleati affidabili" di George Soros, rivela Fausto Biloslavo su Il
Giornale, e sono tutti favorevoli alle Ong e ai migranti. Il Qatar, infatti,
aveva messo in piedi pure un gruppo di amicizia di tredici eurodeputati non
coinvolti nell'inchiesta. Ieri 13 dicembre il presidente, il centrista
spagnolo Jose Ramon Bauza, ha annunciato la sospensione del gruppo. La decisione
è stata presa "alla luce dei gravissimi avvenimenti degli ultimi giorni, e in
attesa che si vada a fondo della questione", ha fatto sapere l'esponente del
partito centrista Ciudadanos e del gruppo Renew Europe. Bauza, pur non essendo
indagato, si è trovato costretto a smentire di avere un rapporto privilegiato
con Doha. "Ho difeso al Parlamento europeo i progressi del Qatar che sono una
buona notizia per il Medio Oriente. Ci ho creduto e ci credo", ha
scritto Bauza su Twitter. "Non ho mai ricevuto, e tantomeno offerto, un solo
euro per difendere alcunché".
Antonio Panzeri,
l'ex europarlamentare arrestato per corruzione, veniva definito in un dossier
per Open society come "alleato affidabile" dell'associazione di George Soros.
"Non a caso Panzeri ha sempre difeso a spada tratta le Ong del mare. Nella lista
degli alleati di Soros compariva anche Andrea Cozzolino, che giura di non essere
minimamente coinvolto, ma negli atti dell'inchiesta ci sarebbe una sua mail che
chiede, senza successo, al gruppo socialisti europei di non votare la
risoluzione contro il Qatar", riporta il Giornale. E Francesco Giorgi, arrestato
insieme alla sua compagna Eva Kaili, era suo consigliere.
"L'ufficio
di Federica Garbagnati, ex collaboratrice di Panzeri, oggi assistente
di Alessandra Moretti, è stato sigillato dagli inquirenti. L'europarlamentare,
non indagata, si è distinta come pasionaria dei migranti lungo la rotta
balcanica. L'intreccio di consiglieri spesso condivisi, coinvolti
nell'inchiesta, sfiora anche chi è estraneo all'indagine come Pietro
Bartolo passato da medico dei migranti a Lampedusa a Strasburgo. E lo
stesso Brando Benifei, capo delegazione del Pd, che sta schiumando giustamente
di rabbia contro i personaggi di sinistra del Qatargate. Anche lui però si
vantava di essere nella lista degli 'alleati affidabili' di Soros". Di più.
"Nello stesso rapporto c'era l'allora neo eurodeputata Elly Schlein oggi
candidata alla segreteria del Pd. Con il Qatar sono sempre stati duri, ma non
hanno mai capito che c'era del marcio nella loro parrocchia".
Il suo ruolo era
quello di gestire i contanti. La confessione di Giorgi e la lista degli
europarlamentari “a libro paga” di Qatar e Marocco: “Ora liberate Eva, nostra
figlia ha 22 mesi”.
Redazione su Il
Riformista il 15 Dicembre 2022
Francesco Giorgi ha
confessato, ha ammesso l’esistenza di una organizzazione al servizio
di Qatar e Marocco con lo scopo di interferire e condizionare gli affari
europei. L’assistente 35enne, originario di Abbiategrasso (Milano), che ha
lavorato prima con l’europarlamentare socialista Antonio Panzeri, poi da qualche
anno con Andrea Cozzolino, ha spiegato lo scorso 10 dicembre ai magistrati belgi
a Bruxelles che il suo ruolo era quello di gestire i contanti.
Giorgi è uno dei
quattro arrestati nell’inchiesta che ha portato al ritrovamento di una ingente
quantità di contanti sia nell’abitazione di Panzeri (500mila euro) che in quella
della oramai ex vicepresidente del parlamento europeo Eva Kaili (750mila euro).
“Farò il possibile affinché la mia compagna sia libera e possa occuparsi di
nostra figlia di 22 mesi” ha spiegato Giorgi, assumendosi ogni responsabilità
sui soldi trovati in casa di Eva Kaili.
Quei soldi erano
destinati solo a lui e a Panzeri, ha ribadito Giorgi nell’interrogatorio.
Secondo quanto scrive il giornale belga, Giorgi avrebbe anche indicato di
sospettare che Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, entrambi europarlamentari del
gruppo S&D, avrebbero preso soldi tramite Antonio Panzeri. Il Marocco sarebbe
coinvolto nella vicenda di sospetta corruzione attraverso il suo servizio di
informazione esterna, la Dged. In base ai documento consultati dai due
quotidiani – si legge ancora sul giornale – Panzeri, Cozzolino e Giorgi
sarebbero stati in contatto con con la Dged e con Abderrahim Atmoun,
l’ambasciatore del Marocco in Polonia.
Secondo la
televisione privata greca MegaTv, sarebbero oltre 60 gli eurodeputati nel mirino
della maxi-inchiesta sul Qatargate condotta dalla giustizia belga. I
parlamentari europei che potrebbero essere toccati da indagini e perquisizioni,
sempre secondo l’emittente ellenica, sarebbero per la maggior parte appartenenti
alle famiglie politiche dei Socialisti & Democratici, del Partito popolare
europeo e di altri partiti di sinistra. Le indiscrezioni sono state rilanciate
anche dalla testata online tedesca Focus.de, ma non trovano alcuna conferma da
parte della procura federale belga.
Intanto, la prima
udienza per i quattro fermati davanti alla camera di Consiglio del tribunale di
Bruxelles ha restituito i primi pronunciamenti della giustizia belga: l’ex
eurodeputato Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, compagno dell’ex presidente del
Parlamento europeo Eva Kaili, resteranno ancora in carcere per almeno un mese,
mentre Niccolò Figà-Talamanca potrà uscire sotto regime di sorveglianza
elettronica. Resta invece in sospeso il destino di Kaili che ha chiesto e
ottenuto il rinvio della decisione al 22 dicembre prossimo.
A Strasburgo,
l’Eurocamera riunita in plenaria ha chiesto lo stop all’intesa Ue-Qatar
sull’aviazione e la sospensione di tutti i fascicoli legislativi legati a Doha,
provocando irritazione nella Lega perché esclusa dalla sottoscrizione della
risoluzione comune che dovrà ora essere messa ai voti.
Cozzolino, le
indagini dei pm e la mail dei sospetti: «Il Qatar? Sarebbe un errore
ostacolarlo».
Simona Brandolini e Marco Imarisio su Il Corriere della Sera il
16 Dicembre 2022.
In una mail del 24
novembre l’eurodeputato del Pd invitava a votare contro una parte di risoluzione
in cui si sosteneva che Doha aveva ottenuto la Coppa del Mondo grazie alla
corruzione
Andrea Cozzolino
aveva invitato i colleghi a non votare contro una parte del testo perché «il
Parlamento Ue — si legge nella mail — non dovrebbe accusare un Paese senza prove
delle autorità giudiziarie competenti»
«Guardate che è solo
una questione politica, a quello che ho scritto io ci credo veramente». Così
sosteneva Andrea Cozzolino nella chat interna degli eurodeputati del Pd. I suoi
colleghi lo avevano accusato, non troppo velatamente, di aver fatto fare a tutta
la delegazione italiana una brutta figura per via della mail inviata a tutto il
gruppo dei Socialisti&Democratici. Nella quale, poco prima del voto del 24
novembre sulla risoluzione per i diritti umani ai Mondiali di calcio, invitava a
votare contro una parte del testo in cui si sosteneva che il Qatar aveva
ottenuto la Coppa del Mondo grazie alla corruzione. «Il Parlamento Ue non
dovrebbe accusare un Paese senza prove delle autorità giudiziarie competenti»,
si legge nella mail.
In questi giorni
l’episodio è stato riletto e interpretato con l’abituale senno di poi, e sarà
così ancora a lungo, alla luce delle ultime rivelazioni fatte dal suo
assistente Francesco Giorgi, il quale ha detto di sospettare che il suo datore
di lavoro abbia preso soldi tramite Antonio Panzeri. Anche per questo la procura
di Bruxelles lo considera il possibile «terzo uomo» dell’inchiesta.
Ieri Cozzolino ha
rotto il silenzio. Chiuso per tutta la mattina nel suo ufficio a Strasburgo, ne
è uscito con un comunicato che è doveroso riportare, dato che in questa vicenda
anche la presunzione di innocenza ne sta uscendo a pezzi. «Sono indignato per le
vicende giudiziarie che apprendo dalla stampa e che minano fortemente la
credibilità delle istituzioni europee. A livello personale sono del tutto
estraneo alle indagini». L’europarlamentare napoletano del Pd precisa di non
essere indagato, di non essere stato interrogato, di non avere subito
perquisizioni e di non avere mai avuto rapporti con l’ambasciatore del Marocco
in Polonia, il presunto corruttore Abderrahim Atmoun, e con l’intelligence di
Rabat.
«Non ho mai
incontrato persone vicine ad agenzie o servizi di sicurezza, né tanto meno ho
mai perseguito interessi, vantaggi o utilità personali nella mia vita politica.
Sono pronto a tutelare la mia storia e la mia onorabilità in ogni sede». È il
suo destino, quello di essere oggetto di speculazioni, fin dai tempi di Napoli,
quando era considerato l’eterno papabile a ogni carica. Antonio Bassolino ne
descrisse l’ambizione con una battuta caustica. «Non dite a Cozzolino che nel
palazzo di fronte ci sono le elezioni condominiali, perché si candida anche lì».
Ma questa è una storia diversa, molto più pesante. Diventa quasi normale
guardare a ritroso, i primi a farlo sono i suoi colleghi come sa bene anche
Cozzolino. Ogni parola, opera o omissione, rischiano di diventare elementi di
sospetto. Come la sua mancata firma all’interrogazione con richiesta di risposta
scritta che la maggior parte della delegazione italiana di sinistra
presenta dopo le frasi sul «danno mentale» dell’omosessualità e sul fatto che
essere gay «è proibito» pronunciate dall’ambasciatore della Coppa del Mondo in
Qatar Khalid Salman. Pochi giorni dopo, nella sottocommissione Droi per i
diritti umani il clima è teso. L’ospite in aula è il ministro del Lavoro Ali Bin
al-Marri. Molti europarlamentari del gruppo S&D sono pronti a fare la voce
grossa. Cozzolino prende la parola per primo. Esordisce con una battuta.
Per motivi
calcistici, ha dubbi sul Mondiale che va a cominciare, perché il suo Napoli è
primo in classifica «e interrompere il Campionato per due mesi crea qualche
problema». Prosegue così. Testuale. «Mi pare imponente il lavoro che si è fatto
in Qatar, soprattutto il dialogo sociale. Con gli organismi internazionali, con
le Ong, con i sindacati. Noi dobbiamo incoraggiare questo dialogo e questo
programma di riforme. Guai se nel momento in cui sta cominciando, noi come
organismi internazionali come il Parlamento europeo frapponessimo ostacoli a
questo sviluppo. Sarebbe un errore». Sono parole che significano tutto e niente.
Ma Cozzolino sa che è così che gira il suo mondo. Da tempo. Ne ha macinata di
strada l’europarlamentare napoletano del Pd, dal movimento studentesco
anticamorra alla Fgci. Pane e partito. Per anni è stato considerato il delfino
di Antonio Bassolino, anche se i rapporti con l’ex sindaco di Napoli si sono poi
logorati. Consigliere regionale nel 2000, superassessore nel 2005. Non prima
però, di aver tentato di diventare vicesindaco di Rosa Russo Iervolino,
operazione stoppata per un conflitto d’interessi. La moglie è una imprenditrice
che in città gestisce varie attività.
L’annus horribilis,
per lui e per il Pd, è il 2011. Cozzolino prova a diventare sindaco. È il
capitolo terribile delle primarie dello scandalo, quelle delle file dei cinesi
ai seggi, che fece dire a Walter Veltroni: «O sono cinesi democratici o c’è
qualcosa che non va». Da una parte c’è Cozzolino che stando ai dati avrebbe
vinto, dall’altro il figlio politico di Giorgio Napolitano, Umberto Ranieri, che
grida ai brogli. Il partito viene commissariato. Da allora e per i successivi
dieci anni il Pd a Napoli perde tutte le elezioni. Nel frattempo, Cozzolino ha
preso il primo volo per Bruxelles.
Eva Kaili: «Non
diventerò Ifigenia, niente a che fare con quei soldi».
Storia di Redazione
Online su Il Corriere della Sera il 15 Dicembre 2022.
L’ex vicepresidente
del Parlamento europeo indagata nello scandalo soprannominato Qatar-gate , Eva
Kaili, torna a rivendicare la sua innocenza e assicura, tramite il suo avvocato,
che non farà la fine della figlia di Agamennone e di Clitemnestra che nel mito
greco viene sacrificata. Ha dichiarato: «Non diventerò Ifigenia» «Kaili non ha
alcun coinvolgimento con i soldi che sono stati trovati, tranne che lei stessa
era nella casa in cui è stato trovato il denaro», ha detto Michalis
Dimitrakopoulos, avvocato di Kailis e dei suoi familiari, alla tv greca ANT1.
«Tutte le azioni e le iniziative della signora Kaili sono state approvate dal
Parlamento europeo. Non c’era un’agenda personale della signora Kaili, tutto era
una decisione politica del Consiglio europeo e della Commissione e non solo del
Parlamento europeo e della signora Metsola», ha spiegato Dimitrakopoulos. Quanto
al compagno Francesco Giorgi, l’avvocato dell’ex vicepresidente del Pe sostiene
che «il marito conferma ciò che la signora Kaili dice sui soldi: tutto è
successo in quelle ore, quando Kaili ha visto i soldi, non ha avuto una risposta
convincente sulla loro origine e ha subito chiesto che i soldi uscissero di
casa. Suo padre si è preso la responsabilità di essere il corriere, perché non
c’era nessun altro». Attraverso il suo avvocato, Kaili fa sapere che comprende
la sua destituzione dalla carica di vicepresidente del Parlamento europeo: «Se
fossi presidente, farei lo stesso fino a quando il caso non sarà chiarito».
Kaili-Giorgi, la
trincea di Eva («Io non sarò Ifigenia») e la confessione di Francesco.
Giuseppe
Guastella su Il Corriere della Sera il 16 Dicembre 2022.
Il legale di Kaili:
quando ha visto i soldi ha chiesto che uscissero di casa. La procura europea
vuole che le venga tolta l’immunità per un altro caso.
Alla fine, crolla e
ammette quello che proprio non poteva negare Francesco Giorgi. E cioè di aver
ricevuto lui, solo lui, i soldi trovati nella casa che divide nel centro di
Bruxelles con la compagna Eva Kaili , ed erano suoi anche quelli stipati nel
trolley che il padre della donna trascinava mentre lasciava l’albergo Sofitel in
tutta fretta. In totale, oltre 750 mila euro che Giorgi (chi è) esclude avessero
a che fare con la deputata del Pasok perché venivano dagli affari che lui aveva
combinato fino a poco prima dell’arresto con Antonio Panzeri, il suo capo al
Parlamento di Bruxelles quando Giorgi era assistente dell’altro che era un
deputato del Pd (in questo articolo, com’è nato il legame tra i due: Panzeri
invitato a scuola a Cisliano dal papà preside di Giorgi).
Nell’interrogatorio
di sabato scorso subito dopo l’arresto Giorgi è un fiume in piena. Parla per
dieci ore costringendo il giudice istruttore a rinviare al giorno dopo gli
interrogatori degli altri imputati. Fa nomi e cognomi, dà spiegazioni, dice a
chi sono andati i soldi della ong Fight impunity che, fondata nel 2019 da
Panzeri, riceveva laute donazioni anche grazie al prestigio assoluto garantito
dal proprio consiglio d’onore in cui sedevano premi Nobel, ex commissari europei
ed ex premier. Giorgi si assume per intero la titolarità del «malloppo» in
banconote fruscianti, percorrendo la stessa strategia attuata della sua
compagna: separare il destino dell’uno da quello dell’altro per provare a
salvare chi, come la Kaili, ha più da perdere come mamma e in termini di
reputazione da questa vicenda che ha sconvolto il Parlamento europeo. «Nei non
sa niente dei soldi», aveva ripetuto più volte l’avvocato Michalis
Dimitrakopoulos, il legale della vicepresidente, poi destituita.
E le banconote nella
valigia del padre? «Tutto è successo in quelle ore, quando Kaili ha visto i
soldi, non ha avuto una risposta convincente sulla loro origine e ha subito
chiesto che uscissero di casa. Suo padre si è preso la responsabilità di essere
il corriere perché non c’era nessun altro», è la spiegazione. Sulla testa della
Kaili si abbattono altre due indagini. La procura europea ha chiesto che venga
revocata l’immunità a lei e alla connazionale del Ppe Maria Spyraki, per poter
procedere a un’indagine sulla retribuzione degli assistenti parlamentari che
ipotizza una «frode a danno del bilancio dell’Ue» («Non ho alcun legame con il
Qatargate e accetto volentieri la richiesta di revoca», dice Spyraki).
Da Atene, invece, il
procuratore finanziario Christos Bardakis annuncia un’inchiesta sulla Kaili per
corruzione e riciclaggio, anche se non potrà partire prima della conclusione di
quella belga. Eva Kaili «non ha alcun legame con i soldi che sono stati trovati,
tranne il fatto che lei stessa era nella casa in cui sono stati trovati»,
dichiara ancora l’avvocato Dimitrakopoulos, che ricorda come «tutte le azioni e
le iniziative della signora Kaili sono state approvate dal Parlamento europeo.
Non c’era un’agenda personale della signora Kaili, tutto era una decisione
politica del Consiglio europeo e della Commissione e non solo del Parlamento
europeo e della signora Metsola». La risposta indiretta della presidente arriva
quando ammonisce che «questo fatto coinvolge tutti, coinvolge l’Europa» davanti
ai leader del Consiglio europeo i quali rispondono di avere «piena fiducia
nell’inchiesta giudiziaria» e di dare «pieno supporto» alla stessa Metsola.
Kaili è nel mezzo di
un dramma che lei, greca, innalza a tragedia classica: «Non diventerò Ifigenia»,
dice all’avvocato, non vuole essere destinata al sacrificio come la figlia di
Agamennone e Clitemnestra. Giorgi non è da meno: «Voglio che sia libera per
pensare alla nostra bambina di 22 mesi».
Ma.Bre. per “La
Stampa” il 15 Dicembre 2022.
Ci sono diversi modi
per influenzare le scelte di un'istituzione o dei suoi membri e conquistare un
trattamento di favore. Secondo le indagini della procura belga, il Qatar avrebbe
scelto quelli illegali con alcuni deputati e assistenti del Parlamento europeo,
offrendo loro valigie piene di soldi, per ammansire l'assemblea che è sempre in
prima linea nelle battaglie per la difesa dei diritti. Ma con le altre due
istituzioni dell'Unione europea le cose sono andate in modo molto più semplice e
legale.
Eppure Doha ha
ottenuto esattamente gli stessi risultati.
Da un paio di anni a
questa parte, e soprattutto dopo l'invasione russa in Ucraina, il Qatar si è
guadagnato un posto di tutto rispetto tra i cosiddetti "partner strategici"
dell'Ue.
L'esigenza di
colmare il buco lasciato dal gas russo ha permesso a Doha di rendersi
"indispensabile" per Bruxelles, che con il passare dei mesi ha messo da parte
tutti i dubbi sul rispetto di diritti umani nel Paese del Golfo, ha archiviato
le indagini sui comportamenti anticoncorrenziali della principale società
energetica del Qatar e anzi ha stretto ulteriormente i legami diplomatici con il
Paese, ha portato avanti l'iniziativa per concedere ai cittadini qatarini la
libertà di venire in Europa senza visto e ha spalancato le porte dei propri
cieli alla compagnia QatarAirways.
Il 18 ottobre di un
anno fa, la Commissione europea ha annunciato la sigla di un accordo definito
"storico": un'intesa per consentire a tutte le compagnie aeree di poter operare
voli diretti da qualsiasi aeroporto dell'Unione verso il Qatar, che è un Paese
di 2,9 milioni di abitanti.
In cambio,
QatarAirways ha ottenuto la possibilità di poter operare voli diretti verso
tutti gli scali dell'Unione, entrando in un mercato fatto di 450 milioni di
cittadini. Un protocollo decisamente vantaggioso per la principale compagnia
europea di Doha. L'accordo è entrato in vigore in via provvisoria subito dopo la
firma, ma ora deve essere ratificato dal Parlamento europeo. Che di fronte allo
scandalo di questi giorni ha deciso di alzare la paletta rossa.
C'è il timore che
gli emissari di Doha possano essere intervenuti per sminare possibili problemi
sull'iter della ratifica, che non è iniziato. Fin qui ci sono state soltanto
riunioni preparatorie a porte chiuse. Durante una di queste, secondo quanto
risulta a La Stampa, un'eurodeputata del gruppo dei socialisti-democratici
avrebbe chiesto di organizzare una missione in Qatar. Richiesta respinta. La
presidente della commissione Trasporti, Karima Delli, ha scritto una lettera ai
rappresentanti dei gruppi proponendo sostanzialmente due cose.
La prima:
«Declassificare tutte le decisioni prese durante le riunioni dei coordinatori
che riguardano il Qatar». La seconda prevede di mettere la pratica in stand by:
«Concedere il consenso a questo accordo - si legge nella lettera della
presidente - potrebbe essere difficile finché non si stabilirà che le condizioni
sono state trasparenti e imparziali».
C'è poi il capitolo
energia. Nel marzo scorso la Commissione europea ha deciso di rimettere nel
cassetto un'indagine Antitrust aperta tre anni prima su QatarEnergy (che
all'epoca si chiamava Qatar Petroleum), accusata insieme con altri importatori
di aver ostacolato il mercato unico europeo. Da quel giorno, il Paese del Golfo
è diventato uno dei pochi appigli ai quali aggrapparsi per contrastare la crisi
d'astinenza dal gas russo.
Il metadone per
cercare di sopravvivere senza il metano di Mosca. E così sono arrivati i
maxi-accordi siglati da Paesi come Francia, Germania e Italia e dai rispettivi
colossi energetici. Eni e TotalEnergy sono entrate nella partnership per
l'espansione del North Field East, il più grande progetto di gas naturale
liquefatto al mondo.
Bruxelles ha offerto
solida sponda diplomatica, che l'ha portata ad aprire un'ambasciata dell'Ue in
Qatar. Per inaugurarla si è scomodato il presidente del Consiglio europeo in
persona. «La mia presenza qui - aveva detto Charles Michel il 7 settembre scorso
- è il segnale della nostra volontà politica di rafforzare i legami con il
Qatar. Affrontiamo sfide globali importanti e siamo assolutamente convinti che
l'amicizia con il Qatar sia una leva importante».
Nel suo discorso non
c'è traccia del tema "diritti umani", ma in compenso ha sottolineato i progressi
fatti nella liberalizzazione dei visti. Già, perché la celebre riunione della
commissione Libe del Parlamento europeo per consentire ai cittadini qatarini di
muoversi liberamente sul territorio Ue per 90 giorni non è stata un punto di
partenza, ma un punto di arrivo (anche se ora il file è stato congelato).
I 27 governi avevano
già dato il loro via libera a tempo di record il 29 giugno, a soli due mesi
dalla proposta della Commissione. Nel documento adottato il 27 aprile
dall'esecutivo Ue si legge che "anche se restano sfide nell'area dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, il Qatar ha subìto un processo di
trasformazione della società per quanto riguarda i diritti delle donne, dei
lavoratori e la libertà di religione".
(ANSA il 15 Dicembre
2022) – Tra i servizi europei che hanno collaborato alla fase di intelligence
nell'indagine sul cosiddetto 'Qatargate' ci sono anche le agenzie italiane Aise
ed Aisi, per i rispettivi ambiti di competenza. Lo si apprende da fonti
dell'intelligence.
Marco Imarisio per
il “Corriere della Sera” il 15 Dicembre 2022.
Funzionava così. «In
occasione della Festa Nazionale del Qatar, l'ambasciatore in Belgio e
Lussemburgo Khalid Bin Fahad Al Hajri e il capo della delegazione presso
l'Unione europea e la Nato Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki richiedono la vostra
compagnia al ricevimento che si terrà l'8 dicembre a partire dalle 18 presso
l'hotel Steinberger Wiltcher di Bruxelles».
La lista degli
invitati, oltre cinquanta posti sui 250 previsti, era gestita a proprio
piacimento da Antonio Panzeri, che una settimana prima aveva fatto diramare le
convocazioni dopo opportuni sondaggi. Alcuni nomi erano stati indicati di
default, ex colleghi di gruppo, eurodeputati amici personali.
Altri erano frutto
di un'attività di esplorazione, chiamiamola così, alla quale il fondatore
dell'Organizzazione non governativa Fight Impunity si dedicava con un certo
scrupolo. Ai deputati che nel 2024 non si ricandideranno, a quelli che sanno già
di non avere alcuna possibilità di essere rieletti, offriva la possibilità di
una seconda vita all'interno delle Ong, la sua e quella presieduta dal suo amico
Marc Tarabella, che avevano sede negli stessi uffici di Rue Ducale a Bruxelles.
L'ultima volta fu il
primo dicembre. Una visita più mirata. Si presentarono insieme, dando
appuntamento ad alcuni deputati. Scelti non a caso. Quasi tutti membri della
Commissione sui diritti umani in Unione europea (Libe), che poco dopo l'ora di
pranzo avrebbero dovuto votare sul libero ingresso, senza bisogno di visti, dei
cittadini qatarioti. Si era trattato di un parto sofferto. Quella mattina,
Panzeri si limitò a lasciar intravedere offerte di impieghi futuri, ricordando
con fare bonario che da lì a poco ci sarebbe stata una votazione importante.
C'era stata maretta
nella riunione preparatoria a porte chiuse dei redattori ombra, uno per ogni
famiglia politica, che avevano chiesto conto al relatore ufficiale, il verde
Erik Marquardt, della disparità di trattamento tra Kuwait e Qatar. Entrambi
Paesi dove è in vigore la pena di morte. I negoziati per liberalizzare i visti
del primo sono bloccati, quelli del secondo invece procedevano di buona lena
verso una conclusione positiva.
L'imbarazzo di
Marquardt risultò evidente. C'erano posizioni diverse, aveva detto.
C'era chi sosteneva
che non si poteva far pagare al Qatar quello che aveva fatto il Kuwait, che
durante il soggiorno del vicepresidente Ue, il greco Margaritis Schinas, aveva
eseguito sette condanne capitali.
Esiste un lungo
messaggio WhatsApp, della quale il Corriere ha preso visione, indirizzata solo
ad alcuni esponenti dell'Alleanza progressista dei Socialisti e Democratici che
facevano parte della commissione Libe, che riassume questa tesi, estremizzandone
il contenuto. Termina così: «Il Qatar oggi si presenta come una società dai
tratti senz' altro non convenzionali, ma che sulla base dei progressi compiuti
anche grazie allo stimolo delle istituzioni europee può essere legittimamente
considerata come una democrazia quasi compiuta».
La firma è di
Francesco Giorgi, l'assistente storico di Panzeri, «il bastone della mia
vecchiaia», come lo chiamava lui, l'uomo che aveva soppiantato ogni altro
collaboratore dell'ex sindacalista milanese, che gli dettava la linea. La sua
compagna, Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo, considerata una
creatura politica di Schinas, si presentò a sorpresa alla votazione.
Gli altri deputati
pensarono che fosse il sostituto di un assente, pratica consentita. Ma il
presidente fece notare, e lo disse al microfono, che risultava un socialista in
più in aula. Come se su quella delibera fosse necessario imprimere un marchio di
appartenenza. Adesso che sono caduti in disgrazia, non c'è parlamentare della
loro ex famiglia socialista che non abbia un ricordo, una conversazione, un
messaggio, che prova l'indefessa attività di lobbying fatta da Panzeri e Giorgi,
alla luce del sole.
È farina dello
stesso sacco anche l'ormai famosa mail dell'europarlamentare Andrea Cozzolino
inviata lo scorso 24 novembre a tutti i colleghi del gruppo S&D con la quale
invitava a votare contro la risoluzione sui diritti umani in Qatar, quella che
citava anche la Coppa del Mondo 2006 in Germania come esempio di corruzione.
Il deputato, che ora
si è autosospeso dal gruppo, la rivendica come una sua posizione personale. Ma
agli atti risultano anche una serie di mail «preparatorie» inviate da Giorgi a
Cozzolino, del quale era diventato assistente dopo il ritiro di Panzeri a vita
privata. Non era l'unico a riceverle, altri suoi colleghi erano stati messi in
copia. A volte, la memoria. Al ricevimento organizzato dal Qatar erano
ovviamente presenti sia Panzeri che Giorgi. Poche ore dopo, veniva giù tutto.
Claudio
Tito,Giuliano Foschini,Luca De Vito per “la Repubblica” il 15 Dicembre 2022.
Il club "degli
amici". Negli atti che hanno portato all'arresto della cricca italiana dentro il
Parlamento europeo c'è una definizione che rende l'idea di quello che, al
momento, secondo gli investigatori è "l'Italian job": un sistema, all'interno
del Parlamento europeo e in particolare del gruppo socialista, che per conto del
Marocco e del Qatar ha «rappresentato un pericolo certo per l'equilibrio della
democrazia».
Chi faceva parte del
club? È su questo che si interrogano i magistrati belgi provando a ricostruire,
sulla base delle dichiarazioni e delle intercettazioni telefoniche e
telematiche, il sistema. Il gruppo principale era composto da Antonio Panzeri e
Francesco Giorgi, attualmente agli arresti. Il primo collegamento diretto -
stando alla ricostruzione degli investigatori - era l'europarlamentare del
partito democratico Andrea Cozzolino, per il quale Giorgi lavorava.
Mentre gli altri
parlamentari "vicini" citati negli atti sono Eva Kaili, Maria Arena, il
capogruppo del Partito democratico Brando Benifei e Alessandra Moretti.
Cozzolino era il
presidente della delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb e delle
commissioni parlamentari miste Ue-Marocco. Era inoltre membro della commissione
Diritti umani, dalla quale sono passate le risoluzioni più problematiche per il
Qatar: ricopriva, dunque, per i due principali "finanziatori" del gruppo, un
ruolo cruciale. Ma in che cosa è consistito il ruolo di Cozzolino? Il
parlamentare ha sicuramente avuto rapporti con l'ambasciatore marocchino in
Polonia, Abderrahim Atmoun, accusato di aver consegnato alcuni regali a Panzeri
e famiglia. E considerato il tramite tra il gruppo e i servizi marocchini.
Lo dimostra, per
esempio, una fotografia che ritrae l'europarlamentare italiano proprio in
compagnia di Atmoun e Cozzolino. Cozzolino, hanno ricostruito gli investigatori,
sulla base degli atti parlamentari ha poi avuto sempre una posizione in qualche
modo morbida, sicuramente più morbida rispetto al suo gruppo, nei confronti del
Qatar. Si è per esempio astenuto su nove emendamenti nella risoluzione del 24
novembre scorso sulla «situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del
mondo Fifa in Qatar».
Agli atti è
allegata, inoltre, una mail che lo stesso eurodeputato aveva inviato ai colleghi
prima del voto. «Vi ribadisco - aveva scritto - la mia posizione che ho portato
nell'incontro di ieri e vi chiedo di votare contro... Si sostiene che la Coppa
del Mondo sia stata assegnata dalla Fifa al Qatar grazie ad abusi e corruzione.
Il Parlamento europeo non dovrebbe accusare un Paese senza prove. E in ogni
caso, se vogliamo discutere di corruzione nello sport, allora forse sarebbe
necessario riflettere su tutto, compresa la Coppa del Mondo che si è giocata in
Germania nel 2006».
Una posizione che
aveva aperto anche uno scontro durissimo con i colleghi tedeschi. Cozzolino ha
spiegato a Repubblica che la sua è stata una posizione completamente «pubblica e
politica». E di non aver mai subìto alcuna pressione. I magistrati belgi però
dicono che vogliono approfondire la sua posizione (non risulta indagato) anche
sulla base delle dichiarazioni del suo assistente, Francesco Giorgi.
Nell'interrogatorio nel quale ha confessato, il braccio destro di Panzeri
risponde a una domanda ben precisa da parte del magistrato: «Chi ha preso denaro
da Panzeri? » gli viene chiesto. «È sempre Panzeri - risponde - che ha gestito
questi contatti. Io ho sospettato Tarabella, Cozzolino».
Netto invece il
parere su Moretti e Arena. «Non ne ho mai sentito parlare. Sono persone che
rispetto e credo che la loro integrità non c'entri nulla in questo contesto». A
Repubblica risulta che Moretti nell'ottobre scorso abbia effettuato un viaggio
in Qatar, come risulta dal suo profilo Twitter, con una Ong vicina al governo di
Doha. Gli investigatori stanno cercando traccia di questo viaggio: la segreteria
della sua assistente è, infatti, tra quelle sotto sequestro. E in queste ore si
sta spulciando nei documenti e nei computer. Nessuna domanda, invece, è stata
fatta a Giorgi sul ruolo di Benifei.
A conferma che il
principale collegamento è dato da alcuni ex collaboratori di Panzeri finiti poi
a lavorare con il capogruppo del Pd. E a proposito di assistenti, una delle
collaboratrici di Arena fa sapere di «non aver avuto alcuna collaborazione » con
Panzeri se non una collaborazione con la sua Ong, Fight Impunity. Ong cruciale
però nell'indagine. I belgi sostengono di avere le prove che nei conti correnti
della società siano arrivati direttamente fondi dal Qatar. A conferma che le
contabilità della corruzione sarebbero due: la prima, quella in contanti. La
seconda, quella che gira invece sui conti della Ong. Ed è proprio da quei conti
che sarebbero partiti, per l'impostazione iniziale della Procura, alcuni
bonifici per "ammorbidire" le posizioni di persone vicine alla cricca. Come ha
raccontato ieri Repubblica, Giorgi in uno dei suoi interrogatori ha confermato
ai magistrati che le Ong servivano proprio «a far girare il denaro».
Estratto
dell'articolo di Claudio Tito,Giuliano Foschini,Luca De Vito per “la Repubblica”
il 15 Dicembre 2022.
Non è una semplice
storia di corruttori e corrotti.
Il "Qatargate" sta
diventando un vero e proprio "Spy-game". Con un protagonista principale: il
Dged. Ossia, il servizio segreto marocchino. E una serie di coprotagonisti:
l'Intelligence del Belgio con la collaborazione di Paese alleati dell'Unione
europea, e il governo del Qatar. Con il Marocco e Doha nelle parti dei grandi
corruttori. O meglio dei grandi «infiltrati» dentro le istituzioni dell'Ue, in
particolare il Parlamento. E un solo obiettivo: condizionare l'Unione e farlo
attraverso l'arma convincente dei soldi e della corruzione.
È questo il disegno
che "Repubblica" è in grado di ricostruire e che viene tratteggiato nel mandato
di cattura con cui venerdì scorso sono stati fermati l'ex europarlamentare
Antonio Panzeri, la vicepresidete dell'Eurocamera, Eva Kaili, il suo assistente
e compagno, Francesco Giorgi, e il direttore generale della Ong "No Peace
Without Justice", Niccolo Figà Talamanca.
Tutto, allora nasce
cinque mesi fa. Gli 007 belgi, assistiti da altri servizi europei, vengono a
conoscenza che c'è una «rete» che lavora «per conto» del Marocco e del Qatar.
L'atto messo a punto dalla procura di Bruxelles mostra una incredibile dovizia
di particolari.
E una serie di
operazioni che vengono decise e concordate all'interno di un sistema rodato.
Ogni mossa infatti è volta a compiere una «attività di ingerenza» nelle sedi
dell'Ue e nei posti chiave delle istituzioni comunitarie, in particolare il
Parlamento.
Lo sfondo è il ruolo
di Rabat nel Sahara Occidentale e i flussi migratori. Il Marocco vuole che l'Ue
non si metta di traverso sull'occupazione di quel pezzo d'Africa e punta ad
avere meno problemi possibili dal punto di vista dei flussi dei migranti.
E in seno al Palazzo
che ha preso il nome di Altiero Spinelli c'è una parte politica decisamente
«influenzata»: il gruppo socialista di S&D. Attraverso una sorta di cricca
composta da tre italiani: Panzeri, Cozzolino (europarlamentare) e Giorgi. Anche
se alcuni media della Grecia, addirittura ipotizzano che dentro il Parlamento
europeo potrebbero essere una sessantina i nomi coinvolti.
Il più attivo nel
cercare l'«influenza» è comunque lo «Stato del Marocco». Incontri, colloqui,
cene con i più alti dirigenti dei servizi segreti di Rabat sono una costante di
questo sistema. La "cricca", infatti, è stata agganciata prima da un ufficiale
del Dged, di stanza a Rabat la capitale del paese magrebino. Si tratta di
Belharace Mohammed, il quale ha potuto contare sulla intermediazione anche di un
diplomatico di base a Varsavia: Abderrahim Atmoun. A dimostrazione che si
trattava di una macchinazione di Stato a pieno titolo.
Tutte informazioni
in un primo momento raccolte dal Vsse, ossia dai servizi segreti del Belgio. Nel
mandato di cattura, infatti, si riportano le analisi dell'intelligence
brussellese: i tre della "cricca" collaborano con i servizi marocchini, è «fuori
di dubbio».
Il ruolo del
diplomatico di Rabat che si muove lungo l'asse Varsavia- Bruxelles, è centrale.
Tutti, alla fine, prendono ordini da lui.
Ma c'è un anello che
è ancora più importante in questa catena che si è stretta intorno
all'Europarlamento: Mansour Yassine, direttore generale del Dged. I tre lo hanno
incontrato. Cozzolino lo ha fatto ad esempio diverse volte e almeno in una
sarebbe andato in Marocco, nel 2019. Secondo la ricostruzione dei pm belgi,
infatti, un ufficiale dell'intelligence marocchina ha prenotato due biglietti
aerei sul volo Alitalia Casablanca- Roma del 2 novembre 2019 e sulla successiva
tratta Roma-Napoli. Su questo, le "spie" del Belgio hanno però un dubbio: non
sanno con certezza se Cozzolino sia effettivamente salito sull'aereo. Ma nella
descrizione fatta dai magistrati sembra quasi una cautela più che un dubbio.
Tanto che, riportando sempre le informazioni del Vsse, raccontano che anche
Panzeri è volato verso lo stato magrebino per incontrare ancora lo stesso
Mansour. In questo caso era il luglio del 2021.
Ma l'aspetto più
interessante è la motivazione che viene assegnata a questo colloquio: discutere
la «strategia» del Parlamento europeo. E condizionarla. Anche in questo caso gli
007 si prendono una prudenza: non confermano che il colloquio sia effettivamente
avvenuto. Ma che sia stato organizzato sì. Resta il fatto che ogni scelta di
Atmoun, il diplomatico, è stata organizzata con Panzeri e/o Cozzolino. In una
rete di cui faceva parte anche Figà Talamanca, il vertice della Ong "No Peace
without justice".
(...)
All'interno di
questo quadro, Francesco Giorgi (compagno della ex vicepresidente del Parlamento
europeo, la greca Kaili) veniva identificato come una sorta di «agente» di
Panzeri. Almeno i Servizi marocchini lo utilizzavano in quel modo. Ma erano
Cozzolino e Panzeri a gestire l'accordo: al fine di consentire «l'ingerenza del
Marocco ».
Il sistema del Qatar
non cambiava molto. Le regole, alla fine, erano le stesse. E gli obiettivi
analoghi. In questo caso gli obiettivi sono quelli di rendere accettabili le
procedure adottate da Doha sui lavoratori. In particolare quelli impegnati nella
costruzione dei mondiali di calcio e quelli messi al servizio
dell'organizzazione della competizione calcistica ormai giunta alla partita
finale.
Le autorità qatarine
sono persino più dirette di quelle marocchine. Non usano direttamente le spie.
Ma ricorrono al governo. Gli incontri, infatti, sono fatti con il ministro del
lavoro, Bin Samikh al Marri. E il tutto avviene - secondo il mandato di cattura
- con l'aiuto di un personaggio misterioso. Lo chiamano Bettahar. Ma il
soprannome è ancora più opaco: «l'Algerino ».
Certo - si
sottolinea - il Qatar non aveva gli stessi obiettivi del Marocco. A loro
interessava soprattutto curare l'immagine del paese in relazione ai diritti
civili.
Gli inquirenti, poi,
non hanno dubbi: Panzeri e Giorgi dividevano tutto al 50%. E il resto era per
Figà Talamanca. Insomma «l'obiettivo erano i soldi». La "cricca" riceveva
pagamenti per le sue attività. Come? In due modi quando venivano Doha:
attraverso i conti della Ong Fight Impunity o addirittura i contanti. O con
qualche "regalo".
Quando il
finanziatore era Rabat, allora non si andava per il sottile: la moneta in
contanti veniva trasferita in alcune buste o borsoni attraverso la
intermediazione del diplomatico di stanza in Polonia Atmoun. Una modalità da
"spallone". Un passaggio da Varsavia verso Bruxelles.
(ANSA il 15 Dicembre
2022) - A dare il via all'inchiesta Qatargate, che sta terremotando il
Parlamento europeo, sarebbe stata una segnalazione arrivata dagli Emirati Arabi
Uniti all'intelligence del Belgio che per mesi ha lavorato con i servizi segreti
di altri 5 Paesi, ma non con quelli dell'Italia, "che sarebbero stati esclusi
dall'operazione nonostante tutto sembri ruotare attorno a figure di nazionalità
italiana".
E' quanto
ricostruisce il Corriere della Sera in un articolo pubblicato oggi. La
segnalazione degli Emirati, scrive il Corriere, "ha portato gli 007 sulle tracce
di un centro di studi del Marocco a Bruxelles dietro il quale si nascondeva una
centrale di spionaggio.
I servizi belgi
hanno appurato che il centro culturale aveva collegamenti con l'ambasciatore
marocchino in Polonia Abderrahim Atmoun che nelle carte dell'inchiesta è citato
come colui al quale Panzeri doveva affidare dei regali da lui ricevuti affinché
fossero trasferiti in Marocco".
"Partito nel 2021
come un caso di 'sicurezza nazionale' per la minaccia di interferenza da parte
di un Paese straniero sui processi decisionali del Parlamento europeo - continua
il Corriere - il dossier evidentemente ad un certo punto perde di pericolo e si
trasforma in una questione di corruzione internazionale, altrettanto grave, ma
meno allarmante per gli 007 locali che lo passano alla magistratura ordinaria. I
magistrati ci lavorano e puntano anche ai rapporti con il Qatar, specie della
vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili".
Estratto
dell’articolo di Giuseppe Salvaggiulo e Monica Serra per “La Stampa” il 15
Dicembre 2022.
[…] Il 19 luglio,
dopo una «ispezione clandestina» in casa Panzeri, un dettagliato rapporto è
stato consegnato nelle mani del giudice istruttore Michel Claise. […] Quando,
una settimana fa, ha ordinato ai poliziotti dell'Ufficio centrale per la
repressione della corruzione di fare irruzione nella residenza di Antonio
Panzeri, ex eurodeputato di Pd e Articolo 1, e del suo ex assistente Francesco
Giorgi, ha agito a colpo sicuro. Sapevano che avrebbero trovato il tesoro in
contanti già visto nella «ispezione clandestina».
Contattata dal
quotidiano belga Le Soir, l'agenzia di sicurezza non ha confermato. Ma lo ha
fatto il ministro della Giustizia Vincent Van Quickenborne, definendo l'indagine
«un punto di svolta» e plaudendo all'uso efficace di tecniche investigative già
sperimentate con successo contro la mafia, come il cracking dei telefoni
criptati.
[…] Qatar e Marocco,
dunque, ma forse le «innumerevoli interferenze straniere» sono anche altre. In
estate un report del Copasir, richiamato ieri dal ministro Adolfo Urso che
allora lo presiedeva, aveva certificato «ingerenze di Qatar, Emirati, Arabia
Saudita e altri Paesi».
L'inchiesta procede
seguendo le tracce dei soldi. A Bruxelles, come a Milano, dove sabato è arrivato
un ordine di investigazione europeo finito sulla scrivania del procuratore
aggiunto Fabio De Pasquale, a capo del pool Anticorruzione internazionale.
Immediate sono scattate le perquisizioni dell'aliquota di polizia giudiziaria
della Guardia di finanza e gli accertamenti su sette diversi conti correnti
bancari italiani, riconducibili alla famiglia di Panzeri, al suo ex assistente
Giorgi, e al segretario del sindacato mondiale (Ituc) Luca Visentini,
inizialmente fermato, poi rilasciato dagli investigatori belgi.
I movimenti su quei
conti potrebbero fornire nuovi spunti per ricostruire che giro facessero i soldi
che, a palate, arrivavano dal Qatar. O magari altre conferme alle ipotesi di
un'indagine che continua ad allargarsi. E che punta a identificare tutti i nomi
degli europarlamentari che - questa è l'ipotesi - a partire almeno dal gennaio
2021 erano a libro paga dell'organizzazione criminale che ruotava attorno alla
Ong Fight Impunity e alla figura di Panzeri.
Nella sua casa di
famiglia, a Calusco sull'Adda, 8 mila abitanti nella Bergamasca, la Guardia di
Finanza milanese ha sequestrato orologi di valore, computer, cellulari e 17 mila
euro in contanti nascosti nell'armadio, mentre la moglie Maria Dolores Colleoni
e la figlia Silvia, assistite dall'avvocato Angelo De Riso, sono ai domiciliari
in attesa delle udienze del 19 e 20 dicembre, in cui la Corte d'Appello di
Brescia deciderà sulla loro estradizione.
Denaro cash come i
20 mila euro sequestrati a Giorgi.
Nella villetta dei
suoi genitori, in una strada tranquilla e residenziale di Abbiategrasso, a una
ventina di chilometri da Milano, dov' è cresciuto e dove ha vissuto fino
all'università, quando poi è partito per far carriera da assistente parlamentare
a Bruxelles, i finanzieri domenica sera hanno trovato la chiave di una cassetta
di sicurezza. La filiale della banca chiaramente nel weekend era chiusa. Ci sono
tornati martedì e hanno trovato 20 mila euro, sempre in contanti.
Sarà quasi
impossibile scoprire da dove siano arrivati quei soldi e quando Giorgi li abbia
chiusi in quella cassetta. Viceversa parte dei soldi trovati a Bruxelles, sia in
casa Panzeri che in casa Giorgi, hanno lasciato una traccia. La fascetta che li
avvolgeva consente di risalire ai conti correnti belgi da cui sono state
prelevati.
Ciò potrebbe
permettere di identificare chi li abbia consegnati a Panzeri, nella doppia
presunta veste di corrotto e corruttore di altri parlamentari e funzionari.
Soldi di cui Eva Kaili, compagna di Giorgi ed ex vicepresidente socialista del
Parlamento europeo, continua a dire di non sapere niente. Inoltre riferisce
tutte le sue iniziative sul Qatar come «pianificate ai più alti livelli
dell'Ue». Una strategia difensiva che, unita alla richiesta di rinvio
dell'udienza di convalida dell'arresto, pare delineare la volontà e il tentativo
di sganciarsi dal destino processuale di Giorgi.
Metodo Doha. L’Ue
non è l’unico bersaglio della corruzione del Qatar.
Valerio Moggia su
L’Inkiesta il 16 Dicembre 2022.
Lo scandalo che ha
travolto Bruxelles e le sue istituzioni è solo l’ultimo di una serie di casi
sospetti che vede coinvolto il piccolo Paese mediorientale
Il Qatargate che ha
travolto le istituzioni europee dovrà passare dalle mani di giudici e avvocati
ma è già diventato una delle storie più insolite e delicate per
europarlamentari, commissari, funzionari di Bruxelles e varie famiglie
politiche. Sull’altra riva del fiume, invece, i sospetti di corruzione fanno
ormai parte dello scenario locale: la famiglia reale del Qatar da anni è
abituata a destare sospetti, a far discutere per i suoi modi di fare politica e
di costruire relazioni con Stati e istituzioni.
Prima che il
dibattito si spostasse sui diritti Lgbtq+ o sulle morti dei lavoratori, si era
parlato dei Mondiali in Qatar per le accuse sull’assegnazione del torneo al
piccolo Paese del Golfo. Già nel giugno 2011, a sei mesi dalla decisione della
Fifa, il Sunday Times denunciava l’opera di corruzione del Qatar nei confronti
dei leader delle federazioni del calcio africano: Issa Hayatou, che dal 1988 era
a capo della Caf, l’omologa africana della Uefa, aveva ricevuto un milione e
mezzo di dollari per votare per la Coppa del Mondo in Qatar. La stessa cosa era
successa anche con altri due grandi nomi della politica del calcio africano,
l’ivoriano Jacques Anouma e il nigeriano Amos Adamu.
Che gran parte
dell’Africa abbia sostenuto la candidatura di Doha non ha mai stupito nessuno.
Dal 2007, il governo del Qatar, attraverso la prestigiosa Aspire Academy, versa
grandi quantità di denaro nelle casse delle federazioni locali grazie al
progetto Football Dreams, ufficialmente un programma di scouting per reclutare
giovanissimi talenti da far crescere a Doha. Da quando è stato lanciato, questo
programma – che per il Qatar è uno “strumento umanitario” per togliere i giovani
dalla povertà – ha ricevuto numerose accuse, da chi lo considera uno strumento
di sfruttamento delle risorse umane dell’Africa a chi invece lo ritiene una leva
del soft power di Doha, oltre che un metodo per corrompere la politica locale.
D’altronde, il
confine tra politica e corruzione è spesso labile: in quale momento investire in
un determinato settore o Paese per ricavarne benefici più o meno diretti smette
di essere legittimo? Tra i principali difensori del Qatar in questi giorni c’è
per esempio Paul Kagame, il noto Presidente del Ruanda, che è anche accusato di
repressione del dissenso. Kagame è volato a Doha a inizio Mondiali per salutare
l’emiro, e più di recente ha dichiarato che contro il Paese arabo c’è stato un
«incessante assalto di propaganda negativa». Il leader del Ruanda difende il
Qatar in maniera non tanto dissimile da quanto fatto da Eva Kaili al Parlamento
europeo: dopotutto, la famiglia Al Thani sta investendo tantissimo nel nuovo
aeroporto di Kigali e nello sviluppo del turismo nel Paese africano, al punto
che lo sponsor “Visit Rwanda” campeggia sulle maglie del Paris Saint-Germain.
Ma non è solo
l’Africa, ovviamente. In questi anni il Qatar avrebbe corrotto dirigenti
sportivi in quasi tutto il mondo, anche nell’area Concacaf, quella del Nord e
Centro America. Sempre nel 2011, una nuova indagine fece emergere un piano di
corruzione che coinvolgeva Jack Warner, l’uomo più potente del calcio di questa
regione, presidente Concacaf dal 1990. D’accordo con Mohamed bin Hammam,
presidente della confederazione asiatica e capo assoluto del calcio in Qatar,
Warner avrebbe organizzato alcuni incontri con i leader delle federazioni
caraibiche durante i quali Bin Hammam avrebbe avuto modo di corrompere diverse
persone. In cambio, il dirigente qatariota voleva i voti per essere eletto
presidente della Fifa al posto di Blatter, e guidare così l’associazione durante
gli storici Mondiali del 2022, di cui lui stesso era in un certo senso il vero
ideatore.
Non c’è un
continente che non abbia ricevuto soldi dal Qatar, a quanto pare, e pure le
ultime rivelazioni sull’Europa in realtà suonano nuove fino a un certo punto.
Nell’estate 2015, Joseph Blatter, a sua volta al centro all’epoca di accuse di
corruzione, assicurò che dietro l’assegnazione del Mondiale al Paese arabo c’era
lo zampino addirittura del Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy.
Sarebbe stato lui a organizzare il famigerato pranzo all’Eliseo a cui erano
presenti, oltre allo stesso Blatter, anche il capo della Uefa Michel Platini e
l’allora principe qatariota (oggi emiro) Tamim bin Hamad Al Thani. E in
quell’occasione si sarebbero formalmente decise sia l’impegno della UEFA per
indirizzare il voto delle federazioni europee verso Doha, sia l’acquisizione del
PSG da parte del fondo sovrano qatariota. Blatter dice che, oltre a questo, ci
fu un altro intervento decisivo della politica europea in favore del Qatar, e fu
portato avanti da Christian Wulff, ai tempi Presidente federale della Germania.
Il quadro che ne
emerge è abbastanza inquietante, e racconta bene la pervasività del potere
qatariota nel mondo. Attraverso l’economia, Doha ha saputo rendersi
indispensabile in varie aree strategiche del pianeta, e i Mondiali sono stati
solo uno dei banchi di prova di questa rete di relazioni. Ma parlare di
corruzione non è mai facile. Tutte le accuse piovute addosso al Qatar in questi
ultimi dodici anni non hanno infatti avuto alcuna conseguenza legale concreta.
La Fifa aveva anche
affidato un’inchiesta interna all’avvocato indipendente Michael Garcia, che si
era avvalso della collaborazione di Phaedra Almajid, la fonte della prima
inchiesta del Sunday Times del 2011, poi costretta a ritrattare (pare) dietro
minacce. Nel settembre 2014, dopo oltre due anni di lavoro, Garcia consegnò il
suo report sulla controversa assegnazione dei Mondiali in Qatar al responsabile
etico della Fifa Hans-Joachim Eckert, ma quando il documento venne pubblicato
l’autore lamentò che fosse stato pesantemente tagliato, alterando il senso del
suo lavoro. Lo scandalo che sembrava aver provato la volontà della Fifa di
nascondere la polvere sotto il tappeto finì però per sgonfiarsi nel 2017, quando
la Bild diffuse il report completo, rivelando che non conteneva nulla più che
supposizioni e testimonianze, e nessuna prova.
Per cui, mentre i
Mondiali in Qatar stanno per terminare, l’unica cosa certa che possiamo dire
sulla corruzione di Doha è che tutti assicurano esista, ma nessuno l’ha mai
dimostrato. Ogni probabilità di ribaltare questo trend risiede oggi nelle borse
piene di contanti rinvenute in casa dei funzionari di Bruxelles.
Scandalo
corruzione Qatar, tutti i nomi delle persone coinvolte nell’Europarlamento.
YOUSSEF HASSAN HOLGADO su Il Domani il 15 dicembre 2022
Tutti i nomi dei
funzionari europei e dei loro assistenti. Nelle ultime ore lo scandalo si è
allargato anche ad alcuni rapporti con i servizi segreti del Marocco
Man mano che passano
i giorni emergono nuovi nomi di persone coinvolte nell’inchiesta della polizia
belga sul caso di corruzione riguardo alcuni funzionari dell’europarlamento che
in cambio di soldi hanno perseguito gli interessi del Qatar e del
Marocco all’interno dell’Unione europea. Ma chi sono le persone coinvolte? Dal
quadro investigativo iniziale ai vertici della rete c’erano tre persone: Antonio
Panzeri, Francesco Giorgi ed Eva Kaili. Altri personaggi, invece, hanno ruotato
intorno alla rete come Niccolo Figà Talamanca a capo della Ong No peace without
justice e altri assistenti europarlamentari.
Le accuse formali
nei confronti degli indagati sono di associazione a delinquere, corruzione e
riciclaggio di denaro. Più di un milione di euro sarebbe stato trovato durante
le perquisizioni insieme a gioielli e beni di lusso. Gli inquirenti non
escludono che parte dei soldi veniva poi distribuita ad altri europarlamentari e
dall’interrogatorio a Giorgi sperano di ottenere nuovi nomi.
ANTONIO PANZERI
Quando lo scorso 9
dicembre è stata diffusa la notizia dello scandalo, il primo nome a essere stato
reso pubblico è stato quello di Antonio Panzeri. Ex europarlamentare del gruppo
dei Socialisti e democratici (S&D) a capo anche della commissione diritti umani,
Panzeri è considerato uno dei vertici del gruppo accusato di corruzione. Durante
le perquisizioni la polizia belga ha trovato circa 500mila euro in contanti
nella sua casa in Belgio, altri soldi sono stati invece trovati nella sua
abitazione in Italia. Sempre in Italia sono state arrestate anche la figlia
Silvia Panzeri e la moglie Maria Colleone.
La carriera politica
di Panzeri ruota attorno al mondo del sindacato e della sinistra italiana. Molto
vicino all’ex presidente del Consiglio Massimo D’alema, Panzeri è stato
responsabile delle politiche europee della Cgil e nel 2004 ha iniziato la sua
carriera all’interno dell’Europarlamento. In Italia era nelle file del Partito
democratico prima di passare ad Articolo 1, che ha già fatto sapere di averlo
espulso dagli iscritti.
Da quando ha smesso
la sua attività da europarlamentare, Panzeri è entrato nel board
dell’Associazione ex dipendenti europei mentre in Belgio fonda l’organizzazione
Fight Impunity che nel suo honorary board contava figure di rilievo come l’ex
commissario alle Migrazioni, il greco Dimitris Avramopoulos, e l’ex
rappresentante per la politica estera Federica Mogherini, oltre all’ex primo
ministro francese Bernard Cazeneuve.
EVA KAILI
L’eurodeputata greca
è una dei 14 vice presidenti del parlamento europeo. Attualmente si trova agli
arresti ed è accusata anche lei di corruzione. Ad Atene le autorità greche hanno
congelato i suoi beni ma per il suo avvocato «il denaro che è stato trovato
nella sua casa (cica 150mial euro ndr.) non le apparteneva, Giorgi è l'unico che
può fornire risposte sula loro esistenza di cui lei non ne sapeva nulla». In un
primo momento la polizia belga aveva anche fermato il padre di Kaili, poi
rilasciato dopo poche ore, mentre trasportava centinaia di migliaia di euro in
contanti.
Nel mirino uno dei
suoi ultimi discorsi al parlamento europeo in difesa del Qatar pronunciato lo
scorso 21 novembre, a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di calcio: «Signora
presidente, oggi i mondiali di calcio in Qatar sono la prova di come la
diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un paese con
riforme che hanno ispirato il mondo arabo. Ho solo detto che il Qatar è
all'avanguardia nei diritti del lavoro, abolendo la kafala e riducendo il
salario minimo. Nonostante le sfide che anche le aziende europee stanno negando
per far rispettare queste leggi, si sono impegnati in una visione per scelta e
si sono aperti al mondo. Eppure, alcuni qui chiedono di discriminarli. Li
maltrattano e accusano di corruzione chiunque parli con loro o si impegni. Ma
nonostante ciò, prendono il loro gas. Eppure, le loro aziende vi traggono
profitti miliardari. Da greca ho ricevuto una lezione e ricordo a tutti noi che
abbiamo migliaia di morti a causa del nostro fallimento nel trovare vie legali
di migrazione in Europa. Possiamo promuovere i nostri valori, ma non abbiamo il
diritto morale di fare conferenze per ottenere un'attenzione mediatica a buon
mercato. E non imponiamo il nostro modo di fare, lo rispettiamo, anche senza
Lng. Sono una nuova generazione di persone intelligenti e istruite. Ci hanno
aiutato a ridurre la tensione con la Turchia. Ci hanno aiutato con l'Afghanistan
per salvare attivisti, bambini, donne. Ci hanno aiutato. E sono negoziatori di
pace. Sono buoni vicini e partner. Possiamo aiutarci l’un l’altro a superare le
nostre carenze. Hanno già raggiunto l’impossibile».
FRANCESCO GIORGI
Giorgi è il collante
tra Panzeri ed Eva Kaili. Ex assistente del primo e compagno della seconda – con
al quale ha anche una figlia – avrebbe confessato di aver gestito i soldi
dell’organizzazione pur percependo circa 2500 euro mensili dalla sua attività di
assistente. Giorgi è stato incriminato e incarcerato dal giudice Michel Claise
per corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un’organizzazione
criminale.
Nella sua casa di
Abbiategrasso la guardia di finanza di Milano ha trovato circa 20mila euro in
contanti. Attualmente Giorgi è l’indagato che sta fornendo il quadro più chiaro
della situazione. Agli inquirenti avrebbe anche suggerito altri nomi da
approfondire e secondo quanto riporta Repubblica sarebbero Marc Tarabella e
Andrea Cozzolino (di cui Giorgi è assistente), entrambi europarlamentari del
gruppo Socialisti e democratici ma non indagati.
NICCOLO FIGÀ
TALAMANCA
C’è un quarto
personaggio ed è l’italiano Niccolo Figà-Talamanca che si trova in regime di
sorveglianza elettronica (braccialetto) con l’accusa di aver avuto un ruolo
nella spartizione del denaro. È il direttore generale dell’Ong No peace without
justice che secondo gli inquirenti insieme alla Ong di Panzeri Fight Impunity
raccoglieva parte del denaro qatarino.
MARC TARABELLA
Tarabella è
vicepresidente della delegazione del parlamento europeo per le relazioni con la
penisola arabica. La sua casa è stata perquisita dalla polizia belga nei giorni
scorsi ma non è ancora indagato. Per il momento si è autosospeso dal gruppo dei
Socialisti e Democratici.
LUCA VISENTINI
Luca Visentini è
stato il segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (Etuc)
prima di assumere, da novembre, la guida di quella internazionale (International
Trade Union Confederation). È stato rilasciato dopo poche ore dalla polizia
belga. In diverse interviste, tra cui anche una a Domani, ha negato un suo
coinvolgimento nella vicenda. «Io sono stato coinvolto perché ho partecipato ad
alcune iniziative di Fight Impunity – ha spiegato – questa associazione, che era
riconosciuta dal Parlamento europeo, che veniva condotta da parlamentari in
carica o ex eurodeputati, e che per quanto io ne sapevo e per quanto fosse
pubblicamente noto era una fondazione che si occupava di difesa dei diritti
umani, a quanto pare, in base alle indagini in corso, sembrerebbe che in realtà
fosse una organizzazione criminale finanziata dal governo del Qatar per
corrompere in particolare i membri dell’Europarlamento e per indurli a prendere
posizioni più favorevoli nei confronti del governo del Qatar. Il mio nome è
finito in questa indagine per la mia partecipazione a quelle iniziative: sono
stato accusato di essere parte di questa organizzazione, di essere stato
corrotto da loro per ammorbidire le posizioni mie e della confederazione
sindacale internazionale (Ituc) nei confronti del Qatar».
ANDREA COZZOLINO
Il nome più caldo
nelle ultime ore è quello di Andrea Cozzolino, che secondo Giorgi sarebbe
coinvolto nelle relazioni tra Panzeri e i servizi segreti del Marocco,
interessati a fare pressioni sugli europarlamenti per evitare interferenze di
Bruxelles sulla questione del Sahara occidentale. Attualmente Cozzolino non è
indagato e in alcune sue dichiarazioni nega un suo coinvolgimento dicendo che si
tratta di politica ed è tutta attività pubblica. Nel mirino degli inquirenti una
sua mail inviata ad alcuni colleghi in vista del 24 novembre scorso sulla
«situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo Fifa in Qatar».
Nel testo scriveva: «Vi ribadisco la mia posizione che ho portato nell'incontro
di ieri e vi chiedo di votare contro... Si sostiene che la Coppa del Mondo sia
stata assegnata dalla Fifa al Qatar grazie ad abusi e corruzione. Il Parlamento
europeo non dovrebbe accusare un paese senza prove. E in ogni caso, se vogliamo
discutere di corruzione nello sport, allora forse sarebbe necessario riflettere
su tutto, compresa la Coppa del Mondo che si è giocata in Germania nel 2006».
GLI ALTRI NOMI
Tra gli uffici
perquisiti dagli inquirenti anche quelli dell’ex assistente
dell’eurodeputato Pietro Bartolo ora con Lara Comi, e di Alessandra Moretti.
Anche l’ufficio dell’assistente dell’eurodeputata Marie Arena è stato sigillato.
Arena si è dimessa dalla carica di presidente della sottocommissione per i
diritti umani ma non è stata interrogata dagli inquirenti e non risulta
indagata. Per il momento anche Bartolo e Cozzolino si sono dimessi dai loro
incarichi ma non da europarlamentari.
YOUSSEF HASSAN
HOLGADO. Giornalista di Domani. È laureato in International Studies
all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della
Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si
occupa di Medio Oriente e questioni sociali.
Quel trilione
"scomparso" che può essere usato per colpire l'Occidente.
Il trilione di
dollari di surplus delle autocrazie può aiutarle a sfidare l'Occidente. Occhio a
Cina, Russia, Arabia Saudita: ecco come si muovono i flussi finanziari. Andrea
Muratore il 16 Dicembre 2022 su Il Giornale.
400 miliardi di
dollari la Cina, massima potenza esportatrice industriale globale, 250 la
Russia che guadagna dal boom dei prezzi energetici nonostante le sanzioni; 200
l'Arabia Saudita con le maggiori risorse petrolifere mondiali; 150 i miliardi
scomparsi dai T-Bond Usa: il "trilione scomparso" dalle autocrazie è il
tesoretto che può rivolgersi verso l'Occidente in termini di spesa clientelare,
investimenti, acquisizioni.
Un tempo i regimi
autoritari non avevano altro desiderio se non riversare nei mercati occidentali
i loro introiti da commercio o produzione. Le entrate del surplus commerciale
cinese finivano in asset, infrastrutture, imprese e fondi; la Russia ha
diversificato ovunque, dalle squadre di calcio al lusso, creando feudi come
"Londongrad". L'Arabia Saudita e le altre monarchie del Golfo, come Qatar e
Emirati Arabi Uniti, sono la patria dei celebri "petrodollari" riversatisi nella
finanza e nel real estate. Oggi invece gli investitori notano che tra
disinvestimenti, sanzioni (nel caso russo) e ricerche di altri mercati, complice
la fine del periodo occidentale di vacche grasse, l'ammontare di risorse
dirottato da questi mercati è inferiore di un trilione di dollari rispetto alle
aspettative.
Repubblica ha
analizzato questo tema ricordando che le autocrazie sono in surplus, le
democrazie in deficit commerciale. E questo si riflette sulla bilancia dei
pagamenti, caduta in rosso perfino per la virtuosa Germania: "Gli ultimi
sommovimenti dell'economia mondiale e, in particolare, il boom dei prezzi dei
beni energetici hanno aperto buchi nella bilancia dei pagamenti non solo di
paesi cronicamente in deficit nei conti esteri, come gli Stati Uniti, ma anche
in Gran Bretagna e - novità - anche in chi, normalmente, è in condizioni di
surplus, come l'Unione europea e il Giappone". Questo modifica notevolmente
l'indirizzo degli investimenti diretti esteri.
Xi Jinping può
permettersi di siglare in Arabia Saudita accordi miliardari; la Russia elude le
sanzioni difendendo il cambio sul rublo; l'Arabia Saudita investe in Saudi
Vision 2030 e progetta nuove strategie costose. L'Europa e gli Usa invece si
litigano quote di mercato, innovazione, talenti. E non riescono a controbattere
con piani e strategie come il Global Gateway a progetti quali la Belt and Road
Initiative.
L'Occidente globale
è in deficit e il pallino del gioco della partita della gestione del debito
mondiale, anche per colpa dell'inflazione, non è più in mano sua. Le altre
nazioni dirottano altrove i propri investimenti: il reshoring e la
deglobalizzazione orientano anche le mosse delle autocrazie che hanno
partecipato alla grande festa dei mercati globali finché è stato loro possibile.
Ora invece i loro
fondi "potrebbero servire a rinsaldare influenze politiche. A puntellare il
regime di Erdogan nella Turchia sommersa da una inflazione non lontana dalla tre
cifre, nel caso della Russia. A sostenere il traballante Egitto di Al Sisi, per
i paesi arabi. O il Pakistan in ginocchio, per la Cina": una vera e
propria finanza "autoritaria" parallela capace di sfidare in termini di potere e
attrattiva quella occidentale basata sul Fondo monetario internazionale.
Non sono blocchi
fissi ovviamente, ma l'Occidente è economicamente sotto assedio. Fiaccato dalla
Grande recessione, dal Covid, dalla crisi energetica e dal ritorno
dell'inflazione il suo modello non è più l'epicentro globale degli investimenti.
La lunga fase di vacche grasse finanziarie ha coperto il problema degli
investimenti in conto capitale, della corsa del resto del mondo all'innovazione,
della dipendenza energetica da Russia e Medio Oriente, della difficoltà nella
proiezione fuori dal blocco coincidente col G7.
Il "trilione
scomparso" si è diretto altrove, cercando obiettivi politici: il potenziamento
dell'influenza e la ripresa dell'espansione commerciale (Cina), la difesa dalle
sanzioni e la costruzione di hub energetici non occidentali (Russia), il riarmo
e la proiezione geopolitica regionale (Arabia Saudita). Tre strategie con un
unico comune denominatore: portare le risorse lontane da un Occidente che tra
reshoring e crisi è in difficoltà.
Parliamo di una
minaccia che sottende un'opportunità: vincolare con maggior forza democrazia e
mercati rinnovati e più sicuri anche politicamente dalle proiezioni straniere.
Un'opportunità che, scrutinando investimenti e promuovendo il friend-shoring nei
settori chiave (dalla transizione ai chip) l'Europa e gli Usa possono
sviluppare, a patto di cooperare. E pare proprio questo, alla luce degli ultimi
sviluppi, lo step più grande da superare per contrapporre un fronte unito alla
frastagliata avanzata finanziaria delle autocrazie.
I "copia e
incolla" dell'ong di Panzeri per ottenere finanziamenti a sei zeri.
Così l'ex
deputato del Pd riusciva ad ottenere fondi europei preclusi alla maggioranza
delle associazioni, senza presentare mai bilanci. Luca Fazzo il 16 Dicembre 2022
su Il Giornale.
Pochi mesi per
scrivere quattrocento pagine di rapporto sulle violazioni dei diritti umani
nell'intero pianeta: e per incassare un finanziamento da duecentomila euro dal
Parlamento europeo. Tra i miracoli di Fight Impunity, la ong fondata dall'ex
eurodeputato pd Antonio Panzeri, c'è anche la sorprendente rapidità con cui ai
suoi esordi la ong sforna il suo rapporto, pubblicandolo attraverso una piccola
casa editrice milanese. Un esempio di superefficienza o, come appare più
probabile, un clamoroso «copia e incolla».
Ad analizzare la
vicenda è ieri Le Soir, il quotidiano belga che per primo ha portato allo
scoperto il Qatargate. E che ieri definisce senza mezzi termini la Ong di
Panzeri «il paravento ideale per attività sospette».
Tra le tante
anomalie della associazione - nel cui board fino al momento dello scandalo
sedevano nomi prestigiosi, da Federica Mogherini a Emma Bonino al premio Nobel
Denis Mukwege - c'è che nei tre anni trascorsi dalla sua fondazione, il 25
settembre 2019, Fight Impunity non ha mai depositato il suo bilancio al
tribunale di Bruxelles. Al terzo anno in teoria si dovrebbe venire cancellati,
ma in questo caso non è successo.
Anzi, la ong riesce
in breve tempo a ottenere aiuti che enti ben più noti faticano a incassare.
Dalla sua, ha il tessuto di relazioni creato da Panzeri in tre mandati da
europarlamentare e l'appoggio esplicito di suoi cari amici come la deputata
belga Marie Arena. Secondo Le Soir, le richieste di finanziamenti a Fight
Impunity vennero sponsorizzate oltre che dalla Arena da Isabel Santos,
portoghese, anche lei deputata del gruppo Socialisti & Democratici. Il 23
febbraio 2021, ad appena un anno e mezzo dalla sua fondazione, Fight Impunity si
vede assegnare 175mila euro di finanziamento. Una performance che lascia di
sasso gli esperti del settore intervistati dal quotidiano belga.
A stupire è in
particolare la storia del rapporto «Impunità nel mondo» pubblicato da Fight
Impunity alla fine del 2020, e presentato al Parlamento in bozze l'11 dicembre
2020. Quando l'anno dopo va in stampa, assomma a 430 pagine. Nel mondo dei
difensori dei diritti umani, che una struttura neonata partorisse in poche
settimane una simile fatica destò un certo stupore. Le Soir sottolinea come il
libro in realtà nell'introduzione appaia realizzato da un'altra realtà,
l'Associazione Società Informazione onlus, e i diritti appartengano alla casa
editrice milanese Milieu. La quale in realtà avrebbe ricevuto il file dalla ong
di Panzeri e si sarebbe limitata a farlo stampare in poche centinaia di copie.
Quindi Fight
Impunity si limita a copiare il rapporto annuale che dal 2003 viene realizzato
da Società Informazione e da Diritti Globali, dietro i quali ci sono la Cgil e
numerose altre sigle sindacali. Tra queste la Ituc, la federazione
internazionale il cui segretario era il friulano Luca Visentini, arrestato
insieme a Panzeri e scarcerato poco dopo. Grazie al «copia e incolla» del
rapporto Fight Impunity si accredita ancora di più a Bruxelles. E iniziano a
fioccare i quattrini.
Meloni: caso
devastante Metsola: no a impunità. Nel Pd caccia ai sospetti.
Al vertice Ue la
presidente invoca riformee niente sconti. Ma è resa dei conti tra partiti. Laura
Cesaretti il 16 Dicembre 2022 su Il Giornale.
«L'inchiesta è un
danno per la democrazia, l'Europa e ogni cosa per cui combattiamo. Servono anni
per costruire la fiducia, ma un momento per perderla». La presidente del
Parlamento europeo Roberta Metsola, al vertice Ue, usa parole ben pesate e
drammatiche per avvertire del pericolo che il dilagare dello scandalo comporta.
Non tanto per la reputazione dei singoli personaggi coinvolti o dei loro
partiti, ma per l'idea stessa di Europa e di società aperta, assediata da regimi
illiberali che vorrebbero distruggerla. Metsola promette un «pacchetto di
riforme» per impedire l'infiltrazione di interessi politico-economici esterni, e
intanto l'aula da lei presieduta approva a tempo di record, e con una
schiacciante maggioranza (541 sì due i contrari e tre gli astenuti) una
risoluzione che denuncia lo scandalo e chiede la sospensione di tutti i
fascicoli relativi al Qatar e dell'accesso alle istituzioni europee ai
rappresentanti dell'Emirato. «Questo non è business as usual - sottolinea la
presidente Metsola - farò tutto quello che posso per ripristinare la posizione
della casa della democrazia come legislatore, come istituzione che prende
decisioni, che è trasparente e che non è in vendita ad attori stranieri che
cercano di minarci». Anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni,
arrivata ieri a Bruxelles per il suo primo Consiglio europeo, non maschera
l'allarme: «Lo scenario è oggettivamente preoccupante, le notizie che escono
raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato e dai contorni devastanti.
Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione, che deve
essere ferma e decisa. Si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti.
Ne va della credibilità dell'Unione europea e delle nostre nazioni».La
drammaticità della vicenda, sottolineata da Meloni e Metsola, non impedisce che
venga utilizzata per giochini di parte tra gli schieramenti politici. Mentre il
Pse, nell'occhio del ciclone, promette «tolleranza zero» contro le pecore nere,
il gruppo del Ppe ne approfitta per bastonarli: «Dobbiamo affrontare questa
ipocrisia: il gruppo dei Socialisti, il più santo dei santi è l'epicentro del
Qatargate ed è ora che siano ritenuti responsabili». E c'è anche chi utilizza la
vicenda del cosiddetto Qatargate per autoassolversi da un recente passato di
rapporti politici troppo stretti con un altro Stato canaglia, dedito da decenni
alla corruzione e all'inquinamento delle pubbliche opinioni occidentali, come la
Russia. «Da anni infangano la Lega cercando rubli (che non ci sono) con
articoli, inchieste e commissioni», dice Matteo Salvini, ma allo stesso tempo
«gli passavano sotto il naso milioni di euro in corruzione dai paesi islamici.
Penosi». Ma anche nel Pd, terremotato dalle rivelazioni sul caso, il Qatargate
minaccia di diventare materia da battaglia propagandistica, e persino
congressuale: «nuovi» contro «vecchi», puri contro sospetti, con sventolio del
solito santino berlingueriano. Lo agita Giuseppe Conte, che spera di lucrare un
po' di voti dalla crisi Dem e proclama: «Non dobbiamo abbassare la guardia, la
questione morale è la premessa indispensabile per qualsiasi azione politica». Ma
lo fa anche Elly Schlein, candidata alla segreteria Pd: «La questione morale è
più attuale che mai, a destra come a sinistra. Va posta al centro, è l'impegno
che mi sto prendendo nel tentativo di ricostruzione del nuovo Pd». Quanto
all'arrestato Panzeri, suo collega di gruppo quando erano entrambi eurodeputati,
Schlein taglia corto: «Sospetti? No, non c'era nessun elemento. Altrimenti mi
sarei rivolta alle autorità».
E la grillina
elogiava i cantieri del Qatar.
Nel 2021 la
capodelegazione 5s Beghin: "Grandi riforme sul lavoro". Pasquale Napolitano il
16 Dicembre 2022 su Il Giornale.
È il 25 settembre
del 2021, quando il capo delegazione del M5s al Parlamento europeo, Tiziana
Beghin, vola a Doha per tenere, con i colleghi Marc Tarabella, finito
nell'inchiesta sul giro di mazzette tra gli emissari dell'Emirato e politici
dell'Unione europea, e Jose Ramon Bauza, una conferenza stampa al termine di una
missione del Parlamento Ue nell'emirato. Missione servita ad «accertare il
processo di riforme avviato del governo del Qatar».
La grillina, nel suo
intervento pubblico in conferenza, usa parole al miele verso l'Emirato:
«Riscontriamo una grande dignità negli alloggi dei lavoratori». E non si tira
indietro se c'è da sottolineare - «l'importanza delle riforme del lavoro,
inclusa l'abolizione del sistema Kafala e l'introduzione del salario minimo
avviate dal Qatar». Il capo delegazione del M5s in Europa le definisce
«importanti tappe nel cammino di cambiamento che porteranno a una maggiore
equità e al rispetto dei diritti umani».
Un vero e proprio
endorsement al rinascimento qatarino. Della visita dell'europarlamentare
pentastellata non c'è alcuna traccia. Né sui giornali italiani, né sulle agenzie
o sulle pagine social del capo della truppa pentastellata a Bruxelles. A scovare
quella visita dei tre parlamentari europei è un sito arabo. Prima
dell'esplosione dello scandalo sono stati tanti i parlamentari che non si sono
tirati indietro quando c'è stata l'occasione per rivolgere un elogio al Qatar.
Ora però in molti restano in silenzio con il timore di essere risucchiati nel
vortice politico-giudiziario. Perché quelle uscite potrebbero essere lette sotto
la luce dell'inchiesta avviata dai magistrati del Belgio. Ovviamente non è il
caso dell'europarlamentare grillina che non risulta coinvolta nell'inchiesta. I
media parlano di oltre 60 europarlamentari al soldo di Qatar e Marocco. Uno
scandalo che rischia di far tremare le stanze di Bruxelles. Il Qatar aveva buone
sponde nel Parlamento Ue. E da tempo consolidava con relazioni e viaggi la rete.
Al fianco della grillina rimbalza la foto di Marc Tarabella, l'eurodeputato
belga di origine italiana finito nell'inchiesta sulla presunta corruzione da
parte del Qatar nei confronti di eurodeputati e funzionari del Parlamento Ue.
Qatargate, tutti
i legami tra Panzeri e il Marocco. Una storia lunga 11 anni.
Giuseppe Guastella,
inviato a Bruxelles, su Il Corriere della Sera il 17 Dicembre 2022
Qatargate, il
viaggio nel 2011 a Tindouf organizzato da Rabat per «rendere credibile»
l’europarlamentare arrestato a Bruxelles
Da almeno undici
anni il Marocco considera Antonio Panzeri un amico importante e prezioso.
Consolidatisi durante i due mandati al Parlamento europeo, i contatti sono
proseguiti ancora più intensamente dal 2019 quando Panzeri ha fondato la
Ong Fight impunity. Un legame che con il tempo è diventato troppo stretto al
pari di quello analogo con lo stato del Qatar. Tutti e due hanno fatto finire in
carcere Panzeri ed altre persone con l’accusa di aver incassato soldi e denaro
in un’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al riciclaggio che
aveva l’obiettivo di condizionare le scelte politiche del Parlamento agli
interessi dei due Stati.
Un’inchiesta delle
testate beghe Le Soir e Knack ricostruisce il rapporto con il Marocco rapporto
partendo da quando Chris Coleman, un hacker dal nome anglosassone ma
dall’identità marocchina, tra il 2014 e il 2015 mise in rete una serie di
documenti riservati di Rabat. Tra essi c’era una nota diplomatica dell’ottobre
2011 partita da Bruxelles in cui parlava di un contatto avvenuto tra un
rappresentante della missione del Marocco all’Ue e l’ex parlamentare europeo
italiano. Si comunicava che in un incontro informale a margine di una sessione
plenaria del Parlamento a Strasburgo, «il consigliere» di Panzeri aveva portato
un messaggio da trasmettere alle «autorità marocchine».
Potrebbe essersi
trattato di un nomale avvicinamento del tutto legittimo nell’ambito
dell’attività di un assistente parlamentare, tanto è vero che la nota aveva lo
scopo di preparare la visita che due settimane dopo sarebbe stata compiuta a
Rabat da Panzeri che in quel momento era presidente della Commissione Maghreb
del Parlamento. Ma c’è qualcosa di più, c’è l’attenzione dei marocchini a non
mettere in difficoltà l’allora parlamentare che, magari su sua scelta, fu fatto
sostare in un’area in cui c’erano campi di profughi sahariani prima di
trasferirlo a Rabat: «La visita di Tindouf è essenziale per rafforzare la
credibilità del signor Panzeri presso l’Algeria e il Polisario» (il movimento
attivo nel Sahara Occidentale) che altrimenti lo avrebbero potuto considerare
troppo filo marocchino, spiegava il documento.
In un’altra nota, ma
del 2013, la stessa missione diplomatica presso la Ue annunciava un piano per
contrastare gli oppositori del Marocco all’interno del Parlamento con convegni,
dibattiti e visite coordinando la propria «azione con il presidente della
Delegazione Maghreb al PE, il signor Antonio Panzeri, amico intimo del Marocco».
Dal 2019 i rapporti si trasferiscono dagli uffici del Parlamento a quelli
della Figth impunity e, almeno a quanto sostiene la magistratura belga, dal
primo gennaio 2021 si trasformano in un tema penalmente rilevante. Panzeri,
infatti, avrebbe legato troppo con l’ambasciatore del Marocco in
Polonia Abderrahim Atmoun, personaggio che si muoveva in un centro studi di
Bruxelles alla cui ombra avrebbero operato i servizi segreti di Rabat.
Panzeri, la moglie e
la figlia avrebbero anche inteso trasferire in Marocco attraverso il diplomatico
alcuni regali che avevano ricevuto. Nelle indagini della Procura Federale ci
sono parecchi incontri tra i due e viaggi fatti in Marocco di recente da
Panzeri. Sono stati registrate anche frequentazioni sospette tra Atmoun e il
parlamentare europeo Pd (ora dimessosi dal gruppo) Andrea Cozzolino. C’è poi il
filone dei legami con il Qatar che, però, risalirebbero a tempi molto più
recenti. I magistrati si stanno concentrando, infatti, su un viaggio compiuto da
Panzeri nel Paese del Golfo agli inizi di novembre. Anche il questo caso,
sostiene l’accusa, lo scopo del Paese era di ottenere una politica favorevole.
In particolare nel dibattito sui rispetto dei diritti umani e dei lavoratori
durante la realizzazione delle opere dei Mondiali di calcio.
Lunedì la moglie e
la figlia di Panzeri, che sono state arrestate in provincia di Bergamo su
richiesta degli inquirenti di Bruxelles, compariranno di fronte alla Corte
d’appello di Brescia che deve decidere se tradurle in Belgio. Intanto le
indagini in territorio italiano sul patrimonio della famiglia Panzeri — ma anche
sui conti degli italiani coinvolti direttamente, come Francesco Giorgi, il
compagno dell’ex vicepresidente del Parlamento Ue Eva Kaili — hanno già portato
all’individuazione di somme «consistenti». Nella richiesta di consegna al Belgio
delle due donne i magistrati di Bruxelles chiedono anche di sentire testimoni e
individuare tutti i documenti utili alle indagini nonché altre persone coinvolte
«in questa organizzazione fraudolenta».
Marco Bresolin
per “La Stampa” il 16 dicembre 2022.
«Panzeri era un
amico e sui di lui mi ero indubbiamente sbagliata. Ma voglio che una cosa sia
chiara: non ero la sua amante». Il nome di Maria Arena è stato sin da subito
accostato alla vicenda del Qatargate.
Uno dei primi a
emergere ai margini dell'inchiesta giudiziaria. Ex ministro belga, di origini
siciliane, l'esponente socialista è alla sua seconda legislatura al Parlamento
Ue. Nei corridoi la definiscono «una della cricca di Panzeri», alludendo - al di
là dei gossip - alla sua vicinanza quantomeno politica col protagonista
dell'indagine. Come dimostrano foto e video pubblicati in Rete, era una presenza
fissa agli appuntamenti dell'ong "Fight Impunity", con la quale si era spesa in
prima persona in una serie di attività all'interno del Parlamento.
«Conoscevo il signor
Panzeri come molti altri lo conoscono al Parlamento europeo» taglia corto
l'eurodeputata, infuriata perché nei suoi confronti «i media hanno costruito una
presunzione di colpevolezza su chissà quali informazioni sbagliate». Maria Arena
non risulta essere nell'elenco degli indagati, ma la sua attività politica e la
sua vicinanza a Panzeri hanno subito concentrato l'attenzione su di lei.
«Non sono citata in
questa indagine - insiste - non ho ricevuto perquisizioni, non sono stata
interrogata. Il mio nome proprio non figura». Gli uffici e la casa della sua
assistente, l'italiana Donatella Rostagno, sono stati perquisiti dagli
inquirenti. E per questo lei si è autosospesa «temporaneamente» dal ruolo di
presidente della sottocommissione Diritti Umani, quella che il 14 novembre
scorso ha ricevuto in audizione il ministro del Lavoro del Qatar. Il gruppo del
Ppe ha chiesto la sua rimozione definitiva.
«Conosco la mia
assistente dal 2014 perché abbiamo lavorato insieme su questioni relative
all'Africa - continua l'eurodeputata -. Lei era stata chiamata da Fight Impunity
nel 2021 per una consulenza di sei mesi e io l'ho reclutata nel 2022, ma non per
questo, bensì per la sua esperienza sull'Africa. Le perquisizioni sono legate al
periodo in cui lei ha lavorato con Fight Impunity. Ma non hanno proprio nulla a
che vedere con me».
Da lastampa.it il 16
dicembre 2022.
La commissione di
Garanzia del Pd ha deciso di sospendere "cautelativamente" l'eurodeputato Andrea
Cozzolino, coinvolto nella vicenda Qatargate. Il provvedimento «è immediatamente
esecutivo». La commissione si è riunita oggi, su richiesta urgente del
segretario Enrico Letta e «i componenti hanno deliberato di sospendere
cautelativamente l'onorevole Andrea Cozzolino dall'Albo degli iscritti e degli
elettori del Pd, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse
eventualmente essere parte. E ciò fino alla chiusura delle indagini in corso da
parte della Magistratura relative allo scandalo Qatargate.
«Il provvedimento -
che applica le norme dello Statuto del PD, del Codice Etico e del Regolamento
delle Commissioni di Garanzie, e che mira a tutelare l'immagine del Partito
Democratico e a consentire all'Onorevole Cozzolino (giá comunque autosospesosi
dal Gruppo S&D del Parlamento Europeo) la più ampia difesa delle proprie
posizioni - è immediatamente esecutivo».
Visentini:
“Donazione da Ong presa in buona fede”
Il presidente della
Ituc Luca Visentini, coinvolto nell'indagine Qatargate, afferma di avere
accettato «in buona fede» la donazione proveniente dalla Fight Impunity per «la
campagna per il congresso di Ituc che si è svolto a Melbourne dal 12 al 22
novembre scorso». «Il sindacato internazionale riceve regolarmente donazioni per
campagne e progetti da varie fondazioni e Ong - prosegue -.
In questo caso, si
trattava di un'organizzazione per la difesa dei diritti umani che collaborava
col mondo sindacale, per cui questa donazione non risultava sospetta in alcun
modo ed è stata accettata in assoluta buona fede. Tutto il contributo è stato
utilizzato per spese trasparenti e dimostrabili. Ituc non è in alcun modo
coinvolta nell'indagine».
«Stare in carcere in
isolamento per 48 ore è stato terribile, sapendo di essere innocente. Essere
coinvolto in questa storia è stato uno choc per me e la mia famiglia». Luca
Visentini parla così della sua breve esperienza in prigione a Bruxelles. «Io
sono innocente - prosegue -. Non ho mai fatto nulla in mala fede, non sono mai
stato corrotto e mai avrei potuto immaginare cosa ci fosse dietro questa
organizzazione. Il mio primo pensiero è tutelare la reputazione di Ituc e la mia
personale».
Francesca Sforza e
Francesco Grignetti per “La Stampa” il 16 dicembre 2022.
Un'unica grande
conversazione a cielo aperto, la Bruxelles di questi giorni, dove la frase
ricorrente è: «Si sapeva che prima o poi qualcosa sarebbe uscito». E chi lo
sapeva? «Un po' tutti». Con le sue 300 missioni diplomatiche, per un totale di
circa 26 mila diplomatici registrati, le numerose stanze delle istituzioni
europee e della Nato, e oltre 100 organizzazioni internazionali registrate, la
capitale belga è un crocevia di spie paragonabile alla Berlino della Guerra
Fredda.
I primi avvertimenti
della sicurezza del servizio esterno europeo risalgono al 2019: tutti i
funzionari erano pregati di fare molta attenzione - si consigliava - ogni volta
che si esprimevano in un caffè o in un ristorante del centro, e di preferire gli
spazi aperti per le conversazioni di lavoro. L'allarme era riferito in
particolare alla presenza di agenti cinesi e russi, che secondo fonti
diplomatiche tedesche arrivavano a toccare quasi quota 500. Ma come ha detto
recentemente a Politico un funzionario del servizio segreto belga: «Se qualcuno
ha il numero preciso delle spie presenti in città faccia la cortesia di
comunicarcelo».
Negli ultimi
quindici mesi ai russi e cinesi si sono aggiunti i rappresentanti delle
monarchie del Golfo, in particolare Qatar, Arabia Saudita e Emirati arabi uniti.
«Sono in molti a vedere nella fuga di notizie uno sgambetto del controspionaggio
saudita», ci dice un lobbista che preferisce non essere citato. E fa notare che
comunque i funzionari del Qatar si sono mostrati incompetenti, oltre che
fraudolenti: «Senza l'approvazione del Consiglio tutto quello che fa il
Parlamento non è mai vincolante, in altre parole non conta».
Il problema delle
spie esiste, tanto che si moltiplicano le voci che reclamano una euro-Cia,
un'organizzazione cioè che coordini i 27 servizi di spionaggio nazionali come fa
Europol per le forze di polizia. Le resistenze però sono diverse, ed
equiparabili a quelle sollevate sul tema della difesa europea: «Non tutti hanno
voglia di mettere in comune informazioni riservate e di consegnare il proprio
capitale di conoscenze a un'istituzione terza», spiegano funzionari Ue.
Un passo indietro,
anzi due. Che il Qatar si stesse muovendo in maniera un po' troppo
spregiudicata, a Bruxelles lo avevano capito in diversi. Quale sia stata la
fonte iniziale dell'indagine non è chiaro, ma i servizi segreti del Belgio a un
certo punto iniziano un'attività classica. Pedinamenti, intercettazioni,
perquisizioni clandestine. Lungo la strada, visto che l'inchiesta si stava
strutturando su più piani e in diversi Paesi, come è d'uso, i belgi hanno
chiesto la collaborazione ai Servizi collegati. Lo hanno fatto alla maniera
degli 007, cioè senza raccontare più del necessario.
Per parte italiana
collaborano sia l'Aisi sia l'Aise, cioè l'Agenzia interna e l'Agenzia esterna,
non prima di avere avuto il via libera dal governo. Chi doveva sapere, insomma,
sapeva. Anche ai piani alti del Parlamento europeo. Tra 2020 e 2022, è al lavoro
una commissione presieduta dal socialista francese Raphael Glucksmann sulle
ingerenze straniere nei processi decisionali europei. Procedono con molte
audizioni e tanto lavoro di analisi.
Guarda caso, quando
nel marzo scorso sintetizzano i loro lavori, il Qatar è uno dei Paesi citati
espressamente come esempio di ingerenza malevola. Scrivono: «Paesi come la Cina
e la Russia, ma anche il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia hanno
investito pesantemente nelle operazioni di lobbying a Bruxelles».
C'è da considerare
che queste Relazioni vengono edulcorate fino all'inverosimile. È quello che c'è
dietro, che conta. Glucksmann, per dire il giorno di marzo in cui si vota la sua
Relazione, dice: «Chiediamo alle istituzioni di adottare delle raccomandazioni
prima che scoppi una crisi», è ora di «mettere fine all'indolenza colpevole e
all'ingenuità dei dirigenti europei».
Qualche settimana
dopo, arrivano a Bruxelles i membri del Copasir italiano, presieduto in quel
momento dal senatore Adolfo Urso, FdI. Anche loro stanno approfondendo il tema
delle ingerenze. Ascoltano i responsabili di alcuni uffici molto particolari
della Commissione europea; poi incontrano i colleghi della commissione
Glucksmann.
Tornano a Roma ed
ecco che cosa scrivono nella loro ultimissima Relazione: «I principali attori
ostili sono, come è noto, la Russia e la Cina che fanno un uso ampio dei vari
strumenti di disinformazione e di ingerenza sia sul fronte interno che
all'estero nei Paesi considerati nemici. Anche altri Paesi più o meno
estesamente sfruttano tali strumenti. Vi sono attori che svolgono una pesante
attività di lobbying presso l'Ue, come la Turchia, il Qatar, gli Emirati arabi
uniti e l'Azerbaigian».
Rieccolo, il
ricchissimo arrembante Qatar. Dice a denti stretti uno dei membri del Copasir:
«Ovviamente, prima di prenderci la responsabilità di citare un Paese estero in
un nostro documento, qualche riscontro lo facciamo». Intende dire che non si
fidarono a occhi chiusi dei lavori della commissione Glucksmann, ma sentirono
anche l'opinione della nostra comunità di intelligence. Le informazioni
arrivarono. E a quel punto andarono avanti.
Giulia Zonca per “la
Stampa” il 16 dicembre 2022.
«Ici c'est Paris», è
scritto a caratteri cubitali nel nuovo cuore di Doha, a Msheireb, dove il
deserto incontra il design e dove il Comitato supremo ha piazzato il quartier
generale, sede della festa per la finale ideale. In pieno Qatargate si compone
la sfida Messi contro Mbappé costruita sulla rotta Parigi-Doha. Un intreccio di
soldi ed emozioni che è già il ritorno di un investimento miliardario.
Il Mondiale costato
220 miliardi di euro, per rifare la nazione intera, si ripaga con un poster. Il
sette volte pallone d'oro contro l'ultima meraviglia del calcio che ha già vinto
una Coppa del mondo a 19 anni e potrebbe fare il bis a 23. Entrambi giocano nel
Psg e nessuno dei due definirebbe l'altro compagno di squadra.
Messi ha firmato nel
2021, dopo 17 anni al Barcellona per un totale di 550 milioni da guadagnare in
cinque anni. In teoria, al momento dell'acquisto record, il Psg avrebbe dovuto
rispettare il tetto salariare, ma la Francia di Macron, scatenato tifoso in
tribuna nella semifinale contro il Marocco, ha preferito rilassare le regole
usando il Covid come scusa. Liberi tutti e non è esattamente la prima volta,
proprio Parigi è stata il ponte essenziale tra il Qatar e la Fifa (ancora
targata Blatter) nella sciagurata assegnazione del 2010, quella che ha portato
per la prima volta il torneo in un Paese arabo ma pure la più inquisita di
sempre.
Messi e Mbappé sono
il meglio del meglio e giocano sopra un terreno che ha visto il peggio del
peggio. Così la partita perfetta per gli organizzatori è pure quella che
racconta le contraddizioni di una competizione riuscita a meraviglia, a prezzi
giganteschi. Non si parla di dollari, quelli ce li ha messi il Qatar e se li può
permettere ma di sostenibilità, diritti, legittimità, per usare la parola che il
calcio proprio non regge: morale. Questo sport può sempre sbandierare tutte le
cose buone che fa (parecchie) e tutti gli aiuti che dà a cause benemerite
(abbondanti), per giustificare il marcio che gira.
Il Qatar ha pagato
il rinnovo più caro della storia: mentre Messi incassa 41 milioni a stagione e
trova metà della sua fortuna in sponsorizzazioni non legate all'attuale club,
Mbappé ha un contratto intricato con clausole a salire e bonus a raddoppiare. Se
gli tiene fede dovrebbe guadagnare quasi 630 milioni in tre anni, eccesso più
eccesso meno, ma lui già scalpita, come ogni estate, per passare al Real
Madrid.
Forse ora glielo
lasceranno fare. L'ultima volta pare che a sbloccare i dubbi residui, poi
placcati d'oro, ci abbia pensato proprio una telefonata di Macron. La
conversazione resta privata ma il tema era all'incirca: la patria ha bisogno di
te per i suoi affari con il terzo produttore di gas al mondo. Ora la prospettiva
cambia.
Messi contro Mbappé
potrebbe pure essere la coda di un'operazione sostenuta per l'immagine
dell'intero Qatar. Un'enorme carissima e riuscita pubblicità. L'emiro Nasser
Al-Khelaifi ha acquistato il Psg nel 2011, giusto un anno dopo l'assegnazione di
questi Mondiali, per 70 milioni e adesso ipotizza una vendita con una base
d'asta di 4 miliardi. Il fondo qatariota ne ha messi in circolo 1,6 in questi 11
anni.
Lo scettro dello
sportwashing, quel sistema che scambia i campioni con la credibilità
internazionale, passa all'Arabia Saudita che immagina un campionato con Ronaldo
(subito) e Messi (a breve), che ha già il numero 10 argentino sotto contratto
come uomo copertina e avanza candidature per i Mondiali 2030. Quando la finale
sarà probabilmente tra due dei futuri assi del Newcastle, la squadra rilevata
dai sauditi per aprirsi le porte dell'Occidente. Il Qatar insegna si gode la sua
finale.
(ANSA il 16 dicembre
2022.) - "Non esiste un patto di non aggressione tra S&D e Ppe". Così il
portavoce del Partito popolare europeo riguardo alle indiscrezioni su un
possibile patto tra le due formazioni per fronteggiare le conseguenze del
Qatargate sugli equilibri politici nell'Europarlamento e, più in generale, a
livello europeo.
"A quasi una
settimana dall'inizio dello scandalo i socialisti non hanno riconosciuto il vero
problema: una rete corrotta di politici e assistenti all'interno della propria
famiglia politica insabbiata da dubbie Ong. È giunto il momento per loro di
affrontare i fatti dello scandalo sulla corruzione del Qatar", sottolineano dal
Ppe.
Estratto
dell’articolo di Emanuele Lauria per “la Repubblica” il 16 dicembre 2022.
Il terrore è sui
volti di tutti. Gli esponenti delle istituzioni europee sanno che il Qatargate
può sconquassare l'Unione europea. E cercano di correre ai ripari. Tanto che
inizia per la prima volta a emergere una linea bipartisan per arginare lo
scandalo.
Ieri pomeriggio,
infatti, il nuovo presidente del Pse, lo svedese Stefan Löfven, ha incontrato
l'omologo del Ppe, Manfred Weber. L'esito del colloquio è forse il più
inaspettato. Al di là di una dichiarazione pubblica, Weber stringe un accordo
con Löfven. I Popolari non attaccheranno il Pse sull'inchiesta. Distingueranno
le responsabilità politiche da quelle personali.
Non è una cosa da
poco. Anche perché le motivazioni che sottintendono la scelta di Weber non
riguardano solo un atteggiamento di lealtà tra due partiti che a Bruxelles
stanno collaborando da anni. Ma concernono il pericolo che le indagini dei
magistrati tocchino anche il loro partito. Nessuno, insomma, può escludere che
il "caso" possa andare oltre l'esclusiva socialista.
Un modo, dunque, per
ammettere che tutti si possono ritrovare sulla stessa barca.
Anche perché le
scelte compiute dall'amministrazione del Parlamento europeo qualche dubbio
iniziano a generarlo.
A giugno scorso, ad
esempio, il segretario generale, il tedesco di provenienza popolare Klaus Welle,
ha firmato con Antonio Panzeri un patto ufficiale. Un accordo di "partenariato"
con la Ong Fight Impunity. Un vero e proprio contratto che prevedeva
l'organizzazione in comune di alcuni eventi con il contributo di spese e di
logistica da parte dell'Eurocamera.
Ma al di là
dell'effettiva partecipazione finanziaria, l'endorsement rappresentava la più
grande legittimazione interna ed esterna per Panzeri. Nonostante la sua Ong non
fosse regolarmente registrata. Un benefit gigantesco.
Gli stessi fremiti
di allarme hanno attraversato ieri il Consiglio europeo. Con tutti i leader
impegnati a capire, nella prima parte del vertice, le conseguenze
dell'"Affaire". E un incubo costante: che la macchia d'olio del malaffare possa
espandersi dal Parlamento alla Commissione. Ipotesi che non solo fa rabbrividire
i vertici dell'Unione europea, ma farebbe scattare un vero e proprio effetto
domino in tutti i centri di potere brussellesi. […]
Estratto
dell'articolo di Giuliano Foschini per “la Repubblica” il 16 dicembre 2022.
Primo quadro: maggio
del 2018. All'interno del Parlamento europeo sorridono a favore di un fotografo
Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino e Abderrahim Atmoun. Diranno: «Il Marocco e
l'Unione europea hanno e avranno rapporti sempre migliori».
Secondo quadro:
hotel Mamounia, il più bello di Marrakech, tra i migliori al mondo. Antonio
Panzeri stappa una bottiglia accanto ai suoi amici, alla sua famiglia che ha
portato per festeggiare. L'ambasciatore ha riempito di regali le loro valige.
«Mamma, come cazzo portiamo il regalo di Atmoun?» chiede la figlia.
Terzo quadro: sede
della Dged, i servizi segreti marocchini. Dal ministero degli Esteri hanno
chiesto informazioni su questo Panzeri che torna spesso in una serie di report
diplomatici. Scrive il funzionario: «Antonio Panzeri, il nostro caro amico».
Per leggere meglio
il Qatargate, per andare all'inizio di questa storia, è necessario abbandonare
il Qatar. E spostarsi in Marocco, muovendosi tra Rabat, Marrakech. E Bruxelles.
Il grande scandalo è cominciato qui. [...]
Dunque: gli spagnoli
avvisano i belgi. I belgi muovono i francesi e chiedono conferme, che arrivano,
anche dai polacchi sul ruolo di Atmoun. Il nome di Panzeri trova sempre più
forza. A quel punto i belgi provano e trovano un'interlocuzione anche con i
nostri servizi.
Ma - motivo che crea
oggi molto imbarazzo, e anche delusione nei nostri apparati: sono certi che con
una maggiore collaborazione, anche a livello giudiziario, si sarebbe potuti
arrivare a informazioni migliori e più precise già in questa fase - quello che
arriva è molto parziale: si chiedono, cioè, informazioni su Panzeri e Giorgi.
Ma senza spiegare
l'oggetto della questione, senza fare riferimento al grande giro di corruzione
che si sospetta. Raccolte tutte le informazioni, la Vsse, i servizi di
intelligence belgi, decide di fare un blitz a casa Panzeri per capire se le
dritte erano giuste. [...]
Estratto
dell’articolo di Giuliano Foschini e Claudio Tito per “la Repubblica” il 16
dicembre 2022.
Un gruppo composto
da tre persone: Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e l'eurodeputato del Partito
democratico Andrea Cozzolino. Un gruppo con una «motivazione prioritaria: il
lavoro con il Marocco e il Qatar in cambio di denaro. Il gruppo riceveva
pagamenti per le sue attività. E nel 2019 aveva concluso un accordo per
effettuare ingerenze a favore del Marocco in cambio di denaro». Parte da qui -
da quello che i magistrati belgi scrivono nel decreto che ha portato all'arresto
la scorsa settimana di Panzeri e Giorgi - la seconda fase dell'inchiesta del
Qatargate.
Del gruppo, secondo
le informazioni che i servizi belgi hanno girato alla Procura, farebbe parte un
terzo uomo: Cozzolino, appunto. Che però al momento non è stato indagato perché
non ci sono prove di dazioni di denaro. E, soprattutto, perché gode
dell'immunità da parlamentare.
[…] Determinante è
quello che racconterà il suo assistente, Francesco Giorgi.
Nel primo
interrogatorio davanti al giudice Michel Claise ha parlato per più di dodici
ore, facendo saltare tutto il programma di giornata di testimonianze. In
quell'occasione, Giorgi a domanda specifica su Cozzolino, cioè se Panzeri avesse
mai pagato l'europarlamentare italiano, ha detto di "supporre" che uno scambio
ci possa essere stato.
Ipotesi che, però,
ieri il parlamentare del Pd ha respinto con sdegno. […] Cozzolino sostiene di
non aver mai potuto influire né per il Qatar né per il Marocco. E che tutte le
sue mosse - come per esempio la mail, pare scritta da Giorgi, nella quale
chiedeva al gruppo socialista di ammorbidire la posizione nella votazione sulla
mozione contro il Qatar - sono state dettate tutte da volontà politiche.
[…] Cozzolino si
dice pronto a essere interrogato ma in questo momento i magistrati belgi nulla
possono fare nei suoi confronti senza chiedere l'autorizzazione al Parlamento.
Cosa che, appunto, potrebbe accadere a breve, non appena cioè la Polizia
concluderà gli accertamenti sui computer sequestrati.
Ma, a questo punto,
gli accertamenti non saranno soltanto dei magistrati belgi. La Guardia di
Finanza ha ricevuto delega dalla procura di Milano di mettere il naso nei conti
di Panzeri e Giorgi: analisi dei movimenti bancari, carte di credito, acquisti
immobiliari dell'ultimo periodo sulla base del sospetto, fondato su "elementi
idonei", che ci siano altre somme in Italia. […]
Estratto
dell’articolo di Ma.Bre. per “la Stampa” il 16 dicembre 2022.
«Sono frastornato».
Andrea Cozzolino è a pezzi. «È tutto surreale, surreale» ripete mentre cerca a
fatica di tornare a casa sua, a Napoli.
[…] «Una giornata
terribile, mi sento come dentro una bolla». La giornata terribile era iniziata
leggendo le indiscrezioni sul suo presunto ruolo di mediatore con i servizi
marocchini. «E io sono caduto dalle nuvole», ripete al telefono. «Le prime due
ore le ho trascorse cercando di tranquillizzare mia moglie». Secondo le
ricostruzioni, Cozzolino avrebbe incontrato Mansour Yassine, direttore generale
dei Servizi marocchini: «Ma ti pare che il capo dei Servizi segreti incontri
me?».
L'eurodeputato del
Pd, che si è auto-sospeso dal gruppo dei socialisti-democratici, assicura di non
aver «mai incontrato persone vicine ad agenzie o servizi di sicurezza». Insiste:
«Sono del tutto estraneo alle indagini. Non sono indagato, non sono stato
interrogato, non ho subìto perquisizioni». E comunque sempre «a completa
disposizione dell'autorità giudiziaria per qualsiasi chiarimento».
Le ricostruzioni
parlano di un suo viaggio in Marocco, durante il quale avrebbe incontrato
proprio Yassine. «Devo essere sincero - ripete cercando di fare ordine - non mi
ricordo di essere andato in Marocco, devo controllare l'agenda. Sono stato due
volte in Tunisia, due in Algeria, ma si trattava di missioni per conto del
Parlamento europeo. Io ero presidente della delegazione per le relazioni con il
Maghreb e in questo ruolo tenevo i rapporti politici, non mi occupavo dei
dossier tecnici». Dunque, questa la sua tesi, non avrebbe avuto possibilità di
«incidere» sui file legislativi.
Oltre a quello di
Yassine, Cozzolino è associato anche al nome di Abderrahim Atmoun, ambasciatore
del Marocco in Polonia. «Sì, lo conoscevo» ammette. Difficile dire il contrario,
visto che il marocchino ha pubblicato una sua foto a Strasburgo in compagnia
proprio di Panzeri e Cozzolino.
«Ma lo conosco solo
perché era stato deputato e aveva partecipato a un incontro al Parlamento
europeo». Oltre al Marocco, c'è poi il Qatar. E quella mail che Cozzolino aveva
inviato ai colleghi per chiedere di votare contro la risoluzione di condanna:
«Ho semplicemente seguito una linea politica. E alla fine ho votato a favore
della risoluzione, anche se purtroppo questo non risulta agli atti perché si è
votato per alzata di mano». […]
Giuseppe
Salvaggiulo, Monica Serra per “la Stampa” il 16 dicembre 2022.
L'inchiesta sulla
Tangentopoli europea delinea una ragnatela di corruzione creata da Antonio
Panzeri quando ha fondato nel 2019 a Bruxelles, dopo la mancata rielezione,
Fight Impunity. Un centro di smistamento di tangenti, provenienti da Qatar e
Marocco e distribuite nel Parlamento Ue dopo essere transitate, schermate, dai
conti correnti della Ong paladina dei diritti umani.
Gli investigatori
belgi sospettano che della ragnatela facesse parte anche Andrea Cozzolino,
eurodeputato campano del Pd, dopo che nell'interrogatorio Francesco Giorgi ha
fatto il suo nome come possibile percettore di parte dei soldi. Giorgi è il
trait d'union tra i due: ex assistente di Panzeri, dal 2019 lavorava per
Cozzolino. L'altro nome fatto da Giorgi è quello del deputato socialista belga
Marc Tarabella, già perquisito. Entrambi negano illeciti. La Procura federale
cerca riscontri, valutando la possibilità di chiedere l'autorizzazione a
procedere al Parlamento.
Formalmente, la
principale attività della Ong era redigere un rapporto annuale. A quello del
2021 ha lavorato anche Giacomo Bartolo, figlio di Pietro, un altro eurodeputato
Pd.
«Aveva un contratto
a partita Iva da circa 1.900 euro lordi mensili - spiega -. Ha lasciato dopo
sette mesi perché la vita a Bruxelles era troppo cara e il lavoro non pienamente
soddisfacente». Due assistenti di Bartolo, uno dei quali aveva lavorato per
Panzeri, sono stati perquisiti. Il suo nome, invece, non compare nei mandati di
arresto.
Per il momento sono
i deputati socialisti italiani e belgi nel mirino. Ma nella ragnatela c'è «un
gruppo indeterminato e molto ampio di persone dedito alla consumazione di fatti
di corruzione e operante all'interno di strutture europee». Lo scrivono anche i
magistrati italiani nei decreti di perquisizione e sequestro disposti sulla base
dell'ordine di investigazione europeo trasmesso a Milano. Per poi sottolineare
che si tratta di soggetti «con o senza legami con l'Unione europea».
I soldi cash trovati
a Bruxelles sarebbero solo una piccola parte delle tangenti. Sono sette i conti
correnti italiani che ora gli investigatori dell'aliquota di pg della Gdf stanno
setacciando, «perché è presumibile che il provento dei fatti illeciti sia stato
trasferito sui conti bancari». Ed effettivamente, negli estratti conti
consegnati dalle banche, alcuni movimenti di interesse investigativo sono già
stati individuati.
Una pista su cui gli
investigatori hanno appena iniziato a lavorare per ricostruire il «quadro
internazionale dell'organizzazione criminale» che pagava «ingenti somme di
denaro in cambio dell'attività» di eurodeputati e non solo finiti «a libro paga»
dei Paesi corruttori. Giorgi ha ammesso di far parte di un'organizzazione usata
sia dal Marocco che dal Qatar per intervenire negli affari europei, confermando
che Panzeri ne era il capo e di aver avuto il ruolo di gestire le grandi
quantità di denaro. Panzeri era considerato «amico» dai servizi di sicurezza
marocchini.
Con l'attuale
ambasciatore del Marocco a Varsavia, Abderrahim Atmoun, considerato l'agente
della corruzione, aveva lavorato a Bruxelles nel 2017, nell'ambito di una
commissione bilaterale. Era invece tutt' altro che amico del Marocco
l'eurodeputato spagnolo Miguel Urbán, eletto con Podemos. Nel maggio 2021 aveva
denunciato un'intrusione notturna nella sua casa di Madrid.
Erano stati rubati
due hard disk, foto di famiglia e il salvadanaio di sua figlia, ma non oggetti
di maggior valore. Insospettitosi, aveva denunciato il fatto alla polizia
spagnola e al servizio di sicurezza del Parlamento Ue, che aveva valutato
l'episodio come sospetto in quanto frutto di «mani esperte». David Sassoli,
allora presidente, aveva allertato i ministeri degli Interni di Spagna e Belgio.
Anche questa vicenda è oggetto di valutazione da parte degli investigatori
belgi.
Qatargate, lo
scandalo mazzette investe la "maggioranza Ursula".
Storia di Redazione
Tgcom24 il 16 dicembre 2022. La tregua sul caso Qatargate chiesta dalla
presidente Metsola e i suoi appelli a non strumentalizzare la vicenda "per
questioni politiche" sono durati una manciata d'ore: lo scandalo euromazzette
rischia di rovesciare gli equilibri dell'Eurocamera e far naufragare una volta
per tutte la cosiddetta "maggioranza Ursula", la grande coalizione ancora al
potere a Bruxelles.
Le voci di un
possibile patto di non aggressione tra popolari e socialisti sono state
fermamente smentite da uno dei portavoce del Ppe, che al telefono ha accusato
duramente i socialisti: "Stanno naufragando e invece di pensare a salvarsi
provano a lanciarci addosso tutto ciò che gli è rimasto".
Video
correlato: Scandalo Qatar-UE, nuovi sospetti (Mediaset)
La prima rottura in
aula è arrivata giovedì sul voto sulla risoluzione per i diritti umani in
Bahrain, Stato del Gofo storicamente avversario del Qatar e su cui il Ppe,
assieme alle destre di Id e Ecr, hanno scelto di astenersi. Ma sulla decisione
sono piovute le critiche dei Socialisti e di Renew Europe, che via Twitter hanno
risposto: "Il silenzio del Parlamento europeo sulle violazioni dei diritti umani
è esattamente ciò che le tangenti del Qatar miravano a ottenere". Ed è finito
sotto accusa da parte del gruppo di Renew Europe il ruolo dell'eurodeputato ceco
Tomas Zdechovsky, presidente del Gruppo di amicizia Bahrain-Eurocamera e molto
vicino al governo degli emiri, scelto dai popolari proprio come relatore del
testo sui diritti nel Paese del Golfo.
Dopo il voto i toni
tra gli alleati si sono fatti via via più bruschi. Alle accuse sul voto sul
Bahrain i popolari hanno risposto via social con rabbia. "Altro che Qatargate,
questo è uno scandalo socialista", recitava un post del Ppe immediatamente
diventato virale e seguito da una altro: "Si sentivano i più puliti e invece
questo scandalo ha un nome e un cognome: i socialisti europei".
La scelta del Ppe di
schierarsi con le destre tuttavia non è inedita. Anzi ha fatto la sua prima
apparizione proprio con l'elezione del successore di David Sassoli. Roberta
Metsola all'inizio di quest'anno è stata eletta anche grazie ai voti di Ecr e
della corposa delegazione leghista. Il dialogo con i Conservatori - il cui
partito è presieduto da Giorgia Meloni - è un dato di fatto.
A seconda di come
andranno le elezioni in Spagna e Polonia, cruciali per gli equilibri europei,
potrebbe attenuarsi o infittirsi ulteriormente. Per il leader del gruppo Id,
Marco Zanni, "quanto avvenuto in casa dei socialisti rappresenta l'ennesimo
segnale di una maggioranza giunta ormai, nei fatti, al capolinea e senza piu'
alcuna ragione di esistere", ha detto. Il leghista ha più ben più di qualche
sassolino da levarsi dalle scarpe. "L'evidenza ha dimostrato che la vera
minaccia all'Ue da isolare con un antidemocratico e vergognoso cordone sanitario
non eravamo noi", ha sottolineato Zanni, che poi ha teso la mano ai popolari:
"Il Ppe, se ancora ha a cuore certi valori, batta un colpo e dia un segnale,
è ora di cambiare questa Europa e noi ci siamo". Dalla casa popolare per ora
silenzio, ma il messaggio, fanno sapere, è stato ricevuto.
Il Qatargate
dell’ambasciatore: «il gigante» Atmoun, le spie a Varsavia, la vera partita del
Marocco.
Storia di Maria Serena Natale su Il Corriere della Sera il 16
dicembre 2022.
Dalle finestre si
vede «la torta di Stalin», l’imponente Palazzo della Cultura a metà tra art déco
e realismo socialista che i polacchi ebbero in dono dall’odiato leader sovietico
e che oggi è un simbolo di Varsavia. L’ambasciata marocchina si trova cinque
chilometri più a sud, nella verde area residenziale di Mokotów, blocchi di
appartamenti moderni, ristoranti e silenziosi vialetti sulla riva sinistra della
Vistola. Luogo ideale per scambi riservati e intrighi di spie da Guerra fredda.
La rete di riciclaggio e corruzione che da Rabat e Doha si allungava fino a
Bruxelles trovava qui un centro nevralgico. Quello che nelle prime ricostruzioni
figura tra i manovratori del Qatargate arriva nel 2019. È il nuovo ambasciatore
di Sua Maestà Muhammad VI, Abderrahim Atmoun.
Alto profilo, lunga
navigazione politica ed esperienza internazionale con anni di relazioni strette
sulla direttrice Rabat-Parigi-Bruxelles. In costante ascesa. Nato nel 1955 nella
città mineraria di Khouribga, già governatore regionale e parlamentare con il
partito filo-monarchico Autenticità e modernità, partecipa ai lavori della
Commissione Esteri, Difesa nazionale e Affari islamici; dal 2009 guida il Gruppo
d’amicizia tra il Senato marocchino e quello francese; dal 2011 presiede la
Commissione parlamentare mista Marocco-Ue che si occupa di economia, rapporti
bilaterali, diritti umani e lotta al terrorismo: in questa veste nel 2017
collabora con Antonio Panzeri, allora eurodeputato con S&D e presidente della
Commissione del Parlamento europeo per i problemi economici e monetari. Vive a
lungo in Francia e nel 2011 diventa il primo politico marocchino a ricevere la
Legion d’onore, la più alta onorificenza conferita dalla Repubblica, presidente
Nicolas Sarkozy.
Nel 2019 Muhammad VI
lo vuole ambasciatore a Varsavia, incaricato di fare della Polonia la
piattaforma diplomatica ed economica del Regno per l’intera Europa
centro-orientale. Sull’altra sponda del Mediterraneo il Marocco si propone come
porta d’Africa per le aziende polacche. Atmoun spinge la cooperazione a tutti i
livelli e nel 2021 dopo una tessitura di mesi riesce a portare una delegazione
imprenditoriale in trasferta non solo a Casablanca ma anche a Dakhla e Laayoune.
Si tratta di due città sulla costa atlantica del Sahara occidentale, il
territorio rivendicato dal Fronte Polisario che nel 1976, un anno dopo la fine
della dominazione coloniale spagnola, proclamò l’indipendenza dal Marocco e
fondò la Repubblica araba democratica dei Sahrawi, indomito popolo tribale
arabo-berbero sostenuto dall’Algeria. Terra di fatto annessa per l’80% da Rabat
e ricca di fosfati, preziosissimi dall’agricoltura all’industria alimentare:
dopo Cina e Stati Uniti, il Marocco ne è il terzo produttore mondiale. Il più
grande deposito del pianeta? Khouribga, città natale di Atmoun.
La lotta del
perseguitato popolo Sahrawi è tra i dossier internazionali più delicati e causa
di divisioni tra i 27 Stati Ue, con il Nord Europa schierato al fianco del
Fronte e Paesi come Francia e Spagna più concilianti con il Marocco. Per la
Spagna — che durante la pandemia ha comunque accolto e curato il leader del
Fronte Polisario malato di Covid — esiste anche il fronte Ceuta e Melilla, le
exclave fortificate che i migranti sognano di raggiungere prima di essere
fermati «dall’eccessivo uso della forza» degli agenti marocchini, definizione
Onu. La scorsa estate si sono scontrate sul Sahara occidentale, con ricadute sui
prezzi del gas algerino, Madrid e Algeri dopo la svolta del governo di Pedro
Sánchez a favore dell’ultima offerta del Regno ai Sahrawi: autonomia, non piena
sovranità. L’offensiva lobbistica e le manovre di corruzione marocchine emerse
con il Qatargate miravano proprio a condizionare la posizione storicamente
ambigua dell’Europa che disporrebbe in realtà di forti leve economiche con
entrambe le parti.
Così il vento del
Sahara raggiunge le stanze di Varsavia dalle quali Atmoun può girare contatti ai
servizi segreti e dove le trame dell’intelligence s’incrociano con le visite
di Panzeri&Co. Le carte dell’ inchiesta citano «regali» per «l’amico» italiano
provenienti dal Marocco, regali che sarebbero stati trasportati da moglie e
figlia di Panzeri, entrambe attualmente agli arresti su mandato europeo. In una
conversazione telefonica citata da fonti di stampa marito e moglie parlerebbero
di una carta di credito a loro disposizione intestata al «gigante», Atmoun.
A che punto è
l’inchiesta sul Qatargate
Un sistema che
intercetta gli interessi delle capitali, si nutre delle loro divergenze per
perseguire obiettivi strategici e rivela ogni giorno nuove ramificazioni.
Bruxelles è il primo fornitore di aiuti umanitari ai campi profughi dei Sahrawi
in Algeria e ne appoggia la lotta per l’autodeterminazione. Di fatto però non ha
mai assunto un ruolo attivo nella ricerca di una risoluzione del conflitto e
mantiene forti legami con il Marocco: è del 2000 l’Accordo di associazione,
seguito da partnership e intese che hanno fatto del Paese maghrebino il
principale destinatario di sostegno finanziario Ue nell’ambito dei programmi di
vicinato. Dal 2006 l’Unione partecipa con oltre 50 tra Paesi e istituzioni al
Processo di Rabat su migrazioni e sviluppo. Nel 2021 è dovuta intervenire la
Corte di giustizia europea annullando due clausole dell’Accordo del 2019 sui
diritti di pesca Ue-Marocco che includeva le acque di pertinenza del Sahara
occidentale: secondo i giudici il testo sanciva «il diritto di sfruttamento di
uno Stato occupante in un territorio riconosciuto internazionalmente non
autonomo». Altra questione di massimo interesse per Rabat, il culto musulmano in
Belgio — in passato Atmoun aveva gestito anche il dossier espatriati.
Negli ultimi anni
sono aumentati i riconoscimenti in sede europea dei pur reali sforzi della
monarchia dell’ambizioso Muhammad VI, legatissimo a Washington e agli Stati del
Golfo Persico, per migliorare i propri standard sui diritti umani malgrado le
persistenti violazioni della libertà di stampa e di espressione. Tra singole
iniziative e spinte più o meno esplicite per ottenere graduali spostamenti nei
toni e nell’approccio generale alle relazioni bilaterali si allunga l’ombra del
sospetto, in questa storia la ferita più grave. In una dichiarazione congiunta
del 2019 Unione europea e Regno del Marocco si dicono «uniti non solo negli
interessi derivanti da geografia e storia, ma nei valori condivisi che entrambi
hanno scelto di sottoscrivere. Da semplici vicini, Ue e
Hobby Lobby:
missione Schengen.
Edoardo Sirignano su
L'Identità il 16 Dicembre 2022
L’interesse del
Qatar sull’Europa parte da lontano. Stesso discorso vale per le relazioni con
chi dovrebbe rappresentare il nostro continente nel più grande serbatoio di
idrocarburi del pianeta. A dirlo gli stessi parlamentari della perla del Golfo
Persico, in un incontro, avvenuto lo scorso marzo e a cui presi parte come
inviato del quotidiano “Il Giornale”.
La richiesta della
Shura: superare Schengen
In una conversazione
con una delegazione congiunta di Camera e Senato, gli esponenti della Shura,
l’assemblea legislativa di Doha, chiesero all’Italia una mano per quanto
riguarda il superamento di Schengen. Gli uomini in “thobe” dissero chiaramente
alla nostra politica: “Servono delle misure che possono aiutarci, a partire
dallo spazio continentale di circolazione delle merci, che così com’è, crea non
pochi problemi a chi vuole investire”. Furono gli stessi eletti e nominati dalla
nobilità qatarina ad aver rivelato ai nostri portavoce l’avvio di diverse
iniziative con alcuni eurodeputati per superare quel trattato base dell’Ue e di
aver bisogno di un ulteriore sostegno da parte della politica nazionale,
affinché nei palazzi romani si potesse istituire una commissione in grado di
occuparsi esclusivamente delle questioni tanto care ai padroni del petrolio. In
quella conversazione, venne spiegato ai nostri onorevoli la necessità di andare
oltre lo storico visto continentale, che si sarebbe tradotto in risorse per
l’Europa. Snellire un apparato burocratico complesso, secondo gli organizzatori
dei mondiali, significa sviluppo e ripresa. In quel vertice, ad esempio, venne
fatto più di un semplice riferimento alla moda, dove grazie all’innamoramento
della moglie dell’emiro per “Valentino” si sono realizzate importanti operazioni
commerciali. I sette parlamentari (sei del Movimento 5 Stelle e uno di Forza
Italia), sentendosi impotenti rispetto a tali pretese, dissero di non potersi
accollare una causa così grande, ma allo stesso tempo presero l’impegno di
riportare il problema a chi di dovere. Ciò venne ribadito anche nel corso di una
conferenza stampa, tenutasi nell’hotel Four Seasons e trasmessa in diretta su Al
Jazeera. Da quel momento in poi, le pressioni sembra siano andate avanti, anche
se senza alcun esponente politico di quella delegazione. La stessa macchina che
organizzò la missione primaverile, si è attivata per altri confronti, che poi
effettivamente si sono realizzati nei mesi precedenti all’evento calcistico più
importante del pianeta, questa volta con onorevoli provenienti da tutto il
continente.
Un costume diffuso
I senatori e i
deputati, coinvolti nella delegazione a cui facciamo riferimento, certamente,
non hanno nulla a che vedere con i fatti di corruzione degli ultimi giorni.
Stiamo parlando di persone oneste, il cui unico interesse era quello di capire
qualcosa in più sui tanto discussi diritti umani. Quest’incontro, però, è
fondamentale per comprendere come l’interesse del Qatar per Schengen, esisteva
già prima che la piccola realtà mediorientale finisse sotto i riflettori dei
network per l’organizzazione di eventi internazionali. Si trattava, appunto, di
relazioni antiche per superare ostacoli burocratici e trovare partnership
economiche. Non è un caso che il governo di Doha sia stato uno di quelli che si
è speso di più per l’Italia dal punto di vista energetico, soprattutto quando si
sono chiusi i rubinetti russi a causa del conflitto in Ucraina. Un accordo, in
tal senso, fu siglato dall’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, amatissimo a
quelle latitudini. La sua fotografia, almeno fino alla scorsa primavera, era
esposta come una reliquia nei campi di lavoro destinati ai rifugiati di guerra
afghani. Sono, comunque, tantissimi gli italiani, che vivono nelle “Corniche”, i
grattacieli che oggi vediamo durante gli intervalli delle partite. Stiamo
parlando, d’altronde, di un Paese innamorato del made in Italy.
“Un vero erede della
discedenza – ci spiegarono i nobili in sandali e veste bianca – deve portare,
almeno una volta ogni cinque anni, la propria moglie a spendere nelle lussuose
boutique di via Monte Napoleone, così come mangiare un piatto di spaghetti o una
pizza”.
Occhetto: Lo
scandalo? Ho pianto per molto meno il Pd chieda scusa.
Edoardo Sirignano su
L'Identità il 16 Dicembre 2022
“Dopo Qatargate,
sarebbe opportuno chiedere scusa. Ho pianto per molto meno”. Così Achille
Occhetto, ultimo segretario del Partito Comunista Italiano, noto per le lacrime
della Bolognina, simbolo di svolta per la sinistra, commenta il caso Bruxelles,
che vede coinvolti diversi esponenti dell’universo dem. Il cofondatore del
Partito del Socialismo Europeo, presenta due proposte al nostro giornale. La
prima è indirizzata a chi vuole succedere a Enrico Letta e riguarda un atto
politico comune per la questione morale, terminando così il valzer di
dichiarazione . La seconda, invece, vuole mettere fine a un politica generica di
difesa delle Ong.
Cosa ne pensa di
Qatargate?
Non posso che
pensarne malissimo. Sono particolarmente sconvolto nel vedere qualcosa che, ai
miei tempi, era inimmaginabile. Non si poteva mai pensare, dopo le vicende della
questione morale, che potesse avvenire un fatto più grande, che qualcuno potesse
operare contro i propri valori per ottenere una funzione lobbistica o di denaro.
Una mostruosità indicibile.
La sinistra, sin da
Berlinguer, si è battuta per la questione morale. Poi cosa è venuto meno?
Berlinguer, nella
conversazione con Scalfari, mise sott’attacco la gestione di interessi loschi,
macchine di potere e clientele. In quel momento, però, non tutti furono
d’accordo. Stiamo parlando di un aspetto da sempre sottovalutato. Sono stato
testimone del suo tormento dinnanzi all’irrompere dei primi segnali della
devastante questione morale, accompagnata dall’esigenza che i partiti, come
diceva il segretario, facessero un passo indietro rispetto ai problemi di
gestione. Si trattava, in sostanza, del tema riguardante un’alta riforma della
politica.
Se fosse stata
effettuata questa riforma, cosa sarebbe cambiato?
Non sarebbe stato
necessario il doveroso intervento, come si disse polemicamente, a gamba tesa
della magistratura in politica. Per capire, cosa è successo dopo la scomparsa di
Berlinguer, occorre fuggire da ricostruzioni di maniera. Le cose non stavano,
come si dipingono. Non si può dimenticare l’isolamento di Enrico nell’ultima
fase della vita da parte di molti del gruppo dirigente. Allo scontro esterno con
Craxi si sovrapponeva un durissimo conflitto interno che tendeva a presentare il
segretario del Pci come un uomo superato dalla modernità. Stesso discorso vale
per la sua battaglia sulla questione morale, derisa da tanti. Si parlò
addirittura di manifestazione démodé. Qui va cercato il nucleo di quanto accade
oggi, ovvero non è stata accolta una lezione.
Da quel momento in
poi, possiamo dire che si è abbassata la guardia?
Certamente. Da quel
momento in poi, è calata l’attenzione su determinate questioni.
Cosa è cambiato oggi
rispetto ad allora?
La situazione, per
certi versi, è peggiore rispetto a quella denunciata da Berlinguer. Ci troviamo
di fronte a un problema sistemico generale. Abbiamo Paesi extraeuropei che fanno
lobby attraverso la corruzione. La presidentessa del Parlamento Europeo sostiene
che la democrazia è in pericolo. Ciò è grave perché significa che l’inchiesta si
allargherà e dimostrerà una verità raccapricciante.
Detto ciò, perché le
mele marce trovano la porta d’ingresso in una sinistra, che invece dovrebbe
tenerle lontane?
Ong che dovrebbero
combattere per i diritti civili, sul Qatar, capovolgono la loro vocazione. Sul
piano concreto si capisce il perché, ovvero queste ultime sono volute entrare
laddove c’era l’opposizione più forte. Il Pd, infatti, è stato il più duro nel
combattere una battaglia. Tuttavia, anche quest’aspetto, non ci esime
dall’indagare sul perché a sinistra si trovano dei figuri che imbrattano i
nostri valori, contemporaneamente l’Europa, le sue istituzioni e l’Italia.
Stiamo parlando di “Italian Job”.
È giusto prendersela
solo con qualche collaboratore o bisognerebbe parlare di sistema radicato?
La teoria delle mele
marce va superata. Si considera, purtroppo, naturale che chi ha fatto politica,
chi ha avuto delle funzioni nelle istituzioni, invece, di andare in pensione e
coltivare giardinaggio o cucina debba fare il lobbista. Per quanto riguarda il
lobbismo dei politici, sono scandalizzato. Indipendentemente dai risvolti
giudiziari, ritengo inconcepibile che una persona che abbia ottenuto notorietà e
influenza, grazie al sostegno di cittadini che l’hanno votata per difendere
interessi e valori, possa usare le sue funzioni per vendere gas e armi. Così non
va. Il tema deve essere affrontato alla radice.
Le lacrime al
congresso della Bolognina, ancora oggi, rappresentano una pagina di storia. In
questo particolare momento, per cosa varrebbe la pena piangere?
Forse è bene che
ciascuno possa piangere anche in privato. Il problema è dimostrare la volontà di
fare atti clamorosi.
Ci spieghi meglio…
Faccio una proposta
politica. Di fronte allo scempio del Qatargate, chiedo che i candidati alla
segreteria del Pd, invece, di fare dichiarazioni separate si distinguano per un
atto politico, si uniscano con un documento per rimettere al centro la questione
morale, non parlando di mele marce, ma andando alle radici di quella visione
distorta della politica e del potere, che ha fatto ad alcuni abbassare la
guardia. Pur essendo composta la sinistra prevalentemente da onesti, bisogna
metter mano al cesto. Si tratta di una battaglia per la vera sinistra, per i
migranti, per i braccianti, quelli veri. Tante sono le realtà oneste, che a
causa di pochi, sono messe in condizione di disagio. Altra proposta che voglio
lanciare sulle colonne de “L’Identità” è che non si faccia più una politica
generica di difesa delle Ong.
Come difenderle?
La sinistra ha il
dovere di controllo, di distinguere i buoni dai cattivi. Solo così non si butta
con l’acqua sporca il bambino. Serve un esame di coscienza, rivedere una
politica e perché no chiedere scusa, come ho orgogliosamente fatto per cose
molto meno gravi di quelle attuali. Non c’è niente di male a dire di aver
commesso un errore, di aver abbassato la guardia sulla questione morale.
Stesso discorso,
d’altronde, potrebbe essere fatto anche per il caso Soumahoro…
Tutto quanto ho
detto in precedenza, vale anche per questa triste vicenda.
Quegli intrecci
tra Panzeri e gli 007 marocchini.
Le trasferte
"schermo" in Sahara e i rapporti con l'ambasciatore di Rabat a Varsavia. Luca
Fazzo il 17 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Prima del Qatar, i
rapporti col Marocco. Ora che l'inchiesta della Procura di Bruxelles sulla
presunta corruzione nel cuore del Parlamento europeo si è allargata al Paese
africano, emergono nuovi dettagli sulla rete di Antonio Panzeri. Centrale per
gli inquirenti sarebbe Abderrahim Atmoun, ambasciatore del Marocco a Varsavia.
Al centro degli interessi del Marocco verso l'attività dell'Europarlamento
soprattutto la pesca e le risorse del Sahara Occidentale, al centro di una
disputa decennale con la popolazione locale saharawi. Ad occuparsi del
collegamento in Belgio con l'ex eurodeputato sarebbero stati invece gli uomini
della Dged, il servizio di intelligence marocchino alle dirette dipendenze di re
Muhammad. Mentre il capo della Dged, Yassine Mansouri, è ora sospettato dalla
procura di Bruxelles di essere un personaggio chiave dello scandalo mazzette. I
quotidiani belgi Le Soir e Knack fanno peró un passo indietro e riavvolgono il
nastro di questa storia fino al 2011. A quando Panzeri - che la Procura di
Bruxelles definisce l'anima di «una vasta organizzazione fraudolenta» - da
presidente della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti col il
Maghreb, sarebbe volato in Marocco, programmando una tappa a Tindouf, nel Sahara
algerino, d'accordo con le autorità marocchine.
Una visita, quella
nella capitale del popolo Saharawi, organizzata, rivelano i due quotidiani,
pensata per «preservare la credibilità dell'amico italiano, già accusato di
essere filomarocchino dal Fronte Polisario, che ha storici rapporti con la
sinistra italiana», e che combatte per l'indipendenza del Sahara Occidentale. Le
Soir e Knack citano tra virgolette documenti diffusi tra il 2014 e il 2015 da un
hacker, Chris Coleman. Tra i leaks rubati c'era anche questa nota inviata a
Rabat nell'ottobre 2011 dalla Missione marocchina presso l'Ue contenente la
preparazione della visita di Panzeri, nelle due settimane successive, a Tindouf,
dove si trovavano campi di rifugiati del popolo Saharawi. Tappa che avrebbe
ricevuto l'esplicito avallo di Rabat: «La visita a Tindouf è indispensabile per
rafforzare la credibilità di Panzeri presso l'Algeria e il Fronte Polisario,
dopo che quest'ultimo lo ha accusato di essere pro-marocchino - è la nota
pubblicata da Le Soir - Non è nell'interesse del Marocco» che Panzeri possa
essere percepito «come pro-Rabat». Anni dopo, nel 2019, secondo quello che
Francesco Giorgi, ex assistente di Panzeri, avrebbe confessato agli inquirenti
belgi, l'ex eurodeputato si trova in difficoltà perché, dopo tre legislature di
fila a Bruxelles, non viene rieletto. É allora, secondo Le Soir, che Panzeri
avrebbe stretto un patto con i servizi di intelligence marocchini, attraverso
l'intermediazione dell'ambasciatore di Rabat in Polonia, Atmoun.
Qatargate, Paolo
Mieli: "Cozzolino? Ricordo che sulla Russia..."
Libero Quotidiano il
17 dicembre 2022
Il Pd ha sospeso
l’europarlamentare Andrea Cozzolino. Pur non risultando attualmente indagato, i
dem hanno deciso di sospenderlo dato che il suo nome è saltato fuori all’interno
dello scandalo del Qatargate. “Il provvedimento mira a tutelare l’immagine del
Pd - si legge nella nota ufficiale - e a consentire all’onorevole Cozzolino la
più ampia difesa delle proprie posizioni”.
Intervenuto
a Tagadà, su La7, Paolo Mieli ha fatto notare che Cozzolino “si era auto-sospeso
come tutti, come Soumahoro. Questo rito dell’auto-sospensione io non lo capisco
perché non comporta nulla, solo che la gente se ne sta a casa per un po’ di
giorni. Vorrei ricordare che il partito socialista greco ha buttato fuori quella
signora coinvolta nello scandalo non appena sono uscite le prime cose: non ha
aspettato di fare questa ritualità… Il caso di Cozzolino è però doppiamente
importante: non hanno aspettato che lo arrestassero o trovassero banconote”.
“Ma sono venuti
fuori elementi imbarazzanti”, ha sottolineato Mieli, che ha poi ricordato anche
un altro aspetto che riguarda l’europarlamentare dem: “Cozzolino era uno di quei
parlamentari che sulla Russia si fecero venire insofferenze un mese fa, quando
persino il M5s si limitò ad astenersi al Parlamento europeo, mentre lui se non
ricordo male votò contro”.
Retorica a
pagamento.
Le "mazzette" del Qatar raccolte dai fondatori di una Ong dal
nome fatidico "Fight Impunity" fanno il paio con l'avviso di garanzia alla
compagna del deputato del Pd, Aboubakar Soumahoro. Augusto Minzolini il 16
Dicembre 2022 su Il Giornale.
Le «mazzette» del
Qatar raccolte dai fondatori di una Ong dal nome fatidico «Fight Impunity»
(combatti l'impunità), vicina alla sinistra, per coprire l'assenza di democrazia
e di diritti in quel Paese, fanno il paio con l'avviso di garanzia alla compagna
del deputato del Pd, Aboubakar Soumahoro, per la gestione della cooperativa per
migranti dal nome altrettanto enfatico, «Karibu», che in lingua swahili
significa «benvenuto». Un nome che però cozza con l'accusa di sfruttamento alla
base dell'indagine che la riguarda.
In entrambi i casi,
infatti, si usano purtroppo delle buone cause e dei giusti valori per specularci
su o, peggio, per fare l'esatto contrario di ciò che si professa. Lo dico senza
polemica, ma anzi con una punta di rammarico: è l'altra faccia del «buonismo»,
quando il «buonismo», come avviene spesso al mondo d'oggi, si trasforma in
un'ideologia.
Ci sono parole ed
espressioni potenti che si trasformano in lasciapassare per mettere in piedi
qualsiasi cosa per supposte battaglie ideali, sulle quali c'è però il rischio
che qualcuno lucri. I diritti umani, i migranti, la difesa delle libertà,
l'ambientalismo, la pace, l'Europa, addirittura la lotta alla mafia (basta
ricordare l'inchiesta sulla gestione dei patrimoni sequestrati alle cosche che
ha coinvolto un giudice a Palermo): sono tutti temi che vengono avvolti da una
spessa patina di retorica che impedisce di distinguere ciò che è giusto da ciò
che è sbagliato. Basta la patente di combattente per una buona causa, spesso
indefinita, per diventare intoccabili, per trasformarsi in entità su cui è
addirittura peccato nutrire dubbi o riserve. È lo stesso meccanismo alla base di
quei banchetti che incontri agli angoli delle strade, dove ti chiedono «una
firma per la lotta alla droga», tema sul quale è difficile non essere d'accordo,
accompagnata poi dalla richiesta di un obolo di cui non è chiara la
destinazione.
Ora, naturalmente,
sarebbe sbagliato gettare il bambino insieme all'acqua sporca, ma è anche vero
che di certe filippiche che si sentono in tv, di certa retorica a buon mercato
che impera nei «talk show», di certo buonismo basico e a volte persino banale
che caratterizza alcuni corsivi da quotidiano, si potrebbe pure fare a meno.
Anche perché la realtà - come ci ricordano le cronache di questi giorni - è ben
più complessa di come si presenta. Per cui i dubbi non sono solo leciti, ma a
volte anche funzionali ad evitare pericolosi miraggi che arrecano danni
irreparabili a quegli stessi valori che si vorrebbero difendere. Soprattutto
bisognerebbe fare a meno di quella retorica, che a volte sconfina
nell'ipocrisia, parente stretta di certo buonismo. La verità è che le buone
cause si servono con una buona dose di pragmatismo, di realismo e di apertura al
confronto, perché le belle idee che si trasformano in ideologia a volte rendono
ciechi. È la triste storia del secolo breve.
Il dito, la luna,
il Qatar e la Russia. Il deep state autoritario internazionale e la corruzione
legale dell’Occidente.
Carmelo Palma su
L’Inkiesta il 14 Dicembre 2022.
La potenza economica
delle non democrazie è cresciuta così rapidamente che oggi possono comprarsi
progetti di ricerca, cattedre universitarie, testate giornalistiche, influencer.
E non lo fanno lungo le linee del mondo privato, ma con l’infiltrazione pubblica
Del caso Panzeri &
Co. penso che l’essenziale – di cui discutere, su cui interrogarsi, di cui
davvero preoccuparsi – non stia nel sospetto o nell’accusa di corruzione (ancora
tutta da dimostrare) nei confronti degli indagati, arrestati o a piede libero,
di un’inchiesta che, anche se non fosse condotta da un magistrato belga
incolpevolmente paragonato, da un giornale italiano, ad Antonio Di Pietro,
meriterebbe comunque di essere presa con le pinze e nei dettagli, non con la
pala e all’ingrosso.
Questo purtroppo si
è però abituati a fare in un Paese, che ha un’idea della giustizia costruita sul
paradigma di Tangentopoli e in cui la flagranza di reato di uno diventa, per
proprietà transitiva, una prova di colpevolezza per tutti e dove comunque, come
disse un famoso maître à penser di Mani Pulite, non esistono innocenti, ma solo
colpevoli che non sono ancora stati scoperti.
Antonio Panzeri, Eva
Kaili e tutti gli altri accusati di avere parlato e fatto parlare bene del Qatar
dietro laute e non dichiarate ricompense sono il dito – forse penalisticamente
sporco, forse no: deciderà un giudice a Bruxelles – di una luna cattiva, ma
irraggiungibile per via giudiziaria, rappresentata dall’enorme potere di
condizionamento che gli Stati canaglia (al diverso grado di canaglierìa di
ognuno) possono esercitare legittimamente e illegittimamente, legalmente e
illegalmente, per determinare e propiziare il consenso delle opinioni pubbliche
dei Paesi liberi o supposti tali.
È fenomeno che in
Italia ha avuto una manifestazione letteralmente mostruosa rispetto alla Russia
di Putin, per quasi un ventennio nobilitata e legittimata – gratis et amore Dei,
non c’è dubbio – dai vertici dell’establishment politico e economico italiano
(dico Romano Prodi e Silvio Berlusconi, mica Marco Rizzo e Giuliano Castellino),
molto prima delle frequentazioni dell’Hotel Metropol da parte di Gianluca
Savoini per trattare, a quanto pare per finta, la cresta sulle forniture di
idrocarburi.
La stessa
cosa, mutatis mutandis, ma molto più in piccolo, anzi in piccolissimo, può pure
dirsi del Qatar, che ha conquistato i Mondiali di calcio senza neppure far
troppo finta di non essere quello che era.
La potenza economica
delle non democrazie nel mondo è cresciuta rapidamente negli ultimi decenni. Gli
investimenti produttivi, finanziari e pubblicitari di società statali e non
statali legate al deep state autoritario internazionale sono sempre più
determinanti per l’economia dell’Occidente.
Possono comprarsi o,
per così dire, affittare legalmente progetti di ricerca, cattedre universitarie,
testate giornalistiche, istituzioni culturali, think tank, opinion leader,
influencer e qualunque altra cosa faccia successo e immagine senza bisogno di
riempire le valigette di euro in nero, che a Bruxelles sarebbero state trovate a
casa di alcuni indagati. E così stanno facendo, con notevole e indiscutibile
successo.
La luna che gli
stolti non vogliono vedere è che la penetrazione degli Stati canaglia nel soft
power del potere occidentale non viaggia lungo le linee della corruzione
privata, ma dell’infiltrazione pubblica. Ed è un problema enorme per società e
economie aperte e quindi esposte anche a questa forma di cattura ideologica,
prima che corruttiva, che può trovare argini effettivi solo sul piano
politico-culturale, non su quello repressivo-giurisdizionale.
Pensare di fermare
questo fenomeno spiando le vacanze di questo e di quell’altro politico o
lobbista non dichiarato è, nella migliore delle ipotesi, un’illusione ingenua e
nella peggiore, e più frequente, una forma di cattiva coscienza.
Lo vediamo
quotidianamente a proposito della guerra russa all’Ucraina, in cui senza bisogno
di dazioni illecite e di mazzette nascoste un pezzo dell’informazione e della
politica italiana si è fatta da dieci mesi altoparlante della propaganda
moscovita, del «non ci sono prove che…», «però la Nato si era allargata troppo»,
«la Crimea è sempre stata russa» e «…ma in Donbass era in corso un genocidio».
Il «non si dica che Putin non vuole la pace», cioè il refrain gratuito della
campagna elettorale di Conte, mentre il famoso pacifista del Cremlino faceva
crimini a livello di Srebrenica, è stato molto più invasivo e epidemico delle
timide difese dei progressi del Qatar da parte degli eurodeputati socialisti,
indiziati di avere difeso a gettone le condizioni di lavoro degli immigrati
impegnati a costruire gli stadi per i Mondiali di calcio.
Purtroppo la
corruzione politica dell’Occidente – quella che davvero costa, pesa e determina
gli esiti delle elezioni, non i viaggi premio dei promoter – è oggi legalissima,
perché è indissolubilmente connessa al funzionamento e alla fragilità del
mercato politico e mediatico delle nostre democrazie. Questo sarebbe un bel tema
di cui discutere, se l’Italian connection di Bruxelles non fosse diventata la
nuova forma di scopofilia giudiziaria da cui la politica e l’opinione pubblica
italiana non sembra avere intenzione di guarire.
La dispercezione
sulla gravità del pericolo e del fenomeno, unita alla perversione guardonistica
che fa apparire esistente e vero solo ciò che trova spazio nelle aule dei
tribunali, è proprio ciò che ha portato negli scorsi anni a considerare come un
atto di folklore la sfilata di Matteo Salvini e dell’attuale presidente della
Camera Lorenzo Fontana con le magliette pro Putin nell’aula del Parlamento
europeo e porta oggi a spiare con trepidazione e allarme le email riservate pro
Qatar di Andrea Cozzolino.
Chi parla bene di
Putin, chi traduce in italiano i dispacci della propaganda moscovita, chi spiega
che di questo Zelensky e del suo regime nazisteggiante proprio non ci possiamo
fidare, può tranquillamente fare il Savonarola contro gli accusati e arrestati
di Bruxelles. Rimaniamo un Paese così, a misura di Fatto Quotidiano.
Anacronistiche
ossessioni. Anche a sinistra ci sono politici di debole tempra morale, ma non
c’è nessuna «questione».
Francesco Cundari su
L’Inkiesta il 17 Dicembre 2022.
Cosa c’entra il caso
Soumahoro con il Qatargate? E cosa c’entrano passati e presenti episodi di
corruzione o malversazione con Berlinguer, il Pci e il mito della diversità
comunista? Non ha senso commentare l’attualità con il lessico di un’altra epoca
Da giorni sulla
stampa e in tv si continuano a mescolare, come fossero due facce della stessa
medaglia, l’inchiesta internazionale sulle influenze esercitate dal Qatar nel
Parlamento europeo, che ha coinvolto diversi parlamentari ed ex parlamentari del
gruppo socialista, e il caso che riguarda la cooperativa gestita da moglie e
suocera del deputato eletto con Sinistra e Verdi Aboubakar Soumahoro. Non
stupisce che sia la destra a mettere vicende così diverse sullo stesso piano,
per farne il piedistallo da cui potersi scagliare contro tutti i suoi bersagli
preferiti, dalla sinistra alle ong, dai migranti ai burocrati di Bruxelles.
Stupisce che lo facciano la stampa, gli opinionisti e gli intellettuali
progressisti. Ma forse non dovrebbe stupire neanche questo.
Da quasi mezzo
secolo, ogni mattina, quando si alza il sole, un editorialista si sveglia e sa
che non importa quanto grave, esteso o circoscritto, epocale o microspico sia
l’episodio comparso in cronaca giudiziaria riguardante un qualche politico di
sinistra: da quel momento, volente o nolente, dovrà cominciare a scrivere un
commento sulla «questione morale». Dovrà citare due righe da quella lunghissima
intervista di Enrico Berlinguer a Eugenio Scalfari di ormai oltre quarant’anni
fa, dovrà ricordare sempre gli stessi bolsi aneddoti sul mito della diversità
comunista, sui militanti di una volta che preparavano tortellini e salamelle
alle feste dell’Unità, se necessario allargare il quadro alla pera di Luigi
Einaudi e al cappotto rivoltato di Enrico De Nicola, e chiudere quindi con
«altri tempi!» o una qualsiasi analoga esclamazione.
Confesso di avere
partecipato anch’io, infinite volte, a questo strano rito collettivo,
manifestando le mie personali riserve sul valore dell’intervista di Berlinguer a
Scalfari e ancor di più sul modo in cui nel corso del tempo è stata enfatizzata
e dilatata, fino a catturare e deformare l’intera figura di Berlinguer (uomo
politico che, nel bene e nel male, ha fatto e detto parecchie altre cose, assai
più rilevanti) utilizzandolo di volta in volta per regolare tutt’altri conti.
Resta per me ad esempio indimenticabile come, ai tempi del caso Unipol e della
scalata alla Rcs, i grandi giornali evocarono la memoria del segretario del
Partito comunista italiano quale icona della separazione tra politica ed
economia, confondendolo forse con Milton Friedman. Ma anche questo, già allora
anacronistico, è un dibattito di quindici anni fa.
Quante volte ancora
dovrà finire questo mito della diversità comunista? Quante volte ancora dovrà
essere infranto questo secolare tabù? L’intervista sulla «questione morale» è di
quarant’anni fa, il Partito comunista non esiste più da trenta, non è possibile
che di fronte a ogni piccolo o grande caso di corruzione, malversazione,
malaffare, ogni volta, dobbiamo fare ricorso a un lessico famigliare del secolo
scorso, che non ha più nessuna relazione con il presente, e che paradossalmente,
anche quando è utilizzato per criticare quella presunzione di superiorità,
finisce per alimentarla e confermarla, come se non soltanto i comunisti
dovessero essere per principio immuni da qualsiasi tentazione, ma persino i loro
discendenti, fino alla settima generazione. Così da giustificare, ogni volta, un
nuovo dolente dibattito tra politici e giornalisti, e naturalmente attori,
registi e cantautori, tutti lì a parlarci del trauma rappresentato per loro da
questo o quello scandalo, e delle sofferenze del popolo della sinistra, e della
mutazione genetica dei suoi dirigenti, e della perdita dell’innocenza (ma anche
questa benedetta innocenza: quante volte la vogliamo perdere? Quand’è che ci
possiamo rassegnare, metterci una pietra sopra e rifarci una vita?).
Siamo forse tutti
abbastanza grandi, ormai, per riconoscere che ci sono i ladri, ci sono i
farabutti, ci sono politici corrotti o comunque di debole tempra morale, anche a
sinistra, e non solo tra quelli che ci stanno antipatici, ma non c’è nessuna
«questione» che tenga insieme vicende tanto disparate, passate e presenti.
Il “Qatargate” è
uno squallore, ma Panzeri e soci non sono mostri.
Il fatto che le
persone coinvolte appartengano alla sinistra stupisce solamente gli elettori di
sinistra...Daniele Zaccaria Musco su Il Dubbio il 16 dicembre, 2022.
Le valigie con il
milione e mezzo in tagli da venti e cinquanta euro nascoste sotto il divano, i
viaggi regalo negli hotel a cinque stelle di Marrakesh, le bottiglie di
champagne, le vacanze sfarzose, gli yacht, l’abbronzatura, i selfie tutti
sorrisoni bianchissimi sullo sfondo di scorci mozzafiato.
Le istantanee del
“Qatargate”, che i media vogliono descrivere come un’apocalittica spy story,
addirittura un attacco al cuore della democrazia europea, ricordano molto più la
trama sbrindellata di un cinepanettone.
Con al centro una
combriccola di provinciali arricchiti che si perdono e si trastullano
nell’ebrezza del lusso e dei soldi facili fino a quando, poi, non finiscono nei
guai. Climax inevitabile.
Come l’ex
sindacalista Antonio Panzeri, passato dalla camera del lavoro di Milano dove era
soprannominato “il panzer” ai bordo piscina degli emiri del Golfo, roba da far
perdere la testa. Ci vedresti bene Renato Pozzetto nei panni di un personaggio
del genere, che poi è una delle tante versioni del paraculo, un po’ ruffiano e
un po’ mitomane che ha fatto le fortune della commedia all’italiana, lo specchio
distorto delle pubbliche virtù che riflette i nostri vizi privati. E in effetti
da chi gravita attorno all’Europarlamento, specie da chi ha un mandato popolare,
ci si aspetterebbe che le istituzioni europee non vengano usate come un autobus
per rimpinguare il conto in banca.
Il fatto che le gran
parte delle persone coinvolte nello scandalo appartenga a partiti di sinistra
stupisce soltanto gli elettori di sinistra ancora convinti di esercitare una
qualche superiorità morale sulla società ed è una manna per la narrazione della
destra, che può speculare all’infinito su quanto gli amici del popolo siano
lontani dal popolo e le ong che aiutano i migranti un covo di ipocriti e
squallidi affaristi che si arricchiscono alle spalle dei poveri diavoli. Questo
elemento simbolico conta più di ogni altra considerazione nella percezione
mediatica del “Qatargate” perché il contrasto tra predicare e razzolare è
accecante.
Va da sé, anzi,
dovrebbe andare da sé che nessuna delle persone finora coinvolte è stata
condannata da un tribunale, che al momento non ci sono imputati formali e che
l’unico europarlamentare indagato è la socialista greca Eva Kaili, attualmente
in custodia cautelare in un carcere belga per decisione del procuratore-sceriffo
Michel Claise.
I media dicono che
l’affaire è destinato ad allargarsi, che ad esempio sarebbero almeno sessanta i
deputati europei contattati dai servizi segreti marocchini per aver in cambio
non si sa quali favori. «A libro paga!», titolano intanto le edizioni online dei
principali giornali anche se i magistrati devono ancora definire i contorni
dell’ingerenza di Rabat.
Ma anche nel caso
fossero riconosciuti colpevoli al termine di un processo gli eventuali reati
commessi dalla combriccola non sembrano andare oltre la frode fiscale (l’unica
evidenza è che quei soldi non sono stati dichiarati). Panzeri è soci non hanno
infatti stornato fondi pubblici destinati alla costruzione di strade, scuole e
ospedali e fino ad ora non si ha notizia di benefici concreti ottenuti dai loro
generosissimi finanziatori se non un generico ritorno di immagine.
In un discorso
pronunciato nell’emiciclo di Strasburgo Eva Kaili aveva pronunciato parole di
grande elogio nei confronti del Qatar, «paladino dei diritti dei lavoratori» se
confrontato agli emirati confinanti, salutando la decisione della Fifa di
assegnare a Doha i Mondiali di calcio 2022 e bacchettando l’occidente e il suo
sguardo “coloniale” nei confronti dei paesi arabi. Intervento imbarazzante alla
luce dello scandalo, ma Kaili non ha influenzato nessuna scelta politica, non ha
orientato nessuna assegnazione, nessuna votazione.
Avrebbe solo
intascato una cospicua somma per “parlare bene” dei suoi facoltosi sponsor.
Anche perché nella maggior parte dei casi il lobbismo funziona proprio in questo
modo, quasi come un investimento a fondo perduto per avere in cambio un vago
ritorno di immagine. In Paesi come l’Italia o la Francia e in parte la Germania
il lobbista viene associato automaticamente a una figura losca e traffichina che
persegue interessi privati contrapposti al bene generale. Nel mondo
anglosassonee così anche all’europarlamento invece è un ruolo regolamentato, con
tanto di status ed è considerato come espressione di parte ma legittima della
società civile.
Mani pulite a
Bruxelles (ma più crudeli). Scandalo Qatargate, la figlia di Eva Kaili e
Francesco Giorgi usata per ricattare il papà.
Piero Sansonetti su
Il Riformista il 16 Dicembre 2022
Il Qatargate si sta
trasformando in un Marocco-gate. Cambiano i nomi ma anche un po’ la sostanza.
Il Marocco non è il Qatar, i diritti umani, in Marocco, sono considerati in modo
diverso. Non penso che sia uno stato con un grado di democrazia uguale a quello
delle democrazie europee, ma quasi. Dico che cambia la sostanza perché una cosa
è prendere soldi per fare propaganda a una orrida dittatura, una cosa diversa è
se il committente della lobby è un paese democratico.
Vedremo. Anche
perché prima o poi dovranno pur dirci di quale reato sono accusati Panzeri,
Giorgi e la deputata Kaili. Per ora c’è ancora nebbia fitta sul reato. Sappiamo
solo che è considerato così grave che si è deciso di tenere tutti in carcere,
senza concedere i domiciliari almeno ad uno dei genitori di una bambina di 22
mesi. Non ha ancora due anni Ariadni, la figlia dell’on. Kaili: sicuri che è
necessario privarla sia del papà che della mamma? In genere in questi casi si
cerca di lasciare almeno uno dei due genitori, possibilmente la madre, ai
domiciliari, anche in presenza di reati certi e magari molto più gravi di quelli
che forse saranno poi contestati alla coppia diabolica.
La politica – come
si dice con termine generico e moderno – non è affatto interessata a questi
dettagli. La sentenza l’ha già emessa con decisione unanime e non ritiene di
doverla correggere. Sono una coppia diabolica e basta, anzi un terzetto
diabolico, e anzi, a quanto pare, un’associazione a delinquere di almeno 60
persone diabolica. Perché 60? Perchè si dice così, circola questo numero e i
giornali lo pubblicano. 60 deputati corrotti per parlare bene del Qatar. Il
peggior scandalo politico – dicono – di tutti tempi. Altro che i miliardi dati
alla Libia per imprigionare, torturare e talvolta uccidere i migranti che
cercano di raggiungere l’Europa. O gli ulteriori miliardi concessi – allo stesso
scopo – al governo di Erdogan. Quella è politica, è realpolitik, non è scandalo.
Parlar bene di un regime totalitario è una cosa vergognosa, finanziarlo e
spingerlo a uccidere è saggezza e prudenza. La sinistra italiana è
allineatissima su questa posizione. del resto è proprio la sinistra che firmò ed
esaltò l’accordo coi libici, no? Non c’è differenza apprezzabile tra le
dichiarazioni dei dirigenti del Pd e i titoli scandalizzati dei giornali della
destra.
Inutile dire che in
questo clima nessuno ha voglia di sollevare qualche obiezione su come le
indagini sono state svolte. Chi le ha condotte? I servizi segreti belgi. Già.
Non ci credete? Sì, anche per me è una cosa stupefacente e confesso la mia
ignoranza. Non sapevo che esistessero dei paesi europei dove i servizi segreti
possono svolgere indagini e persino effettuare perquisizioni senza
autorizzazione della magistratura. Gli 007 italiani ora dichiarano che c’erano
anche loro. Speriamo che, come spesso gli succede, mentano. Sapevo che in
passato queste cose le faceva l’Ovra, la polizia fascista, e il Kgb in Russia, e
la Stasi nella Germania dell’Est. Immaginavo che fossero pratiche del passato. E
non sapevo nemmeno che esistessero paesi dove si possono arrestare i deputati.
Dicono gli esperti: la Kaili è stata arrestata sebbene godesse di immunità
parlamentare perché è stata colta in flagrante. Che vuol dire in flagrante? In
flagranza di reato. Ma come si può stabilire se c’è flagranza se ancora non si
sa neppure quale sia il reato?
Sì, il clima è
quello che noi italiani abbiamo vissuto ai tempi di Tangentopoli. Però le
illegalità sono più gravi e l’accanimento furioso è maggiore. Anche i metodi
sono cambiati. In peggio. Non credo francamente che Di
Pietro e Colombo avrebbero negato i domiciliari a una mamma che ha una bambina
di 22 mesi, la quale bambina, oltretutto, ha anche il papà in prigione. E mi
pare di aver capito che il papà è stato indotto a parlare, e forse a confessare,
con la minaccia di una lunga carcerazione e dunque dell’abbandono di Ariadni.
Non ricordo nessuna indagine giudiziaria nella quale un neonato sia stato usato
come arma di ricatto contro i genitori. Non so se i politici italiani, così
indignati per Panzeri, siano altrettanto indignati per questo uso infame di un
bambino. Non mi risulta che siano state presentate interrogazioni parlamentari.
la cosa lascia tutti indifferenti. Per me è una mascalzonata senza precedenti.
Il Qatar-Gate comunque ha squadernato un problema che nessuno vuol vedere.
Quello delle lobby. Delle lobby buone e delle lobby cattive. Di quelle regolate,
come in America, e di quelle non regolate, come in molti paesi europei.Cosa sono
le lobby? Una forma di organizzazione politica che ha sostituito i partiti, i
sindacati, quelli che i politologi definiscono i corpi intermedi. Una volta
la lotta politica, e la difesa degli interessi, era affidata ai partiti e
ai sindacati. I quali rappresentavano interessi di classe, o di ceto, o
di genere, o anche di gruppi sociali più o meno grandi. La sede nella quale gli
interessi venivano esposti, analizzati, e poi posti sul tavolo della contesa,
era quella della battaglia politica. Lì si misuravano i rapporti di forza, le
capacità di influenza dei singoli partiti, e anche i rapporti tra interessi di
gruppo e interesse generale, nazionale.
Poi, via via,
soprattutto negli ultimi anni, i partiti si sono indeboliti sempre di più, anche
per via delle varie iniziative populiste e reazionarie (guidate dai 5 Stelle ma
con il consenso o la rassegnazione di tutti) che ne hanno limitato i diritti e i
finanziamenti; e gli interessi hanno preso altre strade: le lobby. Le quali
addirittura, come vediamo ora, sono riuscite a diventare protagoniste non solo
della politica economica e della vita interna, ma anche della politica
internazionale.
Qual è la differenza
tra le lobby e i partiti? I partiti sono democratici e sono il nerbo della
democrazia. Le lobby non hanno nulla di democratico. Sono solo strumenti dei
gruppi, o degli stati, e in ogni caso dei più forti. La decadenza della nostra
democrazia ha molto a che vedere con questo mutamento. I partiti erano un
esercizio quotidiano di democrazia diretta e rappresentativa. Ma i partiti, e la
nostra fragilissima intellettualità, oggi non sono in grado di accorgersene.
Tantomeno è in grado la rete ormai rinsecchita dei giornali e dei mass media.
Piero Sansonetti.
Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di
cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004
al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per
poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre
2019.
Come ai tempi di
Mani Pulite. Visentini: ho preso i soldi però li ho versati al sindacato.
Il leader
della sigla Ituc: "Ricevetti in buona fede le donazioni da Panzieri". Luca Fazzo
il 17 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Ci sono la Russia,
la Bielorussia, l'Iran, l'Afghanistan e il Myammar. Nell'elenco dei Paesi che il
mese scorso il congresso mondiale dell'Ituc a Melbourne richiamò con una
risoluzione al rispetto dei diritti umani e dei lavoratori brilla un assenza: il
Qatar. La potente organizzazione sindacale internazionale, che raduna 388 sigle
di centinaia di paesi, è sembrata dimenticarsi di uno dei temi più caldi: le
condizioni di sfruttamento della manodopera nei cantieri dei Mondiali di calcio.
Ora quella
dimenticanza pesa inevitabilmente sulla figura di Luca Visentini, sindacalista
della Uil che nel congresso di Melbourne venne eletto segretario generale della
Ituc, arrestato il 9 dicembre a Bruxelles insieme all'ex eurodeputato Antonio
Panzeri e ad altre tre persone.
Visentini è stato
scarcerato dopo l'interrogatorio, e ieri ha rilasciato una intervista all'Agi
definendo «terribile» il periodo trascorso in prigione e fornendo la sua
spiegazione sui soldi ricevuti da Fight Impunity, la ong di Panzeri al centro
del Qatargate: una «donazione» di diverse migliaia di euro, utilizzata secondo
Visentini per i bisogni dell'Ituc, «il sindacato internazionale riceve
regolarmente donazioni per campagne e progetti da varie fondazioni e Ong, questa
donazione non risultava sospetta in alcun modo ed è stata accettata in assoluta
buona fede. Tutto il contributo è stato utilizzato per spese trasparenti e
dimostrabili».
Gli inquirenti
belgi, a quanto pare, hanno preso in parte per buona la spiegazione, e hanno
liberato Visentini (che però risulta essere ancora sotto inchiesta). Ma la
spiegazione fornita non dissipa i dubbi sui rapporti tra Panzeri e Visentini.
Anzi. Perché nello statuto della ong dell'ex eurodeputato Pd non figura in alcun
modo tra le spese sociali il sostegno di colossi sindacali come l'Ituc. E perché
nei documenti dell'Ituc è palpabile - anche se nell'intervista Visentini cerca
di negarlo - l'atteggiamento benevolo verso il Qatar. Non c'è solo la
dimenticanza nei documenti congressuali. C'è un testo dell'ottobre precedente di
ossequio quasi comico al Qatar che metterebbe in campo «leggi sul lavoro e un
moderno sistema di relazioni industriali». Un testo assai simile a quello
pubblicato pochi mesi prima a firma di Panzeri sul sito di Fight Impunity.
Di fatto attraverso
Panzeri una parte dei fondi stanziati dal Qatar per addomesticare il parlamento
europeo arrivano, tramite Visentini, nelle casse del sindacato internazionale, e
ottengono il medesimo risultato. A ottobre, quando viene diffuso il benevolo
rapporto Ituc, Visentini non è ancora segretario generale. Ma è a capo della
sezione europea ed è in stretti rapporti con la segretaria Sharan Burrow che il
mese dopo sarà tra i suoi sponsor nella vittoriosa battaglia per la leadership
contro il turco Kemal Ozkan, sostenuto dai potenti sindacati tedeschi.
È dunque uno
scenario sempre più tentacolare quello che viene ricostruito delle attività
della ong di Panzeri (il cui co-fondatore Gianfranco Dell'Alba ieri si dissocia
platealmente, «Panzeri è come mister Hyde»): addomesticare gli eurodeputati non
bastava, serviva tenere buoni anche i sindacati internazionali.
Intanto
l'australiana Alison Smith, moglie e collaboratrice del segretario di No Peace
Without Justice Niccolò Figà Talamanca, anche lui arrestato, diffonde un
comunicato: «Siamo certi della correttezza del suo operato. Verrà scagionato da
ogni addebito».
La
giustificazione che non regge.
Esiste la "modica
quantità" di consumo di stupefacenti. Non sapevamo però vi fosse il principio di
"modica mazzetta". Marco Gervasoni il 17 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Esiste la «modica
quantità» di consumo di stupefacenti. Non sapevamo però vi fosse il principio di
«modica mazzetta». Eppure il sindacalista Luca Visentini, indagato ma scarcerato
nell'inchiesta Qatar, si giustifica dicendo che avrebbe usufruito solo di una
«modica donazione» da parte della ong di Panzeri, poi utilizzata per il
sindacato. Non siamo giustizialisti mozzaorecchi o moralisti un tanto al chilo,
perciò: 1) I soldi in politica sono indispensabili 2) Siamo per il sistema
statunitense, ognuno doni a chi vuole e nelle quantità desiderate, purché
pubblicamente 3) Visentini, così come Panzeri e gli altri, sono da considerare
innocenti fino a condanna definitiva. Ma ci preoccupa un po' l'idea, emergente a
sinistra per confondere le acque, che si debba distinguere tra coloro che hanno
accettato finanziamenti per il bene del partito (o del sindacato) e invece
quelli che li avrebbero utilizzati per vacanze da 9000 mila euro a persona. Da
un punto di vista penale non vi sarebbe differenze, ma da quello etico-politico
si. Ciò fa il paio con la proposta di un parlamentare dem di ripristinare il
contribuito statale ai partiti, in nome del ritorno della supremazia della
politica. Eh no, altro che supremazia della politica. Prima di tutto, i partiti
dei tempi di Tangentopoli non esistono più: oggi sono agglomerati di correnti o
organizzazioni al servizio del capo. Che comunque costano, anzi forse più dei
vecchi partiti di massa. E finanziarli in maniera illegale nulla ha a che vedere
con la politica. In secondo luogo, i post comunisti utilizzano ora lo stesso
refrain dei partiti della prima repubblica: rubavamo, ma per il partito, non per
noi. A parte che, come lamentava già allora Rino Formica, «il convento è povero
e i frati sono ricchi», chi è in grado di raggranellare, in maniera non
trasparente, il maggior numero di risorse economiche, è anche quello che è in
grado di condizionare la vita del partito: quindi si ritorna al prevalere della
corrente e del capo, altro che supremazia della democrazia. Infine, a proposto
di etica, qui non si tratterebbe di mazzette sui lavori pubblici ma di ingenti
flussi di denaro da Stati dispotici, che praticano la violazione dei diritti più
elementari, delle donne ma anche dei lavoratori. Il sindacato finanziato da
regimi che trattano gli operai come gli antichi egizi gli schiavi. Compagni,
trovate un argomento migliore.
LA LETTERA DOPO
L’INCHIESTA DI DOMANI. Non solo Qatar. Gli eurodeputati chiedono chiarezza alla
Commissione sul caso Heiko von der Leyen.
FRANCESCA DE
BENEDETTI su Il Domani il 16 dicembre 2022
Su conflitti di
interesse, influenze improprie e porte girevoli, è il momento di fare chiarezza
in tutte le istituzioni europee. Anche Ursula von der Leyen non può esimersi: è
questo il messaggio che un gruppo di eurodeputati verdi ha appena spedito per
lettera alla Commissione europea.
La presidente von
der Leyen ha cominciato il suo mandato con grandi annunci sulla «trasparenza»,
ma si avvia a concluderlo all’insegna dell’opacità. Il modo in cui ha gestito
gli acquisiti dei vaccini, i messaggini mai resi pubblici con Pfizer, hanno già
messo in allerta la mediatrice europea, la Corte dei conti Ue e la procura
europea. A ciò si aggiunge il caso del marito Heiko, che ha incarichi di
spicco in una società che ha beneficiato anche di fondi europei.
Il suo
ruolo nell’hub di Padova e per Orgenesis Germania è stato portato alla
luce dagli articoli di Domani, ai quali fa riferimento la lettera a firma
di Michèle Rivasi, David Cormand, Rosa D’Amato, Damien Careme, Claude Gruffat,
Bénoit Biteau, François Alfonsi e Caroline Roose. Gli eurodeputati pretendono
chiarezza sui potenziali conflitti di interesse, in un momento in cui «la
credibilità del progetto europeo è in gioco».
LA LETTERA DEGLI
EURODEPUTATI
Proprio facendo
riferimento al lavoro giornalistico di Domani, gli eurodeputati verdi chiedono
spiegazioni alla Commissione europea. Si rivolgono in particolare alla
commissaria Vera Jourová, perché ha la delega alla trasparenza e allo stato di
diritto. «Lo scandalo in corso all’Europarlamento ha un impatto devastante su
tutta Europa, e questo è il momento di agire per fare pulizia di tutti i casi
non solo di corruzione ma pure di conflitti di interesse nelle istituzioni
europee». Von der Leyen, scrivono gli eletti, si è detta sconcertata per il caso
Qatar e aveva promesso trasparenza, «eppure non ha fatto nulla per reagire ai
casi di porte girevoli, né per rivedere le regole di trasparenza e di etica».
Poi la lettera entra nel merito del caso Heiko von der Leyen: «Siamo
particolarmente preoccupati dopo aver letto gli articoli pubblicati in Italia e
in Germania riguardo all’attività di Orgenesis, società americana attiva nei
paesi europei e per la quale lavora il marito della presidente von der Leyen».
FARE CHIAREZZA
Gli eurodeputati
mettono in fila i fatti, portati alla luce dalla stampa: Heiko von der Leyen
dirige Orgenesis Germany GmbH. Era anche nel comitato di sorveglianza dello hub
di Padova. Orgenesis e le sue filiali europee non sono nel registro di
trasparenza Ue. Un consorzio diretto da una filiale (Mida Biotech) ha ricevuto
quattro milioni di euro nella cornice dei finanziamenti europei per la ricerca e
l’innovazione. «Il marito della presidente della Commissione europea ha un ruolo
manageriale di primo piano in quanto direttore medico e direttore generale di
una società privata, coinvolta in progetti finanziati o cofinanziati coi
programmi europei. Porsi domande su eventuali conflitti di interesse è a dir
poco legittimo».
Quindi la richiesta
alla commissaria Jourová, perché verifichi che tutto questo sia compatibile col
ruolo istituzionale di Ursula von der Leyen. Gli eurodeputati segnalano anche
l’urgenza di un organo etico indipendente che abbia potere di indagine e di
sanzione. «Mostriamo di essere davvero esemplari – è l’esortazione finale
– visto che oggi è in gioco la credibilità del progetto europeo.
FRANCESCA DE
BENEDETTI. Europea per vocazione. Ha lavorato a Repubblica e a La7, ha scritto
(The Independent, MicroMega), ha fatto reportage (Brexit). Ora pensa al Domani.
DAGOREPORT il 16
dicembre 2022.
C’è del marcio al
parlamento europeo di Bruxelles e non soltanto nel mondo pallonaro, ma le
mazzette - come vedremo si tratta di spiccioli trovate sotto il materasso della
vicepresidente Eva Kaili e dell’ex eurodeputato Pd, Antonio Panzieri, sono
soltanto la puntina (mance) di un iceberg corruttivo miliardario del Qatargate.
Uno scandalo,
insomma, annunciato e tenuto sotto la sabbia coperto o, peggio, sostenuto, dalle
autorità governative di mezzo mondo grazie alla complicità dei massimi dirigenti
sportivi della Fifa e dell’Uefa.
Poltronissime oggi
occupate dall’avvocato svizzero, Gianni Infantino, e dal suo collega sloveno,
Aleksander Ceferin. Il primo succeduto a Sepp Blatter, il secondo, alla leggenda
del calcio francese Michel Platini. Soltanto quest’anno sono stati scagionati
dalle accuse di corruzione e frode da un tribunale svizzero.
Tutto, in realtà, ha
inizio nel 2010 quando i mondiali 2022, a sorpresa, vengono “scippati” agli
Stati Uniti e assegnati agli emiri del Qatar. Tant’è che le autorità americane,
che pure hanno alcune basi militari strategiche nel golfo Persico, vogliono
vederci chiaro su una bocciatura che profumava di petrodollari.
Come testimoniava
anche questo disgraziato sito il 3 giugno 2015 che, raccogliendo le informazioni
da fonti ufficiali, titolava: “TODOS INDAGADOS! L'FBI APRE UN'INCHIESTA ANCHE
SUI MONDIALI DI QATAR E RUSSIA. E L'INTERPOL INSERISCE I DIRIGENTI FIFA TRA I
PIÙ RICERCATI AL MONDO - MERKEL: "L'ADDIO DI BLATTER È UNA BUONA NOTIZIA".
CHISSÀ CHI HA ASSEGNATO I MONDIALI 2006 ALLA GERMANIA, CON STRASCICO DI SOLITE
ACCUSE DI CORRUZIONE?”.
Cosa era successo?
Qualcosa di clamoroso e impensabile.
Il Dipartimento di
Giustizia degli Stati Uniti, non la pretura di Canicattì, il 27 maggio di sette
anni fa pubblicava un report, con cui incriminava “nove funzionari della Fifa e
cinque dirigenti aziendali per associazione a delinquere e corruzione”.
Un documento
accusatorio, firmato dal procuratore generale di New York Loretta E Lynch e dal
direttore dell’Fbi, James B. Comey, non dalla tenenza dei carabinieri di Rignano
sull’Arno, per aver assegnato (“comprato”?) grazie alla Fifa i mondiali del 2008
alla Russia e del 2022 al Qatar.
“Le autorità
svizzere – batteva l’Ansa - hanno annunciato l'avvio delle indagini sui Mondiali
di Russia e Qatar la scorsa settimana. E l'annuncio dell'Fbi mostrava come le
indagini per corruzione si stavano ampliando negli Stati Uniti. I Mondiali del
2018 e del 2022 - continuava l’agenzia di stampa - sono stati assegnati cinque
anni fa, dando via a una serie di critiche e polemiche a Sepp Blatter. La scelta
da subito ha fatto discutere, sollevando dubbi soprattutto sul Qatar, che manca
di esperienza calcistica e di infrastrutture”.
L'Interpol, scriveva
il “New York Times” aveva emesso sei “red notice” nei confronti di due ex
dirigenti Fifa e di 4 manager. Si allungava così la lista delle persone
ricercate il giorno dopo le dimissioni di Blatter. L'allerta, su richiesta Usa,
riguardava Jack Warner, Nicolas Leoz, Alejandro Burzaco, Hugo e Mariano Jinkis e
Jose' Margulies. I sei individui erano ricercati per diversi capi d'accusa,
inclusi “criminalità organizzata e corruzione”. Lo stesso Blatter ammetterà che
era stata manipolata l’assegnazione dei mondiali attraverso un giro di tangenti
milionario.
Federico Strumolo
per “Libero quotidiano” il 16 dicembre 2022.
I soldi arabi,
ormai, rappresentano una componente essenziale nel mondo del calcio. Ne è la
dimostrazione il Mondiale in Qatar, che si concluderà domenica con l'imperdibile
finale tra Argentina e Francia, e non ne fa certo un'eccezione la serie A, come
dimostrato dagli ingenti investimenti dal Medio Oriente anche nel nostro
campionato. Da ieri, d'altronde, è ufficiale il rinnovo della collaborazione tra
il Milan e Fly Emirates.
Un accordo per lo
sponsor di maglia che permetterà al club rossonero di più che raddoppiare le
entrate rispetto alla vecchia intesa, passando da 14 milioni di euro a stagione,
a 30. Così, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi continuerà a ricoprire
il ruolo di Official Airline Partner e Principal Partner del Diavolo: il logo
Fly Better sarà presente, come detto, sulle maglie del Milan e il marchio
Emirates comparirà anche sulle divise delle giovanili coinvolte nel progetto Ac
Milan Academy in Italia e all'estero (oltre a includere la presenza del marchio
Emirates all'interno dello stadio di San Siro e ulteriori iniziative di
marketing).
Un binomio, tra i
due colossi, nato nel 2007, con il marchio della compagnia aerea apparso per la
prima volta sulle maglie rossonere nella stagione 2010/11, subentrando alla
società di scommesse Bwin (e in quella stagione arrivò il diciottesimo
scudetto). «Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con il Milan e di
creare nuove opportunità per interagire con una delle tifoserie più passionali
al mondo - dice il presidente di Emirates Airline Tim Clark -. La collaborazione
con il club rossonero si aggiunge agli importanti investimenti realizzati in
Italia negli ultimi tre decenni».
E i (tanti) soldi in
arrivo da Emirates, permetteranno al club campione d'Italia di aumentare le
entrate dagli sponsor di maglia, rendendo le divise rossonere più ricche che
mai. Basti pensare che ai già citati 30 milioni dell'accordo ufficializzato
ieri, si aggiungono altri 30 milioni dello sponsor tecnico Puma (rinnovato lo
scorso giugno), più i 7 milioni da Wefox (accordo annunciato a febbraio per il
retro sponsor) e i 5 milioni di Bitmex (per lo sponsor sulla manica, dopo
l'intesa ufficializzata lo scorso agosto), per un totale di ben 72 milioni, a
cui vanno aggiunti anche una decina di bonus.
Un'attenzione, del
Milan verso i mercati arabi, evidenziata anche dalla decisione del club di via
Aldo Rossi di aprire un nuovo ufficio a Dubai, con l'obiettivo di potenziare la
strategia comunicativa e commerciale dei rossoneri in tutto il Medio Oriente. E
non è un caso che la squadra di Stefano Pioli si trovi proprio nella capitale
dell'omonimo emirato per preparare la ripresa del campionato (che per il Milan
avverrà mercoledì 4 gennaio alle 12.30 in casa della Salernitana: da lì riparte
la rincorsa al Napoli e alla seconda stella) e, nel mentre, giocare amichevoli
di lusso che attirano i tifosi di quella parte del mondo (martedì è arrivata la
sconfitta 2-1 contro l'Arsenal e in tribuna erano presenti tanti appassionati
con la maglia rossonera; oggi alle 16.30 italiane si gioca Milan-Liverpool, in
diretta esclusiva su Dazn).
Al gruppo si è
aggiunto proprio ieri anche Simon Kjaer, rientrato dopo il deludente Mondiale
con la sua Danimarca, terminato con l'ultima posizione nel gruppo D, proprio
quello vinto dalla Francia di Theo Hernandez e Olivier Giroud, unici milanisti
ancora in Qatar e per cui tutti i compagni faranno il tifo domenica pomeriggio.
Dalla Camera del
lavoro a quella delle tangenti: ecco come funzionava la Ong di Panzeri al
Parlamento Europeo.
Redazione CdG 1947
su Il Corriere del Giorno il 16 Dicembre 2022
Al momento nel
mirino della Procura ci sono i deputati italiani e belgi del gruppo dei
Democratici & Socialisti . Ma nella ragnatela scrivono i magistrati italiani nei
decreti di perquisizione e sequestro nelle case italiane di Panzeri e Giorgi
disposti sulla base dell’ordine di investigazione europeo trasmesso a Milano "Ci
troviamo di fronte ad un gruppo indeterminato e molto ampio di persone dedito
alla consumazione di fatti di corruzione e operante all’interno di strutture
europee con o senza legami con l’Unione europea".
La Ong Fight
Impunity fondata da Pier Antonio Panzeri nel 2019 a Bruxelles, dopo la mancata
rielezione ha un ruolo centrale nella corruzione su cui verte inchiesta sulla
Tangentopoli europea della magistratura belga, un vero e proprio centro di
distribuzione di tangenti, provenienti da Qatar e Marocco e distribuite nel
Parlamento Ue dopo essere arrivate, ed occultate, nei conti correnti della Ong
che con la scusa dei diritti umani, era un fiume di soldi in nero.
Gli investigatori
belgi hanno più di qualche sospetto sull’ipotesi che nel giro di tangenti sia
coinvolto anche l’ eurodeputato campano del Pd, Andrea Cozzolino, a seguito
delle confessioni verbalizzate da Francesco Giorgi nell’interrogatorio di
garanzia, il quale avrebbe fatto il suo nome come possibile percettore di parte
delle tangenti provenienti dal Qatar e Marocco. Cozzolino al momento non è stato
indagato perché non ci sono tracce e prove di passaggi di denaro, ma
soprattutto, perché gode dell’immunità da parlamentare.
Cozzolino, secondo
quanto hanno ricostruito gli investigatori, sulla base degli atti parlamentari
ha avuto sempre una posizione “morbida”, sicuramente più morbida rispetto al suo
gruppo parlamentare, nei confronti del Qatar. Ad esempio si è astenuto su nove
emendamenti nella risoluzione del 24 novembre scorso sulla “situazione dei
diritti umani nel contesto della Coppa del mondo Fifa in Qatar”. Agli atti
dell’inchiesta è allegata anche una mail inviata dall’ eurodeputato napoletano
del Pd ai colleghi prima del voto, in cui scriveva:. “Vi ribadisco la mia
posizione che ho portato nell’incontro di ieri e vi chiedo di votare contro… Si
sostiene che la Coppa del Mondo sia stata assegnata dalla Fifa al Qatar grazie
ad abusi e corruzione. Il Parlamento europeo non dovrebbe accusare un Paese
senza prove. E in ogni caso, se vogliamo discutere di corruzione nello sport,
allora forse sarebbe necessario riflettere su tutto, compresa la Coppa del Mondo
che si è giocata in Germania nel 2006″.
Francesco Giorgi, ex
assistente di Panzeri ora al servizio di Cozzolino
Giorgi è il punto di
collegamento tra i due: dopo aver fatto l’ assistente di Panzeri, è passato a
lavorare dal 2019 per Cozzolino. Un altro nome fatto da Giorgi è quello del
deputato socialista belga Marc Tarabella, che è stato già perquisito. Tutti
negano addebiti di illeciti, mentre la Procura federale è impeganata alla
ricerca riscontri, valutando la possibilità di chiedere l’autorizzazione a
procedere al Parlamento. Ma è su questo che in questi giorni stanno lavorando
gli investigatori delegati dai magistrati attraverso l’analisi di “criminal
forensics” dei computer, dai telefoni, dalle chat anche quelle cancellate
recuperate grazie ai sofisticati mezzi a disposizione della polizia belga, con
cui stanno cercando di reperire delle eventuali accuse a carico di Cozzolino per
poi chiedere al Parlamento di procedere nei suoi confronti. Determinante sarà
quello che ha raccontato e racconterà il suo assistente, Francesco Giorgi.
Giorgi è stato molto
chiaro sulle eurodeputate Moretti e Arena. “Non ne ho mai sentito parlare. Sono
persone che rispetto e credo che la loro integrità non c’entri nulla in questo
contesto“. Il quotidiano La Repubblica scrive che a loro risulta
che Alessandra Moretti nell’ottobre scorso abbia effettuato un viaggio in Qatar,
come risulta anche dal suo profilo Twitter, con un’altra Ong vicina al governo
di Doha. Gli investigatori stanno cercando riscontri di questo viaggio, ed è il
reale motivo per cui l’ufficio della sua assistente è finito tra quelli sotto
sequestro. E in queste ore gli investigatori stanno verificando fra i documenti
e nei computer.
Nessuna domanda,
invece, è stata fatta a Giorgi sul ruolo di Bonifei. A conferma che il
principale collegamento è dato da alcuni ex collaboratori di Panzeri finiti poi
a lavorare con il capogruppo del Pd. E a proposito di assistenti, una delle
collaboratrici di Arena si è coperta di ridicolo facendo sapere di “non aver
avuto alcuna collaborazione” con Panzeri , ma solo una collaborazione con la sua
Ong, la Fight Impunity, che rimane cruciale però nell’indagine. I belgi
sostengono di avere le prove che nei conti correnti della società siano arrivati
direttamente fondi dal Qatar. A conferma che le contabilità della corruzione
sarebbero due: la prima, quella in contanti, e la seconda che gira invece sui
conti della Ong. Ed è proprio da quei conti che sarebbero partiti, secondo
l’impostazione iniziale della Procura, alcuni bonifici per “ammorbidire” le
posizioni di persone vicine alla cricca del Qatar. Giorgi in uno dei suoi
interrogatori ha confermato ai magistrati che le Ong servivano proprio “a far
girare il denaro“.
La principale
attività formale della Ong Fight Impunity era quella di redigere un rapporto
annuale. All’ultimo, quello del 2021, ha lavorato anche Giacomo Bartolo, il
figlio di Pietro Bartolo, un altro eurodeputato Pd. “Aveva un contratto a
partita Iva da circa 1. 900 euro lordi mensili – ha rivelato Giorgi –. Ha
lasciato dopo sette mesi perché la vita a Bruxelles era troppo cara e il lavoro
non pienamente soddisfacente”. Due assistenti dell’eurodeputato Bartolo, uno dei
quali aveva lavorato per Panzeri, sono stati perquisiti. Il suo nome non compare
nei mandati di arresto.
Al momento nel
mirino della Procura ci sono i deputati italiani e belgi del gruppo dei
Democratici & Socialisti . Ma nella ragnatela scrivono i magistrati italiani nei
decreti di perquisizione e sequestro nelle case italiane
di Panzeri e Giorgi disposti sulla base dell’ordine di investigazione europeo
trasmesso a Milano “Ci troviamo di fronte ad un gruppo indeterminato e molto
ampio di persone dedito alla consumazione di fatti di corruzione e operante
all’interno di strutture europee con o senza legami con l’Unione europea”. ha
scritto la procura nel decreto di perquisizione. Un gruppo che avrebbe venduto
la “propria attività” in cambio di “ingenti somme di denaro“.
Gli altri
parlamentari “vicini” alla Fight Impunity citati negli atti sono Eva
Kaili, Maria Arena, il capogruppo del Partito democratico Brando
Benifei e Alessandra Moretti. Cozzolino era il presidente della delegazione per
le relazioni con i Paesi del Maghreb e delle commissioni parlamentari miste
Ue-Marocco. Era inoltre membro della commissione Diritti umani, dalla quale sono
passate le risoluzioni più problematiche per il Qatar: ricopriva, dunque, per i
due principali “finanziatori” del gruppo, un ruolo cruciale.
I soldi in contanti
scovati dalla Polizia a Bruxelles costituirebbero solo una minima parte delle
tangenti. Nel frattempo gli investigatori della Guardia di Finanza stanno
spulciando sette conti correnti italiani che “perché è presumibile che il
provento dei fatti illeciti sia stato trasferito sui conti bancari”. Ed infatti
sono già stati individuati negli estratti conti resi disponibili dalle banche,
alcuni movimenti di notevole interesse investigativo. Una traccia sulla quale
gli investigatori hanno appena iniziato a lavorare per ricostruire il quadro
internazionale dell’organizzazione criminale che versava ingenti somme di denaro
in cambio dell’attività di fiancheggiamento degli eurodeputati (e non solo) che
erano sul libro paga delle tangenti pagate dai Paesi corruttori.
E’ stato Francesco
Giorgi a rivelare di far parte di un’organizzazione utilizzata sia dal Marocco
che dal Qatar per influenzare gli affari europei, confermando che Panzeri era il
capo di questa organizzazione, che si celava dietro la facciata della Ong Fight
Impunity e di aver avuto il ruolo di gestire le grandi quantità di
denaro. Panzeri era considerato un “amico” dai servizi segreti del Marocco, ed
aveva lavorato a Bruxelles nel 2017 con l’attuale ambasciatore del Marocco in
Polonia, Abderrahim Atmoun, ritenuto l’agente della corruzione, nell’ambito di
una commissione bilaterale.
L ’eurodeputato
spagnolo Miguel Urbán, eletto con Podemos, non veniva ritenuto “amico” del
Marocco, ed aveva denunciato nel maggio 2021un’intrusione notturna di ignoti
nella sua casa di Madrid. dove sono stati rubati due hard disk, foto di famiglia
e il salvadanaio di sua figlia, ma lasciati oggetti di maggior
valore. Urbán insospettitosi, aveva denunciato l’ accaduto alla polizia spagnola
ed al servizio di sicurezza del Parlamento Ue, che avevano valutato l’episodio
come sospetto in quanto realizzato da “mani esperte”. David Sassoli, all’epoca
dei fatti presidente, aveva immediatamente allertato i ministeri degli Interni
di Spagna e Belgio. Alla luce dei fatti emersi negli ultimi giorni anche questo
episodio è diventati oggetto di valutazione da parte degli investigatori belgi.
Tra le indagini in
corso su richiesta della magistratura belga, anche la convocazione delle persone
che hanno lavorato con la Ong Fight Impunity, fondata dall’ex parlamentare
europeo Panzeri, perché viene considerata uno dei cuori dell’inchiesta. La
polizia belga ha accertato che parte dei fondi arrivati sui conti correnti della
Ong giungessero direttamente dal Qatar. Quello che ha raccontato Francesco
Giorgi ha trovato conferma: “le Ong servono a far girare il denaro”, che è
quello che è stato contestato a Luca Visentini, il segretario del sindacato
mondiale, fermato e poi rilasciato la scorsa settimana.
Visentini aveva
ricevuto dalla Fight Impunity un finanziamento per la campagna elettorale che lo
ha eletto segretario. La Procura sospetta che sia stato uno scambio per ottenere
dichiarazioni pro-Qatar, alla vigilia dei campionati del mondo. Visentini si è
difeso comprovando che i bonifici erano stati registrati ed i soldi utilizzati,
effettivamente, per la campagna elettorale. Provando che le posizioni del
sindacato nei confronti del Qatar erano state sempre molto dure. Il giudice ha
creduto a queste giustificazioni, e per questo, lo ha rilasciato.
Redazione CdG 1947
Giacomo Amadori
François De Tonquédec per “la Verità” il 17 dicembre 2022.
L'indagine del
giudice istruttore belga Michel Claise sulla corruzione all'Europarlamento, come
in ogni inchiesta che si rispetti, sta seguendo la scia dei soldi. E quella
pista starebbe portando i segugi belgi verso le latitudini temperate del Sud
America.
Prima, però, di
andare avanti con il nostro racconto conviene fare un breve riassunto delle
puntate precedenti.
Claise sta indagando
su «un'organizzazione criminale», finanziata da Marocco e Qatar, di cui si
ipotizza facciano parte l'ex sindacalista della Cgil ed eurodeputato del Pd e
poi di Articolo Uno Pier Antonio Panzeri, il suo ex assistente Francesco Giorgi,
il segretario generale dei sindacati globali (Ituc) Luca Visentini e Nicolò Figà
Talamanca, segretario della Ong No peace without justice.
Un'organizzazione
che opererebbe all'interno del Parlamento europeo con la collaborazione di
persone designate come «amici». Per questo, tramite un ordine europeo di
indagine, ha chiesto all'Italia di eseguire investigazioni mirate. In queste ore
circolano poche informazioni sulle attività della Guardia di finanza coordinata
dal procuratore aggiunto di Milano, Fabio De Pasquale. Ma dal Belgio trapela che
Claise avrebbe chiesto di investigare su sette conti correnti italiani
riconducibili a Panzeri (due), alla figlia Silvia (uno), a Visentini (tre) e a
Giorgi (uno).
Ma la vera novità è
un'altra: a casa di Panzeri le Fiamme gialle sarebbero andate alla ricerca di
«tutti i documenti, anche informatici, relativi a conti bancari in Italia e
all'estero, presso Lift bank (Brasile) e altrove». Un istituto che si vanta di
essere la prima banca digitale per imprenditori del Paese sudamericano. Dunque
sembra che a Bruxelles ipotizzino che l'ex sindacalista abbia messo al sicuro il
proprio denaro sui conti di un istituto che ha il quartier generale nella città
di Vitoria, in una nazione governata da un altro ex sindacalista, Inacio Lula Da
Silva.
È lì che Panzeri ha
nascosto il proprio tesoro? Le indagini dovranno rispondere a questo quesito.
Gli investigatori sono andati anche alla ricerca di titoli, contanti, oro,
orologi di valore, documenti, cartacei e digitali, relativi al Marocco e al
Qatar e ai rapporti con altri personaggi coinvolti a vario titolo
nell'inchiesta: dalla compagna di Giorgi, l'ex vicepresidente dell'Unione
europea Eva Kaili all'ex parlamentare Davide Zoggia, ex presidente della
Provincia di Venezia e deputato del Pd, oggi assistente dell'europarlamentare
piddino Pietro Bartolo, a Giuseppe Meroni, da poco assistente (licenziato)
dell'eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, ma in precedenza collaboratore
dello stesso Panzeri.
Destinatari di una
perquisizione anche gli uffici di Opera della commercialista Monica Rossana
Bellini. Nel corso dell'indagine sarebbe emerso «chiaramente» che la signora
Bellini «è la responsabile della consulenza gestionale e finanziaria della
coppia Panzeri-Colleoni (Maria Dolores, la moglie dell'ex sindacalista, ndr)».
Per gli investigatori, secondo cui i guadagni di Panzeri «sembrano di natura
criminale», «l'intervento dello studio Bellini potrebbe far parte di operazioni
di riciclaggio».
Dagli inquirenti
Panzeri è considerato un personaggio sospetto anche per un precedente
riguardante l'utilizzo dei fondi europei, essendo stato condannato dal tribunale
dell'Unione in un caso di somme indebitamente versate quando era membro del
Parlamento europeo.
Dal sito Altalex
apprendiamo che la vicenda riguardava la legislatura 2004-2009 e il contratto di
prestazione di servizi di assistenza parlamentare stipulato da Panzeri nel 2004
con l'associazione «Milano Più Europa».
La vicenda era
iniziata nel 2009 con un'indagine dell'Olaf (Ufficio europeo per la lotta
antifrode) e nel 2016 il tribunale di primo grado dell'Ue aveva respinto un
primo ricorso di Panzeri contro la richiesta del Parlamento europeo di
rimborsare la somma di 83.764 euro indebitamente percepita dall'associazione
incaricata dell'assistenza parlamentare. Poi la condanna, che nelle carte
dell'inchiesta viene data come definitiva.
Ma è dal Belgio che
arriva la storia più clamorosa, ovvero i dettagli sul coinvolgimento
nell'inchiesta di Visentini, il capo dei sindacalisti mondiali che, dopo che è
uscito il suo nome sui giornali, ebbe a dichiarare il 14 dicembre di aver
«incontrato Panzeri un paio di volte quando era ancora europarlamentare, ma per
ragioni istituzionali, partecipando a riunioni, audizioni dove c'era anche lui».
La loro conoscenza
risalirebbe a «un anno, un anno e mezzo fa». Il capo dell'Ituc ha affermato
anche di avere accettato «in buona fede» la donazione proveniente dalla Fight
impunity per «la campagna per il congresso di Ituc che si è svolto a Melbourne
dal 12 al 22 novembre scorso».
Dopo il fermo
Visentini ha detto: «Le accuse riguardavano solo me (e non il sindacato, ndr),
ma poi nel corso dell'indagine non sono neanche state trovate evidenze che io
fossi in qualche modo collegato con questa vicenda». Dall'ordine europeo di
indagine risulta che per Claise i conti italiani di Visentini sarebbero stati
finanziati dal Belgio e probabilmente, sempre secondo l'accusa, con i proventi
dei reati di corruzione. Il Marocco e il Qatar, nell'ambito del loro disegno di
ingerenza, avrebbero pianificato l'elezione di Visentini al vertice dell'Ituc e
il finanziamento del sindacato con i petrodollari qatarioti.
Per arrivare a
questa conclusione, gli investigatori belgi e gli 007 del Vsse (Sicurezza di
Stato) hanno pedinato sia Panzeri che Visentini e il 10 ottobre 2022 devono aver
pensato di aver fatto bingo. Infatti hanno pizzicato Visentini mentre riceveva
tre buste a loro avviso piene di euro nel bell'appartamento di Bruxelles di
Panzeri. Inoltre gli inquirenti belgi hanno annotato che tra il 4 gennaio 2021 e
il 17 ottobre 2022 sarebbero stati trasferiti dal conto belga di Visentini sui
suoi tre conti italiani circa 140.000 euro.
Ma le sorprese non
sono finite. Gli investigatori il 9 ottobre, ovvero il giorno prima del presunto
scambio di soldi tra Panzeri e Visentini, avevano assistito a un'altra scena per
loro fondamentale: Panzeri aveva incontrato nientemeno che il ministro del
lavoro del Qatar in un hotel della Capitale belga.
Dunque il sospetto,
che affiora dall'ordine europeo di indagine, è che il capo dei sindacalisti di
tutto il mondo, l'uomo che dovrebbe rappresentare e tutelare a livello globale i
diritti dei lavoratori, possa essere stato prezzolato, attraverso un altro
sindacalista, l'ex presidente della Camera del lavoro di Milano, dal ministro
del lavoro di un Paese in cui si ritiene che circa 6.000 lavoratori senza nessun
diritto siano morti sotto il sole, mentre costruivano gli stadi di calcio del
Mondiale.
Una contestazione
che assomiglia molto a quella di essere la guida di un sindacato giallo, cioè
un'organizzazione che si ritiene di fatto asservita al datore di lavoro o ad
altri soggetti i cui interessi siano contrapposti a quelli dei lavoratori. Un
attacco che lascerà sgomente le persone che hanno combattuto a fianco di
Visentini e Panzeri per quei diritti e che li hanno difesi in buona fede.
Ovviamente ci auguriamo per loro, che i due sindacalisti riusciranno ad
allontanare da sé tali odiosi sospetti. Anche perché Visentini, dopo il fermo, è
stato rilasciato.
Estratto
dell’articolo di Monica Serra per “la Stampa” il 17 dicembre 2022.
Somme «consistenti»
di denaro, ma anche movimenti bancari di «interesse investigativo». Tracce
importanti, che la procura di Milano sta seguendo sui sette conti correnti
segnalati dai colleghi belgi, per provare a ricostruire quale giro facessero i
soldi che, a fiumi, per l'accusa, Marocco e Qatar hanno versato per
«infiltrarsi» nelle istituzioni europee e «condizionare» le politiche
dell'Unione.
Accertamenti
condotti di pari passo a quelli della polizia federale belga che si è
concentrata sui finanziatori della Ong Fight Impunity dell'ex eurodeputato Pier
Antonio Panzeri e che, come ha spiegato l'assistente parlamentare Francesco
Giorgi, «serviva a far girare i soldi». Di chi?
[…] il donatore più
importante di Fight Impunity era Sekunjalo Development Foundation: una
fondazione sudafricana che, secondo il Jerusalem Post, riceverebbe finanziamenti
dal Qatar. Nella veste di collettore delle tangenti versate proprio da Qatar e
Marocco per corrompere «un gruppo indeterminato e molto ampio di persone
operante all'interno di strutture europee, con o senza legami con l'Unione
europea», Panzeri viene dipinto come «l'anima dell'organizzazione fraudolenta»
[…]
[…] Per gli
investigatori di Bruxelles, «è presumibile che il provento dei fatti illeciti
sia stato trasferito sui conti bancari» per poi essere «riciclato» in qualche
altra attività.
Per questo, con un
ordine di investigazione europea mandato a Milano sabato, hanno chiesto al
procuratore aggiunto Fabio De Pasquale di compiere tutti gli accertamenti
necessari sui sette conti. Che appartengono alla famiglia Panzeri, a Giorgi e al
segretario generale della confederazione mondiale dei sindacati, Luca Visentini,
l'unico dei tre a essere stato rilasciato dopo il fermo. […]
Estratto
dell’articolo di Luca De Vito e Sandro De Riccardis per “la Repubblica” il 17
dicembre 2022.
Sette conti correnti
bancari. L'anello di congiunzione tra l'indagine di Bruxelles e la caccia ai
soldi che è partita in Italia. Sette depositi in altrettanti istituto di
credito, riferibili all'ex deputato europeo Antonio Panzeri, al suo ex
assistente Francesco Giorgi (poi transitato negli uffici dell'eurodeputato Pd
Andrea Cozzolino), e al segretario generale del Sindacato internazionale Luca
Visentini. […]
Quanti soldi sono
transitati su quei conti? Da dove sono arrivati i versamenti? Come sono stati
utilizzati in Italia? […] Per la procura belga Panzeri, ora in carcere a
Bruxelles, avrebbe «sviluppato e animato» una «vasta organizzazione fraudolenta»
i cui «atti criminali» avrebbero avuto una «natura complessa, organizzata e
ripetitiva». […] Il finanziamento alla campagna elettorale di Luca Visentini,
fondi arrivati dalla ong di Panzeri Fight Impunity, ammonterebbe a circa 50mila
euro. I magistrati belgi sospettano che sia denaro elargito dal Qatar per
ottenere dichiarazioni e prese di posizione favorevoli, considerato che
l'immagine dell'emirato era entrata in crisi proprio sul tema del lavoro, in
seguito ai dossier sugli operai morti per la realizzazione degli stadi per il
mondiale. […]
Da “la Repubblica”
il 17 dicembre 2022.
Caro Merlo, come
l'amore, la corruzione si fa in due. Non so mai capire chi ha più
responsabilità, se il corruttore o chi si fa corrompere. Attilia Giuliani
Risposta di
Francesco Merlo
Corrotti e
corruttori sono complementari, si trovano perché si cercano, si ingravidano a
vicenda, ma raramente si somigliano. Nessuno si meraviglia che un Paese di
pessima reputazione come il Qatar corrompa per avere il calcio, che ha la forza
di cancellare tutto. In questo caso, dunque, sono i corrotti a sorprendere
perché trafficavano con la virtù del sindacato, delle Ong Al contrario, negli
anni dell'abbondanza di Tangentopoli conducevano (quasi) tutti una vita sobria i
grandi capi dei partiti corruttori, da Andreotti a Forlani sino a Bettino Craxi.
Quel potere corrompeva con un distacco personale verso il danaro che qualche
volta era disprezzo.
L'esempio più
significativo del nobile corruttore incorrotto venne da Helmut Kohl. E poi
c'erano i tesorieri - Balzamo del Psi e Citaristi della Dc - che erano i monaci
poveri del convento ricco, come poi il ragionier Spinelli, l'ufficiale pagatore
del sesso sporco di Berlusconi. A volte i corruttori sono giganti sulle cui
spalle giganteggia il nano e altre volte sono nani che nanizzano i giganti.
Paolo Bracalini
per ilgiornale.it il 17 dicembre 2022.
«Con il rapporto
della Commissione sulle ingerenze straniere, il Parlamento europeo manda
finalmente un messaggio molto chiaro e inequivocabile contro le interferenze
straniere nei processi democratici e presenta proposte inequivocabili per
contrastare qualsiasi tipo di interferenza. Per troppo tempo abbiamo
sottovalutato gli effetti delle campagne di disinformazione sull'Ue e sui suoi
membri».
A fidarsi delle
parole di Pierfrancesco Majorino, europarlamentare Pd e anche candidato del
centrosinistra alla Regione Lombardia, c'era da stare tranquilli. Quali
ingerenze straniere potevano mai infiltrarsi in un parlamento dotato di una
attentissima commissione appunto contro le ingerenze straniere, organismo di cui
Majorino è uno dei coordinatori. La «Commissione speciale sulle ingerenze
straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la
disinformazione» (nome in codice della commissione: Inge) è nata nel 2020, la
presiede il francese Raphaël Glucksmann, eurodeputato del gruppo socialista in
pole per prendere il posto di Eva Kaili, l'ex vicepresidente destituita dopo
l'arresto nel Qatargate.
La commissione si è
data molto da fare: audizioni, scambi di vedute con esperti, dossier, briefings
e studi analitici su varie tematiche, come «Investire nella destabilizzazione:
come i soldi stranieri sono usati per minacciare la democrazia in Ue», o
«L'impatto della disinformazione sui migranti in Europa», o «Campagne di
disinformazione sulle persone LGBT+ in Europa e influenze straniere».
E poi dei bei viaggi
formativi, o meglio «missioni», in giro per il mondo per i membri della
commissione, da Taiwan a Washington all'Australia e via girando. Molto
impegnati, forse troppo, per riuscire a vedere le mazzette qatariote e
marocchine che passavano a pochi metri da loro, tra i parlamentari del gruppo
Socialisti e Democratici soprattutto. In effetti la Inge è stata sì molto
interessata alle interferenze delle potenze straniere sul Parlamento europeo, ma
in particolare ad alcune, quelle della Russia.
La Russia viene
citata più volte nei dossier, mentre i regimi arabi (Iran, Arabia Saudita,
Qatar) molto meno frequentemente. Nella relazione finale della commissione,
votata dalla plenaria del Parlamento Ue a marzo, la Russia è citata 60 volte, il
Qatar solo due.
E infatti il voto si
è trasformato in un processo ai partiti di destra (dalla Lega alla Le Pen),
definiti dal coordinatore della commissione, Majorino, «utili idioti» funzionali
alle ingerenze di Mosca in Europa. «Crediamo che il Parlamento europeo debba
tenere un faro acceso sulla Lega e i suoi dirigenti», concludeva l'eurodeputato
e candidato governatore in Lombardia. Fari accesi sui soldi (mai trovati) dalla
Russia, fari spenti sulle valigie di contante dal Qatar ai deputati di sinistra.
Controcorrente,
Toti asfalta la sinistra sul Qatargate: "Giudicano e si sentono immuni".
Il Tempo
il 17 dicembre 2022
Il presidente della
Liguria Giovanni Toti, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete4
sabato 17 dicembre, spiega qual è il peccato commesso dalla sinistra riguardo lo
scandalo Qatargate, al centro del dibattito della puntata. Secondo Toti la
sinistra e anche il Movimento 5 Stelle, hanno sbagliato a giudicare gli errori
di qualche politico sentendosi immuni.
"Io mi comporto in
questa vicenda come al solito e come ahimè non ho visto comportare altre forze
politiche, comprese le forze progressiste di questo Paese. Per me gli imputati,
gli accusati, gli avvisi di garanzia sono innocenti fino al terzo grado di
giudizio della giurisdizione che li giudicherà" spiega Toti. "Il fatto che
qualcuno abbia sbagliato a comportarsi o che ha avuto atteggiamenti illeciti o
impropri per il loro ruolo politico riguarda la singola persona e la sua
coscienza e le misure che le autorità proposte prenderanno. Non ho mai fatto di
tutta l'erba un fascio, non ho mai giudicato una comunità politica sulla base
del comportamento di qualche soggetto che ne faceva parte" prosegue.
"Purtroppo, negli
ultimi 10 anni, ho visto fare alla politica di questo Paese l'esatto contrario:
giudicare un corteo dal fatto che una persona rompesse una vetrina o avesse un
braccio alzato come se fosse un corteo di fascisti o facinorosi e dall'altra
parte giudicare un atteggiamento lassista come un'attitudine morale perché
qualcuno era stato preso con le mani nella marmellata condannando un'intera
comunità politica. Ecco, io credo che se tutti la smettessero, ma diciamo che
questo è un peccato della sinistra in tutte le sue forme e aggiungo anche il
M5S che ha messo il turbo quanto a giudizi semplicistici sul mondo. Questa è
sempre stata, dai tempi della questione morale di Berlinguer in poi,
un'attitudine della sinistra: giudicare gli sbagli di qualche singola persona
attitudine comune ad una comunità umana estesa come quella della destra o di
altri e a considerarsi in qualche modo immuni da tutto questo. Bruxelles ci dice
che nessuno è immune ma che nessuno deve essere per forza contagiato dal fatto
che il suo vicino di scrivania fa qualcosa che non deve fare" conclude Toti.
Controcorrente,
Rampini svela l'errore della sinistra su Kaili: "Dovevano cacciarla".
Il Tempo
il 17 dicembre 2022
Il caso Qatargate è
al centro del dibattito della puntata di controcorrente di sabato 17 dicembre su
Rete4. Federico Rampini analizza la vicenda spiegando qual è il problema
culturale della sinistra progressista, emerso ben prima della vicenda delle
tangenti.
"Io vedo un problema
di cultura della sinistra. C'è almeno un'imputata eccellente che non è
italiana: è Eva Kaili la ex vicepresidente greca. Parto da lei perché mi ha
colpito molto la sua frase, divenuta tristemente celebre, e molto antecedente
alla vicenda delle mazzette trovate a casa sua. Quando disse che il Qatar era un
modello per i diritti umani: un'affermazione ignobile e immonda visti i migranti
morti nei cantieri per i mondiali. E subito dopo aggiunse anche: non possiamo
dare lezioni sui diritti degli immigrati. Questo è il vangelo di una parte di
mondo che si auto definisce progressista e che secondo me non lo è e che
profondamente anti occidentale e che sostiene che solo l'occidente si macchia di
peccati ignobili contro i diritti umani" spiega Rampini.
"Solo noi siamo
oppressori, sfruttatori, colonizzatori mentre il resto del mondo è un'umanità
buona che ha diritto di risarcimento nei nostri confronti. È da questa cultura
di un mondo che io definisco sedicente e progressista di cui fanno parte anche
alcune ong di quella galassia Panzeri e Kaili. Proprio Kaili, secondo me,
avrebbe dovuto essere cacciata dal partito socialista greco e quindi
europeo solo per quella frase prima ancora che i poliziotti scoprissero a casa
sua le banconote. C'è un problema politico che andava affrontato alla radice.
Quello che poi fa si che un certo mondo accetta le tangenti perché se vengono
dall'emisfero sud del pianeta vengono dalla parte buona dell'umanità che ha
subito dei torti e che deve essere risarcita. Questo è il tema serio e grave
della cultura progressista. Noi avremo bisogno del Qatar a lungo perché è ricco
di gas naturale quindi il commercio con il Qatar lo dovremo fare chiudendoci il
naso ma questo non significa che dovremo genufletterci riconoscendogli una
superiorità morale che è una cosa indecente" conclude.
Antonio Panzeri e
il mistero dei 100 mila euro: controlli sui conti dei suoi contatti.
Giuseppe
Guastella su Il Corriere della Sera il 18 Dicembre 2022.
Buco nella somma
sequestrata all’eurodeputato. E la Grecia congela i beni della famiglia Kaili
Gli 007 belgi
entrano nell’appartamento del lussuoso residence di Bruxelles sapendo di avere a
disposizione tutto il tempo necessario per un lavoro accurato. È luglio, Antonio
Panzeri non tornerà presto dalla vacanza. Imbottiscono le stanze di microspie e
si mettono a contare fino a 700 mila, tanti quanti sono gli euro in contanti che
hanno trovato. Quando meno di cinque mesi dopo la polizia torna per arrestare il
fondatore della ong Fight Impunity, all’appello mancano 100 mila euro. Che fine
hanno fatto è questione di cui potrebbe interessarsi presto la procura della
repubblica di Milano.
È il 7 dicembre
scorso, mancano due giorni al blitz che incrinerà la già precaria immagine del
Parlamento europeo con l’arresto di Antonio Panzeri, di Francesco Giorgi, suo
assistente quando fino al 2019 fu parlamentare europeo del Pd e di Articolo 1 ed
ora lavora per Andrea Cozzolino (non indagato e sospeso dal Pd), e di altre
persone alle quali all’ultimo si aggiunge la eurodeputata greca Eva Kaili
(giovedì l’udienza sull’arresto), uno dei 14 vicepresidenti del Parlamento,
sorpresa in casa in flagranza di reato dopo che il padre era stato fermato per
strada con un trolley con dentro 600 mila euro in banconote. Si tratta di un
giro di tangenti, denaro e regali dal Qatar e dal Marocco per organizzare
«interventi politici presso membri del Parlamento europeo» con lo scopo di
migliorare la reputazione dei due paesi nel dibattito sui diritti umani. Il
primo, per il trattamento dei lavoratori dei cantieri dei mondiali di calcio
che, secondo alcune stime, avrebbero registrato 6.500 morti bianche; il secondo,
per la condizione degli immigrati che dal Sahel attraversano il Marocco per
raggiungere l’Europa e per le mire espansioniste nel Sahara occidentale.
Gli investigatori
hanno accertato collegamenti tra Panzeri, Giorgi, Cozzolino e l’ambasciatore del
Marocco in Polonia Abderrahim Atmoud, personaggio attivo in un centro studi di
Rabat a Bruxelles all’ombra del quale opererebbero i servizi marocchini. Dal
Marocco la ong avrebbe ricevuto finanziamenti bancari e in contanti finiti a
Panzeri (700 mila euro) e Giorgi, il quale ha scagionato la compagna Kaili
dicendo che lei non sapeva nulla e che i 750 mila euro trovati in casa e nel
trolley erano solo i suoi. Ieri l’autorità greca antiriciclaggio ha congelato i
beni della famiglia Kaili accendendo un faro anche su una società immobiliare
costituita dalla parlamentare e dal compagno di recente in un quartiere alla
moda e su una ong fondata nel 2017 dalla sorella Matalen. È la Elontech che,
secondo la stampa ellenica, sarebbe stata usata come veicolo per attrarre
programmi europei fino a 15 milioni di euro, cosa smentita dal legale della
famiglia. Torniamo alla data del 7 dicembre in cui la magistratura greca chiede
al procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, che guida il pool affari
internazionali della procura di Milano, di eseguire due giorni dopo le
perquisizioni nei confronti di un lungo elenco di persone connesse a Panzeri e
Giorgi che hanno conti correnti e beni in Italia. Nella richiesta si fa preciso
riferimenti ai 700 mila euro in banconote contati dagli 007 in casa Panzeri, di
cui però ne verranno ritrovati «solo» 600 mila. Sulle tracce dei 100 mancanti
potrebbe mettersi a lavoro De Pasquale che per conto dei colleghi belgi ha fatto
già perquisire l’abitazione di Panzeri a Calusco D’Adda, dove sono stati trovati
altri 17 mila euro, e quella di Giorgi ad Abbiategrasso, in cui ce n’erano 20
mila, oltre ad acquisire i conti di un persone a loro connesse. Tra questi,
quelli di assistenti di europarlamentari i cui uffici di Bruxelles sono stati
sequestrati dopo perché Panzeri, nella sua «attività di ingerenza» per conto di
Qatar e Marocco, avrebbe dato soldi anche a questi personag gi, denaro di cui
potrebbe essere rimasta traccia nei loro conti.
Il giudice
istruttore Michel Claise scrive chiaro anche che Antonio Panzeri «sembra aver
sviluppato e animato un’organizzazione fraudolenta» con «atti criminali» di
«natura complessa, organizzata e ripetitiva». L’inchiesta belga, precisa Claise,
si muove con interrogatori, confronti, ricerca di documenti e di fondi «oggetto
di questa appropriazione indebita» e per smantellare «possibili circuiti di
riciclaggio di denaro». Una rete di persone e di soldi sui quali i pm milanesi
potrebbero non limitarsi a fare solo il lavoro per conto del Belgio.
Il
documento pro-Qatar e l’Ong di Panzeri: spunta pure Rula Jebreal.
La giornalista -
paladina della sinistra - è stata invitata al Parlamento europeo per parlare di
una relazione nella quale si spendevano parole al miele per Doha. Massimo
Balsamo il 17 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Le indagini degli
investigatori belgi proseguono senza sosta e con il passare delle ore aumentano
le novità su quello che è stato ribattezzato Qatargate. Restano ancora molti
aspetti da chiarire e sono attesi aggiornamenti a stretto giro di posta.
Riflettori accesi sulle attività di europarlamentari e assistenti coinvolti
nello scandalo: tra questi, la socialdemocratica belga Maria Arena, presidente
della sottocommissione per i Diritti dell’uomo. Ebbene, lo scorso 10 maggio fu
proprio quella commissione a ospitare la presentazione del rapporto annuale di
Fight Impunity la Ong di Panzeri, con tanto di dibattito su un documento nel
quale si sosteneva - tra le altre cose - che gli Emirati Arabi cercassero di
corrompere gli eurodeputati per “screditare l’immagine dei Paesi rivali, come
Qatar e Turchia”. Tra gli ospiti esterni la professoressa Shelby Grossman e,
soprattutto, Rula Jebreal.
Rula Jebreal e il
documento pro-Qatar
Paladina della
sinistra, la giornalista italo-palestinese fu invitata a Bruxelles per dire la
sua su un documento che tratteggiava il Qatar come vittima degli Emirati Arabi
Uniti, storici nemici socio-politico-economici. Gli EAU si sono “inseriti con
successo nella mappa dello sport globale e nel settore dello spettacolo” grazie
alle“icone pop Lady Gaga e Jennifer Lopez che si sono esibite in occasione di
eventi di gala, alimentando l'idea di una società araba liberale” nonostante
la “discriminazione significativa contro le donne denunciata da Human Rights”,
l’analisi del rapporto riportata da Libero.
Affiancata dalla
dem Alessandra Moretti – che non faceva parte di quella sottocommissione – Rula
Jebreal partecipò al dibattito alla Droi sul documento che biasimava apertamente
il posizionamento del Qatar all’85esimo posto della classifica dei diritti
umani, con gli EAU 13esimi. Forse dimenticando migliaia di morti durante la
costruzione degli stadi per i Mondiali, la limitazione della libertà e i vari
diritti a rischio. E ancora, le critiche nei confronti l’embargo imposto al
Qatar da parte di Emirati, Arabia, Bahrein ed Egitto, "nonostante Doha avesse
«sostenuto le rivolte popolari in Egitto e Tunisia".
L’analisi di Susanna
Ceccardi
Rula Jebreal per il
momento non ha preso posizione, ma in passato sul suo profilo Twitter non aveva
lesinato difese nei confronti del Qatar. Tornando alla sottocommissione,
l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi ha rivelato di aver presentato
un’interrogazione al vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell per
chiedere che l’Ue “chiarisse i legami tra il Qatar e alcuni gruppi
terroristici”: “Avevo chiesto se intendesse valutare la possibilità di imporre a
Doha misure restrittive per limitarne l'intervento finanziario in Europa”. Nulla
da cambiare, la replica di Borrell. La Ceccardi, inoltre, ha ricordato la
provocazione di Rula Jebreal nei suoi confronti in quel 10 maggio:“Io capisco
che alcuni del movimento di estrema destra (la Lega secondo la giornalista) sono
pronti a farsi pagare da Putin...”.
"Cifre
consistenti". Da Milano è caccia alle mazzette del Qatargate.
Sotto la lente di
ingrandimento sono finiti versamenti e modalità di utilizzo del denaro. L'accusa
di riciclaggio potrebbe essere formulata anche a Milano. Luca Sablone il 17
Dicembre 2022 su Il Giornale.
Cercare e
possibilmente trovare i soldi del caso Qatargate. Quanto denaro è realmente
transitato? I versamenti da dove provengono? In quale modo sono stati poi
utilizzati? Sono molte le domande che devono assolutamente trovare risposta
nello scandalo di presunta corruzione che ha coinvolto più di qualche membro del
Parlamento europeo. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti alcuni conti
correnti di personalità che risultano essere di primo rilievo nella vicenda
emersa di recente.
La caccia alle
"mazzette"
Sarebbero già stati
eseguiti diversi accertamenti del caso su alcuni dei sette conti italiani che
la Guardia di Finanza, delegata Procura di Milano in esecuzione di un ordine di
investigazione europeo nell'ambito dell'indagine sul Qatargate, starebbe
acquisendo. Come spiegato dall'Adnkronos, si tratterebbe di una serie di
controlli richiesti dalla magistratura di Bruxelles che avrebbero la finalità di
fare luce sui possibili movimenti sospetti in grado di rafforzare la tesi
dell'accusa. In questo momento la magistratura milanese non ha provveduto ai
sequestri di iniziativa e resta in attesa di ulteriori indicazioni da parte di
Bruxelles.
Chi ha eseguito i
primi accertamenti parla di "cifre consistenti". I conti correnti sarebbero
riconducibili anche ad Antonio Panzeri (ex europarlamentare del Partito
democratico) e a Luca Visentini (segretario generale della confederazione
internazionale dei sindacati). Al momento comunque non è possibile quantificare
del tutto i saldi in questione e la filiera dei bonifici, visto che allo stato
attuale si hanno in possesso solo "alcuni spunti".
Tra le opzioni
future sul tavolo c'è anche l'apertura di un'indagine autonoma a Milano, anche
se i tempi non sono certi. Si attendono eventuali mosse da parte del
dipartimento Affari internazionali guidato dall'aggiunto Fabio De Pasquale. Come
riferito da La Repubblica, non è da escludere che l'accusa di riciclaggio possa
essere formulata anche nel capoluogo lombardo. Il motivo? Il Corriere della
Sera spiega che il sospetto degli inquirenti è che il tutto non si limita
ai sacchi di contanti trovati. Solo pochi giorni fa la polizia federale belga
avrebbe sequestrato un totale di 1,5 milioni di euro in contanti nell'ambito
dell'inchiesta sul Qatar.
Gli sviluppi sul
Qatargate
L'Ansa ha fatto
sapere che nel mandato di arresto europeo notificato a Maria Colleoni e Silvia
Panzeri (moglie e figlia di Antonio Panzeri) viene scritto che l'ex eurodeputato
dem "sembra aver sviluppato e animato" una "vasta organizzazione fraudolenta" i
cui i presunti "atti criminali" avrebbero avuto una "natura complessa,
organizzata e ripetitiva".
"Anima di
un'organizzazione fraudolenta": ecco come funzionava il sistema Panzeri
Ieri è arrivata la
mossa su Andrea Cozzolino, che è stato sospeso cautelativamente dall'Albo degli
iscritti e degli elettori del Partito democratico fino alla chiusura delle
indagini sul Qatargate. Il Pd ha deciso di intraprendere questa scelta sia per
"tutelare" la propria immagine sia per consentire all'onorevole Cozzolino "la
più ampia difesa delle proprie posizioni".
"Un amico
intimo". Una nota rivela i legami tra Panzeri e il Marocco.
Alcuni documenti
riservati confermerebbero il rapporto tra Antonio Panzeri e i diplomatici di
Rabat. In una nota del 2013, l'ex europarlamentare veniva definito "amico intimo
del Marocco". William Zanellato il 17 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Più passano le ore,
più il caso Qatargate è destinato ad allargarsi. Sia sul versante politico sia
sul piano geografico. Nei giorni scorsi gli inquirenti belgi, autori
dell’indagine che ha portato in carcere l’ex eurodeputato Antonio Panzeri e il
suo ex assistente Francesco Giorgi, hanno reso noti i tentativi di corruzione da
parte del Qatar. Oggi il quadro geografico sembra allargarsi e la pista
marocchina dell’indagine si fa sempre più concreta.
La lettera del 2011
Il legame
tra Antonio Panzeri e il Marocco potrebbe essere confermato - e qua ci
riserviamo di aspettare la ratifica degli inquirenti - da una serie di documenti
riservati di Rabat. A rivelare queste carte è un’inchiesta delle testate
belghe Le Soir e Knack che ricostruisce il rapporto tra il Parlamento europeo e
il Marocco partendo dai documenti pubblicati da un hacker marocchino dal nome
anglosassone, Chris Coleman. Da almeno 11 anni Antonio Panzeri era stato scelto
dal Marocco per difendere gli interessi di Rabat all’interno del Parlamento
europeo. È quanto emerge da una corrispondenza tra il ministro degli Esteri
marocchino e l’ambasciatore di Rabat presso l’Unione Europea inviata nel 2011 e
ripresa questa mattina da La Stampa. La lettera fa riferimento a una visita
a Tindouf di Antonio Panzeri. Tindouf è la città algerina dove ha sede il
governo in esilio della Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi, chiamata anche
Sahara Occidentale. L’oggetto della visita è significativo perché rientra negli
interessi politici del Marocco: mantenere il controllo del Sahara Occidentale,
regione rivendicata da Rabat.
Il "messaggio di
Panzeri"
La preparazione di
questa visita (e questo sarebbe il dato rilevante) certifica un contatto e una
stretta organizzazione tra Panzeri e le autorità marocchine. A pochi giorni
della partenza infatti, emerge una nota diplomatica dell’ottobre 2011 dove si
porta all’attenzione di Rabat un colloquio informale tra un consigliere di
Panzeri e l’ambasciatore marocchino presso l’Ue. Panzeri in quel momento era
presidente della Commissione Maghreb del Parlamento; quindi potrebbe essersi
trattato di un normale contatto diplomatico. Tuttavia il messaggio di Panzeri,
riferito da un suo consigliere alle autorità marocchine, sembrerebbe nascondere
secondi fini. “La visita a Tindouf - recita il documento - è indispensabile per
supportare la credibilità del sig. Panzeri presso l’Algeria e il Polisario,
visto che lui è stato accusato di essere pro-Marocco. Non è nell’interesse del
Marocco che il sig. Panzeri sia percepito come tale” . Panzeri, secondo quanto
riferito dal suo consigliere alle autorità marocchine, era molto attento a non
nominare l’autonomia né a fare dichiarazioni in quel senso per quanto riguarda
il Sahara Occidentale.
Il contenuto
del “messaggio di Panzeri", secondo quanto riporta il quotidiano torinese, è
stato ampiamente apprezzato dalle autorità marocchine: “A prima vista è
rassicurante, l’interessato è molto consapevole della sensibilità della sua
visita nei campi di Tindouf e fa uno sforzo per non compromettere i contatti con
il Marocco”. Le autorità marocchine sembano approvare “l’ambiguità
costruttiva” degli atteggiamenti dell’ex europarlamentare e la sua visione
portata avanti per mantenere l’asse Rabat-Bruxelles. Allo stesso tempo i
diplomatici di Rabat riconoscono l’importanza strategica del signor Panzeri
all’interno degli uffici di Strasburgo. “È difficile non vedervi un capacità di
disturbo, in quanto dimostra come l’interessato possa essere un alleato di peso
o un avversario da temere”.
"Un amico intimo del
Marocco"
In un’altra nota, ma
del 2013 (quindi due anni più tardi), Panzeri viene citato nuovamente dalle
autorità marocchine sempre in merito di una missione diplomatica presso l’Ue per
contrastare gli oppositori del Marocco all’interno del Parlamento. Come
riportato dal Corriere della Sera, Antonio Panzeri viene definito “amico intimo
del Marocco” e la sua figura viene presa come punto di riferimento per attuare
un “Piano d’azione per il Parlamento europeo”. L’obiettivo finale del piano di
Rabat era quello di influenzare le scelte dell’Ue attraverso l’organizzazione di
convegni, visite e dibattiti.
Pietro Bartolo,
il paladino dei migranti col portaborse indagato.
Carlo Nicolato su
Libero Quotidiano il 18 dicembre 2022
Pietro Bartolo non è
un membro del Parlamento Europeo qualsiasi, uno dei tanti superflui nomi in
quota al Pd e quindi al gruppo dei Socialisti e Democratici di cui a fatica si
ricorda il nome. Certo, Bartolo è anche vicepresidente del Libe, la Commissione
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ma soprattutto è il
"medico dei salvataggi" di Lampedusa, di cui è stato consigliere e vicesindaco
per tanti anni e per quasi trenta è stato il responsabile sanitario delle prime
visite ai migranti che sbarcano sull'isola. Pietro Bartolo è la storia di
migliaia di immigrati sbarcati sulle nostre coste, è un documentario
di Gianfranco Rosi (Fuocoammare) che ha vinto l'Orso d'Oro al festival di
Berlino ed è stato candidato all'Oscar nella sua categoria. È anche un più
recente film interpretato da Sergio Castellitto (Nour).
Pietro Bartolo è
Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è tanti
riconoscimenti di cui non basterebbe lo spazio per elencarli, come il "Premio
Sérgio Vieira de Mello" per essersi distinto tra «coloro che si adoperano per la
coesistenza e cooperazione pacifica tra società, religioni e culture», o il
"Premio Don Beppe Diana - per amore del mio popolo". Bartolo è anche un libro
dal titolo Lacrime di sale (Mondadori, 2016), scritto con la giornalista Lidia
Tilotta, anche quello gratificato col suo bel premio letterario, il Vitaliano
Brancati. Insomma Pietro Bartolo è uno di quei massimi simboli della sinistra
italiana ed europea, contro cui a suo tempo si è ripetutamente scontrato il
ministro Salvini e poi, più tardi, il presidente Meloni. E in quanto tale non
può di certo venire offuscato da basse questioni di mazzette provenienti da
Paesi che non rispettano i diritti umani. Il Qatargate, sia detto subito, lo ha
solo sfiorato, lui non c'entra proprio nulla, e già prima che che la procura
belga cominciasse a interessarsi del suo assistente Davide Zoggia, ha rimesso il
suo mandato da relatore ombra del gruppo dei Socialisti e Democratici del testo
sulla liberalizzazione dei visti a Kuwait e Qatar. Un atto dovuto perché è il
gruppo che per primo ha preso le distanze e chiesto la sospensione dell'iter
riguardante i visti, ma anche un segnale per dire che «io con questo schifo non
voglio aver niente a che fare».
Bartolo ha poi
chiarito che il suo collaboratore è condiviso con un altro eurodeputato, Brando
Benifei, sottolineando che Zoggia «non c'entra nulla con questa storia» ma si è
ritrovato coinvolto in quanto abitava in subaffitto nella casa di Giuseppe
Meroni, ex assistente di Antonio Panzeri. Insomma gli inquirenti sono andati in
quella casa per cercare Meroni ma hanno trovato Zoggia «che è caduto dalle
nuvole». Bartolo ha poi ribadito che il suo fidato assistente non ha si è mai
occupato di questa brutta faccenda: «È una cosa schifosa che sta gettando fango
su tutti». Aggiungendo che se le accuse che riguardano Panzeri e tutti gli altri
«sono vere devono rinchiuderli e buttare le chiavi nella fossa delle Marianne».
Fra Lampedusa e
Doha, il medico eroe che tiene famiglia.
Un tempo idolatrato
per le visite ai migranti ora viene tirato in ballo per i voti sull'emirato.
Luca Fazzo su Il Giornale il 22 Dicembre 2022
Che non è indagato».
C'è un nome, nelle cronache di questi giorni sul Qatargate, cui i giornali
italiani - assai severi con tutti gli altri protagonisti della vicenda -
riservano una sorta di trattamento di riguardo, ripetendo ad ogni occasione
quella clausola di salvaguardia: «Non è indagato». Il motivo è semplice: si
parla di un eroe civile, un cittadino sbarcato negli agi di Bruxelles dopo avere
speso anni in difesa degli ultimi. Si chiama Pietro Bartolo, di mestiere medico,
l'uomo che a Lampedusa si occupava di curare le migliaia di profughi sbarcati
dalle navi della Costiera e delle ong nel centro di accoglienza dell'isola
siciliana. Fatica improba e meritoria.
Ma nel 2019 Bartolo
decide che Lampedusa può fare a meno di lui. Si candida nel Pd alle Europee, fa
il pieno di voti, sbarca a Bruxelles. E qui la scena cambia. Perché si trova
catapultato in pieno in quella sentina di traffici che è il gruppo parlamentare
dei Socialisti & Democratici, di cui fino al giorno prima faceva parte l'ex
sindacalista Antonio Panzeri. E di cui sono esponenti di spicco Eva Kaili, Marc
Tarabella, Andrea Cozzolino, Marie Arena, insomma tutti i nomi resi oggi celebri
dalle indagini sulle attività occulte di Fight Impunity, la ong fondata da
Panzeri dopo la fine del mandato.
Nel gruppo accolgono
Bartolo a braccia aperte. Lo nominano vicepresidente della commissione Libe, che
si occupa di giustizia e di libertà civili. Diventa anche «relatore ombra» -
cioè portavoce del gruppo sul tema cruciale della rimozione dei visti d'ingresso
in Europa per alcuni Stati: tra cui il Qatar. Il regime caro al suo compagno di
partito Panzeri.
I rapporti tra
Panzeri e Bortolo sono ottimi. Tra il pragmatico sindacalista bergamasco e il
medico-eroe, tra l'ex deputato che conosce i meandri del Parlamento e il maturo
« debuttante, l'affiatamento è tale che Bartolo assume nel suo staff uno degli
uomini di fiducia di Panzeri, l'assistente parlamentare Giorgio Meroni. Meroni a
Bruxelles ha messo su casa, che affitta a un altro deputato italiano, il dem
veneziano Davide Zoggia, indagato e poi prosciolto per gli appalti del Mose.
Quando Meroni viene investito in pieno dalla indagine della Procura di Bruxelles
sul Qatargate, il suo ufficio accanto a quello di Bartolo viene perquisito e
sigillato. Ma «Bartolo non è indagato», specificano le cronache: e uno.
Siamo solo agli
inizi: perché poco dopo salta fuori che Bartolo ha un figlio di nome Giacomo che
lo ha seguito a Bruxelles e che cerca un lavoro. Dove lo piazza il papà? A Fight
Impunity, la ong che è il braccio operativo degli affari di Panzeri, una lobby
non registrata al soldo del miglior offerente. Poco meno di 2mila euro di
stipendio: troppo pochi per Bartolo junior, che dopo 7 mesi si dimette. Sette
mesi non sono pochi, nella breve vita di Fight Impunity. Cosa ha visto o capito
Bartolo junior? Mistero. «Bartolo (senior) non è indagato», specificano i
giornali dando la notizia: e due.
Ma quando piove
piove davvero. Comincia a «cantare» Francesco Giorgi, anche lui ex assistente di
Panzeri. E racconta che un emendamento a favore del Qatar presentato dal dem
Andrea Cozzolino faticava a venire fatto proprio dal gruppo. Così viene
ripresentato con un'altra firma: quella di Pietro Bartolo. Che, ovviamente, «non
è indagato». E tre.
Va a finire che
Bartolo si dimette da «relatore ombra» sulla faccenda dei visti: lo presenta
come un gesto di sdegno, «non voglio avere niente a che fare con questo schifo»,
in realtà a chiedergli (eufemismo) di farsi da parte è stata la capogruppo
Iratxe Garcia Perez dopo le perquisizioni e i sigilli a Meroni. «Bartolo non è
indagato»: e quattro. Benissimo. Ma in questi tre anni il medico-eroe dove aveva
la testa?
Qatargate. Che
cos'è il Qatargate e come si è sviluppato.
Storia e conseguenze
dello scandalo giudiziario più importante che ha colpito le istituzioni europee.
Mauro Indelicato il 17 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Il Qatargate è il
nome attribuito a uno scandalo giudiziario che ha coinvolto l'Europa e, in
particolar modo, il parlamento europeo. Il termine rimanda al Qatar, proprio
perché le indagini principali riguardano presunte tangenti arrivate dal piccolo
emirato sul Golfo per influenzare e determinare a proprio favore la politica
dell'europarlamento e rideterminare in positivo l'immagine dello stesso Paese
arabo.
Ma oltre al Qatar
risultano anche altri Paesi coinvolti. A partire dal Marocco, i cui servizi
segreti sono sospettati di aver organizzato un giro di mazzette elargite ad
alcuni politici europei. Non viene scartata anche una pista che porta all'Iran,
visti gli ottimi rapporti tra Doha e Teheran e il coinvolgimento di almeno un
analista politico considerato vicino alla Repubblica Islamica.
Il caso crea
scandalo soprattutto per il peso dei nomi coinvolti nell'inchiesta. La polizia
belga infatti arresta, tra gli altri, il vice presidente del parlamento europeo,
la parlamentare greca Eva Kaili, l'ex eurodeputato italiano Antonio
Panzeri (eletto con il Pd e poi passato ad Articolo1, da cui viene sospeso dopo
l'arresto), l'assistente Francesco Giorgi, compagno di Kaili.
L'inizio del
Qatargate
La prima notizia di
una perquisizione negli uffici di Eva Kaili si ha il 9 dicembre 2022. Gli
inquirenti mandano gli agenti belgi negli uffici e nell'abitazione del vice
presidente del parlamento europeo in cerca di indizi per le proprie indagini. Il
giorno dopo si ha la conferma del fermo dell'europarlamentare ellenica.
"Borse piene di
banconote". L'eurodeputata Kaili arrestata in flagranza
Oltre a lei vengono
arrestati il padre, secondo gli inquirenti pronto alla fuga, e il compagno
Francesco Giorgi. Quest'ultimo nella passata legislatura risulta assistente di
Antonio Panzeri, anch'egli arrestato. Su di lui si addensano non poche ombre per
via del ritrovamento, all'interno della propria abitazione, di almeno 500.000
Euro in contanti.
Valigie e borsoni
pieni di soldi vengono trovati anche nella casa di Giorgi e Kaili. Per i
magistrati di Bruxelles si tratta della “pistola fumante”. Coinvolti anche Luca
Visentini, rilasciato come il padre di Kaili, e Niccolò Figa-Talamanca.
Europarlamentari,
diplomatici e assistenti: chi è coinvolto nel Qatargate
Il quadro probatorio
per gli inquirenti belgi è tanto semplice quanto drammatico: alcuni eurodeputati
sono stati pagati dal Qatar e dal Marocco per orientare le scelte di Bruxelles a
favore di questi due Paesi. Secondo i magistrati, il lavoro messo in campo da
Doha e Rabat va oltre una semplice attività di lobbying, spingendosi invece
verso una vera e propria attività di corruzione.
Antonio Panzeri,
eurodeputato fino al 2019, viene visto con sospetto già diversi mesi prima dello
scandalo Qatargate. Sotto accusa i suoi viaggi sia in Qatar che in Marocco. In
alcune conversazioni, come sottolineato dalla stessa stampa belga, la moglie
(anch'essa coinvolta, come la figlia, nell'indagine) fa il nome di Abderrahim
Atmoun. Si tratta dell'attuale ambasciatore del Marocco in Polonia, in passato
membro del parlamento marocchino e particolarmente attivo a Bruxelles. Qui,
sempre secondo i magistrati, nel centro studi del Marocco in Belgio avrebbe
allestito una vera e propria base politica di Rabat. Sia la moglie che la figlia
di Panzeri citano Atmoun a proposito di regali concessi dall'ambasciatore, in
ottimi rapporti con l'ex eurodeputato da diversi anni.
Il centro di studi,
i regali e le valigie coi soldi: così agivano gli 007 marocchini
Nel 2018 ad esempio,
c'è una foto che li ritrae assieme con una terza figura in quell'immagine:
quella di Andrea Cozzolino. Anche lui europarlamentare eletto con il Pd e anche
lui, da questa legislatura, ha come consigliere e collaboratore Francesco
Giorgi. Per questo, dalle prime notizie sul Qatargate, il suo nome viene
costantemente tirato in ballo. Sospeso dal Pd, al momento però Cozzolino non
risulta tra gli indagati.
Per quanto riguarda
i riferimenti della consorte di Panzeri, i magistrati ipotizzano siano il frutto
della corruzione dell'ex deputato. Regali importanti, dell'ordine di migliaia di
Euro, consistenti anche in vacanze e soggiorni in alberghi lussuosi, sempre
secondo gli investigatori. Un quadro accusatorio ovviamente ancora da dimostrare
nelle prossime fasi. Intanto però, la magistratura belga crede di poter chiudere
il cerchio attorno a Panzeri investigando, tra le altre cose, anche sui
suoi viaggi in Marocco. Almeno uno di questi sarebbe stato pagato dal Dged, il
servizio segreto di Rabat. E sempre in uno dei viaggi nel Paese nordafricano,
Panzeri avrebbe incontrato il direttore Mansour Yassine. L'ambasciatore Atmoun,
in questo contesto, avrebbe fatto da tramite. Mentre ad agganciare Panzeri
sarebbe stato invece un altro esponente del Dged, Belharace Mohammed.
Ricatti sui
migranti, regali e 007: così il Marocco si è inflitrato a Bruxelles
Sotto accusa anche i
viaggi dell'ex eurodeputato in Qatar. Qui entra in gioco Francesco Giorgi,
collaboratore prima di Panzeri e poi di Cozzolino, ma noto anche per essere il
compagno di Eva Kaili. Quest'ultima, parlamentare greca eletta tra le fila
del Pasok, partito di centro-sinistra ellenico, avrebbe sostenuto diverse cause
particolarmente care a Doha in cambio di soldi. Giorgi in questo contesto,
secondo gli inquirenti potrebbe aver avuto un ruolo importante nella gestione
del denaro elergito in contante. Ad ogni modo, sembrerebbe che i deputati
coinvolti non siano gli unici a ritrovarsi dentro un giro di mazzette dal Qatar.
Secondo la stampa greca, le indagini in questo momento stanno puntando su almeno
sessanta eurodeputati. Tra questi ad esempio anche il belga socialista Marc
Tarabella, a cui viene perquisito l'ufficio alcuni giorni dopo l'emersione dello
scandalo.
Un lungo lavoro di
intelligence
Il nome dato alla
vicenda è Qatargate, ma le prime inchieste da Bruxelles vertono sul Marocco.
Come descritto da Repubblica il 16 dicembre, i belgi vengono allertati da un
servizio segreto europeo circa la presenza di un gruppo di eurodeputati su cui
Rabat può contare per estendere la propria influenza politica sulle istituzioni
comunitarie. Il servizio segreto in questione, anche se non ci sono conferme
ufficiali in tal senso, sarebbe quello spagnolo. Madrid conosce del resto molto
bene dinamiche e orientamenti delle forze di sicurezza marocchine.
Nell'informativa
trasmessa ai colleghi belgi, si fa riferimento a due nomi. Uno è quello
dell'ambasciatore Abderrahim Atmoun, l'altro è invece di Belharace Mohammed.
Scatta così, a metà del 2021, l'inchiesta. Belharace si trova già nei database:
risulta essere stato fermato all'aeroporto parigino di Orly alcuni mesi prima in
possesso di documenti segreti e in quell'occasione ha provato a corrompere un
poliziotto.
Ci si mette quindi
sulle tracce dei due nomi sospetti. Bruxelles chiede aiuto ai servizi spagnoli,
così come a quelli francesi e polacchi. Da Parigi infatti si aspettano maggiori
informazioni su Belharace, mentre a Varsavia si chiede di fare luce
sull'ambasciatore marocchino Atmoun. I dati raccolti permettono all'inchiesta di
andare avanti. Emerge in questo contesto il nome di Panzeri ed escono fuori i
suoi possibili rapporti con il Dged. Per questo il Belgio chiama in causa anche
i nostri servizi segreti. In un primo momento, l'intelligence italiana non viene
citata tra le agenzie di sicurezza che collaborano con i belgi, ma sono fonti
degli stessi nostri servizi a smentire e a confermare, al contrario, la
partecipazione all'indagine. Con i vari elementi in mano agli inquirenti, scatta
quindi tra il 9 e il 10 dicembre il blitz che porta in carcere Panzeri e gli
altri coinvolti.
Anche l'Italia ha
collaborato alle indagini sul Qatargate
L'operazione non
riguarda solo il presunto giro di mazzette dal Marocco, ma anche dal Qatar.
Fonti investigative di Bruxelles fanno sapere al quotidiano Le Soir che il
filone su Doha nasce dall'informazione di un altro servizio segreto, quello
degli Emirati Arabi Uniti. È Abu Dhabi quindi ad avvertire Bruxelles. In questo
contesto salta ancora una volta fuori il nome di Panzeri, più volte volato sulle
sponde del Golfo. Qui entrano in gioco l'Ong da lui curata, la Fight Impunity, e
il suo ex collaboratore Francesco Giorgi. E, di riflesso, la compagna di lui Eva
Kaili. Gli incontri in questo caso non sarebbe avvenuti tramite l'intelligence
di Doha, ma direttamente con esponenti del governo locale. E, in particolare,
con il ministro del Lavoro qatariota Ali Bin Samikh Al Marri. Dall'emirato
respingono le accuse e dichiarano di essersi sempre mossi nel rispetto del
diritto internazionale.
Quei soldi trovati a
casa dei sospettati
A dare una forte
accelerazione alle indagini è il ritrovamento, lo scorso 12 luglio, di almeno
700.000 Euro a casa di Panzeri. Lo scrive Repubblica nell'articolo del 16
dicembre. Dopo una prima raccolta di dati, i servizi segreti belgi decidono a
luglio di entrare nell'abitazione dell'ex eurodeputato, in quel momento fuori
Bruxelles perché in vacanza. E lì trovano quella che considerano la prima vera
prova della corruzione.
Mezzo milione di
Euro viene invece trovato nel momento dell'arresto di Panzeri. Banconote che,
secondo il quotidiano Le Soir, avrebbero numeri di serie belgi. Un grattacapo a
livello investigativo: da un lato questa circostanza confermerebbe i sospetti
sui pagamenti in contanti, consegnati in borse e borsoni, dall'altro però
smentirebbe le ricostruzioni sui soldi presi direttamente in Marocco.
Ad ogni modo, tutto
viene messo sotto sequestro e si continua a indagare. Banconote vengono trovate
anche a casa di Eva Kaili. Il suo avvocato da Atene respinge ogni accusa e
afferma di non sapere la quantità di denaro ritrovata dai poliziotti belgi
nell'abitazione della sua assistita. La quale, nel frattempo, pochi giorni dopo
l'arresto viene destituita dalla carica di vice presidente del parlamento
europeo con un voto quasi unanime e ai sensi dell'articolo 21 del regolamento
dell'aula di Strasburgo. Gli occhi sono puntati anche su alcuni bonifici. In
particolare, quelli elargiti dal Qatar a favore dell'Ong Fight Impunity fondata
da Panzeri.
La pista qatariota,
marocchina e iraniana: ecco dove si concentrano i sospetti
Le indagini quindi
portano dritte su due specifiche piste: una qatariota e una marocchina. Partendo
da quest'ultima, secondo gli inquirenti le fila vengono tirate dagli stessi
servizi segreti di Rabat. L'obiettivo è portare diversi eurodeputati a sostenere
gli interessi del Regno del Marocco. Viene vista ad esempio con sospetto la
votazione, passata con più di 400 voti favorevoli, dell'accordo sulla pesca tra
Ue e Marocco nel 2019. Anche Panzeri in quel caso vota Sì a quel documento,
bocciato poi dalla Corte Europea due anni più tardi in quanto includeva anche i
territori del Sahara Occidentale, rivendicato da Rabat ma sulla cui sovranità
ancora oggi ci sono posizioni divergenti.
La pista qatariota
porta dritta alla proposta sull'esenzione di visti che consente ai cittadini
dell'emirato di viaggiare liberamente in Europa, misura approvata dalla
commissione Libe (libertà civili, giustizia e affari interni) il primo dicembre
scorso. A partecipare, come sostituta, a quel voto è anche Eva Kaili. La quale
esprime il suo parere favorevole, in contraddizione con molti del suo gruppo
parlamentare di riferimento, i Socialisti e Democratici. Il voto favorevole è
comunque trasversale e coinvolge più partiti. Ovviamente impensabile parlare di
Qatar senza menzionare i mondiali di calcio giocati nell'emirato tra novembre e
dicembre. Obiettivo di Doha, secondo gli inquirenti, è “ammorbidire” le
posizioni della politica europea sul rispetto dei diritti dei lavoratori e dei
diritti civili nel Paese.
C'è però anche un
terzo binario, quello relativo all'Iran. Francesco Giorgi viene infatti ritenuto
molto vicino a Eldar Mamedov. Quest'ultimo è un analista politico presente a
Bruxelles in qualità di collaboratore del gruppo Socialisti e Democratici. Ha
passaporto lettone ma origini iraniane. Come sottolineato dal Corriere della
Sera, nella sede del parlamento europeo viene considerato un lobbista pro Iran.
Considerando i buoni rapporti tra Doha e Teheran, c'è chi sostiene l'esistenza
anche di una pista direttamente ricollegabile alla Repubblica Islamica.
Il ruolo delle Ong
Importante in questa
vicenda il ruolo di almeno due Ong. La prima è quella fondata nel 2019 da
Antonio Panzeri, la Fight Impunity. La sua sede è a Bruxelles, in Rue Radical.
Viene descritta sul sito come una Ong il cui obiettivo è quello di “promuovere
la lotta contro l’impunità per gravi violazioni dei diritti umani e crimini
contro l’umanità avendo il principio di responsabilità come pilastro centrale
dell’architettura della giustizia internazionale”. Ha al suo interno membri
onorari di un certo peso, come Emma Bonino e l'ex alto rappresentante per la
politica estera europea, Federica Mogherini. Ci sono anche i nomi dell'ex primo
ministro francese Bernard Cazeneuve, dell'ex commissario Dimistris Avramopoulos
e del premio Nobel per la pace Denis Mukwege. Gli inquirenti però sospettano che
Panzeri usi l'Ong per i propri scopi personali e nasconda nei conti
dell'organizzazione i proventi della corruzione in Qatar.
"Stava per
entrare...". La rivelazione della segretaria della Ong di Panzeri
L'altra Ong invece
si chiama No Peace Without Justice. Il coinvolgimento è testimoniato
dall'arresto del suo segretario, Niccolò Figa-Talamanca. Fondata nel 1993 da
Emma Bonino, non è chiaro però il suo coinvolgimento nell'inchiesta. Si sa che
condivide gli uffici con la Fight Impunity, per il resto i collegamenti con
l'Ong di Panzeri si chiudono qui. Intervistata su IlDomani, Emma Bonino dichiara
di non essere a conoscenza dei dettagli dell'indagine e di essere completamente
estranea ai fatti in questione.
Gli interessi
geopolitici in ballo
Il principale
interesse del Qatar è legato alla propria immagine alla vigilia del mondiale di
calcio. Il più grande evento ospitato in medio oriente già da anni è nell'occhio
del ciclone per le notizie sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori.
Circostanza che fa temere Doha circa un possibile boicottaggio del torneo e un
mancato ritorno turistico. Da qui dunque, secondo gli inquirenti, il tentativo
di avvicinare, con mazzette e tangenti, gli eurodeputati. Non solo ma, come
detto, il Qatar fa pressione per la concessione dell'esenzione dei visti ai
propri cittadini. Circostanza percepita dall'emirato come importante e su cui
avvia quindi un'attività di lobbying destinata, sempre secondo gli investigatori
belgi, a diventare vera e propria opera di corruzione.
Cosa ha comprato il
Qatar con i soldi ai deputati corrotti
Il Marocco ha invece
due storici obiettivi politici: la firma di trattati commerciali con l'Ue, come
quello sulla pesca del 2019, e il riconoscimento del Sahara Occidentale come
regione sotto la propria sovranità. Un obiettivo quest'ultimo ritenuto
fondamentale e più abbordabile dopo il riconoscimento, avvenuto nel 2020, degli
Stati Uniti alla sovranità marocchina sulla regione. Rabat spinge da tempo
l'Europa affinché appoggi la sua proposta, presentata all'Onu nel 2007, di
concessione dell'autonomia al Sahara Occidentale in cambio del riconoscimento
della sua sovranità. Per gli investigatori, la volontà marocchina di giungere
quanto prima al suo obiettivo determina anche in questo caso un'attività di
lobbying sfociata in corruzione.
Qatargate, cosa
sappiamo sullo scandalo che fa tremare l’Europa.
Maria Serena Natale
su Il Corriere della Sera il 18 Dicembre 2022.
Il blitz, le accuse,
i protagonisti: la ricostruzione del più grave caso di corruzione nella storia
dell’Unione europea
Il 9 dicembre 2022
ai Mondiali di calcio in Qatar si giocano Croazia-Brasile e Olanda-Argentina,
l’indomani il Marocco piega il Portogallo e va in semifinale. La presidente
dell’Europarlamento Roberta Metsola è a Malta quando squilla il cellulare. La
polizia belga la richiama a Bruxelles per poter perquisire in sua presenza la
casa di uno dei 14 vicepresidenti, la greca Eva Kaili. L’indagine
dell’Anticorruzione è partita a luglio ma è da molto prima che il giudice
istruttore Michel Claise aspetta questo giorno. Gli agenti fanno irruzione in 19
tra uffici e abitazioni, dal Belgio all’Italia gli arresti sono 8. Il
quotidiano Le Soir è il primo a dare la
notizia. Corruzione, riciclaggio, associazione a delinquere. È il Qatargate, il
più grave scandalo nella storia dell’Unione europea.
Il giudice e
Ifigenia
Nemico giurato di
abuso e privilegio, tessitore di intrighi internazionali nei gialli che scrive
nel tempo libero, Claise ha mirato al cuore di un sistema basato sulla
contiguità tra politici e lobbisti, sul confine tra diplomazia e interesse,
sulla relazione tra potere, ideali, denaro. Il primo a cadere nella rete
è Antonio Panzeri, 67 anni, ex segretario generale della Camera del Lavoro di
Milano, eurodeputato dal 2004 al 2019 con il gruppo Socialisti e Democratici
(all’inizio Ds, poi Pd, infine Articolo 1). Tra i 19 indirizzi nel mirino degli
inquirenti c’è il 41 di Rue Ducale, sede della Ong che Panzeri ha fondato subito
dopo aver lasciato l’emiciclo, Fight Impunity, combattere l’impunità. Siamo in
una delle vie più eleganti del centro di Bruxelles a pochi passi dalla residenza
del premier belga, dall’ambasciata Usa e dalla cittadella delle istituzioni
comunitarie dove si muovono funzionari, osservatori, spie, 12 mila lobbisti
registrati (ma si stima siano almeno il doppio). La Ong, che con il fine
dichiarato di promuovere i diritti umani organizza eventi e incontri di
altissimo livello, può contare sul profilo autorevole del fondatore, sui
rapporti costruiti nel tempo e su un comitato consultivo che include figure del
calibro di Emma Bonino e Federica Mogherini — del tutto estranee allo scandalo,
hanno immediatamente lasciato il board. A casa Panzeri gli agenti trovano 600
mila euro in contanti.
Nel 2019 Panzeri
«passa» a Eva Kaili, ex giornalista televisiva ed eurodeputata socialista con
studi tra Salonicco e Harvard, il proprio assistente, Francesco Giorgi,
originario di Abbiategrasso, laureato in Scienze Politiche alla Statale di
Milano e istruttore di vela. Oggi Kaili e Giorgi, 44 e 35 anni, hanno una figlia
di 22 mesi. Nel loro appartamento la polizia requisisce 150 mila euro cash,
altri 600 mila spuntano dal trolley che il padre di Kaili, Alexandros, tenta di
trascinare fuori dall’hotel Sofitel di Place Jourdan quando viene fermato dalla
polizia. In totale sequestri per 1,5 milioni di euro. Eva nega qualsiasi
coinvolgimento, attribuisce il denaro a Panzeri e in una vertigine tragica poco
adatta a questa storia di mazzette e abbuffate giura: non sarò Ifigenia (la
figlia che nel mito Agamennone accetta di sacrificare per far ripartire alla
volta di Troia le navi greche bloccate in Aulide). Giorgi ammette di essersi
lasciato «reclutare» ma difende la compagna, si assume la responsabilità anche
della fuga di Alexandros e fa il nome del suo attuale principale,
l’eurodeputato Antonio Cozzolino. Cozzolino non risulta indagato né ha subito
perquisizioni ma si è autosospeso dal gruppo S&D e in Italia è stato sospeso in
via cautelare dal Pd. Gli altri arrestati nel mega blitz sono Luca Visentini,
segretario della Confederazione internazionale dei sindacati poi rilasciato,
e Niccolò Figà-Talamanca, capo della Ong No Peace Without Justice, ora in
libertà vigilata. Perquisizioni e sigilli agli uffici di assistenti parlamentari
in buona parte italiani che non mancano di attirare nei corridoi ironie e
indignazione sul vecchio Italian Job, ma il «gate» si è appena aperto e
l’inchiesta rivela ogni giorno nuove ramificazioni. Fonti di stampa parlano già
di 60 eurodeputati coinvolti.
I corruttori
A cosa servivano
quei soldi? La pista investigativa porta a Qatar e Marocco, in cerca di sponde
interne ai palazzi Ue per perseguire obiettivi strategici e riscattare la
propria immagine di Stati autoritari con pessimi standard sui diritti umani.
Accordi economici, riconoscimenti dei progressi compiuti. Tra le priorità del
Qatar, che da anni infiltra l’Occidente con investimenti e acquisizioni dalla
difesa all’immobiliare e in piena crisi energetica per la guerra ucraina vuole
blindare la leadership nell’export di gas naturale liquefatto, c’erano proprio i
Mondiali e il tentativo di mettere in ombra le condizioni di schiavitù imposte
ai lavoratori che hanno costruito gli stadi e in moltissimi casi perso la vita.
Lusso, commesse militari, centri culturali e moschee: oltre al radicamento
nell’economia e sul territorio, Doha cercava un posto nel salotto buono
d’Europa. Una delle ipotesi sul Qatargate è che la soffiata decisiva ai servizi
belgi, che hanno poi passato il fascicolo alla magistratura, sia arrivata dagli
Emirati, storici rivali regionali. Quanto al Marocco, che con l’Europa ha
relazioni più antiche e radicate per ragioni geografiche e storiche, i dossier
più sensibili sui quali sollecitare uno sguardo tollerante quando non
compiacente andavano dalla pesca alla libertà di espressione al conflitto con il
Fronte Polisario in lotta per l’autodeterminazione del popolo Sahrawi nei
territori del Sahara occidentale. Una crisi che divide i Ventisette e sulla
quale la Ue ha sempre mantenuto una posizione di ambigua terzietà.
Spie e regali
Dalle petromonarchie
del Golfo Persico alle nebbie da Guerra fredda di Varsavia. La rete passava
dalle stanze dell’ambasciatore del Regno del Marocco in Polonia, Abderrahim
Atmoun, politico di lungo corso con ottime entrature tra Parigi e Bruxelles,
chiamato da re Muhammad VI alla carriera diplomatica nel 2019 ed emerso nelle
prime ricostruzioni dell’inchiesta come uno dei manovratori nonché intermediario
con i servizi segreti di Rabat. Le carte citano «regali» per «l’amico» italiano
provenienti dal Marocco che sarebbero stati affidati a moglie e figlia di
Panzeri, Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, entrambe attualmente agli
arresti su mandato europeo: domani la Corte d’appello di Brescia decide sulla
consegna ai belgi. Nelle intercettazioni telefoniche marito e moglie parlano di
conti per nascondere il denaro e di una carta di credito a disposizione
intestata al «gigante» Atmoun. Alla famiglia il Qatar avrebbe offerto una
vacanza da 100 mila euro.
Metsola annuncia una
rapida revisione delle norme sulla trasparenza. La ferita più grave è il
sospetto che s’allunga sulle battaglie di un’Europa vulnerabile nei principi. I
principi che sono la sua forza, tanto più agli occhi di chi vorrebbe
corromperla.
Scandalo Qatar.
Quale è il vero obiettivo dell’inchiesta sul Qatar, il ruolo dei servizi
segreti.
Piero Sansonetti su Il Riformista il 17 Dicembre 2022.
I giornali iniziano
un po’ ad ansimare. Il Qatar-gate non dà più molto. Dovevano spuntare nomi,
partiti, miliardi. Qui pare che un anno e mezzo di indagini abbia portato solo
alla scoperta di un paio di valigette di banconote. Delle quali si ignora la
provenienza, l’eventuale natura criminale, e soprattutto l’obiettivo. A quasi
una settimana dall’esplodere di quello che è stato definito lo scandalo politico
del secolo ancora nessuno è in grado di dirci qual è il reato che si contesta
agli arrestati. Dal momento che nessuno crede che il Qatar possa essersi messo
in moto per ingerirsi negli affari dell’Europa allo scopo unico di ottenere da
una deputata greca un discorsetto, ascoltato da pochi intimi, di lievi lodi per
il regime di Doha. E allora?
Non ho idea. Non ho
informazioni, anche perché né io né i giornalisti del mio giornale hanno
contatti coi servizi segreti. Noi siamo un giornale un po’ particolare. Niente
veline, niente manine, niente 007. Diciamo solo quel che vediamo. E su cui – se
ci è possibile – ragioniamo. Oggi io vedo due cose. Una chiara, certa. L’altra
fumosa. Ma sono due cose che sin qui non hanno sollevato nessun interesse da
parte della stampa e della politica. Quella chiara è che le autorità giudiziarie
belghe, in violazione di qualunque principio giuridico e della dichiarazione
universale dei diritti umani (1948) stanno usando una bambina di 22 mesi come
ostaggio e strumento di pressione per far confessare e ottenere eventuali
delazioni dai genitori che hanno catturato e messo in carcere. Peraltro è chiaro
più o meno a tutti che l’arresto dell’onorevole Kaili, mamma della bambina, è
stato del tutto illegale perché la deputata europea godeva, evidentemente, della
immunità della quale godono tutti i parlamentari, almeno nella parte più
avanzata del mondo.
Il sequestro della
bambina e il suo uso come strumento di pressione verso genitori è una vera
infamia. Possibile che la cosa lasci tutti indifferenti? Possibile che nessuno
conosca i bisogni di una bambina di 22 mesi (a quell’età molti bambini ancora
prendono il latte dal seno della mamma)? Possibile che non ci sia una
sollevazione contro una azione così inumana, mentre monta lo sdegno verso
l’on Cozzolino, che a me risulta non sia neppure indagato? Sarà una mia
ossessione, ma io penso che per sollevare la questione morale bisogna almeno
possedere un abbozzo di morale. Mi dite che morale c’è nell’indignarsi per
Cozzolino e non per il sequestro di un bambino?
La seconda questione
che vorrei sollevare è quella degli 007. Cosa sappiamo, fin qui, di questa
inchiesta e delle sue origini? Sappiamo che tutto nasce da alcune inchieste
delle procure americane, le quali avevano deciso di indagare sul Qatar che era
riuscito a soffiare agli Stati Uniti l’assegnazione dei mondiali di calcio del
22. Dopodiché la faccenda è stata presa in mano dai servizi segreti belgi. Ma i
servizi segreti spesso non sono segretissimi, e così pare che agli 007 belgi si
siano affiancati 007 di svariati altri paesi. Forse anche italiani. Forse no. I
quali hanno agito senza informare la magistratura, sottotraccia, utilizzando
mezzi di indagine che difficilmente possono essere considerati regolari nei
paesi europei a stato di diritto. Comprese delle perquisizioni. E
naturalmente pedinamenti, intercettazioni, infiltrazioni.
Ora magari voi
potete pensare che io sia legato a vecchi cliché politici. Può darsi. Io penso
invece che sia solo esperienza: quando un’indagine è guidata dagli 007 c’è poco
da fidarsi. Molto spesso è una operazione che ha fini che noi non possiamo
conoscere, spesso ha dei mandanti, spesso i mandanti sono imprevedibili, spesso
dietro ci sono interessi politici inconfessabili. Non saprei dire quali. A
occhio mi sembra una operazione volta a colpire la credibilità e l’autorevolezza
dell’Europa in un momento di grande scombussolamento delle relazioni e dei
rapporti di forza internazionali. Ma immagino che tutto ciò non interessi a
nessuno. Ora la cosa importante è capire quante randellate dare a Cozzolino. La
questione morale è tutta qui.
Piero Sansonetti.
Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di
cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004
al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per
poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre
2019.
Giuseppe Salvaggiulo
per “la Stampa” il 17 dicembre 2022.
Antonio Panzeri, ex
eurodeputato agli arresti da una settimana con l'accusa di essere a capo di
un'associazione criminale dedita alla corruzione internazionale, era stato
scelto dal Marocco per difenderne gli interessi nel Parlamento europeo almeno
dal 2011. È quanto emerge da una corrispondenza riservata tra l'ambasciatore
marocchino presso l'Unione Europea e il ministro degli Esteri a Rabat. «Oggetto:
visita a Tindouf del presidente della Delegazione Maghreb del Parlamento
Europeo, Antonio Panzeri».
Tindouf è la città
algerina dove ha sede il governo in esilio della Repubblica Araba Democratica
dei Sahrawi, chiamata anche Sahara Occidentale, che rivendica dal 1976 la
sovranità su una porzione di Marocco, denunciando violazioni di diritti umani.
La causa è promossa in tutto il mondo dal Fronte Polisario, movimento
indipendentista che gestisce anche i campi profughi a Tindouf.
Il Marocco deve
evitare condanne che avrebbero pesanti conseguenze economiche, poiché, sull'onda
delle primavere arabe, l'Ue ha deciso di premiare economicamente i Paesi
nordafricani più «audaci» su diritti umani e democrazia. Una partita che per il
Marocco vale quasi 200 milioni l'anno, il finanziamento più ricco tra i Paesi
della regione.
In questo contesto,
il viaggio di Panzeri è strategico.
Dai documenti
riservati si scopre che è stato diabolicamente preparato in combutta con il
Marocco. A pochi giorni dalla partenza, il 27 ottobre 2011, l'ambasciatore
«porta a conoscenza» del ministro che «a margine della sessione plenaria del
Parlamento Europeo abbiamo avuto un colloquio informale con il consigliere del
signor Antonio Panzeri, portatore all'attenzione delle autorità marocchine di un
messaggio da parte di quest' ultimo».
Il messaggio è
rassicurante: il Marocco non ha da temere, «la visita a Tindouf è indispensabile
per supportare la credibilità del sig. Panzeri presso l'Algeria e il Polisario,
visto che lui è stato accusato di essere pro-Marocco. Non è nell'interesse del
Marocco che il sig. Panzeri sia percepito come tale. Il sig. Panzeri ha fatto il
possibile per evitare la data del 6 novembre», anniversario della Marcia Verde
di decolonizzazione del 1975, considerata un punto di svolta per il Fronte
Polisario.
«Il 7 novembre è un
compromesso ragionevole, nel senso che visitare i campi nel contesto di una
visita in Algeria è simbolico e costituisce una migliore opzione (per il
Marocco) rispetto a una visita ad hoc nei campi».
Secondo quanto
riferito ai marocchini dal suo emissario, «Panzeri conta di non nominare
l'autonomia con il Polisario, né fare dichiarazioni in questo senso durante la
visita.
Ha indicato che si
accontenterà di ascoltare i suoi interlocutori». E ha delineato la visione
strategica sull'asse Rabat-Bruxelles: «Esiste una forte domanda nel Parlamento
Europeo a riguardo della questione Sahara, regolarmente sollevata dagli
eurodeputati e molto sfruttata da parte dei pro-Polisario, che fanno forti
pressioni (sul gruppo socialista e democratico). Il miglior modo di gestire
queste pressioni è circoscriverle e incanalarle attraverso il sig. Panzeri, che
sa essere un interlocutore credibile per tutte le parti».
Dopo aver riferito
al ministro il contenuto del «messaggio di Panzeri», il diplomatico marocchino
lo analizza: «A prima vista è rassicurante. L'interessato è molto consapevole
della sensibilità della sua visita nei campi di Tindouf, e fa uno sforzo
significativo per giustificarla e non compromettere in modo duraturo i contatti
con il Marocco. Sembra prendere sul serio la raccomandazione di non recarsi a
Est del dispositivo di difesa e promette di tenere informata la nostra Missione
sull'evoluzione del suo programma a Tindouf».
Il documento
inquadra la visita «nell'estensione del lavoro metodico iniziato dal sig.
Panzeri dopo i primi
mesi seguiti alla sua elezione alla testa della delegazione Maghreb. I suoi
contatti con il Polisario e con le autorità algerine, la fiducia che ha saputo
costruire con gli interlocutori marocchini e soprattutto "l'ambiguità
costruttiva" dei suoi atteggiamenti verso gli uni e gli altri sono
manifestazioni di un'agenda politica di lungo respiro, portata avanti in modo
volontario, a volte pericoloso, ma sempre con tatto e padronanza. È difficile
non vedervi anche una dimostrazione subliminale di "capacità di disturbo", in
quanto dimostra come l'interessato possa essere un alleato di peso o un
avversario da temere».
Infine il
diplomatico si profonde in un giudizio lusinghiero: «Visti da questa
angolazione, gli sviluppi recenti denotano, nella linea politica di Panzeri, una
continuità raramente osservata in altri eurodeputati. In questa logica, c'è
motivo di pensare che, lontano dall'essere un'operazione di comunicazione, la
visita a Tindouf sia un traguardo tattico nella sua agenda personale». Prima
della visita, Panzeri transiterà a Rabat. Il diplomatico si raccomanda di
«organizzare incontri che un responsabile che lo possa briffare sulla questione
Sahara in modo appropriato e, se necessario, gli anticipi i messaggi che lui
riceverà durante le tappe di Algeri e di Tindouf». Nasce così, nel 2011, il
patto Panzeri-Marocco. Che ha dato i suoi frutti per undici anni. Fino a una
settimana fa.
Francesca Sforza
per “la Stampa” il 18 Dicembre 2022.
«Alle valigie piene
di cash non ci si arriva subito», spiega un ex funzionario europeo che ha
lavorato a lungo in un dipartimento strategico della Commissione. La diplomazia
delle monarchie del Golfo, in particolare, è molto avvertita, e con gli anni è
diventata sempre più scaltra. Il funzionario - spagnolo di nascita, francese di
lingua, britannico d'adozione, oggi a Bruxelles per una seconda vita da
consulente - ricorda di quando, anni fa, un suo collega fu omaggiato da un emiro
di Dubai con una Aston Martin bianca.
«Ovviamente il
regalo fu respinto, ma la reazione dell'emiro fu interessante». Si riprese
l'Aston Martin, si informò su quale fosse la soglia sopra la quale non si poteva
andare con i regali, e dopo aver preso conoscenza del fatto che esisteva una
clausola sulla "deperibilità", fece dono di un vassoio (di valore inferiore ai
150 euro, come vuole la regola europea) e sopra ci aggiunse dieci chili di
caviale beluga, che essendo effettivamente "deperibili" potevano non essere
restituiti.
Ricorda anche un
giovane funzionario italiano, che un giorno tornò in ufficio contento di essere
stato invitato al Gran Premio di Monza con suo figlio da un lobbista conosciuto
a Bruxelles: «Questa è la differenza che ho notato tra gli italiani e ad esempio
i tedeschi o gli olandesi: non sempre colgono quando si è di fronte
all'escalation collusiva». I biglietti in questione non portarono nei fatti ad
alcuna richiesta ulteriore, il funzionario si confermò integerrimo e leale nel
suo lavoro, «ma altri non avrebbero accettato lo stesso».
Perché appunto, non
si comincia con le valigie piene di contante: si passa per il regalo di poco
superiore a 150 euro (oltre quella cifra l'oggetto va restituito, ma su 705
parlamentari si sono contate dal 2020 soltanto 39 restituzioni, da parte di otto
persone), si va avanti con i biglietti per un concerto all'opera o a una partita
o a un altro evento sportivo, si continua con gli inviti in alberghi a cinque
stelle per partecipare a conferenze o seminari, e a quel punto i rapporti si
fanno più stretti, il regalo stesso cambia di senso.
Come ha detto a Le
Soir Nabil Ennasri, docente di Scienze Politiche e tra i partecipanti del Forum
di Davos, «in Qatar e in molti Paesi arabi il sentimento di ospitalità può
facilmente portare a transazioni collusive: si va dalla diplomazia dei summit
(dal Forum di Doha al Word Innovation Summit for Education) a quella dei Rolex».
Nel 2016, il ministro francese Bruno Lemaire raccontò al giornalista Christian
Chesnot di essersi visto recapitare un Patek Philippe cerchiato di diamanti del
valore di 85 mila euro, dopo aver accompagnato l'emiro Hamad in una visita per
Parigi.
L'oggetto fu
restituito ma con l'occasione Chesnot approfondì il tema e riuscì a stilare una
classifica interessante sulle regole non scritte della diplomazia qatarina: i
Patek Philippe sono per il massimo rango, seguono gli Audemars Piguet per le
delegazioni, Omega e Rolex per parlamentari, poi i Cartier, infine le scatole di
penne. Quanti rifiutano? Quanti accettano?
L'interrogativo
circola con sempre maggiore insistenza a Bruxelles, insieme a quello, posto più
sottovoce, sull'esistenza di una filiera non italiana all'interno dell'inchiesta
(i pregiudizi sono duri a morire: gli italiani a Bruxelles sono molto
imbarazzati, gli altri trattengono sorrisetti, e non aiutano le molte occasioni
di scambi multilaterali di auguri prima della pausa natalizia, in cui alla fine
si finisce sempre per sentire la stessa domanda: «Ma saranno solo italiani o
salterà fuori anche qualcun altro?»).
Gli eurodeputati
comunque hanno già abbozzato una risoluzione per ottenere maggiori risorse per
il Registro della Trasparenza Ue, un database di lobbisti e Ong, che preveda
anche l'obbligo di rendere pubbliche le agende degli incontri («qualcuno già lo
fa, ma non tutti», dice ancora il funzionario). La presidente della Commissione
von der Leyen - che in questa cupa congiuntura, col Parlamento a pezzi, assume
sempre di più i contorni di autorità morale - si è già espressa per la creazione
di un organismo etico indipendente che vigili tutte le istituzioni dell'Unione.
Controllare i controllori, questo è il clima.
Estratto
dell’articolo di Marco Bresolin per “la Stampa” il 18 Dicembre 2022.
Dimitris
Avramopoulos era molto più che un semplice membro onorario dell'associazione
Fight Impunity, l'ong di Antonio Panzeri finita al centro dell'inchiesta della
procura di Bruxelles. L'ex commissario europeo di nazionalità greca era infatti
«molto più coinvolto» nelle attività dell'associazione rispetto agli altri
membri onorari. E per questo è stato «retribuito per un periodo di un anno» a
partire dal 1° ottobre del 2020, come riporta un documento della Commissione
europea visionato da "La Stampa" che però non menziona l'importo.
Si tratta di un
compenso «ufficiale», quindi del tutto legittimo, tanto che il 3 febbraio del
2021 è stato approvato da Ursula von der Leyen in persona, come emerge da un
secondo documento. Ma alla luce di quel che è successo, la sua retribuzione fa
sorgere almeno due questioni con ripercussioni quantomeno sul piano politico. La
prima: Avramopoulos potrebbe aver ricevuto fondi "sporchi", se è vero che Fight
Impunity funzionava come «centrale di riciclaggio» per i finanziamenti occulti
arrivati dal Qatar.
La seconda: oggi
Avramopoulos è uno dei due candidati favoriti per il ruolo di rappresentante
speciale dell'Unione europea per i Paesi del Golfo (l'altro è Luigi di Maio). E
il solo sospetto che possa aver ricevuto, anche se a sua insaputa, "fondi
sporchi" dal Qatar rappresenta un ostacolo enorme nella sua corsa verso il nuovo
ruolo istituito dall'Alto Rappresentante Josep Borrell. […]
Estratto
dell’articolo di Valeria Di Corrado per “il Messaggero” il 18 Dicembre 2022.
Un'altra
organizzazione non governativa è finita nel ciclone giudiziario del Qatargate
scoppiato a Bruxelles, ma che ora sta coinvolgendo anche la magistratura di
altri Stati europei: dall'Italia alla Grecia. Dopo la ong Fight Impunity dell'ex
eurodeputato socialista arrestato, Antonio Panzeri, e la ong No peace without
justice, riconducibile al suo segretario Niccolò Figà-Talamanca (anche lui
arrestato), sarebbero in corso verifiche anche sull'Osservatorio giuridico
europeo per le nuove tecnologie ElonTech. Si tratta di una ong fondata nel 2017
da Matalena Kaili, sorella dell'ex vice presidente del Parlamento europeo Eva
Kaili (tra i quattro arrestati dalla magistratura di Bruxelles insieme al
compagno Francesco Giorgi).
Le autorità locali
sono impegnate a controllare i finanziamenti e i flussi di denaro
dell'Osservatorio giuridico europeo per le nuove tecnologie ElonTech. La società
in questione, secondo la tv greca Ert, dichiara la propria sede a Kolonaki,
precisamente nello stesso edificio in cui ha sede la società immobiliare fondata
dall'eurodeputata del Pasok Eva Kaili. Secondo i quotidiani greci, le sorelle
Kaili sono inseparabili e hanno presenziato anche agli eventi dell'ong che si
sono svolti al Parlamento europeo.
Quello che le
procure stanno esaminando è se Eva Kaili, e per estensione la Ong della sorella,
siano stato il «veicolo» per attrarre programmi europei che sono sovvenzionati
al 100%, fino a 15 milioni di euro. Cifre stellari, insomma, rispetto al milione
e mezzo in contanti già sequestrato dagli inquirenti belgi a Bruxelles, 750mila
nella sola casa della ex vicepresidente del Parlamento europeo.
Ma il suo avvocato,
Michalis Dimitrakopoulos, nega: «La ElonTech non è una ong e non ha ricevuto un
euro di finanziamenti». «Si tratta di un'iniziativa giuridica di scienziati e
ricercatori nel campo del diritto e delle nuove tecnologie; non è una entità
legale», ha fatto sapere il legale, precisando che «non è di Eva Kaili».
Ma si è già
mobilitata l'Autorità Antiriciclaggio e il responsabile, Charalambos Vourliotis,
ha ordinato il congelamento totale in Grecia dei beni dell'eurodeputata, del
compagno Giorgi, dei genitori e della sorella, avviando controlli su tutte le
loro proprietà, con un'ordinanza inoltrata a banche e catasto. Sotto la lente di
ingrandimento anche gli immobili della Kaili, come l'appartamento di 170 metri
quadrati acquistato nel 2019 per 260mila euro, ma anche una casa ad Anixi,
acquistata nel 2009 per 290mila euro. […]
Estratto
dell’articolo di Luca De Vito, Giuliano Foschini e Claudio Tito per “la
Repubblica” il 18 Dicembre 2022.
I computer e i
telefoni sequestrati ormai una settimana fa ad Antonio Panzeri, Francesco Giorgi
e soprattutto agli assistenti parlamentari toccati dall'indagine (nessuno di
loro è però indagato) stanno cominciando a parlare. E confermano ai magistrati
belgi quello di cui erano certi: era Giorgi a indirizzare, probabilmente su
mandato di Panzeri, i voti più delicati su Qatar e Marocco. Era lui a decidere
quale emendamento doveva essere presentato. E quale no. Lui a dare le
indicazioni di voto del gruppo.
[…] secondo l'accusa
Giorgi riusciva a muovere le file dell'intero gruppo socialista. È emerso il
caso, per esempio, della mozione pro Qatar - sollecitata da Panzeri - bocciata
dal gruppo e ripresentata sotto forma di emendamento da Giorgi attraverso
l'onorevole Pietro Bartolo (non indagato), il cui figlio per alcuni mesi ha
lavorato per la Fight Impunity di Panzeri. O le strane sostituzioni in
commissioni in cui non faceva parte di Kaili e ciò nonostante correva a votare
secondo le indicazioni del compagno.
Ma c'è un ulteriore
particolare, assai inquietante. Giorgi ha seguito con grande interesse - tanto
da fare in modo che Cozzolino seguisse direttamente il dossier - l'inchiesta che
il Parlamento europeo ha aperto su Pegasus, il programma sviluppato dalla
società di sicurezza israeliana Nso, che alcuni paesi avrebbero utilizzato -
secondo le accuse - per spiare altri Stati.
Il Marocco è stato
accusato da un'inchiesta giornalistica di Forbidden Story e Amnesty di aver
utilizzato Pegasus per sorvegliare il presidente francese, Emmanuele Macron. Ma
anche un pezzo di Commissione europea. Seguire l'inchiesta su Pegasus, "essendo
alle direttive del Marocco", come per lo meno sostiene la procura di Bruxelles,
è sicuramente un cortocircuito.
[…] sui conti
correnti di Fight impunity, la Ong di Panzeri, siano arrivati fondi direttamente
dal Qatar e poi girati da Panzeri per corrompere o avvicinare persone a
Bruxelles. […] Un capitolo a parte riguarda poi i regali che la "cricca" avrebbe
elargito. Nell'elenco ci sono orologi di lusso, una casa in montagna e viaggi.
Panzeri era di casa all'hotel Mamounia di Marrakech, uno dei più belli alberghi
del mondo, dove invitava colleghi parlamentari e assistenti. Ma, più
recentemente, era facile trovare lui e i suoi amici anche in un resort in Oman.
[…]
Qatargate:
“Nemesi contro sinistra e rigore Ue”.
Redazione CdG 1947
su Il Corriere del Giorno il 18 Dicembre 2022. L'editoriale di Marco Follini
Oggi, forse i
dirigenti della sinistra oltre a battersi il petto, doverosamente, per le mele
marce trovate nei loro cesti, dovrebbero anche rivedere la retorica degli anni
scorsi. E magari, senza assolvere nessuno dei colpevoli di quella stagione,
chiedersi anche se tutta la lettura che è stata data a suo tempo di Tangentopoli
non meriti una revisione che la renda meno unilaterale di quanto non sia stata
fin qui.
Lo scandalo che in
questi giorni si snoda lungo la tortuosa rotta tra Doha e Strasburgo capovolge
due stereotipi in una volta sola. Uno è quello della sinistra intesa come
primatista morale. L’altro è quello dell’Europa austera e rigorosa. Entrambi
minacciano di avere conseguenze a lungo andare.
Del primo aspetto si
è parlato in lungo e in largo. Ora, si tratta di responsabilità personali,
strettamente personali, e dunque far carico di questa vicenda al gruppo dei
socialisti e democratici europei è politicamente (oltre che penalmente)
improprio. E tuttavia si avverte un certo stridore tra i comportamenti di
alcuni, appena svelati, e tutte le prediche che in questi anni sono discese dai
pulpiti della sinistra all’indirizzo dei propri avversari politici. (Molti dei
quali, peraltro, se le meritavano tutte.)
Ma la nemesi
funziona appunto così. E per tutte le volte che la sinistra ha scagliato le
frecce della sua indignazione cercando di colpire i comportamenti non sempre
adamantini dei propri avversari, altrettante volte quelle stesse frecce sono
tornate indietro al modo di un boomerang. Così oggi la destra non deve neppure
fare la fatica di esprimere a sua volta altrettanta indignazione. Anzi, essa
sembra quasi pattinare sulle storiacce di questi giorni con una sorta di
benevola e forse quasi divertita signorilità.
Ora, è evidente che
la sinistra paga alcuni eccessi giustizialisti del suo passato. Quella pretesa
di ergersi a campioni della pulizia al cospetto di avversari moralmente meno
degni sembra infatti prestarsi magnificamente al proprio rovesciamento. E non
appena sul banco degli imputati finiscono alcuni (solo alcuni, sia chiaro) dei
suoi esponenti diventa quasi inevitabile imputare loro anche l’eccesso di zelo
predicatorio e fustigatorio dei loro antenati di appena qualche stagione fa.
Così, oggi, forse i
dirigenti della sinistra oltre a battersi il petto, doverosamente, per le mele
marce trovate nei loro cesti, dovrebbero anche rivedere la retorica degli anni
scorsi. E magari, senza assolvere nessuno dei colpevoli di quella stagione,
chiedersi anche se tutta la lettura che è stata data a suo tempo di Tangentopoli
non meriti una revisione che la renda meno unilaterale di quanto non sia stata
fin qui. Compito che tradisce un minimo di imbarazzo, ma che a questo punto
andrebbe svolto con onestà intellettuale almeno pari all’onestà materiale di cui
si mena vanto.
Ma v’è un altro
aspetto, più cupo e profondo, che queste vicende stanno portando a galla. Ed è
lo stridente contrasto tra l’Europa finanziaria che predica austerità, spulcia
nei conti degli stati membri, impone regole contabili fin troppo rigorose per i
loro bilanci, si propone come guardiana del nostro collettivo decoro economico
in nome delle generazioni che verranno, e il suo Parlamento che diventa così
permeabile alle influenze corruttive che abbiamo appena visto all’opera.
Anche in questo
caso, non si tratterà di capovolgere i valori morali, tutt’altro. La costruzione
europea è fondata su di un certo rigore contabile che è l’altra faccia della
medaglia delle diffidenze che corrono tra i suoi paesi e della difformità di
alcuni suoi interessi. Dunque, quel rigore somiglia a un precetto
costituzionale, che ci piaccia oppure no. Ma è altrettanto evidente che quel
precetto sarà più difficile da celebrare al cospetto di quelle mazzette che
hanno reso tragicamente evidente la permeabilità delle istituzioni alle
influenze più disdicevoli degli stati più lontani dai nostri standard di etica
pubblica.
Sono strade in
salite, tutte e due. Quella che è chiamata a imboccare la sinistra, ripensando
se stessa. E quella che dovrà percorrere un’Europa troppo severa con gli altri
per essere indulgente con se stessa. Percorsi faticosi, tutti e due Redazione
CdG 1947
“Lo scandalo si
allargherà Il Pd non può darci più nessuna lezione di morale”.
Edoardo
Sirignano su L’Identità il 18 Dicembre 2022
“Non si possono fare
sempre lezioni di moralità e di superiorità ed accusare sempre altri di aver
distrutto la sinistra”. A evidenziarlo Nicola Danti, europarlamentare e attuale
vice presidente di Renew Europe.
Lei è stato tra i
primi europarlamentari a lasciare il Pd. Aveva già notato qualcosa che non
funzionava a Bruxelles?
Come me, altri
colleghi di quel gruppo, hanno iniziato l’esperienza a Bruxelles nel 2014,
quando con Matteo Renzi il Pd prese oltre il 40%. Ma per qualche ragione,
piuttosto che continuare a portare avanti il riformismo che caratterizzò quella
stagione, al Parlamento Europeo come a Roma, ho visto tanti iniziare ad
allontanarsi, prendere le distanze, arrivando persino a sposare la linea di
Conte punto di riferimento dei progressisti. Per me aderire a Renew Europe è
stata una scelta di coerenza, questa è la mia storia.
Aveva mai immaginato
che potesse venir fuori uno scandalo come Qatargate?
Ciò a cui stiamo
assistendo è fuori da ogni più lontana immaginazione. Ognuno di noi, parlo degli
eurodeputati, ogni giorno incontra portatori di interesse, lobbisti,
rappresentanti di Ong, associazioni, delle più diverse categorie. Il nostro
mestiere è ascoltare i punti di visti diversi e poi, liberamente, decidere. Per
questo esiste un codice di comportamento, regole di trasparenza e pubblicità che
devono essere rispettate. I fatti che stanno emergendo non hanno nulla a che
fare con ciò che legittimamente può essere fatto secondo le regole. Sono reati
che hanno a che fare con il codice penale, non con il codice comportamento del
Parlamento Europeo.
A suo parere il caso
può allargarsi e vedere altre persone coinvolte?
Le cose che leggo
sui giornali mi sembrano già molto rilevanti. Attendiamo le indagini e i
processi per avere più chiarezza. Quello che è certo però è che il danno fatto
alla nostra istituzione è enorme e recuperare la fiducia dei cittadini, anche
per tutti i deputati che fanno onestamente il loro lavoro, non sarà facile.
Che idea ha rispetto
agli ex parlamentari, che dopo aver finito il loro mandato, intraprendono la
strada del lobbismo?
La mia idea è che
loro come tutti gli altri, abbiano il dovere di rispettare la legge. Il
lobbismo, nonostante la narrazione che viene fatta, non è il male. Il male è la
corruzione e il non rispetto delle regole.
Prima lo scandalo
Soumahoro, oggi quello relativo alle mazzette di Doha. Dove ha origine il cancro
della sinistra? Qualcuno dovrebbe pentirsi, come ha chiesto Occhetto, che
dichiara di aver pianto per molto meno?
Non si possono fare
sempre lezioni di moralità e di superiorità ed accusare sempre altri di aver
distrutto la sinistra. Contro di noi, contro Italia Viva e contro Matteo Renzi,
è stato usato un vero e proprio armamentario di odio, che dovrebbe proprio
essere estraneo alla politica. Mi dispiace ricordare che spesso le espressioni
di odio peggiori siano venute proprio da chi per decenni ha coltivato la sua
superiorità morale.
Il Pd, a suo parere,
oggi ha ragione di esistere? Non sarebbero meglio due partiti: uno moderato che
guarda al Terzo Polo e un altro alla sinistra?
Oggi il punto vero
non è la più la distinzione, secondo lo schema dalemiano, fra centro e sinistra.
La differenza è fra il riformismo, di chi fa politica con serietà e pragmatismo
e il populismo ideologico. In questo senso il Pd andando dietro a Conte,
Fratoianni e Bonelli, ha intrapreso una china evidente che non ha nulla a che
fare con un percorso riformista.
Qualcuno accusa
Bonaccini di essere troppo renziano. Con lui potrà esserci un confronto vero?
Se dovessi stare a
vedere chi era renziano o troppo renziano avrei una lunga sfilza di dirigenti
che ieri si sedevano in prima fila e oggi invece salgono sulle barricate
dell’anti renzismo. Voglio fare un favore al Pd, evito di parlare del loro
congresso. L’unico consiglio che mi sento di dargli è che cerchino di declinare
qualche idea per il futuro piuttosto che parlare di un passato di successo che
però hanno deciso di distruggere. Detto questo, credo che il Pd, persino a
prescindere dal segretario che sarà eletto dalle primarie, sia destinato ad un
rapporto sempre più stretto con il M5S, che avrà come naturale conseguenza, il
definitivo tramonto di un approccio riformista interno.
Il Pd ha sbagliato a
non sostenere Moratti e consegnare così la Lombardia alle destre?
L’alleanza del Pd
con il M5S e il mancato sostegno alla Moratti, è una scelta che non guarda ad
alcuna possibilità di vittoria, ma risponde a un chiaro segnale politico di
carattere nazionale. È la strada che hanno deciso di percorrere, non avendo
imparato evidentemente nulla della lezione delle politiche. Hanno voglia di
riperdere, saranno accontentati presto. Noi invece, con Letizia Moratti,
giocheremo una partita molto difficile, ma dall’esito non impossibile.
Renzi, a volte,
viene accusato di essere troppo generoso nei confronti della Meloni. È
d’accordo?
Io ascolto gli
interventi in Aula, vedo la protesta per 18app, per il Mes, vedo i voti
contrari. Mi pare piuttosto che il Terzo Polo sia l’unico a fare opposizione
vera. Ciò significa incalzare la maggioranza, anche facendo proposte, e non
protestando e basta. Si chiama politica. E Matteo la fa. Non è la prima volta
che lo attaccano per questo.
A suo parere su
quali punti può e deve essere intensificata la collaborazione con il governo?
Noi faremo la nostra
opposizione, come stiamo facendo, sui contenuti e per questo darà molta noia
alla maggioranza, più di quella ideologica della sinistra. Questo, però, non ci
impedirà di dare il nostro sostegno costruttivo su singoli aspetti se sposeranno
alcune battaglie che condividiamo, come sulla giustizia o sulla posizione
atlantista in continuità con quella di Draghi. Insomma, non rinnegheremo le
nostre idee e i nostri ideali perché qualcun altro li porta avanti.
La dem Covassi:
“L’errore del Pd? Più attento al potere che ai deboli”.
Edoardo Sirignano su
L’Identità il 18 Dicembre 2022
“Esiste una grande
differenza tra fare il lobbista e prendere le mazzette. Il Pd, negli ultimi anni
è stato più attento alla gestione del potere che alle istanze della povera
gente”. A dirlo Beatrice Covassi, eurodeputata del Partito Democratico e già a
capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Che impressione le
ha fatto la vicenda Qatargate?
Mi sono insediata
lunedì e mi sono trovata subito protagonista di una sessione storica. Si può
solo immaginare il clima che si è creato dopo lo scandalo. Ho visto la maggior
parte dei colleghi sotto shock. Allo stesso tempo, però, devo dire di aver
trovato un’istituzione reattiva.
Cosa intende?
Abbiamo già votato
la destituzione della vice presidente Kaili, mai era successa una cosa del
genere. Giovedì, invece, prima della fine della plenaria, abbiamo approvato una
risoluzione in cui viene chiesto con urgenza l’istituzione di un organismo
etico. Abbiamo, poi, sospeso il lavoro del Parlamento sui visti per il Qatar,
sul libero accesso di Qatar Airways allo spazio aereo continentale. Ci stiamo,
infine, battendo sia per una commissione interna relativa al comportamento dei
deputati, che per una commissione d’inchiesta, focalizzata sui fatti corruttivi
degli ultimi giorni e sull’influenza dei i Paesi terzi. Deve essere un
imperativo accertare tutte le responsabilità e ricostruire la fiducia dei
cittadini nelle istituzioni europee, migliorando i processi all’insegna della
trasparenza, dell’etica e della responsabilità.
Si aspettava che
dietro ai suoi colleghi potesse esistere il mondo sommerso, di cui oggi parlano
i giornali?
Assolutamente no.
Resto convinta del fatto che la stragrande maggioranza dei colleghi sia
integerrima.
Quanto il Pd esce
danneggiato?
Il primo dolore, da
europeista convinta, è stata l’ondata di discredito gettata sull’Ue. La mia
sensazione è che in una fase così delicata sia necessario prestare attenzione
all’importanza dell’Europa per il futuro di tutti noi.
Cosa ne pensa di
questi signori, che dopo aver finito il mandato da deputati intraprendono la
carriera da lobbisti?
Esiste una grande
differenza tra fare il lobbista e accettare delle tangenti. Stiamo parlando, in
quest’ultimo caso, di episodi corruttivi, di rilevanza penale, che nulla hanno a
che vedere con un lavoro. Detto ciò, occorre rafforzare le regole, la
trasparenza e stroncare comportamenti lassisti.
Achille Occhetto,
qualche giorno fa, su queste colonne, ha dichiarato “io ho pianto per molto
meno, il Pd dovrebbe chiedere scusa”. È d’accordo?
Non bisogna
generalizzare, ma non si può non fare un esame di coscienza sul futuro del Pd,
su cosa vuol dire essere progressisti oggi. Serve una forza che torni a far
sognare la gente, in grado di avere visione. I mea culpa non bastano e neppure
le psicoanalisi collettive. Bisogna ripensare un soggetto politico e avviare una
riflessione su determinati temi, a partire dalla selezione della classe
dirigente.
In cosa si è
sbagliato?
Negli ultimi anni,
il Pd è stato più attento a gestire il potere che a interpretare le esigenze
della povera gente. Essere di centrosinistra per me vuol dire, come diceva La
Pira, stare dalla parte dei più deboli.
Preferisce, quindi,
un partito orientato a sinistra e al M5s o uno che sposi la causa del Terzo
Polo?
Trovo sbagliato
scelte di radicalizzazione tra massimalisti e riformisti. Non possiamo
schiacciare il Pd tra il populismo di alcuni pentastellati e il neoliberismo. La
nostra forza è originale perché consente di fare sintesi tra più identità, anime
e culture politiche. Dire di andare verso Conte o Renzi è assurdo e non risolve
i nostri problemi perché la vera sfida è ripartire dai valori di fondo che ci
caratterizzano.
Il prossimo
congresso potrà dare una mano verso tale direzione?
Lo auspico.
Preferivo un congresso basato sui temi e non esclusivamente sui nomi, come
quello che sto leggendo sui giornali. I classici schieramenti devono essere
superati. Al centro devono esserci le idee, le sfide per l’avvenire. Basti
pensare al cambiamento climatico, alla globalizzazione, al digitale o
all’intelligenza artificiale. Tutti dimenticano che viviamo già in un
“metaverso” che cambia la vita di ognuno di noi.
Chi preferisce tra
Bonaccini e Schlein?
Entrambi hanno punti
di forza e proposte interessanti. Nei prossimi giorni, seguirò con attenzione
quanto diranno. Vedremo chi avrà la capacità di dire no a radicalizzazioni
inutili e al contrario di unire e proporre una nuova sintesi che vada oltre
l’esistente. Non è detto, poi, che non possano crearsi spazi per altre
personalità.
Quale la strada per
riprendersi una credibilità perduta?
È importante non
solo ridare credibilità alla politica, ma tornare a sognare, a pensare al futuro
in modo positivo. Ho una figlia di 11 anni e quando le ho detto che diventavo
parlamentare, mi ha chiesto di diffondere il messaggio che il mondo è ancora una
cosa bella. Credo ancora che fare politica significhi dare speranza. E questo è
il vero bene comune.
Estratto
dell’articolo di Valeria Di Corrado per “il Messaggero” il 18 Dicembre 2022.
«Sono stato rapito,
torturato e tenuto in un carcere segreto dell'intelligence marocchina. A un
certo punto mi hanno anche offerto dei soldi per lavorare con loro dall'Italia.
Io ho rifiutato e allora mi hanno lasciato 7 mesi in una prigione sotto terra.
[…]».
L'inchiesta della
Procura federale belga, che sta smascherando la rete di corruzione diffusa
all'interno e all'esterno del Parlamento europeo, non stupisce affatto Mohamed
Dihani, soprattutto quando si parla della capacità di infiltrazione degli 007 di
Rabat. L'attivista sahrawi e difensore dei diritti umani, il 22 luglio scorso,
[…] è riuscito ad entrare sul territorio italiano per poter chiedere la
protezione internazionale.
«[…] Nel 2012 gli
007 marocchini giravano per le carceri dove c'erano i presunti terroristi e
proponevano di liberarli subito a patto di andare in Siria. […]».
[…] Quanto sono
potenti gli 007 di Rabat?
«Il Marocco è
ovunque, noi Sarhawi lo chiamiamo il polpo serpente. Il direttore dei servizi
segreti marocchini è venuto in Italia più di una volta per parlare di sospetti
terroristi, ma so che in ballo c'era di più. Io l'ho denunciato anche dalla
prigionia e avevo chiesto all'Italia di controllare tutti i viaggi sospetti
fatte dal 2010 al 2016 in Marocco da parlamentari italiani, eurodeputati
italiani, associazioni e istituti di ricerca che si rifiutavano di ascoltare le
voci sarhawi, trasmettendo solo quelle filo-governative. Ufficialmente venivano
per motivi di turismo, ma erano viaggi spesati.
Lo spyware Pegasus è
stato usato come braccio armato degli 007 marocchini per ricattare l'Europa e il
resto del mondo. Hanno spiato per tre anni giornalisti, politici algerini e
francesi: uno dei cellulari del presidente Emmanuel Macron appare nell'elenco
dei 50.000 numeri di telefono che sono stati presi di mira da questo software
spia. Nel 2019 è stato pubblicato un primo documento dalla Commissione europea,
e quest' anno un secondo, che invita tutti i politici a prestare attenzione,
denunciando il fatto che ci sono più di 500 agenti segreti marocchini infiltrati
nelle istituzioni dell'Ue. Gli eurodeputati vengono controllati a loro insaputa
dagli 007».
Anche i migranti
vengono usati come arma di ricatto?
«Sì, certo. Se per
esempio il ministro degli Esteri spagnolo dice di voler sostenere la causa del
popolo sahrawi, il Marocco apre le frontiere in massa e i migranti si riversano
sulle coste spagnole. C'è un bosco vicino alla città di Nadur dove tengono
recluse decine di migliaia di migranti in condizioni terribili, li utilizzano
anche nel trasporto della droga in Europa».
Come mai per Rabat è
fondamentale avere il controllo del Sahara Occidentale?
«Quella terra è
pienissima di risorse ed è la via più sicura tra l'Europa […] per questo è
disposto a corrompere tutti. […]».
Tutti gli
investimenti immobiliari qatarioti e quella visita a Doha che aprì la strada.
Dall'alimentare agli immobili al lusso. E l'emiro disse: "Da voi corruzione".
Gian Micalessin il 19 Dicembre 2022 su Il Giornale.
A volte il passato,
anche recente, può sembrare comico. O surreale. Di certo così appaiono, oggi, le
cronache dell'ottobre 2012 quando l'allora premier Mario Monti vola in Qatar.
Sono passati solo pochi mesi dall'assegnazione dei mondiali di calcio 2022
approdati a Doha sull'onda di compravendite di voti e generose mazzette. Eppure
durante la visita l'Emiro non tralascia di esibire al nostro premier la
preoccupazione d'investire in un'Italia «in preda alla corruzione».
In verità l'Italia
del 2012 è solo un paese distrutto dallo «spread» e dalle manovre
politico-economiche messe in campo per far fuori Silvio Berlusconi. Un paese
dove però si possono fare ottimi affari a prezzi di saldi. E proprio la
trasferta di Monti apre a Doha le porte della grande svendita. Il primo frutto
della visita è la costituzione, a marzo 2013, della joint venture «IQ Made in
Italy Investment Company S.p.A» controllata al cinquanta per cento dalla Qatar
Holding LLC e dal «Fondo Strategico Italiano Spa» - la holding di Cassa Depositi
e Prestiti. Dotato di un capitale di 300 milioni di euro, destinato ad
investimenti nelle eccellenze italiane che spaziano dall'alimentazione al lusso,
il fondo acquisisce nel 2014 il 28,4 per cento delle quote di Cremonini, gruppo
leader nell'esportazione di carne. Ma nell'aprile del 2012 la Qatar Holding ha
già messo le mani sugli immobili della costa Smeralda in Sardegna acquisendo
quattro hotel extralusso (Cala di Volpe, Romazzino, Cervo Hotel, Pitrizza), la
Marina e il Cantiere di Porto Cervo, l'esclusivo Pevero Golf Club e ben 2.400
ettari di terreno. Un giro d'acquisti del valore di 650 milioni di euro a cui si
aggiungono il controllo dell'ex-ospedale San Raffaele di Olbia e gli accordi su
Meridiana che portano, nel febbraio 2020, al fallimento e alla liquidazione la
compagnia aerea. Dalla Sardegna le operazioni finanziarie si allargano ben
presto all'abbigliamento e al lusso. Nel luglio 2013 la «Mayhoola for
Investment», controllata dallo sceicco Hamad bin Kahlifa al Thani, sborsa 700
milioni di euro per il controllo del marchio Valentino. Un anno dopo, si
aggiudica anche il marchio «Pal Zilieri» al prezzo di 37 milioni. Nel frattempo
si scatena la caccia agli alberghi extra-lusso. Nell'aprile 2013 i qatarioti
versano 150 milioni di euro per il Palazzo della Gherardesca di Firenze sede del
«Four Seasons Hotel». L'hotel fiorentino entra così a far parte di una
collezione che già comprende il Gallia di Milano acquisito per 134 milioni,
l'«Excelsior De Regis»di Roma pagato 222 milioni e, sempre nella capitale,
l'hotel Intercontinental di Trinità dei Monti ed il Westin Excelsior di via
Veneto costati oltre 220 milioni.
Il vero colpo gobbo
arriva, però, nel febbraio 2015 quando il Qatar acquisisce, grazie ad un
investimento da poco più di due miliardi, i 25 palazzi e grattacieli di Porta
Nuova simbolo e volto della Milano del Duemila.
(ANSA-AFP il 18
Dicembre 2022) Il Qatar mette in guardia sull'"impatto negativo" che può avere
sui rapporti tra il paese del Golfo e l'Ue la decisione di bloccare l'accesso di
Doha al parlamento europeo, misura presa in reazione allo scandalo che ha
investito alcuni eurodeputati accusati di corruzione in un'inchiesta della
Giustizia belga. La decisione di imporre "una restrizione così discriminatoria"
prima che l'inchiesta sia conclusa "avrà un effetto negativo sulla cooperazione
regionale e globale e sui colloqui in corso su energia, povertà e sicurezza". Lo
ha sottolineato un diplomatico del Qatar.
Dalla Russia al
Qatar, dalla padella alla brace (sempre a gas).
Stefano Piazza su Panorama il 19 Dicembre 2022.
Doha ha minacciato
di chiudere i rubinetti in caso di sanzioni ai suoi diplomatici sul caso
Qatargate e ci sbatte in faccia la verità: siamo in una posizione di debolezza
Mentre lo scandalo
denominato Qatargate è ben lungi dall’essere chiarito, visto che non si conosce
ancora il numero esatto degli europarlamentari corrotti dal governo di Doha,
aumentano le possibilità che si complichino e non di poco i rapporti con
l’Emirato nel quale ieri sono terminati i mondiali di calcio.
A proposito
dell’inchiesta avviata a Bruxelles la stampa europea non manca di additare
l’Italia, e i suoi politici, come dediti al malaffare. Fermo restando che in
questa vicenda alcuni esponenti politici (e non) sono finiti al centro
dell’inchiesta è bene ricordare che il Qatar così come la Russia e la Cina da
decenni mantengono rapporti non sempre limpidi con i politici di tutta Europa
tanto che l’ambasciata del Qatar a Parigi era considerata una sorta di bancomat
per l’intera classe politica francese, un fatto questo provato da numerose
inchieste. Lo stesso vale per i russi che hanno investito negli ultimi decenni
centinaia di milioni di euro per «fideizzare» il maggior numero di politici,
militari, scienziati, giornalisti e chiunque potesse servire ai disegni del
Cremlino e lo stesso hanno fatto i cinesi che si stanno comprando tutto quello
che c’è da comprare anche grazie agli «amici» che gli spalancano le porte e non
certo gratis. Quindi prima di puntare il dito contro la scassatissima classe
politica italiana chi oggi fa la morale, farebbe meglio a guardare in casa
propria. Fatta questa doverosa premessa va registrata l’ira di Doha dopo che è
stato deciso il divieto di accesso degli emissari del Qatar all'interno
dell’Europarlamento. Un diplomatico qatarino ad Al Mayadeen, emittente tv
panaraba con sede in Libano ha dichiarato: «La decisione di imporre una
restrizione così discriminatoria che limita il dialogo e la cooperazione con il
Qatar prima che il processo legale sia terminato, influenzerà negativamente la
cooperazione in materia di sicurezza regionale e globale, nonché le discussioni
in corso sulla povertà e la sicurezza energetica globale. Respingiamo fermamente
le accuse che associano il nostro governo a cattiva condotta». Il diplomatico ha
poi aggiunto: «Abbiamo osservato con grande allarme la condanna selettiva del
nostro paese di questa settimana poiché i pubblici ministeri belgi affermano di
aver indagato sulla corruzione del parlamento dell'UE per oltre un anno prima
che iniziassero gli arresti all'inizio di questo mese», infine ha concluso
dicendo: «È profondamente deludente che il governo belga non abbia fatto alcuno
sforzo per impegnarsi con il nostro governo per stabilire i fatti una volta
venuti a conoscenza delle accuse»; il diplomatico ha inoltre sottolineato, non
certo a caso, che il Belgio e il Qatar hanno forti legami che risalgono a
Covid-19 e il fatto che il Qatar sia uno dei principali fornitori di gas
naturale liquefatto (GNL) del Belgio. Il Qatargate arriva probilmente nel
momento peggiore della storia recente visto che la guerra in Ucraina tra le
molte conseguenze negative ha obbligato il Vecchio Continente a ridisegnare le
proprie politiche energetiche a partire dalla sostituzione delle fortiture di
gas provenienti dalla Russia. Rileggendo le affermazioni del diplomatico non
sfugge il passaggio ricattatorio: «Le restrizioni discriminatorie, che limitano
il dialogo e la cooperazione con il Qatar prima della fine delle indagini,
influenzeranno negativamente la cooperazione nonché i colloqui in corso sulla
carenza di energia e sulla sicurezza globale», che tradotto suona più o meno
così: «Cari europei, fate i bravi perché noi potremmo non darvi più il gas di
cui avete molto bisogno e che vi abbiamo promesso per i prossimi anni». Davvero
il Qatar perderebbe l’occasione di prendersi le quote di mercato di Gazprom, il
colosso energetico russo che fino all'anno scorso ha rifornito di gas a basso
prezzo i Paesi della Ue? Difficile che gli emiri di Doha passino dalle minacce
ai fatti visto che dopo anni anni di forniture di gas naturale liquefatto verso
i Paesi asiatici, vuole soppiantare i russi e diventare il leader del mercato in
Europa ma non solo visto che sta stringendo sempre più il rapporto con la Cina.
Un fatto questo che non piacerà a Vladimir Putin che punta a vendere tutto il
gas che gli europei non compreranno più dalla Russia proprio a Pechino. In ogni
caso dai ricatti russi si è passati a quelli degli emiri del Qatar che dopo aver
corrotto per anni importati personalità politiche all’Europarlamento con sacchi
pieni di banconote una volta che sono stati presi con le mani nella marmellata
si indignano e minacciano di tagliare le forniture di gas. Peggio di così non ci
poteva andare. LEGGI ANCHE Qatar, il Mondiale sbagliato ›
Tangentopoli
europea: ora è il Qatar a minacciare l’Europa.
Giorgia Audiello su
L'Indipendente il 19 Dicembre 2022.
Si inaspriscono le
tensioni diplomatiche tra Qatar e Unione Europea dopo il cosiddetto scandalo del
Qatargate: in seguito alle ingenti somme di denaro ricevute da alcuni
eurodeputati dalle istituzioni di Doha per millantare il miglioramento delle
condizioni per i diritti umani del Paese arabo, è stata avviata una inchiesta
denominata “cash for influence”, condotta dalla polizia belga, per fare
chiarezza sull’accaduto. Si tratta del più grande caso di corruzione – fatto
trapelare pubblicamente – della storia dell’Unione. Nel frattempo, a Strasburgo,
gli eurodeputati hanno votato quasi all’unanimità un testo in cui si «chiede con
urgenza che i titoli di accesso dei rappresentanti degli interessi del Qatar
siano sospesi fino a quando le indagini giudiziarie non forniranno informazioni
e chiarimenti pertinenti». Al momento non è ancora stata presa alcuna decisione,
ma gli eurodeputati hanno deciso di sospendere «tutti i lavori sui fascicoli
legislativi relativi al Qatar, in particolare per quanto riguarda la
liberalizzazione dei visti, l’accordo con il Qatar nel settore del trasporto
aereo e le visite programmate, fino a quando le accuse non siano state
confermate o respinte». La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola,
ha dichiarato che intende immediatamente chiedere alla conferenza dei presidenti
circa la volontà di bandire dal Parlamento i rappresentanti del Qatar o altri
funzionari governativi implicati nello scandalo.
Immediata è stata la
reazione di Doha alla decisione di sospendere i fascicoli relativi al Qatar ed
estromettere eventualmente i suoi rappresentanti: l’emirato arabo, infatti, ha
fatto sapere che «La decisione di imporre una tale restrizione discriminatoria
al Qatar, limitando il dialogo e la cooperazione prima della fine del
procedimento giudiziario, avrà un effetto negativo sulla cooperazione in materia
di sicurezza regionale e globale, nonché sulle discussioni in corso sulla
scarsità energetica globale e sulla sicurezza». Doha ha respinto, infatti, ogni
accusa, tacciando le autorità belghe di «inaccuratezza» delle informazioni.
«Respingiamo fermamente le accuse che associano il nostro governo a cattiva
condotta», ha affermato Doha in un comunicato. «Il Qatar non è stata l’unica
parte nominata nelle indagini, eppure esclusivamente il nostro Paese è stato
criticato e attaccato», prosegue la missiva, che parla di «condanna selettiva».
«Le nostre nazioni hanno collaborato durante la pandemia di Covid-19 e il Qatar
è un importante fornitore di Lng per il Belgio», ha sottolineato il governo
qatariota.
La collaborazione
delle istituzioni europee con il Paese arabo non è di certo recente: eppure,
solo ora le istituzioni comunitarie paiono essersi accorte che il Qatar è uno
stato controverso dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, dopo che la
monarchia del Golfo si è mossa per diventare uno dei principali fornitori di gas
naturale per l’Europa. Dopo essersi parzialmente liberata dalla dipendenza
russa, dunque – non senza costi enormi per l’economia europea – la Ue ripete il
medesimo schema con un altro stato annoverato tra i Paesi autocratici. Tradotto,
la Ue si sta smarcando da Mosca per finire però ad essere dipendente da altre
nazioni con cui è in conflitto geopoliticamente e “culturalmente”, pagando così
le conseguenze della mancanza di una politica energetica autonoma.
La monarchia araba
ha intensificato i suoi rapporti commerciali ed energetici con i Paesi europei:
L’Eni ha stretto un accordo della durata di 27 anni per aumentare le forniture
di gas, tramite il North Field East che dovrebbe entrare il funzione nel 2025;
mentre la Germania ha stipulato un contratto di 15 anni con Doha che prevede la
fornitura di due milioni di tonnellate di gas all’anno. Tuttavia, il gas del
Qatar rappresenta una piccola frazione di quello che forniva Mosca a Berlino e
non arriverà prima del 2026. Anche la francese Total ha siglato un’intesa con
Doha per sviluppare il più grande giacimento di gas naturale del mondo. D’altra
parte, però, nell’ultimo periodo la monarchia araba ha aumentato le sue
esportazioni anche verso l’Asia, stringendo così le sue relazioni diplomatiche
ed economiche con le potenze emergenti come la Cina, avversarie di
Washington: Pechino ha concluso un importante accordo con l’azienda
QatarEnergy che fornirà quattro milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto
(GNL) a Sinopec per 27 anni a partire dal 2026. Si tratta della collaborazione
più lunga mai stabilita in questo settore che segna anche lo spostamento
dell’asse geopolitico del piccolo emirato verso i BRICS, cosa che non può non
disturbare gli Stati uniti e i suoi “vassalli” europei.
L’indignazione
europea verso Doha arriva, dunque, solo dopo la conclusione di importanti
accordi commerciali che legano ancora una volta completamente il continente
europeo a potenze straniere, vanificando e palesando l’inutilità degli sforzi
fatti per emancipare l’Europa dal gas russo. Doha, infatti, ha la forza e le
possibilità di ricattare energeticamente i Paesi dell’Unione, esponendo il
Vecchio Continente ad un aggravamento della crisi energetica. Complici le
politiche ipocrite e poco lungimiranti dell’Unione Europea, emerse con lo
scandalo del Qatargate. [di Giorgia Audiello]
Adesso Doha
minaccia ritorsioni. E ricatta l'Europa (Italia inclusa) con l'arma del gas.
Nel pieno dello scandalo per l'inchiesta sulla presunta corruzione nel cuore
delle istituzioni europee da parte di Marocco e Qatar, l'Emirato contrattacca.
Lodovica Bulian il 19 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Nel pieno dello
scandalo per l'inchiesta sulla presunta corruzione nel cuore delle istituzioni
europee da parte di Marocco e Qatar, l'Emirato contrattacca. E minaccia
conseguenze sulle forniture di gas. All'indomani del terremoto giudiziario e
degli arresti, Bruxelles aveva sospeso ogni discussione in Plenaria riguardante
il Paese, a partire dal dossier sulla liberalizzazione dei visti, e aveva
vietato l'accesso dei suoi rappresentanti all'Eurocamera. Ora Doha reagisce. Un
diplomatico qatariota della missione presso la Ue, in una serie di dichiarazioni
riprese dall'emittente «Al Mayadeen», fa capire senza troppi giri di parole che
ci saranno ripercussioni se le contromisure adottate dal Parlamento dovessero
continuare. La decisione di imporre «queste restrizioni discriminatorie, che
limitano il dialogo e la cooperazione con il Qatar prima della fine delle
indagini, influenzeranno negativamente la cooperazione in materia di sicurezza
regionale e globale, nonché i colloqui in corso sulla carenza di energia e sulla
sicurezza globale». Avranno cioè un «impatto negativo» anche sulla fornitura
globale di gas ai Paesi della Ue. Il Qatar, continua, è un «importante
fornitore» di gas naturale liquefatto al mondo, e lo è anche per lo stesso
Belgio. Di certo dallo scoppio della guerra in Ucraina, è diventato un
interlocutore primario nei dei processi di diversificazione per le forniture di
gas in Europa. Che ora rischia di finire sotto ricatto.
Il Qatar lamenta
l'assenza di collaborazione da parte del governo del Belgio di cui, il Paese del
Golfo si dice partner «stretto» e rivendica una vicinanza durante la pandemia:
«È profondamente deludente che il governo belga non abbia fatto alcuno sforzo
per impegnarsi con il nostro governo per stabilire i fatti una volta venuti a
conoscenza delle accuse».
Quanto
all'inchiesta, «respingiamo fermamente le accuse che associano il nostro governo
a cattiva condotta. Il Qatar non è stata l'unica parte nominata nelle indagini,
eppure esclusivamente il nostro Paese è stato criticato e attaccato», dice il
diplomatico, che parla di una «condanna selettiva». L'Emirato, oltre a essere un
importatore di armamenti da diversi Paesi europei, è anche uno dei tre
principali paesi produttori di gas al mondo con Stati Uniti e Australia. Sta
sviluppando il più grande giacimento esistente al mondo, il North Field East, un
progetto off shore che il Qatar condivide con l'Iran, nel nord-est del Golfo
Persico: la produzione dovrebbe passare dalle attuali 77 milioni di tonnellate
all'anno a 126 milioni entro il 2027. Per accelerare l'ampliamento delle
infrastrutture, la società di stato QatarEnergy aveva annunciato di aver aperto
alla collaborazione degli operatori occidentali. Anche Eni era stata selezionata
come partner internazionale. Quegli stessi Paesi occidentali insomma avrebbero
molto da perdere, è stato il messaggio chiaro dal Paese del Golfo.
L'inchiesta va
avanti. In Italia la moglie dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri - lui in
carcere a Bruxelles con l'accusa di corruzione e riciclaggio - comparirà davanti
alla corte d'Appello di Brescia che dovrà decidere sulla sua consegna al Belgio.
Domani sarà la volta della figlia. Le donne sono accusate dagli inquirenti belgi
- sulla base di intercettazioni - di essere state pienamente consapevoli, oltre
che beneficiarie, della presunta corruzione nei confronti di Panzeri da parte
del Qatar e del Marocco. Nelle intercettazioni citate dalla Procura di Bruxelles
a sostegno della richiesta di arresto si parlava della disponibilità per la
famiglia Panzeri di una carta di credito di una terza persona chiamata «il
gigante». Madre e figlia sono state destinatarie una settimana fa di un mandato
di arresto europeo e ora sono ai domiciliari. Il loro avvocato ha ribadito la
loro «totale estraneità» ai fatti contestati.
Da rainews.it il 18
Dicembre 2022.
Angelina Jolie ha
annunciato le sue dimissioni dal ruolo di inviata speciale dell'UNHCR (l’Agenzia
Onu per i rifugiati) dopo oltre 20 anni di collaborazione. L'attrice, 47 anni,
ha svolto più di 60 missioni sul campo con l'UNHCR, accendendo i riflettori
sulla condizione di milioni di persone sfollate dalle loro case negli ultimi due
decenni.
“Dopo 20 anni di
lavoro all'interno del sistema delle Nazioni Unite, sento che è giunto il
momento di lavorare in modo diverso, impegnandomi direttamente con i rifugiati e
le organizzazioni locali e sostenendo la loro azione di advocacy per trovare
soluzioni” ha dichiarato la Jolie in un comunicato. “Continuerò a fare in futuro
tutto ciò che è in mio potere per sostenere i rifugiati e gli altri sfollati”.
L'UNHCR l'ha
definita una delle più influenti sostenitrici dei diritti dei rifugiati. La star
statunitense, vincitrice di un Oscar, collabora con l'UNHCR dal 2001 ed è
diventata inviata speciale nel 2012. Angelina Jolie ha “lavorato
instancabilmente […] per testimoniare storie di sofferenza, ma anche di speranza
e resilienza” ha commentato l'agenzia Onu con sede a Ginevra.
“Siamo grati per i
suoi decenni di servizio, per il suo impegno e per la differenza che ha fatto
per i rifugiati e le persone costrette a fuggire” ha dichiarato il capo
dell'Agenzia, Filippo Grandi. “Dopo un lungo periodo di successo all'interno
dell'UNHCR, apprezzo il suo desiderio di cambiare impegno e sostengo la sua
decisione” ha aggiunto ancora Grandi.
(ANSA il 19 dicembre
2022) - In Procura a Milano al momento non è ancora aperta un'inchiesta autonoma
sul cosiddetto 'Qatargate'. E' probabile, tuttavia, che nei prossimi giorni,
sulla base di ulteriori atti che potrebbero arrivare dai magistrati belgi o per
altre attività necessarie a fronte dell'ordine di investigazione europeo
trasmesso da Bruxelles ai pm milanesi, si arrivi all'iscrizione di un fascicolo
con indagini del pool guidato dall'aggiunto Fabio De Pasquale.
I magistrati
milanesi, dopo le perquisizioni dei giorni scorsi nell'abitazione di famiglia,
nella Bergamasca, di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato in carcere a Bruxelles,
nella casa ad Abbiategrasso dei genitori di Francesco Giorgi, ex collaboratore
di Panzeri, e nello studio di una commercialista, hanno già acquisito sette
conti correnti che sono al vaglio della Gdf.
Nell'ordine di
investigazione europeo di una quarantina di pagine viene indicato ai pm milanesi
anche di sentire i genitori di Giorgi, definiti persone "interessate"
all'indagine, e di farlo con la qualifica di indagati.
Come riportato oggi
da La Verità, i magistrati belgi si concentrano anche su alcuni trasferimenti di
denaro effettuati proprio dai genitori di Giorgi dall'Italia al Belgio e serviti
per l'acquisto di un immobile a Bruxelles.
Per queste e altre
audizioni potrebbe essere necessario aprire un filone di indagine tutto
milanese. Allo stesso tempo, se dal Belgio arrivassero ulteriori atti, come in
ipotesi stralci dei verbali dell'ex assistente di Panzeri, nonché compagno
dell'ormai ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, gli inquirenti
milanesi potrebbero cercare riscontri indagando in autonomia su un presunto
riciclaggio in Italia dei soldi delle tangenti pagate da Qatar e Marocco per
favorire gli interessi dei due Paesi
(ANSA il 19 dicembre
2022) - Non va consegnata al Belgio Maria Dolores Colleoni, la moglie dell'ex
eurodeputato Antonio Panzeri, pure lei come il marito tra gli arrestati
nell'indagine di Bruxelles Qatargate, in quanto questo rappresenterebbe "una
violazione dei diritti dell'uomo".
Lo hanno sostenuto
in aula davanti alla Corte d'Appello di Brescia gli avvocati Angelo De Riso e
Nicola Colli, difensori della donna - ora ai domiciliari e che stamani ha reso
dichiarazioni spontanee -, opponendosi così alla richiesta di consegna contenuta
nel mandato d'arresto europeo.
"Abbiamo sostenuto
che non ci sono ragioni di consegnare la nostra assistita al Belgio" in quanto
ciò presuppone che finisca in carcere. "Una misura più afflittiva - hanno
proseguito i legali - non solo sarebbe incoerente con la misura dei domiciliari
disposti lo scorso 9 dicembre dal giudice d'appello ma poiché tale misura non è
stata violata significherebbe violare quando prevede la Corte europea dei
diritti dell'uomo". La difesa aveva chiesto alla Corte d'Appello un rinvio che
non è stato concesso. La decisione è attesa attorno alle 16.30.
Giacomo Amadori
François De Tonquedec per “la Verità” il 19 dicembre 2022.
L'inchiesta del
giudice istruttore belga Michel Claise punta anche alla rete famigliare degli
indagati per reati che vanno dalla partecipazione a organizzazione criminale
alla corruzione.
Nel mirino sono
finiti soprattutto l'ex europarlamentare del Pd Pier Antonio Panzeri e il suo ex
assistente, il trentacinquenne Francesco Giorgi, entrambi arrestati lo scorso 9
dicembre. Nel mirino anche le loro reti famigliari che, come vedremo, sono
collegate dai servizi di una commercialista, perquisita, la cui figura sta
emergendo come sempre più significativa.
Di Panzeri sono
stati messi sotto osservazione almeno tre conti correnti italiani (intestati due
a lui e uno alla figlia Silvia) e la documentazione di una banca brasiliana, la
Lift, in cui potrebbe essere stato depositato il tesoretto dell'ex sindacalista.
Ma le attività di indagine delegate alla Procura di Milano e coordinate da Fabio
De Pasquale puntano anche a Giorgi.
Nell'ordine europeo
di indagine (Oie) Claise ha chiesto alle autorità italiane di fornire tutte le
informazioni disponibili in merito all'identità di sette persone: Panzeri, la
sua commercialista Monica Rossana Bellini, il sindacalista Luca Visentini,
l'attivista Nicolò Figà-Talamanca e poi buona parte della famiglia Giorgi.
Claise, scrittore di
gialli di successo, ha chiesto di estendere i controlli anche ai parenti di
Francesco e principalmente al padre Luciano, sessantacinquenne originario di
Abbiategrasso, e alla madre Iole Valli, sessantanovenne nativa di Rho.
A colpire la
fantasia del giudice è stata «l'acquisizione di attività finanziarie in Belgio a
nome di Francesco Giorgi», dal momento che, a giudizio degli inquirenti,
«durante l'indagine è emerso chiaramente» che questa è il «risultato di
trasferimenti dall'Italia».
Invii che sarebbero
serviti per l'acquisto di un edificio a Bruxelles da parte di Giorgi.
Una compravendita
per cui sarebbero partiti alcuni bonifici dai conti italiani di papà Luciano e
mamma Iole. In particolare sotto la lente di ingrandimento del giudice sono
finiti tre invii.
Il primo da 40.000
euro, datato 5 ottobre 2022, è riconducibile alla Valli; lo stesso giorno altri
40.000 euro sono stati trasferiti dal conto del marito, il quale il 31 agosto
aveva già inviato altri 4.000 per la stessa operazione immobiliare. Tra questi
trasferimenti è stato segnalato un bonifico del 30 settembre da 10.000 euro del
figlio Francesco sempre destinato allo stesso acquisto.
Insospettito da
questa operazione Claise ha chiesto di procedere alla perquisizione del
domicilio di Abbiategrasso di Francesco Giorgi e di qualsiasi altra sua
«residenza effettiva» e «di procedere all'audizione, in qualità di indagata,
della persona che ha l'uso dei locali, ovvero suo padre e sua madre, Luciano
Giorgi e Iole Valli».
Martedì scorso
nell'abitazione gli uomini della Guardia di finanza hanno sequestrato 20.000
euro in contanti e altra documentazione che, come specificato nell'Oie, dovrà
essere trasferita a Bruxelles.
Ricordiamo che nel
trolley che aveva con sé Alexandros Kaili, suocero di Giorgi e padre della
compagna dello skipper, Eva, in quel momento vicepresidente del Parlamento
europeo, gli investigatori belgi hanno trovato 600.000 euro.
Invece
nell'abitazione di Eva e Francesco sono stati sequestrati altri 150.000 euro. Ma
le mazzette di contanti sono un po' il leit motiv di questa storia. Infatti
anche nella casa di Panzeri, arrestato il 9 dicembre, nella capitale belga sono
stati sequestrati 600.000 euro.
Il totale dei tre
sequestri ammonta a 1,35 milioni di euro cash, ma gli inquirenti belgi hanno
fatto sapere di aver sequestrato più di 1,5 milioni.
Ma ritorniamo ad
Abbiategrasso. La villa, suddivisa in dieci vani, ha una superficie di 250 metri
quadrati a cui ne vanno aggiunti 50 di autorimessa. È stata acquistata nel 2005
ed è intestata a entrambi i genitori, ma non al figlio che non risulta avere
beni immobili in Italia.
In compenso i suoi
genitori nel 2019 hanno comprato una casa al mare, un bilocale, che si trova a
Cervo, in provincia di Imperia, all'interno di un edificio denominato Mimosa.
Il rogito viene
perfezionato il 15 giugno 2019 a Borghetto Santo Spirito. A vendere è un
torinese residente a Roma. I genitori di Giorgi pagano l'immobile 150.000 euro e
saldano con un assegno datato 12 giugno 2019 di Banca Intesa del valore di
135.000 euro che va sommato alla caparra inviata il 10 maggio 2019 con un
bonifico di 14.990 euro partito da un conto Ing (la banca olandese) intestato a
Luciano Giorgi.
La contabile del
bonifico viene firmata da un funzionario dell'ufficio della Ing bank n.v. Milan
branch. Sempre dal conto Ing il 15 giugno escono i 3.660 euro che Giorgi senior
paga all'agenzia immobiliare. Insomma per fare il loro acquisto i genitori non
hanno avuto bisogno di ricorrere ad alcun mutuo o perlomeno questo è quello che
appare dal rogito.
Ma se la radiografia
degli immobili dei Giorgi è molto interessante, lo è ancora di più studiare la
storia delle società di famiglia. Che si incrociano clamorosamente con le
operazioni finanziarie di Panzeri. E l'anello di congiunzione è la già di citata
ragioniera Benelli, di cui Claise ha chiesto la perquisizione.
Il motivo è spiegato
nell'ordine europeo di indagine, dove si legge che nel corso dell'inchiesta
sarebbe emerso «chiaramente» che la signora Bellini «è la responsabile della
consulenza gestionale e finanziaria della coppia Panzeri-Colleoni (Maria
Dolores, la moglie dell'ex sindacalista, ndr)».
Per gli
investigatori, secondo cui i guadagni di Panzeri «sembrano di natura criminale»,
«l'intervento dello studio Bellini potrebbe far parte di operazioni di
riciclaggio».
Il 28 dicembre 2018,
a cinque mesi dalle elezioni europee del 2019, viene costituita la Equality
consultancy srl, con sede legale a Opera, in provincia di Milano, proprio nello
studio della commercialista, in via Martiri di Belfiore.
Ma nella compagine
azionaria non compare Panzeri (in quel momento la situazione delle candidature è
fluida e l'ex sindacalista della Cgil annuncerà di aver rifiutato l'investitura
solo il 9 aprile) bensì il padre del suo assistente parlamentare (dal 2009)
Francesco Giorgi.
Babbo Luciano (che
detiene il 70 per cento delle quote) fa parte della compagine sociale insieme
con il figlio minore Stefano (25 per cento) e con la Bellini (5) che è anche
amministratrice della società insieme con Giorgi junior.
I loro poteri sono
disgiunti per le attività ordinarie. L'oggetto sociale della Equality
consulting, che ha un capitale di 10.000 euro, è praticamente quello di una ong
e non ha niente a che fare con il lavoro di rappresentante di prodotti
farmaceutici di Giorgi senior. Leggiamo gli obiettivi: «Realizzare una rete
ampia, trasparente e ben informata di partenariati.
Aiutare a rimuovere
alcuni degli ostacoli alla collaborazione esistenti tra le culture differenti
attraverso iniziative volte a promuovere e divulgare i diritti umani e la
protezione delle libertà fondamentali», «sviluppare reti tra diversi soggetti,
Ong, organizzazioni imprenditoriali e controparti nei Paesi terzi, per
facilitare il dialogo e le opportunità che consentono legami economici e
culturali più forti all'interno dell'Ue e nei suoi Stati membri» e, infine,
«promuovere gli scambi e la cooperazione tra soggetti, situati in altre aree
geografiche di riferimento».
Nelle mani del più
giovane dei Giorgi (che secondo la sua pagina Linkedin in quel momento era
apprendista in una società di autonoleggi), insomma, c'è, come detto, una specie
di organizzazione non governativa. Che il primo anno ottiene ottimi risultati. A
fronte di un valore della produzione iscritto a bilancio di 240.000 euro,
l'utile di esercizio è di 102.500 euro. Ma quando quel bilancio viene chiuso,
Giorgi padre e figlio hanno lasciato la società. Il 23 luglio 2019, a 20 giorni
dalla prima plenaria del Parlamento europeo che si è svolta il primo luglio, i
due cedono le quote.
Una parte (il 40%
della società) di quelle di Luciano va a Dario Vittorio Scola, suo socio di
vecchia data (dal 2001) in un'altra ditta, la Sunflower srl che si occupava
(attualmente risulta inattiva) della rappresentanza di prodotti farmaceutici.
Altre quote (il 30%) del genitore finiscono in mano a tale Manfred Forte, che
rileva anche una parte (il 10%) di quelle di Stefano. Il restante 15% viene
ceduto dal giovane Giorgi alla solita Bellini, la commercialista di Panzeri e,
sembra, non solo sua.
Il 5 settembre
Stefano lascia alla donna anche la guida della società, che grazie a una
modifica allo statuto passa all'amministratore unico. In quello stesso mese
Panzeri fonda la sua ong a Bruxelles, la Fight impunity, di cui Francesco (che
nel frattempo è diventato assistente dell'europarlamentare Andrea Cozzolino)
ricopre il ruolo di «senior advisor». Nel 2020, forse anche per la pandemia, le
cose per la Equality consultancy non vanno come il primo anno: il valore della
produzione crolla a 81.000 euro e il bilancio annota perdite per 51.000.
E così il 18
novembre la società viene messa in liquidazione e la Bellini ha il compito di
portare avanti le ultime pratiche della società, tra cui l'approvazione del
bilancio del 2020. Dall'8 giugno del 2021 la Equality consultancy non esiste
più.
Ieri siamo andati ad
Abbiategrasso per cercare di parlare con i genitori di Francesco Giorgi, agli
arresti in Belgio. Un'enorme siepe protegge la famiglia da occhi indiscreti.
Solo dall'ingresso pedonale e da quello del box auto si riesce a scorgere
qualcosa. Per esempio i sobri addobbi natalizi, una coccarda appesa al
cancelletto e un filo di lucine gialle. Le persiane sono chiuse. Fuori da una
finestra è appesa una bandiera arcobaleno della pace. Un citofono semi distrutto
stride con tutto il resto. Suoniamo ma non risponde nessuno. I vicini passano
frettolosamente. Qualcuno evita di rispondere alle domande. Altri ci liquidano
con un «non so nulla» di circostanza. Sarà il prosieguo delle indagini a dirci
qualcosa in più. Ha collaborato Salvatore Drago.
Giuseppe Guastella
per corriere.it il 19 dicembre 2022.
La richiesta è stata
trasmessa da Eurojust il 7 dicembre, due giorni prima dell’operazione che a
Bruxelles ha sconvolto il Parlamento europeo con l’arresto di sei persone
accusate di aver preso soldi dal Marocco e dal Qatar per favorire gli interessi
di questi due Paesi nella massima istituzione elettiva europea corrompendo a
suon di bustarelle europarlamentari compiacenti.
Destinataria la
Procura di Aosta. Oggetto: un appartamento a Cervinia che si sospetta sia stato
acquistato con i soldi del giro di mazzette. Una classica operazione di
riciclaggio, la stessa che potrebbe celarsi dietro a un investimento fatto dalla
coppia Kaili-Giorgi per costruire una villa da favola nella bellissima isola
greca di Paros.
Al di là di una
molto generica accusa di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio,
a dieci giorni dal blitz non è ancora chiaro perché siano state arrestate le
persone che, sembra ormai dato per scontato, ruotavano intorno alla Fight
impunity, la Ong dell’ex europarlamentare pd Antonio Panzeri che avrebbe dovuto
combattere a favore dei diritti umani ma che invece avrebbe brigato a suon di
denaro, incassato e poi girato, con «interventi politici presso»
europarlamentari con lo scopo di migliorare la precaria immagine di Marocco e
Qatar in tema di diritti umani.
A partire da uno dei
14 vice presidenti, la greca del Pasok Eva Kaili (destituita), di cui i
cittadini europei sanno solo che è finita in carcere perché era in flagranza di
un qualche reato dopo che nella casa che divide con il suo compagno Francesco
Giorgi, descritto come il complice di Panzeri, sono stati trovati più di 750
mila euro in contanti che dovrebbero provenire da Qatar e Marocco, ma che Giorgi
giura essere i suoi.
Al riserbo
strettissimo dei magistrati sfuggono solo particolari secondari dell’accusa che
ogni giorno contribuiscono a mettere sulla graticola nuovi personaggi, anche se
solo hanno avuto rapporti con gli indagati. Come il pd Andrea Cozzolino, che non
è indagato, ma che aveva legami «pericolosi» con Panzeri e con l’ambasciatore
del Marocco in Polonia Abderrahim Atmoud, il cui nome è negli atti come colui al
quale la famiglia Panzeri voleva affidare dei regali che aveva ricevuto per
portarli in Marocco.
Si dice che operasse
in un centro studi che sarebbe la base a Bruxelles dei servizi segreti di Rabat.
Di lui parla la moglie (intercettata) di Panzeri che è stata arrestata con la
figlia e comparirà oggi in Appello a Brescia perché il Belgio chiede la sua
consegna. «Non darà il suo consenso, non ci sono i presupposti né giuridici né
di merito», afferma il suo legale, l’avvocato Angelo De Riso.
Un’ipotesi di
riciclaggio dovrebbe aleggiare su una casa acquistata ad aprile scorso a
Cervinia da Niccolò Figà-Talamanca, il segretario della No peace without
justice, l’altra Ong finita nell’inchiesta, arrestato e poi messo ai domiciliari
dai magistrati belgi con il braccialetto elettronico.
Come ha rivelato La
Verità, si tratta di un appartamento di cinque vani su 90 metri quadrati
acquistato il 29 aprile scorso per 215 mila euro dalla società belga Nakaz di
cui è amministratore Figà-Talamanca. Potrebbe essere sequestrato su richiesta
della Procura di Aosta nel sospetto che i fondi siano arrivati dalla Fight
impunity di Panzeri oppure con un percorso diretto dal Qatar o dal Marocco.
L’altra Procura
italiana interessata da Eurojust è quella di Milano che, su richiesta di
Bruxelles, sta lavorando sui flussi di denaro da e per il Belgio su sette conti
correnti che fanno capo alla famiglia Panzeri e a Giorgi.
L’aggiunto Fabio De
Pasquale sentirà testimoni e analizzerà documenti per capire se il denaro sia
stato, anche in questo caso, riciclato, come i 100 mila euro in contanti che
mancherebbero ai 600 mila trovati a casa di Panzeri a Bruxelles. Anche in Grecia
sono in corso indagini patrimoniali sulla Kaili e sulla sua famiglia, sempre a
caccia di soldi di provenienza illecita che potrebbero essere stati
reimpiegati.
La magistratura,
secondo la stampa greca, punta a un investimento da 300 mila euro fatto nove
mesi fa da Eva Kaili e dal suo compagno Francesco Giorgi per acquistare un
terreno di 36 mila metri quadrati a Paros sul quale costruire una favolosa villa
con piscina. In attesa degli sviluppi delle indagini in Belgio, tutti i beni
della famiglia Kaili in Grecia sono stati congelati.
Estratto
dell’articolo di Giuliano Foschini e Luca De Vito per “la Repubblica” il 19
dicembre 2022.
Poiché sono i
particolari a raccontare le storie, questo spiega molto di cosa è questo
Qatargate: Antonio Panzeri consegnava i soldi del Qatar con cui tentava di
corrompere la politica di Bruxelles in buste con Babbo Natale ben stampato
sopra. Siccome però aveva la casa invase di microspie, la polizia belga ha
registrato alcuni di questi scambi.
Il 10 ottobre
scorso, per esempio, quando, nel suo salotto, si presentò Luca Visentini, allora
numero uno del sindacato europeo in corsa per essere eletto, un mese dopo nel
congresso di Melbourne, leader del sindacato mondiale, Panzeri gli consegnò tre
buste - «sembriamo quelli di Ocean's Eleven» scherzava Panzeri - piene di
contanti.
[…] Quello che
interessa gli investigatori è il modus operandi di Antonio Panzeri: che pagava
in contanti chi riteneva potesse essergli utile utilizzando la cassa del Qatar.
Ed è questo che il giudice Claise sta cercando di capire in questi giorni,
facendo leva sulle migliaia di intercettazioni telefoniche e ambientali a
disposizione. E soprattutto sulla collaborazione di Francesco Giorgi che ai
magistrati di Bruxelles ha rivelato di aver avuto un ruolo da responsabile della
"cassa".
La questione
principale è capire chi prendeva i soldi. E per cosa. Sul primo punto le
dichiarazioni dell'ex assistente di Panzeri e dell'eurodeputato Cozzolino
saranno importantissime, dopo alcune ammissioni nel primo interrogatorio. Sarà
fondamentale anche l'analisi dei conti correnti e dei movimenti che - tra il
Belgio, l'Italia e il Sudamerica - hanno visto spostare somme ingenti.
Un'analisi che potrebbe portare gli inquirenti ad allargare l'indagine.
Sul secondo punto
invece - per ricostruire cioè gli atti e soprattutto le modalità a cui si è
arrivati al voto - gli investigatori stanno analizzando computer e telefoni
sequestrati agli assistenti. Da un'analisi sta emergendo, chiaro, il ruolo di
Giorgi: era lui a dare le indicazioni sugli emendamenti da presentare e sulle
modalità di voto.
Giuseppe Salvaggiulo
per “la Stampa” il 19 dicembre 2022.
Dopo telefonate,
mail e bonifici, spuntano le intercettazioni ambientali delle mazzette. Lo
schema del sistema di corruzione internazionale svelato dall'inchiesta della
Procura federale belga si delinea su diversi piani investigativi. Le
perquisizioni a tappeto negli uffici e il sequestro di computer e telefoni di
una ventina di assistenti parlamentari mirano a «incartare», in mailing list e
chat, le prove dell'eterodirezione di un significativo pezzo del gruppo
socialista del Parlamento europeo da parte della cricca con a capo l'ex
eurodeputato Antonio Panzeri.
Le indagini bancarie
e patrimoniali puntano a ricostruire da un lato i flussi di finanziamento della
Ong di Panzeri, Fight Impunity, ritenuta uno schermo per gestire il sistema
corruttivo; dall'altro i canali attraverso cui le tangenti venivano ripulite
rientrando nel circuito finanziario legale. Reinvestite in asset patrimoniali in
giro per il mondo.
In mezzo c'è il
passaggio materiale delle tangenti da Panzeri - presunto corrotto da Marocco e
Qatar, ma anche collettore per loro conto verso eurodeputati e attivisti dei
diritti umani - agli altri indagati. Ferma la presunzione di non colpevolezza
fino a sentenza definitiva, gli investigatori contano su mesi di intercettazioni
telefoniche e ambientali, pedinamenti e persino registrazioni delle dazioni.
In particolare
avrebbero filmato Panzeri mentre consegna denaro in diverse buste con l'effigie
di Babbo Natale a Luca Visentini, sindacalista italiano proveniente dalla Uil,
presidente dei sindacalisti europei dal 2015, neoletto durante il congresso di
Melbourne a fine novembre, pochi giorni prima di essere arrestato, segretario
generale dell'International Trade Union Confederation (Ituc), il sindacato
mondiale che conta più di 250 confederazioni e oltre 200 milioni di iscritti.
«La prima emergenza è il diffondersi dei governi autoritari», dichiarava dopo
l'elezione.
Ignaro che gli
investigatori belgi ne monitoravano da tempo le connessioni con Panzeri,
sospettando che costui fosse il tramite di governi come quelli di Qatar e
Marocco.
Pedinato nei suoi
incontri con Panzeri, anche nella casa brussellese dell'ex eurodeputato dove poi
sono stati sequestrati 600 mila euro in contanti, Visentini è anche stato
filmato. Il video viene considerato una prova centrale. L'ipotesi dell'accusa è
che Panzeri, per conto terzi, abbia alimentato l'ascesa di Visentini per
assicurare agli Stati finanziatori un sindacato «controllabile».
La posizione
dell'Ituc sul Qatar, peraltro, è cambiata nel tempo. Un documento pubblicato a
ottobre, poco prima dell'elezione di Visentini, elogia la legislazione sul
lavoro come degna di un moderno sistema di relazioni industriali.
Arrestato il 9
dicembre con lo stesso Panzeri, il «principe degli assistenti parlamentari»
Francesco Giorgi, l'ex vicepresidente del Parlamento Ue Eva Kaili e il
segretario della Ong Non c'è pace senza giustizia Niccolò Figà Talamanca,
Visentini è stato l'unico scarcerato, due giorni dopo in seguito
all'interrogatorio. Fino a marzo è libero, salvo divieto di contatti con altri
indagati e autorizzazione del giudice per viaggi all'estero. Visentini si è
dichiarato «innocente e pronto a fornire qualsiasi ulteriore chiarimento o
informazione».
Quanto ai soldi,
prima ha spiegato di «non aver ricevuto un finanziamento elettorale da Fight
Impunity ma solo una donazione da poche migliaia di euro versata al sindacato».
Poi ha parlato di
«poche decine di migliaia di euro trasferite al sindacato per spese
tracciabili».
Infine ha ammesso di
aver «ricevuto una donazione da Fight Impunity, per un importo complessivo
inferiore a 50 mila euro», specificando che «questa somma consisteva in denaro
sotto forma di donazione per rimborsare alcuni dei costi della mia campagna per
il congresso della Ituc, e in denaro sotto forma di donazione che ho trasferito
come tale al fondo di solidarietà della Ituc, per sostenere i costi di viaggio
al congresso per i sindacati che hanno mezzi finanziari limitati o inesistenti».
Resta la domanda:
perché in contanti? «Per la qualità del donatore e per il suo carattere non
profit - si è difeso -. Non mi è stato chiesto nulla in cambio del denaro e non
sono state poste condizioni di alcun tipo per questa donazione, che non è stata
collegata ad alcun tentativo di corruzione, né di influenzare la mia posizione
sindacale sul Qatar o su altre questioni, né di interferire con l'autonomia e
l'indipendenza mia e dell'Ituc».
Versione da
verificare nel corso dell'indagine, incrociando i trasferimenti di denaro dal
suo conto corrente in Belgio e ai tre in Italia, che ammonterebbero a circa 140
mila euro negli ultimi due anni e su cui si concentra l'ipotesi di riciclaggio.
Che per gli altri indagati verte principalmente su investimenti immobiliari: in
Grecia (Kaili e Giorgi), a Cervinia (Figà Talamanca). La moglie e figlia di
Panzeri, ora ai domiciliari, sono accusate di essere «pienamente consapevoli».
Entrambe, come tutti i presunti sodali della «associazione criminale e
fraudolenta» a parte Giorgi, si proclamano innocenti.
Qatargate. Il
tribunale di Brescia consegna al Belgio Maria Dolores Colleoni moglie di
Panzeri.
Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 19 Dicembre 2022.
Antonio Panzeri
nelle celle di Bruxelles, nega qualsiasi illegalità: con un atteggiamento che
ricorda quello che Primo Greganti mantenne durante "Mani pulite". Una linea che
gli valse il soprannome di "Compagno G".
La moglie dell’ex
eurodeputato Antonio Panzeri, Maria Dolores Colleoni, 68enni, destinataria
insieme alla figlia Silvia di un mandato d’arresto europeo della procura di
Bruxelles, questa mattina in udienza a porte chiuse, davanti ai giudici della
Corte d’Appello di Brescia che doveva decidere sull’arresto, sulla sua richiesta
consegna alle autorità del Belgio, Stato principale al centro del Qatargate,
l’inchiesta che sta facendo tremare il Parlamento europeo ha reso dichiarazioni
spontanee in aula.
L’udienza è durata
circa mezz’ora, poi i giudici sono entrati in camera di consiglio. La decisione
è prevista nel pomeriggio odierno. “Il procuratore generale ha chiesto la
consegna alle autorità belghe – ha riferito il legale di Colleoni,
l’avvocato Angelo De Riso -. Noi abbiamo depositato una memoria in diritto,
sostenendo che non ci sono ragioni perché la nostra assistita venga consegnata.
Il carcere sarebbe una misura afflittiva più grave dei domiciliari, stabiliti
dal giudice italiano, una violazione della Convenzione dei diritti dell’uomo,
perchè la misura sarebbe aggravata senza che l’indagata abbia violato i
domiciliari”. La difesa di Colleoni ha anche spiegato in udienza che se “fossero
necessarie altre attività istruttorie, gli interrogatori possono essere fatti a
distanza”.
La Corte d’Appello
di Brescia ha accolto la richiesta di consegna inoltrata dal Belgio di Maria
Dolores Colleoni, la moglie dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri, al centro
dello scandalo delle tangenti da Marocco e Qatar. La decisione del collegio
presieduto dal giudice Anna Maria Dalla Libera, sostenuta in aula dal
pg Giovanni Benelli, è arrivata alle 19.30 di oggi dopo quasi 5 ore di camera di
consiglio. Gli avvocati Nicola Colli e Angelo De Riso, che assistono anche la
figlia Silvia Panzeri, a questo punto hanno cinque giorni di tempo per giocare
la carta del ricorso in Cassazione. In caso di condanna, la Corte ha stabilito
che sconti la pena in Italia.
Il collegio ha
deciso sulla base di tre elementi. Il primo è la reciprocità del reato. I reati
contestati devono cioè essere contemplati dai codici penali di entrambi i Paesi,
in questo caso Belgio e Italia. L’associazione per delinquere, ad esempio, in
diverse nazioni non esiste. I giudici dovranno poi valutare se esistono cause
ostative alla consegna e infine, più importante, verificare se sussistono i
gravi indizi di colpevolezza. Una verifica, quest’ultima, evidentemente
sommaria, visto che dal Belgio, con l’indagine ancora aperta, è arrivato lo
stretto necessario in quanto ad atti.
Domani si svolgerà
l’udienza per l’ avv . Silvia Panzeri, figlia dell’ex politico considerato dagli
inquirenti belgi “l’anima” del sistema di corruzione che avrebbe condizionato i
lavori del Parlamento per “migliorare”‘” l’immagine del Paese che ha ospitato il
campionato mondiale di calcio. Dal mandato di arresto europeo, si legge che “le
due donne sembrano essere pienamente consapevoli delle attività del
marito/padre” e sembrano “partecipare nel trasporto dei ‘regali’ dati al Marocco
dall’ambasciatore marocchino in Polonia”.
Sempre sulla base
delle risultanze investigative dell’inchiesta Maria Dolores Colleoni avrebbe
anche detto a suo marito “di aprire un conto bancario in Belgio e aveva
apparentemente insistito che non voleva che lui facesse operazioni senza che lei
potesse controllarle (…). Questo indica che Maria Colleoni esercita un qualche
tipo di controllo sulle attività del marito o che perlomeno cerca di mantenere
un qualche controllo”. Nelle perquisizioni eseguite nell’abitazione della
famiglia Panzeri a Calusco d’Adda dalla Guardia di Finanza, su disposizione
della procura di Milano, sono stati rinvenuti ben occultati, 17mila euro ed
alcuni orologi di valore, dei quali le due donne non avrebbero saputo fornire
giustificazione.
Nel frattempo, “Sono
tutte consulenze. È attività di lobbing, non è corruzione. Faccio il mio
lavoro“. Nessuna ammissione, muro contro muro per difendere la sua Fight
Impunity, l’Ong fondata nel 2019. Il pm belga Michel Claise si è trovato di
fronte ad una sfinge, che risponde, ma non rivela con un atteggiamento che
ricorda quello che Primo Greganti mantenne durante “Mani pulite”. Una linea che
gli valse il soprannome di “Compagno G”.
Redazione CdG 1947
Marco Bresolin
per “la Stampa” il 19 dicembre 2022.
La Commissione
europea ha avviato una serie di «verifiche interne» per far luce sullo stipendio
e sul ruolo di Dimitris Avramopoulos nell'associazione Fight Impunity, l'Ong di
Antonio Panzeri finita al centro dell'inchiesta della procura di Bruxelles con
l'accusa di essere una «centrale di riciclaggio» del denaro usato dal Qatar per
corrompere deputati e funzionari Ue. La Commissione è inoltre pronta a convocare
l'ex commissario greco per chiedergli spiegazioni, come conferma il portavoce di
Ursula von der Leyen.
Un nuovo fronte si
apre dunque nel Qatargate, proprio nel giorno in cui Doha minaccia ritorsioni
nei confronti dell'Ue per il provvedimento adottato dal Parlamento: tutti i
portatori d'interesse qatarini saranno banditi dai locali dell'Eurocamera. Il
Qatar considera «discriminatoria» la misura adottata e dice che avrà un impatto
«negativo» sulle relazioni bilaterali: dalla cooperazione per la sicurezza alle
trattative per le forniture di gas.
Come rivelato ieri
da La Stampa, Avramopoulos ha ricevuto un compenso dall'Ong di Panzeri per il
suo ruolo di "membro onorario" del board: secondo quanto risulta da fonti
consultate da questo giornale, avrebbe ricevuto un assegno mensile da cinquemila
euro per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 1° febbraio di quest' anno. In
totale, 60 mila euro per «partecipare a conferenze, pubblicare articoli, dare
interviste e discutere con organizzazioni, governative e non, gli obiettivi di
Fight Impunity».
Un'attività del
tutto legittima per la quale l'esponente del Ppe - che non risulta essere
indagato - era stato autorizzato da Ursula von der Leyen nel febbraio del 2021,
ma che ora fa sorgere dubbi quantomeno di opportunità politica perché potrebbe
trattarsi di soldi "sporchi", incassati da un politico che è in corsa per
diventare inviato speciale dell'Ue per i Paesi del Golfo.
Le fonti di
finanziamento di Fight Impunity non sono note in quanto l'associazione non è mai
stata iscritta nel registro per la trasparenza dell'Ue: nel dicembre del 2020,
Avramopoulos aveva spiegato al comitato etico della Commissione che Panzeri
intendeva farlo al termine del lockdown. Ma la registrazione non è mai avvenuta.
Per contro, il greco aveva comunicato a Bruxelles che il principale finanziatore
dell'Ong era la Sekunjalo Development Fund, una fondazione sudafricana legata
all'omonimo maxi-gruppo d'investimento.
«La Commissione sta
naturalmente seguendo gli sviluppi del caso - spiega Eric Mamer, portavoce
dell'esecutivo Ue -. Stiamo effettuando verifiche interne e contatteremo il
signor Avramopoulos qualora vi fossero indicazioni che non abbia rispettato le
condizioni stabilite nell'autorizzazione concessagli». Mamer sottolinea inoltre
che «la Commissione ha rispettato un accurato processo di due diligence prima di
concedere l'autorizzazione al signor Avramopoulos per la sua attività
professionale con questa organizzazione».
Nel caso di Federica
Mogherini, anche lei membro del board onorario, non è stato necessario il parere
del comitato etico della Commissione perché «è diventata membro
dell'associazione nel 2022, ovvero dopo la fine del periodo di controllo (due
anni dopo la fine del mandato, ndr)». Mogherini ha spiegato di non aver
partecipato attivamente alle iniziative di Fight Impunity né di aver percepito
una remunerazione. Fino alla tarda serata di ieri non è stato possibile
raggiungere l'ex commissario Avramopoulos per un commento.
Gli aspetti
giudiziari del Qatargate sono ora destinati ad avere importanti ripercussioni
economiche e geopolitiche nelle relazioni tra l'Ue e Doha. L'altro giorno il
Parlamento Ue ha votato una risoluzione che chiede di togliere il badge
d'accesso ai suoi locali a tutti i rappresentanti d'interesse del Qatar e ieri è
arrivata una dura reazione.
«La decisione di
imporre una restrizione così discriminatoria che limita il dialogo e la
cooperazione prima che l'iter giudiziario sia concluso - si legge in una nota
diplomatica diffusa da Doha - colpirà negativamente la sicurezza e la
cooperazione regionale e globale». Non solo: il Qatar, che sta diventando uno
dei principali fornitori di gas liquefatto dell'Ue, minaccia anche ripercussioni
sui negoziati in corso per le forniture energetiche. «Non siamo l'unico soggetto
citato nelle indagini, eppure solo il nostro Paese è stato criticato e
attaccato»: un chiaro riferimento al Marocco, contro il quale l'Ue non ha
adottato alcun provvedimento.
Marco Bresolin
per “la Stampa” il 20 dicembre 2022.
Due conferenze - una
online e una in Grecia - e un articolo scritto su un sito web. Sono queste le
uniche tracce del lavoro di «promozione attiva delle attività dell'associazione
Fight Impunity» per il quale Dimitris Avramopoulos ha ricevuto un compenso di 60
mila euro. L'ex commissario europeo ieri ha confermato le notizie pubblicate da
La Stampa e ha ammesso di aver ricevuto 5 mila euro al mese per un anno dall'Ong
di Antonio Panzeri, finita al centro dell'inchiesta della procura di Bruxelles
perché considerata una «centrale del riciclaggio».
Ma accusa di essere
vittima di un «complotto da parte di alcuni ambienti in Italia per distorcere
l'immagine della mia partecipazione completamente legale e formale a Fight
Impunity» al fine di «indebolire la mia candidatura alla carica di
Rappresentante Speciale dell'Ue nel Golfo Persico e rafforzare l'appoggio per
Luigi Di Maio. Ma tutti sanno che il favorito sono io».
L'esponente del Ppe
ha poi sottolineato di aver ottenuto «l'autorizzazione scritta da Ursula von der
Leyen», anche se l'Ong non era iscritta al registro Ue della trasparenza. Un
dettaglio che sta creando un notevole imbarazzo ai piani alti del Palazzo
Berlaymont, tanto che l'esecutivo Ue ha subito annunciato un'indagine interna
per verificare eventuali comportamenti non corretti da parte del politico di
nazionalità greca.
In particolare
l'attenzione si sta concentrando sui suoi incontri con i membri dell'attuale
Commissione. Avramopoulos non risulta direttamente coinvolto nell'inchiesta sul
presunto giro di corruzione e riciclaggio di denaro che sarebbe stato
orchestrato dal Qatar e dal Marocco per influenzare le decisioni del Parlamento
europeo.
Ha lasciato
l'incarico di membro onorario del board dell'Ong il giorno stesso degli arresti.
Ma alcuni elementi relativi alla sua collaborazione con Fight Impunity sono
quantomeno controversi. Innanzitutto la sua attività di promozione dell'Ong. La
presidente della Commissione europea lo aveva autorizzato a ottenere una
remunerazione in virtù del fatto che lui avrebbe dovuto fare «campagne di
sensibilizzazione, come ad esempio pubblicare articoli, partecipare a convegni,
lanciare eventi, rilasciare interviste».
Avramopoulos, però,
ha partecipato soltanto a due eventi pubblici di Fight Impunity. Il primo risale
al 12 luglio del 2021: è intervenuto per pochi minuti durante l'introduzione di
un webinar online organizzato dal Delphi Economic Forum, in occasione del quale
Avramopoulos aveva anche scritto un articolo sulla lotta all'impunità,
pubblicato sul portale NewEurope.
Il secondo risale
invece al 13 aprile del 2022: un convegno in Grecia, sempre del Delphi Economic
Forum, che ha visto l'ex commissario sul palco in compagnia di Panzeri. Anzi,
«il mio grande amico Panzeri», come lo ha presentato il politico greco di
centrodestra, definendo l'esponente di Articolo Uno «una figura di spicco della
politica italiana».
Tra l'altro, nella
nota diffusa ieri Avramopoulos spiega di esser stato pagato da Fight Impunity
soltanto fino a febbraio di quest' anno. «Poiché l'attività dell'organizzazione
era fortemente diminuita - ha dichiarato - ho chiesto la fine del compenso. Dopo
marzo, la mia partecipazione era sostanzialmente finita». La partecipazione al
Delphi Economic Forum, però, risale all'aprile del 2022.
Ieri la questione ha
tenuto banco al quotidiano briefing con la stampa della Commissione europea.
«Stiamo verificando se durante questo suo incarico abbia rispettato le
condizioni restrittive, ossia di non prendere contatti con la Commissione». Dal
profilo Twitter di Avramopoulos risulta che il 3 ottobre scorso ha avuto un
incontro con Vera Jourova, che è la vicepresidente della Commissione con delega
alla Trasparenza e ai Valori.
A luglio era invece
in vacanza in Grecia con Johannes Hahn, commissario Ue al Bilancio. L'impegno di
Avramopoulos era di non fare lobbying con i commissari per conto di Fight
Impunity e potrebbe aver incontrato gli ex colleghi a titolo personale, ma è
chiaro che il confine che delimita una violazione del codice di condotta è molto
sottile. Non risultano invece recenti riunioni pubbliche con esponenti di Doha.
L'ultimo incontro
ufficiale a Bruxelles è stato con il segretario generale del ministero degli
Affari Esteri Ahmed bin Hassan Al Hammad, durante il quale i due hanno discusso
dei «rapporti di cooperazione tra il Qatar e l'Ue, nonché le questioni di
interesse comune». Era il 27 novembre del 2019, tre giorni prima della fine del
suo mandato da commissario.
"Tutto per
favorire Di Maio...". Avramopoulos grida al complotto.
L'esponente
greco, in lizza per il ruolo di rappresentante Ue nel Golfo Persico, grida al
complotto dopo gli accertamenti chiesti da Bruxelles per la sua collaborazione
con l'Ong di Panzeri. Marco Leardi il 20 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Si dichiara
vittima di un "complotto" ordito da presunti ambienti italiani per screditarlo.
Per favorire Luigi Di Maio al posto suo. L'ex commissario Ue
all'immigrazione, Dimitris Avramopoulos butta la palla sugli spalti: mentre
Bruxelles avanza dubbi sulla sua attività di "sensibilizzazione" svolta per la
Ong di Antonio Panzeri, lui grida alla cospirazione. Il politico greco, che in
ogni caso non risulta coinvolto nel Qatargate, sostiene infatti che quei
sospetti sarebbero stati sollevati per ostacolare la sua corsa verso il ruolo di
Rappresentante Speciale dell'Ue nel Golfo Persico, carica per la quale sta
concorrendo anche l'ex ministro grillino.
L'accusa di
Avramopoulos
Intervenendo
nelle scorse ore sulla vicenda, Avramopoulos ha spiegato di sentirsi colpito da
un "complotto" perpetrato da "alcuni ambienti in Italia". L'obiettivo
dell'improbabile operazione - ha spiegato l'esponente del Ppe - sarebbe
"distorcere l'immagine della mia partecipazione completamente legale e formale a
Fight Impunity" al fine di "indebolire la mia candidatura alla carica di
Rappresentante Speciale dell'Ue nel Golfo Persico e rafforzare l'appoggio per
Luigi Di Maio. Ma tutti sanno che il favorito sono io". L'impressione tuttavia è
che il nostro Paese c'entri davvero poco o nulla e che, invece, la faccenda sia
tutta europea.
Lo choc per il
Qatargate ha infatti indotto le istituzioni di Bruxelles ad
avviare controlli più serrati sul mondo che gravitava attorno ai protagonisti
della vicenda. E siccome Avramopoulos riceveva pure un compenso dalla Ong di
Panzeri (tutto regolare e consentito dalla Comissione Ue, spiega lui), gli
accertamenti interni sono destinati a riguardare anche la sua posizione. Più che
altro, a Bruxelles sarebbero interessati a capire e l'ex commissario greco
avesse rispettato o meno le condizioni restrittive (ossia di non prendere
contatti con la Commissione) nell'ambito delle sue "campagne di
sensibilizzazione".
Tali accertamenti
appaiono ancor più motivati dal fatto che il politico ellenico sia considerato
tra i favoriti per il ruolo diplomatico nel Golfo Persico sul quale si attende
solo l'ultima parola di Josep Borrell. In lizza per l'incarico effettivamente
c'è anche Luigi Di Maio, che nei colloqui propedeutici alla nomina si era
classificato primo. Avramopoulos - spiegano fonti Ue - si era invece piazzato
terzo.
Ora, nel rush
finale, la partita si fa stringente. L'ex leader di Impegno Civico potebbe
essere ostacolato dal fatto che il Qatargate abbia coinvolto dei rappresentanti
italiani, quasi tutti provenienti dal gruppo Socialista, ma anche il greco
Avramopoulos rischia ora di dover fare i conti con una posizione piuttosto
scomoda.
Fonti Ue:
"Vicenda politicizzata, nessuna macchinazione"
Dalle istituzioni
europee intanto è trapelato un certo fastidio per le parole di Avramopoulos. "La
vicenda che riguarda la nomina dell'inviato Ue nella regione del Golfo è stata
politicizzata oltremodo: non esiste nessuna macchinazione o piano maligno al
riguardo", ha fatto sapere alla stampa un alto funzionario europeo a conoscenza
del dossier sull'attesa assegnazione della carica. La procedura per la
designazione, ha precisato la medesima fonte, è ancora in corso e non si
prevedono al momento "accelerazioni" al riguardo. L'ex ministro degli Esteri
Luigi di Maio, secondo la fonte, sarebbe ancora in corsa per la carica.
“C’è un
complotto italiano per favorire Di Maio”. L’accusa di Avramopoulos.
Il
Qatargate fa esplodere la polemica tra Italia e Grecia. L’ex commissario evoca
il “complotto” sulla carica di inviato nel Golfo. Matteo Milanesi su
Nicolaporro.it il 20 Dicembre 2022.
Procedono le
indagini sul Qatargate. Nelle ultime ore, i giudici della Corte d’Appello di
Brescia hanno disposto la consegna della moglie di Antonio Panzeri alle autorità
competenti del Belgio, accogliendo la richiesta, contenuta nel mandato d’arresto
europeo, per moglie e figlia dell’ex deputato del Partito Democratico.
E mentre la
procura di Bruxelles annuncia l’ulteriore estensione dell’inchiesta, parlando di
“vasta organizzazione fraudolenta”, ecco che, secondo alcune discrezioni, l’ex
vicepresidente del Parlamento Europeo, Eva Kaili, avrebbe confessato di aver
nascosto le mazzette di denaro e di essere a conoscenza dell’attività portata
avanti dal marito, Francesco Giorgi, con l’ex eurodeputato Antonio Panzeri.
Eppure, l’avvocato dell’ex eurodeputata socialista smentisce e ribalta la
versione: “La signora Kaili è venuta a conoscenza di questo denaro all’ultimo
minuto e ha chiesto che tornasse immediatamente al suo proprietario, il signor
Panzeri”.
Di Maio e la
poltrona nel Golfo
Ma le novità non
finiscono qui: il Qatargate potrebbe alla fine interessare pure Luigi Di Maio.
Non nel senso di una indagine a suo carico o di chissà quale scandalo. Anzi.
Come noto l’ex leader del Movimento 5 Stelle è in corsa per diventare inviato
speciale dell’Ue nel Golfo Persico. A contendersi la poltrona ci sono altri
quattro big dell’Europa, tra cui l’ex commissario Ue all’immigrazione, Dimitris
Avramopoulos. Giggino ha sostenuto tutti i colloqui del caso e un panel apposito
lo ha “suggerito” a Joseph Borrell come primo della lista. La sua candidatura
però aveva perso quota all’insorgere dei malumori nell’attuale governo italiano,
che tutto vorrebbe vedere tranne assegnare una poltrona europea di peso ad un
avversario trombato alle ultime elezioni.
Di fronte alla
diffidenza di Roma, nelle ultime settimane in Ue aveva ripreso quota il nome di
Avramopoulos, che pure sarebbe terzo nella classifica tecnica. Tutto procedeva
per il verso giusto finché non è scoppiato il Qatargate che lambisce lo stesso
ex ministro greco. Come rivelato da Giuseppe De Lorenzo sul Giornale alcuni
giorni fa, dalle parti di Bruxelles potrebbe suonare stonato “premiare” con una
nomina chi deve ancora chiarire i propri rapporti con le Ong invischiate nel
caso Qatargate.
L’accusa di
Avramopoulos
L’ex commissario
risulta godere infatti di un incarico remunerato – circa 60mila euro all’anno –
nella Fight Impunity di Panzeri. Una partecipazione “legittima”, dice lui, di
cui si sente onorato vista la folta compagnia Vip (Federica Mogherini, Emma
Bonino e Bernard Cazeneuve) e che era stata autorizzata per iscritto da Ursula
von der Leyen in persona. Sommerso comunque dalle polemiche, l’ex commissario ha
dunque evocato una sorta di complottone a suo carico: “C’è uno sforzo
organizzato da parte di alcuni circoli in Italia – ha detto Avramopoulos – per
indebolire la candidatura che ho presentato per il ruolo di rappresentante
speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico e, naturalmente, sostenere il
candidato socialista italiano”. Ovvero Di Maio. “Tutti a Bruxelles sanno che
sono in vantaggio per questa posizione. Ritengo che la decisione finale verrà
presa in ritardo”.
L’ultima parola,
comunque, spetterà all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza, Josep Borrell. Matteo Milanesi, 20 dicembre 2022
Ma.Bre. per “la
Stampa” il 21 dicembre 2022.
Dimitris
Avramopoulos ha incontrato almeno nove commissari europei durante il suo periodo
di attività (retribuita) per l'Ong Fight Impunity di Antonio Panzeri e gli
incontri sono avvenuti tutti all'interno del Palazzo Berlaymont.
Si tratta di un
dettaglio non di poco conto, visto che una delle condizioni poste al politico
greco prevedeva il divieto di fare attività di lobbying nei confronti degli
attuali membri del collegio guidato da Ursula von der Leyen. Per questo è subito
scattata un'inchiesta interna: tutti i gabinetti dei commissari hanno ricevuto
ieri mattina una comunicazione «urgente», nella quale si chiedeva di rendere
noti a stretto giro tutti gli incontri avuti con Avramopoulos nel periodo dal 3
febbraio al 1 dicembre 2021 e di indicare i temi discussi. Non solo: i vertici
dell'esecutivo Ue hanno scritto allo stesso Avramopoulos, che ora dovrà fornire
«ulteriori informazioni su come ha rispettato le condizioni relative alla sua
attività».
Avramopoulos ha
incontrato nove commissari, tra cui i due vice-presidenti esecutivi Frans
Timmermans e Margrethe Vestager, oltre ai vicepresidenti Vera Jourova, Maros
Sefcovic e Margaritis Schinas. Tutti gli incontri sono avvenuti prima del 30
novembre 2021, termine entro il quale scadeva il periodo di due anni durante i
quali un ex commissario è tenuto a rispettare determinate condizioni.
Dalle prime
spiegazioni ricevute dai commissari, il portavoce della Commissione ha detto che
si è trattato di «brevi visite di cortesia» e che «in nessuno di questi
incontri, da quanto ci risulta, stava rappresentando l'Ong per la quale aveva
richiesto l'autorizzazione (Fight Impunity, ndr) né che siano state discusse
questioni del genere».
Lunedì il portavoce
della Commissione aveva annunciato l'avvio delle «verifiche interne»,
aggiungendo: «Contatteremo il signor Avramopoulos qualora vi fossero indicazioni
che non abbia rispettato le condizioni stabilite nell'autorizzazione
concessagli». Ieri l'ex commissario è stato contattato e ora dovrà fornire una
serie di chiarimenti sui suoi incontri al Palazzo Berlaymont e «anche su come ha
rappresentato» l'associazione di Panzeri, dalla quale ha ricevuto un compenso di
sessantamila euro.
Avramopoulos, che
non figura nell'inchiesta della magistratura sul Qatargate, ha confermato di
aver ricevuto una remunerazione, ma ha assicurato di non aver avuto ruoli
esecutivi all'interno di "Fight Impunity". Il greco ha invece denunciato un
complotto italiano nei suoi confronti: secondo l'ex commissario, le notizie
sulla sua partecipazione all'Ong di Panzeri (da lui confermate) sarebbero solo
un modo per ostacolare la sua candidatura a inviato Ue per i Paesi del Golfo, in
modo da favorire quella di Luigi Di Maio.
I contatti
di Avramopoulos: quei nove colloqui sotto accusa.
Mauro Indelicato
il 23 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Aperta
un'inchiesta interna sui contatti certificati tra l'ex commissario e almeno nove
commissari dell'attuale esecutivo europeo
Il Qatargate continua ad agitare la politica europea e il Natale in arrivo
potrebbe essere tra i più turbolenti degli ultimi anni a Bruxelles. Nell'occhio
del ciclone già da giorni è finito l'ex commissario europeo Dimitris
Avramopoulos.
Che cos'è il
Qatargate e come si è sviluppato
Nel mirino alcuni
suoi contatti con gli attuali membri della commissione, circostanza vietata dal
regolamento interno dell'esecutivo europeo. Ma qual è il nesso tra Avramopoulos
e il Qatargate? Si tratta soprattutto sul ruolo che il politico greco ha avuto
all'interno dell'Ong Fight Impunity, la stessa guidata da Antonio Panzeri, l'ex
eurodeputato al centro dello scandalo giudiziario.
I contatti di
Avramopoulos con alcuni membri della commissione
I regolamenti
parlano chiaro: quando scade un mandato a un membro della commissione,
quest'ultimo non può intrattenere rapporti di natura politica o lobbistica con
membri della nuova commissione per almeno due anni.
Un ex commissario
quindi non può influenzare il lavoro dei suoi successori e di chi ha preso il
suo posto. Non può soprattutto promuovere una lobby o un interesse particolare.
Avramopoulos è stato commissario dal novembre 2014 al novembre 2019. Ha guidato
in particolare la sezione dell'esecutivo europeo dedicata agli Affari Interni e
all'immigrazione. Quella, per intenderci, oggi retta da Ylva Johannson.
Scelto in quota
Nuova Democrazia, partito di centrodestra greco, dal presidente della
commissione Jean-Claude Juncker, il mandato è scaduto nel novembre 2019. Quindi,
per regolamento, fino al novembre 2021 non poteva rappresentare alcun interesse
specifico e lobbistico in seno alla nuova commissione guidata da Ursula Von Der
Leyen.
Eppure, come
sottolineato su La Stampa, da membro attivo dell'Ong Fight Impunity, ha
incontrato almeno nove commissari. A partire dal connazionale Margaritis
Schinas, attuale vice presidente della commissione. Così come i vice presidenti
esecutivi Frans Timmermans e Margrethe Vestager, oltre che Vera Jourova e Maros
Sefcovic. Tra i vari contatti, anche quelli con Ylva Johannson, Mariya
Gabriel, Stella Kyriakydes e con Johannes Hahn.
Incontri
avvenuti, secondo un'indagine interna alla commissione, prima del novembre 2021.
Prima quindi della scadenza dei termini per il divieto imposto agli ex
commissari di incontrare i successori.
Quali sono stati
i temi affrontati nei vari incontri, al momento non è dato sapere. L'indagine
interna all'esecutivo europeo ha come obiettivo proprio quello di svelare i
contenuti dei vari colloqui. Un portavoce della commissione ha spiegato nelle
scorse ore che, almento per il monento, non sono emersi dettagli compromettenti
dall'inchiesta interna.
I commissari
coinvolti infatti, a proposito degli incontri con Avramopoulos, avrebbero
parlato di “brevi visite di cortesia e – si legge nelle dichiarazioni del
portavoce – in nessuno di questi incontri, da quanto ci risulta, stava
rappresentando l'Ong per la quale aveva richiesto l'autorizzazione né che siano
state discusse questioni del genere”. L'Ong a cui si fa riferimento è per
l'appunto quella di Panzeri.
I timori della
commissione
Avramopoulos non
risulta indagato nell'ambito del Qatargate. Ma il suo ruolo in Fight Impunity
sta imbarazzando e non poco la commissione. Lui stesso ha ammesso di aver
operato per l'Ong fondata da Panzeri, ricevendo per questo un compenso di
sessantamila Euro. Ma, al tempo stesso, ha dichiarato di non aver mai avuto
ruoli dirigenziali.
Tuttavia la Fight
Impunty è sospettata dagli inquirenti belgi di essere stata usata da Panzeri per
i piani corruttivi del Qatar. Doha potrebbe aver versato, è il sospetto su cui
si sta indagando, somme sui conti dell'Ong per attivare il gruppo vicino all'ex
eurodeputato.
"Stava per
entrare...". La rivelazione della segretaria della Ong di Panzeri
Il fatto che
Avramopoulos ha incontrato, durante il suo periodo di collaborazione retribuita
con Fight Impunity, nove commissari europei in un momento peraltro in cui per
regolamento non poteva con loro intrattenere rapporti, potrebbe mettere in
difficoltà la commissione. Specialmente a livello politico e questo a
prescindere dai risvolti penali della vicenda.
Intanto il
diretto interessato ha smentito ogni attività lobbistica a favore dell'Ong di
Panzeri e ha smentito anche l'esistenza di "zone grigie" nel suo operato.
Parlando, al contrario, di un complotto italiano per favorire Luigi Di
Maio quale inviato Ue per il Golfo Persico, carica per la quale sono in lizza
proprio Avramopoulos e l'ex ministro degli Esteri di Roma.
Valter Delle
Donne per secoloditalia.it il 20 Dicembre 2022.
La Cia, il
servizio segreto più famoso del mondo, è anche il più sopravvalutato? Qualche
dubbio viene, se si va leggere il sito ufficiale Cia.gov, una vetrina mondiale
per l’agenzia di controspionaggio Usa. Da anni, infatti, una loro sezione in
particolare viene presentata come il fiore all’occhiello degli 007 americani.
Si chiama World
Factbook: per noi italiani può essere accomunabile alla vecchia “Garzantina”
cartacea. Tutto quello che vorreste sapere su una nazione estera, dalla densità
di popolazione alle statistiche su sanità, economia, criminalità e altro,
aggiornati in ogni dettaglio. C’è tutto, ma proprio tutto.
Finora preso come
oro colato. Finora. Basta andare a controllare gli aggiornamenti e le
informazioni relative all’Italia per capire come siamo (sono) caduti in basso a
Washington. Dopo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il
presidente del Consiglio, Giorgia Meloni la clamorosa gaffe: i due
vicepresidenti del Consiglio sono rimasti quelli del governo Conte. Matteo
Salvini e fin qui nessun errore, e con lui Luigi Di Maio.
Sì, proprio l’ex
grillino, rimasto fuori anche dal parlamento dopo le ultime elezioni, per
l’intelligence più potente e più efficiente del mondo è ancora lui numero 2 del
governo Meloni.
Una gaffe non da
poco: sarebbe come immaginare che i nostri servizi di sicurezza abbiano nei loro
dossier come vice del presidente Joe Biden ancora Mike Pence (ex numero 2 di
Trump) anziché Kamala Harris. Una topica ancora più clamorosa se si considera
che il nostro attuale vicepremier, ignorato dalla Cia, Antonio Tajani è anche
ministro degli Esteri.
Il CIA World
Factbook è una vera e propria Bibbia internazionale della Central Intelligence
Agency (CIA): riporta i dati statistici fondamentali e una sintesi di
informazioni riguardanti tutti i Paesi del mondo. Inizialmente la pubblicazione
era destinata esclusivamente ai dipendenti di organi governativi statunitensi,
venne pubblicato per la prima volta nel 1962 come documento riservato. Dal 1971
ne esiste una versione pubblica. E da quando esiste il web è in Rete. Un fiore
all’occhiello: basti pensare che c’è stato un tempo, almeno fino a una decina di
anni fa, che il cambio di un sottosegretario in un governo italiano appariva sul
sito della Cia pressoché in contemporanea agli aggiornamenti di Palazzo Chigi.
Ma la svista su
Di Maio non è solo un danno d’immagine per il mito dell’efficienza a “stelle e
strisce”, è anche un colpo letale a lettori e cinefili che avevano idealizzato
gli analisti della Cia come nei romanzi di Tom Clancy o nei film con Robert
Redford. Precipitare da “I 3 giorni del Condor” al “Una pallottola spuntata” è
un attimo.
Mantalena Kaili,
la sorella di Eva: «Nessun illecito. Io non ho avuto un euro dalla Ue».
Andrea
Galli su Il Corriere della Sera il 20 Dicembre 2022.
Verifiche sulla sua
Elontech, lei si difende: «Noi facciamo ricerca scientifica». I legami con la
nota commercialista delle municipalizzate milanesi Rossana Bellini
Chiediamo
a Mantalena Kaili cos’abbia da dire su questa sua (presunta) famiglia
criminale: la sorella Eva, ex vicepresidente del Parlamento europeo arrestata
insieme al compagno Francesco Giorgi, il loro papà sorpreso con un borsone pieno
di soldi sporchi, la sua stessa Ong, nel senso di Mantalena, sulla quale,
secondo i giornali greci, i magistrati starebbe indagando...
Ebbene Mantalena,
attiva nei settori delle consulenze e dell’innovazione sociale, risponde che non
ci sono verdetti ma unicamente «impressioni» mediatiche e di conseguenza della
gente, e che nel suo caso specifico manca qualsiasi tipo di base giudiziaria per
muovere accuse. Lei non ha ricevuto nulla, tant’è che domanda per quale motivo
dovrebbe commentare «illeciti che non risultano agli atti». Fonti tra gli
investigatori greci ripetono che l’attuale narrazione sulle avventure
delinquenziali dei Kaili era inconcepibile in quanto davvero persone al di sopra
d’ogni cattivo pensiero fin dagli esordi professionali e politici a Salonicco.
Mantalena conosce
bene Francesco Giorgi per averlo ospitato con Eva nella propria casa di Atene
durante la pandemia (sedici mesi), ma non vuole fare cenno alcuno al 35enne di
Abbiategrasso il cui padre è amico di antichissima data di Antonio Panzeri.
Infatti i due, per
interessi di dichiarazioni dei redditi e di acquisizioni societarie, hanno
condiviso nel tempo i servizi della commercialista Monica Rossana Bellini, una
figura assai nota a Milano in virtù delle plurime apicali cariche che ha
ricoperto e ricopre a cominciare da «Milanosport», municipalizzata che detiene
il monopolio delle piscine, dall’ospedale Gaetano Pini e dalla «Sogemi», che
gestisce i mercati all’ingrosso.
Ma tornando
a Mantalena, si è letto di accertamenti mirati contro appunto la sua Ong, la
Elontech, che però Ong non sarebbe: si tratta al contrario, spiega la donna, di
un «Osservatorio scientifico sulle nuove tecnologie formato da giuristi e
accademici». Ha ricevuto finanziamenti dal Parlamento europeo? «Non ho ricevuto
un solo euro». Ci sono stati in dei collegamenti con Bruxelles? «Abbiamo
partecipato alla quarta conferenza sull’intelligenza artificiale. Ospitata dal
Parlamento europeo, ha avuto il patrocinio della Repubblica greca» nonché «la
collaborazione di Unesco, Consiglio d’Europa e Ocse».
Dopodiché, «su Eva
ci sono indagini, ci sarà un processo» e staremo a vedere, insiste Mantalena,
fondatrice in aggiunta di una piattaforma che supporta iniziative legate ai
rifugiati. Ulteriori sollecitazioni per avere una più corposa difesa della
famiglia, ottengono la richiesta di formularle netti capi d’imputazione
individuali altrimenti non ha senso proseguire; il colloquio s’interrompe di
colpo al terzo tentativo di illustrarle i comportamenti di sorella e
genitore. Che poi la Elontech abbia un’ampia agenda di eventi e una ricca
schiera di collaboratori rimane comunque elemento d’interesse per i magistrati
che puntano ad approfondire anche la figura della commercialista Bellini (non
indagata alla pari di Mantalena) la quale, al Corriere, non ha concesso
dichiarazioni.
Qatargate.
"C'erano persone come Bonino e Mogherini...". La rivelazione
di Visentini sull'Ong di Panzeri.
Il sindacalista
spiega di non aver mai avuto sospetti sulla Fight Impunity. "Era un'Ong
rispettata che agiva con personalità di alto livello..." Marco Leardi il 19
Dicembre 2022 su Il Giornale.
Pronto a fare un
passo indietro, a "rimanere lontano dalla posizione e dai doveri di segretario
generale" pur di fornire tutti i chiarimenti necessari. Luca Visentini,
arrestato e poi scarcerato nell'ambito dell'inchiesta Qatargate, ha ribadito
così la propria estraneità dalla vicenda che ha fatto tremare le istituzioni
europee. In particolare, il sindacalista è tornato a parlare dei suoi rapporti
con la Ong dall'ex eurodeputato Pd Antonio Panzeri, a seguito dei quali gli
investigatori gli avevano domandato chiarimenti. Sul punto, il segretario
generale della Ituc (International Trade Union) ha spiegato come quella
organizzazione non governativa fosse ben accreditata e avesse rapporti con
personalità di alto livello.
Per questo,
Visentini ha sottolineato di non aver mai sospettato "comportamenti illegali o
non etici" da parte della Fight Impunity. "Era una Ong rispettata che agiva in
difesa dei diritti umani con diverse personalità di alto livello nel suo
consiglio di amministrazione come Denis Mukwege (Nobel per la Pace), Bernard
Cazeneuve (ex primo ministro francese), Emma Bonino (senatrice
italiana), Federica Mogherini (rettore del collegio d'Europa, ex Alto
Rappresentante della Ue)", ha argomentato il sindacalista, menzionando in
effetti nomi blasonati del panorama sociale e politico, dai quali si evince
quanto l'organizzazione operasse ad alti livelli.
Al riguardo, vale la
pena ricordare come Emma Bonino fosse stata colta da una emblematica
smemoratezza quando, alla luce del caso deflagrato a Bruxelles, era stata
interpellata dalla stampa sul nome di Panzeri. "Non mi ricordo di lui, può
essere che l'abbia incontrato qualche volta quando ero al Parlamento europeo",
aveva spiegato l'ex leader radicale al Corriere. Ma, secondo quanto riferito da
Visentini, i contatti tra l'esponente politica e l'ex eurodeputato dem sarebbero
stati poco compatibili con quella sorta di amnesia.
Quanto alla propria
posizione, Visentini (non indagato, lo ricordiamo) ha dichiarato: "I soldi dalla
Fight Impunity? Li ho accettati in contanti per la qualità del donatore e per il
suo carattere non profit". La donazione ricevuta dalla Ong - ha sostenuto il
sindacalista in una nota - "non è stata collegata ad alcun tentativo di
corruzione, né di influenzare la mia posizione sindacale sul Qatar". E ancora,
il segretario generale Ituc ha proseguito: "Non mi è stato chiesto né ho chiesto
nulla in cambio del denaro e non sono state poste condizioni di alcun tipo per
questa donazione", che ammontava a una "somma inferiore ai 50mila euro".
Gli inquirenti belgi
intanto cercano di fare chiarezza sulla natura delle altre elargizioni sospette
che Panzeri avrebbe concesso a chi - secondo le accuse - poteva essergli utile.
Al vaglio dei magistrati, anche il contenuto di alcune intercettazioni.
Christophe Berti
per “la Repubblica” il 19 dicembre 2022.
L'autore è direttore
di Le Soir
[...] Per Le Soir,
il lavoro inizia a settembre. Due giornalisti investigativi della nostra
redazione, Joel Matriche e Louis Colart, ricevono una "soffiata" secondo cui
un'indagine senza precedenti intorno al Parlamento europeo avrebbe potuto
coinvolgere potenze straniere decise a influenzare le decisioni europee. Bomba
atomica. Ma bisogna controllare, incrociare le fonti, trasformare le voci in
informazioni.
[...] In questa
questione esplosiva e delicata c'è un altro fattore, decisivo, che costringe la
polizia belga a camminare su dei gusci d'uovo: l'immunità parlamentare europea.
Fondamentalmente, se la polizia vuole intercettare un parlamentare o perquisire
il suo ufficio, deve chiedere il permesso.
Spetta quindi agli
inquirenti lavorare sui personaggi non protetti da questa immunità : Antonio
Panzeri, Francesco Giorgi, Luca Visentini, Niccolò Figà-Talamanca. La polizia
vuole agire durante la Coppa del Mondo e teme che tutto questo piccolo mondo
parta per le vacanze di Natale e non torni. Quindi è venerdì 9 che tutto
esplode.
Dobbiamo aspettare
che Giorgi lasci la sua casa. È stato arrestato per strada e la macchina
giudiziaria è stata messa in moto: 20 perquisizioni, arresti e
l'ufficializzazione dell'indagine. Con un colpo di scena degno di un film: nel
loro piano iniziale gli investigatori non immaginavano di raggiungere
immediatamente Eva Kaili, vice presidente del Parlamento.
Ma l'arresto a
sorpresa di suo padre, che lascia un hotel con una valigia piena di soldi,
consente di saltare la serratura dell'immunità con l'unico elemento possibile:
flagranza di reato. Gli agenti di polizia che hanno effettuato le perquisizioni
mattutine si sono precipitati nel quartiere europeo per entrare nella casa di
Kaili. E scoprono altre centinaia di migliaia di euro.
Un risultato
incredibile per la polizia belga, che non si aspettava un tale successo.
Per il giudice
Michel Claise specializzato nella lotta alla corruzione - è a capo
dell'inchiesta sulla corruzione che scuote il calcio belga - questa è una grande
vittoria. Spesso dice, giustamente, che deve attaccare «fortezze con catapulte
», riferendosi alla palese mancanza di mezzi finanziari della giustizia belga.
Ha lanciato la catapulta nel posto giusto.
Questo è l'inizio di
una serie di rivelazioni, da parte di Le Soir, sui dettagli dell'indagine: come
i servizi segreti hanno lanciato le ostilità prendendo di mira Panzeri, come
Marc Tarabella è stato perquisito un sabato sera in extremis (in Belgio non si
può perquisire una casa dopo le 21) riportando da Malta la presidente Roberta
Metsola, come Giorgi ha parlato con gli investigatori, come sono coinvolti anche
il Marocco e i suoi servizi segreti. Una settimana pazzesca per la nostra
redazione, inondata da decine di richieste di interviste, provenienti da tutta
Europa e soprattutto dall'Italia.
[...] Questa
indagine è un'ulteriore prova che il Belgio è un obiettivo. E Bruxelles in
particolare. La città ha "solo" un milione di abitanti, ma ospita la sede della
Commissione, del Parlamento europeo e della Nato.
E così, centinaia di
istituzioni, varie organizzazioni, lobbisti di ogni tipo, ecc. Il tutto formando
un sistema opaco in cui denaro e politica si fondono in un cocktail che può
essere pericoloso. Infine, e questo è fondamentale per noi, l'inchiesta mostra
quanto i controlli e gli equilibri della giustizia e della stampa siano
indispensabili. Il giornalista serve solo l'accuratezza delle informazioni.
E il giudice,
rispetto della legge. Punto. Se giudici e giornalisti sono in prima linea in
questo caso, è perché altre leve hanno fallito: la debolezza degli uomini di
fronte al denaro, la mancanza o l'inadeguatezza degli organi di controllo
europei. E a coloro che dicono che le nostre rivelazioni, alla fine,
aumenteranno il populismo in Europa, possiamo rispondere che il nostro ruolo è
quello di rivelare le informazioni. Niente di più, niente di più. Un adagio
della stampa americana si adatta perfettamente alla conclusione: «Se non vuoi
che sia scritto, non farlo».
Perché degli
scandali della destra in Italia non parla più nessuno?
PIERO IGNAZI,
politologo, su Il Domani il 20 dicembre 2022 • 18:22
Nei giorni in cui
scoppiava il cosiddetto Qatargate è stato associato alle carceri italiane l’ex
senatore e sottosegretario di Forza Italia Antonio D’Alì con la sentenza di
concorso esterno all’associazione mafiosa.
Gli appelli a
riscoprire la questione morale invocati a gran voce dalla sinistra anti-Pd hanno
un suono un po’ farlocco.
Il Pd non ricorre
né a difese d’ufficio, né al silenzio, né al garantismo alle vongole sbandierato
dalla destra.
Scandali? Solo
a destra. Anche se poi non ci sono.
Negli ultimi anni
la sinistra ci ha abituato a una lettura della realtà adottando il criterio dei
due pesi e due misure. Francesco Giubilei il 21 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Negli ultimi anni
la sinistra ci ha abituato a una lettura della realtà adottando il criterio dei
due pesi e due misure. Implacabili fustigatori e giustizialisti della peggior
specie quando si tratta di attaccare personalità, politici, giornalisti,
intellettuali di centrodestra, gli esponenti della sinistra nostrana si scoprono
all'improvviso garantisti nel momento in cui a sbagliare è uno di loro fedeli al
motto «sono compagni che sbagliano».
Con il caso
Qatargate si sono però superati e, cercando di difendere l'indifendibile, da
giorni assistiamo a perifrasi, giochi di parole, bizzarre giustificazioni,
maldestri tentativi di addossare la colpa alla destra. Quando in passato a
essere corrotti sono stati esponenti del centrodestra (perché la corruzione non
ha colore politico), sul banco degli imputati è finita un'intera area politica e
non i singoli, se avviene la stessa cosa a sinistra a causa dei comportamenti di
un già europarlamentare del Partito Democratico, il Pd diventa parte lesa.
L'apice di questo
modus operandi è stato raggiunto con il tentativo di mettere sullo stesso piano
due vicende che nulla hanno in comune: lo scandalo corruzione all'Europarlamento
e l'inchiesta giornalistica realizzata nei confronti dell'eurodeputato Carlo
Fidanza su una presunta «lobby nera».
Ci ha provato
Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo (lo stesso per cui
Eva Kaili era in prossimità di passare al centrodestra) che, intervenendo in
televisione, ha affermato: «C'è Fidanza, braccio destro della Meloni per tanti
anni, che è a piede libero indagato per corruzione e finanziamento illecito ed è
qua al Parlamento europeo». Sulla stessa falsariga il parlamentare Arturo
Scotto, coordinatore di Articolo Uno (il partito di Roberto Speranza) per cui
«un tale Fidanza accusato di corruzione oltre che essere uno che non lesinava
saluti romani».
Paragonare lo
scandalo di tangenti e corruzione all'europarlamento con l'inchiesta giornalista
realizzata da Fanpage, è fuori luogo per una serie di motivi. Da un lato c'è un
affare di corruzione internazionale con un'indagine dei servizi segreti e di
polizia che va avanti da tempo, dall'altro di un'inchiesta mediatica con un
giornalista infiltrato che cerca di spingere Fidanza a compiere reati.
Nel caso del
Qatargate sono stati trovati a casa del vicepresidente del parlamento europeo
sacchi pieni di soldi mentre nei confronti di Fidanza non ci sono prove di
corruzione al punto che la Procura di Milano sta per chiedere l'archiviazione
dell'inchiesta aperta nei mesi scorsi. Cade così anche l'ultimo tentativo di
trovare alibi o sviare l'attenzione dallo scandalo dell'Europarlamento cercando
di tirare in ballo vicende imparagonabili invece di assumersi le proprie
responsabilità politiche.
Estratto
dell’articolo di Concetto Vecchio per “la Repubblica” il 20 dicembre 2022.
[…] È giusto che un
ex uomo di Stato come Massimo D'Alema faccia il lobbista?
«No, affatto. Offre
un esempio negativo. Un uomo di Stato rimane tale sempre».
D'Alema non fa più
politica.
«Un rappresentante
dell'élite politica di un Paese democratico è come il sacerdote di una comunità.
Dura tutta la vita. Questa dignità si mantiene. Il prete è tale anche da
spretato. Tutto ciò autorizza il sospetto che il suo comportamento precedente
sia stato insincero di fronte al mandato fiduciario degli elettori». […]
Estratto
dell’articolo di Carmelo Lopapa per “la Repubblica” il 20 dicembre 2022.
[…] Nulla a che
vedere con le inchieste, ma in questi giorni si è tornato a discutere del ruolo
degli ex premier D'Alema e Renzi, che hanno intrattenuto a vario titolo rapporti
non propriamente politici con i Paesi e gli emirati del Golfo. Voi più volte
avete attaccato Renzi, perché distinguerlo da D'Alema?
«È inaccettabile che
un senatore della Repubblica, pagato dai cittadini, vada in giro per il mondo a
fare il testimonial di regimi autocratici dietro pagamento di lauti compensi".
Non è una frase mia ma di Calenda, pronunciata prima di allearsi con Renzi. Per
una volta la penso come lui, ma non dobbiamo personalizzare: nessun parlamentare
italiano deve ricevere contributi, a qualsiasi titolo, da un altro Stato. Quanto
a D'Alema, ha dismesso da tempo incarichi pubblici. La differenza non è di poco
conto».
A proposito di
questione morale, Renzi sollecita una commissione di inchiesta sul Covid per
l'operato del suo governo.
«Siamo favorevoli,
nessun problema. L'importante è che si voglia approfondire in maniera puntuale e
seria, che ci si voglia interrogare sullo stato della nostra sanità e su come è
stata gestita la pandemia anche a livello regionale, evitando che venga
utilizzata per scopi polemici e strumentali».
Estratto
dell’articolo di Stefano Cappellini per “la Repubblica” il 19 dicembre 2022.
Goffredo Bettini,
molti elettori di sinistra sono sotto shock. Esponenti progressisti con sacchi
di banconote in casa.
"Sono molto
amareggiato. La sinistra è permeabile all'incursione dell'affarismo perché se si
affievolisce una critica rispetto ai valori dominanti, al mito della ricchezza,
del lusso, del successo a tutti i costi, e ci si stacca da chi fatica a vivere,
le difese si possono allentare".
Il timore di molti è
che sia solo l'inizio: è difficile pensare che Panzeri sia un caso isolato.
"Le responsabilità
penali sono sempre individuali e vanno giudicate nella loro specificità, non
gettate in un calderone che travolge tutto. Alcuni indagati sono stati colti in
flagrante, con un mucchio di contanti in casa. Altri, come Cozzolino, allo stato
attuale non sono neppure indagati, eppure sono finiti nei titoli dei giornali
come malfattori. Aspettiamo il lavoro degli inquirenti".
Il Pd può dirsi
estraneo?
"Il Pd è ancora sano
nel suo complesso, ma deve rimuovere ogni apologia dell'esistente, che premia il
denaro che dà la forza e la forza che disprezza e schiaccia la debolezza".
Giusto parlare di
questione morale? O rischia di essere fuorviante? Forse si ruba e si fanno
affari opachi anche perché non c'è più alcuna bussola politica.
"C'è un intreccio
tra questione morale e questione democratica, come pensava Berlinguer. Se la
rappresentanza si fa incerta, il Parlamento decide e controlla sempre di meno, i
poteri sono sbilanciati, le lobby economiche debordano, le decisioni si assumono
in cerchie ristrette, opache, nascoste, i partiti sono delegittimati e ridotti a
scheletri di potere, è del tutto chiaro che hanno buon gioco gli interessi
economici. Finisce il comando della politica e inizia la "festa" del puro
profitto".
[…] Politica, affari
e lobbismo. Due ex leader dem ed ex presidenti del Consiglio, Renzi e D'Alema,
sono oggi anche consulenti e uomini d'affari. Tutto legale, eppure discutibile.
"Sono casi diversi,
anche se entrambi permessi dalla legge. D'Alema si è da tempo dimesso da ogni
incarico pubblico e svolge ruoli di consulenza con contratti regolari che
finanziano anche le sue attività editoriali e di studio. Renzi è un capo di
partito e senatore".
[…] A proposito di
alleanze, che senso ha alle regionali l'intesa Pd-5S in Lombardia, dove peraltro
rischia di servire a poco, e non nel Lazio dove c'era già un accordo di governo?
"Nel Lazio rompere
l'alleanza che governava è stato un atto di irresponsabilità. Si trattava
semplicemente di continuare l'esperienza virtuosa di Zingaretti".
L'alleanza l'ha
rotta Conte, di cui lei è un noto estimatore. Molti lo considerano l'esempio del
più vieto trasformismo. E a sinistra l'avete sdoganato voi.
"Conte è stato
contestato, disprezzato e insultato. Ha le sue debolezze, ma ha governato bene
l'Italia per un anno e mezzo insieme al Pd. Ha commesso un errore nel far cadere
Draghi, noi abbiamo fatto l'errore di rompere subito dopo ogni possibilità di
dialogo. Ora il M5S fa una corsa solitaria. Può guadagnare qualche voto, ma
indebolisce ogni possibile alternativa alla destra".
Vede il rischio che
il Pd, per riconquistare gli elettori passati a votare per forze populiste di
destra o di sinistra, insegua quel modello?
"Toccare e
attraversare il popolo sono il contrario del populismo. Sono le condizioni per
una politica umana, non sopraelevata rispetto alle persone. I leader populisti,
al contrario, si sostituiscono al popolo. Pretendono di esserne la sola voce e
lo privano di sovranità".
Che cosa le piace e
cosa no dei due candidati principali al congresso Pd, cioè Elly Schlein e
Stefano Bonaccini?
"Elly Schlein
l'avverto più vicina nella lettura critica del modello di sviluppo. Bonaccini è
un ottimo amministratore e rivendica una radice storico-popolare che certamente
non mi è estranea".
Può essere Gianni
Cuperlo il candidato della sinistra dem?
"Cuperlo è un
dirigente e un intellettuale di prim'ordine. La sinistra del Pd, che da anni
svolge una battaglia concreta e coraggiosa, poteva esprimere una propria
candidatura. Temo sia troppo tardi".
C'è chi dice che nel
Pd il problema, prima che ancora che di linea politica, è la credibilità di
tutto il gruppo dirigente storico. Quindi anche la sua.
"Il problema del Pd
è politico. Sul gruppo dirigente non si può fare di tutta un'erba un fascio.
Sarebbe pura demagogia "rottamatrice". Ciascuno ha la sua storia e le sue
responsabilità. Per quanto riguarda me, ho influenzato alcune fasi della
sinistra, come la nascita del Conte II, in altre sono rimasto appartato. Non
cerco nulla se non continuare con passione a trasmettere qualcosa alle nuove
generazioni".
[…] Nel suo libro
lei deplora appunto il fatto che la sinistra abbia lasciato sotto le macerie del
muro di Berlino anche parte della sua identità e dei suoi valori. Ha nostalgia
del comunismo?
"Al contrario. La
consapevolezza degli errori ed orrori del socialismo realizzato poteva essere
l'occasione di rilanciare i valori di liberazione umana, di giustizia, di ascesa
dei diseredati. Questo non è accaduto. Hanno vinto le ideologie neoliberiste e a
noi è rimasta solo la possibilità di andare talvolta al governo.
Abbiamo salvato
l'Italia, la democrazia e l'economia, ma abbiamo perso di vista i processi
"terragni" e la vita concreta delle persone. Superare questa condizione non è
nostalgia del comunismo, ma il ritorno ad un necessario conflitto riformatore e
democratico. Per quanto riguarda la nostalgia, la considero un sentimento
potente che spinge ad agire. Non riguarda quasi mai ciò che hai vissuto, ma ciò
che avresti voluto vivere e non ti è stato concesso. È il rovello che induce a
tentare, e ancora tentare, una vita migliore"
Qatargate. E l'ex
Pci manda in soffitta la questione morale.
Pure D'Alema
archivia, in nome degli affari, la lezione di Berlinguer. Roberto Chiarini il 19
Dicembre 2022 su Il Giornale.
Vi immaginate
Antonio Gramsci o Palmiro Togliatti che lasciano la politica per consacrarsi
alla consulenza di società (capitalistiche) internazionali? Quella del
consulente è invece l'attività che Massimo D'Alema, comunista non pentito, si
vanta di aver intrapreso. Al giornalista che gli chiede se non convenga con lui
sulla dubbia compatibilità tra la sua originaria passione politica e l'odierna
attività di consulente di governi stranieri e di multinazionali risponde che non
va confusa l'attività di «consulente» con quella dell'«affarista». È
improponibile ogni accostamento tra le sue collaborazioni con società
internazionali con i traffici dell'ex compagno di partito Antonio Panzieri,
nella cui abitazione di Bruxelles sono stati trovati sacchi sospetti di
banconote.
È inoppugnabile - ci
mancherebbe - la distinzione tra le due attività sul piano della legalità e pure
su quello della moralità. La distinzione regge meno però (ma forse ci sbagliamo)
sul piano dell'opportunità. Non è comunque su questo punto che ci sembra
essenziale puntare l'attenzione, ma piuttosto su quanto questa mutazione di
destini professionali sia rivelatrice di un'altra mutazione in atto nella
sinistra italiana e europea. Vorrà pur dire qualcosa il fatto che il mestiere di
manager e di procacciatore d'affari stia diventando la vocazione principe di
molte figure di ex leader della sinistra - da Tony Blair a Gerhard Schroeder
fino a Massimo D'Alema: tutti ex primi ministri che a fine carriera abbracciano
l'attività di business man, pronti a concedere la loro consulenza anche a uomini
di stato che non vantano una coscienza democratica propriamente immacolata.
Contrapponendo
l'affarismo alla consulenza, come fa il già lider maximo della sinistra
italiana, ha voluto far intendere che è l'onestà ciò che fa la differenza. Con
ciò, salva inequivocabilmente la sua personale onorabilità. Non coglie però il
punto politico chiave della questione che sta alla base dell'impasse in cui s'è
incagliata la sinistra ex comunista dopo l'abbandono dell'originaria fede
anticapitalista. Politici e intellettuali di sinistra cercano di ridurre lo
scandalo delle mazzette all'europarlamento solo a un fatto (indubitabile) di
disonestà personale indicando la soluzione al richiamo della lezione di Enrico
Berlinguer sulla «questione morale» quando l'allora segretario del Pci
denunciava la degenerazione dei partiti ridotti a «macchine di potere» che
«hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni».
La sua era certo una
meritoria denuncia del malcostume politico ormai imperante. Era però anche un
atto d'accusa rivolto all'intero sistema dei partiti su cui si era retta la vita
pubblica nazionale dalla caduta del fascismo in poi contro cui veniva
contrapposto il popolo tradito.
Non s'è mai prestata
adeguata attenzione al fatto che con l'elevazione da parte del Pci della
«questione morale» a stella polare della sua futura azione politica il Pci
consumava il cambio di due suoi storici paradigmi culturali.
Il primo. Berlinguer
superava l'idea del primato della politica che lo aveva permeato il partito per
tutto il lungo dopoguerra conferendo al confronto politico un carattere
«gladiatorio sui valori» e alla politica una connotazione «alta». Accantonava
l'idea che sia la politica a determinare i grandi movimenti della storia, che
«la persona venga giudicata in base all'ideologia cui ispira le sue azioni, non
per la moralità o immoralità di quelle».
Il secondo paradigma
con cui il Pci rompeva era con la precedente valorizzazione del partito a
architrave di sostegno della democrazia. Ora individuava la lotta alla
partitocrazia quale essenza del suo conclamato nuovismo. Portava acqua con ciò
al mulino della tesi, allora popolare, di una società civile sana contrapposta a
una società politica malata, e con ciò disarmandosi nei confronti dell'ordine di
idee e di comportamenti propri della società capitalistica di cui «la
consulenza» finisce per essere la fisiologia e «l'affarismo» la patologia.
Per queste ragioni,
la perdita degli anticorpi dall'infezione affaristica che oggi la sinistra
lamenta non può limitarsi ad attribuirla al venir meno della tensione morale che
contraddistingue ormai la vita di tutti i partiti. Una responsabilità a monte va
ricercata nell'aver sostituito di fatto la questione morale alla questione
sociale come orizzonte strategico della sinistra.
Qatargate: perché
il Pd si processa da solo?
I dem sono i primi a
condannarsi per l’inchiesta che ha travolto l’europarlamento. Anche se al
momento non c’è un solo iscritto al partito che risulti indagato...Valentina
Stella su Il Dubbio il 19 dicembre,
Qatargate, la
domanda è: perché il Partito democratico si sta processando da solo e
addirittura autocondannando politicamente se al momento non ci sono indagati tra
le sue fila?
L’INCHIESTA
GIUDIZIARIA
Per provare a
rispondere alla domanda innanzitutto ricapitoliamo brevemente il punto
sull’inchiesta della magistratura belga: il blitz della polizia viene effettuato
il 9 dicembre. Vengono arrestati con l’accusa di corruzione, riciclaggio,
associazione a delinquere quattro persone: Antonio Panzeri, 67 anni, ex
segretario generale della Camera del Lavoro di Milano, eurodeputato dal 2004 al
2019 con il gruppo Socialisti e Democratici (all’inizio Ds, poi Pd, infine
Articolo 1), attualmente detenuto come il suo ex assistente Francesco Giorgi,
collaboratore dell’europarlamentare Pd Andrea Cozzolino. Quest’ultimo non
risulta indagato né ha subito perquisizioni ma si è autosospeso dal gruppo
Socialisti&Democratici e in Italia è stato sospeso in via cautelare dal Pd.
In manette anche Eva
Kaili, compagna di Giorgi, vicepresidente (sospesa) dell’Europarlamento ed
esponente socialista, ancora rinchiusa in carcere. Sulla sua posizione si
deciderà il 22 dicembre, in quanto non è stata possibile portarla prima dinanzi
ai magistrati a causa di uno sciopero all’interno della prigione dove è
detenuta. Per Niccolò Figà-Talamanca, segretario generale di No Peace Without
Justice, è stato invece disposto il regime di sorveglianza con braccialetto
elettronico. L'ufficio del procuratore federale ha presentato ricorso contro
questa decisione della Chambre du Conseil di Bruxelles. Intanto la Ong è stata
al momento sospesa in via precauzionale dal Transparency Register del Parlamento
Ue, dove era accreditata da dieci anni.
Fermato dalla
polizia belga anche Luca Visentini, segretario della Confederazione
internazionale dei sindacati. L’uomo è poi stato rilasciato. Ha raccontato al
magistrato Michel Claise che nelle tre buste che gli consegnò Panzeri lo scorso
10 ottobre c’erano circa 50 mila euro poi trasferiti al «Fondo di Solidarietà
della Ituc, per sostenere i costi di viaggio al Congresso per i sindacati che
hanno mezzi finanziari limitati o inesistenti, in conformità con le pratiche
della Ituc». Per questo denaro, ha detto Visentini, «non mi è stato chiesto, né
ho chiesto nulla in cambio del denaro e non sono state poste condizioni di alcun
tipo per questa donazione».
L’ESTRADIZIONE
La Corte d'Appello
di Brescia ha dato il via libera alla consegna alle autorità belghe di Maria
Dolores Colleoni, 67 anni, moglie di Panzeri, accusata di concorso in
associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio, accogliendo così la
richiesta del mandato d'arresto europeo firmato da Michel Claise, titolare
dell'inchiesta. L'avvocato Angelo De Riso, difensore della donna insieme al
collega Nicola Colli, aveva presentato «una memoria in diritto», sostenendo che
con la consegna al Belgio la 67enne andrebbe in carcere, aggravando così la
misura che la vede attualmente ai domiciliari, e questo «violerebbe la
Convenzione europea dei diritti dell'Uomo». Avranno cinque giorni per il ricorso
in Cassazione.
LA QUESTIONE
POLITICA
Detto tutto questo,
in una discussione generale dove impropriamente si stanno mischiando il piano
giuridico, quello politico, quello morale, quello mediatico e quello regolatorio
sulle lobbying, stiamo assistendo ad una sorta di harakiri da parte del Partito
democratico. Come abbiamo visto, nelle sue fila non ci sono indagati. Il
problema, dal punto di vista dei dem, sarebbe però che Panzeri lo hanno fatto
eleggere anche loro. Eppure il fondatore di Fight Impunity avrebbe commesso i
reati che gli vengono contestati non da eurodeputato del Pd ma da lobbista
rimasto a Bruxelles dopo l’esperienza politica. Ma il quadro oggettivo della
situazione non basta al Pd.
Goffredo Bettini su
Repubblica ieri ha detto che «la sinistra è permeabile all'incursione
dell'affarismo». Gli ha fatto eco Andrea Orlando su La Stampa sulla reazione dei
suoi allo scandalo: «C'è stato un primo momento di spaesamento, poi le risposte
sono arrivate, adesso ne devono arrivare altre».
Ma già qualche
giorno fa proprio da queste pagine il tesoriere Walter Verini aveva spiegato:
«Berlinguer diceva che i partiti devono essere sobri e non occupare spazi
impropri, non lottizzare. Nelle nomine vanno privilegiati i criteri di
competenza e capacità. Questo è il salto culturale che aiuta un partito a
sviluppare anticorpi. Se poi l’occupazione del potere diventa un fine, allora si
allentano i legami con l’etica politica che sono fondamentali. La questione
morale è un tema politico di grande attualità che deve trovare il Pd preparato e
inflessibile».
È paradossale che a
menar contro il Pd non siano tanto gli avversari politici quanto il Pd stesso.
Nessuno nega che via del Nazareno stia attraversando una profonda crisi di
identità, sancita dalle elezioni del 25 settembre, ma non si riesce a capire
perché prendersi la responsabilità politica per una questione giudiziaria
riguardante l’arresto di un ex esponente, innocente poi fino a prova contraria.
Panzeri sarebbe solo la punta di un iceberg caratterizzato da tempo dall’omesso
controllo sui candidati, dall’aver abbassato l’asticella della presunta
superiorità morale, nell’aver trasformato il potere da mezzo a fine, nell’aver
dimenticato la lezione di Berlinguer.
C’è chi all’interno
del Pd ci ricorda addirittura la massima di Gaber (anche se a dirla sarebbe
stato Gian Piero Alloisio): «Non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me».
Altri sarebbero persino pronti a farsi carico della questione del non indagato e
deputato Aboubakar Soumahoro: eletto sì con Fratoianni, ma il suo partito Avs si
è presentato alle elezioni con l’alleanza di centro-sinistra. «Possibile che a
nessuno è venuto in mente di controllare?», ci dice una fonte del Pd.
In questo strano
corto-circuito c’è poi un’altra fonte di Articolo 1 che invece teme che il Pd
voglia addossare tutta la colpa a loro, come pretesto per depotenziare
ulteriormente un loro ritorno all’ovile. A questo punto il timore pare
assolutamente infondato.
Enrico
Morando: «Sotto attacco noi liberali Pd, estranei a tutto: sconcertante».
Parla
l'esponente dem, presidente di "Libertà eguale": «Nelle analisi secondo cui il
Qatargate svelerebbe la crisi identitaria del nostro partito, si punta contro la
cosiddetta terza via, la prospettiva indicata dalla componente liberalsocialista
a cui appartengo, anche se le poche figure coinvolte provengono dal fronte
opposto: com'è possibile?» Errico Novi su Il Dubbio il 21 dicembre,
«Sono sconcertato
da un capovolgimento di senso». Spieghi pure, onorevole Morando. «Mi sconcerta
il paradosso per cui, nelle analisi di questi giorni sul Qatargate, a finire
sotto attacco è la cosiddetta terza via del Pd, la cultura liberalsocialista a
cui personalmente appartengo. È davvero spiazzante, considerato che i singoli
coinvolti nell’indagine sono al limite riconducibili a quella rispettabilissima
area socialdemocratica, a quella sinistra del Pd che la terza via ha sempre
osteggiato. Non intendo affatto dire che va messa sotto processo un’altra
famiglia, interna al nostro partito, nel quale, oggettivamente, non c’è un solo
esponente che risulti indagato. Voglio semplicemente notare però che è
incredibile fare il contrario e ribaltare completamente il quadro a danno della
componente liberale».
Enrico Morando ha
una capacità, incrocia nelle sue osservazioni tre elementi: il congresso dem, il
garantismo in affanno nel partito e le distorsioni interpretative degli ultimi
giorni. Già parlamentare dell’ala liberal interna al Pd appunto, Morando è il
presidente di Libertà eguale ed è tra i sottoscrittori di un documento elaborato
in vista del congresso insieme a figure, tra le altre, come Giorgio Gori, Marco
Bentivogli, Tommaso Nannicini e Umberto Ranieri, intitolato “Un nuovo inizio”.
Mentre qui pare
che si sia giunti addirittura a un capolinea, a una Caporetto del Pd. Non
sarebbe più semplice dire, rivendicare che non c’è un solo indagato con la
tessera del Pd, nell’indagine sul Qatargate? Un atto di ribellione garantista
che rovesci le analisi più critiche, come quella firmata ieri da Ezio Mauro su
Repubblica?
Direi che la
rivendicazione garantista di cui lei parla è un po’ sopravanzata dalla
dimensione che la vicenda assume non certo per il Partito democratico italiano
ma per l’intero Europarlamento. Premessa: il ritrovamento di borsate di soldi
nella disponibilità di componenti dell’Assemblea di Strasburgo o di loro
collaboratori costringe a valutare la gravità del rischio a cui siamo esposti.
Solo che non condiviso la prospettiva desolante e un po’ catastrofista,
forse, che si dà a proposito appunto del Parlamento Ue. A me sembra chiaro che
qui i presunti corruttori, gli autocrati stranieri cercano, Qatar in testa, di
comprare un pronunciamento favorevole. E noi stessi ora ci siamo resi conto di
quanto siamo influenti e credibili. Non solo e non tanto per le attività
regolative svolte dall’Europarlamento, ma per i giudizi di valore che può
esprimere, appunto, in relazione a Stati autocratici estranei all’Unione. Vuol
dire che Strasburgo è diventata più autorevole, e i suoi giudizi più temuti, di
quanto abbiamo pensato finora. Mi pare che una chiave del genere sia rimasta
piuttosto esclusa dai commenti di questi giorni. Dopodiché, se questo sorprende,
la sostituzione di cui parlavo all’inizio, vale dire la cosiddetta terza via,
l’idea liberale del Pd, messa nel mirino nonostante i presunti protagonisti dei
casi su cui indagano i giudici belgi provengano da una componente esattamente
opposta, è, come detto, incomprensibile. Sconcertante.
Il nodo è
l’identità: può esserci nel centrosinistra un partito dall’identità così
plurale, vista la concorrenza di Terzo polo al centro e 5S a sinistra?
Rovescio la
domanda: abbiamo perso, il 25 settembre, certo. Ma davvero si crede che in
futuro un centrosinistra capace di portar via il primato alla destra-centro
di Meloni si possa costruire attorno al Terzo polo o al Movimento 5 Stelle? A me
sembra assolutamente che non sia così. Che esiste competizione con la destra-
centro a patto che vi sia un partito a vocazione maggioritaria, il nostro,
capace di rappresentare una vera alternativa.
Ancora a
proposito di identità: non sarebbe il caso di distinguersi, sulla giustizia, dal
M5S, come lei, Ceccanti e pochi altri avete provato a fare con l’adesione a tre
dei cinque referendum, nella scorsa primavera?
Caspita,
assolutamente sì. Certo che dobbiamo essere riconoscibili, distinti da una
forza, il Movimento 5 Stelle, apertamente giustizialista. Dobbiamo farlo in nome
dell’articolo 111 della Costituzione, secondo cui davanti a un giudice terzo e
imparziale devono giustapporsi due parti, una pubblica, vale a dire l’accusa, e
naturalmente la difesa. Serve la separazione delle carriere, come ricordiamo
persino nel capitolo sulla giustizia richiamato sul portale di Libertà eguale.
Separare le carriere dei magistrati realizza un principio di civiltà e di
equilibrio tra i poteri che nessuno può confondere con le ipotesi di chi
aspirava, almeno fino a qualche anno fa, a sottomettere la magistratura alla
politica. E noi, che dobbiamo saper interpretare davvero i valori della
democrazia liberale, anche nel campo della giustizia, possiamo essere, in questa
sfida, credibili come nessun altro.
Qatargate,
vero scandalo o montatura dei giornali?
Sembra di
rivivere la gloriosa stagione di Tangentopoli: ma questa volta a esplodere in
mille pezzi sarebbe l’intera Ue. Daniele Zaccaria su Il Dubbio il 20 dicembre,
Che emozione per
i giornali questo scandalo del “Qatargate”, probabilmente gli sembra di rivivere
la gloriosa stagione di Tangentopoli, le mazzette nascoste nei pouf, i potenti
decaduti, la caccia alle mega tangenti, gli avvisi di garanzia che fioccano qua
e là. E la prima Repubblica che esplode in mille pezzi.
La suggestione
parallela delle vedove di Mani Pulite è che l’inchiesta condotta da Michel
Claise, il magistrato belga dalla manetta facile e dal volto sempre a favore di
telecamera, potrebbe fare lo stesso con il Parlamento europeo e, per estensione,
con tutta la Ue.
“L’affaire che
rischia di distruggere l’Europa”, gridano da giorni un po’ tutti, aggiungendo di
volta in volta dettagli tanto pruriginosi, quanto irrilevanti dal punto di vista
giudiziario. È quasi un filone letterario, che si incrocia con le aggressive
tecniche di marketing dell’informazione online (i pezzi di colore sulle valigie
gonfie di denaro fanno guadagnare più click e visualizzazioni), con titoli
drogati a introdurre articoli di fuffa evocativa, puntando il faro sugli emiri
dei fondi sovrani petroliferi, sui servizi segreti del Marocco, sugli ex
comunisti che diventano lobbisti perdono la testa in un fiume di lusso e
quattrini.
Dicono inoltre
che nei prossimi giorni spunteranno nuovi, inquietanti risvolti, che l’inchiesta
si allargherà a macchia d’olio toccando altri europarlamentari, che i milioni
sbucheranno dai divani, dai cassetti, dalle botole e dai controsoffitti. Forse
ci sarebbe una vera e propria associazione criminale dietro lo scandalo.
Il clima di
isteria generale rischia peraltro di far smarrire la misura anche alle stesse
vittime del “Qatargate”, come la presidente de Parlamento europeo, l’avvocata
maltese Roberta Metsola che parla di «attacco alla democrazia» da parte di
potenze straniere con la stessa gravità di Winston Churchill prima della
battaglia di Inghilterra contro la Luftwaffe. Viene un senso di smarrimento a
immaginare che le autocrazie del Golfo affidino al pasciuto Panzeri e alla sua
banda di amici il compito di smantellare le nostre libertà democratiche.
Pare che le
indagini del procuratore Claise vadano avanti da oltre un anno e mezzo ma per il
momento il perimetro dei fatti accertati resta limitato come rimangono fumosi e
indefinibili gli obiettivi dei corruttori e i vantaggi da loro ottenuti pagando
i lobbisti. Cosa potrà aver mai spostato l’elogio del Qatar pronunciato dalla
socialista greca Eva Kaili lo scorso 21 novembre di fronte a qualche decina di
parlamentari annoiati e distratto?
Intanto, però,
Eva Kaili resta in carcere, il procuratore Claise spera infatti che la custodia
cautelare la faccia crollare, che la spinga a “confessare” e sembra che in parte
ci stia riuscendo. Si chiama tortura psicologica. Gli stessi metodi utilizzati
dal pool di Mani Pulite che tanto eccitano i nostri media per i quali il
Quatargate più che uno scandalo è una speranza.
Il Papa contro
i processi mediatici: «Il caso Lula è paradigmatico».
«L’iter
processuale è iniziato con notizie false sui media. Guardatevi da coloro che
creano l’atmosfera per un processo, qualunque esso sia». Il Dubbio il 18
dicembre,
Nell’intervista
al quotidiano spagnolo Abc, in cui Papa Francesco ha annunciato di aver già
firmato la lettera di dimissioni in caso di malttia, il Pontefice ha anche
parlato del caso Lula e dei processi mediatici figli delle fake news. Bergoglio
è apparso molto colpito dalle vicende del leader brasiliano, rieletto presidente
del suo Paese dopo essere stato processato e incarcerato. «È un caso
paradigmatico», ha detto il Papa. Paradigmatico perchè «l’iter processuale è
iniziato con notizie false sui media» che hanno creato «un’atmosfera che ha
favorito il suo processo». «Il problema delle fake news sui leader politici e
sociali è molto serio. Possono distruggere una persona», aggiunge Bergoglio.
Lula era stato
condannato per corruzione passiva, ha trascorso 580 giorni in carcere e gli è
stato impedito a candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018, fino al 2021,
quando la Corte Suprema ha annullato tutte le sentenze. «Non so come sia andata
a finire. Non dà l’impressione che si sia trattato di un processo alla altezza»,
prosegue Francesco. «E a questo proposito, guardatevi da coloro che creano
l’atmosfera per
un processo, qualunque esso sia. Lo fanno attraverso i media in modo tale da
influenzare coloro che devono giudicare e decidere. Un processo deve essere il
più pulito possibile, con tribunali di prima classe che non abbiano altro
interesse che mantenere pulita la giustizia. Questo caso in Brasile è storico,
non mi occupo di politica. Sto raccontando quello che è successo».
L'inchiesta
inesistente. Scandalo Qatar, furia manettara e fake news di Repubblica che
ricordano il 1992.
Paolo Comi su Il
Riformista il 20 Dicembre 2022
A Repubblica non
vedono proprio l’ora che scoppi una nuova Mani pulite. Sono talmente eccitati
dal Qatargate da arrivare anche ad ‘inventare’ le notizie di sana pianta.
Leggendo l’apertura di sabato scorso del giornale diretto da Maurizio Molinari,
“Milano, caccia ai soldi”, pareva di essere tornati direttamente al 1992, con le
retate quotidiane di politici accusati di prendere mazzette a go go dagli
imprenditori. Scorrendo poi il titolo ed il sommario dell’articolo principale,
“Conti correnti al setaccio, Milano cerca le mazzette degli ‘amici’ del Qatar.
L’inchiesta meneghina è coordinata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale”,
il lettore avrà subito pensato che quarto piano del Palazzo di giustizia del
capoluogo lombardo, dove ha sede la Procura, i pm, i super eroi senza macchia e
senza paura che lottano contro il male, fossero tutti intenti a scrivere
richieste di custodia cautelare e decreti di sequestro.
Purtroppo, il
desiderio irrefrenabile di manette era destinato a sciogliersi come neve al
sole. Ancora ieri mattina, infatti, non risultava aperta nessuna inchiesta
a Milano nei confronti dei soggetti tirati in ballo dai giornali in questi
giorni, ad iniziare da Antonio Panzeri. Nulla di nulla. Nemmeno mezza iscrizione
nel registro degli indagati. L’unica attiva svolta a Milano era stata quella di
dare esecuzione a delle richieste da parte dell’autorità giudiziaria belga. Non
essendo previsto che i pm belgi vengano in Italia per effettuare delle
acquisizioni di atti o verifiche sui conti correnti, costoro avevano delegato
per la loro esecuzione i colleghi milanesi. Una normalissima attività di
cooperazione internazionale, come se ne fanno a centinaia secondo procedure ben
codificate, è stata quindi spacciata per “inchiesta”.
Invece di
questa ‘disinformazione’ che ha contribuito a dare una lettura suggestiva degli
accadimenti, il giornale di Largo Fochetti avrebbe fatto bene a sottolineare
l’inopportunità che tali accertamenti, anche se solo delegati, venissero
effettuati da De Pasquale, l’attuale coordinatore del pool affari internazionali
e reati economici transnazionali di Milano. Il magistrato è imputato a Brescia
per omissione d’atti d’ufficio nel procedimento Eni Nigeria. Se fossero
applicate le ‘regole’ di Piercamillo Davigo, diventato celebre con Mani
Pulite, De Pasquale non dovrebbe entrare nemmeno in ufficio. “L’errore italiano
è stato sempre quello di dire aspettiamo le sentenze”, disse una volta
Davigo. “Se invito a cena il mio vicino di casa e lo vedo uscire con la mia
argenteria nelle tasche non devo aspettare la sentenza della Cassazione per non
invitarlo di nuovo”, aveva aggiunto l’ex magistrato.
Dal momento che è
acclarato in una sentenza del tribunale di Milano che De Pasquale non ha
depositato atti a favore dei suoi imputati, desta sorpresa che si occupi di
questo caso che avrà risvolti sulla politica nazionale e non solo. L’impasse,
comunque, è dovuto all’incredibile inerzia del Consiglio superiore della
magistratura che ha sul tavolo da un anno e mezzo la sua pratica per
incompatibilità ambientale. De Pasquale è a rischio trasferimento da Milano a
seguito per le vicende legate a i verbali dell’avvocato Piero Amara e, come
detto, al mancato deposito di prove favorevoli agli imputati del processo sulle
tangenti in Nigeria. Imputati che sono stati poi tutti assolti. Il Csm, a luglio
dello scorso anno, aveva convocato l’allora procuratore Francesco Greco, i suoi
vice, alcuni pm e anche il presidente del Tribunale ed il giudice Marco
Tremolada che ha presieduto il collegio che ha assolto tutti gli imputati per la
corruzione nel fascicolo Eni, per far luce sull’accaduto.
Come se non
bastasse, una delegazione composta dai laici e togati del Csm, fra cui il pm
antimafia Nino Di Matteo, si era recata personalmente lo scorso gennaio
a Milano per ulteriori accertamenti ed acquisizione di testimonianze. Da allora
non si è più saputo nulla. È opportuno, allora, che De Pasquale si occupi di
rogatorie e dia supporto ai magistrati del Belgio? Paolo Comi
«Il Pd c’entra
poco con il Qatargate, ma a chi interessa?
Massimo Cacciari, ex
sindaco di Venezia
Il professore
Massimo Cacciari, già sindaco di Venezia, punta il dito contro i dem: «Parlino
di politica, di amministrazione e di governo. La questione morale ci sarà
sempre». Giacomo Puletti su Il Dubbio il 20 dicembre, 2022
Massimo
Cacciari analizza la gestione del Pd sul caso Qatargate, spiega che la questione
«di certo non riguarda solo il Pd o la sinistra» e che «la questione morale
rimarrà, perché i mascalzoni e i ladri esisteranno sempre, ma sarebbe ora che i
dem comincino a parlare di politica, di amministrazione, di governo». Il vero
guaio per il Nazareno, insiste, è che «l’opinione pubblica non distingue
tra Articolo 1 e Pd».
Professor Cacciari,
pensa che il Pd stia sbagliando la gestione del cosiddetto Qatargate, che
coinvolge esponenti politici solo di lato riconducibili al Pd?
Diciamo che sono
esponenti politici “inventati” da quella parte politica, e su questo non c’è
dubbio. Al tempo stesso, però, è anche vero che alcuni hanno una storia così
antica, e un’esperienza politica così travagliata, a partire da Pierantonio
Panzeri, che con il Pd c’entrano ormai poco. Il problema vero per i dem è che
l’opinione pubblica non distingue tra articolo 1 e Pd. Considera tutti come
“sinistra” e vede che questi personaggi appartengono o appartenevano al gruppo
dei Socialisti e democratici a Strasburgo. Il resto conta poco, e questo è un
grosso guaio per i dem.
Crede che la vicenda
possa avere delle ricadute politiche per il Pd, nel pieno della corsa alla
segreteria e a pochi mesi da elezioni decisive in Lazio e Lombardia?
Non so cosa dicono i
sondaggi ma temo che ci saranno effetti catastrofici per l’immagine del Pd.
D’altronde, sarebbe anche sciocco da parte del Pd far finta che qualcuno possa
distinguere tra i dem e quelli di Articolo 1.
Visto che tra le
altre cose si sono presentati anche insieme alle elezioni. Se in casa hai uno
che ruba, è chiaro che questo rovina la tua immagine politica. Poi è chiaro che
se fosse stato coinvolto, ad esempio, Enrico Letta, sarebbe stato tutto diverso,
così come lo fu quando arrivano gli avvisi di garanzia a Bettino Craxi. Ma anche
in quel caso il disastro che coinvolgeva Psi e Dc era già avvenuto.
Cosa rischia ora il
partito, che è in calo nei sondaggi e che viene tirato per la giacca a sinistra
dal Movimento 5 Stelle e al centro dal terzo polo?
Beh, diciamo che
quella di cui stiamo parlando sembra una questione abbastanza importante. Poi se
si vuol ragionare oltre i fatti contestati, occorre sottolineare che un paese
non va in malore per pochi farabutti. Certo invece il partito rischia ma penso
che la dirigenza ne abbia consapevolezza.
Questa questione
avrà conseguenze fortissime anche dal punto di vista elettorale, di sicuro non
gli farà bene ma potrebbe addirittura fargli malissimo. Ne potrebbero beneficare
un po’ sia il Movimento 5 Stelle che il Terzo polo. Non certo le destre o la
Meloni. Il problema del Pd è di strategia politica, gli è capitata una tegola
sulla testa, è vero, ma non è che prima navigavano nell’oro. Il Qatargate sta
semplicemente allungando l’agonia.
Non crede che il Pd
abbia un atteggiamento masochista, ad esempio nel momento in cui sospende un suo
esponente, l’europarlamentare Andrea Cozzolino, che non è nemmeno indagato?
È sempre stato così,
da Tangentopoli in poi. Li hanno beccati con le valigie piene di soldi, mi
sembra talmente palese la corruzione che c’è poco da parlare di giustizialismo o
di masochismo. Bisognerà aspettare le sentenze, questo è chiaro, ma il giudizio
politico è sotto gli occhi di tutti. La questione è strachiara e la dirigenza
del partito cerca di difendersi come può, anche sospendendo suoi esponenti.
Ha citato il
centrodestra: pensa ci sia un po’ di ipocrisia negli attacchi al Pd o è semplice
dialettica politica?
Diciamo che in
generale questa è la prassi, e in Italia viene accentuata ancora di più. Quando
un partito o movimento politico si trova in una situazione di questo genere, gli
altri gli si avventano contro come sciacalli. Tutto sommato, mi sembra che
questa volta lo stiano facendo in maniera minore che in passato. D’altra parte
la Lega ha avuto problemi simili nel recente passato, quindi cosa vuole che
dicano…
Si parla molto di
questione morale, visto che la sinistra per decenni ne ha fatto il suo cavallo
di battaglia e che oggi sembra tornata necessaria. Che ne pensa?
Ma basta con la
questione morale. La facciano finita. La questione morale rimarrà, perché i
mascalzoni e i ladri esisteranno sempre, ma sarebbe ora che comincino a parlare
di politica, di amministrazione, di governo. Ovviamente ci sono quelli che sono
stati fuori dal giro magico del gruppo dirigente che da anni decide la
candidature, promuove e bocca i nomi, e che ora stanno sparando a zero. Basta
vedere le prime dichiarazioni di De Luca e Bonaccini. Tutti a dire che se ci
fossero stati loro queste cose non sarebbero successe. Ma per favore, Non è
niente di nuovo: tutte cose viste e riviste. Sono comportamenti normali della
politica.
Una politica che è
stata premiata dal denaro di Marocco e Qatar: perché hanno colpito una certa
parte del Parlamento di Strasburgo?
Di certo non
riguarda solo il Pd o la sinistra. Ora i riflettori sono puntati su questi
personaggi, ma vicende simili coinvolgono tutti. In questo caso Marocco e Qatar
hanno cercato appoggi tra i socialdemocratici perché potevano facilmente
immaginare che le massime resistenze rispetto al mondiale in Qatar venissero
proprio dalla sinistra europea. Con la destra e i filoamericani il problema non
si poneva, visto che il Qatar è un alleato strettissimo degli Usa da anni. Quei
voti, insomma, già li avevano, non c’era bisogno di comprarseli.
Da “la Repubblica”
il 19 dicembre 2022.
Caro Merlo,
Repubblica di giovedì scorso riporta una frase pronunciata da Francesco Giorgi,
in carcere per il Qatargate: “Ho fatto tutto per soldi di cui non avevo
bisogno”. Mi chiedo allora: perché? Più si è ricchi e più si è corruttibili?
Sono insaziabili.
Pasquale Regano -
Andria.
Risposta di
Francesco Merlo:
La frase esprime
autocritica etica, pudore e vergogna. Giorgi è infatti un pentito, sconfitto e
colpevole, che non va preso alla lettera. I suoi giudici valuteranno se merita
la clemenza che implicitamente chiede e cosa offre in cambio. Lei ne fa invece
una questione generale di antropologia criminale, crede che ricchezza e
corruzione siano direttamente proporzionali.
È pessimo il
rapporto che l’Italia ha sempre avuto con “mammona” e non solo perché l’Italia è
stata povera e dunque per molto tempo non ha avuto danaro. Ma anche perché la
vecchia sinistra ideologizzava, e qualche volta ancora ideologizza la povertà
disprezzando il consumo.
E la Chiesa crede
che sia popolato di beati poveri il regno dei cieli e di insaziabili diavoli
ricchi quello dei dannati. Totò a chi diceva che l’appetito vien mangiando
rispondeva che “in realtà viene a star digiuni”.
Gian Micalessin
per “il Giornale” il 19 dicembre 2022.
A volte il passato,
anche recente, può sembrare comico. O surreale. Di certo così appaiono, oggi, le
cronache dell'ottobre 2012 quando l'allora premier Mario Monti vola in Qatar.
Sono passati solo pochi mesi dall'assegnazione dei mondiali di calcio 2022
approdati a Doha sull'onda di compravendite di voti e generose mazzette. Eppure
durante la visita l'Emiro non tralascia di esibire al nostro premier la
preoccupazione d'investire in un'Italia «in preda alla corruzione».
In verità l'Italia
del 2012 è solo un paese distrutto dallo «spread» e dalle manovre
politico-economiche messe in campo per far fuori Silvio Berlusconi. Un paese
dove però si possono fare ottimi affari a prezzi di saldi. E proprio la
trasferta di Monti apre a Doha le porte della grande svendita.
Il primo frutto
della visita è la costituzione, a marzo 2013, della joint venture «IQ Made in
Italy Investment Company S.p.A» controllata al cinquanta per cento dalla Qatar
Holding LLC e dal «Fondo Strategico Italiano Spa» - la holding di Cassa Depositi
e Prestiti. Dotato di un capitale di 300 milioni di euro, destinato ad
investimenti nelle eccellenze italiane che spaziano dall'alimentazione al lusso,
il fondo acquisisce nel 2014 il 28,4 per cento delle quote di Cremonini, gruppo
leader nell'esportazione di carne.
Ma nell'aprile del
2012 la Qatar Holding ha già messo le mani sugli immobili della costa Smeralda
in Sardegna acquisendo quattro hotel extralusso (Cala di Volpe, Romazzino, Cervo
Hotel, Pitrizza), la Marina e il Cantiere di Porto Cervo, l'esclusivo Pevero
Golf Club e ben 2.400 ettari di terreno. Un giro d'acquisti del valore di 650
milioni di euro a cui si aggiungono il controllo dell'ex-ospedale San Raffaele
di Olbia e gli accordi su Meridiana che portano, nel febbraio 2020, al
fallimento e alla liquidazione la compagnia aerea.
Dalla Sardegna le
operazioni finanziarie si allargano ben presto all'abbigliamento e al lusso. Nel
luglio 2013 la «Mayhoola for Investment», controllata dallo sceicco Hamad bin
Kahlifa al Thani, sborsa 700 milioni di euro per il controllo del marchio
Valentino. Un anno dopo, si aggiudica anche il marchio «Pal Zilieri» al prezzo
di 37 milioni.
Nel frattempo si
scatena la caccia agli alberghi extra-lusso. Nell'aprile 2013 i qatarioti
versano 150 milioni di euro per il Palazzo della Gherardesca di Firenze sede del
«Four Seasons Hotel». L'hotel fiorentino entra così a far parte di una
collezione che già comprende il Gallia di Milano acquisito per 134 milioni,
l'«Excelsior De Regis» di Roma pagato 222 milioni e, sempre nella capitale,
l'hotel Intercontinental di Trinità dei Monti ed il Westin Excelsior di via
Veneto costati oltre 220 milioni.
Il vero colpo gobbo
arriva, però, nel febbraio 2015 quando il Qatar acquisisce, grazie ad un
investimento da poco più di due miliardi, i 25 palazzi e grattacieli di Porta
Nuova simbolo e volto della Milano del Duemila.
Da Prodi a D'Alema quel vizio a sinistra di fare affari con Stati esteri dai
molti buchi neri.
Pasquale Napolitano
il 20 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Il vizietto per
lobby e affari accomuna tutti gli ex segretari del Pd e leader storici della
sinistra italiana
Il vizietto per
lobby e affari accomuna tutti gli ex segretari del Pd e leader storici della
sinistra italiana. Da Romano Prodi a Enrico Letta. Tutti i capi passati di quel
mondo, smessi i panni della politica, si sono tuffati nel dorato mondo delle
consulenze per Nazioni estere e delle relazioni internazionali. Chi alla luce
del sole e chi in modalità più o meno segrete. Sono attività molto redditizie a
giudicare dalle dichiarazioni patrimoniali, schizzate verso l'alto, non appena
Letta e D'Alema hanno mollato la poltrona da capo di partito. Avversari duri ai
tempi del Pd, come D'Alema, Renzi e Prodi, sembrano oggi avere in comune la vita
da lobbista.
Massimo D'Alema, ex
presidente del Consiglio ma soprattutto a lungo leader indiscusso della sinistra
italiana, dopo la rottamazione renziana che l'ha buttato fuori dalla vita
politica, si è lanciato, con risultati molto interessanti, nel mondo degli
affari. È lui stesso che nell'intervista a Tommaso Labate per il Corriere della
Sera ammette di essere tra i consulenti della cordata di investitori che vuole
acquisire la raffineria Isab di Priolo. Una cordata con al centro l'uomo
d'affari qatarino Ghanim Bin Saad Al Saad, a fianco di investitori italiani.
D'Alema è il ponte con il governo italiano (prima Draghi oggi Meloni). Però
nell'intervista al Corriere tiene a ribadire: «Io però non faccio né l'affarista
né il lobbista. Da diversi anni ho un'attività di consulenza prima di avviare la
quale, è agli atti, ho scritto al segretario Speranza una lettera di dimissioni
dagli organismi dirigenti di Articolo 1. Non ci sono nel mio caso porte
girevoli. Ma diverse stagioni nella vita che devono essere scandite da un rigido
principio di incompatibilità. Io le ho scandite». Messaggio chiaro. D'Alema è
stato però il consulente di un'altra operazione finanziaria che non è andata a
buon fine: una compravendita tra Italia e Colombia di mezzi da guerra prodotti
da Leonardo-Finmeccanica. Il governo di Bogotà stava trattando con Roma
l'acquisto di due sommergibili prodotti da Fincantieri e di alcuni aerei di
Leonardo. A un certo punto in questa negoziazione sarebbe entrato, nel ruolo di
intermediario il lider Maximo. Un altro ex capo del Pd, Matteo Renzi, si muove
bene nel campo delle relazioni internazionali e degli incarichi in società di
Paesi esteri. Lo fa in chiaro, alla luce del sole. Passando dalla Russia
all'Arabia Saudita. Nulla da nascondere, tutto fatturato.
Il pioniere tra i
lobbisti di sinistra è sicuramente Romano Prodi. L'ex presidente del Consiglio e
fondatore dell'Ulivo ha costruito una rete di rapporti culturali e lavorativi
con Pechino. I libri e le lezioni di Prodi spopolano nelle università cinesi. Ma
non solo: negli anni il professore è stato uno dei più convinti sostenitori
dell'espansione commerciale e finanziaria della Cina in Italia ed in Europa.
Nell'aprile scorso la Verità ha svelato la spinta di Prodi per la produzione in
Emilia di auto di lusso made in China. Scorrendo l'elenco dei segretari dem, con
il vizietto per gli affari, spunta Enrico Letta, ancora in carica fino al
prossimo congresso. L'ex premier nel suo esilio parigino annega l'amarezza tra
società cinesi e francesi. Per due anni Letta è stato in Publicis, colosso
pubblicitario francese criticato per i rapporti con i sauditi. E poi è stato
anche vicepresidente per l'Europa occidentale del veicolo di investimento cinese
ToJoy. Tutte lobby e gruppi di interesse che cercano di bussare alla porta dei
leader politici. Al Nazareno la porta sembra essere sempre aperta.
Stefania Craxi:
«La sinistra è passata dall’oro di Mosca ai soldi del Qatar. Moralisti dei miei
stivali».
Sveva Ferri su Il Secolo d’Italia il 19 dicembre 2022.
Resta sempre e
comunque «garantista». Per questo Stefania Craxi sulla vicenda del Qatargate non
dà «giudizi nel merito» rispetto ai soggetti coinvolti. Ma il giudizio politico
lo dà eccome, ricordando che «è un vecchio vizio della sinistra italiana:
finire al servizio di potenze straniere». «Oggi siamo passati dall’oro di Mosca
ai contanti del Qatar. Io resto la più garantista in assoluto: ma allo stesso
tempo non dimentico chi finora mi ha fatto la morale. Ecco, ai tanti moralisti
“dei miei stivali” voglio ricordare che, a maggior ragione dopo l’inchiesta di
Bruxelles, non sono titolati a dare lezioni», ha sottolineando, spiegando che
«se adottassi il metodo usato contro mio padre, oggi dovrei sventolare le
manette: ma noi siamo fatti di un’altra pasta».
Stefania Craxi: «A
sinistra sono passati dall’oro di Mosca ai soldi del Qatar»
Proprio quel «certo
vezzo della sinistra comunista, sempre pronta a fare la morale, affetta da
quello che è stato chiamato il “complesso dei migliori”» è per la presidente
della Commissione Esteri del Senato l’unica «similitudine» che si può trovare
tra il Qatargate e Mani Pulite, due vicende altrimenti troppo distanti per
«tempi, contesti e situazioni» per poter essere accostate. «Vedremo come si
concluderanno le indagini, ma come diceva Nenni, “se giochi a fare il puro,
prima o poi incontri uno più puro di te che ti epura”. Ma i moralisti fanno
sempre una brutta fine: è la storia che si incarica di definirli spergiuri», ha
detto ancora Craxi, intervistata da La Verità e citando con l’ultima frase il
padre Bettino.
La superiorità
morale della sinistra, ha quindi proseguito, non è tramontata con il Qatargate,
perché «non è mai esistita». «Semmai – ha precisato – c’era ieri e in parte
oggi, una “doppia morale”. Altro che virtù pubbliche e vizi privati. Nel ’92 si
sono messi al servizio di un’operazione golpista, ricevendo protezione e
teorizzando una presunta verginità, proprio loro che, oltre alle tangenti dalle
aziende, prendevano soldi e ordini da una potenza militare nemica dell’Italia e
dell’Occidente. Per inciso, senza un minimo di autocritica sul passato, ci danno
anche lezioni sul piano internazionale, mentre a Bruxelles si riempiono la bocca
della parola diritti per poi prendere soldi da governi autocratici».
«Nel Pd fanno bene a
dirsi sconcertati, visto anche quello che hanno detto e fatto contro la Lega»
Quanto al fatto che
nel Pd si dicano «sconcertati», per Stefania Craxi è giusto «visto anche tutto
ciò che più di recente hanno detto e fatto sulla Lega di Salvini. La verità,
però, è che i partiti, o come vogliamo chiamare questi succedanei, vivono nella
società. E nella società ci sono buoni, brutti, disonesti, persone perbene.
Dovrebbero ricordarlo anche quando queste vicende interessano altri, senza
sciacallaggi e mistificazioni. Ma si sa: coltivare la memoria non è il pregio di
questa sinistra». E, ancora, «visto che sono così solerti sulla trasparenza,
perché non accolgono la richiesta del centrodestra di istituire una commissione
di inchiesta su Tangentopoli?».
Stefania Craxi: il
Qatargate dimostra la debolezza della politica e che «manca l’Europa che serve»
In generale,
comunque, la senatrice azzurra ha chiarito che ciò che maggiormente l’ha colpita
è stato «il presunto coinvolgimento di assistenti parlamentari, che denota come
gli apparati, burocratici e parapolitici, hanno preso il sopravvento sulla
politica e le stesse rappresentanze parlamentari». «Ho pensato che la politica è
sempre più debole e influenzabile. Il tema dei condizionamenti stranieri verso
le realtà occidentali, e soprattutto europee, è preminente. Dobbiamo affrontarlo
rapidamente con forza, senza cedere a retoriche più o meno forcaiole, sapendo
che è un nodo di sistema che riguarda la qualità delle nostre democrazie», ha
proseguito Craxi, per la quale la questione su cui riflettere sono anche
«l’assenza di un’Europa politica e una costruzione comunitaria fallace». «Manca
– ha chiarito – l’Europa che serve».
I casi di Matteo
Renzi e Massimo D’Alema
Il tema del primato
della politica torna anche quando Federico Novella, che
firma l’intervista, chiede a Stefania Craxi un commento sui comportamenti di
Matteo Renzi, «in affari con gli arabi», e Massimo D’Alema, «con il suo ruolo di
consulente per una cordata di sceicchi in vista dell’acquisizione della
raffineria di Priolo». «Renzi fa il conferenziere, un mestiere svolto da molti
ex premier in tutto il mondo, ma, certo, a esperienza politica conclusa.
D’Alema, invece, è un caso più unico che raro: lui comunista, come tutt’ora
rivendica, si ergeva a primate della politica, continua a fare e disfare nelle
retrovie, e poi fa il consulente delle multinazionali? Diciamo – ha commentato
l’esponente azzurra – che non Craxi, ma un qualsiasi ex Presidente del Consiglio
della prima Repubblica non l’avrebbe mai fatto».
Il fallimento del
“modello” della sinistra sul tema migranti
E il fatto che al
centro dello scandalo Qatargate, come dei casi Mimmo Lucano e Soumahoro, ci
siano i diritti umani? «Anche qui – ha avvertito la presidente della Commissione
Esteri del Senato – non mischiamo vicende tra loro dissimili e non pensiamo che
tutto sia da buttare via. Conosco bene la realtà di Lampedusa, dove uomini e
donne, associazioni, prestano un’opera meritoria in condizioni inaccettabili.
L’Europa benpensante e perbenista, dovrebbe andare lì e vedere. Ciò che la
sinistra non capisce è che il modello che difendono si presta a storture di ogni
tipo, non affronta i problemi, non li risolve. Non aiuta i migranti, ma – ha
concluso Craxi – spesso li rende schiavi, merce di un sistema inumano».
Gli Stati
corruttori, la nuova questione morale.
Ernesto Galli della
Loggia su Il Corriere della Sera il 19 Dicembre 2022.
Unifica il fronte
dei tiranni il profondo disprezzo ideologico verso l’universo dei valori di
libertà e di eguaglianza dove essi giudicano che «tutto è in vendita»
L’eterna rissa
italiana tra destra e sinistra sulla spinosa questione morale da un lato, e
dall’altro la non eccelsa reputazione di cui godono le istituzioni europee hanno
concentrato l’attenzione suscitata dallo scandalo delle tangenti Ue assai più
sul versante dei corrotti che su quello dei corruttori. Sulla miserabile
congrega di politici di serie B residenti a Bruxelles e di sottopancia
intraprendenti e bellocci anziché su chi elargiva loro i quattrini per i suoi
scopi poco puliti. Ma il vero nodo politico è su questo versante, non
sull’altro. Di corrotti, infatti, ce ne sono sempre stati e sempre ce ne saranno
così come sempre ci sono stati e sempre ci saranno, ad esempio, grandi interessi
economici pronti a cercare chi, in cambio di soldi, si metta al loro servizio. È
considerato in un certo senso talmente fisiologico questo ultimo tipo di ricerca
di «influenza» che esso ha trovato anche un nome presentabile, «il lobbysmo»,
con un adeguato corredo di regole come quelle (forse un po’ troppo generose?)
vigenti a Bruxelles.
Il vero fatto nuovo
del Qatargate, invece, è il Qatar. Il vero fatto nuovo, cioè, è la definitiva
scoperta di un genere di corruttore del tutto inedito, e cioè gli Stati: non già
per ragioni di spionaggio ma per ben altro. Negli ultimi anni ne avevamo avuto
sentore (più di un sentore in verità) ma ora è una certezza. Si tratta perlopiù
di Stati africani e asiatici — con l’importante eccezione della Russia — uniti
tutti dalla caratteristica di essere retti da regimi non democratici.
In un certo senso
quanto sta accadendo lo si potrebbe considerare anche una sorta di nemesi
storica. Una sorta di contrappasso per le tante volte in cui, nel corso dei
secoli, avventurieri europei di ogni risma o addirittura rappresentanti delle
stesse potenze europee se ne andarono in giro in Asia e in Africa con qualche
sacchetto di vetri colorati o di qualche vecchio moschetto arrugginito ad
«acquistare» dai capi locali, in cambio di questa paccottiglia, tutto quello che
potevano: dagli esseri umani da ridurre in schiavitù a immense estensioni
territoriali.
Ma oggi la storia ha
cambiato verso ed è l’Occidente che viene preso di mira a suon di euro o di
dollari. Non già però, come ho detto, nel tentativo di corrompere questo o quel
funzionario per carpire qualche informazione, per aver accesso a un piano o a un
documento, non già a fini di spionaggio insomma, come in sostanza avveniva un
tempo, ma per uno scopo ben più ambizioso e grave: per influenzare lo stesso
processo decisionale di vertice di quel Paese (o nell’ultimo caso l’Unione
europea), per determinarne le scelte politiche anche le più importanti. Perfino
per stabilire chi lo governerà. Il mondo dei tiranni, insomma, ha scoperto che
il mondo delle democrazie, delle istituzioni democratiche, dei partiti e dei
parlamenti, non solo è regolato da procedure aperte e perciò permeabilissime
dall’esterno, ma è altresì pieno di donne e uomini fragili, dagli ideali deboli
o inesistenti, avidi di successo personale, di automobili, di sesso, di Rolex; è
popolato di statisti di serie B interessantissimi conferenzieri da 50 mila
dollari a prestazione. E allora non si fa problemi a pagare. A cercare tra
queste persone chi possa servire ai suoi propositi. Non basta, perché al fine di
falsare le consultazioni elettorali oltre i soldi il mondo dei tiranni mette in
campo anche le risorse del progresso tecnico, della suggestione mediatica, della
manipolazione digitale delle informazioni.
Il fatto è che da
qualche decennio viviamo in una congiuntura storica nuova, nella quale si
sommano e s’intrecciano vari fattori più o meno inediti che, insieme, hanno
segnato per l’argomento di cui ci stiamo occupando una vera e propria svolta.
Sul versante dei
corruttori assistiamo innanzitutto a un’esplosione di attivismo sia da parte
della Cina, ansiosa di giungere al potere mondiale con ogni mezzo — non ultimo
la costruzione di una rete d’influenza commerciale, la planetaria «via della
seta», che però necessita della collaborazione/complicità dei governi dei Paesi
interessati —, sia della Russia che, guidata da una leadership dagli accenti
paranoici, cerca con la violenza di mantenere i suoi antichi domini imperiali e
la sua antica influenza servendosi di qualunque élite occidentale «amichevole»
disposta ad aiutarla in cambio delle sue «risorse» d’ogni genere. Accanto a Cina
e Russia si affollano molti altri attori di calibro minore — Turchia, Marocco,
Corea del Nord, Stati del Golfo - ognuno con le sue mire espansionistiche o
egemoniche a carattere più o meno regionale, pronti a impiegare i propri soldi
per due obiettivi congiunti: acquisire il placet dell’Occidente ai propri
disegni (spesso insieme a forniture militari) ovvero impedire che si faccia luce
sul carattere sempre antidemocratico e perlopiù criminale del proprio regime
interno. Unifica il fronte dei tiranni un elemento comune: il profondo disprezzo
ideologico verso l’universo dei valori di libertà e di eguaglianza — dove essi
giudicano che «tutto è in vendita» — nonché verso l’umanità che è frutto di quei
valori.
Sull’altro versante,
quello dei corrompibili c’è per l’appunto questa umanità, ci siamo noi, c’è il
nostro mondo. Con la sua pronta, obbligatoria disponibilità a tutto ciò che
sappia di diverso dall’Occidente, con il proliferare di mille centri decisionali
e la loro facile penetrabilità, soprattutto con la disarticolazione culturale e
morale delle sue élite: non più tenute insieme da forti valori condivisi o da
antiche regole di educazione e di stile, non difese da consapevoli e forti
identità né istruite adeguatamente ai nuovi compiti e alle nuove responsabilità;
c’è infine il mondo della nostra sfera pubblica dove sembrano avere sempre più
la meglio «la gente nova e i sùbiti guadagni».
La corruzione,
quando coinvolge i vertici, non è più un fatto solo penale: è lo specchio dove è
dato leggere il grado di salute dell’organismo a cui quei vertici presiedono e
talvolta, Dio non voglia, anche il destino che l’aspetta.
Quell’antico
vizio della corruzione (e dell’indifferenza).
«Le accuse che
coinvolgono il Parlamento europeo», dichiara Roberta Metsola, «sono un colpo
alla democrazia e a tutto ciò su cui abbiamo lavorato per molti anni. Gino Dato
su La Gazzetta del Mezzogiorno il 19 Dicembre 2022
«Le accuse che
coinvolgono il Parlamento europeo», dichiara Roberta Metsola, «sono un colpo
alla democrazia e a tutto ciò su cui abbiamo lavorato per molti anni. Ci
vogliono anni per costruire la fiducia, ma solo un momento per abbatterla». La
presidente dell’Europarlamento rappresenta in questi terribili giorni l’ala
oltranzista, alla quale, mentre cresce lo sgomento per il Qatergate
scoperchiato, spetta il compito più duro e deciso: «Non ci sarà impunità, non ci
sarà da nascondere sotto il tappeto, non ci sarà da fare come al solito…».
Una scelta decisa
che si muove tra due poli: la «giustizia retributiva», assai sentita e
condivisa, come può esserlo ogni reazione di un corpo sano rispetto a una
cancrena, con l'intento che la pena-punizione per il crimine appaia
proporzionata al reato-crimine commesso; e una «giustizia riparativa», dove
invece si considera maggiormente l'obbligo, per l'autore del reato, di accedere
a una rieducazione e di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta.
Non crediamo però
che i sentimenti e le riflessioni dell’opinione pubblica possano soffermarsi su
tali questioni, che toccano la natura stessa e gli strumenti della giustizia. Di
sicuro spetta ai corpi sani delle istituzioni reagire con prontezza e fermezza
per una vicenda che dischiude scenari in apparenza poco verosimili, in realtà
più articolati e ricchi di particolari di quanto ci immaginavamo, man mano che
avanzano le indagini. Di sicuro, poi, conviene chiederci, imbracciando il buon
senso di ogni cittadino, se esistono percorsi e metodi e riforme per sconfiggere
un antico male, la corruzione, che non risparmia cultura o paese. Il nostro, per
esempio, è in buona compagnia di altre nazioni della più solida tradizione
democratica.
Facciamo due
verifiche, una di ordine storico, l’altra più di indagine sociologica.
Con la prima
ripercorriamo a ritroso la nostra storia per capire come le vicende pubbliche e
private siano state infangate e corrose da grandi scandali legati al fenomeno
corruttivo, uno per tutti, e il più eclatante, la stagione di Mani pulite.
Con la seconda
proviamo a misurare la corruzione a scala mondiale, scorrendo la classifica del
cosiddetto CPI, Indice di percezione della corruzione nel settore pubblico e
nella politica. Dal CPI, assegnando punti che vanno da 0, per i Paesi più
corrotti, a 100 per quelli meno corrotti, si può capire quali siano i campioni
del fenomeno corruttivo. La media, aggiornata al 2022, staziona da un decennio
intorno ai 42-43 su 100. Ma… udite udite, l’Italia è il fanalino di coda
dell’Europa occidentale, pur avendo di recente guadagnato 3 punti: siamo al
42esimo posto nella classifica mondiale con 56 punti.
Mettendo da parte
falsi moralismi, dobbiamo quindi prendere atto che quello di corrompere (e di
farsi corrompere) è… l’altro più antico mestiere del mondo, così come che gli
sforzi di ordine strutturale-normativo ma anche comportamentale probabilmente
sono destinati a fallire. Pur senza voler, con questo, sbarrare la strada alla
giustizia.
Allora, più che di
una giustizia retributiva e/o riparativa, abbiamo bisogno di una giustizia…
rifondativa, cioè di una rivoluzione del sistema di formazione che restituisca
agli individui, alle cose e ai principi il loro valore reale, per distinguere il
legale dall’illegale, il lecito dall’illecito, per definire il senso di una
norma ma anche del merito e della dignità della persona.
Pensiamo che bisogna
voltar pagina rispetto alla società dell’indifferenza, dove neanche
l’indignazione riesce più a far leva su una tragica storia che né il 68 né
Tangentopoli né la lunga catena di misteri sono riusciti a cambiare.
Pensiamo che bisogna
scuotere le coscienze, a partire da quelle dei giovani, nelle case, nelle
scuole, nei luoghi dove si struttura l’educazione come emulazione degli uomini
onesti e viaggio nel firmamento dei principi.
Estratto
dell’articolo di Luca De Vito, Giuliano Foschini e Claudio Tito per “la
Repubblica” il 20 dicembre 2022.
«La cricca, oltre ad
una azione di lobby legittima, agiva anche con la cooptazione di
europarlamentari, assistenti parlamentari, funzionari del Seae e dei vertici
sindacali». Eccolo il salto di qualità nel Qatargate.
Nell'inchiesta della
Procura belga […] spunta la Commissione europea. Il governo dell'Ue. Perché il
Seae è il servizio europeo per l'azione esterna. Il Ministero degli Esteri
dell'Unione, guidato dallo spagnolo Josep Borrell.
In un allegato degli
atti con cui i magistrati di Bruxelles motivano gli arresti già compiuti,
infatti, spunta una relazione dei servizi segreti del Belgio, il Vsse. E il
riferimento agli uffici della Commissione sono espliciti. Il faro della
magistratura dunque illumina anche Palazzo Berlaymont, o più precisamente gli
uffici che si trovano a Place Schuman.[…] La "cricca" e i loro fiancheggiatori
[…] avevano obiettivi che per loro natura rischiavano di incrinare la sicurezza
dell'Ue e dei singoli stati membri. «Il fine ultimo - si legge nelle motivazioni
- è influenzare le decisioni delle Istituzioni europee ». Ottenendo ovviamente
in cambio «ingenti somme di denaro» che vengono quantificati in «diversi milioni
di euro». «Questo era lo scopo dei tre italiani».
Ma nel concreto le
pressioni a cosa puntavano? Il Marocco e il Qatar in realtà avevano obiettivi
diversi. Che a volte si sovrapponevano. «Per il Marocco - spiegano gli 007 belgi
- l'Ue è un primario partner commerciale, la sua sicurezza energetica dipende in
parte dall'Europa. In gioco c'è l'accordo di libero scambio sulla pesca e
l'agricoltura. La questione migranti e la linea di Bruxelles sul Sahara
Occidentale» che il Marocco ha occupato e che al momento non viene riconosciuto
come territorio marocchino». Per Doha, invece, l'aspetto prioritario consisteva
nel «migliorare l'immagine in relazione ai diritti dei lavoratori ». In
particolare quelli impegnati nella costruzione degli stadi di calcio in vista
dei campionati mondiali appena terminati.
Se queste, allora,
erano le finalità, i risultati concreti ottenuti sono effettivamente
strabilianti e imbarazzanti. Gli inquirenti li elencano con una freddezza che
raggela: «Dar vita a diverse risoluzioni parlamentari » per frastagliare il
fronte dei contrari ai due Paesi. Ottenere «diverse dichiarazioni pubbliche» per
impedire che il giudizio fosse unitario.
«Nominare candidati
al premio Sakharov», ossia il principale riconoscimento dell'Ue che in passato è
stato assegnato a personaggi come Nelson Mandela e quest' anno al popolo
ucraino. «Alterare il rapporto annuale sulla politica estera».
E poi gli aspetti
più inquietanti: «Tentare di collocare alla presidenza o alla vicepresidenza
delle commissioni parlamentari, come la Darp (Delegazione per i rapporti con la
penisola arabica), la Afet (Affari esteri) e la Droi (diritti) persone »
gradite. Cozzolino, ad esempio, era uno di questi. […]
Ma soprattutto ha
ottenuto il «risultato» di fare eleggere la greca Eva Kaili alla vicepresidenza
del Parlamento europeo. «Panzeri e Cozzolino - spiegano gli inquirenti -
segretamente interferivano con il lavoro del Parlamento al fine di influenzare
le scelte. Anche per la Delegazione sul Maghreb».
[…] La "cricca", non
riceveva in contropartita esclusivamente denaro e «regali» per uso privato.
Nelle indagini emerge quello che in Italia verrebbe definito un vero e proprio
"voto di scambio". Le loro interferenze erano attuate, quando serviva, «anche in
cambio del sostegno elettorale». In particolare del Marocco, che elargiva «somme
consistenti » per raggiungere traguardi in occasione di elezioni. Insomma, una
distorsione delle procedure democratiche. E il tutto avveniva secondo uno schema
collaudato. Con un «linguaggio in codice». Perché in questa vicenda di malaffare
e corruzione c'è anche una pagina da "Spy-Story".
(ANSA il 20 dicembre
2022) - L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, in carcere dal 9
dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, davanti agli
inquirenti ha ammesso di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di
denaro e di essere a conoscenza dell'attività portata avanti dal marito,
Francesco Giorgi, con l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, entrambi in carcere.
Lo scrive il
quotidiano belga Le Soir in base a documenti visionati insieme a Knack e La
Repubblica. Anche Panzeri ha riconosciuto in parte il suo coinvolgimento,
puntando poi il dito sull'ex collega socialista Marc Tarabella come beneficiario
dei 'regali' del Qatar.
Giuseppe
Salvaggiulo per “la Stampa” il 20 dicembre 2022.
Qualcosa sapeva, ma
non partecipava alla cricca. Mentre l'inchiesta per corruzione internazionale si
allarga «ad altre persone» non solo italiane e non solo socialiste e il
Parlamento Ue attende dalla Procura federale belga sempre più probabili
richieste di revoca di immunità per almeno un paio di deputati, Eva Kaili e i
suoi avvocati affilano la strategia in vista dell'udienza davanti alla Camera di
Consiglio che giovedì si pronuncerà sulla sua permanenza in carcere.
Arrestata il 9
dicembre con il compagno e assistente parlamentare Francesco Giorgi, l'ex
eurodeputato Antonio Panzeri, il segretario della Ong "Non c'è pace senza
giustizia" Niccolò Figà Talamanca e Luca Visentini, leader della Confederazione
internazionale dei sindacati, Kaili è l'unica a non essere comparsa davanti ai
giudici per la convalida del provvedimento, una settimana fa.
Ufficialmente per
uno sciopero delle guardie penitenziarie, in realtà per una precisa strategia
legale: prendere tempo, separare il destino processuale dagli altri indagati,
giocare le sue carte da sola. Con un obiettivo preciso e immediato: ottenere la
scarcerazione e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in modo da
poter trascorrere il Natale con la figlia di 22 mesi che non vede da dodici
giorni, visto che per tutelarla ha rifiutato la possibilità di una visita in
prigione.
Missione resa
difficile da una serie di elementi: la gravità delle accuse (corruzione e
riciclaggio), il suo rango istituzionale (era la personalità più influente ed
esposta del gruppo), la severità dimostrata finora dai giudici (tre arresti
confermati, uno alleviato in domiciliari) e soprattutto la prova regina che l'ha
privata dell'immunità: la valigia con 600 mila euro portata fuori di casa dal
padre Alexandros.
Kaili intende
distinguere la sua posizione da quella del compagno. Fa parziali ammissioni:
dimostra una certa consapevolezza delle attività parallele e illegali ma a
differenza di Giorgi nega una partecipazione strutturata «all'associazione
criminale e fraudolenta». Sostiene di non aver mai avuto «comunicazioni» con
Panzeri, ritenuto dagli investigatori il capo. E di aver viceversa chiesto conto
a Francesco Giorgi del suo stretto legame con l'ex eurodeputato, sopravvissuto
alla mancata rielezione e consolidato nella Ong Fight Impunity, fondata da
Panzeri e a cui Giorgi collaborava.
Dice che Giorgi
l'aveva motivato con «un obbligo morale» nei confronti di Panzeri, che prima
l'aveva accolto a Bruxelles come giovane stagista e poi promosso di rango,
trasformandolo nel «principe degli assistenti parlamentari». Ma la compagna non
era stata rassicurata del tutto. Lo aveva ammonito: «Stai attento, fai in modo
che sia tutto legale». Giorgi l'avrebbe tranquillizzata «dicendo che non c'era
motivo di dubitarne».
«Io non ho mai visto
i soldi in casa», ha sostenuto subito dopo l'arresto tramite i suoi avvocati. Ma
poi ha corretto il tiro, dimostrando di esserne a conoscenza. E ha ammesso di
essere stata lei a chiedere al padre di portarla via dopo la scoperta del
compromettente contenuto, per «restituirla al proprietario».
Sul piano
istituzionale, Kaili alza la posta. A proposito delle sue visite in Qatar,
sospettate di eccessiva accondiscendenza, chiama in causa i vertici Ue. Non solo
rivendica di aver sempre «portato avanti l'agenda assegnatale dalla presidente
del Parlamento Roberta Metsola». Ma aggiunge di aver «eseguito la politica
ufficiale dell'Ue, pianificata al più alto livello». Ovvero dalla Commissione,
fino alla vicepresidenza. Inoltre chiama a testimone della sua correttezza un
funzionario italiano «che mi ha sempre accompagnato nei viaggi in Qatar e
seguito in ogni passo».
A breve il destino
di Eva Kaili, che secondo il suo avvocato non vuole «diventare Ifigenia»,
dipende da quanto i giudici riterranno plausibili le sue tesi difensive, a
dispetto degli indizi. Da come valuteranno il rischio di inquinamento delle
prove, visto che ha perso tutti gli incarichi. E dal peso che avrà il diritto
della figlia a tornare tra le braccia della mamma dopo quasi due settimane.
Nella mitologia greca, l'eroina Ifigenia viene sacrificata come vittima
propiziatoria dopo essere stata attratta in trappola con una proposta di nozze.
Il suo destino scatena sul padre e sulla famiglia interminabili sciagure.
Andrea Galli per il
“Corriere della Sera” il 20 dicembre 2022.
Chiediamo a
Mantalena Kaili cos' abbia da dire su questa sua (presunta) famiglia criminale:
la sorella Eva, ex vicepresidente del Parlamento europeo arrestata insieme al
compagno Francesco Giorgi, il loro papà sorpreso con un borsone pieno di soldi
sporchi, la sua stessa Ong, nel senso di Mantalena, sulla quale, secondo i
giornali greci, i magistrati starebbe indagando...
Ebbene Mantalena,
attiva nei settori delle consulenze e dell'innovazione sociale, risponde che non
ci sono verdetti ma unicamente «impressioni» mediatiche e di conseguenza della
gente, e che nel suo caso specifico manca qualsiasi tipo di base giudiziaria per
muovere accuse. Lei non ha ricevuto nulla, tant' è che domanda per quale motivo
dovrebbe commentare «illeciti che non risultano agli atti».
Fonti tra gli
investigatori greci ripetono che l'attuale narrazione sulle avventure
delinquenziali dei Kaili era inconcepibile in quanto davvero persone al di sopra
d'ogni cattivo pensiero fin dagli esordi professionali e politici a Salonicco.
Mantalena conosce bene Francesco Giorgi per averlo ospitato con Eva nella
propria casa di Atene durante la pandemia (sedici mesi), ma non vuole fare cenno
alcuno al 35enne di Abbiategrasso il cui padre è amico di antichissima data di
Antonio Panzeri.
Infatti i due, per
interessi di dichiarazioni dei redditi e di acquisizioni societarie, hanno
condiviso nel tempo i servizi della commercialista Monica Rossana Bellini, una
figura assai nota a Milano in virtù delle plurime apicali cariche che ha
ricoperto e ricopre a cominciare da «Milanosport», municipalizzata che detiene
il monopolio delle piscine, dall'ospedale Gaetano Pini e dalla «Sogemi», che
gestisce i mercati all'ingrosso.
Ma tornando a
Mantalena, si è letto di accertamenti mirati contro appunto la sua Ong, la
Elontech, che però Ong non sarebbe: si tratta al contrario, spiega la donna, di
un «Osservatorio scientifico sulle nuove tecnologie formato da giuristi e
accademici». Ha ricevuto finanziamenti dal Parlamento europeo? «Non ho ricevuto
un solo euro».
Ci sono stati dei
collegamenti con Bruxelles? «Abbiamo partecipato alla quarta conferenza
sull'intelligenza artificiale. Ospitata dal Parlamento europeo, ha avuto il
patrocinio della Repubblica greca» nonché «la collaborazione di Unesco,
Consiglio d'Europa e Ocse».
Dopodiché, «su Eva
ci sono indagini, ci sarà un processo» e staremo a vedere, insiste Mantalena,
fondatrice in aggiunta di una piattaforma che supporta iniziative legate ai
rifugiati.
Ulteriori
sollecitazioni per avere una più corposa difesa della famiglia, ottengono la
richiesta di formularle netti capi d'imputazione individuali altrimenti non ha
senso proseguire; il colloquio s' interrompe di colpo al terzo tentativo di
illustrarle i comportamenti di sorella e genitore. Che poi la Elontech abbia
un'ampia agenda di eventi e una ricca schiera di collaboratori rimane comunque
elemento d'interesse per i magistrati che puntano ad approfondire anche la
figura della commercialista Bellini (non indagata alla pari di Mantalena) la
quale, al Corriere , non ha concesso dichiarazioni.
Parziali ammissioni
su soldi e illegalità, chiede i domiciliari per passare Natale con la figlia
"Avevo detto a Francesco di stare attento a Panzeri". L'inchiesta si allarga ad
altri deputati
Monica Serra per “la
Stampa” il 20 dicembre 2022.
Maria Dolores
Colleoni lo ha ripetuto più volte davanti alla Corte d'Appello di Brescia: «Non
so nulla degli affari di mio marito». Ma, dopo cinque ore di camera di
consiglio, i giudici hanno dato il via libera alla consegna alle autorità belghe
della moglie 67enne dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri.
Ora i legali della
donna hanno cinque giorni per presentare ricorso davanti alla Corte di
Cassazione, che avrà altri dieci giorni per decidere. Solo dopo, se la richiesta
del giudice istruttore Michel Claise dovesse essere definitivamente accolta, la
67enne finirà in un carcere belga.
Colleoni, arrestata
con la figlia, l'avvocata Silvia Panzeri, il 9 dicembre a Calusco d'Adda, nella
Bergamasca, su mandato di arresto europeo, per associazione per delinquere,
corruzione e riciclaggio, ha preso la parola per fare alcune dichiarazioni
spontanee.
Avvolta in un
cappotto color cammello, dalla gabbia degli imputati, nel corso dell'udienza a
porte chiuse nell'aula al piano terra del palazzo di giustizia bresciano, ha
negato ogni cosa. Si è detta completamente «estranea» al lavoro del marito,
ritenuto con la sua Ong Fight Impunity «l'anima» di una organizzazione criminale
che avrebbe usato le tangenti di Qatar e Marocco per corrompere «un gruppo
indeterminato e molto ampio di persone operante all'interno di strutture
europee, con o senza legami con l'Unione» e «condizionare» le politiche europee
a favore dei Paesi corruttori.
Colleoni ha negato
aver fatto vacanze da 100 mila euro come sostiene la polizia federale belga. Di
aver avuto un qualche «controllo» sulla gestione di conti correnti dell'ex
segretario della Camera del lavoro di Milano. La donna ha anche negato di aver
partecipato al trasporto di preziosi «doni» ricevuti, secondo l'accusa,
dall'ambasciatore del Marocco in Polonia, Abderrahim Atmoun: «Colleoni ha
dichiarato di aver ricevuto solo creme, regali di poco conto», ha ricostruito il
difensore Angelo De Riso.
Le parole della
donna non sono bastate a evitare la decisione dei giudici che non hanno valutato
nel merito le accuse ma, con una lunga e motivata sentenza, hanno ritenuto gli
elementi di prova raccolti da Bruxelles come «idonei» in diritto a integrare
anche in Italia le ipotesi di reato contestate. La Corte d'Appello ha però
stabilito che «se, al termine del processo in Belgio, Colleoni dovesse essere
condannata in via definitiva, potrà scontare la pena o un'eventuale misura di
sicurezza in Italia», ha sottolineato la difesa, gli avvocati De Riso e Nicola
Colli, che certamente ora si rivolgeranno alla Cassazione.
Per gli inquirenti
belgi tanto la donna, quanto la figlia Silvia, erano «pienamente consapevoli»
degli «intrallazzi» di Panzeri. Tanto che, si legge nel Mae, il termine veniva
utilizzato proprio dalla 67enne quando, intercettata, spiegava ad altri i tanti
viaggi di lavoro del marito. Mentre a Brescia oggi si deciderà anche sulla
consegna di Silvia Panzeri, la procura di Milano, che invece sta indagando in
base a un ordine di investigazione europeo, a breve interrogherà i genitori
dell'assistente parlamentare Francesco Giorgi con le garanzie degli «indagati»:
nel mirino ci sarebbero, tra le altre cose, bonifici partiti dall'Italia a
favore del figlio per l'acquisto di un immobile a Bruxelles.
Estratto
dell’articolo di Sandro De Riccardis per milano.repubblica.it il 20 dicembre
2022.
Un "compendio
indiziario sufficiente". La sintesi giuridica utilizzata dal collegio della
Corte d'Appello di Brescia ha superato ieri ogni argomento che i legali di Maria
Dolores Colleoni hanno utilizzato in aula per impedire che venisse dato l'ok
alla consegna della loro assistita alle autorità belghe.
E sebbene la moglie
dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri abbia "negato gli addebiti", la
sentenza della Corte ha fondato la propria decisione sugli stessi elementi
d'indagine contenuti nel Mae, il Mandato di cattura europeo, notificato dalla
procura di Bruxelles alle autorità italiane. "Sussistono gravi indizi di
colpevolezza", scrive così il collegio presieduto da Anna Dalla Libera.
Per esempio il
riferimento al "giant", il diplomatico marocchino Atmoun, ambasciatore in
Polonia. "I coniugi utilizzano le carte di credito di una terza persona che
chiamano "il gigante"", riporta il collegio bresciano nella sentenza. In più il
tribunale fa riferimento ai dialoghi tra marito e moglie in cui i due parlano
della grande disponibilità di denaro utilizzata in vacanze all'estero e spese di
albergo.
Quelle conversazioni
in cui la donna svela "una vacanza da 100 mila euro come l'anno scorso" e
un'altra nella quale sembra rimproverare il marito per la "proposta attuale da
9mila euro per un soggiorno a persona" ritenuto eccessivo.
E' stato respinto
anche l'argomento difensivo secondo cui trasferire una indagata ai domiciliari
in un carcere estero possa configurare una violazione dei diritti dell'uomo.
"Non ci sono elementi ostativi" al trasferimento anche perché "non c'è un
procedimento penale in Italia sugli stessi fatti" per cui procede la procura
belga. […]
Lo stesso rilievo
sulle condizioni carcerarie belghe è stato avanzato oggi. Non con una memoria
difensiva, ma in via preliminare, con una eccezione all'inizio dell'udienza. E'
questo che ha portato alla sospensione del procedimento relativo alla figlia di
Colleoni, Silvia Panzeri, e al rinvio al 3 gennaio. […]
Da open.online il 21
dicembre 2022.
Davanti ai
magistrati belgi, l’ex europarlamentare Antonio Panzeri ha fatto le prime
ammissioni dicendosi disposto a collaborare con gli inquirenti e puntando il
dito contro il deputato europeo del Pd Andrea Cozzolino, finora non indagato e
neanche mai interrogato. Nel verbale della procura federale di Bruxelles,
riportato da il Fatto Quotidiano, Panzeri dice: «L’accordo prevedeva che avremmo
lavorato per evitare delle risoluzioni contro i Paesi e in cambio avremmo
ricevuto 50mila euro».
Panzeri accusa l’ex
collega belga Marc Tarabella, per poi invitare i magistrati ad approfondire il
ruolo di Cozzolino. Panzeri avrebbe riconosciuto solo una parte delle
contestazioni che gli vengono fatte nell’inchiesta che lo vede per gli
inquirenti protagonista del traffico di mazzette pagate da Marocco e Qatar per
influenzare le decisioni del Parlamento europeo. Stando a quanto scoperto dal
Vsse, il servizio segreto belga che ha dato inizio all’indagine, l’attività di
ingerenza di Panzeri a favore del Marocco sarebbe iniziata almeno dal 2014,
mentre il rapporto con il Qatar risale al 2018.
Le accuse a
Cozzolino
Il verbale di
interrogatorio di Panzeri è stato redatto davanti al giudice istruttore Michel
Claise il giorno dopo l’arresto del 9 dicembre, quando sono scattate le prime
misure cautelari anche nei confronti dell’ex collaboratore Francesco Giorgi,
della compagna di quest’ultimo, l’ex vicepresidente dell’Europarlamento Eva
Kaili, e del sindacalista Luca Visentini poi rilasciato. Davanti al giudice,
Panzeri ha iniziato a fare i primi nomi: «Io aggiungo che non ho prove ma voi
dovreste controllare il presidente attuale della delegazione del Maghreb», vale
a dire Cozzolino. «È il parlamentare di cui Giorgi è l’assistente… Tra l’altro
questo parlamentare è responsabile di chiedere risoluzioni d’urgenza, ma questo
non passa da noi, questo passa direttamente quindi non conosco bene la base ma
so che è successo».
Gli incarichi di
Cozzolino
Panzeri cita le
«risoluzioni d’urgenza», cioè quella procedura accelerata che in una settimana
può portare un testo al voto dell’aula, evitando così di passare dalle
commissioni che potrebbero anche rallentare di mesi l’iter per l’approvazione.
L’ex europarlamentare avrebbe quindi spinto gli inquirenti a guardare meglio
l’attività di Cozzolino come presidente della delegazione del Maghreb, lo stesso
incarico ricoperto dallo stesso Panzeri dal 2009 al 2017.
Negli atti
dell’inchiesta, gli inquirenti si soffermano anche su un altro incarico di
Cozzolino, cioè quello di membro nella commissione speciale del Parlamento Ue
che indaga sull’uso di Pegasus, lo spyware di fabbricazione israeliana di cui il
Marocco è accusato di aver fatto largo uso anche su leader europei.
L’informativa dell’intelligence belga spiega che Cozzolino avrebbe iniziato
l’attività di ingerenza per il Marocco dal 2019, ma il suo nome sulle mazzette
pagate dal Qatar non compare, se non quando viene citato da Panzeri.
Giuseppe Guastella
per corriere.it il 20 dicembre 2022.
Un «accordo» per
«evitare delle risoluzioni contro i Paesi e in cambio abbiamo ricevuto 50 mila
euro»: nell’interrogatorio dopo l’arresto del 9 dicembre, un Antonio Panzeri
«pronto a collaborare» ammette ciò che non può negare dopo che le indagini dei
sevizi segreti e della magistratura hanno accumulato prove ed indizi contro di
lui e contro Francesco Giorgi, il suo socio negli affari della Ong Fight
impunity. Il secondo aveva fatto lo stesso anche perché, come l’ex
europarlamentare di Pd e Articolo 1, gli avevano trovato una quantità di
contanti impossibile da giustificare, tra tutti e due un milione e mezzo di
euro.
Dalle dichiarazioni
di Panzeri, per come le ha rivelate il sito il fattoquotidiano.it, emerge
l’intenzione di circoscrivere per quanto possibile le proprie responsabilità ad
una azione spregiudicata di lobbismo a favore di Paesi che, come Qatar e
Marocco, avevano bisogno di migliorare la propria immagine che eventuali
risoluzioni su temi problematici come i diritti umani d’urgenza avrebbero potuto
offuscare.
L’accordo con il
Marocco sarebbe partito nel 2019 quando Panzeri era ancora europarlamentare
attraverso Abderrahim Atmoun, l’ambasciatore del Marocco in Polonia con il quale
aveva contatti assidui monitorati costantemente dai servizi segreti del Regno
del Belgio. Il compito di Panzeri e degli altri coinvolti nell’inchiesta sembra
dovesse essere quello di bloccare questi missili politici persuadendo i
parlamentari, si sospetta anche a suon di mazzette e regali.
Panzeri fa il nome
di Andrea Cozzolino, il deputato europeo sospeso dal Pd per questa vicenda, che
nel 2019 prese il suo posto nella delegazione Maghreb dell’assemblea, anche se
dice che su di lui non ha prove. Uomo di contatto tra i due è Francesco Giorgi
che dopo essere stato assistente di Panzeri passò a Cozzolino. Spunta anche un
riferimento al parlamentare belga di origini italiane Marc Tarabella (perquisito
nel blitz del 9 dicembre) di cui Panzeri dice che avrebbe preso regali dal
Qatar, mentre esclude il coinvolgimento di Luca Visentini, il segretario del
Confederazione internazionale dei sindacati (arrestato e immediatamente
scarcerato), e di Niccolò Figà-Talamanca, segretario della Ong No peace without
justice che è ai domiciliari ed al quale ieri è stato sequestrato un
appartamento a Cervinia su richiesta dei magistrati belgi.
Uno dei punti
incontrovertibili della vicenda che sta sconvolgendo la politica parlamentare
europea è la presenza di oltre 750 mila euro nella casa che la ex vice
presidente Eva Kaili divide con il compagno Giorgi e di altri 600 mila in quella
di Panzeri. È un fatto di una tale gravità incompatibile per chiunque, a
cominciare da chi ha incarichi politici. La socialista greca ha tentato di
uscirne ammettendo ciò che non poteva negare. «Tutto è successo in quelle ore,
quando ha visto i soldi, non ha avuto una risposta convincente sull’origine e ha
subito chiesto che uscissero di casa», aveva detto il suo avvocato Michalis
Dimitrakopoulos riportando le dichiarazioni della cliente dopo l’arresto.
Secondo fondi di
stampa belghe ed italiane, nella documentazione dei magistrati integrata da
informative dei servizi segreti a verbale Kaili avrebbe ammesso: «Conoscevo le
attività di Panzeri. E sapevo che a casa mia c’erano delle valigie piene di
soldi», frase che dà l’idea di una consapevolezza di vecchia data, ammesso che
tra greco, italiano e francese le traduzioni siano così accurate da cogliere le
sfumature. Forte del fatto che non si sa di bene di cosa sia accusata, e che
detenere tanto denaro di per sé non è reato, Dimitrakopoulos ieri smentisce:
«Non ha mai confessato di aver chiesto a suo padre di trasferire denaro per
nasconderlo»; «ha saputo di questi soldi all’ultimo minuto» e «chiese subito che
andasse al loro proprietario, il signor Panzeri». Comunque, non aveva «alcun
obbligo di denunciare».
Mentre la procura
federale apre un'inchiesta sulle fughe di notizie dopo un esposto degli avvocati
degli arrestati, Emergono frammenti di intercettazioni che sembrano chiarire la
storia dei regali della famiglia Panzeri e dell’ambasciatore del Marocco
Abderrahim Atmoun. Il 4 giugno 2022 Maria Colleoni, moglie di Panzeri (ai
domiciliari), intercettata dagli 007 di Bruxelles con la figlia Silvia, forse
dopo aver passato la dogana in uscita dall’aeroporto in Marocco, chiama il
marito dicendogli che «tutto è andato bene, siamo stati fatti passare come vip»
e di aver preso un caffé con l’ambasciatore, che evidentemente le stava
aspettando.
Secondo
l’intelligence belga, il viaggio era servito a far entrare nel paese regali
ricevuti per la «attività di interferenza» di Panzeri sul Parlamento. Un’altra
intercettazione, riportata da Le Soir , registra una conversazione di fine
luglio 2022 nella casa dei Panzeri a Calusco d’Adda, non si sa fatta come, in
cui la donna si augura che «non entrino qui» perché troverebbero «qualsiasi
cosa».
Corruzione
Qatar. Decisione rinviata a gennaio per Silvia Panzeri. Eva Kaili confessa.
Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 20 Dicembre 2022.
Dopo la decisione
della corte di autorizzare la consegna della madre, oggi la corte d'appello ha
deciso di rinviare al 3 gennaio su richiesta della difesa per valutare le
condizioni di sovraffollamento delle carceri in Belgio.
E’iniziata alle
12,30 di oggi a Brescia l’udienza sulla “richiesta di consegna” chiesto dalle
autorità di Bruxelles di Silvia Panzeri, l’avvocata figlia dell’ex
europarlamentare Pd-Articolo 1 Antonio Panzeri. Ieri si era svolta l’udienza
che ha deciso il trasferimento della madre, Maria Dolores Colleoni, chiesto
dalla magistratura belga. La Corte d’appello di Brescia su richiesta della
difesa ha deciso oggi di rinviare al prossimo 3 gennaio l’udienza per valutare
le condizioni delle carceri in Belgio, in relazione al sovraffollamento. Un
chiaro tentativo dei difensori di ostacolare il trasferimento in Belgio
della Panzeri.
La donna è
accusata come i suoi genitori Antonio Panzeri e Maria Dolores Colleoni di
“associazione a delinquere“, “corruzione” e “riciclaggio”. Secondo gli
inquirenti belgi, le due donne erano «pienamente consapevoli» dei traffici di
soldi e favori con Qatar e Marocco. E avrebbero anche trasportato i regali fatti
arrivare dal Marocco tramite il suo ambasciatore in Polonia, Abderrahim Atmoun.
Regali che Maria Colleoni ha cercato di ridimensionare all’udienza di ieri,
parlando di creme. Silvia Panzeri si trova agli arresti domiciliari come la
madre, è entrata in tribunale dal passo carraio del tribunale per sfuggire ai
flash dei fotografi e delle telecamere, mentre i suoi legali Angelo de Riso e
Nicola Colli l’attendevano in aula.
Il mandato di
arresto europeo era stato eseguito dai Carabinieri lo scorso 9 dicembre
nell’abitazione della famiglia Panzeri a Calusco d’Adda (Bergamo) dove la
successiva perquisizione ha consentito di trovare 17mila euro e orologi di
valore. Dopo l’arresto, convalidato, il Gip aveva applicato la misura cautelare
degli arresti domiciliari. Ora alla difesa dell’indagata resta il ricorso in
Cassazione – da depositare entro cinque giorni – per bloccare la decisione
odierna ed evitare che la 67enne Maria Dolores Colleoni venga trasferita in un
carcere in Belgio.
Sono state rese
note le motivazioni dei giudici riguardo la posizione della Colleoni. Per i
magistrati “sussistono gravi indizi di colpevolezza”. Il collegio, diverso da
quello odierno, ha rigettato anche la richiesta della difesa di verificare il
trattamento carcerario belga ritenuto che “non sono stati addotti gravi e
persistenti problemi di malfunzionamento del sistema penitenziario“.
Eva Kaili
confessa. E Panzeri accusa Tarabella
L’ex
vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre
scorso nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate, davanti agli inquirenti ha
ammesso di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro e di
essere a conoscenza dell’attività portata avanti dal marito, Francesco Giorgi,
con l’ex eurodeputato Antonio Panzeri, entrambi in carcere. Lo scrive il
quotidiano belga Le Soir in base a documenti visionati insieme al
settimanale Knack. Anche Panzeri ha riconosciuto in parte il suo coinvolgimento,
puntando poi il dito sull’ex collega socialista Marc Tarabella come beneficiario
dei “regalì” del Qatar.
La prima udienza
davanti alla camera di consiglio del tribunale di Bruxelles dell’ex
vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre
scorso nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate, si terrà giovedì 22 dicembre
alle 9. Lo comunica la Procura Federale del Belgio. I giudici belgi dovranno
decidere se prolungare la detenzione della politica ellenica, oppure se
rilasciarla con o senza condizioni.
Redazione CdG
1947
Accuse
incrociate sui soldi. Una casa a Cervinia sequestrata al capo dell'ong.
Mezze
ammissioni. E pure qualcosa in più. Per Il Fatto Quotidiano siamo ad una svolta:
"Sono pronto a collaborare", afferma Antonio Panzeri davanti agli inquirenti.
Stefano Zurlo il 21 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Mezze ammissioni.
E pure qualcosa in più. Per Il Fatto Quotidiano siamo ad una svolta: «Sono
pronto a collaborare», afferma Antonio Panzeri davanti agli inquirenti, prima di
offrire su un piatto d'argento la testa dell'eurodeputato belga di origine
italiana Marc Tarabella: «È andato in Qatar». E secondo il quotidiano belga Le
Soir i regali erano per lui.
Tarabella era già
nel mirino degli inquirenti e nei giorni scorsi la sua abitazione era stata
perquisita alla presenza del presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola
ma ora la sua posizione si complica. D'altra parte, tutti gli indagati sono
stati costretti a rivedere la propria strategia alla luce della rapidissima
evoluzione dell'inchiesta che sta travolgendo le istituzioni europee. Anche
l'ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, che oggi compare
davanti ai giudici chiamati a pronunciarsi sul suo destino, ha cambiato
posizione e ha ammesso in sostanza di conoscere il giro vorticoso di tangenti
manovrate dal marito Francesco Giorgi. D'altra parte insistere sulla sua
assoluta estraneità sarebbe stato una sorta di suicidio: il 9 dicembre scorso,
mentre il blitz era in corso e l'indagine usciva allo scoperto, perse
letteralmente la testa: mandò il padre a compiere una missione disperata,
recuperare e far sparire borsoni colmi di banconote cercando di bruciare sul
tempo gli investigatori; risultato: il papà venne bloccato in uno dei più
lussuosi hotel di Bruxelles, il Sofitel, mentre la figlia commetteva un'altra
imperdonabile sciocchezza: «Cercava di avvertire Panzeri e altri due
eurodeputati della presente inchiesta», è scritto nelle carte.
È scattato così
l'arresto per flagranza di reato. Tutto questo accade mentre sul fronte italiano
le difese ottengono un risultato che assomiglia a una vittoria, sia pure
parziale: l'avvocato Angelo De Riso, che tutela Silvia, figlia dell'ex
eurodeputato, sottolinea le criticità del sistema penitenziario belga, insomma
il sovraffollamento già denunciato in un report pubblicato dal Consiglio
d'Europa, e così spinge la corte d'appello di Brescia a disporre una verifica e
a far slittare la decisione al 3 gennaio.
Un successo e
anche una capriola dei giudici bresciani: 24 ore prima, nell'udienza che
riguardava la moglie di Panzeri, Maria Dolores Colleoni, la magistratura era
andata dritta per la propria strada rifiutando lo stesso controllo che viene
accordato alla figlia. Cambia la decisione, non il percorso parallelo delle due
donne: prima di essere spedita in Belgio; la moglie si giocherà la carta del
ricorso in cassazione e in quell'occasione verrà riproposto il tema delle
prigioni.
Certo, per la
magistratura belga le due donne, madre e figlia, «sono pienamente» consapevoli
degli «intrallazzi» e dunque sarebbero parte della rete criminale messa in piedi
da Panzeri, sfruttando i suoi rapporti privilegiati con il Qatar e il Marocco.
Fra l'altro un'intercettazione del 4 giugno dà lo spessore delle trame
sviluppate dalla famiglia: Panzeri chiama le due donne che sono a Rabat. «È
andata bene, ci hanno fatto passare per vip, siamo andate da Atmoun per un
caffè», afferma la moglie riferendosi all'ambasciatore del Marocco in Polonia
Abderrahim Atmoun. Subito dopo, Panzeri parla proprio con lui: chiede «per la
cosa di sua figlia», «per la bozza di convenzione» che sta per spedirgli, per
capire se può andare bene. Si tratta evidentemente di un contratto, forse una
consulenza giuridica, che riguarderebbe «il Consiglio dei marocchini nel mondo».
Dunque, affari e oboli mascherati. Intanto, Panzeri, spalle al muro, inizia a
collaborare: «Avremmo lavorato - spiega nei verbali - per evitare risoluzioni
contro i Paesi» amici «e in cambio avremmo ricevuti 50 mila euro». Poi mette nei
guai Tarabella, presunto destinatario, secondo il ben informato Le Soir, di doni
dal Qatar. E ancora accende i riflettori su Andrea Cozzolino, invitando a
verificare il suo delicato ruolo di Presidente della delegazione per il Maghreb.
Ieri intanto, su richiesta della procura, il gip ha sequetrato una casa a
Cervinia a Nicolò Figà-Talamanca, fondatore della Ong «No peace without
justice».
DAGONEWS il 21
dicembre 2022.
Emiri contro. Ogni
giorno che passa, si rinforzano sempre di più le voci che sostengono che dietro
al Qatargate ci sia la manona degli Emirati Arabi Uniti, nemici storici di Doha
nel Golfo Persico. Un'ipotesi ventilata ormai apertamente dai qatarini (vedi
articolo di Enrico Currò su "Repubblica").
Il presidente
emiratino, Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, avrebbe lasciato campo libero
a suo fratello, Tahnoun bin Zayed Mohammed Al Nahyan, consigliere della
sicurezza nazionale dello stato arabo.
Sarebbe stato
proprio Tahnoun, capo de facto dei servizi segreti di Abu Dhabi, a spifferare
tutto al Belgio, innescando la valanga che sta travolgendo il Parlamento
europeo.
Recentemente,
Tahnoun bin Mohammed è salito alle cronache per una tentata operazione in
Israele.
Gli Emirati Arabi
Uniti, tramite la holding Abu Dhabi ADQ Developmental, guidata proprio dal
fratello del presidente, hanno tentato infatti di comprare una quota
significativa della prima compagnia assicurativa dello stato ebraico, il gruppo
“Phoenix”, che controlla la quota più importante di fondi pensioni di
Gerusalemme.
Tahnoun, che aveva
carta bianca da parte del fratello, ha provato a portare a casa l’operazione,
ricevendo come risposta un no secco da parte del governo israeliano.
Lui ha provato a
giocarsi la carta degli accordi di Abramo, l’intesa siglata tra Israele e
Emirati Arabi per la normalizzazione dei rapporti diplomatici, ma niente.
I rapporti economici
tra i due stati, come ricordava due giorni fa il “Jerusalem Post”, hanno avuto
una svolta impressionante dalla firma di quegli accordi: a maggio è stato
siglato un patto di libero commercio, e il volume degli scambi ha raggiunto i
2,5 miliardi di dollari. Quindi perché gli israeliani hanno sbattuto la porta in
faccia agli emiri? Come ricorda il quotidiano, di orientamento di centro-destra,
c’è un ma.
“In primo luogo,
alcuni funzionari degli Emirati Arabi Uniti hanno lamentato una burocrazia
farraginosa che rende difficile per gli emiratini fare affari qui.
In secondo luogo,
alcuni israeliani affermano che una cosa è se le aziende private degli Emirati
Arabi Uniti investono nell'hi-tech e nelle imprese israeliane, ma Israele vuole
davvero vendere una quota di controllo di importanti istituzioni finanziarie a
società statali di Paesi con cui non aveva relazioni diplomatiche solo tre anni
fa?
Vuole davvero che un
Paese arabo del Golfo sia il custode del suo più grande fondo pensionistico, e
che abbia accesso alle informazioni sensibili di centinaia e migliaia di suoi
cittadini, che sono legate al controllo di tali fondi?
Cosa accadrebbe se
le relazioni con gli Emirati Arabi Uniti si inasprissero improvvisamente per un
motivo o per l'altro? Dopo tutto, siamo in Medio Oriente e sono successe cose
più strane”.
Tahnoun bin Zayed
non avrebbe accettato il no, e starebbe spingendo per chiudere comunque
l’operazione, rendendola la prima grana da sbrogliare per il nascente governo di
Benjamin Netanyahu: “Si tratta di una questione diplomatica - scrive ancora il
"Jerusalem Post" -. Quale messaggio invierà Israele agli Emirati Arabi Uniti se
gli organi normativi israeliani respingeranno l'accordo, dicendo essenzialmente
all'alleato dell'Accordo di Abramo che Israele è interessato ai suoi
investimenti, ma non in tutti i settori?
A rendere ancora più
complicato un simile rifiuto è il fatto che Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan,
fratello del leader emiratino Mohammed bin Zayed Al Nahyan, è a capo della
holding emiratina che vuole acquistare la partecipazione in Phoenix”.
Insomma, gli
israeliani hanno molti dubbi sull’operazione, ma Tahnoun se ne sta altamente
sbattendo, e lo stato ebraico si trova di fronte a un bel dilemma tra stato di
necessità (i soldi) e opportunità (la sicurezza nazionale). Conclude il
"Jerusalem Post": “Se vendere o meno un asset finanziario strategico come
Phoenix agli Emirati Arabi Uniti è una decisione che Israele deve prendere da
solo. Non sarà una decisione facile, poiché da un lato il Paese vuole mantenere
le sue istituzioni finanziarie critiche in mani nazionali. Dall'altro, però,
vuole approfondire e ampliare i legami con gli Emirati Arabi Uniti in tutte le
sfere: sicurezza, intelligence ed economia”.
Estratto
dell’articolo di Enrico Currò per “la Repubblica” il 21 dicembre 2022.
Il luogo
dell'incontro è evocativo: l'hotel che ha ospitato una tra le squadre
protagoniste del Mondiale di calcio appena concluso, causa primaria del
Qatargate. L'interlocutore è un esponente di spicco del Paese del Golfo. È molto
vicino alla famiglia reale e al governo. E proprio per illustrarne la posizione
sulla vicenda, ha accettato di parlare con Repubblica.
Partendo da una
puntualizzazione: se dall'inchiesta belga sulle mazzette agli europarlamentari,
per ammorbidirli sulla discussa immagine internazionale del Qatar, emergesse il
coinvolgimento di un cittadino qatarino, il governo di Doha sarebbe pronto a
punirlo, quale che fosse il suo status: «Lo faremmo sicuramente. Nel recente
passato, non abbiamo esitato ad arrestare il ministro delle Finanze. Non abbiamo
alcun problema, siamo molti limpidi. Ma devono darci una sola prova, devono
portarla in tribunale. E noi le prove non le vediamo». Al momento, dunque, è
impossibile ipotizzare una collaborazione con la magistratura belga.
Quanto all'eventuale
taglio delle forniture di gas all'Europa come conseguenza delle misure del
Parlamento europeo contro il Qatar, adombrato domenica scorsa da una fonte
diplomatica di Doha, il sottile distinguo è di natura economica: «Per il gas il
nostro mercato è prevalentemente asiatico, con contratti lunghi: 27 anni la
Cina, 15 l'India e il Giappone, ad esempio. Non abbiamo intenzione di fermare
alcuna fornitura, non l'abbiamo fatto nemmeno con gli Emirati, malgrado il
blocco contro di noi nel 2017, perché rispettiamo i nostri contratti. Il
problema dell'Europa è che li vuole brevi, di 1 o 2 anni. Ma dovremmo
abbandonare qualche cliente asiatico e a queste condizioni non esiste
possibilità». […]
Il guaio è diventato
appunto il Qatargate, mentre trapelano le voci su un'indagine della magistratura
qatarina per verificare se, nel giro d'affari da 200 miliardi di dollari per la
costruzione delle infrastrutture del Mondiale, ci siano stati episodi di
malversazione e di truffa ai danni dello Stato. «Non ne sappiamo nulla, ma nel
caso non faremmo sconti a nessuno: siamo cristallini». […]
Tuttavia l'inchiesta
della magistratura belga è un nervo scoperto. L'irritazione del governo per il
danno d'immagine internazionale emerge sui media locali, che per la prima volta,
su Doha news, ne hanno parlato ieri, rilanciando le accuse all'Ue di muoversi
secondo "pregiudizi precostituiti" (il Marocco, coinvolto nelle carte di
Bruxelles, non è stato citato dall'Ue).
Il Qatar si sente
vittima dal 2017 di un attacco mediatico orchestrato da Abu Dhabi, con documenti
falsi e fake news. La tesi fa breccia tra i tavolini dei caffè di lusso nel
porticciolo di The Pearl («è tutta una montatura occidentale», si irrita Sara,
imprenditrice qatarina, «qui le donne sono tutt' altro che discriminate »)
[...]
A cinque minuti
d'auto dal grattacielo del ministero del Lavoro, dove il ministro Ali Bin Samikh
Al Barri incontrò il 31 ottobre scorso Eva Kaili, la vicepresidente del
Parlamento europeo arrestata il 10 dicembre, l'interlocutore di Repubblica
rassicura se stesso: «Tre cose contano per un qatarino: famiglia, rapporti con
gli altri popoli, reputazione del nostro Paese. I soldi vengono assolutamente
dopo».
Giacomo Amadori e
François De Tonquédec per “La Verità” il 21 dicembre 2022.
Nel decreto di
perquisizione e di ispezione dei sistemi informatici emesso dalla Procura di
Milano (in esecuzione di un ordine europeo di indagine) nei confronti di Pier
Antonio Panzeri sono elencati dieci nomi. I quali, secondo gli inquirenti,
rappresenterebbero la rete dell'ex eurodeputato pd.
Il procuratore
aggiunto Fabio De Pasquale ha chiesto agli uomini delle Fiamme gialle inviati a
casa dell'ex sindacalista a Calusco d'Adda (Bergamo) di andare alla ricerca di
«titoli, contanti, oro, orologi di valore, di documenti, anche informatici,
relativi a conti bancari in Italia e all'estero, presso la Lift bank (Brasile) e
altrove; tutti i documenti, anche informatici, relativi alle relazioni con il
Marocco e con il Qatar; tutti i documenti, anche informatici, o altri oggetti
relativi alle seguenti persone». E subito dopo, con numeri romani, viene stilato
un elenco di dieci soggetti che evidentemente a giudizio degli inquirenti belgi
formerebbero il cerchio magico di Panzeri.
Al primo posto c'è
Francesco Giorgi, l'ex assistente parlamentare arrestato a Bruxelles e tuttora
in carcere. È considerato una figura chiave dell'inchiesta e sembra aver
coinvolto nei suoi magheggi anche il padre Luciano e il fratello Stefano, i
quali hanno dato vita a una Srl chiamata Equality consultancy, che offriva
servizi nel settore delle relazioni internazionali e delle organizzazioni non
governative.
C'è poi il capo
mondiale dei sindacalisti Luca Visentini che, come rivelato dalla Verità, ha
ricevuto tre buste con circa 50.000 euro da Panzeri come finanziamento all'Ituc
(«Sotto forma di donazione per rimborsare alcuni costi della mia campagna per il
congresso»).
La lista continua
con Giuseppe Meroni, già collaboratore all'Europarlamento prima di Panzeri e
poi, per pochi mesi, dell'eurodeputata Lara Comi , che lo ha immediatamente
licenziato dopo lo scoppio dello scandalo; con Nicolò Figà Talamanca, segretario
generale della Ong No peace without justice, organizzazione fondata da Emma
Bonino. Figà Talamanca è ancora in carcere anche perché uno dei principali
indagati dell'inchiesta, Francesco Giorgi, spiegava ai suoi interlocutori che le
Ong servivano per far girare i soldi. Ieri il gip di Aosta ha fatto sequestrare
in via preventiva la casa di Cervinia comprata dalla sua società Nakaz
Development: un acquisto al centro del filone per riciclaggio di cui avevamo
dato notizia in esclusiva.
Al quinto posto c'è
Simona Russo, segretaria della Ong di Panzeri, Fight Impunity. Al sesto Carlo
Bittarelli, ex consulente politico del gruppo dei Socialisti e democratici,
nonché impiegato nella sub commissione per i diritti umani del Parlamento
europeo, presieduta sino al 2019 proprio da Panzeri. La settima piazza è
riservata a Eva Kaili, ex vicepresidente dell'Europarlamento, la quale, come
vedremo, ha iniziato a scaricare le responsabilità sull'ex sindacalista della
Cgil di origini bergamasche. Segue Mychelle Rieu, ovvero la capo segreteria
della già citata subcommissione.
Tra il 14 e il 15
dicembre alla donna è stato perquisito e sigillato l'ufficio. Al nono posto c'è
Donatella Rostagno, assistente dell'europarlamentare belga di origini italiane
Maria Arena. L'ultimo dell'elenco è Davide Zoggia, ex deputato pd e oggi
assistente dell'europarlamentare Pietro Bartolo (ex sindaco di Lampedusa), suo
compagno di partito. Ricordiamo che il figlio di Bartolo, Giacomo, è stato
assunto per un periodo, a 1.900 euro al mese, presso la Ong di Panzeri.
Ovviamente questo
presunto network è in fase di verifica e molte delle figure indicate potrebbero
presto allontanare da sé i sospetti del giudice istruttore Michel Claise. Il
quale, in questa caccia ai ladri, è assistito da due poliziotti (entrambi
«ispettore principale») di grande esperienza: Bruno Arnold e Ceferino Alvarez
Rodriguez.
Quest' ultimo si è
occupato di criminalità organizzata, riciclaggio e finanziamento al terrorismo
per 26 anni, per poi passare all'ufficio centrale per la lotta alla corruzione.
Risulta consulente esperto dell'Unodc, cioè l'ufficio delle Nazioni unite per il
controllo della droga e la prevenzione del crimine. Ieri quando abbiamo
contattato Arnold, quest' ultimo, prima di interrompere la chiamata, ci ha solo
chiesto: «Chi vi ha dato il mio numero di cellulare?».
Ieri, intanto, la
Corte d'appello di Brescia ha rinviato al 3 gennaio l'udienza sull'estradizione
di Silvia Panzeri. I giudici italiani cercheranno informazioni sulle condizioni
carcerarie in Belgio, prima di decidere se consegnare o meno la donna. In
Marocco la trentottenne bergamasca e la madre, Maria Dolores (Colleoni),
sarebbero state trattate come personalità di rilievo. Una serie di
intercettazioni effettuate dalla Sûreté nationale (il servizio segreto belga),
che il quotidiano Le Soir ha divulgato ieri, offre un quadro del contesto che ha
portato le autorità a chiedere l'arresto e l'estradizione.
Il 4 giugno 2022 le
donne sono in Marocco. Panzeri chiama la consorte per chiedere notizie. La
Colleoni risponde: «È andato tutto bene, siamo state presentate come Vip, siamo
andati da Atmoun (Abderrahim, un diplomatico marocchino citato negli atti, ndr)
a prendere un caffè». A quel punto Panzeri sembra alludere ai «regali» citati
nei mandati di cattura: «Hai visto le scatole?». La Colleoni risponde: «Sì,
viste! Perché dopo ha infilato qualche prodotto nei sacchetti prima di andare
via! Eh eh!».
Gli investigatori
annotano che Panzeri ricambia la risata.
L'intercettazione è
contenuta in una nota dei servizi belgi, declassificata per l'invio alla Procura
federale. Gli 007 di Bruxelles sono convinti che il viaggio non fosse di
piacere, ma avesse come scopo «riportare (in Italia, ndr) possibili retribuzioni
per attività di ingerenza a favore del Marocco». È la telefonata che ha portato
ai domiciliari le due donne.
Nei mandati di
cattura internazionali, come prova del loro presunto coinvolgimento, è annotato
che «sembrano essere pienamente a conoscenza delle attività del loro
marito/padre e si occupano persino del trasporto dei "doni" dati in Marocco da
Abderrahim Atmoun, l'ambasciatore del Marocco in Polonia». Poche ore dopo la
telefonata è lo stesso Atmoun a confermare a Panzeri (che accoglie la notizia
con una risata) di aver messo «prodotti» nella borsa della moglie.
Poi i due parlano di
affari e Panzeri chiede notizie sulla «cosa di sua figlia» alla quale intende
far scrivere una «bozza di convenzione», apparentemente riferita al «consiglio
dei marocchini nel mondo» che avrebbe inviato lui stesso ad Atmoun. Il
diplomatico conferma e parla di un contratto «per l'anno». In un'intercettazione
ambientale risalente a fine luglio 2022 nella residenza italiana della coppia,
trascritta dalla Sûreté nationale, parlano di beni acquisiti in modo
potenzialmente illecito. I belgi hanno piazzato nell'appartamento italiano dei
Panzeri delle microspie e queste hanno intercettato una frase della Colleoni,
considerata molto importante, ma che tradotta in francese dagli inquirenti, non
risulta chiarissima: «Dobbiamo sperare di non tornare qui, troveremmo di tutto e
di più!».
Il quotidiano belga
ricorda che proprio in quella abitazione gli investigatori italiani hanno
rinvenuto 17.000 euro in contanti.
Panzeri intanto
avrebbe iniziato a collaborare e avrebbe spiegato che cosa prevedesse l'accordo
occulto: «Che avremmo lavorato per evitare delle risoluzioni contro i Paesi e in
cambio avremmo ricevuto 50.000 euro». Poi, però, avrebbe accusato l'ex collega
belga Marc Tarabella e fatto allusioni anche su Andrea Cozzolino: «Non ho prove,
ma voi dovreste controllare il presidente attuale della delegazione del
Maghreb».
Intanto, seguendo le
orme del compagno Giorgi, anche l'ex vicepresidente (S&D) del Parlamento
europeo, la greca Eva Kaili, avrebbe iniziato a parlare con i magistrati. In
particolare avrebbe ammesso di essere stata lei a chiedere a suo padre di
nascondere i 600.000 poi rinvenuti nel trolley che l'uomo aveva con sé. Il
genitore è stato fermato poche ore dopo l'arresto di Giorgi, mentre cercava
rifugio al Sofitel di Bruxelles.
Nel mandato di
cattura emesso contro la Kaili il 9 dicembre dal giudice istruttore Claise si
legge, infatti, che «l'imputata ha ammesso di aver incaricato il padre di
nascondere il denaro». E ancora: «Afferma di aver saputo in passato
dell'attività del marito (Francesco Giorgi, ndr) con il signor Panzeri e che per
il suo appartamento passavano valigie di biglietti». Quando la polizia piomba
sul marito che aveva appena lasciato il loro appartamento in rue Wiertz, la
Kaili avrebbe perso la testa. Oltre a coinvolgere il padre, la donna «ha tentato
di avvertire Panzeri, ma anche due eurodeputati citati nella presente
inchiesta».
Ma secondo i media
greci Michalis Dimitrakopoulos, legale della politica, avrebbe respinto
l'indiscrezione: «La signora Kaili non ha mai confessato di aver chiesto a suo
padre di trasferire denaro per nasconderlo». E avrebbe aggiunto che la sua
assistita «ha saputo di questi soldi all'ultimo minuto e ha chiesto subito che
andassero al loro proprietario». Che secondo Dimitrakopoulos sarebbe «il signor
Panzeri». In base alla ricostruzione dell'avvocato della Kaili quindi, più che
di un tentativo di nascondere i soldi si sarebbe trattato di un maldestro
tentativo di restituzione.
Per gli inquirenti
belgi, però, sarebbe stata la stessa europarlamentare a intervenire «a difesa
degli interessi del Qatar, avendo incontrato», su richiesta di Panzeri, «il
ministro del Lavoro» del governo di Doha. Lo stesso che, a ottobre, aveva
portato il denaro da consegnare, diviso in tre buste, al sindacalista Visentini.
Panzeri «avrebbe impartito» i suoi ordini alla Kaili, annotano gli inquirenti,
«per il tramite del marito». L'ex eurodeputato Pd sarebbe arrivato a intimare a
Giorgi: «Eva non deve parlare con l'olandese!».
Ricordiamo che,
secondo quanto risulta alla Verità, sarebbero stati uno o più eurodeputati dei
Paesi bassi a far partire l'inchiesta, denunciando i tentativi dei servizi
segreti marocchini di ingerire nell'attività dell'Europarlamento. Infine le
indiscrezioni sull'indagine pubblicate sui media hanno messo in allarme i
magistrati belgi, che hanno annunciato di aver aperto un fascicolo per fughe di
notizie.
(ANSA il 21 dicembre
2022) - L'ufficio di presidenza del gruppo S&D all'Europarlamento ha deciso di
sospendere un suo funzionario per 'colpa grave' nell'ambito delle indagini in
corso sul cosiddetto Qataragate. Secondo quanto si è appreso da fonti
dell'Eurocamera, si tratterebbe di un consigliere politico di nazionalità non
italiana che ha lavorato nell'ambito della commissione esteri del Pe. Il
segretariato del gruppo ha immediatamente informato le competenti autorità del
Belgio.
(ANSA il 21 dicembre
2022) - Francesco Giorgi, l'assistente parlamentare nell'indagine della procura
di Bruxelles sul 'Qatargate', ha raccontato alla polizia federale e poi al
giudice istruttore belga Michel Claise che le mazzette del Qatar passavano
tramite un contatto con "l'algerino".
Ha parlato poi del
meccanismo di quelle del Marocco, di un incontro con i sauditi, di un'altra Ong
coinvolta per finanziare Fight Impunity, la Human Rights Foundation, e ha
sostenuto che la compagna Eva Kaili pur sapendo dei soldi "non faceva parte
della rete".
Lo rivela il Fatto
Quotidiano parlando di tre lunghi verbali, riferendo anche passaggi
dell'informativa degli 007 belgi che ha dato il via all'inchiesta in cui si
parla di un affare da "diversi milioni di euro".
Su come il Qatar
pagava le mazzette a Bruxelles, svela il quotidiano, Giorgi ha raccontato di
aver ricevuto il contatto da "l'algerino": "È uno che lavora per il governo del
Qatar e si chiama Boudjellal. Mi metteva in contatto con una persona in Turchia,
credo di origine palestinese". Quello gli dava un numero di telefono del Belgio:
"Dovevo chiamarlo per avere i soldi".
Si trattava di una
persona sempre diversa. "E io ogni volta cancellavo quei numeri, per non
lasciare traccia". "Il totale era variabile, per me è difficile stimarlo, erano
loro a decidere", ha affermato Giorgi, spiegando che la triangolazione avveniva
"due o tre volte all'anno".
Per il Marocco,
invece, le mazzette arrivavano in contanti da Abderrahim Atmoun, l'ambasciatore
di Rabat in Polonia: "Portava ogni tanto dei soldi ma non in modo regolare.
Erano importi di qualche decina di migliaia di euro. Io stimo la somma totale in
50mila euro", ha raccontato l'assistente parlamentare.
"Atmoun veniva a
Bruxelles, oppure andavamo a Parigi, a casa sua, nel suo appartamento. Quando
andavamo a prendere dei soldi dicevamo che andavamo a prendere delle cravatte o
degli abiti". Dal Marocco arrivava anche altro: "A dicembre Atmoun voleva
regalare un viaggio a Marrakech a me, Panzeri e le rispettive famiglie. Ho un
po' esitato all'inizio, poi ho detto sì. Avevamo parlato anche per la sorella e
il cognato di Eva, alla fine non hanno accettato".
Giorgi ha parlato di
accordo, per importi minori, anche con la Mauritania che aveva "problemi di
immagine". "Io ho affittato il mio appartamento all'ambasciatore e quella era la
mia controparte: 1.500 euro + 300 di spese. Panzeri ha preso 25mila euro cash".
"Siamo andati all'ambasciata della Mauritania una settimana fa e abbiamo
incontrato il loro ambasciatore e quello saudita, che voleva informazioni su
quello che si diceva al Parlamento Ue sul suo Paese".
Marco Bresolin
per “La Stampa” il 21 dicembre 2022.
«E comunque vorrei
che una cosa fosse chiara: io e il mio partito non avevamo sostenuto la
candidatura a vice-presidente di Eva Kaili. Iratxe era stata informata di
questo». Strasburgo, 12 dicembre 2022, pochi minuti prima delle 17. Gli
eurodeputati del gruppo dei socialisti-democratici sono in una sala del
Parlamento di Strasburgo per un vertice a porte chiuse. Non ci sono nemmeno gli
assistenti.
È la prima riunione
dopo gli arresti che hanno sconvolto l'Eurocamera e portato in carcere una
vice-presidente. La tensione nella stanza è palpabile. Lo sfogo è di Nikos
Androulakis, che oltre a essere uno dei due eurodeputati del Pasok è anche il
presidente del partito socialdemocratico greco. A gennaio Eva Kaili era stata
candidata alla vicepresidenza dell'Aula contro la volontà del suo stesso
partito: una cosa piuttosto inedita.
Gli altri
eurodeputati, compresi quelli del Pd, cadono dalle nuvole. Non Iratxe Garcia
Perez, la capogruppo spagnola, che effettivamente era al corrente. Tutti si
aspettano una spiegazione, ma suona la campanella: bisogna entrare in Aula
perché Roberta Metsola sta per aprire una delle sedute più difficili del
Parlamento europeo. La risposta ancora deve arrivare, ma ieri il gruppo dei
socialisti-democratici ha deciso di avviare un'indagine interna su tutti i fatti
anomali che si sono registrati quest'anno tra plenaria, commissioni e gruppi di
lavoro.
Al centro
dell'attenzione ci sono soprattutto le mosse di Eva Kaili, che specialmente
nell'ultimo anno ha tessuto una rete di relazioni totalmente autonoma dal Pasok,
il suo partito. «Lei era il Cavallo di Troia di Nuova Democrazia»: così l'ha
definita lo stesso Androulakis, riferendosi al partito di centrodestra che
governa ad Atene. Tanto che a settembre aveva comunicato a Iratxe Garcia Perez
la volontà di non ricandidarla alle Europee del 2024.
Lei però stava già
lavorando a un piano B: diventare sindaco di Salonicco con l'appoggio del
centrodestra. Del resto, in occasione della sua elezione a vice-presidente, con
lei si erano congratulate pubblicamente alcune figure del governo di Atene. E il
quotidiano filo-governativo «Proto Thema» aveva rivelato che il premier Kyriakos
Mitsotakis si era battuto in prima persona per la sua nomina. Il Pasok, invece,
l'aveva subita. Kaili aveva un ottimo rapporto con Margaritis Schinas, ex
portavoce della Commissione Juncker e attuale vice-presidente dell'esecutivo
Ursula von der Leyen, anche lui esponente di Nuova Democrazia.
Il 18 novembre
scorso Kaili e Schinas si erano incontrati ad Abu Dhabi in occasione del viaggio
in Qatar del commissario per il match inaugurale dei Mondiali (con loro c'era
anche un viceministro di Atene). «Abbiamo preso soltanto un caffè, greco» si è
giustificato di recente il commissario. Pochi giorni dopo, il 21 novembre, lei
ha pronunciato l'ormai celebre intervento in Aula in difesa di Doha e si è
astenuta sulla risoluzione che definiva la Russia «uno Stato terrorista». Ieri
l'Alto Rappresentante Ue, Josep Borrell, ha avuto il primo contatto diplomatico
con il governo qatarino dall'inizio dello scandalo: in Giordania ha incontrato
il ministro degli Esteri Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. «È necessario che le
indagini in corso facciano piena chiarezza».
Negli ultimi mesi
Kaili si è data molto da fare anche all'interno delle attività del Parlamento
per far luce sullo scandalo Pegasus, lo spyware utilizzato da alcuni governi per
spiare giornalisti e oppositori politici. Un'attività sulla quale oggi si
concentra l'attenzione della procura belga proprio perché la commissione
d'inchiesta dovrà indagare anche sul Marocco.
La greca, molto
attiva sul fronte delle criptovalute, lo scorso anno era stata relatrice ombra
del provvedimento. E quest'estate si era nuovamente scontrata con il collega
Androulakis, vittima di spionaggio da parte del governo di Atene. Lei aveva
cercato di frenare l'attività investigativa del Parlamento Ue, dicendo che si
trattava di un software diverso da Pegasus.
A settembre Kaili
aveva fatto andare su tutte le furie il suo gruppo per aver votato a favore
della nomina di Alessandro Chiocchetti a segretario generale del Parlamento Ue,
proposto da Roberta Metsola e sostenuto dal centrodestra. Gli altri tre
vicepresidenti socialisti, come da indicazioni, si erano astenuti, mentre il Pd
aveva comunicato che Pina Picierno avrebbe votato a favore di Chiocchetti «in
quanto italiano». Kaili, invece, aveva giustificato il suo sì dicendo che «tanto
avrebbe vinto lo stesso».
L'ultimo episodio
sotto la lente risale al 1° dicembre, quando Kaili si è imbucata nell'ormai
famosa seduta della commissione Libe, facendo figurare un voto in più. Si votava
la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Qatar. E il video della
sessione si conclude con lei che corre dal collega Marc Tarabella per un
caloroso abbraccio di sollievo.
Da open.online il 21
dicembre 2022.
Davanti ai
magistrati belgi, l’ex europarlamentare Antonio Panzeri ha fatto le prime
ammissioni dicendosi disposto a collaborare con gli inquirenti e puntando il
dito contro il deputato europeo del Pd Andrea Cozzolino, finora non indagato e
neanche mai interrogato. Nel verbale della procura federale di Bruxelles,
riportato da il Fatto Quotidiano, Panzeri dice: «L’accordo prevedeva che avremmo
lavorato per evitare delle risoluzioni contro i Paesi e in cambio avremmo
ricevuto 50mila euro».
Panzeri accusa l’ex
collega belga Marc Tarabella, per poi invitare i magistrati ad approfondire il
ruolo di Cozzolino. Panzeri avrebbe riconosciuto solo una parte delle
contestazioni che gli vengono fatte nell’inchiesta che lo vede per gli
inquirenti protagonista del traffico di mazzette pagate da Marocco e Qatar per
influenzare le decisioni del Parlamento europeo. Stando a quanto scoperto dal
Vsse, il servizio segreto belga che ha dato inizio all’indagine, l’attività di
ingerenza di Panzeri a favore del Marocco sarebbe iniziata almeno dal 2014,
mentre il rapporto con il Qatar risale al 2018.
Le accuse a
Cozzolino
Il verbale di
interrogatorio di Panzeri è stato redatto davanti al giudice istruttore Michel
Claise il giorno dopo l’arresto del 9 dicembre, quando sono scattate le prime
misure cautelari anche nei confronti dell’ex collaboratore Francesco Giorgi,
della compagna di quest’ultimo, l’ex vicepresidente dell’Europarlamento Eva
Kaili, e del sindacalista Luca Visentini poi rilasciato. Davanti al giudice,
Panzeri ha iniziato a fare i primi nomi: «Io aggiungo che non ho prove ma voi
dovreste controllare il presidente attuale della delegazione del Maghreb», vale
a dire Cozzolino. «È il parlamentare di cui Giorgi è l’assistente… Tra l’altro
questo parlamentare è responsabile di chiedere risoluzioni d’urgenza, ma questo
non passa da noi, questo passa direttamente quindi non conosco bene la base ma
so che è successo».
Gli incarichi di
Cozzolino
Panzeri cita le
«risoluzioni d’urgenza», cioè quella procedura accelerata che in una settimana
può portare un testo al voto dell’aula, evitando così di passare dalle
commissioni che potrebbero anche rallentare di mesi l’iter per l’approvazione.
L’ex europarlamentare avrebbe quindi spinto gli inquirenti a guardare meglio
l’attività di Cozzolino come presidente della delegazione del Maghreb, lo stesso
incarico ricoperto dallo stesso Panzeri dal 2009 al 2017.
Negli atti
dell’inchiesta, gli inquirenti si soffermano anche su un altro incarico di
Cozzolino, cioè quello di membro nella commissione speciale del Parlamento Ue
che indaga sull’uso di Pegasus, lo spyware di fabbricazione israeliana di cui il
Marocco è accusato di aver fatto largo uso anche su leader europei.
L’informativa dell’intelligence belga spiega che Cozzolino avrebbe iniziato
l’attività di ingerenza per il Marocco dal 2019, ma il suo nome sulle mazzette
pagate dal Qatar non compare, se non quando viene citato da Panzeri.
Giuseppe Guastella
per corriere.it il 21 dicembre 2022.
Un «accordo» per
«evitare delle risoluzioni contro i Paesi e in cambio abbiamo ricevuto 50 mila
euro»: nell’interrogatorio dopo l’arresto del 9 dicembre, un Antonio Panzeri
«pronto a collaborare» ammette ciò che non può negare dopo che le indagini dei
sevizi segreti e della magistratura hanno accumulato prove ed indizi contro di
lui e contro Francesco Giorgi, il suo socio negli affari della Ong Fight
impunity. Il secondo aveva fatto lo stesso anche perché, come l’ex
europarlamentare di Pd e Articolo 1, gli avevano trovato una quantità di
contanti impossibile da giustificare, tra tutti e due un milione e mezzo di
euro.
Dalle dichiarazioni
di Panzeri, per come le ha rivelate il sito il fattoquotidiano.it, emerge
l’intenzione di circoscrivere per quanto possibile le proprie responsabilità ad
una azione spregiudicata di lobbismo a favore di Paesi che, come Qatar e
Marocco, avevano bisogno di migliorare la propria immagine che eventuali
risoluzioni su temi problematici come i diritti umani d’urgenza avrebbero potuto
offuscare.
L’accordo con il
Marocco sarebbe partito nel 2019 quando Panzeri era ancora europarlamentare
attraverso Abderrahim Atmoun, l’ambasciatore del Marocco in Polonia con il quale
aveva contatti assidui monitorati costantemente dai servizi segreti del Regno
del Belgio. Il compito di Panzeri e degli altri coinvolti nell’inchiesta sembra
dovesse essere quello di bloccare questi missili politici persuadendo i
parlamentari, si sospetta anche a suon di mazzette e regali.
Panzeri fa il nome
di Andrea Cozzolino, il deputato europeo sospeso dal Pd per questa vicenda, che
nel 2019 prese il suo posto nella delegazione Maghreb dell’assemblea, anche se
dice che su di lui non ha prove. Uomo di contatto tra i due è Francesco Giorgi
che dopo essere stato assistente di Panzeri passò a Cozzolino. Spunta anche un
riferimento al parlamentare belga di origini italiane Marc Tarabella (perquisito
nel blitz del 9 dicembre) di cui Panzeri dice che avrebbe preso regali dal
Qatar, mentre esclude il coinvolgimento di Luca Visentini, il segretario del
Confederazione internazionale dei sindacati (arrestato e immediatamente
scarcerato), e di Niccolò Figà-Talamanca, segretario della Ong No peace without
justice che è ai domiciliari ed al quale ieri è stato sequestrato un
appartamento a Cervinia su richiesta dei magistrati belgi.
Uno dei punti
incontrovertibili della vicenda che sta sconvolgendo la politica parlamentare
europea è la presenza di oltre 750 mila euro nella casa che la ex vice
presidente Eva Kaili divide con il compagno Giorgi e di altri 600 mila in quella
di Panzeri. È un fatto di una tale gravità incompatibile per chiunque, a
cominciare da chi ha incarichi politici. La socialista greca ha tentato di
uscirne ammettendo ciò che non poteva negare. «Tutto è successo in quelle ore,
quando ha visto i soldi, non ha avuto una risposta convincente sull’origine e ha
subito chiesto che uscissero di casa», aveva detto il suo avvocato Michalis
Dimitrakopoulos riportando le dichiarazioni della cliente dopo l’arresto.
Secondo fondi di
stampa belghe ed italiane, nella documentazione dei magistrati integrata da
informative dei servizi segreti a verbale Kaili avrebbe ammesso: «Conoscevo le
attività di Panzeri. E sapevo che a casa mia c’erano delle valigie piene di
soldi», frase che dà l’idea di una consapevolezza di vecchia data, ammesso che
tra greco, italiano e francese le traduzioni siano così accurate da cogliere le
sfumature. Forte del fatto che non si sa di bene di cosa sia accusata, e che
detenere tanto denaro di per sé non è reato, Dimitrakopoulos ieri smentisce:
«Non ha mai confessato di aver chiesto a suo padre di trasferire denaro per
nasconderlo»; «ha saputo di questi soldi all’ultimo minuto» e «chiese subito che
andasse al loro proprietario, il signor Panzeri». Comunque, non aveva «alcun
obbligo di denunciare».
Mentre la procura
federale apre un'inchiesta sulle fughe di notizie dopo un esposto degli avvocati
degli arrestati, Emergono frammenti di intercettazioni che sembrano chiarire la
storia dei regali della famiglia Panzeri e dell’ambasciatore del Marocco
Abderrahim Atmoun. Il 4 giugno 2022 Maria Colleoni, moglie di Panzeri (ai
domiciliari), intercettata dagli 007 di Bruxelles con la figlia Silvia, forse
dopo aver passato la dogana in uscita dall’aeroporto in Marocco, chiama il
marito dicendogli che «tutto è andato bene, siamo stati fatti passare come vip»
e di aver preso un caffé con l’ambasciatore, che evidentemente le stava
aspettando.
Secondo
l’intelligence belga, il viaggio era servito a far entrare nel paese regali
ricevuti per la «attività di interferenza» di Panzeri sul Parlamento. Un’altra
intercettazione, riportata da Le Soir , registra una conversazione di fine
luglio 2022 nella casa dei Panzeri a Calusco d’Adda, non si sa fatta come, in
cui la donna si augura che «non entrino qui» perché troverebbero «qualsiasi
cosa».
Qatar, l’avvocato
di Kaili: «È stata tradita da Giorgi».
Redazione politica
su Il Corriere della Sera il 21 dicembre 2022.
Per il legale
dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo le ricostruzioni circolate sulla
stampa «non corrispondono a verità». Per i Servizi «sono girati milioni di
euro». Figà-Talamanca: la casa a Cervinia? Ho il mutuo
La nobile causa dei
diritti umani era un’ipocrita copertura dietro la quale Antonio
Panzeri e Francesco Giorgi facevano il loro vero lavoro con la Ong Fight
Impunity , quello di influenzare la politica del Parlamento europeo per il quale
erano stati reclutati dai Servizi segreti del Marocco e da personaggi del Qatar
che li hanno ricoperti di denaro contante. Come i 750 mila euro sequestrati
nella casa che Giorgi divide con la compagna Eva Kaili, di cui lei dice di non
saperne nulla. «Si fidava e lui l’ha tradita», dichiara l’avvocato della
eurodeputata Mihalis Dimitrakopoulos dopo averla incontrata ieri nel carcere di
Haren.
I Servizi belgi, che
hanno dato il via all’inchiesta, sono convinti che siano girati «diversi milioni
di euro» partiti da Marocco e Qatar per evitare iniziative politiche che
potevano danneggiare l’immagine di questi Paesi non sempre in prima linea nel
rispetto dei diritti umani. Che fine hanno fatto? La risposta arriva da
un’informativa degli 007 che per mesi hanno tenuto sotto controllo Panzeri e
Giorgi i quali — scrivono — facevano «squadra» con il deputato europeo Andrea
Cozzolino (sospeso dal Pd). Giorgi vorrebbe investire in un immobile, «Panzeri
usa il denaro in due modi: per mantenere un tenore di vita superiore alle sue
entrate» e per pagare personaggi «di vertice nel mondo istituzionale europeo».
Chi siano e quanto hanno avuto non è chiaro.
I magistrati
sospettano che qualcosa sia finito anche a Niccolò Figà-Talamanca, segretario
della Ong No peace without justice, arrestato, che ha acquistato per 230 mila
euro un appartamento a Cervinia che è stato sequestrato su richiesta del
giudice Michel Claise, nonostante i suoi avvocati abbiano dimostrato come sia
stato stipulato un mutuo da 200 mila euro ed il resto arrivasse dalla famiglia.
Le indagini parlano
di «una rete» che corrompeva ricevendo direttive dall’agente marocchino Mohamed
Belharache tramite l’ ambasciatore di Rabat a Varsavia, Abderrahim Atmoun, lo
stesso che pagava il «lavoro» a Panzeri e Giorgi. Interrogato a lungo,
Giorgi rivela che per ordini e denaro dal Qatar c’era «l’algerino», tale
Boudjellal, che lo metteva in contatto con un palestinese in Turchia che lo
passava e ad un soggetto in Belgio. Quanti soldi a volta?: «Il totale era
variabile, per me è difficile stimarlo, erano loro a decidere». Quando era in
azione, Giorgi faceva attenzione a non lasciare tracce.
Stesso schema con il
Marocco tramite l’ambasciatore in Polonia Abderrahim Atmoud, personaggio
considerato legato ai Servizi di Rabat, che «portava ogni tanto dei soldi ma non
in modo regolare. Importi di qualche decina di migliaia di euro. Io stimo la
somma totale in 50 mila euro», dice aggiungendo che «veniva a Bruxelles, oppure
andavamo a Parigi, a casa sua, nel suo appartamento. Quando andavamo a prendere
dei soldi dicevamo che andavamo a prendere delle cravatte o degli abiti». Emerge
infine un’analoga attività a favore della Mauritania per la quale Giorgi sarebbe
stato retribuito con un affitto, sembrerebbe fittizio, per il suo appartamento
da 1.500 euro al mese più 300 di spese, mentre Panzeri avrebbe incassato «25
mila euro cash». Per oggi è prevista l’udienza in cui la difesa chiederà la
scarcerazione di Eva Kaili. «Le cose sono difficili», ammette l’avvocato
Dimitrakopoulos: «Sono ottimista. È innocente».
Proselitismo
fondamentalista. Il Qatargate fa parte della strategia di Doha per conquistare i
musulmani d’Europa.
Carlo Panella su
Linkiesta il 22 Dicembre 2022
Il Paese del Golfo
adesso minaccia di tagliare le forniture di metano al Vecchio Continente, dove
da anni ha avviato una grande operazione di penetrazione ideologica e religiosa
Il ricatto del Qatar
che minaccia di tagliare le indispensabili forniture di metano a un’Europa
colpevole solo di aver scoperto i suoi loschi maneggi a Bruxelles ci ricorda che
gli dei dell’Olimpo, per rompere la noia della propria immortalità, amano
giocare scherzi atroci agli umani.
Infatti Giove, non
contento di avere punito ferocemente Prometeo perché aveva regalato il fuoco
agli uomini, ha fatto in modo che da un secolo in qua il combustibile di quella
fiamma si trovi in massima parte proprio sotto i piedi di autocrati. Solo un dio
iracondo e annoiato infatti ha potuto fare in modo che la gran parte del
petrolio e del metano del pianeta si trovi nel sottosuolo delle peggiori
dittature. Scherzo atroce che obbliga le poche nazioni che hanno saputo
faticosamente costruire libertà e democrazia a sottostare ai ricatti dei
dittatori.
Scherzo nello
scherzo, Giove ha poi fatto sì che un terzo del petrolio e un quarto del metano
esportati nel mondo sia nella disponibilità di regimi islamici fondamentalisti.
Il che è già stato fonte di guai enormi se solo si pensa che dal 1945 al 2018,
periodo nel quale gli Stati Uniti cessarono di essere esportatori di energia per
diventare importatori, tutta la politica estera della più grande potenza del
mondo, così come quella dell’Europa, fu subordinata alle pretese egemoniche di
nazioni musulmane.
Per dirne una, fu
solo a causa del ricatto energetico che prima l’Europa nel 1980, col Consiglio
Europeo di Venezia, e poi gli Stati Uniti, decisero di accettare un terrorista
feroce, demagogo e avventurista come Yasser Arafat quale rappresentante unico
della Palestina, al posto del saggio re Hussein di Giordania, causando così un
disastro che giunge sino ai giorni nostri e pagato duramente dallo stesso popolo
palestinese.
Ma il vero problema
non è solo nel ricatto geopolitico che i Paesi dittatoriali esportatori di
energia impongono al mondo libero. C’è un altro problema troppo sottovalutato.
Dal 1973 infatti,
dalla guerra del Kippur tra Israele, Egitto e Siria, si è verificato un fenomeno
pericolosissimo. I Paesi islamici esportatori di energia ne hanno usato gli
enormi proventi per finanziare una tendenza innata dell’Islam storico: fare
proselitismo, allargare la Umma musulmana, vuoi convincendo le coscienze, vuoi
con le armi. Anche in Europa.
Nel 1973, appunto,
l’embargo totale sul petrolio non solo fermò l’esercito israeliano che, con
Ariel Sharon, era alle porte del Cairo, ma provocò e anche il balzo del costo
del barile da tre dollari, prima a dieci dollari, poi a venti dollari, per
arrivare a cento dollari nel 1980, dopo la rivoluzione iraniana dell’ayatollah
Khomeini.
Sono note le
conseguenze geopolitiche di quel vertiginoso rincaro, ma sono stranamente
ignorate quelle religiose.
Il flusso di
centinaia, migliaia di miliardi di petrodollari nelle casse dei Paesi islamici
ha infatti finanziato, come si è detto, una poderosa operazione di proselitismo
musulmano nel mondo. Nei primi decenni ne è stata protagonista l’Arabia Saudita
che nei soli anni Settanta ha finanziato l’impianto di non meno di duemila
moschee salafite nel mondo. Moschee che hanno diffuso a macchia d’olio ovunque,
in Asia, Africa, Europa e persino negli Stati Uniti, un Islam fondamentalista
che predicava e predica il rigido rispetto di una legge islamica, la sharia,
fissata nel 900 d.C., nel basso Medioevo.
L’accorrere in
massa, anche in Europa, di musulmani nelle organizzazioni jihadiste, da al
Qaeda, ai Talebani, all’Isis, nei decenni successivi è stato prodotto dunque
proprio dalla predicazione di queste migliaia di moschee finanziate con i
petrodollari.
Ma con l’11
settembre del 2001, l’Arabia Saudita è stata obbligata a fare i conti col frutto
avvelenato del suo proselitismo salafita, che ormai confliggeva con gli stessi
interessi geopolitici del regno.
Quindi, ad opera del
potente principe Turki ben Feisal, capo del Mukhabarat, il Servizio Segreto e
poi del re Abdallah bin Abdulaziz, ha operato una poderosa epurazione dei più
estremisti tra i suoi predicatori, sia in Arabia Saudita che all’estero. Ha
interrotto i rapporti, sino ad allora intens,i con i Fratelli Musulmani (grazie
ai quali, per dirne una, Osama Bin Laden si era indottrinato nell’universitá
king Abdulaziz di Gedda alle lezioni di Muammed Qutb, fratello di Sayyed Qutb,
ideologo massimo del jihadismo più estremo) che si è mutato in un contrasto
aperto dopo le primavere arabe del 2011.
Ma, proprio quando
si è affievolito il proselitismo fondamentalista su scala planetaria dei
sauditi, si è affacciato quello del Qatar, i cui proventi energetici si sono
moltiplicati all’ennesima potenza con la riconversione dell’estrazione di
petrolio in estrazione di metano, che ne fa oggi il secondo Paese esportatore al
mondo dopo la Russia.
Un proselitismo
fondamentalista, quello del Qatar, ben più moderno di quello dei sauditi,
veicolato dalla televisione al Jazeera, grande supporter dei Fratelli Musulmani
durante le primavere arabe, che irradia in tutto il mondo musulmano la
trasmissione “Sharia e vita” dello sceicco Yusuf al Qaradawi, nuovo ideologo
massimo della Fratellanza, che raccoglie milioni di spettatori. Il tutto
pianificato con spregiudicata lungimiranza dalla dinastia degli sceicchi al
Thani, che hanno la scabrosa tradizione familiare di figli che spodestano
bruscamente dal potere il proprio padre.
Ma il Qatar ha
avviato anche una grande operazione di penetrazione ideologica e religiosa in
Europa. Fonda e finanzia il “Consiglio Europeo della fatwa e della ricerca”,
punto di riferimento indispensabile per i Fratelli Musulmani in Europa sempre
diretto da Yusuf al Qaradawi; finanzia la scuola per Imam di Chateau Chinon in
Francia, che prepara ideologicamente i responsabili delle mosche della
Fratellanza; compra, letteralmente, una cattedra a Oxford per Tariq Ramadan,
nipote di Hassan al Banna fondatore della Fratellanza, capace di maneggiare il
lessico progressista per affascinare i gauchisti europei e soprattutto finanzia
a suon di milioni moschee e istituzioni islamiche fondamentaliste, se non
jihadiste, in Europa.
Sono settantacinque
i milioni di dollari profusi nel proselitismo nel vecchio continente dal Qatar
2015 in poi, ventiquattro dei quali destinati in Italia all’Ucoii,
organizzazione islamica egemonizzata dai Fratelli Musulmani.
Comprare dalla Fifa,
con regalie varie, il diritto a organizzare i campionati del mondo di calcio che
abbiamo appena visto, e poi organizzare la rete di lobbisti e faccendieri a
Bruxelles per evitare attacchi e critiche allo spregiudicato “modello Doha”, è
stato uno sforzo dispendiosissimo, che si inserisce in una strategia di
acquisizione, o meglio, di acquisto del consenso che ha una complessa profondità
di campo: mira a conquistare i musulmani d’Europa, a convincerli a praticare
l’Islam fondamentalista qatariota. E anche questo è un pericolo per la nostra
democrazia.
Il dito e la
mezzaluna. L’ombra del Marocco (e del Sahara Occidentale) dietro il Qatargate.
Alessandro Ferri su Linkiesta il 22 Dicembre 2022
Lo scandalo
all’Europarlamento ha riacceso i riflettori sui legami di potere illeciti con le
autocrazie, ma sono anni che Rabat spinge la sua agenda sulla regione, anche
spiando politici e ministri
In ogni locale
pubblico del Marocco c’è una foto di re Muhammad VI. Non sono solo foto
ufficiali, tutte uguali come quelle del Presidente della Repubblica nei nostri
uffici statali, no. Ci sono anche immagini che lo ritraggono con i figli, in
vacanza con la moglie, in atteggiamenti quotidiani, magari mentre beve un tè.
La monarchia è
talmente tanto insita nel tessuto sociale marocchino da diventarne
implicitamente parte della quotidianità, senza che nessuno ci faccia troppo
caso, mentre gira tra i vicoli di Jemaa el Fnaa, o mentre attraversa l’Atlante
in macchina, magari per andare da Ouarzazate a Marrakech.
Quella del Marocco
non è però solo la storia di un Paese bello, capace di sorprendere con i suoi
tramonti tra le dune del deserto e di emozionare il mondo del calcio con la sua
nazionale. È soprattutto la storia di una corona ingombrante, autoritaria, che
da anni occupa un territorio senza alcun diritto, contro le decisioni della
comunità internazionale, facendo pressioni sugli Stati europei, corrompendo e
spiando i politici più importanti.
Il Qatargate ha
acceso i riflettori sui legami di potere illeciti e sulle manovre che alcuni
regimi fanno sul Parlamento europeo per ottenere un miglior trattamento. Nello
specifico, se il Qatar ha fatto in modo che a Bruxelles si parlasse bene
dell’organizzazione dei Mondiali appena conclusi, il Marocco ha spinto perché
fosse riconosciuta la sua autorità sul Sahara Occidentale.
Facciamo un piccolo
passo indietro (neanche troppo piccolo). Per la prima volta nel 1973, la Spagna,
che andava verso la fine del franchismo, iniziò a valutare, a causa delle
pressioni dell’Onu, l’ipotesi di dare autonomia al Sahara Occidentale, Paese che
era una sua colonia.
Questa volontà di
chiudere la pagina del colonialismo si scontrò fin da subito con le mire di Re
Hassan II, il padre di Muhammad VI, che voleva avere potere sulla regione perché
ricca di materie prime, perché rappresenta il quaranta percento della superficie
attuale dello Stato maghrebino, ma anche per portare avanti l’ideologia distorta
di «Grande Marocco».
Questa idea, nata
nel 1937, è ripresa dal monarca alawide, secondo cui Rabat avrebbe dovuto
conquistare la Mauritania, la regione occidentale del Sahara algerino, parte del
Mali occidentale, Ceuta, Melilla, le Isole Alhucemas, le Isole Chafarinas, Peñón
de Vélez de la Gomera, Perejil, Alboran, le Isole Canarie, l’Arcipelago di
Madeira e, per l’appunto, il Sahara Occidentale.
La questione venne
portata all’attenzione della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, che nel
1975 emise una sentenza in cui rispondeva ad alcune domande. Alla più importante
(Erano Rio de Oro e Saguia El Hamra al momento della colonizzazione della Spagna
un territorio che non apparteneva a nessuno, terra nullius?), la risposta fu
(testualmente):
«La Corte dichiara
che né gli atti interni né gli atti internazionali invocati dal Marocco indicano
l’esistenza nel periodo di riferimento dell’esistenza o del riconoscimento
internazionale dei legami giuridici di sovranità territoriale tra il Sahara
Occidentale e lo Stato del Marocco. […] Essi forniscono, tuttavia, indicazioni
che un vincolo legale di lealtà esisteva nel periodo in questione tra il Sultano
e alcuni, ma solo alcuni, dei popoli nomadi del territorio, attraverso
i leader tribali della regione di Noun, e loro testimoniano che il Sultano ha
dimostrato loro, ed è stato riconosciuto da altri Stati di possedere, qualche
autorità o influenza nei confronti di tali tribù».
Il tutto suffragato
da una relazione successiva delle Nazioni unite che specificava che: «Nel
territorio la popolazione o per lo meno la quasi totalità delle persone che ha
incontrato si è pronunciata categoricamente in favore dell’indipendenza e contro
le rivendicazioni territoriali del Marocco e della Mauritania. […] Il Fronte
Polisario, che era considerato come clandestino fino all’arrivo della missione,
è apparso come la forza politica dominante nel territorio. Ovunque nel
territorio, la missione ha assistito a manifestazioni di massa in suo favore».
Questa querelle si
concluse il 6 novembre del 1975, quando trecentocinquanta mila marocchini,
scortati da venticinque mila uomini dell’esercito, invasero il Sahara
Occidentale, con la scusa di una manifestazione non violenta che prese il nome
di Marcia Verde (un evento talmente importante che fino al 2013 è stato ritratto
sulla banconota da cento Dirham).
Da quel momento il
Marocco occupa il Sahara Occidentale e la popolazione che un tempo abitava la
regione vive oggi in campi profughi, la maggior parte su territorio algerino,
Paese che ha dato rifugio a centinaia di migliaia di persone. Se ve lo state
chiedendo, sì, gran parte dei Saharawi ha vissuto la sua intera vita dentro
tende di fortuna nel mezzo del deserto.
Dal 1991 è presente
la missione Onu Minurso, che oggi è guidata dall’italo-svedese Staffan De
Mistura e che in trentun anni non ha portato nessun risultato, benché meno
l’inizio del censimento per impostare il referendum sull’autodeterminazione che
i Saharawi chiedono da quasi mezzo secolo e che le Nazioni Unite, almeno sulla
carta, sosterrebbero (Minurso sta per Mission des Nations Unies pour
l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental).
Oggi la questione
del Sahara Occidentale, che i media non trattano mai con grande interesse, torna
su tutte le prime pagine del mondo, complice il Qatargate. L’inchiesta che fa
tremare il Parlamento europeo tira fuori ogni giorno nuovi dettagli. Mettendo
insieme i puntini però appare evidente che il ritratto che viene fori è quello
rubicondo di re Muhammad VI.
Andiamo con ordine.
A maggio scorso il deputato basco Aitor Esteban aveva accusato il regno del
Marocco di aver spiato i cellulari personali di alcuni dei ministri più
importanti di Spagna. Alle sue parole fecero seguito inchieste e dibattiti,
finché il Guardian non è arrivato al vero proprio scoop: oltre duecento telefoni
spagnoli, compreso quello del Premier Pedro Sanchez, sono stati infettati
dallo spyware Pegasus.
Madrid non ha mai
polemizzato con Rabat, per non alimentare lo scontro tra i due Paesi, divampato
durante l’emergenza coronavirus, quando il presidente della Repubblica del
Sahara Occidentale Brahim Ghali fu ricoverato sotto falso nome e con passaporto
algerino proprio in Spagna, contro il parere di Muhammad VI. Il giornale inglese
però ha trovato i numeri di cellulare in una lista di contatti, circa
cinquantamila, raccolta dal Marocco nel 2019.
Una vicenda
senz’altro preoccupante, ma cosa c’entra Qatargate? C’entra nel momento in cui,
in una lettera che il ministero degli esteri marocchino inviò nel 2011 al suo
ambasciatore presso l’Unione Europea, venne scritto che: «La visita a Tindouf
(città in Algeria dove ha sede il governo della Repubblica del Sahara
Occidentale, ndr.) è indispensabile per supportare la credibilità del sig.
Panzeri presso l’Algeria e il Polisario, visto che lui è stato accusato di
essere pro-Marocco. Non è nell’interesse del Marocco che il sig. Panzeri sia
percepito come tale».
In parole povere, il
Marocco avrebbe scelto a suo tempo Panzeri come “agente sotto copertura” per
visitare i campi Saharawi, mostrarsi accogliente, ma allo stesso tempo portare
avanti a livello europeo le politiche contro l’autodeterminazione. Ancora, nel
documento si chiarisce, sempre riguardo Panzeri, che: «È difficile non vedervi
un capacità di disturbo, che dimostra come l’interessato possa essere un alleato
di peso o un avversario da temere».
Potrebbe essere
sicuramente una coincidenza, un caso isolato. Beh, sì, se non esistesse un’altra
nota, stavolta del 2013, in cui Panzeri viene definito un «amico intimo del
Marocco» e in cui si parla della sua importanza centrale nell’attuazione del
«piano d’azione per il Parlamento Europeo».
In che modo però gli
eurodeputati avrebbero potuto aiutare Muhammad VI nella battaglia per mantenere
lo status d’occupazione nel Sahara Occidentale? Semplice: organizzando
conferenze, eventi, incontri, alimentando dibattiti in cui rilanciare la
«soluzione marocchina» (che prevede il solo riconoscimento dello status di
regione a statuto speciale, a discapito dell’autodeterminazione) nell’opinione
pubblica, ma soprattutto, contrastando le conseguenze della sentenza della Corte
di Giustizia Europea che dal 2016 garantisce ai Saharawi una rendita per lo
sfruttamento delle risorse della loro terra (su tutte: fosfati e pesce).
Un approccio
sistematico che trova riscontri ovunque, andando a cercare. Anche nei
cablogrammi marocchini del 2014, quasi un decennio fa. Al tempo, c’era grande
preoccupazione per la posizione dei socialisti europei, generalmente avversi al
Marocco e sensibili alla causa Saharawi. Nei loro messaggi di corrispondenza,
inviati stavolta dall’ambasciata di Bruxelles verso Rabat si legge, senza troppi
giri di parole:
«Il nuovo alto
rappresentante (per gli esteri e la sicurezza, ndr.) Federica Mogherini,
proveniente dal Pd, partito promotore della mozione contro il Marocco al
Parlamento italiano, ha assunto posizioni favorevoli alla tesi dei separatisti
sulla questione del Sahara Occidentale. Pertanto, è necessario agire con gli
amici del Marocco (alti funzionari europei e membri del partito S&d, in
particolare Gilles Pargneaux e Antonio Panzeri) per sensibilizzare su questo
tema».
In definitiva: i
tentacoli del Marocco arrivano senza troppa difficoltà dentro le aule dei
Parlamenti del nostro continente: si annidano tra i banchi, nelle tasche, nei
cellulari, per portare avanti interessi oscuri, con buona pace delle popolazioni
del Sahara Occidentale, mentre la Mezzaluna Rossa, ciclicamente, avverte che la
situazione umanitaria nella regione è al collasso, e mentre la guerra sembra
sempre più vicina, dopo che nel novembre 2020 l’esercito marocchino ha violato
la tregua che resisteva dal 1991. Il tutto nell’inconsistenza di una missione
Onu che non ha ancora neanche posto le basi per
un referendum sull’autodeterminazione.
Chissà cosa ne
faranno i Saharawi, circondati da 2720 chilometri di muro disseminato da due
milioni di mine antiuomo, delle foto di Re Muhammad VI che gioca con i figli, o
prende il tè.
Lo scandalo
Qatargate. Le torbide intercettazioni degli 007 belgi fanno indignare persino
Travaglio.
Paolo Comi su
Il Riformista il
21 Dicembre 2022
A dar retta
a Marco Travaglio, il Qatargate, l’inchiesta che da giorni sta mandando in
fibrillazione le redazioni dei giornali nostalgici di Mani pulite, non sarebbe
dovuto nemmeno iniziare. Le ‘indagini’, infatti, sono state effettuate facendo
grande ricorso alle intercettazioni, ambientali e telefoniche, da parte
dei servizi segreti del Belgio. Per il direttore del Fatto Quotidiano questo
tipo di intercettazioni, quelle appunto effettuate dai servizi segreti,
sarebbero il male assoluto in quanto gestite da “spioni”, non “garantite” e
spesso utilizzate come arma di “ricatto”. Dal momento che il ministro della
Giustizia Carlo Nordio ha proposto nei giorni scorsi una loro modifica,
Travaglio si è scatenato ieri con un editoriale di fuoco. Le modifiche
ipotizzate da Nordio, al momento, riguardano però il solo sistema di pagamento
di tali ascolti da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sollevando
via Arenula da ogni responsabilità.
Vale allora la
pena ricordare come è nato il Qatargate. Il Sureté de l’Etat, il servizio
segreto del Belgio – non è ancora chiaro se grazie a una soffiata di
un’assistente parlamentare che non riconfermata nell’incarico, avrebbe deciso di
vendicarsi, oppure da informazioni fornite da un altro Paese – decise di
effettuare delle intercettazioni a tappeto, ad iniziare proprio da Antonio
Panzeri. L’appartamento dell’ex europarlamentare lombardo a Bruxelles venne
messo sotto controllo, piazzando cimici ovunque, mentre lui venne pedinato e
intercettato. Gli agenti segreti, dopo aver avviato le operazioni di ascolto nei
primi mesi del 2021, declassarono il dossier nello scorso luglio a caso di
corruzione internazionale, inviandolo alla magistratura ordinaria, E qui scatta
la ‘seconda fase’ dell’inchiesta, coordinata dal giudice istruttore belga Michel
Claise, che ha fatto emergere il coinvolgimento dell’ex vice presidente del
Parlamento Eva Kaili, trovata in possesso di 750mila euro, del suo
compagno Francesco Giorgi, ex collaboratore di Panzeri poi assistente
parlamentare del Pd Andrea Cozzolino e del segretario dell’Ong No peace without
justice Niccolò Figà Talamanca.
Il fascicolo
risulta aperto per “associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio di
denaro, commessi dal gennaio 2021 all’8 dicembre scorso”. Che la genesi delle
indagini sia dei servizi segreti lo ha confermato il ministro della Giustizia
belga, Vincent Van Quickenborne. Per il Guardasigilli si è trattato di un’ampia
indagine dell’intelligence, e il “servizio di sicurezza dello Stato sta
lavorando da più di anno, assieme ai servizi di intelligence stranieri, per
identificare la sospetta corruzione di membri del Parlamento europeo da parte di
vari Stati”. Una cosa del genere in Italia non sarebbe, ovviamente, possibile.
Lo ha ricordato ieri in una intervista a Repubblica Giovanni Salvi, che prima di
essere nominato procuratore generale in Cassazione è stato procuratore generale
a Roma, l’ufficio che per legge è preposto alla gestione a questo genere
di intercettazioni.
«Le
intercettazioni dei servizi – ricorda Salvi – si sono sempre distanziate da
quelle del processo penale e riguardano aree che non hanno nulla a che fare con
ipotesi reato». Si tratta di ascolti che hanno finalità molto diverse, ad
esempio, da quelle del contrasto ai reati dei colletti bianchi che tanto
piacciono a Travaglio. L’ex pg della Cassazione ha poi voluto sottolineare un
concetto molto spesso sottovalutato: «Faccio presente che in tanti anni non vi è
mai stato un solo caso in cui il contenuto delle intercettazioni delle agenzie
sia filmato indebitamente all’esterno». Ecco, forse, perché Travaglio è cosi
nervoso. Come farebbe il suo giornale senza chiavette? Paolo Comi
Qatargate,
l’imprenditore del Sudafrica che a Panzeri ha dato 250 mila euro.
Franco
Stefanoni su Il Corriere della Sera il 23 Dicembre 2022
Editore e
«filantropo» discusso in patria per gli affari con fondi pubblici, Iqbal Survé
ha rapporti con il Qatar e risulta esser stato il più generoso con Fight
impunity
Della Fight
impunity, Ong guidata dall’ex eurodeputato Antonio Panzeri tra i protagonisti
dell’inchiesta belga su presunte tangenti in favore di parlamentari Ue, sbuca un
finanziamento di 250 mila euro, il maggiore ricevuto, da parte di un
imprenditore, medico, «filantropo» ed editore sudafricano. Si tratta di Iqbal
Survé: con la sua Sekunjalo development foundation (Sdf) con sede a Johannesburg
nel 2020 ha sostenuto le attività della Ong. Secondo quanto dichiarato da Survé
stesso, a spingerlo sarebbero state le attività della Fight impunity: battersi
contro il traffico di esseri umani, gli abusi sui detenuti e a favore del
ripristino di pace e giustizia nel mondo. Come ha raccontato il quotidiano La
Verità, Survé è uomo discusso in patria, per i disinvolti utilizzi di fondi
pubblici e fondi pensione e per i legami con i vertici della Anc (African
national congress) un tempo di Nelson Mandela (di cui Survé afferma di essere
stato amico e medico personale). L’uomo di affari avrebbe conosciuto la Ong di
Panzeri a Davos, in Svizzera, durante un World economic forum, da cui
successivamente sarebbe nata la richiesta di finanziamenti da parte di Fight
impunity.
Legami con Doha
È in un parere
del Comitato etico indipendente della Ue, datato dicembre 202o, che il
finanziamento della Sdf viene reso noto, contestualmente all’avvio della
collaborazione retribuita dell’ex commissario europeo Dimitris Avramopoulos con
la Ong. Survé, intervistato poi dalla testata sudafricana Daily Maverick, ha
detto di non poter commentare il fatto di essere stato il principale sostenitore
delle attività di Panzeri. Quest’ultimo è accusato di associazione per
delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro. Il suo arresto il 9 dicembre
scorso, insieme a quello di altre sette persone tra cui la moglie, la figlia e
la vicepresidente del Parlamento Ue Eva Kaili, vede come principale ipotesi
d’accusa l’aver fatto da collettore di tangenti pagate da Marocco e Qatar con lo
scopo di migliorare la propria reputazione di Stati attraverso iniziative
parlamentari. E proprio il Qatar risulterebbe avere legami con la Sdf di Survé.
La fondazione, infatti, interviene soprattutto in Sudafrica e altri paese
africani, ma anche nelle zone del Golfo, come è stato segnalato in un articolo
del Jerusalem post. L’acquisto per esempio nel 2013 del gruppo editoriale
sudafricano Indipendent media group, per 200 milioni di dollari, è indicato come
operazione consentita con fondi del Qatar, anche se Survé ha smentito.
Aisi e Aise
sentiti dal Copasir. Dietro lo scandalo Qatar spunta una manina di Dubai, tutti
i misteri.
Aldo Torchiaro su Il Riformista il 22 Dicembre 2022
L’intreccio Qatargate–servizi segreti si aggroviglia. Nell’ambiente delle barbe
finte si ricostruisce la genesi: una soffiata arrivata dall’intelligence
degli Emirati Arabi Uniti – acerrimi rivali dei Qatarini – ai servizi belgi, che
poi hanno fatto aprire i dossier alla magistratura di Bruxelles. Sarebbe poi
stato nell’ambito dell’interscambio delle informazioni tra agenzie europee che i
nostri servizi avrebbero preso contezza dell’affaire. Un circuito atipico,
inedito. Giovedì scorso una velina filtrata da Piazza Dante, il Quartier
generale dell’intelligence italiana, parlava di “Aise e Aisi: hanno collaborato
alla fase di intelligence anche le due agenzie italiane, per i rispettivi ambiti
di competenza”.
Perché metterci
la firma, a cose fatte? E se fosse vero che gli apparati erano a conoscenza del
filone di inchiesta già dal dicembre 2021, perché il 6 marzo scorso – con Mario
Draghi a Palazzo Chigi – l’Ad Eni, Claudio Descalzi e l’allora ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, sono stati incoraggiati ad andare a Doha per sancire la
nuova alleanza energetica Italia-Qatar? Gli interrogativi sulla vicenda sono
tanti. E per dare qualche risposta, dopo il capo dell’Aise, generale Giovanni
Caravelli, ieri è stata la volta del generale Mario Parente, direttore
dell’Agenzia informazioni per la sicurezza interna, al Copasir nella seconda
audizione presieduta dall’ex ministro della difesa, il dem Lorenzo
Guerini. Entrato alle 9, il generale ha svolto l’audizione come sempre a porte
chiuse e telecamere spente. Un incontro classificato Segreto. Ne è uscito poco
dopo le 10 e c’è da scommettere che qualche luce in più si è fatta
sul Qatargate.
Lo scenario
internazionale, con Zelensky in visita negli Stati Uniti e una auspicabile
schiarita sul fronte di guerra, punta a definire la lista delle armi da inviare
una volta per sempre e poi a ridisegnare la mappa delle forniture energetiche.
La sicurezza energetica nazionale sarà al centro dell’azione del nuovo governo,
fanno trapelare fonti dell’esecutivo. Così come la sicurezza informatica, posto
che gli attacchi informatici contro le istituzioni dall’estero sono previsti in
aumento già in occasione delle festività in arrivo. Per quanto riguarda le
attività dei lobbisti e le loro interazioni con le istituzioni italiane,
il Copasir starebbe valutando audizioni mirate ad appurare se pressioni e
ingerenze internazionali sono state effettivamente esercitate da soggetti simili
a quelli che hanno tentato la spallata con le istituzioni europee.
Il mondo arabo –
quello dei Paesi del Golfo e quello del Maghreb – è d’altronde terreno ben noto
all’ambasciatore Pietro Benassi, attuale rappresentante permanente del nostro
paese presso l’Unione Europea. L’ambasciatore aveva conosciuto una accelerazione
di carriera con il Conte II: il 21 gennaio 2021 era diventato sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del governo giallorosso e
l’indomani gli era stata assegnata la delega al Sistema dell’informazione per la
sicurezza. Assunta l’autorità delegata per i servizi, è stato il ponte tra
intelligence e diplomazia, tra mondo arabo e istituzioni europee dell’epoca
recente. Non si può escludere che anche grazie ai suoi uffici le indagini
abbiano potuto procedere con tanta profondità. Gli interessati sono colti di
sorpresa.
Gli
interrogatori, ieri quello dell’ex Vice presidente del Parlamento europeo, Eva
Kaili, che si è detta “tradita” dal compagno Francesco Giorgi, sembrano
concentrare la pista intorno alle attività di Antonio Panzeri. La magistratura
belga ha chiesto all’Italia, attraverso Eurojust, di congelare due conti
correnti, uno intestato a Panzeri, l’altro alla figlia Silvia. I due conti
oggetto della richiesta della magistratura belga rientrano tra i sette acquisiti
nei giorni scorsi dalla GdF, coordinata dalla procura di Milano, sulla base
dell’ordine di investigazione europea. Il sospetto è che sui quei conti siano
transitate somme provento della presunta corruzione, di cui l’ex
europarlamentare è accusato, per moderare la posizione del Parlamento europeo
sulle violazioni di diritti umani nell’emirato del Golfo.
Degli iniziali
sessanta eurodeputati coinvolti, ne risultano agli atti non più di cinque.
L’inchiesta si estenderà a macchia d’olio o si rivelerà un bluff? Se lo chiede,
spazientito, l’europarlamentare Andrea Cozzolino. Sospeso “cautelativamente”
dal Pd (Ma il Pd conosce cose che la magistratura non sa?) Cozzolino pur non
avendo ricevuto alcun avviso di garanzia intende essere ascoltato dal magistrato
belga che conduce le indagini, Michel Claise. Anche in Grecia l’intreccio
servizi-magistratura fa discutere: l’eurodeputato Giorgos Kyrtsos, membro
del gruppo Renew Europe, ha presentato una denuncia contro i responsabili della
sua presunta intercettazione illecita, tra i quali figura l’ex capo dei Servizi
segreti greci (EYP): ad Atene si parla ormai di “watergate greco”.
Aldo Torchiaro.
Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003.
Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.
Giacomo Amadori e
Francois de Tonquedec per “la Verità” il 23 dicembre 2022.
I primi ad arrivarci
sono stati i cronisti della Verità. Sabato ci eravamo inerpicati in località
Cielo alto, a Cervinia, e avevamo raggiunto il condominio Schuss I. Un palazzone
di cemento con un centinaio di alloggi e tra questi l’appartamento di 90 metri
quadri intestato alla società belga Nakaz development di Nicolo Figa Talamanca,
segretario generale della Ong No peace without justice fondata da Emma Bonino e
uno dei principali indagati del Qatargate, tuttora agli arresti in Belgio.
Il giudice
istruttore Michel Claise ha chiesto il sequestro preventivo della casa,
contestando alla presunta organizzazione, di cui farebbero parte l’ex
europarlamentare Pier Antonio Panzeri, il suo ex assistente Francesco Giorgi, il
segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati Luca
Visentini (sospeso ieri dalla sua organizzazione) e altri, i reati di
associazione per delinquere, la corruzione e il riciclaggio.
L’ipotesi
dell’accusa e che l’immobile possa essere stato acquistato con soldi provenienti
dal Qatar. Noi domenica avevamo raccontato nei dettagli le contestazioni e la
storia dell’acquisto. Ma il gip di Aosta, Giuseppe Colazingari, nel suo decreto
di sequestro preventivo, firmato il 20 dicembre, aggiunge ulteriori particolari
rispetto a quelli presenti nell’ordine europeo di investigazione: «Secondo le
indagini svolte finora la struttura criminale ha iniziato a far circolare molto
denaro in contanti. In seguito la struttura si e organizzata meglio facendo
circolare i fondi attraverso Ong e/o associazioni non profit gestite da Figa
Talamanca. In pratica vi sono Stati “corruttori” che versano denaro sul conto di
societa con sede all’estero e, successiva- mente, il denaro viene versato su uno
dei conti di una Ong/Onp di Talamanca, il cui ruolo parrebbe essere quello di
garantire che il denaro venga poi convogliato ai destinatari della corruzione».
Uno schema svelato
per primo da Giorgi, ex assistente parlamentare a Bruxelles anche del piddino
Andrea Cozzolino. Il giudice continua: «Figa Talamanca ha anche una societa con
la moglie (la Nakaz, ndr) ed e attraverso questa societa che riceve i suoi
compensi. Poi, attraverso il conto della sua societa finanzia i lavori per la
casa che ha appena acquistato in Italia». Per Colazingari «e quindi evidente
che, dovendosi ritenere a livello gravemente indiziario che l’immobile sia stato
acquistato con denaro di provenienza delittuosa, deve darsi corso al
provvedimento di congelamento e disporsi il sequestro preventivo».
L’immobile e costato
215.000 euro, come si apprende dal rogito del 29 aprile scorso, e le autorita
belghe hanno attenzionato i flussi di denaro tra Bruxelles e l’Italia, in
particolare il conto del notaio E.S. «finanziato per un importo totale di
207.200 euro tra il 26 aprile 2022 e il 28 aprile 2022 con la causale “acquisto
appartamento V.aBrue il Cervinia” dal conto Belga intestato a Nakaz». Il
fratello di Nicolo Figa Talamanca, Giovanni, ci ha informato che l’immobile
sarebbe stato acquistato anche grazie a un mutuo acceso in Belgio, di cui pero
non si fa cenno nel rogito. Alla nostra richiesta di documentazione purtroppo
non abbiamo ricevuto risposta.
Intanto, per
ricostruire il network che attraverso i servizi segreti marocchini avrebbe
tentato di influenzare le istituzioni europee gli investigatori di Bruxelles
hanno disegnato un vero e proprio organigramma. In cima a tutti c’e il piu
potente: Yassine Mansouri, direttore della Dged, il servizio segreto marocchino,
che avrebbe avuto due contatti diretti: Cozzolino e Panzeri. Subito sotto
troviamo Abderrahim Atmoun, soprannominato «il gigante», ambasciatore del
Marocco in Polonia. Il diplomatico di Rabat faceva riferimento a Mohamed
Bellahrach, ufficiale di collegamento della Dged, gia coinvolto anche in una spy
story in Francia nel 2008.
Viene segnalato
anche il collegamento di Atmoun con Maria Arena, l’eurodeputata socialista belga
legata politicamente a Panzeri. Nel documento gli 007 della Surete nationale
scrivono che «il Marocco ha costituito una rete d'ingerenza per promuovere i
suoi interessi all’interno del Parlamento europeo». Con questi risultati:
«Numerose risoluzioni votate; numerose dichiarazioni della Dmag (la delegazione
per le relazioni con il Maghreb ndr); la nomina di candidati per il premio
“Sakharov - per la liberta di pensiero”; l’alterazione del rapporto annuale del
Parlamento europeo sulla politica estera e della sicurezza comune; diverse
nomine di eurodeputati come membri o vicepresidenti di commissione sono state
in- fluenzate».
Mentre ieri
magistrati di Bruxelles hanno chiesto di congelare i conti correnti di Silvia
Panzeri e della madre Maria Colleoni, il capofamiglia Pier Antonio ha scaricato
l’ex collega Cozzolino: «E responsabile di chiedere risoluzioni d’urgenza.
Questo non passa da noi, questo passa direttamente da lui». Da parte sua Giorgi,
compagno dell’ex vicepresidente dell’Europarlamento Eva Kaili, ha cercato di
scagionare la madre di sua figlia («Mi aveva chiesto piu volte di smettere visto
che la mettevo in pericolo») e, in un verbale rivelato dal Fatto Quotidiano, ha
raccontato il sistema con cui il Qatar corrompeva i rappresentanti delle
istituzioni europee.
Il «gancio» sarebbe
stato un uomo conosciuto come «l’algerino». Il quale avrebbe spinto Panzeri a
fondare la sua Ong, la Fight impunity.L’uomo lavorerebbe per il governo del
Qatar e si chiamerebbe «Boudjellal». In Turchia avrebbe messo in contatto Giorgi
con una persona «di origine palestinese». Quest’ultimo avrebbe consegnato, di
volta in volta, numeri di telefono belgi di soggetti da chiamare «per avere i
soldi».
Atmoun, invece,
avrebbe consegnato a Giorgi mazzette per un importo complessivo di circa 50.000
euro. Le consegne avvenivano a Bruxelles o nell’abitazione parigina del
marocchino, dove Giorgi e Panzeri si recavano dicendo di andare «a prendere
delle cravatte o degli abiti». Per cercare di migliorare la propria immagine
avrebbe utilizzato gli stessi metodi anche il governo della Mauritania, pagando,
pero, tangenti molto piu modeste. «Per esempio io ho affittato il mio
appartamento all’ambasciatore e quella era la mia controparte: 1.500 euro + 300
di spese. Panzeri ha preso 25.000 euro cash» ha spiegato Giorgi.
Lui e Panzeri
avrebbero recentemente fatto visita all’ambasciatore della Mauritania e a quello
saudita «che voleva informazioni su quello che si diceva al Parlamento Ue sul
suo Paese». Ieri i legali della ragioniera Monica Rossana Bellini, considerata
dagli inquirenti belgi la «responsabile della consulenza gestionale e
finanziaria della coppia Panzeri-Colleoni» e per questo sospettata di aver
veicolato «operazioni di riciclaggio», ci hanno fatto sapere che la loro
assistita «non e la consulente finanziaria o contabile dei coniugi Panzeri».
La Bellini con un
quotidiano ha aggiunto: «Il mio gruppo di lavoro si e occupato dalla contabilita
forfettaria dello studio legale di Silvia, la figlia. Nient’altro». Mentre ha
definito Luciano Giorgi, padre di Francesco, uno dei suoi tanti clienti, senza
specificare, pero, di aver fondato con lui una societa che doveva funzionare
come una Ong.
Da open.online il 23
dicembre 2022.
È terminata
l’udienza al piano interrato del Palais de Justice di Bruxelles. Si attende la
decisione sulla custodia cautelare di Eva Kaili: il giudice sta valutando se
trattenere o meno in carcere la politica greca. L’ex vicepresidente del
Parlamento europeo, da alcune settimane, è detenuta nell’istituto penitenziario
di Haren, nell’estrema periferia della capitale belga: è coinvolta nello
scandalo ribattezzato Qatargate.
Il team legale che
supporta Kaili ha chiesto alle autorità giudiziarie di sottoporre l’assistita a
regime di sorveglianza elettronica. Intanto, secondo quanto riporta Il Fatto
Quotidiano, in una delle testimonianze rilasciate dalla greca sarebbero stati
citati, non si sa a che titolo, i nomi di alcuni eurodeputati del Partito
democratico: Brando Benifei, Andrea Cozzolino e Alessandra Moretti. Prima
dell’inizio dell’udienza, l’avvocato della politica greca, Michalis
Dimitrakopoulos, aveva ribadito ai cronisti che la sua assistita «non è mai
stata corrotta».
Il legale,
circondato da decine di giornalisti che lo hanno scortato fino all’ingresso del
tribunale, aveva detto di «sperare nella scarcerazione – poiché Kaili – non è né
una sospetta fuggitiva né può manomettere le prove dell’indagine». Con la
stampa, in prima mattinata, si era anche giustificato per la scarsità di
informazioni condivise con i giornalisti: «Dovete sapere che c’è il segreto
istruttorio e non posso dirvi di più».
I giornalisti,
accalcandosi intorno all’avvocato, hanno rischiato di ferirsi: vicino agli
ingressi del tribunale le autorità hanno disposto l’installazione dei cavalli di
Frisia, con tanto di filo spinato e filo a lamette. Queste soluzioni, che in
Italia sottostanno a una normativa più rigida, sono invece correntemente usate a
Bruxelles a fini di ordine pubblico.
«Rispetto ad alcune
indiscrezioni uscite sulla stampa devo precisare con chiarezza e fermezza alcuni
aspetti. Non sono mai stato in Qatar o in Marocco, non avevo nessuna
frequentazione fuori dal lavoro nel Parlamento europeo con nessuna delle persone
coinvolte nello scandalo Qatargate, ogni mia interrogazione o votazione è andata
sempre contro le posizioni politiche sui temi in questione che questi esponenti
politici portavano avanti». Lo dice in una nota il capodelegazione degli
Eurodeputati Pd.
Non è la prima volta
che Benifei viene citato dagli organi di stampa, benché al momento risulti
totalmente estraneo all’inchiesta. «Alla fine della scorsa legislatura sono
stato uno dei pochi europarlamentari del Pd che ha votato per il rinvio per
annullamento alla Corte di giustizia dell’accordo Ue-Marocco, in aperto
contrasto con le posizioni di Panzeri e della maggioranza del Parlamento europeo
di allora.
Respingo quindi con
fermezza qualunque accostamento alle azioni di queste persone e sono disponibile
a collaborare con la magistratura insieme a tutta la delegazione degli
eurodeputati Pd per fare luce al più presto su tutti gli aspetti di questa
vicenda».
(ANSA il 23 dicembre
2022) - "Abbiamo chiesto che la signora Kaili possa essere sottoposta al regime
di sorveglianza elettronica". Lo hanno detto i due avvocati dell'ex
vicepresidente del Parlamento europeo, Andrè Rizopoulos e Mihalis
Dimitrakopoulos, al termine dell'udienza alla camera di consiglio al tribunale
di Bruxelles.
Estratto
dell’articolo di Gabriele Rosana per “il Messaggero” il 23 dicembre 2022.
«Eva Kaili si fidava
del compagno Francesco Giorgi. Lui l'ha tradita». Alla vigilia dell'udienza
preliminare prevista per oggi a Bruxelles nell'ambito dell'inchiesta sulle
presunte tangenti dal Qatar. Michalis Dimitrakopoulos, legale dell'ex
vicepresidente del Parlamento europeo ha avuto, ieri, un incontro di quasi
cinque ore con la sua assistita nel carcere di Haren, a poca distanza
dall'aeroporto della capitale belga. L'obiettivo è convincere i giudici a
rimettere Kaili in libertà, anche per stare vicino durante le feste alla bimba
di poco meno di due anni avuta con Giorgi, che finora e stata affidata al nonno
materno.
Marco Bresolin
per “la Stampa” il 22 dicembre 2022.
Un controverso
personaggio entra prepotentemente nell'inchiesta sul Qatargate. Si tratta di
Eldar Mamedov, consigliere politico del gruppo dei socialisti-democratici (S&D),
detto "l'iraniano". Un nome che potrebbe aprire nuovi scenari, allargandone i
confini. Il funzionario era già nel mirino degli inquirenti per una serie di
atteggiamenti sospetti, come quel "cinque" dato al suo amico Francesco Giorgi
dopo il voto sulla liberalizzazione dei visti per il Qatar. Ma ora c'è una
segnalazione formale all'autorità giudiziaria, fatta dal segretariato generale
del gruppo S&D, d'intesa con i servizi di sicurezza dell'Europarlamento.
Tutto questo mentre
l'italiano Andrea Cozzolino ha chiesto di essere ascoltato dal giudice Michel
Claise per fugare ogni sospetto nei suoi confronti, annunciando di essere pronto
a rinunciare all'immunità. Mamedov è stato sospeso dal gruppo per una «grave
colpa legata all'indagine giudiziaria».
L'elemento concreto
che ha fatto scattare l'allarme riguarda il fatto che il funzionario avrebbe
ricevuto alcuni regali dal Qatar, cosa vietata dal codice etico: fonti
parlamentari rivelano che avrebbe accettato un "pacchetto vacanza completo" per
andare in Qatar e assistere a una partita dei Mondiali, compreso il biglietto
dello stadio.
Ma il sospetto è che
il suo coinvolgimento sia molto più ampio e riguardi le sue manovre all'interno
del Parlamento per condizionare i provvedimenti relativi all'Iran e anche alla
Russia. Mamedov, che lavora per la commissione Affari Esteri, viene descritto
come «un agente al servizio di Teheran».
Conosciuto da tutti
come "l'iraniano", in realtà è nato a Riga 50 anni fa. I suoi genitori sono
originari di una regione dell'Azerbaigian, ma lui negli ultimi anni ha sempre
espresso posizioni estremamente critiche nei confronti di Baku, in rotta di
collisione con Teheran. Grande esperto del Golfo Persico, in passato ha lavorato
come diplomatico per il ministero degli Esteri lettone, prestando servizio nelle
ambasciate di Madrid e Washington.
All'epoca dei fatti,
secondo quanto risulta da articoli di stampa, gli Stati Uniti avevano segnalato
al governo di Riga le sue frequentazioni filo-iraniane, cosa che aveva di fatto
posto fine alla sua carriera diplomatica. Dal 2007 ha iniziato a lavorare al
Parlamento europeo come "political advisor" (consigliere politico) del gruppo
dei socialisti e in parallelo ha portato avanti un'intensa attività da analista,
scrivendo su diversi siti e riviste di geopolitica, promuovendo l'agenda di
Teheran.
Appassionato di
sigari, di Frank Sinatra e del Real Madrid, secondo un report dell'agenzia di
stampa azera "Aze.Media", le Guardie rivoluzionarie iraniane avrebbero
ritagliato per lui un ruolo da «analista indipendente con opinioni liberali
europee», sfruttando le sue informazioni e i suoi contatti per scambiarli con
Mosca.
Resta da capire come
possa aver lavorato per quindici anni all'interno del Parlamento europeo come
consigliere dei socialisti, visto che diversi eurodeputati oggi raccontano che
su certe questioni, effettivamente, «aveva posizioni molto rigide» e cercava di
influenzare quelle degli eurodeputati.
Per esempio in
occasione della recente risoluzione che definiva la Russia uno Stato «sponsor
del terrorismo»: inizialmente il gruppo non aveva sostenuto il testo, ma poi i
parlamentari avevano votato sì perché temevano di essere percepiti come
filo-Putin. Non tutti: Eva Kaili si era astenuta, mentre Andrea Cozzolino,
Pietro Bartolo e Massimiliano Smeriglio avevano votato contro, giustificando la
decisione con motivazioni politiche. Oggi ci sarà la prima udienza in Camera di
Consiglio per Eva Kaili, che sosterrà la sua innocenza, dirà di esser stata
"tradita" da Giorgi e chiederà di essere scarcerata per poter tornare a casa
dalla figlia.
Gianluca Paolucci
per “la Verità” il 23 Dicembre 2022.
Sekunjalo
Development Foundation, la fondazione sudafricana che nei documenti della
Commissione Ue risulta il principale finanziatore della Fight Impunity di Pier
Antonio Panzeri, ha donato nel 2020 un totale di 4,5 milioni di Rand (circa
250.000 euro al cambio attuale) alla Ong a centro dello scandalo di corruzione
che sta scuotendo le istituzioni europee. A dichiararlo è Iqbal Survé, discusso
imprenditore sudafricano a capo del gruppo Sekunjalo. Il rapporto tra Survé e la
Ong di Panzeri sarebbe nato durante il World Economic Forum di Davos, in
Svizzera.
Il nome della
Sekunjalo Development Foundation compare nel parere rilasciato dal Comitato
etico indipendente nel dicembre del 2020, che dà il via libera all'ex
commissario Dimitris Avramoupolos per collaborare con Fight Impunity e ricevere
dalla Ong un compenso per la sua attività. Il documento del Comitato etico non
indica però le cifre, limitandosi a indicare la fondazione sudafricana come
«principale finanziatore» della Ong di Panzeri. Survé, imprenditore molto
discusso in patria, spiega di essere di essere stato avvicinato da «un
referente» della Ong a margine di un incontro del World Economic Forum di Davos.
«Le successive
conversazioni hanno portato alla richiesta formale di Fight Impunity di una
donazione da parte della Sekunjalo Development Foundation (Sdf) nel corso del
2020. Un totale di 4,5 milioni di rand è stato donato a Fight Impunity tra
giugno e settembre del 2020», ha dichiarato l'imprenditore in una risposta
scritta alle richieste della testata sudafricana Daily Maverick.
Nella nota Survé
aggiunge di «non poter commentare» il fatto di essere stato il principale
finanziatore di Fight Impunity ma che questi «sono gli unici fondi forniti» alla
Ong di Panzeri, quella che «Sdf riteneva essere una credibile e legittima
organizzazione coinvolta nella lotta al traffico di esseri umani e agli abusi su
detenuti, nonché il ripristino di pace e giustizia».
Sdf è una fondazione
attiva prevalentemente in Africa ma «non è inusuale per le fondazioni (che fanno
capo Survé, ndr) fare donazioni a organizzazioni al di fuori dell'Africa, dato
che le fondazioni sono delle entità globali e effettuano donazioni per molte
cause diverse in varie parti del mondo». In effetti, il Sekunjalo Group compare
anche nell'elenco dei finanziatori della campagna elettorale di Hillary Clinton
per le presidenziali americane del 2016.
Eppure, nel sito del
gruppo Sekunjalo le attività filantropiche sono elencate in una pagina dedicata
e a proposito della Sdf si riporta che l'attività della fondazione è focalizzata
sui «bisogni socio-economici delle comunità nelle quali (il gruppo Sekunjalo,
ndr) porta avanti le sue attività». Ovvero, prevalentemente il Sudafrica e gli
altri paesi della regione, altri paesi africani e alcuni paesi del Golfo come
Qatar, Arabia Saudita ed Emirati.
Il legame tra il
gruppo Sekunjalo e il Qatar è stato paventato anche da un commento apparso sul
Jerusalem Post nei giorni scorsi e scritto dal presidente di Ngo Monitor, Gerald
M. Steinberg. Nell'articolo, lo studioso prende spunto dallo scandalo di Fight
Impunity per sottolineare come l'Unione europea abbia la necessità di un
meccanismo di supervisione delle Ong e porre fine a un sistema che ha consentito
ad alcune organizzazioni di esercitare una influenza anche a livello politico
senza dover rendere conto del proprio operato.
Nella sua replica,
Survé sottolinea che «a oggi, le fondazioni (che fanno capo allo stesso Survé,
ndr) hanno avuto un impatto positivo su oltre 100 milioni di persone in Europa,
Usa, Asia e Africa con donazioni per oltre 100 milioni di dollari». Malgrado
siano basate in Sudafrica, «hanno finanziato anche organizzazioni svedesi come
la World Children Prize for the Rights of the Child».
L'uomo d'affari
sudafricano, che si presenta come «imprenditore e filantropo», è da anni oggetto
di forti critiche per l'uso disinvolto di fondi pubblici in iniziative del suo
gruppo e per i legami con la politica, in particolare con l'elite dell'Anc, il
partito che fu di Nelson Mandela e che è rimasto ininterrottamente al potere in
Sudafrica dalla fine dell'Apartheid a oggi malgrado i numerosi scandali che
hanno coinvolto i suoi esponenti di punta. Il salto di qualità il gruppo
Sekunjalo lo effettua nel 2013, quando acquista uno dei principali gruppi dei
media del Paese, l'Independent Media Group (Img) per circa 200 milioni di
dollari.
All'epoca, si disse
che parte dei fondi necessari per l'operazione sarebbero arrivati proprio dal
Qatar, anche se Survé ha smentito. Nel consorzio c'erano invece i fondi pensione
di due importati sindacati sudafricani e un investitore cinese, oltre a una
quota del fondo statale di sviluppo Pic. Recentemente, il gruppo Sekunjalo ha
portato di fronte all'autorità per la concorrenza sudafricana nove tra le
principali banche del Paese che avevano chiuso i conti del gruppo oppure messo
delle limitazioni alle movimentazioni di fondi per ragioni reputazionali legate
alle varie vicende anche giudiziarie nelle quali è stato coinvolto. Il tribunale
nel settembre scorso ha imposto alle banche la ripresa della regolare attività
con Sekunjalo, ma ha escluso dalla sua decisione un conto personale di Survé
presso Nedbank.
G. Gua. per
il “Corriere della Sera” il 23 Dicembre 2022.
La casa della più
bella coppia del Parlamento europeo era la cassaforte dove Antonio Panzeri
metteva al sicuro la montagna di contanti ricevuti da Qatar e Marocco protetti
dall'immunità parlamentare di Eva Kaili.
La ex giornalista
greca nel signorile appartamento di Bruxelles ci viveva con il compagno
Francesco Giorgi prima che entrambi e Panzeri fossero arrestati. Interrogata,
Kaili addossa al fondatore di Fight impunity i 600 mila euro in contanti trovati
nella valigia che suo padre trasportava «inconsapevolmente» quando fu fermato
dalla polizia.
Al giudice Michel
Claise, dopo l'arresto, la deputata europea greca, come ha rivelato
ilfattoquotidiano.it , ha affermato che a casa sua Panzeri anche «prima del
Covid aveva lasciato dei soldi e poi è venuto a prenderli. Si fida più di
Francesco che del suo appartamento», «penso che sia a causa della mia immunità»,
afferma. Giorgi faceva da custode «forse anche per il suo boss attuale Andrea
Cozzolino (che non risulta indagato, ndr )».
Lo avrebbe fatto per
«un obbligo morale» verso Panzeri, che lo aveva preso alle sue dipendenze quando
era parlamentare europeo, e verso Cozzolino, che gli ha riconfermato l'incarico.
Giorgi «non sapeva dire di no, era troppo gentile. Io forse avrei dovuto dire
qualcosa perché sono più anziana», ammette, anche perché lei non si fidava di
quello che i tre facevano, seppure lei stessa si rivolgesse a Panzeri per avere
consigli su come muoversi in politica.
Quando la polizia è
entrata in casa, Kaili ha telefonato a Panzeri ma, non trovandolo, ha chiesto di
lui agli eurodeputati socialisti belgi Marc Tarabella e Maria Arena, i cui nomi
sono nelle carte dell'inchiesta ma anche loro non risultano indagati. Non
sapevano dove fosse.
«Solo» i 150 mila
euro trovati nell'appartamento sarebbero stati di Giorgi, che li aveva presi in
prestito per comprare la loro nuova casa, dato che non era in buone condizioni
economiche. «Il mutuo è a mio nome, io pago per quello e i lavori», precisa
Kaili aggiungendo che lui «chiede prestiti ai suoi genitori ogni tanto. Forse
anche ad Antonio», ma non esclude che i soldi potessero arrivare da altri. Il
giorno prima dell'arresto aveva visto in casa due borse piene di contanti che
attribuisce a Panzeri.
Quando il giudice
Claise le chiede di fare i nomi delle persone che erano intorno a Panzeri, i
verbali pubblicati da ilfattoquotidiano.it riportano nomi di parlamentari
europei e loro collaboratori di cui la Kaili dice di non sapere se avessero
ricevuto regali. Poi lo sfogo con il quale sembra rivendicare la sua innocenza:
«Hanno confuso la missione di Panzeri con la mia».
Lei si occupava
«della liberalizzazione dei visti per l'Ue da alcuni Paesi del Medio Oriente. Il
Kuwait, il Qatar e l'Oman erano considerati la priorità, non solo perché sono
fornitori di gas, ma anche perché rispettavano le condizioni necessarie più
degli altri. Anche la Commissione faceva molta pressione su questo e anche io
ero d'accordo» ed in questo periodo erano in corso «discussioni molto intense
sui diritti dell'uomo e del lavoro. Io credo che sia per questo che si
confondono la missione di Panzeri, orientata sui diritti dell'uomo, e la mia che
era orientata sui visti e l'energia».
Marco Bresolin
per “la Stampa” il 23 Dicembre 2022.
Chi intraprende
un'attività privata dopo aver fatto il parlamentare o il ministro, anche per
un'Ong, per almeno cinque anni non potrà più occuparsi dei temi che ha trattato
lavorando per le istituzioni. È la proposta che Brando Benifei, capo-delegazione
del Pd a Strasburgo, lancia al suo partito. Una norma interna sulle "porte
girevoli", da trasformare poi in legge dello Stato, per rispondere al
caso-Panzeri.
Negli interrogatori,
gli investigatori hanno fatto il suo nome e pare che Eva Kaili abbia fatto
riferimento a un suo presunto coinvolgimento: perché?
«Quello che avrebbe
detto Kaili non è affatto chiaro. Sul fatto che sia stato citato il mio nome
nelle domande, credo sia normale in quanto sono il capo-delegazione del Pd e
dunque ho un ruolo».
Ma proprio per
questo, come è possibile che non si sia mai accorto di nulla di strano?
«In questi anni sono
emerse posizioni anche contrastanti all'interno del gruppo sui vari temi, ma si
tratta di divergenze legate a rispettabili posizioni politiche. È successo anche
sulla Cina, per esempio».
Il gruppo dei
socialisti-democratici ha sospeso e denunciato un funzionario perché sospettato
di essere corrotto da Doha e di lavorare per l'Iran, ma era lì da 15 anni...
«Se ci sono stati
comportamenti scorretti, è giusto aver preso queste decisioni. Ricordo che su di
lui giravano strane voci e che per questo avevo sollevato la questione, che ora
dovrà essere approfondita coi vertici del gruppo».
Le prese di
posizione su Marocco e Qatar non hanno mai destato alcun sospetto?
«Per capire che non
si trattava di legittime posizioni politiche è servito il lavoro di cinque
Servizi segreti, le intercettazioni. Detto questo, sul Qatar qualche discussione
politica si era aperta, seppur solo recentemente e in seguito ad alcuni episodi,
come l'incomprensibile discorso di Kaili in plenaria o dopo la mail di
Cozzolino. Sul Marocco invece le cose sono un po' diverse».
C'è stata una
sottovalutazione?
«La magistratura
stabilirà se ci sono state ingerenze, ma secondo me sul Marocco il gruppo S&D ha
tenuto posizioni sbagliate, contrarie a quelle che io difendevo. Tanto che avevo
co-firmato alcune iniziative con Ana Gomes, che ha fatto grandi battaglie. Sono
stato uno dei pochi a votare per il rinvio alla Corte di Giustizia dell'accordo
commerciale che non rispettava i diritti del popolo Sahrawi. Sul Marocco avevo
posizioni opposte a quelle di Panzeri».
Che rapporti ha
avuto con lui dopo la fine del suo mandato?
«Mi è capitato di
parlarci di questioni di politica nazionale, era un dirigente di Articolo Uno.
Ma non mi ha mai contattato per questioni di politica estera: forse proprio
perché sapeva come la pensavo. Con Giorgi non mi sono mai scambiato nemmeno un
whatsapp».
Dunque lei non ha
nulla da rimproverarsi?
«Dovendo fare
un'auto-critica, direi che abbiamo sbagliato a fidarci di Panzeri. Era ancora
molto presente nei corridoi del Parlamento, ma chi mai avrebbe pensato che
facesse le cose di cui ora è accusato?
Del resto a giugno
pure la presidente Roberta Metsola era a un convegno co-organizzato da Fight
Impunity all'interno del Parlamento. Ora abbiamo capito che la fiducia non basta
più, servono regole e il Pd dovrebbe urgentemente dare l'esempio con norme
stringenti sulle porte girevoli per impedire a chi ha lavorato nelle istituzioni
di sfruttare le proprie relazioni».
In che modo?
«Bisogna stabilire
un periodo di "cooling-off": chi ha fatto il parlamentare, l'europarlamentare o
il ministro, per un determinato periodo non potrà più occuparsi nelle sue
attività private dei temi che ha trattato. Io dico per almeno cinque anni. E
questo dovrebbe essere esteso anche alle attività all'interno delle Ong, che
purtroppo sono state screditate da questa vicenda. Come eurodeputati Pd
proponiamo al partito di dotarsi subito di regole chiare per dare l'esempio e
poi fare una battaglia per introdurre un'apposita legge».
Il Qatargate non
è nato oggi e non è solo Panzeri.
Stefano Piazza su Panorama il 23 Dicembre 2022.
Colloquio con
Alexander Del Valle, politologo, che racconta cosa succede da anni tra i palazzi
della politica europea e Doha
Un miliardo di euro
è questa la cifra che il Qatar avrebbe investito nelle ultime elezioni del
Parlamento europeo pagando le campagne elettorali di politici italiani, belgi e
francesi e la corruzione è proseguita anche dopo il voto. Ne parliamo con
Alexander Del Valle geopolitologo, scrittore e giornalista.
Qatargate, il
sindacalista Visentini: «Orribile la prima notte in cella, solo un libro mi ha
salvato. I contanti? Una donazione».
Storia di Giuseppe
Guastella su Il Corriere della Sera il 23 Dicembre 2022.
Due settimane non
sono bastate a Luca Visentini per superare completamente lo choc delle 48 ore di
arresto per le tangenti del Qatargate passate, dicono i magistrati, dalla Ong
Fight impunity di Antonio Panzeri. Incontriamo il segretario dell’Unione
internazionale dei sindacati (Ituc) in un bar in centro.
Cosa ha provato
quando la polizia è arrivata a casa sua? «Incredulità e senso di smarrimento.
Sapevo di non avere fatto nulla di male e non capivo cosa stesse capitandomi e
perché».
Lo avrà capito
dall’ordine d’arresto.
«Me l’hanno fatto
solo leggere, molto in fretta. In quella situazione era molto difficile
comprendere tutto, anche perché era in francese e io non parlo quella lingua. Mi
resi conto che si faceva riferimento a una rete di corruzione internazionale».
La prima notte in
cella?
«Orribile perché
sapevo di essere innocente. Per fortuna mi hanno permesso di tenere un libro con
me. È servito a provare a distrarmi».
Arresto venerdì 9,
sabato l’interrogatorio del giudice viene rinviato al giorno dopo. Mentre la
riportavano in cella cosa pensava?
«Provavo angoscia e
frustrazione per non avere potuto spiegare e chiarire la mia innocenza. La notte
è stata pessima. Avevo un mal di testa fortissimo e non mi permettevano di
prendere medicine. Pensavo continuamente alla mia famiglia e ai colleghi del
sindacato».
Il giorno,
interrogatorio.
«È durato circa
un’ora. Le domande riguardavano l’ accusa di essere parte di un’associazione a
delinquere, c’erano poi corruzione e riciclaggio. Le ho contestate tutte e ho
fornito al giudice tutte le informazioni e le spiegazioni che mi sono state
richieste. Ho subito detto che io avevo partecipato solo ad attività culturali
pubbliche e gratuite sui diritti umani».
La accusano di aver
ricevuto da Panzeri due buste con in tutto 50 mila euro. Perché gliele ha date?
«Era una donazione
dell’associazione Fight impunity che, come avviene normalmente, è stata usata in
parte per rimborsare i costi della mia campagna per il congresso del sindacato
mondiale, in parte per sostenere la partecipazione al congresso dei sindacati
che avevano limitate risorse economiche».
Non le sembrava
strano se non sospetto che le desse dei soldi in contanti?
«Mi è sembrato
strano, ma non avevo sospetti su una Ong che sembrava avere una reputazione
specchiata. Ricordo che chiesi a Panzeri perché mi dava dei contanti, la sua
spiegazione fu che l’associazione raccoglieva i finanziamenti da donatori che
operavano in paesi con regimi autoritari e che per questo non possono utilizzare
canali bancari perché altrimenti verrebbero individuati».
Dopo, però, andò in
Qatar con lui a inizio novembre. A fare che?
«Ero stato invitato
dall’ organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite e dal governo
che, come sempre avviene in visite istituzionali di questo tipo, si faceva
carico del costo del viaggio. Alla fine della visita ho rilasciato un’
intervista ad un’ agenzia di stampa internazionale spiegando che, nonostante
alcune importanti riforme, in Qatar la situazione dei diritti umani e dei
lavoratori è ancora assolutamente insoddisfacente e c’è bisogno di mantenere
alta la pressione sul governo e sulle imprese, anche dopo la fine dei Mondiali.
Una posizione molto critica».
Le indagini
proseguono con l’accusa che continua a ritenere che a lei siano andati più soldi
dei 50 mila euro. «Non è così».
Conosceva Giorgi,
Kaili e Andrea Cozzolino, che viene associato a Panzeri?
«Nessuno di loro».
Quando l’hanno
scarcerata, come si è sentito?
«Sollevato e
felice».
Panzeri e Giorgi
sembrano averla scagionata.
«Sono contento che
la verità stia emergendo».
Ha ricevuto
solidarietà? «Da tutto il mondo, da tantissimi colleghi e amici».
E dal
sindacato? «Sono in una situazione di sospensione per consentire all’Ituc di
chiarire tutte le implicazioni e l’impatto di questa vicenda. È un percorso che
condivido e spero di poter riprendere il mio lavoro quando tutto sarà chiarito.
Ho dedicato tutta la mia vita al sindacato, la difesa dei lavoratori è la mia
missione».
Estratto
dell’articolo di Leonardo Coen per “il Fatto quotidiano” il 23 Dicembre 2022.
Mercoledì 14
dicembre. Si gioca Francia-Marocco, semifinale dei controversi Mondiali del
Qatar. A Washington, Biden si concede una "pausa soccer" per seguire la partita,
assieme all'ospite marocchino, il premier Aziz Akhennouch. Dall'altra parte
dell'Atlantico, nello stadio Al-Bayt di Al-Khawr, in tribuna d'onore a tifare i
Leoni dell'Atlante c'è Mohammed Yassine Mansouri, uno dei più alti responsabili
dei Servizi marocchini, capo dell'agenzia di controspionaggio Dged (Direzione
generale degli studi e della Documentazione) con sede a Rabat.
Il giorno dopo, il
nome di Mansouri spunta fuori dalle pagine dell'inchiesta guidata dal giudice
Michel Chaise. L'imbarazzo serpeggia tra le cancellerie di Francia, Belgio e
Spagna, le più coinvolte per interessi geopolitici e commerciali con il Marocco.
Parigi, per esempio, deve moltissimo alla collaborazione che l'intelligence
marocchina ha offerto per debellare le cellule responsabili degli attentati del
2015 […]
Pure i belgi sono
strettamente collegati ai Servizi di Rabat, considerati tra i più affidabili ed
efficaci, una reputazione conquistata coi suoi agents de terrein, ossia le
risorse umane civili che assicurano una fitta rete laddove le comunità della
diaspora marocchina è più fiorente. […] Insomma, il Moroccogate potrebbe
mettere in crisi anni di proficui rapporti. Senza dimenticare le ottime
relazioni con l'Fbi e Cia […] Agli occhi delle intelligence occidentali il
Marocco rappresenta un'isola di sicurezza e stabilità in un'area di minacce
terroristiche e criminalità transfrontaliera.
[…] Molti
eurodeputati ricordano che quando Panzeri presiedeva dal 2004 al 2019 la
sottocommissione Droi (quella dei diritti umani), si spendesse molto a favore
del Marocco, riguardo i contenziosi commerciali, o quelli per i diritti di
pesca, la delicatissima questione del Sahara Occidentale di cui re Mohammed VI
vorrebbe fosse riconosciuta da Bruxelles la marocanité. Mansouri, amico del
sovrano (hanno studiato assieme al Collegio Reale), seguiva la partita a fianco
di Nasser Bourita, ministro degli Esteri e di Abdellatif Hammouchi, capo della
polizia e dei Servizi di sicurezza nazionale del Marocco, uno degli uomini più
temuti nel mondo delle barbe finte. Non lontano da loro, Macron.
KAILI RIMANE IN
CARCERE NEGATI I DOMICILIARI PM A CACCIA DELLE TANGENTI.
Redazione L'Identità
il 23 Dicembre 2022
di MIRIAM NIDO
“Eva Kaili è
innocente e non è stata mai corrotta. Si fidava del compagno e lui l’ha
tradita”. È su questa linea difensiva, tracciata dagli avvocati André Rizopoulos
e Mihalis Dimitrakopoulos, che la ex vicepresidente greca dell’Europarlamento si
è giocata la possibilità di lasciare il carcere di Haren, in cui è detenuta dal
giorno in cui lo scandalo del Qatargate è deflagrato in Europa. Ma non c’è stato
nulla da fare: Kaili resterà in prigione almeno al 22 gennaio. È reclusa dal
giorno in cui la polizia belga ha fermato suo padre, mentre tentava di portare
via dalla casa della Kaili una valigia piena di banconote, per un totale di
750mila euro, che per gli inquirenti sono frutto del sistema corruttivo di
tangenti dal Qatar messo in piedi dall’ex eurodeputato dem Antonio Panzeri e dal
compagno della Kaili, Francesco Giorgi. Ed è verso quest’ultimo, che sta
collaborando e ha ricostruito un giro in cui sarebbero coinvolti oltre sessanta
europarlamentari, che Kaili sta puntando il dito, per salvarsi dalla galera e
poter almeno andare ai domiciliari, per riabbracciare la figlioletta di due
anni, avuta dal compagno. L’ex vicepresidente, infatti, ha giurato ai magistrati
di non sapere niente di quelle banconote, di non essere neppure a conoscenza del
fatto che fossero nascoste nella casa che condivideva con Francesco Giorgi. Una
versione alla quale i giudici non hanno creduto, sulla base degli atti che
raccontano un’altra storia. Perché secondo gli inquirenti, Eva Kaili è
“intervenuta a difesa degli interessi del Qatar, avendo incontrato il ministro
del Lavoro” del governo di Doha, proprio su indicazione di Panzeri, il quale le
“avrebbe impartito ordini per il tramite del marito”. E contro di lei ci sono
anche le telefonate e le intercettazioni, tra cui quelle del giorno dell’arresto
del padre, fermato al lussuoso hotel Sofitel, in cui l’ex vicepresidente
dell’Eurocamera avrebbe dato istruzioni al genitore di nascondere le tangenti. E
quando scattarono le le manette anche per il compagno Giorgi, la Kaili “ha
tentato di avvertire Panzeri e due eurodeputati della presente inchiesta”, hanno
scritto gli inquirenti per motivare le esigenze di custodia cautelari nei
confronti della donna, ravvisando la flagranza di reato che si è configurata nel
ritrovamento dei soldi in casa, e l’inquinamento delle prove, messo in atto con
la fuga del padre e le telefonate di Eva per avvisare dell’inchiesta gli
interessati. Atti che certamente pesano sull’istanza della difesa, che proprio
ieri hanno chiesto ai giudici la scarcerazione della Kaili. “Collabora
attivamente ma contesta ogni accusa di corruzione”, hanno detto i legali uscendo
dal palazzo di giustizia di Bruxelles dove, in alternativa, avevano avanzato la
possibilità che venissero almeno concessi i domiciliari, con braccialetto
elettronico. “Abbiamo preso l’impegno di non parlare perché l’inchiesta è seria
e segreta, dunque vi dico che Kaili è innocente e non è mai stata corrotta, mai.
Non sapeva dei soldi, mai”, ha aggiunto la difesa. Un’inchiesta che nel mentre
si sta allargando. Oltre al Qatar e al Marocco, spunta anche l’ombra dell’Iran
sulla cricca di Panzeri, considerato l’anima della “vasta organizzazione
fraudolenta”, i cui “atti criminali” avrebbero avuto una “natura complessa,
organizzata e ripetitiva”. Perfino sfacciata, visto che gli indagati agivano con
spregiudicatezza e scherzavano mentre si passavano le buste con le mazzette.
“Sembriamo quelli di Ocean’s Eleven”, diceva Panzeri, che aveva trasformato
Bruxelles nel suo casinò. E di fronte alle prove contestate, l’ex eurodeputato
di Articolo Uno ha cominciato ad ammettere parzialmente alcune delle accuse. Ha
confermato l’esistenza di un accordo con il Qatar”per evitare risoluzioni
contrarie” da parte dell’Europarlamento, in cambio di “50 mila euro” e l’impegno
di fare lobbying a livello europeo per ripulire l’immagine di Doha al fine di
creare un clima di favore nei confronti dell’Emiro. Panzeri, inoltre, ha
chiamato in causa nel sistema di tangenti anche Andrea Cozzolino, l’eurodeputato
sospeso in via cautelativa dal Pd e al momento non indagato. Il quale, per
fugare ogni sospetto, ha rinunciato all’immunità parlamentare e ha chiesto ai
giudici di essere ascoltato.
I contatti
di Avramopoulos: quei nove colloqui sotto accusa.
Aperta un'inchiesta
interna sui contatti certificati tra l'ex commissario e almeno nove commissari
dell'attuale esecutivo europeo. Mauro Indelicato il 23 Dicembre 2022 su Il
Giornale.
Il Qatargate continua ad agitare la politica europea e il Natale in arrivo
potrebbe essere tra i più turbolenti degli ultimi anni a Bruxelles. Nell'occhio
del ciclone già da giorni è finito l'ex commissario europeo Dimitris
Avramopoulos.
Che cos'è il
Qatargate e come si è sviluppato
Nel mirino alcuni
suoi contatti con gli attuali membri della commissione, circostanza vietata dal
regolamento interno dell'esecutivo europeo. Ma qual è il nesso tra Avramopoulos
e il Qatargate? Si tratta soprattutto sul ruolo che il politico greco ha avuto
all'interno dell'Ong Fight Impunity, la stessa guidata da Antonio Panzeri, l'ex
eurodeputato al centro dello scandalo giudiziario.
I contatti di
Avramopoulos con alcuni membri della commissione
I regolamenti
parlano chiaro: quando scade un mandato a un membro della commissione,
quest'ultimo non può intrattenere rapporti di natura politica o lobbistica con
membri della nuova commissione per almeno due anni.
Un ex commissario
quindi non può influenzare il lavoro dei suoi successori e di chi ha preso il
suo posto. Non può soprattutto promuovere una lobby o un interesse particolare.
Avramopoulos è stato commissario dal novembre 2014 al novembre 2019. Ha guidato
in particolare la sezione dell'esecutivo europeo dedicata agli Affari Interni e
all'immigrazione. Quella, per intenderci, oggi retta da Ylva Johannson.
Scelto in quota
Nuova Democrazia, partito di centrodestra greco, dal presidente della
commissione Jean-Claude Juncker, il mandato è scaduto nel novembre 2019. Quindi,
per regolamento, fino al novembre 2021 non poteva rappresentare alcun interesse
specifico e lobbistico in seno alla nuova commissione guidata da Ursula Von Der
Leyen.
Eppure, come
sottolineato su La Stampa, da membro attivo dell'Ong Fight Impunity, ha
incontrato almeno nove commissari. A partire dal connazionale Margaritis
Schinas, attuale vice presidente della commissione. Così come i vice presidenti
esecutivi Frans Timmermans e Margrethe Vestager, oltre che Vera Jourova e Maros
Sefcovic. Tra i vari contatti, anche quelli con Ylva Johannson, Mariya
Gabriel, Stella Kyriakydes e con Johannes Hahn.
Incontri avvenuti,
secondo un'indagine interna alla commissione, prima del novembre 2021. Prima
quindi della scadenza dei termini per il divieto imposto agli ex commissari di
incontrare i successori.
Quali sono stati i
temi affrontati nei vari incontri, al momento non è dato sapere. L'indagine
interna all'esecutivo europeo ha come obiettivo proprio quello di svelare i
contenuti dei vari colloqui. Un portavoce della commissione ha spiegato nelle
scorse ore che, almento per il monento, non sono emersi dettagli compromettenti
dall'inchiesta interna.
I commissari
coinvolti infatti, a proposito degli incontri con Avramopoulos, avrebbero
parlato di “brevi visite di cortesia e – si legge nelle dichiarazioni del
portavoce – in nessuno di questi incontri, da quanto ci risulta, stava
rappresentando l'Ong per la quale aveva richiesto l'autorizzazione né che siano
state discusse questioni del genere”. L'Ong a cui si fa riferimento è per
l'appunto quella di Panzeri.
I timori della
commissione
Avramopoulos non
risulta indagato nell'ambito del Qatargate. Ma il suo ruolo in Fight Impunity
sta imbarazzando e non poco la commissione. Lui stesso ha ammesso di aver
operato per l'Ong fondata da Panzeri, ricevendo per questo un compenso di
sessantamila Euro. Ma, al tempo stesso, ha dichiarato di non aver mai avuto
ruoli dirigenziali.
Tuttavia la Fight
Impunty è sospettata dagli inquirenti belgi di essere stata usata da Panzeri per
i piani corruttivi del Qatar. Doha potrebbe aver versato, è il sospetto su cui
si sta indagando, somme sui conti dell'Ong per attivare il gruppo vicino all'ex
eurodeputato.
"Stava per
entrare...". La rivelazione della segretaria della Ong di Panzeri
Il fatto che
Avramopoulos ha incontrato, durante il suo periodo di collaborazione retribuita
con Fight Impunity, nove commissari europei in un momento peraltro in cui per
regolamento non poteva con loro intrattenere rapporti, potrebbe mettere in
difficoltà la commissione. Specialmente a livello politico e questo a
prescindere dai risvolti penali della vicenda.
Intanto il diretto
interessato ha smentito ogni attività lobbistica a favore dell'Ong di Panzeri e
ha smentito anche l'esistenza di "zone grigie" nel suo operato. Parlando, al
contrario, di un complotto italiano per favorire Luigi Di Maio quale inviato Ue
per il Golfo Persico, carica per la quale sono in lizza proprio Avramopoulos e
l'ex ministro degli Esteri di Roma.
Estratto
dell'articolo di Giuliano Foschini e Luca De Vito per “la Repubblica” il 23
Dicembre 2022.
C'è una storia,
all'interno del Qatargate, che è più grande delle altre. Lo è perché, per dirla
con le parole di un alto dirigente della nostra intelligence, «rappresenta uno
dei casi più clamorosi di spionaggio, anzi direi il più clamoroso, mai accaduto
nell'Unione europea». Un caso in cui l'Italia, o meglio "les italiens", giocano
un ruolo da protagonisti assoluti tanto che in queste ore l'Italia sta
verificando chi e che ruoli ha giocato nella commedia. […]
La storia è quella
del programma Pegasus, il software israeliano che sarebbe stato utilizzato da
decine di governi per spiare politici, giornalisti e attivisti in tutto il
mondo. Compreso in Europa. La procura belga - come dimostrano i documenti che
Repubblica ha potuto consultare - sostiene che uno dei principali motivi per cui
il Marocco abbia deciso di intervenire e corrompere il gruppo Panzeri sia
proprio controllare il dossier Pegasus: troppi interessi in ballo per poter
stare fuori dalla partita.
Tutto comincia nel
marzo del 2022 quando il Parlamento europeo - con 635 voti favorevoli, 36
contrari e 20 astenuti - decide di istituire una commissione d'inchiesta
sull'uso di Pegasus e altri spyware di sorveglianza. Lo fa dopo la pubblicazione
di alcune inchieste giornalistiche che documentano come alcuni paesi stranieri,
tra cui il Marocco, abbiano utilizzato il software per spiare in Europa: proprio
i servizi segreti di Rabat sono accusati, raccontano alcuni documenti agli atti
depositati dell'inchiesta, di aver utilizzato il software per spiare il telefono
del presidente francese Emmanuel Macron.
L'apertura di
un'inchiesta specifica da parte del Parlamento preoccupava i marocchini per due
ragioni: per dove sarebbero potuti arrivare e soprattutto per le conseguenze che
potevano esserci. Avevano necessità di conoscere in tempo reale cosa accadeva
per, eventualmente, prendere contromisure.
Per questo, per lo
meno per come la procura ricostruisce la questione, fanno una mossa. Anzi tre.
«Spingono l'adesione del deputato Andrea Cozzolino alla commissione speciale
parlamentare», «dato il coinvolgimento pubblico del Marocco in questo file». E,
non contenti, piazzano anche altri due del gruppo: «La vicepresidente Eva Kaili
e la parlamentare belga Marie Arena». Il compito che viene loro affidato è,
sempre la ricostruzione che ne fanno i belgi, preciso e raffinato. Intervenire,
senza però mai dare l'impressione di lavorare per il nemico.
«Il team lavora a
servizio del Dged», il servizio marocchino, e del suo numero uno, Yassine
Mansouri, che ha incontrato almeno in un'occasione direttamente Cozzolino. E in
due Panzeri. «In tale contesto - annota ancora la polizia belga - il gruppo
degli italiani opera con una discrezione che va oltre la mera prudenza. Evitando
di apparire troppo apertamente filo-marocchini all'interno del Parlamento.
Usando un linguaggio in codice» […]
Cosa volevano sapere
esattamente i marocchini? E ancora: possiamo essere sicuri che Pegasus non sia
stato mai utilizzato dal gruppo, su obiettivi italiani, per altri interessi?
Proprio sul nostro Paese esiste un precedente imbarazzante. «In Italia - scrive
la commissione del Parlamento nel report pubblicato nei giorni scorsi, dopo
l'esplosione dello scandalo, e acquisito dalla polizia belga - esiste un caso di
utilizzo di Pegasus: l'ex primo ministro e presidente della Commissione europea
Romano Prodi sarebbe stato preso di mira con Pegasus. Prodi era l'inviato
speciale delle Nazioni Unite nel Sahel, relativo al rilascio di Sahara
occidentale, un territorio conteso tra il Marocco e la Repubblica Araba. Secondo
le informazioni a controllare il telefono di Prodi sarebbe stato il servizio
segreto marocchino». […]
"Les italiens" a
servizio del Marocco: così volevano fermare l'inchiesta su Pegasus.
Emergono
anche coinvolgimenti di Rabat, tramite il gruppo di Panzeri e Giorgi, nella
commissione dell'europarlamento chiamata a indagare sul caso Pegasus. Mauro
Indelicato il 23 Dicembre 2022 su Il Giornale.
Non solo la
questione del Sahara Occidentale e degli accordi commerciali con l'Ue. Se
il Marocco si è mosso, secondo gli inquirenti belgi, è anche per altri motivi.
Rabat ha avvicinato la presunta cricca capeggiata dall'ex eurodeputato Antonio
Panzeri, assieme al suo ex collaboratore Francesco Giorgi, anche per mettere le
mani sulla commissione di inchiesta relativa all'affaire Pegasus. Dal nome del
software con cui alcuni servizi segreti, compresi quelli del Marocco, avrebbero
spiato leader politici europei.
La commissione
Pegasus
Nelle scorse
ore Repubblica ha pubblicato alcuni passaggi dei documenti dell'inchiesta della
magistratura belga sul cosiddetto Qatargate. Un nome però che tradisce lo
sviluppo a “doppio binario” delle indagini. Non c'è infatti soltanto Doha
coinvolta nel presunto giro di mazzette, ma anche per l'appunto Rabat. Fino a
oggi si è ipotizzato come il Dged, il servizio segreto marocchino, abbia agito
su Panzeri e su altri esponenti politici europei unicamente per la questione
del Sahara Occidentale e degli accordi commerciali con l'Ue.
La pista delle
mazzette porta in Marocco: ecco gli interessi in gioco
Con le nuove
rivelazioni però, sembrerebbe adesso che gli obiettivi del Marocco fossero
altri. In particolare, Rabat voleva vederci chiaro sulla commissione Pegasus. La
commissione cioè nata nel marzo del 2022 all'interno del parlamento europeo per
indagare su possibili casi di spionaggio.
In quelle settimane
è infatti emerso che con il software Pegasus, creato dalla società
israeliana Nso, alcuni importanti leader politici europei sono stati spiati. Tra
questi il presidente francese Emmanuel Macron. Ma non sarebbero stati immuni da
casi di spionaggio anche diversi membri della commissione europea.
Chi ha spiato i
politici del vecchio continente? È proprio questa la domanda a cui i membri
della commissione devono dare risposta. In alcuni articoli giornalistici, è
emerso un ruolo del Marocco nell'uso di Pegasus. Un ruolo, per la verità, ancora
da accertare e con Rabat comunque non come unica indiziata nel caso.
Ad ogni modo, gli
inquirenti belgi del Qatargate avrebbero notato un tentativo marocchino di
infiltrare proprio uomini all'interno della commissione. I servizi di Rabat, in
particolare, “spingono l'adesione del deputato Andrea Cozzolino alla commissione
speciale parlamentare – si legge nelle carte degli investigatori di Bruxelles –
dato il coinvolgimento pubblico del Marocco in questo file". “Inoltre – si legge
ancora – nella commissione ci sono anche la vicepresidente Eva Kaili e la
parlamentare belga Marie Arena”. Kaili è la vice presidente del parlamento
europeo, compagna di Francesco Giorgi e attualmente in stato di fermo per via
dei soldi ritrovati nella propria abitazione. Secondo gli inquirenti di
Bruxelles, Cozzolino (non indagato nell'affaire Qatargate), Kaili e Arena
avrebbero composto un vero “team che lavora a servizio del Dged” e, in questo
contesto “il gruppo degli italiani – scrivono gli investigatori – opera con una
discrezione che va oltre la mera prudenza. Evitando di apparire troppo
apertamente filo-marocchini all'interno del Parlamento. Usando un linguaggio in
codice”.
I possibili
obiettivi di Rabat
Viene chiamato
gruppo di italiani anche se non ci sono solo nostri connazionali coinvolti. Il
riferimento è quindi probabilmente più a Panzeri e Giorgi e al loro ruolo di
vertice nel presunto gruppo pro Marocco.
Ad ogni modo,
l'obiettivo principale di Rabat era quello probabilmente di sapere fin nel
dettaglio l'andamento dei lavori all'interno della commissione Pegasus. In tal
modo, i servizi marocchini sarebbero eventualmente potuti intervenire.
Se il quadro
accusatorio belga dovesse essere confermato, allora il coinvolgimento del
Marocco nella vicenda potrebbe avere ripercussioni anche sulla stessa inchiesta
Pegasus e capire meglio come il software sia stato usato nei confronti di
diversi leader politici europei. Tra questi, è il sospetto trapelato su
Repubblica, anche Romano Prodi in qualità di inviato speciale delle Nazioni
Unite per il Sahel.
IO, DOHA E
PANZERI.
Rita Cavallaro su L’Identità il 23 Dicembre 2022.
Sono le rivelazioni
esclusive a L’Identità di Tayeb Benabderrahmane, 41 anni, uomo d’affari
franco-algerino e lobbista al servizio di Ali ben Samikh Al-Marri, il ministro
del Lavoro del Qatar finito nelle carte dell’inchiesta sulla corruzione
all’Europarlamento che, grazie alla mediazione di Antonio Panzeri e Francesco
Giorgi, il primo novembre aveva incontrato l’allora vicepresidente Eva Kaili.
Tayeb, finito in un’intrigo internazionale per un video hard e documenti
scottanti su Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain. Un dossier
che gli sarebbe stato commissionato proprio dal ministro qatariota per fini
ricattatori e che, alla fine, ha portato al suo arresto. Rinchiuso in una
prigione segreta di Doha dal 13 gennaio al 31 ottobre 2020, Tayeb è stato
torturato, per essere poi rilasciato solo dopo aver firmato, sotto costrizione,
un protocollo transazionale con il quale si impegnava a fornire al Qatar un
certo numero di dati in suo possesso.
Signor Tayeb
Benabderrahman, lei conosce bene Al-Marri, il ministro considerato il legame tra
le tangenti al Parlamento europeo e al Qatar. Come funziona l’Emirato e qual è
il suo obiettivo?
Jean de La Fontaine
ha scritto una favola che riassume la statura del Qatar a livello
internazionale: “La rana che vuole diventare grande come il bue”. Nel Qatar le
famiglie che contano sono poche, ma condividono una fortuna sconcertante. Questo
Paese dalla ricchezza insolente ha appena 312.000 cittadini. I restanti 2,3
milioni, l’88% degli abitanti, sono espatriati. Il Qatar ha quindi un bisogno
vitale degli stranieri, ma li tratta, una volta lì, con disprezzo e
condiscendenza. I qatarioti cercano di creare un’identità nazionale, ma la
famiglia reale non tollera il dissenso e non garantisce i diritti umani. Il
Qatar insomma è un miraggio: un paese che finge la modernità, ma rimane
fondamentalmente tribale. Mi sono reso conto tardi di questa realtà: Ali bin
Samikh al-Marri e suo cugino Ali bin Fetais al-Marri non amano al-Khelaïfi. Ali
bin Samikh al-Marri mi ha fatto credere che stava lavorando per combattere la
corruzione, ma stava giocando la sua carta. Cercava di consolidare la propria
posizione fingendo di essere “più del Qatar dei Qatari”.
Quali sono le
personalità di rilievo a livello globale sulle quali il Qatar ha puntato o ha
cercato di influenzare?
Va ricordato che nel
2017 il Qatar ha vissuto una grave crisi diplomatica con diversi paesi del
Golfo, tra cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Molto isolato sulla
scena regionale, e di fronte ai blocchi, anche diplomatici, organizzati
dall’Arabia Saudita, il Qatar ha poi cercato staffette dai Paesi in particolare
europei, per difendere la sua posizione. Questa campagna di pubbliche relazioni
al più alto livello implicava poter contare su una rete di influenza presso
molti governi e istituzioni internazionali. Non sapevo la portata di ciò che il
Qatar aveva messo in atto nell’ambito di questa politica nei confronti dei Paesi
e delle Istituzioni europee e conosco solo poche persone su cui il Qatar si è
affidato in questa campagna di pubbliche relazioni. So in particolare che il
gruppo Edile Consulting o il Ceps hanno fornito servizi all’Emirato. Ho anche
potuto vedere che, nel 2017-2019, diversi responsabili politici chiave erano in
collegamento diretto e stretto con Ali bin Samikh al-Marri, che allora occupava
il ruolo strategico di presidente del Comitato nazionale per i diritti umani del
Qatar (Nhrc). Rachida Dati e Michèle Alliot Marie erano in contatto regolare con
Al-Marri e si sono così recate a Doha su suo invito nel dicembre 2018. Mi sono
anche imbattuto in una ripresa del signor Panzeri a Doha, il 14 aprile 2019,
durante una conferenza internazionale sui diritti umani. Tuttavia, non conosco
le condizioni, soprattutto finanziarie, che li hanno portati a lavorare per il
Qatar.
E lei come è
intervenuto sull’Europa?
Sono intervenuto
principalmente come consigliere speciale del presidente del Nhrc nel continente
africano attraverso azioni di intermediazione sulla crisi libica e per impedire
il licenziamento degli ambasciatori del Qatar dai paesi africani. Sono anche
intervenuto per avvisare i responsabili politici, in particolare in Francia e in
Italia presso la Santa Sede, sulle conseguenze umanitarie che il blocco stava
comportando per le popolazioni del Qatar.
E incontri al
Parlamento Europeo?
Ho organizzato, per
il martedì Primo ottobre 2019 alle ore 10.30 a Bruxelles, una riunione tra
Al-Marri e il coordinatore per la lotta contro il terrorismo Gilles de Kerchove.
Lei è diventato una
vittima di questo modus operandi del Qatar, che opera attraverso corruzione e
ricatti. Ed è stato, a sua insaputa, uno degli attori di questo sistema. Quando
e come si è reso conto che il dossier e il video non servivano per stabilire un
caso di corruzione ma era ricatto?
Quando mi ha
reclutato, Ali bin Samikh al-Marri mi ha detto che la lotta alla corruzione
all’interno degli organi finanziati con denaro pubblico e il dirottamento della
ricchezza del Qatar era diventato una priorità per le più alte autorità dello
Stato del Qatar e mi ha incaricato di raccogliere tutti gli elementi relativi a
questi argomenti per quanto riguarda gli investimenti del Qatar in Francia e in
Europa. La situazione del paese con il blocco era molto tesa. Naturalmente, il
Paris Saint Germain era uno degli argomenti a cui dovevo interessarmi. È in
quanto tale, come consigliere speciale del presidente del Comitato nazionale per
i diritti umani del Qatar, che ho ricevuto un’ampia varietà di informazioni.
Tutte queste informazioni sono state memorizzate in supporti digitali e
chiavette Usb, con il resto dei dati che avevo raccolto sia in Qatar che durante
il resto della mia attività professionale di consulente in geopolitica e
geoeconomia. Non sospettavo per un solo momento che il mio datore di lavoro
mirasse, con queste indagini, non a combattere la corruzione, ma a danneggiare
Nasser Al-Khelaïfi, presidente e amministratore delegato del Paris Saint-Germain
e presidente del consiglio di amministrazione di BeIn Media Group.
E cosa ha provato
quando ha capito il vero motivo?
Ero sempre più
imbarazzato dagli elementi che stavo scoprendo e comunicando al mio supervisore.
Infatti, anche se non sono mai stato informato sui casi di corruzione politica,
in quello che ora è noto come “Qatargate”, ritenevo che alcuni dei fatti che
avevo scoperto fossero gravi e richiedevano una risposta da parte del Nhrc. Ma
quando le risposte non arrivavano ho presentato le dimissioni. Ero diventato, al
quel punto, lo straniero che aveva messo a nudo gravi disfunzioni di cui tutti i
circoli di potere, anche apparentemente antagonisti, avrebbero sofferto. Ne
sapevo sicuramente troppo e dovevo essere messo a tacere.
Cosa ha subito
durante la sua detenzione illegale nella prigione segreta di Doha?
Il 13 gennaio 2020,
al mio ritorno in Qatar dopo le feste in Francia, sono stato arrestato. Durante
la detenzione sono stato sottoposto a ripetuti atti di tortura, in una prigione
segreta, chiuso in una cella di meno di 2 metri per 2. Sono stato torturato
fisicamente e psicologicamente. Minacciato di morte, mi impedivano di dormire.
Mi hanno minacciato di uccidere i membri della mia famiglia, di violentare mia
figlia. Non non ho potuto avere un avvocato.
Perché le hanno
fatto tutto questo?
L’unico oggetto del
mio arresto e della mia detenzione era costringermi a consegnare tutte le
informazioni riservate e sensibili che avevo ottenuto. Mia moglie è stata
costretta a portare ai qatarioti i vari supporti che contenevano queste
informazioni.
Qatargate, la
fuga di notizie fa infuriare avvocati e procura: «Indegno».
Il direttore de Le
Soir al Foglio: «Dall’Italia mi chiedono altri nomi, ma non è una serie Netflix
e la storia ci pare già abbastanza grave così». Eva Kaili resta in carcere:
prolungata la detenzione di un mese. Simona Musco su Il Dubbio il 22 dicembre
2022
«Cosa penso delle
fughe di notizie? Non ho mai visto un tale grado di assunzione di violazioni
frontali del segreto istruttorio. Non sono l'unico a pensarlo. Il procuratore
federale ha avviato un'inchiesta al riguardo». André Rizopoulos, uno dei legali
di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo finita in carcere con
l’accusa di corruzione, è scioccato dalla fuga di notizie del caso Qatargate.
Una fuga che ha riguardato soprattutto l’Italia, dove da due settimane i
giornali pubblicano atti e intercettazioni cercando di ricostruire la rete dei
nomi delle persone coinvolte nel più grande scandalo della storia delle
istituzioni europee. E così sui giornali è finito di tutto, compresi i nomi di
chi, al momento, non risulta formalmente coinvolto nell’inchiesta.
La caccia al
colpevole ha stranito anche Christophe Berti, direttore del quotidiano belga Le
Soir, che ha dato per primo la notizia scoop del terremoto che rischia di
abbattere l’europarlamento. Le parole di Berti al Foglio, che lo ha
intervistato, sono chiarissime: da giorni i colleghi italiani lo inondano di
telefonate per conoscere altri nomi, altri particolari. Una pressione costante,
a tratti incomprensibile, per il giornalista. «Ma non c’è altro, quello che
dovevamo scrivere lo abbiamo scritto. Non ci risultano altri nomi, non è una
puntata di una serie su Netflix, e la storia ci pare già abbastanza grave così.
Intanto attendiamo gli sviluppi. L’esame dei documenti e le eventuali
confessioni potrebbero permettere di aprire le porte del Parlamento europeo», ha
dichiarato il direttore. Che non ha mai usato l’evocativa espressione
“Qatargate”, utilizzata in Italia per ribattezzare l’indagine. Metodi di lavoro
diversi, probabilmente. Tant’è che i giornalisti di Le Soir hanno preferito
andarci con i piedi di piombo prima di pubblicare qualcosa sul caso, lavorando
«a lungo per avere conferme alle voci, controllando e incrociando i dati».
D’altronde la stessa
procura ha preferito muoversi con cautela, senza diffondere i nomi ma solo le
iniziali (facilmente tradotte poi dai giornalisti, ad onor del vero) e ora ha
deciso di vederci chiaro anche sulle fughe di notizie, in quanto «possono
mettere a rischio il caso, ed è per questo che stiamo avviando un’indagine per
violazione del segreto professionale», ha affermato un portavoce dell’autorità
giudiziaria. Rizopoulos, dal canto suo, si è detto «indignato». «Sono l’unico
che rispetta le regole?», si è chiesto prima di chiudersi nel silenzio. «Non
faremo alcuna altra dichiarazione, perché è pregiudizievole sia per la difesa
della signora Kaili - ha concluso -, sia all'accertamento della verità in un
dossier di questa natura».
Eva Kaili,
prolungata la detenzione di un mese
I giudici hanno
intanto prorogato di un mese la carcerazione preventiva di Kaili. «Se, entro 24
ore, viene proposto ricorso contro tale decisione, l'interessata comparirà entro
quindici giorni dinanzi alla camera d'accusa presso la Corte d'appello di
Bruxelles», ha reso noto la Procura federale di Bruxelles in una nota emessa al
termine dell'udienza di convalida. L’ex vicepresidente è rimasta in silenzio in
aula, ma «non è mai stata corrotta», ha assicurato l’altro legale della
politica, Mikhalis Dimitrakopoulos, all’uscita del Palazzo di Giustizia,
assediato da giornalisti e curiosi tenuti a bada da cavalli di Frisia, filo
spinato e filo a lamette. «Abbiamo preso l'impegno di non parlare troppo, perché
l'inchiesta è seria e segreta», ha sottolineato l’avvocato.
Kaili sapeva dei
soldi? «No no, mai», ha ribadito, smentendo dunque le ricostruzioni. Ma
nonostante il silenzio, Kaili - da giorni detenuta nel carcere di Haren,
all'estrema periferia della capitale belga, vicino all'aeroporto - «partecipa
attivamente all'inchiesta» e «contesta ogni accusa di corruzione a suo carico».
I suoi legali avevano chiesto la concessione dei domiciliari o il regime di
sorveglianza elettronica mediante braccialetto. Ma intanto l'autorità
antiriciclaggio greca ha sequestrato un terreno di 7mila metri quadrati che
l'eurodeputata greca e il suo compagno Francesco Giorgi avevano acquistato
sull'isola greca di Paros. Il sequestro è stato deciso nell'ambito dell'indagine
penale preliminare che la Procura per i reati economici greca ha aperto nei
confronti dell'ex vice presidente del Parlamento europeo per la presunta
commissione dei reati di riciclaggio e corruzione passiva.
Che sia necessario
centellinare le parole è chiaro anche da quanto apparso sui giornali, che nei
giorni scorsi hanno dato conto di una presunta “confessione” della donna, che
avrebbe ammesso di sapere dei soldi che giravano attorno a suo marito, Francesco
Giorgi, e all’ex europarlamentare Antonio Panzeri. «Conoscevo le attività di
Panzeri - avrebbe detto - e sapevo che a casa mia c’erano delle valigie piene di
soldi». Secondo il magistrato Michel Claise, Kaili sarebbe «intervenuta a difesa
degli interessi del Qatar, avendo incontrato il ministro del Lavoro» del Qatar
su indicazione di Panzeri, che le «avrebbe impartito ordini per il tramite del
marito». Ma che ci sia stata una confessione è un fatto smentito dalla difesa
dell’ex vicepresidente: «La signora Kaili è venuta a conoscenza di questo denaro
(quello rintracciato a casa sua, ndr) all'ultimo minuto e ha chiesto che
tornasse immediatamente al suo proprietario, il signor Panzeri».
Da “la Stampa” il 23
Dicembre 2022.
Eva Kaili sarebbe
andata negli Stati Uniti per due volte con i soldi del Centro di Uguaglianza di
Genere di Atene, finanziato dall'Eurocamera. «Viaggi effettuati solo per scopi
personali». È questa l'accusa lanciata da Sofia Mandilara, ex assistente che ha
lavorato per l'ex vicepresidente del Parlamento europeo dal 2013 al 2014.
Mandilara ha
raccontato alle telecamere Mediaset di «non essere rimasta sorpresa» dello
scandalo. «Infatti - aggiunge - già nel 2013, pur non essendo autorizzata nominò
sua sorella al vertice del di Uguaglianza di Genere di Atene».
L'attacco alla
sinistra e i nemici dell'Ue. A cosa serve lo scandalo Qatar, il vero obiettivo
dell’inchiesta e tutte le cose che non tornano.
Renato Mannheimer,
Pasquale Pasquino su Il Riformista il 24 Dicembre 2022
La vicenda del
Qatargate occupa le prime pagine dei giornali da ormai diversi giorni.
L’episodio è stato interpretato come assai grave. Secondo molti commentatori,
esso ha gettato discredito sia sulle formazioni politiche
del centrosinistra, sia sulle stesse istituzioni europee, minando la loro
credibilità. Che la vicenda abbia peggiorato l’opinione dei cittadini del nostro
paese (ma probabilmente anche di altri) nei confronti delle forze “progressiste”
è fuori di dubbio.
Un tempo queste
ultime avevano assunto l’emblema del “Partito degli onesti”, vantando in ciò una
pretesa differenza – quasi antropologica – rispetto agli esponenti delle forze
di centrodestra, sia sul piano etico, sia su quello dei comportamenti adottati
nella pratica. Questa caratteristica è stata per molti anni (e ancora di
recente) uno degli elementi di comunicazione della sinistra in Italia, una sorta
di attributo da vantare con orgoglio. Ma il tempo ha mostrato, attraverso
svariati episodi – tra i quali il Qatargate non è che l’ultimo in ordine di
tempo – che “la carne è debole” e che tutte le forze politiche –
indipendentemente dalla loro collocazione – possono essere coinvolte in episodi
di malaffare o di disonestà.
Ci sono già effetti
sull’opinione pubblica. Un sondaggio di Euromedia, condotto da Alessandra
Ghisleri, mostra una ulteriore erosione di voti al Pd, dovuta, afferma la
ricercatrice, proprio al Qatargate. E, nella stessa ricerca, emerge come una
quota significativa di elettori ritenga che “la politica sia tutta marcia ma i
Dem lo siano più degli altri”. Anche i dati Swg, pubblicati successivamente,
evidenziano un ennesimo calo di consensi (virtuali) dei Dem. A livello
internazionale, quanto è accaduto ha già portato a una minore fiducia dichiarata
per l’Unione europea, ma, in particolare, per il nostro paese. Come fa
notare Luca Ricolfi nella sua intervista al “Fatto Quotidiano”, nella stampa
straniera si parla sempre più dell’ ”Italian Job”, assumendo che quando si
tratta di affari loschi, c’è sempre un italiano coinvolto (il che, alla luce
dell’esperienza, non è affatto vero). Resta il fatto che quanto è accaduto fa
male all’Italia ed ai paesi che al nord dell’Europa chiamano ironicamente il
“club Med”.
Gli effetti
sull’opinione pubblica – e sulle relazioni internazionali -, dunque, ci sono già
stati e forse si intensificheranno in futuro, quando si verrà a conoscenza di
altri dettagli della vicenda. Perché, per ora, molti aspetti lasciano dubbi
sull’intero episodio e fanno sospettare che dietro ci sia ben altro e da diverso
tempo. Svariati elementi portano a questa supposizione. Ad esempio, l’entità
delle somme intercettate sin qui. Che sono obbiettivamente modeste. È vero che
quelli scoperti sono già un sacco di soldi, ma, per quel che se ne sa, come
osserva anche Mauro Calise sul “Mattino”, nei casi di corruzione
internazionale circolano di solito cifre molto maggiori e consistenti. Che non
sono regolate in contanti, ma su conti cifrati nei paradisi fiscali. Quelle di
cui si è parlato sembrano una sorta di mance o di cash destinato ad essere
distribuito ulteriormente. Anche i personaggi coinvolti sino ad ora non sembrano
perdipiù di primo piano: in particolare Eva Kaili è stata nominata
vicepresidente del Parlamento Europeo solo nel Gennaio 22 e non ha mai assunto
un ruolo significativo nel Parlamento europeo.
Inoltre, non è molto
chiaro quale significativa influenza abbiano avuto Panzeri e gli altri indagati
sulle decisioni del Parlamento: tutto questo intrigo solo per ottenere qualche
dichiarazione compiacente nei confronti del Marocco o del Qatar? Dunque, sotto
tutto il fumo emerso sin qui, c’è probabilmente ben altro arrosto. Va ricordato
che la decisione di assegnare il campionato di calcio al Qatar è di molto tempo
fa e va ricondotto all’epoca della presidenza Sarkozy in Francia. Forse,
l’emergere proprio oggi dello scandalo potrebbe in realtà essere indirizzato
soprattutto a gettare discredito sull’UE da parte di chi ha assunto una
posizione e un atteggiamento di ostilità nei confronti delle istituzioni
europee, in un momento particolarmente delicato per queste.
Dopo una fase di
ritrovata coesione, specie in occasione della reazione unitaria alla minaccia
del Covid, l’UE sta infatti attraversando un periodo di relativa difficoltà,
minata dai numerosi dissidi interni sulle relazioni con la Russia e,
specialmente, sulla politica energetica e la gestione dell’emergenza sulle
forniture di energia. Con uno dei paesi protagonisti, la Germania, che assume
posizioni non sempre nette e costruttive per la coesione degli stati membri.
Insomma, le istituzioni europee paiono vivere oggi una condizione di relativa
debolezza, opportuna per sferrare nuovi attacchi all’istituzione in questione da
parte di chi considera l’Unione come una minaccia o, quantomeno, una presenza
fastidiosa. Ciò nonostante, va ricordato che, proprio in questo stesso periodo
le istituzioni europee stanno, per altri versi, lavorando molto bene: ad esempio
nei confronti delle violazioni sui diritti rilevate in alcuni stati membri come
l’Ungheria o la Polonia.
In quest’ultimo caso
è evidente come la UE difenda – e spesso ottenga – l’esistenza di una anche
minima forma di separazione dei poteri e di indipendenza del potere giudiziario
all’interno delle nazioni che ne fanno parte. Ma tutta l’enfasi mediatica sulla
vicenda della corruzione porta, inevitabilmente, a dire assai poco – se non
nulla – su tutto quanto di positivo fa l’Unione. Molto opportunamente, in un
editoriale sul “Carriere della Sera”, Sabino Cassese ha ribadito come proprio
quanto à accaduto mostri che “Il Parlamento Europeo conta molto più di quanto si
creda” e che, al tempo stesso, negli ultimi giorni, il PE ha saputo “reagire e
decidere sollecitamente”.
Ma, al di là
di Cassese, pochi hanno sottolineato questo elemento: la scarsità di attenzione
sul ruolo e sulle iniziative del PE è, di fatto, un effetto collaterale dello
scandalo, da cui per ora si fa fatica ad uscire. Di qui la necessità, a nostro
avviso, di un’azione e di una comunicazione volta proprio in questo momento
a rafforzare l’Unione, ad esplicitarne il ruolo positivo ed essenziale e ad
aiutare a portarla fuori dalla tempesta in cui si trova in questo
periodo: l’Europa è necessaria.
Renato Mannheimer,
Pasquale Pasquino
Parla l'ex
parlamentare torinese. “Il Pd è un covo di giustizialisti”, parla Stefano
Esposito.
Aldo Torchiaro su Il Riformista il 24 Dicembre 2022
L’ex parlamentare
torinese Stefano Esposito, deputato del Pd nella XVI legislatura e senatore
nella XVII legislatura, si distingue sui social per la posizione garantista, a
sinistra: guarda all’inchiesta del Qatargate con tutte le perplessità e i dubbi
che gli stessi dem non riescono a esprimere. «Sono un libero cittadino
perseguitato dalla giustizia», dice. «E questo mi dà una doppia libertà di
parlare».
Qatargate. Che idea
si è fatto?
Conoscevo poco
Panzeri e Cozzolino, ma difendo il beneficio del dubbio per due che vengono
appesi per i piedi già oggi, senza uno straccio di documento processuale. Non
sappiamo di che reati sono accusati. Non sappiamo se hanno mai ceduto alla
corruzione. Di certo non c’è niente: si parla di servizi segreti, di accordi
opachi. Di ong. Nessun atto parlamentare preso in favore del Qatar, per quanto
ne sappiamo.
Dicono solo che
Panzeri fosse il regista di una rete di soft power qatarino.
Adesso risulta quasi
un Richelieu. Nessuno di noi lo sapeva, ma scopriamo che Panzeri era un
finissimo stratega, uno che praticamente avrebbe tenuto, lui da solo, in pugno
l’intero Parlamento europeo. Lui che non era più stato eletto, poteva davvero
condizionare, fino a un mese fa, tutte le scelte europee in politica
internazionale? Passavano per lui gli accordi di protocollo con il Qatar?
Conoscendo un po’ i meccanismi, tendo a dubitarne.
Perché ci sono
articoli di stampa che riporterebbero affermazioni che direbbero: ‘Non abbiamo
certezze, ma forse anche Cozzolino era vicino al Qatar’. Comunque vada a finire
questa vicenda, Cozzolino è già finito. Non ci sarà modo di riabilitarlo anche
se tra poco verrà fuori che non aveva alcuna responsabilità. Il Pd insegue il
momento, senza con questo frenare la perdita di consensi. Quando la macchina del
fango parte, non si ferma più.
Cosa suggerisce ai
candidati segretario del partito?
Dobbiamo incidere
nel nostro Dna che non esistono presunti colpevoli, ma presunti innocenti.
Ricordo loro che coltivare il dubbio è il primo comandamento di un garantista. E
invece oggi l’unico dubbio che viene coltivato è sul grado di colpevolezza
dell’indagato. E per me questo è un livello di barbarie inaccettabile.
Il Pd sta diventando
grillino?
Questa è una cosa
che è iniziata dal 2013: rincorre la cultura grillina. Per il Pd il M5S non è
una spina nel fianco, è una spina nel cuore. E purtroppo su questo terreno ha
vinto quella cultura lì, e lo dico con grandissimo dolore. Lo dico con dolore:
il Pd non difende mai i suoi. Nessuno dei suoi.
Vero. Ma perché,
qual è la ratio?
Perché in fondo il
Pd non è mai diventato una comunità. È nato da una fusione a freddo che non ha
mai prodotto il calore di una comunità. È un brand, ragiona come le aziende in
termini di reputazione del marchio a prescindere dalle storie delle persone che
lo incarnano.
Chi viene anche solo
sfiorato dalle inchieste, porta lo stigma e viene messo al bando.
Se parli con i
singoli, è diverso. Ti danno tutti ragione. Però rispondono a una logica
perversa, e le azioni del partito sono altre: l’abbandono, la messa al bando.
Quando in un gruppo una persona ha bisogno di una mano, e invece di un braccio
teso si vede arrivare una pedata, non la si può più definire comunità. Il Pd è
una cordata. Quando uno può diventare un peso, perché preso di mira da un
magistrato, gli altri tagliano la corda. Lo fanno come riflesso di
sopravvivenza, sempre. La lista sarebbe lunga.
Qualche nome merita
di essere fatto: Antonio Bassolino, Catiuscia Marini, Simone Uggetti, Filippo
Penati, Marcello Pittella… Forse Nordio aggiusterà il tiro sull’abuso d’ufficio,
meglio tardi che mai.
Oltre alla riforma
dell’abuso d’ufficio, segnalo l’urgenza di mettere mano al traffico di
influenze.
Altro mostro
giuridico. Quello che ha colpito anche lei.
Il traffico di
influenze in Italia può essere applicato a chiunque, per qualunque cosa. Chi ha
un ruolo politico non può venir meno alla richiesta di qualche cittadino.
Sull’anarchico
Cospito, leader No-Tav, lei che era il portabandiera della Tav, chiede un atto
di clemenza. Perché?
Io sono stato un
forte propugnatore della Tav e dai comitati ho ricevuto minacce e intimidazioni.
Cospito è la mia antitesi, da un certo punto di vista. E dico che su di lui
stanno sbagliando tutto. Lo Stato non può agire con cinismo e cattiveria,
altrimenti i piani si invertono. Credo che Cospito sia colpevole, ma va messo in
condizione di scontare la sua pena con dignità e umanità. Chiunque si dica di
sinistra dovrebbe pensarla come me. Ecco, quello che mi stupisce. Che la
sinistra, persino davanti al rischio che la vicenda Cospito si traduca in
tragedia, perché andrà avanti con lo sciopero della fame, non dica niente. Il
silenzio della politica è il segno che siamo morti noi, prima di lui.
Aldo Torchiaro.
Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003.
Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.
Giacomo Amadori “La
Verità” il 24 dicembre 2022.
In corso Buenos
Aires a Milano, una delle principali vie cittadine dello shopping, le spese
natalizie paralizzano, come sempre, il traffico. In una parallela, però, in via
Castel Morrone la viabilità è molto più scorrevole. Ma, per il Qatargate, questa
è una via ancora più importante. Una specie di crocevia degli affari all'ombra
della premiata ditta Pier Antonio Panzeri & Francesco Giorgi, l'europarlamentare
e l'assistente accusati di associazione per delinquere, corruzione e
riciclaggio.
Ieri, poco dopo le
16, su mandato della Procura di Bergamo, due giovani finanzieri, un uomo e una
donna, hanno varcato il portone di un elegante palazzo costruito nella prima
metà del '900 e hanno notificato il sequestro delle somme rinvenute sul conto di
Silvia Panzeri, l'avvocato che qui si trova agli arresti domiciliari.
Il giudice
istruttore di Bruxelles Michel Claise aveva inviato un ordine europeo di
indagine alla Procura di Milano in cui veniva chiesto il «sequestro e il blocco»
di sette conti, due dei quali intestati ai Panzeri e uno a Silvia. Ma essendo
Pier Antonio Panzeri e la moglie residenti a Calusco d'Adda, gli inquirenti di
Milano hanno trasmesso la richiesta a Bergamo e la locale Procura ha ordinato il
sequestro preventivo.
Il domicilio della
figlia coincide, invece, con quello indicato sull'albo degli avvocati. La
portiera, calabrese di Cosenza, prova a difendere la professionista
trentottenne: «Per me lei non c'entra nulla, a mio giudizio è tutta colpa del
padre. Ma lei li denuncerebbe i suoi genitori?». Ieri la Procura ha fatto sapere
che sui tre conti, quella con più denari era proprio Silvia, che aveva da parte
200.000 euro, contro i 40.000 del padre.
Esaminando il suo
curriculum si scopre che la donna deve al padre sindacalista molto, quantomeno
per gli orientamenti. Per esempio è specializzata in diritto del lavoro e tra le
«referenze», sul suo sito, inserisce il perfezionamento in diritto dell'Unione
europea e in particolare il corso in materia di diritto dell'Unione europea e in
materia di ricorsi alla Corte di Giustizia frequentato presso l'università degli
Studi di Milano.
Dunque qualcosa non
torna nella difesa d'ufficio della portiera. E Castel Morrone aiuta a capire
perché. Basta uscire dal portone di casa Panzeri, girare a sinistra e percorrere
250 metri. Si arriva all'angolo. Qui si trova il Victory cafè, un bar senza
troppe pretese, con insegna luminosa e arredamenti un po' anni '80. Fuori il
dehor è frequentato dagli amanti degli aperitivi.
I piattini
consistono in qualche tartina e patatine. A portarli ai tavoli è un uomo dai
capelli bianchissimi e gli occhi azzurri. Un tipo non troppo sorridente e molto
concentrato sulle sue mansioni. Impeccabilmente vestito di nero si divide tra la
cucina e la sala, mentre il collega colombiano prepara caffè e versa vino e
distillati al bancone.
Il sito del bar, più
che discettare di eventi e beveraggi, dedica diversi post alle comunicazioni
dello studio di Silvia Panzeri e di una collega, rivolte agli pubblici
esercenti. Per esempio in uno viene spiegato «come ottenere rimborso causa
coronavirus», in un altro quali fossero «le principali novità nel decreto
rilancio».
Il bar è di
proprietà di due imprenditori di origine siciliana, i cinquantasettenni, Carmelo
e Giuseppe e di un loro socio, (al 2 per cento) Manfred Forte, di un anno più
giovane. Forte è originario di Maribor, in Slovenia, ed è il barista canuto che
abbiamo descritto poco righe sopra. È divorziato e risulta residente nello
stesso palazzo in cui vive la Panzeri. All'interno dello stabile ci hanno
riferito che l'uomo dovrebbe essere il compagno dell'arrestata, che, infatti,
per scontare i domiciliari non ha lasciato il suo appartamento.
La società Magica
Srl, che controlla il locale, ha un bilancio negativo (nel 2021 ha registrato un
fatturato di circa 300.000 euro e perdite per quasi 40.000). Manfred è l'unico
che dichiara un reddito di poco superiore ai 10.000 euro. Ricapitolando: a pochi
metri dall'abitazione di Silvia Panzeri c'è un bar di estimatori
dell'avvocatessa (uno addirittura sembra essere un condomino) che divulgano le
notizie che lo studio diffonde a favore dei commercianti. Fin qui nulla di
particolarmente strano direte voi.
Ma c'è uno curioso
intreccio tra via Castel Morrone, zona d'azione di Silvia Panzeri, e gli affari
della famiglia Giorgi e della misteriosa ragioniera Monica Rossana Bellini,
perquisita per la gestione dei soldi dei Panzeri (anche se la donna ha
rivendicato di essersi occupata solo della contabilità forfettaria di Silvia).
Infatti la
contabile, con un passato di assessore in una giunta a guida Pds e tanti
incarichi come tecnico d'area dem, era socia del barista montenegrino del
Victory cafè in una ditta che ha cessato l'attività l'8 giugno 2021. Il nome era
Equality consultancy e nel suo statuto descriveva attività che la facevano
assomigliare a una specie di Ong mascherata. Come si capisce dai punti D, E e F
dello statuto: «Realizzare una rete ampia, trasparente e ben informata di
partenariati.
Aiutare a rimuovere
alcuni degli ostacoli alla collaborazione esistenti tra le culture differenti
attraverso iniziative volte a promuovere e divulgare i diritti umani e la
protezione delle libertà fondamentali», «sviluppare reti tra diversi soggetti,
ong, organizzazioni imprenditoriali e controparti nei paesi terzi, per
facilitare il dialogo e le opportunità che consentono legami economici e
culturali più forti all'interno dell'Ue e nei suoi stati membri» e, infine,
«promuovere gli scambi e la cooperazione tra soggetti, situati in altre aree
geografiche di riferimento».
Come abbiamo già
scritto lunedì è stata fondata il 28 dicembre 2018, 5 mesi prima delle elezioni
europee, e aveva 10.000 euro di capitale e sede legale a Opera presso lo studio
della Bellini. Ma nella compagine sociale all'epoca non faceva parte Forte. Alla
nascita il 70 per cento delle quote era in mano al preside di una scuola di
Abbiategrasso.
La sua professione
non deve stupire, infatti non si tratta di un dirigente scolastico qualunque,
bensì di Luciano Giorgi, il padre di Francesco Giorgi, tuttora in carcere
nell'ambito del cosiddetto Qatargate. Oltre a Giorgi senior comparivano
nell'azionariato anche il figlio minore Stefano (25 per cento) e la Bellini (5),
la quale era amministratrice della società insieme con Giorgi junior.
Nel 2019, a fronte
di un valore della produzione iscritto a bilancio di 240.000 euro (ricavi delle
vendite e delle prestazioni), l'utile di esercizio è stato di 102.500 euro. Non
è chiaro quali clienti abbiano trasformato la neonata ditta in un gioiellino nel
settore delle consulenze anche internazionali.
Ma quando quel
bilancio viene chiuso, Giorgi padre e figlio hanno già lasciato la società. Il
23 luglio 2019, una ventina di giorni dopo la prima plenaria del Parlamento
europeo, i due cedono le quote. Luciano trasferisce il 40 per cento a Dario
Vittorio Scola, suo socio di vecchia data (dal 2001) in un'altra ditta. Stiamo
parlando della Sunflower Srl, di cui Scola è anche amministratore e che si
occupa (sebbene attualmente risulti inattiva) della rappresentanza di prodotti
farmaceutici e di erboristeria.
Anche Scola c'entra
poco con le attività della Equality essendo infatti un tecnico federale di
nuoto. Nel 2021 ha percepito redditi sia dalla Federazione italiana nuoto che da
Sport e salute (società controllata dal Ministero dell'Economia) e dalla società
Canottieri Milano.
L'altro 30% del
genitore passa al barista di via Castel Morrone, il quale rileva anche un 10% di
Stefano. Il restante 15% viene ceduto alla solita Bellini. Il 5 settembre
Stefano lascia il timone dell'azienda alla donna e in quello stesso mese Panzeri
fonda la sua Ong a Bruxelles, la Fight impunity, di cui Francesco Giorgi diventa
«senior advisor».
Nel 2020, forse
anche per la pandemia, le entrate della Equality calano notevolmente: il valore
della produzione si ferma a 81.000 euro e il bilancio annota perdite per 51.000.
E così il 18 novembre la società viene messa in liquidazione.
Nel verbale di
assemblea ordinaria del 4 maggio 2021, il non certo benestante Manfred,
segretario della riunione, e la presidente-liquidatrice Bellini, decidono di
«approvare la proposta di copertura della perdita di esercizio pari a 51.360
euro». L'8 giugno 2021 la Equality viene chiusa definitivamente.
Non è chiaro perché
Forte e Scola abbiano accettato di accollarsi una società che stava andando a
rotoli e che ha chiuso i battenti poco dopo il trasferimento delle quote.
Nessuno di loro ha voluto darci spiegazioni. Scola non ha proprio risposto alle
nostre domande inviate via Whatsapp. Invece Forte, che abbiamo incontrato al
bar, ha replicato a mezza bocca: «Chi le ha detto che mi abbiamo chiesto di
prendere le quote della Equality? Potrei averlo chiesto io» ha tagliato corto.
Non ci ha voluto
nemmeno spiegare i rapporti tra i soci del bar (uno vive sempre in via Castel
Morrone) e Silvia Panzeri. Nessuna delucidazione anche sui rapporti con la
Bellini e la famiglia Giorgi. Mentre lo interrogavamo gli occhi azzurri di
Manfred hanno tradito solo un insopportabile fastidio. E così lo abbiamo
lasciato alla cassa e ci siamo rituffati in via Castel Morrone, la strada dei
molti misteri.
QATACLISMA SUI
CONTI.
Rita Cavallaro su L’Identità il 24 Dicembre 2022
Lo scandalo
Qatargate si allarga a macchia d’olio, coinvolge nuovi Paesi e sfiora altri
europarlamentari, tirati in ballo da chi, in carcere, non vuole rimanere. E la
Magistratura setaccia conti, alla ricerca dei soldi della cricca di Bruxelles,
ritenuti frutto delle tangenti pagate dal Qatar per condizionare l’azione
politica al Parlamento europero. Ieri il dem Antonio Panzeri, considerato
l’anima del sistema corruttivo messo in piedi per conto dell’Emiro, è stato
raggiunto da una nuova misura cautelare patrimoniale. Dopo la scoperta di 1,5
milioni di euro in contanti, che ha portato in carcere Panzeri, il gip di
Bergamo, con un decreto di sequestro preventivo, ha congelato sei conti correnti
intestati all’ex eurodeputato, alla figlia Silvia, all’ex segretario generale
della Confederazione internazionale dei sindacati Luca Visentini e a Francesco
Giorgi, il compagno di Eva Kaili. Il procuratore Antonio Chiappani ha
sottolineato che sono stati bloccati circa 200mila euro su un conto di Silvia e
40mila euro su uno del padre. Poche migliaia di euro, invece, su quelli di
Visentini e Giorgi. L’attività, ha detto Chiappani,”è scaturita dalla richiesta
di assistenza giudiziaria internazionale emessa dal giudice istruttore presso il
Tribunale di prima istanza di Bruxelles, che sta procedendo per i delitti di
corruzione pubblica, associazione per delinquere e riciclaggio di denaro”. Reati
pesanti di cui risponde anche la moglie di Panzeri, Maria Dolores Colleoni, per
la quale i giudici italiani, vista la sussistenza di “gravi indizi di
colpevolezza”, hanno disposto l’estradizione in Belgio. Contro la decisione
della Corte d’Appello di Brescia, gli avvocati Angelo De Riso e Nicola Colli,
legali della donna, hanno depositato ricorso in Cassazione, sulla base di
“problemi persistenti nelle carceri belghe, tra cui il sovraffollamento di lunga
data e la carenza di personale”. Elementi che hanno portato un altro collegio di
giudici bresciani a rinviare a gennaio la decisione sull’estradizione della
figlia Silvia, dopo che il Ministero della Giustizia effettuerà approfondimenti
sulle condizioni dei penitenziari belgi. Le due restano ai domiciliari, visto
che il ricorso della Colleoni blocca l’esecutività della consegna alle autorità
di Bruxelles. Almeno fino alla decisione della Cassazione, che si esprimerà in
una decina di giorni. Intanto per l’ex vicepresidente dell’Eurocamera, Eva
Kaili, è sfumata la speranza della scarcerazione e la possibilità di
riabbracciare la figlia, avuta da Giorgi, almeno a Natale. Il Tribunale ha
infatti deciso che dovrà restare nel carcere di Haren fino al 22 gennaio. “È
molto triste, è lontana da sua figlia, sta vivendo una catastrofe”, ha detto
l’avvocato Mihalis Dimitrakopoulos, che ha fatto visita alla sua assistita dopo
la decisione della magistratura belga. La greca ha iniziato a collaborare, ha
risposto alle domande del giudice Michel Claise, ma la sua linea difensiva tesa
a minimizzare le sue responsabilità e a puntare il dito contro il suo compagno,
l’unico responsabile di aver nascosto le mazzette in casa dice lei, non ha
convinto. E contro Eva sono arrivate pure le accuse della sua assistente, la
quale sostiene che la Kaili usò fondi Ue per almeno due viaggi personali negli
Stati Uniti.
Majorino oltre il
ridicolo: perché vuole querelare Salvini.
Fabio Rubini su
Libero Quotidiano il 25 dicembre 2022
In Lombardia la
campagna elettorale per le Regionali è entrata nel vivo. E tra Matteo Salvini e
il candidato di Pd e M5S Pierfrancesco Majorino volano parole grosse. Impegnato
in una visita all'ospedale Buzzi di Milano, il leader di Milano attacca
l'esponente Pd, che a sua volta aveva accusato gli europarlamentari della Lega
di essersi astenuti rispetto a un emendamento da lui proposto e riguardante
l'ingerenza di paesi esteri in Europa e tra questi anche il Qatar. «Uno è
innocente fino a prova contraria - ribatte Salvini -, che però dal Pd vengano a
fare la morale in casa altrui, quando il problema è tutto a sinistra...».
E ancora: «Il tempo
è galantuomo sempre e Majorino su questo dovrebbe avere solo il buongusto di
tacere: qua ci sono solo alcuni milioni di euro in contanti trovati nella
valigia di parlamentari di sinistra, con Majorino che era europarlamentare della
Commissione che doveva controllare queste cose». Poi Salvini ricorda che «Io ho
fatto l'europarlamentare per tanti anni, sono stato in Qatar, in Marocco e non
ho mai portato a casa valigette piene di Pierfrancesco contanti. A me dispiace
perché non godo delle disgrazie altrui, però fossi nel Pd, e fossi nella
sinistra chiederei scusa per annidi insulti, restituirei le somme e mi
dimetterei. Capisco l'imbarazzo di Majorino che conosce poco la Lombardia e
anche l'Europa, visto che doveva controllare e gli è passato sotto il naso un
trolley pieno di soldi...».
Accuse che
il candidato governatore della sinistra non ha gradito. «Ho dato mandato al mio
avvocato di valutare ogni azione a tutela della condotta diffamatoria di Salvini
- spiega in una nota l'europarlamentare - Si vergogni, è un esperto di
interferenze esterne visti i traffici coi russi del suo Majorino (Ftg) amico
Savoini. Quindi semplicemente prima i leghisti spieghino perché a differenza mia
si sono astenuti nel marzo scorso sul rapporto sulle ingerenze esterne dove,
grazie a me e ad altri colleghi, si denunciava l'opera del Qatar poi però
taccia». Sull'episodio dei presunti soldi russi, giorni fa Salvini aveva
fulminato la sinistra ricordando come «a furia di cercare inutilmente i rubli
della Lega, hanno trovato gli auro del Pd...».
Qatargate,
gl’intrecci d’affari a Milano tra i Panzeri, i Giorgi e la commercialista
Bellini.
Storia di Franco Stefanoni su Il Corriere della Sera il 24
dicembre 2022.
Un bar di Milano,
Victory cafè, da cui via social partono post dedicati alle comunicazioni dello
studio legale in cui a Locate Triulzi (Milano) lavora Silvia Panzeri; la
proprietà del bar in parte facente capo a Manfred Forte, sloveno, residente nel
vicino palazzo milanese in via Castel Morrone in cui vive la stessa Silvia
Panzeri; una società di consulenza, la Equality consultancy con uffici a Opera
(Milano), in passato partecipata da Forte e da Monica Rossana Bellini,
commercialista il cui studio (sede della società) ha come cliente sempre Silvia
Panzeri; infine Luciano e Stefano Giorgi, padre e fratello di Francesco, vecchi
soci della medesima Equality consultancy. Ha questo sullo sfondo quanto
ricostruito dal quotidiano La Verità, a valle del Qatargate. Scandalo e
inchiesta che vedono, tra gli altri e a diverso titolo (associazione per
delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro), arrestati su mandato della
magistratura belga l’ex eurodeputato Antonio Panzeri (padre di Silvia pure lei
sottoposta a custodia cautelare) e Francesco Giorgi, ex assistente di Panzeri e
compagno di Eva Kaili, ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo, anch’essa
arrestata.
In base a quanto
sarebbe emerso, l’oggetto sociale della Equality consultancy farebbe
assomigliare l’iniziativa originariamente dei Giorgi a una Ong attiva nel campo
dei diritti umani, capace di ottimi profitti almeno fino al 2019 (102.500 euro
di utile d’esercizio a fronte di un valore della produzione di 240 mila). Dopo
alcuni passaggi societari i Giorgi tuttavia escono di scena in favore appunto di
Forte e Bellini (che nell’indagine madre non è indagata). Nel settembre 2019,
quando Antonio Panzeri fonda la Ong Fight impunity ora al centro dell’inchiesta
belga per presunte tangenti a favore di europarlamentari disposti a difendere
gli interessi di Qatar e Marocco, nella società entra nel frattempo Francesco
Giorgi come senior advisor, ma le cose vanno male e nel novembre 2021 la società
è messa in liquidazione e successivamente chiusa, dopo la copertura delle
perdite per oltre 50 mila euro da parte di Forte e Bellini. Da allora, strade
diverse.
Giacomo Amadori
per “La Verità” il 27 dicembre 2022.
In un moderno
palazzo a forma di parallelepipedo grigio, di fronte a un bar e a un sexy shop
potrebbe essere custodito uno dei segreti del Qatargate. Siamo nel centro di
Tallin, capitale dell'Estonia, non distante dall'imponente Palace hotel,
location perfetta per una spy story da guerra fredda. In via Tatari 2,
all'interno di un business center, aveva la sua sede la Equality consultancy, la
società gemella dell'omonima srl italiana di cui abbiamo parlato nei giorni
scorsi. Protagoniste della nostra storia sono la famiglia Panzeri e la famiglia
Giorgi.
Diversi componenti
delle due casate sono stati arrestati, altri sono indagati. Il giudice
istruttore belga Michel Claise ha spedito in cella l'ex europarlamentare Pd Pier
Antonio Panzeri, mentre ha mandato ai domiciliari la moglie Maria Dolores
Colleoni e la figlia Silvia; in gattabuia è finito anche Francesco Giorgi, ex
assistente di Panzeri a Bruxelles, mentre per i suoi genitori, Luciano e Iole,
Claise ha chiesto un interrogatorio in veste di indagati per alcuni bonifici
sospetti inviati a Bruxelles per un acquisto immobiliare.
I Panzeri e i Giorgi
sono accusati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Il filo
rosso che unisce queste persone è rappresentato dai servigi di una ragioniera di
Opera (Milano), la cinquantacinquenne Monica Rossana Bellini. Ma anche dalla
Equality, una ditta impiegata in Italia dal 2018 al 2020 in attività collegate
al mondo delle Ong e delle relazioni internazionali e che, forse, era stata
pensata per avere un significativo ruolo all'interno del Qatargate.
La Equality estone
dista 2.500 chilometri dalla sorella italiana di Opera, ma la sua compagine
societaria era esattamente sovrapponibile, come abbiamo scoperto consultando
l'atto costitutivo, siglato il 6 settembre 2018 davanti al notaio Aivar
Mesikäpp. Le quote di entrambe erano infatti in mano alla ragioniera Bellini, a
Luciano Giorgi, 66 anni, nato e cresciuto ad Abbiategrasso, e al di lui figlio,
Stefano, classe 1990. La prima deteneva il 5 per cento, Giorgi senior il 70 e
l'erede il 25. Il capitale sociale in Estonia era di 2.500 euro, in Italia di
10.000.
Il 28 dicembre 2018
nasce la Equality italiana. Il 9 aprile 2019 Panzeri annuncia di aver rifiutato
la ricandidatura alle Europee. Il 18 giugno 2019, pochi giorni dopo le elezioni
per il Parlamento di Bruxelles, l'assemblea della ditta estone delibera lo
scioglimento e, su istanza del liquidatore, Erik Salur, la società, il 15 aprile
2020, viene cancellata dal registro. La compagine italiana va nella stessa
direzione: il 23 luglio 2019 i due Giorgi cedono le loro quote; il 5 settembre
Stefano lascia alla Bellini il ruolo di amministratore unico; nel novembre del
2020, la Equality di Opera viene messa in liquidazione; l'8 giugno del 2021
cessa di esistere.
In Italia l'ultimo
bilancio segna perdite per 51.000 euro, a Tallin invece la Equality, tra l'11
settembre 2018 e il 18 giugno 2019, non avrebbe svolto alcun tipo di attività
economica, chiudendo l'esercizio con un attivo di 2.500 euro, ovvero il capitale
investito. Ma a che cosa doveva servire quella scatola vuota? E perché una
ragioniera con lo studio a Opera e un preside scolastico di Abbiategrasso si
sono spinti sin sulle rive del Mar Baltico per fondare una società di consulenza
a livello internazionale?
La mente contabile
di queste iniziative sarebbe proprio la bergamasca Bellini. In Lombardia è
figura nota avendo ottenuto numerosi incarichi di derivazione politica in Comuni
e società partecipate ed avendo lei stessa, negli anni 90, ricoperto il ruolo di
assessore in una giunta a guida Pds.
Claise la considera
«responsabile della consulenza gestionale e finanziaria della coppia
Panzeri-Colleoni» e sospetta che la donna possa aver veicolato «operazioni di
riciclaggio». Per questo ne ha ordinato la perquisizione, anche se a giudizio
dei legali della Bellini l'indagine sarebbe «unicamente a carico di terze
persone».
Per gli avvocati la
loro assistita non sarebbe «la consulente finanziaria o contabile dei coniugi
Panzeri» e la stessa con un altro quotidiano ha specificato che il suo gruppo di
lavoro «si è occupato dalla contabilità forfettaria dello studio legale di
Silvia Panzeri». La Bellini ha anche dichiarato che Giorgi senior non sarebbe
altro che «uno dei suoi tanti clienti», omettendo, però, di ricordare di aver
fondato con lui e con suo figlio le due Equality. La cui costola italiana, che,
come abbiamo già scritto, pur occupandosi di questioni molto distanti dal mondo
della scuola, ma molto vicine al raggio di azione di Francesco Giorgi e Panzeri
senior, è riuscita a fatturare per prestazioni 240.000 euro nel 2019 e 81.000
l'anno successivo. Davvero un bel risultato.
Ma chi sono stati i
clienti che in meno di 24 mesi hanno gonfiato le casse della srl, con 321.000
euro? Le Equality sono nate quando Panzeri senior era eurodeputato e non poteva
essere remunerato da soggetti terzi. Poi l'ex sindacalista non è stato rieletto
e ha fondato la sua Ong Fight impunity, diventando praticamente un lobbista.
A questo punto le
due Equality sono state smantellate quasi contemporaneamente. Si tratta di un
semplice caso? Forse no. Un indizio parrebbe certificare lo stretto legame che
c'era tra le società di consulenza dismesse e Panzeri: sapete a chi ha ceduto il
40 per cento delle sue quote Luciano Panzeri in Italia? Al cinquantaseienne
sloveno Manfred Forte. E chi è costui? Grazie ad alcune fonti il 24 dicembre
abbiamo svelato che sarebbe niente meno che il compagno di Silvia Panzeri.
Un legame che ci fa
intravedere il filo rosso che conduce dall'Equality a Panzeri, anche se a
costituire l'azienda ufficialmente sono stati padre e fratello del suo
assistente parlamentare e la ragioniera che seguiva la contabilità della figlia
Silvia. Ieri abbiamo provato a chiedere alla ragioniera se quella scatola estone
fosse stata pensata per far transitare verso l'Italia pagamenti che sarebbe
stato meglio non far giungere direttamente nel nostro Paese, fosse anche solo
per questioni di opportunità politica o di possibili conflitti d'interesse.
Nei piani iniziali i
soldi dal Qatar o quelli Marocco avrebbero dovuto passare dal Baltico? Il gip di
Aosta Giuseppe Colazingari ha spiegato in un recente decreto di sequestro ai
danni di Nicolò Figà-Talamanca, segretario generale della Ong No peace without
justice, pure lui arrestato in Belgio, quale sarebbe lo schema della presunta
associazione per delinquere: «Vi sono Stati "corruttori" che versano denaro sul
conto di società con sede all'estero e, successivamente, il denaro viene versato
su uno dei conti di una ong/onp di Talamanca, il cui ruolo parrebbe essere
quello di garantire che il denaro venga poi convogliato ai destinatari della
corruzione».
Qualche Stato
«corruttore» avrebbe dovuto inviare i soldi anche alla Equality? Ieri abbiamo
provato a domandarlo sia a Luciano Giorgi che alla Bellini. Quest' ultima ci ha
risposto con due sole parole: «Mi perseguita». Ma noi siamo solo alla ricerca di
qualche risposta.
Da editorialedomani.it il 27 dicembre 2022.
Ci sono nomi ancora
coperti da segreto sui personaggi politici coinvolti nel Qatargate, lo scandalo
delle tangenti dell’emirato per comprare la benevolenza del parlamento europeo
sui Mondiali di calcio 2022 e non solo. Adesso cominciano a circolare sulla
stampa le intercettazioni telefoniche di Antonio Panzeri, l’eurodeputato
socialista arrestato dalla giustizia belga perché considerato il punto di
riferimento di lobbisti qatarioti e marocchini per intervenire sulle decisioni
di Bruxelles.
I testi pubblicati
da Repubblica raccontano da una parte come come il gruppo Panzeri si muovesse
per raggiungere gli obiettivi dei loro «datori di lavoro», e, secondo il giudice
belga Micheal Claise «infiltrare e inquinare la democrazia europea», e
dall’altra la vita di lusso che si concedeva l’ex politico di Articolo 1 insieme
alla famiglia.
IL MAROCCO
I rapporti poco
trasparenti con il Marocco emergono ancora una volta nei favori concessi. In
calendario - dopo il viaggio a Doha in autunno a spese, secondo quello che
emerge dall'indagine, del governo del Qatar - otto giorni al Mamounia di
Marrakech, un hotel con spa e casinò da 1.800 euro a notte in su, dove la
famiglia Panzeri aveva il proposito di passare il Capodanno. Da quanto emerge a
carico del Marocco. «A proposito vengono pure mia figlia e il marito», diceva
Panzeri all’ambasciatore marocchino a Varsavia, Abderrahim Atmoun. I rapporti
sono estremamente informali: «Anche lui!». «E dai sei un rompi scatole», la
risposta.
A un certo punto
Atmoun chiede a Panzeri notizie di Andrea, loro «amico». Per la procura «è molto
probabile che anche questa persona li accompagni durante il soggiorno». L'ex
sindacalista risponde «non ancora», ma poi sembra rassicurarlo con altro:
«Stasera sono a cena con Maria».
Secondo gli
investigatori potrebbe trattarsi di Andrea Cozzolino, l’eurodeputato che ha
modificato la risoluzione sul Qatar oggi sospeso dal Pd per salvaguardare
l’onorabilità del partito, mentre Maria sia l'eurodeputata socialista belga
Maria Arena, con cui Panzeri pianificava investimenti, a conferma, secondo
l'accusa, che Atmoun sarebbe ben di più che una semplice conoscenza "mondana” e
“diplomatica” per i due europarlamentari italiani.
I PARLAMENTARI
Quello che emerge
con ancora maggiore chiarezza è come Panzeri pilotasse i lavori parlamentari. Ci
sono contatti e telefonate con eurodeputati il cui nome al momento coperti da
"omissis". Il circolo sarebbe però soprattutto italiano, spetterà al parlamento
decidere se dare il via libera alla procura.
Il 14 novembre,
racconta ancora Repubblica, giorno in cui si sono riunite a Bruxelles le
commissioni Diritti dell'Uomo e Libertà civili, Giustizia e Affari interni,
hanno presenziato in aula diversi ufficiali del Qatar. Francesco Giorgi,
l’assistente di Cozzolino e compagno compagno della vicepresidente agli arresti
Eva Kaili, anche lui in arresto, tiene aggiornato Panzeri al telefono. Si
assicura che ci sia la «ragazza», ovvero Alessandra Moretti.
Panzeri dà
indicazioni su cosa dire anche a Marc, ovvero Tarabella altro europarlamentare
di cui Giorgi è stato assistente. Per Panzeri Tarabella di intervenire, quando
Giorgi dice di averlo fatto, gli suggerisce di dire: «Non vedevo questo
interesse quattro anni fa quando c'erano i Mondiali in Russia», e cerca di
allontanare l’ipotesi di un’indagine nei confronti della Fifa al Parlamento
europeo. Due ore dopo Panzeri si complimenta con una donna riferendo che anche
il Qatar è compiaciuto.
LA PLENARIA
Qui torna la
plenaria sul tema del Qatar e dei diritti umani. Pochi giorni prima al telefono
con un uomo (non identificato) diceva: «Volevo solo parlarti perché nel gruppo
si sta formando un certo atteggiamento di spinta per la plenaria riguardante il
Qatar, e noi abbiamo risposto che c'è l'evento del 14 novembre... si... appunto
abbiamo invitato alti rappresentanti del sindacato, ma oggi nel gruppo eh,...
sono i tedeschi? eh... sì, chi spinge un po’ per questa cosa, quindi è pazzo,
Dobbiamo trovare un modo per calmare questa dimensione».
L’ipotesi per
ammorbidire i politici prima del voto era regalare i biglietti per assistere al
mondiale di calcio, ma il capo del partito socialista belga e sindaco di
Charleroi, Paul Magnette, riportano i cronisti, «ha vietato a tutti i
parlamentari di andare ai Mondiali. Ecco perché Marc ha difficoltà ad
andare...».
Estratto
dell’articolo di Claudio Tito per “la Repubblica” il 27 dicembre 2022.
La valigia. […] È
uno dei tratti distintivi delle indagini sul Qatargate. Il "veicolo" delle
mazzette. Il "mezzo" per assicurare il passaggio dei soldi. […]
Eppure basta
sfogliare i documenti che accompagnano e motivano i provvedimenti adottati dai
magistrati di Bruxelles per capire che molto delle operazioni condotte da
Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e gli emissari del Qatar ruotasse proprio
intorno alle valigie. Le foto e la sequenza di un incontro specifico tra i due
italiani e il ministro del lavoro qatarino, Ali Ben Samikh al-Marri, ne sono una
testimonianza. E a quel colloquio la procura di Bruxelles assegna una
particolare importanza. Una delle prove di come circolassero le "mazzette".
È il 10 ottobre
scorso. Mancano cinque settimane all'inizio dei Mondiali di calcio. La scena si
svolge in uno degli hotel di maggior lusso della capitale belga. È lo
Steigenberger Wiltcher' s. […]
Sono le 17,30 circa.
Arrivano e parcheggiano tre Mercedes di colore nero nella piccola rotonda
davanti all'albergo. Tutte intestate alla rappresentanza diplomatica del Qatar.
Dalle vetture scende una delegazione governativa di Doha, guidata appunto dal
ministro del lavoro. Con lui ci sono altri cinque uomini: scorta e - forse non a
caso - un portavaligia. I magistrati belgi si sono fatti consegnare video e
immagini dalla sicurezza dell'hotel. E tutto viene allegato agli atti.
[…] Il 10 ottobre,
dunque, il ministro del lavoro entra nell'hotel e viene accompagnato al quarto
piano: lì c'è la sua suite. Poco dopo arrivano Panzeri e Giorgi. Le foto della
sicurezza interna ritraggono l'ex eurodeputato italiano con una valigetta in
mano. Una specie di ventiquattrore. All'apparenza vuota. O almeno questo è il
commento degli inquirenti.
Il suo ex assistente
addirittura si presenta con la figlia di venti mesi. La madre è Eva Kaili, in
quel momento ancora vicepresidente del Parlamento europeo. Spinge il passeggino.
Come se nulla fosse. Due uomini della delegazione qatarina li accolgono e li
accompagnano proprio al quarto piano. Ogni pa ssaggio è provato da uno scatto o
da una ripresa.
Lungo il corridoio
che conduce alla suite di Al Marri si intravede un altro uomo di Doha che,
seguendo Panzeri, trascina un altro trolley. Tutto si svolge intorno alle ore
18. Dopo mezz' ora Giorgi lascia la camera. Scende nella hall. La figlia indica
una persona che sembra conoscere bene. Il padre la lascia con quella persona. E
risale immediatamente al quarto piano. Magari ha pensato che il colloquio stesse
entrando nella fase più calda.
Passa un'altra ora.
L'incontro finisce. Panzeri lascia l'hotel con in mano la stessa valigetta che
aveva all'ingresso. Ora, però, viene evidenziata dalla Procura con un bel
cerchio rosso. Perché? «Sembra più piena», scrivono gli uffici della
magistratura di Bruxelles. Il sospetto dei magistrati, insomma, è che questo sia
stato uno degli incontri in cui si organizzava la consegna del denaro in
contanti. Da un trolley ad una ventiquattrore.
Un sistema
collaudato. Fatto, appunto, solo di denaro "fresco". Perché come scrivono a più
riprese i procuratori di Bruxelles «l'obiettivo della cricca era l'"argent"». Il
denaro.
Nel caso specifico,
inoltre, quell'appuntamento non poteva essere casuale. Per due motivi. Il primo:
solo dieci giorni dopo, ossia il 22 ottobre, sempre Panzeri in compagnia di Luca
Visentini, il presidente del federazione mondiale dei sindacati, vola verso
Doha. Prende un aereo della Qatar Airways da Parigi. […] Gli inquirenti
sottolineano un elemento: i biglietti aerei sono stati emessi da una agenzia di
viaggio di Doha.
[…] Il secondo
motivo: il mese successivo, a novembre, la sessione plenaria del Parlamento
europeo avrebbe dovuto votare le risoluzioni sul Qatar e sul rispetto dei
diritti dei lavoratori. Appuntamento cui l'emirato attribuiva particolare
importanza. […]
Giuseppe Guastella
per il “Corriere della Sera” il 27 dicembre 2022.
Bruxelles Il 9
dicembre la vita di Eva Kaili è precipitata nel baratro di una cella del carcere
di Haren, dopo che nella bella casa che divide con il compagno Francesco Giorgi
nel centro di Bruxelles la polizia ha trovato tanti soldi in contanti.
Accusata
nell'inchiesta che ha terremotato il Parlamento europeo di cui era
vicepresidente di essere una delle pedine di Giorgi e di Antonio Panzeri per
influenzare a suon di tangenti la politica a favore di Qatar e Marocco,
l'eurodeputata del Pasok è stata destituita dalla vicepresidenza dell'assemblea.
Giovedì scorso, i giudici hanno rigettato la sua richiesta di scarcerazione
prolungando la detenzione preventiva di un mese.Avvocato Michalis
Dimitrakopoulos, lei difende Kaili con il suo collega André Risopoulos. Come ha
trascorso il Natale la ex vicepresidente?
«Eva Kaili in
carcere sta vivendo un incubo, una catastrofe perché è innocente. L'unica
persona che l'ha visitata nel giorno di Natale è stato il padre».
Dopo l'udienza del
22 dicembre, non avete fatto ricorso contro la decisione dei giudici di
prolungare la custodia. Non avete fiducia nella giustizia belga?
«Ho fiducia completa
nel sistema giudiziario del Belgio. Io e il mio collega belga André Risopoulos
facciamo gli avvocati da più di 30 anni e l'esperienza ci indica che se
facessimo ricorso in corte d'appello ed esso venisse rigettato, allora le
possibilità che Kaili in futuro venga scarcerata sarebbero praticamente nulle.
Sarebbe davvero difficile che, se chiedessimo alla Corte di prima istanza di
scarcerarla, i giudici andassero contro la decisione già presa da giudici di
grado superiore».
Al momento, le
accuse di cui abbiamo conoscenza sono generiche. Sarebbe necessario sapere
meglio chi ha fatto cosa, in che modo e quando. Come avvocato di Kaili ne sa di
più?
«Secondo il mandato
di arresto, le accuse sono corruzione di pubblico ufficiale, riciclaggio e
associazione criminale. Ciò che posso dire è che sono molto vaghe e che non sono
fondate su circostanze vere, ma solo sul fatto che il denaro è stato trovato
sotto lo stesso tetto che Eva Kaili divideva con il compagno».
Avvocato, ha già
dichiarato che la sua assistita sta collaborando con la giustizia belga. È stata
interrogata di nuovo recentemente?
«Ha fatto una nuova
dichiarazione la settimana scorsa alla polizia. Era la prima volta che si
trovava in condizioni psicologiche sufficientemente buone per essere pienamente
consapevole di quanto affermava, ed è stata la prima volta che ha avuto un buon
interprete».
Cosa sta provando
Kaili in questo momento?
«Dopo quello che ha
letto negli atti dell'indagine, si sente tradita. Il suo nome è stato usato a
sua insaputa, prima del giorno dell'arresto non sapeva nulla del denaro che è
stato trovato nell'abitazione, i soldi non erano suoi né li custodiva».
Kaili ha detto di
comprendere la decisione di destituirla nonostante basata solo su notizie di
stampa. A due settimane dall'arresto, la pensa ancora così?
«Credo che la
custodia preventiva alla quale è sottoposta sia sbagliata perché non ci sono
gravi indizi di colpevolezza, non era una latitante e non avrebbe potuto
cancellare le prove dell'indagine. In ogni caso, la sua posizione è che la
rimozione decisa dalla presidente Metsola sia corretta mentre c'è un'indagine in
corso».
Cosa sapeva dei
rapporti tra Giorgi e Panzeri che, per l'accusa, agivano dietro la Ong Fight
impunity ? Ritiene di essere la loro vittima?
«Ciò che lei sa è
che Panzeri conosceva e collaborava con Giorgi da molti anni. Kaili, però, non
era stata mai a conoscenza del grado e del tipo di collaborazione tra loro e per
lei sarebbe una dolorosa sorpresa se le accuse nei loro confronti fossero
confermate in giudizio».
Ha mai votato in
Parlamento in base a cosa le hanno chiesto Giorgi o Panzeri?
«Ha sempre votato
secondo coscienza, né Panzeri né il padre della sua bambina hanno mai
influenzato il suo voto. La creazione di relazioni commerciali con il Qatar è
stata una politica centrale dell'Unione europea. L'Europa ha bisogno del gas del
Qatar per non rimanere al freddo.
Dopo che il
presidente del consiglio europeo Charles Michel ha visitato il Qatar e ha avuto
colloqui ai massimi livelli ufficiali, dopo che il presidente Metsola ha
incontrato ufficialmente un ministro del Qatar, dopo che Joseph Borrell,
rappresentate Ue per gli affari esteri, ha pubblicamente supportato le relazioni
commerciali con il Qatar, è ipocrita sostenere che Kaili aveva un'agenda
personale con il Qatar.
La sola e unica
volta che ha votato a favore dell'ingresso senza visto in Europa di chi arriva
dal Qatar ha seguito la linea della politica centrale del Parlamento europeo. Il
risultato è stato di 70 sì e 30 contrari, quindi il suo voto non ha avuto alcun
peso».
Quando tornerà in
libertà, cosa farà? Resterà in Belgio o tornerà in Grecia?
«In caso sia
rilasciata resterà in Belgio e combatterà fino a quando non sarà riconosciuta la
sua innocenza».
È immaginabile come
si senta senza la sua bambina.
«Il suo cuore sta
letteralmente sanguinando per la sua bambina di 22 mesi che è sola e che può
contare solo sull'anziano nonno».
Qatargate, tra
Calusco d’Adda e Doha: il filo rosso che unisce «équipe», famiglie e soldi.
Giusy Fasano su Il Corriere della Sera il 28 dicembre 2022
I venti giorni
dell’inchiesta che ha terremotato l’Europarlamento. Una storia di famiglie
precipitate nel burrone, che fa ombra alle istituzioni, che chiama in causa
servizi segreti e diritti umani, mondiali di calcio e Ong
In alto da sinistra
in senso orario: Niccolò Figà-Talamanca, Antonio Panzeri, Silvia Panzeri, Eva
Kaili, Abderrahim Atmoun, Mark Tarabella, Andrea Cozzolino e Francesco Giorgi
Nelle sue carte la
procura federale di Bruxelles la chiama «équipe». Nel senso di «cricca». «Equipe
Panzeri-Giorgi-Cozzolino», dice una delle pagine iniziali dell’inchiesta. Lo
scandalo doveva ancora scoppiare ma le indagini avevano già tracciato la via da
percorrere: la stessa dei tre uomini-chiave.
L’«équipe».
Questa è una storia
di famiglie precipitate tutte assieme nel burrone, una storia che fa ombra al
Parlamento europeo, che chiama in causa servizi segreti e diritti umani,
mondiali di calcio e Ong... E in mezzo a tante cose dette, semi-dette, smentite
e (poche) confermate, è evidente che il cosiddetto Qatargate è destinato ad
andare ben oltre ciò che abbiamo saputo fin qui.
Partiamo dal 9
dicembre.
È il giorno nero
di Antonio Panzeri, 67 anni, un uomo che ha fatto prima la storia della Cgil e
poi un’esperienza da europarlamentare nelle file del Partito democratico per
passare infine ad Articolo 1. Dal 2019 il lavoro di Panzeri è la presidenza di
Fight impunity, Ong (sede a Bruxelles) attiva sul fronte dei diritti umani e che
lui stesso ha fondato. Ma il 9 dicembre tutto si interrompe. Lui finisce in
carcere con l’accusa di associazione criminale (la nostra associazione per
delinquere), corruzione e riciclaggio.
Una storia di
famiglie, dicevamo.
Assieme a lui
l’inchiesta della procura di Bruxelles travolge anche sua moglie, Maria Dolores
Colleoni, sua coetanea, e sua figlia Silvia, 34 anni, avvocatessa con studio a
Milano. Casa Panzeri è a Calusco D’Adda (Bergamo) ed è lì che la notizia del suo
arresto (a Bruxelles) arriva assieme alla richiesta della stessa misura — e
stessi reati — per le due donne.
Per capire tutto,
però, serve un passo indietro.
Torniamo alla
primavera del 2021 a un racconto che ha molti punti oscuri. Si narra che servizi
segreti del Belgio abbiano ricevuto una segnalazione dai colleghi di un Paese
imprecisato (forse gli Emirati) per un caso di «sicurezza nazionale». La
minaccia: interferenza di un Paese straniero sui processi decisionali del
Parlamento europeo. I belgi ricevono indicazioni su un centro culturale sospetto
che ha collegamenti con l’ambasciatore marocchino in Polonia, Abderrahim Atmoun,
il quale a sua volta ha contatti con Panzeri e la sua famiglia. Un nome tira
l’altro. Panzeri ha un uomo-ombra che lo segue in ogni attività e in ognidove: è
il suo ex assistente di quand’era parlamentare, Francesco Giorgi, milanese e
compagno di Eva Kaili, giornalista greca che ha scalato la vicepresidenza del
Parlamento europeo per i socialisti del Pasok e che è madre di una bambina di 22
mesi (figlia di Giorgi).
Nell’annotare nomi
su nomi, i servizi incappano anche in quello di Andrea Cozzolino, deputato
europeo del Pd che ha voluto come assistente proprio Francesco Giorgi dopo
l’addio di Panzeri al Parlamento di Bruxelles. L’inchiesta dell’intelligence
approfondisce il caso: si decide una «visita» a casa Panzeri (a Bruxelles)
mentre lui è in vacanza. E gli 007 scoprono borse con 700 mila euro in contanti.
Fotografano, imbottiscono l’appartamento di microspie e se ne vanno.
Tempo qualche
settimana e la «sicurezza nazionale» diventa un più banale — diciamo così — caso
di corruzione. Così le informazioni passano nelle mani della procura ordinaria e
i magistrati scoprono in breve tempo un’«associazione criminale», come la
chiamano loro, che li lascia sbalorditi. Valigie piene di soldi, regali e
vacanze da migliaia e migliaia di euro per piegare il Parlamento europeo alle
decisioni politiche in favore del Qatar e del Marocco. Spinte per aiutare quei
due Paesi anche davanti alle violazioni dei più elementari diritti umani o delle
più basiche norme sulla sicurezza del lavoro nei cantieri dei mondiali.
La procura, quindi,
il 9 di dicembre decide di avere abbastanza elementi per fare irruzione. Arresta
Panzeri in Belgio e chiede lo stesso provvedimento per la moglie e la figlia (ai
domiciliari a Calusco): sapevano (dicono i magistrati) che lui usava la Fight
impunity come centrale di raccolta dei soldi pagati da Qatar e Marocco. Sapevano
che si trattava di corruzione, non di attività da lobbista. E avevano loro
stesse rapporti con quell’ambasciatore del Marocco in Polonia, Abderrahim Atmoun
(non indagato), ritenuto l’anello di collegamento fra i servizi segreti
marocchini e Panzeri. Per la cronaca: al momento dell’arresto nella casa di
Bruxelles gli inquirenti trovano 600 mila euro in contanti: non più i 700 mila
fotografati dai servizi belgi mesi prima.
Avviene tutto negli
stessi minuti. Mentre Panzeri viene portato via, gli agenti si presentano a casa
di Eva Kaili. Arrestano lei e il compagno, Francesco Giorgi. Da qualche parte,
in casa, ci sono 150 mila euro in contanti («non ne so niente, chiedete a
Francesco», dirà poi nell’interrogatorio), e non è tutto. Poco prima il padre di
lei era stato fermato mentre usciva da un hotel con una valigia piena di altri
contanti, 600 mila euro. Lei ripete di non sapere niente di tutti quei soldi,
che ne è venuta a conoscenza soltanto al momento dell’arresto. Giorgi conferma
la sua versione ma la procura non vuole sentir parlare di arresti domiciliari,
nemmeno in nome della sua bimba di 22 mesi.
Il 9 dicembre è
stato il giorno del terremoto anche per Andrea Cozzolino che (non risulta
inquisito) dopo l’arresto del suo collaboratore decide di autosospendersi. C’è
poi Marc Tarabella. Italo-belga, europarlamentare di S&D, vicepresidente della
delegazione per i rapporti con la Penisola arabica: casa perquisita e
nessun’altra notizia sul suo conto. Nuvole ben più nere, invece, per Niccolò
Figà-Talamanca, segretario generale dell’ong No peace without justice che
condivide gli uffici con la Fight impunity e che proprio ieri ha ricevuto un no
agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Venti giorni così, di
linea dura e di nessuna concessione. Nel nome dell’Europa.
Le
intercettazioni a Panzeri: così pilotava europarlamentari italiani.
Continuano a restare in carcere gli indagati del Qatar gate. Sia quello che
viene considerato dai magistrati belgi l'uomo chiave dell'inchiesta, Antonio
Panzeri, e l'altro italiano coinvolto, Niccolo Figà Talamanca. Lodovica Bulian
su Il Giornale il 28 Dicembre 2022.
Continuano a restare
in carcere gli indagati del Qatar gate. Sia quello che viene considerato dai
magistrati belgi l'uomo chiave dell'inchiesta, Antonio Panzeri, e l'altro
italiano coinvolto, Niccolo Figà Talamanca, ex segretario della ong No Peace
Without Justice, considerata dagli investigatori, insieme con quella fondata nel
2019 da Panzeri, la «Fight Impunity», un veicolo della presunta corruzione da
parte di Qatar e Marocco. I due sono comparsi ieri davanti alla Corte d'appello
di Bruxelles. La procura federale del Belgio ha fatto sapere che per Talamanca,
«la modalità del braccialetto elettronico, concessa il 14 dicembre 2022» è stata
«sostituita da una semplice estensione della custodia cautelare» e per Panzeri,
su richiesta dei suoi legali, l'udienza è stata rinviata al 17 gennaio.
Francesco Giorgi, compagno della ex vicepresidente greca Eva Kaili, non aveva
presentato appello alla misura cautelare in carcere. Segno non solo di una
strategia di collaborazione che è in pieno corso, ma anche probabilmente della
consapevolezza degli stessi avvocati della complicata posizione dell'italiano
che era stato ex assistente di Panzeri quando era europarlamentare fino al 2018.
Dalle centinaia di
atti depositati nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di mazzette per cui
si ipotizza associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio, emergono
intercettazioni - rivelate ieri dal Fatto Quotidiano - in cui Panzeri parlerebbe
con la moglie e la figlia (arrestate anche loro su richiesta della procura
belga) di borse «piene» portate dal Marocco. Secondo gli inquirenti i tre
avrebbero utilizzato un viaggio nel giugno 2022 per riportare in Italia delle
«ricompense per attività di interferenza» a favore del paese africano. E agli
atti ci sarebbero anche le immagini di un incontro il 10 ottobre scorso in un
hotel a Bruxelles tra l'ex eurodeputato Panzeri, il suo assistente Giorgi e il
ministro del Lavoro di Doha. Secondo gli inquirenti - scrive Repubblica - in
quell'occasione sarebbe avvenuto un presunto scambio di denaro. Le immagini
riprendono Panzeri e Giorgi che entrano con un trolley e una borsa, secondo i
magistrati vuoti all'ingresso dell'hotel ma forse non all'uscita. Tra le chat e
le intercettazioni depositate ci sarebbero anche i nomi di altri
europarlamentari. Le indiscrezioni delle scorse settimane - dopo soprattutto
l'inizio della collaborazione di Giorgi con i magistrati, grazie alla quale
l'inchiesta ha subito una accelerazione - parlavano della possibilità di una
sessantina di europarlamentari potenzialmente convolti dalle indagini, ma tutti
protetti da immunità parlamentare, un muro difficile da valicare per gli
inquirenti. Ora sarebbero spuntate diverse conversazioni o scambi di messaggi
tra Panzeri ed eurodeputati, anche italiani, di cui non si conoscono i nomi.
Secondo Repubblica alcuni di loro avrebbero ricevuto indicazioni dal gruppo che
faceva riferimento di Panzeri su interventi da fare all'Eurocamera.
Gli indagati per ora
restano tutti in carcere, fatta eccezione per il sindacalista Luca Visentini che
si è proclamato innocente e che è stato rilasciato pochi giorni dopo l'arresto.
Anche la greca Eva Kaili dovrà attendere la prossima udienza tra meno di un mese
per sperare in una attenuazione della misura. Intanto si proclama del tutto
estranea alle attività del compagno Giorgi.
La guerra degli
007: chi c'è dietro il Qatargate.
Storia di Federico
Giuliani su Il Giornale il 28 dicembre 2022.
Il Qatargate come
punto di arrivo di un'inchiesta di malaffare, che riguarda giusto un paio di
Paesi e qualche personaggio ben inserito nel motore politico di Bruxelles,
oppure come una punta di un enorme e misterioso iceberg ancora tutto da
scoprire? La sensazione è che il terremoto che ha scosso l'Europa, o meglio le
fondamenta dell'Unione europea, possa essere inserito in un dossier molto più
corposo di quanto non si possa immaginare. E non solo per i molteplici misteri,
ancora irrisolti, che rendono la questione degna di un film di spionaggio
d'altri tempi. Ma anche perché, tra gli ultimi sospetti, c'è chi inizia a
parlare di Mosca.
I misteri del
Qatargate
Tralasciando il
fatto di cronaca nudo e crudo – i soldi ritrovati nelle abitazioni di Eva
Kaili e Antonio Panzeri – o meglio partendo da qui, è interessante interrogarsi
sul ruolo giocato dai partiti, sul denaro stesso, su chi ha fatto partire
l'indagine e su tutti i soggetti coinvolti. Una volta gettate le fondamenta e
acceso i riflettori su ruoli e protagonisti, allora si potrà iniziare a
completare il puzzle, pezzo dopo pezzo, fino al completamento del quadro.
L'impresa si è già
rivelata ardua. Intanto perché, come ha scritto Paolo Cirino Pomicino su Il
Giorno, la vicenda di Bruxelles assomiglia molto ad un "illecito arricchimento
di singole persone che nulla avevano a che fare con i partiti". Improbabili, se
non impossibili, i paragoni con altre vicende del passato. Dopo di che, passando
ai misteri irrisolti, ci si potrebbe chiedere perché inviare tutti quei soldi
per sostenere in sede parlamentare l'evoluzione riformatrice del Qatar.
Senza dubbio questo
dossier avrà dei probabili, letali, effetti politici e democratici a lungo
termine. Da qui in poi ogni singola mozione di minoranza o dichiarazione verrà
guardata con sospetto, vanificando quindi il principio che dovrebbe regolare la
democrazia europea.
Il sospetto su Mosca
Ecco perché
bisognerebbe da ragionare sugli attori coinvolti, focalizzandosi su un aspetto
da non trascurare: l'indagine è stata avviata dai servizi segreti e non dalla
magistratura. Ma, allora, chi ha allertato i servizi segreti del Belgio?
Rispondere a questa domanda, adesso, è complicato. Se non altro perché l'intero
affare è ancora avvolto nella nebbia. Attenzione, però, a non tralasciare
il quadro geopolitico europeo.
Non è un caso che
Pomicino si interroghi sul presunto – ancora non accertato né ufficialmente
tirato in ballo – ruolo giocato della Russia di Vladimir Putin in seno al
Qatargate. Considerando che i rapporti tra l'emiro al Thani e il capo del
Cremlino sono più che ottimi, Pomicino ha messo sul tavolo una ricostruzione
plausibile, o almeno, da non scartare a priori: Mosca potrebbe (il condizionale
è d'obbligo) aver ricevuto la notizia dell'affaire da Doha e averla diffusa
per indebolire l'Ue. A quale fine? Semplice: punire Bruxelles per la vicinanza
espressa all'Ucraina, ma anche danneggiare i servizi occidentali, la loro
credibilità nonché l'immagine.
Tra le altre
opzioni, oltre alla Russia, c'è chi ha parlato degli Emirati Arabi e ipotizza
che la segnalazione ai servizi del Belgio possa esser partita da Abu Dhabi, che
nega tuttavia ogni coinvolgimento. Il sospetto nasce dalle turbolente relazioni
tra Qatar ed Emirati, con questi ultimi che nel 2017 ruppero i rapporti con Doha
accusandola di sostenere il terrorismo. La crisi, poi, è rientrata, ma le scorie
potrebbero essere rimaste. Certo è che nel Qatargate la geopolitica occupa un
ruolo rilevante.
François De
Tonquédec per “La Verità” il 28 dicembre 2022.
Emergono nuovi
retroscena sull'attività di lobbing portata avanti dai servizi segreti
marocchini che ha fatto esplodere il cosidetto Qatargate. Siamo alla fine del
2021, e a Bruxelles si lavora a un documento, una sorta di black list dei Paesi
che non rispettano i diritti umani.
Le autorità di Rabat
si attivano per evitare che il Marocco finisca nell'elenco. Dalla loro, secondo
le informazioni raccolte dai servizi segreti belgi e olandesi e confluite
nell'inchiesta, almeno due figure di spicco che sarebbero state a libro paga
dell'intelligence marocchina già dal 2019.
Si tratta dell'ex
eurodeputato Pier Antonio Panzeri e del suo collega (tutt' ora in carica) Andrea
Cozzolino, che si è sempre dichiarato estraneo alla vicenda. Per gli 007 di
Bruxelles e Amsterdam i due sarebbero stati dei veri e propri «agenti» che
curavano gli interessi del Dged (il servizio segreto marocchino).
La posta in gioco
però è alta e le barbe finte di Rabat cercano una ulteriore sponda in Olanda,
dove vanno in trasferta per avvicinare fisicamente alcuni europarlamentari. Il
tentativo viene però denunciato alle autorità, dando il via alla prima fase
dell'inchiesta.
Per l'intelligence
belga e per quella olandese il coinvolgimento con il Dged di Cozzolino e Panzeri
sarebbe provato anche da un episodio legato ad Abderrahim Atmoun, diplomatico di
Rabat di cui La Verità ha raccontato i rapporti con Panzeri e la sua famiglia.
Quando Atmoun viene trasferito a Varsavia (dove è attualmente ambasciatore del
Marocco) gli 007 avrebbero proposto a Cozzolino e Panzeri un nuovo
interlocutore.
Sentendosi, però,
rispondere dai due politici che il loro riferimento doveva continuare a essere
Atmoun, che quindi avrebbe continuato a fare la spola tra Varsavia a Bruxelles.
Intanto, i nuovi
atti depositati dagli inquirenti belgi offrono ulteriori elementi sulll'incontro
tra Panzeri e Ali Ben Samikh al-Marri, ministro del Lavoro del Quatar svelato
dalla Verità il 17 dicembre.
L'ordine europeo di
indagine (Oie) trasmesso dal giudice istruttore belga Michel Claise ai colleghi
della Procura di Milano che La Verità ha avuto modo di visionare, aveva infatti
reso noto l'incontro.
Che veniva associato
alla successiva consegna da parte di Panzeri di tre buste contenenti circa
50.000 euro in contanti a Luca Visentini segretario generale (sospeso) della
Confederazione internazionale dei sindacati. Ma dalla ricostruzione completa
fatta dagli investigatori e dagli 007 della Sûreté nationale emergono nuovi
dettagli.
Ad esempio quello
che al meeting con il ministro ha partecipato anche Francesco Giorgi, già
assistente di Panzeri e compagno dell'ex vice presidente del Parlamento Europeo
Eva Kaili. Nel tardo pomeriggio del 10 ottobre scorso, i due si recano all'hotel
Steigenberger Wiltcher' s, un lussuoso 5 stelle situato nel centro della
capitale belga.
Poco dopo le 17
davanti all'albergo si è fermato un piccolo corteo formato da tre Mercedes nere,
con targa diplomatica del Qatar. Secondo la ricostruzione degli investigatori di
Bruxelles Ben Samikh al-Marri prende alloggio in una suite ubicata al quarto
piano. Ed è lì che intorno alle 18 Panzeri e Giorgi lo raggiungono. Nei fermo
immagine estratti dalle telecamere si vede Panzeri con in mano una borsa.
Morbida, il che permette agli inquirenti di valutare e annotare che sembra
vuota.
Giorgi arriva nella
hall con un passeggino con dentro la figlia di venti mesi avuta con la Kaili.
Due membri dello staff della delegazione diplomatica di Doha li accompagnano
nella suite del ministro. Dietro ai due italiani, un terzo uomo del Qatar, che
ha con sé un trolley. Dopo mezz' ora Giorgi scende brevemente nella hall, dove
lo aspetta una persona non identificata a cui affida la bambina, poi risale e
lui e Panzeri restano nell'hotel per un'altra ora. Quando l'ex eurodeputato
lascia l'albergo per gli investigatori però qualcosa è cambiato. La borsa
«sembra più piena», annotano, dopo aver evidenziato il dettaglio del fermo
immagine con un cerchio rosso.
L'ipotesi è che in
quella circostanza ci sia stato una consegna di denaro, con il trolley dell'uomo
di Doha che in realtà sarebbe stato una sorta di cassaforte. L'Oie trasmesso
alle autorità italiana evidenziava che quello stesso giorno gli investigatori di
Bruxelles avevano pizzicato Visentini (che è l'unico tra gli arrestati ad essere
stato rilasciato) mentre riceveva tre buste a loro avviso piene di euro
nell'appartamento di Bruxelles di Panzeri.
Gli inquirenti
collegano però l'incontro con il ministro qatarino anche al viaggio in Qatar di
Panzeri e Visentini del 22 ottobre. I due viaggiano sullo stesso aereo, un volo
Parigi-Doha della Qatar Airways. I biglietti dei due, annotano gli investigatori
belgi, sono stati emessi in Qatar. Una circostanza che li porta a ipotizzare che
i due siano stai ospiti del governo qatarino. Il viaggio avrebbe avuto lo scopo
di illustrare a Visentini alla vigilia dei mondiali di calcio i presunti
progressi del Qatar in materia di diritti dei lavoratori.
Sul fronte
processuale ieri la Corte d'appello di Bruxelles ha deciso di annullare la
decisione di prima istanza (sospesa in attesa del giudizio di ieri) sulla
concessione del braccialetto elettronico per Nicolò Figà-Talamanca e prolungare
la custodia cautelare. Per Panzeri, invece, su richiesta dello stesso imputato
l'udienza è stata spostata al 17 gennaio.
Estratto
dell'articolo di Luca De Vito e Giuliano Foschini per “la Repubblica” il 28
dicembre 2022.
«So che mio marito
stava custodendo qualcosa per il suo vecchio capo, Antonio Panzeri, e forse
anche per il suo attuale capo, Andrea Cozzolino». Eppure non sapevo cosa né
perché: «Non credo di fidarmi più di nessuno dopo quello che è successo». La
linea difensiva di Eva Kaili fa perno qui, sulla giustificazione che quanto
avvenuto sia stato il frutto di macchinazioni nell’ombra organizzate da Panzeri
e dal suo compagno Francesco Giorgi. Traffici di cui, sostiene, lei stessa non
voleva sapere.
Nel primo verbale
rilasciato agli inquirenti, l’eurodeputata greca del Pasok ed ex vicepresidente
del Parlamento europeo, finita in carcere con l’accusa di corruzione e
riciclaggio nell’inchiesta Qatargate, ha dovuto spiegare molte cose ai due
agenti della polizia giudiziaria di Bruxelles che l’hanno interrogata […]
«Dopo che il mio
compagno è stato arrestato sono entrata nel suo ufficio. Ho guardato tra le sue
cose per capire perché fosse stato arrestato». Kaili trova la valigia, così come
un pc e un telefono. «Allora ho chiamato mio padre, che era con la bambina. Gli
ho chiesto di venire a prendere la valigia. (…) È una valigia per Panzeri che
mio marito teneva in casa. (…) Sapevo che mio padre avrebbe raggiunto mia figlia
perché nella valigia che aveva preso avevo messo dei biberon».
Subito dopo prova a
chiamare anche l’ex sindacalista e i suoi amici: «Ho prima provato a chiamare
Panzeri (che parla solo italiano) ma non sono riuscita a trovarlo, quindi ho
provato a contattare Marc Tarabella e Maria Arena. Non sapevano perché Panzeri
non avesse risposto».
Le parziali
ammissioni fatte da Kaili, che rigetta le accuse di corruzione, riguardano
proprio il denaro. «Ho aperto la valigia. Ho anche aperto la cassaforte. So che
(Francesco Giorgi, ndr ) stava custodendo qualcosa per il suo vecchio capo,
Antonio Panzeri, e forse anche perl’attuale capo, Andrea Cozzolino».
La valigia quindi
era di Panzeri, assicura Kaili, aggiungendo poi però che «c’era un’altra borsa
che conteneva denaro. Era questo che (Giorgi,ndr ) aveva preso in prestito per
la proprietà immobiliare». La coppia ha infatti appena comprato un appartamento.
Il mutuo è a nome dell’eurodeputata, che paga il canone e i lavori, il denaro
cash invece «era il contributo del mio compagno ». Nella borsa c’erano «50 o
60mila euro, non lo so esattamente perché non ho intenzione di indagare nei suoi
affari». […]
Non mancano dei
rimpianti. Dei «rapporti (di Giorgi, ndr) con Panzeri e Cozzolino non sempre mi
fidavo. Francesco aveva un obbligo morale verso Antonio e Andrea, ma era troppo.
Ogni volta che gli altri gli chiedevano qualcosa, si sentiva in dovere di
rispondere e mettersi a disposizione. Non sapeva dire di no. Forse avrei dovuto
dire qualcosa perché sono più grande di Francesco. È troppo accomodante, troppo
gentile con i suoi amici in generale» […]
Estratto
dell'articolo da affaritaliani.it il 28 dicembre 2022.
[….] La "cricca" -
prosegue Repubblica - lavorava così. Infiltrando, secondo il parere degli
inquirenti, proprio i comitati o le commissioni dell’Europarlamento. "Svolgiamo
la nostra ricerca — si legge in uno dei documenti allegati dai magistrati belgi
ai mandati di cattura dei primi cinque indagati e datato 12 settembre — sulla
base delle Commissioni di cui fanno parte le persone interessate dal
fascicolo".
Questo metodo di
lavoro da parte dei magistrati del Belgio apre scenari inquietanti su quanto
fosse estesa la rete dei rapporti.
La rete del
Qatargate: «Azioni di ingerenza in altre istituzioni Ue».
Giuseppe Guastella
su Il Corriere della Sera il 29 Dicembre 2022.
I sospetti dei
magistrati nelle carte su Panzeri e il Parlamento europeo. L’accusa: «La
politica del gruppo dei socialisti sarebbe stata influenzata da una squadra di
tre italiani»
Anche altre
«istituzioni europee» avrebbero subito l’ingerenza di Marocco e Qatar attraverso
una rete di personaggi influenti inseriti in snodi determinanti di cui gli
arrestati Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e la ex vice presidente del
Parlamento europeo Eva Kaili rappresentano solo alcune maglie. Dagli atti
dell’inchiesta che ha terremotato il Parlamento europeo emerge con evidenza che
il lavoro degli inquirenti non è finito e potrebbe avere sviluppi deflagranti.
La squadra
A tre settimane dal
blitz, leggendo i mandati di cattura si riescono a cogliere sfumature che
precisano meglio i contorni dell’inchiesta. Come l’incipit in cui il giudice
Michel Claise spiega che l’indagine, partita da una operazione dei servizi
segreti belgi del Vsse e di «altri servizi di sicurezza europei», riguarda
«azioni di ingerenza in seno alle istituzioni dell’Unione europea» da parte del
Marocco e del Qatar «attraverso la corruzione di persone inserite ai vertici del
mondo istituzionale europeo» in generale, ma al momento l’obiettivo della
magistratura resta principalmente ciò che è accaduto nel Parlamento dove «la
politica del gruppo “Socialisti e democratici” (S&D) sarebbe stata influenzata
per conto del Marocco e/o del Qatar da una squadra di tre italiani» i cui nomi
vengono elencati in questo ordine: Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino
(eurodeputato sospeso dal Pd che non risulta indagato) e Francesco Giorgi.
Il Marocco
Sarebbe stato il
Marocco il primo a rivolgersi per coltivare i suoi plurimi interessi al gruppo
facendolo guidare nelle operazioni da Mohamed Belharace, un ufficiale dei Dged,
il servizio segreto di Rabat. Belharace avrebbe agito attraverso l’ambasciatore
del Marocco in Polonia Abderrahim Atmoun, un personaggio che «lavorerebbe
strettamente con i servizi segreti marocchini» che si è incontrato più volte con
Panzeri e Cozzolino a Bruxelles e a Varsavia. Per operare, i tre italiani
avrebbero contato «sulla collaborazione di un gruppo di membri del Parlamento
europeo definiti come “amici”. Essi sono tutti membri del gruppo parlamentare
“S&D”. I più vicini sarebbero Kaili Eva, Arena Maria, Moretti Alessandra,
Benifei Brando Maria». Tranne la prima, gli altri non risultano coinvolti nelle
indagini.
Panzeri, Giorgi
(definito l’agente del primo nel Parlamento) e Cozzolino «prenderebbero ordini
il più delle volte da Atmoun Abderrahim», ma «sarebbero altresì in contatto
diretto con Mansouri Yassine, il direttore generale del Dged» che Cozzolino
«avrebbe incontrato personalmente (…) in Marocco nel 2019» . Nei mandati di
arresto sono riportati i voli di andata e ritorno prenotati nell’autunno 2019
dal Dged per Cozzolino, ma non c’è certezza che l’europarlamentare sia poi
salito sugli aerei, analogamente ai voli pagati per Panzeri. Per il giudice
Claise, quindi, c’è il forte sospetto che Cozzolino e Panzeri abbiano «concluso
un accordo nel 2019 con il Dged attraverso l’intermediario Atmoun per praticare
l’ingerenza in favore del Marocco in seno al Parlamento in cambio di denaro».
Il Qatar
L’attività per il
Qatar, invece, si sarebbe mossa agli ordini del ministro del lavoro Ben Samikh
Al Marri Ali, con l’aiuto di un assistente, Bettahar Boudjellal, denominato
«l’algerino». Nel caso del Paese del Golfo, i contanti servivano a migliorare
«la propria immagine sul piano dei diritti dei lavoratori, deteriorata a causa
dei rapporti che denunciano gli abusi nei siti di costruzione degli stadi della
Coppa del Mondo di calcio 2022». La squadra sarebbe stata composta da Panzeri e
da Giorgi, che si sarebbero divisi i soldi al 50%.
Durante il blitz del
9 dicembre, è stato sequestrato più di un milione e mezzo di euro in contanti
nell’abitazione di Panzeri e in quella che Giorgi divide con la compagna Kaili.
La Vsse ha monitorato i due uomini per mesi scoprendo che il primo usava il
denaro per sostenere «un tenore di vita superiore ai suoi redditi legittimi» e
«per pagare i membri della rete»; il secondo stava per «acquisire un bene
immobile». Come hanno ricevuto le mazzette? Dal Marocco attraverso Atmoun, dal
Qatar si sospetta sia transitato per i conti di Niccolò Figà-Talamanca, ma anche
consegnato a Panzeri durante un viaggio nel Paese.
Lo scandalo
mazzette. Qatargate, perché la Bonino tace?
I giudici tengono
agli arresti Panzeri e Figà-Talamanca. Ma la leader radicale fischietta. Nicola
Porro il 28 Dicembre 2022.
Ieri la Corte
d’appello di Bruxelles ha deciso di prolungare la custodia cautelare
dell’ex-eurodeputato Antonio Panzeri e Niccolò Figà-Talamanca, entrambi
coinvolti nel caso Qatargate. Vedete: la questione Panzeri ha a che fare con la
cattiva coscienza della sinistra. Figà-Talamanca era il segretario generale
della Ong “No Peace Without Justice” di cui la Bonino è fondatrice. Possiamo
dire che Panzeri sta a D’Alema molto meno di quanto Figà-Talamanca stia
ad Emma Bonino.
I due si conoscono
da quarant’anni e, quando il suo braccio destro finisce in carcere, la Bonino
non fa una dichiarazione né a difesa né d’attacco.
Capite bene che la
Bonino non può fischiettare e far finta di nulla. Non può, non per questioni di
giustizia, bensì perché la storia del Partito Radicale le dovrebbe imporre di
fare chiarezza quantomeno dal punto di vista politico. Nicola Porro, 28 dicembre
2022
Estratto
dell’articolo di Gabriele Rosana per il Messaggero il 29 Dicembre 2022.
Adesso è Francesco
Giorgi a vuotare il sacco, a fare i nomi, a illustrare il listino prezzi e
ricostruire le battute da cui ha preso le mosse la rete internazionale di
euro-corruzione svelata dal Qatargate. Che si estenderebbe pure a Marocco e
Mauritania. La versione che il collaboratore parlamentare ha affidato agli
inquirenti belgi inchioda il suo ex capo Pier Antonio Panzeri e, parzialmente,
la compagna Eva Kaili, vicepresidente dell'Eurocamera destituita due settimane
fa. La greca «era a conoscenza dell'origine del denaro» custodito dal partner
per conto di Panzeri nell'appartamento di rue Wiertz in cui vivono insieme: «Ma
Eva è estranea a questa rete. Anzi, mi ha chiesto più volte di smettere».
(...) Nella
ricostruzione di Giorgi rientrano pure Marocco e Mauritania: l'accordo con Rabat
prevedeva «che avremmo lavorato per evitare risoluzioni del Parlamento contro il
Paese, in cambio di 50mila euro». L'interlocutore di riferimento sarebbe stato
l'ambasciatore marocchino in Polonia Abderrahim Atmoun, spesso ritratto in foto
con i due italiani. La Mauritania, invece, «ha un problema d'immagine, e per
questo s' è rivolta a Panzeri. Ho affittato il mio appartamento (a due passi dal
Parlamento, ndr) all'ambasciatore. Quella era la mia controparte. Panzeri ha
invece incassato 25mila euro in contanti». Intanto, il dem Andrea Cozzolino, pur
non indagato, ha chiesto di essere sentito dagli inquirenti. Cozzolino si è
auto-sospeso dai ruoli nel gruppo S&D e dalla presidenza della delegazione per
le relazioni con i Paesi del Maghreb.
Estratto
dell’articolo di Giuseppe Salvaggiulo per “la Stampa” il 29 Dicembre 2022.
Sia l'ex
eurodeputato Antonio Panzeri sia il suo ex assistente a Bruxelles Francesco
Giorgi, protagonisti del Qatargate, ammettono di aver contratto un accordo
corruttivo con altri Stati, per tutelarne gli interessi al Parlamento europeo.
Ma le due versioni divergono sulle date. Secondo Panzeri, il patto sporco nasce
alla fine del 2019, quando era tornato un privato cittadino, non più rieletto al
Parlamento Ue.
Invece Giorgi lo
retrodata ai primi mesi dello stesso anno, quando Panzeri era ancora in carica.
La differenza di versioni non è irrilevante, ma la sostanza dell'accordo
avvalora l'ipotesi della Procura federale belga, che ha arrestato entrambi con
l'accusa di associazione criminale, corruzione e riciclaggio. Inoltre, secondo
Giorgi, Panzeri si era messo a disposizione di tre Stati: Marocco, Qatar e
Mauritania.
Che il governo
marocchino considerasse Panzeri «un intimo amico» risulta dai documenti
riservati della diplomazia di Rabat dal 2011. L'anno dopo, Panzeri ospitava alla
Festa nazionale dell'Unità di Reggio Emilia Abderrahim Atmoun, all'epoca
senatore marocchino, poi ambasciatore a Varsavia, ritenuto dagli inquirenti
l'agente della corruzione.
Nel 2015, Panzeri
era relatore del rapporto annuale del Parlamento Ue sui diritti umani che, per
la prima volta, non menzionava la disputa territoriale sul Sahara Occidentale,
spina nel fianco di Rabat. Al contrario, ne elogiava «i lodevoli sforzi per i
diritti umani».
Era proprio Atmoun a
rallegrarsene infierendo sulla «sconfitta dei lobbisti antimarocchini». Secondo
la Procura belga, già in quel momento il rapporto tra Atmoun e Panzeri non era
innocente ma corruttivo. Denaro, regali e viaggi per tutta la famiglia fino a
poche settimane fa.
Il format era stato
replicato con il Qatar dopo l'elezione di Panzeri a presidente della commissione
per i diritti umani del Parlamento europeo nel 2017. Il suo interlocutore
«naturale» era Ali ben Samikh Al Marri: ex presidente del Comitato nazionale per
i diritti umani (organismo non indipendente, ma di emanazione governativa) e
attuale ministro del lavoro del Qatar. Il grande tessitore dell'operazione per
salvaguardare l'immagine del Paese in vista dei mondiali di calcio.
Fino all'audizione
del 14 novembre davanti alla commissione diritti umani del Parlamento Ue,
presieduta dalla socialista belga Maria Arena, fedelissima di Panzeri. Il quale,
benché ex deputato, concorda con lo stesso ministro qatarino contenuti e ritmi
del dibattito, per evitargli spiacevoli sorprese. Panzeri sostiene che tutto sia
cominciato non prima di ottobre o novembre 2019, negando «conflitti di
interessi» durante il mandato da eurodeputato. «La collaborazione è cominciata
all'inizio del 2019», dice invece Giorgi, che allora era assistente di Panzeri
dopo aver scavalcato nel ruolo Giuseppe Meroni, a sua volta perquisito dalla
polizia belga.
Giorgi aggiunge
dettagli: «Abbiamo definito gli importi per i nostri rispettivi interventi». È
vago sugli importi, non sul fatto che «erano in contanti». Dopo la mancata
rielezione di Panzeri, spiega Giorgi al giudice, la cricca si era strutturata
attraverso la Ong Fight Impunity «perché bisognava trovare un sistema chiaro che
non desse l'allarme». L'associazione umanitaria, mai registrata a Bruxelles,
fungeva da canale per far transitare le mazzette.
In cambio, secondo
la Procura belga, Panzeri e Giorgi condizionavano le posizioni del Parlamento Ue
sul Qatar. Tra i premi forniti dal Paese che ospitava i mondiali, anche
biglietti per le partite, che sarebbero stati distribuiti da Panzeri sia a
parenti che a soggetti politici.
[…] Giorgi aggiunge
un terzo contraente del patto scellerato: la Mauritania. A sua volta gravata da
«un problema di immagine», si sarebbe rivolta a Panzeri, il quale è stato nella
capitale Nouakchott anche recentemente, il 28 giugno, per un convegno.
In questo caso, la
remunerazione sarebbe stata per Panzeri in contanti (25mila euro) e per Giorgi
sottoforma di affitto fittizio del suo appartamento brussellese (quasi 2mila
euro mensili). Nel suo interrogatorio, riferendosi agli altri due Paesi, Panzeri
aveva parlato di una «tariffa» da 50mila euro. […]
Estratto
dell’articolo di Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera” il 29 Dicembre
2022.
Anche altre
«istituzioni europee» avrebbero subito l'ingerenza di Marocco e Qatar attraverso
una rete di personaggi influenti inseriti in snodi determinanti di cui gli
arrestati Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e la ex vice presidente del
Parlamento europeo Eva Kaili rappresentano solo alcune maglie. Dagli atti
dell'inchiesta che ha terremotato il Parlamento europeo emerge con evidenza che
il lavoro degli inquirenti non è finito e potrebbe avere sviluppi deflagranti.
[…] Il Marocco
Sarebbe stato il
Marocco il primo a rivolgersi per coltivare i suoi plurimi interessi al gruppo
facendolo guidare nelle operazioni da Mohamed Belharace, un ufficiale dei Dged,
il servizio segreto di Rabat. Belharace avrebbe agito attraverso l'ambasciatore
del Marocco in Polonia Abderrahim Atmoun, un personaggio che «lavorerebbe
strettamente con i servizi segreti marocchini» che si è incontrato più volte con
Panzeri e Cozzolino a Bruxelles e a Varsavia. Per operare, i tre italiani
avrebbero contato «sulla collaborazione di un gruppo di membri del Parlamento
europeo definiti come "amici". Essi sono tutti membri del gruppo parlamentare
"S&D".
I più vicini
sarebbero Kaili Eva, Arena Maria, Moretti Alessandra, Benifei Brando Maria».
Tranne la prima, gli altri non risultano coinvolti nelle indagini. Panzeri,
Giorgi (definito l'agente del primo nel Parlamento) e Cozzolino «prenderebbero
ordini il più delle volte da Atmoun Abderrahim», ma «sarebbero altresì in
contatto diretto con Mansouri Yassine, il direttore generale del Dged» che
Cozzolino «avrebbe incontrato personalmente () in Marocco nel 2019».
Nei mandati di
arresto sono riportati i voli di andata e ritorno prenotati nell'autunno 2019
dal Dged per Cozzolino, ma non c'è certezza che l'europarlamentare sia poi
salito sugli aerei, analogamente ai voli pagati per Panzeri. Per il giudice
Claise, quindi, c'è il forte sospetto che Cozzolino e Panzeri abbiano «concluso
un accordo nel 2019 con il Dged attraverso l'intermediario Atmoun per praticare
l'ingerenza in favore del Marocco in seno al Parlamento in cambio di denaro».
Il Qatar
L'attività per il
Qatar, invece, si sarebbe mossa agli ordini del ministro del lavoro Ben Samikh
Al Marri Ali, con l'aiuto di un assistente, Bettahar Boudjellal, denominato
«l'algerino».
Nel caso del Paese
del Golfo, i contanti servivano a migliorare «la propria immagine sul piano dei
diritti dei lavoratori, deteriorata a causa dei rapporti che denunciano gli
abusi nei siti di costruzione degli stadi della Coppa del Mondo di calcio 2022».
La squadra sarebbe stata composta da Panzeri e da Giorgi, che si sarebbero
divisi i soldi al 50%.
Durante il blitz del
9 dicembre, è stato sequestrato più di un milione e mezzo di euro in contanti
nell'abitazione di Panzeri e in quella che Giorgi divide con la compagna Kaili.
La Vsse ha monitorato i due uomini per mesi scoprendo che il primo usava il
denaro per sostenere «un tenore di vita superiore ai suoi redditi legittimi» e
«per pagare i membri della rete»; il secondo stava per «acquisire un bene
immobile». Come hanno ricevuto le mazzette? Dal Marocco attraverso Atmoun, dal
Qatar si sospetta sia transitato per i conti di Niccolò Figà-Talamanca, ma anche
consegnato a Panzeri durante un viaggio nel Paese.
Giacomo Amadori e
François de Tonquédec per “La Verità” il 29 Dicembre 2022.
Le confessioni degli
indagati nell'inchiesta sul Qatargate, pezzo dopo pezzo, stanno svelando quello
che i lettori della Verità già sanno. Ma anche qualche informazione inedita.
Come i presunti viaggi a Doha dei parenti di Pier Antonio Panzeri e della
ragioniera di famiglia, al secolo Monica Rossana Bellini.
Una trasferta di cui
il nostro giornale ha trovato una clamorosa conferma. Ieri abbiamo dato la
notizia che l'intelligence olandese e quella belga, a inizio 2022, hanno
riferito agli inquirenti di Bruxelles che l'ex eurodeputato e il suo compagno di
partito Andrea Cozzolino sarebbero stati a libro paga del Qatar già a partire
dall'inizio del 2019. E sempre ieri il quotidiano belga Le Soir ha confermato il
nostro scoop, riportando quanto avrebbe riferito ai magistrati l'ex assistente
di Panzeri, Francesco Giorgi, oggi in carcere come la sua compagna Eva Kaili, ex
vicepresidente greco dell'europarlamento.
A verbale Giorgi,
che fino all'arresto lavorava per Cozzolino, avrebbe infatti dichiarato:
«All'inizio del 2019 è iniziata la collaborazione. Abbiamo definito gli importi,
che ho qualche difficoltà a ricordare, per i nostri rispettivi interventi. Era
in contanti». Secondo il racconto dell'ex collaboratore, solo pochi mesi dopo,
nel settembre del 2019, il sistema sarebbe stato reso più «professionale» con la
creazione dell'organizzazione non profit Fight Impunity, la creatura di Panzeri
con sede a Bruxelles.
Il motivo? «Perché
dovevamo trovare un sistema chiaro che non desse l'allarme». E il Qatargate
insegna che non esiste scatola più sicura delle Ong per portare avanti certi
traffici. L'idea, sempre secondo le dichiarazioni rilasciate da Giorgi durante
gli interrogatori, sarebbe nata nel 2018, quando Panzeri era ancora presidente
della sottocommissione Diritti umani del Parlamento europeo.
Ali ben Samikh al
Marri, già presidente del Comitato nazionale per i diritti umani del Qatar e
attuale ministro del Lavoro, avrebbe avuto l'idea di usare l'italiano per fare
lobbying nella capitale belga. E il loro sodalizio si sarebbe consolidato al
punto che ancora il 10 ottobre 2022, quattro anni dall'inizio della
collaborazione, lo stesso al Marri si sarebbe presentato con un trolley pieno di
soldi all'hotel Steigenberger wiltcher' s per incontrare Panzeri e Giorgi e
rifornirli di cash.
Circa 50.000 euro,
il giorno dopo, sono stati consegnati al sindacalista Luca Visentini, il quale
ha spiegato che si trattava di una donazione che sarebbe servita per sua
campagna per il congresso del sindacato mondiale e, in parte, per sostenere la
partecipazione delle delegazioni con limitate possibilità economiche.
Ma il 28 dicembre
del 2018, cioè nel periodo in cui alla presunta cricca viene la «pazza idea»,
viene fondata la Equality consultancy Srl, le cui quote erano per il 95% nelle
mani di Luciano Giorgi, di professione preside, e del figlio Stefano
(rispettivamente padre e fratello minore di Francesco), mentre il restante 5%
era detenuto dalla Bellini, per gli inquirenti belgi «consulente» di Panzeri.
Insomma, quando
iniziano a trafficare con il Qatar, viene costituita una Srl che verrà
velocemente dismessa e che ha nella ragione sociale temi di respiro
internazionale come «sviluppare reti tra diversi soggetti, ong, organizzazioni
imprenditoriali e controparti nei Paesi terzi»; costruire «legami economici e
culturali più forti all'interno dell'Ue e nei suoi stati membri» o «promuovere
gli scambi e la cooperazione tra soggetti, situati in altre aree geografiche di
riferimento».
Tutte questioni che
hanno a che vedere con le relazioni internazionali e i diritti umani, ma poco o
niente con la scuola. A settembre del 2018 era nata la gemella della Equality, a
Tallin, in Estonia, il Paese con il regime fiscale più favorevole di tutta
l'Unione. Una scelta singolare per un preside, il figlio trentenne e una
commercialista con lo studio a Opera, paesone a sud di Milano.
Infatti anche in
questo caso dentro alla compagine societaria c'erano i Giorgi e la Bellini. Poi
entrambe le Equality sono state dismesse ed è nata la Fight impunity non appena
Panzeri ha lasciato l'incarico di eurodeputato, lasciandosi alle spalle i
possibili conflitti di interesse. È forse per questa sospetta coincidenza
cronologica che l'ex sindacalista nella sua presunta confessione ha posticipato
l'inizio della collaborazione con Qatar e Marocco.
Secondo lui
l'accordo con Doha risalirebbe al novembre del 2019, mentre quello con il regno
del Maghreb sarebbe iniziato «dopo il 2019» e prevedeva che Panzeri si attivasse
per evitare l'approvazione di risoluzioni scomode per Rabat, in cambio di
«50mila euro». Esattamente quanto abbiamo anticipato ieri citando le informative
dei servizi del Benelux. Ma le sorprese non sono finite.
Giorgi avrebbe
aggiunto che tramite Panzeri sarebbero stati distribuiti biglietti aerei per
Doha anche a consiglieri politici, famigliari e amici, compresa una
commercialista. Ed è qui che torna in auge la donna che noi della Verità
riteniamo essere una figura chiave di tutta questa storia: la Bellini. La quale,
a quanto ci risulta, è stata in Qatar durante i Mondiali di calcio.
La commercialista
citata da Giorgi è con ogni probabilità lei. La signora è atterrata a Malpensa
il 28 novembre verso l'ora di pranzo, dopo essere partita da Doha intorno alle 8
del mattino su un aereo della compagnia ufficiale dell'emirato: la Qatar
airways. Il giorno prima, ma sarà certamente una coincidenza, si era giocata
allo stadio Al-Thumama Belgio-Marocco, la partita vinta a sorpresa dalla squadra
africana. Insomma l'incontro tra il Paese su cui la lobby doveva fare pressioni
e il Marocco, che quelle pressioni finanziava. Noi siamo certi che la
Ragioniera, riservata cinquantacinquenne bergamasca, conosca molti segreti di
questa vicenda.
Il giudice
istruttore Michel Claise la considera «responsabile della consulenza gestionale
e finanziaria della coppia Panzeri-Colleoni» e sospetta che la donna possa aver
veicolato «operazioni di riciclaggio». Per questo ne ha ordinato la
perquisizione, anche se a giudizio dei legali della Bellini, Franca De Candia e
Liliana Crescimanna, l'indagine sarebbe «unicamente a carico di terze persone».
A onor del vero
nell'ordine europeo di indagine, dove viene richiesta la perquisizione dello
studio Bellini, si specifica che «il rappresentante della persona giuridica» è
proprio la Ragioniera, citata con nome e cognome, e «si prega anche di
descrivere l'attuale posizione della persona interessata nel procedimento».
Ovvero quella di «persona sottoposta a indagini o imputato». Per gli avvocati la
loro assistita non sarebbe «la consulente finanziaria o contabile dei coniugi
Panzeri».
Inoltre la Bellini
con un altro quotidiano ha specificato che il suo gruppo di lavoro «si è
occupato dalla contabilità forfettaria dello studio legale di Silvia Panzeri».
Cioè della figlia giuslavorista dell'ex segretario della Camera del lavoro di
Milano. Anche lei agli arresti. La Bellini ha pure dichiarato che Giorgi senior
(a sua volta sotto inchiesta) non sarebbe altro che «uno dei suoi tanti
clienti», ma non ha specificato di aver fondato con lui e con suo figlio le due
Equality e di aver traghettato la ditta italiana sino alla chiusura quando socio
di maggioranza era diventato il cinquantaseienne sloveno Manfred Forte, barista
e compagno della stessa Silvia Panzeri.
Ricordiamo che la
Bellini, pur essendo tecnico di esperienza, ha una connotazione politica
piuttosto definita: in Lombardia ha ricoperto numerosi incarichi di derivazione
politica in Comuni e società partecipate e, negli anni '90, ha ricoperto il
ruolo di assessore in una giunta a guida Pds. Ricapitolando: una professionista
d'area, dopo i primi accordi tra Panzeri e Giorgi con il Qatar, costituisce una
scatola societaria perfetta per ricevere finanziamenti.
Quando Panzeri fonda
la sua Ong, la Ragioniera chiude le Srl. Infine, a pochi giorni dall'esplosione
dello scandalo, vola a Doha per partecipare alla festa mondiale. La signora nel
2022 ha fatto tappa anche a Londra in almeno due occasioni, ma non sappiamo se
per affari o per diletto. Tutte questioni che la donna, ieri, ha preferito non
affrontare con i cronisti. «Se dovrà dare spiegazioni lo farà con i magistrati»
ha tagliato corto la sua legale Franca De Candia.
Ecco come
nascono (nel 2019) i traffici fra Panzeri e il Qatar.
Luca Fazzo il 30
Dicembre 2022 su Il Giornale.
L'assistente
parlamentare Giorgi smentisce il suo capo. Le tangenti risalgono al suo mandato
da eurodeputato
Non ha aspettato la
fine del mandato, per iniziare a trafficare sottobanco. Quando era ancora
europarlamentare, all'inizio del 2019, Antonio Panzeri - eletto nelle liste del
Partito democratico e transitato poi al seguito di Massimo D'Alema e Pierluigi
Bersani in Articolo Uno - aveva già avviato l'attività di lobby occulta
destinata prima ad arricchirlo in modo spettacolare e poi a farlo finire nella
cella dove si trova tuttora. E dove gli tocca adesso fare i conti con le pesanti
accuse che il suo ex assistente Francesco Giorgi - anche lui in carcere - gli
sta scaraventando addosso nel tentativo di prendere le distanze dal suo ex capo.
I traffici, racconta
Giorgi nei suoi verbali di interrogatorio, iniziano ancora prima che venga
fondata Fight Impunity, la ong di Panzeri: che, spiega l'ex assistente, nasce
solo per dare giustificazione formale ai soldi versati a Panzeri dai governi di
cui si faceva portavoce. Cioè il Qatar, il Marocco e anche - rivela Giorgi - la
Repubblica Islamica della Mauritania. Un paese dove, secondo le denunce degli
attivisti per i diritti umani, il venti per cento della popolazione vive in
stato di sostanziale schiavitù e dove l'omosessualità è un crimine punito con la
morte. Ma per Panzeri, membro attivo e influente del gruppo parlamentare dei
Socialisti&Democratici, anche i soldi dei colonnelli mauritani non avevano un
cattivo odore.
«É iniziato tutto
all'inizio del 2019 - racconta Giorgi ai pm belgi - abbiamo definito le cifre,
che ho difficoltà a ricordare, per i nostri rispettivi interventi». É una
smentita piena alla linea difensiva di Panzeri che ha sempre detto di avere
iniziato a muoversi come lobbista solo alla fine del 2019, dopo avere cessato
l'incarico. Tutti i pagamenti, spiega Giorgi, avvenivano in contanti. Ma proprio
il flusso di banconote rese necessario «professionalizzare» l'attività creando
Fight Impunity, di fatto una «copertura per non destare allarme».
Sotto l'egida di
Fight Impunity, Panzeri inizia a darsi da fare anche per i militari mauritani.
Il paese africano, spiega Giorgi, «ha un problema d'immagine». Panzeri per i
suoi interventi avrebbe ricevuto dal paese africano 25mila euro. Nei suoi
verbali, Giorgi non specifica quali attività avrebbe compiuto l'ex sindacalista
a favore dei nuovi clienti. Da notare è comunque che a gestire i contatti per
conto dell'europalamento con il governo mauritano è la Dmag, la delegazione per
i rapporti con il Maghreb, guidata da un altro esponente dem, Andrea Cozzolino:
proprio quello che eredita Giorgi come assistente da Panzeri. Di lui ha parlato
nei suoi verbali la deputata socialista greca Eva Kaili, divenuta la moglie di
Giorgi e anche lei arrestata: «So che mio marito - ha detto la donna - stava
custodendo qualcosa per il suo vecchio capo Antonio Panzeri e forse anche per il
suo attuale capo, Andrea Cozzolino».
Su cosa si intenda
la Kaili sul «qualcosa» custodito da Giorgi per i suoi capi si possono fare solo
delle ipotesi. Della provenienza del denaro che suo marito teneva a casa in
grandi sacchi (e di cui lei tentò maldestramente di liberarsi dopo l'arresto di
Giorgi) la Kaili si è sempre detta all'oscuro. Ma nei suoi nuovi verbali Giorgi
- che inizialmente aveva cercato di scagionarla - va giù pesante: la Kaili non
faceva parte dell'organizzazione ma era al corrente che i soldi erano il frutto
della attività di lobbing sotterraneo.
Le
confessioni-accuse di Giorgi sono un passo avanti per l'inchiesta e sono un
nuovo guaio per il gruppo S&D: sempre più in difficoltà a spiegare come mai
nessuno si sia accorto del gran daffare che si dava il compagno Panzeri.
Da “Libero
quotidiano” il 30 dicembre 2022.
Le autorità greche
hanno chiesto a Panama informazioni su possibili trasferimenti di soldi (20
milioni) dal Qatar ai conti dell'ex vicepresidente Ue Eva Kaili, in carcere a
Bruxelles. La richiesta è arrivata dopo che sui social sono iniziati a circolare
post che mostrerebbero documenti bancari per conti panamensi appartenenti a
Kaili e famiglia.
Giacomo Amadori e
François de Tonquédec per “La Verità” il 30 dicembre 2022.«Il Qatargate? Non è
un italian job, magari è un socialist job». Così ieri la premier Giorgia Meloni
durante la conferenza stampa di fine anno. Ma forse sarebbe meglio puntualizzare
che lo scandalo potrebbe non riguardare solo i socialisti, ma anche i radicali.
A partire da Nicolò Figà-Talamanca, attivista arrestato il 9 dicembre e ancora
recluso nel carcere di Saint Gilles nel centro di Bruxelles.
Nato a Genova nel
1971 da padre romano e madre greca, sino a venti giorni fa era segretario
generale della Ong No peace without justice (Non c'è pace senza giustizia),
un'«associazione internazionale senza fini di lucro», fondata da Emma Bonino nel
1993.La Bonino è tutt' ora presidente della Ong, che ha due sedi, una a
Bruxelles e una Roma.
Nei giorni scorsi il
gip di Aosta Giuseppe Colazingari, su richiesta del giudice istruttore belga
Michel Claise, ha ordinato il sequestro di un appartamento di Cervinia di
proprietà di una società di Figà-Talamanca, la Nakaz development.
La presunta cricca
dell'europarlamento avrebbe fatto «circolare i fondi attraverso ong e/o
associazioni non profit gestite da Figà-Talamanca [] il cui ruolo parrebbe
essere quello di garantire che il denaro venga poi convogliato ai destinatari
della corruzione» ha scritto il giudice.
L'immobile,
acquistato il 29 aprile scorso, è costato 215.000 euro e le autorità belghe
hanno attenzionato i flussi di denaro tra Bruxelles e l'Italia, in particolare i
bonifici transitati dal conto belga della Nakaz su quello del notaio valdostano
che ha firmato il rogito. La famiglia di Figà-Talamanca con La Verità aveva
evidenziato che la casa non era stata comprata cash, ma attraverso il mutuo
accordato da un istituto di credito belga alla Naqaz developement Sprl.
In effetti la banca
Belfius ha prestato quasi l'intera somma necessaria all'acquisto: 200.000 euro.
Ma contrariamente a quanto di solito avviene in Italia, non attraverso un mutuo
ipotecario, bensì con un «credito d'investimento», concesso il 22 aprile, una
settimana prima del rogito, da rimborsare in 120 rate mensili, con un tasso
annuo nominale del 2,42%. Costituita nel 2007, la Nakaz developement è anche
della moglie di Figà-Talamanca, Alison Smith, la quale non sarebbe, però,
indagata. La donna, laurea in legge e nazionalità australiana, dirige dal 2004
l'«international criminal Justice program » della Ong fondata dalla Bonino.
In queste ore la
posizione di Figà-Talamanca sembra essersi complicata a causa delle
intercettazioni. L'8 novembre scorso uno dei principali indagati dell'inchiesta,
Francesco Giorgi, in un'intercettazione riportata dal Fatto quotidiano, dice al
telefono a Panzeri: «Vedo Niccolò alle 11... sì... verso le 11:30, mi vuole
vedere, poi contatto Simona che mi manda il programma e... poi, ecco, come vuoi
tu, gli dico che dovrà preparare una campagna... mmm, mmm... così ci
divertiremo, per assegnare la coppa 27/28 agli Emirati».
L'incontro
sembrerebbe finalizzato ad avere l'appoggio della Ong di Figà-Talamanca in vista
di un'assegnazione non meglio definita. Ma chi conosce bene Figà-Talamanca non
ci sta: «Secondo me scherzano, prendono in giro, come due cazzoni, Nicolò per il
suo lavoro di denuncia delle violazioni dei diritti umani anche negli Emirati»
ha ipotizzato un amico. Ricordandoci che in pubblico Figà-Talamanca si è
espresso più volte duramente contro gli Emirati. Lo stesso 8 novembre, aveva
organizzato una conferenza sull'«uso spietato della magistratura come strumento
di oppressione» in Paesi come Egitto, Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti.Tra
le carte agli atti si trova anche un'intercettazione del 7 ottobre, in cui il
segretario dell'Ong chiama un negozio di Bruxelles specializzato in
compravendita di orologi.
Nell'occasione
avrebbe detto di voler cedere un «Cartier nuovo, in garanzia» che sarebbe stato
«un regalo di lavoro».
Per la polizia belga
«questa tecnica di rivendita di orologi di lusso» sarebbe «molto usata negli
ambienti della criminalità» e permetterebbe di «trasferire a livello
internazionale grossi valori senza attirare l'attenzione delle autorità doganali
o di altri servizi di polizia».
L'amico di Niccolò
con cui abbiamo parlato, ironizza: «Come si può pensare di diventare ricettatori
rivolgendosi a un negozio e per di più chiamandolo al telefono».
La sede della Ong al
centro dell'attenzione si trova in palazzina bianca di Rue Ducale 41 a
Bruxelles, immobile che ospita anche l'altra Ong citata nell'inchiesta, la Fight
impunity di Pier Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato finito a sua volta in
carcere.
A collegare con la
sua persona le due principali organizzazioni non governative è un signore
livornese di 67 anni. È residente all'estero dal 2014 e vive a Bruxelles. È
cofondatore della prima e presidente del board della seconda. Si tratta di
Gianfranco Dell'Alba, uomo di stretta fiducia della stessa Bonino ed ex
parlamentare europeo (dal 1994 al 2004) proprio sotto le insegne dei Radicali.
Dal 1998 al 2009 è
stato segretario generale di No peace without justice. Dal 2006 al 2008 è stato
capo di gabinetto della Bonino quando quest' ultima era ministro per le
Politiche europee del secondo governo Prodi. Tra il 2008 e il 2011 è stato
titolare di una ditta individuale di pubbliche relazioni.
Attualmente ricopre
incarichi anche a Bruxelles, dove, per esempio, è tesoriere del Gruppo di
iniziativa italiana (l'associazione delle imprese tricolori presenti nella
capitale belga) ed è senior advisor di Ania, l'associazione italiana delle
compagnie assicurative. Ma al suo curriculum manca un passaggio fondamentale: da
marzo 2009 a settembre 2017 è stato direttore della delegazione di Confindustria
presso l'Unione europea a Bruxelles. E proprio in questa veste, Dell'Alba è
inciampato in una truffa ai danni dell'associazione degli industriali costata
alle casse della confederazione 500.000 euro.
Nel settembre del
2017 Dell'Alba riceve al suo indirizzo di posta elettronica un messaggio che le
cronache dell'epoca sintetizzavano così: «Caro Gianfranco, dovresti eseguire un
bonifico di mezzo milione di euro (in realtà la cifra pare un po' inferiore,
ndr) su questo conto corrente. Non mi chiamare perché sono in giro con il
presidente e non posso parlare». La mail risultava inviata da Marcella Panucci,
all'epoca dg di Confindustria.
Dell'Alba avrebbe
eseguito senza farsi domande e senza chiamare la Panucci. Che però non era la
reale mittente della mail, che sarebbe stata inviata da un hacker che si sarebbe
impossessato dell'indirizzo di posta elettronica della manager. Subito dopo
questo incidente Dell'Alba è stato licenziato in tronco: «La vicenda si concluse
con l'intervento dell'assicurazione che, riconoscendo che fui vittima di una
truffa (phishing), rimborsò integralmente la somma (come confermato dalla stessa
Confindustria)» puntualizza il diretto interessato. Il quale, però, non fece
ricorso contro quel licenziamento.
«Abbiamo concluso il
rapporto di lavoro nel rispetto dei diritti di entrambe le parti» spiega.
Dell'Alba rivendica,
«in virtù della mia militanza quarantennale a fianco di Emma Bonino e Marco
Pannella», di essere stato «tra i promotori di Non c'è pace senza giustizia 30
anni fa» e di essere oggi «presidente del consiglio direttivo dell'omonimo
comitato, che opera per la protezione dei diritti umani e la promozione della
giustizia penale internazionale».
L'ex
europarlamentare non vuole rispondere alle domande su Figà-Talamanca («sospesosi
dalla sua carica di segretario generale») «per rispetto del lavoro della
magistratura e della presunzione di innocenza», ma ci assicura che «il comitato
è estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta».
E su Fight impunity
che cosa ci può dire? «Nel 2019, sono stato, su richiesta di Panzeri, che
conoscevo come ex eurodeputato, fra i fondatori di questa Ong, partecipando poi,
come membro dell'associazione, a due o tre riunioni interne l'anno in gran parte
dedicate al rapporto annuale sull'impunità che l'associazione ha prodotto e che
in due occasioni ho presentato nel corso di un'audizione al Parlamento europeo,
lontano mille miglia dal pensare alle accuse che stanno emergendo verso il
presidente. Mi sono ritirato da Fight impunity dieci giorni fa come tante altre
personalità».
Dell'Alba nei giorni
scorsi ha anche assicurato di non aver avuto «il minimo sentore che Panzeri
stesse portando l'associazione in una determinata direzione, orientandola in
quel modo...». Quindi ha esclamato: «Uno poi si chiede: "Ma allora sono io che
sono fesso?". Ma purtroppo può succedere». A lui sembra essere accaduto almeno
tre volte. Ha collaborato Giorgia Chiodo.
Qatargate,
l'indagine entra nella fase 2 con nuovi indagati: pronta la richiesta di
revocare l'immunità ad alcuni eurodeputati.
Giuliano
Foschini, Claudio Tito su La Repubblica l’1 gennaio 2023.
Il Parlamento
europeo sarà chiamato a pronunciarsi, dalla procura di Bruxelles, sulla sorte di
alcuni esponenti coinvolti nell'inchiesta. È l'espansione a macchia d'olio dello
scandalo
Il "Qatargate" è
solo all'inizio. È la prima punta di un iceberg. Sotto c'è ancora un mondo da
scoprire. E già la prossima settimana la procura di Bruxelles farà partire una
nuova esplorazione. Probabilmente già lunedì prossimo scatterà la "Fase 2"
dell'Inchiesta. Con nuove indagini e soprattutto con nuovi indagati. E il
Parlamento europeo sarà stavolta chiamato in causa direttamente. Dovrà
esprimersi formalmente sul "caso" che ormai da tre settimane ha scosso uomini e
uffici di Bruxelles e di Strasburgo. Proprio in queste ore, infatti, è partita
una comunicazione ufficiosa da parte dei magistrati belgi all'ufficio di
presidenza dell'EuroCamera. Per avvertire che gli inquirenti stanno valutando di
spedire in tempi molto brevi la richiesta di revocare l'immunità ad alcuni
parlamentari europei. Il segno appunto che l'inchiesta sta compiendo il primo
salto di qualità.
I procuratori
brussellesi stanno mettendo a punto la loro domanda. Che riguarderebbe al
momento due esponenti del Parlamento: l'italiano Andrea Cozzolino e il
belga Marc Tarabella. Mentre, allo stato, sarebbe tenuta in sospeso la posizione
di un'altra belga di origine italiana, Maria Arena.
Questo passaggio
determinerebbe inevitabilmente l'espansione a macchia d'olio dello scandalo.
Nuovi atti, nuove indagini, nuove perquisizioni. A questo, infatti, servirà la
revoca dell'immunità. Senza la quale i magistrati non possono invece non fare
alcunché. Gli europarlamentari possono essere raggiunti dai provvedimenti
giudiziari solo in caso di flagranza di reato. Come è accaduto per la greca Eva
Kaili, fino a pochi giorni fa vicepresidente dell'Assemblea.
Quando la richiesta
dei magistrati sarà stata formalmente depositata, la presidente del
Parlamento, Roberta Metsola, annuncerà la questione in Aula e poi deferirà
preliminarmente l'esame della domanda alla commissione giuridica (Juri). Che
dovrà adottare una raccomandazione all'Assemblea in cui chiede la bocciatura o
l'approvazione della richiesta. A quel punto - alla prima occasione utile - il
Parlamento voterà sulla raccomandazione e la decisione sarà approvata a
maggioranza semplice.
Le intenzioni di
Roberta Metsola sono comunque di prestare la massima collaborazione ai
magistrati. Se, allora, la richiesta effettivamente pervenisse la prossima
settimana, è possibile che la Commissione giuridica tratti l'argomento nella
settimana tra il 9 e il 15 gennaio. Le prime giornate di lavoro, quindi, per le
Commissioni dopo la pausa natalizia. E se la raccomandazione venisse elaborata
rapidamente, sarà la sessione plenaria che si riunisce a Strasburgo dal 16
gennaio a esprimere il parere finale.
Considerata
l'attenzione e lo sconquasso provocato dal Qatargate, è difficile pensare che
sarà negata l'autorizzazione a procedere. E se così sarà, la "Fase 2"
dell'inchiesta prenderà sostanzialmente il via a metà gennaio.
Ma come si è
arrivati fino a questo punto? Basta rileggere le carte dell'inchiesta per
descrivere cosa si sono trovati dinanzi giudici e servizi segreti.
"In cambio di
soldi". C'è un passaggio, nell'informativa che i servizi belgi fanno al giudice
istruttore di Bruxelles, Michel Claise, che spiega perfettamente cosa potrebbe
essere questa seconda fase del Qatargate: il passaggio dai corruttori ai
corrotti. L'ingresso della Polizia all'interno del palazzo di vetro del
Parlamento europeo. Oltre la porta della vicepresidente Eva Kaili. Secondo
quanto scrive l'intelligence belga "in cambio di soldi" almeno un deputato
italiano, Andrea Cozzolino, "sarebbe intervenuto all'interno del Parlamento
europeo per promuovere gli interessi del Marocco".
"Nel 2019-2020-2021
avrebbero ricevuto parecchi centinaia di migliaia di euro dal Dged", il servizio
segreto marocchino, scrivono. Ora, di questi soldi al momento negli atti di
indagine non c'è traccia. Cozzolino non è indagato (anche se il sistema
giudiziario belga è diverso dal nostro, un istituto simile non esiste) e ha
chiesto di essere ascoltato immediatamente dai magistrati belgi, rivendicando la
sua assoluta estraneità ai fatti e quindi la sua innocenza. "E' vero" ha detto a
Repubblica, "Giorgi era il mio assistente e capisco che il mio nome finisca in
questa storiaccia. Ma io non sapevo nulla della sua attività e soprattutto non
ho mai preso nemmeno un euro o un vantaggio per un atto contrario ai miei
doveri. Non scherziamo".
Fatto sta che la
"Fase 2" dell'indagine punta esattamente a verificare questo. Se è vero che
Cozzolino facesse parte di un gruppo che "opera con una discrezione che va oltre
la semplice prudenza, evitando di apparire troppo apertamente pro Marocco
all'interno del Parlamento Ue, usando un linguaggio in codice e nascondendo i
soldi nei propri appartamenti" come si legge negli atti. Ed è perciò che, già
nelle prossime ore, potrebbe essere chiesta l'autorizzazione a procedere. Oltre
agli elementi emersi dall'indagine dei servizi prima e della polizia belga poi,
agli atti ci sono poi le dichiarazioni degli arrestati. Giorgi ha raccontato di
"supporre" che Panzeri potesse aver dato del denaro a Cozzolino.
Kaili ha detto, a
proposito del denaro trovato a casa sua, che il suo compagno Giorgi è "possibile
custodisse qualcosa anche per il suo capo, Andrea Cozzolino". Lo stesso Panzeri
ha provato a scaricare su Cozzolino: "Non ho prove ma voi dovreste controllare
il presidente della delegazione del Maghreb, Cozzolino. È il parlamentare di cui
Giorgi è l'assistente. Tra l'altro è responsabile di chiedere risoluzioni
d'urgenza ma questo non passa da noi, quindi non conosco bene, ma so che è
successo".
La posizione di
Cozzolino non è la sola che la polizia belga ha necessità di verificare. È
possibile che la richiesta di autorizzazione riguardi anche Marc Tarabella (la
posizione di Maria Arena al momento è sospesa), che faceva parte direttamente
della rete Panzeri. Diverso invece è il discorso che riguarda gli altri deputati
italiani, il gruppo "degli amici" come vengono definiti negli atti: Alessandra
Moretti, il capodelegazione del Pd, Brando Benifei. I loro assistenti è
possibile facessero parte della rete Panzeri (i computer, i cellulari sono stati
sequestrati e in questo momento li stanno verificando i tecnici della polizia
belga). Ma non ci sono evidenze che i deputati sapessero che dietro Panzeri non
ci fosse una semplice Ong. Ma "paesi corruttori" che volevano comprare la
democrazia europea.
Qatargate, chi
sono gli «amici» della «squadra» di Panzeri?
Storia di Giuseppe
Guastella su Il Corriere della Sera l’1 gennaio 2023.
Quali sono gli
«amici» su cui la «squadra operativa» — così come la chiamano con enfasi gli
investigatori belgi — Panzeri- Giorgi-Cozzolino contava per piegare le decisioni
del Parlamento europeo ai desideri a pagamento di Qatar e Marocco? E chi, come
loro, e per gli stessi obiettivi dei medesimi Stati, agiva dall’interno delle
altre istituzioni europee? Una prima risposta a queste domande cruciali la
magistratura di Bruxelles potrebbe darla già nei prossimi giorni quando
ripartiranno le indagini e potrebbe essere chiesta all’assemblea la revoca
dell’immunità per gli eurodeputati coinvolti nell’indagine.
L’inchiesta per
associazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro che ha terremotato il
Parlamento europeo è partita da una operazione dei servizi segreti del
Belgio (Vsse) in coordinamento con quelli di altri quattro Paesi e riguarda,
come è scritto negli atti, le « azioni di ingerenza in seno alle istituzioni
dell’Unione europea». Quindi non del solo Parlamento, dove per il giudice
istruttore Michel Claise operavano l’ex eurodeputatodel Pd e poi di Articolo Uno
Pier Antonio Panzeri, l’attuale eurodeputato dem Andrea Cozzolino e Francesco
Giorgi, ex assistente del primo e collaboratore del secondo. I tre sarebbero
stati in grado di influenzare «la politica del gruppo parlamentare Socialisti &
democratici» per limitare o evitare i danni che avrebbero potuto causare le
decisioni del Parlamento all’immagine di Qatar e Marocco, i quali avevano
parecchi problemi con il rispetto dei diritti umani sui propri territori.
Dagli arresti del 9
dicembre, la Procura federale di Bruxelles e il giudice Claise hanno navigato
sott’acqua, e forse anche per questo, al di là delle generiche accuse e delle
altrettanto vaghe ricostruzioni che sono negli atti enormemente meno dettagliati
di come impone la legge in Italia, non è stato ancora possibile capire bene cosa
gli indagati abbiano fatto, quando e in cambio esattamente di che.
Video
correlato: Qatargate, le conversazioni tra Panzeri e l'ambasciatore marocchino a
Varsavia (Mediaset)
I sacchi di soldi in
contanti (oltre 750 mila euro) trovati nella casa di Bruxelles che Eva Kaili, la
vice presidente greca del Parlamento destituita per l’inchiesta, condivide con
il compagno Francesco Giorgi (entrambi arrestati) sono impossibili da
giustificare sul piano politico, ma devono essere tradotti in una qualche
condotta penalmente rilevate da parte degli che, nelle poche carte che sono
emerse, non spiegano, per esempio, che cosa ha fatto la Kaili oltre a detenere
denaro in contanti. Lo stesso vale per gli altri 600 mila euro scovati
nell’appartamento di Panzeri, sulla cui origine si sa solo che è legata a Quatar
e Marocco attraverso triangolazioni o consegne dirette. Dopo gli arresti, i
detective si sono dedicati all’analisi dei documenti e del materiale informatico
sequestrato. È da lì che si dice che presto potrebbero arrivare novità e nuove
azioni.
Negli atti ancora
segreti non possono non esserci altri particolari. Per esempio, quali e di che
natura precisa siano i rapporti tra Panzeri, Giorgi, che è considerato il suo
braccio destro e socio al 50% negli affari all’ombra della ong Fight impunity, e
quelli che vengono definiti gli «amici» nel gruppo S&D. Quali sono questi amici?
Compaiono i nomi del deputato italo-belga Marc Tarabella, che è stato anche
perquisito il 9 dicembre alla presenza della presidente Roberta Metsola arrivata
da Malta per presenziare all’atto. Ci sono poi riferimenti molto vaghi a Maria
Arena, anche lei europarlamentare italo-belga, agli italiani Alessandra Moretti
e Brando Benifei, entrambi pd i quali, come Tarabella e Arena, non risultano
indagati e hanno escluso con decisone qualsiasi tipo di condizionamento e
favore, reso o ricevuto. E non pare plausibile un loro coinvolgimento. La
Moretti, per esempio, ha ricordato di aver preso pubblicamente posizione contro
il Qatar.
Qatargate, le cose
da sapere
Più complessa la
situazione di Cozzolino. Di lui i Servizi belgi, come riporta il giudice, dicono
che «non c’è alcun dubbio» che con Panzeri e Giorgi avrebbe cooperato con gli
007 marocchini prendendo ordini tramite l’ambasciatore del Marocco in Polonia
Abderrahim Atmoun e incontrandosi con il direttore generale dell’agenzia di
Rabat Dodge Yassine Mansouri.
Se c’è una «rete»
che fa capo a Panzeri e Giorgi, inevitabilmente tutte le maglie sono ancora da
svelare. Si parla appunto di richieste della Procura federale nei prossimi
giorni di revoca dell’immunità per alcuni parlamentari europei, mentre quella
della Kaili è già caduta con l’arresto in flagranza di reato dopo che aveva
detto al padre di portare via da casa una valigia con 600 mila euro dentro. Sarà
il momento in cui gli investigatori dovranno scoprire almeno qualcuna delle
carte che tengono gelosamente in serbo.
Il ritorno al
metodo Di Pietro.
Chi ha avuto modo di
parlare in queste settimane con i difensori degli italiani arrestati in Belgio
l'8 dicembre nella retata del Qatargate ha ricevuto descrizioni crude del
sistema carcerario locale. Luca Fazzo su Il Giornale il 3 Gennaio 2023
Chi ha avuto modo di
parlare in queste settimane con i difensori degli italiani arrestati in Belgio
l'8 dicembre nella retata del Qatargate ha ricevuto descrizioni crude del
sistema carcerario locale. Dalle celle squallide, ai colloqui quasi impossibili,
all'assenza di assistenza psicologica: nulla è stato fatto per rendere meno
traumatico l'impatto con la detenzione. Si dirà: è giusto così, i colletti
bianchi vanno trattati come i criminali comuni. Vero. Fa specie, semmai,
apprendere che a pochi chilometri dai lussi dell'Europarlamento non si trovino i
fondi per garantire sistemazioni decenti ai carcerati, qualunque sia il reato
loro attribuito. Ora però si pone un altro problema, che va aldilà delle
condizioni di detenzione più o meno confortevoli riservate a Panzeri & C., ed
investe l'utilizzo del carcere preventivo ai fini dell'inchiesta. È un tema che
in Italia è presente dall'epoca di Mani Pulite: quando la prassi di tenere la
gente in cella fin quando non confessava i propri reati e accusava amici e
compagni era persino teorizzata dal pool. «Chi «canta» può uscire perché si è
reso inaffidabile verso i suoi complici»: questo era il mantra che permise la
demolizione per via giudiziaria della Prima Repubblica. Sta accadendo qualcosa
del genere anche a Bruxelles? Il fatto che un giornale locale abbia definito
l'inchiesta sul Qatargate una «Mani Pulite in chiave europea» aveva già
suscitato il timore che insieme agli obiettivi il giudice Claise avesse mutuato
da Di Pietro anche i metodi. E le ultime iniziative degli inquirenti rafforzano
i sospetti. Prima la decisione di tenere dentro arrestati che non si capisce
quali altri reati possano commettere e quali prove possano inquinare, poi
l'iniziativa di richiedere all'Europarlamento di togliere l'immunità a altri due
deputati, aprendo la strada non solo alla loro incriminazione ma anche al loro
arresto, hanno un significato preciso. È un segnale mandato a Tarabella, a
Cozzolino e insieme a loro a tutti i potenziali indagati: collaborate finché
siete in tempo, l'alternativa è la cella. E - come spiegava ieri al Giornale il
fratello di un altro arrestato, Niccolò Figà Talamanca - «il sistema giudiziario
belga consente un uso illimitato della custodia cautelare». Le accuse mosse a
Panzeri e confortate dalle prove - quattrini compresi - emerse nel frattempo
sono di gravità estrema, l'allargamento dell'inchiesta a altri membri della sua
rete e ad altre reti che sicuramente esistono è doverosa. Ma se il sistema è
fare tintinnare le manette, forse sarebbe giusto chiedersi se ne vale la pena
(adesso, non trent'anni dopo come si è fatto da noi).
Una borsa piena
di soldi da Al-Marri per Panzeri e Giorgi.
Redazione L'Identità
il 3 Gennaio 2023
di MIRIAM NIDO
“Non ci sarà
impunità. Nessuna”. Parola di Roberta Metsola, presidente dell’Europarlamento,
che ieri ha messo una nuova pietra sullo scandalo Qatargate, il giro di mazzette
pagate dal Paese del Golfo a una cricca di eurodeputati e funzionari per
influenzare le politiche su Doha. Il Parlamento Europeo, infatti, su richiesta
del giudice istruttore Michael Claise, ha avviato la procedura per la revoca
dell’immunità parlamentare all’esponente autosospesosi dal Pd Andrea Cozzolino e
al socialista belga Marc Tarabella. Il termine della procedura per la revoca
dell’immunità parlamentare, che prevede una serie di passaggi, dovrebbe
concludersi entro il 13 febbraio. E Metsola, nel chiedere la priorità assoluta,
ha sottolineato come “fin dal primo momento il Parlamento europeo ha fatto tutto
ciò che era in suo potere per assistere nelle indagini e continueremo a
garantire che non ci sia impunità. I responsabili troveranno questo Parlamento
dalla parte della legge. La corruzione non può vincere e faremo di tutto per
combatterla”. Il sistema corruttivo a Bruxelles, d’altronde, è più vasto di
quanto sembra. Perché se l’anima di questo cerchio magico al soldo del Qatar è
l’ex eurodeputato di sinistra Antonio Panzeri, finito in carcere con l’ex
vicepresidente dell’Eurocamera Eva Kaili e con il compagno di quest’ultima
Francesco Giorgi, l’inchiesta coinvolgerebbe almeno una sessantina di politici,
i quali, consapevolmente o ignari delle mazzate, avrebbero favorito il Qatar.
Doha, almeno da un paio d’anni, avrebbe portato valigette piene di contanti. E
gli inquirenti hanno documentato altri episodi di corruzione, oltre ai passaggi
di bustarelle con Babbo Natale tra Panzeri e il segretario generale della
Confederazione Internazionale dei Sindacati, Luca Visentini. Il 9 ottobre
un’intercettazione ambientale certifica l’incontro alquanto sospetto tra
Panzeri, Giorgi e una delegazione qatariota, capeggiata dal ministro del Lavoro,
Ali ben Samikh Al-Marri. Il gruppo si vede nella suite 412 dello Steigenberger
Wiltcher’s, un hotel a cinque stelle in Avenue Louise. Panzeri e Giorgi vengono
accolti da un rappresentante del Qatar, che ha in mano una borsa. È lo stesso
Giorgi a parlare del summit con gli inquirenti, con i quali ormai sta
collaborando. In quell’occasione viene organizzata l’audizione al Parlamento
Europeo prevista per il 14 novembre e lo stesso Panzeri avrebbe preparato
l’intervento di Al-Marri. “Con preparare intendo spiegargli il punto di vista
europeo e consigliarlo su come reagire”, spiega Giorgi, il quale si era occupato
di tradurre, visto che Panzeri non parla inglese. Un’ora e mezza dopo, alle
19.21, i filmati mostrano l’ex europarlamentare e l’assistente lasciare la
lussuosa suite, ma con una borsa più spessa di quella all’arrivo. In quella
valigetta, secondo gli inquirenti, c’erano le mazzette, che sono andate ad
alimentare quei 1,5 milioni di euro in contanti sequestrati a Panzeri e i
750mila nascosti in casa Kaili-Giorgi, che il padre dell’allora vicepresidente
aveva tentato di portare via nel giorno dell’arresto della figlia. Inoltre, ha
confessato il compagno della greca, il discorso che Al-Marri fece in audizione
era stato scritto da Panzeri, che avrebbe chiesto consiglio alla dem Alessandra
Moretti e a Cozzolino. Le domande degli eurodeputati al ministro qatariota
sarebbero inoltre state stabilite in anticipo. In quella sala, il 14 novembre,
c’erano tutti quelli sui quali si indaga. Giorgi e Panzeri a coordinare, poi
circa duecento persone. Tra questi Visentini, Cozzolino, Tarabella e la
socialista belga Marie Arena, la cui posizione nelle indagini è tenuta al
momento in sospeso. Nei prossimi giorni scatteranno nuovi avvisi di garanzia.
Eva Kaili, Atene
chiede a Panama informazioni sui conti: «20 milioni trasferiti dal Qatar».
Giuseppe Guastella, inviato a Bruxelles su Il Corriere della Sera il 3 Gennaio
2023.
Le autorità greche
hanno chiesto a Panama informazioni su possibili trasferimenti di denaro dal
Qatar a conti appartenenti all'europarlamentare Eva Kaili, adesso detenuta a
Bruxelles
Di certo c’è che
l’Antiriciclaggio della Grecia ha chiesto a Panama di verificare se risultano
trasferimenti di soldi dal Qatar a conti bancari di Eva Kaili e di suoi
familiari, dopo che sui social greci si sono replicati a macchia d’olio post
secondo cui la ex vicepresidente del Parlamento europeo avrebbe nascosto 20
milioni di euro nel Paese centroamericano. «Calunnie» le chiama il difensore di
Eva Kaili, mentre l’europarlamentare Andrea Cozzolino è pronto a rinunciare
all’immunità.
La richiesta
del presidente dell’autorità Antiriciclaggio Charalampos Vourliotis, che aveva
già congelato i beni della famiglia Kaili, risale al 29 dicembre quando hanno
cominciato a girare notizie che dicevano che nella banca Bladex di Panama erano
confluiti 20 milioni di euro su due conti intestati ad Eva Kaili, arrestata il 9
dicembre nell’inchiesta sulle presunte interferenze di Qatar e Marocco nel
Parlamento europeo, mentre a suo padre Alexandros e sua madre Maria Ignatiadou
erano arrivati su altri conti 4 milioni ciascuno. I soldi provenivano da Doha,
dicevano i post. L’esistenza dei conti era stata smentita già il 21 dicembre
dalla Bladex che aveva definito «false le informazioni» dato che nella banca,
che fornisce servizi solo ad altre banche o a imprese importanti, non risultano
«fondi» riferibili in modo «diretto o indiretto» a persone coinvolte
nell’inchiesta. «La falsità di questi ipotetici bonifici è provata oltre ogni
dubbio», aveva rincarato l’avvocato di Kaili, Michalis Dimitrakopoulos.
Dopo l’arresto in
flagranza di reato suo e di suo padre che si stava allontanando con 600 mila
euro in contanti, la europarlamentare greca del Pasok non può contare
sull’immunità fino alla richiesta di processo. Invece la Procura federale di
Bruxelles ha dovuto chiedere al Parlamento la rimozione della protezione per il
deputato campano Andrea Cozzolino, sospeso dal Pd, e per il suo collega
italo-belga del gruppo S&D Marc Tarabella, coinvolti nell’inchiesta per
associazione criminale, corruzione e riciclaggio.
Lunedì Tarabella ha
detto di rinunciare all’immunità, ora si prepara a fare lo stesso Cozzolino dopo
una lunga riunione via Zoom con gli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e
Dimitri De Beco. Cozzolino è rimasto a Napoli dove lo ha raggiunto la notizia,
non inattesa, della richiesta della magistratura. Non a caso il 21 dicembre a
sorpresa aveva chiesto di essere ascoltato dai magistrati «per contribuire
all’accertamento della verità, rinunciando a tal fine alle guarentigie
dell’immunità parlamentare», in un annuncio che preannunciava di fatto la
decisione futura. E oggi, proseguendo su quella linea, dovrebbe chiedere di
essere sentito anche dalla commissione Affari giuridici (Juri)
dell’Eurocamera che dal 16 gennaio si occuperà del caso. In quella sede,
Cozzolino dovrebbe ribadire l’intenzione di non avvalersi dell’immunità, anche
se il regolamento del Parlamento europeo non concede al singolo eurodeputato il
diritto alla rinuncia, la cui revoca deve essere discussa e poi decisa
dall’Assemblea. Anche se tutto fa prevedere che la revoca ci sarà e anche in
tempi brevi, vista la corsia preferenziale annunciata dalla presidente Roberta
Metsola.
Nella vicenda del
Qatargate il nome di Cozzolino è messo in primo piano dalla Procura federale di
Bruxelles e dal giudice istruttore Michel Claise. Con il suo assistente
Francesco Giorgi e con Antonio Panzeri, l’ex potente assessore campano farebbe
parte della «squadra» in grado di condizionare l’orientamento politico di
Socialisti&Democratici a favore di Qatar e Marocco. Negli atti si parla di
legami tra Cozzolino e i servizi segreti del Marocco, anche attraverso
l’ambasciatore di Rabat in Polonia Abderrahim Atmoun dal quale avrebbe ricevuto,
afferma Claise, ordini che arrivavano da Yassine Mansouri, il capo dell’agenzia
Dedg che avrebbe anche incontrato personalmente. «Non ho fatto nulla, è
inaccettabile», ha sempre ripetuto l’europarlamentare. I tempi perché si
presenti ai giudici o sia convocato non sono prevedibili. «Ho massima fiducia
nella magistratura del Belgio», afferma con una formula che è anche di maniera.
Ieri, rinvio al 16
gennaio in Appello a Brescia dell’udienza sulla consegna al Belgio di Maria
Colleoni e di Silvia Panzeri, moglie e figlia del presidente dell’ong Fight
impunity arrestato perché considerato il fulcro delle macchinazioni pro Qatar e
Marocco. Non sono arrivate da Bruxelles le informazioni chieste dai giudici dopo
che gli avvocati Angelo De Riso e Nicola Colli, difensori delle due donne (ai
domiciliari), hanno sollevato dubbi sulle condizioni di vita nelle carceri
belghe.
Salta l'immunità
per gli eurodeputati indagati. Qatargate, la Metsola già condanna Cozzolino e
Tarabella: il caso senza precedenti a Bruxelles.
Paolo Comi su Il
Riformista il 3 Gennaio 2023
Nessuna immunità per
l’italiano Andrea Cozzolino e il belga Marc Tarabella. Con una decisione senza
precedenti, la presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola, ha
avviato ieri la procedura d’urgenza per la revoca dell’immunità per i due
europarlamentari appartenenti al gruppo Socialisti e democratici (S&d).
Cozzolino e Tarabella sono al momento indagati, in stato di libertà, per non
meglio precisate accuse di “appartenenza a un’organizzazione criminale”,
“riciclaggio di denaro” e “corruzione”. A chiedere di revocargli l’immunità era
stata nei giorni scorsi l’autorità giudiziaria belga che sta indagando da oltre
un anno nei loro confronti. Metsola, invece di rispedire indietro l’irrituale
richiesta del tribunale federale di Bruxelles, ha messo il turbo facendo sapere
che alla prima riunione del Parlamento in seduta plenaria, in programma il
prossimo 16 gennaio, annuncerà ufficialmente l’apertura del procedimento. Una
volta avvisati ufficialmente i parlamentari, la richiesta di revoca
dell’immunità sarà trasmessa alla Commissione giuridica (Juri) che nominerà un
relatore e potrà procedere all’audizione di Cozzolino e Tarabella. Terminati i
lavori, ci sarà allora la discussione e il voto sulla relazione.
La Commissione
giuridica, a quel punto, adotterà una raccomandazione formale che a sua volta
dovrà essere sottoposta al voto del Parlamento. Per l’approvazione è sufficiente
la maggioranza semplice. Metsola, poi, ha fatto sapere ieri di aver chiesto a
tutti i Servizi e alle Commissioni di dare priorità a questa procedura, fissando
come termine ultimo per la conclusione il 13 febbraio, meno di un mese. «Il
Parlamento europeo ha fatto tutto ciò che era in suo potere per aiutare le
indagini e continueremo a garantire che non ci sia impunità. La corruzione non
può pagare e noi faremo di tutto per combatterla», ha quindi aggiunto tutta
soddisfatta la presidente Metsola.
Andrea Cozzolino,
l’europarlamentare finito nello scandalo Qatar: “Indignato ma del tutto estraneo
a vicenda”
Tarabella, la cui
abitazione era stata perquisita il 10 dicembre scorso all’indomani dell’arresto
della ex vicepresidente del Parlamento Eva Kaili, del suo compagno Francesco
Giorgi e dell’ex europarlamentare italiano Antonio Panzeri, in queste settimane
ha sempre dichiarato di non aver mai ricevuto regali da Qatar. «Il mio assistito
non si nasconde dietro l’immunità: dall’inizio di questo caso è a disposizione
della giustizia e ha anche chiesto di essere ascoltato rapidamente per potersi
difendere», ha ricordato sempre ieri il suo difensore, l’avvocato
brussellese Maxim Toller.
Diversa la posizione
di Cozzolino che è stato tirato in ballo da Giorgi, il suo assistente
parlamentare, il quale avrebbe invece ammesso di aver ricevuto denaro
dal Marocco e dal Qatar per promuovere i loro interessi all’interno del
Parlamento. Anche Cozzolino, comunque, ha chiesto recentemente tramite i propri
avvocati di essere ascoltato dagli inquirenti, dichiarandosi estraneo ai fatti
contestati. Paolo Comi
(ANSA il 3 Gennaio
2023) - "Andrea Cozzolino non è in una commissione Pnrr, è in un gruppo di
lavoro dell'area metropolitana che non si è ancora insediato. Aspettiamo che si
completi questa fase per capire la posizione di Cozzolino, fino ad allora il
gruppo non si insedia".
Lo ha detto il
sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commentando l'inchiesta Qatargate che vede
tra gli indagati anche l'europarlamentare partenopeo cui il Comune pensava di
affidare un ruolo di coordinamento nella gestione dei fondi del Pnrr.
"So che il Pd - ha
aggiunto Manfredi - lo ha sospeso dal partito, ma io parto dal presupposto che
aspettiamo che ci siano prove certe del suo coinvolgimento, vediamo".
L'Europa come
l'Italia: vuole arrestare i deputati senza ragione. Qatargate, l’inchino di
Metsola e il ‘ricatto’ dei pm a Giorgi e Kaili per rivedere la loro bimba.
Piero Sansonetti su Il Riformista il 3 Gennaio 2023
I magistrati belgi
hanno chiesto al Parlamento europeo di revocare l’immunità parlamentare per due
deputati. Ragionevolmente si tratta dell’italiano Andrea Cozzolino e del
belga Marc Tarabella. La presidente del Parlamento, Roberta Metsola, anziché
chiedere alla procura il perché di una richiesta così insolita, e su quali basi
essa si fondi, e se ci sono prove documentali o indizi molto forti a carico dei
due indagati, ha preferito dichiararsi a disposizione della magistratura, e
pronta a collaborare e ad affrettare i tempi.
Io credevo che il
compito di una presidente di un parlamento fosse quello di difendere le
prerogative del parlamento, la sua indipendenza e la sua insindacabilità. E
anche di difendere il diritto all’immunità dei suoi componenti.
La Metsola invece, forse sull’esempio della politica italiana, ha preferito
schierarsi in modo inequivocabile dalla parte della magistatura. Il
tradizionale inchino della politica al potere giudiziario che, evidentemente non
solo in Italia, condiziona e sottomette la politica, scalfendo almeno – se non
compromettendo – la struttura stessa della democrazia e dello Stato di diritto.
Su quale base si
chiede l’arresto di due parlamentari europei? A occhio sulla base delle
dichiarazioni di altri arrestati (forse illegalmente) e cioè Giorgi e Kaili, i
quali sono stati indotti a parlare col ricatto, facendo loro balenare l’idea che
solo se parlano e dicono quel che i magistrati vogliono che dicano potranno
tornare a casa dalla loro bambina di 22 mesi. Che è stata abbandonata su ordine
della procura. Un parlamento che si rispetti risponderebbe ai magistrati: quegli
interrogatori non valgono niente. Confessioni e chiamate di correo estorte. Se
avete le carte per accusare i nostri parlamentari bene, sennò tornatevene in
procura.
Gli americani
farebbero così. Resta poi la domanda di fondo: a cosa serve arrestare due
parlamentari dopo averli indagati per circa tre mesi (l’arresto non potrebbe
avvenire comunque prima di febbraio)? Certo non per impedirgli di inquinare le
prove o scappare. E allora? Perché evidentemente si pensa che il carcere li
potrebbe ammorbidire e indurre a parlare. E’ legale tutto ciò? No, è
assolutamente illegale. Però piace ai populisti e la politica si accuccia
volentieri.
Piero Sansonetti.
Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di
cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004
al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per
poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre
2019.
Il tariffario di
Panzeri e compagni.
Storia di Luca
Fazzo su Il Giornale il 5 gennaio 2023.
La parola d'ordine
adesso sembra: minimizzare. «Non ci sono prove», dice il portavoce del
Parlamento europeo per spiegare perché l'Alto rappresentante per la politica
estera Joseph Borrell (ovvero il ministro degli esteri della Ue) andrà
tranquillamente in visita oggi e domani in Marocco. Cioè in uno dei paesi che
hanno foraggiato per anni l'attività di lobby occulta di Fight Impunity, la ong
dell'ex eurodeputato del Pd Antonio Panzeri, in carcere dall'8 dicembre. Mentre
sui giornali di mezzo mondo si raccontano dei sacchi di soldi trovati a casa di
Panzeri e degli altri arrestati, dei contatti con i servizi segreti del Marocco
e di come Panzeri addomesticò e teleguidò l'incontro del 13 novembre scorso tra
una commissione del Parlamento europeo e il ministro del lavoro marocchino, il
portavoce del Parlamento Peter Stano ricorda che «a questo punto ci sono accuse
e non prove né conclusioni di indagini. Nessuno ha ancora affermato dal punto di
vista giuridico che il Marocco sia un Paese colpevole e che dovrebbe essere
evitato negli incontri internazionali». Non una riga, come si vede, a proposito
del fatto che l'Alto rappresentante Borrell, esponente del Psoe spagnolo,
provenga dallo stesso gruppo parlamentare, i Socialisti&Democratici, di cui era
membro Panzeri fino al 2019 e di cui fanno parte la greca Eva Kaili, già in
carcere, nonché i due nuovi incriminati dalla Procura di Bruxelles, l'italiano
Andrea Cozzolino e il belga Marc Tarabella, tutti attivissimi pro-Marocco e
pro-Qatar.
La cautela del
portavoce Stano spiega bene l'imbarazzo in cui il Qatargate ha precipitato il
Parlamento comunitario. L'allargamento a macchia d'olio dello scandalo non fa
che rendere più evidenti l'inefficienza dei sistemi di controllo interno: a
partire dalla libertà di movimento che veniva garantita a Panzeri nei corridoi e
nelle iniziative del Parlamento nonostante non coprisse più alcuna carica e la
sua ong non risultasse nel Registro della trasparenza. Basti pensare che il 20
luglio 2020 il gruppo degli S&D per presentare il libro dedicato al ricercatore
italiano Giulio Regeni, assassinato in Egitto, si affida proprio a Panzeri, che
è il relatore principale. A presiedere l'incontro la belga Marie Arena, il cui
nome ora ricorre insistentemente nelle cronache sul Qatargate: la sua assistente
personale è stata perquisita dagli inquirenti, avendo lavorato a lungo con la
ong di Panzeri; durante l'incontro del 13 novembre con i marocchini, la Arena fa
un intervento per il quale subito dopo Panzeri la ringrazia. Secondo un articolo
del quotidiano fiammingo De Standaard, documenti trapelati nella versione
marocchina del caso Wikileaks dimostrano che già nel 2014, quando era ancora
deputato, Panzeri era considerato da Rabat «un alleato per combattere il
crescente attivismo dei nostri nemici in Europa». Per ogni emendamento
anti-Marocco bloccato, secondo De Standaard la cricca di Panzeri riceveva 50mila
euro. E gli emendamenti bloccati sono stati 147.
Le cifre, dunque,
iniziano a salire. E rendono meno inverosimile la cifra impressionante cui
starebbe dando la caccia la giustizia greca: i venti milioni di euro
riconducibili a Eva Kaili, la vicepresidente socialista dell'Europarlamento. La
richiesta di assistenza a Panama, dove il bottino sarebbe posteggiato, è ancora
in attesa di risposta. Sullo sfondo, una domanda irrisolta: quanti sono i regimi
impresentabili che hanno ottenuto a pagamento la benevolenza dell'Europa?
L'inchiesta
scuote il Marocco "Attacco ai rapporti con l'Ue".
Il ministro degli
Esteri si lamenta con Bruxelles. Sotto la lente i legami fra Panzeri e la belga
Arena. Luca Fazzo il 6 Gennaio 2023 su Il Giornale.
Prima lo definiva
«un amico». Adesso parla di «amicizia professionale», come a prendere un po' di
distanze. Di sicuro Marie Arena, brillante deputata socialista belga, non potrà
mai dire di non conoscere Antonio Panzeri. Perché negli atti dell'inchiesta sul
Qatargate gli inquirenti, analizzando i tabulati telefonici, hanno trovato 389
contatti tra i due. Una intensità che si spiega solo con una robusta comunanza
di interessi. Di fatto, quando Panzeri lascia dopo tre mandati l'Europarlamento,
nel 2019, il suo braccio operativo diventa la Arena, che eredita il suo posto
alla guida della commissione Diritti umani. E si spende a favore dei paesi che
foraggiano l'ong messa in piedi da Panzeri, Fight Impunity: il Qatar e
soprattutto il Marocco. È Panzeri a teleguidare l'intervento della Arena
nell'incontro del 13 novembre con il ministro del Lavoro marocchino, che viene
trattato con tutti i riguardi.
L'asse preferenziale
che Panzeri garantisce a pagamento al governo di Rabat per i suoi rapporti con
l'Unione europea è innegabile. Eppure ieri quando l'Alto rappresentante della Ue
Jospeh Barrell arriva in Marocco per una visita ufficiale si trova a fare i
conti con la sdegnata presa di posizione del governo locale. I marocchini non
fanno chiarezza, non spiegano se e quali incarichi avessero dato a Panzeri e
alla sua lobby, quanti soldi abbiano versato, ma in compenso si proclamano
vittime di un complotto straniero e fanno sapere che l'inchiesta mette a rischio
i rapporti tra il paese maghrebino e l'Europa.
«Il partenariato tra
l'Ue e il Marocco è importante e va protetto», dice il ministro degli Ester
Nasser Bourita, che parla «attacchi giuridici e mediatici» provenienti «anche
dall'interno delle istituzioni europee». Queste manovre sarebbero «il risultato
di azioni che hanno il Marocco al centro e oggetto di calcoli di altri per
colpire questa relazione». Nessuna spiegazione, come si vede, sui ripetuti
contatti tra Panzeri e l'ambasciatore marocchino a Varsavia, Abderrahim Atmoun e
per suo tramite con Mohammed M., funzionario della Dged, i servizi segreti di
Rabat. Contatti che garantirono un trattamento di favore del Marocco soprattutto
sulla spinosa questione del Sahara occidentale, il territorio di cui il Fronte
Polisario rivendica l'autonomia.
I traffici con il
Marocco risalgono a oltre dieci anni fa, quando Panzeri era ancora eurodeputato.
Agli atti dell'indagine un rapporto della missione marocchina a Bruxelles che
tranquillizza il governo di Rabat: gli incontri che Panzeri si accinge a fare
con gli alleati del Polisario sono solo una sceneggiata per apparire imparziale,
«lui è un nostro caro amico».
Quando nel 2019,
dopo tre mandati, Panzeri cessa la carica e si mette in proprio fondando Fight
Impunity, nelle posizioni chiave per favorire il governo marocchino approdano
due suoi buoni amici: ai Diritti umani viene nominata la Arena, quella delle 389
telefonate; alla commissione per i rapporti col Maghreb arriva il piddino
napoletano Andrea Cozzolino. È Panzeri a presentare a Cozzolino l'ambasciatore
Atmoun, e a coinvolgerlo nelle operazioni di sostegno al governo marocchino.
Ieri nella sua
missione in Marocco il rappresentante della Ue si ritrova stretto tra questa
massa di elementi di accusa e l'indignazione del governo locale. Borrell se la
cava in qualche modo, «è una questione che evidentemente ci preoccupa, le accuse
sono gravi e non ci può essere impunità per la corruzione». Ma non spiega se,
almeno in privato, ha chiesto ai marocchini di spiegare cosa combinassero
insieme Atmoun e Panzeri.
Le accuse del
suo avvocato. Il ‘ricatto’ dei magistrati di Bruxelles, Eva Kaili potrà vedere
la figlia dopo 28 giorni di carcere: “Volevano spingerla a confessare”.
Carmine Di Niro su Il Riformista il 6 Gennaio 2023
Eva Kaili potrà
finalmente rivedere nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 gennaio, la figlia di 22
mesi avuta dal compagno Francesco Giorgi. L’ex vicepresidente del Parlamento
Europeo, rinchiusa nel carcere di Haren con l’accusa di associazione criminale,
corruzione e riciclaggio di denaro nell’inchiesta ribattezzata
‘Qatargate’, potrà vedere la figlia dopo 28 giorni.
Ad accompagnare
la bambina sarà il nonno, a sua volta arrestato e poi rilasciato subito dopo,
fermato in possesso di una valigia contenente circa 60mila euro in contanti. Da
quel momento, con madre e padre agli arresti, era stato lui e la moglie ad
accudire la bambina.
A spiegarlo è
l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos in una intervista al Corriere della Sera.
Tre ore, questo il massimo che è riuscito a strappare agli inquirenti del
Belgio: 180 minuti con la propria bambina dopo quasi un mese di lontananza, con
le altre richieste avanzate nelle scorse settimane respinte ufficialmente perché
non c’era abbastanza personale in carcere durante le feste.
E l’avvocato non
a caso ci va giù durissimo con la procura di Bruxelles, accusata di aver usato
la figlia per fare pressione sulla madre per confessare il suo
ruolo nell’indagine sulla presunta corruzione organizzata per conto di Qatar e
Marocco dall’ex eurodeputato italiano Antonio Panzieri e dalla ong Fight
Impunity.
“Mi sono fatto
l’idea che probabilmente non le permettevano di vedere la bambina per farle
pressione affinché confessasse, ammettesse di aver commesso qualcosa. Ma la
signora Kaili non ha nulla da confessare perché è completamente estranea a ogni
genere di accusa”, spiega oggi l’avvocato Dimitrakopoulos nell’accusare i
magistrati belgi.
C’è tanto che non
torna in questa storia, secondo il legale dell’ex vicepresidente del Parlamento
europeo. A partire proprio dalla reclusione nel carcere di Haren.
Dimitrakopoulos sottolinea infatti che nell’udienza tenuta lo scorso 22 dicembre
a Bruxelles, “il giudice istruttore che sta investigando sul caso, il
signor Michel Claise, ha affermato di non avere le prove che sostengono l’accusa
di corruzione contro Eva Kaili. Come avvocato con 33 anni di esperienza, mi
chiedo come il signor Claise abbia deciso che la signora Kaili deve rimanere in
custodia in carcere quando non ci sono prove sull’accusa fondamentale che è
quella di corruzione”.
Il prossimo
appuntamento chiave per Kaili è fissato il 22 gennaio, con l’udienza che
riesaminerà la custodia cautelare. Per l’avvocato la linea difensiva è chiara:
“Ribadiremo che la signora Kaili non è mai stata a servizio del Qatar. Lei ha
seguito la linea politica dei centristi europei elaborata da Charles Michel e
da Ursula Von der Leyen. Non ha ricevuto mai un solo euro dal Qatar”.
Quanto ai soldi
trovati nella valigia portata via dal padre, Kaili “ha spiegato al giudice
che ha saputo dei soldi solo nel momento in cui il suo compagno Francesco Giorgi
è stato arrestato. Questo l’ha fatta precipitare nel panico. Allora ha chiamato
suo padre e gli ha detto di andare nel suo appartamento, prendere la valigia
della bambina e i suoi biberon. Non sapeva niente di cosa la valigia contenesse
perché non l’aveva aperta e non immaginava che dentro ci fosse denaro in
contanti”.
Carmine Di Niro.
Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato
di politica, sport e tecnologia
La Mani pulite
europea. Qatargate, le zone grigie e la criminalizzazione generalizzata della
cooperazione internazionale.
Iuri Maria
Prado su Il Riformista il 5 Gennaio 2023
Nessuno dice che
in nome del fin di bene si debbano tollerare o mandare assolti i casi
di corruzione e illecito arricchimento personale di cui i recenti scandali
europei avrebbero reso evidenza. Ma tutti dovrebbero capire che quando alcuni
casi di probabile malversazione diventano – ed è ciò che sta succedendo –
l’espediente per destituire di legittimità interi settori e diffuse comunità
della cooperazione internazionale, allora e ancora una volta non ci si rivolge
all’accertamento della verità e alla sanzione dei possibili illeciti, ma
all’ennesima opera di moralizzazione per via giudiziaria che non risana nessun
diritto e ne sacrifica molti, non ripristina nessun ordine e li disarticola
tutti, non chiarisce nulla e intorbida tutto in un mare di chiacchiere
onestamente demagogiche.
Ma, accanto a
queste considerazioni per così dire generali, un’altra e specifica mi pare
urgente e del tutto trascurata in un dibattito che più provinciale non si può: e
cioè che il lavorìo diplomatico e politico nei rapporti con ordinamenti
autoritari, dittatoriali e di sistematica violazione dei diritti umani è molto
diverso rispetto a quello che corre quando si ha a che fare con il governo di un
Paese cosiddetto civile e democratico. In quell’ambito, l’operatore agisce
sempre e per definizione in zona grigia, sul crinale di una legalità
approssimativa e nel pericolo inevitabile di essere lambito da faccende
apparentemente poco raccomandabili.
Per capirsi: se
non devo discutere di tutela dei cetacei con un plenipotenziario scandinavo, ma
di lapidazioni e mani mozzate con un autocrate africano, ben può darsi che per
ottenere qualche limitazione di quello scempio io debba chiudere un occhio su
qualcos’altro, ben può darsi che io decida di concedere qualcosa che in un
salotto europeo farebbe alzare il sopracciglio dell’osservatore civile,
figurarsi quello del moralista togato. È questa una realtà che ormai decenni di
storia della cooperazione internazionale e umanitaria dovrebbero aver insegnato,
e se è vero che negli interstizi ambigui di quel mondo, di quella complessa e
multiforme realtà, si coltivano anche interessi illeciti, è vero altrettanto che
proprio in quelle aree d’ombra si esercitano attività – di allocazione di
risorse, di scambio di informazioni, di intelligence – senza le quali non si
sarebbero raggiunti risultati importantissimi nella tutela della vita e dei
diritti di moltissimi: altrimenti assistiti, si fa per dire, dalle perfezioni di
una legalità completamente inerte.
Guardare la
questione da questo punto di vista significa mandare dove merita l’obiezione
facile secondo cui i borsoni pieni di soldi non servivano in questo caso a
fermare lo scudiscio sulla schiena delle adultere, ma a prenotare il resort da
novemila euro a notte. Obiezione che avrebbe un senso, appunto, se qui si
trattasse di sanzionare specifici casi di comportamenti illeciti e non,
piuttosto, della generalizzata e generalizzante criminalizzazione di un ambito
delicatissimo che riguarda i rapporti tra gli Stati, il posizionamento
delle organizzazioni non governative, l’immensa rete di relazioni e investimenti
rivolti faticosamente a insinuare diritti e miglioramenti di vita dove questa e
quelli non valgono nulla. Il tutto, sulla base del supponente approccio da Mani
Pulite poliglotta che smonta l’Europa come un giocattolo e la rimette nel canale
dell’onestà.
Iuri Maria Prado
Stefania
Craxi: «Sul Qatargate il Pd è vittima del suo stesso giacobinismo giudiziario».
La senatrice di Forza Italia: «Nella stagione ’92-’94 il
Parlamento, sotto i colpi pressanti di una campagna mediatico-giudiziaria senza
pari, ha abolito l’immunità parlamentare. Non ripetiamo oggi gli stessi errori
in Europa». Valentina Stella su Il Dubbio il 5 gennaio 2023
Stefania Craxi
non ha dubbi: la mediatizzazione giudiziaria del cosiddetto Qatargate è una
«barbarie». Di più: «Una deriva continua rispetto alla quale sembriamo esserci
assuefatti dopo l’indegna “falsa rivoluzione” di Tangentopoli». Tra le poche
voci ancora lucide, almeno sulla giustizia, Craxi si ritrova a difendere la
dignità anche di chi, anni fa, ha brandito l’arma giudiziaria contro suo padre,
Bettino Craxi: «Io non difendo le persone. Difendo le idee e i valori in cui
credo, la dignità dell’individuo», spiega.
Onorevole Craxi,
che idea si è fatta del Qatargate: responsabilità di pochi o le istituzioni
europee sono state infiltrate dalla corruzione?
Il tema su cui
riflettere è diverso da quello su cui si stanno concentrando larga parte dei
media e della politica. La questione su cui soffermarsi non è l’episodio di
corruzione in sé. La corruzione esiste, è sempre esistita e sempre esisterà,
perché la politica non è un corpo mistico avulso dalla società. Va perseguita e
condannata, senza cedere a demagogie e senza dar vita a processi sommari. Ma in
questa vicenda sembrerebbero emergere gravi condizionamenti da parte di uno
Stato sovrano, non di una company. È un qualcosa che deve farci riflettere ben
oltre le contingenze, dobbiamo porci il problema di come rafforzare le nostre
istituzioni democratiche, un tema che riguarda non solo le democrazie europee ma
occidentali.
Crede davvero che
ci sia un attacco alle istituzioni europee?
Se per attacco
intende il tentativo di condizionare la vita democratica delle nostre realtà,
tanto nazionali che europee, è un dato di fatto. Lo stesso Europarlamento si è
interessato al tema, visto che ha istituito da tempo una “commissione speciale”
per far luce sul numero crescente di interferenze esterne e sulle campagne di
disinformazione volte ad influenzare il dibattito pubblico nella UE. Certo,
l’uso talvolta è stato strumentale, spesso ha favorito una lettura
auto-assolutoria dei mali che affliggono l’Unione, scambiando così i sintomi con
la malattia. Non possiamo pensare, ad esempio, che una certa disaffezione e
critica verso Bruxelles, al pari di alcuni risultati elettorali – penso alla
Brexit –, possano essere solo il frutto di interferenze e disinformazione e non
di una certa riottosità, se non quando di una vera e propria ottusità, delle
élite comunitarie sui temi economici (più crescita, meno austerity) e
democratici (più rappresentanza, meno regolamenti ed euroburocrazia). Ma tutto
ciò non toglie che il tema interferenze c’è. Esiste. E le nostre debolezze
interne non fanno altro che prestare il fianco.
Come spiega
l'atteggiamento del Pd che crede che questo scandalo sia la loro Mani Pulite?
Il Pd non è
travolto dallo scandalo ma piuttosto dal suo moralismo, dalla sua ipocrisia,
dalla retorica di una presunta diversità su cui ha costruito, non da oggi, una
mai esistita superiorità. Ma rispetto a questo caso stanno rispondendo in
maniera confusa, autolesionista, guidati dal solito giacobinismo e
giustizialismo di maniera che rischia di fare male sia alle istituzioni che alla
vita politica e democratica.
Sostengono che si
sia dimenticata la lezione di Berlinguer: il potere come strumento e non come
fine.
Scusi, ma di
quale lezione parliamo? La lezione di Berlinguer era quella che prevedeva il
finanziamento illegale al PCI da parte di una potenza straniera nemica
dell’Italia e dell’Occidente come l’URSS? Basta con questa ipocrisia stantia e
con la mistificazione della storia. La cosiddetta “questione morale” è stata una
strategia politica miope e fallimentare per un partito senza rotta e senza
bussola, orfano del “compromesso” e sconfitto dalla storia, guidati da un leader
chiuso in una torre d’avorio che non leggeva più le dinamiche della società. Non
lo dico solo io, lo hanno scritto i suoi figliocci negli anni… E poi la
soluzione al tema della riforma dei partiti e del loro rapporto perverso con le
istituzioni già al tempo era un’altra.
Qual era?
Era la “grande
riforma”, una democrazia compiuta e quindi una democrazia dell’alternanza. Era,
per inteso, quella riforma immaginata e voluta dai socialisti sul finire degli
anni ‘70 alla quale si sono sempre opposti i comunisti (e i loro epigoni) perché
erano parte integrante del sistema di gestione del potere, nel quale avevano un
ruolo preminente. Regioni, giunte rosse e poi, specie sul finire degli anni ’80,
amministrazioni DC-PCI…. Senza contare il loro trasversalismo, specie quando
c’erano da approvare leggi di spesa con voto segreto. Voto segreto che, per
inciso, fu poi abolito proprio dall’odiato Craxi…
Come giudica il
fatto che i coinvolti nell'inchiesta siano già stati condannati sui giornali?
Una barbarie. Una
assoluta barbarie. Una deriva continua rispetto alla quale sembriamo esserci
assuefatti dopo l’indegna “falsa rivoluzione” di Tangentopoli. Anche se non
conosco nessuno dei personaggi coinvolti, anche se alcuni di loro hanno brandito
l’arma giudiziaria verso gli avversari, non trovo degno di un Paese civile il
processo mediatico. I processi non si fanno sui giornali, la gogna pubblica è di
per sé una condanna senz’appello. Capisco che anche nel mio schieramento, dopo
anni di insulti e di offese gratuite, ci possa essere il legittimo desiderio di
rivincita ma non bisogna cadere in questo errore, per il bene del Paese.
Lei in un
editoriale sul Giornale chiede di non abolire l'immunità parlamentare al
Parlamento europeo. Perché?
Sarebbe
sufficiente dire che dagli errori si fa tesoro. Nella stagione ’92-’94 il
Parlamento, sotto i colpi pressanti di una campagna mediatico-giudiziaria senza
pari, ha abolito l’immunità parlamentare. Solo pochi coraggiosi votarono
contro. Ma cosa abbiamo risolto? Niente! Abbiamo solo distrutto un istituto
posto a garanzia dell’autonomia della politica dai padri costituenti,
delegittimato la stessa, rese deboli e condizionabili le istituzioni. Non è un
caso se abbiamo assistito nell’ultimo quarto di secolo ad un crescendo di
conflitti con l’Ordine giudiziario, con gli esiti e le devianze che conosciamo.
Ecco, da questa deriva voglio salvaguardare le istituzioni comunitarie, che
vanno radicalmente riformate ma non distrutte. Ovviamente, cosa diversa e
concedere l’autorizzazione nei casi di particolare gravità…
Sotto accusa ci
sono i discendenti di quelli che hanno accusato suo padre. Quanto le pesa
difenderli?
Brandire la clava
giudiziaria non è mai un bene, specie se lo si fa per vendetta, un sentimento
che non mi appartiene. Semmai, sono animata da un desiderio di verità, ben
sapendo che niente e nessuno potrà riapre i torti subiti e i danni apportati al
Paese. Dobbiamo sempre diffidare dai garantisti un tanto al chilo, quelli che
vanno a corrente alternata seguendo la logica dell’opportunismo, lo schema
amico-nemico. E poi, io non difendo le persone. Difendo le idee e i valori in
cui credo, la dignità dell’individuo che trascende dal fatto che possa essere
colpevole o innocente. Le persone passano, le vicende cambiano, ma i principi
restano. La barbarie non fa mai giustizia, ma solo strage della ragione prima
ancora che del diritto.
Qatargate? Non
solo, la svolta dell'islam: meno jihad, più "soft power".
Francesco Carella su
Libero Quotidiano l’08 gennaio 2023
Gli psicologi
sostengono che la consapevolezza di un pericolo dipende da quanto e come se ne
parli. Se l'oggetto di una minaccia scompare dal dibattito pubblico e dalle
conversazioni private esso viene depotenziato fino ad essere relegato nell'album
dei ricordi. Si pensi a ciò che sta accadendo in relazione ai difficili rapporti
fra Occidente cristiano e mondo islamico. Sembra che fra questi due universi
politici, culturali e civili sia improvvisamente scoppiata la pace dopo anni di
terrore. Eppure, basta poco per richiamare alla memoria le angoscianti immagini
delle stragi jihadiste che hanno seminato panico e ucciso persone a migliaia
negli ultimi anni. Chi si occupa di storia dei rapporti fra queste due comunità
sa che il problema non è rappresentato dai fondamentalisti, ma riguarda l'islam
in quanto tale.
Si tratta, come
osserva Samuel P.Huntington, di «una civiltà diversa le cui popolazioni sono
convinte della superiorità della propria cultura e che hanno in odio la civiltà
occidentale. Fino a quando l'islam resterà tale e l'Occidente resterà
l'Occidente il conflitto fra questi due mondi è destinato a continuare senza
sosta». Giusto il contrario di ciò che si ostinano ancora a credere politici e
intellettuali della sinistra, negando verità ormai incontrovertibili. Per oltre
mille anni dal primo sbarco moresco in Spagna al secondo assedio turco di Vienna
nel 1683 l'Europa si è trovata sotto la costante minaccia dell'islam, rischiando
molte volte la sua sopravvivenza quale entità culturale. Infatti, la natura
degli scontri ha riguardato solo marginalmente questioni di tipo territoriale.
Le ragioni
risultano ogni volta riconducili a temi di civiltà a partire da una differenza
di fondo : l'islam non ha mai riconosciuto la separazione fra sfera politica e
religiosa, mentre il precetto cristiano-occidentale si è affermato fin da subito
sotto il segno della netta distinzione fra Cesare e Dio ossia fra potere
temporale e potere spirituale. Intanto, mentre la cronaca registra numeri
crescenti di sbarchi di immigrati irregolari sulle coste italiane, ci si
avvicina sempre di più allo scenario previsto dalla demografa francese Michèle
Tribalat quando parla di «processo di sostituzione dell'Europa». In tal senso,
una riflessione andrebbe avviata soprattutto alla luce di un palese cambio di
strategia da parte del mondo musulmano.
La sensazione è che
sia stata accantonata, per il momento, la tradizionale arma terroristica, per
cercare di sviluppare una forma di egemonia attraverso una lenta ma progressiva
penetrazione culturale. Con l'attuale debolezza europea - pronta a negare in
nome del politicamente corretto le proprie radici spirituali e civili esaltando
quelle dei Paesi in cui vengono negate le libertà e i diritti fondamentali
(il Qatargate è la punta dell'iceberg) la scelta islamica potrebbe rivelarsi
vincente. In tal caso, l'Eurabia, come ammoniva Oriana Fallaci, è a noi vicina
più di quanto si possa immaginare.
Giuseppe Salvaggiulo
per la Stampa il 7 gennaio 2023.
«La cecità della
politica di fronte alla corruzione genera un senso di impunità». Da un mese
Michel Claise è il giudice più famoso d’Europa. La sua inchiesta denominata
Qatargate sta terremotando le istituzioni dell’Ue. Ex avvocato, giudice-sceriffo
autore di inchieste clamorose, massone dichiarato, romanziere di successo,
fustigatore del malcostume politico, Claise non si tira indietro. In una lunga
conversazione che il quotidiano belga L’Echo ha voluto condividere con La
Stampa, senza entrare nel merito del Qatargate affronta tutti i temi che
emergono.
Il fenomeno
«Si calcola che la
corruzione rappresenta il 6% del Pil mondiale, e il riciclaggio di denaro sporco
altrettanto. C’è un numero enorme di casi di corruzione: negli ultimi anni non
hanno mai smesso di aumentare, anche se non tutti sono noti all’opinione
pubblica. Tutti, però, sono al corrente dell’aumento del fenomeno. Serve una
Procura nazionale sui crimini finanziari, separata e del tutto indipendente,
perché nei grandi casi politici vi sono poste in gioco politiche. È
inconfutabile. Nella corruzione pubblica queste poste in gioco politiche sono
enormi. A partire da questo, quando c’è una Procura nazionale assolutamente
indipendente si ha la garanzia che non ci saranno ripercussioni nei vari
dossier».
Il condizionale
«Il ricavato della
criminalità deriva da due reati, due mammelle straordinarie: il riciclaggio di
denaro sporco e la corruzione. L’incompetenza dei dirigenti politici nella lotta
alla corruzione determina una sensazione di impunità per le organizzazioni
criminali. Di recente mi sono trovato su un set televisivo con due importanti
politici. Hanno iniziato il loro intervento sul tema della criminalità
finanziaria dicendo che è indispensabile tener conto che la situazione è grave.
Hanno detto anche
che sarebbe necessario fare qualcosa in merito. Il fatto stesso che abbiano
usato il condizionale in pratica li rende complici! Qui non si tratta più di
parlare al condizionale: si deve parlare al presente. Si deve fare qualcosa! Se
è possibile far cambiare la mentalità della classe politica? Sono molto
pessimista».
Il consenso
«La loro motivazione
sembra essere la tutela del loro elettorato. La gente non capisce che la
criminalità finanziaria è il peggior avversario sleale che si possa immaginare
in rapporto alle organizzazioni legali. Si ha l’impressione che prendendo
provvedimenti contro la criminalità organizzata si vada a infastidire gli
imprenditori tradizionali, ma non è vero. Da un lato c’è un commerciante onesto
che non sa come pagare le bollette della luce; dall’altro sappiamo dalle
intercettazioni telefoniche che ci sono criminali che, quando esitano
sull’acquisto di una Ferrari o di una Porsche, finiscono con il comprarle
entrambe».
I giovani
«Penso che sia
troppo tardi per tutta una serie di motivi. Si può assimilare questa situazione
a quella del clima: è in atto una deregolamentazione economica, proprio come è
in atto una deregolamentazione climatica. Ciò fa sì che ci troviamo di fronte
una situazione irreversibile, ma non per questo dobbiamo restarcene con le mani
in mano di fronte dell’ingiustizia nella quale viviamo. Tenuto conto che c’è
ancora la possibilità di salvare alcune zone del pianeta, c’è ancora modo di
salvare alcune generazioni. Penso che lo stesso sia vero per la
deregolamentazione dell’economia».
Le banche
«Prima di passare
alla repressione, è indispensabile fermare il fenomeno. Il sistema bancario
internazionale continua a essere implicato nel riciclaggio di denaro sporco. Si
dovrebbero prendere in considerazione sanzioni enormi che, al momento giusto,
possano permettere di dissuadere i criminali e di rimpatriare il denaro».
La pistola alla
tempia
«Il peggior nemico
della giustizia è il tempo. I patteggiamenti sono utili a condizione che sia la
Procura a negoziare, puntando la pistola alle tempie delle persone indagate.
Rivedere il sistema delle sanzioni permetterebbe di svuotare le aule di
tribunale e di poter andare fino in fondo in modo rapido per tutti coloro che
hanno contestazioni in ballo».
L’impatto nascosto
«L’idea di partenza
è sapere a quanto ammontano con precisione i danni per la società connessi a
tutto questo. Quando poi si saranno individuati gli importi esatti della
criminalità finanziaria, serviranno economisti e sociologi per quantificare
l’impatto sulla democrazia. Penso che il giorno in cui conosceremo le cifre
esatte resteremo estremamente sorpresi. Questo è il mondo oggi».
Il ruolo del
giudice
«Esercitare il mio
mestiere mi piace e cominciamo ad avere qualche risultato. Nelle reazioni nei
miei confronti incontro persone che auspicherebbero di spingersi addirittura
molto oltre. Mi sollecitano a intervenire alle conferenze, e questo mi permette
di continuare a battere sullo stesso tasto. La Procura europea? Si tratta di un
bambino che inizia a muovere adesso i suoi primi passi».
Quanto al suo
futuro, che molti a Bruxelles preconizzano in politica, Claise fa una lunga
pausa, poi sibila: «Scriverò romanzi».
Giuseppe Salvaggiulo
per lastampa.it il 7 gennaio 2023.
«I regimi
autocratici cercano di interferire, con la corruzione, nelle nostre decisioni.
Il problema è che miei colleghi, stando alle accuse, hanno accettato enormi
tangenti, diventando cavalli di troia per interferenze straniere nel Parlamento
Ue. Ciò mina nel profondo la democrazia e la fiducia dei cittadini. E riafferma
anche ingiusti stereotipi sull’Italia e gli italiani». Hannah Neumann,
eurodeputata tedesca dei Verdi, ha visto la cricca all’opera in quanto
presidente della Delegazione per le relazioni con la penisola arabica e
componente della commissione diritti umani.
Sorpresa dallo
scandalo?
«Non mi sorprende
che Stati terzi provino a influenzare i parlamentari con viaggi favolosi e cene
di lusso. Accettarli non è illegale, se il parlamentare li dichiara in modo
appropriato. Sono però sorpresa e indignata dall’energia criminale e dalla
quantità di denaro. Altro che zona grigia».
ei ha mai ricevuto
offerte di questo tipo?
«L’ambasciata del
Qatar mi ha offerto viaggi privati nel loro Paese, organizzati e pagati».
In che periodo?
«Molte volte.
L’ultima per assistere a una partita dei mondiali di calcio. Non ho mai
accettato “regali” del genere, per poter esercitare il mandato in piena
indipendenza».
Lei è stata eletta
nel 2019: ha avuto modo di conoscere Panzeri, che non era più eurodeputato?
«Una volta. Chiese
di incontrarmi all’inizio della legislatura. Prendemmo un caffè. Mi spiegò
l’idea alla base della Ong Fight Impunity che aveva fondato. Ma non ero molto
interessata, così da allora non ci siamo più visti».
Era solo?
«Con un assistente.
Ma non ricordo se fosse uno di quelli coinvolti nel Qatargate: sono passati tre
anni e ho visto molte centinaia di persone in altrettanti incontri di quel
tipo».
Le chiese qualcosa
in particolare?
«Mi illustrò il suo
piano per creare un osservatorio internazionale contro l’impunità. Pur
condividendo la causa, ma non ho mai capito appieno l’utilità dello strumento.
Quindi non mi sono fatta coinvolgere in alcun modo».
E invece Eva Kaili?
«Avevamo un rapporto
stretto, perché era non solo vicepresidente del Parlamento con delega sul Medio
Oriente, ma anche membro della delegazione da me presieduta. Facevamo missioni
all’estero insieme».
Era pro Qatar?
«Da quando la
conosco, è molto interessata al Qatar e piuttosto positiva nel giudizio. Il suo
discorso nella plenaria a novembre, tuttavia, è stato impressionante. Pura
propaganda che ha lasciato perplessi tutti noi presenti, compresi i socialisti.
Tutti alzavano gli occhi al cielo».
Come si
comportavano Tarabella e Cozzolino nella commissione diritti umani?
«Non erano molto
attivi».
Notò qualcosa di
strano nella riunione della commissione diritti umani dedicata al Qatar il 14
novembre?
«Un’insolita
attenzione mediatica. Mi lasciò perplessa l‘intervento del ministro Al-Marri,
che accusava gli altri di razzismo con un tono piuttosto aggressivo, insolito
per lui. Sembrava una sceneggiata destinata più all’opinione pubblica del suo
Paese che al Parlamento Ue. E venne filmata da una persona a me sconosciuta».
Perché è saltata la
vostra missione in Qatar a fine ottobre?
«Ci lavoravamo da
due anni e l’avevamo programmata a ridosso dei mondiali, per esaminare la
situazione dei lavoratori migranti e sottolineare la nostra richiesta di non
interrompere i progressi, una volta finita la ribalta internazionale. Ma
all’ultimo minuto i qatarioti l’hanno annullata, adducendo “motivi logistici”».
Di che tipo?
«Hanno detto che
l’edificio del Parlamento era in ristrutturazione. Allora io ho proposto di
spostare l’incontro in una sala del ministero degli Esteri, o piuttosto in un
ristorante. Ma mi hanno risposto che era impossibile».
Lei come ha reagito?
«Ero piuttosto
frustrata, e ancora di più quando ho scoperto da twitter che Eva Kaili era stata
ospitata calorosamente lì durante la stessa settimana».
Qual è stata la sua
reazione?
«Mi sentivo presa in
giro dal Qatar: rifiutava la delegazione ufficiale che avrebbe fornito un
resoconto equilibrato della situazione e invitava qualcuno che non avrebbe
pronunciato una sola parola critica».
Ha chiesto
spiegazioni a Eva?
«Naturalmente. Lei
sapeva che la nostra missione era stata annullata per volere del Qatar, quindi
non avrebbe dovuto accettare un invito né tantomeno proporsi per un viaggio,
specialmente nello stesso periodo. Ero piuttosto arrabbiata e gliel'ho detto».
E lei?
«Sembrava non
cogliere il problema politico, si scusava solo per non avermi informato in
anticipo».
Le aveva creduto?
«Allora mi sembrava
un passo falso politico. Ora credo che le borse piene di soldi abbiano giocato
un ruolo importante in questa storia».
Quella mani
pulite belga peggiore dell’originale, il vero Italian Job è dei pm.
Questa
storia ricorda tanto, e forse in peggio (ove mai possibile), i gloriosi anni 90,
con Paolo Brosio tutti i giorni a fare il gazzettiere della Procura. I reati
contestati sono confusi, gli indizi assai incerti, eppure ci sono già arresti.
Gian Domenico Caiazza su Il Dubbio il 6 gennaio 2023
Se nascondi sacchi
di denaro contante in casa, qualcosa di poco lecito hai sicuramente commesso. E
se sei un Parlamentare, cioè un rappresentante del popolo, intanto devi renderne
conto immediatamente ai tuoi elettori. Ma dal momento che un indizio grave di un
ancora ignoto reato non è di per sé un reato, è compito di chi investiga
scoprire quale sia il reato che hai molto verosimilmente commesso, o concorso o
agevolato a commettere. Ed è proprio qui, esattamente in questo punto della
vicenda, che si biforca la strada tra paesi civili e non.
In un Paese civile,
che fonda cioè il proprio patto sociale sull’habeas corpus, sulla presunzione di
innocenza, sull’onere probatorio a carico dell’accusa, non dovrebbe essere
consentito che accada quel che sta accadendo in Belgio. E cioè che quelle
persone cui son state trovate i borsoni gonfi di soldi vengano arrestati prima
di aver accertato, con un corredo indiziario più vicino alla certezza che al
sospetto, la ragione, la provenienza e la destinazione di quei borsoni di denaro
contante. Salvo che detenere denaro contante in misura incongrua non sia già di
per sé un reato, cosa che non mi risulta essere.
Sappiamo poco di
cosa esattamente si contesti agli indagati, e questo di per sé non sarebbe un
fatto grave, anzi è certamente un fatto virtuoso – per noi del tutto inconsueto
- la tenuta del principio di segretezza delle indagini. Ma ad una condizione:
che invece sia chiaro agli indagati cosa esattamente gli si stia contestando, e
sulla base di quali elementi di indagine. Perché se nemmeno agli indagati
dovesse essere chiaro di cosa l’eroico giudice istruttore in concreto li accusa
- date, luoghi, persone, atti concreti sintomatici del o dei reati ipotizzati -
le cose cambiano assai. E cambiano per la semplice ragione che quegli indagati
sono stati privati della libertà personale; la qual cosa – nei paesi civili - è
lecito che avvenga solo eccezionalmente, non certo perché detenere borsoni di
denaro contante sia una cosa assai disdicevole.
Occorre severamente
indagare sulle ragioni di quei borsoni, senza sconti e senza riguardi per
nessuno. Ma se si sceglie di fare il passo della privazione della libertà, nei
Paesi civili si invertono le regole del gioco: sei tu investigatore, sei tu
giudice che devi rendere accuratamente ragione di questo passo gravissimo,
spiegando bene - soprattutto - perché esso fosse indispensabile.
Ora, suggerisco di
leggere con attenzione l’intervista del Corsera all’avvocato difensore della
ormai ex vice-presidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, alla quale solo dopo
28 giorni è stato concesso di passare - in carcere - un paio di ore con la
figlia di 20 mesi (anche il padre è in carcere); cosa che - in un paese civile -
sarebbe spiegabile, forse, solo se la mamma fosse, chessò, indagata di aver
assassinato il fratellino, non di aver avuto in casa (ma lei nega) 600mila euro
in contanti, non si sa bene ancora perché. Ed infatti il difensore, alla domanda
di come sia stata possibile una simile vergogna, risponde garbatamente: «Mi sono
fatto l’idea che probabilmente non le permettevano di vedere la bambina per
farle pressione affinché confessasse, ammettesse di aver commesso qualcosa. Ma
la signora Khaili non ha nulla da confessare perché è completamente estranea a
ogni genere di accusa».
Si, pensiamo tutti
la stessa cosa, e senza il “probabilmente”; e dunque, in un Paese civile, il
giudice dovrebbe essere chiamato a rispondere di una simile vergogna, salvo a
ritenere che la bambina di 20 mesi fosse depositaria o potenziale tramite di
informazioni sui borsoni di denaro, giusto? E invece, a leggere la stampa, tutta
Europa guarda con ammirazione a questa indagine, che più passano i giorni e meno
appare chiara nei suoi esatti contenuti. Ma se tu arresti e impedisci per un
mese ad un padre ed a una madre di vedere la figlia di 20 mesi anche solo in
carcere, oltre che ad usare metodi vergognosi ed infami, significa che hai molto
poco in mano, oltre i borsoni di denaro, e vuoi che te lo raccontino gli
indagati stessi, sotto la pressione delle sbarre (ma allora tiriamogli via
direttamente le unghie, che facciamo prima), perché tu non hai saputo, ad oggi,
dare un seguito investigativo concreto al più che legittimo sospetto.
Ed infatti il
difensore ci informa che «nell’udienza che si è svolta il 22 dicembre a
Bruxelles, il giudice istruttore Michel Claise ha affermato di non avere le
prove che sostengono l’accusa di corruzione contro Eva Khaili». Beh, fantastico!
E quando rompi le regole dello Stato di diritto, noi lo sappiamo benissimo, la
deriva diviene incontrollabile. Come, ad esempio, la notizia di conti milionari
esteri della Khaili, che - ci informa il difensore - le banche interessate hanno
smentito ufficialmente e formalmente, ma continua a circolare, come usa farsi in
questi casi con il fango nel ventilatore. O come l’appartamentino in montagna di
Figà Talamanca, che però ci paga il mutuo.
Ma c’è grande
eccitazione giustizialista, intorno a questa indagine, e tanta voglia del nuovo
“Di Pietro belga”, e della nuova “Mani Pulite” europea. Cosicché questa storia è
diventata, a tutto tondo, un “italian job”, sia dal lato degli indagati che per
il marchio di fabbrica di questa indagine. Che effettivamente ricorda tanto, e
forse perfino in peggio (ove mai possibile), i gloriosi anni 90, con Paolo
Brosio tutti i giorni a fare il gazzettiere della Procura su chi fosse stato
arrestato di bello quella mattina, e chi stesse per esserlo. E magari anche chi
si fosse suicidato. Orgogliosi? Résister, résister, résister!
Qatargate.
Populismo giudiziario sulla Kaili.
Siamo tutti figli di
Eva, ma la figlia effettiva di una Eva contemporanea, l'eurodeputato Kaili,
usata come strumento di pressione per far confessare la madre, ci sembra che
vada ben oltre anche la concezione non proprio garantista dell'Antico
Testamento. Marco Gervasoni il 7 gennaio 2023 su Il Giornale.
Siamo tutti figli di
Eva, ma la figlia effettiva di una Eva contemporanea, l'eurodeputato Kaili,
usata come strumento di pressione per far confessare la madre, ci sembra che
vada ben oltre anche la concezione non proprio garantista dell'Antico
Testamento. Anzi, ci sembra proprio una barbarie. Già che i parlamentari possano
essere arrestati e tenuti in carcere, senza che il Parlamento si sia espresso
sulla loro immunità, è qualcosa che ci sembra abnorme, e per molto meno nel XVII
secolo gli inglesi tagliarono la testa al loro re. E non perché i parlamentari
siano dei privilegiati, come bercia la demagogia populista: ma perché essi
rappresentano il popolo che li ha votati, e se un potere dello Stato, quello
giudiziario, impedisce al legislativo di esprimersi, siamo fuori
dall'ordinamento liberale. Ma che poi, secondo la denuncia del suo avvocato, a
Kaili non solo non siano stati concessi gli arresti domiciliari (eppure non è
accusata di omicidio o di terrorismo) ma che addirittura la figlia sia stata
utilizzata come merce di scambio per farla parlare, ci fa accapponare la pelle.
E anche la scena della bimba portata in carcere per vedere la madre, è qualcosa
che rimanda a una idea di diritto che riporta ai momenti bui della storia. Anche
perché, nel frattempo, si trova in carcere anche il padre, l'ex assistente di
Panzeri, Giorgi.
Il metodo di
utilizzare la carcerazione per far confessare era già stato condannato, nel
1774, dall'illuminista milanese Cesare Beccaria, il cui Dei delitti e delle pene
non è solo, come spesso si legge, un trattato contro la pena capitale. Purtroppo
nella storia, anche delle democrazie, tale pratica è stato utilizzata ma oggi è
condannata esplicitamente da tutta la giurisprudenza. Fu però, per ammissione di
diversi dei pm, un cavallo di battaglia del metodo «Mani pulite» che applicò
alcune leggi eccezionali, introdotte nel nostro ordinamento per la lotta contro
terrorismo e mafia. E meno male che gli indagati di allora erano prevalentemente
maschi e in ogni caso di età piuttosto avanzata, senza figli piccolissimi.
Credevamo o almeno speravamo che questi metodi non fossero più in uso, o che
almeno fossero tipici della storia italiana, e che paesi con una storia meno
tragica e complessa della nostra, non li utilizzassero. Invece pare non sia
cosi. Il sospetto finale è che vi sia una sorta di accanimento, da parte dei
magistrati, proprio perché a essere indagato è il mondo politico. E che la
pressione mediatica faccia il resto. Ma abbiamo già visto cosa ha prodotto nel
nostro paese il populismo giudiziario. E non è il caso di esportarlo in Europa.
Qatargate.
"500mila inquisiti". "Si sciacqui la bocca". Rissa Calenda-Fdi sul Qatargate.
L'ira di Fratelli d'Italia sul segretario di Azione, che in tv aveva commentato
il Qatargate attaccando Fratelli d'Italia. Zedda: "Guardi ai partiti in cui si è
candidato". Marco Leardi il 6 gennaio 2023 su Il Giornale.
"Calenda dovrebbe
sciacquarsi la bocca". Da Fratelli d'Italia, la replica al segretario di Azione
è arrivata a tempo record. Durissima, esplicita, categorica. A zittire il leader
del terzo polo è stata in particolare la senatrice meloniana Antonella Zedda,
infastidita da alcune parole che l'ex ministro dello sviluppo economico aveva
pronunciato nel pomeriggio in tv, commentando il Qatargate. Su Rai1, infatti,
Calenda aveva scomodato incautamente il partito di Giorgia Meloni:
quell'improvvida uscita gli è valsa un'immediata reprimenda.
Rispondendo a una
domanda sul fatto che Meloni ritenga il Qatargate un problema dei socialisti,
Calenda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico aveva commentato: "Non lo
so, è un problema dei singoli. La responsabilità è personale. Meloni ha
avuto 500mila inquisiti nel suo partito ma non per questo è camorrista o fa
parte della 'ndrangheta". Parole che - al di là della discutibile
argomentazione - sono risuonate come un vero e proprio attacco al partito di cui
il premier è leader.
Così, da Fdi è
partita una secca replica al rappresentante del terzo polo. "500mila inquisiti
in Fratelli di Italia? Calenda dovrebbe sciacquarsi la bocca quando parla di
Fratelli di Italia, gli consiglio di guardare ai partiti in cui si è candidato e
portare attenzione alla sua coalizione parlamentare", ha contrattaccato
Antonella Zedda, vicecapogruppo di FdI a Palazzo Madama, infilzando il
segretario di Azione con un'affilata stoccata politica. "Il riferimento al
Qatargate fatto dalla Meloni è semplice: accusavano che fosse un fatto italiano,
ha risposto semplicemente riferendosi alla parte politica attualmente coinvolta.
Per altro precisando che in quel momento il coinvolgimento fosse solo al gruppo
dei socialisti, dopotutto così è", ha spiegato ancora la senatrice di Fratelli
d'Italia.
"Le persone
coinvolte - greci, italiani, belgi - hanno tutti due punti in comune, il gruppo
politico di appartenenza il Qatar", ha concluso l'esponente della maggioranza.
L’avvocato di
Kaili: «Se avesse saputo, avrebbe lasciato Giorgi». Un mese di Qatargate.
Storia di
Giuseppe Guastella su Il Corriere della Sera il 9 gennaio 2023.
«Sono provate come
tutte le persone che sono agli arresti domiciliari ma stanno bene», dice
l’avvocato Angelo De Riso al termine dell’udienza a Bergamo in cui ha contestato
il sequestro dei conti correnti della moglie e della figlia di Antonio Panzeri
nell’inchiesta sulle presunte corruzioni al Parlamento europeo a favore di Qatar
e Marocco che ha portato il capofamiglia nel carcere di Bruxelles. Ma a un mese
dal blitz che ha terremotato il Parlamento europeo resta ancora da capire cosa è
avvenuto all’ombra dell’ong Fight impunity di Panzeri e quali siano le esatte
responsabilità delle persone coinvolte.
Per velocizzare le
pratiche tra stati, il mandato di arresto europeo (con cui il Belgio ha ottenuto
dall’Italia l’arresto delle due donne) prevede una proceduta semplificata con
accuse descritte in modo sommario, in cui i difensori possono contestare
questioni tecniche e giuridiche. Ieri, gli avvocati De Riso e Nicola Colli hanno
chiesto ai giudici di annullare il sequestro sostenendo «la lacunosità
dell’ordinanza e del decreto di congelamento» emessi dalla magistratura di
Bruxelles. Ciò che si sa dagli atti è che le due donne sono accusate di sembrare
«perfettamente al corrente» dell’attività di Panzeri e di aver portato dei
regali dal Marocco in Italia. Al di là della generica imputazione di
associazione criminale, corruzione e riciclaggio, la questione della carenza di
informazioni su indagini e accuse trova d’accordo gli avvocati di tutte le
persone coinvolte.
Qatargate, chi sono
gli «amici» della «squadra» di Panzeri?
Dopo un mese
dall’arresto di Eva Kaili, la europarlamentare greca del Pasok compagna di
Francesco Giorgi, socio di Panzeri al 50%, e di Niccolò
Figà-Talamanca segretario della ong No peace without justice, si sa che nella
casa che la ex giornalista tv divide a Bruxelles con Giorgi, padre della sua
bambina di quasi due anni, c’erano 750 mila euro. La presenza di tanti contanti
in casa non è giustificabile per nessuno, specie per un politico, perché tanto
denaro può solo avere una provenienza quantomeno sospetta, per non dire
illecita, tanto che è costata alla donna l’arresto in flagranza di reato con
l’accusa che stava facendo sparire 600 euro in una valigia tramite il padre. Il
suo legale, l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos, però afferma che ad ora non ci
sono elementi contro di lei, e fa un esempio: «Se in una casa si trovano dei
soldi provenienti da una rapina in banca significa che anche la moglie di chi
vive in quella casa ha partecipato alla rapina? No, naturalmente». Spiega: «Per
essere considerati complici non si deve essere soltanto a conoscenza
dell’esistenza dei soldi ma si deve aver partecipato alla rapina. La signora
Kaili non ha preso parte alle attività che il signor Giorgi intraprendeva con
Panzeri. Se lei fosse stata a conoscenza di queste attività losche, avrebbe
intimato al marito di smettere oppure lo avrebbe lasciato».
L’accusa, però,
sostiene che Kaili, con altri, come il deputato l’italo-belga Marc Tarabella,
era uno degli «amici» su cui Panzeri poteva contare per le sue manovre pro
Marocco e Qatar nel gruppo dei Socialisti & Democratici di cui ha fatto parte
fino al 2019. Con il sistema inquisitorio il giudice istruttore,però, può tenere
segreti molti atti, e quindi è ipotizzabile che ci sia molto di più sulla sua
scrivania. Qualcosa potrebbe emergere lunedì prossimo quando a Strasburgo la
presidente Roberta Metsola annuncerà la richiesta della magistratura di
rimuovere l’immunità parlamentare per Tarabella e Andrea Cozzolino, accusato di
far parte integrante della squadra di Panzeri e Giorgi con i quali era in
contatto con i servizi marocchini. Il giorno dopo, Panzeri comparirà di fronte
ai giudici per l’esame della sua posizione dopo l’arresto.
Estratto
dell'articolo di Sandro De Riccardis e Luca De Vito per “la Repubblica” il 13
Gennaio 2023.
Bonifici mensili da
due ong, l'italiana No Peace Without Justice e l'americana Human Rights
Foundation, coinvolte nel Qatargate insieme a Fight Impunity dell'ex deputato Pd
(poi in Articolo 1) Antonio Panzeri. Più che il saldo da duecentomila euro sul
conto della figlia avvocato Silvia Panzeri, a incuriosire gli investigatori sono
le movimentazioni degli ultimi due anni, sui quali indaga la procura di
Bruxelles. […]
No Peace Without
Justice è comparsa già nei primi giorni dell'inchiesta. Il suo direttore
generale, Niccolò Figà- Talamanca, accusato di aver incassato denaro sui conti
dell'associazione per riciclare i proventi della corruzione, era stato arrestato
il 9 dicembre insieme ad Antonio Panzeri, Francesco Giorgi ed Eva Kaili.
Di Human rights
foundation, una delle più autorevoli ong che si occupano di diritti umani nel
mondo, aveva invece parlato nel suo interrogatorio in Belgio, Francesco Giorgi,
il compagno di Kaili, che dopo essere stato assistente di Panzeri lo è stato
anche dell'europarlamentare Pd Andrea Cozzolino.
Dalle prime evidenze
sui versamenti a favore della figlia di Panzeri, i pagamenti mensili in entrata
sarebbero più consistenti da parte della ong italiana, e di entità inferiore da
quella americana. […]
Sono due i conti
della famiglia Panzeri analizzati: uno, con un saldo di circa 40mila euro,
intestato ad Antonio Panzeri e alla moglie Maria Dolores Colleoni; l'altro della
figlia, con un saldo appunto di duecentomila euro. Proprio due giorni fa, il
tribunale del Riesame di Bergamo ha respinto la richiesta di revoca di sequestro
sui 240mila euro proposta dagli avvocati Angelo De Riso e Nicola Colli, sulla
base di asseriti vizi formali nel provvedimento con cui la procura di Bruxelles
ne aveva chiesto il congelamento. Una tesi che però non è stata accolta dal
tribunale. I conti restano sequestrati. […]
I magistrati
dovranno capire anche a che titolo erano effettuati i versamenti da No Peace
Without Justice. «Il rapporto professionale con l'avvocato Silvia Panzeri, oggi
interrotto, era stato instaurato dal dottor Figà Talamanca, che lo gestiva -
precisa l'avvocato della ong, Guido Camera - . In base agli elementi al momento
a disposizione dell'associazione No peace without justice non emerge in alcun
modo che i compensi percepiti dall'avvocato Panzeri abbiano rilevanza penale in
relazione ai fatti di corruzione e riciclaggio di cui si parla sui giornali.
Qualora le indagini in corso svelassero una realtà diversa, l'associazione ne
trarrà le dovute conseguenze». Hrf invece non ha risposto alla nostra richiesta
di chiarimenti.
Di fronte al giudice
istruttore di Bruxelles Michael Claise, Giorgi aveva invece ricostruito il
legame tra la Fight Impunity di Panzeri e la ong americana. Definendolo un
sistema malsano, il braccio destro di Panzeri aveva spiegato che era stato l'ex
europarlamentare del Pd a parlare della costituzione di una ong (appunto Fight
Impunity) per far arrivare il denaro, su suggerimento de "l'algerino", ovvero
Bettahar Boudjellal, emissario dei qatarini. […]
Le affermazioni di
Giorgi sono tutte da verificare, anche perché è lui stesso ad affermare di non
avere prove del fatto che il Qatar finanziasse la ong americana. Ma i riscontri
fatti sui conti della famiglia Panzeri sembrano muovere in questa direzione.
(AdnKronos il 17
gennaio 2022) - L'ex eurodeputato del Pd prima e di Articolo Uno poi Pierantonio
Panzeri si è pentito e ha accettato di collaborare con la giustizia belga
nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura federale belga per sospetta
frode all'interno del Parlamento Europeo.
Oggi, informa la
Procura, si è verificata una "importante evoluzione" nelle indagini. Panzeri,
uno dei "protagonisti importanti" del dossier, accompagnato dai suoi avvocati,
ha firmato un memorandum con il procuratore federale, in base ad alcuni articoli
del codice di procedura penale belga che riguardano i "pentiti".
Panzeri, accusato
di "aver partecipato ad una organizzazione criminale in qualità di dirigente, di
riciclaggio di denaro e di corruzione pubblica, attiva e passiva", si impegna
nel memorandum firmato oggi "ad informare la giustizia e gli inquirenti in
particolare sul modus operandi, gli accordi finanziari con Stati terzi, le
architetture finanziarie messe in atto, i beneficiari delle strutture messe in
atto e i vantaggi proposti, l'implicazione delle persone conosciute e di quelle
ancora non conosciute nel dossier, ivi inclusa l'identità delle persone che
ammette di aver corrotto".
(ANSA il 17 gennaio
2022) - L'ex eurodeputato in carcere per il Qatargate, Antonio Panzeri, avrebbe
confessato alla giustizia belga di aver versato a rate una somma tra i 120mila e
i 140mila euro al collega socialista Marc Tarabella.
E' quanto riportano
Corriere.it, ilfattoquotidiano.it e il belga L'Echo indicando che l'ammissione
sarebbe stata messa a verbale dall'ex eurodeputato di Articolo 1 lo scorso 10
dicembre. Panzeri avrebbe anche invitato a verificare la posizione
dell'europarlamentare dem Andrea Cozzolino, senza però indicare versamento di
denaro.
(AGI/AFP il 17
gennaio 2022) – L'accordo siglato tra l'ex eurodeputato Antonio Panzeri e la
procura federale belga prevede "una condanna a cinque anni, ma con sospensione
condizionale della pena per la parte eccedente un anno". Lo ha dichiarato ad Afp
l'avvocato di Panzeri, Laurent Kennes. "Subira' un anno di detenzione, parte del
quale sotto braccialetto elettronico", ha spiegato.
Panzeri si pente
e parla, l’accordo con i pm: «Un anno di carcere».
Francesca Basso e
Giuseppe Guastella su Il Corriere della Sera il 18 Gennaio 2023.
Per l’ex
europarlamentare la legge belga sui collaboratori. Aveva detto: «A Tarabella
oltre 120 mila euro pur di risolvere la questione»
Messo all’angolo da
accuse sempre più pesanti e con la drammatica prospettiva di una lunga
carcerazione anche per figlia e moglie, Antonio Panzeri decide di collaborare e
firma un accordo con la procura federale di Bruxelles in base alla legge sui
«pentiti» che lo obbliga a rivelare tutte le sue manovre, a chi ha dato i soldi
ricevuti da Qatar e Marocco e che gli garantisce appena un anno di carcere. «È
distrutto, depresso e vuole uscire dal tunnel», dice il suo legale, l’avvocato
Laurent Kennes.
La svolta comincia
ad intravedersi ieri mattina quando emerge che tra gli atti depositati al
Parlamento europeo dai pm per chiedere la rimozione dell’immunità che protegge
il deputato italiano Andrea Cozzolino ed il collega belga Marc Tarabella,
coinvolti nell’inchiesta, c’è un verbale in cui Panzeri confessa di aver
versato tra i 120 e i 140 mila euro in contanti a Tarabella perché lo aiutasse
nella questione Qatar. Molto legati, tifosi sfegatati dell’Inter, i due sono
stati insieme nel gruppo S&D dal 2004 al 2019, quando Panzeri non si ripresentò
alle elezioni per fondare la ong Fight impunity all’ombra della quale avrebbe
corrotto componenti dell’assemblea e loro collaboratori per favorire Qatar e
Marocco. Tarabella, che era stato sempre duro verso il mancato rispetto dei
diritti umani nel Paese del Golfo, il 14 novembre interviene nella
sottocommissione diritti umani e a sorpresa prende posizione a favore del Qatar
alla presenza del ministro del lavoro Ali Bin Samikh Al Marri che voleva evitare
a tutti i costi danni all’immagine del Paese a 6 giorni dal via ai Mondiali. Su
Cozzolino, invece, la richiesta fa solo qualche accenno all’accusa, uguale per
tutti, di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio. Di lui Francesco
Giorgi, arrestato con la compagna Eva Kaili, aveva detto che «era coinvolto con
il Marocco», cosa peraltro emersa dai contatti con l’ambasciatore di Rabat a
Varsavia e in relazione a un presunto incontro con il capo dei servizi
marocchini.
È la prima volta
dagli arresti che l’inchiesta fa un passo avanti così forte, ed è la prima
volta che Panzeri ammette di aver corrotto un deputato e con queste somme.
Quando ieri Panzeri arriva in cellulare nel palazzo di giustizia di Bruxelles,
rinuncia al riesame del suo arresto e chiede ai giudici di rinviare l’udienza
rimanendo in carcere un altro mese, è palese che qualcosa sta accadendo. La
notizia si materializza nel pomeriggio e viene confermata dalla nota della
Procura che annuncia che l’ex parlamentare ha deciso di pentirsi in base alla
legge conosciuta con il curioso nome italiano «Pentiti» (in riferimento alla
legge italiana antimafia, precisano i pm) applicata prima solo nel 2021 nella
Calciopoli belga con il pentimento dell’agente dei giocatori Dejan Veljkovic.
Panzeri e i suoi legali, Laurent Kennes e Marc Uyttendaele, firmano un
«memorandum» in cui l’ex eurodeputato si impegna a rivelare strategie criminali,
accordi finanziari, Paesi e persone coinvolte, incluse tutte quelle che «ammette
di aver corrotto», il che alza ulteriormente la temperatura nei corridoi del
Parlamento. Qui qualcuno potrebbe iniziare a temere, visto che il verbale sui
soldi a Tarabella è del 10 dicembre, il giorno dopo l’arresto. Da allora
potrebbe aver detto molte cose.
Oltre al carcere (o
braccialetto elettronico) per un anno, invece che una pena fino a 10 anni,
l’accordo prevede una multa di 80 mila euro, la confisca di tutti i beni
acquisiti con il denaro provento di reati che sono stimati in un milione di
euro, compresi i 600 mila sequestrati in contanti nella sua casa di Bruxelles.
Qatargate, Giorgi
rivela il viaggio in Qatar di Antonio Panzeri.
Il Tempo il 18
gennaio 2023
Un viaggio in Qatar
durante i Mondiali di calcio. Francesco Giorgi, marito di Eva Kaili ed ex
assistente parlamentare, ricostruisce le dinamiche che hanno consentito i
passaggi di denaro contestati all'ex europarlamentare Panzeri nello scandalo
Qatargate. «A inizio 2019, credo, Panzeri ritenne che, anziché prendere il
denaro in contanti, sarebbe stato preferibile creare una struttura giuridica in
cui avremmo potuto partecipare - soprattutto lui perché io avevo un lavoro - e
quindi gestire il flusso di denaro in un modo legale - ha detto Giorgi nelle
dichiarazioni contenute nel mandato d’arresto europeo eseguito nei confronti
della commercialista Monica Rossana Bellini - Per questo motivo Panzeri si
rivolse alla sua contabile. Monica Bellini, che a proposito andò in Qatar con
Panzeri durante i Mondiali di calcio. Una società di consulenza, Equality, venne
creata in Italia. La società forniva servizi per una compagnia con sede in
Inghilterra».
L'ex assistente
parlamentare fornisce anche dettagli preziosi sul ruolo di Silvia Panzeri, la
figlia dell'europarlamentare. «È stato il palestinese che suggerì di rivolgersi
a Hakan e alla sua compagnia in Inghilterra, di cui non ricordo il nome. Dal
momento che era coinvolta una società inglese, i documenti dovevano essere
preparati in inglese. Il mio ruolo fu quello di mettere Panzeri, sua figlia
Silvia e la sua contabile Monica Bellini (nessuno di loro parla inglese) in
contatto con Hakan)», ha messo ancora a verbale il marito dell’ex vicepresidente
dell’Europarlamento Eva Kaili. «Silvia - continua Giorgi - preparò le carte come
avvocato mentre io contribuii alla creazione di "Equality" con le mie conoscenze
linguistiche. Per giustificare l’uso di una compagnia italiana a una inglese, i
servizi dovevano essere fatti in Inglese. Quindi chiesi a conoscenti della mia
famiglia, che parlano in inglese, di fornire un aiuto concreto senza sapere cosa
stesse succedendo».
(ANSA il 18 gennaio
2023) - Antonio Panzeri è arrivato a firmare l'accordo di collaborazione con la
procura federale belga "in stato di vero e proprio shock emotivo" ed è pronto a
"dire tutta la verità e a contribuire all'efficacia dell'indagine".
Lo ha detto
all'ANSA Marc Uyttendaele, legale dell'ex eurodeputato in carcere per il
Qatargate, all'indomani del patteggiamento del politico socialista. Panzeri "è a
disposizione degli inquirenti a tutte le ore del giorno e della notte per
rispondere a tutte le loro domande", ha evidenziato l'avvocato, spiegando che il
suo assistito "spera che non accada nulla di doloroso" alla figlia e alla
moglie.
Il legale dell'ex
eurodeputato ha riferito di attendersi che i primi interrogatori di Panzeri si
tengano con tutta probabilità già nei prossimi giorni. Si tratterà di incontri
"confidenziali e riservati", ma il politico lombardo "intende di certo mantenere
l'impegno che ha preso" nei confronti della giustizia e "restare nel quadro
dell'accordo", ha spiegato Uyttendaele.
Il memorandum di
collaborazione dovrà tuttavia passare al vaglio anche della Camera di consiglio,
che a metà febbraio dovrebbe nuovamente esprimersi anche sulla custodia
cautelare del politico socialista. Ma il calendario per Panzeri è tutto da
definire sulla base dell'esito degli interrogatori.
"Panzeri ora è a
posto con se stesso, ciò che è successo è stato un vero shock per lui, che non
gli permetteva di avere una prospettiva sul futuro", ha evidenziato l'avvocato.
"E' chiaro - ha aggiunto - che l'accordo non migliorerà sostanzialmente la sua
posizione, al di là della pena ridotta a un anno, tuttavia gli permetterà di
fare ciò che intendeva fare, vale a dire non nascondere nulla sul dossier",
chiarendo i modi e le vie tramite le quali ha agito l'organizzazione criminale
alla quale ha ammesso di aver preso parte in modo attivo per influenzare le
decisioni politiche Ue su Qatar e Marocco, e "sapere cosa lo attende" nel suo
futuro.
Domani mattina alle
9, nel frattempo, toccherà all'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva
Kaili, comparire davanti alla Camera di consiglio per il riesame della sua
detenzione. Il legale della politica ellenica, Mihalis Dimitrakopoulos, è
partito questa mattina da Atene e in queste ore si trova a Bruxelles per
preparare l'udienza che avrà luogo al Palais de Justice.
Giovedì 26 gennaio
sarà invece il turno del compagno di Kaili e braccio destro di Panzeri,
Francesco Giorgi, mentre si attende ancora la conferma sulla data dell'udienza
della quarta persona arrestata, il responsabile della Ong No Peace Without
Justice, Niccolò Figà-Talamanca.
Estratto
dell’articolo di Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera” il 18 gennaio
2023.
[…] Spiega Panzeri:
«Alcuni parlamentari hanno appoggiato tali posizioni, ma per semplice
convinzione, e Giorgi ed io, qualche volta io da solo, qualche volta Giorgi, li
abbiamo invitati a una riflessione. Poi li consigliamo, diciamo loro che
"sarebbe utile..." ma non tutti sono d'accordo». Con Tarabella non basta. Lui «è
stato ricompensato più volte per un importo totale, a memoria, tra i 120 e i 140
mila euro. Il denaro è stato pagato in contanti».
Le banconote non
lasciano tracce. «Gli ho dato più volte denaro in contanti», «in luoghi diversi»
e in «sacchi (buste, ndr ) di carta», anche alla presenza di Giorgi. Un rapporto
corruttivo che Panzeri dice «cominciato due anni fa» quando con Giorgi chiese a
Tarabella «se fosse d'accordo a difendere certe posizioni, e se voleva poteva
disporre di diversi regali, incluso denaro».
Ogni volta erano di
«circa 20 mila euro» con consegne a «distanza di due o tre mesi, l'ultima sei
mesi fa». Sono le convinzioni passate improvvisamente da molto critiche a
«particolarmente elogiative» verso il Qatar e le condizioni «dei lavoratori
migranti» impegnati nelle opere dei mondiali a dirigere i sospetti su Tarabella.
Come quando afferma «che il dato di 6.500 morti (nei lavori, ndr ) sarebbe
ampiamente sovrastimato».
[…] Si cominciò con
il Marocco che era «molto importante» per Panzeri che lì aveva ricevuto la
Legion d'onore e aveva «molti amici». Giorgi conferma «l'accordo» con Abderrahim
Atmoun, ambasciatore di Rabat a Varsavia considerato il tramite con i servizi
segreti marocchini che «ha un po' lo stesso ruolo del ministro del Qatar. Le
discussioni vertevano sul controllo dei dibattiti in Parlamento, in particolare
gli attacchi dell'Algeria e le questioni geopolitiche tese».
Estratto
dell’articolo di Gabriele Rosana per il Messaggero il 18 gennaio 2023.
I nomi e i dettagli
del Qatargate in cambio di un importante sconto di pena. Pier Antonio Panzeri si
è pentito. L'ex eurodeputato lombardo e fondatore della ong Fight Impunity, al
centro dello scandalo delle euro-tangenti per cui si trova da oltre un mese in
custodia cautelare, ha deciso di collaborare con gli inquirenti belgi.
(...)In realtà,
contro l'ex sindacalista «sarà pronunciata una condanna a cinque anni, ma con
sospensione della pena per la parte eccedente un anno», ha spiegato a sera uno
dei due avvocati dell'ex europarlamentare, Laurent Kennes, interpellato
dall'Afp: Pier Antonio Panzeri «sconterà un anno di detenzione, parte del quale
con la modalità del braccialetto elettronico».
È solo la seconda
volta nella storia giudiziaria del Belgio, si legge in una nota della Procura,
che un procedimento penale si chiude con l'applicazione della cosiddetta legge
sui pentiti (introdotta sull'esempio della normativa italiana anti-mafia).
(...)
In un verbale
d'indagine risalente al 10 dicembre scorso (il giorno dopo l'arresto che diede
il via al caso) e allegato alla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare
degli eurodeputati socialisti Marc Tarabella e Andrea Cozzolino, Panzeri avrebbe
spiegato agli inquirenti di aver dato «un importo, a memoria, di 120-140mila
euro in contanti all'esponente belga in cambio del suo aiuto sul dossier Qatar».
La consegna delle somme a Tarabella sarebbe cominciata due anni fa e «avveniva
in luoghi diversi. Il denaro si trovava in sacchi di carta». Panzeri avrebbe poi
invitato a verificare la posizione di Cozzolino, senza però indicare consegne di
denaro. Nel resoconto fatto agli inquirenti, ha spiegato che «cercavamo
parlamentari che fossero disponibili ad appoggiare posizioni in favore del
Qatar». Il coinvolgimento dei due sarebbe confermato dalla versione fornita agli
inquirenti da Francesco Giorgi, braccio destro dell'ex sindacalista. Panzeri,
invece, tira fuori l'eurodeputata belga Maria Arena: «Lei non c'entra niente».
(...)
(AGI il 18 gennaio
2023) - Anche la commercialista della famiglia Panzeri, Monica Rossana Bellini,
è stata arrestata in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalle
autorità belghe nell'ambito dell'inchiesta Qatargate.
Il provvedimento è
stato eseguito ieri dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di
Finanza. La donna, accusata di associazione per delinquere, corruzione e
riciclaggio, è stata portata in carcere in attesa dell'udienza di convalida
davanti alla quinta sezione penale della Corte di appello del capoluogo
lombardo.
(AGI il 18 gennaio
2023) - Lo studio della professionista cinquantacinquenne a Opera (Milano) era
stato già perquisito ai primi di dicembre dai finanzieri, su delega del
procuratore aggiunto Fabio De Pasquale del pool Affari internazionali,
nell'ambito dell'ordine di investigazione europeo arrivato a Milano dal Belgio.
Una perquisizione - da quanto appreso in ambienti investigativi - che aveva dato
esito negativo.
Euro-tangentopoli: Panzeri comincia a collaborare e fa tremare il Parlamento
europeo.
Giorgia Audiello su L'Indipendente il 19 gennaio 2023.
Antonio Panzeri, uno
degli attori chiave dello scandalo Qatargate riguardante le presunte mazzette
pagate da Qatar e Marocco ad alcuni eurodeputati, ha deciso di pentirsi e
collaborare con la giustizia belga, firmando un memorandum con la procura
federale di Bruxelles in base alla legge «Pentiti», assistito dai suoi legali.
Accusato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, in qualità di
capogruppo, riciclaggio di denaro e corruzione attiva e passiva, l’ex
eurodeputato socialista dovrà quindi collaborare con le autorità rivelando
l’impianto e il modus operandi alla base del meccanismo di tangenti e corruzione
che ha coinvolto il Parlamento europeo. In cambio otterrà uno sconto di
pena pari a un solo anno di reclusione – invece che dieci – in aggiunta ad
un’ammenda e alla confisca di tutti i vantaggi patrimoniali acquisiti, valutati
al momento intorno al milione di euro. Tanto basta per far tremare gli ambienti
politici di Bruxelles, dove molti più eurodeputati di quelli emersi fino ad ora
potrebbero essere coinvolti nello scandalo.
La procura ha
accolto la decisione dell’ex eurodeputato di Articolo 1 definendola «una
importante evoluzione» nelle indagini: Panzeri ha spiegato ai giudici che
«l’iniziativa portava avanti in Parlamento era un’iniziativa di lobbying e
ovviamente cercavamo dei parlamentari che fossero disponibili ad appoggiare
certe posizioni in favore del Qatar. In questo quadro alcuni parlamentari hanno
appoggiato tali posizioni per semplice convinzione e io e Giorgi, a volte io da
solo, qualche volta Giorgi, li abbiamo invitati a una riflessione su queste
posizioni». La svolta decisiva nelle indagini è arrivata con un verbale –
risalente allo scorso 10 dicembre – in cui Panzeri confessa di aver versato tra
i 120 e i 140 mila euro all’amico e collega socialista Marc Tarabella perché lo
aiutasse sulla questione Qatar. Il verbale, insieme ad altre dichiarazioni, è
stato utilizzato dagli inquirenti per chiedere la revoca dell’immunità dello
stesso Tarabella e dell’eurodeputato Andrea Cozzolino, coinvolto con il Marocco.
Panzeri ha detto di aver dato più volte il denaro in contanti a Tarabella:
«talvolta ero accompagnato da Giorgi Francesco. Consegnavo il denaro a Tarabella
in luoghi diversi. Il denaro si trovava in sacchi di carta. È cominciato due
anni fa», ha confessato l’ex sindacalista. Il tutto era finalizzato a promuovere
il supposto miglioramento del Qatar sul tema dei diritti umani, in cambio di
mazzette, appena prima dei Mondiali nel Paese del Golfo. Tarabella, che era
sempre stato duro nei confronti dell’emirato arabo sul rispetto dei diritti
umani, il 14 novembre avrebbe preso parte alla sottocommissione “diritti umani”,
schierandosi a sorpresa a favore del Qatar, alla presenza del ministro del
lavoro Ali Bin Samikh Al Marri che voleva evitare danni all’immagine del Paese
ad appena sei giorni dall’inizio dei Mondiali.
Per quanto riguarda
Cozzolino, invece, la richiesta di revoca dell’immunità si basa sull’accusa,
uguale per tutti, di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio. L’ex
assistente di Panzeri, Francesco Giorgi, ha dichiarato che «Cozzolino era
coinvolto con il Marocco, aveva dei contatti con Atmoun (Abderrahim Atmoun,
ambasciatore marocchino in Polonia e, secondo le indagini, ponte tra il gruppo
al Parlamento Ue e i servizi segreti di Rabat, nda) grazie a Panzeri. Panzeri
era il presidente della commissione Maghreb, poi ha passato il testimone a
Cozzolino. Prendeva delle cravatte o degli abiti. Panzeri ne prendeva anche dopo
questo passaggio di testimone. Non conosco gli importi esatti ma sono inferiori
a quelli del Qatar, si parla di qualche decina di migliaia di euro». Anche
quest’ultima dichiarazione è stata inserita nella richiesta di revoca
dell’immunità dell’eurodeputato. Giorgi, inoltre – arrestato con la compagna ed
ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili – ha spiegato che Panzeri
aveva diversi agganci in Marocco dove aveva ricevuto anche la Legione d’onore.
La prossima
udienza per il riesame della custodia cautelare di Panzeri – in carcere dal 9
dicembre scorso – dovrebbe tenersi entro un mese, cioè a febbraio, come
precisato dalla procura federale belga, spiegando che il politico resterà in
carcere almeno fino a quel momento. La prima riunione della commissione
giuridica dell’Eurocamera sulla procedura di revoca delle immunità per Andrea
Cozzolino e Marc Tarabella, invece, si terrà il 23 gennaio a Bruxelles, a porte
chiuse. La decisione di Panzeri di collaborare con la giustizia potrebbe essere
legata anche alla prospettiva di una lunga carcerazione per la moglie e la
figlia, Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, accusate anch’esse di essere
coinvolte nel sistema di corruzione e al momento agli arresti domiciliari. La
Corte d’appello di Brescia ha dato il primo via libera per la loro consegna al
Belgio. La collaborazione di uno dei principali architetti del sistema di
corruzione con le autorità giudiziarie potrebbe altresì allargare lo scandalo se
l’ex eurodeputato facesse emergere nuovi fatti e nuovi nomi nell’inchiesta.
Motivo per cui più di qualche eurodeputato a Bruxelles potrebbe non dormire
sonni tranquilli. [di Giorgia Audiello]
Convalidato
arresto ai domiciliari di Monica Rossana Bellini, la commercialista di Panzeri.
I due insieme in Qatar durante i mondiali di calcio.
Redazione CdG 1947
su Il Corriere del Giorno il 18 Gennaio 2023.
La richiesta partita
dai magistrati belgi che indagano sul caso di corruzione all'Europarlamento. La
professionista era stata portata in carcere a San Vittore a Milano. Tanti gli
incarichi in società partecipate anche del Comune di Milano
Monica Rossana
Bellini la commercialista della famiglia Panzeri, è stata arrestata dal nucleo
di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e
dall’aliquota di polizia giudiziaria delle Fiamme Gialle, su esecuzione di un
mandato di arresto europeo emesso dai magistrati belgi nell’inchiesta sul
Qatargate, che aveva portato all’arresto tra gli altri dell’ex
eurodeputato Antonio Panzeri. Il Gip del Tribunale di di Milano Roberto
Arnaldi nel pomeriggio ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per la
commercialista Bellini che risponde delle accuse di “associazione per
delinquere, corruzione e riciclaggio“.
La Bellini titolare
dello studio di commercialista in via Martiri di Belfiore 7 a Opera, ha un
curriculum da cui risultano moltissimi incarichi come revisore dei conti in
società a partecipazione pubblica e in diversi comuni dell’hinterland:
da Milanosport ad Atm e Sogemi, passando per i comuni di Pieve Emanuele,
Buccinasco, Peschiera Borromeo. Bellini risulta sindaco effettivo in alcune
società che fanno riferimento all’Eni: Eni Angola spa ed Eni Fuel spa. Ha anche
un ruolo da presidente del cda di Assemi (Azienda Sociale Sud Est Milano).
La commercialista
assistita dagli avvocati Liliana Crescimanna e Franca De Candia, , su richiesta
sempre della magistratura di Bruxelles nelle scorse settimane era già stata
perquisita dalla Guardia di Finanza coordinata dal procuratore aggiunto Fabio De
Pasquale. “Monica Rossana Bellini – è l’accusa mossa alla commercialista
contenuta nel formulario del mandato d’arresto europeo – sembra aver avuto un
importante ruolo nel rientro del denaro contante proveniente
dal Qatar attraverso la creazione, insieme a Silvia Panzeri, la figlia di Pier
Antonio, di una rete di società che avrebbero dato al flusso di denaro un
aspetto legale“.
Sempre nel
formulario del mandato d’arresto europeo eseguito a carico della Bellini si
legge che , la commercialista della famiglia Panzeri, “andò in Qatar con l’ex
eurodeputato durante i Mondiali di calcio”, come ha messo a verbale davanti ai
magistrati belgi l’ex collaboratore di Panzeri, Francesco Giorgi. Le
contestazioni sono relative a movimenti finanziari effettuati attraverso una
serie di strutture societarie a lei riconducibili. Tra queste società al centro
di questo filone di indagine c’è soprattutto la Equality Consultancy srl fondata
nel dicembre 2018 e che aveva come soci di maggioranza il padre e il fratello
di Francesco Giorgi, ex collaboratore dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri,
anche lui arrestato dal giudice belga Michel Claise. Mentre la
commercialista Monica Rossana Bellini , 55 anni, consulente della
famiglia Panzeri, deteneva una quota di minoranza. La società era stata
formalmente creata per “sviluppare rapporti tra ong, imprese e controparti nei
Paesi terzi”.
Basandosi sugli atti
dell’indagine belga nello stesso periodo sarebbe stata costituita un’altra
società simile in Estonia sempre dalla Bellini insieme alla famiglia Giorgi. Per
la magistratura di Bruxelles, come già emerso nel corso dell’indagine
, Bellini si sarebbe occupata della “consulenza gestionale e
finanziaria” di Panzeri e della moglie, mettendo in atto, sarebbe questo il
sospetto agli atti, “operazioni di riciclaggio” attraverso alcune società.
La Procura di
Milano chiederà all’aliquota di polizia giudiziaria della Gdf di compendiare nei
prossimi giorni in un’annotazione tutte le risultanze investigative finora
acquisite sulla base delle attività delegate dalla magistratura belga che indaga
sullo scandalo Qatargate. Sulla base del resoconto dei finanzieri – da quanto
appreso – non si esclude l’apertura di un fascicolo autonomo a Milano. La svolta
potrebbe arrivare dall’arresto della commercialista Monica Rossana
Bellini ‘ideatrice’ – secondo l’ipotesi investigativa del giudice istruttore di
Bruxelles Michel Claise – della rete di società su cui la famiglia Panzeri e
l’ex assistente parlamentare Francesco Giorgi avrebbero fatto transitare le
somme provento della corruzione del Paese del Golfo e del Marocco.
Un elemento che
potrebbe delineare profili di riciclaggio differenti da quelli contestati in
Belgio. Nel frattempo la prossima settimana è previsto un incontro a Milano tra
gli investigatori di Bruxelles con i colleghi italiani per fare un punto
sull’inchiesta che sta scuotendo l’Europarlamento e anche per effettuare le
copie forensi dei dispositivi informatici sequestrati agli indagati italiani lo
scorso dicembre nell’ambito dell’ordine di investigazione europeo. Dal Nazareno
quartier generale del PD tutto tace … Redazione CdG 1947
Qatar, arrestata
la commercialista di Panzeri: "Era lei a far transitare tutte le tangenti".
Pronto a "dire tutta la verità", "a disposizione degli inquirenti a tutte le ore
del giorno e della notte per rispondere a tutte le loro domande". Luca Fazzo il
19 Gennaio 2023 su Il Giornale.
Pronto a «dire tutta
la verità», «a disposizione degli inquirenti a tutte le ore del giorno e della
notte per rispondere a tutte le loro domande». É l'annuncio di una resa senza
condizioni quello che l'avvocato di Antonio Panzeri, ex eurodeputato del Partito
democratico, rende noto ieri pomeriggio. Nella cella dove è rinchiuso dal 9
dicembre, Panzeri ha già vuotato parte del sacco e continuerà a farlo, in cambio
della promessa di cavarsela con un anno di carcere. La sensazione che ormai la
diga sia rotta viene confermata da quanto accade nelle stesse ore a Milano: dove
la commercialista Monica Rossana Bellini, anche lei di area dem, che per anni ha
gestito gli affari occulti di Panzeri viene arrestata su richiesta di Bruxelles,
portata a San Vittore, interrogata e subito mandata ai domiciliari.
Anche la donna
avrebbe dunque scelto di «chiarire» con gli inquirenti quanto accaduto intorno a
Equality consultancy, la società fondata dai genitori di Francesco Giorgi,
all'epoca assistente parlamentare di Panzeri: e divenuta, secondo il mandato di
cattura internazionale, il veicolo di riciclaggio dei fondi illeciti. Ad
accusare la Bellini è stato proprio Francesco Giorgi, al cui padre era
inizialmente intestata la srl: è lei, ha detto, «l'artefice della rete
societaria» di Panzeri. L'arresto della Bellini appare destinato ad aprire un
nuovo fronte: se il canale di riciclaggio delle tangenti passava per Milano,
l'apertura di una inchiesta autonoma anche da parte della Procura del capoluogo
lombardo appare inevitabile.
La genesi della
Equality consulting racconta bene che lo sbarco nel grande affare del lobbying
iniziò quando Antonio Panzeri era ancora parlamentare europeo: la fondazione
risale al dicembre 2018, pochi mesi prima il rinnovo dell'assemblea di
Strasburgo. Il brillante ex sindacalista bergamasco si stava dunque già
preparando una seconda vita, remunerativa quanto e più la carica di deputato.
L'asset principale
di Panzeri erano le relazioni cucite per dodici anni all'interno del gruppo
parlamentare di sinistra, i Socialisti&Democratici: ed è lì, tra compagni ed ex
compagni di Panzeri, che oggi in tanti guardano con ansia alle rivelazioni
dell'arrestato. Il socialista belga Marc Tarabella è la prima vittima del
pentito, i 120mila euro in contanti di cui parla Panzeri rendono ovvia la revoca
dell'immunità parlamentare e quasi certo l'arresto. «Falsità, Panzeri parla in
cambio di qualcosa», dice ieri il legale di Tarabella. Ma è un clima un po' alla
Mani Pulite, in cui rischia di partire la corsa a chi si pente per primo e di
più.
Panzeri, dice il suo
legale Marc Uyttendaele, ha deciso di parlare trovandosi «in stato di vero e
proprio shock emotivo che non gli permetteva di avere una prospettiva sul
futuro», «ora è a posto con se stesso», «spera che non accada nulla di doloroso
alla figlia e alla moglie». Modo elegante per dire che nell'accordo stretto con
il procuratore federale Frédéric Van Leeuw c'è anche la richiesta di un
trattamento soft anche per le due familiari di Panzeri, tuttora in attesa di
estradizione verso il Belgio.
C'è chi dalle
confessioni di Panzeri conta di essere scagionato: come Marie Arena, la
socialista belga che il neo-pentito avrebbe già riabilitato («la considera una
persona estremamente retta», dice il legale). Ma sono di più quelli che
preferirebbero stesse zitto.
Chi è la
commercialista di Panzeri e perché è coinvolta nel caso corruzione del Qatar.
YOUSSEF HASSAN HOLGADO su Il Domani il 19 gennaio 2023.
«Sembra aver svolto
un ruolo importante nel rimpatrio del denaro contante dal Qatar creando, insieme
a Silvia Panzeri, figlia di Pier Antonio (l’ex eurodeputato considerato il capo
dell’organizzazione ndr.), una struttura di società che desse al flusso di
denaro una veste legale», scrivono gli inquirenti belgi.
Sospettano che sia
implicata nel riciclo del denaro ottenuto da Panzeri da Qatar e Marocco.
Ha avuto decine di
ruoli da consulente all’interno di diversi enti comunali del nord Italia, oltre
a due incarichi per l’Eni.
Emergono nuovi
dettagli sulla rete di corruzione all’interno del parlamento europeo finanziata
dal Marocco e dal Qatar. Nel mandato di arresto nei confronti della
commercialista Monica Rossana Bellini si legge che la donna «sembra aver svolto
un ruolo importante nel rimpatrio del denaro contante dal Qatar creando, insieme
a Silvia Panzeri, figlia di Pier Antonio (l’ex eurodeputato considerato il capo
dell’organizzazione ndr.), una struttura di società che desse al flusso di
denaro una veste legale».
A supportare la tesi
degli inquirenti è l’interrogatorio di Francesco Giorgi, compagno dell’ex
vicepresidente del parlamento europeo Eva Kaili ed ex collaboratore di
Panzeri. «All’inizio del 2019, credo, Panzeri ha pensato che, invece di prendere
i contanti, sarebbe stato preferibile creare una struttura legale all’interno
della quale avremmo potuto partecipare – soprattutto lui, perché io avevo il mio
lavoro – e quindi gestire il flusso di denaro in modo legale. Per questo Panzeri
si è rivolto alla sua commercialista, Monica Bellini, che tra l’altro era andata
in Qatar con Panzeri durante i mondiali», dice Giorgi spiegando il sistema di
riciclaggio messo in piedi.
«È stata creata una
società di consulenza, Equality, in Italia. Essa forniva servizi a una società
con sede in Inghilterra. Fu il palestinese a suggerire di rivolgersi a Hakan e
alla sua società inglese, di cui non ricordo il nome. Poiché si trattava di una
società inglese, era necessario preparare documenti in inglese. Il mio
coinvolgimento fu quello di mettere in contatto Panzeri, la sua commercialista
Monica Bellini e sua figlia Silvia Panzeri (nessuno dei quali parlava inglese)
con Hakan. Silvia ha preparato i casi come avvocato, io ho contribuito alla
creazione di Equality sulla base delle mie conoscenze linguistiche. Per
giustificare l’utilizzo di un'azienda italiana da parte di una inglese, i
servizi devono essere forniti in inglese».
Per il momento la
Corte d’appello di Brescia ha deciso di dare il via libera per l’estradizione in
Belgio di Silvia Panzeri.
CHI È LA
COMMERCIALISTA
Il curriculum vitae
di Monica Rossana Bellini è lungo diverse pagine. Ha avuto decine di ruoli da
consulente all’interno di diversi enti comunali del nord Italia, oltre a due
incarichi per l’Eni. Il primo, nell’aprile del 2016 quando ha avuto un ruolo nel
collegio sindacale di Eni Angola. Il secondo incarico, invece, è di aprile 2019
con un ruolo all’interno di Eni Fuel Spa.
Dal 1994 al 2005 è
stata assessore tecnico al Bilancio di Finanze e contenzioso presso il Comune di
Pieve Emanuele.
YOUSSEF HASSAN
HOLGADO
Estratto
dell'articolo di Giacomo Amadori e Francois De Tonquedec per “La Verità” il 19
gennaio 2023.
Nel Qatargate è
finita in manette anche quella che abbiamo chiamato la «commercialista dei
misteri» e che per molti giorni è stata una pista seguita solo da questo
giornale. Ieri è stata arrestata la ragioniera di Opera Monica Rossana Bellini.
[…]
Le accuse
contestate alla Bellini, che rischia fino a 10 anni di carcere, sono
associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Reati che per la Procura
di Bruxelles sarebbero stati commessi tra l'1 gennaio 2018 e, addirittura, il 26
dicembre 2022, quando lo scandalo era già scoppiato e la donna era stata già
perquisita in veste di indagata.
Secondo la
richiesta di arresto e di estradizione emessa il 16 gennaio, «la signora Bellini
Monica Rossana sembra aver svolto un ruolo importante nel rimpatrio del contante
dal Qatar creando, insieme a Silvia Panzeri, figlia di Pier Antonio, una
struttura di società che desse al flusso di denaro una veste lecita».
Le accuse si basano
su una dichiarazione resa da Francesco Giorgi, ex assistente al Parlamento di
Bruxelles del già arrestato eurodeputato Pier Antonio Panzeri (i due sono stati
entrambi arrestati e si trovano attualmente in carcere): «All'inizio del 2019,
credo, Panzeri ha pensato che, invece, di prendere contanti sarebbe stato
preferibile creare una struttura giuridica all'interno della quale avremmo
potuto avere una partecipazione - principalmente lui, perché io avevo il mio
lavoro - e quindi gestire il flusso di denaro in modo legale.
Per questo Panzeri
si è rivolto alla sua commercialista, Monica Bellini, che tra l'altro è andata
in Qatar con Panzeri durante i mondiali (come già rivelato dalla Verità, ndr).
Una società di consulenza, Equality, è stata fondata in Italia. Ha fornito
servizi per una società con sede in Inghilterra».
Qui torna
d'attualità il ruolo di un misterioso «palestinese» e del suo gancio in Gran
Bretagna, un certo Hakan. La catena di complici era stata rivelata sempre da
Giorgi a dicembre. Il primo anello sarebbe stato un uomo che lavorava per il
Qatar di nome Boudjellal e conosciuto come «l'algerino».
Questi avrebbe
spinto Panzeri a fondare la sua Ong, la Fight impunity. In Turchia avrebbe messo
in contatto Giorgi con una persona «di origine palestinese». Quest' ultimo
avrebbe consegnato, di volta in volta, numeri di telefono belgi di soggetti da
chiamare «per avere i soldi».
Nel documento
stilato il 16 gennaio dalle autorità belghe il racconto dell'ex assistente
prosegue: «Fu il palestinese a suggerire di rivolgersi ad Hakan e alla sua
compagnia in Inghilterra, di cui non ricordo il nome. Essendo stata coinvolta
una società inglese, i documenti dovevano essere preparati in inglese. Il mio
coinvolgimento è consistito nel mettere in contatto Panzeri, la sua
commercialista Monica Bellini e sua figlia Silvia Panzeri (nessuna delle quali
parlava inglese) con Hakan. Silvia ha preparato i casi come avvocato.
Ho anche
contribuito alla creazione di Equality sfruttando le mie conoscenze
linguistiche. Per giustificare l'utilizzo di una società italiana da parte di
una inglese, i servizi devono essere forniti in inglese. Pertanto, ho chiesto a
conoscenti della mia famiglia che parlano inglese di fornire servizi concreti,
senza che sapessero cosa stesse succedendo». Dunque lo schermo per far girare i
soldi sporchi provenienti da Qatar e Marocco sarebbe stata una srl […]
[…] questo giornale
aveva raccontato in esclusiva, il 19 dicembre, la genesi della Equality
consultancy srl, costituita Il 28 dicembre 2018, cinque mesi prima delle
elezioni europee del 2019, con sede legale a Opera, in provincia di Milano,
proprio nello studio della commercialista. Ma nella compagine azionaria non
compariva Panzeri bensì Luciano Giorgi, il babbo di Francesco.
[…] Nel suo primo
anno di attività la Equality ottiene risultati lusinghieri sebbene nessuno dei
soci sembri avere competenze nel settore di attività. A fine 2019 il valore
della produzione è di 240.000 euro e l'utile di esercizio è di 102.500 euro. Ma
quando quel bilancio viene chiuso, i due Giorgi hanno già ceduto le loro quote.
Lo hanno fatto il 23 luglio 2019, quando si è già svolta la prima assemblea
plenaria del Parlamento europeo con Panzeri fuori dai giochi.
Una fetta del 15
per cento era passato alla Bellini, mentre il 40% era andato a un barista di
origine slovena, Manfred Forte. Quest'ultimo altri non era che il compagno della
figlia di Panzeri, Silvia, recentemente estradata in Belgio. Il 18 novembre 2020
la società, con i conti ormai in rosso, viene messa in liquidazione, compito
affidato alla Bellini, e l'8 giugno del 2021 viene chiusa definitivamente.
Il 20 dicembre
scorso abbiamo svelato il particolare curriculum della Bellini e i suoi
incarichi in aziende pubbliche tutte probabilmente ottenute anche grazie ai suoi
ottimi rapporti con la politica di centrosinistra (è stata pure assessore in una
giunta a guida Pds). […]
Dopo pochi giorni,
il 27 dicembre, rivelammo ai nostri lettori l'esistenza di una società gemella
(e omonima) della Equality consultancy, fondata, però, in Estonia, il 6
settembre 2018. Dopo le elezioni per il Parlamento di Bruxelles, il 18 giugno
2019, anche l'assemblea della ditta baltica deliberò lo scioglimento e il 15
aprile 2020 venne cancellata dal registro. […]
Estratto
dell'articolo di Monica Serra per “La Stampa” il 19 gennaio 2023.
Quando martedì sera
la Guardia di finanza è tornata a bussare alla porta del suo studio a Opera,
Monica Rossana Bellini era ancora al lavoro. Su mandato europeo appena spiccato
da Bruxelles, la ragioniera cinquantacinquenne con un curriculum eccellente è
stata arrestata per organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio.
«Sembra aver
giocato un importante ruolo nel rimpatrio dei soldi dal Qatar», si legge nel
provvedimento firmato dal giudice Michel Claise. Che l'accusa di aver creato,
insieme a Silvia Panzeri, la figlia dell'ex eurodeputato socialista al centro
del Qatargate «una struttura societaria che doveva dare al flusso di denaro una
veste legale».
Il primo a tirare
in ballo nel sistema la consulente, che per trent'anni ha collezionato incarichi
importanti nei collegi sindacali delle municipalizzate milanesi, e non solo,
come Milanosport, Afol e Sogemi, è stato l'ex assistente parlamentare di
Panzeri, Francesco Giorgi.
[…] in mano ai
magistrati milanesi c'è molto di più. […] l'apertura di un fascicolo autonomo
per riciclaggio sembra imminente.
«A inizio 2019,
Panzeri ha pensato che invece di continuare a prendere soldi cash, sarebbe stato
preferibile creare una struttura giuridica in cui avremmo potuto partecipare -
soprattutto lui, perché io avevo un lavoro - e quindi gestire il flusso di
denaro in una maniera legale». Almeno all'apparenza. Come ha ricostruito
Francesco Giorgi davanti alla polizia federale belga, fu questo il motivo per
cui «Panzeri decise di coinvolgere la sua consulente, Monica Bellini». […]
Così, con l'aiuto di
Bellini, finita ai domiciliari dopo la convalida dell'arresto e una notte nel
carcere di San Vittore, «una società di consulenza, Equality, fu creata in
Italia». E qui Giorgi racconta come, attraverso una società inglese, i soldi del
Qatar venissero triangolati per essere ripuliti facendo il nome di un, non
meglio precisato, Hakan.
Equality, spiega
Giorgi, «forniva servizi per una compagnia con sede in Inghilterra. È stato il
palestinese che suggerì di rivolgerci ad Hakan e alla sua compagnia in
Inghilterra, di cui non ricordo il nome». […]
La professionista
vicina al Pd che a Milano colleziona incarichi. "Ora Sala spieghi".
Qualcuno
la chiama già "la compagna B", vista la ridda di incarichi pubblici che le forze
politiche di sinistra le avevano attribuito. Felice Manti il 19 Gennaio 2023 su
Il Giornale.
Qualcuno la chiama
già «la compagna B», vista la ridda di incarichi pubblici che le forze politiche
di sinistra le avevano attribuito. Rischia di travolgere il Pd milanese e il
sindaco Giuseppe Sala la vicenda della commercialista milanese Monica Rossana
Bellini, arrestata ieri dal Nucleo di polizia economico finanziaria della
Guardia di Milano su mandato di arresto europeo emesso dai magistrati di
Bruxelles nell'inchiesta ribattezzata Qatargate con l'accusa di associazione per
delinquere, corruzione e riciclaggio.
Visto il suo
curriculum è difficile dire che fosse soltanto la commercialista dell'ex
eurodeputato Antonio Panzeri, che si sarebbe rivolto alla professionista- questa
è l'ipotesi degli inquirenti confermata da alcune rivelazioni degli indagati -
perché invece di prendere soldi cash serviva una struttura giuridica e gestire
il flusso di denaro in modo legale.
Spulciando il suo
curriculum saltano fuori una quarantina di incarichi nelle società comunali o
partecipate, di cui una decina ancora in corso, da Milano Sport a Afol
Metropolitana: la Bellini era componente in quota Pd del Collegio sindacale di
SCC Srl, Azienda Ospedaliera Guido Salvini, Fondazione Pontirolo, F.I.D.A.S e
Sogemi Spa e anche presidente del Collegio sindacale di Amiacque Srl e Ama Spa,
del Comune di Pieve Emanuele (di cui era assessore). «Perché i democratici
continuano a far finta di niente e, addirittura, a non conoscerla più? Sala non
ha nulla da dire?», si chiede Fratelli d'Italia con Riccardo De Corato. Enrico
Marcora venti giorni fa aveva presentato un'interrogazione, rimasta lettera
morta, sin da quando la professionista era stata perquisita lo scorso dicembre
dalla Gdf.
La responsabilità
penale riguarda i magistrati ma questi soldi sono finiti in campagna elettorale?
Hanno per caso inciso nei rapporti con il mondo islamico e Israele? Sul
territorio ci sono state delle distorsioni? «Siamo garantisti, e proprio perché
lo siamo chiediamo che la politica parli. Se fossero tre nomine si potrebbe dire
che era vicina al Pd, ma con 40 incarichi si può dire che è il Pd...», dice al
telefono Manfredi Palmeri, consigliere comunale della lista Moratti in corsa al
Pirellone. Anche la Lega con il capogruppo Alessandro Verri vuole vederci chiaro
e punta il dito sul Pd. Al telefono un consigliere comunale dem - che preferisce
l'anonimato - dice che il suo curriculum era sufficientemente ricco da
garantirle tutti questi incarichi: «Non credo ci fosse qualcuno dietro di lei,
certamente queste storture rischiano di danneggiarci in campagna elettorale se
non facciamo chiarezza». Qualcuno ricorda i suoi rapporti con un importante
consigliere Pd della Provincia «ma non credo fosse il suo burattinaio», dice una
fonte dentro Forza Italia che conosce le dinamiche interne agli incarichi a
Palazzo Marino: «Tecnicamente è decaduta da questi incarichi, immagino si
dimetterà, anche se le società devono prendere provvedimenti». Vedremo.
Anche l'Ordine dei
Commercialisti ha preso le distanze: «Abbiamo attivato tutte le procedure
previste in queste situazioni con la apertura del fascicolo disciplinare - dice
al Giornale la presidente Marcella Caradonna - in queste situazioni appare con
evidenza come l'iscrizione all'Ordine sia un importante presidio di legalità».
Al Consiglio di disciplina dell'Ordine bocche cucite: non ci sarebbero
precedenti ma il fascicolo sarebbe già aperto.
Cozzolino si
autosospende dai socialisti Ue. Ma ora l'inchiesta piomba sul congresso dem.
Rimossa la Kaili, il Pse si riprende la vicepresidenza a Strasburgo. È bufera.
Pasquale Napolitano il 19 Gennaio 2023 su Il Giornale.
Il fantasma di
Antonio Panzeri si aggira nelle stanze del Nazareno. Il Qatargate piomba come
una bomba sul congresso Pd. Bonaccini, Schlein e De Micheli non ne parlano.
Dribblano l'argomento. É un nervo scoperto. Ma lo scandalo, tutto interno alla
sinistra italiana ed europea, rischia di travolgere i democratici. Soprattutto
dopo la decisione di Panzeri, perno del sistema corruttivo tra gli emissari del
Qatar e i politici, di collaborare gli inquirenti belgi. Quei verbali potrebbero
far tremare il Pd. Partito nel quale Panzeri, anche dopo il passaggio ad
Articolo Uno, continuava a tenere relazioni. Trema quel pezzo della sinistra
italiana, da D'Alema a Cozzolino, che ha avuto rapporti con l'ex
europarlamentare al centro dell'inchiesta. I vertici del partito democratico si
limitano a parole di circostanza. L'imbarazzo si percepisce. E si teme la
slavina. Nel frattempo i socialisti si tengono stretta la poltrona della
vicepresidenza dell'Europarlamento precedentemente occupata da Eva Kaili,
rimossa dall'incarico in seguito al coinvolgimento nello scandalo Qatargate.
L'eurodeputato
lussemburghese Marc Angel (S&D) è stato eletto ieri con 307 voti favorevoli -
vicepresidente. Annalisa Tardino (Lega) ha ricevuto 185 voti, e Gwendoline
Delbos-Corfield (Verdi) 98 voti. Il Carroccio si ribella: «È sconcertante quanto
successo all'Europarlamento: dopo lo scandalo che ha travolto il Pd e i suoi
alleati socialisti, al posto dell'arrestata Kaili è stato eletto un altro
socialista come vicepresidente che si aggiunge ad altri quattro dello stesso
schieramento. A sinistra usano le istituzioni europee come il Qatar: arraffano e
pretendono tutto il possibile. È il sistema che difende se stesso». Il
vicepremier Matteo Salvini attacca: «Dalla socialista Kaili al socialista Angel.
Dopo lo scandalo Qatar, il Parlamento europeo sceglie l'usato insicuro». Al
netto della polemica, i timori in casa Pd crescono dopo la decisione di Panzeri
di vuotare il sacco. L'avvocato di Panzeri conferma: «Antonio è arrivato a
firmare l'accordo di collaborazione con la procura federale belga in stato di
vero e proprio shock emotivo» ed è pronto a dire tutta la verità e a contribuire
all'efficacia dell'indagine. É a disposizione degli inquirenti a tutte le ore
del giorno e della notte per rispondere a tutte le loro domande» - dice all'Ansa
Marc Uyttendaele. Decisione che provoca il primo scossone: Andrea Cozzolino,
uomo forte del Pd (oggi sospeso) al Sud con legami stretti con Andrea Orlando e
tutta la corrente dei giovani turchi aderisce all'invito a farsi sentire
rivoltogli dalla Commissione giurisdizionale del Parlamento Europeo, per
ribadire la sua totale estraneità ai fatti. In vista della sua audizione,
Cozzolino ha deciso di autosospendersi dal gruppo dei socialisti onde consentire
che i lavori della Juri «si svolgano nelle migliori condizioni di autonomia e
terzietà» riferiscono i suoi legali. È il primo effetto in casa dem del
pentimento di Panzeri.
(ANSA il 19 gennaio
2023) - L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, è stata
sottoposta a una condizione di tortura in carcere la scorsa settimana. Lo
denunciano i due legali della politica greca, Mihalis Dimitrakopoulos e André
Risopoulos, al termine dell'udienza sul riesame della custodia cautelare.
Il legale Mihailis
Dimitrakopoulos ha spiegato che "da mercoledì 11 gennaio a venerdì 13 gennaio
Eva Kaili è stata in isolamento su ordine del giudice istruttore Michel Claise.
Per sedici ore è stata in una cella di polizia, non in prigione, e al freddo. Le
è stata negata una seconda coperta e le hanno tolto il cappotto, la luce della
stanza era sempre accesa impedendole di dormire, era nel suo periodo di ciclo
mestruale con abbondanti perdite di sangue e non le era consentito lavarsi.
Questa è tortura".
"Eva Kaili - ha
proseguito leggendo un documento redatto d'accordo con la stessa ex
vicepresidente del Parlamento europeo - è accusata ma c'è sempre la presunzione
di innocenza. Siamo in Europa, questi atti violano la Convenzione europea dei
diritti dell'uomo. Questo è il Medioevo". L'avvocato ha reso pubblica la
richiesta di Kaili a mezzi di informazione di "rendere questi fatti pubblici,
perché la trasparenza è l'anima della giustizia". "Speriamo - ha aggiunto - che
vi sia un processo equo. Siamo in Europa".
(ANSA il 19 gennaio
2023) - "Abbiamo chiesto ancora una volta la scarcerazione di Eva Kaili con
misure alternative come il braccialetto elettronico o altri tipi di misure
simili". Lo hanno detto i due legali della politica greca, Mihalis
Dimitrakopoulos e André Risopoulos, al termine dell'udienza sul riesame della
custodia cautelare.
Eva Kaili "è
innocente" e "non ha avuto alcuna collaborazione con Pier Antonio Panzeri". Lo
ha detto l'avvocato dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Mihalis
Dimitrakopoulos, al termine dell'udienza sul riesame della custodia cautelare.
"Per ora la signora Kaili è la sola politica ad essere detenuta. E' detenuta in
condizioni difficili e questo è estremamente preoccupante", ha evidenziato
l'altro avvocato André Risopoulos, sottolineando che la politica ellenica "non
deve diventare la persona che paga il prezzo più alto" con "la detenzione dura,
siccome non è certo lei al centro dell'inchiesta. Questo è insopportabile".
L'ex vicepresidente
del Parlamento europeo, Eva Kaili, "in sei settimane di carcere" per il
Qatargate "ha avuto la possibilità di vedere sua figlia di ventitré mesi
solamente due volte. Per noi questa è una "rottura" con "il buon senso" e con
"misure adeguate in relazione alla situazione". Lo ha detto l'avvocato della
politica ellenica, André Risopoulos, al termine dell'udienza sul riesame della
custodia cautelare. Se i giudici oggi decideranno di estendere la detenzione,
Kaili non potrà rivedere la figlia "fino a febbraio", ha aggiunto.
Il signor Panzeri si
sta comprando un futuro. Va bene e da avvocato lo capisco perfettamente. Lui ora
sa quando finirà il suo periodo di detenzione, sa chi sono le persone che ha
deciso di proteggere, probabilmente in primis la sua famiglia". Lo ha detto
André Risopoulos, il legale dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva
Kaili in carcere per il Qatargate, al termine dell'udienza di riesame della
custodia cautelare. (ANSA)
Eva Kaili in
carcere un altro mese, gli avvocati sbottano: “Torturata come nel Medioevo, in
cella al freddo senza lavarsi”.
Carmine Di
Niro su Il Riformista il 19 Gennaio 2023
Tortura.
L’avvocato Mihailis Dimitrakopoulos non usa mezzi termini per definire il
trattamento subito dalla sua assistita Eva Kaili. L’ex vicepresidente del
Parlamento europeo, eurodeputata socialista greca al centro assieme al
compagno Francesco Giorgi e all’ex europarlamentare di PD e Articolo 1 Antonio
Panzeri del cosiddetto ‘Qatargate’, si trova ancora in carcere in Belgio.
Lì oggi è in
programma presso il tribunale di Bruxelles l’udienza sulle misure cautelari da
applicare alla politica greca arrestata oltre un mese fa nell’ambito
dell’inchiesta sulla presunta corruzione internazionale che avrebbe coinvolto la
stessa Kaili.
Le parole di
Dimitrakopoulos sono durissime. Assieme all’altro legale André Risopoulos, con
cui ha chiesto ai magistrati la scarcerazione dell’ex vicepresidente
dell’Europarlamento e l’adozione di misure alternative come il braccialetto
elettronico “o altri tipi di misure simili”, ha spiegato che la sua assistita
“da mercoledì 11 gennaio a venerdì 13 gennaio è stata in isolamento su ordine
del giudice istruttore Michel Claise. Per sedici ore è stata in una cella di
polizia, non in prigione, e al freddo. Le è stata negata una seconda coperta e
le hanno tolto il cappotto, la luce della stanza era sempre accesa impedendole
di dormire, era nel suo periodo di ciclo mestruale con abbondanti perdite di
sangue e non le era consentito lavarsi. Questa è tortura“.
Nel leggere un
documento redatto d’accordo con la stessa ex vicepresidente del Parlamento
europeo l’avvocato greco ha voluto poi ricordare che nonostante le gravi accuse
“c’è sempre la presunzione di innocenza. Siamo in Europa, questi atti violano la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questo è il Medioevo”.
Quindi il collega
André Risopoulos ha ricordato come la Kaili “in sei settimane di carcere” per il
Qatargate “ha avuto la possibilità di vedere sua figlia di ventitré mesi
solamente due volte. Per noi questa è una rottura con il buon senso e con misure
adeguate in relazione alla situazione“.
Se i giudici oggi
decideranno di estendere la detenzione, Kaili non potrà rivedere la figlia “fino
a febbraio“, ha aggiunto.
Quanto all’altro
‘big’ indagato nell’inchiesta della magistratura belga, l’ex europarlamentare
italiano Panzeri che nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo con la procura,
per Risopoulos “si sta comprando un futuro. Va bene e da avvocato lo capisco
perfettamente”. Panzeri “ora sa quando finirà il suo periodo di detenzione, sa
chi sono le persone che ha deciso di proteggere, probabilmente in primis la sua
famiglia”, ha aggiunto l’avvocato ellenico.
Risopoulos ha
anche spiegato che “nessuno” ha chiesto ai legali della Kaili di fare un accordo
con la giustizia belga come quello sottoscritto da Antonio Panzeri e che quando
sono state poste delle domande alla sua assistita, “lei ha sempre risposto. Dal
suo primo interrogatorio avvenuto sabato 10 dicembre fino all’ultima audizione
all’indomani della notte nella cella” dove Kaili è stata isolata di recente,
“lei ha sempre risposto in modo specifico e completo alle domande che le sono
state poste. Partecipa all’inchiesta, si dichiara innocente e risponde alle
domande“.
La decisione
Il ricorso degli
avvocati Risopoulos eDimitrakopoulos però non hanno avuto effetto, anzi. L’ex
vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili detenuta nel carcere di Haren
dal 9 dicembre scorso, dovrà restare ancora in carcere per almeno un altro mese.
Lo si è appreso dalla procura federale del Belgio dopo la delibera della Camera
di consiglio del tribunale di Bruxelles.
Carmine Di Niro.
Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato
di politica, sport e tecnologia
Estratto
da ilgiornale.it il 20 Gennaio 2023.
L’inchiesta
ribattezzata Qatargate ha superato il punto di non ritorno. Le rivelazioni di
Antonio Panzeri al magistrato “sceriffo” Michel Claise cominciano a far paura
negli uffici del Parlamento europeo. Il primo ad essere colpito dal “canto”
dall’ex eurodeputato Pd è il suo collega socialista: Marc Tarabella.
L’europarlamentare
dei socialisti & democratici si sente “tradito” dal signor Panzeri e i suoi
legali provano a difenderlo così: “È incredibile che sia proposto un accordo a
chi, come Antonio Panzeri, è riconosciuto essere il capo dell’organizzazione
criminale, senza avere mai messo al confronto quello che dice con il mio cliente
Marc Tarabella”.
Le accuse di
Panzeri e Giorgi
L’ex eurodeputato
del Pd poi passato in Articolo 1, Antonio Panzeri, avrebbe confessato alla
giustizia belga di aver versato a rate una somma tra i 120mila e i 140mila euro
al collega socialista Marc Tarabella. Soldi che, secondo gli inquirenti belgi,
sarebbero serviti per essere più indulgenti nei confronti dei diritti umani a
Doha.
La difesa di
Tarabella non tarda ad arrivare e, incalzato dal Corriere della Sera, l’avvocato
Maxim Töller passa in rassegna tutte le contraddizioni che avvolgono il caso
Qatargate. Il legale smentisce la ricostruzione di Panzeri, figlia di un
patteggiamento con la procura belga, e difende a spada tratta la posizione del
suo cliente: “È assolutamente falso. Panzeri lo dice per negoziare una pena
minore”. In effetti uno sconto di pena, seppur lieve, c’è stato. Secondo il
legale Antonio Panzeri avrebbe ottenuto “la più bassa pena inflitta in questi
casi”. Tarabella, per voce del suo avvocato, esprime tutta la sua delusione
verso le accuse di Panzeri, che “lo apprezzava per il suo carisma politico”.
Panzeri non è
l’unico ad aver coinvolto Tarabella nel giro di mazzette e presunta corruzione.
Nel corso dell’interrogatorio del 13 dicembre scorso, Francesco Giorgi, compagno
di Eva Kaili e anche lui agli arresti, a quanto emerge dai verbali, avrebbe
spiegato ai giudici che i due deputati ad essere “corrotti indirettamente” erano
Andrea Cozzolino e Marc Tarabella. Il legale risponde alle accuse e ribadisce:
“Ha detto che sospettava di Tarabella ma ha anche detto di non aver mai visto
nulla di persona e di non aver assistito ad un pagamento a Tarabella da parte di
Panzeri”.
(...)
Qatargate, i
tormenti di Antonio Panzeri in carcere: «Ho deluso chi mi credeva, ho
danneggiato la sinistra». Francesca
Basso e Giuseppe Guastella su Il Corriere della Sera il 21 Gennaio 2023.
L’intervista
all’avvocato dell’ex europarlamentare italiano Antonio Panzeri: «Così ha scelto
di collaborare. Non è lui la mente, è un intermediario. L’accordo riguarda lui
ma parla sperando di aiutare moglie e figlia»
«Ciò che più gli
dispiace è di aver tradito la fiducia di tante persone che hanno creduto in
lui»: Antonio Panzeri lo ha ripetuto al suo difensore, l’avvocato Laurent
Kennes, uno dei più celebri del Belgio, che dall’arresto del 9 dicembre, insieme
a Marc Uyttendaele, lo assiste nell’inchiesta che ha squassato il Parlamento
europeo e che individua nel’ex eurodeputato di Pd e Articolo 1 un corruttore al
soldo di Qatar e Marocco.
Avvocato Kennes,
perché Panzeri si è pentito?
«Ammette le sue
responsabilità e vuole negoziare una pena ridotta».
Dopo 40 giorni di
carcere, come sta?
«Male perché
confronta la sua condizione attuale con quella passata di uomo rispettato e
rispettabile. Ora tutti sanno che ha fatto qualcosa di deprecabile. Dice a sé
stesso di avere deluso la sua famiglia, chi gli era vicino e chi ha creduto
nella sua politica».
In Italia il suo
arresto ha avuto un grande clamore.
«Anche in Belgio.
È rammaricato per avere danneggiato la sinistra, la sua parte politica, con il
suo comportamento. All’inizio era entrato in contatto con la sinistra del Qatar,
che è sempre molto a destra rispetto ai nostri standard, ma che ha mostrato un
minimo di impegno per il rispetto dei lavoratori contribuendo, tra il 2017 e il
2019, a migliorare la situazione. All’inizio il contatto non era negativo, era
in linea con le sue convinzioni».
Quando ha deciso
di collaborare e perché?
«Alcuni giorni
dopo essere stato arrestato, prima di Natale, ha cominciato a valutare l’ipotesi
di collaborare. Considerando che ha 68 anni e che probabilmente il processo
comincerà quando ne avrà 72, vuole che questa vicenda si chiuda al più presto».
Perché è accusato
di essere corrotto e di aver corrotto?
«Corrotto, perché
prima del 2019 era un parlamentare europeo, corruttore perché è ritenuto il capo
di un’organizzazione criminale dedita alla corruzione».
L’accordo con la
magistratura è per una condanna a 5 anni, di cui uno in carcere. Piuttosto poco.
«No. È nella
media. La pena massima per chi corrompe è di quattro anni di reclusione, 5 per
il corrotto.Per l’organizzazione criminale è 10 anni».
Ma lei ha
dichiarato che Panzeri non è il cervello dell’organizzazione criminale.
«È uno dei
dirigenti di un’organizzazione che non è una struttura piramidale con un grande
capo in stile mafioso. Ci sono persone del Qatar e del Marocco che propongono la
corruzione ad altre persone. Panzeri è solo l’intermediario. Non parla francese
né inglese, solo l’italiano. Così è difficile essere il capo e discutere con il
Qatar e il Marocco».
Chi è o chi sono
i capi?
«A questa domanda
non posso rispondere».
L’accordo
riguarda anche la moglie e la figlia che sono ai domiciliari?
«No, ma il mio
cliente spera in un trattamento migliore anche per loro».
Si è impegnato a
rivelare molto di più. Ci sono altri parlamentari coinvolti?
«Non posso
rispondere».
È vero che ci
sarebbero altri Paesi coinvolti?
«Il mio cliente è
stato accusato di avere corrotto per conto del Qatar e del Marocco».
Perché nessuno
del Qatar o del Marocco è stato coinvolto fino ad ora?
«Non lo so. Si
tratta comunque di persone che non stanno in Belgio e che godono di immunità
ministeriali o diplomatiche nei loro Paesi».
Quante volte
Panzeri è stato interrogato?
«Mai da quando ha
chiuso l’accordo (martedì scorso, ndr) come collaboratore di giustizia. Prima ha
parlato, ma non con lo stesso rapporto di fiducia che ci sarà ora».
Come sono le
condizioni in carcere?
«È detenuto a
Saint Gilles, una delle due peggiori prigioni del Belgio. Ci sono diversi
giudici che hanno riconosciuto che lì le condizioni sono contrarie alla dignità
umana. Il mio cliente è nella stessa situazione degli altri detenuti».
Come passa il
tempo?
«In cella è da
solo, può leggere, guardare la tv e incontrare gli altri detenuti».
Tarabella nega di
aver preso soldi da Panzeri.
«Non parlo di
quello che il mio cliente ha detto o dirà alla giustizia».
Kaili ha detto
che la borsa con i soldi a casa sua era di Panzeri. Come mai?
«Kaili cerca di
difendersi. Panzeri parlerà, dirà la verità. L’accordo con la procura prevede
una dichiarazione anticipatoria, ma non sarà l’accusatore degli altri».
L'accusa
dell'avvocato. Perché Eva Kaili è stata arrestata illegalmente: torturata in
cella come in Iran o Cina.
Piero
Sansonetti su Il Riformista il 20 Gennaio 2023
Gli avvocati
di Eva Kaili hanno denunciato un fatto gravissimo: l’ex presidente
del Parlamento europeo è stata torturata. Al momento non ci sono smentite. La
deputata sarebbe stata chiusa per due giorni in totale isolamento, in una cella
gelida, senza coperte, le è stato sottratto il cappotto, senza acqua, senza
potersi lavare sebbene avesse le mestruazioni, con una luce sempre accesa per
disturbarle il sonno. In modo che arrivasse all’interrogatorio “ammorbidita”.
Questo sarebbe avvenuto per ordine del giudice istruttore che sta guidando
l’indagine.
Dopo
l’interrogatorio il giudice ha deciso un altro mese di carcere perché Kaili non
ha detto quello che lui voleva che dicesse. Non ci sono precedenti:
dal dopoguerra a oggi mai, nell’Europa occidentale, un parlamentare era stato
torturato. Io mi chiedo come sia possibile che nessuno intervenga. La tortura è
vietata da molti decenni, in quasi tutti gli Stati europei. Non conosco le leggi
del Belgio – che fino a una sessantina di anni fa era uno degli stati coloniali
più feroci e contrari al diritto e si macchiò di delitti orrendi, compreso
l’omicidio a freddo di Lumumba – ma io credevo che anche le leggi del Belgio
fossero state scritte, o riformate, dentro la cornice dei diritti universali
dell’uomo e della donna. Forse non è così. In questo caso bisognerebbe
controllare se le leggi del Belgio sono compatibili o no con i principi
fondamentali dell’Unione Europea, o se non sia necessario immaginare
provvedimenti nei confronti di Bruxelles. In ogni caso qui c’è una questione
anche più grande. La persona sottoposta a tortura è una parlamentare europea.
È il parlamento
europeo che deve intervenire per chiedere alla magistratura belga la
restituzione dell’ostaggio. Perché la Metsola non ha ancora parlato? Perché non
ha chiesto chiarimenti ai giudici belgi? Se in condizioni analoghe a quelle che
si sono realizzate a Bruxelles, Eva Kaili fosse stata arrestata – sequestrata e
poi torturata – in Cina, o in Iran, o in qualsiasi paese africano o asiatico o
dell’America latina, l’Europa avrebbe fatto fuoco e fiamme, denunciato
l’illegalità, avrebbe chiesto la restituzione della prigioniera e stabilito
sanzioni nei confronti dello Stato oppressore. Guardate che non sto affatto
esagerando. Non è una polemica quella che sto facendo, è una analisi oggettiva
dei fatti. Sono i fatti ad essere assolutamente esagerati. Eva Kaili è stata
arrestata nonostante godesse dell’immunità parlamentare.
Per arrestarla,
il giudice ha invocato la flagranza di reato ma non ha saputo indicare il reato,
e dunque è da escludere che ci fosse flagranza. L’arresto è illegale.
L’inchiesta per la quale è stata arrestata non l’ha condotta la magistratura ma
i servizi segreti belgi e di altri quattro paesi stranieri, dunque è al di fuori
da qualunque norma del diritto internazionale. Anche l’inchiesta è illegale. La
bambina di meno di due anni della deputata è stata lasciato sola, con l’arresto
dei due genitori, e il suo dolore, e i danni psicologici permanenti che sta
ricevendo, sono stati usati per ricattare gli imputati. È illegale. A tutto
questo oggi si sono aggiunte le torture. L’uso della tortura in Francia fu
vietato alla fine del settecento con una motivazione molto semplice: la tortura
è già una pena e, in punta di diritto, la pena non può essere usata come
strumento di indagine perché può essere solo successiva all’indagine. I belgi
questo principio, evidentemente, non lo hanno mai accettato. Peraltro tutta
l’inchiesta Qatar fa acqua.
Anche la recente
decisione dei magistrati di trattare con Panzeri, proponendogli, senza processo,
una pena di un solo anno di detenzione (ai domiciliari) anziché cinque, in
cambio del suo impegno ad accusare un certo numero di parlamentari, anche senza
prove e riscontri, è una forma di giustizia medievale che non ha nessuna
parentela con qualunque tipo, pur rudimentale, di diritto. Panzeri è stato
incoraggiato a sottomettersi al diktat del giudice belga con l’arresto e la
concessione dell’estradizione di moglie e figlia. Sempre i parenti usati per
fare pressione sugli imputati. Una pratica anche questa illegale. E molto, molto
vigliacca. Per favore, amici giustizialisti, dite tutto quel che volete, ma
fateci la grazia: non usate mai più la parola “legalità”.
Piero Sansonetti.
Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di
cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004
al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per
poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre
2019.
Qatargate, i
legali di Kaili: per essere scarcerata le dissero di dichiararsi colpevole.
Storia di Francesca Basso e Giuseppe Guastella su Il Corriere della Sera il 21
gennaio 2023.
«Dal primo momento
hanno proposto ad Eva Kaili di dichiararsi colpevole per essere scarcerata e
così poter finalmente riabbracciare sua figlia». Con la stessa franchezza e
determinazione con cui nell’atrio del palazzo di giustizia di Bruxelles aveva
sostenuto che il trattamento subito da Eva Kaili dopo l’arresto fosse «una
tortura» medioevale, ora l’avvocato greco Michalis Dimitrakopoulos lancia una
nuova, pesante accusa alla magistratura belga.
Giovedì scorso i
giudici della Camera di consiglio di Bruxelles hanno rivalutato le esigenze
cautelari che da più di sei settimane tengono rinchiusa nel carcere di Haren la
ex vicepresidente del Parlamento europeo. Arrestata nell’inchiesta sulle
presunte interferenze sul Parlamento europeo ordite da Qatar e Marocco con il
pagamento di tangenti passate per la ong Fight impunity dell’ex eurodeputato di
Pd e Articolo 1 Antonio Panzeri, Kaili si è vista prolungare la carcerazione di
un altro mese.
La donna si è sempre
professata innocente dichiarando alla Polizia e al giudice istruttore Michel
Claise di non sapere nulla degli affari di Panzeri e Francesco Giorgi, padre
della sua bambina di 23 mesi, attraverso la ong. Così come ha ripetuto a verbale
di non aver saputo fino al giorno dell’arresto del compagno, avvenuto il 9
dicembre, che nella loro casa ci fossero 750 mila euro in contanti, 600 mila dei
quali sono stati trovati dalla polizia nel trolley che il padre di Kaili,
Alexandros, trascinava uscendo dal lussuoso hotel Sophitel di Bruxelles. L’uomo
aveva ricevuto una telefonata in cui la figlia gli chiedeva di raggiungerla in
casa per prelevare una valigia da restituire a Panzeri.
Video
correlato: Qatargate, legale Kaili: "E' triste, sta vivendo una
catastrofe" (Mediaset)
La ex giornalista
televisiva greca è stata scagionata subito dal compagno Giorgi, ma gli
inquirenti non hanno creduto alla versione della coppia, convinti che la donna
faccia parte della rete di Panzeri e abbia tentato di aiutarlo a far sparire il
denaro frutto delle manovre corruttive. Ed infatti la accusano di corruzione e
di tentativo di nascondere il frutto di un delitto.
In sei settimane di
carcere, la deputata del Pasok ha potuto incontrare la figlia solo due volte, la
prima il giorno della Befana. «Nonostante il fatto che stare lontana dalla sua
bambina sia la più grande tortura psicologica, lei non ha accettato di
confessare qualcosa che non ha fatto», dichiara ancora l’avvocato
Dimitrakopoulos.
Nei due lunghi
interrogatori, con la Polizia giudiziaria prima e con Claise dopo, Kaili ha
ripetuto più volte di non aver mai favorito il Qatar o il Marocco come
parlamentare europeo e di essersi allineata con convinzione ai colleghi della
sua area politica. Quando il giudice Claise le ha contestato di aver incontrato
con Giorgi il ministro del lavoro del paese del Golfo Ali Bin Samikh Al Marri
nell’hotel Steigenberger Wiltcher’s di Bruxelles, Kaili ha dichiarato che si
trattò di un appuntamento ufficiale per la preparazione dell’audizione del
qatarino nella sotto-commissione sui diritti dei lavoratori del 14 novembre.
L’accusa annota che nello stesso albergo, ma in un altro momento, si sarebbero
recati Giorgi e Panzeri: il secondo, all’uscita, aveva con sé una borsa piena.
L’ex vicepresidente
del Parlamento europeo «non vuole che sua figlia erediti lo stigma di una madre
che è stata una donna politica corrotta, perché non è vero», prosegue l’avvocato
Dimitrakoupulos. «Con questi pensieri nella mente, Eva Kaili ha dato battaglia
nella Camera di consiglio pronunciando con dignità parole chiare e fornendo
argomenti concreti per essere rimessa in libertà». Senza «tentare di commuovere
nessuno, ma solo convincere della sua innocenza». Ciò nonostante, «tremava
mentre riferiva al giudice, che era una donna, le torture che ha subito, non in
carcere, ma nella cella della polizia. «Ciò che ha vissuto ricorda il film Fuga
di mezzanotte (il film-denuncia sulle condizioni dei detenuti nelle carceri
turche negli anni ‘70, ndr), ma sfortunatamente questo sta accadendo nel centro
dell’Europa».
La protesta non si
ferma qui. L’avvocato greco è pronto a portare la battaglia legale più in alto:
«La prossima settimana faremo ricorso alla Corte suprema. Quando qualcuno viene
arrestato è immediatamente protetto dalla legge. Mi chiedo se sia stato così
anche a Bruxelles?».
Eva Kaili
lapidata, questa non è giustizia!
Massimiliano
Smeriglio su Il Riformista il 22 Gennaio 2023
Ho sempre pensato
che uno Stato di diritto maturo, che cerca giustizia e non vendetta, si può
misurare da come tratta i colpevoli, non gli innocenti o i pentiti. Il carcere è
già la pena, anche se l’obiettivo della reclusione dovrebbe essere più nobile
della pena stessa. Non c’è bisogno di calcare la mano. Non in una democrazia
europea, soprattutto quando innocenti e colpevoli sono ancora da stabilire.
Eppure quello che sta accadendo intorno al Qatargate e alla carcerazione di Eva
Kaili appare gravissimo, almeno ascoltando le dichiarazioni degli avvocati.
Non vi è dubbio
che lo scandalo in corso deve interrogarci sulla capacità delle istituzioni
comunitarie di tutelarsi dalla illegalità e, contestualmente, divincolarsi dalla
presa di lobby pubbliche e private che spendono 1,5 miliardi l’anno per
promuovere i propri prodotti, a partire da farmaci e armi. Sono 12mila i
lobbisti accreditati presso il parlamento europeo. Nell’ultimo periodo le grandi
Companies hanno investito sempre più risorse per attività di lobbying. Google 6
milioni di euro, Microsoft 5 milioni, Huawei 2,2 milioni, Leonardo 400mila, per
non parlare di quanto speso durante la pandemia dalle Big pharma (Pfizer,
Astrazeneca, Johnson & Johnson), circa 36 milioni di euro. Così come è
palpabile, tra i corridoi di Bruxelles, la presenza di Stati autoritari
impegnati in attività che definire diplomatiche non aiuta a comprendere il
contesto.
Questo per dire
che forse più che delle mele marce dovremmo occuparci della cesta. Tuttavia le
dichiarazioni del magistrato che sta indagando sembrano arrivare direttamente
dal cuore del populismo giustizialista. Accusare tutti i politici di connivenza
con la criminalità finanziaria come fa in un’intervista in cui afferma
che “sarebbe necessario fare qualcosa in merito”. Così come è preoccupante
paragonare la corruzione e il riciclaggio alla lotta contro il clima. Né è
accettabile l’immagine della Procura che negozia i patteggiamenti “puntando la
pistola alle tempie delle persone indagate”. In questo clima il legale della
Kaili Mihailis Dimitrakopoulos ha spiegato che “da mercoledì 11 gennaio a
venerdì 13 gennaio Eva Kaili è stata in isolamento su ordine del giudice
istruttore Michel Claise. Per sedici ore è stata in una cella di polizia, non in
prigione, e al freddo. Le è stata negata una seconda coperta e le hanno tolto il
cappotto, la luce della stanza era sempre accesa impedendole di dormire, era nel
suo periodo di ciclo mestruale con abbondanti perdite di sangue e non le era
consentito lavarsi. Questa è tortura”. “Eva Kaili – ha proseguito leggendo un
documento redatto d’accordo con la stessa ex vicepresidente del Parlamento
europeo – è accusata ma c’è sempre la presunzione di innocenza. Siamo in Europa,
questi atti violano la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questo è il
Medioevo”.
Inoltre, in 45
giorni è riuscita a vedere la figlia di 23 mesi solo due volte. Una bimba senza
più la presenza della mamma né del papà. Un atto violento che pagherà la bambina
e che ha tutto il sapore di una pena aggiuntiva, da riscuotere prima ancora
della celebrazione del processo. Sia chiaro, in Parlamento stiamo operando per
rendere più stringerti le norme e i comportamenti. Evitare le porte girevoli che
trasformano i politici in portatori d’interesse, fare trasparenza,
accountability, responsabilità, più attenzione alle ingerenze di Paesi
ostili, regole chiare per individuare e prevenire il lobbismo disonesto ed
evitare qualsiasi forma di corruzione e manipolazione del processo decisionale.
Così come osserviamo con rispetto la magistratura che indaga e che può aiutarci
a fare chiarezza e riscattare l’onore dell’assemblea parlamentare europea.
La Commissione JURI prenderà in carico nei prossimi giorni il dossier sulla
revoca dell’immunità per i parlamentari coinvolti e siamo tutti d’accordo che
una risposta incisiva sia l’unico modo per provare a recuperare la fiducia delle
cittadine e dei cittadini europei.
Incisiva ma
fondata sul diritto e le prove, non su stati d’animo da cavalcare con destrezza
al fine di propaganda politica che rischia di indicare il capro espiatorio e non
cogliere la dimensione politica generale del problema. La magistratura si occupa
dei reati e delle responsabilità individuali. Noi dovremmo riflettere e agire
sul contesto che favorisce o meno le degenerazioni senza inseguire la pubblica
opinione che, a volte, sa essere feroce. Ma c’è di più. Come nel caso di Abou la
dimensione razziale ha svolto la sua parte, in questo caso il fatto di trovarci
di fronte ad una donna giovane, bella, “scaltra”, con un “toy boy”, non è
sembrato vero alla narrazione machista che guarda il mondo dal buco della
serratura. E che cerca la rappresaglia portando colpi alla dimensione affettiva,
la gestione della bambina, e alla sua intimità, come nel caso del ciclo
mestruale, per ricattare e umiliare la detenuta è semplicemente inaccettabile.
Per l’Europa la gestione di questa crisi è un passaggio di civiltà decisivo,
perché la giustizia e la ricerca della verità giudiziaria siano fondate sulla
presunzione di innocenza e lo stato di diritto. Le lapidazioni combattiamole
ovunque e in tutte le forme possano manifestarsi. In Europa e nel resto del
mondo. Massimiliano Smeriglio
Tutti contro
Panzeri Tarabella e Kaili: “Si compra la libertà”.
Eleonora Ciaffoloni
su L’Identità il 21 Gennaio 2023
Tanti nemici, tanto
onore. Eppure, fino a qualche mese fa, i litiganti erano tutti amici. A finire
nell’occhio del ciclone come nemico numero uno, è Antonio Panzeri, l’ex
eurodeputato del Pd poi Articolo 1 indagato nell’inchiesta Qatargate
dell’europarlamento. Ora Panzeri è accerchiato: la sua colpa? Aver chiuso
l’accordo di collaborazione con la procura belga e aver iniziato a parlare del
sistema di mazzette che lo vede coinvolto insieme ai suoi ex “amici”. Marc
Tarabella lo accusa di tradimento, Eva Kaili di “comprarsi il futuro”, la Human
Rights Foundation di rivolere indietro il denaro, mentre Cozzolino si allontana
e si dice pronto a parlare. Panzeri, attualmente, avrebbe altre cose a cui
pensare: la figlia, arrestata su mandato di arresto europeo nell’inchiesta
Qatargate, ha fatto ricorso, depositato in queste ore in Cassazione, per
impedire la propria consegna alle autorità del Belgio dopo la decisione della
corte d’appello dello scorso lunedì; e la moglie dell’ex eurodeputato, che
comparirà davanti alla Suprema Corte il prossimo 31 gennaio. Tuttavia, Panzeri
ora deve cominciare a difendersi: non solo con gli inquirenti – a cui ha
raccontato di non essere lui “la mente del Qatargate” – ma anche con i suoi
avversari che lanciano colpi a destra e manca. A scoccare la freccia è
l’avvocato del collega Tarabella, Maxim Töller, che smentisce la ricostruzione
di Panzeri “figlia di un patteggiamento con la procura belga” e difende a spada
tratta la posizione del suo cliente. Panzeri “è assolutamente falso. Parla per
negoziare una pena minore” dice il legale, a conferma della riduzione della pena
per l’indagato. Contro Panzeri interviene anche direttamente Tarabella, che
deluso dichiara “lo apprezzo per il suo carisma politico”. Altro attacco, arriva
dall’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, o meglio, sai suoi
legali, visto che la deputata greca si trova attualmente in carcere sempre
accusata di corruzione all’interno dell’inchiesta Qatargate. “Il signor Panzeri
si sta comprando un futuro. Va bene e da avvocato lo capisco perfettamente. Lui
ora sa quando finirà il suo periodo di detenzione, sa chi sono le persone che ha
deciso di proteggere, probabilmente in primis la sua famiglia”. Ha detto
l’avvocato André Risopoulos al termine dell’udienza di riesame della custodia
cautelare. In quella sede poi, gli stessi difensori di Kaili non hanno perso
l’occasione per riconfermare l’innocenza dell’imputata sottolineando come “non
ha avuto alcuna collaborazione con Pier Antonio Panzeri”. Di seguito, a far
sentire la propria voce, anche il capo della Human Rights Foundation Thor
Halvorssen. L’organizzazione americana, finita nelle carte dello scandalo che ha
coinvolto l’istituzione europea torna dietro Panzeri e chiede indietro il denaro
finito tra le mazzette. “Pagavamo la Ong di Panzeri, ora vogliamo i soldi
indietro” ha detto il numero uno di HRF, sottolineando anche di aver pagato
“150mila euro per un evento al Parlamento Ue e 3mila euro al mese alla figlia di
Panzeri” e anche di non avere “legami con il Qatar”. Il cerchio dei nemici si
chiude con Andrea Cozzolino, l’eurodeputato eletto nel Pd ma recentemente
autosospeso dal gruppo S&D dopo le accuse di coinvolgimento arrivate proprio
dalle dichiarazioni di Panzeri. Cozzolino, di risposta, si era autosospeso dal
gruppo e aveva espresso la volontà di essere ascoltato. E così sarà. Il prossimo
martedì alle ore 9.30, sarà interrogato dalla commissione Affari giuridici del
Parlamento europeo, in una audizione a Bruxelles a porte chiuse, nel quadro
della richiesta della magistratura inquirente belga di revoca della sua immunità
parlamentare. Ma Cozzolino sarà nella capitale belga già lunedì pomeriggio,
quando si svolgeranno, sempre a porte chiuse, le prime discussioni nella
commissione giuridica sulla richiesta di revoca dell’immunità. Per lui
l’appuntamento è fissato alle ore 17.50, mentre per il collega Marc Tarabella –
che invece non ha richiesto l’audizione – l’incontro sarà poco dopo, alle 18.10.
Parte lesa. I
paladini dei diritti ignorano, anzi istigano, le forzature dell’inchiesta sul
Qatargate.
Iuri Maria Prado su L’Inkiesta il 23 Gennaio 2023.
La sinistra è
frettolosa nel sacrificare gli indagati, ma dovrebbe aprire gli occhi davanti a
un apparato inquisitorio palesemente orientato a ottenere “collaborazione”
facendo violenza a loro e alle loro famiglie, bambini compresi
È strano (si fa per
dire), che il popolo «dei diritti», quello che spulcia il curriculum morale
della Polonia e conta quante volte Viktor Orbán si infila le dita nel naso,
assista impassibile alla scena di un Paese che nel centro dell’Europa, latifondo
delle burocrazie comunitarie che perpetuano il proprio potere in nome dei
«settant’anni di pace», si comporta come uno Stato-canaglia proprio in materia
di diritti.
Fa semplicemente
ribrezzo che la sinistra decida di assolversi dalle contiguità con i presunti
trafficoni del Qatargate accettando e quasi istigando la giustizia che li sta
sacrificando in questo modo, senza aver nulla da obiettare davanti all’evidenza
di un apparato inquisitorio palesemente orientato a ottenere la “collaborazione”
degli indagati facendo violenza a loro e alle loro famiglie, bambini compresi.
La bieca
soddisfazione degli avversari nel veder messi in croce i signorini dei diritti e
della questione morale è molto più comprensibile e molto meno condannabile –
solita destra plebea e reazionaria – rispetto all’atteggiamento vigliacco del
clan che, dicendosi parte lesa, fa prendere a sassate i propri affiliati caduti
in disgrazia.
Ci fosse uno, di
quel popolo progressista in preparazione di congresso valoriale – i valori delle
partecipate e delle consulenze democratiche – e in attesa di poetica avventura
coi fascistelli di Mister Graduidamende, ce ne fosse uno che abbia bensì
reclamato l’esigenza di un accertamento rigoroso ma equanime delle
responsabilità, e tuttavia nella simultanea condanna di un’azione investigativa
e giudiziaria che grida vendetta per come infierisce sui diritti degli indagati.
Oltretutto dai lombi
di un Paese – il Belgio, appunto – gravemente compromesso nei decenni in casi di
denegata giustizia su vicende a dir poco mostruose, come la tratta dei minatori
italiani tenuti a vivere come bestie nelle baracche ai margini dei pozzi dove
quelli crepavano a migliaia o come l’altro pozzo infame, quello di cui non si
parla e nel quale finisce la moltitudine di bambini preda degli orchi che hanno
fatto del Belgio la patria della violenza impunita sull’infanzia.
Questi di questa
sinistra farebbero anche impalare pubblicamente quei loro esponenti destituiti,
se servisse a dimostrare che nonostante il pasticcio hanno ancora le mani
pulite. Fanno schifo. Schifo.
Qatargate,
Bruxelles rinuncia alla «consegna» delle Panzeri.
Giuseppe Guastella
su Il Corriere della Sera il 24 gennaio 2023.
Svolta dopo l’intesa
tra l’ex eurodeputato e i magistrati. Il giudice belga Claise oggi a Milano per
incontrare gli investigatori
Niente carcere in
Belgio per la figlia e la moglie di Antonio Panzeri che restano agli arresti
domiciliari in Lombardia perché la procura federale di Bruxelles rinuncia alla
loro consegna. È la svolta legata all’accordo con la magistratura belga per cui
l'ex eurodeputato si è impegnato a collaborare con la giustizia rivelando tutto
ciò che sa sulle «manovre a suon di mazzette in contanti» di Qatar e Marocco per
influenzare la politica del Parlamento europeo. L’inchiesta è in evoluzione e si
estende sempre più in Italia. In questo quadro oggi arriverà a Milano il giudice
istruttore belga Michel Claise, che incontrerà il procuratore Marcello Viola,
l’aggiunto Fabio De Pasquale e gli investigatori della Guardia di finanza.
Con il pentimento,
oltre ad un trattamento favorevole per moglie e figlia, Panzeri ha prima di
tutto ottenuto una condanna a 5 anni di reclusione di cui uno solo da scontare
in carcere, più la confisca di un milione di euro, tra cui i 600 mila trovati in
casa sua a Bruxelles. Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri sono state
arrestate il 9 dicembre a Calusco d’Adda perché accusate di far parte della rete
del capofamiglia. La figlia, che è avvocato, è sospettata di aver allestito con
la commercialista Monica Rossana Bellina (ai domiciliari) una struttura
societaria per riciclare il denaro in contanti versato dagli emissari del Qatar
e Marocco.
«Panzeri è un
testimone inattendibile che, nel tentativo di salvare sua figlia, sua moglie e
sé stesso firmerà qualunque cosa gli sia chiesto di firmare» dichiara
l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos, che difende la ex vice presidente Eva
Kaili (ancora in carcere). «Potrebbe coinvolgere politici del Belgio, della
Germania, della Francia», aggiunge Dimitrakoupoulos specificando che si tratta
solo di «ipotesi non basate su alcuna conoscenza. Non voglio essere frainteso».
La risposta dell’avvocato belga di Panzeri, Laurent Kennes, arriva a stretto
giro: «Il signor Panzeri non è stato ancora ascoltato come pentito. È quindi
assurdo dire che non sarebbe credibile».
Ieri Andrea
Cozzolino, l’europarlamentare campano coinvolto nell’inchiesta per la quale la
magistratura belga ha chiesto sia rimossa l’immunità, è comparso di fronte alla
commissione Juri. I riferimenti nei suoi confronti vengono dall’interrogatorio
di Francesco Giorgi che parla genericamente di rapporti di interesse tra
Cozzolino e Panzeri. Le indagini hanno registrato legami con l’ambasciatore
marocchino in Polonia Abderrahim Atmoun e un viaggio non confermato in Marocco
dove avrebbe incontrato il capo dei servizi di Rabat. Accompagnato dai suoi
legali, gli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De Beco,
l’eurodeputato campano esordisce in commissione ricordando di aver chiesto al
giudice Claise di essere interrogato, ma di non aver avuto risposta, e afferma
di stare vivendo «un surreale e mortificante processo mediatico» che «sta
devastando me e la mia famiglia su un mero sospetto», «generico ed aleatorio». È
convinto che su queste basi il Parlamento italiano mai revocherebbe l’immunità.
Se dovesse avvenire a Bruxelles, ciò lo esporrebbe al rischio teorico di
arresto. Sul Marocco, sottolinea di aver votato solamente una mozione, critica,
sul trattamento dei migranti e che con Atmoun aveva gli stessi rapporti di
«tanti altri miei colleghi», perché è stato presidente della commissione mista
Marocco-Ue.
Per il Qatar,
un’accusa riguarda una mail partita dal suo indirizzo in cui chiedeva al suo
gruppo di votare contro una risoluzione sulla violazione dei diritti dei
lavoratori delle opere dei Mondiali. Dichiara che fu il suo assistente Giorgi ad
inviarla «in totale autonomia e senza il mio assenso» e che lui ha poi votato
una mozione che «stigmatizzava la condotta per nulla positiva del Qatar».
PANZERI’S LIST.
Eleonora Ciaffoloni su L’Identità il 25 Gennaio 2023.
Attacco e difesa.
Così si muovono Eva Kaili e Andrea Cozzolino, i protagonisti che aleggiano
attorno alla figura di Antonio Panzeri, il “pentito” e “la mente” dello scandalo
Qatargate. A puntare il dito contro l’ex eurodeputato di Pd e Articolo 1 sono
ancora una volta gli avvocati della ex vicepresidente del Parlamento europeo che
avevano già accusato Panzeri di tradimento e di essersi “comprato il futuro”
grazie all’accordo fatto con la procura federale belga. Con Kaili in carcere, i
legali continuano a buttare benzina sul fuoco e, parlando alla tv greca Kontra,
l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos ha lanciato l’esca parlando di “messaggi e
notizie” da Bruxelles che anticipano come Panzeri “farà alla giustizia nuovi
nomi di eurodeputati italiani, tedeschi, belgi e francesi”. Ciò, secondo il
legale, sarebbe dovuto al fatto che l’ex europarlamentare sia diventato
“completamente inaffidabile” perché “tutto ciò che gli interessa è salvare sua
moglie sua figlia” e che, di conseguenza “qualunque cosa gli diano lui firmerà”.
Il legale offre poi ulteriori dettagli – che non sono emersi da Bruxelles – su
quanto accordato da Panzeri e dai federali, ovvero che l’ex socialista “deve
dire tutta la verità alle autorità giudiziarie belghe e non nascondere nulla”,
altrimenti non solo “si rompe l’accordo” ma sarà anche accusato di “pervertire
il corso della giustizia”. E non finisce qui: Dimitrakopoulos guarda anche
dentro la bolla di cristallo e dichiara che “ci saranno forti reazioni da parte
delle persone che Panzeri accuserà” e, andando nello specifico, parla di due
eurodeputati belgi che “sono già contro di lui e dovrebbero rivelare cose
contro”. Allora se Panzeri deve dichiarare tutto, l’accordo salterà? Perché
all’ex Articolo 1 è stata scontata la pena a un anno di reclusione e, a patto
concluso, potrebbe effettivamente fare emergere ulteriori dettagli sul giro di
mazzette e nuovi nomi da inserire tra gli indagati, oltre ai vari Eva Kaili,
Francesco Giorgi e i colleghi Marc Tarabella e Andrea Cozzolino. E se Tarabella
ha scelto la via del silenzio, in attesa della decisione sull’immunità
parlamentare della plenaria del 13 febbraio, a parlare ci pensa il compare.
Andrea Cozzolino, recentemente autosospeso dal gruppo S&D, è stato ascoltato
come da lui stesso richiesto dalla commissione Affari giuridici del Parlamento
europeo (Juri), in audizione a porte chiuse a Bruxelles. Dopo il muro costruito
dal giudice belga Michael Claise, Cozzolino è finalmente riuscito a dire la
propria e si è dichiarato estraneo a tutte le accuse di traffico di influenza e
“di non aver mai ricevuto direttamente o indirettamente né denaro contante né
altre forme di sostentamento e di essere totalmente all’oscuro delle attività
realizzate da Giorgi e da Panzeri” affermando di essere pronto a rinunciare alla
propria immunità parlamentare. E anche sui tasti dolenti risponde fermo: con
l’ambasciatore del Marocco in Polonia Abderrahim Atmoun – sospettato
nell’inchiesta come tramite – ha affermato di avere relazioni “cordiali come con
molti altri colleghi”; mentre su Francesco Giorgi ha ricordato la prassi del
parlamento di “assumere funzionari accreditati nelle precedenti legislature”.
Infine, la stoccata, per la difesa finale, torna sul campo di Panzeri: da lui
“non è uscito nulla che potesse andare oltre il ‘could be’ o il ‘should be’”.
Nessuna prova, quindi? Ancora una volta, tutti pendono da Antonio Panzeri.
Qatargate, Fabio
De Pasquale? Chi è il giudice imputato chiamato a indagare.
Alessandro
Gonzato su Libero Quotidiano il 26 gennaio 2023
La moglie e la
figlia di Antonio Panzeri tornano libere. Da oggi, salvo clamorosi quanto
improbabili colpi di scena, Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri non saranno
più sottoposte agli arresti domiciliari. Resta solo da capire aquali
limitazioni, pur minori, dovranno continuare a sottostare. La misura dei
domiciliari a Calusco d’Adda (Bergamo) - dov’erano stati trovati 17mila euro in
contanti - gli era stata imposta il 10 dicembre con l’accusa di aver favorito le
attività dell’ex eurodeputato Dem e Articolo 1, corruzione, riciclaggio e
associazione a delinquere. La revoca degli arresti giunge dopo che la procura di
Bruxelles ha rinunciato all’estradizione in Belgio di entrambe, provvedimento
che ormai avrebbe potuto scongiurare soltanto la Cassazione.
La nota con cui la
magistratura belga spiega di non avere più interesse alla consegna è stata
girata dal presidente della Corte d’appello di Brescia Claudio Castelli ai due
collegi che nelle scorse settimane avevano dato il via libera al trasferimento
di Colleoni e figlia in un carcere di Bruxelles. La revoca dei domiciliari per
Colleoni e figlia (alla quale sono stati congelati 200mila euro sul conto
corrente) potrebbe essere collegata all’accordo di collaborazione firmato da
Panzeri, diventato ufficialmente collaboratore di giustizia: nel carcere belga
di Saint-Gilles (dove in virtù dell’accordo rimarrà al massimo un anno) sta
fornendo informazioni sul Qatargate. Ma la revoca dei domiciliari potrebbe
essere anche conseguenza della posizione, che si starebbe aggravando, della
commercialista di Panzeri, Monica Rossana Bellini, la quale - accusata da
Panzeri - avrebbe riciclato il denaro in Italia, e per questo è possibile che a
Milano venga aperto un fronte a sé dell’inchiesta.
Ieri il procuratore
federale belga Frederic Van Leeuw e il giudice istruttore Michel Claise,
titolare dell’indagine sul mega scandalo di mazzette tra Belgio, Qatar e Marocco
sono arrivati nel capoluogo lombardo per incontrare i vertici dell’ufficio e gli
ufficiali della guardia di finanza: si lavora sui supporti informatici
sequestrati alla famiglia Panzeri. Titolare dell’inchiesta sul fronte italiano
del Qatargate è il giudice Fabio De Pasquale, procuratore aggiunto di Milano,
recentemente rinviato a giudizio (assieme al collega Sergio Spadaro) per rifiuto
d’atti d’ufficio in relazione al processo sul caso Eni-Nigeria.
L’altra novità è che
sarebbero coinvolte altre Ong oltre alla Fight Impunity di Panzeri. Sempre oggi,
al palazzo di giustizia di Bruxelles, sono previste le udienze di Francesco
Giorgi e Niccolò Figà-Talamanca. I due, ricordiamo, sono rispettivamente lo
storico collaboratore di Panzeri e dell’eurodeputato Dem Andrea Cozzolino al
quale di fatto è già stata tolta l’immunità parlamentare (ci ha rinunciato, ma a
oggi non è indagato), e il presidente (auto-sospesosi a seguito dello scoppio
dello scandalo) della Ong No Peace Without Justice, a oggi estranea
all’inchiesta. Per Giorgi e Figà-Talamanca le accuse sono di associazione a
delinquere, corruzione e riciclaggio. Giorgi è anche il compagno di Eva Kaili,
la vicepresidente destituita del parlamento Ue, anche lei in carcere a
Bruxelles, il cui avvocato ha dichiarato che presto potrebbero finire
nell’inchiesta anche altri europarlamentari, tra cui altri italiani.
Perché Panzeri si
è pentito: ha accettato di dire ai magistrati quello che vogliono lui dica…Piero
Sansonetti su Il Riformista il 27 Gennaio 2023
I magistrati di
Brescia hanno disposto la scarcerazione di Silvia Panzeri e di Maria Dolores
Colleoni. Per noi è un’ottima notizia. Qui, in questo giornale, siamo abituati a
festeggiare quando scarcerano qualcuno e sospendono la medievalità della
prigione. Perdipiù in questo caso si trattava di carcerazione preventiva che
quasi sempre, e anche, direi, in questo caso, oltre ad essere contro i principi
del diritto è anche contro la Costituzione e contro la legge. Conclusi i
festeggiamenti per la scarcerazione, però, ragioniamo un attimo. Chi
sono Silvia e Maria Dolores e perché i magistrati hanno deciso di scarcerarle?
Silvia è la figlia
di Antonio Panzeri, Maria Dolores è sua moglie. Antonio Panzeri, come tutti
ricordate, è il principale imputato per il Qatargate. È sospettato di avere
incassato dei soldi dal Qatar, o forse dal Marocco, o da entrambi i paesi, per
fare l’ufficio stampa e il lobbista a favore di questi paesi, allo scopo di
migliorarne l’immagine internazionale. Le due donne furono arrestate e messe ai
domiciliari perché sospettate di avere aiutato Panzeri. Poi il Belgio chiese
l’estradizione e il loro trasferimento in una prigione del Belgio. E la Corte
d’Appello di Brescia, che doveva decidere in merito, nonostante i molti dubbi
sulla regolarità dell’inchiesta dei magistrati del Belgio, decise di concedere
l’estradizione delle due donne.
Ora perché la Corte
d’Appello decide di liberarle? La legge italiana dice che si possono arrestare
delle persone, prima della condanna, a condizione che il reato sia di una certa
gravità, e che esistano rischi di occultamento delle prove, o di fuga, o di
reiterazione del reato. E di conseguenza si possono liberare, in attesa del
processo, se queste condizioni vengono a cadere. Bene. Forse non c’è più il
rischio che la moglie e la figlia di Panzeri occultino le prove? Se non c’è ora
non c’era neanche allora, visto che nel frattempo non è stata trovata nessuna
nuova prova. Forse non c’è più il rischio che fuggano ai Caraibi? Idem: se non
c’è adesso non c’era neppure al momento dell’arresto. Forse allora è caduto il
rischio che reiteri il reato? Il rischio, a occhio, non è mai esistito. O forse
non esiste più neppure il reato? Sì, forse, ma anche in questo caso non è
cambiato niente rispetto a qualche settimana fa: se non c’è reato ora non c’era
neppure allora. Dunque perché le hanno liberate? Cosa è cambiato dal momento
dell’arresto? Le hanno liberate perché i magistrati belgi hanno ritirato la
richiesta di estradizione. Non le vogliono più. E i magistrati italiani si son
detti: se non le vogliono i Belgi, che le teniamo a fare alla catena?
E allora ecco la
nuova domanda: perché i magistrati belgi, che sembravano inflessibili, non sono
più interessati alle due donne? Ecco, qui le cose si complicano. I magistrati
belgi sono ancora interessati, ma hanno firmato un patto con Antonio Panzeri. Il
quale ha accettato di dire ai magistrati belgi quello che loro vogliono che lui
dica. E cioè che si dichiari colpevole e che accusi un certo numero di
parlamentari europei sostenendo che sono suoi complici. È il meccanismo classico
del pentitismo. Ti arresto, ti chiudo in cella, e ti ci tengo finché non
collabori e dici quel che io voglio che tu dica. In questo caso alla violenza
diretta sull’imputato si aggiunge la violenza sui familiari. “Se non cedi al
ricatto imprigioniamo e torturiamo anche loro”. È un metodo che potrebbe
sembrare mutuato da quello della parte più violenta della mala.
L’imputato, quando
si trova davanti al ricatto, decide se affrontarlo, e farlo affrontare dai suoi
cari, o dai suoi amici, oppure se cedere e trattare. Panzeri ha ceduto e
trattato. Come si fa al mercato, alla bancarella. Non sappiamo quali confessioni
e delazioni abbia accettato di concedere, e in quali tempi, sappiamo cosa ha
ottenuto in cambio: la liberazione di moglie e figlia e una pena molto piccola.
Un solo anno da scontare ai domiciliari e la confisca dei soldi che gli sono
stati trovati e che, secondo l’accusa, sono la prova del reato. Nello stesso
processo, l’altra superimputata, e cioè la deputata europea Eva Kaili, ha fatto
una scelta diversa. Si è dichiarata innocente e non ha accettato di trattare.
Così – sebbene ci siano moltissimi dubbi sul fatto che il suo arresto sia legale
– viene tenuta in prigione senza motivo, le viene impedito di stare con la sua
bambinetta di due anni da compiere, viene persino sottoposta a una leggera forma
di tortura, durata 48 ore, prima dell’interrogatorio, per ammorbidirla. La
tortura, per quel che ne so, fu proibita in Francia perché considerata un mezzo
illegale di indagine e di pressione, alla fine del 700. Si dice che
il Belgio sia sempre indietro rispetto alla Francia. Lo diceva
anche Baudelaire. Però tre secoli sono molti.
Ora la questione
generale, posta dagli avvenimenti che vi ho riassunto, supera le singole vicende
degli imputati, e le polemiche politiche che si sono accese. Il problema è
questo: ha molto a che fare col diritto un metodo di indagine che in assenza di
prove le fabbrica offrendo a un imputato la possibilità di evitare la pena in
cambio di sue accuse – forse vere, forse false – che travolgano delle persone
fin qui fuori delle indagini? La trasformazione della giustizia in un sistema di
compravendita e di mercato che si ispira alle degenerazioni del mercato
capitalista, e che si tiene lontana dalla necessità di appurare la verità, è
compatibile con la civiltà e con le regole generali del diritto che vigono
in Europa? Noi in Italia questi metodi li conosciamo bene, perché abbiamo
vissuto gli anni di Tangentopoli. Qui però si stanno superando i limiti di
quella vicenda, già di per sé aberrante. La politica, cioè la struttura dei
partiti democratici, intende reagire a questo calpestamento del diritto, che la
riguarda da vicino, o preferisce accucciarsi e lasciare via libera alla satrapìa
dei magistrati? Ecco, a occhio la risposta è la seconda.
Piero Sansonetti.
Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di
cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004
al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per
poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre
2019.
Il legale di Eva
Kaili: “Panzeri darà altri nomi, ma è inaffidabile...”
L’avvocato Greco:
“Farà nomi di eurodeputati di Germania, Francia, Italia e Belgio”. Il Dubbio il
24 gennaio 2023.
Antonio Panzeri, la
presunta mente dello scandalo Qatargate, dopo aver firmato un accordo di
pentimento con la Procura federale belga dovrebbe dare alla giustizia nuovi nomi
di eurodeputati provenienti da Germania, Francia e Italia coinvolti nello
scandalo. Lo ha riferito l'avvocato dell'eurodeputata greca Eva Kaili, Michalis
Dimitrakopoulos.
“Arrivano messaggi e
notizie che farà nomi di eurodeputati di Germania, Francia, Italia e Belgio. Per
quanto riguarda le persone provenienti dalla Grecia, non posso escludere nulla,
soprattutto perché è un periodo pre-elettorale”, ha detto il legale in
un'intervista al canale televisivo Kontra, secondo quanto riporta Euractive.
“Gli hanno detto che resterà in carcere un anno, ma darà loro i nomi che
vogliono”, ha aggiunto. "Ora è completamente inaffidabile, e tutto ciò che gli
interessa è salvare sua moglie e sua figlia, e qualunque cosa gli diano,
firmerà", ha rimarcato l'avvocato greco.
Intanto, in un
articolo pubblicato sul quotidiano Il Riformista, l'eurodeputato S&D
Massimiliano Smeriglio denuncia le condizioni di detenzione dell’ex
vicepresidente Ue, posta in isolamento in una cella di polizia – racconta la
difesa -, non in prigione, al freddo e con la luce sempre accesa. “Ho sempre
pensato che uno Stato di diritto maturo, che cerca giustizia e non vendetta, si
può misurare da come tratta i colpevoli, non gli innocenti o i pentiti. Il
carcere è già la pena, anche se l'obiettivo della reclusione dovrebbe essere più
nobile della pena stessa. Non c'è bisogno di calcare la mano”, dice
Smeriglio. “Non in una democrazia europea, soprattutto quando innocenti e
colpevoli sono ancora da stabilire. Eppure quello che sta accadendo intorno al
Qatargate e alla carcerazione di Eva Kaili appare gravissimo, almeno ascoltando
le dichiarazioni degli avvocati”.
Esclusiva Tg1: "Il Qatar
pagò gli afghani per non combattere ... Da
repubblica.it il 2023/02/01
I documenti rivelati dal
telegiornale Rai delle ore 20 dimostrerebbero il pagamento di ingenti somme di
denaro a figure chiave del governo, tra cui l'ex presidente Ghani.
DAGONEWS il 15
febbraio 2023.
Com’è andato
l’incontro, ignorato da tutti i giornaloni, tra il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani?
Il baffuto sovrano
di Doha, che ha incontrato la Mummia sicula e non la Meloni, preferendo un
faccia a faccia tra pari grado, cioè capi di stato, è stato accolto al Quirinale
in maniera molto morbida e felpata.
L’accordo
diplomatico tra gli sherpa era stato siglato prima dell’arrivo di al-Thani:
nessun riferimento allo scandalo Qatargate che ha travolto il Parlamento
europeo, e ha scoperchiato il "sistema Panzeri" e la sua rete italiana.
All’incontro ha
partecipato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, perché il Qatar
voleva manifestare al governo italiano l’interesse ad investire in armamenti di
fabbricazione tricolore.
I qatarini vogliono
creare una base navale tutta loro sul Golfo Persico (ora ospitano quella
americana) e hanno bisogno di fregate, corvette, e unità anfibia come la "Al
Fulk", varata da Fincantieri a Palermo qualche settimana fa.
Come scriveva “il
Sole 24 ore” il 24 gennaio, “La nave fa parte di un contratto, firmato nel 2016,
del valore di quasi quattro miliardi che prevedeva la fornitura di sette navi di
superficie, di cui quattro corvette della lunghezza di oltre 100 metri, una nave
anfibia (LPD - Landing Platform Dock) e due pattugliatori (OPV - Offshore Patrol
Vessel)”
Durante l’incontro
si è affrontato anche il tema più rilevante per i termosifoni nostrani: la
fornitura di gas. Il Qatar è disposto ad aumentare l’erogazione all’Italia, ma
va superato l’ostacolo della “trasformazione”: il gas fornito da Doha è liquido
e servono rigassificatori e impianti di distribuzione. L’idea del governo
italiano, a tal proposito, dopo i problemi sorti a Piombino, è di investire su
un ulteriore, nuovo, impianto, la cui posizione deve essere ancora individuata.
Il realismo politico
che ha spinto il Quirinale a non toccare il dolente tasto del Qatargate porterà
benefici: al-Thani ha promesso nuovi ricchi investimenti in Italia.
Nuovo scandalo al
Parlamento UE: francesi indagati per appropriazione di fondi pubblici.
Salvatore Toscano
su L'Indipendente il 2 febbraio 2023.
Piove sul bagnato a
Strasburgo, sede del Parlamento Europeo. Dopo lo scandalo del Qatargate, 13 ex
eurodeputati francesi sono finiti nel mirino della Procura di Parigi che, dopo
cinque anni di indagini, li ha accusati di assunzione irregolare di assistenti
parlamentari e appropriazione di fondi pubblici. In poche parole, i funzionari
appartenenti al Partito Democratico Europeo (EDP) avrebbero usato i fondi
comunitari per assumere assistenti e portaborse e metterli a servizio del
proprio partito nazionale, il Movimento Democratico (MoDem), che oggi occupa 48
seggi (su 577) nella Camera più importante del Parlamento francese, l’Assemblée
nationale. Coinvolto nello scandalo anche François Bayrou, fondatore e
presidente delle due formazioni politiche, nonché più volte ministro negli
ultimi esecutivi e alleato di Emmanuel Macron. La Procura parigina ha chiesto di
dare seguito alle indagini e avviare dunque il processo contro i 13 funzionari.
L’uragano che si è abbattuto
sul Parlamento Europeo, istituzione rappresentativa per eccellenza, non accenna
a lasciare Strasburgo. Tra il 2009 e il 2014, 13 eurodeputati francesi avrebbero
fatto uso di fondi pubblici indebitamente, per un danno alle casse comunitarie
pari a 1,4 milioni di euro. Tra le persone coinvolte nelle indagini, oltre a
François Bayrou, figurano anche l’ex ministro della Giustizia Michel Mercier, ai
tempi del governo Sarkozy, e l’attuale vice governatore della Banca di Francia
Sylvie Goulard. Il MoDem non è nuovo a episodi di illegalità; nel 2017,
un’inchiesta giornalistica travolse il partito e, per motivi simili all’attuale
scandalo, i politici centristi Jean-Luc Bennhamias e Nathalie Griesbeck furono
condannati a versare un indennizzo di 45 e 100 mila euro al Parlamento Europeo.
[di Salvatore Toscano]
Tangentopoli
europea: ora spuntano anche i lobbisti dall’Azerbaigian.
Michele Manfrin su
L'Indipendente il 7 Febbraio 2023.
Per quanto concerne
la tangentopoli europea si continua a parlare di Qatargate nonostante che nelle
indagini – ancora in corso – sia certa la presenza di almeno un altro Stato
coinvolto, il Marocco. Eppure, come molti commentatori ed europarlamentari hanno
detto, la faccenda rappresenterebbe solamente la punta di un iceberg che però,
ancora, non sembra essere arrivato allo sguardo di chi indaga.
Giornalisticamente parlando c’è chi invece indaga anche altre piste e, nello
specifico, dei rapporti di alcuni parlamentari europei con l’Azerbaigian.
Quest’ultimo, noto per la sua “diplomazia al caviale”, è attivo da molti anni
sul fronte lobbistico europeo col fine di attrarre investimenti nel Paese,
far chiudere un occhio sulla violazione dei diritti umani e trovare soggetti che
sostengano le mire e le ambizioni dell’Azerbaigian nella politica internazionale
regionale.
Assenza di
trasparenza di europarlamentari appartenenti a RUMRA
Alla fine di
settembre scorso, come riportato dall’inchiesta condotta dalla testata
giornalistica svedese Blackspot, una delegazione europea
ha raggiunto l’Azerbaigian per una visita al Paese. La delegazione era composta
da membri dell’associazione intergruppo chiamata RUMRA & Smart villages (The
Group for Rural, Mountainous and Remote Areas and Smart Villages):
l’europarlamentare sloveno Franc Bogovic (gruppo Democratico Cristiano),
Presidente di RUMRA; l’eurodeputato tedesco Engin Eroglu (gruppo Renew); il
tedesco Adam Mouchtar che è il coordinatore del gruppo RUMRA; il lituano Angele
Kedaitiene; e altri accompagnatori personali.
Il tedesco Engin
Eroglu, che è anche parte della delegazione alle commissioni di cooperazione
parlamentare con gli Stati dell’Asia centrale, tra cui l’Azerbaigian, proprio
due settimane prima del viaggio, ha criticato la Presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, per non aver condannato l’invasione dell’Armenia
da parte dell’Azerbaigian. I parlamentari europei, al contrario del regolamento
che norma i rapporti tra funzionari europei e soggetti terzi, non hanno prodotto
una relazione politica ed economica entro i termini stabiliti; solo
successivamente ai termini prescritti, sono stati forniti i dettagli del viaggio
condotto in Azerbaigian dalla delegazione europea. Infatti, rispetto al viaggio
nel Paese asiatico, sia Eroglu che lo sloveno Franc Bogovic non hanno
inizialmente prodotto la relazione necessaria per ogni viaggio che compie un
eurodeputato, da rendere pubblica entro un mese come stabilito dal regolamento
per la trasparenza, ma soltanto dopo la pressione esercitata delle domande dei
giornalisti. La relazione sul viaggio in Azerbaigian arriva, per entrambi,
e identica, il 6 dicembre 2022. I due dichiarano di avere viaggiato dal 21 al 24
settembre e di aver alloggiato al Marriot Hotel di Baku, con costi coperti in
gran parte dal Paese ospitante. Nelle dichiarazione, in allegato troviamo anche
il programma della visita dei politici europei. In seguito al venire alla luce
del viaggio, Niklas Nienass, tedesco del Partito dei Verdi, ha scelto
di dimettersi dal consiglio di RUMRA accusando i due europarlamentari di aver
infranto le regole sulla trasparenza e sull’integrità e di non aver mai
informato, né prima né dopo, del viaggio in Azerbaigian a nome e per conto di
RUMRA. In merito all’esito del viaggio Nienass ha detto: «Non so se è solo il
viaggio che li ha fatti parlare positivamente dell’accordo sul gas con
l’Azerbaigian». Il 19 novembre, due mesi dopo il viaggio, e prima ancora che
fosse redatta la relazione per la trasparenza alle istituzioni europee, Engin
Eroglu ha postato sulla sua pagina Facebook un elogio all’accordo commerciale
energetico con l’Azerbaigian, per la diversificazione dal gas russo, e si
impegna ad essere parte del processo di pace tra Azerbaigian e Armenia,
raccontando di aver incontrato, la settimana prima, l’ambasciatore azero in
Germania.
Il viaggio in
Azerbaigian
Lo scopo principale
del viaggio della delegazione era quello di visitare i cosiddetti villaggi
intelligenti. Il concetto di villaggi intelligenti, di cui si occupa
l’associazione intergruppo europea RUMRA, basa lo sviluppo dei centri urbani su
principi legati all’accessibilità, all’utilizzo tecnologico e all’adattamento
alle esigenze del momento (la tanto decantata resilienza). Nonostante le dure
critiche, specie di Engin Eroglu, durante una intervista, condotta in inglese su
un media azero durante il periodo del viaggio, i due europarlamentari hanno
parlato in termini positivi dell’Azerbaigian, spiegando che l’UE dovrebbe
sviluppare la cooperazione con il Paese asiatico in vari settori dell’economia,
soprattutto in quello energetico.
Il giorno precedente
alla visita ai villaggi intelligenti, il 22 settembre, la delegazione di RUMRA
ha incontrato il Capo del Comitato per l’Economia, Industria e
Imprenditorialità, prima di fare visita al ministero dell’Agricoltura e
all’Export and Investment Promotion Agency of the Republic of Azerbaijan
(AZPROMO). Quest’ultima è una creazione del ministero dell’Economia, istituita
nel 2003, per attrarre investimenti stranieri nel settore non petrolifero e
incoraggiare le esportazioni di prodotti non petroliferi.
La visita del 23
settembre, ha riguardato la regione di Zangilan, riconquistata dall’Azerbaigian
con la seconda guerra del Nagorno-Karabakh, nel 2020. Nello specifico, gli
europarlamentari si sono recati ad Agali Smart Village e a Shusha City. I
villaggi sono descritti dai media azeri come innovativi, concentrati sul
business locale e sullo sviluppo tecnologico e digitale. In merito alla
questione tecnologico-digitale ricordiamo che l’Azerbaigian ha una legislazione
sulla privacy praticamente inconsistente e utilizza in maniera consistente
sistemi di sorveglianza quali Pegasus.
Eurasianet,
finanziata dagli Stati Uniti, una delle principali piattaforme mediatiche in
lingua inglese che copre la regione, ha dimostrato che le terre intorno
a Zangilan sono state date quasi esclusivamente a persone con stretti
rapporti con gli amici della famiglia presidenziale, Ilham Aliyev. Ciò include
ricchi uomini d’affari e persone con legami con il presidente turco Recep Tayyip
Erdogan. La costruzione dei villaggi intelligenti è finanziata dallo stato
azero, ma i contratti di costruzione sono stati dati a persone molto vicine alla
famiglia Aliyev. Tra le altre cose, la società NMS LLC coinvolta nello sviluppo
è legata a AS Group, fondata da Shahin Movsumov, fratello di Shahmar Movsumov,
il quale è assistente di Ilham Aliyev nonché capo dell’Autorità per gli affari
economici e lo sviluppo innovativo.
La diplomazia del
caviale
Come
ampiamente spiegato dall’European Stability Initiative, la “diplomazia del
caviale” ha preso piede a partire dal 2001, non molto tempo dopo che
l’Azerbaigian è entrato a far parte del Consiglio d’Europa ed ha preso velocità
dopo che Ilham Aliyev, che aveva servito nell’assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa (APCE), è diventato presidente dell’Azerbaigian nel 2003.
Questo tipo di diplomazia ha potuto poi espandere la propria portata quando, nel
2005, l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan è stato completato. L’Azerbaigian, tramite
una serie di enti e organizzazioni apparentemente indipendenti e che invece sono
collegate al governo cerca di fare pressione sui singoli Stati europei come
anche all’interno delle istituzioni comunitarie dell’Unione Europea, e spesso in
maniera opaca e mai del tutto trasparente.
Negli ultimi anni ci
sono stati vari casi che hanno riguardato il rapporto tra politici occidentali e
Azerbaigian. In Germania c’è stato il caso che ha riguardato alcuni parlamentari
di quella che allora era l’alleanza di centro-destra guidata da Angela Merkel, i
quali spesso viaggiavano senza spese in Azerbaigian e con stretti rapporti con
uomini d’affari azeri. Così come c’è stata la vicenda in Svezia che ha visto
coinvolti l’Institute for Security and Development Policy e il ministero
dell’Economia, con finanziamenti milionari dal secondo verso il primo nonostante
gli stretti rapporti, per tramite del rettore dell’istituto, Svante Cornell, con
l’Azerbaigian. L’Italia ha visto invece il caso di Luca Volontè,
europarlamentare appartenente al partito politico italiano UdC (Unione dei
Democratici Cristiani e Democratici di Centro), che nel gennaio 2021 è stato
condannato in primo grado a 4 anni di carcere per corruzione internazionale
dalla X Sezione Penale del Tribunale di Milano, per aver ricevuto, tra il 2012 e
il 2013, dall’allora rappresentante dell’Azerbaijan all’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa, mezzo milione di euro per orientare il voto del proprio
gruppo parlamentare in maniera contraria al rapporto del socialdemocratico
tedesco Straesser che denunciava le condizioni di 85 prigionieri politici
detenuti in Azerbaijan. Lo scorso anno è però intervenuta la prescrizione del
reato, facendo cadere ogni accusa e così anche l’interdizione dai pubblici
uffici che era stata inflitta a Volontè insieme ai 4 anni di carcere. Essendo
arrivata la prescrizione dopo una prima pronuncia di condanna, e quindi di
accertamento dell’avvenuto reato di corruzione internazionale, rimane la
confisca del mezzo milione di euro sottratti a Volontè, ricevuto dalla società
azera Baktelekom dietro conti bancari offshore presso la Danske Bank, in
Estonia, e la Baltikums Bank, in Lettonia, e pervenuti sino al 19 marzo 2013
alla Fondazione Novae Terrae e alla società L.G.V della moglie di Volonté.
Insomma,
l’Azerbaigian ha una ricca tradizione di lobbismo che appare sempre quantomeno
opaca se non addirittura del tutto di tipo corruttivo. Le indagini sulla
tangentopoli europea sembrano non riuscire, almeno per il momento, ad andare
aldilà della cerchia di Panzeri e soci, sebbene molti siano coloro che hanno
affermato essere solo una piccola parte della corruzione che circola nelle sedi
europee e spesso, a quanto pare, tramite l’utilizzo di ONG, fondazioni e
associazioni che fungano da luogo di passaggio dei soldi spesso giustificati
come consulenze. [di Michele Manfrin]
Quell’Europa
indifesa nelle mani dei burocrati della lobby degli affari.
Redazione su
L’Identità il 9 Febbraio 2023.
di EDOARDO GREBLO e
LUCA TADDIO
È opinione diffusa
che l’Unione europea soffra di un deficit di democrazia e abbia assunto il
profilo di un superstato nelle mani di burocrati e tecnocrati. In realtà, anche
se il discorso porterebbe troppo lontano, le istituzioni dell’Unione europea e i
detentori del potere istituzionale non hanno deficit democratici. Piuttosto, e
le vicende di questi giorni lo stanno dimostrando, il deficit può essere
riscontrato nei processi decisionali, in particolare nella loro vulnerabilità
all’assalto dei gruppi di interesse e delle lobby dei più diversi tipi. Si
tratta di un problema ben noto e a cui le istituzioni europee hanno da tempo
prestato la dovuta attenzione. Il Registro per la trasparenza prevede infatti
alcune precise regole di condotta nei confronti delle pressioni che gli
interessi organizzati possono esercitare nel campo delle iniziative legislative.
Certo, queste regole non sempre funzionano, ma l’offensiva frontale portata
avanti contro i gruppi di interesse, qualificati spregiativamente e
indistintamente con l’etichetta di “lobby”, prende di mira il bersaglio
sbagliato. In fondo, se la democrazia è (e deve continuare a essere)
pluralistica, tutti gli interessi legittimi hanno eguale diritto a ricevere
ascolto. E infatti l’articolo 11 del Trattato sull’Unione europea recita: “Le
istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso
gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare
pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione. Le
istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le
associazioni rappresentative e la società civile”. Purtroppo, quando si parla di
lobbying, lobby e lobbisti il dibattito è inquinato dai pregiudizi e le
iniziative volte a influenzare chi formula l’agenda vengono automaticamente
equiparate a forme di corruzione. In realtà, corrompere e fare lobbying sono
attività completamente diverse.
Il lobbying è il
tentativo fisiologico di influenzare il processo decisionale di chiunque sia
responsabile delle scelte pubbliche. La corruzione, invece, è il tentativo
patologico di versare denaro per comprare un voto o una decisione. Il lobbying
non è perciò di un’attività illecita di per sé, perché garantisce a gruppi
organizzati di cittadini la possibilità di comunicare le loro preferenze agli
europarlamentari e di influenzarne le scelte, un’opzione pressoché obbligata
rispetto a un organismo che, proprio per la sua natura sovranazionale, ha
bisogno di una rete di “sensori” capaci di comunicare informazioni utili al
legislatore. Ad esempio, perché mai le associazioni ambientaliste non dovrebbero
far sentire la loro voce per far valere istanze rispettose dell’ambiente?
Oppure, perché i gruppi che si battono per i diritti umani non dovrebbero
patrocinare iniziative a favore del rispetto dello Stato di diritto egualmente
valide in tutti i Paesi membri dell’Ue? Più in generale, se correttamente
regolamentata, l’attività delle lobby è un’azione che può migliorare la qualità
delle scelte pubbliche nel momento in cui vi è una varietà di gruppi di
pressione che, in competizione tra loro, partecipano al conseguimento
dell’interesse comune.
Tuttavia, come si è
visto e come si è detto, le regole attuali non sempre funzionano. E ciò perché
si è fatto eccessivo affidamento sulla capacità normativa delle misure di
trasparenza: il registro (non obbligatorio) per la trasparenza dei lobbisti, i
diari delle riunioni per i commissari, i direttori generali della Commissione e
gruppi selezionati di deputati al Parlamento europeo, i codici di condotta (per
lobbisti e commissari) e così via. L’assunto di base è che la pubblicità (oppure
il timore della pubblicità) possa essere un incentivo abbastanza forte da
frenare le occasioni di corruzione. Ora, la trasparenza è certamente utile per
aiutare il lavoro delle organizzazioni non governative, dei giornalisti e dei
ricercatori che documentano la vita quotidiana delle istituzioni dell’Ue e per
favorire l’accountability sostanziale dei decisori nei confronti delle loro
decisioni. Ma non basta, come dimostra il cosiddetto Qatargate. La nostra
dipendenza collettiva dai servizi di polizia degli Stati membri in cui hanno
sede le istituzioni dell’Ue non può non preoccupare, visto il significativo
declino delle norme sullo Stato di diritto che si sta verificando in diversi
Stati membri.
Proprio per questo
l’Unione europea dovrebbe cogliere l’occasione per dotarsi di servizi in grado
di svolgere autonomamente queste indagini e affrontare i (purtroppo probabili)
casi futuri di corruzione, se non altro per evitare che le norme già in vigore
restino lettera morta e valgano come una testimonianza di inefficacia e di
impotenza.
Qatargate,
mandato d’arresto europeo per Andrea Cozzolino.
Il Tempo il 10
febbraio 2023
Mandato d'arresto
europeo per Andrea Cozzolino. La Guardia di Finanza lo ha notificato su mandato
della procura federale belga. Lo apprende l’Adnkronos. Il mandato d’arresto,
emesso nell’ambito dell’inchiesta Qatargate è stato notificato in una clinica
nella quale Cozzolino è ricoverato per problemi di salute. In precedenza i
finanzieri si erano recati nell’abitazione napoletana dell’europarlamentare ma
non l'avevano trovato. Intanto è stata perquisita anche la sua abitazione a
Bruxelles. I finanzieri hanno bussato alla porta di casa nel quartiere collinare
del Vomero ma l’europarlamentare del Pd era già in una struttura ospedaliera per
accertamenti clinici.
Cozzolino, per gli
inquirenti belgi, era parte integrante «della squadra di Panzeri e Giorgi». Per
il giudice di Bruxelles Michel Clais, l’eurodeputato del Pd era «una pedina
fondamentale per il Marocco», perchè sarebbe stato in contatto diretto con
«Abderrahim Atmoun, l’ambasciatore del Marocco in Polonia», l’uomo che avrebbe ì
elargito tangenti in contanti. Il sospetto è che Cozzolino si sia anche recato
in Marocco con un volo pagato, scrive Claise, «dai servizi segreti di Rabat»,
anche se su questo punto non c’è alcuna conferma che l’eurodeputato campano sia
mai salito su quell’aereo.
«È inaccettabile che
Manfredi non spieghi perché ha scelto Cozzolino, per il quale sarebbe stato
spiccato un mandato di arresto europeo per il Qatargate, ai vertici della cabina
di regia della città di Napoli sui fondi pubblici. Il silenzio è sospetto». È il
tweet di Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, relativo alle scelte del suo
successore.
Qatargate,
arrestati gli eurodeputati Andrea Cozzolino (Pd) e Marc Tarabella (S&D).
Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 10 Febbraio 2023
La loro immunità
parlamentare è stata revocata dall'Aula insieme a quella di Andrea Cozzolino, lo
stesso eurodeputato belga Marc Tarabella ha chiesto di revocarla e ha votato in
questo senso in Aula. Era già stato espulso dal gruppo S&D al Parlamento europeo
e chiedeva dallo scorso dicembre di essere ascoltato dal giudice. Cozzolino si è
fatto trovare dai finanzieri che gli notificavano l'arresto, ricoverato in una
clinica di Napoli
In mattinata
l’eurodeputato italo-belga Marc Tarabella, era stato ascoltato dal magistrato
istruttore, Michel Claise e condotto a Bruxelles per essere interrogato
nell’ambito dell’inchiesta Qatargate. Tarabella, che è anche sindaco di
Anthisnes, un comune della provincia di Liegi, in Vallonia, è stato prelevato da
casa sua ed arrestato . “Finalmente, vi aspetto da due mesi, ora potrò essere
ascoltato” con queste parole Tarabella ha accolto gli agenti di polizia questa
mattina come si apprende da fonti dell’entourage dell’eurodeputato.
Lo scorso 2 febbraio
il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di revoca dell’immunità
parlamentare per due eurodeputati, entrambi del gruppo S&D-Socialdemocratici :
l’italiano Andrea Cozzolino e il belga Marc Tarabella. L’aula ha votato
all’unanimità la domanda avanzata a metà gennaio dalla Procura di Bruxelles.
Il politico belga di
origine italiana secondo le dichiarazioni di Pier Antonio Panzeri messe a
verbale nel suo pentimento giudiziario, avrebbe ricevuto tra 120 e 140mila
euro perché addolcisse le proprie posizioni riguardo al Qatar, accusa questa
che Tarabella ha respinto e negato. La sua immunità parlamentare è stata
revocata dall’Aula insieme a quella di Andrea Cozzolino (Pd), lo stesso
eurodeputato belga ha chiesto di revocarla e ha votato in questo senso in Aula.
Era già stato espulso dal gruppo S&D al Parlamento europeo e chiedeva dallo
scorso dicembre di essere ascoltato dal giudice.
Nel corso delle
indagini dell’inchiesta avviata dalla procura federale belga vi sono diverse
“perquisizioni” in Belgio. E’ stata perquisita una cassetta di sicurezza di una
banca situata a Liegi, intestata a Tarabella. Inoltre sono stati perquisiti
alcuni uffici del municipio di Anthisnes. Il giudice istruttore deciderà se
l’eurodeputato dovrà comparire in udienza per un’eventuale conferma
dell’arresto.
E’ stato messo sotto
sequestro anche l’ufficio dell’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, oltre a
quello di Marc Tarabella. Da settimane il politico napoletano è finito al centro
dell’indagine. Il 2 febbraio scorso il Parlamento europeo aveva deciso di
revocare a entrambi l’immunità parlamentare, e Cozzolino ha preferito seguire
l’esito della votazione dalla sua abitazione di Napoli per evitare le prigioni
belghe. Gli inquirenti ipotizzano un loro coinvolgimento nella trama di
corruzione organizzata dall’ex eurodeputato ora pentito Antonio Panzeri, che ha
portato in carcere anche l’assistente Francesco Giorgi, e l’ex vicepresidente
del Pe, Eva Kaili.
Cozzolino si è
manifestato contrariato dalla procedure seguite in queste tre settimane.
Soprattutto ha sparato ad alzo zero contro Panzeri accusandolo di volerlo
coinvolgere nello scandalo per salvare se stesso e ottenere il patteggiamento
della pena a un solo anno di reclusione. “Apprendiamo dalla stampa che la
richiesta di revoca dell’immunità nei confronti dell’on. Cozzolino è stata evasa
dalla Commissione Juri, prima, e dal Parlamento Europeo, dopo, in tempi record –
è stato il primo commento degli avvocati di Cozzolino – e con un iter meramente
burocratico, senza nessuna discussione sui temi e sugli interrogativi posti in
commissione sulla matrice e la natura dell’inchiesta, e senza tenere in alcun
conto la sua stessa attività parlamentare sui dossier Qatar e Marocco, pur
essendo del tutto incompatibile con l’accusa, invero alquanto generica,
formulata al suo indirizzo”. I legali ricordano che il loro assistito si è
presentato all’audizione in Commissione ma di quelle parole “è rimasta solo la
sua rinuncia all’immunità”.
In serata è stato
spiccato e notificato un mandato d’arresto. l’arresto all’europarlamentare
Cozzolino in una clinica di Napoli , dove si era ricoverato . La residenza di
Cozzolino nel quartiere di Ixelles, a Bruxelles è stata perquisita dalla polizia
federale belga. Lo ha reso noto la procura federale. L’eurodeputato italiano
eletto nelle liste del Partito Democratico era assente. Redazione CdG 1947
Scandalo
corruzione, arrestato l’eurodeputato Andrea Cozzolino. Manfredi sotto accusa.
GAIA ZINI su Il Domani il 10 febbraio 2023
L’eurodeputato è
stato arrestato, dopo una sequela di perquisizioni a Ixelles e a Napoli. Lui si
trovava in clinica. Il Pd si schermisce: lo aveva già sospeso. E il sindaco di
Napoli? «Se ha sbagliato pagherà»
La procura belga ha
infine arrestato l’eurodeputato Andrea Cozzolino per l’affaire della corruzione
all’Europarlamento. Peccato che per lunga parte della giornata lui fosse
introvabile, fino a che è stato il suo stesso avvocato, Dezio Ferraro, a
confermare che «è ricoverato in una clinica per problemi di salute».
PERQUISIZIONI A
IXELLES E A NAPOLI
Mentre l’ufficio di
Cozzolino all’Europarlamento è già sotto sigillo, questo venerdì assieme al
mandato di arresto sono scattate le perquisizioni. L’eurodeputato non gode più
dell’immunità da europarlamentare. Due le perquisizioni quindi, sia
nell’abitazione a Ixelles, che in quella napoletana. A Napoli è intervenuta la
guardia di finanza locale, per notificare a Cozzolino il mandato di arresto.
LA POSIZIONE DEL PD
Il Partito
democratico a livello nazionale tira un sospiro di sollievo solo perché già
quando lo scandalo è esploso, la commissione di garanzia del partito ha
decretato la sospesione dell’eurodeputato dal Pd. Dai dem arriva anche
l’intenzione dichiarata di costituirsi parte civile nel processo; un impegno che
era già stato annunciato a livello europeo dalla capogruppo S&D alla fine del
2022.
E IL SINDACO?
Sotto attacco
dell’opposizione il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che aveva assegnato a
Cozzolino un incarico per la cabina di regia della Città metropolitana per
l'attuazione e il coordinamento dei fondi europei e del Pnrr. Manfredi ha
spiegato che «le attività della cabina erano state sospese» e ha aggiunto – tra
gli strali e le accuse di Luigi De Magistris – che «se Cozzolino ha sbagliato
deve pagare».
IL CASO TARABELLA
Mentre Cozzolino
risultava introvabile in entrambe le abitazioni, «vi aspettavo» pare siano le
parole pronunciate da Marc Tarabella, il socialista belga che è stato
interrogato in stato di fermo.
L’affaire
corruzione, che riguarda non solo il Qatar ma anche il Marocco, ha prodotto
vittime illustri: la greca Eva Kaili, colta in flagranza di reato con le
mazzette, è stata spodestata dal ruolo di vicepresidente del Parlamento europeo;
è ora rimpiazzata dal socialista lussemburghese Marc Angel.
GLI EFFETTI
SULL’EUROPARLAMENTO
Al Parlamento Ue è
in corso un processo di riforma per prevenire episodi simili. A dicembre gli
eurodeputati hanno approvato a larghissima maggioranza questo piano, ma da
allora la bozza di riforma concertata dalla presidente dell’Europarlamento si è
notevolmente ridimensionata nelle ambizioni. Chissà che la nuova ondata di
arresti non scuota l’aula. Intanto il gruppo socialdemocratico
all’Europarlamento ha già avviato una indagine interna.
Il dem che portò
i cinesi alle primarie e votò contro la risoluzione anti Putin.
Quattro volte
eletto in Europa, Manfredi gli ha affidato la torta dei fondi del Pnrr.
L'imbarazzo nel partito: "Siamo parte lesa". Pasquale Napolitano l’11 Febbraio
2023 su Il Giornale.
Dalla Cina al Qatar.
Passando per la Russia. Andrea Cozzolino è l'uomo d'Oriente a cui il sindaco di
Napoli Gaetano Manfredi affida la torta dei fondi Pnrr. L'ultima tentazione di
Cozzolino? Il passaggio nel M5s. La trattativa con il capo dei Cinque stelle
Giuseppe Conte si è arenata allo scoppio della bomba Qatargate. Politico di
lungo corso, una vita passata a sinistra, sotto l'ala di Antonio Bassolino,
Cozzolino è da ieri destinatario di un mandato d'arresto europeo. Al momento
della notifica, l'europarlamentare era irreperibile. «Si trovava in clinica per
accertamenti medici» ha spiegato il suo legale.
Chi è l'ultimo
socialista travolto dall'inchiesta condotta dai magistrati belgi sul giro di
mazzette tra il Qatar e il Parlamento europeo? Un macinatore di voti. Arriva
dalla vecchia guardia del Pds, che nel post tangentopoli ha dominato la
Campania. Per ben quattro volte è stato eletto al Parlamento europeo. In passato
ha ricoperto l'incarico di assessore regionale e comunale. Nel 2011, alla
vigilia delle elezioni comunali di Napoli, il suo nome rimbalza su tutti i media
nazionali: Cozzolino è accusato dai dirigenti del suo stesso partito (il Pd) di
aver portato al seggio delle primarie per la scelta del candidato sindaco di
Napoli i cinesi. Le immagini faranno il giro del web e diventeranno un
tormentone. La polemica finisce sulla scrivania dell'allora presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano (napoletano e comunista come Cozzolino) che
solleciterà l'annullamento delle primarie. Dopo la Cina, la Russia. Il nome di
Cozzolino diventa ancora una volta famoso a novembre di quest'anno: al
Parlamento europeo si vota una risoluzione che definisce la Russia uno Stato
terrorista. Cozzolino si sfila e vota contro. Si giustifica. Ma dal Pd nessun
provvedimento. Anzi arriva il premio: il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi gli
affida a fine dicembre il coordinamento dei fondi europei e del Pnrr. Un
incarico affidato e riconfermato nonostante il nome dell'europarlamentare fosse
già presente nel fascicolo dell'inchiesta Qatargate. Dal Pd Cozzolino si
sospende subito. La poltrona per la gestione dei fondi Pnrr resta, al contrario,
ben salda.
E ieri dal Nazareno,
dopo la notizia del mandato di arresto, i vertici precisano: «Il Partito
Democratico ha assunto, sin dal principio, una posizione netta e rigorosa. Nello
specifico, nei confronti dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, il giorno
stesso in cui è affiorato per la prima volta il suo presunto coinvolgimento
diretto nella vicenda, i vertici del partito hanno convocato la commissione
Nazionale di Garanzia che a sua volta ha deliberato la sospensione di Cozzolino
medesimo, applicando con inflessibilità le regole di tipo cautelativo previste
dallo Statuto». Il Pd ribadisce: «Siamo parte lesa». Ma ormai la bomba Qatargate
è piomba in casa. E agita il rush finale del congresso.
Sequestrati gli
uffici dell'europarlamentare belga e dell'italiano Cozzolino. Qatargate, da mesi
chiede di essere interrogato: Tarabella in stato di fermo ‘grazie’ a Panzeri.
“Vi stavo aspettando”.
Redazione su Il
Riformista il 10 Febbraio 2023
Dallo scorso
dicembre chiede di essere interrogato e oggi la procura belga, ‘grazie’ alle
dichiarazioni dell’ex europarlamentare Pier Antonio Panzeri, ha deciso di
ascoltarlo dopo mesi. Il parlamentare europeo Marc Tarabella si trova ora in
stato di fermo nell’ambito dell’inchiesta Qatargate a Bruxelles. Nelle scorse
ore la procura belga ha effettuato diverse perquisizioni che riguardano il
politico espulso nelle scorse settimane dal gruppo S&D.
“Finalmente, vi
aspetto da due mesi, ora potrò essere ascoltato” queste le sue parole all’arrivo
degli agenti di polizia presso la sua abitazione di Anthisnes, in provincia di
Liegi.
“Nell’ambito di un
dossier della procura federale, guidato da un giudice istruttore di Bruxelles,
legato a sospetti di corruzione pubblica, questa mattina – fa sapere la stessa
Procura – sono avvenute diverse perquisizioni. La prima ha riguardato
una cassaforte di una banca a Liegi, appartenente al parlamentare europeo Marc
Tarabella. Sono stati perquisiti anche alcuni uffici del municipio
di Anthisnes“.
“Tarebella è stato
arrestato in vista di un’udienza. Il giudice istruttore deciderà se dovrà
comparire davanti a lui nelle prossime ore per un’eventuale conferma
dell’arresto” informa la Procura. Tarabella è temporaneamente privato della
libertà nell’ambito dell’inchiesta su fatti di presunta corruzione volta a
influenzare i processi decisionali dell’Ue e viene interrogato dalla Polizia, su
ordine del giudice istruttore Michel Claise. A seconda dell’esito
dell’interrogatorio, Claise deciderà se interrogarlo lui stesso e se confermare
lo stato di arresto o meno.
Secondo la
ricostruzione del quotidiano belga Le Soir, Tarabella è stato prelevato stamani
a casa sua (è sindaco della città di Anthisnes, un comune della provincia di
Liegi, in Vallonia) e condotto a Bruxelles per essere interrogato. Secondo le
dichiarazioni messe a verbale da Pier Antonio Panzeri, il politico belga, di
origine italiana, avrebbe ricevuto tra 120 e 140mila euro perché addolcisse le
proprie posizioni riguardo al Qatar. Accuse che Tarabella ha sempre negato.
Nelle scorse settimane, il 2 febbraio, la sua immunità parlamentare è stata
revocata dall’Aula insieme a quella di Andrea Cozzolino con lo stesso
eurodeputato belga che aveva chiesto di revocarla e ha votato in questo senso in
Aula.
Secondo quanto
riporta l’Ansa, gli uffici al Parlamento europeo degli eurodeputati Tarabella e
Cozzolino sono sotto sequestro. Gli inquirenti ipotizzano un loro coinvolgimento
nella trama di corruzione organizzata dall’ex eurodeputato ora pentito Antonio
Panzeri, che ha portato in carcere anche l’assistente Francesco Giorgi, e l’ex
vicepresidente del Pe, Eva Kaili.
Le gravi
violazioni allo Stato di diritto. Carcere duro, l’Italia fa scuola anche in
Belgio.
Marco Perduca su Il Riformista il 10 Febbraio 2023
Esploso come
scandalo di annacquamento di documenti del Parlamento europeo relativi a
violazioni di diritti umani, il Qatargate sta mettendo a nudo gravi violazioni
dello Stato di Diritto in Belgio. Ma in pochi lo denunciano. Malgrado il ferreo
segreto istruttorio belga si ha notizia sulla pessima qualità della detenzione
dei coinvolti, della custodia cautelare in carcere e dell’applicazione della
normativa sui collaboratori della giustizia ricalcata sulle leggi antimafia
italiane.
Ma ricapitoliamo i
fatti: il 9 dicembre 2022 vengono arrestati l’ex eurodeputato Antonio Panzeri,
il suo ex-assistente Francesco Giorgi, Eva Kaili, all’epoca vice-presidente
dell’europarlamento e Niccolò Figà-Talamanca, segretario dell’Ong “Non c’è pace
senza giustizia” accusati di associazione per corruzione e riciclaggio. Il 3
febbraio Figà-Talamanca è stato liberato senza condizioni, gli altri restano
dentro. Il 17 gennaio è emerso che Panzeri ha iniziato a collaborare con la
giustizia firmando un memorandum che prevede un anno di reclusione, 80.000 euro
di sanzione e la confisca dei proventi dalle attività criminali (circa 1 milione
di euro). Nel 2018 il Belgio ha modificato alcuni articoli del codice di
procedura penale che “riguardano sospetti che si sono pentiti”. Il patto sarebbe
stato siglato a 24 ore dall’arresto.
La legge belga sui
collaboratori di giustizia si rifà talmente tanto alla nostra che si usa
l’espressione italiana “pentiti” per riferirsi a chi se ne avvale.
Il Qatargate è la seconda volta che queste norme vengono applicate, la prima fu
il cosiddetto “Footbelgate” del 2017-19 nel corso delle cui indagini 23 persone
furono accusate di uno o più reati ma 17 furono rilasciate su condizioni, sei
senza. L’uso dei “pentiti” in Belgio è autorizzato a due condizioni cumulative:
“che le esigenze dell’indagine lo richiedano e che altri mezzi non siano
sufficienti alla manifestazione della verità”. La misura riguarda reati di una
certa gravità. L’avvocato di Panzeri s’è affrettato a chiarire che il suo
assistito ha firmato in stato di shock; indipendentemente dal fatto che si sia
di fronte a una reale volontà di revisione delle proprie condotte, l’inchiesta
ora si baserà su quelle dichiarazioni non occorre cercare prove di colpevolezza,
il Procuratore Claise ha usato le confessioni di chi è stato scioccato dalla
detenzione per cancellare l’immunità euro-parlamentare a Marc Tarabella e Andrea
Cozzolino. Anche Giorgi ha iniziato a parlare ma non si sa se da “pentito”.
Chi invece continua
a proclamare la propria estraneità ai fatti è Kaili. Il giorno del suo
arresto Eva Kaili è stata rinchiusa in una camera di sicurezza senza poter
andare in bagno malgrado avesse le mestruazioni e privata del cappotto malgrado
la stanza fosse gelida. Cosa ancora più disumana e traumatizzante, dalla sua
“traduzione” al carcere di Haren continua a essere tenuta separata dalla figlia
di due anni. È eccessivo parlare di tortura in questo caso? Rileggiamo l’art.
1 della Convenzione ONU che definisce la tortura come “qualsiasi atto mediante
il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti,
fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza
persona informazioni o confessioni…”
La legge belga
prevede che le detenute madri possano avere con sé prole fino a tre anni di età,
dopodiché i bambini non possono restare in carcere. A febbraio 2023 in Belgio le
madri detenute con figli sono sei. Perché non si rispetta la legge nei confronti
di una persona che, tra l’altro, si trova in regime di custodia cautelare?
Possibile che, tranne la deputata italiana Deborah Bergamini che, nella sua
veste di membro della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa, ha formalmente interrogato Maria Buric, Segretaria Generale
del Consiglio, sulle condizioni di detenzione di Kaili, le istituzioni europee
stiano zitte?
A dicembre 2022 un
giudice olandese ha richiamato una recente relazione del Comitato europeo per la
prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa sulle carceri in Belgio per
negare un’estradizione. A oggi in Belgio sono ristrette 11.199 persone per una
capienza regolamentare di 9.739 posti in strutture spesso vecchie anche di 150
anni. La carenza di agenti penitenziari ha fatto scattare scioperi che per
settimane hanno impedito che i detenuti ricevessero biancheria o visite. La
moglie di Figà-Talamanca è stata rimandata a casa un paio di volte.
Il Belgio non ha
ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura – un
accordo per prevenire pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che
consente la visita di autorità internazionali nelle carceri dello
Stato dell’Onu. Anche in mancanza di obblighi internazionali, però, parlamentari
nazionali o europei possono far richiesta di visita ispettiva a istituti di pena
in Europa. Possibile che nessuno ci abbia provato? Neanche tentare l’impresa
rende conniventi a queste patenti violazioni di diritti umani. Marco Perduca
Qatargate, perché
ora il Pd non può chiamarsi fuori.
Renato Farina su
Libero Quotidiano il 12 febbraio 2023
Manette per
l’eurodeputato Andrea Cozzolino, esponente napoletano del Partito democratico,
dotato di seggio a Strasburgo dal 2009. Viene dopo l’arresto di Antonio Panzeri,
che la poltrona l’aveva perduta, ma non lo sportello dove ritirare il bottino e
dividerlo con quelli della banda. E poi assistenti parlamentari, consulenti,
parenti: tutti incardinati a sinistra. Panzeri si era accasato in un altro
partito post-comunista (articolo 1 di Bersani e a pagina 5 D’Alema), tanto per
variare il menù. Dello stesso eurogruppo parlamentare S&D (socialisti e
democratici) la greca Eva Kaili e il belga Marc Tarabella.
E adesso? Sulle
colpe dei singoli vedremo, chi siamo noi per giudicare? Presunti innocenti lo
sono senz’altro. Il fatto certo è che non stanno balzando su dalle acque
dell’ipocrisia mariuoli cattivelli, ma l’intreccio di corruzione della sinistra
europea. Come ha potuto questa rete propagarsi? Onestà e questione morale? Balle
da offrire come fieno al popolo bue.
Le indagini
costringono a prendere atto dell’esistenza di una vera e propria rete,
coordinata ed efficiente, per garantire il certificato di Stato di diritto a
Paesi che hanno usato questo lasciapassare morale per schiacciare minoranze
religiose ed etniche, donne e dissidenti, e avere così via libera ad affari
lucrosi e la possibilità di finanziare serenamente parliamo del Qatar - i
Fratelli musulmani e le moschee dove si sono formati militanti del terrorismo
jihadista.
Intanto Cozzolino...
Lo hanno afferrato per i piedi e trascinato nel pozzo nero i suoi compagni di
fede, ma amici no, proprio no. Il suo nome è apparso dapprima in certi documenti
dell’intelligence marocchina, al servizio non tanto del re maghrebino ma degli
emiri del Qatar. Panzeri ha indicato lui come strumento privilegiato per piegare
le leggi e i trattati della massima istituzione europea alle voglie dei padroni
del calcio mondiale e dei nostri grattacieli, oltre che meravigliosi fornitori
di gas a prezzo equo.
Ho usato
l’espressione “compagni di fede”. Fede in che? Nel sol dell’avvenire? Prima di
splendere sulle masse popolari, a quanto pare, l’astro doveva provvedere a
scaldare l’avidità dei suoi adoratori. Qui non si tratta di singoli spuntati dal
nulla, ma della fioritura di piante carnivore che hanno trovato terreno idoneo
per nascere, crescere, coordinarsi.
Il Partito
democratico a dicembre si era chiamato fuori dallo scandalo, constatando
l’approdo bersaniano di Panzeri, capo emerito dei sindacalisti comunisti di
Milano. Ora sta conducendo una operazione ovvia da acchiappagonzi. Si erge ad
accusatore dei reprobi, annuncia che si presenterà come parte civile al processo
perché si ritiene danneggiato dai suoi sodali.
Ma qui dovrebbero
essere gli italiani a presentarsi come parte civile contro il Pd che li ha
selezionati e poi coperti, senza mai trovare il modo di farli sentire fuori
posto. Ci stavano benissimo nella sinistra, sono pescecani che in quelle acque
nuotavano sereni. Ha ragione il Ppe a denunciare il doppio standard usato da
S&D, sbandieratore spudorato della propria diversità, ed oggi con la pretesa di
aprire ali d’angelo per volare sopra le sue deiezioni. Questi partiti hanno
offerto la mascherina rossa ai propri partigiani per rapinare la buona fede dei
cittadini europei.
P.S. Con tutto
questo, il protagonismo del magistrato inquirente di Bruxelles non ci piace,
bisogna vigilare comunque sui metodi. Il garantismo vale specie per chi gli
avversari. Quando Michel Claise, il procuratore alle prese con il Qatargate,
accusa la politica in quanto tale e invoca manifestazioni di piazza a sostegno
del suo repulisti, francamente ci fa paura. In Italia abbiamo già dato.
The show must go
on. Qatargate, nuovi arresti e zero riscontri: lo show va avanti, è la
magistratura bellezza.
Piero Sansonetti su
Il Riformista l’11 Febbraio 2023
Hanno arrestato il
deputato belga al Parlamento europeo Marc Tarabella. stanno cercando
anche Andrea Cozzolino, parlamentare italiano del Pd. Vogliono portare in
prigione pure lui. Tarabella lo hanno preso alle sei di mattina e trascinato
all’interrogatorio. Probabilmente in nottata lo porteranno in cella. È
il Qatargate, che va avanti così: rispetto del diritto zero, show a tutto gas.
Lo show deve procedere e se non esce niente di nuovo è la magistratura belga a
trovare il modo per non farlo afflosciare.
Ieri è stata decisa
la liberazione anche della fiscalista di Panzeri, Monica Rossana
Bellini. Purtroppo pare che a suo carico si trovi poco e niente. C’è il rischio
serio che sia innocente. Non è un gran problema perché tanto la signora è stata
già fatta a pezzi e sputtanata dalla stampa italiana e difficilmente potrà
riprendersi. Però è un peccato che non sia emerso niente contro di lei. Quando
la catturarono un giornale titolò a tutta pagina: arrestata la contabile
del Pd. Lei non è contabile, non è del Pd e probabilmente è innocente. Però è
vero che è stata arrestata. Una parola di quel titolo era veritiera, ed è già
molto.
Un paio di giorni fa
era stato scarcerato il radicale Niccolò Figà Talamanca, l’uomo che doveva
dimostrare la colpevolezza di Emma Bonino. Purtroppo, anche qui, non si è
trovato niente contro di lui. Maledizione! A quel punto, sai com’è, liberato
Figà, liberata Bellini, liberate moglie e figlia di Panzeri, si rischiava la
figuraccia brutta. Ci voleva un arresto pesante. Meglio se due. Non restava che
attaccarsi alle accuse di Panzeri, barattate in cambio di un fortissimo sconto
di pena. E Panzeri aveva accusato Tarabella di avere ricevuto un po’ di soldi in
contanti di origine qatarina. Ottima cosa no?
Panzeri non sapeva
neppure quanti soldi. Di questi soldi nessuna traccia. Tarabella nega. Nessun
riscontro. Niente di niente, però una bella occasione per rilanciare il caso.
Con l’aiuto di un Parlamento europeo prostrato alla procura di Bruxelles. Il
quale aveva tolto a Tarabella l’immunità parlamentare, su richiesta della
procura, senza neppure chiedere le carte, o qualche delucidazione, e senza
discutere una decina di minuti sulla scelta. Ha detto subito: figuratevi,
l’immunità è un assurdo privilegio, arrestate pure chi volete, signori
magistrati.
Ma
forse Tarabella minaccia di fuggire? No,certo, sarebbe già fuggito. Forse può
inquinare le prove? No, certo, le avrebbe già inquinate. Forse potrebbe
reiterare il reato? No, certo non potrebbe, è sotto controllo. E allora era
necessario arrestarlo? No, chiaro che non era necessario, dal punto di vista del
diritto e delle indagini, però serviva per lo show. Lo show must go on, come
abbiamo scritto nel titolo di prima pagina ed è giusto che la politica si
adegui. In fondo la magistratura di solito questo lavoro fa: lo show. Pensavate
che fosse così solo in Italia? No, no: tutto il mondo è paese (Meloni direbbe:
tutto il mondo è nazione…).
Ma l’arresto
di Tarabella è sufficiente per tenere su il Qatargate? Insieme all’arresto
di Eva Kaili, che è stata anche torturata, però non si è decisa a confessare né
ad accusare qualche collega, e quindi resta iun carcere e la sua bambina di due
anni resta sola. E’ sufficiente?
No, alla procura non
bastano Tarabella e Kaili ( più il compagno di Kaili, Giorgi). E allora, sotto
con l’italiano Cozzolino. Anche lui deputato europeo, anche lui privato senza
tante storie dell’immunità parlamentare. Ottimo boccone. Cozzolino. Ieri mattina
gli hanno perquisito l’ufficio, ieri sera la casa dove abita a Bruxelles.
Pare che non si
trovi proprio niente per accusare, ma questo non vuol dire che non possa essere
arrestato (anche per lui il coraggioso Parlamento ha dato il via libera). Spesso
anche Torquemada non trovava niente contro i dissidenti. E talvolta anche a lui
andava male pure la tortura. Mica per questo si fermava. Era un tipo tosto
Torquemada. Anche il magistrato belga pare che lo sia. E infatti ieri sera ha
firmato l’ordine di arresto per Cozzolino.
Piero Sansonetti.
Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di
cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004
al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per
poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre
2019.
Garantista con se
stesso, giustizialista con il centrodestra: la metamorfosi di Cozzolino.
Cozzolino
ha sempre cavalcato le inchieste giudiziarie contro gli avversari politici.
Domenico Ferrara il 12 Febbraio 2023 su Il Giornale.
«A fare a gara a
fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura», diceva Pietro Nenni. Ma
se il puro e l'epurato sono la stessa persona la situazione diventa ancora più
paradossale. È il caso di Andrea Cozzolino, arrestato su mandato della procura
belga nell'ambito della cosiddetta inchiesta Qatargate e da ieri agli arresti
domiciliari dopo aver passato una notte al carcere di Poggioreale.
All'europarlamentare vengono contestati i reati di organizzazione criminale,
corruzione e riciclaggio per regali e denaro ricevuto per favorire il Marocco
nella sua attività politica. Lui si professa innocente e sostiene di confidare
nell'operato della magistratura. Eppure, non è sempre stato così garantista.
Infatti, c'era un tempo non troppo lontano in cui Cozzolino vestiva quasi i
panni del giustizialista e si ergeva a simbolo della legalità. Naturalmente nei
confronti degli avversari politici. Per carità, ancora le accuse contro di lui
sono tutte da dimostrare e l'udienza sulla richiesta di estradizione si terrà il
prossimo 14 febbraio, però colpisce il doppiopesismo con cui Cozzolino nel 2017
affrontava lo scandalo che coinvolse l'allora sindaco di Torre del Greco
(Napoli), Ciro Borriello, sostenuto da una maggioranza di centrodestra. Fin dal
giorno seguente al suo arresto per l'accusa di corruzione e truffa, Cozzolino
iniziò subito a scagliarsi contro l'avversario politico. Era l'8 agosto 2017 e
Cozzolino tuonava: «L'arresto del sindaco di Torre del Greco è un episodio
gravissimo. Al di là delle presunte responsabilità dei singoli, questa vicenda
deve spingerci ad aprire una profonda riflessione rispetto al tema della
corruzione. Un cancro che si annida nel sottobosco delle istituzioni e che mina
dalle fondamenta la credibilità della politica». Alla faccia del garantismo,
della presunzione di innocenza e della fiducia nell'operato della magistratura.
Fa un certo effetto rileggere queste dichiarazioni roboanti e così nette.
Dichiarazioni che Cozzolino dovrebbe allora rivolgere a se stesso, seguendo
quantomeno una coerenza di pensiero. Troppo facile essere indulgenti con se
stessi e inflessibili giustizialisti con gli altri.
Dopo aver lodato le
dimissioni in blocco dei consiglieri, Cozzolino si rivolgeva poi al Partito
Democratico e alle forze migliori della società civile torrese che «hanno ora il
dovere politico-morale di costruire una credibile proposta alternativa al
malaffare e alla malapolitica. L'augurio è che dopo una stagione di bonifica
commissariale si possa tornare al voto cancellando così una delle pagine più
tristi e buie della storia di una città gloriosa e importante, anche a livello
europeo, come Torre del Greco».
Come se non
bastasse, due giorni dopo, Cozzolino rincarava la dose, chiedendo ufficialmente
al ministero dell'Interno «di accelerare le procedure relative alla nomina del
commissario prefettizio chiamato a guidare la città di Torre del Greco» per
uscire presto da questo «vortice del malaffare che ha caratterizzato, secondo
gli inquirenti, una delle stagioni più nere della storia politica campana».
Insomma, la cautela
non era proprio all'ordine del giorno. Fino a quando di mezzo non c'è stato lui.
Come sta succedendo adesso in uno dei principali scandali che ha colpito la
sinistra e in cui regna la corruzione, la stessa che Cozzolino definiva «un
cancro che si annida nel sottobosco delle istituzioni».
Estratto
dell'articolo di Alessandro Gonzato per “Libero quotidiano” il 14 febbraio 2023.
Ricordate il viaggio
in Qatar della dem Alessandra Moretti per i diritti dei lavoratori? Per renderne
conto a Bruxelles l’europarlamentare ha impiegato quasi 3 anni, 1.066 giorni, a
fronte dei 60 di tempo massimo. Il viaggio è del 16 e 17 febbraio 2020 e la
dichiarazione di partecipazione è stata compilata il 17 gennaio di quest’anno,
scoppiato il mega-scandalo mazzette legato al Paese che ha ospitato i mondiali
di calcio oltre al Marocco. […]
Spieghiamo: gli
eurodeputati, quando i viaggi non sono direttamente finanziati dall’istituzione,
dunque quando sono pagati da Stati terzi o associazioni, hanno l’obbligo di
dichiararli entro la fine del mese successivo indicandone i dettagli.
Se si va a spulciare
il sito deputato per deputato ci si accorge di una drastica inversione di
tendenza da prima a dopo lo scoppio del Qatargate: tra gennaio e novembre 2022
si registravano in media 4 dichiarazioni al mese, mentre da dicembre 2022 e
gennaio 2023 ne sono state depositate 104.
Un caso? Forse. Ma
è difficile non pensare a una voglia di dimostrare maggiore trasparenza legata
ai timori (magari anche infondati) dell’inchiesta. […]
La Moretti, in
quella visita del febbraio 2020, ha alloggiato al Ritz-Carlton, invitata dalla
Commissione qarariota dei diritti dell’uomo, arrivata in business class. La
moderatrice di una sessione del dibattito era Eva Kaili, la vicepresidente
destituita del parlamento Ue, in carcere dal 9 dicembre con le stesse accuse di
Antonio Panzeri, il grande “pentito” del Qatargate. Tra i relatori in Qatar,
anche Dimitris Avramopoulos, che più tardi sarebbe entrato nella Ong di Panzeri,
la Fight Impunity.
C’era pure il
socialista belga, anche lui arrestato, Marc Tarabella, in quei giorni al Ritz di
Doha, e lui era arrivato prima e se n’è andato dopo rispetto alla Moretti (che
per il Qatargate non è indagata, va ricordato). E anche a Tarabella è venuto in
mente 3 anni dopo di render conto del viaggio. […]
Le Soir ha
evidenziato che tra gli “smemorati” il 61,4% fa parte del ritardo gruppo
socialdemocratico (di cui fa parte il Pd) seguito dai Verdi (43,6). Il Ppe è al
23,9, l’Ecr (di cui fa parte Fratelli d’Italia, al 3,2) e Id (Lega) non ha
ritardatari. Il record-man di viaggi (legali) a scrocco è il Verde Reinhard
Butikofer, tedesco, “gretino” che in 6 mesi ne ha collezionati 22, oltre a
quelli ufficiali: alla faccia dell’ambiente. […]
Estratto
dell’articolo di François de Tonquédec per “La Verità” il 15 febbraio 2023.
La Ong No Peace
without justice ha sempre professato la sua estraneità al Qatargate, l’inchiesta
per una presunta corruzione che ha scosso le fondamenta delle istituzioni
europee. Anche quando il suo segretario generale Nicolò Figà Talamanca era stato
arrestato su mandato del giudice istruttore belga Michel Claise, con l’accusa di
essere uno dei sodali dell’ex europedutato Pier Antonio Panzeri, considerato
dagli inquirenti di Bruxelles il deus ex machina delle attività a favore del
Marocco e del Qatar.
Nei giorni scorsi
Figà Talamanca è stato liberato «senza condizioni», ma questo non ha spento i
riflettori che il Parlamento europeo ha acceso sul mondo delle Ong, in
particolare quelle citate negli atti dell’inchiesta sulla corruzione.
Un documento interno
firmato dal commissario europeo Johannes Hahn che La Verità ha potuto visionare
ricostruire infatti il flusso di denaro che la Ong fondata da Emma Bonino ha
ricevuto dalle istituzioni europee a partire dal 2006.
Complessivamente, i
7 progetti finanziati (su 9 presentati) hanno portato nelle casse di No Peace
without justice la bella cifra di «non più di 4,62 milioni di euro». Ma tre dei
progetti portati a termine avevano più «beneficiari» facendo salire il totale
delle somme uscite dalle casse dell’Ue a circa 5 milioni di euro. […]
Secondo il documento
che Hann ha inviato alla presidente della Commissione per il controllo dei
bilanci Monika Hohlmeier, al momento dell’esplosione del Qatargate aveva in
corso progetti per un valore di circa 2,7 milioni di euro, in parte già erogati.
I restanti 1,37 milioni di euro non ancora erogati dalla Commissione, spiega il
documento, «sono ora sospesi in via cautelare».
Ma su cosa
vertevano i progetti finanziati con fondi comunitari? Secondo il documento,
hanno perseguito vari obiettivi tra cui «il rafforzamento del sistema di
giustizia penale internazionale, la promozione e la protezione dei diritti umani
dei bambini e dei giovani in Siria e il miglioramento della capacità di
segnalazione del governo libico e della società civile in materia di diritti
umani».
Anche la Ong Droit
au droit (Diritto ai diritti), che condivide con No peace without justice lo
stesso indirizzo a Buxelles, ha beneficiato di fondi comunitari. […] Nello
stesso palazzo ha sede anche la Ong Fight for impunity, fondata da Panzeri nel
2019, che però non ha ricevuto «alcun sostegno finanziario dai fondi dell’Ue
gestiti direttamente dalla Commissione».
Una ricostruzione
che rafforza l’ipotesi che la costituzione della Ong fosse funzionale alla
gestione dei rapporti che Panzeri intratteneva con Qatar e Marocco. […]
Giovedì la Camera
di consiglio del tribunale di Bruxelles dovrà decidere se convalidare il carcere
per Tarabella, accusato di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio.
[…] I giudici belgi torneranno sempre giovedì mattina a riesaminare anche la
custodia cautelare dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili,
detenuta dal 9 dicembre scorso nella prigione di Haren. […]
Qatargate,
Cozzolino arrestato per una cravatta...Nel
mandato d’arresto del procuratore belga Michel Claise nessun indizio concreto. E
in mancanza di prove si sbattono gli indagati in cella per farli confessare.
Daniele Zaccaria su Il Dubbio il 15 febbraio 2023.
Pare che Andrea
Cozzolino non possa tornare in libertà per motivi di «pubblica sicurezza». È
quanto sostiene il procuratore belga Michel Claise, titolare dell’inchiesta
Qatargate che nel mandato di arresto dell’eurodeputato del Pd sottolinea «lo
stato d’animo» e «la personalità dell’indagato» tali da spingerlo «a commettere
nuovi reati simili o più gravi», «a far sparire le prove», o «provocare false
testimonianze».
Le accuse
formalizzate da Claise sono «associazione a delinquere», «corruzione» e
«riciclaggio». Cozzolino farebbe dunque parte di un’organizzazione criminale
animata dall’ex sindacalista Pier Antonio Panzeri, dal suo ex collaboratore
Francesco Giorgi e dal deputato europeo Marc Tarabella allo scopo di favorire
gli interessi del Qatar e del Marocco negli alti organismi comunitari in cambio
di lauti compensi. In particolare Cozzolino si sarebbe occupato di perorare la
causa marocchina su mandato di Abderrahim Atmoun, ambasciatore di Rabat a
Varsavia, con il quale avrebbe avuto diversi incontri.
Attorno alla figura
di Atmoun la procura bruxellese ha costruito una specie di romanzo con tratti da
spy story. L’ambasciatore prenderebbe infatti istruzioni da un sulfureo
funzionario della Dged (i servizi di intelligence marocchini), che si chiama
Mohamed Belharache e che nel 2016 fu accusato di aver infiltrato i servizi
antiterrorismo francesi, reduci dal massacro del Bataclan e ignari della strage
che sarebbe avvenuta a Nizza a luglio dello stesso anno. Belharache, che aveva
una residenza fittizia in Alsazia, era ufficialmente ricercato dalle autorità
transalpine ma non è mai stato individuato. Un curriculum controverso, quello
dell’agente segreto di Rabat, ma che non fornisce elementi concreti per vederci
più chiaro nell’inchiesta d i Claise. Si ha quasi l’impressione che il suo nome
venga evocato per scopi letterari più che per sostenere le tesi dell’accusa.
Ma veniamo ai fatti
più “concreti”. A tirare in ballo Cozzolino è stato lo stesso Giorgi, spremuto
in galera dagli inquirenti: «Cozzolino era implicato con il Marocco, aveva avuto
dei contatti con Atmoun grazie a Panzeri che era presidente della commissione
maghreb che gli ha passato il testimone. Entrambi hanno ricevuto regali e
denaro, non conosco la cifra esatta, ma parliamo di alcune decine di migliaia di
euro, meno che dal Qatar».
Il primo giugno
dello scorso anno Cozzolino aveva incontrato Atmoun in Polonia -scrivono gli
inquirenti- e in quell’occasione ha ricevuto «un’onorificenza» e in dono «una
cravatta» e «avrebbe discusso (o avrebbe voluto discutere) della linea da
seguire nella Commissione parlamentare mista Ue-Marocco». In un incontro
dell’anno precedente avvenuto nell’appartamento di Cozzolino a Bruxelles,
quest’ultimo avrebbe chiesto ad Atmun di poter parlare urgentemente con il
ministro degli esteri del Marocco «che gli avrebbe affidato una missione».
In
un’intercettazione telefonica Panzeri e Giorgi si sarebbero poi messi d’accordo
per far entrare Cozzolino e l’eurodeputata greca Eva Kaili nella Commissione
speciale Pegasus che si occupa di spionaggio informatico ai danni dell’Ue
«nell’ottica di difendere gli interessi marocchini». La testimonianza di Giorgi
e le deduzioni di Claise non sembrano però offrire più luce a un’inchiesta vaga
e fumosa che promette da mesi di «allargarsi a macchia d’olio», che stuzzica il
sensazionalismo dei media tutti eccitati nell’evocare “il più grande scandalo
nella storia dell’Ue” , ma che gira sempre intorno agli stessi elementi.
Claise sostiene che
Panzeri e Giorgi «avrebbero operato clandestinamente in cambio di remunerazione
affinché certe decisioni, dichiarazioni e risoluzioni venissero prese a favore
del Marocco in sede di Parlamento europeo». A quali importanti decisioni si
riferisce il procuratore non è però dato saperlo, anche perché non esiste a
memoria nessuna votazione o risoluzione specifica dell’europarlamento che abbia
favorito gli interessi del Marocco con il ruolo attivo degli indagati. L’unica
circostanza evidenziata da Claise sarebbe una dichiarazione di Cozzolino a
favore del riavvicinamento diplomatico tra Spagna e Marocco che gli avrebbe
chiesto Atmoun tramite l’intercessione di Panzeri. Non molto per stabilire il
reato di corruzione e associazione a delinquere.
Ma il procuratore
belga, come spiega nelle tante interviste concesse ai giornali, ha intenzione di
andare fino in fondo con il suo romanzo giudiziario. E a tenere in carcere gli
indagati il più tempo possibile per farli confessare. Il caso dell’ex
vicepresidente dell’europarlamento Eva Kaili, è emblematico: arrestata dalla
polizia giudiziaria belga che ha violato l’immunità parlamentare sostenendo che
fosse stata colta in flagranza di reato anche se il reato è attualmente
sconosciuto, è in prigione da oltre due mesi. Madre di un bambino di 22 mesi
privato di entrambi i genitori (il padre è per l’appunto Francesco Giorgi anche
lui in arresto) Claise non le ha concesso i domiciliari per poter occuparsi di
suo figlio, nella speranza che questo la facesse “crollare”. Nelle dittature per
farti parlare ti tirano via le unghie e minacciano di morte i tuoi familiari, in
democrazia questo non si può fare, ma alcuni magistrati, come il mediatico
Michel Claise, si affidano agli stessi principi approfittando al massimo e anche
oltre dei poteri investigativi che gli concede la legge e calpestando
allegramente la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa.
L’impressione, molto
fastidiosa, è che la pressione fisica e psicologica sugli imputati sia
inversamente proporzionale ai successi e agli avanzamenti dell’inchiesta. E non
c’è bisogno di essere degli ultras del garantismo per notare la contraddizione
come ha fatto peraltro l’ex procuratore antimafia molto duro sull’uso smodato
della custodia cautelare da parte dei colleghi belgi e sulla totale mancanza di
gravità indiziaria emersa finora dalle carte del “Qatargate”.
Oggi la decisione
sulla scarcerazione. Caso Qatargate, Tarabella chiede ricusazione del giudice
Claise: “Violata la presunzione di innocenza”.
Carmine Di Niro su
Il Riformista il 16 Febbraio 2023
Istanza
di ricusazione nei confronti del giudice istruttore Michael Claise “per
legittimo sospetto“. È la carta che si gioca la squadra legale dell’eurodeputato
socialista belga Marc Tarabella, arrestato venerdì scorso nell’ambito
dell’inchiesta Qatargate.
Ad annunciare la
richiesta è stato l’avvocato Maxim Toeller prima dell’inizio dell’udienza per la
convalida della detenzione del politico belga, con i magistrati del Palais de
Justice di Bruxelles che saranno tenuti oggi a decidere se convalidare il
carcere per l’eurodeputato dopo le “rivelazioni” dell’ex parlamentare
europeo Pier Antonio Panzeri, che ha patteggiato con la giustizia belga un anno
di carcere e che lo ha trascinato nell’indagine insieme al collega Andrea
Cozzolino, ora agli arresti domiciliari a Napoli.
“Secondo il codice
giudiziario, ‘ogni giudice può essere impugnato se vi è un legittimo sospetto‘.
E sospetti legittimi ci sono: a più riprese abbiamo potuto interrogarci sul
rispetto della presunzione di innocenza“, evidenzia il legale di Tarabella.
Sospetti che
sarebbero evidenti già nelle frasi utilizzate da Claise nel mandato di arresto,
dove si legge che “le posizioni pubbliche” di Tarabella “erano inizialmente
contro il Qatar, e poi sono state ribaltate quando è stato rilevato il movimento
sospetto di fondi‘” che ha innescato lo scandalo di corruzione, che secondo
l’avvocato Toeller “violano chiaramente la presunzione di innocenza“.
“Con questa
dichiarazione categorica il giudice lascia chiaramente intendere la sua opinione
sulla colpevolezza del signor Tarabella in questo fascicolo” e “in altre parole,
sembra evidentemente dare per scontati i fatti contestati e sui quali verte
l’indagine che sta dirigendo“, prosegue il penalista, sottolineando come “il
fascicolo non riveli alcun movimento di fondi sospetti a carico di Marc
Tarabella” e come “in questa fase nessuna analisi finanziaria sia stata
effettuata dal gip, il che è a dir poco inquietante“.
Quella odierna è una
giornata importante anche per gli altri indagati agli arresti nell’ambito
dell’inchiesta sulla presunta corruzione internazionale. A comparire davanti
alla Camera di Consiglio sarà infatti anche l’ex vicepresidente del Parlamento
europeo, l’esponente socialista greca Eva Kaili, rinchiusa dal 9 dicembre scorso
nella prigione di Haren.
Carmine Di Niro.
Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato
di politica, sport e tecnologia
Estratto
dell'articolo da “Libero quotidiano” il 17 febbraio 2023.
Niente
scarcerazione. Antonio Panzeri ed Eva Kaili restano in carcere a Bruxelles. Sono
dentro dal 9 dicembre, dallo scoppio ufficiale del Qatargate, con le accuse di
corruzione, riciclaggio e associazione a delinquere. Panzeri, ex eurodeputato
dem e di Articolo 1, ha ammesso le proprie responsabilità, è diventato
ufficialmente un “pentito” e in cambio ha ottenuto una pena massima a un anno,
oltre che una multa.
[…] La Kaili,
stando a fonti giudiziarie, dovrebbe rimanere dentro almeno altri 2 mesi.
L’altro socialista, l’eurodeputato Marc Tarabella, ha ricusato il giudice. Anche
per lui, comunque, è stato confermato il carcere.
Fabio Amelondara
per “La Verità” il 17 febbraio 2023.
Un’istanza di
ricusazione per «legittimo sospetto» tiene lontano Michel Clais, il giudice
istruttore che fa tremare l’ala sinistra del Parlamento europeo, dall’udienza
sulle mazzette pagate da Qatar e Marocco per influenzare le decisioni di
Bruxelles. È stato il difensore del deputato socialista Marc Tarabella a giocare
la carta anti Clais.
Secondo l’avvocato
Maxim Toller, Clais avrebbe mostrato dei pregiudizi nei confronti del suo
assistito: «Le frasi di Claise indicate nel mandato di arresto, nel quale si
legge che “le posizioni pubbliche” di Tarabella “erano inizialmente contro il
Qatar e poi sono state ribaltate quando è stato rilevato il movimento sospetto
di fondi”, violano chiaramente la presunzione di innocenza».
Stando alla
richiesta di ricusazione, «con questa dichiarazione categorica il giudice»
lascerebbe «intendere la sua opinione sulla colpevolezza di Tarabella in questo
fascicolo». Secondo la difesa, invece, «il fascicolo non rivela alcun movimento
di fondi sospetti a carico di Tarabella». Inoltre, alcuna analisi finanziaria
sarebbe stata effettuata dal gip, «il che», secondo i difensori, «è a dir poco
inquietante». In attesa che la Corte d’appello si esprima sull’istanza, Clais è
stato momentaneamente sostituito. […]
[…] Eva Kaili,
rinchiusa dal 9 dicembre scorso nella prigione di Haren, invece, ieri, con il
nuovo difensore, Sven Mary, noto per aver difeso il terrorista Salah Abdeslam
(uomo del commando degli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi), ha provato a
chiedere un’attenuazione della detenzione. «Le condizioni di Kaili sono
difficili, deve stare a casa con la figlia di 24 mesi. Abbiamo chiesto la
scarcerazione oppure che venga disposto per lei un regime di sorveglianza
elettronica», ha spiegato l’avvocato Mary.
[…] Alla fine però
i giudici hanno lasciato Kaili in carcere. E anche Panzeri, nonostante abbia già
patteggiato con la giustizia belga un anno di carcere, trasformandosi nella gola
profonda dell'inchiesta Qatargate. […]
L'inchiesta belga
sempre più fragile. Scandalo Qatar: i garantisti a dondolo sono peggio dei
manettari.
Gian Domenico Caiazza su Il Riformista il 19 Febbraio 2023
Esiste
un garantismo a corrente alternata, assai diffuso nella politica nostrana, che
fa più danni del peggiore fanatismo giustizialista. Esso, infatti, accredita
l’idea che la invocazione dei principi di garanzia in favore delle persone
indagate o imputate di un qualche reato sia in realtà motivata non da autentica
fedeltà a quei principi, ma da ben più mediocri ed occasionali ragioni di
convenienza politica. Quei principi, perciò, ne risultano sviliti e resi deboli
e non credibili agli occhi della pubblica opinione, che li vede invocati o
negletti dalle stesse persone, a seconda di chi siano gli indagati, e di quale
sia la convenienza politica.
Esemplare, tra le
ultime, è la recente vicenda giudiziaria belga su presunte corruzioni
di parlamentari europei, in prevalenza italiani (ma non solo). Ne abbiamo già
parlato, ma occorre ritornarci su, perché più passa il tempo, più la natura di
quella indagine appare inspirata a metodi inquisitori arbitrari indegni di un
paese civile. Ovviamente, come abbiamo già avuto modo di dire, detenere borsoni
con centinaia di migliaia di euro nascosti sotto il letto dà subito la certezza
di affari illeciti in corso, o già consumati. E se questo accade ad un uomo
politico, la conseguenza immediata – salvo spiegazioni credibili – è la fine
immediata della carriera, con una buona dose di ignominia.
Ma le regole del
processo penale sono diverse: è onere di chi accusa ed indaga scoprire di quali
attività illecite certe e concrete quei soldi siano il frutto. E quello che non
può assolutamente accadere è che la libertà personale degli indagati, la gran
parte dei quali non ha peraltro nemmeno il borsone sotto il letto, venga
sacrificata prima di una sentenza di condanna senza che l’accusa abbia assolto
l’onere di allegare chiari e consistenti indizi dei reati che vengono
contestati.
Ebbene, più
trascorre il tempo e meno abbiamo cognizione di approdi concreti sulle
materiali attività illecite poste in essere dai vari indagati, nonostante -a
quando apprendiamo- siano da tempo in corso attività collaborative da parte di
alcuni di essi. Quali attività di favore, quali atti parlamentari, quali
delibere esattamente sono state proposte e magari anche approvate su iniziativa
da ciascuno degli indagati, da parte del Parlamento Europeo, in cambio di quel
denaro? Sono perplessità espresse, per esempio, anche dalla Corte di Appello di
Napoli a proposito della misura cautelare richiesta nei confronti
dell’on. Cozzolino.
Quale atto illecito
concreto e certamente identificabile si addebita a costui, da mesi braccato come
un pericoloso criminale dal vorace giudice istruttore belga? E non parliamo
della ex Vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, in carcere da tre
mesi, con divieto di incontrare la piccola sua figlia se non in saltuarie ed
eccezionali occasioni: quali atti materiali le si addebitano, commessi quando e
come? E prima ancora, quali sarebbero le esigenze cautelari (fuga? inquinamento
delle prove? reiterazione del reato?) che giustificano una così implacabile
privazione della libertà personale prima di una sentenza di condanna? Insomma,
perché questa donna non può essere indagata a piede libero, o almeno
agli arresti domiciliari?
Il sospetto, più che
legittimo ed ogni giorno che passa più concreto, è che il famoso giudice
istruttore Claise stia aspettando che la donna confessi un qualche reato del
quale egli sospetta, ma non ha saputo ad oggi raccogliere alcuna concreta
traccia investigativa. Ebbene, tutti coloro che hanno a cuore elementari
principi di garanzia della persona indagata, chiunque essa sia e di qualunque
reato sia indagata, dovrebbero insorgere indignati. E invece, la collocazione
politica degli indagati italiani fa sì che il fronte politico opposto esulti,
magnificando il giudice sceriffo con titoli cubitali sui giornali di area.
L’occasione politica
è imperdibile, ed ecco allora che i princìpi del garantismo, in altre occasioni
invocati con veemenza ed indignazione, vengono senza esitazione accantonati. E
lo stesso vale al contrario: l’articolo dell’on. Roberti che denunzia la
inconsistenza delle accuse al suo collega di partito è del tutto condivisibile,
ma facciamo fatica a pensare che ne avremmo letto uno analogo se indagato fosse
stato invece un suo antagonista politico.
Sarebbe il caso di
riflettere seriamente, da parte di tutti, sui danni che si provocano praticando
e predicando, con questa faziosità e con questo doppiopesismo, principi
fondamentali di garanzia dei diritti della persona che sono credibili solo se
praticati e predicati sempre, senza eccezioni. L’opinione pubblica guarda,
ascolta, e ne trae le conseguenze. Non meravigliamoci, poi, se l’oggetto più in
voga e di maggiore successo popolare continui ad essere la forca. Ed è sempre
bene non dimenticare quello che la storia ci ha immancabilmente insegnato:
quando la forca è in piazza, non è difficile, prima o poi, finirci impiccati.
Gian Domenico
Caiazza Presidente Unione CamerePenali Italiane
I verbali di
Panzeri: «Anche per Lara Comi (Forza Italia) soldi dal Qatar». Giuseppe
Guastella su Il Corriere della Sera il 25 Febbraio 2023.
Il pentito del
Qatargate: «Mi arrivarono anche 600 mila euro per l’ex segretaria della Cgil
Camusso, ma ne diedi solo 50 mila al suo assistente». Tutti gli interessati
smentiscono
Il fiume in piena
delle confessioni a Bruxelles del pentito Antonio Panzeri aggrava la posizione
nel Qatargate degli eurodeputati Andrea Cozzolino, Eva Kaili e Marc Tarabella,
introducendo sospetti, tutti da chiarire, su altri due personaggi che vengono
inseriti tra coloro che, nei progetti dell’organizzazione, avrebbero dovuto
essere obiettivo dei finanziamenti in contanti provenienti dal Golfo
Persico: l’ex segretario generale della Cgil italiana Susanna Camusso e
l’attuale eurodeputata di Forza Italia Lara Comi. Per la prima volta, inoltre,
Panzeri dichiara che a Cozzolino, Kaili e Comi erano destinati 250 mila euro a
testa per aiutarli nella campagna elettorale del 2019.
Mentre a Bruxelles
gli avvocati di Tarabella hanno chiesto al giudice istruttore Michel Claise di
astenersi dall’inchiesta per presunti comportamenti irregolari e la difesa di
Kaili continua a protestare per il trattamento riservato in carcere della ex
vice presidente del parlamento europeo arrestata con gli atri il 9 dicembre, in
Belgio il quotidiano Le Soir e il settimanale Knak e, in Italia, La
Repubblica, pubblicano ampi stralci dei verbali riempiti da Panzeri il 12 e il
13 febbraio, dopo il pentimento che ha garantito 5 anni di reclusione, di cui
appena uno in carcere o ai domiciliari, all’ex euro deputato di Articolo uno
stratega delle manovre pro Qatar e Marocco, ai quali ora aggiunge anche la
Mauritania, per condizionare la politica del parlamento a favore dei tre stati.
La procura federale,
che affianca Claise, giovedì ha anche detto sì ai domiciliari per Francesco
Giorgi, ex assistente di Panzeri, suo socio nelle manovre e attuale assistente
di Cozzolino. Oltre Panzeri, in cella in Belgio restano solo gli «irriducibili»
Eva Kaili e l’italo-belga Tarabella, e in Italia, ma ai domiciliari, Cozzolino.
Tutti e tre si dichiarano innocenti.
Il Qatar principale
«azionista»
In tutto, rivela
Panzeri, dai tre Stati con Giorgi avrebbe incassato dal 2018 al 2022 circa 2,6
milioni di euro, 2,2 dal solo Qatar, che è il principale finanziatore delle
trame dell’ex sindacalista lombardo all’ombra della sua ong Fight impunity.
Panzeri, secondo quanto riporta Le Soir, dichiara che l’accordo con il Qatar
risale al 2018 con l’obiettivo di migliorare l’immagine del Paese, che aveva, ed
ha, non pochi problemi sul piano dei diritti umani e che 4 anni dopo avrebbe
ospitato il Mondiale di calcio. Fu Ali bin Samikh Al Marri, allora presidente
del Comitato per i diritti umani e attuale potente ministro del lavoro, ad
invitare in Qatar lui e il suo assistente-socio. I due spartiranno gli introiti
al 50%. «Io e Francesco Giorgi ci siamo messi d’accordo per un lavoro di
lobbying. Abbiamo deciso di impiegare un milione di euro nel 2018 e nel 2019 e
250 mila euro pro capite all’anno dopo, dal 2020 al 2024». Il denaro, però,
sembra arrivare attraverso una società turca, non tutto, ma solo 250 mila euro
alla società Equality creata in Italia e poi chiusa dalla commercialista di
Panzeri Monica Bellini, che è ai domiciliari. Per Panzeri, che già prefigurava
di non tornare al parlamento europeo nel 2019, l’attività lobbistica
rappresentava il futuro. Per questo motivo «era necessario scommettere su
parlamentari che sarebbero stati certamente eletti. Avevo dato due nomi ai
qatarini: Andrea Cozzolino e Lara Comi. E Francesco Giorgi ha parlato della sua
compagna Eva Kaili» i quali «avevano bisogno di soldi per la loro campagna» e
avrebbero partecipato ad una riunione che si sarebbe tenuta a Doha tra marzo e
aprile 2019. «Sono sicuro che alla fine di questa riunione, i qatarini hanno
deciso di mettere a disposizione per le campagne elettorali dei tre 250 mila
euro ciascuno». Il legale di Comi, l’avvocato Giampiero Biancolella, smentisce
il finanziamento e la riunione.
Panzeri, invece,
afferma, sempre secondo Le Soir, che a casa di Giorgi arrivarono un milione e
250 mila euro in contanti: «C’erano anche 250 mila per me e Francesco Giorgi
nell’ambito di questo accordo. Francesco Giorgi ha distribuito questi soldi a
tutti, compreso me. Li ha consegnati a Eva (Kaili), Andrea
(Cozzolino)». Riguardo Laura Comi, non sa se abbia mai ricevuto denaro, ma
raconta un’altra storia, e cioè che fu lei a chiamarlo «in aprile o maggio 2019»
per chiedergli «se potevo ritirare una borsa dal suo appartamento a
Bruxelles». Pochi giorni dopo, Comi viene arrestata a Milano nell’inchiesta
Mensa dei poveri. Panzeri dichiara che a quel punto andò a prendere la borsa con
l’assistente di allora della Comi, Giuseppe Meroni. Dentro stima ci fossero
«60-70.000 euro», che però non contò. «Ho preso tutto, ho deciso di buttare i
soldi nella spazzatura». Non avrà più contatti con Comi che non sarà rieletta e
rientrerà all’ europarlamento solo dopo che Silvio Berlusconi si dimetterà con
l’elezione a settembre 2022 al Senato italiano. L’avvocato della Comi, Giampiero
Biancolella, smentisce che la sua cliente abbia ricevuto finanziamenti.
Il Qatar e i
sindacati
Il Qatar voleva
avere il favore dei sindacati internazionali per i problemi che aveva, ed ha,
con i diritti del lavoratori impegnati nella costruzione degli stadi. In questo
ambito compare il nome di Susanna Camusso che era candidata nel 2018 alla
segretaria generale della Confederazione sindacale internazionale, posto al
quale salirà nel 2022 Luca Visentini, inizialmente coinvolto nel Qatargate ed
immediatamente scarcerato per 50 mila euro ricevuti da Panzeri ed in parte usati
per la campagna della nomina. Panzeri afferma che il Qatar gli aveva consegnato
600 mila euro per aiutare la Camusso ma che, alla fine, l’assistente della
stessa, avrebbe detto di aver bisogno «solo» di 50 mila euro. Avrebbe poi
spartito 50 mila euro con Giorgi e tenuto per sé i restanti 500 mila, che sono
la gran parte dei 600 mila trovati a casa sua dopo l’arresto del 9 dicembre.
Camusso, al
quotidiano Le Soir, ha affermato di aver incontrato nel 2018 Panzeri che le
presentò «il rappresentante di una ong che, secondo lui, era impegnata nel
settore dei diritti umani in Qatar (…) Durante l’incontro, non mi è stato
chiesto di sostenere il governo del Qatar in alcun modo, e non abbiamo parlato
affatto di soldi. Abbiamo parlato solo della necessità di promuovere i sindacati
in Qatar».
Kaili ai Mondiali
Eva Kaili è indicata
da Panzeri anche per aver sostenuto gli interessi del Qatar durante la cerimonia
di inaugurazione dei Mondiali, alla quale partecipò su invito nel Paese. In
quell’ occasione avrebbe chiesto al presidente della Fifa Gianni Infantino di
intervenire sul presidente francese Emmanuel Macron che era contrario a
concedere la esenzione, in discussione in parlamento europeo, per i cittadini
del Qatar dal visto di ingresso nei paesi Ue. «Non so se l’ha fatto», specifica.
Tra i motivi per i quali la procura vuole che la parlamentare greca resti in
carcere, c’è anche l’intercettazione di una conversazione con la quale
chiederebbe ad un parente in visita di recuperare un telefono cellulare e delle
chiavette Usb che si troverebbero a casa sua.
Il nodo Cozzolino
Panzeri, come
detto, parla anche di 250 mila euro destinati ad Andrea Cozzolino, sospeso dal
Pd, negli atti per l’attività presunta a favore del Marocco. «Cozzolino è sempre
alla ricerca di risorse finanziarie», «vuole sempre più soldi» si legge nei
verbali pubblicati da Le Soir. «Atmoun (ambasciatore di Rabat a Varsavia,
coinvolto nelle indagini, ndr) mi ha chiamato, perché Cozzolino gli stava
rompendo le scatole con i soldi. Mi ha chiesto se potevo anticipargli 10 mila
euro per Cozzolino. L’ho fatto». Cozzolino e i suoi legali hanno sempre negato
alcun pagamento.Arriva la conferma delle accuse già esposte dalla Procura di
Bruxelles che, per ottenere da Parlamento la rimozione dell’immunità al
Parlamento per Tarabella, ha scritto che avrebbe ricevuto tra 120 e 140 mila
euro da Panzeri. Come gli altri, anche lui avrebbe dovuto incassare 250 mila
euro entro la fine della legislatura.
La Mauritania
Giorgi aveva detto
di aver affittato un appartamento all’ambasciata della Mauritania per 1.500 euro
al mese più 300 di spese. Era un modo di dare un’apparenza d legalità ad un
passaggio di soldi per fare lobbismo a favore dello stato africano. Altri 25
mila euro andarono a Panzeri il quale, però ora specifica che tra il 2019 e il
2021 hanno ricevuto in tutto 100 mil euro a testa.
Estratto
dell’articolo di Sandro de Riccardis e Luca De Vito per “la Repubblica” il 25
febbraio 2023.
«C’è stato un
incontro a Doha, nella primavera del 2019, con il ministro Al Marri, Francesco
Giorgi, l’algerino (Boudjellal, ndr) e io, Andrea Cozzolino, Lara Comi. Penso
che Eva Kaili fosse presente, ma la decisione presa, in termini di denaro per i
deputati, includeva anche lei. Al termine, i qatarini hanno deciso di mettere a
disposizione per le campagne elettorali dei tre, 250.000 euro ciascuno. Ed è
stato fatto».
È il 13 febbraio
scorso: l’ex europarlamentare Pd (poi di Articolo 1) Antonio Panzeri
ricostruisce con i pm di Bruxelles Michael Claise e Raphael Malagnini la rete di
politici a libro paga di Qatar, Marocco e Mauritania. Dove per la prima volta
spunta l’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi.
Ma Panzeri parla
anche dei presunti finanziamenti qatarini per la campagna di Susanna Camusso a
leader del sindacato mondiale, e delle presunte pressioni di Kaili sul capo del
calcio mondiale, Gianni Infantino, per il problema dei visti. Panzeri ha
partecipato all’accordo con cui Cozzolino, Comi e Kaili avrebbero accettato il
denaro dal Qatar.
«È importante
smentire l’idea che io sia il grande capo. Queste persone accettavano denaro in
cambio della tutela degli interessi del Qatar come parte del loro lavoro
parlamentare. Si stabilì che Giorgi assumesse il ruolo di assistente di
Cozzolino. I soldi sono arrivati a casa sua, un milione e 250mila euro in
contanti. C’erano anche 250mila euro per me e per lui».
«Nel 2019 Comi mi
ha chiamato chiedendo un favore, se potevo ritirare una borsa dal suo
appartamento a Bruxelles e metterla da parte». Panzeri riceve la telefonata a
Milano, così chiede all’assistente Giuseppe Meroni di ritirare la borsa.
«Meroni cercava la
borsa, che portò con sé».
Panzeri ricorda che
poi Comi venne arrestata nell’inchiesta “Mensa dei poveri”. «A seguito della
situazione, sono andato da Meroni e abbiamo aperto la borsa. Ho visto dei
vestiti e dei libri vuoti all’interno, con contanti tra 60 e 70mila euro, non li
ho contati. Quindi ho preso tutto, ho deciso di buttare via i soldi nella
spazzatura. Meroni ha visto i soldi ma non ha preso niente».
Panzeri dice di
aver parlato con Comi. «Le ho solo detto che i soldi non c’erano più. (...)
Sulla borsa, le ho detto che il caso è chiuso e non mi ha chiesto altro. Non so
da dove vengano i soldi di questa borsa». L’ex eurodeputato non è quindi in
grado di ricostruire se si trattasse di parte dei 250mila euro derivanti
dall’accordo col Qatar o di una somma legata ad altre vicende. L’avvocato di
Comi, Gian Piero Biancolella, precisa che «Comi non ha mai accettato
finanziamenti illeciti per la campagna 2019».
Nel precedente
interrogatorio del 2 febbraio, Panzeri parla dell’amicizia con Abderrahim
Atmoun, ambasciatore marocchino a Varsavia. «Nel 2014 mi disse che voleva
aiutarmi con la mia campagna elettorale. Suggerì di organizzare una festa alla
quale fossero invitati i marocchini autoctoni che avevano votato in Italia».
Panzeri racconta di aver affittato ilBlue Note , a Milano, pagato da Atmoun,
«circa 50mila euro (...)». Nel 2014, dopo l’elezione, ho ricevuto una forma di
Legione d’Onore a Rabat dal re del Marocco. Era la Festa del Trono. Mia figlia
era lì».
[…] Il gruppo si
occupa anche dell’elezione del presidente dell’Unione globale dei sindacati del
2018. Panzeri ricorda un incontro a Bruxelles. «Eravamo Giorgi, Al Marri,
l’algerino e io. Mi è stato chiesto chi fosse l’italiana candidata. Dissi che
conoscevo Camusso perché eravamo stati nello stesso sindacato (Cgil, ndr.). Mi
dicono che l’avrebbero incontrata volentieri e l’avrebbero aiutata. Ho parlato
con lei a Milano e mi dice di essere disponibile per questo incontro, che si è
tenuto poche settimane dopo». Non si parlava di soldi ma di aiuti ai sindacati
africani e al medio Oriente. «In precedenza, avevamo individuato una cifra di
600mila euro (…) che mi sono stati dati dall’algerino in una borsa e sono una
buona parte dei soldi trovati nella mia casa. Poi ho saputo che bastavano solo
50mila. Mi restavano quindi 500mila che ho tenuto».
«Non mi è stato
chiesto di supportare il Qatar in nessun modo, né si è parlato mai di denaro -
replica Camusso - . So che alcune donazioni sono state ricevute da altri
sindacati per le organizzazioni più povere. Non ero coinvolta direttamente e non
conosco i dettagli
Estratto
dell’articolo di Sandro De Riccardis e Luca De Vito per “la Repubblica” il 26
febbraio 2023.
Brando Benifei,
Andrea Cozzolino, Alessandra Moretti. Davanti ai magistrati di Bruxelles,
Antonio Panzeri, spiega che i tre europarlamentari del Pd sono stati eletti in
Europa nel 2019 grazie ai voti «decisivi» della comunità marocchina nei loro
rispettivi collegi. A quella tornata elettorale, Panzeri decide di non
candidarsi. E l’ambasciatore marocchino a Varsavia Abderrahim Atmoun gli chiede
di indicare chi «poteva aiutarlo in Italia». «Gli ho dato i nomi di Benifei,
Moretti e Cozzolino — mette a verbale Panzeri —. Questi parlamentari erano
rappresentati dai rispettivi assistenti durante un importante incontro che si è
tenuto a Roma con Atmoun e il responsabile dei cittadini marocchini nel mondo di
cui non ricordo più il nome».
Nei verbali, che
Repubblicaha letto insieme a Le Soir e Knack ,Panzeri spiega che «la comunità
italomarocchina è la seconda straniera in Italia, e ascolta con attenzione le
direttive date da questo uomo di Stato. […]»
Benifei, in una
nota, precisa: «Non ho mai avuto contatti diretti, né tramite miei assistenti,
con il signor Atmoun, in generale o per la campagna elettorale. Ricordo la
proposta di Panzeri e del suo assistente Meroni per un incontro a Roma in cui si
diceva che ci potevano essere buoni contatti da incontrare per le elezioni e
avevano menzionato Atmoun, ma io non andai e non mandai nessuno a partecipare».
Panzeri ripercorre
il suo rapporto con Atmoun. Parla di «un’amicizia» che va avanti da oltre dieci
anni, consolidata da inviti reciproci, viaggi con le rispettive famiglie,
vacanze di lusso.
[…] È nel 2014 che
Atmoun, ricorda Panzeri, «mi disse che voleva aiutarmi con la mia campagna
elettorale». Il sostegno va a buon fine. Panzeri viene eletto. «La mia amicizia
con Atmoun si è consolidata nel tempo. Dal 2014 sono stato invitato con la
famiglia, sei o sette volte, in Marocco. Eravamo io, mia moglie e mia figlia. La
scorsa Pasqua c’era anche il compagno di mia figlia».
Panzeri tiene a
precisare che «tra il 2014 e il 2019 non ci sono mai stati rimborsi. Solo viaggi
che hanno rafforzato la nostra amicizia. Infatti, da parte mia, ho invitato
anche Atmoun e la moglie due volte a Rimini e due volte a Milano. Mi sono
occupato di hotel e ristoranti. Ho nuovamente offerto una settimana di vacanza a
Cuba per tre persone nell’ottobre 2018. Con me c’era Atmoun e Giuseppe Meroni».
Meroni è stato il
suo assistente a Bruxelles, passato nell’ufficio di Lara Comi dopo le elezioni
2019. Le cortesie venivano ricambiate. Altri viaggi venivano pagati da Atmoun.
«Penso a una settimana trascorsa al Mamounia di Marrakech, nel 2017 o nel 2018».
Nell’hotel di gran lusso erano presenti, «Meroni e la sua compagna, Lucia Rocca
(tra i fondatori della Ong Fight Impunity , ndr ),Francesco Giorgi ed Eva Kaili.
Questi viaggi sono stati totalmente, esclusi gli extra, organizzati e pagati da
Atmoun che ci ha inviato i numeri dei voli tramite sms».
Secondo Panzeri,
«anche Cozzolino e la moglie sono stati invitati alle stesse condizioni da
Atmoun. So che doveva andare a Tangeri e ha continuato il suo soggiorno a
Marrakech». Altri viaggi ancora: «Nel 2015, in occasione del suo 60esimo
[…] Ai pm di
Bruxelles interessano anche i rapporti di Atmoun con altri politici italiani.
«Cozzolino è sempre alla ricerca di risorse finanziarie — dice Panzeri —. Vuole
sempre più soldi e mi ha chiesto cosa potevamo fare con il Marocco. È così che
ho proposto ad Atmoun di incontrarlo a Varsavia». Secondo Panzeri, «si è creato
un vero e proprio rapporto tra i due. Ad esempio, Atmoun mi ha chiamato perché
Cozzolino lo infastidiva con i soldi. Mi ha chiesto se potevo anticipargli
10mila euro per lui e l’ho fatto. Ho portato questa somma a Cozzolino nel 2021.
Questa somma non mi è stata rimborsata».
Panzeri parla anche
di Moretti. «Atmoun ha conosciuto Moretti in Veneto. Lui è stato sposato con
un’italiana e, di tanto in tanto, si recava in questa regione per vedere la sua
famiglia. Moretti ha mantenuto i rapporti con Atmoun e so che anche lei, con la
sua assistente, è già stata a Varsavia e in Marocco». Moretti in una nota ha
spiegato: «Ho conosciuto il signor Atmoun nel 2019, perché Panzeri me lo ha
presentato. Non abbiamo mai affrontato temi particolari né mi sono interessata a
questioni legate al Marocco negli ultimi anni».
(ANSA il 27 febbraio
2023) - La Procura europea (Eppo) di Milano con la Guardia di Finanza di Brescia
ha eseguito un sequestro di oltre 170mila euro nei confronti della eurodeputata
bresciana della Lega Stefania Zambelli, e nei confronti di quattro dei suoi
assistenti, nell'ambito di un'indagine su possibili frodi in materia di
indennità parlamentari.
L'indagine riguarda
un sospetto di frode ai danni del bilancio Ue, riguardante la retribuzione di
quattro assistenti parlamentari assunti in Italia, ma che non avrebbero svolto
le attività connesse alla funzione per la quale erano stati assunti, o le hanno
svolte solo parzialmente, documentando falsamente la loro attività al Parlamento
europeo. Avrebbero anche travisato i propri titoli di studio, avendo dichiarato
competenze scolastiche e professionali che, secondo le indagini, non avevano.
Si ritiene che
l'eurodeputato, strettamente legato ad almeno una delle persone assunte, abbia
beneficiato anche delle somme corrisposte dal Parlamento europeo per le attività
lavorative che il personale avrebbe dovuto svolgere. I danni stimati al bilancio
dell'UE ammontano a 172.148,82 euro. Stefania Zambelli era candidata anche alle
recenti elezioni regionali ed è la prima dei non eletti a Brescia.
(ANSA il 27 febbraio
2023) - "In merito ai fatti che hanno determinato l'esecuzione del sequestro
preventivo a mio carico, tengo a precisare che né io né i miei collaboratori
abbiamo commesso alcun illecito. Il nostro operato è sempre stato improntato
alla massima lealtà e trasparenza nei confronti delle Istituzioni e della
collettività". Così sul suo profilo Facebook l'eurodeputata della Lega Stefania
Zamberlli dopo la notizia dell'indagine Eppo.
"Mi preme
sottolineare che l'assistente parlamentare che con la sua denuncia ha dato
origine a questo procedimento, è la stessa persona che mi aveva già denunciato
al Parlamento europeo nel 2019, con le stesse argomentazioni", prosegue
Zambelli. "In quella circostanza, per i medesimi fatti, questa assistente è
stata all'esito del giudizio licenziata per giusta causa, secondo le indicazioni
ricevute dagli stessi funzionari del Parlamento europeo, mentre nei miei
confronti non è stato emesso alcun provvedimento. Sono a completa disposizione
delle Autorità Giudiziaria per qualsiasi chiarimento", conclude Zambelli.
Nell'ambito
dell'inchiesta su una presunta truffa all'Unione Europea per le indennità
parlamentari che ha coinvolto l'eurodeputata bresciana della Lega Stefania
Zambelli, risulta indagato anche l'ultrà del Milan Marco Pacini, appartenente
alle Brigate rossonere, compagno della figlia della deputata e che risulta nello
staff dell'esponente bresciana. Una parte del sequestro da 170 mila euro ha
riguardato anche Pacini a cui gli uomini della Guardia di Finanza hanno
sequestrato anche un'auto. (ANSA)
Truffa al
bilancio europeo: sequestrati 172 mila euro all’eurodeputata della Lega Stefania
Zambelli.
Redazione CdG 1947 su Il Corriere delGiorno il 27 Febbraio 2023
Non è questa la
prima volta che un eurodeputato viene indagato per l’utilizzo dei fondi del
Parlamento europeo previsti per gli assistenti parlamentari. Nel 2019, la
forzista Lara Comi era stata denunciata per truffa ai danni dell’istituzione Ue
proprio perché sospettata di aver usato i fondi per gli assistenti per fini
personali. Il processo è ancora in corso, mentre Comi è tornata a sedere sui
banchi del Parlamento europeo
Sequestrati oltre
172 mila euro all’europarlamentare Stefania Zambelli (Lega) 51 anni, ed a
quattro suoi collaboratori a Bruxelles. Secondo la Procura Europea e la Guardia
di Finanza di Brescia la cifra corrisponde ai danni stimati al bilancio dell’Ue
per una presunta truffa relativa fondi erogati al suo staff assunto in Italia.
Per gli inquirenti, i collaboratori della Zambelli non avrebbero svolto o in
alcuni casi solo parzialmente le attività relative alle funzioni per cui erano
stati assunti e avrebbero falsificato la documentazione sul loro operato al
Parlamento europeo, mentendo anche sui loro titoli di studio ed esperienze
professionali pregresse, mai conseguite e tantomeno raggiunte.
Alla Zambelli
dipendente amministrativa dell’Asst Garda in aspettativa, viene poi contestato
di essere strettamente legata ad almeno una delle persone assunte e di avere
beneficiato anche delle somme corrisposte dal Parlamento europeo per le attività
lavorative che il personale avrebbe dovuto svolgere. Tra i collaboratori
co-indagati risulta esserci anche Marco Pacini detto “Pacio” ultrà del Milan
appartenente alla Curva Sud, e compagno della figlia della eurodeputata
leghista.
“Secondo gli
elementi di prova – si legge in un comunicato dell’Eppo – i quattro membri del
personale non hanno svolto le attività connesse alla funzione per la quale erano
stati assunti, o le hanno svolte solo parzialmente, documentando falsamente la
loro attività al Parlamento europeo. Inoltre, hanno travisato i propri titoli di
studio, avendo dichiarato competenze scolastiche e professionali di cui, secondo
l’inchiesta, non disponevano. Si ritiene – continua il comunicato – che
l’eurodeputata, strettamente legata ad almeno una delle persone assunte, abbia
beneficiato anche delle somme corrisposte dal Parlamento europeo per le attività
lavorative che il personale avrebbe dovuto svolgere“.
Una parte del
sequestro da 172 mila euro, eseguito lo scorso giovedì 23 febbraio, ha
riguardato anche un’auto di sua proprietà. “Né io né i miei collaboratori
abbiamo commesso alcun illecito. Il nostro operato è sempre stato improntato
alla massima lealtà e trasparenza nei confronti delle Istituzioni e della
collettività“, ha dichiarato Zambelli su Facebook. “Mi preme sottolineare che
l’assistente parlamentare che con la sua denuncia ha dato origine a questo
procedimento, è la stessa persona che mi aveva già denunciato al Parlamento
Europeo nel 2019, con le stesse argomentazioni” ha sottolineato l’esponente del
Carroccio. “In quella circostanza, per i medesimi fatti, questa assistente –
aggiunge la Zambelli – è stata all’esito del giudizio licenziata per giusta
causa, secondo le indicazioni ricevute dagli stessi funzionari del Parlamento
Europeo, mentre nei miei confronti non è stato emesso alcun provvedimento. Sono
a completa disposizione della autorità giudiziaria per qualsiasi
chiarimento”. Stefania Zambelli si è candidata anche alle recenti elezioni
regionali ed è la prima dei non eletti a Brescia.
Non è questa la
prima volta che un eurodeputato viene indagato per l’utilizzo dei fondi del
Parlamento europeo previsti per gli assistenti parlamentari. Nel 2019, la
forzista Lara Comi era stata denunciata per truffa ai danni dell’istituzione Ue
proprio perché sospettata di aver usato i fondi per gli assistenti per fini
personali. Il processo è ancora in corso, mentre Comi è tornata a sedere sui
banchi del Parlamento europeo. Anche Eva Kaili, l’ex vicepresidente
dell’Eurocamera arrestata nell’ambito del Qatargate, è accusata dello stesso
tipo di truffa. Redazione CdG 1947
Udienza su
estradizione rinviata al 14 marzo. “Sul Qatargate aleggia azione Servizi
segreti, da Panzeri pentitismo interessato”, le bordate sull’inchiesta di
Cozzolino.
Carmine Di Niro su Il Riformista il 28 Febbraio 2023
Il Qatargate? Più
che una inchiesta giudiziaria è “uno scenario sempre più opaco” che nasconde
“una partita di politica estera sul ruolo delle istituzioni europee parallela e
sotterranea, e sul cui sfondo continua ad aleggiare l’azione dei servizi
segreti, che ci fa fondatamente dubitare che il sistema giudiziario belga possa
garantire a Cozzolino un giusto processo”.
Ne sono convinti gli
avvocati difensori di Andrea Cozzolino, l’europarlamentare del Partito
Democratico oggi presente presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, dove i
giudici della sezione misure di prevenzione della Corte di Appello sono chiamati
a decidere sulla richiesta di estradizione avanzata dalla procura federale
belga.
Udienza rinviata al
prossimo 14 marzo. Fino a questa mattina infatti è stata messa messa a
disposizione degli avvocati Conte e Ferraro solo la traduzione della scheda
informativa `SiS. Mancano, al momento, la traduzione del mandato arresto
internazionale emesso dal procuratore federale belga e anche l’informativa sulle
istanze degli avvocati riguardo alla presenza di una medicheria nella struttura
carceraria belga, che dovrebbe accogliere Cozzolino, il quale soffre di
patologie cardiache.
Cozzolino era stato
raggiunto lo scorso 10 febbraio da un mandato di arresto europeo spiccato dal
Tribunale di primo grado di Bruxelles e notificato dai finanzieri del Gico di
Napoli mentre si trovava in una clinica del quartiere Vomero per accertamenti
diagnostici. Dopo una notte trascorsa in carcere nel padiglione ‘Firenze’ del
penitenziario di Poggioreale, Cozzolino era stato poi sottoposto agli arresti
domiciliari. Secondo gli investigatori belgi, avrebbe ricevuto indebitamente
denaro per favorire, attraverso le sue funzioni da parlamentare, gli interessi
del Marocco in seno al Parlamento Europeo
Dai legali di
Cozzolino, gli avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro, lanciano poi bordate nei
confronti del “grande accusatore” Pier Antonio Panzeri, che dopo l’accordo con
la procura belga a un anno di condanna è diventato di fatto un “pentito”. Per la
difesa di Cozzolino, l’ex eurodeputato di Pd e Articolo1 compie “un racconto
immaginifico e gassoso, tipico di chi non sa niente e inventa l’incredibile per
guadagnarsi i benefici promessi e ottenuti”.
Secondo i due legali
“è il lato oscuro del pentitismo interessato, ma quello che più rileva è che sia
dato alle sue parole tanto credito, in mancanza di elementi esterni di
riscontro. Non può lasciare indifferenti, infatti, che egli avrebbe reso tali
dichiarazioni il 14 febbraio ovvero dopo l’arresto di Cozzolino, avvenuto il 10
febbraio, senza che ancora vi fossero elementi nei suoi confronti“.
“Ci inquieta altresì
che queste dichiarazioni siano state diffuse dalla stampa, in violazione del
segreto istruttorio, – sottolinea l’europarlamentare – subito dopo che
l’imparzialità dell’iniziativa giudiziaria belga è stata messa in discussione da
una istanza di ricusazione diretta al giudice Claise e che il noto giornale
londinese, The Times, ne ha messo in discussione l’attendibilità rivelando
che Panzeri e Giorgi avrebbero condiviso la stessa cella in carcere mentre
venivano interrogati“.
Carmine Di Niro.
Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato
di politica, sport e tecnologia
Estratto
dell’articolo di Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera” il 3 marzo
2023.
A chi sono finiti
gli oltre trecentomila euro partiti da Inghilterra e Turchia ed arrivati in
Italia nella casse della Equality ideata da Antonio Panzeri? Le indagini della
Guardia di finanza di Milano seguono le tracce lasciate da questo consistente e
sospetto flusso di denaro e l’ipotesi di un sistema creato per riciclare e
girare in patria le mazzette incassate dall’ex eurodeputato arrestato in Belgio.
Vita breve ma
intensa quella della Equality costituita ad Opera (Milano) dalla commercialista
della famiglia Panzeri Monica Bellini, che è ai domiciliari dopo l’arresto
chiesto dalla magistratura di Bruxelles nell’indagine sulle mazzette ricevute da
Antonio Panzeri e dal suo «socio» Francesco Giorgi per corrompere membri
dell’assemblea europea all’ombra della ong Fight impunity a favore di Qatar,
Marocco e Mauritania.
[…] Equality
Consultancy nasce nel dicembre del 2018 per chiudere a giugno 2021 dopo un
cambio in corsa della compagine sociale con l’uscita dei Giorgi e l’ingresso di
Manfred Forte e Dario Vittorio Scola.
L’oggetto sociale,
tra l’altro, prevede di «sviluppare reti tra diversi soggetti, Ong,
organizzazioni imprenditoriali e controparti nei paesi terzi». Il primo bilancio
si chiude nel 2019 con 240 mila euro di ricavi e 102 mila di utile, quello
dell’anno successivo con 75 mila di ricavi e una perdita di 51 mila: quindi un
totale di poco più di 300 mila euro che sarebbero stati fatturati, secondo le
indagini, a tre società inglesi e ad una turca. Su questo lavorerà l’inchiesta
per riciclaggio che sarà aperta dal procuratore aggiunto di Milano Fabio De
Pasquale.
[…] È stato Giorgi
a svelare al giudice belga Michel Claise la funzione di Equality quando ha messo
a verbale che, invece di continuare a ricevere i contanti dal Qatar, Panzeri
«pensò che era preferibile creare una struttura» attraverso la quale «gestire il
flusso di denaro in modo legale». Si rivolse alla Bellini la quale, annota
Claise, così ha «giocato un ruolo importante nel rimpatrio del contante».
Equality «forniva servizi a una società con sede in Inghilterra» che, afferma
Giorgi, era stata indicata da un tale «Palestinese» e faceva riferimento a un
certo «Hakan». […]
Estratto
dell'articolo di Giacomo Amadori, Camilla Conti per la Verità il 5 marzo 2023.
Quel giorno l’allora
cinquantenne Hakan Camuz, legale di origini turche, (è nato ad Ankara
nell’ottobre 1971) atterra da Londra. La sua presenza viene registrata ai
controlli dei passeggeri extra Ue e mostra un passaporto da cui risulta avere
nazionalità britannica. Ripartirà il giorno dopo. Che cosa ha fatto a Milano
questo professionista con gli occhiali, la barba già bianca, i capelli radi e
l’aspetto rotondo in quei due giorni?
Ha incontrato gli
amministratori e i soci della Equality consultancy srl di Opera che da società a
lui riconducibili o collegate alla Turchia hanno ricevuto oltre 300.000 euro per
servizi davvero poco chiari?
Uno dei principali
indagati del Qatargate, l’ex assistente parlamentare di Pier Antonio Panzeri,
Francesco Giorgi, ha descritto il lavoro della ditta fondata nel 2018 da suo
padre Luciano, dal fratello Stefano e dalla ragioniera Monica Rossana Bellini.
Il racconto di
Giorgi prosegue: «Fu il palestinese a suggerire di rivolgersi ad Hakan (Camuz,
ndr) e alla sua compagnia in Inghilterra, di cui non ricordo il nome. Essendo
stata coinvolta una società inglese, i documenti dovevano essere preparati in
inglese. Il mio coinvolgimento è consistito nel mettere in contatto Panzeri, la
sua commercialista Monica Bellini e sua figlia Silvia Panzeri (nessuna delle
quali parlava inglese) con Hakan. Silvia ha preparato i casi come avvocato. Ho
anche contribuito alla creazione di Equality sfruttando le mie conoscenze
linguistiche. Per giustificare l’utilizzo di una società italiana da parte di
una inglese, i servizi devono essere forniti in inglese. Pertanto, ho chiesto a
conoscenti della mia famiglia che parlano inglese di fornire servizi concreti,
senza che sapessero cosa stesse succedendo».
(…)
Ma chi è davvero
Camuz? A celebrare il suo talento è una rivista turca chiamata Arti90 per la
comunità dei residenti all’estero che nel gennaio 2013 gli dedica ben quattro
pagine all’interno del numero che in copertina ha una grande foto del presidente
Recep Tayyip Erdogan sotto al titolo: «Non sei solo». Ebbene, a pagina 24
comincia la lunga intervista con una breve introduzione: «La vita di Hakan Camuz
è come un film». Nel 1991 litiga con suo padre e lascia Ankara per volare a
Londra, lì «oggi possiede uno studio legale, è presidente di Musiad (una specie
di Confindustria turca, ndr), risolve i problemi dei turchi in Inghilterra» dove
è conosciuto come «fratello Hakan».
(…)
Dopo la laurea, la
mia vita ha iniziato a rimettersi in carreggiata. Ho incontrato la mia seconda
moglie […] guadagnavo lavorando come traduttore e assistente legale».
Questo è quanto
Camuz raccontava di sé nel 2013. Su Linkedin si definisce «capo degli affari
legali con esperienza e una lunga storia di lavoro nell’impresa della pratica
legale», sul sito di una delle sue aziende, «consulente legale senior».
Facendo una
ricognizione nella banca dati delle imprese britanniche c’è tutta una galassia
di società riconducibili a Camuz, o che lo vedono tra gli amministratori. Come
la già citata Stoke white consultancy, la Musiad, la Sirone ltd, la Nomos
international (che si occupa delle violazioni dei diritti umani che si svolgono
contro la popolazione civile siriana), la Turken foundation Uk, la Septimum, la
Black pearl consultancy. E la Turken foundation Uk. Fondazione che è
riconducibile alla famiglia di Erdogan (a maggio 2022 il leader dell’opposizione
Kemal Kiliçdaroglu ha accusato Erdogan di aver trasferito denaro all’estero
attraverso le sue fondazioni, accennando a Türgev, Ensar e Turken). Non solo. In
passato Camuz ha assistito anche Bilal Erdogan, figlio terzogenito del
presidente turco, che conosce bene l’Italia e parla un po’ l’italiano per gli
studi fatti a Bologna alla Johns Hopkins (la stessa università dove insegnavano
Romano Prodi e anche il padre di Elly Schlein). Nel 2003 l’allora premier Silvio
Berlusconi fu suo testimone di nozze.
Sui siti Internet
delle sue aziende apprendiamo che Camuz «si occupa di casi per conto di governi,
Ong e privati» e che è stato «decisivo nello stabilire la struttura di diverse
organizzazioni benefiche con sede nel Regno Unito» e che «continua a contribuire
alle organizzazioni umanitarie e al lavoro dei diritti umani in tutto il mondo».
Già, i diritti umani. Il 15 dicembre, sul suo profilo Twitter dove si qualifica
proprio come direttore della Stoke white (al cui sito internet, ricordiamolo,
corrisponde il codice della Stoke white limited), Camuz ha ricordato la sua
battaglia davanti all’Aja contro l’Autorità palestinese, accusata della morte di
un attivista avvenuta nel 2021. La Stoke white ha presentato una denuncia alla
Corte penale internazionale.
(...) Nel report di
Disinfo lab si legge che ha diretto la Turken foundation UK, dalla sua
costituzione nel 2015 fino al 2019. Il sito ufficiale della Turken foundation Uk
non è attivo; tuttavia, la sua versione cache reindirizza alla Turken foundation
Usa, che è stata costituita nel 2014 da due organizzazioni turche: Ensar
foundation (nata nel 1979) e Turgev (fondata nel 1996 dall’attuale presidente
turco Erdogan).
Di Camuz si è
interessato anche un reporter investigativo indiano, (…) Sottolineando che «uno
dei fondatori» della Stoke white, il nostro Camuz, «sembra avere uno stretto
legame con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan».
Dunque nel nostro
caso i «buoni», i difensori dei diritti, farebbero parte di una rete che più che
difendere gli oppressi di occuperebbe di fare gli interessi della Turchia e dei
suoi alleati, con il supporto di vari servizi segreti.
E tra i principali
partner c’è proprio il Qatar. Il 5 giugno 2017 Bahrein, Egitto, Arabia Saudita
ed Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’interruzione dei rapporti diplomatici
con il Qatar, innescando una crisi che ha coinvolto l’intero mondo arabo. Il
boicottaggio politico-economico contro Doha, ha indotto la leadership qatarina a
cercare sponde esterne al Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) per aggirare
la pressione e preservare la propria sovranità. Da allora, la Turchia è il paese
islamico che più si è prodigato per sostenere il Qatar sotto assedio.
Nel maggio 2020 la
Turchia ha incrementato le linee di scambio di valuta con la Banca centrale di
Doha. Nel novembre 2022 il presidente Erdogan si è recato in Qatar per la
cerimonia d’apertura del mondiale nonostante la Turchia non fosse qualificata.
La visita è servita a dare nuova linfa a rapporti grazie anche alla «diplomazia
del pallone». In quei giorni a Doha ci sono anche Panzeri e la Bellini, la
ragioniera che ha amministrato la Equality sino alla sua chiusura definitiva,
avvenuta nel 2021.
Non sappiamo se ci
fosse anche Camuz. Lo scorso 12 febbraio il sovrano del Qatar, lo sceicco Tamim
bin Hamad Al-Thani, è volato in Turchia per incontrare Erdogan in segno di
solidarietà con il Paese dopo il devastante terremoto. Gli inquirenti belgi
sospettano che i soldi inviati dalle società di Camuz e dalla misteriosa Team
organizasyon di Istanbul siano il provento del riciclaggio messo in piedi dal
Qatar per pagare i servigi di Panzeri, ingaggiato a colpi di petro-euro per
difendere la reputazione di Doha a Bruxelles. Adesso occorre capire se questa
triangolazione sia stata studiata dai qatarioti, da Panzeri o se in questa
operazione abbia avuto un ruolo il governo turco. In tal caso il Qatargate
potrebbe assumere contorni ancora più preoccupanti, avendo tra i possibili
registi della massiccia opera di corruzione dei rappresentanti dell’Unione
europea non più solo Qatar, Marocco e Mali, ma uno dei protagonisti principali
dello scacchiere internazionale, la Turchia di Erdogan.
Estratto
dell’articolo di Beda Romano per “il Sole 24 Ore” il 7 marzo 2023.
È una vicenda
alquanto imbarazzante quella che ha appena colpito la Commissione europea.
L’ombudswoman europea, Emily O’ Reilly, ha inviato all’esecutivo comunitario una
serie di precise domande relative ai viaggi effettuati da un alto funzionario e
pagati da un Paese terzo, ancora una volta il Qatar, lo stesso paese del Golfo
Persico coinvolto in uno scandalo di corruzione scoppiato alla fine del 2022 e
che riguarda alcuni europarlamentari.
Protagonista del
caso è il direttore generale Trasporti, l’estone Henrik Hololei, che secondo il
sito d’informazione Politico ha compiuto a spese del Qatar una serie di viaggi
nell’emirato, Paese con il quale stava negoziando un accordo aereo.
La vicenda
«solleva legittimi interrogativi su una possibile influenza indebita sul
processo decisionale della Ue in questo settore», ha scritto la signora O’Reilly
in una lettera inviata alla presidente Ursula von der Leyen.
In particolare,
l’ombudswoman chiede a Bruxelles di precisare la procedura con cui ha
autorizzato questi viaggi tra il 2015 e il 2021 e di spiegare come intende
aggiornare le sue regole. Inoltre, chiede di sapere in quali casi le spese
relative alle missioni dei commissari e dei funzionari siano state pagate da
entità terze dal 2021 in poi.
[…] La vicenda è
particolarmente imbarazzante perché ieri la stessa Commissione è stata costretta
ad ammettere che i viaggi del direttore Hololei sono stati autorizzati da lui
medesimo. «Le nostre linee guida prevedono che eventuali conflitti d’interesse
vengano segnalati, anche se non si tratta di un obbligo giuridico», ha ammesso
Balazs Ujvari, […] portavoce della Commissione europea. Le linee guida sono
oggetto di una revisione dal novembre scorso, ha poi aggiunto. Secondo lo stesso
Ujvari, «appena l’1,5% delle missioni effettuate dai funzionari della
Commissione è pagato da partner terzi». […]
Estratto
dell'articolo di Giacomo Amadori per “La Verità” Il 6 marzo 2023.
Il giudice
istruttore di Bruxelles, Michel Claise, ha ordinato il «sequestro e il blocco»
del conto italiano della Ong fondata da Emma Bonino, «Non c’è pace senza
giustizia». Il 22 febbraio la Guardia di finanza è scesa a Roma per interrogare
come indagata per riciclaggio l’ex segretaria del Partito radicale Antonella
Casu e tesoriera del comitato.
Il 3 febbraio,
dopo la scarcerazione senza condizioni di Nicolò Figà-Talamanca, segretario
generale (autosospeso) della Ong, quel filone sembrava essersi prosciugato. Ma
nel secondo Ordine europeo di indagine (Oei, che La Verità ha visionato) inviato
a fine gennaio dalle autorità belghe a quelle italiane, Claise dimostra di
puntare ancora molto su questa pista. Per questo ha chiesto di procedere alla
perquisizione della sede romana di «Non c’è pace senza giustizia» e
dell’abitazione romana della Casu, di bloccare il conto e di recuperare «i
documenti di apertura dei conti e gli ultimi estratti conto dall’1 gennaio 2021
a oggi».
[…] Il motivo
dell’attenzione? «Nell’ambito del fascicolo abbiamo svolto un’indagine
finanziaria dalla quale è emerso il conto bancario di “Non c’è pace senza
giustizia”», che sembrerebbe aver alimentato i rapporti bancari di alcune «asbl
belghe» (associazioni senza scopo di lucro). Per questo, gli inquirenti di
Bruxelles ritengono che «il finanziamento di questo conto potrebbe essere
sospetto».
Nell’atto,
eseguito dalla Guardia di finanza, si legge che «si deve prestare particolare
attenzione a titoli, contanti, oro, orologi di valore ecc.; tutti i documenti
relativi ai conti bancari in Italia e soprattutto all’estero; tutti i documenti
relativi alla contabilità di questa società; tutte le apparecchiature
informatiche e telefoniche devono essere portate via; tutti i documenti o altro
in relazione alle persone sospette».
[…] L’avvocato
Gianpaolo Catanzariti, legale della Casu, ieri sera ci ha spiegato: «Per quanto
è a nostra conoscenza non vi è stato alcun blocco o sequestro del conto corrente
intestato al comitato “Non c’è pace senza giustizia”, non essendoci stato
notificato alcun provvedimento di sequestro specifico. […]
Ricordiamo che, a
dicembre, Claise aveva chiesto e ottenuto il sequestro preventivo di un
appartamento acquistato a Cervinia da Figà-Talamanca. L’ipotesi dell’accusa è
che l’immobile possa essere stato acquistato con soldi provenienti dal Qatar.
Il gip di Aosta
Giuseppe Colazingari nel suo decreto, firmato il 20 dicembre, aveva scritto:
«Secondo le indagini svolte finora, la struttura criminale ha iniziato a far
circolare molto denaro in contanti.
In seguito, la
struttura si è organizzata meglio facendo circolare i fondi attraverso Ong e/o
associazioni non profit gestite da Figà-Talamanca. In pratica vi sono Stati
“corruttori” che versano denaro sul conto di società con sede all’estero e,
successivamente, il denaro viene versato su uno dei conti di una Ong/Onp di
Talamanca, il cui ruolo parrebbe essere quello di garantire che il denaro venga
poi convogliato ai destinatari della corruzione».
La Procura di
Milano, che ha aperto un fascicolo per riciclaggio per le attività della
Equality consultancy Srl, attende le carte da Bruxelles per capire se le accuse
messe a verbale da Panzeri in Belgio possano far aprire nuovi filoni
d’inchiesta. In particolare, le dichiarazioni, citate in alcune riunioni tra
magistrati e investigatori dei due Paesi, sull’ex segretario della Cgil Susanna
Camusso, oggi senatrice del Pd (la quale ha smentito ogni coinvolgimento), a cui
sarebbe stata finanziata la campagna elettorale per la Confederazione sindacale
internazionale (così come era stata finanziata quella del segretario generale
della stessa organizzazione, Luca Visentini) e sui soldi che sarebbero stati
dati alla ex eurodeputata Lara Comi. […]
Qatargate,
l’avvocato turco vicino a Erdogan e i soldi alla Equality di Panzeri.
Storia di
Giuseppe Guastella su Il Corriere della Sera il 7 marzo 2023.
Per ottenere quelli
che definisce «Servizi di lobbying etico» che portassero a prese di posizione
del Parlamento europeo contro il conflitto in Siria e i crimini di guerra nello
Yemen, Hakan Camuz, un importante avvocato che opera a Londra vicino al
presidente Recep Erdogan, tra il 2019 e il 2021 avrebbe versato 75 mila euro a
alla Equality consultancy di Opera (Milano) che faceva capo ad Antonio Panzeri e
a Francesco Giorgi. Altri 200 mila euro sono arrivati alla stessa Equality da
una società turca nel 2018, quando Panzeri era ancora deputato europeo di
Articolo uno.
A rivelare le trame
di questo nuovo mistero nell’ inchiesta che sta sconvolgendo il Parlamento
europeo da tre mesi è il Financial Times. Equality è al centro delle indagini
del procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale che ha iscritto per
riciclaggio nel registro degli indagati, in una inchiesta autonoma rispetto a
quella di Bruxelles che ha portato all’arresto di Panzeri e Giorgi, due dei tre
soci della società chiusa un Italia nel 2021. La Equality, come rivelato dal nei
giorni scorsi, ha ricevuto nella sua breve vita circa 300 mila euro pervenuti
dall’Inghilterra e dalla Turchia. Delle connessioni tra il legale turco e la
Equality ha scritto La Verità che ha anche riferito di un viaggio dello stesso
avvocato a Milano. Al quotidiano economico inglese, Hakan Camuz non ha spiegato
perché le sue due società non si sono rivolte alla ong Fight impunity fondata
nel 2019 da Panzeri ma hanno preferito bussare alla porta della Equality con
sede nell’ufficio della commercialista Monica Bellini (che è ai domiciliari),
che invece era stata ideata da Panzeri e Giorgi come un paravento per far
arrivare in Italia i soldi provenienti in contanti dal Qatar mascherandoli come
pagamenti di consulenze.
Con la magistratura
belga, Giorgi ha messo a verbale che per fare questo un tale «palestinese» gli
suggerì di rivolgersi ad «Hakan» in Inghilterra per individuare una società alla
quale fatturare le consulenze e che lui aveva il compito di tenere i contatti
tra Panzeri, sua figlia Silvia, la commercialista dei Panzeri Monica Bellini e
questo «Hakan» perché era l’unico a parlare in inglese. Al Financial Times,
Camuz ha negato di conoscere Bellini e Silvia Panzeri, le quali gli erano state
descritte da Giorgi come componenti del «suo staff».
Il legale turco
invece ha dichiarato che due dei suoi gruppi hanno stipulato «contratti di
consulenza» con Panzeri, attraverso Giorgi, per presunti «servizi parlamentari»
che includevano l’aiuto per organizzare incontri con altri deputati, eventi
pubblici a Bruxelles, interrogazioni parlamentari e l’ottenimento di
finanziamenti europei per iniziative umanitarie. Ha sostenuto che i risultati
dell’attività da lui pagata sarebbero stati molto scarsi. Nel 2019 The Radiant
trust, di cui Camuz è fiduciario, ha versato 50 mila euro ad Equality che nel
2021 ha ricevuto 25 mila euro anche da Pronesis, altra società di Camuz. Non è
ancora chiaro a chi faccia capo, invece, la società turca con sede ad Istambul
che ha contribuito con 200 mila euro a fine 2018 al bilancio della Equality, che
è stata fondata a dicembre dello stesso anno mentre Panzeri sedeva ancora al
Parlamento europeo.
Al Financial
Times Camuz ha dichiarato di essere stato «devastato» dalle dichiarazioni con le
quali Giorgi al giudice istruttore di Bruxelles Michel Claise ha rivelato la
vera natura di Equality e di stare valutando un’azione legale contro di lui. Con
avrebbe fatto «un accordo pensando che stessimo trattando con un’entità
legittima che ci avrebbe aiutati a sensibilizzare sui casi di cui ci occupiamo»,
ha detto Camuz al quotidiano economico precisando che sarebbe stato Giorgi a
proporgli «servizi di lobbying etico a Bruxelles a basso costo».
Estratto
dell'articolo di Giacomo Amadori, Camilla Conti per la Verità l’8 marzo 2023.
Quel giorno l’allora
cinquantenne Hakan Camuz, legale di origini turche, (è nato ad Ankara
nell’ottobre 1971) atterra da Londra. La sua presenza viene registrata ai
controlli dei passeggeri extra Ue e mostra un passaporto da cui risulta avere
nazionalità britannica. Ripartirà il giorno dopo. Che cosa ha fatto a Milano
questo professionista con gli occhiali, la barba già bianca, i capelli radi e
l’aspetto rotondo in quei due giorni?
Ha incontrato gli
amministratori e i soci della Equality consultancy srl di Opera che da società a
lui riconducibili o collegate alla Turchia hanno ricevuto oltre 300.000 euro per
servizi davvero poco chiari?
Uno dei principali
indagati del Qatargate, l’ex assistente parlamentare di Pier Antonio Panzeri,
Francesco Giorgi, ha descritto il lavoro della ditta fondata nel 2018 da suo
padre Luciano, dal fratello Stefano e dalla ragioniera Monica Rossana Bellini.
Il racconto di
Giorgi prosegue: «Fu il palestinese a suggerire di rivolgersi ad Hakan (Camuz,
ndr) e alla sua compagnia in Inghilterra, di cui non ricordo il nome. Essendo
stata coinvolta una società inglese, i documenti dovevano essere preparati in
inglese. Il mio coinvolgimento è consistito nel mettere in contatto Panzeri, la
sua commercialista Monica Bellini e sua figlia Silvia Panzeri (nessuna delle
quali parlava inglese) con Hakan. Silvia ha preparato i casi come avvocato. Ho
anche contribuito alla creazione di Equality sfruttando le mie conoscenze
linguistiche. Per giustificare l’utilizzo di una società italiana da parte di
una inglese, i servizi devono essere forniti in inglese. Pertanto, ho chiesto a
conoscenti della mia famiglia che parlano inglese di fornire servizi concreti,
senza che sapessero cosa stesse succedendo».
(…)
Ma chi è davvero
Camuz? A celebrare il suo talento è una rivista turca chiamata Arti90 per la
comunità dei residenti all’estero che nel gennaio 2013 gli dedica ben quattro
pagine all’interno del numero che in copertina ha una grande foto del presidente
Recep Tayyip Erdogan sotto al titolo: «Non sei solo». Ebbene, a pagina 24
comincia la lunga intervista con una breve introduzione: «La vita di Hakan Camuz
è come un film». Nel 1991 litiga con suo padre e lascia Ankara per volare a
Londra, lì «oggi possiede uno studio legale, è presidente di Musiad (una specie
di Confindustria turca, ndr), risolve i problemi dei turchi in Inghilterra» dove
è conosciuto come «fratello Hakan».
(…)
Dopo la laurea, la
mia vita ha iniziato a rimettersi in carreggiata. Ho incontrato la mia seconda
moglie […] guadagnavo lavorando come traduttore e assistente legale».
Questo è quanto
Camuz raccontava di sé nel 2013. Su Linkedin si definisce «capo degli affari
legali con esperienza e una lunga storia di lavoro nell’impresa della pratica
legale», sul sito di una delle sue aziende, «consulente legale senior».
Facendo una
ricognizione nella banca dati delle imprese britanniche c’è tutta una galassia
di società riconducibili a Camuz, o che lo vedono tra gli amministratori. Come
la già citata Stoke white consultancy, la Musiad, la Sirone ltd, la Nomos
international (che si occupa delle violazioni dei diritti umani che si svolgono
contro la popolazione civile siriana), la Turken foundation Uk, la Septimum, la
Black pearl consultancy. E la Turken foundation Uk. Fondazione che è
riconducibile alla famiglia di Erdogan (a maggio 2022 il leader dell’opposizione
Kemal Kiliçdaroglu ha accusato Erdogan di aver trasferito denaro all’estero
attraverso le sue fondazioni, accennando a Türgev, Ensar e Turken). Non solo. In
passato Camuz ha assistito anche Bilal Erdogan, figlio terzogenito del
presidente turco, che conosce bene l’Italia e parla un po’ l’italiano per gli
studi fatti a Bologna alla Johns Hopkins (la stessa università dove insegnavano
Romano Prodi e anche il padre di Elly Schlein). Nel 2003 l’allora premier Silvio
Berlusconi fu suo testimone di nozze.
Sui siti Internet
delle sue aziende apprendiamo che Camuz «si occupa di casi per conto di governi,
Ong e privati» e che è stato «decisivo nello stabilire la struttura di diverse
organizzazioni benefiche con sede nel Regno Unito» e che «continua a contribuire
alle organizzazioni umanitarie e al lavoro dei diritti umani in tutto il mondo».
Già, i diritti umani. Il 15 dicembre, sul suo profilo Twitter dove si qualifica
proprio come direttore della Stoke white (al cui sito internet, ricordiamolo,
corrisponde il codice della Stoke white limited), Camuz ha ricordato la sua
battaglia davanti all’Aja contro l’Autorità palestinese, accusata della morte di
un attivista avvenuta nel 2021. La Stoke white ha presentato una denuncia alla
Corte penale internazionale.
(...) Nel report di
Disinfo lab si legge che ha diretto la Turken foundation UK, dalla sua
costituzione nel 2015 fino al 2019. Il sito ufficiale della Turken foundation Uk
non è attivo; tuttavia, la sua versione cache reindirizza alla Turken foundation
Usa, che è stata costituita nel 2014 da due organizzazioni turche: Ensar
foundation (nata nel 1979) e Turgev (fondata nel 1996 dall’attuale presidente
turco Erdogan).
Di Camuz si è
interessato anche un reporter investigativo indiano, (…) Sottolineando che «uno
dei fondatori» della Stoke white, il nostro Camuz, «sembra avere uno stretto
legame con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan».
Dunque nel nostro
caso i «buoni», i difensori dei diritti, farebbero parte di una rete che più che
difendere gli oppressi di occuperebbe di fare gli interessi della Turchia e dei
suoi alleati, con il supporto di vari servizi segreti.
E tra i principali
partner c’è proprio il Qatar. Il 5 giugno 2017 Bahrein, Egitto, Arabia Saudita
ed Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’interruzione dei rapporti diplomatici
con il Qatar, innescando una crisi che ha coinvolto l’intero mondo arabo. Il
boicottaggio politico-economico contro Doha, ha indotto la leadership qatarina a
cercare sponde esterne al Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) per aggirare
la pressione e preservare la propria sovranità. Da allora, la Turchia è il paese
islamico che più si è prodigato per sostenere il Qatar sotto assedio.
Nel maggio 2020 la
Turchia ha incrementato le linee di scambio di valuta con la Banca centrale di
Doha. Nel novembre 2022 il presidente Erdogan si è recato in Qatar per la
cerimonia d’apertura del mondiale nonostante la Turchia non fosse qualificata.
La visita è servita a dare nuova linfa a rapporti grazie anche alla «diplomazia
del pallone». In quei giorni a Doha ci sono anche Panzeri e la Bellini, la
ragioniera che ha amministrato la Equality sino alla sua chiusura definitiva,
avvenuta nel 2021.
Non sappiamo se ci
fosse anche Camuz. Lo scorso 12 febbraio il sovrano del Qatar, lo sceicco Tamim
bin Hamad Al-Thani, è volato in Turchia per incontrare Erdogan in segno di
solidarietà con il Paese dopo il devastante terremoto. Gli inquirenti belgi
sospettano che i soldi inviati dalle società di Camuz e dalla misteriosa Team
organizasyon di Istanbul siano il provento del riciclaggio messo in piedi dal
Qatar per pagare i servigi di Panzeri, ingaggiato a colpi di petro-euro per
difendere la reputazione di Doha a Bruxelles. Adesso occorre capire se questa
triangolazione sia stata studiata dai qatarioti, da Panzeri o se in questa
operazione abbia avuto un ruolo il governo turco. In tal caso il Qatargate
potrebbe assumere contorni ancora più preoccupanti, avendo tra i possibili
registi della massiccia opera di corruzione dei rappresentanti dell’Unione
europea non più solo Qatar, Marocco e Mali, ma uno dei protagonisti principali
dello scacchiere internazionale, la Turchia di Erdogan.
Estratto
dell’articolo di Giacomo Amadori e Camilla Conti per “La Verità” il 9 marzo
2023.
L’informativa della
Guardia di finanza inviata il 2 marzo 2023 alla Procura di Milano e che ha messo
nel mirino delle indagini il consulente legale turco Hakan Camuz, uomo legato al
presidente Recep Tayyip Erdogan, è stata innescata da un articolo della Verità
pubblicato la vigilia di Natale.
Nelle 22 pagine
dell’annotazione sono riportati lunghi stralci dell’articolo e c’è la nostra
prima pagina intitolata «Giorgi cedette una finta Ong al barista sloveno
“compagno della Panzeri”». La nostra inchiesta ha fatto partire le indagini e da
quel momento è iniziata la slavina.
I personaggi
principali della storia sono Pier Antonio Panzeri, ex europarlamentare europeo,
il suo vecchio assistente Francesco Giorgi e la ragioniera Monica Rossana
Bellini, la quale, secondo gli investigatori, «si sarebbe prestata alla
costituzione di un apposito “veicolo" societario, denominato Equality, al fine
di riciclare flussi finanziari garantiti a Pier Antonio Panzeri a titolo di
corruzione».
[…] sono finiti sul
registro degli indagati gli ultimi due soci della ditta, Manfred Forte, compagno
dell’avvocato Silvia Panzeri (la figlia di Pier Antonio), e l’istruttore di
nuoto Dario Vittorio Scola, considerati entrambi prestanome. I veri attori per
ora restano indagati in Belgio, in futuro vedremo.
Ma intanto è
possibile leggere nei dettagli i conti della Equality […]. Tra il 6 dicembre
2018 e il 4 maggio 2021, quando la ditta è stata chiusa definitivamente (era
stata messa in liquidazione nel novembre 2020), la Equality consultancy srl ha
emesso fatture per complessivi 318.180 euro.
Giorgi ai
magistrati belgi ha raccontato come in Turchia sia stato messo in contatto
dall’assistente del ministro del lavoro del Qatar con una persona «di origine
palestinese» che avrebbe dovuto fargli avere le mazzette e che gli avrebbe
consigliato di rivolgersi ad Hakan Camuz e alla sua società inglese.
In effetti i primi a
inviare bonifici sono i turchi della Team organizasyon basin yayin ticaret
limited sirketi che le Fiamme gialle non sono riuscite a identificare
compiutamente. Non è quindi possibile sostenere al momento che dietro a questa
società ci fosse proprio Camuz. Quello che possiamo sostenere è che già il 28
dicembre, sedici giorni dopo l’iscrizione della Equality alla Camera di
commercio, la società di Opera (Milano) emette una fattura da ben 145.000 euro
verso quella di Istanbul.
Il 27 febbraio ne
produce una seconda da 55.000 euro. In sostanza la piccola società di consulenza
internazionale che svolge compiti simili a quelle delle Ong riceve ben 200.000
euro dalla Turchia nel giro di due mesi. A questo punto entrano in gioco le
società inglesi direttamente riconducibili ad Hakan Camuz e alla giovane Cemre
Eren Camuz (classe 1994).
[…] La Equality
emette undici fatture verso la Stoke white, che ha tra gli amministratori la
giovane Cemre Eren: tre da 10.000 da ottobre a dicembre 2019 (una per mese) e
sette (tre da 10.000, tre da 5.000 e una da 2.000) da gennaio a luglio 2020.
In tutto fa 77.000
euro, a cui bisogna sottrarre una nota di credito da 22.000 euro emessa nel
novembre 2020. Quindi alla fine in due anni la Stoke white sborsa 55.000 euro,
30.000 nel 2019 più 25.000 nel 2020. Il Radiant Trust entra in gioco come la
Stoke white a fine 2019, precisamente nel dicembre 2019, quando la Equality
emette una fattura da 10.000 euro. Anche qui nel 2020 troviamo nel libro
giornale una fattura al mese a luglio (tutte da 10.000 più una da 2.000 a
luglio) per un totale di 62.000 euro a cui bisogna sottrarre una nota di credito
da 12.000 di novembre. Insomma, il trust in otto mesi sgancia 60.000 euro.
Nel fondo Hakan
Camuz funge da fiduciario. C’è infine la Phronesis consultants Uk limited che
tra maggio e giugno 2020 riceve fatture per 54.000 euro (tre da 18.000) tutte
annullate da una nota di credito di pari importo emessa il 29 giugno 2020. Il
risultato finale è che la Equality riceve 200.000 euro dalla Team organizasyon,
55.000 dalla Stoke white e 60.000 euro dal Radiant trust.
Questo ha fatto sì
che nel 2019 la Equality mettesse a bilancio 240.000 euro di fatturato, con un
utile di esercizio di 102.000 euro. […] A luglio 2019 Luciano e Stefano Giorgi,
rispettivamente padre e fratello di Francesco e titolari insieme alla Bellini
delle quote societarie, lasciano l’azienda e l’attività viene portata avanti
sino alla messa in liquidazione dai due indagati Forte e Scola. Sino al luglio
del 2019 la ditta aveva emesso fatture solo alla ditta turca Team organizasyon.
Risulta difficile credere che anche qui non avesse messo lo zampino Camuz, visto
quanto dichiarato da Giorgi sulle modalità della loro conoscenza.
[…] L’indagato ha
anche spiegato: «Essendo stata coinvolta una società inglese, i documenti
dovevano essere preparati in inglese. Il mio coinvolgimento è consistito nel
mettere in contatto Panzeri, la sua commercialista Monica Bellini e sua figlia
Silvia Panzeri (nessuna delle quali parlava inglese) con Hakan.
Silvia ha preparato
i casi come avvocato. Ho anche contribuito alla creazione di Equality sfruttando
le mie conoscenze linguistiche. Per giustificare l’utilizzo di una società
italiana da parte di una inglese, i servizi devono essere forniti in inglese.
Pertanto, ho chiesto a conoscenti della mia famiglia che parlano inglese di
fornire servizi concreti, senza che sapessero cosa stesse succedendo».
I nomi della Panzeri
e della Bellini compaiono anche alla voce uscite della Equality. Dividendi a
parte, circa la metà del denaro incassato dalla ditta è finito proprio sui conti
della ragioniera. La Equality ha ricevuto dal gennaio 2019 al gennaio 2021 25
fatture del medesimo importo: 5.200 euro al mese per un totale di 130.000 euro
(62.400 euro l’anno nel 2019 e nel 2020).
Lo studio Bellini
ha invece emesso fatture per 31.958,57, di cui 8.994,87 nel 2019, 17.923,70 nel
2020 e 5.040,00 nel 2021. Quindi alla socia Bellini sono andati più di 161.000
euro. Sono rimasti tutti a lei? Toccherà agli investigatori rispondere a questo
quesito. Dal conto della Equality sono usciti anche 14.352 euro destinati a
Silvia Panzeri, in due tranche di pari importo: la prima come «pagamento
parziale al 50 per cento» e la seconda come «saldo nota pro forma del 10
novembre 2020».
Sempre sul rapporto
bancario della Panzeri, tra il 17 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 sono stati
indirizzati dalla Bellini due bonifici per complessivi 5.060 euro e altri tre
dalla studio Bellini per un totale di 5.709,86 tutti aventi come causale «saldo
pro forma». Ma nelle interviste rilasciate dalla ragioniera sembrava che a
lavorare per la Panzeri fosse la Bellini e non viceversa.
Parla Camuz
Ieri, dopo i nostri
scoop, Camuz ha deciso di rispondere alle domande del quotidiano britannico
Financial Times. A cui ha raccontato che Francesco Giorgi lo avrebbe contattato
facendogli sapere che «poteva aiutarlo a fare servizi di lobbying etico a
Bruxelles a basso costo ed è stato molto convincente perché parlava di aiutare
le vittime di crimini di guerra e le vittime di violazioni dei diritti umani».
[…] La notizia è che anche anche dal racconto di Camuz risulta chiaramente che a
trattare per la Equality fosse direttamente Giorgi e non i titolari delle quote
o i suoi amministratori.
Estratto
dell'articolo di Alessandro Gonzato per “Libero quotidiano” il 9 marzo 2023.
È una persona
educata, Antonio Panzeri, perché invece di buttare i soldi per terra se li
teneva in tasca, a volte pare nella ventiquattro ore, fino a quando per strada
non incrociava un cestino. Rispettoso come i giapponesi, l’ex euro deputato del
Pd, attento sì agli affari, ma anche all’ordine e all’ambiente. Panzeri-san.
Ma come: il reo
confesso del Qatargate, quello beccato dalla polizia con in casa una valigia
stipata di banconote, oltre 600mila euro mazzette dal Qatar, dal Marocco e dalla
Mauritania, questa l’accusa - invece di tenersi il denaro lo gettava
nell’immondizia? Sì, a volte capitava, pare, tanto era il flusso.
«Avevo troppi
contanti, non sapevo cosa farmene», avrebbe detto in uno dei recenti
interrogatori al giudice titolare dell’“inchiesta Qatargate”, Michel Claise,
dettaglio riportato dall’emittente tedesca Deutsche Welle. […]
[…] Il giro
d’affari col Marocco, stando ai verbali, sarebbe cominciato nel 2014 (Panzeri è
stato europarlamentare dal 2004 al 2019, prima Pd e poi Articolo 1) ma le borse
di contanti sarebbero spuntate solo negli ultimi mesi di mandato dello storico
rappresentante della Cgil milanese.
A quel punto, tra
fine 2018 e inizio 2019, riporta Deutsche Welle che cita i documenti
dell’inchiesta, Panzeri e l’assistente Francesco Giorgi (quest’ultimo compagno
della vicepresidente destituita del parlamento Ue Eva Kaili, ancora in carcere)
si sarebbero accordati con Rabat su un compenso da 50mila euro a testa in cambio
di voti e pareri positivi sul Marocco al parlamento europeo. Panzeri negli
stessi giorni avrebbe raggiunto un’intesa molto simile con la Mauritania.
Ma è l’accordo col
Qatar, un milione a testa per il 2018 e il 2019 (a lui e Giorgi) - riferisce
l’emittente tedesca- ad aver fatto fare a Panzeri il vero salto di qualità. I
soldi arrivavano da «un uomo d’affari turco e il suo avvocato a Londra». Un
fiume in piena di soldi, e a quel punto Panzer - come viene chiamato dai tempi
della Camera del lavoro di Milano avrebbe deciso di cambiare sistema, «perché i
soldi erano troppi», non sapeva più dove infilarli.
[…]
Il nome del turco
non viene fatto. Ma un turco nel taccuino del giudice Claise c’è, si chiama
Hakan Camuz, indicato dai qatarioti come il tramite con la Equality Consultancy
riconducibile a Panzeri e in cui ha ricoperto un ruolo centrale la sua
commercialista, Monica Rossana Bellini. Camuz sarebbe vicino al presidente turco
Erdogan.
Panzeri, il grande
pentito del Qatargate, ha siglato un accordo di collaborazione con la giustizia
belga che prevede la detenzione al massimo di un anno, oltre a una multa, in
cambio di informazioni sul mega-scandalo che ha investito il parlamento europeo.
Un anno anziché cinque.
[…] A Panzeri,
secondo i verbali riportati dai tedeschi, hanno sfilato dalla valigia […] 15mila
euro, mentre era sul treno tra Parigi e Bruxelles. Non è stato facile, perché
erano nascoste in due parti diverse del bagaglio. E dire che se i ladri glieli
avessero chiesti, magari insistendo un po’ glieli avrebbe dati lui quei soldi.
[…]
“Qatargate” il
giudice Claise resta al comando dell’inchiesta.
È stata respinta
l’istanza di ricusazione. Delusi legali di Tarabella: «È parziale». Rinviata
l’udienza per decidere l’estradizione di Andrea Cozzolino. Daniele Zaccaria su
Il Dubbio il 15 marzo 2023
Michel Claise, il
mediatico procuratore del Qatargate rimarrà dunque a capo della “sua” inchiesta:
la Corte d’appello di Bruxelles ha infatti respinto l’istanza di ricusazione
presentata dagli avvocati di Marc Tarabella (in prigione dallo scorso 10
febbraio) stabilendo a porte chiude che il magistrato non è animato da
pregiudizio nei confronti dell’eurodeputato belga, nonostante i metodi da
“sceriffo” e l’impiego smodato della carcerazione preventiva con cui sta
portando avanti le indagini.
Secondo i giudici
di Bruxelles la richiesta della difesa sarebbe del tutto legittima in quanto non
ha intenti «dilatori né abusivi», ma è «infondata» nel merito e quindi da
respingere al mittente.
Non la pensa così
l’avvocato Maxim Toeller per il quale Claise avrebbe violato il principio di
presunzione di innocenza di Tarabella nella stessa stesura del mandato di
arresto: «Siamo convinti che la questione dell’imparzialità di Claise rimanga in
piedi come la violazione dei diritti del mio assistito», allo stesso
tempo Toeller rimane convinto di riuscire a dimostrare l’innocenza di Tarabella:
«Naturalmente siamo delusi, ma se la procedura di ricusazione riuscirà a farci
ottenere un’istruttoria imparziale, non sarà stata vana. Continueremo a
difendere i diritti del signor Tarabella ovunque e quando necessario perché non
ha mai ricevuto denaro o regali in cambio delle sue opinioni».
Il socialista belga
è stato tirato in ballo dall’ex sindacalista ed ex eurodeputato Pier Antonio
Panzeri - il grande pentito dell’inchiesta che ha patteggiato uno sconto di
pena- di aver ricevuto 120mila euro in contanti dal governo del Qatar allo scopo
di perorare gli interessi dello stato arabo nelle istituzioni europee. Fino ad
ora però non esiste alcuna prova che Tarabella e le altre persone arrestate
da Claise abbiano concretamente favorito il Qatar in una sede ufficiale.
Ed è proprio la
mancanza di riscontri robusti alle accuse del procuratore che rende
il Qatargate innanzitutto un’inchiesta mediatica con il giudice
istruttore Claise che tenta di acquisire le sue prove attraverso lo strumento
coercitivo della custodia cautelare, un metodo vecchio come il mondo quello di
far confessare gli indagati privandoli della libertà. Particolarmente brutale il
trattamento riservato alla greca Eva Kaili, ex vicepresidente
dell’europarlamento, dietro le sbarre dallo scorso 9 dicembre e separata dalla
figlia di 22 mesi.
I suoi avvocati non
hanno esitato a parlare di «ricatto» e «tortura», denunciando l’accanimento
degli inquirenti furiosi perché Kaili proprio come Tarabella si dichiara
innocente e non ha alcuna intenzione di confessare nonostante sia in prigione da
cinque mesi senza processo. Lo stesso arresto della politica greca solleva seri
dubbi di legalità: Kaili era infatti protetta dall’immunità parlamentare che le
è stata tolta sulla base di una immaginaria “flagranza di reato”, ovvero i
sacchi di denaro ritrovati nel suo appartamento di Bruxelles, un indizio che non
può mai giustificare le accuse di corruzione e associazione a delinquere
lanciate da Claise.
È stata invece
rinviata al prossimo 11 aprile l’udienza che dovrà decidere sull’estradizione
verso il Belgio dell’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, attualmente agli
arresti domiciliari nella sua casa di Napoli. Anche Cozzolino è stato accusato
da Panzeri, in questo caso di aver ricevuto regali e contanti dal Marocco
tramite l’ambasciatore di Rabat a Varsavia in cambio del suo lobbismo in seno
all’Ue, e anche in questo caso senza grandi riscontri tranne «una cravatta» (
sic) donata dal diplomatico marocchino come si legge nel lunare mandato di
arresto scritto dalla procura belga.
Cozzolino, tramite i
suoi difensori, respinge tutte le accuse sostenendo che Panzeri si è inventato
tutto allo scopo di alleggerire la sua posizione La decisione della Corte
d’appello di Napoli di rinviare l’udienza dipende dalle condizioni di salute di
Cozzolino e le sue patologie cardiache definite «importanti e gravi»
dall’avvocato Federico Conte e Dezio Ferraro per i quali l’eventuale
estradizione dell’europarlamentare sarebbe incostituzionale. Peraltro
il Belgio come ha sottolineato un recente rapporto del Consiglio europeo è noto
per il sovraffollamento e le condizioni più che critiche dei suoi istituti di
pena dove sono frequenti le violenze tra detenuti che spesso non hanno accesso a
nessuna attività al di fuori delle celle.
Duro colpo per la
difesa di Tarabella. Il giudice-sceriffo Claise resta al comando dell’inchiesta
Qatargate, respinta la richiesta di ricusazione.
Carmine Di Niro su
Il Riformista il 15 Marzo 2023
Michel Claise, il
giudice istruttore che si sta occupando delle indagini sul presunto scandalo di
corruzione ribattezzato “Qatargate”, potrà continuare a guidare la “sua”
inchiesta. I giudici della Corte d’Appello di Bruxelles, secondo quanto riferito
dalla procura federale belga, hanno respinto l’istanza di ricusazione presentata
dagli avvocati di Marc Tarabella, l’eurodeputato socialista belga indagato e
recluso in carcere dallo scorso 10 febbraio proprio nell’ambito dell’inchiesta
Qatargate.
Claise, che sta
portando avanti l’indagine sul presunto sistema corruttivo messo in piedi da
rappresentati del Qatar e del Marocco in seno al Parlamento europeo, è ormai
noto per i suoi metodi mediatici e per l’impiego smodato della carcerazione
preventiva come metodo di indagine.
Per la Corte
d’Appello di Bruxelles invece l’istanza di ricusazione “è stata ritenuta
ammissibile ma infondata” e che il giudice istruttore Michel Claise “non ha
pregiudicato la colpevolezza del ricorrente“. I giudici belgi notano inoltre che
“nell’esercizio della sua funzione, in particolare quando procede alle indagini
ed emette un mandato di arresto, il gip potrebbe dover prendere decisioni”
ritenute “delicate”
Masticano amaro i
legali di Tarabella, che ovviamente si aspettavano un esito diverso e da
settimane vanno denunciando il “pregiudizio” di Claise nei confronti del loro
assistito. “Rimaniamo convinti che vada posta la questione dell’imparzialità del
giudice e che i rischi di vedere violata la presunzione di innocenza siano una
realtà”, ha sottolineato il team legale che assiste l’eurodeputato belga.
“Se la procedura di
ricusazione ha potuto ottenere un’istruttoria imparziale, non sarà stata vana.
Continueremo a difendere i diritti del signor Tarabella ovunque e quando
necessario“, hanno aggiunto i legali. L’eurodeputato “ha continuato a proclamare
la sua innocenza sin dal primo giorno e afferma di non aver mai ricevuto denaro
o regali in cambio delle sue opinioni“, ha concluso il team di legali.
Inchiesta, quella di
Claise, per ora traballante e che si fonda in particolare sulle dichiarazioni
di Pier Antonio Panzeri, ex eurodeputato italiano passato dal Partito
Democratico ad Articolo 1 diventato poi il “grande pentito” dell’indagine
tirando in ballo lo stesso Tarabella. Pentimento che ha fruttato a Panzeri
il patteggiamento di un importante sconto di pena: l’ex eurodeputato italiano ha
accusato il collega belga di aver ricevuto 120mila euro in contanti dal governo
del Qatar allo scopo di perorare gli interessi dello stato arabo nelle
istituzioni europee, anche se al momento non esiste prova di un concreto
favoreggiamento di Tarabella e delle altre persone arrestate da Claise di un
“favoreggiamento” concreto del Qatar.
Sullo sfondo, per
modo di dire, la gestione “allegra” della custodia cautelare da parte dello
stesso giudice istruttore belga: impossibile non citare il trattamento riservato
all’ex vicepresidente dell’europarlamento Eva Kaili, con l’esponente socialista
greca in carcere dallo scorso 9 dicembre, separata dalla figlia di due anni e
sottoposta ad un trattamento che i suoi legali hanno definito “tortura”.
Carmine Di Niro.
Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato
di politica, sport e tecnologia
Eva Kaili dal
carcere: «All’inizio ho pensato al suicidio, non mi sento una vittima ma un
trofeo».
Lorenzo Salvia
su Il Corriere della Sera il 31
Marzo 2023
Parla dal carcere
di Bruxelles la politica greca arrestata nell’ambito dell’inchiesta sulle
presunte mazzette versate da Qatar e Marocco a membri del Parlamento europeo,
cui ha fatto visita la deputata Bergamini (FI)
«Sono innocente,
lo dimostrerò. Ma non mi sento una vittima, mi sento un trofeo». Un trofeo? «Sì,
il trofeo di una persecuzione politica di cui fa parte un pregiudizio, un
pregiudizio che comunque c’è nei confronti dei parlamentari e dei politici del
Sud Europa. I maltesi, i greci, gli italiani e così via».
Ma persecuzione
da parte di chi? Lei alza gli occhi al cielo.
Bruxelles, lunedì
scorso. Nella sala colloqui del carcere di Haren Eva Kaili entra con un sorriso,
nonostante tutto. Jeans, sneaker, sopra la camicia bianca il gilet verde bordato
di nero che in Belgio devono indossare tutti i detenuti. Dall’altra parte del
tavolo c’è Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, membro della delegazione
Italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. E che proprio sulla
detenzione di Kaili a gennaio ha presentato un’interrogazione alla segretaria
generale del Consiglio europa Marija Buric. «Grazie per essere venuta a trovarmi
— le dice l’ex vice presidente del Parlamento europeo, prima ancora di mettersi
a sedere — apprezzo il suo coraggio». Coraggio? «Sì, coraggio. Lei è la prima
parlamentare che viene qui in carcere per vedere come sto. Finora non è venuto
nessuno. Nessuno dal mio partito, nessuno dalla mia Grecia». Non è un dettaglio.
I suoi avvocati avevano detto che era stata «sottoposta a tortura» perché nelle
prime sedici ore dopo l’arresto era stata lasciata senza acqua, al freddo, con
una luce sempre accesa. Adesso del regime carcerario non si lamenta. «Ma dopo il
clamore dei primi giorni di questa vicenda non parla più nessuno. Vengo
ignorata, sono stata dimenticata, anzi cancellata».
Sono passati
quasi quattro mesi dall’inizio del Qatargate, più di cento giorni da quel 9
dicembre, quando Kaili è stata arrestata insieme ad altre otto persone, tra le
quali il suo compagno Francesco Giorgi, assistente parlamentare che a Bruxelles
aveva lavorato con l’ex deputato europeo Antonio Panzeri, anche lui finito in
carcere. Un intreccio complicato da leggere anche per gli investigatori belgi.
«Panzeri è stato molto manipolativo con il mio compagno» commenta lei, vincendo
una certa resistenza a parlare delle altre persone coinvolte.
L’accusa è quella
di corruzione. Kaili avrebbe tentato di influenzare le decisioni del Parlamento
europeo che riguardavano il Qatar in cambio di denaro. Contro di lei ci sono i
600 mila euro in contanti che la polizia le ha trovato a casa, il suo discorso
al Parlamento europeo in cui definiva il Qatar «in prima linea per i diritti dei
lavoratori». Le indagini sono in corso, a fine aprile i magistrati dovranno
decidere se prolungare la carcerazione preventiva. «I crimini contestati sono
gravissimi — dice Bergamini — e se sarà dichiarata colpevole dovrà pagare. Ma la
presunzione d’innocenza è inalienabile e deve valere per tutti, anche per i
politici. Altrimenti vengono in mente periodi bui della nostra storia».
«Nelle prime sei
settimane — le ha raccontato Kaili — mi è capitato di pensare al suicidio. Più
volte. Poi è scattato qualcosa». L’ex presidente del Parlamento europeo si ferma
qui. Ma la fine di quelle sei settimane è molto vicina al momento della svolta
dell’inchiesta, quando Panzeri decide di collaborare con i magistrati e per
questo ottiene uno sconto di pena e gli arresti domiciliari. Difficile che sia
solo una coincidenza. Possibile, invece, che quella scelta di Panzeri sia
diventata una ragione per voltare pagina e mettere da parte quei pensieri neri.
La prima preoccupazione, però, resta la figlia di due anni, avuta proprio con
Giorgi che nel frattempo ha ottenuto anche lui i domiciliari. La può vedere solo
due volte al mese. «Se Kaili ha delle colpe – dice Bergamini - il sistema
giudiziario le accerterà. Ma sua figlia non ha alcuna colpa. E invece si trova a
vivere un’affettività spezzata che avrà conseguenze sulla sua vita».
Nella sua cella
singola Kaili si è messa a studiare francese e olandese. «Quando questa storia
finirà— dice — io voglio ricominciare a fare politica». Bergamini racconta di
averla trovata emotivamente provata ma combattiva, non depressa. La conclusione
la tira lei, ripensando al momento in cui l’ha salutata prima di uscire dal
carcere: «L’inchiesta farà il suo corso, come giusto che sia ma, ripeto, la
presunzione di innocenza dovrebbe valere per tutti. Sono veramente stupita del
silenzio della politica e dall’ipocrisia che circonda questa vicenda. E invece
quando cade una donna di potere, giovane, bella e in ascesa come lei, c’è una
sorta di compiacimento collettivo. Magari inconsapevole ma purtroppo diffuso».
Mattia Feltri per la
Stampa l’1 aprile 2023.
Chiedo: è diritto
tenere in cella per centodieci giorni, in detenzione preventiva, Eva Kaili, ex
vicepresidente del Parlamento europeo? È diritto averle fatto trascorrere le
prime sedici ore in carcere senza riscaldamento e senza acqua? È diritto negarle
gli arresti domiciliari e negarle di stare con la figlia che ha due anni? È
diritto negare da quasi quattro mesi a una bambina di due anni il diritto di
stare con la madre? È diritto tenere in carcere i bambini per non scarcerare le
madri?
È diritto negare a
questi bambini il diritto minimo di crescere in case famiglia con le loro madri
per il gusto di incarcerare madri sospettate di usare i loro figli per non
andare in carcere? È diritto ma, soprattutto, è logica? È diritto, poiché è
finita la pandemia, sottrarre la possibilità ai detenuti di fare una telefonata
al giorno a casa, e tornare a una sola telefonata a settimana? È diritto o è
burocrazia? È diritto o è vendetta? È diritto, poiché è finita la pandemia,
proibire a un bambino o a un ragazzo di salutare ogni giorno il padre
incarcerato?
È diritto – come ha
scritto qui ieri magnificamente Massimo Cacciari – vietare all'anarchico Alfredo
Cospito di leggere la Bibbia poiché è sottoposto al 41-bis, il famoso carcere
duro? È diritto vietargli di leggere la Bibbia perché lo si giudica ancora
pericoloso? È diritto o è ferocia? Lo chiedo soprattutto alla premier, alla
donna, alla madre e specialmente alla cristiana: è diritto? E lo chiedo a tutti
noi, che ogni giorno chiediamo diritti: abbiamo il diritto di pretendere
diritti, noi che davanti alla violazione del diritto, il più basilare, non
battiamo ciglio?
Perquisito il
quartier generale del Ppe a Bruxelles. Il caso Voigt deflagra in Ue.
FRANCESCA
DE BENEDETTI su Il Domani il 04 aprile 2023
Cosa faranno ora i
popolari europei, dopo aver speso le settimane dello scandalo Qatar a prendere
di mira le ong? Questa mattina la polizia belga ha fatto irruzione nel quartier
generale del Partito popolare europeo a Bruxelles. Il raid è legato a Mario
Voigt, figura politica prominente della Cdu, per corruzione. Ma le indagini ora
mirano al livello Ue
Cosa faranno ora i
popolari europei, dopo aver speso le settimane dello scandalo Qatar a prendere
di mira le ong? Questa mattina la polizia belga ha fatto irruzione nel quartier
generale del Partito popolare europeo a Bruxelles. Il raid è legato alle
indagini su Mario Voigt, figura politica prominente della Cdu, per
corruzione. Le ricerche si allargano anche al personale del partito a livello
europeo. E una ragione c’è: anche se oggi Voigt concentra la sua attività
politica nella dimensione locale tedesca, nel 2019 con il supporto del leader
del Ppe Manfred Weber aveva fatto attività su scala europea per le elezioni Ue
della scorsa tornata. Il caso ora avrà riflessi sulle prossime europee, quelle
del 2024, qualora vengano acclarati coinvolgimenti del partito europeo.
LA VERSIONE
UFFICIALE DEL PPE
«Il Partito popolare
europeo conferma che le forze dell’ordine di Germania e Belgio si sono
presentate al quartier generale del partito questo martedì. La visita è connessa
a un’indagine in corso in Turingia, in Germania. Il partito sta cooperando in
piena trasparenza con le autorità coinvolte; sta cioè fornendo tutte le
informazioni rilevanti e la documentazione. Visto che le indagini sono in corso,
non forniremo come Ppe ulteriori commenti».
IL CASO VOIGT
Il nodo che ha
portato al raid consisterebbe in verifiche su eventuali frodi legate a Voigt che
aveva lavorato al Ppe. Attualmente, il suo incarico è di presidente del gruppo
parlamentare della Cdu in Turingia. Ecco perché a perquisire la sede brussellese
del Ppe c’erano anche i funzionari dell'Ufficio statale di investigazione
criminale della Turingia. Le indagini su Voigt vanno avanti da tempo, e già
nell’autunno del 2022 erano scattate perquisizioni nei suoi uffici e abitazioni
in Germania, in Turingia appunto. La stampa locale aveva ricostruito cosa aveva
fatto scattare le indagini, e cioè l’assegnazione di un appalto da parte di
Voigt a un’agenzia digitale, e il sospetto che lui ne avesse ricevuto una
commissione di consulenza di circa 17mila euro. Da qui le accuse di corruzione
del pm tedesco. Ma la faccenda non è strettamente locale.
I RAPPORTI CON WEBER
Pare infatti che la
ricerca di assistenza sul fronte digitale fosse legata alla campagna elettorale
del Ppe per le europee. E siccome era stato proprio l’attuale plenipotenziario
del Ppe Manfred Weber – oggi anche presidente del partito, dal 2014 capogruppo e
nel 2019 spitzenkandidat ovvero frontrunner alle europee – a cooperare con
Voigt, i due livelli tedesco e belga di indagine ora si intrecciano. Il primo
punto da verificare è il coinvolgimento di Voigt nell’assegnazione dell’appalto
all’agenzia digitale.
IL CONTESTO
Da quando è esploso
lo scandalo corruzione all’Europarlamento, noto come “QatarGate”, Weber ha
anzitutto puntato il dito contro il gruppo direttamente toccato da quelle
indagini, e cioè quello socialista. Non significa però che il Ppe abbia promosso
riforme incisive di stampo etico in Ue, e anzi già da qualche anno il gruppo
aveva boicottato le richieste di un organo etico indipendente. Negli ultimi mesi
il refrain di Weber e del gruppo popolare da lui guidato era concentrato contro
le ong.
FRANCESCA DE
BENEDETTI. Europea per vocazione. Ha lavorato a Repubblica e a La7, ha scritto
(The Independent, MicroMega), ha fatto reportage (Brexit). Ora pensa al Domani.
Estratto
dell’articolo di Francesca De Benedetti per “Domani” il 5 aprile 2023.
Cosa faranno ora i
popolari europei, dopo aver passato le settimane dello scandalo Qatar a prendere
di mira le ong? Ieri mattina la polizia belga ha fatto irruzione nel quartier
generale del Partito popolare europeo a Bruxelles. Il raid è legato alle
indagini su Mario Voigt, figura politica prominente della Cdu, per frode
finanziaria.
Le ricerche si
allargano anche al partito a livello europeo. E una ragione c’è: anche se oggi
Voigt concentra la sua attività politica nella dimensione locale tedesca, nel
2019 con il supporto del leader del Ppe Manfred Weber aveva prestato le sue
attività su scala europea per la campagna elettorale Ue della scorsa tornata. Il
caso ora avrà riflessi sulle prossime europee, quelle del 2024, qualora vengano
acclarati coinvolgimenti del partito europeo.
[…] Il nodo che ha
portato al raid consisterebbe in verifiche su eventuali frodi legate a Voigt che
aveva lavorato al Ppe. Attualmente, il suo incarico è di presidente del gruppo
parlamentare della Cdu in Turingia. Ecco perché a perquisire la sede brussellese
del Ppe c’erano anche i funzionari dell'Ufficio statale di investigazione
criminale della Turingia. Le indagini su Voigt vanno avanti da tempo, e già
nell’autunno del 2022 erano scattate perquisizioni nei suoi uffici e abitazioni
in Turingia appunto.
La stampa locale
aveva ricostruito cosa aveva fatto scattare le indagini, e cioè l’assegnazione
di un appalto da parte di Voigt a un’agenzia digitale, e il sospetto che lui ne
avesse ricevuto una commissione di consulenza di circa 17mila euro. Da qui le
accuse di frode finanziaria del pm tedesco. Ma la faccenda non è strettamente
locale.
Pare infatti che la
ricerca di assistenza sul fronte digitale fosse legata alla campagna elettorale
del Ppe per le europee. Ed era stato proprio l’attuale plenipotenziario del Ppe
Manfred Weber – oggi anche presidente del partito, dal 2014 capogruppo e nel
2019 spitzenkandidat ovvero frontrunner alle europee – a cooperare con Voigt,
che era incaricato di seguire il versante digitale della campagna. Ecco perché i
due livelli tedesco e belga di indagine ora si intrecciano. Il primo punto da
verificare è il tipo di coinvolgimento di Voigt nell’assegnazione dell’appalto
all’agenzia digitale. […] esploso lo scandalo […] “QatarGate”, Weber si è
anzitutto scagliato contro il gruppo […] socialista. […]
Qatargate,
scarcerato Panzeri: andrà ai domiciliary.
L’ex eurodeputato
continuerà a scontare la pena a casa con il braccialetto elettronico: a gennaio
aveva “negoziato” uno sconto di pena firmando una testimonianza di pentimento.
Il Dubbio il 6 aprile 2023
L’ex eurodeputato
Antonio Panzeri verrà scarcerato e andrà agli arresti domiciliari con il
braccialetto elettronico, dopo la confessione in riferimento all’inchiesta della
magistratura belga. Lo ha confermato il suo avvocato Laurent Kennes, come
riporta il quotidiano Le Soir.
Considerato la
mente del cosiddetto Qatargate, l’ex europarlamentare italiano dovrebbe essere
rilasciato nelle prossime ore o nei prossimi giorni, dopo aver trascorso quasi
quattro mesi nel carcere brussellese di Saint-Gilles, nel quale era stato
condotto il 9 dicembre scorso. La decisione del tribunale di Bruxelles arriva
dopo che, nel gennaio scorso, Panzeri aveva firmato con la Procura federale
belga una testimonianza di pentimento, che gli ha consentito di beneficiare di
una pena ridotta in cambio di informazioni “complete e sincere” sui reati e gli
illeciti commessi da lui o dai suoi complici nello scandalo di corruzione che ha
travolto il Parlamento europeo.
Panzeri, accusato
di «aver partecipato ad una organizzazione criminale in qualità di dirigente, di
riciclaggio di denaro e di corruzione pubblica, attiva e passiva», in
particolare si è impegnato nel memorandum «ad informare la giustizia e gli
inquirenti in particolare sul modus operandi, gli accordi finanziari con Stati
terzi, le architetture finanziarie messe in atto, i beneficiari delle strutture
messe in atto e i vantaggi proposti, l'implicazione delle persone conosciute e
di quelle ancora non conosciute nel dossier, ivi inclusa l'identità delle
persone che ammette di aver corrotto». E’ la seconda volta nella storia della
giustizia belga, dalla messa in atto della legislazione sui pentiti (il termine
è riportato in italiano nel testo della Procura, perché è ispirata "alla legge
italiana che consente le inchieste di mafia", ndr) che si arriva alla firma di
un memorandum con un “pentito”. In entrambi i casi si è trattato di inchieste
«attuate dalla Procura Federale».
Eva Kaili esce
di prigione (finalmente). La decisione dei giudici in Belgio: l’ex
vicepresidente del Parlamento Ue, arrestata per il caso Qatargate, va ai
domiciliary. Giuseppe
De Lorenzo su Nicola Péorro il 12 Aprile 2023
Eva Kaili esce
dal carcere, finalmente. L’ex vicepresidente del Parlamento Europeo, arrestata
in pompa magna nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate, torna a casa. I giudici
hanno disposto per lei gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico.
Bene. Bravi. Bis. Ci voleva così tanto?
Già, perché Eva
Kaili intanto si è fatta quattro mesi di prigione da innocente. Innocente non
solo perché lei continua a dichiararsi tale (“Non ha confessato reati che non ha
commesso”, dice oggi il suo avvocato) ma perché lo è fino a prova contraria,
secondo il principio cardine della cultura giuridica occidentale.
Una cultura
giuridica che in Italia, ma evidentemente non solo, da qualche anno dimostra di
essere sconosciuta ai più. Eva Kaili era l’ultima persona rimasta in carcere tra
tutte le persone coinvolte nello scandalo delle tangenti europee. La scorsa
settimana hanno ottenuto i domiciliari Antonio Panzeri, l’eurodeputato Marc
Tarabella e pure il fidanzato della Kaili, Francesco Giorgi, era riuscito a
ottenere i domiciliari. Al netto di Andrea Cozzolino, che attende l’udienza per
l’estradizione, mancava solo lei, madre di una bimba di 26 mesi, l’unica a
quanto pare a non aver “cantato”.
Su questo sito lo
avevamo detto sin dall’inizio, quando lo scandalo tangenti era caldo e l’ardore
giustizialista bello alto. Eva Kaili andava scarcerata perché madre di una
figlia di meno di due anni, perché era (ed è) irrazionale costringere una bimba
a vedere la mamma solo due volte al mese peraltro in un luogo sconosciuto
come il carcere di Haren. Certo, alla bella greca hanno trovato secchi di soldi
in casa e immaginare che sia una santa può apparire difficile per molti.
Tuttavia lei sostiene non fossero i suoi, pensa di essere stata ingannata dal
compagno, giura di non essere stata corrotta e di non sapere da dove venissero
tutte quelle banconote. Vero? Falso? Poco importa, adesso.
Il punto è che
Eva Kaili non poteva fuggire, non aveva alcun modo per reiterare il reato o per
inquinare le prove. Infatti non è più la vicepresidente dell’Europarlamento, è
stata espulsa dal suo Partito, appare sputtanata politicamente e risulta ormai
innocua per la società. Oltre ad essere, come dicevamo prima, tecnicamente
innocente. I domiciliari sarebbero stati sin da subito una misura più che
sufficiente a permettere il sereno svolgimento del processo. Ma giudice
istruttore belga Michel Claise ha preferito il carcere preventivo e le manette.
Il cui tintinnio piace a tanti. Anche quando di mezzo c’è una bambina.
Giuseppe De
Lorenzo, 12 aprile 2023
Qatargate,
scarcerata Eva Kaili. La difesa: “Esce a testa alta”.
L’ex
vicepresidente del Parlamento europeo va ai domiciliari con il braccialetto
elettronico. Era in cella in Belgio dal 9 dicembre scorso. Il Dubbio il 12
aprile 2023
L’ex
vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, coinvolta nel Qatargate, è
stata scarcerata. Per lei il tribunale di Bruxelles ha deciso gli arresti
domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. “Esce dal carcere a testa
alta e con dignità, non ha confessato reati che non ha commesso, lotterà per la
sua innocenza fino alla fine”, ha dichiarato il suo avvocato, Michalis
Dimitrakopoulos.
Quattro mesi dopo
lo scoppio dello scandalo, Kaili era l'ultima delle persone coinvolte
nell’inchiesta della magistratura belga ad essere ancora in carcere. Nell'ultima
settimana hanno avuto i domiciliari l'ex europarlamentare, Antonio Panzeri, e
l'eurodeputato socialista Marc Tarabella.
Il compagno di
Kaili, Francesco Giorgi, ex assistente parlamentare di Panzeri, è stato
rilasciato a febbraio per essere sottoposto al braccialetto elettronico, mentre
il direttore generale della Ong No Peace Whitout Justice, Niccolò
Figà-Talamanca, era stato liberato senza condizioni a inizio febbraio. Resta
ancora da esaminare la richiesta di estradizione nei confronti dell'eurodeputato
italiano (sospeso dai socialisti), Andrea Cozzolino. I giudici di Napoli hanno
rinviato l'esame a inizio maggio.
Durante i quattro
mesi di detenzione, la difesa di Kaili aveva più volte criticato la giustizia
belga per averla tenuta lontano dalla figlia di due anni. Le era permesso
vederla in carcere solo due volte al mese. Per abbracciarla dovrà ancora
attendere qualche giorno: il rilascio effettivo potrebbe avvenire venerdì o
lunedì prossimo, ha ipotizzato l'altro legale, Sven Mary.
Lo scorso
dicembre la polizia federale fece una perquisizione a casa di Kaili a Bruxelles
- dove viveva con il compagno Francesco Giorgi - e rinvenne contanti per
centinaia di migliaia di euro che le costarono l'arresto in flagranza di reato,
facendo decadere la sua immunità da eurodeputata e rendendola il volto del
Qatargate. Gli inquirenti ritengono che quella montagna di contanti sia stata
ottenuta dal Qatar (e altri Paesi come il Marocco e la Mauritania) come
corruzione in cambio di posizioni favorevoli all'Eurocamera.
«Su Eva Kaili
pressioni per farla confessare. Trattata da trofeo».
L’ex vicepresidente del
Parlamento europeo è in attesa del braccialetto elettronico per riabbracciare la
figlia dopo quattro mesi di carcere.
Simona Musco
Il Dubbio il 13
aprile 2023
«Troppe persone
facevano pressioni su di lei perché confessasse perché altrimenti sarebbe
rimasta in prigione e probabilmente sono stato l'unico a dirle “se sei innocente
non puoi confessare qualcosa che non hai fatto”. Da quando glielo abbiamo
annunciato, ho parlato con lei 4-5 volte. È la prima volta che la sento felice,
è la prima volta che sorride e mi dice: “mi stai dicendo la verità Michalis,
vedrò mio figlio?” Questa è stata la sua reazione, profondamente umana». A dirlo
è Michalis Dimitrakopoulos, avvocato di Eva Kaili, l’ex vicepresidente del
Parlamento europeo in carcere da quattro mesi nell’ambito dell’inchiesta
Qatargate.
Per Kaili, ieri,
è arrivato il via libera per i domiciliari con il braccialetto elettronico, una
decisione che fa il paio con le confessioni dell’ex eurodeputato di Pd e
Articolo Uno Antonio Panzeri, uscito oggi dal carcere di Saint-Gilles, a
Bruxelles, dopo oltre quattro mesi. Secondo la procura, infatti, la possibilità
di inquinare le prove da parte di Kaili sarebbero state ridotte all’osso,
proprio grazie alle confessioni di Panzeri, che ha trovato un accordo con le
autorità che gli consentirà di scontare solo un anno di detenzione ai
domiciliari. Panzeri, così come Kaili, potrà ora tornare a casa con il
braccialetto elettronico. Stessa decisione è stata presa a favore
dell'eurodeputato belga Marc Tarabella. L'eurodeputata è accusata di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro
per influenzare le decisioni dell'Ue su Qatar e Marocco. Accuse che ha sempre
respinto, chiarendo dal carcere che «non confesserò mai crimini che non ho
commesso, anche se mi fanno a pezzi».
La procura ha
chiarito che il rilascio dell’europarlamentare non è un’ammissione della sua
innocenza: «Premesso che permangono i presupposti espressi nell'ordinanza di
custodia cautelare confermati dai giudici inquirenti rispetto al rischio di
recidiva, collusione ed evasione della pena - si legge nel documento firmato dal
procuratore Michel Claise -, tuttavia nulla osta alla prosecuzione della
carcerazione preventiva con braccialetto elettronico». Insomma, le prove,
secondo l’accusa, rimangono solide, concetto che viene invece contestato dai
legali della donna, secondo cui tale decisione avrebbe dovuto essere presa
«molto tempo fa». E ciò perché «ci sono molti elementi nel fascicolo che
stabiliscono senza alcun dubbio che sarà assolta - ha spiegato ai media locali
Dimitrakopoulos -. Rispettiamo semplicemente la segretezza delle indagini
preliminari e dell'interrogatorio, ed è per questo che non facciamo trapelare
altro».
Nessuna impronta
sui soldi
Il punto debole
del caso, secondo la difesa, starebbe proprio in quella che per la procura belga
è la pistola fumante: i soldi trovati in casa di Kaili e del marito Francesco
Giorgi, arrestato nell’ambito della stessa inchiesta e spedito ai domiciliari
con il braccialetto elettronico a fine febbraio. «I risultati dimostrano che lei
non aveva nulla a che fare con quei soldi. Nessuna impronta digitale di Eva
Kaili è stata trovata sulle mazzette di denaro. Questa è la prova più forte e ce
ne sono altre», ha aggiunto il legale. Che si dice certo del fatto che l’ex
vicepresidente del Parlamento europeo «non ha ricevuto un solo euro» sfruttando
il suo ruolo politico. Questi quattro mesi in carcere sono trascorsi «in
condizioni tragiche - ha aggiunto l’avvocato -, che fino ad oggi non abbiamo
reso pubbliche. Posso dirvi che sta uscendo di prigione a testa alta, con
dignità e senza aver confessato crimini che non ha commesso». Kaili verrà
rilasciata tra oggi e lunedì. E il suo principale pensiero è quello di
riabbracciare la figlia, che in questi lunghi quattro mesi ha potuto vedere solo
due volte. «Il primo giorno voglio solo essere a casa con mia figlia - ha
dichiarato Kaili, come riportato ieri da Repubblica -. Tutto il giorno con lei.
Da gennaio la vedevo solo due volte al mese. Rimarrò a Bruxelles, continuerò a
lottare per la mia innocenza», ha sottolineato.
«Violate le
prerogative parlamentari»
Al netto delle
prove che possano giustificare l’arresto di Kaili, ad essere violate, secondo un
altro dei difensori della donna, Spyros Pappas, sono state le regole
parlamentari. Sentito da Mega, Pappas ha parlato di «un ingiustificato ostacolo
alla sua funzione parlamentare», garantita dal Trattato con l'immunità
parlamentare, violata «sia durante la perquisizione della sua abitazione sia
durante la perquisizione dell'area inviolabile dei suoi uffici presso il
Parlamento europeo e durante i suoi 4 mesi di custodia cautelare. Si tratta di
una grave patologia della democrazia a livello Ue».
Pappas ha
presentato un ricorso al Tribunale dell’Ue contro la decisione della Procura
europea di richiedere la revoca dell’immunità dell’europarlamentare, sostenendo
l’illegittimità di tale richiesta. Ciò in quanto la prima condizione per la
revoca dell’immunità di un deputato dell’Ue – essere colti in flagranza di reato
– non è stata soddisfatta. «La polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento
dopo aver arrestato il padre a qualche chilometro di distanza, fuori da un
hotel, con la famigerata valigia presumibilmente presa dal suo appartamento - ha
detto il legale qualche settimana fa ad Euractiv -. L’isolamento degli uffici di
Kaili e dei suoi assistenti è stata una violazione dei locali del Parlamento
europeo. Questo avrebbe potuto essere consentito solo dopo l’autorizzazione
della Corte di giustizia dell’Ue, che non c’è stata».
Trattata come un
«trofeo»
A commentare il
caso anche Sven Marie, altro legale di Kaili, secondo cui gli investigatori
belgi non avrebbero nuove prove contro Kaili, trattata come un «trofeo» dagli
inquirenti. «Kaili è stata interrogata per due settimane, più di 15 ore in
totale. Ha risposto a tutte le domande e a tutte le accuse degli inquirenti.
Allora dev'esserci un problema perché né il giudice istruttore, né il
procuratore federale, né gli investigatori vogliono sentire le risposte della
signora Kaili. Nella loro visione a senso unico, vogliono sentire certe
risposte, ma non quelle di Eva Kaili - ha dichiarato ad Euronews -. In casi come
questo, persone come Kaili, sono considerati un trofeo o un simbolo e vengono
mostrati come la Coppa del mondo di calcio. Come un calciatore alza la Coppa del
mondo, qui Eva Kaili viene alzata come un simbolo per dimostrare che anche chi
ricopre alti incarichi può rimanere in carcere e soprattutto per spaventare gli
altri parlamentari».
«Eva Kaili
interrogata per 15 ore. Così volevano spingerla a confessare il falso».
Intervista esclusiva a Sven Mary, difensore dell’ex
vicepresidente del Parlamento Ue: «Non credo che Panzeri stia raccontando la
verità, ma la verità che fa comodo a lui e alle persone che vuole proteggere».
Simona Musco Il Dubbio il 14 aprile 2023
«Mia figlia mi
sta aspettando. Sono molto felice oggi. La lotta continua con determinazione da
parte dei miei avvocati». L’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva
Kaili non ha detto di più ai giornalisti che hanno letteralmente assalito l’auto
nera con i vetri oscurati che ieri l’ha portata fuori dalla prigione di Haren,
in Grecia. E si è mostrata sorridente, felice - pur se costretta ai domiciliari
con il braccialetto elettronico - di poter riabbracciare la figlia, che negli
ultimi tempi ha potuto vedere solo in prigione, dove è rimasta negli ultimi
quattro mesi. «Per la procura belga è stata un trofeo», spiega al Dubbio uno dei
suoi legali, Sven Mary, secondo cui gli inquirenti l’hanno usata come «simbolo»
per dimostrare che anche chi ricopre ruoli di vertice può finire in cella. La
politica greca si trovava in carcere dal 9 dicembre scorso, dopo essere finita
nello scandalo Qatargate, con l’accusa di corruzione, riciclaggio di denaro e
partecipazione a un'organizzazione criminale, che prevedeva il pagamento di
«ingenti somme di denaro» da Qatar e Marocco, per influenzare i processi
politici comunitari. Accuse che Kaili ha sempre respinto, ma senza convincere la
autorità giudiziarie del Belgio, che nel frattempo hanno trovato sponda in un
altro ex europarlamentare coinvolto nell’inchiesta, Antonio Panzeri. Un
“pentito” sulla cui sincerità Mary ha molti dubbi: «Se parla deve dire tutta la
verità, non solo quella che fa comodo. E lui sta proteggendo qualcun altro».
Avvocato, come
sta la sua assistita ora che finalmente è tornata in libertà?
È felice di
tornare a casa e poter riabbracciare sua figlia. Ed è importante, ora, che le
indagini vadano avanti. Risponderemo a tutte le domande quando la polizia vorrà
sentirci. Questo caso si basa per la parte più importante su quanto dichiarato
da Panzeri, dichiarazioni nelle quali polizia e autorità giudiziaria ripongono
molta fiducia. Ma vedremo in futuro se quanto dice è corretto: come pentito deve
dire tutta la verità. E avremo modo di vedere cosa significa questa verità.
Lei non crede
nella sua sincerità?
Non credo che
Panzeri stia raccontando la verità. Piuttosto, sta raccontando una verità che fa
comodo a lui e alle persone che vuole proteggere. Non farò nomi, ma ci sono
persone che Panzeri vuole proteggere, oltre a voler proteggere se stesso. Non si
sta comportando come un vero pentito. I veri pentiti sono quelli degli anni ‘80,
come Tommaso Buscetta, che parlò con Giovanni Falcone. Panzeri è tutta un’altra
cosa: racconta solo ciò che fa comodo a lui. Ed è molto, molto pericoloso dover
combattere contro questo tipo di dichiarazioni.
Il suo collega
Michalis Dimitrakopoulos, che insieme a lei difende Kaili, ha parlato di
pressioni per farla confessare: davvero hanno tentata di farla ammettere delle
responsabilità con la forza?
Dimitrakopoulos
ha ragione. Kaili ha risposto a tutte le domande per due settimane, nel corso di
interrogatori durati più di 15 ore. Probabilmente la polizia aveva una propria
visione delle cose e quindi se la risposta della mia assistita non coincideva
con ciò che gli ufficiali volevano sentirsi dire ciò, nella loro testa, faceva
di lei una bugiarda. Kaili ha risposto a tutte le domande e quando andremo
davanti ai giudici vedremo se le risposte che ha dato sono vere o false e le
confronteremo con le risposte che ha dato Panzeri. A quel punto capiremo chi ha
raccontato la verità. In queste condizioni sono felice che non abbia confessato:
le pressioni che ha subito non sono servite a nulla, perché non c’era nulla da
confessare. È stata forte per oltre quattro mesi, molto forte.
Pensa che sua
figlia sia stata usata come elemento per farla confessare?
Non credo che sia
stata usata, ma quando puoi vedere tua figlia una volta a settimana in una
cella, questo ti condiziona molto psicologicamente. Credo abbiamo “giocato” il
loro ruolo, che non si possa parlare di tortura, ma certamente tutto questo ha
avuto un forte impatto su di lei. Per rivedere i propri figli le persone sono
pronte a fare un sacco di cose, ma lei è stata comunque forte, coraggiosa e ha
fatto le cose che doveva fare.
Come risponde
Kaili alle dichiarazioni di Panzeri?
Preferisco non
parlare dei dettagli della vicenda giudiziaria. Ma so che molti giornalisti
hanno usato le dichiarazioni di Panzeri: penso a questo pubblicato da Politico o
dal Corriere della Sera, che avevano molte informazioni di cui nemmeno noi
avvocati eravamo in possesso nel momento in cui se ne stava parlando e ciò
nonostante ne avessimo fatto richiesta. Penso sia molto strano discutere di un
caso sui giornali: il luogo in cui una vicenda giudiziaria deve essere
affrontata è un tribunale e noi è lì che la affronteremo.
Però avete
parlato di elementi in grado di certificare la sua innocenza. Il suo collega ha
parlato, ad esempio, dell’assenza di impronte sui soldi trovati in casa. Quali
altri elementi dimostrano la vostra tesi?
Panzeri dice che
Kaili è stata corrotta. Francesco Giorgi, marito della signora Kaili ed ex
braccio destro di Panzeri, non ha mai parlato della mia assistita. Delle due
l’una: qualcuno sta mentendo. E se Panzeri ha ragione, come può dimostrarlo?
Quali sono gli elementi che porta per dimostrare che sta dicendo la verità? Sono
quattro mesi che aspetto di conoscere queste cose, ma senza successo. Sono
davvero molto curioso.
L’immunità
parlamentare della sua assistita è stata violata?
Questa è una
discussione che affronteremo in futuro. È una domanda molto interessante e ci
sono serie possibilità che l’immunità sia stata violata. Ma porteremo la
questione fino in fondo.
C'erano requisiti
cautelari per tenerla in carcere così a lungo?
No. Kaili è l’ex
vicepresidente dell’Europarlamento, credo lei abbia rappresentato un trofeo per
la procura. È stata usata per dire e dimostrare che anche quando si ricopre un
ruolo così importante è possibile finire in cella. È diventata un simbolo. Ma i
simboli non dovrebbero mai essere usati per fare giustizia.
Quindi ritiene
che sia stata usata come strumento per spaventare altri eurodeputati?
È una
considerazione che ho fatto.
Pensa che ci sia
stato un accanimento mediatico contro di lei?
Basta fare un
giro su internet, a partire da wikipedia, per vedere cosa si trova su di lei.
Sui giornali sono finite le accuse e tutti i dettagli dell’inchiesta in
violazione del principio di presunzione di innocenza, che nel mio Paese va
rispettato.
Ha notato
differenze rispetto alla gestione del caso nei Paesi coinvolti nell'inchiesta?
In Italia, la
posizione di Andrea Cozzolino è ancora in sospeso, nel rispetto delle regole del
diritto. E penso che ogni Paese della Comunità europea dovrebbe avere a cuore i
diritti e le regole.
Siamo tornati
ai tempi di Mani Pulite. Eva Kaili è stata torturata, ma l’Europa è rimasta
muta: stesso clima del golpe del ’92.
Luigi Corbani su Il Riformista il 20 Aprile 2023
Dopo quattro mesi
di carcere, in isolamento, al freddo, senza luce, con l’umiliazione di impedirle
di lavarsi durante il ciclo mestruale, con l’impossibilità di vedere la figlia
di due anni, la vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, che ha sempre
negato ogni addebito, è oggi agli arresti domiciliari. Il Parlamento europeo
sulla vicenda della Kaili, del “Qatargate” ha dimostrato di essere inesistente e
di avere una presidente, Metsola, dannosa.
Un Parlamento in
cui la presidente destituisce dalla sera alla mattina una vicepresidente, senza
atti ufficiali a disposizione di tutti i parlamentari e senza una istruttoria
pubblica e palese della Assemblea elettiva, è delegittimato, è alla mercè di
qualsiasi magistrato in combutta con i servizi segreti di questo o di quel
paese, persino extraeuropeo. Per di più, un Parlamento che non
denuncia condizioni carcerarie da tortura, preventive, senza uno straccio di
prova, è un organismo senza dignità.
Nelle democrazie
liberali, a tutela della autonomia e della indipendenza di chi rappresenta il
popolo. vi è l’insindacabilità dei parlamentari (per le opinioni espresse
nell’esercizio del loro mandato), l’immunità e l’inviolabilità dei
parlamentari che non possono essere sottoposti a perquisizione personale o
domiciliare, ovvero arrestati (tranne nei casi di flagranza di reato o in
presenza di una sentenza irrevocabile di condanna) senza l’autorizzazione della
assemblea elettiva cui appartengono.
Un parlamentare
può anche parlare bene del Qatar senza che questo sia un reato. Del resto, ne
hanno parlato bene in tanti, in primis, i vertici mondiali del calcio che, per
soldi nelle casse della Fifa, Fédération Internationale de Football
Association, hanno assegnato i campionati mondiali, a dicembre (date del tutto
inusuali) al Paese del Golfo: nessuno è stato indagato. Vivo in una città in cui
il maggiore attore immobiliare è il fondo del Qatar che praticamente ha in mano
il centro della città, la costruzione del villaggio olimpico, e si sta
adoperando (con il favore di quotidiani di “informazione”) per avere altri
affari in città e fuori città, ricevendo dal Comune anche dei consistenti premi
volumetrici per costruire di più. E nessuno ha mai sollevato problemi, anzi in
Comune sono contenti perché la massiccia presenza del fondo del Qatar dimostra
che Milano è “attrattiva”, è “appetibile”.
Ora, una cosa è
il giudizio politico (a me non va bene la presenza del fondo
del Qatar a Milano, e non mi vanno bene tantomeno i finanziamenti del Qatar a
Paesi e organizzazioni nel Medio Oriente); una cosa è la condanna politica di
chi prende le difese del Qatar, considerandolo un Paese “quasi democratico” o
nel quale sono rispettate le tutele e la sicurezza del lavoratori; una cosa è
il giudizio morale (disapprovo, disistimo, censuro e critico chi prende i soldi
dalle attività lecite o illecite del Qatar); una cosa è un reato
tributario (ricevono dei soldi per attività lecite, ma non li dichiarano e
quindi evadono il fisco); una cosa è un reato penale di corruzione e/o
di riciclaggio. In questo caso il reato deve essere dimostrato dal magistrato
inquirente, e nel caso di un parlamentare, gli atti giudiziari, con le prove,
devono essere inviati al Parlamento, prima di perquisirne l’abitazione o
addirittura di arrestarlo.
Non basta
pubblicare foto con soldi contanti su un tavolo o in una borsa, per giustificare
l’arresto (illegale) e per suscitare lo sdegno e l’indignazione della opinione
pubblica o del “popolo”. Ed è inammissibile, in uno stato di diritto e in uno
stato democratico, in una Europa che dovrebbe avere principi liberali ben saldi,
che un cittadino, e tanto più un parlamentare, sia gettato in carcere senza
prove in modo da fargli confessare anche quello che non ha mai commesso o da
costringerlo a dare le dimissioni dal suo incarico pubblico.
È quello che è
successo in Belgio, è già accaduto in Italia con il colpo di stato del
procedimento retoricamente e fasullamente chiamato “mani pulite”: oggi qualcuno
è apparso sorpreso dalle dichiarazioni di un magistrato protagonista di quella
operazione che confermava un uso scellerato del carcere preventivo. E così
abbiamo visto tanti sepolcri imbiancati, persone e atteggiamenti ipocriti e
falsi che pensano così di nascondere la loro partecipazione alla distruzione
della Repubblica: come se i vari direttori dei giornali (La Stampa, l’Unità,
Repubblica, Il Corriere della Sera) all’epoca non concordassero ogni giorno i
titoli e non sapessero che il carcere era uno strumento per costringere a
confessare reati di cui i magistrati non avevano prove o per far dimettere
deputati, senatori o consiglieri comunali e regionali o per bloccare nomine come
quella del presidente della Repubblica, quando il candidato non era gradito a
quei magistrati che andavano in televisione a proclamare quanto il governo o il
parlamento poteva fare o non fare.
Tv e giornali,
sepolcri imbiancati, che incensavano il tripudio delle forze reazionarie e
del popolo “giustiziere”, “girotondino” quando i suddetti magistrati sfilavano
per la galleria di Milano come eroi assoluti di una stagione da repubblica delle
banane, che aveva cancellato lo stato di diritto. Ancora oggi, in questa vicenda
del cosiddetto “Qatargate” non è chiaro quale sia il reato e quali siano le
prove dell’eventuale reato.
Ma come sempre
dietro questa cortina fumogena, moralistica, non si affrontano i
necessari correttivi politici e istituzionali per distinguere il lecito
dall’illecito, nelle attività delle Ong e delle lobby. Esistono regolamenti e
norme per le attività di lobby con i parlamentari in carica, ma non per gli ex
parlamentari o i direttori (in carica o ex) della Commissione europea, che
possono persino chiedere l’aspettativa, fare attività lobbistica di una
multinazionale e poi tornare a fare il direttore.
La cosa infine
che non mi sorprende più è l’assoluto silenzio di “Renew Europe” e della
“Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici” al Parlamento
europeo. Singoli parlamentari si sono mossi, ma non vi è stata una
mobilitazione, in questi quattro mesi, dei liberali, dei socialisti o dei
“democratici” a difesa di sacrosanti principi liberali come quello della
presunzione di innocenza o dello stato di diritto. E ovviamente, questo vale
anche per i popolari, e per tutti quelli che ci parlano dei sacrosanti valori
dell’occidente.
Ancora una volta,
vi è stato il silenzio quando non la compiacenza verso campagne mediatiche
moralistiche di massa, guidate da demagoghi, interessati anche a distruggere la
reputazione delle istituzioni comunitarie: si spinge sugli istinti,
sull’anatema, sull’invettiva moralistica, sulle immagini ad effetto, sui
titoloni dei giornali, piuttosto che sulla ragione, sul confronto, o sull’esame
pacato ed attento dei fatti, sull’analisi differenziata.
E popolari,
liberali e “sinistra” dovrebbero sapere che queste campagne finiscono sempre a
favore della destra, non quella conservatrice, ma quella reazionaria, e che,
come diceva Polibio, queste sono forme degenerate della democrazia, sono quella
oclocrazia che ai valori della libertà, che è sempre basata sul rispetto di
regole, sostituisce i sentimenti e gli umori del popolo. Per questo, un
Parlamento che non difende le prerogative dei suoi deputati è un Parlamento
morto. Luigi Corbani
Estratto dell’articolo di
Fabio Rubini per “Libero quotidiano” il 24 maggio 2023.
Ammontano a oltre 6 milioni e
mezzo di euro i fondi europei finiti alle Ong implicate nel Qatargate,
l’inchiesta che ha messo nel mirino alcuni europarlamentari e una serie di
Organizzazioni non governative che, secondo le accuse, avrebbero fatto da filtro
a finanziamenti illeciti.
A rendere nota l’entità dei
finanziamenti europei alle Ong è stata l’eurodeputata della Lega Susanna
Ceccardi. Lo scorso 3 febbraio, assieme ad altri colleghi la Ceccardi aveva
presentata un’interrogazione scritta alla Commissione. La risposta è arrivata
ieri e per certi versi è sorprendente.
[…]
Si scopre così che mentre la
Fight Against Impunity (quella dell’ex parlamentare Panzeri, per intenderci) non
ha ricevuto fondi e non è mai stata audita dalla Commissione; alla Ong “Droit au
Droit”, il cui presidente ha subito una perquisizione per via di rapporti
giudicati “sospetti” con gli Emirati Arabi è stato elargito in una quindicina
d’anni poco più di mezzo milione di euro.
Ben più consistenti i soldi
che la Ue ha versato alla Ong “No Peace Without Justice” che fa capo a Niccolò
Figà-Talamanca, messa sotto inchiesta per una serie di bonifici in favore della
figlia di Panzeri. Ecco questa organizzazione ha incassato fondi per circa 6
milioni di euro, relativi a sette differenti progetti presentati e regolarmente
finanziati. […]
Kaili: «Eurodeputati spiati dal Belgio,
questo il vero scandalo». La vicepresidente
dell’europarlamento parla in un’intervista esclusiva al CorSera dopo la
scarcerazione. «Torturata in carcere per farmi confessare come Panzeri». Il
Dubbio il 4 giugno 2023
Il "vero scandalo" è quello degli eurodeputati
spiati dal Belgio. La denuncia, in un'intervista esclusiva rilasciata al
Corriere della Sera (prima che il giudice Michel Claise le vietasse di
rilasciare dichiarazioni alla stampa), è di Eva Kaili, arrestata in Belgio sei
mesi fa perché accusata di far parte di un ipotetico sistema di corruzione al
parlamento europeo legato a Qatar e Marocco che faceva capo ad Antonio Panzeri,
tornata libera da pochi giorni. «Dopo tutti questi mesi non è venuto fuori nulla
di nuovo. Il Parlamento ha protezioni che nessun lobbista può abbattere», dice
l'europarlamentare, sottolineando che c'è però «una cosa inquietante che vorrei
sollevare: dal fascicolo giudiziario i miei avvocati hanno scoperto che i
servizi segreti belgi avrebbero messo sotto osservazione le attività dei membri
della commissione speciale Pegasus (Indaga sulle intercettazioni di leader
europei fatte illegalmente dal Marocco, ndr.). Il fatto che i membri eletti del
Parlamento siano spiati dai servizi segreti dovrebbe sollevare maggiori
preoccupazioni sullo stato di salute della nostra democrazia europea. Penso sia
questo il vero scandalo».
Kaili è stata 4 mesi in cella e due ai
domiciliari. La vicepresidente del Parlamento europeo avvenne poiché la stessa
chiese al padre di portare via da casa una valigia con dentro 700 mila euro in
contanti che, per i magistrati, erano i soldi incassati con il marito Francesco
Giorgi. La coppia sin da subito si è difesa dichiarando che quei soldi erano
dell’ex parlamentare europeo Antonio Panzeri.
«Subito dopo l’arresto, al commissariato di
polizia sono stata messa in isolamento in una cella con luci e telecamera di
sorveglianza sempre accese, senza acqua corrente. Ho sofferto il freddo gelido
perché mi è stato tolto il cappotto - ha spiegato parlando delle condizioni di
detenzione in carcere -. Ero preoccupata per la mia bambina, perché i primi
giorni non mi è stato permesso di chiamare un avvocato, né la mia famiglia. Il
carcere, però, non cambia ciò che siamo, è il modo in cui reagiamo ciò che ci
definisce. Il mio avvocato greco Michalis Dimitrakopoulos mi ha chiesto di
parlare perché ho avuto la rara opportunità di assistere e osservare come
vengono trattate le persone nelle carceri in Belgio. Invece di chiudere i centri
penitenziari e ridurre l’uso della detenzione preventiva, si stanno costruendo
carceri più grandi e le vecchie carceri vertono in condizioni disumane e sono
sovraffollate. Pene più estreme non rendono una giustizia più giusta».
Perché far portare via i soldi dal padre?, chiede
il giornalista del CorSera. «Quando Francesco è stato arrestato e gli hanno
sequestrato l’auto, ho pensato ad un incidente stradale. Poi mi hanno mandato la
notizia che anche Panzeri era stato arrestato. Sono andata in panico. Sapevo che
nel suo ufficio che è nella stanza di sopra (l’appartamento è un bilocale su due
piani, ndr.), dove non vado mai, c’era una valigia di Panzeri e ho trovato un
sacco di soldi. Non riuscivo a capire cosa fosse successo, ma volevo allontanare
da casa quel denaro per ridarlo a Panzeri, colui che credevo ne fosse il
proprietario. Non ho pensato minimamente di avvalermi della mia immunità
parlamentare, e questo dimostra che non sapevo assolutamente ciò che quel denaro
rappresentava realmente».
Ciò che sapeva, afferma, è che «Panzeri riceveva
donazioni. Data la sua esperienza negli affari esteri e nei diritti umani, ha
avuto contatti con diverse persone di paesi terzi (non Ue, ndr) e attraverso la
sua ong Figth impunity promuoveva una causa nobile. Ci sono testimonianze
documentate sulla sua attività nel Parlamento e sulle persone che ha coinvolto.
Io non sono tra quelle. Le commissioni parlamentari di cui faccio parte e il mio
lavoro legislativo non hanno alcuna relazione con le sue attività. Anche i
servizi segreti confermano che non faccio parte di nessuna organizzazione
criminale. Nessuno può corrompermi. Dopo più di un anno di indagini i miei conti
correnti e le mie proprietà sono state controllate e sono risultate cristalline.
Sulle banconote trovate non ci sono le mie impronte digitali. Con i miei
avvocati dimostrerò la mia innocenza». È stato Panzeri, dopo il suo pentimento,
a dichiarare che a Kaili erano destinati 250mila euro. Dichiarazioni non sincere
secondo la politica. «Penso che il pentimento e le confessioni di Panzeri siano
state ottenute sotto minaccia. Il messaggio era chiaro: se fai i nomi, ti
offriamo un accordo e liberiamo tua moglie e tua figlia dalla prigione - ha
aggiunto -. Sono metodi non degni di uno stato di diritto. Hanno fatto lo stesso
con me. Dichiarandomi colpevole o facendo nomi importanti sarei tornata subito
da mia figlia, ma dato che avrei dovuto mentire, non ho mai nemmeno pensato che
potesse essere un’opzione. Durante il primo interrogatorio e prima di pentirsi,
Panzeri ha fatto i nomi di due membri del Parlamento di lingua italiana e non il
mio e non parla di me neppure nelle intercettazioni telefoniche. Il primo è
stato arrestato, l’altra persona non ha avuto problemi, mi chiedo ancora perché.
Forse perché protetta da un’immunità speciale?». Per gli investigatori la rete
di Panzeri era legata ai servizi segreti del Marocco e comprendeva
l’ambasciatore di Rabat in Polonia Atmoun. «Non sono membro di nessuna
commissione parlamentare che poteva interessare Panzeri e Atmoun - ha
evidenziato - e non parlo le loro lingue. Sapevo di una forte amicizia tra i
due. Non avevo motivo di mettere in discussione la relazione che li legava».
Kaili ha incontrato due volte il ministro del
lavoro del Qatar, che gli inquirenti considerano un finanziatore della
corruzione. «Nel mio ruolo di vicepresidente responsabile delle relazioni con i
paesi del Medio Oriente ho incontrato diversi ambasciatori e ministri, e avevo
in programma delle visite ufficiali in tutti i paesi del Golfo. Era una missione
di diplomazia parlamentare fatta per conto della presidente del Parlamento
europeo, Roberta Metsola. L'Ue considera il Qatar come un partner fondamentale
nella regione. È l'unico paese del Golfo ad aver condannato l'invasione russa
dell'Ucraina e la sua posizione geopolitica come esportatore alternativo di Gnl
verso la Russia lo rendono strategicamente importante per gli Stati membri.
Inoltre, l’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro, ndr.) ha descritto il
Qatar come leader nel mondo arabo nell’ambito dei diritti dei lavoratori e ha
deciso di aprire un ufficio nel paese, e l'Ue ha recentemente aperto
un'ambasciata in Qatar. In quel contesto ho incontrato due volte il ministro del
Lavoro il quale, negli stessi giorni, ha incontrato i ministri degli Affari
Esteri e del Lavoro del Belgio e altri colleghi parlamentari». Gli inquirenti
fanno intendere che le indagini si estenderanno, al momento non è accaduto.
«Credo che le aspettative create dai media fossero alte e le fughe di notizie
selettive e illegali sulla stampa hanno trasformato i dibattiti televisivi
mondiali in aule di tribunale. I giornalisti avevano le informazioni prima dei
miei avvocati, il che ha portato a speculazioni estreme. Dopo tutti questi mesi
non è venuto fuori nulla di nuovo - ha aggiunto - . Il Parlamento ha protezioni
che nessun lobbista può abbattere. Tuttavia, c'è una cosa inquietante che vorrei
sollevare. Dal fascicolo giudiziario i miei avvocati hanno scoperto che i
servizi segreti belgi avrebbero messo sotto osservazione le attività dei membri
della commissione speciale Pegasus (Indaga sulle intercettazioni di leader
europei fatte illegalmente dal Marocco, ndr.). Il fatto che i membri eletti del
Parlamento siano spiati dai servizi segreti dovrebbe sollevare maggiori
preoccupazioni sullo stato di salute della nostra democrazia europea. Penso sia
questo il vero scandalo».
Sulla revoca dell’immunità parlamentare voluta da
Metsola, Kaili ha evidenziamo come sia «triste vedere come non venga rispettata
la presunzione di innocenza. Mi dispiace che nessuno degli eurodeputati mi abbia
cercato per ascoltare la mia versione. Ho apprezzato la posizione di
Massimiliano Smeriglio (Sd) e sono molto riconoscente a Deborah Bergamini (Pdl),
la deputata italiana più coraggiosa che ha osato venirmi a trovare in prigione e
ha denunciato i metodi inumani usati contro di me».
Kaili ha potuto incontrare sua figlia in carcere
solo a gennaio, un mese dopo l’arresto. «È stato terribile. Separare una madre
per 4 mesi dalla figlia di 2 anni non solo è considerata una forma di tortura
nei paesi fondati sullo stato di diritto, ma è in piena violazione della
Convenzione sui diritti dei minori delle Nazioni Unite ratificata dal Belgio. Un
minore non dovrebbe mai essere separato dai propri genitori se non c'è pericolo
per la sua incolumità fisica o mentale. È una tortura inutile perché le indagini
avrebbero potuto procedere allo stesso modo con me agli arresti domiciliari. I
bambini sotto i tre anni possono stare con le loro madri, ma a me non è stato
permesso. Usare mia figlia per farmi pressione è stato un atto spietato e sono
riconoscente ad Amnesty International Italia per aver sollevato la questione.
Durante i nostri rari incontri, si nascondeva e piangeva per non lasciarmi. Ora
mi tiene la mano o mi mette le mani intorno al collo per dormire».
In merito al suo ritorno all’Europarlamento, Kaili
ha annunciato la volontà di «essere in aula già lunedì 12, ma devo avere
chiarimenti dai miei legali su come mi devo comportare».
Nemmeno se
fosse accusata di omicidio avrebbe senso una simile vergogna. Il caso Kaili una
vergogna per l’Europa: nessuna differenza tra questa indecenza e la tortura.
Gian Domenico Caiazza Il Riformista il 10 Giugno 2023
Un borsone pieno
di contanti in casa della vice-Presidente del Parlamento europeo legittima
certamente le più severe indagini a carico dell’on.Eva Kaili, e onera costei di
darne conto senza riserve e con la massima chiarezza alle istituzioni ed ai
propri elettori. Ma nei suoi confronti, come nei confronti di qualunque altro
cittadino europeo, restano fermi e non derogabili i princìpi di civiltà
giuridica che appartengono a tutti i sistemi democratici moderni.
Princìpi che
possiamo riassumere così: non si usa il carcere preventivo per ottenere
confessioni; è un’indecenza impedire a una bambina di due anni di vedere la
madre per mesi, se non per poche ore e per sovrappiù in carcere; è infatti del
tutto ovvio che nessun pregiudizio alle indagini potrebbe mai derivare dai
colloqui e dagli abbracci di una madre con la figlioletta di due anni. Non c’è
nessuna differenza tra questa indecenza, imposta per ottenere una confessione
che colmi i vuoti dell’indagine, ed una qualsivoglia altra forma di tortura.
Più in
generale, è onere dell’Accusa fornire la prova della colpevolezza della persona
indagata, e non esiste a carico di quest’ultima alcun dovere di collaborazione
con il Magistrato inquirente. Anche perché è del tutto plausibile – non so se
veritiera, ma certamente plausibile – la versione dei fatti fornita dalla
signora Kaili: chiedete a mio marito e al suo datore di lavoro, io nulla
so. Trovi la Procura elementi idonei a smentire l’attendibilità di questa
affermazione. Si prenda tutto il tempo che ritiene e che sarà necessario per
provare quella ipotesi di corruzione della quale, a molti mesi di distanza
dall’esordio di questa clamorosa inchiesta, non è dato rilevare nemmeno la più
labile traccia. Lo faccia senza riguardi per nessuno. Ma lo faccia rispettando
le basilari regole del vivere civile.
Qualcuno spieghi
a questo Magistrato belga che le persone indagate non son prede sulle quali
infierire. E soprattutto, non sono, in nessun momento, sue personali prede.
Qualcuno spieghi a questo signore che i provvedimenti giudiziari, tanto più se
restrittivi della libertà personale, vanno debitamente e credibilmente motivati,
sicché ancora aspettiamo di capire per quali ragioni, se non tecnicamente
estorsive, si è sottratta brutalmente e per molti mesi una madre ad una figlia
di due anni. Nemmeno se quella madre fosse accusata di omicidio avrebbe senso
una simile vergogna. Le responsabilità dell’on. Kaili dovranno essere accertate
e, se provate, adeguatamente punite. Quelle del Magistrato Michel Claise, però,
sono già chiarissime.
Gian Domenico
Caiazza
Eva Kaili, l'intervista: «Se avessi fatto
nomi importanti sarei tornata da mia figlia, ma avrei dovuto mentire». Giuseppe
Guastella su Il Corriere della Sera il 4 giugno 2023.
La giornalista e politica greca arrestata
nell'inchiesta Qatargate: «Le confessioni di Panzeri ottenute sotto minaccia, ma
non ha mai parlato di me. Io non sono tra le persone che lui ha coinvolto. Non
ho mai pensato di avvalermi della mia immunità parlamentare».
Sei mesi fa è stata arrestata in Belgio perché
accusata di far parte di un ipotetico sistema di corruzione al parlamento
europeo legato a Qatar e Marocco che faceva capo ad Antonio Panzeri. Nonostante
accuse estremamente vaghe e fumose che ancora oggi non spiegano come, quando e
con precisione perché avrebbe ricevuto le mazzette, tanto è vero che la
relazione finale della polizia belga del luglio 2022 dice che «non ci sono
elementi per dire che facesse parte dell’organizzazione», è stata 4 mesi in
cella e due ai domiciliari. L’arresto avvenne perché durante la retata del 9
dicembre chiese al padre di portare via da casa una valigia con dentro 700 mila
euro in contanti che, per i magistrati, erano i soldi incassati con il
marito Francesco Giorgi. La coppia sin da subito si è difesa dichiarando che
quei soldi erano dell’ex parlamentare europeo Antonio Panzeri. Kaili ha sempre
negato con forza ogni responsabilità. Da pochi giorni è libera.
Le domande sono state inviate ai legali di Eva
Kaili prima che il giudice Michel Claise le vietasse di rilasciare dichiarazioni
alla stampa con un provvedimento successivo alla revoca dei domiciliari e alla
rimessione in libertà e che apre molti dubbi.
Come si sente?
«Più forte. Apprezzo di più ogni momento con la
mia bambina, non riesco a smettere di guardarla».
Quali sono state le sue condizioni in carcere?
«Subito dopo l’arresto, al commissariato di
polizia sono stata messa in isolamento in una cella con luci e telecamera di
sorveglianza sempre accese, senza acqua corrente. Ho sofferto il freddo gelido
perché mi è stato tolto il cappotto. Ero preoccupata per la mia bambina, perché
i primi giorni non mi è stato permesso di chiamare un avvocato, né la mia
famiglia. Il carcere, però, non cambia ciò che siamo, è il modo in cui reagiamo
ciò che ci definisce. Il mio avvocato greco Michalis Dimitrakopoulos, mi ha
chiesto di parlare perché ho avuto la rara opportunità di assistere e osservare
come vengono trattate le persone in un commissariato in Belgio. Invece di
chiudere i centri penitenziari e ridurre l’uso della detenzione preventiva, si
stanno costruendo carceri più grandi e le vecchie carceri vertono in condizioni
disumane e sono sovraffollate. Pene più estreme non rendono una giustizia più
giusta».
Tanti soldi in contanti in casa sono difficili da
giustificare, ancora di più per un politico. Perché fece venire suo padre a
prenderli?
«Quando Francesco è stato arrestato e gli hanno
sequestrato l’auto, ho pensato ad un incidente stradale. Poi mi hanno mandato la
notizia che anche Panzeri era stato arrestato. Sono andata in panico. Sapevo che
nel suo ufficio che è nella stanza di sopra (l’appartamento è un bilocale su due
piani, ndr.), dove non vado mai, c’era una valigia di Panzeri e ho trovato un
sacco di soldi. Non riuscivo a capire cosa fosse successo, ma volevo allontanare
da casa quel denaro per ridarlo a Panzeri, colui che credevo ne fosse il
proprietario. Non ho pensato minimamente di avvalermi della mia immunità
parlamentare, e questo dimostra che non sapevo assolutamente ciò che quel denaro
rappresentava realmente».
Cosa sapeva?
«Che Panzeri riceveva donazioni. Data la sua
esperienza negli affari esteri e nei diritti umani, ha avuto contatti con
diverse persone di paesi terzi (non Ue, ndr) e attraverso la sua ong Figth
impunity promuoveva una causa nobile. Ci sono testimonianze documentate sulla
sua attività nel Parlamento e sulle persone che ha coinvolto. Io non sono tra
quelle. Le commissioni parlamentari di cui faccio parte e il mio lavoro
legislativo non hanno alcuna relazione con le sue attività. Anche i servizi
segreti confermano che non faccio parte di nessuna organizzazione criminale.
Nessuno può corrompermi. Dopo più di un anno di indagini i miei conti correnti e
le mie proprietà sono state controllate e sono risultate cristalline. Sulle
banconote trovate non ci sono le mie impronte digitali. Con i miei avvocati
dimostrerò la mia innocenza».
Cosa sapeva dei rapporti tra Panzeri e Giorgi?
«Capisco che ora tutto sembri sospetto, ma allora
non lo era. Panzeri è stato il datore di lavoro di Francesco e lo ha assunto
quando era solo uno studente di venti anni. Ha lavorato per lui come assistente
e traduttore personale e ha continuato ad aiutarlo anche dopo la fine del suo
mandato al Parlamento. Francesco aveva un senso di gratitudine e di obbligo
morale molto profondo nei suoi confronti».
Dopo essersi pentito, Panzeri ha dichiarato che a
lei erano destinati 250mila euro. Cosa ha da dire?
«Non ho ricevuto denaro. Penso che il pentimento
e le confessioni di Panzeri siano state ottenute sotto minaccia. Il messaggio
era chiaro: se fai i nomi, ti offriamo un accordo e liberiamo tua moglie e tua
figlia dalla prigione. Sono metodi non degni di uno stato di diritto. Hanno
fatto lo stesso con me. Dichiarandomi colpevole o facendo nomi importanti sarei
tornata subito da mia figlia, ma dato che avrei dovuto mentire, non ho mai
nemmeno pensato che potesse essere un’opzione. Durante il primo interrogatorio e
prima di pentirsi, Panzeri ha fatto i nomi di due membri del parlamento di
lingua italiana e non il mio e non parla di me neppure nelle intercettazioni
telefoniche. Il primo è stato arrestato, l’altra persona non ha avuto problemi,
mi chiedo ancora perché. Forse perché protetta da un’immunità speciale?»
Si sta riferendo ai deputato italo-belgi Marc
Tarabella e Maria Arena?
«I nomi sono negli atti».
Per gli investigatori la rete di Panzeri era
legata ai servizi segreti del Marocco e comprendeva l’ambasciatore di Rabat in
Polonia Atmoun .
«Non sono membro di nessuna commissione
parlamentare che poteva interessare Panzeri e Atmoun e non parlo le loro lingue.
Sapevo di una forte amicizia tra i due. Non avevo motivo di mettere in
discussione la relazione che li legava».
Ha incontrato due volte il ministro del lavoro del
Qatar, che gli inquirenti considerano un finanziatore della corruzione. Perché?
«Nel mio ruolo di vicepresidente responsabile
delle relazioni con i paesi del Medio Oriente ho incontrato diversi ambasciatori
e ministri, e avevo in programma delle visite ufficiali in tutti i paesi del
Golfo. Era una missione di diplomazia parlamentare fatta per conto della
presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. L'Ue considera il Qatar come
un partner fondamentale nella regione. È l'unico paese del Golfo ad aver
condannato l'invasione russa dell'Ucraina e la sua posizione geopolitica come
esportatore alternativo di Gnl verso la Russia lo rendono strategicamente
importante per gli Stati membri. Inoltre, l’Ilo (Organizzazione internazionale
del lavoro, ndr.) ha descritto il Qatar come leader nel mondo arabo nell’ambito
dei diritti dei lavoratori e ha deciso di aprire un ufficio nel paese, e l'Ue ha
recentemente aperto un'ambasciata in Qatar. In quel contesto ho incontrato due
volte il Ministro del Lavoro il quale, negli stessi giorni, ha incontrato i
Ministri degli Affari Esteri e del Lavoro del Belgio e altri colleghi
parlamentari».
Gli inquirenti fanno intendere che le indagini si
estenderanno, al momento non è accaduto.
«Credo che le aspettative create dai media fossero
alte e le fughe di notizie selettive e illegali sulla stampa hanno trasformato i
dibattiti televisivi mondiali in aule di tribunale. I giornalisti avevano le
informazioni prima dei miei avvocati, il che ha portato a speculazioni estreme.
Dopo tutti questi mesi non è venuto fuori nulla di nuovo. Il Parlamento ha
protezioni che nessun lobbista può abbattere. Tuttavia, c'è una cosa inquietante
che vorrei sollevare. Dal fascicolo giudiziario i miei avvocati hanno scoperto
che i servizi segreti belgi avrebbero messo sotto osservazione le attività dei
membri della commissione speciale Pegasus (Indaga sulle intercettazioni di
leader europei fatte illegalmente dal Marocco, ndr.). Il fatto che i membri
eletti del Parlamento siano spiati dai servizi segreti dovrebbe sollevare
maggiori preoccupazioni sullo stato di salute della nostra democrazia europea.
Penso sia questo il vero scandalo».
Metsola le ha subito revocato la vice presidenza e
pochi hanno parlato in suo favore. Delusa?
«È triste vedere come non venga rispettata la
presunzione di innocenza. Mi dispiace che nessuno degli eurodeputati mi abbia
cercato per ascoltare la mia versione. Ho apprezzato la posizione di
Massimiliano Smeriglio (Sd) e sono molto riconoscente a Deborah Bergamini (Pdl),
la deputata italiana più coraggiosa che ha osato venirmi a trovare in prigione e
ha denunciato i metodi inumani usati contro di me».
Ha potuto incontrare sua figlia in carcere solo a
gennaio, un mese dopo l’arresto. Il suo avvocato ha detto che è stata una
tortura.
«È stato terribile. Separare una madre per 4 mesi
dalla figlia di 2 anni non solo è considerata una forma di tortura nei paesi
fondati sullo stato di diritto, ma è in piena violazione della Convenzione sui
diritti dei minori delle Nazioni Unite ratificata dal Belgio. Un minore non
dovrebbe mai essere separato dai propri genitori se non c'è pericolo per la sua
incolumità fisica o mentale. È una tortura inutile perché le indagini avrebbero
potuto procedere allo stesso modo con me agli arresti domiciliari. I bambini
sotto i tre anni possono stare con le loro madri, ma a me non è stato permesso
(ha potuto incontrarla la prima volta dopo un mese ndr.). Usare mia figlia per
farmi pressione è stato un atto spietato e sono riconoscente ad Amnesty
International Italia per aver sollevato la questione. Durante i nostri rari
incontri, si nascondeva e piangeva per non lasciarmi. Ora mi tiene la mano o mi
mette le mani intorno al collo per dormire».
Chi l’ha sostenuta?
«Coloro che mi conoscono e gli amici di sempre, ma
anche persone che non conosco. Sono una giornalista e so che quando c'è una
tempesta mediatica contro di te, devi stare fermo e aspettare che passi per
parlare.
Tornerà al parlamento? Quando?
«Vorrei essere in aula già lunedì 12, ma devo
avere chiarimenti dai miei legali su come mi devo comportare».
E con Francesco Giorgi come va?
«Lo scopriremo con il tempo. È un ottimo padre per
mia figlia».
Tu parla, e puoi vedere tua figlia. Eva
Kaili vittima del metodo Mani Pulite, la doppia faccia di Bruxelles: denuncia
violazione diritti ma dimentica quelli dell’imputato.
Benedetta Frucci su Il Riformista il 6 Giugno 2023
Diversi anni fa venni a conoscenza di una storia
da brividi: una donna, ai tempi di Mani Pulite, venne arrestata e collocata in
una cella con una sieropositiva. Lo scopo? Farle confessare i presunti crimini
del suo compagno, politico di spicco. Leggendo le parole di denuncia di Eva
Kailī, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, non può non venire in
mente quella stagione: la stagione della carcerazione preventiva utilizzata come
leva per far confessare i crimini.
Tu parla, e ti libero. Tu parla, e puoi vedere tua
figlia. Tu parla, e come te l’ho tolta, ti ridò un briciolo di dignità. È
il metodo Mani Pulite, ma anche quello seguito ancora oggi da alcuni magistrati
in spregio a qualunque garanzia costituzionale e che dimostra come una riforma
della carcerazione preventiva sia più che mai urgente. Un metodo che, a quanto
pare, la procura belga ha esportato e copiato con successo.
Una donna, abituata a una vita agiata, viene
privata della dignità, lasciata al freddo e senza acqua corrente, minacciata
utilizzando la figlia. Questa è la storia di Eva Kailī, di cui non deve
interessare se sia colpevole o innocente. Quello che dovrebbe interessare è che
nel cuore dell’Europa, vi è stata una violazione dei diritti umani.
Già, perché tutti coloro che a Bruxelles sono
prontissimi a denunciare violazioni di diritti, si scordano troppo spesso che a
quel novero appartengono anche i diritti dell’imputato. Quei diritti che sono
stati ignorati dal Belgio in modo sistematico. La denuncia di Kailī non si
limita infatti al tema della detenzione: l’aspetto più inquietante della sua
denuncia è quello che riguarda i servizi segreti, che avrebbero intercettato
illegalmente dei parlamentari. E qui, anche a Roma potrebbero fischiare le
orecchie… Benedetta Frucci
"Nessuno degli eurodeputati mi ha
cercato". Eva Kaili e la bolla Qatargate: “Eurodeputati spiati da servizi
segreti e minacciati da pm: Panzeri ha fatto nome di un protetto”.
Redazione su Il Riformista il 5 Giugno 2023
“Eurodeputati spiati dai servizi segreti belgi,
questo è il vero scandalo”. A denunciarlo, in una intervista esclusiva
al Corriere della Sera, è Eva Kaili l’ex vicepresidente
del Parlamento europeo arrestata nell’ambito
dell’inchiesta Qatargate–Maroccogate, ai domiciliari da inizio aprile dopo oltre
quattro mesi di carcere e rilasciata una decina di giorni fa “sotto condizioni”
con la procura belga che non ha specificato quali siano le prescrizioni.
Madre di una bambina di due anni che ha potuto
vedere appena due volte al mese nell’arco degli oltre 120 giorni di carcere,
Kaili, che si è sempre professata innocente. Nell’intervista, rilasciata prima
che il giudice Michel Claise le vietasse di parlare con la stampa, Kaili lancia
accuse durissime. Venne arrestata in Belgio sei mesi fa, a inizio dicembre 2022,
perché accusata di far parte di un ipotetico sistema di corruzione al parlamento
europeo legato a Qatar e Marocco che faceva capo ad Antonio Panzeri. L’arresto
avvenne perché durante la retata del 9 dicembre chiese al padre di portare via
da casa una valigia con dentro 700 mila euro in contanti che, per i magistrati,
erano i soldi incassati con il compagno Francesco Giorgi. La coppia sin da
subito si è difesa dichiarando che quei soldi erano dell’ex parlamentare europeo
Antonio Panzeri.
Rilasciata perché “dopo tutti questi mesi non è
venuto fuori nulla di nuovo. Il Parlamento ha protezioni che nessun lobbista può
abbattere“, dice l’europarlamentare, sottolineando che c’è però “una cosa
inquietante che vorrei sollevare”, ovvero che “dal fascicolo giudiziario i miei
avvocati hanno scoperto che i servizi segreti belgi avrebbero messo sotto
osservazione le attività dei membri della commissione speciale Pegasus (Indaga
sulle intercettazioni di leader europei fatte illegalmente dal Marocco, ndr.).
Il fatto che i membri eletti del Parlamento siano spiati dai servizi segreti
dovrebbe sollevare maggiori preoccupazioni sullo stato di salute della nostra
democrazia europea. Penso sia questo il vero scandalo”.
Kaili torna poi sull’inchiesta che, settimana dopo
settimana, ha evidenziato le mancanza di prove raccolte dalla procura belga: “Se
avessi fatto nomi importanti sarei tornata da mia figlia, ma avrei dovuto
mentire“. “Quando Francesco (Giorgi, ndr) è stato arrestato e gli hanno
sequestrato l’auto, ho pensato ad un incidente stradale. Poi mi hanno mandato la
notizia che anche Panzeri era stato arrestato. Sono andata in panico. Sapevo che
nel suo ufficio che è nella stanza di sopra, dove non vado mai, c’era una
valigia di Panzeri e ho trovato un sacco di soldi. Non riuscivo a capire cosa
fosse successo, ma volevo allontanare da casa quel denaro per ridarlo a Panzeri,
colui che credevo ne fosse il proprietario”.
Kaili dice di sapere “che Panzeri riceveva
donazioni” ma “le commissioni parlamentari di cui faccio parte e il mio lavoro
legislativo non hanno alcuna relazione con le sue attività”. Quanto ai rapporti
tra Panzeri e Giorgi, “Panzeri è stato il datore di lavoro di Francesco e lo ha
assunto quando era solo uno studente di venti anni” e “Francesco aveva un senso
di gratitudine e di obbligo morale molto profondo nei suoi confronti”.
Sulle dichiarazioni e le accuse di Panzeri
(secondo cui all’eurodeputata greca spettavano 250mila euro), Kaili sottolinea
convinta:”Penso che il pentimento e le confessioni di Panzeri siano state
ottenute sotto minaccia. Il messaggio era chiaro: se fai i nomi, ti offriamo un
accordo e liberiamo tua moglie e tua figlia dalla prigione. Sono metodi non
degni di uno stato di diritto. Hanno fatto lo stesso con me. Dichiarandomi
colpevole o facendo nomi importanti sarei tornata subito da mia figlia, ma dato
che avrei dovuto mentire, non ho mai nemmeno pensato che potesse essere
un’opzione”.
Kaili poi rivela che uno dei due “nomi” fatti da
Panzeri “non ha avuto problemi”, ovvero non è stato coinvolto nello scandalo
Qatargate. “Durante il primo interrogatorio e prima di pentirsi, Panzeri ha
fatto i nomi di due membri del parlamento di lingua italiana e non il mio e non
parla di me neppure nelle intercettazioni telefoniche. Il primo è stato
arrestato, l’altra persona non ha avuto problemi, mi chiedo ancora perché. Forse
perché protetta da un’immunità speciale?“.
In questi mesi Kaili è stata isolata dai colleghi
all’Europarlamento. Nessuna telefonata, nessun messaggio di solidarietà, tranne
qualche rara eccezione. “È triste vedere come non venga rispettata la
presunzione di innocenza. Mi dispiace che nessuno degli eurodeputati mi abbia
cercato per ascoltare la mia versione. Ho apprezzato la posizione
di Massimiliano Smeriglio (Sd) e sono molto riconoscente a Deborah Bergamini
(Pdl), la deputata italiana più coraggiosa che ha osato venirmi a trovare in
prigione e ha denunciato i metodi inumani usati contro di me”.
Lo scandalo Qatargate. Se la figlia di
Eva Kaili un giorno rileggerà i giornali italiani…Magari
potrà guardare il video dell’intervista resa dal magistrato che la teneva
lontano dalla madre, che si ritiene in diritto di parlare in faccia a una
telecamera, mentre ingiunge all'eurodeputata di tenere la bocca chiusa. Iuri
Maria Prado su L'Unità il 6 Giugno 2023
Confesso di non sapere come la stampa belga abbia
trattato il cosiddetto Qatargate e in particolare la vicenda giudiziaria di Eva
Kaili. Nel Paese che organizzò la tratta dei minatori italiani, messi a vivere
come bestie nelle baracche ai margini dei pozzi in cui crepavano a centinaia,
sorvegliato da una giustizia che intervenne con qualche spicciolo risarcitorio,
il lavoro giudiziario sulla carne di una parlamentare accusata non si capisce di
che cosa potrebbe anche essere considerato come la riprova di uno zelo
inquisitorio finalmente ripristinato.
E chissà, nel Paese più compromesso al mondo
nell’abuso dell’infanzia e nell’assicurazione del regime di indefettibile
impunità che lo presidia, chissà che impressione avrà fatto lassù l’immagine di
una bambina di ventidue mesi mano nella mano del nonno, nella pioggia, minuscola
e fasciata di un piumino rosa mentre copre di piccoli passi incerti il lastrico
di quel cortile, lo squallore grigio su cui incombe la prigione in cui è
rinchiusa la mamma. Chissà.
Ma sappiamo com’è stato trattato qui da noi il
caso di quella giustizia aguzzina. Ultra-attiva e di inenarrabile sfrontatezza
nel provvedimento che vieta a Eva Kaili di rendere dichiarazioni alla stampa –
una misura solo più tenue ma identica in ratio e ignominia alla mordacchia
imposta al bestemmiatore – qui da noi la sopraffazione giudiziaria inflitta a
quella donna ha goduto per un verso dell’attenzione della destra in orgasmo per
una Mani Pulite europea che scoperchiava il paiolo della malversazione
progressista, e per altro verso ha trovato riscontro nella remissività vigliacca
di una controparte che arrivava all’affronto di dirsi “parte lesa”: lesa non da
quella pubblica macellazione dei diritti degli indagati, ma dallo spiacevole e
tuttavia confinato scandalo provvidenzialmente affidato a una giustizia cui si
giura fedeltà collaborazionista.
Non erano importanti le implorazioni di quella
madre, cui si impediva per settimane di vedere la propria figlia neppure di due
anni: era importante, su un fronte, riempire pagine con le fotografie delle
borse piene di soldi a dimostrazione che la sinistra è sporcacciona; ed era
importante, sull’altro fronte, produrre le prove della specchiatezza
progressista ingiustamente messa in dubbio dalla propaganda che strumentalmente
indugiava su poche mele marce.
Un torbido e gravissimo attentato all’effettività
del potere rappresentativo comunitario, che si consumava nel sacrificio
spettacolare dei diritti dei suoi esponenti e che ora si reitera
nell’intimazione al silenzio rivolta a una signora che la giustizia si è
costretta a liberare, era elevato al rango del mirabile repulisti che
restituisce onore, via servizi segreti, a quell’istituzione assediata
dall’affarismo corruttore. Questo si è fatto qui da noi. Con sparute eccezioni,
certo: ma così, qui da noi, abbiamo seguito e rappresentato quella vicenda.
Cresciuta, quella bambina potrà darsi a una
rassegna stampa degli editoriali quaggiù incarogniti sulla madre malandrina
beccata con tutti quei soldi, che se l’hanno messa in galera qualcosa avrà pur
fatto; potrà apprezzare gli sconsolati commenti a braccia allargate perché
quella povera figlia non aveva colpe, ma la giustizia doveva pur fare il suo
corso. E magari potrà guardare il video dell’intervista resa dal magistrato che
la teneva lontano dalla madre, il magistrato che si ritiene in diritto di
parlare abbondantemente, in faccia a una telecamera, mentre ingiunge a Eva
Kaili di tenere la bocca chiusa. Iuri Maria Prado 6 Giugno 2023
INCHIESTA L’ESPRESSO / ICIJ. Ericsson, le
tangenti pagate dal colosso in tutto il mondo hanno una regia made in Italy. Paolo
Biondani su L'Espresso il 6 Giugno 2023
La multinazionale patteggia una super multa da 1,2
miliardi di dollari confessando alle autorità americane decine di corruzioni
dall’Africa alla Cina, dall’Indonesia all’Iraq. La sentenza finale spiega che lo
schema corruttivo fu architettato da due manager italiani
Due manager della Ericsson, nel 2011, si scambiano
una serie di email riservatissime. I messaggi descrivono «un sofisticato sistema
di corruzione» da applicare in Africa, ma sono scritti in italiano.
Nel 2019 la multinazionale delle telecomunicazioni
viene incriminata dalle autorità americane, che la accusano di aver pagato
tangenti in diverse nazioni, dall'Egitto all'Indonesia, dal Kuwait alla Cina,
per più di quindici anni. Lo scandalo spinge i vertici svedesi del gruppo a
negoziare un patteggiamento costosissimo: una multa da un miliardo di euro, con
l'obbligo di collaborare pienamente con la giustizia e denunciare tutti gli
illeciti. Le email italiane però non vengono consegnate ai procuratori
statunitensi. Vengono nascoste in un deposito sotterraneo di Stoccolma, in uno
scatolone sigillato, con altre carte e archivi informatici da tenere segreti.
Quei messaggi italiani sulla corruzione in Africa
restano chiusi a chiave negli scantinati della Ericsson per più di dieci anni. A
rivelarne l'esistenza, nel febbraio 2022, è un'inchiesta giornalistica
internazionale coordinata dal consorzio Icij, rappresentato in Italia da
L'Espresso. Pochi giorni dopo, il Dipartimento di giustizia americano annuncia
che la Ericsson è di nuovo sotto inchiesta, con l'accusa di aver violato
l'accordo di patteggiamento.
I documenti portati alla luce dal consorzio
internazionale dei giornalisti investigativi mostrano che il colosso svedese
aveva tenuto nascosti molti altri casi di corruzione su scala mondiale, che
riguardano almeno 14 nazioni mai nominate prima. L'accusa più grave è di aver
pagato tangenti in Iraq, nel 2014, a presunti tesorieri e perfino a combattenti
dell'Isis, come risulta dalle indagini interne della stessa multinazionale,
riemerse dai magazzini aziendali insieme alle mail italiane.
Ora la nuova istruttoria ha convinto la Ericsson a
chiedere un nuovo patteggiamento, approvato nel marzo scorso dai giudici
americani. La multinazionale ha accettato di pagare altri 206 milioni di
dollari, che portano il totale dei risarcimenti a oltre un miliardo e 270
milioni: è la cifra più alta mai versata nel mondo per chiudere un processo per
tangenti.
Nelle motivazioni della sentenza la portata delle
accuse viene riassunta elencando una mezza dozzina di «omesse denunce di
corruzioni». Il primo caso riguarda proprio le email italiane. I due manager
della Ericsson descrivono uno schema corruttivo architettato per corrompere un
ministro di Gibuti, un piccolo e poverissimo Stato africano, che la
multinazionale occidentale considerava strategico nello scontro globale contro
il colosso cinese Huawei per le tecnologie del 5G. I messaggi precisano che le
tangenti, per oltre due milioni di dollari, vengono pagate a finte società di
consulenze, in realtà controllate dalla moglie del ministro. «Lui in persona!»,
sottolinea un manager all'altro, che risponde: «Ok, ho capito». La vicenda di
Gibuti è considerata grave perché lo stesso schema corruttivo («bribing scheme»)
è stato poi applicato e replicato in altre nazioni. Per questo fu tenuto
nascosto. La sentenza non fa i nomi dei manager, indicati solo «dipendente 1» e
«3», ma precisa che tra loro parlano e si scrivono in italiano e che all'epoca
erano «alti dirigenti della Ericsson per l'Africa».
I nuovi casi di corruzione sono stati denunciati e
comprovati negli ultimi mesi dalla stessa azienda svedese. Ma la sentenza di
patteggiamento contesta alla multinazionale di averli segnalati alle autorità
americane soltanto «dopo essere stata interpellata da un consorzio di
giornalisti».
L'amministratore delegato della Ericsson, Börje
Ekholm, ha dichiarato che il nuovo patteggiamento «significa che il problema
delle violazioni ora è risolto»: «Oggi l'azienda è molto diversa e continuerà a
collaborare con la giustizia in tutto il mondo».
Estratto dell’articolo di Giuseppe Guastella
per “il Corriere della Sera” il 20 giugno 2023.
Il colpo di scena arriva in serata e scuote
l’inchiesta sulle presunte corruzioni al Parlamento europeo: il giudice Michel
Claise lascia le indagini dopo che sono emersi «di recente alcuni elementi» che
«potrebbero sollevare alcune domande sul funzionamento oggettivo dell’indagine»,
recita uno scarno comunicato della Procura federale di Bruxelles.
Secondo alcune fonti, la decisione è legata al
fatto che uno dei figli del giudice sarebbe socio in un’azienda (che
commercializza cannabis legale) del figlio di Maria Arena, la parlamentare
italo-belga che è coinvolta nelle indagini. Nel pomeriggio di ieri il giudice
Claise aveva interrogato per quattro ore l’europarlamentare italiano Andrea
Cozzolino che, al termine, è stato trattenuto in un commissariato di polizia in
arresto in vista di un nuovo interrogatorio previsto per oggi.
Protagonista indiscusso dell’inchiesta che ha
scosso la massima istituzione rappresentativa continentale con gli arresti del 9
dicembre 2022, Claise ha condotto le indagini da quando la Procura federale
nell’estate scorsa gli ha trasmesso una relazione basata su atti dei servizi
segreti su una presunta «rete» di complicità per favorire gli interessi del
Marocco e del Qatar in seno al parlamento europeo a suon di mazzette.
Questa organizzazione criminale ruotava,
principalmente, intorno all’ex eurodeputato del Pd e poi di Articolo 1 (fino al
2019) Antonio Panzeri e al suo allora assistente Francesco Giorgi, marito della
allora vice presidente dell’assemblea Eva Kaili, ad Andrea Cozzolino, attuale
parlamentare europeo del Pd (sospeso) e ad altre persone.
[…] Dal 9 dicembre le indagini sembrano ancora
muoversi su accuse non proprio consistenti che appaiano mancare ancora di
elementi oggettivi sulle responsabilità esatte dei singoli indagati. Le
dimissioni di Claise per un possibile conflitto di interessi, afferma la
Procura, sono una «misura precauzionale per fine di consentire alla giustizia di
continuare il suo lavoro in serenità e mantenere una necessaria separazione tra
vita privata e familiare e responsabilità professionali».
La decisione è arrivata «nonostante l’assenza di
elementi effettivi che potrebbero mettere in dubbio la probità di qualsiasi
soggetto e il conseguente lavoro che lui e gli investigatori hanno svolto in
questo caso». Maria Arena, molto legata a Panzeri, per gli inquirenti farebbe
parte integrante della rete pro Marocco e Qatar tessuta da Panzeri.
Le indagini vanno ad «un altro giudice istruttore
che è già intervenuto più volte in precedenza nel fascicolo», spiegano i pm. Ai
domiciliari per più di due mesi a Napoli su mandato di arresto europeo emesso da
Claise, Cozzolino aveva avuto la revoca della misura per presentarsi a
Bruxelles. […]
(ANSA il 21 giugno 2023) - L'eurodeputato Andrea
Cozzolino, indagato nell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, è stato rilasciato.
Accompagnato dai suoi legali, il politico ha lasciato la sede della procura
federale a Bruxelles dopo un interrogatorio di cinque ore con il nuovo giudice
istruttore Aurélie Dejaiffe.
"Ha risposto a tutte le domande, negando ogni
addebito", ha spiegato il suo difensore, Federico Conte, precisando che
l'eurodeputato, al pari di altri indagati rilasciati nelle settimane scorse,
dovrà rispettare alcune prescrizioni, tra cui l'obbligo di restare a
disposizione delle autorità e di comunicare l'eventuale intenzione di lasciare
il Belgio.
Cozzolino era stato raggiunto lo scorso 10
febbraio, mentre si trovava a Napoli, da un mandato d'arresto europeo spiccato
dal giudice istruttore Michel Claise. Da quel momento l'eurodeputato, sospeso
dal Pd, ha trascorso oltre quattro mesi in detenzione preventiva nella sua
abitazione campana.
Lunedì, dopo la revoca dei domiciliari, si era
recato a Bruxelles per essere ascoltato dagli inquirenti, che lo avevano posto
in stato di fermo. Al termine dell'ultimo interrogatorio, il nuovo giudice
istruttore Aurélie Dejaiffe - subentrata ieri a Claise alla guida delle indagini
- ne ha disposto il rilascio. All'uscita dai locali della procura federale
belga, l'eurodeputato, visibilmente commosso, ha preferito non rilasciare
dichiarazioni.
Cozzolino, ha evidenziato il legale che lo
accompagnava, "si è difeso da tutti addebiti, contestandoli puntualmente punto
per punto, negando di aver ricevuto soldi e di aver mai fatto parte di
un'associazione criminale". Tra le altre prescrizioni previste nel provvedimento
di rilascio, vi è anche l'obbligo di non avere contatti con le altre persone
indagate.
Estratto dell’articolo di Giuseppe Guastella per
il “Corriere della Sera” il 21 giugno 2023.
Il nome «Arena Maria» è stampato, ben chiaro ed in
evidenza, sulla prima pagina della relazione consegnata il 15 luglio 2022 dalla
polizia giudiziaria alla magistratura belga che lo inserisce tra i personaggi
che avrebbero tramato per condizionare a suon di mazzette l’attività del
Parlamento europeo a favore di Marocco e Qatar.
[…] il coriaceo giudice Michel Claise, celebrato
in patria come integerrimo paladino dell’anticorruzione, non si è sentito in
dovere di astenersi immediatamente dall’inchiesta visto che il figlio della
Arena è socio di suo figlio in un’azienda che commercializza derivati dalla
cannabis di libera vendita.
Lo ha fatto solo lunedì, quando il bubbone è
scoppiato ed ormai era troppo tardi per evitare un colpo durissimo alla già
compromessa credibilità dell’inchiesta. Convinti che Arena sia stata fino ad ora
risparmiata dalle indagini, gli avvocati di Eva Kaili chiedono ora che la
Procura accerti «se ci sono state omissioni deliberate in relazione» e sollevano
dubbi sulla imparzialità di Claise.
La lettera
Ci ha pensato Maxim Toeller, difensore
dell’eurodeputato italo-belga Marc Tarabella, a «ricordare» al giudice che lo ha
tenuto mesi in galera il suo rapporto di sponda filiale con la Arena. Lunedì
pomeriggio gli ha fatto recapitare una lettera in cui evidenziava il conflitto
di interessi dopo che aveva scoperto che Nicolas Claise, figlio trentaduenne del
giudice, è socio del coetaneo Ugo Lemaire, che è figlio di Maria Arena.
Qualche ora dopo, la Procura ha comunicato che
Claise aveva lasciato l’inchiesta […]. Da ieri il nuovo giudice istruttore è
Aurélie Dejaiffe. Nata per volontà dei servizi segreti, concentratasi su
personaggi italiani o collegati all’Italia, dopo sette mesi l’indagine ancora
non va oltre i contanti trovati (1,6 milioni) senza essere in grado di dire
quali siano le esatte responsabilità delle persone finite in carcere ma
limitandosi ad accuse generiche di corruzione, associazione a delinquere e
riciclaggio.
[…] Nonostante la polizia scriva che non «è
possibile dire» che Kaili facesse parte della rete criminale di Panzeri, la ex
giornalista si è fatta sei mesi tra carcere e domiciliari. Battono su questa
differenza di trattamento con Arena i suoi legali, gli avvocati Sven Mary e
Michalis Dimitrakopoulos.
«Ci siamo chiesti perché Maria Arena non sia stata
mai interrogata da Claise», dicono, e ora che arriva la «sorpresa sconcertante»
vogliono sapere perché le indagini su Arena «non sono mai cominciate», cosa che
solleva dubbi «enormi ed ovvie domande sull’imparzialità» degli atti che hanno
portato all’arresto di Kaili, e concludono invitando Claise a chiarire i legali
tra suo figlio e quello della Arena, chiedendo addirittura una indagine della
Procura.
«Insabbiamento» C’era qualcuno che sapeva del
conflitto di interessi di Claise tra chi lavora al Qatargate. A dirlo è Toeller
che punta il dito contro «un poliziotto» che lavora alle indagini e che avrebbe
«insabbiato» l’informazione evitando di girarla alla Procura. «Chiederemo il suo
allontanamento», annuncia l’avvocato che ora ha gioco facile ad attaccare
l’intera indagine sollevando interrogativi «sulla sua attendibilità», a partire
dalle rivelazioni fatte da Antonio Panzeri dopo che si è pentito in cambio di un
solo anno di carcere di cui più della metà già scontato ai domiciliari. Per il
legale non sono assolutamente credibili perché sono «la parola corrotta di un
uomo corrotto».
Un (altro) giudice a Bruxelles. Il
mistero buffo del Qatargate e un processo che rischia di diventare farsa.
Mario Lavia su L'Inkiesta il 22 Giugno 2023
Ci sono molti aspetti che non tornano in sette
mesi di indagini sulle attività di alcuni eurodeputati. La decisione di cambiare
in corsa il grande inquisitore per un presunto conflitto di interessi pone più
di un dubbio sui metodi poco ortodossi utilizzati dagli inquirenti
Qualcuno prima o poi spiegherà perché Andrea
Cozzolino, eurodeputato del Partito democratico, è stato agli arresti
domiciliari per quattro mesi? I magistrati di solito rispondono: succede,
serviva alle indagini. Ma se dopo quattro mesi e un interrogatorio lunghissimo
svolto da un giudice diverso da quello che ha iniziato l’azione penale (che nel
frattempo se n’è andato), quell’europarlamentare viene rilasciato gli si chiede
scusa? Ed è una coincidenza che l’arrivo di una nuova inquirente abbia portato
al rilascio dell’onorevole Cozzolino, che beninteso resta indagato
nell’inchiesta sui presunti scandali di Bruxelles e che continua a proclamarsi
estraneo ai fatti? Non si può escludere che abbia collaborato, il che farebbe
anche sorgere il dubbio che la carcerazione sia servita per ottenere elementi
nuovi.
Vedremo che cosa succederà, ma già adesso ce n’è
abbastanza per dire che almeno sin qui è stato causato un danno enorme,
personale e politico, a lui e al suo partito che lo ha sospeso diversamente da
quello che ha disposto il gruppo del socialismo europeo che lo ha
espulso. Quello di ieri è l’ultima puntata di una vicenda che da tragica rischia
di diventare farsesca, con una giustizia da cui ora – si apprende – trapelano
elementi che «potrebbero sollevare alcune domande sul funzionamento oggettivo
dell’indagine», come ha scritto Iuri Maria Prado sull’Unità.
È un fatto che tutti coloro che erano stati
arrestati dopo l’esplosione del cosiddetto Qatargate sono stati rilasciati, a
cominciare dalla ex vicepresidente Eva Kaili che si è fatta quattro mesi di
carcere e due di domiciliari.
Le indagini iniziate nel dicembre del 2022 come
detto stanno proseguendo ora con un’altra giudice, Aurélie Dejaiffe, dopo che
Michael Claise, il grande inquisitore, aveva deciso qualche giorno fa di
lasciare la guida dell’inchiesta «in via cautelare e per consentire alla
giustizia di continuare serenamente il suo lavoro e di mantenere una necessaria
separazione tra vita privata e familiare e responsabilità professionali», come
aveva scritto la procura in una nota evidenziando che nel dossier «di recente
sono comparsi alcuni elementi» che «potrebbero sollevare alcune domande sul
funzionamento oggettivo dell’indagine».
La decisione del giudice Claise sarebbe legata al
fatto che, secondo fonti qualificate riportate dall’Ansa, uno dei suoi figli
avrebbe lavorato per una delle persone indagate. Un possibile conflitto
d’interessi. A sette mesi dallo scoppio dello scandalo dunque siamo se non
davanti a un punto morto certamente davanti a una possibile ripartenza o forse a
uno sgonfiamento di un caso che ha sputtanato molte persone, diversi partiti,
soprattutto l’istituzione europea. I metodi sono stati spesso al di fuori dei
binari che la legislazione italiana ha fissato nel nome di una certa cultura
garantista.
Gli avvocati di Cozzolino, Federico Conte e Dezio
Ferraro, in passato hanno parlato di «uno scenario sempre più opaco dietro il
quale si sta giocando una partita di politica estera sul ruolo delle istituzioni
europee parallela e sotterranea, e sul cui sfondo continua ad aleggiare l’azione
dei servizi segreti, che ci fa fondatamente dubitare che il sistema giudiziario
belga possa garantire a Cozzolino un giusto processo». Quanto alle condizioni
carcerarie denunciate da Kaili c’è un solo termine: disumane.
Probabilmente dunque siamo fuori dalle regole
europee dello stato di diritto, quello stato di diritto che bisogna difendere.
In Italia e in Europa. Ci vorrebbe un monsieur Nordio a Bruxelles.
Cosa scriveranno i giornali? Qatargate,
emergono elementi che sollevano dubbi sull’inchiesta.
Il giudice si è dimesso e dopo sei mesi di giustizia piombata, trapelano
elementi che “potrebbero sollevare domande sul funzionamento indagine”. Iuri
Maria Prado su L'Unità il 21 Giugno 2023
Il 10 dicembre 2022, erette in prima pagina e
poste a sostegno di titoloni strepitosi, le colonne della stampa quotidiana –
pressoché tutta – si dedicavano alla descrizione della “tangentopoli europea”,
lo scandalo dei borsoni pieni di soldi che il giorno prima portava in galera un
manipolo di corruttori accertati per decreto editoriale.
Il fatto che la detenzione di una valigia di
denaro meriti chiarimenti, ma non provi di per sé proprio nulla, non turbava le
sicurezze dei confezionatori di quelle prime pagine, che anche nei giorni
successivi ci davano dentro con identico tono senza nessuna perplessità. E
nessuno, tra quei romanzieri della Mani Pulite comunitaria, era toccato dal
sospetto che ad attentare al potere rappresentativo europeo potesse esserci,
accanto all’eventuale responsabilità – tutta da provare – degli indagati per
corruzione, il doppio insulto rispettivamente costituito da un’indagine
prepotente e dalla remissività, se non complicità, del potere politico che vi
assisteva.
E a nessuno, nei ranghi di quella claque, veniva
da obiettare che di “democrazia europea sotto attacco” forse valeva la pena di
discutere pensando meno ai “malvagi” delle presunte mazzette e piuttosto
al collaborazionismo parlamentare che spogliava di cariche e prerogative i
propri rappresentanti, compiacendosi di vederli affidati alla giustizia che li
sbatteva in galera non solo prima del processo, ma in base a imputazioni tanto
misteriose quanto le indagini che, via servizi segreti, le avevano preparate.
Non andava meglio sui contrapposti fronti degli
schieramenti politici, ovviamente. Da un lato i noti garantisti di destra, in
orgasmo per la riprova esemplare della sporcaccioneria della controparte, anche
più meritevole di sanzione preventiva perché svendeva i diritti delle persone
trafficando con le autocrazie mediorientali (cosa intollerabile per una parte
politica risaputamente sensibilissima – “prima gli italiani” – alla violazione
dei diritti umani nel mondo, e costituzionalmente avversa ai regimi che se ne
rendono responsabili).
Dall’altro lato, i serissimi ruminatori di
compostezza di una sinistra complessivamente attestata in difesa, sulla linea
onorevole e fiera della giustizia che deve fare il suo corso, del lavoro della
magistratura che va rispettato e dell’onestà di partito che mai e poi mai può
essere messa in dubbio per la presenza di qualche mariuolo da sacrificare senza
cedimenti al deplorevole impunitismo tanto caro agli amici dei corrotti.
Tra l’arresto di Panzeri, della moglie e della
figlia, dunque di Eva Kaili e del compagno (la figlia no, troppo piccola: quella
si limitavano a tenerla lontana dalla madre) e la notizia, ieri, relativa
all’abbandono delle indagini da parte del giudice che sinora le aveva condotte,
sono stati sei mesi di giustizia piombata, una giustizia inquisitoria che
ripagava in pena ridotta le confessioni fatte e puniva quelle mancate con
la protrazione della custodia cautelare. Una giustizia da cui ora – si apprende
– trapelano elementi che “potrebbero sollevare alcune domande sul funzionamento
oggettivo dell’indagine”.
Non sappiamo se tra queste domande ci sia quella
semplice e noiosa, il quesito da garantisti pelosi riguardante la sproporzione
tra la gravità dei provvedimenti che si sono abbattuti
sulla vita, sulla libertà e sulla carriera degli indagati e la persistente
vacuità delle prove poste a sostegno di un’accusa di cui si sa poco o nulla non
perché se ne tenevano riservati i contenuti, ma perché poco o nulla aveva messo
insieme. Si sa, appunto, che il magistrato che ne aveva la titolarità ora ha
mollato il dossier, non senza il colpo di coda dell’ultimo arresto. E chissà se
i dubbi sul “funzionamento oggettivo dell’indagine” lambiscono il provvedimento
con cui il magistrato che si sarebbe dimesso di lì a poco ingiungeva a Eva
Kaili, una volta scarcerata, di non parlare con i giornali.
Chissà se questi, i giornali, orienteranno ora in
maniera un po’ più sorvegliata e civile le proprie titolazioni. Chissà se quelli
che li scrivono e li dirigono faranno i giornalisti anziché gli assistenti della
giustizia che per settimane impedisce a una madre di vedere la figlia di meno di
due anni, e che in sei mesi gliela fa vedere due volte, e che quando finalmente
la scarcera, perché quella non confessa, le ordina di stare zitta altrimenti
sono guai. Iuri Maria Prado 21 Giugno 2023
Così il pm mediatico Claise ha perso la
scena della ribalta. Il magistrato lascia l’inchiesta
sul Qatargate: svelato il rapporto tra il figlio e la parlamentare Arena, mai
indagata ma spesso evocata nelle indagini. I legali di Tarabella: «Non è
imparziale». Simona Musco su Il Dubbio il 20 giugno 2023
Una vera e propria bufera si abbatte sul
Qatargate. E questa volta a rischio sono i magistrati che hanno condotto
l’inchiesta, ai quali ora le difese chiedono di chiarire eventuali omissioni e
favoritismi. Mentre l’eurodeputato Andrea Cozzolino rimane in stato di fermo a
Bruxelles al termine di un doppio interrogatorio, il super-magistrato Michel
Claise è stato infatti costretto a mollare l’indagine, a seguito del legittimo
sospetto sollevato dalla difesa dell’eurodeputato belga Marc Tarabella, che ha
tirato fuori i rapporti tra il figlio del giudice istruttore e quello di un
altro membro del Parlamento europeo, Maria Arena.
Claise, di fronte all’accusa di un possibile
conflitto di interessi, nella serata di lunedì - quando già si era abbattuta
sull’Europarlamento l’accusa di una violazione dell’immunità parlamentare e di
spionaggio ai danni dell’ex vicepresidente Eva Kaili - ha deciso di lasciare
l’indagine. A prendere il suo posto la procuratrice federale Aurélie Dejaiffe,
che oggi deciderà se convalidare l'arresto di Cozzolino, disporre misure
alternative o autorizzarne il rilascio.
A svelare il possibile conflitto di interessi di
Claise è stato l’avvocato Maxime Toller, che è riuscito a scoprire un fatto
necessariamente noto a Claise sin dall’inizio dell’indagine: uno dei figli del
magistrato, infatti, possiede dal 2018 il 50 per cento di una società di vendita
legale di cannabis insieme a Ugo Lemaire, figlio di Arena. Il nome
dell'eurodeputata, mai indagata né interrogata, compare più volte negli atti
dell’inchiesta, dato il suo legame di amicizia con l’ex eurodeputato Pier
Antonio Panzeri, il primo “pentito” del Qatargate, che si è dichiarato colpevole
in cambio di una pena ridotta e che ha sempre escluso qualsiasi coinvolgimento
della collega.
L’inchiesta, come noto, riguarda una presunta
organizzazione criminale finalizzata al riciclaggio di denaro, corruzione e
concussione che prevedeva il pagamento di «ingenti somme di denaro» da Qatar e
Marocco, per influenzare i processi politici comunitari. Ed ora è proprio il
mancato coinvolgimento di Arena a far sorgere dubbi alla difesa di Tarabella. Ma
non solo: il potenziale conflitto di interessi sarebbe ancora più grave, secondo
la difesa, dal momento che «il contabile della società di questi due giovani» è
stato perquisito perché in quanto «contabile di aziende, organizzazioni no
profit che hanno un rapporto con il signor Panzeri», ha sottolineato Toller,
interpellato dal quotidiano Rtbf.
La difesa di Tarabella già a febbraio aveva
provato, senza riuscirci, a ricusare il giudice per legittimo sospetto per
violazione della presunzione di innocenza, dati i termini accusatori utilizzati
nel mandato di arresto, nel quale sarebbe emersa «chiaramente» l’opinione di
Claise circa la colpevolezza di Tarabella. Questa volta, però, le informazioni
scovate da Toller hanno colto nel segno, tanto da spingere la procura a chiarire
la situazione: «A titolo preventivo, e affinché la giustizia possa svolgere il
proprio lavoro in tranquillità e mantenendo la necessaria separazione tra vita
privata e responsabilità professionali, il giudice istruttore Michel Claise ci
ha comunicato di aver deciso di abbandonare il caso», si legge in una nota.
Per i legali di Tarabella, gli elementi scoperti
suscitano però diversi dubbi sulla gestione delle indagini. «Ci siamo chiesti
per un po' perché non abbiano verificato la parola di Panzeri, perché non
abbiano verificato le prove, sia a carico che a discarico, visto che l'unica
prova contro il signor Tarabella è la parola di Panzeri - ha aggiunto Toller a
Rtbf -. Quando ci siamo posti queste domande, a poco a poco, abbiamo individuato
alcuni elementi, alcuni problemi che ci sembrano giustificare» la ricusazione di
Claise. Elementi che avrebbero dovuto essere noti subito, ma mai presi in
considerazione. «Questa informazione non è nuova - ha sottolineato -. È nuova
per noi che la scopriamo, ma non è nuova per i protagonisti. Ed è stata
problematica sin dal primo giorno di questa indagine in cui sono stati citati
gli stessi nomi. Ciò che mi sconvolge profondamente è che quando ho avviato una
procedura di contestazione su altri elementi non abbiano approfittato
dell'opportunità di ritirarsi perché dietro c'era un problema di fondo». E
questo problema di fondo, ora, rischia di rendere inutilizzabili le prove
raccolte finora e a mettere in dubbio le modalità di svolgimento dell’indagine,
a partire da ciò che non è stato fatto in termini di perquisizioni e
interrogatori. «Chiaramente, dubitiamo della sua imparzialità in questo caso»,
ha aggiunto Toller, che ha intenzione di chiedere al magistrato che ha
sostituito Claise di «riconsiderare questa indagine scavando davvero nelle
parole di Panzeri».
Sorpresi anche i legali di Eva Kaili, Sven Mary e
Michalis Dimitrakopoulos: «Questa informazione, che non è stata smentita,
solleva interrogativi importanti ed evidenti sull'imparzialità dei doveri di
indagine», hanno evidenziato, chiedendo alla procura federale di indagare su
possibili omissioni da parte di Claise nel corso delle indagini.
Estratto dell’articolo di Giuseppe Guastella per
il “Corriere della Sera” il 26 giugno 2023.
Un intreccio inestricabile lega politica,
imprenditoria e giustizia in Belgio all’ombra dell’inchiesta Qatargate. È in
questo scenario [...] che una settimana fa matura la decisione del giudice
istruttore Michel Claise di astenersi dalla guida delle indagini che a dicembre
hanno fatto tremare il Parlamento europeo.
In un paese poco più grande della Lombardia,
guidato dalle élite vallona e fiamminga finisce che tutti sono in qualche modo
collegati a tutti. Anche tra i protagonisti del Qatargate ci si conosce bene,
forse troppo.
Considerato un paladino della lotta alla
corruzione, in un’ intervista al quotidiano di Bruxelles Le Soir, che lo
celebrava anche per la sua attività di scrittore di gialli ed in cui affermava
che a causa della corruzione la democrazia «è fottuta», il giudice Claise è
stato costretto ad astenersi dall’inchiesta che lo ha reso famoso nel mondo dopo
che è emerso che suo figlio è da anni in società con il figlio di Maria Arena in
un’azienda che commercializza prodotti di libera vendita derivati dalla
cannabis.
Arena è la europarlamentare dei Socialisti
coinvolta nel Qatagrate strettissima amica di Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato
Pd e poi Articolo uno considerato il collettore delle ipotetiche tangenti
arrivate in contanti da Qatar e Marocco per condizionare l’attività del
Parlamento europeo.
Claise è un orgoglioso massone. Nella stessa
intervista a Le Soir ha raccontato di essere entrato nella massoneria 35 anni fa
quando si avviava all’avvocatura nello studio legale del suo «maestro» Guy
Uyttendaele, famoso avvocato di Bruxelles scomparso, al quale fu introdotto dopo
la laurea dal figlio Marc, cui era legato da una profonda amicizia.
Secondo il quotidiano online Moustique di
Bruxells, Uyttendaele era a sua volta un massone. Ora il figlio Marc, nonostante
l’amicizia con Claise che 20 ani fa è diventato giudice, è uno dei difensori di
Panzeri che dopo meno di due mesi dall’arresto si è pentito accordandosi con la
Procura per un solo anno di carcere ai domiciliari di cui quasi 8 mesi già
scontati. «Essere massone non mi limita, sono libero», dichiarò Claise.
In Belgio i magistrati possono appartenere alla
massoneria a differenza che in Italia dove l’iscrizione può portare a
provvedimenti disciplinari. Ora che ha fatto il passo indietro, sui media belgi
compaiono retroscena, [...] secondo il quale Claise «ben prima» delle dimissioni
per conflitto di interessi avrebbe «subito un’osservazione» da un altro «massone
della sua loggia» che gli avrebbe fatto capire che «stava facendo troppo per
coprire Arena», con la quale si sarebbe anche «incontrato più volte» in
Parlamento tra il 2015 e il 2017.
[...] È massone anche l’ex primo ministro
socialista Elio Di Rupo originario di Mons come Arena, considerata destinata a
raccogliere la sua eredità politica. Arena ha divorziato da Olivier Lemaire,
padre del giovane socio del figlio di Claise, il quale ha sposato l’attuale
ministra degli esteri del Belgio, Hadja Lahibib.
Curiosamente, il 14 novembre Lahibib ha incontrato
il ministro del lavoro del Qatar Al Marri il quale [...] è ritenuto il pagatore
delle tangenti attraverso la ong Figth impunity di Panzeri, che aveva incontrato
il 10 ottobre in un hotel di Bruxelles. «Abbiamo discusso di diritti umani,
inclusi quelli delle donne e Lgbtqia+. Ho confermato che il Belgio riconosce che
i significativi progressi del Qatar» twittò la ministra.
Le stesse considerazioni fatte da indagati sono
state considerate come prezzo della corruzione. Al Corriere della Sera , la ex
vice presidente del Parlamento Eva Kaili [...] si chiedeva come mai la Arena,
pur coinvolta nelle indagini, «non ha avuto problemi» e se fosse «protetta da
un’immunità speciale?». Si dice che Claise voglia entrare in politica dopo la
pensione a inizio 2024. «Non voglio appendere trofei al muro», ma «prevenire il
minimo errore», diceva settimane fa al Financial Times . Non pare ci sia
riuscito.
«Ecco i lobbisti per
Doha». Così è nato il “Qatargate”.
GIOVANNI TIZIAN E STEFANO
VERGINE su Il Domani il 10 luglio 2023
Nome in codice:
“Costellazione”, riferimento alle stelle che adornano la bandiera europea. È
ottobre del 2018. Dopo aver mappato la presunta rete dei Fratelli Musulmani in
Europa, gli Emirati chiedono all'investigatore privato Mario Brero di
individuare i lobbisti usati tra i palazzi dell'Ue dal Qatar.
Un piano “offensivo” ed
“efficace”, indicano da Abu Dhabi i clienti dell'agenzia Alp Services. Secondo
documenti ottenuti da Mediapart, condivisi con Domani e il consorzio di
giornalismo investigativo Eic, la società svizzera ha fornito agli Emirati, per
centinaia di migliaia di euro, un elenco con dozzine di nomi di politici e
funzionari europei. Tutti etichettati come sostenitori del Qatar. Come lobbisti
«traditional» o «dark», queste le due famiglie in cui sono stati divisi. La
sorpresa è che, scorrendo l'elenco, si ritrovano alcuni di quelli che oggi sono
i sospettati principali del cosiddetto Qatargate, l'inchiesta della magistratura
belga che contesta la corruzione tra le istituzioni europee.
L’agenzia di investigazione
aveva segnalato Panzeri, Tarabella, Kaili: tutti poi accusati dai pm di
Bruxelles
Nome in codice:
“Costellazione”, riferimento alle stelle che adornano la bandiera europea. È
ottobre del 2018. Dopo aver mappato la presunta rete dei Fratelli Musulmani in
Europa, gli Emirati chiedono all'investigatore privato Mario Brero di
individuare i lobbisti usati tra i palazzi dell'Ue dal Qatar. Un piano
“offensivo” ed “efficace”, indicano da Abu Dhabi i clienti dell'agenzia Alp
Services. Secondo documenti ottenuti da Mediapart, condivisi con Domani e il
consorzio di giornalismo investigativo Eic, la società svizzera ha fornito agli
Emirati, per centinaia di migliaia di euro, un elenco con dozzine di nomi di
politici e funzionari europei. Tutti etichettati come sostenitori del Qatar.
Come lobbisti «traditional» o «dark», queste le due famiglie in cui sono stati
divisi. La sorpresa è che, scorrendo l'elenco, si ritrovano alcuni di quelli che
oggi sono i sospettati principali del cosiddetto Qatargate, l'inchiesta della
magistratura belga che contesta la corruzione tra le istituzioni europee.
LA GUERRA EMIRATI – QATAR
Come spesso accade nei
progetti di Alp Services, tutto inizia con un invito al sole. Hotel di lusso e
cene sotto i grattacieli di Abu Dhabi intervallano incontri discreti in cui si
parla di affari e strategie di lobbying. A ottobre del 2018 Alp ha già stretto
forti legami con gli Emirati, con l'agente Matar e con lo sceicco Ali Saeed
al-Neyadi, consigliere per la sicurezza nazionale. Come abbiamo rivelato venerdì
scorso, nell'agosto 2017 una delegazione guidata da Brero ha fatto una prima
visita al cliente. Il rapporto si è sviluppato bene: con due progetti sui
Fratelli Musulmani, Alp ha già incassato oltre 1 milione di euro. È a questo
punto che parte il nuovo piano per contrastare il Qatar.
A marzo 2019, uno dopo
l'altro, Alp produce tre documenti: il report “constellation – stage 1”,
un'infografica di accompagnamento con la mappatura della cosiddetta rete del
Qatar a Bruxelles e, infine, un “report investigativo” dedicato esclusivamente
ad Avisa Partners, un'altra società di intelligence privata. Brero e i suoi
scrivono che per farsi largo nelle istituzioni Ue, il Qatar usa principalmente
Avisa, sedi a Parigi e Bruxelles, «specializzata in campagne di comunicazione
occulta», scrive Alp. Nel giugno del 2022 i colleghi di Mediapart se ne sono
occupati: nel proprio spazio per i blog, aperto ai lettori-abbonati, il giornale
francese ha scoperto ben 634 post scritti da profili anonimi utilizzati da
Avisa. Post su commissione, per veicolare informazioni utili. La stessa tecnica
della Alp.
La guerra tra Qatar ed
Emirati, combattuta sul terreno dell'Ue, è un groviglio d'interessi, spionaggio
e controspionaggio. I 17 gygabyte di dati interni alla Alp sono solo un pezzo
del tutto, ma permettono di capire concretamente com'è stata combattuta questo
conflitto. Al termine del progetto, Brero e i suoi preparano per i clienti
emiratini report e mappe con le conclusioni raggiunte dal piano
“Costellazione”.
PANZERI, KAILI E TARABELLA
Alp indica una serie di
potenziali bersagli da colpire per contrastare l'influenza del nemico: quasi 70
persone, fisiche e giuridiche. Tra loro ci sono anche tre principali accusati
per il Qatargate: i parlamentari Marc Tarabella (Belgio) ed Eva Kaili (Grecia) –
associati al gruppo di amicizia Ue-Qatar – e la presunta mente, l'ex
europarlamentare italiano Pier Antonio Panzeri.
È l'inizio del 2019 e alla Alp
Services non pensa assolutamente di aver appena catalogato tra gli oscuri
lobbisti del Qatar coloro che, a distanza di anni, diventeranno protagonisti di
uno scandalo internazionale, per ora presunto visto che siamo ancora in fase
d'indagine. Agli investigatori svizzeri, però, non sfugge un evento che si
rivelerà cruciale nel Qatargate. Ad aprile del 2018 Panzeri, allora presidente
della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento, è stato in visita a
Doha e si è impegnato ad organizzare nei mesi successivi un'audizione al
Parlamento europeo di Ali Bin Samikh Al-Marri, allora presidente del Comitato
nazionale per i diritti umani.
Secondo le stesse
dichiarazioni rese da Panzeri agli inquirenti belgi, ha scritto lo scorso
febbraio Le Soir, è stato proprio durante questo viaggio del 2018 che Al-Marri e
l'ex eurodeputato italiano avrebbero stretto il patto corruttivo. Culminato,
secondo l'accusa, con il ritrovamento di 700mila euro in contanti nella casa di
Panzeri a Bruxelles, lo scorso 9 dicembre.
Alle domande di Eic per questo
articolo, i legali di Panzeri non hanno risposto. Quelli di Kaili hanno invece
sottolineato due aspetti: «In primo luogo, le conclusioni tratte per conto dei
servizi segreti degli Emirati Arabi Uniti nel 2019 sono le stesse contenute nel
rapporto dei servizi segreti belgi del 2022. In secondo luogo, è preoccupante
che il Parlamento europeo sia diventato un 'campo di battaglia' per i servizi
segreti di Paesi che mettono deliberatamente sotto sorveglianza le attività di
deputati democraticamente eletti, in violazione della loro immunità e dello
stato di diritto europeo». Marc Tarabella ha risposto tramite il suo ufficio:
«Essendo stato vicepresidente della delegazione della penisola arabica, non
sorprende che abbiano cercato di raccogliere informazioni su di lui. La cosa
molto più sorprendente è leggere che Marc Tarabella avrebbe fatto parte di un
gruppo di amicizia con questo Paese il Qatar, ndr), il che è totalmente falso»
DA MOGHERINI A CAPEZZONE
Nelle mappe di Alp, i tre
politici sono solo alcuni dei 70 componenti della lobby «tradizionale» del Qatar
in Ue. Al loro fianco due figure importanti nell'Ue: l'ex vicepresidente della
Commissione, Joaquin Almunia, e l'allora Alto rappresentante per la politica
estera europea, l'italiana Federica Mogherini. La cui presenza, spiega l'agenzia
privata ingaggiata dagli Emirati in un documento, deriva dal fatto che Mogherini
«sembra abbia subito pressioni» da parte del gruppo di amicizia Ue-Qatar.
Se in generale i politici
europei accusati da Alp di fare gli interessi di Doha sono di centrosinistra,
c'è una sorpresa nell'elenco dei membri della «dark lobbying»: Daniele
Capezzone, allora deputato del partito Direzione Italia di Raffaele Fitto, già
portavoce di Forza Italia e Pdl. Alp cita Capezzone come uno degli «agente
chiave del Middle East Dialogue Center», un «think tank creato dall'ambasciata
del Qatar in Belgio». Secondo Alp è il Middle East Dialogue Center il veicolo
principale usato per fare «dark lobbying» in Ue. E Capezzone è uno dei suoi
snodi: «Secondo alti professionisti e lobbisti delle relazioni pubbliche
italiane, Cappezone è un lobbista mercenario abile nel vendere i suoi contatti
nel mondo della politica e degli affari italiani», scrive Alp.
Tra i soggetti schedati perché
considerati nemici degli Emirati c'è poi un altro nome reso noto dalle cronache
giudiziarie del Qatargate: quello di Niccolò Figà-Talamanca, il segretario
dell'ong “No Peace Without Justice”, rilasciato dopo due e mesi e mezzo di
carcere con l'accusa di associazione criminale, corruzione e riciclaggio. A una
richiesta di commento per questo articolo, Figà-Talamanca non ha risposto. Alp
lo ha inserito nell'elenco degli attenzionati, ma non ha evidenziato alcuna
connessione tra l'esperto di diritti umani e politici come Panzeri, Kaili o
Tarabella. Figà-Talamanca viene schedato solo perché segretario della ong di cui
è parte anche un altro italiano, l'ex deputato dei Radicali Marco Perduca. La
sua colpa? Aver pubblicato su The Guardian, nel luglio del 2019, un articolo per
denunciare il mancato rispetto dei diritti umani dei carcerati negli Emirati. Un
mese dopo l'editoriale, Alp ha già pronto un dossier su di lui.
Nelle 26 pagine del documento
si evidenziano i legami di Perduca con Più Europa, Emma Bonino, l'Associazione
Luca Coscioni. Una serie di collegamenti porta a George Soros, noto finanziatore
di Più Europa. E poi al Qatar, alla ong “No Peace Without Justice” e al suo
segretario Figà-Talamanca. Tutti insieme, senza troppe distinzioni,
nell'operazione organizzata de Brero per stanare i presunti nemici degli Emirati
. Alcuni dei quali, quasi quattro anni dopo, sono stati arrestati dalle autorità
belghe proprio con l'accusa di aver aiutato Doha in cambio di denaro. GIOVANNI
TIZIAN E STEFANO VERGINE
Qatargate e se il vero abuso fosse
l’inchiesta della procura? Una trama occulta degli
Emirati per diffamare il Qatar e una lista "fake" di lobbisti all'origine dello
"scandalo". Daniele Zaccaria su Il Dubbio l'11 luglio 2023
La geopolitica del mondo arabo è materia assai
complessa, in particolare quella della penisola arabica, segnata da fitte trame
di interessi, conflitti incrociati e soprattutto alimentati dalle smisurate
ambizioni delle petromonarchie e dell’altrettanto smisurata voglia di allargare
la loro sfera di influenza. Guerre sotterranee combattute a colpi di miliardi di
dollari attinti dalle inesauribili riserve dei fondi sovrani e con i metodi
“sporchi” e spregiudicati dei servizi di intelligence.
In questo grumo sta emergendo uno scenario che ha
dell’incredibile, una manovra di killeraggio mediatico che, partendo dal Golfo è
arrivata fino alle istituzioni e alle procure europee e che potrebbe aver
partorito persino la celebre inchiesta del Qatargate. La vicenda è stata
rivelata da alcune testate europee legate al Consorzio giornalistico Eic, dal
belga Le Soir a Domani, passando per il sito investigativo francese Mediapart:
dopo un lungo lavoro d’inchiesta hanno definito i contorni di una scellerata
opera di diffamazione di massa.
Tutto partirebbe dagli emirati Arabi e dalla loro
violenta rivalità con i vicini del Qatar. E dire che lo scorso 19 giugno i due
Paesi avevano riallacciato le relazioni diplomatiche dopo sette anni di gelo
riaprendo le ambasciate nelle rispettive capitali. Un riavvicinamento tattico
che non cancella la reciproca diffidenza, le manovre segrete e la volontà di
disturbarsi, di ostacolarsi. All’epoca dei fatti gli 007 di Abu Dabi volevano
colpire Doha, al cuore, azzopparne l’ ascesa e il credito di cui il potere
qatariota gode nel vecchio continente.
Lo fanno appoggiandosi a una società di
intelligence privata svizzera, la Alp service, sita in Rue de Montchoisy a
Ginevra con lo scopo di individuare lobbisti pro- Qatar, reali, potenziali ma
soprattutto immaginari. Un lavoretto pagato circa sei milioni di euro. Il suo
fondatore si chiama Mario Brero, «esperto di rapporti confidenziali», di
nazionalità italo- svizzera è un personaggio talmente equivoco e così poco
preoccupato di nasconderlo al grande pubblico da risultare addirittura
simpatico. Anche se i suoi “servizi” di simpatico hanno ben poco. Negli ultimi
anni il nome di questo diffamatore seriale con la sua factory di hacker ed ex
agenti di cybersicurezza poliglotta e la sua rete di contatti che vanno
dall’Africa ai Balcani, dall’Europa occidentale all’Asia centrale passando per
la Russia, è spuntato in decine di vicende dai contorni più o meno oscuri.
Tra queste c’è il dossier “Abu Dabi Secrets” che
sarebbe una lista di 160 persone e 80 organizzazioni accusati di sostenere la
causa del movimento islamista egiziano Fratelli Musulmani, storicamente legato
al Qatar accusato dai Emirati e dai sauditi di diffondere propaganda islamista
tramite il noto network Al Jazira.
Ma come emerso dall’inchiesta del Consorzio Eic le
persone sono state citate spesso a caso, al di là di un filo logico o senza che
avessero alcun legame, neanche alla lontana con Doha o con i militanti
islamisti. Una opera di calunnia collettiva tanto feroce quanto rozza,
all’immagine della biografia di Brero.
Ci sono giornalisti, imam, professori
universitari, ma anche personalità politiche di rilievo come la ministra
dell’ambiente belga Zakia Khattabi indicata come vice presidente dell’Esecutivo
dei musulmani del Belgio, carica che non ha mai occupato. «Sono notizie del
tutto infondate e molto inquietanti», è stato il suo commento. Chissà con
quale spirito-Khattabi parteciperà alla conferenza COP 28 sui cambiamenti
climatici che si terrà questo inverno proprio negli Emirati arabi, i principali
responsabili del killeraggio mediatico. In ogni caso venerdì scorso
l’ambasciatore di Abu Dabi a Bruxelles è stato convocato al ministero degli
Esteri belga per chiarimenti.
Nella lista compilata dagli spioni di Brero,
guarda un po, figurano anche i nomi dei tre principali accusati del Qatargate:
l’europarlamentare belga Marc Tarabella, l’ex vicepresidente
dell’europarlamento Eva Kaili e l’ex sindacalista e lobbista Antonio Panzeri. E
a questo punto una domanda sorge spontanea: come è possibile che le conclusioni
a cui era giunta la procura di Bruxellese e l’allora titolare dell’inchiesta
Michel Claise siano le stesse di Alp service, dell’intelligence emiratina e
degli stessi servizi segreti di Bruxelles? Sembra quasi che gli 007, come dei
burattinai, abbiano “apparecchiato” una sceneggiatura fantasy sul tavolo del
procuratore Claise sicuri che il magistrato avrebbe fatto il lavoro al loro
posto. E vai a vedere che, alla fine, l’unico reato del Qatargate non sarà
il Qatargate stesso...
Qatargate. La brutale detenzione di Eva
Kaili e il Parlamento Ue sotto attacco del giustizialismo.
Iuri Maria Prado su L'Inkiesta il 18 Luglio 2023
La decisione legittima di sospendere subito
l’eurodeputata socialista dalla sua carica sarebbe stata più rispettabile se
qualcuno avesse sollevato qualche dubbio anche sul trattamento riservato a lei
in carcere e su una indagine che finora non è stata condotta nel migliore dei
modi
L’altro giorno è tornata all’esercizio delle sue
funzioni Eva Kaili, la ex vicepresidente del Parlamento europeo imprigionata per
mesi senza imputazioni, infine rilasciata con l’ordine di non parlare alla
stampa mentre emergevano indizi di pasticci nell’inchiesta sul cosiddetto
Qatargate, un’azione giudiziaria condotta sulla scorta di attività spionistiche
dei servizi segreti e gestita da un giudice allontanato per conflitto di
interessi. Ma la notizia è che i voti espressi da Eva Kaili sulle questioni di
cui ha ricominciato a occuparsi non saranno intestati al gruppo dei Socialisti
cui apparteneva, e dal quale è stata esclusa dal giorno in cui è stata
arrestata.
Si potrebbe dire che dopotutto sono faccende di
quell’aggregazione parlamentare, la quale ha tutto il diritto di escludere dai
propri ranghi quelli che ritiene indegni di militarvi. E si potrebbe aggiungere
che si tratta infine di un caso singolo, immeritevole di troppa attenzione. Ma è
sufficiente guardare tutta la faccenda dalla prospettiva opposta per capire che
è possibile cavarne un significato ben diverso e di portata generale.
Quell’istituzione, il Parlamento europeo, e i
sodali di coalizione di Eva Kaili, si compiacevano delle requisitorie che la
presidente dell’assemblea rivolgeva ai «nemici della democrazia» e agli «attori
malvagi», presi con le mani nel sacco da una magistratura davanti ai cui ordini
batteva i tacchi la politica secondina, quella che annunciava di aver prestato
la propria collaborazione ai magistrati e alle forze dell’ordine partecipando
fisicamente alle perquisizioni domiciliari. Pensavamo fosse prerogativa di
certi ministri leghisti o grillini di casa nostra, travestiti da poliziotti e
carcerieri davanti alle telecamere chiamate all’evento dell’arresto in
mondovisione: e invece no, hanno fatto i compiti giustizialisti anche lassù e
siamo arrivati alle operazioni di polizia giudiziaria con embedded il presidente
dell’Europarlamento.
La decisione di destituire la Kaili dalla sua
funzione, come quella di escluderla dal suo gruppo, sarebbero state più
rispettabili se fossero state accompagnate almeno da qualche gemito di dubbio
sul trattamento riservato a una signora tenuta al freddo e senza accesso ai
servizi igienici nel corso del suo ciclo mestruale, e poi privata per settimane
della possibilità di vedere la figlia di ventidue mesi. Quel rigore disciplinare
e istituzionale sarebbe stato rispettabile, per quanto discutibile, se non
avesse mancato di denunciare lo schifo di una giustizia che costringe una
bambina di meno di due anni a stare lontana dalla madre, e a vederla due volte
in sei mesi: quell’immagine, con la bimba che attraversa il cortile del carcere
accompagnata dal nonno, diffama l’Europa, la politica dell’Europa e la giustizia
dell’Europa più di qualsiasi giro di supposte tangenti.
E così l’ordine alla Kaili di tenere la bocca
chiusa, l’intimazione rivolta dal giudice abituato alle interviste televisive
durante le quali illustra quanto è bravo a incastrare i corrotti: nessuno ci ha
trovato qualcosa di storto, evidentemente. La giustizia che fa comizio mentre
impone il bavaglio all’indagata. E ancora nulla abbiamo sentito venire da quegli
ambienti istituzionali, pur nel persistere degli interdetti ai danni di Eva
Kaili, quando dagli stessi lombi di quelle procedure inquisitorie e persecutorie
emergeva il riconoscimento che qualcosa probabilmente non filava per il verso
giusto, e cioè la presenza di elementi che «potrebbero sollevare alcune domande
sul funzionamento oggettivo dell’indagine».
Comunicati a petto in fuori, allo scatto delle
manette. Doveroso riserbo, all’emergere delle magagne. Si è detto che il
Parlamento Europeo era «sotto attacco». Sarà interessante capire da dove venisse
l’attacco al Parlamento: se solo da quella girandola di presunte tangenti, o
anche da chi vi faceva irruzione mentre gli eletti dal popolo sovrano facevano
da uscieri.
Francesca Basso e Giuseppe Guastella per
il “Corriere della Sera” giovedì 20 luglio 2023.
«Aumentare la comprensione reciproca e gli scambi»
tra Ue e Qatar attraverso una «cooperazione rafforzata» in cui «i contatti
interpersonali» devono essere la «priorità»: è la linea politica che ad ottobre
2022 l’Alto rappresentante dell’Ue (in pratica il ministro degli Esteri) il
socialista Josep Borrell, indica ad Eva Kaili, allora vicepresidente socialista
del Parlamento Ue.
Meno di due settimane dopo Kaili sarà arrestata
nel Qatargate, accusata di avere preso denaro per portare avanti la linea a
favore del Qatar, che di fatto era la linea Ue. Un’inchiesta avvolta da più di
un dubbio.
Siamo a metà 2022, è in corso la guerra in Ucraina
e a novembre in Qatar ci saranno i Mondiali di calcio. Determinante fornitore di
gas all’Ue in piena crisi energetica a causa del conflitto, criticato per lo
scarso rispetto dei diritti dei lavoratori […] e del mondo Lgbtqi+, ma
«promosso» dall’ International Labour Organization (Ilo), l’agenzia Onu su cui
si basano le valutazioni della Commissione Ue, il Qatar chiede che i propri
cittadini possano entrare in Europa senza visto e che si plachino le polemiche
sul campionato.
Il 27 gennaio 2022, tre giorni dopo l’invasione
della Ucraina e mesi prima del Qatargate, la presidente Ursula von der Leyen
twitta: «Ottima telefonata con sua altezza l’emiro Tamim Bin Hamad sul
rafforzamento del partenariato Ue-Qatar, anche in materia di energia. È
importante rafforzare la sicurezza energetica dell’Europa con tutti i partner
affidabili […]
Eva Kaili è attesa per il 31 ottobre a Doha
dall’Emiro del Qatar che in precedenza aveva accolto Borrell e il presidente del
Consiglio europeo Charles Michel. Tre giorni prima riceve con altre 7 persone
una lunga nota, che il Corriere ha potuto consultare, in cui Borrell indica la
linea dell’Ue enfatizzando che le «relazioni Ue-Qatar stanno attraversando un
momento positivo senza precedenti». […]
La Commissione Ue è pronta a trattare con il
Qatar l’abolizione dei visti appena Parlamento e Consiglio daranno il via libera
alla sua proposta. «Sarà una chiave per aumentare la comprensione reciproca e
gli scambi», scrive Borrell, ma Kaili deve far comprendere ai qatarini che è
necessario che il Paese continui a confrontarsi «strettamente con il Parlamento
Ue affinché ciò accada». E poi: «L’energia è attualmente una priorità assoluta
per l’Ue» e «vi siamo immensamente riconoscenti per la vostra prontezza
nell’aiutarci ad accelerare la nostra indipendenza dal gas russo» perché «un
partenariato» con il Golfo «è la prima strategia in assoluto» per l’Europa.
Si arriva al punto cruciale: «Plaudiamo alle
riforme intraprese dal Qatar, in particolare sulle questioni del lavoro, e vi
incoraggiamo a proseguire costantemente su questo promettente percorso oltre la
Coppa del Mondo Fifa, che siamo certi sarà un successo», aggiunge l’Alto
rappresentante.
Kaili si atterrà a quella linea anche nel
dibattito della plenaria del 21 novembre passato alle cronache come la prova
della sua responsabilità conseguente alle tangenti versate dal ministro del
lavoro del Qatar Ali Bin Samikh Al Marri ad Antonio Panzeri e ipoteticamente
arrivate a lei, come 250 mila euro di cui parla il pentito Panzeri per le
elezioni 2019 di cui però, a oltre otto mesi dallo scoppio dello scandalo, non
c’è alcuna prova.
Ci sono, invece, i 750 mila euro in contanti
trovati in casa sua nella valigia che aveva fatto prelevare dal padre per
«restituirla a Panzeri». Per questo è finita in carcere per 4 mesi e altri due
ai domiciliari.
Chiesto un commento sul documento, il portavoce di
Borrell, Peter Stano, ricorda che «nell’Ue esiste una chiara divisione del
lavoro e delle competenze e l’Alto rappresentante non può e non ha dato alcuna
istruzione o “ordine” al Parlamento Ue o ai suoi membri». Nel caso specifico «il
gabinetto dell’Alto Rappresentante ha risposto a una richiesta standard del
gabinetto della presidente del Parlamento Ue di fornire input per il briefing
sulla visita di un eurodeputato in Qatar» e «fornito un riassunto fattuale delle
posizioni consolidate dell’Ue in merito alle relazioni e alla cooperazione con
il Qatar […]
«L’incolpata è intervenuta per difendere gli
interessi del Qatar, avendo incontrato il ministro del Lavoro che appare essere
il manovratore delle attività del signor Panzeri», si legge nel mandato con il
quale il 9 dicembre il giudice Michel Claise ha arrestato Eva Kaili nonostante,
secondo la Polizia federale belga, non ci fossero elementi per dire che facesse
parte della rete tessuta da Panzeri.
Kaili incontra Al Marri alla vigilia della sua
audizione in commissione diritti umani del 14 novembre. «Ho ricevuto il mandato
dal presidente (Roberta Metsola, ndr) perché la Commissione ha insistito molto
per chiudere il dossier e votare in Parlamento sulla questione», dichiarerà a
verbale a Claise, mentre viene espulsa dal suo partito perché «le sue posizioni
e valori sono incompatibili con il Pasok». Né Metsola, che si affrettò a
«scaricare» subito la vice, né Borrell risulta siano stati chiamati a
testimoniare, nonostante l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos, difensore
dell’indagata, abbia fatto specifico riferimento alle loro direttive dopo
l’arresto.



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: