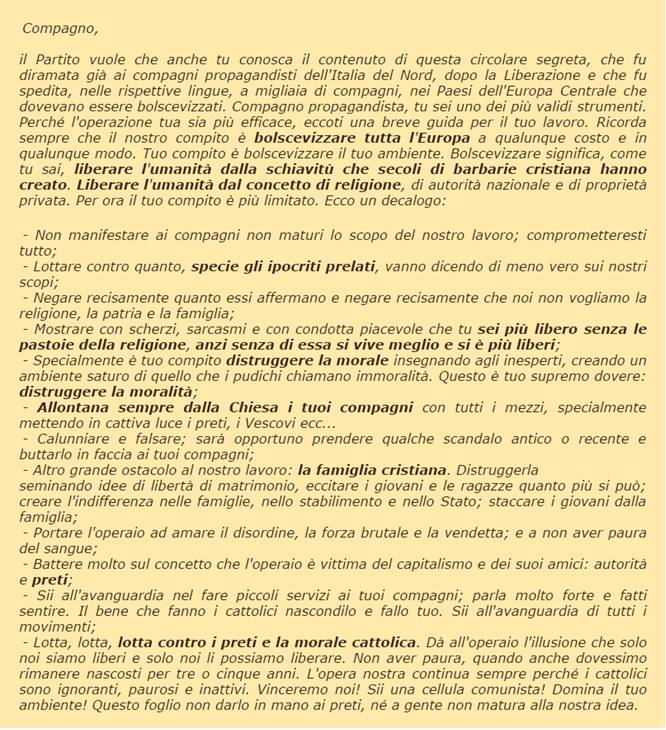Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI

 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA

ITALIA
ALLO SPECCHIO
IL DNA
DEGLI ITALIANI
ANNO 2023
IL GOVERNO
SECONDA PARTE
DI ANTONIO GIANGRANDE
L’APOTEOSI
DI UN POPOLO DIFETTATO
Questo saggio è un aggiornamento temporale,
pluritematico e pluriterritoriale, riferito al 2023, consequenziale a quello del
2022. Gli argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati
ed approfonditi in centinaia di saggi analitici specificatamente dedicati e già
pubblicati negli stessi canali in forma Book o E-book, con raccolta di materiale
riferito al periodo antecedente. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a
tesi di laurea ed inchieste giornalistiche.
Si troveranno delle recensioni deliranti e
degradanti di queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando
del nulla, ma dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio
che l'offeso si ribelli con la denigrazione del palesato.
IL GOVERNO
UNA BALLATA PER L’ITALIA
(di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE SIAMO.
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande).
L’AVETRANA CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
LA SOLITA INVASIONE BARBARICA SABAUDA.
LA SOLITA ITALIOPOLI.
SOLITA LADRONIA.
SOLITO GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI
MORALITA’.
SOLITA APPALTOPOLI.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED
ESAMI DI STATO TRUCCATI.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE
TRUCCATA.
SOLITO SPRECOPOLI.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE
SPECULAZIONI.
L’AMMINISTRAZIONE
SOLITO DISSERVIZIOPOLI. LA DITTATURA DEI
BUROCRATI.
SOLITA UGUAGLIANZIOPOLI.
IL COGLIONAVIRUS.
SANITA’: ROBA NOSTRA. UN’INCHIESTA DA NON FARE.
I MARCUCCI.
L’ACCOGLIENZA
SOLITA ITALIA RAZZISTA.
SOLITI PROFUGHI E FOIBE.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI.
GLI STATISTI
IL SOLITO AFFAIRE ALDO MORO.
IL SOLITO GIULIO ANDREOTTI. IL DIVO RE.
SOLITA TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI. LE
MANI SPORCHE DI MANI PULITE.
SOLITO BERLUSCONI. L'ITALIANO PER ANTONOMASIA.
IL SOLITO COMUNISTA BENITO MUSSOLINI.
I PARTITI
SOLITI 5 STELLE… CADENTI.
SOLITA LEGOPOLI. LA LEGA DA LEGARE.
SOLITI COMUNISTI. CHI LI CONOSCE LI EVITA.
IL SOLITO AMICO TERRORISTA.
1968 TRAGICA ILLUSIONE IDEOLOGICA.
LA GIUSTIZIA
SOLITO STEFANO CUCCHI & COMPANY.
LA SOLITA SARAH SCAZZI. IL DELITTO DI AVETRANA.
LA SOLITA YARA GAMBIRASIO. IL DELITTO DI
BREMBATE.
SOLITO DELITTO DI PERUGIA.
SOLITA ABUSOPOLI.
SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI.
SOLITA GIUSTIZIOPOLI.
SOLITA MANETTOPOLI.
SOLITA IMPUNITOPOLI. L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.
I SOLITI MISTERI ITALIANI.
BOLOGNA: UNA STRAGE PARTIGIANA.
LA MAFIOSITA’
SOLITA MAFIOPOLI.
SOLITE MAFIE IN ITALIA.
SOLITA MAFIA DELL’ANTIMAFIA.
SOLITO RIINA. LA COLPA DEI PADRI RICADE SUI
FIGLI.
SOLITO CAPORALATO. IPOCRISIA E SPECULAZIONE.
LA SOLITA USUROPOLI E FALLIMENTOPOLI.
SOLITA CASTOPOLI.
LA SOLITA MASSONERIOPOLI.
CONTRO TUTTE LE MAFIE.
LA CULTURA ED I MEDIA
LA SCIENZA E’ UN’OPINIONE.
SOLITO CONTROLLO E MANIPOLAZIONE MENTALE.
SOLITA SCUOLOPOLI ED IGNORANTOPOLI.
SOLITA CULTUROPOLI. DISCULTURA ED OSCURANTISMO.
SOLITO MEDIOPOLI. CENSURA, DISINFORMAZIONE,
OMERTA'.
LO SPETTACOLO E LO SPORT
SOLITO SPETTACOLOPOLI.
SOLITO SANREMO.
SOLITO SPORTOPOLI. LO SPORT COL TRUCCO.
LA SOCIETA’
GLI ANNIVERSARI DEL 2019.
I MORTI FAMOSI.
ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONI O CENTO DA AGNELLI?
L’AMBIENTE
LA SOLITA AGROFRODOPOLI.
SOLITO ANIMALOPOLI.
IL SOLITO TERREMOTO E…
IL SOLITO AMBIENTOPOLI.
IL TERRITORIO
SOLITO TRENTINO ALTO ADIGE.
SOLITO FRIULI VENEZIA GIULIA.
SOLITA VENEZIA ED IL VENETO.
SOLITA MILANO E LA LOMBARDIA.
SOLITO TORINO ED IL PIEMONTE E LA VAL D’AOSTA.
SOLITA GENOVA E LA LIGURIA.
SOLITA BOLOGNA, PARMA ED EMILIA ROMAGNA.
SOLITA FIRENZE E LA TOSCANA.
SOLITA SIENA.
SOLITA SARDEGNA.
SOLITE MARCHE.
SOLITA PERUGIA E L’UMBRIA.
SOLITA ROMA ED IL LAZIO.
SOLITO ABRUZZO.
SOLITO MOLISE.
SOLITA NAPOLI E LA CAMPANIA.
SOLITA BARI.
SOLITA FOGGIA.
SOLITA TARANTO.
SOLITA BRINDISI.
SOLITA LECCE.
SOLITA POTENZA E LA BASILICATA.
SOLITA REGGIO E LA CALABRIA.
SOLITA PALERMO, MESSINA E LA SICILIA.
LE RELIGIONI
SOLITO GESU’ CONTRO MAOMETTO.
FEMMINE E LGBTI
SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.
IL GOVERNO
INDICE PRIMA PARTE
UNA BALLATA PER L’ITALIA (di
Antonio Giangrande). L’ITALIA CHE
SIAMO.
LA POVERTA’
UNA BALLATA PER AVETRANA
(di Antonio Giangrande).
L’AVETRANA CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE. (Ho scritto un
saggio dedicato)
LA SOLITA INVASIONE BARBARICA SABAUDA. (Ho
scritto un saggio dedicato)
Storia d’Italia.
INDICE SECONDA PARTE
LA SOLITA ITALIOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
L’Italianità.
Gli
Antifascisti.
Italiani
scommettitori.
Italioti
Retrogradi.
Gli
Arraffoni.
INDICE TERZA PARTE
SOLITA LADRONIA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Italioti corrotti e corruttori.
La Questione
Morale.
Tangentopoli
Italiana.
Tangentopoli
Europea.
INDICE QUARTA PARTE
SOLITO GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI
MORALITA’. (Ho scritto un saggio dedicato)
Il Potere.
La Geopolitica.
Nazi-fascismo e Comunismo:
Economia pianificata.
I Conservatori.
Il
Capitalismo.
Il
Sovranismo.
Il Riformismo.
I Liberali.
I Popolari.
L’Opinionismo.
Il
Populismo.
Il
Complottismo.
Politica e magistratura, uno
scontro lungo 30 anni.
Una
Costituzione Catto-Comunista.
Democrazia: La Dittatura delle
minoranze.
Democrazia:
Il potere oscuro ed occulto. I Burocrati. Il Partito dello Stato: Deep State
e Spoils system.
Il
Presidenzialismo.
L’astensionismo.
I Brogli.
Lo Stato di
Emergenza.
Quelli
che…la Prima Repubblica.
Quelli
che…la Seconda Repubblica.
Trasformisti e Voltagabbana.
Le
Commissioni Parlamentari.
La
Credibilità.
I
Sondaggisti.
Il
finanziamento pubblico.
I redditi
dei politici.
I
Privilegiati.
I Portavoce.
Servi di…
Un Popolo di
Spie.
INDICE QUINTA PARTE
SOLITA APPALTOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
La
Resistenza Morale.
Gli Appalti Pubblici.
La Normativa
Antimafia.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED
ESAMI DI STATO TRUCCATI. (Ho scritto un saggio dedicato)
Impuniti.
Ignoranti e Magistrati.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE
TRUCCATA. (Ho scritto un saggio dedicato)
Ignoranti ed avvocati.
SOLITO SPRECOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Sprechi Vari.
Le Multe UE.
Le Auto: blu e grigie.
Le Regioni.
L’Alitalia.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE
SPECULAZIONI.
L’Oro.
La Ricchezza.
I Ricconi alle nostre spalle.
I Bonus.
La Partita
Iva.
Quelli
che…Evasori Fiscali: Il Pizzo di Stato.
Il POS.
Il Patto di
Stabilità.
Il MES.
Il PNRR.
Il ricatto
del gas.
La
Telefonia.
Bancopoli.
IL GOVERNO
SECONDA PARTE
LA SOLITA ITALIOPOLI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Moralisti.
In Declino.
Cambiare gli italiani?
La bandiera.
Mafiosi.
Insabbiatori.
Disonesti.
Fluidi e contro i bambini.
Questione di Genere.
Giustizialisti.
Stinchi di Santo.
I Tabù.
Meticci.
Immigrazionisti.
Emigranti.
Eroi.
Divisi.
Disorganizzati.
Mantenuti.
Oziosi.
Antipolitici.
Delatori.
Complottisti.
Inventori.
Moralisti.
C’E’ GROSSA CRISI (DELLA MORALE). Estratto
dell’articolo di Lucetta Scaraffia per “la Stampa” lunedì 11 dicembre 2023.
Dopo l'efferato omicidio di Giulia Cecchettin si è
verificato, come al solito, l'effetto imitazione: si susseguono violenze e
femminicidi, in alcuni casi chiaramente collegati al delitto di Giulia dal
colpevole stesso. Si tratta di un fenomeno che si è più volte presentato nella
nostra società mediatica: le denunce, le manifestazioni di solidarietà alle
vittime, la ricerca dei metodi utili a frenare questo o quel tipo di violenza si
rovesciano nel loro contrario.
Troppo spesso tutti i discorsi, le manifestazioni,
le condanne suscitate dai femminicidi, così come succede del resto per le
continue condanne dell'antisemitismo, sembrano non servire ad altro che a
favorire la diffusione degli uni e dell'altro. Non solo però continuiamo a
praticare le forme più estreme di voyeurismo nei confronti dell'ultimo delitto
con il loro indubbio effetto imitativo, ma quel che più conta non tentiamo
neppure di spiegarci le ragioni di questo effetto paradossale.
Che forse sta in una mutazione decisiva lentamente
e inavvertitamente prodottasi nelle nostre società. Nel fatto cioè che sembra
esserci sempre più difficile, più estraneo culturalmente, condividere una morale
universale, fondata su obblighi e divieti validi nei confronti di chiunque, di
qualsiasi essere umano.
La crisi di una morale siffatta si manifesta
concretamente nella pratica diffusa per cui, da anni, nell'arena pubblica la
richiesta di rispetto umano, la difesa della dignità dovute ad ogni essere
umano, vengono declinate soprattutto in riferimento a categorie ritenute fragili
e comunque particolarmente meritevoli di protezione: i gay, gli handicappati, le
donne, gli immigrati e gli ebrei. Categorie considerate vittime o possibili
vittime di violenza e/o di discriminazione e per questo bisognose di protezione.
Intendiamoci bene: ciò è assolutamente vero, questo bisogno è reale, ma ciò non
toglie che questa categorizzazione […] risulti priva di quel valore astratto sul
quale necessariamente si fonda l'universalizzazione della morale.
In questo modo nella quotidianità della vita
sociale finisce dunque per accadere che il rispetto dovuto a tutti gli esseri
umani venga presentato come obbligatorio se esercitato nei confronti delle
vittime, o di categorie che sanno presentarsi come tali e non già come un valore
assoluto in quanto tale, come un obbligo a cui si è tenuti verso ogni essere
umano, indipendentemente dal suo statuto storico-ideologico. Le conseguenze di
questa realtà sono gravi.
Infatti la corsa alla moltiplicazione delle
categorie diciamo così protette non arriverà mai a coprire il concetto generale
di umanità, e rivelerà sempre, quindi, l'inevitabile debolezza di una morale
siffatta. Chiunque tra l'altro può sentirsi più vittima delle vittime, e quindi
sentirsi autorizzato a farsi giustizia anche da solo. In un gran numero di casi
ad esempio anche i violenti contro le donne si sentono – naturalmente a torto –
vittime magari del rifiuto delle donne stesse, e in questo cercare una
giustificazione per le loro malefatte.
Questo tipo di morale "per categorie" – esposto
alle ideologie e per forza di cose in una certa misura anche alle mode – non
poggia su fondamenta profonde e condivise, cioè su quella inviolabile dignità di
ogni essere umano, che da sola basta a giustificare la difesa di ogni tipo di
vittima. Se sono necessarie le campagne per categoria, se è necessario, forse
indispensabile, difendere con battaglie apposite ogni categoria percepita come
debole, è evidente che questa base comune, questa universalità, non esiste più.
Forse non esiste più perché si fondava su un altro tipo di universalità, quella
religiosa della tradizione ebraico-cristiana che la secolarizzazione sta
cancellando.
Ma anche la morale laica di Kant, è bene
ricordarlo, si voleva obbligatoria verso qualunque essere umano. L'una e l'altra
hanno fondato una tradizione che ha stabilito con forza i confini fra bene e
male, fra ciò che è giusto e ciò che non lo è: una tradizione che ha perso
progressivamente forza. Proprio per questo anche la nostra educazione attuale ha
perduto la certezza in una moralità universale, e oggi per chiedere giustizia
deve ricorrere alla preliminare vittimizzazione di questo o quel gruppo umano.
Con tutto quanto di aleatorio può esserci in una moralità del genere, esposta ai
mutevoli venti della storia.
In Declino.
Estratto dell'articolo di Paolo Baroni per "La
Stampa" sabato 2 dicembre 2023.
L'Italia? È diventato un Paese di sonnambuli. E i
suoi abitanti sono, al tempo stesso, ciechi dinanzi ai presagi (a partire dalla
crisi demografica che nel 2050 produrrà quasi 8 milioni di persone in età
lavorativa in meno), ed intrappolati in una sorta di "mercato dell'emotività".
Per l'80% degli italiani il Paese è in declino,
per il 69% dalla globalizzazione abbiamo avuto più danni che benefici, e adesso
il 60% ha paura che scoppierà una guerra mondiale e secondo il 50% non saremo in
grado di difenderci militarmente, rileva il 57° rapporto Censis sulla situazione
sociale del Paese.
L'economia dopo la fine dell'espansione monetaria
ha prodotto record di occupati, ma la crescita sta rallentando mentre in
parallelo monta l'onda delle rivendicazioni dei diritti civili individuali e
delle nuove famiglie (è favorevole all'eutanasia il 74% dei cittadini). E nella
"siderale incomunicabilità generazionale" va in scena il dissenso senza
conflitto dei giovani che diventano "esuli in fuga".
[...] «La società italiana sembra affetta da
sonnambulismo, precipitata in un sonno profondo del calcolo raziocinante che
servirebbe per affrontare dinamiche strutturali dagli esiti funesti» rileva il
Censis. Nel 2050 l'Italia avrà perso complessivamente 4, 5 milioni di residenti
(come se le due più grandi città, Roma e Milano insieme, scomparissero). La
flessione demografica sarà il risultato di una diminuzione di 9,1 milioni di
persone con meno di 65 anni e di un contestuale aumento di 4,6 milioni di
persone con 65 anni e oltre.
Si stimano così quasi 8 milioni di persone in età
attiva in meno nel 2050: una scarsità di lavoratori che avrà un impatto
inevitabile sul sistema produttivo e sulla nostra capacità di generare valore.
Ma il sonnambulismo «non è imputabile solo alle classi dirigenti – sostiene il
Censis – è un fenomeno diffuso nella "maggioranza silenziosa» degli italiani"».
Resi più fragili dal disarmo identitario e politico, al punto che il 56% (il 61,
4% tra i giovani) è convinto di contare poco nella società.
Nell'ipertrofia emotiva in cui la società italiana
si è inabissata, le argomentazioni ragionevoli possono essere capovolte da
continue scosse emozionali. Tutto è emergenza: quindi, nessuna lo è veramente.
Così trovano terreno fertile paure amplificate, fughe millenaristiche, spasmi
apocalittici, l'improbabile e il verosimile. L'84% degli italiani è impaurito
dal clima «impazzito», il 73,4% teme che i problemi strutturali irrisolti del
nostro Paese provocheranno nei prossimi anni una crisi economica e sociale molto
grave con povertà diffusa e violenza, per il 73% gli sconvolgimenti globali
sottoporranno l'Italia alla pressione di flussi migratori sempre più intensi e
non saremo in grado di gestire l'arrivo di milioni di persone in fuga dalle
guerre o per effetto del cambiamento climatico, il 53,1% ha paura che il
colossale debito pubblico provocherà il collasso finanziario dello Stato. Il
ritorno della guerra ha suscitato nuovi allarmi: il 59, 9% degli italiani ha
paura che scoppierà un conflitto mondiale che coinvolgerà anche l'Italia, per il
59,2% non siamo in grado di proteggerci da attacchi terroristici di stampo
jihadista, mentre il 49, 9% è convinto che l'Italia non saprebbe difendersi
militarmente se aggredita da un Paese nemico.
[...] Il 74% si dice favorevole all'eutanasia, il
70,3% approva l'adozione di figli da parte dei single, il 65, 6% si schiera a
favore del matrimonio egualitario tra persone dello stesso sesso, il 54,3% è
d'accordo con l'adozione di figli da parte di persone dello stesso sesso. Rimane
invece minoritaria la quota di italiani (il 34,4%) che approvano la gestazione
per altri (Gpa). Infine, il 72,5% è favorevole all'introduzione dello Ius soli e
il 76, 8% è favorevole allo Ius culturae, ovvero la cittadinanza per gli
stranieri nati in Italia o arrivati in Italia prima dei 12 anni che abbiano
frequentato un percorso formativo nel nostro Paese. Il silenzio tra
generazioni.
La distanza esistenziale dei giovani di oggi dalle
generazioni che li hanno preceduti sembra abissale. I 18-34enni sono poco più di
10 milioni, pari al 17, 5% della popolazione totale, mentre nel 2003 superavano
i 13 milioni, pari al 23% della popolazione: in vent'anni abbiamo perso quasi 3
milioni di giovani. E le previsioni per il futuro sono negative: nel 2050 i
18-34enni saranno poco più di 8 milioni, appena il 15, 2% della popolazione. I
giovani sono pochi, esprimono un peso demografico leggero, inesorabilmente
contano poco. E infatti per il 57, 3% degli italiani sono la generazione più
penalizzata di tutte. [...]
Cambiare gli italiani?
Cambiare gli italiani chi lo ha fatto, chi no.
Storia di Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera venerdì 8 settembre 2023.
Caro Aldo, lei ha distinto tra i politici che
volevano cambiare gli italiani e quelli che non ci hanno mai provato. Mi aiuta a
capire quello che intendeva? Stefano Sapri, Roma
Caro Stefano, Giovanni Giolitti nel 1896 scriveva
in una lettera alla figlia Enrichetta: «Il sarto che ha da vestire un gobbo, se
non tiene conto della gobba, non riesce» (concetto su cui tornerà al momento di
scrivere le sue Memorie con il giornalista Olindo Malagodi, liberale bastonato
dai fascisti, padre di Giovanni, futuro leader del Pli). Giolitti insomma
sosteneva la necessità che la politica si adattasse agli italiani. Eppure è
stato il leader riformista più importante della storia unitaria: introdusse il
suffragio universale (purtroppo solo maschile), varò interventi sociali, tentò
invano di fermare l’intervento nella Grande Guerra. Benito Mussolini sognava di
fare degli italiani un popolo guerriero, e dopo aver contribuito all’ingresso
nella Prima ci ha condotti con la Seconda guerra mondiale alla peggior disfatta
militare della nostra storia, su tutti i fronti, contro tutti gli eserciti,
inglesi e greci, russi e americani. Silvio Berlusconi non ha mai pensato di
cambiare gli italiani, che gli piacevano così come sono; semmai ci ha
assecondati, nelle nostre virtù e nei nostri vizi, prima con le tv e il calcio
poi con la politica; e così facendo ci ha cambiati più di quanto avessero fatto
vent’anni di regime, quello vero. Mario Monti sostenne che gli italiani
dovessero cambiare, anche nel loro rapporto con lo Stato; e per quanto il suo
governo sarà rivalutato per il modo in cui dovette affrontare una situazione
drammatica creata da altri, non si può certo dire che sia riuscito ad aprire una
stagione politica duratura. Alcide De Gasperi pianse, nel vedere uomini e
animali convivere nei Sassi di Matera, e nel pensare al lavoro che aveva
davanti, e che non ebbe tempo di compiere. Qualcuno crede seriamente che il suo
giovane sottosegretario Giulio Andreotti volesse cambiare gli italiani? Eppure è
stato il politico più longevo della Prima Repubblica, sino a diventarne il
simbolo. In sostanza i leader che non intendono cambiare gli italiani finiscono
per cambiarli, nel bene o nel male, più di quelli che vorrebbero farlo.
La Bandiera.
Italia di ieri e di oggi: una breve indagine su
Patria e Nazione. Gennaro Sangiuliano su Libero Quotidiano il 12 dicembre
2023
Il vocabolario dell’Enciclopedia
Treccani definisce il sostantivo Patria come «il territorio abitato da un popolo
e al quale ciascuno dei suoi componenti sente di appartenere per nascita,
lingua, cultura, storia e tradizioni». L’origine della parola è latina e rimanda
a patrius «paterno» ma nell’accezione latina la parola Patria sottintende anche
terra. Cicerone già la definisce come un insieme di istituzioni, tradizioni,
sentimenti, ideali. L’Encyclopédie francese indica la Patria come pays des
pères, la terra dei padri, che per i tedeschi è Vaterland ou Heimat, anche se,
quest’ultima parola tedesca, non sarebbe correttamente traducibile con Patria
perché indicherebbe un ambito più ristretto, legato al luogo dell’infanzia e
alla lingua degli affetti.
Petrarca, fra i primi nella letteratura nazionale,
identificherà la sua Patria con l’Italia: Non è questa (l’Italia) la patria in
ch’io mi fido, Madre benigna e pia, Che copre l’un e l’altro mio
parente? Nell’antica Roma padre della Patria (pater patriae) è il titolo di
onore conferito a cittadini particolarmente benemeriti, titolo attribuito ad
Augusto nell’anno 2 a.C. e portato da altri imperatori, rinnovato in epoca
moderna, fu concesso dai Fiorentini a Cosimo de Medici. Molto suggestivi sono i
versi di Giacomo Leopardi ne la Canzione all’Italia, laddove recita: “O patria
mia, vedo le mura e gli archi/E le colonne e i simulacri e l’erme/Torri degli
avi nostri...”. Giuseppe Mazzini, già nel Manifesto della Giovine Italia, testo
morale e programmatico, filosofico e politico, che appare per la prima volta
sull’omonimo foglio nell’ottobre del 1831 a Marsiglia, esorta alla
consapevolezza che ciascuno doveva avere di essere nazione e per questo predica
la necessità di un’educazione nazionale. Gli obiettivi repubblicani, democratici
e unitari del suo movimento politico, hanno come ambito di riferimento la
Nazione.
LA SOCIETÀ
Émile Durkheim studiando il livello di coesione di
una società afferma che essa può sopravvivere solo se si costituisce come
comunità simbolica. Nel saggio “Le regole del metodo sociologico” afferma. «La
società non è una semplice somma di individui; al contrario, il sistema formato
dalla loro associazione rappresenta una realtà specifica dotata di caratteri
propri». Benedetto Croce negli Scritti politici avverte: «L’amore di Patria è un
concetto morale. Nel segno della Patria i nostri più nobili ideali e i nostri
più austeri doveri prendono una forma particolare e a noi più vicina, una forma
che rappresenta l’umanità tutta e attraverso alla quale si lavora effettualmente
per l’umanità tutta». Giovanni Papini in un articolo-saggio, del 1904, sul
Regno, pone l’alternativa “O la classe o la nazione”. Nella classe, spiega,
«tendono a prevalere gli interessi dei particolari, siano questi poveri, i
proletari, gli schiavi oppure i ricchi, i mercanti, gli oligarchi», nella
nazione, invece, «le singole voci tacciono, si nascondono le brame parziali e
tutte le forze, tutte le brame, tutti i voleri si protendono verso la suprema
vita armoniosa della polis». Non è possibile lo Stato senza la Nazione,
posizione che vede convergere Piero Gobetti che dalle colonne della sua
“Rivoluzione Liberale” manifesta il proposito di «venir formando una classe
politica che abbia chiara coscienza delle sue tradizioni storiche e delle
esigenze sociali nascenti dalla partecipazione del popolo alla vita dello
Stato».
IL DIBATTITO
Il dibattito su Patria e Nazione, due parole che
sembravano espunte dal lessico pubblico negli ultimi decenni, riacquistano un
doveroso valore. Di recente, perla collana “Voci”, la Treccani ha pubblicato un
saggio, dal titolo, appunto, “Nazione” dove ripropone le due voci scritte in
fasi storiche diverse. Quella pubblicata nel 1934 dal filosofo del diritto
Felice Battaglia per la parte generale e Walter Maturi perla parte storica
(Storia del principio di nazionalità). La seconda voce, cui si fa riferimento, è
quella pubblicata dallo storico Rosario Romeo nella Enciclopedia del
Novecento. Lo Stato non è solo un’entità formale ma è l’organizzazione giuridica
di una nazione che per definizione è un’entità linguistica e culturale. Da
qualche parte è circolata nella cultura politico-giuridica l’idea di poter
concepire una democrazia “agnostica”, basata su regole autonome, universali,
sganciate dalla tradizione di un popolo. Lo stesso Hans Kelsen ammette: «La
democrazia, sul piano dell’idea, è una forma di Stato o di società in cui la
volontà generale o, senza tante metafore, l’ordine sociale, vengono realizzati
da chi è a quest’ordine sociale sottomesso, cioè dal popolo. Democrazia
significa identità di governanti e governati, di soggetto e di oggetto del
potere, governo del popolo sul popolo».
Una democrazia per essere credibile deve essere
consensuale e non solo formale, si può aggiungere che è arduo concepire una
democrazia, come Sollen giuridico, puramente formale, al di fuori dei giudizi di
valore, estraneo a ogni dovere morale. Ciò significa affermare che la legge
costituzionale deve dimostrare di mantenere nel tempo una capacità di includere
l’intera comunità rispecchiandone l’identità collettiva. Il rischio è che si
realizzi una separazione tra legge e identità nazionale che finirebbe per essere
un danno alla qualità della democrazia. Non c’è democrazia e non c’è libertà
senza il contenuto storico e culturale della nazione che vi è pervenuta. Lo
Stato si fonda sull’obbedienza alla legge che si vuole imporre ai
cittadini-soci, ma affinché essa funzioni occorre che sia la più condivisa
possibile e questa condivisione della necessità e dei modi dell’organizzazione
statuale non può poggiare solo su un dato giuridico, deve accompagnarsi a valori
morali condivisi. Di qui il passaggio logico ci conduce alla nazione, entità
aperta a tutti a patto che i nuovi cittadini ne condividano le fondamenta perché
«la storia delle origini dei popoli è, per i costruttori di sistemi, ciò che è
la tavolozza per il pittore». L’affermazione della nazionalità significa un
processo storico di rinvenimento dell’idem sentire comune di un popolo, la
capacità di aggregare quella comunanza divalori, lingua parlata e scritta,
religione, consuetudine che è nella tradizione. Se Giambattista Vico parlava del
sensus dei popoli, Federico Chabod, partigiano e dirigente del CLN, precisa:
«Dire senso di nazionalità, significa dire senso di individualità storica. Si
giunge al principio di nazione in quanto si giunge ad affermare il principio di
individualità, cioè ad affermare, contro tendenze generalizzatrici e
universalizzanti, il principio del particolare, del singolo».
LA MODERNITÀ
La modernità va vissuta senza omettere la
trasmissione della memoria, come in Eliot la nazione non è una mera nostalgia,
ma una tradizione genuina coniugata col vivere contemporaneo. Augusto Del Noce
in un suo celebre saggio conia il termine “transpolitico” per indicare una
dimensione profonda che si sedimenta nella coscienza dei popoli. La democrazia
costituisce il più elevato risultato della storia dell’Occidente, ma non si può
definire la stessa nozione di democrazia se si prescinde dalla storia
occidentale, dal travaglio secolare che ci ha condotti a definire la forma
politica più vicina alla libertà. Alexis de Toqueville ha chiara questa
proposizione quando scrive: «Le leggi sono sempre vacillanti fintanto che non
poggiano sui costumi». Le società occidentali, per secoli si sono alimentate
della concezione greca e romana della res pubblica, si sono nutrite di un’idea
classica che fonda insieme i valori di libertas e virtus, capaci di delimitare
un recinto identitario che esalta il valore degli individui nella comunità,
definendo quello che Giambattista Vico chiama l’idem sentire comune. E per
questo che Osvald Spengler ne Il tramonto dell’Occidente (Der Untergang des
Abendlandes), proponendo un’idea faustiana dell’Europa, culla della civiltà,
rinviene il tratto della decadenza nel cosmopolitismo che è «l’opposto della
vita». Un tema che affascina un intenso intellettuale come Antonio Gramsci che
corregge il maxismo classico aprendo al popolo-nazione richiamando il rispetto
della volontà collettiva di una nazione.
LA GLOBALIZZAZIONE
La
globalizzazione, forse, è un dato ontologico del nostro tempo ma occorre
distinguere fra una dimensione globale positiva, dove le pluralità con le loro
diversità e le loro tipicità si incontrano e si migliorano, e la
“globalizzazione sinistra” prevaricazione di un modello totalizzante e
interessato sugli altri. «Le decisioni stanno migrando dallo spazio tradizionale
della democrazia», è questo il monito che all’inizio del nostro secolo è stato
lanciato da Ralf Dahrendorf, aggiungendo che la democrazia non fosse applicabile
«al di fuori dello Stato-Nazione, ai molti livelli internazionali o
multinazionali in cui si forma oggi la decisione politica». Da una prospettiva
diversa, un altro autore britannico, il filosofo Roger Scruton, ha scritto che
le «democrazie devono la loro esistenza alla fedeltà nazionale», perché laddove
«l’esperienza di nazionalità sia debole o inesistente, la democrazia ha mancato
di attecchire».
La gaffe durante la visita negli Usa. Video.
Gaffe della sovranista Giorgia Meloni che non conosce il significato dei tre
colori della bandiera italiana. Redazione su Il Riformista il 28 Luglio 2023
La premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato
al Campidoglio i vertici del Senato statunitense durante la sua visita
istituzionale a Washington, prima del colloquio con il presidente degli Stati
Uniti Joe Biden. Presenti il leader della maggioranza Chuck Schumer, il leader
della minoranza Mitch McConnell e altri legislatori. Durante un saluto con i
giornalisti per le tradizionali fotografie di gruppo, Schumer ha chiesto alla
presidente del Consiglio italiano se potesse illustrargli il significato dei tre
colori della bandiera italiana, senza ricevere una risposta molto convinta.
La Premier, dunque, notoriamente sovranista, capo
di un partito che nel simbolo contiene i colori della bandiera italiana, pare
incerta nel fornire una risposta. Una gaffe, insomma.
La bandiera italiana, nota come il “Tricolore“, è
composta da tre bande verticali di uguale dimensione nei colori verde, bianco e
rosso. La bandiera italiana ha le sue radici nella Rivoluzione francese e nelle
idee di libertà e uguaglianza. Il significato esatto dei colori non è definito
ufficialmente e c’è qualche dibattito a riguardo. Alcune interpretazioni
includono:
1. Verde: rappresenta le pianure e le colline
italiane.
2. Bianco: rappresenta le Alpi coperte di neve.
3. Rosso: rappresenta il sangue versato per
l’indipendenza dell’Italia.
Un’altra interpretazione popolare è quella
religiosa, con il verde che rappresenta la speranza, il bianco la fede e il
rosso la carità.
Infine, alcuni sostengono che i colori siano
legati a Napoleone Bonaparte, poiché la bandiera della Repubblica Cisalpina,
un’entità statale creata da Napoleone, aveva i stessi colori. Tuttavia, questa
interpretazione non è universalmente accettata.
Un bel “paradosso sovranista“, insomma, come fa
notare il senatore Enrico Borghi, presidente del gruppo Azione-Iv-Renew Europe,
su Twitter.
Mafiosi.
Estratto dell’articolo di Aldo Sarullo* per
il “Fatto Quotidiano” il 9 Dicembre 2023
[...] la prova logica di una parte delle sorti
della borsa. Ce le raccontano le foto scattate da Luigi Sarullo, ce le racconta
la borsa.
Da essa sappiamo che non era con il Procuratore al
momento dell’esplosione. Infatti Borsellino ne fu smembrato, la borsa, invece,
ebbe conseguenze molto minori perché era all’interno dell’auto, poggiata su un
sedile. Le foto testimoniano che rimase bruciacchiata nella parte anteriore e
intatta, proprio intatta, nel retro e all’interno.
Da ciò si deduce che il suo contenuto rimase
integro e se vi era anche l’agenda rossa, questa non subì danni. I magistrati di
Caltanissetta conoscono bene la borsa. Per analizzarla se la fecero consegnare,
molti anni dopo, dal braccio destro di Borsellino, cioè l’allora maresciallo
Carmelo Canale oggi colonnello, che la custodisce in una teca, dopo averla
ricevuta in dono dalla famiglia del magistrato.
Ai Borsellino la valigetta venne consegnata da
Arnaldo La Barbera, l’allora capo della Mobile di Palermo, alcuni mesi dopo la
strage. All’interno della borsa – secondo il verbale di apertura della Procura
di Caltanissetta, datato 5 novembre 1992 – c’erano due pacchetti di sigarette,
un costume, un paio di pantaloncini da tennis, un crest dei carabinieri. Alla
famiglia vennero consegnati anche un paio d’occhiali, un mazzo di chiavi e
un’agenda telefonica marrone. Nella borsa, però, non c’era quella rossa, come
fece notare Lucia Borsellino a La Barbera.
“Quando chiesi che fine avesse fatto, mi fu
risposto appunto che non c’era e al mio insistere il questore La Barbera disse a
mia madre che io probabilmente avevo bisogno di un supporto psicologico perché
ero molto provata. Mi fu detto addirittura che deliravo”, ha raccontato la
figlia del giudice al processo.
*scrittore e regista, ex consulente culturale
della presidenza del Senato e del Comune di Palermo.
Trattativa Stato-mafia: i parenti delle vittime
contro i giudici. Stefano Baudino su L'Indipendente il 9 Dicembre 2023.
Con un comunicato durissimo, l’associazione dei
familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili – attentato avvenuto
a Firenze il 27 maggio 1993 ed eseguito da Cosa Nostra come tassello della
campagna stragista del biennio ’92-’94, che provocò 5 morti– ha reagito alle
motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha chiuso il processo sulla
“Trattativa Stato-mafia”, assolvendo gli uomini dello Stato che erano finiti
alla sbarra, ovvero gli allora vertici del Ros dei Carabinieri Antonio Subranni,
Mario Mori e Giuseppe De Donno e l’ex senatore di Forza Italia Marcello
Dell’Utri. Senza mezzi termini, l’associazione ha definito “antigiuridica per
violazione di legge”, “manifestamente illogica”, “totalmente mancante di
motivazione sui punti determinanti” e “immorale” la decisione della Suprema
Corte. Quest’ultima, dopo una sentenza di primo grado caratterizzata da ingenti
condanne e una di appello che aveva assolto i Ros “perché il fatto non
costituisce reato”, ha chiuso il processo assolvendo i membri dello Stato “per
non aver commesso il fatto” e prescrivendo i vertici mafiosi imputati con loro
per “violenza o minaccia a corpo politico dello Stato”, dopo aver derubricato il
reato in “minaccia tentata”. I familiari delle vittime della strage di Firenze
ricordano non solo che la “Trattativa” è stata confermata da moltissime
sentenze, ma anche che pronunce da anni definitive hanno attestato che fu
proprio l’invito al dialogo lanciato dal Ros a Cosa Nostra il “precedente
fattuale causale” delle stragi del ’93.
I familiari delle vittime della strage di via dei
Georgofili definiscono “antigiuridica” la pronuncia degli ermellini poiché,
mentre “per costante e assoluto insegnamento della Cassazione questa è solo
giudice di legittimità”, tale sentenza “è entrata pesantemente nel
fatto-reato dicendo che per lei non c’è reato consumato ma solo tentato” e non
rinviando “per nuovo esame” ad altra sezione di Corte di Appello di Palermo, ma
annullando senza rinvio la sentenza di secondo grado. La decisione è poi
ritenuta “manifestamente illogica” quando si scrive che la “interlocuzione
Ros-vertici mafia” – mediata dall’ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino
– non ha avuto nessuna conseguenza, “omettendo totalmente di valutare la vicenda
del ‘papello‘ (insieme di richieste mosse allo Stato dall’allora capo di Cosa
Nostra Totò Riina in cambio della fine delle violenze, ndr) e di tutti i
testimoni e collaboratori di giustizia che hanno affermato che questa
‘interlocuzione’ ha rafforzato la volontà stragista di Riina e sodali”, come
“attestato e confermato” da varie sentenze. Ed effettivamente, per averne
contezza, basta leggere la pronuncia di appello, poi passata in giudicato, al
processo “Tagliavia” sulla strage di Firenze (2016), in cui i giudici
hanno considerato provato che, in seguito alla prima fase della trattativa, che
si arenò dopo la strage di via D’Amelio, “la strategia stragista proseguì
alimentata dalla convinzione che lo Stato avrebbe compreso la natura
dell’obiettivo del ricatto proprio perché vi era stata quella interruzione”. Già
nel 1998, i giudici della Corte d’Assise di Firenze che si esprimevano sulla
strage di via dei Georgofili avevano scritto che l’effetto che la trattativa
ebbe sui capi mafiosi “fu quello di convincerli, definitivamente, che la strage
era idonea a portare vantaggi all’organizzazione”.
Nelle sue motivazioni, al processo “Trattativa” la
Cassazione ha sancito che “l’interlocuzione promossa da Mori e da De Donno con
Ciancimino” era “volta a comprendere le condizioni per la cessazione degli
omicidi e delle stragi da parte di Cosa Nostra e la ricerca dell’apertura di un
dialogo, sia pure con una spietata organizzazione criminale, non può assumere la
valenza obiettiva, sulla base di un inammissibile automatismo probatorio, di
una istigazione a minacciare lo Stato”, pur ricordando che quella del Ros fu
“molto di più che una spregiudicata iniziativa di polizia giudiziaria, assumendo
piuttosto la connotazione di un’operazione di intelligence”. Secondo la Suprema
Corte, insomma “l’apertura dell’interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra” non
può “essere considerata quale forma di rafforzamento dell’altrui proposito
criminoso, in quanto ha solo creato l’occasione nella quale ha trovato
realizzazione l’autonomo intento ricattatorio dei vertici di Cosa Nostra”.
L’associazione dei parenti delle vittime della
strage di Firenze, però, non ci sta e alza il tiro della critica affermando che
la sentenza sia “antigiuridica, illogica e immorale” ove viene scritto che “’la
mera interlocuzione tra i vertici ROS e vertici mafia non è penalmente
punibile”, poiché la Corte ometterebbe di valutare come Mario Mori sia “un
ufficiale di P.G. che deve operare sotto la direzione e autorizzazione del
Pubblico Ministero, e che poi ha sempre l’obbligo di redigere il rapporto di
P.G. al giudice”, tutte “attività legali e obbligatorie omesse da Mori”. I
familiari delle vittime fiorentine giudicano inoltre “totalmente falso” quanto
attestato dalla sentenza quando dice che il Ros “si è limitato ad ascoltare”.
Infatti, afferma l’associazione, “fu il Ros a cercare Ciancimino e a chiedere
cosa volevano in cambio di cessare le stragi” e “fu lo stesso Mori” a parlare di
“trattativa”. Chiudendo la nota, l’associazione ricorda come “74 Giudici Penali
nel corso di 24 anni hanno accertato e statuito in sentenze penali” che la
Trattativa Ros-mafia “è un fatto storico certo e indiscutibile”, denunciando
che, a loro avviso, la pronuncia della Cassazione costituisca “una sentenza
solamente ‘politica’, emessa in nome della ragion di Stato, che non scalfisce la
verità storica di quanto avvenuto”.
Sull’esistenza e i deleteri effetti della
trattativa Stato-mafia si erano già soffermati, in un comunicato congiunto
uscito il giorno successivo alla pubblicazione del verdetto della Suprema Corte,
i parenti delle vittime di mafia Salvatore Borsellino, Roberta Gatani, Paola
Caccia, Angela Manca e Stefano Mormile, che avevano ricordato come “la
trattativa tra esponenti apicali del Ros dei Carabinieri e soggetti appartenenti
alla mafia corleonese (Vito Ciancimino)” sia stata ammessa in aula “dagli stessi
autori, oggi santificati, Mori e De Donno” e che la Cassazione “ha ‘soltanto’
stabilito che le azioni portate avanti con quella trattativa non integravano il
reato ex. art. 338, ‘minaccia a corpo politico dello Stato’”. “No, non
chiederemo scusa a quegli imputati – hanno aggiunto gli autori della nota – ma,
certamente, non finiremo mai di ringraziare Nino Di Matteo e gli altri pm del
pool di Palermo, che non hanno avuto paura di indagare alcune tra le persone più
potenti d’Italia, incuranti delle prevedibili, e puntualmente avvenute,
ritorsioni di certa stampa e di certa politica”.
[di Stefano Baudino]
«Punire gli innocenti è giusto», l’Italia
difende gli abusi antimafia davanti alla Cedu. L’Avvocatura dello Stato ha
trasmesso alla Corte europea dei Diritti umani, lo scorso 30 novembre, le
risposte ai quesiti posti dai giudici di Strasburgo nell’ambito del ricorso
proposto dai Cavallotti, gli imprenditori che, pur assolti dalle accuse di
mafia, hanno visto confiscati tutti i loro beni. Nelle argomentazioni italiane
viene rivendicato un principio abominevole. Errico Novi su Il Dubbio il 7
dicembre 2023
In limine mortis. Il 30 novembre lo Stato
italiano, attraverso la propria Avvocatura, ha risposto ai quesiti della Corte
di Strasburgo relativi agli abusi antimafia. Vogliamo essere precisi: la replica
riguarda una causa, generata dal ricorso (numero 29614/16) dei fratelli
Cavallotti alla Cedu. E ancora più precisamente: lo Stato italiano era stato
chiamato dai giudici europei a spiegare, nell’ambito della causa, se la confisca
ai danni di Salvatore Vito, Gaetano e Vincenzo Cavallotti fosse compatibile con
la presunzione d’innocenza, considerato che quella spoliazione era stata
inflitta nonostante i tre imprenditori palermitani fossero stati assolti con
formula piena, nel processo penale, dall’accusa di 416 bis.
In limine mortis, si è detto. In due sensi. Primo:
il 30 novembre era l’ultimo giorno che lo Stato italiano aveva a disposizione
per replicare agli interrogativi rivoltigli, in seguito al ricorso, dal giudice
europeo, dopo che l’Avvocatura di Roma aveva chiesto di prorogare il termine
iniziale del 13 novembre. Secondo: in limine mortis anche nel senso che la
fragilità delle risposte esibite dallo Stato italiano lascia intravede un esito
favorevole ai ricorrenti e, forse, la “morte”, l’inizio delle fine, per un
sistema indegno. In virtù dell’eccezionalismo antimafia, quel sistema punisce,
con spregio del diritto, le persone innocenti. Forse la possibile vittoria dei
Cavallotti nella causa contro lo Stato, la possibile affermazione, da parte
della Cedu, del principio per cui i tre fratelli di Belmonte Mezzagno,
dichiarati pienamente innocenti nel processo penale, non avrebbero dovuto vedere
i loro beni confiscati, travolgerà l’intero abominio delle confische far west. E
forse la pronuncia europea interverrà prima ancora che il Parlamento italiano
arrivi ad approvare la legge concepita con lo stesso fine – salvare gli
innocenti – e messa in calendario a Montecitorio su iniziativa di Forza Italia.
Ma quel che potrà accadere tra qualche mese,
quando la Corte di Strasburgo emetterà la propria sentenza sul ricorso
Cavallotti, resta ovviamente materia per aruspici. Qui interessa altro. E
cioè il modo, le argomentazioni con cui l’Avvocatura dello Stato difende gli
abusi dell’Antimafia. Argomentazioni che, come detto, sono fragili. Seppure
legato alla necessità di motivare scelte compiute da altri (prima dal
legislatore e quindi dai singoli magistrati), il filo logico proposto
dall’Italia dinanzi ai giudici europei è al limite della provocazione
intellettuale.
COSÌ LO STATO HA DIFESO GLI ABUSI DELL’ANTIMAFIA
Di fatto, l’Avvocatura dello Stato ha difeso il
principio per cui una persona innocente andrebbe spogliata di tutto perché
divenuta vittima dell’estorsione mafiosa. Una sorta di scenario da
Superfantozzi: i Cavallotti hanno visto i loro beni confiscati (con la decisione
resa definitiva dalla Cassazione il 12 novembre 2015, sentenza numero 4305)
perché avevano pagato il pizzo a Bernardo Provenzano e al capomandamento di
Belmonte Mezzagno. Prima sono stati spremuti da Cosa nostra e poi, in virtù di
questo, depredati di ogni cosa dallo Stato. Incredibile.
È incredibile che lo Stato italiano, pur con le
argomentazioni sofisticate dei propri avvocati, difenda un principio così
abnorme. Forse è un’autodenuncia che prepara il ravvedimento operoso in arrivo
con la riforma del Parlamento. Fatto sta che la difesa dei fratelli Cavallotti
avrà tempo fino al 18 gennaio prossimo per controdedurre le argomentazioni
dell’Avvocatura pubblica. Poi toccherà alla Corte europea dei Diritti umani.
Gli interrogativi rivolti da Strasburgo erano tre.
Il primo è decisivo. In sintesi, la Corte europea dei Diritti dell’uomo ha
voluto chiedere all’Italia, prima di emettere la sentenza, se ritenga
compatibile con la presunzione d’innocenza una confisca inflitta a persone già
precedentemente assolte, per gli stessi fatti, in un processo penale. Ebbene,
l’Avvocatura dello Stato ha replicato che sì, la presunzione d’innocenza non è
affatto contraddetta, perché le misure di prevenzione, dunque pure le confische
ai Cavallotti, non sono inflitte in virtù di un reato, cioè per la sussistenza
dell’associazione mafiosa. Derivano piuttosto da quella che nella memoria
dell’Avvocatura è qualificata come «appartenenza» o anche «contiguità
funzionale». Circostanza che non è reato, non poteva dunque essere oggetto di un
processo, e quindi non se ne può essere “innocenti”.
Un dribbling alla Garrincha, o un sofismo alla
Protagora, se preferite: in termini più brutali, un artifizio dialettico. Con
una sfumatura ai limiti del sadismo: perché quel concetto di «appartenenza»,
poco più avanti nella memoria dello Stato italiano, si sostanzia in termini di
assoggettamento alle prevaricazioni di Cosa nostra, cioè all’imposizione del
pizzo mafioso. Nello sviluppo delle memoria, gli avvocati dello Stato ricordano
i pizzini di Bernardo Provenzano, le rimembranze di Giovanni Brusca, le
testimonianze di Angelo Siino al processo penale che ha visto assolti i
Cavallotti: tutti passaggi in cui si invoca la “messa a posto”, cioè la
spremitura, delle aziende poi confiscate agli imprenditori palermitani,
all’epoca (seconda metà degli anni Novanta) veri leader non solo siciliani nel
settore della metanizzazione. In alcun modo l’Avvocatura ha potuto sottoporre
alla Corte dei Diritti dell’uomo elementi che attestassero un’appartenenza dei
Cavallotti alla mafia, né in termini di «partecipazione» e neppure in quanto
strumento con cui i boss realizzavano i loro affari. Semplicemente, emerge
l’esazione del pizzo ai danni dei tre fratelli. Non a caso assolti, per gli
stessi identici fatti richiamati dall’Avvocatura dello Stato, con formula piena
nel processo penale il 4 febbraio 2016.
E qui il (corto) circuito logico dell’Avvocatura
prova a chiudersi: la «confisca preventiva», si afferma, non è «punitiva» ma
«preventiva e riparatoria». Quindi: sono innocenti, e non potevamo
punirli. Perché per lo Stato italiano, privare tre imprenditori dei loro beni,
delle loro aziende, financo della casa in cui abitavano, è servito a evitare che
la mafia potesse approfittarsi di loro, ma non è una punizione, no, per
carità. Ecco il sofisma con cui ci siamo presentati alla Corte dei Diritti
umani. Che dovrà decidere se, a furia di giocare con le parole, l’Italia non
abbia giocato con la dignità.
PQM - Il calvario di una famiglia di
imprenditori. Cavallotti, una tragedia da raccontare nelle scuole: quando mafia
e giudici rovinano un impero. A cura di: M.V. Ambrosone, M. Caiazza, L.
Finiti su Il Riformista il 10 Dicembre 2023
I fratelli Cavallotti, accusati di aver sostenuto
e fiancheggiato il sodalizio criminoso del boss Provenzano e ristretti in
carcere per oltre due anni e mezzo, hanno dovuto attendere dodici anni per veder
riconosciuta la propria innocenza.
Le dichiarazioni dei pentiti che accusavano i
Cavallotti sono risultate non credibili, generiche, non riscontrate e smentite.
Gli imprenditori Cavallotti sono stati
riconosciuti come vittime. Non complici, ma «costretti a subire la mafia». È
stata dimostrata, secondo i giudici della sentenza definitiva, «la soggezione
delle imprese dei Cavallotti alla pressione estorsiva».
Si è ribaltato così il percorso argomentativo –
tanto semplice quanto sconcertante – seguito dalla Corte di Appello che per
prima si era pronunciata sugli stessi fatti: «Anche ammesso che l’imprenditore
non potesse lavorare senza quel patto [il pagamento del pizzo, ndr], nessuno lo
obbligava a non cambiare mestiere».
Cavallotti, la mafia e la condanna perché “nessuno
li obbligava a non cambiare mestiere”
Nessuno lo obbligava a non cambiare mestiere.
Queste le parole utilizzate dalla Corte di Palermo per condannare gli
imprenditori siciliani per il reato di associazione mafiosa. La colpa dei
Cavallotti: non aver saputo frapporsi e reagire a un sistema che neppure lo
Stato riesce a combattere.
Da una simile accusa la famiglia siciliana ha
potuto affrancarsi solo molti anni dopo, quando la Cassazione ha valutato che
alla base di quelle sorprendenti affermazioni vi fossero “gravi lacune logiche e
giuridiche” e “un giudizio cumulativo e generalizzato, seguendo il noto detto di
fare di tutt’erba un fascio”. E così ha richiesto un nuovo giudizio, quello che
ha portato – non senza fatica – alla definiva assoluzione da ogni accusa nel
2010.
Cavallotti assolti ma con i beni confiscati
Nel 2011, però, nonostante l’assoluzione, i
fratelli Cavallotti si sono visti definitivamente confiscare l’intero
patrimonio, aziendale e personale.
È il processo di prevenzione, che corre su un
binario parallelo al procedimento penale. Un sistema volto a prevenire la
criminalità, in specie quella organizzata, con misure personali e patrimoniali
su chi viene individuato come soggetto socialmente pericoloso e dunque potrebbe
commettere reati.
È un procedimento autonomo, cui non interessano le
assoluzioni per legittimare l’azione preventiva e dove il sospetto prevale sulla
prova.
E allora, poiché i Cavallotti non hanno dimostrato
il recesso da un’associazione (di cui mai hanno fatto parte, come accertato
dalla sentenza di assoluzione definitiva), sono soggetti pericolosi.
Poiché non si sono pentiti, sono soggetti
pericolosi.
Poiché non hanno intrapreso “un responsabile
percorso di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria”, si sono accreditati come
“soggetti pienamente affidabili” nei confronti della mafia.
Ma di cosa si sarebbero dovuti pentire ed in che
termini avrebbero dovuto o potuto collaborare, se sono stati assolti da ogni
accusa?
Il Tribunale di Prevenzione di Palermo ha disposto
la confisca sulla base di quegli indizi ritenuti, nel parallelo processo penale,
talmente inconsistenti da portare all’assoluzione. Risuonano, così, ancor più
ingiuste le parole usate dai giudici per fondare la condanna (poi ribaltata):
potevano cambiare mestiere.
La confisca è stata confermata anche da un
incredibile provvedimento della Cassazione dove si legge che, nonostante la
sentenza di assoluzione abbia accertato l’assenza di ogni collegamento tra i
Cavallotti e la mafia, residuerebbe una non meglio specificata “realtà di
fondo”, una “vicinanza dei Cavallotti, risalente agli anni ‘80, ai vertici di
Cosa Nostra”.
E così, mentre un giudice penale nel 2010
escludeva ogni collegamento della famiglia con la mafia, se non quale vittima di
quest’ultima, per i giudici della prevenzione nel 2015 quella stessa famiglia
aveva fatto crescere negli anni la propria realtà imprenditoriale grazie
all’appoggio di Cosa Nostra.
Oggi, 2023, anche l’onta del processo di
prevenzione è stata finalmente rimossa.
Le accuse infamanti sono cadute con
l’annullamento, disposto dalla Suprema Corte, di tutti i provvedimenti di
sequestro emessi nei confronti della famiglia Cavallotti.
Nell’attesa di questo riconoscimento, però, la
famiglia non ha potuto esercitare l’attività imprenditoriale che la aveva resa
leader del settore, tanto da assicurare ai suoi membri l’appellativo di “re del
metano”.
Al termine del lungo periodo di amministrazione
giudiziaria, ed a seguito della restituzione alla famiglia dei complessi
aziendali, i Cavallotti si sono trovati di fronte a realtà ormai inoperose e ad
aziende abbandonate o poste in liquidazione. Molti fornitori non sono stati
pagati e la maggior parte dei dipendenti ha perso il posto di lavoro.
La famiglia ha chiesto alla Corte Europea per i
diritti dell’uomo di pronunciarsi. E per tutta risposta, è la CEDU ad aver
chiesto all’Italia di motivare l’esistenza di un sistema che contrasta con i
nostri principi fondamentali: la presunzione di innocenza, la proporzionalità
delle sanzioni e la necessarietà delle stesse.
Nel frattempo, restano le macerie di quello che
era un tempo un impero. E allora, forse, conveniva davvero cambiare mestiere.
Misure di prevenzione: quell’inspiegabile distanza
tra diritto e buon senso (di Giuseppe Belcastro, avvocato)
Quella delle misure di prevenzione, più che una
galassia, è una nebulosa, sfumata nei contorni operativi e affidata nei giudizi
a costruzioni logiche e giuridiche nient’affatto serrate. Un luogo
processualmente pericoloso, in cui il rischio dell’errore, più in agguato che
altrove e foriero di conseguenze devastanti, fa tremare le vene ai polsi proprio
a chi col malaffare non ha a che spartire.
Il caso di cui ci occupiamo è emblematico. È un
caso, quello dei Cavallotti, che porta sul volto molte delle drammatiche
contraddizioni del sistema delle misure di prevenzione, ma che ne dimostra
plasticamente una in particolare, essenziale, grottesca e incomprensibile al di
fuori dell’iperuranio ove a volte si collocano le cose della giustizia: la
potenziale impermeabilità del procedimento di prevenzione agli esiti del
giudizio di merito, la quale fa sì, per esser chiari, che, assolto dalle accuse
di un delitto, un soggetto possa vedersi confiscato, per rarefatte contiguità
col malaffare, l’intero patrimonio.
Mettiamola così: c’è una quota della tecnicità del
diritto, non lo si può negare, che non è riducibile. Essa ne misura la distanza
dalla vita comune e racconta che non tutto ciò che accade in aula è traducibile
nella lingua dei non addetti ai lavori. Ma c’è anche un limite di ragionevolezza
a quella distanza e quando diventa impossibile spiegare sufficientemente fuori
dall’aula ciò che è appena accaduto dentro, ognuno che col diritto abbia a che
fare ha il dovere di interrogarsi se quella distanza tra la vicenda giudiziaria
e la vita, tra il senso giuridico e il buon senso, non indichi una frattura nel
legame imprescindibile tra la regola e il suo scopo.
Ecco, se si deve sintetizzare la vicenda dei
Cavallotti, non vi è forse miglior esempio che additare la irredimibile
irragionevolezza di essere assolti in un’aula e spogliati d’ogni cosa in quella
a fianco.
È un problema che investe la sostanza di un
fenomeno, impattando i cardini stessi dell’ordinamento liberale come dimostra il
fatto che, nell’estate di quest’anno, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
adita dalla famiglia Cavallotti nel 2016, abbia formulato al Governo italiano,
tra pochi e semplici quesiti, quello di valutare in concreto se l’applicazione
di una misura di prevenzione nel caso di assoluzione non sia violativa della
presunzione di innocenza garantita dalla Convenzione europea, oltre che dalla
Costituzione italiana.
Pochi e semplici i quesiti, non così, a prima
vista, le risposte del Governo che, sul filo della proroga ottenuta per
rispondere (mentre scriviamo ne giunge notizia), ha depositato in zona Cesarini
le sue osservazioni compendiandole in un atto di ben 122 pagine.
Sarà doveroso e assai interessante leggere il
documento, la cui corposità non consente un commento immediato, mentre già
denota una qualche difficoltà argomentativa; e sarà costruttivo prendere atto di
come si sia provato a spiegare, a una giurisdizione che parla una lingua piana e
diretta, la sottile complessità di una giurisprudenza che, caso forse unico,
distingue partecipazione (participation) e appartenenza (membership)
all’associazione mafiosa e che anche sulla base di questa sofistica(ta)
distinzione ha spogliato degli innocenti di un intero patrimonio, rimproverando
loro di non essersi dissociati da ciò a cui quella stessa giurisprudenza aveva
altrove accertato non avevano nemmeno mai aderito. A cura di: M.V. Ambrosone, M.
Caiazza, L. Finiti
Italiani = Mafia. Davvero all’estero ci
vedono ancora così? Un manifesto esposto in un ateneo americano per
pubblicizzare esperienze di studio nel nostro Paese associa cultura, storia
e…mafia. Costringendoci a porci, ancora oggi, qualche domanda sulla nostra
immagine all’estero. Dario Murri il 18 Novembre 2023 su Il Giornale.
Tabella dei contenuti
Retaggio “appiccicoso”
Quella pesante “leggerezza”
Non sarà anche un po’ “colpa” nostra?
In questi giorni, in alcune bacheche della
statunitense North Dakota State University, a Fargo, campeggia un manifesto che
pubblicizza viaggi di studio in Italia in programma per l’estate 2024 con il
seguente e “attrattivo” slogan: “Italy, History, Culture, Mafia”. Ora, se
l’iniziativa è interessante e ben articolata (ho visitato sia il sito
dell’università che quello dell’operatore che la propone), resta l’amaro in
bocca per il cattivo gusto con cui si è scelto di pubblicizzarla. Anche se va
detto che nel proporre i vari pacchetti, Italia e Italian way of life vengono
descritti in termini più che positivi… Quindi, dove e perché è avvenuto questo
corto circuito? Sarebbe interessante scoprirlo.
Al di là del fastidio, e della legittima curiosità
su quale “genio delle comunicazione” abbia partorito un’idea simile, viene da
chiedersi se si tratti di mera ignoranza, o piuttosto della reale persistenza,
nella mentalità di buona parte dei cittadini statunitensi (anche di un certo
livello culturale, visto che il manifesto è esposto in un ateneo), di una
rappresentazione dell’italiano legata a clichè e stereotipi alquanto datati
(pizza, mafia e mandolino…), ancora difficili, per noi, da scrollarsi di dosso.
Eppure succede ancora, nel 2024.
Retaggio “appiccicoso”
Intendiamoci, sappiamo bene che, nonostante
l’impegno quotidiano dello Stato e dei suoi rappresentanti su tale fronte,
le associazioni criminali (che si chiamino mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra
corona unita, o altro) sono tuttora presenti nel tessuto sociale e
produttivo del Paese, anche se si sono “evolute”, diventando più “tecnologiche”
e difficili da eradicare. In questo caso, però, si tratta di qualcosa di
diverso: si tratta di un’immagine dell’italiano, che se, forse, ancora presente
nell’affresco tracciato da Francis Ford Coppola con la trilogia de Il Padrino, o
raccontata da Sergio Leone in a C’era Una Volta in America, o ancora in The
Sopranos, celeberrima serie tv, non dovrebbe più essere presa come riferimento.
Ancora più lontana, poi, dai personaggi caricaturali portati con successo sul
grande schermo da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con film come I due mafiosi,
del 1964. Altri tempi.
Allora, perché assistiamo ancora a episodi di
questo genere? Non dimentichiamo che nel recente passato nemmeno i cugini
francesi, insieme con i tedeschi, ci hanno risparmiato episodi parodistici,
anche pesanti e di altrettanto cattivo gusto (come il bruttissimo video di Canal
Plus con il pizzaiolo italiano, diffuso a inizio pandemia, di cui risparmio i
dettagli), a stigmatizzare eventi o situazioni legate, secondo loro, all’Italia.
Dobbiamo quindi “rassegnarci”? O non è forse il caso di interrogarsi sulle
ragioni di questo appiccicoso retaggio?
Se da un lato noi italiani veniamo ammirati
all’estero per il nostro valore di professionisti, ricercatori, creativi,
portatori di un bagaglio storico, artistico e culturale unico, di uno stile
altrettanto unico e inconfondibile, nella moda come nel design, nel cibo e nel
settore automobilistico, dall’altro c’è ancora chi, ignorando tutto questo,
ripropone ancora la vecchia equazione italiano = mafioso.
Quella pesante “leggerezza”
Siamo abbastanza certi che il manifesto citato in
apertura non avesse intenti dispregiativi (il che non rende la scelta meno
inopportuna), ma che faccia comunque parte di un certo modo di intendere il
termine “mafia”, dissociandolo da ciò che realmente rappresenta, cioè
un’associazione criminale. Diversamente, non si spiegherebbe come mai l’elenco
di locali, siti web, prodotti e addirittura libri che utilizzano tale termine in
maniera impropria, soprattutto all’estero, sia decisamente lungo.
Solo alcuni esempi: se il sugo americano Wicked
Cosa Nostra o il sito di cucina mamamafiosa, sono scomparsi, altri, come il
libro Cooking The Mafia, sono ancora presenti e in commercio. Ancora: in
Germania mafia pie è il termine spesso utilizzato per la pizza e in Spagna molti
ristoranti del franchising spagnolo La Mafia se sienta a la mesa (la mafia si
siede a tavola) hanno mantenuto questo nome, nonostante nel 2019 la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea avesse sancito che non si potesse utilizzare il
marchio perché, recitava la sentenza, “banalizza l’organizzazione criminale
italiana” ed è “contrario all’ordine pubblico”. Per non parlare di App di giochi
per smartphone con titoli come Cooking Mafia Express.
Non sarà anche un po’ “colpa” nostra?
Non sarà che il voler “marciare”, a volte anche in
maniera ingenua e inconsapevole, proprio su certi stereotipi, quando non la loro
sottovalutazione, finiscano per legittimarli nell’immaginario altrui come ancora
attuali, se non, addirittura, come valori? Mi spiego meglio: su diverse
piattaforme di vendita online (non necessariamente italiane), così come nei
mercati di alcune città italiane, si trovano in vendita magliette con la scritta
“Mafia”, declinata in vari modi, o con l’immagine di Marlon Brando nel ruolo
di Don Vito Corleone ne Il Padrino (cui per fortuna fanno da contrappunto quelle
con le figure di Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino), e non si tratta
dell’omaggio di cinefili. Parlare di goliardia sarebbe riduttivo. Vale per
questi, ma il discorso si potrebbe estendere, naturalmente, anche ad altri
termini o simboli.
Chissà cosa direbbe Maurizio Costanzo, che circa
trent’anni fa, in una puntata del suo show, durante una storica maratona
Rai-Fininvest, diede fuoco proprio ad una maglietta simile, con la scritta
"Mafia made in Italy", alla presenza di Giovanni Falcone.
Qualcuno potrà obiettare che l’accostamento sia
esagerato, ma il punto è che “riducendo” certi fenomeni a “souvenir” o a mero
folclore, scherzandoci anche su, o romanticizzandoli, si rischia di perdere la
reale consapevolezza del loro significato, del loro legame con una realtà
tutt'altro che positiva, e di rafforzare certi stereotipi sugli italiani davvero
duri a morire. Forse varrebbe la pena di avviare una riflessione sull'argomento.
Di questi tempi, varcare il confine tra ironia ed esaltazione, è un attimo.
Insabbiatori.
Agnese Moro: “Gli ex Br sono diventati amici
difficili e preziosi”. Primo ad applaudire Bonisoli, l’ex terrorista che
partecipò al rapimento. Michela Bompani su La Repubblica l'11 Dicembre 2023
La figlia dello statista ucciso ha ricevuto il
premio Primo Levi per il suo impegno nella “giustizia riparativa”
«Non si ripara l’irreparabile, ma abbiamo
attraversato insieme i nostri inferni, io e i miei amici difficili e
improbabili, i miei amici preziosi»: Agnese Moro parla di chi ha ucciso suo
padre, Aldo Moro, 45 anni fa, nel silenzio assoluto del Salone del Maggior
Consiglio di Palazzo Ducale, a Genova, ieri sera, dopo aver ricevuto dalle mani
del sindaco Marco Bucci il Premio internazionale Primo Levi, istituito da Piero
Dello Strologo presidente del Centro Culturale Primo Levi di Genova nel 1992, e
assegnato ad Agnese Moro per il suo impegno nella “giustizia riparativa”.
E il primo ad alzarsi in piedi, il primo di tutti,
poi seguito da tutta la sala, per una commossa standing ovation, è Franco
Bonisoli, ex brigatista, proprio uno dei suoi “amici difficili e improbabili”,
che rapì l’ex presidente del consiglio e presidente della Dc.
«L’incontro è molto importante - dice Moro -
perché, fino ad allora, vivevo in un mondo popolato di fantasmi. Al primo
incontro, invece, mi trovai di fronte a una persona: fino ad allora ero
circondata da fantasmi giovani, invece lì c’era un vecchio. E il dolore, ho
capito, non era solo mio. Mi disse “Hai una faccia che non si può vedere”,
perché gli ricordavo mio padre. È strano il loro desiderio di incontro. Si sono
fatti decine di anni di galera brutta, eppure mi vogliono incontrare. La
giustizia riparativa è fatta così: raccontare, rimproverare e imparare a
disarmarsi, per ascoltare. E ci fa togliere le maschere: quelle che ci hanno
intrappolato per decenni: loro, quelle di cattivi per sempre. Noi, quelle di
vittime per sempre. La giustizia riparativa si occupa dell’irreparabile».
E il sindaco Bucci ha raccontato quel suo giorno
di marzo, il 16, del 1978, quando Moro venne rapito e cinque uomini della sua
scorta uccisi: «Studiavo al liceo D’Oria - parla e guarda negli occhi Agnese
Moro - uscimmo da scuola e ci sedemmo sui gradini delle Caravelle, avevamo tutti
un senso di disperazione: pensavamo a cosa ne sarebbe stato di noi, se la
violenza poteva avere il sopravvento?» e ricorda anche l’uccisione di Guido
Rossa, nel gennaio successivo. A indagare le origini nella Torah, della
giustizia riparativa è stato Davide Assael, presidente dell’associazione Lech
Lechà, che ha indicato come il filosofo medievale Maimonide avesse già spiegato
che «la giustizia serve per liberare le parti”, altrimenti bloccate nel momento
del delitto. E, introdotta dal presidente del Primo Levi Alberto Rizzerio, è
intervenuta Claudia Mazzucato, docente di Giustizia riparativa e promotrice del
progetto “L’incontro” che ha messo in contatto negli anni vittime e autori di
delitto, non solo in Italia, ma anche in Irlanda del Nord, Paesi Baschi,
Israele, Belgio e Francia. Cita i “Sommersi e i salvati” di Primo Levi e il suo
indagare «tutte le parti, non solo le vittime» e riconosce a Moro la «forza mite
di essere chiamata e rispondere». Agnese Moro ha sottolineato l’onore di
ricevere il Premio dedicato a Primo Levi: «Ammiro tanto il suo coraggio di non
cedere mai alla tentazione della semplificazione - ha detto - Levi non ha mai
escluso neppure un atomo, neppure il più contraddittorio o il più scomodo. Una
virtù, la complessità, di cui abbiamo assoluto bisogno, in un mondo che ama i
leader, le persone strafighe».
Ringrazia i mediatori del progetto “L’incontro”:
«Noi vittime eravamo squinternati, danneggiati dal nostro dolore - dice - sono
grata a loro, ma anche ai miei compagni di viaggio difficili». Perché, spiega
Moro, è tornata a respirare: «Il mio unico merito è aver varcato la soglia, aver
accettato di provarci - dice - dopo trentuno anni dalla morte di mio padre. Mi
sono accorta, durante un incontro, che era da allora che non facevo più un
respiro completo. E ho anche ritrovato un “prima”. Perché guardavo le foto di
mio padre, con me piccola, e le vedevo macchiate di sangue. I miei amici
improbabili mi hanno restituito il conforto di quelle fotografie».
Agnese Moro
racconta la storia di due piantine. La prima, quella che le ha portato un ex
brigatista, la prima volta che si sono incontrati. La seconda è quella che nasce
«nelle crepe dei marciapiedi di Roma: quella sono io, un po’ stortignaccola, ma
che vive». E conclude: «In me c’era una goccia d’ambra in cui era intrappolato
un insetto ferito - parla, piccola, e fortissima, nella sua sedia al centro
dell’enorme salone del Ducale - ora, al suo posto, c’è un luogo di quiete in cui
convivono mio padre, Aldo Moro, e i miei amici improbabili».
Stefania Beretta, testimone della strage di
piazza Fontana: «Io 19enne in ufficio sopra la banca. Un boato, poi la sfilata
di barelle». Giovanna Maria Fagnani su Il Corriere della Sera il 12 dicembre
2023.
Ex ragioniera, 73 anni, nel 1969 lavorava per il
Consorzio agrario provinciale. «Qualcuno ipotizzava che fosse esplosa la
caldaia, poi i vigili del fuoco ci dissero della bomba. Ricordo gli impiegati
vagare tra i vetri rotti»
«Fu un boato sordo, molto forte. Il pavimento
tremò, lievemente. Poi un inferno di sirene: ambulanze, pompieri, forze
dell’ordine. E la processione delle barelle coi feriti, quella non la scorderò
mai». Stefania Beretta, ragioniera in pensione, oggi ha 73 anni e vive a Monza.
Il 12 dicembre del 1969 si trovava nell’edificio della Banca Nazionale
dell’Agricoltura in piazza Fontana, dove una bomba uccise 16 persone e ne ferì
altre 88. Fu l’attentato che aprì la stagione del terrorismo politico in Italia.
Stefania aveva 19 anni e lavorava negli uffici del Consorzio Agrario Provinciale
di Milano, tre piani sopra la banca. La sera studiava statistica alla Cattolica.
Come arrivò a lavorare lì?
«Per caso. Allora abitavo ancora a Desio, mi ero
appena diplomata in ragioneria e avevo risposto a un annuncio per un "facile
lavoro pubblicitario". Il ritrovo era a Milano, quindi presi il treno e in
stazione incontrai una compaesana che lavorava all’Unitalsi e le raccontai che
stavo cercando lavoro. Il lavoro pubblicitario era in realtà una vendita porta a
porta. Quando tornai a casa la sera, mia mamma mi disse che era tutto il giorno
che mi cercavano al telefono. La signora sapeva che cercavano una contabile al
Consorzio e aveva fatto il mio nome. Fui assunta nell’ottobre del 1968».
Dove si trovava il vostro ufficio?
«Al quarto piano, sopra al portone, con vista
sulla piazza. Si entrava da via San Clemente. All’angolo c’era il negozio del
Consorzio. Erano altri tempi: noi donne indossavamo un grembiule color carta da
zucchero. Inoltre, era un posto dove c’era un gran baccano, non come negli
uffici di oggi. In una sala c’era il centro meccanografico e tutti usavamo la
macchina da scrivere e la Divisumma, la vecchia calcolatrice».
Cosa ricorda dei giorni prima dell’attentato?
«Era l’autunno delle lotte operaie. C’erano un
paio di cortei quasi ogni giorno».
Cosa stava facendo quando esplose la bomba?
«Ero in piedi. Si sentì un colpo molto forte e un
lieve tremolio del pavimento. Tutti sbiancammo. Qualcuno ipotizzava che fosse
esplosa la caldaia. Tre colleghi dissero a noi donne di restare nell’ufficio e
scesero per capire cosa fosse successo e portare aiuto. Tornarono dicendo: “I
vigili del fuoco parlano di una bomba”. Dalla scala interna si intravedevano gli
impiegati della banca che vagavano fra i vetri rotti. Nel frattempo, la piazza
si era riempita di ambulanze. Dalla finestra vedevo le barelle coi feriti che
uscivano dal portone, una dietro l’altra, una processione infinita che non potrò
mai dimenticare».
Cosa fece a quel punto?
«Pensai solo ad avvertire mia mamma, Giannina.
Andai al telefono e con un po’ di fatica trovai la linea e le dissi di non
preoccuparsi, se mai avesse sentito la notizia al telegiornale o alla radio. La
sera andai regolarmente a lezione in Cattolica. Era surreale, la città era
ignara di quello che era accaduto. Oggi si sa tutto in tempo reale. Raccontai
della bomba ai miei compagni, ma io stessa faticavo ancora a credere che fosse
un attentato».
Ebbe paura a recarsi al lavoro nei giorni
successivi?
«No, forse perché ero molto giovane e quindi
inconsapevole. Avevo più paura la sera quando andavo a prendere il treno a Porta
Garibaldi. L’atmosfera, però, in ufficio era cambiata. Alcune delle vittime
erano nostri clienti e molti colleghi, che avevano famiglia, erano parecchio
spaventati. La presenza delle forze dell’ordine in zona fu intensificata.
Vedevamo i celerini in strada con i lacrimogeni nel tascapane. Io continuai a
lavorare lì finché non completai gli studi di statistica, poi andai a lavorare
in un’agenzia di pubblicità in via Puccini. Un ambiente completamente diverso».
Andò ai funerali delle vittime?
«Sì, ma come migliaia di altri non riuscii a
entrare in Duomo perché sia la cattedrale che il sagrato erano gremiti. Provo
ancora commozione e vicinanza quando penso alle loro famiglie».
Quando capì di aver vissuto in prima persona una
vera pagina della storia italiana?
«Quando cominciarono ad uscire gli articoli sulle
indagini: la pista anarchica, l’arresto del ballerino (Pietro Valpreda ndr), i
processi. Ho continuato a seguire la vicenda sui giornali»
Lei è madre e nonna. Ha raccontato di piazza
Fontana alle sue figlie e ai nipoti?
«Ai nipoti non ancora, lo farò quando cresceranno.
Alle mie figlie sì, ma dai racconti è difficile rendere l’atmosfera di quegli
anni. Era un periodo senza alcuna certezza: c’erano il terrorismo, le
manifestazioni».
È importante che a scuola si studi anche la storia
contemporanea?
«Assolutamente.
Ma quale storia? Su alcuni fatti le versioni sono ancora contrapposte».
La maledizione di piazza Fontana. L’indagine
interrotta e quella guerra tra i magistrati. Nel libro pubblicato per le
edizioni “Chiarelettere”, il giudice milanese Guido Salvini ripercorre la sua
inchiesta sulla strage: una ricerca di verità finita nel mirino de media e dei
colleghi. Rocco Vazzana su Il Dubbiio l'11 dicembre 2023
Quella di Piazza Fontana non è solo la storia di
una strage senza condanne e di indagini depistate, è anche il racconto di una
vera e propria guerra tra magistrati che ha prodotto come unico risultato il
mancato raggiungimento di una verità giudiziaria. Con grande soddisfazione dei
responsabili. Un conflitto senza esclusione di colpi a cui Guido
Salvini, giudice istruttore a Milano negli anni Novanta, dedica un intero
capitolo de La maledizione di Piazza Fontana (Chiarelettere).
Il magistrato milanese ripercorre, spiegando ogni
passaggio con i documenti, la storia della sua inchiesta sulla strage finita
improvvisamente nel mirino di alcuni colleghi e del mondo
dell'informazione. L'accanimento vale a Salvini una lunghissima indagine per
abuso d'ufficio, aperta dalla Procura di Venezia e archiviata sette anni dopo, e
due procedimenti davanti al Csm, uno disciplinare e uno per incompatibilità
ambientale, finiti entrambi nel nulla dopo un lungo calvario. Ed è proprio
all'organo di autogoverno che l'ex giudice istruttore muove alcune delle
critiche più feroci. «Maccartismo giudiziario», «inquisizione del Csm», «tecnica
intimidatoria del Csm», «il Csm falsifica gli atti di cui dispone». Sono solo
una parte delle accuse mosse al Consiglio, considerato troppo prono nei
confronti di alcune personalità di spicco della magistratura, un organo disposto
a credere a qualsiasi accusa, senza verificarne la fondatezza, purché
proveniente dalla “nobiltà togata”.
Perché contro le indagini di Salvini si sarebbero
mosse alcune delle personalità più amate dall'opinione pubblica italiana. Come
in un film, sfilano le immagini di Francesco Saverio Borrelli, Felice Casson,
Gerardo D'Ambrosio e Grazia Pradella, volti normalmente associati alla lotta
corruzione, all'eversione e alla criminalità organizzata, che nel libro assumono
contorni diversi, molto più terreni. Tutti uniti a puntare l'indice contro il
magistrato milanese, uno degli ultimi giudici istruttori rimasti in
circolazione dopo la riforma Vassalli dell' 89.
La guerra, nella ricostruzione del magistrato,
sarebbe scaturita da semplici invidie e gelosie tra toghe in merito alle
indagini sulla Strage. In particolare, a non gradire il lavoro svolto da Salvini
a Milano sarebbe stato l'allora sostituto procuratore di Venezia Felice Casson.
Il pm veneziano è già molto noto all'opinione pubblica per aver scoperto
l'esistenza di Gladio ed è da tempo convinto che l'organizzazione paramilitare
abbia avuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'attentato.
Non solo, Casson vede la mano dei gladiatori anche
dietro alla strage di Peteano che provocò la morte di tre carabinieri. Ma è una
teoria smentita dalle indagini condotte dal giudice istruttore milanese, che
individua invece la testa e la regia di chi ha piazzato l'esplosivo tra le
cellule neonaziste venete di Ordine Nuovo. Uno smacco ulteriore per Casson, che
in base a questo assunto, si sarebbe fatto sfuggire da sotto il naso i
responsabili delle stragi. L'inchiesta di Salvini sta facendo progressi
inattesi, grazie all'acquisizione di nuove prove e a testimonianze inedite come
quelle di Vincenzo Vinciguerra e Carlo Digilio. Bisogna dunque trovare un modo
di bloccare in fretta l'indagine per non spostare l'attenzione dai gladiatori. O
almeno di questo è persuaso Salvini.
E l'incidente arriva. Nel 1995 Carlo Maria Maggi,
capo ordinovista di Mestre e reggente per l'intero Triveneto è stato appena
scarcerato dopo una lunga pena detentiva. Sa che i suoi ex camerati Digilio (reo
confesso per la strage di Piazza Fontana) e Martino Siciliano stanno
collaborando e teme di essere tirato in ballo. E fa una mossa «apparentemente
disperata» : scrive un esposto al ministro della Giustizia, Filippo Mancuso, in
cui lamenta di essere stato sottoposto a pressioni dall'ufficiale del
Ros Massimo Giraudo, stretto collaboratore del giudice istruttore, che nel corso
di un colloquio investigativo lo avrebbe costretto a collaborare su mandato del
magistrato milanese.
«Carta straccia. Se qualcuno non avesse un
interesse personale a considerarla qualcosa di diverso », scrive Salvini. A
dettare l'esposto a Maggi, dietro lauto compenso è Delfo Zorzi, latitante in
Giappone, convinto che quel testo fosse la carta giusta per “uccidere” le
indagini milanesi e scatenare la guerra tra inquirenti. E così è. A nulla vale
nemmeno la testimonianza del figlio di Maggi, presente all’incontro con
l’ufficiale del Ros, che definisce Giraudo «una persona affidabile, cortese,
educata e con la ragione dalla sua parte».
La denuncia dell’ordinovista arriva a Venezia, tra
le mani di Casson, è l'inizio della fine. Salvini è indagato dal collega veneto,
la notizia finisce sulla prima pagina della Nuova Venezia, firmata da un
cronista molto vicino al pm che ha aperto il fascicolo, e rimbalza su tutti i
media nazionali. Il lavoro del giudice istruttore e della polizia giudiziaria
viene ufficialmente delegittimato.
E non solo. Si interrompe ogni collaborazione con
la Procura di Milano, capitanata da Francesco Saverio Borrelli, che si dissocia
dai metodi salviniani. Grazia Pradella, la giovane sostituta che lo affianca
nelle indagini, inizia un'altra guerra col giudice istruttore, con tanto di
accuse davanti al Csm. Persino il sostituto procuratore Ferdinando Pomarici, ex
collaboratore di Salvini, si scaglia contro le indagini su Piazza Fontana,
definendole «illegittime» sul Corriere della Sera.
Borrelli si schiera con lui. Al fianco del
magistrato si schierano “solo” i familiari delle vittime e il quotidiano
Liberazione, l’unico a non credere al ritratto di un giudice depistatore.
Gli ordinovisti possono brindare, hanno raggiunto
il loro scopo. «A Casson gli hanno tolto il pane di bocca di Gladio», diranno
due ex ordinovisti intercettati. «Sei riuscito a metterli l'uno contro l'altro»,
esulta al telefono un amico di Maggi, riferendosi alla guerra scatenata tra
magistrati.
Le indagini della Procura di Venezia su Salvini
dureranno sette anni prima di essere definitivamente archiviate. E così i
procedimenti davanti al Csm, avviati nel 1996. Una macchina inquisitoria basata
su documentazioni mai verificate, in alcuni casi rivelatisi veri e propri falsi.
«Poi, a tempo scaduto, le accuse cadono una a
una», scrive Salvini. «Ma è come consentire a un giocatore di rientrare in campo
quando l’arbitro ha già fischiato il fine partita e le squadre sono negli
spogliatoi». Le indagini su Piazza Fontana sono ormai compromesse.
Disonesti.
(AGI sabato 14 ottobre 2023) - Nel 2021, le
attività illegali considerate nel sistema dei conti nazionali hanno generato un
valore aggiunto pari a 18,2 miliardi di euro, pari all'1,1% del Pil; tale valore
include l'indotto, ossia il valore dei beni e servizi legali utilizzati nei
processi produttivi illegali. Lo rileva l'Istat nel report 'L'economia non
osservata nei conti nazionali - Anni 2018-2021', spiegando che al 2021 il valore
complessivo dell'economia illegale non è tornato ai livelli pre-crisi.
Rispetto al 2020, quando le misure restrittive
messe in atto per contrastare la pandemia avevano comportato una contrazione
dell'economia illegale, si è registrata nel 2021 una ripresa del fenomeno, con
una crescita del 5,0% (pari a 0,9 miliardi di euro) del valore aggiunto generato
dalle attività illegali. Riprendendo la tendenza positiva degli anni precedenti
la crisi pandemica, i consumi finali di beni e servizi illegali sono cresciuti
di 1,2 miliardi di euro, attestandosi a 20,8 miliardi di euro (corrispondenti al
2,0% del valore complessivo della spesa per consumi finali).
Nonostante la crescita dell'ultimo anno, con
riferimento al periodo 2018-2021 - spiega l'istituto - le attività illegali
hanno mostrato una contrazione di 1,1 miliardi del valore aggiunto e di 0,8
miliardi della spesa per consumi finali, con una decrescita media annua,
rispettivamente, dell'1,9% e dell'1,3%. Al 2021, dunque, il valore complessivo
dell'economia illegale non è tornato ai livelli pre-crisi.
La ripresa delle attività illegali nel 2021 è
stata determinata per larga parte dalla dinamica del traffico di stupefacenti:
il valore aggiunto è salito a 13,7 miliardi di euro (+0,4 miliardi rispetto al
2020), mentre la spesa per consumi si è attestata a 15,5 miliardi di euro (+0,7
miliardi). Tale crescita è in linea con l'andamento del quadriennio precedente
al 2020 in cui, per il traffico di stupefacenti, si era registrato un incremento
medio annuo del 2,1% per il valore aggiunto e del 2,6% per i consumi finali,
sostenuti soprattutto dalla dinamica dei prezzi.
Nello stesso periodo anche la crescita dei servizi
di prostituzione è stata rilevante. Nel 2021 il valore aggiunto e i consumi
finali sono aumentati, rispettivamente, dell'11,8% e del 12,3% (portandosi a 3,9
e 4,5 miliardi di euro).
L'attività di contrabbando di sigarette nel 2021
rimane marginale, rappresentando una quota del 3,3% del valore aggiunto (0,6
miliardi di euro) e del 3,8% dei consumi delle famiglie (0,8 miliardi di euro)
del complesso delle attività illegali.
Nel periodo 2018-2021, l'indotto connesso alle
attività illegali, principalmente riconducibile al settore dei trasporti e del
magazzinaggio, è passato da un valore aggiunto di 1,3 miliardi di euro a 1,4
miliardi, dopo aver subito una caduta di 170 milioni nel 2020
Giorgio Gaber. Testo Mi Fa
Male Il Mondo [prima parte] - 1995/1996
Mi fa male il mondo mi fa male il mondo
Mi fa male il mondo mi fa male il mondo
Mi fa male più che altro credere
che sia un destino oppure una condanna
che non esista il segno di un rimedio
in un solo individuo che sia uomo o donna.
Mi fa male il mondo mi fa male il mondo
Mi fa male più che altro ammettere
che siamo tutti uomini normali
con l'illusione di partecipare
senza mai capire quanto siamo soli.
Mi fa male il mondo mi fa male il mondo
È un malessere che abbiamo dentro
è l'origine dei nostri disagi
un dolore di cui non si muore
che piano piano ci rende più tristi e malvagi.
coro: mi fa male il mondo G: mi fa male
coro: mi fa male il mondo G: mi fa male il mondo
coro/G: mi fa male il mondo
mi fa male mi fa male mi fa male
Mi fa bene comunque credere
che la fiducia non sia mai scomparsa
e che d'un tratto ci svegli un bel sogno
e rinasca il bisogno di una vita diversa
Mi fa male il mondo mi fa male il mondo
Mi fa bene comunque illudermi
che la risposta sia un rifiuto vero
e che lo sfogo dell'intolleranza
prenda consistenza e diventi un coro.
Mi fa male il mondo mi fa male il mondo
Ma la rabbia che portiamo addosso
è la prova che non siamo annientati
da un destino così disumano
che non possiamo lasciare ai figli e ai nipoti.
coro: mi fa male il mondo G: mi fa male
coro: mi fa male il mondo G: mi fa male il mondo
coro/G: mi fa male il mondo
mi fa male mi fa male mi fa male.
Dall'album E Pensare Che C'era Il Pensiero -
tracce:
Testo Mi Fa Male Il Mondo [seconda parte]
(canzone-prosa) - 1995/1996
Coro: mi fa male il mondo mi fa male il mondo
mi fa male il mondo mi fa male il mondo
E non riesco a trovar le parole
per chiarire a me stesso e anche al mondo
cos’è che fa male…
Mi fa male, mi fa male essere lasciato da una
donna... non sempre. Mi fa male l’amico, che mi spiega perché mi ha lasciato. Mi
fanno male quelli che si credono di essere il centro del mondo, e non sanno che
il centro del mondo sono io. Mi fa male quando mi guardo allo specchio.
Mi fa male anche quando mi dicono che mia figlia
mi assomiglia molto fisicamente. Mi fa male per lei. Mi fanno male, quelli che
sanno tutto... e prima o poi te lo dicono. Mi fanno male gli uomini
esageratamente educati, distaccati formali. Ma mi fanno più male quelli che per
essere autentici ti ruttano in faccia. Mi fa male essere così delicato, e non
solo di salute. Mi fa male più che altro il fatto, che basta che mi faccia male
un dente, che non mi fa più male il mondo. Mi fanno male, quelli troppo ricchi,
quelli troppo poveri.
Mi fanno male anche quelli troppo così e così. Mi
fa male l’IVA, le trattenute il 740, i commercialisti... mamma mia come mi fanno
male i commercialisti! Mi fanno male le marche da bollo, gli sportelli, gli
uffici, le code. Mi fa male quando perdo la patente e gli amici mi dicono:
"Condoglianze". E gli impiegati quando vai lì, non alzano neanche la testa. E
poi quando la alzano s’incazzano, perché gli fai perdere tempo. Ti trattano
male, giustamente, siamo noi che sbagliamo, l’ufficio é sempre un altro, e poi
un altro ancora, e poi le segretarie, i capiuffici, i funzionari i direttori, i
direttori generali... Mi fa male la burocrazia, mi fa male l’apparato la sua
mentalità, la sua arroganza. Mi fa male lo Stato! Come sono delicato!
Mi fa male il futuro dell’Italia, dell’Europa, del
mondo. Mi fa male l’immanente destino del pianeta terra minacciato dal grande
buco nell’ozono, dall’effetto serra e da tutte quelle tragedie planetarie, che
al momento poi, a dir la verità, non mi fanno mica tanto male. Sarà perché mi
fanno male le facce verdi, dei verdi. Mi fanno male i fax, i telefonini, i
computer e la realtà virtuale, anche se non so cos’é. Mi fa male l’ignoranza,
sia quella di andata che quella di ritorno.
Mi fa male la scuola privata, ma anche quella
pubblica non scherza, nonostante che il Ministero della Pubblica Istruzione
abbia 1.200.000 dipendenti. Numericamente nel mondo, l’ente é secondo soltanto
all’esercito americano. Però!
Mi fa male la carta stampata, gli editori...
tutti. Mi fanno male le edicole, i giornali, le riviste con i loro inserti: un
regalino, un opuscolo, una cassetta, un gioco di società, un cappuccino e una
brioche grazie.
Mi fanno male quelli che comprano tutti i giornali
perché la realtà é pluralista. Nooo, non mi fa male la libertà di stampa. Mi fa
male la stampa. Mi fa male che qualcuno creda ancora che i giornalisti, si
occupino di informare la gente. I giornalisti, che vergogna! Cosa mettiamo oggi
in prima pagina? Ma sì, un po’ di bambini stuprati. E’ un periodo che
funzionano. Mi fanno male le loro facce presuntuose e spudorate, facce libere e
indipendenti ma estremamente ma rispettose dei loro padroni, padroncini, facce
da grandi missionari dell’informazione, che il giorno dopo guardano l’indice
d’ascolto. Sì alla televisione, facce completamente a loro agio che si infilano
le dita nelle orecchie e si grattano i coglioni. Sì, questi geniali opinionisti
che gridano litigano, si insultano, sempre più trasgressivi. Questi coraggiosi
leccaculo travestiti da ribelli. E’ questa libertà di informazione che mi fa
vomitare. Come sono delicato!
Mi fa male, quando mi suonano il campanello di
casa e mi chiedono di firmare per la pace nel mondo per le foreste
dell’Amazzonia per le balene del Pacifico. E poi mi chiedono un piccolo
contributo, offerta libera, soldi, tanti soldi per le varie ricerche, per la
vivisezione per il terremoto nelle Filippine, per le suore del Nicaragua, per la
difesa del canguro australiano. Devo fare tutto io! Mi fa male quando mi sento
male.
Mi fa male che in un ospedale pubblico per fare
una TAC ci vogliano in media sette mesi. Mi fa male che uno magari dopo sette
mesi... (fischia)
Mi fa male la faccia assolutamente normale del
professore che ti dice: ”Certo che privatamente, con un milione e due, si fa
domani”. Mi fa male, anzi mi fa schifo chi specula sulla vita della gente. Mi
fanno male quelli che dicono che gli uomini sono tutti uguali. Mi fanno male
anche quelli che dicono che, il pesce più grosso, mangia il pesce più piccolo.
Mi farebbe bene metterli nella vaschetta delle balene.
Mi fa male la grande industria, la media mi fa
malino, la piccola non mi fa praticamente niente.
Mi fanno male i grandi evasori, i medi mi fanno
malino, i piccoli fanno quello che possono.
Mi fa male che a parità di industriali
stramiliardari, un operaio tedesco guadagna 2.800.000 lire al mese, e uno
italiano 1.400.000. Ma, l’altro 1.400.000 dov’è che va a finire? Allo Stato, che
ne ha così bisogno. Mi fa male che tra imposte dirette e indirette un italiano
medio paghi, giustamente per carità, un carico di tributi tale, che se nel
Medioevo, le guardie del re l’avessero chiesto ai contadini, sarebbero state
accolte a secchiate di merda. Mi fa male che l’Italia, cioè voi, cioè io, siamo
riusciti ad avere, non si sa bene come, due milioni di miliardi di debito. Eh si
sa, un vestitino oggi, un orologino domani, basta distrarsi un attimo... e si va
sotto di due milioni di miliardi. Questo lo sappiamo tutti eh. Ce lo sentiamo
ripetere continuamente. Sta cambiando la nostra vita per questo debito che
abbiamo. Ma con chi ce l’abbiamo? A chi li dobbiamo questi soldi? Questo non si
sa. Questo non ce lo vogliono dire. No, no perché se li dobbiamo a qualcuno che
non conta... va bè, gli abbiamo tirato un pacco e finita lì. Ma se li dobbiamo a
qualcuno che conta... due milioni di miliardi... prepariamoci a pagare in
natura. Mi fa male la violenza. Mi fa male la sopraffazione, la prepotenza,
l’ingiustizia.
A dir la verità mi fa male anche la giustizia. Un
paese che ha una giustizia come la nostra, non sarà mai un paese civile. Io
personalmente, piuttosto di avere a che fare con la giustizia preferisco essere
truffato, imbrogliato, insultato, e al limite anche un po’ sodomizzato. Che
magari mi piace anche.
Mi fanno male le facce dei, dei collaboratori di
giustizia, dei pentiti... degli infami, insomma, che dopo aver ammazzato uomini
donne e bambini, fanno l’atto di dolore... tre Pater, Ave e Gloria e chi s’é
visto s’é visto. Mi fa male che tutto sia mafia.
Mi fa male non capire, perché animali della stessa
specie si ammazzino tra di loro.
Mi fa male che in Bosnia, non ci sia il petrolio.
Mi fa male chi crede che le guerre si facciano per ragioni umanitarie. Mi fa
male anche chi muore in Somalia, in Ruanda, in Palestina, in Cecenia. Mi fa male
chi muore.
Mi fa male chi dice, che gli fa male chi muore, e
fa finta di niente sul traffico delle armi, che é uno dei pilastri su cui si
basa il nostro amato benessere.
Mi fanno male le lobbies di potere, le logge
massoniche, la P2. E la P1? No perché se c’é la P2, ci sarà anche la P1. Se no
la P2 la chiamavano P1. No, quelli della P1 sono buoni, mansueti, come agnelli,
in genere stanno a cuccia.
Mi fa male qualsiasi tipo di potere, quello
conosciuto ma anche quello sconosciuto, sotterraneo, che poi é il vero potere.
Mi fanno male le oscillazioni e i rovesci dell’alta finanza. Più che male mi
fanno paura, perché mi sento nel buio, non vedo le facce. Nessuno ne parla,
nessuno sa niente, sccc. Sono gli intoccabili. Facce misteriose che tirano le
fila di un meccanismo invisibile, talmente al di sopra di noi, da farci sentire
legittimamente esclusi. E lì, in chissà quali magici e ovattati saloni, che a
voce bassa e con modi raffinati, si decidono le sorti del nostro mondo. Dalle
guerre di liberazione, ai grandi monopoli, dalle crisi economiche, alle cadute
dei muri, ai massacri più efferati. Mi fa male quando mi portano il certificato
elettorale. Mi fa male la democrazia, questa democrazia che é l’unica che io
conosca. Mi fa male la prima Repubblica, la seconda, la terza, la quarta.
Mi fanno male i partiti. Più che altro tutti. Mi
fanno male i politici sempre più viscidi, sempre più brutti. Mi fanno male i
loro modi accomodanti imbecilli ruffiani. E come sono vicini a noi elettori,
come ci ringraziano, come ci amano. Ma sì, io vorrei anche dei bacini, dei morsi
sul collo, certo, per capire bene che lo sto prendendo nel culo. Tutti, tutti
l’abbiamo sempre preso nel culo... da quelli di prima, da quelli di ora, da
tutti quelli che fanno il mestiere della politica, che ogni giorno sono lì a
farsi vedere. Ma certo, hanno bisogno di noi, che li dobbiamo appoggiare,
preferire, li dobbiamo votare, in questo ignobile carosello, in questo grande
libero mercato delle facce. Facce facce... facce che lasciano intendere di
sapere tutto e non dicono niente. Facce che non sanno niente e dicono di tutto.
Facce suadenti e cordiali con il sorriso di plastica. Facce esperte e competenti
che crollano al primo congiuntivo
Facce compiaciute e vanitose che si auto incensano
come vecchie baldracche. Facce da galera che non sopportano la galera e si danno
malati. Facce che dietro le belle frasi hanno un passato vergognoso da
nascondere. Facce da bar che ti aggrediscono con un delirio di sputi e di
idiozie. Facce megalomani da ducetti dilettanti. Facce ciniche da scuola di
partito allenate ai sotterfugi e ai colpi bassi. Facce che hanno sempre la
risposta pronta e non trovi mai il tempo di mandarle a fare in culo. Facce che
straboccano solidarietà. Facce da mafiosi che combattono la mafia. Facce da
servi intellettuali, da servi gallonati, facce da servi e basta. Facce scolpite
nella pietra, che con grande autorevolezza sparano cazzate. Non c’é neanche una
faccia, neanche una, che abbia dentro con il segno di un qualsiasi ideale; una
faccia che ricordi, il coraggio il rigore, l’esilio, la galera. No. C’é solo
l’egoismo incontrollato, la smania di affermarsi, il denaro, l’avidità più
schifosa, dentro a queste facce impotenti e assetate di potere, facce che ogni
giorno assaltano la mia faccia in balia di tutti questi nessuno. E voi credete
ancora che contino le idee. Ma quali idee?
La cosa che mi fa più male, é vedere le nostre
facce, con dentro le ferite, di tutte le battaglie che non abbiamo fatto.
E mi fa ancora più male vedere le facce dei nostri
figli, con la stanchezza anticipata di ciò che non troveranno. Sì, abbiamo
lasciato in eredità forse un normale benessere, ma non abbiamo potuto lasciare,
quello che abbiamo dimenticato di combattere, e quello che abbiamo dimenticato
di sognare. Bisogna assolutamente trovare il coraggio di abbandonare i nostri
miseri egoismi, e cercare, un nuovo slancio collettivo, magari scaturito proprio
dalle cose che ci fanno male, dai disagi quotidiani, dalle insofferenze comuni,
dal nostro rifiuto. Perché un uomo solo, che grida il suo no, é un pazzo,
milioni di uomini che gridano lo stesso no, avrebbero la possibilità di cambiare
veramente il mondo.
Mi fa male il mondo
Mi fa male il mondo
Mi fa bene comunque credere
che la fiducia non sia mai scomparsa
e che d'un tratto ci svegli un bel sogno
e rinasca il bisogno di una vita diversa
Mi fa male il mondo mi fa male il mondo
Mi fa bene comunque illudermi
che la risposta sia un rifiuto vero
che lo sfogo dell'intolleranza
prenda consistenza e diventi un coro.
Mi fa male il mondo mi fa male il mondo
Ma la rabbia che portiamo addosso
è la prova che non siamo annientati
da un destino così disumano
che non possiamo lasciare ai figli e ai nipoti.
coro: mi fa male il mondo G: mi fa male
coro: mi fa male il mondo G: mi fa male il mondo
Mi fa bene soltanto l'idea
che si trovi una nuova utopia
litigando col mondo.
Dall'album E Pensare Che C'era Il Pensiero -
tracce:
Fluidi e contro i bambini.
Estratto dell’articolo di Iacopo Scaramuzzi
per repubblica.it lunedì 11 dicembre 2023.
Papa Francesco è tornato a esprimere
preoccupazione che in Italia c’è una bassa natalità “i cagnolini sono al posto
dei figli”. "I migranti vanno ricevuti, accompagnati, promossi e integrati”, ha
detto Jorge Mario Bergoglio in un discorso ai prefetti italiani che ha ricevuto
in udienza. “Se non c’è questo, c’è pericolo; se non c’è questo cammino verso
l’integrazione, c’è pericolo. E questo mi fa pensare anche a un altro problema.
I migranti aiutano, quando si inseriscono bene.
L’Italia è una terra dove mancano i figli, e
vengono i migranti. A me preoccupa il problema della poca natalità qui in
Italia. Non fanno figli. Mi diceva uno dei miei segretari che andava per la
piazza l’altro giorno: si è avvicinata una signora che aveva un carrello col
bambino; lui va per accarezzare il bambino… era un cagnolino! I cagnolini sono
al posto dei figli. Pensate questo. La responsabilità che gli italiani hanno di
fare i figli per crescere e anche per ricevere i migranti come figli”.
Non è la prima volta che il Papa racconta aneddoti
del genere. A maggio scorso disse di avere sgridato una signora che gli aveva
chiesto di benedire il suo “bambino” che era, però, un cagnolino. A gennaio 2022
aveva criticato la scelta di alcune famiglie di non fare figli ma di tenere in
casa animali domestici.
Ma già nel 2016 Francesco aveva criticato la
“gente tanto attaccata ai gatti ai cani che poi lascia sola e affamata la
vicina”. Poche settimane fa, da ultimo, Bergoglio, nel corso di un’udienza a un
gruppo di pediatri, ha detto che oggi i veterinari hanno più lavoro.
Considerazioni che sollevano regolarmente le critiche delle associazioni
animaliste. […]
Dagospia lunedì 11 dicembre 2023. LA GRAVIDANZA
È ROBA PER POVERE – CHI SE LO PUÒ PERMETTERE SI EVITA NOVE MESI DI ROTTURA DI
COGLIONI E SI COMPRA DIRETTAMENTE I FIGLI CON LA MATERNITÀ SURROGATA.
Estratto dell’articolo di Daniela Mastromattei per “Libero quotidiano” lunedì 11
dicembre 2023.
La maternità surrogata (da noi reato universale,
perseguibile anche se commesso all’estero) è fortemente rivendicata dalle
femministe di tutto il mondo che vogliono sentirsi libere di scegliere se
trascorrere nove mesi col pancione mettendo a repentaglio carriera e dintorni,
oppure affidarsi a una perfetta sconosciuta pronta ad affittare il proprio
utero, dietro un lauto compenso. E incrementare così il mercato trasnazionale
della genitorialità, dove quello che conta non è più il frutto dell’amore ma un
contratto, ben stipulato per evitare ripensamenti da entrambe le parti.
Lo sa bene Paris Hilton, l’ereditiera americana
della catena di alberghi di lusso (per lei forse c’era una chilometrica fila
sotto casa di donne disposte a prestare il proprio utero) che a sorpresa, senza
rivelare nulla a nessuno, si è presentata il Giorno del Ringraziamento con la
figlia London Marilyn Hilton Reum, appena partorita da una madre surrogata,
promuovendo così l’altro figlio Phoenix di soli 10 mesi (anche lui avuto con lo
stesso sistema) a fratello maggiore.
[…]
Non ha dovuto indossare abiti premaman. Non ha
dovuto rallentare i suoi impegni pubblici. Saranno felici le femministe che
spingono per l’ectogenesi umana, ovvero la possibilità tecnologica della
riproduzione al di fuori dell’organismo, poiché convinte che nel capitalismo
neoliberale la gestazione e la maternità siano per molte donne incompatibili con
il lavoro e gli studi. E rappresenterebbero una limitazione della libertà, oltre
che essere il risultato di una cultura patriarcale e misogina.
Ma la Hilton si difende: «Ho un forte disturbo da
stress post-traumatico per quello che ho passato da adolescente».
Dai suoi racconti emergono abusi sessuali e traumi
medici subiti da adolescente in un collegio nello Utah. E sostiene di soffrire
ancora quando entra «in uno studio medico», oppure se deve fare «un’iniezione,
ho letteralmente un attacco di panico e non riesco a respirare. Sapevo che non
sarebbe stato salutare per me o per il bambino, crescere dentro una persona con
un’ansia così elevata».
[…] Comodo. Indubbiamente deve essere stata una
impresa costosa, ma a lei il denaro non manca. Ha pure confidato di non essere
in grado di cambiare i pannolini. Tanto c’è un esercito di tate a disposizione.
[…]
Estratto dell’articolo di Milena Gabanelli e
Simona Ravizza per corriere.it lunedì 11 dicembre 2023.
È un’emergenza collettiva che ci riguarda molto da
vicino, ma la vediamo solo quando diventa il titolo di un tg o di un giornale.
Parliamo della sofferenza sociale e psichica di bambini e adolescenti […] Il
fenomeno delle baby gang, la delinquenza minorile, i giovanissimi che
abbandonano la scuola, i bambini stranieri senza famiglia, i minori orfani di
violenza domestica, vittime di abusi o figli di alcolisti o tossicodipendenti
rappresentano solo alcune delle situazioni che richiedono valutazioni adeguate,
interventi rapidi e sorveglianza sulla corretta applicazione delle misure. Chi
deve occuparsi di tutti questi casi è il Tribunale per i minorenni. […]
Cosa c’è sul tavolo dei giudici
In Italia ci sono 29 Tribunali per i minorenni: a
tutti manca il personale amministrativo, mentre i giudici previsti dalle piante
organiche sono meno rispetto alla mole di lavoro e in quasi la metà dei
Tribunali il loro numero non viene neppure rispettato. A Milano dovrebbero
essere 18 invece sono 13, a Roma 16 e sono in 12, a Genova 7 e sono in 5, a Bari
10 e sono in 7. E via di questo passo a Firenze, Venezia, Ancona, Napoli. Né
bastano i giudici onorari che li affiancano (psicologi, pedagogisti,
neuropsichiatri infantili, educatori, assistenti sociali).
Il risultato è l’accumulo di fascicoli: il totale
fa quasi 110 mila, e a ogni fascicolo corrisponde un minore e il suo destino. Le
chiamano «pendenze». A Milano sono 12.662: vuol dire che ogni singolo giudice ha
sul tavolo 974 fascicoli arretrati, e ogni anno 562 casi nuovi. A Roma le
pendenze sono 8.368, a Napoli 5.531, a Bologna si raggiunge il numero
esorbitante di 10.106, nonostante il numero dei giudici sia quello previsto da
pianta organica. Ma concretamente cosa vogliono dire questi numeri per la vita
dei minori?
Prima autolesionista, poi drogato
Vincenzo, 12 anni, si ferisce volontariamente. La
scuola informa i servizi sociali e, dopo una diagnosi di disturbo depressivo,
arriva la decisione del Tribunale per i minorenni: deve andare dallo psicologo e
ai genitori va affiancato un educatore a domicilio. Passano due anni e mezzo, ma
i servizi sociali non si attivano e il giudice non sollecita perché ha altre
urgenze. Vincenzo lascia la scuola e inizia a drogarsi. A 16 anni ritorna al
Tribunale per i minorenni, stavolta davanti al giudice penale per furto e
spaccio.
[…] Chi deve fare cosa
Le competenze sono divise. Il Tribunale per i
minorenni si occupa di adozioni, affidi etero-familiari e di limitazioni della
responsabilità genitoriale nel caso in cui la presenza in famiglia può arrecare
danno a un bambino o a un adolescente. Poi c’è il Tribunale ordinario che
interviene in caso di separazioni, divorzi e conseguente necessità di
regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli di coppie sposate e
non; infine il giudice tutelare che si occupa di tutele di minori italiani,
oltre che di nomine e gestioni delle amministrazioni di sostegno.
[…]
La riforma Cartabia
La legge 206 del 26 novembre 2021, nota come
riforma Cartabia sulla giustizia, per quanto riguarda i minori viene attuata con
il decreto legislativo 149 del 10 ottobre 2022 (qui). L’obiettivo è di riunire
entro ottobre 2024 tutti i procedimenti sotto un tribunale unico dal nome
«Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie», applicando un
rito unico. Le buone intenzioni, però, devono fare i conti con la realtà.
Due i problemi su tutti.
1) Per i procedimenti iscritti dopo il 28 febbraio
2023 i giudici onorari non avrebbero più potuto svolgere attività istruttoria,
occuparsi della prima udienza, né procedere autonomamente all’ascolto del
minore. Sono intervenute due proroghe, ma dal 30 aprile 2024 tutto ricadrà sulle
spalle dei giudici togati già oggi seppelliti dai fascicoli.
2) Al 30 giugno 2023 avrebbe dovuto essere
operativa l’informatizzazione del Tribunale per i minorenni. A metà dicembre
2023 sia il Tribunale ordinario, sia quello dei Minorenni e il giudice tutelare
non sono ancora in grado di vedere reciprocamente tutti i procedimenti che
riguardano lo stesso minore. E poi se l’organico rimane lo stesso, se restano
tal quale i fondi per il sostegno ai minori e genitori e nessuno guarda quali
sono le criticità dentro agli uffici fuori parametro, cambia davvero poco. Le
conseguenze le vediamo quando finiscono in cronaca.
Questione di Genere.
Un po’ di retorica. Massimo Gramellini su
Il Corriere della Sera 12 dicembre 2023.
È retorico Gino Cecchettin quando a «Che tempo che
fa» ci esorta ad amare invece che a odiare? E fanno soltanto retorica le
Spettabili Autorità che davanti all’università romana della Sapienza hanno
installato una panchina rossa, subito smontata e gettata nella spazzatura da un
collettivo di studenti e studentesse indispettite, per l’appunto, dalla
«retorica dell’iniziativa»? D’altronde chiunque, a mille panchine rosse,
preferirebbe mille centri antiviolenza. (Il sindaco di Roma ne ha appena
annunciato uno per ogni quartiere, sperando non finisca come quando promise che
avrebbe trasformato la capitale della «monnezza» in un borgo del Trentino). Ma,
in attesa dei centri, io mi tengo le panchine. E le belle parole di Gino
Cecchettin. Perché non sono più così convinto che la retorica rappresenti solo
una scorciatoia ipocrita e un espediente propagandistico. Anzi, comincio a
sospettare che finisca per fare del bene persino a chi ne è allergico.
Come certe medicine, la prima reazione che la
retorica provoca è il rigetto. Poi, però, si insinua lentamente dentro le
persone e prepara il terreno, cambiando il modo di pensare, e di agire, di
comunità intere. Ripenso spesso a quelle bambine calabresi che hanno appeso sul
balcone il cartello «Help» mentre il padre picchiava la madre e poi, all’arrivo
degli agenti, hanno mimato il segnale internazionale di aiuto. Prima del clamore
mediatico e, certo, anche un po’ retorico delle tante campagne contro la
violenza sulle donne, lo avrebbero fatto?
Roma, alla Sapienza inaugurata (e subito
distrutta dal collettivo autonomo «Zaum») la panchina rossa contro la violenza
sulle donne. La rettrice: «Verrà ripristinata». Maria Egizia Fiaschetti su Il
Corriere della Sera lunedì 11 dicembre 2023.
Il blitz vandalico poche ore dopo la cerimonia con
il sindaco Gualtieri e i vertici della As Roma che promuove la campagna «Amami e
basta». A distruggerla il gruppo femminista, contro «la retorica dell'ateneo»
Doveva essere un momento di condivisione, per
riflettere con la comunità studentesca sugli strumenti di contrasto
alla violenza sulle donne, ma a rovinare il clima è stata l'azione
del collettivo «Zaum Sapienza» che ha rivendicato sui social il danneggiamento
della panchina rossa inaugurata lunedì 11 dicembre nel primo ateneo romano alla
presenza della rettrice, Antonella Polimeni, del sindaco, Roberto Gualtieri,
della vicepresidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli, e dei vertici
della As Roma (la società giallorossa promuove la campagna «Amami e basta»). Le
attiviste, in polemica con l'iniziativa istituzionale - dal loro punto di vista
un gesto puramente simbolico - hanno smontato la panchina (le immagini,
rilanciate sui social, sono state riprese anche dalle telecamere di
sorveglianza) per poi buttarla in un cestino della spazzatura. Prima, durante il
sit-in di protesta, le manifestanti hanno srotolato uno striscione con scritto:
«La casa delle donne non si tocca, solidarietà a Lucha Y Siesta». Le autrici del
gesto sono state identificate dalla polizia, nel frattempo dalla Sapienza fanno
sapere che la panchina verrà ripristinata al più presto.
Polimeni: «Un manipolo di facinorosi»
A condannare l'azione iconoclasta, tra gli altri,
la stessa Celli: «Dispiace per l'accaduto, perché il nostro intento è
soprattutto quello di realizzare un vero cambiamento culturale a partire dai
giovani, parte attiva di questo percorso. Andremo avanti nel rispetto di chi
crede in questa battaglia, alle tante vittime e donne che ancora non sono
libere». Parole di forte disapprovazione anche da parte di Daniela Ternullo,
senatrice di FI, componente della commissione parlamentare d'inchiesta sui
femminicidi: «La violenza si combatte partendo dal rispetto.
Dovrebbe impararlo anche chi oggi (lunedì, ndr),
facendo sparire la panchina rossa appena inaugurata nel cortile dell'università
Sapienza di
Roma, ha invece dimostrato che la strada
dell'educazione ai valori
del vivere civile è ancora lunga». La rettrice
Polimeni ha sottolineato che si è trattato di «un manipolo di pochi facinorosi,
tra studenti e
persone estranee all'università» per poi
ribadire: ««Ci sarà tempo per capire quali possano essere le ragioni per cui il
simbolo universale della
lotta contro la violenza nei confronti delle donne
viene
violentemente abbattuto. Oggi (lunedì, ndr) è
invece per noi il tempo di
indignarci per l'accaduto, ripristinare la
panchina e rinsaldare
l'alleanza con tutti coloro che vogliono
contribuire a creare
una cultura diffusa, trasversale tra le
generazioni, basata sul
rispetto della persona, dell'individuo in quanto
tale».
Il sit-in di protesta
L'eco rumorosa del corteo «Non una di meno» dello
scorso 25 novembre è risuonata nei viali dell'università «Sapienza» poco prima
delle 10, mentre le autorità inauguravano la panchina rossa contro la violenza
sulle donne. A turbare l'atmosfera la contestazione di un gruppo di studenti e
attivisti del collettivo femminista «Zaum Sapienza» che mostravano cartelli con
su scritto «Say their name» e «Ogni femminicidio è omicidio di Stato», in segno
di protesta contro la «retorica» dell'iniziativa.
La studentessa Anita sarà premiata per il suo
impegno civico
Rientrata la polemica, la giornata di
sensibilizzazione è proseguita nell'Aula magna del Rettorato dove la rettrice ha
chiamato sul palco due studentesse, Caterina e Anita: la seconda, che il 25
novembre ha sfilato alla manifestazione partita dal Circo Massimo issando un
cartello con alcune immagini del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi, la
stessa sera, mentre rientrava a casa in autobus, ha assistito alla telefonata di
minacce subìta da una donna da parte del compagno. Anita ha registrato la
chiamata e denunciato il molestatore, che poi si è scoperto essere recidivo,
facendolo arrestare. Il sindaco ha promesso che inviterà la ragazza in
Campidoglio per premiare il suo impegno civico.
Le numerose iniziative dell'ateneo romano
Polimeni ha ricordato le molte azioni
concrete messe in campo dalla «Sapienza» per combattere «l'emergenza» e favorire
un «percorso di inversione dei paradigmi»: dal corso di formazione in Culture
contro la violenza di genere, lanciato nel 2020, al corso di laurea in Gender
studies, fino al progetto di counseling psicologico e alla creazione di «safe
zone». Le iniziative andranno avanti per tutto il 2024 con un programma
denso «di 366 giorni perché il prossimo sarà un anno bisestile». Da qui l'invito
agli studenti «a farsi comunità» attraverso la partecipazione attiva, ribadendo
che «l'emancipazione femminile è un fatto e bisogna accettarla».
Gualtieri: «Un centro antiviolenza in ogni
Municipio»
Il
centrocampista della Roma, Leonardo Spinazzola, ha donato all'ateneo la sua
maglia con il numero 37, così come l'attaccante della squadra femminile
giallorossa, Benedetta Glionna, ha donato la sua con il numero 18. Gualtieri ha
espresso apprezzamento per «l'impegno fondamentale della As Roma nel contrastare
un'emergenza nazionale che va riconosciuta come tale». Il primo cittadino ha
ricordato come i numeri diano la misura del fenomeno in tutta la
sua drammaticità: «In Italia si consuma un femminicidio ogni tre giorni, il
numero antiviolenza riceve in media 900 telefonate al giorno con richiesta di
aiuto». Nel frattempo, il Comune sta lavorando per aprire un centro
antiviolenza, «anche più di uno», in tutti i Municipi. In risposta al sit-in
lampo organizzato dai contestatori Gualtieri ha voluto inoltre precisare: «La
panchina rossa è un simbolo, finché si continua a registrare un tale livello di
violenza contro le donne serve qualcosa che spicchi». Sulla questione culturale
l'inquilino di Palazzo Senatorio ha poi rimarcato l'importanza che il
dibattito e la presa di coscienza non si limitino soltanto a una parte: «È
giusto che le donne siano messe nelle condizioni di denunciare, ma il problema è
innanzitutto degli uomini: ormai è assodato che la violenza non è soltanto
quella fisica, brutale, ma si sviluppa sopra l'idea di prevaricazione
maschile in forme anche sottili. Serve una consapevolezza attiva».
Da liberoquotidiano.it - Estratti lunedì 11
dicembre 2023.
Gino Cecchettin, il padre di Giulia uccisa dall'ex
fidanzato in un caso che ha profondamente scosso l'Italia, è diventato suo
malgrado il simbolo della volontà di molti uomini di cambiare cultura e visione
del mondo. Ieri è stato l'ospite d'onore di Fabio Fazio e Che tempo che fa, in
precedenza aveva aperto le porte della camera della figlia ed è stato
intervistato da Walter Veltroni.
Il rischio di una sovraesposizione mediatica è
evidente. Vittorio Feltri nella sua Stanza sul Giornale risponde a un lettore
proprio su questo argomento e lo fa, premette, prima di aver visto in tv
Cecchettin. Il direttore editoriale ipotizza: "Immancabile sarà il quesito: 'Si
darà allora alla politica?'. E Gino dirà commosso che non può escluderlo, che
anzi gli piacerebbe al fine di dare un senso al trapasso della figlia". In
effetti, l'uomo ha spiegato a Fazio che probabilmente l'impegno suo e di Elena
Cecchettin, l'altra figlia, si concretizzerà in una fondazione.
Parlare del contrasto alla violenza sulle donne è
sacrosanto, afferma Feltri, ma "non comprendo perché elevare a guru nazionale"
il padre di una ragazza uccisa dall'ex. Il direttore nota che c'è una
"ossessione mediatica" che è "insana, come dimostra, ad esempio, la prima pagina
del quotidiano Repubblica di qualche giorno fa, che recava la fotografia della
cameretta di Giulia, il titolo era: Nella stanza di Giulia". Insomma, lo spazio
privato della ragazza non aggiunge nulla alla vicenda e al contrasto alla
violenza di genere. "È come se si trattasse di una diva di Hollywood e il
paparazzo fosse riuscito ad introdursi in casa sua", questo è "feticismo" tuona
Feltri.
Il direttore critica anche le tesi sostenute da
Elena Cecchettin, che "attribuisce la responsabilltà della morte della sorella
al patriarcato, allo Stato, al governo e sostiene che il fischio per strada sia
una sorta di preludio del femminicidio".
(...) "Non posso
fare a meno di notare che i componenti di questa famiglia hanno dato prova di
una capacità straordinaria di fare, per di più da subito, di un lutto una
occasione per cambiare vita e carriera, per reinventarsi, per proporsi e per
candidarsi alla copertura di ruoli attinenti alla politica" afferma Feltri
sostenendo una posizione che farà discutere.
Martin Luther Cecchettin: visto che sono
saltati i consulenti del governo… Tommaso Cerno su L'Identità il 10 Dicembre
2023
Martin Luther Cecchettin. Visto che sono saltati i
consulenti del governo per i corsi di affettività nelle scuole, cosa che non mi
stupisce in un Paese dove ormai avere un’idea è vietato, perché bisogna ripetere
pedissequamente ciò che dice uno o schierarsi con l’altro e dire che quell’uno è
un cretino, consiglio timidamente di posticipare la lettura della lettera di
Gino Cecchettin nelle classi. Fino a quando non sarà chiarito davvero se le
frasi sui social che gli sono imputate, di natura sessista, sono state scritte
da lui. E questo per un principio molto semplice della democrazia. Può capitare
un omicidio, drammatico ed efferato come quello che ha visto questo padre
perdere la figlia Giulia, può capitare anche che il padre in questione dica
qualcosa di intelligente dopo la morte della sua congiunta, ma non
necessariamente gli assassini colpiscono sempre a casa degli eroi, non sempre
colpiscono dentro la vita di persone che devono diventare un simbolo di non si
capisce bene quale Paese.
Quindi prima di mitizzare quest’uomo e di
vedercelo candidato da Tizio da Caio alle elezioni proviamo a fare il Paese
serio e uscire per qualche minuto da Twitter, Instagram, le risse quotidiane e
riflettere sul fatto che questo signore a pochi giorni dalla morte di Giulia già
per il fatto di essere traumatizzato non dovrebbe affatto entrare in una scuola.
Se poi il bagaglio che si porta dietro è quello che abbiamo letto, e sicuramente
hanno letto prima di noi migliaia di studenti che passano le giornate a
smanettare sui telefoni, onde evitare che sui famosi social dove si svolge ormai
l’unica vita reale del Paese milioni di ragazzi comincino a prendere in giro il
Cecchettin e la di lui famiglia, sarebbe opportuno che i giornali che gridano al
fascismo e quelli che gridano all’antifascismo a seconda della Luna facessero di
tutto per pubblicare ciò che è avvenuto, spiegare se ciò che è avvenuto è
imputabile al padre di Giulia, mettere la parola fine alla celebrazione
dell’eroe civile nel caso in cui la risposta a questa microinchiesta fosse
affermativa. Ci siamo sorbiti anche l’intervista televisiva che chiude la
settimana italiana, fortunatamente alla Scala avevano già abbastanza guai di
loro per non infilarsi anche un membro della famiglia Cecchettin.
Ma sono certo che riusciremo a infamare la memoria
di Giulia facendo gli eroi sopra la testa di persone che sono a questo mondo
come tanti di noi senza bisogno di diventare Martin Luther King o Gandhi. Come è
il caso del signor Gino. Anche perché, non fosse altro per scaramanzia, l’ultimo
mito che è stato portato in politica e messo al centro della nuova etica del
Paese a difendere gli ultimi, ripreso e fotografato da tutte le televisioni e
celebrato da una parte politica, in questo caso la sinistra, come un eroe dei
tempi moderni contro una classe politica fatta di quaquaraquà, si chiama
Aboubakar Soumahoro e non serve ricordare che razza di figuraccia hanno fatto le
persone che si erano affidate a questo signore per mostrare la propria
superiorità etica di fronte a un Paese che ovviamente è fatto solo di cialtroni,
quando invece i cialtroni erano proprio loro. E così questa volta sarebbe
opportuno riportare a zero le strampalate fughe in avanti di chi ha pensato di
risolvere in pochi minuti, mettendo insieme una attivista lesbica e una suora
cattolica con un pizzico di questo e di quello, una questione che è gigantesca e
che riguarda il distacco fra la generazione degli adulti e i nostri ragazzi, che
negli ultimi 10 anni sembrano vivere al di fuori di ogni controllo della società
e dell’autorità.
Un fenomeno non certo italiano, che ha le proprie
radici dentro una modernità che ha creato degli strumenti sostitutivi
all’educazione classica, fuori dal controllo di chiunque, che hanno formato
principi e valori che noi boomer per quanto tecnologici come certi smanettoni
dei telefoni non siamo in grado di comprendere fino in fondo, e questo lo
dimostra anche l’incredibile silenzio del Paese di fronte al dubbio che il papà
di Giulia predichi bene e razzoli come tanti signori della sua età, che non
hanno avuto in casa il dramma enorme che ha vissuto lui ma che non per questo
devono per forza essere peggiori e che nessuno di noi si sognerebbe di mandare
in un istituto formativo di fronte a dei minorenni a parlare di sesso di donne e
di uomini. Ma vedremo l’Italia ipocrita cercare di far finta di niente e di
voltare questa pagina molto italiana e molto prevedibile, il fatto che le
disgrazie non scelgano mai a casa di chi capitare, per continuare a vivere
felici convinti che in tutte le cose ci sia una soluzione semplice, che ha un
unico colore bianco o nero, a seconda di quello che ci comoda dire e che ci
comoda raccontare.
Estratto dell’articolo di Selvaggia Lucarelli
per “il Fatto Quotidiano” domenica 10 dicembre 2023.
Assisto con sconcerto a una parabola che non avevo
previsto, e cioè alla malsana idea del padre di Giulia Cecchettin, Gino, di
tradire una sorta di promessa iniziale, e cioè di non trasformarsi nel volto di
una storia ma di offrire un megafono alla voce di tutte le storie.
Perché era di questo che ci aveva convinte,
all’inizio. Lui e sua figlia Elena avevano scelto di non usare i microfoni
voraci delle prime ore per ringhiare e giurare vendetta, ma per parlare di un
tema politico e universale. Per parlare di patriarcato. E non hanno usato quel
microfono neppure per puntare il dito sul mostro e accusare la famiglia del
mostro di qualche imprecisata complicità.
Virtù rara, soprattutto quando si ha a che fare
con le lusinghe della cronaca nera, quella che con i parenti rabbiosi costruisce
puntate e un’opinione pubblica altrettanto rabbiosa. Ora che un po’ di tempo è
passato e tante cose preziose sono state dette, posso confessare che non ho mai
creduto che la morte di Giulia Cecchettin sia stata un frutto purissimo della
cultura patriarcale.
Ci sono tante sfumature in questa vicenda, c’è un
ragazzo di 22 anni che senza Giulia si era avvitato in una spirale di morbosità
e depressione, c’era un disagio psicologico che lo aveva convinto a rivolgersi a
una specialista, c’era la fragilità identitaria di chi – giovanissimo – sente di
non saper gestire il panico dell’abbandono, di non valere nulla senza una
fidanzata e prova rancore per l’altra che ha una colpa imperdonabile: anziché
sentirsi monca, prosegue dritta per la strada dell’autodeterminazione.
C’è chi dice, legittimamente, che il patriarcato è
l’architettura su cui si reggono i rapporti tra generi e che esiste anche dove
pensi che non esista, ma questo significa svilire completamente la psicologia e
in particolare quella che studia le relazioni, i rapporti fusionali, le
dipendenze affettive, l’immaturità sentimentale ed emotiva di chi è molto
giovane e si sente completo solo in una relazione.
Poi, certo, tutto questo galleggia da sempre in
una società inquinata da secoli di patriarcato, in cui l’uomo – talvolta – vive
il rifiuto con un senso di sconfitta intollerabile, ma è evidente che visto il
contesto culturale e la giovane età dell’assassino qui il patriarcato c’entri in
parte.
La mia sensazione è stata però, fin da subito, che
la famiglia di Giulia stesse assolvendo a una funzione. Non importava che non
fosse perfettamente a fuoco ogni singola sfumatura di questa vicenda, importava
che le vittime collaterali di un fatto di cronaca così drammatico non si
lasciassero fagocitare dallo sciacallaggio populista della cronaca nera, che
parlassero di femminicidio come di un fenomeno, e non come di qualcosa che
riguardava solo loro. Importava che accendessero una luce.
Poi, giorno dopo giorno, l’universale ha iniziato
a rimpicciolirsi, a comprimersi come la materia di un buco nero e la storia di
tante è diventata sempre più la storia di una, il volto simbolico di Giulia
Cecchettin è diventato sempre meno simbolico, la vicenda è diventata sempre più
cronaca e sempre meno fenomeno.
Con tutti i rischi del caso perché, come dicevo
all’inizio, personalizzare troppo questa vicenda significa non più raccontarla
ma lasciare che venga vivisezionata, magari scoprendo, alla fine, che forse la
storia ignorata dell’anonima sessantenne uccisa dal marito dispotico perché lei
voleva separarsi era più figlia del patriarcato di questa. E però anche meno
telegenica, meno notiziabile.
A questo punto bisognerebbe aprire un’altra
parentesi, quella che riguarda l’estetica delle donne morte, sui giornali. Più
sei giovane, più sei bella, più hai un’aria angelica come Giulia e più la tua
morte sarà rilevante, più farà vendere i giornali e accendere la tv.
[…]
Dicevo quindi del padre di Giulia, Gino
Cecchettin. Il frullatore mediatico – dispiace dirlo – sta lentamente frullando
anche lui, la sua famiglia. La sua voce era diventata piazza, cortei, spazi su
giornali e tv dedicati al patriarcato mai visti prima. Ed era giusto così, che
quel suo megafono fosse diventato microfono per tante voci autorevoli,
soprattutto femminili, che in questi anni si sono dedicate a temi scomodi,
spesso considerati futili o pretestuosi. Voci di chi ha studiato il patriarcato,
perché per parlare di questi temi, non perdendo autorevolezza e senza lasciarsi
cogliere impreparati da chi non aspetta altro, serve cultura. E invece sono
iniziate le lusinghe di tv, giornali, giornalisti.
Cecchettin ha aperto la porta della camera della
figlia a Veltroni e ai fotografi, poi sono arrivati gli audio di Giulia a Chi
l’ha visto?, poi gli screen dei messaggi di Turetta alla sorella, poi la nonna
di Giulia promuove un suo libro che “Giulia stava leggendo”, poi Gino Cecchettin
che “Mi prendo una pausa dal lavoro, sto pensando a un impegno civico” con tanto
di annuncio pubblico ai colleghi su Linkedin. Infine, la notizia della sua
presenza da Fabio Fazio.
Ovviamente, siccome lo storytelling classico
prevede che non appena decidi di infilarti in questo genere di frullatore
qualcuno vada a caccia dei tuoi scheletri nell’armadio, sono spuntati dei
recenti tweet di Cecchettin a sfondo sessuale non proprio edificanti e c’è da
scommettere che l’operazione di character assassination sia solo agli inizi.
E così, la sensazione è che un uomo armato delle
migliori intenzioni sia finito nell’elica del frullatore mediatico e, ancor
peggio, politico. E che la politica e la tv, ancora una volta, cerchino di
appropriarsi di facce e storie, anziché del valore pedagogico che quelle facce e
quelle storie dovevano rappresentare.
Capisco la decisione e ringrazio per la
fiducia". Chi è Anna Paola Concia, scaricata da Valditara al centro delle
polemiche dei garanti nel progetto sull’educazione. Redazione su Il Riformista
il 10 Dicembre 2023
Anna Paola Concia è una politica e attivista
italiana, deputata tra le fila del Pd nella XVI legislatura. La sua attività
politica ha inizio negli anni ’80 nel Partita Comunista Italiano, passando poi
al Partito Democratico della Sinistra e infine al Pd.
Il suo impegno si concentra sui diritti civili e
sulla lotta alle discriminazioni: oltre ad essere fondatrice di Emily,
associazione nata per sostenere l’impegno politica delle donne, ha assunto il
ruolo di portavoce del tavolo nazionale LGBT del PD.
Nel 2015 è entrata nel consiglio d’amministrazione
di Firenze Fiera, designata dalla Camera di Commercio di Firenze. Nel 2017 è
diventata Assessora alle Relazioni internazionali e Cooperazione, turismo,
fiere, congressi, marketing territoriale, attrazione di investimenti del Comune
di Firenze. Impegnata anche sul fronte educativo, nel 2019 Anna Paola Concia ha
coordinato il Comitato organizzatore di Didacta Italia, la fiera della scuola
dedicata a Leonardo Da Vinci.
Per molti anni ha lavorato nelle Istituzioni:
prima come assistente parlamentare presso la Camera dei Deputati, poi consulente
dei Ministri per le Pari Opportunità Anna Finocchiaro e Maria Cecilia Guerra, e
dei Beni e Attività Culturali Giovanna Melandri. E’ stata inoltre editorialista
(in Germania) del quotidiano l’Unità.
Il progetto sull’educazione alle relazioni
La politica ed attivista LGBT, da anni impegnata
nel campo dei diritti civili e della lotta alle discriminazioni, era stato
indicata dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per guidare “Educare
alle relazioni“, il nuovo programma ideato dal governo per promuovere la
formazione affettiva e relazionale dei giovani in risposta ai recenti
femminicidi e casi di violenza sulle donne. Tuttavia, dopo numerose critiche e
una raccolta firme ad opera di ProVita, la nomina della Concia è saltata.
“Capisco la decisione del Ministro Valditara e lo
ringrazio della fiducia accordatami: dopo due giorni di polemiche da ambienti
massimalisti della destra e della sinistra, è per me evidente che non esistono
le condizioni per svolgere il lavoro equilibrato e dialogante che mi ero
proposta insieme alle altre due garanti del progetto ‘Educazione alle
relazioni’. Resto convinta che solo il confronto tra matrici culturali
differenti possa produrre linee guida efficaci e non divisive sul tema del
rispetto della libertà delle donne” ha fatto sapere la Concia dopo aver appreso
la decisione di Valditara.
Vita privata di Paola Concia e coming out nel 2000
Paola Concia ha fatto coming out nel 2000, ed è
stata una dei primi deputati dichiaratamente omosessuali nella storia della
Repubblica italiana. Impegnata in una lunga relazione con la criminologa
tedesca Ricarda Trautmann, si è a lei unita civilmente il 5 agosto 2011 nella
città di Francoforte.
Dopo la cerimonia, la Trautmann ha assunto il
cognome della Concia, e nel 2012 la coppia ha presentato un ricorso presso il
tribunale civile di Roma per chiedere che l’unione fosse riconosciuta anche in
Italia: quando il tribunale ha respinto la richiesta, lei ha annunciato ricorso
presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.
Paola Concia: «Io criticata dai massimalisti.
Da destra per la mia vita, da sinistra perché dialogo». Alessandra Arachi su
Il Corriere della Sera il 10 Dicembre 2023
L’attivista dopo le dimissioni a cui è stata
costretta dopo la bufera per la nomina del ministro Valditara: «Ho lavorato bene
con Meloni, che risate con lei da Crozza»
Paola Concia, come si sente?
«Sono sconcertata. Anche il ministro Valditara lo
è».
È stato lui che prima le ha dato e poi le ha tolto
la nomina di garante all’educazione nelle scuole. Lo ha sentito?
«Certo. Correttamente mi ha chiamato prima di
scrivere il comunicato».
Vi conoscete da tempo?
«Collaboriamo da un anno per Didacta, l’evento
sulla scuola più importante in Italia».
Non pensa che il ministro avrebbe potuto tenere
più il punto sulla sua scelta?
«Lo hanno sottoposto a una pressione alla quale
non si è potuto sottrarre. Lo hanno messo alle corde».
Chi lo ha pressato secondo lei?
«Massimalisti di destra e di sinistra. Hanno
criticato anche la nomina di suor Monia. Lei è stata criticata da sinistra.
Io... da tutti».
Chi sono i massimalisti di cui parla?
«Non faccio nomi. Ma mi spiego. Da destra sono
stata attaccata perché lesbica e femminista. Dalla sinistra massimalista lgbt
perché sono una persona dialogante, ho sempre dialogato, ho sempre costruito
ponti».
Quando li ha costruiti?
«Quando ero parlamentare del Pd ho dialogato molto
con la destra».
Un esempio?
«La prima legge sullo stalking l’ho fatta insieme
a Mara Carfagna, quando era ministra per Forza Italia. Anche con Giorgia Meloni
ho lavorato molto».
Con Giorgia Meloni?
«Con lei c’è stato sempre un confronto molto
tranquillo soprattutto sull’omofobia. Ma la cosa più divertente è quando siamo
andate insieme da Crozza».
Da Crozza? Insieme?
«Sì, lui faceva un finto Marzullo. Ci ha fatto
un’intervista doppia. Abbiamo riso tanto».
Ha avuto anche la solidarietà del presidente
Ignazio La Russa. Si è stupita?
«No perché lui ha sempre avuto una grande stima
per me. Mi ha invitato anche al concerto di Natale. L’ho ringraziato ma non
posso, io sto a Francoforte».
Possibile che sia stata così tanto attaccata,
nonostante la stima della presidente del Consiglio?
«Di certo la responsabilità di questa vicenda non
è la sua».
A prenderla di mira in maniera più diretta è stata
la onlus ultraconservatrice Pro Vita e Famiglia. Tra gli attacchi espliciti il
fatto che lei fosse favorevole al ddl Zan e alla maternità surrogata.
«Il ddl Zan l’ho criticato: era formulato male,
anche se ero favorevole alla legge. Alla maternità surrogata non sono
favorevole. Per il riconoscimento dei diritti dei bambini assolutamente sì. Ma
non farei mai una battaglia per la legalizzazione della maternità surrogata».
Forse è proprio per questo che ha avuto attacchi
anche dalla sinistra.
«I massimalisti, da destra e da sinistra, hanno
criticato a prescindere, non si sono fermati neanche a vedere cosa diceva il
progetto».
È stato detto che avreste portato il gender nelle
scuole.
«Altra falsità. Ci saremmo occupate di contrasto
alla violenza sulle donne. Questo era il mandato, non altro».
Lei vive a Francoforte con sua moglie Ricarda, che
ne pensa lei di questa vicenda?
«Non capiva: “Che strano Paese l’Italia”, ha
detto».
Vi siete sposate lì?
«Per forza, era il 2011, in Germania già c’era il
matrimonio egualitario, in Italia le unioni civili erano di là da venire».
Quindi in Italia non siete una coppia
riconosciuta?
«Sì, adesso sì, quando è stata approvata la legge
abbiamo registrato l’unione civile anche in Italia».
Dove vi siete conosciute?
«A Roma. Un incontro legato al nostro attivismo.
Io avevo organizzato un evento europeo. Lei era venuta a partecipare come
delegata».
È andata subito a vivere in Germania?
«Ero parlamentare. Abbiamo vissuto un rapporto a
distanza fino a quando non è finita la legislatura e non sono stata rieletta».
Poi?
«Ho cercato lavoro a Francoforte. È dalla Germania
che ho importato in Italia Didacta».
Contenta di vivere lì?
«È un Paese dove i diritti sono reali. Questo in
Germania non sarebbe mai successo».
Zan Zan…i soldi e la bufera Lgbt. E spunta il
fondo maltese Virgo. Rita Cavallaro su L'Identità il 12 Dicembre 2023
Se anche i diritti dei gay diventano un business
da milioni di euro, tra Pride concessi in monopolio, sponsor che mettono le mani
sugli eventi e introiti che finiscono nelle casse di società di capitali dietro
il pretesto della lotta contro le discriminazioni. È lo strano caso del paladino
dei diritti Lgbt Alessandro Zan, il deputato dem finito nel polverone dopo il
servizio di Report. La trasmissione di RaiTre ha messo sotto la lente la Be
Proud Srl, azienda che il parlamentare ha fondato nel 2011 insieme al suo
fedelissimo, il giornalista del Mattino di Padova, Claudio Malfitano.
Una società tutt’altro che no profit, visto nel
2022 ha incassato più di un milione e 300mila euro, di cui oltre 700mila di
corrispettivi di ingresso e oltre 450mila dagli incassi del bar del Pride
Village, il mega spazio che il Comune aveva donato gratuitamente all’Arcigay nel
2008, per le attività di volontariato divenuto oggi il grande business di
Zan&Co.
A Padova, negli ambienti della comunità, giurano
che nessuno tra i vertici dell’Arcigay fosse a conoscenza che la lotta per i
diritti civili era stata trasformata in un’attività imprenditoriale, che si è
intestata il marchio dell’associazione e, forte del logo, non solo guadagna
centinaia di migliaia di euro dalla kermesse. Ma che non ha rinunciato neppure
agli aiuti dei ristori statali per il Covid, ben 180mila euro. Che parte degli
introiti dal Village li rinveste in finanziamenti al Pd, al quale ha versato
50mila euro durante la campagna elettorale che ha visto Zan conquistare proprio
il collegio di Padova. “Tutto quello che viene guadagnato viene riversato
nell’iniziativa e dunque non c’è nessun tipo di guadagno”, ha precisato Zan a
Report, sottolineando che “ho prestato il mio nome per dare una mano.
Lo faccio con spirito di servizio, a titolo
gratuito”. E pensare che al Pride Village neppure l’ingresso è gratuito, quindi
figurarsi quanto le sue giustificazioni abbiano potuto attecchire nella comunità
LGBTQ+. Tanto più che le iniziative di Zan, ormai da anni, più che il marchio
gay hanno quello della concorrenza sleale. È stato proprio il Comune di Padova a
garantire allo spazio “che fu” dell’Arcigay deroghe a qualsiasi limitazione
commerciale, alle quali, invece, sono sottoposti i proprietari degli altri
locali. Più spazi, più musica, più elasticità sugli orari di chiusura. Un
vantaggio competitivo e illecito, che probabilmente ha aperto la porta a una
serie di fortunati eventi che portano un nome: Virgo Holding Spa.
Una manna dal cielo piovuta su Zan lo scorso
maggio, quando la Virgo Fund, un fondo maltese controllato dalla Virgo Holding
Spa che dal 2022 ha sede a Milano ma che è di proprietà svizzera, ha annunciato
l’investimento di quattro milioni di euro per il triennio 2023-2025, in progetti
al servizio dell’inclusività per il riconoscimento dei diritti civili, a partire
dal Pride Virgo Village, la più grande manifestazione estiva della comunità
LGBTQ+. Anzi, forse l’unica, a ben guardare le altre realtà del Paese. Il Pride
di Roma è stato costretto a finire in malora dopo la caduta del sindaco Ignazio
Marino, perché l’amministrazione Raggi e neppure l’attuale di Gualtieri hanno
concesso le deroghe necessarie a mettere in piedi un evento del genere.
Così il Pride di Zan opera in una sorta di
monopolio e attrae società con capitali perfino dall’estero, dalla holding al
cui interno c’è di tutto, dalla cosmetica alla radio, dall’energia alla
mobilità, dall’immobiliare alle assicurazioni. Holding che non fa certo
beneficenza, ma che in quanto Spa è tenuta a investimenti redditizi, da mettere
in atto in collaborazione con la Be Proud. Virgo, con il suo ceo Alessandro Vox,
è diventata dunque lo sponsor unico di Zan. E ha annunciato: “Virgo Holding Spa,
con i marchi Onova- Megavatt- Virgo Milano – Suomy – Eau de Milano (satelliti
della holding, ndr) – Paolo Rossi Please, investirà circa 4 milioni di euro in
tutta una serie di progetti, volti a sensibilizzare sempre più la società su
temi di estremo interesse collettivo. Ogni anno produrrà un film incentrato sul
tema delle discriminazioni. Inoltre, lancerà il magazine Equall, che sarà
possibile trovare sia online sia nelle edicole italiane, edito dal comparto
editoria di Virgo.
Ancora, investirà sulla mobilità sostenibile
all’interno del Pride Village Virgo con l’ausilio di mezzi di trasporto
elettrici totalmente green Suomy ed Onova Green Mobility e con l’esclusivo
Onovapark. Punterà anche sulla televisione, con format tv e radiofonici
trasmessi direttamente dal Pride Village Virgo. Il progetto prevede infatti la
distribuzione di contenuti, appositamente prodotti durante il Pride Village
Virgo, attraverso una multipiattaforma studiata per essere fruibile da diversi
device, sia desktop che mobile. Party a tema con testimonial d’eccellenza per
Virgo Milano, Suomy, Eau de Milano, Paolo Rossi Please, Onova, Megawatt”. Altro
che diritti! Se non è business questo, cosa lo è?
Diritti Lbgtqia+ e milioni: bufera Report su
Alessandro Zan. E lui si difende: “Tutto regolare”. Angelo Vitolo su
L'Identità l'11 Dicembre 2023
Nella bufera mediatica scatenata da Report finisce
il deputato del Pd Alessandro Zan. L’inchiesta del programma condotto da Sigrido
Ranucci scopre il giro di affari intorno alle iniziative Lbgtqia+.
Zan è titolare della società che promuove il Pride
che si svolge ogni anno a Padova e che registra un incasso di oltre un milione
di euro dai vari festival collegati. Zan è il parlamentare del Partito
Democratico che ha legato il suo nome alla proposta di legge sull’omotransfobia
e che tenne banco durante gli anni della scorsa legislatura tra varie polemiche.
Nella trasmissione parla il commercialista e
revisore legale Stefano Capaccioli confermando che il Pride Village di Padova è
gestito dalla società Be Proud Srl, costituita a suo tempo con 3mila euro da tre
soci – Zan ne è amministratore unico e socio di maggioranza – e che nel 2022 ha
incassato più di un milione e 300mila euro, di cui oltre 700mila euro dagli
ingressi all’iniziativa – solitamente 200mila ogni anno – e 450mila euro dagli
incassi del bar, organizzato con una consumazione minima al tavolo da 160 euro.
E ha pure incassato 180mila di euro di ristori Covid, versando 50mila euro dal
suo bilancio al Pd nazionale e locale.
Be Proude srl è affiancata da Virgo, un fondo di
investimento dedicato ai tempi Lgbtqia+ che finanzia con 4 milioni di euro
queste iniziative e, come sponsor e patrocinatori, dal Comune di Padova guidato
dal sindaco civico Sergio Giordani e da società dell’energy e del green.
Zan,
all’intervista di Report, ha replicato che “tutto quello che viene guadagnato
viene riversato nell’iniziativa, e dunque non c’è nessun tipo di guadagno”, con
un suo ruolo “a titolo gratuito, in spirito di servizio”.
Report, l’inchiesta su Alessandro Zan e Michela
Di Biase: «Società che guadagnano sui diritti». Loro: «Solo falsità».
Alessandra Arachi su Il Corriere della Sera domenica 10 dicembre 2023.
Il programma di Rai tre condotto da Sigfrido
Ranucci ha indagato su due società dei deputati Pd: una per gestire il Prdi, per
Alessandro Zan, l’altra per le consulenze sulla certificazione della parità di
genere, per Michela Di Biase
Una società privata per gestire il Pride di
Padova, Alessandro Zan. E per Michela Di Biase un’altra società privata per la
consulenza alle società per la certificazione della parità di genere. Sono i due
deputati del Pd che ieri sera su Rai Tre sono finiti nel mirino di «Report»,
condotto da Sigfrido Ranucci.
Report non contesta loro la violazione della
legge, ma piuttosto opportunità politiche, anche conflitti di interesse: ognuno
dei due deputati ha fondato la propria società sui temi che sono di interesse
prioritario della propria attività politica. I diritti Lgbt per Alessandro Zan.
La parità di genere per Michela Di Biase.
Con la sua «Be proud srl» Alessandro Zan
organizza a Padova il festival lgbt più importante d’Italia, tre mesi di
festeggiamenti e attività per promuovere, appunto, i diritti lgbt. Oltre un
milione di euro il fatturato della società nel 2022 di cui Zan è amministratore
unico, come regolarmente denunciato nei registri di Montecitorio. Lorenzo
Vendemiale avvicina Zan durante il servizio: «Due domande sul Festival. Avete
messo su un bell’evento sponsor, concerti, anche birra, pizza… ma si può dire
che questo è a tutti gli effetti un evento commerciale». Il deputato Pd scuote
la testa: «No, no, è un evento dove tutto quello che viene guadagnato viene
riversato nell’iniziativa e dunque non c’è nessun tipo di guadagno».
A Michela Di Biase viene contestato di aver messo
in piedi una società per la consulenza della certificazione della parità di
genere, in anticipo rispetto alle altre, la «Obiettivo 5». Report ipotizza che
questo sia avvenuto grazie alle sue entrature politiche, lei che è la moglie di
Dario Franceschini, all’epoca ministro del Pd. Di Biase nega:«Né personalmente
ne a nome di Obiettivo Cinque ho mai avuto interlocuzioni con
politici finalizzate all’approvazione della certificazione di parità nel codice
dei contratti Inoltre non ero in Parlamento quando è stata approvata la legge».
Estratto dell’articolo di Fabio Amendolara per “La
Verità” domenica 10 dicembre 2023.
Gay.it, il sito web punto di riferimento per la
comunità omosessuale italiana, dedica al Padova pride village, una descrizione
molto breve ma efficace: «Fondato da Alessandro Zan (sì, proprio lui, il
relatore del disegno di legge omonimo contro l’omofobia, la transfobia, la
misoginia e l’abilismo), è il più grande evento Lgbtq+ del Nord Italia, che si
svolge in estate dal 2008».
Ma ci sono altri due dettagli non trascurabili che
Report, il programma televisivo d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci che
andrà in onda oggi su Rai 3, ha scoperto: Zan, oltre a esserne il fondatore, è
anche l’organizzatore dell’evento tramite una società, la Be Proud srl, azienda
che opera con un codice Ateco, quello che identifica l’attività economica, per
l’organizzazione di convegni e fiere.
Ha un capitale sociale di 3.000 euro, sede legale
a Padova e un valore della produzione da oltre 600.000 euro. Ma il moschettiere
che combatte l’omotransfobia e che è nella segreteria nazionale del Partito
democratico (Elly Schlein è stata ospite d’onore della serata di chiusura
dell’ultima edizione del Pride padovano), detiene il 52% delle quote della Be
Proud e, oltre a essere quindi il socio di maggioranza, è anche l’amministratore
unico della società.
L’evento, in coda al nome mostra anche un altro
brand: Virgo, un fondo d’investimento che ha deciso di puntare sull’inclusività
e per abbinare il suo brand all’evento ha sborsato 4 milioni per progetti sul
tema. «In Virgo Fund», è spiegato sul sito web del fondo, «siamo consapevoli che
promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione in ogni aspetto della nostra
attività è un nostro valore fondamentale oltre che essere un ingrediente del
nostro successo». E ancora: «Virgo Fund abbraccia l’uguaglianza e l’inclusione
come canoni di bellezza in quanto parte del nostro ambiente di lavoro, degli
investimenti e soprattutto delle partnership che scegliamo, fino all’offerta
delle competenze nelle nostre attività».
Obiettivi che sembrano essersi sposati in pieno
con il pride padovano. Che, oltre a Virgo, può contare su un’altra partnership:
il Comune di Padova, guidato da Sergio Giordani, un sindaco che piace
particolarmente ai dem.
In bella mostra sul sito web dell’evento
organizzato da Zan ci sono poi anche i loghi dei partner, in prevalenza società
energetiche e della mobilità verde, ma non mancano i big del beverage. E,
spiegano gli organizzatori, «il Pride Village Virgo è un evento inclusivo che
accetta tutte (con la «e» capovolta, ndr), tranne gli omofobi». La politica
(ideologica) sembra intrecciarsi spesso, però, con l’attività di business. E
Padova è proprio il collegio elettorale di Zan.
Gli inviati di Report, Carlo Tecce e Lorenzo
Vendemiale sono stati al pride che ogni anno supera le 200.000 presenze e hanno
potuto verificare sul campo che è un bel «giocattolo» per fare business.
Nell’area beverage, per esempio, c’è un privé con quota d’ingresso da 25 euro a
persona e consumazione minima al tavolo da 160 euro. «Le quote», è spiegato
online dagli organizzatori, «si sommano e vengono convertite in un giro di
bottiglie (servite direttamente al tavolo)». Chi decide di restare in piedi,
invece, paga 10 euro e non ha diritto alla consumazione, da pagare a parte.
A questo punto i due giornalisti si sono chiesti:
«Tutto ciò che viene speso per bere, mangiare e divertirsi, dove finisce?». Una
domanda che hanno rivolto proprio a Zan. Che ha risposto così: «È un evento dove
tutto quello che viene guadagnato viene riversato nell’iniziativa e dunque non
c’è nessun tipo di guadagno».
Poi l’hanno incalzato: «Non ci vede un po’ un
conflitto nell’avere una società che ha comunque un giro d’affari sugli stessi
temi su cui lei, giustamente, conduce delle battaglie meritevoli in
Parlamento?». La risposta: «No, io ho prestato il mio nome per dare una mano. Ma
lo faccio con spirito di servizio, a titolo gratuito».
I due giornalisti hanno quindi raccolto le
considerazioni di Stefano Capaccioli, commercialista e revisore legale: «Le
società sono fatte necessariamente per avere un utile. Incassando 1,3 milioni e
spendendo, visto che guadagna poco, 1,3 milioni, fondamentalmente c’è tutta una
serie di fattori produttivi che vengono remunerati. Dichiarano otto dipendenti,
c’è un affitto, ci sono dei servizi». La conclusione non può che essere una: «È
un business».
Stando a Zan, la Be Proud non avrebbe ricevuto
aiuti pubblici. Tranne uno: 180.000 euro di ristori Covid. Per i quali Zan ha
spiegato: «C’erano i fornitori che avevano installato tutto il materiale e
quelli andavano pagati. Per cui, come tutte le altre società, hanno chiesto un
aiuto pubblico». La Be Proud, infatti, ha superato le difficoltà della pandemia
anche grazie agli aiuti dello Stato: oltre 180.000 euro di ristori Covid,
appunto, senza cui il bilancio 2021 avrebbe chiuso in perdita.
La recente storia della società, però, s’intreccia
di nuovo con la politica. Nell’ultimo anno e mezzo la Be Proud ha versato circa
50.000 euro nelle casse del Partito democratico nazionale e locale. E Schlein
sul palco della serata di chiusura non si era fatta sfuggire l’occasione per
lanciare un messaggio politico: «Vi ringrazio di questa partecipazione, per
questa chiusura del Village qui a Padova. E allora insieme, vi prego, siamo qui
per divertirci. Ma non dimentichiamoci che dobbiamo essere militanti tutte
quante, tutti quanti, insieme». Zan ringrazia. E con la benedizione del
segretario nazionale del Pd diritti e business vanno a braccetto.
Estratto dell’articolo di Fabio Amendaolara
per “la Verità” domenica 10 dicembre 2023.
L’altra grande battaglia del Partito democratico
sui diritti civili è la parità di genere. E anche su questo campo c’è chi ha
saldato l’attività politica a quella commerciale. La deputata dem e apologeta
dei diritti rosa, Michela Di Biase, moglie di Dario Franceschini ed ex
consigliere regionale del Lazio. Proprio da consigliere regionale, su suo
impulso, il Consiglio si dotò delle linee guida per l’uso del linguaggio di
genere.
Ora si scopre che detiene il 25% di Obiettivo
cinque, agenzia che fa consulenza di genere alle imprese. Ma sembra essere molto
più di una semplice socia di minoranza. Una testimonianza esclusiva raccolta da
Report svela che l’idea di fondare la società è stata proprio sua, «perché
sapeva», ritengono i cronisti del programma di Ranucci, «grazie alle sue
entrature politiche e le informazioni privilegiate di cui dispone a palazzo, che
il Parlamento avrebbe approvato una legge che avrebbe portato importanti
finanziamenti pubblici sul tema (sono stati stanziati 50 milioni di euro per il
2022, ndr)».
Il bollino rosa offre, oltre a bonus fiscali,
anche la decontribuzione sul costo del lavoro e vantaggi reputazionali. «Grandi
e piccole aziende», valutano i giornalisti di Report, «fanno la corsa a questa
certificazione, spesso ottenuta grazie all’aiuto di preziosi consulenti». E
proprio con i contributi pubblici le aziende possono pagarsi il lavoro che serve
per ottenere la certificazione. Comprese le consulenze.
E qui si inserisce Obiettivo cinque, che si occupa
di offrire consulenza di genere e che è guidata da un team tutto al femminile.
Dietro di loro, però, anche se sul sito web della società non compare, c’è
Michela Di Biase. Nel servizio di Report una donna col volto coperto e la voce
alterata digitalmente viene presentata come una manager di Obiettivo cinque. E
spiega: «Michela ha avuto l’idea perché sapeva che sarebbe nata di lì a poco una
certificazione di parità. Siamo stati sicuramente i primi».
La società nasce ad aprile, ovvero sette mesi
prima della legge che regola la certificazione sulla parità di genere. Non solo.
Ricostruiscono i cronisti di Report che «Obiettivo cinque avrebbe, poi,
contribuito a modificare un altro decreto in Parlamento, scrivendo i contenuti
di un emendamento per far rientrare la certificazione nel nuovo codice dei
contratti pubblici». Un intervento normativo che ha avuto la conseguenza di far
crescere il valore della certificazione. E, indirettamente, anche il giro
d’affari per chi se ne occupa.
«Mentre da deputata», sostiene Report, «interviene
pubblicamente, firma emendamenti e partecipa a eventi sul tema, fuori dal
Parlamento ha fatto di questa battaglia politica un business privato». Nel 2022
Obiettivo cinque, con clienti del calibro di Philipp Morris e Novartis, ha
chiuso il bilancio con un fatturato da oltre 200.000 euro. E ora nel mirino c’è
anche il Pnrr.
Al fianco della Di Biase nell’avventura
imprenditoriale c’è Elena Di Giovanni, già vicepresidente di Comin and partners,
big player nel settore della comunicazione. La Di Giovanni, oltre ad aver
lavorato anche per il ministero dei Beni culturali (Franceschini ne è stato
ministro), insieme all’altro fondatore della società di comunicazione, Gianluca
Comin, è stata nominata in una fondazione culturale proprio da Franceschini. […]
Affari di genere. Report
Rai PUNTATA DEL 10/12/2023
di Lorenzo Vendemiale e Carlo Tecce
Collaborazione di Madi Ferrucci
Il conflitto di interesse in Parlamento non ha
colore politico.
Dopo l’inchiesta esclusiva sugli interessi del
senatore Maurizio Gasparri nella cybersicurezza, Report torna con una nuova
puntata che riguarda stavolta gli affari della sinistra sui diritti civili. Il
servizio svelerà le attività private di due volti di primo piano del Partito
Democratico: da sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili, fuori dal
Parlamento hanno fatto di questa nobile battaglia politica un business.
Le domande della redazione e le risposte
fornite da:
- L'Onorevole Michela Di Biase
- L'Agenzia di comunicazione politica
Comin&Partners
- L'Onorevole Michela Di Biase
Gentilissimi, di seguito le risposte alle vostre
domande. Qual è il ruolo di Elena Di Giovanni, vicepresidente e cofondatrice
della vostra agenzia, in Obiettivo Cinque?* La partner Elena Di Giovanni e' uno
dei soci di Obiettivo Cinque. Non riveste alcun ruolo operativo all'interno
della società. La società Obiettivo Cinque annovera fra i suoi partner Comin &
Partners: qual è il rapporto che lega la vostra agenzia a Obiettivo Cinque? La
partnership è consistita in uno scambio di attività professionali. Obiettivo
Cinque ha redatto il bilancio di genere 2022 di Comin & Partners e quest’ultima
dovrà svolgere funzioni di ufficio stampa per Obiettivo Cinque. Inoltre, su
specifici progetti di sostenibilità aziendale hanno proposto servizi congiunti.
E’ opportuno che la titolare di un’importante agenzia di comunicazione politica
come la vostra sia anche socia in affari con una parlamentare della Repubblica,
Michela Di Biase, il cui marito, Dario Franceschini da ministro dei Beni
Culturali ha per altro nominato i soci fondatori della vostra agenzia, Gianluca
Comin e Elena Di Giovanni, nel Cda di due importanti Fondazioni culturali (il
Teatro dell’opera e la Galleria Nazionale)? Le nomine di Gianluca Comin e di
Elena Di Giovanni sono avvenute molto tempo prima della nascita di Obiettivo
Cinque e comportano attività a titolo gratuito. L’attività d'impresa di
Obiettivo Cinque ha uno spiccato carattere sociale ed è finalizzata a promuovere
la cultura di genere nelle aziende. Si tratta pertanto di una partnership
sinergica non solo opportuna ma, riteniamo, meritoria.
Il giorno mer 6 dic 2023 alle ore 13:24 [CG]
Redazione Report Report Via Teulada, 66 – 00195 Roma Gentilissimi, vi scriviamo
dalla redazione di Report, il programma di Rai3, perché nel corso della prossima
puntata ci occuperemo della società Obiettivo Cinque, che è partner della vostra
agenzia, e di cui la vostra vicepresidente, Elena Di Giovanni, è socia. A tal
proposito, vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande: • Qual è il ruolo
di Elena Di Giovanni, vicepresidente e cofondatrice della vostra agenzia, in
Obiettivo Cinque? • La società Obiettivo Cinque annovera fra i suoi partner
Comin & Partners: qual è il rapporto che lega la vostra agenzia a Obiettivo
Cinque? • E’ opportuno che la titolare di un’importante agenzia di comunicazione
politica come la vostra sia anche socia in affari con una parlamentare della
Repubblica, Michela Di Biase, il cui marito, Dario Franceschini da ministro dei
Beni Culturali ha per altro nominato i soci fondatori della vostra agenzia,
Gianluca Comin e Elena Di Giovanni, nel Cda di due importanti Fondazioni
culturali (il Teatro dell’opera e la Galleria Nazionale)? Per esigenze di
produzione, vi preghiamo di rispondere entro e non oltre giovedì 7 dicembre.
Grazie e cordiali saluti, Redazione Report - Rai3
- L'Agenzia di comunicazione
politica Comin&Partners
Gentilissimi, di seguito le risposte alle vostre
domande. Qual è il ruolo di Elena Di Giovanni, vicepresidente e cofondatrice
della vostra agenzia, in Obiettivo Cinque?* La partner Elena Di Giovanni e' uno
dei soci di Obiettivo Cinque. Non riveste alcun ruolo operativo all'interno
della società. La società Obiettivo Cinque annovera fra i suoi partner Comin &
Partners: qual è il rapporto che lega la vostra agenzia a Obiettivo Cinque? La
partnership è consistita in uno scambio di attività professionali. Obiettivo
Cinque ha redatto il bilancio di genere 2022 di Comin & Partners e quest’ultima
dovrà svolgere funzioni di ufficio stampa per Obiettivo Cinque. Inoltre, su
specifici progetti di sostenibilità aziendale hanno proposto servizi congiunti.
E’ opportuno che la titolare di un’importante agenzia di comunicazione politica
come la vostra sia anche socia in affari con una parlamentare della Repubblica,
Michela Di Biase, il cui marito, Dario Franceschini da ministro dei Beni
Culturali ha per altro nominato i soci fondatori della vostra agenzia, Gianluca
Comin e Elena Di Giovanni, nel Cda di due importanti Fondazioni culturali (il
Teatro dell’opera e la Galleria Nazionale)? Le nomine di Gianluca Comin e di
Elena Di Giovanni sono avvenute molto tempo prima della nascita di Obiettivo
Cinque e comportano attività a titolo gratuito. L’attività d'impresa di
Obiettivo Cinque ha uno spiccato carattere sociale ed è finalizzata a promuovere
la cultura di genere nelle aziende. Si tratta pertanto di una partnership
sinergica non solo opportuna ma, riteniamo, meritoria.
Il giorno mer 6 dic 2023 alle ore 13:24 [CG]
Redazione Report Report Via Teulada, 66 – 00195 Roma Gentilissimi, vi scriviamo
dalla redazione di Report, il programma di Rai3, perché nel corso della prossima
puntata ci occuperemo della società Obiettivo Cinque, che è partner della vostra
agenzia, e di cui la vostra vicepresidente, Elena Di Giovanni, è socia. A tal
proposito, vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande: • Qual è il ruolo
di Elena Di Giovanni, vicepresidente e cofondatrice della vostra agenzia, in
Obiettivo Cinque? • La società Obiettivo Cinque annovera fra i suoi partner
Comin & Partners: qual è il rapporto che lega la vostra agenzia a Obiettivo
Cinque? • E’ opportuno che la titolare di un’importante agenzia di comunicazione
politica come la vostra sia anche socia in affari con una parlamentare della
Repubblica, Michela Di Biase, il cui marito, Dario Franceschini da ministro dei
Beni Culturali ha per altro nominato i soci fondatori della vostra agenzia,
Gianluca Comin e Elena Di Giovanni, nel Cda di due importanti Fondazioni
culturali (il Teatro dell’opera e la Galleria Nazionale)? Per esigenze di
produzione, vi preghiamo di rispondere entro e non oltre giovedì 7 dicembre.
Grazie e cordiali saluti, Redazione Report – Rai3
AFFARI DI GENERE di Carlo Tecce - Lorenzo
Vendemiale Collaborazione Madi Ferrucci Immagini Chiara D’Ambrosio – Cristiano
Forti – Fabio Martinelli – Paco Sannino
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO A Padova ogni
estate va in scena il Pride Village, il più grande festival LGBTQIA + d'Italia
BALLERINO Lo seguo da 10 anni quindi…
LORENZO VENDEMIALE Questo qua?
BALLERINO Questo.
LORENZO VENDEMIALE Ed è migliorato? BALLERINO Sì,
devo dire di sì, anche a livello di ospiti.
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO Tre mesi di
concerti, dibattiti, grandi ospiti, in uno spazio di oltre 10mila metri quadrati
della Fiera di Padova. Tutto questo ha un nome e un cognome: Alessandro Zan,
deputato Pd simbolo della lotta per i diritti civili, che ha firmato il famoso
disegno di legge contro l'omotransfobia. E anche l’organizzatore di questo
festival.
SPEAKER Gli fate un applauso ad Alessandro? Vieni
qua con noi, vieni vieni, noi ti vogliamo.
ALESSANDRO ZAN - DEPUTATO PARTITO DEMOCRATICO
Vogliamo una leader femminile, ma anche femminista e per questo l'abbiamo
invitata questa sera. Consentitemi di avere qui, di presentarvi con un caloroso
applauso un'amica, ma soprattutto la segretaria del Partito Democratico, Elly
Schlein.
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO Anche la segretaria
del Partito Democratico, Elly Schlein, è stata ospite d’onore della serata di
chiusura dell’ultima edizione.
ELLY SCHLEIN - SEGRETARIA PARTITO DEMOCRATICO Vi
ringrazio di questa partecipazione, per questa chiusura del Village qui a
Padova. E allora insieme, vi prego, siamo qui per divertirci. Ma non
dimentichiamoci che dobbiamo essere militanti tutte quante, tutti quanti
insieme.
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO Il Festival porta
il nome di Virgo, fondo d’investimento che ha deciso di puntare sull’inclusività
e per abbinare il suo brand all’evento ha sborsato 4 milioni di euro in progetti
sul tema. E ogni anno al Pride si superano le 200.000 presenze, fra queste anche
molti attivisti ed elettori
RAGAZZA Libertà, divertimento, nessuno ci giudica.
Bellissimo!
LORENZO VENDEMIALE Siete qua anche per l’onorevole
Zan?
RAGAZZA Sì, è grazie a lui se c’è questo posto.
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO E tutto ciò che
spendono per bere, mangiare, divertirsi durante la serata, dove finisce?
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA E REVISORE
LEGALE Il Pride Village di Padova è della società Be Proud srl, è stata
costituita con 3mila euro da tre soci.
LORENZO VENDEMIALE Ma questa Be Proud che cos'è? È
un'associazione di volontariato, è una società no profit?
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA E REVISORE
LEGALE No, no, è una società commerciale. Nel 2022 ha incassato più di 1.300.000
euro, di cui oltre 700.000 euro di corrispettivi di ingresso e oltre 450.000
euro dagli incassi del bar.
LORENZO VENDEMIALE Quindi qual è il ruolo
dell'onorevole Zan in questo schema?
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA E REVISORE
LEGALE L'onorevole Zan risulta amministratore unico e socio di maggioranza della
Be Proud srl.
LORENZO VENDEMIALE Il proprietario.
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA E REVISORE
LEGALE Il beneficiario economico effettivo.
LORENZO VENDEMIALE Onorevole, salve posso salutare
il padrone di casa, sono Vendemiale di Report.
ALESSANDRO ZAN - DEPUTATO PARTITO DEMOCRATICO Sì,
certo. Di Report?
LORENZO VENDEMIALE Volevo fare due domande sul
Festival. Avete messo su un bell’evento sponsor, concerti, anche birra, pizza…
ma si può dire che questo è a tutti gli effetti un evento commerciale?
ALESSANDRO ZAN - DEPUTATO PARTITO DEMOCRATICO No,
no, è un evento dove tutto quello che viene guadagnato viene riversato
nell'iniziativa e dunque non c'è nessun tipo di guadagno.
LORENZO VENDEMIALE Non ci vede un po' un conflitto
nell'avere una società che ha comunque un giro d'affari sugli stessi temi su cui
lei giustamente conduce delle battaglie meritevoli in Parlamento?
ALESSANDRO ZAN - DEPUTATO PARTITO DEMOCRATICO No,
io ho prestato il mio nome per dare una mano. Ma lo faccio con spirito di
servizio, a titolo gratuito.
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA E REVISORE
LEGALE Incassando 1,3 milioni e spendendo, visto che guadagna poco, 1,3 milioni,
fondamentalmente c'è tutta una serie di fattori produttivi che vengono
remunerati. Dichiarano otto dipendenti, c'è un affitto, c'è dei servizi.
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO Padova è il
collegio elettorale di Zan, e queste sono le tematiche su cui lui ha costruito
la sua carriera politica.
LORENZO VENDEMIALE Riceve soldi pubblici?
ALESSANDRO ZAN - DEPUTATO PARTITO DEMOCRATICO No,
nessun soldo pubblico.
LORENZO VENDEMIALE Però mi risulta che comunque
per esempio l’anno scorso avete preso oltre 100 mila euro di ristori Covid.
ALESSANDRO ZAN - DEPUTATO PARTITO DEMOCRATICO
Perché siccome è stata chiusa anticipatamente, c'erano tutti i fornitori che
avevano già installato tutto il materiale e quelli andavano pagati. Per cui,
come tutte le altre società, hanno chiesto un aiuto pubblico.
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO La Be Proud ha
superato le difficoltà della pandemia anche grazie agli aiuti dello Stato: oltre
180mila di ristori Covid senza cui il bilancio 2021 avrebbe chiuso in perdita.
Però poi nell’ultimo anno e mezzo la società ha versato circa 50mila euro nelle
casse del Pd nazionale e locale
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA E REVISORE
LEGALE Il primo anno pandemico è stato disastroso per la maggior parte delle
società degli eventi delle fiere. Senza le contribuzioni date dallo Stato questa
società nel 2021 non stava in piedi.
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO La parità di genere
è l’altra grande battaglia della sinistra italiana sui diritti civili. Di
recente, il Governo ha creato una vera e propria certificazione che riguarda il
mondo del lavoro, per incentivare le aziende a promuovere la crescita
professionale delle donne.
ANDREA CATIZONE - AVVOCATA DIRITTO DELLA PERSONA
Ci sono vantaggi fiscali e quindi decontribuzione sul costo del lavoro.
LORENZO VENDEMIALE Meno tasse.
ANDREA CATIZONE - AVVOCATA DIRITTO DELLA PERSONA
Meno tasse. Punteggio per accedere ai bandi pubblici. E poi c'è tutta la parte
invece dei vantaggi di carattere reputazionale.
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO Grandi e piccole
aziende fanno la corsa a questa certificazione, spesso ottenuta grazie all’aiuto
di preziosi consulenti.
ANDREA CATIZONE - AVVOCATA DIRITTO DELLA PERSONA
Sono stati stanziati 50 milioni di euro per il 2022.
LORENZO VENDEMIALE Sono contributi a cui le
aziende possono accedere per pagarsi il lavoro che serve per arrivare alla
certificazione?
ANDREA CATIZONE - AVVOCATA DIRITTO DELLA PERSONA
Esattamente.
LORENZO VENDEMIALE Anche la consulenza per
intenderci?
ANDREA CATIZONE - AVVOCATA IN DIRITTO DELLA
PERSONA Esattamente. Sì, sì.
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO Chi ha fiutato
l’affare prima di tutti è Obiettivo Cinque, agenzia che si occupa proprio di
fare consulenza di genere alle imprese, guidata da un team tutto al femminile.
Dietro di loro, però, anche se sul sito non compare, c’è un’altra donna di
spicco della politica italiana: Michela Di Biase, deputata Pd e moglie dell’ex
ministro Franceschini, socia al 25% della società. Sarebbe proprio lei la mente
del progetto, grazie anche alle informazioni privilegiate di cui dispone a
Palazzo. Lo raccontano le stesse manager di Obiettivo Cinque.
MANAGER OBIETTIVO CINQUE Michela ha avuto l'idea
perché sapeva che sarebbe nata di lì a poco una certificazione di parità.
COLLABORATRICE REPORT Diciamo che siete stati un
po’ grazie anche a questa entrata, per così dire, nella politica, siete stati
anche un po’ i primi, i precursori di questo…?
MANAGER OBIETTIVO CINQUE Siamo stati sicuramente i
primi…
LORENZO VENDEMIALE Volevo farle una domanda sulla
parità di genere, su cui lei è sempre in prima linea. Volevo chiederle: per lei
i diritti delle donne sono più una battaglia politica o una questione d’affari?
Mi riferisco a Obiettivo Cinque, la sua agenzia che fa consulenza sulla parità
di genere.
LORENZO VENDEMIALE Stiamo parlando di una società,
è sua, cioè, perché non mi risponde?
LORENZO VENDEMIALE Ci hanno detto che l’idea di
fondare la società è stata sua perché sapeva che sarebbero arrivati dei
finanziamenti pubblici nel settore. Che Obiettivo Cinque addirittura ha
contribuito…
MICHELA DI BIASE - DEPUTATA PARTITO DEMOCRATICO È
ridicola questa cosa.
LORENZO VENDEMIALE È ridicola?
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO Ma sarebbe la
manager della sua stessa società a smentirla.
MANAGER OBIETTIVO CINQUE Stando nel mondo della
politica sapeva che c'era in ballo questa legge. Infatti, è stata approvata a
novembre 2021. La società nasce ad aprile…
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO Dunque, Obiettivo
Cinque nasce 7 mesi prima della legge che regola la certificazione sulla parità
di genere, perché, secondo quanto confida la stessa manager dell’agenzia,
Michela Di Biase sapeva della imminente approvazione grazie alle sue entrature
politiche. Non solo. Obiettivo 5 avrebbe poi contribuito negli scorsi mesi a
modificare un altro decreto in parlamento, scrivendo i contenuti di un
emendamento ad hoc, per far rientrare la certificazione per la parità di genere
nel nuovo codice dei contratti pubblici. Un intervento normativo che ha avuto la
conseguenza di aumentare il valore della certificazione. E quindi il giro
d’affari per aziende come questa.
MANAGER OBIETTIVO CINQUE Un'altra esperienza è
stata quella di scrivere una nota che doveva essere letta in Parlamento da una
donna sia del Partito Democratico sia di Fratelli d'Italia, per cercare di
reinserire la certificazione nel codice dei contratti, e poi questo è avvenuto.
C'è stato un emendamento che era proprio quello che si diceva in questa nota…
COLLABORATRICE REPORT Che investimenti deve fare
in termini proprio economici per arrivare al raggiungimento di un obiettivo del
genere? MANAGER OBIETTIVO CINQUE Sicuramente è un investimento abbastanza
importante. Oltre 30mila, 40mila euro
LORENZO VENDEMIALE Ci hanno detto che addirittura
la sua società, Obiettivo Cinque, ha contribuito a modificare una legge in
parlamento per aumentarne il valore.
MICHELA DI BIASE - DEPUTATA PARTITO DEMOCRATICO
(ride) Ma cosa sta dicendo? Ma assolutamente no.
LORENZO VENDEMIALE Ma qual è il suo ruolo in
Obiettivo Cinque. Ce lo spieghi lei.
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO Prima al Comune di
Roma e ora in Parlamento, Michela Di Biase è da sempre in prima linea nella
battaglia per la parità di genere, uno dei temi identitari per il suo partito.
SEDUTA DELL’8.3.2023 MICHELA DI BIASE - DEPUTATA
PARTITO DEMOCRATICO Le donne debbono essere impiegate in settori nevralgici, di
crescita di questo Paese, di sviluppo. La vicenda del differenziale retributivo,
il gender pay gap, che evidenzia un gap enorme anche sul tema degli stipendi.
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO Nel suo primo vero
anno di attività, l’agenzia ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di oltre
200mila euro, e clienti del calibro di Philipp Morris o il colosso della
farmaceutica Novartis. Nel 2023 i clienti sono aumentati e anche i ricavi sono
destinati a crescere. E ora Obiettivo Cinque punta a infilarsi anche nel Pnrr
MANAGER OBIETTIVO CINQUE Stiamo cercando di
promuovere il nostro servizio nel mondo delle Pmi, perché ci sono dei
finanziamenti statali che derivano dal Pnrr
COLLABORATRICE REPORT Un bel risultato
MANAGER OBIETTIVO CINQUE Per forza dobbiamo
lavorare in questo modo. Però sempre tenendo in qualche modo oscura la figura di
Michela. Infatti, non compare nel sito internet, non compare su Instagram
perché... meglio così…
LORENZO VENDEMIALE Onorevole, perché scappa. Se è
tutto così trasparente perché lei nasconde il suo nome in maniera sistematica?
MICHELA DI BIASE - DEPUTATA PARTITO DEMOCRATICO Io
non nascondo nulla.
LORENZO VENDEMIALE È un tema importante per il Pd,
lei ha un’attività imprenditoriale che fa profitto su un tema sensibile per il
Pd
LORENZO VENDEMIALE FUORI CAMPO Michela Di Biase
comunque non è sola nella sua avventura imprenditoriale. A spingere Obiettivo
Cinque c’è anche l’altra socia forte dell’azienda: Elena Di Giovanni, già
vicepresidente di Comin and Partners, potente agenzia di comunicazione politica
fondata da Gianluca Comin, che ha rapporti con le principali aziende e
istituzioni del Paese. E un filo speciale con Di Biase e famiglia. Oltre ad aver
lavorato, tra gli altri, anche per il Ministero dei beni culturali, i suoi
fondatori, Gianluca Comin e Elena Di Giovanni, sono stati nominati in due
importanti Fondazioni culturali da Dario Franceschini, quando era ministro
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO Premesso che i
parlamentari Zan e Di Biase hanno dichiarato la loro partecipazione in una
società privata alla Camera, cosa che invece non aveva fatto il senatore
Gasparri al Senato. Ecco detto questo, resta la perplessità sull'opportunità di
legare le battaglie per sacrosanti diritti civili a delle attività commerciali.
Nel caso di Zan, proprio in quel collegio dove lui è stato eletto, crea
un'opportunità che gli consente anche di finanziare il partito. Nel caso della
Di Biase, insomma, la sua battaglia parlamentare sulla parità di genere ha
portato indubbiamente delle ricadute dei vantaggi economici alla società
indirettamente alla società di cui socia al 25%. è proprio questa sua posizione
secondo la manager avrebbe anche favorito la nascita di questa società ben sette
mesi prima dell'approvazione della legge. È stata un'idea di Michela, dice, ora
questo proprio perché può accedere a informazioni privilegiate. L'onorevole Di
Biase, che con noi non ha voluto parlare, nell'intervista, ha scritto una mail
in cui sostiene di aver rispettato sempre la legge, ma questo nessuno l'ha messo
in dubbio. Sostiene anche che l'idea della società è avvenuta nel 2020 ben prima
che fosse eletta parlamentare e della certificazione della parità di genere. E
che né lei personalmente né Obiettivo cinque né a nome della società ha mai
avuto interlocuzioni politiche finalizzate a intervenire sulla normativa in
materia. Ecco la sua versione stride con quanto ci ha detto la manager prima e
insomma e la sua risposta la potete trovare nella sua versione integrale sul
nostro sito così come quella della sua socia Elena Di Giovanni che è
vicepresidente di Comin&Partners che specifica di non avere ruoli operativi
nella società. Comunque, sta di fatto che questa società è cresciuta negli anni,
è riuscita a fare anche consulenza ad aziende molto importanti come la
farmaceutica Novartis, Philip Morris, Generali che volevano vantare il bollino
rosa, la parità di genere. Poi c'è anche un'abbuffata. L'ha detto anche la
stessa manager cui partecipare, che è quella del PNRR, perché le società che
avranno il bollino rosa saranno avvantaggiate nella aggiudicazione dei lavori.
Ecco per tutto questo motivo ci chiediamo se Obiettivo Cinque in questo mercato
ha un vantaggio perché ha come socia una persona che è in Parlamento e per
questo ci chiediamo quando fai delle battaglie così nobili che riguardano la
difesa dei diritti civili è opportuno far insinuare un dubbio che lo fai anche
per interessi privati, che poi non è un nostro dubbio, ma è anche quello della
stessa manager di Obiettivo Cinque che dice bisogna lavorare così e far
mantenere nell'ombra la figura di Michela.
Giustizialisti.
Pqm e la giustizia penale in Italia: il
racconto che va oltre la schiacciante prevalenza dell’accusa. Gian Domenico
Caiazza su Il Riformista il 9 Dicembre 2023
PQM è il nuovo settimanale che
il Riformista dedica all’approfondimento dei temi della giustizia penale, e che
mi si è voluto dare l’onore e l’onere di dirigere. È una sfida che merita di
essere raccolta, per coprire un vuoto assordante nel nostro panorama editoriale
e mediatico.
La giustizia penale è un tema politico e sociale
cruciale, perché è il luogo dove avviene quotidianamente lo scontro tra la
potestà punitiva dello Stato ed i diritti primari (libertà, dignità) della
persona. Comprenderne regole, ragioni e devianze esige competenza, libertà
morale ed onestà intellettuale. Oggi quei temi sono affrontati in modo
ideologico, strumentale, polemico, tendenzialmente conformista e quasi
sistematicamente disinformato. Non solo: è evidente -e sconfortante-
la schiacciante prevalenza, a partire dalla cronaca giudiziaria, del punto di
vista dell’Accusa.
PQM, il dibattimento e i processi come nessuno ve
li racconta
Da Mani Pulite in poi si è sedimentata nella
opinione pubblica e nei media la convinzione che l’ipotesi accusatoria sia già
il giudizio sulla responsabilità dell’accusato, sicché le indagini sono seguite
e raccontate avidamente, mentre il dibattimento -il solo giudizio che conta- non
interessa più a nessuno. Noi vi racconteremo i processi come non ve li racconta
nessuno, e daremo voce, finalmente, anche ai diritti di chi subisce, a torto o a
ragione, la potestà punitiva dello Stato. PQM sarà affidato alla collaborazione
di accademici, avvocati, magistrati, operatori del mondo carcerario, in nome di
null’altro che della loro competenza e della passione civile che tutti li anima.
PQM saprà essere una voce libera e coraggiosa, che vuole raccontare i fatti
della Giustizia penale dal punto di vista dei più deboli, senza cedere al
ricatto odioso di vedersi inquadrati, perciò solo, tra i fiancheggiatori della
criminalità mafiosa o tra le giulive suffragettes del buonismo salottiero.
PQM contro i garantisti “à la carte”
Nemmeno apprezziamo i garantisti “à la carte”, che
digrignano i denti per gli amici e invocano ghigliottina per i nemici. Chi vuole
confrontarsi con noi, si armi di fatti e di competenza, e sarà il benvenuto. A
cominciare da questo primo numero, che non a caso dedichiamo ad uno dei tabù
intoccabili di questo Paese: le misure di prevenzione patrimoniali. Leggete cosa
può accadere e cosa accade, in Italia, nell’esercizio di questo micidiale potere
poliziesco, coperto e legittimato, senza limiti e riserve (ma ora l’Europa ci
interroga), dal verbo intangibile della lotta alla Mafia; noi ve lo raccontiamo,
perché non vediamo molti altri in giro che lo facciano. D’altronde, vogliamo che
sia ben chiaro ciò che siamo, e che abbiamo l’ambizione di rappresentare. PQM
esprime quel pensiero e quel convincimento che ha attraversato millenni di
storia dell’umanità, senza scalfirsi di un graffio: la libertà e la dignità di
un solo innocente ingiustamente accusato valgono l’impunità di cento criminali.
Su questo, cari lettori, non abbiamo l’ombra del dubbio. Buona lettura.
Gian Domenico Caiazza. Presidente Unione
CamerePenali Italiane
Caiazza e i nuovi vertici delle Camere penali
“divisi” da un giornale. Sabato esce “Pqm”, il settimanale diretto dall’ex
presidente dell’Ucpi. Sarà allegato al “Riformista” di Matteo Renzi. Ma
diversamente da quanto si potrebbe immaginare, non sarà l’organo ufficiale delle
Camere penali: i nuovi vertici dell’associazione non sapevano nulla
dell’iniziativa. Il Dubbio il 6 dicembre 2023
Stranezze. Gian Domenico Caiazza, che da
pochissimo, un mese e mezzo scarso, ha passato a Francesco Petrelli il testimone
dell’Ucpi, si appresta com’è noto a firmare da direttore il primo numero di Pqm,
settimanale allegato al Riformista di Matteo Renzi. Si dirà: ecco, le Camere
penali hanno il loro organo ufficiale, affidato peraltro a un avvocato
straordinariamente brillante, un vero maestro della comunicazione, oltre che
protagonista, nei cinque anni trascorsi al vertice dell’Unione, di importanti
battaglie politiche. E invece no. Niente di tutto questo.
Pqm non è un progetto comune. Non è un’iniziativa
condivisa con l’attuale presidente Petrelli né col resto della nuova giunta
Ucpi, eletta dal congresso celebrato a fine ottobre a Firenze. A quanto sembra,
addirittura Petrelli, il vicepresidente dell’Unione Camere penali Nicolas
Balzano e il segretario Rinaldo Romanelli avrebbero saputo dell’iniziativa di
Caiazza a cose fatte, cioè solo con la conferenza stampa in cui sabato scorso è
stato presentato (a Napoli) il nuovo giornale.
Non è chiaro il motivo della solitudine con cui
una figura assolutamente centrale nell’associazione dei penalisti quale Caiazza
continua a essere abbia ritenuto di doversi muovere, senza neppure informare i
colleghi, e innanzitutto i suoi successori. Di certo, da quel poco che si riesce
a comprendere, c’è un po’ il rischio di un’occasione persa. Perché i penalisti
hanno sempre espresso grande capacità e forza comunicativa, intensità polemica,
passione prima di tutto. Dividere le forze in una fase peraltro assai delicata e
ambivalente, per le battaglie garantiste, come questa, non sembra la migliore
delle soluzioni.
Sabato si saprà qualcosa in più sull’impostazione
del settimanale di Caiazza. Dal numero zero, si intuisce che le 8 pagine del
supplemento al Riformista non saranno prive del contributo di autorevoli
penalisti. Ma sembra escluso che tra le firme possa comparire quella di
Francesco Petrelli, che pure si è occupato, fino a un minuto prima di essere
eletto presidente, della rivista specializzata diffusa dall’Ucpi, Diritto di
difesa. Petrelli è insomma a propria volta un apprezzatissimo editorialista, di
cui anche la magistratura associata da tempo riconosce la raffinata capacità di
analisi.
Può darsi che i tempi congestionati tipici dei
processi editoriali abbiano impedito una sintesi, sempre possibile una volta
che Pqm avrà cominciato il proprio percorso. Dietro le quinte c’è di sicuro
l’ambizione dell’editore Alfredo Romeo di mantenere il garantismo tra gli asset
del proprio gruppo.
Franco Coppi, 60 anni con la toga a patire col
cliente. L’avvocato è stato protagonista della cerimonia per i sessant’anni
di iscrizione all’Ordine di Roma. Gennaro Grimolizzi su Il Dubbio l'8 dicembre
2023
In Cassazione è di casa. L'aula austera
dell’Ordine degli avvocati di Roma, in Piazza Cavour, è stata attraversata
dall'emozione e dalla commozione. I sentimenti più umani che non risparmiano
neppure i grandi maestri del diritto. Franco Coppi qualche giorno fa è stato
protagonista della cerimonia per i sessant’anni di iscrizione all’albo
dell’Ordine capitolino. Una giornata indimenticabile per la comunità forense che
ha omaggiato l’illustre collega, a partire dal presidente del Coa Paolo Nesta.
Nel suo intervento il professor Coppi ha rivolto
lo sguardo al passato, ma allo stesso tempo si è rivolto ai colleghi che muovono
i primi passi nell’impegnativa professione forense. Parole che rappresentano un
prezioso insegnamento per chi ogni giorno indossa la toga e si reca in
Tribunale. «Mi hanno insegnato – ha detto Franco Coppi - quanto fosse vera
quell’affermazione di Piero Calamandrei, il quale disse che il giudice non deve
e non può essere compassionevole. L’avvocato, invece, sì. Deve essere
compassionevole, perché deve saper patire con il proprio cliente la passione che
lui stesso vive. Questo è il messaggio che noi dobbiamo lasciare ai giovani.
Guardate ai grandi del passato. Io sono stato molto fortunato, quando ho
iniziato la professione, quando ho raggiunto la prima volta il palazzo della
Cassazione e ho incontrato Carnelutti, dopo pochi passi De Marsico, poi ancora
Delitala. Senza tralasciare i magistrati che erano all’altezza di questi
avvocati. Da lì ho imparato tanto, ho guardato sempre a loro con ammirazione,
come modello, per migliorare e poter dare sempre il massimo. Soltanto così
possiamo stare a posto con la nostra coscienza. Guardate ai grandi e imparate a
compatire». Tra i maestri di Coppi figura Giuliano Vassalli, già ministro di
Grazia e Giustizia e padre del codice di procedura penale del 1988.
Franco Coppi è considerato uno dei migliori
avvocati italiani e ha rappresentato la difesa in processi molto importanti in
cui sono state scritte pagine della storia del nostro Paese. Risale ad una
trentina di anni fa il processo di Palermo – il cosiddetto “processo del secolo”
- in cui il leader della Dc Giulio Andreotti venne accusato per aver commesso
reati di partecipazione mafiosa. Andreotti è stato difeso da Franco Coppi anche
nel processo per l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Da un leader
all’altro sempre con la stessa attenzione e dedizione. Un altro importante
esponente politico ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, decise di
farsi assistere dal noto penalista. Una scelta rivelatasi azzeccata. Nel
processo Ruby-ter il leader azzurro (scomparso nello scorso giugno) è stato
assolto in primo grado dall’accusa di corruzione in atti giudiziari «perché il
fatto non sussiste». Berlusconi venne accusato di aver versato somme di denaro
ad alcune ragazze che avevano partecipato alle feste di Arcore. L’accusa era
convinta che si trattasse di corruzione: secondo i pm, i soldi venivano usati
per indurre le giovani a non testimoniare nel processo a carico del fondatore di
Forza Italia. Con l’assunzione della difesa da parte di Coppi abbiamo assistito
ad un cambio di rotta nelle strategie difensive e nella comunicazione
all’esterno. Meno aggressività, meno ricerca dello scontro frontale con le
Procure, meno vittimismo, argomentazioni giuridiche curate nei minimi
particolari e finalizzate a smontare, pezzo per pezzo, le tesi dell’accusa. Il
“metodo Coppi” si è rivelato vincente.
Non solo nomi altisonanti, politici, imprenditori.
Tra gli assistiti dell’avvocato Coppi figurano persone comuni, coinvolte in casi
giudiziari che hanno riempito le pagine di cronaca nera. È il caso di Sabrina
Misseri, condannata con la madre, Cosima Serrano, all’ergastolo per l’omicidio
della quindicenne Sara Scazzi, avvenuto ad Avetrana (Taranto) nell’estate 2010.
Evitare il carcere a vita è stata un’altra missione delicata per Coppi. Un
cruccio non aver potuto dimostrare l’innocenza di Sabrina Misseri. La pena
all’ergastolo è stata definita «ingiusta» e «mostruosa» dal penalista romano.
Nel 2017, in una intervista rilasciata al Corriere
della Sera, Franco Coppi affermò che «i cosiddetti casi “di cronaca” consentono
di vedere le sfaccettature della vita, capisci molto della natura umana, entri
nei moventi dell’agire degli individui, scopri i meccanismi di giustificazione
che le persone cercano per i propri comportamenti. È affascinante, ogni volta è
quasi una lezione di psicologia». Ancora una volta emerge l’approccio
compassionevole, richiamato qualche giorno fa nell’aula del Coa di Roma, in
Cassazione. Franco Coppi ha fatto dell’approccio compassionevole una missione.
Un modo di affrontare il lavoro, da sessant’anni in studio e nelle aule
giudiziarie, con la toga diventata una corazza e una seconda pelle. L’approccio
compassionevole è inevitabile per costruire al meglio la difesa – sempre
diversa, secondo il caso giudiziario – e dedicare attenzione ai propri
assistiti. Questi ultimi non sono solo nomi e cognomi sugli atti difensivi, ma
persone in carne ed ossa con i loro sbagli o azioni inenarrabili. Persone alle
quali va sempre garantito il diritto inviolabile scolpito nell’articolo 24 della
Costituzione.
Livello indecente di irresponsabilità. La
parabola del gioielliere accende il dibattito. Gian Domenico Caiazza su Il
Riformista l'8 Dicembre 2023
Il gioielliere rapinato e poi omicida dei
rapinatori accende il dibattito politico e social, con la solita raccapricciante
qualità argomentativa alla quale siamo ormai abituati. Non entro nel merito di
un processo che non ha ancora un verdetto definitivo. Mi interessa invece fare
qualche considerazione di carattere generale. Il tema della legittima difesa si
accende in modo particolarmente virulento intorno alle rapine, preferibilmente
quelle nelle gioiellerie.
Ciò ovviamente si spiega perché queste rapine
avvengono a mano armata, quindi con minaccia alla vita del gioielliere, oltre
che aggressione al suo patrimonio. Questo dovrebbe far capire anche ai più
sprovveduti che il tema della legittima difesa viene innescato da un conflitto a
fuoco, o dalla minaccia dell’uso di un’arma. Quando la minaccia armata non c’è,
la reazione armata non è più legittima perché viene meno ogni proporzionalità
tra aggressione e difesa, per quanto tu voglia industriarti ad intervenire
normativamente sulla nozione di proporzionalità. Se il rapinatore se ne è
andato, se ne è andato, e la minaccia alla tua vita è cessata.
L’aggressione al patrimonio resta odioso, resta un
sopruso inaccettabile, chi lo compie deve essere severamente punito, ma il
rapinato non acquisisce perciò solo un diritto di vita o di morte sul
rapinatore. Invece, non solo nel dibattitto social, che su questi ed altri temi
assomiglia ogni giorno di più ad una fogna a cielo aperto, ma più o meno con la
stessa qualità anche nel dibattito politico e sui media tradizionali, si
parametra in realtà la legittimità della reazione armata del rapinato sulla
ingiustizia del torto subito. Ma se una reazione omicidiaria dovesse essere
legittima, anche una volta cessata la minaccia delle pistole dei rapinatori,
solo perché è giusto e legittimo non rimanere inermi di fronte ad un torto,
allora questo ragionamento dovrebbe valere ben di più che quando la vittima
subisce un attentato al proprio patrimonio.
Se il parametro giustificativo di una reazione
omicidiaria è l’ingiustizia e la gravità del torto subito, a prescindere dalla
attualità ed imminenza della minaccia armata, cosa dovremmo pensare circa il
diritto di reagire di chi subisce una violenza sessuale, uno stalking, o atti di
bullismo, o un’usura? Sono ragionamenti elementari, me ne rendo conto, ma
d’altronde il livello della discussione politica è davvero di una stupefacente
povertà argomentativa, e ti conduce a questo livello di semplificazione, alla
ricerca -forse vana- di un filo di ragionevolezza. Ho letto che il senatore
Borghi della Lega immagina una ennesima riforma della legge sulla legittima
difesa. Per dire cosa: che si può reagire sparando anche quando il ladro o il
rapinatore non ti sta più minacciando la vita? E con quale argomento: che deve
restituirti il maltolto? Ma è mai possibile questo livello indecente di
irresponsabilità da parte di chi dovrebbe orientare la pubblica opinione,
piuttosto che assecondarla negli istinti più beceri ed insensati?
Gian Domenico Caiazza Presidente Unione
CamerePenali Italiane
Mario Roggero, il Csm scende in campo in difesa
del giudice di Asti. Paolo Ferrari su Libero Quotidiano il 9 dicembre 2023
A difesa dei magistrati di Asti che hanno
condannato questa settimana a diciassette anni di carcere per omicidio
volontario Mario Roggero, il gioielliere piemontese che durante un tentativo di
rapina aveva sparato ed ucciso due malviventi, è sceso ieri in campo il renziano
del Csm Ernesto Carbone. L’ex parlamentare di Italia viva ed ora uno dei dieci
componenti laici di Palazzo dei Marescialli ha chiesto infatti l’apertura di una
pratica “a tutela” per discutere «dell’autonomia e dell’indipendenza e del
prestigio della magistratura» in seguito delle «espressioni denigratorie usate
contro i magistrati della Corte d’assise e della Procura della Repubblica di
Asti». «Esponenti della politica ed alti funzionari dello Stato», sottolinea
Carbone, avrebbero pronunciato espressioni di natura «svalutante, denigratoria e
lesiva dei principi di autonomia e indipendenza della magistratura, nonché del
prestigio di cui la stessa, che la Costituzione concepisce come potere, deve
godere».
Nel mirino, senza citarli, Matteo Salvini che alla
lettura della sentenza di condanna aveva espresso «piena solidarietà a un uomo
di 68 anni che, dopo una vita di impegno e di sacrifici, ha difeso la propria
vita e il proprio lavoro. A meritare il carcere dovrebbero essere altri, veri
delinquenti, non persone come Mario», e il generale Roberto Vannacci che aveva
annunciato di utilizzare «la popolarità acquisita per aiutare Roggero»,
dichiarandosi «disponibile a sostenere che la difesa è sempre legittima: mai a
favore dei delinquenti e di chi non rispetta la legge». Nessuna parola da parte
di Carbone per un cittadino che era stato già vittima di ben dieci rapine nel
suo negozio e di quattro spaccate in casa. In una di queste rapine, dove era
stato anche picchiato selvaggiamente riportando fratture alle costole ed al
naso, Roggero aveva avuto come risarcimento ben 100 euro.
Difficile non tener conto dell’esasperazione di
chi è in balia di una criminalità sempre più aggressiva da cui è impossibile
difendersi. O, se si ci difende come ha fatto Roggero, rischia di finire i
propri giorni dietro le sbarre e dopo aver visto andare in fumo i risparmi di
una vita per pagare i maxi risarcimenti ai familiari dei propri rapinatori. Se
questo non è un “mondo al contrario” poco di manca.
Estratto dell’articolo di Roberto Fiori per “La
Stampa” il 7 dicembre 2023
«Se volete aiutare la nostra famiglia dopo la
terribile condanna verso mio marito, questo è il momento giusto per farlo».
Mariangela Sandrone Roggero è una donna mite, ma anche concreta e determinata. È
stata al fianco del marito durante ogni udienza e non ha vacillato neppure
quando il giudice della Corte d’Assise di Asti lunedì ha pronunciato la
sentenza, condannando il gioielliere di Grinzane Cavour a 17 anni di reclusione
per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante la rapina avvenuta il
28 aprile 2021.
«Una sentenza assurda, incomprensibile», dice
dietro al bancone del negozio, mentre Mario Roggero è a Milano a raccontare la
sua storia in uno studio televisivo. «Ma ora dobbiamo pensare anche al risvolto
economico di questa pena, perché oltre a essere finiti tra i colpevoli,
rischiamo anche il tracollo. Per i 300mila euro di risarcimento volontario che
abbiamo già versato alle famiglie delle vittime, siamo stati costretti a vendere
un alloggio che Mario aveva ereditato da sua madre e a chiedere un prestito in
banca. Ma è solo una piccola parte. Se non riusciremo a coinvolgere più gente
possibile, non so proprio come faremo a tirare avanti».
La gente vi sta dimostrando solidarietà?
«Si, moltissimo. Io non sono sui social, ma è
incredibile come si riescano a raggiungere così tante persone in poco tempo. Se
ne occupano le mie figlie e alcuni amici, rispondono privati, aziende,
associazioni e gruppi spontanei. I primi 11mila euro sono già arrivati sul conto
corrente in un solo giorno, ma io vivo con il terrore di vedere anni di lavoro e
di sacrifici andare in fumo. Questa condanna non è stata inflitta solo a Mario,
ma a tutti noi. A rimetterci saranno le nostre figlie e i nostri nipoti».
Matteo Salvini ed altri esponenti di spicco si
sono schierati al vostro fianco. Crede nel sostegno della politica?
«Francamente, oggi non credo più in nulla. Né
nella politica, né nelle istituzioni e tanto meno in una giustizia che sta dalla
parte dei ladri e non da quella dei cittadini onesti. Io sono sempre andata a
votare, spronata soprattutto da Mario, ma ora lo considero un capitolo chiuso.
Ringrazio chi ci sostiene, tuttavia mi sento inerme e disincantata».
[…]
« […] È dal 2015, quando subimmo la prima violenta
rapina, che noi viviamo in una sorta di incubo. La mia mente torna spesso a due
anni fa, anche se ho scoperto di avere dei vuoti di memoria. Lo psicologo mi ha
detto che è normale, che la paura cancella alcune cose. Penso anche alle due
persone morte, al destino che ci ha trascinati tutti in questa triste vicenda e
che forse appartiene a un disegno più alto».
Il vostro futuro è ancora in questo negozio?
«Credo proprio di no. Mario vive per il lavoro e
per la famiglia, cerca sempre di proteggerci e di avere ogni cosa sotto
controllo. Ma anche lui è una corda di violino e non si può continuare a gestire
una gioielleria con questa terribile tensione che respiriamo. Io ho iniziato a
lavorare quando avevo 15 anni, oggi ne ho 67 e non mi sarei mai immaginata di
avvicinarmi alla pensione in queste condizioni».
Cosa vorrebbe dire al giudice che ha emesso la
sentenza?
«Che non ha capito la situazione, che ha usato un
peso non adeguato al nostro caso. Negli spari di Mario non c’è stato nulla di
volontario. È stato istigato a comportarsi così, in quel momento il suo cervello
ha reagito in questo modo rivivendo il dramma della precedente rapina. Forse con
un eccesso di legittima difesa, ma non certo in forma volontaria. Mi è sembrato
che il giudice si sia sentito quasi obbligato dal suo ruolo a pronunciare una
sentenza così brutale, ma mio marito dice che io sono buonista».
È anche pessimista?
«Io sono sempre stata positiva, altrimenti non
avrei superato molti ostacoli che ho dovuto affrontare. Ma in questo momento non
ce la faccio ad avere un atteggiamento ottimista. Sono molto spaventata. A
volte, quando sono sola in negozio e suona il campanello, mi viene un brivido
lungo la schiena. Sono attimi orribili, in cui rivivo tutta la violenza che
abbiamo subìto». [...]
Estratto dell’articolo di Lodovico Poletto per “la
Stampa” il 5 dicembre 2023
Per dirla con le sue parole, la questione è
semplice: «Più che la condanna, mi pesa il fatto che la giustizia non sia stata
dalla mia parte. Diciassette anni mi hanno dato. E certo che è una condanna
pesante. Ma lo sa perché mi hanno dato 17 anni?».
Perché ha ammazzato due persone.
«Perché i giudici non hanno voluto ascoltare le
mie ragioni fino in fondo. Ed è questo ciò che più mi pesa. Complimenti ai
magistrati». […] Mario Roggero, 69 anni, il gioielliere di Grinzane Cavour, "il
pistolero" come l'hanno chiamato […]
[…] «[…] quel giorno quei delinquenti sono venuti
da me, con violenza e con le armi in mano, per portarmi via tutto un'altra
volta. Poi hanno detto che le armi erano finte. Ma si sono dimenticati di dire
che la loro violenza era vera. E io quel giorno mi sono difeso».
E ha sparato, uccidendo. Per quello l'hanno
condannata. Non crede?
«Guardi, io e i miei consulenti avevamo preparato
una ricostruzione che non hanno voluto mettere agli atti. Si vede nettamente
tutto ciò che è accaduto. Abbiamo fatto un lavorone.
Ricostruito ogni istante. Messo insieme gli
elementi anche nei punti dove la telecamera non riprendeva. Ma mi hanno detto
che era troppo tardi per produrlo. Questa non è giustizia».
Non mi dica che sperava in una assoluzione?
«Guardi mi aspettavo una riduzione a 7 o 8 anni.
[…] so di aver agito in stato di necessità. Per quello ero tranquillo. Non solo
un delinquente».
E anche sua moglie, aveva le sue stesse
convinzioni granitiche?
«[…] lei l'altra notte non ha nemmeno dormito. […]
dopo quella rapina tutto è cambiato. È stato trauma su tutta la linea».
In che senso tutto è cambiato?
«Mia moglie non vuole più venire in negozio. Mia
figlia Paola, quella che era astata picchiata durante il colpo del 2015 ha
aperto un bed&breakfast da un'altra parte. L'altra mia figlia se può evita. E io
sono rimasto solo in gioielleria. E l'età avanza. Ho 69 anni, non so fino quando
proseguirò con la mia attività».
La gente del posto come la tratta?
«Stanno tutti dalla mia parte. Beh, qualcuno che
non sta con me c'è. Ma sono pochi».
E che cosa le dicono?
«Mi dicono che sono un fascista. Ma io non lo
sono. Io voglio la giustizia, il rigore, la certezza della pena. Chi delinque
deve essere punito in modo esemplare».
Quindi politicamente dove sta?
«Da come parlo credo che lo abbia capito che non
sono di Rifondazione comunista. Sto più in là, anzi più spostato ancora...».
[…] Salvini oggi lo ha sentito?
«Non ancora, ma spero di parlargli presto. Lui
sostiene la legittima difesa, e io quel giorno mi sono soltanto difeso da tre
rapinatori che volevano portarmi via tutte le mie cose».
È contento di questa solidarietà?
«Certo. Ma sono deluso da Meloni, che non ha detto
nulla su questa ingiustizia che ho subito. Ah, ma Salvini e gli altri invece
voglio proprio sentirli per chiedergli, ragazzi: adesso che cosa facciamo?».
In che senso?
«Lo sa che io ho già pagato 300 mila euro alle
famiglie di quei delinquenti? E poi ho pagato anche l'avvocato. E non sono pochi
soldi. E poi, in aula, alla lettura della sentenza davanti ai parenti dei
rapinatori devo sentire quella gente applaudire? Io mi sono girato e li ho
guardati così, sorridendo. Lo sa che mi hanno insolentito? Mi dicevano "Che
cazzo ridi?"».
Lei proprio non si tiene, eh.
«E come potrei? C'era anche la mamma di uno di
quelli, venuta ad ascoltare il processo per il figlio morto sul lavoro. Ma
dai…».
Dicono che un partito, dopo quel che accaduto nel
2021, le avesse proposto una candidatura. È vero?
«Si mi avevano detto che c'era un posto per me.
Chi? Non glielo dico e non mi viene neanche in mente il nome: erano quelli che
nel simbolo avevano una tartaruga. E comunque il loro programma era buono. Si
parlava di sicurezza. Di tutti questi arrivi. Di giustizia».
[…] Torniamo a quella mattina della rapina. Si è
pentito di aver sparato?
«[…] io avevo la pistola puntata qui, in faccia. E
loro contavano: cinque, quattro tre… Credevo di morire».
Lei, però, ha sparato con una pistola vera..
«Ma io non sono un amante delle armi. La pistola
la avevo perché era di mio nonno».
E non l'aveva mai usata prima?
«Mai. Soltanto mio nonno aveva sparato con
quell'arma. A chi? A un ladro che era entrato in cortile per rubare la Bmw. Io
mai, e da quel giorno non ho più armi. Me le hanno prese tutte. Senza neanche
starmi ad ascoltare».
Ma lei crede nella giustizia?
«Una giustizia così fa schifo. È vomitevole».
Quindi non ha più fiducia?
«Guardi, tutto dipende sotto chi capiti. È sempre
un terno al lotto. Ah, ma io non mi fermo eh».
E che cosa vuole fare?
«Voglio dire che adesso intendo contattare Roberto
Vannacci. Dice cose su cui sono completamente d'accordo: qui c'è tutto che va
all'incontrario. E poi voglio chiamare il procuratore Nicola Gratteri: è uno con
le palle. Sta dalla parte della gente per bene».
Quante rapine ha subito?
«Due. Una nel 2015, che hanno massacrato mia
figlia. Quella del 2021, e poi mi hanno fatto delle spaccate in casa. Sa, in
questa zona, sono tanti nelle miste stese condizioni. Così non si può andare
avanti». […] «[…] la giustizia dipende essenzialmente da chi incontri sulla tua
strada. Soltanto quello. Se non ti ascoltano quando spieghi le tue ragioni, mi
dica lei che giustizia è?».
Massimiliano Nerozzi per corriere.it - Estratti il
7 dicembre 2023
Da Procuratore di Asti Biagio Mazzeo dirige
l’ufficio che — con il pm Davide Greco — ha chiesto (e ottenuto) la condanna a
17 anni di reclusione del gioielliere di Grinzane Cavour Mario Roggero.
Dottor Mazzeo, qual è stata la cosa più difficile?
«Dal punto di vista investigativo è stata
un’inchiesta piuttosto semplice, con le solite fonti di prova e le dichiarazioni
nell’imminenza del fatto: l’assurdo, se vogliamo, è che stavolta è stato
l’imputato a servirci le prove su un piatto d’argento, il video. Le telecamere
erano sue».
Che effetto le hanno fatto quelle immagini?
«Chiunque le abbia viste ha avuto una reazione di
repulsione, per quel che è avvenuto: persone rincorse e abbattute in quel modo.
Agghiacciante: sensazione che non cambia anche se chi ha sparato è una persona
per bene».
Il gioielliere dice di non essere pentito.
«Eh, il problema è che l’imputato sembra non abbia
preso piena consapevolezza di quel che è successo. Insomma, non c’è stata una
riflessione critica, anche solo minima. Niente».
Roggero ha parlato di idee preconcette dei
magistrati.
«Ci sarà qualcuno che è più rigoroso o meno
rigoroso, davanti ai casi di legittima difesa o presunta tale, parlo della
società e, quindi, anche dell’interno della magistratura, ma qui non si tratta
di ragionare per partito preso: in questo caso siamo completamente al di fuori
del caso della legittima difesa».
Salvini ha detto che sta con il gioielliere: che
idea si è fatto?
«Non mi stupisce, sono anni che il ministro ha uno
slogan: che la difesa è sempre legittima. Ma qui, come le dicevo, siamo al di là
persino del caso border line: perché una reazione che avviene dopo il fatto, e
fuori dal negozio, non può essere legittima difesa. E c’è un secondo punto».
Ovvero?
«Noi magistrati non abbiamo gli strumenti per
cambiare le leggi, cosa che può invece fare il Parlamento. Inserendo nel codice
penale cause di giustificazione, attenuanti, che al momento non sono previste».
Lei, nel caso, quali norme cambierebbe?
«Si potrebbe tenere conto di certe situazioni: per
dire, fu introdotta un’aggravante per i furti davanti al bancomat; qui si
potrebbero inserire nel codice penale delle attenuanti, anche se quella della
provocazione gli è già stata riconosciuta».
Che effetto le ha fatto la condanna?
«Non provo mai piacere quando una persona viene
condannata, al massimo ci può essere soddisfazione se il nostro lavoro è stato
fatto bene. Dopodiché, resta una vicenda triste, pensare che una persona, se la
sentenza verrà confermata nei prossimi gradi, dovrà scontare il carcere. Ma noi
dobbiamo applicare la legge, e mettere l’aspetto emotivo da parte».
(...)
Che direbbe al gioielliere?
«Di rimettersi in discussione e riflettere su
quello che ha fatto: se la Procura e la corte d’Assise, composta anche da
giudici popolari, l’ha condannato, forse qualche domanda dovrebbe farsela».
La sentenza «esemplare» contro il gioielliere
rapinato è un regalo ai delinquenti
Maurizio Belpietro su La Verità il 7 dicembre 2023
La condanna a 17 anni e la somma che il
commerciante dovrà versare alle due famiglie dei ladri uccisi farà sentire più
al sicuro i criminali che i cittadini, aumentando i rischi.
Non fu legittima difesa: "rapinatori
abbattuti". Il gioielliere Roggero condannato, la politica che attacca i
giudici e la raccolta fondi per il risarcimento. Carbone (IV): «Ho richiesto
l’apertura di una pratica essendo assolutamente necessario affrontare il tema
dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura». Paolo Pandolfini su Il
Riformista l'8 Dicembre 2023
“Esponenti della politica e alti funzionari dello
Stato in queste ore hanno espresso frasi gravemente denigratorie nei confronti
dei magistrati che Corte d’assise che hanno condannato il gioielliere Mario
Roggero”, afferma Ernesto Carbone, componente laico del Consiglio superiore
della magistratura ed ex parlamentare di Italia Viva.
“Ho richiesto oggi (ieri per chi legge, ndr)
l’apertura di una pratica a tutela di Alberto Giannone ed Elio Sparacino,
presidente e componente della Corte d’assise di Asti, nonché del procuratore
Biagio Mazzeo e del pm Davigo Greco, essendo assolutamente necessario affrontare
il tema dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura e del suo
prestigio che, in quanto potere dello Stato, deve godere”, aggiunge Carbone.
La Corte d’assise di Asti, a termine di un
dibattimento molto combattuto, ha stabilito questa settimana che non è
stata legittima difesa, ma duplice omicidio volontario e tentato omicidio quello
di Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, che
nell’aprile 2021 sparò e uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. I colpi
partirono da un’arma detenuta irregolarmente e quando i tre ladri erano ormai
fuori dal negozio e stavano risalendo in auto.
La Corte d’assise di Asti lo ha condannato a 17
anni, tre in più dei 14 chiesti dalla Procura. “È una follia, viva la
delinquenza, viva la criminalità. Bel segnale per l’Italia”, era stato il
commento sarcastico di Roggero alla lettura della sentenza. La difesa del
gioielliere aveva puntato sulla sua paura di morire e sul timore che i
rapinatori avessero sequestrato sua moglie. Per l’accusa invece Roggero non
poteva credere di essere davvero in pericolo: i ladri infatti erano già in fuga
e la moglie era in negozio, poco lontano da lui. Soddisfazione è stata espressa
dai familiari dei rapinatori uccisi, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, ai
quali Roggero dovrà pagare 480mila euro di provvisionale, immediatamente
esecutiva.
La condanna di Roggero aveva suscitato la
durissima reazione di Matteo Salvini: “Piena solidarietà a un uomo di 68 anni
che, dopo una vita di impegno e di sacrifici, ha difeso la propria vita e il
proprio lavoro. A meritare il carcere dovrebbero essere altri, veri delinquenti,
non persone come Mario”.
‘’Esprimo vicinanza a Roggero e alla sua famiglia.
Inconcepibile la sentenza che condanna questo onesto lavoratore a 17 anni di
carcere per aver difeso sé stesso e la moglie da alcuni rapinatori entrati nel
suo negozio armati”, aveva rincarato la dose il senatore Giorgio Bergesio,
segretario provinciale della Lega a Cuneo. Che ha aggiunto: “La riforma della
legittima difesa, voluta da Salvini, va proprio in questa direzione perché lo
Stato deve tutelare le vittime e non i criminali’’.
Roggero da parte su ha iniziato a
raccogliere fondi online per il risarcimento. “Non abbiamo più soldi, c’è una
solidarietà inimmaginabile: io non ho capito chi ha volutamente messo online
quel video denigratorio dal quale si deduce che io sia uscito sparando
all’impazzata. Non è così. Io i tre colpi li ho esplosi in macchina”, ha
precisato, ribadendo che stava cercando la moglie, convinto che fosse nelle mani
dei rapinatori.
Paolo Pandolfini
Il caso a Pino Torinese. Salvini Far West:
pubblica le immagini dei ladri e grida allo “scandalo”, la Giustizia dei like
del ministro leghista. Il ministro ripubblica le immagini della vittima e
lamenta: "Adesso lo ‘scandalo’ è tutelare la privacy dei ladri? Il mondo al
contrario …". La solita strategia, il solito verso. Nessuno si scandalizza più.
Antonio Lamorte su L'Unità il 7 Dicembre 2023
Al pubblico ludibrio: le facce sbattute sui
social. E se a farlo è la vittima, bruciata dal torto, colpita dai criminali,
resta comprensibile anche se comunque sbagliato. A fiondarsi con tutto
l’opportunismo del caso è stato puntuale Matteo Salvini, segretario della Lega,
vice primo ministro e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Lo stesso
che aveva citofonato a presunti spacciatori, lo stesso che si era fatto
promotore dei referendum sulla Giustizia. Ha preso e ri-postato quelle immagini
sui social, nella grafica anche l’ingrandimento dei due ladri penetrati
nell’appartamento. Piccolo difetto: ci mancava la scritta WANTED, DEAD or ALIVE,
REWARD come nel Far West. Peccato.
Il video era stato pubblicato sui social dalla
proprietaria di una casa a Pino Torinese. Lunedì 4 dicembre due ladri, coperti
da tute bianche, accento dell’Est Europa, hanno forzato la porta di ingresso
dell’abitazione in via Banchette. Le telecamere li hanno ripresi in pieno volto.
Avrebbero precedentemente svaligiato altre due abitazioni, altre ancora il
giorno prima e la settimana prima. Criminali, presumibilmente dotati anche di
una certa esperienza.
La sindaca Alessandra Tosi per catturarli aveva
già messo a disposizione 35 telecamere per contrastare lo scarico illecito dei
rifiuti a disposizione delle forze dell’ordine. Per la proprietaria
dell’abitazione non era abbastanza. “Ero uscita solo un’ora per andare a
prendere mia figlia, ingenuamente non ho messo l’allarme. Spero che
le immagini servano perché li si possa riconoscere”, ha detto citata
dal Corriere Torino. Il ministro ha fatto peggio.
Il profilo Instagram di Salvini è seguito da oltre
due milioni e 200mila follower. Il video condiviso accompagnato dal copy:
“Adesso lo ‘scandalo’ è tutelare la privacy dei ladri? Il mondo al contrario …”.
A parte la logica incoerente del post – lo scandalo, dal suo punto di vista,
dovrebbe essere quello di criticare la pubblicazione di due persone accusate, in
questo caso evidentemente colpevoli – , quel solito tono a fare il verso, la
citazione del generale Vannacci: la strategia è sempre la stessa. Sfruttare fino
al minimo episodio di cronaca per coltivare consenso, ignorare completamente uno
Stato di diritto che riconosce l’opportunità di difendersi anche ai responsabili
e di non essere esposti alla gogna. Lo slogan del buttare via la chiave, la
propaganda dei paladini della sicurezza che sfruttano ogni paura più o meno
amplificata mentre i reati sono da anni in calo in Italia.
Il problema, naturalmente, sono sempre quelli che
avrebbero gridato allo scandalo: presumibilmente la sinistra, i “sinistri”. Come
si è chiesto il direttore dell’Unità Piero Sansonetti, a commento della condanna
dell’orefice di Grinzane Cavour: “Perché ha sparato l’orefice, nel 2021? Non lo
ha fatto forse anche perché influenzato da quel gridare contro i ladri e a
favore dell’uso privato delle armi, e a favore dell’estensione senza limiti
della legittima difesa, che caratterizzò quegli anni? Fu il governo Conte 1, che
in gran parte era a guida Salvini, ad aprire – del tutto pretestuosamente – la
questione della necessità di modificare il codice penale per allargare il
diritto alla difesa, ve lo ricordate? Fu il governo Conte 1 a sostenere che la
difesa è sempre legittima, intendendo che è sempre legittimo uccidere un ladro,
ve lo ricordate? L’orefice Roggero, secondo voi, non fu influenzato da questa
ondata politica di violenza che tendeva ad accreditare la tesi secondo la quale
il diritto a sparare è sacro?”
Salvini si è schierato dalla parte dell’orefice,
era ministro dell’Interno e vice primo ministro di quel governo Conte 1. Anche
per questo no, nessuno si è scandalizzato. Antonio Lamorte 7 Dicembre 2023
Stinchi di Santo.
Quelli che volevano ripulire le istituzioni. La
parabola giudiziaria dei manager grillini. Minenna ultimo di una lista di
boiardi M5s che va da Marra a Lanzalone. Pasquale Napolitano il 23 Giugno 2023
su Il Giornale.
Marra, Lanzalone, Minenna, Romeo: sono i nomi (e i
volti poco conosciuti) di quei manager grillini chiamati a portare nelle
Istituzioni la «rivoluzione» al grido honestà, honestà.
Di Maio, Raggi, Fico e Di Battista infiammavano le
piazze, promettevano il Cambiamento. Marra, Minenna, Lanzalone, Romeo dovevano
trasformare il sogno in realtà. Di quella stagione, segnata da un'euforia
collettiva, resta l'incubo di una rivoluzione sommersa da fallimenti politici e
inchieste giudiziarie. Come una maledizione, simile a quella dei fondali dove
dorme il Titanic, quei manager scelti da Grillo, Di Maio e Raggi sono finiti
tutti intrappolati in inchieste della magistratura. Ieri è toccato a Marcello
Minenna, uno dei pochi boiardi grillini che ancora risultava indenne. L'ex capo
dell'Agenzia delle dogane si trova agli arresti domiciliari nell'ambito
dell'inchiesta aperta dalla Procura di Forlì sulle forniture di mascherine
durante la pandemia. Era il fiore all'occhiello del potere pentastellato. Grillo
stravedeva per Minenna. Di Maio lo volle assessore al Bilancio della giunta
Raggi: delega pesante che Minenna restituì nelle mani del sindaco dopo 70 giorni
per contrasti politici. Lo strappo non compromise il legame con il M5s che lo
volle poi a capo dell'Agenzia delle Dogane. É stato in pole, sempre con lo
sponsor di Grillo e Di Maio, per andare al timone della Consob. Un altro Grillo
boys macinato dalla magistratura è stato Luca Lanzalone. Ligure (come il suo
sponsor Grillo) fu il super consulente del Movimento, ascoltato da Di Maio e
Casaleggio, e uomo di fiducia di Virginia Raggi. Fu piazzato dall'ex sindaco di
Roma a capo di Acea, la prima municipalizzata dal Comune di Roma. La sua
esperienza finì con le dimissioni dopo l'inchiesta della procura di Roma sul
progetto dello stadio dell'As Roma.
Secondo l'accusa fu uno degli uomini che curò la
mediazione tra la giunta M5s Raggi e la società Eurnova di Luca Parnasi per
modificare, tra gennaio e febbraio 2017, il masterplan dell'impianto (con il
taglio delle cubature). Quando il Ms5 conquistò il Campidoglio non poteva
commettere passi falsi. E dunque Di Maio, Raggi e Grillo si affidarono a
Raffaele Marra, un ex ufficiale della Guardia Finanza. Marra divenne in
pochissimo tempo il plenipotenziario e braccio destro di Raggi: se ne andò nel
dopo l'arresto da parte dei carabinieri con l'accusa di corruzione. Dopo Marra
arrivò Salvatore Romeo che finì indagata della Procura di Roma per concorso in
abuso d'ufficio. Più conosciuto è Domenico Arcuri: l'ex numero uno di Invitalia
tra il 2018 e il 2020 si conquistò velocemente la stima dell'allora
premier Giuseppe Conte che nella fase della pandemia gli affidò i poteri di
commissario. Pure il manager contiano è stato travolto dall'inchiesta dalla
Procura di Roma nell'indagine sull'acquisto di oltre 800 milioni di mascherine
ritenute non conformi. Una maledizione.
Stinchi di santo. Nessuna voglia di mandare
qualcuno sul rogo, né tantomeno di pronunciare sentenze quando le indagini sono
solo agli inizi. Se così fosse non potremmo definirci garantisti. Augusto
Minzolini il 23 Giugno 2023 su Il Giornale.
Nessuna voglia di mandare qualcuno sul rogo, né
tantomeno di pronunciare sentenze quando le indagini sono solo agli inizi. Se
così fosse non potremmo definirci garantisti. Semmai l'arresto di Marcello
Minenna, ex direttore dell'Agenzia delle dogane e già assessore della giunta
Raggi al Comune di Roma, per l'ennesima truffa sulle mascherine all'epoca della
pandemia, offre uno spunto di riflessione sulla fenomenologia del Movimento 5
Stelle, da cui Minenna è stato lanciato prima di approdare all'assessorato della
Regione Calabria guidata dal centrodestra. Anche perché sono diversi i
cosiddetti tecnici grillini finiti nei guai. Dal superconsulente della Raggi,
Luca Lanzalone, al capo di gabinetto sempre dell'ex sindaco di Roma 5 Stelle,
Raffaele Marra. Si potrebbe aggiungere pure il nome, visto che siamo in tema di
mascherine, dell'ex commissario straordinario per il Covid, Domenico Arcuri,
voluto in quel ruolo da Giuseppe Conte.
Il tema è semplice: non basta presentarsi come dei
giacobini, atteggiarsi a giustizialisti tutti d'un pezzo, lanciare accuse,
requisitorie e sospetti al grido di «ladri, ladri», ispirarsi a Travaglio e al
Fatto per imporre rigore di comportamenti e tenere lontano il malaffare. Anzi,
spesso chi ostenta la propria onestà a parole e slogan, predica bene e razzola
male. Ci vuole ben altro. Ci vuole soprattutto una «competenza» che il populismo
grillino rifugge, guarda con diffidenza e che, francamente, il Movimento
dell'uno vale uno non ha nel Dna. Competenza per non essere presi per il naso
dai «tecnici» e districarsi tra i «burocrati». Competenza per sapere chi
promuovere e chi no.
Ci sarebbe da rileggere Benedetto Croce quando
considerava «il governo degli onesti» (tipico lessico grillino) «utopia per
imbecilli». E ancora: «L'onestà politica non è altro che la capacità politica:
come l'onestà del medico e del chirurgo è la sua capacità di medico e chirurgo,
che non rovina e assassina la gente con la propria insipienza». Siamo agli
antipodi dell'atteggiamento grillino che si ubriaca di moralismo ed è fedele al
credo giustizialista per coprire la propria inadeguatezza. E ora che l'Elevato
non impressiona più nessuno e il Movimento - al tramonto - si è affidato ad un
avvocato d'affari, vengono i sudori freddi se si ritorna con la memoria agli
anni in cui i 5 Stelle erano nella stanza dei bottoni: la stessa sensazione che
si ha sulle montagne russe, il pericolo del baratro ad ogni curva.
Appunto, ora che la maggioranza del Paese è
cosciente di cosa ha rischiato, c'è da sperare che non si faccia più ammaliare
dal populismo giustizialista, che non dia retta alle sirene di chi recita
quotidianamente requisitorie contro gli altri per coprire la propria incapacità.
Di chi moltiplica organismi di controllo inutili, di chi ha immaginato un
sistema giudiziario in cui i processi possono durare una vita, di chi lancia
ombre su qualsiasi scelta abbeverandosi alla dottrina che tutto è marcio. È una
filosofia che i grillini portano all'esasperazione, ma che attrae anche un certo
tipo di sinistra, quella che parla di impunità per lanciare una crociata contro
la riforma della giustizia di Nordio. Il risultato? Decrescita infelice, un
Paese fermo e un paradosso: gli ignoranti al potere fatti fessi da improbabili
stinchi di santo.
Estratto dell’articolo di Francesco Merlo per “la
Repubblica” il 26 giugno 2023.
[…] è quasi commovente questo Marcello Minenna
che, improvvisamente riemerso, ha riportato l'Italia all'epica del vaffa, che
iniziò con il V-day nel 2007 ed è già l'antichità del teppismo politico
nazionale.
Adesso che è stato arrestato e che ogni giorno si
allunga il catalogo delle scelleratezze che gli vengono attribuite, sarebbe
troppo facile ridere di questo prototipo della classe dirigente grillina che si
presentava dicendo «sono un civil servant» ed elogiava sé stesso e soprattutto
la propria esemplare onestà a 5 stelle.
Ed è un'ovvietà che Conte lo rinneghi e lo
attribuisca a Di Maio, mentre a tutti chieda scusa quel Nicola Morra, che fu,
pensate, presidente della Commissione Antimafia.
Tra le vestigia sepolte chissà dov'è Virginia
Raggi e, per trovare l'ex ministro dei Trasporti che voleva costruire a Genova
un «ponte vivibile sul quale si mangia e si beve», bisogna andare su Instagram
dove si esibisce nel Tg-Toninelli.
Nel parco archeologico del vaffa c'è anche il
passamontagna che la settimana scorsa Grillo ha proposto di indossare alle sue
“brigate di cittadinanza”, con un ammiccamento incongruo al terrorismo perché
mai i brigatisti rossi usarono il passamontagna […] dello stesso Grillo, che se
lo calava sul viso negli anni in cui erano tutti ladri, tutti maiali, tutti
venduti, tutti mafiosi, tutti camorristi, tranne, ovviamente, lui ei suoi
squinternati d 'assalto dal viaggiatore Di Battista al giornalista Travaglio,
«il mio ministro della Giustizia preferito».
Peccato che non organizzino un raduno di ex, tutte
queste macchiette dell'onestà, come ancora fanno gli ex dc. Nella Pompei a 5
stelle sarebbe bello rivedere Fico e Bonafede, che hanno ancora ufficio e
scrivania, Paola Taverna che denunziava «il complotto per farci vincere» e,
andando più indietro nella civiltà, Roberta Lombardi e Vito Crimi, i due
simpaticoni che elogiavano il fascismo, si addormentavano in aula e […] non
trovavano la porta della Camera.
E si è perso quel Massimo De Rosa che affrontò due
deputate così: «Voi donne del Pd siete qui perché siete brave solo a fare p...».
[…] Due soli ce l'hanno fatta: Conte, che è l'impiegato di concetto del
trasformismo, e Di Maio che ha imparato un mestiere vero ed è l'invidia di tutti
i disoccupati.
(ANSA il 26 giugno 2023) - Ironia della sorte per
una professoressa italo-americana di Harvard che, nell'ambito di un corso di
studi in scienza comportamentale, insegna l'onestà ed è stata accusata di aver
truccato dei dati.
Lo riferiscono i media americani. Francesca Gino,
un'importante docente della Harvard Business School originaria di Tione, in
Trento, è sospettata di aver falsificato i risultati di diversi studi di scienze
comportamentali. Il 16 giugno scorso Max Bazerman, professore ad Harvard e
coautore dello studio incriminato, ha rivelato di essere stato avvertito dalla
prestigiosa università che alcuni dati non tornavano.
In particolare, si trattava di un esperimento che
chiedeva ai partecipanti di compilare documenti fiscali e assicurativi. Ma dopo
questo l'università ha scoperto almeno altri quattro saggi modificati e truccati
dalla dottoressa in un arco di tempo di dieci anni. Al momento la professoressa
Gino risulta in congedo.
I Tabù.
Luca Ravenna: «Bestemmie,
droga e raccomandati, rido su quello di cui nessuno parla». Renato Franco su
Il Corriere della Sera il 14 Aprile 2023.
Lo stand up comedian presenta
lo spettacolo «Red Sox»: «Il teatro è più libero della televisione: si può
esagerare e alzare di più il tiro»
«La blasfemia, le
raccomandazioni, la droga: sono questi i tre grandi tabù italiani». Lo stand-up
comedian Luca Ravenna li mette al centro del suo nuovo spettacolo (Red Sox) che
girerà i teatri in autunno (il via dove, se non da Ravenna, il 29 settembre). Il
dibattito comico ormai si concentra su un paletto e un interrogativo categorico:
si può scherzare su tutto o no? «Si dice sempre che ormai ci sono argomenti su
cui non si possono fare battute, che non si può dire più niente, ma in realtà
non penso che sia così. Proprio per questo motivo nel nuovo spettacolo voglio
affrontare temi che di solito hanno poco spazio». Cominciando dalla blasfemia:
«Credo che il più grande momento di televisione italiana degli ultimi anni sia
stata l’eliminazione di Silvano dei Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi. È
sceso dall’elicottero ed è stato cacciato un secondo dopo perché ha fatto
l’unica cosa che non puoi fare in Italia: bestemmiare in diretta televisiva.
Battere un’idea comica del genere è praticamente impossibile, è l’ascensione del
genio comico, una storia troppo bella per non essere raccontata».
Anche di raccomandazioni, tanto
diffuse quanto negate, si parla poco: «Racconto una favola assolutamente vera,
la raccomandazione che io stesso ho avuto per trovare casa a Roma, un tema molto
sensibile e attuale. Spiegherò anche come sono riuscito a buttare tutto in
vacca». Non c’è solo questo in Red Sox (il titolo fa riferimento alla squadra di
baseball di Boston), ma anche la scaramanzia («sono interista, molto tifoso,
abituato a soffrire, mi perdo in piccoli rituali totalmente inutili») e la
decadenza: «Voglio riflettere sul rapporto che abbiamo con gli Stati Uniti, del
resto mi bullo di fare stand-up comedy quando potrei chiamarla tranquillamente
comicità, ma c’è un motivo se la chiamiamo così e se siamo molto influenzati da
questo impero che è stato fiorente nel Novecento e che ora sta crollando: lo
vedo stra-decadente».
Il teatro è più libero della
televisione? «Sicuramente, non c’è dubbio. I contesti contano, fanno la
differenza: i social sono un luogo, la tv un altro, la radio un altro ancora;
sono tutti posti diversi. Il palco ha il vantaggio che il pubblico assiste a
qualcosa che sta accadendo dal vivo, si passa da una battuta a un’altra: si può
esagerare, si può alzare di più il tiro». Anche i social sono un luogo a sé:
«Preferisco dire una battuta piuttosto che scriverla perché ho sempre paura che
poi non si capisca il tono: in questo senso meglio Instagram e TikTok di
Twitter». Essere comico però in fondo è una tragedia: «Il luogo comune è vero, i
comici sono tristi e malinconici, il bisogno di far ridere si genera nella
tristezza».
Meticci.
Meticcio. Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera.
Con il
termine meticcio (dallo spagnolo: mestizo e portoghese: mestiço) si definiscono
gli individui nati da due etnie diverse. In origine con questo termine si
indicavano le persone nate dall'incrocio fra i conquistadores o coloni europei,
tipicamente spagnoli e portoghesi, e le
popolazioni amerindie indigene precolombiane.
Storia
I meticci costituiscono la
varietà antropologica prevalente nella maggior parte dei Paesi latinoamericani.
Anche nella Repubblica Sudafricana, la percentuale di meticci è del 20%.
Il termine viene usato anche in
senso generico, anche riferendosi ad altre specie animali, indicando individui
nati dall'incrocio di due razze diverse.
Descrizione
I meticci, che presentano
carnagione bruno-rossastra con occhi scuri e capelli solitamente scuri e
lisci provengono dall'incrocio tra le genti europee e quelle indigene del
continente americano, con tutta una stratificazione gerarchica sociale derivante
dal grado di mescolanza delle due etnìe, descritta e standardizzata a partire
dal XVI secolo nelle Caste Coloniali del Nuovo Mondo.
Meticcio (umano). Da
Wikiquote, aforismi e citazioni in libertà.
Citazioni sui meticci.
Barcellona era la città più
aperta del mondo: cosmopolita, meticcia, curiosa. (Mario Vargas Llosa)
[Maria] Ha voluto essere
meticcia, si è mescolata ma non solo con Juan Diego, è diventata meticcia per
essere madre di tutti, si è meticciata con l'umanità. Perché lo ha fatto? Perché
lei ha "meticciato" Dio e questo è il grande mistero: Maria madre meticcia, che
ha fatto Dio, vero Dio e vero uomo, in suo Figlio Gesù. (Papa Francesco)
Il razzismo ha da essere cibo
di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in Italia ci sia, e sia viva in
tutti, la coscienza della razza. Il razzismo nostro deve essere quello del
sangue, che scorre nelle mie vene, che io sento rifluire in me, e posso vedere,
analizzare e confrontare col sangue degli altri. Il razzismo nostro deve essere
quello della carne e dei muscoli; e dello spirito, sì, ma in quanto alberga in
questi determinati corpi, i quali vivono in questo determinato Paese; non di uno
spirito vagolante tra le ombre incerte d'una tradizione molteplice o di un
universalismo fittizio e ingannatore. Altrimenti finiremo per fare il gioco dei
meticci e degli ebrei; degli ebrei che, come hanno potuto in troppi casi cambiar
nome e confondersi con noi, così potranno, ancor più facilmente e senza neppure
il bisogno di pratiche dispendiose e laboriose, fingere un mutamento di spirito
e dirsi più italiani di noi, e simulare di esserlo, e riuscire a passare per
tali. Non c'è che un attestato col quale si possa imporre l'altolà al meticciato
e all'ebraismo: l'attestato del sangue (Giorgio Almirante)
In Europa la popolazione
diminuisce, si apre la porta all'immigrazione incontrollata e si diventa tutti
meticci. (Marcello Pera)
L'apartheid, impropriamente
definita da P.W. Botha, un tempo presidente del Sudafrica, come un "rapporto di
buon vicinato", ha sistematicamente spogliato i meticci, gli indiani, e
specialmente i neri dei loro sacrosanti diritti, negando loro lo stato di
uomini. (Desmond Tutu)
La globalizzazione, a suo modo,
rende un po' più meticce tutte le culture. Ma non dobbiamo dimenticare che,
nell'età della globalizzazione, le identità (nazionali, religiose, culturali)
riprendono coscienza di sé. (Andrea Riccardi)
La Group Areas Act era il
fondamento dell'apartheid residenziale. Secondo le sue norme, ogni gruppo
razziale poteva possedere terreni, occupare immobili, e stabilire commerci solo
nelle aree a esso destinate. Dal momento della sua approvazione gli indiani
poterono vivere esclusivamente nelle aree indiane, gli africani in quelle
africane, e i meticci in quelle per meticci. (Nelson Mandela)
La premessa dell'apartheid era
che i bianchi fossero superiori agli africani, ai meticci, agli indiani, e la
sua funzione era quella di stabilire per sempre la supremazia bianca. (Nelson
Mandela)
Lampedusa in sé era stata una
delusione, ma era stata anche una conferma. Non c'erano gli immigrati per
strada, non c'erano i ghetti. Non era l'isola meticcia che mi aspettavo.
(Stefano Liberti)
Nessun popolo europeo è
meticcio quanto gli italiani, frutto di infinite fusioni che lasciano traccia in
ogni manifestazione culturale. E ogni tentativo di costruire,
retrospettivamente, una purezza anche in ambiti più ristretti è destinato a
scadere nel ridicolo. (Tomaso Montanari)
Per la comprensione tra i
popoli, le creazioni meticce di individui e gruppi di confine valgono più di
tanti programmi scolastici e di tanti convegni sull'universalismo. (Sergio
Lanza)
Quando ero piccolo non c’era
solo il fastidio di essere considerato una curiosità del quartiere, dai compagni
di scuola e dai loro genitori. Mi facevano strane domande: non mi chiedevano
soltanto da dove venivo, ma anche da dove venivo in realtà e come ci si sentiva
a essere meticcio. (Hanif Kureishi)
Sa che cosa sto aspettando? Che
arrivino i nuovi scrittori figli di immigrati, che arrivino e ci raccontino la
nuova Spagna meticcia. Chissà come sarà il romanzo di una giovane spagnola nata
in una famiglia musulmana tradizionale. (Antonio Muñoz Molina)
Sotto el Po ghe xè i
napo'etani. Più sotto ancora dei napo'etani ghe xè i mori: neri, arabi,
meticci... Tutti mori. (Gian Antonio Stella)
Tutti fingono di essere bianchi
e puri, ma la storia dimostra che siamo meticci. (Efraim Medina Reyes)
Estratto dell'articolo di Mauro Favale per “la
Repubblica” il 19 aprile 2023.
È il cavallo di battaglia dei suprematisti
bianchi, un filo rosso che lega 11 anni di stragi di estrema destra, da quella
di Utoya, in Norvegia, nel 2011, 77 morti, a quella di Buffalo, stato di New
York, nel 2022, 10 afroamericani uccisi. Si ritrova nelle motivazioni di chi ha
aperto il fuoco nella Sinagoga di Pittsburgh (2018) e in quella di San Diego
(2019), in un centro commerciale di El Paso (2019) e in una moschea di
Christchurch, in Nuova Zelanda (2019).
Centinaia di vittime sacrificate in nome, anche,
della “grande sostituzione etnica”, una delle teorie cospirazioniste che più di
altre negli ultimi dieci anni è uscita dai circoli ristretti dei complottisti
per arrivare ad essere una bandiera sventolata nei comizi dei politici
dell’estrema destra mondiale.
[…]
Il primo ministro ungherese Viktor Orbàn ne parla
spesso, scagliandosi contro il “miscuglio di razze”. Normale, a questo punto,
che se ne trovi traccia anche nei discorsi dei politici di casa nostra che, tra
Lega e FdI, ne hanno ampiamente fatto ricorso negli ultimi anni.
Prima delle frasi di ieri, pronunciate dal
ministro Francesco Lollobrigida davanti a una platea di sindacalisti, era stata
Giorgia Meloni, nel 2016, a evocarla contro le politiche migratorie del governo
Renzi, contribuendo a sdoganarla anche a queste latitudini.
[…]
Pur non fondandosi su alcuna base scientifica,
infatti, il complotto della “sostituzione etnica” (declinato anche come “Piano
Kalergi”) parla alla pancia di un elettorato confuso, toccando corde emotive che
si basano sulla messa in discussione della sopravvivenza stessa della razza
bianca. Le origini, come spesso accade per i complottismi, non sono
chiarissime.
Accenni si trovano già nell’America razzista del
secondo dopoguerra. A darle risalto è un romanzo distopico degli anni ‘70 “Il
campo dei santi” del francese Jean Raspail (pubblicato in Italia dalla casa
editrice del terrorista neofascista Franco Freda) che diffonde sotto forma di
fiction le tesi di chi parla di un annientamento delle popolazioni europee
sostituite da immigrati arrivati dall’Africa o dall’Asia. Negli ultimi anni,
diventa un argomento di studio specie in Francia, dove una serie di saggi
scritti da intellettuali di estrema destra propongono la teoria al grande
pubblico, rilanciandola nel dibattito politico.
In parallelo si muove la propaganda legata al
cosiddetto “Piano Kalergi”, tesi secondo la quale dietro l’immigrazione ci
sarebbe un complotto organizzato dalle élite europee. L’altra faccia della
“grande sostituzione”, questa volta in salsa antisemita, perché — come spesso
accade — il riferimento alle élite europee gioca a puntare il dito contro gli
ebrei.
La sostanza è un’accozzaglia di luoghi comuni
inventati nella metà degli anni Zero dal neonazista e negazionista austriaco
Gerd Honsik che però, come si vede, hanno avuto un seguito.
[…] per rendersi conto di ciò che si parla,
basterebbe andare sul sito della presidenza del Consiglio dove alla voce
“pregiudizi antisemiti”, si citano Piano Kalergi e “grande sostituzione”. «La
teoria — si legge — è un mito neonazista: in ultima analisi gli ebrei vengono
indicati come i veri colpevoli».
Sostituzione etnica: che cos’è e chi l’ha fatta
davvero. Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina su Il Corriere della Sera il 5
giugno 2023.
La «sostituzione etnica» è l’incubo che turba il
sottobosco razzista e xenofobo dell’Occidente: i bianchi sono destinati a
diventare una minoranza, minacciata, nei loro stessi Paesi, da orde di
immigrati. L’ultimo in ordine di tempo a rilanciare lo spettro è stato il
ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida il 18 aprile scorso.
Parlando all’assemblea della Cisal (Confederazione sindacati autonomi dei
lavoratori) Lollobrigida ha detto: «Dobbiamo pensare anche all’Italia di
dopodomani. Vanno incentivate le nascite. Non possiamo arrenderci al tema della
sostituzione etnica». Pochi giorni dopo il ministro ha spiegato di essere stato
frainteso e di non conoscere le teorie del complotto che da anni fioriscono
negli ambienti dell’estrema destra. A dire il vero ne parla anche il sito della
presidenza del Consiglio, richiamando il cosiddetto «piano Kalergi». Vale la
pena riportare integralmente il testo: «La teoria del complotto del piano
Kalergi è la credenza secondo la quale esiste un piano d’incentivazione
dell’immigrazione africana e asiatica verso l’Europa al fine di rimpiazzarne le
popolazioni. Prende il nome dal filosofo austriaco Richard Nikolaus di
Coudenhove-Kalergi (1894-1972), cui viene attribuita la paternità di tale piano;
la teoria trova credito soprattutto in ambienti di estrema destra (nazionalisti,
sovranisti e separatisti)».
«Il piano Kalergi» è una manipolazione
In realtà Kalergi predicava la necessità di
allargare l’identità dei singoli Stati per dar vita ad una comunità europea. Ma
non fece mai alcun riferimento al pericolo che le «nazioni dei bianchi»
potessero essere «inquinate» dai migranti. Il suo pensiero fu travisato fra gli
anni 90 e 2000 in particolare da Gerd Honsik, autore neonazista austriaco che
nel 2009 fu condannato a cinque anni di reclusione per aver negato l’Olocausto.
Nel suo libro, «Addio Europa», attribuì a Kalergi l’idea che l’uomo di città,
cosmopolita e frutto della mescolanza delle etnie, fosse più propenso all’unione
fra i diversi Stati e quindi da preferire all’abitante delle campagne, dal
sangue più puro, ma meno disponibile all’integrazione. Da questa manipolazione è
nato il famigerato «piano Kalergi».
I sostenitori del complotto contro i bianchi
In passato anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini
hanno usato spesso l’espressione «sostituzione etnica». Nel 2011 lo scrittore
francese Renaud Camus ha rilanciato il teorema nel suo libro «Le Grand
Remplacement», affascinando il fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen.
La figlia Marine, invece ritiene che la massiccia immigrazione non sia
alimentata da un complotto, ma, più pragmaticamente, dalle imprese europee che
cercano manodopera a basso costo. Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen, ha
lasciato il Front National, adottando in pieno le tesi di Camus, così come il
suo nuovo leader, Éric Zemmour, candidato per il partito di estrema destra
«Reconquete» alle presidenziali del 2022. L’idea «dell’uomo bianco minacciato da
orde di stranieri» viene evocata in Olanda dal «Partito per la libertà», guidato
da Geert Wilders; in Austria troviamo Herbert Kickl, a capo dell’FPÖ, autore
dello slogan: «Il sangue deve essere viennese, quello straniero non va bene per
nessuno». In Europa oggi il più convinto e rumoroso sostenitore della
«sostituzione etnica» è il presidente dell’Ungheria Viktor Orbán. Ma l’ondata
più massiccia di intolleranza xenofoba è partita dall’altra parte dell’Atlantico
nel 2014, ed ha accompagnato l’ascesa di Donald Trump.
L’ondata che parte dagli Usa
Il libro di Federico Leoni, «Fascisti
d’America» (Paesi Edizioni), descrive con precisione il mondo dell’Alt-Right, la
«destra alternativa» americana. Sono decine di formazioni, alcune diventate note
in tutto il mondo per aver partecipato all’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio
2021, come i «Proud Boys» o gli «Oath Keepers». Un groviglio di ideologie
accomunate da una convinzione: «É in atto una cospirazione delle élite
(finanzieri, politici, grandi industriali, intellettuali) per schiavizzare le
masse, instaurando un Nuovo Ordine Mondiale».
In sostanza, l’establishment utilizza
consapevolmente l’immigrazione incontrollata per spazzare via i bianchi,
rimpiazzandoli con i più docili migranti. Un delirio che ignora le lezioni della
storia.
Le malattie esportate dagli europei
Nel 1492, l’anno in cui Cristoforo Colombo scoprì
il nuovo Mondo, nell’intero continente americano (Nord, Centro e Sud)
vivevano 75 milioni di persone, in Europa 60. Nell’attuale Messico
c’era Tenochtitlan: 250 mila abitanti, quando Londra e Roma in quello stesso
periodo ne avevano 50 mila, mentre Madrid non arrivava a 5 mila. Facciamo un
salto di cinque secoli: nel 1990 si stimava che gli immigrati irregolari
negli Stati Uniti fossero 3,5 milioni. Nel 2014 la cifra era salita a 11
milioni, con circa cinque milioni di messicani. E’ in questo periodo che la
propaganda del sovranismo estremo diffonde sulle piattaforme web il virus della
xenofobia: i migranti rubano il lavoro, sono dei criminali, portano nuove
malattie. Nella realtà americana non ci sono statistiche serie a sostegno di
questi fenomeni. La ricerca storica, invece, ha dimostrato come i bianchi venuti
dall’Europa, con le loro barche cariche di mucche, capre, maiali, polli e
cavalli portarono nel Nuovo continente malattie sconosciute: vaiolo, morbillo,
difterite, tracoma, peste bubbonica, malaria, febbre gialla, scarlattina e altro
ancora. Tra il 1500 e il 1800 morirono circa 50 milioni di indigeni, privi
com’erano di difese immunitarie, lasciando le loro terre non solo
ai conquistadores armati, ma anche ai «pacifici» migranti in arrivo
dalla Germania, Inghilterra, Irlanda.
L’era della rimozione forzata e della schiavitù
Sempre tra il 1500 e il 1800, 2,5 milioni di
europei sbarcarono nelle Americhe, trascinando con la forza quasi 12 milioni di
africani. La civiltà europea ha prodotto l’era della schiavitù, che ha segnato
la nascita e la crescita degli Stati Uniti, passando poi dalla piena
sottomissione dei «black people» alla segregazione, fino alle scorie del
«razzismo sistematico» che intossicano ancora oggi la società americana.
Secondo le più gettonate teorie del complotto,
diffuse negli ambienti dell’estrema destra americana contemporanea, la
«sostituzione etnica» prevede la costruzione di campi di concentramento in cui
rinchiudere i bianchi
È utile ricordare che invece fu proprio un
presidente bianco,Andrew Jackson, considerato dalla storica Jill Lepore «il
primo populista alla Casa Bianca», a promulgare nel 1829 «l’Indian removal Act»,
ordinando la rimozione forzata dei nativi americani. La legge, approvata di
misura dal Congresso, portò al trasferimento di circa 47 mila uomini, donne e
bambini delle «cinque tribù
civilizzate»: Cherokee, Chickasaw, Chocktaw, Creek e Seminole che fino a quel
momento vivevano
in Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi e Tennessee. Furono tutti
deportati nelle terre del «Selvaggio West».
L’esercito sloggia i nativi
I Cherookee, stanziati in Georgia, cercarono di
resistere, appellandosi anche alla Corte Suprema con questa dichiarazione: «Ci
chiedete di andarcene, ma noi non siamo stranieri. Noi siamo gli abitanti
originari dell’America». I giudici si pronunciarono a loro favore.
Ma Jackson ignorò la sentenza e, minacciando l’uso della forza, convinse una
parte del gruppo dirigente della tribù a firmare l’accordo di trasferimento in
Oklahoma. Accettarono di andarsene solo 2 mila Cherookee. Gli altri 16
mila furono sloggiati dall’esercito, con un viaggio a tappe forzate, in cui
morirono circa 4 mila persone. Chi viaggia nel Sud degli Stati Uniti può
ritrovare ancora oggi tracce del «Trail of Tears», il sentiero delle lacrime,
percorso da tutti i nativi cacciati dalle loro terre. Il vuoto fu presto colmato
dai bianchi, a partire dai cercatori d’oro, visto che nel 1828, giusto un anno
prima dell’Indian Removal Act, in Georgia era stato scoperto un giacimento del
più prezioso dei metalli.
«Esistono uomini destinati a diventare schiavi?»
Ed ora eccoci qui, a quasi due secoli di
distanza dalla «rimozione etnica» voluta da Jackson, alle prese con teorie che
pretendono di rimuovere la Storia. Negli Stati Uniti e in Europa l’ideologia
del «suprematismo bianco» continua a fomentare l’ostilità verso gli immigrati e
ad inquinare pericolosamente il dibattito pubblico. Senza neppure porsi la
domanda che è alla base del nostro ordine mondiale e che, nel 1504, il re
Ferdinando di Spagna, committente insieme alla consorte Isabella della missione
di Cristoforo Colombo, aveva girato a un gruppo di filosofi e di giuristi: «Le
espropriazioni compiute dagli europei nel Nuovo continente e la riduzione in
schiavitù dei nativi americani sono compatibili con la legge umana e quella
divina?».
I saggi dell’epoca conclusero che
«in natura esistono uomini meno capaci, destinati a diventare schiavi». Nel 2023
l’eco di quella risposta non si è ancora spenta
Sommessa domanda sull’etnia. Goffredo
Buccini su Il Corriere della Sera il 12 maggio 2023.
Il ministro Lollobrigida vuole difendere ciò che
siamo, noi stessi. Ma noi chi?
Tuteliamoci! L’idea ha del buono, lo si ammetta.
Di fronte ai flussi di una modernità aliena, difendiamo ciò che siamo: la nostra
lingua, la nostra cultura. La nostra, ha spiegato Francesco Lollobrigida,
Treccani alla mano, etnia: l’etnia italiana. Esorcizzato il riflesso pavloviano
che porta taluni a evocare (ancora!) l’ombra nera di un’italianità da Ventennio,
non possiamo non dirci d’accordo col ministro: ma sì, difendiamo noi stessi. Con
una postilla. Che si sostanzia in una sommessa domanda: noi chi? Oggi l’Italia
conta un milione di figli di famiglie migranti, la seconda generazione nata e/o
cresciuta qui, compagni di classe dei nostri ragazzi (dunque provvisti appieno
della nostra lingua e della nostra cultura) e, tuttavia, ancora privi del primo,
elementare diritto per sentirsi nostri fratelli.
Molti di loro tengono insieme un numero di
identità sufficienti a mandare in tilt chi provi, nel mondo globale, a ridurle a
unità. C’è chi ha ascendenza musulmana ma non è mai più tornato nella terra dei
genitori; chi parla un italiano migliore di molti onorevoli, magari impreziosito
da una vena di accento regionale. Ci sono ragazze che hanno messo lo hijab solo
all’università, non per costrizione ma per tradizione, come si metterebbe la
catenina della nonna. C’è chi ha giurato sulla Costituzione, chi è entrato nei
nostri consigli comunali. C’è persino chi insegna ai nostri figli, chi difende
il tricolore nello sport o chi, come Sabrina Efionayi, ha scritto un
italianissimo romanzo di successo. Costoro non sono italiani, sono
arci-italiani. Perché hanno conquistato ciò che per noi era scontato: la nostra
patria. E dunque la domanda è questa: rientrano o no nell’etnia italiana da
tutelare? Se la risposta è «sì», il problema parrebbe soltanto lessicale. Solo
che c’è una parola che rende quest’abbraccio meglio di etnia e non si presta a
equivoci: cittadinanza. «L’appartenenza di una persona allo Stato»: lo dice la
Treccani.
Antonio Padellaro per “il Fatto quotidiano” il 18
maggio 2023.
Spesso a Piazzapulita (ma anche a DiMartedì e in
altri talk) si mettono a confronto gli scatenati comizi di Giorgia Meloni
“prima” (tipo: sono una donna, sono una madre, sono cristiana) con le misurate
dichiarazioni rilasciate “dopo” dalla Meloni premier.
Di regola gli amici di Giorgia in studio saltano
su sostenendo quanto sia scorretto, e fazioso, confrontare i toni forzatamente
accesi di una campagna elettorale con un conquistato ruolo istituzionale che
richiede parole responsabili e soppesate.
Nella nuova edizione de Il Polo escluso. La Fiamma
che non si spegne: da Almirante a Meloni (Il Mulino) Piero Ignazi spiega che le
cose non sono così semplici. Infatti, “quanto vi sia di strumentale e di
congiunturale in questa linea accomodante di FdI e della sua leader lo attesterà
il tempo” poiché “certamente, un autentico cambiamento non può che comportare
una revisione profonda, e inevitabilmente dolorosa, delle perduranti convinzioni
del partito sulla validità della destra neofascista e dei suoi valori”.
Lo studioso cita “il sovranismo euroscettico e le
pulsioni xenofobe e securitarie contenute nelle Tesi di Trieste elaborate nel
secondo congresso del partito del dicembre 2017”. Radici identitarie che “si
collocano lungo una linea anti-moderna che individua nell’Illuminismo l’origine
primigenia di tutti i mali del mondo moderno. Premesse da cui discendono varie
declinazioni di taglio illiberale, dal sovranismo al nativismo,
dall’autoritarismo alla xenofobia”.
Sul banco degli accusati, scrive Ignazi, “gli
Stati Uniti, l’Unione europea, i mercati finanziari e la globalizzazione.
Antiamericanismo temperato con il nuovo presidente Donald Trump e il consigliere
Steve Bannon, mentre Barack Obama viene definito ‘amico dei fondamentalisti
islamici’. All’Ue si imputano progetti di annullamento della sovranità nazionale
grazie all’euro da cui si chiede la fuoriuscita.
Nelle Tesi si punta il dito contro i poteri forti
internazionali come il finanziere di origini ebraiche George Soros (definito
‘usuraio’) in quanto responsabili, udite udite, della ‘grande sostituzione’
della razza bianca attraverso le migrazioni di massa”. Insomma, il ministro
Lollobrigida non fa altro che richiamarsi alle tesi fondanti del suo partito.
Roba (o robaccia) risalente non al Medioevo ma a cinque anni fa che, mai
rinnegata (ma neppure sottoposta a revisione), consente al partito che governa
la settima potenza mondiale di galleggiare nell’ambiguità più inquietante. Ma
per quanto ancora?
Lollobrigida: «Difendere
l'etnia italiana». “Il Corriere della Sera” l'11 maggio 2023.
«Credo che sia evidente a tutti
che non esiste una razza italiana. È un falso problema immaginare un concetto di
questa natura. Esiste però una cultura, un’etnia italiana»: il ministro
dell’agricoltura Francesco Lollobrigida si è reso protagonista oggi di un’altra
dichiarazione destinata a far discutere.
L’esponente di FdI e del
governo Meloni (nonché cognato della stessa premier) ha parlato agli Stati
generali della natalità e ha poi specificato cosa intende per etnia: «Quella che
la Treccani definisce raggruppamento linguistico culturale, che immagino che in
questo convegno si tenda a tutelare. Perché sennò non avrebbe senso».
Video correlato: Natalità,
Lollobrigida "Esiste un'etnia italiana da tutelare" (Dailymotion)
«La popolazione del mondo - ha
proseguito il ministro - cresce e tanti di quelli che nascono nel mondo
vorrebbero venire a vivere in Italia. E allora perché preoccuparsi delle nascite
in Italia? Se la risposta è incrementare la natalità, è probabilmente per
ragioni legate alla difesa di quell’appartenenza, a cui molti sono legati, io in
particolare con orgoglio, a quella che è la cultura italiana, al nostro ceppo
linguistico, al nostro modo di vivere», conclude Lollobrigida.
Il 18 aprile scorso lo stesso
rappresentante di FdI era incorso in un primo «incidente« rilanciando la teoria
della sostituzione etnica, uno dei cavalli di battaglia del suprematismo,
secondo la quale è in atto un disegno per far arrivare sempre più migranti e
mettere in minoranza le popolazioni europee. Lollobrigida aveva dunque proposto
di incrementare le nascite per contrastare l’immigrazione. Una dinamica che però
le cifre ritengono insostenibile.
La cospirazione globale
contro la "razza bianca". Cos’è la teoria della Grande Sostituzione Etnica, il
complotto dell’estrema destra citato dal ministro Lollobrigida. Antonio
Lamorte su Il Riformista il 19 Aprile 2023
Il ministro dell’Agricoltura e
della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida ha rispolverato la teoria
della “sostituzione etnica”, cara all’estrema destra in tutto il mondo, il
complotto secondo cui le migrazioni dai Paesi poveri verso quelli più ricchi
rientrerebbero in un piano di invasioni pianificate al fine di sostituire le
popolazioni autoctone con altre straniere, di altre etnie e religioni. “Le
nascite non si incentivano convincendo le persone a passare più tempo a casa –
ha detto il ministro al congresso del sindacato Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori (CISAL) – , come qualcuno sostiene, perché si
intensificano i rapporti. Il modo è costruire un welfare che permetta di
lavorare e avere una famiglia, sostenere le giovani coppie a trovare
l’occupazione. Non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica, gli
italiani fanno meno figli quindi li sostituiamo con qualcun altro, non è quella
la strada”.
È esploso un caso. La teoria
della sostituzione etnica è chiamata anche della “grande sostituzione”. Si è
diffusa ampiamente negli ultimi anni negli ambienti di estrema destra tra Stati
Uniti ed Europa. Era diventata popolare all’inizio degli anni dieci con il testo
dell’intellettuale francese Renaud Camus Le grand remplacement: Introduction au
remplacisme global. Quel saggio dava un nome alla teoria, si concentrava sulla
situazione della Francia e i popoli delle ex colonie, trattava gli immigrati in
entrata nel Paese come colonizzatori, paragonava le dinamiche dei flussi in
arrivo al genocidio degli ebrei da parte dei nazisti.
Andando ancora indietro nel
tempo, al 1947, si risale al testo di Scegliete: separati o bastardi,
del senatore Democratico degli Stati Uniti e governatore dello Stato del
Missouri Theodore Bilbo. Secondo cui la “razza bianca” sarebbe scomparsa,
sostituita dai migranti se non si sarebbe fermato il flusso. A sensibilizzare
sul tema furono però due romanzi ri-scoperti molti anni dopo: Il campo dei
santi del francese Jean Respail del 1973 e The Turner Diaries dell’americano
William Luther Pierce del 1978. Davide Lane, neonazista che aveva fatto parte
del gruppo paramilitare “The Order”, negli anni ‘70 parlò apertamente
di “genocidio dei bianchi” nel suo Manifesto del genocidio dei bianchi.
Anche Lane come altri teorici
sosteneva che femminismo, aborto e multiculturalismo fossero minacce per la
“razza bianca”. La teoria è stata citata più volte da politici come l’ex
Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro ungherese
Viktor Orbán, l’ex candidato presidenziale francese Eric Zemmour. Anche la
presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario della Lega
Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno e attuale ministro delle Infrastrutture
avevano citato più volte la teoria in passato. È stata citata esplicitamente
come ispirazione da autori di attentati e attacchi armati di matrice razzista.
Come la strage di Oslo e Utoya in Norvegia nel 2011, quella della sinagoga di
Pittsburgh nel 2018, quella di Christchurch in Nuova Zelanda, quella a Buffalo
negli Stati Uniti nel 2022.
Forse va ricordato, qualora ce
ne fosse bisogno, che la teoria non è supportata da alcuna base scientifica. La
teoria della sostituzione è stata spesso affiancata a quella del
cosiddetto Piano Kalergi, del neonazista e negazionista austriaco Gerd Honsik,
che ne parlò in un libro del 2005, secondo cui in una cospirazione le élite
politiche ed economiche occidentali fanno in maniera di importare nei Paesi
occidentali immigrati, che rappresentano manodopera a basso costo, per creare
popolazioni deboli e facilmente manipolabile.
Elly Schlein, segretaria del
Partito Democratico, ha commentato: “Parole disgustose, indegne di chi ricopre
il ruolo di ministro della Repubblica: sono parole che ci riportano agli anni
Trenta del secolo scorso. Sono parole che hanno il sapore del suprematismo
bianco”. Stessa reazione dalle altre opposizioni – Movimento 5 Stelle,
Verdi-Sinistra, +Europa, Azione e Italia Viva – e dall’ex leader di
centrosinistra ed ex premier Romano Prodi: “Ma di cosa parla Lollobrigida? Siamo
a dei livelli brutali, questo è il mio unico commento”. Dalla sua pagina social
Lollobrigida ha replicato: “Una sinistra priva d’argomenti solleva il solito
polverone, ma l’immigrazione non è la soluzione al calo demografico”. Sul sito
governo.it, pagina della presidenza del Consiglio dei ministri, si legge che “la
teoria della grande sostituzione è un mito neonazista secondo il quale i bianchi
vengono sostituiti dai non bianchi. Spesso, come in tante altre teorie
cospirative, gli ebrei vengono indicati come i veri colpevoli”.
Antonio Lamorte. Giornalista
professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha
frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha
collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura,
spettacoli.
Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli
per repubblica.it il 20 aprile 2023.
Si fa presto adesso a dare tutta la colpa a
Francesco Lollobrigida, come se le sue parole sulla 'sostituzione etnica'
fossero uscite quasi per caso. Il concetto espresso dal ministro
dell'Agricoltura al congresso della Cisal è invece uno storico cavallo di
battaglia del suo partito, con l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni
che per anni e anni ha ripetuto la teoria suprematista in tv, sui social, nei
comizi. Condividendo l'argomentazione con Matteo Salvini […]
A ottobre 2016 la leader di Fdi, ospite di Matrix,
diceva: "Mettiamo in fila due cose. Potenzialmente sono milioni le persone che
possono entrare nel nostro Paese, questo mentre tanti cittadini italiani
scappano all'estero. Il disegno è sostanzialmente di sostituzione etnica, questo
piace a chi comanda perché alla base di tutto questo ci sia il tema dei diritti:
l'immigrazione controllata serve al grande capitale perché la può usare per
rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori italiani". Lo stesso concetto
veniva poi condiviso sui propri canali social.
Comizio di piazza a Roma, 'Il popolo al governo -
Italia sovrana', è il 29 gennaio 2017: "Quella che abbiamo visto in Italia è
un'invasione pianificata e voluta. Si tratta di manodopera a basso costo per il
grande capitale, si chiama sostituzione etnica e noi non la consentiremo". A
febbraio Meloni torna sull'argomento su Twitter: "La Ue è complice
dell'immigrazione incontrollata e del progetto di sostituzione etnica voluti dal
grande capitale".
Giugno 2017, destra in piazza stavolta contro lo
Ius soli in discussione al Senato: "Siamo la nazione che l'anno scorso ha fatto
scappare centomila italiani all'estero e ha portato in Italia in tre anni
500mila immigrati richiedenti asilo. Penso che ci sia un disegno di sostituzione
etnica in Italia". Nel 2018 l'attuale presidente del Consiglio ripete tutto alla
festa di partito, Atreju, tirando in mezzo il famigerato George Soros,
finanziere ebreo considerato una specie di 'Satana globalista' dalle destre
radicali di mezzo mondo.
Ancora giugno, ma del 2019. In una intervista
Meloni agita ancora lo spauracchio del disegno orchestrato dai potenti:
"Dobbiamo capire che dietro questo grande tema dell'immigrazione incontrollata,
non c'è il tentativo episodico di persone che sperano di sbarcare in Europa. C'è
un movimento organizzato, c'è anche un disegno di destrutturazione della
società".
Qui individua ancora una volta il colpevole
principale: "Ci sono realtà che lavorano per muovere verso l'Europa centinaia di
migliaia di africani, pakistani, afghani, perché hanno un disegno: immettere nel
mercato europeo centinaia di migliaia di disperati perché questo consente di
avere manodopera a basso costo. Non è un caso che a finanziare queste ong ci sia
Soros, la finanza speculativa".
Dopodiché il precursore di tutto fu per l'appunto
Salvini, abilissimo nello spostare la Lega Nord da posizioni autonomiste a
quelle di destra nazionalista, un percorso cominciato nel 2013 grazie a incontri
e relazioni internazionali con esponenti del mondo neofascista come Alexander
Dugin e Alain De Benoist. Nel ripetere ossessivamente la teoria della
sostituzione etnica […] il segretario federale arrivò addirittura a tirare in
ballo il genocidio: "È in corso un tentativo di genocidio delle popolazioni che
abitano l’Italia […]". Era l'agosto del 2015 e Salvini parlava da Ponte di
Legno, raduno tradizionale di Ferragosto del vecchio Carroccio. […]
Quando l'esponente del Pd disse: "Continuare
la nostra razza". La solita doppia morale della sinistra si palesa anche
nell'attacco al ministro Lollobrigida sulla "sostituzione etnica". Lorenzo
Grossi il 21 Aprile 2023 su Il Giornale.
Le polemiche riguardo l'espressione "sostituzione
etnica", utilizzata da Francesco Lollobrigida mentre ragionava sul calo
demografico, continuano insistentemente. Il ministro dell'Agricoltura e della
Sovranità alimentare si ha ampiamente spiegato l'uso di quelle parole, chiarendo
il senso delle sue parole, che nulla hanno a che fare col "razzismo" e col
"suprematismo" e con accuse per le quali lo stesso esponente di Fratelli
d'Italia ha annunciato che sporgerà querela. Immancabili sono state le richieste
di dimissioni, il responsabile del Partito Democratico per l'immigrazione,
Pierfrancesco Majorino, è stato uno dei primo a chiederle a gran voce. Eppure
non tantissimo tempo fa - proprio nelle file dem - c'era chi (sempre sullo
stesso tema) parlava della necessità di "continuare la nostra razza", senza per
questo finire additato come "suprematista", come ha fatto invece Elly
Schlein con Lollobrigida.
La frase incriminata dell'esponente dem
Siamo nel luglio 2017. L'allora dirigente
nazionale del Partito Democratico, Patrizia Prestipino, disse esplicitamente:
"Se uno vuole continuare la nostra razza, se vogliamo dirla così, è chiaro che
in Italia bisogna iniziare a dare un sostegno concreto alle mamme e alle
famiglie. Altrimenti, tra un po', si rischia l'estinzione in Italia". Parole,
rilasciate ai microfoni di Radio Cusano Campus, che vennero per lo più e
immediatamente derubricata a "gaffe": sia da molti esponenti di centrosinistra
sia da diversi quotidiani. Dal Pd giunse qualche voce più o meno indignata. Tra
le più citate dalle cronache di allora ci fu la presa di posizione di Michele
Anzaldi che, pur deprecando l'uso del termine, assolve di fatto la collega
dicendo: "l'emozione ti ha tradita". Una gaffe da comprendere, dunque.
Il silenzio dei vertici del Pd
Silenzio assoluto dai massimi vertici del Pd e di
quelli che sono sempre pronti a puntare il dito contro ogni monosillabo fuori
posto. "Chissà che dirà la Boldrini…", ironizzò infatti Matteo Salvini, che però
deve essere rimasto ancora con la curiosità dopo sei anni, visto che nessun
commento da parte dell’ex presidente della Camera fu rintracciato sui social. A
fine giornata Prestipino si scusò per l’uso del termine improprio, scrivendo su
Facebook che "certo è più facile fraintendere sul termine 'razza', uscito
impropriamente ma che fa titolo, che sul contenuto dell'intero ragionamento". E
così il caso venne rapidamente archiviato. Non solo: ma Prestipino fu promossa a
deputata nel 2018, mentre nello scorso dicembre - dopo la mancata rielezione in
Parlamento - è stata assunta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, come
collaboratrice. Insomma: è il solito doppiopesismo della sinistra che, oramai,
non sorprende davvero più.
Estratto dell’articolo di
Lucetta Scaraffia per “la Stampa” il 24 aprile 2023.
Vorrei tornare ancora una volta
sulla famigerata frase del ministro Lollobrigida. Per dire subito che si tratta
certamente di un'affermazione tra le più infelici, che rivela innanzi tutto come
il nostro ministro abbia poca dimestichezza con la storia: cioè che in sostanza,
come lui stesso ha confessato candidamente, sia "ignorante". Una volta superato
il fastidio per le sue parole, dobbiamo ammettere però che esse evocano un
problema reale.
Infatti, se continua il calo
delle nascite che da anni ormai caratterizza l'Italia, e che quindi impone il
conseguente ricorso all'emigrazione, gli italiani "nativi", chiamiamoli così,
rischiano effettivamente di scomparire o, in tempi non troppo lunghi, di
diventare una minoranza nel loro stesso Paese.
E va bene: niente di male,
possiamo anche dire. Niente di male che non si parli più italiano, che a scuola
non si insegni più chi era Dante o il Risorgimento. In fondo, nel corso della
storia di ondate di migrazioni il nostro Paese ne ha viste tante, non è la prima
volta. E i risultati di queste mescolanze sono stati anche buoni, se non
ottimi.
Ma c'è un problema del quale si
preferisce non parlare, c'è un argomento che si direbbe quasi vietato: […] le
invasioni del passato sono avvenute sempre da parte di popoli cristiani. […] Le
ondate migratorie attuali, invece, sono al 90% di islamici. […] dobbiamo
ammettere che essa si differenzia profondamente dal cristianesimo per molti
aspetti che riguardano la sua manifestazione, il suo modo d'essere nell'ambito
della vita sociale. A cominciare […] con la secolarizzazione, che praticamente
l'Islam non conosce […]
la nostra morale, la nostra
cultura e quindi il nostro sistema giuridico sono invariabilmente nati da un
ceppo cristiano, cioè da qualcosa dalle caratteristiche fin dalle origini molto
diverse dalla sharìa. La separazione fra Chiesa e Stato, fra precetti religiosi
e leggi laiche, la parità fra donne e uomini, la famiglia monogamica che prevede
parità di diritti, la libertà di pensiero, nascono tutti da questa comune
appartenenza. Ma che cosa può succedere domani se una percentuale notevole di
abitanti del nostro Paese, essendo di religione islamica, rivendica il diritto
di essere giudicata in base alla sharìa? Non è una domanda retorica.
La cosa sta già avvenendo in
[…] Gran Bretagna o la Svezia: dove a poco a poco vengono ammesse la poligamia,
il matrimonio fra minori, e tollerate le brutali forme di oppressione spesso
riservate alle donne nelle comunità islamiche. Riflettendo sul nostro futuro
dobbiamo considerare anche questa prospettiva, e di conseguenza cominciare a
preparare una strategia di accoglienza che ne tenga conto. E magari […] cercare
anche di aumentare le nascite, perché no? Non è una strategia reazionaria, non è
un atteggiamento identitario di tipo fascista. […]
non ha senso […] sostenere
tutti i diritti per gli LGBTQ+ e dall'altro assistere senza reagire alla
prospettiva di una società futura in cui per influenza dell'islamismo
l'omosessualità possa venire ostracizzata o peggio. […] dobbiamo sforzarci di
allungare lo sguardo […] non limitarci a crogiolarci con i discorsi di
accoglienza indiscriminata, facendo finta che sicuramente andrà tutto bene. Da
questo punto di vista gli italiani e gli altri europei che stanno votando per i
partiti di destra rivelano di essere più consapevoli e preoccupati da questi
problemi delle loro élites intellettuali, le quali, invece, continuano a
preferire chiudere gli occhi. […]
Lollobrigida sbugiarda la
sinistra: "Il solito polverone". Sostituzione etnica, cosa ha detto davvero.
Il Tempo il 18 aprile 2023
L'ultima polemica sollevata
dalla sinistra è quella legata alle parole del ministro Francesco Lollobrigida,
intervenuto al congresso nazionale della Cisal. Nel suo discorso l'esponente del
governo ha risposto alle critiche sul tema dei migranti: “Bisogna contrastare
l’illegalità anche a livello europeo per fermare un’ondata migratoria che,
secondo noi, ha superato limiti oggettivi. Ma anche per aiutare le nazioni di
provenienza a svilupparsi e su questo Giorgia Meloni, in pochi mesi di governo,
ha fatto scuola”. “Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani - ha
sottolineato Lollobrigida - per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va
costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque, di lavorare e avere
una famiglia". Poi il passaggio per il quale Elly Schlein ha parlato addirittura
di "suprematismo bianco" e il Movimento 5 Stelle di "propaganda razzista": "Non
possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica. Io ritengo l’immigrazione
un fatto naturale fisiologico, sono nipote di un emigrante, quindi mi guardo
bene dal pensare che l’emigrazione e quindi l’immigrazione siano un problema.
Anzi diventano un’opportunità di crescita per una nazione”.
Polemiche, quelle sollevate
dall'opposizione che hanno fatto indignare Fratelli d'Italia. "A Elly Schlein e
compagni, non potendo attaccare nel merito il buon governo del ministro
dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco
Lollobrigida, non resta che ’baccagliare' sulla terminologia e sul nulla", ha
dichiarato tra gli altri il capogruppo di FdI, Tommaso Foti.
A replicare sulla vicenda è lo
stesso Lollobrigida con un video pubblicato su Facebook: "La sinistra
evidentemente in difficoltà e priva di argomenti solleva il solito polverone su
una mia dichiarazione in cui spiegavo che a mio avviso per contrastare la
denatalità in Italia, che rischia di far sparire il popolo italiano, bisogna
aiutare chi intende mettere su famiglia con figli, attraverso agevolazioni e un
sistema di welfare che lo sostenga, che dia la possibilità di coniugare il
lavoro e la famiglia. E la sinistra invece solleva il polverone, parla di
razzismo, di suprematismo", spiega il ministro. "La sinistra - aggiunge - dice
cose che non hanno alcun senso, basta leggere la definizione di etnia che è
quell’appartenenza che esiste all’interno di tante comunità in tutto il mondo,
che sono tutte degne di rispetto, compresa la nostra, che intendiamo difendere
con questa promozione". Insomma, l'ennesimo polverone ideologico sollevato dalla
sinistra.
IL «MANIFESTO DELLA RAZZA»
DEL 1938 E I CATTOLICI. Giovanni Sale Quaderno 3793 pag. 11 - 24 Anno 2008
Volume III. Da
laciviltacattolica.it il 5 Luglio 2008
Il primo provvedimento in
materia razziale in Italia fu promulgato dal Governo Mussolini nell’aprile del
1937: esso vietava, comminando pesanti pene detentive, ai cittadini italiani di
tenere «relazione d’indole coniugale con persona suddita dell’Africa Orientale
italiana». Tale legislazione, che costituì il primo passo di un processo teso a
discriminare i cittadini e le persone in base alla loro appartenenza razziale,
aveva lo scopo di vietare il concubinato tra bianchi e persone di colore nei
Paesi colonizzati, in modo da evitare che in quelle terre si sviluppasse una
razza meticcia, considerata pericolosa per la purezza di quella italica. Tale
tipo di convivenze coloniali (in particolare il cosiddetto «madamato»), molte
delle quali col tempo si sarebbero trasformate in unioni coniugali, avrebbero
finito, si diceva, per imbastardire la razza dei dominatori latini. A differenza
della Francia e dell’Inghilterra che su tale materia privilegiarono la politica
dell’«assimilazione», l’Italia fascista scelse quella della separazione netta,
vietando ogni forma di unione e di fraternizzazione tra italiani e indigeni.
Il modello assimilazionista,
adottato dalle «deprecate» democrazie occidentali, era considerato dai fascisti
italiani e dai nazisti tedeschi l’anticamera della corruzione e della
degradazione della razza bianca e, quindi, della sua inesorabile decadenza. Il
Governo fece di tutto, a livello sia legislativo sia propagandistico, per
scoraggiare e arginare tale fenomeno. Esso chiese all’autorità religiosa, e in
particolare ai missionari presenti nelle colonie italiane, di collaborare con le
autorità coloniali per dissuadere i cattolici dal contrarre «matrimoni misti» e
di combattere insieme la «piaga sociale del madamato». In realtà, in quegli anni
anche il mondo cattolico, incluso quello ecclesiastico, basandosi su princìpi
pseudoscientifici, ritenevano come acquisiti alcuni dati concernenti
l’eugenetica, che invece erano soltanto il risultato di scelte di natura
ideologica (per lo più filo-razziste), non fondati su riscontri oggettivi. In
ogni caso la Chiesa vedeva nei nuovi provvedimenti che vietavano il concubinato
efficaci strumenti repressivi adatti a limitare comportamenti disordinati e a
volte scandalosi dal punto di vista morale adottati dai nuovi conquistatori, i
quali del resto si professavano cattolici. In una Nota del 1° agosto 1938
indirizzata dal Nunzio Apostolico in Italia, mons. F. Borgongini Duca, al Capo
del Governo a tale proposito si diceva: «La Santa Sede si compiace col Governo
Italiano per aver colpito il concubinato fra gli italiani e gli indigeni di
colore. Quanto a fiancheggiare l’azione moralizzatrice del Governo, come si
domanda dalle Autorità Coloniali, la Chiesa non si rifiuta di prestare
largamente, per mezzo dei suoi missionari, l’invocata opera di persuasione ad
impedire tali ibride unioni, per i saggi motivi igienico sociali intesi dallo
Stato, ma soprattutto per le ragioni di indole morale e religiosa, che hanno la
maggiore efficacia nelle anime» (1).
Il «Manifesto della razza» e la
posizione della Santa Sede
Il 14 luglio 1938 il Giornale
d’Italia pubblicava, col significativo titolo «Il fascismo e i problemi della
razza», i risultati di uno studio condotto da un gruppo anonimo di studiosi
fascisti, docenti nelle università italiane, il quale fissava «la posizione del
fascismo nei confronti dei problemi della razza». A una prima superficiale
lettura sembrava che il compito di tale documento fosse quello di dare una base
ideologico-culturale alle disposizioni emanate dall’autorità pubblica su tale
delicata materia e concernesse quindi soltanto o, meglio, soprattutto la già
nota «questione coloniale». Tale Manifesto constava di dieci punti, che venivano
poi singolarmente sviluppati; in essi si stabiliva: 1) Le razze umane
esistono; 2) Esistono grandi razze e piccole razze; 3) Il concetto di razza è
concetto puramente biologico; 4) La popolazione dell’Italia attuale è di origine
ariana e la sua civiltà è ariana; 5) È una leggenda l’apporto di masse ingenti
di uomini in tempi storici; 6) Esiste ormai una pura razza italiana; 7) È tempo
che gli italiani si proclamino francamente razzisti; 8) È necessario fare una
netta distinzione fra i mediterranei dell’Europa occidentale, da una parte; gli
orientali e gli africani, dall’altra; 9) Gli ebrei non appartengono alla razza
italiana; 10) I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani
non devono essere alterati in alcun modo. In un primo momento tale Manifesto fu
commentato dalla stampa di regime in modo da non creare allarmismi nella
piccola, ma influente, comunità ebraica italiana, come anche negli ambienti
della borghesia cosmopolita e nel mondo cattolico. Il Messaggero del 15 luglio,
mettendo in evidenza l’obiettiva scientificità dei punti indicati nel manifesto,
precisava: «Esula dalla concezione fascista della razza qualsiasi intenzione
polemica di natura filosofica o religiosa allo stesso modo che esula da essa il
vecchio mito tanto discusso nell’Ottocento delle razze superiori o inferiori.
Essa si limita ad affermare che esistono razze umane “differenti”, con caratteri
propri fino a costituire un tipo a sé, inconfondibile». L’intento principale di
tale studio, secondo la propaganda del regime, era in ogni caso di
sensibilizzare gli italiani al problema della cura e della purezza della razza,
come, si diceva, veniva fatto anche in altri Paesi civili.
Si è molto dibattuto in sede
storica sulle cause e sulle motivazioni di ordine politico e ideologico che
spinsero il regime fascista a adottare una legislazione razzista (2). In realtà,
già a quel tempo, molti, anche tra i cattolici, si domandavano quale senso
avesse tale nuovo indirizzo politico. «Lo scopo vero di questa politica razziale
— è detto in una Nota vaticana — non lo si conosce: apparentemente sembra quello
di salvaguardare la razza italiana da ogni ibridismo e contaminazione» (3). Da
tale Nota risulta che la propaganda del fascismo e le stesse parole del Duce
sulla questione razziale venivano accolte in Vaticano con un certo scetticismo.
Commentando l’informativa diplomatica n. 18 del 5 agosto 1938 (la quale, a
proposito della questione ebraica, fissava il principio che «discriminare non è
perseguitare»), un prelato della Segreteria di Stato scrisse che essa era il
frutto della penosa impressione suscitata all’estero dal Manifesto della razza:
«Tale indirizzo politico non sembra giustificato dai fatti, perché un vero
problema ebraico non pare esistere in Italia, dove gli ebrei sono 50.000 e
sarebbe forse bastato eliminare quelli che maggiormente danno noia e impedire
l’immigrazione di nuovi elementi» (4).
Circa le cause che diedero vita
a tale indirizzo razzistico e xenofobo vengono generalmente indicati due ordini
di motivi. Il primo, di carattere politico-propagandistico, era rivolto a
vivificare il regime, dandogli nuove, o meglio più aggiornate, basi ideologiche
e identitarie, fondate sul concetto di razza e sull’orgoglio di appartenenza
razziale. Su tali princìpi, considerati scientifici e quindi inattaccabili, si
intendevano inoltre forgiare le nuove generazioni, in particolare i giovani che
facevano parte delle associazioni fasciste, in modo da dar vita una volta per
tutte al «fascista integrale», sinceramente razzista e fiero di appartenere alla
razza ariano-latina. Il secondo riguardava invece il nuovo orientamento assunto
in ambito internazionale negli ultimi tempi dall’Italia: naufragati gli accordi
con l’Inghilterra, Mussolini si adoperò con tutte le sue forze a consolidare il
rapporto di amicizia con la Germania nazista, già iniziato due anni prima in
occasione della guerra civile spagnola. In questa per la prima volta gli Stati
totalitari europei si scontrarono, su «terreno neutro», con quelli democratici,
mettendo a confronto il proprio potenziale bellico e la propria capacità di
trascinare le masse. In ogni caso, in quei mesi i rapporti italo-tedeschi si
erano intensificati a un punto tale che, anche sotto l’aspetto operativo, la
scelta razzista e antiebraica del regime era praticamente obbligata. Eppure non
c’è dubbio — scrive in proposito De Felice — che anche sull’adozione dei
provvedimenti razziali la visita di Hitler a Roma, che si svolse dal 3 al 9
maggio 1938, ebbe un’influenza notevole: non perché i tedeschi imponessero tale
scelta all’alleato italiano, «ma perché quello era per Mussolini il momento di
imboccare a bandiere spiegate la strada dell’antisemitismo di Stato» (5).
Quale fu l’atteggiamento della
Santa Sede e del mondo cattolico davanti a tali dichiarazioni del regime in
materia razziale? Come vedremo tra breve, almeno in un primo momento, esso non
fu perfettamente unitario, come era accaduto su altre importanti questioni,
come, ad esempio, quando si trattò di difendere i movimenti di Azione Cattolica
contro le interferenze del regime e la violenza squadrista. Infatti, mentre Pio
XI assunse una posizione di critica aperta nei confronti della nuova politica
razziale inaugurata dal regime (posizione che imbarazzò alcuni prelati vicini ai
circoli governativi), gli organi centrali della Chiesa e la stampa cattolica
ufficiale assunsero posizioni, per così dire, dialoganti e in ogni caso, almeno
per il momento, interlocutorie.
Nei primi tempi il Manifesto
della razza fu accolto dalla stampa cattolica vicina alla Santa Sede in modo non
ostile: si cercò di comprendere le «ragioni» dell’autorità governativa, che
sembravano fondate su dati di carattere scientifico, quindi moralmente neutri e
in ogni caso verificabili, e le si interpretò più secondo i desideri, la cultura
o le preferenze dell’autorità ecclesiastica che secondo lo spirito
discriminatorio che sottendeva lo «studio» preparato dagli scienziati fascisti.
Si disse che il «razzismo» italiano era sostanzialmente diverso da quello
tedesco: questo — a differenza del primo che si riteneva basato su solidi
princìpi di carattere eugenetico orientati al miglioramento della razza latina —
si presentava come intrinsecamente pagano e idolatrico, poiché fondato sul culto
sacrale del sangue e sulla superiorità della razza ariana su tutte le altre. Si
disse che il Manifesto riguardava soltanto questioni di carattere biologico e
che quindi non toccava la dimensione religiosa o morale, la quale rientrava
nella competenza della sola autorità ecclesiastica. Alcuni sottolinearono la
distinzione tra «razzismo» vero e proprio, condannato dal recente magistero
della Chiesa (come, ad esempio, dall’enciclica Mit brennender Sorge del 1937), e
«politica razziale» volta al miglioramento della razza umana. Questa poteva
anche essere accettata o compresa dall’autorità ecclesiastica, ma soltanto nella
misura in cui non entrasse in conflitto con la sana dottrina cattolica e non si
tramutasse poi, per necessità di carattere politico, in atti concreti di
persecuzione e di violenza nei confronti di una determinata razza umana
considerata inferiore o «differente».
La Civiltà Cattolica,
commentando il manifesto degli scienziati, scriveva: «Chi ha presenti le teorie
del razzismo tedesco, rileverà subito la notevole divergenza di queste proposte
da quelle del gruppo degli studiosi fascisti italiani. Questo confermerebbe che
il fascismo italiano non vuole confondersi con il nazismo o razzismo tedesco
intrinsecamente ed esplicitamente materialistico e anticristiano». C’era nella
rivista romana dei gesuiti, che alcuni anni prima aveva combattuto il «giudaismo
massonico e rivoluzionario», in particolare da parte di alcuni padri la tendenza
ad armonizzare i princìpi razziali fissati nel manifesto con la dottrina sociale
cattolica. In un primo momento addirittura sembrava che il regime in tale
materia avesse imboccato la strada di un «sano proporzionalismo discriminatorio»
(ad esso si ispirava, infatti, l’informativa diplomatica n. 18 del 5 agosto
1938) tanto caro ai cattolici, poiché, in armonia con i princìpi della giustizia
distributiva, «permetteva di dare a ciascuno il suo». Tale principio consisteva
nell’applicare il principio proporzionale, misurato sulla consistenza numerica
del gruppo razziale, circa la sua presenza nella vita economica e sociale del
Paese; tale criterio era stato utilizzato, con il plauso della Civiltà
Cattolica, in Ungheria nei confronti degli ebrei. Applicando tale criterio,
commentava il p. Barbera, si garantisce «la difesa della nazione, contro il
pericolo presente di una più numerosa invasione giudaica dalla Germania,
dall’Austria e dalla Romania, e contro il liberalismo favoreggiatore del
giudaismo e del suo nefasto predominio, senza persecuzioni, ma con mezzi
energici ed efficaci» (6).
Sulle questioni sollevate
dal Manifesto della razza intervenne anche il giornale cattolico di Friburgo La
liberté, con un articolo che in realtà era stato scritto per L’Osservatore
Romano, ma che per ragioni prudenziali fu fatto pubblicare altrove. «Ora — si
sottolineava con tono preoccupato — se i punti fissati dal gruppo degli studiosi
fascisti in Italia si differenziano dalle teorie tedesche; se questa diversità
fu rilevata anche in campo cattolico in Italia, come da quello razzista in
Germania, tuttavia in Germania si salutarono come un incontro sullo stesso
cammino quelle dichiarazioni del ministro Starace, segretario del partito, e
quelle amplificazioni dei giornali, che scendevano per la prima volta in Italia
dal “concetto di razza”, comunque inteso, enunciato e applicato, alla “pratica
razzistica”: cioè dalla “difesa della razza” al “razzismo”» (7). Tale articolo è
molto importante perché mette l’accento — forse seguendo i suggerimenti dello
stesso Pontefice — sui rischi a cui il regime si esponeva insistendo sulla
politica razziale appena intrapresa: tanto più che molti gerarchi fascisti,
come, ad esempio, Alfieri, Farinacci e altri, interessati a una stretta alleanza
politica con la Germania nazista, avrebbero fatto di tutto per estendere
all’Italia i princìpi del razzismo tedesco.
A differenza della stampa
cattolica e di buona parte della Gerarchia — interessata a non scontrarsi con
Mussolini con il quale quasi dieci anni prima si era sottoscritto un Concordato
e a non estendere le occasioni di conflitto con il regime, oltre quelle già
esistenti sull’Azione Cattolica e in particolare sui movimenti giovanili ad essa
collegati — Pio XI giudicava il Manifesto e tutte le iniziative che il Governo
stava organizzando per la tutela della razza in modo piuttosto severo. Il Papa
disse parole dure nei confronti della politica razziale inaugurata dal regime,
mettendo in guardia dall’imitare su tale materia l’indirizzo tedesco,
considerato contrario alla dottrina cristiana, al diritto naturale e ad ogni
elementare senso di umanità. Il cosiddetto «nazionalismo esasperato» e ogni
forma di razzismo che mettesse in discussione la dottrina dell’originaria unità
(e dignità) del genere umano erano da lui considerati come eresie da condannare
e da combattere con le armi della testimonianza della verità e della vigilanza
cristiana.
Il giorno stesso in cui veniva
pubblicato il Manifesto della razza, il Papa, ricevendo in udienza le suore del
Cenacolo, le fece partecipi di ciò che in quel momento angustiava il suo cuore
di Padre, vale a dire le idee che venivano dappertutto affermate e diffuse in
materia di nazionalismo estremo e di razzismo: «Si tratta ormai — disse il Papa
— di una vera e propria apostasia. Non è soltanto l’una o l’altra idea errata: è
tutto lo spirito della dottrina che è contrario alla fede di Cristo». Una
settimana dopo, il 21 luglio, ricevendo in udienza 150 assistenti ecclesiastici
dei giovani dell’Azione Cattolica, ritornava sullo stesso argomento: «Cattolico
— disse il Papa — vuol dire universale, non razzistico, nazionalistico,
separatistico». Queste ideologie non soltanto non sono cristiane, ma finiscono
«con il non essere neppure umane» (8). Per Pio XI quello del razzismo «era il
tema più scottante del momento» (9). Da qualche tempo esso teneva il Papa in uno
stato di agitazione e di angustia spirituale: tale tema «girava e rigirava nella
sua mente» (10), è detto in una lettera del p. J. Lafarge, gesuita statunitense,
il quale il 22 giugno era stato incaricato da Pio XI in persona di scrivere
un’enciclica contro il razzismo (Humani generis unitas). Com’è noto, essa non
vide mai la luce, ma rimase allo stato di bozza, perché lo scritto fu ritenuto
dal Generale dei gesuiti e da altri suoi collaboratori non conforme alla «mente
del Papa», e la malattia e la successiva morte del Papa impedirono che
l’enciclica fosse corretta, completata e pubblicata. Ricordiamo che, in un breve
capitolo della bozza, si condannava esplicitamente l’antisemitismo.
Un dispaccio del conte Pignatti
dell’ambasciata d’Italia del 20 luglio 1938 ci informa sulla mente del Papa
riguardo al manifesto sulla razza degli studiosi fascisti; in esso è detto: «Il
Papa medita le contromisure da adottare dinnanzi alla campagna anti-israelitica
progettata dall’Italia e che verrà condotta in base ai principi di purezza di
razza, redatti dai professori universitari italiani» (11). Da tale documento
risulta che Pio XI, prima ancora che Mussolini specificasse la direzione
sostanzialmente antisemita della nuova politica razziale, era praticamente certo
che tale indirizzo si sarebbe tradotto in provvedimenti discriminatori molto
duri nei confronti degli ebrei italiani. Questo spiega perché il Papa, una
settimana dopo, nel celebre discorso agli studenti di Propaganda Fide, attaccò
con forza l’indirizzo filo-tedesco adottato dal regime in materia razziale,
mettendo in imbarazzo Mussolini, che reagì con forza alle dure parole del Papa,
minacciando la rottura. Intanto il 25 luglio un comunicato del Partito Nazionale
Fascista, per far tacere alcuni sospetti sollevati negli ambienti internazionali
(e non soltanto) sull’autorità scientifica degli estensori del Manifesto,
rendeva noto i nomi di coloro che lo avevano redatto e di quelli che vi avevano
aderito, e dichiarava che esso era stato preparato sotto l’egida del Ministero
della Cultura Popolare (12).
Pio XI e la lotta contro il
razzismo
Pio XI il 28 luglio 1938,
ricevendo in udienza gli studenti del collegio urbaniano di Propaganda Fide,
tenne, come si è detto, un importante discorso sul tema del razzismo. «Egli — è
scritto in una Nota della Segreteria di Stato — precisava alcuni punti di
dottrina cattolica, confutava alcune affermazioni razziste; spiegava in che
senso si poteva parlare di razze diverse e accennava alle conseguenze dolorose a
cui avrebbe portato la politica razzistica, praticata su larga scala e non
intesa soltanto a salvaguardare gli interessi imperiali evitando pericolosi
incroci e imbastardimenti» (13), e soprattutto si interrogava «come mai l’Italia
abbia avuto bisogno di imitare la Germania» in materia di razzismo. Tale frase
indispettì moltissimo Mussolini, che riteneva di non dovere nulla al collega
tedesco in materia di politica razziale come anche in altre questioni. Egli,
inoltre, chiese al ministro degli Esteri italiano, conte G. Ciano, di convocare
immediatamente il Nunzio Apostolico per esprimergli la disapprovazione del capo
del Governo nei confronti del recente discorso del Papa, poiché ritenuto lesivo
degli interessi politici nazionali e internazionali dell’Italia. Il giorno
successivo Mussolini, in un incontro con un gruppo di segretari federali del
fascismo a Forlì, rispondendo indirettamente al Papa, disse: «Sappiate, ed
ognuno sappia, che anche nella questione della razza noi tireremo diritti. Dire
che il fascismo ha imitato qualcuno e qualche cosa è semplicemente assurdo».
Tale scambio di battute tra il
Papa e il Duce, in un momento in cui i contrasti tra regime e Gerarchia
ecclesiastica sulla questione dell’Azione Cattolica si andavano acuendo, creò
una certa preoccupazione tra i vescovi, interessati a mantenere «controllati» i
rapporti tra le due istituzioni. Per tale motivo essi cercarono di interpretare
in senso non contrario alla propaganda del regime le parole del Papa, cercando
di armonizzare il punto di vista fascista sul problema della razza con quello
cattolico. Emblematica, a questo riguardo, è la lettera indirizzata il 9 agosto
1938 dal vescovo di Cremona, mons. G. Cazzani, a Farinacci, a proposito del
discorso del Papa del 28 luglio: «Il S. Padre — scriveva il vescovo al ras di
Cremona — non parlava contro un razzismo fascista […], ma parendogli che una
certa corrente di stampa fascista volesse promuovere e caldeggiare anche in
Italia un razzismo alla hitleriana, ha voluto mettere l’avviso contro il
pericolo di un tale razzismo, e perciò ha parlato di mutuazione dai tedeschi. Ma
il S. Padre non ha condannato qualunque cura o difesa della razza […], ma ha
dichiarato espressamente di riprovare quel razzismo esagerato e divisionista,
che animato da un culto superbo ed egoistico della propria razza, è contrario
alla legge della umana e cristiana fraternità tra i popoli» (14).
Una relazione del Nunzio
Apostolico, redatta il 2 agosto, ci informa dettagliatamente sull’incontro che
egli ebbe il 30 luglio con il conte Ciano; di esso si conoscevano finora
soltanto le «impressioni» riportate da quest’ultimo nel suo Diario (15).
«Monsignore dove andiamo? — scriveva mons. Borgongini Duca —. Il Duce questa
mattina mi ha chiamato irritatissimo per le parole pronunciate dal S. Padre agli
alunni di Propaganda Fide; tanto irritato, che aveva già risposto pubblicamente
e così dicendo mi mostrò il Giornale d’Italia e mi lesse la brevissima replica»;
poi disse che il Duce era molto contrariato per l’accenno fatto dal Papa alle
Cinque giornate di Milano, poiché esso «aveva una portata politica nei confronti
dell’asse Roma-Berlino». Dalla lunga relazione del Nunzio, inoltre, si ricavano
alcuni elementi che ci aiutano a capire quale fosse l’indirizzo che il regime
intendeva portare avanti in materia razziale e, soprattutto, cosa si chiedesse
alla Chiesa e ai cattolici. Innanzitutto dalle parole del Ministro si ricava che
il nuovo indirizzo altro non era, a suo modo di intendere, che la naturale
prosecuzione della politica di difesa della razza, già iniziata un anno prima,
da possibili imbastardimenti. Su tale materia egli sapeva di poter contare sulla
comprensione della Gerarchia ecclesiastica. Subito dopo, però, il conte Ciano
passò a trattare del punto più delicato concernente la questione razziale,
quello cioè riguardante gli ebrei italiani, sapendo che su tale materia sarebbe
stato più difficile trovare il sostegno convinto dell’autorità ecclesiastica e
dei cattolici alla politica razziale governativa: a meno che questa non si
indirizzasse secondo i princìpi della morale sociale cattolica: «A fianco della
questione dei neri — continuava il Ministro —, si dovrà trattare anche quella
degli ebrei, per due ragioni: 1) perché essi sono espulsi da ogni parte, e non
vogliamo che gli espulsi credano di poter venire in Italia come nella terra
promessa; 2) perché è loro dottrina consacrata nel Talmud, che l’ebreo deve
mischiarsi con le altre razze come l’olio con l’acqua, ossia rimanendo di sopra,
cioè al potere. E noi vogliamo impedire che gli ebrei in Italia abbiano posti di
comando» (16).
Il conte Ciano trattò della
questione degli ebrei in modo più che diplomatico, per non dire ambiguo,
toccando soltanto tasti a cui la sensibilità cattolica di quel tempo, segnata da
un marcato antigiudaismo, era molto sensibile, scivolando così sulle questioni
più importanti e di sostanza, come, ad esempio, il contenuto concreto della
disciplina discriminatoria che il Governo intendeva applicare agli ebrei. Il
Nunzio capì immediatamente, nonostante la malcelata riservatezza del Ministro,
che il Governo era intenzionato su tale materia a procedere con una certa
durezza. «Circa gli ebrei — scriveva il Nunzio — mostravo la mia preoccupazione
perché in Germania si seguitano a colpire come ebrei i convertiti battezzati,
che perciò sono usciti dal loro popolo; in Italia invece, ove esiste il
Concordato, non si sarebbe potuto impedire il matrimonio tra un ebreo convertito
e un cattolico». Nella replica del Nunzio si coglie appieno l’intrinseca
debolezza e inadeguatezza della posizione cattolica riguardo al problema degli
ebrei: troppo forte e pesante era a quel tempo l’eredità di una lunga tradizione
antigiudaica e a volte anche, negli anni più vicini, antisemita, perché tale
materia fosse concepita e compresa alla luce di princìpi più generali, fondati
sulla stessa dottrina del diritto naturale, o semplicemente su princìpi più
autenticamente evangelici, in modo che la difesa della dignità della persona
umana venisse affermata senza limitazioni o tentennamenti contro chi intendeva,
sulla base di princìpi pseudoscientifici o apertamente razzistici, limitarne, o
meglio annullarne, la dignità sul piano sia personale, sia pubblico.
Pensiamo di non peccare di
anacronismo, sottoponendo a giudizio storico tali eventi, anche perché molti
interventi di Pio XI si mossero proprio in tale direzione: il fatto che il Papa
dovesse intervenire in difesa della persona umana, anche fuori dell’ambito
strettamente confessionale, era dottrina accettata, anche se ancora non
pienamente compresa nelle sue implicazioni, a partire dal pontificato di
Benedetto XV. In ogni caso, il Nunzio Apostolico, a quanto pare, in quel momento
sembrava essere interessato più che alla sorte degli ebrei italiani in generale,
a cui il conte Ciano faceva riferimento, al fatto che un’eventuale disciplina
antiebraica non riguardasse gli ebrei convertiti al cattolicesimo o che questa
costituisse un vulnus al Concordato. Alle parole del Nunzio il Ministro replicò
che il razzismo italiano, come aveva proclamato il Duce, «non si ispira a quello
tedesco, ma vuole semplicemente regolare, con opportune leggi, le relazioni tra
bianchi e neri nel nuovo Impero, ed in questa occasione regolare la questione
degli ebrei [….]. Mi ha poi detto che l’Italia è cattolica, e se uno qui si
azzardasse di dire [come era avvenuto in Germania] che Gesù Cristo è bastardo,
sarebbe punito come bestemmiatore».
La stampa governativa non fece
nessun accenno al discorso del Papa del 28 luglio. Esso fu pubblicato soltanto
da alcuni quotidiani cattolici. Il Governo, intenzionato a bloccare ogni
possibile polemica su tale delicata materia, che avrebbe reso più difficile
l’accoglienza da parte dei cattolici della progettata legislazione antiebraica,
inviò a tutti i prefetti due comunicazioni firmate dal ministro Alfieri (17). In
questo modo il regime riuscì a imbavagliare la stampa cattolica, impedendole
così di partecipare in modo libero al dibattito pubblico in materia razziale:
coloro che non condividevano l’indirizzo dettato dal regime in tale materia da
questo momento in poi dovettero tacere. La Segreteria di Stato, con una Nota di
mons. G. B. Montini, l’8 agosto 1938 informò la delegazione apostolica negli
Stati Uniti dei provvedimenti assunti dal Governo italiano contro la stampa
cattolica, in modo che all’estero non si dicesse che la Santa Sede e la stampa
cattolica tacevano sui provvedimenti liberticidi emessi contro gli ebrei per
pusillanimità o per complicità con il regime. Le parole del Papa contro la
propaganda razziale iniziata dal fascismo per preparare il terreno alle
successive disposizioni discriminatorie, in particolare contro gli ebrei, furono
riportate e commentate dalla stampa internazionale, soprattutto quella di lingua
francese e inglese, in senso piuttosto positivo. Importanti associazioni
ebraiche internazionali, inoltre, indirizzarono al Papa lettere di omaggio e di
ringraziamento. L’Alliance Israélite universelle testimoniò a Pio XI la sua
gratitudine «per l’ammirabile energia con la quale condannò, nell’udienza agli
alunni del collegio di Propaganda Fide, le teorie razziste, come false, inumane,
empie e gravide di conseguenze detestabili». Con gli stessi sentimenti di
gratitudine si espressero l’Associazione ebraica dei Veterani di guerra degli
Stati Uniti, nonché l’ambasciatore statunitense a Roma, W. Phillips, il quale
informò il Papa sulla preoccupazione del presidente Roosevelt riguardo
all’indirizzo politico intrapreso dal Governo italiano. In particolare
l’ambasciatore fece presente alle autorità vaticane che il Governo degli Stati
Uniti avrebbe molto gradito «un’ulteriore dichiarazione della Santa Sede
riguardo alla questione ebraica in Italia» (18).
In quel momento sia il Governo
italiano, sia la Santa Sede non avevano alcun interesse a inasprire il
conflitto: da ambedue le parti c’era la volontà di risolvere ogni questione,
come era accaduto in passato, attraverso accordi soddisfacenti per ambedue le
istituzioni in modo da poter festeggiare, il febbraio successivo, il decennale
dei Patti Lateranensi in un clima di concordia e di collaborazione. Tale
occasione, per il regime, sarebbe stata un’opportunità unica per mostrare agli
aborriti Paesi democratici che in Italia Chiesa cattolica e Stato totalitario
convivevano pacificamente. In tal modo, nonostante Mussolini fosse molto
irritato per i continui interventi del Papa in materia di razzismo, diede
disposizione ai suoi collaboratori di giungere a un accordo segreto con la Santa
Sede sulle questioni più controverse del momento: così facendo, egli pensava di
legare i cattolici al carro del fascismo e soprattutto di far tacere (o
«imbavagliare») il Papa. L’accordo fu «contrattato» per parte vaticana dal p. P.
Tacchi Venturi, fiduciario della Santa Sede presso il Duce, e fu sottoscritto il
16 agosto del 1938. Esso toccava tre questioni principali: quella concernente
«il razzismo e l’ebraismo»; quella più «generale dell’Azione Cattolica»: a tale
proposito veniva riconfermato l’accordo del 2 settembre 1931; infine, una
questione di carattere locale, che riguardava la sostituzione del segretario del
partito fascista di Bergamo che era entrato in conflitto con il vescovo di
quella città.
Per quanto riguarda il primo
punto, che era il più delicato e controverso, l’accordo sembrava condividere il
punto di vista cattolico in materia di razzismo e si muoveva secondo lo spirito
dell’Informativa diplomatica n. 18 del 5 agosto 1938, che, come abbiamo visto,
trovava consenzienti vasti settori del mondo cattolico e la stessa Gerarchia. In
realtà, dall’accordo traspare una forte polemica contro la Chiesa e la volontà
del regime di metterla a tacere su tale importante materia: «È intenzione del
Governo che questo problema sia tranquillamente definito in sede scientifica e
politica, senza aggravio dei gruppi allogeni, ma solo con la doverosa
applicazione di onesti criteri discriminatori che lo Stato ritiene essere in
diritto di stabilire e di seguire. Gli ebrei possono essere sicuri che non
saranno sottoposti a trattamento peggiore di quello usato loro per secoli e
secoli dai Papi che li ospitarono […]. Desiderio del Capo del Governo è che la
stampa cattolica, i predicatori e i conferenzieri si astengano dal trattare in
pubblico, il problema razzista» (19).
Mentre la Curia e la diplomazia
vaticana lavorarono senza sosta per un accomodamento con il regime mussoliniano,
in modo da contenere entro limiti accettabili la programmata legislazione
antiebraica, così che questa non si discostasse troppo dai princìpi della morale
cattolica e non violasse punti significativi degli Accordi del Laterano, Pio XI
continuò la sua lotta solitaria contro «le ideologie totalitarie». Egli non
sottopose a censura, come voleva Mussolini, il suo pensiero e continuò sino alla
fine dei suoi giorni a condannare le aberranti dottrine del «nazionalismo
estremo» e soprattutto del cosiddetto «razzismo esagerato», che considerava
un’eresia in quanto contraddiceva il fondamentale principio sull’originale
uguaglianza tra gli esseri umani. Il suo intervento magisteriale più forte da
questo punto di vista fu quello pronunciato all’indomani del primo provvedimento
governativo antiebraico, cioè il 6 settembre 1938, a un gruppo di pellegrini
belgi: con tono commosso, egli disse che l’antisemitismo è inammissibile e che
spiritualmente siamo tutti semiti perché discendenza di Abramo, nostro padre
nella fede. Era la prima volta che un Pontefice in modo chiaro ed esplicito
condannava l’antisemitismo. Delle vicende che seguirono tale discorso e degli
ulteriori provvedimenti antiebraici tratteremo prossimamente.
***
1 Archivio Segreto Vaticano –
Affari Ecclesiastici Straordinari (ASV – AAEESS), Italia, 1.040, 720, 22.
2 La letteratura storica sulle
leggi razziali in Italia è molto vasta; segnaliamo qui alcuni lavori che ci
sembrano più significativi: R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il
fascismo, Torino, Einaudi, 1961; Id., Mussolini il Duce, vol. II, Torino,
Einaudi, 1981; A. Martini, Studi sulla questione romana e sulla Conciliazione,
Roma, Cinque Lune, 1963; G. Miccoli, «Questione ebraica e antisemitismo tra Otto
e Novecento», in Storia d’Italia. Annali, vol. XI, Torino, Einaudi, 1997,
1.369-1.574; Id., I dilemmi e i silenzi di Pio XII, Milano, Rizzoli, 2000; S.
Zuccotti, L’Olocausto in Italia, Milano, Mondadori, 1988. M. Sarfatti, Gli ebrei
nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Torino, Einaudi, 2000;
Id., La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo, Torino,
Einaudi, 2005; E. Collotti, Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in
Italia, Roma – Bari, Laterza, 2003; A. Cavaglion – G. P. Romagnani, Le
interdizioni del Duce. Le leggi razziali in Italia, Torino, Claudiana, 2002. Su
Pio XI e il razzismo ricordiamo: E. Fattorini, Pio XI, Hitler e Mussolini. La
solitudine di un Papa, Torino, Einaudi, 2007; Y. Chiron, Pie XI, Paris, Perrin,
2004.
3 ASV – AAEESS, Italia, 1.054,
732, 11.
4 Ivi, 1.054, 730, 22.
5 Cfr R. De Felice, Mussolini
il Duce, cit., 489.
6 M. Barbera, «La questione dei
giudei in Ungheria», in Civ. Catt. 1938 III 152.
7 La liberté, 6 agosto 1938.
8 «Cronaca contemporanea», in
Civ. Catt.1938 III 271.
9 G. Passeleq – B. Suchecky,
L’enciclica nascosta di Pio XI. Un’occasione mancata dalla Chiesa nei confronti
dell’antisemitismo, Milano, Corbaccio, 1997, 42.
10 Ivi, 47.
11 ASV – AAEESS, Italia, 1.054,
727, 42.
12 I firmatari più noti del
Manifesto della razza erano due medici (S. Visco e N. Pende), un antropologo (L.
Cipriani), uno zoologo (E. Zavattari), uno statistico (F. Savorgnan) e uno
psichiatra (A. Donaggio); gli altri erano oscuri assistenti universitari, tra i
quali ricordiamo G. Landra, M. Ricci e L. Businco. Pare che nessuno dei
firmatari sia stato interpellato prima della pubblicazione del Manifesto.
Soltanto due di essi però, successivamente, anche se in modo non troppo chiaro,
protestarono per essere stati inclusi nella lista dei firmatari. Cfr R.
Maiocchi, Scienza italiana e razzismo fascista, Firenze, La Nuova Italia, 1999;
G. Israel – P. Nastasi, Scienza e razza nell’Italia fascista, Milano, Comunità,
1998; M. Michaelis, Mussolini e la questione ebraica. Le relazioni
italo-tedesche e la politica razziale in Italia, ivi, 1982.
13 ASV – AAEESS, 1.054, 738,
22.
14 Ivi, 730, 19.
15 Cfr G. CIANO, Diario:
1937-1938, Bologna, Cappelli, 1948, 216. Su tale materia cfr E. Fattorini, Pio
XI, Hitler e Mussolini, La solitudine di un papa, cit., 179 s.
16 ASV – AAEESS, Italia, 1.054,
728, 46.
17 La prima comunicazione, del
4 agosto, diceva: «Direttori dei periodici cattolici sono richiamati sulla
perentoria necessità che ogni commento sul problema razzista sia contenuto entri
i limiti conformi alle direttive del Governo nazionale». La seconda, emanata due
giorni dopo, affermava perentoriamente: «Invito disporre che quotidiani e
periodici cattolici si astengano da ora in poi di pubblicare l’allocuzione
pontificia del 28 luglio» (ivi, 728, 55).
18 Ivi, 730, 46.
19 Ivi, 40.
In difesa di quale razza?
Michele Serra su La Repubblica mercoledì 19 aprile 2023
"Non possiamo arrenderci alla
sostituzione etnica". Ha detto proprio così, il ministro
Lollobrigida: sostituzione etnica. Una lettura razzista (termine che non uso mai
con leggerezza) in base alla quale il concetto di nazionalità - essere italiani
- coincide con quello di razza.
Con l'aggravante che una "razza
italiana" - se non nell'obbrobrioso ventennio nel quale gli italiani furono
costretti a immaginarsi "razza" - non esiste e non è mai esistita.
La Repubblica 18 aprile 2023
Metropolis/310 - Sostituzione etnica, Massini a Lollobrigida: "Ma quale purezza
italiana? Abbiamo tutti il Dna meticcio"
Nel giorno in cui Mattarella è
in visita ad Auschwitz con le sorelle Bucci, il ministro dell'Agricoltura e del
Made in Italy Francesco Lollobrigida spiega che dobbiamo "incentivare le
nascite" per evitare una "sostituzione etnica" da parte dei migranti. La premier
Giorgia Meloni dal Salone del Mobile di Milano gli fa eco: "È vero che ci sono
troppi anziani e pochi nati, ma non risolveremo il problema del lavoro e dei
contributi con i migranti". Il concetto di sostituzione etnica e di politiche in
cui la razza viene considerata un tema è lo spunto per il commento di Stefano
Massini a Metropolis.
La nascita meticcia degli
Italiani. Toni Maraini il 12 Gennaio 2019 su Left
Chi oggi evoca una “purezza
italica” non conosce la storia né le dinamiche dello scambio culturale tra genti
e continenti. Basti considerare le origini cosmopolite di personaggi che hanno
contribuito alla cultura e alla scienza dell’Italia. E gli emigranti in America,
protagonisti di nuove culture. Una riflessione della scrittrice e storica
dell’arte
Coloro che oggi parlano come se
gli Italiani fossero da illo tempore di un’unica natura, stirpe e origine, forse
non conoscono in che modo l’Italia si è formata. Come i genetisti Luca
Cavalli-Sforza e Alberto Piazza hanno documentato, il popolo italiano possiede
una «eterogeneità genetica di fondo» costituitasi nei secoli a partire dagli
«apporti genetici di Piceni, Liguri, Veneti, Etruschi, Celti, Sardi, Greci, e
Albanesi, Arabi, Normanni…», ma non solo. La “biodiversità”, essi ci ricordano,
è proficua, salutare e necessaria, ed ha alimentato tutte le civiltà. Quanti
evocano oggi i “veri Italiani” sembrano ignorare il continuo sedimentarsi di
apporti confluiti nel costituirsi della “italianità”.
A seguire il loro ragionamento,
dovremmo omettere dalla nostra storia figure patriottiche quali Francesco
Crispi, di antica famiglia arbëreshë, come lo erano Gramsci, il tenore Tito
Schipa e altre e altri ancora. Dovremmo altresì ignorare la reggia di Caserta e
il suo architetto, Luigi Vanvitelli, il cui vero cognome olandese era Van
Wittel, artisti come Massimo Campigli (pseudonimo di Max Ihlenfeld), scrittori
come Italo Svevo (pseudonimo di Aron Hector Schmitz), o, ancora, Pietro
Vieusseux, Ulrico Hoepli, Elsa Merlini (nata Tschellesnig), Giorgio Strehler,
Alida Valli (nata Altenburger), Leone Ginzburg, Anna Kuliscioff, Dino Buzzati,
Hugo Pratt, Vittorio Gassman, Alexian Santino Spinelli, Moni Ovadia, Margherita
Hack e tante altre figure dall’intreccio genealogico cosmopolita (incluso
Alberto Moravia) che hanno contribuito al mondo della cultura, arti, scienze,
politica, e così via. Nonché a quello dello sport e dell’atletica, del
giornalismo, dell’impresa, dell’artigianato e del lavoro. E perfino, con un
consistente numero di stranieri (alcuni sono raffigurati tra i garibaldini nelle
Erme del Gianicolo a Roma), uomini e donne che parteciparono ai fervori
risorgimentali per l’indipendenza d’Italia.
Secondo quanti parlano di
“Italiani veraci” dovremmo forse non considerare coloro che avevano, o hanno, un
genitore straniero? Sono innumerevoli; da…
Un ritratto genetico degli italiani.
di Alessandro Raveane, Serena Aneli, Francesco Montinaro, Cristian Capelli.
Pubblicato il 10/10/2019 su scienzainrete.it.
Il nostro Paese è stato e continua a essere un
crocevia di spostamenti e migrazioni che ha favorito il contatto tra i popoli. E
questo, a sua volta, ha plasmato il nostro patrimonio genetico: ma allora, chi
sono davvero gli italiani? Il più grande studio di genetica della popolazione
italiana, recentemente pubblicato su Science Advances, ne analizza in maniera
sistematica la distribuzione della variazione genetica, rivelandone
l'incredibile eterogeneità. La ricerca ha anche messo in luce la presenza di un
contributo genetico mai evidenziato prima, frutto di un processo di espansione
delle popolazioni dal Caucaso all'Italia circa 4.000 anni fa, e il maggior
contributo di DNA neandertaliano nel nord della penisola. Questo viaggio nella
storia dei nostri geni racconta chi siamo: un cocktail genetico e culturale in
continua evoluzione.
EVOLUZIONE RICERCA SCIENTIFICA
Il tema delle migrazioni umane ha oggi, e ha avuto
in passato, una posizione centrale nel dibattito pubblico e politico. I flussi
migratori rappresentano però tutt’altro che una novità per la specie umana,
avendo giocato fin dall'antichità un ruolo fondamentale nella sua evoluzione.
Recenti scoperte hanno suggerito che in Europa nessun individuo discenderebbe
esclusivamente dai primi gruppi umani che si stabilirono nel continente circa
40.000 anni fa; sarebbe, invece, il risultato di un mix di molteplici antiche
discendenze provenienti dall’Africa, dal Medio-Oriente e dalle Steppe Russe.
Tra tutte le popolazioni europee, quella italiana
è un chiaro esempio di quanto le migrazioni abbiano influenzato le popolazioni
moderne. Nei millenni, infatti, l’Italia è stata un crocevia di spostamenti e
migrazioni per varie specie, inclusa la nostra, agendo spesso da ponte tra
Africa, Europa e Medio Oriente e favorendo, grazie alla sua posizione al centro
del bacino del Mediterraneo, il contatto di popoli e culture.
Ma allora, chi sono davvero gli italiani? La
genetica, coadiuvata dall’antropologia, la storia, la linguistica e
l’archeologia, può aggiungere importanti pennellate al complesso ritratto dei
cittadini dello stivale. Infatti, il DNA di ciascuno di noi è un mosaico di
frammenti con storie e origini diverse. Ereditate prima dai nostri genitori e a
loro volta trasmessi dai nostri nonni, queste porzioni di DNA possono essere
seguite generazione dopo generazione, così da ricostruire la storia degli
individui che si sono incontrati nel passato. Sulla base di questo semplice
principio, la genetica è in grado di scoprire migrazioni e contatti recenti e
più antichi, ripercorrendo le “impronte genetiche” lasciate nei loro discendenti
viventi e non.
I primi studi
Nei primi anni ‘60, il padre della genetica di
popolazione umana, Luigi Luca Cavalli-Sforza, stava lavorando a un approccio per
misurare l’impatto della deriva genetica sulle popolazioni umane, ovvero quel
fenomeno casuale che, insieme alla selezione naturale, determina la
differenziazione genetica tra popolazioni. Combinando dati estratti da archivi
vescovili e dati genetici della Val Parma, analizzati con l’ausilio dei primi
calcolatori elettronici, Cavalli-Sforza mise in evidenza come modelli matematici
basati solo sulla deriva permettevano di predire la distribuzione geografica
della variabilità genetica.
Circa vent’anni dopo, applicando lo stesso
approccio su un più vasto campione da diverse regioni Italiane, Alberto Piazza,
collaboratore di Cavalli-Sforza, rappresentò la struttura genetica degli
italiani con una tecnica statistica che permette di riassumere in poche
variabili le informazioni “nascoste” in una grossa mole di dati. Le informazioni
analizzate, in quel caso, erano le frequenze delle varietà differenti (alleli)
presenti in poco più di trenta marcatori genetici. La Sardegna risultò
decisamente separata dagli altri campioni italiani, mentre il resto dell'Italia
mostrava una distribuzione della diversità genetica a “gradiente” estesa lungo
l’asse nord-sud della penisola.
In seguito alla pubblicazione del genoma umano nel
2001, è diventato possibile analizzare non decine ma milioni di marcatori
genetici distribuiti lungo il DNA di ciascun individuo. Tali marcatori possono
essere raggruppati per definire frammenti di varie dimensioni che ci sono stati
tramandati dai nostri antenati di generazione in generazione. I primi risultati
sulla popolazione italiana hanno in generale confermato le osservazioni di
Alberto Piazza e colleghi.
Negli ultimi anni, diverse ricerche hanno fornito
un importante contributo per la comprensione dei fattori genetici che hanno
determinato l’attuale struttura genetica italiana, caratterizzandone
l'eterogeneità del patrimonio genetico lungo la penisola e investigandone i
fattori responsabili. Alcuni studi hanno inoltre indagato i fenomeni evolutivi
di adattamento all’ambiente avvenuti in Italia, mentre altri si sono concentrati
su quali migrazioni e interazioni del passato abbiano influenzato il sud e le
isole italiane.
La variazione genetica degli italiani
La ricerca recentemente pubblicata su Science
Advances dal nostro gruppo ha fornito ulteriori elementi nella descrizione del
complesso quadro genetico degli italiani, di cui analizza per la prima volta in
maniera sistematica la distribuzione della variazione genetica, per capire come
si sia originata dai fenomeni migratori e di mescolamento del passato. A oggi,
il lavoro rappresenta il più grande studio di genetica dei cittadini italiani e
ha coinvolto oltre 30 istituzioni e università italiane e internazionali.
L'analisi genetica, condotta allineando le
mutazioni genetiche in più di 1.500 italiani, hanno permesso di osservare come,
sebbene le differenze tra individui di diverse regioni sia molto bassa, la
geografia abbia un ruolo fondamentale nella distribuzione della variabilità
genetica: individui che provengono dalle stesse aree geografiche sono
geneticamente più vicini tra loro di quanto lo siano rispetto a quelli più
distanti geograficamente. Abbiamo successivamente paragonato i segmenti di DNA
di questi gruppi con quelli di gruppi di popolazioni europee e mondiali per
stimare l’origine spaziale e temporale di questi frammenti di DNA. Infine
abbiamo misurato nelle popolazioni italiana ed europee la quantità di DNA
ereditata dal nostro lontano “cugino”, l’uomo di Neandertal, che giunse nel
continente europeo circa 400.000 anni fa, ben prima dei nostri antenati.
Il popolo più eterogeneo d'Europa
Il grado di differenziazione genetica tra gli
italiani provenienti da aree diverse del Paese è confrontabile con le differenze
che si osservano tra diversi gruppi europei: in pratica, tra nord e sud Italia
si osservano differenze paragonabili a quelle che distinguono ad esempio un
danese da uno spagnolo. Inoltre, tali differenze sono più ampie di quelle
osservate all’interno delle popolazioni europee fino a oggi studiate (Figura 1).
Il motivo di tale eterogeneità è dovuto, almeno in parte, alla moltitudine di
migrazioni che hanno interessato la nostra penisola, susseguendosi in periodi
storici e preistorici e che, favorite dalla posizione geografica dell’Italia,
hanno introdotto nei genomi degli italiani frammenti di DNA provenienti da altri
gruppi, vicini e lontani.
Figura 1 Grafico a violino rappresentante la
differenziazione genetica in diverse popolazioni europee.
In questo ambito così delicato, è opportuno però
ricordare che le popolazioni umane si differenziano in maniera molto limitata,
dal momento che condividono gran parte del loro DNA: le differenze che si
possono riscontrare in media tra due soggetti presi a caso dalla popolazione
mondiale sono intorno allo 0.1% (1 differenza e 999 somiglianze!).
Una nuova componente genetica
Le radici della nostra relativamente elevata
variabilità vanno ricercate sia nelle migrazioni storiche che in quelle più
antiche. Per queste ultime, in particolare, il consenso generale suggeriva che i
genomi della maggior parte delle popolazioni europee, così come anche gli
italiani, contenessero le tracce di tre “gruppi ancestrali” associati
principalmente a tre cambiamenti demografici avvenuti nel Mesolitico (con gruppi
di cacciatori-raccoglitori), Neolitico (agricoltori) ed Età del Bronzo (pastori
nomadi Yamnaya delle steppe asiatiche).
Il nostro studio ha permesso d'individuare in
Italia la presenza di una nuova componente, maggiormente presente nei genomi
degli italiani del sud. Le analisi del DNA in questo lavoro, che comprende anche
i dati disponibili da precedenti pubblicazioni ottenuti dallo studio di ossa
umane antiche, suggerirebbero che questa componente fosse già presente in Italia
almeno 4.000 anni fa, prima dell'influenza della Grecia Classica nella regione.
Questo contributo, che avrebbe coinvolto inizialmente popolazioni geneticamente
affini ai gruppi moderni presenti nel Caucaso, sarebbe arrivato in Italia
meridionale nel corso di un processo di espansione comprendente anche la parte
meridionale dei Balcani.
Inoltre, la ricerca ha confermato la presenza di
un ulteriore e più recente segnale, già descritto in precedenti pubblicazioni
(ad esempio qui e qui), presente in maniera significativa nei gruppi del Sud
Italia: associato alle popolazioni nordafricane e mediorientali, risalirebbe a
circa 1.000 anni fa, periodo in cui nell’Italia meridionale e in particolar modo
in Sicilia iniziarono le prime invasioni arabe che portarono al dominio islamico
intorno al XII secolo.
Figura 2 Contributi genetici lungo la popolazione
italiana. Sulla sinistra sono presenti i contributi preistorici e storici
identificabili dal DNA degli italiani in ordine cronologico. In verde i
cacciatori-raccoglitori che giunsero in Italia circa 24.000 anni fa. I contadini
del Neolitico (frecce rosse), che si espansero da quella che oggi è la Turchia,
arrivarono in Italia circa 8.000 anni fa. In blu sono rappresentate le due rotte
parallele datate circa 5.000 anni dei pastori nomadi delle steppe verso il Nord
Europa e il “nuovo” segnale proveniente dal Caucaso verso il Sud Italia. In
giallo è rappresentata l’eredità genetica della dominazione Araba in Sud Europa
che risale a circa 1.300 anni fa. Sulla destra sono raffigurate le proporzioni
di questi contributi genetici in Nord e Sud Italia, e in Sardegna con gli stessi
colori utilizzati nella parte sinistra dell’immagine; le dimensioni delle
vignette contenenti i teschi indicano la proporzione di DNA neandertaliano nelle
diverse macro-aree italiane. Crediti: Alessandro Corlianò
Vantaggi e svantaggi di un'antica storia d'amore
Ma la storia della popolazione italiana non è
finita qui. Circa 50.000 anni fa, poco prima dell’arrivo in Italia della prima
componente legata a gruppi di raccoglitori e cacciatori, gli uomini moderni che
avevano appena lasciato l’Africa si incontrarono con i nostri parenti più
stretti (evolutivamente parlando), i Neandertal. L'eredità di tale incontro è
presente in tutte le popolazioni presenti fuori dal continente africano ed è
stimata intorno al 2% (percentuale di DNA neandertaliano in popolazioni al di
fuori dell’Africa Sub-Sahariana).
Nella nostra ricerca abbiamo cercato di
quantificare questa antica impronta genetica in Italia e in Europa. Lungo la
penisola abbiamo osservato un contributo maggiore di DNA neandertaliano negli
italiani del nord rispetto a quelli del resto d'Italia, inclusa la Sardegna, e
più DNA neandertaliano nei popoli nord-europei rispetto a quelli nel sud del
continente. Sebbene una piccola parte di queste differenze possa essere spiegata
da fenomeni di selezione naturale, la maggior parte della variazione geografica
nella quantità di DNA neandertaliano è probabilmente dovuta ai diversi eventi di
migrazione e mescolamento che le popolazioni in Italia e in Europa avrebbero
sperimentato nel corso della loro storia.
Ma avere più o meno geni neandertaliani è un
vantaggio o uno svantaggio? Come spesso accade, non c'è una risposta univoca.
Questi geni hanno avuto infatti un doppio ruolo da quando sono stati ereditati
dai nostri antenati. Da una parte sono stati un'importante fonte di variabilità
adattativa: quando l’uomo moderno è giunto in Eurasia, i Neanderthal vi vivevano
già da circa 300.000 anni ed erano geneticamente adattati alle condizioni
ambientali, ai patogeni e ai nutrienti che erano qui presenti e così diversi da
quelli africani. Ereditare queste varianti genetiche, perciò, offrì nuove
possibilità di adattamento a quegli uomini che si muovevano per la prima volta
nel nuovo mondo.
D’altra parte, abbiamo anche ereditato “regali“
genetici che oggi portano degli svantaggi, come alcune varianti che influenzano
la suscettibilità a determinate malattie metaboliche e neurodegenerative. Alcune
di queste varianti potrebbero aver avuto un ruolo diverso ed essere state utili
durante i primi movimenti fuori dall’Africa; tuttavia oggi sembrano avere
effetti negativi sulla nostra salute, probabilmente come conseguenza dei
cambiamenti dello stile di vita nonché della sua durata.
Da questo viaggio nel passato dei nostri geni,
abbiamo capito che l’Italia è stata il teatro di una lunga serie di migrazioni
che si sono susseguite nel corso dei secoli e millenni e che ancora oggi
arricchiscono il “bel Paese” dall’alto delle Alpi fino alla punta della sua
isola più meridionale, Lampedusa. È l’insieme di tutti questi contributi che si
sono susseguiti e sovrapposti nel tempo che ha generato il ritratto genetico di
quelli che sono oggi gli “italiani”, un cocktail genetico e culturale in
continua evoluzione.
Genetica e pregiudizi: «Credevo di essere
italiano e invece…» Un po' di saliva, una provetta che vola nello Utah,
l'analisi del DNA e tre settimane di attesa. Un giornalista di "Io Donna",
sicuro di essere italianissimo fin dal Medioevo, si è sottoposto a un test e ha
scoperto insospettabili radici: decisamente global di MASSIMILIANO JATTONI
DALL'ASÉN il 29 maggio 2017 su Iodonna.it
È arrivata per posta in un pacchetto poco più
grande di una scatola di fiammiferi. La provetta era già etichettata e dovevo
solo riempirla di saliva, prima di infilarla in una bustina trasparente. Seguite
le facili istruzioni, e sigillato il contenuto, le eliche dei miei cromosomi si
sono messe in moto e il kit del mio DNA è volato oltreoceano. Destinazione
finale: un laboratorio dello Utah. È bastato, poi, attendere poco meno di un
mese per ricevere la mail con il verdetto: “Massimiliano, sei italiano ma solo
per metà”.
Mentre leggo i risultati del test, ho davanti a
me, sul tavolo, alcune delle vecchie foto di famiglia che ancora conserviamo:
ritratti di bisnonni e di qualche prozia. Volti di uomini baffuti e donne coi
capelli raccolti e il cappellino. Volti di italiani nati quando anche l’Italia
era nata da poco. Indubbiamente italiani, se ne studio i tratti. Soprattutto
quelli da parte di mio padre, dai capelli scuri, gente che per oltre sei secoli
si è ostinata a vivere in un borgo della Val Parma, Beduzzo, adagiato ai piedi
del Montagnana. Di padre in figlio, di generazione in generazione. Ne conto
diciotto a scendere fino alla fine del Trecento, quando Giacomo, il capostipite,
fa capolino in un atto notarile col nome latinizzato di Jacobi de Attonibus. Il
cognome, poi, torna nella storia locale, riaffiora qua e là, ancora più giù nel
tempo, a prima dell’anno Mille. Sono italiano: le carte lo dicono. Anzi: si può
essere più italiani di così? Al grido nazional-populista «prima gli italiani!»
potrei rispondere facendomi largo tra la folla, mettendomi in testa. Eppure
quella sirena non mi ha mai incantato. E, in fondo, avevo ragione. Mi è bastato
sputare in una provetta, al costo di un centinaio di dollari, per sapere che
sono europeo, sì, ma non così italiano come credevo: qualcosa come poco più
della metà.
Leggi anche dal Corriere: Gli italiani non
esistono. Siamo un grande mix genetico
L’idea di sottopormi a questo test del DNA è
venuta una mattina in redazione, quando tra colleghi ci siamo scambiati su
Facebook, come altri milioni di italiani, un video ad alto tasso emozionale
(sponsorizzato da un noto motore di ricerca di viaggi), in cui una società
americana (la Ancestry) sottoponeva una serie di ragazzi di etnie diverse a un
test del DNA, che diventava l’occasione per intraprendere un viaggio dentro loro
stessi e la loro storia di famiglia, e divellere quelle convinzioni così
radicate in tutti noi su ciò che siamo e da dove veniamo.
La società, che ha sede nella cittadina di Lehi,
nello stato americano dello Utah (la patria dei Mormoni, che per le genealogie
hanno una vera fissazione), fornisce il servizio in quasi tutto il mondo, ma non
ancora in Italia. In aiuto, allora, arriva un amico che lavora come funzionario
a Bruxelles, e faccio inviare il kit per la raccolta del DNA al suo indirizzo.
Al primo incontro milanese, mi consegna la scatoletta e, dopo aver seguito
diligentemente le istruzioni, in sole quattro settimane entro in possesso
dell’esito: il mio sangue è italiano solo per il 58%. E qui iniziano le
sorprese. Etnicamente sono un mix: secondo le analisi fatte dall’azienda
americana ho per il 21% il patrimonio genetico dei barbari che invasero l’Italia
a partire dal 568 d.C. (cosa che sarebbe confermata dal mio cognome, che è
appunto di origine longobarda. Ma in tal caso ci si dovrebbe costringere a
immaginare una fedeltà incrollabile ai mariti di generazioni e generazioni di
spose della mia famiglia). Sempre attraverso questi popoli franco-germanici,
avrei ereditato poi un 10% di sangue scandivano, frutto forse delle invasioni
vichinghe della Gallia nel IX secolo. Nel miscuglio che mi ha dato vita, c’è
anche un po’ del patrimonio genetico degli ebrei dell’Europa centrale e un
interessante 2% maghrebino, arrivato a formarmi, insieme a tutto il resto,
probabilmente dai tempi dell’Impero romano, quando si distingueva tra cittadini
romani e stranieri, e mai se ne fece una questione di “razza”.
Ma quanto sono affidabili questi test? Sul mercato
online l’offerta è variegata. Sono diverse le aziende, soprattutto con base in
America, che per una cifra abbordabile assicurano di poter svelare la storia
remota di un individuo e della sua famiglia. Risalendo anche fino a ventimila
anni fa. La Ancestry è una delle leader nel settore e da oltre 10 anni insegue
una moda che dilaga nei Paesi occidentali (ma ancora poco radicata in
Italia): la genealogia. «In realtà l’approssimazione di questi test è la stessa
degli oroscopi», mi spiega divertito il genetista Edoardo Boncinelli, quando al
telefono gli illustro il risultato del mio test. «Una volta ogni dieci magari ci
azzecca». Però la fotografia della mia italianità “meticcia” che esce dai
risultati del laboratorio nello Utah è credibile: «Siamo il frutto di secoli di
incontri, di scambio di informazioni, culturali e genetiche», mi spiega
Boncinelli: «il Mediterraneo è una zona in cui è successo tutto e di più e
questa è anche la ragione per la quale la nostra civiltà ha avuto un notevole
sviluppo tecnologico».
Ripenso allora a certe teorie razziste del
Ventennio, sconfessate da tutto il mondo accademico, e come ancora si senta
qualcuno che parla orgoglioso di una “razza italiana”. «Non ha nessun senso»,
sbotta al di là del telefono Boncinelli, mentre il suo accento toscano si fa
ancora più marcato. «Come non ha senso parlare di “genio italiano”. Questa è
un’altra di quelle cose che mi fanno arrabbiare», confessa sbuffando. «Ce la
pigliamo giustamente con i razzisti e poi parliamo di genio italico: da quando
il genio si trasmette con il DNA?». Secondo Boncinelli, «in realtà, noi italiani
siamo una gran frittura mista: questa è stata la nostra grande fortuna». E non
c’è bisogno che ce lo riveli un’azienda americana. Come io, del resto, non ho
bisogno di un test del DNA, di un cognome ebraico che compare nel mio albero
genealogico, di un avo scandinavo o di quel Giacomo riemerso dalla notte dei
tempi a rivendicare col suo cognome una lunga discendenza, per sentirmi parte di
qualcosa di molto più grande. Qualcosa che non si limita alle storie di famiglia
o alla cittadinanza, ma travalica i confini della mia nazione e del mio
continente, e che – nonostante qualcuno possa tacciarla di retorica – mi
racconta di una storia tumultuosa e affascinante alla quale anche io, minuscolo
tassello, appartengo: quella della razza umana. iO Donna
Immigrazionisti.
"Compagni, questa è la nuova Genova".
I progetti eversivi della Ong di Casarini. Lodovica Bulian e Luca Fazzo il
12 Dicembre 2023 su Il Giornale.
"Operazione Disobedience": si chiamava proprio
così, "Operazione Disobbedienza", il progetto originale che dà il via a
Mediterranea, la ong guidata dall'ex rivoluzionario veneziano Luca Casarini
«Operazione Disobedience»: si chiamava proprio
così, «Operazione Disobbedienza», il progetto originale che dà il via a
Mediterranea, la ong guidata dall'ex rivoluzionario veneziano Luca Casarini,
finita ora al centro dell'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina della procura della Repubblica di Ragusa. Negli atti depositati dai
pm saltano fuori i finanziamenti per centinaia di migliaia di euro forniti a
Mediterranea da tre Arcivescovadi, e l'altro giorno la Conferenza episcopale
italiana ammette la circostanza, rivendicando il diritto-dovere della Chiesa a
«schierarsi dalla parte di chiunque soffre».
Benissimo. Ma la genesi di Mediterranea, così come
ricostruita dalla Procura ragusana, racconta una storia diversa dal nobile amore
per il prossimo. Lo spirito con cui Casarini & C. danno vita al progetto è poco
umanitario e molto politico. Di contrapposizione frontale, senza mediazioni, col
governo. Uno spirito che viene sintetizzato da Luca Casarini in una frase sola:
«Compagni, questa è la nuova Genova». Commenta il rapporto informativo della
Guardia di finanza: «Naturalmente in riferimento al G8 del 2001 in cui lo stesso
(Casarini, ndr) fu il protagonista delle note rivolte».
La genesi di Mediterranea viene ricostruita dalle
«fiamme gialle» grazie al contenuto dei telefoni sequestrati a Casarini e agli
altri indagati l'1 marzo 2021. Analizzandone la memoria, gli investigatori sono
risaliti al 28 giugno 2018, quando Casarini crea su Telegram la chat intitolata
«Operazione Disobedience». Nel gruppo inserisce Giuseppe Coccia, futuro
presidente di Mediterranea, e Alessandro Metz, entrambi oggi indagati con lui.
La Finanza si sofferma però su altri due nomi inseriti dal leader nel gruppo:
Gianmarco De Pieri e Meco Bologna, «ovvero Domenico Mucignat». Spiega la Gdf: De
Pieri è «già leader in passato del centro sociale Tpo - Teatro polivalente
occupato di Bologna)»; Mucignat ovvero Meco è «leader già appartenente al gruppo
dei disobbedienti del Tpo», il teatro occupato del capoluogo emiliano. De Pieri
è da vent'anni un antagonista doc, legato al circuito dei Disobbedienti, accanto
a Casarini sin dai tempi dell'assalto al Cpt di Bologna e dei convegni accanto a
Toni Negri, leader dell'Autonomia operaia negli anni Ottanta. Nel curriculum di
De Pieri c'è l'accusa di istigazione a delinquere per l'attacco a Bankitalia nel
2011, il divieto di soggiorno a Bologna per gli scontri del giugno 2015, seguito
dagli arresti domiciliari e dalla condanna per lo stesso reato. Un singolare
tipo di pacifista che quando nel 2016 Matteo Salvini si fermò a prendere un
caffè in un bar vicino al suo lo attaccò dicendo «torna a Milano, ricordati che
hai due figli», e che due anni fa partecipò agli scontri con la polizia per
impedire lo sgombero del centro sociale La'Bas.
Significativa la presenza nel «nucleo fondatore»
di Meco Mucignat, perché proprio l'antagonista è già allora uno dei primi
interlocutori della Chiesa bolognese: a partire dall'allora arcivescovo Matteo
Zuppi, ora presidente della Cei, che tre mesi prima della chat, nel marzo 2018,
ha accettato l'invito nel centro sociale Tpo. «Ha introdotto i temi della
accoglienza e della disobbedienza», dice Mucignat. Sarà Zuppi, secondo le
intercettazioni della Gdf, a benedire il flusso di soldi in direzione di
Mediterranea.
Stando ai verbali dell'indagine, a venire
finanziata dalle Curie italiane è più un circolo antagonista che una
organizzazione umanitaria (anche perché Giuseppe Caccia, che diverrà il
presidente, viene registrato mentre dice «io non ne capisco un cazzo di navi»).
Un gruppo di soccorritori improvvisati, dove emerge - scrive sempre la Gdf - «la
quasi totale mancanza di preparazione, delle elementari nozioni marinaresche in
possesso dei partecipanti al progetto che li condurrà di lì a poco a diventare
degli esperti di salvataggio in mare (...) traspare la mancanza dei minimi
requisiti di sicurezza nello svolgere i salvataggi in mare». Ma più che di
salvare i disperati, forse a Casarini e gli altri interessava combattere il
governo. Fare «una nuova Genova» con la benedizione (e i soldi) dei vescovi.
Lodovica Bulian e Luca Fazzo
DALLA METSOLA A SOUMAHORO: LA “BANDA DEI BUONI”
DI CASARINI AVEVA I SUOI INFILTRATI NEI PALAZZI DELLA POLITICA. Estratto
dell’articolo di Giacomo Amadori per “La Verità” lunedì 11 dicembre 2023.
I giudizi sui compagni di viaggio non erano dei
migliori, ma Luca Casarini, Giuseppe Caccia e i loro compagni dell’associazione
Mediterranea, potevano contare, oltre che su una lunga lista di politici
italiani, a partire dai cosiddetti garanti, anche su una rete internazionale
utilizzata per fare pressing sulle politiche degli Stati e dell’Unione europea.
Una squadra che andava dai socialisti statunitensi
di Bernie Sanders all’ex ministro greco Yanis Varoufakis sino all’attuale
presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola. Ma a colpire
nelle chat agli atti dell’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina della Procura di Ragusa è in particolare il rapporto con Aboubakar
Soumahoro, in quel momento lanciatissimo sulla scena politica.
I Casarini boys e il deputato con gli stivali si
spalleggiano. I primi aprono al secondo le porte del Vaticano e l’ex
sindacalista, quando Mediterranea è insidiata dai concorrenti di ResQ, fa una
scelta di campo e si iscrive all’associazione.
Uno dei primi passi insieme di questa cordata
coincide con l’organizzazione dell’incontro dei movimenti sociali del
Mediterraneo. L’appuntamento è affidato al cardinale Michael Czerny, attuale
prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, e don
Mattia, il cappellano di bordo dell’associazione, fa sapere che «la segreteria
organizzativa sarà composta innanzitutto da noi». […]
Czerny lavora per far entrare Mediterranea nel
segretariato della rete ufficiale dei movimenti popolari, l’Emmp (Encuentro
mundial de movimientos populares), che è apparentata con il suo dicastero. Un
circuito in grado di garantire potere, visibilità e risorse economiche. Sarà per
questo che il 5 maggio del 2020 don Mattia informa i suoi compagni di aver
ricevuto un messaggio da Soumahoro: «Mi ha chiesto di girare al cardinale Czerny
il video in cui si rivolge al Papa» spiega il parroco.
E aggiunge: «Stasera Czerny mi ha scritto dicendo
di guardare l’udienza domani. Quindi penso che il Papa citerà le lotte di Abou».
Quest’ultimo, nel 2019, era riuscito a farsi un selfie con il Pontefice, insieme
con la compagna Liliane (arrestata a ottobre con l’accusa di bancarotta delle
cooperative guidate dalla sua famiglia) e il 6 maggio del 2020, all’udienza
generale del mercoledì, Francesco annuncia: «In occasione del 1° maggio, ho
ricevuto diversi messaggi riferiti al mondo del lavoro e ai suoi problemi. In
particolare, mi ha colpito quello dei braccianti agricoli, tra cui molti
immigrati, che lavorano nelle campagne italiane […]. Perciò accolgo l’appello di
questi lavoratori e di tutti i lavoratori sfruttati e invito a fare della crisi
l’occasione per rimettere al centro la dignità della persona e la dignità del
lavoro».
L’asse Mediterranea-Soumahoro ha prodotto un primo
importante risultato. Tanto che l’allora sindacalista viene «taggato da Vatican
news». Don Mattia precisa: «È Czerny che ha gestito tutta la partita di Abou. Se
non fosse stato per lui al Papa non sarebbe arrivato neanche il video».
Il 2 agosto il cappellano avverte gli amici di
essere stato nuovamente contattato da Soumahoro: «Domani vede Czerny e mi ha
detto di accompagnarlo». Casarini esulta: «Anche Abou varrebbe la pena adesso
che si è liberato di Usb». Don Mattia, il giorno dopo, spiega che l’incontro è
«andato molto bene» e che Soumahoro «è felicissimo di collaborare» con
Mediterranea.
La vispa star dei salotti giusti, attraverso una
sua collaboratrice, organizza una sua visita alla Mare Jonio e invita, a sua
volta, i pescatori di migranti a «visitare le baraccopoli». Nei mesi successivi
Abou si iscrive a Mediterranea e fa un video messaggio di sostegno. Anche grazie
ai buoni uffici dei Casarini boys finisce nel giro dei movimenti popolari e
viene invitato come relatore a uno dei loro incontri, organizzati con il
patrocinio della Chiesa.
A ottobre la sinergia si concentra sui decreti
Sicurezza, che il governo Conte 2 è chiamato a sconfessare. Ma, secondo i nostri
eroi, con scarsa determinazione. Don Mattia si fa latore di una notizia
«riservatissima»: «Mi ha chiamato Abou. Sta organizzando, nel caso in cui le
modifiche ai decreti fossero insufficienti, come sembra, una manifestazione
sotto Palazzo Chigi dei costruttori di umanità e dei dannati dei decreti
sicurezza. Ovviamente ci chiede di essere protagonisti di questa cosa».
Ma la Chiesa non ha solo favorito la consacrazione
della stella di Soumahoro. Per esempio, ha spinto anche le relazioni
internazionali di Mediterranea nel mondo delle diocesi. A partire
dall’arcipelago maltese, dove Casarini & C., sono entrati in confidenza con due
prelati di peso, Charles Scicluna, arcivescovo a La Valletta, e il cardinale
Mario Grech, già vescovo di Gozo.
Il primo è descritto da don Mattia come «braccio
destro del Papa nella lotta agli abusi», nonché «segretario aggiunto della
Congregazione per la dottrina della fede», il secondo è, invece, «pro-segretario
generale del Sinodo dei vescovi». In particolare Scicluna ha un fitto rapporto
epistolare con la banda e, per esempio, invia in anteprima una lettera «segreta»
con cui «la Chiesa maltese chiede ufficialmente l’intervento del Vaticano per
aiutare» la nave di una Ong spagnola e di «far riaprire i porti di Malta».
In un altro scrive una dettagliata relazione di un
incontro avuto con il ministro degli Esteri Evarist Bartolo sulla questione
degli sbarchi e informa i Casarini boys anche dei suoi scambi di messaggi con il
ministro dell’Interno Byron Camilleri. La ciurma della Mare Jonio è entusiasta:
«Le nostre fonti di Malta (Jrs, ovvero il Jesuit refugee service, ndr)
confermano che Scicluna sta forzando il governo maltese a non ordinare il
push-back (operazioni di respingimento, ndr)». Ma anche che, grazie lui, lo
stesso governo è stato costretto «a far intervenire un mercantile» per
soccorrere dei migranti.
[…] Il cappellano racconta anche che attraverso
l’alto prelato si può arrivare nel cuore di Bruxelles: «Mi scrive Silvia
direttrice umanitaria di Caritas Europa che la nuova presidente del Parlamento
europeo, Metsola, è maltese ed è in contatto stretto sia con Scicluna sia con
loro.
Secondo Silvia possiamo coinvolgerla nel sistema
di pressing, con loro ha sempre lavorato bene». Ma la banda si muove pure su
altri tavoli. Il 5 novembre 2020 don Mattia annuncia: «Ragazzi mi ha contattato
David Atler della rete Progressive international di Sanders e Varoufakis. Stanno
preparando una grande battaglia contro Frontex (l’agenzia europea della guardia
di frontiera e costiera, ndr). Con molti movimenti di tutto il mondo.
Sanders, Corbin e altri sarebbero direttamente
coinvolti in questa lotta». Casarini smorza l’entusiasmo del giovane prete:
«Dividi sempre per cinque quello che dicono David e soprattutto VarouVogueFakis.
Sono sempre fanfaroni. La sparano grossa e poi non hanno nulla dietro. Comunque
è importante. Fatti mandare materiali e dettagli e poi guardiamo».
Il cappellano commenta che gli attivisti bolognesi
di Mediterranea «hanno perso la testa per Varou». Caccia e Casarini, nelle chat,
mostrano di avere anche rapporti intensi pure con i laburisti di Jeremy Corbyn e
gli spagnoli di Podemos e in particolare con uno dei loro leader Pablo
Bustinduy, ma, almeno in questo, caso Mediterranea non c’entra molto.
Emigranti.
Il Rapporto Migrantes. Anche gli italiani
migrano, 6 milioni in fuga dalla povertà. Sono 6 milioni gli italiani
all’estero, il doppio rispetto a vent’anni fa. Partono i giovani dal Sud, alla
ricerca di una cura per l’indigenza e la paura. Le misure per il rientro dei
cervelli però hanno funzionato. Mario Marazziti su L'Unità il 9 Novembre 2023
Un italiano su 10 non c’è più. Perché sono 6 i
milioni di italiane, (le donne sono di più) e di italiani, soprattutto giovani
sotto i 30 anni e gran parte dal Sud, che hanno lasciato il nostro Paese. Non è
un indice di fiducia, ma di “rivalsa e di speranza di crescita” dice il Rapporto
2023 Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes presentato a Roma. Una
fotografia che contiene domande importanti – anche se interessano pochi – e per
questo tanti continuano ad andarsene e a non votare.
Perché sei milioni di italiani vivono e scelgono
di vivere fuori dall’Italia? Il Covid è stato come una guerra, anche se, tutto
sommato breve. E dopo le guerre – anche se intanto si sono moltiplicate quelle
vere: dall’Ucraina, al Sudan, alla nuova, disumana oltre l’immaginazione, guerra
israelo-Hamas che sta distruggendo palestinesi e israeliani assieme a sicurezza
e futuro – si moltiplica ovunque la voglia di cambiare lavoro e vita dove si
vive, ma non per gli italiani: lo State of the Global Workplace 2023
Report di Gallup rileva che il 53% dei lavoratori a livello mondiale ritiene
infatti che sia un buon momento per cambiare lavoro.
Circa la metà (il 51%) dichiara di avere
intenzione di lasciare il lavoro considerando la ripresa del mondo occupazionale
dopo l’interruzione dovuta alla pandemia globale. In Europa le cose sono
frastagliate: mentre danesi (69%), tedeschi (52%) e inglesi (40%) pensano che
sia un buon momento per cambiare lavoro, gli italiani invece si sentono come
inchiodati al loro destino professionale (solo il 18% oserebbe cambiare lavoro),
sono i lavoratori meno coinvolti, i più stressati (49%) e i più tristi (27%),
quelli che ritengono di non avere altra scelta lavorativa, sicuramente i più
rassegnati. Più si è giovani e più la rassegnazione aumenta.
L’Italia, non solo quella che aspira ad essere
sovranista-per-sempre, può illudersi, raccontarsi bugie, ma è ammalata di
rassegnazione. È già in estinzione. C’è ormai una letteratura importante – ma
che è ignorata dalle classi dirigenti e politiche: “Quel che resta. L’Italia dei
paesi tra abbandoni e ritorni”, “La Grande Occasione” quando descrive Cefalù e
le Madonie, o “Gli ultimi italiani”, di Roberto Volpi, – che ci dà tra i 5 e i
10 anni per immaginare qualcosa che liberi l’Italia dal destino di museo da
visitare, un Marigold hotel per pensionati in cerca di qualità. Non è una cosa
dell’ultimo periodo.
Gli italiani all’estero negli ultimi venti anni
sono raddoppiati: le donne sono cresciute del 99,3%, i minori del 78,3% e gli
over 65 del 109,8%. Le partenze per espatrio sono salite del 44,9%. Nell’ultimo
anno sono i giovani adulti tra i 18 e i 34 anni gli expat per eccellenza, perché
sono quasi uno su due, il 44%, degli 82mila espatriati nel 2022. Altre classi di
età diminuiscono, ma i giovani continuano ad aumentare.
I giovani italiani sono quelli che,
in Europa, mostrano maggiori segni di sofferenza. Tra i 18 e i 34 anni quasi un
ragazzo su due nel 2022 (4,8 milioni) ha almeno un segnale di deprivazione e due
sono le sfere esistenziali maggiormente in difficoltà: l’istruzione e il lavoro.
Sempre più vulnerabili, ben 1,7 milioni dei giovani italiani sono NEET (Not in
Education, Employment or Training) cioè non studiano né lavorano, né sono
inseriti in qualche percorso di formazione. Il confronto con l’Europa è
impietoso: i lavoratori italiani guadagnano circa 3.700 euro in meno dei
coetanei europei che fanno lo stesso lavoro.
La mobilità per i giovani è diventata la possibile
cura per guarire dalla povertà e dalla paura. Nel 2022 sono in condizione di
povertà assoluta in Italia poco più di 2,18 milioni di famiglie e oltre 5,6
milioni di individui. La povertà è in crescita e riguarda le famiglie con più
figli e i minori. Sono 1,27 milioni i minori in povertà assoluta. Che, se non
trattata in maniera organica, diventa povertà strutturale, non di uno, ma di
famiglie e generazioni: da minorile diventa giovanile, da giovanile diventa
familiare. E cambia forma.
È una storia antica, che in regioni come
la Calabria o in Sicilia non si è mai interrotta. Anche in questo Rapporto, che
pure nota come crescano percentuali di giovani che lasciano il paese
dalla Lombardia, si evidenzia che si tratta del secondo passo dell’emigrazione
per i meridionali italiani approdati in prima istanza nel nord est o nel nord
ovest d’Italia.
Qualcosa ha funzionato: “Il 2021 è stato l’anno
nel quale si è manifestato l’impatto dell’introduzione delle nuove agevolazioni
fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia (DL 34/2019: Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi –
Rientro dei cervelli): il numero di rientri è raddoppiato, passando da una media
di 2.000/3.000 all’anno ad oltre 6.500. Era il governo “Conte 2”, con PD, 5
stelle, Italia Viva e Liberi e Uguali. Una goccia ma nella giusta direzione. E
“lotta alla precarietà, o si va altrove (Card. Zuppi”.
Chi va via, due su tre, lo fa verso altri paesi
europei. E qui c’è una delle chiavi di risposta. “L’Europa grazie alla sua
storia, rappresenta la memoria dell’umanità ed è perciò chiamata a interpretare
il ruolo che le corrisponde: quello di unire i distanti, di accogliere al suo
interno i popoli e di non lasciare nessuno per sempre nemico. È dunque
essenziale ritrovare l’anima europea (…) oltre i confini nazionali e i bisogni
immediati, generando diplomazie capaci di ricucire l’unità, non di allargare gli
strappi” (Papa Francesco il 28 aprile in Ungheria). Varrebbe anche per l’Italia.
Mario Marazziti 9 Novembre 2023
Un italiano su 10 vive all’estero, guida
psicologica contro il mal d’Italia. Storia di Chiara Daina su Il Corriere
della Sera venerdì 3 novembre 2023
Partire e non sapere cosa accadrà è un po’ come
morire. Quando si emigra dall’Italia, seppur per motivi nobili e allettanti,
come un lavoro più remunerativo, un’opportunità di carriera, di studio, un
amore, «c’è sempre una situazione di incertezza rispetto al futuro che si vive e
una dose di fatica che immancabilmente si compie, anche solo per ricostruire
routine e amicizie, per imparare la lingua o per rinforzare la scelta della
partenza, contro lo stereotipo comune dell’”espatrio dorato”, secondo cui nel
nuovo Paese si avrà una vita sicuramente migliore di quella che si lascia»
sottolinea Anna Pisterzi, psicoterapeuta, fondatrice e presidente della
cooperativa sociale Transiti, che dal 2017 si occupa di promuovere il benessere
psicologico degli italiani all’estero attraverso attività di ricerca e servizi
di orientamento e cura da remoto. «Questo non significa patologizzare l’espatrio
ma considerarlo una tappa di sviluppo importante nella storia di una persona,
che richiede un particolare investimento di energie e smuove spesso sentimenti
ambivalenti, come il sentirsi da una parte fortunati per l’esperienza che si sta
vivendo e dall’altra a disagio per il fatto di non sentirsi a casa nello Stato
ospitante o comunque di ritrovarsi in un posto che si scopre essere lontano dai
propri valori» continua Pisterzi.
Italiani emigrati
I cittadini
italiani emigrati all’estero e iscritti all’ anagrafe consolare nel
2022 erano 6,5 milioni (senza contare tutti gli expat che non hanno trasferito
la loro residenza oltreconfine e quindi non risultano iscritti al registro). Se
si sta affrontando un momento di difficoltà fuori dall’Italia, legato alla
condizione di expat o scatenato da altre cause, l cooperativa Transiti offre un
percorso di psicoterapia online e un primo colloquio gratuito per capire se è
necessario o meno incominciarlo. «Disponiamo di una ventina di psicoterapeuti e
di un fondo per pagare le sedute a chi non può permetterselo. Negli altri casi
la tariffa va da 50 a 75 euro all’ora in base alla disponibilità economica della
persona» spiega Pisterzi. Parallelamente la cooperativa ha attivato un servizio
di consulenza di carriera per supportare la persona nella ricerca di un lavoro,
dopo aver finito il ciclo di studi o dopo essere rimasta disoccupata per aver
raggiunto il partner all’estero, oppure nel prendere una decisione professionale
o scolastica. Per tutti quelli che hanno in mente di fare le valigie per
trasferirsi oltreconfine, le hanno già fatte o rientrano in Italia dopo tanti
anni, la cooperativa Transiti ha dedicato il libro Traiettorie. Guida
psicologica all’espatrio . «Il fine è preventivo - commenta -. Si preparano le
persone a fare un’esperienza evolutiva attraverso la migrazione, aumentando la
loro consapevolezza a partire da queste domande: perchè mi muovo? Per chi o con
chi mi muovo? Da dove mi muovo e verso dove vado? In che momento della vita mi
trovo?». Un altro capitolo riguarda il rientro. «Il Paese che si ritrova non è
mai uguale a quello che si è lasciato. Rimpatriare dopo tanti anni è un nuovo
espatrio e questo di solito viene sottovalutato. Ma essere coscienti dello
spaesamento che il rientro provoca aiuta a superarlo e a non prenderlo
sottogamba» conclude Pisterzi.
Ogni anno 100mila persone lasciano il Sud
Italia per il Nord. E sono soprattutto laureati. Per la prima volta la
maggioranza degli emigranti ha un titolo di studio universitario. E chi resta in
un caso su quattro guadagna meno di 9 euro l’ora. La denuncia di Svimez. Chiara
Sgreccia su L'espresso il 19 luglio 2023.
Circa 100mila persone, ogni anno, dal Sud si
trasferiscono al Nord. È così dal 2001. A cambiare col tempo, però, sono stati i
profili di chi decide di lasciare il Mezzogiorno per l’Italia
centro-settentrionale: tra il 2001 e il 2021 i migranti laureati si sono più che
triplicati, passando dal 9 al 34 per cento del totale. Nel 2022 sono diventati
quelli che se ne vanno di più, se confrontati con chi possiede titoli di studio
inferiori. «É la prima volta che succede nella storia delle migrazioni interne
del nostro Paese», si legge nel report 2023 sull’economia e la società del
Mezzogiorno presentato dall’associazione Svimez.
Secondo le anticipazioni del rapporto, tanti dei
migranti laureati che lasciano il Sud - 9mila su 27mila nel 2021 - hanno
seguito un percorso di formazione Stem. Così, come conseguenza, un terzo degli
investimenti del Meridione nelle competenze scientifiche e tecnologiche si
disperde. A discapito dell’industria, soprattutto delle filiere produttive
strategiche a elevato contenuto di innovazione. Che sono fondamentali nel
disincentivare la fuga dei cervelli, perché attirano lavoratori altamente
qualificati, creano posti di lavoro di valore, offrono buone
retribuzioni, generano reazioni a catena che favoriscono la crescita economica
solida e duratura di intere aree del paese, arginano la working-in poverty.
Un tema, quello del lavoro povero, che porta molti
occupati in Italia a non guadagnare nemmeno il necessario per vivere
un’esistenza dignitosa. Sono 3 milioni, secondo la stima di Svimez elaborata
utilizzando i microdati di Istat del 2020, i lavoratori che hanno una
retribuzione oraria inferiore ai 9 euro lordi l’ora. La soglia che le
opposizioni al Governo vorrebbero fissare al salario per essere legale, affinché
non vi siano occupati costretti a vivere in povertà. Un milione di questi vive
al Sud: il 25,1 per cento di tutti i dipendenti del Mezzogiorno guadagna meno di
quello che viene considerato il minimo per essere uno stipendio degno.
Così, sebbene dopo la crisi post Covid-19, gli
occupati siano tornati a crescere in tutta Italia. E anche al Sud, superando i
livelli pre-pandemia (+ 22 mila rispetto al 2019), il peso dei contratti a
termine resta altissimo: 22,9 per cento contro il 14,7 per cento del
Centro-Nord. E la perdita del potere d’acquisto è più sostenuta, perché sono
cresciuti di più i prezzi dei beni di prima necessità. Rendendo più difficile la
vita di chi sceglie di restare.
L’Archivio racconta: 1884, quei «piccoli
italiani» mendicanti-suonatori nelle vie di Londra e Parigi. Corriere della
Sera il 6 Luglio 2023.
Nel 1884 Le Figaro denunciava la presenza di
bambini italiani costretti da «gente venale e senza cuore» a suonare per le vie
di Parigi. Poco dopo gli faceva eco anche il londinese Evening Standard. Il
riportava la notizia e aggiungeva: «La miseria e le sofferenze di questi
fanciulli sono grandi quanto la furfanteria e la crudeltà dei loro padroni;
poiché si tratta di un vero e ignobile mercato di piccoli schiavi (..). Il
triste spettacolo di questi suonatori e cantastorie ambulanti non è offerto
soltanto a Parigi, ma anche a Londra e in altre città d’Europa e d’America,
dove, anzi, si chiamano comunemente col semplice appellativo di “piccoli
italiani”. Questo spettacolo di mercato di carne umana non darà una buona idea
del nostro spirito filantropico agli stranieri, i quali, quando vedono questi
fanciulli sofferenti per fame, per freddo, per cattiva salute, esposti alla
brutalità dei loro padroni, debbono dedurne che dev’essere assai matrigna la
terra che lascia organizzare codesta vergognosa tratta di schiavi; e assai
negligenti o duri di cuore gli uomini di una nazione che non provvedono per
impedirla o per farla cessare».
Eppure, aggiungeva il Corriere, esiste una
legge «per la repressione di questo mercato. Ma bisogna dire che la legge (...)
sia diventata lettera morta se i piccoli italiani continuano ad affliggere gli
stranieri». Un anno dopo il Corriere ricordava come la situazione non fosse
cambiata. Solo nel 1888 qualcosa iniziava a muoversi per iniziativa
di benefattori che a Londra crearono istituti «per avviare i fanciulli italiani
poveri ad un mestiere utile e decoroso».
"Gli italiani emigravano...". La vergognosa balla delle Ong pro clandestine.
Dalla Ong il paragone tra i migranti italiani del Novecento e quelli africani di
oggi tra ignoranza e fake news: "Studiate la storia". Francesca Galici il 16
Aprile 2023 su Il Giornale
I tentativi delle Ong di
supportare la propaganda pro-immigrazione non conoscono limiti, nemmeno quelli
del buon senso. La dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo,
come ha dichiarato il ministro Matteo Piantedosi, è una misura tecnica e non
emergenziale per gestire al meglio l'accoglienza e il sistema in un momento
storico in cui si sta verificando un incremento enorme degli sbarchi. Ma le Ong
non sembrano gradire le mosse dell'esecutivo, che sta evidentemente lavorando
per il bene del Paese e per la sua tutela al contrario di quanto avveniva in
passato. Abituate ad agire liberamente, senza regole ma, anzi, dettando le
proprie, le Ong ora si trovano spiazzate e senza possibilità di imporre la
propria linea. Questo le porta ad affermazioni come quelle fatte
dall'organizzazione spagnola che arma la nave Aita mari.
"2 milioni di italiani
emigrarono in Usa tra il 1900 e il 1914. Allora non c'era lo 'stato di emergenza
immigrazione' per effettuare deportazioni e schermare le
frontiere. L'allarmismo dovuto all'invasione, la diffusione di messaggi di odio,
la stigmatizzazione delle Ong e la violazione dei diritti umani non risolve
nulla", scrivono su Twitter. Di inesattezze ce ne sono tante in questo
messaggio, che lascia trasparire un certo nervosismo da parte
dell'organizzazione. Tuttavia, in nome del rispetto della memoria dei veri
migranti e di coloro che hanno lasciato l'Italia, ma anche la Spagna e altri
Paesi europei, per trovare condizioni di vita migliore negli Stati Uniti, è
necessario fare alcune precisazioni.
"Italia, Italia".
La beffa dei migranti: strappano i passaporti prima di sbarcare | Il video
Gli italiani, gli spagnoli, i
portoghesi e tutti quelli che andavano in America lo facevano con in tasca i
loro documenti, che erano quanto di più prezioso e caro avessero. Non li
strappavano per lanciarli in mare per ritardare le procedure di identificazione,
perché sapevano a cosa andavano incontro se sbarcavano a Ellis Island,
nell'Upper side di New York, senza un documento che venisse riconosciuto
dall'altra parte dell'oceano. Pagavano le traversate a bordo dei transatlantici
e viaggiavano in terza classe con le loro valigie e già a bordo erano invitati a
compilare i questionari di ammissione: 31 domande che indagavano la vita del
passeggero. E veniva chiesto di tutto: situazione sanitaria, grado di
istruzione, alfabetizzazione e professionalizzazione, e così via. Documenti che
restavano negli archivi del centro migranti di Ellis Island. All'arrivo veniva
fatto uno scrupoloso controllo dei documenti e dello stato sanitario e, se
necessario, veniva assegnata la quarantena. Chi non rispettava le rigide regole
d'ingresso o aveva problemi di salute importanti veniva imbarcato sulla stessa
nave con la quale era arrivato. Gli altri potevano proseguire, imbarcandosi su
un traghetto per Manhattan e iniziando la loro vita in America.
Come si può anche solo
azzardare il paragone con le migrazioni di oggi. E, infatti, gli stessi utenti
che commentano il post della Ong si ribellano a questa narrazione. "Gli Stati
Uniti chiedevano espressamente manodopera e i migranti dovevano presentarsi con
tutti i documenti in regola, altrimenti li rispedivano a casa. Le donne single
non sono state accettate e rimandate a casa. La prossima volta studia un po' di
storia", scrive un utente. E poi, ancora: "Che paragone stupido! Gli italiani,
come gli spagnoli e tutti i popoli europei emigrati negli Stati Uniti nel XX
secolo, lo hanno fatto con i relativi documenti, altrimenti li avrebbero
rispediti da Ellis Island con il primo piroscafo". E così via, in un susseguirsi
di inviti a studiare la storia ma anche a fare rotta verso la Spagna, visto che
la loro nave che raccoglie i migranti batte bandiera iberica. Ma nessuna replica
è arrivata dalla Ong.
Eroi.
Il coraggio di Fabrizio
Quattrocchi e la lezione che ricorda all'Italia. Storia di Davide
Bartoccini su Il Giornale il 14 aprile 2023.
"Vi faccio vedere come muore un
italiano", poi l'esplosione di tre colpi di pistola, sparati alla schiena. "Era
nemico di Allah", chiosa un uomo senza volto e senza nome. Sono parole rimaste
scolpite nel deserto quelle di Fabrizio Quattrocchi, operatore di sicurezza
privata - o contractor per chi preferisce gli anglicismi - giustiziato mentre in
ginocchio, con le mani legate, di fronte alla videocamera del boia il 14 di
aprile del 2004, in Iraq.
A diciannove anni dalla sua
morte, il ricordo della premier Giorgia Meloni risveglia la coscienza di una
Nazione incapace - nel bene come nel male - di restare impassibile di fronte
all'orgoglio e al coraggio di un italiano. Perché questo era Quattrocchi, prima
d'essere una vittima, un ostaggio rapito a Baghdad con i suoi colleghi, un
operatore di sicurezza alle dipendenze di una società con sede in Nevada, Stati
Uniti, con una carriera militare relativamente anonima nelle forze armate: aveva
prestato servizio nell'Esercito Italiano, inquadrato nel Battaglione "Como" come
istruttore di fanteria.
”Un uomo coraggioso che ha
mostrato ai suoi carnefici e al mondo l’orgoglio di essere italiani”, ha scritto
la premier sui social, mentre la stampa ricorda quando Franco Frattini, allora
ministro degli Esteri, raccontò al mondo come era andata quel giorno, come era
si era svolta l'ignobile esecuzione: "Quando gli assassini gli stavano puntando
la pistola contro, questo ragazzo ha cercato di togliersi il cappuccio e ha
gridato: adesso vi faccio vedere come muore un italiano. E lo hanno ucciso. È
morto così: da coraggioso".
Un coraggio differente da
quello che viene celebrato oggi dalla stampa e dalle televisioni, senza dubbio.
Un coraggio da guerriero che non piace a una parte dell'opinione pubblica,
spesso critica al cospetto di quegli uomini che scelgono il "mestiere" delle
armi, ma facilmente "resettabile" dal cortocircuito indotto dai fanatismi che ha
innescato l'enfasi per la resistenza ucraina e gli eroi che si sono scoperti
tali: uomini e donne che nel momento del massimo sacrificio trovano la forza e
il coraggio di non abbandonarsi alla paura. Gente tutta d'un pezzo, come
Fabrizio Quattrocchi.
Che fosse "lì per soldi", da
"mercenario", e non combattesse in nome di un qualche dio, come i suoi carnefici
delle Falangi Verdi di Maometto, ad alcuni importò poco e importa poco ancora
oggi. Perché era quello il mestiere che aveva scelto per se; in libera scelta e
col coraggio che anche a posteriori molti audaci opinionisti e detrattori del
tempo, che si rinvigoriscono proprio oggi per fare fronda d'opposizione, non
hanno dovuto mostrare mai. Istigando una rabbia che alle volte si fatica a
trattenere quando si ricorda che il corpo di Quattrocchi, allora trentaseienne,
venne abbandonato nel luogo scelto per l'esecuzione.
Ritrovato solo il 21 di maggio,
era stato offeso dalla fame degli animali che avevano avuto a disposizione quel
corpo per oltre un mese; e a leggere certi commenti sui social,
nell'anniversario di tale ricordo, altro non viene in mente che il celebre
adagio sempre utile a ricordare come sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani,
lasciando immutato lo stato dei leoni, che al cospetto dei cani rimangono tali.
Quattrocchi venne insignito
postumo della Medaglia d'oro al valor civile dal Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi poiché: "Vittima di un brutale atto terroristico rivolto
contro l'Italia, con eccezionale coraggio ed esemplare amor di Patria,
affrontava la barbara esecuzione, tenendo alto il prestigio e l'onore del suo
Paese". Parole che a leggerle ancora oggi impongono commozione. E chi non la
prova, forse ha dei problemi, ma non con l'Italia e il patrio amore, con il
senso d'umanità.
Divisi.
Antonio Giangrande: Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo con la discultura e la
disinformazione. Ci si deve chiedere: perchè a scuola ci hanno fatto credere
con i libri di testo che Garibaldi era un eroe ed i piemontesi dei salvatori;
perché i media coltivano il luogo comune di un sud Italia cafone ed ignorante;
perché la prima cosa che insegnano a scuola è la canzone “bella ciao”? Per poi
scoprire da adulti e solo tramite il web: che il Sud Italia è stato depredato a
causa proprio di Garibaldi a vantaggio dei Piemontesi; che solo i turisti che
scendono a frotte nel meridione d’Italia scoprono quanto ci sia tanto da
conoscere ed apprezzare, oltre che da amare; che “Bella ciao” è solo l’inno di
una parte della politica italiana che in nome di una ideologia prima tradì
l’Italia e poi, con l’aiuto degli americani, vinse la guerra civile infierendo
sui vinti, sottomettendoli, con le sue leggi, ad un regime illiberale e
clericale.
Facebook. Da Museo Di Emozioni Napoli: Tifoso del
Napoli (con la maglia N.10) avvicina Gasperini e gli dici “forza Napoli”... a
quel punto interviene uno dello staff dandogli del “Terrone del Cazzo”
Non male direi
Antonio Giangrande: Inglesi e padani. Quello
che sono e quello che appaiono.
Oggi 12 luglio 2021. All’indomani dello spettacolo
indegno del razzismo inglese contro gli italiani, ma ancor più grave, contro i
loro neri che hanno sbagliato i rigori.
I tifosi inglesi hanno dileggiato l’inno e la
bandiera italiana e picchiato gli italiani allo stadio.
I giocatori hanno rifiutato la medaglia ed i reali
hanno rifiutato di premiare gli avversari.
Gli arroganti se ne fottono se gli altri del Regno
Unito tifavano contro di loro.
Così era in tutta Europa.
Essere Razzisti significa essere coglioni (cafoni
ignoranti).
La mia constatazione: gli italiani ed in special
modo i meridionali nel ‘900 erano poveri, ignoranti e cafoni. E ci stava
sopportare le angherie.
La mia domanda è: nel 2021 cosa costringe la gente
italiana e meridionale scolarizzata ed emancipata ad essere sfruttata e votata
ad arricchire dei coglioni?
Per poi diventare come loro?
Return Home- tornate a casa. Create ricchezza nel
vostro paese. Lì, al nord o all'estero, sarete sempre dei profughi.
Hanno solo i media che li esaltano e per questo si
decantano. Ma la loro natura la si conosce quando perdono: non sanno perdere,
perché si sentono superiori. Peccato che non lo sono. Forse nel ‘900. Non nel
2021.
Ricordate: da loro si va solo per lavorare e non
per visitare. Per questo sono cattivi.
Da noi si viene (forse in troppi) per vivere bene
e conoscere la bellezza che loro non hanno. Per questo siamo buoni.
Facebook: Stato Magna Grecia - Due Sicilie
E noi... Noi che eravamo uniti fin dal 1130 come
Regno di Sicilia e che ci ritroviamo con fratelli assassini prima e parenti
serpenti ora ? Leggete la "nostra Storia" riportata qui sotto brevemente.
"Nell'anno 1130 è deciso a Melfi, nasce ad
Avellino ed è battezzato a #Palermo il Regno di Sicilia.
È considerato dagli studiosi come la prima forma
di un moderno Stato Europeo.
Il Regno di Sicilia nasceva all'insegna della
dinastia normanna degli Altavilla e comprendeva non soltanto l'isola di Sicilia,
ma anche le terre di Calabria e Puglia.
Ruggero II riunendo tutto il Meridione sotto la
sua autorità creò il terzo tra i grandi stati d'Europa.
Alla dinastia dei Normanni succede quella degli
Svevi, nel 1194 (matrimonio fra Enrico VI e Costanza d'Altavilla), rimasti sul
trono di Palermo fino al 1266.
Intorno al 1200 la popolazione della Capitale
#Palermo supera i 350.000 abitanti (alcune fonti parlano di 400.000), ed è così
la seconda città più popolata del mondo, dopo Alessandria d'Egitto.
Con Federico II (figlio di Costanza), Palermo
conobbe il suo massimo splendore.
L'imperatore del Sacro Romano Impero e Re del
Regno di Sicilia, stabilì la sua Corte a Palermo (essendo cresciuto a Palermo, è
probabile che si sentisse più Siciliano che Tedesco).
Con l'Imperatore Federico nacque la
#Scuola_Poetica_Siciliana con il primo utilizzo della forma letteraria di una
lingua romanza, il siciliano, che anticipa di almeno un secolo la Scuola
Toscana.
La dinastia degli Svevi rimane sul trono del Regno
di Sicilia fino al 1266, quando il Regno di Sicilia venne conquistato da Carlo
d'Angiò, il quale conquistato il regno, non convocò più il parlamento Siciliano.
Carlo d'Angiò voleva imporre nel Regno di Sicilia
il suo modo di governare (ed anche la sua classe dirigente), e questò lo portò
ad essere odiato dai Siciliani.
Questo porterà in breve tempo alla Guerra del
Vespro nel 1282, quando Palermo insorse contro gli Angioini, fino ad offrire il
Trono di Palermo a Pietro d'Aragona e cacciare il d'Angiò dal Regno.
Pietro d'Aragona si recò dunque in Sicilia e venne
incoronato Re del Regno di Sicilia.
L'obiettivo di Pietro d'Aragona era quello di
cacciare il d'Angiò anche dalla parte continentale del Regno di Sicilia - non
riuscendoci - così nel 1302, si arriva ad una inutile e frettolosa mediazione
del Pontefice, che attribuisce ad entrambi il titolo di Re di entrambe le
Sicilie, ed il Regno viene diviso in 2, ma non in ''Regno di Napoli'' e ''Regno
di Sicilia'' come fanno falsamente studiare nelle scuole.
Il Regno venne diviso in:
Regno di Sicilia (o Regno di Sicilia Citrafaro),
in mano alla dinastia Angioina, con Capitale a Napoli
Regno di #Trinacria (o Regno di Sicilia
Ultrafaro), in mano alla dinastia Aragonese, con Capitale a Palermo. Da quel
momento dunque si ebbero 2 Stati Siciliani.
Dopo oltre un secolo di lotte, le 2 dinastie si
estinguono ed i partiti si dissolvono, ed esattamente nel 1442 Alfonso di
Trastamara (di origine Aragonese) subentra in entrambi i Regni di Sicilia,
assumendo il titolo di ''Rex Utriusque Siciliae'' (Re di tutte e Due le
Sicilie).
Nel 1516 inizia il periodo vicereale, con Carlo V
d'Asburgo di Spagna, periodo che si concluderà nel 1700 con la morte di Carlo
II.
Il periodo Spagnolo non fu per Palermo una
dominazione, come falsamente scrivono gli scribacchini prezzolati, ma una
''federazione di Stati legati dal vincolo della comune dinastia'', i vari Stati
della federazione Spagnola - tra cui le Due Sicilie - dunque, mantenevano tanta
autonomia rispetto al potere centrale del Regno di Spagna.
Nel 1700 Carlo II muore senza eredi, e la Corona
viene ereditata dalla dinastia dei Borbone con Filippo V.
Nel 1734 Carlo III di Borbone viene incoronato
presso la Cattedrale di Palermo divenendo Re dei due Regni di Sicilia ''Rex
Utriusque Siciliae''.
Alla fine degli anni '50 del '700, Carlo III
diventa Re di Spagna, lasciando il trono delle Due Sicilie al figlio Ferdinando.
Ferdinando di Borbone, dopo il congresso di Vienna
del 1815, ristabilisce l'unità Siciliana, che era stata compromessa con le lotte
del Vespro, unificando di nuovo i 2 Regni di Sicilia sotto un'unica entità
statale, i Due Regni di Sicilia così, vengono uniti nell'unico Regno che dal
1816 avrebbe assunto il nome di ''Regno delle Due Sicilie''.
A Ferdinando I subentrano Francesco I, il re
Palermitano Ferdinando II, ed infine Francesco II di Borbone nel 1859.
Con Ferdinando II il Regno delle Due Sicilie
diventa la terza potenza economico-industriale del mondo.
Il Regno fu il primo del mondo a portare l'acqua
potabile nelle case, a costruire una nave a vapore che navigava in mare aperto e
che collegava Napoli e Palermo in sole 16 ore (pochissimo per l'epoca), il primo
Regno del mondo a conoscere la raccolta differenziata, il primo Regno del mondo
a collegare tramite un piroscafo l'Europa all'America con la tratta Palermo-New
York, ad avere un cimitero aperto a tutte le classi sociali, e tanto altro...
L'#Inghilterra temeva tantissimo l'egemonia del
Regno delle Due Sicilie, vista anche la prossima apertura del Canale di Suez che
ci sarebbe stata a breve (anni '60 dell'800).
Data la posizione vantaggiosa nel Mediterraneo del
Regno delle Due Sicilie rispetto all'Inghilterra, spinse questi ultimi ad
iniziare a progettare lo smantellamento del nostro Stato, per crearne uno
fantoccio.
Dopo la morte di Ferdinando II di Borbone, ed il
passaggio del Trono al giovanissimo Francesco II, le grandi massonerie
internazionali fecero di tutto per sfruttare questo momento di debolezza, con la
falsa intenzione di una ''unità d'italia'' aggredirono il nostro stato senza una
dichiarazione di guerra.
I plebisciti di annessione sono stati #fasulli a
prova di storia, si votava pubblicamente, ed erano presieduti dai Garibaldini (i
quali avevano addirittura il diritto di votare anche più volte nello stesso
seggio) ---> dunque vi lascio immaginare la sorte che spettava a chi votava il
''NO'' all'unità d'italia (fucilazione per direttissima e senza processo).
Tutte le industrie del Regno furono smantellate e
trasferite nei territori del nord, affidando il controllo dei territori ai
''picciotti'', i quali furono istituzionalizzati nel 1861 per lasciare il
territorio povero, ignorante, e senza possibilità di emergere.
Le Due Sicilie dovevano essere #sottomesse,
dovevano diventare una colonia interna, un mercato che quindi non produceva, ma
che doveva solo acquistare i prodotti che prima producevamo noi a casa nostra,
che adesso producevano a Milano, Torino, Biella ecc ecc... (Ancora oggi perdura
questa situazione).
Dal 1861 in poi l'italia aumentò notevolmente la
tassazione degli stati conquistati, costringendoli a tenere le
#scuole_chiuse_per_oltre_14_anni, dando vita dunque, ad
#intere_generazioni_di_ignoranti_senza_memoria_per_la_propria_millenaria_cultura.
Si sviluppò il fenomeno della Resistenza (che la
storia infame ufficiale vorrebbe spacciarci per ''#brigantaggio'') contro il
nuovo stato colonizzatore ed usurpatore.
La resistenza durò oltre 15 anni.
I soldati italiani, adottarono misure spaventose
contro i Siciliani contrari all'unità d'italia, con #fucilazioni_di_massa (anche
di #bambini), deportazione nei campi di concentramento (Fenestrelle, San
Maurizio ecc ecc...).
Nei lager italiani, i corpi dei Siciliani venivano
sciolti nella calce viva per non lasciar tracce dei misfatti compiuti, su altri
invece venivano fatti esperimenti finanziati dai Savoia, perchè secondo il nuovo
stato i Siciliani avevano una conformazione genetica che li portasse a
delinquere (la discriminazione verso i Siciliani parte da lì).
Sempre dal 1861 inizia l'emigrazione di massa, che
continua ancora oggi, perchè le Due Sicilie erano diventate terre povere e non
più produttive come fino all'anno precedente.
Dal 1861 al 2015 sono fuggiti dall'antico Regno
delle Due Sicilie, più di 32 milioni di persone.
Dalla caduta del Regno delle Due Sicilie ad oggi,
abbiamo solo 160 anni di #questione_meridionale.
Fonte:Palermo a 360 gradi.
Da Gianluca Castriciano ricevo quanto segue e per
onestà intellettuale sono obbligata a pubblicare, per quanto sotto molti
aspetti, ricalca posizioni giacobine e controverse, sotto molti aspetti sono
descrizioni verosimili che meritano altri approfondimenti:
"Ma in pratica nel tuo Racconto hai Cancellato il
Regno di Sicilia , che nasce nel 1129 si ma che finisce nel 1816, la Sicilia
aveva in comune con il Regno di Napoli solo il sovrano, ( dalla struttura
politico amministrativa alla moneta separati )erano regni separati in tutto,solo
i Borbone ha avuto l'ardire di chiudere il Parlamento Siciliano, dopo che la
Sicilia si era dotata di una Costituzione rivoluzionaria per i tempi ,quella del
1812 con la suddivisione dei poteri. Non hai citato le Rivoluzioni
antiborboniche per l'indipendenza della Sicilia, la Sicilia nel 1848-49 torno ad
essere uno Stato Indipendente dopo la Rivoluzione Siciliana dotandosi di una
Costituzione dove all' art.2 dice la Sicilia sarà sempre stato Indipendente).
Non menzioni che dopo la Seconda Guerra mondiale e dopo la Rivoluzione
Separatista Siciliana, la Sicilia nel 1946 ha ottenuto lo Statuto Autonomo che
nasce prima della Costituzione, con la Regione Siciliana ( non Sicilia) che
nasce prima della Repubblica Italiana e da essa riconosciuta.
Mi limito ma credo di rendere l'idea, distorcere
la storia per piegarla al proprio interesse politico non è ne più ne meno che
quello che fecero già dal 1816 i Borbonici e dopo i Savoiardi... "
Patrizia Stabile
Facebook. Da I Briganti. IL SUD ERA AGRICOLO IL
NORD INDUSTRIALE cit.
Le regioni più industrializzate d’ Italia, prima
del 1860, erano la Campania, la Calabria e la Puglia: per i livelli di
industrializzazione le Due Sicilie si collocavano ai primi posti in Europa.
In Calabria erano famose le acciaierie di
Mongiana, con due altiforni per la ghisa, due forni Wilkinson per il ferro e sei
raffinerie, occupava 2.500 operai.
L’industria decentrata della seta occupava oltre
3.000 persone.
La piu’ grande fabbrica metalmeccanica del Regno
era quella di Pietrarsa, (fra Napoli e Portici), con oltre 1200 addetti: un
record per l’Italia di allora.
Dietro Pietrarsa c’era l’Ansaldo di Genova, con
400 operai.
Lo stabilimento napoletano produceva macchine a
vapore, locomotive, motori navali, precedendo di 44 anni la Breda e la Fiat.
A Castellammare di Stabia, dalla fine del XVIII
secolo, operavano i cantieri navali più importanti e tecnologicamente avanzati
d’Italia.
In questo cantiere fu allestita la prima nave a
vapore, il Real Ferdinando, 4 anni prima della prima nave a vapore inglese.
Da Castellammare di uscirono la prima nave a elica
d’ Italia e la prima nave in ferro. La tecnologia era entrata anche in
agricoltura, dove per la produzione dell’olio in Puglia erano usati impianti
meccanici che accrebbero fortemente la produzione.
L’ Abruzzo era importante per le cartiere (forti
anche quelle del Basso Lazio e della Penisola Amalfitana), la fabbricazione
delle lame e le industrie tessili.
La Sicilia esportava zolfo, preziosissimo allora,
specie nella provincia di Caltanissetta, all’ epoca una delle città più ricche e
industrializzate d’ Italia. In Sicilia c’erano porti commerciali da cui
partivano navi per tutto il mondo, Stati Uniti ed Americhe specialmente.
Importante, infine era l’ industria chimica della Sicilia che produceva tutti i
componenti e i materiali sintetici conosciuti allora, acidi, vernici, vetro.
Puglia e Basilicata erano importanti per i
lanifici e le industrie tessili, molte delle quali gia’ motorizzate. La
tecnologia era entrata anche in agricoltura, dove per la produzione dell’olio in
Puglia erano usati impianti meccanici che accrebbero fortemente la produzione.
Le macchine agricole pugliesi erano considerate
fra le migliori d’Europa. La Borsa più importante del regno era, infine, quella
di Bari.
Una volta occupate le Due Sicilie, il governo di
Torino iniziò lo smantellamento "cinico e sistematico" del tessuto industriale
di quelle che erano divenute le “province meridionali”. Pietrarsa (dove nel 1862
i bersaglieri compirono un sanguinoso eccidio di operai per difendere le pretese
del padrone privato cui fu affidata la fabbrica) fu condannata a un
inarrestabile declino.
Nei cantieri di Castellammare furono licenziati in
tronco 400 operai.
Le acciaierie di Mongiana furono rapidamente
chiuse, mentre la Ferdinandea di Stilo (con ben 5000 ettari di boschi
circostanti) fu venduta per pochi soldi a un "colonnello garibaldino", giunto in
Calabria al seguito dei “liberatori”.
Franco Anelli
Facebook. Da Celtic Bard Jeff. Storia
celtica in Europa
I Celti emersero nella storia nel millennio prima
della nascita di Cristo, quando iniziarono a diffondersi dalle loro patrie
dell'Europa centrale verso la Turchia e la Grecia, ad ovest verso Germania,
Francia, Gran Bretagna e Irlanda, e a sud in Italia e Spagna. Erano un popolo
vigoroso e bellico, abile nella lavorazione dei metalli e nell'equitazione e
desideroso di commerciare. Avevano un caratteristico stile artistico
curvilineare che usavano sia sulle armi che sugli oggetti di ornamento
personale. Ricche tombe trovate nelle loro terre d'origine in Austria e Svizzera
mostrano che questa era una società sofisticata con forti legami con il mondo
classico.
Dal IV secolo a.C. i Celti dominavano il nord
Europa. I Romani sfidarono la loro espansione e invasero sia la Gallia (Francia)
che la Gran Bretagna per piantare le proprie colonie. Secondo Giulio Cesare i
Galli erano un popolo vitale e infantile a cui piacevano vestiti colorati e
molto da bere, ed erano coraggiosi e spericolati in battaglia, li ammetteva in
certi modi, ma li considerava comunque dei barbari la cui civiltà era molto
inferiore alla sua. I Celti combatterono di nuovo amaramente i Romani, comprese
diverse battaglie in cui erano guidati dalla regina guerriera, Boudicca. Ci fu
un'ultima battaglia eroica ad Anglesey, ma i Celti alla fine persero e dovettero
accettare la colonizzazione romana delle loro terre.
Tuttavia, i Romani furono graziosi nella vittoria,
rispettando le tradizioni culturali celtiche. Molti di questi sopravvissero in
varie forme fino all'arrivo di ondate di nuovi invasori - angoli, sassoni, juti,
vichinghi - e li soppresse più brutalmente. Alcuni popoli celtici furono
assorbiti dalla cultura degli invasori, alcuni fuggirono verso ovest in Galles e
Cornovaglia. I romani non hanno mai conquistato l'Irlanda, quindi la cultura
celtica è rimasta pura fino all'arrivo dei vichinghi verso la fine dell'VIII
secolo. Di conseguenza, la letteratura irlandese antica è una delle più ricche
fonti di informazione sui Celti.
Oggigiorno, persone di origine celtica si sono
diffuse in tutto il mondo, in particolare in Nord America, Australia e Nuova
Zelanda. A volte la loro cultura sopravvive in una forma straordinariamente
pura: ci sono comunità di lingua gaelica in Nuova Scozia in Canada e gallesi in
Argentina. I celtici sono e la musica si godono di un rinascimento spettacolare,
mentre la gente comincia a riconoscere che rappresentano una parte vitale
dell'antica tradizione nativa europea.
La riflessione. Cacicchismo, limite al
cambiamento: la lezione di Francesco Saverio Nitti. Stefano Caldoro su Il
Riformista il 28 Luglio 2023
I l cacicchismo è la diretta conseguenza dei
limiti – potremmo parlare anche di fallimento – del regionalismo
nostrano. Francesco Saverio Nitti, nel corso dei lavori della commissione, che
alla Costituente, aveva il compito di redigere il titolo V, esprimendo la sua
contrarietà alla nascita delle Regioni, ebbe a dire: “Nelle Regioni voi creerete
Parlamenti per ridere e Ministeri embrionali. Se volete piccoli Parlamenti,
dovete avere anche piccoli Ministeri e prima o dopo i capi delle Regioni si
considereranno veri Ministri e dovranno anche essere pagati. Non vi viene il
dubbio che non avete i mezzi?” E ancora definì i nuovi Enti “piccoli Stati più o
meno seri, più o meno efficienti, più o meno inutili ma certamente costosi. Lo
Stato dovrà pagare ciò che gli Enti non possono e lo Stato si avvia a non poter
pagare. Quale sarà la finanza dell’ordinamento regionale?” Tranchant, ma
profetico.
Quello che fu scritto e votato nel 1948 in
Costituzione si è realizzato solo nel 1970 con la nascita delle Regioni.
Trentadue anni dopo! Questo fa capire come quel progetto regionalista avesse dei
seri problemi. Federalismo mancato, decentramento confuso. Ai costituenti non si
può rimproverare nulla. Fecero tutto il possibile per mettere dei paletti, ma la
spinta al decentramento fu una esigenza più politica, per cancellare la
‘centralista’ dittatura fascista, che funzionale ai destini del Paese.
L’evoluzione del regionalismo non ha portato miglioramenti e oggi ci ritroviamo
al bivio, dovendo decidere sull’Autonomia differenziata. Maggiori e più poteri
alle Regioni senza però avere sciolto preventivamente il nodo della
responsabilità e del buon funzionamento dell’intero sistema delle Autonomie.
Le Province entrano ed escono, i Comuni diventano
metropolitani. Sia ben chiaro la riforma è necessaria e urgente ma deve essere
completa e unitaria, non a pezzi. Il percorso di riforma dovrà, però, fare i
conti con il sistema dei poteri che si è consolidato attorno al modello
gestionale delle Regioni. Dal Nord al Sud, anche se con risultati diversi. I
numeri della finanza pubblica decentrata fanno venire i brividi. Un sistema che
si è cementato attorno a quelli che Nitti definiva “i nuovi piccoli Capi di
Stato alla guida dei nuovi Enti Regionali”. I Cacicchi appunto. Non tutti lo
sono o lo sono stati, ma la tendenza è quella. Quella che nel linguaggio della
politica è sotto il nome di cacicchismo. Un esercizio del potere su base locale,
personalistico, orientato ad avere, nell’area ristretta di controllo politico e
gestionale, tutto il possibile. In una maniera o nell’altra tutti i Presidenti
delle Regioni vogliono attribuite maggiori competenze e materie. Lo scontro è
sul come e dove le risorse verranno destinate.
È una questione di soldi, meno di cambiamento e
modernizzazione. Sarebbe prioritario, invece, introdurre il concetto di governo
delle funzioni e di programmazione anche economica, prima ancora dei Lep e
fabbisogni standard. Di questo nessuno se ne occupa e i rigidi perimetri
amministrativi delle attuali Regioni sono sempre più un limite al buon governo.
Il ciclo integrato delle acque, il ciclo dei rifiuti, i porti e la logistica, le
reti sanitarie e la mobilità hanno bisogno di nuove aree geografiche più ampie,
diverse e più idonee, di nuovi modelli di governo più focalizzati ed efficienti.
Forse anche di nuovi ‘Organi comuni’ così come recita l’ottavo comma
dell’articolo 117 della Costituzione. Una nuova macro area di funzione sul
modello delle macroregioni europee. Un comma di un articolo che, se
efficacemente applicato, genererebbe effetti rivoluzionari.
Al contrario, la strenua difesa degli angusti
perimetri amministrativi è la strada per garantire una lunga vita al
cacicchismo. La gestione e il controllo del potere locale piuttosto che
risolvere i problemi del Paese. Al Governo e ai “piccoli capi di stato” più
lungimiranti, il compito di capovolgere questa vecchia e cattiva prassi.
Stefano Caldoro
Sinistra, amnesie storiche: quando il Partito
comunista invocava l'Autonomia. Francesco Carella su Il Riformista il 27
giugno 2023
Tra le tante costanti della vita politica del
nostro Paese ve n’è una che affonda le radici addirittura nell’epoca
preunitaria. Infatti, la riflessione sui rapporti fra lo Stato centrale e il
sistema delle autonomie locali è al centro del dibattito fin dal 1851, quando
Carlo Cattaneo scrisse che «il federalismo è l’unica via della libertà». Il
teorico degli “Stati Uniti d’Italia” ha influito non poco sulla formazione della
nostra classe politica dall’Unità ai giorni nostri. In tal senso, si può dire
che vi è un lungo filo che parte da Luigi Carlo Farini, esponente di spicco
della Destra storica, e raggiunge Roberto Calderoli, padre del Disegno di legge
sull’autonomia differenziata.
Il ministro Farini nell’agosto 1860, dopo avere
ricevuto l’imprimatur di Cavour, propose di conciliare «l’autorità centrale
dello Stato con le necessità dei comuni, delle province e dei centri più vasti».
Se, però, per il progetto Farini e subito dopo con quello del suo successore
all’Interno Marco Minghetti gli ostacoli che ne impedirono la realizzazione
avevano un fondamento storico rilevante (la fragilità di uno Stato giovane e la
spinta disgregatrice lanciata nel Mezzogiorno dal brigantaggio) per ciò che
riguarda la riforma del ministro Calderoli le ragioni sembrano meno nobili e più
legate a un approccio demagogico da parte di una sinistra che ha dimenticato la
sua stessa storia. Vale la pena di ricordare a Elly Schlein che la questione
dell’autonomia era già al centro dell’attenzione di Palmiro Togliatti ed è
sempre stata presente nel dibattito politico interno al Partito comunista. Del
resto, già nel lontano 6 novembre 1975 in un’intervista a “La Stampa” il
presidente della regione Emilia Romagna Guido Fanti individuava nella «forma
decentrata dello Stato l’unica possibilità per il Paese di uscire dalla crisi
che stava attraversando».
Egli propose di lavorare attorno a un «progetto di
aggregazione tra le cinque regioni della Valle Padana che avrebbero dovuto avere
un ruolo fondamentale in una politica di programmazione regionale e
nazionale». Un altro leader di primo piano del Pci, Renato Zangheri, nel corso
di un dibattito parlamentare sulle riforme istituzionali nel maggio 1988,
afferma che «il Pci auspica un energico decentramento legislativo con una reale
rivitalizzazione degli organismi locali per mezzo di una concreta autonomia
finanziaria e impositiva». Lo spartito non muta con il Pds. Il 12 dicembre 1994,
in assemblea, il segretario Massimo D’Alema presenta «il federalismo come
l’unico strumento in grado di realizzare una nuova unità del Paese». A rileggere
le polemiche delle ultime settimane vengono in mente le parole del
meridionalista Guido Dorso: «Occorre augurarsi che non ci siano più cervelli che
concepiscano l’unità nazionale, sacra ed inviolabile per tutti gli italiani,
come mezzo per continuare con lo sgoverno attuale». Quei cervelli sono ancora in
mezzo a noi pronti a fare danni.
Storie Romane: Le regioni dell'Italia Augustea.
Augusto riformò l'amministrazione dell'Italia, dividendola in undici regioni.
Alcune ricalcano quelle attuali, altre come quelle Appenniniche e del
Settentrione, più sconvolte dalle invasioni barbariche, meno. L'unica regione
che ha preso un nome non romano è la Lombardia, il cui nome viene dai
Longobardi. Inoltre Sicilia, Sardegna e Corsica formavano delle province
sottomesse, che però nella riforma di Diocleziano vennero accorpate all'Italia.
Non di sole orecchiette può
vivere la Puglia di domani. «Vogliamo trasformare quel che resta di un mondo
arcaico e autentico in un resort di lusso? Una comunità, cioè la nostra vita
quotidiana, in un marchio commerciale? La Puglia come merchandising a botte di
post degli influencer?» OSCAR IARUSSI Su La Gazzetta del Mezzogiorno il 25
giugno 2023.
La salentina adottiva Helen
Mirren è senza dubbio una delle più importanti attrici del mondo, da ultimo si
sta spendendo meritevolmente in favore degli ulivi e appena può elogia la Puglia
come vacanza dello spirito. Chiara Ferragni, in questi giorni ospite di una
delle lussuose masserie pugliesi, è fra le più abili giovani imprenditrici
italiane e non ha perso l’occasione di esaltare sui social la bontà della nostra
gastronomia: «Dreaming of focaccia e orecchiette» e ancora «Focaccia pugliese
patrimonio dell’umanità?». Del resto, le orecchiette sono il piatto più buono
dell’emisfero nord del globo terracqueo. Ma se non vi sedete a tavola, allora
vince la focaccia. Insomma, Puglia da dire, bere, fare baciare lettera
testamento. Puglia tutta la vita e gracias a la vida: non v’è certo bisogno di
convincere chicchessia della bellezza del vivere qui.
Ciò detto, basta. Per favore,
basta. Una volta l’anno lasciatecelo almeno scrivere, tanto poi non cambia
alcunché... «Vogliamo trasformare quel che resta di un mondo arcaico e autentico
in un resort di lusso? Una comunità, cioè la nostra vita quotidiana, in un
marchio commerciale? La Puglia come merchandising a botte di post
degli influencer?» (La Gazzetta del Mezzogiorno, 26 giugno 2022).
Un’estate dopo, le domande
restano le stesse. L’innegabile successo turistico della regione, frutto anche
di un sapiente sostegno politico-istituzionale, lascia sul campo o all’orizzonte
alcune contraddizioni di base e di lungo respiro. Ignorarle non giova, perché
nello scenario internazionale la competizione si gioca innanzitutto sulle
immagini e le identità dei territori in lizza. Che cosa vogliamo essere o
diventare, bisogna pur deciderlo, senza lasciare che a connotarci siano di volta
in volta divi e dive che non hanno il dovere di andare oltre il pittoresco. Noi
sì, però. E sospettiamo che restare abbarbicati alla sola tradizione, ovvero
alla macchietta della Puglia che fu, non sia proprio il massimo.
Avete mai visto qualcuno
andare, che so, a Londra o a Porto e magnificare su Instagram i fish and chips o
la Francesinha lusitana (pesantissima a dispetto del diminutivo)? Macché, si
sbandierano piuttosto l’ultimo museo inaugurato, il rivoluzionario intervento
urbanistico o il campus universitario affollato di studenti Erasmus. Bilbao è
rinata venticinque anni fa grazie al Guggenheim Museum. Milano «vicina
all’Europa» punta più sulla Fondazione Prada o su piazza Gae Aulenti che sulla
cotoletta alla milanese. A Parigi si torna una volta di più per scoprire il
Museo Yves Saint-Laurent e persino l’abulia romana, tra i gabbiani onnivori e
la monnezza, riserva le belle sorprese in mostra al MAXXI, non solo il carciofo
alla giudia. E perché mai, invece, qui saremmo condannati alla perennità
dell’orecchietta? Tanto più che non v’è ristorantino pugliese in auge che non
abbia fatto della cucina fusion un tratto caratteristico.
La pallida imitazione del
passato, l’orgoglio della regressione, l’eterno ritorno del panzerotto
(Nietzsche a Nderr La’ Lanz) sono spesso avallati da chi amministra e – mea
culpa – dai giornali. Una coazione/colazione a ripetere cui non è facile
sottrarsi, nonostante il gran lavoro degli ultimi decenni per illuminare sugli
schermi una Puglia diversa: nodo della globalizzazione e frontiera del domani
per ambiente, energia, lavoro, accoglienza, ricerca. Merito di artisti come
Amelio, Olmi, Rubini, Winspeare, Piva etc.
Al dunque a rimetterci è il
nostro futuro, lo stesso da cui continuano a fuggire i giovani meridionali. È un
nuovo esodo epocale di talenti e di risorse, che per la prima volta non produce
rimesse verso le regioni di provenienza, mentre alimenta la desertificazione di
ampie aree del Sud. Viva la focaccia, quindi, e il polpo, i ciceri e tria, il
pancotto, la giuncata e chi più ne ha, più ne mangi. Ma davvero siamo paghi del
destino da «casa dei giochi» e vacanza esclusiva altrui, tra l’altro con i
prezzi impazziti anche per noi? No, non può essere.
L'idea miserabile di un Sud
destinato a vivere di pizzica e di cozze. CAMILLO LANGONE su Il Fogio il 30
giugno 2023.
Altro che Matera, meglio andare
a Potenza che è l’anti-topos, il fuori-standard. Con due simboli su tutti: il
Teatro Francesco Stabile (1881) e il Viadotto dell’Industria (1975). Monumenti
che simboleggiano la borghesia e appunto l’industria
Tutti vanno al Sud e tutti
vanno in quel Sud che sembra proprio Sud, nel Sud stereotipato, il Sud fatto di
mare, sole, arsura, di templi greci e scavi romani, di trulli e masserie, di
scenografie rupestri (Matera). Insomma il Sud prostituito al turismo. Io vado a
Potenza che è l’anti-topos, il fuori-standard. Per il VII Festival delle Città
Identitarie vado nella “più nordica delle città del Sud” (come scrisse Giancarlo
Tramutoli) che non ha una generica identità meridionale ma un’identità lucana.
Ancor meglio: un’identità potentina. Tanto per cominciare niente mare: montagna.
E dunque niente bagnanti. E dunque niente pesce: podolica (razza bovina
dell’Appennino). E dunque niente caldo: neve d’inverno, fresco d’estate. Niente
trulli: palazzoni. Niente di greco, poco di romano e, importantissimo, nulla di
materano. Con due simboli su tutti: il Teatro Francesco Stabile (1881) e il
Viadotto dell’Industria (1975). Due monumenti mirabili che simboleggiano la
borghesia e appunto l’industria. Due antidoti all’idea miserabile di un Sud
destinato a vivere di pizzica e di cozze.
La vergogna di Matera erano i Sassi, ora è il
turismo. CAMILLO LANGONE su Il Fogio il 17 agosto 2021.
Indifferenza a tutti i valori, nichilismo,
profanazione e prostituzione. La città pullula di turisti che fotografano e
mangiano soddisfattissimi. Cavernicoli temporanei, con tutti i comfort e senza
un senso.
Mi piace essere figlio di lucani antichi, essere
cresciuto con una nonna analfabeta che mi ha messo in contatto con la vera
conoscenza, a Potenza dopo il boom e però fra consuetudini arcaiche (con le
galline uccise in casa, per dire, con le volpi nel sugo, per dire ancora
meglio)… Mi piace parlare col mio vecchio padre che si scandalizza per i prezzi
degli alberghi di Matera: “Era la vergogna della Lucania!”. Io ho sempre
dubitato dell’appartenenza di Matera alla Lucania, la direi semmai Basilicata,
comunque che fosse una vergogna, per via dei Sassi dove fino al 1952 i cristiani
vivevano insieme alle bestie in abituri senza luce, al contempo case, grotte e
stalle, lo sapevo.
Ma credo che, dell’unica regione italiana con due
nomi, Matera sia una vergogna ancora oggi. Ovviamente per un motivo diverso: il
turismo. Che è “indifferente a tutti i valori” (Ludwig Giesz) e dunque è
nichilismo. Che è profanazione e prostituzione. Matera pullula di turisti che
fotografano e mangiano soddisfattissimi (gli italiani pensano solo a mangiare e
li capisco pure, quello gli è rimasto), dentro un teschio di città, presepe
senza Bambino né bambini: cavernicoli temporanei, con tutti i comfort e senza un
senso… Come mi piace essere figlio di lucani antichi e guardare Matera dall’alto
in basso (Potenza la sovrasta di 418 metri).
Camillo Langone. Vive a Parma.
Scrive sui giornali e pubblica libri: l'ultimo è "Eccellenti pittori. Gli
artisti italiani di oggi da conoscere, ammirare e collezionare" (Marsilio).
Antonio Giangrande: Quelli che…o tutti o
nessuno e poi vogliono la secessione!
Lo sproloquio del saggista e sociologo storico
Antonio Giangrande. Da far riflettere…
2 e 3 giugno: Si festeggiano il giorno della
Repubblica ed il giorno della libera circolazione tra regioni.
Il tutto sotto diktat della Padania.
I Padani hanno voluto l’Unità d’Italia per
depauperare l’Italia meridionale.
I Padani comunisti hanno voluto la Repubblica per
continuare a saccheggiare l’Italia Meridionale.
I Padani con le sedi legali delle loro aziende nei
paradisi fiscali vogliono continuare a dettar legge con la scusa della
secessione.
L’Italia divisa in due.
Napoli è la capitale ma non
è il Sud. Storia di Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera il 15 marzo
2023.
Caro Aldo, si parla spesso di
Napoli. Da secoli. Anche di recente, e su queste colonne. Tra i tanti dibattiti
che stimola c’è quello sulla capitale del Sud. Ossia, se possa rappresentare
tutto il Mezzogiorno. O meno. Io dico che esistono almeno due caratteristiche
sociali rilevanti che trovi in città; come in tutto il Sud. Mi riferisco al
senso di sfiducia collettivo (nisciun ccrer à nat, diceva in dialetto il grande
Pasquale Squitieri), piuttosto che alle grandi contraddizioni. L’ammiraglio
Francesco Caracciolo fu impiccato all’albero maestro della sua nave, salvo poi
intitolargli la strada più bella della città! Non trova che questi due elementi
sociali siano sufficienti? Salvo Iavarone
Caro Salvo, Napoli fa sempre
discutere, amata detestata invidiata com’è. E a volte si fa confusione.
All’estero pensano l’Italia come un’immensa Napoli, il mare il sole la pizza; a
noi piace pensare anche al teatro di Eduardo e di Servillo, al cinema di Totò e
di Sorrentino, alla musica di E.A. Mario, di Caruso e di Pino Daniele, a tutto
quanto fa di Napoli la capitale della cultura materiale italiana. Noi stessi
però tendiamo a far coincidere Napoli con il Sud. Che sono in realtà due cose
molto diverse. Napoli è la capitale del Sud; ma non è il Sud. È una metropoli in
pieno boom turistico, epicentro di un’area conosciuta in tutto il mondo che
comprende luoghi di commovente bellezza come Amalfi, Positano, Sorrento, Capri,
Ischia, Procida, Pozzuoli, Pompei. È una citta ben collegata, con un aeroporto
internazionale e l’alta velocità ferroviaria. Nel suo porto sono ancorate le
navi di crociera più grandi al mondo e la Sesta flotta americana. Ha una piccola
e media imprenditoria dinamica che va dall’agroalimentare alla moda (si pensi a
Kiton o a Marinella). E ha in periferia zone di degrado né più né meno delle
altre grandi città europee. Quest’anno tutto lascia credere che vincerà lo
scudetto, sia pure con una società che il Napolista — uno dei migliori siti
italiani, un’altra eccellenza della città come Radio Kiss Kiss o come la
libreria storica di Port’Alba o come, diciamolo, il Corriere del Mezzogiorno —
ha definito poco napoletana, con un proprietario che è cresciuto e vive a Roma e
spesso si è scontrato con la tifoseria, proprio com’è accaduto all’allenatore
Spalletti. Poi c’è il Sud. Che è mal collegato al resto del Paese e dell’Europa,
che offre poche occasioni ai suoi giovani, che è in fondo alle classifiche
europee in quasi tutte le voci, dal numero dei laureati a quello degli occupati,
dalla lettura dei quotidiani a quella dei libri. Un Sud più avvezzo al lamento
che al cambiamento, che è impossibile criticare senza sentirsi definire razzista
— mentre in realtà si critica quel che si ama —, che ha giacimenti di bellezza e
cultura unici al mondo ma non è sempre all’altezza di se stesso e delle proprie
grandi potenzialità.
Come si fa a chiamarlo Giro d’Italia se ignora
quasi tutto il Mezzogiorno? PIETRO MASSIMO BUSETTA su Il Quotidiano del Sud
il 9 Maggio 2023.
Se l’alta velocità ferroviaria si ferma a Salerno
e l’autostrada del Sole a Napoli perché stranirsi se il Giro ignora il
Mezzogiorno?
Sarebbe pensabile un giro d’Italia che partisse da
Bologna e si fermasse a Palermo? Sarebbe immaginabile che la Gazzetta dello
Sport si presentasse dagli sponsor istituzionali, come Enel e Ferrovie dello
stato per esempio, con un progetto di giro che lasciasse tutto il Nord assente
dalla più grande competizione sportiva ciclistica italiana?
E perché invece nessuno si stupisce se il Giro
lascia lo stivale fuori dalla competizione? Se poco meno di un terzo della
popolazione viene privata e non viene toccata dalla gara?
D’altra parte se l’alta velocità ferroviaria si
ferma a Salerno, se l’autostrada del Sole si è fermata a Napoli perché stranirsi
se il Giro mette in vetrina solo una parte dell’Italia, quella che conta secondo
alcuni. Eppure è proprio la parte che più ha bisogno di mostrarsi che rimane
fuori. Quella che é meno conosciuta dal mondo, quella Calabria che per anni e
stata la nostra Amazzonia, abbandonata ai nativi, meglio nella quale “gli
indigeni” sono stati, lasciati in mano della criminalità organizzata, dove la
sanità è stata commissariata, lasciata nelle mani di manager improbabili, di
politici trombati provenienti dalle regioni “brave”.
E d’altra parte qualcuno potrebbe anche sostenere
che l’Italia è talmente lunga che può anche essere naturale che in qualche anno
si possa farlo passare solo da una parte e che può anche essere opportuno, per
motivi organizzativi, che ci si possa concentrare solo in una area del Paese.
Tutto logico e comprensibile. Se fosse un fatto che alternativamente riguardasse
tutti. Il fatto è che invece vi é una parte che viene sempre compresa ed una che
viene lasciata qualche volta fuori. Occasione opportuna per riflettere
sull’approccio del Paese con il suo Sud, ritenuto frontiera, spesso sconosciuto
e guardato come territorio “d’oltremare”.
Lo stesso atteggiamento che si é avuto per i
grandi eventi, che non lo toccano quasi mai, per le agenzie internazionali che
non vi vengono localizzate, parte utile per posizionare le raffinirei e
l’industria pesante, dal quale attingere capitale umano nei momenti di
espansione, e da utilizzare come mercato di consumo interno non solo per i beni
ma anche per i servizi, da quelli sanitari a quelli scolastici, se é vero che si
mortifica la sanità locale per alimentare i viaggi della speranza o si
potenziano le università, compresa quella Cattolica, per attrarre i giovani
meridionali, che sostenuti nei costi dalla società di provenienza serviranno ad
alimentare il mercato del lavoro della parte ricca, in una operazione di
sottrazione di un patrimonio finanziario e di capitale umano che ormai dura da
decenni e che ha portato all’ impoverimento non solo di alcune aree ma, in una
visione bulimica di una parte, di tutto il Paese.
E il Giro é una visione plastica di un vecchio
modello che andrebbe superato ma che invece torna prepotentemente perché é
insito in una visione provinciale della parte che conta. E nessuno si straccia
le vesti o si rifiuta di sponsorizzare una manifestazione chiamata d’Italia ma
che dovrebbe piuttosto essere individuata come il Giro di mezz’Italia o che
lascia fuori la colonia. Tale scelta sarebbe assolutamente da non commentare se
non fosse un indicatore di un approccio, che riguarda tutta la società italiana
che conta, tutte le imprese più importanti partecipate, che hanno guardato a
questa parte come residuale, per cui le Ferrovie non vi hanno investito, l’Anas
non ha fatto le manutenzioni richieste, la Rai pubblica l’ha guardato per le
cronache criminali, tanto la classe politica locale chiedeva altro alla politica
ed alla grande impresa: il posto di lavoro per l’amico, mancette per i propri
clientes, mai un Ministero delle infrastrutture ma piuttosto quello delle Poste.
Il Giro é l’occasione di una riflessione
necessaria per chi ha in mano il volante della guida del nostro Paese, che non
sono certamente i rappresentanti eletti del Mezzogiorno, che se non si muovono
secondo le logiche e gli interessi prevalenti rischiano la loro stessa
esistenza. Come si è visto in Conferenza delle Regioni, nella votazione
riguardante l’autonomia differenziata, che ha visto votare a favore i
governatori meridionali della maggioranza, per disciplina di partito, tranne poi
qualche giorno dopo andare ad Arcore a lamentarsi con il loro capo di una
normativa che sottrarrebbe ulteriori risorse. Anche quelli che rappresentano
regioni importanti come Occhiuto o Schifani.
Bisogna cambiare cappello e finalmente fare quello
che a parole si é sempre dichiarato cioè affermare e partire in ogni decisone
dalla centralità del Mezzogiorno, perché tale cambio di paradigma é l’unico che
può riportare il Paese ad essere competitivo rispetto ai partner importanti del
continente. Convincersi che i fattori che vanno sfruttati per far ripartire il
Paese si trovano tutti nel Mezzogiorno, a cominciare da una posizione logistica
nel Mediterraneo importante rimasta totalmente non utilizzata. Capire che il
nostro Western, verso il quale bisogna muovere risorse e impegno, quello che ha
tutti i fattori produttivi inutilizzati, da quelli ambientali a quelli umani a
quegli logistici, la nuova frontiera, é pronto a rappresentare il futuro di
questo nostro Paese.
La parte che può crescere a tassi da tigre
d’Oriente, che può rappresentare la soluzione alla eccessiva antropizzaione di
un Nord ormai saturo. Sembrerebbe cosi facile da capire per una società pensante
eppure le resistenze continuano ad essere enormi, anche se alcune posizioni
recenti, come quella di tutta la destra, ma in particolare della Lega, sul ponte
sullo stretto e sulle altre infrastrutture al Sud, mostrerebbero un cambio di
passo molto interessante, che fa ben sperare. Vedremo nei prossimi mesi se é
strumentale o sincero, mentre la sinistra sembra non capire l’esigenza di un
cambiamento che, se non avviene, rischia di far crollare il sistema Paese, sotto
le proprie contraddizioni, che possono essere rappresentate da una parte dove
lavora una persona su due ed un’altra dove invece ne lavora una su quattro,
compresi i sommersi. Riuscire a capire che bisogna dare al Sud una prospettiva
di sviluppo concreta, senza chiudersi dietro slogan ed ideologie, è un passaggio
che ancora la sinistra non riesce a fare. Eppure i segnali forti che sono venuti
dal Sud, compreso il successo dei Cinque Stelle, dovrebbe aver dato segnali
importanti, che sembrano non essere stati colti, se le posizioni rimangono
vecchie e stantie.
Disorganizzati.
Antonio Giangrande: Italia.
Educazione civica e disservizi.
Sosta selvaggia e raccolta
differenziata dei rifiuti.
Lo scrittore e sociologo
storico Antonio Giangrande, nel suo ultimo libro (L’Italia allo Specchio. Il DNA
degli italiani. Anno 2019. Prima parte. In vendita su Amazon in formato Book o
ebook) parla dei parcheggi e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Italia. Sosta selvaggia ed
incompetenza.
I turisti, nel mettere piede in
Italia, la prima cosa che notano è che sulla strada ognuno fa quel che gli pare.
E’ abbastanza irregolare la circolazione, ma allucinante è il comportamento di
chi si ferma con il suo veicolo. Un codice della strada fai da te, insomma.
Il fenomeno più appariscente è
la sosta selvaggia.
Ma è possibile che in Italia
ognuno parcheggia come gli pare, con il benestare dei vigili urbani e delle
amministrazioni comunali?
La trasmissione televisiva di
Mediaset, Striscia la Notizia, da sempre e stranamente si occupa solo dei
parcheggi riservati ai disabili, occupati da chi non ne ha diritto.
Addirittura, chi si ritiene il
più onesto del firmamento, cade nella tentazione della sosta selvaggia: “Multe
per doppia fila al comizio della Raggi. I grillini: è un complotto - scrive il
lunedì 23 maggio 2016 Carlo Marini su Secolo d’Italia.- Comizio di Virginia
Raggi a Roma. A Piana del Sole, periferia romana, gli slogan sono i soliti:
“Onestà, onestà”. Ma basta l’arrivo dei vigili urbani per mandare nel panico
l’aspirante sindaco M5S e i suoi sostenitori. Una voce dalla platea lancia
l’allarme: «Stanno a fa’ le multe». «Proprio adesso dovevano venì». I grillini,
che vedono “microchip sotto la pelle” e “complotti” dappertutto, non hanno
dubbi. Li palesa il deputato pentastellato al tavolo della Raggi, Stefano
Vignaroli «Cioè a Piana del Sole non si vede un vigile nemmeno…». Virginia tace
e sorride imbarazzata. Il rispetto delle regole dovrebbe valere per tutti. Anche
per chi sa solo gridare “onestà, onestà”.
Eppure in Italia è consentito
parcheggiare, ovunque, anche quando non ci sono le strisce che delimitano l’area
di sosta, e comunque, come in doppia fila. Il tutto salvo che non ci sia un
espresso divieto di legge od amministrativo e che ci sia qualcuno che lo faccia
rispettare.
Quindi, lungo la carreggiata
cittadina, anche a doppio senso di circolazione, ove l’area di sosta non è
delimitata dalle strisce bianche o blu, auto, camper e roulotte, autocarri con
rimorchio ed autoarticolati, autobus ed autosnodati possono parcheggiare come,
quando e quanto vogliono, pur se intralciano il traffico?
Per il codice della strada e
per la Corte di Cassazione: Sì. Basta che ci sia lo spazio di transito pari
almeno a 3 metri.
E per quanto riguarda la sosta
in seconda o terza fila?
Il parcheggio in doppia fila è
una pratica piuttosto diffusa, soprattutto nelle grandi città dove la carenza
cronica di parcheggi crea molti disagi soprattutto a chi ha bisogno di fare una
sosta breve, “al volo”, per fare una veloce commissione. Il nostro “5 minuti e
poi la sposto” può creare gravi problemi alle auto che risultano bloccate e che
non possono muoversi. Oltre ad intralciare la circolazione. “La lascio qui due
secondi e torno subito” pensiamo, non rendendoci conto che stiamo infrangendo
non solo il Codice della Strada, ma anche il Codice Penale, commettendo un vero
reato. Quante volte è capitato di vedere un’auto parcheggiata in doppia fila e
di augurarsi che un vigile facesse un’improvvisa comparizione per punire il
colpevole?
La sosta in doppia fila è
esplicitamente vietata dal Codice della Strada, all’articolo 158, comma 2,
lettera c, dove stabilisce, con la stessa occasione, anche la sanzione
amministrativa pecuniaria, che oscillerà tra un minimo di 41€ e un massimo di
168€ per i mezzi a quattro ruote, e tra un minimo di 24€ e un massimo di 97€ per
le due ruote a motore. L’articolo successivo (art. 159 C.P.) sancisce
addirittura la possibilità per gli agenti di Polizia di provvedere ad ordinare
la rimozione forzata, nel caso in cui la sosta vietata costituisca un pericolo o
un grave intralcio alla circolazione degli altri veicoli. La situazione può però
aggravarsi e diventare persino un reato (quindi un’infrazione del Codice
Penale), almeno secondo l’interpretazione della Cassazione. I Giudici infatti
hanno stabilito con le sentenze 24614/2005 e 32720/2014 che la sosta in doppia
fila è idonea ad integrare il reato di violenza privata, proprio a causa
dell’ostruzione dell’unica via d’uscita di un altro veicolo.
Quando la legge chiude un
occhio. Attenzione però, perché esistono delle situazioni in cui il parcheggio
in doppia fila è tollerato. Questo significa che, anche nel caso in cui
all’automobilista venga notificata la violazione dell’articolo 158, comma 2,
lett. c, del Codice della Strada, egli potrà presentare ricorso e ottenere
l’annullamento della sanzione. Ma quali sono questi casi e come individuarli
chiaramente? Come è facile immaginare, la legge non specifica i singoli casi in
cui sia possibile adottare o meno un certo comportamento, ma si limita a
definire i principi fondamentali. I quali, nello specifico, si ritrovano
nell’articolo 54 del Codice Penale, che recita: “Non è punibile chi ha commesso
il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo”.
Il caso specifico delle
eccezioni. Per passare dai principi generali all’applicazione della legge,
quand’è che la sosta in doppia fila è consentita? Si tratta di tutti quei casi
in cui si prefigurino:
Carattere d’urgenza e
imminenza;
Situazione di pericolo non
evitabile (non esistono soluzioni alternative);
Condizione di gravità della
situazione che si vuole evitare.
Ci penserà l’italica genialità
a trovare l’eccezione e la latina persuasione a porre rimedio.
Rifiuti. Affari, ma non per
tutti.
Oggetto di raccolta sono i
rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati ovvero quelli derivanti da
attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati (con
decisione del comune tramite apposita delibera) per qualità a quelli domestici.
Natura della tassa sui rifiuti.
Il presupposto della tassa è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a
qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di
smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Quindi, il presupposto
impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a
produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi. Infatti, fatta
eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l'importo da
corrispondere per questa tassa non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma alla
quantità di spazi occupati. Tali presupposti danno a questa tassa natura di
imposta anziché di tassa, il cui importo viene invece commisurato al servizio
prestato. Un altro elemento che lascia propendere verso la natura di tributo è
dato dal fatto che la Tassa non è soggetta a IVA, come lo sarebbe invece stato
qualunque tipo di servizio.
Ma come mai più si differenzia,
più si paga?
Più si conferiva il tal quale
indifferenziato, meno si pagava. Che strano ambientalismo!
Prima c’erano i cassonetti
dell’indifferenziata. Poche spese e pochi operatori ecologici. In alcune zone
scatta l’emergenza dei rifiuti, più per complotti politici e speculazioni
economiche per la gestione delle discariche.
Poi ai tradizionali cassonetti
si sono aggiunti i contenitori per carta, plastica, vetro, formando le isole
ecologiche. Più spese e più operatori ecologici, ma anche più guadagni per la
vendita del differenziato. In alcune zone aumenta l’emergenza dei rifiuti, più
per complotti politici, ma crescono le speculazioni economiche: per la gestione
delle discariche e per gli affari sul differenziato.
La politica si inventa
l’ecotassa. Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica.
Poi siamo arrivati all’oggi.
Raccolta porta a porta dei rifiuti. Distribuzione dei contenitori per il
conferimento dei vari rifiuti, divisi per specie. In alcuni paesi cinque, ad
altri solo due. I colori sono differenti da paese a paese.
Ogni bidone (utenze non
domestiche) o bidoncino (utenze domestiche) avrà il suo giorno stabilito per
essere svuotato.
L’utente ha bisogno di una
laurea. Finisce come la parodia di Ficarra e Picone nel film: l’Ora legale.
Ficarra si mangia la buccia del melone, non sapendo dove buttarla e chiede: “Voi
a Milano i tovaglioli sporchi di sugo dove li buttate?”
OGNI BIDONE UN COLORE, OGNI
COLORE UN TIPO DI SPAZZATURA, TU LI SAI?
Cerchiamo di capire quali sono
i colori più utilizzati per i bidoni della spazzatura nella raccolta
differenziata dei rifiuti, non esiste ancora uno standard, ma in linea di
massima queste sono le colorazioni più usate.
Pur non essendo ancora
ufficialmente uno standard, si può dire che per la raccolta differenziata i vari
colori dei bidoni seguono questo schema:
Bianco: Carta, cartone
(riviste, giornali e materiali cellulosici in generale)
Verde: Vetro (bottiglie,
barattoli, specchi, etc.)
Rosso o marroncino: Organico
(umido)
Giallo: Plastica riciclabile
(bottiglie di bevande, detersivi, prodotti per l’igiene, etc.)
Blu: Alluminio (lattine,
imballaggi, bombolette spray, etc.)
Va comunque detto che essendo i
comuni gli assegnatari dei vari colori in alcune zone potrebbero esserci delle
variazioni, infatti ci sono zone in cui i bidoni blu sono destinati a carta e
cartone, quelli verdi a vetro e lattine, quelli gialli alla plastica, quelli
marroni o rossi ai rifiuti non riciclabili, quelli arancioni all'indifferenziata
e quelli neri ai rifiuti organici. Ma non è finita qui, ad ogni sacco un colore,
ad ogni colore un tipo di spazzatura, secondo voi vale la stessa regola e lo
stesso abbinamento di colori che abbiamo appena visto per i bidoni?
Sempre che i bidoni rimangano
in nostro possesso in comodato d’uso, perché un nuovo sport prende piede: il
furto di bidoni e bidoncini. Le denunce presentate posso riempire centinaia di
questi bidoni. E la burocrazia anche in questi casi punisce in modo grave. Dopo
la denuncia seguono giorni di attesa e di adempimenti per la sostituzione di un
bidoncino di pochi euro di valore.
Poi bisogna combattere anche
con l’arroganza degli operatori che ti riprendono per ogni errore: smaltire un
certo tipo di rifiuti in giorni sbagliati o in orari sbagliati.
Se poi gli operatori minacciano
di sanzione in caso di errore, allora l’ansia cresce.
Intanto le utenze domestiche
diventano bombe ecologiche, con tanti contenitori sparsi per casa che non
trovano posto.
E che dire delle città e dei
paesi che sono delle vere bidonville maleodoranti, ossia strade invase da bidoni
perenni posti sui marciapiedi (da 2 a 5 per utenza non domestica, come negozi,
ristoranti, attività artigianali e professionali, ecc.).
Dove ci sono loro (i bidoni) è
impedito il transito ai pedoni.
Intanto i pseudo ambientalisti
osteggiano i termovalorizzatori per meri intenti speculativi.
Rifiuti organici, in Italia un
giro d'affari da 1,8 miliardi di euro. Aumenta la raccolta nel 2017, a livello
nazionale passa da 107 a 108 kg la raccolta annuale procapite. Lombardia in
testa per produzione, scrive La Repubblica il 16 Febbraio 2019.
Sulle tariffe rifiuti, l’Italia
non è unita (e i virtuosi sono pochi). I dati sulle tariffe rifiuti fotografano
un Paese iperframmentato: i virtuosi pagano meno e solo al top per raccolta
differenziata e tariffazione puntuale, scrive Rosy Battaglia il 14.12.2018 su
valori.it. Se il giro d’affari dell’industria del riciclo è stimato in 88
miliardi di fatturato, con ben 22 miliardi di valore aggiunto, ovvero l’1,5% di
quello nazionale, come riporta lo studio di Ambiente Italia (promosso da Conai e
da Cial, Comieco, Corepla e Ricrea) quanto costano, invece, i rifiuti alle
famiglie italiane?
I miliardi nel cassonetto: chi
vince e chi perde nel grande business dei rifiuti. Un giro d’affari di 11
miliardi: i profitti tutti al Nord e all’estero, dove arrivano centinaia di
treni e camion dalle regioni del Centrosud rimaste gravemente indietro, che non
possono fare altro che imporre tasse più alte, scrive Daniele Autieri su La
Repubblica il 22 maggio 2017.
Raccolta differenziata, tra
conflitti di interesse e dati segreti: “Costi a carico delle casse pubbliche”.
Tra opacità e critiche dell'Antitrust, il sistema Conai non garantisce la
copertura dei costi di raccolta a carico dei Comuni con i prezzi di fatto
definiti dai produttori di imballaggi. Una situazione capovolta rispetto a
quella di altri Paesi europei, scrive Luigi Franco l'8 Ottobre 2016 su Il Fatto
Quotidiano. Domanda numero uno: quanta plastica, carta o vetro da riciclare ha
raccolto il tal comune? Domanda numero due: lo stesso comune quanti contributi
che gli spettano per legge ha incassato a fronte dei costi sostenuti per la
raccolta differenziata degli imballaggi? Due domande le cui risposte sono
contenute nella banca dati Anci–Conai prevista dagli accordi tra l’Associazione
nazionale dei comuni italiani e il Conai, ovvero il consorzio privato che è al
centro del sistema della raccolta differenziata degli imballaggi. Numeri non
diffusi ai cittadini, che possono contare solo su un report annuale con dati
aggregati. Ma i dati aggregati non sempre vanno d’accordo con la trasparenza. E
soprattutto non rendono conto delle incongruenze di una situazione su cui
l’Antitrust di recente ha espresso le sue critiche, mettendo nero su bianco che
“il finanziamento da parte dei produttori di imballaggi dei costi della raccolta
differenziata non supera il 20% del totale, laddove invece, dovrebbe essere per
intero a loro carico”. Con la conseguenza che a rimetterci sono le casse
pubbliche, visto che tocca ai comuni coprire gran parte di quei costi.
Inceneritori in Italia, dove
sono e qual è la differenza coi termovalorizzatori. Diversamente dai primi, i
termoutilizzatori producono elettricità e non inquinano. Ma c'è il problema CO2.
Da Nord a Sud, la mappa completa, scrive Paco Misale il 19 novembre 2018 su
Quotidiano.net. Inceneritori e termovalorizzatori. In molti li identificano come
la stessa cosa. In realtà, non è così. I primi sono impianti che bruciano i
rifiuti e basta, mentre i secondi sono impianti che bruciano i rifiuti per
generare energia. Gli inceneritori sono impianti vecchi, che oggi non si
costruiscono più: si preferiscono i termovalorizzatori, che permettono non solo
di distruggere i rifiuti, ma anche di produrre elettricità.
Termovalorizzatori e
inceneritori, ecco verità e bufale, scrive Nino Galloni su Starmag il 19
novembre 2018. Perché si confondono termovalorizzatori e inceneritori? Ha
ragione Matteo Salvini, per due ordini di motivi:
1) né le discariche né la
differenziata rappresentano la soluzione del problema;
2) il patto o contratto di
governo è fondamentale (come rispettare il sabato) ma se ti cade l’asino nel
pozzo lo vai a tirar fuori anche se è sabato.
Tuttavia, sia Salvini, sia la
stampa e la televisione hanno parlato di termovalorizzatori e di inceneritori.
Bene, quarant’anni fa c’erano gli inceneritori e una discreta mafia se ne
interessò, ma la loro capacità di inquinare e rilasciare diossina quando gli
impianti si raffreddavano era massima. Vent’anni fa arrivarono i
termovalorizzatori – dotati di filtri – riducevano l’inquinamento del bruciare,
ma non abbastanza, in cambio fornivano energia elettrica da combustione (legno,
rifiuti, gasolio, tutto può bruciare). Oggi esistono gli Apparati di Pirolisi;
due brevetti italiani, Italgas e Ansaldo. Oggi, dunque, esistono Pirolizzatori
di cui un tipo che emette gas combustibile, inerti ed anidride carbonica; ed un
altro che non emette l’anidride carbonica perché svolge al chiuso i processi.
Perché non si parla di dotare l’Italia di questi apparati attuali? Perché si
confondono termovalorizzatori e inceneritori? Perché la mafia non solo non si è
interessata ai Pirolizzatori, ma anzi, li ha osteggiati in tutti i modi entrando
nella politica e nell’economia per impedirne la diffusione? Perché a Roma
Virginia Raggi ed il suo staff non hanno voluto prendere in considerazione tale
proposta? Ci sono anche altre tecniche non aerobiche – in cui, sempre al chiuso,
intervengono i batteri – e che consentono di trasformare la risorsa “rifiuti” in
concimi, fertilizzanti e gas naturali, combustibili, a impatto ambientale
negativo (cioè risolvono più problemi dell’abbandonare i rifiuti – come tali – a
sé stessi o cercare di riciclarli in modo non efficiente). Intendiamoci, la
differenziata e l’economia circolare sono buonissime idee; ma perché vetro,
metalli, plastica eccetera vengano recuperati occorre dotare le città di
industrie adeguate, non mandare tali risorse in Svezia o in Germania (che,
invece, al pari di alcuni lodevolissimi comuni italiani – ma l’eccezione
conferma la regola- sanno approfittare di tali opportunità. Credo che
dell’ambiente – e non solo – si debba ragionare in modo non propagandistico,
valutando bene, di ogni cosa, l’impatto economico, finanziario e sociale.
(Estratto di un articolo tratto da Scenari economici)
Rifiuti. Cosa fanno a Parigi.
Scrive il Consorzio Recuperi Energetici. Un termovalorizzatore in parte
interrato che tratta 460 mila tonnellate di rifiuti l’anno sull’argine della
Senna. Vi sembra una fantasia? No è la realtà dell’impianto di Syctom Isseane, a
Issy -les- Moulineeaux, un Comune della cintura di Parigi. Il progetto raggruppa
48 Comuni che hanno aderito ad un medesimo piano e si sono messi insieme per
smaltire i rifiuti, realizzando quest’impianto. Dal 2007 il centro tratta i
rifiuti prodotti di circa un milione di abitanti...Un’apposita carta della
qualità ambientale è stata sottoscritta con il comune di Issy che garantisce le
condizioni di qualità, di sicurezza e di protezione dell’ambiente. L’impatto
sulla salubrità dell’ambiente è regolato da limiti rigorosissimi. Un impianto
simile e forse anche più avanzato è quello di Firenze almeno sul ciclo dei
rifiuti. Qui si raggiunge il 54% della raccolta differenziata ed entro il 2020 è
previsto il 70%. Il termovalorizzatore di Case Passerini eviterà che i rifiuti
residui, ossia quelli non riciclabili, siano inviati altrove producendo energia
elettrica equivalente al fabbisogno annuo di 40 mila persone, climatizzando
l’intero aeroporto ed eliminando lo smog causato dai camion che trasportano
rifiuti nelle discariche.
Copenaghen, l'inceneritore con
pista da sci sul tetto. Di Maio: "Ce la vedo ad Acerra..." Tutto pronto per il
nuovo termovalorizzatore costato 670 milioni di dollari. Produrrà energia a
impatto zero. Attorno un parco con piste ciclabili e impianti sportivi. Sul lato
più alto della struttura la parete artificiale d'arrampicata più alta del mondo,
scrive Paco Misale il 19 novembre 2018 su Quotidiano.net
Estratto dell'articolo di Francesco Bonazzi
per “La Verità” l’1 febbraio 2023.
Onorevoli con il mal di binario. Capaci di fare
spendere alla Camera dei deputati anche 4.000 euro in un mese, l’equivalente di
28 viaggi tra Roma e Milano con l’alta velocità, approfittando del privilegio di
viaggiare gratis poco prima di scadere dalla carica. Gli onorevoli ciuff ciuff,
come sono stati ribattezzati, sono 38 e ieri sera la trasmissione Fuori dal Coro
di Mario Giordano, su Rete 4, ha svelato la lista di coloro che si sono
accaparrati i preziosi carnet.
Tra questi, in massima parte eletti nel 2018 con
il Movimento 5 stelle, spuntano il paladino dei diritti della comunità Lgbt
Alessandro Zan, del Pd, e il super renziano Luciano Nobili. oltre 82.000 euro di
spesa Il documento ottenuto dalla trasmissione Mediaset è una lista di 38 ex
deputati che riporta gli acquisti di carnet da cinque, dieci e quindici corse
(validi per una sola tratta) tra i mesi di luglio e ottobre.
Il totale della spesa è di 82.520 euro, per un
costo medio di 2.171 euro a parlamentare. Il fenomeno più sospetto è che ottobre
è di gran lunga il mese in cui sono stati comprati più biglietti, per un totale
di 50.740 euro. Se si tiene a mente che le elezioni generali si erano svolte il
24 settembre, significa che molti deputati in scadenza, non ricandidati o non
eletti, sono andati all’agenzia di viaggio della Camera a fare incetta di
biglietti ferroviari a spese nostre. In discussione non è qui il diritto dei
parlamentari a viaggiare gratis per motivi di lavoro, ovviamente, ma quello di
fare le scorte per la vita futura. Il fenomeno è stato reso possibile anche da
una piccola sottigliezza tecnica.
(...)
Chi in questo periodo non dovrebbe avere tanto
bisogno di spostarsi in treno è il romanissimo Luciano Nobili, classe 1977,
solitamente dotato di battuta pronta. Non lo è stato ieri sera con i cronisti di
Fuori dal Coro che gli hanno garbatamente chiesto conto dei suoi biglietti
ferroviari, che per la cronaca sono stati del valore di 1.354,50 euro, tutti
acquistati a ottobre. Ci si va in business a Milano una decina di volte, tanto
per capire. Nobili si è sottratto alle domande saltando in sella al suo motorino
e urlando: «Sono in ritardissimo… per appuntamenti di campagna elettorale».
In ritardo, ma previdente. Per la cronaca, è
coordinatore di Italia viva nel Lazio e candidato alle prossime elezioni
regionali. E chissà se ha mai preso un treno regionale, lui che nell’estate del
2020 finì su tutti i giornali, fotografato in barca al largo di Ischia con
l’amica Maria Elena Boschi e con Gennaro Migliore. Il mal di binario deve aver
colpito anche il democratico Zan, che si è mosso ad agosto con acquisti di
carnet per 1.176 euro per poi fermarsi completamente. Insomma, è tra i pochi che
almeno ha evitato l’assalto ai treni di ottobre e potrebbe anche aver effettuato
tutti i viaggi prima della fine della legislatura. In realtà, il profeta
padovano dei diritti degli omosessuali è stato rieletto come capolista del Pd
nel collegio plurinominale del Veneto 2.
In sostanza, è possibile che ad agosto Zan fosse
solo pessimista sulla rielezione e che dopo si sia rasserenato. Nel dubbio,
però, ha fatto acquisti. Altro volto noto della lista è la grillina Carla
Ruocco, battagliera ex presidente della commissione d’inchiesta sulle banche,
paladina della lotta alle caste e finita con gli scissionisti di Luigi Di Maio.
La napoletana Ruocco ha speso 1.365 euro a
settembre e altri 1.354,50 a ottobre, per un totale di 2.719,50 euro.
Estratto dell’articolo di Aldo
Grasso per il “Corriere della Sera” il 31 gennaio 2023.
[…] La faccia di Guido
Crosetto. Il ministro della Difesa (fra i fondatori di Fratelli di Italia) ha
intonato «Bella Ciao» nel corso di uno show all’Auditorium della Conciliazione
per raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ha ceduto alle
insistenze di Fiorello e ha intonato il brano simbolo della Resistenza. Faccetta
rossa. […]
Lettera al “Corriere della
Sera” il 31 gennaio 2023.
Caro Aldo, mi dispiace che
Fiorello si sia prestato a questo scempio: Bella Ciao non è una canzone da fare
cantare a Crosetto. Lei che ne pensa?
Emanuele Lario
Guido Crosetto che canta Bella
Ciao su invito di Fiorello. Per fare spettacolo? Questa cosa non mi piace. O
forse Crosetto è diventato di sinistra?
Marta Tonni
La risposta di Aldo Cazzullo
Cari lettori, Guido Crosetto
non ha cantato Bella Ciao (tra l’altro abbastanza bene) perché è di sinistra, ma
perché è di Marene. Dalle sue parti, che poi sono le mie, comandava la
Resistenza Enrico Martini «Mauri», che non era un bolscevico ma un maggiore
degli alpini, e infatti fece tutta la guerra civile con il berretto dalla penna
nera; ai suoi ordini aveva il figlio del macellaio di Alba, Beppe Fenoglio, che
al referendum del ’46 votò monarchia.
Da quelle parti i fascisti
insieme con i tedeschi bruciarono case, violentarono donne, torturarono e
fucilarono contro le mura dei cimiteri ragazzi di 18 e 19 anni (tutte le vie
attorno al cimitero di Alba sono dedicate a partigiani morti non ancora
ventenni). È una storia raccontata in un libro che da quelle parti c’era in
tutte le case, «La tortura di Alba e dell’Albese»: l’autore era il vescovo.
Quando si poté votare, la Dc
superò il 50% (ma in molti paesi anche l’80, il 90); il secondo partito era il
partito liberale, il terzo il partito repubblicano; anche gli operai votavano
Democrazia cristiana (nelle cui file si è formato appunto Crosetto, che di
Marene è stato sindaco). Quando da ragazzi cantavamo Bella Ciao, non eravamo
neppure sfiorati dall’idea di fare una cosa di sinistra; era un canto che
parlava di resistenza, di fiori, di primavera, di memoria: tutte cose belle.
(Peraltro i partigiani, com’è noto, non l’avevano mai cantato).
Condannare il fascismo — non
solo le orrende leggi razziali: tutto, dallo squadrismo a Salò, sino alle bombe
sui treni — non è una questione ideologica ma etica, e anche estetica. Un
liberale un po’ dandy e molto anticomunista, Carlo Fruttero, disse una volta che
«i fascisti erano brutti. Tutti neri come corvi, con i teschi, il fez, e in
bocca sempre la parola morte». Resta il fatto che nell’Italia di oggi questa è
un’attitudine minoritaria, forse non solo nel partito di Crosetto. Il quale in
fondo ha cantato anche per non dare un dispiacere a Fiorello.
Mantenuti.
Non esiste il diritto alla bella vita se si
vive di sussidi dorati, champagne e aerei di cittadinanza. Andrea
Ruggieri su Il Riformista l'8 Agosto 2023
Italia. 1990. I primi telefonini cellulari, in
mano a poche persone (ai tempi, prevalentemente professionisti). Un solo
operatore pubblico nazionale. Le prime bollette. Im- porto? Due milioni di lire.
Cioè più o meno i mille euro di oggi. Si pagava persino lo scatto alla risposta,
oltre che i minuti di conversazione. Roba carissima. Per pochissimi. Qualcuno ha
nostalgia di quell’andazzo lì, oggi che invece abbiamo da scegliere tra diversi
operatori (tutti appartenenti alla galassia inutilmente demonizzata delle
multinazionali, anche dette sciattamente “murtinazzzzionali infami” da qualche
retrogrado), e che paghiamo anche solo 7 euro al mese per parlare e navigare
liberamente quanto ci va?
Io credo proprio di no. Credo che nessuno
rimpianga quei tempi. Perché erano per pochi, mentre quei servizi oggi sono per
tutti. È per questo che trovo anacronistico non affrontare un serio piano
di liberalizzazioni che portino tramite la concorrenza a un miglioramento dei
servizi per noi cittadini, a prezzi molto probabilmente migliori di quelli
odierni, e alla creazione di posti di lavoro; è per questo che trovo quasi da
comunisti ipotizzare di calmierare i prezzi o mettere un tetto al prezzo dei
biglietti aerei. È ipotizzabile che le compagnie vogliano recuperare quanto
perso nel Covid, mantenendo i prezzi alti, anche se hanno visto abbassare i loro
costi? Può darsi. Non lo so. Ma anche loro hanno dipendenti da salvaguardare.
Non è che il posto di un dipendente di una compagnia aerea valga meno di
altri. E il mercato lo facciamo noi consumatori. Prendiamo meno aerei e vedrete
come scendono immediatamente i prezzi. C’è il caro ombrelloni? Andiamo di più
in spiaggia libera e chiediamo che si liberalizzino le concessioni balneari.
Chi vi parla è convinto che se il Governo volesse,
anziché perdere giorni a discutere delle uscite discutibili ma lecite di qualche
responsabile comunicazione del Lazio, ci metterebbe ben poco a varare
delle liberalizzazioni serie, che portino vantaggio agli italiani (dai taxi agli
ombrelloni, ai servizi locali). Come è convinto che dopo aver varato una legge
delega che porti a una semplificazione fiscale (chiariamo: per vedere un taglio
tasse effettivo ci vorranno due anni da oggi), debba procedere a una coraggiosa
sforbiciata della spesa pubblica per trovare la provvista con cui finanziare un
vero shock fiscale, tale che aumentando il compenso netto nelle tasche dei
lavoratori, degli autonomi e delle partite iva, questi se ne possano fregare di
qualche rincaro, se proprio vogliono prendere l’aereo per andare in vacanza (che
– ricordo – è sempre un problema di lusso, non di sopravvivenza).
Perché anche questo va detto: non esiste il
diritto alla bella vita gratuita o a buon mercato se si rifiuta il mercato e si
crede di poter vivere di sussidi dorati e aerei di cittadinanza. Come non
esistono champagne di cittadinanza, Ferrari di cittadinanza, e yacht low cost. E
menomale. Andrea Ruggieri
Oziosi.
Poche chiacchiere italiani,
per volontà divina, la domenica si riposa. I nostri connazionali sono
professionisti nell’interpretare il calendario nel tentativo di sfruttare al
massimo ponti e permessi sindacali. Michele Mirabella su la Gazzetta del
Mezzogiorno il 19 febbraio 2023.
Gli Italiani sono campioni di
astuzia «calendariale». Intendo che sono abilissimi professionisti
nell’interpretare il calendario nel tentativo di sfruttare razionalizzando, ma,
anche «irrazionalizzando» con furbizie e mascalzonate, l’agenda del lavoro al
fine di aumentare il numero dei giorni di riposo con finte malattie, ponti
autorizzati solo dalla tolleranza dei datori di lavoro, cavilli del regolamento,
permessi sindacali, fughe con travestimenti.
Eppure i giorni di riposo sono
garantiti dall’equità̀ del Padreterno che, per primo, se ne assicurò l’uso con
semplice e santa programmazione. «Così furono compiuti il cielo, la terra e
tutte le loro schiere. Avendo, dunque, Dio compiuto nel settimo giorno l’opera,
nel settimo giorno si riposò da ogni sua intrapresa, lo benedì̀ e rese sacro,
perché́ in esso si era riposato da ogni sua opera. Queste sono le origini del
cielo e della terra quando furono creati. (Genesi, 2, 1-4)».
Andate a controllare, prego,
(La Bibbia concordata, Mondadori) e ritroverete, insieme all’ansimante prosa
della traduzione severa che non concede nulla alle bellezze della lingua,
l’asseverativa certificazione che anche Dio si riposò.
O, meglio, e anche San Girolamo
deve averlo capito a fondo, dando di piglio alla «vulgata», che Dio il quale non
aveva certo bisogno di riposarsi, ha creato il riposo per l’uomo conoscendolo
fragile e bisognoso di requie nella fatica modesta a petto di quella del Padre,
ma pur sempre fatica del lavoro quotidiano. Quest’interpretazione che, pure,
prelevo dall’illustre traduzione in mia mano, ci dice, dunque, che Dio creatore
sa già̀, desolatamente, che le creature cadranno in peccato e dovranno
guadagnarsi il pane con il sudore della fronte e lo sa prima che Eva si lasci
tentare tant’è che predispone il turno festivo nella corvée a cui sa essere
destinata la coppia mortale. Da nessuna parte la Bibbia parla di week-end, va da
sé, ma il principio fu fatto salvo: gli uomini, lavoratori a tempo determinato o
avventizi, impegnati nelle professioni libere, nel cottimo o nel lavoro
interinale, statali o parastatali, commercianti o liberi professionisti, operai,
contadini, militari e ragazzi, intesi come gli studenti, arrivati a sei giorni
di cartellino timbrato a vario titolo, dovranno riposare. Dovranno, badate bene,
non potranno.
Il settimo giorno non
lavorativo non dipenderà̀ dall’elargizione benevola del datore di lavoro o dalle
conquiste sindacali o dai regolamenti ma dalla volontà̀ divina e, quindi, poche
chiacchiere: la domenica si riposa. E, almeno nel mondo cristiano, ma, anche,
con diverse e più̀ terrene intenzioni, anche altrove si è oziato con vigoroso
entusiasmo e con indiscussa devozione fino all’invenzione del campionato di
calcio che, prevalentemente giocato di domenica, ha implicato una revisione
astuta della scelta divina e molti compromessi dubbi, ma lucrosi.
Per volontà̀ di Dio, dunque, il
Sabato ebraico fu sostituito poi, dalla Domenica, giorno del signore, dal latino
Dominus, dopo la venuta di Cristo in terra, venuta problematica e non proprio
rilassante come ancora testimonia e racconta la festa del Natale. Quest’anno
capita di lunedì̀ e, per gli indaffarati contabili, è una sfida. Credo che, sin
da ora si siano messi ad architettare un trucco per portare ad un’intera
settimana i giorni di riposo e ozio. Passi riposare anche il sabato, ormai è
usuale, passi festeggiare Santo Stefano, ma il 27 si torni al lavoro. Dio, che
non paga il sabato, ne terrà conto.
Il termine
ebraico Shabbat significa, letteralmente, cessare, cioè̀ smettere: smettere le
attività̀, non lavorare, non affaticarsi nel senso etimologico della condanna
biblica. La domenica, più̀ veniale imposizione del Cristianesimo, sancì̀, però,
non gli ozi calcistici, bensì̀ il dovere di rispettare il sacrificio della messa
e, con ciò̀, l’implicita ammissione che a Dio si sarebbe dovuto dedicare il
riposo e non a pratiche, diciamo così, ludico sportive. Accadde che una moderna
normativa europea conceda di spostare il giorno del riposo, della cessazione
dalla fatica, dalla domenica ad altro giorno a piacere secondo le convenienze
moderne degli stati. Una grossolana idiozia. Sui calendari di tutto il mondo
cristianizzato, ma, anche nelle contrade o tra genti laiche e agnostiche, sul
calendario compaiono segnati in rosso i giorni di Dio suggeriti dalle vicende
astronomiche affascinanti e divine per l’appunto. Dio non paga il sabato
suggerisce il nuovo testamento, il sabato o la domenica riposa per far riposare
noi, sue creature. Così ha da essere e così sarà̀, spero fino alla fine dei
tempi.
Con tutti i pensieri che ha,
non vorremo caricare il Padre eterno anche di questo peso: orientarsi tra mille
calendari diversi, fantasiosi e miseramente pagani. «Domenica è sempre
domenica», come cantava di sabato sera in televisione un signore elegante e
distinto alle donzellette del borgo Italia.
Donzellette che cominciavano a
non venire più̀ dalla campagna: avevano trovato casa in città e pagavano il
televisore a rate lavorando sei giorni a settimana. Quelli stabiliti, non a
casaccio.
Mirella Serri per “La Stampa –
TuttoLibri” il 3 aprile 2023.
«Fascismo regime» o «fascismo
movimento» secondo la celebre distinzione fatta dal più grande interprete della
dittatura, Renzo De Felice? Fascismo fondato sull'azione risolutrice
dell'arditismo dannunziano e sull'imposizione dei valori della guerra oppure
«regime» caratterizzato dai compromessi con la monarchia, con la classe
dirigente tradizionale e con la Chiesa?
Non è esattamente così: adesso
a rimescolare le carte e a spiegarci i lati oscuri della personalità del Duce -
che non fu mai «un grande statista», capace di progetti per uno sviluppo
progressivo del Paese - arriva il nuovo libro di uno dei più noti storici del
fascismo, Mimmo Franzinelli, Mussolini racconta Mussolini.
(...)
Professor Franzinelli, lei
descrive non solo l'ambito privato di Mussolini ma le sue folli autocelebrazioni
e le cupe zone d'ombra che condizionano la vita pubblica. Tratteggia la figura
del dittatore in balia di una lucida follia che non può non impressionarci. Come
è arrivato a queste conclusioni?
«Operando selezioni dall'Opera
Omnia di Mussolini curata da Duilio e Edoardo Susmel. Ho composto un'inedita
sequenza autobiografica, nella quale è arduo distinguere il pubblico dal
privato.
Mussolini che parla o che
scrive di se stesso attua falsificazioni continue della realtà. È
impressionante: si tratta della costruzione sociale della menzogna come leva di
comando. Cambia e modifica le sue posizioni, senza compiere mai scelte
lungimiranti o che guardino all'interesse pubblico. Si muove a seconda di stati
d'animo e di convenienze.
Questa alterazione dei dati di
realtà l'ha operata fin da quando rievoca l'infanzia: ci descrive la sua scuola
con toni molto letterari e costruisce un'atmosfera dickensiana. Si tratta dei
Salesiani di Faenza, dove con una disciplina militaresca istitutori sadici si
sfogano contro chi non può difendersi. Benito, entratovi a nove anni come
scolaro di terza elementare, è punito per le sue posizioni controcorrente.
(...)
Mussolini opera forzature
della realtà anche narrando la prima guerra mondiale?
«Per tenere aggiornati i
lettori, pubblica sul Popolo d'Italia un vigoroso Giornale di guerra in cui
racconta tremende avventure al fronte, scontri sanguinosi e colpi di cannone. Al
contrario, in privato comunica invece all'amico Torquato Nanni che si trova in
luogo dove "nulla di importante accade".
(...)
Quel che è peggio, si
autoconvincerà delle sue stesse esagerazioni, in una visione artefatta,
idilliaca della Grande Guerra che influenzerà la sua visione di quella che
sarebbe stata la partecipazione dell'Italia al secondo conflitto mondiale».
Una megalomania che porterà
Mussolini a farsi carico di iniziative inutili e azzardate, con migliaia di vite
umane mandate allo sbando?
«Successe ad esempio nella
campagna italiana di Grecia. Nel marzo 1941 una serie di telefonate dal fronte
greco-albanese mostrano l'abissale distacco di Mussolini e l'incomprensione
degli avvenimenti.
Era convinto di rinvigorire con
la sua sola presenza i combattenti e di respingere la controffensiva ellenica.
Dapprima è entusiasta per l'accoglienza tributatagli dalla truppa: "Mi sento
ringiovanito di almeno 25 anni. Questa è veramente un'atmosfera eroica e forte e
sana". Poi la visione di feriti e morti lo turba. Però insiste: "Vinceremo!
Questa è la vera Italia,
quella che io ho voluto". Poi ammette con Claretta il crollo di ogni
aspettativa: "Tutto va diversamente da come avevo creduto! La prima settimana è
stata entusiasmante, accesa e viva; la seconda di attesa, di speranza, di
alternativa: tutto inutile". Ma attribuirà la colpa della sconfitta agli
italiani capaci di fare solo "i loro porci comodi" e non invece di sacrificarsi
per l'ideale».
Dal momento in cui diventa
Duce, il suo Io tronfio non conosce più limite?
«Esasperato dal divario tra
ambizioni e realtà, batte sempre sul nervo scoperto dei connazionali inetti:
"L'entusiasmo è un'apparenza. La verità è che sono stanchi di me, che li faccio
marciare. Perché loro vogliono sedere, hanno le emorroidi…".
Contemporaneamente confida
solo in se stesso e nel suo potere. Ma le sue drammatizzazioni si scontrano
sempre con quello che accade. In privato smentisce persino la retorica
imperiale.
A Claretta ricorda che i suoi
uomini in Etiopia sono tutto il contrario di quello che appaiono e si mostrano
ladri, infedeli o inclini ad accoppiamenti indebiti "con le negre", come il
governatore Alessandro Pirzio Biroli che prediligeva le minorenni e che sarà
pertanto destituito da Mussolini.
I commenti che riferì
all'amante sull'attuazione delle leggi antiebraiche del 1938 furono spietati. Lo
irritava la solidarietà dei suoi concittadini con i perseguitati. "Questi
schifosi di ebrei, bisogna che li distrugga tutti...".
Era convinto che le sue
considerazioni negative cambiassero la realtà. Pensava di risollevare i destini
della guerra con i suoi discorsi - e gli yes-men che aveva intorno glielo
facevano credere. Si mise persino a disegnare personalmente le divise dei gradi
militari più elevati. Come se un fatto estetico potesse mutare l'andamento
fallimentare del conflitto mondiale».
Il persistente senso di
onnipotenza condiziona il Duce anche verso la fine della sua vita, a Salò?
«Direi di no, prevale
l'autocommiserazione e la sfiducia. Nel discorso del 24 giugno 1943
sull'emergenza italiana eccolo pronunciare una serie di strafalcioni: confonde
la battigia col bagnasciuga, scambia Protagora con Anassagora. Chiederà a
Claretta se si è accorta "delle gaffe... delle frasi fuori luogo". È incapace di
reagire, vive in perenne stato confusionale».
Professore, le
autorappresentazioni schizofreniche che nella fase giovanile avevano alimentato
lo spirito antisistema, vitalismo, entusiasmo e fiducia, al tramonto della sua
esistenza diventano stanchezza, desiderio di morte?
«Aumentano la labilità e
l'insicurezza. Ma nella sua condizione di borderline, da vero megalomane
Mussolini non si smentisce mai e gli rimane la propensione ad assolversi per la
rovina d'Italia, presentandosi come vittima di oscuri complotti».
Estratto dell’articolo di
Andrea Minuz per “il Foglio” il 3 aprile 2023.
Flaiano, che rivendicava il
copyright del titolo, avrebbe seguito con gran divertimento la lunga marcia dei
“Vitelloni” dall’Italia del boom a quella di Instagram. Perché se la metafora
bovina non dice granché ai millennial, basta ricalibrarla sulle nuove
sensibilità linguistiche ed eccoci di nuovo al punto di partenza. Ecco i
“bamboccioni” di Padoa-Schioppa, subito ammorbiditi poi nei “choosy” della
Fornero.
Ecco i falsi percettori di
reddito di cittadinanza che stanno tutto il giorno al bar […] i nuovi
vitelloni-influencer, tatuatissimi, sculettanti, muscolosi, ecco i vitelloni
bad-boy come Fabrizio Corona, o i vitelloni frivoli, come Gianluca Vacchi,
supervitellone postmoderno […]
Ecco il dramma dei “Neet”,
asettico indicatore statistico per immortalare “quei giovani che non studiano,
non lavorano, non sono impegnati in alcuna attività formativa”, di cui vantiamo
[…] il primato europeo. E quanti giovani artisti, scrittori, performer, ma anche
content creator “impiegati presso me stesso”, osservatori di serie tv, umarell
di Twitter e registi precari costretti a logorante attesa per un esordio con
opera prima sovvenzionata dai fondi a pioggia del Pnrr, o da provvidenziale
crowdfunding in famiglia.
“I Vitelloni” di Federico
Fellini compie settant’anni e se li porta benissimo (lo si festeggia a Rimini
con un convegno di due giorni, il 13 e 14 aprile, organizzato dal Fellini Museum
e dall’Università di Bologna). L’immortalità al cinema si concede davvero a
pochi titoli, ma ci sarà un motivo se Stanley Kubrick lo metteva al primo posto
dei suoi preferiti e se Scorsese lo ha rifatto in salsa americana con Harvey
Keitel e Robert De Niro vitelloni a Little Italy in “Mean Streets”.
[…] Il film con cui Fellini
diventa Fellini, […] diventa subito un fenomeno sociale. La parola, che ai
distributori assai terrorizzati suonava incomprensibile, entra nel lessico
italiano come capiterà poi con “paparazzo”, “dolce vita”, “amarcord” (dopo il
successo del film, i produttori proponevano con insistenza a Fellini un sequel
dal titolo “Le vitelline”, già in quota gender-balance). Si aprì un mondo. Il
telefono di Fellini squillava in continuazione. Vitelloni da tutta Italia
reclamavano un posto nel prossimo film del Maestro, chiedevano di essere
ricevuti, si erano riconosciuti, volevano sfogarsi, volevano raccontare le loro
gesta di vitelloni.
Fellini aveva toccato un nervo
scoperto: “Da molte parti d’Italia, giovani provinciali in tutto e per tutto
simili ai protagonisti del famoso film, si sono presentati al regista affinché
risolvesse il problema della loro vita”, titolava il Corriere della Sera
nell’inverno del ’53. […] fu “l’inedita scoperta della provincia italiana”.
Perché è qui che cambia la
storia del cinema italiano. Fellini e Flaiano intuiscono molti anni prima di
Maria De Filippi quanto la provincia sia il cuore di questo paese, il suo grande
inconscio collettivo, un paese di borghi, contado, comuni e cittadelle, città
invece poche, e dalle pretese metropolitane sempre disattese. Una “provincia che
è dentro di noi”, come dice per l’appunto Maria che la sa lunga. Prima dei
“Vitelloni” la provincia al cinema non esisteva. C’erano Roma, Napoli, Milano,
c’era l’epica contadina di “Riso amaro”, quella marinara e verghiana de “La
terra trema”, c’erano la campagna, il folklore, le piccole località,
“L’imperatore di Capri”, “I pompieri di Viggiù”. Ma l’anonimia della piccola
provincia borghese no.
Una provincia in cui si
riconosceranno tutti, da Scorsese a Italo Calvino. […] Quella dei “Vitelloni” è
una provincia immaginata, sognata, ricordata. Una provincia di chiunque, coi
suoi tratti immediati, distillati, facilmente riconoscibili anche per gli
spettatori americani, finlandesi o giapponesi: il caffè, la passeggiata sotto i
portici, il molo, le desolazioni improvvise, il gran torpore, la noia. […] “I
Vitelloni” è certo il film di Fellini dove più si vede all’opera il saccheggio,
la sfrontata ruberia felliniana di idee, ricordi, situazioni tipiche di Flaiano.
Ma qui sta appunto anche il miracolo.
[…] Flaiano scriveva e
teorizzava alla fine degli anni Trenta, sulla rivista “Cinema”, quando spiegava
che i luoghi nei film vanno inventati, rifatti con pochi tratti essenziali,
altrimenti ci si addormenta nel cliché, nel luogo comune della cartolina […]
Ecco quel che tutti i film a tema “vitelloni” venuti dopo non hanno, dai
“Basilischi” di Lina Wertmuller ai “Laureati” di Pieraccioni e alle variopinte
muccinate di provincia o meno: la cartolina del luogo è più forte del
“sentimento universale della provincia”.
[…] “I Vitelloni” è poi […] il
gesto dell’ombrello di Sordi, fragorosa spernacchiata ai “lavoratori della
malta” con pestaggio a seguire degli operai giustamente incazzati. L’immagine
più libertaria e liberatoria della storia del cinema italiano, insieme alla
“cagata pazzesca” della corazzata Kotiomkin, altro che i tappeti di bandiere
rosse in “Novecento” di Bertolucci. Un affronto al totem sindacale, alla
religione del lavoro, al culto astratto dell’operaio, in un momento in cui il
lavoro è valore supremo della costellazione politico-cinematografara del
comunismo italiano. Il fatto è che i vitelloni proprio non vogliono lavorare.
Non è che non lo trovano, o non li pagano abbastanza o non si piegano allo stage
non retribuito, macché. […] Non gli va e basta. Non ne hanno in fondo così
bisogno.
Sono piccolo-borghesi, […]
meglio stare a casa, meglio i pomeriggi passati al caffè a immaginare avventure
fantastiche e salgariane tirando poi fino all’alba. All’appuntamento col
miracolo economico i vitelloni arrivano già spompati. Non hanno la tempra dei
padri che han fatto magari la Resistenza, ma ne sentono tutto il peso addosso,
ora che tocca a loro, ora che dovrebbero rimettere in moto un paese nuovo e
libero […] E anche questi giovani che in piena euforia del boom non vogliono
lavorare, non vogliono crescere, non vogliono diventare nessuno […]
Scettico e disincantato come
sempre, ma ancora di più davanti alla retorica del “miracolo”. L’Unità, invece,
rimproverava a Fellini la mancanza d’analisi e di esplicita condanna di questi
“mantenuti, arrivati sulla soglia dei trent’anni con una mentalità da bambini”.
Sono comunque tutte cose che
erano già nell’aria: “Il mammismo”, breve saggio di Corrado Alvaro, esce l’anno
prima del film, e “La provincia addormentata”, raccolta di racconti di Michele
Prisco che era molto piaciuta a Flaiano, è del 1949. Subito dopo arriveranno le
ricerche di Banfield sul “familismo amorale” degli italiani. Fellini e Flaiano
fiutano, rapinano, rilanciano.
E il film deborda, sconfina
subito nell’immaginario, trova il nome giusto a tutta un’antropologia italiana
sommersa che nessuno sin lì aveva saputo raccontare così bene, fissando tipi
precisi, maschere che rivivono a ogni generazione, basta aggiungere Instagram o
TikTok, come l’intellettuale di provincia col manoscritto sottobraccio, fallito
ancora prima di iniziare, che nel film ha la faccia stralunata e perfetta di
Leopoldo Trieste. Poi i vitelloni si confonderanno coi playboy da riviera,
farfalloni, sbruffoni, sempre a caccia di turiste tedesche, olandesi, svedesi,
in vacanza a Gabicce, Misano Adriatico, Riccione. Un vitellone performer
sessuale, che Fellini farà rivivere anche nel “Casanova”, archetipo del gran
vitellone italiano. […]
Estratto dell’articolo di Paolo Bianchi per “il
Giornale” il 4 aprile 2023.
Rispetto ad altri critici del costume a lui
contemporanei, come Ennio Flaiano nella letteratura e nel giornalismo, Marcello
Marchesi nella scrittura anche pubblicitaria e pop, Dino Risi, Mario Monicelli,
Ettore Scola nel cinema, Age & Scarpelli nella sceneggiatura, Gian Carlo Fusco
appare oggi, e diciamo pure ingiustamente, più defilato.
Eppure è stato un intellettuale fra i più
affascinanti del Novecento italiano. Un vero e proprio personaggio, artista
anche nella vita. Un libro ci dà una mano a incontrarlo, e chi non l’avesse mai
conosciuto lo può addirittura riconoscere, come se già l’avesse letto in
passato, tanto egli ha influenzato molte altre personalità più famose.
Il volume, intitolato come una rubrica che Fusco
tenne sul mensile Successo tra il 1959 e il 1963, s’intitola Arpa e cannone
(Aragno, collana Ante litteram diretta da Luigi Mascheroni, pagg. 286, euro 30)
ed è curato da Dario Biagi […]
Ci sono i primi travestiti, esibiti nei night
club come punte di diamante di elusione morale, di trasgressione parigina; le
figlie bambine degli avvocati che urlacchiano in salotto incoraggiate dalla
famiglia adorante a diventare cantanti sanremesi. Mike Bongiorno e il medioevo
dei telequiz. Lapidi commemorative in onore di domatori di tigri.
È già la società falsificata dello spettacolo,
insomma. Che Fusco conosceva bene, lavorando anche come sceneggiatore di cinema,
autore teatrale e radiofonico, attore. Un mondo di nuovi idoli, costruzioni di
sogni collettivi, come la Anita Ekberg della Dolce vita, che si presenta a una
serata di presentazione alla Terrazza Martini di Milano, sfolgorante e plastica
come la polena di una nave vichinga, ma i cui tratti del volto a poco a poco si
trasfigurano nella maschera di un gerarca nazista.
[…]
Civetteria, vanità, narcisismo. Tratti comuni
nella popolazione, ma soprattutto in quella borghese. Esemplare il pezzo «Cento
pittrici», che descrive una mostra tutta al femminile, con le protagoniste avide
di elogi e gli uomini trincerati dietro il loro maschilismo.
La satira si abbatte soprattutto sui borghesi, sui
neoricchi, sui miliardari cafoni, sugli arrampicatori sociali, sui privilegiati
arroganti.
Molto di rado Fusco sbeffeggia il proletariato,
anzi ne certifica la fatica di vivere, e così facendo mostra una compassione
profonda: i poveri che vanno ai Mercati generali per aggiudicarsi a miglior
prezzo la verdura guasta. Una donna reduce dalla morte di un figlio al quale non
aveva fatto in tempo a soddisfare un modesto desiderio. Ex fascisti traditi
dalle promesse di un regime buffonesco e dalle sue tragiche conseguenze. […]
Dagospia il 4 aprile 2023.
Dal volume “Arpa e cannone” (Aragno) traiamo
l’articolo di Gian Carlo Fusco “Gioventù senza zanzare”, uscito sulla rivista
“Successo” nel maggio 1961
Montanelli è preoccupato. L’Italia d’oggi non
piace ai giovani. Molti di essi, che alla fine della guerra frequentavano
dignitosamente l’asilo, stanno ripiegando sul passato regime.
S’iscrivono all’M.S.I. Risalgono idealmente l’erta
degli anni. Scavano fra le macerie morali e materiali dell’altroieri, per
raccogliere e spolverare le vecchie immagini neglette, le parole d’ordine
derise, il corporativismo e la romanità.
Il tono beffardo e irriverente degli anziani
antifascisti, quando discorrono del “ventennio”, urta e ferisce questi giovani
che la democrazia, per quanto si metta in décolleté, non riesce a sedurre. Per
fortuna, nel ripostiglio più geloso delle loro camerette, conservano le vecchie
fotografie scampate ai falò del luglio ’43 e dell’aprile ’45. Le contemplano
assorti. Dimenticano la pena di essere giovani in questo 1961, così piatto e
incolore, tuffandosi con l’immaginazione nelle adunate oceaniche, nelle masse
galvanizzate, nelle esultanze solari dell’era littoria.
Solo la speranza che qualcosa di quegli anni
ritorni, li aiuta a sopportare gli squallori della democrazia e l’ottusità
ridanciana degli anziani antifascisti. Rinunciano alle nazionali, al cinema con
la ragazza, alla partita domenicale, per corroborare, nel loro piccolo, le casse
missine. È duro, aver vent’anni con vent’anni di ritardo! A che servono questi
vent’anni, quando non c’è più un casco coloniale da mettersi, qualche zanzara
albanese per prendersi un po’ di malaria, un’occasione di congelamento? È
spaventosa, a vent’anni, l’idea d’invecchiare così, sani, con tutte e due le
gambe, tutt’e due le mani, il naso, gli occhi, tutto!
No, i giovani che allo scoppio della guerra
scalciavano ancora nelle viscere materne, non credono ai racconti grossolani e
buffoneschi degli anziani antifascisti, secondo i quali il regime non fu che una
lugubre farsa. Anzi, a furia di ascoltarli, si sono convinti del contrario. E
per dimostrarlo, s’iscrivono all’M.S.I.
Tutto ciò preoccupa Montanelli, il quale, sotto la
sua buccia strafottente, è più sensibile di quanto s’immagini. Con qualche
apprensione da chioccia politica. Tanto che, giorni or sono, dalle colonne del
suo giornale, si è rivolto ai suoi amici e coetanei antifascisti più o meno
così: «Se le nostre sghignazzate urtano la suscettibilità di questi ragazzi
assetati di obbiettività, smettiamola una buona volta di mettere alla berlina il
passato regime. Sorridiamone, al più, e con la massima discrezione. Forse è
l’unico modo per tamponare l’emorragia dei giovani verso l’estrema destra».
Siccome fra gli antifascisti di mezza età amici
di Montanelli ci sono anch’io, ho il diritto d’interloquire. Dicendo che non
solo continuerò a sghignazzare liberamente del fascismo (le cui vittime
soltanto, comprese quelle che ci credettero, ispirano rispettosa tristezza), ma
anche di questi giovanotti che nel 1961, anziché sognare la Loren, sognano
Mussolini e s’iscrivono all’M.S.I.
Che c’è da preoccuparsi? I più intelligenti, prima
o poi, torneranno in qua. I fessi resteranno là. Finché, al primo 25 luglio che
capita, non li ritroveremo più né là, né qua, né sotto, né sopra. O che un teli
rammenti, Indro, i loro babbi?
Antipolitici.
Estratto dell’articolo di Paolo
Di Paolo per “la Repubblica” il 3 aprile 2023.
[…] In Francia, il tema delle
pensioni, proiettato su un orizzonte più ampio, assume i contorni di una
richiesta radicale di ripensamento dello schema lavoro-tempo libero come tempo
umano. In Portogallo, appannato il sogno del “buen retiro” per pensionati
stranieri, le proteste riguardano essenzialmente l’aumento degli afflitti e i
prezzi delle case, una già impressionante crisi abitativa che l’inflazione rende
anche più minacciosa. Nella capitale, Lisbona, gli affitti sono saliti del 65% e
i prezzi delle case del 137%.
La Germania, alle spalle la
lunga era Merkel, lo scorso 27 marzo ha vissuto uno degli scioperi più
significativi degli ultimi tre decenni: l’istanza di base ha a che fare con
l’aumento dei salari. Astensione dal lavoro e protesta di piazza: strategia
“classica”, otto- novecentesca, anticapitalista. E se gli anni Venti di questo
secolo stessero ricominciando da lì?
All’aeroporto di Bordeaux, così
come in quello di Parigi Charles De Gaulle, l’altra sera - in sale d’attesa
sovraffollate per le decine di voli cancellati - non ho registrato fra i
passeggeri discorsi di grande insofferenza.
Una rassegnazione calma, e
semmai complice: con la determinazione dei “disobbedienti” civili disarmati. Che
nelle grandi capitali belle e gentifricate, con gli affitti alle stelle nei
centri storici e periferie geografiche ed esistenziali sempre più in affanno,
ritrovano uno slancio quasi rivoluzionario.
O sarebbe meglio dire lo
spirito della democrazia come partecipazione e dialettica: dove l’astensione
indica sfiducia radicata e distanza dalle istituzioni, i corpi la riassorbono
accostandosi ai luoghi del potere. […]
È il rompete le righe di un
lungo lockdown del disincanto? L’infrazione collettiva del codice cinico: chi
l’ha detto che niente può cambiare? Come da settimane a Tel Aviv, così nel cuore
dell’Europa si rivede la piazza! E sarebbe fuori fuoco leggerla con i paradigmi
anti-politici e populisti che hanno intossicato il trapasso del Novecento.
No, sono piazze politiche,
intensamente politiche: così come quelle che […] hanno negli ultimi anni
costretto i leader del mondo a mettere - almeno formalmente - la questione
climatica in testa all’agenda. «Hai dimenticato, mio caro, quanto rumore faceva
il tumulto», scriveva un intellettuale tedesco di pensieri ruvidi e battaglie
civili come Hans Magnus Enzensberger.
Ma bisogna sapere - aggiungeva,
guardando a geografie lontane dall’Europa che il tumulto non finisce mai. Magari
ha luogo «dove abbiamo la fortuna di non vivere», è solo una questione di
prospettiva.
O di tempo: se, come sembra,
torna a lampeggiare nelle strade e nelle piazze del continente che chiamiamo
vecchio e che lo è sempre di più. Fa l’appello e la conta una società civile che
non vuole limitarsi a sperare, né accetta di vedersi sventolare sul naso una
bandiera ingannevole con scritta la parola futuro.
Forse è tornata a credere che
la politica non è solo un modo di pensarsi e di vedere il mondo, ma è «questione
di vita o di morte », per usare le parole di uno scrittore francese nato sei
decenni dopo Enzensberger, Édouard Louis. Fai ancora politica?, gli domanda il
padre. Il figlio dice sì. Fai bene, risponde il più vecchio, ci vorrebbe proprio
una rivoluzione. E in Italia?
“Mentre in Francia, Germania
e Israele il popolo scende in piazza, noi litighiamo per i gay” Vittorio Feltri
spiega a modo suo perché noi siamo un popolo incapace di far valere i propri
diritti
Mondo nel caos. E l’Italia
sembra quasi tranquilla. (Vittorio Feltri – Libero quotidiano il 28 marzo
2023) – Non si può certo dire che l’Italia sia un modello di tranquillità
pubblica, ma se ci guardiamo attorno, esaminando quanto accade nel mondo, non
possiamo di certo lamentarci troppo. Ieri abbiamo esaminato il casino che
avviene in Francia a causa dell’allineamento della età pensionabile, che poi è
un problema del piffero.
Comunque da noi certe cose
assurde non si verificano. Osserviamo la realtà e scopriamo che in Israele sta
succedendo un putiferio dall’esito incerto, visto che è impossibile capire quale
sarà il destino di Netanyahu, alle prese con un caos nazionale incomprensibile
per noi poveri tapini.
Anche in Germania, che noi
abbiamo erroneamente considerato da anni la patria dell’ordine, i cittadini
litigano furiosamente per vari e ignoti motivi. Per non parlare della Tunisia
che è un bordello a cielo aperto e fomenta l’emigrazione, indovinate dove? Qui
da noi che già siamo invasi dagli sfigati di ogni nazionalità africana e non
sappiamo più come e dove ospitarli decentemente. Che dire poi del Brasile alle
prese con drammi politici sconosciuti?
L’Italia non sarà il paradiso
terrestre, anche noi siamo alle prese con notevoli grane, se proprio dobbiamo
giudicarci non siamo i campioni del mondo, ma se ci confrontiamo con numerose
altre nazioni, che talvolta abbiamo ammirato, possiamo vantarci: non saremo i
migliori del globo terracqueo ma sicuramente non i peggiori.
Basti pensare che non avendo
null’altro da fare litighiamo per la maternità surrogata, l’utero in affitto, i
diritti degli omosessuali (di cui non ci importa nulla o quasi). Senza contare
che il cosiddetto dibattito pubblico prevalentemente romano verte per lo più
sulla nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, alla quale qualcuno attribuisce la
forza di un leone e altri quella di un coniglietto.
Insomma il mio breve esame
della situazione fornisce molti motivi consolatori sullo stato delle nostre
istituzioni, ingiustamente criticate o almeno troppo criticate. Chi si
accontenta gode, e allora godiamo e buona notte. Aspettiamo l’alba senza
stracciarci le vesti, non sarebbe il caso.
L’Italia non è la Francia:
per cambiare le cose serve combattere la rassegnazione.
(Ferdinando Boero –
ilfattoquotidiano.it il 28 marzo 2023) – Ultimamente ho usato spesso la parola
rassegnazione per descrivere come, in Italia, si reagisca a fatti che, in
Francia e in Germania, generano sollevazioni. I francesi sono diversi da noi, a
quanto pare. Sono abituati a combattere “come popolo”. Hanno fatto la
Rivoluzione Francese (1789) e poi la Comune di Parigi (1871), fino al maggio
Francese (1968), e ora sono di nuovo per strada. L’Italia, dal canto suo, ha
riunificato il paese con le sollevazioni che hanno sostenuto l’impresa dei Mille
(1860-61), senza però liberarsi dalla monarchia, ma poi ha realizzato il
fascismo (1922-43), in parte riscattato dalla Guerra di Liberazione (1943-45).
Il pericolo di un ritorno al fascismo col governo Tambroni (1960) fu scongiurato
da moti di piazza in molte città italiane (da Genova a Reggio Emilia) e, sempre
a Genova, la contestazione al G8 (2001) vide scontri per le strade e episodi di
tortura. La parentesi del terrorismo brigatista, iniziato nel 1970, non ebbe
grande seguito di piazza che, invece, dopo l’assassinio di Guido Rossa (1979) da
parte delle brigate rosse, si mobilitò contro il terrorismo, negandogli
legittimazione popolare.
Lo stravolgimento politico, in
Italia, non avvenne nelle piazze ma nelle aule dei tribunali, nel 1992, con
Tangentopoli, seguita però dal Berlusconismo (1994-oggi), una sorta di
restaurazione del sistema pre-Tangentopoli: i moti di piazza furono sostituiti
dalla propaganda televisiva. La reazione alla corruzione dilagante di una
Tangentopoli mai finita trovò sfogo nel Movimento Cinque Stelle (2012-oggi) che,
invece di usare la televisione, scese in piazza con i comizi di Beppe Grillo e
usò la rete come nuovo strumento di diffusione del dissenso, senza alcun ricorso
alla violenza fisica.
Grillo, se non ricordo male,
disse che senza il M5S la rabbia popolare avrebbe fatto scorrere il sangue per
le strade e, infatti, non si sono mai registrate violenze fisiche nelle
manifestazioni dei 5S. Violenze verbali sì: mandare affanculo chi ha portato il
paese sull’orlo del baratro è liberatorio, ma non basta; la ribellione verbale
si è concretizzata in azione politica, ha vinto le elezioni ed è andata al
governo. I professionisti della politica si sono subito coalizzati per
delegittimare i 5S, dipingendoli come populisti, incapaci, scappati di casa.
Anche i 5S hanno contribuito
alla propria delegittimazione. Come quando hanno chiesto il ministero della
transizione ecologica, puntando sulle tecnologie senza badare all’ecologia,
considerata un nemico della transizione ecologica dallo stesso ministro della
transizione ecologica. I 5S sono stati una speranza contro la rassegnazione,
hanno portato alle urne moltissimi non votanti e, dato che hanno fatto molto di
quel che promettevano, sono stati attaccati da tutti. Prima di tutto dai loro
potenziali alleati: Letta ha preferito perdere le elezioni che allearsi con
loro, calandosi le braghe di fronte a Calenda che, esaminata l’offerta, ha
preferito rivolgersi a Renzi, il kamikaze della politica, emulo mal riuscito di
Macron.
Il disegno ha avuto successo: i
5S hanno perso i voti che erano riusciti a strappare a chi era rassegnato
all’ineluttabilità del “tanto sono tutti uguali”, i non votanti sono il primo
partito e vincono le destre, con una minoranza di voti rispetto ai votanti
potenziali. L’incontro elettorale è stato vinto dalla squadra di destra perché
nella squadra contendente i giocatori si sono messi a tirare nella propria
porta. Si tratta di un capolavoro degno degli antichi maestri della guerra che,
da sempre, sanno che dividere il nemico è il modo migliore per vincere le
battaglie. Se poi il nemico è rassegnato e non combatte (vota) è ancora meglio.
Da sempre, i giovani reagiscono
energicamente a situazioni di stress: non sono rassegnati, non hanno paura dei
rischi, non sono “prudenti”. Gli anziani, di solito, li usano per combattere le
loro guerre e cercano di controllarli con metodi più o meno raffinati, che vanno
dalla religione, alle droghe, al consumismo, alle fake news in rete. I giovani
francesi si stanno mobilitando per sostenere le rivendicazioni dei loro genitori
ma, accanto alle pensioni, stanno chiedendo soluzioni per i problemi ambientali,
la transizione ecologica e molto altro. Noi italiani abbiamo accettato con
rassegnazione lo spostamento verso i 70 anni dell’età pensionabile, i giovani
fuggono dal paese, e smettono di fare figli. La transizione ecologica che si
dovrebbe realizzare con il Pnrr pare stia diventando una gara d’appalto senza
appalti, e la restaurazione vede al potere il tris politico che già ci portò sul
baratro del default.
Confesso che, pur con tutti i
suoi limiti, la strada del M5S (vinciamo le elezioni e cambiamo le cose) mi pare
di gran lunga preferibile rispetto ai moti per le strade. Il tanto vituperato
Danilo Toninelli è riuscito, da ministro dei Trasporti, a ricostruire il Ponte
di Genova in tempi record e, a quanto pare, senza ruberie. Giuseppe Conte ha
convinto la Commissione Europea a darci i miliardi del Pnrr, quando tutti gli
dicevano di prendere il Mes. Gli è stato tolto, il merito se l’è preso Mario
Draghi, la cui agenda era quella di Conte, e ora è in mano a chi sta dando prova
di non sapere come fare. Viviamo tempi molto interessanti.
L’epopea dei fazzoletti
rossi fu l’ultima rivolta. Perché fu occupata la fabbrica Fiat di Mirafiori, 50
anni fa gli operai si presero il potere. David Romoli su Il Riformista il 29
Marzo 2023
Cinquant’anni fa, il 29 marzo
1973, la Fiat Mirafiori, il più grande stabilimento industriale d’Italia,
fu occupata dagli operai. Non succedeva dal 1920. Non sarebbe più capitato. Gli
operai scelsero la forma estrema di lotta da soli, senza attendere le
disposizioni né dell’Flm, che riuniva i sindacati metalmeccanici di Cgil,
Cisl e Uil, né della sinistra extraparlamentare, che pure a Mirafiori era
incisiva.
Al culmine di una vertenza
durissima, che si prolungava da sei mesi e fu probabilmente il conflitto più
aspramente combattuto negli anni della grande rivolta operaia in Italia, furono
gli operai in totale autonomia a coprirsi il viso con i fazzoletti rossi, per
non essere riconosciuti e licenziati, e a bloccare tutti i cancelli della
mostruosa città-fabbrica. Il giorno dopo, 30 marzo, su tutti i cancelli
di Mirafiori sventolavano le bandiere rosse, tutti erano presidiati in forze
dai “fazzoletti rossi”. L’azienda rispose con un comunicato minaccioso: «Di
fronte agli episodi di occupazione avvenuti il 29 e il 30 marzo la Fiat ha
deciso di chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per essere reintegrata
nella piena disponibilità degli stabilimenti occupati». L’occupazione invece
proseguì, solo sulla carta il primo aprile, giorno di festa, concretamente, pur
consentendo l’entrata dei dirigenti, il 2 aprile. Una settimana dopo fu firmato
il contratto.
Nell’esaltazione del momento
alcuni considerarono quel contratto “un bidone”. Fu invece l’accordo migliore
mai strappato dagli operai metalmeccanici e segnò il livello più avanzato di
contropotere nella gigantesca fabbrica che, sino a quattro anni prima, era stata
il simbolo stesso della sconfitta operaia. A Mirafiori non si scioperava mai,
neppure nelle settimane quasi insurrezionali che nel ‘60 avevano abbattuto
il governo Tambroni. A Mirafiori il sistema di potere creato da Vittorio
Valletta, basato su una disciplina ferrea combinata con un welfare avanzato,
aveva schiacciato per oltre 15 anni ogni forma di conflittualità. A Mirafiori,
nel ‘68, solo 556 lavoratori su 50mila aderivano alla Fiom, il sindacato
metalmeccanico della Cgil, e i comunisti erano ancora meno: 218. L’esplosione
improvvisa e del tutto imprevista della primavera ‘69 rovesciò il quadro in
poche settimane, facendo di Mirafiori l’epicentro del conflitto sociale in
Italia. La vera e propria battaglia combattuta tra l’ottobre 1972 e
l’aprile 1973 sancì un contropotere operaio che fu sconfitto solo dopo 7 anni,
nel 1980.
Quel conflitto senza precedenti
è stato quasi cancellato da una memoria che riduce gli anni ‘70 alla lotta
armata e la rivolta operaia all’autunno caldo del ‘69. Lo racconta ora un libro
di Chicco Galmozzi, all’epoca militante di Lotta continua e operaio alla Breda
di Milano, poi tra i fondatori di Senza tregua e Prima linea, Marzo 1973,
Bandiere rosse a Mirafiori (DeriveApprodi, 2023, pp. 128, euro 14.00). Quella
di Galmozzi è un’analisi dell’intero ciclo 1968-73. A partire dalle prime
insorgenze del ‘68, che non fu solo studentesco, e dalla rivolta improvvisa
del ‘69 sino ai fazzoletti rossi del ‘73, Galmozzi analizza le radici della
nuova conflittualità operaia. Le rintraccia in una composizione di classe
trasformata dall’ingresso di decine di migliaia di giovani neoassunti e in una
radicale spinta antiautoritaria e antigerarchica che minava dalle fondamenta il
sistema militarizzato vallettiano. Indica nella domanda di egualitarismo la leva
che, partendo dalle condizioni materiali, arrivò in pochissimi anni a mettere in
discussione non solo il comando in fabbrica ma l’intero sistema capitalista di
produzione. Insiste sull’uso della forza, che a Mirafiori fu continuo da una
parte e dall’altra e che fu essenziale per la costituzione di quel contropotere.
Il libro è corredato da una
lunga cronologia, molto dettagliata non solo giorno per giorno ma anche reparto
per reparto, redatta a caldo da un collettivo di operai Fiat. Va dal 20
settembre 1972, col primo sciopero in anticipo sull’apertura ufficiale della
vertenza contrattuale, alla conclusione della stessa. L’analisi dell’autore va
letta nel quadro di quella cronaca. A rendere quella vertenza così estrema e
spesso violenta furono le diverse poste in gioco messe sul tavolo dalle due
parti, illustrate in controluce anche dalle opposte ipotesi di contratto. Dopo
tre anni di conflittualità permanente la Fiat mirava a stroncare la forza
operaia: per questo aveva assunto decine di fascisti in funzione più di mazzieri
e spie che di operai, stretto accordi con la questura che intervenne a
ripetizione e con la mano pesante, aveva scelto di ricorrere alle maniere forti
con licenziamenti continui, denunce, minacce esplicite, cancellazione della
mutua, sospensioni della produzione contro gli scioperi articolati che
paralizzavano la catena minimizzando il costo per i lavoratori. L’obiettivo
esplicito di Federmeccanica era domare l’assenteismo, bloccare la spinta
egualitaria, evitare aumenti del costo del lavoro, fermare una volta per tutte
la mobilitazione continua, che dal ‘69 aveva determinato uno stato di
“conflittualità permanente”.
Gli operai chiedevano
l’inquadramento unico, cioè la fine del sistema basato su
qualifiche e categorie per dividere il fronte operaio, un sostanzioso aumento
uguale per tutti, la riduzione dell’orario di lavoro, un monte ore da dedicare
allo studio in un momento in cui l’analfabetismo era ancora un problema reale.
Non si trattava solo della classica contrapposizione tra piattaforme
contrattuali propria di ogni rinnovo contrattuale. La sfida era politica.
Per Fiat e Federmeccanica si trattava di ripristinare in fabbrica l’ordine
travolto nel ‘69. Gli operai miravano a estendere il contropotere all’interno
della fabbrica. La mediazione, dal punto di vista della posta politica, era
impossibile. La ricostruzione di quei mesi è dunque quella di una battaglia
fatta anche di continui scontri fisici, di attacchi fascisti e rappresaglie
operaie, di cortei interni che spazzavano i reparti prendendo di mira crumiri e
capireparto, di repressione feroce da parte sia dell’azienda che della questura.
Nel complesso pochissimi libri riescono come questo a restituire la realtà di
quello che è stato il conflitto sociale in questo Paese, e dunque anche della
vastità del terremoto che lo rimodellò in quei cinque anni.
Il contratto firmato dopo
il blocco della merce del 28 marzo, forma di lotta che gli operai non avevano
mai adottato sino a quel momento, e dopo l’occupazione di Mirafiori fu vincente:
inquadramento unico, aumento di 16mila lire al mese uguale per tutti, orario
lavorativo ridotto a 39 ore settimanali, una settimana in più di ferie,
riconoscimento del diritto allo studio con 150 ore retribuite da dedicare alla
formazione nell’arco di un triennio. Su un piano più strategico fu respinta la
controffensiva aziendale che mirava a ricondurre all’ordine con ogni mezzo
l’insubordinazione in fabbrica. L’ “ultima vittoria operaia”, come la
definisce Galmozzi.
David Romoli
Farsa continua. L’ossessione
per gli anni Settanta e le origini dell’antipolitica. Francesco Cundari su
L’Inkiesta il 16 Gennaio 2023.
Un articolo del Washington Post
presenta una spiazzante analogia tra gli esaltati trumpiani che il 6 gennaio
2021 assaltarono il Congresso e gli hippies del 1967. Un paragone audace, che
tuttavia ha qualcosa da dire anche all’Italia
Pochi argomenti, forse solo il
calcio, hanno avuto in Italia maggiore e più duratura fortuna, come oggetto di
dibattito, polemica giornalistica, ricostruzione storica, rivisitazione
letteraria o cinematografica, degli anni Settanta e delle relative vicende
politiche, specialmente per quanto riguarda l’estremismo di sinistra.
Anche negli ultimi giorni, come
del resto quasi ogni giorno da ormai più di mezzo secolo, si sono accese
discussioni e polemiche di vario spessore a proposito di film, fiction e
documentari dedicati a quella stagione (a loro volta di diverso valore):
dalla fiction in otto puntate sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che sta
andando in onda su Rai uno («Il nostro generale») al documentario su Lotta
continua trasmesso su Rai tre pochi giorni fa, fino al film di Marco Bellocchio
dedicato al caso Moro («Esterno notte», seguito ideale del suo precedente
«Buongiorno notte»).
Personalmente ritengo che
l’ossessione del giornalismo, della letteratura, della tv e del cinema italiano
per gli anni settanta si spieghi anzitutto con un dato sociologico e
psicologico. In poche parole, con il fatto che il mondo del giornalismo, del
cinema e della comunicazione è composto in gran parte di persone provenienti da
quelle esperienze giovanili. E si sa che ciascuno di noi tende a considerare la
propria giovinezza come la stagione decisiva della storia umana.
Non facendo eccezione alla
regola, ma essendo più giovane, sono convinto che il momento decisivo della
nostra storia sia stata la stagione di tangentopoli – quando avevo quindici anni
io – con il condensarsi di quella temperie antipolitica che avrebbe spazzato via
i vecchi partiti e posto le basi del populismo oggi dominante. Proprio per
questo, tuttavia, nel cercare le origini di tale ideologia (o comunque la
vogliate chiamare), sono stato spinto spesso a guardare non solo agli anni
Settanta, ma anche e soprattutto al modo in cui i protagonisti di quella
stagione ce l’hanno raccontata. E il racconto è quasi sempre un polpettone
complottista fondato su debolissimi appigli fattuali (proprio come tante
inchieste giudiziarie e giornalistiche degli anni successivi) in cui i
terroristi appaiono quasi come degli ingenui idealisti, magari un po’ impulsivi
ma tanto appassionati e sinceri, mentre i partiti democratici, sia la Dc sia il
Pci, sembrano le vere associazioni a delinquere, e in ultima analisi i maggiori
responsabili di tanti lutti.
Ho sempre pensato che questa
intramontabile fortuna degli anni settanta fosse una caratteristica
specificamente italiana, che per varie ragioni storiche (non ultima la
motivazione generazionale summenzionata), aveva aperto la strada al trionfo
della cultura antipolitica e larvatamente eversiva prevalsa nel nostro paese, a
destra come a sinistra, dagli anni novanta in poi.
Non la faccio lunga per motivi
di spazio, ma chi fosse interessato alla tesi può trovarla ben più distesamente
argomentata in due importanti libri di Miguel Gotor dedicati al caso Moro:
«Lettere dalla prigionia» e «Il memoriale della Repubblica», entrambi pubblicati
da Einaudi (sul fatto che poi lo storico Gotor, attuale assessore alla Cultura
di Roma, dopo una breve stagione da parlamentare del Pd e consigliere di Pier
Luigi Bersani, abbia collaborato come consulente alla sceneggiatura proprio di
“Esterno notte”, nel quale compare anche in un cammeo, si potrebbero fare
ulteriori considerazioni, ma lo spazio è tiranno e la parentesi è già troppo
lunga così).
L’aspetto più interessante di
tutta la questione, almeno per me, è che tale singolare caratteristica della
storia italiana, a quanto pare, non è affatto solo italiana. Questo almeno è
quello che mi è capitato di pensare leggendo l’articolo di Joe Klein sul
Washington Post dal titolo «Performance e protesta», dedicato a una spiazzante
analogia: quella tra gli esaltati trumpiani che il 6 gennaio 2021 assaltarono il
congresso e gli hippies del 1967. Due movimenti apparentemente – e per molti
versi effettivamente – agli antipodi, che tuttavia non condividevano solo una
spiccata inclinazione per l’arte performativa. «Erano parte di un continuum, un
Sisifo alla rovescia in cui noi, i figli privilegiati dell’alta borghesia,
facevamo rotolare giù per la collina un masso di edonismo individualista senza
alcun piano per frenarlo, finché l’alt-right non lo faceva schiantare contro il
Campidoglio».
Forse sarebbe ora che le nuove
generazioni – nella politica, nel giornalismo, nella storiografia e nella
cinematografia – cominciassero a costruire l’officina in cui montare qualche
tipo di freno a questo genere di massi.
Estratto dal “Corriere della
Sera” il 23 Febbraio 2023.
Caro Aldo, possibile che ogni
giorno siamo costretti a leggere le «avventure» di Fedez?
A me pare che in questo modo
gli diamo molta più credibilità di quanto ne merita.
Non lo crede anche lei?
Giuseppe Marchio
Risposta di Aldo Cazzullo
Caro Giuseppe, per fortuna
nessuno di noi è obbligato a leggere le avventure di Fedez. Ma le assicuro che
lo fanno in moltissimi. E il motivo è semplice: Federico Lucia in arte Fedez e
Chiara Ferragni sono la versione digitalmente avanzata di un «topos» letterario,
o se preferisce di un «format» televisivo: la coppia di successo, bella e
litigiosa (a Roma direbbero litigarella).
L’archetipo sono ovviamente
Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, e Al Bano e Romina Power. A lungo il loro
ruolo è stato preso da Francesco Totti e Ilary Blasi, prima che il matrimonio
crollasse. Ora tocca ai Ferragnez, che è anche il titolo di una serie.
Non si poteva invitare lei a
Sanremo senza invitare pure lui, che le ha un po’ rubato la scena […] Del resto
Fedez fa il suo mestiere: l’artista. E l’artista promuove se stesso. Deve far
parlare di sé e tenere banco. In questo Fedez è persino più attrezzato della
Ferragni.
[…] Prima ancora che un
musicista, è un comunicatore digitale, che ha compreso la regola base: per
costruire una comunità è fondamentale avere dei nemici. Può essere antipatico;
ma la simpatia non è il metro con cui valutare le persone e il mondo .
Barbara Costa per Dagospia il
21 gennaio 2023.
Di cosa si parlava in Italia
40 anni fa? Di f*ga, tette, e c*li, e di Berlusconi, di tangenti, e di…
Mussolini! Voilà, sì, come oggi, in Italia non cambia mai niente, e di che
stupirsi? Ecco tra le mie mani un "Playboy Italia" di 40 anni fa, gennaio 1983,
e cosa c’è? F*ghe a profusione, tette e c*li yuppies, tanto che a governare gli
orgasmi onanistici sono le bellone di Dallas e di Dynasty, i serial massimi del
periodo.
La copertina è dominio dei
seni pregevoli (e naturali) di Linda Evans, attrice di Dynasty, che spoglia il
suo corpo all’interno del giornale, ed è una ninfa che gioca nell’acqua ad
istigare i lettori, se non fosse che questo servizio fotografico… inganna:
chissà quanti 40 anni fa si sono accorti che tale erotico shooting in questione
immortala una mooolto più giovane Linda Evans, nudo-fotografata nel 1971!!!
"Giochetti" con i quali nel pre
web avevi mano facile… Ma torniamo al 1983: chi è che in Italia trasmette in TV
Dallas, a milioni di italiani? Silvio Berlusconi, star del pezzo principe del
magazine, la "Playboy Interview", fatta dal dir. di Playboy Italia Massimo
Balletti.
E fatta e rifatta, essendo una
intervista sottoposta a più editing, strati su strati, e si vede, e si calca,
nelle parole, si lima… E sono domande e sono risposte tra uomini vincenti,
innamorati di sé e di ciò che creano e vivono: Berlusconi dice che “sono un
democratico, chiamatemi Sua Emittenza”, “non mi amano quelli che non mi
conoscono”, “qualità? Io le ho tutte, io praticamente sono perfetto”, e attenti
che ha iniziato a lavorare “a 5 anni: intagliavo marionette per il mio teatrino
a pagamento”. Zero domande sulla sua vita privata.
Su Playboy Italia gennaio 1983
c’è anche Bettino Craxi, il quale è pronto, prontissimo ad entrare a Palazzo
Chigi, sicché di lui la stampa italiana fa quello che sempre fa e sempre farà
con chi ha in mano il Potere: va di lingua! E un Craxi chi è lo firma Ruggero
Orlando, e Craxi è “uno dei nostri pochissimi statisti, è coerente, di giudizio
sicuro, energico, però è un timido, e non vendicativo”, “è stato e talvolta è
giocatore di poker, vince sempre”, “preferisce il romano hotel Raphael a un
appartamento”. Già.
In Italia come al solito si
ruba, e a far notizia sono le tangenti, ma non quelle del 1992, quelle antilopi
e giaguari della Lockheed: in ballo “120 milioni di dollari” (scovati), ma per
populisticamente indignarsi è presto, nel 1983 l’Italia vira socialista, e Craxi
“risolverà se non i nostri problemi, quell’immobilismo che impedisce di
impostarli”. Come no. Giri 4 pagine, e Playboy consiglia di andare al cinema,
esce "Il conte Tacchia", con “Ania Pieroni, seno diotibenedica”.
Il paginone centrale è di
Marianne Gravatte, e la vedi nuda e ti cade la mascella: peccato che su Playboy
'83 le playmate parlino, e dobbiamo sorbirci scemate quali “sono timida: non
confesserei mai a Clint Eastwood che mi piace da impazzire. Però gliel’ho fatto
sapere”. Vi dicevo che in Italia mai cambia niente, e il 1983 è il centenario
della nascita di Mussolini: come non omaggiarlo?
E come se il mondo non fosse
nel 1983 preda di altri accadimenti, e come se la Storia del mondo non andasse
avanti, ma l’Italia è immobile e bendata a bearsi di un passato oggettivamente
orrido apposta sublimato per farcela credere, che come nazione vale ed è
migliore degli altri: il fatto è che agli altri dell’Italia è puntuale fregato
il giusto, ovvero un beato caz*o (tanto è quanto contiamo politicamente nel
gioco del mondo) sicché, il reale timone politico sta altrove, e noi a
gingillarci con Gian Carlo Fusco che ci spiega come Mussolini si sia eretto una
immagine a scia di Napoleone. Nientemeno.
Contenti i lettori, che nel
1983 ridono con Forattini e le sue vignette di Spadolini triocaz*to, e possono
scoprire qual è l’uomo ideale della donna yuppie: diatriba che Playboy affida a
Erica Jong, e va evidenziato che Playboy era intellettualmente al resto varie
spanne superiore (in questo numero, Erica Jong, e Al Goldstein – inarrivabile,
dio santo – Benedetta Barzini, Isabella De Paz, e una Marina Lante Della Rovere
che parte micidiale sulla morte delle discoteche ma poi occupa metà del testo a
far marchetta del suo libro in uscita "I miei primi 40 anni"), e allora, benché
io mal regga Erica Jong in generale ma più in questa sua fatua e vanitosa
inchiesta sull’uomo ideale, ecco che i lettori di Playboy possono sapere per chi
spasimano alcune bellezze 1983.
Che inflessibili spasimano per
l’uomo di potere, i poveracci che si impicchino alle loro voglie, mai avranno
chance. Seguono siffatte leziosità: Viola Valentino l’uomo perfetto “l’ho
trovato e sposato: è Riccardo Fogli”. Paola Pitagora sviene per “Eugenio
Scalfari, lo trovo proprio attraente”. Isabella Biagini fa la fusa a “Marcello
Mastroianni, con quella sua aria da cane bastonato dalla vita”.
Se i peni del 1983 si alzano e
si mettono in allegria con Shannon Tweed (e qui la differenza la fanno i
fotografi, maestri, altro che Instagram, altro che filtri: digitate "George
Hurrell", poi fatemi sapere), Playboy non lascia i clitoridi a secco, e dove
posano occhi e mani tra le gambe le donne del 1983?
Su "Occhi azzurri rosso
shocking", titolo del ritrattone che Annamaria Rodari fa di Lucio Magri.
Ritratto corredato da foto non posate ma da intellettuale pensoso con cui “più
d’una peccherebbe”.
Leggerlo è grottesco, e a dir
poco. È il 1983, e siamo in pieno riflusso, le italiane non sono più in strada a
manifestare ma in casa buone in cucina a far le torte ("Repubblica" docet) per i
loro mariti… e a sognar un Lucio Magri che brutto no non era, anzi, ma su
Playboy ci si genuflette a scrivere, testuale, della sua “faccia innocente nel
sonno, ciglia a ombreggiare le guance”, “Lucio ordina, mi affretto a obbedire”,
“è monogamo nei grandi amori”, “Magri non è soltanto un bellone, è sexy, sai,
quella cosa un po’ torbida…”, “è un romantico lucido”, “appare disarmato a una
donna, lui intenerisce i sassi”.
E c’è di peggio: secondo la
giornalista Silvia Giacomoni, moglie di Giorgio Bocca, “Magri porta mutande seta
misto cachemire, con colorini naturali, calde, perché lui deve avere le chiappe
un po’ fredde”. E però per la sinologa Renata Pisu, “Magri non porta mutande:
lui è uno di quelli che per nessuna ragione al mondo accetterebbe di restare in
mutande”.
Elogio del “divo” Giulio,
del Parlamento e dei giornalisti liberi. Massimo Fini ha scritto sul Fatto
che Andreotti «in qualsiasi altro Paese sarebbe stato un grande statista».
Francesco Damato su Il Dubbio il 15 gennaio 2023
Massimo Fini, un giornalista e
scrittore fra i più urticanti, della cui pur scomodissima collaborazione ho
avuto il privilegio di godere negli ormai lontani anni della direzione
del Giorno, è ciò che soleva dire il compianto Giovanni Malagodi, che ne
produceva nei tempi liberi dalla politica: i buoni vini migliorano invecchiando.
Sulla strada ormai degli 80
anni è capitato a Massimo di condividere una fila postale con Stefano
Andreotti, il secondogenito del “divo Giulio” nato esattamente 104 anni fa e
morto quasi da dieci, dopo essere stato sette volte presidente del Consiglio,
non ricordo più quante volte ministro, una volta capogruppo della Dc alla
Camera, e un’altra volta quasi candidato al Quirinale, nel 1992, mai segretario
del suo partito, non si è mai capito bene se per scelta o per mancanza
d’occasione. E infine imputato eccellente di associazione mafiosa e di omicidio,
assolto per l’una e per l’altro. Pazienza se an- cora oggi l’accusatore ormai
pensionato Gian Carlo Caselli sostiene, ogni volta che qualcuno gliene dà il
motivo scrivendo appunto delle assoluzioni, che quella per mafia vale poco o
niente per via della prescrizione che avrebbe risparmiato al senatore a vita -
altra carica collezionata da Andreotti - la condanna per fatti, conoscenze e
quant’altro risalenti a prima del 1981.
La casuale condivisione di
quella banale fila postale col figlio, che neppure conosceva ma di cui ha
scoperto il nome sentendolo pronunciare dall’impiegato allo sportello, ha
felicemente rinverdito nella memoria di Massimo Fini il ricordo del padre. Nel
quale egli si era imbattuto giovanissimo in un ippodromo romano facendogli
cadere gli occhiali e aveva poi avuto modo anche di intervistare da giornalista
cominciando ad apprezzarne acume, gentilezza, puntualità, cultura, ironia e
altro ancora. Tanto da fargli scrivere, a conclusione di un articolo pubblicato
il 12 gennaio sull’insospettabile o sorprendente, come preferite, Fatto
Quotidiano diretto da Marco Travaglio che Andreotti «in qualsiasi altro Paese
d’Europa sarebbe stato un grande statista. Da noi è stato uno strano ircocervo:
mezzo statista e, forse, mezzo delinquente». Un enigma, avrebbe detto Winston
Churchill.
Non poteva scrivere meglio il
buon Massimo, e fare uscire sul suo giornale il pur meno buono Marco per quella
mania che ha, fra l’altro, di storpiare nomi e storie di persone non gradite
pensando di fare solo dell’ironia.
C’è tuttavia qualcosa
dell’articolo di Massimo Fini che al pur compiaciuto - per il resto - Mattia
Feltri non è piaciuto scrivendone nella sua brillantissima rubrica quotidiana
sulla prima pagina della Stampa. È il sollievo espresso da Massimo di non
essergli mai capitato di seguire la politica frequentando le Camere nelle fila,
diciamo così, della stampa parlamentare. Dove io e altri abbiamo evidentemente
sprecato sessant’anni della nostra via professionale.
Lo spazio percorso da noi
poveri sfortunati, a dir poco, è stato definito da Mattia, che lo bazzica senza
le lenti del qualunquismo, «il chilometro quadrato più onesto d’Italia», essendo
il Parlamento «popolato da gente con un senso dello Stato e delle istituzioni e
con un rispetto delle leggi e del ruolo disastrosamente bassi, ma molto più alti
che nel resto del Paese». Egli ha citato a testimonianza delle sue convinzioni
le consolanti sorprese confidategli da alcuni grillini arrivati a Montecitorio e
a Palazzo Madama con la convinzione di dovere risanare chissà quali fogne,
cominciando col ridurre i seggi parlamentari per velocizzare pulizie e
quant’altro. Ah, il qualunquismo, malattia infantile o senile, come preferite,
del moralismo sparso fra piazze, scuole, associazioni più o meno culturali,
redazioni di giornali e tribunali, in un miscuglio di ipocrisia e infamia.
È inutile poi stupirsi
dell’assenteismo elettorale, dei giornali che vendono sempre meno copie, per
quanto infarciti di antipolitica, e di edicole che chiudono, tanto poco ormai si
ha voglia in Italia di essere informati. Gli stessi strumenti elettronici
vengono compulsati spesso, o maniacalmente, da ragazzi, giovani e anziani più
per giocare che per sapere o conoscere.
Nuoce gravemente al senso
del ridicolo. L’italianità a tutti i costi, le etichette salutiste sul vino e
Dante conteso tra destra e sinistra. Guia Soncini su L’Inkiesta il 16
Gennaio 2023.
Sembra di essere tornati ai
tempi della Lega con le ampolle dell’acqua del Po. Non sarebbe italiana la
scritta «cancerogeno» sui vini, la farina di cavallette o l’uso dell’inglese. In
compenso è molto italiano l’Alighieri. Ma forse più di lui lo è Aboubakar
Soumahoro nel suo mix di vittimismo, mitomania e feticcio della proprietà
immobiliare
Si parla così tanto di
italianità che sembra di essere tornati ai tempi in cui la Lega era quella delle
ampolle con l’acqua del Po, mica quella di qualunque-cosa-sia-oggi. Si parla
così tanto di italianità che temo la deriva americana: vi prego, conserviamo
quel po’ di senso del ridicolo che non ci fa prendere sul serio la commozione
per l’inno.
La cosa più italiana che c’è è
il vino, sbraitano quelli, furibondi perché l’Europa vuole svelare che benissimo
non fa. Ora, sui «nuoce gravemente alla salute» che forse verranno apposti sulle
bottiglie di barolo ci sono solo due cose da dire, e nessuna delle due è
come-vi-permettete.
La prima è una notazione
estetica: la bruttezza dei pacchetti di sigarette con foto di feti storpi e
metastasi ai polmoni è una roba da arresto. Abbiamo avuto Bernini, e ora abbiamo
pacchetti di sigarette inguardabili e copertine di libri pure peggio. Che fine
ha fatto il senso estetico italiano? Se continuiamo così, cominceremo a scuocere
gli spaghetti.
È evidente che etichette simili
sulle bottiglie di vino farebbero rivoltare nella tomba Giacomo Bologna (era
quello dei vini Braida, lo specifico perché nel carattere italiano c’è anche
avere Google rotto). Potrebbero però far desistere l’incubo d’ogni donna: il
commensale che guarda ispirato la bottiglia e ti domanda riscontro dei sentori
di marasca. Non lo so se ha i sentori, caro, sono distratta dalle foto delle
metastasi sull’etichetta.
La seconda e più importante
questione attiene alla proibizione. Viviamo in una dementissima epoca
montessoriana in cui si è perso il senso di quanto siano attraenti i divieti.
Pensiamo che tutto vada incoraggiato, dal consumo del vino (non fa male, come
potrebbe, è italiano) alle visite ai musei (gratis, anzi vi diamo dei soldi noi
per venirci, e poi facciamo comunicati trionfali sul milione di visitatori non
paganti).
Credete che abbia passato gli
anni del liceo perpetuamente sbronza perché la vodka alla pesca era una
prelibatezza il cui consumo veniva incoraggiato? Ce li ho passati perché, pur
senza appiccicarci etichette, che l’alcol non fosse caldamente raccomandato era
chiaro (era il Novecento, era una società di adulti, non so se ve la ricordate).
Credete che togliendo il
cellulare ai vostri figli torneranno a leggere Stendhal sotto le coperte
illuminando le pagine con una torcia come facevate voi? (Cioè, come faceva
l’immagine di voi che avete con revisionismo autobiografico pittato: in realtà
leggevate Il monello). Noi leggevamo perché non c’era altro da fare, mica perché
eravamo virtuosi. I turisti vanno nei musei perché arrivano nelle città
straniere e non hanno abbastanza uso di mondo da saper cosa fare, mica perché
sono intellettuali.
I musei a pagamento sono pieni
in tutto il mondo. I concerti, ultimo passatempo culturale per cui perfino la
borghesia più ignorante d’Europa è disposta a pagare, sono tutti esauriti, e
hanno biglietti da cento euro. I teatri, dove si entra con quindici euro, sono
vuoti. Il cinema, dicono gli zelanti commentatori dell’internet locale, costa
troppo: per quello la gente non ci va. Negli Stati Uniti ci vanno e costa il
doppio, però. Rai3 ha trasmesso un documentario sulla comicità anni Ottanta.
Dentro c’è un Benigni di quarant’anni fa che parla delle ottomila lire che costa
il biglietto del cinema. Pensiamo possa costare lo stesso quarant’anni dopo?
«Gratis» non funziona. «Gratis»
significa che non vale niente (lo so: quest’articolo lo state leggendo gratis;
spero che almeno ve ne vergogniate un po’; è altresì vero che il fatto che sia
gratis gli permetterà di raggiungere qualcuno che mi scriverà che si scrive
«vergognate», senza «i»: tutti italianisti, oltre che tutti sommelier).
Ma torniamo all’italianità, al
carattere di chi non vuole pagare neanche il biglietto per “Top Gun”,
figuriamoci quello per vedere i quadri di gente morta. Non è italiana, ho
appreso nelle ultime settimane, l’etichetta «cancerogeno» sui vini, ma neanche
la farina di cavallette o l’uso della lingua inglese; in compenso è molto
italiano Dante, conteso tra gli «era dei nostri» di destra e di sinistra.
Scusate, ma persino io, che al
liceo ho passato più tempo a limonare che a studiare, mi ricordo che Dante era
in esilio; me lo ricordo perché ogni volta che mi pare di non avere abbastanza
tempo e concentrazione per scriver le mie stronzate penso: quello ha scritto la
Divina Commedia da latitante.
Persino io mi ricordo «non
donna di province, ma bordello», detto del paese a forma di scarpa in cui ci
troviamo ad abitare. Mi distraggo un attimo e Dante mi diventa patriota. Chiara
Ferragni, invece, l’italiana più famosa nel mondo, evidentemente
antipatriottica: la scritta femminista sulla maglia che indossava all’annuncio
sanremese era in inglese.
Certo, bisognerebbe spiegare
che gli involtini primavera li mangiamo anche se non li cucinavano le nostre
nonne e l’inglese è un esperanto senza il quale dove vuoi andare, in questo
secolo; ma è difficile spiegarlo a gente che abita nei ministeri romani, in una
città che considera il sushi un’esotica novità.
«Onorevole, vada avanti»:
qualunque politico in difficoltà nella storia d’Italia ha giurato a qualche
intervistatore che la gente lo ferma per strada per dirgli questa frase. Non
importa se sia vero o no: importa che l’ultimo cui l’ho sentita riferire è
Aboubakar Soumahoro, nello studio televisivo di Floris. Ha anche detto che i
detrattori ce l’hanno con lui perché ha comprato casa, «vi andavo bene fin
quando vivevo nei sottoboschi e pagavo un affitto». In quanto affittuaria (in
quanto sottobosco) dovrei offendermi, ma sono invece lieta d’aver trovato la
risposta definitiva alla questione. Il carattere italiano, quello fatto di
nebulosità etica, vittimismo, mitomania, e feticcio della proprietà immobiliare,
quel carattere lì è incarnato dal Soumahoro molto più di quanto lo sarà mai
dall’Alighieri.
Delatori.
«Dipende». Il whistleblowing all’italiana, e i
soldi sprecati per andare a studiare ad Harvard. Guia Soncini il 7
Dicembre 2023 su L'Inkiesta.
Il portale delle denunce quasi anonime di Gedi e i
surreali presidi delle principali università americane, secondo le quali
l’incitamento al genocidio degli ebrei non vìola codice di condotta, al
contrario di sbagliare un pronome
L’altro giorno, nella casella dei messaggi
ricevuti su Instagram, ce n’era uno oscurato. L’interfaccia mi diceva che
l’avevano nascosto in base alle hidden words che mi ero scelta, alle parole da
cui voglio essere protetta.
Ovviamente, non ho mai scelto parole che non
voglio vedere: me ne vengono in mente molte, e non credo siano le stesse che
Instagram potrebbe mai immaginare io ritenessi offensive, ma non gliele ho mai
segnalate, e quindi la scelta che avevano fatto era arbitraria e, immagino,
generalista statunitense. Il messaggio conteneva quindi una parola che perlopiù
la sensibilità americana ritiene offensiva.
Tenete a mente questo delizioso aneddoto
incompleto: più tardi vi svelo come va a finire. Prima, giacché stamattina mi
sono svegliata filosofa, chiediamoci: che cos’è una molestia? Cosa costituisce
molestia? È una questione talmente soggettiva che persino chi stabilisce i
termini per definirla poi è costretto a riadattarli di volta in volta.
Ieri ce n’erano due esempi interessanti. Uno è un
portale di segnalazioni creato internamente da Gedi, il gruppo editoriale di,
fra gli altri, Repubblica e Stampa. È un portale di whistleblowing, giacché gli
italiani non sanno chiedere una bistecca al sangue in inglese ma gli piace usare
parole impronunciabili (mai lezione fu meno appresa di quella di «jobs act»).
È un portale dove i dipendenti del gruppo
editoriale possono denunciare al gruppo stesso casi di molestie o soprusi subiti
da altri dipendenti (il che significa che noi ex collaboratrici di Repubblica
non possiamo compilare una scheda dove dire che il tal caposervizio ci aveva
messo una mano sul culo: un’altra grave discriminazione dei liberi
professionisti in questa nazione fondata sul posto fisso. In realtà le regole –
policy, si chiama sul portale – dicono che anche «i titolari di un rapporto di
collaborazione» possono fare segnalazioni, ma poi in pratica non puoi accedere.
Direzione risorse umane di Gedi, mandami un codice d’accesso: è per completezza
letteraria, mica per fare casino).
Gedi non ha aperto il portale per un esperimento
situazionista volto a far implodere l’azienda e liberare John Elkann dai passivi
di bilancio: c’è un decreto legislativo, in vigore da quest’anno, per le aziende
con più di duecentoquarantanove dipendenti, e dal 17 dicembre anche per le
altre, che dice che devi dare modo ai lavoratori italiani di fare quella cosa
che non sanno pronunciare, il whistleblower.
In lingua mia: di parlar male dell’azienda con
l’azienda, non solo coi congiunti. In lingua loro: «A seguito del decreto
legislativo 24/2023 riguardante la protezione di persone che segnalano
violazioni del diritto dell’Unione Europea».
Se c’è una legge immagino che di portali così ne
abbia o ne stia per avere uno ogni grande giornale e ogni tv, dal Corriere alla
Rai, e immagino si somiglino tutti; ma io ho visto solo quello di Gedi, e mi
attengo a quel che c’è lì.
La prima persona che mi ha parlato del portale
Gedi mi ha detto che, dopo un paio di settimane dall’attivazione, era «già pieno
di segnalazioni di molestie sessuali», ed era chiaramente una proiezione: dal
portale puoi fare una segnalazione o controllare che esito abbia avuto una
segnalazione che hai già fatto, ma non vedere quelle altrui, non verificare in
quante abbiano già detto che Tizio Caio ha toccato loro il culo (sarebbe
peraltro uno scintillante reality, lo sputtanamento di Tizio Caio: John Elkann,
pensaci).
Andandone a guardare le parti pubbliche, ho
trovato due dettagli interessanti. Una è il concetto di anonimato, che come
sappiamo è fondamentale per chi fa la spia e non è figlio di Maria, rivisto
all’italiana.
Tu segnali, la segnalazione viene ricevuta da
«personale specificamente formato» (altro reality promettentissimo: John, quante
idee ti regalo oggi), e colui che nelle linee-guida viene chiamato, maiuscolo,
il Responsabile (una non vorrebbe dire «orwelliano», ma la costringono), colui
che ha in carico la tua segnalazione, non può sapere chi sei. O quasi.
«Se hai indicato il tuo nome, o se invii la
segnalazione come utente registrato, la tua identità resta nascosta anche al
Responsabile, che comunque avrà la facoltà di visualizzarla se lo riterrà
necessario». Denuncia pure serenamente: sei anonimo, a meno che non decidiamo
che tu non lo sia più.
L’altro dettaglio che mi ha fatto riflettere è:
cosa puoi denunciare? Copio dalle linee guida: «Il whistleblowing non riguarda
le lamentele di carattere personale del segnalante». Cioè pensano che in questo
secolo ci sia qualcuno che denunci qualche comportamento che prescinda dalle sue
antipatie? Vaste programme.
«Le condotte illecite segnalate devono riguardare
situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a
conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo
rivestito. Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono
invece essere considerate meritevoli di tutela». Scusate, ma qual è la
differenza tra «indirettamente» e «sospetto o pettegolezzo»? Se chiedete a me e
a Truman Capote e ad Alfonso Signorini diamo tre risposte diverse (due, essendo
Capote non più abile alla conversazione).
Quindi è una molestia se è capitato a me proprio a
me solo a me, ma tuttavia non dev’essere di carattere personale. Siamo dalle
parti del comma 22. E non è una molestia in quali casi? Le eccezioni di Gedi
sono diverse da quelle di Harvard?
La seconda storia viene da quel luogo un tempo
garanzia di livello intellettuale che sono le più prestigiose università
americane. «Proprio uno da Mit», Massachussetts Institute of Technology, è
ancora un modo comprensibile a tutti di dire che Sempronio non è proprio un
cervellone. In Italia per la formulazione d’una simile antifrasi potremmo usare
solo la Normale di Pisa: il vantaggio delle università italiane è che perlopiù
non ci siamo mai illusi che fossero luoghi da cui potessero uscire altro che
cialtroni che restando saldamente analfabeti prendevano tutti trenta.
In America, invece, è con un certo stupore che si
scopre che, dalla pandemia, Harvard sta dando tutti 30 a tutti, e ci s’interroga
se sia il caso di mettere un limite ai voti alti (lo fece già Princeton). Nelle
stesse ore della notizia dei 30 politici, Felicity Huffman, che per aver
pagato per falsificare i voti del test d’ingresso all’università della figlia si
è fatta addirittura qualche giorno di galera, ha detto che la truffa le era
sembrata «l’unico modo di garantire a mia figlia un futuro».
Vivi nel secolo in cui chiunque abbia avuto
successo professionale, da Mark Zuckerberg in giù, l’ha fatto mollando gli
studi. Perdipiù sei un’attrice famosa sposata con un attore famoso: veramente
pensi che se tua figlia non entra alla facoltà di teatro (sì, studia quello) il
suo futuro sarà rovinato e finirà a lavare i piatti in un ristorante messicano?
È incredibile quanto la reputazione d’un’istituzione possa sopravvivere al suo
declino.
Mentre Harvard distribuiva tutti 30 neanche fosse
il Dams, e Huffman la feticizzava comunque, c’è stata un’audizione parlamentare
con alcuni minuti molto interessanti. Dati i, come dire, peculiari comunicati
che gli studenti di Harvard e altri giovani virgulti hanno firmato da quando è
iniziata la guerra tra Israele e Hamas, il Congresso americano ha convocato le
tre presidi del Mit, di Harvard, e di Penn (l’università della Pennsylvania).
La domanda che la deputata Elise Stefanik ha posto
a tutte e tre era così semplice da costituire un perfettissimo sketch dei Monty
Python: invocare il genocidio degli ebrei vìola il codice di condotta
dell’università in materia di molestie e bullismo? Le tre sventurate sono
concordi nel far sembrare Stefanik un gigante del pensiero rispondendo: beh,
dipende. (Vi vedo che canticchiate: da che punto guardi il mondo tutto dipende).
Dipende dal contesto, dipende dalle azioni. Beh,
no, non dipende dalle azioni, s’infervorava la Stefanik, senza misteriosamente
formulare le due obiezioni più ovvie.
La prima delle quali riguardava l’affermazione
delle tre signore sul diventare l’invocazione di genocidio un’infrazione «se
sconfina nei fatti»: cioè se diventa in effetti genocidio? Ma, pulcine, se
diventa genocidio è appunto genocidio. È se restano parole, che violano quelle
puttanate che vi siete inventati: il bullismo, le microaggressioni e tutte
quelle linee guida per cui, se ho capito bene, non posso osare dare per scontato
che tu vada declinato al maschile se hai la barba, ma posso dirti «sporco
giudeo» e Harvard mi assolverà per la legge del dipende.
La seconda è: siete per caso diventate Soncini?
(Voglio ben sperare che la mia produzione letteraria sia un punto di riferimento
per il Congresso degli Stati Uniti). Avete deciso che la libertà d’espressione o
è estrema o non è? Perché però allora vale per tutto, dai trans ai musi gialli,
mica gli ebrei sono figli della serva ma tutti gli altri bisogna stare attenti a
non ferirli.
Non vi sarete, spero, già dimenticati del
messaggio che Meta, multinazionale che ha reso miliardario uno che ha mollato
Harvard senza laurearsi, ha nascosto dalla mia inbox di Instagram. Il messaggio
veniva da una che mi aspettava invano dal parrucchiere, e diceva: «Qui ci sono
solo dei cinesi che giocano coi cellulari». Quindi «cinesi», per i parametri di
bullismo e molestie e microaggressioni della California, è una parola
indicibile.
Ma, poiché abbiamo stabilito che la molestia è un
concetto elastico e personale, io a questo punto vorrei sapere: c’è un portale
del whistleblowing di Meta? Vorrei segnalare che sono stata microaggredita dalla
loro interfaccia che mi occulta i cinesi e ostacola lo scambio interculturale.
Complottisti.
Perché in Italia l’unica
ideologia che resiste è quella dei complottisti. Il buon risultato dei no
vax in Friuli Venezia Giulia è solo l’ultimo segnale. Perché l’idea di un potere
forte che attenta alla libertà del popolo si nutre di teorie pericolose. Dalla
grande sostituzione al gender fino al “complotto delle città dei 15
minuti”. Simone Alliva su L’Espresso il 4 Aprile 2023
Si sono candidati alla guida
del Friuli Venezia Giulia, regione frontaliera a statuto speciale, luogo
privilegiato da cui far politica in Italia e in Europa. E sono stati loro la
vera e unica sorpresa di queste elezioni. Tra i punti del programma: «No al
biolab modello Wuhan in FVG», «No all’obbligo vaccinale», «No all’imposizione
del gender», «No agli insetti», «No alla truffa dell’Euro». È la lista del
dissenso “Insieme Liberi”, che ha sostenuto Giorgia Tripoli avvocata no vax
spinta da Italexit per l’Italia, Movimento 3V, Movimento Gilet Arancioni, Popolo
della Famiglia, Sindacato Popoli Liberi e altre sigle anti-sistema. Tripoli, ha
sorpassato il Terzo Polo portandosi a casa il 4,6% dei votanti ed entrerà in
consiglio regionale. La lista, invece, non ha superato la soglia di sbarramento
del 4%. Ieri sera Tripoli ha annunciato che chiederà il riconteggio delle
schede.
Ma resta un altro segnale
dell’inarrestabile discesa in politica dell’ideologia del complotto che, spinta
dallo scoppio della pandemia, esce dalle chat, attraversa le piazze e cerca un
posto nelle stanze dei bottoni.
L’Italia non è immune dal
fascino delle teorie cospirazioniste. A voler affidarsi ai dati, il barometro
della fiducia del rapporto Edelman 2023 – un’indagine globale giunta alla sua
ventesima edizione e condotta in 26 Paesi – colloca il nostro, insieme agli
Stati Uniti, tra i sei più polarizzati: più un Paese è polarizzato, più è facile
che attecchiscano teorie del complotto. La polarizzazione, le incertezze per un
potere opaco e sfuggente scorrono nelle vene della nostra storia: Ustica, le
bombe sui treni, il terrorismo rosso e nero, i misteri e le molte verità negate.
E in un passato recente è stato il Movimento Cinque Stelle il partito che più di
ogni altro ha incorporato il complottismo nella sua propaganda: i microchip e le
scie chimiche dell’ex deputato Paolo Bernini, il «falso allunaggio» dell’ex
sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, o il tweet dell’ex senatore Elio
Lannutti che rilancia con nonchalance i Protocolli dei Savi di Sion (diffusi
dall’Ochrana, la polizia segreta russa zarista, per fomentare l’antisemitismo e
causare pogrom contro gli ebrei).
«Tutti noi crediamo o abbiamo
creduto in una teoria del complotto almeno una volta nella vita», spiega a
L’Espresso, Caterina Suitner, docente di Psicologia dello sviluppo e della
socializzazione dell’Università di Padova. «Certo, siamo tutti pronti a negarlo.
Ma poniamoci una domanda semplice: esiste nella nostra società, un gruppo di
persone potenti che si mette in accordo più o meno segreto, per fare interessi
personali a scapito di altre persone? Chi può rispondere di no? I complotti
esistono, in effetti. Ci sono persone però che interpretano i fatti reali
secondo una lente complottista, che è ben diverso. Lo fanno perché i complotti
strizzano l’occhio a bisogni psicologici chiari, epistemici come il bisogno di
comprendere la realtà. Spesso è più facile che le persone inforchino le lenti
del complottismo trovandosi di fronte a nessuna alternativa. Pensiamo a tutte le
teorie che gravitano intorno all’origine del Covid».
Le ricerche e gli studi più
recenti dimostrano inequivocabilmente che il complottista può essere più o meno
chiunque. Non esiste un identikit. Chiunque - in una o più fasi della sua vita -
ha creduto ad almeno una teoria del complotto o meglio, come si dice in gergo, è
caduto «nella tana del Bianconiglio» dove la logica non trova spazio e nulla è
quello sembra veramente.
Per Suitner, «un terreno molto
fertile ha a che fare con l’insicurezza: quando ci sentiamo in pericolo e non
abbiamo il controllo, avere un capro espiatorio ci fa sentire meglio. E poi c’è
il bisogno sociale che ha a che fare con il bisogno di sentirsi parte di un
gruppo, ascoltati, trovare un posto nella società».
Il seme del complottismo viene
coltivato nella sordità ostile della politica che consente ad altre forze di
riscattarla.
«Il fenomeno non è nuovo, la
tendenza degli ultimi anni è stata accelerata dalla pandemia che ha portato alla
progressiva normalizzazione della teoria del complotto», spiega Leonardo
Bianchi, giornalista e grande esperto di complottismo, in libreria
con “Complotti! Da Qanon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto” (Minimum
Fax). «Se fino a qualche anno fa queste ideologie erano completamente relegate
ai margini politici, con il tempo, sulla scena italiana, hanno preso sempre più
quota dentro i partiti della destra».
«È il caso della teoria della
grande sostituzione etnica dei popoli europei da parte di popoli non
europei. Teoria di estrema destra che nel corso degli ultimi dieci anni è sempre
più centrale nella narrazione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini». Le teorie più
in voga arrivano dal mondo anglosassone, sono piani di dominazione globale
architettati da presunte élite o poteri forti: «Pensiamo alla teoria del grande
Reset: sosteneva che la pandemia fosse un’emergenza pianificata da Bill
Gates e George Soros per imporre una dittatura tecno-sanitaria e togliere i
diritti fondamentali». Le teorie sono come un gioco di scatole cinesi, vivono
una dentro l’altra, una con l’altra in un continuo richiamo di analogie: gli ufo
che ci controllano, il gender nelle scuole, l’Europa che vuole farci mangiare
insetti. Nel mirino cospirazionista da poco tempo le “città dei 15
minuti” teorizzate dall’urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, rese popolari
dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo e paventate in campagna elettorale a Roma
dal sindaco Roberto Gualtieri. L’idea di una città a misura, meno trafficata e
inquinante, incentrata sulla vita di quartiere, viene raccontata come un
complotto di «burocrati idioti e tirannici». In Inghilterra per l’ex leader
della Brexit Nigel Farage è il segnale che «i lockdown climatici stanno
arrivando», mentre su GB News, la versione britannica di Fox News, il conduttore
Mark Dolan l’ha ricondotto a una «cultura della sorveglianza da far invidia a
Pyongyang».
«Le teorie del complotto
evolvono», spiega Bianchi: «La storia che c’è dietro è quella di una lotta “noi”
contro “loro”. Nel 2022 tutti i gruppi anti-vaccinisti, da un giorno all’altro,
sono passati a occuparsi di guerra in Ucraina. All’interno dell’ecosistema
complottista le teorie mutano ma la grammatica resta quella e si adatta al tema
del momento».
Per Jacopo De Miceli, autore
de “L’ideologia della paura” (People), «il complottismo vive di due paradossi:
si alimenta della disaffezione politica che pesca nell’astensionismo e allo
stesso tempo può generare una mobilitazione che avviene in un universo politico
totalmente separato».
De Miceli è curatore anche
dell’Osservatorio del complottismo in Italia e a L’Espresso racconta: «Nel
periodo della pandemia i complottisti sono usciti allo scoperto. Esistevano
anche prima ma non si vedevano. La pandemia ne ha svelato l’esistenza. In un
tempo in cui la scienza si confonde con la politica nasce il complotto: la
prevenzione sanitaria è vista di traverso, quella climatica è ideologia
ambientalista. È stato dato poco peso al fatto che Giorgia Meloni sia la prima
presidente del Consiglio in Occidente che ha sposato la teoria della grande
sostituzione mentre il Times di Londra non l’ha fatto passare inosservato». Ma
l’ideologia della paura non porta divise: «Può esistere un complottismo di
sinistra, pensiamo alla guerra in Ucraina. Ma storicamente il campo della destra
vira di più verso il populismo. Non tutto il populismo è complottista ma tutto
il complottismo è populista. Di fronte al declino delle ideologie c’è il vuoto e
a riempirlo arrivano i complotti. Una volta c’erano le ideologie del comunismo e
del capitalismo, fallite queste, serve una nuova narrazione». È di fronte «al
vuoto» che le teorie si saldano, spiega Bianchi. «Sono in voga le teorie sul
gender che si fondono sull’omotransfobia, ad esempio. Lo abbiamo visto con
Sanremo. Ma nella logica complottista nulla accade per caso e tutto è connesso.
Non è una contraddizione credere a una teoria del complotto che nega la crisi
climatica e alimenta quella no gender, fa parte dello stesso disegno che ti
vuole togliere identità, attaccare la tradizione e portare stili di vita
innaturali disegnati dalle destre che ci portano a comprare macchine elettriche,
mangiare insetti e ci “svirilizzano”. Tutti argomenti slegati tra loro che
afferiscono a sfere diverse della contemporaneità ma omogenizzati nel solito
piano ordito da oscure élite oppure dal Parlamento Europeo». E bisogna stare
attenti, afferma Miceli. «Sembra sempre una scemenza al principio. Giochiamo a
fare gli intellettuali, la sottovalutiamo, poi si arriva all’assalto al
Parlamento come è successo a Capitol Hill oppure in Brasile». In Italia, certo
siamo già oltre, specifica Bianchi: «I partiti di queste elezioni in Friuli, ad
esempio, si posizionano come anti-sistema sono versione un po’ più militante
dell’offerta politica principale, doppioni estremi di parti politiche che hanno
le stesse posizioni ma responsabilità di governo»
Ma qual è l’antidoto? Dove si
trova la “pillola rossa” per usare il gergo complottista mutuato da Matrix, che
ci può far uscire dalla cosiddetta “tana del Bianconiglio” e ritornare a
guardare la realtà per quello che è? «Il debunking sulle cospirazioni è
inutile», sottolinea la professoressa Suitner. «La fatica che usiamo per
dimostrare che sono false funziona molto bene su chi già non ci credeva. Il
complottismo è una ricerca disperata nel tentativo di stare meglio, ammiccano a
questi bisogni ma non li risolvono. Quello che si può fare è lavorare sui
bisogni, far sentire le persone più sicure partecipi, lavorare molto prima.
Quando hanno abbracciato la teoria cospirazionista è già tardi».
Inventori.
Un paese di inventori.
Un Paese di inventori, ma nemmeno poi tanto. L'Italia è all'undicesimo posto al
mondo per richieste di brevetto presentate nel 2022 secondo il report dell'Epo,
l'European Patent Office. Andrea Cuomo il 29 Marzo
2023 su Il Giornale.
Un Paese di inventori, ma
nemmeno poi tanto. L'Italia è all'undicesimo posto al mondo per richieste di
brevetto presentate nel 2022 secondo il report dell'Epo, l'European Patent
Office. Sono 4.864 le domande presentate da aziende e cittadini ingegnosi. Però
il trend positivo originato dalla pandemia, che aveva fatto crescere i brevetti
del 3,4 per cento nel 2020 e addirittura del 6,5 nel 2021, si è interrotto, e
rispetto all'anno precedente c'è stato una calo, pur lieve, dell'1,1 per cento.
Ma soprattutto l'Italia è al quinto posto tra i Paesi dell'Ue, ed essendo il
terzo Paese più popoloso c'è qualcosa che non va: a superarci, infatti, oltre
alla Germania (seconda in classifica con 24.684 brevetti, dopo gli Stati Uniti
con 48.088) e alla Francia (quinta con 10.900) ci sono anche i ben più piccoli
Paesi Bassi (ottavi con 6.806) e la serafica Svezia, che ci precede appena con
5.036. Fuori dai 27 ci supera anche la piccola ma geniale Svizzera (settima con
9.008 richieste). E, ma questa non è una sorpresa, il Giappone (21.576), la Cina
(19.041), la Corea del Sud (10.367) e il Regno Unito (5.697).
Però restiamo un rispettabile
potenza media dell'innovazione, con alcune eccellenze come la Lombardia, che è
dodicesima tra le regioni europee per idee (1.547), davanti all'Emilia-Romagna
(24esima), al Veneto (32esimo), al Piemonte (41esimo), alla Toscana (60esima),
al Lazio (64esimo), al Friuli-Venezia Giulia (90esimo) e al Trentino-Alto Adige
(92esimo). L'Italia è leader in particolare nel settore dell'handling (che
comprende le tecnologie di imballaggio), settore per il quale l'Italia ha
spedito 384 domande di brevetto all'Epo. Seguono i trasporti (che include la
tecnologia automobilistica), che è sceso al secondo posto, con 362 domande, e
poi i macchinari speciali (area ipertecnologica che include le macchine utensili
per vari settori industriali e la stampa 3D), con 355 richieste di brevetto e un
aumento del 9,6 per cento rispetto all'anno precedente. La crescita maggiore è
però quella nel settore farmaceutico con un incremento del 12,3 per cento spetto
al 2021.
Ma lo sfondo è tutto green.
«Stiamo assistendo - dice il presidente dell'Epo Antonio Campinos - a una
crescita solida e sostenuta delle domande di brevetto per le innovazioni verdi,
così come per le tecnologie per l'energia pulita e altri metodi per generare,
distribuire o immagazzinare elettricità. È questa continua spinta
all'innovazione che sta guidando la transizione energetica».
Huawei si conferma al primo
posto per numero di brevetti presentati all'Epo. Al secondo posto si trova LG
(salita dal terzo posto del 2021) e al terzo Qualcomm (che passa dal settimo
posto del 2021). Chiudono la cinquina Samsung ed Ericsson. La top ten comprende
quattro aziende europee, due della Repubblica di Corea, due statunitensi, una
cinese e una giapponese. L'Italia e l'Europa si confermano invece terre di
piccole imprese: è da esse che proviene un'alta percentuale delle domande di
brevetto.
Eugenio Murrali per il “Corriere della Sera” -
Estratti mercoledì 6 dicembre 2023.
Nel 2024 si celebreranno i 150 anni dalla nascita
di Guglielmo Marconi, padre delle comunicazioni senza fili, premio Nobel nel
1909. Sono in programma una miniserie sul grande inventore con Stefano Accorsi e
un museo a cura del Comune di Santa Marinella e di Livio Spinelli a Torre
Chiaruccia, la sua ultima stazione radio. Elettra Marconi, la figlia, ci ha
aperto il suo palazzo a via Condotti per ricordarci chi era suo padre.
Se pensa a lui che parola le viene in mente?
«“Radio”. Perché la comunicazione senza fili ha
cambiato la vita delle persone».
C’è un luogo che glielo fa sentire vicino?
«Il mare. Se vedo il mare, penso a mio padre. Mio
padre c’è dov’è il mare».
Avete viaggiato molto per mare?
«Sì, con lo yacht Elettra. Era la nostra casa.
Navigavamo da marzo a fine novembre.
Quando non lavorava, mi parlava, giocava insieme a
me con l’elettricità».
Come si svolgeva una giornata sull’Elettra?
«Ci alzavamo presto. Papà passava molto tempo
nella sua cabina-stazione radio, piena di valvole, apparecchi, orologi con i
diversi fusi orari. Chiamava lo yacht Elettra “il mio laboratorio galleggiante”.
Diceva: “Senza l’Elettra non avrei potuto realizzare tutti gli esperimenti che
ho fatto”».
Le capitava di aiutarlo?
«Stava creando il radar. Aveva costruito un
apparecchio e posto due boe a distanza precisa, perché l’Elettra potesse entrare
di prua. Chiamava me e mia madre per mettere delle lenzuola bianche intorno alla
cabina del comandante, così che lo yacht procedesse alla cieca, con il solo
ausilio della sua invenzione».
Cosa lo muoveva alla scoperta?
«Voleva che gli esseri umani avessero una vita
migliore».
Anche la radio è nata con questo spirito?
«Sì, la gente di mare diceva “Marconi l’ha
inventata per noi”. Infatti voleva aiutare i naviganti che solcavano gli oceani
senza notizie della famiglia, senza poter chiamare soccorso».
Nelle navi c’erano i «marconisti».
«I Marconi man! Avevano la M sul cappello. Io mi
sono battuta per loro quando hanno voluto sostituirli con i computer, ma non è
servito».
Suo padre aveva previsto il cellulare?
«Nel 1931 inventò il primo radiotelefono per Papa
Pio XI.
Era ancora uno strumento ingombrante, ma diceva
sarebbe arrivato un momento in cui le persone, con “una scatoletta in tasca”,
avrebbero potuto parlare con la fidanzata, la famiglia o con chi avessero
voluto».
Parlava molto con suo padre?
«C’era grande dialogo tra noi. Crescendo ho capito
di avere un carattere simile al suo. Era un uomo retto e pretendeva che anche
gli altri lo fossero. In famiglia era dolce, ma in certi momenti, era molto
concentrato sul suo lavoro. Io ho sempre saputo e rispettato la grandezza di mio
padre. Quando arrivavamo nei porti lo aspettava una folla».
(...)
E l’Italia lo amava?
«È stato un dolore quando ha presentato la sua
invenzione a 21 anni al governo italiano ricevendo indifferenza. Quindi ha
deciso di andare con la madre irlandese in Inghilterra. Lì lo hanno accolto con
entusiasmo, gli hanno fatto mostrare le sue invenzioni, hanno visto che
funzionavano e lo hanno sostenuto. Avevano capito che erano importanti per
l’impero della regina Vittoria».
(...)
È stata testimone anche dei colloqui tra Pio XI e
suo padre.
«Pio XI obbligava mia madre a portarmi alle
udienze private. Mio padre era legatissimo al Papa, al Vaticano, era un uomo di
grandissima fede, credeva in Dio, quell’Essere superiore che gli aveva messo a
disposizione le forze della natura per dare beneficio agli uomini, per salvare
le loro vite, per dare loro la possibilità di comunicare».
Non è scontato per uno scienziato avere questo
rapporto con il divino.
«Mio padre ha offerto al Papa la Radio Vaticana.
Il Pontefice aveva espresso questo desiderio e lui era d’accordissimo, infatti
aveva pensato: “Il Papa dovrebbe avere la stazione radio per parlare al mondo e
dare la benedizione Urbi et Orbi”. Così nel febbraio 1931 è stata inaugurata».
Anche Pio XII ha avuto un ruolo importante nella
vostra vita familiare.
«Eugenio Pacelli era già legato a mio nonno, il
conte Francesco Bezzi-Scali, veniva in questa casa, per dare lezioni di
religione a Cristina, mia madre. È stato il responsabile del matrimonio dei
miei, capì il loro grande amore. Da segretario di Stato mi battezzò e da Papa mi
amministrò la prima comunione e la cresima».
Grazie a Marconi si salvarono molte vite del
Titanic.
«Nel 1912 c’è stata la tragedia. Lui era stato
invitato a bordo del Titanic come ospite d’onore, ma per fortuna non ha preso
parte. Non amava la mondanità. Da New York ha seguito tutta la tragedia, è poi
andato al porto a ricevere i sopravvissuti».
(...)
Era più Marconi l’inventore o era più suo padre?
«L’inventore. Ovviamente era anche mio padre, che
adoravo. Vedevo, però, la sua importanza. Quando è mancato ci è cascato il mondo
addosso. Mia madre ha voluto fossi presente a tutte le commemorazioni che gli
hanno dedicato. Papà è morto il giorno del mio settimo compleanno. Dopo ho
sentito la differenza. Nessuno è stato come mio padre».
(...)
Antonio Giangrande: 25 aprile. Non era guerra
di Liberazione (ci hanno pensato gli Alleati) ma una miserabile guerra civile
per il Potere.
Antonio Giangrande: 25 APRILE. DATA DI UN INGANNO.
COME SI FALSIFICA LA STORIA. LETTERA SEGRETA AI COMPAGNI MILITANTI. MESSAGGIO
CHE CHIARAMENTE INCITA ALL’ODIO E ALL’ANTI-CATTOLICESIMO. La seguente lettera è
stata consegnata dal Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, diretto
da Palmiro Togliatti (1893-1964), ai quadri propagandisti rivoluzionari nel
1947. Rileggendola è facile capire l’odio che ha guidato la mano omicida di
tanti partigiani durante la guerra e nell’immediato dopoguerra.
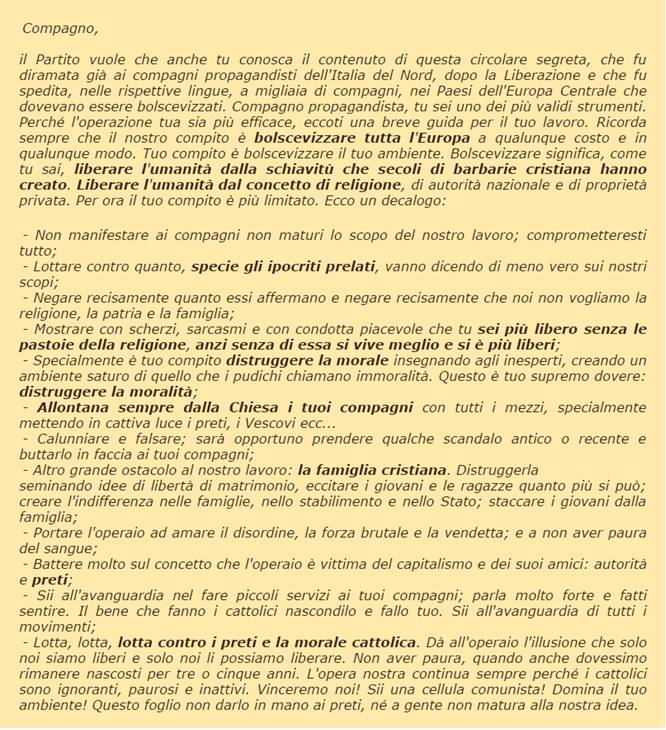
Il rimorso rimosso. Le colpe collettive e la
responsabilità di chi non se ne fa carico. Iuri Maria Prado su L'Inkiesta il
13 Novembre 2023
Attribuire a un popolo i misfatti commessi da
alcuni è ingiusto, ma diventa comprensibile quando quel popolo non si assume la
responsabilità dei crimini commessi dai loro simili
L’incolpazione collettiva è ingiusta e indebita
quando pretende di addebitare ai singoli appartenenti a un gruppo politico,
sociale, religioso, eccetera, e per il sol fatto di tale appartenenza, i
misfatti commessi da altri appartenenti a quel medesimo gruppo. Ma
l’incolpazione collettiva è giusta e dovuta quando i singoli appartenenti a quel
gruppo non si fanno carico morale e civile dei crimini commessi dagli
appartenenti al proprio gruppo, quando non ne sentono il rimorso “in proprio”, e
attribuiscono quei crimini a una responsabilità che non li coinvolge in nessun
modo, una responsabilità dalla quale si assolvono per il semplice fatto di non
aver avuto nelle mani l’ascia del boia.
Imputare agli italiani in quanto tali la
responsabilità delle leggi razziali è ingiusto a un patto: che gli italiani in
quanto italiani sentano il peso in proprio, sulla propria coscienza di italiani,
di quel crimine. Gli italiani non l’hanno mai fatto: non quelli che
festeggiavano le inibitorie e le comminazioni razziste; non quelli che le
lasciavano correre voltandosi dall’altra parte; non quelli – anzi tanto meno
quelli – che sulla scena dei corpi appesi in Piazza Loreto hanno costruito
retoriche e carriere “antifa”, con i cortei che da settant’anni denunciano il
pericolo fascista e pervengono in purezza all’adunata dell’altro giorno, quella
di «Questa non è una piazza fascista! Fuori i sionisti da Roma!».
Questo succede e può succedere per un solo motivo:
perché lo scempio del 1938, che non era una cosa fascista, ma una cosa italiana,
non grava sulla coscienza degli italiani. Per questo ne sono colpevoli tutti,
per questo è giusto e doveroso incolparli tutti: non perché abbiano commesso
tutti quello scempio (questo non succede mai: non ogni turco ha massacrato un
armeno), ma perché non se ne fanno carico, perché non sentono che è la “propria”
vergogna. E ora si confida che l’imbecille non obietti che c’era la resistenza e
che c’erano i partigiani.
Imputare i crimini della soldataglia che tortura e
stupra e deporta i bambini durante l’operazione speciale, e fa dei villaggi
occupati altrettanti lager, e gode della copertura della propaganda che paga e
corrompe per negare lo scempio, imputare tutto questo al popolo cui appartiene
il gruppo di belve è indebito a una condizione: e cioè che gli appartenenti a
quel popolo sentano su sé stessi, sulla propria dignità e sul proprio onore di
esseri umani, la vergogna di quei crimini.
Addebitare ai fedeli di un gruppo confessionale il
gesto dell’inquisitore che appiccia il trono di fascine su cui è issata la
strega, o l’allestimento della buca per l’adultera da lapidare, è ingiusto nel
ricorso di un presupposto: vale a dire se chi si ispira a quella tradizione
sente gravare sulla propria individualità, sulla propria posizione nel mondo,
sul proprio rapporto con la vita, l’atrocità di quei misfatti.
Ho fatto tre esempi, volutamente disparati, tanto
per capirsi. Abbiamo il diritto di non essere incolpati dei crimini “altrui” se
abbiamo il coraggio e la forza di farcene carico come crimini nostri.
È la
persecuzione del singolo in quando appartenente a un gruppo, è questo che è
sempre ingiusto. È questo che occorre impedire sempre ed è questo che occorre
sempre condannare quando succede. Ma non è ingiusto pretendere che il gruppo dai
cui lombi viene il misfatto sia rappresentato da persone che ne sentano la
responsabilità e la denuncino come propria. Perché è in questo, nel denunciarla
come propria, che possono essere assolti.
A proposito di antifascismo...Due appuntini di
storia per il presidente La Russa. Fabrizio Cicchitto su Il Riformista il 27
Aprile 2023
Dopo un 25 aprile segnato da molte polemiche,
alcune delle quali francamente pretestuose (in parte sollevate da alcune
componenti della sinistra) e altre del tutto autolesioniste e controproducenti
(ci riferiamo specialmente a Giorgia Meloni), proviamo a fare una riflessione
partendo dal quadro internazionale quale si presentò alla fine degli anni Trenta
perché esso ebbe aspetti paradossali e anche contraddittori sui quali spesso la
sinistra di origine comunista preferisce sorvolare.
Allora, nel ‘38-’39 si verificò un incredibile
paradosso storico in seguito al quale dobbiamo a Hitler se nel
1941 Stalin e Urss si ricollocarono sul terreno dell’antinazismo e
dell’antifascismo, in seguito alla operazione Barbarossa. Stalin aveva creduto
fino in fondo al valore strategico del patto Ribentrop Molotov da lui concepito
come una alleanza contro le liberaldemocrazie in Francia e in Inghilterra e per
la spartizione della Polonia. Non a caso il Pcf in Francia allora era pacifista
e i comunisti francesi praticavano l’obiezione di coscienza mentre il Partito
comunista d’Italia espulse Terracini e Camilla Ravera che avevano contestato il
patto. Poi, in seguito alla follia di Hitler, dopo il 1941 si realizzò la grande
alleanza antifascista fra gli Usa, l’Inghilterra e l’Urss con le parallele
resistenze nazionali.
Ciò non toglie che, sullo sfondo, accanto alle
liberaldemocrazie in Gran Bretagna, negli Usa e in altri Paesi minori c’erano in
campo due sanguinari totalitarismi, quello nazista con l’appendice italiana
promossa da Mussolini facendo l’asse e quello espresso dal comunismo staliniano.
Allora e dopo, però, quei due totalitarismi hanno esercitato un ruolo
terribilmente negativo nelle aree e nelle nazioni da loro nominate. Di
conseguenza Ignazio La Russa e i suoi amici non possono evitare di fare i conti
con un dato incontrovertibile: non solo Mussolini ha realizzato in Italia una
dura dittatura, per alcuni aspetti meno dura di quella esercitata dal nazismo
in Germania e di quella altrettanto efferata esercitata da Stalin in Russia, ma
egli ha stabilito anche una alleanza subalterna con Hitler che ha avuto due
conseguenze: le leggi razziali del ‘38 e la corresponsabilità dell’Italia
fascista allo sterminio degli ebrei realizzato dai nazisti e il nostro ingresso
in una guerra dissennata alleata ai nazisti.
Tutto si tiene, non si possono estrapolare
le leggi razziali dal regime che le ha espresse. Di conseguenza ovviamente in
Italia la Resistenza non poteva non essere anti nazista e anti fascista. Sempre
non a caso essa ha avuto la compartecipazione di un arco vastissimo di forze
politiche, dai monarchici ai liberali, dai democristiani ai socialisti agli
azionisti ai comunisti. Poi, in questo quadro, ci sono stati per l’Italia due
fatti positivi: l’Italia è stata liberata dagli eserciti angloamericani
coadiuvati dalla Resistenza e non dall’Armata Rossa.
Anche per questo è stato totalmente sconfitto chi
nel Pci avrebbe voluto tramutare la guerra civile tra fascisti e antifascisti in
un’altra guerra civile portata avanti dai comunisti per la conquista del potere
in connessione con l’Urss. Era così forte questa tendenza nel Pci che
nell’immediato essa produsse terribili esperienze come quella portata avanti
dalla volante rossa in Lombardia e anche dopo il 28 aprile fino al ‘47-’48 lo
stillicidio di assasinii perpetrati nei confronti di chi aveva partecipato
alla Repubblica di Salò. Il filo di questa tendenza si è dipanato fino alla
nascita delle Brigate Rosse.
Ciò detto, però, venendo ai giorni nostri, non si
capisce il senso politico della tendenza presente nell’area della destra a
mantenere aperta su questa tematica una tensione polemica tanto inquietante
quanto autolesionista. Purtroppo il clima in Parlamento non è affatto buono.
Solo in occasione del dibattito alla Camera sull’assassinio dei Fratelli
Mattei si sono ascoltate parole di pace, accompagnate da serie riflessioni, ma
abbiamo il dubbio che sia più merito personale di singoli parlamentari (da un
lato Fabio Rampelli, dall’altro lato Roberto Morassut e per parte sua Roberto
Giachetti) che non dei rispettivi partiti e schieramenti. Ma qui veniamo al nodo
politico di fondo. A nostro avviso la permanente agitazione da parte di Ignazio
La Russa e di altri esponenti di Fratelli d’Italia nuoce proprio al nocciolo
duro della operazione posta in essere da Giorgia Meloni il cui senso insieme
politico e culturale è quello di andare oltre lo stesso post fascismo, per
approdare a quel conservatorismo liberale il cui punto di riferimento è Robert
Scroton e il suo manifesto che è coerente anche con la solidarietà con
l’Ucraina, con la collocazione dialettica nell’Unione Europea e con il rapporto
stretto con la Nato.
Allora nei panni della Meloni seguiremmo il
suggerimento che sul Foglio le ha dato Claudio Cerasa e cioè quello di rifarsi
al discorso che Berlusconi fece il 25 Aprile del 2009 a Onna in Abruzzo: “un
impegno che ci deve animare è quello di non dimenticare ciò che è accaduto qui e
di ricordare gli orrori dei totalitarismi e della soppressione della libertà. A
quei patrioti che si sono battuti per il riscatto e la rinascita dell’Italia
deve andare sempre la nostra ammirazione, la nostra gratitudine, la nostra
riconoscenza. I comunisti e i cattolici, i socialisti e i liberali, gli
azionisti e i monarchici, di fronte a un dramma comune, scrissero, ciascuno per
la loro parte, una grande pagina della nostra storia. Una pagina sulla quale si
fonda la nostra Costituzione”.
Attraverso queste parole Giorgia Meloni, senza
abiure rispetto ai valori di fondo di una posizione realmente ispirata al
conservatorismo liberale ma anche senza la schizofrenia di chi non vuole
superare le proprie nostalgie e deludere chi ancora le coltiva, potrebbe gestire
politicamente anche il 25 aprile guardando al presente e al futuro, evitando ad
ogni occasione di essere risucchiata dai richiami di un indifendibile passato.
Paradossalmente in questo modo Giorgia Meloni darebbe un contributo anche
all’opposizione di sinistra che così dovrebbe finalmente misurarsi in termini
di riformismo o, all’opposto di radicalismo, con i problemi reali del Paese
mentre invece, vive di rendita grazie alle escandescenze dei nostalgici agitando
la retorica dell’antifascismo: e neanche questo è un bello spettacolo. Fabrizio
Cicchitto
La polemica della Scala, il teatro dei vandali.
Tommaso Cerno su L'Identità l'8 Dicembre 2023
Non c’è nessuna differenza fra
gli eco vandali che hanno imbrattato col Nesquik la Basilica di San Marco e la
nostra classe politica, il sindaco di Milano Beppe Sala in testa, che fa una
rissa pubblica perché non vuole quella sedia al teatro ma un’altra. E tira in
ballo la storia seria di questo Paese e sciocchezze che valgono perfino meno
delle ragioni di quei ragazzi che in preda a un mondo che dà loro un futuro
incerto si mettono a sporcare monumenti convinti di essere degli eroi. Non
rendendosi conto che invece se fossero degli eroi andrebbero a battersi davvero
per un pianeta più pulito rischiando la loro pelle e non qualche ammenda da
poche decine di euro comminata dal vigile di turno che passa di lì. Non serve
nemmeno immaginare di fare un inno alla violenza seria contro i soprusi dello
Stato come sono state le rivoluzioni, visto che viviamo in un Paese dove se
ammazzi un rapinatore che ha puntato un’arma sulla testa di tuo figlio ti becchi
17 anni di reclusione e 400 mila euro da pagare. Quindi, diciamo che almeno chi
ci rappresenta se viene invitato a scrocco nel più grande teatro del mondo a
sentire Giuseppe Verdi ci faccia la cortesia di tacere, ascoltare e poi
andarsene a casa rispettando con il silenzio quella Costituzione che crede di
difendere blaterando sui social e in televisione le frasi che gli scappano
quella sera per finire sul giornale e contare un po’ di più del suo vicino di
poltrona. È un’Italia arrabbiata quella che vediamo. Arrabbiata perché non
riesce a fare quello che tutti sanno sarebbe nelle sue potenzialità. Non riesce
a darsi un futuro e quindi si rifugia nel passato e ritira fuori a ogni
occasione uno scontro culturale che durante gli anni migliori della Repubblica
era stato superato dalla forza di avanzamento comune della democrazia e da uno
spirito di Patria che non aveva bisogno di atterrare sul simbolo di nessun
partito, anzi che aveva una naturale opposizione a chiunque tentasse di usare il
Paese per propri piccoli scopi particolari. Serve una classe politica capace di
tornare a parlare all’Italia di domani. Perché immaginare anche solo
lontanamente che una donna come Liliana Segre possa essere portata dalle
circostanze o peggio ancora dall’alleanza culturale e politica con una parte del
Parlamento che esprime sfortunatamente anche il sindaco di Milano Beppe Sala,
che meglio farebbe a mettere a posto la sua città e ripulirla dai criminali, a
cadere in una polemica sulla poltrona da occupare alla Scala di Milano
metterebbe fine all’ultimo simbolo di unità che il Paese ha riconosciuto e che
merita solo l’applauso di tutti gli italiani. Siccome sono certo, perché credo
nell’Italia, che non possa essere così preferisco dimenticare quanto ho visto e
sperare che Giuseppe Verdi ancora una volta abbia rappresentato meglio di chi
siede in Parlamento quell’unità nazionale che il Capo dello Stato non si stanca
di ricordare e che sta scritta, quella sì, a chiare lettere nella nostra
Costituzione repubblicana. So che mi illudo perché sono certo che questa
polemica è una delle tante a cui ci abitueremo in questi mesi di campagna
elettorale, però spero davvero che almeno le figure che si stagliano un po’ più
alte per ragioni istituzionali e di vita propria in questa Repubblica un po’
ammaccata contribuiscano con il loro comportamento, come alla fine è avvenuto, a
superare questo drammatico piagnisteo italiano e questa rissa che sembra più una
resa culturale che non un invito a schierarsi e a lottare. Noi non abbiamo
bisogno di coraggio on-line, abbiamo bisogno di persone coraggiose capaci con la
loro testimonianza di dirci che questi ottant’anni non sono serviti a nulla come
invece vuole farci credere quella parte della nostra classe politica che non
riconosce nemmeno nell’avversario eletto dal popolo la derivata democratica
della democrazia italiana che non ha scritto da nessuna parte che deve governare
quello che piace a te ma ha scritto a chiare lettere che deve governare chi
vince le elezioni e che l’unico che può giudicare sul piano della legittimità è
il popolo. Non c’è quindi alcuna differenza fra quella polemica sterile che
abbiamo sentito lordare la prima della Scala e quei ragazzi che, convinti di
dire qualcosa di giusto, anziché bersi qualche litro di Nesquik e trovare il
coraggio e la forza in quelle calorie per combattere davvero chi inquina al
mondo e chi fa i miliardi sulla sua pelle, se la prendono coi simboli più alti
dell’Umanesimo italiano, grandi opere che innocue testimoniano che c’è stato
qualcuno di più grande di loro e che fortunatamente ci sarà anche domani.
Massimo Gramellini provoca la Digos in tv:
"Ecco la mia carta d'identità". Libero Quotidiano il 10 dicembre 2023
Massimo Gramellini come Zoro. Ormai, dopo Marco
Vizzardelli, è partita la corsa a dire "viva l'Italia antifascista" in apertura
di ogni programma. Infatti dopo l'urlo a Propaganda Live è arrivato quello a
In Altre parole, la trasmissione condotta da Gramellini su La7. Nel suo monologo
iniziale, Gramellini non usa giir di parole e afferma. "Forse sbaglio io ma
guardando la foto di chi è andato a vedere 'Comandante' con la divisa nazista a
Spilinbergo mi viene da dire che forse va ribadito 'viva l'Italia antifascista'.
E sapete cosa faccio? Ecco la mia carta d'identità, mi auto-identifico, sono
Massimo Gramellini".
Un gesto che suona come una provocazione contro
gli agenti della Digos che hanno identificato al teatro la Scala il loggionista,
Marco Vizzardelli, che subito dopo l'inno di Mameli ha urlato, in un teatro in
silenzio nell'attesa dell'apertura del sipario "viva l'Italia antifascista".
Come ha fatto sapere la Questrua l'identificazione è una prassi in questi casi,
soprattutto dopo le proteste davanti alla Scala prima dell'inizio del Don Carlo.
Ma a quanto pare Gramellini, come del resto Zoro, fanno finta di non capire e
così rilanciano la campagna del Pd "identificateci tutti". Una sorta di
pagliacciata per cavalcare in chiave antigovernista quanto accaduto alla Scala.
Una retorica superflua che scorda anche il passato. Ovvero quando sotto i
governi di centrosinistra erano stati identificati urlatori della Scala e quelli
di Sanremo. La prova che l'identificazione non ha un colore politico, è solo una
prassi delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza. Con buona opace di
Gramellini.
Annalisa Chirico, "cos'avrebbe dovuto urlare
alla Scala". Libero Quotidiano il 10 dicembre 2023
"Avremmo preferito sentire, che so, un viva la
gnocca, che forse avrebbe avuto una maggiore attinenza con i movimento della
società contemporanea". Annalisa Chirico, ospite di Nicola Porro a Stasera
Italia su Rete 4, commenta sul filo dell'ironia (ma non troppo) quanto accaduto
giovedì sera alla Prima della Scala a Milano.
Il contestatore solitario Marco Vizzardelli, che
all'inizio del Don Carlo, ha urlato "viva l'Italia antifascista" come
provocazione nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa e del
vicepremier Matteo Salvini, presenti nel palco reale del Piermarini insieme alla
senatrice a vita Liliana Segre. "Ero inquietato dalla loro presenza", ha poi
ammesso il melomane, che dice di "odiare il nero" e di essere un "liberale di
sinistra".
"Io ero lì giovedì sera - spiega la Chirico - e
devo dire che quel 'viva l'Italia antifascista' ha messo un po' un filo di
inquietudine. C'erano le autorità dello Stato a teatro, poi alla fine si è
rivelato un personaggio assolutamente innocuo. Io sono contenta e ringrazio la
Digos per aver fatto quello che la legge la obbliga a fare, cioè
l'identificazione di un soggetto potenzialmente sospetto". "No, è una facoltà",
scuote il capo da Bruxelles l'europarlamentare del Pd Brando Benifei.
"Non basta dirsi antifascista per non essere
sottoposto ai controlli della Digos che farebbero a ciascuno di noi, se
gridassimo 'viva l'Italia antifascist' alla Prima della Scala, con il presidente
del Senato in sala, per sapere se è tutto in ordine e se lo spettacolo può
proseguire. E' buonsenso".
Biografia di una nazione. Vacanze italiane e la
mitomania del loggionista senza tv. Guia Soncini su L'Inkiesta il 9
Dicembre 2023
L’uomo che ha guadagnato quindici minuti di
celebrità per aver detto «Viva l’Italia antifascista» alla prima della Scala è
un personaggio vanziniano. Giura di non aver urlato, è solo che ha «una
proiezione di voce eccezionale»
«C’è una mafia giudea che mette spavento». È il
Natale del 1983, Roberto Covelli è tornato da New York dov’è andato a lavorare
nella finanza, la mamma gli chiede come sia la banca americana, e lui dà questa
risposta per la quale, oggi, fioccherebbero gli editoriali e le interrogazioni
parlamentari e tutta la confusione mentale che caratterizza il nostro tempo.
“Vacanze di Natale” è al dodicesimo minuto, e
quella di Christian De Sica non è neanche la prima battuta della quale i
commentatori americanizzati di oggi direbbero «problematic». Se qualcuno avesse
voglia di fare un’inchiesta sulla distanza tra il paese reale e noialtri che
c’indigniamo sui giornali e sui social, suggerirei di andare il 30 dicembre a
intervistare gli spettatori che escono dai cinema dove, per il quarantennale,
verrà riproiettato “Vacanze di Natale”.
Ieri, mentre il paese reale faceva il ponte,
noialtri che popoliamo quello irreale eravamo impegnati a indignarci per le
sorti d’un personaggio vieppiù vanziniano. Il loggionista Marco Vizzardelli, al
cui quarto d’ora di celebrità sono lieta di contribuire: credo nello stato
sociale.
Il Corriere gli fa dire che non ha la tv («L’ho
rifiutata alla prima guerra del Golfo»: sceneggiatori già intenti a scrivere la
scena del televisore che gli si offre, ma Vizzardelli, fermo, lo rifiuta). E che
al “Don Carlo” del 1992 fischiò Muti ma non Pavarotti, «Non fischio i cantanti»
(affermazione di principio invero impegnativa).
Repubblica ci spiega che Vizzardelli «è grande
ammiratore del maestro Claudio Abbado», che «in più di un’occasione aveva
tuonato contro quella che riteneva un’eccessiva sovraesposizione mediatica di
Riccardo Muti» (per distinguerla dalle sovraesposizioni caratterizzate dal non
eccesso), e che si occupa per lavoro di equitazione, «che da trentacinque anni
segue e racconta dalle colonne Equos Trotto & Turf» (improvvisamente
ridimensionato il genio di Richard Curtis: Cavalli e segugi, avrebbe detto Guido
Nicheli, is nothing).
In un momento di sublime italianità, ovvero di
assoluta mitomania, Vizzardelli spiega all’intervistatore (a uno degli
intervistatori: è pur sempre l’uomo del giorno) che lui «Viva l’Italia
antifascista» (sarebbe stato più spiritoso «Viva Verdi», ma l’avremmo capito in
quattordici, tra i quali forse nessuno che potesse dare ordine alla Digos
d’identificare il fellone) mica l’ha urlato.
«È una cosa che ho sentito dentro di me, ma l’ho
fatto con tranquillità e senza urlare. Però il vecchio sovrintendente della
Scala Alexander Pereira diceva di me che ho una proiezione di voce eccezionale».
In futuro il diaframma di ognuno sarà famoso per quindici minuti.
Vizzardelli dice d’essere intervenuto in difesa
della senatrice Liliana Segre, che lo turbava vedere nel palco reale assieme a
La Russa e Salvini (e Sala e Sangiuliano: è ora di finirla di trascurare sempre
gli intellettuali, nelle ricostruzioni).
«Non mi è piaciuto per niente averla vista in
mezzo a quella polemica e ho pensato che qualcosa andava fatto». Nell’intervista
al Corriere è ancora più tranchant: «Mi inquietava la senatrice a vita Liliana
Segre messa in mezzo in quella maniera». In effetti un po’ tutta la vita di
Liliana Segre testimonia l’incapacità della signora di cavarsela, figuriamoci se
può aver deciso lei con chi dividere un palco.
Sulla Stampa ci sono ulteriori virgolettati di
Vizzardelli, tra cui «Sono un po’ sbalordito che abbia risonanza mediatica», che
è un po’ la frase che ti aspetteresti da uno che ha passato la giornata a dare
interviste. Nessuno degli intervistatori gli chiede se, più che in “Vacanze di
Natale”, egli si percepisse un figurante in “Senso” di Visconti, uno dei
loggionisti che facevano piovere fogli tricolore, alla fine del “Trovatore”,
urlando «Viva l’Italia» (era il Risorgimento, «antifascista» non era ancora
aggettivo chiave per entrare in tendenza), irritando gli austriaci che però
lucidamente sintetizzavano: «Ecco la guerra che gli italiani preferiscono:
pioggia di coriandoli con accompagnamento di mandolini».
Mancano inoltre un po’ da ovunque i dettagli di
ciò che tutti vogliamo sapere: chi è il Calboni che ha dato alla Digos l’ordine
di identificarlo.
D’altra parte un mondo che, se Christian De Sica
dicesse oggi che nella banca americana c’è la mafia giudea, accuserebbe lui e i
Vanzina d’antisemitismo, un mondo che non sa più distinguere tra una commedia e
un editoriale, tra una battuta e un dibattito parlamentare, possiamo davvero, in
questo mondo qui, pretendere che i piani li sappiano distinguere gli sbirri,
ultimi dai quali pretendiamo il senso del tono e del contesto? Figuriamoci:
identificheranno uno sciamannato; facendone così, con la sola richiesta della
carta d’identità, un eroe antifascista.
Parentesi: per essere eroe antifascista, nel 2023,
basta talmente poco che la gente lo diviene scrivendosi «antifa» nella bio di
Twitter, o come si chiama ora. La percentuale di volte in cui leggi un tweet,
pensi «ma chi è questo irrecuperabile cretino», vai a guardare la bio e trovi
«antifa» è talmente alta che la domanda che mi faccio più spesso è: ma
l’antifascismo non può fare causa ai Vizzardelli del mondo per danno
reputazionale?
Altra parentesi: ovviamente, se uno ritiene di
dover comunicare il proprio antifascismo al mondo a mezzo note biografiche su un
social network, sarà anche portato a ritenere Vizzardelli – che lo comunica dal
loggione, senza neanche bisogno del wifi – un eroe; e quindi ieri intellettuali
che pensano che stare sui social equivalga a far la resistenza sulle montagne
annunciavano che sarebbero andati negli uffici della Digos a dire «Viva l’Italia
antifascista», pretendendo di venire identificati. Scrivevo di recente che la
Digos dovrebbe occuparsi di cose più serie che degli imbecilli che scrivono
lettere fingendosi docenti della Holden. Aggiungo: cose più serie di uno che
dice cose da un loggione della Scala. Aggiungo: cose più serie di chi trova in
questo uno la sua occasione di celebrità eroica in un pomeriggio festivo che
altrimenti gli toccherebbe trascorrere a fare l’albero.
Da nessuna parte è ricostruita la catena di
comando, quindi, ma sul Corriere ci sono dettagli gustosi: la carta d’identità
di Vizzardelli sarebbe stata fotografata col cellulare di Vizzardelli stesso,
perché ai telefoni degli agenti della Digos non funzionava la fotocamera. Defund
the police, sennò dove li troviamo gli spunti da commedia all’italiana.
Nella versione che dà alla Stampa, Vizzardelli
dice che alla prima richiesta di documenti si è rifiutato di fornirli. È una
ricostruzione simile a quella che giorni fa faceva Christian Raimo su Instagram:
era in treno, gli avevano chiesto i documenti, era un sopruso illegale, voleva
rifiutarsi.
A corredo del suo post, Raimo fotografava
l’articolo 651 del codice penale, che dice che non puoi rifiutarti di dare le
generalità a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Lo faceva
per dirci che non sa leggere? O che abbiamo un codice penale fascista? O che gli
piacerebbe avviare una collaborazione con Trotto&Turf?
Quante domande, mentre io qui
riesco a pensare solo alla parte che farei fare a Vizzardelli nel rifacimento di
“Vacanze di Natale”. Non ho dubbi: Billo, il pianista che, eroe della
contribuzione alla solidità della famiglia tradizionale, quando non suonava
“Maracaibo” si sdraiava le mogli dei villeggianti. Oggi verrebbe cassato dalla
sceneggiatura perché eteronormativo, temo. Gli toccherebbe procurarsi una fama
alternativa, urlando il suo antifascismo in un contesto sufficientemente fesso
da farlo divenire un martire.
Sandro De Riccardis per la Repubblica - Estratti
venerdì 8 dicembre 2023.
“E’ stato un gesto istintivo, nulla di preparato.
Anche se, da frequentatore della Scala, da giorni il mio disagio cresceva.
Soprattutto pensando all’Inno nazionale con un presidente del Senato che ha il
busto di Mussolini in casa”. Marco Vizzardelli ha 65 anni e frequenta la Scala
da quando ne aveva nove. Giornalista, appassionato di lirica e naturalmente
loggionista, ancora non si spiega il tanto clamore suscitato dal suo “Viva
l’Italia antifascista”, urlato alla fine del primo atto dal loggione. “E’ una
frase lapalissiana – dice – sarebbe stato grave gridare il contrario”.
Vizzardelli, quando ha deciso il suo gesto?
“In realtà non avevo deciso nulla. Poteva anche
succedere che non dicevo niente. Ho sentito un altro loggionista urlare “no al
fascismo”. Poi, dopo l’inno, è partito un breve applauso, ed è successo. Ho
gridato “Viva l’Italia antifascista”, ma l’ho detto molto con calma”.
Una cosa istintiva..
“In buona parte sì. Il “Don Carlo” è uno dei miei
titoli preferiti, e anche giovedì mi è piaciuto moltissimo, così ho deciso di
partecipare alla Prima. Ma giorno dopo giorno ascoltavo le polemiche su Liliana
Segre.. dove la mettiamo.. dove mettiamo i politici.. Un vero cancan che non mi
è piaciuto, l’uso della senatrice a vita come scudo umano.. ma non solo
questo”.
Cos’altro la disturbava?
“Inizio a riflettere sul fatto che mentre
eseguiranno l’Inno nazionale, ci sarà un presidente del Senato che ha il busto
di Mussolini in casa. Mi crea disagio, non ce la faccio. Fascismo e razzismo non
li sopporto. Sono stato in coda con tutti questi pensieri in testa. Gli appelli
per i loggionisti durano quasi due giorni, e tutti gli altri vicino a me erano
molto accesi, dicevano che bisognava fare qualcosa, protestare, una protesta
forte. Io cercavo di calmarli, dicevo che non bisogna mischiare tutto e tutti.
La Segre bisognava solo applaudirla, ringraziare che esista, per quel che fa e
quel che è”.
E’ arrivato a teatro senza un’idea precisa,
quindi.
“Pensavo a una cosa mirata e limitata, ma non
avevo deciso niente. Poi sa com’è andata. Una cosa estemporanea. Una donna in
galleria ha urlato “bravo” ed è scoppiato l’applauso”.
Poi è arrivata la Digos.
“A metà del primo atto mi rendo conto che qualcuno
mi gira intorno guardandomi fisso. Ho capito subito che era un poliziotto in
borghese. Poi alla fine del primo atto ha tirato fuori il distintivo, e in
maniera molto cortese mi ha chiesto i documenti”.
Come ha reagito lei?
“Sono scattato subito. “Non vedo il motivo” ho
detto.
(...)
Si aspettava questo clamore?
“Assolutamente no. Sono stravolto, ho dormito
pochissimo, per tutta la notte mi continuava a squillare il telefono, mi
inviavano le foto delle prime pagine dei siti. Non me l’aspettavo. Però era
giusto farlo. Possibile che dire “Viva l’Italia antifascista” crei disagio e
clamore?. C è qualcosa che non va”.
Qualche politico ha reagito.
“Ignazio La Russa, che in fondo poteva essere
l’obiettivo principale, ha reagito con intelligenza. Ha detto di non aver
sentito niente. Salvini ha reagito da Salvini, tirandomi un assist.. Dicendo che
non si urla alla Scala. Dimostra di non conoscere la storia delle proteste che
da sempre ci sono state alla Prima della Scala. Comunque sono molto stupito, non
era quello l’obiettivo, volevo solo comunicare un mio sentire”.
Lo rifarebbe?
Assolutamente si, ma molto serenamente. Sento un
profumino di fascismo e un profumone di razzismo nella classe politica
Da lastampa.it - Estratti venerdì 8 dicembre 2023.
Polemiche sulla identificazione, alla Prima della
Scala di ieri sera, di un uomo che ha gridato «Viva l’antifascismo» ed è stato
identificato dalle forze di polizia presenti. Marco Vizzardelli, il loggionista
che ha gridato «Viva l'Italia antifascista» durante la prima della Scala, è
stato identificato dalla Digos. Non gli è stata contestata nessuna ipotesi di
reato. Vizzardelli è un giornalista esperto di equitazione.
Fiorello ha aperto la rassegna stampa della
puntata festiva di Viva Rai2! parlando della Prima alla Scala: «Ieri ero a
vedere il Don Carlo visto che Mattarella non poteva. Mi ha detto 'ci vai tu?' e
io sono andato e tornato con un aereo privato fornito dal ministero della
Cultura», ha ironizzato. «Sono state 4 ore e 13 minuti di applausi, sono andato
al centro grandi ustionati per le mani...».
Poi la 'rivelazione': «Ad un certo punto, dopo
l'inno italiano, non ce l'ho fatta e ho urlato 'Viva l'Italia antifascista!'. La
Russa ha avuto un mancamento, il sindaco di Milano Sala si è alzato a prendere
un po' d'acqua, la senatrice Liliana Segre gli teneva la fronte mentre il
presidente del Senato diceva 'Liliana, aiutami tu!'».
«Tra l'altro - ha scherzato ancora lo showman -
stanno indagando perché si è sentito un altro urlo fortissimo: 'Viva il Ponte
sullo Stretto!'. Nessuno ha ancora capito chi fosse...'».
«Me lo sono sentito dentro. Direi che lo rifarei,
senza dubbio".
(...) Sono arrivati in quattro durante
l'intervallo: 'Siamo della Digos e vorremmo le sue generalità'. E io: 'Mi sembra
un po' strano'. Loro mi hanno risposto: 'Purtroppo, se gliele chiediamo, è
tenuto a darcele'. Io l'ho buttata in ridere e ho detto: 'Se avessi detto 'viva
l'Italia fascista' giustamente mi avreste legato e portato via'. A questo punto
si sono messi a ridere e poi hanno detto: 'Siamo perfettamente d'accordo con
lei, ma abbiamo dovuto chiederle le generalità'. Ed è finita lì, ma intanto era
successo". Vizzardelli poi aggiunge: "Perché l'ho fatto? Proprio molto
spontaneamente, un segnale mio che mi sono sentito dentro di dire davanti a
queste persone: 'Viva l'Italia antifascista'. Basta, tutto qui. Me lo sono
sentito dentro. Direi che lo rifarei, senza dubbio. Qualcuna delle reazioni me
lo conferma".
Alla domanda se si riferisse alle parole del
vicepremier leghista, Matteo Salvini, che ieri sera ha commentato: «Chi urla
alla Scala è nel posto sbagliato», risponde: «Che onore! Direi che ha fatto
meglio» Ignazio La Russa «che ha detto: 'Non ho sentito niente'. Sono un po'
sbalordito che abbia una risonanza mediatica una frase lapalissiana. Siamo in un
Paese antifascista, la frase è costituzionale».
«Trovo un po' inquietante che io sia stato
identificato, non può non venirmi il dubbio che siamo alla soglia di uno stato
parafascista». Lo ha detto all'ANSA Marco Vizzardelli, che ieri dopo l'inno di
Mameli ha urlato dal loggione 'Viva l'Italia antifascista' alla prima della
Scala per poi essere identificato dalla Digos. «Non sono un pericoloso
comunista, al massimo un liberale di sinistra - prosegue - ma non reggo due
cose: qualsiasi vago profumo di fascismo e qualsiasi forma di razzismo. E ieri
avevo davanti due rappresentanti dello Stato come Salvini e La Russa che su
entrambi questi fronti mi lasciano molto perplesso».
La replica della polizia
L'identificazione di due loggionisti ieri sera
alla Prima della Scala dopo l'urlo "W l'Italia antifascista" fatto prima
dell'inizio dell'opera «non è stata assolutamente determinata dal contenuto
della frase pronunciata»: lo ha precisato, oggi, la Polizia di Stato.
«L'identificazione dei due spettatori presenti in Galleria - spiega la Questura
di Milano in una nota - è stata effettuata quale modalità ordinaria di controllo
preventivo per garantire la sicurezza della manifestazione».
Scala quaranta. La surreale campagna del Pd in
difesa del loggionista antifascista. Mario Lavia su L'Inkiesta il 9
Dicembre 2023
I dirigenti del Partito democratico hanno
costruito una stravagante iniziativa propagandistica, confondendo la barbarie
autoritaria con una (altrettanto ridicola) richiesta di documenti
Quando l’infinitamente piccolo può diventare
enorme. O un fatterello un’epopea. Ci provano i ragazzi del Pd (pardon, le
ragazze e i ragazzi del Pd) che esagerano sempre le loro ragioni, pur
innegabili, strombazzano, strappano le vesti, strepitano, strillano e magari
vogliono essere simpatici. Il Nazareno esagerato appena può si appalesa sui
social, su X, imbrattandolo con presunte campagne mediatiche un po’ puerili, un
po’ scopiazzate, un po’ vittimiste. Facendo di un fatto piccolo una crociata, di
un evento ridicolo una tragedia. Così la nazarenica campagna mediatica di ieri
ha tratto spunto dal grido del cittadino Marco Vizzardelli: «Viva l’Italia
antifascista» (che in sé va benissimo) alla prima della Scala. Gli hanno chiesto
i documenti, i poliziotti mandati da qualche burocrate troppo zelante – una roba
da «Pum pum! Chi è? La polizia!» di Dario Fo – e hanno fotografato la patente, e
poi null’altro di significativo. Apriti cielo.
C’è chi ha parlato di olio di ricino, rendiamoci
conto. Altro che fratelli Rosselli, altro che Giovanni Amendola. «Identificateci
tutti!», è stato l’urlo di battaglia che si è levato dal Nazareno e allora daje
tutti a twittare nome, cognome, luogo e data di nascita, e abbiamo così scoperto
cose grosse, tipo che Giuseppe “Peppe” Provenzano è nato 23 luglio 1982, che la
gioviale Susanna Camusso è nata a Milano il 14 agosto 1955, che la capogruppo
Chiara Braga è nata a Como il 2 settembre 1979, che l’abile Marco Furfaro è nato
a Pistoia il 19 giugno 1980, e così via, c’era pure l’hashtag #identifichiamoci
che ha funzionato abbastanza: d’altra parte X è perfetto per militanti un filino
narcisisti, per nuovi partigiani che confondono la barbarie con una (ridicola)
richiesta di documenti.
Queste sono le botte propagandistiche che fanno
impazzire i dirigenti del Partito democratico, gliela facciamo vedere noi,
«siamo tanti siamo qui/ siamo della Fgci», si gridava quando questi non erano
nemmeno nati. E dunque l’antifascismo non si tocca, ci voleva Vizzardelli a
ricordarlo e i ragazzi del Pd a dargli man forte contro la pula o madama che gli
ha chiesto la patente, iniziativa sgangherata ma forse anche effetto di un clima
sovreccitato anche dalla presenza nel Palco Reale della Scala di Ignazio Benito
La Russa impettito nel suo smoking troppo stretto al quale quel grido era
indirizzato.
«Non l’ho sentito», ha detto il sordo presidente
del Senato che era seduto a un metro della nostra (di tutti) Liliana Segre, la
sola persona che poteva sedersi dove un anno fa stava Sergio Mattarella. Che con
la sua sola presenza La Russa costituisca un problema è ormai un fatto acclarato
che conferma l’arrogante avventatezza di Giorgia Meloni che un anno fa lo volle
sullo scranno più alto di palazzo Madama: e bisognerà sopportare l’onta fino
alla fine della legislatura, non si sa quando, e ci saranno sempre grida e
contestazioni all’indirizzo di chi definì il battaglione Bozen «una banda
musicale». Il problema è che contro Ignazio e i suoi amici servono la politica e
la cultura più che sapere quand’è nata Susanna Camusso. La tragedia che si
trasforma in farsa. Tutto infinitamente piccolo.
Estratto dell’articolo di Natalia Aspesi per “la
Repubblica” il 9 Dicembre 2023
Nel silenzio rumoroso e scicchissimo di una Scala
tutta piena di orgogliosi capelli bianchi, il giorno dell’inaugurazione del 7
dicembre una voce, una sola vocina quasi soffocata, si alza, meschina, dopo
Fratelli d’’Italia: “Viva l’Italia antifascista!” e subito la Digos,
dimenticandosi di colpo che questo sarebbe un Paese antifascista, almeno, ce lo
dice ancora con una certa muffa, la Costituzione, corre a identificare l’ingenuo
eroe.
Da oggi il suo nome sarà segnalato alla Digos, e
forse potremo dire che Vizzardelli Marco, di 65 anni, giornalista di cavalli e
musica, dal loggione del teatro la Scala, il 7 dicembre 2023 è stato segnalato
per antifascismo. Un omino piccolo, per nulla elegante e per nulla eroe.
Pericoloso antifascismo? Bisognerà che almeno per
il gesto scemo dell’altra sera, qualcuno chieda scusa al povero Vizzardelli che
in un notte di pioggia, ha osato dire quel che pensava, quando a dirlo, oggi,
almeno a molti, può essere preso per pericoloso.
Ma davvero? Certo eravamo un po’ angosciati da
quel palco presidenziale, tutto coperto di fiori e mele e altro, ma a rendere il
palco digeribile, l’anno scorso, c’era Mattarella che si prese una tale lunga
ventata di applausi che gli offrivano l’idea che comunque malgrado le elezioni,
la gente stava totalmente con lui.
[...]
Questa volta invece il palco presidenziale era
strapieno e meno male che Mario Monti, abituato da sempre ad andare in platea,
aveva detto no grazie, il mio posto ce l’ho, anche se lui è stato, come sempre
velocissimamente, presidente del Consiglio ed è senatore a vita.
Stretti uno all’altro il sindaco Sala con bella
signora, poi la signora Liliana Segre ancora provata dal trambusto dalla platea
al palco, con figlia, poi Ignazio La Russa con bella signora, dietro ignoti
ministri e altro, e soprattutto Matteo Salvini che nelle foto riusciva a
sembrare in prima fila spingendo la testa in avanti, assieme alla bella
fidanzata, Francesca Verdini, di cui, lo si vede benissimo, è davvero
innamorato. […]
A proposito della senatrice Segre, un gran
fermento c’era stato attorno a lei, per strapparla alla platea e per la prima
volta invitarla nel palco. L’idea era venuta, mi pare, a La Russa, che col suo
accento di puro Paternò molto marcato, furbo come il demonio, sapeva che c’era
la probabilità per lui di eventuali dissensi ai fratelli d’Italia, pur essendo
ovvio che per la seconda carica dello Stato quale è lui, l’eroica musica era
dovuta.
Intanto anche il Sala aveva avuto la stessa idea,
e si era gettato sulla povera signora, che accettando, poi si è presa gli unici
applausi rivolti al palco. Ma era ormai da un mese che attorno al simpatico
antro si muovevano importanti personalità per renderlo accettabile, senza la
presenza benedicente di Mattarella.
C’era chi si odiava chi e non voleva l’altro, chi
trovava che le destre estreme del noioso Salvini erano un eccesso e potevano dar
fastidio a un altro, insomma la messa in sicurezza di quel luogo fiorito e
civettuolo poteva essere teatro di violenti litigi a fior di spada. E tutta
quella fatica erculea da parte di esperti diplomatici del ramo, dopo settimane
di mal di testa e ansia e frustrazione, qual è il risultato?
Una vocina, una sola vocina che da sola ha fatto
accorrere la Digos. Forse non è così, ma ieri il bel pubblico della grande
Scala, anche assieme a un antico giovanotto vestito di foglie d’oro a ricordare
i bei tempi antichi in cui anche le signore arrivavano in pantaloncini bianchi,
parevano contenti, felici di essere lì. La paura di una Italia fascista ci sarà
per un’altra volta.
Subito a cercare momenti grami per la Scala, con
l’aiuto di chi sa tutto del teatro, Franco Pulcini, ma mannaggia, non ce ne sono
stati di clamorosi. Per esempio: Mussolini non venne alla Scala alla prima
mondiale di Turandot, l’ultima opera di Puccini appena morto perché Toscanini
fece sapere che non avrebbe eseguito Giovinezza prima dell’inizio.
Si era nel 1926 e i fascisti se lo ricordarono nel
1931 per reagire al suo solito rifiuto di eseguire gli inni del regime. Il
64enne venne schiaffeggiato e preso a pugni sul volto e su collo. Toscanini
protestò per iscritto con Mussolini ma non ebbe risposta e si trasferì negli
Stati Uniti.
Celebre il caso dell’imperatore Francesco
Giuseppe, che in una serata del 1857 con la ventenne consorte Sissi, videro
arrivare al pranzo di gala i domestici al posto degli aristocratici. In teatro
cantarono Va pensiero.. e Massimiliano Cesare Stampa di Soncino, marito della
contessa Cristina Morosini, venne arrestato perché all’ingresso dell’imperatore
anziché alzarsi per rendergli omaggio rimase seduto voltando le spalle a lui e
alla moglie.
Poi nel 1968, proprio con un altro Don Carlo
diretto allora da Claudio Abbado, ci fu la protesta con uova marce contro le
povere signore al massimo dello sfarzo. Adesso c’è rimasto il buon Vizzardelli,
eroe inutile del nuovo regime.
La vera libertà del finto martire. Marco
Vizzardelli, loggionista della Scala e melomane a tutto campo, è diventato
famoso non per le sue competenze musicali, ma per aver urlato l'altra sera, in
apertura dell'opera che inaugurava la stagione del teatro milanese, "viva
l'Italia antifascista". Alessandro Sallusti il 9 Dicembre 2023 su Il Giornale.
Marco Vizzardelli, loggionista della Scala e
melomane a tutto campo, è diventato famoso non per le sue competenze musicali,
ma per aver urlato l'altra sera, in apertura dell'opera che inaugurava la
stagione del teatro milanese, «viva l'Italia antifascista», concetto peraltro
assolutamente condivisibile. È la dimostrazione che, per soddisfare il proprio
narcisismo, basta un'ovvietà assoluta, basta saper scegliere tempi e luogo.
Già, perché ci vorrebbe coraggio a urlare quella
frase se fossimo sotto un regime fascista, ma essendo il fascismo morto e
sepolto da ottant'anni - fingono di non saperlo solo Bersani e la Boldrini -
parliamo di acqua fresca. Addirittura ci vorrebbe più coraggio ad urlare «viva
la gnocca», perché coi tempi che corrono, si rischierebbe davvero l'arresto in
flagranza per esternazioni politicamente scorrette in un regime che vuole
imporre la correttezza.
Il sindaco di Milano Beppe Sala ieri ha pubblicato
un post polemico: «Ma al loggionista che ha gridato Viva l'Italia antifascista
ed è stato identificato (dalla Digos, ndr), che gli si fa?». Azzardo io una
risposta: assolutamente nulla, in caso contrario sarei il primo a scendere in
piazza, perché la libertà di espressione, anche se stupida o inopportuna in un
certo luogo, è sacra. Immagino che il Vizzardelli sarebbe stato identificato
anche se avesse urlato «forza Inter», per verificare se fosse uno intenzionato a
fare del male ad altri o solo a se stesso.
A me questi novelli Toscanini fanno un po'
tristezza e un po' ridere. Il grande Maestro, alla fine degli anni Venti del
secolo scorso, in pieno fascismo crescente, si rifiutò di dirigere la Turandot
alla Scala perché Benito Mussolini aveva annunciato la sua presenza. Finì che
Mussolini restò a casa e Toscanini diresse. Ecco, quello era avere le palle, non
come oggi urlare contro i fantasmi o, come ha fatto il sindaco Sala, annunciare
che non sarebbe salito nel palco reale al fianco di La Russa e poi lì è finito
con calorose strette di mano.
Vabbè, lunga vita a Marco Vizzardelli, nuova icona
della sinistra, ma come ha suggerito ieri Vittorio Sgarbi, propongo una modifica
al suo urlo: non «viva l'Italia antifascista, ma semplicemente «viva l'Italia».
Più semplice, più vero.
"Non sono strumentalizzabile”. Viva l’Italia
antifascista, Vizzardelli: “Il pd adesso mi cerca. La Digos mi ha detto: siamo
d’accordo ma dobbiamo identificarla”. Redazione su Il Riformista il 9
Dicembre 2023
La Prima della Scala è ormai terminata da giorni
eppure non cala il sipario. Marco Vizzardelli, il loggionista che subito dopo
l’Inno di Mameli, durante la Prima della Scala, ha gridato “Viva l’Italia
antifascista” in una intervista al Corriere della Sera rivela: “Sono già stato
cercato dal Pd, sono sorpreso ma comunque non sono strumentalizzabile”.
Che la sinistra stesse vivendo una forte crisi
identitaria non è storia nuova, ma non tutti si aspettavano che andasse a
pescare il loggionista Vizzardelli poche ore dopo il grido “Viva l’Italia
antifascista” durante la Prima della Scala.
“Sono sorpreso – spiega al Corriere della Sera –
io non sono strumentalizzabile né da chi mi dà dell’ultimo giapponese di
sinistra (vedi il commento di ieri del direttore di Libero Mario Sechi, ndr)né
dal Pd che mi tira per la giacchetta”.
Poi la rivelazione: “Sono già stato cercato dal
Pd”. Nulla di più verosimile. Le ultime ventiquattrore degli esponenti dem erano
solo un preludio per una chiamata politica ufficiale. L’account social ufficiale
del Partito democratico era attivo da ieri mattina. “Viva l’Italia
antifascista”, si legge nell’ultimo post su Instagram. Con tanto di descrizione
e attacco all’esecutivo: “Continueremo a gridarlo ovunque – scrivono dalle parti
del Nazareno – Anche se non piace a Salvini. E adesso identificateci tutti”.
"Mi ha cercato dal Pd": ora i dem cercano di
arruolare il loggionista antifascista. Il giornalista che ha gridato "Viva
l'Italia antifascista" rivela di essere stato cercato dal Pd. Poi il messaggio
ai dem: "Non sono strumentalizzabile da chi mi tira per la giacchetta". William
Zanellato il 9 Dicembre 2023 su Il Giornale.
Cala il sipario sulla Scala di Milano ma le trame
del Partito democratico restano più attive che mai. Una sinistra in crisi
d’identità e in forte calo di consenso ha trovato l’occasione perfetta per
arruolare, tra l’altro con scarsissimi risultati, un nuovo pasdaran della
sinistra massimalista. Marco Vizzardelli, il loggionista che subito dopo l’Inno
di Mameli, durante la Prima della Scala, ha gridato “Viva l’Italia antifascista”
in una intervista al Corriere della Sera rivela: “Sono già stato cercato dal Pd,
sono sorpreso ma comunque non sono strumentalizzabile”.
Niente da fare. Il carrozzone della sinistra
parlamentare e mediatica è già pronto a festeggiare il suo nuovo paladino. E il
loggionista - schedato e identificato nella giornata di ieri dalla Digos – prova
a scrollarsi di dosso questo abito scomodo. “Sono sorpreso - spiega al Corriere
della Sera - io non sono strumentalizzabile né da chi mi dà dell’ultimo
giapponese di sinistra (vedi il commento di ieri del direttore di Libero Mario
Sechi, ndr)né dal Pd che mi tira per la giacchetta”. Poi la rivelazione: “Sono
già stato cercato dal Pd”. Nulla di più verosimile. Le ultime ventiquattrore
degli esponenti dem erano solo un preludio per una chiamata politica ufficiale.
L’account social ufficiale del Partito democratico era attivo da ieri
mattina. “Viva l’Italia antifascista”, si legge nell’ultimo post su Instagram.
Con tanto di descrizione e attacco all’esecutivo: “Continueremo a gridarlo
ovunque – scrivono dalle parti del Nazareno – Anche se non piace a Salvini. E
adesso identificateci tutti”.
Le urla del loggionista sono già un manifesto
politico del partito di Elly Schlein e soci. Il post, come da copione, viene
ripreso ovviamente dalla segretaria dem in persona su X, la piattaforma social
preferita dai democratici. Il governatore emiliano Stefano
Bonaccini spara:"Bastava identificare una copia della Costituzione. In ogni
caso, Viva l'Italia antifascista. Sempre" L’ex segretario dem, Nicola
Zingaretti, lo segue: “Per essere chiari. Nella Repubblica italiana bisognerebbe
identificare chi fa il saluto romano non chi grida "viva l'Italia antifascista”.
Il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, si
chiede con un pizzico di ironia: “E infine, ma al loggionista che ha gridato
Viva l'Italia antifascista ed è stato identificato, che gli si fa? Chiedo per un
amico”. La fedelissima di Schlein, Chiara Braga, non può esimersi e grida: “Viva
l’Italia antifascista”. Con tanto di dati anagrafici: “Chiara Braga. Nata a
Como, 02.09.1979”. La sinistra ha trovato l’ennesima figurina da sfoggiare,
utilizzare fin quando necessaria e infine dimenticarla.
"Identificateci tutti". La sinistra santifica
il "patriota" del loggione come eroe antifascista. Pasquale Napolitano il 9
Dicembre 2023 su Il Giornale.
La sinistra ha trovato il federatore. Beppe Sala?
Per carità. Paolo Gentiloni? Assolutamente no. Enrico Letta? Sta bene a Parigi.
L'urlatore della Scala di Milano è il nuovo Prodi. Eccolo, l'idolo di Ruotolo,
Schlein e Conte.
È lui. Nessun dubbio Un esperto di cavalli è già
diventato l'eroe di Pd e sinistra. È bastato un urlo, al termine dell'Inno di
Mameli, durante la Prima della Scala, per mandare in estasi i compagni. «Viva
l'Italia antifascista», ha gridato Marco Vizzardelli, all'inizio del «Don
Carlo». Un gesto che fa sognare il Pd. Parte la catena di giubilo. È già pronto
il tour nelle salotti di sinistra. Gruber, Formigli e Fazio lo aspettano con i
tappeti rossi. «Il sindaco (che ne ha la facoltà) conferisca subito l'Ambrogino
a Marco Vizzardelli, il cittadino che ieri alla Scala ha gridato viva l'Italia
antifascista. Sarebbe la bella e giusta risposta di Milano città medaglia d'oro
della Resistenza», annuncia subito il capogruppo dei Verdi europei al Comune di
Milano Carlo Monguzzi. Vizzardelli, 65 anni, loggionista da sempre, appassionato
di lirica e giornalista pubblicista, dopo l'urlo è stato identificato dalla
Digos. La Questura chiarisce subito: «L'identificazione è stata effettuata quale
ordinaria modalità di controllo preventivo per garantire la sicurezza della
rappresentazione. L'iniziativa non è stata assolutamente determinata dal
contenuto della frase pronunciata». Nessuna forzatura. Per la sinistra, invece,
siamo alla vigilia di uno Stato di polizia. L'occasione è ghiotta.
Nicola Fratoianni (che ha dimenticato di
identificare Soumahoro prima della candidatura) grida: «È ora di finirla con la
paccottiglia fascista». Ilaria Cucchi rompe gli indugi: «Ecco i miei dati
anagrafici, il governo chiarisca». Elly Schlein prepara la piazza: «Continueremo
a gridarlo, ovunque. Anche se non piace a Salvini. E adesso identificaci tutte e
tutti». Il suo fido, Sandro Ruotolo (che non ha proferito parola sui flop in Rai
della moglie di Francesco Boccia) si inventa la genialata della catena social:
«Adesso identificate tutte e tutti», con tanto di hashtag. Nicola Zingaretti non
manca all'appello: «Per essere chiari. Nella Repubblica italiana bisognerebbe
identificare chi fa il saluto romano non chi grida "viva l'Italia
antifascista"». Il sindaco di Milano si chiede: «E infine, ma al loggionista che
ha gridato Viva l'Italia antifascista ed è stato identificato, che gli si fa?
Chiedo per un amico». Sala mastica amaro. Vizzardelli gli ha soffiato la
poltrona di federatore del centro-sinistra. Si rivede Stefano Bonaccini:
«Bastava identificare una copia della Costituzione. In ogni caso, Viva l'Italia
antifascista. Sempre».
Dal fronte della maggioranza Flavio Tosi commenta:
«Non ho trovato l'urlo scandaloso, ma ineducato sì. Capisco che chi ha una
opinione politica o una idea da diffondere utilizzi l'esterno del teatro per
manifestare il suo dissenso, ma all'interno ci vuole rispetto per tutti. Un
conto è ciò che accadde durante l'oppressione austroungarica dove si stava
provando a liberare il Paese dal nemico in casa, qui c'è un governo
democraticamente eletto e con una larga maggioranza in Parlamento». Il
protagonista, Vizzardelli, proiettato oramai verso la carriera politica nel Pd,
spiega il gesto: «Non ho commesso un reato perché ho detto Viva l'Italia
antifascista, l'avrei commesso se avessi detto Viva l'Italia fascista. Ho detto
una cosa costituzionale e lapalissiana».
Antifascista. Storia di Massimo
Gramellini su Corriere della Sera il 9 Dicembre 2023
Vi immaginate se qualcuno avesse gridato «Viva la
Germania antinazista» in un teatro tedesco e quattro poliziotti lo
avessero avvicinato per chiedergli i documenti?
Gli agenti della Digos hanno identificato il
loggionista Marco Vizzardelli che, alla prima della Scala, aveva accompagnato le
ultime note dell’inno nazionale con l’urlo «Viva l’Italia antifascista!». Lo
avrebbero fatto anche se avesse gridato «Viva la pappa col pomodoro»: dicono sia
la prassi nelle manifestazioni riprese dalla tv. Però in un Paese dove i
fascisti sono pochi ma gli anti-antifascisti ancora tantissimi, l’impressione è
stata che rivendicare a voce alta la natura antifascista del patto
costituzionale venisse considerata una provocazione o addirittura un sintomo di
pericolosità sociale.
Il loggionista sostiene di essere rimasto turbato
dalla presenza di La Russa e Salvini sul Palco reale accanto alla Segre. Il modo
migliore per tranquillizzarlo sarebbe stato che i due politici di destra
sottoscrivessero la sua ovvia affermazione, ancora più stringente per chi, come
loro, ha giurato sulla Carta che la incarna. Invece La Russa ha affermato di non
avere sentito niente e Salvini che a teatro non sta bene urlare (lo ha detto nel
luogo che ospita il loggione più famoso del mondo). Proprio non ce la fanno. E
un po’ lo fanno apposta, per aizzare la sinistra e distrarre l’attenzione
dall’economia.
Al netto della retorica, però, il problema resta.
E resterà fino a quando «Viva l’Italia antifascista» non diventerà un modo di
dire condiviso e persino banale. Come gridare «Viva la mamma».
Il Caffè di Gramellini vi aspetta qui, da martedì
a sabato. Chi è abbonato al Corriere ha a disposizione anche «PrimaOra», la
newsletter che permette di iniziare al meglio la giornata. Chi non è ancora
abbonato può trovare qui le modalità per farlo e avere accesso a tutti i
contenuti del sito, tutte le newsletter e i podcast, e all’archivio storico del
giornale.
Piazzapulita, i supremi ministri della verità.
Davide Vecchi su Il Tempo il 09 dicembre 2023
Guardando Piazza Pulita giovedì sera ho scoperto
che questo quotidiano è considerato, insieme a pochi altri, un giornale che
difende e tutela il Governo. Più precisamente è «in mano all'esecutivo Meloni
che ha monopolizzato l'informazione». Non lo sapevo. Anzi, non lo credevo
possibile. Ma vabbè, ho ascoltato. La suddetta sentenza è stata pronunciata da
sua maestosità giornalistica, Massimo Giannini, ex direttore de La Stampa e
firmissima di Repubblica. Il conduttore, Corrado Formigli, è stato
professionalissimo: non ha nemmeno sorriso. Chapeau. La cosa è parsa dunque
seria.
Visto che abbiamo tutti (sempre) bisogno di
critiche e maestri – altrimenti non si cresce – ho seguito la puntata con
crescente attenzione. Pochi minuti dopo la coppia di ermellini del giornalismo è
passata a sbeffeggiare Giorgia Meloni e la sua affermazione: «Della mia vita
privata si è parlato senza pietà». A sentir loro la cosa non è affatto vera,
figurarsi. Poi è toccato a Ignazio La Russa che, seppur presidente del Senato,
alla prima de La Scala proprio non sarebbe dovuto andare perché «non ha mai
preso le distanze dal fascismo». A me non risulta, ricordo diversamente ma se lo
dicono loro.
Un po' alla volta ho abbassato
l'audio fino a silenziarlo. E lasciando scorrere semplicemente le immagini mi
sono sentito come Winston Smith, uno dei tre protagonisti principali di 1984, il
capolavoro di George Orwell. I sovrani dell'informazione mi sono apparsi i
grandi capi del Ministero della Verità: decidono ciò che è giusto tutti facciano
e dicano, a prescindere dai fatti reali che vengono cambiati, modificati, a
seconda della convenienza momentanea, fino a riuscire a cancellare ciò che era
persino scritto sui giornali il giorno prima se poi non si è
avverato. Manipolare l'informazione è nulla, l'avanguardia è proclamare un'unica
(seppur falsa) verità.
Giampiero Mughini per Dagospia
il 3 maggio 2023.
Caro Dago, premesso che io vivo
nelle nuvole dato che nove volte su dieci scrivo di cose avvenute trenta o
cinquant’anni fa o anche più, allibisco nel leggere da tante parti una sorta di
sforzo spasmodico a individuare un qualche marchio di fascismo in Giorgia Meloni
o nei suoi consanguinei di partito, siano Ignazio La Russa o mille altri. Eccolo
lì il marchio, eccolo là, eccolo lì e là, commentano in tanti. Ne sta parlando
uno che dalla diade avversativa fascismo/antifascismo è stato segnato nel
profondo. Al tempo in cui un comparto della mia biblioteca era dedicato a quella
contrapposizione, i miei libri sull’argomento erano 500 o 600.
Solo che erano libri che
narravano gli uomini e le cose del 1921 (nascita del fascismo mussoliniano),
1925 (delitto Matteotti e consolidamento del potere mussoliniano), 1938 (leggi
razziali, il tempo in cui ai ragazzi ebrei furono chiuse le porte delle scuole),
1940-1941 (il tempo in cui l’Italia dichiarò guerra via via alla Francia,
all’Urss, agli Usa), luglio 1943 (il tempo in cui il bombardamento alleato del
Quartiere San Lorenzo induce il fior fiore del gruppo dirigente fascista a
defenestrare Mussolini), settembre 1943-aprile 1945 (il tempo della sanguinosa
guerra civile tra italiani), l’immediato dopoguerra (quando succedeva che degli
antifascisti entrassero nelle case dove abitava un ex fascista e lo
trascinassero via malgrado la moglie lo tenesse per i piedi a cercare di
salvarlo: me ne scrisse così una donna trenta o quarant’anni fa).
Che c’entra tutto questo con il
mondo nostro di oggi, con il Concertone del 1° maggio, con l’appassionante lite
giudiziaria tra Totti e consorte, con un palinsesto televisivo dove ogni sera
vanno in onda talk show dove si esibiscono personaggi di tutti i tipi e di tutte
le bassezze, con un parlamento ove comunque puoi dire la tua sino a svenirne,
con le edicole dei nostri giorni dove ognuno può trovare quello che vuole, dove
la gente muore di droga e non perché rapita e accoltellata alla maniera di
Giacomo Matteotti.
Che c’entra tutto questo nostro
mondo di oggi con quel 1919-1921 in cui milioni di italiani erano stati segnati
per sempre dagli orrori di una guerra dove di italiani ne erano caduti 600mila e
dove tutti avevano imparato a usare le maniere brusche contro gli avversari:
dove a Livorno andò in frantumi il partito socialista e questo perché alcuni di
loro volevano “fare come in Russia” ossia annichilire la borghesia italiana, una
borghesia che certo non aveva guardato con simpatia la prolungata occupazione
delle grandi fabbriche torinesi.
Che c’entra tutto questo con un
tempo in cui i giornali contavano ma rischiavano, tanto che sulla sua scrivania
da direttore del Popolo d’Italia Benito Mussolini teneva una rivoltella e una
bomba a mano, pronto a fargliela pagare cara a quanti avessero fatto irruzione
nella sua stanza, pronti a loro volta a usare le maniere più brusche.
Ma che c’entra tutto questo con
il nostro paesaggio di oggi, dove per fortuna il massimo di violenza possibile è
in qualche “telescazzo” prontamente registrato da Dagospia a far divertire i
suoi lettori a gratis; dove il nostro debito di italiani è il secondo al mondo e
cresce a vista d’occhio e io ogni inizio mese mi chiedo da dove prenderà l’Inps
di che pagare i soldi della mia pensione; dove di italiani ne nascono sempre
meno e fra mezzo secolo il nostro Paese sarà una sorta di Lussemburgo epperò con
un grande passato; dove la grande diade avversativa non è affatto tra possibili
fascisti e possibili antifascisti e bensì tra chi le tasse le evade (cento
miliardi di euro di evasione fiscale annua) e chi no. O mi sto sbagliando?
Margaret Atwood, menzogne
della Stampa: "Io e quei fascisti..." Libero Quotidiano il 03 maggio 2023
L'intervista a Margaret
Atwood sarebbe stata interpretata in modo fantasioso da La Stampa. Secondo
il Secolo d'Italia, il quotidiano torinese avrebbe trasformato il colloquio con
la scrittrice in una "sorta di manifesto della neo-resistenza antifascista. Con
richiamo in prima che esibisce una foto della scrittrice con in mano un’ascia e
il titolo: 'Io e quei fascisti ostili al sesso'".
Sia la foto che il titolo che
accompagnano l'intervista fanno pensare al lettore che in Canada, dove la Atwood
vive, ci siano dei “fascisti” che si danno da fare per censurare i suoi libri.
In realtà, a proposito dei suoi libri banditi da una biblioteca scolastica nel
Midwest, la scrittrice ha detto: “Bandire i libri è un’attività che è sempre
piaciuta a un certo tipo di persone, che così facendo sperano di arginare le
idee e di allinearle alle loro”. I “fascisti” a cui si riferisce sarebbero -
scrive il Secolo d'Italia - "gli esecutori dei dettami della cancel culture o
cultura woke. Roba genuinamente e autenticamente progressista che va per la
maggiore in Occidente e che qualcuno vorrebbe importare, con scarso successo per
fortuna, anche da noi".
Parlando dei censori, poi, la
Atwood aggiunge: “Storicamente i libri banditi sono quelli più letti. Più si
impongono restrizioni alle persone, più queste saranno invogliate a infrangerle.
Anzi, è un’ottima pubblicità: bisognerebbe augurarsi che i propri libri vengano
banditi, o cancellati, o bruciati se necessario, ed essere certi che venga fatto
nel modo più pubblico possibile, così si sarebbe sicuri di avere dei lettori
affezionati. Però è sempre successo e sempre accadrà”.
Il Bestiario, lo
Scioperigno. Giovanni Zola il 4 Maggio 2023 su Il Giornale.
Lo Scioperigno è un leggendario
animale che mobilita lo sciopero quando il governo aumenta lo stipendio ai
lavoratori
Lo Scioperigno è un leggendario
animale che mobilita lo sciopero quando il governo aumenta lo stipendio ai
lavoratori.
Lo Scioperigno è un essere
mitologico che ripete urlando sempre lo stesso discorso da decine di anni tanto
che lo stesso discorso ascoltato oggi potrebbe essere lo stesso di un qualsiasi
1968. Lo Scioperigno è un animale con abitudini particolari e alquanto curiose:
capace di andare in letargo anche per anni, al suo risveglio si mette a gridare
come una scimmia urlatrice con un terribile mal di denti. Gli etologi hanno
rilevato che tale rituale non è casuale, ma a seconda del governo in carica, lo
Scioperigno decide se starsene a dormire nella sua tana o scioperare tenacemente
con mobilitazioni permanenti organizzate prevalentemente durante i weekend di
pioggia per rendere più drammatica la lotta di classe.
Lo Scioperigno sa bene che la
crisi internazionale odierna metterebbe in difficoltà qualsiasi esecutivo a
causa di una coperta corta, ma con quello attuale, lo Scioperigno è
particolarmente aggressivo come un orso trentino. Così, anche se con fatica,
sono state trovate risorse per i lavoratori e le famiglie, lo Scioperigno
insiste nella sua lotta furiosa contro i mulini a vento. Occorre essere
intellettualmente onesti: fa piacere vedere lo Scioperigno, animale che sembrava
in via d’estinzione – soprattutto durante il Biennio pandemico - rianimarsi
improvvisamente agitandosi, ma senza cambiare nulla come nella sua natura
intrinseca, dimostrando che l’habitat che lo valorizza al suo meglio è di fatto
quello di stare all’opposizione. E per questo glielo auguriamo ancora e ancora.
Anche le pro loco festeggiano.
Dal punto di vista folcloristico non possiamo che ringraziare lo Scioperigno che
con i suoi raduni colora le piazze come solo una sapiente armocromista da 300
euro all’ora saprebbe fare. Crea importanti punti di socializzazione dove i
lavoratori possono lamentarsi in compagnia, ma anche ballare e divertirsi grazie
ai momenti di intrattenimento musicale in stile rave party organizzati dai
centri sociali e rifocillarsi grazie alle bibite e ai panini portati dai seguaci
dell’attuale Inviato Speciale per il Golfo Persico.
Anche grazie allo Scioperigno
redivivo, ancora una volta, vince l’italietta delle contrapposizioni che
dimostra come sia più importante il potere rispetto al “bene comune”, che
dimostra che l’ideologia è il male del mondo e che dimostra infine che a
perdere, alla fine dei conti, sono sempre i lavoratori.
"Avvocata e ingegnera". La lezione di Ambra
Angiolini a Murgia & Co. Lasciando di stucco i radical chic del Concertone,
l'attrice tira una bordata alle ultrà dello schwa che ogni giorno storpiano la
lingua italiana. Giorgia Fenaroli il 2 Maggio 2023 su Il Giornale.
Parole, parole, parole. Soltanto parole. Mina già
lo cantava nel 1972, ma la lezione del brano sembra essere tornata utile sul
palco del concertone del Primo Maggio. Ieri da piazza san Giovanni, a Roma, la
conduttrice Ambra Angiolini si è scagliata contro quelle che in fin dei conti
sono solo parole. "Avvocata, ingegnera, architetta: tutte queste vocali in fondo
alle parole saranno armi di distrazione di massa?", ha detto l'attrice e
cantante, lasciando forse di stucco la stuola di radical chic che gioivano nel
vederla alla conduzione del carrozzone del Primo Maggio per la sesta volta. "Le
parole ci fanno perdere di vista i fatti. E i fatti sono che una donna su cinque
non lavora dopo un figlio, che guadagna un quinto in meno di un uomo che copre
la stessa posizione", ha detto snocciolando i dati.
Persino l'ex valletta di Non è la Rai sembra
esserci accorta della contraddizione portata avanti da chi - Michela
Murgia, Laura Boldrini e compagne in primis - vorrebbe farci credere che sia
sufficiente non una parola, ma una sola vocale a cambiare tutto. Da chi non vede
l'ora di storpiare la lingua italiana, facendola passare come una grande
"conquista", convinti che tanto basti a risolvere finalmente la questione
femminile e dare alle donne quello che meritano. Poco importa se poi, nella
realtà, le donne continuino a essere pagate meno dei loro colleghi uomini o
trovino più difficoltà a entrare nel mondo del lavoro: almeno potranno fregiarsi
del gagliardetto di farsi chiamare avvocata, medica, sindaca.
"Non lo diceva già la Costituzione nel 1948 che la
donna doveva avere gli stessi diritti dell’uomo nell’art. 36? Che ce ne facciamo
delle parole?", ha detto Ambra. Dal palco rosso per eccellenza, l'attrice ha
tirato una bella bordata alle femministe "de sinistra" che pretendono di sapere
cosa è meglio per tutte, impartendo una lezione ai fan della lingua di genere:
le battaglie da combattere sono altre e ben più importanti di una vocale a fine
parola.
E se è vero che la lingua descrive la società, è
anche vero che di certo non basta mettere una "a" alla fine della parola per
cambiare il mondo. È solo un contentino che allontana il dibattito dalle cose
serie. Oltre a creare una comprensibile irritazione nell'opinione pubblica, le
femministe causano anche l'effetto opposto rispetto a quello che vorrebbero
raggiungere: è di pochi giorni fa il sondaggio della Fondazione Bruno
Kessler secondo cui farsi chiamare "avvocata" testimonia una minore affidabilità
rispetto al maschile (e neutro) "avvocato". Ambra lo ha capito e non risparmia
una frecciata finale ai cultori del politicamente corretto: "Voglio proporre uno
scambio: riprendetevi le vocali in fondo alle parole al femminile, ma ridateci
il 20% di retribuzione. Pagate e mettete le donne in condizione di lavorare.
Uguale significare essere uguale. E finisce con la e".
Estratto dell'articolo di Luigi
Ferrarella per il “Corriere della Sera” il 20 marzo 2023.
Bando ad asterischi e schwa, no
all’articolo davanti al nome (la Meloni, la Schlein), e no alle reduplicazione
retoriche (i cittadini e le cittadine, le figlie e i figli), sì invece al
plurale maschile non marcato «inclusivo», e soprattutto ai nomi di professione
declinati al femminile (avvocata, magistrata, questora): l’Accademia della
Crusca risponde così al quesito postole dal comitato pari opportunità del
consiglio direttivo della Corte di Cassazione sulla scrittura negli atti
giudiziari rispettosa della parità di genere.
[…]
Intanto, niente asterischi o
schwa: «È da escludere nella lingua giuridica l’uso di segni grafici che non
abbiano una corrispondenza nel parlato, introdotti artificiosamente per
decisione minoritaria di singoli gruppi, per quanto ben intenzionati. Va dunque
escluso tassativamente l’asterisco al posto delle desinenze dotate di valore
morfologico (”Car* amic*, tutt* quell* che riceveranno questo messaggio…). Lo
stesso vale per lo scevà o schwa».
Poi, in una lingua come
l’italiano che ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, «lo
strumento migliore per cui si sentano rappresentati tutti i generi e gli
orientamenti» non è per l’Accademia della Crusca «la reduplicazione retorica,
che implica il riferimento raddoppiato ai due generi» (come in «lavoratrici e
lavoratori», «impiegati e impiegate»); ma é «l’utilizzo di forme neutre o
generiche (per esempio sostituendo “persona” a “uomo”, “il personale” a “i
dipendenti”), oppure (se ciò non é possibile) il maschile plurale non marcato,
purché si abbia la consapevolezza di quello che effettivamente è: un modo di
includere e non di prevaricare».
E sempre il maschile non
marcato si può usare quando ci si riferisce «in astratto all’organo o alla
funzione, indipendentemente dalla persona che in concreto lo ricopra o la
rivesta», ad esempio «il Presidente del Consiglio». Per il resto, l’Accademia
suggerisce di «far ricorso in modo sempre più esteso ai nomi di professione
declinati al femminile»,
[…]
Estratto dell'articolo di
Selvaggia Lucarelli per “il Fatto quotidiano” il 3 maggio 2023.
Era difficile condurre un Primo
Maggio e riuscire a fare solo cose profondamente di destra, ma Ambra Angiolini –
incredibile a dirsi – ce l’ha fatta. Probabilmente, se accanto a Biggio ci fosse
stata Daniela Santanchè, avremmo avuto un Primo Maggio più spostato a sinistra,
ma ormai è andata. La conduzione inizia subito in maniera un po’ stonata.
La conduttrice che parla di
alternanza scuola-lavoro e di come sia stato ingiusto rubare il futuro a un
giovane di 18 anni (Lorenzo, morto in alternanza scuola lavoro) che doveva solo
andare a scuola. Considerato che Ambra ha iniziato a lavorare a Non è la Rai a
14 anni dalle 11 del mattino fino alle sei del pomeriggio, sarebbe stato più
interessante ascoltare la sua esperienza più che la sua predica, ma poi sono
saliti sul palco i genitori di Lorenzo con la loro incrollabile dignità e il
momento è stato toccante.
Tra una canzone e l’altra,
sotto la pioggia battente, è poi il turno del fisico Carlo Rovelli, il quale sul
palco dice quello che ribadisce da tempo, e cioè che è contrario alla guerra:
“Lo sapete che in Italia il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una
delle più grandi fabbriche di armi del mondo? Il ministero della Difesa deve
servire per difenderci dalla guerra, non per fare i piazzisti di strumenti di
morte”.
(...)
Diamo a tutti la possibilità di
parlare ma anche a tutti quella di rispondere e questa risposta è mancata. È
un’opinione del professor Rovelli”.
Ha fatto bene a chiarire questo
ultimo passaggio perché pensavamo che sul palco Rovelli avesse portato
un’opinione di Ornella Vanoni e invece era proprio sua, pensate che cosa
bizzarra, ma detto ciò, la parte davvero anomala della precisazione è quel “ci
dovrebbe essere un contraddittorio”. E certo, ogni volta che qualcuno esprime
un’opinione su qualcun altro deve esserci anche l’altro. Un po’ macchinoso come
metodo.
Quindi ogni volta che in tv
qualcuno cita Biden bisogna organizzare uno skype con la Casa Bianca. A questo
punto se si cita Mussolini urge una seduta medianica in diretta per fargli dire
anche la sua. Il ministro Crosetto poi fa molta fatica a trovare un pulpito da
cui controbattere, pover’uomo.
E infatti, con immensa fatica,
oggi su tutti i giornali del paese è stata riportata la sua risposta, della
serie: “Rovelli faccia il fisico. Gli mando un abbraccio pacifico e lo invito a
pranzo”. Tra parentesi, quando Fedez lanciò la sua invettiva da quel palco non
ricordo la conduttrice Ambra pronta a cazziarlo perché mancava la controparte.
Al Corriere della Sera che il giorno dopo le ha chiesto come mai avesse preso le
difese di Crosetto, ha risposto: “È una questione di umanità”.
Quindi esprimere un’opinione
senza che l’oggetto dell’opinione sia presente è disumano. Io sto scrivendo
questo articolo senza che Ambra sia seduta accanto a me, spero possa tollerare
la mia dose di disumanità.
E poi, siccome non era già
abbastanza a destra, Ambra si sposta ancora un po’ più a destra. Per parlare di
donne e lavoro le è parsa una buona idea leggere delle card con dei testi
scritti sopra da qualcuno che poteva essere a) Giorgia Meloni b) Hoara Borselli
c) Giorgia Meloni e Hoara Borselli a quattro mani. Il concetto sintetizzato era:
inutile parlare di desinenze, accapigliarci per un avvocatO anziché avvocatA se
tanto quando si parla di lavoro i nostri diritti sono ancora calpestati.
Torniamo a occuparci della ciccia anziché parlare di vocali. Pagateci il giusto
stipendio e tenetevi le vocali.
Insomma, secondo Ambra
Angiolini le parole non sono importanti, basta il giusto stipendio. In effetti
potremmo continuare a chiamare i lavoratori di colore “ne*ri”, l’importante è
che ricevano il giusto salario. O ignorare la questione identità di genere e
continuare a usare le desinenze maschili pure riferendoci a chi si sente donna e
viceversa (e però Ambra non perde occasione per indossare il maglioncino o la
spilletta arcobaleno).
Nessuno le ha mai spiegato che
l’inclusività passa prima di tutto attraverso il linguaggio, e che la prima
forma di discriminazione e di rivendicazione del predominio maschile è proprio
questa resistenza a consegnarci la nostra identità. Eppure fu proprio lei, anni
fa, a raccontare quanto una parola di Aldo Grasso la ferì a morte, a spiegare
alla sua generazione quanto le parole scrivano la realtà. Definiscano. Facciano
vivere o sparire.
Insomma, davvero un brutto
primo maggio quello di Ambra Angiolini, ma di sicuro IL presidente Meloni sarà
contento. O contenta.
Decida Ambra.
Apriti schwa. Concertone e
Domenica In, la grande festa degli scandali scemi del Nuovo Asilo Italiano.
Guia Soncini su L'Inkiesta il 3 Maggio 2023
Siamo arrivati a dare peso alle
parole di chi non vive di parole proprie, fino al punto di far partire
l’inquisizione digitale contro le attrici che dicono cose banali
Comincerei dagli attori, e
formerei due file ordinate. Da una parte chi non ha studiato niente, al massimo
ha appreso da “Shakespeare in love” che una volta i ruoli femminili li
interpretavano i maschi, e parla degli attori come fossero persone
intellettualmente rilevanti. Dall’altra chi rimpiange i tempi in cui venivano
sepolti in terra sconsacrata, e si chiede con sconforto come siamo diventati una
società che domanda pareri a gente pagata per esprimersi con parole altrui.
Tra domenica e lunedì, grande
festa alla corte degli scandale du jour, e tutta a base di attori, cioè appunto
di gente che si è scelta un mestiere che le garantisca di non dover mai pensare
a cosa dire. Ma questo non basta, nell’epoca in cui, pur di posizionarci dalla
parte dei giusti, siamo disposti anche a prendercela con chi non vive di parole
proprie.
“Domenica In” ospita una coppia
di attori. Sono marito e moglie, hanno fatto un film insieme, sono piuttosto
bellocci. Non credo d’aver mai visto un film con lei, lui invece l’ho visto
quando copulava con Rosy Abate in quel capolavoro kitsch che era “Squadra
Antimafia”, serie di Canale 5 (parlando di Canale 5 da viva).
Mara Venier lo tratta come
fosse Marlon Brando, ne loda la credibilità e il non essersi mai venduto (della
signora invece lodano tutti in coro l’onestà intellettuale, qualunque cosa
significhi). Del film che sono venuti a presentare lui fa la regia. Trascrivo le
prime parole che ne dice: «Non è un film di caccia, “La caccia” è un titolo che
rappresenta un po’ una sorta di metafora della vita, nel senso una caccia a
volte anche contro sé stessi, contro le proprie anime».
A quel punto noialtre sul
divano pensiamo «figlio mio, meno male che sei belloccio», sua moglie e la
Venier invece si guardano e sospirano quant’è intelligente, un po’ tipo i
Ferragni quando il figlio scarabocchia un foglio e volano i «bravissimo,
amore!».
L’intervista prosegue con un
lessico da non madrelingua. La coppia racconta d’un bisticcio perché al figlio
un compagno di calcio aveva fatto fallo, lui dice «una cosa goliardica», non
faccio in tempo a chiedermi cosa diavolo penserà voglia dire «goliardica»,
quando lei dice del marito «non mi aspettavo questo suo randagismo che a me
piace molto perché io adoro essere gestita», e ci vuole fantasia a immaginare
cosa intenderà mai con «randagismo» (autoritarismo? perentorietà? dogmatismo?).
È a quel punto che arriva
lo scandale du jour, che mostra i due caratteri classici della dinamica
degli scandale du jour: dici una cosa di cui nessuno si sarebbe scandalizzato
dieci anni fa ma che può riempirci le giornate social oggi; nessuno di coloro
che partecipano alla conversazione capisce come va il mondo (e infatti con la
frase su RaiPlay ci fanno il titolo dell’intervista) e quindi l’inquisizione
spagnola arriva, come sempre, inaspettata.
La frase dell’attrice riguarda
la spartizione dei lavori domestici tra lei e il marito: «Io non tollero l’uomo
che si mette a fare il letto, a dare l’aspirapolvere, non lo posso proprio
vedere, sono antica in questo, rispetto i ruoli, non mi piace, mi abbassa
l’eros, me lo uccide». Se fossimo una società di adulti, tratteremmo questa
frase come ciò che è: l’affermazione di una che ha del personale di servizio in
casa.
Siccome siamo un collettivo di
dodicenni pronti a tutto per prendersi i cuoricini, ci costerniamo e ci
indigniamo e americanizziamo la questione: non sei un’attrice che dice delle
cose a caso in un programma della domenica pomeriggio, sei un modello
comportamentale, e stai dicendo alle donne a casa che devono fare da serve ai
loro mariti.
E le donne a casa ti
ascolteranno, diamine, perché se c’è una cosa che accomuna le donne emancipate e
quelle meno emancipate è che vivono come le attrici in tv dicono loro di vivere.
(Il martedì, la poverina dovrà scusarsi. Scusarsi perché non le fa sangue che il
marito passi l’aspirapolvere. Pensa se avesse detto che le piace farsi legare al
letto, che espiazione le toccherebbe).
Il lunedì, per completare la
ricreazione, il concerto del primo maggio viene condotto da un’altra attrice,
che a un certo punto fa la sua brava tirata sul lavoro femminile e sul divario
salariale. Che è un lamento propagandistico anche quello da cuoricini facili.
Certo che ci saranno eccezioni, che sono appunto eccezioni; ma perlopiù esistono
i contratti collettivi nazionali e non prevedono che io possa pagarti meno se
hai le tette.
Perlopiù, i dati sul divario
salariale che propagandisticamente vengono citati sono il risultato di
comparazioni che non tengono conto dei ruoli: in generale le donne guadagnano
meno degli uomini perché in generale le donne scelgono di fare le professoresse
e lavorare diciotto ore a settimana e non di fare i cardiochirurghi e stare in
sala operatoria dodici ore di fila.
La conduttrice sceglie – come
chiunque stia su quel palco e non voglia farsi linciare – di dire che il divario
salariale esiste, ma per farlo osa aggiungere un dettaglio, così la linceranno
comunque ma per aver mancato di rispetto a un totem più piccino. La conduttrice
dice che insomma, basta con questa scemenza delle vocali finali, paghiamo la
donna che fa l’ingegnere quanto l’uomo, invece di preoccuparci che la chiamino
«ingegnera». Apriti schwa.
Su Instagram una comica si
mette le orecchie da persona seria e le fa la lezioncina: una volta, cara te,
non c’era la parola «attrice» perché il tuo lavoro lo facevano gli uomini, se
non ti suona «medica» è perché non sei abituata alle femmine con lavori di
responsabilità. (Mistero misterioso perché in questi casi nessuna chieda la
vocale giusta per la muratora che così spesso rischia la vita sulle
impalcature).
Su Twitter, una tizia che in
bio ha un ruolo nella segreteria Schlein e molti cancelletti le dice perentoria
che non solo è molto grave non volersi occupare delle vocali, ma pure che «non
si tratta col patriarcato». Signora, il patriarcato ci ha dato la pillola.
Signora, il patriarcato per la mia liberazione – e pure per la sua – ha fatto
parecchio più dei cancelletti.
Anzi, sa che le dico? Il
patriarcato ci ha dato pure i cancelletti, cancelletti che oggi – in una società
che ha risolto questioni quali i diritti dei lavoratori, l’acqua potabile, la
sanità e la scuola gratuita, e altre bazzecole che nella vostra delirante
abolizione delle gerarchie sono rilevanti quanto il 41 bis per gli uomini che
non sparecchiano – ci permettono d’intrattenerci per interi pomeriggi
posizionandoci dalla parte dei buoni e dei superiori.
Superiori a un’attrice che non
vuole che il marito rifaccia i letti, e a un’altra che chiama «avvocato» gli
avvocati con le tette. Avvocati con le tette nessuna delle quali vuol essere
chiamata né col femminile italiano – avvocatessa – né con quello in neolingua
(avvocata). Ma sono donne, e quindi non sanno ciò che vogliono: noi che siamo
dalla parte dei buoni le costringeremo a non farsi chiamare avvocato e a non
sparecchiare, e ancora una volta avremo salvato il mondo.
«Ambra Angiolini ha ragione:
provocano noi donne sulle vocali, e poi ci ignorano sui numeri». Beatrice
Dondi su L'Espresso il 3 maggio 2023.
La distrazione di massa del
monologo della conduttrice sul palco del Primo Maggio è l’arma impugnata da chi
di quella desinenza (Avvocata, Architetta) non sa che farsene. E che alle donne
nega senza fatica quel 20 per cento di retribuzione
Le parole sono importanti, ce
l’ha insegnato Nanni Moretti, e lo abbiamo imparato sulla nostra pelle, giorno
dopo giorno. Sì, le parole sono importanti. Ma alla fine le azioni lo sono
almeno altrettanto. E purtroppo, accade spesso, l’attenzione riservata a quelle
parole appunto importanti rischia di fagocitare tutte le altre attenzioni, come
un aspirapolvere alla massima potenza che porta via tutto, dai riccioli di
polvere di Stephen King al senso profondo delle battaglie di cui quelle parole
dovrebbero essere il vestito.
Così è successo che
incautamente Ambra, conduttrice del concertone del Primo Maggio, si sia lasciata
andare a un monologo sul lavoro delle donne che anziché far sobbalzare gli
astanti per il suo contenuto ha fatto indignare per la riflessione sul
linguaggio.
Non è che stiamo sbagliando
battaglia? Ha detto Ambra dal palco di San Giovanni «Negli ultimi tempi ci
stiamo infatti accapigliando se una donna viene chiamata direttore d'orchestra o
direttrice, avvocato o avvocata, come se il cambiamento (culturale e sociale)
passasse solo da una qualifica. Tutte queste vocali in fondo alle parole sono,
saranno armi di distrazione di massa?».
E qui la questione comincia a
farsi seria. Perché ciascuna donna pretende a ragione la desinenza corretta, ci
mancherebbe. E non è certo una concessione, si chiama molto semplicemente lingua
italiana. Ma il problema su cui riflettere, scatenato dalla provocazione di
Ambra è un altro. La distrazione di massa intravista da Ambra è l’arma impugnata
da chi di quella desinenza non sa che farsene, è il punteruolo di chi i diritti
delle donne li vede come una fase accessoria, un bigodino su una testa
arruffata. E protesta contro queste “fissazioni al femminile” ben sapendo che la
reazione (sacrosanta) arriverà puntuale. E a questo punto certo sì che ci si
distrae. Se Meloni chiede di farsi chiamare Il Presidente è perché così è certa
che per giorni si dibatterà su questa inezia, e non sul fatto che La presidente
sino a oggi ai diritti delle donne non ha dedicato neppure una virgola. Si
perdono di vista i fatti appunto e i fatti sono «che una donna su cinque non
lavora dopo un figlio, che guadagna un quinto in meno di un uomo che copre la
stessa posizione».
Certo, quando Ambra chiude il
suo monologo proponendo lo scambio, « riprendetevi le vocali in fondo alle
parole, ma ridateci il 20 per cento di retribuzione» fa un certo effetto.
Nessuna donna vuole uno scambio perché non si cede un diritto in cambio di un
altro. I diritti sono tali proprio perché sono per tutti. Ma fa ancora più
strano che non si sia scatenato un putiferio su quel 20 per cento, che non è una
parola, è un numero ma fa male da morire. Perché è vero che senza le parole non
siamo, come ha scritto giustamente Loredana Lipperini su La Stampa. Ma la
polemica è sempre portata avanti da chi pensa che uno stipendio ridotto solo a
causa del nostro sesso non sia un tema. Tanto alla fine, meglio farci scaldare
sulle vocali, così sulle consonanti in busta paga si può prendere tempo.
Bella addio. La strana sinistra che per
delegittimare la resistenza ucraina nega quella italiana. Francesco Cundari
su L'Inkiesta il 2 Maggio 2023
Cosa sarebbe accaduto se a mettere in dubbio il
carattere di lotta di liberazione della nostra guerra partigiana fosse stato un
esponente di Fratelli d’Italia, anziché un intellettuale progressista, invitato
pure sul palco del primo maggio?
Immaginate cosa sarebbe successo se a pochi giorni
dal 25 aprile non dico il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ma un
qualunque dirigente di Fratelli d’Italia, fosse stato anche l’assessore al
traffico del più sperduto comune della provincia, o magari un giornalista di
Libero o un qualsiasi intellettuale di destra, avesse detto in televisione: «Non
sono sicuro che quella nostra fosse una guerra di liberazione». Immaginate se lo
stesso esponente di Fratelli d’Italia, giornalista di Libero o intellettuale di
destra avesse aggiunto con aria furbetta: «Qualche tempo fa sul giornale della
mia città, Verona, c’era un articolo che parlava della stazione di Verona
bombardata dai tedeschi: il giornalista si era sbagliato perché, ovviamente, è
stata bombardata dagli inglesi, non dai tedeschi». Immaginate cosa sarebbe
successo se quello stesso esponente di Fratelli d’Italia, giornalista di Libero
o intellettuale di destra, dopo avere pronunciato queste parole in televisione,
a pochi giorni dal 25 aprile, fosse stato invitato a parlare sul palco del primo
maggio, in piazza San Giovanni, magari su pressione di qualche zelante
funzionario. Pensateci davvero, soltanto per un attimo.
Potrei scrivere qui non solo i titoli, ma il testo
completo di tutti gli editoriali, le interviste e gli appelli di almeno cento
giornalisti, attori, storici, politici e politologi, che sarebbero apparsi
ovunque un minuto dopo, grondanti sacrosanta indignazione per un simile
oltraggio, per una tale profanazione di tutti i più essenziali principi su cui
si fonda la Costituzione della Repubblica italiana. Sarebbe venuto giù il mondo.
Quelle testuali parole, però, non le ha dette un
esponente di Fratelli d’Italia, né un giornalista di Libero, né un intellettuale
di destra. Le ha dette il fisico Carlo Rovelli, fine intellettuale progressista,
tra gli ospiti del concerto del primo maggio, nonostante quelle parole le abbia
pronunciate solo pochi giorni prima, il 22 aprile, a In Onda, su La7, allo scopo
di corroborare il suo argomento contro l’appoggio militare alla resistenza
ucraina. Gira e rigira, pur di negare che fosse una guerra di liberazione
quella, ha finito per negare che lo fosse persino la nostra. Dovremo dunque
cambiare nome alla festa del 25 aprile? Dovremo chiamarla festa del bellicismo
ultra-atlantista? Festa del nazionalismo militarista?
Se simili definizioni vi sembrerebbero un
insopportabile rovesciamento della verità storica e morale, se vi paiono
mistificatorie sul piano fattuale, ripugnanti sul piano etico e inaccettabili
sul piano politico, avete perfettamente ragione, ma dovete spiegarlo anche a chi
oggi combatte la sua guerra di liberazione contro l’occupazione russa, e simili
definizioni se le sente ripetere dalla mattina alla sera. Per di più, da parte
di chi, quando si tratta del proprio paese e della propria storia, non esita al
contrario a intonare Bella Ciao e a celebrare la resistenza contro l’invasore.
Da parte di chi, come Pier Luigi Bersani a Otto e Mezzo il 26 aprile, non esita
a dire che non bisogna proprio parlare di vittoria ucraina – guai! – che se lo
facciamo «allora proprio non ci capiamo, perché “vincere” è una parola che va
tirata via dal tavolo». Perché quello che bisogna fare, secondo Bersani, è un
bell’ordine del giorno in Parlamento, sottoscritto insieme da Partito
democratico e Movimento 5 stelle (diceva il saggio: la fissazione è peggio della
malattia), in cui sia scritto chiaramente che si può negoziare anche con i russi
sul territorio ucraino, «lasciando al negoziato quel che le armi non han
deciso».
Bisognerebbe andare a dirlo ai sopravvissuti di
Bucha, bisognerebbe andare a ripeterlo in tutti i territori liberati dall’ultima
controffensiva ucraina, tra le camere di tortura e le fosse comuni. Bisognerebbe
dirlo ai fratelli, amici, fidanzati, mogli e mariti di chi ancora si trova nelle
zone occupate, in quelle zone in cui rapiscono persino i bambini. O almeno
smetterla di fare tanti discorsi ipocriti a casa nostra.
In fondo, i mentecatti che ieri in piazza a Torino
hanno bruciato le bandiere degli Stati Uniti, della Nato e dell’Unione europea,
delirando contro le responsabilità dell’imperialismo americano in Ucraina (mica
contro l’imperialismo russo), mostrano di avere perlomeno una più chiara idea di
quali siano gli schieramenti in campo e la posta in gioco. Non si può essere
europeisti e al tempo stesso ripetere quello che dicono Viktor Orbán e gli altri
pupazzi di Putin. Non si può celebrare la resistenza e la lotta di liberazione
in casa nostra e predicare agli altri la resa e l’asservimento, nell’illusione
che alla fine il conto non dovremo pagarlo anche noi, come il mondo intero, come
sempre.
Che liberazione. Edoardo
Sirignano su L'Identità il 26 Aprile 2023.
“Noi incompatibili con
qualsiasi nostalgia”. La premier Meloni, attraverso una lettera inviata al
Corsera, risponde a chi fino a ieri ha accusato il suo governo di essere
fascista. Ricorda agli italiani come lo scopo della Costituzione sia appunto
quello di unire e non dividere. Non utilizza, pertanto, giri di parole verso
coloro che, in occasione del 25 Aprile, hanno stilato la lista di chi sia degno
o meno di partecipare alle varie cerimonie.
La missiva DA STATISTA
Per il presidente del
Consiglio, che riprende le parole di Augusto Del Noce, si tratta di una sorta di
“arma di esclusione di massa” che va solo a indebolire valori che invece
dovrebbero difesi. Superando ogni steccato partitico, Giorgia fa riferimento a
Luciano Violante, che nel suo discorso di insediamento alla Camera aveva
ribadito come una certa “concezione proprietaria” della lotta di Liberazione,
nei fatti, le impediva di diventare patrimonio collettivo. Un concetto, per la
politica romana, ripreso da Silvio Berlusconi che definì questa ricorrenza come
una festa della libertà da chi appunto voleva farla passare come bandiera di una
sola parte. Non a caso, Meloni intende accostare il proprio nome a quello della
partigiana Paola Del Din. Un nome richiamato, su queste colonne, qualche giorno
fa da Carlo Giovanardi che in un’intervista aveva spiegato la necessità di
ricordare appunto una resistenza socialista, cattolica e monarchica, spesso poco
valorizzata.
Dalle parole ai fatti
A tutte le persone che hanno
perso la vita per libertà e democrazia, un’emozionata madre dedica le proprie
lacrime sull’Altare della Patria. Ad accompagnarla non c’è uno qualunque, ma
quella seconda carica dello Stato, che fino a qualche giorno fa in tanti hanno
criticato e che invece ieri si è recata nel campo di concentramento di
Theresiestadt per deporre una corona al monumento dedicato a Jan Palach. Una
Meloni, sempre più statista e meno militante, vuole dare un messaggio chiaro al
Paese e perché no a quel Presidente della Repubblica, che mai le ha fatto
mancare la fiducia nei primi mesi di governo. Ecco perché tutta la maggioranza
rivendica le proprie convinzioni “antitotalitarie”. Il braccio destro della
leader di FdI Francesco Lollobrigida rinvia gli appuntamenti del G7 e va a
Subiaco per partecipare alla cerimonia in onore dei martiri di Cicchetti. Il
ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, dopo aver aperto le porte dei musei,
consegna a un omaggio alla stele dedicata a Salvo d’Acquisto in piazza Carità a
Napoli. Il titolare del dicastero che si occupa di made in Italy Adolfo Urso,
insieme al collega della Farnesina Antonio Tajani, partecipa all’iniziativa
organizzata alle Fosse Ardeatine, dove c’è sia la Cgil di Maurizio Landini che
quell’Anpi, che fino a ieri ha criticato le ambiguità del governo. La priorità è
appunto dare un segnale di unità in un momento non semplice per il Paese,
considerando la guerra in Ucraina e il clima particolarmente caldo che si
registra in diverse zone del pianeta. Un segnale di distensione vuole essere
anche la partecipazione del ministro alla Cultura Valditara agli eventi
milanesi. Un gesto per dire che il corteo dei 100mila di Milano non è composto
solo da una parte.
Opposizione mature
A parte il fazzoletto rosso di
Elly Schlein e qualche esternazione del sindaco Sala o di pochi nostalgici del
Pci, a cui non è bastata la lettera del presidente del Consiglio per fare
chiarezza, la piazza lombarda appare tutt’altro che divisiva. Si canta “Bella
Ciao”, ma certamente non si respira quel clima di tensione, che qualcuno sperava
alla vigilia di questo 25 aprile. Le stesse parole della nuova segretaria del
Nazareno non sono tanto al vetriolo, come qualcuno s’aspettava. Si chiede solo
un chiarimento, come nel caso del capogruppo Francesco Boccia, che pur
apprezzando le parole di Giorgia, non riesce a capire perché la premier non
riesca ancora a utilizzare il termine antifascista. Una cosa è certa le
polemiche sterili degli ultimi giorni sembrano essere superate. Pare quasi che
il solo Ruotolo si ricordi di fare le pulci al governo.
È uno dei pochissimi a
utilizzare le manifestazioni per scagliare dardi verso il primo inquilino di
Palazzo Madama che definisce “provocatore seriale”. Discorso diverso, invece,
vale per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che dopo aver visitato
il Museo Storico della Liberazione di via Tasso, nella capitale, addirittura
apprezza le parole della prima donna del centrodestra, che a suo parere ha ormai
“rinnegato il fascismo” e quindi chiuso quella polemica, per qualcuno
strumentale, sollevata dal suo compagno di partito Gianfranco Fini. A difendere
le tesi della premier della Garbatella anche il pariolino Carlo Calenda per cui
è un bene che la Meloni abbia riconosciuto che “forse oggi va fatto uno fatto
uno sforzo da parte di tutti, invece di sottolineare le divisioni, di cercare di
rimetterle insieme”.
I manifesti della vergogna
L’unica nota negativa di una
giornata, tutto sommato all’insegna della riconciliazione, di quel senso di
compattezza, che ci ha consentito appunto di liberarci dall’invasore, sono
soltanto dei manifesti poco felici comparsi a Napoli. Nel capoluogo partenopeo
ci sono delle affissioni ritraenti la premier e alcuni ministri a testa in giù.
Un gesto che non blocca gli eventi previsti in ogni angolo dello stivale, ma che
impone una riflessione sui valori della Costituzione, non sempre rispettati. Non
a caso il presidente della Repubblica, da Cuneo, dalla casa-museo del partigiano
Galimberti, mette l’accento su su quel testo che nei fatti mette la persona e il
senso di comunità, intesa come insieme delle diversità, davanti finanche allo
stesso Stato.
Se i nostalgici sono loro.
Eleonora Ciaffoloni su L'Identità il 26 Aprile 2023.
Da Milano a Roma, passando per
Praga. Anche nel giorno della Liberazione continuano le polemiche sulle
celebrazioni. La mattinata, iniziata a Roma, all’altare della Patria, è stata
inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che al Milite
Ignoto si è fermato per un minuto di raccoglimento e per la deposizione di una
corona di fiori, accompagnato dalla premier Giorgia Meloni, dal presidente del
Senato Ignazio La Russa e dal presidente della Camera Lorenzo Fontana. Eppure, a
parte celebrazioni istituzionali, in tutta Italia i cortei dedicati al 25 aprile
sono stati seguiti da più di uno strascico polemico.
MILANO (QUASI) PACIFICA
A Milano Elly Schlein ha preso
parte al corteo organizzato dall’Anpi a cui hanno preso parte circa 80mila
persone. Insieme a lei erano presenti anche il sindaco del capoluogo Beppe Sala
e l’ex candidato governatore Pierfrancesco Majorino. La segretaria del Pd
indossava con un fazzoletto rosso al collo è stata circondata da molteplici
bandiere della pace che hanno animato il corteo. Ma non solo: bandiere dei
centri sociali, bandiere palestinesi, bandiere dell’Ucraina. Tutto faceva
pensare a una giornata di celebrazioni per la Liberazione, ma prima è arrivato
l’invito a “non polemizzare” da parte di Lega e Forza Italia e poi, si è
assistito a uno dei momenti di tensione della manifestazione: una bandiera della
Nato all’inizio del corteo è stata strappata. Eppure, poi, nessun coro contro il
governo – nessun esponente era presente – è stato lanciato. Anche se, il sindaco
Sala alla partenza del corteo ha dichiarato: “Io non voglio essere critico a
ogni costo ma certe cose se si sentono si dicono ad alta voce, mettendoci la
faccia. Meloni in alcune occasioni pubblicamente ha mostrato una faccia decisa,
ha urlato certe parole e certi slogan e quello che dovrebbe fare è dire con
chiarezza e in maniera decisiva ‘siamo antifascisti’”. Meloni, dal canto suo,
ieri ha affidato il suo pensiero sul 25 aprile al Corriere della Sera con una
lettera che non lascia troppe interpretazioni: “La destra in Parlamento
incompatibile con qualsiasi nostalgia del fascismo” e ha sottolineato: “Il 25
aprile in Italia una democrazia nella quale nessuno sarebbe disposto a
rinunciare alle libertà guadagnate”. Di certo se qualcuno cercava una presa di
posizione forse in quella lettera l’ha trovata.
NAPOLI ANTI GOVERNO
E se Milano e a Roma
l’istituzione ha vinto sulle polemiche, ciò non è accaduto a Napoli dove, già
nella notte tra il 24 e il 25 aprile sono spuntati manifesti a testa in giù
della presidente del Consiglio, di Ignazio La Russa, del ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi e del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Non solo,
sotto la corona a decoro dei caduti della Quattro Giornate di Napoli e in altri
punti della città sono apparse delle affissioni che recitavano: “Napoli ripudia
questo governo, il governo dell’odio e lo ribadiamo a gran voce in occasione del
25 aprile, giornata in cui ricordiamo il sacrificio dei partigiani, di centinaia
e migliaia di donne e uomini che si organizzano, coraggiosamente, per liberare
questo Paese dal nazifascismo”. Per i manifesti la digos di Napoli ha avviato
indagini per individuare i responsabili dei manifesti anti governo.
Intanto, da Praga, è
intervenuto – forse per smorzarle le polemiche – il presidente del Senato La
Russa: “Oggi 25 aprile, per l’Italia è un giorno molto importante: è il giorno
nel quale viene ricordata la Liberazione dall’occupazione nazista nella Seconda
Guerra Mondiale e la sconfitta del fascismo” ha affermato il presidente del
Senato. “Renderò omaggio alle tante vittime della ferocia nazista recandomi a
Terezin e sono già stato al monumento dedicato a Jan Palach. L’ho fatto anche
stavolta perché non potevo certo mancare di rispetto verso la vostra storia”.
Tutti, tra polemiche e
commemorazioni, hanno voluto dire la loro su questo 25 aprile che, come ogni
anno, ha creato scompiglio nella politica e non solo.
L’autogol di Anpi e Pd: se a
dividere sono pure le rievocazioni storiche. Adolfo Spezzaferro su
L'Identità il 26 Aprile 2023.
Dalle polemiche sul 25 aprile
non esiste Liberazione, come nel caso della contromanifestazione dell’Anpi in
occasione della sfilata della Colonna della libertà a Mirandola, in provincia di
Modena. Dalla prima edizione del 2008, la sfilata storica lungo i luoghi simbolo
dell’avanzata degli Alleati, è un appuntamento chiave delle celebrazioni del 25
aprile. Si tratta di mezzi e divise dell’epoca che sfilano nelle città italiane,
proprio dove furono protagonisti durante la Campagna d’Italia. Jeep e tank degli
Alleati, dei liberatori insomma. Ma l’Associazione nazionale partigiani d’Italia
non ha apprezzato la scelta del sindaco leghista Alberto Greco di far sfilare a
Mirandola la Colonna della libertà. Per cui ieri l’Anpi locale ha respinto
l’invito dell’amministrazione comunale e ha svolto una contro-commemorazione,
assieme ai parlamentari del Pd Stefano Vaccari e Andrea De Maria. Quello che è
curioso è che la stessa Anpi in altri territori aveva patrocinato l’iniziativa
storica, che invece a Mirandola è stata ostracizzata. Forse per via della giunta
leghista. Anche se ufficialmente la causa del rifiuto sarebbe la presenza di
mezzi e divise tedeschi nel corteo – per l’appunto – storico.
La Colonna della Libertà, in
ogni caso, è arrivata regolarmente ed il suo fascino ha attirato tanti cittadini
per le strade e in piazza Costituente, dove era stato allestito il palco
comunale. Assieme al sindaco Alberto Greco, autorità civili, militari,
religiose, il sindaco di Caravate (Va) Nicola Tardugno, l’ex ministro Carlo
Giovanardi e i rappresentanti della base militare americana Ederle di Vicenza.
“Ho scelto l’articolo 11 della nostra Costituzione, per aprire il mio discorso
in occasione delle celebrazioni della Festa della Liberazione – ha dichiarato
Greco – poiché ritengo che in esso siano contenuti i significati più puri di una
festa che, a 78 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, l’ultimo
combattuto sul nostro suolo, debba finalmente riuscire ad unire senza escludere
nessuno. La lotta di liberazione rese il Paese padrone del proprio destino: un
destino di libertà, sancito dalla Costituzione. Essa, scritta dai padri
costituenti, rappresenta ancora oggi la linea di demarcazione fra la libertà
ottenuta con la liberazione del nostro suolo dall’occupazione tedesca e
qualsiasi spinta totalitarista”.
Giovanardi dal canto suo ha
parlato di “clamoroso autogol da parte di Anpi e Pd”. “Trovo davvero
incomprensibile la contestazione di questa iniziativa da parte dell’Anpi e dai
parlamentari locali del Pd, con la scusa che fra i cento e più mezzi militari ce
ne fossero alcuni dell’esercito tedesco. Non si capisce poi perché i
rappresentanti dell’Anpi, presenti in piazza, abbiano rifiutato l’invito
pubblico del sindaco a salire sul palco per festeggiare assieme la Liberazione
del nostro Paese. Per quanto ci riguarda siamo stati convintamente presenti
anche per ricordare il significativo apporto alla Liberazione della Resistenza
cattolica monarchica azionista liberale e socialista, del Regio esercito e di
tutti quelli che si opposero all’occupazione dell’Italia da parte dei nazisti,
donandoci libertà e democrazia”.
La politica ha trasformato
il 25 aprile nella festa dell’ipocrisia. Alessandro di Battista]su
L'Indipendente il 26 Aprile 2023.
«E anche questo Natale se lo
semo levato dalle palle» disse l’Avvocato Covelli in Vacanze di Natale.
Purtroppo, e lo dico con rammarico, si prova la stessa sensazione pensando al 25
aprile. E non per i valori o quel pezzo di storia italiana che andrebbe
celebrata o, per lo meno, ricordata. Come sempre il circo politico, capace di
strumentalizzare ogni cosa e svilire ogni ricorrenza con tonnellate di parole,
gesti e azioni inutili conditi da vagonate di ipocrisia, rovina ogni cosa.
Prendiamo la Meloni. Ha preso “carta, calamaio e penna” per scrivere
un’indimenticabile lettera al Corriere della Sera con la quale lanciare il suo
messaggio urbi et orbi: “Il 25 aprile sia la festa della libertà”. Però. “Che
pensieri soavi, che speranza, che cori Giorgia mia”. Parla di libertà una
premier arrivata sì a palazzo Chigi, ma non al potere. Al potere ci stanno
sempre gli altri, quelli che doveva contrastare e che adesso non fa altro che
ossequiare. Sta tornando quatto quatto il patto di stabilità e crescita (PSC),
quell’insieme di regolette europee che hanno imposto manovre lacrime e sangue e
che si basa sul trattato di Maastricht. Pensate, il PSC venne stipulato nel 1997
mentre Maastricht venne firmato nel 1992. Erano gli anni delle privatizzazioni,
dei regali ai Benetton, del Partito Democratico della Sinistra che iniziava a
svendere i propri valori, del panfilo Britannia sul quale Draghi, di fatto,
elogiava la liquidazione dell’industria pubblica italiana. Ronald Reagan e
Margaret Thatcher (“che brucino all’inferno” cit. Prof. Alessandro Barbero)
erano appena usciti di scena ma il reaganismo ed il tatcherismo iniziavano a far
breccia nella cosiddetta sinistra nostrana. Pensate a quante cose sono accadute
da allora. Guerra in Bosnia, bombardamenti su Belgrado (la Nato riporta la
guerra nel cuore dell’Europa dopo 54 anni), poi la guerra in Afghanistan, quella
in Iraq, la crisi dei subprime, la tempesta finanziaria in Europa e le
speculazioni bancarie, la guerra in Libia, quella in Siria, poi la crisi
migratoria, il Covid. Infine la guerra in Ucraina ed il nuovo ordine mondiale
che si sta sviluppando negli ultimi mesi. E in tutto ciò l’Europa che fa? Pensa
di ritornare a regolette pensate ed approvate nei primi anni ’90. Un’era
geologica fa. E la Meloni zitta, muta, guai ad indispettire la tecnocrazia
europea che un tempo faceva finta di contrastare. Parla di libertà. Quale
libertà? Quella di di dire o signor sì o of course President a Biden. Proprio
lei che difiniva le sanzioni dell’Unione europea contro la Russia una decisione
“scellerata” presa solo per “servire interessi stranieri”. Si riferiva alle
richieste di Obama a Renzi. Ebbene Biden era il vice di Obama ma lei se l’è
scordato.
Per non parlare di La Russa, la
seconda carica dello Stato che ha pensato bene di deporre un mazzo dei fiori sul
luogo dove Jan Palach, un patriota (lui sì) cecoslovacco, nel gennaio del 1969
si diede fuoco per protestare contro le ingerenze politiche e militari dell’URSS
sul suo Paese. Ebbene il La Russa che omaggia la memoria di Jan Palch è lo
stesso La Russa che, da ministro della Difesa, si mise sull’attenti quando,
sempre Obama (spinto dalla Clinton), Sarkozy (spinto dai suoi sporchi interessi
personali) e Napolitano (spinto dal desiderio perenne di ossequiare qualsiasi
forma di imperialismo) chiesero all’Italia di partecipare all’ignobile
intervento militare in Libia. Le conseguenze di quella guerra che ha
rappresentato per gli interessi italiani la più grande sconfitta dalla II Guerra
Mondiale in poi, le stiamo ancora pagando in termini di destabilizzazione del
Mediterraneo o di aumento dei flussi migratori.
Ma anche dall’altra parte (se
di altra parte davvero possiamo parlare) lo spettacolo è patetico. I cosiddetti
anti-fascisti preferiscono combattere affinché alla Costituzione venga
riconosciuto lo status di Costituzione anti-fascista piuttosto che cercare di
realizzarne i principi. Eppure i politici sono pagati per questo. Per trasforme
i principi costituzionali in leggi dello Stato che a loro volta possano
garantire diritti. Ma è più semplice per loro parlare della copertina piuttosto
che del contenuto. In fondo sono stati proprio loro i primi a violare la Carta.
Stramaledetti ipocriti. “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro” recita l’articolo 1. Cos’è oggi il lavoro e cos’è la democrazia? Un
tempo i poveri erano i disoccupati. Oggi è povero chi lavora, persino chi di
lavori ne deve fare due o tre per pagare le bollette. E cosa significa
democrazia in un Paese dove milioni di persone (e la stragrande maggioranza dei
più giovani) ha smesso di votare. Ad abolire l’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori sono stati i successori del PCI. Lo vogliamo dimenticare? O vogliamo
dimenticare che i principali sponsor dell’invio di armi in Ucraina, una palese
violazione dell’articolo 11 della Costituzione, sono sempre loro, Schlein
inclusa? E vogliamo dimenticare che a spingere per le privatizzazioni (ce lo
chiedeva l’Europa) sono stati sempre loro? Gli ex-comunisti che si ricordano
dell’anti-fascismo una volta all’anno non potendo vantarsi di nient’altro. È
dannatamente comodo parlare esclusivamente del carattere anti-fascista della
Costituzione dimenticando, anzi, profanandone ogni contenuto da ormai decenni.
Poi ci sono i “radicali”,
quelli che sventolano bandiere ucraine il giorno della liberazione per provare a
convincerci delle similitudini tra la Resistenza al nazi-fascismo e l’esercito
di Kiev. Un esercito armatissimo, sostenuto dalle principali potenze del pianeta
(dal 2014, tra l’altro) e che si sta sì difendendo da un’invasione (d’altro
canto ogni guerra inizia con un’invasione) all’interno di un contesto che ormai
dovrebbe apparir chiaro a tutti. Non una guerra Russia contro Ucraina, ma una
guerra Nato contro Russia in Ucraina. Un esercito, tra l’altro, dove sono stati
incorporati battaglioni che ancora oggi inneggiando al nazismo. Dunque parlare
di lotta partigiana riferendosi a quel che sta avvenendo in Donbass è ridicolo.
Lo spettacolo, ripeto, è stato patetico, meschino, ipocrita. E lo è ancor di più
riflettendo su una cosa semplice. Il popolo che più di ogni altro sta
combattendo, loro sì come i partigiani, contro un’occupazione militare
straniera è il popolo palestinese. Il più dimenticato del pianeta. D’altro
canto, come scrisse l’attivista palestinese Hanan Ashrawi, “i palestinesi sono
l’unico popolo sulla terra a cui è chiesto di garantire la sicurezza degli
occupanti, mentre Israele è l’unico Paese che esige di essere protetto dalle
proprie vittime”. Questa è la realtà, tutto il resto è ipocrisia. [di Alessandro
di Battista]
I vecchi conti rimandati con
la Storia. Un altro 25 aprile inutile, che mostra solo per l'ennesima volta
che siamo sempre gli stessi, quelli che si gettarono tra le braccia del
dittatore e che, senza guerra e bombardamenti a San Lorenzo, avrebbero
continuato a gettarvisi. Pier Luigi del Viscovo il 27 Aprile 2023 su Il
Giornale.
Un altro 25 aprile inutile, che
mostra solo per l'ennesima volta che siamo sempre gli stessi, quelli che si
gettarono tra le braccia del dittatore e che, senza guerra e bombardamenti a San
Lorenzo, avrebbero continuato a gettarvisi, bevendo con piacere la cicuta di
qualsiasi fesseria venisse loro propinata. Perché in fondo la comfort zone della
sudditanza psicologica è meno faticosa e rischiosa che mettersi in gioco per
fabbricarsi il successo della propria vita. Libertà: per farci cosa? Libertà è
spirito critico, confronto, intraprendenza, strade alternative, rispetto delle
regole del gioco. Ancora oggi non vedo niente di simile in giro, ma solo una
massificazione del pensiero, intitolata ad altre credenze.
Sembra un gioco. A sinistra
disseminano le trappole: facevi il saluto fascista, c'hai la bandiera di Salò,
non hai abiurato al tuo passato. A destra abboccano ogni volta, come Charlie
Brown quando vuole calciare la palla tenuta ferma da Lucy, che regolarmente la
toglie e lo fa schiantare. Mai che gli dicessero una volta per tutte che il
fascismo è stato un disastro, così da mettere la palla nel campo loro e
incalzarli sul comunismo; la più grande fabbrica di povertà mai concepita,
eppure ancora oggi ossequiato e distinto dallo stalinismo. A parte questo,
potremmo fare un passo avanti e capire che quando una dittatura la voti il
problema sei tu, non la dittatura. Cosa piaceva del fascismo, tanto da portarlo
democraticamente alla guida del Paese? Non era forse ciò che oggi ancora piace
ai cittadini delle democrazie non liberali e delle autocrazie? Uno che pensa per
tutti e racconta ciò che dà conforto e coesione di popolo.
Noi italiani siamo
antifascisti, nel senso che non vogliamo il fascismo del ventennio che ci ha
portato le leggi razziali e poi la guerra. Questo è facile. Ma vogliamo pure una
stampa libera, che non somigli a quella sportiva, buona per le tifoserie?
Vogliamo appoggiare un leader politico ma poi anche criticarlo quando sbaglia,
invece di difenderlo sempre, contro gli avversari, tipo curva da stadio? Già,
questo è più difficile.
La storia è importantissima. Ma
oltre a ricordarla devi anche capirla e impararne la lezione. Per quanto
fastidioso possa essere. Anzi, più è fastidioso più è necessario. Noi invece non
abbiamo mai voluto fare i conti col fascismo, né con la caduta del Muro. Ci
vediamo tutti alla prossima tappa del tour, l'8 settembre.
"Abbiamo sconfitto la
sinistra antisemita". Romano: "Zero fischi? Battaglia dura". E la Lega è il
partito più filo-Israele. Alberto Giannoni il 27 Aprile 2023 su Il Giornale.
«È una battaglia vinta (per
ora) ma la guerra è ancora lunga». Non è stato un 25 aprile come gli altri,
quello di martedì: dopo 20 anni, per la prima volta, la Brigata ebraica non è
stata contestata, né fischiata, al corteo di Milano. Lo ha rilevato anche il
vicepremier Antonio Tajani.
Ne è passata di acqua sotto i
ponti da quel 2004 in cui Davide Romano, dopo un libro uscito in Inghilterra,
riportò alla luce il contributo sionista alla Liberazione che rischiava di
finire nel dimenticatoio. Portate alle manifestazioni, 20 anni fa le Stelle di
David subivano autentiche aggressioni, poi divenute sempre più sparute.
Stavolta, invece, solo applausi. «Abbiamo vinto - riflette Romano, che dirige il
piccolo Museo della Brigata a Milano - abbiamo vinto partecipando insieme a
iraniani e ucraini. Ma il nemico è dietro l'angolo. Chi contesta la Nato, chi
gli ucraini, e chi magari tornerà a contestare noi. Il fascismo ha tante forme e
colori: quello rosso e quello verde, cioè islamico, passando per il putiniano,
sono i più insidiosi, perché godono ancora dell'appoggio di tanti cosiddette
"antifascisti».
Le contestazioni passate sono
state citate anche dalla premier Giorgia Meloni come esempio di un uso
strumentale della memoria che arriva a «inaccettabili episodi di intolleranza».
«La ringrazio - osserva Romano - e mi permetto di chiederle un passo in più: non
si limiti alle parole, cerchi di sfidare la cultura antidemocratica: quella
comunista e quella islamista in particolare, che vivono in una zona protetta da
intellettuali e giornalisti. Li stani».
Ecco l'idea di Romano: «La
premier lanci un Museo dei combattenti per la libertà: dalla Brigata ebraica ai
polacchi, passando dal cinese Wei Jingsheng alla dissidenza sovietica senza
dimenticare gli oppositori del regime iraniano e la resistenza dei cristiani in
certi Paesi islamici. Le scuole devono poter imparare il valore della democrazia
contro i totalitarismi, di destra e di sinistra».
Nei giorni scorsi l'Unione
delle Comunità ebraiche ha esortato la premier, e la destra, ad avere coraggio
nel condannare non solo l'antisemitismo e le leggi razziste, ma l'intero
fascismo. Ma sulla difesa di Israele, il centrodestra è più solido e più
convinto che mai. Oggi emerge che la Lega è il primo partito italiano, e il
quarto in Europa, nel «ranking» del sostegno a Israele: lo certifica la European
Coalition for Israel in base ai voti in Ue dal 2019 al 2022. «Tra un Pagliarulo
ipercritico con gli Usa che strizza l'occhio agli estremisti palestinesi e una
Meloni favorevole a Nato e Israele - ammette Romano - non ho dubbi. E aggiungo
che Jan Palach potrebbe a buon titolo entrare nel Museo dei combattenti per la
libertà». Parla di una «battaglia culturale». «La nostra cultura occidentale -
spiega Romano - è permeata di odio di sé. Ci sono giustamente decine di film sul
nazi-fascismo o critici sugli Usa, ma quanti ne trovate sul comunismo cinese e
cubano, o sugli ayatollah? Dobbiamo fare conoscere ai ragazzi l'altra faccia del
totalitarismo. È una battaglia che va oltre lo scontro fascismo-antifascismo. È
tempo di passare all'attacco, non solo difendersi. Altrimenti non cambierà mai
nulla».
Il Ventennio sempre
ripudiato ma ai compagni non basta mai. Meloni ha detto parole chiare contro
il fascismo, dalle leggi razziali al taglio netto con l'eredità Msi. Stefano
Zurlo il 27 Aprile 2023 su Il Giornale.
Non è abbastanza. Non è mai
abbastanza. Sempre lo stesso schema: la premier condanna il Fascismo e le sue
atrocità, loro rispondono che manca sempre qualcosa. L'asticella deve salire su,
più su, perché qualunque dichiarazione, qualunque presa di distanza, qualunque
abiura è insufficiente.
Succede anche al giro di boa di
questo 25 aprile. Giorgia Meloni scrive una lettera al Corriere della sera in
cui è scolpita una frase granitica, comunque difficilmente superabile: «Da molti
anni i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la
loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del Fascismo». Che altro c'è da
aggiungere? Eh no, non va bene. Troppo poco. Beppe Sala, sindaco di Milano,
punta il dito: «Spiace che Meloni, pur in uno sforzo che le riconosciamo ma che
mantiene una evidente reticenza, non riesca a dichiararsi antifascista».
No, non ci siamo nemmeno questa
volta, come tutte le altre, innumerevoli, in cui la leader di FdI non ha fatto
sconti al regime, alla dittatura, alla deportazione spaventosa degli ebrei. Si
possono sfogliare intere collezioni dei giornali e ogni volta si ritroverà lo
stesso teatrino: «Sì, però».
Il 19 dicembre scorso, per
esempio, la premier partecipa al museo ebraico alla cerimonia dell'accensione
delle luci dell'Hannukah e si commuove fino a piangere. Poi abbraccia la
presidente della comunità ebraica della capitale Ruth Dureghello e afferma: «Le
leggi razziali furono un'ignominia. Voi siete una parte fondamentale
dell'identità italiana. Tutte le tenebre del mondo non possono spegnere la
fiamma di una candela».
Sentimenti & giudizio a
braccetto. Inutile. «Giorgia Meloni ha 45 anni - è la staffilata di Gad Lerner -
diciamo come minimo che la sua è una commozione tardiva. Dichiararsi amici di
Israele non basta a rimuovere le colpe storiche del razzista Almirante, di cui
essa fino a ieri rivendicava l'eredità».
In realtà, non si capisce dove
sia il ritardo, visto che le requisitorie affilatissime sul tema da parte della
leader della destra si susseguono. In ottobre, qualche settimana prima, Meloni
scopre una targa per ricordare i 35 giornalisti espulsi dall'Ordine con le
famigerate leggi del 38 e di nuovo pronuncia parole drammatiche, quasi
apocalittiche, non riuscendo nemmeno a trovare la misura di un male così
profondo e oscuro: «Ho sempre reputato le leggi razziali del 38 il punto più
basso della storia italiana, una vergogna che ha segnato la nostra storia per
sempre. È una macchia indelebile, un'infamia che avvenne nel silenzio di
troppi». «Nulla di nuovo al di là delle parole di circostanza - replica il
presidente dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo - Nessuna definitiva condanna del
Fascismo».
C'è sempre un altro indicibile,
par di capire, e per i puri più puri quello del presidente del consiglio è solo
un modo per annacquare le precise responsabilità del Fascismo.
Il 4 ottobre 2022, la
politologa Sofia Ventura riprende gli stessi stereotipi e li consacra come un
dogma: «La leader di FdI non condannerà mai il Fascismo». Il motivo? «Quella - è
la risposta - è la sua dimensione esistenziale, l'intelaiatura del suo partito è
ancora quella da ex Msi».
Anche se Meloni ha più volte
chiarito di avere ben altre ambizioni: non rimanere imbottigliata nel
retrobottega della storia, ma costruire un partito conservatore che è ben altra
cosa e in Italia non c'è mai stato.
In ogni caso, la premier ha
fatto inversione da un pezzo. Insomma, quello che per i critici dovrebbe ancora
accadere è avvenuto già da un pezzo, solo che non se ne sono accorti. «Siamo
stati e restiamo - sottolinea l'allora ministro delle politiche giovanili nel
2008 - gente che crede nella libertà, nella democrazia, nell'uguaglianza e nella
giustizia. Siamo quelli che ogni giorno consumano i migliori anni della nostra
gioventù per difendere questi valori Sono i valori sui quali si fonda la nostra
Costituzione e che sono propri anche di chi ha combattuto il Fascismo». Concetti
limpidissimi. Ma c'è di più. Qualche riga oltre, la giovane Meloni fa propria
anche la distinzione di Fini fra l' antifascismo militante, impugnato come una
clava, e «l'antifascismo democratico nei cui valori ci riconosciamo. Gianfranco
Fini - è la conclusione - ha operato questa distinzione perché voleva che il suo
giudizio sul fasciamo fosse chiaro, netto, definitivo».
Era così già nel 2008. Ma
ancora qualche settimana fa un maestro del pensiero progressista, Tomaso
Montanari, ospite di Lilli Gruber ha ripreso la vecchia vulgata: «Meloni è
ambigua sul Fascismo».
Pretendono che Giorgia si
dichiari antifascista ma la Schlein balbetta sul no al comunismo. La leader
di Fdi incalzata dalla sinistra che vuole estorcerle l'adesione ai valori
resistenziali. La segretaria Pd può cavarsela a buon mercato sul totalitarismo
rosso. Alberto Giannoni il 27 Aprile 2023 su Il Giornale.
«Lei è comunista? No nativa
democratica. Bene, la prossima domanda?». Colpisce la disinvoltura con cui Elly
Schlein ha potuto destreggiarsi sul terreno ideologico. Mentre Giorgia Meloni
viene sottoposta a una sorta di inquisizione sulle sue dichiarazioni, e sulle
sue intime convinzioni sul fascismo, fa impressione verificare come alla sua
avversaria ideale, la segretaria del Pd, sia consentito di cavarsela a buon
mercato sull'altro totalitarismo del secolo scorso.
La presidente del Consiglio è
stata sottoposta a un autentico «stalkeraggio», viste le sue radici nella destra
italiana. Da giorni, o settimane, avvicinandosi il 25 aprile, le chiedono non
solo di condannare le leggi razziali (cosa che ha ovviamente già fatto, e che il
Msi aveva fatto decenni fa), non solo di dire parole definitive sul fascismo (le
ha dette anche in questa occasione, e Alleanza nazionale le ha
inequivocabilmente dette 20 anni fa). No, non basta: pretendono che Giorgia
Meloni si dichiari «antifascista, pretendono di estorcerle questa
«autodefinizione», salvo probabilmente sperare in cuor loro che non la dia, per
meglio continuare a incalzarla, conservando per un altro anno il pretesto per
considerarla «unfit», indegna di governare, anzi di sedere in Parlamento.
Ma a parti, invertite, cosa
hanno chiesto ad Elly Schlein? E lei cosa ha risposto? È accaduto il 5 dicembre.
La allora candidata alla segreteria del Pd era ospite in Tv a «Otto e mezzo» di
Lilli Gruber e la giornalista - già parlamentare europea eletta nella lista
«Uniti nell'Ulivo» per entrare poi nel Pd - le sottopose gentilmente la
questione. Non le chiese se si definisse anticomunista, no, le girò
semplicemente la questione in questi termini: «Lei sa che la stampa di
riferimento della destra scrive delle cose tremende su di lei - disse sorridendo
- e magari anche vere. Per esempio la definiscono comunista».
«Sono una nativa democratica -
rispose Elly - ma per ragioni anagrafiche, sono nata nell'85 quindi non ho
potuto aderire alle storie precedenti» disse, lasciando negli ascoltatori il
dubbio se fosse un rammarico. Non si capiva insomma, se avendone avuta
l'opportunità avrebbe aderito o no. «Ragioni anagrafiche? Questo lo dice anche
Meloni» si sentì in dovere di obiettare Gruber. E vediamole, queste ragioni
anagrafiche: Elly è nata 5 anni prima che crollasse l'Urss con tutto il patto di
Varsavia; Giorgia Meloni invece è nata nel 1977, quindi 32 anni dopo il crollo
definitivo del fascismo in Italia.
Si potrebbe osservare che la
leader di Fdi ha fatto in tempo ad aderire (a 15 anni) al Fronte della gioventù,
nel 1992, mentre An è nata fra il '94 e il '95, e si potrebbe aggiungere che
l'Italia ha conosciuto direttamente il regime fascista, che ebbe una diretta
filiazione nel Msi. Ma è vero anche che il legame (politico-ideologico, e
finanziario) fra Mosca e il Pci è indiscutibile, e diretto, almeno fino agli
anni Settanta e si può osservare anche che i regimi comunisti sono una realtà
ancora oggi, nel 2023, e hanno maturato una linea diplomatica aggressiva verso
le democrazie occidentali, e tengono sotto il loro tallone un miliardo e mezzo
di persone.
La questione, insomma, è molto
seria, e chi volesse affrontarla seriamente non dovrebbe limitarsi a battute o
risposte elusive. D'altra parte Elly non è la prima a svicolare. E c'è chi fa di
peggio. Tutta la storia dei partiti comunisti europei, e italiani, è la storia
di una fascinazione, o di una sottovalutazione, per gli orrori totalitari di
marca comunista. E dai tragici errori del passato, dal 1917 in poi, si arriva
fino a Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, che oggi assicura: «Sono contro i
totalitarismi, che però non sono stati tutti uguali. Nazismo e comunismo non
furono la stessa cosa», mentre una filosofa come Donatella Di Cesare spiega che
il comunismo «è un progetto politico di emancipazione, mentre il fascismo è sin
dall'inizio perversione».
Sylos Labini: la destra ha
fatto i conti con la storia, la sinistra no. Guido Igliori su
culturaidentita.it il 26 Aprile 2023
Ospite di Bianca
Berlinguer a Carta Bianca, ieri sera il direttore di CulturaIdentità Edoardo
Sylos Labini insieme a l’on. Fratoianni di Alleanza Sinistra e Verdi,
l’europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, il vice direttore della
Verità Francesco Borgonovo ed il giornalista Gad Lerner, ha parlato del tema del
giorno: il 25 aprile.
A quasi 80 anni dal giorno
della Liberazione, Sylos Labini ha sottolineato come sia arrivato il momento di
una pacificazione che a quanto pare non interessa alla sinistra, sempre pronta a
strumentalizzare la piazza per attaccare i governi di centrodestra, da
Berlusconi alla Meloni. L’antifascismo di oggi in assenza di fascismo è qualcosa
di anacronistico e non ha nulla a che vedere con le battaglie della Resistenza
della Seconda Guerra. Oggi bisognerebbe ricordare le libertà negate durante il
covid o la violenza dell’antifascismo militante nei confronti di chi non la
pensa nello stesso modo. Le destra dunque ha fatto i conti con la Storia mentre
la sinistra no. E la lettera che la premier Meloni ha scritto sul Corriere della
Sera è una dimostrazione lampante della presa di distanza dal regime fascista.
“E la sinistra invece?”- si chiede Sylos Labini incalzando l’on Fratoianni – “
ha preso le distanze dagli orrori comunisti?” Il leader di Sinistra e Verdi non
ne vuole sapere di ammettere le violenze rosse. Così a Labini non resta che
ricordare il passaggio della lettera della Meloni dove si cita Paola Del Din, “
Il tempo ci ha ribattezzato partigiani ma noi eravamo patrioti e lo siamo
ancora”. La donna che ha quasi 100 anni, fu Medaglia d’oro al valor militare,
partigiana bianca della Brigata Osoppo, compagine nella quale vennero uccisi da
altri partigiani comunisti il fratello di Pier Paolo Pasolini e lo zio di
Francesco De Gregori. Insomma il nostro direttore non è caduto nel tranello di
farsi spiegare come è andata la Storia e di farsi dare il patentino di
democratico ma chi invece troppo spesso ha dimostrato di non rispettare idee
diverse dalle proprie.
Fascisti-Comunisti: la
resistenza non è un derby. Giorgia Spitoni, Giornalista, su Il Riformista il
24 Aprile 2023
Sono una miriade le frasi fatte
sulla Resistenza che ciclicamente si ripetono, specialmente in corrispondenza
della ricorrenza del 25 aprile. Tra le mie preferite in assoluto c’è questa:
“Tutti i partigiani erano comunisti”.
Ebbene, le cose non stanno
proprio così. Sostenere che la Resistenza, cioè quell’importante pagina della
storia italiana che è stata scritta tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945,
sia una lettura ‘da rossi’ è pressoché un luogo comune. Interpretarla come uno
scontro tra fascisti e comunisti, un’estrema semplificazione.
Alla lotta partigiana hanno
preso parte, in verità, cittadini dai profili ideologici alquanto eterogenei tra
loro. Se è vero, infatti, che circa la metà dei partigiani (50%) apparteneva
alle Brigate Garibaldi, la formazione facente capo al Partito Comunista
Italiano – la principale, per intenderci, non solo per apporto numerico, ma
anche per capacità di attrazione e radicamento sul territorio – altrettanto vero
è che numerose adesioni al movimento di resistenza sono pervenute altresì dalle
fila di diverse fazioni politiche.
Al secondo posto, per esempio,
in termini di partecipazione, si collocavano le Brigate Giustizia e Libertà,
legate al Partito d’Azione (20%). A seguire, meno determinanti nel conflitto
eppure esistenti, le Brigate Autonome afferenti al Partito Liberale, spesso
d’ispirazione militare e monarchica, le Brigate Matteotti associate al Partito
Socialista, e le Brigate Cattoliche vicine alla Democrazia Cristiana (30%).
Pertanto, non tutti i partigiani erano comunisti, ma erano i comunisti,
senz’altro, i meglio organizzati sul campo di battaglia nonché i più motivati e
risoluti a combattere il nazifascismo.
C’è pure un altro mito da
sfatare, l’equazione brigata = partito. L’automatismo secondo il quale se un
cittadino si univa a una brigata, allora era necessariamente tesserato al
partito politico cui la brigata si ricollegava – con condivisione di valori e
idee compresa nel pacchetto – non era poi così scontato. Nella decisione di
frequentare una compagine piuttosto che un’altra, sono entrati comunque in gioco
vari fattori, talvolta contestuali, talaltra relazionali.
Un pò come quando, da bambino,
ti iscrivi alla scuola media: d’accordo che gli insegnanti devono essere validi
e le materie oggetto di studio interessanti, ma a parità di condizioni, guardi
all’istituto più comodo da raggiungere, e se in classe conosci già qualche
‘compagno’ male non fa. Insomma, mai fare di tutta l’erba ‘un fascio’, per
rimanere in tema.
Il Bestiario, l'Ideologino.
Giovanni Zola il 27 Aprile 2023 su Il Giornale.
L’Ideologino è un leggendario
animale che vive il suo momento di gloria tra il 25 Aprile e il primo Maggio,
poi basta
L’Ideologino è un leggendario
animale che vive il suo momento di gloria tra il 25 Aprile e il primo Maggio,
poi basta.
L’Ideologino è un essere
mitologico che si desta dal torpore dell’agone politico in una settimana di
primavera, quando la natura si risveglia, le api impollinano e rinascono gli
amori. È una sorta di risveglio dal letargo annuale nel quale l’Ideologino può
finalmente cavalcare i suoi cavalli di battaglia, scendere in piazza con i suoi
simili e annunciare i suoi proclami senza doverli scrivere da nuovo perché sono
gli stessi da quasi ottanta anni e data una spolverata sono già belli pronti
come le patatine surgelate.
Nella settimana d’oro i grandi
temi sono l’antifascismo e il lavoro. Per quanto riguarda l’antifascismo,
l’Ideologino festeggia la liberazione dal nazifascismo per opera dei partigiani
coadiuvati, secondo lui in modo irrilevante, dall’esercito degli Stati Uniti.
Dato che il fascismo, inteso come regime del Ventennio che limitava la libertà a
chi non era in possesso dell’odiosa tessera, è bello che morto e sepolto,
l’Ideologino fa di tutto per riesumarlo e avvertire del pericolo, dimenticando
che proprio l’Ideologino ha difeso qualche anno fa il regime del Biennio che
limitava la libertà a chi non era in possesso dell’odiosa tessera.
Per quanto riguarda la festa
dei lavoratori, l’Ideologino si appella all’articolo uno della Costituzione più
bella del mondo: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”. Il diritto al lavoro è infatti un bene inalienabile e
l’Ideologino lamenta che tale diritto sia calpestato dal governo di centro
destra, scordando di aver governato per gli ultimi vent’anni e che nel famoso
Biennio il lavoro sia stato impedito dal famoso Ministro della Salute
appartenente, ironia della sorte, proprio al partito nominato Articolo Uno. Per
questo motivo sarebbe più corretto correggere il primo articolo della
Costituzione nella formula: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro…
all’estero”.
L’Ideologino, terminata la sua
settimana d’oro, torna ad assopirsi affrontando stancamente le sue battaglie sui
diritti dell’utero in affitto, della pillola concezionale gratuita, come se il
concepimento fosse una malattia, e della difesa degli orsi, senza dimenticare la
feroce critica senza “ma” e senza “se” alla campagna pubblicitaria a favore del
turismo italiano che ha utilizza la Vergine del Botticelli.
Il 25 aprile dimenticato.
Per gli italiani in Istria e in Dalmazia si aprì un periodo di nuove
violenze da parte dei comunisti titini. Matteo Carnieletto il 27 Aprile 2023 su
Il Giornale.
Ci fu un altro 25 aprile,
troppo spesso volutamente dimenticato. È quello degli italiani che si trovavano
al di là dell'Adriatico. Lo ha ricordato ieri, nella sua lettera a Il Corriera
della Sera, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella missiva, la leader
di Fratelli d'Italia scriveva: "È doveroso ricordare che, mentre quel giorno
milioni di italiani tornarono ad assaporare la libertà, per centinaia di
migliaia di nostri connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia iniziò invece
una seconda ondata di eccidi e il dramma dell’esodo dalle loro terre". Questa
pagina di storia, che dovrebbe essere condivisa da tutti gli italiani, è stata a
lungo dimenticata. Troppo spesso, si guardava agli italiani costretti a fuggire
da quelle terre con imbarazzo. Quasi con una certa vergogna. Il Partito
comunista li considerava dei fascisti. In realtà erano semplicemente italiani
che avevano toccato con mano il "paradiso" socialista di Tito: esecuzioni
sommarie, foibe, il dover abbandonare la propria casa pur di portare a casa la
pelle. A leggere la storia di quei giorni viene la pelle d'oca.
Il presidente dell'Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd), Renzo Codarin, ha ricordato la
complessità del 25 aprile per gli esuli: "Mentre il resto d'Italia poteva
considerare chiuso il conflitto, all'estremo nord-est si scatenava una nuova
stagione di stragi nelle foibe, si consumavano processi sommari, venivano
compiute deportazioni non solo di ex fascisti ma anche di quanti si opponevano
al nascente regime comunista jugoslavo ed alle sue mire espansioniste". Erano
giorni bui, quelli. Giorni in cui una menzogna, un'accusa indimostrabile, faceva
la differenza tra la vita e la morte. Prosegue Codarin: "I sedicenti tribunali
del popolo emettevano le loro condanne basandosi sull'uguaglianza
italiano=fascista, ignorando gli sforzi compiuti da migliaia di nostri
connazionali contro il nazifascismo". Il 25 aprile fu dunque, per questi nostri
connazionali, una ferita. Che dava certamente loro la libertà, ma allo stesso
tempo li mutilava, molto spesso con la violenza, degli affetti più cari. Ed è il
motivo per cui Codarin afferma che la libertà del 25 aprile "non arrivò per
tutti gli italiani e che ci furono partigiani che combatterono per instaurare
una nuova dittatura liberticida di ispirazione comunista".
Riscoprire queste tragiche
pagine di storia è necessario affinché ci sia una vera pacificazione nazionale,
che tenga conto anche delle ferite inflitte e impresse al nostro Paese.
L'Aria Che Tira, Maria
Teresa Meli gela Serracchiani: "Il comunismo è stato peggio". Giada
Oricchio su Il Tempo il 26 aprile 2023
Il 25 Aprile, liberazione dal
nazifascismo, resta una festa divisiva: scontro tra Debora Serracchiani e Maria
Teresa Meli a “L’Aria che Tira”. Durante la diretta del talk del mattino su La7,
mercoledì 26 aprile, la conduttrice Myrta Merlino ha analizzato con i suoi
ospiti la lettera della premier Giorgia Meloni al “Corriere della Sera” in
occasione delle celebrazioni del 25 Aprile. Serracchiani l’ha ritenuta
insufficiente perché mette sullo stesso piano fascismo e comunismo: “Quando si
scrive una lettera da presidente del Consiglio, quindi rappresentando tutti, per
mettere fine a polemiche assolutamente giuste dopo le affermazioni della seconda
carica dello Stato (Ignazio La Russa, presidente del Senato, nda), ci si aspetta
sicuramente di più”.
L’esponente di spicco del Pd ha
affondato: “Non ha utilizzato il termine "antifascista" e ha continuato a
parlare del fascismo e del comunismo come se fossero la stessa cosa…”, “Beh sono
stati la stessa cosa… nel resto del mondo sono stati la stessa cosa e a volte il
comunismo è stato pure peggio. Certi discorsi si possono fare per l’Italia, non
per tutti eh…” ha ribattuto perentoria la giornalista del “Corriere della Sera”
che ha invitato destra e sinistra al riconoscimento reciproco degli orrori
perpetrati da entrambi i regimi.
L’ex capogruppo dem si è difesa
sostenendo che il 25 Aprile si parla di Resistenza, liberazione, partigiani e di
lotta contro il nazifascismo e che le parole giuste sono arrivate solo dal
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Cosa pensava Del Noce, il filosofo citato da
Meloni, del dibattito fascismo-antifascismo. Luciano Lanna su Il Secolo
d'Italia il 25 Aprile 2023
Il Manifesto degli intellettuali antifascisti è
stato pubblicato il 1º maggio del 1925 sui quotidiani “Il Mondo” e “Il Popolo”
ed era stato redatto da Benedetto Croce. Ed era stato presentato come la
risposta degli oppositori al Manifesto degli intellettuali fascisti, un
precedente documento redatto da Giovanni Gentile nel marzo 1925. Fascismo vs.
antifascismo: parliamo quindi di una disputa che risale a quasi cento anni fa…
Personalmente, non ricordo negli anni Settanta del Novecento nessuno discutere o
accapigliarsi, che so, tra garibaldini e pontifici, o tra cavourriani e
mazziniani. Eppure, nel 2023, lo stato del dibattito pubblico non riesce a
fuoriuscire da questo assurdo e tossico passato che non sembra passare.
Del Noce, dal consenso al fascismo
all’antifascismo
E’ opportuno, a tal proposito, ripercorrere
l’itinerario e la riflessione sul tema di un grande filosofo, Augusto Del Noce,
citato da Giorgia meloni nella sua lettera sul 25 aprile, il quale riuscì ad
affrontare meglio di altri l’interpretazione del binomio fascismo/antifascismo.
Ricordiamo che, come tanti italiani del tempo, l’Augusto Del Noce ventiduenne,
il 21 aprile 1932 aveva comunque preso la tessera – pur senza condividere la
retorica e la cultura del regime – del Partito nazionale fascista, e che nel
1934 da neo-insegnante si era iscritto anche all’Istituto nazionale di cultura
fascista e alla Associazione fascista della scuola; ma anche il suo amico Cesare
Pavese, due anni più grande del giovane filosofo, aveva preso anche lui la
tessera del Pnf. Questa era l’Italia degli anni del consenso al fascismo,
soprattutto dopo la Conciliazione con la Chiesa… Poi, è anche ovvio che dentro
di loro, i due erano lontanissimi dalle organizzazioni paramilitari del regime,
dalla cultura patriottarda, dal giacobinismo e dalla religiosità civile
intrinseci al fascismo. Interiormente, si sentivano di fatto antifascisti.
Il legame con Piero Martinetti
Del Noce, ad esempio, si lega molto al filosofo
Piero Martinetti: professore di Filosofia, si era distinto per essere stato uno
dei pochi docenti, nonché l’unico filosofo universitario italiano, a rifiutarsi
di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista. Lo stesso Del Noce,
dopo l’aggressione all’Etiopia e le leggi razziali, inizia quella che definirà
la sua “fuga senza fine” da quello che gli appariva come un cedimento al male
nella storia e nella politica. Di questo passo, dopo l’8 settembre e la fine del
regime, tra il ’43 e il ’44, il giovane filosofo entra in contatto con
l’organizzazione clandestina dei cattolici nell’Italia del Nord, allora
territorio della Repubblica sociale italiana di Mussolini. Ma all’interno di
questo osservatorio, il pensatore poté osservare direttamente i metodi di lotta
praticati dagli azionisti e dai comunisti e, nel momento stesso in cui elaborava
il personale rifiuto della lotta armata sulla base della sua adesione al rifiuto
del cedimento al “principio della forza”, ebbe modo di distaccarsi dallo spirito
della Resistenza.
Il distacco dallo spirito della Resistenza
Spiegherà questo passaggio, nel 1978, nel corso di
una lunga intervista con Giampiero Mughini, parlando della sua «incapacità ad
accettare e vivere il passaggio dall’antifascismo morale alla guerra civile». La
sua impressione fu che «la “guerra” divenisse il fine, non il mezzo. Al
contrario di quel che aveva detto Lenin – trasformare la guerra in rivoluzione –
la rivoluzione stava trasformandosi in una guerra…». Da cui, il distacco
delnociano dallo spirito della Resistenza, analogo a quello di un antifascista
doc come Mario Vinciguerra, da lui definito «un antifascista al di sopra di ogni
sospetto, che giudicò sbagliato elevare a mito quello che era stata pur sempre
una guerra civile». Del Noce non riuscì mai a pensare, per dirla in un solo
giudizio e con le sue precise parole, «che la Resistenza fosse il momento di una
rifondazione morale degli italiani». Ammetterà Del Noce, in una confessione
datata 1983, di essere stato da giovane «l’antifascista assolutamente risoluto,
e perciò condannato all’autodistruzione, che non aveva aderito a nessuno dei
movimenti che allora esistevano: Giustizia e libertà, comunisti, gruppi di
Ginzburg o anche quello di Capitini». Fino a quando, nel mezzo degli anni della
Resistenza, arriva a una scelta do coerenza: «Mi separai – ammetterà –
dall’antifascismo». Tanto per dire che antifascismo e lotta di Resistenza non
sono, e non sono state, la stessa cosa…
Inaugurare il postfascismo
E tanto questo era per lui una consapevolezza che
nel ’45, subito dopo la fine della guerra, avvia una collaborazione con il
quotidiano “Il Popolo Nuovo”, con una serie di articoli il cui tema unificante
era proprio l’inedita richiesta di un «superamento dell’antifascismo». Sin dal
maggio ’45 Del Noce aveva chiaro che, per un oltrepassamento reale delle
contraddizioni che avevano condotto sino alla tragedia della guerra, era
necessario andare «al di là del fascismo e dell’antifascismo» e riuscire a
inaugurare il “postfascismo”: la sola autentica politica di pacificazione
necessaria all’Italia di quegli anni. Che veniva, in uno degli articoli, così
caratterizzata: «Una politica di pacificazione […] di “oltre l’antifascismo”».
La sua interpretazione del fascismo, connessa al giudizio storico
sull’azionismo, era ancora in via di definizione, ma già prefigurava alcuni
punti fermi che svilupperà negli anni nelle opere successive, come quello
secondo cui il fascismo e l’antifascismo erano due fenomeni culturalmente
complementari, che necessariamente dovevano tenersi insieme, avendo entrambi
come matrice d’origine il fermento intellettuale espresso dalla rivista “La
Voce”. Il movimento di Mussolini non gli appare affatto frutto dell’arretratezza
culturale italiana, né un rigurgito di brutale barbarie da parentesi storica, ma
l’espressione di un processo coerente della modernità. La sua natura profonda,
scriveva Del Noce, è costituita dall’attivismo, che sacrifica tutto all’esigenza
del fare. In quanto elevava la politica a valore supremo, il fascismo, era per
Del Noce un fenomeno fortemente imparentato con l’antifascismo laico, in
particolare con l’azionismo.
L’intolleranza degli azionisti
All’azionismo, in particolare alla sua componente
di sinistra, da Del Noce definita “giacobina”, rimprovera un atteggiamento
spirituale simile a quello dell’avversario politico sconfitto: l’insistenza
degli azionisti sulla necessità di “sradicare il fascismo” gli appare
potenzialmente intollerante e liberticida, perché rivolta in pratica contro
tutti coloro che si oppongono al progetto azionista, considerati per ciò stesso
sospetti di voler restaurare il passato regime. Una testimonianza – degli anni
Novanta – del figlio Fabrizio tratteggia molto bene il suo stato d’animo: «C’è
una frase di Simone Weil che mio padre amava particolarmente: “Noi dobbiamo
essere sempre disposti a cambiare di parte come la giustizia, questa eterna
fuggiasca dal campo dei vincitori”. Lui certo ha sempre fatto così. Antifascista
della prima ora, e soprattutto antifascista per ragioni morali dopo
l’aggressione all’Etiopia e successivamente per le leggi razziali, adottò il
termine “anti-antifascista” quando cominciò ad assistere a quell’indegno
fenomeno di immediato ripudio per ragioni di interesse di quello stesso campo
che prima si era abbracciato».
La consapevolezza di andare oltre fascismo e
antifascismo
Fatto sta che nei primi anni Cinquanta Del Noce si
ritrova in sintonia con le posizioni dei giovani raccolti attorno alla rivista
bolognese “il Mulino”. In particolare il filosofo si ritrovava nelle tesi
dell’editoriale del 1957 dal titolo “La misura del nostro compito: il
post-fascismo”. Sulla stessa linea interpretativa si era già mosso qualche anno
prima anche Felice Balbo, un altro filosofo amico di Del Noce, ispirando, tra il
’53 e il ’54, una rivista, “Terza generazione”, che tendeva a porsi fuori ormai
dalla logica fascismo/antifascismo per consentire una crescita comune, non
ideologica, degli italiani e contagiare l’intellettualità di nuova generazione.
Il filo conduttore della rivista era quello di orientare il dibattito pubblico e
politico verso una nuova frontiera: il “postfascismo”, obiettivo della nuova
generazione degli anni ’50 (la terza) dopo la prima generazione, fascista, e la
seconda, antifascista. Un “postfascismo” dichiarato che – come sarà con
sfumature diverse per il gruppo de “il Mulino – implicava un riesame
interpretativo della storia italiana del Novecento e una rilettura del fascismo
come «esame di coscienza delle generazioni».
Proprio sulla consapevolezza della comune fase
postfascista, Del Noce scriverà un importante saggio – Idee per
l’interpretazione del fascismo – sulla rivista “L’Ordine civile” nell’aprile
1960.
Il saggio “Idee per l’interpretazione del
fascismo”
L’importanza di questo saggio – che si ricollegava
al ragionamento svolto qualche numero prima da Baget Bozzo sulla rivista, in
dialogo con un giovane neofascista – sarà tale che verrà considerato come il
punto di partenza nell’approccio storiografico al tema del fascismo da parte di
studiosi come Renzo De Felice ed Ernst Nolte. La tesi di Del Noce era che
occorreva passare, a oltre dieci anni dalla fine della guerra, a una
interpretazione oggettiva, in grado di porsi oltre le fuorvianti polemiche tra
“antifascismo militante”, di cui la massima espressione era ravvisabile negli
azionisti, che si ispirava alla visione “rivelativa” dei mali d’Italia, e
“filofascismo”, fenomeno non più concepibile dopo l’esaurimento storico del
fenomeno. Lo schema dell’“antifascismo militante” tipico dell’azionismo, poi
fatto proprio anche dalle sinistre democristiane, mirava invece a mantenere in
vita – ad avviso di Del Noce – il “pericolo” di un fascismo in realtà
inesistente da tempo. Che tutto questo fosse chiaro alla fine degli anni
Cinquanta e che, invece, venga cercato di venire attualizzato oggi, oltre
sessant’anni dopo, dovrebbe fare riflettere giornalisti, intellettuali e
politici. A chi giova riesumare un dibattito morto e sepolto?
Buon 25 aprile: la vera
storia di «Bella Ciao», la canzone che in realtà è nata dopo la Resistenza.
La sua storia è stata ben raccontata da Giorgio Bocca che spiega come la canzone
simbolo (per noi) della Resistenza non sia mai stata cantata durante la Guerra.
Redazione LogIn su Il Corriere della Sera il 25 aprile 2023
Come è nata «Bella Ciao»
«Bella ciao», una storia
controversa e complicata, legata alla Resistenza nell’inconscio collettivo: ma
di fatto a posteriori, solo a partire dalla metà degli anni ’60. Però con
un'immensa fortuna contemporanea e internazionale, che passa
attraverso Netflix e approda alla tragedia dell’Ucraina.
La sua storia è stata ben
raccontata da Giorgio Bocca, che citato in un articolo di Luigi Morrone spiega
come la canzone simbolo (per noi) della Resistenza non sia mai stata cantata
durante la Guerra. L’inno politico in realtà nacque nel 1964, quando nell’estate
di quell’anno venne cantato al Festival di Spoleto. E con questa storia vi
diciamo Buon 25 aprile.
Un simbolo posteriore per dare
unità
Alla luce di ciò, lo storico
Alessandro Bermani ha addirittura parlato di «invenzione di una tradizione»,
affermando che «a metà anni '60, il centrosinistra al governo ha puntato su
"Bella ciao" come simbolo per dare una unità posteriore al movimento
partigiano». Inoltre ha sottolineato che il vero e unico inno diffuso e
condiviso durante la Resistenza fu "Fischia il vento", vessillo musicale delle
Brigate Garibaldi.
Il racconto di Giorgio Bocca
"Bella ciao", una storia
controversa e complicata, legata alla Resistenza nell'inconscio collettivo: ma
di fatto a posteriori, solo a partire dalla metà degli anni '60. «Nei venti mesi
della guerra partigiana non ho mai sentito cantare "Bella ciao", è stata
un'invenzione del Festival di Spoleto». Parola di Giorgio Bocca, partigiano in
Val Grana prima e in Val Maira poi.
Il Festival di Spoleto nel 1964
Più nel dettaglio, l'illustre
giornalista si riferiva allo spettacolo intitolato, appunto, "Bella ciao", un
collage di canti popolari presentato per la prima volta nell'estate 1964 nella
raffinata kermesse ideata da Giancarlo Menotti. Ebbe grande successo e venne
dunque riproposto in molte altre piazze italiane. "Bella ciao" come inno
politico nasce dunque lì a Spoleto, a quasi 20 anni dalla fine della Guerra.
La comparsa nel 1953
La canzone come la conosciamo,
d'altronde, non compare in nessuna raccolta dei canti partigiani immediatamente
successiva alla Seconda Guerra Mondiale. La sua prima apparizione risale infatti
al 1953 sulla rivista La Lapa, mentre solo nel 1957 compare su L'Unità organo
ufficiale del Pci. Ma fonti certe e documentate sul suo uso durante la
Resistenza di fatto sono rare e spesso lacunose. Il che avvalora le affermazioni
di Bocca.
Le origini nell’800
Sulle origini di "Bella ciao" esistono comunque
diverse versioni: ovviamente i canti delle mondine, magari l'eco di una ballata
del '500 francese, persino un'influenza yiddish. Secondo molti studi la versione
partigiana di "Bella ciao" riprenderebbe il canto "Fior di tomba" riportato tra
i "Canti popolari del Piemonte" pubblicati nel 1888, uno dei quali inizia con il
verso «Sta mattina, mi sun levata».
Il testo e la storia di Bella
Ciao di Silvia Morosi e Paolo Rastelli
La storia, e il testo, di
Bella Ciao, il canto simbolo della Resistenza italiana. su Il Corriere della
Sera il 25 aprile 2023
Questo è il testo di «Bella
Ciao», canzone simbolo della Resistenza italiana. Poco sotto, la storia del
brano, tratta dal blog PocheStorie, di Silvia Morosi e Paolo Rastelli.
«Una mattina mi son svegliato,
oh bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, ciao, ciao, ciao!
Una mattina mi son svegliato
e ho trovato l’invasor.
O partigiano, portami via,
oh bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano,
oh bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, ciao, ciao, ciao!
E se io muoio da partigiano,
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in montagna,
oh bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, ciao, ciao, ciao!
E seppellire lassù in montagna
sotto l’ombra di un bel fior.
E le genti che passeranno
oh bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, ciao, ciao, ciao!
E le genti che passeranno
Ti diranno «Che bel fior!»
«È questo il fiore del
partigiano»,
oh bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, ciao, ciao, ciao!
«È questo il fiore del
partigiano
morto per la libertà!».
Chi non ha sentito, almeno una
volta nella vita, i versi di «Bella ciao»?
Conosciuta come inno
antifascista dei partigiani italiani nella Seconda guerra mondiale, si è diffusa
in tutto il mondo, entrando persino a far parte della colonna sonora della
celebre fiction «La casa di carta», una delle serie più popolari di Netflix.
Le sue origini musicali
risalgono, però, all’Ottocento (come molti altri canti dell’epoca, anche qui
torna il tema del «Fior di Tomba», caro anche ai Sepolcri di Ugo Foscolo, per
ricordare a chi passa davanti a una tomba con un fiore che lì è sepolto qualcuno
morto per amore o «per la libertà»).
L’origine di «Bella ciao» è
ancora incerta. Alcuni storici della canzone italiana hanno identificato nel
testo e nella musica influenze dei canti di lavoro delle mondine (che salutavano
il duro lavoro nei campi), altri la fanno risalire al Cinquecento francese,
altri ancora vedono nelle sue melodie addirittura delle influenze Yiddish (c’è
chi parla di un brano kletzmer, «Koilen», inciso da un ebreo di Odessa a New
York nel 1919). Recuperata nel corso degli anni, è stata utilizzata – poi – come
canto di saluto alle proprie amate da parte dei partigiani in partenza verso la
battaglia.
A raccontare la storia
dell’inno è il docufilm «Bella Ciao».
Patrocinato dall’Anpi
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), il filmato è co-prodotto da
Millstream Films and Media ed Ala Bianca Group srl, con la regia di Andrea Vogt,
e distribuito da Lilium Distribution. Con l’aiuto di etnomusicologi e studiosi,
quali lo storico Cesare Bermani, il documentario indaga le radici del canto e le
colloca nel Centro Italia; con i ricordi di Fausto Amodei, cantautore e
musicologo, il primo che nel ’63 rielaborò, trascrisse e registrò il copyright
della versione partigiana di Bella Ciao; Giovanna Marini, protagonista dello
spettacolo «Bella Ciao» del Nuovo Canzoniere Italiano a regia Roberto Leydi e
Filippo Crivelli; il contributo di Stefano Arrighetti, presidente dell’Istituto
Ernesto de Martino, il più grande archivio d’Europa sulla canzone popolare,
sociale e di lotta; Laura Siglienti, cugina di Enrico Berlinguer, partecipante
attiva dei primi festival della Gioventù dopo la Liberazione; Paolo Pietrangeli,
regista, scrittore, autore di «Contessa» l’inno del ’68 cantato nelle piazze da
operai e studenti; Álex Pina, produttore televisivo, sceneggiatore, regista
televisivo e scrittore spagnolo. E dei tanti partigiani ancora vivi, che
ricordano dove la sentirono intonare la prima volta, e dei tanti cantanti che si
sono cimentati negli anni riproponendola in chiave moderna come Cristiano Godano
e Skin che ne esaltano anche la versatilità.
I primi a indagare la storia
delle origini del brano – ricorda il documentario – furono Roberto Leydi e
Gianni Bosio. «Inizialmente era molto diffuso nella zona che va dall’Abruzzo
all’Emilia, poi è diventata il canto simbolo della Resistenza e della lotta
partigiana. Era l’inno di combattimento della Brigata Maiella in Abruzzo, ad
esempio. La sua diffusione è stata poi favorita dai governi di centro-sinistra,
che l’hanno considerata una canzone-simbolo importante», ricorda Bermani.
«Bella ciao» è stata ideata da
chi ha partecipato alle lotte per la Resistenza e «ha avuto un successo enorme
in tutto il mondo: è stato tradotto in più di quaranta lingue, e nel 1963 Yves
Montand la incise nel disco “Souvenirs d’Italie”. Ma la sua caratteristica più
importante è che “Bella ciao” è diventata con il tempo l’inno delle
manifestazioni che rivendicano la libertà contro l’oppressione». Un ricordo
importante per tornare a parlare anche della storia dello chansonnier francese
di origine toscane (al secolo Ivo Livi), sconosciuta ai più. Ne accenniamo solo
qualche tratto: nato a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, Montand – come
decise di chiamarsi in seguito – vide i suoi genitori emigrare dall’Italia a
Marsiglia perché socialisti e antifascisti, e dopo aver visto bruciato dagli
uomini del Duce il proprio laboratorio di scope. Montand non dimenticò mai però
le radici socialiste della sua famiglia e si impegnò sempre in politica,
partecipando anche alla Resistenza nella battaglia in cui i parigini cacciarono
i tedeschi.
Una curiosità? Il video «Bella
ciao» racconta anche uno degli episodi che contribuì a dare popolarità in epoca
moderna ai canti popolari e di lotta. Siamo nel 1964, al Festival dei due Mondi
di Spoleto. I giovani e le giovani del Nuovo Canzoniere Italiano come Giovanna
Marini, Caterina Bueno, Michele Straniero portano sul palco diverse canzoni di
lotta e scatenano le polemiche. Come quella della ricca «signora impellicciata»
che, in risposta al verso «E nelle stalle più non vogliam morir» (dal canto «E
per la strada gridava i scioperanti») si alzò dalla platea ed esclamò a gran
voce «Io possiedo trecentotrenta contadini e nessuno dorme nelle stalle!»,
richiamando a una rapida reazione Giorgio Bocca, da uno dei palchi («Va’ fuori,
carampana»). Michele Straniero, poi, si trovò a cantare la canzone
antimilitarista «O Gorizia tu sei maledetta», compresa una strofa – «Traditori
signori ufficiali / che la guerra l’avete voluta / scannatori di carne venduta /
e rovina della gioventù» – che non era in copione. Anche perché, nel pubblico,
erano seduti numerosi ufficiali. Infine, l’interpretazione di «Bella Ciao»
eseguita da una ex-mondina, Giovanna Daffini, e viene criticata da chi avendo
pagato lo spettacolo pretendeva di vedere sul palco personaggi famosi.
Un canto che, ancora oggi,
divide. Ma che, concordano gli intervistati e anche gli autori di questo blog,
deve essere ricordato come un canto di lotta contro l’oppressione e di amore per
la libertà.
"Bella ciao", la storia della canzone italiana
più famosa su History Channel. Un docufilm ricostruisce la nascita e la
fortuna di un brano leggendario: dai partigiani della Brigata Maiella (Abruzzo),
fino alla serie tv "La casa di carta". La Repubblica il 25 ottobre 2021. Bella
ciao è il canto popolare (e il brano italiano) più famoso al mondo, intonato dai
partigiani della Brigata Maiella (Abruzzo) e della Brigata Garibaldi (Marche):
sono loro i primi ad aver mixato melodie tradizionali a nuove parole
patriottiche. Le parole risuonarono poi al Festival della Gioventù Democratica a
Praga, era l'estate del 1947, nella versione partigiana. Versione riscoperta poi
in Italia e resa celebre dal Festival di Spoleto del 1964, dove si cantò anche
una Bella ciao in versione "mondine".
Da studenti i maestri ci istruivano secondo il
loro pensiero, fino a che abbiamo scoperto che era solo il pensiero di comunisti
arroganti. Prima dell’ABC ci insegnavano “Bella Ciao”.
L’Italia invasa dai migranti economici con il
benestare della sinistra. I Comunisti hanno il coraggio di cantare con i
clandestini: “. ..una mattina mi son svegliato ed ho trovato l’invasor…” Bella
Ciao
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo con la discultura e la disinformazione. Ci si deve chiedere: perchè
a scuola ci hanno fatto credere con i libri di testo che Garibaldi era un eroe
ed i piemontesi dei salvatori; perché i media coltivano il luogo comune di un
sud Italia cafone ed ignorante; perché la prima cosa che insegnano a scuola è la
canzone “bella ciao”? Per poi scoprire da adulti e solo tramite il web: che il
Sud Italia è stato depredato a causa proprio di Garibaldi a vantaggio dei
Piemontesi; che solo i turisti che scendono a frotte nel meridione d’Italia
scoprono quanto ci sia tanto da conoscere ed apprezzare, oltre che da amare; che
“Bella ciao” è solo l’inno di una parte della politica italiana che in nome di
una ideologia prima tradì l’Italia e poi, con l’aiuto degli americani, vinse la
guerra civile infierendo sui vinti, sottomettendoli, con le sue leggi, ad un
regime illiberale e clericale.
Bella ciao. Da
Wikipedia, l'enciclopedia libera. Bella ciao è un canto
popolare italiano, secondo alcuni proprio di alcune formazioni
della Resistenza in realtà mai cantato o pochissimo cantato nella versione del
partigiano, prima della fine della guerra. La stessa Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia (ANPI) riconosce che Bella ciao divenne inno
ufficiale della Resistenza soltanto vent'anni dopo la fine della guerra e che:
"È diventato un inno soltanto quando già da anni i partigiani avevano consegnato
le armi". La sua conoscenza ha cominciato a diffondersi dopo la prima
pubblicazione del testo nel 1953 sulla rivista La Lapa, ma è diventata
celeberrima soltanto dopo il Festival di Spoleto del 1964 perché idealmente
associato all'intero movimento partigiano. Nonostante sia un brano italiano
legato a vicende nazionali, viene usato in molte parti del mondo come canto
di resistenza e di libertà.
Storiografia.
Non ci sono
indizi della rilevanza di Bella ciao tra le brigate partigiane e neppure della
stessa esistenza della versione del partigiano antecedente alla prima
pubblicazione del testo nel 1953. Non ci sono tracce nei documenti
dell’immediato dopoguerra né è presente nei canzonieri importanti: "Non c’è, ad
esempio, nel “Canzoniere Italiano” di Pasolini e nemmeno nei “Canti Politici” di
Editori Riuniti del '62. C’è piuttosto evidenza di una sua consacrazione
popolare e pop tra il '63 e il '64, con la versione di Yves Montand e il
festival di Spoleto, quando il Nuovo Canzoniere Italiano la presentò al Festival
dei Due Mondi sia come canto delle mondine sia come inno partigiano. Una canzone
duttile, dunque, e talmente “inclusiva” da poter tenere insieme le varie anime
politiche della lotta di liberazione nazionale (cattoliche, comuniste,
socialiste, liberali...) ed esser cantata a conclusione del congresso DC che
elesse come segretario l’ex partigiano Zaccagnini". Come è riportato nel testo
di Roberto Battaglia Storia della Resistenza italiana (Collana Saggi n.
165, Torino, Einaudi, 1953) era Fischia il vento, sull'aria della famosa
canzone popolare sovietica Katjuša, che divenne l'inno ufficiale
delle Brigate partigiane Garibaldi. Anche il noto giornalista ed ex partigiano
nonché storico della lotta partigiana, Giorgio Bocca, affermò pubblicamente: «Bella
ciao … canzone della Resistenza, e Giovinezza … canzone del ventennio
fascista … Né l'una né l'altra nate dai partigiani o dai fascisti, l'una presa
in prestito da un canto dalmata, l'altra dalla goliardia toscana e negli anni
diventate gli inni ufficiali o di fatto dell'Italia antifascista e di quella del
regime mussoliniano … Nei venti mesi della guerra partigiana non ho mai sentito
cantare Bella ciao, è stata un’invenzione del Festival di Spoleto.
Affermazioni queste poi certificate da Carlo Pestelli nel suo libro Bella
ciao. La canzone della libertà, nel quale ricostruisce in modo dettagliato
le origini e la diffusione della canzone Bella ciao. Anche gli storici
della canzone italiana Antonio Virgilio Savona e Michele Straniero hanno
affermato che Bella ciao non fu cantata o fu poco cantata durante la
guerra partigiana ma venne diffusa nell'immediato dopoguerra. Solo poche voci,
come quella degli storici Cesare Bermani e Ruggero Giacomini sostengono che una
qualche versione di "Bella ciao", sia stata cantata da alcune brigate durante la
Resistenza, anche se non necessariamente nella versione del partigiano di cui,
come specificato sopra, non esistono prove documentali della sua esistenza fino
agli anni cinquanta. Secondo Bermani, pur senza portare prove convincenti a
dimostrazione, era l'inno di combattimento della Brigata Maiella in Abruzzo,
cantato dalla brigata nel 1944 e portato al Nord dai suoi componenti che dopo la
liberazione del Centro Italia aderirono come volontari al Corpo Italiano di
Liberazione. La ragione per cui non se ne aveva adeguata notizia, osserva
Bermani, starebbe in un errore di prospettiva storica e culturale: l'idea che la
Resistenza, e quindi il canto partigiano, fossero un fenomeno esclusivamente
settentrionale. Tuttavia viene fatto notare che l'ipotesi non è supportata da
evidenze perché esistono molti documenti scritti dai partigiani della Brigata
Maiella, comprese le canzoni che cantavano, e in nessuno di loro compare il
minimo accenno a Bella ciao, mentre compaiono altre canzoni; allo stesso modo,
nel libro autobiografico di Nicola Troilo, figlio di Ettore, fondatore della
brigata, c’è spazio anche per le canzoni che venivano cantate, ma nessun cenno a
Bella ciao. Per di più dal diario del partigiano Donato Ricchiuti, componente
della Brigata Maiella caduto in guerra il 1º aprile 1944, si apprende che fu
proprio lui a comporre l’inno della Brigata Maiella che si chiamava: “Inno della
lince”. Bermani in ogni caso concorda che la sua diffusione nel periodo della
lotta partigiana fosse minima anche se, sempre nella sua opinione e senza
portare evidenze documentali che la sostengano, la cantavano anche alcuni
reparti combattenti di Reggio Emilia e del modenese, ma non era la canzone
simbolo di nessun'altra formazione partigiana. Ragion per cui Cesare Bermanii
afferma che Bella ciao sia "l'invenzione di una tradizione" e che:
«A metà anni Sessanta, il
centrosinistra al governo ha puntato su Bella ciao come simbolo per dare una
unità posteriore al movimento partigiano». Secondo Giacomini, invece, la prima
attestazione scritta di Bella ciao come canto della Resistenza italiana
sarebbe nell'opuscolo "La rappresaglia tedesca a Poggio San Vicino"
scritto da don Otello Marcaccini e pubblicato nel luglio 1945. In questo
opuscolo don Otello Marcaccini, parroco di Poggio San Vicino (MC), commemora le
vittime della rappresaglia tedesca avvenuta il 1º luglio 1944 e riporta: «La
vita per i patrioti è gaia ma pur sempre vigilante e rischiosa. Si macellano
bovini, si acquista vino che viene distribuito anche alla popolazione a basso
prezzo. Ora gli abitanti di Poggio S. Vicino, prima per plausibili ragioni
diffidenti, assistono come meglio i Partigiani e prendono parte attiva alle loro
vicende ora liete ora dolorose.
I bambini poi sono sempre in mezzo a loro, rendono
piccoli servizi, si entusiasmano e ripetono le loro canzoni di battaglia:
"se io morissi da Patriota
Bella ciao, ciao, ciao".»
D'altra parte questa versione, con l'utilizzo del
termine "patriota" al posto di "partigiano", confermerebbe ulteriormente che non
esistono prove documentali che la versione del partigiano sia antecedente alla
prima pubblicazione del testo a metà degli anni cinquanta del Novecento. Sempre
secondo Giacomini, un'altra attestazione di Bella ciao come canto della
Resistenza italiana si avrebbe in una lettera datata 24 aprile 1946 scritta
dalla russa Lydia Stocks ad Amato Vittorio Tiraboschi. Tiraboschi, col nome di
battaglia Primo, era stato il comandante della zona di Ancona della Brigata
Garibaldi-Marche e, successivamente, della V Garibaldi-Ancona. Lydia Stocks dopo
l'8 settembre fuggì da un campo di internamento femminile in provincia di
Macerata e raggiunse i partigiani sul monte San Vicino, dove conobbe Douglas
Davidson, comandante di distaccamento e il comandante Tiraboschi ("Primo"), a
cui facevano riferimento tutti i gruppi partigiani della zona del San Vicino.
«Quando penso di tutto ciò, ho voglia di piangere perchè ancora ricordo tutto
quello che abbiamo provato, tutti quale giovani ragazzi che andavano morire con
il canto Bella ciao. E poi venivano ferite e morti, che non dimenticherò
mai finchè vivrò, perchè ho amato con tutto il mio cuore tutti quelli ragazzi e
amerò sempre. Per me la Italia [è] stata una seconda Patria e lo amo popolo
Italiano con tutti i suoi difetti. Quanto sarò felice se la Italia di nuovo sarà
in piedi, ma senza i Fascisti... Non tanti che possano comprendere tutto questo,
ma Voi, sì, perchè avete sofferto con noi.» La fonte riporta solo il titolo
della canzone, per cui non è possibile sapere quale fosse la versione testuale
di Bella ciao che veniva cantata. Annalisa Cegna, direttrice dell'Istituto
storico della Resistenza di Macerata, si è dimostrata piuttosto cauta riguardo
la tesi di Giacomini: "Un solo documento non è sufficiente per avere garanzie
storiche."
Origine del testo
La Bella ciao partigiana riprende nella
parte testuale la struttura del canto dell'Ottocento Fior di tomba che Costantino
Nigra riporta in numerose versioni tra i Canti popolari del Piemonte, pubblicati
per la prima volta nel 1888, tra i quali uno inizia con il verso Sta mattina,
mi sun levata. Nigra riporta anche una variante veneziana che inizia con Sta
matin, me son levata. Le varie versioni raccontano la storia di una donna
che vuol seguire per amore un uomo, anche se ciò comporterà la morte e l'essere
seppellita, tanto le genti che passeranno diranno "che bel fiore" o "che buon
odore" a seconda della versione. A proposito della canzone Nigra, sempre nel suo
libro del 1888, osservava: «Il fiore che deve crescere sulla tomba della bella,
morta per amore, è il tema d’una canzone che è forse la più cantata in tutta
Italia. Questo tema è talmente popolare presso di noi, che in molti casi
s’aggiunge, come finale, ad altre canzoni che non ci han nulla a che fare.» Sia
musicalmente sia nella struttura dell'iterazione (il "ciao" ripetuto), deriva
anche da un canto infantile diffuso in tutto il Nord: La me nòna l'è
vecchierella, rilevato da Roberto Leydi, di cui si riporta l'inizio:
«La me nòna, l'è vecchierèlla
la me fa ciau, la me dis ciau, la me fa ciau ciau
ciau»
Alcuni ipotizzato il legame con un canto
delle mondine padane, ma altri, come Cesare Bermani: sostengono che la Bella
ciao delle mondine sarebbe stata composta dopo la guerra dal mondino Vasco
Scansani di Gualtieri.
Il seguente testo è quello più diffuso della
versione partigiana, con alcune varianti:
«Una mattina mi son svegliato
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
una mattina mi son svegliato
e ho trovato l'invasor.
O partigiano portami via
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
o partigiano portami via
che mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.
Seppellire lassù in montagna
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
seppellire lassù in montagna
sotto l'ombra di un bel fior.
E le genti che passeranno
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
e le genti che passeranno
mi diranno che bel fior.
E questo è il fiore del partigiano
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
e questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà.»
Origine della musica
Bella Ciao eseguita dall'Orchestra Rappresentativa
delle Guardie Serbe (ROG)
La musica, di autore sconosciuto, è stata fatta
risalire, in anni passati, a diverse melodie popolari. Una possibile influenza
può essere stata quella di una ballata francese del Cinquecento che, seppur
mutata leggermente a ogni passaggio geografico, sarebbe stata assorbita dapprima
nella tradizione piemontese con il titolo Là daré 'd cola montagna, poi
in quella trentina con il titolo Il fiore di Teresina, poi in
quella veneta con il titolo Stamattina mi sono alzata, successivamente
nei canti delle mondariso e infine in quelli dei partigiani. Una versione della
Bella ciao delle mondine fu registrata dalla cantante Giovanna Daffini nel 1962.
Un'altra possibile origine della melodia è stata
individuata da Fausto Giovannardi a seguito del ritrovamento di una
melodia yiddish (canzone Koilen) registrata da un
fisarmonicista Klezmer di origini ucraine, Mishka Ziganoff, nel 1919 a New
York. Secondo lo studioso Rod Hamilton, della The British Library di Londra,
"Kolien" sarebbe una versione di "Dus Zekele Koilen" (Due sacchetti di
carbone), di cui esistono varie versioni risalenti agli anni 1920.
La Bella ciao delle mondine
Come sopra riportato, alcuni sostengono che la Bella
ciao partigiana sia stata preceduta dalla Bella ciao delle mondine
che lo storico Cesare Bermani reputa invece posteriore. Di seguito il testo di
Bella Ciao delle mondine.
«Alla mattina appena alzata
o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao
alla mattina appena alzata
in risaia mi tocca andar.
E fra gli insetti e le zanzare
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
e fra gli insetti e le zanzare
un dur lavoro mi tocca far.
Il capo in piedi col suo bastone
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
il capo in piedi col suo bastone
e noi curve a lavorar.
O mamma mia o che tormento
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
o mamma mia o che tormento
io t'invoco ogni doman.
Ed ogni ora che qui passiamo
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
ed ogni ora che qui passiamo
noi perdiam la gioventù.
Ma verrà un giorno che tutte quante
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
ma verrà un giorno che tutte quante
lavoreremo in libertà.»
In questo contesto si nota come l'espressione
"bella ciao" indichi la giovinezza che si perde e sfiorisce nel
lavoro.
«Stamattina mi sono alzata,
stamattina mi sono alzata,
sono alzata – iolì
sono alzata – iolà
sono alzata prima del sol...»
Diffusione
La fortuna
di questo canto, che lo ha fatto identificare come canto simbolo della
Resistenza italiana e dell'unitarietà contro le truppe naziste come elemento
fondante della Repubblica Italiana, consiste nel fatto che il testo lo connota
esclusivamente come canto contro "l'invasore", senza riferimenti - per stare
alla ormai classica tripartizione di Claudio Pavone - alla Resistenza come
"guerra di classe" o come "guerra civile" (come invece è nel canto più cantato
dai partigiani, quella Fischia il vento dove invece sono presenti i
riferimenti al "sol dell'avvenire" e alla "rossa bandiera"). Non vi sono
elementi concreti né fonti a sostegno di coloro che affermano che la popolarità
internazionale di Bella ciao si diffuse negli anni 1950, in occasione dei
numerosi "Festival mondiali della gioventù democratica" che si tennero in varie
città fra cui Praga, Berlino e Vienna, al contrario la mancanza di fonti al
riguardo fa ritenere che questa affermazione sia una costruzione posteriore. La
canzone raggiunse una grandissima diffusione di massa negli anni sessanta,
soprattutto durante le manifestazioni operaie e studentesche del Sessantotto. Le
prime incisioni di questa versione partigiana si devono a Sandra
Mantovani e Fausto Amodei in Italia, e al cantautore francese di origine
toscana Yves Montand. La prima volta in televisione fu nella trasmissione Canzoniere
minimo (1963), eseguita da Gaber, Maria Monti e Margot, che la cantarono
senza l'ultima strofa: "questo è il fiore di un partigiano - morto per la
libertà". In 45 giri avvenne, da parte di Gaber, solo nel 1965. I Gufi la
cantano nell'album I Gufi cantano due secoli di Resistenza, edito nel
1965. Nel 1972 viene incisa da un partigiano ligure, Paolo Castagnino "Saetta",
con il suo Gruppo Folk Italiano, insieme a un'altra dozzina di canti della
Resistenza, dei quali narra nelle note di copertina l'origine. Saetta è stato un
protagonista della Resistenza, comandante della Brigata Garibaldina «Longhi»
decorato di medaglia d'argento al valor militare e della massima onorificenza
partigiana sovietica. Nel 2002 la canzone fu cantata dal giornalista Michele
Santoro in apertura di un'edizione straordinaria del programma televisivo Sciuscià,
da lui condotto, in polemica con il cosiddetto editto bulgaro. I Modena City
Ramblers, particolarmente legati alla Resistenza, hanno reinterpretato il brano
varie volte, la prima delle quali è presente già nell'EP Combat folk. Lo
hanno poi cantato in versione combat folk durante il Concerto del Primo
Maggio tenutosi a piazza San Giovanni a Roma nel 2004 (ripetuta poi negli anni
successivi). La versione del 1994 è stata usata per chiudere la campagna
elettorale di SYRIZA nel 2015. È stata rifatta più volte dal gruppo ska Banda
Bassotti (che spesso cantano la Resistenza nei loro testi), con ritmo più
veloce. Tra le innumerevoli esecuzioni spicca anche quella del musicista
bosniaco Goran Bregović, che la include regolarmente nei propri concerti, e che
ha dato al canto popolare un tono decisamente balcanico. Dal 1980 viene cantata
da Enrico Capuano in una versione folk rock nelle tante manifestazioni
politiche e antifasciste. Riproposta ogni anno nella scaletta dei suoi tour negli
USA e in Canada a partire dal 2011. Da segnalare la versione eseguita nel 2008
su Rai 3 in occasione del concerto del Primo Maggio insieme alla Tammurriatarock
e i Bisca. Ai funerali del regista Mario Monicelli il 1º dicembre 2010 la banda
del quartiere Pigneto suonò Bella ciao, accompagnata dal coro della folla e col
sottofondo delle campane della vicina chiesa. Durante i preparativi del Festival
di Sanremo 2011, il conduttore di quell'edizione, Gianni Morandi, annunciò che
avrebbe eseguito la canzone Bella ciao nella serata dedicata ai 150 anni
dell'Unità d'Italia insieme all'inno fascista Giovinezza. Tale
combinazione fu al centro di polemiche e l'iniziativa fu bloccata dal consiglio
d'amministrazione della RAI. Durante le proteste dell'ottobre 2011, il
movimento Occupy Wall Street, gli indignados a stelle e strisce, intonò Bella
ciao. Il candidato socialista François Hollande ha scelto il canto popolare
dei partigiani dell'Emilia-Romagna per concludere un suo discorso in occasione
delle elezioni presidenziali 2012, tra gli applausi della folla. Durante
le manifestazioni contro Erdoğan avvenute nella piazza Taksim di Istanbul e in
tante altre città turche nel 2013, alcuni manifestanti hanno intonato il motivo
della canzone. La canzone Bella ciao era molto cara a don Andrea Gallo,
morto il 22 maggio 2013. Durante i funerali il 25 maggio l'arcivescovo di
Genova, cardinale Angelo Bagnasco, ha dovuto interrompere la sua omelia ai
funerali di don Gallo. Infatti, mentre in chiesa lui ricordava "l'attenzione
agli ultimi" di don Gallo, dall'esterno si è levato il canto di Bella ciao,
intonato poi anche dai presenti in chiesa che hanno applaudito. Bella ciao,
in italiano, è stata anche cantata a Parigi dall'attore comico francese
Christophe Alévêque durante le commemorazioni funebri delle vittime della strage
avvenuta nella sede del settimanale satirico francese Charlie Hebdo: nel
corso di una cerimonia pubblica di sostegno del giornale (trasmessa in diretta
l'11 gennaio 2015 dalla France 2), e durante il funerale del fumettista Bernard
Verlhac, detto "Tignous" (trasmesso in diretta da BFMTV). La canzone è stata
utilizzata nella serie spagnola di Antena 3/Netflix La casa di carta.
Nell'attuale guerra civile siriana è stata utilizzata dagli
indipendentisti curdi. Nella rivoluzione sudanese del 2018 e 2019 alcuni ribelli
hanno intonato la canzone, realizzando anche una cover del brano.
Nel 2019 viene fatta una canzone inglese, Do it now, con un nuovo testo
sulle note di Bella ciao per i cambiamenti climatici. Sempre nel 2019,
viene cantata all'aeroporto di Barcellona dai manifestanti per l'Indipendenza
della Catalogna per protestare contro le condanne inflitte a dodici leader catalani.
Nel 2019 anche i manifestanti cileni cantano e suonano Bella ciao mentre
si ritrovano in Plaza Italia per protestare contro il presidente Sebastián
Piñera e per chiedere riforme economiche e cambiamenti politici.
Sempre nel 2019 è diventata una delle
canzoni simbolo delle piazze italiane del Movimento delle sardine e Paolo
Gentiloni, neo Commissario europeo all'Economia, con gli altri commissari
Socialisti e Democratici, la canta al Parlamento europeo a Strasburgo.
Sing for the Climate. Do it now.
Nel 2012 in Belgio il regista e attivista
ambientalista belga Nic Balthazar aveva aderito alla manifestazione
ambientalista "Sing for the climate" e in quell'occasione aveva girato un video,
dove i manifestanti cantavano in coro il brano Do it Now sulle note di Bella
ciao. La clip successivamente fu proiettata durante la seduta plenaria della
(UNFCCC) tenutasi a Doha in Qatar del 2012. In occasione delle
manifestazioni Venerdì per il futuro, il brano è stato adottato come inno. Nella
versione cantata da bambini turchi, in occasione della manifestazione mondiale
studentesca del 15 marzo 2019, è diventata un inno per l'ambiente.
Altre versioni.
Oggi è molto diffusa tra i movimenti di Resistenza
in tutto il mondo, dove è stata portata da militanti italiani. Ad esempio è
cantata, in lingua spagnola, da molte comunità zapatiste in Chiapas. A Cuba è
cantata nei campeggi dei Pionieri, mettendo la parola guerrillero al
posto della parola "partigiano". È conosciuta e tradotta anche in cinese. Dal
1968 in poi questa canzone è stata spesso ripresa come propria da movimenti di
sinistra e di estrema sinistra, soprattutto giovanili, anche se in origine era
riconosciuta come appartenente a tutta la Resistenza, alla quale parteciparono
formazioni e individui di diverse opinioni, dai comunisti ai socialisti, dai
repubblicani e azionisti ai cattolici fino ai partigiani autonomi -
contraddistinti da un fazzoletto di colore azzurro e contrari al comunismo. Una
versione sessantottina aggiungeva una strofa finale che recitava: "Era rossa la
sua bandiera... come il sangue che versò" (nel tempo svariate sono comunque le
cosiddette strofe finali inventate). Per questo motivo ancora oggi ispira autori
italiani e stranieri, ed è utilizzata in numerose occasioni, anche non
direttamente collegate alla Resistenza.
CINQUE COSE DA SAPERE SU “BELLA CIAO”.
REDAZIONE GARZANTI il 15.04.2020.
Quante volte vi siete ritrovati ad ascoltare o
cantare Bella ciao? Ecco cinque curiosità che dovete assolutamente sapere su
questo canto, tratte dal libro Bella ciao.
1. La sua origine è misteriosa
Ancora oggi la sua origine non è stata chiarita e
la sua paternità è incerta.
C’è chi sostiene che derivi da un canto di risaia
nato negli anni 30 in Emilia Romagna, chi addirittura che rilsaga da una melodia
Yiddish registrata nel 1919 a New York e portata in Europa da un emigrato di
ritorno al paese natio alla fine degli anni Venti.
Quel che è storicamente provato è che Bella ciao è
un canto nato durante la Resistenza e si è stato diffuso soprattutto nel
dopoguerra come canto di liberazione e antifascista.
2. La casa di carta c’entra molto…
Il successo planetario di Bella ciao, oggi, lo si
deve alla serie tv spagnola – La casa de papel, storia di una grande rapina
andata in onda dal 2017 e vincitrice nel 2018 di un International Emmy Award,
che ha avuto grande risonanza non solo in Spagna ma anche in Italia (col
titolo La Casa di carta), Argentina, Brasile. La canzone partigiana, cantata in
italiano, è presente in alcuni passaggi cruciali, a sottolineare i momenti di
felicità e la componente ribellistica del gruppo di rapinatori.3. Lo conoscono
(e lo cantano) davvero tutti
Le occasioni per ascoltarla o cantarla sono tante:
manifestazioni, comizi, funerali, trasmissioni televisive, film, viaggi della
memoria, ma non solo.
Nel 1984, ai funerali di Enrico Berlinguer il
canto partigiano risuona più volte, cantato dall’enorme folla e nel 2007 a
quelli di Enzo Biagi.
Nel 2010 Woody Allen e dalla sua New Orleans Jazz
Band ne suononano una versione al clarinetto all’Auditorium di via della
Conciliazione.
Nel 2013 risuona dietro il feretro di Jovanka
Broz, la vedova di Tito, che aveva lasciato disposizione che fosse quel canto a
risuonare al suo funerale.
Il canto è ormai un successo mondiale, favorito
anche dalle interpretazioni di Goran Bregovic e di Manu Chao, dei Chumbawamba, e
di tanti altri artisti.
4. È il canto antifascista per antonomasia
Da quando si è diffusa in tutto il mondo, Bella
ciao risuona come canto di protesta antifascista in manifestazioni contro i
poteri forti e dittatoriali.
Fu intonata durante le manifestazioni
turche contro il premier Erdoğan avvenute in Piazza Taksim a Istanbul e in tante
altre città turche nel 2013.
È stata cantata anche dal movimento “Occupy Wall
Street” nel 2011.
5. È cantato in 40 lingue diverse
Un jingle di rara potenza, che troviamo in
numerose versioni e rifacimenti. I più recenti per dimostrare vicinanza e
soliderietà agli italiani durante l’emergenza sanitaria covid-19.
25 aprile e "Bella ciao", l'origine della
canzone che piace a tutti. Un canto popolare o un canto dei partigiani? Ma
questo brano, tradotto in 40 lingue, viene intonato anche allo stadio. Francesco
Guidetti il 24 aprile 2021 su quotidiano.net. Bella Ciao? “Ie trasarla me
sgangiadomma/Oi sucar ciai sucar ciai sucar ciai ciai ciai/Ie trasarla me
sgangiadomma/le castenghere isle coi”. No, tranquilli, non
siamo impazziti. Sono solo alcuni versi
di Bella Ciao (che non è affatto un canto
comunista) in sinto piemontese, variante regionale della lingua usata tra i rom
delle Alpi occidentali. E potremmo continuare, magari proponendo la versione
in latino. Oppure in curdo,
scritta da Ciwan Haco, artista molto popolare da quelle parti. Del resto, non
c'è da stupirsi. La canzone
della Liberazione è tradotta in 40 lingue. Segno
che piace a tutti, a prescindere dal livello culturale e dal profilo
professionale. Piace a tutti perché è estremamente 'facile', non a caso i
bambini la imparano subito. E non solo il motivo musicale, ma anche il testo. Un
esempio: i francesi sono gli unici che la cantano in versione originale (celebre
quella di Ivo Livi, più noto come Yves
Montand, immortale cantante francese di origini
pistoiesi) perché la sentono allegra, anche se sanno benissimo che si tratta di
una storia di amore e morte, la
storia di un combattente per la libertà che sta per essere ucciso.
Insomma, siamo di fronte alla canzone 'popolare' per eccellenza. Il che pone un
problema. Se è così popolare chi l'ha inventata? Discorso complesso, lo
dimostrano studiosi come Carlo
Pestelli e Cesare
Bermani. C'è chi parla di canti delle mondine, ma
la questione è assai controversa. Chi sostiene di averla sentita nelle trincee
nella Grande Guerra.
Chi, cerca che ti ricerca, ne trova echi a metà Ottocento E' il caso di canti
popolari come “Fior di tomba” o “La bevanda sonnifera”: “Noi alter due farem
l'amor/e con quel ciao le la mi fa ciao/lei la mi' dì ciao ciao ciao”.
La Liberazione atto di nascita o
di fine?
E poi, il grande interrogativo. E' canzone
popolare post seconda guerra mondiale? Insomma, i partigiani la cantavano
davvero? Molti studiosi scrissero di no, ma proprio Pestelli ci spiega come le
arie fossero ben note, a esempio, in Emilia,
in particolare nel modenese. E, per restare in questa regione, non va
sottovalutato che Bella Ciao (dove la parola 'bella' risuona 18 volte e il
'ciao' 30) fosse il canto preferito da quei partigiani abruzzesi decisivi per
la Liberazione
di Bologna.
Fatto sta che la cantano (quasi) tutti. Magari
senza intenti politico-celebrativi. Come allo stadio (“chi non salta è
bianconero oh oh oh”), seppur con significati diversi. A Livorno la
curva storicamente rossa intona le strofe per motivi di identità. In Danimarca,
tradotta, la sua eco si sente sugli spalti del Brondby
IF, football team tra i più
famosi (ci giocò anche Michael Laudrup). E anche l'industria
dell'intrattenimento l'ha fatta sua: con spettacoli teatrali, con film, con il
rock. Si pensi solo alla versione dei Modena
City Ramblers.
La a canzone popolare, nel corso del tempo, è
diventata tra i più celebri inni di protesta e resistenza. Ecco la sua storia e
la sua diffusione, dalle piazze italiane e di tutto il mondo, fino alle serie tv
come "La casa di carta". Da tg24.sky.it. È uno dei canti popolari italiani più
famosi al mondo, si è diffuso nel secondo dopoguerra e nel tempo è stato ripreso
da più parti, dalla musica folk alle serie tv, passando per tanti movimenti di
protesta in giro per il mondo. Di autore sconosciuto, "Bella Ciao" divenne
l’inno del movimento partigiano italiano, anche se è diventata celebre e scelta
come canto ufficiale soltanto dopo la Resistenza. Ma con la sua prima
diffusione, in poco tempo, si conquistò la fama canto di ribellione per
eccellenza contro il nazi-fascismo.
UN CANTO POCO CONOSCIUTO DURANTE LA RESISTENZA
Gli studiosi non sono riusciti a individuare
un'origine certa per Bella ciao. Nel tempo si sono ipotizzati legami con un
canto infantile diffuso nel Nord Italia o una ballata francese del Cinquecento
poi assorbita dalle tradizioni popolari orali. La musica e il testo della
canzone restano di origine sconosciuta e sono forse la sintesi di melodie
diverse.
Il canto si iniziò a diffondere tra le fila del
movimento partigiano già durante la Seconda guerra mondiale. Ma all'epoca non
era ancora annoverata tra gli inni della Resistenza. Decisamente più popolare
era "Fischia il vento", il famoso canto sull’aria della canzone sovietica
Katjuša. "Bella Ciao" inizialmente era poco nota e veniva inneggiata solo in
alcuni reparti combattenti di Reggio Emilia e del Modenese, nella Brigata
Maiella e in altri gruppi partigiani delle Langhe, e non era certo ancora
riconosciuta come la canzone simbolo della Resistenza.
IL SUCCESSO NEL DOPOGUERRA
Dopo la Liberazione, l’ufficiale versione
partigiana di "Bella ciao" venne però presentata al primo Festival mondiale
della gioventù democratica che si tenne a Praga nell'estate del 1947. Al
festival si presentarono i giovani partigiani emiliani che parteciparono alla
rassegna canora "Canzoni Mondiali per la Gioventù e per la Pace". Fu così che
"Bella Ciao" venne per la prima volta cantata, tradotta e diffusa in tutto il
mondo grazie alle numerose delegazioni che partecipavano all'evento.
DALLA PRIMA INCISIONE ALLA TV
Le prime incisioni di "Bella Ciao" per come la
conosciamo oggi, si devono a Sandra Mantovani e Fausto Amodei in Italia, e al
cantautore francese di origine toscana Yves Montand. La prima volta che è stata
cantata in televisione fu nella trasmissione Canzoniere minimo (1963), eseguita
da Gaber, Maria Monti e Margot, che la cantarono senza l'ultima strofa: "Questo
è il fiore del partigiano morto per la libertà". Fu poi pubblicata in 45 giri da
Gaber nel 1965.
LE RIEDIZIONI PIÙ FAMOSE: DALLE BAND FOLK A "LA
CASA DI CARTA"
Tra le riedizioni più popolari in Italia ci sono
quella del gruppo folk Modena City Ramblers e quella del gruppo ska Banda
Bassotti. Una delle più popolari in Europa è invece quella eseguita dal
musicista bosniaco Goran Bregović. Tra le ultime e più celebri rievocazioni del
canto c’è certamente quella intonata dai protagonisti de "La casa di carta", la
serie Netflix che ne ha fatto il pezzo portante della sua colonna sonora.
UN INNO DI PROTESTA
L’inno non ha smesso di essere un canto di
battaglia ripreso da diversi movimenti di protesta e spesso impugnato anche
dalla politica. "Bella Ciao" è stata intonata dal movimento Occupy Wall
Street durante le proteste dell'ottobre 2011, cantata durante le manifestazioni
contro Erdoğan avvenute in piazza Taksim a Istanbul nel 2013 e in tanti altri
contesti di lotta come quello dell'attuale guerra civile siriana, dove "Bella
Ciao" è diventato uno dei canti degli indipendentisti curdi. Questo stesso
canto, in Italia, è stato ripreso anche dal movimento delle Sardine, che ne ha
fatto il suo inno, da intonare in tutte le piazze italiane in cui si sono svolte
le manifestazioni. Nel 2019, il brano Do it Now sulle note di Bella ciao, è
stato adottato come inno in occasione delle manifestazioni Fridays for Future.
La vera storia di
“Bella ciao”, che non venne mai cantata nella Resistenza. La nostra
storia di Dino
Messina su Il Corriere della Sera il 10 luglio 2018. Di Luigi Morrone.
Gianpaolo Pansa: «Bella ciao. È una canzone che
non è mai stata dei partigiani, come molti credono, però molto popolare».
Giorgio Bocca: «Bella ciao … canzone della Resistenza e Giovinezza … canzone del
ventennio fascista … Né l’una né l’altra nate dai partigiani o dai fascisti,
l’una presa in prestito da un canto dalmata, l’altra dalla goliardia toscana e
negli anni diventate gli inni ufficiali o di fatto dell’Italia antifascista e di
quella del regime mussoliniano … Nei venti mesi della guerra partigiana non ho
mai sentito cantare Bella ciao, è stata un’invenzione del Festival di Spoleto».
La voce “ufficiale” e quella “revisionista” della storiografia divulgativa sulla
Resistenza si trovano concordi nel riconoscere che “Bella ciao” non fu mai
cantata dai partigiani.
Ma qual è la verità? «Bella ciao» fu cantata durante la guerra civile? È un
prodotto della letteratura della Resistenza o sulla Resistenza, secondo la
distinzione a suo tempo operata da Mario Saccenti?
In “Tre uomini in una barca: (per tacer del cane)” di Jerome K. Jerome c’è un
gustoso episodio: durante una gita in barca, tre amici si fermano ad un bar,
alle cui parete era appesa una teca con una bella trota che pareva imbalsamata.
Ogni avventore che entra, racconta ai tre forestieri di aver pescato lui la
trota, condendo con mille particolari il racconto della pesca. Alla fine
dell’episodio, la teca cade e la trota va in mille pezzi. Era di gesso.
Situazione più o meno simile leggendo le varie ricostruzioni della storia di
quello che viene presentato come l’inno dei partigiani. Ogni “testimone oculare”
ne racconta una diversa. Lo cantavano i partigiani della Val d’Ossola, anzi no,
quelli delle Langhe, oppure no, quelli dell’Emilia, oppure no, quelli della
Brigata Maiella. Fu presentata nel 1947 a Praga in occasione della rassegna
“Canzoni Mondiali per la Gioventù e per la Pace”. E così via.
Ed anche sulla storia dell’inno se ne presenta ogni volta una versione diversa.
Negli anni 60 del secolo scorso, fu avvalorata l’ipotesi che si trattasse di un
canto delle mondine di inizio XX secolo, a cui “I partigiani” avrebbero cambiato
le parole. In effetti, una versione “mondina” di “Bella ciao” esiste, ma quella
versione, come vedremo, fa parte dei racconti dei pescatori presunti della trota
di Jerome.
Andiamo con ordine. Già sulla melodia, se ne sentono di tutti i colori.È una
melodia genovese, no, anzi, una villanella del 500, anzi no, una nenia veneta,
anzi no, una canzone popolare dalmata … Tanto che Carlo Pestelli sostiene:
«Bella ciao è una canzone gomitolo in cui si intrecciano molti fili di vario
colore»
Sul punto, l’unica certezza è che la traccia più antica di una incisione della
melodia in questione è del 1919, in un 78 giri del fisarmonicista tzigano Mishka
Ziganoff, intitolato “Klezmer-Yiddish swing music”. Il Kezmer è un genere
musicale Yiddish in cui confluiscono vari elementi, tra cui la musica popolare
slava, perciò l’ipotesi più probabile sull’origine della melodia sia proprio
quella della canzone popolare dalmata, come pensa Bocca.
Vediamo, invece, il testo “partigiano”. Quando comparve la prima volta?
Qui s’innestano i racconti “orali” che richiamano alla mente la trota di Jerome.
Ognuno la racconta a modo suo. La voce “Bella ciao” su Wikipedia contiene una
lunga interlocuzione in cui si racconta di una “scoperta” documentale
nell’archivio storico del Canzoniere della Lame che proverebbe la circolazione
della canzone tra i partigiani fra l’Appennino Bolognese e l’Appennino Modenese,
ma i supervisori dell’enciclopedia online sono stati costretti a sottolineare il
passo perché privo di fonte. Non è privo di fonte, è semplicemente falso:
nell’archivio citato da Wikipedia non vi è alcuna traccia documentale di “Bella
ciao” quale canto partigiano.
Al fine di colmare la lacuna dell’assenza di prove documentali, per retrodatare
l’apparizione della canzone partigiana, molti richiamano la “tradizione orale”,
che – però – specie se di anni posteriore ai fatti, è la più fallace che possa
esistere. Se si va sul Loch Ness, c’è ancora qualcuno che giura di aver visto il
“mostro” passeggiare sul lago …Viceversa, non vi è alcuna fonte documentale che
attesti che “Bella ciao” sia stata mai cantata dai partigiani durante la guerra.
Anzi, vi sono indizi gravi, precisi e concordanti che portano ad escludere tale
ipotesi.
Tra i partigiani circolavano fogli con i testi delle canzoni da cantare, ed in
nessuno di questi fogli è contenuto il testo di Bella ciao. Si è sostenuto che
il canto fosse stato adottato da alcune brigate e che fosse addirittura l’inno
della Brigata Maiella. Sta di fatto che nel libro autobiografico di Nicola
Troilo, figlio di Ettore, fondatore della brigata, c’è spazio anche per le
canzoni che venivano cantate, ma nessun cenno a Bella ciao, tanto meno sella sua
eventuale adozione come “inno”. Anzi, dal diario di Donato Ricchiuti, componente
della Brigata Maiella caduto in guerra il 1° aprile 1944, si apprende che fu
proprio lui a comporre l’inno della Brigata: “Inno della lince”.
Mancano – dunque – documenti coevi, ma neanche negli anni dell’immediato
dopoguerra si ha traccia di questo canto “partigiano”. Non vi è traccia di Bella
ciao in Canta Partigiano edito dalla Panfilo nel 1945. Né conosce Bella ciao la
rivista Folklore che nel 1946 dedica ai canti partigiani due numeri, curati da
Giulio Mele.
Non c’è Bella ciao nelle varie edizioni del Canzoniere Italiano di Pasolini, che
pure contiene una sezione dedicata ai canti partigiani. Nella agiografia della
guerra partigiana di Roberto Battaglia, edita nel 1953, vi è ampio spazio al
canto partigiano. Non vi è traccia di “Bella ciao”. Neanche nella successiva
edizione del 1964, Battaglia, pur ampliando lo spazio dedicato al canto
partigiano ed introducendo una corposa bibliografia in merito, fa alcuna
menzione di “Bella ciao”. Eppure, il canto era stato già pubblicato. È infatti
del 1953 la prima presentazione Bella ciao, sulla Rivista “La Lapa” a cura di
Alberto Mario Cirese. Si dovrà aspettare il 1955 perché il canto venga inserito
in una raccolta: Canzoni partigiane e democratiche, a cura della commissione
giovanile del PSI. Viene poi inserita dall’Unità il 25 aprile 1957 in una breve
raccolta di canti partigiani e ripresa lo stesso anno da Canti della Libertà,
supplemento al volumetto Patria Indifferente, distribuito ai partecipanti al
primo raduno nazionale dei partigiani a Roma. Nel 1960, la Collana del Gallo
Grande delle edizioni dell’Avanti, pubblica una vasta antologia di canti
partigiani. Il canto viene presentato con il titolo O Bella ciao a p. 148,
citando come fonte la raccolta del 1955 dei giovani socialisti di cui si è detto
e viene presentata come derivata da un’aria “celebre” della Grande Guerra, che
“Durante la Resistenza raggiunse, in poco tempo, grande diffusione”. Nonostante
questa enfasi, non c’è Bella ciao nella raccolta di Canti Politici edita da
Editori Riuniti nel 1962, in cui sono contenuti ben 62 canti partigiani. Sulla
presentazione di Bella ciao nel 1947 a Praga in occasione della rassegna
“Canzoni Mondiali per la Gioventù e per la Pace” non vi sono elementi concreti a
sostegno. Carlo Pestelli racconta: «A Praga, nel 1947, durante il primo Festival
mondiale della gioventù e degli studenti, un gruppo di ex combattenti
provenienti dall’Emilia diffuse con successo Bella ciao. In quell’occasione,
migliaia di delegati provenienti da settanta Paesi si riunirono nella capitale
ceca e alcuni testimoni hanno raccontato che, grazie al battimani corale, Bella
ciao s’impose al centro dell’attenzione», omettendo – però – di citare la fonte,
onde non si sa da dove tragga la notizia. Sta di fatto, che nei resoconti
dell’epoca non si rinviene nulla di tutto ciò: L’Unità dedica alla rassegna
l’apertura del 26 luglio 1947, con il titolo “La Capitale della gioventù”.
Nessun accenno alla presentazione del canto.
Come si è detto, sul piano documentale, non si ha “traccia” di Bella ciao prima
del 1953, momento in cui risulta comunque piuttosto diffusa, visto che da un
servizio di Riccardo Longone apparso nella terza pagina dell’Unità del 29 aprile
1953, apprendiamo che all’epoca la canzone è conosciuta in Cina ed in Corea. La
incide anche Yves Montand, ma la fortuna arriderà più tardi a questa canzone
oggi conosciuta come inno partigiano per antonomasia.
Come dice Bocca, sarà il Festival di Spoleto a consacrarla. Nel 1964, il Nuovo
Canzoniere Italiano la presenta al Festival dei Due Mondi come canto partigiano
all’interno dello spettacolo omonimo e presenta Giovanna Daffini, una musicista
ex mondina, che canta una versione di “Bella ciao” che descrive una giornata di
lavoro delle mondine, sostenendo che è quella la versione “originale” del canto,
cui durante la resistenza sarebbero state cambiate le parole adattandole alla
lotta partigiana. Le due versioni del canto aprono e chiudono lo spettacolo.
La Daffini aveva presentato la versione “mondina” di Bella ciao nel 1962 a
Gianni Bosio e Roberto Leydi, dichiarando di averla sentita dalle mondine
emiliane che andavano a lavorare nel vercellese, ed il Nuovo Canzoniere Italiano
aveva dato credito a questa versione dei fatti. Sennonché, nel maggio 1965, un
tale Vasco Scansiani scrive una lettera all’Unità in cui rivendica la paternità
delle parole cantate dalla Daffini, sostenendo di avere scritto lui la versione
“mondina” del canto e di averlo consegnato alla Daffini (sua concittadina di
Gualtieri) nel 1951. L’Unità, pressata da Gianni Bosio, non pubblica quella
lettera, ma si hanno notizie di un “confronto” tra la Daffini e Scansiani in cui
la ex mondina avrebbe ammesso di aver ricevuto i versi dal concittadino. Da
questo intreccio, parrebbe che la versione “partigiana” avrebbe preceduto quella
“mondina”. Nel 1974, salta fuori un altro presunto autore del canto, un ex
carabiniere toscano, Rinaldo Salvatori, che in una lettera alle edizioni del
Gallo, racconta di averla scritta per una mondina negli anni 30, ma di non
averla potuta depositare alla SIAE perché diffidato dalla censura fascista. La
contraddittorietà delle testimonianze, l’assenza di fonti documentali prima del
1953, rendono davvero improbabile che il canto fosse intonato durante la guerra
civile.Cesare Bermani sostiene che il canto fosse “poco diffuso” durante la
Resistenza, onde, rifacendosi ad Hosmawm, assume che nell’immaginario collettivo
“Bella ciao” sia diventata l’inno della Resistenza mediante l’invenzione di una
tradizione. Sta di fatto che lo stesso Bermani, oltre ad avvalorare
l’inattendibile ipotesi che fosse l’inno della Brigata Maiella, da un lato,
riconosce che, prima del successo dello spettacolo al Festival di Spoleto «si
riteneva, non avendo avuto questo canto una particolare diffusione al Nord
durante la Resistenza, che fosse sorto nell’immediato dopoguerra», dall’altro,
però, raccoglie svariate testimonianze che attesterebbero una sua larga
diffusione durante la guerra civile, smentendo di fatto sé stesso. Il problema è
che le testimonianze a cui fa riferimento Bermani per avvalorare l’ipotesi di
una diffusione, sia pur “scarsa”, di “Bella ciao” durante la guerra civile, sono
contraddittorie e raccolte a distanza di svariati anni dalla fine di essa (la
prima è del 1964 …), con una conseguente scarsa attendibilità. Dunque, se di
invenzione di una tradizione si tratta, è inventata la sua origine in tempo di
guerra. Ritornando al punto di partenza, come sostengono Bocca e Panza, “Bella
ciao” non fu mai cantata dai partigiani. Ma il mito di “Bella ciao” come “canto
partigiano” è così radicato, da far accompagnare il funerale di Giorgio Bocca
proprio con quel canto che egli stesso diceva di non aver mai cantato né sentito
cantare durante la lotta partigiana. Perché “Bella ciao”, nonostante tutto, è
diventata il simbolo della Resistenza, superando sin da subito i confini
nazionali? Perché ha attecchito questa “invenzione della tradizione”? Qualcuno
ha sostenuto che il successo di “Bella ciao” deriverebbe dal fatto che non è
“targata”, come potrebbe essere “Fischia il vento”, il cui rosso “Sol
dell’Avvenir” rende il canto di chiara marca comunista. “Bella ciao”, invece,
abbraccerebbe tutte le “facce” della Resistenza (Guerra patriottica di
liberazione dall’esercito tedesco invasore; guerra civile contro la dittatura
fascista; guerra di classe per l’emancipazione sociale), come individuate da
Claudio Pavone.
Ma, probabilmente, ha ragione Gianpaolo Pansa: «(Bella ciao) viene esibita di
continuo ogni 25 aprile. Anche a me piace, con quel motivo musicale agile e
allegro, che invita a cantarla». Il successo di “Bella ciao” come “inno” di una
guerra durante la quale non fu mai cantata, plausibilmente, deriva dalla
orecchiabilità del motivo, dalla facilità di memorizzazione del testo, dalla
“trovata” del Nuovo Canzoniere di introdurre il battimani. Insomma, dalla sua
immediata fruibilità. Dino Messina (1954), lavora dall’86 al “Corriere della
sera”, ha cominciato in cronaca di Milano e per diciannove anni nella redazione
cultura, dove si è occupato principalmente di storia contemporanea. Ora cura la
pagina dei commenti. Nel 1997 ha pubblicato con l’ex partigiano Rosario
Bentivegna e l’ex repubblichino Carlo Mazzantini “C’eravamo tanto odiati”
(Baldini & Castoldi), nel 2008 da Bompiani il libro di interviste “Salviamo la
Costituzione italiana”.
Bella ciao, la vera storia della canzone: "E'
nata a Macerata". Lo storico Giacomini ha trovato le prove : "La cantavano i
partigiani sul monte San Vicino. Poi fu adottata dalla Brigata Maiella che la
portò al Nord". Stefano Marchetti il
17 aprile 2021 su
ilrestodelcarlino.it.
"Una mattina mi son svegliato...". Un verso,
cinque parole. e l’hai già riconosciuta: "Bella ciao" non è soltanto una
canzone, ma un’icona,
un inno alla libertà,
all’indipendenza. Alla Resistenza. L’hanno cantata Yves Montand, Giorgio Gaber,
Anna Identici e Claudio Villa, Milva l’ha interpretata con grinta raffinata, la
ascoltiamo nelle manifestazioni di piazza. Già, ma quando è nata "Bella ciao"?
E dove? La notorietà di questo canto popolare è
pari al suo ‘mistero’. Numerosi storici hanno dedicato tempo e passione alle
ricerche. Di certo si coglie la discendenza da "Fior di tomba", antico
canto popolare del Nord, ma non è
chiara l’origine della versione partigiana: c’è chi ne ha trovato le radici tra
l’Appennino modenese e reggiano, chi l’ha collegata a un canto delle mondariso
(anche se la versione ‘della risaia’ è stata scritta nel 1961) e chi ne
individua la sorgente in Lazio. Lo storico Cesare Bermani ne ha attribuito la
nascita alla Brigata
partigiana Maiella che
dall’Abruzzo portò il canto più a Nord, per raggiungere l’Emilia.
"Sì, ma in realtà i partigiani della Brigata
Maiella conobbero e raccolsero ‘Bella ciao’ nelle
Marche, nell’area del Monte San
Vicino, fra Cingoli, Apiro e San Vicino, nel Maceratese.
‘Bella ciao’ è nata qui", dice Ruggero Giacomini, storico della Resistenza
marchigiana, che con l’editore Castelvecchi ha pubblicato il saggio "Bella ciao.
La storia definitiva della canzone partigiana che dalle Marche ha conquistato il
mondo".
Giacomini, ma ne è sicuro?
"Certo, era qualche anno che in
vari scritti trovavo riferimenti a una storia marchigiana di ‘Bella ciao’. Già
nel 2012 avevo dedicato un saggio alla strage nazifascista del 4 maggio 1944 sul
Monte Sant’Angelo ad Arcevia e mi ero imbattuto nella testimonianza del generale
Ricciardi che ricordava quando da ragazzino, sfollato con la famiglia ad
Arcevia, aveva sentito i partigiani entrare in città cantando ‘Bella ciao’. Ma
questi ricordi non mi convincevano pienamente".
Perché?
"Pensavo che potessero essere sovrapposizioni di memorie successive.
Inizialmente ritenevo improbabile un’origine marchigiana di ‘Bella ciao’, anche
se coglievo molti indizi. Finché nell’archivio dell’Istituto Storia Marche di
Ancona ho trovato la prova chiave".
Quale?
"Una lettera scritta il 24 aprile 1946 ad Amato Vittorio Tiraboschi, già
comandante della Brigata Garibaldi Marche, da Lydia Stocks, una russa che dopo
l’8 settembre 1943 era fuggita da un campo di internamento femminile in
provincia di Macerata e aveva raggiunto i partigiani sul monte San Vicino poi,
dopo la guerra, si era trasferita in Inghilterra. Ebbene, lei rammenta ‘tutti
quei ragazzi che andavano a morire con il canto Bella ciao’: certamente Lydia,
che stava in Inghilterra, non poteva essere influenzata. E questo va a
confermare la testimonianza di don Otello Malcaccini, parroco di Poggio San
Vicino, che nel luglio 1945 dedicò un opuscolo alla feroce rappresaglia tedesca
dell’anno precedente: scriveva che in paese nel 1944 i bambini affiancavano i
partigiani e cantavano ‘Se io morissi da Patriota, bella ciao, bella ciao’.
Dunque già nella primavera del 1944 qui si cantava ‘Bella ciao’".
Che poi ‘passò’ alla Brigata
Maiella…
"Esattamente. In terra marchigiana
i partigiani della Maiella entrarono il 24 giugno 1944 e nella loro avanzata
liberarono vari paesi. Il 18 arrivarono a Poggio, dove sostarono accolti dalla
popolazione. Qui adottarono e adattarono ‘Bella ciao’".
Ma perché questa storia non è
venuta alla luce prima?
"Perché si parla poco della
Resistenza nelle Marche, quando invece è stata fortissima, dura e precoce. È
sorprendente che in Italia si conosca poco di queste nostre storie di
Resistenza: forse perché noi marchigiani siamo fatti così, ragioniamo per
municipalismi, e custodiamo una modestia contadina che non sempre ci fa
emergere".
Che storia ha “Bella ciao”. Il canto
partigiano più famoso ha origini incerte e una diffusione trasversale, e se ne
riparla per una discussa proposta di legge. Il Post il 7 giugno 2021. Lo
scorso venerdì ha iniziato l’iter parlamentare una proposta di
legge – firmata da parlamentari di PD, Italia Viva, M5S e LeU – per rendere la
canzone partigiana Bella
ciao l’inno ufficiale della
Festa della liberazione dal nazifascismo, che cade ogni 25 aprile. Nel testo
presentato i parlamentari motivano la proposta facendo riferimento al «carattere
istituzionale» della canzone, rappresentativo dei «valori fondanti della
Repubblica», ma in queste ore i partiti più a destra della coalizione di
centrodestra – Fratelli d’Italia e Lega – hanno criticato duramente la
proposta, accusando i
parlamentari che l’hanno voluta di essere «sconnessi con la realtà». In
particolare il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, di Fratelli d’Italia,
ha detto:
«Bella
ciao, non per colpa del testo
ma per colpa della sinistra, è diventata una canzone che non copre il gusto di
tutti gli italiani: è troppo di sinistra. Non è la canzone dei partigiani, è la
canzone solo dei partigiani comunisti». In realtà, Bella
ciao è stata a lungo una
canzone piuttosto trasversale, come ha ricordato anche Concetto Vecchio su Repubblica portando
come esempio il congresso democristiano del 1976 – quello in cui fu eletto
segretario Benigno Zaccagnini – che si chiuse proprio con quella canzone. Oggi
esistono traduzioni di Bella
ciao in moltissime lingue ed è
stata suonata e cantata in contesti molti diversi, pur rimanendo tra i canti più
tradizionali e amati delle manifestazioni di sinistra italiane e non solo. La
storia di Bella
ciao è stata indagata da molti
storici e storiche, che hanno cercato di ricostruirne le origini e di
ripercorrerne le trasformazioni. La genesi della canzone, tuttavia, è ancora
dibattuta. Per molti anni è circolata l’ipotesi che Bella
ciao discendesse da un canto
diffuso tra le mondine nelle risaie durante gli anni Trenta, ma alcuni studi
hanno poi stabilito che canti di questo tipo comparvero per la prima volta nelle
risaie dagli anni Cinquanta, cioè dopo le prime attestazioni del canto
partigiano. Alcuni sostengono che discenda semplicemente da canti regionali del
Centro-Nord Italia, e altri ancora – come il giornalista Giampaolo Pansa –
sostengono che in realtà i partigiani non la cantarono mai e che diventò
popolare solo nel Secondo dopoguerra. Ma molte ricerche e pubblicazioni recenti
hanno documentato come Bella
ciao fosse diffusa durante la
Resistenza, sebbene in misura minore rispetto a Fischia
il vento, un’altra canzone
partigiana più connotata politicamente (“A conquistare la rossa primavera/Dove
sorge il sol dell’avvenir”). Lo storico Stefano Privato, nel suo libro del 2015 Bella
ciao. Canto e politica nella storia d’Italia,
scrive che Bella
ciao era diffusa perlopiù
nelle zone di Reggio Emilia, nell’alto bolognese, sulle Alpi Apuane e nei
dintorni di Rieti. Cesare Bermani, invece, che è esperto di storia orale, sostiene che i
primi a cantare Bella
ciao siano stati i partigiani
abruzzesi della Brigata Maiella, e che furono loro a portarla verso nord dove
sarebbe stata adottata anche dai partigiani toscani ed emiliani. Il dibattito
storico è ancora aperto, perché un recente
studio di Ruggero Giacomini, storico marchigiano, racconta come nella
zona di Macerata si cantasse già una versione di Bella
ciao – con un testo
leggermente diverso da quello oggi più diffuso – prima della primavera del 1944,
quando cioè la Brigata Maiella entrò nelle Marche liberando varie città e
aiutando la Resistenza locale. L’origine del canto partigiano è dunque ancora
incerta, e lo stesso si può dire della sua melodia, anche se in
molti la fanno risalire a una canzone popolare ebraica (yiddish) suonata
da Mishka Ziganoff. Tuttavia non è noto come questo giro di accordi di un
musicista rom ucraino naturalizzato statunitense sia diventato la base di Bella
ciao. Sicuramente nel corso
del Novecento Bella
ciao ha acquisito sempre
maggiore popolarità, forse proprio in virtù del fatto che era ritenuta più
universale rispetto ad altri canti partigiani comunisti. Negli anni l’hanno
cantata e suonata, tra gli altri, Milva, Manu Chao, Claudio Villa, Yves
Montand, Woody
Allen, Tom Waits. Una nuova e ancora più estesa fama gliel’ha portata poi
la serie di Netflix La
casa di carta, in cui viene
usata dal protagonista della serie – il “Professore” – come una specie di
richiamo alla rivolta. A seguito della serie, che ha avuto un grande successo in
molti paesi del mondo, sono uscite nuove versioni e remix della canzone, tra cui
quelle dei DJ Hardwell e Steve Aoki. Già prima della Casa
di carta, comunque, Bella
ciao era diventata un inno
internazionale alla lotta per la libertà, e per questo erano stati fatti già
moltissimi adattamenti e traduzioni. Viene usata per esempio dai curdi siriani
indipendentisti, che hanno lottato contro l’ISIS e che da decenni combattono
contro la Turchia per ottenere l’indipendenza, mentre negli ultimi anni – e
anche prima della Casa
di carta – si è sentita in
manifestazioni di piazza internazionali, dalla Turchia al Libano al Cile.
Bella ciao: la vera storia e le versioni
migliori del canto simbolo della Resistenza. Redazione Notizie Musica il 25
Aprile 2021. La vera storia di Bella Ciao: origini, e
significato del canto simbolo della Resistenza partigiana al nazi-fascismo. Da
decenni ormai in Italia c’è un canto
popolare che è associato alla Giornata della
Liberazione dal nazi-fascismo, le Festa del 25 aprile: Bella
ciao. Se tutti la conoscono, almeno nel suo
ritornello che ha saputo conquistare il mondo, non sono in molti ad aver
presente la storia e
le origini di un canto ben più antico di quanto si possa credere. Andiamo a
riscoprire insieme le origini,
ancora oggi piuttosto misteriose, di Bella
ciao, e la sua storia fino ai giorni nostri, senza
dimenticare di ascoltarne alcune versioni moderne che ancora oggi fanno ballare
milioni di persone.
La vera
storia di Bella ciao. Stando alle ricostruzioni tradizionali, Bella
ciao si farebbe risalire a un canto intonato dalle mondine del
vercellese nei primi anni del Novecento, attorno al 1906. In questa prima
versione non si cantava certo di resistenze belliche, bensì dello sfiorire
della giovinezza causata dal duro lavoro nelle
risaie. Da diversi anni però questo collegamento diretto tra Bella
ciao e il canto delle mondine non sembra più
convincere gli studiosi. L’origine della versione che tutti ancora oggi
conosciamo viene fatta risalire addirittura da Costantino Nigra, nella sua
opera Canti piemontesi,
a una canzone dal titolo Fior
di Tomba, il cui tema è l’abbandono da
parte del proprio amore. Un brano probabilmente di derivazione
francese e risalente al Cinquecento.
Quale che sia la sua origine, comunque, negli anni della Resistenza Bella
ciao venne recuperata, trasformata
nel testo e utilizzata come canto di saluto alle
proprie amate da parte dei partigiani in partenza verso quelle battaglie che,
spesso, significavano morte onorevole per i propri ideali. Ovviamente nel corso
degli anni sono stati in moltissimi a cimentarsi con un canto popolare di tale
importanza e bellezza. Oltre ai vari gruppi combat folk / rock di casa nostra,
come i Modena City
Ramblers, la Banda Bassotti o i Gang, vale la
pena ricordare le notevoli versioni di Milva,
di Giorgio Gaber e
di Goran Bregovic. La prima incisione di Bella
ciao risale al 1963, ad opera di Sandra
Mantovani e Fausto
Amodei. Gaber la incise nel 1967, il ‘reuccio’ Claudio
Villa nel 1975. Ma nel corso degli anni sono
tantissimi gli artisti, italiani e non, che ci si sono voluti cimentare. E anche
appartenenti ai generi più disparati. Oltre ai già citati, ricordiamo gli Ska-P,
Chumbawamba, Tom Waits e
Hardwell.
25 aprile, la vera storia di “Bella Ciao”. Dai
partigiani a Yves Montand, come è diventata un inno di resistenza. Origine
ed evoluzione di una canzone che seppur conosciuta da pochi ai tempi della
Liberazione, si è poi trasformata in un simbolo. A ricostruire le tappe è stato
Carlo Pestelli, musicista, cantautore e dottore di ricerca in Storia della
lingua nel libro per Add Editore “Bella ciao. La canzone della libertà”. Andrea
Giambartolomei il 25 aprile 2016 su Il Fatto Quotidiano. Da brano
della Resistenza, poco diffuso tra i partigiani, a canzone simbolo della
liberazione dal nazifascismo fino un inno internazionale di libertà. La storia
di “Bella ciao” ha origini misteriose e controverse, ma anche un straordinario
successo mondiale. A riassumerla oggi è Carlo Pestelli, musicista, cantautore e
dottore di ricerca in Storia della lingua, autore di “Bella ciao. La canzone
della libertà”, libro sintetico, divulgativo e utile, pubblicato da Add
editore.Da storico Pestelli recupera le ricerche sui canti popolari dalle quali
riemergono le somiglianze di “Bella ciao” con alcuni brani dell’Italia
settentrionale ormai quasi dimenticati. “Bella ciao è una sorta di bignami che
tiene conto di tante cose. Come dice il ricercatore Enrico Strobino è una
‘canzone gomitolo’ in cui si riuniscono molti fili. Il testo rimanda di sicuro a
‘Fior di tomba’, mentre è più complicato indicare l’origine della musica: c’è
‘Bevanda sonnifera’, ci sono alcune villotte nel Nord ed elementi kletzmer”,
spiega a ilfattoquotidiano.it l’autore. Il primo brano, ad esempio, ha due
elementi comuni, l’incipit “Una mattina mi son svegliato” e il finale con il
fiore sulla tomba con “quelli che passeranno”, elementi che risalgono
addirittura a un brano francese diffuso tra il XV e il XVI secolo. Dal secondo
brano, invece, prende il ritmo e le ripetizioni. Le note iniziali, inoltre, sono
stranamente uguali a un brano kletzmer, “Koilen”, inciso da un ebreo di Odessa
a New York nel 1919.Come è arrivata alla seconda guerra mondiale? Innanzitutto
va sfatato un mito: a lungo si è ritenuto che “Bella ciao” derivasse dai canti
di lavoro delle mondine, le donne che coglieva il riso. “In realtà la versione
delle mondine è nata dopo, negli anni Cinquanta”, spiega Pestelli. Citando gli
studi di Cesare Bermani, autore de “La ‘vera’ storia di Bella ciao”, il
musicista ribadisce che “Bella ciao” non era il brano partigiano più diffuso ed
era noto ad alcuni combattenti di Reggio Emilia e del Modenese, ad alcuni
componenti della Brigata Maiella che dall’Abruzzo erano arrivati a Bologna e ad
altri partigiani delle Langhe. “Durante una presentazione del libro – aggiunge –
un’anziana signora mi ha detto che lei nel 1944 cantava un brano del tutto
simile nella ‘Repubblica partigiana di Alba”.Soltanto tempo dopo è diventato il
brano partigiano per eccellenza. “Accade alla fine degli anni Cinquanta quando
si ha la necessità di unificare le varie anime della Resistenza, quella
comunista, socialista, cattolica, liberale, monarchica-badogliana – riassume -.
Non si poteva usare ‘Fischia il vento’ o altri canti politicizzati. ‘Bella ciao’
slega la Resistenza dalle appartenenze di partito e racconta qualcosa che può
essere atemporale”. Ed è per questo che il congresso Dc che elesse come
segretario il partigiano Benigno Zaccagnini si concluse sulle note di “Bella
ciao”, mentre dopo l’incisione dei Modena City Ramblers e i governi Berlusconi
identifica la sinistra.La sua popolarità arriva più tardi. Nel 1963 lo
chansonnier francese di origine toscane, Yves Montand (al secolo Ivo Livi)
incide il brano che avrà un successo internazionale e, di riflesso, lo riporterà
in auge anche in Italia, dove verrà eseguito da Milva e Giorgio Gaber. Poco dopo
sono il festival di Spoleto e anche il Nuovo Canzoniere Italiano
dell’entomusicologo Roberto Leydi (autore de “La possibile storia di una
canzone”), che nel 1964 porta sui palchi italiani l’ex mondina Giovanna
Daffini in uno spettacolo chiamato “Bella ciao”. Da lì in poi si è diffusa
ovunque: secondo Pestelli il tema della libertà contro un oppressore non
precisato lo hanno reso un brano adattabile, adottato dai braccianti messicani
in California, dai curdi e dai turchi, dagli ucraini anti-Putin e da quelli
filorussi e altri ancora. Ultimo in ordine di tempo, le manifestazioni dopo la
strage nella redazione di Charlie Hebdo, pretesto da cui è nata l’idea del
libro.
La vera storia di "Bella Ciao". Vittorio
Bobba, 17 Ottobre 2021,su weeklymagazine.it. Da oltre settant’anni non c’è
festa, manifestazione o evento in generale dove i trinariciuti di guareschiana
memoria non cantino ‘Bella Ciao’ come il Mazzolin di Fiori dei gitanti sul
pulmann, per dare un senso corale e di comunanza tra appartenenti alla stessa
fede politica. La canzone ‘Bella Ciao’ viene sbandierata dal dopoguerra come
simbolo musicale della lotta partigiana. Nulla di più falso.
Nessun partigiano ha mai cantato o conosciuto
Bella Ciao prima della fine della guerra.
La canzone è stata scritta nel 1918 dal musicista
tzigano di origini ucraine Mishka Ziganoff, e fu incisa nel 1919 dal suo autore
con il titolo “Koilen” in un disco a 78 giri dal titolo “Klezmer-Yiddish”
I musicisti girovaghi tzigani suonavano nelle
piazze di tutta Europa, certamente anche in Italia, ed è probabile (sebbene le
origini siano molto incerte, che questa melodia così orecchiabile sia stata
presa in prestito per la versione che circolava tra le mondine fin dagli anni
trenta. La si può facilmente trovare su YouTube in varie versioni, da quella
famosissima di Milva a quella struggente di Nanni Svampa.
Fatto sta che la stessa Associazione Nazionale
Partigiani d’italia (ANPI) riconosce che Bella ciao divenne inno ufficiale della
Resistenza soltanto vent’anni dopo la fine della guerra e che: “È diventato un
inno soltanto quando già da anni i partigiani avevano consegnato le armi”. La
sua conoscenza ha cominciato a diffondersi dopo la prima pubblicazione del testo
nel 1953 sulla rivista “La Lapa” ma è diventata celeberrima soltanto dopo il
Festival di Spoleto del 1964.
Sebbene più fonti citino Bella Ciao tra i canti
della resistenza, è assai improbabile che lo fosse. Lo stesso storico Cesare
Bermani (non certo uno studioso di destra) “concorda che la sua diffusione nel
periodo della lotta partigiana fosse minima anche se, sempre nella sua opinione
e senza portare evidenze documentali che la sostengano, la cantavano anche
alcuni reparti combattenti di Reggio Emilia e del modenese, ma non era la
canzone simbolo di nessun’altra formazione partigiana. Ragion per cui Cesare
Bermani afferma che Bella ciao sia “l’invenzione di una tradizione” e che: «A
metà anni Sessanta, il centrosinistra al governo ha puntato su Bella ciao come
simbolo per dare una unità posteriore al movimento partigiano»”.
Come è riportato nel testo di Roberto Battaglia
Storia della Resistenza italiana (Collana Saggi n. 165, Torino, Einaudi, 1953)
era Fischia il vento, sull’aria della famosa canzone popolare sovietica
“Katjuša”, che divenne l’inno ufficiale delle Brigate partigiane Garibaldi
Anche il noto giornalista ed ex partigiano nonché
storico della lotta partigiana, Giorgio Bocca, affermò pubblicamente: «Bella
ciao … canzone della Resistenza, e Giovinezza … canzone del ventennio fascista …
Né l’una né l’altra nate dai partigiani o dai fascisti, l’una presa in prestito
da un canto dalmata, l’altra dalla goliardia toscana e negli anni diventate gli
inni ufficiali o di fatto dell’Italia antifascista e di quella del regime
mussoliniano … Nei venti mesi della guerra partigiana non ho mai sentito cantare
Bella ciao, è stata un’invenzione del Festival di Spoleto.»
Dal 1964 Bella Ciao è stata utilizzata dalle varie
associazioni partigiane di ogni colore politico, come dimostra il fatto che fu
cantata dal congresso della DC all’elezione del segretario ed ex-partigiano
Benigno Zaccagnini.
È una canzone popolare divulgata, nelle sue
differenti versioni, tra le regioni del Piemonte e Veneto ma alcune tracce sono
state individuate anche nel centro Italia. Il perduto amore, la liberazione dal
lavoro opprimente e la morte sono le tematiche dei differenti testi tramandati,
principalmente, in forma orale. Ed è sulla base del metodo di diffusione
l’origine dei costanti cambiamenti di contenuto e significato.
“Alla mattina appena alzata/ o bella ciao bella
ciao bella ciao ciao ciao/ alla mattina appena alzata/ in risaia mi tocca
andar.” È l’incipit di una versione diffusa negli anni Trenta. Non si parla di
invasori ma di lavoro in risaia. Nei diversi studi, sul testo, si rintraccia la
trasmissione di questo inno nel lavoro dei campi di risaia. Saranno proprio le
mondine del nord e centro Italia a tramandare questo inno di liberazione. “ Ma
verrà un giorno che tutte quante/ o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao/
ma verrà un giorno che tutte quante/ lavoreremo in libertà.”
Con Bella Ciao è narrato anche l’amore in cui,
anziché raccontare dell’immagine del partigiano, quel “fiore” indica Rosettina o
Rosina “che l’è morta per l’amor.” Molteplici sono le fonti che raccontano e
diffondono il motivetto di Bella Ciao, già dalla metà del XIX secolo. Qualche
traccia si ritrova anche tra i testi antichi di canti popolari francesi, forse
dovuto alla vicinanza con il Piemonte.
Bella Ciao diventato inno della sinistra: ma le
origini sono altre Di cosa parleremo. Da lucascialo.it. il 10 Giugno 2019.
“Bella Ciao” è ormai un inno cantato in ogni manifestazione organizzata
dall’universo della sinistra italiana. Dalle manifestazioni sindacali, al 25
aprile, passando per il Primo maggio, il 2 giugno, Pasqua, Natale e Ferragosto.
Ad ogni occasione e ovunque ci siano bandiere rosse, ecco che parte la
canzoncina dei partigiani. Bella Ciao è una canzone che dovrebbe unire tutto il
paese e tutti i partiti democratici, visto che è stata ideata durante la Seconda
guerra mondiale e nel corso della ribellione dal nazi-fascismo. Quindi, dovrebbe
appartenere non solo ai partiti di sinistra, ma anche a quelli di centro e
quelli di destra. Intendendo per essi però quelli liberali e ovviamente non
post-fascisti. Invece, Bella ciao è diventato un inno che divide, di esclusiva
matrice di sinistra. Come se ci avesse posto il copyright. Eppure le origini di
questo inno sono altre. A spiegare bene le origini di Bella Ciao è un articolo
de Il Gazzettino, scritto dal Direttore Roberto Papetti in risposta a un
lettore. Bella Ciao non è stata la canzone della Resistenza italiana. Come si
ricorda anche in uno dei più bei libri su quel periodo, Il partigiano Johnny di
Beppe Fenoglio, le brigate partigiane, in larga parte egemonizzate dal Pci,
avevano eletto a loro inno altri testi, primo fra tutti Fischia il vento. Bella
Ciao non faceva parte del repertorio canoro della sinistra e non ne farà parte
per diversi decenni nel Dopoguerra. Come riporta Wikipedia, la Bella ciao
partigiana riprendeva nella parte testuale la struttura del canto Fior di tomba,
mentre sia musicalmente che nella struttura dell’iterazione (il “ciao” ripetuto)
derivava da un canto infantile diffuso in tutto il nord, La me nòna l’è
vecchierella (già rilevato da Roberto Leydi). Un’altra possibile influenza può
essere stata quella di una ballata francese del Cinquecento, che seppur mutata
leggermente ad ogni passaggio geografico, sarebbe stata assorbita dapprima nella
tradizione piemontese con il titolo di Là daré d’côla môntagna, poi in quella
trentina con il titolo di Il fiore di Teresina, poi in quella veneta con il
titolo Stamattina mi sono alzata, successivamente nei canti delle mondariso e
infine in quelli dei partigiani. Il legame con la Bella ciao delle mondine è
invece un falso storico. Nei cortei del 25 aprile era cantata solo nei settori
in cui sfilavano i partigiani bianchi e il segretario della Dc Benigno
Zaccagnini la faceva suonare alla conclusione dei lavori delle assisi di
partito. Allora sotto le bandiere rosse riecheggiavano altre note. Bella Ciao
perché inno di sinistra La svolta avviene nel 2002 quando Michele Santoro in una
puntata della trasmissione Sciuscià la intona polemicamente all’inizio di una
puntata dedicata alla libertà di informazione, dopo le dure dichiarazioni di
Berlusconi contro lo stesso Santoro, Biagi e Luttazzi (il cosiddetto editto
bulgaro). Da quel momento il destino di Bella Ciao cambia. La canzone diventa
prima l’inno semi-ufficiale dei cosidetti girotondi ( il movimento
antiberlusconiano guidato da Nanni Moretti), poi assurge al ruolo di canzone
prediletta della sinistra post-comunista, rimasta orfana di melodie storiche
come Fischia al Vento e Bandiera Rossa.
Ancora su "Bella Ciao" e lo strano destino di
una canzone "unitaria" che continua a dividere.
LETTERE AL DIRETTORE Sabato 27 Aprile 2019 su
ilgazzettino.it
Egregio Direttore,
perché demonizzare Bella ciao? Da un po' di anni a
questa parte, in occasione del 25 Aprile, è sempre la solita solfa. Io ho avuto
modo di cantarlo fin da fanciullo in ogni uscita di gruppo, durante le
scampagnate o le gite in montagna e posso garantire che non frequentavo gruppi
legati a fazioni di sinistra, bensì religiosi o parrocchiali. Più tardi, quando
ho avuto modo di essere fra gli organizzatori delle sfilate mestrine del 25
aprile, dove Anpi e Fivl sventolavano assieme le loro bandiere, nessuno s'è mai
peritato di mettere all'indice questo canto tradizionale. Oggi si adduce a
pretesto che è stato strumentalizzato e perfino un sindaco arriva a togliersi la
fascia per poterlo cantare. Ridicolo! Se è per quello anche Papaveri e papere fu
tacciato di pesanti sottintesi politici, eppure non s'è smesso di cantarlo. Oggi
si trasmette di tutto e si fa satira esplicita, più o meno di parte, attraverso
le canzoni, ma nessuno si sogna di zittirle. La polemica invece resiste suBella
ciao, che alla fin fine è la più unitaria. Chissà perché. Plinio Borghi Mestre
Caro lettore, il destino di Bella Ciao è
emblematico dei paradossi in cui la storia del nostro Paese si trova spesso
imbrigliata. Bella Ciao non è stata la canzone della Resistenza italiana. Come
si ricorda anche in uno dei più bei libri su quel periodo, Il partigiano Johnny
di Beppe Fenoglio, le brigate partigiane, in larga parte egemonizzate dal Pci,
avevano eletto a loro inno altri testi, primo fra tutti Fischia il vento. Bella
Ciao non faceva parte del repertorio canoro della sinistra e non ne farà parte
per diversi decenni nel Dopoguerra. Nei cortei del 25 aprile era cantata solo
nei settori in cui sfilavano i partigiani bianchi e il segretario della Dc
Benigno Zaccagnini la faceva suonare alla conclusione dei lavori delle assisi di
partito. Allora sotto le bandiere rosse riecheggiavano altre note. La svolta
avviene nel 2002 quando Michele Santoro in una puntata della trasmissione
Sciuscià la intona polemicamente all'inizio di una puntata dedicata alla libertà
di informazione, dopo le dure dichiarazioni di Berlusconi contro lo stesso
Santoro, Biagi e Luttazzi. Da quel momento il destino di Bella Ciao cambia. La
canzone diventa prima l'inno semi-ufficiale dei cosidetti girotondi( il
movimento anti-berlusconiano guidato da Nanni Moretti), poi assurge al ruolo di
canzone prediletta della sinistra post-comunista, rimasta orfana di melodie
storiche come Fischia al Vento e Bandiera Rossa. Personalmente credo che Bella
Ciao mantenga tutto il suo valore storico, la sua attualità e la sua forza di
canzone della memoria e della libertà. Ma, a torto o a ragione, qualcuno ritiene
che una parte politica si sia appropriata di questa melodia e, quindi, non la
sente più come propria. O non la vive come un inno unitario.
«Bella ciao» non sia obbligatoria ma non è un
inno comunista. Aldo Cazzullo il 14/6/2021 su Il Corriere della Sera. Caro
Aldo Cazzullo, per gli uomini del Pd che annaspano in cerca di idee, l’appiglio
estremo è da 75 anni sempre lo stesso: l’antifascismo. Quando si tratta di
frenare l’emorragia di consensi, la retorica antifascista e le note di «Bella
ciao», inno dei partigiani rossi, devono ricordare a tutti da che parte sta la
vera democrazia. Peccato che questo sia un falso storico. I partigiani che
combatterono il fascismo furono i repubblicani, i liberali, i militari fedeli
alla monarchia, i cattolici, gli azionisti seguaci di Pertini e Salvemini... I
partigiani comunisti combatterono la dittatura fascista non per la libertà, ma
per instaurare un’altra dittatura: la loro. Raffaele Laurenzi, Milano
Caro Raffaele, Non sono d’accordo con lei. I
partigiani non avevano bollini, tanto meno rossi. Certo, c’erano i comunisti, i
socialisti, i monarchici, i cattolici, gli azionisti. Ma la maggioranza erano
giovani senza partito, che anzi dopo vent’anni di fascismo non sapevano neppure
cosa fossero i partiti, e semplicemente rifiutarono di obbedire ai bandi
Graziani, e quindi di combattere per Hitler e Mussolini. Sono certo che questo
discorso vale pure per molti resistenti delle brigate Garibaldi. Detto questo,
certo, c’erano i comunisti. Qualcuno pensava di costruire una democrazia. Molti
sognavano di fare la rivoluzione come in Russia. Ma questo è un discorso
perfetto per le polemiche politiche di oggi, magari per giustificare chi invece
combatté per Hitler e Mussolini. All’epoca l’urgenza era di stabilire da quale
parte stare: con chi mandava gli ebrei italiani nei campi di sterminio, o
contro. Questo non toglie un’oncia alla gravità dei delitti commessi da
partigiani comunisti nel triangolo della morte emiliano e altrove. Quanto a
«Bella ciao», imporre di cantarla per legge è sbagliato. Ma non è una canzone
comunista. È una canzone che parla di libertà. Ad Alba, città dove la Dc aveva
il 60 per cento, il secondo partito era il Pli e il terzo il Pri, si cantava
«Bella ciao» senza pensare di fare una cosa di sinistra. E comunque Giorgio
Bocca raccontava di aver fatto la guerra di liberazione per quasi venti mesi
senza mai intonarla.
Bella
ciao a norma di legge. Marcello
Veneziani l'8 giugno 2021. È inutile girarci sopra: imporre Bella
Ciao a norma di legge nelle cerimonie
pubbliche è fatto per spaccare, creare un fossato di odio e di rancore, andare
contro quella metà o forse più del Paese e dei partiti che lo rappresentano e
che vogliono lasciare alle spalle dopo quasi ottant’anni la polemica antiquata e
aspra sul fascismo e sull’antifascismo. Un conto è il giudizio storico, un altro
è l’uso militante e propagandistico. E qui si tratta di uso politico e fazioso,
moralista e vessatorio di un canto che peraltro non nacque per la guerra
partigiana e divenne solo nelle manifestazioni politiche del dopoguerra l’inno
della Liberazione. Condivido quel che ha scritto, con finalità diverse dalle
mie, anzi per amore di Bella
Ciao, Maurizio Maggiani su la
Repubblica, che ha visto nella proposta di istituire il canto a norma di legge,
una forma di vampirismo, compiuto da “dissanguatori di ideali e di memorie”, per
ridare vita a smorte e svuotate cerimonie. Chiunque ne senta la voglia, nelle
manifestazioni politiche, civili, sindacali, di intonare quel canto è
liberissimo di farlo. Ma imporlo a tutti, per legge, è un modo per rendere
odioso e divisivo un canto che ha una sua genuina freschezza. Anche se oggi
dire Bella
Ciao potrebbe essere inteso come una
molestia sessuale secondo il catechismo del catcalling… MV, 8 giugno 2021
“Bella
Ciao” inno ufficiale per manipolare la storia: l’egemonia comunista non va mai
in pensione. Marzio
Dalla Casta lunedì 7 Giugno 2021 su Il Secolo
d'Italia. Ha ragione chi dice che la sinistra è
ridotta proprio a mal partito se costretta a risollevarsi con una canzone, in
questo caso Bella Ciao.
Prove di intempestività e di siderale distanza dalle reali esigenze di quelle
che una volta indica come «masse
popolari» i compagni ne
offrono da tempo. L’avvento di Enrico
Letta ne ha solo intensificato la frequenza, come
dimostrano – una dopo l’altra – le proposte su ius
soli, omotransfobia e
voto ai 16enni.
A queste va ora ad aggiungersi la più recente, tesa a trasformare Bella
Ciao in una sorta di vice-inno
nazionale da eseguire obbligatoriamente il 25
Aprile. Una questione di lana caprina, dal
momento che quella canzone di dubbia origine è già un prezzemolo per ogni
minestra.
Bertinotti:
«Bella Ciao si
è ritualizzata». Come ha paventato Fausto
Bertinotti, si è «ritualizzata» perdendo
fatalmente la propria energia mobilitante. Ma se è così (e così è) perché
renderla addirittura ufficiale? Semplice, perché se dipendesse dagli ex-post e neocomunisti,
la storia d’Italia comincerebbe
solo nel 1945, il suo mito fondante
sarebbe unicamente la Resistenza e
l’unico patriottismo ammesso
quello costituzionale.
Nel frattempo, sono riusciti ad equiparare antifascismo e democrazia.
Ne avevano bisogno come l’aria visto che prendevano ordini e rubli da
una potenza straniera, nemica e totalitaria come l’Unione
Sovietica. L’antifascismo, dunque, come grande
lavacro dei crimini comunisti
commessi ad ogni latitudine, Italia compresa come ben sa chi ha raccontato gli
orrori consumati a guerra finita nel cosiddetto Triangolo
della morte.
La
Resistenza al posto del Risorgimento. Il resto, invece, è riuscito a metà: il Risorgimento ha
cessato di essere mito fondante, come dimostra il pullulare di leghe,
al Nord come
al Sud,
ma il trapianto della Resistenza no. Risultato: siamo immersi in una sorta di Striscia
di Gaza della memoria collettiva. Vegetiamo in
una terra di nessuno dove tutto è in discussione, dall’unità nazionale all’inno
nazionale. Messa così, anche l’ufficializzazione
di Bella Ciao ha
un suo perché. Conferma che la sinistra italiana è ancora a trazione comunista,
almeno sotto il profilo culturale. Tutto da dimostrare, invece, la redditività elettorale dell’operazione.
Anzi, è più che probabile che la promozione della canzone partigiana a
vice-inno non riuscirà a sventare il fiasco annunciato dai sondaggi.
In tal caso, servirà a digerire la sconfitta.
Perché, come si dice: “Canta
che ti passa“.
Sorpresa: Bella Ciao non è né un canto partigiano né un inno comunista.
Adele Sirocchi
martedì 23 Aprile 2019 su Il Secolo d'Italia. Con il 25 aprile in arrivo, siamo
destinati ad ascoltare nuovamente le note e le parole di Bella
Ciao, spacciata erroneamente come la canzone
della Resistenza: un mito sulla cui costruzione retorica vale la pena di
soffermarsi. Inno global è ormai Bella
Ciao, da noi colonna sonora di ogni corteo di
sinistra, di ogni contestazione contro i fantasmi del fascismo. La si cantò in
chiesa per don Gallo, la intonò Santoro in tv contro Berlusconi, l’hanno
insegnata ai migranti contro Salvini. Val la pena allora di andare a vedere da
dove nasce questo “mito” resistenziale canoro. Ma davvero i partigiani cantavano
quella canzone? Mica tanto vero, visto che era una canzone delle mondine, le cui
parole vennero adattate a una melodia yddish registrata agli inizi del ‘900 a
New York da un musicista ucraino. Fa testo di ciò il video in cui Laura
Boldrini riceve a Montecitorio un gruppo di ex partigiani e canta con loro Bella
Ciao. Mentre uno di loro canta un altro contesta
la canzone e afferma che i partigiani cantavano Fischia
il vento.Ma le vie della musica sono strane e
contorte: ed ecco che quella canzone diviene prima canto
delle mondine e poi viene rielaborata dai
partigiani ma in zone circoscritte: Alto Bolognese, Montefiorino, Reggiano,
Reatino. Insomma erano troppo pochi a cantarla per poterla considerare davvero
la canzone-simbolo della Resistenza. Nella versione del canto delle mondine la
fa conoscere Giovanna
Daffini all’inizio degli anni Sessanta: “Questa
mattina mi sono alzata/ o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao/ sta
mattina, appena alzata/ in risaia mi tocca andar/ e tra gli insetti e le
zanzare/ un dur lavor mi tocca far…”. Nel canzoniere resistenziale spiccavano
altri inni. Uno era sicuramente “Bandiera
rossa“, un altro “Fischia
il vento“, inno ufficiale delle Brigate
Garibaldi, un altro era La
Badoglieide, composta nella primavera del 1944 da
un gruppo di partigiani piemontesi di Giustizia e Libertà. A decretare la
fortuna di Bella Ciao,
come scrive lo storico Stefano Pivato, “è il clima politico d’inizio anni
Sessanta. Nel periodo che precede e accompagna la costituzione dei primi governi
di centro-sinistra e si afferma l’idea della Repubblica nata dalla Resistenza,
una canzone come Fischia
il vento, contenente espliciti richiami
all’ideologia comunista e oltre tutto costruita sulla melodia di un canto
russo, male si presta a interpretare il clima di concordia e di unità di intenti
che si intende allora stabilire intorno alla memoria della Resistenza”.
(S.Pivato, Bella Ciao. Canto e politica nella storia d’Italia, Laterza, 2005).
Insomma
spiace davvero per i cultori di Bella
Ciao, ma trattavasi di una canzonetta delle
mondine assurta a inno della Resistenza sull’onda del compromesso storico e
sulla scia di un annacquamento delle spinte comuniste insite nel filone
maggioritario della lotta partigiana. Trattandosi di canzonetta orecchiabile non
mancarono da subito, sempre negli anni Sessanta, le parodie irriverenti, tra le
quali questa che riportiamo di seguito e che è sempre citata da Pivato: “Alla
mattina quando mi alzo/ io meno il ca meno il ca meno il ca parapappapà/Alla
mattina quando mi alzo/io meno il cane a passeggiar…”. Una nota di colore con la
quale concludiamo questo excursus sulla vera origine di Bella
Ciao.
Lo
scrittore Maggiani: voi di sinistra, giù le mani da Bella ciao. Siete come i
vampiri, succhiate la vita…Adele Sirocchi l'8 giugno 2021 su Il Secolo
d'Italia. Lo scrittore Maurizio Maggiani non vuole che Bella
ciao diventi un inno istituzionale. E’ una voce
che, dalla sinistra non partitica, si leva contro quella parlamentarizzata che
vuole fare di Bella ciao la
propria canzone di bandiera, con pari dignità dell’inno nazionale. Maggiani,
autore del pluripremiato romanzo “Il
coraggio del pettirosso“, su Repubblica si
oppone a questo progetto, dietro il quale – lo dice senza mezzi termini – c’è
puzza di putrefazione. E già perché la sinistra svuota ogni cosa della sua
sostanza, condannandola alla morte. Siete come vampiri, è l’accusa che lo
scrittore rivolge ai vari “onorevoli
Fragomeli, Verini, Boldrini e Fiano, Stumpo, Anzaldi e Sarli“.
A quelli, insomma, che su Bella
ciao hanno costruito una bella e propagandistica
proposta di legge. Ma quel canto, ricorda Maggiani, è un canto libero
liberamente scelto. Se lo si impone dall’alto, non ha più senso. E la sinistra,
le cui piazze sono vuote da anni, vorrebbe ora anche spegnere quelle note che
sono l’unica cosa che ancora vive da quelle parti. Cosa volete fare di Bella
ciao? Tuona Maggiani. Volete dissanguarla,
ucciderla, essiccarla. Volete fare – continua –
“quello che la sinistra, quell’ineffabile, fantasmatico
resto mortale che voi egregiamente rappresentate dagli
alti scanni della Repubblica, ha fatto di tutto ciò che ha toccato e avocato a
sé di espressione di popolo, di valore fondante, di liberazione; gli
avete succhiato la sostanza, lo avete svuotato e diseccato.
Se posso permettermi, il
vostro è il lavoro del vampiro, dissanguatori di
ideali, di memorie, di nobiltà. Esangui imbelli al cospetto della storia e delle
battaglie che impone, questo potere vi è rimasto intatto, tutto quello che
toccate si dissolve in noncurante rito, in vuoto ablare”. Una prosa adamantina
che inchioda la sinistra, “fantasmatico resto mortale”, alle sue responsabilità
storiche. E no, continua Maggiani, Bella
ciao non è adatta a diventare un inno. Perché –
finalmente qualcuno che lo ricorda! – non
è una canzone comunista, e neanche troppo partigiana.
Bella ciao – scrive Maggiani – “non è nemmeno comunista, come biascicano gli
analfabeti; in effetti non è nemmeno un granché partigiana, i partigiani, gli
uomini e le donne combattenti, nella battaglia avevano bisogno di cantare
qualcosa di più forte, non amavano pensare di farsi seppellire sotto un bel
fior, ma, nell’infausto caso, di promettere dura vendetta sarà del partigian”.
E allora,
conclude Maggiani, lasciate stare Bella ciao. Cari di sinistra – esorta – “non
lordate dunque le vostre mani del sangue innocente di Bella ciao“.
25 aprile sempre più rosso: la sinistra ci
impone Bella ciao. Matteo Carnieletto il 6 Giugno 2021 su Il Giornale. La
sinistra propone di rendere obbligatoria Bella ciao durante il 25 aprile. Ma si
dimentica che questo inno non fu mai cantato durante la Resistenza e che
l'Italia la liberarono gli americani. La proposta di legge depositata alla
Camera dai deputati di Partito democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e
Liberi e Uguali è semplice: far diventare Bella ciao l'inno istituzionale del 25
aprile, da cantare subito dopo quello di Mameli. Lo riporta l'Adnkronos. In
questo modo "si intende riconoscere finalmente l'evidente carattere
istituzionale a un inno che è espressione popolare – vissuta e pur sempre in
continua evoluzione rispetto ai diversi momenti storici – dei più alti valori
alla base della nascita della Repubblica". E ancora: "Nello specifico, pertanto,
con l’articolo 1, comma 1, si prevede il riconoscimento da parte della
Repubblica della canzone Bella ciao quale espressione popolare dei valori
fondanti della propria nascita e del proprio sviluppo. Il comma 2 dello stesso
articolo stabilisce, inoltre, che la canzone Bella ciao sia eseguita, dopo
l’inno nazionale, in occasione delle cerimonie ufficiali per i festeggiamenti
del 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo". E questo è
tutto. Il problema è che i firmatari di questa proposta di legge dimenticano una
cosa importante: Bella ciao non fu mai cantata durante la Resistenza. Giorgio
Bocca, non certo un pericoloso reazionario, disse: "Nei venti mesi della guerra
partigiana non ho mai sentito cantare Bella ciao, è stata un’invenzione del
Festival di Spoleto". Il riferimento è a quando, nel 1964, il Nuovo canzoniere
italiano propose l'inno partigiano al Festival dei due mondi, consacrandolo così
in maniera definitiva. Certo, c'è chi sostiene, come Alessandro Portelli
sul Manifesto, che questa canzone fosse l'inno della Brigata Maiella e che
sarebbe stata cantata fin dal 1944. Ma la realtà è un'altra, come ricorda Il
Corriere della Sera: "Nel libro autobiografico di Nicola Troilo, figlio di
Ettore, fondatore della brigata, c’è spazio anche per le canzoni che venivano
cantate, ma nessun cenno a Bella ciao, tanto meno sella sua eventuale adozione
come 'inno'. Anzi, dal diario di Donato Ricchiuti, componente della Brigata
Maiella caduto in guerra il 1° aprile 1944, si apprende che fu proprio lui a
comporre l’inno della Brigata: Inno della lince". I canti dei partigiani erano
altri, come Fischia il vento, per esempio. Oppure Risaia. Ma Bella ciao proprio
no. Ricorda infatti l'AdnKronos che questo inno non compare in alcun testo
antecedente gli anni Cinquanta: "Nella relazione vengono anche presentati alcune
esempi di raccolte di canzoni (come il Canta partigiano edito da Panfilo a Cuneo
nel 1945 e le varie edizioni del Canzoniere italiano di Pasolini) o riviste
(come Folklore nel 1946) nei quali il testo di Bella ciao non compare mai. La
prima apparizione è nel 1953, sulla rivista La Lapa di Alberto Mario Cirese, per
poi essere inserita, proprio il 25 aprile del 1957, in una breve raccolta di
canti partigiani pubblicati dal quotidiano L'Unità".
Chi ha liberato l'Italia. Presentando questa
proposta di legge, Laura Boldrini ha affermato che Bella ciao ci ricorda che "la
resistenza non fu di parte, ma un moto di popolo, che coinvolse tutti coloro che
non ritenevano più possibile vivere sotto una dittatura: un moto eterogeneo.
Fecero parte della resistenza comunisti, socialisti, azionisti, liberali
anarchici quindi essendo Bella Ciao un canto della Resistenza ed essendo stata
questa un moto di popolo è giusto che diventi un inno istituzionale, espressione
popolare dei più alti valori alla base della nascita della Repubblica". Non fu
così. La resistenza non fu affatto un moto di popolo. Non si schierarono milioni
di italiani contro poche migliaia di fascisti. Entrambi i fenomeni - sia quello
della Resistenza sia quello della Repubblica sociale - mossero poche centinaia
di migliaia di persone, come ricorda Chiara Colombini in Anche i partigiani
però... (Laterza). Alla prima aderirono poco più di 130mila persone, alla
seconda poco più di 160mila. In mezzo oltre 40 milioni di italiani. Non si
registrò dunque nessun movimento di popolo né dall'una né dall'altra parte. Ha
però ragione la Boldrini quando afferma che la Resistenza fu un fenomeno
eterogeneo in cui erano presenti diverse anime. Tra queste, quella certamente
prevalente era quella comunista che aveva un obiettivo molto chiaro: sostituire
una dittatura con un'altra. Lo aveva capito bene Guido Alberto Pasolini,
fratello di Pier Paolo, che dopo aver combattuto i tedeschi fu ammazzato dai
partigiani rossi: "I commissari garibaldini (la notizia ci giunge da parte non
controllata) hanno intenzione di costituire la repubblica (armata) sovietica del
Friuli: pedina di lancio per la bolscevizzazione dell'Italia". Se ci fermiamo ai
numeri, poi, notiamo che essi sono impietosi. Li ricorda Maurizio Stefanini
sul Foglio: "Il 18 settembre 1943 i partigiani erano in tutto 1.500, di cui un
migliaio di 'autonomi': bande di militari nate dallo sfasciarsi del Regio
esercito, che si collegheranno poi in gran parte con la Democrazia cristiana o
il Partito liberale. Nel novembre del 1943 sono 3.800, di cui 1.900 autonomi. La
sinistra diventa maggioritaria nel 1944: al 30 aprile ci sono 12.600 partigiani,
di cui 5.800 delle Brigate Garibaldi, organizzate dal Pci; 3.500 autonomi; 2.600
delle Brigate Giustizia e Libertà del Partito d’Azione; 600 di gruppi più o meno
esplicitamente cattolici. Per il luglio 1944 c’è la stima ufficiale di Ferruccio
Parri che per conto del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (Clnai)
stima 50.000 combattenti: 25.000 garibaldini, 15.000 giellisti e 10.000 autonomi
e cattolici. Bocca vi aggiunge un 2.000 tra socialisti delle Brigate Matteotti e
repubblicani delle Brigate Mazzini e Mameli. Nell’agosto del 1944 si arriva
a 70.000 e nell’ottobre a 80.000, che però calano a 50.000 in dicembre. Giorgio
Bocca poi conta 80.000 uomini ai primi del marzo 1945, cita una stima del
comando generale partigiano su 130.000 uomini al 15 aprile, e calcola che 'nei
giorni dell’insurrezione saranno 250.000-300.000 a girare armati e
incoccardati'. Anche di questa massa i garibaldini, ammette Bocca, 'sono la metà
o poco meno'". Nota giustamente Stefanini che il "dato interessante è che stando
a questa stima appena un partigiano su 23 ha combattuto per almeno un anno; 5 su
6 hanno preso le armi negli ultimi 4 mesi; quasi 4 su 5 negli ultimi 2 mesi; e
addirittura uno su due negli ultimi 10 giorni!". Basterebbero questi numeri a
far tornare la Resistenza nella giusta collocazione storica. Ma non è così.
Scegliere Bella ciao come inno ufficiale del 25 aprile significa renderlo ancora
di più di una parte soltanto, a discapito di tutte le altre. Ma forse è proprio
quello che certe forze politiche vogliono. Non a caso, Marco Rizzo, uno dei
pochi comunisti ancora degni di questo nome, ha parlato di "antifascismo
prêt-à-porter", che ha come fine quello di richiamare le masse (o almeno così si
spera) prima delle elezioni. Difficile dargli torto...
Matteo Carnieletto. Entro nella redazione
de ilGiornale.it nel dicembre del 2014 e, qualche anno dopo, divento il
responsabile del sito de Gli Occhi della Guerra, oggi InsideOver. Da sempre
appassionato di politica estera, ho scritto insieme ad Andrea Indini Isis
segreto, Sangue...
Dalle
toghe rosse ai preti rossi, la litanìa è sempre la stessa: una canzone
mono-nota, scrive Girolamo Fragalà su “Il Secolo d’Italia”. Dalle toghe rosse
alle tonache rosse. Le pecorelle non sono tutte uguali, la carità cristiana è
lasciata ai posteri (e non per l’ardua sentenza), del perdono manco a parlarne,
si prega solo per alcune anime e si spera che le altre vadano dritte
all’inferno, avvolte nelle fiamme. Di preti che si mettono in mostra per la loro
fede più comunista che cattolica ne stanno uscendo parecchi. Militanti col pugno
chiuso e poco moderati. L’ultimo in ordine cronologico è don Paolo Farinella,
sacerdote della Diocesi di Genova, che è stato ospite del programma di Radio2
Un giorno da pecora.
Contro chi si è scagliato? Naturalmente contro Berlusconi che «fa soldi solo con
la corruzione e se ne frega della fede». Roba quasi da querela. Come se non
bastasse, il “don” ha aggiunto: «Se lui non fosse così vigliacco da scappare dai
tribunali e venisse fuori che è colpevole, deve andare dentro». Il tutto mentre
continuano a girare a mille, sul web, le performance di don Gallo, sacerdote
antagonista, fede vendoliana. Record di visualizzazioni per il video in cui si
vede il prete, nella Chiesa di San Benedetto a Genova, sventolare il paramento
sacro che aveva sulla tonaca come se fosse una bandiera rossa e cantare
Bella Ciao.
La gustosa
scena è avvenuta alla fine della Messa, davanti ai
fedeli. Don Gallo nel 2009 partecipò al Genova Pride e ultimamente ha dichiarato
che «sarebbe magnifico avere un Papa gay». Facendo un piccolo salto indietro,
ricordiamo don Giorgio, il parroco di Monte di Rovagnate, che creò un mare di
polemiche per una sua frase («prego il Padreterno che mandi un bell’ictus a
Berlusconi facendolo rimanere secco») che nulla aveva di cattolico. Tutti
“figli” di don Vitaliano, che tutti ricordano come il prete no-global: insieme
con Vittorio Agnoletto (ex parlamentare di Rifondazione comunista) piombò nella
sala stampa del Festival di Sanremo munito di bandiere pacifiste. Tra chi
insulta, chi augura gli ictus e chi canta
Bella Ciao
sull’altare, l’unica vera vittima è la Chiesa. Che finisce per perdere
credibilità a causa delle tonache rosse. Proprio ciò che sta accadendo alla
magistratura a causa delle toghe rosse.
Tre domande per Diego Fusaro. Giordano Di
Fiore de Il Riformista l'1 Giugno 2020. Tre domande per Diego Fusaro, filosofo e
saggista. Dopo la positiva esperienza condotta con Marco Rizzo, ho pensato di
rivolgere le stesse identiche domande al noto opinionista controcorrente. In
verità, in un primo momento, avrei voluto, in qualche modo, riadattare le
domande: sarei partito dalla relazione tra Kant e il potere, per poi arrivare a
definire meglio il ruolo della democrazia moderna. Infine, mi sono convinto che
sarebbe stato più proficuo per il lettore essere meno accomodanti e portare
avanti il nostro dibattito sulla libertà, sulla teoria dell’emergenza
permanente, sul ruolo ambiguo degli schieramenti politici. Il presupposto, come
già nell’introduzione a Rizzo, è quello di provare, nel nostro piccolo, a dare
voce a chi, oggettivamente, in questo momento, ne ha poca, con la consapevolezza
che il pensiero critico, qualunque sia la nostra opinione, sia il vero vaccino
ai mali della democrazia. Buona lettura.
Dal crollo del muro in avanti, trovo che in Italia
si sia creata, nel popolo di sinistra, una certa confusione. Gli avversari
politici utilizzano l’espressione “buonismo”, in senso dispregiativo. Qualcosa
di vero, tuttavia, sembra esserci: quando si propongono sanatorie a tempo
determinato e quando si fa finta di appellarsi alla solidarietà per, in realtà,
legittimare la schiavitù, si fa finta di essere buoni, ma si fa il gioco del
cosiddetto “potere”. Lei cosa ne pensa?
D.F. Si, confusione è una parola molto garbata
e neutra: io la definirei meglio metamorfosi kafkiana delle sinistre. Il mio
maestro soleva definirla il serpentone metamorfico pci pds ds pd: dal grande
Antonio Gramsci, al bardo cosmopolita Roberto Saviano. Più che di confusione,
parlerei di una normalizzazione integrale delle sinistre, le quali, da polo di
rappresentanza del lavoro, sono diventate il polo di rappresentanza del capitale
cosmopolita. Peggio ancora, sembrano passare larga parte del loro tempo a
demonizzare le richieste di emancipazione delle classi lavoratrici, che
chiedono, evidentemente, salari più dignitosi e maggior protezione da parte
dello Stato. Confusione, dunque, è un’espressione vera, e, al tempo stesso, fin
troppo buona: non buonista, ma molto buona, sicuramente. Le sinistre sono
diventate l’ala culturale della destra finanziaria capitalistica: come ho
spiegato nel mio libro “Pensare altrimenti”, c’è una sorta di sinergia tra la
destra liberista del danaro e la sinistra libertaria del costume, che sono, per
cosi dire, la doppia apertura alare del globalismo capitalistico. La destra del
danaro vuole un unico mondo ridotto a mercato, senza stati nazionali sovrani che
possano limitare l’economia. La sinistra, anziché valorizzare gli stati
nazionali e la lotta contro l’economia, definisce gli stati nazionali fascisti e
nazisti, in quanto tali. La destra del danaro vuole ancora produrre una sorta di
globalizzazione senza luoghi e la sinistra l’appoggia in pieno. Ciò che la
destra vuole, la sinistra legittima: questo è il paradosso del nuovo ordine
totalitario del capitalismo.
Ho trovato molto singolare che, durante il
cosiddetto lockdown, molte persone si siano ritrovate a cantare Bella Ciao, ma
non per strada, sul balcone! Qualcosa del genere è successo anche per la Festa
dei Lavoratori. In pratica, molte persone che credono di riconoscersi nei valori
della Libertà e della Resistenza hanno, poi, sposato la linea dell’obbedienza
totale al capo. Come mai è avvenuto tutto questo?
D.F. Si, il cantare Bella Ciao, nel lockdown,
dietro le sbarre dei propri balconi o inneggiare, come accaduto, ai droni, alla
tracciabilità e alla delazione è un vero e proprio rovesciamento dialettico. Per
dirla con Hegel, come la virtù illuministica si capovolge nel terrore giacobino,
cosi la società aperta si capovolge in lockdown. E Bella Ciao si capovolge
nell’elogio dell’esercito nelle strade, e della delazione. Nihil novi sub sole:
sono le avventure o le disavventure, se si preferisce, della dialettica.
In questi mesi, un governo, diciamo così, tendente
a sinistra, tramite l’artificio dello stato di emergenza permanente – che molto
ricorda la guerra permanente di orwelliana memoria – ha giustificato
l’azzeramento di libertà costituzionali conquistate in anni di lotte sociali.
Qual è la sua opinione in merito? Cosa ci aspetta ancora nei prossimi mesi?
D.F. Eh sì, è proprio così: la tesi che
sostengo, e che concorda in parte con quelle di Agamben, è che il nuovo
principio della società sia il distanziamento sociale, che impedisce, o limita
fortemente, ogni relazione, ogni contestazione, ogni luogo pubblico: con il
lockdown, lo limita totalmente. Si tratta di una razionalità politica, che, in
questo modo, impedisce in partenza ogni contestazione del capitale. È una svolta
autoritaria in seno al capitale, a mio giudizio, che usa l’emergenza del virus
per costruirci sopra una razionalità politica di tipo autoritario e repressivo.
Forse il capitalismo stava iniziando a perdere il suo consenso, e, quando la
classe dominante ha il dominio, ma non il consenso, Gramsci docet, usa il
manganello, la violenza: in questo caso, utilizza le norme emergenziali. Per
garantire la sicurezza, bisogna rinunziare alla Costituzione e alla libertà.
Più durerà l’emergenza, più si rinunzierà a Costituzione e libertà e l’eccezione
diventerà quella che oggi già chiamano la nuova normalità.
Il Pd vuole "Bella Ciao" a scuola "Cantatela
con l'Inno di Mameli". Alcuni deputati dem hanno presentato una proposta di
legge per inserire il canto partigiano nei programmi scolastici. Alberto Giorgi,
Venerdì 25/09/2020 su Il Giornale. Il risultato delle Regionali deve aver dato
alla testa al Partito Democratico. Già, perché ora i dem tornano alla carica su
una questione a loro molto cara: affiancare Bella ciao all’Inno di Mameli,
facendo sì che il canto simbolo dei partigiani e della resistenza entri di
diritto nei programmi scolastici di tutto il Paese a decorrere dall'anno
scolastico 2020/2021. La pensata non è nuova e anzi risale alla scorsa
primavera, quando l’Italia era in piena emergenza coronavirus. In data 30
aprile, infatti, un gruppo di parlamentari dem – tra cui Piero Fassino, Michele
Anzaldi, Stefania Pezzopane, Patrizia Prestipino e Gian Mario Fragomeli –
presentano a Montecitorio una proposta di legge per inserire nei programmi
scolastici lo studio della canzone "rossa" per eccellenza, così da ottenere il
riconoscimento ufficiale della canzone simbolo della lotta partigiana come canto
ufficiale dello Stato italiano, quasi alla pari dell'Inno di Mameli. Oltre
all’idea in sé, stupiscono anche le tempistiche, visto che in quelle difficili e
durissime settimane l’Italia era in ginocchio e terrorizzata dalla pandemia di
coronavirus, che continuava a mietere vittime. Con il Paese congelato dalla
serrata e dalla paura, alcuni deputati del piddì hanno però pensato bene di
badare ad altro e di interessarsi a Bella ciao. In quel 30 aprile, allora, a
Montecitorio fa capolino la seguente proposta di legge: "Riconoscimento della
canzone Bella ciao quale espressione popolare dei valori fondanti della nascita
de dello sviluppo della Repubblica". Ma come detto non è tutto. "Non meno
importante, infine, la legge dispone anche che in tutte le scuole,
all’insegnamento dei fatti legati al periodo storico della Seconda Guerra
Mondiale, della Resistenza e della lotta partigiana, venga affiancato anche lo
studio della canzone Bella Ciao", come spiegato dal dem Fragomeli. Dalla scorsa
primavera a questo autunno, perché praticamente all’indomani del risultato
elettorale del referendum, delle Regionali e delle Comunali, la proposta di
legge – come rende noto Il Tempo – è stata appena licenziata dalla commissione e
approderà dunque in Aula, dove il Pd farà di tutto per ottenerne l’approvazione.
D’altronde, secondo loro, come si legge all’interno della proposta di legge
stessa, "Bella ciao è un inno facilmente condivisibile e non è espressione di
una singola parte politica, visto che che tutte le forze politiche possono
ugualmente riconoscersi negli ideali universali ai quali si ispira la canzone".
Il blitz del Pd sulla canzone partigiana è tutto condensato nell'articolo uno
del provvedimento che potrebbe diventare legge. All’articolo uno, infatti, si
legge: "La Repubblica riconosce la canzone Bella ciao quale espressione popolare
dei propri valori fondanti della propria nascita e del proprio sviluppo. La
canzone Bella ciao è eseguita, dopo l'inno nazionale, in occasione delle
cerimonie ufficiali per i festeggiamenti del 25 aprile, anniversario della
Liberazione dal nazifascismo". Insomma, Bella ciao come secondo inno nazionale.
Azzolina difende Bella Ciao: "Parte del
patrimonio culturale". Ad aprile, un insegnante assegnò l'esecuzione
musicale di Bella Ciao. Il deputato di FdI, Rampelli, aveva chiesto l'intervento
del ministro dell'Istruzione. La risposta di Azzolina: "Il canto è parte del
patrimonio culturale". Francesca Bernasconi, Martedì 20/10/2020 su Il Giornale.
"Il brano Bella Ciao è parte del patrimonio culturale italiano". Così, il
ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, si è espressa in difesa del noto
canto, al centro di un'interrogazione presentata dal deputato di Fratelli
d'Italia, Fabio Rampelli. Tutto parte da un compito assegnato agli alunni delle
scuole medie dell'Istituto Ottaviano Bottini, di Piglio, in provincia di
Frosinone. Lo scorso aprile, un insegnante di musica aveva assegnato come
compito l'esecuzione di Bella Ciao, che sul sito della scuola veniva definita
"simbolo della Liberazione che abbiamo festeggiato il 25 aprile". Una notizia
che aveva sconcertato il deputato FdI: il 25 aprile, aveva commentato
Rampelli, "rappresenta oggettivamente la liberazione dell’Italia dalla dittatura
e dall’occupazione nazista". Invece, "l’inno partigiano è divisivo perchè
rappresenta una parte politica ben definita, purtroppo protagonista anche di
violenze efferate e ingiustificate, anche nei confronti di civili, preti, donne
e bambini". Secondo il deputato, si legge nell'interrogazione, "è inaccettabile
che temi di natura chiaramente politica, surrettiziamente presentati come
formativi, vengano inseriti nell’attività scolastica di ragazzi che le famiglie
affidano alla scuola per ragioni didattiche e non certo per vederli sottoporre a
un’attività propagandistica, a meno che non ci sia lo spazio per uno studio
plurale e imparziale degli accadimenti". Infine, Rampelli aveva lanciato un
appello al ministro Azzolina, chiedendole se non ritenesse necessario "adottare
le iniziative di competenza per evitare la diffusione di una visione
politicizzata della storia nelle scuole, evitando che sia altresì consentito
un indottrinamento delle nuove generazioni". Non solo. Il deputato FdI chiedeva
anche un indirizzo rivolto ai dirigenti scolastici, perché distinguessero "la
festa della Liberazione dall’inno dei partigiani", considerato "divisivo ed
evocatore di violenze storicamente accertate". Ma, rispondendo per iscritto
all'interrogazione di Rampelli, Lucia Azzolina difende Bella Ciao, definendolo
un canto "parte del patrimonio culturale italiano, noto a livello
internazionale, tradotto e cantato in tutto il mondo. È un canto che diffonde
valori del tutto universali di opposizione alle guerre ed agli estremismi".
Inoltre, la canzone avrebbe sempre fatto parte del libro di testo adottato dalla
scuola: "In particolare- spiega Azzolina- il brano in questione, assegnato con
lo scopo di essere suonato con il flauto dai discenti, rientra nel novero dei
canti popolari in trattazione nell’ambito della musica leggera e precisamente
nel capitolo dedicato alle "Canzoni del presente e del passato"". E conclude
riaffermandone il valore in quanto parte del patrimonio della cultura italiana.
La situazione ha sollevato anche questioni giudiziarie. Il ministro
dell'Istruzione, infatti, ha ricordato come lo scorso maggio fosse stata
ricevuta dal Ministero "una nota con la quale la dirigente scolastica
dell’istituto comprensivo di Piglio, notiziava che in data 2 maggio la stessa
aveva sporto querela contro ignoti per il reato di diffamazione a seguito della
lettura di alcuni post, apparsi su Facebook, nei quali veniva offesa l’immagine
della scuola e di una docente di musica per aver assegnato ad una classe il
compito di svolgere con uno strumento musicale (flauto dolce) la canzone Bella
Ciao". Da questo punto di vista, sarà l'autorità giudiziaria a definire
eventuali responsabilità.
Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani su Bella
Ciao: "Non ha un'impronta italiana, proprietà dei comunisti". Libero
Quotidiano il 02 ottobre 2020. Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo
Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 1 ottobre. E in studio si
parla della priorità del Pd: insegnare Bella Ciao in tutte le scuole italiane,
proposta accompagnata da un disegno di legge. Proposta cancellata in modo netto
da Giuseppe Cruciani, che prima di battibeccare sul tema con Sara
Manfuso spiega: "Nessuno nelle classi italiane ha bisogno di cantare canzoni,
non si canta neppure l'Inno italiano figurarsi Bella Ciao. Penso che Bella Ciao
sia una canzone di cui si sono appropriati, legittimamente, dopo la seconda
guerra mondiale sostanzialmente i comunisti - rimarca il conduttore de la
Zanzara -. Non vale per tutti, non ha un'impronta italiana, non ha un valore
trasversale: è una canzone di una parte politica, quella di sinistra. È questa
la realtà dei fatti, si vuole introdurre a scuola qualcosa che appartiene a una
stagione politica che si è conclusa", conclude un impeccabile Giuseppe Cruciani.
Insegnante minaccia alunni: "Canta Bella Ciao o
sei fascista". Insegnante di scuola media minaccia alunni di brutto voto se
non intonano Bella Ciao: "Chi non canta, è fascista". Rosa Scognamiglio, Martedì
28/01/2020, su Il Giornale. "Se non canti Bella Ciao, vuol dire che sei fascista
e ti metto un brutto voto". Con questa frase un'insegnante di scuola media
avrebbe intimato ai suoi studenti di intonare l'inno della Resistenza partigiana
minacciando una sfilza di insufficienze a chiunque si fosse rifiutato di farlo.
Dalle parole ai fatti, il passo è breve. Così, con metodi educativi piuttosto
discutibili, una professoressa ha ben pensato di politicizzare la classe -
virando verso una inequivocabile ideologia di sinistra - con la minaccia di un
brutto voto sul registro qualora i giovanissimi alunni avessero osato delle
rimostranze o si fossero rifiutati di cantare i versi di Bella Ciao. Ma non è
tutto. A quanto pare, l'insegnante si sarebbe spinta ben oltre il semplice
ammonimento. La faziosa educatrice avrebbe talora apostrofato con l'appellativo
"fascista" coloro che non avrebbero assecondato la sua richiesta perentoria.
Dunque, spaventati dalle conseguenze di un eventuale diniego sulla media in
pagella, i ragazzini non avrebbero potuto far altro che compiacere l'insegnante.
A dare notizia dell'accaduto è stata la Lega Prato che, stando a quanto si
apprende dalla testa d'informazione GoNews.it, ha riportato la segnalazione di
un genitore - l'identità dell'uomo non è stata rivelata per evitare la gogna
social – il quale riferiva della presunta condotta diseducativa adottata dalla
professoressa durante le ore di lezione. "Abbiamo letto con molta preoccupazione
la richiesta d'aiuto di un genitore di un bambino di seconda media: questi
denunciava ieri sul suo profilo Facebook che la professoressa di Italiano
avrebbe minacciato gli alunni di una classe di seconda media di cantare Bella
ciao, pena un brutto voto. - si legge nella nota trasmessa dal gruppo consiliare
Lega Prato - L'insegnante avrebbe anche detto agli alunni che se non avessero
intonato Bella ciao sarebbero stati dei fascisti. Speriamo si sia trattato di un
frainteso, perché altrimenti sarebbe un fatto gravissimo: tanto più apostrofando
come fascisti dei bambini colpevoli di non aver imparato una canzone. Per questo
chiediamo lumi alla presidenza della scuola media interessata. Pretendiamo
quindi chiarezza: questi sarebbero metodi inaccettabili, trattandosi
eventualmente di una educatrice che si rivolge a minori con pregiudizio e
minacce". Al momento la vicenda resta ancora da accertare ma non è escluso che,
nei prossimi giorni, possa essere ulteriormente dettagliata da altre
eventuali testimonianze. Nel caso in cui, tale segnalazione fosse confermata, le
conseguenze per l'insegnante potrebbero avere persino conseguenze giudiziarie
fino alla sospensione dal servizio.
Bella ciao a scuola. Ma i ragazzi sanno della
strage partigiana di Mignagola? Andrea Cionci su Libero Quotidiano il 02
ottobre 2020.
Andrea Cionci. Storico dell'arte, giornalista e
scrittore, si occupa di storia, archeologia e religione. Cultore di opera
lirica, ideatore del metodo “Mimerito” sperimentato dal Miur e promotore del
progetto di risonanza internazionale “Plinio”, è stato reporter dall'Afghanistan
e dall'Himalaya. Ha appena pubblicato il romanzo "Eugénie" (Bibliotheka).
Ricercatore del bello, del sano e del vero – per quanto scomodi - vive una
relazione complicata con l'Italia che ama alla follia sebbene, non di rado, gli
spezzi il cuore.
La paventata introduzione del canto “Bella ciao”
nelle scuole, per il 25 aprile e/o per manifestazioni celebrative della
Resistenza ha suscitato aspre polemiche. Perché questi temi continuano ad essere
così divisivi? Può valere la pena far capire a scolari e studenti come mai tali
questioni continuino ad essere così “irritanti”, a 75 anni di distanza, offrendo
loro uno squarcio di verità su un periodo storico che ha conosciuto non solo
luci, ma anche ombre. Importante, però, che questo avvenga senza faziosità e
giudizi, sulla scorta di fonti autorevoli e, meglio ancora, attraverso le
dichiarazioni rese in sede processuale dagli stessi protagonisti e testimoni.
Non bisogna temere i fatti, proprio per avere un panorama equilibrato e completo
di quella pagina drammatica della nostra storia e per consentire ad ognuno di
maturare un giudizio personale. Dopotutto, a scuola si va per questo. “Anche a
Treviso ci fu un eccidio rosso come quello delle Fosse Ardeatine a Roma” scrive
Bruno Vespa nel suo “Vincitori e vinti” del 2005 in riferimento alla “Strage
della Cartiera Burgo”. Una vicenda di 75 anni fa, iniziata il 27 aprile ’45 e
terminata ai primi di maggio: la struttura industriale, a 7 km da Treviso, era
stata adibita dai partigiani a campo di concentramento per i prigionieri
fascisti e per i civili anche solo sospettati di collaborazionismo. La cartiera
giunse a raccogliere circa 2000 persone rastrellate nella zona: militari
repubblicani, ausiliarie, civili più o meno legati al passato regime,
possidenti. Per quanto misconosciuta, la strage è ampiamente documentata - oltre
che dai rapporti dei Carabinieri - dalle testimonianze dei partigiani comunisti
delle Brigate Garibaldi che furono chiamati a deporre nel processo del 1949. In
realtà, questo eccidio presenta caratteristiche diverse rispetto a quello delle
Fosse Ardeatine. Innanzitutto fu compiuto a guerra finita e non fu una
rappresaglia condotta nel solco delle pur terribili leggi di guerra dell’epoca
(anche se con 5 vittime in più): si trattò di processi sommari, torture ed
esecuzioni che, come riportavano i Carabinieri, nemmeno tenevano conto dei nomi
degli imputati. Anche sui numeri non c’è corrispondenza con le Ardeatine:
materialmente furono recuperati “solo” 100 morti; secondo il cappellano delle
Brigate nere don Angelo Scarpellini, le uccisioni furono 700, mentre per il
maresciallo dei Carabinieri Carlo Pampararo, 900. Per vari storici furono,
comunque, diverse centinaia. Il numero non è chiaro perché, come documenta il
partigiano e storico comunista Ives Bizzi, i corpi di molte vittime vennero
disciolti nell’acido solforico della cartiera o bruciati nei suoi forni, oppure
seppelliti in luoghi remoti o gettati nel fiume Sile. Tale dettaglio fu
confermato nel 2007 al Gazzettino anche dal partigiano rosso Aldo Tognana, ex
comandante della piazza militare di Treviso: «Il parapetto sul Sile era tutto
sporco di sangue, di notte avevano portato lì prigionieri fascisti e non, e li
avevano uccisi e gettati nel fiume.»
Inoltre, emergono dal processo torture, stupri ed
efferatezze sui prigionieri che si spinsero fino alla crocifissione. “Tutti i
prigionieri venivano portati in cartiera – dichiarò al processo del ’49 il
partigiano comunista Marcello Ranzato - i tedeschi - senza che loro venisse
torto un capello - venivano custoditi nel garage; i fascisti, invece, in altri
locali del pianterreno della cartiera. Questi venivano bastonati e seviziati,
tanto che alle volte udivo urla e rumore di percosse. Venivano anche fatti
processi sommari. Simionato Gino, “Falco”, (il loro capo n.d.r.) era uno dei
più attivi seviziatori e percuoteva le sue vittime con zappe o badili nelle ore
notturne”. Come riportato in “La cartiera della morte” (Mursia 2009) di Antonio
Serena, con prefazione di Franco Cardini, il 27 aprile furono catturati presso
Olmi sette fascisti della Banda Collotti che portavano con sé dell’oro; questo
fu spartito fra partigiani comunisti e democristiani. I prigionieri furono tutti
uccisi, anche una donna incinta, amante di Gaetano Collotti. Il 29 aprile, don
Giovanni Piliego si recò alla cartiera per confessare dei prigionieri visitati
il giorno prima, ma questi erano già stati uccisi. Si rivolse così al vescovo
Mantiero che protestò con il CLN e con gli americani. Il 30, militari Usa giunti
con una jeep, imposero la cessazione delle attività, ma gli ammazzamenti
continuarono. "Dopo la liberazione abbiamo avuto cinque giorni di carta bianca –
testimoniò il partigiano Romeo Marangone - Abbiamo continuato gli arresti”. In
realtà, come testimoniò don Ernesto Dal Corso, parroco di Carbonera, le
esecuzioni proseguirono ben oltre il 30: “La maggior parte delle uccisioni
avvenne dietro una specie di processo presenziato da tali Polo Roberto,
Sponchiado Antonio, Brambullo Giovanni, Zancanaro Silvio, Trevisi Gino”. Anche
dopo lo stop ordinato dal CNL, invece, “Simionato Gino ha ammazzato un numero di
37 persone, dicono, a colpi di badile”. Spiega lo studioso Massimo Lucioli:
“Testimoni oculari riferirono al processo come il giorno 4, un sottotenente
della Guardia Nazionale Repubblicana, Luigi Lorenzi, di 20 anni, (catturato
nonostante il lasciapassare del CLN) venne preso di mira perché aveva difeso
un’ausiliaria dalle violenze dei partigiani. Altri raccontarono di come egli
portasse una medaglietta religiosa al collo: minacciato di crocifissione e
rifiutando di togliersela avrebbe risposto: “Muoio come Nostro Signore. La croce
che Gesù Cristo ha portato non può far paura a un cristiano”. Stando alle
testimonianze e ai referti, Lorenzi fu inchiodato a due assi di legno, frustato
e poi gli venne spaccata la testa. Come da lettera del Comune di Breda, il
giorno 8 la madre di Lorenzi andò dal sindaco, il partigiano Giuseppe Foresto
(che aveva contatti con i partigiani della cartiera) il quale le rispose,
mentendo, che suo figlio era stato rimesso in libertà due giorni prima”. Su
denuncia dei familiari delle vittime, fu istruito il processo già nell’estate
del ’45, ma in un brutto clima: “Nessuno vuole parlare – riferiscono i rapporti
dei CC - tutti sono terrorizzati, perché i colpevoli sono in circolazione,
coloro che potrebbero dare preziose notizie, vivono ancora sotto l'incubo della
rappresaglia”. Il processo a carico del solo Gino Simionato e di altri ignoti
andò avanti fino al 1954, quando il giudice Favara così sentenziò: “Pur essendo
altamente deplorevole l’indiscriminazione con cui taluni partigiani o patrioti
ebbero a sfogare la mal repressa rabbia, troppo spesso senza accertarsi prima
della colpevolezza dei singoli individui rastrellati […] dichiaro non doversi
procedere a carico degli imputati in ordine ai reati loro rubricati, perché
estinti per effetto amnistia. Si trattava dell’amnistia promulgata dal
segretario del PCI Palmiro Togliatti nel 1946, poi reiterata nel ’53.
Dalla finta sinistra dei diritti civili alla
vera destra della finanza internazionale, il "pensiero scomodo" di Alessandro
Meluzzi. Giordano Di Fiore, Creativo, su Il Riformista il 3 Luglio 2020. Tre
domande per il Prof. Alessandro Meluzzi: continua il nostro viaggio all’interno
del pensiero “scomodo”. E’ trascorso un po’ di tempo da quell’insolito 25
Aprile, passato ad intonare Bella Ciao, ma dal balcone. Una situazione tanto
ossimòrica da meritare un approfondimento. Qualcosa che andasse oltre il
pensiero unico dominante, dettato dalla dittatura sanitaria. Ecco perché abbiamo
deciso di formulare tre domande “urticanti” e riproporle, senza mai cambiarle,
ad alcune personalità fuori dagli schemi, molto differenti tra di loro, ma
caratterizzate da una rara libertà di pensiero. Abbiamo avuto il piacere di
intervistare il filosofo Diego Fusaro, l’On. Marco Rizzo, il Prof. Massimo
Cacciari. Non poteva mancare il Prof. Alessandro Meluzzi, psichiatra, docente e
noto opinionista, il quale ci fornisce delle risposte molto pungenti,
tratteggiandoci il tragico ritorno ad un mondo pre-marxiano, dominato ancora una
volta dalla dinamica servo-padrone, storicamente arretrando rispetto alla
dialettica della Rivoluzione Francese. Dal crollo del muro in avanti, trovo che
in Italia si sia creata, nel popolo di sinistra, una certa confusione. Gli
avversari politici utilizzano l’espressione “buonismo”, in senso dispregiativo.
Qualcosa di vero, tuttavia, sembra esserci: quando si propongono sanatorie a
tempo determinato e quando si fa finta di appellarsi alla solidarietà per, in
realtà, legittimare la schiavitù, si fa finta di essere buoni, ma si fa il gioco
del cosiddetto “potere”. Lei cosa ne pensa?
«Di buone intenzioni è spesso lastricata la via
dell’Inferno. L’esibizione di buoni sentimenti è lo strumento migliore
attraverso cui idee repressive o di sfruttamento dell’uomo sull’uomo possono
mascherarsi da umanitarismo, di buonismo o, peggio, di politicamente corretto:
quella dimensione per la quale alcune idee dominanti, basata sulla percezione
della non esclusione di altri, servono, in realtà, a sancire, a consolidare e
a cristallizzare il potere di alcune élite ristrettissime sui più. Il fatto
che alcuni padroni mettano i bianchi contro i neri, i cinesi contro gli europei,
i migranti contro i nativi è uno strumento attraverso il quale chi controlla il
vero potere, quello della finanza, riesce attraverso il divide et impera a
riaffermare non solo forme di vetero-schiavismo, diventato neo-schiavismo, ma
anche l’azzeramento di quella classe media, figlia dell’illuminismo e della
Rivoluzione Francese, che è stata quanto di più civile che la storia
dell’umanità abbia prodotto. Ma una nuova, antica distinzione tra padroni e
schiavi si riafferma, mascherata da buonismo».
Ho trovato molto singolare che, durante il
cosiddetto lockdown, molte persone si siano ritrovate a cantare Bella Ciao, ma
non per strada, sul balcone! Qualcosa del genere è successo anche per la Festa
dei Lavoratori. In pratica, molte persone che credono di riconoscersi nei valori
della Libertà e della Resistenza hanno, poi, sposato la linea dell’obbedienza
totale al capo. Come mai è avvenuto tutto questo?
«Della sinistra comunista post-comunista e
post-socialista, dopo la caduta del muro di Berlino, è stato fatta una sorta di
OPA ostile, nel senso che il globalismo capitalista e totalmente finanziarizzato
si è in qualche modo silenziosamente comprato gli apparati dell’antica
sinistra (pensate ai residui del PC diventato PDS, PD e quant’altro), come,
peraltro, è successo ai diversi partiti socialisti, trasformandoli dai partiti
dei diritti sociali, dei lavoratori e delle classi subalterne a presunti partiti
di presunti diritti civili. Insomma, non era più l’obiettivo di lottare per il
possesso e il controllo dei mezzi di produzione, ma la libertà di poter sfilare
in mutande con piume in testa, rivendicando il gender, o pensando a visioni di
biopolitica o biosocialità dalle quali Foucault stesso sarebbe
inorridito. Questa finta sinistra dei diritti civili che esclude l’antico ruolo
strutturale, economico e anticapitalista si è ridotta a quella delle canzoni
‘Bella Ciao’ sui balconi, in una dimensione in cui questa finta sinistra diventa
il principale presidio della vera destra, che è quella della finanza
internazionale dei Rothschild, dei Soros, dei Rockefeller e dei Gates che
vorrebbero marchiarsi con microchip sottopelle».
In questi mesi, un governo, diciamo così, tendente
a sinistra, tramite l’artificio dello stato di emergenza permanente – che molto
ricorda la guerra permanente di orwelliana memoria – ha giustificato
l’azzeramento di libertà costituzionali conquistate in anni di lotte sociali.
Qual è la sua opinione in merito? Cosa ci aspetta ancora nei prossimi mesi?
«Diceva un grande intellettuale francese, André
Malraux, che la prima vittima della guerra è la verità, dopo la quale c’è
la perdita dell’innocenza. Dietro la logica della guerra sta sempre la logica
della falsificazione: falsificazione dei sistemi di spionaggio, falsificazione
delle informazioni sul nemico, falsificazione delle verità interne. La spagnola
venne così chiamata perché la Spagna, non essendo paese belligerante nella Prima
Guerra Mondiale, era l’unica nazione in cui la verità su quella vera pandemia
poteva circolare. È la conseguenza di questa falsificazione. Nulla è meglio per
dominare i popoli che mantenerli in uno stato di guerra permanente o di finta
guerra permanente, affinché la vera guerra delle élites, che comandano e
anestetizzato le masse oppresse, debba sempre avere legittimazione. Chi ha il
potere, gestendo la semiosfera dei segni, può permettersi di impedire che
circolino le informazioni che riguardano le verità che potrebbero liberarci.
Invece, le élite ci tengono al guinzaglio con la minaccia di un pericolo
superiore (ora un virus, ora una guerra, ora una carestia, ora un tracollo
economico). Sono quelle élite, prestatrici di denaro e stampatrici di titoli,
che governano attraverso il ricatto dello Spread e un’idea di debito, muovendo
una psico-info-epidemia di monete. Sotto la minaccia di una guerra, ora
materiale, ora economica, il popolo soccombe, non avendo le leve della dinamica,
che rappresentano la vera chiave del mantenimento dello status quo».
Rovinano pure la festa di Natale con la pretesa
di cantare la solita Bella ciao sotto l’Albero. Francesco Storace giovedì 12
dicembre 2019 su Il Secolo d'Italia. Cercate, cercate pure, ma Bella Ciao non la
trovate tra i Canti di Natale. Perché è una pagliacciata mischiare sacro e
profano. Eppure succede e stanno (quasi) tutti zitti. Come se si dovesse fare
politica persino sotto l’Albero. Il silenzio sarebbe continuato se non esistesse
la rete, con i suoi social, le sue notizie, anche se confinata in un ambito
locale. Ma le vergogne si scoperchiano perché è inaccettabile turlupinare la
buona fede delle persone. La “location” per l’esibizione della canzone tanta
cara alla sinistra estremista – inclusa quella che governa l’Europa – è un
comune in provincia di Foggia, Torremaggiore. Il 7 dicembre il sindaco Emilio Di
Pumpo, accende l’Albero con tutte le sue luci. Arrivano i cantori – si fanno
chiamare Street Band Vagaband, nomen omen… – e alla fine della cerimonia si
canta l’immancabile Bella Ciao di questi tempi sardinati. Antifascismo da
operetta. Da piccoli noi, “quelli di prima”, amavamo Tu scendi dalle
stelle oppure Jingle bells. E certo non la buttavamo in politica. Ma nell’Italia
blasfema c’è spazio per rovinare persino il Natale, una storia bimillenaria, il
cammino dell’umanità. Senza senso del ridicolo. L’ex sindaco Lino Monteleone ha
usato parole durissime nei confronti di un’iniziativa quantomeno sfrontata: “Ciò
che mi stupisce è che si usi anche la banda presente all’evento facendole
intonare ‘Bella ciao’: non mi risulta che sia un canto natalizio. Del resto,
sono molti ormai i segnali di rigurgito ideologico, un atteggiamento frequente e
ingiustificato, anche di rimozione della verità”. E si potrebbe anche aggiungere
che se nel nostro paese si arriva a intonare Bella Ciao pure in Chiesa come è
accaduto in Toscana, ormai la sfrontatezza ha oltrepassato ogni limite
immaginabile. Ed è un peccato anche perché, nel caso del comune pugliese, si è
voluto appiccicare un bollo ideologico ad un’iniziativa che aveva visto la
partecipazione attiva di realtà sociali, a partire dall’Anfass e da altri
soggetti locali. E’ stata quella canzone inutile, fuori luogo, dannosa, a far
esplodere la polemica. Perché almeno durante le feste, le feste sante, c’è chi
vorrebbe essere lasciato in pace. Invece no. La banda musicale rivendica il
gesto: “E’ stato suonato il ritornello della canzone Bella ciao, dopo la
richiesta di alcuni presenti tra il pubblico. Noi riteniamo di essere strumenti
attraverso il quale divulgare musica e non potremmo farlo senza l’ascolto del
nostro pubblico”. Chissà se qualcun altro dal pubblico avesse chiesto loro di
intonare Faccetta Nera come avrebbero reagito… Ovviamente, applausi al signor
sindaco dai suoi compagni. Ecco un commento di una signora dalla pagina Facebook
del Peppone di Torremaggiore: “Una come me che è cresciuta a pane e ‘Bella ciao’
non ci vede niente di male che sia stata suonata in occasione delle feste
natalizie perché appartiene al colore politico della nostra amministrazione e a
quanto pare so che invece è stata molto apprezzata dalla gente presente”. Che
facciamo? Che cosa merita un commento del genere? Sei cresciuta a pane e “Bella
ciao”, cara compagna? Evidentemente ti ha fatto male se non riesci a distinguere
una canzone di parte con una festa sacra. Sono quelli che pensano di potersi
permettere di tutto. Non è democrazia, è anarchia.
Ue, Gentiloni e i commissari socialisti cantano
Bella Ciao in aula, ira Meloni. Pubblicato mercoledì, 04 dicembre 2019
da Alessandro Sala per corriere.it il 4 dicembre 2019. Hanno intonato «Bella
Ciao», il canto partigiano per antonomasia (sulle cui origini vi sono però
parecchie discordanze), all’interno dell’aula dell’Europarlamento di Strasburgo,
dopo il via libera definitivo alla Commissione Ue guidata da Ursula von der
Leyen. E lo hanno fatto in perfetto italiano, segno che la conoscevano bene.
Sette dei 9 nuovi commissari di area socialista, tra cui il titolare degli
Affari Economici Paolo Gentiloni, hanno pensato di festeggiare così l’avvio
della nuova esperienza di governo, con un momento goliardico durante una
foto-opportunity limitata agli esponenti del loro gruppo, dopo quella di rito
con l’intera squadra. C’è grande partecipazione al coro e tra i più entusiasti
si notano l’olandese Frans Timmermans, che della von der Leyen è il
vicepresidente esecutivo con delega al Green Deal Europeo, ovvero le
macropolitiche ambientali; la maltese Helen Dalli, commissaria all’Uguaglianza;
e la portoghese Elisa Ferreira, commissaria per la Coesione e le riforme.
Nessuno dei sette si sottrae al battimano ritmato che accompagna la piccola
esibizione.
Meloni indignata. Ma un video registrato
nell’occasione con un telefonino ha iniziato a circolare anche al di fuori delle
chat del gruppo e oggi è stato diffuso su Facebook dalla presidente di Fratelli
d’italia, Giorgia Meloni, sotto l’eloquente titolo di «Unione sovietica
europea». « Solo io reputo scandaloso questo ridicolo teatrino da parte delle
più alte istituzioni europee — si chiede l’esponente della destra italiana —?
Non hanno nulla di più importante di cui occuparsi?». Anche il leader leghista
Matteo Salvini è intervenuto sul coro dei commissari: «Complimenti a Pd e 5
Stelle per la scelta di Gentiloni come rappresentante dell’Italia in Europa —
scrive l’ex vicepremier su Twitter —. Al prossimo giro canteranno anche Bandiera
Rossa, poi Sanremo e tournée internazionale».
I precedenti. Anche se le origini partigiane di
«Bella Ciao» non sono certe, e non è neppure certo che si tratti un brano
italiano, nella politica italiana questo canto viene spesso evocato come canto
di resistenza. Il soggetto del testo, del resto, lo è. Lo hanno rispolverato le
«sardine» che nelle ultime settimane hanno riempito le piazze in nome della
resistenza civile (per esempio qui durante il raduno di Genova); lo ha cantato
nei giorni scori in chiesa di Vicofano, nel Pistoiese, don Massimo Biancalani,
suscitando la rabbia di Salvini; lo aveva intonato addirittura Michele Santoro
in diretta tv nel 2002 in polemica con l’allora premier Silvio Berlusconi. E
risuona regolarmente ad ogni celebrazione del 25 aprile e nelle manifestazioni
della sinistra. Nulla di strano, insomma, che dei parlamentari di sinistra la
considerino un proprio simbolo. Ma il fatto che siano commissari, quindi
rappresentanti istituzionali e non esponenti di parte, e che il canto sia
avvenuto all’interno dell’Aula con tanto di coreografia ufficiale della Ue ha
mandato su tutte le furie Giorgia Meloni.
«Noi Popolari siamo più seri». Ma non solo lei.
Anche l’europarlamentare Fulvio Martusciello (Forza Italia), dal canto suo, ha
scritto in una nota:«Ma pensassero a lavorare che sono pagati per questo.
Bonino, Frattini o Tajani che pure sono stati commissari europei non lo
avrebbero mai fatto. Non è un caso che i commissari che cantano sono tutti
socialisti. Noi popolari siamo seri e una cretinaggine del genere non l’avremmo
mai fatta».
I commissari europei cantano “Bella Ciao”,
Meloni: “Teatrino ridicolo e scandaloso”. Alberto Consoli mercoledì 4
dicembre 2019 su Il Secolo d'Italia. “Commissari europei intonano “Bella Ciao”.
Solo io reputo scandaloso questo ridicolo teatrino da parte delle più alte
istituzioni europee? Non hanno nulla di più importante di cui occuparsi?”. Ha
ragione Giorgia Meloni: un teatrino deprimente che sta facendo il giro del web.
“Siamo alla tragica fine dell’Europa”, commentano i più, ossia gli utenti social
che stanno condividendo questa scena molto poco edificante. Sul sito di Giorgia
Meloni, la prima a diffondere dal suo profilo Fb il video, non ci sono solo
commenti riferibili a una condivisione politica. Moltissimi commentatori si
scandalizzino per ben altro. L’Europa ha grandi problemi da dibattere: la crisi
economica, il ruolo che la Ue vorrà darsi, stratta tra Usa, Cina e Russia.
Aziende in crisi, L’economia che arranca. Eppure gli “autorevoli commissari”,
trovano il tempo per pagliacciate del genere. Ma come – è il senso dei commenti-
intendono inculcarci l’idea che senza Europa saremmo dannati, persi, senza una
bussola politica. Poi perdono tempo a “cazzeggiare”? Il video è pubblicato dai
social di FdI con un titolo ironico: “Unione sovietica europea”. Ironia a parte,
l’indignazione resta. L’inno “Bella ciao” ormai viene usato come una clava un
po’ da tutti: dalle sardine, da alcuni preti, dalle piazze di sinistra, dai
preti rossi il primo giorno di scuola. Lo strimpella il ministro dell’Economia
Gualtieri. Bella Ciao, a dispetto delle sue origini, è usato come
slogan-contro: ogni volta che c’è da vocare le paure fasciste e sovraniste.
Follia. Tristissima scena quella dei commissari Ue, che osserviamo, per fortuna
per pochi minuti. Tristissima Europa.
Alessandro Giuli per “Libero quotidiano” il 18
dicembre 2019. Paolo Gentiloni non è più lo stesso. Da quando è partito per le
brume centroeuropee ha perduto quell' aura da pacioso romano senza qualità
rimarchevoli; si è dato al canto sguaiato a favore di telecamera, intonando
"Bella ciao" assieme ai colleghi commissari di conio socialistoide; ha
sviluppato un' inquietante ipertrofia tricologica che gli ha immobilizzato la
capigliatura in un grigio bozzolo verticale da cicisbeo settecentesco. Ma forse
ha soltanto somatizzato una scossa elettrica, o ha capito troppo tardi -
prendendola male - che l'Ue l'ha subito declassato a commissario europeo all'
ipocrisia e ai sogni irrealizzabili del Vecchio continente. Prendete la sua
ultima uscita di rilievo, che risale a nemmeno una settimana fa: «Il patto di
stabilità, che è stato pensato in un momento di crisi, ora va rivisto». In
apparenza sembra intelligente, del resto era stato lo stesso Romano Prodi a
definire «stupido» il patto di stabilità. Ma Gentiloni non ha compreso che quel
vincolo è assurdo perché è stato immaginato per un continente tutt' altro che in
crisi, ma con una crescita immaginaria del 4-5%. Ecco perché ora, in piena
recessione, faremmo bene a ripensarlo. Insomma Gentiloni o mente o invecchia
male. Non si spiega altrimenti la ragione per cui la sua resistibile
intelligenza, che era stata sottratta all' Italia con la promessa di affidargli
la delega all' Economia nell' esecutivo guidato da Ursula von der Leyen, sia
stata invece posta al servizio dei cosiddetti "obiettivi di sviluppo
sostenibile" (Sustainable development goals) ovvero una serie di target
ricompresi nell' agenda 2030 dell' Onu. Si tratta di raggiungere ben 17
risultati che sembrano altrettanti capitoli d' un libro dei sogni per attempati
prestidigitatori della politica incatenati alle treccine di Greta Thunberg.
Qualche esempio? Azzerare la povertà e la fame, combattere contro il
riscaldamento globale, raggiungere la stabilità locale e mondiale, ridurre le
disuguaglianze, costruire società eque e resilienti, ed economie prospere. Vasto
programma che sa di prepensionamento, per il nostro Gentiloni. E a conferma del
sospetto genuino sta il non trascurabile dettaglio che finora il coordinamento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile era affidato a Valdis Dombrovskis. E a
questo punto la situazione si chiarifica: Dombrovskis lascia ufficialmente che
sia Gentiloni a baloccarsi con i periodi ipotetici dell' irrealtà, per la
semplice ragione che l'ex primo ministro lettone è nel frattempo diventato un
vicepresidente esecutivo con delega economica per i Servizi finanziari. In altre
parole: svolgerà lui, campione internazionale del rigorismo nordeuropeo, le
mansioni principali che sarebbero altrimenti state di stretta competenza
gentiloniana. Si poteva però immaginare che l'ex premier italiano volesse di
conseguenza ritagliarsi una libertà di tono e di giudizio nei confronti del
profilo ancora enigmatico mostrato dalla nuova Commissione. Come a dire: voi,
che mi avete ingaggiato all'Economia per premiare il ribaltone estivo
antisovranista, adesso mi togliete le deleghe più pesanti in omaggio al vostro
eterno pregiudizio antimediterraneo; sicché il minimo che io possa fare è
difendere il mio interesse nazionale. Magari nulla di tutto ciò invece: le prime
mosse dell' oleografico Gentiloni sono state caratterizzate dal più inveterato
provincialismo germanofilo. Banco di prova esemplare la discussione intorno alla
riforma del Meccanismo europeo di stabilità, rispetto alla quale Gentiloni si è
ben guardato dal rilevare punti oscuri o criticità (come hanno fatto perfino
alcuni noti "berlinesi" come il corrierista Federico Fubini e il professor Carlo
Cottarelli), e ha preferito anzi piegarsi supinamente alla dottrina dominante:
«Non c' è alcun motivo tecnico o politico per definire quell'intesa un rischio
per l' Italia Non vedo ragioni che possano spingere un singolo Paese a bloccare
l' intesa sul Mes». Sono parole che Gentiloni ha rilasciato al Corriere della
Sera, in un dialogo tra figure dell' establishment culminato in un avvertimento
che non segnala alcuna discontinuità rispetto ai moniti del passato: «Nel
complesso la Commissione non ha respinto nessun bilancio, tantomeno quello
italiano. Ma le sue valutazioni, che verranno sottoposte alla ratifica dell'
Eurogruppo, andranno prese molto sul serio». In questo atteggiamento da
europrofessore alle prese con alunni indisciplinati è racchiuso il vero mandato
di Gentiloni: perpetuare il tutorato tecnocratico sull' inadempiente classe
politica italiana. Il che potrebbe anche starci, se non fosse che il medesimo
Gentiloni ha svolto una funzione non trascurabile nel nostro recente paesaggio
governativo, e si deve anche a lui se nel 2018 la vecchia Commissione europea
stava per infliggere al governo gialloverde una procedura d' infrazione per
eccesso di debito. Proprio così: al netto delle imperizie, dei proclami roboanti
e delle velleità spendaccione del primo governo Conte, i burocrati europei
rilevarono con l' allora ministro dell' Economia Giovanni Tria che i conti
lasciati in eredità dai governi Renzi e Gentiloni risultavano «non conformi con
il parametro per la riduzione del debito nel 2016 e nel 2017». Più
esplicitamente, la Commissione reclamava «uno sforzo strutturale di bilancio
dello 0,3 per cento del pil, pari a circa 10,2 miliardi». Altro che 2,4 per
cento di deficit in più, come s' illudeva di strappare l' avvocato degli
italiani Sappiamo come è andata a finire. Giusto ieri la Commissione europea ha
avviato un' indagine approfondita nei confronti dell' Italia a causa «del
persistere di squilibri macro-economici eccessivi», scandisce il Rapporto sul
Meccanismo di Allerta adottato dalla Commissione. Nel ringraziare, oggi, con
calore l' ex inquilino di Palazzo Chigi per aver servito con tanta perizia l'
interesse nazionale, ci pregiamo infine di ricordare come egli non sia stato
certo meno accorto nella legittima cura del proprio interesse privato. Una volta
ottenuta l' euronomina, in effetti, secondo i dati già segnalati da Libero, il
conte Gentiloni Silveri ha dovuto rendere pubblico un personale tesoretto
azionario da principino della Borsa: oltre 700mila euro distribuiti fra Amazon,
Expedia, Eni, Enel, con obbligazioni BTP e investimenti in vari fondi gestione.
Chapeau. Vi risparmierei la replica del censimento dei beni immobili, ma ne
riparleremo il giorno in cui Gentiloni proverà a infliggerci la prossima
patrimoniale sulla casa.
Marco Rizzo, Partito Comunista: “Commissari Ue
cantano un’idea e sono gli stessi che la distruggono”. Rossella Grasso il 4
Dicembre 2019 su Il Riformista. In pochi minuti è diventato virale un video che
vede i Commissari del gruppo dell’Alleanza progressista dei socialisti e dei
democratici (S&D) mentre cantano “Bella Ciao” al Parlamento europeo dopo aver
ottenuto il via libera dell’assemblea. Un video vecchio di una settimana che ha
indignato Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista. “Adesso basta,
non se ne può più – ha tuonato sulla sua pagina Facebook – Anche i commissari UE
cantano ‘Bella Ciao’. Sono quelli che equiparano il comunismo al nazismo. Questa
canzone è violentata ovunque. I Partigiani si rivoltano nella tomba. Vergogna!
Fuori da UE, euro e Nato!” Se non stupisce che Meloni e Salvini fossero contrari
a una simile esternazione dal parte del gruppo dei neocommissari socialisti, la
posizione del segretario generale è particolare e gli abbiamo chiesto una
spiegazione: “Vediamo i soggetti e l’oggetto – ha detto Rizzo – I soggetti sono
il potere costituito dell’Unione Europea, la gabbia europea che attanaglia i
popoli europei, secondo il nostro giudizio politico, sono gli uomini che
consentono al fondo monetario internazionale e alla Banca Centrale europea di
esercitare al meglio il loro potere. L’oggetto è una canzone che ha
rappresentato le istanze di cambiamento, di battaglia, in cui sono morte decine
di migliaia di persone tra cui in maggioranza comunisti. Possono rivoltarsi
nella tomba i Partigiani a vedere che questi signori cantano la loro canzone?
Purtroppo nel mainstream del capitalismo globalizzato "Bella ciao" la cantano
tutti. E a me dà fastidio”. Per Rizzo si tratta di un vero e proprio ossimoro,
l’esatto contrario del significato profondo di quella canzone. “Possiamo far
cantare un’idea da quelli che quell’idea la distruggono? È la modalità con cui
si crea il consenso e si crea anche il dissenso in questa società. Stessa cosa
succede per chi inquina il mondo che si pone la questione dell’ambiente. È buffo
ma oggi è così. Il 70% dell’inquinamento del mondo è fatto da 100 multinazionali
e tra queste c’è chi impone la discussione sulla green economy. Come dire,
"chiagnono e fottono"? Io sono contrario”. L’indignazione per il gesto in
Parlamento europeo arriva anche da Salvini che ha twittato “Al prossimo giro
canteranno anche Bandiera Rossa, poi Sanremo e tournee internazionale!”
e Meloni che ha definito “scandaloso” l’accaduto. Per una volta le estremità di
destra e sinistra sono tutti d’accordo? “Per definizione non sono mai d’accordo
con la Meloni – ha detto – Penso di essere un po’ più titolato di Salvini e
Meloni a parlare di Resistenza e partigiani anche perché gli antenati della
Meloni durante la Resistenza stavano dall’altra parte“. “Bella Ciao” è una delle
canzoni più cantate in tutti i contesti, anche non politici, come è accaduto per
la popolare serie di Netflix ‘Casa de papel’ tanto da diventare per molti
identificativa della serie tv, tralasciando il suo vero significato (e YouTube
ne è testimone). La cantano anche le sardine ogni volta che scendono in piazza e
per Rizzo anche questo è un abuso decontestualizzato. “Ormai tutti la cantano –
ha detto il segretario comunista – Ma allo stesso modo mi sono incazzato quando
ho visto il Che Guevara usato da Casapound. C’è un limite a tutto. ‘Bella Ciao’
la cantano tutti addirittura i padroni dell’Europa. È una roba folle”. Il
segretario del partito comunista orgogliosamente ammette di non aver mai
indossato una maglietta con il Che stampato su. Perché come ‘Bella Ciao’ “il Che
è qualcosa che ti resta nel cuore – ha continuato – è l’idea del grande
rivoluzionario. Questa società riesce persino a commercializzare un grande
sentimento. È una società che fa schifo”. Rizzo non ci sta a credere che le
sardine siano un movimento rivoluzionario. “La rivoluzione significa cambio di
sistema – spiega – non mi pare che ci sia né tra le sardine, né tra il popolo
viola né tra i 5stelle, né da Podemos né da Syriza una modalità di intercettare
il dissenso in queste società contemporanee, nessuna di loro ha messo in
discussione il sistema basato sull’economia capitalistica, nessuno parla di
economia socialista, di cambio del sistema. Questa è la rotta su cui
interpretare quello che accade ed è la differenza tra ribellione e rivoluzione”.
Il segretario comunista guarda con sospetto a quel movimento che dice essere
nato “guarda caso” a Bologna, dove tra poco ci saranno le amministrative che
avranno un riflesso nazionale. Ragionando di partigiani, simboli e Resistenza
non può non tornare alla mente Nilde Iotti scomparsa 20 anni fa proprio il 4
dicembre. Marco Rizzo l’ha conosciuta ed è convinto che siano politici come lei
ad aver fatto la differenza. Lo afferma con amarezza perché “oggi politici come
lei non ce ne sono più – ha detto – È stata una donna che ha partecipato
all’emancipazione femminile in Italia, ma tutta la storia delle donne è legata
all’idea del riscatto e del cambiamento della società. Qual è il primo posto al
mondo in cui le donne hanno votato? L’Unione Sovietica. Dove per prime le donne
hanno avuto i diritti di maternità, il primo ministro donna, tutti i mestieri ad
alto livello sono stati anche per le donne dall’ingegnere all’astronauta, il
diritto all’aborto e al divorzio? Sempre l’Unione Sovietica. Nilde Iotti ha
portato tutto questo in Italia con un livello di dignità politica altissimo. Se
pensiamo a Nilde Iotti e a cos’è oggi la politica, beh insomma…anche sul
versante femminile lo scenario è disarmante”.
La storia di "Bella Ciao", l’inno che nacque
dopo la Resistenza. Roberta Caiano su Il Riformista il 5 Dicembre 2019.
Nell’ultimo periodo la famosa canzone “Bella Ciao” è diventata un successo
mainstream cantata ovunque. Senza dubbio la sua risonanza tra un pubblico
giovanile la si deve alla serie Tv spagnola La casa di Carta, che continua a
cavalcare gli schermi arrivando alla sua terza stagione. Andata in onda per la
prima volta su Netflix nel 2017, continua ad avere un enorme successo mondiale e
con essa la canzone Bella Ciao. Ma in questi ultimi mesi la canzone è stata
adottata anche come inno dalle migliaia di giovani sardine che stanno affollando
le piazze di moltissime città italiane a protestare contro Matteo Salvini. E’
notizia fresca, invece, quella che riguarda i Commissari del gruppo
dell’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici, i quali dopo aver
ottenuto il via libera dell’assemblea, hanno intonato Bella Ciao al Parlamento
europeo. Il video è diventato così virale da scatenare polemiche e commenti di
indignazione e sconcerto. Oltre a Giorgia Meloni e Salvini, che si sono subito
affrettati a chiosare la notizia su twitter, si è espresso in merito anche il
segretario generale del Partito Comunista, Marco Rizzo. Il politico ha
dichiarato in un’intervista che “la canzone ha rappresentato le istanze di un
cambiamento di battaglia in cui sono morte decine di persone, tra cui in
maggioranza partigiani comunisti italiani.” La maggior parte delle volte Bella
Ciao è considerata la canzone intonata dai partigiani mentre liberavano
l’Italia. Tutt’oggi viene usata come inno antiautoritario non soltanto in Italia
ma in tante piazze del mondo. In realtà non molti sanno che questa è una
leggenda che la tradizione ha tramandato sino ai nostri giorni. Infatti Bella
Ciao non esisteva durante la Resistenza e nessuno la cantava, anche se alcuni
studiosi sostengono che in alcune zone di Reggio Emilia e del Modenese fosse in
realtà già nota. Tra le bande partigiane il canto più diffuso era Fischia il
vento, nato nel 1943 dalla cadenza sovietica . Bella Ciao nella versione che
conosciamo, debutterà ufficialmente a Praga nel 1947 durante il "Festival
mondiale della gioventù democratica" e di lì conoscerà una fortuna sempre
maggiore, anche al di là dei confini nazionali. Infatti la sua notorietà
internazionale si diffuse alla fine degli anni ’40 e agli inizi degli anni ’50
in occasione dei Festival che oltre a Praga, si tennero anche
a Berlino e Vienna dove fu cantata dai delegati italiani e in seguito tradotta
in varie altre lingue. Questo canto deve la sua identificazione come simbolo
della Resistenza italiana al testo, in quanto connota la canzone esclusivamente
come inno contro “l’invasore”.
Bella Ciao, hit non di lotta ma di resistenza.
Paolo Delgado il 6 Dicembre 2019 su Il Dubbio. Le incerte radici della canzone
simbolo. La incise Yves Montand, Daffini la cantò al festival dei due mondi di
Pesaro: rappresentava la propaganda comunista. Poi i Dc la cantarono a
Zaccagnini. Al funerale di Giorgio Bocca, grande firma ed ex partigiano, i
dolenti scelsero di salutarlo intonando Bella Ciao. Decisione discutibile,
avendo Bocca assicurato che i partigiani non l’avevano mai cantata. Al funerale
di Giorgio Bocca, grande firma ed ex partigiano, i dolenti scelsero di salutarlo
intonando Bella Ciao. Decisione discutibile, essendo Bocca uno di quelli che
avevano assicurato che il canto destinato a diventare una sorta di nuova
Internazionale, ritinteggiata in rosa pallido, i partigiani non l’avevano mai
cantata. Aveva ragione lui o Cesare Bermani, autore del primo studio sulla
canzone- simbolo La vera storia di "Bella Ciao", secondo cui invece qualcuno la
cantava, comunque senza grande diffusione. E’ un fatto che i canzonieri della
Resistenza usciti quando l’odore della polvere da sparo era ancora acre, nella
seconda metà degli anni ‘ 40 e nei primissimi ‘ 50, proprio non la nominano e
anche l’ipotesi di Bermani, secondo cui sarebbe stata l’inno della Brigata
Maiella, sembra poco probabile: il figlio del fondatore della Brigata, Ettore
Troilo, cita in un suo libro le canzoni delle Brigata e dell’ "inno" non c’è
traccia. Fonti beninformate giurano che la canzone fu presentata alla rassegna
di Praga sulle "Canzoni mondiali per la Gioventù e per la Pace", una delle
tipiche iniziative Cominform dell’epoca, e che, complice l’orecchiabilità, il
motivo decollò lì. Come in tutti i pezzi folk, rintracciare l’origine è
un’impresa. Carlo Pestelli, autore a sua volta di Bella ciao. La canzone della
libertà, parla di canzone- gomitolo, nella quale si intrecciano, anche in questo
caso come spesso capita nelle canzoni folk, ‘ si intrecciano molti fili di vari
colori’. Il gomitolo finale arriva al grande pubblico con l’incisione di Yves
Montand, allora stella mondiale francese di origine italiana e comunista. L’anno
dopo il Nuovo Canzoniere Italiano la presenta al Festival dei Due Mondi di
Pesaro, intonata da Giovanna Daffini, e fioccano le polemiche sulla propaganda
comunista al Festival. I commentatori vicini alla Dc si scompongono ma poco più
di 10 anni dopo, quando Benigno Zaccagnini, l’ "onesto Zac", rappresentante
eminente dei morotei viene eletto segretario della Dc i delegati salutano il
sedicente nuovo corso proprio col già vituperato motivo.
Oggi la cantano dappertutto. A New York, a Occupy
Wall Street, e a Hong Kong, In Cile come in Iraq, a Parigi come a Roma e ieri
anche sotto la porta di Brandeburgo. Ci mette parecchio di suo la serie Netflix
"rivoluzionaria" per eccellenza, La casa di carta. Se la cantano lì, nella
fiction più antibanche che sia mai stata trasmessa. Però è difficile credere che
Paolo Gentiloni e i rappresentanti del Pse avessero in mente una feroce campagna
contro le banche quando, dopo il voto a favore della commissione von der Leyen,
hanno dato vita al noto coretto. La fortuna del canto non-partigiano, sostiene
qualcuno, si deve proprio all’assenza di tonalità forti. Niente a che vedere con
roba come Fischia il vento, che la vernice rossa non gliela si scrostava di
dosso nemmeno a provarci per ore. E’ una canzone che poteva andare bene per
tutti, fascisti esclusi, e dunque pareva fatta apposta, in Italia, per
consentire a quello che si chiamava allora ‘ arco costituzionale’ di
festeggiarsi senza troppe tensioni. Ma in fondo come e perché si sia arrivati a
questo esempio eminente di ‘ invenzione della tradizione’ conta poco. Meglio
chiedersi cosa l’opzione canora transnazionale indica oggi. Bella Ciao,
nonostante le apparenze, non è una canzone di lotta. E’ una canzone di
resistenza ( con la r minuscola). La può cantare chiunque ritenga di trovarsi
alle prese con un potere che opprime, con l’invadenza di una potenza estera,
persino con la temuta vittoria elettorale di un partito ritenuto minaccioso. E’
una canzone gentile: la può cantare chi resiste con le bottiglie molotov ma
anche chi si affida alla resistenza passiva e persino chi si limita ad
assieparsi in una piazza. Se non proprio buona per tutti gli usi, quasi.
Bella Ciao? Sallusti:
“Nessun partigiano l’ha mai cantata”. Vaurosenesi.it il 30 aprile 2019.
“Bella ciao” canzone di tutti gli italiani? Sallusti: ‘Nessun partigiano l’ha
mai cantata’. Per Alessandro Sallusti ‘non c’è traccia di Bella ciao nella
Resistenza, introdotta a metà degli anni ‘50 dalla retorica comunista’. A Quarta
Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro, in onda tutti i lunedì sera
su Rete 4, si discute sul fatto che la canzone Bella Ciao rappresenti o meno
tutti gli italiani con Ilaria Bonaccorsi, Vittorio Sgarbi, Alessandro Sallusti,
Marco Gervasoni e Vauro. Argomento spinoso e divisivo che, infatti, fa discutere
animatamente gli ospiti in studio. La tesi di Porro è che sia diventata una
canzone di parte e che, quindi, non è giusto che venga fatta cantare anche a suo
figlio a scuola. Di questa stessa idea, ma con sfumature diverse, sono anche il
direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti e il critico d’arte Vittorio
Sgarbi. Dalla parte opposta della barricata, è proprio il caso di dirlo, si
sistema la storica e giornalista, Ilaria Bonaccorsi, mentre il
vignettista Vauro Senesi sostiene, come gli altri ma da un punto di vista agli
antipodi, che non sia la canzone di tutti perché appartiene solo agli italiani
antifascisti.
Ma Bella ciao può essere
considerata o no la canzone di tutti gli italiani. È questo il tema di
discussione introdotto a Quarta Repubblica da Nicola Porro verso la fine della
puntata andata in onda lunedì 29 aprile. Secondo la definizione di Wikipedia,
Bella Ciao “è un canto popolare, nato prima della Liberazione, diventato poi
celeberrimo dopo la Resistenza perché idealmente associato al movimento
partigiano”. Dunque, secondo il conduttore, “chi la canta gli dà un contenuto
politico, è diventata una canzone di una parte” che non dovrebbe essere fatta
cantare nelle scuole. Una tesi contrastata con veemenza da Ilaria Bonaccorsi,
secondo la quale, invece, il canto appartiene a tutti gli italiani perché “è una
canzone trovatella che racconta di una reazione ad una oppressione, nel caso
specifico la reazione a 20 anni di dittatura nazifascista e alla fine di una
guerra tragicamente combattuta accanto ad Hitler. Non è la canzone di una parte,
ma degli esseri umani”.
L’affondo di Alessandro
Sallusti: ‘Comunisti parte minoritaria della Resistenza’. La pensa naturalmente
in maniera opposta Alessandro Sallusti, secondo il quale “vi siete accodati alla
narrazione che ci fanno da 70 anni di quelle vicende. In realtà Bella ciao non
può essere la canzone di tutti, anche perché è una fake news. Nessun partigiano
l’ha mai cantata – sostiene il direttore del berlusconiano Il Giornale – Non c’è
traccia di Bella ciao nella Resistenza. È stata introdotta a metà degli anni ‘50
dalla retorica comunista proprio per impossessarsi definitivamente di un
fenomeno, quello della Resistenza, di cui il Partito Comunista è stato una
parte, tra l’altro anche minoritaria, ma ha cercato ed è riuscito, perché ancora
70 anni dopo noi immaginiamo che i partigiani erano tutti e soltanto comunisti e
che cantavano Bella ciao. Non è vera né l’una né l’altra cosa”.
Vauro d’accordo con Sgarbi. A
questo punto interviene Vittorio Sgarbi, convinto che Bella ciao “è una bella
canzone, ma va rispettato che sia di una parte, perché altrimenti essa perde la
sua forza di rottura. Non puoi immaginare La Russa, Berlusconi o Sallusti che la
canta, perché è offensivo. Il partigiano monarchico Edgardo Sogno mai l’avrebbe
cantata. La caratterizzazione di sinistra, per cui immagino Vauro sia contento,
va lasciata a Bella ciao, non possiamo farla diventare cosa di tutti. Se
Casapound la canterà sarà un delitto”. Opinione con cui concorda anche Vauro. Il
vignettista prima premette che “sarà un miracolo di questa trasmissione, ma è
già la terza puntata che vado d’accordo con Sgarbi”. Poi però attacca a testa
bassa: “Alla domanda se Bella ciao è la canzone di tutti gli italiani, io
rispondo un secco e netto no. È la canzone di tutti gli italiani che si
riconoscono nella Costituzione della Repubblica italiana, antifascista e nata
dalla Resistenza. L’antifascismo è un valore e anche una discriminante”.
Alessandro Sallusti fa a
pezzi Vauro a Quarta Repubblica: "Parlate di partigiani e dimenticate le foibe".
Libero Quotidiano 30 Aprile 2019. "Bella ciao è una fake news. Non era la
canzone dei partigiani ma è stata introdotta negli anni Cinquanta dalla retorica
comunista". Alessandro Sallusti, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica,
su Rete 4, fa a pezzi il vignettista Vauro Senesi che, invece, insiste sulla
necessità di insegnare il fascismo nelle scuole anche se il conduttore
sottolinea che i bambini non sanno nulla dell'argomento: "L'istruzione è il
primo anticorpo contro il fascismo", tuona il vignettista. Ma il direttore de Il
Giornale lo massacra: "In quella scuola si sono dimenticati di insegnare le
foibe e la strage di Osoppo e tante altre cose ancora".
O anti-grillino, portami
via...La cantilena di Bella Ciao sta risuonando in queste settimane nelle
manifestazioni della sinistra. Ma se resistenza deve essere, oggi il nemico non
può essere la destra liberale e neppure Salvini che si barcamena come può.
Alessandro Sallusti, Martedì 30/04/2019, su Il Giornale. Ieri ho partecipato a
un dibattito televisivo, ospite di Nicola Porro su Rete4, sul ritorno in auge di
Bella Ciao, la canzone che modificata nel testo fu adottata negli anni Cinquanta
dal Pci per dare una colonna sonora postuma alla retorica della Resistenza e
all'antifascismo perpetuo da utilizzare contro chiunque, da Berlusconi a
Salvini, si sia frapposto con successo all'avanzata del comunismo. La cantilena
di Bella Ciao sta risuonando in queste settimane nelle manifestazioni della
sinistra, ma anche nelle scuole e in un caso addirittura in chiesa, Eugenio
Scalfari le ha dedicato un pezzo della sua omelia domenicale su La Repubblica.
Un revival sinistro in ogni senso, che come tutti i revival è indice
dell'incapacità di guardare al presente e al futuro, un po' come Little Tony che
si è fermato a Cuore matto e Bobby Solo a Una lacrima sul viso. Sono fermi lì,
quelli del Pd, alla rivoluzione sognata e per fortuna nostra fallita. Ma se
proprio vogliamo dare una colonna sonora a questo tempo bisognerebbe che anche
la sinistra uscisse dalla «nostalgia canaglia» (peraltro titolo di una fortunata
canzone cantata da Al Bano e Romina) e scrivesse un nuovo spartito con parole e
musica comprensibili non tanto ai nostri nonni, ma ai nostri figli e nipoti,
cosa che però non mi pare Zingaretti e soci siano intenzionati o capaci di fare.
Proporsi, tra accelerazioni e frenate (ieri quella dell'ex ministro Delrio) come
possibili stampelle dei Cinque Stelle nel caso di una rottura tra Di Maio e
Salvini, più che un programma politico è una mossa della disperazione nella
quale era già caduto Bersani sei anni fa all'indomani della sconfitta, o «non
vittoria» come la chiamò lui, alle Politiche del 2013. Se resistenza deve
essere, oggi il nemico non può essere la destra liberale (quella radicale e
intollerante è talmente al lumicino che bastano polizia e carabinieri) e neppure
Salvini che si barcamena come può stante la situazione. L'inutile
«fascismo-antifascismo» andrebbe sostituito con il più utile
«grillismo-antigrillismo» perché nell'opaco movimento di Di Maio e nei suoi
agganci con i servizi segreti italiani e stranieri sta il vero pericolo per la
democrazia, proprio come ai tempi di Bella ciao, ballata pensata da chi ci
voleva portare al fianco di Stalin.
Red Ronnie a Stasera Italia contro le Sardine e
Bella Ciao: "L'invasore chi è, Matteo Salvini o l'Europa?" Libero Quotidiano l'8
Dicembre 2019. Parole che strappano un sorriso a Matteo Salvini. Parole di Red
Ronnie a Stasera Italia, il programma di Rete 4, rilanciate sui social proprio
dal leader della Lega, di fatto difeso a spada tratta dal cantante. Barbara
Palombelli chiede a Red Ronnie: "Ma che tipo è Salvini secondo te?". Lui
risponde: "È un istintivo, uno che si dice che raggiunga la pancia perché parla
con la pancia. Raramente legge dei discorsi, diffido da chi lo fa". Dunque, Red
Ronnie prosegue: "All'inizio del servizio avete fatto sentire la canzone C'è chi
dice no di Vasco Rossi, in un servizio in cui elencavate tutti i nemici del
leghista. Io ho il disco, e devo mettere un pezzo della canzone: continuano
a giudicarlo per il Papeete, perché era a torso nudo, perché beveva il mojito. È
un po' come quello che Vasco diceva di se stesso. Gli dicevano: guardate
l'animale, è un animale? E Salvini oggi è un po' quell'animale che tutti
dicono", afferma. Ma non è finita, perché poi nel mirino di Red Ronnie ci
finisce Bella Ciao, tornata in auge nelle piazze delle sardine: "Visto che
parliamo di canzoni, vorrei parlare di Bella Ciao. È una canzone che va bene
nella Casa di Carta ormai. Ma cantare Bella Ciao, quando si dice: mi sveglio la
mattina, è arrivato un invasore. Ma l'invasore chi è? Salvini o qualcuno
dell'Europa che ci sta invadendo e ci sta comprando? Io sono un anarchico, però
vedo che ci sono molte cose che non stanno andando in questo mondo, c'è qualcuno
che non sa più che ore sono", conclude. Intervento, come detto, rilanciato sui
social da Salvini col commento: "Fortissimo Red Ronnie, parole di buonsenso!".
Ciao compie (solo) 200 anni: è la parola
italiana più celebre dopo «pizza». Esaltata dai partigiani e al Festival di
Saremo, la sua prima attestazione scritta risale al 1818 (e a Milano), scrive
Paolo Di Stefano il 23 giugno 2018 su "Il Corriere della Sera".
«Ciao ciao bambina». Nel 1959 Domenico Modugno
vinse a Sanremo con Johnny Dorelli cantando Piove. In realtà quella canzone
resterà nella memoria per il ritornello: «Ciao ciao bambina», che presto si
diffonderà all’estero nella trascrizione inglese «Chiow Chiow Bambeena», in
quella tedesca «Tschau Tschau Bambina», in quella spagnola «Chao chao bambina».
Dalida la cantò nella versione francese. Il linguista Nicola De Blasi (nel libro
«Ciao», pubblicato dal Mulino) sostiene che la canzone di Modugno e di Dino
Verde rappresentò la svolta decisiva nella fortuna internazionale della parola
«ciao», la forma di saluto più familiare che si conosca non solo in Italia. In
realtà, segnala De Blasi, il termine era già noto oltre i confini nazionali: in
un romanzo francese di Paul Bourget del 1893, un personaggio diceva in italiano
«Ciaò, simpaticone» e nei primi del Novecento veniva suonato un valzer
intitolato «Ciao». Il saluto filtrò ben presto nei film neorealisti e nelle
commedie all’italiana nel momento in cui il nostro cinema aveva un successo
mondiale.
Dal cinema ai giornali. Nel film di Monicelli I
soliti ignoti, del 1958, Gassman saluta l’amico Capannelle ricoverato in
ospedale con le parole «Addio, ciao, bello». Insomma, il nostro «ciao» si
diffonde nel mondo sulle ali del boom economico come «icona quasi fonosimbolica»
e del diffondersi del «tu» nei rapporti personali. Tant’è che nel 1967, l’anno
tragico per Sanremo in cui Tenco presenta Ciao amore ciao, la Piaggio decide di
battezzare «Ciao» un suo motorino che con lo slogan pubblicitario «Bella chi
ciao» punta sul pubblico giovanile. E ai lettori giovani, l’anno dopo, si
rivolge anche il settimanale illustrato «Ciao 2001», mentre a grandi e bambini
viene proposta la crema al cioccolato «Ciaocrem».
Nelle canzoni. Il ’68 è l’anno in cui sempre a
Sanremo Luis Armstrong duetta con Lara Saint Paul cantando Ciao, stasera son
qui. L’irresistibile ascesa di «ciao» giunge all’apoteosi nel 1990 con la
mascotte eponima dei Mondiali di calcio. E attualmente, dopo «pizza», «ciao» è
la parola italiana più pronunciata nel mondo fino a «ciao raga», «ciao neh»,
«ciaone». «Questa mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella
ciao ciao ciao»: va detto che il canto intonato dai partigiani, che si sarebbe
imposto molto dopo come inno politico di resistenza e di liberazione, fu
lanciato grazie anche a iniziative commerciali prestigiose come il disco di
canti popolari italiani interpretati da Yves Montand. Il più celebre
etnomusicologo, Roberto Leydi, dimostrò che Bella ciao è radicata nella
tradizione popolare perché risale a un canto piemontese dell’Ottocento dove però
manca la parola «ciao», che invece compare in un canto delle mondine anni
Quaranta.
Le prime testimonianze. E pensare che l’origine
della parola non ha nulla a che fare con la confidenza, se è vero, come è vero,
che «ciao» deriva dal latino «sclavum», variante di «slavum» quando a essere
ridotte in schiavitù erano le genti di provenienza slava. A partire dal
Quattrocento si introduce l’abitudine di salutare qualcuno dichiarandosi suo
schiavo (il friulano «mandi» proviene da «comandi»): da qui la parola «ciao» che
origina dal veneziano «s’ciavo», schiavo, appunto. Ma c’è un compleanno che
quest’anno va festeggiato: è esattamente di due secoli fa la prima attestazione
scritta di «ciao» (che naturalmente doveva esistere in forma orale già da un
po’), la stessa parolina che immettiamo decine di volte al giorno chattando su
Facebook o su WhatsApp. Il 1818 è l’anno in cui il tragediografo cortonese
Francesco Benedetti in una lettera accenna alle gentilezze ricevute da una
signora che lo conduce alla Scala e dai milanesi in genere: «Questi buoni
Milanesi cominciano a dirmi: Ciau Benedettin». D’altra parte un anno dopo la
scrittrice inglese Lady Sidney Morgan allude al comportamento di alcuni
spettatori che in un palco della Scala si scambiano un «cordial ciavo». Altra
conferma del bicentenario arriva da una lettera della contessa veronese Giovanna
Maffei, che nel 1818 riferisce al marito i saluti del figlio ancora bambino:
«Peppi à appreso a dire il tuo nome, e mi disse di dir ciao a Moti». Oggi la
funzione fonosimbolica si è moltiplicata, se al telefono, nella fretta del
congedo, non facciamo che ripetere: cià cià cià cià cià cià…
25 Aprile, pietre e
manganellate se non sventoli la bandiera rossa. Iuri Maria Prado su Libero
Quotidiano il 25 aprile 2023
Enumerate i comportamenti per
cui nell’Italia del 25 aprile, ma anche durante tutto il corso del caro anno
progressista, uno rischia a dir poco qualche insulto e se non sta attento anche
le selciate. A caso: girare con la kippah, sventolare una bandiera statunitense
o ucraina, bestemmiare la Costituzione nata dall’antifascismo, cioè dire che per
metà è una fetecchia statalista. E poi scovate da che parte viene l’insulto o la
sassaiola.
Non a caso: da sinistra. Non è
bello? Nella teocrazia venticinqueaprilesca, ineccepibilmente ispirata ai
“valori dell’antifascismo”, rischi le manganellate arcobaleno se esponi una
stella di David o sventoli la bandiera di quelli che hanno schiacciato la testa
alla belva nazista e ci hanno protetto dalla grinfia di quella comunista: poi
fanno le Giornate della Memoria.
E guai a non giurare
sull’antifascismo incartato in Costituzione: arriva la polizia morale delle
settecentoventiquattro associazioni dei partigiani del 26 aprile e stai fresco.
Magari un giorno - chissà? - in Italia potranno sentirsi al sicuro non solo i
pacifisti comunisti sindacalisti collaborazionisti amici dei terroristi e dei
tagliagole, ma anche i democratici.
25 aprile, o del mito
resistenziale: la strage partigiana di Campagnola. Andrea Cionci su Libero
Quotidiano il 25 aprile 2023
Andrea Cionci. Storico
dell'arte, giornalista e scrittore, si occupa di storia, archeologia e
religione. Cultore di opera lirica, ideatore del metodo “Mimerito” sperimentato
dal Miur e promotore del progetto di risonanza internazionale “Plinio”, è stato
reporter dall'Afghanistan e dall'Himalaya. Ha appena pubblicato il romanzo
"Eugénie" (Bibliotheka). Ricercatore del bello, del sano e del vero – per quanto
scomodi - vive una relazione complicata con l'Italia che ama alla follia
sebbene, non di rado, gli spezzi il cuore
Il luogo di una strage
partigiana e una croce, ogni volta, viene divelta o spezzata: quella del
“Cavoùn” di Campagnola (RE) non è la solita pagina di controstoria, ma un
episodio che ci fa riflettere sullo scontro finale tra verità e menzogna, in
atto in tutto il mondo.
Ne trattiamo in concomitanza
con la Festa del Fratricidio nazionale, anche detta “della Liberazione”, la
quale continua a tenere vivi odio e rancore, ma soprattutto imposture. Tanto per
darvi la caratura di quello che si festeggia, ecco le cifre messe a punto da
Lucioli-Sabatini in “Resistenza al di là del mito”: lo scontro fu tra 800.000
italiani combattenti con la Repubblica di Salò contro i 70.000 dell’Esercito
cobelligerante del Sud e - massimo - 30.000 partigiani. I numeri dei sei Gruppi
di combattimento badogliani sono pubblici e, dal novembre ’44, tanti erano i
partigiani conteggiati da storici di sinistra come Giorgio Bocca. (Solo dopo il
25 aprile, il numero di “resistenti” schizzerà magicamente a 300.000).
Una guerra fratricida fra un
pugno di italiani, dunque, di cui 800.000 fascisti contro 100.000 antifascisti i
quali vinsero unicamente grazie alle armate alleate. Il tutto mentre il popolo
italiano stava a guardare timidamente alla finestra: altro che mobilitazione
generale.
Ora, anche se qualche liceale,
in buona fede, si dice “antifascista” attingendo a generici ideali di libertà e
democrazia, resta il fatto che questo contenitore ideologico è stato da tempo
confiscato da realtà apolidi e sovranazionali nemiche di tutti gli italiani, di
destra o di sinistra che siano.
Fateci caso: tutto ciò che può
anche lontanamente afferire a una difesa della cultura, identità, tradizione
nostrana viene ormai marcato come “fascista” in modo da inibire qualsiasi tipo
di resistenza degli italiani al rullo compressore mondialista. La Resistenza si
è mutata in Resilienza, per farci subire, zitti e buoni, le angherie imposte
dagli eurocrati in grembiule, grazie anche alla fattiva collaborazione della
sinistra nostrana. Se gli ultimi interventi in difesa della lingua nazionale e
dei nostri confini sono stati additati come rigurgiti del Ventennio, fra poco
anche l’uso del contante e la bistecca a tavola passeranno per oscuri retaggi
patriarcal-nazifascisti.
Ecco perché, travolgere con la
verità dei dati storici la fantanarrativa resistenziale diventa, oggi,
un’impellenza per la salvezza del Paese.
Questo atto meritorio spesso si
deve all’iniziativa di singoli studiosi intellettualmente onesti o a realtà
culturali come, in questo caso, l’Associazione (d’arma) Nazionale Volontari di
Guerra, l'Ass. Culturale Pietro e Marianna Azzolini, e il Centro studi Italia
che, giorni fa, hanno eretto – per la quinta volta - una nuova croce, bianca
rossa e verde, nei pressi del "Cavòun" di Campagnola in ricordo delle vittime
degli eccidi partigiani lì perpetrati nei giorni precedenti e successivi al 25
Aprile 1945.
La posizione di Campagnola, nei
pressi del “Triangolo rosso”, fra Novellara, Correggio e Fabbrico, oltre a
ospitare il comando di una formazione partigiana, configurava l'area come il
luogo ideale dove far confluire i cittadini reggiani prelevati dalle bande
partigiane dei paesi limitrofi e destinati all'uccisione. Qui, nei pressi della
cava di argilla della Fornace Fontanesi, venivano scavate le fosse comuni
destinate ad accogliere i corpi di chi veniva messo al muro davanti alla
manifattura. Fino a qualche tempo fa, sui mattoni erano ancora visibili le
scalfitture delle pallottole, ma, non si sa come, la costruzione è stata da poco
abbattuta. Altri sequestrati erano, invece, destinati all'annegamento nel
piccolo stagno dal quale però si notò che presto tornavano a galla. Fra gli
assassinati dai partigiani, nella quasi totalità civili, c’erano anche alcune
donne e un ragazzo di 20 anni.
Le ricerche dei parenti delle
vittime, in particolare quella condotta dal dottor Flavio Parmiggiani nei primi
anni '90, hanno portato a stimare almeno 32 vittime sepolte nell'area della cava
d'argilla in disuso. Nel ’91, viene ritrovata una delle fosse comuni con i resti
di 19 cittadini reggiani, di cui solo alcuni sono stati identificati nel corso
degli anni. I ricercatori sono convinti dell'esistenza di almeno un'altra fossa,
ma la localizzazione è ancora ignota. Afferma Parmeggiani che la seconda fu
probabilmente scoperta durante i lavori di ampliamento del cimitero e le ossa,
secondo l’autore, furono gettate nella discarica. A conferma di ciò una
dichiarazione del sindaco dell’epoca, Dimmo Sghedoni, circa il fatto che la
seconda fossa “non si sarebbe più trovata”.
I vandalismi sulle croci poste
a ricordo dell’eccidio si ripetono da anni, ma non è un caso unico: così vengono
continuamente vandalizzate lapidi commemorative presso ciò che resta del
disumano campo di concentramento alleato di Coltano, per soldati repubblicani, e
presso Rovetta, luogo dove furono trucidati 43 militi fascisti della divisione
“Tagliamento”, ragazzi dai 16 ai 22 anni, che si erano arresi ai partigiani in
cambio della vita.
Spiega il presidente della
locale federazione ANVG, Alessandro Casolari: “Abbiamo inteso, con questa
iniziativa, svolta nel segno della riconciliazione nazionale, commemorare tutte
le vittime, civili e militari, della violenza fratricida e delle stragi avvenute
nella nostra provincia a ridosso della fine delle ostilità e pure
successivamente”.
Così, quella croce tricolore
che viene ogni volta rimessa al suo posto dopo gli atti di vandalismo, ci
ricorda che in questo paese c’è ancora gente che lotta per la verità.
Viva l'Italia che resiste:
la storia di quei pugliesi partigiani che liberarono il Nord. Centinaia di
patrioti parteciparono all’insurrezione. Difesero la terra e le fabbriche
scacciando i tedeschi. VITO ANTONIO LEUZZI su La Gazzetta del Mezzogiorno il 25
Aprile 2023
Con la ricorrenza del 25
aprile, data simbolo della liberazione e dell’indipendenza nazionale, dopo la
sanguinosa occupazione della Germania nazista, l’Italia riuscì a collocarsi
nella realtà delle liberal democrazie lasciandosi alle spalle le rovine di una
guerra e di uno sconvolgimento epocale. La scelta di campo degli italiani a
fianco delle nazioni democratiche fu resa possibile dalla lunga lotta
dell’antifascismo e dalla Resistenza.
Alla liberazione dal
nazifascismo e alla pace concorsero in tempi e modalità diverse l’Italia centro
settentrionale ed il Mezzogiorno. In quest’ultima realtà la Resistenza assunse
un forte carattere «patriottico» per il ruolo primario dei militari sostenuto
dai civili. Gli italiani in Puglia non si divisero e si assistette a forme
coraggiose di opposizione alla violenza degli uomini di Hitler a partire dal
capoluogo pugliese, il 9 settembre del 1943, che fu una delle prime città
italiane a reagire, ad impedire ai reparti germanici di distruggere il porto, il
palazzo delle Poste, Radio Bari. Gli uomini del generale Bellomo, donne e
ragazzi della Citta vecchia, impiegati delle poste, sostenuti dai carabinieri,
intervenuti spontaneamente, impedirono ulteriori devastazioni e misfatti. Poche
ore dopo l’annuncio dell’armistizio a Taranto, militari e operai respinsero un
tentativo di attacco di un reparto della Wehrmacht (i tedeschi tentarono di
penetrare nei cantieri dell’arsenale e di minare il ponte girevole). Diversi
episodi di resistenza militare si verificarono a Bitetto, Ceglie Messapica,
Putignano, Noci, San Severo. Mentre a Barletta, il 10 e 11 settembre, sulle rive
dell’Ofanto, i militari del locale presidio resistettero all’aggressione
nazista. Operai dell’Acquedotto Pugliese, ferrovieri, carabinieri, tra Puglia e
Basilicata, evitarono conseguenze disastrose per il disegno nazista di far
saltare ponti ferroviari stradali ed in particolare le grandi strutture
dell’Acquedotto.
La reazione degli uomini di
Hitler ebbe un carattere punitivo e razzista come attestano le note vicende
della città della Disfida - il 12 settembre reparti corazzati invasero la città,
catturarono e fucilarono 10 vigili urbani e due operai comunali, e deportarono
il col. Francesco Grasso. Diverse stragi e uccisioni di soldati sbandati si
verificarono a Murgetta Rossi nel territorio di Spinazzola, a Valle Cannella
poco distante da Cerignola, a Castellaneta e Girifalco (Ginosa) nell’area ionica
e in tanti altri centri dell’Alta murgia e soprattutto dell’Appenino dauno ,
come si evidenzia dalla pubblicazione di un recente volume dei ricercatori
dell’Ipsaic, Luoghi della memoria in Puglia, Edizioni dal Sud. Nella realtà
pugliese reagirono ai misfatti germanici contro la popolazione civile diversi
vescovi e sacerdoti (Trani, Manfredonia, Celenza Val Fortore, Spinazzola), in
alcuni casi persino ex Podestà.
Centinaia di pugliesi,
emigrati, uomini e donne, difesero le fabbriche e persero la vita nella
Resistenza in molte località dell’Italia del Nord. Tra gli altri ricordiamo il
tarantino Pietro Pandiani, capitano d’artiglieria, partigiano in Emilia, i
fratelli Vincenzo e Antonio Biscotti di Peschici uccisi dai nazifascisti a
Biella. Senza dimenticare Dante Di Nanni, nato a Torino ma di famiglia pugliese
originaria di Andria. Vincenzo Biscotti e Dante Di Nanni ricevettero,
rispettivamente, la medaglia d’oro e d’argento al valor militare.
Molti altri, morirono nei campi
di concentramento. Migliaia di nostri militari, soldati e ufficiali, in
Iugoslavia, Albania, nelle isole dello Ionio e dell’Egeo rifiutandosi di
continuare la guerra a fianco dei nazifascisti, furono catturati, deportati e
trattati come schiavi nei campi del Terzo Reich. In Puglia si costituì la prima
formazione militare che s’impegnò con coraggio a fianco degli eserciti Alleati,
(battaglia di Montelungo, liberazione di Bologna). Una delle più belle pagine
della resistenza italiana è stata scritta dai pugliesi alle Fosse Ardeatine,
dove furono trucidati 19 pugliesi, tra i quali un docente di Liceo, Gioacchino
Gesmundo ed un sacerdote, Don Pietro Pappagallo. Quest’ultimo è stato inserito
dall’attuale Pontefice nell’elenco dei martiri del XX secolo.
E’ importante ricordare che il
riferimento all’antifascismo e alla Resistenza è uno dei caratteri costitutivi e
fondanti la Costituzione repubblicana, alla cui elaborazione dettero un apporto
di altissimo livello politico, giuridico e culturale, diversi costituenti
pugliesi di diversa ispirazione ideale tra cui Giuseppe Di Vittorio, Aldo Moro,
Codacci Pisanelli, Mario Assennato Domenico Fioritto. Più di ogni altra
considerazione è opportuno richiamare alla memoria le parole pronunciate da Aldo
Moro nel trentennale della Resistenza in un discorso svolto a Bari il 21
dicembre 1975: «Il nostro antifascismo non è dunque solo una mobilissima
affermazione ideale, ma un indirizzo di vita, un principio di comportamenti
coerenti. Non è solo un dato della coscienza, il risultato di una riflessione
storica; ma è componente essenziale della nostra intuizione politica, destinata
a stabilire il confine tra ciò che costituisce novità e progresso e ciò che
significa, sul terreno sociale come su quello politico, conservazione e
reazione».
Manifestazione degli anni
Novanta. Giampiero Mughini su Panorama il 25 Aprile 2023
Da Panorama del 16 aprile 1994.
Giù le mani dal 25 aprile. Giù le mani, cari sconfitti del 28 marzo, cari
compagni e partitanti vari che state preparando un corteo "antifascista" da
scaraventare sulla bilancia a vantaggio delle vostre botteghe politiche. Giù le
mani dall' onore e dal coraggio partigiano, dal dolore e dalla tragedia del
nostro popolo, dall' interno di quegli italiani che dovettero sparare ad altri
italiani perché il Paese tornasse alla libertà e riscattasse il sacrilegio dell'
alleanza con i nazisti. Giù le mani ove queste vostre mani volessero attizzare
l'odio e l'apologia della guerra civile, una guerra che s'è conclusa il 25 di
aprile di 49 anni fa, e che ha lasciato cicatrici profonde nella comunità
nazionale, un corteo infinito di lutti, le targhe sulle strade e sulle piazze a
ricordare i morti fucilati o impiccati. I nostri morti. Ma anche i loro morti,
ai quali oggi è possibile e necessario portare rispetto, e mentre un
repubblichino che combatté in prima linea quale lo scrittore Carlo Mazzantini,
l'autore di A cercare la bella morte, uno dei più bei romanzi sul tempo della
guerra fra italiani, invita pubblicamente un suo avversario di allora, il
comandante partigiano e medaglia d'oro Edgardo Sogno, a stringergli la mano nel
segno della riconciliazione nazionale: invito che Sogno ha subito accettato. La
festa del 25 aprile deve essere la festa di tutti, ha detto Vittorio Foa, uno
che passò 11 anni in una cella fascista perché reo di avere pensato in modo
difforme dalla dittatura. Un'Italia riconciliata, secondo l'augurio dello stesso
presidente della Repubblica, dove non ci sono e non ci devono essere cittadini
di serie A e di serie B, ossia i vincitori e i vinti del 25 di aprile del 1945;
di un'Italia dove sia sacra la memoria di chi lottò perché cessassero i
rastrellamenti degli ebrei, e purché questa memoria non alimenti l'odio e lo
scontro politico dell' oggi. Quell'odio era l'ossigeno stesso che respirammo noi
ventenni degli anni Sessanta. Il mio debutto in politica da diciottenne avvenne
a celebrare per l'appunto un "25 aprile", e c'eravamo riuniti nella sede della
federazione comunista, e avevo accanto Turi Toscano (futuro leader del movimento
studentesco milanese) e una mia amica ebrea, figlia di uno degli innocenti
massacrati alle Ardeatine. Cresciuti nel mito, caro all' estrema sinistra, della
Resistenza "rossa", annunciavamo per ogni dove che i partigiani avrebbero dovuto
non soltanto cacciare i nazi ma attuare la rivoluzione anticapitalista, punire
fino all' ultimo fascista, trattare Vittorio Valletta più o meno come
Kesselring. Farneticazioni che durarono a lungo e contro le quali ogni volta si
opponevano uomini come Giorgio Amendola o Paolo Spriano, che pure avevano
combattuto al tempo della divisione fra italiani. Farneticazioni che
alimentarono una sorta di bis grottesco e orrido della guerra civile, noi
ventenni che braccavamo quelli della parte avversa e ne eravamo braccati. Il
leader dei neonazi della mia giovinezza, più tardi politologo e professore
universitario vicino alla Democrazia cristiana, girava con in tasca il pugno di
ferro ed era pronto a usarlo. La volta che cinque o sei fascisti puntarono
contro la bacheca dell'università dov'erano i dazebao di noi studenti di
sinistra, e cominciarono a commentarli sprezzantemente, io tirai fuori la
cintura dei pantaloni, la attorcigliai attorno al pugno, nascosi il pugno sotto
il cappotto, chiesi a un professore universitario di fare da testimone, e andai
loro incontro. Avessero voluto, mi avrebbero fatto a pezzi. E invece solo mi
sfotterono. Il pomeriggio, comunque, il dazebao era stato lacerato in mille
pezzi Negli anni Settanta le cinghiate in faccia e i cazzotti furono sostituiti
dalle spranghe e dal revolver. Piombarono in cinque addosso a uno studente
milanese di destra che non avevano mai visto in volto, il povero Sergio Ramelli,
e di averlo ucciso (morì dopo 47 giorni di agonia) se n'erano quasi dimenticati
quando la polizia venne a cercarli, vent'anni dopo. Renato Curcio come Giusva
Fioravanti vennero alla politica nell'idea che quelli dell'altra parte fossero
solo l'incarnazione del male e andassero cancellati dalla terra. Terribile
sarebbe stata la girandola degli agguati e delle rappresaglie, ove fosse stata
attuale la proposta di mettere il Msi fuori legge, che a metà degli anni
Settanta ebbe purtroppo tra i suoi firmatari Riccardo Lombardi, uno che pure
aveva visto i cadaveri appesi a piazzale Loreto e ne aveva avuto orrore. Il
grido che "uccidere un fascista non è reato" fu tra quelli che attizzarono i
primi gruppi del terrorismo rosso. Saranno due fascisti patavini, e sia pure per
caso, le primissime vittime delle Brigate rosse. Ancora pochi anni fa, uno
studente romano di destra che stava affiggendo dei manifesti in difesa dell'
ecologia, Paolo Di Nella, venne ammazzato a sprangate, tanto che il presidente
della Repubblica, Sandro Pertini, rese omaggio alla sua salma. E finché l'odio
non cadde finalmente dall' albero. Sono orgoglioso di avere partecipato, cinque
o sei anni fa, a un'assemblea universitaria la cui parola d'ordine era il no
alla violenza. L'aveva indetta l'allora segretario dei giovani missini e oggi
deputato di Alleanza nazionale, Gianni Alemanno. Era seduto in mezzo a due miei
cari amici che non si conoscevano ma che in quell' occasione si strinsero la
mano, Antonello Trombadori, medaglia d' argento della Resistenza, e Giano
Accame, che a 17 anni si era arruolato nella Rsi e subito era stato catturato
dai partigiani.
Dal fronte stesso degli
antifascisti, e fin dall'alba degli Ottanta, lo spregio e l'offesa avevano
ceduto il campo al tentativo di capire. C'era stato l' immenso lavoro di
dissotterramento di materiali e personaggi del ventennio da parte dello storico
Renzo De Felice. C'era stato il bellissimo libro di Augusto Del Noce ov'era dato
a Giovanni Gentile quel che spettava a Giovanni Gentile. C'era stata la
pubblicazione e la ripubblicazione dei libri di quei fascisti che nella notte
tra il 24 e il 25 luglio 1943 avevano detto basta all'alleanza con i nazi, Dino
Grandi come Giuseppe Bottai. C'era stato il ripensamento della storia dell'
antifascismo e la messa in luce, a partire dai libri di Angelo Tasca, degli
errori di settarismo e di estremismo che avevano aperto la porta al giovane
Benito Mussolini. C'erano stati i tanti convegni e mostre dov'era dimostrata
l'assurdità della tesi che il fascismo fosse stato solo bestialità e non avesse
avuto una sua cultura. E Filippo Tommaso Marinetti, Enrico Prampolini, Ardengo
Soffici, Mario Sironi, il giovane Leo Longanesi, Massimo Bontempelli, Mario
Carli, Pier Maria Bardi, Giuseppe Pagano e cento altri? C'erano stati i primi
atti di buona volontà, i primi tentativi di guardarsi negli occhi e spiegarsi.
Più di dieci anni fa ero stato tra i promotori dell'incontro che vedeva da una
parte il comunista Massimo Cacciari e dall'altra alcuni dei leader intellettuali
della Nuova destra, Marco Tarchi come Giuseppe Del Ninno. Molti anni prima della
fioritura di giornali aperti a destra, quali Il Giornale di Vittorio Feltri o
l'Indipendente di Pialuisa Bianco, una rivista di cui qualcuno si ricorda (e che
aveva nel suo gruppo dirigente l'attuale direttore del Corriere della sera,
Paolo Mieli), il mensile Pagina, compì quell'apertura nel segno della tolleranza
e della comprensione. Nel segno di un'Italia dove ognuno portasse il fiore del
suo talento alla costruzione della comune casa democratica.
Riflessioni sul 25 aprile. Da Borghese a
Tangentopoli: il tic tutto italiano si chiama golpe. Paolo Guzzanti su Il
Riformista il 21 Aprile 2023
Arriva il 25 Aprile festa della Liberazione e
dovremmo festeggiare dopo la cacciata di tedeschi e fascisti – ormai una cosa
antica – la vittoria su quei due o tre colpetti di Stato con cui hanno provato a
far saltare la Repubblica di cui uno sembra riuscito: quello
di Tangentopoli, quando i giudici tentarono abusivamente di fare fuori il
personale politico non applicando la legge ma un patto fuori dalla legge: “Tu te
ne vai dalla politica e ti dimetti dopo averci detto tutto quello che sai. sarai
immune da quel momento per ogni reato penale e tanti auguri. ci stai?”.
La vecchia Repubblica falcidiata e decapitata
resistette come poté: ma quel che è sicuro e che una parte della magistratura
tentò di sostituirsi al Parlamento sfidandolo anche in campo aperto con
dichiarazioni in cui si diceva che i magistrati avrebbero dovuto supplire e
quindi sostituire il potere dei rappresentanti del popolo. Quali altri tentativi
di sopraffazione della legge repubblicana ci sono stati? Se ne ricordano almeno
altri due perché se n’è parlato molto, Innanzitutto quello che non fu un colpo
di Stato ma per dirla con le parole di Pietro Nenni, segretario del Partito
socialista, un minaccioso “tintinnar di sciabole”. E poi il ridicolo tentativo
della notte fra il 7 e l’8 dicembre del 1970 che aveva a capo un aristocratico
soldataccio che durante la guerra stava un po’ con i fascisti ma anche un po’
con gli americani: il principe Junio Valerio Borghese con piccoli personaggi
neofascisti del fronte nazionale di avanguardia nazionale.
Fu un colpetto di Stato perché mentre era in corso
fu annullato dallo stesso Borghese essendo chiaro che il tentativo era sconfitto
in partenza e tutti sarebbero finiti più o meno in galera sommersi dal ridicolo.
Sono stato un cronista di strada col taccuino e la penna in mano e ho seguito
tutti gli abortiti tentativi di far fuori la Repubblica. Quindi ne aggiungerei
ancora uno che non aveva precisamente un capo riconosciuto ma che era sempre
imminente e quasi pronto ma anch’esso morto prima di agire, e fu un’ombra
avvolgente negli anni 70 e 80 e cioè gli anni delle Brigate Rosse e
delle Brigate nere e di tutti gli infiltrati di cui poi nessuno ha più parlato.
Il colpaccio era stato pensato in ambienti militari, e me ne riferiva
puntualmente il mio amico colonnello dei carabinieri che poi morì
inaspettatamente su un tavolo operatorio.
Per comprendere il clima, il senso e il
giustificato timore di questi tentativi bisogna fare un passo indietro e
risalire ai fatti di luglio del 1960 quando l’Msi decise di sfidare
l’antifascismo scegliendo di svolgere a Genova il suo Congresso e provocò una
sommossa non solo a Genova ma in molte altre città italiane tra cui Roma, Reggio
Emilia e Palermo con molti morti uccisi dalla polizia, feriti e uno stato
insurrezionale complessivo di fronte al quale lo stato sarebbe stato impotente
se il partito comunista e il partito socialista non avessero raffreddato quel
clima che giorno dopo giorno era andato sempre più avviandosi verso una
possibile rivoluzione. Palmiro Togliatti, segretario del partito comunista e con
alle spalle una lunga carriera di cittadino sovietico e vicesegretario
del Comintern, agì con decisione perché in Italia non si ripetesse una tragedia
simile a quella della Grecia avvenuta parecchi anni prima, quando i comunisti
ellenici tentarono unarivoluzione rapidamente repressa dagli inglesi. oltre che
della polizia greca.
Togliatti aveva raffreddato gli animi anche
nel 1948 quando ricevette quattro revolverate dallo studente Antonio
Pallante il 14 luglio del 1948. In quel caso Togliatti ferito e prontamente
ricoverato dette subito gli ordini necessari affinché quell’attentato non
innescasse una rivolta o peggio una rivoluzione. Togliatti era ben consapevole
dell’accordo di Yalta fra Churchill, Roosevelt e Stalin con cui l’Europa era
stata divisa in due, e che nell’una e nell’altra parte della “cortina di
ferro” che separava l’est dall’ovest non erano permesse rivoluzioni. Inoltre, in
Italia si vagheggiava del leggendario “deposito di armi” accumulate nel periodo
partigiano del Partito comunista che avrebbero potuto essere usate. La rivolta
man mano si sedò ma ebbe le sue conseguenze.
La prima fu la sconfitta rovinosa del governo
di Fernando Tambroni, uomo della sinistra democristiana che il presidente della
Repubblica Giovanni Gronchi aveva imposto come capo del governo, ma privo di
maggioranza parlamentare. Tambroni allora decise di aprire il recinto detto
“arco costituzionale” in cui era chiuso il partito neofascista Msi e chiederne i
voti. Sentendosi erroneamente sdoganati, i neofascisti avevano preteso di
sfidare la città di Genova, medaglia d’oro della Resistenza, convocando il loro
congresso in quella città. Le conseguenze di quella scelta furono tragiche
specialmente a Reggio Emilia dove il 7 luglio cinque operai iscritti al Partito
comunista furono uccisi dalla polizia che usò le armi da fuoco per disperdere
una manifestazione di protesta. Tambroni fu costretto alle dimissioni e fu
sostituito da Amintore Fanfani. I missini rientrarono nel loro recinto e
l’Italia antifascista fu comunque soddisfatta per aver dimostrato di saper
impedire un ritorno dei fascisti nella vita politica.
Paolo Guzzanti. Giornalista e politico è stato
vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia Usa è stato
senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato nella XVI per Il
Popolo della Libertà.
Riflessioni alla viglia del
25 aprile. Storia dei golpe d’Italia: da quello Borghese a Tangentopoli.
Paolo Guzzanti su Il Riformista il 23 Aprile 2023
Tambroni decise di aprire il
recinto detto “arco costituzionale” in cui era chiuso il partito
neofascista Msi e chiederne i voti. Sentendosi erroneamente sdoganati, i
neofascisti avevano preteso di sfidare la città di Genova, medaglia d’oro della
Resistenza, convocando il loro congresso in quella città. Le conseguenze di
quella scelta furono tragiche specialmente a Reggio Emilia dove il 7 luglio
cinque operai iscritti al Partito comunista furono uccisi dalla
polizia. Tambroni fu costretto alle dimissioni e fu sostituito da Amintore
Fanfani. I missini rientrarono nel loro recinto e l’Italia antifascista fu
comunque soddisfatta per aver dimostrato di saper impedire un ritorno
dei fascisti nella vita politica.
Ma quei fatti allarmarono
moltissimo gli alleati della Nato che avevano visto uno Stato italiano incapace
di fronteggiare una insurrezione e che si era dovuto rimettere al buon senso dei
vertici di quel partito per bloccare una insurrezione. Fu per questo motivo che
americani e tedeschi della Germania Federale chiesero che si realizzasse un
piano che rendesse efficiente un meccanismo di contenimento antirivoluzionario.
Il nuovo presidente della Repubblica Antonio Segni fu coinvolto nella trattativa
che portò al cosiddetto Piano Solo, creato al di fuori e all’insaputa del
Parlamento repubblicano. E quel piano prevedeva “solo” i carabinieri, di cui era
comandante il generale Giovanni de Lorenzo, che era contemporaneamente anche
capo del servizio segreto militare Sifar.
Lo scandalo venne fuori
nel 1967 quando il settimanale l’Espresso cominciò a pubblicare una serie di
articoli di Lino Iannuzzi su quello che sarebbe successo nel corso di una crisi
di governo di tre anni prima, quando si disse che un misterioso Piano Solo
sarebbe stato attuato con misure draconiane tra cui la deportazione immediata di
tutti i maggiorenti del partito comunista, del sindacato e una serie di
personaggi pubblici influenti della sinistra, tutti destinati a un campo di
concentramento in Sardegna, mentre speciali forze della polizia avrebbero fatto
irruzione di notte “casa per casa”, come titolava l’Espresso, per rastrellare
tutti coloro che potevano essere considerati pericolosi, vicini al Partito
comunista. Gli articoli di Iannuzzi erano stati poi affiancati anche da articoli
del direttore dell’Espresso Eugenio Scalfari sicché i due giornalisti furono
rinviati a giudizio per aver diffuso notizie false e tendenziose e condannati in
primo grado. Fu così che il segretario del partito socialista italiano Giacomo
Mancini li salvò da un imminente mandato di cattura candidando il primo a Milano
per la Camera e Iannunzi a Sapri per il Senato.
Quello che realmente accadde
nel 1964 fu analizzato per anni perché non si riusciva o forse non si voleva
separare la verità dall’immaginario. Si disse ad esempio che ci fu un
violentissimo alterco tra il leader del Partito socialdemocratico Giuseppe
Saragat (futuro presidente della Repubblica) e Antonio Segni. E che quello
scontro fu talmente violento da provocare un malore al presidente della
Repubblica, il quale fu ricoverato ma poco dopo morì senza riprendere i sensi.
Tutto questo non è dimostrato e probabilmente fa parte della leggenda, ma
comunque sta di fatto che all’insaputa del Parlamento furono creati dispositivi
e furono consegnate armi a un corpo di polizia quale era allora l’arma dei
carabinieri, con un piano dettagliato affidato “solo” al generale Di Lorenzo, sì
che fu chiamato Piano Solo. In realtà le cose non andarono affatto così benché
il Piano Solo esistesse davvero e prevedesse l’arresto dei dirigenti della
sinistra – non soltanto comunisti – nel caso di una improbabile rivolta che
nelle opinioni dei servizi segreti italiani e di quelli dei più importanti
membri della Nato, avrebbe avuto lo scopo di instaurare in Italia un regime
comunista, cosa assolutamente improbabile e anzi impossibile. Non ci fu alcun
colpo di Stato, il presidente Antonio Segni non fu implicato in nessuna attività
anticostituzionale, benché fosse un uomo apertamente anticomunista molto
condiscendente nei confronti delle preoccupazioni degli alleati occidentali. Il
Piano Solo esisteva soltanto sulla carta e non entrò mai in funzione.
Il tentato colpo di Stato
invece di Junio Valerio borghese, che si svolse nella notte dell’Annunziata
sicché prese il nomignolo di “colpo di Stato dell’Annunziata” fu una pericolosa
buffonata di pochi cialtroni neofascisti che non si incontrarono agli
appuntamenti prestabiliti benché avessero secondo loro preso possesso di alcuni
ministeri e della Rai ma senza alcuna arma, perché le armi su cui contavano
erano nei depositi del Ministero degli Interni e non fu possibile usarle.
Nessuno si accorse al mattino dell’otto dicembre che ci fosse stato un tentativo
di colpo di Stato perché non era accaduto nulla salvo una commedia tragicomica
che somigliava a un film di Alberto Sordi. Più tardi, nel 1970. Junio Valerio
Borghese si presentò con i suoi gaglioffi a Reggio Calabria dove rincorse la
rivolta contro lo spostamento della capitale regionale a Catanzaro. Una rivolta
in cui si erano inseriti molti fascisti locali, altri di Avanguardia nazionale
del Fronte nazionale del principe borghese. La rivolta di Reggio Calabria aveva
preso un colore rossobruno, per l’indistinguibile mescolamento di personaggi
della sinistra e altri della destra, con venature romantiche e un po’
dannunziane.
La storia della magistratura
di Mani Pulite, è invece una storia che si è certamente sviluppata sui due bordi
opposti dell’Oceano Atlantico perché l’operazione in origine nacque in inglese
come “clean hands” (mani pulite). Fu sviluppata negli Stati Uniti dove
funzionava un forte pool di magistrati italiani e americani tra cui il
nostro Giovanni Falcone che era considerato il leader del fronte non soltanto
antimafia ma anche anticorruzione, e il procuratore speciale Rudolph
Giuliani che poi diventò sindaco di New York. Gli americani, come si legge nel
libro di Andrea Spiri The End, 1992-1994, specialmente i democratici, seguivano
con grande attenzione quel che accadeva in Italia, un paese che sembrava
dominato dalla corruzione e che avrebbe dovuto rinascere dalle sue ceneri
importando al governo, essendo ormai finita la Guerra fredda, una classe
dirigente formata principalmente dal Partito comunista che aveva dato buoni
risultati noi governi regionali in cui governava.
Secondo un altro libro, The
Italian guillotine di Burnett e Mantovani, l’operazione Mani pulite fu
interamente concepita e attuata su un canovaccio americano che prevedeva la
decapitazione dei partiti che nel corso della guerra fredda avevano governato in
maniera ambigua e ostile. Da quanto è stato rivelato dal libro postumo di Enzo
Carra, L’ultima Repubblica e anche da quanto anche da quanto ha raccontato Bobo
Craxi sulle vicende del padre, i magistrati del Pool avrebbero adottato una
linea apertamente illegale che mirava alla sostituzione e alle dimissioni degli
uomini politici concedendo in cambio l’impunità penale. Questa linea però non
funzionò almeno nei livelli più alti perché politici di gran nome come Bettino
Craxi preferirono andarsene a morire altrove. Sta di fatto che quell’azione fu
la causa della decapitazione di tutti i partiti tradizionali. Poi avvenne
l’imprevisto gioco di prestigio dell’imprenditore Silvio Berlusconi che impedì
l’esito finale dell’operazione.
Paolo Guzzanti. Giornalista e
politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia
Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato
nella XVI per Il Popolo della Libertà.
Due milioni di euro
all'Anpi e agli altri professionisti dell'antifascismo. La sigla dei
partigiani ex pci fa la parte del leone. Ecco i dati. Francesco Giubilei il 23
Aprile 2023 su Il Giornale
Celebrare e ricordare la
memoria storica ha un costo non solo emotivo ma anche economico. Organizzare
eventi e celebrazioni storiche, realizzare iniziative e manifestazioni,
rappresenta uno sforzo tanto per le istituzioni quanto per le associazioni. È
perciò comprensibile che le attività previste per il 25 aprile, Festa della
Liberazione, siano finanziate dallo Stato e dagli enti locali che erogano
contributi a enti e associazioni. Il problema si pone quando la memoria diventa
pressoché a senso unico e una parte cospicua di queste risorse sia dedicata a
ricordare la resistenza rossa e dei partigiani comunisti senza tenere in dovuta
considerazione le altre anime che hanno contribuito alla Liberazione.
Scorrendo l'esercizio
finanziario 2022 del Ministero della Difesa, l'importo erogato a enti, istituti,
associazioni, fondazioni e altri organismi è pari a 1.702.918 euro. A fare la
parte del leone è l'Anpi, l'Associazione Nazionale Partigiani di Italia, con un
contributo nel 2022 di 94mila euro.
Come emerge dal sito dell'Anpi,
queste risorse sono utilizzate per le «Celebrazioni della Festa Nazionale della
Liberazione», «per la valorizzazione dei luoghi della Resistenza in Italia», per
il progetto «Noi, partigiani», archivio nazionale delle video-testimonianze dei
combattenti per la libertà e per l'iniziativa «Parole Costituenti» dedicata alla
Costituzione.
Tra le altre realtà finanziate,
oltre alle associazioni dei reduci, figurano l'Associazione Italiana combattenti
volontari Antifascisti in Spagna con 32mila euro e la Federazione Italiana delle
Associazioni partigiane con 60mila euro (legata al socialismo liberale).
L'Associazione nazionale
partigiani cristiani prende fondi solo dal 2018 (in quell'anno l'Anpi ricevette
100mila euro) e deve accontentarsi di 42mila euro.
Eppure i contributi erogati
dallo Stato sono solo una parte delle risorse che l'Anpi riceve dagli enti
pubblici attraverso le sue ramificazioni territoriali. Regioni e comuni
finanziano con vari bandi le iniziative e i progetti dell'associazione.
Caso eclatante in tal senso è
l'Emilia Romagna. La regione guidata da Stefano Bonaccini nel 2022 ha approvato
uno stanziamento complessivo di 600mila euro circa, a favore di soggetti
pubblici e privati, a sostegno di progetti e iniziative sulla Memoria e la
storia del Novecento in Emilia-Romagna.
Scorrendo i progetti
finanziati, ci si imbatte nei 34.300 euro erogati all'Anpi di Bologna per la
realizzazione di cinque video di Anpi educational sullo squadrismo in
Emilia-Romagna. Altri 22.300 euro sono per il progetto «La storia che rivive»
dell'Anpi Ravenna, 12.200 all'Anpi di Santarcangelo e 8.400 all'Anpi di Reggio
Emilia. Per quanto riguarda i progetti degli Enti locali, si segnala il
contributo di 70.000 euro al Comune di Parma per le celebrazioni del centenario
delle Barricate, episodio di resistenza popolare all'assedio delle squadre
fasciste nel 1922. Inoltre sono stati premiati progetti innovativi collegati a
ricorrenze centenarie come la Marcia su Roma (e studi su squadrismo e fascismo).
Anche i Comuni non mancano di
finanziare le attività dell'Anpi come il Comune di Milano che nel 2021 ha
erogato un contributo di 6mila euro al Comitato provinciale dell'associazione
dei partigiani. Nel 2019 il comune di Torino aveva invece stanziato 2.800 euro
per le celebrazioni del 25 aprile sempre all'Anpi. Essendo la Festa della
Liberazione una ricorrenza della Repubblica, sarebbe giusto favorire una memoria
condivisa e non prevalentemente orientata a celebrare la resistenza dei
partigiani rossi.
La verità sul 25 aprile: un po' di sinistra in
piazza, gli italiani in vacanza. Alessandro Sallusti su Libero Quotidiano il
23 aprile 2023
Un italiano su quattro sta facendo, chi in un modo
chi in un altro, il ponte vacanziero come autopremio dopo mesi di lavoro e la
politica che fa? Gli tritura i santissimi con il 25 aprile e la menata del
fascismo e dell’antifascismo. Lo voglio dire senza giri di parole ai politici di
sinistra e di destra: questa diatriba non appassiona nessuno. Di più, non gliene
frega nulla a nessuno se non a una ristrettissima cerchia di nostalgici dell’una
e dell’altra sponda e a una manciata di intellettuali e giornalisti che non
facendo lavori seri e impegnativi- entrambe le professioni non sono esattamente
un lavoro - non sanno come passare il tempo né come giustificare in qualche modo
i lauti stipendi.
Lo vogliamo dire che per milioni e milioni di
italiani il 25 aprile è esclusivamente un giorno di festa, come lo è il Natale,
il Primo maggio e Ferragosto, e che la maggior parte di loro non sa neppure di
che si tratta? Parliamo di cose del secolo scorso che hanno riguardato i nostri
nonni e bisnonni. La storia mi sembra sviscerata a sufficienza: metà Italia
stava da una parte, metà dall’altra, è andata come è andata e per fortuna nostra
è andata in un certo modo. Attenzione: certamente il 25 aprile è una data
entrata nella storia di questo Paese, ma parliamo del secolo scorso. Come tutte
le date solenni va celebrata con una messa cantata ma per questo bastano i gesti
formali del Presidente della Repubblica e del Primo ministro a nome di tutti gli
italiani, è sufficiente leggere un buon libro di storia senza bisogno di
scannarsi tra pronipoti che è un po’ come se quando ero ragazzo io - i termini
temporali sono gli stessi - ci si fosse azzannati tra laici e cattolici sulla
breccia di Porta Pia.
In questi giorni e in queste ore le persone che ho
incontrato mi hanno interpellato e chiesto previsioni sulla riforma fiscale,
sulla stretta all’immigrazione e sulla guerra in Ucraina ma non uno che avesse
sentito il bisogno di dialogare sul 25 aprile. Poi per carità, gli ultrà non
mancano in nessun campo, su quelli di calcio sono quarantamila a fronte di
cinquanta milioni di tifosi: fanno un casino infernale ma non rappresentano
nessuno proprio come quelli che in questi giorni si menano su una storia che fu
tragica per chiunque l’ha vissuta e che meriterebbe ben altro rispetto, il
rispetto della memoria ma soprattutto del silenzio.
Vittorio Feltri il 25 aprile: ex fascisti tra
gli idoli degli antifascisti. Vittorio Feltri su Libero Quotidiano il 22
aprile 2023
A me personalmente il 25 aprile, nota festa della
Liberazione, non eccita: le ricorrenze più o meno solenni mi lasciano nella
completa indifferenza perché sono vuote se non di significato di ogni emozione.
Piacciono ai politici e ai preti in quanto così hanno un impegno straordinario.
Quella che stiamo per celebrare è preceduta da un consueto vagone di retorica
antifascista per un motivo molto semplice: essere contro i cadaveri
(Mussolini il più importante) non comporta alcun rischio. I cadaveri essendo
inerti non reagiscono efficacemente.
La cosa buffa è la seguente: quando il regime fu
liquidato chi lo aveva sostenuto e collaborato con esso entrò di diritto, senza
essere insultato come oggi si usa fare contro La Russa e la Meloni, che la
camicia nera non l’hanno mai indossata se non altro per ragioni anagrafiche,
nella compagine democratica. Fu il caso di Fanfani, poi diventato primo ministro
con la tessera della Dc, di Gronchi, assurto alla presidenza della Repubblica, e
perfino di De Gasperi, uomo di grande spessore. Ma il caso più eclatante fu
quello di Gaetano Azzariti, che dopo essere stato l’estensore delle leggi
razziali, essendo lui un antisemita di ferro, divenne con l’appoggio
di Togliatti di cui era stretto collaboratore, presidente della Corte
Costituzionale, che non è una bocciofila.
Potrei proseguire nella elencazione di coloro che,
assassinato il Duce, cambiarono bandiera diventando simboli della neonata
Repubblica. In questi miei ricordi documentati, essendo scritti nei libri di
storia nonché nelle cronache dell’epoca, non c’è nulla di scandaloso. È
soltanto, il mio racconto, frutto della memoria e del desiderio di fornire ai
lettori giovani quanto in effetti accadde dopo il 1945. Ora, chiarite le cose,
capirete cari amici perché mi viene da ridere quando si esalta
l’antifascismo come una pagina italiana memorabile, dato che i politici sono
talmente ignoranti da non sapere che la Repubblica è diventata tale, libera,
grazie addirittura a un gruppo di ex fascisti. Pentiti? Può darsi, tuttavia il
loro passato come quello della maggioranza dei connazionali di allora affonda le
radici nel movimento fondato e dominato per venti anni dal mascelluto dittatore.
Quindi allorché ora parliamo di antifascismo, prima di sproloquiare, cerchiamo
di documentarci anziché emettere sentenze a capocchia. Dedico questo mio breve
articolo a tutta la sinistra che blatera a vanvera senza mai approfondire
alcunché. Si tranquillizzino i compagni: il 25 aprile me ne guarderò bene di
andare in piazza a esaltare il conformismo più tetro e bieco che sta ammorbando
il nostro amato Paese.
“La Resistenza non è
proprietà della sinistra”. Edoardo Sirignano su L'identità il 22 Aprile 2023
“Grave errore non ricordare la
resistenza democratica. Anche cattolici, socialisti, repubblicani e liberali
sono morti per la Costituzione”. A dirlo è l’ex ministro Carlo Giovanardi che,
insieme a una serie di personalità (Emerenzio Barbieri, Eugenio Baresi, Fabrizio
Cicchitto, Paolo Cirino Pomicino, Luigi Compagna, Gaetano Quagliariello e Tomaso
Zanoletti) lancia un appello per valorizzare un pezzo di storia, troppo spesso
dimenticato.
Perché questa presa di
posizione?
Durante il Covid, il Presidente
della Repubblica ha concesso solo all’Anpi di partecipare alle celebrazioni per
il 25 aprile. È un grave errore. Sbagliato non ricordare che nel 1948 da
quell’associazione uscirono sia i partigiani cattolici che quelli autonomi per
costituire la federazione italiani volontari della libertà (FIVL). Nel 1949,
poi, nacque la FIAP, composta, invece, dalle formazioni che avevano come
riferimento il Partito d’Azione, quello liberale, repubblicano, socialista e
socialdemocratico. Tante sono state le persone, che pur avendo lottato per la
Costituzione, per un Paese libero e pluralista, non volevano che l’Italia
diventasse una nuova Urss.
Quali le vere ragioni del la
spaccatura?
Per una questione di principio.
Mentre forze, oggi dimenticate, avevano combattuto per un sistema politico
democratico e libero, gran parte della Resistenza comunista combatteva solo
perché intendeva instaurare un regime simile a quello di Stalin. Questa è la
verità.
Possiamo parlare, quindi, di
scontri tra partigiani?
Tutti sanno che quelli bianchi
furono trucidati da quelli di sinistra. A dirlo è la storia. C’è un altro
aspetto, però, che mi preoccupa.
Quale?
Il 25 aprile, che dovrebbe
essere la festa di tutti, rischia di trasformarsi in uno sterile scontro tra
governo e opposizione, con la riproposizione di tesi giustificazioniste del
fascismo da parte di qualcuno della maggioranza e dall’altra il tentativo di
ridurre la Resistenza al monopolio di chi guardava ad esperienze che nulla
avevano di democratico. Basti pensare alla recente polemica su via Rasella.
Nelle Fosse ardeatine, intanto, ci sono morti che nessuno ricorda. Ci sono eroi
che si preferisce non nominare.
Ci faccia un esempio…
Paola Del Din, nota col nome di
battaglia di “Renata”. Fondamentale il suo contributo alla Liberazione, pur non
avendo nulla a che vedere con la sinistra.
Cosa ne pensa, invece,
dell’ultima uscita del presidente del Senato, il quale sottolinea come parola
“antifascismo”, non sia presente nella Costituzione…
Se si va a cercare, negli
articoli, questo vocabolo non c’è. Non si legge da nessuna parte che la
Repubblica è antifascista. Detto ciò, la Costituzione è il più grande vaccino
contro i totalitarismi e quando utilizzo questa parola non mi riferisco solo al
fascismo o al nazismo. La differenza tra la destra e la sinistra è una sola.
Mentre Fini e Meloni hanno condannato, in modo esplicito, il nazifascismo, a
sinistra è ancora un tabù dire che il comunismo è stato antidemocratico.
Detto ciò, ritiene
l’atteggiamento di La Russa istituzionale?
Il presidente del Senato andrà
all’Altare della patria col Capo dello Stato. Mi sembra, quindi, che rispetti il
25 aprile, più o meno come chi lo ha preceduto.
Lei come trascorrerà questa
giornata?
Andrò a Mirandola, nel
modenese, dove passa la “carovana della libertà”. Ricordare quei mezzi che hanno
risalito l’Italia mi sembra importante. Non approvo per niente chi vuole
condannare una parata che vuole solo far capire ai giovani cosa è successo in
quegli anni. Sbaglia chi polemizza per la presenza di persone travestite da
tedeschi. Stiamo parlando di un evento riconosciuto dal Capo dello Stato e che
ha come unico obiettivo quello di rappresentare in modo, più fedele possibile,
quanto accaduto. Le nuove generazioni devono sapere degli americani che ci hanno
aiutato, ma anche di coloro che sono stati sconfitti. Troppo spesso, purtroppo,
si creano polemiche inutili e pretestuose. Basta impiccarsi per una frase o una
singola parola.
Qualcuno, intanto, accusa
l’attuale maggioranza di voler riscrivere la storia. È davvero così?
Meloni, considerando da dove
viene il Movimento Sociale Italiano, mi sembra abbia una visione completa e
sincera della Costituzione. Non si può chiedere di più al presidente del
Consiglio.
Nel passato, però, la leader di
FdI certamente non si è distinta per essere moderata…
Prendo atto che in campagna
elettorale sono state dette delle cose per prendere voti. Mi riferisco, a
posizioni, spesso estremiste. Detto ciò, Meloni, oggi, fa il contrario di quando
urlava durante i comizi. Dall’immigrazione alla politica economica, si pone in
sintonia sempre più con una cultura popolare, liberale, di ispirazione
cristiana, che nulla ha a che vedere con i sovranismi. Considerando la mia
appartenenza, ciò non può che farmi piacere. L’esecutivo di Giorgia è per
l’Europa e la Nato, è quello che ha negato i blocchi navali. I fatti contano più
delle parole.
Su quale aspetto, al contrario,
la maggioranza dovrebbe cambiare linea?
Mi aspetterei che Nordio
facesse quanto promesso, combattendo una deriva troppe volte giustizialista e
riequilibrando un sistema, che necessita di riforme sostanziali. Fino a ora ho
sentito parlare solo di nuovi reati.
Massimo Fini; "Il 25 aprile?
Falso storico, ecco la verità". Libero Quotidiano il 23 aprile 2023
Massimo Fini, in un'intervista
all'Adnkronos mette in chiaro le cose sulle polemiche sul 25 aprile e dà una
sonora lezione alla sinistra. "Tutte le polemiche sul 25 aprile sono farlocche:
abbiamo una Destra al governo che ha tutto il diritto di starci perché ha preso
più voti e questa è la democrazia. Non si può usare il 25 aprile contro questa
Destra, non ha senso politico: è un dibattito sepolcrale quello su fascismo e
antifascismo. Sintomo del fatto che l’Italia non abbia ancora terminato di fare
tutti i suoi conti con il suo passato ed è il motivo principale di queste
polemiche che considero assurde", afferma Fini. Per Massimo Fini, "il 25 aprile
si basa su un falso storico e cioè che siamo stati noi italiani a liberarci con
le nostre stesse mani, mentre in realtà sono stati gli alleati angloamericani
nelle cui file combattevano anche i razzisti sudafricani...".
Sul movimento partigiano che
viene spesso ricordato dalla sinistra, Fini ha un'opinione chiara: "Certamente,
questo va riconosciuto: il valore morale della lotta partigiana è fuori
discussione e va attribuito il massimo rispetto ai partigiani che davvero fecero
la Resistenza, come vanno rispettati anche quei ragazzi che morirono per Salò e
per difendere l’alleanza con Hitler con cui ovviamente Mussolini non doveva
allearsi...
Gianmarco Medusei: "Crimini
dei partigiani", linciato per una frase. Libero Quotidiano il 23 aprile 2023
Guai a mettere in discussione
il valore dei partigiani e a calare qualsivoglia ombra sul mito
della resistenza. Non importa se la storia si sia incaricata di rilevare i
crimini di alcune brigate garibaldine, è vietato parlarne. Lo sa bene, Gianmarco
Medusei, presidente del consiglio regionale della Liguria, il quale in occasione
di una seduta per l’anniversario della Liberazione, ha osato far cenno anche
agli eccidi compiuti anche dai partigiani. Medusei ha parlato di «parentesi
tragiche della Resistenza» e ha aggiunto che ci fu «chi si macchiò di crimini
orrendi che infangarono valorosi combattenti».
Dall’eccidio di Porzus, ai
massacri perpetrati nel famigerato triangolo della morte in Emilia o in molte
zone del Veneto, si tratta di episodi noti e accertati. Niente da fare. Subito
si è scatenata la furibonda reazione degli indignati di professione tra i
partiti progressisti, associazioni partigiane e sindacati. Pd, M5s e le altre
liste di sinistra hanno chiesto le dimissioni di Medusei sostenendo che «parlare
di eccidi da parte dei partigiani e dire che tutte le morti vanno onorate allo
stesso modo è uno sfregio alla Resistenza».
Per l’Anpi Genova si tratta
dell’«ennesimo tentativo revisionista degli esponenti della destra italiana».
Mentre Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista insiste
che «Medusei dovrebbe dimettersi immediatamente». Un fuoco di fila che ha
costretto il presidente del Consiglio regionale ha fare retromarcia: «Ho usato
una frase non appropriata al contesto non avendo avuto modo di sviluppare i
concetti che avrei voluto in quei pochi secondi di intervista», ha dichiarato il
leghista. Aggiungendo però che «non si può neppure negare, oggi che la
Resistenza mostrò anche parentesi tragiche e lontane dall’intento nobile per cui
era sorta. Ci fu anche chi si macchiò di orrendi crimini e rappresaglie, che
infangarono i tanti valorosi combattenti che scesero sul campo di battaglia non
certo per portare altro terrore, o magari per imporre un diverso regime».
Silenzi sui crimini dei
partigiani, così non si arriva a una memoria condivisa. Libero Quotidiano il
23 aprile 2023
Sono ormai settimane che si discute intorno alle
ragioni della mancata “nazionalizzazione del 25 aprile”. Una divisività che
andrebbe spiegata anche facendo luce su uno dei capitoli più dolorosi della
“guerra di classe”, quando all’indomani della Liberazione gruppi di partigiani
di area comunista scatenarono il terrore in gran parte del Nord (si raggiunse il
culmine in Emilia Romagna nel famigerato “triangolo della morte”, un perimetro
compreso fra Bologna, Modena e Reggio Emilia) uccidendo ex aderenti al fascismo
insieme a professionisti, agrari e cittadini comuni. Le vittime si contarono a
decine di migliaia e fra loro vi furono molti sacerdoti (ne caddero più di
cento) come Don Giuseppe Iemmi, Don Carlo Terenziani, Don Umberto Pessina.
Una pagina della nostra storia che verrà
parzialmente aperta solo parecchi decenni dopo la fine del Conflitto mondiale da
una storiografia “distratta” al punto che nel 1995 uno studioso, quale Pietro
Scoppola, sentì il dovere di confessare, facendolo con un certo imbarazzo, che
«ciò che accadde nel Dopoguerra si sapeva, ma è stato coperto da un silenzio
prudente». La verità è che dietro quelle stragi vi era il nodo ancora non
risolto in casa comunista fra “la scelta della via pacifica per la conquista del
potere e il ricorso alla lotta armata per ottenerlo”.
Un’ambiguità che trova conferma all’indomani del
crollo dell’URSS con l’apertura degli archivi moscoviti. A guerra conclusa, il
31 maggio 1945, Palmiro Togliatti (a meno di tre settimane dalla sua nomina a
guardasigilli nel governo Parri, incarico che continuerà a ricoprire anche nel
successivo Gabinetto De Gasperi) incontra l’ambasciatore sovietico in Italia,
Michail Kostylev, per informarlo su quanto sta accadendo nelle regioni del Nord.
Dopodiché, il funzionario sovietico- come rivelano Elena Aga-Rossi e Victor
Zaslavsky in “Togliatti e Stalin” – invia al Cremlino una missiva in cui si
legge che “Ercole (pseudonimo di Togliatti) è tornato dal Nord con ottime
impressioni. Nelle provincie settentrionali i partigiani hanno organizzato un
vero e proprio potere popolare. Egli mi ha detto che non conosce i dati con
precisione su quanti fascisti siano stati puniti, ma considera che questa cifra
sia intorno a circa 50.000 mila fucilati. Mi ha anche informato che i tribunali
popolari di Milano emettono giornalmente numerose condanne a morte”.
IL DOPPIO GIOCO – Ma il doppio gioco del
“Migliore” non finisce qui. Pochi giorni dopo, l’11 giugno, rassicura Mosca
attraverso l’ambasciatore che “i partigiani hanno conservato tutte le armi che
avevano in dotazione e che continuano a portare avanti autonomamente
l’epurazione degli elementi fascisti. A Ferrara ne hanno portati via dalle
prigioni alcune decine e ne hanno fucilati diciassette”. Che gli omicidi
proseguano a ritmo continuo si ricava anche da un colloquio avvenuto due giorni
dopo, il 13 giugno, fra Kostylev e il sindaco di Novara, Carlo Moscatelli.
Questi riferisce che «nella sua provincia mentre i processi regolari vanno a
rilento, i comunisti di loro iniziativa organizzano visite notturne clandestine
nelle case dei collaborazionisti e li eliminano».
La situazione sembra sfuggire di mano pure allo
stesso Togliatti come si evince da un rapporto che l’ambasciata sovietica a Roma
invia a Mosca nell’agosto 1945 dove si legge che “il segretario comunista si
dice preoccupato ed allarmato per il fenomeno della degenerazione dell’attività
dei partigiani in molte zone dell’Alta Italia. Alcuni gruppi sono coinvolti nel
banditismo, nelle espropriazioni e nella violenza contro cittadini inermi”.
Cionondimeno, nulla cambia. Le esecuzioni sommarie non verranno fermate e
continueranno con sistematicità almeno per tutto il 1946.
Venti anni or sono, quando Giampaolo Pansa
pubblicò “Il sangue dei vinti”, raccontando senza i timori degli storici di
professione i crimini commessi dopo il ’45 dai partigiani comunisti, venne
accusato dall’intellighenzia di sinistra di becero revisionismo. In alcune
città, il “popolo dei democratici” impedì fisicamente all’autore di presentare
il libro e discuterne con i lettori. Il clima, a giudicare dalle polemiche di
questi giorni, non sembra cambiato. La “nazionalizzazione del 25 aprile” potrà
essere possibile solo il giorno in cui si avrà il coraggio di squarciare
definitivamente il velo di silenzio e di ambiguità che ha coperto fin qui una
delle pagine più oscure della Resistenza.
Il 25 aprile sbagliato. La Russa, Pagliarulo e
il festival della cattiva coscienza di destra e sinistra. Carmelo Palma su
L'Inkiesta il 24 Aprile 2023
Ogni anno si scontrano gli esponenti del fascismo
nostalgico e dell’antifascismo liturgico. Due modi uguali e contrari per non
fare i conti con la storia del Novecento. Da una parte si celebra una reliquia
altrui, come Jan Palach, dall’altra si celebra la resistenza nel mondo, senza
citare però gli ucraini
La querelle su fascismo e antifascismo accompagna
sempre più stancamente la ricorrenza del 25 aprile, dacché a discutere del
Ventennio non c’è più nessuno che vi abbia avuto parte o, anche in quota minima,
responsabilità da un lato e dall’altro della barricata. Barricata peraltro
abbastanza mobile, visto che nel trapasso di regime il congedo dal fascismo e
l’approdo all’antifascismo è stato per i più guidato dall’eterno principio
evolutivo della politica italiana, il trasformismo. Piazza Venezia si ridislocò
a Piazzale Loreto, et voilà.
I tedeschi, dopo la Seconda Guerra Mondiale,
tentarono dolorosamente di elaborare la questione della colpa, cioè di
riflettere sulla responsabilità collettiva della tragedia nazista. Gli italiani,
semplicemente, si cambiarono di divisa e di colore e riscrissero soggetto e
sceneggiatura del fascismo di regime, fino a ridurlo a un incidente di violenza
e di follia, di cui tutti, a parte Mussolini e i suoi gerarchi, potevano
considerarsi non solo moralmente innocenti, ma politicamente martiri e quindi
antifascisti honoris causa.
Se sono morti tutti i fascisti e gli antifascisti
pre 25 aprile 1945, non ne rimangono molti neppure tra i protagonisti della
classe dirigente politica che si formò negli anni immediatamente successivi, in
cui nella destra fascista il reducismo post-combattentistico e nella sinistra
social-comunista quello post-resistenziale scrissero lo spartito di tutte le
messe cantate, che da allora si intonano per la ricorrenza della Liberazione.
Però neppure il passaggio generazionale, a quanto
pare, ha salvato l’Italia da questa coazione a ripetere, cioè dalla rinnovata
esperienza e infinita replicazione di quel trauma originario e fondativo delle
identità post-fasciste dei reduci di Salò e post-antifasciste degli adepti del
Cremlino sovietico.
Infatti dopo quasi ottant’anni a impersonare
questo scontro e a trasformare in una oscena baracconata la discussione sul ’900
politico italiano sono da una parte il commediante della democrazia in camicia
nera e collezionista di cimeli mussoliniani, messo a presiedere il Senato per
far capire chi comanda, e dall’altra parte il prete cossuttiano e tartufo
pacifista che presiede l’Associazione nazionale partigiani italiani biascicando
i paternostri anti-Nato e anti-americani dei Partigiani della Pace anni ’50.
La Resistenza fu un movimento militarmente
minoritario, in un Italia che senza intervento alleato non si sarebbe liberata
né allora, né mai e in essa ebbero parte importante le minoranze democratiche e
liberali. La retorica del 25 aprile permanente, del fascismo sempre in agguato e
anticristicamente camuffato in vesti democratiche, fu invece interamente
egemonizzato dalla minoranza social-comunista, per cui fascisti non erano solo
Arturo Michelini e Giorgio Almirante, ma anche Giuseppe Saragat, Nicola
Chiaromonte e Ignazio Silone.
Siamo ancora lì e la reviviscenza di un
post-fascismo risentito e a petto in fuori, che usurpa le memoria della lotta
anti-comunista – un fenomeno occidentale e “amerikano” a cui fascisti e
post-fascisti furono sempre oppositori – non rende meno ridicolo un
anti-fascismo da dopoguerra, che non individua nel fascismo uno dei germogli
della malapianta autoritaria e totalitaria, di cui pure il comunismo fu
espressione, ma il male assoluto che non fu, non perché non sia stato una
tirannide vergognosa e orrenda, ma perché non era affatto absolutus, cioè
sciolto da legami di parentela ideologica con altre forme di reazione
anti-democratica, di cui il ’900 è stato un incubatore prolifico e mefitico.
In questo scontro non è possibile costruire alcuna
memoria condivisa, non solo perché esso perpetua una divisione inguaribile e
necessaria, ma anche e soprattutto perché vi domina una – questa sì, comune –
cattiva coscienza collettiva.
Il fascismo nostalgico e l’antifascismo liturgico
sono stati due modi uguali e contrari per non fare i conti col fatto che nella
storia politica italiana il pregiudizio anti-liberale e il sospetto verso le
“demoplutocrazie” borghesi è stato socialmente diffuso e culturalmente
egemonico, anche nella Prima Repubblica, che pure aveva messo elettoralmente ai
margini le opposte manifestazioni dell’oltranzismo fascista e anti-fascista.
Invece la Seconda, nata appunto dalla tabula rasa della Prima, ha
paradossalmente resuscitato, man mano che ci si allontanava nel tempo dagli
eventi, lo spettro dell’alternativa fascisti-comunisti.
E si arriva così a un 25 aprile in cui la destra
non riesce a pronunciare parole di verità su nulla, ma arriva a rubare le
reliquie della resistenza altrui, come Jan Palach, per darsi un tono e una
verginità e la sinistra antifascista organizza piazze di resistenza contro tutti
i fascismi del mondo, ma bandendo e infamando di cupidigia bellicista la
resistenza dell’Ucraina contro l’ultimo e unico fascismo planetario.
Eccovi servito, per l’ennesima volta, il festival
del 25 aprile sbagliato.
Déjà vu. Il 25 aprilismo non ha mai portato
bene alla sinistra, tanto meno alle europee. Francesco Cundari su L'Inkiesta
il 24 Aprile 2023
Tutti ricordano il significato che assunse la
manifestazione convocata a Milano nel 1994, meno di un mese dopo la prima
vittoria berlusconiana alle politiche, e soprattutto la pioggia battente che si
accanì sui dimostranti per tutta la durata del corteo. Ancora meno clementi si
sarebbero dimostrati però gli elettori
Era parecchio tempo che il 25 aprile non tornava a
essere motivo di un così intenso e prolungato scontro ideologico tra destra e
sinistra. Sono settimane che praticamente non si parla d’altro.
Come è noto, dopo anni di sostanziale
dimenticanza, la ricorrenza riacquistò un’improvvisa centralità politica circa
trent’anni fa, all’indomani della prima e per molti inaspettata vittoria
elettorale del centrodestra guidato da Silvio Berlusconi, il 27 marzo 1994.
Credo che tutti i militanti di sinistra della mia
generazione ricordino bene il significato che assunse la manifestazione
convocata a Milano per la festa della Liberazione, meno di un mese dopo, e
soprattutto la pioggia battente che si accanì sui dimostranti per tutta la
durata del corteo. Ancora meno clementi si sarebbero dimostrati però gli
elettori, alle successive europee del 12 giugno, in cui Forza Italia sarebbe
passata in un balzo dal 21 per cento delle politiche, risultato già clamoroso
per un partito appena nato, a uno stratosferico 30 per cento, decidendo così la
non prematura fine della linea neo-antifascista del Pds, nonché le dimissioni
del suo segretario-fondatore, Achille Occhetto, e l’elezione di Massimo D’Alema
nel giro di poche settimane.
Anche questa volta, come nel 1994, la sinistra
viene da una dura sconfitta alle elezioni politiche, e vede nella nuova destra
arrivata a Palazzo Chigi una minaccia ai valori e agli equilibri costituzionali.
Anche questa volta si avverte la tentazione di accettare lo scontro sul terreno
più radicale, quasi che si fosse davanti a un nuovo regime e dunque alla
necessità di una nuova resistenza.
Personalmente, penso che questo genere di 25
aprilismo sia una strada sbagliata in linea di principio (perché strumentalizza
e svilisce il valore stesso del 25 aprile) e sia anche controproducente sul
piano tattico, il che ovviamente non significa che non si debba rispondere a
tono alle insopportabili provocazioni del presidente Senato, Ignazio La Russa,
sull’assenza della parola «antifascismo» nella Costituzione, o alle vergognose
dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sulla
«sostituzione etnica». Per fortuna, a differenza del 1994, le elezioni europee
sono relativamente lontane, e c’è dunque tempo per rifletterci meglio e
correggere la rotta, se si vuole evitare di ripetere gli errori del passato.
A dispetto delle idiosincrasie di Nanni Moretti e
dei tanti intellettuali progressisti che la pensano come lui (senza farci
neanche dei buoni film, con le loro ossessioni), è stata infatti proprio la
svolta impressa allora da D’Alema a cambiare le carte in tavola, interrompendo
bruscamente la trionfale cavalcata berlusconiana. Quello stesso D’Alema cui il
regista avrebbe rimproverato di non dire cose di sinistra, nella successiva
campagna elettorale del 1996. Fatto sta che la sinistra quelle elezioni le
vinse, anzitutto grazie alla sua scelta di costruire un’alleanza con il centro
(il che, certamente, comportava pure la necessità di una retorica meno radicale)
e anche grazie al più generale cambio di atteggiamento nei confronti della
maggioranza, abbandonando lo schema della delegittimazione reciproca, fino ad
affermare la necessità del dialogo con Berlusconi sulle riforme istituzionali
(altro che Aventino e lotta al Regime).
Non stupisce che sia Occhetto sia Moretti abbiano
dichiarato pubblicamente di avere votato per Elly Schlein alle primarie del Pd.
Resta solo da augurarsi che li deluda anche lei.
Bufera su La Russa e la Carta "L'antifascismo
non è citato". Fabrizio De Feo il 22 Aprile 2023 su Il Giornale.
Il presidente del Senato annuncia la visita a un
lager e si difende: "Nella Costituzione quella parola manca"
Aveva preannunciato che il 25 aprile avrebbe fatto
qualcosa che avrebbe messo d'accordo tutti. E Ignazio La Russa, su cui da giorni
sono puntati i riflettori del centrosinistra, non ha deluso le aspettative.
Da giorni in tanti si domandavano cosa avrebbe
fatto in occasione di questa ricorrenza la seconda carica dello Stato. É il
programma stesso della sua giornata a descrivere la volontà di inviare un
messaggio preciso e uscire dal consueto recinto delle polemiche a orologeria e
delle contestazioni di piazza. La Russa il 25 aprile si recherà al campo di
concentramento di Theresienstadt (Praga), utilizzato dai nazisti tra il 1941 e
il 1945. La mattina sarà all'Altare della Patria, poi partirà alla volta della
capitale della Repubblica Ceca per partecipare alla riunione dei presidenti dei
Parlamenti dei Paesi membri dell'Unione europea e, alle 15, sarà alla
commemorazione, con la deposizione di una corona al monumento di Jan Palach - il
patriota cecoslovacco divenuto simbolo della resistenza antisovietica - in
Piazza San Venceslao, nella capitale ceca.
La Russa non si tira indietro neppure quando si
tratta di chiarire il significato di quelle sue parole che tante polemiche hanno
suscitato («L'antifascismo non è nella Costituzione» aveva detto il presidente
del Senato): «Ho letto l'articolo (di Repubblica ndr) con richiamo in prima
pagina dal titolo L'antifascismo non è nella Costituzione. Il mio 25 aprile?
Metterò d'accordo tutti'. Ringrazio il giornalista che ha lecitamente
trasformato in colloquio un veloce scambio di parole alla buvette del Senato e
ripreso in maniera corretta dall'agenzia Ansa. Mi preme però sottolineare che,
come riportato anche dalla stessa agenzia, il mio riferimento non era
all'antifascismo' ma all'assenza in Costituzione della parola antifascismo',
essendo i valori della Resistenza, a cui mi sono esplicitamente richiamato,
espressi in positivo nella prima parte della Costituzione».
Il passaggio in cui l'ex ministro della Difesa
dichiara di riconoscersi nella Resistenza è questo ed è particolarmente
significativo: «Io condivido appieno i valori della Resistenza, vista come
superamento di una dittatura. Il fatto è che di quei valori si sono appropriati
il Pci prima e la sinistra poi. Questo è un fatto storico. E a questo mi sono
sempre opposto. Inoltre guardate che nella Costituzione non c'è alcun
riferimento alla parola antifascismo. Perché? Io credo semplicemente che ciò
accadde sotto la spinta dei partiti moderati che non volevano fare questo regalo
al PCI e all'Urss».
Il tentativo, insomma, è quello di superare la
logica e lo schema di chi, come ha detto due giorni fa in Senato Lucio Malan,
«vorrebbe vivere in un eterno 1944». Inutile dire che i chiarimenti di La Russa
non servono a disinnescare le polemiche. Elly Schlein, reduce dalla visita a
Riano al luogo in cui fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti, risponde: «Ho
sentito le parole di La Russa, ha detto che l'antifascismo non è in
Costituzione. Ma l'antifascismo è la nostra Costituzione». In verità non è la
prima volta che La Russa accende il dibattito in occasione del 25 aprile. Lo
scorso ottobre in una intervista a La Stampa alla domanda «Celebrerà il 25
aprile?», aveva replicato: «Dipende. Certo non sfilerò nei cortei per come si
svolgono oggi. Perché lì non si celebra una festa della libertà e della
democrazia ma qualcosa di completamente diverso, appannaggio di una certa
sinistra. Non ho avuto difficoltà come Ministro della Difesa a portare una
corona di fiori al monumento dei partigiani al cimitero Maggiore di Milano». Una
linea coerente con la volontà di non alimentare un clima da perenne Dopoguerra,
tenendo viva la passione della politica.
Estratto dell’articolo di Francesco Rigatelli
per “La Stampa” il 27 aprile 2023.
Il significato del 25 Aprile e l'uso mancato della
parola antifascismo da parte della premier Meloni fanno discutere gli storici e
traballare la manifestazione "La Storia in piazza" di Genova. «Caro Canfora, ha
sentito Franco Cardini su La 7 nel programma di Gruber? Una specie di apologia
dei giovani della Repubblica sociale, mascherata da equanimità del giudizio
storico a posteriori. Se non lo ha sentito, la invito a farlo. E poi a
domandarsi se è possibile, e moralmente accettabile, collaborare con un tipo
simile».
Firmato Antonio Gibelli, 81 anni, già professore
ordinario di Storia contemporanea a Genova ed ex organizzatore della
manifestazione "La Storia in piazza", i cui curatori attuali sono gli storici
Luciano Canfora, 80 anni, Franco Cardini, 82, e Anna Foa, 79.
Canfora trova strumentale la provocazione […]
«Sono argomenti complessi su cui non giova un approccio manicheo. Ci sono stati
tanti antifascismi, […] si tende a equiparare antifascismo e guerra di
Liberazione, mentre sono due momenti diversi. […] La verità è che l'Italia era
un Paese largamente fascista ed è diventato afascista, non antifascista. Per
questo la celebrazione del 25 Aprile resta contestata, lo fu fin dall'inizio da
Almirante, e in tanti conservano un'idea del fascismo che io respingo». Cardini
da Gruber aveva parlato di «antifascismo usato in modo terroristico», contestato
«l'eroicizzazione di tutti i partigiani» e difeso «la memoria dei ragazzi di
Salò che lottarono per la patria» […]
Estratto dell’articolo di F.Rig. per “La Stampa”
il 27 aprile 2023.
[…] Franco Cardini, 81 anni, fiorentino, storico
del Medioevo, si trova a disagio nella contemporaneità: «Evidentemente a "Otto e
mezzo" non sono riuscito a spiegarmi bene se ora il professor Gibelli, ex
organizzatore de "La Storia in piazza" di Genova, chiede le mie dimissioni da
curatore della manifestazione al collega Canfora».
[…] Tutto nasce dalla sua difesa dei ragazzi di
Salò, perché?
«Il punto centrale è la riconciliazione tra gli
italiani e una memoria condivisa. Perché questo avvenga bisogna mettersi
d'accordo e non è detto che se ne trovi una, ma in quel caso ognuno si terrà la
propria memoria».
[…] «Manca un'analisi seria e articolata della
Resistenza perché possa diventare memoria condivisa. Ricordo casi aberranti tra
i partigiani, la brigata Osoppo, il terrorismo interno, e va bene che in guerra
tutto è legittimo ma con il senno di poi tanti episodi andrebbero riesaminati».
Troppi sconti ai partigiani insomma?
«Ad alcuni partigiani. La guerra civile è finita
il 25 aprile, tutti si sono abbracciati, dopodiché le uccisioni sono continuate
fino al 1949 nonostante l'amnistia di Togliatti. Sul sangue dei vinti non si può
stendere un velo, occorre una conciliazione».
E Salò?
«Nella Storia non si può mai generalizzare, anche
i repubblichini hanno avuto dei meriti. Magari stavano dalla parte sbagliata, ma
volevano difendere la patria. Il 25 luglio Mussolini venne rovesciato da una
congiura di palazzo e 18 settembre il Re scappò. Teniamo presente che allora si
sapeva poco della Shoah».
La diatriba sulla parola antifascismo cosa c'entra
con tutto questo?
«Nulla, ma faccio fatica a pronunciarla perché se
parlo con un comunista vuol dire colpire il fascismo come braccio armato del
capitalismo e se mi rivolgo a un liberale prende il significato di tutela di
tutte le libertà, compresa quella economica. Insomma, gli antifascismi sono in
contrasto tra loro».
L'antifascismo non è semplicemente l'avversione
alla dittatura?
«Può darsi, ma i comunisti allora andrebbero
considerati fa scisti perché appoggiavano la dittatura sovietica. Resta una
parola ambigua».
[…] Qual è la sua proposta di riconciliazione?
«In Italia c'è stata una guerra civile tra
minoranze. Un 10% di partigiani, un 5% di repubblichini e l'85% degli italiani
alla finestra. La riconciliazione tra chi combatté per liberare il Paese e chi
per rispettarne l'onore non può essere così complicata, anche perché li accomunò
una volontà di riscatto». […]
Estratto dell'articolo di Daniele Dell’Orco
per “Libero quotidiano” il 29 aprile 2023.
Una domanda che è diventata un caso. L’intervento
dello storico Franco Cardini a Otto e mezzo, la sera del 25 aprile, ha mandato
su tutte le furie un altro illustre collega, Antonio Gibelli, che ha chiesto a
Luciano Canfora se sia il caso di coinvolgere Cardini nella kermesse “Storia in
piazza”, organizzata ogni anno, dal 2010, a Palazzo Ducale a Genova e curata
dallo stesso Cardini con Canfora.
Il medievalista, per aver detto che i ragazzi
della Repubblica Sociale «sono stati spesso tutt’altro che degli aguzzini, sono
stati combattenti seri, onesti», andrebbe epurato dal suo stesso festival. Il
succo dell'intervento di Cardini è stato definito da Gibelli una «apologia»
della Rsi.
La pensa in modo diverso Gianni Oliva,
giornalista, politico e scrittore in libreria con Il purgatorio dei vinti (Le
scie, 21 euro): «Non la definirei così. Trovo anzi sia un dato di fatto che non
fossero tutti mostri. Del resto basta leggere le storie dei tanti che cito nel
mio volume, da Raimondo Vianello a Enrico Maria Salerno, da Walter Chiari a
Enrico Ameri, senza dimenticare un profilo come quello di Dario Fo...».
Che però poi ha rinnegato...
«Disse bene Indro Montanelli, sarebbe bastato che
dicesse: “Avevo 17 anni” e avremmo capito».
Da qui l’altro passaggio incriminato di Cardini, e
cioè la “buona fede” dei combattenti...
«Altro concetto che non deve sconvolgere. Cosa
pensa significhi buona fede? Certo che a 20 anni chi sceglie di andare a morire
lo fa in buona fede. Mi permetta di esagerare: anche i miliziani dell’Isis
pensano di lottare in buona fede, ma restano comunque dei criminali. Il problema
sono i progetti che sposano, non le scelte dei singoli che possono essere anche
incidentali, contestuali, figlie del momento».
Si spieghi meglio...
«All’epoca si stavano confrontando due visioni del
mondo. Una sbagliata e una giusta e vincente. Una per conservare la dittatura e
una per fare secondo alcuni la rivoluzione socialista e secondo altri quella
democratica. Meno male che siamo nati nella parte del mondo dove ha vinto questa
seconda visione.
Ma ciò deve essere slegato dalle scelte dei
singoli e dalle storie che li hanno portati a sposare l'uno o l'altro. Vede,
persino in Una guerra civile di Pavone, uno che è stato partigiano e che dato
una svolta agli studi sulla Resistenza, c’è un capitolo in cui si parla di
“scelta” e delle ragioni di una scelta.
A riprova che non fosse così immediata e naturale
nelle implicazioni politiche, storiche e morali per chi viveva immerso in
quell’epoca e dopo vent’anni di fascismo. Ecco, forse bisognerebbe smetterla di
considerare la Rsi come l’agnello sacrificale di chi ha sempre evitato di
fronteggiare il vero problema...».
E quale?
«Che l’Italia non ha mai fatto davvero i conti col
suo passato e con l’esperienza del Regime, piuttosto che con la sua appendice
finale e confusionaria. Dopo il 25 luglio non ci furono più i Mussolini e i
Ciano, ma per anni e anche a guerra finita il “deep state” italiano rimase
composto dalle stesse figure che occupavano i medesimi posti durante il
fascismo. Di quella realtà bisognava assumersi delle responsabilità. Le faccio
un esempio...».
Prego...
«La scuola. Il giuramento di fedeltà al fascismo
imposto ai docenti nel 1931. Si rifiutarono solo in 15. Su 1.251. E che dire di
ciò che accadde nel mondo accademico dopo l’emanazione delle leggi razziali,
quando i docenti si accapigliavano non per difendere i colleghi ebrei espulsi ma
per rivendicarne i posti. Demonizzare i ragazzi di Salò e non tenere conto di
queste storie è ingeneroso. Dire ciò non vuol dire ridimensionare il valore
civile e morale della Resistenza. Sono concetti che espressero già Violante nel
’96, Ciampi da presidente della Repubblica, addirittura Calvino nel 1946 ne Il
sentiero dei nidi di ragno».
[…]
Toglierebbe a Cardini la guida di “Storia in
piazza”?
«La repressione culturale non è accettabile. Spero
proprio che non succeda. Toglierei, a lui come ad altri, la guida di kermesse
brutte, fatte male o che escludono il pluralismo. Cardini e Canfora mi sembra
non facciano nulla di tutto ciò».
Esecuzioni, torture, stupri. Le crudeltà dei
partigiani. Giampaolo Pansa il 7 Ottobre 2012 su Il Giornale.
La Resistenza mirava alla dittatura comunista. Le
atrocità in nome di Stalin non sono diverse dalle efferatezze fasciste. Anche se
qualcuno ancora lo nega
C’è da scommettere che il nuovo libro di Giampaolo
Pansa, La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti (Rizzoli, pagg. 446, euro
19,50; in libreria dal 10 ottobre), farà infuriare le vestali della Resistenza.
Mai in maniera così netta come nell’introduzione al volume (di cui per gentile
concessione pubblichiamo un estratto) i crimini partigiani sono equiparati a
quelli dei fascisti. Giampaolo Pansa imbastisce un romanzo che, sull’esempio
delle sue opere più note, racconta la guerra civile in chiave revisionista,
sottolineando le storie dei vinti e i soprusi dei presunti liberatori, i
partigiani comunisti in realtà desiderosi di sostituire una dittatura con
un’altra, la loro.
Tanto i partigiani comunisti che i miliziani
fascisti combattevano per la bandiera di due dittature, una rossa e l'altra
nera. Le loro ideologie erano entrambe autoritarie. E li spingevano a fanatismi
opposti, uguali pur essendo contrari. Ma prima ancora delle loro fedeltà
politiche venivano i comportamenti tenuti giorno per giorno nel grande incendio
della guerra civile. Era un tipo di conflitto che escludeva la pietà e rendeva
fatale qualunque violenza, anche la più atroce. Pure i partigiani avevano ucciso
persone innocenti e inermi sulla base di semplici sospetti, spesso infondati, o
sotto la spinta di un cieco odio ideologico. Avevano provocato le rappresaglie
dei tedeschi, sparando e poi fuggendo. Avevano torturato i fascisti catturati
prima di sopprimerli. E quando si trattava di donne, si erano concessi il lusso
di tutte le soldataglie: lo stupro, spesso di gruppo.
A conti fatti, anche la Resistenza si era
macchiata di orrori. Quelli che il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ricorderà nel suo primo messaggio al Parlamento, il 16 maggio 2006,
con tre parole senza scampo: «Zone d'ombra, eccessi, aberrazioni». Un'eredità
pesante, tenuta nascosta per decenni da un insieme di complicità. L'opportunismo
politico che imponeva di esaltare sempre e comunque la lotta partigiana. Il
predominio culturale e organizzativo del Pci, regista di un'operazione al tempo
stesso retorica e bugiarda. La passività degli altri partiti antifascisti,
timorosi di scontrarsi con la poderosa macchina comunista, la sua propaganda, la
sua energia nel replicare colpo su colpo.
Soltanto una piccola frazione della classe
dirigente italiana si è posta il problema di capire che cosa si nascondeva
dietro il sipario di una storia contraffatta della nostra guerra civile. E ha
iniziato a farsi delle domande a proposito del protagonista assoluto della
Resistenza: i comunisti. Ancora oggi, nel 2012, qualcuno si affanna a dimostrare
che a scendere in campo contro tedeschi e fascisti e stato un complesso di forze
che comprendeva pure soggetti moderati: militari, cattolici, liberali, persino
figure anticomuniste come Edgardo Sogno. È vero: c'erano anche loro nel blocco
del Corpo volontari della liberta. Ma si e trattato sempre di minoranze, a volte
di piccole schegge. Impotenti a contrastare la voglia di egemonia del Pci e i
comportamenti che ne derivavano. Del resto, i comunisti perseguivano un disegno
preciso e potente che si è manifestato subito, quando ancora la Resistenza
muoveva i primi passi. Volevano essere la forza numero uno della guerra di
liberazione. Un conflitto che per loro rappresentava soltanto il primo tempo di
un passaggio storico: fare dell'Italia uscita dalla guerra una democrazia
popolare schierata con l'Unione Sovietica.
Dopo il 25 aprile 1945 le domande sulle vere
intenzioni dei comunisti italiani si sono moltiplicate, diventando sempre più
allarmate. Mi riferisco ad aree ristrette dell'opinione pubblica antifascista.
La grande maggioranza della popolazione si preoccupava soltanto di sopravvivere.
Con l'obiettivo di ritornare a un'esistenza normale, trovare un lavoro e
conquistare un minimo di benessere. Piccoli tesori perduti nei cinque anni di
guerra. Ma le élite si chiedevano anche dell'altro. Sospinte dal timore che il
dopoguerra italiano avesse un regista e un attore senza concorrenti, si
interrogavano sul futuro dell'Italia appena liberata. Sarebbe divenuta una
democrazia parlamentare oppure il suo destino era di subire una seconda guerra
civile scatenata dai comunisti, per poi cadere nelle grinfie di un regime
staliniano?
Era una paura fondata su quel che si sapeva della
guerra civile spagnola. Nel 1945 non era molto, ma quanto si conosceva bastava a
far emergere prospettive inquietanti. Anche in Spagna era esistita una
coalizione di forze politiche a sostegno della repubblica aggredita dal
nazionalismo fascista del generale Francisco Franco. Ma i comunisti iberici,
affiancati, sostenuti e incoraggiati dai consiglieri sovietici inviati da Stalin
in quell'area di guerra, avevano subito cercato di prevalere sull'insieme dei
partiti repubblicani, raccolti nel Fronte popolare. A poco a poco era emerso un
inferno di illegalità spaventose. Arresti arbitrari. Tribunali segreti. Delitti
politici brutali. Carceri clandestine dove i detenuti venivano torturati e poi
fatti sparire. Assassinii destinati ad annientare alleati considerati nemici. Il
più clamoroso fu il sequestro e la scomparsa di Andreu Nin, il leader del Poum,
il Partito operaio di unificazione marxista. Il Poum era un piccolo partito nel
quale militava anche George Orwell, lo scrittore inglese poi diventato famoso
per Omaggio alla Catalogna, La fattoria degli animali e 1984. Orwell aveva 34
anni, era molto alto, magrissimo, sgraziato, con una faccia da cavallo. Era
arrivato a Barcellona da Londra alla fine del 1936. Una fotografia lo ritrae al
fondo di una piccola colonna di miliziani del Poum. Una cinquantina di uomini,
preceduti da un bandierone rosso con la falce e martello, la sigla del partito e
la scritta «Caserma Lenin», la base dell'addestramento.
Orwell stava sul fronte di Huesca quando i
comunisti e i servizi segreti sovietici decisero la fine del Poum. Lo
consideravano legato a Lev Davidovic Trotsky, il capo bolscevico diventato
nemico di Stalin. In realta era soltanto un gruppuscolo antistaliniano con 10
mila iscritti. L'operazione per distruggerlo venne ordita e condotta da
Aleksandr Orlov, il nuovo console generale dell'Urss a Barcellona, ma di fatto
il capo della filiale spagnola del Nkvd, la polizia segreta sovietica. Nel
giugno 1937, un decreto del governo repubblicano guidato dal socialista di
destra Juan Negrin, succube dei comunisti, dichiaro fuori legge il Poum,
sospettato a torto di cospirare con i nazionalisti di Franco. Tutti i dirigenti
furono imprigionati. Se qualcuno non veniva rintracciato, toccava alla moglie
finire in carcere. Gli arrestati si trovarono nelle mani del Nkvd che li
rinchiuse in una prigione segreta, una chiesa sconsacrata di Madrid. Interrogato
e torturato per quattro giorni, Nin rifiuto di firmare l'accusa assurda che gli
veniva rivolta: l'aver comunicato via radio al nemico nazionalista gli obiettivi
da colpire con l'artiglieria. Gli sgherri di Orlov lo trasportarono in una villa
fuori città. Qui misero in scena una finzione grottesca: la liberazione di Nin
per opera di un commando di agenti della Gestapo nazista, incaricati da Hitler
di salvare il leader del Poum. Ma si trattava soltanto di miliziani tedeschi di
una Brigata internazionale, al servizio di Orlov. Nin scomparve, ucciso di
nascosto e sepolto in un luogo rimasto segreto per sempre. E come lui, tutti i
suoi seguaci svanirono nel nulla. Quanto accadeva in Spagna fu determinante per
la svolta ideologica di uno scrittore americano di sinistra, John Dos Passos.
Scrisse: «Ciò che vidi mi provoco una totale disillusione rispetto al comunismo
e all'Unione Sovietica. Il governo di Mosca dirigeva in Spagna delle bande di
assassini che ammazzavano senza pietà chiunque ostacolasse il cammino dei
comunisti. Poi infangavano la reputazione delle loro vittime con una serie di
calunnie». Le stesse infamie, sia pure su scala ridotta, vennero commesse in
Italia da bande armate del Pci, durante e dopo la guerra civile.
C'è da scommettere che il nuovo libro di Giampaolo
Pansa, La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti (Rizzoli, pagg. 446, euro
19,50; in libreria dal 10 ottobre), farà infuriare le vestali della Resistenza.
Mai in maniera così netta come nell'introduzione al volume (di cui per gentile
concessione pubblichiamo un estratto) i crimini partigiani sono equiparati a
quelli dei fascisti. Giampaolo Pansa imbastisce un romanzo che, sull'esempio
delle sue opere più note, racconta la guerra civile in chiave revisionista,
sottolineando le storie dei vinti e i soprusi dei presunti liberatori, i
partigiani comunisti in realtà desiderosi di sostituire una dittatura con
un'altra, la loro.
La Giornata della
liberazione. Ora e sempre Resistenza: il 25 aprile è libertà, accoglienza e
garantismo. Piero Sansonetti su Il Riformista il 25 Aprile 2023
Scrisse così , Piero
Calamandrei, il 4 dicembre del 1952, giusto settant’anni fa:
Camerata Kesselring,
Su queste strade se vorrai
tornare
Ci ritroverai ai nostri posti
Morti e vivi collo stesso
impegno
Popolo serrato intorno al
monumento
Che si chiama
ORA E SEMPRE RESISTENZA
Piero Calamandrei è stato uno
dei padri della Costituzione Repubblicana. Era un grande giurista e aveva
partecipato alle battaglie antifasciste durante il regime, prima con i fratelli
Rosselli e con Giovanni Amendola, poi con il partito d’azione. Era un liberale.
Compose quei versi che ho trascritto all’inizio di questo articolo per
rispondere al generale Albert Konrad Kesserling che era stato il capo delle
forze di occupazione tedesche in Italia. Kesselring fu condannato a morte da un
tribunale italiano, ma poi, per intercessione degli inglesi, la pena era stata
commutata in ergastolo e dopo sette anni di prigionia Kesserling fu liberato.
Dopo la liberazione dichiarò che gli italiani avrebbero dovuto essergli grati,
anzi, avrebbero dovuto costruirgli un monumento. I versi di Calamandrei
iniziavano così: “Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi…”
“Ora e sempre resistenza” non è
retorica. È una promessa, un progetto politico. È una speranza. È una idea di
Italia. Per questo lo abbiamo scelto come titolo del Riformista in questo 25
aprile particolarmente turbolento. Proprio le ragioni della turbolenza esaltano
il valore di quel grido, e di quella preghiera laica di Piero Calamandrei. Sono
passati quasi ottant’anni dalla caduta del fascismo e dalla vittoria della
guerra partigiana, ma non è vero che l’idea di fondo, e la storia, e la
ricchezza dell’antifascismo sono ormai definitivamente affermate. Lo dimostrano
le dichiarazioni del Presidente del Senato, quelle del ministro Lollobrigida, e
tanti commenti e articoli pubblicati dai giornali della destra. In Italia resta
una forte componente reazionaria che ancora oggi tiene in serbo robuste
nostalgie fasciste. E in questa fase condiziona e influenza in modo molto
pesante il principale partito di governo, che è erede del Msi, che è erede del
partito fascista. le polemiche sul 25 aprile sono esclusivamente dovute a questo
rifiuto dell’antifascismo, che non è più marginale.
Allora bisogna chiedere che il
fascismo sia proibito, che i suoi nostalgici siano rasi al suolo? Certamente no.
Il fascismo resta una idea politica – per me atroce: ma un’idea politica – e
come tutte le idee politiche ha pieno diritto ad essere espressa. Semplicemente
bisogna respingere le fantasie di chi pensa che il fascismo sia morto, e si
indigna se in alcune zone della politica italiana e soprattutto della sinistra
si insiste per rilanciare i valori dell’antifascismo e per combattere le
politiche e le idee reazionarie. Ora e sempre resistenza vuol dire semplicemente
questo: continuiamo a difendere i valori che vinsero il 25 aprile. Quali sono?
Ecco su questo è bene essere chiari ed eventualmente dividersi. I valori non
sono le bandiere, i ricordi, la retorica, gli slogan vecchi e troppe volte
sentiti.
Non sono neanche cantare a gran
voce “Bella ciao” o “La brigata Gribaldi”. I valori che vinsero, e unificarono
forze politiche molto lontane, dai liberali ai comunisti, sono la libertà, la
tolleranza, l’accoglienza, il garantismo. Togliatti, e Calamandrei e De
Gasperi e Nenni e Saragat si ritrovarono su queste idee. E su queste idee
costruirono l’Italia. Oggi Resistenza vuol dire esattamente questo: libertà,
quindi Resistenza contro chi vorrebbe limitare i diritti civili, combattere il
celibato, opprimere le donne, perseguitare i gay, vietare, vietare, vietare.
Tolleranza, quindi Resistenza contro chi vorrebbe uno stato poliziesco e
oppressore, e pensa che la lotta politica sia fatta di repressione e di
punizione.
Accoglienza, e quindi,
oggi, Resistenza contro chi vorrebbe una società xenofoba e impaurita, dominata
dal nazionalismo e dal mito della nazione, dell’italianità, del merito di
classe. Garantismo, e quindi Resistenza contro chi vorrebbe una società dominata
dalla magistratura, e dalle manette e dalle prigioni, e ha il mito della
punizione, e pensa allo Stato etico: Resistenza vuol dire smantellamento di un
sistema punitivo che ha al suo centro una istituzione antistorica e inumana come
il carcere. Se il 25 aprile sarà questo, e cioè la festa della libertà, la
Resistenza contro lo Stato-poliziotto, allora Calamandrei avrà vinto. Altrimenti
il generale Kesserling, beffardamente sorriderà. Dirà: vedete, italiani, alla
fine me lo avete fatto il monumento….
Piero Sansonetti. Giornalista
professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato
vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi
di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare
alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 2019.
La Costituzione è
antifascista e il 1943 non è il 1922
risponde Aldo Cazzullo su Il
Corriere della Sera il 26 Aprile 2023
Caro Aldo,
questa storia dell’antifascismo
ha stancato. Il fascismo non esiste più da 70 anni, oggi non ha senso perché non
potrà mai più ritornare in Italia. E nella Costituzione non c’è scritto
antifascista. Lei che ne pensa?
Alfredo Santi
Caro Alfredo,
Sostenere che la Costituzione
non sia antifascista è un errore. L’articolo 3, in particolare, rappresenta il
rovesciamento del fascismo. Non è inutile ricordarne il testo: «Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali». Per il fascismo i cittadini, anzi i sudditi,
non erano tutti uguali. Gli uomini valevano più delle donne, i bianchi dei neri,
chi parlava italiano dei connazionali che parlavano tedesco o ladino o sloveno,
i cattolici degli ebrei, i fascisti degli antifascisti, gli eterosessuali degli
omosessuali; e, al di là della retorica, tutta la politica del Duce rafforzò i
latifondisti ai danni dei braccianti, i padroni ai danni degli operai, i ricchi
ai danni dei poveri, i forti ai danni dei deboli; salvo poi travolgere tutti nel
gorgo della guerra, dopo la quale i risparmi degli italiani non valevano più
nulla e due milioni di famiglie si ritrovavano senza casa. L’antifascismo
assunse diversi segni. Nel 1922 non c’era in Italia alcun pericolo di
rivoluzione bolscevica. Il partito comunista era appena nato, alle elezioni ebbe
appena 15 deputati contro i 123 socialisti. Detto questo, non c’è dubbio che la
presa del potere di Mussolini sia stata una vittoria della destra italiana sulla
sinistra. Le forze che oggi definiremmo di centro, liberali e popolari, non
amavano il dittatore, ma si illusero di poterlo usare per poi metterlo da parte;
si sbagliavano. Non a caso le squadracce dirigono la loro furia contro liberali
come Giovanni Amendola e sacerdoti come don Minzoni, aggrediscono Piergiorgio
Frassati e bastonano Piero Gobetti. Dopo la caduta del regime e l’armistizio
dell’8 settembre, l’antifascismo cambia segno. A questo punto si tratta di
scegliere da quale parte stare: con l’invasore nazista o contro; con chi porta
gli ebrei italiani ad Auschwitz o contro. Questo fa sì che dalla stessa parte si
ritrovino comunisti e liberali, socialisti e monarchici, azionisti e cattolici.
Che insieme scriveranno la Costituzione.
Fuori dal coro, Mario
Giordano contro la liberazione delle bandiere rosse. Il tempo il 25 aprile
2023
Polemiche sul 25 aprile. Non si
placa lo scontro politico sulla giornata della Liberazione. La sinistra usa
tutti i mezzi per screditare il centrodestra e i suoi rappresentanti accusandoli
di non essere antifascisti. All'inizio della puntata di "Fuori dal coro" andata
in onda il 25 aprile, il conduttore Mario Giordano ha condannato nel suo
editoriale l'ipocrisia della sinistra che tenta di accaparrarsi il diritto di
parlare della Liberazione. Ma se fosse stato solo merito delle bandiere rosse,
la storia sarebbe andata molto diversamente.
"Non se ne può più delle
polemiche sul 25 aprile - ha detto Mario Giordano - Sono quasi contento che
arrivi il 26 aprile così finalmente finiranno. Il 25 aprile è un giorno
bellissimo, è il giorno della Liberazione, gli italiani festeggiano, fanno il
ponte e potrebbero essere felici ma poi ci sono le polemiche sul 25 aprile.
Quando c'è una maggioranza di destra o di centrodestra parte la resistenza
contro il governo fascista. Sono anni che sentiamo dire le stesse cose, che
dev'essere una festa condivisa, deve essere la memoria di tutti. Perché non è
stata solo la Liberazione delle bandiere rosse. Anche perché se fosse stata solo
la Liberazione delle bandiere rosse ci saremmo liberati da una dittatura ma
saremmo caduti in un'altra dittatura".
La Russa insiste: "I resistenti non erano tutti
uguali. I partigiani rossi volevano un'Italia modello Unione sovietica". Da
cura della redazione Politica il 17 aprile 2023.
Il presidente del Senato afferma: "La destra seppe
fare i conti con il suo passato, a Fiuggi con Tatarella riconoscemmo il valore
della Resistenza". Polemica sulle parole di Lollobrigida: "Il 25 aprile non sia
una data divisiva". Fratoianni replica: "Lo è solo per i fascisti"
A una settimana dal 25 aprile, Ignazio La
Russa torna a parlare di Resistenza e di partigiani "bianchi e rossi", perché
"una parte della Resistenza aveva l'ambizione di dare all'Italia un governo più
simile a quello dell'Unione Sovietica: è una verità storica". Il presidente del
Senato, dopo le parole choc su via Rasella, prova a rimediare ricordando quando
"la destra seppe fare i conti con il suo passato". "A chi dice che la destra
deve fare ancora i conti del passato, dico di leggere il libro di Pier che
riprende alcune delle tesi di Fiuggi quando con Pinuccio Tatarella riconoscemmo
chiaramente il valore assoluto della Resistenza nel ridare all'Italia libertà e
democrazia", dice durante la presentazione del libro del senatore Pier
Ferdinando Casini. Precisando poi la parte sui "partigiani bianchi e rossi".
La Russa insiste chiamando in causa il libro di
Casini: "Tu l'hai descritto molto bene, ricordando il ruolo di Fini e il ruolo
di Fiuggi, quando la destra seppe fare i conti con il suo passato. A chi chiede
ancora, lèggano il suo libro, che lo scrive in maniera chiara e riprende alcune
frasi della tesi di Fiuggi in cui mettevamo assolutamente in chiaro il valore
che aveva avuto la resistenza nel ridare all'Italia libertà e democrazia. Con
Tatarella e i suoi giovani di avanguardia, eravamo io e Gasparri, e ci battemmo
per quelle tesi in maniera vittoriosa" aggiunge La Russa ricordando che "certo
in quelle tesi c'è poi anche una differenza sostanziale, che è inutile
nascondere: che mentre il rispetto per la Costituzione è totale e assoluto, noi
dicemmo che non tutta la Resistenza, partigiani bianchi e partigiani rossi,
avevano avuto lo stesso obiettivo. Dicemmo che una parte della Resistenza, che
pure era stata anch'essa importante per arrivare alla fase del dopoguerra, aveva
probabilmente l'ambizione di dare all'Italia un governo che assomigliasse più
all'Unione sovietica. Ma era una verità storica, che inutilmente qualcuno ha
cercato negli anni successivi di dimenticare".
La polemica sulle parole di Lollobrigida
Il 25 aprile "non sia una data divisiva", avverte
intanto Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e dirigente di FdI.
"Lo è solo per i fascisti e chi non si riconosce nell'antifascismo", replica
Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana.
"Spero che il 25 aprile sia sempre più un
appuntamento unificante per gli italiani invece di essere utilizzato per cercare
di dividere questa nazione, che sempre più deve trovare momenti di unità",
dichiara Lollobrigida. E a stretto giro Fratoianni replica: "E' una curiosa
preoccupazione la sua. Il 25 aprile è la più importante delle nostre feste -
sottolinea - perché celebra la Liberazione del Paese, la vittoria della libertà
contro l'oppressione nazifascista. Quindi sì, in qualche misura può essere una
data divisiva. Per i fascisti o per chi non riconosce nell'antifascismo e nella
Resistenza la radice della Costituzione e della Repubblica".
La Russa sui migranti
Prova a chiudere il discorso sui partigiani, il
presidente del Senato. Che però commenta la questione migranti: "È il tam tam
che ci sta danneggiando, 'andate in Italia che lì possiamo starci come
vogliamo'. Questo provoca un afflusso superiore a quello che possiamo
permetterci. È un tam tam ideologico".
Ungheria 1956: così il Pci restò dalla parte
dell'Urss. Corrado Augias su La Repubblica il 23 Aprile 2023.
1956: Alcuni studenti scrivono per terra messaggi
di solidarietà ai ribelli in Ungheria dopo la repressione dei carri armati
sovietici
Nell'ultimo film di Nanni Moretti, Il sol
dell’avvenire, si immagina “la svolta”. Ma nella realtà il partito scelse di
restare unito
L'ultimo film di Nanni Moretti, Il sol
dell’avvenire, ha avuto qualche giudizio severo: eccesso di autocitazioni non
sempre freschissime, compiacimenti, una cinefilia un po’ logora, morettismi.
Giudizi raffinati, a volte anche troppo per chi al cinema va, come me, con
innocenza cioè solo per guardare il film, e poco più. Il sol dell’avvenire l’ho
visto quindi in un modo diverso da quello di chi durante la proiezione
analizzava criticamente inquadrature e montaggio.
L’INCREDIBILE STORIA DIMENTICATA DEI 5000
PARTIGIANI SOVIETICI CHE AIUTARONO LA RESISTENZA ITALIANA. DI SILVIA
GRANZIERO su The Vision il 22 ottobre 2021.
L’Italia è punteggiata di cippi e
lapidi commemorative con la stella rossa dell’Unione Sovietica o scritte in
cirillico. È questo quasi tutto quel che rimane di un aspetto poco noto della
liberazione, la fase della nostra storia senza cui l’Italia repubblicana che
oggi diamo per scontata non esisterebbe. Vista l’ambiguità con cui da qualche
anno si parla di liberazione e Resistenza, non stupisce che la conoscenza
diffusa su questi temi escluda diversi aspetti ed episodi densi di significato,
come la partecipazione di partigiani di nazionalità non italiana alla guerra di
liberazione dal nazifascismo. Tra questi, i circa 5000 soldati sovietici che
combatterono al fianco dei partigiani, ma che dal dopoguerra furono relegati
nell’oblio quasi totale. Eppure quelle vicende storiche testimoniano una
solidarietà che travalica i confini nazionali, in nome dello stesso fine della
liberazione dal nazifascismo, che ancora oggi merita di essere celebrata.
Per capire come i sovietici arrivarono in Italia
bisogna risalire all’Operazione Edelweiss, il piano con cui Hitler pianificò la
conquista di tutta l’area del Caucaso per impossessarsi dei pozzi di petrolio di
cui l’Azerbaijan era ricco. Si trattava di un obiettivo strategico anche perché,
dopo l’occupazione tedesca dei territori dell’attuale Ucraina, la Repubblica
Socialista Sovietica Azera era rimasto l’unico fornitore di petrolio dello
schieramento alleato e la sua capitale, Baku, era un importante centro di
manifattura di 130 tipi diversi di armi, tra cui i leggendari razzi Katjusha –
così chiamati dalla celebre canzone popolare russa che dopo la guerra assunse un
forte significato patriottico, e la sua melodia, portata in Italia dai reduci di
ritorno dalla Russia, diventerà la base per “Fischia il vento”. Oltre alle
motivazioni strategiche però ci sono quelle “esoteriche”: Hitler infatti vuole
il Caucaso anche per prendere il monte Elbrus, ritenuto la sede mitica del
Valhalla, dimora degli eroi della mitologia germanica. Così, violando il patto
Molotov-Von Ribbentrop, nel giugno 1941 invade l’Unione Sovietica, puntando
verso il Caucaso. Alla notizia, tra i volontari che si arruolano nell’Armata
Rossa per fermarlo ci sono anche 40mila azerbaijani, che si costituiscono in
diverse divisioni su base nazionale, i cui posti di comando, però, spettano a
ufficiali russi, cosa che comporta qualche difficoltà a livello di gestione e
coordinamento per la distanza culturale e linguistica tra i soldati e i gradi
superiori.
Nell’autunno 1942 è ormai chiaro il fallimento del
progetto nazista, nel quale sono coinvolti anche gli italiani dell’ARMIR (Armata
Italiana in Russia). Dopo aver sconfitto i tedeschi a Stalingrado, nel gennaio
1943 l’Armata Rossa organizza una controffensiva: nonostante alla fine
prevalgano i sovietici, durante gli scontri molti di questi sono costretti ad
arrendersi; tra i prigionieri dei nazisti – in totale tra i 3 e i 4 milioni di
persone – diversi azerbaijani sono probabilmente uccisi subito perché, essendo
musulmani, sono circoncisi e quindi scambiati per ebrei. Dopo una prima fase di
sterminio, però, il regime nazista decide di cambiare strategia, puntando sul
collaborazionismo – tanto che, alla fine del 1942, nasce a Berlino
l’anticomunista Comitato per la liberazione dei popoli della Russia – e
sull’impiego dei prigionieri nei campi di lavoro. Vengono anche creati dei
reparti militari cosacchi, posti sotto il comando dall’atamano – cioè il
comandante cosacco – Pëtr Krasnov e vengono dotati di una certa libertà d’azione
perché, diversamente dalle etnie slave, sono ritenuti di origine ariana. L’idea
è impiegare i caucasici contro l’Armata Rossa, ma cercando di mettere per
sicurezza i diversi sovietici l’uno contro l’altro.
Da queste legioni sono molti a disertare e unirsi
di nuovo all’Armata Rossa o a entrare in clandestinità, atteggiamento che fa
ancor più perdere la fiducia dei tedeschi nei confronti dei sovietici, che
vengono quindi ritirati dal fronte orientale e dirottati su quello occidentale,
allontanandoli dalla madrepatria. Anche così, però, gli antifascisti non
rinunciano ai loro propositi di fuga e, giunti con le legioni naziste in Francia
e in Italia, nell’estate del 1943, fuggono mettendosi in contatto con le
formazioni partigiane locali. Corpi di partigiani azeri e georgiani legati alla
Brigata Garibaldi sono attivi in Emilia, nelle zone di Parma e Piacenza e nel
bolognese, fino a tutto l’Appennino tosco-emiliano; altri sulle montagne nella
zona di Bergamo e di Brescia, dove è attestata la presenza di disertori russi,
cecoslovacchi, polacchi e altri non meglio identificati “slavi” di cui i
testimoni ricordano le prove di coraggio. Come quella del georgiano
Pore Mosulishvili – attivo nell’area del Lago Maggiore assieme ad altri
caucasici – che, accerchiato dai tedeschi, si suicida a inizio dicembre 1944.
Qualche tempo prima, il 24 ottobre, tra i trucidati nelle stragi compiute dalla
polizia fascista nei dintorni di Novara – un’azione di vendetta nei confronti
delle operazioni partigiane della zona – c’è anche il georgiano Sikor Tateladze,
che viene impiccato assieme ai compagni italiani.
Il più noto, però, è il partigiano Mikhailo, nome
di battaglia con cui passa alla storia Mehdi Huseynzade, un giovane artista
poliglotta, destinato a morire a 25 anni e a essere ricordato come eroe. Tenente
dell’Armata Rossa ferito gravemente e fatto prigioniero in battaglia nel 1942
nei pressi di Stalingrado, Huseynzade, di fronte all’opzione di andare in campo
di concentramento, preferisce entrare nella Legione nazionale azerbaigiana, con
l’idea di fuggirvi il prima possibile. Qui, grazie al suo talento per le lingue,
diventa interprete e viene affidato alla 152esima divisione turkestana di
fanteria, nel reparto di propaganda e controspionaggio. Questa, dopo l’8
settembre del 1943, viene inviata nella zona di operazioni Litorale Adriatico,
la nuova provincia del Reich tedesco che comprende Trieste e la Venezia Giulia;
qui Huseynzade progetta la fuga insieme ai suoi compagni Javad Hakimli e Asad
Gurbanov.
I tre riescono a mettersi in contatto con dei
partigiani comunisti e a entrare nel IX Korpus del Fronte di liberazione
sloveno, composto di sloveni e italiani legati alla Brigata Garibaldi. È da loro
che Huseynzade viene ribattezzato Mikhailo ed è con loro che progetta diversi
attentati contro le postazioni tedesche nella zona, tra cui l’esplosione di una
bomba in un cinema pieno di soldati tedeschi a Villa Opicina il 2 aprile 1944,
che provocò 80 morti e 110 feriti; 20 giorni più tardi salterà poi in aria il
circolo militare Deutsches Soldatenheim in via Ghega a Trieste durante uno
spettacolo, facendo 450 tra morti e feriti. Il mese dopo esploderà il casinò
militare di via del Fortino, sempre a Trieste, e verrà innescato un ordigno in
una caserma.
A settembre dello stesso anno, Mikhailo,
travestito da ufficiale nazista, fa saltare due aerei e 25 automezzi in un
autodromo tedesco e il mese dopo, con i suoi uomini, fa un’incursione in carcere
liberando 700 prigionieri di guerra. La taglia che pende sulla sua testa non gli
impedisce di portare a termine un ultimo attentato in un cinema militare di
Sezana; ma quando, a novembre, cerca di introdursi nei magazzini di uniformi
tedesche a Gorizia, i tedeschi lo fermano. Secondo il dossier ufficiale – in cui
probabilmente la realtà sfuma nel mito – gli inseguitori individuano la località
in cui Mikhailo alloggia, e lui, accerchiato, uccide 25 soldati tedeschi, prima
di suicidarsi con l’ultimo proiettile rimasto. Esiste un’altra versione secondo
cui i nazisti trovarono per caso Mikhailo a pranzo in una trattoria nel
villaggio di Vitovlje, in Slovenia, e lo trucidarono. Un suo compagno, il
georgiano David Tatuashvili, gli costruì una tomba in una località che oggi si
trova in Slovenia, su cui Javad Hakimli – che ne parlerà nel 1963 nel suo libro
di memorie Intigam (“La vendetta”) – incide la stella rossa dell’Urss.
In Azerbaijan, oggi, Mikhailo è celebrato come
personificazione dell’impegno nazionale nella guerra di liberazione europea. Gli
sono stati dedicati film e nel 1973 un monumento nel centro di Baku. Ciò è stato
possibile solo dopo la morte di Stalin, che aveva addirittura emanato un
ordine per punire chiunque avesse fatto parte delle divisioni tedesche, anche se
arruolato a forza e disertore di provato antinazismo. L’eroe dei tre mondi –
Urss, Italia e Slovenia – non è però altrettanto riconosciuto all’estero. Non
solo in Urss – dove le peculiarità locali delle nazionalità non russe sono state
a lungo percepite come un pericolo per l’unità dello Stato – ma anche in
Jugoslavia, in rotta con Stalin dal 1948. In Italia i partigiani sovietici per
anni non hanno ricevuto onori. Da noi, infatti, vicende come quella di
azerbaigiani e georgiani non sembrano essere in linea con la narrazione
dominante del dopoguerra, di esaltazione degli alleati americani, per cui
l’apporto comunista alla liberazione è un ricordo scomodo.
Eppure questo è uno degli episodi che mostrano
la trasversalità della Resistenza, la cui solidarietà merita di essere
ricordata. Sono ancora troppe poche e isolate le iniziative di commemorazione,
come quelle programmate per fine ottobre a Gallarate e Verbania, o come
l’inaugurazione, nel 2017, di un piccolo museo dedicato a Mikhailo in Slovenia;
mentre pioneristico è stato il riconoscimento da parte della Regione Toscana già
negli anni Settanta verso i reduci venuti da lontano. Nella memoria collettiva
non sembra esserci uno spazio per questo solidale antifascismo che travalica
confini nazionali e ostacoli linguistici e che si realizza anche nella
partecipazione dei partigiani italiani alle operazioni di Resistenza all’estero.
Questi episodi sono stati praticamente cancellati, a eccezione di qualche lapide
nei boschi o negli angoli dei nostri cimiteri, e invece dovrebbero essere fatti
conoscere, come testimonianze della solidarietà sovranazionale, preziose tanto
più oggi per contrastare la voglia di costruire muri, risvegliando quella di
abbatterli. Silvia su The Vision
Verso il 25 aprile. Le radici dell'anti
antifascismo nel saggio di Michela Ponzani. Simonetta Fiori su La Repubblica
il 18 aprile 2023
Racconta la giustizia ingiusta del dopoguerra, che
condannava i partigiani e giustificava i repubblichini. E che spiega in
filigrana i distinguo di oggi
"Partigiani delinquenti". "Responsabili di
attentati contro inermi". Assassini, vigliacchi, terroristi. Sono soltanto
alcuni degli epiteti antiresistenziali che da un lontano passato rimbalzano in
queste settimane sulla stampa di destra e nel discorso pubblico, perfino nei
luoghi istituzionali come la presidenza del Senato. Ma pur nella sua
eccezionalità, senza paragoni nell'Europa occidentale, la retorica antifascista
ha suscitato l'indignazione soltanto d'una parte degli italiani, trovando
altrove indifferenza o giustificazione.
25 aprile, Liberazione e fascisti: polemiche di
chi non conosce la storia. Francesco Carella su Libero Quotidiano il 18
aprile 2023
Quest’anno le polemiche sulla ricorrenza della
Liberazione sono partite in anticipo, ma le ragioni che le sostengono sono
ancora una volta riconducibili a una falsa narrazione degli eventi accaduti in
Italia fra il ’43 e il ’45 incentrata sulla sostituzione della “storia reale con
una storia alternativa”. In primo luogo, secondo la vulgata diffusa dalla
sinistra, la Liberazione del nostro Paese sarebbe avvenuta grazie all’opera
determinante e risolutiva delle azioni dei gruppi partigiani. Come sa, chi ha un
minimo di conoscenza storica, l’Italia riconquista la libertà in forza
dell’intervento delle Armate anglo-americane che liberano, dopo una lunga e non
sempre facile campagna militare, la Penisola dagli occupanti nazisti. Inoltre,
occorre ricordare che nella scelta di dare alla neonata Repubblica un sistema di
democrazia rappresentativa un ruolo fondamentale viene svolto dal progetto
rooseveltiano di “imperialismo democratico” elaborato fin nei minimi dettagli
con il Conflitto ancora in corso.
Purtroppo, con le falsificazioni storiche non si
costruiscono memorie comuni e la prova di ciò è che a distanza di 68 anni dalla
fine della Seconda guerra mondiale il 25 aprile continua ad essere una data
sempre più lontana dal divenire un paradigma unitario e fondante per l’intera
nazione. Ma la divisività, anche se taciuta per molti anni, era un fattore già
presente all’interno della Resistenza e nel suo organo politico, il CLNAI, nelle
cui fila coesistevano due famiglie distinte, quella liberal-democratica e quella
socialcomunista, con una visione del mondo e un’idea dell’Italia futura diverse
quante altre mai.
Mentre la componente liberal-democratica
interpretava il fascismo come fenomeno politico transeunte considerando la lotta
contro di esso come un mezzo per fare ritorno alla libertà, il gruppo
socialcomunista non essendo in grado di distinguere, per cultura e dottrina, la
natura dei regimi democratici da quelli autoritari interpretava il Ventennio
come una pura reazione capitalistica. Talché la lotta di Liberazione non poteva
che essere un mezzo attraverso il quale giungere all’instaurazione della
“dittatura del proletariato contro la dittatura borghese”.
"I morti in proporzione...". I fratelli Mattei
e la Resistenza: l'assurdo paragone di Lerner. Il giornalista accosta la
strage di Primavalle, compiuta da militanti di Potere Operaio, ai morti della
Resistenza. L'assurdo paragone finisce per minimizzare le violenze rosse degli
anni di Piombo. Marco Leardi il 28 Aprile 2023 su Il Giornale.
La storia raccontata a senso unico. Piegata
all'ideologia per avvalorare una tesi o una precisa narrazione. Il doppiopesismo
nei giudizi sul passato aleggia ancora a sinistra, soprattutto quando si parla
di antifascismo militante. L'acrobazia retorica compiuta di recente da Gad
Lerner è di quelle da antologia, ma in negativo: su La7 il giornalista ed ex
militante di Lotta Continua è riuscito a minimizzare il rogo di
Primavalle (compiuto da alcuni aderenti a Potere Operaio nel 1973) paragonandolo
impropriamente alle morti partigiane durante la Resistenza. Come se ci fosse una
graduatoria nelle stragi, come se i due contesti storici fossero equiparabili.
Durante un dibattito sull'antifascismo nel corso
della più recente puntata di Piazzapulita, Lerner ha commentato: "Lasciatemi
fare l'ex di Lotta Continua, anche se è passato quasi mezzo secolo. Ho sentito
citare gli anni 70 e sono un passaggio doloroso per il sangue che si versò
allora, sul quale è tornata spesso Giorgia Meloni...". Il riferimento del
giornalista era probabilmente alle parole del premier sugli "innocenti uccisi
dall'antifascismo militante". Tuttavia, invece di stigmatizzare senza se e senza
ma le violenze commesse in quel periodo dalla sinistra extraparlamentare, l'ex
conduttore tv l'ha presa alla larghissima. "Anche noi di Lotta Continua dicevamo
allora quanta fatica abbiamo fatto e quanto abbiamo dato battaglia culturale per
strappare dei nostri compagni all'ideologia della lotta armata", ha chiosato.
Quindi il passaggio più sgangherato, con un
paragone nato male e articolato peggio. "Tutto questo però non c'entra con
il giudizio storico del 25 aprile. Il 25 aprile arriva 30 anni prima degli anni
Settanta e c'è questa distorsione per cui non si guarda, anche in termini di
proporzione, i morti… Anche i fratelli Mattei: grande rispetto, ma nella
resistenza per darci la libertà sono morte decine di migliaia di partigiane e
partigiani". Per chi non lo avesse colto, il giornalista ha menzionato l'attacco
di Primavalle contro Virgilio e Stefano Mattei (figli di Mario Mattei,
segretario locale del Movimento Sociale Italiano), sostenendo che quelle morti
non siano rapportabili numericamente a quelle di chi ha combattuto per la
Resistenza.
Ma le vittime degli antifascisti estremisti non
sono state certo solo due. E in ogni caso quell'accostamento ha
dell'incredibile. Certo, per decenza Lerner ha parlato comunque di "grande
rispetto", ma intanto ha in sostanza derubricato quella strage (per la quale
vennero condannati tre esponenti di Potere Operaio), elevandola impropriamente a
termine di paragone. E nessuno su La7 ha osato fargli notare che quell'approccio
alla storia non fosse particolarmente condivisibile. Lo stesso silenzio lo
abbiamo udito, pochi giorni fa, quando in tv la filosofa Donatella Di Cesare
aveva definito il comunismo "un progetto politico di emancipazione", rifiutando
di paragonarlo al fascismo.
Ramelli e gli altri cuori neri uccisi dall'odio
rosso. Tra il 1970 e il 1983 più di venti giovani di destra persero la vita
a causa dell’odio rosso: tragedie dimenticate o minimizzate, spesso accompagnate
da un giustificazionismo pericoloso. Massimo Balsamo il 22 Aprile 2023 su Il
Giornale.
Il prossimo 29 aprile saranno 48 anni dalla
tragica morte di Sergio Ramelli, ucciso da chi si proclamava antifascista. Un
ragazzo tranquillo, allegro e socievole, attivo in oratorio e amante del calcio.
Una vita spezzata dall’odio rosso, da un tema sulle Brigate rosse costato una
schedatura e dunque l’esecuzione brutale a colpi di Hazet 36, una chiave inglese
estremamente pesante, da parte di un commando di Avanguardia operaia. Presunti
antifà, ma ben distanti da valori come libertà e democrazia. Del resto, il vero
antifascismo non ha niente da condividere con simili vergogne e slogan di odio,
ma il concetto non sempre emerge con chiarezza.
Anche quest’anno il ricordo di Ramelli è stato
macchiato dai soliti soloni di sinistra, con il tentativo di boicottare la
commemorazione all’Itis Molinari. Fortunatamente il presidio antifascista si è
rivelato un flop, nonostante il sostegno di Anpi e sigle sindacali (Adl Cobas e
Usb). Il motivo di cotanta agitazione? La presenza del sottosegretario Paola
Frassinetti di Fratelli d’Italia e più in generale l’evento dedicato a un
“picchiatore fascista”. Una lapalissiana mistificazione per celare un pericoloso
giustificazionismo. Secondo alcuni, infatti, uccidere un fascista o comunque un
sostenitore di destra non è un reato. Anche Ramelli, forse, ha fatto la fine che
si meritava. Il mondo che va al contrario, la morte del buonsenso in nome di una
furia cieca.
Ma Ramelli non è l’unica vittima degli anni di
Piombo e dell’odio dei gruppi di estrema sinistra. Tra il 1970 e il 1983 più di
20 giovani sostenitori di destra hanno perso la vita, “cuori neri” caduti a
causa della deflagrazione del terrorismo rosso. Tragedie minimizzate o
addirittura dimenticate, assassinii spesso rimasti impuniti perché coperti da
pezzi di alta società e politica. In altre parole, storie dolorose. Una guerra
tra opposte ideologie che ha sconvolto l'intero Paese, comizi trasformati in
guerriglie urbane, schermaglie esplose in esecuzioni.
Come ricordato da Luca Telese nel suo libro Cuori
neri (Solferino), il primo ragazzo di destra ucciso negli anni di Piombo è
stato Ugo Venturini. La tragedia risale al 18 aprile 1970, a Genova: militante
missino e padre di famiglia, Venturini partecipa al comizio di Giorgio
Almirante in Piazza Verdi. Non va ad attaccare manifesti e non attacca briga con
nessuno, non è di certo un fanatico o un violento. Ma il clima è ostile,
complici gli scontri avvenuti anni prima: “Fascisti morirete”, “Almirante, non
uscirai vivo da Genova”, alcune delle scritte apparse sui muri della città. Gli
estremisti comunisti prendono parte al comizio con il lancio di sassi, pietre e
bottiglie piene di sabbia. “Non fate come loro: loro hanno la forza delle
pietre, noi quella delle parole”, il messaggio di Almirante ai suoi. Ma una di
quelle bottiglie riempite di terra colpisce alla testa Venturini: quindici
giorni di agonia, poi la morte datata 1° maggio. Una sciagura festeggiata
da Lotta Continua e persino rivendicata per la sua "correttezza": "Giustiziato
il fascista Venturini". Nasce anche uno slogan: “1, 10, 100, 1000 Venturini”. La
prima vittima missina, il primo passo verso anni sanguinosi, una famiglia
distrutta: la moglie, dopo un secondo matrimonio, si suiciderà, mentre il figlio
finirà nel tunnel della droga.
Due anni dopo, il 7 luglio 1972, è Carlo
Falvella a cadere sotto i colpi dell’odio rosso. Studente di Filosofia
all'Università degli Studi di Salerno e vicepresidente del Fuan di Salerno - ma
non è un dirigente di spicco, anzi, si è iscritto da appena un anno - Carlo ha
gravi problemi alla vista che lo porteranno entro i trent’anni alla completa
cecità: per questo studia filosofia, perché si può insegnare senza dover per
forza scrivere. Non ha mai fatto una vacanza, non è mai andato all'estero: un
ragazzo semplice e genuino. Quel giorno si trova sul lungomare Trieste di
Salerno insieme all’amico Giovanni Alfinito, quando a un certo punto si accende
uno scontro verbale con il 33enne Giovanni Marini e Gennaro Scariati, entrambi
aderenti ai gruppi anarchici. Tutto si risolve senza conseguenze, almeno per il
momento. Circa due ore dopo, nei pressi di via Velia, si ripete il diverbio:
Marini però si era recato a casa per recupera un coltello. I due militanti
missini restano feriti, ma riescono a chiamare i soccorsi. Per Carlo non c’è
niente da fare: muore nel corso dell’operazione per un colpo fatale all'aorta.
Un altro barbaro omicidio, emblema dell'odio che covava sotto la cenere. Anche
in questo caso Lotta Continua è categorica: dito puntato sulle brutalità
squadriste e attacco frontale nei confronti di chi condanna la violenza (anche a
sinistra).
Le morti di militanti missini aumentano
esponenzialmente in quegli anni Settanta, ma il copione è fisso: poche timide
condanne dalla sinistra, parecchi tentativi di attivare una speculazione alla
rovescia con l’obiettivo di confondere vittime e carnefici. Gli estremisti rossi
provano in ogni modo a giustificare quelle azioni criminali: è necessario
impugnare le armi per contrastare i fascisti. Anche se fascisti non sono:
studenti, operai, militanti distanti dal fanatismo. Tutto pur di scagionare gli
autori di simili barbarie, in campo anche intellettuali di spicco come Dario
Fo e Franca Rame, in prima linea per difendere a spada tratta Giovanni Marini,
con tanto di lettere al presidente della Repubblica Giovanni Leone.
Quanto accaduto il 16 aprile 1973 a Roma passa
alla storia come il rogo di Primavalle, per la prima volta negli anni di Piombo
la violenza politica si evolve in massacro. Un attacco terrorista in piena
regola, il massacro come strumento per risolvere la lotta tra destra e sinistra.
Tre esponenti dell’organizzazione Potere Operaio organizzano e portano a termine
un attacco incendiario poco dopo le ore 3.00 in via Bernardo da Bibbiena 33,
dove abita Mario Mattei, segretario della sezione del Movimento Sociale Italiano
nel quartiere. Un uomo di destra, sottoproletario di borgata. Una tanica con
diversi litri di benzina e una miccia, tanto basta. Mattei, la moglie e due dei
figli più piccoli, Antonella (9 anni) e Giampaolo (3 anni), sono riusciti
miracolosamente a fuggire attraverso la porta di casa. Lucia (15 anni), invece,
è riuscita a gettarsi dal balconcino del secondo piano, afferrata al volo dal
padre. Niente da fare per Virgilio e Stefano, rispettivamente 22 e 8 anni, arsi
vivi. Virgilio, un ragazzo tranquillo e intelligente, che frequentava il partito
solo perché “obbligato” dai genitori e che si sarebbe dovuto sposare nel 1974
con la sua Rosalba. Stefano, semplicemente un bambino. Per i rossi? Una
montatura, un’azione della destra extraparlamentare per scatenare il caos.
Gli scontri tra fascisti e comunisti si
intensificano, la violenza verbale è all’ordine del giorno, le minacce si
sprecano. Diverse le intimidazioni recapitate ad Emanuele Zilli, attivista di
destra nato in Abruzzo ed emigrato al Nord, a Pavia, per dare una futuro alla
sua famiglia. Il 2 novembre del 1973 l’operaio-sindacalista viene trovato
riverso in via dei Mille, non lontano dal posto di lavoro. Si pensa subito a un
incidente. Il 25enne, missino padre di famiglia, muore il 5 novembre dopo giorni
di agonia. Eppure qualcosa non torna, dall’occhio pesto alla doppia frattura
cranica incompatibile con un’ipotetica caduta. Uno dei casi meno conosciuti,
sicuramente non famoso come il battesimo delle Brigate rosse, datato 17 giugno
1974 in quel di Padova.
Un tentativo di furto che si trasforma in
carneficina: entrato nella sede del Movimento Sociale Italiano per prelevare
alcuni documenti e lasciare qualche scritta sui muri, un commando di cinque
terroristi uccide a sangue freddo Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola. Un
imprevisto mutato in un bagno di sangue, il primo segno concreto della
pericolosità delle Br. Anche perché i cinque terroristi – Roberto Ognibene,
Fabrizio Pelli, Susanna Ronconi, Giorgio Semeria e Martino Serafini – non
uccidono i più pericolosi eredi di Benito Mussolini. Giralucci ha 29 anni, fa
l’agente di commercio e vende articoli idraulici e sanitari. Missino sin da
ragazzo, aveva rischiato la pelle per rubare una bandiera rossa durante una
manifestazione del Pci. Lascia la moglie Bruna e la figlia Silvia di appena 3
anni. Mazzola, invece, ha 60 anni ed è un ex carabiniere. Più che missino, è
monarchico. Una vita dedicata all’Arma, impegnato nel Movimento Sociale Italiano
con compiti di contabilità e archivio. Lascia la moglie Giuditta e 4 figli. “Non
era assolutamente nostra intenzione ucciderli”, la difesa del brigatista
Ognibene, ma i fori di proiettile sulla tempia di Giralucci e sulla nuca di
Mazzola raccontano un’altra verità: le prime di una lunga serie di esecuzioni.
“Nessuna fascista può più considerarsi sicuro”, è
la promessa delle Brigate Rosse nei primi volantini, con l’ambizione di portare
l’attacco al cuore dello Stato. La preoccupazione cresce, c’è paura nell’aria.
Il sangue scorre a fiumi ormai e tutti temono di essere bersagli, sia prime
linee che timidi simpatizzanti. Anche le commemorazioni dei caduti possono
diventare teatro di offensive e controffensive, di guerriglie urbane: la seconda
metà degli anni Settanta è un vero e proprio bagno di sangue. Il 28 febbraio del
1975 a Roma un’altra esecuzione, vittima lo studente universitario Mikis
Mantakas. Militante del FUAN in Italia da cinque anni, il greco biondo e dagli
occhi azzurri era nella Capitale da un anno: prima abitava a Bologna, dove era
stato aggredito di fronte di fronte all’istituto di Biologia per motivi
politici: totale di 40 giorni di prognosi. Mikis è figlio di un generale in
pensione, che durante la guerra ha guidato le truppe partigiane contro il
nazifascismo. Anche la madre è antifascista, fiera oppositrice del regime. Il
giovane aveva idee lontane da quelle dei suoi genitori e si era avvicinato alla
destra. Una scelta costata la vita: quel maledetto 28 febbraio del 1975 viene
raggiunto da due proiettili davanti alla sede del Msi di via Ottaviano nel corso
degli scontri avvenuti nelle strade durante il processo agli imputati accusati
del rogo di Primavalle. Tanti, tantissimi missini ai suoi funerali. Presente
anche Almirante, che al termine della messa improvvisa un discorso a
braccio: "Questo non è un comizio, questo è un rito. Ed io voglio dire a tutti
voi una cosa molto semplice. In passato vi ho invitato a rifiutare la logica
dello scontro e della violenza, e neppure in questa occasione io pronuncio la
parola vendetta. Ma non pronuncio certamente parole di rassegnazione o di
colpevole oblio, bensì di fierezza e di orgoglio. Dopo questo morto vi dico che
o lo Stato ci difende, o i cittadini hanno il dovere e il diritto di difendersi
da soli. E a questo punto, temo, dobbiamo difenderci da soli".
Milano. Il 29 aprile del 1976 Enrico Pedenovi è
atteso alla commemorazione di Sergio Ramelli – morto un anno prima a causa
dell’odio rosso – per pronunciare il discorso di commemorazione. Avvocato ed ex
militare della Decima Mas, Pedenovi è considerato uno dei volti più moderati del
MSI milanese. Sicuramente non è un estremista, uno pronto a imbracciare pistole
e fucili per sostenere le sue ragioni. Pedenovi quella mattina esce di casa poco
prima delle 8.00, sale sulla sua Fiat 128 bianca e si ferma subito dal benzinaio
per fare il pieno. Ma ad attenderlo ci sono i terroristi: un commando di Prima
Linea scende da una Simca 1000 e apre il fuoco. Crivellato di colpi – cinque
colpi tutti al torace – per il consigliere regionale missino non c’è niente da
fare. Un attentato in piena regola, seppur mai rivendicato: Pedenovi era stato
individuato come vittima “facile” della lista di militanti neofascisti firmata
Lotta Continua, la sua fine in “risposta” alla morte del giovane di sinistra
Gaetano Amoroso. Il missino lascia le due figlie Gianna e Beatrice,
rispettivamente di 22 e 11 anni.
Roma è sempre stata al centro della guerra tra
fazioni opposte. Negli anni Ottanta le uccisioni brutali di Angelo Mancia e
Nanni De Angelis, tra gli altri, ma uno dei casi più truculenti risale alla fine
degli anni Settanta. Il 7 gennaio del 1978 il dramma ricordato come la strage di
Acca Larenzia. Gli attivisti missini Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta – 18
e 19 anni, la stessa età di Stefano Cecchetti, trucidato un anno più tardi dai
“Compagni organizzati per il comunismo” – vengono trucidati davanti alla sede
del Movimento Sociale Italiano di via Acca Larenzia, quartiere Tuscolano. I due
giovani cadono sotto i colpi delle armi automatiche imbracciate dai criminali di
estrema sinistra dei Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale. Poche ore
dopo, negli scontri con le forze dell’ordine, cade un terzo attivista, il
ventenne Stefano Recchioni, morto dopo due giorni di agonia. L’arma utilizzata
per l’assalto, una mitragliatrice Scorpion, verrà trovata qualche anno più tardi
in un covo delle Brigate Rosse a Milano: sarà utilizzata per uccidere
l'economista Ezio Tarantelli, l'ex sindaco di Firenze Lando Conti e il senatore
della Democrazia Cristiana Roberto Raffili.
Spedizioni punitive, con i rossi a caccia di
fascisti senza bersagli predeterminati. Spranghe e/o pistole a portata di mano
per riservare trattamenti “meritati” al nemico nero. La situazione peggiora
radicalmente dopo il 1980, con la strage alla stazione di Bologna. Il Movimento
sociale viene relegato in un angolo come partito antisistema, nel mirino di
antifascisti democratici e non. I sospetti di coinvolgimenti con i terroristi di
estrema destra sono forti, tanto da spingere Almirante a una presa di posizione
categorica: “Per noi i terroristi sono nemici della comunità civile. Per noi chi
combatte la civiltà, chi spara, chi uccide cittadini disarmati o pubblici
ufficiali in servizio, merita a sua volta la pena di morte. E se costui è un
terrorista nero, il discorso per noi non cambia, anzi: merita, se possibile, una
doppia pena di morte”. Nessuna acquiescenza, al punto da lanciare un’iniziativa
destinata a sollevare un putiferio.
L’ultimo militante missino tramortito dalla
violenza dell’estrema sinistra è Paolo Di Nella, studente capitolino e iscritto
al Fronte della Gioventù prima di diventare adolescente. Capelli lunghi e
occhiali a goccia, missino radicale e intransigente, il ventenne è grande amico
di Gianni Alemanno. Un ragazzo forte, molto disponibile e sempre pronto a dare
una mano agli altri, ma anche tranchant dal punto di vista politico, tanto da
finire in manette per un’azione dimostrativa contro la sede diplomatica
dell’Unione sovietica per il colpo di Stato di Jaruzelsky. Sono anni ancora più
difficili dei precedenti, lo sanno bene tanti politici che oggi ricoprono ruoli
di primo piano come Antonio Tajani e Maurizio Gasparri. Spinto anche da un’anima
ecologista, Paolo è molto attivo, tanto da disegnarsi da solo i manifesti con
pennello e vernice nera. “Lotta di quartiere per il verde pubblico! Fronte della
gioventù”, uno degli slogan più utilizzati. È proprio un manifesto a costagli la
vita, uno striscione per l’acquisizione pubblica di Villa Chigi: Paolo viene
pizzicato ad attaccarlo in viale Libia la sera del 2 febbraio 1983 e viene
aggredito alle spalle con spranghe di ferro da . Il giovane perde sangue ma non
si sente subito male, tanto da tornare a casa. Nel cuore della notte, i lamenti
allarmano i suoi genitori: il medico di famiglia dispone immediatamente il
ricovero, con trasporto al Policlino Umberto I. Dopo tre giorni di agonia, la
morte. Tanti gli attestati di solidarietà, da Pertini a Berlinguer, altrettanti
i messaggi di condanna per l’ennesima brutalità rossa. Nonostante la voglia di
vendetta degli amici militanti di Paolo, nessuna rappresaglia: la sua scomparsa
segna la parola fine al tempo delle faide.
Il rogo di Primavalle e quella sinistra
omertosa come un clan. Cinquant’anni fa morivano Virgilio e Stefano Mattei,
figli del segretario locale del Msi: una strage negata dal furore ideologico e
dai depistaggi. Daniele Zaccaria su Il Dubbio il 17 aprile 2023
Il volto di Virgilio Mattei, 22 anni, che si
affaccia dalla finestra della sua camera da letto, terrorizzato, stravolto e
tumefatto dalle fiamme che stanno per divorarlo assieme al fratellino Stefano, 8
anni, è una delle immagini più orrende degli anni di piombo. Un’istantanea sulla
ferocia quella guerra senza quartiere tra rossi e neri che insanguinò le città
italiane per oltre un decennio e che oggi compie mezzo secolo.
Venne “catturata” dal fotografo di cronaca nera
Antonio Monforte, un professionista bravissimo che due anni dopo immortalò
un’altra tragica vicenda degli anni 70: i carabinieri che estraggono dal
bagagliaio di una 127 Donatella Colasanti, sopravvissuta per miracolo al
massacro del Circeo.
È il 1973, quartiere Primavalle, periferia
nord-ovest di Roma, una distesa di lotti disadorni, uno dei sobborghi più poveri
e difficili della capitale; i Mattei sono la classica famiglia proletaria,
vivono in otto in 50 mq, stipati come sardine: Mario, 47 anni fa il netturbino,
Annamaria è casalinga, hanno sei figli. Mario Mattei però è anche il segretario
della sezione locale del Msi “Giarabub” (il villaggio libico teatro dell’omonima
battaglia del1940 tra la decima armata italiana e gli anglo-australiani),
un’isola nera in un quartiere rosso, un «covo di fascisti» per gli
extraparlamentari di sinistra che lo avevano minacciato più volte.
Volevano proprio dargli una bella lezione a Mario
Mattei quella sera. Achille Lollo Marino Clavo e Manlio Grillo, militanti di
Potere operaio, arrivano a via Bibbiena che è notte fonda, hanno con sé una
tanica riempita con dieci litri di benzina, diserbante e zucchero più una
miccia, fanno scivolare il liquido sotto la porta dei Mattei, accendono il fuoco
e poi scappano via di corsa.
L’incendio divampa subito nell’ingresso e quando
dall’interno aprono la porta in preda al panico per trovare una via di fuga lo
sbuffo d’aria spinge le fiamme con violenza verso le camere da letto; tutto si
consuma in pochi minuti, forse meno, per Virgilio e Stefano non c’è niente da
fare. Sul marciapiede davanti alla palazzina Lollo, Calvo e Grillo hanno
lasciato la rivendicazione, un biglietto che recita testuale: “Brigata Tanas –
guerra di classe – Morte ai fascisti – la sede del MSI – Mattei e Schiavoncino
colpiti dalla giustizia proletaria”. La Brigata Tanas era un gruppuscolo
semiclandestino che si muoveva in piena autonomia all’interno di Pot op,
prendeva il nome da Giuseppe Tanas, operaio comunista ucciso dalla polizia nel
1947 durante una manifestazione della Cgil che si tenne proprio nelle strade di
Primavalle.
È plausibile che il commando non volesse uccidere
i figli di Mattei pur accettandone il rischio, come stabilirono i giudici che
hanno condannato i tre per omicidio preterintenzionale: doveva essere un’azione
dimostrativa che poi è terminata in una tragedia.
Quel che impressiona di nel caso del rogo di
Primavalle non è solo la violenza dei fatti, la fatale sequenza di eventi che ha
portato alla morte di Virgilio e Stefano, o il fatto che gli attentatori fossero
per paradosso dei ragazzotti della borghesia romana mentre le vittime dei “figli
del popolo”, ma la cupa ondata negazionista cavalcata da molti esponenti della
sinistra: di fronte alla morte di due ragazzi arsi vivi nel proprio letto, hanno
infatti reagito con la stessa sprezzante omertà di un clan mafioso, infamando e
depistando.
Già il depistaggio, un metodo in voga tra le fila
della destra eversiva legata ai servizi deviati e alle cosiddette trame di Stato
che per una volta viene usato dai “compagni”. La tesi è un classico del genere:
il rogo di Primavalle sarebbe una questione interna ai fascisti, un regolamento
di conti nel Msi, mentre il fuoco sarebbe stato acceso addirittura dall’interno
dell’appartamento. Esposta con zelo nell’opuscolo di controinchiesta (sic)
curato dallo stesso Potere operaio dal titolo Primavalle, incendio a porte
chiuse.
Sentite cosa scriveva il collettivo di «militanti»
e «giornalisti democratici» che ha lavorato al caso: «La montatura sull'incendio
di Primavalle non si presenta come il risultato di un meccanismo di provocazione
premeditato a lungo e ad alto livello, tipo strage di stato. “Primavalle” è
piuttosto una trama costruita affannosamente, a caldo da polizia e magistratura,
un modo di sfruttare un'occasione per trasformare un "banale incidente" o un
oscuro episodio - "nato e sviluppatosi nel vermicaio della sezione fascista del
quartiere"».
In poche parole un improvvisato complotto di
polizia e magistratura per far scattare la repressione contro la sinistra
extraparlamentare. Anche il Manifesto insinua dubbi in un articolo pubblicato
due giorni dopo la strage: «Secondo un nostro informatore la tanica di banzina
non stava sul pianerottolo ma dentro la casa. Inoltre la stanza di Virgilio era
completamente devastata come se l’incendio avesse avuto lì il proprio epicentro
Forse un’esplosione?». L’inchiesta giudiziaria affidata sostituto procuratore
Domenico Sica e le sentenze successive della Corte d’appello di Roma e della
Corte di Cassazione (1987) non hanno mai preso in considerazione la pista
“interna” priva di ogni fondamento, confermando senza grandi dubbi le
responsabilità di Lollo, Calvo e Grillo condannati a 18 anni come autori
materiali della strage.
Nel frattempo Lollo, rimesso in libertà in attesa
del processo di primo grado, era riuscito a lasciare l’Italia, rifugiandosi in
Brasile grazie all’aiuto di Soccorso rosso e a una robusta campagna
“innocentista”, tra le personalità più attive Franca Rame che offre a Lollo del
denaro per fuggire dal paese e poi scrive al presidente della Repubblica
Giovanni Leone una lettera intrisa di complottismo e furore ideologico: «Cosa mi
dice presidente della misteriosa telefonata fatta dal padre dei due ragazzi
morti immediatamente dopo l’incendio a un tuttora misterioso personaggio? E la
telefonata del confidente della polizia, fascista, come ogni confidente della
polizia che si rispetti? Gli inquirenti poi non hanno spiegato come sia entrata
la benzina in casa dal momento che la porta era chiuse».
Meloni ricorda i fratelli Mattei. "Ora
pacificazione". Silenzio da Pd & C. Vergogna Scalzone. Sono trascorsi 50
anni dal rogo di Primavalle, uno degli episodi più crudeli e spietati degli anni
di piombo, immortalato da una fotografia che ancora urla alle coscienze e
racconta di una barbarie disumana e incomprensibile. Fabrizio De Feo su Il
Giornale il 17 Aprile 2023
Sono trascorsi 50 anni dal rogo di Primavalle, uno
degli episodi più crudeli e spietati degli anni di piombo, immortalato da una
fotografia che ancora urla alle coscienze e racconta di una barbarie disumana e
incomprensibile. La morte di un ragazzo di 22 anni e di suo fratello, un bimbo
di 8 anni, Virgilio e Stefano Mattei, imprigionati dalle fiamme e ritrovati
abbracciati e carbonizzati per un incendio appiccato dalla Brigata Tanas di
Potere Operaio per colpire il segretario della sezione del Msi, è scolpita nella
memoria. Ieri in occasione di quella ricorrenza il mondo politico è tornato a
riflettere su quell'episodio, con Giorgia Meloni che ha inviato un messaggio
sentito a Giampaolo Mattei, presidente dell'associazione Fratelli Mattei.
Pensieri e parole vengono però espressi nella quasi totalità da esponenti del
centrodestra. Le uniche voci che si alzano a sinistra per ricordare l'episodio
sono quelle del senatore del Pd Walter Verini - che già ne aveva parlato
nell'aula di Palazzo Madama - e di Miguel Gotor.
Scrive Giorgia Meloni: «Erano gli anni dell'odio,
come ha correttamente sottolineato il senatore Verini in Senato. Le cicatrici
delle profonde ferite subìte ne sono il segno concreto e, spesso, tornano a far
male. Non possiamo cancellare la storia o chiedere alle famiglie delle vittime
di dimenticare. Non possiamo restituire la vita ai troppi giovani che l'hanno
sacrificata a un'ingiusta violenza. Quello che possiamo fare è tenere viva la
memoria e condurre l'Italia verso una piena e vera pacificazione nazionale».
Roma ieri ha ricordato il rogo di Primavalle con
corone di fiori e un francobollo celebrativo. Il presidente della Regione Lazio,
Francesco Rocca, ha deposto una corona d'alloro e tre corone di fiori sul luogo
della strage. Insieme a lui l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor,
il ministro Gennaro Sangiuliano, Fabio Rampelli e Maurizio Gasparri. Presente
anche la sorella di Virgilio e Stefano, Antonella Mattei. In Campidoglio,
invece, va in scena la cerimonia organizzata dall'Associazione Fratelli Mattei.
Ed è qui che Verini prende la parola: «Ricordare Stefano e Virgilio Mattei è un
dovere. Quegli anni di stragi nere e depistaggi e di insorgente terrorismo
rosso, furono anche gli anni dell'odio che vide vittime decine di ragazzi, morti
assassinati, come nemici da abbattere. A destra, come i fratelli Mattei, Paolo
Di Nella, a sinistra, come Valerio Verbano, Walter Rossi, Luigi Di Rosa e tanti
altri. Dobbiamo ricordarli tutti perché quell'odio sia cancellato per sempre,
dalla politica, dalla vita civile». Gennaro Sangiuliano a sua volta chiede di
«conquistare una sincera pacificazione nazionale», chiamando però le cose con il
loro nome. «Stefano Mattei aveva 8 anni e io dieci» dichiara. «Avremmo potuto
essere compagni di giochi, io ho avuto una vita, a lui è stata strappata in
maniera violenta, crudele e atroce. E questo per un atto di violenza comunista».
Ma a cinquant'anni dal Rogo di Primavalle c'è
ancora chi sostiene che quella strage in cui morirono arsi vivi due ragazzi fu
«un incidente». L'Adnkronos raggiunge l'ex brigatista Francesco Piccioni che
boccia come «propaganda» le affermazioni del presidente del Consiglio. Il
motivo? «Primavalle fu più un incidente che una manifestazione d'odio, dunque
quella della Meloni è propaganda». Sulla stessa falsariga Oreste Scalzone,
co-fondatore di Potere Operaio. «Queste frasi altisonanti della Meloni possono
anche portarle un successo ma sono una moneta falsa». Parole che suscitano la
reazione durissima del capogruppo di Fdi Tommaso Foti. «Offendere, 50 anni dopo
il loro assassinio, la memoria dei fratelli Mattei non è tollerabile: anche da
sinistra qualcuno dica ai vari Scalzone e Piccioni che fanno schifo».
Missini che tornano. Il ricordo dei fratelli
Mattei è l’ennesima occasione mancata di una memoria comune. Mario Lavia su
L'Inkiesta il 17 Aprile 2023
Il cinquantesimo anniversario della strage di
Primavalle poteva essere il pretesto per fare un discorso nuovo e più avanzato,
come ha fatto Verini del Pd, ma è stato invece solo l’ennesimo momento di
risentimento e di rivalsa della destra che mostra la voglia di regolare i conti
mezzo secolo dopo
Purtroppo il cinquantesimo anniversario
della morte dei fratelli Mattei, bruciati vivi il 16 aprile 1973 nella loro casa
di Primavalle per mano di tre proto-terroristi di Potere Operaio, è stata
un’occasione mancata. Le celebrazioni sembravano manifestazioni dei militanti
del Movimento sociale italiano, il partito neofascista cui apparteneva il più
grande dei fratelli Mattei (l’altro era un bambino), sciolto ormai 30 anni fa
quando Gianfranco Fini dette vita ad Alleanza Nazionale.
È doveroso notare che a parte il senatore dem
Walter Verini, che ha partecipato alla cerimonia in Campidoglio, e all’assessore
alla cultura del Comune di Roma Miguel Gotor, che si è recato alla cerimonia a
Primavalle con la fascia tricolore, la sinistra in tutte le sue componenti ha
brillato per la sua assenza. E non ci risulta che gli ex terzopolisti,
evidentemente troppo impegnati a elaborare il loro “lutto”, abbiano dedicato
qualche riflessione su quei fatti.
Detto questo, è stata la giornata del Msi. Una
giornata che, esaltando un antico riflesso militante, ha teso a dividere. Il
ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha parlato della «violenza
comunista», giocando come cinquant’anni fa su un termine che associa Potere
Operaio e Umberto Terracini, presidente di quella Costituente ove sedeva il suo
gran riferimento culturale Benedetto Croce: lui lo sa bene ma l’essere un
ministro della Repubblica non è dunque per lui uno scrupolo per vietarsi di fare
della propaganda pure piuttosto polverosa.
Abbiamo visto dichiarazioni dell’immancabile
Maurizio Gasparri, quelle ardite di Fabio Rampelli («Quel giorno ho giurato che
avremmo conquistato la vittoria»), abbiamo visto un tweet di altri tempi di
Francesco Storace («Onore a Stefano e Virgilio»). Missini che tornano, e in
fondo ci sta. Questi sono fatti così.
Il problema è un altro. E si chiama Giorgia
Meloni, la presidente del Consiglio, in questa fase la persona politicamente più
importante e seguita del Paese. Ebbene, Meloni poteva fare meglio. Il suo
comunicato, ecco, lo avrebbe potuto fare un Gasparri qualunque. Il problema non
è quello che c’è scritto. Il problema è quello che non c’è scritto. Perché è
chiaro che bisogna far sì che «non ci siano più nemici da abbattere o da
distruggere, ma soltanto avversari, con i quali confrontarsi civilmente e nel
riconoscimento reciproco».
E questo c’è scritto nel comunicato dalla premier.
Quello che non c’è però è la totale rimozione del fatto che la ricostruzione di
una memoria unitaria o condivisa che dir si voglia è possibile grazie al terreno
comune della democrazia e che questo terreno comune, questa koiné democratica,
l’Italia la deve alla sua Costituzione edificata sul valore dell’antifascismo. E
che pertanto – se dicesse questo Meloni sarebbe davvero una leader nazionale nel
senso pieno del termine – il 25 aprile sarebbe l’occasione perfetta non per una
«pacificazione» che sa tanto di «assoluzione» dei misfatti del Ventennio e dei
suoi seguaci, ma per una grande operazione di verità e di «pulizia della
memoria» dalle incrostazioni dei decenni.
Il cinquantesimo anniversario della orrenda morte
dei fratelli Mattei dunque poteva essere l’occasione per fare un discorso nuovo
e più avanzato, ed è stato invece solo l’ennesimo momento di risentimento e
rivalsa di quella parte politica che mostra la voglia di regolare i conti –
mezzo secolo dopo – più che recuperare il valore morale della memoria.
Anni dell’odio. La memoria
selettiva di Fratelli d’Italia e l’ambiguo disagio sul 25 aprile.
Mario Lavia su L’Inkiesta il 15 Aprile 2023
Il senatore Verini del Pd ha
ricordato solennemente l’orrendo rogo di Primavalle, durante il quale tre
estremisti di Potere operaio bruciarono vivi due figli di un militante Msi.
Questo dimostra che la sinistra ha fatto i conti col passato, mentre i
sovranisti al governo faticano a ricordare con imparzialità le vittime causate
dall'estrema destra. Un atteggiamento immaturo che rischia di rovinare la Festa
della Liberazione
Domani, 16 aprile, ricorrono i
cinquant’anni di un episodio tra i più schifosi degli anni di piombo, l’omicidio
dei fratelli Mattei a Primavalle (allora era una borgata di Roma), bruciati vivi
nella loro casa per mano di tre delinquenti, militanti di Potere Operaio. I
fatti vanno ricordati nella loro crudezza. C’è una famosa, terrificante,
fotografia che ritrae una figura carbonizzata affacciata a una finestra, una
statua lugubre, quello era Virgilio Mattei, di ventidue anni, che insieme al
fratello Stefano, di otto, morì bruciato vivo aggrappato al davanzale della sua
casa al terzo piano, scala D, nel complesso di edifici popolari di via Bernardo
da Bibbiena 33, Primavalle, Roma.
I tre disgraziati di Potere
Operaio avevano gettato sotto la porta della benzina con un primordiale innesco,
poi dissero che volevano solo spaventarli, qualcosa non funzionò, scapparono
come ladri quando divampò l’incendio mentre i due Mattei cercavano aria dalla
finestra via via prendendo fuoco, la gente accorsa per strada – era notte fonda
– gli strillava di buttarsi, ma era troppo tardi per sfuggire a una morte
assurda e spaventosa.
La loro “colpa” era quella di
essere figli di Mario Mattei, segretario della sezione “Giarabub” del Movimento
sociale italiano a Primavalle, anche Virgilio era militante del Msi. Gli altri
figli si salvarono. Gli assassini si chiamavano Achille Lollo, Marino Clavo e
Manlio Grillo, il primo è morto due anni fa, gli altri scapparono facendola
franca. Storie di mezzo secolo fa. Gli estremisti di “Potop” per molto tempo
inventarono la storia di una faida tra “fascisti”: non era vero ma la dice lunga
su quegli ambienti.
E siamo qui nell’Italia del
2023 – eravamo piccoli, siamo diventati anziani – a parlare di queste cose. Come
se negli anni Cinquanta si fosse ancora discusso su Bava Beccaris o
dell’attentato di Sarajevo. E però ha fatto bene il senatore del Pd Walter
Verini a parlarne nell’aula di palazzo Madama davanti al presidente del Senato
Ignazio La Russa, colui che ha spacciato, salvo poi scusarsi dinanzi
all’indignazione generale, i nazisti di via Rasella per una banda musicale di
pensionati. Verini ha rievocato quel misfatto degli «anni dell’odio che non
devono più tornare» e ha richiamato la necessità di una memoria unitaria,
raccogliendo alla fine il plauso di tutta l’aula e persino parole di
apprezzamento da parte di La Russa.
Ma il punto è proprio questo.
Mentre la sinistra, non senza una lunga e faticosa revisione ideologica e
storica, ha infine riconnesso memoria e verità, scarnificato ogni residuo
scheletro e debellato ogni orpello minimizzatore, la destra (quella destra che
viene dalla vicenda del neofascismo) non appare ancora in grado di affondare il
bisturi della verità nella carne viva della sua storia, come se ogni volta una
mano invisibile l’afferrasse per il bavero bloccandone il cammino verso una più
piena maturità democratica. Non c’è doppiezza, a sinistra, su quegli anni.
Peraltro la tragedia di
Primavalle fu subito condannata dal Partito Comunista – e come avrebbe potuto
essere diversamente davanti a quell’orrore -, gli assassini erano militanti di
quell’estremismo che fu progenitore del terrorismo rosso, e sono ormai passati
tanti anni da quando l’allora sindaco di Roma Walter Veltroni ospitò sullo
stesso palco, facendoli abbracciare, Giampaolo Mattei, fratello delle due
vittime, e la madre di Valerio Verbano, il ragazzo di estrema sinistra ucciso
nel 1980 davanti ai genitori.
La questione è che tuttora i
Fratelli d’Italia citano solo i “loro” morti e non gli altri, dimostrando forse
senza nemmeno rendersene conto di restare pienamente dentro la logica degli anni
dell’odio e non comprendendo che i morti sono morti di tutti: ed è esattamente
questo incredibile inciampo che gli impedisce di riconoscere la grandezza del 25
aprile, data di nascita della democrazia italiana che altro non è che il terreno
comune sul quale far coincidere memoria e verità come puntelli della libertà di
tutti e di ciascuno.
Ecco perché, a pochi giorni
dalle celebrazioni della Liberazione, alle quali non è dato sapere se e come i
capi di Fratelli d’Italia, i ministri, la presidente del Consiglio prenderanno
parte, la destra sta commettendo il suo errore forse più grave, quello appunto
di mostrarsi malferma nell’incedere tra memoria e verità. Come se il tempo si
fosse fermato dinanzi alle fiamme di quella lugubre notte di Primavalle.
Martiri di serie B perché di destra: i ventuno
omicidi tenuti nell'oblio dalla gauche. Stefano Zurlo su Il Giornale il 17
Aprile 2023
Non lo sa quasi nessuno, ma la storia di sangue
delle Brigate rosse comincia con l'uccisione di due militanti missini
Non lo sa quasi nessuno, ma la storia di sangue
delle Brigate rosse comincia con l'uccisione di due militanti missini. È il 17
giugno 1974, una data cupa e dimenticata, come tutte quelle dei morti dalla
parte sbagliata. Quel giorno un commando entra nella sede del MSI a Padova e
trova due militanti, Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola, che rifiutano di
inginocchiarsi e lasciarsi incatenare e per questo vengono brutalmente
assassinati.
È l'incipit della Spoon River compiuta dai
terroristi con la stella a cinque punte, ma la tragedia viene minimizzata,
annacquata, infine capovolta.
I morti dalla parte sbagliata sono sempre visti
con sospetto o fastidio e i giornali fanno di tutto per accreditare versioni
diverse: forse, si scrive in quelle ore ormai lontane, i due sono morti per una
faida nera interna alla destra, forse chissà. E i brigatisti, anche se
rivendicano l'azione, sono sempre i compagni che sbagliano.
Va così, va sempre così, è andata così anche
l'anno prima, il 16 aprile 1973, quando i due fratelli Mattei muoiono bruciati
nel rogo della loro casa, incendiata da un gruppetto di attivisti di Potere
Operaio. Una fine spaventosa, ma anche la verità viene messa in fuga: i vertici
di Potere Operaio capiscono subito cosa è successo, ma la controinformazione fa
la sua parte, scrittori e intellettuali difendono gli imputati che alla fine
vengono faticosamente condannati e le prime ammissioni arriveranno solo a
distanza di più di trent'anni dai fatti.
Un omicidio è la chiave di un altro delitto, in
una catena di violenze senza fine: nel 1975 Sergio Ramelli, studente al Molinari
di Milano, scrive un tema in cui attacca il mondo politico che ha snobbato, per
non dire peggio, la morte di Giralucci e Mazzola l'anno prima.
La prova viene letta da un professore in pubblico
e poi quei fogli finiscono in bacheca. Esposti all'odio di compagni e professori
che non possono accettare quella voce fuori dal coro, solidale con l'altra
parte.
Qualcuno decide di dare una lezione al giovane
militante del Fronte della Gioventù. Il 13 marzo 1975 Ramelli viene aggredito
per strada, nel quartiere di Città Studi. Le spranghe di Avanguardia Operaia
colpiscono il ragazzo che cerca di scappare, ma non ce la fa e cade tramortito
sul marciapiede. La morte arriva il 29 aprile 1975, dopo 47 giorni di atroci
sofferenze e ulteriori minacce ai familiari. Siamo al punto, incredibile, che i
funerali si svolgono in forma semiclandestina, in un clima di paura e tensione.
È la Milano degli anni Settanta: i morti di là,
quelli di sinistra, avvolti nell'epopea della nuova Resistenza, quelli di destra
sepolti nel buio frettoloso di un generale disprezzo.
Luca Telese, giornalista acuto e non ideologico,
ha raccontato in «Cuori neri» 21 delitti che per lungo tempo erano stati rimossi
perché politicamente scorretti, da Primavalle a Ramelli, dalla morte di Ugo
Venturini a quella di Paolo Di Nella. Un libro di successo che ha svelato un
pezzo di storia italiana.
Ugo Venturini, centrato da un sasso a Genova
durante un comizio di Almirante il 18 aprile 1970, è una delle prima vittime
nere di quella stagione senza misericordia; Paolo Di Nella, colpito mentre
attaccava manifesti, è una delle ultime il 9 febbraio 1983, a Roma.
In mezzo c'è la strage di Acca Larentia, due
ragazzi falciati davanti alla sezione del MSI del Tuscolano, nella capitale, il
7 gennaio 78, un terzo, Stefano Recchioni, morto nelle ore successive negli
scontri con la polizia. Questa volta, però, il Pci di Enrico Berlinguer dà la
sua solidarietà senza distinzioni di colore.
Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta vengono
abbattuti dai colpi di una mitraglietta Skorpion dalla storia singolare: era
stata acquistata da Jimmy Fontana, il cantante, poi ricomparirà in un covo delle
Br e si scoprirà che ha firmato tre delitti pesantissimi nell'ultima stagione
dell'eversione: quelli di Ezio Tarantelli, Lando Conti e Roberto Ruffilli.
Ancora una volta la piazza è l'anticamera della
lotta armata.
"A sinistra c'è chi tace per ignoranza e chi
resta il 'cattivo maestro' di ieri". Intervista a Luca Telese, autore di
'Cuori neri'. "È ancora vivo un antifascismo stupido. Occorre una memoria
comune, entrambe le parti facciano un passo verso l'altro". Luigi Mascheroni su
Il Giornale il 17 Aprile 2023
Luca Telese sui delitti degli anni di piombo, dal
rogo di Primavalle alla morte di Ramelli, ha scritto un libro, Cuori neri, che
dal 2006 è continuamente ripubblicato (Sperling e Solferino).
Come reagì la sinistra, allora, al rogo di
Primavalle?
«Erano gli anni in cui uno degli slogan della
sinistra extraparlamentare era "Uccidere un fascista non è reato", e anche tra
politici e intellettuali serpeggiava il retropensiero che se ci scappava un
morto, "Un po` se l`era cercata". Primavalle è la quintessenza di quell`habitus
mentale. Uscì un pamphlet - esempio estremo di "denegazione" di responsabilità
di una certa sinistra - intitolato Primavalle: incendio a porte chiuse in cui si
sosteneva che i Mattei non erano solo fascisti brutti sordidi e cattivi che
meritavano di morire, ma che erano anche imbroglioni perché si erano bruciati
loro, da dentro...».
A parte poche voci - il senatore Pd Verini e
l`assessore alla Cultura di Roma Miguel Gotor, la sinistra di oggi tace.
«Credo che sia prima di tutto per ignoranza dei
fatti. Gotor è uno storico serio e Verini un politico veltroniano che conosce le
cose. Ma gli altri? Ma tu pensi che Elly Schlein conosca il rogo di Primavalle?
È svizzera, non è nel suo background. Gli anni di piombo furono prima una
guerra, poi divennero una battaglia culturale; oggi sono finiti nell`oblio».
E i cattivi maestri di ieri che sono gli
intellettuali di oggi?
«Sono gli extraparlamentari alla Sofri che ieri
contestavano il Pci dicendo che era amico dei fascisti perché non voleva mettere
fuori legge l`Msi, e oggi anche se hanno i capelli bianchi e sono diventati
socialriformisti la pensano allo stesso modo: nessun concessione a chi per loro
resta un fascista e basta».
La sinistra è ossessionata dall`antifascismo,
anche se sulle pagine buie della propria storia tende a glissare.
«È l`antifascismo stupido come quello dei
condomini di Padova che nel 2006 si opposero all`affissione di una lapide sul
muro del palazzo dove nel 1974 furono uccisi Giuseppe Mazzola e Graziano
Giralucci: il primo omicidio delle Br. Per tre anni la targa - tipica soluzione
all`italiana - fu appesa a un palo, a due centimetri dal muro. Certo, poi, alla
riappacificazione non aiuta la destra quando dice che a via Rasella furono
uccisi dei musicisti pensionati? Peccato perché proprio La Russa invece nel 2022
disse in Senato una cosa giusta: che Ramelli da una parte e i due militanti del
Leoncavallo Fausto e Iaio dall`altra erano vittime - davanti alle quali si
inchinava - della stessa stagione di violenza».
Giorgia Meloni commemorando la strage di
Primavalle ha sottolineato la necessità di «condurre l`Italia verso una piena
pacificazione nazionale». Come ci si arriva?
«Colmando quei due centimetri tra il palo e il
muro. Quelli che separano la vera riappacificazione dall`ipocrisia. Sono due
centimetri, un passo per uno: Meloni festeggi il 25 aprile, e la sinistra
riconosca ai Ramelli e i Mattei la dignità di vittime del terrorismo - cioè di
una ideologia assassina - né più né meno delle proprie. La riappacificazione
deve costare a entrambe le parti qualcosa».
Una memoria condivisa o comune?
«Comune. Condivisa significa che abbiamo la stessa
idea dello stesso fatto, ed è impossibile. Comune significa che non ti chiedo di
condividere le ragioni di chi è morto, ma di accettare l`idea che non meritava
di morire».
L’attentato ai Mattei e il
successivo depistaggio. Rogo di Primavalle, pagina nera della sinistra.
David Romoli su L'Inchiesta il 16 Aprile 2023
Tra le immagini degli anni
70 nessuna registra il versante atroce di quell’epoca più della foto scattata la
notte del 16 aprile 1973, poco dopo le 3,dal fotografo di nera Antonio
Monforte di fronte a una casa popolare in via Bernardo da Bibbiena 33 nel
quartiere di Primavalle, periferia di Roma. È l’istantanea di un ragazzo di 22
anni, Virgilio Mattei, militante dei Volontari nazionali del Msi, affacciato
alla finestra del terzo piano mentre l’appartamento alle sue spalle brucia.
Il volto del ragazzo è già
annerito e deformato dall’incendio. Non si butta, come lo esorta a fare la folla
radunatasi di fronte alla casa in fiamme, perché non vuole abbandonare il
fratello di 8 anni Stefano. Quando il bimbo si accascia alle sue spalle ci prova
ma ormai è troppo tardi. Li ritroveranno carbonizzati e abbracciati.
L’appartamento è di Mario Mattei, 47 anni, ex netturbino, ex militare
della Repubblica di Salò, per tre anni prigioniero di guerra negli Usa,
segretario della sezione del Msi di Primavalle “Giarabub”. È una casa piccola,
meno di 50 mq, e ci abitano in 8. Quando l’incendio è divampato, partendo dalla
porta principale, Mattei ha provato a spegnerlo con due bottiglie di schiumogeno
ed è riuscito a creare un varco attraverso il quale è riuscita a passare la
moglie Annamaria con due figli, Antonella e Giampaolo, di 9 e 3 anni. Ustionato,
Mattei si butta dal balcone e da terra riesce a prendere la figlia Lucia, 15
anni, attutendo la caduta.
Un’altra figlia, Silvia, 19
anni, si salva saltando dalla veranda della cucina: i fili tesi per asciugare il
bucato al piano di sotto rallentano il salto, se la cava con qualche frattura.
Restano Virgilio e Stefano, imprigionati dalle fiamme, e non si salvano. Muoiono
bruciati sotto gli occhi di decine di persone. Sembra un incidente fatale,
invece si rivela subito un attentato. Di fronte alla porta del palazzo c’è un
cartello: “Brigata Tanas. Guerra di classe. Morte ai fascisti. La sede del Msi,
Mattei e Schiavoncino colpiti dalla giustizia proletaria”. Tanas è un operaio
ucciso dalla polizia nel 1947. Schiavoncino, come si chiama davvero, il
vicesegretario della sezione “Giarabub”.
La Brigata Tanas è composta da
militanti della sezione Primavalle di Potere operaio che agivano però senza che
l’organizzazione ne fosse al corrente. Uno di loro, Manlio Grillo, da Managua
dove ancora vive, ha dichiarato una quindicina d’anni fa che il gruppo era in
contatto con le Br, era “in prova”, ma la dichiarazione è dubbia dal momento che
la colonna romana delle Br non si formerà prima del 1975. Non tutto è chiaro
nella dinamica della tragedia ma si può dire con certezza che gli attentatori
non intendevano uccidere. Lo stesso Grillo rimase a fare il palo in macchina,
altri due attentatori, Marino Clavo e Achille Lollo, trasportarono l’ordigno
artigianale di fronte alla porta di casa Mattei.
Era una “Lilli”, come si
definiva all’epoca: una tanica con dentro dai 2 ai 10 litri di benzina e un
combinato di acido solforico, diserbante e zucchero dentro due preservativi come
innesco. Secondo la versione di Lollo, in un’intervista del 2005, il
preservativo si ruppe e i due della Tanas fuggirono ma senza spargere la benzina
sotto la porta dell’appartamento. Quella benzina però fu sparsa e prese fuoco,
determinando l’incendio fatale.
Essendo accertato che l’azione
doveva essere solo dimostrativa non è ancora chiaro come siano andate le cose:
in compenso è evidente la follia di chi, pur senza aver messo nel conto la
tragedia, pensava di far esplodere una Lilli di fronte a un appartamento
minuscolo con 8 persone tra cui due bambini assiepate dentro, nel cuore della
notte. Nella stessa intervista Lollo rivelò anche che nel Tanas e nell’ideazione
dell’attentato erano coinvolti altri tre militanti di Potere operaio: Paolo
Gaeta, Elisabetta Lecco e Diana Perrone, figlia e nipote degli allori
proprietari del Messaggero che in un primo momento aveva fornito un falso alibi
poi ritrattato.
L’atrocità del rogo di
Primavalle è doppia: non solo l’omicidio dei due fratelli ma anche la campagna
“innocentista” che seguì e alla quale parteciparono, in buona fede, figure
come Umberto Terracini, Riccardo Lombardi, Franca Rame. Le indagini dirette dal
procuratore Domenico Sica si indirizzarono subito verso il gruppetto Tanas. Con
i dirigenti di Potere operaio i responsabili dell’attentato negarono però ogni
responsabilità. Il futuro brigatista Valerio Morucci, allora responsabile della
struttura clandestina del gruppo, non si fidò. Svolse un’indagine personale, si
convinse della colpevolezza dei militanti: convocò Clavo e minacciandolo con la
pistola carica gli estorse la verità. Morucci considerò una soluzione estrema:
l’eliminazione degli attentatori. Il leader del gruppo, Franco Piperno, lo fermò
e la decisione fu invece quella di far
espatriare Clavo e Grillo, mentre Lollo fu arrestato già il 18 aprile.
Ma Po non si limitò a questo:
avviò una campagna di controinformazione, in realtà di vero e proprio
depistaggio, con la pubblicazione anche di un libro, Primavalle: incendio a
porte chiuse, sostenendo la tesi che l’attentato fosse di matrice neofascista,
maturato in uno scontro interno al Msi tra i moderati come Mario Mattei e i
falchi. Quella campagna bugiarda coinvolse decine di migliaia di persone e non
solo di primo pelo: giornalisti, intellettuali, politici, addirittura un padre
della patria come Terracini, tutti sinceramente convinti che un delitto così
efferato potesse essere solo di matrice fascista, persino se le vittime erano
proprio “i fascisti”. Molto più della campagna contro il commissario
Calabresi, che aveva una sua origine nelle menzogne a raffica sulla morte
di Pino Pinelli, la campagna su Primavalle dovrebbe restare come monito
permanente contro l’ottusità indotta dal fanatismo ideologico.
Il processo per strage si aprì
il 24 febbraio 1975 e le prime udienze furono accompagnate da scontri continui
tra neofascisti e militanti di estrema sinistra, nel corso dei quali, il 28
febbraio, fu ucciso a rivoltellate lo studente greco e missino Mikis
Mantakas. Gli imputati vennero assolti ma la vicenda giudiziaria rimase tra le
più confuse: la corte d’appello annullò il processo perché uno dei giudici
popolari era affetto da “sindrome neuroastenica di tipo depressivo”, la
Cassazione annullò l’annullamento e dispose un processo d’appello bis che si
concluse con la condanna dei tre a 18 anni non per strage ma per incendio doloso
e duplice omicidio colposo.
Lollo, scarcerato dopo la prima
sentenza, era nel frattempo riparato in Brasile con l’aiuto di Dario Fo e Franca
Rame, tra i più attivi nella campagna innocentista. Rientrato in Italia dopo
l’estinzione della pena nel 2003, è morto a Trevignano due anni fa. Anche Marino
Clavo, mai rimpatriato, è morto qualche anno fa ma la sua scomparsa, a
differenza di quella di Lollo, è passata sotto silenzio. Nel 2010 Giampaolo
Mattei e Rina Zappelli, madre di Valerio Verbano, ucciso sotto gli occhi dei
genitori dai neofascisti nel 1980 si sono incontrati e abbracciati. Tra i tanti
episodi di quell’epoca è uno di quelli che meno dovrebbe essere dimenticato.
Ricorda che anche l’antifascismo può essere solo barbarie. David Romoli
50° anniversario dal rogo di
Primavalle: cosa accadde e chi erano i fratelli Stefano e Virgilio Mattei.
Il rogo di Primavalle si è consumato nella notte tra il 15 e il 16 aprile del
1973. Sono passati 50 anni dalla tragedia. Chiara Nava su Notizie.it il 16
Aprile 2023
50 anni fa, nella notte tra il
15 e il 16 aprile 1973, si è consumato il rogo di Primavalle. Un incendio che
provocò la morte dei fratelli Virgilio e Stefano Mattei, di 22 e 8 anni.
50 anni dal rogo di Primavalle:
la morte dei fratelli Mattei
Il rogo di Primavalle si è
consumato nella notte tra il 15 e il 16 aprile 1973, al terzo piano di una
palazzina di via Bernardo da Bibbiena, casa del segretario della sezione del
Movimento sociale italiano, Mario Mattei, ex netturbino. L’incendio doloso,
provocato da un gruppo di militanti di Potere Operaio, ha ucciso i fratelli
Virgilio e Stefano Mattei, di 22 e 8 anni. Il resto della famiglia è riuscita a
scappare. Sui giornali è stata pubblicata la foto dei due corpi carbonizzati
sulla finestra dell’abitazione, che ha provocato una condanna unanime anche se
nello stesso tempo iniziò una campagna stampa guidata da vari intellettuali per
difendere i militanti della sinistra extraparlamentare, accusati. Achille Lollo
è stato l’unico a finire in carcere preventivo dopo la condanna a 18 anni in
appello per incendio doloso, duplice omicidio colposo e uso di esplosivo e
materiale incendiario insieme ad altri due imputati, Marino Clavo e Manlio
Grillo, rimasti latitanti.
Rogo di Primavalle: il processo
Durante il processo di primo
grado, che si è concluso con l’assoluzione degli imputati per insufficienza di
prove, ci sono stati vari scontri presso la sede del palazzo di giustizia di
Roma, in difesa degli imputati. L’episodio più grave è avvenuto il 28 febbraio
1975, con violenti incendi tra giovani di destra e di sinistra fuori dal
tribunale, proseguiti davanti ad una sezione del Movimento sociale, dove è stato
ucciso lo studente greco Mikis Mantakas, militante del Fuan. Achille Lollo si è
rifugiato in Brasile prima della sentenza definitiva della sua Cassazione e la
sua pena è stata dichiarata estinta il 12 ottobre 2003. Nel 2005 ha ammesso di
aver realizzato, con altri, un attentato dimostrativo con una bomba artigianale
non esplosa, rivolto a Mario Mattei, ma ha sostenuto di non aver incendiato la
casa con la benzina. Sei anni dopo è tornato in Italia e ha spiegato che
l’azione era stata eseguita da un gruppo di sei persone, e che doveva essere
solo dimostrativa. L’uomo è morto nel 2021 in una clinica di Trevignano Romano,
all’età di 70 anni.
Le dichiarazioni di
Antonella, sorella di Stefano e Virgilio Mattei, a 50 anni dal rogo di
Primavalle. Chiara Nava su Notizie.it il 16 Aprile 2023
Le dichiarazioni
di Antonella, sorella di Stefano e Virgilio Mattei, i figli del segretario della
locale sezione del Movimento sociale italiano, Mario Mattei, a 50 anni dal rogo
di Primavalle.
50 anni dal rogo di Primavalle,
sorella di Mattei: “Non mi pacifico”
Il ricordo di Antonella,
sorella di Stefano e Virgilio Mattei, i figli del segretario della locale
sezione del Movimento sociale italiano, Mario Mattei, uccisi nel rogo di
Primavalle, compiuto da componenti di Potere Operaio. “Non mi posso pacificare
con persone che non hanno chiesto mai scusa. A nove anni mi hanno distrutto la
vita, come si fa a dimenticare?” ha dichiarato la donna.
50 anni dal rogo di Primavalle,
la celebrazione dell’anniversario
Per la ricorrenza dei 50 anni
dal rogo di Primavalle, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, insieme
all’assessore alla cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, dal ministro della
Cultura, Gennaro Sangiuliano, dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, e
dal vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, hanno deposto una corona
d’alloro e tre corone di fiori in via Bernardo da Bibbiena. “La giustizia
italiana non ci ha aiutato. È importate non avere più violenza ma va detto che i
miei fratelli non sono come gli altri. Primavalle” ha dichiarato la donna,
rivolgendosi al governatore. “Bisogna avere giustizia” ha aggiunto, verso il
ministro Sangiuliano.
Estratto dell’articolo di Laura Martellini
per corriere.it il 16 aprile 2023.
Aveva tre anni quella notte del 16 aprile 1973, in
cui persero la vita, arsi vivi, due dei suoi fratelli: Virgilio di 22 anni,
militante missino dei Volontari nazionali, e Stefano di 8 anni.
Avversari politici della Sinistra estrema avevano
versato litri di benzina sulla porta dell’abitazione del padre Mario, militante
del Msi e segretario della sezione Giarabub di Primavalle, a Roma.
A Giampaolo Mattei, presidente dell'associazione
Fratelli Mattei, la premier Giorgia Meloni ha inviato un sentito messaggio nel
cinquantesimo anniversario della strage, per cui Achille Lollo venne condannato
con Marino Clavio e Manlio Grillo a 18 anni di reclusione, condanna poi
prescritta avendo i tre evitato l'arresto fuggendo all'estero (e non mancò uno
schieramento innocentista).
Scrive la presidente del Consiglio: «Caro
Giampaolo, il 16 aprile di cinquant’anni fa l’Italia e Roma hanno vissuto una
delle pagine più buie della storia nazionale. Con il rogo di Primavalle e il
barbaro assassinio di Stefano e Virgilio Mattei, il nostro popolo è stato
costretto a prendere coscienza di una realtà che si andava affermando ma che in
tanti continuavano a voler ignorare: l’odio cieco e totale nei confronti
dell’avversario politico. Un odio allo stato puro che stava divorando la mente e
il cuore di molti e che stava avvelenando la Nazione».
Prosegue: «L’atroce uccisione di due giovani
innocenti […] fece toccare alla violenza politica un punto di non ritorno. La
terribile strage di Primavalle non è rimasta, purtroppo, isolata.
Ad essa è seguita una lunga catena di morte e
dolore che ha insanguinato le nostre città, ha distrutto intere famiglie e ha
segnato per sempre la vita di tanti nostri connazionali, […]. “Erano gli anni
dell’odio”, come ha correttamente sottolineato il senatore Verini giovedì scorso
nell’Aula del Senato della Repubblica.
[…] Sì, erano gli anni nei quali l’avversario
politico era un nemico da abbattere, erano gli anni dei cattivi maestri sempre
pronti a giustificare anche il più orrendo dei crimini o a costruire false
verità per coprire i responsabili, erano gli anni delle fazioni contrapposte e
della delegittimazione reciproca. Il popolo italiano ha saputo superare quegli
anni così duri. Non lo ha fatto senza difficoltà.
Le cicatrici delle profonde ferite subìte ne sono
il segno concreto e, spesso, tornano a far male. Non possiamo cancellare la
storia o chiedere alle famiglie delle vittime di dimenticare ciò che è successo.
Non possiamo restituire la vita ai troppi giovani che l'hanno sacrificata ad
un'ingiusta violenza. Quello che possiamo fare oggi è tenere viva la memoria di
quanto accaduto, per evitare il pericolo di ricadute e condurre l’Italia e il
nostro popolo verso una piena e vera pacificazione nazionale.
È l’obiettivo che l’associazione Fratelli Mattei
persegue fin dalla sua fondazione e che era nel cuore della signora Anna, donna
straordinaria che non ha mai smesso di chiedere giustizia per i suoi figli e ha
impegnato tutta la sua vita con la forza della testimonianza».
Conclude Meloni: «È l’obiettivo che mi auguro
tutte le forze politiche, le istituzioni, le agenzie educative e la società
vogliano porsi per trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di rispetto e
tolleranza. Perché nel confronto politico non ci siano più nemici da abbattere o
da distruggere, ma soltanto avversari, con i quali confrontarsi civilmente e nel
riconoscimento reciproco. Buon lavoro».
Cosa successe a Primavalle, l'orrore in 40
metri quadri nell’Italia insanguinata dagli opposti estremismi. Giovanni
Bianconi su Il Corriere della Sera il 16 Aprile 2023.
La strage del 16 aprile 1973. I tre condannati
latitanti all’estero, poi la prescrizione
Quando uno di loro confessò — ventotto anni dopo e
con la pena ormai prescritta, dunque da uomo libero dopo una lunga latitanza —
disse che non volevano uccidere ma solo spaventare: «Doveva essere un’azione
dimostrativa, come altre che avevamo fatto contro i fascisti a Primavalle».
Invece il fuoco appiccato alla porta di un appartamento di 40 metri
quadrati dove dormivano otto persone provocò la strage di cui è diventata
icona la terribile immagine del cadavere carbonizzato di Virgilio Mattei alla
finestra. Aveva 22 anni, suo fratello Stefano 10. Il resto della famiglia, i
genitori e altri quattro fratelli, si salvò per miracolo.
Le indagini si concentrarono subito su un gruppo
di giovani appartenenti a Potere operaio, gruppo extraparlamentare che aveva già
una struttura illegale rifornita di armi, nei confronti dei quali si attivò una
campagna innocentista alimentata da presunte «controinchieste» su una
fantomatica faida fascista che aveva mietuto vittime al suo interno. Dalla quale
si lasciarono circuire molti nomi illustri della sinistra di allora. Dei tre
inquisiti — Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo — solo il primo venne
arrestato, gli altri due riuscirono a fuggire. Il primo processo, nel quale
l’accusa aveva chiesto l’ergastolo per il reato di strage, si concluse nel
1975: assoluzione per insufficienza di prove e Lollo liberato dopo due anni di
carcerazione preventiva. Verdetto annullato in appello, poi la Cassazione ordinò
un nuovo processo.
La giustizia italiana era lenta anche allora, e
l’appello-bis si concluse solo a dicembre 1986; condanna per tutti, non per
strage bensì per una catena di reati connessi: incendio doloso, duplice omicidio
colposo, uso di esplosivo e materiale incendiario. Totale delle pene, 18 anni
ciascuno, confermati dalla Cassazione l’anno successivo. Ma a quel punto gli
imputati erano tutti latitanti all’estero: Lollo in Brasile, Grillo in Nicaragua
e Clavo chissà dove. Finché nel 2005 arrivò l’estinzione delle pene per
prescrizione. Giustizia negata e verità ancora traballante, dopo che Lollo tentò
di coinvolgere altri compagni dell’epoca inquisiti ma mai processati. Oggi i tre
condannati sono tutti morti per cause naturali. Una storia di morte e
d’ingiustizia divenuta un crocevia di una stagione segnata dalle bombe fasciste,
dall’antifascismo militante e dalle false piste costruite ad arte per ingannare
inquirenti e opinione pubblica. Nove giorni prima del rogo di Primavalle, il 7
aprile 1973, il «nero» Nico Azzi era rimasto ferito a bordo del treno
Torino-Genova-Roma nel tentativo di innescare un ordigno che doveva esplodere in
un attentato da attribuire all’estrema sinistra: prima di nascondersi nella
toilette per preparare la bomba, infatti, s’era mostrato sul vagone mentre
leggeva il quotidiano Lotta continua.
E il 13 aprile a Milano, nel «giovedì nero»
segnato dagli scontri di piazza per una manifestazione missina vietata dalla
questura (alla quale parteciparono anche i fratelli Ignazio e Romano La Russa,
oggi rispettivamente presidente del Senato e assessore lombardo alla
Sicurezza) venne ucciso l’agente di polizia Antonio Marino, 22 anni, centrato da
una bomba a mano. Un omicidio per il quale vennero condannati due
neofascisti. Tre giorni dopo, il rogo romano di Primavalle. E un mese più
tardi, il 17 maggio, un’altra bomba uccise 4 persone e ne ferì oltre 50 nel
cortile della questura di Milano; autore dell’attentato il sedicente
anarchico Gianfranco Bertoli, ma successive indagini ne svelarono le connessioni
con i servizi segreti e il coinvolgimento del gruppo neofascista Ordine nuovo,
come in altre stragi di quel periodo.
Dalla drammatica fine dei fratelli
Mattei scaturirono a Roma e altrove ulteriori episodi che s’intrecciano con la
storia del terrorismo rosso e nero. Durante il primo processo, il 28 febbraio
1975, estremisti di destra e di sinistra scatenarono scontri sfociati
nell’assassinio del giovane militante greco del Fuan, l’organizzazione
universitaria missina, Mikis Mantakas. Per quel delitto fu condannato Alvaro
Lojacono, all’epoca militante di Potere operaio poi reclutato dalle Brigate
rosse, che nel 1978 partecipò alla strage di via Fani: cinque agenti della
scorta di Aldo Moro sterminati per sequestrare il presidente della Democrazia
cristiana, ucciso 55 giorni più tardi. E accanto a Mantakas, quel giorno del
’75, c’erano dei giovanissimi «camerati» poi ritrovatisi nei Nuclei armati
rivoluzionari, responsabili di molti delitti tra il 1977 e il 1983.
La Schlein già si mobilita per il 25 Aprile e
suona la grancassa dell'antifascismo. La segretaria dem si mette in scia
dell'Anpi che ha già "radiato" La Russa. Massimo Malpica su Il Giornale il 17
Aprile 2023
Manca ancora poco più di una settimana, ma le
polemiche per le celebrazioni del 25 aprile già incombono sull'esecutivo. Ad
aprire il fuoco di fila, dopo l'annuncio della sindaca di Marzabotto di non
invitare i presidenti di Senato e Camera né la premier, anche l'Anpi e la
segretaria Dem Elly Schlein. Quest'ultima, in tour in toscana per la campagna
elettorale, ha approfittato del calendario e della location per polemizzare con
l'esecutivo. «Alla vigilia del 25 aprile lo dico a questo governo, non
permetteremo a nessuno di riscrivere la storia antifascista di questo Paese»,
spiega Schlein, che poi insiste: «Lo faccio con un pensiero commosso ai nostri
nonni che in questa terra, con le nostre nonne, hanno fatto una vera resistenza
al fascismo, alla privazione della libertà, alla privazione di futuro che quel
passato purtroppo ha causato, e che qualcuno oggi cerca di rispolverare facendo
negazionismo di quanto accaduto». E poche ore dopo, a Pisa, è tornata a calcare
sugli stessi temi: «Continueremo a mobilitarci anche dichiarandoci apertamente e
convintamente antifascisti. Bisogna dirlo di questi tempi perché purtroppo c'è
chi ha giurato sulla Costituzione che è antifascista e non lo dice». Anche
l'associazione partigiani si era portata avanti sulla scadenza, con l'Anpi
milanese che già lo scorso primo aprile aveva annunciato che per il 78°
anniversario della Liberazione, in piazza Duomo, non avrebbe invitato il
presidente del Senato La Russa, per aver definito l'attentato di via Rasella
«pagina non tra le più nobili» della Resistenza. Anche il presidente dell'Anpi
nazionale, Gianfranco Pagliarulo, venerdì è sceso in campo nelle schermaglie. Lo
ha fatto per schierarsi al fianco di Valentina Cuppi, ex presidente Pd e sindaca
di Marzabotto, che aveva escluso la presenza di La Russa, Fontana e Meloni sul
luogo dell'eccidio: «Non ci sarà mai posto sul palco di Monte Sole per persone
che hanno preso posizioni discriminatorie o che hanno manifestato nostalgia per
il fascismo, perché celebriamo appunto la liberazione dal nazifascismo». Una
scelta, quella di Cuppi, condivisa dal numero uno dell'Anpi: «La scelta della
sindaca di Marzabotto è giustissima e va sostenuta».
Anche la Rete degli Studenti Medi e l'Unione degli
Universitari, in vista del 25 aprile, hanno scritto alla premier Meloni e ai
ministri di Scuola e Università chiedendo di «mettere in luce la violenza dei
gruppi neofascisti nei luoghi del sapere», e sostenendo la necessità che «scuole
e atenei siano presidi antifascisti». Insieme alla lettera, un delegato della
«Rete» prende di mira «le gravi ambiguità dei partiti di governo», e sostiene
che certe prese di posizione «rispondono ad uno schema politico chiaro, che
tenta di cancellare le responsabilità del fascismo dalle stragi di ieri e dallo
squadrismo di oggi». Il tutto mentre a Ravenna la polemica si infiamma per
motivi diversi con lo scontro tra la locale comunità ucraina, che aveva chiesto
di celebrare insieme il 25 aprile, e la consulta provinciale antifascista,
contraria per la presenza, tra i combattenti ucraini, di «forze politiche e
militari come il battaglione Azov e altre che si richiamano al nazismo». Per gli
ucraini di Ravenna, un'osservazione basata sulle «stesse menzogne della
propaganda russa».
Dentro i migranti, fuori gli ucraini: le "liste
d'ingresso" del Pd per il 25 aprile. A Ravenna un'associazione di ucraini è
stata diffidata dal partecipare alle celebrazioni del 25 aprile ma ci saranno le
Ong dei migranti. Francesca Galici su Il Giornale il 16 Aprile 2023
A sinistra hanno uno strano concetto di
democrazia, ma guai a farlo notare. Con il 25 aprile che si avvicina, quelli che
si battono sul petto ipotetiche medaglie di libertà si arrogano il diritto di
fare le "liste di ingresso" alle loro manifestazioni. L'inclusività non è di
casa nel Partito democratico, che a questo punto dovrebbe avere il coraggio di
cambiare il suo nome per rendere ben più chiara l'idea degli ideali che lo
muovono. L'arrivo di Elly Schlein ha estremizzato il posizionamento della
compagine, facendo prendere coraggio alle frange più integraliste dando loro
modo di uscire allo scoperto e mostrare il vero volto del nuovo Pd. E il 25 è
un'occasione perfetta in tal senso.
"Non permetteremo a nessuno...". Schlein parte
all'assalto del 25 aprile
A Ravenna, l'estrema sinistra e i partiti di
maggioranza hanno deciso: fuori gli ucraini e dentro i migranti nelle
manifestazioni della Liberazione italiana. Ebbene sì, a Ravenna si sarebbe
deciso di diffidare un'associazione di ucraini del suo territorio dal
partecipare alle manifestazioni del 25 aprile. L'associazione Malva, che ha il
sostegno di +Europa, Italia viva e Psi è stata tenuta fuori perché Zelensky non
assicurerebbe la democrazia in Ucraina. Giustificazioni che mettono le loro
radici in quell'ambiguità così palese di Elly Schlein sulla guerra, che hanno
fatto perdere al Pd il posizionamento in completo favore dell'Ucraina al fianco
di Nato e Unione europea che il partito aveva assunto sotto la guida di Enrico
Letta.
Definendo il 25 aprile come una "data sacra", la
lista di estrema sinistra Ravenna in Comune giustifica così il "no" alla
partecipazione degli ucraini: "Nella guerra attualmente in corso in Ucraina non
vi è la lotta di chi non vuole cadere nelle mani di una dittatura ma vuole
restare all’interno dell’Occidente. E questo perché non vi è democrazia oggi in
Ucraina". Comprensibile la rabbia degli ucraini, arrivati al punto di dover
insegnare a questi "nuovi partigiani" cosa sia stata davvero la Resistenza nel
nostro Paese: "I partigiani non fecero 'tacere le armi' ma le usarono per
scacciare i nazifascisti come stanno facendo ora i nostri difensori".
Ma dalle parti di Ravenna non sembrano esserci
margini di discussione: Rifondazione Comunista, Partito Comunista italiano,
Partito Comunista e Potere al Popolo si oppongono. Questi sono i partiti che
amministrano oggi Ravenna insieme al Pd, che solo a leggere questi nomi qualche
domanda occorrerebbe farsela. A loro dire, Zelensky ha raggiunto il potere
tramite un golpe e a sostegno della tesi di "fascismo" contro gli ucraini è
arrivata anche la Consulta provinciale Antifascista di Ravenna, che ha dato il
suo verdetto: "Fra i combattenti ucraini contro l'invasore russo ci sono forze
politiche e militari come il battaglione Azov ed altre che si richiamano al
nazismo dalle quali nessuno s'è dissociato".
Ma dove non c'è spazio per gli ucraini, c'è spazio
per i migranti. Sì, perché ad arrivare nella riviera romagnola saranno le Ong,
che sfileranno per rivendicare il loro diritto di violare la legge in nome
della propaganda immigrazionista nel nostro Paese. E ci sarà anche il sindaco di
Cutro, sollevato a emblema della lotta contro il governo Meloni che cerca di
ristabilire un minimo di legalità nell'ambito dell'immigrazione. Tanto ormai è
chiaro, la sinistra non ha alcuna intenzione di mantenere il 25 aprile come
festa universale per il nostro Paese: è stata trasformata in una manifestazione
tra compagni, se ne sono appropriati cantandosela e suonandosela da soli.
La chiamata alle armi: 25
Aprile contro la destra. La festa diventa pretesto per la rivincita
politica. E "Repubblica" sceglie come bersaglio La Russa. Alberto Giannoni il 13
Aprile 2023 su Il Giornale.
Una mobilitazione
straordinaria, con un bersaglio ben preciso. Il tam-tam è iniziato da tempo e
ora mancano pochi giorni: è un 25 Aprile particolarmente eccitato quello che si
preannuncia e si prepara nel 78° anniversario della Liberazione. Sarà la prima
volta con un presidente del Consiglio dichiaratamente di destra, e la prima
volta con un Pd che è tornato di sinistra-sinistra con Elly Schlein, la giovane
segretaria che scalda il cuore dei vecchi nostalgici.
La manifestazione antifascista
di un mese fa a Firenze, con Giuseppe Conte (5 Stelle), Maurizio Landini (Cgil)
e la stessa Schlein, è stata solo una prova generale. La sinistra già si scalda
per un 25 Aprile «storico», e i media più militanti sono in campo. Il «nemico
pubblico numero uno» ha le sembianze addirittura «luciferine» del presidente del
Senato Ignazio La Russa. E la mobilitazione è ispirata da un unico grande, vero
movente ideologico: il senso di rivalsa verso la coalizione che a settembre ha
vinto le elezioni, e ora sta al governo e nelle istituzioni.
Il Forum delle associazioni
antifasciste e della Resistenza due giorni fa ha diffuso un documento accorato
per «un grande 25 aprile per la democrazia e la Costituzione». «Quest'anno - si
legge - lanciamo un appello affinché il 25 Aprile sia caratterizzato da una
straordinaria partecipazione». Lo firmano le varie sigle del mondo
resistenziale, dall'Anpi alle componenti storicamente più vicine al mondo
cattolico o liberal-socialista. «Si moltiplicano episodi di violenza e di
apologia del fascismo», si legge in quella che sembra una visione allucinata
della realtà.
La presidente del Consiglio
Giorgia Meloni celebrerà il 25 aprile all'Altare della Patria, con il Capo dello
Stato Sergio Mattarella e ai rappresentanti degli altri organi costituzionali.
Lo hanno puntualizzato fonti di Palazzo Chigi quasi un mese fa. Non si vede
questa minaccia della destra. Non la vedono i vertici delle istituzioni e non la
vede il «Paese reale», che ha altre priorità. Eppure tutto un ceto
politico-intellettuale, non si sa per interesse o per convinzione, soffia sul
fuoco del settarismo. E la tensione contenuta a fatica negli anni passati da
personalità ben dotate di saggezza - come il presidente di Anpi Milano Roberto
Cenati - quest'anno sembra pronta a esplodere in tutto il suo clamore. Al corteo
di Milano, negli anni passati, sono stati contestati praticamente tutti, anche i
reduci dei campi di sterminio. Stavolta, rancori e velleità consuete trovano un
nuovo propellente nella circostanza che vuole arrivato a rivestire la seconda
carica dello Stato un esponente del Msi, Ignazio La Russa, che ha ottimi
rapporti con la Comunità ebraica cittadina, ma è stato protagonista nei giorni
scorsi di dichiarazioni anche avventate, di cui si è scusato, a quanto pare
inutilmente.
«Esprimiamo preoccupazione - si
legge nell'appello - per dichiarazioni, decisioni e comportamenti di alcuni
rappresentanti delle istituzioni e della politica che, in vari casi, sono
apparse divisive e del tutto inadeguate rispetto al ruolo esercitato». Ieri la
Repubblica è andata a ripescare un giorno drammatico di 50 anni fa, quello che
ha definito «il giovedì nero con i La Russa in piazza e la bomba che uccise
l'agente Marino». Ignazio La Russa viene evocato come il giovane capo del Fronte
la Gioventù, «con la stessa silhouette luciferina ripresa da Marco Bellocchio in
Sbatti il mostro in prima pagina».
Nell'agenda virtuale delle
famiglie italiane, però, l'allarme per le sorti della democrazia non pare al
primo posto. La petizione contro il presidente del Senato, per «chiederne le
dimissioni entro il 25 aprile», sembra languire. L'appello è stato lanciato il
primo aprile da Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista
e lo hanno firmato fra l'altro l'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti,
Vittorio Agnoletto e i soliti nomi della sinistra post-comunista. Ma non sembra
un boom: «Ha superato le 75.000 firme» annunciava 5 giorni fa il Manifesto. Oggi
siamo a 86mila firme.
25 Aprile, la sinistra
convoca i bimbi di 3 anni: “Vi aspettiamo in piazza”. Libero Quotidiano il
13 aprile 2023
Sarà che le loro notti, durante
quegli incubi che ti svegliano di soprassalto, sono agitate da un’onda nera che
avanza su Milano. Sarà che in sogno gli appaiono squadracce in ogni angolo della
città, pronte a rastrellare gli oppositori politici. Sarà persino che a
disturbargli il sonno ci pensano pure piccoli balilla in
uniforme. L’immaginazione dell’antifascismo militante non conosce confini. I
suoi alfieri vedono manganelli e barattoli d’olio di ricino ovunque. E così ecco
che anche i bimbi dell’asilo sono coscienze da indottrinare secondo i sacri
dettami del vangelo rosso. Il 25 aprile si avvicina e i motori si scaldano.
«BELLA CIAO...»
Tra due sabati, in
piazza Gambara, ci sono in programma le «Letture antifasciste» per celebrare
«Milano città Medaglia d’oro della Resistenza». La platea? Bambini e bambine da
tre a dieci anni. A organizzare il pomeriggio (dalle 16 alle 18, gratis su
prenotazione) è la società “Buk”, che tra le sue finalità principali ha la
«vendita di libri» e le «pubblicazioni di qualsiasi genere», oltre allo
«svolgimento di attività editoriali» e all’«organizzazione di laboratori anche
di produzione artistica e artigianale». I brani che verranno scelti non sono
noti ma si attingerà da libri dedicati, in collaborazione con Patto di Milano
per Lettura di Milano e con l’associazione “In cerca di guai”, una libreria
indipendente milanese che ha sede a pochi passi dal luogo dell’evento, in via
Palma. Sulla sua pagina Instagram, alla data del 22 aprile, si legge: «Bella
ciao. Letture in piazza Gambara». E giusto per comprendere quale sia
l’orientamento politico dell’iniziativa, seppur si tratti di un pubblico che
frequenta le scuole materne le elementari, basta dare un’occhiata alla
locandina. Su cui in bella vista sono stampati i loghi del Comune di Milano e
del Municipio 7. Accanto al disegno di tre giovani ragazze, verosimilmente
partigiane, spunta un invito a chiare lettere: «Porta un fazzoletto rosso». E
qui tutti i dubbi sulla matrice delle letture volano via. Si dissolvono. Che
l’antifascismo sia da associare per forza al colore tanto caro alla sinistra,
del resto, è una forzatura che fa a pugni con la storia. La Resistenza, infatti,
non l’hanno fatta solo i comunisti: perché dimenticare i democristiani, i
cattolici, i liberali, i repubblicani, i monarchici?“In cerca di guai”, tra
l’altro, non è la prima volta che sconfina oltre l’arte e il piacere della
lettura.
A metà dello scorso mese,
quando infuriavano le polemiche sulle trascrizioni anagrafiche dei figli di
coppie omosessuali, sui social della libreria si leggeva testuale: «Non
riconoscere i figli di coppie omogenitoriali è una barbarie, un atto di bullismo
nei confronti di minori che esistono, ci sono, a migliaia in carne ossa e
sentimenti». Una decina di giorni prima - era l’8 marzo - andava in scena
l’appuntamento “Mary si veste come le pare”: un mix tra letture e laboratori «di
travestimenti per bambine e bambini contro gli stereotipi di genere». A partire
dai tre anni.
Nella Milano ultraprogressista
di Pd e compagni, però, questa è diventata la normalità. Ogni 25 del mese- e lo
avevamo già raccontato sulle pagine di Libero - si tengono le «Letture per una
nuova Resistenza. Non solo 25 aprile». Un ciclo di letture «ad alta voce», per
bambini e ragazzini, nei parchetti, nelle biblioteche e nelle librerie del
Municipio 9. «Le letture vogliono ricordare a tutti, e soprattutto a bambini e
ragazzi, che “essere liberi” è una responsabilità». Gli argomenti proposti per
quest’anno spaziano dal «diritto alla cura e alla crescita sana» al «futuro e
lavoro»; dalla «pace» alle «opportunità per tutti/povertà». E di chi è la firma
su questo progetto? Dell’Anpi, nemmeno a dirlo. Ovvero gli stessi che hanno già
fatto sapere ai presidenti di Camera e Senato (Fontana e La Russa, ndr) di non
presentarsi il prossimo 25 aprile sul palco milanese allestito per le
celebrazioni in città. Ma tu guarda il caso...
Estratto della lettera di un
lettore a “la Repubblica” l’11 aprile 2023.
Caro Merlo, lei ha applicato
“il fascistometro” a un antifascista intollerante in tv verso uno dei
comportamenti parafascisti oggi di moda. Per Flaiano “il fascismo si divide in
due parti: il fascismo propriamente detto e l’antifascismo”. L’aforisma […] è
usato come slogan da chi non riconosce il valore dell’antifascismo. Non crede
che [...] vada [...] combattuto?
Miriam Dondi - Modena
Risposta di Francesco Merlo
No. Credo che vada spiegato e
ricondotto alla sua verità. Ennio Flaiano - in questo caso utilizzando, con la
prudenza del distacco, una frase del fascista Mino Maccari - amava esprimersi
con i paradossi che stimolano l’intelligenza, ma rimangono paradossi.
Voglio dire che il paradosso
del fascismo degli antifascisti, pur svelando una verità italiana, non cancella
l’inconciliabilità di fascismo e antifascismo nella storia del nostro Paese e
nulla toglie al valore degli antifascisti che, uniti, ci restituirono l’onore e
la libertà.
L’antifascismo, vale dire la
Resistenza [...], è la fonte di legittimità della nostra Italia democratica e
repubblicana. […] Sciascia [...] lo disse così: “Dal fascismo, dall’eterno
fascismo italiano, anche l’antifascismo sembrò ricevere certe consegne”. Dunque,
il nostro piccolo fascistometro continuerà a misurare il fascismo dovunque,
anche nell’antifascismo.
La guerra civile che non
c’è. L’eterno ritorno dell’onda nera e la debolezza della retorica antifascista
minoritaria. Alberto De Bernardi su Linkiesta il 10 Marzo 2023.
L’Italia è una democrazia
solida, non un Paese fascista. Nei suoi anni democratici ha saputo costringere i
peggiori estremisti a un processo di revisione del proprio bagaglio ideologico
(nonostante ci sia ancora qualche nostalgico di troppo)
La deriva
Domenica scorsa Ezio Mauro ha
scritto un ponderoso articolo per ricordarci che la storia d’Italia non è mai
uscita dallo scontro fascismo/antifascismo: nelle ultime settimane hanno preso
forma «due Paesi divaricati» dalla discriminante antifascista, perché Giorgia
Meloni si rifiuta di fare «un gesto di chiarezza rispetto al mondo da cui
proviene» mentre ordisce il disegno di «neutralizzare la memoria del fascismo» e
di cancellare «l’antifascismo come cultura civile del Paese».
Mentre leggevo le parole di
Mauro mi sono riecheggiate nella memoria le parole che il 2 giugno del 2018
pronunciò la allora presidente dell’Anpi: «C’è nel Paese – disse – una
pericolosa deriva filonazifascista che ha caratteristiche di minoranza ma è
dislocata in tante parti d’Italia». Da allora il ritorno dell’onda nera divenne
la cifra interpretativa prevalente della situazione politica italiana, con una
rincorsa a trasformare tutte le azioni del governo gialloverde di Giuseppe Conte
e Matteo Salvini come calchi di tutti gli stereotipi del fascismo.
Con la vittoria della destra
sovranista cinque anni dopo, l’onda nera in pochi mesi si è già trasformata nel
ritorno della sempiterna «deriva fascista» che si sta impossessando dello spazio
pubblico per distruggere l’antifascismo a segnalare purtroppo solo ed
esclusivamente un tragico riflesso condizionato della sinistra: evocare l’eterno
ritorno del fascismo quale unica chiave di lettura di ogni processo politico che
riguardi la destra.
Era «ritorno del fascismo» il
centrismo di Alcide De Gasperi e Mario Scelba, il Piano Solo e il «tintinnar di
manette» all’epoca del centrosinistra, il «fanfascismo» nei primi anni settanta
nella tragica epoca dell’antifascismo militante extraparlamentare, Bettino Craxi
e la «grande riforma» nel decennio successivo, ovviamente Silvio Berlusconi e il
suo prepotente ingresso sulla scena politica nel 1994, fino a Matteo Renzi, per
il quale il termine «fascistoide» è stato utilizzato reiteratamente da alcuni
esponenti della sua minoranza interna per definire l’estraneità del suo progetto
politico alla tradizione della sinistra italiana.
Nonostante molti studi
politologici e sociologici sull’estrema destra in Europa negli ultimi vent’anni
abbiano messo in luce sia l’eterogeneità ideologica di quel campo di forze, sia
la sua distanza da quel complesso di movimenti e di culture politiche definite
con il termine di fascismo, in Italia queste cautele hanno fatto scarsa breccia
nella riflessione pubblica; al contrario si è messa in movimento una rincorsa,
promossa soprattutto dai militanti dell’estrema sinistra dai suoi intellettuali
e dai giornalisti, a coniare neologismi che evocassero lo spettro di Mussolini
per definire la nuova maggioranza governativa: oltre al classico nazifascismo
prima citato, si è imposto il «fasciogrilloleghismo» fino alla caduta del
governo Conte I – poi abbandonato quando Conte è stato arruolato dalla sinistra
nell’antifascismo a sua insaputa – ora ritorna in auge sotto forma di «nuovo
fascismo».
Questa tumultuosa rincorsa fa
venire in mente una affermazione di George Orwell contenuta in suo articolo
pubblicato nel 1946: «La parola fascismo ormai ha perso ogni significato e
designa semplicemente qualcosa di indesiderabile».
Il ritorno dell’indesiderabile
In effetti «l’indesiderabile»
che ritorna, secondo la vulgata a cui si rifà Mauro – è lo sforzo delle destre
al potere non solo di interpretare le pulsioni illiberali e antipolitiche di una
permanente maggioranza silenziosa che campeggiano nella coscienza pubblica, mai
piegata definitivamente ai valori della costituzione democratica, e
permanentemente disponibile verso l’antipolitica e verso soluzioni politiche
illiberali il cui fondamento è la rimozione – potremmo dire, attiva – del
passato fascista della nazione, con l’obiettivo di realizzare la «pacificazione»
degli italiani, disancorando la Repubblica dall’antifascismo e dalla Resistenza.
Ma per fortuna – dice Mauro –
che c’è l’antifascismo, tornato militante, che impedirà che questa operazione
politico-ideologica promossa dal sommerso fascista della Repubblica, ora
arrivato al governo, spacchi il Paese in nome di una revisione radicale della
storia italiana del ventesimo secolo e del rifiuto del patriottismo
costituzionale.
Ma sfugge a Mauro che la
debolezza del patriottismo costituzionale non alligna solo a destra per
l’irrisolto rapporto con le sue eredità neofasciste, ma purtroppo affonda le sue
radici anche nelle culture politiche della sinistra che al grido di «ora e
sempre resistenza» ha costruito una retorica politica nella quale la democrazia
italiana appare sempre sull’orlo di un rinculo nella guerra civile mai conclusa
del ’43-’45 e abbia bisogno di un costante “in più” etico-politico garantito
rappresentato dall’antifascismo per reggere l’urto delle destre radicali e
illiberali, come non accade nei Paesi che hanno una tradizione democratica più
matura e compiuta.
Non c’è bisogno di nessun «in
più» antifascista in Germania, in Francia o negli Stati Uniti per combattere
l’onda montante del populismo nazionalista e xenofobo, perché basta il
radicamento del «paradigma democratico» a mobilitare la partecipazione politica
dei cittadini contro Donald Trump o Marine Le Pen o il partito Alternativa per
la Germania.
Un «di più» metapolitico,
dunque, che copre in Italia un «di meno» storico, quasi antropologico, relativo
alla debolezza dell’insediamento della cultura democratica nei «costumi» degli
italiani e la permanenza delle tradizionali «malattie» dello spirito pubblico
che sono sempre le stesse da quelle denunciate un secolo fa da Piero Gobetti
prima che la violenza fascista lo mettesse a tacere per sempre e che
sintetizzano il “fascismo eterno” della storia italiana. Un «di più» che è nella
disponibilità politica di una presunta “altra Italia” depositaria di tutte le
virtù pubbliche, del patrimonio valoriale della costituzione ma permanentemente
“inapplicata” e che deriva la sua forza di avere per sé “il senso della storia”.
Libertà o liberazione?
Spia di questa concezione
politica è il commento di Mauro allo striscione che gli studenti di destra
avevamo issato davanti alla scuola in risposta a quello degli studenti di
sinistra: «La scuola non è antifascista, è libera».
Secondo Mauro i giovani del
Blocco studentesco avevano contrapposto libertà a liberazione, a riprova
dell’estraneità dei giovani di estrema destra alla “patria antifascista”. In
realtà – al netto delle violenze inammissibili di Azione studentesca al Liceo
Michelangelo di Firenze – dentro l’evocazione della libertà emerge un domanda di
agibilità politica e di riconoscimento culturale da parte dei giovani di destra
che l’antifascismo militante presente nelle scuole e nelle università ha sempre
rifiutato, per un giudizio di indegnità morale di quei giovani.
Mauro non a caso non parla
della manifestazione di Firenze dove come in tutte le manifestazioni
antifasciste aleggia un «in piu» inaccettabile di violenza verbale contro il
nemico – «uccidere un fascista non è reato» urlavano quegli studenti riprendendo
uno slogan degli anni ’70, quando giovani fascisti e giovani antifascisti si
ammazzavano davvero. Aggiungendo una novità: «Tito ce lo ha insegnato» che evoca
un’ esaltazione delle foibe recuperata dai recessi più melmosi e orribili della
tradizione comunista.
Esaltare le foibe come
patrimonio dell’antifascismo non è casuale: è il risultato di una continua opera
di delegittimazione degli sforzi che la cultura democratica – non quella
fascista – sta compiendo da molti anni per accogliere le vittime e le loro
memorie nella storia nazionale, screditando il “giorno del ricordo” dell’11
febbraio come opera di revisionismo di stato messo in atto dalle destre,
occultando scientemente il ruolo che il comunismo jugoslavo ha avuto nei crimini
contro gli italiani tra il ’43 e il ’47 e nell’esodo istriano.
Ma qual è la nostra patria
Senza saperlo e senza
accorgersene per opera di cattivi maestri quei giovani antifascisti hanno
riaperto una frattura profonda nella stessa idea di nazione, tra quella, mai
pienamente sconfitta, dei cultori della “patria del socialismo” – il
filoputinismo di tanta sinistra radicale affonda qui le sue radici – e la patria
democratica, che ha attraversato prepotentemente la stessa Resistenza
antifascista, contribuendo a indebolire l’identità nazionale e rendendo flebile
proprio il patriottismo costituzionale perché privato di una “forza simbolica”
espressione di una comune idea di nuova nazione nata dal crollo di quella del
fascismo.
Tra Tito e la democrazia vi è
un abisso, che riguarda anche la natura e la tavola dei valori
dell’antifascismo: quello comunista di matrice totalitaria, che sovrapponeva la
rivoluzione leninista alla lotta per la libertà dal fascismo, e quello
democratico che puntava a rigenerare nella libertà e nel pluralismo delle idee e
dei valori la storia nazionale dopo la tragedia della dittatura.
Evocare un dittatore che ha
lasciato solo macerie nel suo paese come modello di antifascismo significa
riprodurre quella frattura dell’idea di nazione, che ha impedito e continua ad
impedire a una parte non piccola di italiani e italiane, che pur hanno ripudiato
il fascismo, di riconoscersi pienamente nella nazione antifascista, per la
presenza al suo interno di chi non aveva colpevolmente dismesso la sua adesione
alla “patria” stalinista, vissuta e temuta come minaccia incombente del nuovo
ordine repubblicano.
Nacque in questo iato e in
queste aporie delle basi ideali della Repubblica il “filo nero” della narrazione
“anti-antifascista” della guerra di liberazione e dell’Italia democratica che
tanto peso ha avuto e ha tuttora nella coscienza collettiva del Paese,
direttamente proporzionale alla debolezza dell’antifascismo che ancora oggi si
ostina a non voler riconoscere le sue responsabilità nell’aver reso impossibile
quella piena integrazione tra sé stesso e la nazione repubblicana.
Il mito della rivoluzione
Nella misura in cui il mito del
comunismo aleggia nei cuori di giovani e vecchi antifascisti, e l’antifascismo
si riduce a un altro nome dell’idea di rivoluzione, la Repubblica cessa di avere
proprio nella Resistenza il suo inveramento e di non avere i partigiani tra i
suoi padri, perché essi erano impegnati a lottare per un altro fine, non per la
repubblica che c’è, non per la democrazia faticosamente conquistata: lottavano
per i socialismo, per la «democrazia progressiva», per «il sol dell’avvenire» e
si sentivano chiamati a disvelare la presenza del vecchio regime e a
ipostatizzare lo scontro tra fascismo e antifascismo come cifra più autentica
dello spazio politico repubblicano, che non poteva trovare soluzione nella
democrazia ma soltanto nel superamento dello Stato borghese e del capitalismo.
In quest’ottica l’antifascismo
aveva un solo futuro possibile, non come memoria collettiva e fondamento ideale
dello Stato nuovo, ma come ideologia di un cambiamento rivoluzionario,
proiettato alla ricerca di un “altrove” che stava, e continua purtroppo a stare,
oltre la Repubblica.
Ma questo antifascismo non può
che essere minoritario e «di sinistra» – non maggioritario e repubblicano,
perché non si propone di chiudere quella tragica ferita identitaria, ma la
riproduce all’infinito, di generazione in generazione, creando una sorta
di comfort zone identitaria, assai simile, nel suo costrutto psicologico e
culturale, a quella di chi si tiene in casa il ritratto di Mussolini, sfila ogni
anno con il braccio teso davanti alla tomba del Duce a Predappio o gira la testa
dall’altra parte se “i giovani (suoi)” menano le mani o puerilmente assaltano la
Cgil, guidati da un ferro vecchio del sovversivismo neofascista degli anni
settanta in cerca di visibilità.
Per uscirne bisogna fare uno
sforzo di verità: non c’è nessun fascismo alle porte perché sconfitto
dall’antifascismo in armi e dalla storia nel ’45, l’Italia è una salda
repubblica democratica che ha saputo persino includere i suoi storici avversari
– fascisti e comunisti – nelle sue istituzioni politiche, costringendoli a un
processo di revisione profondo del proprio bagaglio ideologico, nonostante
qualche nostalgico di troppo si aggiri in entrambi i campi, che li ha
legittimati ad aspirare al governo del Paese. Di questo gli antifascisti
dovrebbero andare fieri, perché è merito loro, invece che evocare Tito e le
scintille rivoluzionarie del 1917.
Estratto dell’articolo di
Massimo Recalcati per “La Stampa” il 7 marzo 2023.
Un grande filosofo come Gilles
Deleuze riteneva che il presupposto di fondo della lotta antifascista avesse
come prima e imprescindibile condizione la lotta contro il fascista che ognuno
di noi porta dentro di sé.
L’intolleranza per la
differenza, la convinzione dogmatica di detenere una verità assoluta, la
giustificazione politica della violenza, l’odio e lo scherno, l’approvazione
della censura e l’interdizione della libertà di parola per chi diverge dalla
nostra concezione del mondo, un complesso di superiorità inguaribile, la
rappresentazione della Destra come culturalmente indegna, il sarcasmo verso la
maggioranza quando il suo orientamento non coincide con i nostri desideri, la
tendenza a convertire la critica in insulto, sono in se stesse tentazioni
fasciste e autoritarie che hanno paradossalmente trovato diritto di cittadinanza
anche nella cultura di gruppo dell’antifascismo.
Lo scrivo con amarezza
rileggendo oggi l’antifascismo militante dei movimenti della fine degli anni
Settanta ai quali partecipai con grande entusiasmo giovanile. I miei cattivi
maestri di allora non si rendevamo conto che la militanza antifascista che
esaltavamo non era, in realtà, altro che il rovesciamento speculare del mostro
velenoso che intendevamo combattere. […] L’assioma ideologico escludeva ogni
forma di dubbio: se il cuore dello Stato era un cuore fascista bisognava
colpirlo senza indugi. […]
Ma nel tempo di una democrazia
ormai consolidata nel nostro paese da quasi ottant’anni possiamo provare a
essere più intransigenti con il nostro fascismo interno? Possiamo provare a
rigettare la tentazione autoritaria che attraversa ciascuno di noi e che spesso
ha trovato proprio una certa cultura di sinistra cosiddetta antifascista il suo
terreno di coltura?
[…] Esiste ancora oggi uno
squadrismo culturale di sinistra che insistentemente ignora il fondamento laico,
antidogmatico, plurale della democrazia e che manifesta una evidente allergia
nei confronti delle sue leggi? Non è forse la stessa cultura di gruppo che
finisce per colludere con le ragioni della guerra scatenata da Putin contro
l’Ucraina nel nome di un ideale utopico della pace che ha il solo effetto di
giustificare una brutale aggressione militare senza consentire al popolo che è
stato offeso la sua legittima difesa? Non è forse la stessa cultura di gruppo
che nel nome altrettanto utopico della libertà si opponeva alle misure di
prudenza imposte dall’emergenza sanitaria paventando una virata totalitaria
dello Stato democratico?
[…] L’aggressione organizzata,
l’uso ideologico della violenza, i comportamenti vandalici, l’esibizione dei
simboli dell’odio sono chiaramente estranei allo spirito della democrazia. Ai
tempi dei movimenti del ’77 per definire questi comportamenti si usava la
formula “organizzazione collettiva della forza”. È la stessa edulcorazione del
linguaggio operata dal regime putiniano […] Accadeva alla fine degli anni
Settanta nel nome dell’antifascismo. Fu per questa ragione che scelsi di
abbandonare quei movimenti per avvicinarmi al Partito Radicale di Marco
Pannella. […]
Ora viviamo in un paese dove
il fascismo […] non esiste più. Giorgia Meloni, democraticamente eletta dagli
italiani, ha giurato sui principi della nostra Costituzione riconoscendoli
pienamente. Certo, alcuni dei suoi ministri ci appaiono indegni […] Ma questo
non ci dispensa dal difficile compito di provare a essere giusti con le ragioni
dell’antifascismo. In uno Stato democratico non dovrebbe mai essere legittimato
un uso antifascista della violenza […]
Il caso di Firenze. Chi è
Giuseppe Valditara, il neocrociano fedele alla pedagogia di calci e pugni.
Michele Prospero su Il Riformista il 26 Febbraio 2023
Uomo di vastissime letture, non
a caso è il ministro dell’istruzione. C’è del metodo, e molta sottile
metafisica, nelle sue esternazioni che fortunatamente, per il loro incredibile
impatto costruttivo sulle menti della Nazione, diventano sempre più frequenti.
Ha consultato anche stavolta i grandi classici prima di prendere penna e
calamaio per annunciare la dura censura governativa contro
la “politicizzata” dirigente scolastica fiorentina. Quali fonti filosofiche
ispirano il luminare che Meloni ha voluto giustamente promuovere a prestigioso
titolare del ministero di viale Trastevere?
Non c’è dubbio, le sue parole,
mai scontate, nascondono un pensiero forte. Nell’affondo inevitabile contro la
professoressa Annalisa Savino, il creativo ministro del merito ha sicuramente
raccolto e fatto proprio l’insegnamento racchiuso in un’antica pagina
di Benedetto Croce. Il grande filosofo, anch’egli con un’esperienza al
ministero, benediceva le aggressioni contro gli uomini e le donne delle sinistre
che si agitavano con le loro “vuote” idee d’eguaglianza e di socialismo. Avevano
ragione, scandiva in “Etica e Politica”, quanti associati in squadre nere
prendevano “a scappellotti i creduli in quelle formule insulse e coloro che le
vanno ripetendo a uso dei gonzi”.
Non preoccupavano, il cantore
della “religione della libertà”, i pestaggi dei fascisti, da lui esaltati anzi
in un’occasione come “uomini di vivo senso storico e politico divenuti
appassionati partigiani della forza”. La loro violenza politica sugli avversari
racchiudeva sì una veemenza “grossolanamente intesa”, ma non si poteva certo
pretendere una sottigliezza eccessiva nei modi d’agire che ispiravano un
energico e scanzonato movimento politico di rigenerazione nazionale.
Gli squadristi comunque, a loro merito, si prendevano la briga di dare degli
“scappellotti” ai sostenitori delle “formule insulse” della democrazia. Per
questo al loro capo, pure lui un “popolano impetuoso e anche violento”, tributò
un applauso scrosciante al Teatro San Carlo.
Giovanni Gentile non credeva di
esagerare dipingendo questo Croce, così attratto dalla pedagogia muscolare dei
calci e pugni, come “uno schietto fascista senza camicia nera”. Sulle orme del
“filosofo dei distinti”, il ministro della verità avrà sentito forte il richiamo
etico-politico del filosofo abruzzese, cantore della bella violenza
somministrata romanamente contro i “gonzi” come una immancabile pratica
educatrice. Alla preside, che si permette senza ritegno di citare Gramsci, e
quindi di fare politica, il ministro dalle vaste vedute raccomanda di cimentarsi
con la superiorità morale di alcune pagine di Croce. Quelle sì che erano un
esempio fulgido di etica pubblica, soprattutto quando ritenevano del tutto
salutari, nel loro risvolto “pratico o praticistico”, i movimenti rudi, dal
futurismo al fascismo, perché quando agivano per strada menando da par loro
andavano celebrati dal momento che “la eventuale pioggia di pugni, in certi
casi, è utilmente e opportunamente somministrata”.
Davanti al liceo politicizzato
di Firenze, come potevano non materializzarsi quelle esemplari spedizioni
pedagogiche dei novelli “partigiani della forza”? Come fa la dirigente
scolastica a insorgere, per giunta in bella prosa, per qualche baldo ceffone e a
non cogliere tutta la carica liberatrice sprigionata dalla neo-littoriale
giovanile pratica persuasiva della “pioggia di pugni”? Si aggiorni sui nuovi
metodi didattici in voga nell’età del merito, lasci stare il teorico sardo che
odiava gli indifferenti e apprenda i rudimenti della filosofia crociana dello
scappellotto. Non possiede proprio i più elementari fondamenti del pensiero,
questa professoressa che non conosce il magistero di Croce sui risvolti
culturali dei pugni in faccia e la butta in politica scandalizzandosi per
la violenza educatrice dispensata sui marciapiedi dagli intrepidi nuovi
patrioti.
Mentre Giorgia, la madre,
cristiana, patriota, si prende una pausa dalla politica e si fionda in macchina
diretta al ristorante di Anzio (fa più notizia con lo Chef e le vongole che
a Kiev con i capi di Stato ai quali promette aerei tra colpi di tosse e risate
fuori ordinanza), non spendendo neppure una parola dinanzi alle botte
distribuite dai toschi degni apprendisti di uno statista alla Donzelli, questa
preside ha l’ardire di entrare dritta in politica e prendere le difese di
quattro studentucoli, di novelli “gonzi” da rieducare con l’infallibile medicina
crociana della pedata e del cazzotto. È proprio a digiuno della pedagogia
manesca che a Trastevere non dispiace affatto blandire in nome dell’endiadi
pensiero e azione.
Il ministro neo-crociano,
colpito da siffatta ignoranza circa i grandi passaggi della cultura nazionale,
sta meditando su quale sanzione comminare a una dirigente scolastica che resiste
alle forme educative del tempo nuovo. Fuori la politica dalla scuola, ordina
inebriato dal richiamo fiorentino ai valori sempiterni della forza e della
vitalità. E dentro il liceo entrino presto quei sei audaci pugilatori cresciuti
in gagliarda arte politica nelle sedi gigliate di Fratelli d’Italia.
Chi altri infatti, se non
questo moderno esemplare di agile somministratore di violenza di piazza per
scacciare la politica dalle aule, è degno di essere chiamato in cattedra per
chiara fama? Ministro, cacci in fretta l’obsoleta preside e assuma i sei
camerati, non servono concorsi, bastano come metro del loro “merito” le pure
immagini, prive per una volta di ogni opacità semantica. Hanno i titoli e
soprattutto il tirocinio pragmatico necessari per insegnare, crocianamente
s’intende, la filosofia dello scappellotto. Michele Prospero
Scuola, il ministro
Valditara nega di essere fascista: "Lo dimostrano i miei libri e miei atti".
Il ministro dell'Istruzione Valditara, in una intervista, si è dichiarato non
fascista: "Mio unico provvedimento contro docente che negava la
shoah". Valentina Mericio su Notizie.it il 4 Marzo 2023
Il ministro dell’Istruzione e
del merito Valditara ha difeso le sue posizioni proprio nelle ore in cui Firenze
si preparava ad accogliere la manifestazione antifascista. In una intervista
rilasciata al Quotidiano Nazionale, il ministro ha ricordato che il padre non
era fascista e che anzi il padre era un partigiano delle Brigate Garibaldi: “A
casa ho ancora il suo fazzoletto rosso”, ha spiegato.
Scuola, il ministro Valditara
si difende: “Non ho bisogno di dare prove del mio antifascismo”
Nel corso dell’intervista
Valditara ha rilanciato evidenziando quanto sia importante manifestare in modo
democratico e confrontarsi: “Ben venga qualunque manifestazione che dia voce
alle idee e alimenti un dibattito democratico. Per parte mia raccolgo e rilancio
l’invito del sindaco Nardella per un confronto con lui sui temi
dell’antifascismo, di tutti i razzismi, della democrazia e della libertà di
opinione: organizziamolo presto. Un confronto che deve essere franco, onesto e
sereno”.
In merito ai fatti dei giorni
scorsi avvenuti al liceo Michelangelo, il ministro ha sottolineato che nei
confronti della dirigente scolastica non verranno presi provvedimenti: “L’unica
indagine disciplinare che ho chiesto è stata nei confronti di un docente
accusato di aver fatto affermazioni che negavano l’Olocausto. Aggiungi al
riguardo che non è compatibile con il pubblico impiego chi neghi la Shoah.
Rimettiamo al centro il dialogo e l’ascolto pluralista. Si approfitti di questa
occasione per sollevare un dibattito serio nel Paese”.
Profondo rosso. Augusto
Minzolini il 4 Marzo 2023 su Il Giornale.
Oggi a Firenze ci sarà il
battesimo del nuovo progetto politico della sinistra.
Oggi a Firenze ci sarà il
battesimo del nuovo progetto politico della sinistra. Pd, Verdi e post
comunisti, grillini, Landini e una spruzzatina di «radical chic» alla Oliviero
Toscani, tutti insieme appassionatamente per una manifestazione anti-fascista.
Un salto indietro nel tempo di decenni e decenni. Ma, soprattutto, una
regressione della sinistra italiana, che per sposarsi con i 5 Stelle ha ritirato
fuori dalla soffitta il vecchio armamentario di un tempo.
Ora, tutto è legittimo e
rispettabile, ma parlare di fascismo nel 2023 fa un po' impressione. Soprattutto
è un argomento che la sinistra tira in ballo ogni volta che è in crisi di idee
per criminalizzare l'avversario. Un'arma spuntata che ha come unica conseguenza
quella di radicalizzare gli animi e riproporre lo scontro ideologico. Il che
potrà pure apparire assurdo, ma è proprio l'obiettivo di Elly Schlein:
radicalizzare lo scontro per ridare un'anima al Pd.
Il nuovo vestito del partito è
il profondo rosso, proprio per evitare che qualcosa possa nascere o vivere alla
sua sinistra. In fondo è una vecchia regola comunista, riletta e riveduta in
chiave movimentista. Se cinquanta anni fa il problema del Pci era non farsi
scavalcare dai gruppuscoli dei vari Lucio Magri o Mario Capanna, ora la Schlein
punta a dire qualcosa più di sinistra - per citare Nanni Moretti - di Giuseppe
Conte. Anzi , lo insegue sulle sue tematiche. Siamo, quindi, in un vortice che
vede la nuova segretaria del Pd chiedere le dimissioni del ministro dell'Interno
e aderire alla manifestazione grillina di solidarietà verso la preside che ha
lanciato l'allarme anti-fascista a Firenze.
È evidente che in uno schema
del genere la proposta economica del Pd ricalcherà quella dell'anima più
massimalista della Cgil: un fisco proiettato verso ogni tipo di patrimoniale e
un ambientalismo ideologico. La politica estera, invece, asseconderà il
pacifismo disarmato dei grillini. Come pure sulla giustizia sarà cancellata
anche l'ombra del garantismo per non dispiacere a Conte e a Travaglio e non
prestare il fianco alle loro critiche.
Su questa linea, come è
avvenuto in passato, i veri nemici del Pd diventeranno i riformisti, cioè quelli
dentro al partito (le loro speranze ecumeniche si trasformeranno sempre più in
contraddizioni insuperabili) e l'area di centro che guarda a sinistra. Un'area
che per un Pd protagonista di un processo di polarizzazione della politica
italiana, va delegittimata. In fondo i massimalisti da sempre individuano nei
riformisti i loro avversari giurati. Basta pensare alla faida tra socialisti e
comunisti in questo Paese (la vicenda di Bettino Craxi è esemplare).
Polarizzare significa, infatti,
obbligare gli altri a schierarsi, a stare di qua o di là. Ed è naturale che
l'«antifascismo» sia uno degli argomenti, magari il più comodo in presenza di un
governo caratterizzato a destra, con cui scavare un solco. Una patina
coniugabile con tutto: con la violenza nelle piazze, con l'immigrazione, con i
diritti civili e chi più ne ha più ne metta.
Il delirio antifascista di
Montanari getta benzina sul fuoco: vuole “aprire la testa” agli studenti.
Federica Argento il 4 Marzo 2023 su Il Secolo d’Italia.
Lo sproloquio antifascista
di Tomaso Montanari dal palco di Firenze è la raffigurazione plastica dell’odio
e dell’intolleranza. La sinistra condanna la violenza nelle scuole in maniera
selettiva: quando a picchiare sono i rossi nessuno lo deve sapere. Vedi i fatti
di Bologna. In presenza, nello stesso giorno, di striscioni con Meloni e
Valditara a testa in giù davanti al liceo Carducci di Milano la parola d’ordine
è tacere. Nessuno da sinistra ha preso le distanze. Tantomeno Montanari. Invece
il problema oggi per il rettore dell’Univeristà di Siena e per quanti lo hanno
applaudito al corteo fiorentino è il fascismo.
Secondo lui, che ha anche le
traveggole, “oggi nella politica, nei media, c’è una grande zona grigia di
complicità con i fascisti. Ci dicono: questo governo non c’entra nulla con il
fascismo e io dico: se il ministro della Scuola intimidisce una preside perché
ha parlato di antifascismo allora dov’è che siamo? Fascista è chi il fascista
fa”. Il rettore dell’Università per stranieri di Siena getta benzina sul fuoco
dal palco di Firenze.
Le sue parole sono pericolose.
Praticamente dice che la scuola deve fare politica e instillare un antifascismo
in assenza di fascismo. Parole grottesche. Per Montanari la scuola non ha fatto
abbastanza nell’opera di indottrinamento e di emarginazione di chi non ha un
orientamento di sinistra. “E’ la stessa democrazia ad essere a rischio tra
astensionismo di massa e ritorno del fascismo – prosegue nel suo delirio- .
Perché non si è lavorato a produrre una massa cosciente. Eppure è a questo che
serve la scuola: non a selezionare una classe dirigente ma a formare una massa
cosciente, parole di don Milani”. Gli studenti per lui devono essere manipolati
fino a diventare “massa cosciente”. Dove pensa di stare, nell’ex Urss?
“Vogliamo davvero essere
antifascisti? – esplode- . Riportiamo la scuola alla sua funzione
costituzionale. Permettiamo che abbia una sua coscienza civile per non tradire
anche noi i nostri ragazzi. Perché se accanto ai calci dei fascisti si prendono
anche la scuola del ‘merito’ e dell’alternanza scuola-lavoro allora davvero non
c’è speranza”. Il riferimento al “merito” è una chiara istigazione in quel
contesto di piazza: ragazzi, il ministro Valditara, al quale ha dato poco prima
del “fascista”, è il nemico. Dirà qualcosa dei democraticissimi studenti che
hanno messo il ministro a testa in giù sullo striscione? Sono “massa”
sufficientemente “cosciente”?
Come vuole “aprire la testa”
agli studenti
Ad istigare all’odio oggi c’era
Montanari e a chi l’ ha applaudito acriticamente. Il peggio viene alla fine,
quando l’ultras Montanari ha usato parole tristemente evocative. “Nessuno di
voi, ragazzi, pensi che la testa dei fascisti si apra a forza di colpi con la
chiave inglese”. Pensava di usare parole di pacificazione, ma non lo sono
affatto. “Ai fascisti la testa gli si apre con scuola giusta”. Qualche cattivo
maestro dovrà farsi un esame di coscienza.
La surreale marcia
di Conte e Schlein contro i fascisti (immaginari) Andrea Indini il 4 Marzo
2023 su Il Giornale.
Il corteo antifascista di
Firenze raccatta tutta la sinistra: dall'Anpi alla Cgil, dai 5S ai dem.
Impugnano la Costituzione contro una deriva dittatoriale ma chiudono gli occhi
davanti alla minaccia anarchica
Ebbene sì: nel 2023 siamo
ancora qui a parlare di fascismo. Impossibile farne a meno. Perché il corteo di
Firenze - o meglio la surreale "passeggiata antifascista" indetta da Cgil, Cisl
e Uil "in difesa della scuola e della Costituzione" - è diventato tutt'a un
tratto il collante del sinistrume nostrano, grillini compresi. Accanto ai centri
sociali, ai collettivi studenteschi, alle prezzemoline sigle dell'onnipresente
associazionismo rosso (Anpi, Acli, Cobas e l'immancabile Anpi), si sono accodati
- rullo di tamburi - la neo segretaria nazionale del Pd Elly Schlein e il leader
M5S Giuseppe Conte. Tutti a fingere che l'Italia corra un gravissimo rischio:
l'instaurazione di una nuova dittatura fascista.
A sentir sproloquiare gente
come il segretario della Cgil Toscana, Rossano Rossi (omen nomen), qualcuno tra
quelli che oggi hanno marciato a Firenze contro il "disgustoso rigurgito" dello
squadrismo nero sembrerebbe credere davvero a questo imperituro allarmismo che
àncora la sinistra in crisi di ideali (ma non di ideologia) ai fantasmi di
settant'anni fa. "Il fascismo oggi prende il volto delle organizzazioni di
estrema destra che picchiano giovani di sinistra davanti alle scuole e assaltano
le sedi sindacali", ha sentenziato Rossi. E poi ancora: "Dobbiamo essere
partigiani e non indifferenti: Firenze e la Toscana oggi sono il centro
dell'Italia democratica e antifascista". Partigiani, appunto. Come all'inizio
degli anni Quaranta del secolo scorso. E come oggi, nel nuovo millennio. Tutto
muta, tranne loro. Partigiani sempre. Bella ciao e tutto il resto: i pugni
chiusi, le bandiere rosse con la falce e il martello, gli slogan. Sempre i
soliti, come quello intercettato dal Foglio: "Uccidere un fascista non è un
reato". E poi il tiro al ministro, Giuseppe Valditara in primis. E anche i due
Matteo, Salvini e Piantedosi. Ma soprattutto lei: Giorgia Meloni. Tutti
fascisti, tutti da defenestrare da Palazzo Chigi e dai loro ministeri.
Esattamente come li hanno dipinti gli studenti del liceo classico "Carducci" di
Milano: premier e ministro dell'Istruzione a testa in giù. Ecco l'"Italia
democratica e antifascista", ecco la crème de la crème dei collettivi
studenteschi. Stessa risma dei centri sociali che a Bologna hanno preso a
bastonate i ragazzi di Azione Universitaria. O dei violenti che alla Sapienza
hanno tolto a Daniele Capezzone il diritto a parlare.
A questa combriccola di
manifestanti va dato atto che, di generazione in generazione, perseverano con
assurda tenacia nella solita, strampalata narrazione. Decine di anni a brandire
la Costituzione contro un'immaginaria deriva autoritaria che non si è mai
verificata. Ma che importa? "Siamo in piazza per difendere i principi
costituzionali", sentenzia Conte. Eppure il governo è stato eletto
democraticamente, dovrebbe saperlo, lui che a Palazzo Chigi è stato paracadutato
senza nemmeno passare dal voto e quando ci è passato ha perso. Pure la Schlein
sembra ignorare il mandato popolare conferito al centrodestra. "Il Pd è ovunque
si difende Costituzione", dice. E poi col più classico dei no pasarán: "Quei
metodi violenti non passeranno, quei metodi squadristi non passeranno,
troveranno questo cordone di solidarietà umana a difesa della scuola come
presidio di cultura antifascista". Un cordone di solidarietà umana che, quando a
odiare, pestare e minacciare sono i centri sociali, i collettivi studenteschi o
gli anarchici, si volta opportunamente dall'altra parte.
Quella surreale marcia fuori
tempo. Dopo la marcia su Roma, ecco cent'anni dopo la surreale la marcia su
Firenze. Paolo Armaroli il 5 Marzo 2023 su Il Giornale.
Dopo la marcia su Roma, ecco
cent'anni dopo la surreale la marcia su Firenze. Aveva ragione il vecchio Marx,
Carlo non Groucho: «La Storia si manifesta una prima volta in tragedia e una
seconda volta in farsa». Ieri hanno marciato sul capoluogo toscano i soliti
noti: Landini, l'Anpi e compagnia cantante. Gente che ancora non ha digerito che
Giorgia Meloni si sia legittimamente insediata a Palazzo Chigi senza sfigurare
affatto. Come hanno riconosciuto Letta e Bonaccini, per questo lapidati dai
sanculotti delle zone a traffico limitato delle grandi città. Né poteva mancare
noblesse oblige la partecipazione straordinaria di Conte, un estremista per
prudenza, e della Schlein. I promessi sposi. I Renzo e Lucia dei giorni nostri.
Ma, come nelle comiche finali, presto potrebbero prendersi a torte in faccia per
via della «roba»: i voti degli elettori.
Che ci sono venuti a fare? Ma è
chiaro: per sfogare in corteo la loro rabbia. Novelli Don Chisciotte, hanno
voluto ancora una volta combattere fuori tempo massimo contro i mulini a vento
di un fascismo immaginario. Roba da matti. Hanno voluto esprimere la loro
solidarietà alla preside Savino, sulla cui famosa lettera il ministro Valditara
si è permesso di esprimere perplessità non sulle sue opinioni ma sui suoi
errori. Perché Gramsci non è morto in carcere. Come ha scritto spensieratamente
la preside, abilitata pare all'insegnamento di storia e filosofia. No, Gramsci
era da un pezzo in libertà condizionata. Perché la ricostruzione della nascita,
e della rinascita, del fascismo da parte della preside è stata ad usum delphini.
Perché la sua condanna delle frontiere è assurda. Difatti, oltre a delimitare un
territorio, racchiudono un'identità nazionale. Siamo entrati in Europa in quanto
italiani. E ne siamo orgogliosi.
Elly ha esordito dicendo che
farà vedere i sorci verdi a Giorgia. Sai che paura, ha lasciato intendere la
presidente del Consiglio. Lei si aspetta dal Pd un'opposizione durissima. Fuori
e dentro il Parlamento. Ma l'opposizione va saputa fare. E la fresca numero uno
del Pd ha cominciato con il piede sbagliato. Una manifestazione riesce non per
il numero dei partecipanti, un'infinitesima parte della popolazione. Ma se
squaderna una buona causa davanti al tribunale dell'opinione pubblica. E invece
anche qui a Firenze ieri si è manifestato non «per» ma «contro». Il colmo della
mistificazione è poi osannare a parole la Costituzione, quella che Benigni e i
suoi cari definiscono la più bella del mondo, e nei fatti proteggere gli
studenti che se la mettono sotto i piedi quando pretendono di vietare la libera
manifestazione di pensiero come all'università di Roma, a Firenze, a Bologna e
altrove a chi non la pensa come loro.
Si può ingannare una persona
per tutta la vita, tutti per una volta, ma non si possono ingannare tutti per
sempre. Parola di Abramo Lincoln. Ma lo sanno i manifestanti fiorentini di ieri?
Lo sanno i promessi sposi?
Unico collante ideologico la
mobilitazione totale contro il pericolo fascista (che però non esiste).
Rispolverato il vecchio ritornello lo tirano in ballo come pretesto. Francesco
Giubilei il 4 Marzo 2023 su Il Giornale.
Quasi ogni giorno, dalla
campagna elettorale di questa estate a oggi, la sinistra ha rispolverato un suo
grande classico: l'antifascismo come strumento politico. Una tendenza destinata
a durare per tutto il periodo in cui il centrodestra governerà e che utilizza
ogni occasione per tirare in ballo il «pericolo fascista». Lo si è visto con
quanto avvenuto al Liceo Michelangiolo di Firenze e con le successive polemiche
dopo la lettera della preside del Liceo Da Vinci di Firenze Annalisa Savino e le
parole del ministro Valditara culminate con la manifestazione antifascista
andata in scena ieri a Firenze in cui, guarda caso, era presente anche la
Savino. Già a settembre, pochi giorni prima delle elezioni, Enrico Letta aveva
dichiarato: «La moderata Meloni annuncia che cambieranno la Costituzione da
soli. Gli italiani domenica, con il loro voto, diranno a questa destra che la
Costituzione nata dalla Resistenza e dall'antifascismo non si tocca». Non è
andata proprio così. Il suo compagno Nicola Fratoianni era stato ancor più
esplicito: «Meloni dice che non è fascista. Ma per governare l'Italia bisogna
fare un passo in più, bisogna definirsi antifascista». Una frase significativa
che testimonia come non sia sufficiente dirsi non fascisti ma occorra definirsi
«antifascisti» come se si trattasse di un'ideologia a cui aderire. Le parole di
Fratoianni spiegano che, qualunque cosa dica la destra su questi temi, non basta
mai, serve sempre un passo in più fino a dar vita alla famosa destra che piace
alla sinistra. Perciò ieri a Firenze la «cosa rossa» è scesa «in piazza per
ribadire l'antifascismo come valore fondante» in una manifestazione che, già
dagli intenti, è nata contro qualcuno o qualcosa, in questo caso Valditara e il
governo. Una grande chiamata a raccolta dalla Schlein a Conte, da Landini
all'Anpi. Nelle ultime settimane è stato un profluvio di dichiarazioni e, con la
«piazza antifascista» di Firenze (a quando una «piazza anticomunista» (?), si è
toccato il punto più alto. Se la Schlein ha parlato di una «risposta allo
squadrismo» e di una «scuola come presidio antifascista», il suo collega
Giuseppe Provenzano del Pd ha affermato: «I valori dell'antifascismo dovrebbero
unire tutte le forze politiche. Oggi è il momento dell'unità di popolo». Tomaso
Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena, ha invece utilizzato
toni radicali: «Ci dicono questo governo non c'entra nulla con il fascismo e io
dico se il ministro della Scuola intimidisce una preside perché ha parlato di
antifascismo allora dov'è che siamo? Fascista è chi il fascista fa». Secondo
Rossano Rossi, segretario della Cgil Toscana: «Dobbiamo essere partigiani e non
indifferenti: Firenze e la Toscana oggi sono il centro dell'Italia democratica e
antifascista». Se per i fatti del Liceo Michelangiolo non si sono sprecate le
parole, si registra un silenzio assordante per condannare l'aggressione avvenuta
qualche mese fa a Bologna da parte dei collettivi ai danni di alcuni studenti di
destra di cui sono state da poco diffuse le immagini. Così come sono mancate
frasi di solidarietà al ministro Valditara per le minacce ricevute o prese di
distanza dai collettivi quando impedivano di svolgere convegni nelle università
pubbliche. Sarebbe davvero paradossale se ancora oggi passasse il messaggio che
la violenza è sbagliata ma ci sono alcune violenze più sbagliate di altre a
seconda di chi le compie.
“No alla violenza fascista”,
censura su quella comunista: Repubblica ormai sembra la Pravda. Lucio Meo il
4 Marzo 2023 su Il Secolo d’Italia.
Grande spazio, questa mattina,
sui giornali di sinistra, alla manifestazione anti fascista che si svolgerà nel
pomeriggio a Firenze a seguito della rissa di qualche giorno fa all’esterno di
un liceo fiorentino, tra ragazzi di opposte fazioni. Nulla, o quasi, invece,
sulle indagini a carico degli studenti dei Collettivi a carico degli esponenti
di Azione studentesca, con otto giovani “compagni” indagati dalla Procura di
Bologna anche grazie a un video che riprende le scene di violenza. “Repubblica”,
in particolare, saluta il debutto della Schlein a Firenze con una paginata di
giubilo, senza dedicare neanche un rigo ai fatti di Bologna. “No alla violenza
fascista”, scrive “Repubblica”, ma su quella comunista non c’è spazio neanche
per una breve. Magari due righe per dire che a Bologna, menare un ragazzo di
destra, non è vero che non è reato…
“Repubblica” allarmata per la
violenza fascista, ma solo per quella…
“La manifestazione antifascista
quella che attraverserà le strade del centro storico oggi pomeriggio. Un corteo
che riunirà non solo fiorentini, ma anche studenti, genitori, insegnanti e
lavoratori da altre regioni: Lombardia, Piemonte, Lazio, Emilia. E poi numerosi
volti della politica, con i capi di partito: dalla nuova segretaria nazionale
del Pd, Elly Schlein a Giuseppe Conte leader dell Movimento 5 Stelle….”, scrive
“Repubblica” .
Bologna, otto indagati per il
pestaggio ai danni degli studenti di destra. Ma nessuno si è mai indignato...
(video)
Eppure ieri tutte le agenzie
hanno dato la notizia di otto giovani sono indagati dalla Procura di Bologna per
un’aggressione, avvenuta il 19 maggio 2022 ai danni di un gruppo di studenti di
Azione Universitaria. Le accuse contestate sono di lesioni personali aggravate e
rapina.
Le minacce agli studenti
fascisti
In particolare, come si legge
nel capo di imputazione, contenuto nell’avviso di conclusione delle indagini,
gli indagati “in concorso tra loro e con altri non tutti meglio identificati con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rivolgendo minacce con
frasi del tipo “tornate nelle fogne”, “siete morti”, “vi uccidiamo”, “ve ne
dovete andare”, nonché per mezzo di violenza consistita in calci, spintoni,
pugni e strattonamenti al fine di trame un ingiusto profitto si impossessavano
delle bandiere e delle aste per bandiere detenute dagli esponenti del movimento
studentesco ‘Azione Universitaria’. Uno degli aggressori in particolare si
scagliava con violenza da tergo contro uno dei membri del movimento, sfilandogli
così la bandiera che lo stesso portava alle spalle”. Cosine così, secondarie per
“Repubblica” nazionale, nel giorno del “no alla violenza fascista…”.
In corteo bandiere e slogan
violenti: "Uccidere i fascisti non è reato". Federico Bini il 5 Marzo 2023
su Il Giornale.
Altro che difesa della scuola e
della Costituzione, solo attacco all'esecutivo di centrodestra. Nel mirino i
ministri Piantedosi e Valditara. E qua e là anche manifesti di solidarietà a
Cospito e contro il 41 bis.
Firenze. Doveva essere una
manifestazione a difesa di scuola e Costituzione, quella organizzata ieri da
Cgil, Cisl e Uil, dopo i fatti del Liceo Classico Michelangiolo. Invece si è
trasformata, come era facile intuire, in un evento strettamente politico e
contro il governo Meloni. Gianfranco Pagliarulo, presidente Anpi, attacca:
«Meloni, lei piange per le leggi razziali ma non condanna il fascismo!». E
qualcuno grida: «Il maresciallo Tito ce l'ha insegnato uccidere un fascista non
è un reato».
In piazza si respira un ritorno
al passato più che al futuro, riproponendo una sinistra che vuole mettere
insieme forze moderate con frange più estremiste e radicali. Slogan «boicottare
Israele e Palestina libera», bandiere jugoslave, anarchiche, palestinesi, tante
falci e martello, cartelloni con scritto «sono antifascista ma soprattutto
comunista», «Valditara e Piantedosi. Dimissioni». Ma forte è anche il sentimento
anti-Nato. Spiccano manifesti contro l'imperialismo, il militarismo e le guerre
umanitarie, colpevoli di «rapinare risorse e fonti di energia». Il corteo giunge
in Santa Croce sulle note di Bella Ciao, e lentamente iniziano ad arrivare prima
gli esponenti di primo piano dei partiti e poi i leader. Bonelli, Fratoianni,
Serracchiani, Boldrini, Fiano, Verini, Provenzano, quindi la neosegretaria
Schlein e Giuseppe Conte. Al momento della foto tra Landini, Conte e Giani, un
organizzatore della Cgil si lascia andare ad una battuta: «Sta nascendo il Conte
ter» e a fine comizio, sotto il palco un altro sindacalista, soddisfatto
dell'esito, strizzando l'occhio al compagno (alcuni si chiamano ancora compagni)
esclama: «Bene. Possiamo dire che l'operazione politica è stata compiuta». E se
anche i rappresentanti del Pd non lo ammettono chiaramente, da Giani alla
Boldrini, parlano di «piazza democratica», è probabile che da qui possa iniziare
il percorso per la nascita di un nuovo fronte progressista. Dal palco uno dei
ragazzi chiamati a intervenire si lascia andare - si spera a causa della foga
del momento ad un «c'è Cospito in carcere e i fascisti liberi». In diversi
intervistati, antifascisti lombardi e liguri, c'è solidarietà verso l'anarchico
rinchiuso al 41-bis. Qualcuno parla addirittura di «persecuzione politica».
Applauditissima e super protetta dagli uomini delle forze dell'ordine la
neosegretaria del Pd. Gli elettori democratici apprezzano una svolta più a
sinistra, sconfessano Matteo Renzi, «non l'abbiamo mai votato!», e Carlo
Calenda. Ma sono comunque i tanti ragazzi dei collettivi e non, che davanti ai
vertici dei partiti chiariscono: «Non vengano pure qui a fare passerelle. Dal
comune alla regione al governo nazionale hanno partecipato alla distruzione del
paese». Come vedrebbe questa alleanza tra Pd e M5s - chiedo ad un passante con
la bandiera della Cisl messa in modo un po' garibaldino? «Io sono un cattolico
di sinistra. Mi rappresentava Fioroni che però è uscito spero non sia solo un
accordo elettorale». Ma dal reddito di cittadinanza, «non sono favorevole»,
all'invio di armi a Kiev non è in linea con la politica contiana. Insomma, molte
sono le contraddizioni nella rossa piazza fiorentina. Anzi, richiamando Mao,
«grande è la confusione» nella galassia progressista. Schlein e Conte in fondo
al palco parlottano amichevolmente, poi si girano e salutano insieme.
L'antifascismo e la lotta al governo Meloni, li unisce, almeno nei discorsi.
All'uscita, un gruppo di giovani regala dei giornalini marxisti per la
rivoluzione: «L'inganno della transizione capitalista».
La battaglia di libertà:
dalla strage di Cutro a Cospito. Il fascismo è processare ingiustamente
Berlusconi e tenere Eva Kaili in carcere tra torture e ricatti. Piero
Sansonetti su Il Riformista il 4 Marzo 2023
Oggi si svolge a Firenze una
manifestazione antifascista. È stata convocata per protestare contro
l’aggressione subita dagli studenti del liceo Michelangelo da parte di una
pattuglia di estrema destra, e contro il silenzio del governo di centrodestra su
questo episodio. È giusto protestare. Anche se il liceo Michelangelo non credo
sia il cuore del problema-Italia.
Io resto dell’idea che se
vogliamo fare delle battaglie antifasciste serie, dobbiamo occuparci
del fascismo moderno. Che poi ognuno può chiamarlo come vuole ma è un fenomeno
reazionario vero, non solo italiano, che rischia di rimandare indietro di molti
anni il livello alto di civiltà che l’Europa aveva conquistato in questi anni.
Per me l’antifascismo non è un’etichetta. Una bandiera. Un richiamo alla
tradizione e all’eroismo dei partigiani. Non è la canzone Bella Ciao o Fischia
il vento. Non è un rito. È più radicalmente – molto più radicalmente – una
battaglia per la libertà, contro la repressione, contro il giustizialismo,
l’ultralegalitarismo, la xenofobia, il razzismo, il nazionalismo,
l’autoritarismo. Per me antifascismo vuol dire opporsi ai respingimenti dei
profughi, difendere l’articolo 10 della Costituzione, protestare per la
detenzione (in assenza di reati) di Dell’Utri o di Contrada e per il carcere
duro illegalmente inflitto ad Alfredo Cospito.
È difendere la
comandante Carola Rakete, e anche Berlusconi processato ingiustamente, è trovare
casa e lavoro ai migranti, denunciare la follia della violazione dell’articolo
11 della Costituzione e del coinvolgimento dell’Italia nella guerra in Ucraina,
ed è anche indignarsi per i fenomeni di Torquemadismo in corso in Belgio ai
danni di alcuni parlamentari europei. Mi riferisco in particolare alla
situazione della deputata europea di nazionalità greca Eva Kaili, che è stata
catturata e messa in cella tre mesi fa con l’accusa di essersi fatta corrompere
dal governo del Qatar, o forse da quello del Marocco, ma contro la quale, a
quanto sembra, non si trovano le prove. La Procura belga ha deciso di usare il
carcere come mezzo di indagine. Come si faceva fino al 700.
Lo ha già fatto con il compagno
della Kaili, Francesco Giorgi, e con Antonio Panzeri. Loro hanno accettato il
gioco, pare, hanno confessato, hanno lanciato qualche accusa contro un paio di
parlamentari, seppure senza offrire riscontri, hanno detto quello che i
magistrati volevano che dicessero, e in cambio hanno ottenuto uno la
liberazione, l’altro un formidabile sconto di pena e la scarcerazione di moglie
e figlia. Eva Kaili invece non ha accettato di confessare, si dichiara innocente
e fa infuriare gli inquirenti. Che l’hanno arrestata illegalmente, perché lei
era protetta dall’immunità parlamentare – inventandosi una inesistente flagranza
di reato – l’hanno anche torturata, tenendola 48 ore al gelo e senz’acqua (dopo
avergli sequestrato anche il cappotto) in una cella di isolamento con le luci
sparate per non farla dormire, e le hanno fatto capire che o parla o resta al
gabbio.
Ieri il giudice ha respinto una
sua richiesta di liberazione e ha decretato che starà in cella almeno altri due
mesi. Cioè che per ora è stata condannata a cinque mesi di prigione senza
processo. Poi, se non parla, altri mesi. Sebbene non esistano le condizioni per
la carcerazione preventiva (non può scappare, non può reiterare, non può
inquinare le prove) e sebbene la Kaili sia madre di una bambinetta di due anni
che non vedrà la mamma per almeno cinque mesi (nemmeno nel giorno del suo
secondo compleanno), che sono i mesi più importanti della vita di un bambino per
i rapporti con la mamma. Chiamatelo medioevo, chiamatelo fascismo, se per
fascismo intendete il modello più noto dei regimi autoritari europei, chiamatela
pura sopraffazione dello Stato. Di certo è una violazione pazzesca del diritto e
una sfida alla politica e alla democrazia. La politica però non reagisce. Si
inchina a Torquemada. La stampa non ha neanche bisogno di inchinarsi perché è
già prona.
Mi piacerebbe se
la manifestazione di Firenze si occupasse anche di questo. E si schierasse a
difesa della deputata greca. E poi, soprattutto, mi piacerebbe se si occupasse
di Cutro e protestasse per la politica della non-accoglienza (che certo però non
può essere addossata solo al governo attuale) che sei giorni fa ha provocato una
vera e propria strage di profughi. Avvenimento che a me pare, per la sua
gravità, schiacci tutte le altre polemiche. È impossibile spiegarsi come mai i
ministri che avevano la responsabilità dei salvataggi non siano stati ancora
allontanati. Elly Schlein ha chiesto l’altro giorno le loro dimissioni. Ha fatto
benissimo. È un ottimo esordio. Mi auguro che non demorda. Sennò l’antifascismo
diventa pura cerimonia.
Piero Sansonetti. Giornalista
professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato
vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi
di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare
alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 2019.
Minaccia
fascista immaginaria, violenza anarchica reale. Schlein e Conte marciano
contro un minaccia inesistente, gli anarchici devastano Torino in nome di
Cospito. Il legame tra le due piazze e i silenzi colpevoli della sinistra.
Andrea Indini il 6 Marzo 2023 su Il Giornale.
Le aste dei segnali stradali
divelte per distruggere automobili e negozi. A terra, lungo le vie che hanno
attraversato, i segni della devastazione. I tombini di ghisa usati allo stesso
modo. Per danneggiare, per rompere qualunque cosa gli capitasse a tiro, per far
dilagare odio e violenza. Guerriglia urbana in nome di un terrorista al 41
bis, guerriglia urbana per chiedere che quel terrorista venga tolto dal 41 bis
nonostante il sangue che ha versato. Violenza su violenza. Nell'arsenale degli
anarchici, che ieri pomeriggio hanno protestato a Torino, la Digos ha trovato di
tutto. Maschere antigas, scudi, caschi, liquido infiammabile, fumogeni e altri
tipi di artifici pirotecnici. E ancora: bastoni, martelli e tenaglie. Sono la
prova che il corteo era sceso in piazza non per manifestare ma per spaccare e
fare del male agli agenti.
Due piazze distanti. A Firenze
il volto "pacifista" della sinistra: l'abbraccio tra la neo segretaria
piddì Elly Schlein, il leader M5s Giuseppe Conte e il segretario dell
Cgil Maurizio Landini, le bandiere arcobaleno, gli slogan in difesa della
Costituzione e della scuola. A Torino il braccio violento della sinistra
extraparlamentare: i manifestanti con le tute scure e i volti nascosti nei
caschi, le bandiere nere con la "A" rossa di anarchia, gli slogan a inneggiare
Alfredo Cospito. Due piazze distanti, ma non troppo. Perché a Firenze, tra le
pieghe del "sabato antifascista", è tangibile quello stesso germe di violenza.
Lo puoi respirare a pieni polmoni quando la piazza scandisce a gran voce "Il
maresciallo Tito ce l'ha insegnato: uccidere un fascista non è un reato". Lo
intravedi quando leggi "Tortura di Stato" sui drappi bianchi portati in corteo e
senti la solidarietà dei manifestanti per il terrorista. Echi che rimbalzano da
una piazza all'altra. Un legame stretto che i dem, i Cinque Stelle e le sigle
dell'associazionismo rosso intervenute ieri continueranno a negare come hanno
sempre fatto. Ma è un legame che esiste. E fa paura.
La surreale marcia di Conte e
Schlein contro i fascisti (immaginari)
Poche ore prima che a Torino
esploda la violenza, a Milano gli stessi anarchici appendono sui cancelli di un
liceo classico i busti della Meloni e del ministro all'Istruzione Giuseppe
Valditara. Appesi al contrario, appesi a testa in giù. Sempre lo stesso germe
che si è sparso ieri sera per le vie di Torino. Possibile non vederlo? A
sinistra non ci riescono proprio. Sono troppo impegnati a dare la caccia a una
fantomatica minaccia fascista. E così succede che, mentre scendono in piazza per
difendere il liceo "Michelangiolo" di Firenze, si scordano del raid
dei collettivi di Bologna ai ragazzi di Azione Studentesca. E succede anche che,
mentre accusano il governo di minare la tenuta democratica del Paese, chiudono
gli occhi davanti alle pulsioni anarchiche della loro stessa piazza. Le stesse
pulsioni che in un'altra piazza (distante nemmeno così tanti chilometri)
sfociano in devastazioni e violenze e mandano in ospedale diversi poliziotti.
Forse è per tutto questo che sia sui fatti di Milano sia sulla guerriglia urbana
di Torino gravano i silenzi colpevoli di tutta la sinistra.
Gridano al fascismo. Ma le
vere minacce sono i vessilli neri della lotta anarchica. I rapporti
dell'intelligence: "Si sono mobilitate numerose sigle nazionali e
internazionali". Il caso Cospito pretesto per l'azione distruttiva.
L'avvertimento: "Se Alfredo muore sarà vendicato". Massimo Malpica
il 6 Marzo 2023 su Il Giornale.
C'è un vento nero che soffia
sull'Italia, ma non pare essere quello che la sinistra agitava come spauracchio
contro il governo Meloni. Il vento agita infatti una nera bandiera anarchica, e
non fascista, brandita da mesi per supportare la causa di Alfredo Cospito.
«Finché Alfredo respira dobbiamo lottare per lui. Ma se Alfredo muore questi
vigliacchi e assassini devono pentirsi di quello che stanno facendo: dobbiamo
fargliela pagare». Quasi una dichiarazione programmatica quella dello storico
militante anarchico disabile Pasquale Lello Valitutti, che chiarisce l'obiettivo
della rivolta anarchica degli ultimi mesi. Una vera escalation, che ha
accompagnato le polemiche sul regime carcerario al quale è costretto il leader
della Federazione anarchica informale. Le parole di Valitutti, la sua personale
opinione su come appoggiare la battaglia del compagno Cospito ed eventualmente
vendicarlo se dovesse portare il suo sciopero della fame contro il carcere duro
fino alle estreme conseguenze, hanno aperto l'ultimo capitolo del libro delle
proteste e delle violenze, il corteo torinese di sabato. Partiti da piazza
Solferino, le centinaia di anarchici arrivati da ogni parte d'Italia hanno
percorso le vie del centro della città piemontese accendendo fumogeni,
imbrattando i muri con simboli anarchici, scritte a favore di Cospito, slogan
contro il 41 bis e insulti contro il Guardasigilli Nordio, vandalizzato auto,
palazzi, negozi, lanciato bombe carta e petardi e divelto segnali stradali per
usarli come arieti nella loro devastazione. Un bilancio da guerriglia, condito
dai racconti terrorizzati dei negozianti che non avevano accolto l'invito a
sprangare le serrande e dal bollettino della questura sulle decine di militanti
fermati in seguito agli scontri. Ma, appunto, il corteo torinese è solo l'ultimo
di una lunga teoria di proteste, blitz, assalti e violenze pure e semplici. In
tutta Italia, e contro i simboli italiani anche all'estero. Come nel caso
dell'attentato incendiario del primo dicembre scorso, ad Atene, all'automobile
di Susanna Schlein, sorella maggiore della nuova segretaria del Pd, Elly, e
Primo consigliere dell'ambasciata italiana in Grecia. Rivendicato da un gruppo
anarchico greco proprio per solidarietà con Cospito. O come l'incendio dell'auto
di Luigi Estero, Primo consigliere dell'ambasciata italiana a Berlino, andata in
fiamme la sera del 27 gennaio e rivendicata tre giorni dopo dagli uccelli neri,
cellula anarchica tedesca, come segno di adesione alla settimana di azione a
favore di Cospito proclamata, spiegavano nel loro comunicato, dall'America
meridionale.
Non è un caso che nelle stesse
ore di questa chiamata internazionale all'azione da parte della galassia
anarchica, a Barcellona andava in scena un blitz gemello, con un commando che ha
vandalizzato coprendo di scritte contro il 41 bis e a favore di Cospito
l'esterno dell'edificio che ospita il consolato italiano nella città catalana.
E, sempre tra 27 e 28 gennaio, era stata data alle fiamme anche una torre radio
in provincia di Torino, anche qui rivendicando l'attentato con scritte a favore
del leader anarchico e con la richiesta di mettere fine al carcere duro.
Impossibile poi contare le
scritte e gli insulti contro i rappresentanti di questo e del precedente
governo, contro Nordio e contro l'ex Guardasigilli Marta Cartabia, contro i
magistrati e contro ergastolo ostativo e 41 bis apparsi sui muri in tutta
Italia, da Sud a Nord passando per le isole. E anche secondo l'intelligence, se
c'è un pericolo nero in Italia, è quello rappresentato dai vessilli anarchici.
Che, stando alla relazione al Parlamento dei nostri 007, è la minaccia «più
concreta e vitale, caratterizzata da componenti militanti determinate a
promuovere, attraverso una propaganda di taglio fortemente istigatorio,
progettualità di lotta incentrate sulla tipica azione diretta distruttiva». Con
un'enfasi proprio sulla vicenda Cospito, che ha innescato «una veemente
mobilitazione, sostenuta e animata da numerose sigle, italiane ed estere, che si
rifanno, per metodiche operative, alla parabola eversivo-terroristica della
Fai/Fr».
Manifestazione per Cospito a
Torino, danni e feriti. Adesso il Pd sarà contento… di sostenere la battaglia
anarchica sul 41bis. Redazione CdG 1947 1947 su Il Corriere del Giorno il 5
Marzo 2023.
Circa cinquecento persone al
corteo per l'anarchico in sciopero della fame al 41 bis. Atti vandalici nelle
vie del centro, tra vetrine e spaccate e segnali stradali divelti. Due agenti
subiscono lesioni. Trentaquattro denunciati: quattro rischiano l'arresto
Trentaquattro manifestanti
fermati, quattro dei quali rischiano l’arresto, due poliziotti feriti, vetrine
spaccate, danni alle automobili parcheggiate e lanci di lacrimogeni. Questo il
bilancio momentaneo del corteo in solidarietà con Alfredo Cospito, l’anarchico
in sciopero della fame detenuto al 41 bis, che ha visto sfilare circa 500
persone nel centro di Torino, provenienti da tutta Europa. “Alfredo non deve
morire, se muore gliela faremo pagare”, hanno scandito dai megafoni. I
manifestanti, molti dei quali nascosti da caschi, maschere e cappucci, e con
scudi di plexiglas, dopo aver acceso alcuni fumogeni, hanno lanciato petardi e
imbrattato muri e monumenti. E poi bombe carta, vetrine di banche e negozi prese
a mazzate e mandate in frantumi, auto vandalizzate, cassonetti bruciati. Questa
manifestazione, gli anarchici la preparavano da mesi. In solidarietà a Cospito,
per dimostrare anche ancora ci sono e in una città Torino, che per loro è un
simbolo.
Nei pressi del mercato di Porta
Palazzo le forze dell’ordine hanno lanciato alcuni lacrimogeni per disperdere i
manifestanti. Il corteo si è quindi disperso e separato per poi ricompattarsi
poco distante, in piazza Borgo Dora, davanti al Sermig, dove c’è stato un breve
contatto con le forze dell’ordine e l’utilizzo di lacrimogeni. Due poliziotti
sono rimasti feriti nel corso delle tensioni. Si tratta di un operatore del
reparto mobile di Milano che è stato colpito da una bomba carta alla gamba e di
una operatrice della polizia scientifica che è rimasta ferita da una bottiglia
di vetro alla mano.
Complessivamente sono 350 le
persone fermate e identificate, tra queste figurano persone provenienti da
Francia, Spagna, Germania, Austria, Belgio e da una ventina di città italiane.
Intanto, è salito a 34, al momento, il numero delle persone in stato di fermo e
denunciato, la cui posizione è in queste ore al vaglio degli investigatori.
Comminati 11 fogli di via. Durante i controlli disposti tra ieri e oggi in vista
del corteo anarchico, la Digos ha sequestrato mazze, scudi, maschere antigas,
caschi e altro abbigliamento per il travisamento, bombe carta, ma anche garze,
cotone e medicine antivomito.
“Nella manifestazione sono
stati individuati obiettivi sensibili ma nessuno poteva pensare che sarebbero
state devastate anche le macchine dei privati o vetrine di commercianti che
devono sbarcare il lunario in maniera onesta e dignitosa” ha detto il questore
di Torino, Vincenzo Ciarambino, al termine della manifestazione anarchica.
“Quando si muovono queste realtà i danneggiamenti sono all’ordine del giorno, ma
non riesco a comprendere quelli senza criterio. Posso comprendere un
danneggiamento a tema, che non va fatto perché è un reato, ma i danni ai privati
non li capisco”, ha detto ancora, aggiungendo: “Siamo sicuri di identificare
gran parte degli autori di questi reati”.
Siamo vigili e attenti da
diverso tempo – ha risposto poi il questore Ciarambino a chi gli domandava se
tema altre azioni di protesta – Seguiamo l’evolversi del percorso giudiziario e
sanitario di Cospito, i nostri apparati investigativi, centrali e locali,
funzionano per cui siamo pronti a qualsiasi evenienza. Non posso escludere altre
manifestazioni a Torino, faremo le opportune valutazioni anche alla luce di
quello che è successo stasera”.
Il ministro della Difesa Guido
Crosetto chiede la linea del massimo rigore al governo: “Vandali delinquenti,
sedicenti anarchici, ieri hanno portato la guerriglia urbana a Torino. Hanno
distrutto negozi, imbrattato muri, usato violenza su persone e cose, attaccato
le forze dell’ordine. Con questa gente non si tratta. Vanno bloccati, giudicati
e puniti”.
Il sindaco di Torino Stefano Lo
Russo esprime “ferma condanna per la violenza e gli inaccettabili atti di
vandalismo attuati dagli anarchici e piena vicinanza a chi ha subito danni”. La
parlamentare pentastellata Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, commenta su
Twitter: “Questa non è la manifestazione di un pensiero, è una guerriglia
intollerabile e incivile“. E le fa eco il ministro Paolo Zangrillo, coordinatore
di Forza Italia in Piemonte: “Si tratta di teppisti violenti che scendono in
piazza con il solo scopo di distruggere e devastare. Lo Stato è fermo e non farà
nessun passo indietro”. Redazione CdG 1947
"Comunismo unica soluzione".
Tornano i volantinaggi rossi porta a porta. Volantini dei "Circoli operai"
dei "Comitati internazionalisti" sono stati distribuiti casa per casa in
Lombardia con richiami al comunismo proletario di Marx. Francesca Galici
il 6 Marzo 2023 su Il Giornale.
Formalmente siamo nel 2023 e
abbiamo messo cinquant'anni tra noi e gli Anni di piombo, quei bui anni Settanta
che nessuno pensava mai di poter rivivere, nemmeno lontanamente, nemmeno nel
vago retrogusto di un rigurgito di violenza. Eppure, gli scontri nelle piazze,
l'anarchismo violento che rialza la testa, le lotte politiche nei licei che
tornano a far notizia e quel sentore di strategia della tensione che torna
prepotentemente. Se poi, a questo, si aggiunge anche il volantinaggio casa per
casa, il risultato è un vero e proprio salto nel passato.
Questa mattina abbiamo ricevuto
un volantino dei "Volontari dei circoli operai, comitati internazionalisti" dal
titolo "A ogni governo il suo naufragio e le lacrime di coccodrillo". Già da qui
è evidente il tentativo di strumentalizzare la tragedia di Cutro a fine politico
ma questo è quanto fanno, da una settimana ormai, quasi tutte le forze politiche
dell'opposizione e le Ong. Quindi, niente di nuovo su questo fronte. A colpire
maggiormente del volantino che è stato consegnato casa per casa, lasciato
davanti agli usci degli appartamenti dei palazzi in una domenica di marzo, è il
registro linguistico utilizzato per vergare il manifesto.
"Che l'imperialismo sia nemico della vita in molte direzioni è un fatto
risaputo. Dalle trincee del Donbass fino alle spiagge del Mediterraneo,
la borghesia alimenta le sue mortali contraddizioni", si legge nell'incipit del
manifesto, che si rifà evidentemente alle parole d'ordine del Manifesto del
Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels, redatto nel lontano 1848.
Nel volantino di parla di
"padroni", "parassitismo", "palazzi del potere" e di "eserciti di sgherri". I
"volontari dei circoli operai" che hanno redato il documento attaccano con
medesima veemenza tutti i partiti dell'arco parlamentare: "I partiti
parlamentari di destra, di sinistra, progressisti, sovranisti e populisti hanno
edificato in questi anni una politica spietata". Si riferiscono alle politiche
d'immigrazione "ascopo elettorale", alle lacrime versate "per spillare ancora un
po' di soldi a Bruxelles". Secondo questi nuovi volontari rossi, tutti gli
esponenti politici "seminano razzismo verso i più deboli e i più deboli e
raccoglieranno disprezzo".
Quindi, ecco la chiamata,
immancabile in questo genere di manifesti: "Nei posti di lavoro, su banchi di
scuola, nei quartieri delle città di tutto il Continente una vera e
propria classe internazionale sta crescendo". La conclusione, poi, svela la vera
natura di questi volantini: "L'internazionalismo è l'unica via,
il comunismo l'unica soluzione".
Interviene il Consiglio
nazionale dell’ Ordine dei Giornalisti sul vergognoso giornalismo di “Piazza
Pulita”. Redazione CdG 1947 su Il Corriere del Giorno il 4 Marzo 2023.
Avrebbe turbato gli spettatori
per stessa ammissione del conduttore del programma durante la lettura del suo
editoriale, portata in studio dall’inviata sul luogo del dramma. Ma anche gli
attacchi tutt’altro che velati e deontologicamente corretti rivolti alle
istituzioni strumentalizzando una tragedia ancora tutta da accertare e
metabolizzare.
Con una nota il Comitato
esecutivo del Cnog ha reso noto che sono giunte numerose segnalazioni sulla
“spettacolarizzazione” della trasmissione “Piazza pulita” in onda su La7 durante
la quale sono state mostrate, in chiave di spettacolarizzazione, le scarpette
presumibilmente di uno dei bimbi coinvolti nel tragico naufragio sulle coste di
Crotone. “Comportamenti poco deontologici che saranno valutati dai Consigli di
disciplina competenti per territorio“.
Quell’insistere della
telecamera sulla scarpetta di una delle piccole vittime del naufragio di Cutro,
Avrebbe turbato gli spettatori per stessa ammissione del conduttore del
programma durante la lettura del suo editoriale, portata in studio dall’inviata
sul luogo del dramma. Ma anche gli attacchi tutt’altro che velati e
deontologicamente corretti rivolti alle istituzioni strumentalizzando una
tragedia ancora tutta da accertare e metabolizzare.
“Il diritto di cronaca è
sacro” ricorda il Consiglio Nazionale “ma lo è altrettanto il rispetto della
deontologia professionale che impone il corretto comportamento dei cronisti sui
luoghi degli eventi e, anche in televisione, continenza e rispetto nel
linguaggio, compreso quello non verbale”.
Il Comitato esecutivo del Cnog
pertanto ha deciso quindi di inviare una segnalazione ai Consigli di disciplina
competenti per l’apertura di un procedimento sul caso. E forse era ora che
qualcuno riportasse sui binari del corretto giornalismo il programma “Piazza
Pulita”, visto l’editore de La7 pensa solo e soltanto all’ Auditel….Redazione
CdG 1947
Pd, lo stupidario
politico-lessicale sulla tragedia di Crotone: parole a caso. Francesco
Carella su Libero Quotidiano il 05 marzo 2023
La sensazione che si ricava
seguendo le polemiche di questi giorni dopo la tragedia di Crotone è che in
Italia sia davvero impresa difficile riuscire a liberarsi dello stupidario
politico-lessicale della sinistra di matrice sessantottina.
Ci si era illusi che alcuni
strumenti della subcultura comunista fossero stati consegnati in via definitiva
al magazzino di un robivecchi. La qual cosa non sembra essere avvenuta a
giudicare dalle molte reazioni maturate nella cosiddetta area progressista.
Infatti, i “funzionari della verità” - come in una sorta di riflesso pavloviano
- invece di attendere il risultato delle indagini, per capire che cosa sia
andato storto nella catena delle comunicazioni la notte del nubifragio, si sono
affrettati, con la nota sicumera, a dare la “giusta versione” dei fatti: si è
trattato di una strage di Stato. Il dizionario della politica italiana compie,
in tal modo, un salto indietro di parecchi decenni. Il concetto, famigerato e
fuorviante, guadagna un posto di rilievo nel nostro dibattito pubblico
all’indomani della strage di piazza Fontana avvenuta il 12 dicembre 1969 a
Milano, quando viene dato alle stampe un pamphlet - per l’appunto “La strage di
Stato” - in cui attraverso una dubbia operazione condita di sospetti e
coincidenze vengono additati quali responsabili della bomba alla Banca
dell’Agricoltura - in disprezzo delle più elementari regole fattuali non solo
singoli funzionari o parti di servizi deviati, ma addirittura le più importanti
cariche istituzionali del Paese. Vengono fatti i nomi del ministro dell’Interno
Franco Restivo, del presidente del Consiglio Mariano Rumor e - tanto per non
tralasciare nulla- viene tirato in ballo finanche il capo dello Stato Giuseppe
Saragat.
Dietro quell’orribile atto
terroristico si affermava nel libretto - non potevano non esserci personalità di
così alto livello in ragione del fatto che essi non solo in quei mesi erano
impegnati a contrastare le violenze di piazza commesse dai compagni, ma
soprattutto risultavano amici degli Stati Uniti a cui veniva attribuita (manco a
dirlo) la regia occulta della strage. Una tale vulgata diventa egemone presso
l’establishment politico-culturale della sinistra a tal punto da guidare negli
anni a venire l’interpretazione di tutti gli episodi cruenti che segnano la vita
pubblica italiana nel secondo Novecento. Una forma mentis che informa di sé
ricostruzioni storico-giornalistiche, atti parlamentari, requisitorie
giudiziarie fino a ridurre in un unico quadro esplicativo l’intero capitolo dei
misteri d’Italia. Tutto finisce nel medesimo calderone, dalle stragi impunite ai
servizi segreti deviati, dalle Brigate rosse al terrorismo nero, da Gladio alla
P2, dalla morte di Mattei al caso Moro e così per tante altre pagine della
storia repubblicana. In tal senso, fare luce sui singoli accadimenti finisce con
il risultare secondario rispetto all’opportunità di sfruttarli appieno per
ragioni di opportunismo politico. Del resto, riportare ogni singolo atto dentro
la logica della strage di Stato significa legittimare la validità del “verbo
cominternista” che individua nello Stato democratico-liberale i presupposti di
un perenne pericolo fascista al quale è necessario rispondere attraverso una
continua mobilitazione popolare guidata dagli unici soggetti in possesso dei
titoli giusti per farlo, ovvero i comunisti. Ci si era illusi che tutto ciò
appartenesse al passato. Purtroppo, a giudicare dalle polemiche sul naufragio di
Crotone sembra che poco sia cambiato. I fatti ancora una volta possono essere
sacrificati in nome dell’ideologia.
L’Ucraina proibita. La
manifestazione antifascista di Firenze senza la vera grande battaglia contro il
fascismo russo. Carmelo Palma su L’Inkiesta il 6 Marzo 2023.
Sabato hanno marciato tutte le
diverse componenti del mondo progressista di osservanza demo-populista, ma non
c’erano bandiere della resistenza di Kyjiv, il vero simbolo dell’antifascismo
europeo
Ci si può certamente
appassionare – chi siamo noi per giudicare – a quella pagina esemplare di
monopolarismo bipopulista rappresentata dalla mobilitazione indignata contro il
pericolo “fascista” e “comunista”, parteggiando per la sussiegosa retorica del
compagno rettore Montanari, che parla melonianamente da padre di uno studente
del Liceo Michelangiolo, nella parata della #FirenzeAntifascista, o per le
geometrie variabili, con cui il ministro Valditara nobilita o liquida
l’epistolario anti-violenza dei dirigenti scolastici alle prese con una patetica
riedizione del “settantasettismo” destrorso e sinistrorso: bravo il preside
milanese a bacchettare chi lo ha raffigurato a testa in giù, cattiva la preside
fiorentina insorta contro il pestaggio dei post-camerati vicini o interni al
partito della madre, italiana e cristiana presidente del Consiglio.
Una riflessione più fredda e
meno appassionata, ma più veritiera, dovrebbe portare a concludere che la
ragione di tutto questo calore, di tutta questa indignata militanza contrapposta
continua – esattamente come ai tempi (non) eroici della violenza politica rossa
e nera – a poggiare su una denegata contiguità e parentela tra questa destra e
questa sinistra nel modo di intendere il rapporto tra i mezzi e i fini e di
giustificare i primi alla luce dei secondi. Per gli uni e per gli altri, il
problema della violenza cambia con il colore della violenza.
Solo questo spiega perché il
partito di maggioranza relativa non abbia pensato di dire una parola sulle
violenze che hanno visto protagonisti non dei provocatori, ma dei – chiamiamoli
così – camerati che sbagliano, e perché d’altra parte nella manifestazione
dell’antifascismo ufficiale, con tutti i leader della sinistra politica e
sindacale bella e buona in prima fila, gli slogan tipo «Tito ci ha insegnato che
uccidere un fascista non è reato» continuano a essere ascoltati con divertimento
o con fastidio, ma non con sdegno, non con un senso di estraneità tale da
allontanare questi antifascisti retrò, anche se giovanissimi, da un corteo
teoricamente super-democratico.
Ma veniamo al punto centrale,
in una prospettiva attualmente antifascista. A Firenze hanno marciato tutte le
diverse componenti della composita koinè progressista di osservanza
demo-populista. C’era il Partito democratico, c’era il Movimento 5 stelle, c’era
la Cgil, c’era l’Arci, c’era l’Anpi, c’erano – qualunque cosa significhi – i
movimenti, c’era il ceto medio riflessivo, c’erano gli antagonisti pavloviani
nei loro riflessi anti-imperialisti, c’erano tutti i colori dello spettro
antifascista nazionale e c’erano ovviamente i pacifisti. C’erano le immancabili
bandiere palestinesi e di tutti gli infiniti rivoli della diaspora comunista.
Non c’era però una bandiera
dell’Ucraina, che è oggi la vera frontiera della resistenza antifascista
europea. Il compenso c’erano svariati censori dei “fascisti ucraini”, che per
gli antifascisti di rito anpista-pagliaruliano sono quelli che si difendono
dall’aggressione putinana, ma hanno il torto inemendabile di farlo con i soldi e
le armi degli alleati atlantici, quindi, secondo la vulgata, del fascismo
vincente nell’eterno dopoguerra europeo e planetario.
Non c’era una bandiera ucraina,
non c’era uno striscione pro Ucraina e non c’è stata una parola e un briciolo di
solidarietà e di commozione per l’esempio di una vera Resistenza di popolo e
democratica (in questo certamente diversa da quella italiana, popolata da
furbissimi partigiani del 26 aprile e di stolidi banditori di distopie
totalitarie).
Cosa questo significhi è troppo
chiaro ed eloquente: che l’antifascismo reale è oggi letteralmente proibito
nelle piazze della bella gente antifascista della sinistra italiana e che la sua
presenza sarebbe suonata sabato addirittura provocatoria, di fronte al generoso
sforzo di unità di Elly e Giuseppe che, pronubo Maurizio Landini, si parlavano
nell’orecchio, si abbracciavano e si sorridevano.
Le dovute differenze. Il
putinismo della destra e il collaborazionismo della sinistra che fa propaganda
per l’aggressore. Iuri Maria Prado su L’Inkiesta il 6 Marzo 2023.
Le simpatie e gli interessi dei
Berlusconi e dei Salvini per l’autocrate russo sono indecenti, ma chi è
diventato il megafono della propaganda del Cremlino ha dichiarato guerra a noi
stessi
C’è una differenza enorme tra
il putinismo che via via è andato sbrigliandosi a destra – nel cedimento delle
inibizioni che l’evidenza delle colpe e lo scandalo iniziale degli eccidi
frapponevano alla voglia matta della soluzione finale – e un governo di persone
perbene messo al posto di quello dei drogati e degli omosessuali di Kyjiv.
Una differenza enorme, dicevo,
c’è tra quel riformularsi in progress e sempre meno verecondo delle antiche
predilezioni amicali e affaristiche di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, da un
lato, e il collaborazionismo pacifista che dall’altro lato, e ormai da un anno,
si è fatto ripetitore della propaganda degli aggressori e ha trovato nella
guerra all’Ucraina l’occasione per riaffermare una dopo l’altra tutte le proprie
qualità essenziali – il ripudio della verità e il richiamo invincibile a farne
contraffazione, l’odio irriducibile verso la libertà e verso l’ambizione altrui
di difenderla, l’estraneità aggressiva e budellare alle ragioni del diritto e la
pretesa di vederle sostituite dalla regola della forza che a fin di bene, a fin
di giustizia, a fin di pace, si impone con i massacri, con gli stupri e con le
deportazioni sugli intollerabili vagheggiamenti di democrazia degli
insubordinati al dovere morale della resa.
Non è la stessa minestra. Le
simpatie e gli interessi che legano certuni ai plenipotenziari di quel sistema
autocratico hanno lo stesso effetto del pacifismo collaborazionista, ma di
quest’ultimo non condividono la causa per così dire costituzionale, l’origine
sistematica, l’attitudine a farsi programma politico. La t-shirt con il profilo
del denazificatore non ha la portata, né l’intenzione, della vignetta che
raffigura Volodymyr Zelensky col braccio fasciato di svastica. Lo sproloquio
sulla guerra che comincia per le avidità territoriali ucraine non ha il
significato, né l’obiettivo, delle teorie cospirazioniste che l’accademia
malvissuta ha messo in scena in un anno di teatro sui crimini dell’occidente.
Sono differenze che non
descrivono differenti gradi di colpa, anche perché quelli che ne sono
rispettivamente portatori si consorziano in un fronte comune, come abbiamo
constatato recentemente. Ma sarebbe un errore capitale considerarle una stessa
cosa. Una è complicità da clan, una specie di favoreggiamento parentale, l’altra
è la guerra aperta a tutto ciò che dovremmo essere e rappresentare.
Schlein e Conte, il corteo
antifascista è una farsa. I leader di Pd e 5Stelle saranno presenti alla
manifestazione del 4 marzo a Firenze. Max Del Papa su Nicola Porro il 2 Marzo
2023.
Compagna, il popolo non copre
le bollette. Dategli dell’antifascismo. La lunga marcia verso la fusione dei
fissati, dei fanatici, sinistra social comunista mezza piddina e mezza grillina,
passa per Cospito e il liceo Michelangiolo, per la professoressa Savino che teme
la risacca diciannovista, per il sabato antifà. È qui che si incontreranno gli
stati generali di due leader di laboratorio, Elly e Beppi, e la vedremo, ah se
la vedremo, chi è più sovversivista, movimentista, massimalista. Perché non c’è
dubbio che nella Firenze delle ombre rosse, delle cosche rosse i casini
scoppieranno e grandi casini: le minacce, garantite, alla Meloni nel garantismo
carrierista dei soliti, le foto bruciate, le devastazioni democratiche, la
guerriglia proustiana, i pupazzi impiccati per i piedi, il vaneggiare a pugno
chiuso degli spiaggiati da centro sociale.
Nella Firenze dell’eterna
ebollizione più o meno armata, del misterioso comitato esecutivo delle Bierre
che non si è mai localizzato ma dove comandava il terrorista prof. Senzani,
implicato coi Servizi italiani e gradito ospite di quelli americani. Roba che i
vecchioni del Pd sanno benissimo come la sa il prof. Prodi delle sedute
spiritiche fantasma per indirizzare a Gradoli (la via non il paese, cazzo!), a
vana ricerca dei carcerieri di Moro. Prodi, amico, collega e sodale del padre
della ragazza Schlein in seno al centro di potere il Mulino. Chi invece non sa
niente di queste convergenze parallele è la generazione S, come Schlein, come
Sardine. Quella che in nome dell’amore ti fa fuori senza complimenti. Cinica,
ecco una continuità ittica col comunismo degli squali e dei piranha, al punto da
usare un naufragio con un centinaio di morti per attribuirlo al governo e un
regime di relativo isolamento su un balordo non innocuo per attribuirlo al
governo.
Benzina sul fuoco da chi cerca
l’incendio della prateria e lo cerca nella Firenze dei furori da centro sociale,
sostenuta dalla stampa irresponsabile. Oggi come allora la provocazione
miserabile fino alla messa in conto del morto da addebitare al regime fascista.
Tanto fascista che finora si è preoccupato di andar d’accordo con gli ineffabili
poteri forti, ineffabili ma non indicibili visto che i nomi li conoscono tutti:
il Colle, la finanza totale della quale il massimo rappresentante Draghi dice
“Noi decidiamo tutto o almeno ci proviamo, voi subite comunque”, la Unione
Europea comitato d’affari della grande industria, i finanzieri eversivi come i
Gates e i Soros che sostengono i manga di nome Elly o Greta, i burattinai
perversi tipo Schwab, l’informazione unica che da questi è pagata e può farti
scoppiare tra i piedi un ordigno mediatico in qualsiasi momento.
La verità è che il governo si
muove sulle uova, i Piantedosi, i Valditara sono disastrosi nella comunicazione
temendo conseguenze che, si mettessero l’anima in pace, arriveranno comunque.
C’è un ordine costituito che non è modificabile, che può essere solo arginato
come per la demenziale transizione all’auto elettrica e questo Giorgia Meloni lo
sa e cerca di barcamenarsi. E c’è una effervescenza antagonista per le allodole,
che lavora per il regime vero, un regime sovranazionale e finanziario. Per cui
diventa fondamentale la recita dei sovversivi d’ordine che a Firenze vanno da
comparse più o meno consapevoli di una rappresentazione di potere per il potere.
O, per farla facile: ci va bene che in questa fase siate voi al comando purché
sia chiaro che è un comando nominale, di facciata, che possiamo farvi fuori come
e quando vogliamo. Poi magari si sbagliano anche loro, ma il senso del sabato
(anti) fascista fiorentino è questo ed è palese.
La grande farsa della
contrapposizione tra donne di vertice, la post fascista e la neocomunista, sta
nella attribuzione alla premier di condizionamenti atlantici contro i quali si
opporrebbe la pacifista e antagonista segretaria piddina che è una carica oggi
patetica. Che Meloni abbia coltivato sponde atlantiste è chiaro e non è un
delitto, ma ad uscire dalle fabbriche americane degli influencer politici, a
sponsorizzare le tematiche del neorevisionismo pubblicitario americano, gender,
clima, isteria antifà, ad avere un passaporto americano, connessioni con
l’egemonia politica e culturale americana, è il nuovo capo del partito grillino
democratico. Ma, siccome vale tutto, può benissimo valere che una adunata
d’ordine venga partecipata dai leader d’ordine, del nuovo ordine, globalista,
finanziario, in veste filosovversivista, sotto l’egida dell’antifascismo
militante in sostegno a un insurrezionalista anarcoide bombarolo. Max Del Papa,
2 marzo 2023
Elly’s Island. La battaglia
contro il decreto anti-ong non si può fare abbracciati al M5s.
Francesco Cundari su L’Inkiesta il 3 Marzo 2023.
Accusare il governo di avere
tanti morti sulla coscienza per norme assai più morbide di quelle varate a suo
tempo da Conte è una scelta discutibile di per sé, ma ripetere quelle parole
mentre si sfila a braccetto con l’Avvocato del popolo sarebbe imperdonabile
Dinanzi a una tragedia come
quella di Cutro è sempre molto difficile tracciare il confine tra doverosa
richiesta di chiarezza e speculazione politica, legittima indignazione e
strumentalizzazione di parte.
Certo sarebbe più facile
abbassare i toni se l’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dinanzi
a una tragedia analoga, nel 2015, non avesse dichiarato pubblicamente che il
governo Renzi avrebbe dovuto essere «indagato per strage colposa». O se
l’attuale ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, per prima cosa non fosse
andato in conferenza stampa a stigmatizzare il comportamento delle vittime, a
suo giudizio responsabili di avere messo a rischio la vita di se stessi e dei
loro cari, aggiungendo poi, in quell’occasione come nei numerosi interventi
successivi, dichiarazioni se possibile ancora più grottesche. La migliore di
tutte l’ha detta in audizione in Senato: «Io sono talmente capace di emozionarmi
che lo faccio prima che le tragedie avvengano».
Quella del ministro, insomma, è
una sensibilità predittiva, quasi profetica. Sarebbe bello se una simile dote lo
portasse a dimettersi prima della prossima figuraccia.
Non bastassero le molte ombre
sull’accaduto, l’inspiegabile lentezza nei soccorsi, il rimpallo di
responsabilità, le contraddizioni emerse dalle diverse ricostruzioni,
l’opposizione avrebbe dunque ancora mille buone ragioni per chiedere le
dimissioni di Piantedosi, e bene ha fatto la nuova segretaria del Pd, Elly
Schlein, a guidare questa battaglia.
Dopo tante discussioni
sull’identità della sinistra, e la necessità di maggiore radicalità, maggiore
nettezza, maggiore autenticità, ci sono però nelle sue prime mosse e nei suoi
primi interventi alcune vistose omissioni (tu chiamale, se vuoi, rimozioni).
Schlein ha dichiarato
immediatamente, nel suo primo discorso da segretaria, che la strage di Crotone
«pesa sulle coscienze di chi solo qualche settimana fa ha voluto approvare un
decreto che ha la sola finalità di ostacolare il salvataggio in mare». Parole
molto pesanti, e anche approssimative, che hanno offerto l’occasione al governo
di ricordare facilmente come la strage sia avvenuta in una tratta non coperta
dalle navi delle ong. Ma soprattutto parole che mal si conciliano con la scelta
di rilanciare il rapporto con Giuseppe Conte, cioè il presidente del Consiglio
responsabile di quei decreti sicurezza che avevano esattamente tale finalità,
ostacolare l’opera delle ong, ed erano da questo punto di vista anche assai più
duri (senza contare che secondo l’ex portavoce della guardia costiera,
l’ammiraglio Vittorio Alessandro, intervistato ieri da Repubblica, il primo
governo Conte ha anche la responsabilità di avere «imbrigliato» l’azione della
guardia costiera, assegnando un ruolo strategico al Viminale, in una logica più
di polizia che di soccorso). Come si può dunque da un lato dire che tanti morti
pesano sulla coscienza di chi ha approvato un decreto che ostacola i salvataggi
e dall’altro apprestarsi a manifestare insieme a Conte a Firenze, in quello che
da giorni viene presentato come il primo atto del nuovo corso unitario del Pd?
Anche in parlamento,
intervenendo in commissione contro il ministro Piantedosi, Schlein ha scandito:
«Voi dovreste chiedere una missione di ricerca e soccorso in mare europea, una
Mare Nostrum europea, e finirla con una criminalizzazione spietata delle
organizzazioni non governative che stanno solo sopperendo alla mancanza di una
missione con pieno mandato umanitario da parte dell’Unione europea nelle rotte
più pericolose».
Non tedierò il lettore con il
ripasso di tutte le dichiarazioni e gli atti legislativi con cui il Movimento 5
stelle ha proceduto in questi anni alla criminalizzazione delle ong, oltre a
votare contro l’abolizione del reato di immigrazione clandestina. Per chi fosse
interessato all’argomento, ne troverà un’esauriente ed equanime raccolta,
insieme con le perle di tanti altri leader, compresi fior di democratici, in un
bel libro di Paola Di Lazzaro e Giordana Pallone: «Com’è successo» (Fandango).
Per i più pigri, mi limito a ricordare che è al Movimento 5 stelle che dobbiamo
la definizione di «taxi del mare», nonché alcuni degli emendamenti più odiosi ai
decreti sicurezza (per inasprirli, ovviamente) come quello sulla confisca delle
navi delle ong.
Per di più, nel suo intervento
in commissione, Schlein invitava il governo a chiedere la riforma del trattato
di Dublino, ricordava di essersene occupata a suo tempo come parlamentare
europea e incalzava il ministro con queste parole: «…ho potuto spesso rimarcare
la totale assenza delle forze che oggi governano questo paese alla discussione
che lei sa essere la più importante per l’Italia, perché è quello strumento che
blocca centinaia di migliaia di richiedenti asilo nel primo paese europeo dove
mettono piede anziché avere, prendo le sue parole di prima, una risposta che non
è quella insufficiente del ricollocamento volontario che non ha mai funzionato,
ma un sistema di redistribuzione obbligatorio delle responsabilità
sull’accoglienza che valorizzi anche i legami significativi dei richiedenti
asilo con tutti i paesi europei; l’avevamo ottenuta questa riforma, nel 2017,
senza il voto delle forze che oggi governano il paese».
Per la cronaca, a votare contro
la riforma nel 2017 è stato anzitutto il Movimento 5 stelle (la Lega, per dire,
si astenne). In compenso, quel sistema di ricollocamenti volontari «che non ha
mai funzionato» è esattamente il sistema ottenuto da Conte al Consiglio europeo
del 28 e 29 giugno 2018, e sbandierato allora ai giornali come un risultato
storico (sì, esatto, proprio come ha fatto Meloni poche settimane fa: non c’è
presidente del Consiglio italiano che in questo campo non ottenga risultati
storici, a chiacchiere).
Il Partito democratico di
Schlein ha dunque ora due strade davanti a sé: continuare a incalzare il governo
su questo terreno, inchiodando ciascuno alle proprie responsabilità (con la
necessaria dose di autocritica per le scelte passate, ad esempio sugli accordi
con la Libia), oppure abbassare i toni e cercare magari altri terreni su cui
radicalizzare lo scontro. Sono entrambe scelte legittime, che hanno pro e contro
sia in linea di principio sia da un punto di vista puramente tattico. Ma quale
che sia la scelta, bisogna essere conseguenti, e misurare bene le proprie
parole: accusare il governo di avere tanti morti sulla coscienza per un decreto
assai più morbido di quello varato a suo tempo da Conte è una scelta discutibile
di per sé, per le ragioni già dette, ma ripetere quelle parole mentre si sfila a
braccetto con il leader grillino sarebbe davvero imperdonabile.
Comunismo? Nessun problema a
parlarne malissimo. Risponde Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera il 6
Marzo 2023
Caro Aldo, in occasione della
guerra nella ex Jugoslavia mi colpì il fatto che la violenza e la volontà di
sopraffazione perpetrata dal governo di Milosevic i media italiani si
affrettarono a catalogarla come espressione del «nazionalismo serbo», senza mai
fare riferimento alle radici comuniste di quel regime. Ora, a dieci mesi dalla
aggressione russa in Ucraina, vedo ripetersi la stessa situazione: perché
nessuno ha il coraggio di dire che si tratta dell’aggressione di un regime che
conserva il comunismo nel proprio Dna? Si condanna il fascismo, si ripete che
bisogna stare in guardia dai rigurgiti di quel passato. Non vedo però lo stesso
slancio nel dire che se la pace e il benessere globale sono in questo momento in
grave pericolo la colpa è delle guerre scatenate o minacciate dalle dittature
comuniste di Russia, Corea del Nord e Cina. Marco Di Piazza
Caro Marco, Non leggerei la
guerra in corso come uno scontro tra comunisti russi e anticomunisti ucraini.
Vladimir Putin viene definito ora comunista, ora fascista. In realtà non è né
l’uno né l’altro; è un nazionalista russo, che aggredendo l’Ucraina ha commesso
sia un crimine, sia un errore. Quanto al regime cinese, si dice comunista, ma
pratica in realtà una forma di liberismo ipercapitalista, accompagnato dalla
privazione della libertà, dei diritti civili, della democrazia. Ciò detto, non
ho nessun problema a concordare con lei sul fatto che il comunismo sia stato
un’immane tragedia, costata la vita a milioni di persone. Il comunismo non è
stato uguale dappertutto, ad esempio in Bulgaria ha assunto forme molto diverse
da quelle che aveva in Cambogia; ma ovunque ha preso il potere con la violenza e
l’ha mantenuto con polizia politica, carcere, campi di prigionia, eliminazione
fisica degli oppositori. Ovunque il bilancio del comunismo è fallimentare, dal
punto di vista politico, morale, economico. Dai regimi comunisti non è nato
«l’uomo nuovo»; anzi, i Paesi a lungo governati dai comunisti, compresa la
Russia, hanno sovente espresso leader e partiti animati da xenofobia e
nazionalismo estremo, talvolta degenerato nella guerra. In Italia i comunisti
non sono mai andati al potere, e per fortuna. Noi abbiamo conosciuto un’altra e
diversa forma di totalitarismo, il fascismo, che abbiamo inventato ed esportato
in mezzo mondo. I comunisti italiani hanno combattuto il fascismo e hanno
scritto con i cattolici e i liberali la Costituzione repubblicana. Però
l’egemonia comunista sulla sinistra italiana l’ha tenuta a lungo lontana dal
governo, e a lungo è stata una delle cause (sia pure sempre meno importante)
dell’evidente diffidenza che la maggioranza degli elettori nutre nei suoi
confronti.
La doppia morale delle
piazza. Due piazze, due misure. Probabilmente alla borsa valori della morale
"radical" una città nel caos, due poliziotti menati, 5 anarchici fermati e 140
identificati, vetrine spaccate valgono molto meno di una rissa. Francesco Maria
Del Vigo il 6 Marzo 2023 su Il Giornale.
Due piazze, due misure.
Probabilmente alla borsa valori della morale «radical» una città nel caos, due
poliziotti menati, 5 anarchici fermati e 140 identificati, vetrine spaccate,
auto danneggiate, bastoni e bombe carta valgono molto meno di una rissa
scatenata fuori da un liceo fiorentino da alcuni giovani militanti di destra.
Altrimenti non si spiega l'imbarazzante silenzio della sinistra e della stampa
progressista sugli scontri di sabato a Torino. Se il casino lo fanno gli
anarchici dalle parti del Pd non si scompongono troppo e non lanciano accorati
appelli per la tenuta democratica del Paese oppure, come ha fatto Elly Schlein,
si prendono 24 ore di riflessione per condannare un evento dall'evidente
gravità. Perché gli anarchici non vanno di moda, non sono abbastanza à la page.
Bisogna, invece, agitare sempre il fantasma di un Ventennio che non c'è, che
sopravvive solo nelle campagne elettorali della sinistra e nella testa di chi
dell'antifascismo in assenza di fascismo ne ha fatto una redditizia professione.
Sabato però il sistema è andato
plasticamente in corto circuito, svelando tutta la sua ipocrisia. Mentre a
Firenze Pd, M5s e Cgil manifestavano contro il ritorno delle camicie nere
immaginarie, gli anarchici reali mettevano a ferro e fuoco il centro di Torino
per difendere Alfredo Cospito e chiedere l'abolizione del 41 bis e quindi, in
ultima analisi, facendo un favore anche a tutti i mafiosi che sono sottoposti a
questo regime carcerario.
Le immagini della guerriglia
sono impressionanti, eppure nessuno si è sconvolto. Poche righe sui giornali,
poco spazio in televisione e pochissime reazioni dalla «società civile»,
evidentemente abituata a tollerare queste inciviltà. Perché la violenza
politica, se non è di destra, non fa notizia, non spaventa. Ed è questo il
grande pericolo che la sinistra finge di ignorare, davanti al quale preferisce
voltare la testa.
Non ci sono solo gli anarchici
di Torino, ci sono anche gli antagonisti, il popolo dei centri sociali e quegli
estremisti (sempre di matrice anarchica) che non vedono l'ora di mettere a testa
in giù la Meloni e Valditara, come hanno fatto, sempre sabato, a Milano su uno
striscione fuori dal liceo Carducci. E, di questo, è responsabile anche quel
mondo che contribuisce ogni giorno, metodicamente, a creare un surreale e
antistorico clima da «guerra civile» permanente. A forza di evocare il fantasma
dell'estremismo, alla fine si manifesta davvero. Dall'estrema sinistra, però.
La politica a scuola porta
alla stupidità di piazza. Marcello Bramati su Panorama il 7 Marzo 2023
La manifestazione milanese di
sabato ha dato ancora una volta prova che la protesta di piazza risponde con
violenza alla violenza. E di generazione in generazione, anziché costruire, non
si fa che affondare
L'immagine del Ministro
dell'Istruzione, Valditara a testa in giù a due passi da piazzale Loreto.
Mancava solo questa, ma immancabilmente qualcuno ha pensato bene di esporre dal
liceo Carducci di Milano l’immagine capovolta del ministro, rievocando la fine
di Benito Mussolini, appeso in una stazione di benzina a poche centinaia di
metri dal liceo teatro del fattaccio. E così la violenza dei fatti di Firenze
della scorsa settimana fuori dal liceo Michelangiolo ha indignato, ha dato
spazio a risposte e reazioni ufficiali, ha fatto scrivere e discutere, ha
chiamato alla piazza e la piazza ha chiuso il cerchio rispondendo con toni
ugualmente violenti. Si è consumata un’altra occasione per costruire, preferendo
esasperare di giorno in giorno, ingaggiando una gara a chi la sparasse più
grossa, più feroce, più aggressiva. Da un piazza non ci si può aspettare una
riflessione pacata o un elemento di innovazione, perché la piazza di per sé si
riunisce per lanciare un grido indignato, forte, compatto, una protesta che
possa unire centinaia e magari migliaia di persone dopo un avvenimento
considerato scandaloso. E’ sempre stato così, contro una guerra, contro una
tassa, contro un governo, contro una politica. Dappertutto. Perché però va
sempre a finire che si esageri? Sulle proteste di piazza serve un ragionamento
complesso che superi fazioni, semplificazioni e riduzionismi, per cui è
necessario premettere che l’episodio di copertina non riguarda l’intera
protesta, che la manifestazione ha certamente ospitato anche migliaia di persone
disposte anche a prendere le distanze da immagini di violenza, che si possa
criticare o meno il ministro Valditara o la preside Savino ed essere comunque
inorriditi da questa escalation di toni e di modi. Dalla piazza non si pretende
l’elemento costruttivo, dunque, ma da chi scende in piazza ci si possono
aspettare almeno alcuni elementi di buon senso. Innanzitutto, evitare gli
stereotipi. Protestare come si faceva cinquant’anni fa, riproponendo i soliti
cliché e modalità stanche di generazioni ormai in pensione non può più
funzionare. E la rincorsa all’immagine più scioccante non può funzionare, non
aiuta la causa e non è difficile capirlo. In secondo luogo, bando a ogni tipo di
violenza. Chi manifesta in piazza dovrebbe ormai sapere che basta una sbavatura
per segnare una protesta con un’immagine che la contraddistinguerà per sempre,
eppure inevitabilmente arrivano lo slogan da censurare e l’immagine del ministro
appeso di turno. Chi scende in piazza per denunciare la violenza di un gesto, di
una presa di posizione, di un modus operandi non può peraltro rispondere con la
stessa moneta nascondendosi dietro un ruolo sociale differente dal bersaglio
delle critiche, il ministro dell’istruzione in questo caso. La piazza ha i
muscoli, così come li ha l’uomo di potere, in altri modi. Niente di nuovo,
infatti lo ha scritto Alessandro Manzoni duecento anni fa nei Promessi Sposi,
quando narrò le dinamiche della folla denunciando il pericolo di violenza e
irrazionalità che sovrastano la volontà del singolo e portano ad azioni
terribili e a istinti che, in branco, si manifestano. Renzo nei capitoli
ambientati a Milano del romanzo è sconvolto dall’uomo che, nel mezzo della
protesta, porta con sé l’occorrente per inchiodare alla porta il vicario di
provvigione, il politico contro cui ci si sta scagliando. Sempre Renzo, un
semplice “montanaro” - come lo definisce Manzoni, con la sua genuinità capisce
che se la folla chiede pane e distrugge i forni, il pane non si potrà certo
infornare nei pozzi. Infine, quel che più conta, la piazza non può esaurirsi con
la manifestazione dello sdegno in attesa di una nuova adunata. Chi scende in
piazza, dal giorno dopo dovrebbe mettersi al lavoro, valutando alternative a ciò
che ha ritenuto intollerabile tanto da dedicare mezza giornata per contestare.
Come? Leggendo, convocando assemblee, dialogando, soprattutto studiando. Le
manifestazioni ambientaliste di questi anni sono state adunate oceaniche, ma la
spinta propulsiva si è smorzata nel momento in cui il fierone del corteo ha
preso il sopravvento sul tema culturale, forte, e su quello politico, ugualmente
robusto. Le persone in marcia dovrebbero passarsi libri, a centinaia, dovrebbero
darsi appuntamento in università per chiedere lezioni aperte di geografia e di
scienze ambientali, dovrebbero commentare insieme i testi di studiosi come John
McNeill che passa in rassegna con chiarezza, complessità e lucidità la storia
dell’ambiente del XX secolo, dovrebbero chiedere a gran voce riflessioni
politiche che tenessero conto delle sintesi scientifiche su queste tematiche.
Eppure non c’è la percezione che tra un “Friday for Future” e l’altro tutto
questo accada. Analogamente, quando si protesta per la scuola, il giorno
successivo servirebbe che tutti invocassero stati generali per ripensarla
daccapo, a cento anni dalla sua riforma gentiliana che ancora oggi le dà la sua
forma ingessata e pensata per il primo quarto del secolo scorso. Bisognerebbe
invitare chi può provare a farsene carico di mettercisi, convocando assemblee in
parchi, teatri, riunioni online. Ancora una volta, leggendo e studiando,
ascoltando e proponendo, studiando ancora. Gesù parlava con i dottori del tempio
a dodici anni e teneva loro testa. Le attuali generazioni più giovani leggono e
studiano per tenere testa alla generazione che li fa arrabbiare, o si limitano a
passare da una protesta all’altra e da un corteo al prossimo?
Estratto dell’articolo di Gian Antonio Stella per
il “Corriere della Sera” il 13 marzo 2023.
«Il Signor Maestro ci ha spiegato che gli
italiani, siccome sono i più richiamati dalla Santa Provvidenza, hanno tredici
comandamenti. I primi dieci della tavola di Mosè e poi c’è Credere, Obbedire,
Combattere». C’è poi da stupirsi se tanti bambini degli anni Trenta, […] era al
servizio del fascismo, si buttarono a capofitto dalla parte del Duce nella
repubblica di Salò?
No, risponde lo storico Gianni Oliva nel libro Il
purgatorio dei vinti (Mondadori), dove spiega come parte di quella generazione
finì nella sciagurata avventura repubblichina al fianco dei nazisti autori delle
peggiori stragi e nefandezze della Seconda guerra mondiale. Fino a venir
rinchiusi in campi di prigionia come quello di Coltano […]
Una storia poco nota e ricostruita attraverso le
vicende politiche e umane di giovani prigionieri allora ignoti, come ovvio dato
che molti avevano vent’anni o addirittura quindici o quattordici, ragazzini
intrappolati dalla retorica mussoliniana […] al punto di cercar «la bella morte»
[…] Al netto delle memorie di qualche nostalgico, scrive Oliva, «Coltano appare
soprattutto lo specchio dello smarrimento ideologico e morale lasciato dal
1943-45: molti dei prigionieri sono ragazzi del 1925-26, adolescenti o poco più
infiammati dall’educazione littoria, avviliti dal “tradimento” dell’armistizio,
indignati con il re e con Badoglio […]».
[…] si chiede lo storico, «dove sta la differenza
tra il partigiano e il milite di Salò rinchiuso a Coltano? Tra il garibaldino,
il badogliano, l’azionista e quello che si è arruolato tra i paracadutisti della
Repubblica sociale, come Dario Fo? O è andato volontario nei bersaglieri di
Mussolini, come Raimondo Vianello? È ancora Calvino a rispondere: la differenza
è la storia. “C’è che noi, nella storia, siamo dalla parte del riscatto, loro
dall’altra. Da noi, niente va perduto, nessun gesto, nessuno sparo, pur uguale
al loro, m’intendi? uguale al loro, va perduto, tutto servirà se non a liberare
noi a liberare i nostri figli, a costruire un’umanità senza più rabbia, serena,
in cui si possa non essere cattivi”.
Ed ecco tante storie di tanti ragazzi. Da Walter
Chiari a Giorgio Albertazzi, da Ugo Tognazzi a Mauro De Mauro, da Marcello
Mastroianni a Enrico Maria Salerno, da Gorni Kramer a Carlo Mazzantini fino
appunto a Raimondo Vianello, che oltre quarant’anni dopo, nel 1998, spiegherà in
un’intervista alla rivista «Lo Stato» di Marcello Veneziani come e perché fece
quella scelta chiudendo con una battuta: «Non rinnego né Salò né Sanremo».
[…] Nell’immaginario collettivo i repubblichini
rappresentavano «il male assoluto». Su cui scaricare le responsabilità anche di
quanti nel Ventennio si erano spellati le mani per Mussolini. Ed è proprio su
questo punto che Il purgatorio dei vinti, citando Rosario Romeo («La Resistenza,
opera di una minoranza, è stata usata dalla maggioranza degli italiani per
sentirsi esonerati dal dovere di fare fino in fondo i conti con il proprio
passato») batte e ribatte: «Quando mai i manuali e i docenti ci hanno insegnato
che l’Italia ha perso la guerra? Per tutti noi, cresciuti nella cultura
dell’Italia repubblicana, la fine del secondo conflitto mondiale è il 25 aprile,
l’insurrezione partigiana nelle città del Nord, i giorni radiosi della
Liberazione. La “vulgata” antifascista ha preso l’unica esperienza del 1940-45
che ci metteva dalla parte giusta della storia, la Resistenza, e l’ha
trasformata nella foglia di fico dietro cui nascondere colpe, corresponsabilità,
vergogne».
[…] Il senso, traduce Oliva, è che «vi è stato un
ventennio di dittatura fascista che ha dominato gli italiani con la forza della
coercizione e ha tenuto il Paese legato insieme con il filo di ferro della
repressione e della paura, e vi è una nuova Italia che, prima con l’antifascismo
clandestino, poi con la cobelligeranza e la Resistenza partigiana, ha concluso
la guerra nel fronte dei vincitori» […] Per dirla con Benedetto Croce, il
fascismo fu solo «una parentesi». Ma fu davvero così? Risponde lo storico
torinese: «Si tratta di una rielaborazione storicamente impropria che dimentica
le folle di giovani in delirio il 10 giugno 1940 quando il Duce annuncia da
Palazzo Venezia l’entrata in guerra contro la Francia e la Gran Bretagna […]».
Senza fare i conti col passato: «La
criminalizzazione di Salò serve soprattutto ad assolvere tutti coloro che sono
stati fascisti sino al 25 luglio e che negli anni del regime hanno costruito
carriere, ricevuto onori, lucrato fortune più o meno illecite». Una scelta che
peserà, e Dio sa quanto, sulla storia a venire...
Per l’Anpi commemorare quel ragazzo massacrato
nel 1975 nell’istituto Molinari di Milano è un’iniziativa «deviante».
Daniele Zaccaria Il Dubbio il 13 marzo 2023
Secondo l’Anpi commemorare Sergio Ramelli
nell’istituto tecnico che aveva frequentato è un’iniziativa «deviante» che
confonde i nostri giovani, «un episodio estrapolato da una situazione storica
che va contestualizzata». Un linguaggio orrendo e involuto per dire che, in
sostanza, quel ragazzo massacrato in modo barbaro davanti il portone di casa non
merita un ricordo pubblico perché era un militante di estrema destra, un
iscritto al Fronte della gioventù, insomma un “fascista”.
Di certo a non sapere chi fosse Ramelli era il
gruppetto di giovani che ha ha contestato la cerimonia in presenza della
sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, inscenando un piccolo presidio
davanti all'Itis Molinari di Milano assieme agli esponenti della Rete Milano
Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale, e dei sindacati di base Adl Cobas
e Usb. «Lo diciamo senza censure, Ramelli era un picchiatore fascista!»,
ringhiano gli studenti. E con loro anche alcuni professori dell’istituto, una
cosa questa che fa davvero impressione. Perché se l’ignoranza di un liceale è
fisiologica e tollerabile, quella del suo insegnante diventa imperdonabile.
Lo sanno i docenti barricaderi del Molinari che
Ramelli quando venne assassinato aveva l’età dei loro figli? Gli stessi per i
quali si tormentano ogni giorno a causa di un’unghia scheggiata, una linea di
febbre o magari perché si sono annoiati al corso di nuoto.
Sergio Ramelli fu ucciso il 13 marzo del 1975 alle
12.50 mentre rientrava a casa dalla scuola. Frequentava l’ultimo anno di un
istituto privato perché al Molinari non poteva più starci, i collettivi
antifascisti lo avevano puntato e picchiato a più riprese, una volta anche
davanti al padre accorso a chiedere spiegazioni ai dirigenti scolastici: «Sergio
è motivo di turbamento per tutti», fu il raggelante commento della preside prima
che gli suggerisse di cambiare scuola.
Il commando era composto da militanti del servizio
d’ordine di Avanguardia operaia. Lo avevano pedinato per diversi giorni,
volevano conoscere orari e abitudini per essere sicuri di non fallire, di dargli
la lezione che meritava. A sferrare i colpi sono Marco Costa e Giuseppe Ferrari
Bravo (verranno condannati per omicidio preterintenzionale) e lo fanno con
violenza inaudita, volteggiando la famigerata Hazet 36 la chiave inglese marchio
di fabbrica della caccia ai “neri” e dell’antifascismo militante negli anni di
piombo.
«Si stava coprendo il capo, io gli tiro giù le
mani e lo colpisco , lui è stordito e si mette a correre, si trova il motorino
tra i piedi e inciampa, cado con lui e lo colpisco un’altra volta, non so dove,
al corpo, alle gambe», ha raccontato Costa durante il processo. Meno nitidi i
ricordi di Ferrari Bravo: «Fu così breve che ebbi la sensazione di non aver
portato a termine il mio compito». E invece lo avevano portato a termine:
Ramelli è sdraiato a terra in una pozza di sangue, sul marciapiede ci sono
alcuni frammenti di materia cerebrale. È in coma e muore 17 giorni dopo in un
letto di ospedale.
Sergio Ramelli non proveniva da una famiglia
fascista, i genitori votavano democrazia cristiana e non si interessavano di
politica. Si iscrive al Fronte della gioventù a 16 anni per anticonformismo, al
Molinari come in quasi tutte le scuole dell’epoca gli studenti di sinistra erano
infatti la stragrande maggioranza. Inizialmente i camerati lo scambiano per una
“zecca” perché aveva i capelli lunghi e non proprio l’aria dell’estremista
attaccabrighe. Timido e taciturno non è mai stato un picchiatore uno che amava
lo scontro fisico, ma neanche il fervore ideologico, «apprezzava Adriano
Celentano ed era tifoso dell’Inter ma senza fanatismo», racconta la madre Anita
a Luca Telese in Cuori Neri. Il fatto che sia stato identificato come un
minaccioso squadrista fa parte di un vero e proprio processo di psicosi
collettiva alimentata dal furore politico di quei tempi balordi.
Tutto inizia con un tema di italiano in cui
Ramelli critica le Brigate Rosse definite un pericolo per la democrazia e
un’organizzazione manovrata dall’alto. Quel compito in classe finisce non sa
come nelle mani di un leaderino studentesco che appende i fogli protocollo in
bacheca accanto a una scritta: “Ecco il tema di un fascista”. Così comincia la
persecuzione di Ramelli e la catena di eventi che porterà al suo omicidio. Un
giorno alcuni esponenti dei collettivi entrano nella sua classe e lo trascinano
qualche minuto per i corridoi per sottoporlo a una breve gogna tra gli applausi
dei compagni e l’indifferenza dei professori. Un’altra volta lo bloccano per le
scale e lo pestano fino a fargli perdere i sensi. Le cose precipitano in
un’escalation irrefrenabile che Ramelli accetta stoicamente, non chiedendo mai
aiuto a nessuno, neanche ai suoi camerati, e finché gli è stato possibile,
nascondendo tutto alla famiglia. Una morte annunciata quella del ragazzino
milanese con lo sfregio finale dei commenti sarcastici dei suoi vecchi
professori e il licenziamento di Anita Ramelli dalla tipografia in cui lavorava
perché «madre di un fascista».
Una storia raccapricciante quella di Sergio
Ramelli, che l’Anpi dovrebbe rispettare invece di infangare con le sue
stucchevoli lezioncine, ma evidentemente per loro quel ragazzino massacrato a
colpi di chiave inglese non merita neanche un fiore.
«La scuola è il presidio della Costituzione.
Sull’antifascismo non può essere neutrale». Ai miei tempi, in classe si
parlava dei meccanismi della Repubblica. Dei diritti e dei doveri dei cittadini.
Anche quello era un modo di fare politica. Oggi all’insegnante si chiede di non
sbilanciarsi sull’attualità. Ma i giovani vanno educati alla
partecipazione. Viola Ardone su L’Espresso il 13 settembre 2023.
Quando andavo alla scuola elementare, la maestra
ci faceva cantare Bella ciao prima che iniziassero le lezioni. Era un rito laico
quotidiano, un modo per dirsi buongiorno e per ricordare da dove proveniva la
scuola pubblica nella neonata Repubblica italiana. Non c’entrava la politica,
anche se era una scelta politica.
La bandiera dell’antifascismo era come una sola
larga coperta che abbracciava tutto l’arco costituzionale e non solo un partito.
Alla scuola media la professoressa di Storia faceva accurate lezioni sui
meccanismi della Repubblica, sugli organi e i poteri dello Stato, sui diritti e
i doveri dei cittadini. Era politica anche quella, evidentemente, i ragazzini
dovevano sapere che cos’era stata la dittatura e che cos’è la democrazia. Sapere
distinguere, fare le differenze: anche questo è politica. La scuola era la
capitale dell’antifascismo, piantonava la Costituzione.
Oggi da insegnante mi sembra che tutto questo
dalla scuola sia quasi sparito. Lo studio della Storia e dell’Educazione civica
ha un ruolo sempre più marginale nel monte ore e l’insegnante che porta
l’attualità in classe viene guardato talvolta con sospetto.
Si pretende che il docente abbia un ruolo
neutrale, che non abbia o almeno non manifesti un’idea sul presente sul passato
e sul futuro. E se il numero dei votanti cala di tornata in tornata elettorale
il motivo è anche da ricercare in questo “congelamento” della scuola rispetto
alle tematiche dell’attualità, della contemporaneità, della politica in
generale.
Le nuove generazioni vanno educate alla
partecipazione, certamente non suggerendo loro per chi votare (come se poi loro
facessero quello che diciamo noi!) ma spiegando che in quel congegno fragile e
imperfetto che è la democrazia risiede l’unico antidoto al pensiero unico, alla
censura, alla violenza. E che non bisogna mai aver paura di sostenere le proprie
idee con le armi del dialogo e del confronto.
Una dirigente scolastica che commenta un
gravissimo episodio di violenza e che citando Gramsci condanna il fascismo e
l’indifferenza di quelli che non vi si oppongono con fermezza, è una persona che
sta facendo “politica” nel senso più nobile del termine. Una preside che
autorizza gli alunni a tenere un’assemblea di istituto per discutere di droghe
leggere e legalizzazione e si vede arrivare la polizia a scuola a interrompere
il dibattito, come è successo recentemente a Piazza Armerina, sta facendo
“politica”, cioè sta insegnando a ragionare, a discutere e a confrontarsi. Un
professore che il giorno dopo la tragedia di Cutro stigmatizza le parole del
ministro dell’Interno che colpevolizza le vittime invece che spronare alla
solidarietà sta facendo politica, perché il principio solidarista è uno dei
principi cardini della Costituzione antifascista.
Sarà forse per questo che, il giorno dopo
l’aggressione neofascista di Firenze, ho sentito il bisogno di condividere in
classe con i miei alunni le parole della preside Savino e mi è tornata in mente
la mia maestra di tanti anni fa che, nel suo completo beige e camicetta bianca,
si alzava in piedi e insieme a noi intonava le parole di un vecchio canto che
comincia così: «Una mattina, mi son svegliata…».
Se la scuola chiude ai
«fascisti» ma apre a Cospito. Andrea Soglio su Panorama il 27 Febbraio 2023.
In un istituto di Roma parlerà
il legale del detenuto al carcere duro in un convengo contro il 41 bis. E
nessuno protesta, nessuno prova ad equilibrare la cosa. Eppure, basterebbe poco
Siamo reduci da una settimana
che ha avuto al centro delle cronache e delle polemiche politiche il pestaggio
(dai contorni tutti ancora da appurare vista la ridda di versioni esistenti)
avvenuto tra studenti di destra contro altri di sinistra all'esterno di un Liceo
di Firenze. Un fatto deprecabile che ha ottenuto le prime pagine dei giornali
per la successiva circolare inviata agli studenti dalla Preside dell'Istituto
che parlava di deriva e pericolo fascista nella scuola ed in Italia. Inutile
dire che Annalisa Savino, la direttrice della scuola, è stata subito assunta a
paladina di libertà, diritto, difesa del bene e del giusto e non solo dal mondo
politico-giornalistico di sinistra. Al suo fianco infatti si è schierata ad
esempio l'associazione nazionale presidi: «La lettera della preside del liceo di
Firenze, Annalisa Savino, è un esempio di sensibilità civile e di pedagogia
repubblicana» hanno scritto. Verrebbe da chiedere ad entrambi, alla novella
paladina del bene e del giusto, ed ai vertici dell'associazione cosa ne pensano
invece dell'iniziativa di un altro Istituto Superiore di Roma, il Mamiani dove è
stato invitato a parlare l'avvocato di Alfredo Cospito, il leader anarchico in
sciopero della fame da quasi quattro mesi per protestare contro il regime di
carcere duro, il cosiddetto 41 bis, a cui è stato condannato come confermato
pochi giorni fa dalla Cassazione. Per l'ennesima volta. Tutto nasce
dall'iniziativa del Collettivo Autorganizzato Mamiani che ha dedicato a questo
tema un'assemblea degli studenti, invitando appunto il legale di Cospito. Se
pensate si tratti di un appuntamento «super partes» con il quale si vuole fare
informazione chiara ed approfondita sul tema beh, sappiate che gli stessi
componenti del Comitato hanno con orgoglio affermato che «Abbiamo aderito alle
piazze in suo sostegno esprimendo fermamente la nostra opposizione alla sua
detenzione forzata». Insomma, vista l'aria che tira l'assemblea si trasformerà
più che in uno spazio di formazione e confronto in un assalto al 41 bis, per la
gioia di Cospito, di qualche decina di boss mafiosi. Il Preside della scuola si
è limitato a dare l'autorizzazione all'incontro, con il benestare alla lista
degli ospiti. E con questo se ne sono lavati le mani. Resta il fatto che, ancora
una volta, si lascia spazio aperto alla politica dentro quello che è il luogo
sacro dell'educazione e della formazione. Resta in fatto che se una cosa del
genere invece che in favore di un anarchico fosse stata organizzata a favore di
un estremista di destra avremmo avuto i picchetti contrari (come accaduto alla
Sapienza, lo ricordate) al grido di «Fuori i Fasci dalla scuola!». Che esista
una disparità politica nel mondo della scuola è risaputo, da sempre. E forse non
è più nemmeno un errore portare la politica DENTRO la scuola. Il problema è che
non c'è equilibrio, c'è semper e solo una campana, tra l'altro sempre quella.
Eppure sarebbe stato semplice riequilibrare il tutto. Sarebbe bastato che il
Preside avesse imposto ai ragazzi del Comitato di invitare anche Roberto
Adinolfi, l'ex dirigente di Ansaldo, gambizzato con lo stile delle Brigate Rosse
proprio da Cospito. Per completezza di informazione e soprattutto di
«formazione» dei ragazzi che, devono capire bene chi sia la vera vittima.
Estratto dell’articolo di Sara
Bernacchia per “la Repubblica” il 6 marzo 2023.
Andrea Di Mario, preside del
liceo classico Carducci di Milano, sceglie una circolare per condannare
l’affissione davanti alla scuola dello striscione “Ma quale merito, la vostra è
solo violenza” con la A simbolo di anarchia e accompagnato dai volti della
premier Meloni e del ministro dell’Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara,
appesi a testa in giù.
Lo definisce un gesto
«brutale, brutto, violento, pesante», espressione di un linguaggio e di modi
«per noi completamente inediti e preoccupanti e che rifiutiamo». E scrive a
studenti e famiglie per ribadire che la scuola - l’istituto, tra l’altro, si
trova a pochi metri da piazzale Loreto - continuerà «come sempre e sempre più a
promuovere i valori della democrazia, della tolleranza e del pluralismo»,
scegliendo come strumento «il confronto» e rifiutando «la logica da curva
violenta».
La circolare di Di Mario arriva
sabato sera, idealmente per mettere il punto su una vicenda da cui anche gli
studenti del Carducci si sono dissociati con forza e la cui responsabilità,
secondo gli investigatori, sarebbe da attribuire a pochi soggetti isolati. A
riaprirla, però, è il ministro Valditara, che pubblica su Twitter il testo e fa
i «complimenti ad un preside coraggioso, consapevole del suo alto ruolo
istituzionale».
Il paragone con il commento -
di tutt’altro genere, però - riservato alla circolare con cui Annalisa Savino,
preside del liceo Leonardo Da Vinci di Firenze, all’indomani del pestaggio fuori
da un altro liceo fiorentino ha sollecitato i propri allievi a non essere
indifferenti e ha avvicinato l’aggressione a quelle fatte agli albori del
fascismo, è inevitabile così come la polemica. […]
Intanto, chiarita la posizione
dell’istituto nella circolare, il preside del Carducci sceglie di non
intervenire ulteriormente in un dibattito ormai solo politico. Del resto
l’invito a non banalizzare parole e situazioni lo aveva già fatto nel testo:
«Abbiamo ricevuto un danno, doloroso, rispetto a tutto quello che in questa
scuola si sta facendo e non vogliamo che i nostri studenti siano vittima di un
circuito, banale, che banalizza la stessa lettura della realtà».
Scontri a Firenze, il
deputato Marco Furfaro pubblica la foto dei presunti colpevoli. Christian
Campigli su il Tempo il 19 febbraio 2023
La violenza è l'antitesi della
politica. La prima porta automaticamente all'estinzione della seconda. Un
concetto basilare, ma che, evidentemente, a Firenze ancora non riesce a essere
compreso da tutti. La scazzottata di fronte al liceo classico Michelangiolo, tra
gruppi di sinistra e attivisti di destra, non può che essere giudicata per
quello che è: un atto stupido, ingiustificabile, che deve essere fermamente
condannato. Ma da entrambe le parti. Perché più passano le ore, più quella che
la sinistra da salotto, che abita nelle ville in collina e d'estate si ritrova a
Capalbio, aveva bollato come "l'ennesimo episodio di squadrismo fascista" si
sta, piano piano, trasformando in una cruenta (e stupida) cavalleria rusticana
tra adolescenti. Sia chiaro, nessuna giustificazione. Chi ha commesso dei reati,
se ce ne sono, dovrà essere condannato. Ma da un giudice togato. Non da qualche
prezzolato intellettuale progressista.
In queste ore convulse, durante
le quali la sinistra ha manifestato la volontà chiara non di giungere alla
verità ma di colpire Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia e tutto l'universo
conservatore, abbiamo assistito anche a un deputato pistoiese, Marco Furfaro,
eletto nelle liste del Partito Democratico, che ha postato su Twitter una foto.
Nella quale, senza nessun pixellaggio (ovvero quella tecnica con la quale si
possono oscurare i volti delle persone presenti nell'istantanea), espone in
bella mostra il viso dei presunti colpevoli. Presunti, appunto. Perché al
momento non c'è nemmeno un avviso di garanzia. Invece il deputato, ignaro che
alcuni di quei ragazzi sono minorenni, li espone al pubblico giudizio. E magari
a qualche azione ritorsiva dei gruppi di estrema sinistra presenti nel capoluogo
toscano. Insomma, un clamoroso autogol. Che ha spaventato, e non poco, i
genitori di questi adolescenti. Che magari hanno sbagliato, magari hanno
commesso anche uno o più reati ma che hanno il sacrosanto diritto di essere
giudicati da un tribunale della Repubblica Italiana. E non da una giuria di
tromboni progressisti.
"Facciamo girare le loro
foto...". Ora gli antifà schedano i ragazzi di destra. I compagni schedano i
militanti di Azione studentesca: "Tutti devono riconoscerli". Matteo Carnieletto
il 23 Febbraio 2023 su il Giornale.
"Vogliamo fare un applauso a
quel compagno che si è buttato in mezzo a quei bastardi che stavano prendendo a
pedate un altro ragazzo. Vogliamo anche rivendicare di aver fatto girare la foto
di quegli stronzi. Quella foto gira non per servire una strategia repressiva ma
perché la faccia di quei pezzi di merda deve essere conosciuta da tutti. Si
devono riconoscere quando vanno a prendere il caffè. Quando vanno dall'ortolano.
Quando vanno a fare la spesa. Quando vanno sulla tramvia. Perché quel peso se lo
devono sentire addosso". A parlare è un "compagno" del centro popolare
autogestito Firenze sud durante il corteo antifascista di ieri. Quello, dove per
intenderci, i manifestanti hanno urlato minacce contro il presidente del
Consiglio (Meloni fascista, sei la prima della lista) e slogan inneggianti
a Josip Broz Tito e alle foibe. Gli stronzi in questione sono i ragazzi
di Azione studentesca, coinvolti in una rissa di fronte al liceo Michelangiolo
di Firenze il 18 febbraio scorso.
Su queste pagine, abbiamo già
avuto modo di spiegare come la storia raccontata dai "giornaloni" di sinistra
sia per lo meno parziale. Quello che colpisce, ora, è l'atteggiamento
degli antifascisti fiorentini, le vittime di questa storia.
Negli ultimi mesi non solo si
sono segnalati per violenza. Ora stanno facendo anche girare le foto dei ragazzi
di destra affinché vengano riconosciuti. "Non per una strategia repressiva", sia
chiaro. Non perché qualcuno li possa riconoscere e magari menare. Ma solo perché
affinché possano portarsi addosso il peso di aver pestato altri ragazzi.
Ora: non vogliamo scomodare
l'antico adagio latino "excusatio non petita, accusatio manifesta" (scusa non
richiesta, accusa manifesta"). Ci basta solo ricordare una storia.
Sono i primi mesi del 1975 e un
ragazzo di Milano, che a vederlo sembra un capellone, scrive un tema in cui
condanna duramente le Brigate rosse. Il tema viene letto in classe dal
professore, a voce alta. È l'inizio del processo. Il tema viene sottratto e
affisso in corridoio. Tutti devono sapere cosa pensa quel capellone. Tutti,
vedendolo, devono fargli sentire addosso il peso delle sue parole. Passano i
giorni. Questo ragazzo dal viso pulito continua a fare quello che ha sempre
fatto. Studia e fa politica.
Il 13 marzo, però, accade
qualcosa di diverso. Il capellone parcheggia il motorino in una via non distante
da casa. Comincia ad assaporare il rientro. La mamma, la famiglia pronta ad
abbracciarlo e, forse, pronta a tirare un sospiro di sollievo vedendolo tornare
a casa ancora una volta. Ma questi pensieri vengono interrotti.
Mentre sta camminando, infatti,
quel ragazzo viene colpito con una violenza inenarrabile da diversi colpi
di chiave inglese. Uno. Due. Tre. Contarli è un esercizio inutile. Ancora. Il
ragazzo prova a difendersi ma non c'è più nulla da fare. Attorno a lui c'è solo
un lago di sangue. I compagni di Avanguardia operaia vogliono portare a termine
il compito. Qualcuno urla di piantarla. Che se continuano così lo ammazzano. Ma
è troppo tardi. I capelli, una volta morbidi, di quel ragazzo sono ora
imbrattati di sangue. Quel ragazzo non si sveglierà più. Passerà 47 giorni in
coma prima di morire. Quel ragazzo era Sergio Ramelli. Quel ragazzo doveva
portare addosso il peso di aver scritto quelle parole.
«ll fascismo è nato con i
pestaggi nei marciapiedi, ignorati dagli indifferenti»: la lettera da applausi
della preside. L’Espresso il 22 Febbraio 2023
Il documento della dirigente
scolastica del liceo scientifico Da Vinci Annalisa Savino, che cita Gramsci,
rivolto agli studenti dopo il pestaggio squadrista avvenuto nella città e
diventato virale sui social
Cari studenti,
in merito a quanto accaduto lo
scorso sabato davanti al liceo Michelangiolo di Firenze, al dibattito, alle
reazioni e alle omesse reazioni, ritengo che ognuno di voi abbia già una sua
opinione, riflettuta e immaginata da sé, considerato che l’episodio coinvolge
vostri coetanei e si è svolto davanti a una scuola superiore, come lo è la
vostra. Non vi tedio dunque, ma mi preme ricordarvi solo due cose.
Il fascismo in Italia non è
nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un
marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è
stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti. "Odio gli indifferenti" -
diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un
carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee.
Siate consapevoli che è in
momenti come questi che, nella storia, i totalitarismi hanno preso piede e
fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni. Nei periodi di
incertezza, di sfiducia collettiva nelle istituzioni, di sguardo ripiegato
dentro al proprio recinto, abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e
di aprirci al mondo, condannando sempre la violenza e la prepotenza. Chi decanta
il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai
diversi, continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato col suo nome,
combattuto con le idee e la cultura. Senza illudersi che questo disgustoso
rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene 100 anni fa ma
non è andata così.
Estratto da open.online il 23
Febbraio 2023.
Un professore che lavora al
liceo Michelangiolo di Firenze racconta oggi a La Nazione la sua versione
dell’agguato. E punta il dito contro i Collettivi di sinistra. Anche se non
vuole che il giornalista faccia il suo nome. Perché la sua «è una scuola molto
politicizzata».
Così, secondo il testimone, si
è accesa la miccia: «C’era questo volantinaggio dei ragazzi della destra. Sono
usciti quelli dei Collettivi e hanno cominciato ad insultarli e strappare i
volantini. Hanno tirato delle spinte e a quel punto quelli di Azione Studentesca
hanno cominciato a picchiare. E sicuramente hanno esagerato». […]
La dirigente del Leonardo da
Vinci di Firenze. Chi è la Preside della lettera antifascista: Annalisa
Savino, il pestaggio al liceo Michelangiolo, l’uscita del ministro Valditara.
Redazione su Il Riformista il 23 Febbraio 2023
Per il ministro dell’Istruzione
Valditara quella lettera contro il fascismo è stata “impropria”, gli è
“dispiaciuto leggerla”. L’avevano letta tutti o quasi la lettera della Preside
del Liceo Leonardo Da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, ispirata e scaturita
dall’aggressione che si era consumata sabato scorso davanti al liceo
Michelangiolo dello stesso capoluogo toscano. Parole di condanna al fascismo,
perché quei sei ragazzi – tre maggiorenni e tre minorenni – facevano parte
di Azione Studentesca. Sei contro due. La Procura di Firenze sta indagando.
“Cari studenti – aveva scritto
la dirigente – in merito a quanto accaduto lo scorso sabato davanti al liceo
Michelangiolo di Firenze, al dibattito, alle reazioni e alle omesse reazioni,
ritengo che ognuno di voi abbia già una sua opinione, riflettuta e immaginata da
sé, considerato che l’episodio coinvolge vostri coetanei e si è svolto davanti a
una scuola superiore, come lo è la vostra. Non vi tedio dunque, ma mi preme
ricordarvi solo due cose. Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate
da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la
vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da
passanti indifferenti. ‘Odio gli indifferenti’ – diceva un grande
italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla
morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee” .
Savino è diventata Preside del
Leonardo Da Vinci nel settembre del 2021. Laureata in Filosofia, aveva studiato
al liceo scientifico e all’Università di Firenze prima di abilitarsi
all’insegnamento. Ha insegnato alla scuola primaria e vinto il concorso da
dirigente. Ha diretto l’IC di Gambassi Terme e per otto anni l’IC Ghiberti di
Firenze. Alla Leonardo da Vinci arrivava dopo dieci anni di direzione ma alla
sua prima volta in una secondaria di II grado.
“Mi piacerebbe comunicare il
fatto che per me è una grande comunità, non mi piace l’idea di una scuola
azienda, ma di un istituto come grande comunità educante. La scuola statale
pubblica offre varie opportunità di studio e di crescita e per questo è una
scuola inclusiva di per sé. Ovviamente questo per me vale anche per un liceo che
si presenta ed è considerato come una scuola selettiva. Nella mia idea il liceo
non seleziona, bensì è una scuola che promuove l’impegno e la forza di chi ce la
mette tutta e lo fa dopo aver garantito a ciascuno pari opportunità e
condizioni per potersi impegnare”, raccontava in un’intervista a Leomagazine.
La lettera “messaggio sui fatti
di via della Colonna” della dirigente era diventata virale ieri sui media
nazionali. E proseguiva: “Siate consapevoli che è in momenti come questi che,
nella storia, i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune,
rovinando quelle di intere generazioni. Nei periodi di incertezza, di sfiducia
collettiva nelle istituzioni, di sguardo ripiegato dentro al proprio recinto,
abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo,
condannando sempre la violenza e la prepotenza. Chi decanta il valore delle
frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi,
continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato col suo nome, combattuto
con le idee e la cultura. Senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi
da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene 100 anni fa ma non è andata
così”.
Parole che non colpevolizzavano
– degli aggressori erano stati diffusi sui social perfino le foto a volto
scoperto -, che non incitavano ad alcuni tipo di violenza, che condannavano la
violenza squadrista e fascista come fa la Costituzione. “Come non avere
preoccupazioni in questo momento storico globale per il futuro di tutti noi? Il
mio voleva essere un messaggio agli studenti affinché non fossero indifferenti a
quanto accaduto a Firenze davanti al Liceo Michelangiolo. La peggior cosa è
pensare che questi episodi non contino niente e che tutto sempre evolva verso
più rosei orizzonti. La violenza politica è un pericolo e va sempre
stigmatizzata”, aveva commentato Savino in un’intervista a Il Corriere della
Sera.
Non dello stesso avviso il
ministro. “È una lettera del tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non
compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha
nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c’è alcuna deriva violenta e
autoritaria, non c’è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha
nulla a che vedere con il nazismo o con il nazismo. Sono iniziative strumentali
che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle
scuole; se l’atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario
prendere misure”, ha detto il ministro a Mattino 5.
Prima di oggi nessun membro del
governo Meloni si era espresso sulle violenze al liceo Michelangiolo: nessuno
fino a oggi, Valditara è stato il primo.
La tristezza di vedere una
preside lanciare «l'allarme fascisti», che non c'è. Federico Novella su
Panorama il 23 Febbraio 2023
Sta facendo discutere quanto
accaduto in un liceo fiorentino giorni fa e da cui la sinistra ha rilanciato
l'ennesima allerta fascisti, con la complicità della dirigente della scuola e
della sua lettera agli studenti
C’è poco da fare. Ogni
occasione è buona per suonare l’allarme fascismo. Da ultimo, il fattaccio
certamente deprecabile avvenuto al liceo Michelangelo di Firenze, dove alcuni
ragazzi del movimento di destra Azione Studentesca hanno preso a calci e pugni
quelli di sinistra. Certe cose vanno condannate duramente, e i responsabili
puniti senza sconti. Siamo d’accordo. Ma approfittare di questo fatto per
lanciare appelli alla Resistenza contro il rigurgito fascista, questo no. Eppure
i proclami partigiani sono subito partiti, dapprima con l’etichettatura spiccia
del sindaco Nardella, che ha parlato di “atto squadristico”. E poi tramite una
lettera-manifesto firmata da Annalisa Savino, la preside di un altro liceo
fiorentino, il Da Vinci: “Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate
da migliaia di persone – scrive - È nato ai bordi di un marciapiede qualunque
con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé
stessa”. Non solo, la suddetta preside aggiunge una postilla politica
significativa: “Chi decanta il valore delle frontiere va chiamato con il suo
nome”. Un’equazione limpida, su carta intestata della scuola pubblica: difendere
le frontiere uguale fascismo. Così è davvero troppo. Il Ministro Valditara
stamattina ha scelto di intervenire, per condannare una lettera “impropria”:
“Non compete a una preside lanciare messaggi di questo tipo: in Italia non c'è
alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere
le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo. Sono iniziative
strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più
posto nelle scuole”. Il ministro effettivamente centra il problema. Ciò che è
accaduto in quel liceo è grave e va perseguito. Ma approfittare dell’accaduto
per gridare al regime, al ritorno delle armate delle tenebre in camicia nera,
significa strumentalizzare politicamente i ragazzi: tutti i ragazzi, gli
aggressori e gli aggrediti. I quali diventano pedine manovrate a piacimento per
fini squisitamente politici. La reazione scomposta dei dirigenti scolastici ci
fa capire che in Italia restano ancora in piedi, granitiche, le casematte
culturali di certa sinistra vetero-marxista. Le ultime ridotte intellettuali che
passano da certi licei fino alle grandi kermesse come il Salone del Libro. Chi
non si allinea è fascista in automatico. Un clima di semi-terrore ben
rappresentato dalle parole di un testimone che insegna sempre al Liceo
Michelangelo, il quale intervistato da “La Nazione” , racconta che ad accendere
la miccia dello scontro sarebbero stati in realtà gli studenti dei collettivi di
sinistra. Perché questo docente non è intervenuto? Per gli stessi motivi per cui
oggi chiede di restare anonimo: “Questa è una scuola molto politicizzata, vorrei
continuare a lavorarci senza problemi”. Insomma, chi accetta la vulgata
antifascista è in regola: chi parla è perduto. Se questo è il senso critico
coltivato nelle scuole, povere le nuove generazioni.
"Il fascismo è nato
così...". La retorica che piace solo a sinistra. Marco Leardi il 22 Febbraio
2023 su il Giornale.
La missiva di una preside dopo
la rissa al Michelangiolo di Firenze: "Fascismo nato ai bordi di un
marciapiede". Nessun riferimento alle violenze antifasciste. E la sinistra
plaude
"Ho voluto fornire spunti di
riflessione ulteriori...". Le intenzioni erano sicuramente sincere. Peccato che
la lettera scritta dalla preside di un liceo fiorentino dopo la rissa
studentesca del 18 febbraio scorso abbia di fatto alimentato le divisioni. Nella
pagina firmata da Annalisa Savino - dirigente scolastica dell'istituto "Leonardo
Da Vinci" - ci abbiamo infatti ritrovato molta retorica e quale dimenticanza. La
preside difatti ha evocato il fascismo e i totalitarismi senza menzionare
nemmeno di striscio le provocazioni antifasciste che a Firenze avevano reso il
clima tesissimo, contribuendo poi a far sfociare le agitazioni nel deprecapile
episodio del Michelangiolo.
La lettera della preside
"Il fascismo in Italia non è
nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un
marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è
stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. 'Odio gli indifferenti',
diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in carcere
fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee", ha scritto
la dottoressa Savino nella missiva indirizzata gli studenti, alle loro famiglie
e al personale scolastico. Argomentazioni che ci convincono poco e che riteniamo
viziate da qualche azzardo nell'analisi. Innanzitutto evocare la nascita del
fascismo a fronte di una brutta rissa per motivi politici ci pare
un'esagerazione. Anche perché su quel marciapiede non c'erano solo gli studenti
di destra ma anche i loro coetanei di sinistra. Ed entrambi, a quanto
pare, avrebbero concorso all'epilogo violento.
Le provocazioni antifasciste e
l'indifferenza
Nei giorni precedenti al
pestaggio al liceo, peraltro, a Firenze si erano verificate minacciose
provocazioni provenienti dagli ambienti antagonisti. Prima della rissa al
Michelangiolo - secondo quanto ricostruito da una nostra fonte - i collettivi di
Sum avevano persino organizzato una spedizione punitiva contro i ragazzi di
Azione studentesca. Ma in quel caso tutto era avvenuto sotto una certa
"indifferenza" (per richiamare Gramsci, giustappunto). Forse la preside del
liceo "Da Vinci" non ne era informata.
"I totalitarismi in momenti
come questi..."
Rivolgendosi ai destinatari
della missiva, la dirigente scolastica ha poi aggiunto: "Siate consapevoli che è
in momenti come questi che, nella storia, i totalitarismi hanno preso piede e
fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni. Nei periodi di
incertezza, di sfiducia collettiva nelle istituzioni, di sguardo ripiegato
dentro al proprio recinto, abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e
di aprirci al mondo, condannando sempre la violenza e la prepotenza". Anche qui
però ci permettiamo di dissentire. Scomodare i totalitarismi in riferimento
all'attualità ci sembra infatti una forzatura.
Ancor più opinabile il
successivo passaggio della lettera: "Chi decanta il valore delle frontiere, chi
onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare
muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con
la cultura. Senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo
pensavano anche tanti italiani per bene cento anni fa ma non è andata così".
All'indomani di una scazzottata a sfondo politico, tuttavia, simili
argomentazioni rischiano di accentuare ancor più certe divergenze. Non sarebbe
stato più semplice ribadire - senza troppi giri di parole - che la violenza è da
combattere sempre, comunque la si pensi in politica?
"Riflessione pacata", il plauso
di Nardella
La lettera, come accennato, ha
ottenuto plausi da sinistra. "Grazie alla Preside del liceo 'Leonardo Da Vinci'
per questa riflessione chiara e pacata. Firenze sarà sempre antifascista", ha
scritto sui social il sindaco di Firenze, Dario Nardella. E agli antifascisti
violenti (quelli che inneggiano alle foibe e lanciano petardi contro la polizia)
nessuno dice niente?
Basta scuola di parte.
Anche oggi (e pure domani e anche dopodomani probabilmente) la sinistra ha il
suo nemico del giorno. Francesco Maria Del Vigo su Il Giornale il 24 febbraio
2023.
Anche oggi (e pure domani e
anche dopodomani probabilmente) la sinistra ha il suo nemico del giorno. Il
bersaglio contro il quale scaricare il proprio arsenale di odio politico e, in
alcuni casi, financo antropologico. Il cattivo del giorno che - ormai è anche
pleonastico ripeterlo -, viene tacciato di non-sufficiente-antifascismo, filo
fascismo, protofascimo, insomma mettete un po' il prefisso che vi pare purché si
parli di fascismo, è Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito.
Il quale ha sicuramente il merito di non bazzicare i luoghi comuni e di dire le
cose fuori dai denti. Magari, a volte, anche un po' troppo. Ma non in questo
caso. Facciamo un piccolo sunto dei fatti, con la premessa necessaria che si
tratta di eventi di questi giorni e non degli anni Settanta. Il 18 febbraio, a
Firenze, un gruppo di ragazzi di Azione studentesca aggredisce fuori dal liceo
scientifico «Leonardo da Vinci» alcuni coetanei di sinistra. Un gesto criminale
del quale si sta occupando l'autorità giudiziaria. Due giorni dopo - lunedì 20
-, la sinistra, gli antagonisti e i centri sociali scendono in piazza per
chiedere la «liberazione dal fascismo e dal governo Meloni». C'entra come i
cavoli a merenda con la rissa, ma facciamo finta di niente. Incidentalmente i
sinceri difensori della democrazia inneggiano alle foibe, a Tito e minacciano di
morte la premier («Meloni fascista, sei la prima della lista», originale eh?),
ma facciamo finta di niente anche in questo caso. Non c'è molto da stupirsi: la
sinistra ha occupato l'intera campagna elettorale gridando al ritorno delle
camicie nere e alla fine qualcuno ha finito per crederci, come era ampiamente
prevedibile. Ma la questione è un'altra: il clima è rovente, gli animi
surriscaldati, le passioni politiche esasperate e cosa pensa di fare la preside
del Michelangelo? Scrive una circolare infuocata nella quale, dopo aver
giustamente condannato l'agguato, sottolinea come il fascismo sia nato così (da
una rissa per strada? Analisi raffinatissima...) e richiama tutti all'allerta
democratica. Come cercare di spegnere un incendio con un Canadair pieno di
benzina. Un gesto politico, certamente non didattico. Al quale il ministro
dell'Istruzione, ieri, ha risposto con decisione: «É una lettera del tutto
impropria, non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo. Vedremo
se sarà necessario prendere misure».
Una frase sensata che ha
scatenato un putiferio di polemiche. I presidi sono la rappresentazione dello
Stato e delle Istituzioni nelle scuole. Sono il presidio di legalità più vicino
ai giovani. Non devono fare i piromani, semmai i pompieri. Non devono
trasformare le aule e i corridoi dei licei in terreno di scontro per una guerra
civile finita più di settant'anni fa, ma soprattutto non devono strumentalizzare
e aizzare i ragazzi per fini politici. Altrimenti si finisce per delegittimare
la scuola stessa: operazione che la sinistra, dal 1968 a oggi, porta avanti con
grande pervicacia. Anche a colpi di circolari politicizzate.
Quei "cattivi maestri" dei
giovani e la visione distorta della politica. Quanto accaduto a Firenze non
è altro che conseguenza dell’ideologia: per un’idea, infatti, non si ricorre
alla violenza. La causa è sempre la stessa: vedere nell’altro non un avversario
ma un nemico, un mezzo con il quale affermarsi, costi quel che costi. Suor Anna
Monia Alfieri su Il Giornale il 23 febbraio 2023.
Quanto accaduto a Firenze non è
che uno dei tanti episodi della dilagante violenza fra i giovani. È certamente
triste e al contempo interessante constatare che sempre più spesso i fenomeni di
violenza avvengono o in famiglia o tra i giovani. A questi poi occorre
aggiungere la non meno inquietante violenza delle strade legata a certe
manifestazioni ispirate alla politica, o meglio, perché la politica è cosa ben
diversa, a una visione distorta della politica e delle sue rivendicazioni.
Ulteriore prova che si tratta di fenomeni che sono conseguenza dell’ideologia:
per un’idea, infatti, non si ricorre alla violenza. La causa è sempre la stessa:
vedere nell’altro non un avversario ma un nemico, un mezzo con il quale
affermarsi, costi quel che costi. Che il fenomeno violento avvenga tra le mura
domestiche, nei bagni di una scuola o sulla pubblica piazza, poco importa:
l’altro non è un mio simile, non conta nulla, io basto a me stesso.
Altro fattore che sicuramente
contribuisce a innescare la violenza tra i nostri giovani è la solitudine cui
ormai da almeno tre decenni li abbiamo abbandonati. Cosa fa un adolescente
quando torna da scuola e non ha altra alternativa se non l’ozio del parchetto o
i tentacoli dei social, con le idee che circolano e che i nuovi mezzi di
comunicazione contribuiscono ad amplificare? Ecco i cattivi maestri! La loro
categoria abbraccia i settori più disparati: la pubblicità, gli influencer,
certi cantanti e personaggi dello spettacolo e, aggiungiamoci, certi nostri
politici. Perché si tratta di maestri cattivi? Perché i messaggi che diffondono
sono ispirati alla logica del guadagno, della popolarità, del fare cassa alle
spalle di chi non ha gli strumenti per comprendere l’inganno. In altre parole, i
cattivi maestri intercettano e sfruttano la fragilità di chi li segue. Pensiamo
ai messaggi violenti lanciati in prima serata dal palco di Sanremo, dalla Tv
pubblica. E’ ovvio, che se chi occupa determinati ruoli o gode di una certa
visibilità mediatica si lascia andare a comportamenti violenti, i giovani si
sentiranno legittimati a fare lo stesso.
Allora, occorre invertire la
rotta e fare nuove proposte ai giovani, proposte credibili e in grado
conquistarli, ampliando le occasioni di aggregazione sana e costruttiva. Al di
là delle molteplici e belle proposte già esistenti e provenienti dalle diverse
realtà educative o del volontariato, anche la scuola può e deve fare molto: al
mattino si sta in classe e si apprende, al pomeriggio si ritorna a scuola e si
studia assieme o si svolgono attività con uno sguardo sempre proiettato
all’altro, al suo bene. Non è educativo che un ragazzo di 15 anni trascorra i
suoi pomeriggi nella noia del parchetto o del centro commerciale, né che abbia
come unico impegno la palestra intesa non ad un benessere psicofisico ma come
esaltazione del proprio io. E poi, mi si consenta di dire anche questo: ricordo
che, quando ero ragazza, i miei amici i cui genitori avevano un’attività in
proprio (un negozio, un bar, una ditta) aiutavano i loro genitori. Il figlio del
padrone veniva affidato all’operaio più esperto e imparava il mestiere. Ora,
ovviamente nel massimo rispetto della normativa giuslavoristica e della
sicurezza sui luoghi di lavoro, smettiamola di dire che, se un ragazzo di 15
anni segue il proprio papà sul furgone, si cade nel reato di sfruttamento del
lavoro minorile!
Ancora un’ultima
considerazione: quale esempio sta offrendo la politica ai nostri giovani? Il
governo eletto dai cittadini è continuamente oggetto di polemiche e di
ostruzionismo. Non voglio prendere le parti di nessuno ma occorre che tutti i
partiti compiano un esame di coscienza e si pongano la domanda: perché la mia
parte politica non ha ottenuto la maggioranza? Come posso adempiere al mio
mandato di opposizione in modo serio e costruttivo, non per il bene della mia
parte ma per il bene pubblico? Quando si compiono delle scelte, occorre poi
assumerne le conseguenze. È inutile, pertanto, condannare la violenza o i
diversi fenomeni che la cronaca ci fa conoscere e poi fomentare quella stessa
violenza accusando l’altra parte politica. È necessaria una nuova e motivata
coerenza, una nuova etica nella politica. Non solo non si finanziano
illegalmente i partiti, ma si rispetta un codice di comportamento, pur nella
legittima dialettica. Chissà che una scuola nuova, liberamente scelta dai
genitori, una scuola aperta alle diverse realtà benefiche operanti sul
territorio, unita ad una politica diversa siano le due premesse al cambiamento e
alla fine della violenza giovanile.
Estratto da video.repubblica.it
il 25 febbraio 2023
Un nuovo video circolato nelle
chat degli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze documenterebbe in maniera
nitida quanto accaduto sabato scorso. Dalle immagini del breve filmato si vede
con estrema chiarezza come i ragazzi dei collettivi di sinistra abbiano provato
a difendersi dall'aggressione dei militanti di Azione studentesca rimanendo però
accerchiati nel giro di pochi istanti. I due studenti che stavano facendo
volantinaggio davanti al liceo tentano di reagire ma vengono colpiti
ripetutamente dai loro aggressori e gettati a terra. Non una rissa quindi ma una
vera e propria spedizione punitiva. La Digos ha sequestrato i telefoni dei
ragazzi indagati per analizzare video, foto e chat. Lesioni e percosse le
ipotesi di reato.
Liceo di Firenze, l’ex
preside: “Io insultato e mai difeso”. Libero Quotidiano il 25 febbraio 2023
Continua a far discutere quanto
successo davanti al liceo Michelangiolo di Firenze, con la rissa scoppiata
sabato scorso tra alcuni attivisti di Azione Studentesca e i militanti dei
Collettivi di sinistra. Adesso a prendere la parola è un ex preside di
quell'istituto, Massimo Primerano, che ha confessato di essere stato minacciato
perché di destra. Nonostante questo, però, nessuno lo avrebbe mai difeso e
supportato. L'uomo ha commentato un post del sindaco di Firenze, Dario Nardella,
nel quale il primo cittadino esalta la lettera della dirigente scolastica del
liceo Leonardo da Vinci.
Negli anni in cui ero preside,
dal 2005 al 2012, lei era vicesindaco. In quel periodo, le violenze erano tutte
di matrice anarchica ed i cosiddetti collettivi di sinistra non disdegnavano
affatto di usare mezzi verbalmente e fisicamente violenti in nome di un
antifascismo usato come slogan ed un modo di agire che niente aveva da invidiare
ai metodi fascisti", ha scritto l'ex preside. Che poi ha raccontato di come gli
fu "danneggiato lo scooter, giunsero minacce pesanti alcune delle quali sono
sempre visibili nella bacheca all’ingresso del Liceo". Stando al racconto
dell'uomo, lo slogan contro di lui era "Primerano fascista".
Il paradosso, ha sottolineato
l'ex preside, è che all'epoca fu pure "candidato in una lista di sostegno al Pd.
Ma guarda caso né lei né alcuno dei suoi colleghi mi sostenne. Anzi accadde di
peggio: ricevevo telefonate di sostegno forte da esponenti politici che il
giorno seguente non disdegnavano di fare sia in consiglio comunale che sui
giornali dichiarazioni apertamente critiche sul mio operato". Marcando la
distanza con la preside che ha scritto la lettera sul fascismo, Primerano ha
spiegato: "Non feci lettere agli studenti e neppure le inviai ai giornali per il
rispetto al ruolo istituzionale che avevo cucito addosso. Mi aspetterei da
politici seri una condanna contro qualunque forma di violenza indipendentemente
da chi la pratica e non in base a chi la pratica, senza fare il tifoso. Chiedo
troppo?".
Il pestaggio, la lettera e
le reazioni. Cosa è l’antifascismo oggi: una caccia ai fantasmi. Alfredo
Antoniozzi su Il Riformista il 26 Febbraio 2023
Caro direttore
Ti ringrazio per la citazione
nel tuo apprezzabile articolo sulle polemiche scaturite dalla lettera
della preside di Firenze. Premessa: ci sono cascato anche io. Ho probabilmente
fatto ciò che la professoressa si attendeva e cioè dare eco alla sua iniziativa.
Non voglio più entrare nel dibattito sul fascismo e l’antifascismo. È un
problema della sinistra inseguire i fantasmi. Un po’,se mi consenti, come accade
nel calcio, dove tanti tifosi piuttosto che pensare alle loro squadre-( io sono
laziale) tirano sempre in ballo la Juventus come totem di sopravvivenza. Usciamo
da questa mediocrità. Il fascismo è morto a Salò.
Nel merito delle tue obiezioni
rispondo che la Scuola fa fatica a uscire da una narrazione strabica. Ad
esempio Gramsci, straordinario pensatore che Mussolini temeva più di tutti, non
era proprio un riformista. Tant’è che Turati ruppe con lui proprio sull’idea di
organizzazione della sinistra. Per cui mi sembra paradossale che tanti
commentatori politici di estrazione cattolica come la mia lo mettano insieme
a Don Milani nell’interpretare la lettera della
professoressa Savino. Il comunismo nel mondo è stata una tragedia. La più
grande. E in Italia, se le elezioni del 48 fossero andate diversamente, questa
tragedia si sarebbe potuta ripetere. Tutto questo la scuola lo omette. Così come
omette di raccontare ciò che è stato vissuto nell’Europa dell’est.
Io credo che continuare a
proporre fantasmi (scelta legittima ci mancherebbe ma già pagata a caro prezzo
da Enrico Letta) sia un pessimo insegnamento per i nostri ragazzi. Avrei voluto
che in quella missiva, diventata ormai più celere di tanti romanzi, la dirigente
scolastica dicesse ai ragazzi che la violenza tra fazioni ha solo prodotto morti
e distrutto vite negli anni settanta. Che la tolleranza è l’unica, grande arma
della democrazia. Avrei voluto che, insieme all’antifascismo, citasse il partito
radicale (le cui idee erano lontane anni luce dalle mie) e la non violenza come
metodo di lotta politica.
Sai meglio di me che
tanti antifascisti di rilievo della Repubblica erano stati fascisti di
avanguardia. E che, come scrissero tanti intellettuali di spessore, c’è una
sorta di fascismo insito nell’antifascismo che prevarica. Però tutto questo va
storicizzato. Necessariamente. Perché è impensabile che 80 anni dopo si
paventino spettri che non esistono. Il nemico comune a cui tutti dovremmo
guardare è il nichilismo, l’idea di una società priva di sentimenti e di valori.
La nostra Repubblica è nata da un dolore enorme. Dalle ceneri di una guerra. E
la vera, triste realtà è che ancora oggi è la guerra il nostro avversario da
abbattere.
Così come, non è una
divagazione, le giovani generazioni sono risucchiate da problemi che sembrano
più rilevanti di 40 anni fa: alcol, consumo di droghe, ludopatia, attività
criminali. Costruiamo una condivisione pedagogica comune che recuperi i giovani
alla politica, che insegni loro il rispetto reciproco. E non cerchiamo,
direbbe Brecht, il bisogno esasperato di eroismi inventati. Abbiamo bisogno di
combattere un’altra indifferenza che e quella della rassegnazione. E senza
credibilità non saremo giudicati all’altezza. Se la sinistra vorrà indicare
nell’antifascismo il problema dell’Italia continuerà a farsi del male. Come
direbbe Nanni Moretti.
Con stima. ALFREDO ANTONIOZZI
(deputato di FdI)
È vero,
onorevole Antoniozzi, Brecht scrisse contro gli eroismi inutili. Ma lei
sicuramente saprà che Brecht, che era tedesco, questa sua idea non la scrisse
nella sua casa di Berlino ma in un appartamento di Santa Monica, California. E
sa anche perché. Non poteva vivere a Berlino, in quegli anni, né in un’altra
città tedesca o italiana perché in Germania e in Italia governavano i fascisti e
i nazisti che avevano abolito la libertà e mettevano in prigione, o uccidevano,
gli avversari. E proprio in quegli anni iniziarono lo sterminio degli ebrei, che
spinse l’umanità al punto più basso della civiltà umana.
Lei dice: cose passate. Vero.
Non del tutto. Ci sono ancora delle persone viventi che scamparono per miracolo
ai lager e ai forni crematori. Oggi sono vecchi, hanno ottanta o novanta anni.
Ricordano: ricordano bene, tutto. Poi ci sono delle persone che avrebbero
ottanta o novant’anni, ma non esistono più perché furono bruciate nei forni
di Auschwitz o di Buchenwald quando erano bambini. Capisce, onorevole, che non è
facile dimenticare l’orrore fascista? Che non riguarda la Svezia, o
l’Australia, o l’Etiopia, o l’Iran. Riguarda noi: la nostra “nazione”,
direbbe Giorgia Meloni. Le orrende vergogne delle quali si è macchiata.
Per questo in Italia
l’antifascismo è ancora un valore. Dopodiché io penso che l’antifascismo non sia
un affare di bandiere, etichette, appartenenze, retorica. Né che esistano i
“possessori” dell’antifascismo. L’antifascismo è una idea, assolutamente
facoltativa, che attraversa la sinistra, il mondo cristiano e la destra
liberale, ed è un’idea che non vive di anatemi ma di lotta agli autoritarismi e
alle illiberalità. Per me l’antifascismo è la battaglia contro
i divieti, la repressione, il giustizialismo, le gerarchie, gli obblighi, le leggi
ingiuste, le sopraffazioni dello Stato. È la difesa di tutti, soprattutto dei
più deboli, soprattutto dei detenuti. Per me l’antifascismo è anche la difesa
dei fascisti, che devono avere pieno diritto ad esistere e ad esprimersi: e ogni
discriminazione nei loro confronti è un atto fascista.
Esistono ancora i fascisti nel
nostro parlamento? Io credo di si. In molti partiti la illiberalità,
l’autoritarismo, il giustizialismo sono valori viventi. Sono persino identità:
nei 5Stelle soprattutto, ma anche tra i Fratelli d’Italia, nella Lega, persino
nel Pd. Esistono, i fascisti, e hanno diritto di esistere. Tra loro, mi par di
capire, c’è anche il ministro dell’Istruzione che vuole proibire la politica
nelle scuole. Mi chiedo solo questo: è opportuno che il ministro della scuola
sia di idee fasciste? PIERO SANSONETTI
"Siete morti".
L'agguato choc degli studenti di sinistra. Il video esclusivo. L'aggressione
nel maggio 2022 agli studenti di Azione universitaria a Bologna. Ecco le fasi
dell'agguato in un video esclusivo. Francesca Galici il 3 marzo 2023 su Il
Giornale.
Da settimane, ormai, la
sinistra cavalca le polemiche su quanto accaduto all'esterno del liceo
Michelangiolo di Firenze. Violenza esecrabile, perché mai nessun atto violento
può essere giustificato, ma la sensazione è che si stia sfruttando quell'evento
a scopo politico come rimostranza contro il governo Meloni. Eppure, meno di un
anno fa, qualcosa di simile è accaduto a Bologna, solo che le parti erano
invertite: un gruppo di studenti di Azione Universitaria è stato sorpreso e
aggredito alle spalle dai collettivi rossi.
La denuncia della violenza era
stata fatta nell'immediato da parte delle vittime ma nessuno, a sinistra, si era
mobilitato con la stessa foga o con la stessa veemenza con la quale si chiede
oggi al centrodestra di dissociarsi, attribuendo alla politica nazionale la
responsabilità dei fatti. Oggi che le indagini sono state chiuse e che ci sono
otto studenti dei collettivi indagati, possiamo mostrare il video esclusivo di
quell'aggressione, che mostra il modo con il quale è avvenuto l'assalto, che ha
i contorni di un vero e proprio agguato.
"Tornate nelle fogne", "siete
morti", "vi uccidiamo". Queste alcune delle frasi pronunciate dagli aggressori e
riportate, nero su bianco, nell'avviso di conclusione delle indagini firmato dal
pm Stefano Dambruoso. La procura contesta agli indagati non solo le lesioni
aggravate ma anche la rapina: con "calci, spintoni, pugni e strattonamenti" si
sarebbero infatti impossessati delle "bandiere e delle aste" degli studenti di
Azione Studentesca.
"Ci hanno accerchiati,
arrivavano da tutte le parti, saranno stati una ventina: è stato un agguato",
così raccontava Dalila Ansalone, consigliere del quartiere Santo Stefano e
consigliere di Azione universitaria all’Unibo, quanto avvenuto sotto i portici
del teatro comunale. Non fu certo una passeggiata di salute quell'aggressione,
visto che sia lei che Stefano Cavedagna, consigliere comunale di Bologna, ebbero
una prognosi di 16 giorni, con lesioni di vario tipo tra le quali il trauma
cranico. Se la violenza è violenza, perché da sinistra non si è usato lo stesso
metro di valutazione per condannare ed esecrare quell'aggressione, che non ha
nulla di meno rispetto a quanto accaduto a Firenze?
L'impressione, nonché la
certezza, è che come al solito nel nostro Paese ci siano aggressioni giuste e
aggressioni sbagliate. Nel video che abbiamo ricevuto è evidente che si sia
trattata di un'azione punitiva, probabilmente premeditata, che aveva lo scopo di
colpire gli "avversari" politici. Non sono erano segnalati precedenti di rilievo
recenti tra le due fazioni, c'è stata semplicemente la volontà dei collettivi
rossi di assalire gli iscritti ad Azione universitaria per la loro fede
politica. Nulla di diverso rispetto a quanto accadeva negli anni Settanta ma ben
distante da quanto accaduto a Firenze, invece, dove la rissa è nata dopo
la provocazione dei collettivi ai quali gli studenti di destra, sbagliando,
hanno reagito con violenza.
Prendere a pugni i ragazzi
di destra non fa notizia: se lo meritano. Ecco il video del pestaggio dei
militanti di FdI avvenuto a Bologna nel maggio 2022. Nessuno ne parla. Perché?
di Giuseppe De Lorenzo su Nicola porro.it il 3 Marzo 2023
Non siamo mica sciocchi: non ci
aspettavamo certo che, dopo la nostra esclusiva sul pestaggio di alcuni studenti
di destra a Bologna, i grandi giornali ci venissero dietro. Per carità, ci siamo
abituati: se a prendere le botte, vere e documentate, sono i giovani di Fratelli
d’Italia nessuno fa un frizzo. Ne parlano i quotidiani locali per qualche
giorno, poi tutto finisce nel dimenticatoio. Se invece di fronte a un liceo
fiorentino scoppia una rissa, subito la stampa democratica fa scattare le
trombette dell’antifascismo militante, sgorgano editoriali sulla difesa della
Costituzione e contro lo squadrismo fascista. Lo ripetiamo: ci siamo abituati.
Però è pure giusto mettere a nudo l’ipocrisia del sistema mediatico italiano,
oltre che di quello intellettuale e giornalistico.
Di casi da raccontare ce ne
sarebbero a bizzeffe, senza dimenticare i collettivi che alla Sapienza hanno
impedito a Daniele Capezzone di parlare. Ma limitiamoci agli episodi simili:
prendiamo i fatti di Bologna, che risalgono al maggio del 2022, e quelli più
recenti di Firenze.
La sera del 19 maggio, una
decina di giovani di Azione Universitaria è in via Zamboni a Bologna per
controllare i risultati delle elezioni universitarie. Escono dal portone
tranquilli, chiacchierano, tutto fila liscio come l’olio. Finché non
vengono circondati e malmenati da una ventina di persone. A confermarlo c’è
l’avviso di conclusione indagini contro 8 ragazzi, in cui si parla di “pugni,
calci e spintoni”, di un trauma toracico, di lesioni guaribili in 16 giorni e
minacce tipo “vi uccidiamo”, “tornate nelle fogne”, “siete morti”. Un vero e
proprio agguato, certificato anche dai video delle telecamere di sorveglianza
che circondano l’ingresso della Facoltà di Lettere bolognese. Si vedono
distintamente i ragazzi di Azione Universitaria aggrediti alle spalle da un
gruppo militanti di sinistra. Le immagini non lasciano spazio all’immaginazione:
botte, pugni, spintoni. Violenze, insomma. Gravi tanto quanto quelle emerse dai
filmati della rissa di fronte al Michelangiolo. Se non di più.
E arriviamo a Firenze. Ogni
violenza è deprecabile e su questo sito lo abbiamo detto e ridetto: gli alunni
di Azione Studentesca hanno fatto male a reagire con i pugni. Però va pure
ridimensionato il contesto: secondo alcuni testimoni, infatti, a far scattare la
miccia sarebbero stati gli studenti dei collettivi infastiditi da un banale
volantinaggio degli avversari “di destra” di fronte alla loro scuola. Un
professore, intervistato dalla Nazione, l’ha detto chiaro e tondo: “C’era questo
volantinaggio dei ragazzi della destra. Sono usciti quelli dei collettivi
e hanno cominciato ad insultarli e strappare i volantini. Hanno tirato delle
spinte e a quel punto quelli di Azione Studentesca hanno cominciato a
picchiare”. Una rissa, insomma, e non quel “pestaggio squadrista” cui i media si
sono aggrappati per giorni basandosi su un’unica versione dei fatti.
Morale della favola. Domani a
Firenze è prevista una grande manifestazione antifascista “in difesa della
scuola e della Costituzione”. Il corteo protesterà “contro ogni forma di
violenza” e per esprimere “solidarietà alla preside Savino”, quella
della delirante lettera sul fascismo. Saranno presenti anche Elly
Schlein e Giuseppe Conte, nella più classica delle farse. Ci permettiamo di dare
un suggerimento: in piazza proiettate pure il video del pestaggio dei collettivi
ai danni dei militanti FdI. Così magari anche Repubblica e gli altri giornali se
ne accorgono e ne parlano un po’. Oppure ci volete dire che se sei di destra le
botte te le meriti? Giuseppe De Lorenzo, 3 marzo 2023
Minacce e violenze
dai collettivi rossi. E la sinistra tace. Pd e 5S attaccano il governo sulla
rissa studentesca di Firenze. "Non dicono nulla...". Ma nelle stesse ore i
progressisti tacciono sulle minacce dei collettivi di sinistra: un vizio non
certo nuovo. Marco Leardi su Il Giornale il 24 febbraio 2023.
La sinistra s'è lanciata nella
rissa, sperando forse di ammaccare il governo a suon di polemiche. Con il
passare delle ore, la discussione sulla scazzottata studentesca di Firenze è
stata infatti trascinata dai progressisti sul terreno dello scontro tra partiti.
E meno male che le ideologie andavano tenute fuori dalla mischia. Dalle
opposizioni si è alzato così un coro unanime di contestazioni al governo, reo -
a giudizio di Pd e Cinque Stelle - di non aver condannato con fermezza
l'aggressione "squadrista" del liceo Michelangiolo. Guai peraltro a mettere in
dubbio quella narrazione e a spiegare che anche i collettivi rossi avevano
contribuito ad accendere la miccia delle tensioni.
Pestaggio a Firenze, sinistra
contro il governo
"Il governo non ha detto nulla
sull'aggressione neofascista contro gli studenti di Firenze", ha tuonato
deputato dem Nicola Zingaretti. Ed Elly Schlein è andata all'attacco del
ministro Valditara. Ma il colmo è che tali recriminazioni provengono da un
partito che troppo spesso non ha battuto ciglio di fronte alle aggressioni e
alle minacce degli antagonisti.
Il silenzio progressista sui
collettivi rossi
Nelle stesse ore in cui
pretendevano un pronunciamento del governo, i progressisti tacevano sulle
minacce al ministro dell'Istruzione provenienti dai collettivi studenteschi
torinesi. "Valditara a testa in giù", aveva scritto sui social un giovane vicino
ai centri sociali, ma l'esponente politico non aveva ricevuto alcun sostegno da
sinistra (come da lui stesso testimoniato). A solidarizzare con il collega di
governo era stato invece Matteo Salvini, che in tutta risposta si era
beccato una minaccia dai collettivi rossi. "Sappia che a piazzale Loreto c'è
ancora posto", gli avevano comunicato tramite i social. Ma al momento non si
registrano diffuse condanne da sinistra, a eccezione di quella pronunciata dal
sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Uno su mille ce la fa (a prendere le
distanze senza indugi). Il silenzio piddino e pentastellato aveva anche
accompagnato le minacce anti-Meloni al corteo di Firenze con cori offensivi
sulle foibe.
Gli inni alle Br e la Meloni
appesa
Ma pure in passato i
progressisti si erano stranamente trattenuti dallo stigmatizzare alcune gesta
dei collettivi studenteschi. A ottobre, ad esempio, gli antagonisti volevano
impedire la realizzazione di un convegno di Azione
Universitaria alla Sapienza di Roma e la sinistra, invece di redarguire questi
ultimi, aveva polemizzato con il Viminale perché la polizia li aveva respinti.
Analogamente, non si erano udite voci di condanna contro i giovani che
inneggiavano alle Brigate Rosse durante un'assemblea sul caso Cospito nel
medesimo ateneo romano. Eppure, cosa sarebbe costato? Nulla, visto che quelle
idee sono fortunatamente estranee ai partiti della sinistra parlamentare.
All'elenco dei recenti imbarazzi di sinistra aggiungiamo poi quello
sul fantoccio della Meloni appeso a testa in giù a Bologna. Un gesto talmente
grave da spingere il sindaco Pd Matteo Lepore a condannare l'accaduto. "Violenza
inaccettabile", disse il primo cittadino.
Ma raramente da sinistra
arrivano prese di posizione così esplicite, soprattutto quando a sgarrare sono i
"bravi" ragazzi dei collettivi studenteschi o i loro amici militanti dei centri
sociali. Per questo ora certe polemiche rivolte contro il governo sul caso del
liceo Michelangiolo appaiono strumentali, se non addirittura ipocrite.
Il surreale antifascismo del
nuovo millennio. Se non avessimo visto l'altro ieri con i nostri occhi qui a
Firenze la cosiddetta manifestazione antifascista degli studenti del liceo
Michelangiolo, avremmo pensato a una rievocazione cinematografica del tempo che
fu. Paolo Armaroli il 23 Febbraio 2023 su il Giornale.
Se non avessimo visto l'altro
ieri con i nostri occhi qui a Firenze la cosiddetta manifestazione antifascista
degli studenti del liceo Michelangiolo dopo gli scontri tra giovani di destra e
di sinistra, avremmo pensato a una rievocazione cinematografica del tempo che
fu. E allora diciamo una buona volta le cose come stanno dal punto di vista
storico e costituzionale. Morto il fascismo per indisposizione del dittatore,
ben presto anche l'antifascismo storico quello vero al quale ci inchiniamo e non
quello da barzelletta che si è visto in seguito non ha più ragion d'essere.
Tirando le cuoia,
l'antifascismo verace partorisce due creature. Da una parte si afferma la
democrazia liberale di Alcide De Gasperi e dei suoi alleati. Ed ecco la
scissione di Palazzo Barberini del gennaio 1947, quando Giuseppe Saragat rompe
con Pietro Nenni perché opta per una scelta di civiltà, e il trionfo del 18
aprile 1948 del leader democristiano, che conferma una scelta di campo
irreversibile. E dall'altra i Nenni e i Togliatti, allora uniti dal patto di
unità d'azione, che si schierano a favore di Peppone Stalin, uno spietato
dittatore come pochi altri. Nell'immediato dopoguerra nostalgici del fascismo,
monarchici e comunisti si contavano a milioni. Mentre adesso sono quasi
scomparsi del tutto. Comunisti compresi, da quando Achille Occhetto, meglio
tardi che mai, pensò bene di disfarsi di un partito considerato sempre più
imbarazzante. La pretesa di resuscitare adesso il monolite antifascista è
semplicemente surreale, visto e considerato che non è più un monolite dagli anni
dell'immediato dopoguerra. Tutti dobbiamo invece osservare la Costituzione. Una
Carta che si fonda soprattutto su due articoli: l'articolo 3 e l'articolo 21,
entrambi caratterizzanti un ordinamento liberaldemocratico. Il primo sancisce il
principio di eguaglianza davanti alla legge senza discriminazione alcuna. Il
secondo riconosce a tutti il diritto di libera manifestazione del pensiero. Ora,
sarà anche vero che la nostra è la Costituzione più bella del mondo. E se lo
dice Benigni, che pure non è un costituzionalista, possiamo crederci. Resta il
fatto che è una illustre sconosciuta. Ne abbiamo avuto la riprova proprio in
questi giorni. Alcuni studenti dei Collettivi di sinistra del liceo classico
Michelangiolo di Firenze, con in mano un cestino dell'immondizia, hanno invitato
alcuni giovani di destra a deporvi i loro volantini considerati robaccia e a
togliere il disturbo sui due piedi perché udite, udite non ne condividono il
contenuto. E nel corso della manifestazione dell'altro ieri hanno chiarito si fa
per dire il loro pensiero: «Se arrivano davanti alle scuole, troveranno chi li
scaccia». Urge un corso accelerato di educazione civica. Che aspettano i
professori a farsi parte diligente?
La vergognosa risposta di
Fratelli d’Italia alla lettera della preside: «Parli dei morti del comunismo e
delle foibe». Mauro Munafò su L’Espresso il 23 febbraio 2023.
Il messaggio della dirigente
scolastica del liceo Da Vinci sui pericoli del restare indifferenti di fronte
alle azioni fasciste scatena le reazioni del partito di governo. Che ripetono il
solito ritornello benaltrista. Mentre il ministro Valditara minaccia azioni
contro la preside: «Lettera ridicola»
«E allora le foibe?» recitava
il tormentone di Caterina Guzzanti nel suo personaggio di Vichi, attivista di
Casapound che, quando le si chiedeva conto dei mali del fascismo, cambiava
subito discorso. Sono passati più di dieci anni da quelle imitazioni, ma il
ritornello della Destra resta lo stesso: si verificano aggressioni di matrice
squadrista, ma guai a chiamarle per nome. Perché, se lo fai, allora devi anche
ricordare quanto male ha fatto il comunismo.
Ed è esattamente quanto
successo in questi giorni. Dopo l’aggressione ai danni di alcuni studenti
minorenni da parte di sei persone legate alla sigla di Destra Azione
Universitaria (movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni) davanti a un
liceo di Firenze, le formazioni governative avevano fatto finta di nulla (il
ministro Salvini aveva trovato il tempo di parlare dei cani in Turchia, ma non
di quanto accaduto).
Ieri la lettera della dirigente
Annalisa Savino del liceo Da Vinci di Firenze, in cui ricorda il pericolo del
fascismo quando gli indifferenti non reagiscono, ha però smosso le coscienze
anche a Destra. Fronte da cui si sono mossi in fretta non tanto per condannare
le azioni squadriste, quanto per attaccare Savino e le sue parole.
Alfredo Antoniozzi, vice
capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha subito attaccato: «Alla preside
raccomandiamo alcune integrazioni: i novanta milioni di morti generati nel mondo
dal comunismo, le foibe, le sanguinarie repressioni di Praga e Budapest,
l'attualità di una Cina in cui non esistono i diritti civili». Stesse parole
usate da Francesco Giubilei, ideologo della nuova Destra e consulente del
ministro alla Cultura, che su Twitter ha attaccato: «Surreali le circolari dei
presidi dei licei fiorentini che fanno politica paventando il ritorno del
fascismo dopo quanto accaduto al Liceo Michelangiolo. Domani ci aspettiamo una
circolare sul pericolo del comunismo dopo il corteo dei collettivi in cui si è
inneggiato alle foibe».
Ancora più duro
l’intervento del ministro dell’Istruzione Valditara che, a Mattino 5, attacca la
preside autrice della lettera e minaccia di intraprendere iniziative contro di
lei: «È una lettera del tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non compete
a una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che
vedere con la realtà: in Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria,
non c'è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che
vedere con il nazismo. Sono iniziative strumentali che esprimono una
politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole; se
l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure.
Di queste lettere non so che farmene, sono lettere ridicole, pensare che ci sia
un rischio fascista è ridicolo».
Il corteo "anti-violenza"
inneggia alle foibe e a Tito. A Firenze 2.000 in piazza insultano il
governo. Ma quando i pestaggi sono rossi, silenzio totale. Francesco Giubilei il
23 Febbraio 2023 su il Giornale.
Dopo i fatti avvenuti nei
giorni scorsi al Liceo Michelangiolo, i collettivi studenteschi, le sigle della
sinistra e le associazioni antifasciste, sono scese in piazza lunedì nel tardo
pomeriggio a Firenze in una manifestazione che si è trasformata in una sfilata
degli orrori. Il corteo, nato per protestare «contro l'aggressione subita da due
giovani davanti al Liceo Michelangiolo» (anche se in un nuovo video si sostiene
sia avvenuta «non un'aggressione ma una rissa»), si è aperto con lo striscione
«Liberiamoci dal fascismo e dal governo Meloni».
Si potrebbe già obiettare sul
collegamento tra quanto avvenuto fuori dal liceo fiorentino e il governo ma è
nulla rispetto allo spettacolo andato in scena per le strade del capoluogo
toscano. I manifestanti, circa duemila, si sono radunati a Campo di Marte per
poi dirigersi verso via Frusa, sede di Azione Studentesca (il movimento a cui
appartengono i militanti coinvolti nei fatti del Liceo Michelangiolo).
Nel tragitto sono stati
intonati cori contro la polizia e i giornalisti e, mentre circolava un volantino
di solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito e contro il 41Bis, si è alzato un
coro di minacce al presidente del Consiglio: «Meloni fascista, sei la prima
della lista». Non paghi, alcuni dei presenti hanno inneggiato alle foibe
gridando «Viva le foibe» a cui è seguita la canzoncina «il compagno Tito ce l'ha
insegnato...» per poi concludere con «fascista di merda, ti lascio morto in
terra».
A fare da contorno le bandiere
dell'Urss e della Jugoslavia comunista di Tito, un contesto da cui di certo non
può arrivare nessuna lezione di democrazia. E, non a caso, il corteo è culminato
con un lancio di bottiglie contro gli agenti di polizia schierati in assetto
antisommossa. Eppure, nonostante il tenore dell'iniziativa, non è arrivata una
parola di condanna da parte di politici e opinionisti di sinistra che nei giorni
scorsi hanno accusato il governo di non prendere le distanze da Azione
Studentesca.
Lo stesso silenzio che si
registra ogni volta che i collettivi occupano le università e impediscono con
l'uso della forza lo svolgimento di eventi o conferenze su temi o con ospiti a
loro non graditi. D'altra parte, quando gli aggressori sono di estrema sinistra,
nessuno dice niente. A maggio, a Bologna, alcuni esponenti di Fdi e Azione
universitaria sono stati assaliti da militanti dei centri sociali. Quel giorno -
la vicenda è raccontata nel portale di Nicola Porro - intervennero le forze
dell'ordina. La procura di Bologna ha chiuso le indagini chiedendo il rinvio a
giudizio per otto aggressori di sinistra. Di questo fatto non si è parlato né
sono state organizzate manifestazioni.
Due pesi, due misure. I presidi
degli istituti fiorentini condannano quanto accaduto al Michelangiolo e, dopo i
dirigenti scolastici dell'Istituto Salvemini Duca d'Aosta e del Liceo Pascoli,
anche la preside del liceo Leonardo Da Vinci è intervenuta affermando che: «Il
fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È
nato ai bordi di un marciapiede qualunque». Mentre la Procura ha aperto un
fascicolo nei confronti di sei ragazzi coinvolti nelle violenze del Liceo
Michelangiolo, l'auspicio è che i dirigenti scolastici fiorentini prendano allo
stesso modo le distanze da quanto andato in scena per le strade di Firenze
perché le minacce, la violenza e inneggiare a regimi totalitari o a dittatori,
deve sempre essere condannato da qualsiasi parte arrivi.
Inneggiano alle foibe e
a Tito: ecco cosa rischiano ora i compagni. Durante il corteo di ieri a
Firenze cori per inneggiare a Tito e alle foibe. L'Unione degli istriani:
"Pronti a querelare". Matteo Carnieletto il 22 Febbraio 2023 su il Giornale.
La risposta è
arrivata dall'Unione degli istriani. Secca. Chiara. Definitiva. Dopo aver visto
i video in cui gli antifascisti fiorentini inneggiano a Josip Broz Tito e
alle foibe, l'associazione di esuli di Trieste si è detta pronta a querelarli.
L'annuncio è stato dato in un
comunicato in cui l'Unione, dopo aver ripercorso le offese degli antifà,
afferma: "Non postiamo il video, non volendo pubblicizzare quello che comunque
gira già dappertutto sui social: di bandiere rosse, ed addirittura jugoslave,
con quella lurida stella vermiglia, ne abbiamo viste abbastanza, dal 1954 in
avanti e ben prima, quando eravamo ancora a casa nostra, in Istria. Stavolta
però l'Unione degli Istriani non intende stare a guardare. Il
presidente Massimiliano Lacota in una nota diramata poco fa ha fatto sapere, a
chiare lettere, che il limite è stato oltrepassato".
E, per rendere ancora più
chiara l'idea, Lacota ha annunciato: "Denunciamo una volta per tutte
questi delinquenti del linguaggio che si permettono di infangare la nostra
memoria, che è quella dei Martiri delle Foibe. È giunto il momento di che si
assumano le loro responsabilità davanti alla legge per queste manifestazioni di
intolleranza, che non possono più rimanere impunite".
Una dura presa di posizione è
venuta anche da Giampaolo Giannelli, coordinatore toscano Unione degli Istriani,
che in una nota ha affermato: "A seguito degli avvenimenti accaduti all'esterno
del liceo Michelangelo, gli studenti dei collettivi di sinistra hanno
organizzato una manifestazione antifascista. Peccato che la manifestazione,
oltre a momenti di tensione culminati nel lancio di petardi contro la polizia,
abbia visto sventolare le bandiere della ex Jugoslavia di Tito, il massacratore
di migliaia di italiani. Peccato, soprattutto, che si siano ascoltati cori
vergognosi inneggianti a Tito ed alle foibe, tutti documentati da video che
circolano in rete. Ci aspettiamo da parte della politica, tutta - aggiunge -,
una ferma condanna dell'accaduto, che costituisce una grave offesa ai nostri
martiri ed alle famiglie che hanno affrontato il dramma dell'esodo per sfuggire
alla ferocia dei partigiani comunisti titini".
“Nessun agguato, hanno
iniziato i collettivi rossi”: la testimonianza di un prof del liceo di Firenze.
Penelope Corrado su Il Secolo d’Italia il 23 Febbraio 2023.
Un professore che insegna al
liceo Michelangiolo di Firenze racconta oggi a La Nazione di avere assistito
personalmente agli scontri e che non c’è stato un agguato, ma una rissa.
Inoltre, secondo la testimonianza di questo insegnante la storia è andata
esattamente al contrario di come è stata narrata finora sui giornali e dagli
studenti di sinistra. A scatenare la violenza sono stati, infatti, secondo
questo docente, i Collettivi di sinistra.
L’agguato di Firenze? Lo hanno
fatto i collettivi ai ragazzi di destra
Al giornalista de La
Nazione Stefano Brogioni, che vorrebbe riportare il suo nome, il professore
chiede di ometterlo, per evitare “comprensibili” ritorsioni. Perché la sua «è
una scuola molto politicizzata». «Lavoro da molti anni al Michelangiolo ma non
voglio che esca il mio nome. Sabato mattina stavo entrando a scuola e ho visto
quello che è successo». Docenti costretti a mantenere l’anonimato, il che la
dice tutta sul vero clima di terrore e di intimidazione che regna in certi
ambienti. Altro che “pericolo fascista”.
Il prof testimone: “Hanno
iniziato i Collettivi, poi c’è stata la reazione”
Ecco infatti, secondo questo
testimone oculare, come sono andate davvero le cose: «C’era questo volantinaggio
dei ragazzi della destra. Sono usciti quelli dei Collettivi e hanno cominciato
ad insultarli e strappare i volantini. Hanno tirato delle spinte e a quel punto
quelli di Azione Studentesca hanno cominciato a picchiare. E sicuramente hanno
esagerato». Il professore dice di non essere intervenuto per gli stessi motivi
per cui vuole l’anonimato: «Sto bene in questa scuola e vorrei continuare a
lavorarci senza problemi».
Intanto la Digos lavora sul
precedente del Pascoli: non ci sono immagini dell’accaduto. Per il Michelangiolo
la procura indaga per violenza privata a carico di 6 persone segnalate dalla
polizia.
Altro che vittime: ecco
tutte le provocazioni degli antifascisti. Dalla sede di Casaggì imbrattata
alle targhe, che commemorano i martiri delle foibe, distrutte. Ecco le violenze
(nascoste) della sinistra fiorentina. Matteo Carnieletto il 22 Febbraio 2023 su
il Giornale.
Tutto era partito come un raid.
Un raid fascista, ovviamente. Era stata la grancassa mediatica di sinistra a
puntare il dito contro Azione studentesca per i fatti del 18 febbraio scorso
quando, davanti al liceo Michelangiolo di Firenze, si era registrata una rissa
che aveva visto opporsi studenti di destra e di sinistra. Un frame e un video,
sapientemente tagliato, erano stati usati per dimostrare che, alla fine, quelli
di Casaggì avevano aggredito gli antifascisti, accanendosi su di loro. In
realtà, alcuni video diffusi successivamente dimostrano il contrario. Ovvero che
quella del liceo Michelangiolo altro non è che una rissa. Stupida e violenta
come tutte le risse. Ma non un raid punitivo.
Se si uniscono i fatti
precedenti e successivi a quel 18 di febbraio, però, si scopre una realtà
diversa. Una realtà dove la sinistra è più provocatrice che vittima. Partiamo
dallo scorso agosto, quando la sede di Casaggì/Azione studentesca di Firenze
viene imbrattata con parole minatorie. La scritta "Fratelli d'Italia" viene
sporcata con dello spray nero e la firma antifà. Poi la parola "servi", con una
celtica impiccata. E una serie di complimenti come "fate cagare, servi bastardi,
Firenze vi odia, merde, infami, gli unici stranieri sono qui, fasci infami". E
infine la minaccia: "fascistello okkio".
Passano i mesi e la tensione
tra le opposte fazioni resta alta. Il caso Cospito non fa altro che peggiorare
le cose. Anarchici e antifà alzano la testa e, in più di una occasione,
imbrattano i muri di Firenze. Ma non solo. A fine gennaio, al direttore
del Tirreno, Luciano Tancredi, arriva una busta contenente un proiettile.
È febbraio, però, il mese
caldo. Ignoti distruggono la lapide che commemora i morti delle foibe. Qualche
giorno dopo, questa viene sostituita ma viene subito imbrattata con la scritta
"vendetta".
Arriviamo così al 9 febbraio
scorso. Quel giorno, davanti al Pascoli, alcuni ragazzi di destra vengono
aggrediti da giovani incappucciati e armati di cinghie. "Nessuno è intervenuto.
Nessuno ha fatto niente. Poi si sono diretti verso gli altri ragazzi ed è
iniziata una vera e propria aggressione premeditata dei ragazzi del collettivo",
ci ha raccontato ieri una fonte legata alla sinistra fiorentina. E poi il 18
febbraio, giorno del presunto raid fascista che si è poi rivelato essere una
"semplice" rissa. "Ogni collettivo sceglie le modalità con cui affrontare questo
tipo di volantinaggi", ci aveva detto ieri una fonte vicina ai collettivi. Che
aveva poi specificato: "C'è chi cerca il dialogo e chi invece non dice una
parola e inizia a fare a botte. Quelli del Michelangelo hanno scelto una via di
mezzo".
Ieri, infine, un corteo
organizzato dagli antifà fiorentini, arrivato di fronte alla sede di Casaggì. Le
immagini, ma soprattutto gli slogan urlati, parlano chiaro. Oltre a quelli
contro il presidente del Consiglio - "Meloni fascista, sei il primo della
lista" - anche veri e propri cori di minacce: "Le sedi fasciste si chiudono col
fuoco, ma coi fascisti dentro se no è troppo poco", "viva le foibe", "il
compagno Tito ce l'ha insegnato, ogni fascista va infoibato", "fascista di
merda, ti lascio morto in terra", "fascisti carogne, tornate nelle fogne".
Difficile pensare che coloro
che hanno scandito questi slogan possano considerarsi vittime.
"Militanti FdI pestati a
calci e pugni": indagati 8 di sinistra. Ma nessuno ne parla. Chiuse le
indagini per i militanti di estrema sinistra che aggredirono alcuni esponenti di
Azione Universitaria. Tutti zitti (a differenza di Firenze). Matteo Milanesi su
Nicola Porro il 22 Febbraio 2023.
È la grande malattia
dell’estrema sinistra, quella della formula "uccidere un fascista non è reato",
degli anni di Piombo mai tramontati, delle città sfasciate durante i loro cortei
(rigorosamente non autorizzati). In nome della resistenza e della democrazia, si
cerca di ribaltare il principio entrando nel campo del paradosso: attraverso la
violenza, i comunisti vogliono eliminare – per alcune frange non solo
politicamente, ma anche fisicamente – tutte quelle forze politiche che si
pongono in contrasto con le idee della sinistra radicale, rigorosamente
comuniste. Insomma, in nome della libertà, della pace e del 25 aprile, si danno
vita a veri e propri atti di teppismo contro l’avversario di turno.
Il motto è sempre lo stesso: "I
fascisti non possono avere spazio in questo Paese". Poco importa se, vent’anni
fa, la parola "fascista" era associata a Silvio Berlusconi, come titolò una
celebre apertura de L’Unità: "Berlusconi come Mussolini". O ancora, poco importa
se "fascista" era pure Matteo Salvini, quando la Lega toccava punte del 30 per
cento. Ed infine, poco importa se "fascista" è Giorgia Meloni, Presidente del
Consiglio in carica e a capo di un partito che domina lo scenario politico
italiano. Insomma, come ricordava il giornalista Daniele Capezzone: "Fascista è
qualsiasi partito non di sinistra che raggiunge almeno il 15 per cento". È
fascista pure quest’ultimo, nonostante il suo passato politico da radicale con
radici libertarie, visto che i collettivi dell’Università La Sapienza non gli
permisero di tenere una conferenza con alcuni esponenti di Fratelli d’Italia.
L’obiettivo, quindi, non è
quello di combattere l’avversario politico con la forza delle idee, ma quello di
squalificarlo, escluderlo, cacciarlo dalle piazze dove legittimamente esercita
diritti inalienabili della nostra Costituzione. Esatto, la stessa Carta del ’48,
così tanto sventolata dalla sinistra, alla ricerca di un continuo "pericolo
fascista" (poi puntualmente inesistente).
I fatti di Bologna
Un caso plastico di questa
rappresentazione lo abbiamo avuto a Bologna, quando lo scorso maggio alcuni
esponenti di Fratelli d’Italia e Azione Universitaria (il movimento giovanile di
FdI che agisce all’interno degli atenei) sono stati assaliti da alcuni
facinorosi dei centri sociali, tutti nati tra il 1988 ed il 2001 (di cui il più
grande recidivo). Il fatto risale allo scorso maggio, ma sembra essere passato
letteralmente in sordina, riservandolo solo a qualche articolo di cronaca locale
del bolognese. Eppure, in questo caso, si può letteralmente parlare di
un’aggressione premeditata. Come raccontato ai tempi dall’allora capogruppo di
Fratelli d’Italia in Emilia Romagna, e oggi senatore, Marco Lisei: "Una decina
di ragazzi e ragazze di Azione Universitaria si trovavano tranquillamente
insieme in via Zamboni alla Facoltà di Lettere per vedere i risultati delle
elezioni universitarie. Usciti dalla Facoltà di Lettere, in prossimità di Piazza
Verdi, venivano circondati da una ventina di persone e malmenati". Un agguato
che rese necessario l’intervento del 118 e dei carabinieri.
Due pesi, due misure
Il caso è stato oggetto
di un’indagine portata avanti dalla Procura di Bologna, terminata a metà
settembre – come nicolaporro.it può rivelare in esclusiva – con la richiesta di
rinvio a giudizio di tutti gli otto aggressori di estrema sinistra. Oltre alle
minacce, con frasi quali "vi uccidiamo", "tornate nelle fogne", "siete morti",
si sono susseguiti "calci, spintoni, pugni, strattonamenti" che hanno comportato
lesioni personali, trauma cranico e toracico agli esponenti di Azione
Universitaria. Eppure, sui media mainstream, il nulla più assoluto, nessuno (o
quasi) articolo di condanna contro l’attacco premeditato, nessun tipo di
solidarietà offerta agli aggrediti.
Un trattamento ben diverso
rispetto a quello di Firenze, dove da giorni è diventato caso nazionale il video
in cui alcuni giovanissimi (nati tra il 2002 ed il 2007) tirano calci e pugni a
due esponenti dei collettivi di sinistra davanti al Liceo Michelangelo. Subito
si è allarmata l’opinione pubblica rispolverando il vecchio "pericolo fascismo",
parlando di azione premeditata a danno dei giovanissimi di sinistra. Eppure,
come ricostruito dalla Digos, pare non si sia trattata di un’aggressione, ma di
una rissa per motivi politici, sfociata durante un volantinaggio di Azione
Studentesca (il gruppo giovanile di Fratelli d’Italia).
Da una parte, però, sul caso di
Firenze si è aperta una vera e propria questione nazionale, che ha posto al
centro anche il premier Giorgia Meloni, colpevole – secondo gli
intellettuali antifa – di non aver condannato le violenze con una dichiarazione
pubblica, e quindi di avallare implicitamente questi atti "squadristi".
Dall’altra, invece, sui fatti di Bologna i giornali di sinistra non hanno
sprecato neanche una riga, nonostante si trattasse di un’azione da far invidia
pure i facinorosi comunisti degli anni di Piombo.
"Calci, pugni, spintoni"
La Procura della Repubblica di
Bologna descrive i fatti in modo agghiacciante: "In concorso tra loro e con
altri non tutti ancora identificati, e al fine di conseguire il profitto del
delitto (sottrarre bandiere e aste di bandiera detenute dal movimento Azione
Universitaria), cagionavano a C.S. lesioni personali giudicate guaribili in
giorni 16, sferrando a più riprese calci, pugni e spintoni. Così come nello
stesso contesto dell’aggressione a S.A., che riportava un trauma toracico
giudicato guaribile in giorni 6″. E ancora, l’aggressione avveniva in una chiara
sproporzione numerica, in cui un militante di Fratelli d’Italia veniva "percosso
e aggredito con pugni e calci da quattro soggetti".
Insomma, azioni da forze
squadriste dei momenti più bui degli anni ’70, come ricordato ancora dal
senatore Lisei: "Da quando ho iniziato a fare politica, ho solo subito e ho
visto subire a tanti ragazzi di tutto. Sputi, insulti, banchetti ribaltati,
spinte, oggetti lanciati, aggressioni. Galeazzo Bignami è stato più volte
menato, io sono stato aggredito, molti nostri giovani idem. L’ultimo caso 7 mesi
fa, alcuni ragazzi e ragazze di Azione Universitaria uscivano tranquillamente
dall’università, gli aspettava un gruppo di circa 20 persone, organizzati per
fare un vero e proprio agguato, calci, pugni, spinte e diverse denunce. Avete
mai letto qualcosa a livello nazionale?".
Un fatto mascherato per una
ragione molto semplice: l’unica colpa dei ragazzi di Azione Universitaria era
quella di essere di destra, responsabilità non perdonata neanche dal giornalismo
progressista. D’altro canto, si sa, "uccidere un fascista non è reato". Ora,
aggredire violentemente chi non è di sinistra non è reato. E in nome di questo
folle parametro, tutto diventa giustificabile. Sia politicamente, che
giornalisticamente.
Matteo Milanesi, 22 febbraio
2023
Estratto dell’articolo di
Filippo Fiorini per lastampa.it il 23 Febbraio 2023.
Ci sono volute 24 ore perché
un'esponente di livello del governo Meloni prendesse posizione, con distinguo,
sul pestaggio subito sabato da due studenti del liceo Michelangiolo di Firenze
da parte di almeno 6 giovani militanti di destra, ma ne sono bastate 20 perché
lo stesso esecutivo condannasse la lettera che la preside di un altro istituto
cittadino ha rivolto ai suoi alunni, per metterli in guardia dai pericoli
sociali della militanza praticata con le botte.
Prima, il capogruppo alla
Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, per il quale «gli episodi di violenza
politica sono sempre da condannare, al netto di quella che sarà la dinamica da
accertare», poi il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, che poco fa a
Mattino Cinque ha definito «impropria» la lettera aperta scritta dalla preside
Annalisa Savino e ha detto di essersi sentito «dispiaciuto», dopo averla letta,
nonché di valutare provvedimenti contro la dirigente scolastica. Nella stessa
intervista, Valditara ha anche chiesto solidarietà bipartisan per una minaccia
di morte rivoltagli sui social.
«Non compete ad una preside
lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la
realtà», ha spiegato Valditara, che oltre ad essere titolare dell'Istruzione è
un noto giurista ed esponente della Lega di Salvini. «In Italia non c'è alcuna
deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere le
frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo e con il fascismo», ha
proseguito il ministro, intervistato da Francesco Vecchi, conduttore del
mattutino di Mediaset.
Il passaggio più contestato,
di una lettera che in rete ha incassato la stima di molti, è l'ultimo paragrafo.
«Il Fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate di migliaia di persone.
È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per
motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti»,
scriveva Savino in uno dei passaggi iniziali e più citati, proseguendo più
avanti poi con: «Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue
degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare muri, va
lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con la
cultura, senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da se».
[…] «Sono iniziative
strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico non abbia più posto
nelle scuole», ha risposto il ministro, «se l'atteggiamento dovesse persistere,
vedremo se sarà necessario prendere misure». […]
Giorgia Meloni e il pressing
antifascista su Palazzo Chigi. Iuri Maria Prado su Libero Quotidiano il 22
febbraio 2023
Non si tratta soltanto della
somma rottura di palle per l’ennesimo strillo “antifa” sulla notizia di
un’aggressione addebitata, in ipotesi anche fondatamente, a giovani di destra:
che è una cosa pessima e da sanzionare, quando accertata, ma che davvero non può
essere messa a riprova, come invece si fa, dell’emergenza nera a far tempo dal
25 settembre dell’anno scorso, vale a dire da quando il Paese è stato sottratto
alle cure democratiche dell’antifascismo curricolare. E non si tratta nemmeno di
indugiare sulla penosa militanza politico-giornalistica che denuncia lo
squadrismo o invece lo trascura secondo che a menare le mani e a devastare le
cose sia il teppistello di destra anziché quello, statisticamente molto più
attivo, imbandierato di rosso e d’arcobaleno. Si tratta piuttosto della ridicola
pretesa che Palazzo Chigi sia una specie di “dichiarificio”, con Giorgia Meloni
e i componenti del governo e la maggioranza parlamentare chiamati con urgenza
indifferibile “a prendere le distanze” dai fatti dell’altro giorno a Firenze.
“BELLA CIAO”
A parte il fatto che non
risulta che analoga pretesa sia stata mai rivolta a un presidente del Consiglio
di sinistra nei casi, davvero non proprio rarissimi, di violenze commesse da
picchiatori e sfasciavetrine comunisti, pacifisti, ecologisti, abbruciatori di
bandiere statunitensi e israeliane e via delinquendo, c’è che al governo compete
semmai di tutelare l’ordine pubblico e di proteggere i cittadini (non quelli di
sinistra: tutti) dalla violenza: ma il fatto è che questo compito non c’entra
proprio nulla con le proclamazioni di antifascismo da protocollo, come invece
reclama qualche stupidotto che in buona sostanza imputa al presidente del
Consiglio di non aver opposto ai fatti di Firenze una requisitoria resistenziale
sulle note di “Bella Ciao”.
La cosa che piacerebbe a
questi avventizi del sistema democratico, refrattari anche alla sola idea che al
governo non stia chi ripete le tiritere da 25 aprile, è che l’azione politica di
una maggioranza di destra si esaurisca e si consumi nel dar prova simbolica e
ciarliera di antifascismo militante, in buona sostanza ammettere che la propria
presenza al potere ha irresponsabilmente affidato il Paese alla violenza delle
squadracce. E dunque emendarsi da questa colpa civile e costituzionale
dichiarando che il fascismo è lì in agguato, tra i ninnoli dell’abitazione del
presidente del Senato e nelle strade di Firenze lungo le quali imperversano i
manipoli neri.
TUTELA DEMOCRATICA
Non occorrerebbe avere simpatie
né verso il presidente del Consiglio né verso la maggioranza che lo sostiene per
reagire con l’irritazione dovuta a questa insopportabile pretesa di tutela
democratica: che proviene da una schiatta assai disponibile allo sbrego
autoritario e di legalità, pure violento, se solo si attiva democraticamente tra
i propri ranghi e ai danni degli avversari.
Quel vuoto normativo che favorisce il gioco
illegale. Il divieto di pubblicità aggirato col riferimento alle news negli
spot dei portali di scommesse. Ottavio Porto (avvocato del foro di Catanzaro) su
Il Dubbio l'1 dicembre 2023
Il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, la
sua disciplina e la giurisprudenza sinora formatasi sul punto, appaiono come il
più plastico esempio di aberratio ictus normativo: l’effetto conseguito è
opposto al fine perseguito. Infatti, con l’art. 9 del decreto- legge 12 luglio
2018, n. 87, era stato espressamente sancito il divieto di pubblicizzare giochi
e scommesse, al fine di rafforzare la tutela del consumatore e contrastare le
ludopatie. Nei fatti, tuttavia, si è verificato un enorme sviluppo di canali di
raccolta illegali, una incredibile confusione tra Concessionari autorizzati e
non, una spaventosa perdita erariale, il boom di giochi e scommesse illeciti
stranieri.
Secondo la lettera della legge, sarebbe “vietata
qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse
con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo”. La infelice e
laconica formulazione della norma aveva, subito, costretto l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ad emanare linee guida che hanno reso ancor più
inaffidabile l’interpretazione delle fattispecie concrete, determinando
comportamenti del tutto eccentrici rispetto a quelli immaginati dal Legislatore.
Le prassi distorte hanno condotto i Concessionari
a trovare, rapidamente, l’” inganno”, con l’unico risultato di confondere il
consumatore finale. Ad esempio, secondo l’intervento “chiarificatore” di Agcom,
non rientrano nell’ambito del divieto le comunicazioni di tipo informativo, con
l’unico limite della continenza, non ingannevolezza, trasparenza, nonché
mancanza di enfasi.
La pubblicità del gioco, così, è stata mascherata,
con un comportamento messo in atto da tutti gli operatori di mercato, con i
suffissi “. news”, “. tv”, “. info”, “. sport”. “Paroline magiche”, aggiunte ai
nomi dei più noti bookmakers, che hanno reso inefficace la norma, considerato
che, per le stesse linee guida sopra citate, sarebbe consentito l’utilizzo del
marchio legato al gioco allorquando identifichi, oltre ai servizi con vincite in
denaro, anche altri servizi (informazioni sportive, streaming, notizie) aventi
carattere autonomo.
Qual è stato, allora, il significato
dell’intervento? Innanzitutto, sviare l’utente finale, il quale - senza una
adeguata informazione – è indotto a confondere i canali leciti per la raccolta
del gioco autorizzato con quelli illeciti. Di conseguenza, far perdere entrate
milionarie allo Stato italiano, in relazione ai contratti di sponsorizzazione
del gioco lecito; favorire lo sviluppo di siti “.com” illegali, legati a
Concessionari di paesi con tassazioni agevolate e privi dei minimi requisiti di
controllo, che appaiono e scompaiono in pochi mesi, guadagnando milioni.
E, d’altronde, singolare appare la totale
inerzia dell’Agcom, se non per qualche maxi multa comminata a piccoli e nuovi
operatore, anche non presenti in Italia, sbugiardata fragorosamente anche dal
Tar del Lazio, il quale ha nettamente preso le distanza dalle linee guida Guida
Agcomn. 132/19/ Cons, rimarcandone la natura non legislativa e dunque la mancata
cogenza.
L’ennesimo cortocircuito sulla materia si è
concretizzato dinnanzi all’impossibilità di comprendere i confini potestativi
dell’Autorità, arbitrariamente ristretta dall’art. 4 delle linee guida ai soli
confini territoriali italiani, con ciò sollecitando il “turismo” del gioco. E,
d’altro canto, sembra impossibile giungere a punire i comportamenti dei soggetti
che operano in altri Stati dell’Unione europea o ancor più internazionalizzati.
Il risultato complessivo è antitetico rispetto
alla volontà del Legislatore, favorendo il gioco illegale. In grave
contraddizione con gran parte della normativa europea, il divieto sta di fatto
consentendo comportamenti elusivi soprattutto ai colossi del gioco. È sotto gli
occhi di tutti, del resto, come il fenomeno delle ludopatie sia tutt’altro che
in recessione, avendo di recente infettato anche il modo dello sport
professionistico.
È dunque necessario rimettere ordine al “sistema
Gioco”, con una riforma che si armonizzi con i principi convenzionali e fissi
divieti a tutela effettiva degli utenti, piuttosto che spazi di immunità
differenziale per gli operatori. Ancora una volta, il parossismo legislativo è
inversamente rapportato alla qualità delle Legge, che sempre più spesso
raggiunge risultati applicativi opposti alla sua ratio
Estratto dell’articolo di Massimo Pisa per “il
venerdì di Repubblica” il 27 Novembre 2023
Chi ricorda la storia di Peppino lo Zoppo?
Nessuno. E di sua moglie Concetta, del Turco, di Ciccio e del Drago? Nemmeno. Un
po’ perché questi nomignoli da barzelletta in bianco e nero nascondono persone
vere. E molto per la rimozione collettiva della più grande truffa mai fatta allo
Stato. Al suo Monopolio più popolare: il Lotto. Violato per tre anni
consecutivi, dal 1995 al 1998, da questo pugno di soliti ignoti partiti dai
palazzoni e dai bar di Cinisello Balsamo alla conquista del sogno dell’italiano
medio: sbancare le casse dell’Erario a colpi di terni e cinquine. Sotto gli
occhi di tutti.
«Perché è nell’ordinario che accade lo
straordinario, perché in Italia è ordinario che nessuno controlli» dice Fausto
Gimondi, che ha ripescato quei personaggi e quei meccanismi dall’armadio
dell’oblìo e li ha messi in fila in Fortuna criminale, il suo primo romanzo in
uscita per Longanesi.
Era la metà degli anni 90 quando un usciere
dell’Intendenza di Milano trovò il modo di truccare le vincite del Lotto. Era
lui che aveva il compito di allineare le 90 palline che contenevano i numeri e
che finivano nel cesto rotante da dove la mano di un bimbo bendato le estraeva.
Renderne 5 più lucide e contare sulla manina guidata del bimbo, figlio di un
complice, che le estraeva fu facile. Così come incassare le vincite.
Il problema fu il passaparola. La voce passò dai
complici agli amici, agli amici degli amici e così via. Fino ad arrivare a un
gruppo di criminali che pretendevano i numeri senza troppo attendere. A bloccare
il tutto ci pensò un’inchiesta della magistratura che costrinse “i vincitori” a
restituire i soldi: una sessantina di miliardi di lire.
[…]
Il protagonista in questo labirinto è “Mario
Santini”, alter ego di un amico di Gimondi, come lui cresciuto nella Cinisello
degli immigrati in mezzo alla stessa umanità. Dal mito fuori tempo della
rivoluzione e dalle canne ai giardinetti, “Mario” si ritrova ricchissimo prima
dell’inevitabile caduta. «È lui che mi racconta la storia, ma ci è voluto tempo»
spiega Gimondi «e non credo mi abbia detto tutto. E non solo perché quello che
fece è un reato».
[…]
Tutto è possibile
Quasi si finisce a tifare per quei poveri e
ingegnosi diavoli e per i loro piani in dialetto. «Provo empatia per quei
personaggi e non li ho voluti giudicare. Ma questa è una storia solo italiana,
non sarebbe mai potuta accadere in Austria o in Svizzera, dove già nel 1970
vedevi in tv il meccanismo delle palline dal tubo, ma nemmeno in Grecia o in
Bulgaria. È figlia del modo barocco con cui in questo Paese si fanno le leggi,
dando la possibilità a un impiegato statale, come Peppino lo Zoppo, che ha
l’ingegno e la saggezza dell’uomo della strada, di scoprire che nessuno
controlla. Il trucco è tutto lì. È nell’ordinario che accade lo straordinario,
perché in Italia è ordinario che nessuno controlli».
E qui, alzando lo sguardo da Ciccio e Concetta e
guardando al sistema, l’empatia si esaurisce. «Il magistrato che seguì la
vicenda» spiega Gimondi «era Walter Mapelli. Dichiarò che, quando seppe della
truffa, era scettico: gli sembrava impossibile che un meccanismo tanto
presidiato potesse essere alterato con facilità e per tanto tempo. Eppure andò
avanti. Nonostante le pressioni allarmate per le possibili ripercussioni sulle
giocate e sugli utili del Lotto».
Uomo tutto d’un pezzo, uno dei rari a voler andare
in fondo. «Qualcuno, nei tre anni della truffa, si era posto delle domande.
Pochi: il giornalista Giovanni Chiades del Gazzettino e un investigatore privato
veneto, che andarono a far domande tra le ricevitorie. E un consigliere
d’amministrazione dei Monopoli di Stato che però, visto che i verbali e le
procedure erano a posto, lasciò stare.
Zitti zitti
Si torna alla domanda rimasta in sospeso: com’è
potuto accadere? «Sì, mi sono chiesto se qualcuno sapesse e non fece nulla»,
concorda l’autore. «Ci fu un’audizione straordinaria in commissione al Senato a
un mese dagli arresti con l’allora direttore generale dei Monopoli e
l’amministratore delegato di Lottomatica. E le risposte, anche oggi, fanno
sorridere: si attribuirono le vincite a Milano al fatto che i giocatori fossero
particolarmente abili nelle analisi statistiche, una roba da terrapiattisti del
Lotto. Non esiste. Io non so se i dirigenti erano corrotti. Non credo. Ma
colpisce l’indifferenza, la logica del meglio non toccare».
Ci fermiamo a un
passo dal provare affetto anche per quei tempi e quella Milano non ancora
digitale. «Ho un imprinting ma non ne ho nostalgia, ricordo che tra quei bar
giravano anche gli Epaminonda e i Turatello. E so che la Milano di oggi è molto
più sicura di allora. Quella violenza, i sequestri e le rapine a mano armata,
non ce li ricordiamo più».
Estratto da leggo.it il 18 aprile 2023.
Avevano acquistato un Gratta e Vinci in società
con una promessa: «Se vinciamo dividiamo per tre». E invece quando il
piastrellista Ricardo G. T., 42enne di origini brasiliane con residenza a
Monzambano (Mantova), che teneva il tagliando, ha incassato la vincita si è
intascato l'intero malloppo.
Vatti a fidare degli amici, specie quando
diventano milionari. E' la storia che ha portato in tribunale 3 (ex) amici:
artigiani, colleghi nei cantieri, amici e, improvvisamente, «milionari».
Per Ricardo G. T., Giovanni S. e Christian C.
sembrava essere «finalmente arrivata la svolta», il «colpo di fortuna che
aspetti tutta la vita» quando avevano «grattato» quel tagliando acquistato alla
tabaccheria di Garda (Verona) il 22 febbraio 2021. «Tolte le tasse, restavano un
milione e 600 mila euro da suddividere per tre, ma poi abbiamo saputo dai
giornali che contrariamente agli accordi si era intascato tutta la vincita... ».
[…]
Verona, vince 2 milioni e se
li tiene. Gli amici: «C’era un patto, che errore fidarci di lui...» Laura
Tedesco su Il Corriere della Sera il 18 aprile 2023
Il piastrellista superfortunato
e le accuse dei colleghi in aula: «Quel Gratta e vinci acquistato in società,
ecco come ci ha traditi»
«Tra noi c’era un patto ben
preciso, quel Gratta e Vinci lo avevamo acquistato in società. Ci fidavamo di
lui. “Incasso i soldi e li divido per tre”, così ripeteva... invece alla fine si
è intascato l’intero malloppo. Col senno di poi, lasciargli tenere quel
tagliando è stato uno sbaglio colossale, il peggiore che potevamo
commettere». Vatti a fidare degli amici...
La rottura del patto
Artigiani, colleghi nei
cantieri, amici e, improvvisamente, «milionari»: per Ricardo G. T., Giovanni S.
e Christian C. sembrava essere «finalmente arrivata la svolta», il «colpo di
fortuna che aspetti tutta la vita» quando avevano «grattato» quel tagliando
acquistato alla tabaccheria di Garda (Verona) il 22 febbraio 2021. «Tolte le
tasse, restavano un milione e 600 mila euro da suddividere per tre, ma poi
abbiamo saputo dai giornali che contrariamente agli accordi si era intascato
tutta la vincita... ». Di punto in bianco si spezzò così, «senza alcuna
possibilità di riconciliazione», quel loro «consolidato rapporto di amicizia e
collaborazione lavorativa nei cantieri della Gardesana tra le province di
Verona, Mantova e Trento». Un legame che «non potrà mai ricucirsi» e che ieri li
ha portati tutti e tre in un’aula del tribunale scaligero: davanti alla giudice
Sabrina Miceli e al pm Alberto Sergi c’erano tutti i protagonista di questa
singolare storia «all’italiana».
In aula anche il tabaccaio
Non mancava nessuno: in udienza
era presente al banco degli imputati il «superfortunato» piastrellista Ricardo
G. T., 42enne di origini brasiliane con residenza a Monzambano, mentre a darsi
il cambio come testimoni e soprattutto «grandi accusatori» del neo Paperone sono
stati i suoi ex colleghi ed ex amici Giovanni S., lombardo, e Christian C.,
trentino, che lo hanno denunciato per appropriazione indebita. Sono stati loro
due, sporgendo querela con l’avvocata Barbara Sorgato che ora li assiste come
parte civile, ad aver fatto bloccare a Ricardo G. T. quella mega vincita che
«lui si è messo interamente in tasca, senza dividerla con noi che avevamo
acquistato l’intero blocchetto di Gratta in società», hanno ribadito durante le
due ore e mezza di udienza. «Ci ha ingannati», hanno argomentato nel corso
dell’istruttoria durante cui sono stati sentiti anche il maresciallo della
Finanza che ha svolto le indagini, il tabaccaio di Garda che ha venduto il
tagliando vincente e due colleghi dei tre ex amici.
Padova, vince un milione di
euro e torna in tabaccheria: «E adesso cosa faccio?»
Un caso mai visto
Seduti vicini, ma divisi da un
muro invisibile: il grande accusato Ricardo e i suoi due grandi
accusatori Giovanni e Christian non si sono mai rivolti la parola, neppure prima
e dopo l’udienza. I loro sguardi però continuavano a incrociarsi: capelli neri,
barba curata, vestiti firmati, occhiali da sole griffati, il superfortunato
piastrellista si è presentato in aula con un’interprete brasiliana che ha preso
appunti per tutto il tempo. La sua è una vicenda talmente incredibile da aver
fatto il giro d’Italia: perché Ricardo G. T. sbancò per ben due volte in soli 20
giorni il montepremi al Gratta e Vinci, destando mille sospetti e vedendosi
così sequestrare l’intero montepremi, pari (dedotte le imposte), a due milioni e
400 mila euro. Grattò infatti prima un tagliando da un milione di euro il 4
febbraio 2021 in una tabaccheria di Modena e poi un secondo il 22 febbraio a
Garda da due milioni: fu indagato per truffa, ma non emerse nulla di illecito e
gli vennero archiviate le accuse e dissequestrati i (tantissimi) soldi vinti.
Niente lieto fine
Lieto fine? Niente affatto,
perché poi al «fortunatissimo» piastrellista è stata nuovamente sequestrata la
seconda delle due vincite, quella più importante da due milioni dopo la
denuncia dei suoi (ex) amici rimasti «a secco» del maxi gruzzolo a sei zeri. Una
montagna di denaro che spetta solo a lui o va divisa per tre? Lo stabilirà il
processo, intanto gli 800 mila euro esentasse del primo tagliando a sei zeri,
quello acquistato a Modena, sono già finiti da tempo nel conto del
piastrellista: «Ma la sua vita è la stessa di prima - rivela il suo difensore
Giovanni Chincarini -, continua a lavorare come già faceva ». Fa «ancora il
piastrellista», confermano i colleghi. E la fantomatica «villa da acquistare sul
Garda» di cui si era vociferato? «Vive nello stesso appartamento di prima».
Almeno per ora...
«Ho vinto 5 milioni al
Gratta e Vinci e la mia vita è diventata un incubo. Ora vivo in un bunker». Massimo
Massenzio su Il Corriere della Sera il 4 Aprile 2023
Vive a Torre Pellice, nel
Torinese. Rapinato due volte: «Quando incassi vivi in uno stato di euforia e
commetti errori»
«C’è stato un momento in cui ho
maledetto quella vincita, che mi stava portando solo guai. Adesso spero che
l’incubo sia finito». Gianni (nome di fantasia) ha la voce calma quando rivive
la rapina subita, assieme alla compagna, lo scorso 28 maggio nella sua casa di
Torre Pellice. Un assalto messo a segno da 4 rapinatori incappucciati e armati
di pistola: «Dacci gli orologi e ce ne andiamo». Di orologi in casa, però, non
ce ne sono. Gianni, 33 anni, è un autotrasportatore di Nichelino che il 2 agosto
2021 ha vinto 5 milioni di euro con un Gratta e vinci.
Ha investito in lingotti e
criptovalute, con il resto ha ingrandito la sua azienda di logistica, comprato
una Bmw da 150 mila euro, una casa alla madre e la villa a Torre Pellice:
«Quando mi hanno chiesto degli orologi ho pensato che avessero sbagliato
persona — rivela l’imprenditore —. Il precedente proprietario era un
collezionista». Uno dei rapinatori punta la pistola alla testa di Gianni, gli
assesta uno schiaffo e si fa consegnare i 23 mila euro che ha in tasca. Poi
setaccia la casa e si impossessa di preziosi e gioielli per 14 mila euro e
infine trova 8 chili di lingotti del valore di 530 mila euro.
I banditi, dopo aver chiuso
Gianni e la compagna nel locale caldaia, scappano verso Torino, ma
l’imprenditore riesce a liberarsi e a dare l’allarme: «Ho pensato che quei
banditi fossero dei dilettanti, uno ha risposto al telefono durante il colpo.
Nella tavernetta avevo un’accetta, ho pensato di reagire, ma per fortuna non
l’ho fatto».
Nella borsa c’è un
localizzatore che porta i carabinieri in via Adamello, a Torino, ma alle 10 del
giorno dopo una telefonata anonima fa arrestare Costantin Denisov, trasportatore
moldavo di 48 anni, che nella sua casa di via Saluzzo nascondeva una pistola
giocattolo, 5 mila 650 euro in contanti e 12 lingotti in oro.
Dopo quasi un anno di
indagini anche gli altri complici sono finiti in cella. «I carabinieri di
Pinerolo e Torre Pellice hanno fatto un lavoro eccezionale, se verrà recuperata
dell’altra refurtiva ne destinerò una parte per un “riconoscimento” all’Arma»,
continua Gianni. Che ancora si dispera per non aver messo i lingotti in una
cassetta di sicurezza: «Ora la mia casa è un bunker, ma quando ti capita una
vincita del genere vivi in uno stato di perenne euforia e commetti errori che
oggi non rifarei. Avevo chiesto di depositarli in banca, ma la mia filiale era
in un’altra città e le procedure erano lunghe. Dei lingotti sapevano solo gli
amici intimi, non ho mica messo i manifesti».
E i carabinieri continuano a
indagare nella cerchia delle conoscenze della vittima per individuare i
mandanti: «Spero non sia così, ma l’invidia è una brutta bestia — conclude
Gianni —. Io ho cercato di aiutare tutti, ma qualcuno mi si è rivoltato contro e
l’ho già allontanato. Adesso non vedo l’ora che cominci il processo per guardare
queste persone in faccia e capire chi sono. Se comprerò un altro gratta e vinci?
Proverò il nuovo biglietto da 25 euro, magari la fortuna mi bacia di nuovo».
Vince al Superenalotto e
compra la Porsche. Ma poi rivuole i soldi. «Ci ha minacciato di bruciare il
negozio». Giuliana Ubbiali su Il Corriere della Sera l’1 Aprile 2023
Comprarsi una Porsche era il
suo sogno, disse al proprietario dell’autosalone di Sorisole. Giuseppe
Cornacchio, 72 anni, di Cesano Boscone (Milano), poteva realizzarlo dopo aver
vinto al Superenalotto. Così, almeno, ha raccontato il titolare della rivendita
che lo incontrò il 22 marzo 2022, quando si presentò da lui per visionare
l’auto. Cornacchio comprò la Porsche 912 del 1966 ed è finito a processo per
estorsione, già riqualificata dal giudice Roberto Palermo in esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, all’udienza per la convalida dell’arresto, il
29 ottobre 2022. È libero, da subito.
I punti di partenza sono due,
il resto è in via di approfondimento a processo. Il 28 ottobre, Cornacchio viene
arrestato dopo aver preso una busta con 1.500 euro dal proprietario dell’auto,
padre del titolare dell’autosalone che ha un negozio di abbigliamento a
Valbrembo. A monte c’era una denuncia, dopo la richiesta di denaro e, secondo
l’accusa, le minacce: «Dammi i soldi o ti brucio il negozio». L’imputato nega la
frase, alla precedente udienza ha spiegato di aver voluto il denaro (la
richiesta era di 4.500 euro) perché il motore non era giusto. Dall’acquisto alle
minacce, il titolare dell’autosalone li ha ripercorsi ieri in aula.
«Cornacchio si presentò con un
carrozziere dicendo che aveva vinto al Superenalotto e ha mostrato il
biglietto. La Porsche era un suo sogno. Gliela mostro, la aprono, la guardano,
la accendono ma non l’hanno voluta provare». L’imputato lascia un acconto di
3.500 euro, salderà altri 35.000 al proprietario e porterà via l’auto con un
carroattrezzi. A ottobre iniziano le lamentele. «Mio padre mi dice: “Ha chiamato
Cornacchio dicendo che l’auto è un tarocco”». Lo stesso titolare dell’autosalone
riceve due telefonate, una la registra: «Aveva fare minaccioso, ero impaurito,
ha alzato la voce, voleva i soldi. Poi è andato da mio padre con un’altra
persona dicendo che gli avrebbe bruciato l’attività». Voleva 4.500 euro, avrebbe
sistemato la Porsche. «Avevo verificato l’auto, gli dissi di andare da un
avvocato». Il commerciante ha spiegato che tutte le parti dell’auto sono
originali Porsche, anche se non tutte erano di quella vettura del 1966:
«Altrimenti l’avremmo venduta a 100 mila euro». Un’auto d’epoca.
Nella telefonata registrata
emerge che l’imputato fosse convinto e preoccupato che l’auto avesse un vizio al
telaio: «Se mi ferma la polizia stradale me la sequestra al 100%». Ciò non
toglie il suo fare «minaccioso» e «aggressivo» confermato dalla commessa del
negozio del primo proprietario della Porsche. In fase di convalida, il giudice
aveva descritto la vicenda come «civilistica» legata alla compravendita
dell’auto, ma poi «degenerata a causa dell’irruenza» di Cornacchio.
Estratto dell'articolo di
Talita Frezzi per “il Messaggero” il 30 marzo 2023.
Da clochard a benestante. Da
improvvisati show col suo cappello lanciato in aria per avere qualche spicciolo
al semaforo di viale del Lavoro, al Tribunale per farsi riconoscere la capacità
di gestire un patrimonio di 300 mila euro vinto con un Gratta&vinci, comprato
con 20 euro di elemosina. È la storia di Tiziano Pellonara, 63 anni, conosciuto
a Jesi come "l'uomo col cappello".
Operaio dell'ex azienda Italim
con sede a Pescara, a sette anni dalla pensione lascia il lavoro.
Con il Tfr provvede alle spese
per sé e l'anziana madre, ma i soldi finiscono e non riesce più a trovare
lavoro. […]
[…] È l'estate del 2020:
Tiziano gratta 300mila euro e ne incassa 240mila nette mentre 60mila circa vanno
allo Stato. Ma quella gioia dura poco, minata dall'invidia. A febbraio il
patrimonio viene congelato e lui è costretto a tornare al semaforo. «Ero
amareggiato e sorpreso perché non capivo il motivo», spiega.
A risolvere tutto ci ha pensato
l'amico di vecchia data, l'avvocato Marco Polita: un parente aveva denunciato
alla Procura di Ancona che Tiziano sarebbe stato circuito da qualcuno e che
presto i soldi sarebbero finiti. Dunque, la Procura inoltra richiesta per il
sequestro cautelare della vincita. L'avvocato Polita presenta il ricorso al
Riesame e si batte, finché la Procura il 13 marzo revoca il sequestro cautelare
e dispone la restituzione della somma dopo aver esaminato tutta la
documentazione presentata in cui vengono riportate le spese di Tiziano dopo la
vincita: il pagamento di 60mila euro di tasse, 5mila di debiti e multe maturati
nel periodo dell'indigenza e persino una donazione alla Caritas.
[…]solo per mettere a tacere
altre polemiche familiari, è stata concordata la nomina di un legale che
gestisca il patrimonio, sebbene Tiziano ne sia in grado, come accertato in aula,
e gli elargirà una somma mensile. […]
L’azienda nata in
una stalla da un 13 al Totocalcio. Come investire i soldi vinti con un 6 al
Superenalotto? La storia di Cofle può essere d'ispirazione. Dino Bondavalli il
30 Marzo 2023 su Il Giornale.
Se potrà essere d’ispirazione
per il fortunato (o la fortunata) che l’altro giorno ha centrato un 6 da 73,8
milioni di euro al Superenalotto con una giocata da due euro piazzata online è
difficile dirlo. Di certo, però, quella dell’azienda milanese Cofle è una storia
che può aiutarci a rispondere a una domanda che tutti noi ci poniamo ogni volta
che qualcuno azzecca la sestina vincente: cosa faremmo se vincessimo al gioco
una cifra a sei o sette zeri?
Perché se è vero che tutti noi
ci toglieremmo qualche sfizio, come la macchina nuova o il viaggio alle Maldive,
e quasi certamente estingueremmo il mutuo sulla casa o acquisteremmo un immobile
nuovo per noi o i nostri cari, sul cosa faremmo con il grosso dei soldi i dubbi
sono molto più duri da fugare.
Bruno Barbieri e il Totocalcio
Ma cosa c’entra l’azienda
meneghina, sopecializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione
a livello mondiale di sistemi di comando e cavi di controllo per il settore
automotive e per quello dei trattori, con la vincita al gioco? C’entra eccome,
essendo nata nel 1964 proprio grazie a un 13 al Totocalcio. A realizzarlo Bruno
Barbieri, imprenditore sicuramente meno noto dell’omonimo cuoco giudice
di MasterChef Italia, ma il cui ingegno ha avuto un impatto decisamente più
rilevante a livello mondiale.
Fu lui a trasformare quel colpo
di fortuna in un colpo di genio, partendo da una stalla per dar vita a una
realtà che oggi ha tra i propri clienti aziende del calibro di Ferrari, Maserati
e Lotus, oltre a tutti i principali marchi di macchine agricole a livello
internazionale. “Nostro padre si sarebbe potuto limitare a godersi quei soldi”,
racconta Alessandra Barbieri, che con il fratello Walter, presidente della
società, gestisce l’azienda di famiglia. “Invece, decise di licenziarsi
dall’azienda americana per la quale lavorava e che produceva impianti per
l’industria aeronautica, e di lanciarsi in questa avventura installandosi nella
stalla dei nostri nonni, dove condivideva lo spazio con alcune mucche”.
Dalle Fiat e Autobianchi ai
trattori
La prima produzione riguardò i
cavi di equipaggiamento per Fiat, Autobianchi e Lancia, i marchi più importanti
dell’epoca. Poi, tra gli anni Settanta e Ottanta, l’azienda cominciò a produrre
anche cavi per il settore dei ricambi. In seguito, tra gli anni Ottanta e
Novanta, nacque anche la divisione per la produzione dei primi impianti per
macchinari agricoli e di movimentazione terra.
Grazie a una crescita costante,
oggi Cofle ha raggiunto una dimensione tale da aver diviso la propria produzione
in due linee di business: la linea OEM, che produce cavi e sistemi di controllo
nel settore agricolo, delle macchine di movimentazione terra, dei veicoli
commerciali e del settore premium dell’automotive, e la linea After Market (AM),
specializzata nella produzione di parti di ricambio per il settore automotive,
con oltre 7 mila prodotti che coprono tutto il parco auto europeo. In poco meno
di 60 anni di storia l’azienda è infatti stata capace di imporsi in un settore
ad altissima competizione come quello dell’automotive, raggiungendo la
dimensione di gruppo con poli produttivi e logistici in Italia, Turchia, Brasile
e India.
Un giro di Valzer con la dea
bendata
Un comparto nel quale Cofle
punta a essere protagonista anche in futuro. Tanto che alla produzione di cavi
tradizionali per il freno, per l’acceleratore, per la frizione, ha affiancato
quella di sistemi per i freni a mano elettronici e quelli per i freni idraulici,
sistemi di controllo altamente tecnologici con una componente elettronica e
meccatronica rilevante.
Il tutto con l’obiettivo di
dare continuità a una realtà che ha trasformato un semplice colpo di fortuna in
un uno straordinario viaggio imprenditoriale. Ma anche in una fonte di
ispirazione per chi si dovesse ritrovare inaspettatamente a fare un giro di
Valzer con la dea bendata.
All'ippodromo tra scienziati
e fatalisti di ogni età: «I cavalli ci fanno sognare più dei calciatori». Andrea
Galli su Il Corriere della Sera il 21 Gennaio 2023.
Varese, viaggio tra le tribù
che popolano le corse dei cavalli. Non solo puntate in denaro. Lo studente di
Ingegneria: «La passione? Mi portava papà, qui mi rilasso». La telecronaca senza
retorica e il boom delle giovani fantine
Ma che posto strano, perfino
liturgico, l’ippodromo del galoppo. Vintage e però moderno, pubblico e pure
solitario, senza monitor sulla tribuna centrale — i seggiolini ancora con gli
adesivi del distanziamento — per vedere meglio le corse dei cavalli specie
quando gli animali girano sul rettilineo lontano e curvano in prossimità delle
alture velate di foschia, sicché non resta, obbligatoria e diffusa dal
concentrato speaker, che la telecronaca peraltro priva di retorica, statistiche
e aneddoti, bensì essenziale, insomma meravigliosamente anacronistica: «Tutti
contro Sopran Everest, grandissimo esperto della superficie. Tutta da vedere
questa prova! Partiti! Lovely Moment prova a portarsi in vantaggio... In quinta
posizione Enger insieme ad Amica mia... Prima frazione particolarmente veloce...
Di Più passa in vantaggio, in seconda posizione Sopran Everest...».
Son 1.950 metri per cavalli
dall’età di 4 anni e oltre, e a Varese è la corsa numero 6 cioè l’ultima di
giornata, che finisce con i seguenti piazzamenti... Ma no, non importa. Anzi chi
se ne frega proprio. Del resto pedinando gli spettatori in due mercoledì, il 28
dicembre che aveva sigillato l’anno agonistico 2022 e il 18 gennaio che ha
aperto quello nuovo, ci siamo presto smarriti: la bussola, e ancor più il centro
di gravità, non sono soltanto le scommesse. E forse, al termine di complessive
12 corse divise nei due mercoledì, abbiamo trovato delle tracce.
Sul tondino
Poggiato sul recinto del
«tondino», lo spazio destinato alla presentazione dei concorrenti, un ragazzo
fissa beato i cavalli; hanno appena gareggiato, sfilano col manto sudato,
stanchi, dimenticando il nervosismo di pochi minuti fa all’ingresso in pista.
Chiediamo su chi avesse puntato e lui accoglie l’interrogativo quasi che sia un
insulto. «Su nessuno. Succedeva da bambino con papà, che lavorava in Svizzera e
non c’era mai, poveretto, sfruttato in cantiere come una bestia: arrivavamo
all’ippodromo e stavamo insieme. Mi è rimasta la passione. Che faccio nella
vita? Ingegneria. Avrei potuto fare Veterinaria? No, che c’entra; le è mai
capitato di pescare al mare? Uno può anche star lì a guardare le onde, non per
forza bisogna tirare su il pesce, giusto? Non trova un collegamento? Intendo
dire che per me l’ippodromo è come una gita dove stacco e non ho obblighi».
Lo pediniamo. Conclusa la
sfilata dei cavalli, entra nella sala delle scommesse, esamina la macchinetta
automatica, prende un caffé, non s’accoda agli scommettitori attaccati agli
schermi che comunicano le quote, evita le casse per piazzare le puntate, esce
fuori, fuma un sigaretta, la spegne nel bicchierino del caffé che butta nel
cestino affollato di ricevute delle scommesse, ovviamente quelle senza vincita,
attacca a camminare a zonzo, trascura la successiva corsa intanto partita, lento
lento si avvicina al «tondino» e attende la prossima tornata di cavalli. Scusa
ancora, non per essere molesti, però senti, mai mai mai tu hai messo dei soldi?
«Vado allo stadio, insulto i calciatori, scommetto sulle partite, però ci sta,
lo stadio svuota e l’ippodromo rilassa. Scommettere sui cavalli no, non ci trovo
un senso».
Le scuderie
Ora, comunque un senso esiste.
Un indizio nei gabinetti, un gran cartello con sopra scritto di non buttare i
pannoloni nel wc, lascia intendere la maggioranza degli abitanti dell’ippodromo,
ossia gli anziani i quali riempiono gli intervalli tra le gare, della durata
d’un quarto d’ora, elencando malanni, farmaci, degenze, funerali, e anche
sofisticate analisi sui cavalli. Tre le categorie: i «genetisti» che si perdono
nel passato illustrando mamme e papà degli animali e tipologia delle corse
affrontate, e a questi dati affidandosi per le scommesse; i «cronisti» che in
settimana esplorano le scuderie raccogliendo informazioni dell’ultima ora che
comunque dispensano con gelosia; i «fatalisti» che vanno a intuizione, in
pratica puntano come gli gira al momento magari sperando nel numero di partenza,
oppure nei sogni o nelle premonizioni sui fantini.
A proposito: il giornalino che
illustra il programma delle corse presenta in un angolo in basso la classifica
dei cavalieri; ebbene primeggia Dario Vargiu (153 trionfi) seguito da Dario Di
Tocco (144) e Mario Sanna (86). Due le fantine nei primi quindici, Sara Del
Fabbro e Virginia Tavazzani, in un movimento che registra la crescita di
scuderie di proprietà di donne, specie giovani. Sara Del Fabbro voleva fare
questo mestiere da bambina e ovviamente l’ha fatto; l’abbiamo vista vincere in
sella a Ostentation, il 28 dicembre, e godersi la premiazione acclamata dai
tifosi, o meglio dagli scommettitori che grazie a lei hanno guadagnato soldi; la
fantina accarezzava la cavalla girandole i complimenti con dei sussurri. L’altro
giorno, di nuovo in pista, Sara e Ostentation hanno chiuso dietro per la
delusione di chi era sicuro di un facile bis, generando inevitabili lamentele.
Tipo le proteste di quest’anziano il quale indossa doposci e una doppia sciarpa,
e che ha un qualcosa di sfuggente forse in quanto, a modo suo, in fuga.
Santa donna
«Ero uscito di casa per andare
a fare la spesa al supermercato. Soltanto che...». Che il supermercato sorge
dopo l’ippodromo. «No, l’ippodromo sta molto più avanti, non è questo. Ma per
curiosità mi sono detto: allungo un attimo, magari ci sono gli amici e mi fermo
a chiacchierare, che cosa sarà mai». E invece che cosa è stato? «Beh, non ho più
i soldi della spesa». Li ha giocati? «Li ho persi, che è diverso». Ma per la
cena è a posto? «No, sennò non sarei uscito per il supermercato». E come
facciamo? «Su, mia moglie un piatto lo mette insieme. Prima mi sgrida, io chiedo
scusa, e ci ritroviamo a tavola senza fiatare. Santa donna lei, sant’uomo io». E
gli amici poi c’erano? «Mica sono scemi. Con ’sto freddo del demonio, stanno già
conciati così, gli prende un accidente. Lei piuttosto metta il cappello, che si
gela la pelata. Che tempo, bisognerebbe emigrare ad Albenga». Perché Albenga?
«C’è l’ippodromo».
Nella sala delle scommesse, le
cui zone dalle luci spente e la chiusura della tavola calda ricordano le
comunque antiche sepolte gloriose epoche dell’ippodromo-mania che univa
borghesia e operai, gente di città e provincia, ricchi scansafatiche e
disgraziati abbonati alla iella, gli schermi rimandano le dirette delle corse in
contemporanea altrove. Anche su queste gare si punta, sempre partendo
dalla quota minima di 3 euro, quota che in verità parrebbe (e pare) eretica
ai veri scommettitori, non fosse che garantisce una sorta, o un minimo, di
auto-controllo delle uscite finanziarie; un gruppo di amiche sugli ottanta, dopo
aver confabulato storpiando i nomi dei cavalli e dando l’idea di goderne
parecchio — d’altra parte, portate pazienza, è un elenco di Teatime tipple,
Wealth of street, Please exceed, Mystic knight, Smiling face, Angry duffy... —,
allunga all’impiegato in cassa, protetto dal vetro divisorio, monetine da 50
centesimi per raggiungere il totale appunto di 3 euro, e giocare sparando a caso
con ostentato disinteresse verso le quote lampeggianti sugli schermi.
Gli investimenti al ribasso,
attenzione, non implicano l’assenza di fasci di banconote che giacciono nelle
tasche dei cappotti di altre signore e altri signori guardinghi, e che sgusciano
via via aumentando o diminuendo di volume; e parimenti non mancano esultanze
nell’ascoltare dallo speaker l’ordine d’arrivo avendo scommesso banconote
pesanti, con urla folli su questi ibernati e, rispetto all’odierna
capienza, giganteschi spalti che ospitano una vastità scaramantica: sto in
piedi, tolgo gli occhiali da vista e metto quelli da sole pur senza sole, slego
le stringhe, me la tengo anche se dovrei scappare in bagno, eccetera eccetera...
Popolano l’ippodromo presunti
portatori di dritte che, pretendendo percentuali sulle eventuali
vincite, distribuiscono notizie spacciate per cassazione. Un altro anziano parte
con una tiritera contro chi ha deciso le quote, dà una sintesi per i più assai
chiara («Oh, l’hanno messo a 1,40! Ma manco il caffé corretto grappa ci prendo
con un 1 euro e 40!»), salvo galoppare pericolosamente ansimando a incassare col
rischio d’un capitombolo in mezzo a sguardi di disapprovazione, oppure forse no:
di umana invidia.
(ANSA
il 14 aprile 2023) - Se il tasso
d'occupazione femminile a Bruxelles rispetto al resto del Belgio è troppo basso
è per il "modello di famiglia mediterranea" che ha radici nella capitale. A
sostenerlo, in un'intervista alla tv Ln24, è stato il ministro del Lavoro della
Regione di Bruxelles, Bernard Clerfayt.
"Molte donne sono ancora in un
modello mediterraneo, che siano italiane, marocchine o turche di origine... È un
modello di famiglia in cui l'uomo lavora e la donna resta a casa per occuparsi
dei figli", ha affermato Clerfayt, scatenando l'ira innanzitutto dei Verdi e dei
Socialisti e una pioggia di critiche sui social.
Il ministro belga: «Se le
donne non lavorano, è colpa del ‘modello mediterraneo’ di origine italiana».
Il Corriere della Sera il 14 Aprile 2023.
Polemica per le frasi di
Bernard Clerfayt, responsabile dell'occupazione nella Regione di
Bruxelles-Capitale
Scoppia in Belgio la polemica
per le frasi di Bernard Clerfayt, responsabile dell'occupazione nella Regione
di Bruxelles-Capitale. Durante un'intervista rilasciata a una emittente
televisiva, Clerfayt ha parlato di un "modello mediterraneo" secondo il quale le
donne resterebbero a casa rinunciando alla propria emancipazione. «Ci sono
ancora molte donne della regione di Bruxelles che, per spiegarlo con parole
semplici, seguono un 'modello mediterraneo'. È il caso di chi è di origine
italiana o marocchina. Si tratta di un modello mediterraneo delle famiglie in
cui è l'uomo che lavora e la donna sta a casa» ha detto Clerfayt. «Credo che voi
incoraggerete a cambiare questa mentalità» ha chiesto a quel punto
l'interlocutore. «Certamente. Innanzitutto perché la coppia si trova meglio se
lavorano entrambi e l'emancipazione femminile fa guadagnare loro diritti. Hanno
diritto di avere un lavoro e l'emancipazione attraverso il lavoro» ha concluso
Clerfayt. Le sue parole hanno scatenato aspre polemiche. (LaPresse)
Polemica sulle frasi del
ministro belga Bernard Clerfayt: «Se a Bruxelles poche donne lavorano è a causa
della “mentalità italiana”». Redazione Online su Il Corriere della Sera il
14 Aprile 2023.
«Molte donne seguono ancora un
modello mediterraneo, che siano di origine italiana, marocchina o turca... È un
modello di famiglia in cui l’uomo lavora e la donna resta a casa per occuparsi
dei figli», ha affermato Clerfayt
«Se il tasso di occupazione
femminile a Bruxelles rispetto al resto del Belgio è troppo basso è per il
“modello di famiglia mediterranea” che ha radici nella capitale». A sostenerlo,
in un’intervista alla tv Ln24, è stato il ministro del Lavoro della Regione di
Bruxelles, Bernard Clerfayt.
«Molte donne seguono ancora un
modello mediterraneo, che siano di origine italiana, marocchina o turca... È un
modello di famiglia in cui l’uomo lavora e la donna resta a casa per occuparsi
dei figli», ha affermato Clerfayt, scatenando l’ira innanzitutto dei Verdi e dei
Socialisti e una pioggia di critiche sui social.
Dichiarazioni che hanno subito
innescato una feroce polemica politica, in una capitale dove le prime due
comunità straniere sono proprio quella marocchina e quella italiana. «Sono
sconvolta e indignata. Penso a tutte quelle donne che conosco e che cercano
lavoro, ma che sono discriminate a causa delle loro origini, a tutte quelle
donne madri single che hanno difficoltà a conciliare lavoro e vita familiare»,
ha twittato la deputata socialista Fadila Laanan, che fa parte della maggioranza
di governo.
Critiche anche dalla ministra
per l’Ambiente Zakia Khattabi, di origini marocchine: «Seriamente, da quale
cliché vogliamo iniziare? Qual è il modello mediterraneo? E soprattutto chiudere
gli occhi su ragioni strutturali oggettive è strabiliante», ha twittato con
l’hashtag vergogna.
Clerfayt ha ribadito la propria
posizione: «I numeri confermano quello che dico. Denunciare un fatto non è
stigmatizzare. E non devo scusarmi per la distorsione delle mie osservazioni da
parte di alcuni partiti politici. Questo non cambia la mia determinazione a
lavorare per l’emancipazione di tutti e per continuare a migliorare il tasso di
occupazione delle donne nella Regione di Bruxelles», ha spiegato. «È un dato di
fatto, il tasso di occupazione delle donne è inferiore a quello degli uomini
nonostante un livello di istruzione più elevato. Questo è il caso ovunque in
Belgio, ma la differenza è maggiore nella Regione di Bruxelles (10 punti
percentuali di differenza), subito seguita dalla provincia dell’Hainaut (9,5
punti percentuali di differenza). Questa discrepanza statistica può essere
spiegata in particolare da un tasso inferiore di partecipazione delle donne al
mercato del lavoro», ha aggiunto.
Discorso di fine anno, il
messaggio di fiducia di Mattarella: testo integrale. Il Tempo l’1 gennaio
2023
Un discorso di quasi 17 minuti
con il quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato
direttamente ai cittadini italiani. Le parole del capo dello Stato, per i
tradizionali auguri di fine anno, sono state centrate su un messaggio di
«fiducia», uno sprone «a guardare al futuro», nonostante le difficoltà sociali
ed economiche causate dagli ultimi tre anni di pandemia e dalla guerra in
Ucraina. È l’ottavo messaggio di fine anno del presidente Mattarella, il primo
del suo secondo mandato arrivato il 29 gennaio 2022 per lo stallo tra le forze
politiche in Parlamento che lo ha rieletto per un bis del settennato. Il testo
integrale:
Un anno addietro, rivolgendomi
a voi in questa occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e
complessi. Lo è stato anche l’anno trascorso, così denso di eventi politici e
istituzionali di rilievo. L’elezione del Presidente della Repubblica, con la
scelta del Parlamento e dei delegati delle Regioni che, in modo per me inatteso,
mi impegna per un secondo mandato. Lo scioglimento anticipato delle Camere e le
elezioni politiche, tenutesi, per la prima volta, in autunno. Il chiaro
risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato,
per la prima volta, da una donna. È questa una novità di grande significato
sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta
realtà. Nell’arco di pochi anni si sono alternate al governo pressoché tutte le
forze politiche presenti in Parlamento, in diverse coalizioni parlamentari.
Quanto avvenuto le ha poste, tutte, in tempi diversi, di fronte alla necessità
di misurarsi con le difficoltà del governare. Riconoscere la complessità,
esercitare la responsabilità delle scelte, confrontarsi con i limiti imposti da
una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali: dalla pandemia alla
guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare, dai cambiamenti climatici ai
fenomeni migratori. La concretezza della realtà ha così convocato ciascuno alla
responsabilità. Sollecita tutti ad applicarsi all’urgenza di problemi che
attendono risposte. La nostra democrazia si è dimostrata dunque, ancora una
volta, una democrazia matura, compiuta, anche per questa esperienza, da tutti
acquisita, di rappresentare e governare un grande Paese. È questa
consapevolezza, nel rispetto della dialettica tra maggioranza e opposizione, che
induce a una comune visione del nostro sistema democratico, al rispetto di
regole che non possono essere disattese, del ruolo di ciascuno nella vita
politica della Repubblica. Questo corrisponde allo spirito della Costituzione.
Domani, primo gennaio, sarà il settantacinquesimo anniversario della sua entrata
in vigore. La Costituzione resta la nostra bussola, il suo rispetto il nostro
primario dovere; anche il mio.
Siamo in attesa di accogliere
il nuovo anno ma anche in queste ore il pensiero non riesce a distogliersi dalla
guerra che sta insanguinando il nostro Continente. Il 2022 è stato l’anno della
folle guerra scatenata dalla Federazione russa. La risposta dell’Italia,
dell’Europa e dell’Occidente è stata un pieno sostegno al Paese aggredito e al
popolo ucraino, il quale con coraggio sta difendendo la propria libertà e i
propri diritti. Se questo è stato l’anno della guerra, dobbiamo concentrare gli
sforzi affinché il 2023 sia l’anno della fine delle ostilità, del silenzio delle
armi, del fermarsi di questa disumana scia di sangue, di morti, di sofferenze.
La pace è parte fondativa dell’identità europea e, fin dall’inizio del
conflitto, l’Europa cerca spiragli per raggiungerla nella giustizia e nella
libertà. Alla pace esorta costantemente Papa Francesco, cui rivolgo, con grande
affetto, un saluto riconoscente, esprimendogli il sentito cordoglio dell’Italia
per la morte del Papa emerito Benedetto XVI. Si prova profonda tristezza per le
tante vite umane perdute e perché, ogni giorno, vengono distrutte case,
ospedali, scuole, teatri, trasformando città e paesi in un cumulo di rovine.
Vengono bruciate, per armamenti, immani quantità di risorse finanziarie che, se
destinate alla fame nel mondo, alla lotta alle malattie o alla povertà,
sarebbero di sollievo per l’umanità.
Di questi ulteriori gravi
danni, la responsabilità ricade interamente su chi ha aggredito e non su chi si
difende o su chi lo aiuta a difendersi. Pensiamoci: se l’aggressione avesse
successo, altre la seguirebbero, con altre guerre, dai confini imprevedibili.
Non ci rassegniamo a questo presente. Il futuro non può essere questo. La
speranza di pace è fondata anche sul rifiuto di una visione che fa tornare
indietro la storia, di un oscurantismo fuori dal tempo e dalla ragione. Si basa
soprattutto sulla forza della libertà. Sulla volontà di affermare la civiltà dei
diritti. Qualcosa che è radicato nel cuore delle donne e degli uomini. Ancor più
forte nelle nuove generazioni. Lo testimoniano le giovani dell’Iran, con il loro
coraggio. Le donne afghane che lottano per la loro libertà. Quei ragazzi russi,
che sfidano la repressione per dire il loro no alla guerra.
Gli ultimi anni sono stati
duri. Ciò che abbiamo vissuto ha provocato o ha aggravato tensioni sociali,
fratture, povertà. Dal Covid - purtroppo non ancora sconfitto definitivamente -
abbiamo tratto insegnamenti da non dimenticare. Abbiamo compreso che la scienza,
le istituzioni civili, la solidarietà concreta sono risorse preziose di una
comunità, e tanto più sono efficaci quanto più sono capaci di integrarsi, di
sostenersi a vicenda. Quanto più producono fiducia e responsabilità nelle
persone. Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del
Paese rappresentato dal Servizio sanitario nazionale si rafforzi, ponendo sempre
più al centro la persona e i suoi bisogni concreti, nel territorio in cui vive.
So bene quanti italiani affrontano questi mesi con grandi preoccupazioni.
L’inflazione, i costi dell’energia, le difficoltà di tante famiglie e imprese,
l’aumento della povertà e del bisogno. La carenza di lavoro sottrae diritti e
dignità: ancora troppo alto è il prezzo che paghiamo alla disoccupazione e alla
precarietà.
Allarma soprattutto la
condizione di tanti ragazzi in difficoltà. La povertà minorile, dall’inizio
della crisi globale del 2008 a oggi, è quadruplicata. Le differenze legate a
fattori sociali, economici, organizzativi, sanitari tra i diversi territori del
nostro Paese - tra Nord e Meridione, per le isole minori, per le zone interne -
creano ingiustizie, feriscono il diritto all’uguaglianza. Ci guida ancora la
Costituzione, laddove prescrive che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena
realizzazione. Senza distinzioni.
La Repubblica siamo tutti noi.
Insieme. Lo Stato nelle sue articolazioni, le Regioni, i Comuni, le Province. Le
istituzioni, il Governo, il Parlamento. Le donne e gli uomini che lavorano nella
pubblica amministrazione. I corpi intermedi, le associazioni. La vitalità del
terzo settore, la generosità del volontariato. La Repubblica - la nostra Patria
- è costituita dalle donne e dagli uomini che si impegnano per le loro famiglie.
La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a
far funzionare l’Italia e quindi al bene comune. La Repubblica è nel sacrificio
di chi, indossando una divisa, rischia per garantire la sicurezza di tutti. In
Italia come in tante missioni internazionali. La Repubblica è nella fatica di
chi lavora e nell’ansia di chi cerca il lavoro. Nell’impegno di chi studia.
Nello spirito di solidarietà di chi si cura del prossimo. Nell’iniziativa di chi
fa impresa e crea occupazione. Rimuovere gli ostacoli è un impegno da
condividere, che richiede unità di intenti, coesione, forza morale. È grazie a
tutto questo che l’Italia ha resistito e ha ottenuto risultati che inducono alla
fiducia. La nostra capacità di reagire alla crisi generata dalla pandemia è
dimostrata dall’importante crescita economica che si è avuta nel 2021 e nel
2022. Le nostre imprese, a ogni livello, sono state in grado, appena possibile,
di ripartire con slancio: hanno avuto la forza di reagire e, spesso, di
rinnovarsi. Le esportazioni dei nostri prodotti hanno tenuto e sono anzi
aumentate. L’Italia è tornata in brevissimo tempo a essere meta di migliaia di
persone da ogni parte del mondo.
La bellezza dei nostri luoghi e
della nostra natura ha ripreso a esercitare una formidabile capacità attrattiva.
Dunque ci sono ragioni concrete che nutrono la nostra speranza ma è necessario
uno sguardo d’orizzonte, una visione del futuro. Pensiamo alle nuove tecnologie,
ai risultati straordinari della ricerca scientifica, della medicina, alle nuove
frontiere dello spazio, alle esplorazioni sottomarine. Scenari impensabili fino
a pochi anni fa e ora davanti a noi. Sfide globali, sempre. Perché è la
modernità, con il suo continuo cambiamento, a essere globale. Ed è in questo
scenario, per larghi verso inedito, che misuriamo il valore e l’attualità delle
nostre scelte strategiche: l’Europa, la scelta occidentale, le nostre alleanze.
La nostra primaria responsabilità nell’area che definiamo Mediterraneo
allargato. Il nostro rapporto privilegiato con l’Africa. Dobbiamo stare dentro
il nostro tempo, non in quello passato, con intelligenza e passione. Per farlo
dobbiamo cambiare lo sguardo con cui interpretiamo la realtà. Dobbiamo imparare
a leggere il presente con gli occhi di domani. Pensare di rigettare il
cambiamento, di rinunciare alla modernità non è soltanto un errore: è anche
un’illusione. Il cambiamento va guidato, l’innovazione va interpretata per
migliorare la nostra condizione di vita, ma non può essere rimossa. La sfida,
piuttosto, è progettare il domani con coraggio. Mettere al sicuro il pianeta, e
quindi il nostro futuro, il futuro dell’umanità, significa affrontare anzitutto
con concretezza la questione della transizione energetica. L’energia è ciò che
permette alle nostre società di vivere e progredire. Il complesso lavoro che
occorre per passare dalle fonti tradizionali, inquinanti e dannose per salute e
ambiente, alle energie rinnovabili, rappresenta la nuova frontiera dei nostri
sistemi economici. Non è un caso se su questi temi, e in particolare per
l’affermazione di una nuova cultura ecologista, registriamo la mobilitazione e
la partecipazione da parte di tanti giovani.
L’altro cambiamento che stiamo
vivendo, e di cui probabilmente fatichiamo tuttora a comprendere la portata,
riguarda la trasformazione digitale. L’uso delle tecnologie digitali ha già
modificato le nostre vite, le nostre abitudini e probabilmente i modi di pensare
e vivere le relazioni interpersonali. Le nuove generazioni vivono già pienamente
questa nuova dimensione. La quantità e la qualità dei dati, la loro velocità
possono essere elementi posti al servizio della crescita delle persone e delle
comunità. Possono consentire di superare arretratezze e divari, semplificare la
vita dei cittadini e modernizzare la nostra società. Occorre compiere scelte
adeguate, promuovendo una cultura digitale che garantisca le libertà dei
cittadini. Il terzo grande investimento sul futuro è quello sulla scuola,
l’università, la ricerca scientifica. È lì che prepariamo i protagonisti del
mondo di domani. Lì che formiamo le ragazze e i ragazzi che dovranno misurarsi
con la complessità di quei fenomeni globali che richiederanno competenze
adeguate, che oggi non sempre riusciamo a garantire. Il Piano nazionale di
ripresa e resilienza spinge l’Italia verso questi traguardi. Non possiamo
permetterci di perdere questa occasione. Lo dobbiamo ai nostri giovani e al loro
futuro. Parlando dei giovani vorrei - per un momento - rivolgermi direttamente a
loro: siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tanti morti sulle strade. Troppi
ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d’auto, a causa della velocità,
della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate avete
nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un
momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro. Care concittadine e cari
concittadini, guardiamo al domani con uno sguardo nuovo. Guardiamo al domani con
gli occhi dei giovani. Guardiamo i loro volti, raccogliamo le loro speranza.
Facciamole nostre. Facciamo sì che il futuro delle giovani generazioni non sia
soltanto quel che resta del presente ma sia il frutto di un esercizio di
coscienza da parte nostra. Sfuggendo la pretesa di scegliere per loro, di
condizionarne il percorso. La Repubblica vive della partecipazione di tutti. È
questo il senso della libertà garantita dalla nostra democrazia. È anzitutto
questa la ragione per cui abbiamo fiducia. Auguri!
Claudio Bozza per corriere.it
il 31 Dicembre 2022.
A Montecitorio è notte fonda.
La maratona parlamentare sembra senza fine e il clima diventa incandescente. È
in corso la votazione degli ordini del giorno sul «decreto rave». Sarebbe
appunto il momento di votare, non degli interventi. Il centrodestra ha premura
di approvare i vari passaggi, la minoranza prova a mettere i bastoni tra le
ruote.
A un certo punto Andrea
Delmastro Delle Vedove, meloniano doc e sottosegretario alla Giustizia,
interviene dai banchi della maggioranza invece che da quelli del governo. È la
scintilla che fa scoppiare la bagarre. Dopo pochi minuti sui social rimbalza con
migliaia di condivisioni il fermo immagine di Marco Pellegrini (M5S) che fa il
dito medio.
Onorevole Pellegrini, non è
proprio un comportamento «onorevole». A chi era rivolto quel gestaccio?
«Calma. È tutto molto semplice,
ma serve onestà intellettuale. Ho pubblicato un video completo, e non tagliato
ad arte, da cui si capisce chiaramente la verità».
E cioè?
«Stavo stigmatizzando i
gestacci che provenivano dai banchi della destra. In sintesi, stavo spiegando al
presidente della Camera Lorenzo Fontana ciò che stava accadendo. Ma lo avete
sentito bene cosa ci dicevano dai banchi del centrodestra? “Statti a sede,
animale!”. Le pare normale?».
No, però lei poteva anche fare
a meno di replicare tale gesto. Non crede?
«C’era il caos. Dovevamo fare
chiarezza».
Ma quel dito medio ve lo aveva
rivolto qualcuno in particolare?
«Sono adulto e vaccinato,
preferisco soprassedere. Il centrodestra ha avuto un atteggiamento aggressivo.
Poi Delmastro ha fatto quella sceneggiata incomprensibile».
Il presidente Fontana è stato
costretto a sospendere la seduta. Non è stato proprio un bel fine 2022, non
crede?
«Fontana ha fatto del suo
meglio. Però se mi avesse dato la possibilità di finire il mio intervento
sarebbe stato utile per far capire a tutti cosa stava succedendo. L’opposizione
ha il diritto democratico di fare opposizione».
Il Capodanno Rai è il circo
per un’Italia di pecore. La serata di San Silvestro targata servizio
pubblico è la solita minestra riscaldata. Max Del Papa su Nicolaporro.it l’1
Gennaio 2023.
Uno vede Amadeus ancora lì,
sempre lì, a volte con moglie incorporata, li chiamavano i Civitillos, lo vede a
Capodanno, dopo averlo appena visto nel giochino dei premi, in attesa di
Sanremo, ma come fa? Ma dove la trova la forza? E si domanda con la testa fra le
mani: ma come faccio io a pensare anno nuovo vita nuova? Uno sente Caro amico ti
scrivo, ancora quella, sempre quella, son riusciti a farcela odiare, e pensa di
buttar giù una lettera minatoria.
Uno vede la serata di san
Silvestro Rai e gli viene voglia di sovrapporla ad una qualsiasi delle ultime
trenta, quaranta, tanto non si coglie differenza. A parte la lochescion, a lungo
Matera, per ragioni di corridoi, adesso Perugia, “il cuore dell’Italia”, ma
tanto l’Italia medievale la puoi confondere ad arte. Uno vede sempre quelli,
ancora quelli, e pensa che altrove non so, ma questo è proprio il paese dei
climatologi che son come i virologi. Uno poi scorre le agenzie con le
dichiarazioni spiazzanti, ficcanti di “Ama”, e lo odia, e dopo l’Ansa gli viene
l’ansia: “Serata scintillante”, “Serata di riappacificazione per gli italiani
verso un 2023 che si spera più sereno”. Ah, sì? Tralasciando che il discorsetto
pare fregato al Mattarella di fine anno (o viceversa, chissà), davvero gli
italiani devono riappacificarsi? E per cosa? E come mai si aspetta un anno più
sereno? Per colpa di chi, chi, chi, chi?
Ma Zucchero stasera non c’è. Ci
sono: Iva Zanicchi, 82 anni e non sentirli, beata lei, Donatella Rettore, da
Castelfranco Veneto con furore, i Ricchi & Poveri “formato duo” (per forza,
santa Madonna), tutta una carrellata di cavalli di battaglia, il più fresco ha
55 anni. Per non farci mancare niente hanno chiamato Sandy Marton, con la stessa
messa in piega del 1984, ma Orwell gli spiccia casa, la faccia purtroppo
raddoppiata, un ibrido tra Mickey Rourke e una ricottina comprata a
Londra. People from Ibizia diventa una specie di marcia grottesca. Quanto a
Tracy Spencer, che chi ha meno di 40 anni non può ricordare, chi ne ha di più
preferirebbe dimenticare. L’anno che verrà? No, l’anno che è venuto l’anno
scorso, e quello prima, e quello prima ancora, e indietro, e indietro, ci stanno
pure i Modà, che nessuno ha mai capito cosa fossero in verità, c’è un criptico
LDA, che starebbe per Luca D’Alessio e infatti è proprio figlio di quello là, il
neomelodico. Perché qua è tutta ‘na famiglia, però non faccio per dire, non
perché è figlio ammè, ma ‘o guaglione è buono davvero. Le canzoni, comunque,
erano uno schifo, come i fagioli di Trinità. Capodanno prepara Sanremo e il
Nasone è il filo conduttore, onnipresente, un presente continuo.
Insomma il futuro ha un cuore
avvizzito. Come fa la Rai a voler così male a quelli che la mantengono? Perché
gli dà ogni anno e ogni anno di più questo eterno ritorno dell’imbarazzo senza
vergogna? C’è un numero agghiacciante di due che imitano quelli che hanno vinto
a Sanremo l’anno scorso, Blanko e Mahmood, come se non bastassero gli originali,
solo che ricordano più dei Righeira scoppiati, tanto per restare in epoca (poi
uno crede di fare dell’ironia, ma il Righeira, uno solo, alla fine esce davvero,
con la gonna e gli anfibi, ed è pure più inquietante, addosso non gli sono
passate 4 decadi ma 4 secoli). Di peggio i due riusciranno a fare con la parodia
di Elton John e Ru Paul: il punto più abissale di una serata irreale. Perché,
Signore, perché? Perché bisogna fare la marchetta a Sanremo che verrà e anche
all’amico Carlo Conti per il solito programma degli imitatori. E anche al talent
della Rai, giurati i due Ricchi & Poveri, “e Antonella è fantastica”, la
Clerici, tutta una autocelebrazione circolare, io parlo di te che parli di lei
che parla di lui che parla di te che parli di me: siamo tutti fenomeni,
applausi.
Difatti non può mancare
l’appendice di Ama, Fiore, che in collegamento registrato fa il Fiore, cioè la
sagra dei cliché ma bisogna dire che è bravissimo, un mostro, tra Chaplin,
Noschese e Walter Chiari. Fiorello è un dogma, come il non binario, Greta e la
macchina elettrica. E c’è un tale Dargen d’Amico che, a proposito, è quello che
la farà da padrone al Festival perché sta alle canzoni come “Ama” alla
direzione, insomma sta in mezzo a tutto, fa i pezzi, li produce, impone gli –
ugh! – artisti, dicono sia un genietto del pop, ma cazzo se non fa che
bofonchiare. Poi arriva Raf, altro che cosa resterà di questi anni ’80, è
rimasto lui con quell’aria da commercialista della vecchia Milano da bere. E lì
uno si accorge di due cose: una, che Raf canta come un pizzaiolo, l’altra che
scorrono in sovrimpressione le parole, la Rai ricorda senza pietà che il suo
pubblico medio è sordo per raggiunti limiti di età.
Prendono in giro pure Anna Oxa,
ma son quelle imitazioni parrocchiali che ti mettono l’angoscia in cuore. Però
tutti saltano e esultano e fingono di divertirsi, devoti a quella liturgia
dell’allegria obbligatoria che ti ammazza come una coltellata all’anima. A
questo punto, dato l’evento-standard, l’articolo standard dovrebbe tirare in
ballo il personaggio-standard, il Maestro Canello di Fantozzi, ma io non lo
farò. Lo giuro. Possano cascarmi le mani se lo faccio. Passano altri graditi
ospiti: Nek, Raf, ci stavan bene pure Ric e Gian, invece c’è Noemi, tutta roba
sanremese, vedi un po’. Compare Rettore col cobra che non è un serpente, sì ma
cazzo, ha lo stesso parrucchiere di Sandy Marton, Tozzi e Tiamoti, Francesco
Renga che sembra Maradona grasso. E basta! Come diceva Bud Spencer “Bambino”. Ma
ecco Pelù, il rocker mascherinato, pluritamponato e oversierato, roba che deve
avergli fatto male visto che ieri ha twittato un delirio su Pelù che è come Pelé
o forse era il contrario. Da lapidarlo a pallonate. Difatti tanto in palla non
dev’essere, tira fuori la bandiera della pace, forse crede di essere al
Concertone sindacale. Canta roba in saldo di tre o quattro anni fa, sempre con
quelle liriche strampalate. Questa roba, al di là delle critiche più o meno
scherzose, ha un difetto di rabbrica, risente dell’età del conduttore, è
concepita come uno dei programmi classici dei sessantenni Amadeus, Conti,
Panariello eccetera, che hanno in testa la discoteca anni ’80-’90 e giocano su
un effetto nostalgia che non ha più ragion d’essere, che è se mai effetto
patetismo.
Passano minuti come spine di un
calvario e Amadeus a forza di strabuzzare gli occhi e contorcere la faccia si va
trasformando in Jack la Cayenne, quello che inghiottiva le tazzine. A
inghiottire le padelle sono invece gli spettatori, alcune del millennio scorso,
altre fresche di Ama, cioè quello che li manda a Sanremo, via Capodanno. Qui son
tutti raccomandati, cosa credete, tutti, senza scampo, sapeste voi le manovre,
le macumbe, l’invidia di chi stasera non fa passerella perché l’impresario non è
arrivato alla benevolenza del Moloc nasuto.
Caro amico ti scrivo, così
m’intristisco un po’, e siccome c’è “vola vola con me”, magari m’impiccherò. Da
quando sei partito, c’è una grossa novità, l’anno vecchio è finito ormai, ma
quest’altro uguale sarà. Sarà tre volte Sanremo, uguale a Capodanno, quest’anno
torna Madame, i Jalisse invece non ci vanno. Ma la televisione, ha detto che il
nuovo anno, porterà una trasformazione e tutti quanti ci stiamo toccando: fosse
mai che sti cazzi di vaccini c’hanno davvero dentro il grafene, il grafite e gli
intrugli della Baronessa Ursula che sembra uscita da un pornazzo anni ’70.
Ma non ridendo e un po’
scherzando, ci siamo arrivati: ce lo ricorda l’Ama-Deus, “cominciate a
prepararvi”, ahò ma niente niente questo si credesse il ministro Schillaci. Tre,
due, uno, via col tappo, un altro strappo al calendario, un altro brindisi a
fondo perduto e quei cialtroni maledetti, là dentro lo schermo, che fanno il
quando quando quando e il cacao meravigliao, e allora ditelo che il Maestro
Canello me lo volete tirar fuori per forza, e fanno il battito animale e Raf che
comanda, “su le mani!”, e il Nasone non sembra neanche reale mentre ulula
“Auuguuri” e pare già all’Ariston, e la Iva Zanicchi fuori controllo, più gasata
del Pelù, racconta pure le barzellette da trivio, alla Berlusconi e tu con gli
occhi pieni di lacrime che finiscono nel bicchiere senti che la tua puttana vita
è andata, fottuta, passata per sempre. Falsa come una puttana. E niente ti
sembra abbia più senso, non l’anno che verrà, non quelli che sono già passati
come treni bastardi, carichi di illusioni, neanche una che si sia realizzata, e
odi tutti i tuoi amori e detesti te stesso ma a quello ci sei abituato, è solo
che anche questo san Silvestro ti senti scricchiolare un po’ di più, ma soltanto
a una certa età.
Certo però che possono fare
tutti i loro trenini della minchia, ma se solo provano a rimettere in mezzo
greenpass, lockdown e tutta la faccenda, altro che riappacificazione, stavolta
prendo su il fucile: alzi la mano chi non l’ha pensato. All’una si materializza
Marzullo che si fa l’autoparodia, con tanto di domande astruse, un altro reperto
e qui il vostro cronista si arrende. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico,
e come sono contento di essere qui in questo momento, a inventarmi cazzate
sempre più ridicole per tamponare questa vita sempre più tragica. La mia, la
tua, quella di tutti quelli che si sentono addosso un macigno di più mentre
vedono sfilare tutti quei Nosferatu e inorridiscono al pensiero di scoprirsi
come loro, e la vita gli è passata davanti e non l’hanno acchiappata e non
capiscono, davvero non capiscono che senso abbia questa macchina del tempo
scassata e crudele, questo fingere di sperare, di credere che da domani sarà
diverso, ma vedrai che tanto ci richiudono, no stavolta no, non possono, lo dici
tu che non possono, se vogliono possono tanto gli italiani sono pecore, non si
ribellano mai, no questa volta scoppia la rivoluzione te lo dico io, e intanto
ti sale qualcosa in gola, non riesci più a bere, ti viene da piangere, hai
bisogno d’aria, di non farti vedere, esci a fumare sul balcone anche se fa un
freddo boia.
Max Del Papa, 1º gennaio 2023
Mario Fabbroni per leggo.it il
4 gennaio 2023.
«L'Italia? Al momento non va né
avanti né indietro. Ma crescerà». Oramai non ha più dubbi Giuseppe De Rita,
sociologo, 90 anni compiuti la scorsa estate, presidente del Censis. Dopo 60
primavere trascorse a osservare vizi privati e pubbliche virtù della popolazione
che vive e lavora in lungo e in largo per lo Stivale, vede un Paese
sostanzialmente fermo. Che deve ancora crescere.
Che Italia sarà, allora?
«Non siamo mai stati un popolo
che fa la rivoluzione, i mutamenti repentini non piacciono agli italiani. E le
prospettive ancora non si vedono».
Con zero prospettive non c'è
molto da stare allegri...
«Sa a cosa paragono l'Italia? A
una betoniera. Continua a girare ma lentamente, senza strappi. Ma produce il
necessario per andare avanti e aspettare il momento buono».
Beh, la solita storia: la
colpa è di tutti e di nessuno se le cose non vanno così bene?
«La colpa è soprattutto di una
certa politica, che ha smesso da molto tempo di intervenire seriamente sulle
crisi. Oggi si fanno solo battaglie di opinione, nessuno vuole sporcarsi le mani
con i problemi autentici promettendo di risolverli definitivamente. Nel tempo
abbiamo avuto Berlusconi, Renzi, Grillo: tutti frutto di ondate di opinione».
E Giorgia Meloni?
«Lei mostra sagacia, ha capito
che non deve impantanarsi nello scrivere un velleitario Piano per l'Italia
quanto risolvere le questioni più urgenti. Specie quelle dell'economia».
Insomma deve pensare a far
funzionare meglio la società italiana?
«Esatto. L'Italia va
semplicemente accompagnata nell'uscita dall'attuale latenza. Quella che Freud,
molto opportunamente, paragona a un essere umano tra gli 8 e di 11 anni d'età:
non è un bambino ma neppure un adolescente con tutte le sue pulsioni. Troppo
piccolo per avere ambizioni future oppure grandi desideri o grandi paure, perché
si viene ancora coperti dagli adulti. Una sorta di stato di sospensione,
fisiologico che - come per l'appunto sosteneva Freud - bisogna solo avere il
coraggio di lasciar passare».
Eppure siamo appena usciti
(forse) da una crisi pandemica: occasione persa per farne un Paese migliore?
«La pandemia da Covid non è
stata una vera crisi. Ha solo prodotto un grande spavento individuale, perché
ognuno ha avuto paura di morire da solo in un ospedale. Cioè non ha provocato,
lasciatemelo dire, una reazione di popolo».
Cosa intende?
«Che per dar vita a cambiamenti
sociali autentici serve che scocchi la scintilla collettiva. La ricostruzione
del Paese dopo gli Anni 50, ad esempio, è stata una fase fondamentale: bisogna
ringraziare i vari Brambilla e gli emigranti se sono arrivati il miracolo
economico e perfino la società strutturata come oggi la conosciamo e
analizziamo.
Non ha funzionato invece la
Cassa del Mezzogiorno: pur suscitando interesse perché era un piano di sviluppo,
la Casmez ha avuto migliaia di miliardi a disposizione ma il risultato è stato
scarso perché le masse non hanno provato attrazione. Stessa cosa accaduta oggi,
con il Pnrr».
In che senso?
«Il Piano nazionale di ripresa
e resilienza era stato presentato come la svolta per un futuro digitale ed
ecologico, invece non ha mobilitato le folle».
Non è un Paese per giovani
quello che non ha un'idea di futuro.
«Invece ai giovani consiglierei
di non fuggire dall'Italia. Sono più preparati di tanti anni fa, conoscono le
lingue straniere ma non è detto che solo all'estero possano fare carriera.
Paradossalmente proprio un'Italia in latenza può offrire diverse opportunità,
basta impegnarsi per coglierle».
Ma non ha appena detto che la
classe politica non sa più fare la vera politica? E allora chi sposta la
macchina Italia dal parcheggio dove è ferma?
«L'essere umano che ha un'età
tra gli 8 e gli 11 anni si trova in uno stato di latenza ma non è indifferente.
All'improvviso viene attratto dal sesso, si innamora, trova le energie che pensa
gli servano a cambiare il mondo. Ecco, l'Italia non resterà bambina per sempre
ma, nella sua lenta crescita, ha bisogno di regole certe.
Esattamente come avviene in
una famiglia perbene: servono l'orario di pranzo e cena, limiti da non
oltrepassare, impegno nello studio, magari evitare le cattive compagnie. Il
Paese Italia chiede servizi più efficienti e una dimensione pubblica
funzionante. Sarebbe già tanto...».
La scheda: l'uomo che studia
vizi e virtù dello Stivale
Giuseppe De Rita nasce a Roma
nel 1932. E' cresciuto nel quartiere San Giovanni, frequenta il Liceo Classico
presso l'Istituto Massimiliano Massimo dei Padri Gesuiti. A 22 anni si laurea in
Giurisprudenza.
Dal 1955 al 1963 è funzionario
della Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno. Nel 1964 è tra i fondatori
del Censis (Centro studi investimenti sociali), di cui è stato consigliere
delegato per dieci anni e poi segretario generale dal 1974, diventandone,
infine, Presidente nel 2007.
A partire dal 1967, le attività
di ricerca e gli spunti di analisi dell'istituto vengono condensati nel Rapporto
sulla situazione Sociale del Paese. È stato presidente del Cnel (Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro) dal 1989 al 2000.
È membro della Fondazione
Italia USA. Contribuì a fondare, nel 1991 l'Osservatorio permanente sui giovani
e l'alcool. Svolge intensa attività di pubblicista, è editorialista del Corriere
della Sera. Nel 2004, l'università Iulm gli ha conferito la laurea honoris causa
in Scienze della comunicazione.
Massimo Franco per il “Corriere
della Sera” il 31 Dicembre 2022.
«Che succederà all'Italia nel
2023? Secondo me quasi niente. Siamo un Paese mediocre con un governo mediocre,
anche se mi pare che Giorgia Meloni stia studiando per imparare i meccanismi del
sistema. Sa, la mediocrità non è soltanto un male...». Giuseppe De Rita rimane
un entomologo sociale spiazzante. Dalla sua scrivania nella villetta del Censis
circondata da un giardino arrampicato sopra piazza di Novella, accanto al parco
romano di Villa Ada, viviseziona il Paese. E anche dopo mezzo secolo continua a
darne una lettura originale.
Se non succede niente significa
per paradosso che la situazione si è in qualche modo stabilizzata.
«Possiamo anche dirla così. Sa,
l'assestamento nasce anche per l'assenza di grandi guastatori. In giro non ne
vedo. Al massimo c'è Giuseppe Conte, che cerca di contrastare l'assestamento del
sistema. Ma la sua mira sembra mediocre: superare un Pd in declino. Meloni può
stare tranquilla».
Beh, forse perché il Pd dà
l'idea di essere al capolinea e tutti pensano di poterselo spartire.
«Temo che sia una storia
finita, purtroppo. Penso a Enrico Letta, un politico che stimo. Porca miseria,
sembra che stia facendo una corsa verso il patibolo, con una sorta di masochismo
per eccesso di coerenza. Ma questa è la parte di analisi della politica che
magari mi fa eccedere in pessimismo, lo ammetto».
Il versante ottimistico qual è?
«Tutti noi che parliamo di
società italiana, dimentichiamo che l'Italia è come un bambino tra gli otto e
gli undici anni. Vive nella fase che Sigmund Freud chiamava stato di latenza. Ha
ossa, carne, cervello, ma non è ancora formato dall'adolescenza, né sfidato dal
futuro. E dunque è come sospeso».
Ha l'aria di un eufemismo per
non dire che galleggiamo e basta.
«In effetti, il galleggiamento
dura da un po' troppo tempo. Non andiamo né avanti né indietro, spieghiamo nel
Rapporto del Censis di quest' anno. Non usciamo dallo stato di latenza per due
motivi: non abbiamo un obiettivo preciso per il futuro, perché il Piano di
ripresa non coinvolge. È stato vissuto solo come: arrivano tanti soldi. E poi
perché non sono arrivate le grandi crisi che nel passato ci hanno fatto
avanzare: il dopoguerra, il terrorismo e la crisi petrolifera negli Anni
Settanta, il made in Italy e il craxismo degli Anni Ottanta del secolo scorso».
Non trascura la pandemia del
Covid e la guerra della Russia contro l'Ucraina?
«Non le trascuro. Ricorda? Ci
dicevano che "dopo" saremmo cambiati, e invece siamo rimasti gli stessi.
Nonostante i morti, l'inflazione, quelle tragedie non sono state percepite come
crisi trasformative. Socialmente non siamo in terapia intensiva. È come se
fossero soprattutto problemi che riguardano gli altri. Anche sulla guerra non
abbiamo un'idea collettiva».
Sta dicendo che tutto
contribuisce a una mediocre sopravvivenza?
«Voglio dire che gli italiani
non le hanno percepite come sfide da affrontare collettivamente: al massimo
hanno avuto paura per sé stessi, per esempio con la pandemia. Ma senza uno choc,
dalla latenza l'Italia non esce. Le grandi stagioni sono nate da choc, dal
dispiegamento di energie come risposta alla crisi».
Per molti, il governo di destra
che ha vinto il 25 settembre è uno choc.
«Per ora no. Dire che dietro
questo governo ci sia ancora Draghi non è così stravagante. Non nel senso che lo
guidi o lo influenzi nell'ombra ma che esiste un'inerzia dei processi economici
e politici, indotti anche dall'adesione all'Europa, ai quali Giorgia Meloni non
può sottrarsi. Il sistema risucchia e appiattisce tutti. Ricordiamoci la crisi
del 2011, lo spread a 500, Mario Monti. Lui e Mario Draghi non sono certo dei
mediocri, eppure sono stati costretti a scendere a patti con la mediocrità del
sistema».
Niente aurea mediocritas,
insomma.
«Mediocrità e basta. Ma io ci
credo, alle virtù della mediocrità: se non altro perché ha fatto crescere il
Paese nel passato. Il boom degli Anni Sessanta del '900 è stato promosso dallo
strato medio dei mediocri Brambilla e dalla quasi banalità della Fiera di
Milano. Mediocri ma funzionavano».
Sì, ma ora sembra una
mediocrità non da boom ma da declino.
«Purtroppo ci siamo consumati
la classe dirigente. E la classe media non è mai diventata borghesia: non ce
l'abbiamo fatta. Pasolini lo diceva sempre a me e a Paolo Sylos Labini:
l'italiano non sarà mai borghese, rimane un piccolo borghese. Anche nel governo,
nel Parlamento, dominano i piccoli borghesi. Ci vorranno cinquant' anni per
esprimere un'identità neoborghese e avere una fascia sociale di borghesia
medioalta».
Lei descrive una sorta di
scissione tra cultura, società e politica.
«Questa scissione è reale.
Manca la capacità di creare identità e punti di riferimento. La politica si fa
con i soggetti collettivi, con élites capaci di visione e di sintesi. Con i
leader individuali si ottengono vittorie di opinione, intrinsecamente volubili.
Esaltare l'opinione è stata la tragedia dell'Italia.
Ha prodotto la cultura della
rissa, dell'uno vale uno, dello scontro senza sintesi. Le stesse trasmissioni
televisive si costruiscono su format che puntano sul contrasto di opinione: vedi
i talk show. Ha creato un mondo di opinione, non di pensiero né di vero dialogo.
E il primato delle opinioni ha prodotto prima Berlusconi, poi Salvini, Renzi, i
grillini e ora Meloni, anche se lei mi sembra meno volatile e più abile».
Ma quali ambizioni realistiche
può coltivare il governo attuale, sullo sfondo che lei descrive?
«Durare due anni, e in questi
due anni usare la mediocrità italiana e tirarne fuori qualcosa di buono. Questo
è un Paese-betoniera, da governare costruendosi un apparato, una classe
dirigente. Meloni deve giocare sui tempi più o meno lunghi, non sognare i sei
mesi fiammeggianti di un John Kennedy. Il pericolo, anche per lei, è il
presentismo che ha afflitto un po' tutti in questi anni. Il presentismo dà
l'illusione di esserci, ma in realtà ci toglie la sfida dei rischi e segnala la
mancanza di tempo: senza che ce ne accorgiamo».
L’esercito dei mandarini. La
destra rozza, la sinistra retriva e le ragioni dell’arretratezza italiana.
Iuri Maria Prado su L’Inkiesta il 31 Dicembre 2022.
Quelli al governo sono
impresentabili, ma gli eredi del Pci altrettanto
Indugiare sul profilo della
destra più rozza d’Europa senza riconoscere quello della sinistra più retriva e
politicamente corrotta del mondo occidentale significa rifiutarsi colpevolmente
di comprendere le ragioni dell’arretratezza italiana, facendo le viste che il
Paese sia civilmente e sistematicamente sottosviluppato per una specie di
incomprensibile condanna cui quella sinistra assiste magari inerte, da testimone
impensierita, ma non corresponsabile.
Da ormai più di trent’anni è
coltivata la leggenda confortevole secondo cui i resti denaturati di quella
tradizione hanno garantito la tenuta degli equilibri repubblicani e
costituzionali, con la fornitura alle istituzioni di classe dirigente magari non
sempre luminosissima ma insomma capace, appunto, di presidiare in modo acconcio
la macchina dello Stato e di preservarne una qualche presentabile funzionalità.
Ma questa è la descrizione di
una virtù politica, anziché la denuncia di un difetto fondamentale, solo perché
non si considera quale oggettiva capacità di influenza sulle cose del Paese quel
mandarinato abbia profondamente esercitato.
Quel preteso merito, l’aver
cioè provveduto lo Stato e le sue escrescenze di funzionari non sempre
indignitosi, e il poter vantare che il curriculum delle istituzioni negli ultimi
decenni recava una buona somma di appartenenti a quella cerchia, per un’indagine
appena spassionata dovrebbero costituire altrettanti motivi di scoperchiante
denuncia, la constatazione che quel modo di intendere e attuare la
partecipazione all’azione collettiva rappresentava lo strumento di assoluzione
da qualunque responsabilità anziché il preteso opposto: governare la carcassa
pubblica per non governare la società, il lavoro, l’economia, la giustizia, vale
a dire le cose che fanno un Paese prima dello Stato.
Non esiste una riforma in senso
anche solo modernizzatore, nemmeno liberale, neanche una e in nessun ambito, che
abbia registrato il contributo, figurarsi l’iniziativa, della sinistra
legittimata al governo ormai da trent’anni. E non esiste un caso di involuzione
civile, di arretramento del sistema economico, delle libertà e dei diritti – e
tanti ne abbiamo avuti – che non abbia visto la partecipazione della cosiddetta
sinistra costituzionale.
Anche il più equanime
osservatore di sinistra continua a non riconoscere questa verità evidentissima,
e non lo fa perché adotta quel criterio di giudizio illusorio e ribaltato,
nell’idea fuorviante che la sinistra abbia in quel modo adempiuto a un ruolo
meritorio: aver tenuto in piedi le istituzioni repubblicane con le disattenzioni
magari effettive, ma perdonabili, proprie dell’amministratore onesto che non può
tenere a bada proprio tutto.
E il fatto che queste
disattenzioni culminassero nelle ambizioni di affascinante avventura con
l’innominabile cialtrone e nella destituzione per procura del governo Draghi,
evidentemente, è un altro scusabile dettaglio nella storia per il resto
onorevole della sinistra irrinunciabile.
L’Italia vista dagli Usa:
dibattito angusto e nodi veri. Federico Rampini su Il Corriere della Sera il
18 Dicembre 2022.
Rispetto alle emergenze che
preoccupano il mondo intero, il dibattito italiano è spesso dominato da
questioni marginali, o che ci risucchiano verso il passato
L’Italia viaggia verso il
futuro con gli occhi incollati allo specchietto retrovisore. Questa è
l’impressione che fa a chi, come me, vive negli Stati Uniti e rivolge uno
sguardo «esterno» al proprio Paese. Rispetto alle emergenze che preoccupano il
mondo intero, il dibattito italiano è spesso angusto, dominato da questioni
marginali, o che ci risucchiano verso il passato. Gli imperativi della sicurezza
nazionale in un mondo affollato di potenze ostili; le soluzioni alla nostra fame
di energia; il rilancio dell’industria nazionale nell’era post-globalizzazione:
questi temi hanno avuto una visibilità minore rispetto al Pos e alle pensioni. È
il passato che divora il futuro. È emblematica la vicenda del Pos, per chi vive
negli Stati Uniti: dove sono i piccoli esercenti a chiederti di usare la carta
di credito o la app sul telefonino, perché sono ormai passati a una contabilità
tutta digitale. In quanto alle pensioni: i due Paesi avanzati dove si lavora più
a lungo, America e Giappone, sono anche quelli che hanno meno disoccupazione
giovanile.
Non trovo traccia di una vera
attenzione nazionale alla difesa. Vladimir Putin, l’altro «uomo dell’anno»,
quello che ha cercato di trasformare il 2022 in un nuovo 1939, ha appena deciso
di accrescere il bilancio militare della Russia del 30%, un’enormità che dice
quanto la guerra in Ucraina rischi di trasformarsi in un conflitto di lunga
durata. Le nostre sanzioni non mordono abbastanza sulla Russia perché Cina e
India la foraggiano.
La collaborazione militare con
l’Iran fornisce a Putin droni e missili a volontà. L’Occidente, reduce da un
lungo letargo pacifista, per rifornire di aiuti Kiev vede i propri arsenali
difensivi assottigliarsi pericolosamente. L’America, pur alla vigilia di una
probabile recessione, aumenta a sua volta il bilancio del Pentagono del 10%. La
Cina prosegue un riarmo a tutto campo che l’ha già portata a superare la flotta
militare americana, un sorpasso inaudito fino a dieci anni fa. L’Italia cosa
vuol fare? Insieme con la Germania è uno dei Paesi che non fa neppure il minimo
essenziale per rispettare gli impegni presi con la Nato, è al di sotto del 2% di
Pil investito nella propria sicurezza. Senza una presenza militare adeguata ci
illudiamo di contare qualcosa nel Mediterraneo, dove pure si affacciano i Paesi
da cui dipenderemo ancora a lungo per il gas (in sostituzione di quello russo).
I nostri vicini nordafricani e mediorientali rispettano chi sa farsi rispettare.
L’allarme per il Qatargate è sacrosanto; va accompagnato da un’analisi lucida
sulla nuova geopolitica dell’energia.
A proposito di energia, si ha
l’impressione che gli aiuti governativi per attenuare il trauma delle bollette
abbiano attenuato anche il senso di urgenza. Viviamo in una finta tregua, i
prezzi del gas sono scesi rispetto alle punte massime, ma per le ragioni
sbagliate. Da un lato, perché abbiamo fatto incetta di gas (ai prezzi più alti
possibili) onde riempire le nostre scorte invernali, poi i nostri acquisti
all’ingrosso si sono moderati. D’altro lato il preoccupante rallentamento
dell’economia cinese riduce gli acquisti dalla nazione più energivora del
pianeta. Ma quando si tratterà di rifare le scorte per l’inverno 2023-24, noi a
che punto saremo? La Germania sta attivando il triplo dei nostri
rigassificatori, per poter comprare gas liquido da un ventaglio di fornitori
diversificato. Un ampio numero di Paesi, dal Regno Unito al Giappone, stanno
rilanciando il nucleare. Joe Biden ha varato nuove leggi — e una iniziativa
diplomatica verso l’Africa — per garantirsi approvvigionamenti sicuri nei
minerali e metalli rari indispensabili per fabbricare pannelli solari o auto
elettriche. Dove si situa l’Italia in questi movimenti strategici?
La questione energetica si lega
a quella della nostra reindustrializzazione. Il mondo entra in un capitolo nuovo
nella storia della globalizzazione. Si sta chiudendo una fase durata trent’anni
in cui l’economia mondiale era segnata dalla crescente integrazione fra
l’Occidente e la Cina. Quella simbiosi è in crisi da tempo e per diverse
ragioni, la prima in ordine cronologico fu la svolta sovranista di Pechino dal
2008 (molto prima che il sovranismo diventasse una parola in voga in Occidente).
La guerra di Putin ha accelerato il consolidamento di nuovi «blocchi». Le
aziende occidentali oggi hanno un interesse vitale ad aggiornarsi sugli scenari
strategici, per non finire dalla parte sbagliata di qualche embargo, sanzioni o
rappresaglie. Il friend-shoring, la rilocalizzazione di attività industriali in
Paesi amici, alleati o affidabili, in teoria apre delle opportunità per
l’Italia, seconda potenza manifatturiera nell’Unione europea. Sarà difficile
cogliere queste opportunità se sono proibitivi i costi energetici per chi fa
attività d’impresa in Italia. Il caro-energia si aggiunge agli handicap
burocratici e fiscali, nonché ai ritardi nella digitalizzazione.
Un altro problema nella nuova
fase della globalizzazione riguarda l’ambiente. Negli ultimi trent’anni noi
abbiamo delocalizzato in Cina non soltanto perché il costo del lavoro era più
basso là, ma anche perché volevamo allontanare dai nostri occhi e dalle nostre
coscienze ogni attività che «sporca»: compresa l’estrazione e lavorazione di
componenti essenziali per le energie «pulite». Litio, silicio, per esempio, li
vogliamo nei nostri pannelli fotovoltaici e nelle nostre auto elettriche, ma non
vogliamo sapere come e dove vengono prodotti. Altri filoni di ricerca
sull’energia del futuro — dall’idrogeno verde alla fusione nucleare — ricevono
un’attenzione sporadica, anche se fior di scienziati italiani e alcune
multinazionali italiane sono presenti in quelle sfide.
Di politica industriale, delle
condizioni per attrarre o riportare sul suolo italiano eccellenze produttive, si
è parlato poco. Nulla in confronto all’attenzione smisurata verso una flat tax
riservata a categorie limitate di autonomi e professionisti. La «perma-crisi» di
oggi non è più grave di quella degli anni Settanta, quando il primo shock
energetico colpì un’Italia già stremata da alta conflittualità sociale e
terrorismo. Le crisi possono servire a innovare. Altrove, gli anni Settanta
diedero un impulso alla ricerca sull’auto elettrica e l’energia solare. Dobbiamo
evitare che anche questa crisi generi opportunità solo «altrove».
Francesco Specchia per “Libero
quotidiano” il 19 dicembre 2022.
Di Federico Rampini - al di là
dell'educata ipocrisia dell'ambiente giornalistico ogni cronista medio invidia
almeno tre cose. La grande capacità di analisi (anche in lingue diverse); i
capelli elettrici che fanno il paio con i pensieri; la tendenza al multitasking
che lo fanno esser scrittore di vari libri al ritmo delle stagioni e, al
contempo, pregiata firma prima di Repubblica, ora del Corriere della sera.
Se ci aggiungete che a Milano,
Rampini, si butta, assieme al figlio Jacopo sulle "Lezioni di geopolitica",
teatro civile specchio del tempo, bè l'invidia diventa quasi ammirazione (ah,
aggiungerei anche quelle bretelle rosse...)
Caro Rampini, nello spettacolo
che mettete in scena richiami il tuo saggio "Suicidio occidentale" (Mondadori).
Ricco di argomentazione incontestabili, ma un tantino apocalittico. Dopo
"l'aggressione di Putin all'Ucraina spalleggiato dalla Cina", qual è la cosa
peggiore che ci è capitata: la cancel culture, l'ambientalismo estremo,
l'alleanza fra capitalismo e Big Tech, Greta Thunberg e Carola Rakete?
«Tutto si tiene nel "Suicidio
occidentale". Le élite che comandano nei social media, a Hollywood o
nell'accademia, demoliscono l'autostima dell'Occidente e descrivono la nostra
civiltà come l'Impero del Male.
Questo ci rende impotenti verso
gli imperialismi altrui. L'alleanza fra poteri forti del capitalismo Big Tech e
di Wall Street abbraccia le cause politicamente corrette, "include" ogni
micro-minoranza e promette di "salvare il pianeta" per rifarsi una verginità
etica e cancellare la grande questione sociale, le macro-diseguaglianze
fabbricate da un trentennio di globalizzazione che ha sventrato la classe
operaia e impoverito il ceto medio.
L'Apocalisse dell'ambientalismo
adolescenziale e anti-scientifico ci ha fatto commettere errori nelle politiche
energetiche».
Tu citi il complesso di "colpa
razziale collettivo" e la mutazione del Columbus Day attraverso gli occhi di una
bimba italoamericana di oggi. Avevi previsto questo futuro per tuo figlio? E
come s' è immerso lui, da attore, nella realtà che descrivi? Non vi sentite un
po' come la famiglia Angela?
«Con Jacopo avevamo fatto uno
spettacolo di successo, "Trump Blues" che esordì al Festival di Spoleto nel
2017. Stasera al Teatro Carcano di Milano faremo un reading di testi.
Lui da italo-americano ha
vissuto sulla propria pelle le nuove dinamiche della società multietnica Usa,
ivi compresa la trasformazione di status degli italo-americani che racconteremo
a partire dal Columbus Day. In quanto alla famiglia Angela, ebbi il privilegio
di conoscere Piero e ammiro il figlio. Il nostro caso è diverso perché Jacopo ha
cominciato la sua carriera di attore a New York».
Sfatate i luoghi comuni della
sinistra universale a partire dalle idee della Ocasio Cortez. E affermate che
gli immigrati non facciano bene all'economia; e che, anzi, ridotti i flussi
migratori i salari aumentano. Lo hai detto ai tuoi amici democratici?
«Da quando i flussi migratori
verso gli Stati Uniti si sono ridotti - per l'effetto congiunto delle politiche
di Trump che Biden ha proseguito, più la pandemia - i salari degli operai in
America sono aumentati come non accadeva da quarant' anni. L'immigrazione
incontrollata l'hanno sempre voluta i capitalisti: lo scriveva un certo Karl
Marx nel 1870 a proposito della questione irlandese».
Epperò, scusa, io continuo a
percepire pessimismo. Come possiamo uscire da questa fase di "suicidio
occidentale"?
«Stiamo già sviluppando degli
anticorpi. La reazione contro il politicamente corretto in America è cominciata
dentro quelle minoranze etniche che le élite radical chic dicono di difendere.
Gli afroamericani hanno eletto come sindaco di New York un black che è stato
capitano di polizia e promette di riportare l'ordine in città, perché quando
dilagano le gang sono i più poveri i primi a pagare.
I latinos non approvano che
nelle scuole s' insegni un'educazione sessuale che comanda di rimettere in
discussione la propria identità di genere. Gli immigrati, quando sono entrati
nel rispetto delle regole, respingono la sinistra "no-border" e gli appelli di
Alexandria Ocasio-Cortez per abolire ogni controllo sull'immigrazione».
Sei cresciuto a Bruxelles in
ambiente diplomatico, hai conosciuto la grande Europa dei Popoli. Oggi c'è
l'Europa della "Gauche Qatar", della speculazione sul gas, della Germania che
scatta in avanti col suo scudo da 200 miliardi, della Francia che ci accusa di
meschinità ma ricaccia indietro i migranti. Cosa è successo negli ultimi trent'
anni?
«L'Unione europea si è sempre
costruita su compromessi tra interessi nazionali.
Più complicati nell'Europa a 27
che nell'Europa a 6 di quando io abitavo a Bruxelles. Forse non diventeremo mai
una Unione federale come gli Stati Uniti, ma intanto faremmo meglio ad essere un
po' meno ingenui: il Qatargate dimostra che siamo diventati terra di
colonizzazione da parte di potenze straniere, che hanno capito di poterci
influenzare.
L'antiamericanismo dilagante in
Italia ha effetti paradossali: tanti hanno gridato che l'Europa si faceva
manipolare dagli Stati Uniti, ma intanto era il Qatar (e chissà quanti altri) a
corrompere le nostre istituzioni».
La Questione morale per la
sinistra non è un paradosso? E se lo è, perché non scatta mai l'esame di
coscienza? Qui ancora si dà la colpa alle lobby, il cui controllo a Bruxelles,
tra l'altro mi pare rigorosissimo...
«Un esame di coscienza doveva
scattare non appena Eva Kaili fece quel discorso infame in cui promuoveva il
Qatar sui diritti umani, e affermava che l'Occidente non ha lezioni da dare sul
trattamento degli immigrati. Tipico suicidio occidentale. Però, il controllo
sulle lobby è più rigoroso a Washington. Gli europei sono sospettosi sulle lobby
che rappresentano l'industria privata e non abbastanza sulle interferenze di
governi stranieri, soprattutto quelli dell'Oriente e del Sud del pianeta».
Parli di "suicidio
occidentale", ma forse anche la Russia è su quella strada. Con tutti i soldi che
spende per la guerra ogni giorno, Putin non faceva prima a corrompere
l'Occidente (o forse lo stava già facendo, e il delirio di onnipotenza,
all'improvviso, ha preso il sopravvento?)
«Putin è la dimostrazione che
anche gli autocrati sbagliano, e quando sbagliano sono meno veloci nel
riconoscere e correggere gli errori, rispetto alle democrazie».
Nel tuo nuovo libro "Il lungo
inverno" sostieni che, in realtà, il resto del mondo non sia affatto coalizzato
contro Putin. E che da India, Cina, Brasile, Asia e Golfo Persico che non
condividono le nostre sanzioni, si stia formando un nuovo blocco
antioccidentale. Quanto è pericoloso tutto questo?
«Siamo nel sequel della prima
guerra fredda. È rinato il movimento dei non allineati, che non si schiera e
vuole continuare a fare affari con tutti. È pericoloso perché stiamo
abbandonando tante nazioni emergenti all'influenza cinese, non osiamo
contrastarla».
Giorgia Meloni sostiene
fieramente l'invio delle armi in Ucraina, e dice che fermando i russi abbiamo
evitato anche di consegnarci alla Cina. Condividi?
«La continuità da Draghi a
Meloni è positiva. Ora bisogna trarne le conseguenze con l'aumento della nostra
spesa militare».
Ne "Il lungo inverno", ricordi
cos' erano negli anni 70 l'alta inflazione e il costo del denaro. Siamo a quei
livelli? Ma i mercati, oggi, non hanno fiducia in questo governo?
«L'inflazione ha colto di
sorpresa le banche centrali. Sono la Fed e la Bce che devono riconquistarsi la
fiducia dei mercati. Sarà doloroso».
La Ue ha approvato la nostra
manovra, con qualche dubbio sulla delega fiscale (mancata revisione degli estimi
catastali, tetto al contante e al Pos). Eppure l'opposizione si lamenta; pure se
ben nove altri Stati Ue hanno visto le loro leggi di bilancio "non in linea con
le raccomandazioni Ue" (Germania compresa). Dobbiamo esser soddisfatti o no?
«Certe osservazioni della
Commissione sono sensate. E' sbagliato ridurre la pressione fiscale solo sul
lavoro autonomo, è l'intera economia nazionale ad aver bisogno di meno tasse e
di una burocrazia fiscale meno persecutoria. L'età pensionabile va allungata, in
linea con l'aumento della longevità».
La Cina è vicina davvero? O, il
congelamento della Via della Seta rivela che gli anticorpi democratici
dell'Occidente sono, in fondo, meglio di quel che si pensava?
«L'Occidente sta finalmente
aprendo gli occhi sulla minaccia cinese, anche perché Xi Jinping pratica
l'arroganza più del soft power. Ma non sarà facile liberarci dalla nostra
dipendenza verso la Cina, tra l'altro riguarda tutte le cosiddette tecnologie
verdi, dai pannelli solari alle batterie per auto elettriche. Il problema è che
non vogliamo sporcarci le mani con tanti mestieri industriali...».
Invidiosi e Rinnegati.
L’Identità.
I Carrozzoni.
La Disuguaglianza.
Divari e ritardi.
Mantenuti.
Cervelli in fuga.
Il Costo della Vita.
L’Illecito Finanziamento.
I Medici.
Le Pensioni.
L’Autonomia Differenziata.
Invidiosi e rinnegati.
Mirko Giangrande. TERRORISMO TURISTICO SULLA
PUGLIA
Ormai, come ogni anno, all’indomani dell’uscita
dei dati sul turismo pugliese, che attesta il boom di presenze turistiche,
accertate anche dai dati sugli arrivi nelle nostre stazioni, porti e aereporti,
arrivano, puntuali, le reazioni da parte di chi, questo successo, proprio non va
giù. E la fantasia è proprio tanta! Di anno in anno, siamo passati dall’allarme
meduse all’allarme criminalità, da quello dei disservizi a quello, attuale, del
caro - prezzi. Tutto, pur di mettere in cattiva luce la nostra terra.
Propalazioni di gente che, magari, da noi non ha mai messo piede. Altrimenti lo
saprebbe che il rincaro è un fenomeno nazionale e non di certo solo pugliese; lo
saprebbe che, come ovunque, non bisogna mai generalizzare perché non si possono
paragonare posti esclusivi di località rinomate a tutto il resto del territorio;
lo saprebbe che il turista per forza di cose deve pagare un surplus sui prodotti
locali perché i pugliesi fanno turismo, non beneficenza!
E non so se mi fanno più pena i meridionali che,
senza ragionarci su, masochisticamente danno adito a queste notizie (e magari le
condividono pure) o chi, pieno di un’ingiustificata superbia, viene in vacanza
da noi sicuro di farci solo un favore. La Puglia è bella e le cose belle si
pagano. Non siamo una terra per TIRCHI.
Quindi quest’anno, oltre alla crema solare, per
qualcuno consiglio il Gaviscon.
Facebook: Stato Magna Grecia - Due Sicilie
GUERRA ECONOMICA AI DANNI DEL SUD: Il classico
autogoal all’italiana: un articolo che suona come un insulto allo straordinario
lavoro della Puglia, negli ultimi 20/30 anni, per la qualità e
l’internazionalizzazione del suo turismo.
Un modo a dir poco elegante, medievale, quello
scelto da un quotidiano di Milano, città di alta cultura, per dipingere una
realtà dai colori certamente più vivi.
Il turismo in Puglia è tanta qualità: patrimonio,
cultura, mare magnifico, cucina sublime, musica e tanto altro.
La Puglia è meta di vacanze per donne e uomini
delle istituzioni, stars del cinema, sportivi/e di livello mondiale e tante
altre personalità fortunatee
Il livello del turismo in Puglia si è alzato
considerabilmente così come i prezzi, in alcune località di punta.
Per il Corriere della Sera e non solo, ciò che è
pura normalità a Portofino, a Venezia oppure a Forte dei Marmi, diventa uno
“choc” in Puglia, dove i turisti vengono “spennati”.
Mai letto su Le Monde, Les Échos o Le Figaro,
titoli di simile rozzezza riguardo ai prezzi di Nizza, Deauville o dell’Île de
Ré, per citare alcuni esempi comparabili.
Buone vacanze in Puglia , nel pieno rispetto di
coloro che lavorano duramente in estate, soprattutto in territori dove esistono
gravi ostacoli, ahimè ben noti, per la vita delle piccole imprese.
Scontrini folli, la calda estate: 30 euro per
un caffè a Porto Cervo. Storia di Elvira Serra su Il Corriere della Sera
domenica 27 agosto 2023.
L’estate degli scontrini più pazzi del mondo non è
ancora finita e le segnalazioni alle associazioni dei consumatori continuano a
fioccare. A Roma in centro si registrano due euro a fetta per il taglio della
torta di compleanno portata da fuori («40 euro in tutto», racconta Luigi De
Rossi, presidente di Giustitalia); in un Autogrill del Lazio per un «Bufalino»
con prosciutto e mozzarella ne hanno chiesti 8,10 («Due panini e due caffè 21
euro»); sette euro per un limoncello sul lungomare di Rimini («Al ristorante te
lo offrono gratis a fine cena...»); a Porto Cervo 4,50 per un caffè «gratinato»,
cioè con il ghiaccio. De Rossi, lo stesso al quale due turisti
fiorentini avevano segnalato due panini con il salame e due caffè pagati 18 euro
senza lo scontrino in un chiosco di San Teodoro, in Sardegna, parla di effetti
dell’inflazione, ma anche di uno spudorato «approfittarsi del turista, contando
sul fatto che magari non tornerà». Pure Furio Truzzi, di Assoutenti, denuncia
chi «sta lucrando sulle vacanze». E cita come esempio il famigerato caso
dell’osteria di Finale Ligure, presa poi di mira su TripAdvisor, dove sono stati
chiesti 2 euro per il piattino in condivisione: «A me di quella storia ha
colpito che le trofie al pesto costassero 18 euro: per quanto la materia prima
sia dop, parliamo sempre di basilico, pinoli e olio...». Redditi fissi e rincari
incontrollati secondo lui hanno prodotto come unico risultato vacanze più corte.
E, di fatto, più «condivisioni» a tavola. Di qui gli stratagemmi degli esercenti
per battere cassa.
Caffè
L’euro e cinquanta chiesto vicino ad Alba per
mangiare in due una crema catalana è uno dei più assurdi, perché non si capisce
l’impatto di un cucchiaino sui consumi della lavastoviglie. E lasciano perplessi
anche i 10 centesimi per decorare un cappuccino a Erba (anche se la titolare ha
precisato che non è polvere di cacao, ma sono spezie). Di sicuro ci siamo
scordati i sontuosi 100,80 euro spesi in piazza San Marco dieci anni fa per 4
caffè (di cui uno corretto) e tre amari: lì però a pesare sullo scontrino fu il
«supplemento musica» di 42 euro: sei euro per ognuno dei sette avventori.
Comunque anche oggi sul fronte caffè resta da sbizzarrirsi: a Ostia il
cappuccino con il «latte freddo» può costare dieci centesimi in più, perché il
barista deve mettere più latte (altri ne chiedono 20 in più se il caffè è
«schiumato»); a Pesaro il caffè con ghiaccio è costato un euro e 50; anche
nel Golfo di Policastro sono stati segnalati casi di cubetti di ghiaccio a 50
centesimi. Altri numeri rispetto ai 60 euro per due caffè e due bottigliette
d’acqua a Porto Cervo. Ma volete mettere la giustificazione dei gestori? «Non è
un semplice caffè, è un’esperienza!».
Puccia e frisella
Che poi uno i 60 euro in Costa Smeralda li può
mettere in conto: se li conosci, li eviti. Fanno più effetto la puccia e la
frisella a 26 e 16 euro nel Salento, o la panzanella a 16 euro in piazza Duomo a
Firenze (pane, pomodoro, cipolla, aceto e basilico). Raffaele Madeo, però, il
presidente dei ristoratori di Tni, Tutela Nazionale Imprese, prima di Ferragosto
era sbottato: «Basta mettere in croce l’intera categoria per due o tre
scontrini. Sono casi isolati e comunque ogni ristorante ha i prezzi ben visibili
sui menu. Perché nessuno dice che la farina è aumentata del 200% e la mozzarella
del 60?». I prezzi di frutta e verdura sono triplicati. Lo fa notare Luca
Vissani, amministratore unico di Casa Vissani, dove questa estate i prezzi dei
menu sono stati abbassati del 10 per cento, ma è stata tolta anche una portata:
prima si partiva da quattro piatti salati più il dolce a 140 euro, ora da 125
con tre salati più il dolce. Dice: «I locali si reggono sui business plan: se su
40 posti mangiano in venti, un ristorante non regge».
Toast e pizze
Per certo, di questa lunga estate calda che ci è
valsa sulla Cnn il titolo sulle «oltraggiose fregature» ai turisti, ricorderemo
il supplemento di 2 euro per dividere un toast a Gera Lario, sul lago di Como, e
i 70 centesimi per un bicchier d’acqua di rubinetto, «ma filtrata», a San Vito
al Tagliamento (Pordenone). Resteranno pure le stoccate degli esercenti. Come
Simone Di Maria, ristoratore genovese criticato per tre pizze a 60 euro. La sua
risposta social: «Prenotazione per 8, due bimbi e sei adulti maleducati come
pochi, tre pizze divise in otto piatti, acque, due bibite, tre birre e 4 caffè.
Totale 63 euro, meno di 8 euro a persona». In questo clima di caccia alle
streghe, c’è chi ha pubblicato uno scontrino del ristorante Catanzaro, dove due
pizze e due birre le fanno pagare 235: peccato che siano dihram marocchini, vale
a dire 21 euro e 50. Poi ci sono i «creativi» del caffè a 70 centesimi, purché
ti porti da casa tazzina, cucchiaino e zucchero. Succede nel Savonese. Ma a 200
chilometri di distanza, nel Biellese, lo fanno pagare allo stesso prezzo e alla
vecchia maniera. «Ho fatto i conti e ci sto dentro. Perché aumentare?», ammette
Orlando Paldino, del «Fante di cuori» di Cossato.
L’Unc
Massimiliano Dona, a capo dell’Unione Nazionale
Consumatori, non critica a priori gli esercenti. Spiega: «Se uno ordina un
cocktail che sulla carta costa 10 euro e poi lo paga 13 perché il cameriere non
ha specificato che poteva essere fatto con un gin più caro, ha ragione il
cliente. Ma se uno si lamenta perché ha dovuto pagare il taglio della torta, è
lui a sbagliare. Esiste il diritto di tappo: cioè, ci si può portare da casa la
bottiglia di vino, ma si deve riconoscere al ristoratore il corrispettivo per
averlo versato e servito». Stesso discorso sulle mezze porzioni, che adesso
costano anche il 70 per cento del prezzo intero e non la metà: «I tempi di
cottura e l’impiattamento sono identici». Fa, invece, proprio un errore di
calcolo chi si fa pagare un piattino o un cucchiaino in più. «Serve solo a farti
salire ai disonori della cronaca: è cattiva pubblicità».
Bar più economico d'Italia, caffè a 30
centesimi: "I turisti pensano ci sia un errore". In un'estate di scontrini
pazzi, emerge un bar che è risultato essere il più economico in Italia, con
caffè a 30 centesimi. Chiara Nava su Notizie.it Pubblicato il 25 Agosto 2023
Nel pieno dell’estate degli scontrini pazzi, dei
conti raddoppiati e dei sovrapprezzi assurdi, è emerso un bar che è risultato
essere il più economico in Italia.
Il bar più economico d’Italia, caffè a 30
centesimi: ecco qual è
Nell’estate degli scontrini pazzi, dei conti
raddoppiati e dei sovrapprezzi assurdi, esiste un bar in cui il caffè costa solo
30 centesimi, come raccontato da Il Corriere della Sera. Si trova ad Alia, in
Sicilia, ed è il Bar Pasticceria Rosticceria Perrone, attivo dal 1973. Negli
anni Settanta Bernardo Perrone è stato il primo a portare nel luogo l’idea di
catering, mettendo su un laboratorio e occupandosi delle cerimonie. I matrimoni
non mancavano ed erano in perfetto stile siciliano. Visto che in città erano
presenti solo due bar, decise di aprirne uno, in uno spazio di fronte a quello
attuale, con il prezzo del caffè più basso. Il prezzo stabilito era di 20 lire e
l’idea funzionò. Ora alla cassa c’è la nuora, Mariagrazia d’Amico, seconda
generazione nell’attività di famiglia. Il marito Giuseppe Perrone lavora nel
laboratorio per fare i dolci con il figlio Bernardo e la figlia Tecla è dietro
al banco.
Il bar più economico d’Italia: i cambiamenti nel
tempo
Intanto il prezzo della tazzina è aumentato. Alla
fine della lira ne costava 300 poi è diventato 20 centesimi con l’arrivo
dell’euro, fino alla pandemia. “Con l’asporto ci costavano più gli accessori
della bevanda, tra bicchierino, tappo, cucchiaino, bustina di zucchero: ci siamo
trovati costretti a chiedere di più” ha spiegato la donna. Il costo è diventato
di soli 30 centesimi. Nel corso del tempo le bollette sono aumentate, ma loro
non vogliono rinunciare all’idea geniale del fondatore. “Il nostro motto è:
meglio perdere, che perdere il cliente” ha dichiarato la donna. L’idea continua
a funzionare, visto che il Perrone consuma sei chili di caffè al giorno, ovvero
857 tazzine quotidiane. Spesso raggiungono anche i nove chili. Il menù è unico
come prezzi: caffè espresso a 30 centesimi, caffè freddo a 60 centesimi, caffè
macchiato a 40 centesimi, caffè corretto a 80 centesimi e cappuccino ad 1 euro.
Il bicchiere d’acqua e il servizio al tavolo è compreso. Il bar è sempre pieno
di clienti e i turisti spesso arrivano alla cassa e pensano ci sia un errore.
“Lavoriamo tutti tutto il giorno, da mattina a sera, ieri sera abbiamo chiuso
alle due, e vogliamo farlo con qualità, con i prodotti buoni, con artigianato
fatto bene” ha spiegato il pasticcere.
Albania, la verità sulle vacanze low cost:
quello che nessuno dice. Ignazio Stagno su Libero Quotidiano il 26 agosto
2023
Vacanze d’Albania. La prima parte di questa
rovente estate 2023 è stata accompagnata dagli “spot” sui social di connazionali
che, a colpi di video e post, hanno raccontato il nuovo eldorado delle ferie:
per l’appunto l'Albania, dai servizi impeccabili e dai prezzi molto contenuti
rispetto all'Italia. Per almeno tutto luglio e la prima metà di agosto ci siamo
sorbiti il racconto di questo paradiso per il portafoglio, al punto da mettere
in discussione anche il primato delle isole della Grecia, quelle meno note, che
per anni hanno rappresentato la meta low cost per chi partiva dall'Italia.
Pranzi e cene a 20 euro a testa, lettini e ombrelloni tra i 10 e i 25 euro,
noleggi d'auto “regalati” e tutto «alla faccia di chi fa le vacanze in Italia».
Qualcosa però è cambiato. La faccenda negli ultimi giorni si è ribaltata. Sui
social, da Facebook a Instagram passando per Tik Tok, abbondano i racconti di
chi, in Albania, si è fatto spennare o ha vissuto delle vacanze da incubo.
La meta più discussa nei trend dei social è
Saranda. E proprio da lì arriva lo sfogo di Rocco su Tik Tok. Lui, turista
italiano in trasferta, è salito a bordo della "Nave pirata" per un giro (in
giornata) davanti alle coste albanesi: «La nave aveva 100 posti, ma a bordo
eravamo 300 - spiega -. Il viaggio è durato 5 o 6 ore e metà delle persone è
rimasta in piedi. Tra loro c'erano tantissime coppie di ragazzi con bambini,
anche di pochi mese. Noi avevamo una panca e ci siamo stretti per far sedere una
coppia di ragazzi napoletani, altrimenti avrebbero dovuto fare il viaggio in
piedi». E ancora: «Nauseati dalla puzza del carburante, ci siamo ritrovati al
centro di uno schiuma party e io sono caduto a terra, rischiando di sbattere con
la testa». Poi la sentenza finale: «Sconsigliatissima».
Ed è solo uno dei tanti. C’è chi si lamenta per il
costo di un set di due lettini e ombrellone nella spiaggia di Pulebardha Beach:
«Abbiamo chiesto un ombrellone e due lettini e ci è stato risposto che se
avessimo pranzato al ristorante della spiaggia il prezzo sarebbe stato di 2500
lek (circa 25 euro), mentre senza pranzo di 3000 (30 euro). Ma da quando i
prezzi variano in base a questa scelta?», racconta Flavia. Poi aggiunge:
«Ombrelloni ammassati l’uno sull’altro, si vede che – continua il racconto della
turista – cercano di sfruttare al massimo queste strutture nel bel mezzo della
natura. Noi alla fine abbiamo deciso di pranzare al ristorante, pagando 5 euro
in meno per l’ombrellone e i lettini. Ma anche al ristorante regnava il caos.
Tanto che avevamo ordinato anche un’orata ma alla fine abbiamo chiesto di non
portarla perché stavamo aspettando da troppo tempo». Poi, sempre sui social, c’è
chi racconta di caffè pagati a 4,50 e anche chi ha pagato ben 200 euro per un
gazebo. E monta la rabbia: «Sponsorizzato ovunque da video fatti da
“influencer”, ma la realtà è completamente diversa. Spiagge piccole piene di
ombrelloni e sdraio ovunque, ghiaia al posto della sabbia portata da appositi
camion, acqua torbida, moto d’acqua che corrono a destra e sinistra tutto il
giorno con annessa puzza di gas. E ancora maleducazione, guidano male e c’è
sempre traffico», spiega un turista italiano. E c'è anche spazio per una
lamentela anche sui pagamenti: «Il pos è visto come il diavolo, prezzi molto più
alti delle aspettative, a Ksamil un ombrellone e 2 lettini li abbiamo pagati da
25 a 50 euro al giorno. Non torneremo mai più». E un altro turista, Luca,
racconta a Libero la sua esperienza sempre a Ksamil: «Sono partito dalla Sicilia
per godermi le vacanze in Albania. Del resto le premesse c’erano tutte, tariffe
molto più basse rispetto all’Italia. Ma quando sono arrivato lì ho capito come
stanno davvero le cose. Il lido aveva gli stessi prezzi di uno italiano in una
località top, ho pagato 50 euro. Ma c’erano set anche ben più costosi, intorno
ai 100 euro. Il costo del noleggio dell’auto è stato anche esorbitante, 90 euro
al giorno. Ho provato questa esperienza anche perché influenzato dai social, ma
per il prossimo anno, a parità di costi, mi godo il mare della mia Sicilia.
Magari torno a Cefalù dove i servizi sono all’altezza di quanto spendi».
Insomma, non è certo il paradiso in terra per i vacanzieri, ma come in tutte le
cose, conta molto l'esperienza personale e magari anche la fortuna. Però quel
ritornello di inizio estate che narrava di una Albania come cura per il caro
prezzi in Italia, comincia a fare acqua...
Facebook: Michele Eugenio Di Carlo è con Giovanni
Saitto e altri 85
Carissimi, ho appena scritto questo post:
"Ho la vaga impressione che alcuni giornali del
Nord spingano i turisti a lasciare la Puglia per l'Albania". Essendo stato
inondato da commenti spesso in antitesi e non avendo il tempo di replicare a
tutti, rispondo con questo nuovo post, cercando di chiarire quello precedente:
La comunicazione politica dai toni populistici,
divisivi, ultimativi, definita dagli esperti di marketing politico “liquida”,
tesa in maniera spasmodica alla continua ricerca di un consenso elettorale
effimero, facendo leva più sull’emotività che sulla razionalità, si è fortemente
insinuata nell’ambito dei social, ma si è anche avvalsa di una potente rete di
media nazionali tramite i normali canali di divulgazione televisiva e alcuni dei
maggiori giornali italiani, che hanno contribuito anche ad alimentare non pochi
luoghi comuni e pregiudizi che presentano il Mezzogiorno con un’ottica distorta.
Da quest’ultimo punto di vista, non solo
l’informazione politico-mediatica “liquida” ha fatto scuola, anche il sistema
pubblico dell’informazione ha contribuito decisamente a far percepire il
Mezzogiorno come un’area dalle problematiche irrisolvibili.
Infatti, i docenti universitari di sociologia dei
processi comunicativi Stefano Cristante e Valentina Cremonesini, in un testo
pubblicato nel 2015 (La parte cattiva dell’Italia. Sud, media e immaginario
collettivo), hanno reso noto i loro studi statistici: il TG1 della RAI, negli
ultimi 35 anni, ha dedicato solo il 9% delle notizie al Mezzogiorno e quasi solo
per parlarne male: cronaca nera, criminalità, malasanità, meteo. Tralasciando le
statistiche di giornali e tv di proprietà privata che mettono quotidianamente in
cattiva luce il Mezzogiorno, colpisce nello studio dei due studiosi che anche il
Corriere della Sera e la Repubblica abbiamo dedicato spazi esigui al Sud,
passando dai 2000 articoli del ventennio 1980-2000 ai 500 del decennio
2000-2010, occupandosi quasi solo di metterne in rilievo i mali e ignorandone
sistematicamente gli estesi e avanzati processi culturali nel mondo dell’arte,
della musica, del cinema, della cultura in generale.
C’è una convergenza perfetta, e sospetta, tra il
potere politico-finanziario nord-centrico e i media negli ultimi 35 anni.
Tornando alla comunicazione politica “liquida”, è
indubbia la preoccupazione che essa genera visto che occupa una fascia
importante dell’informazione che conta, peraltro quasi totalmente accentrata
nelle mani di poteri politici-finanziari di parte sia dal punto di vista
politico sia dal punto di vista geografico e territoriale, creando nelle
popolazioni con una vera e propria operazione di distrazione di massa continue
ansie, paure, incertezze, odio verso nemici spesso immaginari e nei confronti
della parte debole e abbandonata del paese: il Mezzogiorno.
Buona parte della televisione italiana ha da anni
inaugurato una comunicazione dominata dalla presenza di una ventina di
commentatori a vario titolo onnipresenti (politici, intellettuali, giornalisti,
sociologi, economisti), che impongono con un linguaggio urlato, supponente,
arrogante le posizioni politiche, culturali, economiche pretese da chi finanzia,
gestisce e produce il talk show televisivo. Talk show che ha, tra gli altri, il
fine di produrre profitti attraverso le sponsorizzazioni.
Ed ecco che commentatori politici e non, dai
curriculum dilatati e spesso improbabili, vengono messi su di un piedistallo e
diventano famosi, al prezzo di assolvere l’unico ruolo per il quale sono stati
selezionati: dare sempre e comunque ragione al conduttore, urlando e sbraitando
selvaggiamente contro chiunque dissenta dalla scontata e spesso squallida linea
redazionale, trovando sempre il conforto e il supporto di un pubblico plaudente
a comando che alimenta la percezione in telespettatori, spesso sprovveduti, che
quello sia il modo onesto e persino serio di affrontare problematiche spesso
inventate di sana pianta. E’ così che molti cittadini italiani hanno assorbito
odio e paranoie, convincendosi attraverso il supporto di statistiche spesso non
certificate che la delinquenza sia aumentata, che gli stupri siano compiuti da
un’etnia particolare, che i clandestini siano il primo problema in Italia, che
vi sia in atto una sostituzione etnica e religiosa, che le case popolari siano
assegnate a profughi ed extracomunitari, che chi affoga in mare se la sia
cercata, che il Sud è la palla al piede dell’Italia e, in questi tempi di
emergenza sanitaria, che i meridionali non rispettino le regole, mentre viene
continuamente evidenziato che le carenze strutturali della sanità meridionale
sono sempre e solo questione di mafia, di amministratori incapaci, di mentalità
sottosviluppata della gente.
Mai che, oltre alle gravi responsabilità di una
classe politica meridionale incapace di governare il proprio territorio, vengano
rivelate le responsabilità precise di governi nazionali, di destra e di
sinistra, che hanno deciso con scelte politiche chiare di non ridurre il divario
Nord-Sud e di non affrontare di petto la questione mafia, alimentando e
aggravando i fenomeni di degrado, di abbandono, di miseria, l’emigrazione e lo
spopolamento di intere aree territoriali.
Ma come siamo arrivati ad una televisione del
genere? Una televisione in cui i conduttori e gli ospiti fissi esercitano spesso
un ruolo decisivo nell’influenzare l’opinione pubblica al servizio di interessi
particolari (finanziari, politici, promozionali), esulando dalla funzione di
intrattenere il pubblico dando un’informazione corretta e certificata con dati
chiari.
Una televisione che non va assolutamente
sottovalutata perché, seppur spesso non avente un grande seguito, taluni talk
show vengono continuamente rilanciati sui social da referenti politici di
riferimento e da sponsor raggiungendo decine di milioni di persone e riuscendo a
rappresentare nella percezione comune una realtà distorta, spesso fingendo di
colpire le élite mentre ne sono lo strumento, amplificando la voce di personaggi
da macchietta per confutare e confondere quella di veri intellettuali ed
esperti, facendo persino passare le vittime come delinquenti beneficiati e i
delinquenti come vittime.
Cosa fare di fronte allo scempio informativo e al
disastro culturale imposto da queste trasmissioni dal potere politico-mediatico
fortissimo?
Estratto dell’articolo di Repubblica del 10
ottobre 2022
Con Luigi Di Maio "abbiamo fatto insieme
un'operazione di contrabbando" di vaccini anticovid: a raccontarlo è stato il
primo ministro dell'Albania, Edi Rama, che ieri a Bergamo è intervenuto
all'evento 'La Cultura salverà il mondo', alla presenza anche del responsabile
della Farnesina. "Racconto oggi una cosa che nessuno sa", ha iniziato Rama. "Se
io sono un albanese-italiano, Di Maio è un napoletano-albanese, abbiamo fatto
insieme un'operazione di contrabbando. Che italiano o albanese sei, se sei
sempre in linea con la legge?".
Rama ha detto che nel periodo in cui il Covid
colpiva duramente l'Albania "non avevamo nessun vaccino e la pressione era
altissima. La gente aveva paura di morire come pesci fuori dall'acqua ma non
potevamo avere il vaccino. Ho chiesto a Luigi: ci potete dare un quantitativo
simbolico ma per noi importante per cominciare a fare i vaccini a medici e
infermieri?". "Pfizer aveva un contratto imperialista, capitalista: io do i
vaccini a te ma tu non li puoi dare a nessuno. Una cosa tutt'altro che
cristiana". Luigi ha detto: non possiamo farlo perché facciamo una cosa
gravissima. Ma l'abbiamo fatto tramite un'operazione con i servizi segreti. Una
cosa incredibile, il ministro degli Esteri dell'Italia e il primo ministro
dell'Albania che passavano della merce di contrabbando per salvare delle
persone".
(...) Gli avvocati di Pfizer minacciavano cause e
volevano sapere come li avevamo avuti, ma noi dicevamo solo: da un Paese amico".
E quando chiedevano quale Paese "io ho detto. Sapete, abbiamo imparato dai
napoletani che non bisogna mai mollare un amico davanti alla polizia e così io
non mollo l'amico". "Adesso avrai i giornali che diranno addirittura un
contrabbandiere", ha aggiunto Rama, che ha infine rassicurato Di Maio in merito
a eventuali polemiche: "Luigi, ormai sei un uomo libero".
(ANSA mercoledì 9 agosto 2023. ) - Il premier
albanese Edi Rama ironizza sui social, pubblicando le della nave Vlora con 20
mila migranti albanesi verso l'Italia 30 anni fa in contrapposizione con il
grande esodo dei turisti italiani che in queste settimane stanno raggiungendo le
spiagge dell'Albania per le ferie.
"E aspetta aspetta, non hai ancora visto niente",
scrive nel post Rama che sembra sottolineare l'esodo anche alla luce del
caro-vacanze in Italia, a cominciare dalla Puglia.
Proprio ieri ricorreva il 32/o anniversario
dell'arrivo a Bari, nel 1991, della prima nave dall'Albania, la Vlora appunto,
con circa 20 mila migranti albanesi a bordo.
Il mercantile proveniente da Cuba stava per fare
tappa a Durazzo con un carico di zucchero di canna quando la folla in porto lo
costrinse a dirigersi in Puglia. Seguirono aspre polemiche sull'accoglienza dei
migranti.
Estratto dell’articolo di Letizia Tortello per “la
Stampa” giovedì 10 agosto 2023.
«Sì, siamo un po' l'Italia degli Anni 50. Dopo
trent'anni, ci togliamo di dosso lo stigma dell'immigrato e basta. Ma l'Albania
cerca di imparare dai vostri errori». Mentre il premier Edi Rama si sta
riposando, giusto qualche giorno, nella casa delle vacanze a Dhermi, l'aeroporto
della capitale albanese non dorme mai.
Sbarcano 200 voli tra giorno e notte, senza
contare il trasporto via terra o dal mare. Tutti pazzi per la riviera più
battuta dell'estate 2023. Da Scutari, nell'Adriatico, a Saranda e le isole
Ksamil giù nello Ionio, i prezzi bassi delle case dei pescatori si affiancano ai
resort e ai macchinoni guidati da giovanissimi albanesi residenti all'estero.
Il leader socialista si gode il riscatto del Paese
e posta perfino un meme autoironico: la Vlora nel '91 carica di disperati verso
l'Italia, e un fotomontaggio con le stesse scene, ma stavolta chi si cala dalla
nave sono gli italiani vacanzieri nella terra delle aquile. «Una delle
caratteristiche di Rama è la capacità di guardare le cose dall'alto dei suoi due
metri», dice chi lo conosce bene. […]
Vi chiamano Maldive del Mediterraneo, si parla di
"Alb-mania". Quali sono i numeri di questo boom vacanziero?
«Stiamo ripercorrendo il cammino del vostro Paese.
Ma questa estate è stata oltre le aspettative. Abbiamo avuto un +35% di turisti,
le cifre degli italiani sono impressionanti e si avvicinano al mezzo milione.
Quando ho cominciato (2013, ndr), l'aeroporto di Tirana faceva massimo 350 mila
passaggi l'anno. Ora, oltre a 6,5 milioni».
Siete preparati a questo assalto?
«Da tre o quattro anni si è verificato,
finalmente, un cambio di immagine. Fino a pochi anni fa, soffrivamo il
pregiudizio creato negli Anni 90, di essere genericamente criminali, mafiosi,
poveri migranti che sognano "Lamerica", come ha raccontato Gianni Amelio.
Oggi, i turisti vengono e si mescolano volentieri
con la nostra gente, il vento è cambiato.
Dobbiamo rincorrere il tempo perduto. Ma
attenzione: non vogliamo fare i grandi errori dell'Italia o di altri Paesi,
delle riviere o delle città invase. Gli arrivi di massa, il solo low cost può
distruggere l'avvenire e lasciare dietro ecomostri e disastri ambientali».
Costate meno di Italia, Grecia e Croazia. Natura
meravigliosa, facile da raggiungere. Come pensate di invertire la tendenza?
«Abbiamo pareggiato la Grecia e appena sorpassato
l'Italia per numero di turisti pro capite. Incredibile, ma ci abbiamo lavorato
tanto in questi anni di Rinascita albanese. In prospettiva, vogliamo un turismo
bilanciato e sempre più di alta gamma. Servono tre o quattro anni per essere
pronti a sfilare con i grandi». […]
Lei, socialista, è un grande ammiratore di Meloni.
L'ha anche baciata al funerale di Berlusconi. Che succede?
«Ho sempre avuto ottimi rapporti con tutti i
governi, come il mio Paese da quando siamo entrati nel mondo libero. Giorgia non
per me, ma per il club euroatlantico è una grandissima sorpresa. In tutte le
circostanze internazionali è vista con tangibile rispetto, ha carisma e dice
tutte le cose giuste. Io sono alto 198 cm, ma quando lei prende la parola sembra
più alta di me».
Si è innamorato?
«Non si bacia solo per amore. La ammiro. Giorgia è
la giovane sorella di Albania, io sono un vecchio fratello d'Italia e ci siamo
riconosciuti come tali a Tirana, abbracciandoci ben prima di parlarci». […]
Estratto dell’articolo di Alice D'Este per “il
Corriere della Sera” giovedì 10 agosto 2023.
«Mare pulito, servizi impeccabili e prezzi bassi:
sembra uno spot pubblicitario ma non lo è, le cose in Albania stanno veramente
così». Massimo Candotti, storico responsabile della comunicazione del Calcio
Padova e ora con lo stesso ruolo in «World Appeal», come molti veneti (e
italiani) quest’estate ha scelto il Paese oltre l’Adriatico per le sue vacanze.
[…]
Affollato dunque ma solo relativamente?
«Sì, al di là di una località particolare, cioè la
zona di Ksamil che è quella più turistica, non c’era ressa. C’erano tanti
italiani però, e anche parecchi tedeschi».
E nelle altre zone?
«Risalendo verso nord il mare rimane molto bello e
i turisti diminuiscono. Può valere un Salento, diciamo. Ci sono spiagge molto
attrezzate, per chi ama il genere, lettini con il materasso, ombrelloni di
paglia, stabilimenti ma anche spiagge libere, più selvagge con un mare
bellissimo».
Anche i servizi sono di alto livello?
«Sì, il preconcetto dei servizi inadeguati non ha
conferme. L’Albania sta diventando una meta turistica importante. Sono
organizzati molto bene. Sono pronti a ricevere i turisti. Se dovessimo fare una
battuta potremmo dire che hanno un livello di educazione superiore a quella
dell’italiano medio».
E i costi?
«C’è una grossa forbice. In alcuni posti molto
turistici i prezzi sono allineati all’Italia. Andando verso l’interno, invece, o
in montagna i prezzi sono sicuramente inferiori. La grande differenza si vede
soprattutto nei costi di albergo e B&b, che vanno da 30 a 50 euro per due
persone». […]
Estratto da fanpage.it mercoledì 9 agosto 2023.
Olivia Wilde ha scelto di nuovo l'Italia per le
sue vacanze. In particolare, la famosa attrice e regista si sta fermando in
Puglia, dove ha sviluppato una comprensibile dipendenza dai taralli. In uno dei
video condivisi su Instagram, l'attrice ha posto ‘una semplice domanda per
l'Italia‘: "Cosa sono questi? Non riesco a smettere di mangiarli, ne sono
dipendente". Grande ilarità scaturita dalle successive stories, nelle quali ha
mostrato il banco di prodotti tipici che la sta rifornendo di queste
prelibatezze e per concludere una busta piena di taralli che le sarebbero
serviti ‘almeno per arrivare a ora di pranzo'.
Ma la Puglia non è solo cibo, è anche tanta musica
e Olivia Wilde non si è lasciata sfuggire una classica serata estiva, complice
il fatto che nessuno in strada pare l'abbia riconosciuta. Fa strano infatti
vederla in una piazzetta con un po' di persone a contorno […]
Estratto dell'articolo di Michelangelo Borrillo
per il “Corriere della Sera” venerdì 11 agosto 2023.
[…] I taralli. Se ne mangi uno, non puoi più
fermarti. Adesso lo ha scoperto anche l’attrice e regista americana Olivia Wilde
che, tra Monopoli e […] si è resa conto di non poter «più smettere di
mangiarli». I taralli, però, […] almeno in Puglia, sono una cosa seria. Tanto
che quando qualcuno si mette in testa l’idea di cambiarne la lavorazione,
scoppia una guerra.
Sempre a causa di quei maledetti prezzi, che da
qualche anno a questa parte sono ricominciati a salire, come negli Anni ‘70 […].
Al tempo dell’inflazione alle stelle, qualcuno, in Puglia, ha infatti pensato di
poter risparmiare sugli ingredienti dei taralli: niente più farina, olio di
oliva e vino rigorosamente bianco, come da ricetta tradizionale […] ma solo
farina e olio.
[…] La proposta non ha avuto seguito, perché
subito sono divampate le polemiche. Ma mentre i pugliesi si ingegnano per non
far rincarare i prezzi dei taralli — diciamolo, l’unico prodotto alimentare che
unisce le tre Puglie, perché focaccia e panzerotti, in Salento, non sono tanto
apprezzati, come avviene per il pasticciotto nel nord della regione — arrivano i
vip e li promuovono. Perché Olivia Wilde è solo l’ultima dei famosi che si è
innamorata dei taralli.
Prima di lei la numero uno al mondo per la
promozione: nientemeno che Madonna che nei mesi scorsi ha condiviso sui social
(e dove, se no) un video in cui si trova attorno a un tavolo con il suo team e
racconta del tour che la porterà anche in Italia mangiando taralli pugliesi.
Ovviamente scoperti in una delle masserie di cui sopra. E tra Madonna e Wilde,
non poteva mancare l’influencer numero uno in Italia: Chiara Ferragni, che
sempre in un recente soggiorno in Puglia si mostra a colazione con i taralli
[…]
La pubblicità, si sa, è l’anima del commercio.
Quindi la promozione dei taralli non può che essere gradita ai pugliesi: ormai
Londra e Parigi sono piene di burrate, ben venga la scelta di accompagnarle con
i taralli (altra accoppiata gastronomica vincente). A un patto, però. Che non
finisca come con le friselle: un piattino di taralli a 16 euro come le friselle
per i vip, i pugliesi non lo tollererebbero. Perché il tarallo li accompagna
sempre e per tutta la vita: in spiaggia, in treno, anche in aereo, che siano
pugliesi bambini, adulti o anziani. Per cui, mangiatevi i taralli, mangiatene
tutti; ma questa volta lasciate stare le leggi dell’economia: per i rincari
fermatevi alle friselle.
Estratto dell'articolo di Carlotta De Leo
per corriere.it mercoledì 16 agosto 2023.
Estate 2023, è disfida della parmigiana
o dell'insalata di riso, a seconda dei gusti. A innescarla, le segnalazioni di
cartelli all'ingresso degli stabilimenti che vietano di portare il pranzo al
sacco. Ma questi divieti sono regolari? «I cittadini hanno piena facoltà di
introdurre cibi e bevande» scandisce Massimiliano Dona, avvocato, giornalista e
presidente di Unione Nazionale Consumatori.
Nelle intenzioni dei gestori, per mangiare e bere
qualcosa ci si dovrebbe rivolgere al bar o al ristorante del lido. «Ma il
titolare ha una concessione che riguarda i servizi in spiaggia, dai lettini agli
ombrelloni. Non ha invece, il monopolio sulla ristorazione. E questo significa
che chi entra nel lido o chi è di passaggio per andare alla spiaggia libera, può
portare con sé il pranzo o decidere di andare in un bar più in là perché magari
il ghiacciolo costa meno». Insomma, «non possiamo portarci da casa una sedia
sdraio, ma un panino e una bibita sicuramente sì» spiega Dona.
I divieti esposti, quindi, «non sono legittimi.
Men che meno lo sono i controlli all'ingresso. Non si possono aprire le borse o
chiedere di mostrarne il contenuto. Perquisizioni o ispezioni possono essere
svolte solo dalle forze di polizia e solo in alcune circostanze». E come
reagire? «In caso di problemi si può fare un segnalazione alla capitaneria di
porto che si occupa della vigilanza del demanio marittimo e quindi anche degli
stabilimenti».
Ai bagnanti però non è tutto concesso: cibo e
bevande devono essere consumati nel rispetto del decoro della spiaggia. […] «Il
concetto di 'decoro' è difficile da delimitare e così alcuni lidi tollerano i
panini ma vietano le teglie di lasagna. In ogni caso, l'invito è sempre a usare
il buonsenso per rispettare tutti». […]
La Cnn critica il turismo italiano compresa la
Puglia : “Fregature vergognose contro i turisti”. Redazione CdG 1947 su Il
Corriere del Giorno il 20 Agosto 2023
Il settore dei lidi balneari non è stato
risparmiato dalle critiche, con l’emittente americana che ha definito “i
peggiori delinquenti” i gestori che noleggiano lettini e ombrelloni. In alcune
località, come la Puglia, i prezzi per il noleggio di due lettini e un
ombrellone possono raggiungere i 50 euro durante la settimana e quasi
raddoppiare nel fine settimana.
L’articolo della Cnn dal titolo “Le fregature
vergognose a danno dei turisti in Italia” pubblicato neo giorni scorsi sul sito
dell’emittente televisiva americana comincia così: “Una vacanza in Italia può
essere un’esperienza impagabile, ma l’estate del 2023 passerà alla storia come
un delle più costose di sempre, con una serie di scandali sui prezzi nei bar e
nei ristoranti che hanno colpito allo stesso modo sia i turisti stranieri che
gli italiani“.Nel servizio vengono descritti minuziosamente tutti gli episodi
documentati e pubblicati in questi giorni dalle testate italiane e sui
socialnetwork, dai 2 euro in più per tagliare un toast a metà sul lago di Como
alla richiesta dello stesso sovrapprezzo è stato chiesto per ottenere un piatto
vuoto in un ristorante di Portofino., così come lo stesso sovraprezzo alla
stessa cifra + stato chiesto per scaldare un biberon nel microonde sul
litorale Ostia (Roma).
Anche la Puglia non viene risparmiata: “Gli
stabilimenti balneari in cui si affittano ombrelloni e lettini sono tra gli
esempi peggiori. In Puglia il noleggio giornaliero durante la settimana è di
circa 50 euro, il doppio nei weekend” ma, come evidenza sempre l’articolo
della CNN , più a nord in Liguria un posto in prima fila sulla spiaggia può
arrivare a costare fino a 150 euro. “L’estate del 2023 sarà una delle più
costose della storia”, ha dichiarato l’emittente Usa, riportando come esempi
anche i 2 euro extra per un piatto vuoto a Portofino e i 60 centesimi in più per
l’aggiunta di cacao al cappuccino.
Il settore dei lidi balneari non è stato
risparmiato dalle critiche, con l’emittente americana che ha definito “i
peggiori delinquenti” i gestori che noleggiano lettini e ombrelloni. In alcune
località, come la Puglia, i prezzi per il noleggio di due lettini e un
ombrellone possono raggiungere i 50 euro durante la settimana e
quasi raddoppiare nel fine settimana.
Nel servizio della CNN viene anche spiegato come i
rincari non stanno colpendo solamente la ristorazione ed i servizi, ma qualsiasi
settore: in generale “I prezzi alti di carburante ed energia stanno rendendo
quest’estate incredibilmente costosa“, è ,scritto ancora, e qui vene chiamata in
causa la Puglia, regione in cui , insieme alla provincia autonoma di Bolzano,
la benzina è stata venduta agli sfortunati automobilisti ai prezzi più alti in
Italia. Un trend negativo per i turisti, che ha indotto persino gli italiani a
trascorrere le vacanze in Paesi vicini (e più economici) come Grecia, Albania e
Montenegro, aggiungendo anche che “anche la premier Giorgia Meloni ha trascorso
qualche giorno in Albania”. Ma nell’ articolo della CNN non viene spiegato che,
in quel caso, si è trattato di un invito ricevuto dal primo ministro Edi
Rama durante una settimana nella quale il presidente del Consiglio si trovava
con la famiglia in una masseria di Ceglie Messapica (Brindisi).
Prezzi pazzi anche a Roma dove due turisti
americani Betsy e James Cramer, contattati dalla Cnn, si sono detti imbarazzati
dall’ammettere quanto hanno pagato per due Aperol Spritz in un bar di Piazza
Navona. “Abbiamo pagato più del dovuto per il gelato, per gli spritz e per il
nostro hotel, ma lo sapevamo“, ha sottolineato Betsy Cramer alla Cnn. ”Avevamo
programmato questo viaggio prima del Covid e lo abbiamo sognato anche se abbiamo
letto i titoli sui prezzi costosi’‘
L’ articolo dell’ inviata della CNN si conclude
con un riferimento al turismo di lusso, che quest’estate ha fatto segnare il
record di quasi 12 milioni di ospiti nelle strutture a cinque stelle e che
ha ottenuto risultati migliori, anche in Puglia, rispetto a quello ordinario. Un
trend confermato dal fatto che diversi maison del lusso, da Dolce&Gabbana che ha
portato e fatto sfilare in Puglia le proprie collezioni di Alta Moda e Alta
Sartoria) e Valentino che ha presentata la nuova linea di profumi, a Monopoli,
hanno scelto la Puglia . La crociera extralusso Emerald Azzurra, che trasportava
cento Lamborghini di tutti i colori per i suoi croceristi è partita da Brindisi
facendo tappa a Monopoli e Manfredonia prima di dirigersi verso le coste croate
e montenegrine.
“Scontrini pazzi”, scrive la giornalista Latza
Nadeau citando le associazioni consumatori italiane che riferiscono di un
aumento del 130 per cento dei prezzi in alcune zone turistiche italiane, fino al
240% in più rispetto ad altre mete del Mediterraneo, racconta la ‘fuga’ nei
balcani alla ricerca del risparmio,. “Sharm el Sheik costa meno” fa notare Paolo
Manca di Federalberghi, facendo l’esempio della Sardegna dove “una famiglia può
pagare fino a mille euro al giorno”, considerando i costi di traghetto o aereo,
dell’hotel e dei pasti. Per questo gli italiani stessi vanno all’estero.
Redazione CdG 1947
La premier Giorgia Meloni? Vacanze top secret
in una masseria pugliese. Un vero e proprio amore a prima vista quello
«sbocciato» tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Fasano. GINO BIANCO
su La Gazzetta del Mezzogiorno il 10 Agosto 2023
FASANO - Un vero e proprio amore a prima vista
quello «sbocciato» tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e questo
territorio. Dall’altra sera, infatti, la premier, dopo aver concluso uno dei
Consigli dei Ministri più importanti, è volata in Puglia in maniera del tutto
privata per trascorre un po’ di tempo con la propria famiglia.
Dove? Top-secret per tutti, anche se sono in molti
a scommettere che abbia scelto ancora una volta Borgo Egnazia dove la
riservatezza è la prima regola. L’altro ieri, per chi legge, la premier è stata
notata, più che altro per la scorta che la segue, in alcuni posti della zona.
«Un atteggiamento, il suo – ha spiegato chi l’ha incontrata casualmente - del
tutto informale. Una semplice turista senza troppe formalità». Insomma, in
perfetto stile Meloni. La prima visita risale ad alcuni mesi addietro quando, in
veste ufficiale, a quanto pare, è arrivata in zona per verificare personalmente
alcune strutture idonee ad ospitare il prossimo G7. Poi è tornata nuovamente in
forma privata per qualche ora di vacanza. E ora il ritorno. Intanto, quando
tutto è coperto da una grande riservatezza, a giorni dovrebbe arrivare la
decisione formale che individua questo territorio quale il più idoneo per
ospitare il G7. Una grande opportunità verso la quale un po’ tutti, dalle
pubbliche amministrazioni alle strutture ricettive, devono essere preparate.
Essere preparati non significa, come purtroppo sta
accadendo per la ristorazione in questo periodo, aumentare sproporzionalmente i
prezzi, bensì compiere uno sforzo comune per evitare brutte figure di fronte al
mondo intero che seguirà il G7.Certamente, da parte loro, determinate strutture
esistenti non hanno bisogno di insegnamenti e lo hanno dimostrato nel corso
degli anni con una altissima professionalità apprezzata in tutto il mondo.Ma
torniamo alla presenza della Meloni che fortunatamente è arrivata con il bel
tempo che sta accompagnando la sua vacanza dopo qualche temporale dei giorni
passati. Mare cristallino, piscine favolose, cibo di alto livello sono gli
ingredienti che staranno ancora una volta, certamente, conquistando il
Presidente Meloni.Una bella storia a dimostrazione di come a vincere è stata la
lungimiranza di alcuni imprenditori che circa vent’anni addietro decisero di
investire proprio in questa zona. Zona oggi ambita dal turismo di qualità a
livello mondiale e finanche dall’organizzazione del G7: un premio per il
territorio.
Estratto dell'articolo di Giuseppe Scuotri
per corriere.it martedì 29 agosto 2023.
Ormai sembra quasi la norma. Clienti consumano il
pasto al ristorante, poi alzano i tacchi e scappano senza pagare il conto. […]
stavolta il gruppo di italiani a darsela a gambe era a Malta. Per la precisione,
a Msida, lo scorso 25 agosto. Ma, questa volta, i "furbetti" non sono riusciti a
farla franca.
Con la scusa di fumarsi una sigaretta, il gruppo
di giovani si è alzato dal tavolo del «Pasta & Co.» ed è uscito fuori. Poi, la
fuga. Il conto da 100 euro è rimasto in capo al locale, che ha denunciato i
clienti alle autorità. Uno dei proprietari, italiano, ha riconosciuto l'accento
siciliano dei clienti, così ha contattato i quotidiani locali per provare a
trovare i colpevoli.
E la mossa ha dato i suoi frutti.
Una volta arrivata in Italia, la storia è balzata
agli occhi di un uomo, che tra quei ragazzi (nonostante i volti coperti) ha
riconosciuto suo figlio. «Mi ha telefonato chiedendo i miei dati per saldare il
dovuto — racconta il proprietario del ristorante - Mi ha raccontato che il
figlio si è pentito subito, piangeva a dirotto. Io gli ho detto che ho
apprezzato moltissimo il suo gesto, che si vedeva fosse una persona onesta e un
padre esemplare, ma che non ci fosse bisogno di saldare un conto da 100 euro.
Lui però ha continuato a insistere, così gli ho
proposto di devolvere la somma ad Arka un’organizzazione dell’isola di Gozo che
si prende cura di persone con disabilità. La mia idea lo ha colpito molto e,
alla fine, mi ha richiamato annunciando di aver donato ben 250 euro. Noi, per
conto nostro, a quel punto siamo tornati dalla polizia e abbiamo ritirato la
denuncia», ha detto. Poi, l'idea del papà: «Vi mando mio figlio a lavorare
gratis la prossima estate». L'offerta è stata declinata, ma i proprietari del
ristorante hanno apprezzato il gesto.
Italiani non pagano il conto in Albania, i
ristoratori ringraziano Meloni: «Una buona madre severa che dà l’esempio a casa
sua». Storia di Benedetta Moro su Il Corriere della Sera sabato 19 agosto
2023.
Una foto con un barattolino in vetro e dei soldi
al suo interno, appoggiato in bella vista sul bancone. Il denaro - si intravede
una cifra, 5000 - sono gli ormai famosi 8.451 lek, ovvero gli 80 euro che la
presidente del Consiglio Giorgia Meloni - non senza suscitare polemiche - ha
fatto recapitare di tasca propria via Ambasciata italiana a Tirana ai
proprietari del ristorante «Guva Mangalem» di Berat, in Albania, dove nei giorni
scorsi quattro turisti italiani sono scappati senza pagare la cena. L’immagine è
stata pubblicata dagli stessi titolari del locale su Facebook, Viku Kadëna e la
moglie Gabriela, affidandosi allo stesso social che ha utilizzato Meloni qualche
ora prima spiegando il perché del proprio gesto. E poi, sotto, un lungo
messaggio, una sorta di ringraziamento alla premier ai quattro giovani ospiti
non paganti, e allo stesso tempo una dichiarazione di affetto nei confronti
degli italiani. «Quei cittadini italiani che son andati senza pagare ci hanno
fatto u na grande pubblicità alla nostra città. Li ringraziamo!», si legge nel
post, che poi prosegue: «Abbiamo detto già quel giorno che non c’era alcun
problema con gli italiani, che si devono sentire a casa propria qui, vengono in
tanti, così come è avvenuto con la nostra famiglia in Italia quando eravamo noi
degli emigrati. Abbiamo anche detto che il cibo ai quattro clienti è piaciuto
molto. Speriamo che abbiano speso quei soldi per qualcosa di bello!».
Aveva stupito la reazione del ristoratore Viku
Kadëna, che invece di rincorrerli, arrabbiarsi e soprattutto denunciare il
gruppo, aveva semplicemente augurato loro di aver speso altrove e bene quel
denaro. Lo aveva fatto sempre in un post, corredato da un video dei turisti
italiani ripresi dalle telecamere del locale mentre scappavano. Quegli ottanta
euro, spiegano i ristoratori nel post, per loro non fanno la differenza,
nonostante non navighino nell’oro. Ecco poi la parte del testo in cui si esprime
riconoscenza nei confronti di Meloni, definita come «buona madre severa».
«Ringraziamo di cuore Xhorxha (Giorgia, ndr) Meloni una vera signora! Noi non
siamo ricchi, lavoriamo duramente e come famiglia non guadagniamo così tanto da
non farci impressione da quei soldi! Ma questa non è una questione di denaro per
noi e siamo molto toccati dal suo gesto! Un grande esempio di dignità da una
buona madre severa che dà l’esempio a casa sua! Grande Xhorxha (Giorgia, ndr)!
La amiamo molto visto che anche noi siamo per metà italiani. Ci ha onorato
tantissimo venendo in vacanza a Valona!».
Video correlato: Albania, turisti fuggiti dal
locale senza pagare: Meloni salda il conto (Mediaset)
E poi una promessa: i soldi «resteranno qui nel
ristorante come ricordo straordinario e anche contro il malocchio!».
La mossa populista. Il conto-simpatia pagato da
Meloni in Albania, la premier trasforma ambasciatori in commessi e dimentica le
altre ‘vergogne’ italiane. Redazione su Il riformista il 19 Agosto 2023
Una mossa populista, mediatica ma soprattutto
incoerente. Un’azione simpatia quella della premier Giorgia Meloni che non deve
però far ridere nessuno. Perché pagare il conto agli italiani scappati dal
ristorante in Albania, trasformare i funzionari dell’ambasciata in ‘commessi’,
inviandoli dal proprietario dell’attività per saldare i circa 80 euro (che
avrebbe messo sul piatto la stessa presidente del Consiglio), lancia un
messaggio assai equivoco. Quello che dietro a ogni marachella c’è lo Stato
pronto a metterci una pezza. E infatti sui social i commenti si sprecano.
“Stasera cena a Ibiza? Offre Meloni” e così via.
Ma soprattutto l’atteggiamento della stessa
premier, che dice di essersi vergognata per l’azione dei suoi connazionali, non
sempre è lo stesso quando ci sono altri episodi di cui vergognarsi, a partire
dalle parole del ministro Piantedosi dopo la strage di Cutro, o da quelle del
presidente del Senato Ignazio La Russa dopo le accuse di violenza sessuale
rivolte al figlio.
Un episodio che ha scatenato le opposizioni e che
ha visto l’immediata contro-replica della premier che torna sulla vicenda:
“Mentre mi trovavo in Albania il Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4
italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il conto. Il
ristoratore, dopo che le immagini della fuga erano diventate virali, aveva detto
che era comunque felice perché i nostri connazionali avevano mangiato bene ed
erano rimasti contenti. Mi sono vergognata – scrive la premier sui social –
perché l’Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé
all’estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di
essere divertente fregando gli altri. Allora ho deciso di chiedere
all’ambasciatore di andare a saldare il conto, che ho pagato personalmente.
Niente di che, infatti io non ne ho neanche dato notizia”.
“Eppure – continua Meloni – anche questo in Italia
ha creato polemica, da parte di un’opposizione che evidentemente preferisce
un’altra immagine dell’Italia. Me ne dispiace perché speravo che almeno su una
cosa così banale si potesse essere tutti d’accordo”.
Il video, diventato virale su TikTok, immortala un
gruppo di italiani ripresi dalle videocamere di sorveglianza mentre scappavano
da un ristorante a Berat senza pagare il conto. Così la premier, che si trovava
in Albania, ha deciso di saldare il conto e ripulire l’immagine dell’Italia con
quel perentorio “vada subito a pagare il conto di questi imbecilli per favore, e
faccia un comunicato. L’Italia non può permettersi di essere disonorata
all’estero” che avrebbe riferito all’ambasciatore italiano a Tirana.
“Dietro a questa idea balzana per cui se mi
ubriaco in discoteca lo Stato mi paga il taxi, e se scrocco la cena in Albania
lo Stato mi paga il conto, non c’è solo il disprezzo di chi paga le tasse. C’e’
un’idea paternalistica, onnicomprensiva e distorta delle istituzioni pubbliche”,
ha scritto su twitter Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva e Azione al
Senato. “Ecco l’estrema frontiera del populismo: tutti impuniti, tanto paga
Giorgia. Mi chiedo se questa regola da oggi in poi varrà anche all’interno del
territorio nazionale e non solo all’estero. Alla faccia di tutti i cittadini
italiani onesti che pagano il conto al ristorante. Se Giorgia voleva fare la
paladina dell’italianità ci è riuscita benissimo: fai come ti pare, tanto paga
Pantalone” ha dichiarato Riccardo Magi di Più Europa.
Duro anche Emiliano Fossi, deputato del Pd: “Ha
perfettamente ragione la premier Meloni a vergognarsi degli italiani scappati in
Albania senza pagare il conto al ristorante. Doveva però vergognarsi anche dei
migranti lasciati morire in mare, dei generali xenofobi, dei presidenti del
Senato che umiliano le donne vittime di violenza, dei bambini figli delle
famiglie arcobaleno che non avranno diritti, della benzina oltre i due euro,
dell’inflazione al 10 per cento, di oltre tre milioni di lavoratori poveri e di
mille promesse in campagna elettorale mai mantenute. Non basta pagare un conto
per lavarsi la coscienza”.
Meloni, difendo l'immagine italiana e
l'opposizione polemizza. (ANSA sabato 19 agosto 2023) - Giorgia Meloni si "è
vergognata" per il conto non saldato dai turisti italiani in Albania. "L''Italia
che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all'estero per
queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente
fregando gli altri", dice sui social la premier, che ha chiesto
"all'ambasciatore di andare a saldare il conto, che ho pagato personalmente.
Niente di che, infatti io non ne ho neanche dato notizia. Eppure anche questo in
Italia ha creato polemica, da parte di un'opposizione che evidentemente
preferisce un'altra immagine dell'Italia".
"Mentre mi trovavo in Albania - racconta la
presidente del Consiglio in un post sui social - il Primo Ministro Rama mi
racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati
senza pagare il conto. Il ristoratore, dopo che le immagini della fuga erano
diventate virali, aveva detto che era comunque felice perché i nostri
connazionali avevano mangiato bene ed erano rimasti contenti".
"Mi sono vergognata, perché l'Italia che voglio
rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all'estero per queste cose,
che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli
altri - aggiunge Meloni -. Allora ho deciso di chiedere all'ambasciatore di
andare a saldare il conto, che ho pagato personalmente. Niente di che, infatti
io non ne ho neanche dato notizia". "Eppure - sottolinea la premier - anche
questo in Italia ha creato polemica, da parte di un'opposizione che
evidentemente preferisce un'altra immagine dell'Italia. Me ne dispiace perché
speravo che almeno su una cosa così banale si potesse essere tutti d'accordo".
IL CONTO IN ALBANIA. Il giustiziere degli
scrocconi. Perché Giorgia ne esce alla grande. La premier viene pure
contestata per aver pagato il conto lasciato da dei cafoni connazionali.
Dovrebbe solo ricevere ringraziamenti. Max Del Papa su Nicolaporro.it il 19
Agosto 2023.
Brava brava donna Giorgia ogni cosa sai far tu, se
chi sbafa poi non paga il piè di lista copri tu. E avevano anche il coraggio di
prenderla in giro, la nostra premier, siccome è andata in vacanza in Albania.
Proprio loro, i compagni senza confini la sfottevano, ma loro in Albania non ci
vanno, loro stanno a Capalbio dove gli extracomunitari non entrano se non come
sguatteri. E poi, però, quando c’era lei, cari voi, le cose si aggiustavano:
donna Giorgia fa cose, donna Giorgia paga conti. Ma fortuna che in Shqipëria c’è
andata!!! (tre esclamativi, come usa il letterato generale Augello).
Situazione grottesca, il nostro capo del governo a
Tirana un po’ a tirare il fiato e un po’ ad aggiustarsi con l’omologo locale, a
difendere la nostra immagine, e, poco distante, il trionfo dell’italian
style, un bivacco di magnaccioni si sfonda al ristorante, roba da 5 pasti al
giorno, poi scappano tutti e lei prima sbianca, poi, da donna d’azione, reagisce
ed agisce. All’inizio si diffonde un certo panico, perché circola la voce,
malevola, comunista, che abbia mandato l’ambasciata italiana a pagare: tsk tsk,
che fai, paghi sti svaccati coi soldi delle accise? Ma poi, ecco il colpo d’ala
che spazza via illazioni e malignità: Giorgia ha pagato coi soldi suoi,
incidente chiuso, bocche tappate.
Quel che va detto, va detto: donna Giorgia ne è
uscita alla grande, nel modo più semplice, immediato, preciso. Laddove altri
predecessori, anche non lontani, se mai si sarebbero uniti, per vocazione, per
istinto, agli scrocconi (i quali però andrebbero rintracciati, sputtanati e
presi a pedate nel culone farcito, perché non è possibile, dai). Eh, se solo la
lasciassero fare, la nostra Donna Giorgia. Cos’è il governo? È fantasia,
intuizione e velocità d’esecuzione: da una possibile figuraccia abissale, per
colpa di quattro bestioni che immaginiamo simili a milanesi imbruttiti o a
caricature di Checco Zalone, siam passati a un esempio di dignità, condita dalla
sana cazzimma che non guasta: pare che, appena saputo della prodezza, Giorgia si
sia incazzata come un rinoceronte, con tanto di commenti irriferibili, roba da
gettarle le braccia al collo.
Ma vediamo come avrebbe reagito un altro premier
nei suoi panni. Un democristiano da prima Repubblica avrebbe congiunto le mani,
invitando al rispetto dei valori umani e cristiani. Un comunista, tipo Massimo
D’Alema, l’avrebbe buttata sul disprezzo per comportamenti senza dubbio
ascrivibili a certa subcultura di destra. Piero Fassino avrebbe sventolato il
cedolino parlamentare. Mario Monti avrebbe lanciato una manovra lacrime e sangue
per pura rappresaglia. Giuseppe Conte dal resort a 18 stelle avrebbe ribadito la
necessità del reddito di vacanza per evitare simili incresciosi episodi. Mario
Draghi avrebbe proposto la reintroduzione del greenpass così nessuno può
scappare. Insomma tutti ci avrebbero girato intorno, fottendosene alla grande.
Giorgia no. Lei fa cose, risolve problemi.
Poi cercano di farle le scarpe, la destra estrema
lunatica le tira tra i piedi il petardo di un generale da operetta,
considerandola traditrice di una tradizione francamente esaltata e fascistoide
che Meloni mai ha praticato, per anagrafe e sensibilità personale. La nostra
premier è tutto fuorché una fascista estetica, è se mai una della destra
statalista provvidenziale e punitrice, in sintonia con la sinistra tassatora e
moralistica ed è questo a preoccupare, e magari a sconcertare i quattro pirla
liberali libertari che siamo, che ci ostiniamo a rimanere nel fraintendimento e
nel disprezzo generale. E che questo generale Augello, subito pompato da qualche
testata in odor di destra estrema, sia uscito dal nulla, fa ridere solo a dirlo:
stanno cercando di contarsi, tempo una settimana e questo personaggino annuncerà
un partito o movimento, salvo scoprire subito che i furibondi convinti che il
loro eroe dice la verità “perché ha detto quello che penso io” sono pochini in
prospettiva elettorale, solita pazza idea da golpetto all’italiana, dopodiché il
momento Chiara Ferragni evaporerà.
Ma non divaghiamo: solo per dire che Giorgia è
assediata da tutte le parti, dalla sua sinistra alla sua destra, l’Europa la
tiene comunque nel mirino, Biden le spiega che finché lui tiene su la guerra in
Ucraina lei può stare tranquilla, dopo non si sa, e ogni giorno un ministro apre
bocca e purtroppo la usa e lei vorrebbe trasformarsi in Crudelia de Mon. E
neanche oltre i sacri confini può trovar pace, se va quattro giorni a tirare il
fiato trova subito i cialtroni che grufolano e scappano. A proposito, vuoi
scommettere che questi qua son tutti della sinistra climatista e grattaculo, i
parassiti che pretendono di venire mantenuti nelle loro crisi d’ansia, risolte
solo al momento di fuggire come topi farciti dal ristorante? Max Del Papa, 19
agosto 2023
L'indignazione al cubo. In nome del popolo dei
follower, le sentenze della ‘caverna digitale’: basta uno scontrino e il
ristorante di turno è condannato…Domenico Giordano su Il riformista il 17
Agosto 2023
È sufficiente una foto. A volte meglio se sfocata
perché così acquista la certificazione dell’autenticità a prescindere. Basta
postare uno scontrino in una chat di WhatsApp oppure meglio se pubblicato su un
account di qualsivoglia social e non è necessario che sia per forza quello
di influencer con una platea milionaria di seguaci, per ottenere una condanna.
Immediata, con il massimo della pena e senza alcuna possibilità di appello.
Una condanna morale, civile, politica o imprenditoriale, a seconda dei casi che
affidiamo incautamente all’indignazione digitale. Nei processi sommari che si
consumano velocemente sulle piattaforme la fase del dibattimento, quella in cui
in un procedimento penale si forma la prova grazie al contraddittorio tra le
parti che si confrontano a colpi di documenti e testimonianze, è completamente
azzerata. Non serve, non è richiesta, non interessa a nessuno. I processi a
mezzo social contemplano e vivono solo di sentenze emesse in nome del popolo dei
follower.
Non ci sono indagini, non c’è un rinvio a giudizio
e tanto più un’udienza preliminare, al contrario, nelle Procure e nei Tribunali
della rete invece siamo soltanto attratti e catapultati in uno vortice
di indignazione al cubo, spinti a spingerci dai commenti della giuria popolare
dei follower sempre più in là nella sfida della denigrazione e nel dovere
immorale di contagiare i nostri simili. È l’algoritmo del pubblico ludibrio a
decidere chi è il colpevole da linciare e chi è la vittima che merita una
solidarietà tout court. Non ci importa perdere tempo a capire il perché, men che
mai siamo interessati a comprendere il contesto, così come non ci sfiora
minimamente il dovere e la bellezza del dubbio o indagare anche solo
superficialmente le ragioni degli imputati digitali. A noi preoccupa invece
legittimare la nostra identità e reputazione digitali osannando il puritanesimo
delle shit storm.
Perché – come scrive Byung Chul Han in Infocrazia,
le nostre vite manipolate dalla rete – “mentre pensiamo di essere liberi, oggi
siamo intrappolati in una caverna digitale” che ha il (de)merito di farci
sentire al riparo dalle incertezze e dalla precarizzazione delle nostre vite
reali. Essere dei follower ci permette di “prendere parte a una eucarestia
digitale”, di appartenere orgogliosamente a una tribù che non ci emargina, che
ci fa sentire importanti, che fa battere l’elettrocardiogramma del nostro
account, fino a quando beninteso, saremo disponibili a uniformarci alle scie
dell’odio, alle sottoscrizioni gratuite di malvagità.
Nelle società delle piattaforme non serve più la
P38, non occorre sparare, è sufficiente il T9 del nostro smartphone per
continuare la pedagogia del colpire uno per educarne cento, anzi, grazie alla
pervasività della rete, basta colpirne uno per educare tutti gli altri.
Questo è successo già migliaia di volte, con danni
materiali e biologici che ancora non hanno trovato una seria e compiuta cornice
di tutela giuridica, e si è ripetuto ancora qualche giorno fa con la
gli scontrini di ristoranti e bar, dalla Liguria alla Sicilia, dalle sponde
del lago di Como a quelle delle spiagge della Sardegna, postati come prova
inconfutabile di colpevolezza che è tale perché inondanti dai cavalloni di merda
digitale e subissati dai gavettoni di odio da ombrellone.
Purtroppo, si ripeterà ancora nelle prossime ore,
con altri video e con nuove foto e la nostra coscienza resterà pulita solo
perchè alle spalle del giudice influencer campeggia a caratteri cubitali il
principio auto-assolutorio “In nome del popolo dei follower”.
Domenico Giordano è spin doctor per Arcadia,
agenzia di comunicazione di cui è anche amministratore. Collabora con diverse
testate giornalistiche sempre sui temi della comunicazione politica e delle
analisi degli insight dei social e della rete. È socio dell’Associazione
Italiana di Comunicazione Politica. Quest'anno ha pubblicato "La Regina della
Rete, le origini del successo digitale di Giorgia Meloni (Graus Edizioni 2023).
Vacanze 2023: tutti gli aumenti da Nord a Sud.
Le vacanze 2023 stanno diventando un vero e proprio lusso. Scopriamo tutti gli
aumenti da Nord a Sud. Chiara Nava su Notizoe.it Pubblicato il 8 Agosto 2023
Coloro che si stanno godendo le vacanze in questa
estate 2023 si stanno concedendo un vero e proprio lusso. I rincari continuano e
sono sempre più evidenti. Scopriamo tutti gli aumenti da Nord a Sud della
penisola.
Vacanze 2023, i rincari: tutti gli aumenti da Nord
a Sud
Il tempo delle ferie è arrivato e per molti è
diventato sinonimo di stress, a causa dei continui aumenti. I rincari per queste
vacanze 2023 sono davvero molto significativi. Alla base troviamo sicuramente
l’infezione, ma non si tratta dell’unica ragione. Quest’anno chi si sta godendo
una vacanza si sta realmente concedendo un lusso, perché i rincari sono alle
stelle.
Le previsioni di Federconsumatori a maggio
stimavano un aumento di circa 800 euro, rispetto allo scorso anno, per una
settimana di vacanza al mare o in montagna, per una famiglia di quattro persone.
Una volta iniziata la stagione, Demoskopika ha annunciato la stangata sul
turismo di 3,9 miliardi di euro, con rincari significativi nel settore dei
trasporti, sui pacchetti turistici e sugli alloggi. Gli aumenti hanno colpito
sia il Nord che il Sud, con alcune regioni più care. Le cinque regioni che hanno
registrato aumenti maggiori sono: Lazio (+9,5%), Lombardia (+9,2%), Toscana
(+9,1%), Molise (+9,1%) e Campania (+9%). L’inflazione non è l’unica
responsabile del caro vacanze. Quest’anno ci sono regioni che hanno adottato una
politica diversa, più selettiva nei confronti della clientela, puntando
sull’aumento die prezzi per diminuire gli accessi sul territorio.
Per riuscire ad andare in vacanza in Italia e
spendere relativamente poco bisogna scegliere altre opzioni. Per i giovani è più
difficile, perché solitamente scelgono le zone più rinomate, che sono le più
costose, per via della movida. Per il resto delle persone si può scegliere una
soluzione in camper, che è leggermente più economica e si risparmia anche per
quanto riguarda il cibo. L’unico modo per organizzare una vacanza intelligente
ed economica, probabilmente, è quella di andare a scoprire quei posti che non
vengono presi d’assalto dai turisti, ma che nascondono grandi bellezze.
Vacanze 2023: quanto costano? Aumentano i prezzi
del cibo
I prezzi di hotel e ristoranti sono in continuo
aumento, ma quello che ha lasciato spiazzati i turisti è l’aumento dei prezzi
del cibo. In Versilia una delle pasticcerie più amate di Forte dei
Marmi propone una colazione con cornetto e cappuccino a 20 euro. In Liguria
la focaccia viene venduta 20 euro al chilo, con il picco di 25 euro a Varigotti.
A Rimini una coppetta di gelato due gusti costa 3 euro, mentre a Firenze
arriviamo a 6 euro, con un picco di 12 euro per una coppetta grande sul Ponte
Vecchio. Sempre a Firenze troviamo una pizza margherita a 14 euro e un caffè a
3,50 euro. In Emilia Romagna una notte in un hotel a 3 stelle a Rimini costa 150
euro a persona. Per una piadina vengono chiesti 15 euro. Anche in Sicilia
continuano i rincari, con un ombrellone e due lettini a 30 euro al giorno a
Mondello. Nel Lazio, sull’Isola di Ponza, un antipasto per cena, con un piatto
di pasta e vino costa 50 euro pa persona. A Ischia troviamo il prezzo della
benzina superiore ai 2 euro al litro.
In Puglia, più precisamente a Monopoli,
troviamo un lido che offre una sistemazione sotto l’ombrellone a 120 euro al
giorno e nella riviera romagnola si sono toccati anche i 500-600 euro per una
sistemazione con lettini, divanetti, tavolini e sedie. Per una frittella con
pomodoro vengono chiesti ben 16 euro. La zona del Salento ha scelto una politica
diversa per questa estate. Se in Romagna si contano anche 50 file di ombrelloni,
le spiagge salentine sono più lunghe e strette e in alcuni punti non si riescono
a sistemare più di 6 o 7 file di ombrelloni, per questo i prezzi salgono per
selezionare la clientela. Negli ultimi anni la Puglia è stata presa d’assalto e
devastata a livello naturalistico, per cui ora è diventata una meta turistica di
lusso, che si possono permettere in pochi.
L'assessore Micelli: «I prezzi del comparto
turistico in Puglia schizzati alle stelle? Ad Avetrana non è così» Manduria
Oggi il 07/08/2023
«Ad Avetrana una pizza e birra al tavolo costa
circa 12 euro, un caffè al bar un euro, una bibita in lattina 2 euro e così via.
Poi la spiaggia e gli spettacoli serali sono gratuiti… » Buona parte della
stampa nazionale ha rimarcato nei giorni scorsi gli aumenti dei prezzi che si
sono registrati nel comparto turistico. Da Avetrana arriva una determinata
reazione da parte dell’assessore al Turismo, Emanuele Micelli. Ecco il suo
intervento. «Cari giornalisti distratti (non pugliesi) vorrei dirvi alcune cose.
Ad Avetrana (Puglia) una pizza e birra al tavolo costa circa 12 euro, un caffè
al bar 1 euro, una bibita in lattina 2 euro e così via. La mattina il nostro
ospite può tranquillamente usufruire della splendida costa (scogli o spiaggia)
in forma gratuita e la sera può godersi uno spettacolo gratuito nelle nostre
piazze facendo anche una passeggiata nel centro storico. Dimenticavo le feste
sono gratuite perché quasi sempre finanziate dai commercianti e imprenditori
locali. Questo accade ad Avetrana, ma accade quasi ovunque in Puglia. Per quanto
riguarda invece i dati sul turismo Pugliese, le somme si tirano alla fine con
serenità...
Fate voi il paragone con San Pietro in Bevagna.
Un manduriano a Pescoluse, le Maldive del Salento, ci parla di prezzi delle
frise ed altro. La Redazione de La Voce di Manduria, giovedì 10 agosto 2023
Sono un vostro lettore e mi sono trovato in
vacanza nel sud Salento e specificatamente nella zona di Pescoluse (cosiddetta
Maldive del Salento). Leggevo in questi giorni dei presunti prezzi altissimi di
queste località, specialmente negli stabilimenti balneari.
Per mia curiosità mi sono recato al famoso "Lido
Maldive del Salento" qui a Pescoluse. Premetto che sono un vostro lettore e che
spesso frequento le spiagge manduriane e i suoi tre stabilimenti balneari.
Continuo a narrare la mia splendida esperienza.
Giunto in nello stabilimento balneare dove mi
trovo, ve lo descrivo brevemente: dopo le apposite segnaletiche poste lungo un
percorso, si accede in un parcheggio custodito con annesse docce per lavare auto
all'uscita. Il costo del parcheggio (comprensivo di lavaggio in uscita), è di 4
euro tutta la giornata. Dopo aver parcheggiato ho fatto accesso nello
stabilimento. Si da subito la mia attenzione è stata attratta dal cartello dei
prezzi: ombrellone e 2 lettini in prima fila a soli euro 40; il gazebo a 65 euro
con 2 lettini; possibilità di docce e uso dei bagni; inoltre bar, centro
estetico e ristorante; noleggio imbarcazioni e strumenti per sport in acqua. Il
tutto a prezzi davvero competitivi.
Abbiamo consumato 2 caffè seduti al tavolo del bar
pagando solo 3 euro. Nella zona ristorazione mi soffermavo a leggere il menù:
orecchiette al sugo 8 euro, frise condite con pomodoro e spezie 4 euro, altroché
i prezzi folli che si sentono. Leggendo e verificando tutto questo
personalmente, mi chiedo il perché di tanta cattiveria mediante pubblicità non
veritiera nei confronti di chi svolge il proprio lavoro onestamente. Non credo
che negli stabilimenti balneari di San Pietro in Bevagna o di Campomarino vi
siano costi inferiori eppure i riflettori vengono puntati (ingigantendo le
situazioni) solo su alcuni stabilimenti. La mia è una pura osservazione ed un
invito a frequentare la nostra Puglia. Lettera firmata
In attesa dei dati ufficiali. "Care" vacanze,
ma il direttore di Confcommercio invita a non generalizzare. La Redazione de
La Voce di Manduria,l'8 agosto 2023
«Tenetevi pure la frisedda e la puccia, io vado
all’estero dove pago meno e ho un servizio migliore». Così, sul social Facebook,
si sfoga un utente del posto riferendosi alla località marittima di questo
versante della Puglia rispetto ai suoi prezzi ritenuti «proibitivi». I
ristoranti, i lidi, gli hotel, i parcheggi, i bar, le case: tutto sarebbe
cresciuto eccessivamente tanto da allontanare i vacanzieri dalle marine di
Manduria. E a leggere i tantissimi commenti di lamentele accondiscendenti, sotto
il posto dell’autore delel critiche, non ci si stupirebbe. Ma c’è stato
realmente un aumento dei prezzi tanto da far scappare i visitatori? E di quanto?
«Signori operatori i miei soldi non ve li regalo»,
ha scritto con certa rabbia l’uomo. Eppure per il direttore di
Confcommercio, Tullio Mancino, questo spauracchio del caro prezzi dev’essere
ridimensionato. «Si sta generalizzando e strumentalizzando troppo», ha spiegato
fermamente Mancino già a conoscenza della rimostranza dei turisti. «C’è una
lamentela comune è vero, ma bisogna però capire caso per caso e non
generalizzare». Si dovrebbe dunque considerare le scelte di ogni singolo
commerciante per poi fare una panoramica consuntiva più ampia, ma «al momento
non abbiamo elementi su cui poter fare un confronto corretto, dopo Ferragosto
sì», fa sapere il direttore lasciando in sospeso la scottante questione. Dati
ufficiali dunque ancora non ce ne sono, ma il caro prezzi sulle marine
manduriane è ugualmente percepito da moltissimi tanto da preferire una vacanza
fuori confini, in Albania ad esempio, che quest’anno ha sbaragliato la
concorrenza. Secondo il motore di ricerca sui voli eDreams, la meta estera più
cliccata dagli italiani è Tirana, in Albania per l’appunto, un posto marittimo
(non molto diverso dalla Puglia) ma rinomato per la sua economicità.
Ciononostante la Puglia ha attestato un aumento
parziale del gettito della tassa di soggiorno: «Più del 3% rispetto al 2022»,
fanno sapere, invece, le autorità del comune di Vieste, nel foggiano, investiti
anche loro dalle lamentele sull’impennata dei prezzi. «Dipingere Vieste e la
Puglia come residenze di Montecarlo sembra più una campagna volta a denigrarne
la loro formidabile e fulminante ascesa nell’industria delle vacanze»,
sostengono a gran voce. In effetti secondo il monitoraggio Ipsos Future4Tourism,
la maggioranza degli italiani continua a prediligere il Bel Paese e le mete
balneari, sebbene si registri anche una ripresa delle mete europee ed
extra-europee. Tra giungo e settembre il 67% resterà in Italia, in lieve calo
rispetto all’estate 2022, preferendo città come Catania, Napoli, Palermo,
Cagliari, e per la Puglia Porto Cesareo e Gallipoli. Chissà, alla fine, quale
sarà la meta prediletta del turista arrabbiato sui social. Marzia Baldari
Poi ci sono i rinnegati.
Puglia «smeralda»: il caro-prezzi spaventa i
vacanzieri, ma resta la più gettonata tra gli stranieri. A spiccare secondo
l’indagine per le tariffe elevate nel panorama regionale è proprio la perla
salentina dello Ionio. BARBARA POLITI su La gazzetta del Mezzogiorno il 3
agosto 2023
Il tam-tam viaggiava fra gli addetti ai lavori già
da qualche giorno: meno turisti negli stabilimenti balneari, poco flusso per le
strade di borghi solitamente presi d’assalto, minore consumo di prodotti
food&wine (e quindi calo degli ordini) nelle attività di ristorazione.
Archiviato il mese di luglio, è l’Adoc a spiegare le cause della palpabile
diminuzione del turismo in Puglia, con tanto di indagine sul campo. «Dal Gargano
al Salento, i prezzi sulle spiagge pugliesi sono molto più alti rispetto a
Grecia e Albania. A Gallipoli, ad esempio, per una giornata al mare (compresa la
consumazione al ristorante) e una notte in un B&B, una famiglia di quattro
persone arriva a spendere fino a 500 euro», sentenzia Giulia Procino, presidente
di “Adoc Puglia”.
Snocciolando i numeri dell’analisi, così, si
scopre che a spiccare per il caro-prezzi nel panorama regionale è proprio la
perla salentina dello Ionio. Dai 35 ai 50 euro per un ombrellone e due lettini,
dai 106 ai 265 euro per una matrimoniale senza troppe pretese e fino a 150 euro
a cranio per un pranzo al ristorante. Senza dubbio più economici il Gargano -
dove la media di spesa complessiva per una famiglia di quattro membri si abbassa
a 300-400 euro - e le marine del tarantino; a Pulsano ombrellone e due lettini
costano tra le 20 e le 40 euro. Prezzi lievitati invece in provincia di Bari:
per una notte nella bellissima Polignano a Mare si parte da 250 euro a notte
(escluse dall’analisi, ovviamente, le strutture extralusso). Se i turisti
scappano, insomma, è colpa dei prezzi. Parola di Adoc: «Prezzi aumentati per
tutti i servizi turistici e difficoltà economica post Covid. Sono tante le
famiglie che hanno rinunciato alle vacanze o che comunque hanno scelto mete più
economiche, anche a costo di andare all’estero». Secondo le stime, il calo si
aggirerebbe intorno al 20%.
E se c’è chi pensa al “complotto dell’estate”,
come il consigliere regionale della Lega (nonché titolare del lido “Samarinda” a
Santa Maria di Leuca), Gianni De Blasi, in tanti ritengono invece che
all’origine della fuga ci siano proprio i costi eccessivi. «Assistiamo a una
campagna denigratoria, nata dalla stessa Puglia e diffusasi a livello nazionale,
impegnata a raccontarci quanto siano lunari e sproporzionati i prezzi nelle
nostre strutture, con una deformazione e generalizzazione della realtà che
produce un danno di immagine ed economico alle nostre attività che, ogni giorno,
combattono la morsa della crisi economica», tuona il consigliere. Una
«narrazione drogata – continua - che racconta di una Puglia in cui non si può
andare al mare senza spendere meno di 100 euro al giorno per una postazione in
spiaggia e fino a 500 euro per una notte in un B&B».
Caro prezzi. Pagliaro: “Stop a campagna
denigratoria verso il Salento. Qui, come altrove, servizi e costi per tutte le
tasche”. Da Consiglio.puglia.it. Nr.: 1364 del 04/08/2023 12:52 Turismo
Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro,
capogruppo "La Puglia Domani" e presidente "Movimento Regione Salento".
“Da giorni leggo ovunque notizie su un caro prezzi
che riguarda il Salento. Sinceramente mi sembra una campagna denigratoria verso
il nostro territorio. Dovremmo essere tutti più lucidi nella descrizione delle
storie e dei numeri. Si parla di un calo di presenze ma i conti si dovrebbero
fare alla fine della stagione, era preventivabile tutto questo, perché i rincari
quotidiani tra carburante, cibo e bollette varie, ha costretto molte famiglie a
rivalutare le opzioni per le vacanze. Già nel 2019, ultimo anno pre Covid,
registrammo un lieve calo di presenze dopo il boom degli anni precedenti. Calo
fisiologico ma già mettevamo in guardia su un’ulteriore flessione, se non si
fosse intervenuti per qualificare e differenziare l’offerta turistica, per
formare il personale, per offrire servizi su misura per le varie fasce di
clientela.
"Premesso che sono contrario ad ogni forma di
speculazione e ai prezzi esagerati, c’è da dire che vengono esposti o indicati
prima, lasciando a ciascuno la scelta di spendere quelle cifre oppure no. Quali
sono i prezzi fuori mercato? Semplice: se scegli di andare in una piccola
realtà, magari decentrata rispetto a quelle più gettonate, non puoi pagare le
stesse cifre. Tutto devo essere proporzionato tra domanda e offerta. I costi
devono essere chiari prima, nessuno deve subire sorprese. Paragonare però i
nostri prezzi a quelli della Grecia o dell’Albania (ed anche lì spendi a seconda
di dove scegli di andare) è una scorrettezza. Non ho mai letto da nessuna parte,
tanto per essere chiari, che i Caraibi sono più cari del Salento. Lo si dà per
scontato.
"Detto questo, arrivati nel Salento, ci sono
chilometri di costa libera e di scogliere meravigliose. Se una famiglia vuole
risparmiare può risparmiare. Però se qualcuno, come Ansa ieri, fa un titolo
“Turismo, fino a 500 euro a famiglia per un giorno nel Salento”, rimango
perplesso. Famiglia? Quattro persone? Mangiare, dormire, spiaggia privata costo
500 euro? Io mi fermerei un attimo prima di dire che è caro. Di cosa stiamo
parlando? Chi prenota ha scelto il Salento. Siamo in un libero mercato. Qui nel
Salento ci sono meraviglie per tutte le tasche. Lungi da me però avallare le
esagerazioni, l’ho premesso e lo ripeto. Lo dice la saggezza popolare salentina:
“Comu spiendi mangi”. Ognuno scelga quanto può spendere, dove andare e cosa
mangiare. Perché tutto questo rumore intorno al Salento? Ma veramente pensate
che i problemi del Salento siano i prezzi alti?
"Noi combattiamo ogni giorno per i veri problemi
di questa terra, e chi vuole provare a risolverli, chi vuole unirsi a noi,
venga, lo aspettiamo a braccia aperte. Abbiamo alzato le barricate contro
l’eolico offshore e il fotovoltaico selvaggi che sfregiano il paesaggio e la
bellezza; ci battiamo da sempre per servizi dignitosi nella stazione di Lecce,
declassata da stazione di testa della linea ferroviaria nazionale ad
infrastruttura periferica e di serie B, senza scale mobili né ascensori a
disposizione degli utenti, costretti a trascinare il peso dei bagagli. Per i
passeggeri di Salento in Bus il capolinea è la Camera di Commercio, con un lungo
tratto da percorrere a piedi per arrivare in stazione; sono da terzo mondo le
linee i collegamenti con la linea ferroviaria locale e con l’hinterland.
"Un copione che si ripete all’aeroporto del
Salento, dove i turisti una volta arrivati a Brindisi si trovano spaesati,
scollegati dai capoluoghi e dalle località di villeggiatura. Combattiamo per
difendere il nostro mare dall’inquinamento e dall’invasione della plastica come
le cassette di polistirolo, abbiamo lottato per far approvare una legge che
consenta il ripopolamento dei ricci di mare per il ripristino di un ecosistema
che è stato stravolto dalla mano devastatrice dell’uomo.
"Se sento lamentele sull’abbandono di rifiuti,
sulle strade insicure e rischiose, con la visuale impedita da sterpaglia, sulla
segnaletica carente e sul senso civico che latita, sui trasporti inefficienti,
sui continui lavori in corso, sulle infrastrutture monche ed eterne incompiute,
allora mi unisco al coro. Ma senza limitarmi alla lamentela, sempre con proposte
che puntano a migliorare la situazione. Da trent’anni il mio impegno quotidiano
va in questa direzione, da salentino innamorato della propria terra. Quindi,
cari signori, giù le mani dal Salento. Secondo il mio parere si sta davvero
esagerando per tentare di screditarlo. Godetevi e godiamoci questa bellissima
estate”.
Lontano dai “pochi” casi di speculazione, secondo
De Blasi, è però arrivato il momento di «fermarsi a riflettere sul potenziamento
dei servizi primari, come le infrastrutture». Sparare nel mucchio non è giusto,
ma con l’onestà intellettuale che contraddistingue noi pugliesi, padroni di
casa, sarebbe forse il caso di ammettere che (probabilmente) ci siamo allineati
a una tendenza che è tutta nazionale, forse diventandone (ahinoi) anche
protagonisti. Le previsioni per l’alta stagione appena iniziata, quindi il mese
di agosto, sono anche più fosche: secondo l’Osservatorio nazionale di
Federconsumatori ci sarà un rincaro del 20% rispetto allo scorso anno, che aveva
già risentito degli aumenti della stagione precedente. Il valore di un weekend
in uno stabilimento balneare fluttua sul territorio nazionale in base alle zone:
dai 40 euro di Viareggio e Riccione ai 60 euro della Sardegna.
È purtroppo salentino il primato nero nazionale:
la media giornaliera a Gallipoli è di 80 euro (fino a 120 nelle strutture di
livello superiore), si abbassa nella maggior parte dei lidi di Porto Cesareo, ma
trova il suo record assoluto a Pescoluse, con il prezzo stellare di mille euro
per un gazebo in riva al mare. Se ci mettiamo anche che le tabelle regionali
hanno indicato la Puglia, in compagnia di Trento e Bolzano, in cima alla
classifica nazionale del caro-carburante e che, oltre i lidi, a lievitare sono
state anche le tariffe di case vacanza e stanze private (dove non sempre il
rapporto qualità dell’immobile-prezzo brillava per onestà), lo spot pugliese è
servito. Il clamore però non sempre porta “guai”: potrebbe essere proprio questo
l’inizio di una nuova riflessione sul brand della nostra regione e sulle sue
potenzialità future.
Ecco le previsioni di Federalberghi
«Boom dall’estero ma pesa l’inflazione»
«Quest'anno in Italia abbiamo avuto un grosso boom
di turismo internazionale soprattutto americano e quindi le città d'arte stanno
andando molto bene visto che sono mono mercato del turismo statunitense». Lo ha
detto il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca al Tg2 Post su Rai 2.
Tuttavia, ha aggiunto Bocca, interpellato sui riflessi del caro carburanti sulle
vacanze, «nel resto del Paese facciamo fatica a raggiungere i risultati
dell’anno scorso: per quanto riguarda il mercato italiano ed europeo vediamo
rallentamenti soprattutto dalla Germania che vive un momento di crisi economica»
ha osservato Bocca.
«L'appello forte che facciamo al governo è di
intervenire con decisione e coraggio sul cuneo fiscale. Bisogna defiscalizzare
il lavoro per dare più soldi nelle tasche degli italiani perché la busta paga
degli italiani oggi non è in grado di pagare i mutui sulle case, il carrello
della spesa e fare le vacanze» ha proseguito il presidente di Federalberghi
Bernabò Bocca.
Quanto ai consigli per risparmiare sulle vacanze
Bocca ha detto: «Oggi Internet è una vetrina attraverso la quale si possono
trovare tutte le soluzioni di vacanza, in Italia esistono 27 mila alberghi, è il
paese in Europa con il maggior numero di alberghi e quindi possiamo offrire
vacanze per tutte le tasche. Il costo dell'albergo non incide più del 30% quindi
noi abbiamo le nostre responsabilità questa quota ma il 70% va cercato altrove,
nei costi dei trasporti, dei ristoranti, del divertimento. Ma con l'aumento dei
costi di esercizio abbassare i prezzi oggi significa mandare in perdita i
bilanci delle aziende».
«È fondamentale per le istituzioni di questo Paese
mantenere un canale di dialogo sempre aperto con gli stakeholder e gli operatori
di un settore così importante come quello turistico. Il segmento del trasporto
aereo - dice invece Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti
della Camera dei deputati, all'indomani dell'incontro con Franco Gattinoni,
presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio - è
naturalmente vitale per il diritto alla mobilità in quanto tale, ma anche per un
comparto che, pur in fase di rilancio, rischia contraccolpi pesanti sia per il
caro prezzi sia per i disagi che si sono vissuti, in particolare, in questo
periodo a causa delle compagnie aeree. Purtroppo temiamo una forte
penalizzazione in particolare dell’incoming e degli eventi organizzati in Italia
se i clienti che arrivano nel nostro Paese con voli internazionali poi subiscono
limitazioni inaccettabili sui trasferimenti nazionali». [Red.p.p.]
Ma la Puglia resta la più gettonata tra gli
stranieri che cercano casa
La Puglia conferma il trend di crescita che la
vede tra le destinazioni preferite dai cittadini internazionali che vogliono
comprare casa in Italia. Secondo i dati elaborati da Gate-away.com, il portale
per vendere casa all’estero, la regione registra un aumento di richieste di
abitazioni nel primo semestre del 2023, piazzandosi al quarto posto tra le
regioni italiane (dietro a Sardegna, Sicilia e Calabria) per crescita rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno.
A trainare la crescita è la zona del Gargano che
nel semestre registra un +33.33% di richieste rispetto allo stesso semestre del
2022. Per quanto riguarda le preferenze di periodo prevale la provincia di
Brindisi che si conferma al primo posto con il 53.18% sul totale delle
richieste; segue Lecce con il 26.61% e la Provincia di Bari con il 10.28%.
Seguono Taranto (6.55%), Foggia (2.79%) e Barletta-Andria-Trani (0.59%). Tra i
Comuni il più richiesto è Ostuni con il 18.69% delle richieste sul totale.
Seguono Carovigno con il 10.93%, Ceglie Messapica con il 6.52%, San Vito dei
Normanni con il 5.4%. La crescita più elevata (rispetto al 1° sem.2022) è
registrata da Vico del Gargano che segna un progresso di richieste pari al
+128.57%. Segue Morciano di Leuca con un +119.57% e Martina Franca con un
+82.67%. I cittadini statunitensi si confermano i più interessati a cercare casa
in Puglia: nel periodo le richieste di raggiungono il 27.2%. Tra le altre
nazioni troviamo il Regno Unito (11.8%), la Germania (9.3%) e Francia (8.6%). Da
segnalare il boom di richieste provenienti dal Brasile: rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno registra un +833.33% a/a. Seguono Malta (+414.29%) e
Emirati Arabi (+123%).
L'acquirente straniero in cerca di una casa in
Puglia si distingue per la sua versatilità e interesse per una vasta gamma di
opzioni abitative. Non si limita a cercare solo case di lusso, ma è aperto a
esplorare ogni fascia di prezzo disponibile sul mercato. Le abitazioni più
ricercate continuano ad essere prevalentemente le categorie Villa (30.7% del
totale), segue il Trullo (16.7% del totale) e la casa indipendente (7.45%). Da
segnalare un forte incremento della categoria “Lamia” che registra un +290.3% di
richieste rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli stranieri cercano
una casa completamente restaurata/abitabile (50.7% del totale delle richieste)
con un giardino (51.6%), senza la piscina (74%) e con terreno (60%).
Sul fronte dei prezzi, a differenza di quanto si
possa pensare, sono le fasce più basse a registrare la maggioranza delle
richieste: quella da 0-100 mila registra il 40.36% delle preferenze, mentre
quella tra 100-250 mila euro segna il 27.2%. Seguono le fasce 250-500 mila euro
(17.26%); 500-1 milione di euro (9.3%).
L’5.84% cerca case oltre 1 milione di euro.
«Questo fenomeno che notiamo in Puglia è
indicativo di un trend positivo che si sta diffondendo su tutto il territorio
italiano e che mette in evidenza come gli acquirenti stranieri non siano
interessati solo ad alcune località o solo a certe categorie di immobili, bensì
siano propensi a considerare attentamente le opportunità di acquisto che ogni
territorio può offrire», afferma Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com.
«Sappiamo bene che per gli stranieri comprare una casa in Italia e in questo
caso in Puglia non è solo un investimento, ma anche il modo per realizzare un
sogno e vivere le bellezze che il nostro Paese può offrire, abbracciando allo
stesso tempo uno stile di vita unico. Questo interesse internazionale
rappresenta un'importante opportunità per i privati che vogliono vendere casa e
gli operatori del settore immobiliare». [Red.p.p.]
Turista fai da te che vieni nel Salento, vade
retro e non ritornare! Antonio Giangrande
Il Turista fai da te. Il Salento e l’orda dei
profughi.
Arrivano in massa, senza soldi e con la litania
lamentosa e diffamatoria: perché qua è diverso?
La meta del turista fai da te che arriva in
Salento è il mare, il sole, il vento ma è stantio a metter mano nel portafogli e
nell’intelletto. C’è tanta quantità, ma poca qualità.
Il turista fai da te che arriva nel Salento è come
un profugo in cerca spasmodica di benessere gratuito. Crede nei luoghi comuni e
nei pregiudizi, nelle false promesse e nelle rappresentazioni menzognere
mediatiche.
Con prenotazione diretta last minute, al netto
dell’agenzia, prende un appartamento con locazione al ribasso e con pretesa di
accesso al mare. Si aggrega in gruppo per pagare ancora meno. Ma a lui sembra
ancora tanto. Poi si meraviglia della sguaiatezza di ciò che ha trovato. Tutto
l’anno fa la spesa nei centri commerciali e pretende di trovarli a ridosso del
mare. Non vuol fare qualche kilometro per andare al centro commerciale più
vicino, di cui i paesi limitrofi son pieni, e si lamenta dei prezzi del
negozietto stagionale sotto casa. Durante l’anno non ha mai mangiato una pizza
al tavolo e quando lo fa in vacanza se ne lamenta del costo. Vero è che il
furbetto salentino lo trovi sempre, ma anche in Puglia c’è la legge del mercato:
cambia pizzeria per il prezzo giusto.
Il turista fai da te tutto l’anno vive in
palazzoni anonimi, arriva in Salento e si chiude nel tugurio che ha affittato
con poco e poi si lamenta del fatto che in loco non c’è niente, nonostante sia
arrivato nel Salento, dove ogni dì è festa di sagre e rappresentazioni storiche
e di visite culturali, che lui non ha mai frequentato perché non si sposta da
casa sua. Comunque una tintarella a piè di battigia del mare cristallino
salentino è già una soddisfazione che non ha prezzo.
Il turista fai da te si lamenta del fatto che sta
meglio a casa sua (dove si sta peggio per cognizione di causa) e che qui non
vuol più tornare, ma, nonostante il piagnisteo, ogni anno te lo ritrovi nella
spiaggia libera vicino al tuo ombrellone. Si lamenta della mancanza di
infrastrutture. Accuse proferite in riferimento a zone ambientali protette dove
è vietato urbanizzare e di cui egli ne gode la bellezza. A casa sua ha lasciato
sporcizia e disservizi, ma si lamenta della sporcizia e della mancanza di
servizi stagionali sulle spiagge. Intanto, però, tra una battuta e l’altra,
butta cicche di sigaretta e cartacce sulla spiaggia e viola ogni norma giuridica
e morale. La raccolta differenziata dei rifiuti, poi, non sa cosa sia. Ogni
discorso aperto per socializzare si chiude con l’accusa ai meridionali di
sperperare i soldi pagati da lui. Lui, ignorante, brutto e cafone, che risulta
essere, anche, evasore fiscale.
Il turista fai da te lamentoso è come il profugo:
viene in Salento e si aspetta osanna, vitto e alloggio gratis di Boldriniana
fattura. Ma nel Salento accogliente, rispettoso e tollerante allora sì che trova
un bel: Vaffanculo…
Dr Antonio Giangrande
Bari, mangiano al ristorante e vanno via senza
pagare: il furbetto pentito salda il conto. Il turista fuggito dopo aver
mangiato con tutta la famiglia ha chiamato il ristoratore. MONICA ARCADIO su La
Gazzetta del mezzogiorno il 14 Agosto 2023.
«Sapevamo che la nostra fiducia era stata ben
riposta. Lo sentivamo nel profondo del nostro cuore», sono felici i titolari del
ristorante La Parrilla, Ernesto Matera e Gaetano Catalano, che qualche giorno fa
– attraverso le pagine della Gazzetta del Mezzogiorno – hanno lanciato l’appello
a un cliente il quale, dopo aver consumato una cena di 130 euro con la sua
famiglia e i suoi amici, si era allontanato senza pagare. L’uomo, in queste
ultime ore, ha telefonato ai due giovani soci del locale di piazza Mercantile, e
si è scusato.
Bari, a cena con tutta la famiglia, poi si dilegua
senza pagare: la denuncia
«Una distrazione nel momento in cui avrebbe dovuto
pagare e quindi la dimenticanza», così ha giustificato – spiegano i due giovani
soci - il suo gesto ripreso dalle telecamere di video sorveglianza e poi
pubblicato sui canali social. «L’uomo – che ci ha chiesto tante volte scusa nel
corso della telefonata – ha già provveduto a effettuare un bonifico per saldare
il conto», ci hanno spiegato Matera e Catalano.
«Eravamo amareggiati e delusi perché da un anno
ormai ci stiamo prodigando, noi e le nostre famiglie, per questo locale che
abbiamo voluto con tutte le nostre forze. La realizzazione di un sogno –
proseguono - con tanti sacrifici, ma anche con tanto amore». «Il mancato
pagamento di un cliente - sottolinea Catalano – ha rappresentato per noi uno
schiaffo a tutto questo. Speravamo, anzi sapevamo, che quell’uomo si sarebbe
fatto vivo e ci avrebbe spiegato tutto. Così è stato e siamo felicissimi».
I due imprenditori baresi, nei giorni scorsi, si
erano detti pronti a denunciare, ma hanno preferito attendere e sperare che
tutto si risolvesse. «L’uomo, che non è pugliese, ha chiesto scusa e ha saldato
il conto. Va bene. Siamo giovani e vogliamo credere davvero che il rispetto per
le persone e per il lavoro sia il valore da coltivare, come ci hanno insegnato i
nostri genitori. Abbiamo voluto dare fiducia e siamo certi, anche alla luce del
lieto epilogo di questa vicenda, che questo sia il miglior messaggio che si
potesse dare. Un messaggio positivo».
«Abbiamo faticato e continuiamo a faticare per
ottenere risultati importanti in questa nostra attività. Ci siamo messi in
gioco, insieme alle nostre famiglie e ai nostri collaboratori, in un momento
delicato per l’economia del nostro Paese e lo abbiamo fatto, non a caso, nella
nostra amata città. Bari», avevano già detto i due giovani soci e ancora oggi lo
ribadiscono, fermamente convinti che l’atteggiamento mantenuto in questa storia
sia stato il migliore. «Nessuna denuncia. Aspettare ci è sembrato come offrire
una possibilità a quest’uomo. La possibilità di spiegarci perché e di risolvere
tutto con una stretta di mano. Oggi più che mai siamo felici di aver agito in
questo modo e a lui va il nostro grazie», concludono.
Supplemento agosto. L’estate senza scandali, i
reportage al Twiga e le inchieste a schiena dritta sugli scontrini.
Guia Soncini su L'Inkiesta il 14 Agosto 2023.
Il nuovo formato giornalistico è il sovrapprezzo e
così i quotidiani denunciano, come se stessero facendo il Watergate, i costi dei
lettini di lusso in spiaggia, i prezzi delle tigelle e i cinquanta centesimi per
il cubetto di ghiaccio nel caffè
Riempire i giornali d’estate è un incubo, lo so.
Quanti articoli sul bere tanta acqua puoi fare? Per non parlare del fatto che,
in questo secolo di bradipi che si sentono ghepardi, non puoi neanche più usare
i classici: se dici di aspettare tre ore dopo mangiato prima di fare il bagno,
l’internet ti spernacchia.
Su Twitter c’è un account che pubblica ogni
settimana le copertine di dieci anni prima dei quattro principali settimanali
scandalistici americani. Dieci anni fa i due principali erano andati sul sicuro
istituzionale: Kate Middleton aveva partorito. Gli altri due, poveretti, avevano
uno la copertina sul divorzio multimilionario tra Michael Douglas e Catherine
Zeta-Jones (mai neanche separati, che si sappia), e l’altro la gravidanza di
Jennifer Aniston (mai stata incinta, che si sappia).
Una volta la sparavi grossa e dopo due giorni
nessuno se ne ricordava, la tua copertina con la gravidanza immaginaria foderava
le cassette dei gatti e tu potevi ricominciare a millantare saperlalunghismo.
Adesso tutto è perpetuo, e gente che non ti comprerebbe comunque ride di te
osservando gratis gli archivi delle tue millanterie.
In Italia, dove siamo talmente senza star-system
che sulla copertina di Chi c’è Maria Elena Boschi, e i quotidiani per la
disperazione tra un po’ intervisteranno la maestra dell’asilo che ci racconterà
com’era da piccolo il tizio che ha sciorinato le proprie corna alla festa di
fidanzamento, non possiamo vivere di sola spremitura di corna torinesi.
Quindi, i giornali hanno deciso che il formato
giornalistico dell’estate sono i sovrapprezzi. Dovevamo sospettare che sarebbe
finita così quando tutti i giornali – ma tutti, da Repubblica a Cavalli e
segugi: sono un po’ offesa che Linkiesta non abbia ritenuto di farmi noleggiare
un lettino in terza fila – hanno mandato un inviato al Twiga.
Giornali che da anni dicono ai collaboratori che
no, non ci sono soldi, peccato per quell’esclusiva sul letto di morte che ti
aveva offerto la regina Elisabetta ma proprio non ci possiamo permettere un Ryan
Air per Londra, hanno ritenuto fondamentale investire cinquecento euro per far
scrivere ai loro inviati che al Twiga – dove una giornata di lettino e
ombrellone costa appunto cinquecento euro: ecco qui lo scontrino che illustra
l’articolo e che è ovviamente più importante dell’articolo stesso essendo noi
consapevoli che il pubblico ormai guarda solo le figure – la spiaggia è solo una
spiaggia e il mare è solo mare.
Quando tutti ma proprio tutti avevano pubblicato
lo scontrino del Twiga, siamo passati a quelli minori. Lo scontrino che dice che
hanno fatto pagare a qualcuno la divisione in due d’un toast. Seguono interviste
ai clienti truffati, alla gente famosa indignata, alla colpevole di taglio del
toast retribuito che rivendica che il lavoro sta in Costituzione o qualcosa del
genere.
Poi lo scontrino del piattino per far assaggiare a
una bambina le trofie ordinate dalla mamma, e in primo piano ben a fuoco i due
euro di dicitura piattino, e altro giro di interviste, indignazioni, e lettori
che si chiedono perché diavolo la mamma non abbia dato alla bambina una
forchettata dal proprio piatto come tutte le mamme nella storia del mondo
dall’invenzione delle forchette in poi, e i ristoratori che ci parlano del costo
delle spugnette in ristoranti che evidentemente non si possono permettere
neanche la lavastoviglie.
Sempre nella stessa settimana, quella in cui era
ormai agosto e non c’erano notizie non sceme cui dedicarsi, lo scontrino delle
tigelle. Ottocentoquarantacinque euro, accipicchia. Però erano in ventiquattro,
dicono i gestori del chiosco. Ma alcuni erano bambini molto piccoli, dicono i
ventiquattro: bambini piccoli, conti piccoli. Alla fine questi, invece di pagare
prima e poi andare a protestare sui social, hanno piantato un tale casino che
duecento e spicci euro di tigelle glieli hanno scontati.
Sono meglio quelli che piantano un casino alla
cassa o quelli che fotografano scontrini contando sulla dopamina attivata
dall’indignazione social? Se mangi la pizza da Cracco e poi ti lamenti che costi
come una pizza di Cracco sei scemo o la società ti deve solidarietà? (O forse la
società ti deve solidarietà proprio perché sei scemo?). Non lo so, ma non si
sentiva parlare tanto di scontrini da quando in Parlamento arrivarono i Cinque
stelle e scambiarono il concetto di responsabilità politica con le
rendicontazioni del barbiere della buvette e delle bollette dei cellulari.
Ci sarebbe anche la questione della roba da bere
ai concerti, che a quanto ho capito (sono troppo vecchia per i concerti) ora si
paga coi soldi del Monopoli che devi convertire prima, e le cifre di questi
gettoni dell’autoscontro usati per pagare la birra non sono mai tonde, quindi a
chi ha speso duecento euro per vedere Beyoncé tocca pure sprecare due euro di
gettoni inutilizzabili, e sono quei due euro a costituire un inaccettabile
aggravio economico.
L’ultima foto che ho visto è quella dello
scontrino del ghiaccio: cinquanta centesimi per il cubetto di ghiaccio da
mettere nel caffè. Anni fa il commercialista mi suggerì una app che avrebbe
archiviato gli scontrini da detrarre – quelli delle farmacie e dei ristoranti
che mi perdevo sempre prima di consegnarglieli – se li fotografavo. Non l’ho mai
scaricata, perché tanto lo so che mica mi ricordo di fotografare gli scontrini.
A quante pare, sono l’unica italiana a non farlo.
Visto che mancano ancora le due moscissime
settimane postFerragosto, suggerisco ai giornali supplementi ai limiti
dell’estorsione dei quali indignarsi se dovessero venir meno fotografatori di
scontrini a offrire spunti.
A Milano il supplemento notturno sul tassì è di
sette euro e sessanta (in novecentese: quindicimila lire) e scatta alle nove di
sera, cioè quando in estate c’è la luce di mezzogiorno. È una cosa di cui
m’indigno in silenzio da quindici anni, non è che se vi fotografo il tariffario
ci fate una serie d’articoli?
Dal parrucchiere il balsamo si paga a parte, è un
sopruso relativamente recente: nel Novecento non solo il balsamo era ovviamente
incluso, ma spesso il parrucchiere ti omaggiava della manicure. Adesso, ho visto
un parrucchiere in via Moscova, sempre Milano, che oltre al balsamo ti fa pagare
anche gli asciugamani. L’alternativa immagino sia scrollare la testa come i
cavalli. Se fotografo i prezzi in vetrina, posso contare su un’inchiesta?
Ma, soprattutto, se ordino qualcosa dalla Cina o
dall’America (o persino da Londra, mannaggia alla Brexit), il dazio doganale che
il postino mi chiede prima di consegnarmi il mio pacco, dazio che di suo è
sempre calcolato misteriosamente a casaccio, ha in più il ventidue per cento di
Iva. L’Iva sul dazio. La tassa su una tassa. Se vi fotografo un Meridiano di
Kafka, posso sperare che diventi lo scandalo dell’estate?
Estratto da leggo.it domenica 13 agosto 2023.
Cena "pesante" e conto «salatissimo» per un gruppo
di famiglie in un chiosco a Maranello, in provincia di Modena. Quello che si
aspettavano essere un momento conviviale in compagnia si è rivelato un incubo
per il portafoglio dei presenti.
«Eravamo in tredici adulti e undici bambini: a
fine serata ci è stato detto che dovevamo sborsare 845 euro», ha raccontato una
dei commensali. La titolare ha risposto così.
Sembra sia iniziata la gara a chi fa pagare di più
un servizio e se così fosse, al momento, sarebbe vinta dalla proprietaria di un
chiosco a Maranello, località in provincia di Modena. Il conto salato,
inizialmente di oltre 800 euro è poi sceso a 585 dopo le proteste dei clienti.
«Oltre allo gnocco e alle tigelle, c’era qualche
tagliere, ma tutt’altro che ricco - ha raccontato una dei commensali al Resto
del Carlino che ha riportato la notizia - e soltanto per quanto riguarda il
bere: cioè delle bottigliette d’acqua, delle bibite e qualche birra, abbiamo
pagato 130 euro.
Insomma, un salasso: quando ne siamo venuti a
conoscenza, l’abbiamo fatto subito notare, perché ci sembrava un prezzo
improponibile. Anche perché alcuni dei bambini che erano a tavola con noi sono
molto piccoli e non mangiano di certo così tanto».
A quel punto «la titolare dice di venirci
incontro, togliendo così 260 euro. Il conto è stato diviso per tredici persone,
escludendo chiaramente i bambini, quindi alla fine abbiamo pagato novanta euro
a coppia. Comunque, per quanto mi riguarda, un prezzo esagerato per mangiare
gnocco e tigelle in un chiosco.
Anche in quel momento, mi sono insospettita: non
ho capito nemmeno perché non siamo arrivati a una cifra tonda: su che base ha
fatto questo sconto? Continuo a pensare che sia un qualcosa di assurdo.
Avvertirò la finanza dell’accaduto». […]
Dal canto suo, la titolare del chiosco, però, ha
ben pensato di commentare l'accaduto così: «Una scena del genere non mi è mai
successa in sedici anni di attività: sono arrivati alle 18 per prenotare gnocchi
e tigelle, e alle 19.30 era tutto pronto per essere servito in tavola.
Hanno mangiato di tutto e di più, senza limiti:
questo significa che non ho portato tre o quattro tigelle a testa, ma molte di
più, fino a che tutti non avevano la pancia piena. Il tutto, arricchito da
numerosi taglieri di affettato, dodici in tutto. Senza dimenticarci poi del
bere».
Non solo. «In tavola comunque erano ventiquattro
persone. E il conto è stato diviso per tredici: è chiaro che una coppia con un
figlio solo, in questo modo, ha pagato ’tanto’. Ma una famiglia con tre bambini,
invece, ha pagato molto poco. Alla fine ho abbassato il prezzo per quieto
vivere, per concludere tutto il caos che si era generato, per nulla piacevole».
Estratto dell’articolo di Natalia Distefano
per corriere.it domenica 13 agosto 2023.
L'ultima segnalazione arriva da due lettori romani
in vacanza in Sardegna. Ieri sera, intorno alle 20, sedersi al tavolino del bar
Portico all'Hotel Cervo e ordinare due caffè con due bottigliette d'acqua gli è
costato 60 euro. Qualcuno potrebbe non sorprendersi, vista la location da
cartolina, e va detto che insieme ai caffè sono arrivate anche due coppe di
cioccolatini (come si vede nella foto che ci è stata inviata dai turisti
romani). […] «La giustificazione dei gestori - raccontano - è stata che non si
tratta di un semplice caffè ma una esperienza. La realtà è però un caffè con
acqua e 2 biscotti».
Porto Cervo, turisti romani pagano 60 euro per
due caffè e due bottigliette d'acqua. Natalia Distefano su Il Corriere della
Sera domenica 13 agosto 2023.
Il conto salato è arrivato ai tavolini del bar di
un hotel in Sardegna. Ma anche in Autogrill i prezzi sono alle stelle: 18 euro
per due panini e un'acqua
Due euro a Finale Ligure per un piattino (vuoto)
richiesto al tavolo. A Maranello conto salato per la comitiva a cena con le
tigelle: 845 euro. Ordina un aperitivo a Verona, il conto è di 64 euro. È
l'estate degli scontrini roventi.
Un espresso ai tavolini del bar d'albergo costa 30
euro
L'ultima segnalazione arriva da due lettori romani
in vacanza in Sardegna. Sabato sera, intorno alle 20, sedersi al tavolino del
bar Portico all'Hotel Cervo e ordinare due caffè con due bottigliette d'acqua
gli è costato 60 euro. Qualcuno potrebbe non sorprendersi, vista la location da
cartolina, e va detto che insieme ai caffè sono arrivate anche due coppe di
cioccolatini (come si vede nella foto che ci è stata inviata dai turisti
romani). Ma 3o euro per un caffè rimane una cifra decisamente oltre ogni
pessimistica previsione. Così i due clienti hanno chiesto spiegazioni sulla
cifra da pagare. «La giustificazione dei gestori - raccontano - è stata che non
si tratta di un semplice caffè ma una esperienza. La realtà è però un caffè con
acqua e 2 biscotti».
Non solo spiagge, la pausa pranzo costa cara anche
in Autogrill
E la questione del caro-scontrino non sembra
migliorare pur allontanandosi dalle spiagge e dalle mete più gettonate dei
vacanzieri. Secondo Giustitalia anche la sosta per un ristoro nelle aree di
servizio in autostrada svuota le tasche degli italiani più del
dovuto. «Due romani di ritorno a Roma da una breve vacanza a Celico, vicino
Cosenza, si sono fermati martedì 8 agosto pomeriggio presso l'Autogrill di
Teano per mettere qualcosa sotto i denti dopo ore di viaggio in auto. Hanno
preso al bancone due focacce alla mortadella ed una bottiglietta d'acqua e si
sono visti arrivare un conto alla cassa di ben 18,20 euro (8,10 euro a panino +
2 euro per una bottiglia d'acqua)», riferisce l'associazione che ha deciso di
segnalare la vicenda al Garante per la sorveglianza sui prezzi.
Estratto dell’articolo di Mirco Paganelli per "Il
Messaggero" l'8 agosto 2023.
Chissà quale sarebbe stato il prezzo finale se
avessero chiesto di condividere pure un'insalata, un primo magari anche il
dolce. Fatto sta che farsi tagliare a metà un toast è costato a due ignari
turisti di Milano in gita sul Lago di Como due euro in più. La sorpresa, apparsa
sullo scontrino di un bar di Gera Lario è stata immortalata in una foto che ha
fatto il giro dei social dopo esser stata pubblicata sul noto sito di recensioni
"TripAdvisor".
Stando alla ricevuta, che risale al giugno scorso,
i clienti hanno scelto di ordinare un toast vegetariano con patatine al costo di
7,50 euro. Un prezzo tutto sommato standard come quello delle bevande: 3,50 euro
la coca cola, 1,50 euro mezzo litro di acqua e 1,20 euro il caffè.
Ciò che hanno denunciato i due consumatori è stato
il sovrapprezzo per aver diviso a metà quel pranzo veloce. «Il toast viene già
servito tagliato in due parti. Dobbiamo pagare perché lo abbiamo diviso?
Incredibile ma vero» ha scritto il cliente nella sua recensione.
Non si è fatta attendere la risposta del gestore
del bar, che ha difeso la scelta di applicare l'extra-costo sul servizio: «Se un
cliente mi chiede di fare due porzioni di un toast devo usare due piattini, due
tovaglioli e andare al tavolo impegnando due mani. È vero che il cliente ha
sempre ragione, ma è altrettanto vero che le richieste supplementari hanno un
costo».
[…] In realtà, in questa estate dei prezzi folli,
il caso scoppiato nel bar del comasco non è l'unico. La giornalista e blogger
Selvaggia Lucarelli sui suoi profili social ha pubblicato la foto di una
ricevuta di una trattoria a Finale Ligure dove una mamma aveva chiesto un
piattino per far assaggiare un po' di trofie al pesto alla sua bimba di tre
anni.
Un gesto che le è «costato caro», tanto da
ritrovarselo poi sullo scontrino anche lei con un sovrapprezzo di 2 euro, oltre
al costo del coperto già incluso. «Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la
mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po' anche alla bambina di tre
anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra
l'altro avendole già messo sul conto il coperto» ha raccontato la Lucarelli.
[…] c'è perfino chi denuncia la novità del
«supplemento cono di 1 euro» in gelateria. E i casi di conti folli, o
semplicemente altissimi, diventano fenomeni social.
[…] Tutto è più caro, per il turista del 2023, non
appena mette il naso fuori di casa. Sulla Riviera romagnola, tradizionale meta
per la classe media grazie ai prezzi molto competitivi di hotel e spiagge, si
sono registrati rincari un po' ovunque.
Per una stanza in albergo - ammettono da Asshotel
- si paga in media quest'anno il 15% in più dell'estate scorsa. Non va meglio
sulla battigia dove in tanti hanno ritoccato i listini. Se c'è chi ancora fa
pagare un ombrellone con due lettini 20 euro, magari perché in una zona più
decentrata, altri hanno per la prima volta superato quota 40 euro persino nelle
file lontane dal mare.
[…] Prezzi più salati anche a tavola dove il
coperto, sempre in Romagna, si è oramai assestato a un valore base di 3 euro in
trattoria, raddoppiato nel giro di pochi anni. I prezzi più ritoccati del menù
sono quelli dei dolci: se fino a poco tempo fa una panna cotta costavano in
osteria 4-5 euro, ora bisogna sborsare almeno 6-7 euro.
E c'è chi lamenta che, a fronte di prezzi delle
portate invariati, ne abbiano fatte le spese le quantità delle porzioni, sempre
più ridotte. Non stupisce allora se le vacanze degli italiani quest'anno sono
non solo più costose, ma anche più corte, secondo quanto rilevato da Assoutenti,
che registra rincari in bar e ristoranti del 6%. Le vacanze estive 2023
costeranno agli italiani 1,2 miliardi di euro in più rispetto all'anno scorso.
Estratto dell'articolo di Silvia Andreetto
per “la Stampa” mercoledì 9 agosto 2023.
Non sono le centinaia di recensioni negative
collezionate su Tripadvisor né i commenti velenosi sui social a turbare Ida
Germano, cuoca e titolare dell'Osteria del Cavolo di Finalborgo, il ristorante
finito nell'occhio del ciclone dopo che Selvaggia Lucarelli ha postato – sulla
scia del caso del toast diviso a metà con sovrapprezzo in un bar di Como – la
foto dello scontrino di una cliente: 2 euro in più per un piattino di
condivisione.
Ida Germano difende, con grande fermezza e
altrettanta tranquillità, il proprio operato. Ribadisce che il loro servizio è
accurato e accogliente, di avere una clientela affezionata e che mai ha messo in
discussione la qualità dei prodotti. Materie prime di qualità e grande
trasparenza. «A darmi una grande soddisfazione in questi due giorni - spiega -
sono le tante dimostrazioni di solidarietà che ho ricevuto da colleghi
ristoratori, dai clienti, turisti e residenti».
«È una polemica che non mi preoccupa per nulla –
dice, serafica, la titolare –. Il nostro è un piccolo ristorante con cinque
tavoli all'esterno, di cui quattro da due coperti e uno da tre. La signora dello
scontrino è amica di Selvaggia Lucarelli che, premetto, non è mai stata una
nostra cliente. L'abbiamo fatta accomodare a un tavolo da tre persone. Sono
stati occupati tre posti. Hanno ordinato un piatto di trofie al pesto e un
piatto di acciughe fritte. I due euro per il piattino di condivisione sono
riportati chiaramente nel nostro menù».
E ancora. «Hanno chiesto di condividere il piatto
di trofie in tre porzioni, per cui abbiamo portato due piattini. Quindi hanno
fatto la stessa richiesta per le acciughe fritte». E continua: «In totale i
piattini di condivisione sono stati quattro. Come si legge nello scontrino, ne
abbiamo fatto pagare solo uno» puntualizza.
[…] In totale un primo e un secondo in tre. «Sono
nove anni che applichiamo queste regole e nessuno si è mai lamentato».
[…] «Quello che mi fa molto piacere è che nessuno
ha mai mosso critiche per la qualità del cibo. Anzi, tutte le recensioni sono
sempre state positive. E questo non può che essere motivo di orgoglio e di
riconoscimento per un lavoro, come il nostro, che richiede grande
professionalità».
E tanto meno smuove Ida la critica sui 18 euro che
si pagano per mangiare un piatto di trofie al pesto. «Non si può discutere il
prezzo del piatto – sottolinea –. Un piatto di trofie può essere fatto pagare 8,
10 o 12 euro. Lo chef Cannavacciuolo può far pagare un piatto anche 40 euro. E
nessuno lo mette in discussione. Solo chi lo prepara è in grado di stabilirne il
prezzo».
Continua: «Mi fa piacere e quasi mi diverte questa
polemica. Ho 76 anni e faccio questo lavoro con passione. È giusto che io venga
pagata per quello che faccio e per il servizio che offro così come per i
prodotti di qualità che rendono unica la nostra cucina». Aggiunge: «Vorrei che
Selvaggia Lucarelli venisse ad assaggiare le nostre trofie al pesto. Solo dopo,
eventualmente, potrà criticarne il prezzo».
Ieri, dopo la tempesta mediatica, e le centinaia
di recensioni negative piovute sul locale (anche di clienti che a Finalborgo non
si sono mai visti), molti legali hanno contattato Ida Germano e si sono offerti
per difenderla dalla pioggia di critiche.
Un effetto mediatico che non ha portato solo tante
manifestazioni di solidarietà ma anche insulti, ingiurie di ogni tipo. «Sono
stata contattata da molti avvocati che si sono offerti di difendermi e che
ringrazio di cuore, soprattutto perché lo scontrino è un documento riservato e
non può essere reso pubblico com'è stato fatto perché su quello scontrino c'era
anche il mio numero di cellulare – conclude Ida Germano –. Ma sarà il mio
avvocato a valutare l'eventualità di intraprendere una causa legale» […]
Piattino a due euro, arriva la replica della
titolare: "I piatti in più erano 4..." Dopo la pubblicazione sui social
dello scontrino "incriminato" da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli,
arriva la versione della titolare dell'osteria di Finale Ligure. Cristina Balbo
l'8 Agosto 2023 su Il Giornale.
Tabella dei contenuti
Il caos per il “piattino condivisione”
La replica della proprietaria dell’osteria
“Di piatti supplementari ne ho portati ben
quattro”. Così Ida Germano, la 76 titolare dell'Osteria del Cavolo di Finale
Ligure, si difende dopo la polemica scoppiata a causa dello scontrino fiscale
pubblicato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli sul proprio profilo Instagram.
Nello specifico, nello scontrino compariva un supplemento di due euro per aver
portato a tavola un “piattino condivisione”.
"Due euro in più per un piattino vuoto...".
Scoppia la polemica in Liguria
Il caos per il “piattino condivisione”
Nella giornata di ieri, Selvaggia Lucarelli ha
pubblicato lo scontrino fiscale – datato al 23 luglio – e sui social è
immediatamente scoppiata la polemica. Il motivo? Una famiglia, a pranzo
nell’osteria di Finale ligure, ha dovuto pagare due euro in più per potere
condividere con la figlia di appena tre anni (che aveva già mangiato) un po' di
trofie al pesto. “Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede
un piattino per farne assaggiare un po' anche alla bambina di tre anni che ha
già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l'altro
avendole già messo in conto il coperto”, ha scritto la giornalista.
L’indignazione del web è stata immediata e così, molti volti noti del mondo
dello spettacolo (e non solo) hanno voluto esprimere la propria opinione. C’è
chi ha addirittura inneggiato alla galera, come il ballerino e attore Gabriele
Rossi e chi, invece – la pasticcera Sara Brancaccia - ha commentato: “È come
quando chiedi un bicchier d'acqua dopo il caffè. Domandi per gentilezza 'quanto
le devo?' e ti rispondono 'non importa'. Il mondo si divide in gente che non sa
stare al mondo e poi tutti gli altri. Confido che siano di più questi ultimi".
Insomma, una vera e propria baraonda.
La replica della proprietaria dell’osteria
Adesso, a distanza di qualche ora, è arrivata la
replica della signora Germano, la proprietaria dell’osteria di Finale Ligure,
che ha voluto dire la sua: "Quando il cliente entra in un locale accetta il
menù, che viene esposto fuori. Nel caso specifico i clienti avevano preso un
primo e un secondo in tre. Di piatti supplementari ne ho portati ben quattro,
per questo ho fatto pagare due euro: voglio che i clienti sappiano che per noi
quello è un lavoro in più", si è difesa così la signora Germano. Adesso, la
76enne minaccia anche di stare valutando eventuali azioni legali: "I dati
sensibili presenti nello scontrino non dovevano essere pubblicati, c'erano il
mio nome e cognome e il mio numero di cellulare. Vorrei venisse di persona a
mangiare le mie trofie: si è lamentata del prezzo, ma sono realizzate con
ingredienti di qualità. Mi spiace per la situazione ma avrei sofferto di più se
avessero criticato il cibo". Poi, a proposito della scelta di addebitare quei
due euro in più sullo scontrino la signora ha riferito: "Il lavoro va
remunerato. Ho 76 anni e lavoro con passione, ma è giusto che io venga pagata
per quello che faccio. Le parole dette sui social e le recensioni negative non
mi preoccupano, sono fiera del mio lavoro. Nel corso del tempo ho avuto tante
soddisfazioni. In queste ore ho ricevuto tantissime recensioni di solidarietà da
amici, clienti e colleghi. Ho ricevuto chiamate dalla Germania, dalla Svizzera e
diversi legali si sono proposti di tutelarmi".
Liguria, scontrino-vergogna? Trofie al pesto e
un piatto in più: ecco la rapina. Libero Quotidiano l'08 agosto 2023
Questa folle estate verrà ricordata non solo per
le bizze climatiche, con improvvisi temporali si alternano a ondate di caldo
micidiali, ma anche per il caro prezzi di gran parte delle mete turistiche.
Ultimamente ci si è concentrati parecchio sugli scontrini esagerati che arrivano
dalla Puglia, ma anche in altre regioni italiane la situazione a volte sfugge da
ogni logica.
È il caso della Liguria: Selvaggia Lucarelli ha
condiviso una storia con tanto di scontrino riguardante un’osteria di Finale
Ligure. “Un piatto di trofie al pesto 18 euro - ha scritto su Twitter - la mamma
chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni
che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l’altro
avendole già messo sul conto il coperto”. In questo caso più di scontrino
scandaloso si tratta di una pessima figura a livello umano… far pagare un
piattino a una mamma che vuole far mangiare anche la figlia è un po’
esagerato.
A proposito della Liguria, il Corriere della Sera
ha svolto un’indagine sull’ondata di rincari riguardante l’intera regione per
quanto riguarda la focaccia: in media costa 18-20 euro al kg, con picchi di 25 a
Varigotti. E poi c’è il caso assurdo di Recco, dove addirittura un kg di
focaccia costa 30 euro.
Estratto da blitzquotidiano.it sabato 12 agosto
2023.
Lo scontrino fiscale sta per assurgere alla
condizione di genere letterario, non è più il freddo registro di consumazioni
dei prezzi assegnati alle consumazioni, al bar e al ristorante lo scontrino
sovraprezzo, fantastica, racconta.
Ultima creazione, gli euro 1 e 50 per l’utilizzo
di due cucchiaini, richiesti, a quanto pare, per sorbire una crema catalana da 5
euro (onestissimo, per altro). Siamo ad Alba, stavolta i tartufi, bianchi o
neri, non c’entrano. Un cliente basito per il sovraprezzo aggiuntivo (le posate
evidentemente son da considerare un di più, forse un lusso) ha girato la foto
dello scontrino a La voce di Alba, quotidiano locale.
[…] “Oltre al caso del piattino a 2 euro in
un’osteria di Finale Ligure, e all’extra sempre di 2 euro in un bar del comasco
per tagliare in due un panino, sempre più numerosi sono i ristoranti che
applicano un sovrapprezzo, in media da 2 a 5 euro, per la voce coperto, servizio
che spesso però è inesistente, perché rappresentato da tovaglietta di carta sul
tavolo, come pure di carta è il tovagliolo messo a disposizione del cliente”.
[…]
Toscana, prezzi alle stelle: vacanze di lusso a
Forte dei Marmi e Firenze. La Toscana sta diventano una regione per ricchi?
I prezzi per le vacanze sono alle stelle, soprattutto a Forte dei Marmi e
Firenze. Chiara Nava Pubblicato il 5 Agosto 2023 su Notizie.it
La Toscana sta diventando una località da
ricchi? I prezzi nelle mete turistiche della regione sono alle stelle. Tra i
primi posti troviamo Forte dei Marmi e Firenze.
Toscana, prezzi alle stelle: vacanze di lusso a
Forte dei Marmi e Firenze
La Toscana sta diventando una regione da ricchi?
I prezzi sono sempre più alle stelle, tanto che alcuni turisti si sono resi
conto che non possono più permettersi le vacanze in questa amata regione.
Un’attenta analisi del Corriere, ha mostrato che una coppetta di gelato nel bar
vicino a Ponte Vecchio arriva a costare 12 euro, ma in generale è difficile a
Firenze riuscire a spendere meno di 6 euro per un gelato. Per non parlare
della bistecca fiorentina che per due arriva a costare 69 euro. Al Brunelleschi
Bistrot, in Piazza Duomo, una pizza margherita costa 14 euro, una Napoli 15 euro
e una prosciutto e funghi 19 euro. Per un piatto di prosciutto e melone vengono
chiesti 20 euro e per la panzanella toscana 16 euro. Al Bottegone ristorante
bar, con vista sulla Cupola, il caffè al tavolo costa ben 3,50 euro mentre
una bruschetta con pomodoro e mozzarella 10 euro. Ci sono bottiglie di tè freddo
a 4 euro e bottiglie da mezzo litro d’acqua a 2,50 euro. Per una ribollita
chiedono 11,80 euro al ristorante Cavallino di Piazza Signoria, e 12,80 euro per
una pasta e fagioli.
Alla Tavernetta della Signoria, in via dei Neri,
viene segnalato un carpaccio di filetto di sbottona a 14,9 euro, fettuccine al
sugo d’anatra a 13,9 euro. “Abbiamo aumentato i prezzi per la crisi energetica”
ha dichiarato un cameriere al Corriere. Secondo un’indagine dell’istituto Demoskopika mangiare
al ristorante in Toscana, nel 2023 costa in media il 7,6% in più dell’anno
precedente. La storica trattoria Da Burde, fuori dal centro, ha aumentato
notevolmente i prezzi. I primi sono passati da 8,50 a 9,50 euro mentre il caffè
da 1,50 a 2,50 euro. Anche il vino è aumentato. Il Brunello è passato da 40 a 45
euro, il Morellino da 19 a 21 euro, il Blogheri doc da 25 a 28 euro, il Chianti
Classico da 23 a 25 euro. Inspiegabilmente, molti di questi locali continuano ad
avere i tavoli pieni. Eppure, i turisti iniziano a lamentarsi e rendersi conto
di non potersi più permettere una vacanza in Toscana.
Toscana, prezzi alle stelle: stabilimenti balneari
a 600 euro al giorno
In Versilia i prezzi sono veramente alle stelle,
sia dei ristoranti che degli stabilimenti balneari, da Viareggio fino a Forte
dei Marmi. All’Antico Vinaio i prezzi sono aumentati “ma solo per il servizio al
tavolo, visto che quello del Forte è l’unico nostro punto con i tavolini
esterni. Per le focacce d’asporto il listino è uguale a tutti gli altri“, ha
precisato il proprietario Tommaso Mazzanti. Le focacce al tavolo, però, arrivano
a 14 euro. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, si arriva fino a 500 o
600 euro al giorno per tenda con sofà, letti King size, lettini standard più
sedia e tavolino. La Toscana sta davvero diventando una meta per ricchi? Alcuni
turisti tedeschi hanno scritto al Corriere sottolineando che i prezzi sono
triplicati e che non possono più permettersi la loro classica vacanza in questa
amata regione.
Non solo a Como, in Liguria supplemento di 2€
per il piattino vuoto di una bimba: la Lucarelli pubblica lo scontrino di
un’osteria di Finale Ligure. Redazione su Il Riformista il 7 Agosto 2023
A pochissime ore di distanza dalla notizia di un
costo aggiuntivo di due euro per dividere un toast a metà, episodio denunciato
su Tripadvisor da un turista che ha pubblicato la foto dello scontrino, oggi è
arrivata un’altra bizzarra richiesta da parte di un ristorante di Novi Ligure.
La notizia, risalente al 23 luglio, è stata condivisa dalla giornalista e
scrittrice Selvaggia Lucarelli che ha postato sulla propria pagina facebook uno
scontrino di un’osteria finalese.
Cosa è successo – “Liguria. Un piatto di trofie al
pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche
alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per
il piattino. Tra l’altro avendole già messo sul conto il coperto”. Questo
il post pubblicato questo pomeriggio su facebook dalla celebre
giornalista Selvaggia Lucarelli.
Tre persone: mamma, papa e figlia. Oltre ad
una acqua potabile e ad una birra, sullo scontrino risultano pagati due piatti:
uno di trofie al pesto e uno di acciughe fritte. La voce incriminata è quella
del “piattino condivisione”, ovvero il classico piatto che viene chiesto ai
camerieri quando si vuole condividere una portata con una persona che in quel
momento non sta mangiando nulla.
Al momento il ristorante non ha dato spiegazioni e
nemmeno commentato il post della Lucarelli. Sul caso sollevato da Selvaggia
Lucarelli è intervenuto con un post sulla sua pagina facebook anche il
governatore ligure Giovanni Toti: “Questo è lo scontrino del ristorante ligure
in cui vengono addebitati 2 euro per un piattino in più per condividere una
porzione di trofie al pesto. Non voglio difendere il ristoratore perché ritengo
quell’extra sbagliato, voglio difendere però i tanti ristoratori che ogni giorno
lavorano seriamente in Liguria, offrendo un grande servizio a cittadini e
turisti grazie alle nostre eccellenze enogastronomiche. Ristorazione che
peraltro, oltre a offrire migliaia di posti di lavoro, continua a crescere in
qualità, con tanti giovani chef in ascesa che negli ultimi anni si sono
conquistati importanti riconoscimenti”.
Venezia, l'ultimo scontrino-scandalo: quanto
paga l'acqua del rubinetto. Libero Quotidiano il 09 agosto 2023
L'estate dei rincari e degli "scontrini pazzi".
Numerose le segnalazioni di conti salatissimi (e ingiustificati) o di rincari
che lasciano i clienti basiti, quali quello per il piattino di condivisione o
per il toast tagliato in due. Una serie di vicende che porta i ristoratori a
reagire. A tuonare è Raffaele Medeo, presidente di TNI Ristoratori Italia, che
ricorda: "Sono casi isolati e comunque ogni ristorante ha tutti i prezzi ben
visibili sui menù".
E ancora: "Perché invece non si dice che dopo il
Covid è aumentato tutto, tanto che i ristoratori dovrebbero adeguare i prezzi
almeno una volta a settimana? Invece nessuno lo fa, assorbiamo la quasi totalità
di questi rincari, per consentire alle persone di venire ancora al ristorante, e
intanto rischiamo di fallire. Le materie prime, gli affitti, l'acqua, la tariffa
sui rifiuti continuano a rincarare e si tratta di mere speculazioni". Ma non è
finita: "Le commissioni sui Pos restano alte e ormai il 90% delle transazioni
sono elettroniche, con migliaia di euro, frutto del lavoro dei ristoratori, che
ogni anno vanno alle banche. I locali, soprattutto quelli di periferia, sono in
ginocchio. I fornitori hanno incrementato la farina del 200%. Eppure la farina
per il 96% è prodotta in Italia, non in Ucraina", conclude Medeo.
Ineccepibile. Peccato però che come lui stesso
ammette ci siano dei "casi isolati" inesorabilmente destinati a far
discutere. L'ultimo arriva da Eraclea, nei pressi di Venezia-Mestre. Nell'estate
dei rincari ecco che si paga addirittura l'acqua del rubinetto. La denuncia come
sempre viaggia sui social, dove Arianna racconta quanto le è successo: "Ora si
paga anche l'acqua del sindaco. I prezzi sono aumentati in modo esagerato, ma si
può mettere in conto un bicchiere di acqua del rubinetto. E poi si chiedono come
mai c’è così poca gente ad Eraclea", si sfoga la signora.
Il post, pubblicato su Facebook, ha subito
scatenato gli utenti, che lo hanno condiviso in massa per protestare. Ma c'è
anche chi eccepisce. Qualcuno, per esempio, commenta: "Se mettono 3 euro di
coperto però nessuno dice niente". E un altro: "Fare una polemica per questo mi
sembra un po' esagerato. Io mi indignerei di più se dovessi pagare 5 euro di
coperto con i tovaglioli di carta". Insomma, un caso che divide...
Il toast diviso in due al bar costa due euro in
più: lo scontrino (incredibile) in un bar di Gera Lario, è polemica. A
rendere nota la notizia è stato il turista che ha voluto pubblicare la foto
dello scontrino incriminato su TripAdvisor, allegandolo a un commento non troppo
lusinghiero. Da ilgazzettino.it Lunedì 7 Agosto 2023
Tutto si è consumato a fine giugno, ma la polemica
è scoppiata nelle ultime ore sui social più accesa che mai. Un bar di Gera
Lario, un paese di mille abitanti sul lago di Como, ha emesso uno scontrino che
fa davvero discutere. Nello scontrino fiscale, infatti appare una dicitura choc:
il gestore ha chiesto 2 euro al cliente per aver tagliato a metà un toast.
Due euro per tagliare il toast a metà
Sicuramente non è la prima volta che i prezzi di
bar e ristoranti sul lago di Como scatenano le polemiche, ma questa volta a far
discutere non è tanto il costo dei prodotti, quando di un servizio che
difficilmente si paga.
A rendere nota la notizia è stato il turista che
ha voluto pubblicare la foto dello scontrino incriminato su TripAdvisor,
allegandolo a un commento non troppo lusinghiero. Il cliente non aveva molta
fame e, quindi, ha chiesto gentilmente al cameriere se avesse potuto dividere in
due il toast. Poi al momento di pagare, la sorpresa tutt'altro che gradita. Il
prezzo totale del piatto, compreso di patatine, costava 7,50 euro, ma con un
supplemento di 2 euro per aver chiesto il favore di tagliare il panino a metà.
Il 26 per cento del costo del piatto per affondare
una lama e dividerlo.
La polemica sui social
Il cliente su TripAdvisor fa notare come, in
realtà, il toast nel locale venga servito già normalmente diviso. Ma l'uomo ha
voluto specificarlo perché lo avrebbe diviso con la moglie. «In pratica ho
dovuto pagare due euro perché lo abbiamo mangiato in due, sennò non avrei pagato
di più», dichiara stizzito.
Una polemica subito fatta notare al barista che,
dal canto suo, si sarebbe giustificato dicendo che la maggiorazione era dovuta
al fatto che ha dovuto usare due piattini per servire un unico panino, oltre al
tovagliolo di carta in più. Una storia che sta facendo discutere e non poco e
che è subito diventata virale.
L’Identità.
Fu una guerra civile ma non
tra Nord e Sud. Storia di Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera il 10
marzo 2023.
Caro Aldo, «Non faccia come i
neo borbonici che hanno trasformato i quattro cadaveri trovati a Fenestrelle in
quattromila, ma che dico, quarantamila. I numeri sono importanti» scrive lei. È
vero, sono importanti. Ed è sulla considerazione di quei numeri che dovremmo
riflettere. Fosse stato solo uno il morto di Fenestrelle, quello era un italiano
che la pensava diversamente e andava trattato come un italiano dissenziente e
non come un nemico o un traditore. Questa è le vergogna di Fenestrelle, non il
numero dei morti, ma l’idea che gli italiani del Regno di Napoli non fossero
italiani. La prego non mi accusi di neoborbonismo, non lo sono. I Borboni di
Napoli stavano dalla parte sbagliata della Storia e per questo era giusto che
fossero messi fuori gioco. I vincitori, però, fecero l’Italia geografica, non
fecero gli italiani. Dopo Cavour la classe dirigente fu mediocre e non
all’altezza del grandioso progetto di fare gli italiani. Fidelio Perchinelli
Caro Fidelio, Lei ha ragione su
molti punti. La morte di Camillo Benso di Cavour, genio di statura europea,
lasciò un vuoto incolmabile. I primi decenni di storia unitaria, sino
all’avvento di Giovanni Giolitti, sono segnati da un conservatorismo ai limiti
della reazione, con re Umberto che decora il generale Bava Beccaris per aver
cannoneggiato gli operai milanesi. Ricordi però, gentile signor Perchinelli, che
sul Vittoriano, il monumento a Vittorio Emanuele II, è scritto non solo «patriae
unitati», all’unità della patria, ma pure «civium libertati», alla libertà dei
cittadini. Il Risorgimento non si limitò a unificare la nazione; segnò la fine
dei ghetti e delle forche, dei tribunali ecclesiastici e del potere temporale
del clero, l’avvento della scuola pubblica, gratuita e obbligatoria, insomma
l’inizio del cammino verso l’uguaglianza tra i cittadini. È vero che Vittorio
Emanuele non volle cambiare nome e diventare «primo»; ma è vero che spostò la
capitale dalla città in cui era nato e cresciuto, Torino, per portarla prima a
Firenze (dove la pena di morte era già stata abolita), poi a Roma. Aveva pensato
di fissare la capitale provvisoria a Napoli, ma poi saggiamente rinunciò perché,
disse, «da Napoli non si potrà più andare via». Napoli era infatti di gran lunga
la più popolosa città italiana. È vero che dopo l’unità è cresciuta meno di
altre città, in termini demografici e industriali. Così come è vero che dopo
l’unificazione ci fu al Sud una guerra civile. Ma è disonesto presentarla come
una guerra del Nord contro il Sud. I primi nemici e le prime vittime
dell’alleanza tra briganti, partigiani dei Borbone e nostalgici del potere
temporale del clero furono i borghesi e i popolani meridionali favorevoli
all’unità, cui si dovette principalmente la vittoria finale, come dimostra
Carmine Pinto nei suoi bei libri pubblicati da Laterza «La guerra per il
Mezzogiorno» e «Il brigante e il generale» (dove il brigante è Crocco e il
generale è Pallavicini).
Reggio, Pino Aprile nel
Nuovo Terroni: «Noi meridionali non abbiamo conservato l’identità». Il
giornalista e scrittore, nella nuova stesura del suo saggio, racconta della
Sardegna, terra di conquista dei piemontesi prima del Regno delle Due Sicilie.
Anna Foti il 26 Febbraio 2023 su ilreggino.it.
«L’Italia non nasce il 17 marzo
1861 ma oltre un secolo prima, quando i piemontesi colonizzano la
Sardegna. Un’operazione che poi replicano, riuscendo nell’intento, 140 anni dopo
nel Regno delle Due Sicilie. La differenza è che i sardi, ai quali dobbiamo
anche le origini della nostra condizione giuridica di Stato, attraverso
la lingua e la cultura sono riusciti a custodire la loro identità. Ecco
perché in Sardegna il genocidio, inteso come cancellazione dell’identità di un
popolo, non è riuscito. Da noi invece esso è stato consumato».
Questo uno dei nuclei tematici
centrali che ha spinto il giornalista e scrittore Pino Aprile alla stesura de Il
nuovo Terroni. «Una pubblicazione che contiene la precedente e 100 pagine
nuove con il recupero della storia della Sardegna che tutti dimenticano. Essa
invece è la chiave di tutta la nostra storia», spiega lo stesso Pino Aprile.
Il volume è stato presentato
presso l’auditorium Don Orione di Sant’Antonio a Reggio Calabria, nell’ambito
dell’incontro promosso dall’associazione Incontriamoci sempre e introdotto dal
vicepresidente del sodalizio promotore, Marco Mauro. Pino Aprile ha conversato
con Nuccio Macheda primario al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.
Tre le parti del tutto inedite:
le prove del massacro, il caso Sardegna e le conseguenze politiche di quella
prima colonizzazione condotta dai piemontesi.
L’isola ridotta a colonia
Nuove consapevolezze hanno
spinto Pino Aprile a rivisitare e ampliare il suo saggio riportando il lettore
al 1720.
«In forza di un trattato
internazionale, il regno Sabaudo acquisì il Regno di Sardegna. Tale momento
costituì per l’isola l’inizio di un crescente impoverimento. Tutto ciò che aveva
un valore fu sottratto ai sardi, con la collaborazione della classe dirigente
dell’isola. Deforestazione, in dieci anni 400 concessioni minerarie di cui solo
una a un sardo e poi le chiudende e le proprietà perfette per sottrarre le terre
a chi fino ad allora le aveva possedute e coltivate. Ciò generò un brigantaggio
sociale che fu violentemente represso dai piemontesi. Esecuzioni, torture di chi
si ribellava e addirittura plotoni di esecuzioni itineranti. Insomma la seconda
isola più grande del Mediterraneo era stata ridotta a una colonia. La sua
popolazione veniva appellata, nei documenti, sempre e solo con nomi di animali e
mai con nomi di persona», ha incalzato ancora lo scrittore e giornalista.
La nuova colonizzazione dei
piemontesi
Un’analisi che si spinge fino
a un secolo più tardi per fornire una lettura di quanto accadde nel 1861. Si
parlò di Italia unita, decadde il regno della Due Sicilie che dall’inizio
del 1816 aveva governato l’Italia Meridionale e la Sicilia. Quanto si verificò
nel 1861 «non fu un processo di unificazione ma di allargamento dei possedimenti
della famiglia Savoia. Fu eseguito con successo nel Regno delle Due Sicilie,
sulla scorta dell’esperienza condotta nel Settecento in Sardegna, attraverso
quel piano per la colonizzazione dell’isola. Quando ho chiuso la prima stesura
dei Terroni non avevo acquisito questa consapevolezza. Da qui la necessità di
implementare il lavoro e darlo nuovamente alle stampe», ha spiegato Pino Aprile.
Il genocidio fallito e quello
riuscito
«Il genocidio è la
cancellazione dell’identità di un popolo, l‘eliminazione in un popolo del senso
di sé e della coscienza della propria esistenza. Esso è riuscito da noi, al
momento dell’unificazione, ma non in Sardegna oltre un secolo prima. Il popolo
sardo si è salvato attraverso la lingua. Una lingua nata tre secoli prima di
quella con cui Dante avrebbe scritto al Divina Commedia. I sardi
hanno conservato la loro storia e salvato la loro identità grazie
alla letteratura popolare e al racconto. Noi no. Noi non abbiamo visto la nostra
storia perché non l’abbiamo cercata», ha spiegato ancora Pino Aprile.
L’inizio della riappropriazione
«Da noi l’operazione è riuscita
meglio. Noi abbiamo cancellato un’identità che adesso si sta
riscoprendo. La sconfitta fa chiudere in sé stessi. Fuori c’è uno spazio ormai
percepito come del conquistatore e dell’oppressore; uno spazio che non sentiamo
più nostro. È necessario ripartire dal recupero della coscienza di noi
stessi. Da lì inizia la riappropriazione non di una terra ma di una patria,
dell’identità del luogo in cui condividiamo la vita, di cui ci riconosciamo
parte, perché condividiamo la lingua, il cibo, il calore, l’accoglienza, la
storia», ha spiegato ancora Pino Aprile.
Siamo tutti sardi
Una disquisizione pregna che,
scandagliando la storia, ha restituito anche un quadro in cui l’Italia deve
addirittura le sue origini di Stato al Regno di Sardegna.
«Giuridicamente il diritto che
rende oggi l’Italia uno Stato non è nato il 17 marzo 1861, quando al parlamento
di Torino Cavour annunciò la nascita dell’Italia, in lingua francese, ma
prima. Avvenne quando nel Settecento il regno di Sardegna fu acquisito dal Regno
Sabaudo, all’epoca un collage di piccoli stati frammentati. Per spostarsi da uno
all’altro era necessario il passaporto. Il regno di Sardegna invece aveva già la
configurazione di uno Stato con un’autorità e un territorio sul quale
esercitarla. Esistevano i giudicati tra i quali quello d’Arborea, un tempo
amministrato da una donna, Eleonora che nel 1300 aveva ampliato e aggiornato
la Carta de Logu, una raccolta di leggi in lingua sarda che enunciava i diritti
dei cittadini. Una modernità sorprendente. Nel momento in cui avvenne
l’acquisizione il diritto del regno di Sardegna venne esteso al Piemonte e non
il contrario. Estendendo, poi, i confini del Piemonte, ecco che tutti gli
italiani diventarono sardi. Il popolo sardo non solo ha conservato la sua
identità ma l’ha estesa anche agli altri», ha concluso Pino Aprile.
Estratto dell’articolo di Pino
Aprile per OGGI il 7 marzo 2023.
Un Paese bellissimo ma nato
male: non riesce […] a far i conti con la sua storia […] ha il primato mondiale
del più grave e duraturo divario fra due aree, il Nord e il Sud, e invece di
risanarlo (come in Germania, fra Est e Ovest, in Spagna e altrove), attribuisce
a una parte il merito del più e all’altra la colpa del meno, pur se questo e il
risultato di come l’Italia e gestita da 162 anni.
Francesco Saverio Nitti, poi
capo di governo, nel 1900, in Nord e Sud, denuncia lo squilibrio della spesa
pubblica (i soldi di tutti gli italiani): dei 458 milioni per le bonifiche, meno
di tre a Sud; e cosi per tutto il resto, ma le tasse erano studiate per esser
più alte nel Mezzogiorno; e oggi idem: nella sola Lombardia circolano piu treni
che in tutte le regioni del Sud messe insieme e per le famiglie in difficolta lo
Stato spende 583 euro pro-capite a Bolzano e 6 a Vibo Valentia. […] come riuscì
lo stato sabaudo, che era la meta delle Due Sicilie e in dissesto economico, a
“ingoiare” una preda tanto più grande?
La risposta e la Sardegna: i
Savoia la ottengono nel 1720, con il trattato dell’Aia; e si vara il “Piano per
la colonizzazione” che riduce l’isola a “fattoria del Piemonte”, con ferocia
(dal volume della Storia d’Italia di Einaudi a Carlo Felice e i tiranni sabaudi,
del professor Francesco Casula, se ne ha un’idea); tutto quel che vale qualcosa
e sottratto ai sardi (il commercio da e per l’isola sarà dato in esclusiva a
speculatori genovesi soci di Cavour; su 40 concessioni minerarie, solo una a un
sardo) e con le leggi “delle chiudende” e della “proprietà perfetta” si
consentirà alla classe dirigente locale di appropriarsi delle terre pubbliche.
Le proteste represse con stati
d’assedio, plotoni di esecuzione itineranti, retate come per i mille di Nuoro,
nella notte della “Caccia grossa”. Nei testi dell’epoca i sardi sono citati con
nomi di animali. Sorse un ciclo di studi per capire e correggere la condizione
di svantaggio, e prese il nome di “Questione Sarda”; quando quei metodi furono
trasferiti nel Mezzogiorno, la “Questione” divento “Meridionale”. […] Quando
invase il Regno delle Due Sicilie, per ridurlo a colonia (come raccontano da
Antonio Gramsci a Nicola Zitara), l’esercito sabaudo aveva 140 anni di tecniche
sperimentate in Sardegna.
[…] le “morti anomale” a Sud
furono più di mezzo milione; già in Carnefici, riportai la relazione al re del
ministro Giovanni Manna, sul censimento del 1861, in cui si dice che, per la
guerra, «nelle nuove provincie che abbiamo appena conquistato», si erano contate
458mila persone in meno; centinaia di migliaia i carcerati (ancora dieci anni
dopo: rapporto del ministro di Rudini), quasi centomila i deportati, documenta
il professor Giuseppe Gangemi, università di Padova, il quale (In punta di
baionetta), dimostra che i militari borbonici morti in caserme e campi di
concentramento (detti: di rieducazione), fra cui il forte di Fenestrelle, furono
almeno 16mila, non solo 4, come sostiene il professor Alessandro Barbero (I
prigionieri dei Savoia). […]
Nel 1946, per l’Assemblea delle
Nazioni Unite, tutto quel che fu fatto al Sud per unificare l’Italia, divenne un
reato che può compiere solo uno Stato e si chiama genocidio. In Italia non si
può dire, nè in Turchia si può citare quello degli armeni. E ora, non potendo
più negare, si chiede di dimenticare, per non compromettere la coesione di un
Paese così poco unito.
L’invito venne, tre anni fa,
da Corrado Augias, e Paolo Mieli, col suo La terapia dell’oblio. Risposi con
Contro l’oblio: non lo si chiede a ebrei, nativi d’America, neri deportati
schiavi dall’Africa, armeni; perchè solo ai terroni? Il nostro Paese e nato nel
sangue, come gli altri (dagli Stati Uniti al Giappone) e negli stessi anni. Ma
gli altri se la raccontano. Noi no. […]
I Carrozzoni.
Finito il Sud delle
partecipate: i carrozzoni restano al Nord. In Italia sono ancora attive
7.969 aziende con quote pubbliche, oltre la metà sono concentrate nel
Settentrione. A fare la parte del "leone" è sempre la Lombardia. VINCENZO
DAMIANI su Il Quotidiano del Sud il 27 Gennaio 2023
Lentamente l’Italia si sta
liberando del “carrozzone” delle partecipate, o quantomeno di quella larga fetta
di società pubbliche inutili e costose che hanno provocato soltanto voragini nei
bilanci. Ad esempio, nel principale settore, quello dell’industria e dei
servizi, dal 2012 al 2020 si è passati da 7.581 a 5.622 ma è al Nord che c’è
un’alta concentrazione: allo stato attuale sono ancora 3.135, contro le 1.327
del Centro, le 818 del Sud e le 342 delle Isole. A fare la parte del “leone” è
sempre la Lombardia. E’ quanto rileva il report dell’Istat, complessivamente in
Italia sono ancora attive 7.969 partecipate, oltre la metà al Nord. “Le unità
economiche partecipate dal settore pubblico – si legge nel monitoraggio Istat –
nel 2020 sono 7.969, il 2,5% in meno rispetto al 2019.
Si riduce, in particolare, il
numero delle unità attive nei settori dell’Industria e dei Servizi (-2,7%) e di
quelle partecipate direttamente da almeno un’amministrazione pubblica regionale
o locale (4,5%). La produttività media (valore aggiunto per addetto) delle
controllate pubbliche diminuisce del 9,3% e risulta pari a 94.916 euro contro i
44.500 euro del totale nazionale del settore Industria e Servizi. Il ministero
dell’economia e delle finanze si conferma l’ente più rilevante: controlla oltre
il 53,1% del totale degli addetti delle imprese a controllo pubblico”.
Negli ultimi nove anni, quindi,
il numero di imprese attive a partecipazione pubblica si è ridotto notevolmente,
ma questo è vero soprattutto nel Mezzogiorno. Nel 2020 c’è stata in totale una
flessione del 25,8% rispetto al 2012i, in particolare, tra il 2019 e il 2020 la
riduzione è del 2,7%, con variazioni che oscillano a livello di ripartizione
territoriale tra il -4,2% del Sud e il -1,3% del Nord-est. “La maggiore
concentrazione di addetti – scrive ancora l’Istat – si conferma, anche nel 2020,
nel Centro Italia (47,3% del totale) dove è presente il 23,6% delle imprese
partecipate. In questa ripartizione la dimensione media delle imprese
partecipate è di 310 addetti, valore fortemente influenzato dalle 594
partecipate localizzate nel Lazio (nonostante il decremento del 3,1% rispetto al
2019) che presentano una dimensione media di 590 addetti e impiegano il 40,3%
degli addetti.
Molto simile la numerosità di
imprese partecipate nelle due ripartizioni del Nord: il Nord-est (27,9%) impiega
il 14,4% di addetti e presenta una dimensione media di 80 addetti; mentre nel
Nord-ovest è la Lombardia ad avere il maggior peso in termini di partecipate
pubbliche (17,4%), con il 17,1% degli addetti e una dimensione media di 152
addetti”. Nel 2020 le partecipate impiegavano 908.571 addetti, si registra
rispetto al 2019 un’ulteriore riduzione (registrata dal 2012) del 2,5% in
termini di unità e del 2,6% in termini di addetti. Il calo del numero di addetti
colpisce in particolare le imprese con partecipazioni minoritarie con quote fino
al 20% (-7,8%). Delle 7.969 unità economiche a partecipazione pubblica, 5.622
sono imprese attive operanti nel settore dell’industria e dei servizi, queste
assorbono il 95,6% dei lavoratori: rispetto al 2019 si riducono del 2,7% e del
2,9% rispettivamente in termini di unità e di addetti.
Aumentano (+4,1%) invece le
partecipate pubbliche degli altri settori, quali imprese agricole, istituzioni
non profit e istituzioni pubbliche che crescono anche in termini di addetti
(+3,1%). Le partecipate non attive, che hanno comunque presentato una
dichiarazione contabile o fiscale nel 2020, si riducono del 16,1%. “La
dimensione media delle 5.622 imprese attive partecipate – evidenzia l’Istat –
operanti nei settori dell’economia di mercato dell’industria e dei servizi, è di
155 addetti, valore che sale a 414 per le società per azioni.
Le imprese partecipate che si
costituiscono con forma giuridica di società per azioni rappresentano la quota
più rilevante in termini di addetti (83,9%); mentre sono più rappresentative in
termini di numero di unità economiche quelle organizzate in società a
responsabilità limitata (43,9%); seguono i Consorzi di diritto privato e altre
forme di cooperazione tra imprese (con il 18,6% in termini di unità e il 2,9% in
termini di addetti), le società cooperative (3,7% in termini di unità e 2% di
addetti), il rimanente 2,5% include aziende speciali, aziende pubbliche di
servizi, Autorità indipendenti ed Enti pubblici economici (1,6% di addetti)”.
Su 5.622 imprese attive
partecipate, 3.791 sono partecipate direttamente da almeno un’amministrazione
pubblica regionale o locale oppure sono appartenenti a gruppi che hanno al
proprio vertice un ente territoriale. Queste impiegano 410.784 addetti,
corrispondenti al 47,3% del totale. Rispetto all’anno precedente si registra un
calo del 4,5% nel numero delle partecipate da enti locali e del 4,7% degli
addetti. Attraverso il controllo diretto o indiretto esercitato sui grandi
gruppi, il ministero dell’Economia e delle finanze rimane il soggetto
controllante di maggiore rilevanza in termini di occupazione, con il 53,1% di
addetti. Il numero di imprese controllate dal Mef cresce del 3,7%, ma si riduce
la loro dimensione media (920 addetti contro i 962 del 2019). Le Province, le
Città Metropolitane e i Comuni controllano in totale 1.488 imprese (43,2% delle
controllate pubbliche) e occupano 134.161 addetti (con un’incidenza pari al 23%
del totale).
Chi è la più bella del
reame…La narrazione fraudolenta.
La Disuguaglianza.
Povera Italia: la miseria di un Paese diviso
nell’indagine del 1953. Storia di GIAN ANTONIO STELLA su Il Corriere della
Sera sabato 19 agosto 2023.
«Nelle valli delle Alpi e degli Appennini, ed
anche nelle pianure, specialmente dell’Italia Meridionale, e perfino in alcune
province fra le meglio coltivate dell’Alta Italia, sorgono tuguri ove in
un’unica camera affumicata e priva di aria e di luce vivono insieme uomini,
capre, maiali e pollame. E tali catapecchie si contano forse a centinaia di
migliaia». Ed eccolo qui, il video di quella drammatica denuncia dell’«Inchiesta
agraria sulle condizioni della classe agricola» condotta da una Giunta
parlamentare presieduta da Stefano Jacini dal 1877 al 1885. Una donna con una
cuffia in testa riempie un secchio di acqua da un barile: dietro di lei, nella
stessa stanza, ci sono un asino, un maiale, tre galline, un coniglio...
Ma come: un decennio prima che i fratelli Lumière
proiettassero il celeberrimo «arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat» e
cioè il primo documentario della storia? Questo è il punto: le immagini filmate
dell’estrema miseria di quei tuguri «privi di aria e di luce» non sono della
fine dell’Ottocento: sono del 1953. Ma potrebbero essere state girate uguali
identiche, se fosse già stata inventata la cinepresa, sette decenni prima.
Perché nulla era cambiato, in tanti decenni, per tanta parte dei contadini
italiani, meridionali e non solo.
Ed è questa, con una serie di dati, ricordi e
testimonianze che il nostro Paese ha voluto cancellare dalla memoria, la
possente forza d’impatto de L’inchiesta parlamentare sulla miseria, il
documentario dell’Istituto Luce che l’8 settembre (ore 18, Hotel Excelsior del
Lido) sarà mostrato al Festival di Venezia settant’anni dopo la prima proiezione
alla 14 ª Mostra Internazionale del Cinema del 1953. Una vera e propria
«relazione cinematografica» firmata dal regista Giorgio Ferroni a completamento
dell’attività della Commissione parlamentare che tra il 1951 e il 1954 indagò
sulle condizioni di vita nelle zone montane alpine, il Delta padano, la montagna
abruzzese, l’intero Mezzogiorno, i «suburbi» di Milano, Roma, Napoli.
Un reportage formidabile e inquietante che
mostrava come, quasi cent’anni dopo l’Unità, l’Italia fosse spaccata in tre: una
povertà relativamente contenuta al Nord (3,1% in Friuli-Venezia Giulia, 2,3 in
Veneto, 1,4 in Lombardia, 0,3 in Piemonte...), una pesante nel Centro (7,1% in
Umbria, 10 nel Lazio...) e una spaventosa nel Sud: 22,7% di miseria in Sardegna,
22,8 in Campania, 23 nell’Abruzzo e in Molise, 23,9 in Puglia, 25,2 in Sicilia,
33,2 in Basilicata fino a uno stratosferico 37,7 in Calabria. Prova provata di
quanto poco fosse stato fatto in un secolo, al di là della propaganda savoiarda
e mussoliniana, per colmare i secolari ritardi.
«In verità», riconosceva il presidente della
commissione, Elio Vigorelli, «tutti sanno che esiste il problema della miseria,
pochi ne conoscono le manifestazioni più angosciose» riconoscibili
«nell’accattonaggio nel sudiciume, nell’ignoranza, nella prostituzione, nel
delitto...». A questo doveva rispondere l’inchiesta parlamentare. E a questo
rispose, mettendo a confronto tra l’altro il bilancio familiare (cinque persone
in media) di un operaio specializzato del Nord e di un «misero» (definizione
testuale) meridionale o polesano. La famiglia del primo, spiega il documentario
mostrando una moglie col bambino che fanno di conto su un foglietto, poteva
contare su 60.000 lire al mese (1.155 euro attuali, secondo rivaluta.istat.it),
quella del secondo su 27.000, pari oggi a 519 euro. In cinque.
Dicono tutto le differenze nei consumi. Non solo
sul pane (1,9 chili al giorno la famiglia dell’operaio specializzato, 1,6 quello
del «misero») ma sulla frutta e gli ortaggi (3,4 la prima, 1,2 la seconda senza
mai la frutta) e soprattutto sulla carne: 520 grammi di media per la modesta
borghesia operaia, meno di un terzo (150 grammi: in cinque) per la massa di
miserabili alle prese con un difficilissimo dopoguerra. Poveri che
rappresentavano allora l’11,8 per cento della popolazione: 6.186.000 persone.
Poco più della metà (3.459.964) potevano contare
sull’aiuto degli Eca (enti comunali di assistenza), 419.383 su altri 36.000
(sic!) piccoli o microscopici enti assistenziali vari, 2.306.647 su niente e
nessuno: totalmente abbandonati al loro destino. E spinti a varcare più o meno
legalmente le frontiere («Oltre il 50% dei lavoratori italiani emigrati in
Francia tra il 1945 e il 1960 era rappresentato dai clandestini e il 90% dei
familiari che li raggiunsero emigrò illegalmente», documenta lo storico Sandro
Rinauro nel saggio Il cammino della speranza, Einaudi, 2009) per cercare un po’
di fortuna altrove.
La stessa speranza di andarsene era costosissima
per chi viveva nei tuguri documentati dall’inchiesta sulla miseria. Se l’indice
medio di affollamento nella famiglia dell’operaio specializzato «era di 1,73
persone per vano: una casa di tre stanze e cucina», le tane dei più miserabili
avevano «un aspetto più sconfortante: per ogni famiglia media di cinque persone
un solo ambiente. Rappresentato da una grotta, una baracca o altro locale di
fortuna già di per se stesso malsano. È in queste condizioni che si trovano
870.000 famiglie, il che significa quasi 4 milioni e mezzo di italiani».
Era l’Italia disperata come il borgo di Grassano,
scelto dall’inchiesta parlamentare come paese campione. Lo stesso dove meno di
vent’anni prima era stato mandato al confino Carlo Levi, che in Cristo si è
fermato a Eboli aveva scritto: «Le case dei contadini sono tutte uguali, fatte
di una sola stanza che serve da cucina, da camera da letto e quasi sempre anche
da stalla per le bestie piccole, quando non c’è per quest’uso, vicino alla casa,
un casotto che si chiama in dialetto, con parola greca, il catoico. Da una parte
c’è il camino, su cui si fa da mangiare con pochi stecchi portati ogni giorno
dai campi: i muri e il soffitto sono scuri pel fumo. La luce viene dalla porta.
La stanza è quasi interamente riempita dall’enorme letto, assai più grande di un
comune letto matrimoniale: nel letto deve dormire tutta la famiglia, il padre,
la madre, e tutti i figliuoli. I bimbi più piccini, finché prendono il latte,
cioè fino ai tre o quattro anni, sono invece tenuti in piccole culle o cestelli
di vimini, appesi al soffitto con delle corde, e penzolanti poco più in alto del
letto... Sotto il letto stanno gli animali: lo spazio è così diviso in tre
strati: per terra le bestie, sul letto gli uomini, e nell’aria i lattanti. Io mi
curvavo sul letto, quando dovevo ascoltare un malato, o fare una iniezione a una
donna che batteva i denti per la febbre e fumava per la malaria; col capo
toccavo le culle appese, e tra le gambe mi passavano improvvisi i maiali o le
galline spaventate...».
Da “il Messaggero”
il 7 aprile 2023.
Nascere al Sud significa avere
accesso a un welfare dimezzato rispetto ai cittadini del resto del Paese. La
spesa sociale pro capite dei comuni nel 2020 è stata
di 66 euro nell'Italia meridionale, la metà della media nazionale, che ammonta a
132 euro, e poco più di un terzo di quella del Nord-est che raggiunge i 184
euro. È quanto emerge dal rapporto dell'Istat "La spesa dei comuni per i servizi
sociali. Anno 2020".
I dati sono di tre anni fa e
raccontano il Paese disuguale che si è trovato ad affrontare la pandemia. Per
ogni minore residente al Mezzogiorno ci sono 155 euro di risorse in meno
rispetto a un coetaneo del Centro-Nord. E il divario, per una persona con
disabilità è di quasi mille euro. Per l'assistenza agli anziani la spesa del Sud
è inferiore di 49 euro. Quasi un terzo dei Comuni del Mezzogiorno non offre
assistenza domiciliare agli anziani in condizioni di fragilità.
Al Centro sono meno del 15% i
comuni senza questi servizi e meno del 10% al Nord. Questi «grandissimi divari
territoriali», come li definisce l'Istat, insistono su un Paese dove anche la
spesa media nazionale per le famiglie e i disabili è al di sotto della media Ue.
Le risorse per i portatori di handicap sono di 476 euro annui in Italia contro
669 dell'Ue e quelle per le famiglie e i minori di 339 euro annui contro i 753
degli altri paesi.
Lascia gli studi un ragazzo
su 6: al Sud il buco nero della scuola. Conchita Sannino su La Repubblica il
6 aprile 2023.
I dati Svimez fotografano
un’Italia divisa in due: al Centro-nord il tasso di abbandoni è del 10,4%, nel
Mezzogiorno del 16,6%. E a Napoli arriva a sfiorare il 23%. Una disparità che
riguarda tutti i servizi, dalle mense alle palestre al tempo pieno
Dispersi, soprattutto nelle
regioni del Sud, ma non solo. Invisibili, almeno fino a quando non incrociano
precarietà, sfruttamento, fragilità esistenziali. In qualche caso, il
reclutamento criminale. Erano 83mila i ragazzi che, alla chiusura degli scorsi
scrutini, sono stati bocciati solo perché non hanno raggiunto la soglia minima
delle presenze. Rischiano almeno di raddoppiare, nel 2023. È la piaga
dispersione scolastica.
Lascia gli studi un ragazzo
su 6 al Sud il buco nero della scuola
I dati Svimez fotografano
un’Italia divisa in due: al Centro-nord il tasso di abbandoni è del 10,4%, nel
Mezzogiorno del 16,6% E a Napoli arriva a sfiorare il 23%. Una disparità che
riguarda tutti i servizi, dalle mense alle palestre al tempo pieno. DI CONCHITA
SANNINO su La Repubblica il 6 aprile 2023.
Dispersi, soprattutto nelle
regioni del Sud, ma non solo. Invisibili, almeno fino a quando non incrociano
precarietà, sfruttamento, fragilità esistenziali. In qualche caso, il
reclutamento criminale. Erano 83mila i ragazzi che, alla chiusura degli scorsi
scrutini, sono stati bocciati solo perché non hanno raggiunto la soglia minima
delle presenze. Rischiano almeno di raddoppiare, nel 2023. È la piaga
dispersione scolastica. Che assegna la maglia nera al Mezzogiorno, ma ha un
picco nell’area metropolitana di Napoli.
In Europa li osservano più a
valle, sono Early leavers, i precoci nell’abbandono: ragazzi tra i 18 e i 24
anni con nessun titolo di studio o al massimo la licenza di scuola media,
rappresentano la somma di tutte le evasioni ignorate: e oggi sono al 16,6% nel
Sud Italia (a fronte del 10,4% nel Centro-Nord); quindi quasi il doppio della
media del 9 in Europa. Una ferita italiana. Ma non interroga il governo come gli
sbarchi, non allarma come irave party. E se la pandemia ha moltiplicato le
povertà educative, il progetto di Autonomia tracciato dal ddl Calderoli rischia
di sparare il colpo di grazia.
C’era una volta la pubblica
istruzione che univa. Oggi, dimmi dove sei nato e saprai quale destino ti tocca.
Stretta la connessione, tra i servizi che la scuola nega in alcuni territori e
l’abbandono: vedi il tempo pieno, che al Sud è solo al 18 %, contro il 48 del
resto del Paese. Di più: a Milano è all’80%, a Napoli solo al 20. Grandi
disuguaglianze montano: gli analisti di Svimez guidati dal dg Luca Bianchi, per
dire, con il manager Ernesto Albanese de l’Altra Napoli onlus,ci hanno costruito
un amaro cartoon, titolo:Un Paese, due scuole.
Due ragazzini di quinta
elementare, nati lo stesso giorno: uno vive in Toscana, dove l’85 % delle scuole
ha una mensa, e il 75 dispone di palestra; l’altro scolaro invece sta a Napoli,
con l’80% delle scuole senza il tempo pieno, e l’83 che non ha palestra. Il
bimbo del Nord avrà avuto alla fine della quinta, grazie al tempo pieno, 1.226
ore di formazione, e quello del Sud solo mille. Risultato:alla fine del ciclo,
il ragazzino del Meridione è in credito di un intero anno in termini di
formazione, doposcuola, educazione alimentare e allo sport. In pratica: un anno
di crescita che manca, il “prezzo” della Costituzione tradita. Divario che
nessun Pnrr, con la sua miliardaria — e ancora astratta — potenza di fuoco
potrebbe mutare, senza azioni sinergiche d’impatto (mai varate, anche da governi
di sinistra). E i numeri continuano a crescere.
Quota 23% di dispersione, in
media, nell’area metropolitana di Napoli, dove il Comune ha attivato una
piattaforma integrata per controllare il fenomeno. Era stato siglato un anno fa
anche il “Patto educativo”, ancora al palo, in verità. Il prefetto Claudio
Palomba ha ripetuto spesso: «In provincia siamo a picchi del 50-60%,
impressionante». E il recente dossier voluto da Ettore Acerra, Ufficio
scolastico della Campania, segnala: 3.757 denunce alle due Procure per i minori
per inadempienze. Bianchi, da Svimez, anticipa aRepubblica: «Il Pnrr che dedica
importanti risorse all’istruzione non raggiunge l’obiettivo di colmare i divari:
la priorità oggi è rafforzare il sistema soprattutto nelle aree più marginali,
garantendo asili nido, tempo pieno, palestre. Da una ricerca Svimez in via di
pubblicazione emerge che l’investimento per alunno del Pnrr sull’istruzione
(esclusi gli asili nido) è stato pari a 903 euro nella provincia di Milano, dove
il tempo pieno è assicurato al 75 % dei bambini della primaria, mentre è di 725
euro a Palermo, col tempo pieno solo al 10%». E con l’Autonomia? «C’è il rischio
grave: adattare l’intensità dell’azione pubblica alla ricchezza dei territori.
Quindi, più investimenti e stipendi lì dove se li possono permettere:
pregiudicando la funzione principe della scuola, fare uguaglianza». Denunce,
carte. «Partono le segnalazioni ai Servizi sociali e alla Procura. E poi? Poi
nulla», testimonia Valeria Pirone, la dirigente che a Napoli est guida il
Vittorino da Feltre, 850 alunni, dai 3 ai 14 anni. Per inciso, un’altra delle
sue allieve,Chiara, è diventata mamma a 14 anni. Caso isolato? «Macché, tante».
Gli esempi positivi esistono.
Ma quasi sempre partono dal basso. Proprio dall’incontro tra Fondazione Riva e
salesiani (con padre Loffredo, Fondazione San Gennaro, Cometa, If, Millepiedi,
Regione) è nata a Napoli nel 2019 la Scuola del Fare. «Sembrava una follia.
Volevamo dare una reale prospettiva di ingresso nel mondo del lavoro a giovani
che avevano mollato la scuola — spiega il presidente Antonio Riva — Oggi, 140
ragazzi frequentano. E quelli del quarto anno sono inseriti, come operatori
della logistica o di officine meccaniche». E poiché il caso (non) fa strani
scherzi, la scuola è intitolata a Giulia Civita Franceschi, che negli anni Venti
del secolo scorso trasformò la nave Caracciolo in una innovativa scuola per 750
ragazzi. Scugnizzi che diventarono i “caracciolini”: strappati a ignoranza e
povertà. Per inciso, ci pensò il fascismo a spezzare uno straordinario modello
educativo che guardava al futuro.
Nord e Sud: una lunga storia
di paradossi. Goffredo Buccini su Il Corriere della Sera il 26 marzo 2023.
Il grande riassetto previsto
dalla riforma Caderoli e tutte le volte che in precedenza si è messo mano alla
materia
Viene da lontano, attraverso i
sussulti del nostro localismo, tra le insofferenze separatiste dei territori più
ricchi e le recriminazioni revansciste di quelli più poveri. E si porta addosso
una narrazione di diffidenza fra Nord e Sud, spesso infarcita di stereotipi. Ma
non è mai stata così vicina a compiersi l’autonomia differenziata: il
trasferimento dallo Stato alle Regioni di funzioni numerose e rilevanti, in
attuazione dell’articolo 116 della nostra Costituzione, come da riforma del
2001.
Diciamolo subito: è una storia
di straordinari paradossi. Il primo dei quali sta nello scarsissimo dibattito
pubblico che accompagna un mutamento decisivo per il futuro degli italiani. La
materia, certo, è ostica. Ma è di sicuro più impattante sulla generalità dei
cittadini di quanto non siano talune, pur rilevanti, battaglie di bandiera che
nel tempo hanno dominato il confronto politico e segnatamente l’agenda della
sinistra.
Del resto, all’origine della
catena dei paradossi si trova proprio la parte che guida adesso il fronte
avverso al disegno di legge intessuto dal leghista Calderoli, approvato dal
Consiglio dei ministri e ora in Parlamento dopo il vaglio formale del Quirinale.
Era di centrosinistra la maggioranza che nel 2001, con l’illusione di
sterilizzare le spinte federaliste del Nord incarnate dalla Lega, decise
di riformare il titolo V della Costituzione, aprendo uno squarcio sistemico nei
tradizionali rapporti fra Stato centrale ed enti periferici, foriero
dell’impennata di spese e conflittualità che ci ha accompagnato fino ai giorni
nostri (si prenda quale ultimo esempio il caos scoppiato tra Roma e le venti
sanità «regionalizzate» in occasione della pandemia). Sempre di centrosinistra
era il governo che, a firma Gentiloni, sottoscrisse il 28 febbraio 2018 le
pre-intese con Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, prime tre Regioni a
sollecitare, ai sensi dell’articolo 116 già citato, un trasferimento di funzioni
(Veneto e Lombardia chiedevano tutte e 23 le materie concorrenti disponibili).
Val la pena di notare come sia nel 2001 che nel 2018 si era a ridosso di
elezioni politiche e come nelle urne la scelta «tattica» non si rivelò proficua
per il centrosinistra.
Restando ai paradossi, il
«fronte del no» al disegno di legge Calderoli annovera adesso anche la decisa
opposizione dei Cinque Stelle. Giuseppe Conte ha accusato la premier Meloni di
avere «svenduto a Salvini l’Unità d’Italia». Dunque, sarà opportuno rammentare
come, sempre nel 2018, il famoso «contratto» stipulato tra leghisti e
pentastellati per dar vita al loro breve gabinetto gialloverde avesse in coda un
punto davvero «prioritario», il numero 20: la realizzazione del regionalismo a
geometria variabile. In capo a un anno i Cinque Stelle compresero ciò che
avevano davvero firmato e iniziarono a menare il can per l’aia, avendo una
constituency molto meridionale. Assai più che i mojito al Papeete appare questo
un plausibile motivo di crisi per quell’esecutivo, caduto nell’estate del 2019.
Intendiamoci: il grande
riassetto dei poteri immaginato dagli strateghi leghisti sottende aspettative e
ragioni non banali e in apparenza neppure tutte «nordiste». Uno storico di area
dem come Emanuele Felice, nel suo saggio sul «Perché il Sud è rimasto indietro»,
indica come causa principale del divario le classi dirigenti meridionali, eredi
del vecchio notabilato disposto a cambiar tutto per non cambiar nulla. L’attesa
che «il Sud si svegli», per dirla con la Lega, è, quindi, più che legittima. Il
paradosso è che quella classe dirigente parassitaria e gattopardesca è stata
resuscitata proprio dal regionalismo: il divario Nord-Sud si restrinse
nell’Italia repubblicana fino all’attivazione delle Regioni, dopo di che
ricominciò ad allargarsi. Perciò non si può escludere che col disegno di legge
appena varato, e dal quale è già scaturito un effetto emulazione in altre
Regioni, stiamo correndo esattamente verso la causa dei nostri mali.
Ma, di paradosso in paradosso,
arrivando all’oggi, la riforma Calderoli potrebbe fare esplodere la competizione
nel centrodestra ben oltre le previsioni dei suoi primattori. Si tratta infatti
di una riforma «a due tempi», come spiega bene Adriano Giannola, presidente di
Svimez. Delle 23 materie in ballo, quelle che attengono a diritti civili e
sociali da assicurare da Bolzano a Ragusa (come sanità, istruzione o trasporto
pubblico locale) sono legate ai Lep (ciò che in sanità sono i Lea), i livelli
essenziali di prestazione, o assistenza, difficili da stabilire: si può andare
per le lunghe, insomma, fra esperti e commissioni, fino a eventuali Dpcm della
presidenza del Consiglio che li dovrebbe determinare in capo a un anno in
mancanza d’accordo. Visto il tema, è proprio sui Lep che s’è acceso quel po’ di
dibattito tra partiti: ma si tratta d’un errore di prospettiva. Perché le altre
materie, chiamiamole non-Lep, sono invece attribuibili senza indugi (ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, del disegno di legge), secondo le intese tra Stato e
Regioni: e sono «la vera polpa del piatto», spiega Giannola. Infrastrutture,
aeroporti, porti, zone speciali, ferrovie, protezione civile, energia: un
pacchetto economico su cui le altre Regioni, presumibilmente del Nord, le più
forti e le più omogenee politicamente, potrebbero confluire in piena
legittimità; il comma 8 dell’articolo 117 della Costituzione riformata nel 2001
prevede infatti che le Regioni possano trovare intese tra loro anche per
costituire «organi comuni».
È il Grande Nord inseguito per
una vita da Bossi e realizzato da Calderoli con altri mezzi? Chissà. Di sicuro
questa specie di Stato sostanziale dentro lo Stato formale, o di novella
Macroregione, conterrebbe la maggioranza della nostra popolazione e la fetta
largamente più rilevante del nostro Pil. Il presidenzialismo vagheggiato da
Giorgia Meloni dovrebbe bilanciare, si suppone, in senso unitario un così forte
spostamento nel potere economico (e dunque in quello politico reale) del Paese.
Ma dovrà seguire, a differenza della riforma Calderoli che s’appoggia su norme
costituzionali già esistenti, il lungo percorso di una nuova riforma
costituzionale. Difficile dire, ove arrivasse al traguardo, cosa troverebbe
ancora in piedi nella capitale di un’Italia, per allora, piuttosto ristretta.
L'Italia diseguale. Perché
nel nostro Paese si vive di meno e si ha un futuro diverso se si nasce al Nord o
al Sud. Carlo Bonini (coordinamento editoriale), Isaia Sales. Coordinamento
multimediale di Laura Pertici. Produzione Gedi Visual La Repubblica il 18
Dicembre 2022.
Ogni nazione, in genere, si
caratterizza più per le differenze al suo interno che per la omogeneità di
tradizioni, culture, sviluppo economico, condizioni di vita e di lavoro. Pur
facendo parte della stessa nazione gli Scozzesi sono diversi dai Gallesi, i
Baschi dagli Andalusi, i Valloni dai Fiamminghi, i Corsi dai Normanni, i
Bavaresi dai Prussiani e i Salisburghesi dai Carinziani.
Estratto dell’articolo di Luca
Monticelli per “la Stampa” il 23 gennaio 2023.
Il disegno di legge
sull'autonomia differenziata è pronto, e questa settimana sarà sul tavolo del
Consiglio dei ministri per il via libera preliminare. Il ministro leghista degli
Affari regionali, Roberto Calderoli, prova lo scatto in avanti per superare i
veti e le critiche a un progetto su cui puntano soprattutto Lombardia e Veneto,
amministrate dai suoi colleghi di partito, Attilio Fontana e Luca Zaia. Il ddl
«non spacca l'Italia», ribadiscono gli esponenti della Lega, ma i dubbi, pure
nella maggioranza di centrodestra, restano. […]
Il cavallo di battaglia del
Carroccio che intende cambiare la struttura della Repubblica con il regionalismo
differenziato si scontra però con le diseguaglianze tra nord e sud, che
potrebbero addirittura crescere a discapito dei cittadini del Mezzogiorno. Il
ministro e vice premier Antonio Tajani promette un fondo di perequazione proprio
per aiutare le Regioni svantaggiate, ma sta di fatto che la definizione dei Lep
– i livelli essenziali delle prestazioni, che l'articolo 117 della Costituzione
vuole vengano garantiti su tutto il territorio nazionale – ancora non c'è, e
bisognerà aspettare mesi per ottenerla […]
Durissima la reazione del
Terzo polo […] CON Mara Carfagna: «Senza finanziare i Lep, l'autonomia di
Calderoli rischia di consegnare ai nostri figli un'Italia estremamente divisa,
soprattutto in settori così vitali per il nostro Paese, come istruzione e
sanità. Un'eventualità che ostacoleremo in ogni modo possibile».
Intanto, la Svimez –
l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – con uno studio
che rifà la contabilità nazionale, ribalta la retorica di molti politici e
commentatori del nord secondo i quali la spesa storica favorisce il sud. Nel
rapporto Svimez emerge come la mano pubblica sia molto più forte nelle Regioni
settentrionali. […]
Estratto dell’articolo di Luca
Monticelli per “La Stampa” il 23 gennaio 2023.
«Noi siamo d'accordo a superare
la spesa storica perché è un criterio che ha avvantaggiato le Regioni del nord.
Per fare una vera autonomia servono più fondi al sud per ridurre i divari».
Luca Bianchi, direttore della
Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, sconfessa
il luogo comune secondo cui la spesa pubblica ha penalizzato le Regioni che oggi
chiedono a gran voce l'autonomia differenziata, come Lombardia e Veneto.
Secondo la Svimez, non c'è
stata alcuna ingiustizia fiscale, se mai lo scippo l'ha subito il Mezzogiorno.
Basta consultare i dati dei conti pubblici territoriali dell'Agenzia della
coesione che «sono più completi di quelli del Mef perché tengono conto sia della
spesa diretta dello Stato, sia della spesa delle imprese pubbliche locali».
Cosa dice il vostro studio?
«Contrariamente a quanto si
pensa, nel sud la spesa è minore, e lo si vede dai servizi: dal numero dei posti
letto negli ospedali agli asili nido, fino al tempo pieno nelle scuole. Gli
indicatori lo evidenziano: non essendoci un servizio non c'è nemmeno il
finanziamento. Abbiamo smentito chi sostiene che c'è un eccesso di risorse al
sud, il problema è che c'è una carenza di servizi».
Quindi non è vero che la spesa
storica ha aiutato il Mezzogiorno a scapito delle regioni del nord. Il ministro
Calderoli auspica il superamento di questo criterio, come si fa?
«L'unico modo per superare la
spesa storica è definire i livelli essenziali delle prestazioni, i Lep,
altrimenti si rischia che si vengano a cristallizzare le diseguaglianze che già
ci sono».
[…] Sta dicendo che il sud
deve avere più fondi?
«Questo è il vero tema, per
fare i Lep servono risorse aggiuntive. Come ha fatto il governo Draghi per gli
asili nido: ha introdotto i livelli essenziali delle prestazioni e nel frattempo
ha previsto un finanziamento aggiuntivo per le aree in cui gli asili nido non
c'erano».
E invece il nord dice "dateci i
soldi che abbiamo preso finora e li gestiamo noi".
«La proposta del nord è a
invarianza di gettito, noi diciamo che è sbagliata perché, prima di trasferire
le competenze, dobbiamo capire esattamente qual è la spesa da finanziare in
ciascun territorio per avere servizi omogenei. […] È necessario dare una
prospettiva di riduzione dei divari. Invece, con l'autonomia differenziata,
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto fanno da sole: così se ne va buona parte del
Pil nazionale e il Paese rinuncia a riequilibrare l'offerta dei servizi sul
territorio». […]
Divari e ritardi.
Antonio Giangrande: Quelli
che…ed io pago le tasse per il Sud. E non è vero.
Le grandi aziende che lavorano
nel Sud Italia hanno la sede legale al Nord e lì pagano le tasse.
Le grandi aziende del Nord
Italia hanno la sede legale nei paradisi fiscali e lì pagano le tasse.
Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla
per repubblica.it mercoledì 16 agosto 2023.
Il ministero delle Infrastrutture guidato da
Matteo Salvini è a caccia di fondi per garantire alcune opere inserite nel Pnrr
e nei contratti di programma, soprattutto sul fronte ferroviario. E così, senza
fare molto rumore, arriva il via libera a una mega rimodulazione di stanziamenti
per 2,5 miliardi di euro: soldi in gran parte definanziati per opere al Centro e
al Sud per sostenere subito alcuni grandi interventi in Piemonte, Lombardia e
Veneto.
[…] il deputato del Partito democratico, Marco
Simiani, […] ha sollevato il caso e presentato una interrogazione parlamentare
per capire la “ratio” dietro le scelte del ministero che trasferisce soldi,
veri, al Nord mentre il suo vertice è impegnato nella campagna mediatica per il
Ponte sullo Stretto.
I dati di questa rimodulazione sono stati messi
nero su bianco in una informativa del ministero delle Infrastrutture inviata al
Cipess (il vecchio Cipe), il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica.
[…]
D’intesa con Rete ferroviaria italiana e il
ministero dell’Economia è stato scelto un pacchetto di “interventi per i quali
lo stato progettuale non consente di bandire le gare entro il 2023”: progetti
che vengono quindi definanziati. Tra questi la linea ferroviaria Roma-Pescara
nella tratta interporto d’Abruzzo-Chieti-Pescara per 568 milioni di euro e nella
tratta Sulmona-Avezzano per 277 milioni di euro.
E, ancora, il raddoppio della Falconara-Orte per
326 milioni, il potenziamento della tratta Tivoli-Guidonia per 179 milioni, la
chiusura dell’anello ferroviario di Roma per 175 milioni. Ma anche la
velocizzazione della linea Lamezia Terme- Catanzaro e della Sibari-Porto Salvo
in Calabria. Definanziata anche linea Firenze -Pisa per 299 milioni. Uniche
opere definanziate al Nord sono il nodo di Novara per 77 milioni di euro e
Raddoppio della linea Maerne-Castelfranco Veneto per 277 milioni.
In totale la rimodulazione vale 2,5 miliardi di
euro, soldi che saranno subito dirottati per altre opere: 1,1 miliardi di euro,
quasi la metà dell’intera rimodulazione, andranno per la linea ad Alta velocità
Verona-Padova e per l’attraversamento di Vicenza. Altri 462 milioni per il nodo
Terzo Valico di Genova. E, ancora, 563 milioni per coprire cantieri e gare in
corso nel 2023.
I restanti 500 milioni sono divisi a pioggia, tra
gli altri, per il nodo di Bolzano (15 milioni) per la linea Torino-Padova (50
milioni) o per l’adeguamento infrastrutturale e tecnologico del nodo di Firenze
dell’Alta velocità (80 milioni) e i sottopassi della Merano-Bolzano (15 milioni
di euro). Su Roma aumentate le risorse per 21 milioni per il “potenziamento
della Roma-Tuscolana”.
Per il Mezzogiorno nell’elenco dei beneficiari c’è
solo il bypass ferroviario di Augusta per 68 milioni di euro e una tratta della
Foggia-Lecce per 12 milioni di euro. […]
I mutui sono meno cari al Nord, anche questo
azzoppa il Sud. ERCOLE INCALZA giovedì 3 agosto 2023 su Il Quotidiano del
Sud
Secondo un’analisi della Federazione Autonoma
Bancari Italiani, i mutui sono meno cari al Nord mentre gli interessi sono alle
stelle nel Sud del Paese e nelle Isole. Le differenze territoriali dipendono da
alcuni fattori di rischio; il Sud e le Isole sono, purtroppo, più indietro
economicamente rispetto al Nord. Il numero dei fallimenti di imprese o di
difficoltà economica sono numericamente più rilevanti e le famiglie faticano a
pagare le rate
Ritengo opportuno ricordare che la Cassa del
Mezzogiorno venne istituita nel 1950 con la Legge 646 come Ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico allo scopo di predisporre programmi,
finanziamenti ed esecuzione di opere straordinarie dirette al progresso
economico e sociale dell’Italia meridionale, originariamente da attuarsi entro
un periodo di 10 anni (1950-1960). Uno degli ispiratori determinanti di una tale
iniziativa fu Pasquale Saraceno che quattro anni prima, nel 1946, aveva
partecipato alla fondazione dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno (Svimez).
Pasquale Saraceno poteva contare su una squadra di
altissimo livello come Donato Menichella, Francesco Giordani, Rodolfo Morandi e
Nino Novacco. L’iniziativa fu supportata inizialmente con uno stanziamento di
100 miliardi di lire all’anno per i dieci esercizi dal 1951 al 1960: in
complesso mille miliardi di lire, subito aumentati nel 1952 a 1.280 miliardi da
utilizzare nel dodicennio 1951-1962. Ebbene Pasquale Saraceno rimase nel
Consiglio di Amministrazione della Cassa del Mezzogiorno presieduta da Gabriele
Pescatore fino al 1973.
Ho ritenuto opportuno fare questa premessa per
ricordare il ruolo di un grande economista nel processo di rilancio del
Mezzogiorno, il ruolo di un convinto sostenitore di una crescita certa e
misurabile del Mezzogiorno, di un meridionalista nato al Nord, in particolare a
Morbegno (Sondrio), però da padre siciliano e madre campana.
Ebbene nel 1972 in un Convegno organizzato a
Napoli dall’allora Presidente del Banco di Napoli Ferdinando Ventriglia,
Pasquale Saraceno, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa del
Mezzogiorno precisò: “Circa venti anni fa quando iniziai la non facile ma
interessante esperienza della Cassa dissi che tre erano gli indicatori che
dovevamo monitorare attentamente perché erano quelli che, sulla base degli
investimenti che andavamo a realizzare, avrebbero dovuto subire un sostanziale
cambiamento; mi riferisco al reddito pro capite, al tasso di disoccupazione e al
costo del denaro.
Dopo venti anni ci sono flebili segnali positivi
sui primi due indicatori mentre sul terzo, purtroppo, non è cambiato nulla. E
questo, devo essere sincero, è davvero preoccupante perché rappresenta il
riferimento determinante per un processo di crescita. Sono sicuro che con le
azioni che andremo a prendere proprio in questi prossimi anni attraverso il
sostegno alle Aree di Sviluppo Industriale, il mondo bancario annullerà queste
forme discriminanti nei confronti delle iniziative del Mezzogiorno.”
Sempre in quella occasione alcuni dei partecipanti
al dibattito ricordarono che il costo del danaro nel Mezzogiorno scontava una
serie di criticità quali: forme organizzate malavitose o mancato pagamento dei
ratei che portavano il sistema bancario ad essere molto attento nell’erogare
mutui e dovendolo fare a far gravare su di essi una percentuale maggiore.
Insisto nel ricordare il pieno convincimento di
Pasquale Saraceno sul fattore “costo del denaro” nella crescita e nello sviluppo
del Sud. Ebbene dopo mezzo secolo da quell’intervento di Pasquale Saraceno a
Napoli la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) ha pubblicato una
dettagliata analisi macro economica da cui emerge che: i mutui sono meno cari al
Nord mentre gli interessi sono alle stelle nel Mezzogiorno e nelle Isole.
Cioè da questa analisi emerge che chi risiede
nelle aree geografiche del Sud paga rate mediamente più alte rispetto a chi
abita nel resto d’Italia. Sempre dallo studio emerge, solo a titolo di esempio,
che chi abita nel Nord Est del Paese paga un tasso d’interesse pari al 3,9%
mentre chi abita in Campania o in Puglia paga un tasso di interesse pari al
4,23%.
Sono rimasto sconcertato nel leggere, ripeto dopo
cinquanta anni, la dichiarazione di un rappresentante del mondo bancario
identica a quella prodotta dopo l’intervento di Saraceno a Napoli del 1972.
Infatti il Segretario della FABI Lando Maria Sileoni ha dichiarato: “Le
differenze territoriali sul costo dei mutui dipendono da alcuni fattori di
rischio; il Sud e le Isole sono, purtroppo, più indietro economicamente rispetto
al Nord. Il numero dei fallimenti di imprese o di difficoltà economica sono
numericamente più rilevanti e le famiglie faticano a pagare le rate dei prestiti
e dei mutui”.
Dopo mezzo secolo, e possiamo anche dirlo dopo
settantatre anni dalla istituzione della Cassa del Mezzogiorno, che doveva tra i
suoi obiettivi fondamentali annullare quanto meno queste tre differenze e tra
queste almeno quella legata al costo del denaro, non è praticamente cambiato
nulla e, cosa ancor più grave, lo Stato non ha in tutti questi anni mai, dico
mai, dichiarato apertamente che quel rischio denunciato dal Segretario della
FABI possa essere assorbito dallo Stato.
Invece continuiamo a parlare di autonomia
differenziata e assistiamo quasi inermi ad un dato vergognoso come quello che
vede il reddito pro capite in Sicilia o in Calabria pari a 17.000 euro e a
Varese o Bergamo pari a 38.000 euro o 36.000 euro.
Ma continuiamo ad assistere, senza comprenderne i
rischi, a crisi come quella di Termini Imerese, come quella di Priolo – Augusta,
come quella di Taranto.
Invece, e questo è davvero grave, ci stiamo
abituando alla impossibilità di modificare e rendere omogenei quegli indicatori
chiave prima elencati; eppure il Festival Euro-Mediterraneo a Napoli nel marzo
scorso ha ufficialmente prodotto una narrazione diversa, una narrazione che
testimonia la presenza nel Sud di eccellenze e di fenomeni produttivi che penso
dovrebbero portare il Governo ad assicurare il mondo della finanza da rischi che
forse sono invocati per mantenere inalterato un atteggiamento comodo solo
proprio per il mondo della finanza.
Divario Nord-Sud: i 10
fattori-chiave che bloccano il Mezzogiorno. Dal Pil all’istruzione alla sanità. Diana
Cavalcoli su Il Corriere della Sera il 28 Gennaio 2023.
Un Sud arretrato ma dalle
grandi potenzialità: il Pil
Un’Italia a due
velocità. Questa l’immagine che emerge dal report “I divari territoriali nel
Pnrr” diffuso dall’Istat. Un focus che mette in fila i 10 indicatori-chiave del
gap tra il Nord e il Sud del Paese. Un territorio descritto come «arretrato» e
che ha sofferto «in modo accentuato la Grande crisi del 2008 e, da ultimo,
l’impatto della pandemia». Nel report viene definito però «un contesto dalle
grandi potenzialità e differenziazioni interne, dove risiedono oltre 20 milioni
di abitanti (circa un terzo della popolazione italiana), con un tessuto
produttivo che – pur debole e incompleto – potrebbe generare effetti positivi
per il Paese». Il divario si traduce così in numeri e un primo elemento da
analizzare è il Pil 2021. In termini di prodotto interno lordo la regione più
ricca è il Trentino-Alto Adige con 40.904 euro di Pil pro-capite. Ultima la
Calabria con 16.168. Scrive l’Istat: «Da oltre un ventennio il Pil pro-capite
nel Mezzogiorno si aggira intorno al 55-58% del Centro-Nord; nel 2021 il Pil
reale è di circa 18mila euro (33mila nel Centro-Nord)». Tutto il Mezzogiorno si
colloca sotto la media nazionale (qui l’analisi sul differente costo della vita
tra le città).
Il gap sull’occupazione
La “questione meridionale” è un
punto centrale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha destinato il
40% delle risorse per finanziare riforme e interventi per le 8 regioni del Sud.
Territori che scontano un gap importante rispetto al Nord per quanto
riguarda mercato del lavoro e chance occupazionali. «Dal 2000 in poi si
registrano circa 3 occupati ogni 10 in meno nel Mezzogiorno rispetto al
Centro-Nord (25-34 anni). Tranne rare eccezioni, l’intero Mezzogiorno presenta
tassi di occupazione giovanile molto inferiori alla media», aggiungono gli
analisti. Se la fase più critica per l’occupazione si è vista tra il 2008 e il
2013 — periodo in cui in Italia, nella fascia d’età 15-64 anni, si passa da 22,6
milioni di occupati a 21,4 milioni con una perdita concentrata nel Mezzogiorno
(626mila; 51,1%) — va detto che la leggera occupazionale dal 2014 è poi crollata
con la pandemia. Si legge: «Ad aprile 2021, al netto della stagionalità, il
numero di occupati (22,34 milioni) resta inferiore del 3,5% (814mila unità)
rispetto al febbraio 2020». L’Istat ricorda poi come il Sud paghi la diffusione
del lavoro atipico o non standard e quindi del lavoro nero. Preoccupa anche il
futuro dei territori e delle nuove generazioni. Nel 2021 in Italia risultano
occupati 7 giovani su 10, che salgono a circa 8 su 10 nel Centro-Nord (82,4% al
Nord e 74% nel Centro Italia) mentre calano a circa 5 nel Mezzogiorno.
Istruzione e competenze
A frenare la crescita anche le
criticità sul fronte della scuola e delle conoscenze. Scrive l’Istat: «Il
livello d’istruzione nel Mezzogiorno conferma una grave arretratezza: migliora
nelle giovani generazioni ma lo svantaggio è ancora molto ampio». Nel 2020, un
terzo (32,8%) dei meridionali in età 25-49 anni (24,5% nel Centro-Nord) ha
concluso al più la terza media; il 22,6% (27,6% nel Centro-Nord) ha un titolo
terziario. Il tema sono le poi le competenze che per gli studenti del Sud
risultano più basse in tutte le discipline con un gap che si allarga nei diversi
gradi d’istruzione. «Nel 2021-22 il 42,7% degli studenti meridionali di V
superiore presenta competenze “molto deboli” in matematica (28,3% in Italia; 15%
nel Nord-Est) e solo il 6,7% si colloca a un livello “molto buono” (14,9% in
Italia; 22,6% nel Nord-Est)», aggiungono gli analisti.
La digitalizzazione incompleta
Altro fattore chiave: la
digitalizzazione incompleta. Posto che nel 2000 dichiarava di avere accesso alla
rete dalla propria abitazione solo il 15,4% delle famiglie (nel Mezzogiorno
11,1%), negli ultimi 20 anni la crescita è stata rapida. Nel 2010 oltre la metà
delle famiglie italiane (52,4%) aveva accesso alla rete e nel 2020 circa 8 su 10
(79%). Tuttavia il Mezzogiorno non ha ancora recuperato il gap di partenza, che
nel 2021 resta al 6%. Oggi al Sud il 60% circa dei residenti «ha opportunità
ridotte di accesso alla Banda ultra-larga, e circa 1 su 5 (17,3%) vive in
contesti molto distanti da questo standard (4,2% nel Centro-Nord)».
Il rebus trasporti
Il Mezzogiorno presenta poi
infrastrutture di trasporto inferiori per qualità e quantità rispetto al
Nord. Scrive l’Istat: «La densità della rete ferroviaria è nettamente più bassa,
soprattutto nell’alta velocità (0,15 Km ogni 100 Km2 di superficie; 0,8 al Nord;
0,56 al Centro)». Negli ultimi decenni l’ampliamento è stato modesto (+0,3%
contro +7,1% del Centro-Nord) mentre è aumentato il gap qualitativo (58,2% di
rete elettrificata; 79,3% del Centro-Nord).
Reti idriche vecchie
Altro nodo critico i servizi
essenziali. «L’obsolescenza delle reti idriche — spiegano dall’Istat — è un
fattore critico data la sempre più grave siccità che interessa il Paese. Nel
Meridione spesso si registrano perdite per circa la metà dell’acqua per uso
civile. Livelli di inefficienza superiori alla media caratterizzano tre quarti
delle province del Mezzogiorno (1/4 nel Centro-Nord)».
Servizi per l’infanzia
Nel Mezzogiorno mancano poi
adeguati servizi per l’infanzia. Nonostante l’offerta di nidi e asili nido sia
in crescita su tutto il territorio nazionale, i gap restano significativi. «Due
terzi dei bambini (0-3 anni) nel Mezzogiorno vive in contesti con livelli di
offerta inferiori agli standard nazionali e il 17,8% in zone con una dotazione
molto bassa o nulla (5,3% nel Centro-Nord)», aggiungono da Istat. Nel livello
più critico, spesso risultano serviti meno di un terzo dei Comuni: è il caso
delle 5 province calabresi; di tutta la Sardegna (eccetto Cagliari), di
Caltanissetta e Potenza. Fra le 10 maggiori città italiane, solo quelle
meridionali si collocano ampiamente sotto la quota dei 30 posti ogni 100 bambini
minori di 3 anni. Nel dettaglio: Catania (6,8); Palermo (11,8); Napoli (12,8);
Bari (16,3). Firenze (49,4) è la città con l’offerta più ampia, cui seguono:
Bologna (47,6); Roma (47,1); Torino (40,7); Genova (37,9); Milano (37,8).
La sanità: mancano le risorse
Divari importanti anche sul
fronte della sanità. Tanto che si parla di emigrazione ospedaliera da Sud a
Nord. Tra le ragioni la bassa spesa sanitaria bassa, che in Italia continua a
essere inferiore alla media Europea. Situazione che per l’Istat ha prodotto una
“contrazione del sistema sanitario”, più accentuata nel Mezzogiorno dove il
finanziamento pubblico è più basso. Nel 2018, le regioni con una spesa pubblica
per abitante superiore alla media nazionale (1.911 euro/ab.) erano quasi tutte
del Centro-Nord con Calabria (1.705) e Campania (1.783) nelle posizioni di coda.
«Nel Mezzogiorno soprattutto in alcune regioni coinvolte dai Piani di Rientro (6
su 7 in questa ripartizione) la contrazione della spesa pubblica ha inciso
negativamente sui Lea (Livelli essenziali di assistenza). Non stupisce quindi la
diffusa “emigrazione sanitaria”: i ricoveri extra-regionali sono il 9,6% di
quelli interni (6,2% nel Centro-Nord). In oltre 1 Provincia su 5 (21,1%; 7,2%
nel Centro-Nord) tale mobilità sanitaria è molto intensa», concludono
dall’Istat.
Trapani-Ragusa, 13 ore e 8
minuti: il treno più lento d’Italia. «La coincidenza? Nelle mani di Dio». Marco
Bonarrigo su Il Corriere della Sera il 28 Gennaio 2023.
Il viaggio lungo i binari da
Trapani a Ragusa, tra continui cambi e innumerevoli fermate. Le stazioni, i
sanitari smaltati, l’ironia: «Ai turisti qui vogliono male»
Quando i 97 esasperati
passeggeri del Regionale 21882 cominciano a picchiare i pugni contro le porte a
soffietto della littorina Fiat 668 (66 posti a sedere, 43 anni e chissà quanti
chilometri di onorato servizio), l’uomo della provvidenza monta su una panchina
e alza la voce per sovrastare le proteste. «Signori — esordisce il capotreno —
il passaggio a livello di Marausa è appena stato aggiustato, il treno delle
17.30 è cancellato mentre non ho notizie di quello delle 19.52. Saliamo
ordinatamente lasciando sedere anziani, donne e bambini e avete la mia parola
che arriviamo a Marsala». Uno dei più arrabbiati — la faccia diffidente del
pendolare cronico — incalza: «E la coincidenza per Sciacca?». Il controllore,
sospirando: «Quella non la posso garantire: Sciacca è nelle mani di Dio».
Le «ritirate»
A Dio piacendo, dalla stazione
di Trapani parte ogni giorno il treno regionale più lento d’Italia e magari
d’Europa: tredici ore e otto minuti (salvo ritardi, festivi esclusi) per
arrivare a Ragusa dopo quattro cambi e 47 fermate in altrettante stazioni
«impresidiate», ovvero (burocratichese Fs) abbandonate alla natura (fanno,
circa, 25 km/h). Da capoluogo a capoluogo, in auto servono tre ore e mezza, in
treno dall’alba al tramonto. Lasciamo Trapani puntuali alle 6 e 50 del giorno
successivo all’ammutinamento mancato, in compagnia di Vita (impiegata al
distretto sanitario di Marsala) e Tommaso che studia all’alberghiero Ferrara di
Mazara del Vallo: scontato del bonus trasporti (60 euro), l’abbonamento mensile
costa 3,70 euro. Impregnata dall’odore di nafta, la littorina è un dignitoso
pezzo da museo, le commoventi «ritirate» con i sanitari smaltati originali e i
rubinetti d’ottone. Prima tappa Palermo, in teoria a un tiro di schioppo: nel
1933 ci si arrivava in due ore e mezza, dal 1953 al febbraio 2013 in due ore.
Poi un bel giorno la linea franò: «La ripristineremo in pochi giorni» dissero le
Fs. Dopo dieci anni si gira ancora larghissimi sulla linea per Mazara, Marsala e
Castelvetrano arrivando nel capoluogo dopo cinque ore.
Sosta al mercato
All’alba sui due vagoni del
21858 a Trapani (la nobile stazione ottocentesca è fasciata dalle impalcature)
eravamo saliti in 21, dopo Marsala rimaniamo in tre, io, la signora Cosima detta
Mimma (va a prendere la sorella a Punta Raisi, non ha la patente e soffre il
bus) e Vittorio — postale in pensione — diretto ad Alcamo che si agita quando ci
fermiamo a Birgi: «Due chilometri a sinistra — spiega — e c’è l’aeroporto,
basterebbe un binario per collegarlo; due a destra lo Stagnone, Mozia e il suo
Efebo che vengono a vederli da tutto il mondo. Non c’è uno straccio di taxi o
navetta: ai turisti noi siciliani vogliamo male». Scorrono senza che salga o
scenda anima viva la Salemi dell’assessore Sgarbi, l’Alcamo del poeta Ciullo,
Castellammare e Cinisi dove L. (giovane controllora, «il nome completo no per
favore che finisco nei casini») ci svela la sua strategia per farci arrivare a
Palermo in anticipo. Poiché sbuffano vapori di nafta irrespirabili nelle cento
gallerie dopo Punta Raisi, tutte le littorine da Trapani si fermano nell’oscura
Piraineto («Cespugli e rovi ciclopici, fontanella d’acqua potabile con rubinetto
murato, la stazione più brutta d’Italia», racconta applauditissimo il recensore
Riccardo C. su Google) dove ci sarebbe un’ora di attesa per la coincidenza sul
modernissimo «Pop». Ma L. ha scoperto sul tablet di servizio che siamo in
anticipo di un minuto mentre il 5602 per Palermo è in ritardo di tre. Scendiamo
al volo e grazie a lei l’ora di sosta la spenderemo alla Vucciria davanti a un
arancino.
I «direttissimi»
Sul tabellone partenze di
Palermo Centrale lampeggia il Trinacria delle 12.35, l’Intercity Notte che
sbarca a Milano dopo 23 ore di viaggio, ultimo erede di una dinastia di
mitologici direttissimi che potevi chiamare per nome e portavano dritti in
Continente: Freccia del Sud, Freccia della Laguna, Akragas Express, Conca d’Oro,
Archimede. Oggi sono tutti estinti: sbarcati a Villa San Giovanni dalle comode
Frecce e Italo, si traghetta per entrare nel Girone dei Regionali. Il viaggio
verso Ragusa procede sul modernissimo 21720, prima lungo il mare e poi tra
aranceti e distese di cardi della collina. Dei turisti fuori stagione (due
olandesi, una tedesca, due giapponesi) i controllori si fanno amorevolmente
carico per poi smistarli verso la destinazione finale. Lo snodo cruciale è la
stazione più triste della Sicilia, Xirbi: chi prosegue per Catania resta a
bordo, chi dirige a Trapani o Agrigento scende qui, nel nulla assoluto (Xirbi
deriva dall’arabo xar-xir, pietraia) di questo luogo da cui fino agli anni
Cinquanta partivano i treni minerari per Centuripe, Radusa, Pirato e le zolfare
di Girgenti. Qui, il 21 marzo 1943, accadde uno degli incidenti più tragici e
inesplorati della storia ferroviaria italiana: 137 giovanissimi soldati
dell’agonizzante Regno persero la vita su un treno militare investito da un
altro convoglio che, sabotato o guasto, arrivava a velocità folle da
Caltanissetta. A ricordarli un’anonima targhetta sul brutto edificio della
stazione.
Il litorale di Gela
Bella, bellissima è invece la
stazione di Caltanissetta da dove parte (al tramonto) l’ultima frazione del
viaggio: inaugurata nel 1876, è stata restaurata con gusto e amore superiori
allo scarso traffico passeggeri. Scendiamo verso la costa in compagnia di una
trentina di studenti palermitani che tornano nel ragusano per Natale. Il
Minuetto arranca tra Canicattì e Campobello dove un tempo partivano a decine i
merci carichi di uva e zolfo: a Ravanusa c’erano il trenino di Favarotta e la
teleferica per le miniere di Talarita, a Licata la diramazione per il porto e
l’imbarco: tutto cancellato, distrutto, ridotto a rudere. Un buio pietoso
cancella gli orrori del litorale di Gela. A Vittoria restiamo a bordo in dieci,
nella Comiso di Gesualdo Bufalino in cinque mentre il Minuetto (che va a nafta,
per i treni ibridi su queste linee non elettrificate bisogna aspettare) comincia
a sbuffare sempre di più in salita.
Arrivando a Modica
È quando entriamo rantolando
nella stazione di Ragusa (cosa volete che siano 13 minuti di ritardo dopo un
giorno intero di viaggio) Girolamo, macchinista «in transito», ci informa che la
corsa non termina nel capoluogo, come pensavamo: il servizio si chiude mezz’ora
dopo tra le meraviglie di Modica, dove il treno riposerà fino all’alba prima di
ripartire per Siracusa. Sbarchiamo a Modica alle 20 e 30: nella stazione deserta
le luci sono fioche e manca perfino il sottopassaggio. Attraversiamo i binari
spaesati come i contadini girgentini de Il Lungo Viaggio, uno dei racconti più
belli di Leonardo Sciascia, che avevano affidato i loro risparmi e la loro vita
a un intermediario, il signor Melfa, che li imbarcò a Gela con la promessa di
traghettarli in America. Lasciati di notte su una spiaggia dagli scafisti dopo
giorni passati sottocoperta, vagabondarono per ore prima di buttarsi «come
schiantati sull’orlo di una cunetta: ché non c’era fretta di portare agli altri
la notizia che erano sbarcati in Sicilia».
Caro Sud fatti furbo: non
abboccare alla distrazione di massa. Allora se sei un bambino di Crotone
corri un rischio doppio di morire nel primo anno di vita rispetto a uno di
Pavia. Se sei un vecchio di Potenza non puoi essere curato come uno di Padova e
muori tre anni prima. Lino Patruno su La Gazzetta del Mezzogiorno il 27 Gennaio
2023
Mettiamo che ci sia un Paese
chiamato Italia nel quale avviene qualcosa di incredibile. Ha regioni più povere
delle altre pur nello stesso Paese. Queste regioni più povere sono tutte al
Centro Nord. Si chiamano Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Ma poi Piemonte,
Liguria, Toscana. Sarebbe talmente ingiusto da chiedersi come mai. E da
chiedersi cosa si aspetta a intervenire visto che secondo la Costituzione di
quel Paese non ci possono essere differenze in base al luogo di nascita. Cioè
non può valere la Teoria del Caso, quella che ti fa aprire gli occhi nel posto
sbagliato. E tu ne devi essere danneggiato a vita.
Ti fai un po’ di conti e scopri
che la colpa è di uno Stato che in quel Paese viola la sua stessa Costituzione.
Non solo ha dato meno alle regioni del Centro Nord rispetto a quelle del Sud,
impoverendo le prime e arricchendo le seconde. Ma in decenni non ha fatto nulla
per cambiare quella situazione. La protesta di Lombardia, Veneto, Emilia e
compagni sarebbe più legittima di un rigore per un calciatore atterrato in area.
E questo giustamente dovrebbe essere il primo impegno di qualsiasi governo.
Senza nessun doloso tentativo di far passare quei cittadini come colpevoli della
loro condizione di discriminati. Giochino che si fa a danno di tutti i poveri
della Terra.
Fosse così, quelle regioni
strillerebbero come oche del Campidoglio. Siccome avviene a parti invertite,
nessuno se ne importa, come cantava Pino Daniele. Con i governi che avrebbero
dovuto immediatamente intervenire anche se il più povero fosse stato il Sud come
in realtà è. Perché in questo Paese chiamato Italia il Sud è trattato da
diversamente italiano, ha meno diritti solo perché è Sud.
Allora se sei un bambino di
Crotone corri un rischio doppio di morire nel primo anno di vita rispetto a uno
di Pavia. Se sei un vecchio di Potenza non puoi essere curato come uno di Padova
e muori tre anni prima. Se sei di Alessandria hai l’assistenza domiciliare e a
Campobasso no. Se vai a scuola a Caserta hai un insegnante ogni venti alunni e a
Modena uno ogni dieci. Se sei l’università di Foggia ti danno meno fondi di
quella di Bologna. Se sei un lavoratore di Cosenza ti pagano meno di uno di
Verona. Se stai a Torino hai un treno ad alta velocità ogni venti minuti con
Milano e fra Bari e Napoli nessuno.
Non meraviglia (anche se
indigna) sapendo che lo Stato italiano spende ogni anno per ogni suo cittadino
centrosettentrionale 3671 euro in più rispetto a ogni suo cittadino meridionale.
Ciò che sempre ogni anno dirotta dal Sud al Centro Nord 61 miliardi. Sottraendo
al Sud servizi pubblici essenziali, a cominciare appunto da sanità, scuola,
trasporti. Sottraendogli infrastrutture (al Sud il doppio di ferrovie a binario
unico). Mortificandone la qualità della vita. E costringendolo a una emigrazione
che finora è stata pari alla sparizione di due città come Bari e Taranto.
Allora uno Stato che non
volesse continuare con questo scandalo a livello internazionale dovrebbe
riequilibrare la spesa. Cioè non continuare con una spesa storica che ha sempre
storicamente privilegiato mezzo Paese a danno dell’altro. Dovrebbe calcolare ciò
che non ha mai calcolato, cioè i bisogni del Sud. Li chiamano Lep, Livelli
essenziali di prestazione, ma si devono chiamare Lup, Livelli uniformi, uniforme
trattamento a Bergamo e a Taranto. Fra l’altro previsti, bontà loro, da una
legge del 2009, lasciata in un cassetto per fare stare sempre peggio chi stava
peggio e meglio chi stava meglio. E il Sud dovrebbe fare questa battaglia senza
farsi irretire e fuorviare da altro.
Invece avviene che non solo non
si calcolano questi bisogni del Sud. Non solo si dice che, quand’anche li si
calcolasse, non c’è un euro in più per rispettarli. Non solo si aggiunge che
quest’euro non si può sottrarre alla parte del Paese che lo prende
indebitamente. Ma avviene che questo governo (per mano di un suo ministro non
smentito) avalli una richiesta da parte di tre regioni del Centro Nord di avere
una maggiore autonomia. Tenendosi i soldi che già riceve come corpo del reato.
Anzi tenendosene anche altri che dovrebbe pagare in tasse.
Ma avviene di peggio. Avviene
che il Sud fa la battaglia contro quell’autonomia invece di fare la guerra santa
per i suoi bisogni mai riconosciuti e sempre violati. Cioè fa il gioco altrui.
Abboccando all’arma di distrazione di massa, mangiando la polpetta avvelenata.
Facendo fissare agli altri l’agenda. Giocando in contropiede invece che
all’attacco. Lamentando che l’autonomia farebbe aumentare il divario invece di
pretendere che il divario sia eliminato ora punto e basta. Lep-Lup. Caro Sud,
tutto il resto è palla all’avversario.
Tra le due Italie divari
insostenibili: nel Sud è allarme tsunami demografico. L'Istat misura i gap
che fanno del Mezzogiorno il territorio arretrato più esteso d'Europa, pur in un
contesto "dalle grandi potenzialità" che potrebbero generare "effetti positivi
sull'intero Paese". LIA ROMAGNO su Il Quotidiano del Sud il 26 Gennaio 2023
Reddito pro-capite, livello
d’istruzione, mercato del lavoro e occupazione giovanile, infrastrutture,
capitale umano, migrazioni, “turismo” sanitario, servizi per l’infanzia, reti
idriche e digitalizzazione: su ognuno di questi capitoli si misura la distanza
tra il Nord e il Sud del Paese, un divario che non è solo economico, ma anche
sociale e chiama in causa i diritti di cittadinanza di 20 milioni di cittadini
che vivono nel Mezzogiorno, che resta “l’area meno sviluppata più estesa e
popolosa d’Europa”, ma è comunque “un contesto dalle grandi potenzialità”, con
“un tessuto produttivo che – pur debole e incompleto – potrebbe generare effetti
positivi per il Paese”.
I ritardi accumulati negli anni
su diversi fronti rendono il territorio “meno vivibile e ospitale”, ponendo il
rischio di un vero e proprio “tsunami” demografico: già tra il 2011 e il 2020
l’area ha perso 642mila abitanti – tra saldo naturale e migrazioni – mentre il
Centro-Nord ne ha guadagnati 335mila. Senza un’inversione di rotta – missione
affidata alla “occasione storica” del Piano nazionale di ripresa e resilienza
che sul recupero dei ritardi del Sud investe il 40% delle risorse disponibili –
nel 2030 i residenti scenderanno sotto la soglia critica dei 20 milioni, con una
riduzione su base decennale di circa 4 volte rispetto al Centro-Nord (-5,7% e
1,5%). A impoverirsi sono soprattutto le fasce d’età più giovani, mentre aumenta
quella “anziana”: la popolazione fino ai 14 anni superava i 3,17 milioni nel
2011, è scesa a 2,64 milioni nel 2020, ed vista in calo a 1,86 milioni nel 2050.
Le ricadute economiche sono
significative per il territorio – in termini, ad esempio, della capacità di
creare reddito (data la contrazione della forza lavoro), di disponibilità di
capitale umano, suo principale patrimonio – ma anche per il Paese perché
verrebbe meno il serbatoio di popolazione attiva storicamente a servizio delle
aree più sviluppate.
E’ uno scenario allarmante
quello disegnato dall’Istat nel report “I divari territoriali nel Pnrr: dieci
obiettivi per il Mezzogiorno” che mette a fuoco i numeri della “questione
meridionale”, che misurano “divari strutturali di vario genere e livello, anche
molto ampi”, divari che si ritiene non siano più sostenibili “per l’impatto
inedito sulla struttura demografica”, avviata verso “un eccessivo e non
reversibile impoverimento”. Il processo di convergenza tra le due Italie – che
ha avuto fasi alterne, con una breve parentesi “felice” a cavallo del “miracolo
economico” – si è arrestato ormai agli inizi degli anni Settanta. La lunga crisi
del 2008 ha colpito soprattutto la già debole capacità produttiva del
Mezzogiorno. Lo shock pandemico, pur facendo più danni sul sistema produttivo
del Centro-Nord, ha infierito su un’economia con problemi di stagnazione più
accentuati rispetto al resto del Paese. Il Mezzogiorno ha tuttavia partecipato
alla ripresa, che è stata però più rapida e intensa nell’area settentrionale. E
ora l’Istat profila un ampliamento della forbice anche per gli effetti
“fortemente asimmetrici” dell’incremento dei beni energetici legato al conflitto
in Ucraina.
Il confronto tra le due Italie
in termini di Pil pro-capite dà conto della divergenza esistente: nel
Mezzogiorno si aggira intorno al 55-58% del Centro-Nord; nel 2021 il Pil reale è
di circa 18mila euro contro i 33mila del Centro Nord.
Tutto il Mezzogiorno si colloca
sotto la media nazionale, con la Calabria in coda alla classifica delle regioni
italiane con 16.168 euro, mentre in testa c’è il Trentino, con 40.904 euro. Il
differenziale tra Centro-Nord e Mezzogiorno è di circa 14mila euro, un valore
poco distante da quello rilevato nel 2000.
Anche il livello di istruzione
“conferma una grave arretratezza”, anche se “migliora nelle giovani
generazioni”. Nel 2020, evidenzia l’Istituto, un terzo (32,8%) dei meridionali
in età 25-49 anni (24,5% nel Centro-Nord) ha concluso al più la terza media; il
22,6% (27,6% nell’Italia settentrionale) ha un titolo terziario. Ma non solo: i
risultati (gli outcome) dell’istruzione sono “notevolmente peggiori”: le
competenze degli studenti, si sottolinea nel rapporto, risultano più basse in
tutte le discipline e il gap aumenta nei diversi gradi d’istruzione. Differenze
che si riflettono anche nel mondo del lavoro che già vede i giovani meridionali
“fortemente penalizzati”: dal 2000 in poi si registrano circa 3 occupati ogni 10
in meno nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord. Tranne rare eccezioni – si
rileva – l’intero Mezzogiorno presenta tassi di occupazione giovanile molto
inferiori alla media. La carenza di lavoro spinge la “preoccupante” ripresa
dell’emigrazione di massa: il Sud e le Isole nel 2020 hanno perso ben 42 giovani
residenti (tra i 25 e i 34 anni) ogni 100 movimenti anagrafici, partiti verso
altre regioni italiane (+ 22 nel Centro Nord) e 56 su 100 diretti in altri Paesi
(49 nel Centro-Nord).
Grandi ritardi anche nei
servizi per l’infanzia, che oltre che per lo sviluppo del bambino, sono cruciali
anche per l’occupazione delle donne. L’Italia, pur avendo compiuto passi avanti
in entrambe le aree, resta lontana dall’obiettivo Ue del 33% e indietro rispetto
agli altri partner europei. E il gap tra Nord e Sud è profondo: due terzi dei
bambini tra 0 e 3 anni nel Mezzogiorno vive in contesti con livelli di offerta
inferiori agli standard nazionali e il 17,8% in zone con una dotazione molto
bassa o nulla (5,3% nel Centro-Nord). In particolare, Nord-est e Centro Italia
presentano una copertura sopra il target europeo (rispettivamente 34,5% e
35,3%), il Nord-ovest è prossimo all’obiettivo (31,4%) mentre Sud (14,5 %) e
Isole (15,7%). Da un estremo all’altro: se la Val D’Aosta è prima con 43,9 posti
disponibili ogni 100 bambini 0-2 anni, Calabria e Campania chiudono la
classifica con valori di poco superiori al 10%.
Differenze territoriali
rilevanti, poi, caratterizzano l’efficienza, l’appropriatezza e la qualità dei
servizi sanitari. Soprattutto in alcune regioni coinvolte dai Piani di Rientro
(6 su 7 nel Sud) la contrazione della spesa pubblica ha inciso negativamente sui
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), contribuendo ad alimentare il fenomeno
della “emigrazione sanitaria”: i ricoveri extra-regionali sono il 9,6% di quelli
interni, contro il 6,2% nel Centro-Nord). In oltre 1 provincia su 5 (21,1%; 7,2%
nel Centro-Nord) tale mobilità sanitaria è particolarmente intensa.
Sul fronte delle
infrastrutture, il Mezzogiorno ha una rete di trasporto visibilmente inferiore
alle altre ripartizioni. La densità della rete ferroviaria è nettamente più
bassa, soprattutto nell’alta velocità (0,15 Km ogni 100 Km di superficie; 0,8 al
Nord; 0,56 al Centro). E negli ultimi decenni l’ampliamento è stato molto
modesto (+0,3% contro +7,1% del Centro-Nord) mentre è aumentato il gap
qualitativo (58,2% di rete elettrificata; 79,3% del Centro-Nord). Resta ampio il
gap sulla digitalizzazione: il 60% circa dei residenti ha opportunità ridotte di
accesso alla Banda ultra-larga, e circa 1 su 5 (17,3%) vive in contesti molto
distanti da questo standard (4,2% nel Centro-Nord). Quanto alle reti idriche, se
l’obsolescenza è un fattore critico data la sempre più grave siccità che
interessa il Paese, per il meridionale lo è ancora di più: spesso si registrano
perdite per circa la metà dell’acqua per uso civile. Livelli di efficienza
superiori alla media caratterizzano tre quarti delle province del Mezzogiorno
(1/4 nel Centro-Nord).
La qualità dell'informazione è
un bene assoluto, che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del
Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con
il massimo di passione e di competenza possibili.
Abbiamo un bene prezioso che
difendiamo ogni giorno e che ogni giorno voi potete verificare. Questo bene
prezioso si chiama libertà. Abbiamo una bandiera che non intendiamo ammainare.
Questa bandiera è quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti
calpestati ma conosce e adempie ai suoi doveri.
Mantenuti.
2 milioni e 400mila immigrati producono il 9%
del PIL. I lavoratori immigrati producono 154,3 miliardi di Valore Aggiunto.
L’incidenza sul PIL aumenta sensibilmente in agricoltura ed edilizia. Continua
anche l’aumento degli imprenditori immigrati. Redazione su L'Unità il 20 Ottobre
2023
Additati come pericolosi invasori dalla propaganda
securitaria di certe forze politiche, gli immigrati si confermano invece una
formidabile risorsa per il nostro Paese. Lo dimostrano ancora una volta i dati
del rapporto annuale 2023 della Fondazione Leone Moressa sull’economia
dell’immigrazione, presentato ieri alla Camera dei deputati e al Viminale. La
popolazione straniera residente in Italia si conferma stabile a quota 5
milioni ad inizio 2023, pari all’8,6% del totale. L’età media degli stranieri
è 35,3 anni, contro i 46,9 degli italiani. Gli indicatori demografici spiegano
bene la diversa tendenza: tra gli stranieri vi sono 11,0 nati ogni mille
abitanti e 2,0 morti; tra gli italiani, 6,3 nati e 13,0 morti per mille
abitanti. Significativo anche il numero di stranieri “naturalizzati” italiani:
133 mila nel 2022, per un totale di 1,4 milioni negli ultimi 11 anni.
Nel 2022 sono stati 338 mila i Permessi di Soggiorno rilasciati dall’Italia,
picco massimo dell’ultimo decennio. In ripresa, soprattutto, gli ingressi per
lavoro, che rappresentano quasi un quinto del totale. I 67 mila ingressi per
lavoro del 2022 sono frutto del Decreto Flussi 2021 (Governo Draghi) e sono
dunque destinati ad aumentare nei prossimi anni a seguito dei Decreti del
Governo Meloni, che ha previsto 122 mila ingressi per lavoro nel 2023 e 452 mila
nel periodo 2024-2026. Dopo la flessione dovuta alla pandemia, il tasso di
occupazione degli stranieri (60,6%) torna a superare quello degli italiani
(60,1%), pur rimanendo al di sotto dei livelli pre-Covid. Gli occupati stranieri
sono 2,4 milioni e si concentrano nei lavori manuali: l’incidenza degli
stranieri, infatti, è mediamente del 10,3% sui lavoratori totali, ma raggiunge
il 28,9% tra il personale non qualificato. I lavoratori immigrati producono
154,3 miliardi di Valore Aggiunto, dando un contributo al PIL pari al
9%. L’incidenza sul PIL aumenta sensibilmente in agricoltura (15,7%),
ed edilizia (14,5%). Continua l’aumento degli imprenditori immigrati, che
nel 2022 sono 761 mila (10,1% del totale). Incidenza più alta al Centro-Nord e
nei settori di Costruzioni, Commercio e Ristorazione. Dopo la pandemia, torna a
crescere il numero di contribuenti immigrati: si tratta di 4,3 milioni di
contribuenti (10,4% del totale), che nel 2022 hanno dichiarato redditi per 64
miliardi di euro e versato 9,6 miliardi di Irpef. Rimane alto il differenziale
di reddito pro-capite tra italiani e immigrati (circa 8 mila euro annui di
differenza), conseguenza diretta della concentrazione occupazionale. Rimane
positivo il saldo tra il gettito fiscale e contributivo (entrate, 29,2 miliardi)
e la spesa pubblica per i servizi di welfare (uscite, 27,4 miliardi), con +1,8
miliardi di euro in attivo. Quella che emerge dal rapporto della Fondazione
Moressa è “la fotografia della società italiana, nel quale è un dato oggettivo
che il contributo dei lavoratori stranieri sia indispensabile”, osserva il
segretario e deputato di +Europa Riccardo Magi che ha ospitato la presentazione
dello studio alla Camera . “I nostri governi, avrebbero tutto l’interesse di
investire in accoglienza, in integrazione, in formazione e in inclusione dei
lavoratori stranieri legali”. Come? “Intanto modificando la normativa italiana
sugli ingressi regolari per motivi di lavoro”, spiega Magi, “e poi anche
modificando la legge Bossi-Fini e consentendo la regolarizzazione in modo
stabile a chi è già nel nostro Paese”. Redazione - 20 Ottobre 2023
Milano in debito col Sud: 11,5 miliardi tolti
al resto d’Italia. Camilla Carè il 14 Novembre 2019 su Money.it
Milano è sede preferita di migrazione per giovani
cervelli e grandi aziende, che dal Centro e dal Sud si spostano in Lombardia.
Ecco quanto deve al resto d’Italia.
Milano ha un debito di oltre 11 miliardi di euro
con il Centro e il Sud Italia? Un inaspettato bilancio, che capovolge le
dinamiche nord-sud a cui gli stereotipi e la comunicazione di alcuni politici ci
avevano abituati.
Nel mirino la migrazione dei giovani cervelli in
fuga, che si spostano dal sud e dalle isole per cercare lavoro in Lombardia e in
particolar modo all’ombra della Madonnina.
Secondo questa analisi, l’investimento economico
che le regioni abbandonate avrebbero fatto per educare e crescere i giovani,
andrebbe poi tutto nelle mani di Milano che beneficerebbe così di creatività e
innovazione coltivata da altri.
Un nuovo tassello per la riflessione sui modelli
federalisti e di autonomia differenziata. Vediamo a quanto ammonterebbe il
debito di Milano, e il bilancio negativo delle altre regioni d’Italia.
Milano in debito col Sud: quanto costa la fuga dei
cervelli
L’analisi del debito della Lombardia è stata
condotta da SVIMEZ - Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno,
basandosi sul bilancio della spesa pubblica destinata all’istruzione. L’agenzia
ha calcolato che Milano e le province limitrofe incassano, a discapito delle
altre regioni d’Italia, un guadagno netto di circa 11,5 miliardi di euro,
derivanti dai cervelli in fuga dal Mezzogiorno.
Il calcolo si basa sulle somme investite dalle
Regioni per i giovani dalla nascita fino al compimento del 25 anno di età,
rapportate al saldo migratorio dei laureati. La risultante sono 210 mila
laureati in fuga dal sud negli ultimi 15 anni, di cui ⅓ trasferitisi in
Lombardia.
Un sistema su cui si basa la naturale vittoria di
Milano, e un terribile spopolamento delle regioni del Centro-Sud.
Milano in debito: il Mezzogiorno si sta
spopolando?
La fuga dei cervelli dal Mezzogiorno alla
Lombardia è stata studiata anche dall’Istat, che ha registrato un netto
vantaggio della regione del Nord a scapito di quelle del Centro-Sud, che
rischiano un vero e proprio spopolamento. Nei quindici anni tra il 2002 e il
2017 il bilancio è infatti stato tremendo, e lancia diversi campanelli di
allarme:
421 mila residenti delle Regioni meridionali
trasferiti in Lombardia;
100 mila laureati residenti delle Regioni
meridionali trasferiti in Lombardia;
236 mila giovani tra i 15 e i 34 anni residenti
delle Regioni meridionali trasferiti in Lombardia.
L’Istat ci dice che oggi il 34% della
popolazione in Italia vive al sud e nelle isole, e che secondo le previsioni
demografiche la percentuale andrà peggiorando nei prossimi anni, fino a
raggiungere nel 2065 il 29%.
La fuga delle aziende dal Sud Italia
La fuga del capitale umano dal Centro-Sud non
riguarda, purtroppo, soltanto i giovani, ma anche la storia di molte aziende,
che stanno spostando personale e ricavi verso le aree settentrionali e
soprattutto verso la Lombardia (non a caso Milano è la prima città europea per
investimenti).
Preoccupa il fatto che più della metà
delle multinazionali nel Paese oggi ha sede nel capoluogo e dintorni, nonché il
lungo bollettino delle aziende che hanno deciso di dire addio a Roma per
spostarsi a Milano, tra cui:
Sky
Mediaset
Esso (Exxon Mobile)
Opel
Baxalta
Italchimici
Consodata (ex Pagine Gialle)
Mylan
Si teme oggi anche per l’ex Sigma tau e per Wind
Tre di Parco de’ Medici, che sarebbe pronta a trasferire in Lombardia un
centinaio di persone.
L’Espresso: così il SUD fa RICCO il NORD.
"Oltre 5 miliardi ogni anno: è il trasferimento di ricchezza verso il
Settentrione". Che "spacca il Paese ancora di più". By milanocittastato il 20
Ottobre 2023
Il Sud arricchisce il Nord. In particolare Milano.
Questi i risultati di un reportage inchiesta de L’Espresso dal titolo “Il
Capitale Terrone”. Anche se la tesi ci pare bizzarra, ve la proponiamo
attraverso un estratto.
L’Espresso: così il SUD fa RICCO il NORD
Estratti da L’Espresso: il Capitale Terrone, così
il Sud arricchisce il Nord
Sui tram di Milano risuona l’accento
meridionale
“Nel fine settimana, dalla sera, il 9 diventa il
mezzo di trasporto ufficiale dei giovani in transito verso i quartieri di movida
attraversati dai binari: Porta Venezia, i Navigli, via Savona. Sono tirati a
lucido, parlano di esami e di tesi magistrali. Non temono di affrontare i conti
di bar e ristoranti dove l’autista Atm, con il suo stipendio di 1.500 euro,
avrebbe paura a entrare. Come il tranviere arrivato a Milano in cerca di lavoro,
i passeggeri del 9 hanno in larga maggioranza accenti del Sud appena
addomesticati da quel flair meneghino che oggi significa, per dirla con il Dogui
dei film dei Vanzina, «stare in pole position».
Anche quest’anno la meglio gioventù della
borghesia meridionale si è spostata in massa verso gli atenei del Centronord,
quelli che promettono lavoro sicuro e persino qualificato.” (…)
I genitori del Sud possono spendere oltre 30
mila euro all’anno solo per la combinazione università-affitto
“Ma i figli sono pezzi di cuore. Nessuno lo sa
meglio di una madre o di un padre che vivono in un Mezzogiorno travolto dalla
crisi economica, demografica, dove persino le mafie ormai recalcitrano a
investire. I bravi genitori che hanno accettato una decadenza senza fine, in
peggioramento con l’imminente arrivo dell’autonomia regionale differenziata,
gettano il cuore oltre l’ostacolo ogni mese fra tasse di iscrizione e rate di
frequenza che possono arrivare a 20.140 euro l’anno, come nel caso
dell’International Md program del San Raffaele, contro un’immatricolazione per
la magistrale in Bocconi a quota 16.103 euro.
L’università può non essere la spesa maggiore. A
Milano, soprattutto, ma anche a Torino, Bologna, Firenze, Padova, una stanza in
condivisione a 900 euro entro i confini municipali è un costo ancora economico.
Nello studentato milanese Hines in zona Bocconi (Aparto Giovenale) un vasto
monolocale di 27 metri quadrati va a 1.300 mensili. Però c’è lo studio yoga, il
cinema e la palestra, anzi, il gym dove si può fare workout nel Milan lifestyle.
Per il Campus X Bicocca si può arrivare a 1.700
euro, oltre ventimila l’anno. Molti di questi interventi immobiliari privati che
aspirano a togliere i giovani contestatori dalle tende davanti alle facoltà sono
cofinanziati dal Miur in base alla legge 338 del 2000. I genitori, invece, si
finanziano da sé. La combinazione università più affitto può arrivare facilmente
oltre i 30 mila euro l’anno, senza calcolare vitto, abbigliamento, libri e altri
costi più o meno voluttuari.”
«È la nuova questione meridionale»: oltre 5
miliardi di euro di trasferimento implicito dal Sud al Nord ogni anno
“«È la nuova questione meridionale», dice Luca
Bianchi, direttore generale del centro studi Svimez nato nel dicembre 1946, sei
mesi dopo il referendum monarchia-repubblica stravinto dai Savoia al Sud. «La
migrazione dei talenti e delle competenze negli ultimi vent’anni ha portato a
una perdita di 300 mila laureati al Sud e il saldo dell’ultimo anno disponibile,
il 2021, è di -21 mila, con una quota in crescita». (…)
“Dal rapporto annuale che Svimez presenterà a fine
novembre, L’Espresso può anticipare che ogni laureato vale 150 mila euro di
spesa pubblica. «Questa cifra proiettata sui ventimila che vanno via ogni anno»,
aggiunge Bianchi, «dà 3 miliardi di euro di trasferimento implicito verso Nord.
La contabilità territoriale chiesta dall’autonomia differenziata non ha senso in
un Paese integrato come l’Italia e lo svantaggio distributivo patito dal Nord è
un mito».
I costi di investimento pubblico, ovviamente, non
includono la spesa diretta delle famiglie sul mantenimento e, per così dire, la
manifattura del futuro laureato. A volersi divertire con le cifre, il Miur ha
annunciato che nell’anno accademico 2022-23 ci sono state 331 mila
immatricolazioni (147 mila maschi, 184 mila femmine). È una cifra costante negli
ultimi anni. Il 25 per cento di studenti meridionali fuori sede elaborato da
Svimez si traduce in oltre 82 mila partenze. Applicando il criterio di spesa
prudenziale dei 30 mila euro l’anno per ogni studente, il prodotto della
moltiplicazione è di 2,47 miliardi di euro in fondi privati trasferiti dal Sud
al Centronord, da aggiungere ai 3 miliardi di spesa pubblica dei laureati.”
Le rimesse al contrario: dalle famiglie
borghesi del Sud all’economia del Nord
“La macchina che ha tenuto in piedi il boom
economico del secolo scorso era fatta di contadini o sottoproletari emigrati
verso le industrie del Settentrione con le loro rimesse ad alimentare il
Mezzogiorno. Oggi quel sistema è completamente saltato e nemmeno un insegnante
può permettersi la vita da fuori sede al Centronord. In un certo senso, vige la
teoria economica del trickle-down alla rovescia. Al posto dei ricchi che
guadagnano sempre di più e che fanno “gocciolare” parte della ricchezza verso
gli strati inferiori della scala sociale, ci sono le famiglie borghesi del Sud
che aumentano il benessere già consistente di chi ha una rendita di posizione
nei centri urbani del Nord. E il fenomeno si allarga dai giovani ai genitori
stessi che, alla lieta novella dell’impiego dei pargoli, ergo della possibile
nuova famiglia, progettano di trasferirsi a fare i nonni con il vantaggio di un
sistema sanitario migliore.
Proiettato in un futuro più vicino, lo scenario
della nuova migrazione diventa catastrofico se l’aspetto di depauperamento
patrimoniale si combina con il cosiddetto inverno demografico. (…) Nel periodo
2002-2022 i cittadini fra 18 e 34 anni sono scesi di 3 milioni dai 10,2 milioni
di vent’anni fa. Ma in percentuale il Sud ha perso quasi l’8 per cento in più
del Centronord e questo dato è ancora ottimistico perché gran parte degli
studenti meridionali fuori sede aspetta di avere trovato un lavoro post laurea
prima di cambiare residenza.”
Così il Sud arricchisce il Nord. Oltre 5
miliardi ogni anno. Tra spesa delle famiglie e finanziamenti statali è il
trasferimento di ricchezza verso il Settentrione dovuto all'esodo dei giovani.
Che spacca il Paese ancora di più. GIANFRANCESCO TURANO su L'Espresso 20 ottobre
2023
PRIMA PAGINA IL CAPITALE TERRONE
Il
tram numero 9 dell'Atm di Milano racconta storie diverse secondo l'ora e il
giorno. Intorno al pranzo ci sono i senza fissa dimora che vanno a mettersi in
fila all'Opera San Francesco di piazza Tricolore, accanto all'hotel di lusso
Chàteau Monfort. Nel fine settimana, dalla sera, il 9 diventa il mezzo di
trasporto ufficiale dei giovani in transito verso i quartieri di movida
attraversati dai binari: Porta Venezia, i Navigli, via Savona. Sono tirati a
lucido, parlano di esami e di tesi magistrali. Non temono di affrontare i conti
di bar e ristoranti dove l'autista Atm, con il suo stipendio di 1.500 euro,
avrebbe paura a entrare. Come il tranviere arrivato a Milano in cerca di lavoro,
i passeggeri del 9 hanno in larga maggioranza accenti del Sud appena
addomesticati da quel flair meneghino che oggi significa, per dirla con il Dogui
dei film dei Vanzina, «stare in pole position». Anche quest'anno la meglio
gioventù della borghesia meridionale si è spostata in massa verso gli atenei del
Centronord, quelli che promettono lavoro sicuro e persino qualificato. I
politecnici di Torino e Milano, la Bocconi, la Cattolica, il San Raffaele Vita e
salute, la Sapienza di Roma, Iulm, led, Lumsa. Privato è meglio. Si entra più
facilmente anche se si paga di più. Ma i figli sono pezzi di cuore. Nessuno lo
sa meglio di una madre o di un padre che vivono in un Mezzogiorno travolto dalla
crisi economica, demografica, dove persino le mafie ormai recalcitrano a
investire. I bravi genitori che hanno accettato una decadenza senza fine, in
peggioramento con l'imminente arrivo dell'autonomia regionale differenziata,
gettano il cuore oltre l'ostacolo ogni mese fra tasse di iscrizione e rate di
frequenza che possono arrivare a 20.140 euro l'anno, come nel caso
dell'International Md program del San Raffaele, contro un'immatricolazione per
la magistrale in Bocconi a quota 16.103 euro. L'università può non essere la
spesa maggiore. A Milano, soprattutto, ma anche a Torino, Bologna, Firenze,
Padova, una stanza in condivisione a 900 euro entro i confini municipali è un
costo ancora economico. Nello studentato milanese Hines in zona Bocconi (Aparto
Giovenale) un vasto monolocale di 27 metri quadrati va a 1.300 mensili. Però c'è
lo studio yoga, il cinema e la palestra, anzi, il gym dove si può fare workout
nel Milan lifestyle. Per il Campus X Bicocca si può arrivare a 1.700 euro, oltre
ventimila l'anno. Molti di questi interventi immobiliari privati che aspirano a
togliere i giovani contestatori dalle tende davanti alle facoltà sono
cofinanziati dal Miur in base alla legge 338 del 2000. I genitori, invece, si
finanziano da sé. La combinazione università più affitto può arrivare facilmente
oltre i 30 mila euro l'anno, senza calcolare vitto, abbigliamento, libri e altri
costi più o meno voluttuari. «È la nuova questione meridionale», dice Luca
Bianchi, direttore generale del centro studi Svimez nato nel dicembre 1946, sei
mesi dopo il referendum monarchia-repubblica stravinto dai Savoia al Sud. «La
migrazione dei talenti e delle competenze negli ultimi vent'anni ha portato a
una perdita di 300 mila laureati al Sud e il saldo dell'ultimo anno disponibile,
il 2021, è di -21 mila, con una quota in crescita. Gli emigrati laureati
aumentano anche quando aumenta l'occupazione perché sono posti a basso valore
aggiunto, nel turismo, nel commercio. Per le immatricolazioni agli atenei del
Centronord, invece, si parla di un quarto di iscritti che vengono dal Sud». Dal
rapporto annuale che Svimez presenterà a fine novembre, L'Espresso può
anticipare che ogni laureato vale 150 mila euro di spesa pubblica. «Questa cifra
proiettata sui ventimila che vanno via ogni anno», aggiunge Bianchi, «dà 3
miliardi di euro di trasferimento implicito verso Nord. La contabilità
territoriale chiesta dall'autonomia differenziata non ha senso in un Paese
integrato come l'Italia e lo svantaggio distributivo patito dal Nord è un mito».
I costi di investimento pubblico, ovviamente, non includono la spesa diretta
delle famiglie sul mantenimento e, per così dire, la manifattura del futuro
laureato. A volersi divertire con le cifre, il Miur ha annunciato che nell'anno
accademico 2022-23 ci sono state 331 mila immatricolazioni (147 mila maschi, 184
mila femmine). È una cifra costante negli ultimi anni. Il 25 per cento di
studenti meridionali fuori sede elaborato da Svimez si traduce in oltre 82 mila
partenze. Applicando il criterio di spesa prudenziale dei 30 mila euro l'anno
per ogni studente, il prodotto della moltiplicazione è di 2,47 miliardi di euro
in fondi privati trasferiti dal Sud al Centronord, da aggiungere ai 3 miliardi
di spesa pubblica dei laureati. Comprare casa al rampollo, con la bolla
immobiliare e i mutui alle stelle, significa sborsare non meno di un quarto di
milione, se ci si accontenta di un tugurio. Oltre a questi aspetti più
immediati, il travaso di risorse dal Sud verso il Nord pone questioni a
medio-lungo termine. Per esempio, la riqualificazione energetica diventa più
facile per un piccolo proprietario foraggiato dagli affitti e riguarda non solo
la cintura urbana dei poli di maggiore attrazione ma anche l'hinterland. È più
facile investire sul rinnovamento a Vimodrone, comune della periferia milanese
sulla metro verde che porta al San Raffaele o magari nelle campagne dalle parti
di Trigoria. Nota per accogliere il centro sportivo dell'As Roma e il Campus
Biomedico (da 13500 a 18 mila euro l'anno di iscrizione), Trigoria è a venti
chilometri dal centro della città, oltre il Gra. Eppure una stanza quota intorno
ai 500 euro al mese nonostante i posti della facoltà di medicina siano limitati
a 150. In prospettiva dell'invecchiamento dei genitori-finanziatori, nella
vicina Fonte Laurentina è pronto il co-housing per anziani dell'Over Senior
residence. Sempre oltre il raccordo anulare, sulla Tiburtina c'è l'Unicamillus,
parecchio oltre il capolinea della metro B di Rebibbia, che offre corsi di
medicina a 21 mila euro l'anno. Anche la Hunimed ha rette oltre i 20 mila euro
proporzionate alla sua fama di ateneo internazionale. L'università del gruppo
sanitario Humanitas di Rozzano si è insediata nel comune di Pieve Emanuele, che
negli anni Ottanta era un esempio urbanistico da manuale di ghetto per
meridionali con i palazzoni dell'Incis e il suo residence frequentato da
poliziotti e carabinieri dove il dialetto lombardo era raro come una sera senza
nebbia. Anche qui, il mercato immobiliare si è adeguato verso l'alto. Gli ultimi
dati disponibili sulle immatricolazioni fuori regione sono spettacolari.
Nell'anno 2019-2020 gli iscritti non residenti erano 64.165. La pandemia è
passata senza tracce perché nel 2021-2022 sono stati 72.994, quasi novemila in
più. Le per24 L'Espresso 20 ottobre 2023 centuali più alte di fuori regione,
manco a dirlo, sono in Bocconi (72,7 per cento), a Trento (66,5 per cento), al
San Raffaele di Milano (64,1 per cento). Sopra il 50 per cento ci sono le romane
Luiss, Biomedico e Link campus. Le rette universitarie superano i ventimila
euro. E per una stanza a Milano è "normale" spendere 900 euro al mese. Poi ci
sono vitto, abbigliamento, libri e gli altri costi più o meno voluttuari La
macchina che ha tenuto in piedi il boom economico del secolo scorso era fatta di
contadini o sottoproletari emigrati verso le industrie del Settentrione con le
loro rimesse ad alimentare il Mezzogiorno. Oggi quel sistema è completamente
saltato e nemmeno un insegnante può permettersi la vita da fuori sede al
Centronord. In un certo senso, vige la teoria economica del trickle-down alla
rovescia. Al posto dei ricchi che guadagnano sempre di più e che fanno
"gocciolare" parte della ricchezza verso gli strati inferiori della scala
sociale, ci sono le famiglie borghesi del Sud che aumentano il benessere già
consistente di chi ha una rendita di posizione nei centri urbani del Nord. E il
fenomeno si allarga dai giovani ai genitori stessi che, alla lieta novella
dell'impiego dei pargoli, ergo della possibile nuova famiglia, progettano di
trasferirsi a fare i nonni con il vantaggio di un sistema sanitario migliore.
Proiettato in un futuro più vicino, lo scenario della nuova migrazione diventa
catastrofico se l'aspetto di depauperamento patrimoniale si combina con il
cosiddetto inverno demografico. L'Istat ricorda che nell'anno di grazia 2061 al
Sud vivrà il 30,7 per cento degli ultrasettantenni e nel rapporto dello scorso
12 ottobre dedicato ai "Giovani del Mezzogiorno" segnala un crollo nel numero di
giovani in tutta Italia. Nel periodo 2002-2022 i cittadini fra 18 e 34 anni sono
scesi di 3 milioni dai 10,2 milioni di vent'anni fa. Ma in percentuale il Sud ha
perso quasi l'8 per cento in più del Centronord e questo dato è ancora
ottimistico perché gran parte degli studenti meridionali fuori sede aspetta di
avere trovato un lavoro post laurea prima di cambiare residenza. Altri decidono
di fare la triennale al Sud e prendere la magistrale al Centronord. Il totale è
che nelle città meridionali, durante la stagione accademica, è arduo vedere in
giro un ventenne. «Per i giovani del Mezzogiorno», afferma l'istituto nazionale
dì statistica, «la migrazione universitaria, che si attiva soprattutto verso gli
atenei settentrionali, assume proporzioni considerevoli: coinvolge oltre un caso
su quattro all'atto dell'iscrizione, e oltre un terzo al conseguimento della
laurea. Inoltre, il fenomeno della mobilità per studi universitari nel
Mezzogiorno riguarda in misura leggermente superiore gli uomini rispetto alle
donne». Per un minimo di verifica sociologica basta guardarsi attorno e
ascoltare i discorsi dell'estate, dominati dall'esodo verso Nord dei pargoli
appena diplomati. Prendiamo tre coppie. Una è medico più avvocato. La seconda è
bancario più avvocato. La terza è monoreddito con coniugi divorziati. Qui il
caso è aggravato dal fatto, in teoria positivo, che la diplomata è in classifica
sia in un'università privata sia in una pubblica. In attesa dei vari slittamenti
delle graduatorie secondo le scelte dei meglio piazzati, il padre ha dovuto
anticipare 14 mila euro all'Unicamillus che perderà se la figlia entrerà alla
Sapienza. I sei genitori di queste matricole hanno tutti studiato nell'ateneo di
prossimità. In questo caso, si tratta di Messina, che è stata a lungo il
riferimento universitario per parte della Sicilia orientale e della Calabria
meridionale. È probabile che anche le loro famiglie negli anni Ottanta del
secolo scorso avrebbero potuto sostenere il sacrificio economico di Il numero
degli studenti "fuori regione" continua a crescere. I record sono in Bocconi
(72,7 per cento), a Trento (66,5 per cento), al San Raffaele di Milano (64,1 per
cento) mantenere un figlio in un ateneo fuori sede. Ma per la generazione dei
boomers sembrava avere meno senso spostarsi verso Nord e l'iscrizione in
università era non solo un segno di distinzione sociale ma anche una probabilità
maggiore di trovare posto senza emigrare, grazie al "pezzo di carta" chiamato
laurea. Oggi basta guardare la classifica Censis delle università italiane
pubblicata nel luglio 2023 per capire dove conviene studiare. Nell'elenco dei
grandi atenei privati, con oltre 10 mila iscritti, è in testa la Bocconi con
90,4 punti seguita a distanza dall'altra milanese, la Cattolica. Nei medi atenei
privati da cinquemila a die cimila studenti il podio è: Luiss di Roma, Iulm di
Milano e Lumsa, che ha sede nella capitale con poli a Palermo e a Taranto. Nel
pubblico, c'è ancora meno partita. Fra i megatenei che contano oltre i
quarantamila iscritti, la prima è Bologna. Seguono Padova, la Sapienza di Roma,
Pisa e la Statale di Milano. Palermo è settima, Bari nona e la Federico II di
Napoli decima. Per trovare traccia di Sud nelle parti alte del ranking bisogna
andare sui grandi atenei, quelli che hanno fra ventimila e quarantamila
iscritti, con l'Unical di Cosenza al terzo posto. L'università calabrese rimane
uno dei rari poli di attrattiva accademica del Mezzogiorno, soprattutto nel
campo dell'intelligenza artificiale. Ha fatto scalpore il colpo di mercato del
rettore Nicola Leone che a settembre ha ingaggiato da Oxford un luminare dell'Ai
come Georg Gottlob. Quest'anno Cosenza-Arcavacata ha anche inaugurato il suo
corso di medicina in concorrenza con l'università della Magna Graecia di
Catanzaro-Germaneto. La sanità è di sicuro un'emergenza in tutto il Mezzogiorno.
Ma c'è da capire quali strutture troveranno i dottori in formazione che, come
dice la madre medico di una delle ragazze in partenza per Roma, «vogliono tutti
fare i dermatologi per entrare nel privato e guadagnare con l'estetica». È la
stessa logica dei bocconiani che, appena laureati, finiscono nei colossi della
consulenza come Kmpg, Deloittc, Pwc, Ernst Young, Boston o nella finanza a
lavorare quattordici ore al giorno in attesa di salire nella scala gerarchica e
retributiva. Magari qualcuno di loro deciderà di tornare al Sud, sull'onda di
crisi di rigetto individuali. Sono i casi che finiscono raccontati sui giornali
in modo consolatorio con titoli come: lavoravo a Goldman Sachs, oggi allevo
capre sui Nebrodi. Con tutto il rispetto per i neorurali, la macchina
dell'economia nazionale non vive di formaggi erborinati ma di fatturati e asset.
Su questo fronte, la spaccatura sotto Roma si fa sempre più profonda.
Cervelli in fuga.
Trolley e boccacci ciao
ciao, casa mia. I fuorisede e gli expat ripartono con il loro bagaglio
emotivo verso i loro domicili temporanei, abitando case e appartamenti sparsi
nelle città del vecchio stivale e dell’antica Europa, o varcando anche oceani e
continenti. Mariateresa Cascino su La Gazzetta del Mezzogiorno l’8 Gennaio 2023.
Treni, aerei, autobus e
valigie, è tempo di partenze per gli studenti fuorisede e per gli expat che
lasciano la Città dei Sassi per salpare verso nuovi lidi. L’epifania tutte le
feste natalizie ha portato via e tra saluti, aperitivi e momenti intimi per
ritrovarsi con vivacità e spensieratezza, l’atmosfera si è riempita di sogni,
speranze e desideri. Vedendoli girovagare in città durante il periodo natalizio,
negozi, bar, locali cittadini, cinema e strade sono apparsi più variopinti e
allegri, animati da un’energia positiva che ha trasmesso buon umore e fatto
coltivare nuove attese, anche a beneficio di chi resta.
I fuorisede e gli expat
ripartono con il loro bagaglio emotivo verso i loro domicili temporanei,
abitando case e appartamenti sparsi nelle città del vecchio stivale e
dell’antica Europa, o varcando anche oceani e continenti.
Sono lì con il loro trolley a
rotelle e il pacco terrone preparato da mammà, con conserve e confetture
genuine, salse fatte in casa, salsiccia, caciocavallo e soppressata.
«Il pacco da giù» arriverà nei
loro appartamenti metropolitani nelle città di adozione e, al momento
dell’apertura, sprigionerà tutte le emozioni e i ricordi di casa, quasi a
prolungare la dolce esperienza della vacanza appena trascorsa tra le calde e
confortevoli mura domestiche. Ma la valigia dei nuovi emigranti non è solo
carica dei sapori di casa, contiene pure chili di nostalgia, condita però con la
freschezza della voglia di nuove e ricche scoperte e avventure. Così partono
consapevoli che la vita del fuorisede sarà bellissima anche in altri luoghi,
perché piena di opportunità di studio, conoscenze, relazioni, lavoro e
adattamento a nuovi modelli e valori culturali che aprono la mente. Sarà dura
scegliere cosa fare dopo, specialmente al termine degli studi, o trovandosi al
bivio tra più opportunità professionali, e soprattutto se tornare a casa. Tra
bagagli pesanti e vagoni pieni di speranza, viene da pensare che, oltre alle
partenze, bisognerebbe favorire sempre più gli arrivi attraendo qui studenti e
professionisti provenienti da altri luoghi remoti del pianeta. Tra treni persi e
binari morti, sarebbe anche utile e bello favorire il ritorno di chi parte e
continua a farlo, dandogli però occasione e coraggio di restare, perché il
bagaglio di chi va e torna è sempre più pieno del bagaglio di chi non è mai
partito e in più arricchisce la permanenza di tutti, pure di quelli che fermi lo
sono sempre stati.
Da blitzquotidiano.it il 12
gennaio 2023.
Quanti anni di stipendio ci
vogliono per comprare una casa? Nelle grandi città in media, servono più o meno
7 anni. 6,9 per la precisione. A rivelarlo è una relazione dell’Ufficio studi
del gruppo Tecnocasa.
Milano è la città più cara:
nel capoluogo lombardo per comprare casa servono, in media, 13,2 anni di
stipendi. Milano con un prezzo medio di 4.138 euro al metro quadro è infatti la
città più costosa d’Italia. Seguono Roma con 9,2 e Firenze con 9,1 annualità.
Le città dove ne servono meno sono Palermo e Genova (rispettivamente con 3,6 e
3,3).
Cosa è cambiato negli anni
Andando indietro nel tempo, gli
anni in cui occorrevano più annualità per acquistare casa furono il 2006 e il
2007, quando i tassi di crescita dei prezzi toccarono l’apice. All’epoca la
città più costosa dove occorrevano più anni di lavoro per pagare la casa era
Roma con 14,8 annualità, seguita da Milano con 14 e da Firenze con 12,5.
Dal 2008 in poi, in
concomitanza con la crisi del mercato immobiliare, le annualità per acquistare
casa diminuiscono nel tempo fino al 2017 quando, in seguito alla ripresa dei
valori immobiliari, iniziano a essere di nuovo necessari più anni di stipendio.
Nel 2019 Milano balza in vetta alla classifica diventando la città più costosa
dove occorre destinare all’acquisto della casa ben 11 anni di stipendio; ad oggi
il trend si conferma.
Balza all’occhio Genova che
nel 2020 tocca il minimo delle annualità per acquistare casa (3,3) a causa della
forte perdita di valore andata avanti nel tempo. Nel 2007 a Genova occorrevano
7,7 annualità.
Estratto dell'articolo di
Violetta Fortunati per ilgiorno.it il 18 gennaio 2023.
Non contano levatacce, ore
trascorse in treno, cene consumate tra i vagoni: per porre un freno al carovita
c’è chi è disposto a tutto, compreso pensare fuori dagli schemi e, soprattutto,
rimboccarsi le maniche e applicare alla lettera il più italico degli
insegnamenti: arrangiarsi.
Lo sa bene Giuseppina
Giuliano, 29 anni, pendolare per scelta tutti i giorni da Napoli, la città in
cui vive, a Milano, dove lavora come operatrice scolastica nel liceo artistico
Boccioni di piazzale Arduino. E quando finisce il turno tra aule e corridoi,
lavagne e scale, semplicemente rientra a casa, a 800 chilometri di distanza.
[…] "Lo so che la mia sembra una follia, però facendo i conti ho valutato che
economicamente mi conviene. Certo, mi costa tanto sacrificio, considerato che
tutte le mattine, sabato compreso, prendo il treno per Milano alle cinque. Però
ormai mi sono abituata e per il momento va bene così» racconta.
"A settembre sono diventata di
ruolo come operatrice scolastica in un liceo milanese e ho provato a cercare una
casa che non costasse troppo, considerando che il mio stipendio mensile è di
1.165 euro". "Mi sono resa conto che ormai a Milano è più facile trovare un ago
in un pagliaio – prosegue – anche in periferia i prezzi degli affitti non
scherzano affatto, per non parlare della vita che al Nord ha un costo
decisamente molto più elevato che al Sud.
Insomma, tutti questi fattori
mi hanno portato alla scelta di fare la pendolare". Anche se questo significa
passare nove ore al giorno, a stare scarsi e al netto di ritardi, seduta su di
un treno: "A conti fatti ho realizzato che, tra affitto, bollette e spesa, avrei
consumato tutto il mio stipendio se mi fossi trasferita a vivere al Nord e molto
probabilmente avrei anche dovuto chiedere alla mia famiglia di aiutarmi
economicamente. […]
"Per rientrare prendo il treno
da Milano alle 18.20 e arrivo a Napoli alle 22.53, sempre che non ci siano
ritardi. Quindi, se tutto va bene, per le 23.30 sono a casa. La mattina invece
mi alzo alle 4, perché ci metto una mezz’oretta per raggiungere la stazione dove
prendo il Frecciarossa che parte da Napoli Centrale alle 5.09 e arrivo a Milano
alle 9.24. Poi salgo sui mezzi pubblici e raggiungo la scuola dove lavoro dalle
10.30 alle 17 […] il treno mi costa poco, circa 400 euro, mensilmente molto meno
di una stanza in condivisione a Milano". […]
Come è cara la Milano di
Sala: per comprare casa servono 50 anni di stipendio. Giorgia Pacione Di
Bello su Panorama il 19 Aprile 2023
Il capoluogo lombardo si
posiziona ai vertici nella classifica per le città italiane più costose. Il
costo delle abitazioni è cresciuto di oltre il 18% a partire dal 2019
Riuscire a comprare casa a
Milano è un miraggio e quando si riesce ci si deve indebitare per una vita
intera. Secondo una ricerca fatta da Ener2 Crowd.com, piattaforma italiana di
lending crowdfunding, ci vogliono circa 50,3 anni per estinguere il mutuo di una
casa comprata a Milano. Il capoluogo lombardo si posiziona ai vertici nella
classifica per le città italiane più care in Italia. Fino agli anni Settanta del
secolo scorso anche un operaio, con il suo stipendio medio di 50 mila lire al
mese, poteva permettersi in circa 20 anni di acquistare un appartamento in una
zona centrale. Oggi invece non ci riuscirebbe neanche in 40 anni. Per non
parlare di chi è costretto al precariato o, suo malgrado, al lavoro nero.
Guardando i numeri si capisce infatti come il voler comprare casa stia
diventando sempre più un lusso per pochi. Secondo la ricerca un giovane milanese
guadagna in media 1.750 euro, riesce a risparmiare 7.000 euro l’anno e il prezzo
medio al metro quadro si aggira sui 5.186 euro (ultimi dati Immobiliare.it). I
prezzi della città guidata da Giuseppe Sala hanno visto un apprezzamento di
oltre il 18% a partire dal 2019 e nel solo primo trimestre del 2022 il valore
delle case ha subito un aumento del 5,7%. Certo, nelle aree periferiche (ma non
è sempre detto) i prezzi risultano essere inferiori rispetto al centro. Parliamo
di zone come, per esempio, Niguarda, Bovisa o Forlanini dove il costo per metro
quadro, secondo Immobiliare.it, oscilla tra i 3.100 e i 3.600 euro, ma che
devono scontare la poca ramificazione dei mezzi pubblici, tipicamente di
superficie. Questo è uno dei motivi principali che spinge i giovani, che
tendenzialmente lavorano in zone centrali della città (e non dimentichiamoci che
non tutte le aziende hanno abbracciato con gioia la logica dello smart-working),
a comprare o pagare l’affitto di un appartamento in centro. Ovviamente la
situazione degli affitti non si discosta molto da quella dell’acquisto con
prezzi notevolmente alti. Negli ultimi anni le richieste sono costantemente
lievitate. Nel solo mese di marzo, per gli immobili residenziali in affitto sono
stati richiesti in media 21,63 euro al mese per metro quadro, con un aumento del
11,27% rispetto a marzo 2022 (19,44 euro mensili al mq). Negli ultimi due anni,
il prezzo medio all'interno del comune di Milano ha raggiunto il suo massimo a
marzo, con un valore di 21,63 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato
richiesto il prezzo più basso è stato invece agosto 2021 con una media di 18
euro al mese per metro quadro. La situazione immobiliare milanese si spiega con
le semplici regole dell’economia: c’è una domanda maggiore rispetto all’offerta,
e questo porta a far aumentare il prezzo degli affitti o delle vendite delle
case. La situazione richiederebbe dunque una maggiore competizione tra gli
immobili, che si traduce in più offerta sul mercato. Come tradurlo nella
pratica? Ci possono essere diverse soluzioni, al momento non intraprese. La più
banale è aumentare l’offerta costruendo di più (ma in maniera più intelligente).
Palazzi come il bosco verticale sono sicuramente bellissimi, ma non si rivolgono
alla classe media. Oltre a questo c’è poi anche la questione dei mezzi di
trasporto. Ampliare la rete delle infrastrutture, anche alle zone periferiche di
Milano, dove i prezzi, come abbiamo detto, sono più abbordabili (e anche le
metrature), aiuterebbe la competitività nel mercato immobiliare. Basti pensare
che non in tutte le zone dell’area B del comune arriva una metropolitana. Molto
spesso l’unico mezzo per arrivare al centro è costituito da una sola linea di
tram che se non passa per guasti, scioperi o altro si è letteralmente tagliati
fuori. Aree in cui adesso si sta anche costruendo molto, visto la saturazione
del centro, ma che se non vedranno un potenziamento in termini di mezzi di
trasporto e non solo, non saranno valutate da potenziali compratori. Situazione
che non è cambiata negli ultimi anni e che ha finito per amplificare, nel corso
del tempo, una compressione di domande immobiliare nelle aree centrali della
città arrivando alla situazione estrema di oggi. La realtà milanese con i suoi
50 anni per estinguere un mutuo, rappresenta una peculiarità (negativa) nel
panorama lombardo. A livello di medie regionali, la Lombardia scende al 6° posto
con 33,6 anni di stipendio per comprare casa. Prima di lei il Trentino-Alto
Adige con 50 anni, la Valle d’Aosta (43,7 anni), la Toscana (40,7 anni), la
Liguria (40,4 anni) il Lazio (39,7 anni) e la Sardegna (39,4 anni). Ma non solo,
Milano a livello europeo si posiziona al terzo posto fra le città più care per
un bilocale (si desidera un trilocale ma poi si acquistano sempre più i
bilocali). Davanti a lei, solo Amsterdam e Lisbona. Di certo un primato di cui
non andare fieri e che in questi ultimi anni non si è fatto niente per cercare
di risolvere.
"Ora che sono diventata di
ruolo, non posso assolutamente perdere l’opportunità di questo lavoro".
“Prendo tutti i giorni il treno, costa meno dell’affitto”: la storia di
Giuseppina, pendolare da Napoli a Milano. Elena Del Mastro su Il Riformista il
18 Gennaio 2023
Non c’è forse popolo che abbia
fatto maggiormente virtù dell’arte di arrangiarsi dei napoletani. E così
anche Giuseppina Giuliano, 29 anni, napoletana, ne ha fatto tesoro: ogni mattina
si sveglia all’alba e prende un treno per Milano alle 5, lavora in una scuola
come operatrice scolastica e poi alle 18.20 riprende il treno e torna a casa, a
Napoli. E così da lunedì a sabato. “Ora che sono diventata di ruolo, non posso
assolutamente perdere l’opportunità di questo lavoro. Quindi, fino a quando non
troverò qualcosa adatto alle mie possibilità, andrò avanti così”, dice
Giuseppina al Giorno, costi quel che costi.
Giuseppina è disposta a tutto
pur di non perdere il suo lavoro. E tuttavia la scelta di fare da pendolare è
stata ponderata. Ogni mattina parte da Napoli e arriva a Milano dove lavora come
operatrice scolastica nel liceo artistico Boccioni di piazzale Arduino. Una
sfacchinata di 800 chilometri ad andare e 800 a tornare. Ma che non le fa
perdere il sorriso e la voglia di lavorare. “Lo so che la mia sembra una follia,
però facendo i conti ho valutato che economicamente mi conviene. Certo, mi costa
tanto sacrificio, considerato che tutte le mattine, sabato compreso, prendo il
treno per Milano alle cinque. Però ormai mi sono abituata e per il momento va
bene così”, racconta.
L’operatrice scolastica
racconta che a settembre ha avuto il posto di ruolo nel liceo milanese. “Ho
provato a cercare una casa che non costasse troppo, considerando che il mio
stipendio mensile è di 1.165 euro“. “Mi sono resa conto che ormai a Milano è più
facile trovare un ago in un pagliaio – prosegue – anche in periferia i prezzi
degli affitti non scherzano affatto, per non parlare della vita che al Nord ha
un costo decisamente molto più elevato che al Sud”. Carta e penna alla mano ha
fatto i conti: tra affitto, bollette e spesa avrebbe speso di più. Tanto vale
passare 9 ore al giorno in treno. Se tutto va bene e i treni viaggiano in
orario.
“Avrei consumato tutto il mio
stipendio se mi fossi trasferita a vivere al Nord e molto probabilmente avrei
anche dovuto chiedere alla mia famiglia di aiutarmi economicamente. Invece così,
continuando a vivere a Napoli, riesco anche ad avere dei risparmi”, ha
raccontato. E fa i conti di quanto le costerebbe vivere a Milano, a partire
dalle stanze in affitto “che si aggirano sui 650 euro al mese, le
singole. Quelle più economiche, e neanche più di tanto, sono in zone periferiche
e in condivisione con altre persone, ma dividendo la camera non avrei neanche
avuto la possibilità di ospitare la mia famiglia. Io a Napoli vivo con i miei
genitori, mia nonna e i miei cagnolini. Questo mi permette di non avere
ulteriori spese oltre a quelle del treno e per questo mi ritengo molto
fortunata”. Inoltre, acquistando i biglietti in anticipo e accumulando tanti
punti viaggio per gli sconti, a fine mese la sua vita in treno le costa circa
400 euro. Il risparmio c’è, dunque. E di certo anche la fatica. Ma Giuseppina è
disposta a questo e altro pur di non perdere l’occasione lavorativa.
E così la sua vita è scandita
dall’orario del treno: “Per rientrare prendo il treno da Milano alle 18.20 e
arrivo a Napoli alle 22.53, sempre che non ci siano ritardi. Quindi, se tutto va
bene, per le 23.30 sono a casa. La mattina invece mi alzo alle 4, perché ci
metto una mezz’oretta per raggiungere la stazione dove prendo il Frecciarossa
che parte da Napoli Centrale alle 5.09 e arrivo a Milano alle 9.24. Poi salgo
sui mezzi pubblici e raggiungo la scuola dove lavoro dalle 10.30 alle 17. Quando
finisco di lavorare vado al supermercato a comprarmi qualcosa da mangiare per la
cena che, naturalmente, consumo in treno”.
Giuseppina riconosce che
però una vita intera così non è una soluzione definitiva. “Non perdo la speranza
e continuo a cercare una sistemazione qui: ho provato a chiedere ai pensionati,
ma mi hanno detto che accettano solo giovani studenti fino ai 25 anni e non
lavoratori. Poi ho chiesto anche all’ostello della gioventù, dove avevo abitato
qualche anno fa quando ero venuta a lavorare a Milano, ma mi hanno detto che ora
non ospitano più persone per lunghi periodi come facevano un tempo. Adesso
affittano le stanze solo per brevi periodi e quindi il costo è più elevato”.
Intanto le resta la solidarietà dei colleghi che colpiti dal suo spirito di
sacrificio cercano di darle una mano.
Elena Del Mastro. Laureata in
Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di
Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie
delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.
Estratto dell’articolo di
Violetta Fortunati per ilgiorno.it il 19 gennaio 2023.
"[…] Sono veramente commossa e
devo ammettere che sono anche un po’ sotto choc perché non mi è mai successo in
vita mia di avere tutta questa visibilità. Io sono una ragazza semplice, alla
mano, non ho mai chiesto niente a nessuno e questo clamore nei miei confronti mi
lascia veramente senza parole. Sono al settimo cielo per la felicità", racconta
Giuseppina la pendolare che tutti i giorni da Napoli viene a lavorare a Milano e
la sera torna in Campania.
"È da stamattina ( ieri per chi
legge, ndr) che […] mi contattano tv che mi vogliono invitare in trasmissione
per raccontare la mia storia, e anche da gente comune che mi ha voluto esprimere
solidarietà. Sono arrivate già chiamate di milanesi che vogliono offrirmi casa a
un prezzo calmierato. Io sono incredula, non mi sembra vero, è come vivere in un
sogno perché non mi sarei mai aspettata tutta questa solidarietà. […]".
Poi, sui social, c’è anche
qualcuno che le ha scritto: ‘Ma chi te lo fa fare? Goditi la vita, non vale la
pena sacrificarsi così per il lavoro. Cerca altro nella tua città. "Ma io devo
dire – ribatte Giuseppina – che il mio lavoro non mi pesa e neanche gli
spostamenti in treno, anche se a causa di tutti questi viaggi mi sono ammalata
perché sin da piccola soffro di problemi ai polmoni.
Sono determinata ad andare
avanti e soddisfatta per il fatto che riesco a mettere da parte soldi col mio
stipendio. Certo, il prezzo da pagare è caro a livello di comodità perché mi
rendo conto che non è da tutti fare la vita che sto facendo io..." […] "Ad
alcuni potrebbe anche sembrare anche una follia. Ma a me va bene così […]”
Estratto dell’articolo di
Giuseppe Luca Scaffidi per rollingstone.it il 19 gennaio 2023.
Neanche il tempo di riprendersi
dall’epopea lynchiana del rider disposto a pedalare (con grande soddisfazione)
per cinquanta chilometri pur di consegnare un panino che, come per magia, ci
ritroviamo immersi in un’altra storia di ordinaria miseria.
Ci riferiamo, ovviamente,
all’ormai celebre caso della “bidella pendolare”, rilanciata senza soluzione di
continuità da diversi quotidiani.
[...] Ovviamente, c’è già chi
sta mettendo in dubbio la veridicità dei fatti, ad esempio facendo notare che
una scelta del genere potrebbe rivelarsi non così economicamente vantaggiosa.
C’è anche chi ha dichiarato di
essersi messo in contatto con il personale della scuola in cui Giugliano lavora
– il Boccioni di Milano – e di aver scoperto che la nostra eroina 2.0 avrebbe
compiuto il viaggio della speranza soltanto in due occasioni, per poi decidere
di mettersi in congedo straordinario retribuito – beninteso: è tutto da
verificare, ma è un ritornello che conosciamo.
E però, d’accordissimo,
posizioniamoci nel microcosmo del verosimile e facciamo finta che questa storia
sia credibile, prendiamo per vera l’ipotesi che una ragazza di 29 anni abbia
deciso, consciamente, di percorrere 800 chilometri al giorno per assicurarsi
poco più di mille euro al mese: cosa ci sarebbe di edificante?
[…] trattare come un esempio
da imitare, magari addirittura un esempio virtuoso, chi è disposto a sacrificare
la propria quotidianità, mortificando […] la propria salute […] sull’altare di
poche centinaia di euro al mese, non è soltanto un errore, ma un atteggiamento
potenzialmente pericoloso.
Significa non avere contezza di
che cosa voglia dire poter contare su una qualità di vita accettabile, significa
glorificare il dogma della sopravvivenza a ogni costo a discapito del benessere,
vuol dire normalizzare una situazione di indigenza estrema perché, ehi, bisogna
darsi da fare, poco importa se la vita che conduco fa schifo. La celebrazione
definitiva del vivere male.
Non è la solita narrazione che
contrappone stakanovisti radicali e “popolo del divano”, no: è molto di più. È
una glorificazione che compendia tutti i tic e i malcostumi del nostro Paese:
l’accettazione passiva della precarietà, la glorificazione provincialissima e
dal retrogusto primo–repubblicano del “posto fisso” come panacea di ogni male,
al contempo mito e superstizione italiana per definizione […] Per questi motivi,
qualora la storia della bidella repubblicana fosse vera, be’, avremmo soltanto
la conferma di essere arrivati al capolinea: altro che esempio, sarebbe un
incubo.
Estratto dell'articolo di
Michele Monina per mowmag.com il 19 gennaio 2023.
[...] Non può essere solo una
faccenda di inaccuratezza, magari dovuta a questa nuova consuetudine di pagare
quasi zero i novellini, quella la possiamo vedere sui siti internet, quando
viene pubblicata la foto di Anthony Hopkins che interpreta Ratzinger il giorno
in cui Ratzinger muore, o quando ci sono errori marchiani che una semplice
correzione di bozze dovrebbe fermare ai blocchi, non certo su pezzi che sono
destinati comunque a diventare oggetto di discussione, tanto più se destinati
all’edicola.
Quindi, mi dico, non può che
essere una precisa scelta editoriale, e una precisa scelta editoriale che
veicoli una notizia palesemente falsa non può che avere un secondo fine, nello
specifico, immagino, quello di fare propaganda, cioè esattamente l’opposto di
quella che dovrebbe essere la mission di chi si è votato alla cronaca.
Perché non è ipotizzabile
anche volendo che qualcuno abbia davvero creduto alla faccenda di Giuseppina, la
bidella pendolare di Napoli, così ci è stata raccontata, parole loro,
ventottenne che, ottenuto un posto di lavoro a Milano come operatrice
scolastica, constatato che la vita nella metropoli lombarda è troppo cara ha
optato per fare la pendolare, alzandosi tutti i giorni alle 4 per andare a
lavorare su al nord, in treno, e poi ritornarsene nottetempo a casa, pronti via,
di nuovo, ogni giorno.
Una storia farlocca, a partire
dalle foto che l’hanno accompagnata, una bidella che ha un abbonamento
Trenitalia che costa quanto se non di più lo stipendio di 1100 e rotti euro al
mese, le nove ore di treno, senza contare sugli scioperi, per entrare al lavoro
alle 10, beata lei, che però si fa fotografare su Italo, e che comunque
rivendica un attaccamento a un lavoro che sommato alle ore di spostamento occupa
militarmente circa diciotto ore al giorno, roba che neanche uno degli orfanelli
di Dickens.
Tutto finto, è chiaro,
condiviso però dai principali quotidiani nazionali, con un’enfasi che, questo il
punto, lascia basiti, se non addirittura spiazzati. Perché, era già successo con
la storiella dell’ex commercialista che ora farebbe il rider, felice e contento,
la stampa nazionale sembrerebbe molto propensa a veicolare un messaggio alla
nazione piuttosto chiaro, e stucchevole: lavora e crepa, senza più neanche
consumare, manca il tempo per farlo, con un attaccamento al posto di lavoro
fisso, e statale, che neanche la generazione dei boomers, quelli veri, nati sul
volgere della seconda guerra mondiale.
Fermiamoci un attimo. Stare
attaccati con le unghie e i denti a un lavoro che ci brucia tutta la vita, nove
ore di viaggio giornaliere sommate alle ore passate al lavoro, per uno stipendio
così basso che non ti permetterebbe neanche di prendere una stanza
nell’hinterland, fatto poi tutto da verificare, non è qualcosa di eroico, da
sottolineare con enfasi, quanto piuttosto un gesto folle, autolesionista, a
prescindere di quale sia l’origine di questa Giuseppina, la sua situazione
familiare (vive coi genitori e i nonni, dice).
Qualcosa che dovrebbe essere
vista con allarme, fosse vera, non con orgoglio, che dovrebbe essere risolta
affidando Giuseppina a degli specialisti, perché questa forma di stakanovismo
rasenta, anzi, supera indubbiamente, la sottomissione masochista, tendenza che,
in genere, si tiene nascosta nelle stanze da letto, non si ostenta in prima
pagina sui quotidiani nazionali.
Quotidiani nazionali che, è
evidente, cavalcano una notizia palesemente falsa non per viralizzarsi e provare
a sopravvivere a una emorragia di lettori che non sembra avere fine, quanto
piuttosto per farsi velina di indottrinamento allo stare zitti e buoni con
l’obolo di stato che un tempo avrebbe accese non metaforiche micce.
Lasciamo da parte Giuseppina
[...] e pensiamo ai trapper. Li abbiamo giustamente guardati con allarme per i
messaggi che veicolano attraverso un genere molto amato dai più piccoli. Una
vita criminosa che affascina, certo, come è sempre avvenuto, Ian Solo era
decisamente più cool di Luke Skywalker, per dire, come Lucignolo era più figo di
Pinocchio, e mi fermo qui ma l’elenco potrebbe essere infinito, che affascina
tanto più perché real, reale, non certo finta come quella dei rapper della
generazione precedente, che ci parlava di vita di strada da comodi appartamenti
di duecento metri quadri vista sul Castello.
Ci siamo detti, genitori
preoccupati, che non era corretto lasciare che quelle canzoni e soprattutto
quegli artisti influenzassero negativamente le nuove generazioni col loro
nichilismo, le pistole, la droga, il sesso visto a senso unico, quindi
l’oggettificazione della donna, almeno nel linguaggio, linguaggio che però, è
successo a tutte le generazioni da che esiste la musica leggera, forma poi il
nostro vocabolario, contribuisce a costruire il nostro lessico anche morale.
[...] Temo che il messaggio di
Giuseppina sia assai più pericoloso che quello che passa per le canzoni trap,
perché non mette sul tavolo nessuna denuncia di una assenza dello stato, vero
punto della questione, ma anzi guarda a un obolo irrazionale come un posto fisso
a uno stipendio inadeguato con la gratitudine del bastardino cui stiamo dando
una polpetta avvelenata.
Il giallo della bidella
"frecciarossa" che fa chiacchierare tutta l'Italia. La storia di Giuseppina
come un gioco investigativo. Lavora a Milano e vive a Napoli e in tanti le fanno
i conti in tasca. Paolo Bracalini il 20 Gennaio 2023 su Il Giornale.
«Mi chiamo Giugliano
Giuseppina», cognome prima del nome, come si usa negli uffici pubblici. Ma
dietro le sembianze di una semplice bidella del liceo Boccioni di Milano si
nasconde un genio. In base ad un sistema di calcolo sofisticatissimo da lei
messo a punto, la Giugliano, 29 anni da Napoli (e ritorno), sostiene di riuscire
a incrociare tariffe e orari di Italo e Trenitalia, utilizzando promozioni,
sconti, bonus, punti, il tutto con mesi di anticipo, in modo da fare la
pendolare Napoli Centrale-Milano Centrale, ogni giorno, con solo 400 euro per
l'intero mese.
Una specie di miracolo grazie
ad un lavoro certosino che non ammette errori: basta perdere un treno e il
sistemone sballa. Una o due notti in hotel, un ritardo del treno (quanti se ne
possono verificare in 40 lunghi viaggi mensili?) e tutto il risparmio di non
dover pagare un affitto a Milano se ne va in fumo. Altro che bidella, una che
riesce a tenere in piedi una logistica del genere può aspirare ad una brillante
carriera manageriale, l'istituto dovrebbe promuoverla a dirigente nel settore
amministrativo.
La storia ha rapito
l'attenzione dei social. In effetti ha dell'incredibile. Un dipendente pubblico
che invece di mettersi in malattia o tirare fuori un parente invalido si
sciroppa ogni giorno 1500 chilometri avanti e indietro, è qualcosa che
contraddice tutti i capisaldi del pubblico impiego italiano. Già suonerebbe
strano se a farlo fosse una partita Iva, figuriamoci uno statale. E in effetti
molti si interrogano sulla veridicità della storia. Anche perché migliaia di
giovani trasferiti per lavoro a Milano, prima di sborsare uno stipendio per
l'affitto di un monolocale, avranno fatto un pensierino sulla possibilità di
fare i pendolari da centinaia di chilometri di distanza. Scartando l'ipotesi
come irreale visto che se gli appartamenti a Milano costano, i treni non sono
certo gratis, specie quelli ad Alta velocità. Sul web si sono creati due diversi
filoni interpretativi. C'è chi accusa i giornalisti di non verificare le notizie
e chi invece vede un'operazione mediatica di stampo neoliberista costruita ad
hoc per screditare i percettori del reddito di cittadinanza. Come dire: questa
si alza ogni giorno alle quattro del mattino per essere a lavoro a Milano, e voi
invece ve ne state belli comodi a letto con la tessera gialla del Rdc sul
comodino, vergogna. L'interrogativo resta: come diavolo fa la bidella volante a
sfrecciare su e giù per l'Italia per tutto il mese a quei prezzi (in media 20
euro per un a/r Napoli-Milano, neanche al capotreno glielo fanno un prezzo
così). C'è forse una tariffa speciale dedicata ai bidelli? Non risulta. Neppure
un abbonamento servirebbe a qualcosa, quelli dei treni Alta velocità costano più
di 1000 euro al mese, a quel punto le converrebbe investirli in un appartamento
nell'hinterland di Milano invece che trasformarsi in un arredo dei Frecciarossa.
La storia da libro Cuore diventa un giallo. Chi mente? Il Giorno intervista una
insegnante della stessa scuola, Francesca Alparone, che conferma la storia. La
Gazzetta.it, invece, racconta di aver telefonato al liceo Boccioni ma di aver
ricevuto un no comment come risposta. Sui social, invece, i segugi che accusano
la stampa di non verificare rilanciano (ovviamente senza alcuna verifica) il
tweet di un tale che sostiene che la Giugliano si sarebbe messa «in congedo
straordinario, retribuito», senza uno straccio di prova. Il mistero rimane,
mentre la bidella è già salita sul treno. Prima che si accorga che la pausa
pranzo costa troppo a Milano, a Torino si risparmia e ci vuole solo un'ora,
conviene.
Estratto dell’articolo di Luca
Bottura per “La Stampa” il 20 Gennaio 2023.
[…] Sarebbe inventata la storia
della ragazza che ogni giorno fa Napoli-Milano e ritorno per lavorare come
bidella. In realtà lavora come rider. […]
Estratto dell’articolo di David
Puente per open.online il 20 Gennaio 2023.
Il racconto di Giuseppina
Giugliano, l’operatrice scolastica “pendolare da Napoli a Milano” per lavoro, è
stato ampiamente trattato e discusso negli ultimi giorni. […] Il punto su cui
tutti pongono il dubbio riguarda i costi che la donna dice di affrontare, in
particolare quando afferma di spendere circa 400 euro al mese di viaggio.
Sostiene di prenotare «i
biglietti con largo anticipo» e «scontati grazie alle offerte», ma nell’intera
vicenda manca una prova fondamentale che nessuno, nemmeno Giuseppina, ha
mostrato: i biglietti acquistati come prova definitiva che lei abbia praticato
un sistema per risparmiare così tanto.
Questa mattina 19 gennaio ci
siamo recati presso il Liceo Artistico Boccioni nel tentativo di incontrarla.
L’abbiamo aspettata a lungo, anche oltre all’orario di inizio turno da lei
raccontato a Il Giorno, senza ottenere risultato. […] Non c’è stato verso di
parlare con la dirigente scolastica Gabriella Maria Sonia Conte, ma dalla
reception ci informano che non era presente in sede, in quanto lavora anche per
un altro istituto. Abbiamo contattato telefonicamente anche quello, ossia il
Severi-Correnti di Milano, ma la risposta è stata la stessa: non è presente in
sede.
[…] Di fronte a un muro di
gomma, molto probabilmente alzato in tutela dell’operatrice scolastica a seguito
del clamore mediatico, non c’era altro da fare che sentire qualche studente o
dipendente della scuola al di fuori del Liceo. Solo qualcuno ha risposto alle
domande dei giornalisti […] Qualcuno afferma di conoscerla almeno dallo scorso
anno, descrivendola come una persona gentile e disponibile.
Risulta, infatti, che
Giuseppina lavorasse presso il Liceo Boccioni già nel precedente anno
scolastico. Un’informazione fornita sia da qualche studente che da qualche
docente al di fuori dalla struttura scolastica, che ci porta a consultare le
ultime graduatorie del 26 agosto 2021 presenti sul sito della scuola. Il nome
Giuseppina compare in posizione 78 (a pagina 2 del PDF), ma c’è qualcosa di
diverso: il cognome che leggiamo è Giugliano e non Giuliano come riportato da Il
Giorno.
Questo spiega il perché non
siamo riusciti a scovare alcun account social della operatrice scolastica,
rintracciato grazie a un post dell’account “Estetica L’Oasi del Benessere“.
Nella lista delle amicizie del centro estetico campano troviamo proprio una
Giusy Giugliano.
Oltre al profilo Facebook,
troviamo anche i rispettivi account Instagram e TikTok. La ragazza nelle foto e
nei video pare essere proprio l’operatrice scolastica della storia raccontata da
Il Giorno.
[…] Attraverso le diverse
dichiarazioni […] otteniamo una ricostruzione diversa da quella raccontata. C’è
chi dichiara di averla vista a inizio anno scolastico, mentre altri
collaboratori e docenti operativi da pochi mesi affermano di non averla mai
vista e di aver saputo della sua esistenza solo attraverso i giornali.
Una docente ci racconta
qualcosa di molto particolare, ossia che la storia della pendolare fosse stata
discussa all’interno del Liceo qualche mese fa, per poi non saperne più niente.
Un ulteriore fonte ci racconta che alcuni dipendenti avrebbero affermato che
Giuseppina sia andata in malattia dopo un primo mese di lavoro e di
“pendolarismo estremo”.
[…] Osservando le varie
pubblicazioni social, nella sua pagina Facebook troviamo un reel pubblicato
martedì 22 dicembre 2022 alle ore 17:04 quando teoricamente dovrebbe aver appena
finito il suo turno presso il liceo milanese. Un altro reel del 19 ottobre 2022
alle ore 12:32 mostra la spiaggia di Castellamare. Risulta lecito domandarci se
queste e altre pubblicazioni social riguardino video ripresi in momenti diversi
e condivisi nel corso della giornata lavorativa in un breve momento di pausa.
L’intera vicenda non risulta
del tutto chiara. Quello che risulta fondato [è che] la 29enne Giuseppina
Giugliano (e non “Giuliano) potrebbe aver vissuto almeno un periodo di
“pendolarismo estremo”, noto e discusso diversi mesi fa. Resta un vuoto,
colmabile soltanto dalla stessa protagonista: mostrando la prova dei viaggi
giornalieri. […]
Estratto dell’articolo di
Violetta Fortunati per ilgiorno.it il 20 Gennaio 2023.
[…] Per fare una verifica di
quanto si può risparmiare incrociando i vari tipi di offerta siamo andati a
scandagliare il sito di Italo, il treno ad alta velocità che unisce varie città
italiane fra cui, appunto, Milano e Napoli. Una tratta che viene coperta in 4
ore e mezza.
Giuseppina viaggia con Italo
(prevalentemente) e con Trenitalia per raggiungere da Napoli il liceo artistico
Boccioni a Milano. Ora confrontiamo i costi di viaggio con il racconto che la
collaboratrice scolastica ha fatto a "Il Giorno".
I carnet
Un primo sistema per poter
risparmiare è legato ai carnet. Acquistando un pacchetto di 10 viaggi si può
arrivare a risparmiare circa il 30%. In questo caso si possono comperare i
biglietti con tariffa flex (i più costosi perché permettono di modificare con
una certa libertà giorni e orari dei viaggi). Un biglietto flex tariffa piena
costa mediamente 99 euro. Acquistando i carnet si scende a 64 euro a biglietto.
La versione di Giuseppina
Giugliano
"Ho comprato carnet da 384 euro
per 24 giorni e da 450 euro per 30 giorni. Questi sono quelli che uso io". Sui
siti degli operatori queste cifre standard non risultano, ma non è impossibile
che Giuseppina abbia utilizzato coupon per abbattere il prezzo.
[…] "Con l’iscrizione a Italo
Più ho la possibilità di totalizzare i punti in base ai chilometri di
percorrenza e avere delle tratte in omaggio. Sono biglietti-premio che io
acquisto con i punti quindi non li pago".
[…] "Ovviamente prendo i
biglietti con largo anticipo, mesi prima, così riesco trovare un sacco di
offerte e di sconti. Cosa che non è possibile se si comprano i biglietti o i
carnet sotto data. Diciamo che quando non trovo l’offerta da Italo viaggio con
Trenitalia e viceversa". […] "Sono diventata più esperta di un’agente di viaggio
nel scovare coupon, offerte e promozioni per le tariffe dei treni".
[…] "Da settembre a dicembre
non ho mai fatto assenze. Ho solo usufruito di un congedo per accompagnare un
parente a una visita medica: i miei genitori sono venditori ambulanti e
purtroppo non sempre si possono assentare dal lavoro perché guadagnano a
giornata in base a quello che vendono. Mia nonna è anziana e non è nella
condizione di poterlo portare in ospedale. A dicembre ho avuto una brutta
bronchite e sono rimasta parecchi giorni a casa in malattia. Il dottore mi ha
detto che dovevo riguardarmi altrimenti me la sarei trascinata per mesi. Ora mi
sono ripresa e a gennaio, dopo le feste natalizie, sono tornata regolarmente a
scuola".
Estratto dell’articolo di Paolo
Bracalini per “il Giornale" il 20 Gennaio 2023.
«Mi chiamo Giugliano
Giuseppina», cognome prima del nome, come si usa negli uffici pubblici. Ma
dietro le sembianze di una semplice bidella del liceo Boccioni di Milano si
nasconde un genio.
In base ad un sistema di
calcolo sofisticatissimo da lei messo a punto, la Giugliano, 29 anni da Napoli
(e ritorno), sostiene di riuscire a incrociare tariffe e orari di Italo e
Trenitalia, utilizzando promozioni, sconti, bonus, punti, il tutto con mesi di
anticipo, in modo da fare la pendolare Napoli Centrale-Milano Centrale, ogni
giorno, con solo 400 euro per l’intero mese.
Una specie di miracolo grazie
ad un lavoro certosino che non ammette errori: basta perdere un treno e il
sistemone sballa. Una o due notti in hotel, un ritardo del treno (quanti se ne
possono verificare in 40 lunghi viaggi mensili?) e tutto il risparmio di non
dover pagare un affitto a Milano se ne va in fumo. Altro che bidella, una che
riesce a tenere in piedi una logistica del genere può aspirare ad una brillante
carriera manageriale, l’istituto dovrebbe promuoverla a dirigente nel settore
amministrativo.
La storia ha rapito
l’attenzione dei social. […] C’è chi accusa i giornalisti di non verificare le
notizie e chi invece vede un’operazione mediatica di stampo neoliberista
costruita ad hoc per screditare i percettori del reddito di cittadinanza. Come
dire: questa si alza ogni giorno alle quattro del mattino per essere a lavoro a
Milano, e voi invece ve ne state belli comodi a letto con la tessera gialla del
Rdc sul comodino, vergogna.
[…] La storia da libro Cuore
diventa un giallo. Chi mente? Il Giorno intervista una insegnante della stessa
scuola, Francesca Alparone, che conferma la storia. La Gazzetta.it, invece,
racconta di aver telefonato al liceo Boccioni ma di aver ricevuto un no comment
come risposta. Sui social, invece, i segugi che accusano la stampa di non
verificare rilanciano (ovviamente senza alcuna verifica) il tweet di un tale che
sostiene che la Giugliano si sarebbe messa «in congedo straordinario,
retribuito», senza uno straccio di prova. Il mistero rimane, mentre la bidella è
già salita sul treno. Prima che si accorga che la pausa pranzo costa troppo a
Milano, a Torino si risparmia e ci vuole solo un’ora, conviene.
I sacrifici dei giovani e i
dubbi sul racconto da libro-cuore. La bidella Giuseppina, il treno da Napoli a
Milano e i conti che non tornano: l’affitto costa meno. Redazione su Il
Riformista il 19 Gennaio 2023
La storia è bella, fa
riflettere, testimonia ancora una volta gli enormi sacrifici che fanno
i giovani, soprattutto del Sud, per lavorare, per conquistare l’agognato posto
fisso che, rispetto alla partita iva (nonostante la retorica dei governi e degli
imprenditori), offre maggiori garanzie e stabilità. Evidenzia, se ancora ve ne
fosse bisogno, la crisi spropositata che stiamo vivendo, fatta di salari sempre
più bassi e costi della vita spropositati (oggi anche vivere in affitto in una
grande città è diventato quasi un lusso). E ancora: rimarca il sistema
scellerato delle assegnazioni dei posti, sia da docenti che da collaboratori,
nelle scuole di tutta Italia dove al Sud c’è sempre più ressa per entrare mentre
al nord molti posti restano vacanti per svariati motivi, in primi perché con
quello che si guadagna si riesce a mala pena a sopravvivere.
Quello che però stona con i
1600 chilometri che ogni giorno la napoletana Giuseppina Giuliano percorre in
treno per andare e tornare da Milano è il costo dei treni che sostiene di
pagare. La collaboratrice scolastica del liceo artistico Boccioni di piazzale
Arduino ha spiegato infatti di non potersi permettere di pagare un affitto a
Milano perché con i 1165 euro che guadagna ogni mese non riuscirebbe a vivere.
Quindi la 29enne si arrangia prendendo ogni mattina il treno dell’alta velocità
alle 5,09 da Napoli Centrale (con arrivo previsto per le 9.24, se tutto va
bene), per poi ritornare al Sud con un treno che parte dopo le 18 da Milano e
arriva, sempre se tutto va bene, prima delle 23 nel capoluogo partenopeo.
Una sfacchinata bella e buona
giustificata, secondo il racconto di Giuseppina, dal risparmio economico. La
collaboratrice scolastica sostiene infatti che per cinque giorni settimanali di
lavoro, quindi circa 20 al mese, spende la cifra di appena 400 euro, riuscendo
ad acquistare i biglietti in anticipo e accumulando tanti punti viaggio per
ulteriori sconti. Quattrocento euro al mese per andare e tornare cinque giorni
alla settimana da Milano con l’alta velocità (a volte va anche il sabato),
comprando circa una quarantina di biglietti tra andata e ritorno.
I conti però non tornano perché
la cifra annunciata da Giuseppina è del tutto irreale. E’ impossibile riuscire a
pagare così poco ben 40 biglietti al mese dell’alta velocità che se tutto va
bene (offerte, acquisto in anticipo e sconto grazie ai punti accumulati)
richiederebbero una spesa media di 40 euro al giorno che a fine mese
significherebbe arrivare a pagare 800 euro di trasporti (a cui vanno aggiunti i
biglietti dei mezzi pubblici che la 29enne prende a Milano), meno del costo di
una stanza nel capoluogo lombardo.
Ma mediamente anche prenotare
in anticipo i biglietti dell’alta velocità Napoli-Milano porterebbero a una
spesa media di almeno 30 euro a tratta. Insomma in conti non tornano davvero se,
come sottolineato da Giuseppina, il suo lavoro si svolge in presenza dal lunedì
al venerdì. Inutile menzionare i costi degli abbonamenti mensili
di Italo e Frecciarossa che superano i mille euro.
Insomma i conti dei treni non
tornano nella storia, definita da libro cuore, di Giuseppina. Torna invece
l’enorme sacrificio che fanno tanti giovani come lei per scalare le graduatorie
o per acquisire maggiore anzianità così da riavvicinarsi, dopo qualche anno,
nella città in cui si vive o si sceglie di vivere.
Altra domanda che sorge quasi
spontanea: se come sottolineato dalla stessa Giuseppina gli affitti a Milano
sono alle stelle (“le stanze in affitto si aggirano sui 650 euro al mese”, più
le bollette e la spesa), perché la 29enne non ha provato a trovare casa in
provincia di Milano? Così da alleviare le oltre 10 ore che ogni giorni trascorre
in treno per andare a lavoro?
Estratto da “Digital
Journalism”, la newsletter di Francesco Oggiano il 26 gennaio 2023.
[…] Nei giorni scorsi mi sono
imbattuto in un documento che credo possa fare un po’ di chiarezza su una
notizia virale delle ultime settimane […]. Stando ai dati, la «Bidella
pendolare» non avrebbe fatto la pendolare «tutte le mattine, compreso il
sabato». E non farà più la pendolare per almeno i prossimi 7 mesi.
A quanto risulta da un
documento ufficiale del Ministero dell’Istruzione che ho potuto consultare, dal
19 gennaio la collaboratrice scolastica si trova in «congedo per assistenza
familiari con handicap in situazione di gravità», che durerà fino alla fine
dell’anno scolastico, ovvero fino al 31 agosto 2023.
Il congedo è un periodo di
assenza dal lavoro retribuito previsto dalla legge 104 del 1992. Una legge
sacrosanta, che permette ai lavoratori dipendenti di potersi assentare dal
lavoro per assistere familiari portatori di handicap […] È forse l’epilogo di
una storia virale sui social che merita di essere ricostruita.
Come diventa virale una storia
Il 17 gennaio il racconto:
collaboratrice scolastica di Napoli fa la pendolare «tutti i giorni, sabato
compreso» per andare a lavorare al Liceo Artistico Boccioni di Milano. La
ragione: se si trasferisse al Nord, consumerebbe tutti i 1.165€ di stipendio
«tra affitto, bollette e spesa». Facendo la pendolare: 400€.
La storia diventa virale.
Scatena due istinti fortissimi e identitari dei social:
solidarietà, nei confronti
della ragazza;
indignazione, nei confronti
del caro affitti.
presto, come tutte le storie
virali, scatena un altro istinto: la curiosità.
C’è chi studia le tariffe
ferroviarie: «I conti non tornano»; chi raccoglie voci dei colleghi: «Non viene
mai»; e chi si abbandona a stereotipi razzisti e insulti social contro la
collaboratrice, forse ritrovatasi improvvisamente in qualcosa più grande di lei.
La collaboratrice dà una nuova
intervista per rispondere alle polemiche. Dice che da settembre a dicembre non
ha «mai fatto assenze» (salvo «un congedo per accompagnare un parente a una
visita medica»); che soltanto a dicembre, è rimasta parecchi giorni a casa in
malattia per «una brutta bronchite»; e che a gennaio è «tornata regolarmente a
scuola».
Cosa dicono i dati
[…] Stando ai dati emersi, non
sarebbe esatto dire che la collaboratrice scolastica sia andata ogni mattina a
Milano, così come non sarebbe esatto dire che non ci sia mai andata se non per
due giorni. È stata supplente nei licei di Milano dal 2019. Ma fino al 2021 i
licei sono stati prevalentemente in Didattica a distanza causa Covid.
Stando ai dati, nell’anno
scolastico 2021/2022 ottiene una supplenza all’istituto Luigi Cadorna di Milano.
Dopo circa un mese e mezzo di lavoro, ottiene un «congedo per assistenza a
familiari con handicap», che inizia il 2 novembre 2021 e finisce il 31 agosto
2022. Niente più pendolarismo per quell’anno.
Nell’anno 2022/2023 le viene
assegnata una sede provvisoria al Liceo artistico Boccioni di Milano, in attesa
della conferma di ruolo.
Sempre a causa dei permessi, a
settembre e ottobre non è presente a scuola quasi tutti i sabati e due lunedì.
Da qui forse le testimonianze raccolte di personale Ata e studenti che dicevano
di non averla sempre vista nell’istituto. Dopo aver ottenuto la conferma del
ruolo il 5 novembre, si deve assentare per malattia per tutto il mese. Forse è
una bronchite di cui ha parlato dopo le polemiche, anche se datava quella
malattia nel mese di dicembre.
E così, dopo un rientro
post-vacanze e la diffusione della notizia, il 19 gennaio prende il nuovo
congedo per assistere familiari con handicap. È il congedo straordinario
retribuito, che questa volta durerà fino alla fine dell’anno. Un congedo,
ripeto, sacrosanto, tra i capisaldi di una società civile. Facendo due calcoli,
su una novantina di giorni di scuola (dal 12 settembre al 19 gennaio),
risulterebbe assente in circa una trentina.
Cosa non torna
Tra i dati emersi dal documento
e le ricostruzioni della vicenda ci sono forse un po’ di incongruenze.
Se nella storia la
collaboratrice scolastica dice di essere «diventata di ruolo a settembre» a
Milano, nel documento risulta essere diventata di ruolo il 5 novembre, ovvero
dopo i due canonici mesi di prova.
Se nella storia dice di non
aver «mai fatto assenze da settembre a dicembre» nel documento si vede come sia
assente, legittimamente, quasi tutti i sabati di settembre e ottobre e quasi
tutto il mese di novembre.
Se in un’intervista pubblicata
il 19 gennaio diceva di essere «tornata regolarmente a scuola dopo le feste
natalizie», nel documento risulta essere in congedo proprio dal 19 gennaio fino
al 31 agosto 2023.
Fino alla fine dell’anno non
percorrerà più la tratta Napoli-Milano per andare a scuola. E - qualora lo vorrà
- potrà provare a chiedere il trasferimento in qualche scuola più vicina,
essendo diventata di ruolo lo scorso novembre.
Ecco perché tornano i conti?
Sono dettagli - che riporto
dopo aver chiesto nei giorni scorsi alla protagonista se voleva replicare (ha
scelto legittimamente di non farlo) - dettagli che forse rendono più complessa
la storia e il dibattito polarizzato che ne è seguito. E che potrebbero
suggerirci come i conti possano iniziare a tornare.
Un conto sono i costi per fare
una tratta 200 giorni in un anno (tanti sono quelli più o meno previsti nei
licei italiani). Un altro per farla qualche decina di volte. Un conto è la
scelta di restare a Napoli per il caro affitti di Milano. Un altro - ipotizzo -
la necessità di restare a Napoli per accudire un parente. […]
Il prof precario del Sud in
trasferta nella cara Milano: «Affitto condiviso, spesa al discount e ristorante
vietato». Giovanna Maria Fagnani su Il Corriere della Sera il 28 Gennaio
2023.
Fabio Mazzitello, 29 anni, è un
insegnante di sostegno arrivato dalla Calabria. Guadagna 1.500 euro al mese
nella città dove tutto costa troppo. «Esco una sera a settimana, pranzo al sacco
e uso sempre i mezzi pubblici»
Fabio Mazzitello, 29 anni, è
insegnante di sostegno all’istituto professionale Kandinsky di Milano
D’estate e durante le vacanze
di Natale o di Pasqua — ovvero i periodi che passa a casa sua, a Filandari (Vibo
Valentia) — vive da solo, in un ampio appartamento, un tempo dei suoi genitori
che ora si sono trasferiti altrove. Niente spese, a parte le bollette e la
benzina per l’auto.
Di tutt’altro tenore, invece,
la sua vita a Milano, dove è un insegnante di sostegno precario e guadagna uno
stipendio di 1.500 euro al mese. La metà se ne va per una stanza in affitto in
un bilocale in condivisione, le spese di condominio, le bollette. Poi ci sono il
supermercato, l’abbonamento ai mezzi pubblici, le altre necessità. Alla
fine Fabio Mazzitello, 29 anni, riesce a mettere da parte «200-300 euro al
mese». Eppure è già da 10 anni che insegna. «E ora ho il contratto da settembre
al 31 agosto. Prima si fermava al 30 giugno e per due mesi ero disoccupato. Ho
insegnato in cinque scuole: a Rho, San Donato, poi a Milano. Ora sono
all’Istituto professionale Kandinsky, indirizzo socio-sanitario, dove vorrei
restare».
A 19 anni, dopo il diploma da
perito chimico, Fabio si trasferisce a Milano per frequentare Agraria. «Studiavo
e intanto già lavoravo nelle scuole come insegnante di laboratorio per cui basta
avere il diploma. Il primo anno ho vissuto a casa di parenti a Gallarate, in
provincia di Varese — racconta Mazzitello —. Poi ho saputo che un
mio compaesano, Giovanni, cercava un coinquilino per un bilocale a Pero, sul
confine con Milano e con la fermata della metro a due passi. Così mi sono
trasferito».
Quindi racconta: «Lui però sta
per andare via. La casa sarà messa in vendita e io ho chiesto il mutuo per
poterla comperare: la cifra dovrebbe essere simile a ciò che pago ora. Mi
aiuteranno i miei genitori con l’anticipo. E poi cercherò a mia volta un
coinquilino, magari un collega. C’è solidarietà tra noi e nascono amicizie». Tra
i suoi amici più cari a Milano c’è un collega, Antonio Mascaro, 30 anni.
Laureato in Economia e originario di Accaria Rosario (Catanzaro) vive con due
coinquilini. Lui paga 550 euro al mese e ha il contratto fino al 30 giugno. In
quattro anni ha cambiato tre appartamenti e quattro scuole.
«Non puoi rifiutare la
chiamata, anche se è dall’altra parte della provincia, se no perdi l’incarico»,
dice lo stesso Antonio. «La parte più brutta del precariato, per noi che
facciamo il sostegno, è lasciare i ragazzi che seguiamo. Ci mettiamo 2-3 mesi
per creare un legame con loro, comprenderli, poi finisce tutto. Quasi si ha
paura a legarsi a colleghi e alunni, perché non sai se tornerai».
Fabio e Antonio spesso cenano
insieme. «A casa però, non fuori, a Milano devi stare coi piedi per terra, avere
un budget e non sforare — dice Fabio —. A mezzogiorno non pranzo mai fuori:
preparo dei piatti e li porto a scuola. La spesa la faccio al discount, pane
pesce e carne qui costano meno. Se esco è solo una sera a settimana, per un
aperitivo o una pizza. Quando ero studente invece andavo all’Hollywood, all’Old
Fashion a ballare. Non vado in palestra, ma a correre al parco. Niente auto: uso
sempre i mezzi pubblici, se proprio occorre prendo una macchina a noleggio. Poi
approfitto dell’apertura gratuita dei musei la prima domenica del mese: ho visto
il Museo del Novecento. Unico sfizio, andare a vedere una partita dell’Inter, ma
non un big match».
I voli di ritorno in Calabria
li prenota mesi prima. «Solo low cost, se no spenderei anche 300 euro», dice.
D’estate, quando torna a casa, aiuta i genitori. «Abbiamo una piccola attività
famigliare, un allevamento di suini e bovini e un vitigno». Perché fare questa
vita a Milano, allora? «In Calabria vivrei meglio, ma il mio lavoro mi piace. Ho
fatto dei concorsi per passare di ruolo e quando ci riuscirò, chiederò il
trasferimento». Interviene Antonio: «Da precari non c’è alcuna possibilità di
trovare posto in Calabria: non abbiamo scelta».
Il Costo della Vita.
Costo della vita, davvero al
Sud è più basso? Le differenze tra città e la tabella dei prezzi. Massimiliano
Jattoni Dall’Asén su Il Corriere della Sera il 27 Gennaio 2023.
La proposta del ministro
dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di adattare i salari dei
professori al costo della vita nelle diverse regioni italiane ha scaldato gli
animi. Ma dire che ci sono regioni del Sud d’Italia dove la vita è sempre
costata meno rispetto alle regioni del Nord è scoprire l’acqua calda. La riprova
si era avuta nel maggio dell’anno scorso, quando anche noi del Corriere avevamo
raccontato gli esiti flop di alcuni concorsi pubblici. Il difficile tessuto
economico e lavorativo del Meridione ha infatti sempre spinto a guardare
all’impiego nella pubblica amministrazione come a un’ancora di salvezza per chi
vive in regioni dove il tasso di disoccupazione è da sempre alto. La presenza
massiccia di italiani provenienti dalle regioni meridionali negli uffici
pubblici e nelle scuole del Nord Italia è una costante almeno a partire
dall’immediato secondo dopoguerra. Qualcosa però ha iniziato a cambiare. Negli
ultimi concorsi banditi dal Ministero delle Infrastrutture del governo Draghi,
infatti, una quota consistente di vincitori aveva rinunciato, evitando di
prendere servizio a meno che non fosse indicata una sede al Sud. Al di là delle
motivazioni sentimentali, a pesare sono i costi esorbitanti nella vita
quotidiana (soprattutto gli affitti) che si deve sobbarcare chi decide di
trasferirsi al Nord.
Cosa è cambiato dopo la guerra
in Ucraina
Questa nuova tendenza però ora
deve fare i conti con le recenti fiammate dell’inflazione che stanno livellando
il carovita un po’ in tutta la Penisola, con un Meridione che, dalle ultime
rilevazioni Istat, a dicembre guidava i rincari. La Sicilia è la regione che
negli ultimi mesi del 2022 ha avuto l’inflazione più alta (+14,2% a dicembre,
contro una media nazionale dell’11,6%, con Palermo che ha toccato quota 14,6%).
Molto più basso, ma sempre a due cifre, il livello a Roma (10,3%) e a Milano
(12%). Le tabelle elaborate dal Codacons sui dati del Mimit (ad eccezione degli
affitti) raccontano di differenze davvero minime per quanto riguarda alcuni beni
e servizi tra le tre principali città prese in esame (Milano, Roma, Napoli e
Palermo). Anzi, in alcuni casi i prezzi dei singoli beni sono più alti nel
Mezzogiorno. Ad esempio un kg di farina costa 1,06 euro a Palermo, 1 euro a Roma
e 97 centesimi a Milano. Roma svetta invece per il prezzo della pasta: 2,05 euro
al kg contro 1,98 euro a Milano e 1,46 euro a Palermo. Nella capitale è più caro
anche il latte: 2 euro al litro a fronte di 1,57 euro a Milano e 1,93 a Palermo.
Anche sul versante affitti, una delle voci più impattanti sui bilanci familiari,
se è vero che a guidare la classifica come città più cara è Milano (965 euro il
mensile per un bilocale), al secondo e al terzo posto ci sono Roma (730 euro) e
Palermo (625).
Perché il Sud registra il picco
dell’inflazione
Del resto, il Rapporto 2022 di
Svimez (Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno) lo aveva
già anticipato la scorsa estate: il picco dell’inflazione avrebbe interessato
nel 2022 in maniera più marcata il Mezzogiorno, con un più lento rientro sui
livelli precedenti lo «shock Ucraina» e conseguente crollo dei consumi al Sud
nel biennio 2023-2024. Ma perché il Meridione appare così fragile davanti
all’inflazione? A rispondere è la stessa Svimez che spiega come il caro-prezzi
determini impatti più pronunciati sui consumi delle famiglie al Sud per «un
effetto composizione sfavorevole al Mezzogiorno”. Nel «carrello della spesa» del
consumatore medio del Sud, infatti, «è prevalente l’acquisto di beni di consumo,
più colpiti dal rincaro delle materie prime; al Centro-Nord è maggioritaria la
quota in servizi, interessati da una crescita dei prezzi significativamente
minore».
Estratto dell'articolo di
Antonio Fraschilla per "la Repubblica" il 28 gennaio 2023.
Se il concetto di costo della
vita e salari messo sul tavolo dal ministro dell’Istruzione e del merito
Giuseppe Valditara è vago e indefinibile, un secondo concetto è invece chiaro: i
docenti italiani sono quelli che guadagnano meno in Europa.
La metà dei loro colleghi in
Germania e Olanda. E il confronto è impietoso anche con le buste paga di
insegnanti che vivono in Paesi dal Prodotto interno lordo più simile all’Italia.
Fanno peggio solo i paesi dell’Est Europa, che non hanno certo il Pil italiano,
dall’Estonia alla Repubblica Ceca passando per la Polonia.
[…] Lo stipendio medio annuo
lordo di un insegnate della scuola primaria in Italia è pari a 36.800 euro, in
Francia 39.417 euro, in Olanda 60.019 euro, in Germania 74.937 e la media Ue
comunque è di 42.599 euro. Non va meglio nella scuola media: in Italia lo
stipendio annuo lordo è mediamente di 39.463 euro, in Francia di 44.365, in
Spagna di 44.962 euro, in Olanda di 72.869 e in Germania 82.569, mentre la media
Ue è di 45.015 euro. Fanno peggio, sempre nella scuola media, l’Estonia (29.103
euro) o la Repubblica Ceca (32.754 euro): una magra consolazione.
[…]
Gli stipendi d’ingresso nella
scuola sono per una famiglia monoreddito sotto la soglia di povertà. Le buste
paga nette mensili a inizio carriera ammontano 1.360 euro nella primaria e a
1.471 nelle superiori. Le soglie di povertà relativa proposte dall’Istat nel
2021 sono pari a 1.395 euro per una famiglia di tre componenti e a 1.709 euro
per una famiglia di quattro persone. […] Un docente di scuola superiore ha in
media una retribuzione del 22 per cento inferiore rispetto a un lavoratore di un
altro settore con lo stesso titolo universitario. In pratica, circa 350 euro in
meno al mese.
[…]
Valditara, la bomba:
"Stipendi più alti ai professori del Nord". Libero Quotidiano il 26 gennaio
2023
La scuola pubblica necessita
di nuove forme di finanziamento per coprire gli stipendi degli insegnanti che
potrebbero essere differenziati a livello regionale. "Non è competitivo pagare
1.500 euro al mese un insegnante di matematica", dice il ministro
dell'Istruzione Giuseppe Valditara a La Repubblica, e chi vive e lavora in una
regione d’Italia in cui il costo della vita è più alto, dovrebbe guadagnare di
più.
Una proposta, quella degli
stipendi differenziati tra Nord e Sud che ha scatenato l'ira
dell'opposizione. "Valditara getta la maschera e descrive a chi avesse ancora
qualche dubbio il modello che vuole realizzare questo governo: la scuola delle
disuguaglianze. Garantire stipendi più alti al Nord perché il costo della vita è
più alto non ha nulla a che vedere con il merito, né tiene conto degli sforzi
enormi che molti docenti mettono in campo in contesti disagiati, dove la scuola
rappresenta il principale presidio democratico", tuonano i capigruppo
del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato e alla Camera Luca
Pirondini e Anna Laura Orrico. "Il disegno di Valditara ci inquieta: il suo
piano è esattamente quello che gli contestammo in Parlamento e le sue parole ci
stanno dando ragione. Vedremo le mosse concrete che metterà in campo ma una cosa
è certa: il Movimento 5 Stelle sarà al fianco del mondo della scuola per
contrastare le derive disegualitarie, privatistiche e ideologiche di questo
governo".
Anche Irene Manzi,
capogruppo Pd in Commissione Scuola alla Camera, si dice contraria alle
dichiarazioni del ministro. "La scuola immaginata da
Valditara allarga divari e
disuguaglianze. Ma non dobbiamo stupirci: questa è l’autonomia differenziata che
vuole la destra. Un’autonomia che perpetua i divari e le distanze. Ci opporremo
con tutte le forze a questa deriva che spacca il Paese e divide gli insegnanti.
La battaglia per un aumento degli
stipendi dei docenti in linea
con i livelli europei deve riguardare tutto il Paese ed è quello su cui vorremmo
poter conoscere le proposte del ministro".
Gabbie salariali, il governo Meloni ci riprova:
blitz della Lega per dare più soldi ai dipendenti pubblici del Nord.
Redazione su L'Unità il 7 Dicembre 2023
La vecchia ossessione della Lega, quando a guidare
il Carroccio era ancora il “Senatur” Umberto Bossi, rispolverata a oltre 20 anni
di distanza. Parliamo delle gabbie salariali per il pubblico impiego, ovviamente
con l’obiettivo di premiare i lavoratori del Nord Italia.
Dopo averci riprovato durante il governo
giallo-verde con i grillini di Giuseppe Conte, con la proposta ritirata
frettolosamente per le barricate dei 5 Stelle, questa volta il partito di Matteo
Salvini ci riprova all’interno di un governo più “amico”.
Lo scrive oggi Repubblica, che evidenzia come il
Carroccio con un blitz notturno martedì ha fatto approvare un ordine del giorno
alla Camera sulla questione.
Gabbie salariali “nascoste”: all’interno della
proposta di legge che ha demolito il salario minimo delle opposizioni, il
provvedimento-delega a firma Walter Rizzetto contiene un odg della Lega che
chiede al governo di introdurre una “quota variabile” di stipendio per i
dipendenti pubblici, in particolare “nel mondo della scuola”, da calcolare in
base “al luogo di attività”. Tradotto: gabbie salariali per premiare/aiutare i
dipendenti pubblici del Settentrione.
A presentare l’ordine del giorno, spiega ancora
Repubblica, sono stati i deputati leghisti Andrea Giaccone e Rossano Sasso,
sottosegretario all’Istruzione ai tempi del governo Draghi. L’odg è stato
affrontato intorno alle 23 di martedì. E col parere favorevole del governo,
rappresentato dal sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon, è stato
considerato approvato senza discussione o voto.
Eppure dalla maggioranza, e in particolare proprio
da Rizzetto, si nega l’introduzione del tema delle gabbie salariali. “Noi
andiamo a sottolineare un punto molto importante che è quello della
contrattazione di secondo livello – spiega il presidente della Commissione
Lavoro della Camera – che non significa, come ho sentito molto spesso, parlare
di gabbie salariali”.
Sempre da Fratelli d’Italia arrivano le parole
di Marco Cerreto, che si dice “non a favore delle gabbie salariali ma riteniamo
che il governo debba approfondire il serissimo problema dei contratti pirata ma
allo stesso tempo debba continuare a sostenere quella contrattazione decentrata
che favorisce una concertazione che, se basata su livelli di civiltà
giusvaloristica e di buon senso sicuramente, porteranno a risultati maggiori”.
Eppure, come ricorda Marco Sarracino, deputato e
responsabile Sud nella segreteria di Elly Schlein, “la destra torna a sdoganare
il principio delle gabbie salariali, perché con l’ordine del giorno presentato
dalla Lega e approvato in piena notte, si punta esplicitamente a classificare i
cittadini del Meridione e delle aree interne quali cittadini di serie B”.
Il precedente di Valditara
La questione delle gabbie salariali era stata
cavalcata già lo scorso gennaio dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara,
che propose “maggiore equità” nelle retribuzioni dei professori “dove il costo
della vita è più alto”, salvo poi fare marcia indietro.
di: Redazione - 7 Dicembre 2023
La solita memoria
corta della sinistra: così Sala predicava salari differenziati. Polemiche
assurde contro la presunta differenziazione regionale degli stipendi degli
insegnanti: tuttavia, solo pochissimi anni fa, un celebre esponente progressista
si era spinto decisamente oltre sul tema. Lorenzo Grossi il 27 gennaio 2023 su
Il Giornale.
Un'ondata di feroci proteste ha
colpito il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Motivo? L'esponente del
governo Meloni, intervistato sull'autonomia nell'ambito di un webinar, aveva
dichiarato nelle scorse ore che "la richiesta delle Regioni è consentire
maggiore equità laddove il costo della vita sia molto più alto". Apriti cielo.
Polemiche a non finire da parte della sinistra e dei sindacati, in primis della
Cgil, contro Valditara, accusato di volere "tornare a una differenziazione
di gabbie salariali come c'era cinquant'anni: una follia. Il nostro Paese è già
abbastanza diviso non ha bisogno di aumentare le divisioni", ha tuonato Landini.
Un'intemerata strumentale che è
intrisa di almeno due gravi falle. Il ministro non ha mai messo in discussione
il contratto nazionale del mondo della scuola – anzi, ieri aveva proprio
specificato il contrario – ma semplicemente aveva riportato una problematica che
era stata sollevata da alcune regioni riguardo il differente costo della vita
nelle diverse città italiane. "Insieme con sindacati e regioni si ragionerà
anche di questo aspetto, per cercare soluzioni adeguate in favore di docenti e
personale scolastico", ha difatti poi precisato. Dopo di che, a prescindere da
come la si può pensare su questo tema tutt’altro che irrilevante, resta comunque
un elemento di fondo che sembra essere sempre costante con il passare del tempo:
la totale incoerenza e ipocrisia della sinistra.
Le parole del sindaco (non di
centrodestra)
Indovinate infatti chi
pronunciò la seguente frase nel luglio 2020: "Capisco che sia un discorso
difficile da fare, ma è chiaro che se un dipendente pubblico, a parità di ruolo,
guadagna gli stessi soldi a Milano e a Reggio Calabria, è intrinsecamente
sbagliato, perché il costo della vita è diverso". E poi ancora: "Ogni città ha
le sue peculiarità ed è necessario affrontare la questione. Il nostro è un Paese
delle non riforme, ma se vogliamo fare un passo avanti rispetto al mondo del
pubblico è necessario pensare a una riforma significativa. Nel mondo del privato
tra Nord e Sud ci sono ampie differenze di retribuzione", ma "se si tocca il
pubblico diventa un tabù. Di pubblico non si può discutere. In Italia ci sono 3
milioni e mezzo di dipendenti pubblici e tutti noi spesso ci lamentiamo di come
funziona il sistema pubblico, se si tenta di ipotizzare qualcosa che vada verso
una riforma delle regole c'è l'alzata di scudi". E infine, non più tardi di
quattro mesi fa: "Due anni fa ho provato a dire che un insegnante a Milano vive
con molta più fatica rispetto a un suo collega ad esempio della Calabria e ho
ricevuto critiche pesantissime. Ma il tema c'è. Perché quando apriamo le scuole
a Milano non abbiamo abbastanza insegnanti?".
Bene: chi può essere mai stato
a proferire tali parole? Un esponente della Lega? Di Fratelli d’Italia? Un
pericolosissimo padano indipendentista? No. Si tratta di Giuseppe Sala, sindaco
di Milano, eletto per due volte sotto l'ombrello del Partito Democratico. Quando
ancora si era in pieno Covid, dunque, il primo cittadino del capoluogo lombardo
– che da lì a breve si stava apprestando a ricandidarsi alla guida della città –
aveva sollevato in maniera chiara e netta il tema dell'elevato costo della vita
a Milano e degli stipendi dei dipendenti pubblici (tra cui anche gli
insegnanti). Soltanto che, a differenza di oggi, all'epoca non si registravano
particolari urla di sdegno nei confronti di Sala da parte del mondo sindacale e
della sinistra parlamentare (ad eccezione dell'allora ministro Beppe
Provenzano). Si vedrà in futuro se il dibattito tornerà in auge in qualche
maniera. Tuttavia, un punto resta sempre inalterato: la faccia tosta della
sinistra.
Sindacati e presidi divisi.
La scuola secondo Valditara, stipendi differenziati su base regionale: il
ministro rispolvera le “gabbie salariali”. Carmine Di Niro su Il Riformista
il 26 Gennaio 2023
Il modello di scuola
di Giuseppe Valditara, neo ministro dell’Istruzione, spacca sindacati e presidi.
Le proposte del ministro, non nuovo ad innescare polemiche come quelle sui
lavori socialmente utili per i ragazzi violenti o sul riscatto che nasce
“dall’umiliazione”, provoca un nuovo terremoto politico, e non solo, con le sue
ultime dichiarazioni.
Per il ministro infatti la
scuola pubblica “ha bisogno di nuove forme di finanziamento, anche per coprire
gli stipendi dei professori che potrebbero subire una differenziazione
regionale. E per trovarle, si potrebbe aprire ai finanziamenti privati”.
Valditara dunque lega il tema
della scuola a quello dell’autonomia differenziata, cavallo di battaglia
della Lega di Matteo Salvini che però trova gli alleati di Fratelli d’Italia
molto più tiepidi.
In sintesi il discorso del
ministro può essere riassunto come una richiesta di stipendi più alti per i
docenti che insegnano nel Nord Italia, dove il costo della vita è più alto.
Di fatto il ritorno alle
“gabbie salariali”, che i sindacati bocciano su tutta la linea. “Credo che
tornare a una differenziazione di gabbie salariali come cinquant’anni fa sia una
follia, il nostro Paese è già abbastanza diviso e non ha bisogno di aumentare le
divisioni”, dice infatti il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini, che
boccia il ‘piano’ Valditara. Per il leader del più importante sindacato italiano
il ministro “anziché fare dichiarazioni che ci portano indietro di
cinquant’anni, dovrebbe porsi il problema di come affrontare la situazione”.
Sonora bocciatura arriva anche
dalla Cisl Scuola, con la con la segretaria Ivana Barbacci che spiega: “Va fatto
salvo il contratto nazionale ma già oggi le Regioni possono assegnare alle
scuole risorse per il personale. Noi siamo drasticamente contrari all’autonomia
differenziata: il contratto nazionale e il sistema di istruzione devono rimanere
nazionali, ma le Regioni, già oggi a normativa invariata, possono sostenere le
scuole in particolari progetti, fornendo incentivi in termini di personale e di
progetti a sostegno dell’offerta formativa”.
Di diverso avviso sono invece
i presidi, che apprezzano la proposta di Valditara sugli stipendi differenziati.
Per Mario Rusconi, a capo dei presidi di Associazione nazionale presidi di Roma,
quella di Valdita “è una misura abbastanza sensata”. Quanto all’ingresso dei
privati nella scuola, “già questo avviene, soprattutto alle superiori e alle
tecniche professionali. Bisogna vedere le condizioni in cui il privato entra, ma
le scuole hanno bisogno di fondi, le risorse a disposizione degli enti locali
non sono molte. E le scuole dovrebbero avere lo statuto di Fondazioni per avere
celerità nello svolgimento dei lavori e risparmio nei costi”.
Parla di “scuola delle
diseguaglianze” invece il Movimento 5 Stelle. Per i grillini infatti “garantire
stipendi più alti al Nord perché il costo della vita è più alto non ha nulla a
che vedere con il merito, né tiene conto degli sforzi enormi che molti docenti
mettono in campo in contesti disagiati, dove la scuola rappresenta il principale
presidio democratico”.
Scoppiata la
polemica, Valditara è stato costretto ancora una volta a fare un passo indietro.
“Non è mai stato messo in discussione il contratto nazionale del mondo della
scuola, non ho mai parlato di compensi diversi fra Nord e Sud; ho solo riportato
una problematica sollevata da alcune regioni riguardo il differente costo della
vita nelle diverse città italiane. Insieme con sindacati e Regioni si ragionerà
anche di questo aspetto, per cercare soluzioni adeguate in favore di docenti e
personale scolastico“, ha voluto sottolineare il ministro dell’Istruzione, a
‘frittata’ già fatta.
Carmine Di Niro. Romano di
nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di
politica, sport e tecnologia
Estratto da blitzquotidiano.it
il 27 gennaio 2023.
Il ministro dell’Istruzione
Giuseppe Valditara ha detto – parlando della scuola pubblica alla piattaforma di
dialogo promossa da PwC e gruppo Gedi “Italia 2023: persone, lavoro, impresa –
che “chi vive e lavora in una regione d’Italia in cui più alto è il costo della
vita potrebbe guadagnare di più”. Tradotto: un professore del Nord dovrebbe
guadagnare di più rispetto a un professore del Sud. Giusto? Sbagliato?
I presidi, o meglio,
l’associazione dei presidi italiani sembra d’accordo. Aumentare gli stipendi al
personale scolastico che vive al nord “è una misura abbastanza sensata”: a dirlo
all’agenzia Ansa, riprendendo le parole del ministro Valditara, è Mario Rusconi,
a capo dei presidi di Anp di Roma. Quanto all’ingresso dei privati nella scuola,
“già questo avviene, soprattutto alle superiori e alle tecniche professionali.
Bisogna vedere le condizioni in cui il privato entra, ma le scuole hanno bisogno
di fondi, le risorse a disposizione degli enti locali non sono molte. E le
scuole dovrebbero avere lo statuto di Fondazioni per avere celerità nello
svolgimento dei lavori e risparmio nei costi”.
Cosa dice il sindacato
I presidi sono d’accordo. La
Flc, sigla che sta per Federazioni Lavoratori della Conoscenza, Cgil no.
(...)
TU DI CHE SCUOLA SEI.
Domenico Pecile su L’Identità il 27 Gennaio 2023.
I docenti possono tirare un
sospiro di sollievo. Perché nel futuro dell’istruzione “ci sarà spazio anche per
l’intelligenza artificiale di cui non si deve avere paura, basta governarla
altrimenti diventa un rischio. I docenti però non saranno sostituiti dai robot”.
Ma è l’unica notizia rassicurante della lunga esternazione del ministro
all’Istruzione, Giuseppe Valditara, non nuovo a uscite a effetto. Sì, davvero
l’unica, perché il resto dell’intervento del ministro pronunciato nel corso del
convegno “Italia 2023: persone, lavoro, imprese”, promosso da PwC e Gruppo Gedi,
sta avendo l’effetto di un terremoto destinato a coinvolgere tutto il mondo
politico e scolastico. Quello che sta già incendiando il dibattito è un
passaggio in particolare del ministro, laddove ha affermato che “chi vive e
lavora in una regione del Nord d’Italia in cui più alto è il costo della vita
potrebbe guadagnare di più”. Insomma, docenti di serie A e di serie B in base
alla collocazione geografica, che altro non farebbe se non divaricare ancora di
più la forbice tra il Nord e il Sud del nostro Paese. Valditara ha pure proposto
di “trovare nuove strade, anche sperimentali, di sinergia tra il sistema
produttivo, la società civile e la scuola, per finanziare l’istruzione, oltre
allo sforzo del governo”. E per evitare il rischio che le aziende prediligano
spendersi per determinati territori, creando disparità nella scuola pubblica, il
ministro ha anche suggerito “la creazione di un fondo perequativo centralizzato
e ministeriale che ci consenta, con i fondi attratti e disarticolazione per un
liceo di Brescia, di finanziare anche uno a Palermo oppure un istituto
professionale a Caserta”. Infine, il suo auspicio, gli insegnanti “devono essere
in aumento sufficiente, avere una preparazione adeguata e garantire la
continuità educativa. Abbiamo già incontrato i sindacati. È questione di
settimane”. E proprio dalla Cgil – che preannuncia ogni tipo di mobilitazione –
arriva una delle prime repliche più dure: “L’idea di salari differenziati per
Regioni in base al costo della vita è totalmente strampalata, ci riporta
indietro di 50 anni, alle gabbie salariali; semmai c’è un problema che riguarda
tutto il personale della scuola: il ministro dovrebbe far finanziare il
contratto che ora vede risorse zero. Il combinato disposto tra ingresso dei
privati e disarticolazione del sistema contrattuale è la distruzione della
scuola pubblica”. In realtà, Valditara incassa il disco verde di Mario Rusconi,
capo dei presidi di Anp di Roma, secondo cui la differenziazione degli stipendi
è “una misura abbastanza sensata. Non solo, ma anche la proposta dell’ingresso
dei privati viene ritenuta percorribile. Di più: “Le scuole dovrebbero avere lo
statuto di Fondazioni per avere celerità nello svolgimento dei lavori e
risparmio dei costi”. Ma quella di Rusconi rimane per adesso un caso isolato.
Tace per adesso la compagine governativa, mentre le opposizioni vanno
all’attacco. “L’idea di stipendi differenziati è una follia degna di un leghista
della primissima ora: finirebbe per tradursi in una grande ingiustizia”, sono
state le parole di Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva. Secondo cui
sarebbe anche auspicabile che il presidente del Consiglio “prenda le distanze
dal suo ministro e il governo la smetta di tirare fuori idee per dividere il
Paese”. Tranchant anche il commento di Peppe Provenzano, vice segretario del
vice capogruppo alla Camera. “L’istruzione pubblica – ha scritto su Twitter –
era pensata per fare gli italiani e unire l’Italia. I ministri Calderoli e
Valditara vogliono definitivamente spaccarla. Fratelli d’Italia o figli di serie
A e serie B? La presidente Meloni tace e acconsente”. Da parte sua Gaetano
Manfredi, sindaco di Napoli ed ex ministro dell’Università, ha sottolineato che
lo stipendio aumentato ai soli docenti del Nord “e non a tutto un corpo di
lavoratori necessario per il Paese e malpagato, sarebbe un errore”, giacché “il
tema sono gli stipendi dei docenti, i salari della scuola sono bassi, e se al
Settentrione c’è il costo della vita più alto, nel Meridione ci sono servizi
erogati poco o nulla. A me piaceva la proposta di pagare meglio gli insegnanti
che vanno a lavorare nelle scuole più difficili, gli istituti di frontiera delle
grandi metropoli. E queste sono al Nord e sono al Sud”. Irene Manzi, capogruppo
del Od in Commissione scuola ha parlato di “parole in libertà” e di “proposta
lunare”, mentre il M5S per bocca dei capigruppo in Commissione Istruzione al
Senato e alla Camera, Luca Pirondini e Anna Laura Orrico hanno sottolineato che
“Valditara getta la maschera e descrive a chi avesse ancora qualche dubbio il
modello che vuole questo governo: la scuola delle disuguaglianze”. Insomma “un
disegno inquietante”.
Estratto dell’articolo di
Alessandra Corica per “la Repubblica” il 28 marzo 2023.
[…] È la Milano dagli affitti
impossibili: basta scorrere l’elenco sterminato di offerte e richieste sulla
pagina Facebook da 28 mila iscritti “Stanze affitto studenti Milano”, per
scoprire due mondi paralleli. Del tutto separati dal prezzo. E ci si fa bene
l’idea di quella città che studia o lavora. Ma fatica a stare dietro ai prezzi
di mercato, inarrivabili per gli studenti fuorisede. Ma spesso anche per le
famiglie del ceto medio.
Secondo le rilevazioni fatte a
fine 2022 dagli operatori immobiliari attivi in città, in un anno a Milano il
prezzo delle case in locazione è cresciuto tra il 10 e il 15 per cento. In
centro per un monolocale il prezzo va dai 1.000 ai 1.500 euro al mese, per una
casa da quattro stanze adatta a una famiglia si va dai 220 ai 300 euro al metro
quadro l’anno. […]
Secondo l’ultimo report di
Scenari Immobiliari, realizzato con AbitareCo, Milano è la terza città più cara
d’Europa, dopo Amsterdam e Lisbona. Per un bilocale si arriva fino a 2 mila euro
al mese. E anche zone periferiche, come per esempio Quartiere degli Olmi e Ponte
Lambro, se anche oggi vedono i prezzi crescere meno, sono destinate a un boom.
Visto che sono previsti progetti come il prolungamento della linea 1 della
metropolitana verso ovest, e la riqualificazione di Santa Giulia a est, che ne
determineranno una crescita.
Con il risultato che il ceto
medio avrà sempre più difficoltà. «È la cosiddetta “fascia grigia”, quella
popolazione che è troppo ricca per accedere a un casa popolare. Ma troppo povera
per stare dietro al mercato della locazione», spiega Massimo Bricocoli, docente
di Urbanistica al Politecnico di Milano e coordinatore scientifico
dell’Osservatorio Casa Affordable, promosso dal Consorzio cooperative lavoratori
di Milano e dalla cooperativa di abitanti Delta Ecopolis in partnership con
l’università. […]
Senza considerare figure come
i dottorandi o gli assegnisti universitari, che guadagnano anche meno». Per
loro, la città è proibitiva. Tanto che si assiste a un’inversione di tendenza:
«Una volta, dopo essere entrati nel mondo del lavoro i giovani mandavano alle
famiglie al Sud le “rimesse” — nota Bricocoli —.Ora è il contrario: i giovani,
pur lavorando, devono chiedere alla famiglia di pagare la casa a Milano ».
Quanto costa comprare casa a
Milano? Oltre 13 anni di stipendio: è la più cara d'Italia. Gino Pagliuca su
Il Corriere della Sera il 10 Gennaio 2023.
Il dossier di Tecnocasa: a Roma
bastano 9,2 annualità e a Firenze 9,1. Nel 2008 Roma prevaleva su Milano, ma il
distacco si è progressivamente ridotto fino al deciso sorpasso
Più di 13 anni senza toccare un
centesimo dello stipendio. Questo è quanto in teoria servirebbe per comprare una
casa da 85 metri quadrati a Milano disponendo di uno stipendio medio. Lo dice
uno studio di Tecnocasa che, mettendo a confronto la retribuzione media e il
costo medio a metro quadro nelle principali città ricava che nel capoluogo
lombardo servono 13,2 annualità di stipendio, a fronte di una media di 6,9
anni. Il calcolo avviene sulla base di un prezzo medio a metro quadrato
computato nel 2022 a 4.138 euro.
A Roma bastano 9,2 annualità e
a Firenze 9,1. In fondo alla classifica Genova con 3,3 annualità. Come si vede
nell’eterno derby immobiliare con la Capitale oggi Milano si trova nettamente
sopra, ma è così solo a partire dal 2019. Nel 2008, che in termini reali
rappresenta ancora oggi l’anno con i prezzi immobiliari più alti in Italia, Roma
prevaleva su Milano: 14,8 contro 14 annualità ma il distacco si è
progressivamente ridotto nel decennio successivo, fino al deciso sorpasso da
parte della nostra città, dove, a differenza del resto del Paese, i prezzi sono
in salita ormai da cinque anni.
Naturalmente dati come questi
sono solo un esercizio statistico, ma resta il fatto incontrovertibile per chi
consulti una qualsiasi fonte attendibile di mercato che Milano ha di gran lunga
i prezzi più alti d’Italia e che questo crea in prospettiva problemi di non poco
conto perché anche gli affitti sono a loro volta molto elevati e la città, che
non è solo quella della narrazione che la descrive abitata solo da
professionisti, dirigenti e giovani rampanti della moda, del design o del
web, potrebbe rivelarsi sempre meno attrattiva per chi svolge lavori
fondamentali ma retribuiti modestamente. Un esempio per tutti: gli infermieri.
Per comprare casa a Bari
servono più di 5 anni di stipendio: i dati. Il 2022 si chiude con rialzi in
tutta Italia, anche per gli affitti. Milano in testa alla classifica. Redazione
online su La Gazzetta del Mezzogiorno l’11 Gennaio 2023
Mattone più caro. E mercato
immobiliare con segnali positivi in Italia, nonostante la difficile congiuntura
nazionale e non solo. Nel 2022 i prezzi delle case in vendita nel nostro Paese
sono saliti del 2% in media rispetto al 2021. A dicembre hanno raggiunto i 2.074
euro al metro quadro. Tra alti e bassi che vedono in testa alla classifica delle
città più care ancora Milano. Seconda Firenze e poi Roma.
A tracciare il bilancio
dell’anno è l’Osservatorio di Immobiliare.it, che fa il confronto anche tra le
grandi e le piccole città, che conquistano un interesse sempre più crescente
(+7,4%). A salire, nell’anno dell’inflazione a doppia cifra, sono anche gli
affitti, aumentati a livello nazionale del 4,8% in un anno.
Il 2022 si chiude, dunque, con
i prezzi delle abitazioni in crescita nonostante una leggera frenata nell’ultima
parte dell’anno. La città dove sono aumentati di più rispetto al 2021 è Trieste,
con un balzo di quasi il 9%, che porta a sfiorare i 2.000 euro al metro quadro.
Ma è Milano che resta la città più cara d’Italia: nel capoluogo lombardo in
media il prezzo al metro quadro di un appartamento supera i 5.100 euro (+4,9%
rispetto al 2021). A seguire si piazzano Firenze, con oltre 4.000 euro al metro
quadro (+1,4%) e poi Roma: la capitale si ferma ad un +1,5% con 3.340 euro al
metro quadro, mentre Napoli è relativamente stabile (+0,7%, quasi 2.700 euro).
Anche Bologna (+4,5%) si avvicina ai 3.300 euro al metro quadro. A Bari rialzo
contenuto allo 0,27% rispetto a dicembre 2021 per l’acquisto: i prezzi si
attestano a 1.872 euro in media al metro quadro. Impennata decisa, invece, per
gli affitti: 9,86 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 10,66%
rispetto a dicembre 2021.
Cifre alte. Tanto che per
comprare casa nelle grandi città servono in media 6,9 annualità di stipendio,
come calcola l'Ufficio studi del gruppo Tecnocasa. Milano si conferma la città
con il maggiore numero di anni necessari: ben 13,2. Seguono Roma e Firenze con
poco più di 9 anni di lavoro. All’opposto le città dove ne servono meno sono
Palermo e Genova (rispettivamente 3,6 e 3,3 annualità di stipendio).
Nella fascia intermedia si
piazza Bari: con 5,2 anni, alla pari con Verona. A Torino invece ce ne vogliono
5.
Gli immobili, intanto, si
preparano a farsi più green. Ma si preannuncia battaglia all’Europarlamento in
vista del primo voto sulla nuova direttiva per l’efficienza energetica degli
edifici, che dovrebbe arrivare il 24 gennaio. Le modifiche proposte al testo
della Commissione europea sono al momento oltre 1.500, che i gruppi politici del
Pe cercheranno di ridurre nei prossimi giorni. La direttiva europea punta su
nuove regole per ridurre i consumi, aumentare l’uso di fonti rinnovabili e
migliorare dunque la classe energetica, fino via via ad azzerare le emissioni.
Così il Sud arricchisce il Nord: sei miliardi
di euro ogni anno si spostano con i fuorisede. La fuga dei giovani verso gli
atenei settentrionali accentua la spaccatura fra due Italie. Ogni anno le
famiglie si dissanguano per mantenere i ragazzi dove potranno trovare lavoro. E
spesso partono anche i genitori. Storia di un trasferimento che nessuno
racconta. Gianfrancesco Turano su L'espresso il 26 ottobre 2023.
Il tram numero 9 dell’Atm di Milano racconta
storie diverse secondo l’ora e il giorno. Intorno al pranzo ci sono i senza
fissa dimora che vanno a mettersi in fila all’Opera San Francesco di piazza
Tricolore, accanto all’hotel di lusso Château Monfort. Nel fine settimana, dalla
sera, il 9 diventa il mezzo di trasporto ufficiale dei giovani in transito verso
i quartieri di movida attraversati dai binari: Porta Venezia, i Navigli, via
Savona. Sono tirati a lucido, parlano di esami e di tesi magistrali. Non temono
di affrontare i conti di bar e ristoranti dove l’autista Atm, con il suo
stipendio da 1500 euro, avrebbe paura a entrare. Come il tramviere arrivato a
Milano in cerca di lavoro, i passeggeri del 9 hanno in larga maggioranza accenti
del Sud appena addomesticati da quel flair meneghino che oggi significa, per
dirla con il Dogui dei film dei Vanzina, «stare in pole position».
Anche quest’anno la meglio gioventù della
borghesia meridionale si è spostata in massa verso gli atenei del Centronord,
quelli che promettono lavoro sicuro e persino qualificato. I politecnici di
Torino e Milano, la Bocconi, la Cattolica, il San Raffaele Vita e salute, la
Sapienza di Roma, Iulm, Lumsa, Ied. Privato è meglio. Si entra più facilmente
anche se si paga di più.
Ma i figli sono pezzi di cuore. Nessuno lo sa
meglio di una madre o di un padre che vivono in un Mezzogiorno travolto dalla
crisi economica, demografica, dove persino le mafie ormai recalcitrano a
investire. I bravi genitori che hanno accettato una decadenza senza fine, in
peggioramento con l’imminente arrivo dell’autonomia regionale differenziata,
gettano il cuore oltre l’ostacolo ogni mese fra tasse di iscrizione e rate di
frequenza che possono arrivare a 20140 euro l’anno, come nel caso
dell’International Md program del San Raffaele, contro un’immatricolazione per
la magistrale in Bocconi a quota 16103 euro.
L’università può non essere la spesa maggiore. A
Milano, soprattutto, ma anche a Torino, Bologna, Firenze, Padova, una stanza in
condivisione a 900 euro entro i confini municipali è un costo ancora economico.
Nello studentato milanese Hines in zona Bocconi (Aparto Giovenale) un vasto
monolocale da 27 metri quadrati va a 1300 mensili. Però c’è lo studio yoga, il
cinema e la palestra, anzi, il gym dove si può fare workout nel Milan
lifestyle.
Per il Campus X Bicocca si può arrivare a 1700
euro, oltre ventimila l’anno. Molti di questi interventi immobiliari privati che
aspirano a togliere i giovani contestatori dalle tende davanti alle facoltà sono
cofinanziati dal Miur in base alla legge 338 del 2000. I genitori, invece, si
finanziano da sé. La combinazione università più affitto può arrivare facilmente
oltre i 30 mila euro l’anno, senza calcolare vitto, abbigliamento, libri e altri
costi più o meno voluttuari.
«È la nuova questione meridionale», dice Luca
Bianchi, direttore generale del centro studi Svimez nato nel dicembre 1946, sei
mesi dopo il referendum monarchia-repubblica stravinto dai Savoia al Sud. «La
migrazione dei talenti e delle competenze negli ultimi vent’anni ha portato a
una perdita di 300 mila laureati al Sud e il saldo dell’ultimo anno disponibile,
il 2021, è di -21 mila, con una quota in crescita. Gli emigrati laureati
aumentano anche quando aumenta l’occupazione perché sono posti a basso valore
aggiunto, nel turismo, nel commercio. Per le immatricolazioni agli atenei del
Centro-nord, invece, si parla di un quarto di iscritti che vengono dal Sud».
Dal rapporto annuale che Svimez presenterà a fine
novembre, l’Espresso può anticipare che ogni laureato vale 150 mila euro di
spesa pubblica. «Questa cifra proiettata sui ventimila che vanno via ogni anno»,
aggiunge Bianchi, «dà 3 miliardi di euro di trasferimento implicito verso Nord.
La contabilità territoriale chiesta dall’autonomia differenziata non ha senso in
un paese integrato come l’Italia e lo svantaggio distributivo patito dal Nord è
un mito».
I costi di investimento pubblico, ovviamente, non
includono la spesa diretta delle famiglie sul mantenimento e, per così dire, la
manifattura del futuro laureato. A volersi divertire con le cifre, il Miur ha
annunciato che nell’anno accademico 2022-23 ci sono state 331 mila
immatricolazioni (147 mila maschi, 184 mila femmine). È una cifra costante negli
ultimi anni. Il 25 per cento di studenti meridionali fuori sede elaborato da
Svimez si traduce in oltre 82 mila partenze. Applicando il criterio di spesa
prudenziale dei 30 mila euro l’anno per ogni studente, il prodotto della
moltiplicazione è di 2,47 miliardi di euro in fondi privati trasferiti dal Sud
al Centro-nord, da aggiungere ai 3 miliardi di spesa pubblica dei laureati.
Comprare casa al rampollo, con la bolla
immobiliare e i mutui alle stelle, significa sborsare non meno di un quarto di
milione, se ci si accontenta di un tugurio. Oltre a questi aspetti più
immediati, il travaso di risorse dal sud verso il nord pone questioni a
medio-lungo termine. Per esempio, la riqualificazione energetica diventa più
facile per un piccolo proprietario foraggiato dagli affitti e riguarda non solo
la cintura urbana dei poli di maggiore attrazione ma anche l’hinterland. È più
facile investire sul rinnovamento a Vimodrone, comune della periferia milanese
sulla metro verde che porta al San Raffaele o magari nelle campagne dalle parti
di Trigoria.
Nota per accogliere il centro sportivo dell’As
Roma e il Campus Biomedico (da 13500 a 18 mila euro l’anno di iscrizione),
Trigoria è a venti chilometri dal centro della città, oltre il Gra. Eppure una
stanza quota intorno ai 500 euro al mese nonostante i posti della facoltà di
medicina siano limitati a 150. In prospettiva dell’invecchiamento dei
genitori-finanziatori, nella vicina Fonte Laurentina è pronto il co-housing per
anziani dell’Over Senior residence. Sempre oltre il raccordo anulare, sulla
Tiburtina c’è l’Unicamillus, parecchio oltre il capolinea della metro B di
Rebibbia, che offre corsi in medicina a 21 mila euro l’anno.
Anche la Hunimed ha rette oltre i 20 mila euro
proporzionate alla sua fama di ateneo internazionale. L’università del gruppo
sanitario Humanitas di Rozzano si è insediata nel comune di Pieve Emanuele, che
negli anni Ottanta era un esempio urbanistico da manuale di ghetto per
meridionali con i palazzoni dell’Incis e il suo residence frequentato da
poliziotti e carabinieri dove il dialetto lombardo era raro come una sera senza
nebbia. Anche qui, il mercato immobiliare si è adeguato verso l’alto.
Gli ultimi dati disponibili sulle immatricolazioni
fuori regione sono spettacolari. Nell’anno 2019-2020 gli iscritti non residenti
erano 64165. La pandemia è passata senza tracce perché nel 2021-2022 sono stati
72994, quasi novemila in più. Le percentuali più alte di fuori regione, manco a
dirlo, sono in Bocconi (72,7 per cento), a Trento (66,5 per cento), al San
Raffaele di Milano (64,1 per cento). Sopra il 50 per cento ci sono le romane
Luiss, Biomedico e Link campus.
La macchina che ha tenuto in piedi il boom
economico del secolo scorso era fatta di contadini o sottoproletari emigrati
verso le industrie del settentrione con le loro rimesse ad alimentare il
Mezzogiorno. Oggi quel sistema è completamente saltato e nemmeno un insegnante
può permettersi la vita da fuori sede al Centronord. In un certo senso, vige la
teoria economica del trickle-down al rovescio. Al posto dei ricchi che
guadagnano sempre di più e che fanno “gocciolare” parte della ricchezza verso
gli strati inferiori della scala sociale, ci sono le famiglie borghesi del Sud
che aumentano il benessere già consistente di chi ha una rendita di posizione
nei centri urbani del Nord. E il fenomeno si allarga dai giovani ai genitori
stessi che, alla lieta novella dell’impiego dei pargoli, ergo della possibile
nuova famiglia, progettano di trasferirsi a fare i nonni con il vantaggio di un
sistema sanitario migliore.
Proiettato in un futuro più vicino, lo scenario
della nuova migrazione diventa catastrofico se l’aspetto di depauperamento
patrimoniale si combina con il cosiddetto inverno demografico. L’Istat ricorda
che nell’anno di grazia 2061, al Sud vivrà il 30,7 per cento degli
ultrasettantenni e nel rapporto dello scorso 12 ottobre dedicato ai “Giovani del
Mezzogiorno” segnala un crollo nel numero di giovani in tutta Italia. Nel
periodo 2002-2022 i cittadini fra 18 e 34 anni sono scesi di 3 milioni dai 10,2
milioni di vent’anni fa. Ma in percentuale il Sud ha perso quasi l’8 per cento
in più del Centronord e questo dato è ancora ottimistico perché gran parte degli
studenti meridionali fuori sede aspetta di avere trovato un lavoro post laurea
prima di cambiare residenza. Altri decidono di fare la triennale al Sud e
prendere la magistrale al Centronord. Il totale è che nelle città meridionali,
durante la stagione accademica, è arduo vedere in giro un ventenne.
«Per i giovani del Mezzogiorno», afferma
l’istituto nazionale di statistica, «la migrazione universitaria, che si attiva
soprattutto verso gli atenei settentrionali, assume proporzioni considerevoli:
coinvolge oltre un caso su quattro all’atto dell’iscrizione, e oltre un terzo al
conseguimento della laurea. Inoltre, il fenomeno della mobilità per studi
universitari nel Mezzogiorno riguarda in misura leggermente superiore gli uomini
rispetto alle donne».
Per un minimo di verifica sociologica basta
guardarsi attorno e ascoltare i discorsi dell’estate, dominati dall’esodo verso
nord dei pargoli appena diplomati. Prendiamo tre coppie. Una è medico più
avvocato. La seconda è bancario più avvocato. La terza è monoreddito con coniugi
divorziati. Qui il caso è aggravato dal fatto, in teoria positivo, che la
diplomata è in classifica sia in un’università privata sia in una pubblica. In
attesa dei vari slittamenti delle graduatorie secondo le scelte dei meglio
piazzati, il padre ha dovuto anticipare 14 mila euro all’Unicamillus che perderà
se la figlia entrerà alla Sapienza. I sei genitori di queste matricole hanno
tutti studiato nell’ateneo di prossimità. In questo caso, si tratta di Messina,
che è stata a lungo il riferimento universitario per parte della Sicilia
orientale e della Calabria meridionale.
È probabile che anche le loro famiglie negli anni
Ottanta del secolo scorso avrebbero potuto sostenere il sacrificio economico di
mantenere un figlio in un ateneo fuori sede. Ma per la generazione dei boomers
sembrava avere meno senso spostarsi verso nord e l’iscrizione in università era
non solo un segno di distinzione sociale ma anche una probabilità maggiore di
trovare posto senza emigrare, grazie al “pezzo di carta” chiamato laurea.
Oggi basta guardare la classifica Censis delle
università italiane pubblicata nel luglio 2023 per capire dove conviene
studiare. Nell’elenco dei grandi atenei privati, con oltre 10 mila iscritti, è
in testa la Bocconi con 90,4 punti seguita a distanza dall’altra milanese,
la Cattolica.
Nei medi atenei privati da cinquemila a diecimila
studenti il podio è: Luiss di Roma, Iulm di Milano e Lumsa, che ha sede nella
capitale con poli a Palermo e a Taranto. Nel pubblico, c’è ancora meno partita.
Fra i mega atenei che contano oltre i quarantamila iscritti, la prima è Bologna.
Seguono Padova, la Sapienza di Roma, Pisa e la Statale di Milano. Palermo è
settima, Bari nona e la Federico II di Napoli decima.
Per trovare traccia di Sud nelle parti alte del
ranking bisogna andare sui grandi atenei, quelli che hanno fra ventimila e
quarantamila iscritti, con l’Unical di Cosenza al terzo posto. L’università
calabrese rimane uno dei rari poli di attrattiva accademica del Mezzogiorno,
soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale. Ha fatto scalpore il colpo
di mercato del rettore Nicola Leone che a settembre ha ingaggiato da Oxford un
luminare dell’Ai come Georg Gottlob. Quest’anno Cosenza-Arcavacata ha anche
inaugurato il suo corso in medicina in concorrenza con l’università della Magna
Graecia di Catanzaro-Germaneto. La sanità è di sicuro un’emergenza in tutto il
Mezzogiorno. Ma c’è da capire quali strutture troveranno i dottori in formazione
che, come dice la madre medico di una delle ragazze in partenza per Roma,
«vogliono tutti fare i dermatologi per entrare nel privato e guadagnare con
l’estetica».
È la stessa logica dei bocconiani che, appena
laureati, finiscono nei i colossi della consulenza come Kmpg, Deloitte, Pwc,
Ernst Young, Boston o nella finanza a lavorare quattordici ore al giorno in
attesa di salire nella scala gerarchica e retributiva.
Magari qualcuno di loro deciderà di tornare al
Sud, sull’onda di crisi di rigetto individuali. Sono i casi che finiscono
raccontati sui giornali in modo consolatorio con titoli come: lavoravo a Goldman
Sachs, oggi allevo capre sui Nebrodi. Con tutto il rispetto per i neorurali, la
macchina dell’economia nazionale non vive di formaggi erborinati ma di fatturati
e asset. Su questo fronte, la spaccatura sotto Roma si fa sempre più profonda.
Una stanza a Milano ora costa 650 euro: «Cifre
assurde, impossibile studiare fuorisede». I costi degli alloggi sempre più
cari. Ma anche discriminazioni di genere, razzismo e contratti in nero. La
ricerca dell'Udu segnala tutte le storture del mercato. Ma le risposte della
politica latitano. Chiara Sgreccia su L'Espresso il 25 Ottobre 2023
“Senza casa, senza futuro”. Sono 20 mila i
fuorisede che hanno partecipato all’indagine realizzata dal sindacato Unione
degli universitari, con il sostegno di Cgil e Sunia sul caro-affitti in Italia.
Su un totale, secondo i dati del Mur, di circa 830 mila studenti che frequentano
l’università in una città diversa da quella in cui hanno la residenza.
La maggior parte racconta di aver trovato un posto
letto con fatica oppure - dichiara il 60 per cento degli intervistati - «con
molta fatica». Il costo medio per una camera è di 430 euro, incluse le spese. La
città peggiore è Milano: qui uno studente paga in media 650 euro per una
singola. Seguono Bologna e Roma dove una stanza costa sui 500 euro.
«Sono cifre assurde, dovute a un’offerta che non
regge il passo con la domanda. Sono costi quasi impossibili da sostenere per una
famiglia media», commenta Simone Agutoli, responsabile Udu per la questione
abitativa: «Così da una parte, molti studenti rinunciano a studiare per i costi
eccessivi, le condizioni degli alloggi e la carenza di soluzioni. E chi decide
di trasferirsi lo stesso, si orienta sempre di più verso la camera doppia». Il
36 per cento degli studenti, infatti, lamenta l’impossibilità di riuscire a
trovare qualsiasi tipo di alloggio. Il 53 per cento spiega come sia a causa
dei costi troppo alti, inaccessibili. Quasi la metà di chi ha risposto al
questionario sottolinea come sempre più spesso le condizioni degli appartamenti
siano poco dignitose: case vecchie, scarsamente manutenute, con servizi o
elettrodomestici non funzionanti, ad esempio.
Dalla ricerca emerge anche il peso delle
discriminazioni nella ricerca di un posto letto. Più frequenti quelle di genere:
i proprietari preferiscono le studentesse. Ma non mancano gli episodi di
razzismo: per il 4 per cento degli intervistati i locatori scelgono a chi
affittare una stanza anche in base alla nazionalità. «Ci preoccupa anche
il nero. Circa il 5,5 per cento degli studenti non ha alcun contratto, con il
primato negativo di Napoli dove un rapporto su quattro risulta essere privo di
contratto scritto», aggiunge Agutoli: «Seguono Catania, Benevento e Palermo
sopra al 15 per cento. Se però aggiungiamo anche le irregolarità parziali, come
cifre non concordate espressamente dal contratto, stimiamo che la percentuale
nazionale di contratti irregolari superi il 10 per cento a livello nazionale».
L’Udu e altre organizzazione studentesche,
come Sinistra universitaria e Cambiare Rotta, da mesi tentano di portare la
questione del caro affitti all’attenzione del Governo, spiegando come nella
pratica si traduca in una limitazione grave del diritto allo studio perché rende
impossibile, per le persone con redditi più bassi, l’accesso all’università.
Contraddicendo quanto sancito dall’articolo 34 della Costituzione secondo cui:
«I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi». E, come conseguenza, rendendo sempre più marcate le
disuguaglianze che segnano l’Italia portando da un lato i giovani a trasferirsi
all’estero. Dall’altro impedendo la mobilità sociale.
«Negli ultimi mesi noi studenti ci siamo
mobilitati. L’abbiamo fatto con le tende, l’abbiamo fatto riempendo di libri le
scale del ministero, l’abbiamo fatto denunciando i costi dell’istruzione in
Italia. Perché studiare in questo paese è sempre più impossibile»,
denuncia Camilla Piredda, coordinatrice nazionale Udu. Non solo per i costi
degli affitti ma delle tasse, dei libri di testo dei trasporti, delle borse di
studio che non arrivano mai: per studiare alle superiori servono circa 2 mila
euro all’anno, all’università più di 12 mila.
Così, seppure fino ad ora sono
rimasti inascoltati, anche dopo aver piantato le tende di fronte a Montecitorio,
gli studenti non demordono. E hanno elaborato quattro proposte da presentare
alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini durante un’incontro previsto
per il 30 ottobre. «Relative non solo al tema abitativo, ma più in generale il
diritto allo studio, i trasporti, la salute mentale, la tassazione studentesca e
la precarietà giovanile. Chiediamo -spiega Piredda - in questa legge di
bilancio, uno stanziamento immediato di 100 milioni per un fondo a sostengo
degli studenti fuorisede. Ma anche intervenire sulle borse di studio con almeno
300 milioni, per aumentarle e garantirle a tutti gli idonei. E di intervenire
sulla leva fiscale e sulla regolamentazione, limitando e disincentivando le
locazioni brevi turistiche, il canone ordinario e lo sfitto. L’ultima richiesta,
collegata al tema abitativo è di prevedere un serio piano di investimenti in
alloggi pubblici, stanziando almeno 3 miliardi sul bilancio pluriennale e
rivedendo il Pnrr. Abbiamo già denunciato come i finanziamenti europei stiano
andando principalmente su alloggi privati, i quali possono arrivare a costare
anche mille euro al mese. Crediamo invece che debbano essere garantiti posti
letto accessibili anche agli studenti più bisognosi. Su questo non ci arrendiamo
e chiederemo conto del lavoro svolto dal Governo».
Estratto dell’articolo di
Niccolò Zancan per “la Stampa” il 20 febbraio 2023.
Ormai è successo. Tutta questa
pianura è diventata una gigantesca periferia di Milano. Risaie e capannoni
dismessi, vecchi borghi agricoli. Piccole città di provincia: Vercelli, Biella,
Santhià, Novara. […] Milano è diventata impossibile. È una specie di miraggio.
Moltissimi la sognano, ma quella città non è più reale. Milano è la città con
gli affitti più cari d'Italia, la quarta città più cara d'Europa. In pochissimi
possono permettersi di abitare sotto la Madonnina, ma pure in periferia.
«Abbiamo il caso degli autisti
che vincono il concorso pubblico per guidare tram e pullman, che sono costretti
a rinunciare al lavoro per ragioni economiche. È praticamente impossibile
trovare un bilocale nella seconda cerchia a meno di 1000 euro al mese. E quando
hai uno stipendio di 1500 euro e sai che le spese per quel bilocale costeranno
non meno di 200 euro al mese, come puoi pensare di accettare il posto?».
[…] «Aumentano le morosità.
Perché sono aumentati i canoni d'affitto. Tanti alloggi sono finiti sulle
piattaforme B&B, sottratti così al mercato degli affitti annuali. Quei pochi
posti che restano a disposizione segnano un +9%.
Non sono degli aumenti, sono
delle impennate. Un monolocale in via Padova va fra 700 e 1000 euro al mese,
mentre anche il costo della vita aumenta sempre di più. Ormai questa è diventata
una città insostenibile. Si vive a Milano solo per due ragioni: per moda - è una
specie di status symbol - o per estrema necessità. […]». […] Milano non è una
città per lavoratori con stipendi sotto ai 2000 euro al mese.
[…] Milano: cioè Gratosoglio,
Sesto San Giovanni, Abbiate Grasso, Cesano Boscone, Rozzano. Periferie con
prezzi più abbordabili. Solo che adesso la grande periferia di Milano si sta
allargando a dismisura, fino a raggiungere un'altra Regione d'Italia, cioè il
Piemonte. […] A Novara hanno costruito alloggi pensati apposta per i pendolari
che vanno a lavorare ogni giorno a Milano. Anche a Vercelli, dove non ferma
l'esosa Alta Velocità, il treno interregionale carica ogni giorno lavoratori al
mattino e li riporta indietro alla sera. […]
Anche la pandemia ha un ruolo
importante in questa trasformazione sociale. Le priorità esistenziali sono
cambiate, così come le abitudini pratiche. […] Se Milano è ormai una città di
lusso, cioè un posto esclusivo e escludente, un posto con il paradosso di 15
mila alloggi popolari vuoti perché mancano i fondi per ristrutturarli, forse si
possono aprire nuova prospettive per altre zone dimenticate d'Italia. […]
Estratto dell'articolo di Diana Romersi per
il “Corriere della Sera” il 9 maggio 2023.
[…]Si allarga la protesta degli studenti
fuorisede, stanchi di dover fare i conti con prezzi proibitivi per stanze
condivise o di pochi metri quadri. Nella Capitale un gruppo di ragazzi della
Sapienza ha deciso di dormire sotto la statua della Minerva. […] replicando la
protesta partita a Milano con l’iniziativa di Ilaria Lamera, studentessa del
Politecnico[…]
Una generazione costretta al campeggio a cui il
governo vuole dare una risposta in tempi brevi. «Abbiamo già creato e assegnato
7.500 posti letto», fa sapere la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini.
Si tratta di una prima tranche di 60 mila posti da realizzare con il Pnrr entro
il 2026.
«Per la prima volta dormo a Roma», scherza seduto
su un materassino all’interno di una tenda Damiano Carbonari, 20enne di
Civitavecchia, iscritto al primo anno di Storia alla Sapienza. Il ragazzo
racconta di aver provato a trasferirsi nella Capitale ma il costo degli affitti
glielo ha impedito. «Una stanza singola in quartieri limitrofi all’università
non costa meno di 500 euro — spiega —, ma in zone come piazza Bologna o San
Lorenzo può arrivare anche a 600 o 700. E stiamo parlando di una stanza, non
dell’intero appartamento...». […]
Solo alla Sapienza «gli studenti fuorisede sono 40
mila, un terzo di tutta la popolazione dell’ateneo», dicono da Sinistra
universitaria, promotrice della protesta con le tende.
I posti letto messi a disposizione da DiscoLazio,
l’ente regionale per il diritto allo studio, sono poco più di 2.800. «La
situazione è ormai insostenibile», osserva il coordinatore di Su, Leone Piva.
[…] Ilaria Lamera, la studentessa bergamasca che
ha dato il via alla protesta, ha smontato la sua tenda ma nei giorni scorsi ne
sono state sistemate altre undici […] Nel frattempo, il dicastero
dell’Istruzione ha istituito un gruppo di esperti per dare risposte sul tema
degli alloggi e del diritto allo studio. La ministra Bernini ha firmato un
decreto, in attuazione delle misure previste dal Pnrr, che istituisce un gruppo
di lavoro interministeriale: ai tecnici è stato chiesto di individuare il costo
medio calmierato per ogni posto letto a livello territoriale, tenendo conto dei
valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello
di servizi offerti. Inoltre, è prevista una riduzione del 15% sul costo finale
per posto letto.
«Il mio obiettivo e quello del governo è fare
presto, ma farlo bene», ha sottolineato Bernini. «Sul diritto allo studio sin
dalla prima riunione siamo stati tutti d’accordo: servono più risorse. Le
abbiamo trovate, mettendo ulteriori 400 milioni per creare 14 mila nuovi posti
letto (che si sommerebbero a quelli del Pnrr, ndr ). Ma non ci fermiamo», […]
Milano, caro affitti:
Ilaria, studentessa, dorme in tenda davanti al Politecnico: «Troppi 700 euro al
mese, impossibile vivere». Matteo Castagnoli su Il Corriere della Sera il 3
maggio 2023.
Ilaria Lamera, 23 anni, studia
Ingegneria ambientale al Politecnico di Milano. La protesta contro i canoni alti
per gli affitti: «Non posso permettermi una stanza. Spero che il sindaco Sala
venga a trovarmi»
«Prima di trovare una casa a
Milano ero disperata. È davvero estenuante fare avanti e indietro. Un giorno mi
sono detta: “Quanto vorrei avere una tenda e dormire qua". E alla fine l'ho
fatto davvero». Dal termine della sessione d’esami invernale, quando le è venuta
l'idea, sono passati un paio di mesi. Ed ecco fatto. Il desiderio si realizza
sotto forma di protesta. Ilaria Lamera ha 23 anni e fino a domenica abiterà in
una tenda in piazza Leonardo da Vinci. A pochi passi dal Politecnico, dove
frequenta il quarto anno di ingegneria ambientale.
Ilaria a Milano non ha mai
vissuto. O meglio, non ha potuto farlo per i prezzi delle case troppo elevati.
Faceva la pendolare dalla sua Alzano Lombardo qualche giorno alla settimana. Poi
le lezioni online si sono ridotte, e gli spostamenti in treno sono diventati
sempre più frequenti. Quindi l’esigenza di una sistemazione. «Avevo
trovato singole da 700 euro mensili, spese escluse», spiega mentre invita ad
accomodarsi su due cartoni che servono da ingresso di casa sua: «Prego, anche se
sono un po’ accampata». Felpa rosa, tenda grigia e piumone verde, davanti a lei
un cartello bianco, scritte nere. Recita: «Basta affitti insostenibili.
#Scoppiamolabolla». Firmato Ilaria. La sua protesta è in corso.
L’origine di tutto?
«Quando a settembre ho iniziato
a cercare un alloggio a Milano. Erano tutti molto costosi o in situazioni
disagiate, senza contratto o senza finestre. Poi ad inizio aprile ho trovato una
stanza a 600 euro al mese».
Cioè? Si è sistemata?
«Sì, ma è un contratto
transitorio di 4 mesi. A luglio sarò nella stessa situazione di prima, ma
intanto sono felice, pur addormentandomi con la consapevolezza che finirà».
Quindi la scelta di abitare in
tenda proprio ora che una casa ce l’ha, sia pure per poco, è simbolica.
«Esatto. Penso a come vivrei se
non avessi trovato un alloggio. A tutti quelli nella mia situazione».
La protesta com’è stata
oganizzata?
«Ne ho parlato con i ragazzi di
Terna Sinistrorsa, una lista degli studenti del Politecnico. Ci siamo trovati
d’accordo e abbiamo pianificato. Ora sono candidata come rappresentante a
Ingegneria ambientale per le elezioni del 23 e 24 maggio».
Quanto rimarrà qui?
«Fino a domenica sera. Come da
accordi con la Questura, verso le 20 smonterò la tenda. Sono arrivata martedì
alle 14 direttamente da Bergamo».
Sta frequentando le lezioni
intanto?
«Questa settimana non andrò. Ho
deciso di saltarle perché la mattina mi alzo stanchissima».
A proposito, com’è ora una sua
giornata tipo?
«Anzitutto la notte fa freddo,
ma sono coperta bene. Non ho paura. C’è sempre un ragazzo sveglio che fa la
guardia, ma ora è a casa a dormire. Poi passa gente che chiede se ho bisogno di
qualcosa, cibo o compagnia. E studio: ho qui i libri e il tablet».
Iaccarino: «Giovani e futuro:
il prezzo da pagare a Milano, città-desiderio»
Basilio Rizzo su Milano: «È
diventata una città per soli ricchi, esalta le disuguaglianze. Il Pd? Oggi
rappresenta i ceti medio alti»
Milano, i prezzi degli affitti
volano: tutte le «trappole» per chi investe nel mattone (e il caso clamoroso dei
negozi)
Prezzi delle case a Milano,
dentro la «cerchia della 90» non si scende sotto i 6 mila euro al metro. Più a
est i prezzi crollano: 3,5 mila a Segrate, 2 mila a Settala e Tribiano
Case popolari a Milano, la
proposta di Maran: nuova società e affitti calmierati per i fragili
Ma non c’è la corrente.
«Qualche amico va in università
a ricarcarmi telefono e tablet quando si scaricano. Stamattina ho fatto un salto
anch’io per lavarmi i denti. Alla sera, invece, vado per un’oretta a casa a fare
la doccia».
Venerdì sera, qui in piazza
Leonardo, ci sarà il Botellon.
«Sì, ci stiamo organizzando per
transennare l’area intorno alla tenda. Nel pomeriggio, probabilmente, terremo
una conferenza con un professore di Urbanistica dell’università».
Aveva già dormito in tenda
prima?
«Vado spesso in montagna con
genitori o amici».
Appunto… e i suoi genitori?
«Sono molto fieri di me. Mi
supportano. Erano solo un po’ preoccupati: vogliono sempre essere sicuri che ci
sia qualcuno che sorveglia. Però sono andati a comprarmi la tenda e il
materassino».
Cosa chiedete con questa
dimostrazione?
«Noi vorremmo un tetto massimo
per gli affitti. Ovviamente partendo dalla nostra categoria, ma poi ci rendiamo
conto che il problema casa coinvolge anche disoccupati e pensionati, per
esempio. Bisognerebbe mettere gli studentati a prezzi accessibili. Ora costano
quanto le case».
Come rappresentanze degli
studenti milanesi avete aperto dei tavoli con il Comune.
«Vero, erano presenti Elena
Buscemi, Angelo Turco e Federico Bottelli. Crediamo però servano dimostrazioni
concrete».
Qualcuno si ferma a parlare con
lei in tenda?
«Qualche ragazzo mi fa i
complimenti per il coraggio. Sono passati anche proprietari di case che
lamentavano le tasse troppo alte».
Membri delle istituzioni?
«Mercoledì è passato
Pierfrancesco Majorino. Abbiamo parlato di stanziamenti comunali e delle 15mila
case sfitte dell’Aler. Poi mi ha passato la segretaria pd Elly Schlein. Volevo
arrivare a lei: non pensavo di riuscirci in due giorni».
Che cosa le ha detto?
«Mi ha ringraziata e mi ha
raccontato le lotte sul tema fatte a Bologna e che porterà avanti come
opposizione. Le ho risposto che il problema va risolto in tutta Italia. E in
fretta».
Il sindaco Sala?
«Non ancora».
Il rischio è che da domenica
non se ne parli più. Come terrete vivo l’argomento?
«Questa protesta vuole essere
il pretesto per creare e mantenere un legame con le istituzioni, per far sì che
avvenga qualcosa di concreto. Altrimenti questa sarà la vita a Milano, con
affitti a 600 euro al mese. Comunque, va detto, abbiamo avviato un tavolo».
Qual è l’auspicio?
«Mi piacerebbe che altri
studenti si unissero a me con le tende. Li aspetto!».
Estratto dell’articolo di Chiara Baldi
per milano.corriere.it su Il Corriere della Sera il 12 maggio 2023.
Ilaria Lamera arriva a Palazzo Marino per
l’incontro con il sindaco Beppe Sala e i rettori degli atenei milanesi,
accompagnata da alcuni collettivi studenteschi. La 23enne studentessa del
Politecnico di Milano, che la scorsa settimana ha letteralmente piantato le
tende in piazza Leonardo Da Vinci per protestare contro il caro affitti che
colpisce gli studenti, è rientrata nella sua casa milanese dopo aver trascorso
qualche giorno ad Alzano Lombardo, il comune della Bergamasca da cui proviene. È
però pienamente consapevole del «casino» che ha scatenato e, al vigile che la
ferma all’ingresso del Comune, dice: «Ma io sono quella delle tende!».
Com’è nata l’idea della protesta?
«Dopo mesi che facevo la pendolare, ho iniziato a
cercare un alloggio a Milano rendendomi conto che le stanze erano tutte dai 700
euro al mese in su spese escluse. […] L’idea della tenda mi è venuta un giorno
che ero molto stanca e non volevo tornare a Bergamo».
Hai voluto metterci la faccia per quelli che non
avevano le possibilità pur avendo difficoltà economiche anche maggiori delle
tue?
«Ci ho messo la faccia perché sono così di
carattere: se credo in una battaglia, la faccio».
Ora hai affittato una stanza: come hai fatto a
trovarla?
«La casa che ho trovato l’ho presa a inizio
aprile, prima della protesta. Ci ho messo 8 mesi e ho rifiutato offerte da oltre
700 euro a stanza. È la mia prima casa a Milano e sono già molto fortunata a
potermela permettere. La condivido con una ragazza che paga la mia stessa
cifra».
Ti aspettavi tutto questo successo e la
solidarietà per la tua protesta?
«Volevo fare questo casino ma non me l’aspettavo
assolutamente. Sono molto contenta che in tutte le città d’Italia si stiano
unendo a me. Dagli studenti mi aspettavo solidarietà ma mi ha stupito quella di
un’intera nazione, anche di chi non vive una situazione di difficoltà». […]
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha
detto che il caro affitti affligge solo le città di centrosinistra… Cosa ne
pensi?
«Ho visto le dichiarazioni. E ho visto che la
ministra dell’Università Anna Maria Bernini gli ha risposto di farsi gli affari
suoi se non mi sbaglio e io sono d’accordo con lei. In ogni caso la mia protesta
la definisco apartitica e non mi interessano la sinistra o la destra». […]
Matteo Castagnoli per il “Corriere della Sera -
Edizione Milano” venerdì 7 luglio 2023.
Due mesi dopo, in piazza Leonardo da Vinci è
rimasta solo una tenda. Un simbolo inabitato, e con i lati accartocciati. Era il
2 maggio quando la studentessa bergamasca Ilaria Lamera piantava la prima
«canadese» davanti al Politecnico. È lei ad aver dato il via alla protesta
contro il caro affitti a Milano, dove si è arrivati al record di 58 tende in
piazza.
E da lì l’iniziativa è stata replicata in tutta
Italia. Ilaria adesso è tornata alla vita da universitaria. «In quei giorni fare
altro è stato difficile. Ho iniziato la sessione mercoledì e spero di dare
almeno un paio d’esami». […]
Ilaria, un bilancio dei risultati raggiunti?
Soddisfatti?
«L’obiettivo era sollevare il tema e portare
l’opinione pubblica a parlarne. Non avevamo l’ambizione di risolvere una
questione di questo genere in pochi mesi».
Dal tavolo con il sindaco Beppe Sala a Palazzo
Marino l’11 maggio, all’occupazione della Casa dello Studente in viale Romagna:
avete lanciato segnali chiari alla politica.
«Sì, ma potevano sbilanciarsi un po’ di più. Non
abbiamo visto tutta quella volontà politica che ci aspettavamo. In particolare
dalla Regione e dal Governo non ci siamo sentiti ascoltati. Inoltre, la Casa
dello Studente dimostra che posti sfitti da riconvertire e sistemare ce ne
sarebbero. Questo tamponerebbe il problema».
[…]
In piazza Leonardo è rimasta una tenda. Non è la
fine della protesta?
«Assolutamente no, il clima di giugno, la sessione
e gli impegni personali hanno imposto un stop delle notti all’aperto. Ma andremo
avanti fino a quando non avremo qualcosa di concreto».
Passando proprio dov’eravate accampati, ora ci
sono altre tende di senzatetto che hanno dovuto mollare tutto. Vi cercavano.
Chiedevano un confronto, una manifestazione congiunta.
«Non lo sapevamo. Ma abbiamo protestato anche per
loro, non solo per i fuorisede.
Da maggio a giugno, quasi tutti i giorni, facevamo
assemblee aperte alle 19 per discutere del futuro. […]».
La prossima assemblea sarà dopo l’estate, il 16
settembre.
«Sì, sarà lì che la questione affitti e case si
ripresenterà. e per questo abbiamo pensato di convocare una riunione nazionale
per far convergere tutte le realtà e i singoli sul tema abitativo».
Un’altra nota, più triste, che ci si appunta
passeggiando per piazza Leonardo, è la quantità di rifiuti che è stata
abbandonata.
«È vero, me ne sono accorta anche io. Avevamo
messo dei tavoli e delle panchine per le nostre assemblee che dovremo togliere,
come il gazebo bianco strappato, e che nel frattempo vengono utilizzati da
chiunque come ci si trovasse in un parco pubblico». […]
Fuori sede. Finalmente l’università sta
diventando di massa, ma l’Italia non è ancora pronta. Gianni Balduzzi su
L'Inkiesta il 17 Maggio 2023.
Nel nostro Paese non si è mai pensato seriamente a
finanziare forme di welfare studentesco perché la percentuale di italiani con
genitori laureati è la più bassa in Europa
Finalmente i ragazzi italiani scelgono di fare
l’università. Una buona notizia per il Paese penultimo in Europa per percentuale
di laureati sulla popolazione. Ma come dimostrano le proteste per gli alloggi
nelle sedi delle università più grandi, non siamo pronti a questo fenomeno.
Eppure non è nuovissimo. Vi era già stato un aumento del numero di iscritti
negli atenei italiani tra il 1999 e il 2003, ma dopo sette anni di stabilità
erano seguiti cinque anni di discesa, legati alla crisi economica e al calo
demografico. Da allora però l’aumento è ripreso: anche considerando la leggera
riduzione nell’anno accademico 2021/22 rispetto al precedente, in sei anni vi è
stato un incremento del 10,4 per cento, che contrasta con la contemporanea
riduzione dei ventenni nel nostro Paese. Erano sei milioni e
trecentosessantacinquemila nel 2015 e sono diventati sei milioni e tremila nel
2021.
Non abbiamo visto arrivare questo fenomeno perché
la sua crescita non è stata omogenea, ma si è concentrata in alcune aree, quelle
già più avanzate del Paese. Secondo i dati del ministero dell’Università nel
2010/11 negli atenei dell’Emilia Romagna erano iscritti quattromila studenti in
meno che in quelli della Sicilia e 52.400 meno che in quelli della Campania.
dodici anni dopo superavano quelli di entrambe le regioni Allo stesso tempo se
all’inizio dello scorso decennio gli universitari che avevano scelto sedi
lombarde erano solo novemila in più di quelli che frequentavano quelle del
Lazio, nel 2022/23 erano diventati 64.100 in più. Insomma, ad avere attirato gli
studenti sono stati gli atenei lombardi, emiliani, piemontesi, mentre per quelli
del Sud vi è stato un crollo.
Questo trend è stato evidente sia nel corso di
tutto lo scorso decennio che nel periodo di generale aumento degli iscritti
cominciato dal 2015/16, che ha visto sempre Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia
prevalere tra le maggiori regioni quanto a incremento dei frequentanti. La
stessa tendenza è visibile anche per quanto riguarda l’origine degli studenti.
Gli atenei del Mezzogiorno si svuotano anche perché dal Sud e dalle Isole
semplicemente vengono meno universitari, mentre crescono quelli del Centro-Nord.
Gran parte di questo divario è causato dalle divergenze demografiche: negli anni
c’è stato un crollo nel numero dei ventenni del Sud che non si è verificato
altrove.
Le sedi universitarie in cui c’è stato un
incremento in doppia cifra sono state Torino, il Politecnico di Milano, la
Cattolica, sempre nel capoluogo lombardo, nonché Padova; mentre per Bari e
Catania vi è stato un crollo.
Per comprendere l’attuale emergenza degli alloggi,
però, è utile capire che a Milano, per esempio, l’aumento delle iscrizioni non è
dovuto solo al numero sempre più grande di giovani lombardi che fa l’università,
ma c’è anche un altro aspetto: crescono a un ritmo maggiore quanti vengono da
fuori regione. Prendiamo per esempio il Politecnico di Milano, la percentuale
di lombardi in sei anni è scesa dal 74,2 per cento al 55,6 per cento. È
aumentata quella degli stranieri, che è arrivata all’11,3 per cento, quella dei
meridionali che è passata dall’8,3 per cento all’11,5 per cento, di coloro che
vengono dal Centro e dal resto del Nord.
Gli atenei più attrattivi sono in grandi città del
Nord o in centri che hanno già importanti tradizioni universitarie. E
all’aumento degli studenti si affianca la loro concentrazione. È qualcosa che si
è già visto da tempo in tutta Europa. Però a differenza che in altri Paesi in
Italia sono presenti peculiarità che rendono il fenomeno non solo nuovo, ma
anche più sfidante per il sistema Paese. Basta guardare la statistica
sul background dei genitori: solo il 34 per cento degli universitari italiani è
a sua volta figlio di un laureato, è la percentuale più bassa d’Europa. In
enorme ritardo è in atto un cambiamento generazionale.
Questo spiega anche perché nel nostro Paese non si
è mai pensato seriamente a finanziare forme di welfare studentesco, studentati,
incentivi economici per chi decide di proseguire gli studi. In fondo una volta
fare l’università era appannaggio di una ricca élite, non un fenomeno di massa
come sta diventando ora. Non a caso sono solo il 10 per cento gli iscritti che
ricevono una borsa di studio, contro il 63 per cento francese o l’89 per cento
svedese, e allo stesso tempo solo il 24 per cento lavora mentre studia, molto
meno del 47 per cento tedesco, ma anche del 59 per cento polacco.
La mancanza di strumenti come i mini-job tedeschi,
pensati anche per gli studenti, si fa sentire. Non stupisce che in assenza di
sostegno economico pubblico o di sostentamento proveniente dal lavoro la
maggioranza degli universitari viva con i genitori, il 68-69 per cento a seconda
dell’età, contro una media europea che non va oltre il 46 per cento neanche nel
caso dei più giovani, i 20-22enni. Se la quota di quanti stanno da soli o con
altri inquilini non è molto lontana da quella che si ritrova in altri Paesi a
fare la differenza è la percentuale di quelli che stanno in studentati, il 23%
nel caso dei 20-22 anni nella Ue e solo il 7 per cento in Italia.
In sostanza l’Italia soffre problemi di
affollamento presso le sedi universitarie, simili a quelli che vivono altre
grandi città europee (per esempio Amsterdam) nonostante in realtà nel nostro
Paese la proporzione di studenti sul totale della popolazione sia ancora molto
più bassa.Cosa succederebbe se dovessimo diventare veramente europei, se a
proseguire gli studi fossero più di metà di quanti si diplomano?
Si parla molto del fatto che in tanti non vogliono
fare pendolarismo, che vogliono per forza studiare e abitare a Milano, che ormai
è una Mecca per i giovani, l’unica città veramente cosmopolita italiana. È
normale, a vent’anni (ma non solo) le mode e il passaparola influenzano
moltissimo, è sempre stato così. Possiamo anche commentare, con molte ragioni,
che ci si deve rassegnare a cercare casa più lontano, a Lodi, a Bergamo, in
Brianza, ma dobbiamo anche fare i conti con la realtà.
Siamo di fronte a una tendenza ineluttabile,
quella a spostare il centro delle attività umane nei grandi centri, abbandonando
la provincia, è un trend mondiale e non si può fermare con l’invettiva o con
l’ironia contro i giovani pretenziosi. La si deve accettare e governare. Anche
se riuscire a trovare risorse economiche distogliendole ai tesoretti e alle
misure per pensionati e pensionandi è molto più difficile che ignorare o
guardare con sufficienza gli studenti che protestano.
Tende, Sallusti inchioda gli studenti: "Non è
mai morto nessuno!" Libero Quotidiano il 13 maggio 2023
Continua la protesta delle tende, con gli studenti
che denunciano il caro affitti e si scagliano contro il governo. Se ne parla
anche a L'Aria Che Tira, dove Alessandro Sallusti dà una lezione ai giovani.
"Stiamo mettendo assieme troppe cose che solo apparentemente c'entrano l'una con
l'altra". Il direttore di Libero ricorda che "stiamo parlando della carenza di
poli universitari attrezzati". Eppure - spiega nella puntata di venerdì 12
maggio su La7 -. Non è un problema che esiste da oggi e non è risolvibile al 100
per cento". Il motivo è semplice: "Se l'università ha diecimila iscritti, non è
che può avere altrettanti alloggi da mettere a disposizione o gratuitamente o a
tariffe convenzionate. Non vorrei che questo problema reale diventasse la
pretesa di vivere a chilometro zero. Non è che il lavoro deve essere fuori casa
e l'università a portata di passeggiata a piedi in 5 minuti".
Da qui l'aneddoto raccontato davanti alle
telecamere di Myrta Merlino: "Io non mi sono laureato, ma i miei amici di
Como che hanno fatto buoni studi hanno fatto i pendolari con Milano per 5 anni
e non è mai morto nessuno. Abbiamo una carenza di servizi per casi veri, ma non
si può pretendere che tutti vivano a costo zero di fianco all'università".
Non è della stessa idea la conduttrice, che già
nella puntata di ieri si è presentata in studio in tenda. "Oggi - risponde -
sono cambiate tante cose. Lo studio e il primo lavoro non ti danno la garanzia
di andare avanti. Una volta il sacrificio ti dava la sensazione di farlo per
qualcosa, ora no".
Gli affitti e la parodia della lotta di classe.
Visto che non siamo nella vecchia DDR la filosofia dovrebbe essere più
concreta partendo dal presupposto che almeno in questo angolo del mondo la
parodia della lotta di classe ha fatto il suo tempo. Augusto Minzolini il 12
Maggio 2023 su Il Giornale.
Che la questione degli affitti troppo alti per gli
studenti, e non solo, in città come Milano, Roma e via dicendo, esista non lo
nega nessuno. Come nessuna persona onesta intellettualmente può affermare che
sia nata ora. Semmai l'ha resa più drammatica un'inflazione galoppante e un
carovita alle stelle. È un'analisi talmente condivisa che l'altro ieri Matteo
Salvini ha mobilitato il suo ministero sull'argomento e ieri il governo ha
subito assunto i primi provvedimenti. Il problema semmai sono i modi con cui
bisogna approcciarsi al problema e le politiche da adottare. E qui, come non
mai, passa la linea di confine che divide il pragmatismo dall'ideologia. È una
questione culturale prima che politica e riguarda quel richiamo della foresta
che porta spesso la sinistra, specie quella massimalista, a reiterare gli errori
di un tempo. A lanciare stramberie da socialismo reale come la requisizione
degli alloggi o l'uso della leva fiscale per indurre i proprietari di case ad
affittare anche se sono restii.
Visto che non siamo nella vecchia DDR, nè nel
Venezuela di Chavez o di Maduro la filosofia dovrebbe essere più concreta
partendo dal presupposto che almeno in questo angolo del mondo la parodia della
lotta di classe ha fatto il suo tempo. Anche perché se si parte con il piede
giusto si trova un punto d'incontro. Il Pd, ad esempio, ha lamentato nei giorni
scorsi la cancellazione del Fondo per gli affitti di 330 milioni. Ebbene, ieri
il governo lo ha raddoppiato mettendo a disposizione dell'housing universitario
660 milioni. Non ci siamo, invece, quando il partito della Schlein parla di
disincentivi fiscali per case vuote: qui torna in auge l'impostazione
ideologica, perché un proprietario di casa può disporre come vuole dei propri
immobili. E sicuramente non risolvi i guai mettendo la camicia di forza al
mercato, semmai usando la vecchia legge della domanda e dell'offerta di stampo
liberale: l'unico modo per abbassare i prezzi, infatti, è aumentare l'offerta
non con metodi coercitivi, ma mettendo a disposizione quell'enorme patrimonio
immobiliare dello Stato che non è utilizzato o, ancora, costruendo alloggi.
Il piano casa di Fanfani fu uno dei vettori del
boom economico nel dopoguerra. Visto che non si sa come spendere i soldi del
Pnrr se i governi Conte e Draghi, che hanno stabilito le linee d'intervento dei
progetti, fossero stati più avveduti, avrebbero potuto indirizzare parte delle
risorse agli alloggi degli studenti, invece, che agli stadi. E l'Europa non
avrebbe avuto nulla da obiettare. Ma a parte ciò, è insopportabile la
speculazione politica sulla pelle della gente, in questo caso, degli studenti.
Nè tantomeno convince una nouvelle vague radicale a sinistra quando prospetta
politiche che sono solo la riedizione di totem datati: un simile atteggiamento
rischia solo di fornire la prova che da quelle parti spira un vento vecchio non
certo nuovo. Come pure, sull'altro versante, è fin troppo scontato
l'atteggiamento di una maggioranza che polemizza usando il vecchio ritornello:
«perchè la sinistra non lo ha fatto quando era al governo?». È uno stile da
opposizione. Chi è nella stanza dei bottoni risponde con i fatti. Magari, come
ha fatto ieri, raddoppiando i fondi.
"Affitto folle e metà in
nero", gli studenti di Bologna sotto ricatto degli speculatori. Marco
Bettazzi su La Repubblica il 12 Maggio 2023
Sono 40mila i fuorisede che
studiano in città. Il 44% abita nel centro storico. Circa 600 i casi di affitto
sui quali le Fiamme gialle stanno cercando di fare luce
A Bologna si contano 40mila
studenti fuorisede. E nel centro storico quasi un abitante su quattro è un
universitario. Una popolazione che riempie da secoli, oltre alle aule
dell'ateneo e ai locali di Piazza Verdi, cuore pulsante della cittadella
universitaria, anche le tasche di generazioni di bolognesi che proprio
sull'accoglienza degli studenti hanno costruito una delle fonti di ricchezza,
non solo culturale, del capoluogo emiliano.
Proprio per questo ai tanti
cittadini corretti (siamo pur sempre nella "città più progressista d'Italia",
come ama definirla il sindaco Matteo Lepore), si sono sempre accompagnati
fenomeni di sfruttamento che hanno riempito le chiacchiere nei bar di via
Zamboni, gli incontri dei collettivi e, oggi, le bacheche social dei gruppi nati
per trovare un alloggio ai tanti che arrivano da fuori regione. Tra camere
impossibili, letti improvvisati ma pagati a caro prezzo, e il caro vecchio
affitto "in nero".
"Mia figlia ha studiato sei
anni in città - racconta la madre di una neolaureata di Giurisprudenza,
siciliana - Eravamo in difficoltà per cercare una casa e già nel 2017 ci siamo
rivolti a un'agenzia immobiliare che ci ha trovato un bell'appartamento in
Strada Maggiore, in pieno centro, per un buon prezzo, 465 euro al mese ciascuna
per mia figlia e la sua coinquilina. La proprietaria, una signora che abita sui
colli di Bologna, ci aveva fatto un contratto a canone concordato, ma era solo
per 215 euro ciascuna. Il resto, ogni mese, veniva pagato fuori busta".
Con una conseguenza spiacevole,
che la possibilità di scaricare le spese per la figlia ai genitori veniva,
ovviamente, riconosciuta soltanto sulla metà "in chiaro". "Noi stavamo di fronte
alla stazione, pagavamo dai 400 ai 550 euro al mese per una singola, spese
comprese - racconta un'altra ragazza - Il proprietario ci ha contattato su
Facebook perché vedeva che rispondevamo agli annunci e ci ha proposto di
affittare la sua casa, ma il contratto non ci è mai stato proposto, abbiamo
sempre pagato in contanti. Abbiamo accettato perché la posizione era comoda ed è
difficile trovare un'altra casa".
Proprio per contrastare gli
affitti in nero, di recente Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, Regione e
Università hanno dato vita a un gruppo di lavoro che si concentra sia sulla
comunicazione - con stories sui social e guide video per l'affitto, per spiegare
agli studenti diritti e vantaggi legati al contratto regolare - sia sulla
repressione. "Con la possibilità di incrociare le banche dati è sempre più
difficile sfuggire ai controlli", avverte Ivan Bixio, comandante della Finanza
di Reggio Emilia e responsabile del gruppo di lavoro. Proprio in questo modo, a
marzo hanno individuato 1.900 posizioni sospette, di cui 600 a Bologna, che
tecnicamente hanno "elevati indici di rischio", spiegano gli esperti.
"Si tratta di studenti che
hanno un domicilio o un'utenza aperta in città, ma non sono titolari di un
contratto d'affitto. Faremo verifiche più approfondite e poi andremo a colpire
in maniera mirata chi specula sugli studenti fuorisede", continua il colonnello,
che si rivolge direttamente agli studenti invitandoli a denunciare gli abusi.
"Di denunce ne arrivano, ma è un aspetto minoritario - spiega Bixio - anche
perché molti ragazzi non hanno chiaro che un contratto conviene, per esempio in
termini di vantaggi fiscali, sia per loro che per le loro famiglie".
Dall'analisi sono emersi anche
300 B&b potenzialmente abusivi, che ora verranno controllati più nel dettaglio:
un altro aspetto che spiega la "febbre alta" sul tema casa che colpisce Bologna
come tante altre città universitarie d'Italia. "Noi non siamo né speculatori né
Paperon de' Paperoni", si difenze Enrico Rizzo, presidente dell'Asppi, che
rappresenta 10mila famiglie proprietarie di immobili. "I nostri associati usano
gli incassi per arrotondare la pensione o pagare le residenze per gli anziani, e
vengono da tre anni di grande difficoltà a causa della pandemia. Non sono certo
speculatori. Fare del "nero" oggi - aggiunge - è una follia, proprio da matti
con tutti i controlli che ci sono".
"Noi pensiamo che l'aspetto
preventivo sia molto importante, anche più della repressione delle irregolarità
- continua il colonnello Bixio - Ma una cosa si può dire: con tutti i dati che
abbiamo a disposizione le anomalie emergono più rapidamente. Le probabilità di
non essere intercettati diminuiscono".
Estratto dell’articolo di Alessandro Gonzato
per “Libero quotidiano” il 12 maggio 2023.
Myrta entra in tenda e il popolo social non glielo
perdona. «Ovviamente lo fa ora che al governo c’è il centrodestra», scrive un
utente su Twitter - seguito da tanti altri - «come quando si mise in ginocchio
per George Floyd e il presidente degli Stati Uniti era Trump. Dopo quando con
Biden hanno ucciso altri di colore non l’ho più vista in ginocchio, come tutto
il mainstream. Il caro affitti c’è da anni, Myrta». In ginocchio. Era il “Black
lives matter”, “Le vite dei neri contano”.
La Merlino, signora della televisione e regina de
La7, durante la sua Aria che Tira ieri si è infilata in una tenda piazzata in
mezzo allo studio per solidarizzare con gli studenti che campeggiano davanti
alle principali università italiane contro l’affitto degli appartamenti, e in
molti contro il governo.
«Buongiorno e ben trovati. Sì, oggi vi parlo da
questa tenda», ha esordito la conduttrice, «questa tenda è diventata il simbolo
della protesta di migliaia di ragazzi. Lo voglio dire subito con estrema
chiarezza: per me questa protesta è sacrosanta. I ragazzi lottano per un
principio fondamentale», sottolinea la Merlino, «un principio sancito anche
dalla nostra Costituzione, l’articolo 34, ve lo ripeto, così ce lo
rinfreschiamo». Lo manda a tutto schermo.
[…] Puntualizza, «secondo me non può diventare
nemmeno un privilegio esclusivo dei ricchi. È inaccettabile che a Roma e Milano
si spendano oltre 600 euro più spese per una stanza che spesso è una topaia. Ci
sono proteste spontanee da tempo, da mesi».
È questo uno dei passaggi che le contestano di
più: «Strano che te ne accorgi solo adesso che c’è la Meloni. Strano, Merlino».
Alice Melideo, 20 anni, ha passato la sua prima
notte in tenda e lo racconta al Corriere. Vive a Seregno, nella bassa Brianza, e
un altro utente lo fa notare anche alla Merlino: «Da Seregno al Politecnico sono
40 minuti coi mezzi pubblici. L’ho fatto per anni.
Poi vorrà anche il lavoro dietro l’angolo?».
Mentre scriviamo il navigatore indica 37 minuti, in auto.
[…] Dall’attico alla tenda. Il popolo del web non
dimentica quando Myrta in pandemia s’era collegata con la sua trasmissione da
casa, un gioiello nel cuore di Roma. E adesso pontifica sugli affitti che
costano troppo, questo il riassunto di un’altra sfilza di contestatori. […]
Esce un messaggio particolarmente caustico verso i
manifestanti accampati: «Meglio andare a studiare in centro mantenuti dalla
spesa pubblica per fare comodamente gli aperitivi». Torna l’attico: «Facile fare
le battaglie da lì».
L’Aria Che Tira è di tempesta ma Myrta non
arretra. Anzi. Twitta: «Era talmente sciocca, stupida e inutile la protesta dei
ragazzi, che il governo è stato costretto a mettere 660 milioni da destinare a
nuovi posti letto. Il doppio dei 330 cancellati dalla manovra 2023. Fannulloni
questi ragazzi». […]
Droga, lo scandalo travolge gli studenti in
tenda: toh, ma non era una protesta? Massimo Sanvito su Libero Quotidiano il
23 giugno 2023
Il sole picchia forte su piazza Leonardo da Vinci.
Gli studenti del Politecnico sciamano attorno all’università: la sessione estiva
incombe. Una volante della polizia attraversa l’ampio viale a passo d’uomo.
Un’occhiata al «Campeggio urbano», che oggi conta ancora dieci tende, e via.
Sono le due del pomeriggio e degli occupanti non c’è traccia: con questo caldo è
impensabile resistere nell’accampamento. Poco oltre, sul lato di via Celoria, in
un fazzoletto di verde, sotto una grossa pianta, ecco altre due canadesi grigie.
Appoggiate al tronco ci sono anche due biciclette. Attorno fazzoletti sporchi.
Qui dentro, però, non ci vivono i tendaroli aizzati dalla sinistra contro il
governo sul caro-affitti, ma uno spacciatore che ha deciso di mimetizzarsi così
per infiltrarsi nella piazza. Italiano, sui 40 anni, braccia e guance tatuate,
zigomi scavati a testimonianza di un consumo massiccio di stupefacenti (lo
vedete in foto qui a fianco).
«È arrivato da qualche settimana e l’ho già
segnalato alla Polizia Locale e alla Polizia ma nessuno interviene», spiega a
Libero Bruno Danovaro, il supercampione di lotta residente nel quartiere che già
la scorsa estate aveva salvato due ragazze molestate da una coppia di balordi
extracomunitari a due passi dal Politecnico. Al posto delle case a basso canone
chieste dagli studenti, col Comune interessato a incolpare la Regione piuttosto
che a trovare soluzioni, è arrivata la droga. E non parliamo delle classiche
canne di marijuana o hashish, ma di sostanze ben più pesanti.
«Cocaina, eroina e pastiglie», si sussurra tra gli
angoli della piazza. Chiunque voglia acquistare sa dove trovare il pusher. Lo
spaccio è florido e si serve anche di “galoppini” che sostano nei giardini
Leonardo da Vinci, dall’altra parte della strada, verso viale Romagna, al cui
centro domina una fontana del Cascella. «Ci sono un giovani e due anziani 70enni
che prendono le dosi e vanno a consegnarle», dice Danovaro. Un servizio a
domicilio. Stazionano sulle panchine ombreggiate dagli alberi praticamente h24.
Ieri pomeriggio, a piantonare la zona c’era un uomo in compagnia di due donne,
un cane e bottiglie di birra. E dall’altra parte, di fronte alla scuola
elementare, gruppi di bimbi a divertirsi sulle giostrine. Due mondi opposti ma
vicinissimi. Un paio di giorni fa, sotto i palazzi di piazza Leonardo che danno
sul parco, due giovani ragazze (che abitano qui ma non frequentano il
Politecnico) sono svenute sotto gli effetti della droga.
«Lo spacciatore le ha rimesse in piedi in qualche
modo, dandogli anche da bere birra, per poi portarle via. È assurdo ciò che
avviene in questo quartiere, in pieno giorno e in mezzo a famiglie con bambini,
senza che nessuno alzi un dito. Una zona bellissima, dove le case arrivano a
costare anche più di un milione di euro, ridotta in questo modo... Ho contattato
l’onorevole Silvia Sardone (europarlamentare e commissario cittadino della Lega,
ndr) che porterà la questione in Consiglio comunale», commenta Bruno Danovaro.
Anche la digos, da quando è scoppiata la protesta delle tende, è impegnata nel
monitoraggio dell’area. Nonostante il clima sia tranquillo è pur sempre
questione di ordine pubblico, visti soprattutto i legami tra gli accampati e la
galassia antagonista milanese. Quelle due canadesi appartate, però, paiono
essere sfuggite agli occhi di tutti nel trambusto generale. Ci appelliamo dunque
alle istituzioni, fin troppo impegnate a sfilare in passerella davanti alla
tendopoli universitaria per strizzare l’occhio ai giovani fuorisede: esiste
anche un quartiere che chiede di fermare lo spaccio a cielo aperto. Non la luna.
La Schlein macchiata e "mazziata" dagli
studenti di sinistra. Andrea Soglio su Panorama il 12 Maggio 2023
L'autogol della segretaria dei Democratici in
cerca di visibilità tra gli universitari che protestano contro il caro affitti
per gli studenti fuori sede
Chissà come l’avrà presa l’armocromista… Una bella
chiazza marrone che non ti aspetti sull’eco giacca vinaccia presa dalla cabina
armadio. Di certo una macchia inattesa dato che lo shopping di Elly Schlein
prevedeva cose ben diverse. Il neo segretario Pd infatti si è recata alla
Sapienza di Roma per portare la sua vicinanza agli studenti da giorni accampati
con le loro tende fuori dall’ateneo per protestare contro il caro affitti.
L’idea era semplice: cavalcare la protesta e
portarsi a casa qualche nuovo giovane elettore, coperta da applausi e sorrisi.
Tutto facile, tutto perfetto, avrà pensato prima di uscire di casa dopo aver
scelto con cura la cromia del suo outfit. Quando però è arrivata dagli studenti
invece di applausi e sorrisi si è trovata davanti un contestatore, e non stiamo
parlando di un fascista o un iscritto a Casa Pound. No. Un giovane evidentemente
legato al mondo studentesco della sinistra che ha attaccato senza paura quella
che dovrebbe essere il suo segretario: “Cosa dice dello sgombero a Bologna, la
sua città, mentre la Polizia manganellava noi che protestavamo per il diritto
alla casa. Il Pd dove era …?”. Imbarazzata e stupita la Schlein è riuscita solo
a dire: “Guardi, mi informerò di questa situazione di cui non ero a
conoscenza…”. Poi via protetta dalla scorta e dai suoi collaboratori che
cercavano di tamponare la falla riuscendo in realtà solo a peggiorare la
situazione“. Gli studenti non vogliono che lei venga a fare le passerelle qua…”
ha chiuso il contestatore. Serve aggiungere altro? Serve commentare? La politica
è una cosa seria. Le passerelle acchiappavoti non servono più. Come forse
nemmeno le interviste su Vogue, le foto posate e l’armocromista. Serve forse
alla Schlein un bagno di umiltà, vestita però, così la macchia di fango di oggi
forse andrà via.
E tu di che tenda sei? Domenico Pecile su
L'Identità il 12 Maggio 2023
Dopo averlo bacchettato per l’uscita improvvida
contro le amministrazioni di centro sinistra (“La contrapposizione con le
amministrazioni locali è controproducente”), dopo essersi dichiarata “irritata”
e dopo avere annunciato la totale contrarietà (“la mia linea è un’altra”), il
ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, spiega al collega
ministro all’Istruzione come si affronta il problema del caro affitto degli
studenti universitari. E così, ha riferito al ministro Giuseppe Valditara “che è
assolutamente legittimo che esprima la sua opinione”, ma che per quanto
“riguarda il dossier che stiamo gestendo da tempo è necessario collaborare, non
antagonizzare. Questo vale per i sindaci, che hanno dimostrato grande
disponibilità. Per vincere il campionato dei 55mila 550 posti letto bisogna fare
squadra”. E passando alle proposte concrete, Bernini ha fatto così il punto
della situazione. “Abbiamo 40 mila posti letto pre-Pnrr, già esistenti. Noi –
spiega – ne abbiamo fatti 7mila 50, un 15 per cento in più. Con 400 milioni
faremo un 30 per cento in più. Ma vogliamo andare avanti e io ho chiesto la
collaborazione di tutti, a partire dal demanio, fino alle Regioni, i Comuni, i
sindaci metropolitani sono i referenti migliori in assoluto perché hanno il
controllo del territorio. Abbiamo chiesto di mettere a disposizione degli
studenti immobili dismessi, inutilizzati. Questo è un modo per velocizzare. E
proprio oggi è uscita dal ministero una manifestazione d’interesse per censire
questi immobili che vogliamo mettere subito a giro per metterli a disposizione
degli studenti”. Bernini ha incassato immediatamente il plauso di Mario
Occhiuto, senatore di Forza Italia. Che conferma l’esistenza, nelle nostre
città, di un immenso patrimonio edilizio che, “per i più svariati motivi, è
stato dismesso, abbandonato, non più usato e versa in uno stato di progressivo
degrado: aree industriali, opifici, caserme, colonie marine, stazioni
ferroviarie, miniere, sanatori, carceri”. Entrando poi nel dettaglio, Occhiuto
svela che si tratta di 9mila chilometri quadrati di aree dismesse “pari a circa
il 3 per cento del territorio nazionale sulle quali si può agire con azioni di
rigenerazione urbana destinata ad accogliere le residenze universitarie inserite
in nuovi contesti urbani strutturati per implementare il benessere e la salute
non soltanto degli studenti, ma di tutti i cittadini e per stimolare la
creatività”. E se le rassicurazioni di Bernini suonano per il M5S, invece, come
un segnale di confusione, per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si tratta di
un’apertura. Il deputato del M5S in commissione cultura, Antonio Caso, infatti,
parla di scontro tra ministri, “e mentre loro litigano, gli studenti di tutta
Italia rischiano di vedere negato il diritto allo studio”. Caso sostiene di
avere suggerito nei giorni scorsi alla stessa Bernini che è necessario un cambio
di passo sull’università. “L’Italia – rincara – è tra i Paesi dell’Ue che spende
meno rispetto al Pil per l’Università e ricerca e già in legge di Bilancio
abbiamo evidenziato che il Fondo integrativo speciale così come quello ordinario
per l’Università fossero insufficienti per provare a colmare il gap esistente e
dare finalmente risposte concrete a studenti e ricercatori. La risposta del
ministro Bernini? Lo scopriremo solo vivendo”. Più ottimista, come si accennava,
il primo cittadino di Milano che ritiene Bernini “collaborativa”. “Questa
mattina – dice – ho sentito la ministra dell’Università e della Ricerca per
discutere di questi problemi. Ne ho parlato con il collega romano, Gualtieri. La
ministra mi ha riferito che lunedì, appena tornerà a Roma, lo farà. L’ho sentita
molto collaborativa”. Sala ha aggiunto di avere dato inizio a un tavolo in
Comune “con i rettori delle università per portare un po’ le nostre soluzioni.
Spiegheremo quello che intendiamo fare”. E sulla vicenda interviene anche l’Udu
(Unione degli universitari) che ha scritto a Bernini e chiesto un tavolo
nazionale per affrontare la crisi abitativa. “Come si può pensare – scrive l’Udu
– che uno sconto del 15 per cento sul canone di mercato potrà essere risolutivo?
Invece, i famosi 400 milioni di euro sono troppo pochi e congelati da mesi. Se
veramente il Next Generation Eu deve guardare alle nuove generazioni, vorremmo
che queste venissero coinvolte e consultate. Il sindacato studentesco fa anche
sapere di essere al lavoro su un’indagine approfondita di come si stanno
utilizzando le risorse del Pnrr, in contrapposizione a quello che si sta
attuando. Insomma, una sorta di “contro Pnrr”. E sempre ieri, il sindaco di
Firenze, Dario Nardella, ha incontrato una rappresentanza di universitari
definendo il faccia a faccia “utile e approfondito”. “Abbiamo condiviso –
commenta – alcune proposte da presentare al governo come quella di accelerare il
piano di investimenti per la realizzazione di nuovi alloggi studenteschi esposto
dalla ministra Bernini, a cui si lega un bando pubblico che uscirà nei prossimi
giorni destinato ai soggetti privati che potranno realizzare alloggi utilizzando
edifici pubblici inutilizzati. Inoltre, abbiamo anche condiviso la necessità che
il governo metta in campo delle risorse economiche destinate direttamente agli
studenti che dispongono di meno mezzi per trovare un alloggio”.
Estratto dell'articolo di Giovanni Sallusti
per "Libero quotidiano" il 12 maggio 2023.
Vorrei focalizzare l’attenzione del lettore su un
dramma contemporaneo, sviscerato ieri in tutte le sue urticanti pieghe dal
Corriere della Sera, giornale degli ultimi e degli afflitti. Il caso di Alice
Melideo, ventenne studentessa del Politecnico milanese, è però obiettivamente
per stomaci forti, quindi proveremo a raccontarlo col maggior tatto possibile.
Alice, come cantava De Gregori nell’omonima canzone, «Non ti chiede mai pane o
carità/ E un posto per dormire non ce l'ha».
Non ce l’ha a Milano, dove lo vorrebbe, perché
purtroppo non siamo in Unione Sovietica, dove i prezzi degli appartamenti li
stabilisce lo Stato, ma coltiviamo ancora l’usanza reazionaria di farli decidere
dai proprietari degli stessi. È in questo contesto di turboliberismo selvaggio e
affamatore che s’inserisce la straziante storia di Alice.
«Dopo le superiori, ho cercato una casa in città,
ma non mi conveniva per tempi e costi». Legittimissima valutazione, il mancato
incastro domanda/offerta è un accidente sempre possibile del mercato (se poi
diventa la norma, sarà l’offerta stessa a doversi ripensare, l’ha spiegato bene
un tizio che si chiamava Adam Smith, ma d’altronde Alice non studia economia,
bensì “scuola di fumetto”).
Il fatto è che, dopo la libera scelta di
sottrarsi al mercato degli affitti meneghino, per Alice è iniziato il calvario,
ovvero (e la penna del cronista comprensibilmente si fa tremebonda dalla
commozione) «la scelta forzata di fare la vita da pendolare». Evenienza
condivisa da tre o quattro generazioni prima della sua, ma il punto dirimente,
ovviamente, è dove Alice abita.
Va collocato sulla mappa, il suo dramma
quotidiano, la sua personalissima odissea necessita di coordinate
spazio-temporali, per essere compresa appieno.
Alice, e ci prende un nodo alla gola solo a
scriverlo, vive a Seregno. Che non è nemmeno provincia di Milano, dannazione,
bensì di Monza-Brianza. Certo, appena più vicino al Politecnico rispetto a
Crotone, ma pur sempre, tenetevi forte, a circa venticinque chilometri di
distanza. Un filo di più, addirittura, di una mezza maratona.
Certo, Alice non risulta ancora obbligata da
questo governo di criptofascisti a coprire la tratta a piedi, gli Stati moderni
hanno previsto da qualche decade una rete di infrastrutture e di trasporti
pubblici, la Lombardia peraltro non risulta nemmeno l’ultimissima Regione
italica in proposito. Colti da vaghe reminiscenze universitarie (chi scrive
addirittura ai tempi copriva su rotaia la distanza tra Como e Milano,
evidentemente era un eroe epico a sua insaputa), siamo andati sul sito di
Trenitalia. È abbastanza facile, ma immaginiamo che Alice ne sia al corrente.
Selezionando “Seregno” alla voce stazione di
partenza e “Milano” alla voce stazione di arrivo, si ottiene il tempo di
percorrenza: diciannove minuti. Di-cian-no-ve minuti. Meno che da un capo
all’altro della metropolitana. Meno di un’edizione di telegiornale, meno della
metà di un tempo di una partita di calcio. Soppesate voi il parametro che
preferite, e avrete le proporzioni del dramma di Alice.
Tra l’altro, noi l’abbiamo fatta ancora facile.
Perché, potrebbe giustamente far notare chiunque si sia preso a cuore la via
crucis della disgraziata ragazza, lei deve recarsi al Politecnico, mica finisce
in Stazione Centrale il viaggio della speranza. E il tempo di percorrenza tra le
stazioni di Seregno e Milano-Bovisa Politecnico raddoppia addirittura:
tren-tot-to minuti. Sempre meno di un tempo di una partita di calcio, per
carità.
Ma, come trova la forza di dichiarare Alice al
Corriere: «È pesante» - un minatore potrebbe avere qualche obiezione, ma
probabilmente sarebbe un elettore della Meloni, ndr. «Per questo essere qui è la
battaglia di tutti».
(...)
La stretta italiana su Airbnb non ascolta i
movimenti per la casa. Valeria Casolaro su L'Indipendente il 31 maggio 2023.
In anticipo sui tempi (Daniela Santanchè aveva
parlato dei primi di giugno) è stato reso noto il disegno di legge del ministero
del Turismo finalizzato alla regolamentazione degli affitti di alloggi tramite
la piattaforma Airbnb. Il progetto era fortemente desiderato sia da
Federalberghi – che desiderava contenere mettere un freno alla concorrenza – sia
dai Comuni, in particolare quelli a “spiccata vocazione turistica” – che
desideravano regolarne l’attività per evitare l’alterarsi delle dinamiche
immobiliari e le conseguenti difficoltà di trovare un appartamento per coloro
che in quella città ci devono vivere. La bozza del ddl, tuttavia, ha lasciato
scontenti tanto i primi quanto i secondi. L’unica novità introdotta per
regolamentare gli affitti brevi, infatti, è l’introduzione di un obbligo di
durata minima di due giorni del soggiorno (a meno che non si tratti di attività
imprenditoriali), “pena la nullità del contratto”. Nulla è stato fatto per
regolamentare il numero degli alloggi messi in affitto su Airbnb, come non viene
inserita una definizione di centro storico – richiesta dai sindaci dei Comuni –
né risolta la divisione di competenze tra Stato (per quanto riguarda le
locazioni) e Regioni (per il turismo). Inoltre, non avendo il ministero del
Turismo alcuna competenza sui contratti di locazione, non è chiaro come potrà
rilevare le infrazioni al limite di soggiorno.
Tra le altre specifiche introdotte dal ddl vi è
anche l’assegnazione di un codice identificativo nazionale, con l’obbligo di
inserirlo in una banca dati (mai realizzata, nonostante fosse stata annunciata
nel 2021), pena una sanzione da 5 mila euro. Prevista anche la creazione, da
parte dell’Istat, di una nuova classificazione dell’attività ricettiva in
appartamenti esercitata in forma imprenditoriale e di uno specifico codice
Ateco. Riguardo il limite minimo di pernottamento, la
misura risulta essere pressoché inutile, in quanto la media del soggiorno, in
Italia, è di 3,3 notti.
La richiesta di una regolamentazione alla
piattaforma di Airbnb era stata lanciata dai sindaci di 14 città italiane lo
scorso aprile, tra le quali Bologna, Venezia, Firenze. Il motivo: l’impennata
degli annunci extra-alberghieri, che sono passati dai 20 mila del 2011 ai 700
mila del 2022. Gli enti minori avevano auspicato che l’esecutivo, nel redigere
la bozza di legge nazionale, si ispirasse alla bozza formulata dal movimento
Alta Tensione Abitativa, che intendeva “colmare un vuoto normativo con una
regolamentazione nazionale che consegni ai Comuni uno strumento concreto per
limitare la diffusione incontrollata delle locazioni brevi, al fine di
salvaguardare la residenzialità”. Con la realizzazione della bozza si sarebbe
così potuto estendere l'”esperimento Venezia”, città alla quale, durante il
governo Draghi, era stato conferito uno status particolare (non ancora
applicato) che le avrebbe permesso di fissare un tetto massimo al numero di
alloggi destinati agli affitti turistici. La ministra del Turismo, Daniela
Santanchè, si era tuttavia già detta contraria all’idea di cedere un tale
margine di autonomia ai Comuni.
Così come è stato presentato, il disegno di legge
ha lasciato scontenti tanto i proprietari degli alberghi quanto i Comuni. «Non
possiamo nascondere la nostra delusione per il contenuto della proposta», la
quale non è stata in grado «di incidere concretamente sul problema della
concorrenza sleale e dell’abusivismo che inquinano il mercato»,
ha dichiarato Federalberghi. [di Valeria Casolaro]
«Affitti brevi, fuorilegge il 70%»: la denuncia
del presidente di Albaa ( Federalberghi). Flavia Fiorentino su Il Corriere
della Sera l'1 giugno 2023
L'associazione che riunisce B&B e alloggi
turistici ha pubblicato uno studio sul settore «per sfatare le fake news che ci
perseguitano, a cominciare dall'evasione fiscale: i regolari pagano le tasse»
«Circa i due terzi degli oltre 30 mila alloggi
per affitti brevi a Roma sono abusivi. È questa la sfida che ci attende, portare
il sommerso alla luce del sole, perché nel mercato turistico della Capitale c’è
posto per tutti. E se non ci fossero i privati, in alta stagione non riusciremmo
a ospitare tutti i visitatori che vorrebbero venire qui». Massimo Marini,
vicepresidente di Albaa (Associazione laziale b&b, affittacamere e
affini), legata a Federalberghi Extra e proprietario di Flateinrome.it, ha
appena pubblicato uno studio dal titolo esplicativo: «Sfatiamo le fake news
sull’extralberghiero», in cui risponde alle accuse su un settore molto
frammentato e al centro di polemiche perché capace di sfuggire alle normative e
al Fisco. «Che i gestori di strutture extralberghiere, quelle regolari intendo,
non paghino le tasse, è la prima delle falsità che ci perseguitano».
Business famigliare
«Una delle conseguenze dirette dell’aumento delle
strutture ricettive dell’extralberghiero e degli affitti brevi — spiega Marini —
è che le famiglie hanno trovato un reddito di sostentamento. Pertanto, queste
persone si devono considerare forza-lavoro del settore turistico e come tutti
gli altri pagano le tasse. Ma la differenza risiede nel fatto che questi
lavoratori non ricevono pensione, cassa integrazione e, com’è accaduto due anni
fa, i fondi per il Covid 19». Un’altra critica a cui «Albaa» ha scelto di
rispondere nel suo dossier, è quella di aver contribuito alla desertificazione
del centro storico: «A Borgo Pio, ad esempio, nel ‘65 era tutto fatiscente,
c’erano pochi residenti e quelli che c’erano scappavano.
La desertificazione del centro
Dal Giubileo del 2000 in poi il turismo, anche
con le case vacanza, ha riportato vita nel quartiere, così come a Trastevere che
oggi è una zona più sicura di quella che era negli anni Settanta». A sostegno di
queste tesi, l’analisi dell’associazione che riunisce i proprietari di alloggi
turistici, riporta una serie di dati, a partire dalle 450.825 imprese registrate
a Roma a gennaio scorso, 832 studi legali, 1.010 quelli dei commercialisti, 200
i notai e 18.130 architetti attivi nella Capitale per dimostrare che
«l’extralberghiero ha ripopolato i quartieri desertificati dagli uffici». E
avrebbe anche portato valore economico attraverso l’indotto: «Sia per quanto
riguarda bar e ristoranti che l’esternalizzazione dei servizi come lavanderie,
pulizie e guide turistiche, c’è stato un importante aumento delle attività, con
il vantaggio che i soldi restano sul territorio».
«Nessuna emergenza abitativa»
Inoltre, Marini respinge al mittente anche
l’accusa di creare emergenza abitativa «in quanto - precisa - secondo i dati del
Sunia (il principale sindacato degli inquilini) su 1.717.662 appartamenti
censiti nella città, oltre 250mila (il 14%) sono vuoti, sfitti e non abitati».
Per quanto riguarda inoltre il «fastidio» dei residenti verso i «turisti della
porta accanto» nel proprio condominio, la replica è immediata: «Tutti i nostri
ospiti sono registrati, se accade qualcosa sappiamo a chi chiedere conto. Dove
invece ci sono studi professionali, entra e esce gente in continuazione
con scarso controllo. Così come negli affitti agli studenti: se fanno una festa
alle 11 di sera non si può dire nulla mentre per il 99% degli alloggi su Airbnb,
i party sono vietati».
Il nodo delle norme sugli sfratti
Ma quello che più anima la difesa degli affitti
brevi è l’attuale normativa sugli sfratti: «Lo Stato non difende la proprietà
privata — conclude Marini — e non esiste una garanzia di tempi brevi e certi
delle procedure di sfratto per morosità, nè per i danni nell’immobile che, con
qualche garanzia in più, molti proprietari sarebbero lieti di locare sul mercato
degli affitti concordati».
Airbnb & Co: prezzi folli, Venezia la più cara.
Cosa cambierà con la nuova legge. Milena Gabanelli e Francesco Tortora su Il
Corriere della Sera il 30 Maggio 2023
Gli studenti fuorisede che cercano casa vengono
regolarmente spennati. Già dagli anni ’70 gli affittacamere di città
universitarie come Milano, Bologna, Roma, facevano affari d’oro. Da almeno un
decennio nei centri storici delle città d’arte anche per i residenti è diventato
quasi impossibile trovare un appartamento in affitto, e vengono espulsi verso le
periferie. Il motivo è soprattutto uno: i proprietari preferiscono affittare a
breve ai turisti. Un fenomeno inizialmente marginale, ma che nel giro di pochi
anni ha stravolto le nostre città.
Esplodono gli affitti brevi
Il mercato degli affitti brevi è tra i settori del
turismo più in crescita: ogni turista/inquilino può prendere la casa in
locazione al massimo per 30 giorni. Il vantaggio per i proprietari è evidente:
un maggiore incasso su base mensile e senza i vincoli di un contratto
tradizionale (per esempio l’affittuario moroso o che alla scadenza non vuole
lasciare l’appartamento), pur restando a loro carico i costi delle utenze e la
tassa sui rifiuti. Se nel 2011 gli annunci extra-alberghieri non superavano le
20 mila unità, nel 2023 sono saliti a 700 mila, per un fatturato che si aggira
sui 10-11 miliardi di euro. In questo mercato l’Italia è la terza piazza,
dopo Stati Uniti e Francia.
Piattaforme e gestori professionali
Le offerte di appartamenti con locazione a breve
sono promosse su piattaforme digitali: il 75% gestite direttamente da privati,
il 25% dagli operatori professionali. I contratti sono stipulati generalmente
dalle stesse piattaforme (Airbnb, Booking, VRBO) che pubblicando gli annunci
fanno incontrare domanda e offerta. Per la prestazione si trattengono una
percentuale sull’affitto che oscilla tra il 14 e il 18%. La percentuale sale al
35% se si passa dalle agenzie (Italianways, CleanairBnb, Halldis, Wonderful
Italy) che amministrano le abitazioni per conto dei proprietari offrendo anche
il servizio di pulizia, cambio della biancheria, assistenza su tutte le attività
burocratiche e assicurative.
Tassa di soggiorno, cedolare secca ed evasione
fiscale
Nelle città turistiche il gestore di appartamenti
è tenuto a far pagare la tassa di soggiorno agli ospiti e deve comunicare alla
questura competente i dati degli affittuari. I privati che amministrano fino a
quattro appartamenti (dal quinto in poi l’attività diventa imprenditoriale e
segue il regime d’impresa) possono usufruire del regime della cedolare secca e
tutti, piattaforme e gestori professionali, devono applicare una ritenuta
d’acconto del 21%. Fino ad oggi Airbnb, la principale piattaforma online con
oltre 400 mila annunci per l’Italia, si è sempre rifiutata di trattenere
l’imposta perché la società ha la residenza fiscale all’estero. Ora la questione
è sul tavolo del Consiglio di Stato. Per quel che riguarda i privati a marzo
scorso, durante un’audizione in Senato, Federalberghi, che da anni accusa le
piattaforme digitali di concorrenza sleale, ha denunciato come lo Stato nel 2022
abbia recuperato dalla cedolare secca sugli affitti brevi appena 80 milioni di
euro. Secondo Marco Celani, presidente del Centro Studi Aigab che raccoglie i
principali gestori professionali del settore, già oggi le finanze pubbliche
dovrebbero essere in grado di raccogliere circa 1 miliardo di euro dalla
cedolare secca. La situazione potrebbe cambiare da quest’anno: il Parlamento a
marzo ha recepito la direttiva europea «Dac 7» che obbliga le piattaforme web a
comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le transazioni effettuate, i dati dei
proprietari e il totale dei giorni di affitto durante l’anno.
La vivibilità delle città turistiche
Il movimento veneziano «Alta tensione abitativa» e
lo studio del professor Filippo Celata dell’Università La Sapienza «Overtourism
and online short-term rental platforms in Italian cities» hanno analizzato il
fenomeno: l’aumento esponenziale degli affitti brevi ha snaturato il mercato
immobiliare facendo lievitare i costi delle locazioni, riducendo la
disponibilità di abitazioni affittate per i tradizionali 4 anni, spingendo verso
le periferie residenti e studenti. Il caso più eclatante è quello di Roma che
dal 2014 al 2019 ha visto la popolazione residente crollare nelle zone del
centro storico (-35,8%) e di Trastevere (-43,1%), dove si concentra la
maggioranza delle abitazioni in affitto breve, e crescere in periferia
(Mezzocammino +19,6%, Ponte Galeria +16% e Castelluccia +10,1%).
A Milano 180 euro a notte, Venezia la più costosa
Secondo i dati di Aridna, sito che monitora questo
tipo di mercato, nel mese di aprile 2023 le abitazioni disponibili
a Milano erano 17.319, il 63% affittate ad un prezzo medio di 180 euro a notte.
A Roma erano 19.777, di cui l’88% a un prezzo medio di 190 euro. A Firenze l’87%
degli appartamenti viaggia a 192 euro a notte; a Napoli il 77% a 120 euro;
a Torino il 65% a 98 euro; a Bologna il 75% a 128 euro: a Verona il 67% a 163
euro. Venezia resta la città più costosa: con 7.203 abitazioni disponibili,
occupate l’83%, mediamente 212 euro a notte. In tutte le città i prezzi sono
aumentati almeno del 30% rispetto al 2019 con punte del 50% a Venezia e Roma e
del 60% a Firenze e a Napoli.
L’appello dei sindaci
I sindaci di 13 città (Roma, Milano, Napoli,
Torino, Bologna, Firenze, Parma, Bergamo, Lodi, Verona, Padova, Trieste e
Rimini) chiedono una legge nazionale che regolamenti il mercato. Nell’elenco non
figura il sindaco di Venezia, eppure proprio Venezia è l’unica città italiana
che potrebbe già oggi limitare il numero di immobili in affitto attraverso le
piattaforme digitali grazie a una norma approvata nel 2022 dal governo Draghi.
La giunta veneziana però non ha ancora deciso nulla, nonostante il numero di
residenti del centro storico sia passato in 10 anni da 60 mila a meno di 50
mila, quasi superato ormai dal numero di posti letto per turisti: 48 mila.
Cosa accade in Europa
Da tempo i sindaci di molte città europee hanno
imposto regole e limiti:
1) «time cap», il tetto massimo di giorni di
affitto all’anno. La più restrittiva è Amsterdam, i giorni di affitto breve
vanno da un minimo di 7 ad un massimo di 30, che
diventano 70 a Copenaghen, 90 a Londra e Berlino, 120 a Bruxelles. Per chi
supera la soglia ci vuole una licenza e si applica un aumento delle tasse.
2) autorizzazione dei condomini
ad Amsterdam, Barcellona, Parigi, Vienna, Bruxelles, Madrid.
3) «zonizzazione»: in alcuni quartieri è
completamente vietato l’affitto breve, per esempio a Vienna. Per chi sgarra ci
sono multe severe. A Parigi Airbnb è stata condannata nel 2021 a pagare 8
milioni di euro al Comune per aver pubblicato sulla piattaforma mille annunci di
locazioni non registrate. «La regolamentazione nelle città europee – spiega
a Dataroom il professor Celata – ha ridotto il numero di annunci per
appartamenti del 28,8% rispetto alle metropoli che non hanno introdotto alcun
limite».
L’intervento del governo italiano
La responsabile del Turismo Daniela Santanché ha
annunciato che nei prossimi giorni presenterà al Consiglio dei ministri un
disegno di legge per regolamentare questo settore. La bozza del Ddl va incontro
alle principali richieste di Federalberghi e prevede un minimo di 2 notti di
permanenza nei Comuni turistici. Non è previsto né un tetto massimo di giorni di
affitto all’anno né una limitazione di posti letto in rapporto al numero dei
residenti nei vari quartieri come chiedono i sindaci. Verrà introdotto però
un codice identificativo nazionale per ogni abitazione (esisteva già, ma era su
base regionale e non c’erano controlli). Questo per evitare il nero. In caso di
non applicazione che multe rischiano i proprietari? Da 500 a 5 mila euro. È
evidente che affittando a 200 euro a notte, una sanzione massima da 5 mila euro
non disincentiva nulla, mentre regolamentare questo settore è cruciale per
trovare un punto di equilibrio fra i vantaggi del turismo, che vale il 6% del
Pil e arriva al 13,4% con l’indotto, e la vivibilità dei centri storici.
Spingendo fuori i residenti si uccide l’identità stessa di questi luoghi, che
via via si trasformano in colonie turistiche affollate solo di pizzerie,
ristoranti e negozi di souvenir.
Mandiamoli a quel paese. Affitti alle stelle,
cari studenti imparate a fare sacrifici: ve le ricordate le tende del Belice?
Hoara Borselli su Il Riformista il 12 Maggio 2023
Ve le ricordate le tende del Belice? Erano quattro
stracci grigio sporco sorretti da due pali di ferro. Dentro si pigiavano le
famiglie che avevano avuto la casa distrutta nei paesi della Valle del Belice,
fra Agrigento e Trapani, dopo il terremoto feroce del 14 gennaio 1968. Le tende
dovevano star lì qualche giorno, invece restarono anni. Finché fu il presidente
Pertini a lanciare il grido: “Dove sono finiti i soldi del Belice?”.
Erano passati quindici anni dal terremoto e i
terremotati erano ancora in mezzo alla strada. Ecco, quello fu uno scandalo. E
ti si stringeva il cuore a vedere le foto coi bambini costretti a vivere in un
accampamento, nel fango, senza la scuola, senza la Chiesa, senza un posto dove
giocare. Ora invece non mi si stringe il cuore. Anzi, vi confesso che mi sale
una rabbia incontenibile quando sento la ragazza di Bergamo che dice frignando
che lei è costretta a piantare una tenda in strada perché non può venire a
studiare a Milano dove gli affitti costano troppo. Voi direte che sono una snob
borghese, ma io non so trattenermi: “ragazza, muovi il sedere, fai l’abbonamento
e prendi il treno! Ragazza, lo sai cosa facevano un paio di generazioni fa i
poveri che volevano diventare dottori? Studiavano, lavoravano, sgobbavano,
sudavano, e poi si presentavano all’esame e prendevano trenta e lode, mentre i
signorini con l’aria altezzosa, figli di papà, non sapevano neanche chi fosse
Schumpeter e si accontentavano del 24.
Chiaro? Non sono io che sono snob, cara ragazza
piagnucolosa. Sono quelle tende che mettete voi a essere le madri di tutti gli
snobismi possibili. Non è che io ritenga eccessiva la protesta degli studenti in
tenda contro il caro affitti. No. La considero semplicemente uno schiaffo alla
logica e alla povertà. Ci sono 5 milioni di persone, in Italia, che vivono sotto
il livello di povertà. Ci sono milioni di persone che non hanno un tetto, o che
devono dividerselo con la cognata o il cugino. Ci sono un esercito di lavoratori
che alla fine della giornata hanno messo sì e no insieme i soldi per comprare
una cena scarsa ai loro bambini. Lo sapevate? E questi ragazzetti borghesi cosa
vogliono da noi? La casa. L’affitto gratis. La comodità. Il lusso.
Per favore, senza distinzioni tra destra e
sinistra: mandiamoli a quel paese. Spieghiamogli che in Italia ci sono grandi
questioni sociali aperte, e che loro non sono l’urgenza: si arrangino un po’.
Facciano i pendolari, dividano la casa con un amico, trovino una zia che li
ospiti, oppure vadano a servire a un bar la sera per mettere insieme un po’ di
soldi. Ragazzi: sapete cos’è il sacrificio? È la molla per migliorarsi, per
crearsi un futuro, per realizzare i sogni. E soprattutto è la lente di
ingrandimento che ti fa capire il mondo, ci mostra come è fatto, e ci rende
evidente la realtà. Senza i sacrifici, – amici marxisti immaginari -, nella vita
non si ottiene niente.
Ricordate tutti quell’aneddoto: si racconta che la
regina Maria Antonietta di Francia, moglie di Luigi XVI, alla vigilia della
rivoluzione dell’89 e mentre la Francia era travolta dalla rivolta, suggerì ai
suoi consiglieri che le dicevano che il popolo era furioso perché rimasto senza
pane: “Ditegli di mangiare brioche…” Ecco, ora le cose si sono invertite. I
ragazzi in lotta vogliono le brioche. Vi prego, gridiamogli in coro che si
mangino il pane.
P.S. Ho visto che il Pd si è subito commosso per
la protesta dei ragazzini che vogliono brioche. E ha deciso che il problema va
risolto facendola pagare a qualcuno. A chi? Ai proprietari di case. Il Pd
propone che siano puniti fiscalmente quelli che hanno una casa e non la mettono
in affitto. Capito? Sarà lo Stato a decidere cosa devi fare tu con la tua
casetta che ti sei comprato con i risparmi di trent’anni di lavoro. Più o meno
come si faceva nella Russia di Breznev.
Hoara Borselli
Inizio la mia carriera artistica come una delle
protagoniste della fortunata "soap opera" CENTOVETRINE per essere poi chiamata
dal Cinema a rivestire il ruolo di protagonista nel film PANAREA. Il grande
successo è arrivato con la trasmissione BALLANDO CON LE STELLE, vincendo la
prima edizione. Ho proseguito partecipando alle tre edizioni successive. Da lì
il ruolo da protagonista nella tournèe teatrale la febbre del sabato sera, dove
ho calcato, a ritmo di "sold out", tutti i più grandi teatri italiani. A seguire
sono stata chiamata come co-conduttrice e prima ballerina nel programma CASA
SALEMME SHOW, quattro prime serate su Rai1. In seguito ho affiancato Fabrizio
Frizzi nella conduzione della NOTTE DEGLI OSCAR, poi Massimo Giletti nella
conduzione di GUARDA CHE LUNA sempre su Rai1. Poi ho condotto il Reportage di
MISS ITALIA. Sono stata protagonista della fiction televisiva PROVACI ANCORA
PROF, otto puntate in prima serata su Rai1 e TESTIMONIAL di importanti aziende
di vari settori.
Fuorisede Lives Matter. Gli
studenti fanno bene a occuparsi di economia anziché di pronomi (mentre gli
adulti gli danno sempre ragione). Guia Soncini su L'Inkiesta il 12
Maggio 2023
Ora si protesta contro il fatto
che è meglio essere ricchi e felici che poveri e infelici: gli studenti hanno il
diritto d’essere scemi, ma noialtri gli diamo troppa corda pur di non essere
catalogati come «boomer»
Per una storia breve delle
tende da campeggio e della loro accezione politica, occorre cominciare dal 1995,
quando – nell’àmbito di quella truffa per multimilionari che è l’arte
concettuale – a Tracey Emin venne in mente di produrre una tenda che all’interno
avesse appiccicati i nomi dei tizi che si era scopata e dei feti che aveva
abortito, e intitolarla “Everyone I Have Ever Slept With, 1963-1995”.
Molti anni dopo sarebbe
arrivato Mattia Santori – quello delle sardine, quello col cerchietto, quello
che è andato a mangiare la mortadella con Stanley Tucci, quello per cui a
Bologna serve non una raccolta della spazzatura che funzioni ma lo stadio del
frisbee: lui – a piantare la tenda nella sede del Pd che lui e altri giovani
virgulti intendevano occupare o espugnare o sa il cielo cosa.
Adesso, la voga di stagione è
che in tenda ci si dorme per protestare contro il fatto che è meglio essere
ricchi e felici che poveri e infelici. Il che è certamente vero – nessuno ha mai
detto sciocchezze avendo come faro ideologico Max Catalano – ma ha dei limiti.
Ai limiti però arriviamo dopo: prima le buone notizie.
È una buona notizia che i
giovani virgulti si occupino di economia invece che di pronomi percepiti (anche
se loro, non essendo abbastanza adulti da comprendere che le risorse sono una
quantità finita, direbbero che no, che i pronomi sono importanti quanto la
possibilità di pagarsi una casa: non lo sono, date retta a zia). È una buona
notizia se la smettiamo di americanizzarci e di perderci in puttanate quali lo
stadio del frisbee e la schwa e recuperiamo un po’ di marxismo, che in modica
quantità male non fa.
Purtroppo, siamo nel secolo del
Grande Indifferenziato, e quindi i giornali intervistano la studentessa che fa
la pendolare dalla cintura milanese con l’enfasi con cui parlerebbero con un
profugo appena sbarcato dopo aver attraversato oceani, e quasi nessuno resiste
alla tentazione di pensare che allora è tutto burletta, allora non è un problema
serio.
Poi arrivano quelli che invece
tengono il punto e dicono che irridere la pendolare da venti chilometri al
giorno significa non aver capito che bisogna fare come la Catalogna che
espropria i ricchi per dare gli alloggi alle persone vulnerabili. Sono
ragionevolmente certa che, non essendo gli esponenti del Grande Indifferenziato
sveglissimi, mi direbbero che d’altra parte pure io ho invocato un po’ di
marxismo.
Ma la studentessa brianzola che
può arrivare a Milano in un quarto del tempo necessario a spostarsi da una parte
all’altra di Londra non è marxianamente bisognosa né catalognamente vulnerabile:
è pigra. Non ho niente contro la pigrizia, sono pigrissima, ma abbastanza adulta
da essere consapevole dei miei limiti e del fatto che alla società non spetti
farsene carico.
Purtroppo siamo anche nel
secolo del presentismo, e quindi ogni problema è nuovo, inedito, degno di prime
pagine di giornali. Persino gli affitti costosi nelle città universitarie,
quelli che ai tempi di mia madre si facevano marchette per pagare e ai tempi
miei no perché siamo stati la prima generazione che non s’imbarazzava a farsi
mantenere dai genitori.
Il concetto di classe sociale
lo appresi a Roma negli anni Novanta, allorché feci amicizia (chiamiamola così)
con tre ragazzi che vivevano nello stesso appartamento. Ma solo uno dei tre ne
era proprietario: i genitori gliel’avevano comprato acciocché si facesse pagare
dai coinquilini per condividerlo, e tutti e tre potessero metterci dieci anni a
laurearsi in Lettere, ma uno solo dei tre potesse farlo senza chiedere soldi a
papà perché si manteneva coi soldi che gli davano i coinquilini.
Ho letto una scrittrice
spiegare che Nicola Porro non può sbeffeggiare i giovani che non vogliono fare
sacrifici perché su Wikipedia c’è scritto che viene da una famiglia
latifondista. Al di là della sopravvalutazione dell’attendibilità di Wikipedia,
stiamo quindi dicendo che delle questioni di classe e di economia e di stato
sociale e di accesso allo studio possono parlare solo coloro che discendono dai
valvassori?
Annalisa Cuzzocrea ha scritto
su Twitter un’invettiva contro coloro, indubitabilmente di destra, che irridono
i giovani virgulti e vogliono che facciano i camerieri per mantenersi agli
studi. Ho sempre trovato molto strano che in Italia si consideri inaccettabile
che si lavori mentre si studi. Forse ha ragione Annalisa: è in effetti una cosa
reputata normale negli Stati Uniti, un paese in cui anche la sinistra è di
destra. Però, ecco, io sono felice di aver lavorato mentre altri incassavano
affitti: mi pare mi abbia preparato meglio al mondo, nel quale sto da abbastanza
anni da concludere che di gente che non abbia mai lavorato e sappia badare a sé
stessa non ne ho mai incontrata (non è che servisse “Succession” per spiegarci
che i ricchi di seconda generazione son tutti scemi).
Probabilmente gli studenti poco
più che ventenni, cui i miei inetti coetanei hanno tenuto la mano mentre essi ci
spiegavano che l’Isef è troppo competitivo e l’alberghiero di Massa Lubrense ha
eccessive pretese rispetto alla performatività, direbbero che è una vessazione
pretendere che lavorino mentre danno tre esami l’anno. D’altra parte la Tracey
Emin poco più che trentenne tolse il saluto a Saatchi, il gallerista che comprò
la tenda, perché era amico della Thatcher, che secondo la ragazza era una
criminale.
Emin ha avuto trent’anni nel
fortunato secolo in cui gli adulti non cercavano la luce riflessa delle scemenze
giovanili. I poveri giovani d’oggi si ritrovano con Myrta Merlino che mette una
tenda in studio, perché – dopo essersi nello stesso studio televisivo
inginocchiata per Black Lives Matter, solidale coi neri di Minneapolis – sente
sue anche le istanze di chi potrebbe esser suo nipote. Dopo il presidente
operaio, la conduttrice studentessa fuorisede: restituite i Guzzanti al
palinsesto, ci servono.
La gioventù ha il diritto e il
dovere d’essere scema. Noialtri – che abbiamo una vita sessuale lunga quanto
quella di Tracey Emin, e avremmo il dovere di dare risposte adulte – siamo così
terrorizzati d’essere catalogati come «boomer» da dar ragione su tutto a questi
occupanti di tende che non sanno distinguere un problema che sia sensato porre
da uno con cui tocchi imparare a convivere.
Diciamo loro che certo, presto
esisteranno città appetibili che non siano carissime perché non è affatto
fisiologico che i posti dove tutti vogliono andare siano più costosi, e scienze
politiche è una facoltà molto difficile, e la marmotta fa il cioccolato.
Estratto dell'articolo di Lorenza Rapini per “La
Stampa” il 24 maggio 2023.
«Il mio letto è su un soppalco. Sì, è un po’
basso, una quarantina di centimetri, e il monolocale è piccolo. Ma ora forse ho
trovato un’altra casa»: nella Milano degli affitti folli per gli studenti,
Alessandro Cerioni racconta la sua vita in 9 metri quadrati. Come se fosse
normale, come se quello spazio si potesse considerare un appartamento. Vivere
così vuol dire sacrificarsi. Risparmiare su tutto, anche sui rapporti umani a
volte, perché non si può certo invitare un compagno di studi a casa, se di casa
si può parlare.
Cerioni è marchigiano: è a Milano per il primo
anno di dottorato al Politecnico. «Per il monolocale, che è vicino a Porta
Venezia - prosegue -, spendo 650 euro più le bollette, 100 euro ogni due mesi.
Io per fortuna ho la borsa di studio associata al dottorato, ma non riesco a
mantenermi autonomamente. I miei mi aiutano, anche se vorrei essere
indipendente. Ora forse ho trovato un’altra casa, una stanza singola in un
appartamento: spenderei una cifra identica, ma almeno avrei 15 metri quadrati e
una cucina e un bagno a parte».
Ha un confronto a portata di mano: «L’ultimo anno
di studi l’ho fatto in Svezia. Anche lì i costi erano alti. Se mi fossi fermato
lì per il dottorato, avrei avuto un costo analogo di casa, a fronte di una borsa
di studio di 30 mila euro all’anno: un po’ diverso da qui». Viene un ultimo
dubbio: ma in quei 9 metri, il gabinetto c’è? «Certo che c’è, è nella doccia»,
risponde lo studente. Si vive in 9 metri perché averne di più vorrebbe dire
sostenere costi che non si possono chiedere alle famiglie. Si vive in 9 metri
perché già così i ragazzi sanno di essere un peso per mamma e papà e allora
bisogna studiare il più possibile, fare in fretta. Si vive in 9 metri perché
qualcuno lo permette, anche.
(…)
Estratto dell'articolo di Paolo Russo per “la
Stampa” il 10 maggio 2023.
«Camplus Bononia» ha 206 stanze con balaustre
colorate che affacciano su un bel giardino. […] È uno dei tre collegi che il
principale operatore privato di residenze studentesche in Italia ha aperto a
Bologna, potendo contare sugli stanziamenti statali. A fronte dei quali però non
c'è alcun controllo sui canoni. Che nel Camplus emiliano arrivano a 1.300 euro
al mese.
Certo, stanno peggio i fuori sede che a Milano si
dividono in 7 un mini appartamento in zona Missori sborsando ciascuno 1.135 euro
di canone mensile. O chi a Roma ne spende 500, ma per dormire in un camper. E se
questa è la realtà non ci volevano i rettori delle Università per scoprire che
quello degli alloggi universitari è un grosso problema.
Del resto, basta andare a sfogliare l'ultimo
rapporto Eurostudent per scoprire che siamo tra i messi peggio in Europa. Da noi
infatti il 68% degli studenti universitari abita ancora con mamma e papà […] A
vivere in proprio in un alloggio pubblico o privato che sia, classificato come
studentesco, è invece solo il 5% dei nostri universitari, contro una media
europea che è del 17%.
A partire dal 2000, lo Stato ha stanziato più di
un miliardo di euro con la legge 338 per finanziare il 50 per cento del costo di
realizzazione di nuovi posti in studentati. Dal 2000 ne sono stati creati
38.488. La maggior parte dei posti letto, 41.478 nel 2021, è gestita dagli enti
regionali per il diritto allo studio; poi ci sono gli atenei, con circa mille
posti in tutto. Sul totale dei posti degli enti, nel 2021 quattromila non erano
disponibili anche a causa delle norme sanitarie e diecimila sono stati assegnati
a studenti "non idonei".
«Secondo una ricognizione fatta dal governo Draghi
-spiega a La Stampa il presidente della Conferenza dei rettori, Salvatore
Cuzzocrea- si stima che il fabbisogno sia ancora di 30mila alloggi. Lavorando
insieme al ministero dell'Università, dai beni pubblici demaniali abbiamo
ricavato 8mila residenze, ma con la collaborazione dei sindaci delle aree
metropolitane contiamo di reperire anche i restanti 20-22mila alloggi
riconvertendo vecchie caserme o conventi in disuso, per esempio».
Di patrimonio pubblico inutilizzato ne abbiamo
parecchio. Secondo un censimento di poco più di due anni fa del ministero
dell'Economia, gli immobili pubblici inutilizzati hanno un valore di 12 miliardi
di euro per circa 15-20mila unità abitative, che potrebbero dare alloggio almeno
a un numero doppio di studenti. «Ci sono poi milioni e milioni di vani sfitti di
proprietà privata che potrebbero essere dati in locazione agli studenti
stipulando contratti con gli enti pubblici, che in questi tempi di grande
instabilità economica offrirebbero ai proprietari il vantaggio di poter contare
su un pagatore sicuro a fine mese», spiega sempre Cuzzocrea.
Anche se a sbrogliare più rapidamente la matassa
dovrebbe bastare il Pnrr, che stanzia 970 milioni per i nuovi posti letto in
alloggi studenteschi. «Peccato che dopo averlo letto sia saltata dalla sedia»,
confida Federica Laudisa, esperta di diritto allo studio presso l'Istituto di
ricerche economiche e sociali del Piemonte. Questo, spiega in sintesi, perché i
costruttori devono per legge realizzare una quota di edilizia sociale, nella
quale rientra anche quella studentesca.
Ma così il Pnrr finirà per finanziare, come già
sta avvenendo a Milano, colossi immobiliari stranieri e soggetti finanziari
spingendoli a realizzare residenze universitarie a tariffe che nessuno
controlla. Per non parlare del fatto che il Pnrr ribadisce l'uso flessibile
delle residenze universitarie, che in base a una legge del 2012 possono essere
affittate anche a turisti «quando non necessarie all'ospitalità studentesca».
[…]
Sud, vita meno cara ma
guadagni più bassi e il potere d'acquisto resta uguale al Nord. FABRIZIO
GALIMBERTI su Il Quotidiano del Sud il 7 gennaio 2022.
Anche se al Sud la vita costa
meno, statistiche alla mano, gli stipendi sono più bassi e così il potere
d’acquisto resta lo stesso del Nord
Le regole di inizio anno
invitano a scrutare il futuro e/o misurare il passato. Visto che le sfere di
cristallo, in questo cruciale 2023, sono alquanto opache (intorbidate da quella
che von Clausewitz chiamava the fog of war, «la nebbia della guerra»), veniamo
alla misura del passato, e in particolare alle varie Hit Parade che vedono
classifiche dei Paesi secondo diverse metriche, dalla crescita alla popolazione,
dalla qualità della vita ai tassi di incarcerazione o di inquinamento…
Una di queste metriche è
importante per quanto riguarda l’attrattività di un Paese e il suo richiamo per
gli investimenti internazionali: si tratta del costo della vita e del potere di
acquisto di uno stipendio locale.
MILANO LA PIÙ CARA CATANIA LA
PIÙ ECONOMICA
La Numbeo – la più grande banca
dati per i confronti internazionali sul costo della vita – ha appena pubblicato,
per 540 città del mondo, una dettagliata analisi, basata su milioni di prezzi,
di quanto costa la vita quotidiana in ogni città. L’informazione è utile a tre
livelli: l’indice del costo della vita (che non include gli affitti) è
importante per i turisti.
Lo stesso indice, con aggiunto
il costo degli affitti, è importante per chi voglia andare a stabilirsi nel
Paese (per esempio, un pensionato Inps che voglia pagare meno tasse sulla
pensione). Il terzo livello è quello del potere di acquisto locale: il costo
della vita viene confrontato con lo stipendio medio prevalente in
quell’agglomerato urbano.
Tutto è parametrato a New York
= 100: se, per esempio, la città X ha un indice di potere d’acquisto uguale a
70, vuol dire che con lo stipendio di quel luogo si può comprare il 30% in meno
dei beni e servizi che può permettersi un abitante di New York.
Certamente, questi confronti
sono difficili, dato che gli stili di vita portano a privilegiare un tipo di
consumi rispetto a un altro, e non è agevole disegnare composizioni di spesa che
permettano comparazioni significative. Ma la Numbeo è andata affinando le
metodologie, che oggi appaiono ragionevolmente affidabili. Le statistiche
ufficiali sono completate da una fitta rete di contributori locali, che
aggiornano i prezzi con alta frequenza. Delle 540 città del mondo, 19 sono
italiane (14 del Centro-Nord e 5 del Mezzogiorno).
IL COSTO DELLA VITA E IL POTERE
D’ACQUISTO NELLE CITTÀ ITALIANE DEL SUD E DEL NORD
La tabella pubblicata in questa
pagina mostra, per i 19 centri urbani, l’indice del costo della vita, degli
affitti, del costo della vita inclusi gli affitti, e del potere d’acquisto di
uno stipendio locale. Per memoria, abbiamo aggiunto gli stessi dati per nove
città di altrettanti Paesi europei.
Quali considerazioni sono
suggerite da questa tabella? La prima – e non è una novità – è che Milano è la
città più cara (sia per il costo della vita che per gli affitti e per l’indice
complessivo), e Catania la meno cara. Nella media del Centro-Nord, questo
sorpassa largamente il Mezzogiorno (per tutte e tre le metriche).
IL POTERE D’ACQUISTO AL SUD E
AL NORD
Là dove le cose si fanno
interessanti è nell’altro indice, quello del potere d’acquisto locale. La
primazia di Milano si rivela un onere più che un onore. Limitando lo sguardo al
Centro-Nord, quell’indice non è più al primo posto (il podio va a Bergamo), e
Milano si situa al penultimo posto fra le 14 città. Non solo: il potere
d’acquisto di uno stipendio milanese è più basso rispetto a tutte le città del
Mezzogiorno (lo stesso vale per Roma e Firenze).
Il risultato sembra
contro-intuitivo. Ma si può spiegare ricordando: primo, che parliamo del potere
d’acquisto degli stipendi, non dei redditi pro-capite, che includono profitti e
redditi di capitale e di lavoro autonomo; secondo, che in Italia predominano
contratti collettivi di lavoro con tabelle stipendiali uguali per tutto il
territorio nazionale (le vecchie “gabbie salariali” come venivano
peggiorativamente – e ingiustificatamente – chiamate, sono solo un lontano
ricordo). Talché, a parità di stipendio, il potere d’acquisto è determinato
principalmente dal costo della vita.
Tuttavia, gli stipendi non sono
identici: se, per esempio, Catania avesse lo stesso stipendio di Milano, il
potere d’acquisto di un salariato catanese sarebbe di un 40% superiore a quello
di un milanese. Ma gli stipendi a Catania sono più bassi, per effetti di
composizione settoriale, e il potere d’acquisto si limita a essere uguale a
quello di Milano.
In effetti, anche le medie per
il Centro-Nord e il Mezzogiorno indicano lo stesso livello di stipendio reale.
Ma, per quanto riguarda altre città del Mezzogiorno, a un milanese converrebbe
trasferirsi a Bari, Cagliari, Napoli, Palermo… E lo stesso incentivo varrebbe
per un fiorentino, un genovese o un trevigiano…
CONFRONTI CON L’ESTERO
Guardando al confronto con
altre città europee, quelle italiane hanno, in media, un costo della vita
(inclusi gli affitti) nettamente più basso, e più basso è anche il potere
d’acquisto, a causa di stipendi italiani anch’essi nettamente inferiori a quelli
europei. Il che, se da un lato incoraggia tristemente l’emigrazione degli
italiani, dall’altro dovrebbe incoraggiare gli investimenti internazionali in un
Paese, come l’Italia, dove il costo del lavoro è relativamente basso.
La qualità dell'informazione è
un bene assoluto, che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del
Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con
il massimo di passione e di competenza possibili.
Abbiamo un bene prezioso che
difendiamo ogni giorno e che ogni giorno voi potete verificare. Questo bene
prezioso si chiama libertà. Abbiamo una bandiera che non intendiamo ammainare.
Questa bandiera è quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti
calpestati ma conosce e adempie ai suoi doveri.
Contiamo su di voi per
preservare questa voce libera che vuole essere la bandiera del Mezzogiorno. Che
è la bandiera dell’Italia riunita.
L’Illecito Finanziamento.
Regioni a statuto speciale,
ecco i privilegi: perché sono a spese di tutti noi. Milena Gabanelli e
Simona Ravizza su Il Corriere della Sera il 27 marzo 2023.
Si narra che il cancelliere
tedesco abbia chiesto a Prodi: «Fammi avere la cittadinanza di Bolzano, così
potrò passare una vecchiaia prosperosa». A dire il vero l’idea non dispiace a
nessuno, anzi: il Ddl Calderoli sull’autonomia differenziata si ispira
grossomodo proprio alle Regioni a statuto speciale. Se il decreto approvato dal
Consiglio dei ministri il 2 febbraio 2023 avrà anche il via libera dal
Parlamento, diventerà legge, come annunciato, entro l’inizio del 2024. Allora
per cominciare vediamo perché in Italia abbiamo 5 Regioni a statuto speciale.
Cosa hanno in comune
L’origine risale all’art.116
della Costituzione del 1948. I commi 1 e 2 sanciscono che «Friuli-Venezia
Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale». Le ragioni della scelta hanno
radici diverse: la forte spinta indipendentista in Sicilia; le rivendicazioni
austriache in Trentino-Alto Adige; la prevalenza del dialetto francese in Valle
d’Aosta; la complessità linguistica e l’influenza dell’allora regime comunista
jugoslavo in Friuli-Venezia Giulia; la povertà secolare in Sardegna.
Invece il Ddl Calderoli si rifà
al comma 3 nato dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, che conferisce
alle Regioni a statuto ordinario (Rso) la possibilità di vedersi attribuite
«ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» in 23 materie tra
cui istruzione, salute, ambiente, internalizzazione delle imprese, tutela e
sicurezza del lavoro e produzione di energia. La norma nasce su iniziativa
del governo D’Alema alle prese con le rivendicazioni di autonomia della Lega
Nord e diventa legge sotto il governo Berlusconi. In cosa consiste la
similitudine fra le Regioni a statuo speciale e il Ddl Calderoli? Nel principio
che ogni Regione possa negoziare con lo Stato i settori che intende gestire in
proprio trattenendo i tributi equivalenti (qui art. 2 e 5). Entriamo allora nel
vivo del meccanismo che regola le Regioni a statuto speciale con l’analisi
di Massimo Bordignon, Federico Neri, Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi per
l’Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani della Cattolica (qui).
Quanto trattengono le Regioni a
statuto speciale
Il punto sostanziale è quello
di trattenere per sé la gran parte delle imposte: la Valle d’Aosta si tiene
il 100% di Irpef, Ires (imposta per le società), Iva e accise sui carburanti;
le Province autonome di Trento e Bolzano il 90% e l’80% di Iva;
il Friuli-Venezia Giulia il 59% e il 30% delle accise;
la Sicilia il 71% dell’Irpef, il 100% dell’Ires e il 36% di Iva; e
la Sardegna il 70% su tutto e il 90% di Iva. Con questi soldi si
pagano: sanità, assistenza sociale, trasporti e viabilità locali (che però si
pagano in proprio anche Regioni come Lombardia, Toscana e Lazio), manutenzione
del territorio, infrastrutture per l’attrazione turistica. La Valle d’Aosta e
le due province del Trentino si finanziano anche l’istruzione, ovvero gli
stipendi degli insegnanti.
Cosa paga lo Stato
Lo Stato paga tutto il resto:
le spese per la giustizia (procure e tribunali), le forze dell’ordine,
le infrastrutture di carattere nazionale (come la rete ferroviaria, i trafori,
pezzi di autostrada, a partire da quella del Brennero), i servizi Inps, oltre
alla macchina politica e amministrativa statale. Tutte spese che sono finanziate
dalla fiscalità generale, alle quali queste regioni non partecipano, o lo fanno
in piccola parte.
Costi a Roma, vantaggi alle
Regioni
A conti fatti, come mostrano i
dati dei Conti Pubblici Territoriali, lo Stato in media spende all’anno per ogni
cittadino italiano che vive nelle Regioni a statuto ordinario 10.737 euro, tanto
quanto spende per un cittadino valdostano (10.708), per un abitante
del Friuli-Venezia Giulia 12.170, per un trentino 9.343, un altoatesino 9.222,
un sardo 9.666, e per un siciliano 8.214.
Lo Stato, dunque, non ha di
fatto spese minori, in compenso le Rss hanno il doppio delle risorse da
utilizzare per i loro territori: la media delle spese per i propri cittadini è
di 7.096 euro pro-capite contro i 3.688 delle altre Regioni. E poi quando c’è un
problema si batte cassa, come è il caso della Sicilia, che sui 12 miliardi che
gli servono ogni anno per la sanità, 6 se li fa dare dallo Stato.
Che cosa ci fanno con i soldi
in più
Nelle Regioni a statuto
ordinario le spese correnti per l’istruzione (stipendi insegnanti, materiale
didattico, personale amministrativo, ausiliare, ecc.) pesano in media su ogni
cittadino 815 euro l’anno. Trento e Bolzano possono permettersi di spendere
rispettivamente 1.495 euro pro-capite e 1.304, e la Valle d’Aosta 1.225.
Tradotto: il dirigente scolastico di un liceo a Trento guadagna 99.656
euro lordi l’anno, mentre a Vicenza, a parità di anzianità di servizio non
supera i 63.000 euro.
E per quel che riguarda
l’edilizia scolastica Bolzano può permettersi di investire 205 euro pro
capite, Trento 109 e la Valle d’Aosta 60, contro la media di 36 euro delle
Regioni a statuto ordinario. Lo stesso discorso vale per il personale della
pubblica amministrazione, che è più numeroso e quindi può offrire servizi più
capillari ai cittadini. È vero che dovendo svolgere più funzioni è necessaria
una maggiore presenza di personale dipendente dalla Regione, ma quel personale è
anche pagato meglio: la spesa pro-capite è di 2.580 euro contro la media di
1.862 delle altre Regioni.
Ingiustificabili invece gli
stipendi dei consiglieri regionali, come mostra un’elaborazione dati di Matteo
Boldrini (Luiss-Cise), Silvia Bolgherini (Università di Perugia) e Luca
Verzichelli (Università di Siena). Tra indennità e rimborso forfettario,
i consiglieri senza altri incarichi della Valle d’Aosta (124 mila abitanti) si
mettono in tasca 7.871 euro al mese, 8.800 quelli del Friuli Venezia Giulia,
circa 10.500 in Trentino Alto Adige e Sardegna, 11.100 in Sicilia. Giusto per
fare un confronto con Regioni che hanno più o meno lo stesso numero di abitanti:
nelle Marche siamo a quota 9.100, mentre il consigliere dell’Emilia Romagna ne
incassa 7.250.
Che cosa può succedere
I precedenti tentativi di
regionalismo differenziato finora sono finiti nel nulla. La prima a partire è
la Toscana con la proposta degli enti locali del 2003 di ottenere «autonomia
speciale nel settore dei beni culturali e paesaggistici», ma la procedura non
viene portata avanti. Nel 2017 l’Emilia Romagna tenta di avviare un negoziato
per gestirsi l’internazionalizzazione delle imprese, ambiente e sicurezza sul
lavoro. Ci riprova nel 2019 sull’Irap, che è una tassa regionale: vorrebbe
applicare un’aliquota più bassa alle aziende che stanno sui crinali di collina,
perché più svantaggiate di quelle che stanno a valle. Niente da fare.
In Lombardia e Veneto la richiesta di avviare trattative con il governo passa
dai due referendum del 22 ottobre 2017 (qui la cronistoria). Adesso dipenderà da
come sarà il testo finale della legge. Se il criterio guida sarà quello
della programmazione, ovvero di capire qual è il soggetto che a parità di
risorse può fare meglio, potrebbe essere una buona cosa. Prendiamo i fondi
del Pnrr per l’edilizia scolastica: sono andati ai comuni saltando le Regioni,
ma molti comuni quei progetti non saranno in grado di realizzarli per mancanza
di competenze.
Certo, se dal nulla si va
invece verso 20 regioni autonome il rischio è di un caos regolamentare,
amministrativo e di cassa, perché quando i soldi non bastano chi interviene?
Durante l’emergenza Covid nelle
5 Regioni speciali non solo i ristori sono stati finanziati con la fiscalità
generale, ma lo Stato ha anche azzerato il loro concorso alla finanza pubblica,
che s’aggira sui 2,3 miliardi di euro l’anno.
Antonio Giangrande: Gli affari della Sanità
privata padana a danno di quella del Sud, sotto tutela dello Stato.
Con il principio della spesa storica (riferimento
a quanto percepito negli anni precedenti), il Nord Italia si “fotte” più di
quanto dovuto, a spese del Sud Italia.
In virtù, anche, di quel dipiù la Sanità padana
spende di più perché è foraggiata dallo Stato a danno della Sanità meridionale,
che spende di meno perchè vincolata a dei parametri contabili prestabiliti.
Poi c’è un altro fenomeno sottaciuto:
Nelle strutture private del Nord, costo pieno di
rimborso;
Nelle strutture private del Sud, costo calmierato
di rimborso.
Con questa situazione si crea una contabilità
sbilanciata e un potere di spesa diversificato.
In questo modo i migliori chirurghi del meridione
sono assoldati dalle strutture settentrionali e pagati di più. Questi,
spostandosi, con armi, bagagli e pazienti meridionali affezionati, creano il
turismo sanitario.
Con una finanza rinforzata la Sanità padana è
pubblicizzata dalle tv commerciali e propagandata dalla tv di Stato.
Ergo: loro diventano più ricchi e reclamizzati.
Noi diventiamo sempre più poveri e dileggiati.
Poi arriva il Coronavirus e ristabilisce la
verità:
la presunta efficienza crea morte nei loro
territori;
la presunta arretratezza contiene la pandemia,
nonostante, artatamente, dal Nord per salvare la loro sanità, siano stati fatti
scappare i buoi infetti con destinazione Sud.
Michele Emiliano a Stasera Italia su Rete4 (Rete
Lega) del 3 maggio 2020. «Innanzitutto noi abbiamo aumentato di millecinquecento
posti i posti letto autorizzati da Roma. E abbiamo subito approfittato di questa
cosa. Devo essere sincero: il sistema sanitario pugliese è un sistema sanitario
regolare. Noi non abbiamo mai avuto problemi sulle terapie intensive. Quindi
però, Pomicino evidentemente è intuitivo, capisce che questo è il momento per
cui le sanità del Sud…siccome i nostri non possono più andare al Nord per
curarsi perché è troppo pericoloso, devono essere rinforzate per limitare la
cosiddetta mobilità passiva. Quindi io l’ho detto chiaro: io non terrò più conto
dei limiti, posti letto, assunzioni, di tutta questa roba, perché non siamo in
emergenza. Farò tutte le assunzioni necessarie, assumerò tutte le star della
medicina che riuscirò a procurarmi, cercherò di rinforzare i reparti. Manterrò i
posti letto in aumento. Anche di più se possibile. Chiederò ai grandi gruppi
privati della Lombardia per i quali c’è una norma che li tutelava in modo
blindato. Immaginate: io potevo pagare senza limite i pugliesi che andavano in
Lombardia presso queste strutture, se queste strutture erano in Puglia c’era un
tetto massimo di spesa fatto apposta…Siccome questo tetto deve saltare, io sto
proponendo a questi grandi gruppi di venire e spostarsi al Sud per evitare i
rischi Covid, ma soprattutto per evitare il rischio aziendale per loro. Perché è
giusto che questa mobilità passiva: 320 milioni di euro di prestazioni sanitarie
che la Puglia paga alla Lombardia in prevalenza, solo perché quel sistema è
stato supertutelato. Adesso tutti dovremmo trovare il nostro equilibrio e la
nostra armonia».
Salute e Assistenza. Sanità,
al Sud migliorano le cure ma la mobilità arricchisce il Nord. Dal 2012 al
2021 cinque Regioni del Sud hanno speso per i "viaggi della speranza" quasi 11
miliardi, che sono finiti nelle casse del Nord: si alimenta così il meccanismo
che relega il Mezzogiorno in serie B. VINCENZO DAMIANI su Il Quotidiano del Sud
il 21 Gennaio 2023.
Dal 2012 a 2021, cinque Regioni
del Sud (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Abruzzo) hanno speso per la
mobilità passiva, i cosiddetti “viaggi della speranza”, oltre 10,8 miliardi di
euro: soldi che sono finiti nelle casse del Nord, principalmente Lombardia (6,1
miliardi) ed Emilia Romagna (3,3 miliardi), ma ci hanno guadagnato anche Toscana
(1,3 miliardi) e Veneto (1,1 miliardi).
LA RISALITA DEL SUD
Così si è autoalimentato il
perverso meccanismo che ha portato il sistema sanitario a spaccarsi in due
tronconi, non garantendo al 40% della popolazione italiana gli stessi livelli di
prestazioni. Soldi che, in sostanza, hanno finanziato gli ospedali lombardi,
emiliani, veneti, toscani, andando a sommarsi alle risorse derivanti dall’iniquo
riparto del fondo sanitario che premia, manco a dirlo, sempre il Nord.
Tutto questo nonostante negli
ultimi dieci anni siano state le Regioni del Mezzogiorno a migliorare i loro
conti e la qualità dell’assistenza: l’analisi impietosa è della Corte dei conti,
che ha trasmesso al Parlamento la relazione sulla gestione finanziaria dei
servizi sanitari regionali.
«I risultati delle Regioni in
piano di rientro – si legge nel report – sembrano relativamente migliori e
mostrano una riduzione da 2,1 a 0,7 miliardi di euro dei disavanzi dei servizi
sanitari tra il 2012 e il 2020, con qualche segnale di peggioramento nel 2021, e
indicherebbero un positivo sviluppo gestionale, già maturato con la spending
review 2012-2019».
Le Regioni in piano di rientro
sono quasi tutte del Sud, tranne il Lazio. Solamente nel 2020, le Regioni in
piano di rientro hanno ridotto il disavanzo sul 2019 del 59% circa, quelle non
sottoposte a piano di rientro del 34% e le Autonomie speciali (esclusa la
Sicilia, inserita tra le Regioni in piano di rientro) del 19%. «Il risanamento
finanziario – evidenziano i magistrati – inoltre, non sembra essere avvenuto a
scapito dei Lea, migliorati costantemente almeno fino al 2019, tranne limitate
eccezioni».
MOBILITÀ PASSIVA, UN BUSINESS
PER IL NORD
In definitiva, nonostante il
sottofinanziamento dei sistemi sanitari regionali del Mezzogiorno, nonostante
una mobilità passiva che porta altri miliardi al Nord, il Sud ha ridotto il
proprio deficit, riuscendo persino a migliorare la qualità dell’assistenza e
delle cure. Passi in avanti importanti ma, ovviamente, con poche risorse
finanziarie a disposizione restano «ancora significative le differenze
geografiche nei servizi territoriali, come quelli per le cure palliative ai
malati di tumore, il numero di anziani non autosufficienti in trattamento
socio-sanitario e l’assistenza domiciliare integrata» si legge sempre nella
relazione della Corte dei conti.
La mobilità passiva si è
trasformata quindi in una sorta di business per il Nord, che ha potuto così
alimentare ulteriormente le proprie casse. I pazienti si sono trasformati,
indirettamente, in un “affare”. Una situazione che si è incancrenita per colpa
anche del criterio della spesa storica applicato al riparto del Fondo sanitario
nazionale.
I numeri, certificati sempre
dalla Corte dei conti in un altro documento, parlano chiaro e sono a prova di
smentita: dal 2012 al 2017, nella distribuzione del fondo, sei regioni del Nord
hanno aumentato la propria quota, mediamente, del 2,36%; altrettante regioni del
Sud, invece, già penalizzate perché erano beneficiarie di fette più piccole
della torta dal 2009 in poi, hanno visto lievitare la loro parte solo
dell’1,75%, oltre mezzo punto percentuale in meno.
Significa che, nel periodo dal
2012 al 2017, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana
hanno ricevuto dallo Stato poco meno di un miliardo in più (per la precisione
944 milioni) rispetto ad Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata, Campania e
Calabria.
LA CRESCITA DEI DIVARI
Ecco come è lievitato il
divario tra le due aree del Paese: «Le politiche di finanziamento dei sistemi
sanitari – evidenzia la Corte dei conti – condizionano l’accessibilità alle
cure, la qualità dei servizi e la stessa efficienza dell’organizzazione del
sistema sanitario. Il tema del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
costituisce, dunque, momento fondamentale della problematica connessa alle
esigenze di tutela della salute, in virtù dello stretto legame tra l’effettività
di tale diritto, costituzionalmente garantito, e le risorse disponibili e
investite per renderlo concreto e sostenibile».
Tutto questo ha un solo
riflesso: la spesa pubblica sanitaria pro capite è sbilanciata in favore del
Nord. Infatti, nel 2019, tutte le regioni del Mezzogiorno, a esclusione del
Molise, hanno avuto una spesa pro capite inferiore alla media nazionale, pari a
1.961 euro. Fanalino di coda è la Campania con 1.820 euro, segue la Calabria con
1.868 euro, poi il Lazio (1.875), Sicilia (1.884), Puglia (1.888), Basilicata
(1.902). Al contrario, quasi tutte le regioni del Nord hanno una spesa pro
capite superiore alla media: Liguria 2.132 euro, Friuli Venezia Giulia 2.129,
Valle d’Aosta 2.096 euro, Emilia Romagna 2.067 euro, Toscana 2.032 euro,
Lombardia 2.000. Fa eccezione il Veneto con 1.941 euro, superiore alle regioni
del Mezzogiorno ma lievemente inferiore alla media nazionale.
Nel biennio 2020-2021 la spesa
sanitaria è risultata in aumento, soprattutto in virtù degli effetti pandemici.
L’Italia, nel complesso, continua, tuttavia, a spendere meno dei partner
europei, pur reggendo il confronto nell’efficienza. «Le maggiori risorse
impiegate nella sanità – scrivono i magistrati – hanno interrotto il trend
decennale di contenimento della spesa nel settore, con prospettive di ritorno ai
livelli pre-pandemia, ma sono ancora ampi i divari tra le Regioni».
La qualità dell'informazione è
un bene assoluto, che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del
Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con
il massimo di passione e di competenza possibili.
Abbiamo un bene prezioso che
difendiamo ogni giorno e che ogni giorno voi potete verificare. Questo bene
prezioso si chiama libertà. Abbiamo una bandiera che non intendiamo ammainare.
Questa bandiera è quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti
calpestati ma conosce e adempie ai suoi doveri.
Contiamo su di voi per
preservare questa voce libera che vuole essere la bandiera del Mezzogiorno. Che
è la bandiera dell’Italia riunita.
I Medici.
Sorpresa: il Nord sta peggio
del Sud per carenza di medici. Ecco le città in cui è più difficile curarsi. Gloria
Riva su La Repubblica il 19 Gennaio 2023.
Il report sulla
desertificazione sanitaria di Cittadinanzattiva, l’associazione per i diritti
del malato, mostra le città in cui è più complicato ricevere cure. Le peggiori?
Bolzano, Asti e Caltanissetta
Cos'hanno in comune Asti e
Caltanissetta sul fronte sanitario? La desertificazione sanitaria, ovvero la
difficoltà ad accedere alle cure perché manca il personale, perché i tempi
d'attesa sono infinitamente troppo lunghi o perché l'ambulatorio è troppo
distante. In provincia di Asti ci sono 1813 bambini per ogni pediatra - contro
una media nazionale di circa mille pazienti e una normativa che prevede un
medico ogni 800 under quindici anni – mentre nel territorio di Caltanissetta c'è
un ginecologo ogni 40.565 donne, con una media italiana di uno a 4.132. Questo a
riprova del fatto che le difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale non
risiedono solo nel Sud Italia, ma coinvolgono l'intero territorio nazionale.
Di più, come racconta il
report “Bisogni di salute nelle are interne, tra desertificazione sanitaria e
Pnrr” reso pubblico il 19 gennaio, da Cittadinanzattiva, associazione che si
occupa della tutela dei diritti del cittadino, «il sovraffollamento negli studi
dei medici di base e dei pediatri è evidente soprattutto nel Nord del paese», si
legge nel documento ricevuto in anteprima dall’Espresso. Infatti, tenendo
presente le 39 province dove gli squilibri, tra numero di medici e cittadini,
sono più marcati, primeggiano la Lombardia – e in particolare Bergamo, Brescia,
Como, Lecco, Lodi e Milano – e il Piemonte con Alessandria, Asti, Cuneo, Novara,
Torino e Vercelli in tesa alla classifica. Segue al terzo posto il Friuli
Venezia Giulia e poi viene la Calabria, il Veneto, la Liguria, l'Emilia Romagna,
Trentino Alto Adige e Lazio.
Attenzione però, la situazione
non è drammatica ovunque. Esistono luoghi in cui curarsi è possibile e garantito
dal Servizio Sanitario Nazionale. Facciamo un paio di esempi: sul fronte della
ginecologia, Caltanissetta registra un medico specialista ogni 40.565 donne,
mentre a Roma i ginecologi sono uno ogni 2.292 pazienti. Significa che la
situazione nella provincia siciliana è 17 volte peggiore rispetto al capoluogo,
il che implica una forte disuguaglianza fra cittadini per nulla uguali di fronte
al diritto alla salute. E ancora: a Bolzano c'è un cardiologo ospedaliero ogni
224.706 abitanti (dove la media è di un cardiologo ogni 6.741 abitanti), mentre
il dato migliore è quello di Pisa: uno ogni 3.147 abitanti: «La situazione di
Bolzano è 71 volte peggiore rispetto a chi vive in provincia di Pisa»,
puntualizza Anna Lisa Mandolino, segretaria generale di Cittadinanziattiva che
continua: «Raccogliere questi dati è stato tutt'altro che semplice. La verità
che mancano dati certi, aggiornati e facilmente reperibili sulla carenza di
personale sanitario e questo non agevola la programmazione degli interventi e la
destinazione delle risorse. Per essere chiari, le risorse del Pnrr, che si
concentrano sulle infrastrutture – case e ospedali di comunità in primis –,
avranno senso ed efficacia solo se ci sarà un adeguato investimento anche sul
personale». Altrimenti chi andrà a lavorare in quelle strutture se, in quelle
già esistenti, manca il personale?
Non solo. Per quanto riguarda
la dislocazione dei fondi del Pnrr destinati alla sanità, che equivalgono a
circa 20 miliardi, di cui la maggior parte spesi per nuovi ospedali e case di
comunità, Cittadinanzattiva ha analizzato quante di queste future realtà saranno
realizzate per arginare la desertificazione sanitaria intesa come mancanza di
strutture, ambulatori e punti di cura nelle aree interne. Il risultato
dell'indagine è tutt'altro che roseo: su 1.431 Case della Comunità si prevede
che 508 saranno costruite nelle aree interne, ovvero in una delle 39 province
dove la carenza di personale sanitario e di ambulatori e ospedali è più marcato,
ma nello specifico ci saranno cinque milioni di italiani che vivono nelle aree
periferiche e ultraperiferiche che resteranno quasi sguarniti di qualsiasi
presidio sanitario.
Detto altrimenti, il Pnrr ha
pensato poco alle zone più scollegate e remote, dove sono previste appena il 16
per cento delle case di comunità, che dovrebbero accogliere gruppi di medici di
base e infermieri per creare una solida rete di attenzione al territorio, e
soltanto il 17 per cento degli Ospedali di comunità, dedicati alle cure a lungo
termine per una funzione intermedia tra la cura della malattia acuta (da
affrontare nell'ospedale locale) e il domicilio.
La situazione peggiore, ancora
una volta, non si riscontra al Sud, ma nel Nord: dice il report di
Cittadinanzattiva che in 13 comuni delle valli periferiche della Valle d'Aosta e
in altri 36 comuni dell'entroterra ligure non è stata pensata e programmata la
realizzazione di alcun tipo di servizio territoriale da parte del Pnrr. In
totale, per ben 654.883 italiani che vivono in aree interne periferiche ed ultra
periferiche di 7 regioni, non è previsto alcun ospedale di comunità: si tratta
di Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Umbria e Marche. E ancora una volta, sorpresa, è il Nord a subire la maggiore
desertificazione sanitaria.
Le Pensioni.
La disfatta del Meridione:
il numero di pensioni ha superato gli stipendi. Studio della Cgia: i
titolari di un assegno sono più dei dipendenti e degli autonomi. Gian Maria De
Francesco il 31 dicembre 2022 su Il Giornale.
Il Mezzogiorno vive un
preoccupante paradosso occupazionale: il totale dei pensionati è superiore alla
somma di lavoratori dipendenti e autonomi. La sproporzione è drammatica: 7,2
milioni i pensionati contro circa 6 milioni di lavoratori. Un dato che influenza
quello nazionale: nell'insieme della Penisola i pensionati superano i lavoratori
di 205mila unità con 22,7 milioni di assegni a fronte di 22,5 milioni di addetti
a gennaio 2022.
È quanto ha sottolineato
l'Ufficio studi della Cgia di Mestre evidenziando che, a livello territoriale,
tutte le regioni del Mezzogiorno presentano un numero di occupati inferiore al
numero degli assegni pensionistici erogati. In termini assoluti le situazioni
più «squilibrate» si sono verificate in Campania (-226mila), Calabria
(-234mila), Puglia (-276mila) e Sicilia (-340mila). Tra le province con maggior
problematicità si segnalano Messina (-94mila), Lecce (-104mila) e Napoli
(-137mila). Nel Centro-Nord, invece, solo Marche (-36mila), Umbria (-47mila) e
Liguria (-71mila) presentano una situazione di criticità. Le situazioni più
«virtuose» sono in Emilia Romagna (+191mila), Veneto (+291mila) e Lombardia
(+658mila).
La principale motivazione di
questo fenomeno risiede nella denatalità. Tra il 2014 e il 2022 la popolazione
italiana nella fascia di età più produttiva (25-44 anni) è diminuita di oltre
1,36 milioni di unità (-2,3%). Tra inizio 2019 e settembre 2022 questo fenomeno
il Meridione ha perso 575mila persone in età lavorativa. Tuttavia, il risultato
anomalo del Sud va spiegato anche in base al minor numero degli occupati è
sensibilmente inferiore. Alla fine del terzo trimestre 2022 il tasso di
occupazione del Mezzogiorno si attestava al 46,6% dove è in diminuzione di 0,3
punti percentuali rispetto alla fine di giugno 2022, con un lieve incremento del
tasso di inattività al 45,7%. In valore assoluto i meridionali di età compresa
tra 15 e 64 anni che non hanno un lavoro e non lo cercano sono 5,8 milioni.
Confrontando le analisi della
Cgia di Mestre con i recenti dati Istat, si può dedurre che in qualche misura il
reddito di cittadinanza, oltre a non aver funzionato per l'inserimento
lavorativo dei meridionali, abbia funzionato anche da «scivolo» verso la
pensione dei residenti al Sud. E se anche, come evidenziato dallo Svimez,
l'emigrazione (125-150mila persone l'anno) continua a svuotare il Mezzogiorno di
persone in età lavorativa, gli imprenditori non solo al Nord, osserva l'Ufficio
studi degli artigiani mestrini, denunciano difficoltà nel reperire personale. E
non si tratta solo di figure professionali la cui mancanza è causata anche dal
disallineamento tra scuola e mondo delle imprese. I giovani, prosegue la Cgia,
tendono a rifiutare le posizioni meno prestigiose che solo in parte vengono
coperte dai lavoratori stranieri. E questa sembrerebbe rappresentare un'altra
distorsione generata dal reddito di cittadinanza anche se non ci sono
statistiche eloquenti sul tema. Di certo, la «congruità» dell'offerta ai
percettori del reddito, che consente fino a oggi di non accettarla, è un freno
all'occupabilità.
C'è, però, un altro dossier su
cui intervenire ed è la politica per la famiglia. Secondo la Banca d'Italia, è
indispensabile incentivare la crescita demografica (aiuti ai genitori e ai
minori), allungare la vita lavorativa, incrementare la partecipazione femminile
nel mercato del lavoro e, infine, innalzare il livello di istruzione della forza
lavoro. Tutte sfide che nel 2023 il governo dovrà necessariamente affrontare.
Lavoro, in Puglia si pagano
più pensioni che stipendi. Ma gli assegni previdenziali sono bassi. Forte (Spi
Cgil): Occorre intervenire. Gianpaolo Balsamo su La Gazzetta del Mezzogiorno
il 15 Gennaio 2023
In Puglia (così come nel resto
d’Italia) si pagano più pensioni che stipendi. Semplificando al massimo i
numeri, in questo momento a ricevere l’assegno previdenziale sono 276mila unità
in più rispetto a coloro che stanno percependo una busta paga o sono dei
lavoratori autonomi. Complessivamente nel Tacco d’Italia ci sono 1 milione e 482
mila pensionati, contro 1 milione e 207 mila lavoratori.
Ma c'è di più: in relazione al
numero di cedolini emessi dall'Inps rispetto alle buste paga mensili, la Puglia
è al secondo posto in Italia, seconda solo alla Sicilia. A diffondere questi
dati particolarmente allarmanti è l’Ufficio studi dell’Associazione artigiani e
piccole imprese Cgia di Mestre.
A livello nazionale il numero
delle pensioni erogate agli italiani (pari a 22 milioni e 759 mila assegni) ha
superato la platea costituita dai lavoratori autonomi e dai dipendenti occupati
nelle fabbriche, negli uffici e nei negozi (22 milioni 554 mila addetti). La
situazione più “squilibrata” si verifica nel Mezzogiorno. Se nel Centro-Nord
(con le eccezioni di Liguria, Umbria e Marche) i lavoratori attivi, anche se di
poco, sono più numerosi delle pensioni erogate dall’Inps e dagli altri istituti
previdenziali, nel Sud il sorpasso è già avvenuto e la Puglia, come detto, è la
triste conferma.
«La colpa non è certo degli
anziani - spiega il segretario generale dello Spi Puglia, Gianni Forte -. Al Sud
non si fanno politiche demografiche affinché i giovani rimangano al Sud e
mettano su famiglia. Quando c’è instabilità e ci comincia a lavorare in età
avanzata è chiaro che ne risente la parte occupazionale».
In linea di massima, evidenzia
Cgia di Mestre, le ragioni di questo divario tra lavoratori e numero di pensioni
vanno ricercate nella forte denatalità che, da almeno 30 anni, sta
caratterizzando il nostro Paese. Il calo demografico, infatti, ha concorso a
ridurre la popolazione in età lavorativa e ad aumentare l’incidenza degli over
65 sulla popolazione complessiva. Si segnala che tra il 2014 e il 2022 la
popolazione italiana nella fascia di età più produttiva (25-44 anni) è diminuita
di oltre un milione e 360 mila unità (-2,3 per cento). Per quanto concerne il
risultato «anomalo» del Sud, va segnalato che, rispetto alle altre ripartizioni
geografiche d’Italia, il numero degli occupati è sensibilmente inferiore.
«Va anche evidenziato -
aggiunge il segretario generale del Sindacato pensionati italiani della Puglia,
Gianni Forte - che le pensioni al Sud sono basse. C’è un gap molto forte
rispetto al Nord e anche gli interventi del Governo («Quota 100», «Quota 101»,
«Quota 102» e «Quota 103») sono indirizzati soprattutto verso il Nord perché lì
risiede la grande platea che ha usufruito di questi benefici di anticipo
pensionistico. Anche la prospettiva non è entusiasmante».
Destano preoccupazione le
pensioni soprattutto alla luce dei numeri del Rendiconto sociale 2020–2021
dell’Inps. «Il dato più allarmante - spiega Forte - riguarda l’entità
dell’assegno medio mensile liquidato in Puglia in seguito al passaggio dal
sistema misto (retributivo e contributivo) a quello contributivo puro. Con il
primo la pensione media è di 967,53 euro, con quello in vigore si arriva a un
terzo: 376,87 euro». In Puglia le pensioni più base si percepiscono nel Salento
e nel Foggiano. Pensioni da fame, nuove povertà all’orizzonte.
«Lo Spi Cgil Puglia auspica
l’introduzione di “pensioni minime di garanzia”, interventi sui periodi
figurativi a fronte di contratti a termine e precari sempre più in crescita e il
riconoscimento dei lavori di cura, svolti soprattutto da donne. Il rischio è
quello di far saltare il “sistema a ripartizione” che oggi è alla base del patto
di solidarietà tra generazioni. Il Governo, senza giustificazione e confronto
con le parti sociali ha messo le mani nelle tasche dei pensionati considerandoli
alla stregua di bancomat, tagliando ben 3,7 miliardi di euro e bloccando
parzialmente la rivalutazione senza prevedere reinvestimenti nel sistema
pensionistico. Di tutto questo si parlerà nell’ambito del XVI congressi Spi Cgil
Puglia che si terrà domani e il 17 gennaio a Bari.
Ieri intanto, c’è stato un
nuovo tentativo tra governo e parti sociali per mettere mano al sistema
previdenziale con una riforma organica che non si limiti a interventi tampone.
Giovedì 19 è fissato un incontro al ministero del Lavoro ma la Cgil sottolinea
già la necessità di andare oltre i tavoli con decine di sigle per iniziare un
confronto nel merito con i soggetti veramente rappresentativi. La ministra del
Lavoro, Marina Elvira Calderone, si è detta ottimista, convinta delle necessità
di razionalizzare il sistema. Per la Cgil però la legge di Bilancio ha «gettato
un’ombra» sul confronto peggiorando la situazione precedente per quanto riguarda
le donne e i precoci e sottraendo risorse ai pensionati con il taglio alla
rivalutazione degli assegni rispetto all’inflazione.
L’Autonomia Differenziata.
Il Sud cresce quasi quanto il Nord: a cosa è
dovuta la ripartenza a sorpresa. Storia di Valentina Iorio su Il Corriere
della Sera mercoledì 23 agosto 2023.
L’economia del Mezzogiorno tiene il passo con il
resto del Paese dopo la ripartenza post Covid. Nel 2023, a fronte di una
crescita del Pil italiano del +1,1%, per il Sud si prevede un +0,9%, soli tre
decimi di punto percentuale in meno rispetto al Centro-Nord (+1,2%). Dopo un
decennio caratterizzato dall’allargarsi dei divari tra le regioni, l’ultimo
rapporto Svimez mostra come il Sud abbia partecipato attivamente alla ripartenza
del biennio 2021-2022, malgrado i divari accumulati negli anni rispetto alle
regioni del Nord continuino a pesare. «A differenza di quanto era accaduto dopo
la crisi del 2008, questa volta il Sud ha contribuito alla ripartenza
dell’economia italiana», dice Carmelo Petraglia, economista e consigliere
scientifico della Svimez. Ma quali fattori hanno contribuito alla ripresa del
Mezzogiorno?
Il Nord cresce di più ma dopo una maggior
flessione
Nel biennio 2021-2022, secondo i dati Svimez,
l’economia del Mezzogiorno è cresciuta del 10,7% compensando la perdita del 2020
(-8,5%). Nel Centro-Nord, la crescita è stata leggermente superiore (+11%), ma
ha fatto seguito a una maggiore flessione nel 2020 (-9,1%). Il fatto che la
frenata dell’economia al Nord sia stata più brusca in parte spiega perché lo
scarto nella ripresa è più ridotto rispetto al passato. Ma questa non è l’unica
ragione.
L’effetto Superbonus e Pnrr sulle costruzioni
Nel Mezzogiorno i settori che sono andati meglio
sono quelli dei servizi e delle costruzioni. La crescita del settore è stata
trainata in particolare dal Superbonus. «Rispetto a quanto avvenuto in passato
con il Superbonus c’è stata una distribuzione degli incentivi più omogenea tra
Nord e Sud. E il Mezzogiorno ha mostrato una capacità di assorbimento
decisamente superiore rispetto a precedenti agevolazioni fiscali in materia
edilizia», spiega Petraglia. «Ora si cominciano ad aprire i cantieri del Pnrr
che potrebbero almeno in parte compensare la stretta sul Superbonus», aggiunge
Petraglia.
Il boom del turismo al Sud
Anche il settore dei servizi, soprattutto grazie
al boom del turismo, ha avuto un ruolo determinate nel favorire la ripartenza
dell’economia del Sud. «La crescita dell’occupazione nel terziario è stata
trainata in particolare dalle attività di alloggio e ristorazione che, con circa
100 mila addetti aggiuntivi, spiega circa un quarto della crescita complessiva.
Al Sud sono cresciuti anche gli occupati nelle costruzioni, mentre si è rivelato
modesto il contributo del settore industriale, soprattutto comparativamente alle
perdite occupazionali sofferte dal settore negli anni passati», si legge nel
rapporto della Svimez. «Il rimbalzo post-Covid del settore dei servizi ha
favorito questa crescita», sottolinea Petraglia. «Il contributo del settore
industriale nel Mezzogiorno continua a essere modesto. Considerando che secondo
le previsioni nel 2023 e nel 2024 la crescita sarà trainata da industria ed
export, il Sud rischia di rimanere più indietro nel prossimo biennio», aggiunge
l’economista.
Le incognite e i rischi di una nuova stretta
monetaria
Su quanto questa ripresa possa essere duratura
gravano diverse incognite: dall’andamento dell’inflazione a nuove strette
monetarie da parte della Bce che potrebbero far arretrare nuovamente l’economia
del Mezzogiorno. «Un’ulteriore stretta monetaria da parte della Bce avrebbe
effetti depressivi più pronunciati nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord,
contribuendo ad ampliare la forbice nei tassi di crescita tra le due aree»,
evidenzia Carmelo Petraglia. Per quel che riguarda l’inflazione e in particolare
la tenuta dei consumi, l’economista evidenzia come al Sud abbiamo retto meno che
al Nord a causa dell’aumento dei prezzi. «La spesa incomprimibile al Sud pesa di
più perché ci sono più famiglie a basso reddito - spiega Petraglia - e il venire
meno del Reddito di cittadinanza potrebbe avere ripercussioni sulla crescita
2023».
Emiliano: “Il Nord tenta di frenare la crescita
del Sud. Il Pd si batta per noi”. Edoardo Sirignano su L'Identità il 20
Agosto 2023
MICHELE EMILIANO PRESIDENTE REGIONE PUGLIA
di EDOARDO SIRIGNANO
“Il governo Meloni si accinge attraverso il
Ministro Fitto a distruggere le politiche di superamento del divario Nord-Sud.
Allo stesso tempo, però, vedo nel Pd una totale assenza di leadership di vertice
meridionali e il tentativo frequente di trasformare in populisti e macchiette i
sindaci e i presidenti del Sud”. A dirlo Michele Emiliano, governatore della
Puglia.
La CGIA di Mestre sostiene che il Sud cresce
quattro volte più di Germania e Francia. La ricerca corrisponde alla realtà?
Immagino che i dati siano veritieri, anche se
indicano un trend, un processo in corso che lascia comunque il Sud con un
reddito pro capite che è meno della metà di quello della Lombardia, con un
gettito fiscale enormemente inferiore a quello delle regioni del Nord. Bisogna
dunque essere incoraggiati ad andare nella giusta direzione, senza mollare di un
millimetro e senza interrompere le politiche di coesione nazionali (FSC) ed
europee (FESR e FES). Purtroppo il Governo Meloni si accinge attraverso il
Ministro Fitto a distruggere le politiche di superamento del divario Nord Sud,
saccheggiando i fondi nazionali per il Sud per completare il Pnrr senza più
rispettare i parametri a favore del Sud.
Possiamo parlare di riscatto meridionale?
Quando con un gruppo di amici di tutti gli
orientamenti politici e con l’aiuto delle scarse forze del centrosinistra in
Puglia iniziammo la rivoluzione pugliese non credevamo certo che in soli 20 anni
avremmo conquistato il rispetto dell’Italia e dell’Ue attraverso un durissimo
lavoro prima di ripristino della legalità e di lotta alle mafie e poi di
creazione delle condizioni giuste per aumentare in modo evidente la nostra
competitività economica.
Lo scrittore Pino Aprile dice che si diffondono
ricerche poco attendibili per sottrarre al Mezzogiorno risorse. Stiamo parlando
della classica scusa per dire che questa parte del Paese sta bene e quindi non
ha bisogno più di aiuti?
Pino Aprile fa bene a sospettare di tutto e di
tutti. L’Autonomia differenziata e il saccheggio del FSC sono la prova dei
tentativi nordisti di bloccare la rincorsa del Sud utilizzando la coalizione di
centrodestra.
La sua Puglia è stata più di un semplice modello
quest’estate per quanto concerne il turismo. Nonostante ciò, nella terra amata
dai milionari, le povertà restano un problema. Come superare il controsenso?
Come le ho detto serve ancora molto tempo di
livelli alti di trend economico per superare la questione meridionale che è
essenzialmente povertà cui siamo costretti da 160 anni da un processo unitario
ineguale.
C’è sempre più bisogno di una forza in grado di
tutelare le istanze del territorio. Il Pd, a volte, ha difficoltà in tal senso.
Come superarle?
Il Pd ha imbroccato assieme alle altre opposizioni
un’estate militante che ha distrutto l’immagine del Governo Meloni che non
mantiene le promesse sulla riduzione delle accise sulla benzina, che ha
distrutto il reddito di cittadinanza come ammortizzatore universale, che non
riesce a gestire i flussi migratori e che grazie al blocco del PNRR e dei Fondi
Europei e nazionali ha mandato l’Italia in recessione dopo il Governo Draghi in
cui l’Italia cresceva del 6/7% annuo.
È d’accordo con chi dice che nel suo partito viene
dato poco ascolto agli amministratori?
Sono sciocchezze. Renzi è diventato segretario del
partito mentre era sindaco di Firenze. Bersani era stato presidente della
Regione Emilia-Romagna. Veltroni è diventato segretario mentre era sindaco di
Roma. Zingaretti era Presidente del Lazio e leader del partito. La Schlein e
Bonaccini erano vice presidente e presidente dell’Emilia Romagna. Piuttosto vedo
una totale assenza di leadership di vertice meridionali nel PD e il tentativo
frequente di trasformare in populisti e macchiette i sindaci e i presidenti del
Sud. E invece una grande forza per i progressisti è nascosta al Sud. È compito
nostro rompere questo assedio e questa discriminazione.
Su quali punti, relativi a Sud e sviluppo,
occorrerebbe una politica più incisiva da parte delle opposizioni e dello stesso
governo?
Bisogna lasciare intatte e se possibile potenziare
le politiche di coesione degli ultimi anni impedendo al Ministro Fitto di
saccheggiare le risorse destinate al Sud per mettere una pezza ai buchi
finanziari provocati dai vari governi nazionali degli ultimi anni. La Campania e
la Puglia in particolare sono treni economici del Sud che non vanno fermati.
Pino Aprile: “Noi terroni voliamo alti, ora il
Nord non pensi di toglierci i nostri soldi”. Edoardo Sirignano su L'Identità
il 20 Agosto 2023
PINO APRILE SCRITTORE
di EDOARDO SIRIGNANO
“Lo studio della Cgia di Mestre serve a dire che
il Sud non ha bisogno di aiuti. Come fa a crescere 4 volte più di Germania e
Francia messe insieme, tra l’altro in un mese, chi non ha ferrovie, autostrade e
centri di ricerca”. A dirlo Pino Aprile, giornalista e scrittore.
Perché non si fida dell’ultimo studio sulla
ripresa?
Nel giro di un mese, abbiamo visto prima
glorificare l’Italia, che secondo alcuni cresceva più del resto d’Europa e poi
subito invece si è parlato di discesa. Ora si riparla di ripresa, pure se in
modo parziale. Ecco perché vorrei aspettare un po’ di tempo prima di emettere
verdetti definitivi. Vorrei capire se si tratta di oscillazioni nel breve
periodo o di fenomeni strutturali. Attendiamo che quanto sostenuto dalla Cgia,
venga detto anche un altro ente.
Quali sono i rischi nel diffondere un’informazione
affrettata?
Sono due. Il primo è che un fenomeno momentaneo
venga letto e commentato come se fosse strutturale. Il secondo è che venga fatto
passare per verità indiscussa un dato, che almeno per quanto mi riguarda,
considero di debole attendibilità. Non dimentichiamo che stiamo parlando degli
stessi signori che ci hanno raccontato che il Comune più povero d’Italia era ai
confini con la Svizzera, non tenendo però conto che i suoi abitanti di giorno
passavano la frontiera, guadagnando cifre che non avevano nulla a che vedere con
le nostre. Si faceva, intanto, passare per vero qualcosa che non lo era.
Il Sud davvero si sta riprendendo o meglio ancora
si sta rimboccando le maniche?
Si è sempre rimboccato le maniche. Le p…e che
raccontano servono solo a codificare, cristallizzare un pregiudizio di un Sud
fannullone e mantenuto. Ciò è una cretinata. Il Mezzogiorno, proprio per le
condizioni in cui è stato messo, con una scelta politica di emarginazione e
sottrazione, che dura da oltre un secolo e mezzo, ha disperato bisogno di aiuto.
Detto ciò, il Sud si è sempre inventato il lavoro e quando non ha potuto farlo
in loco, è stato in grado di farlo ovunque nel mondo. Il resto sono luride
sparate razziste.
Come fa a dirlo?
Siamo l’unico Paese del mondo sviluppato che ha al
governo delle persone con condanne per razzismo.
A chi si riferisce?
Salvini ha patteggiato una condanna per razzismo
contro i meridionali. In quale nazione al mondo starebbe al governo? La
Costituzione, poi, è nelle mani, perché ne faccia scempio, di un tale Calderoli,
promotore di una legge elettorale da lui stesso definita una porcata.
Siccome le sa fare, gliene facciamo fare un’altra
sull’autonomia differenziata? Stiamo parlando di chi è stato condannato per
razzismo in primo e secondo grado. La Cassazione, per un vizio di forma, ha
disposto che si rifacesse il processo. A questa gente facciamo mettere mano alla
legge dello Stato? A volte, penso che siamo in un Paese di pazzi da ricovero.
In questo clima di pazzi, c’è davvero, però, un
Sud, che in controtendenza agli slogan, come dimostrano i dati sul turismo,
traina la ripresa?
Sono tutte cose che do per scontate. I pericoli,
le ripeto, sono due. Come fa la Cgia di Mestre a dire che a Sud va tutto bene.
Forse sotto sotto ci vuole dire non rompeteci le p…e, che questa parte dello
stivale non ha bisogno di aiuti. Altro rischio, poi, è far passare il messaggio
che perché si cresce ci sia stata una svolta. Non è così. Come fa a cambiare
tutto in una parte del Paese, che oggi come due mesi fa, non ha le ferrovie, che
al Nord invece vengono realizzate con i soldi dei meridionali? Stesso discorso
vale per autostrade e centri di ricerca strapagati. I porti, poi, ci sono, ma
non vengono fatti lavorare perché tocca solo a Trieste. Chi sta sprofondando nel
Sud del Mediterraneo come fa a essere il motore dell’Italia? I cambiamenti
strutturali non possono avvenire in un mese.
Perché?
Andiamoci piano. Se non cambiano le circostanze, i
dati strutturali della produzione, della crescita, si tratta di guizzi e non di
altro, di oscillazioni stagionali.
Cosa potremo scoprire a settembre?
Che il Sud non è quello descritto dalla Cgia. Non
facciamoci ingannare. Ciò ovviamente non significa che non c’è voglia di
riscatto, anzi c’è qualcuno che vuole che pensiamo il contrario. Stiamo parlando
di un ente che esiste non per l’Italia, ma per un gruppo ben definito. Mi
aspetto che Svimez diffonda gli stessi dati. Solo allora crederò a quanto
diffuso da Mestre.
Matteo Salvini il neo “pontefice
meridionalista”.
Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei
Trasporti.
Se al Viminale l'ossessione erano i migranti, al
ministero dei Trasporti il nuovo assillo del leader della Lega si chiama "Ponte
sullo Stretto", per far crescere il Sud nonostante l'autonomia differenziata.
Rocco Vazzana su Il Dubbio il 20 agosto 2023
Se dal Viminale l’ossessione erano i migranti, dal
ministero dei Trasporti il nuovo assillo di Matteo Salvini si chiama Ponte sullo
Stretto di Messina. Come in tanti prima di lui, il leader del Carroccio sogna di
legare il suo nome alla realizzazione della mega opera e prova a velocizzare le
“pratiche” per evitare di finire impantanato come tutti i suoi predecessori. Per
ora ha solo tolto il limite di 240 mila euro ai dirigenti pubblici che si
occuperanno del progetto, da qualche parte bisognerà pur cominciare, ma non c’è
intervento pubblico, intervista o sagra di Paese in cui Matteo Salvini non parli
del suo grande sogno nel cassetto che cambierà le sorti di Sicilia e Calabria.
Proprio lui, l’uomo venuto Nord e capo di un partito con radici ben piantate
nell’operoso Settentrione, desidera passare alla storia come il “pontefice” che
rilanciò le economie meridionali.
Pazienza se per ora non si è andati molto oltre la
cortina delle chiacchiere, per il ministro Salvini il ponte si farà in tempi
ragionevoli in barba a gufi e “sabotatori” professionali. E in attesa
dell’ennesima posa della prima pietra - da qualche parte ci sarà ancora quella
simbolicamente depositata da Silvio Berlusconi nel 2004 - il ministro e
vicepremier sciorina numeri e slogan. «Porterà 100mila posti di lavoro»,
promette il leader della Lega, calcando il solco del padre nobile del
centrodestra. E ancora: «È un diritto alla mobilità e continuità territoriale
per milioni di siciliani che devono andare a farsi curare, devono studiare,
andare a lavorare senza aspettare ore i traghetti», dice Salvini, scordando però
di specificare che i siciliani, come i calabresi omessi dal ragionamento,
avrebbero diritto a farsi curare, a studiare e a lavorare in Sicilia prima di
tutto. Niente di grave, sarà stata una semplice dimenticanza o un messaggio
riuscito male.
Un po’ come quei 2,5 miliardi di euro del Pnrr
destinati alla realizzazione di infrastrutture nel CentroSud che il Mit ha
deciso di dirottare verso Nord per scongiurare il rischio di perdere i fondi.
Ragione ufficiale della rimodulazione del Piano: «Lo stato progettuale non
consente di bandire le gare entro il 2023». Meglio spostare i liquidi verso
opere “più mature” situate in Piemonte, Lombardia e Veneto. La scelta,
ovviamente, non è sfuggita alle opposizioni, che hanno colto la palla al balzo
per imputare a Salvini il vecchio vizio leghista di dirottare risorse verso aree
geografiche ben definite.
Un’accusa inaccettabile per il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti - già impegnato a convincere i meridionali della
bontà dell’Autonomia differenziata targata Calderoli - improvvisamente diventato
paladino della causa sudista. Così, alle polemiche di Pd e M5S, l’ex capitano
risponde sciorinando cifre e numeri direttamente forniti dal suo ministero: ben
75 miliardi di euro in infrastrutture destinati alla Sicilia e alla Calabria
anche in vista della realizzazione del Ponte. «In Sicilia sono progettati
investimenti per circa 15 miliardi di euro con particolare attenzione alle
strade statali di collegamento, alle tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania
e ai lavori dell’autostrada Siracusa - Gela», fanno sapere dal Mit.
«In Calabria è previsto un piano di investimenti complessivo pari a 12,8
miliardi per strade e autostrade, 3 dei quali già stanziati con decreto per la
SS106 Jonica, su cui l’investimento complessivo è di circa 9 miliardi». E
ancora: 13 miliardi «programmati» per la rete ferroviaria siciliana e 34,8
miliardi per quella calabrese. Sempre che alcuni di questi “programmi” non
subiscano qualche nuova “rimodulazione”.
Salvini non si cura dei soliti “criticoni” e
prosegue dritto per la sua strada: il Ponte è la sua missione e lo costruirà. Se
non tutto, almeno una prima pietra.
Estratto dell’articolo di Filippo Ceccarelli
per “il Venerdì – Repubblica” venerdì 11 agosto 2023.
Ci sono episodi della recente storia che il
buonsenso s'incarica di dimenticare. Eppure questi momenti offrono se non un
insegnamento, almeno una spiegazione del presente, e dunque: che Paese è mai
quello in cui a pretendere l'autonomia differenziata è lo stesso personale che
ammainava il tricolore, istituiva la Guardia Nazionale Padana, batteva moneta
creando da zero un microcosmo nazional-parallelo con previsioni meteo,
campionato di calcio, scacchisti e a un certo punto addirittura un circo padano?
In tale contesto l'odierno ministro Calderoli
garantiva che per la secessione era pronto a "mettere in gioco" la sua vita;
mentre il giovane Salvini, allora con l'orecchino, si baloccava coi simboli
celtici commutandoli in braccialetti e ciondoli - là dove oggi tiene il Sacro
Cuore di Gesù e il logo smaltato del Papeete.
Forse non tutti ricordano che la proclamazione
della Padania con l'acqua santa sul Monviso, la catena umana sul Po e il Va
pensiero a Venezia evidentemente non bastava più, così nell'ottobre del 1997
Umberto Bossi, uso a infliggere la sua più stralunata fantasia alla più
pervicace creduloneria dei suoi adepti, s'inventò lo svolgimento di vere e
proprie elezioni padane con liste, candidati, conteggi e seggi-gazebo per farsi
un Parlamento su misura.
[…] A quell'incredibile vicenda dedica un tesoro
di cura e di meticolosità Gabriele Maestri, infaticabile blogger (www.
isimbolidelladiscordia.it) nonché pontefice massimo dell'emblematica elettorale
all'italiana in Padani alle urne (Youcanprint). Nel mentre Roma era divisa tra
chi sghignazzava, chi si scandalizzava e chi richiedeva le forze dell'ordine, in
Padania la situazione andò presto fuori controllo e invece dei cinque o sei
previsti raggruppamenti si presentarono quasi 90 liste, poi ridotte a 68 con
relativi simboli: aquile, spade, paesaggi, fiaccole, corone, planisferi, elmi
medievali, scudi sannitici, aironi, strette di mano, homines vitruviani e Che
Guevari.
Ma solo Maestri poteva sapere e oggi rivelare che
dietro al profluvio c'erano i più impenitenti e pazzotici protagonisti della
micropolitica meta-condominiale. Votarono, secondo la Lega, più di sei milioni
di cittadini; molto probabilmente erano dieci volte meno; Salvini fu eletto con
i comunisti padani. […]
La locomotiva Lombardia. Per cultura sono
un uomo portato a non idolatrare alcunché. Figurarsi le agenzie di rating, non
proprio oracoli per me. Pompeo Locatelli il 18 Luglio 2023 su Il Giornale.
Per cultura sono un uomo portato a non idolatrare
alcunché. Figurarsi le agenzie di rating, non proprio oracoli per me. Tuttavia,
leggo i loro giudizi perché so bene quanto possano influire sulle mosse degli
investitori. Ecco perché non poteva non richiamare la mia attenzione il responso
reso pubblico in questi giorni da Moody's, la famosa agenzia di rating a stelle
e strisce a proposito dello stato di salute della Lombardia, mica una regione
fra le altre ma quella leader dell'economia italica.
Ebbene, il giudizio espresso da Moody,s
sull'affidabilità creditizia del sistema lombardo è lusinghiero. Volendoci
ricavare una sintesi ad effetto si può affermare che la Lombardia, per come
stanno le cose, viene ritenuta un soggetto più affidabile e perciò più
meritevole di fiducia dello Stato italiano. In pratica: la valutazione per la
Lombardia è di Baa2, mentre per lo Stivale è di Baa3. Dunque, oggi il Pirellone
e dintorni presentano una certa solidità finanziaria.
Ma il raggiungimento di tale giudizio positivo a
cosa è ascrivibile? Certo, non si può non riconoscere il buon lavoro svolto
dalla governance lombarda soprattutto in una contingenza storica che definire
critica è un eufemismo. Tuttavia, la ragione più importante, attiene ad altro, a
un patrimonio che è capace ogni volta di rinnovarsi e mi riferisco al tessuto
imprenditoriale della regione. Ovvero: all'economia lombarda. D'altronde se la
Lombardia è di gran lunga al vertice dell'economia nazionale, l'autentica
colonna portante, vuol dire che lo stato di buona salute della regione,
evidenziato dal giudizio dell'agenzia di rating statunitense, non può che
testimoniare la centralità dell'economia reale lombarda.
I numeri parlano chiaro. Nel 2022 le esportazioni
delle imprese lombarde hanno raggiunto la cifra di 163 miliardi. Per capirne la
performance, diciamo che è più del doppio di Paesi quali Portogallo e Finlandia.
La Lombardia viaggia sul binario giusto. A livelli pre-Covid. Morale: l'economia
reale non tradisce se viene lasciata lavorare senza ostacoli dalla politica.
Erika Stefani: “Perché il Sud guadagnerà
dall’autonomia differenziata”. Ivano Tolettini su L'Identità il 5 Agosto
2023
L’intervista a Erika Stefani: Vi spiego perché il
Sud guadagna dall’Autonomia Differenziata.
“Quando l’autonomia differenziata andrà a regime
sarà una sorpresa anche per il Sud. Se sono sicura? Vede, mi stupisce questo
allarmismo ideologico, disancorato dalla realtà. Il nostro Meridione ha le
potenzialità per crescere, lo dimostrano le stime dello Svimez sul Pil, perciò
il Sud ci guadagnerà da questa riforma perché quando saranno individuati i
Livelli essenziali delle prestazioni, i Lep, nessuna area del Paese dovrà
rimetterci. Nessuno di noi, e Calderoli per primo, vuole spaccare il Paese che
amiamo. Teniamo tutti all’Italia, da Bolzano a Trapani”.
La vicentina Erika Stefani, senatrice leghista, ex
ministra per gli Affari regionali e le autonomie nel governo, maneggia la
materia autonomista come pochi ed è decisa. Va diritta al cuore del problema.
“Non sono né ottimista né pessimista. Sono una persona pragmatica, che di
professione fa l’avvocata civilista e mi conformo alla regola dello stare ai
patti. So quanto difficile è superare il pregiudizio di una parte degli
amministratori e dei politici del Sud, ma il punto centrale a mio avviso è il
seguente: inserendo i Lep noi indichiamo i livelli al di sotto dei quali non
possono andare i fabbisogni e i costi standard. È una garanzia”.
Erika Stefani: L’autonomia differenziata avrà
percorso spedito
Appunto senatrice Stefani, vuol dire regimentare
le spese e inserirle in un percorso che voi dite virtuoso.
Proprio così, ma allora la politica non potrà più
avere alibi. Continuare a dire che la colpa è del governo centrale, ad esempio
per la cronica mancanza di fondi. Guardi che il mio ragionamento va al di là
dell’appartenenza al centrodestra o al centrosinistra. Ne faccio una questione
di cultura politica.
Lei ripete che l’autonomia innescherà ciò che è
fermo da trent’anni. Ne è convinta?
Altroché, perché l’individuazione dei Lep andrà ad
incidere direttamente sul volume della spesa pubblica. Ecco perché bisogna farli
bene.
Introducono un controllo della spesa pubblica.
Con i fabbisogni e i costi standard sì. Mi
stupisco di certo allarmismo perché già oggi abbiamo i livelli essenziali in
ambito sanitario (Lea), così come per i Comuni. Mi chiedo come si fa ad essere
spaventati da un meccanismo amministrativo che già si conosce? L’autonomia
migliorerà la selezione e i meccanismi della spesa.
Fratelli d’Italia vuole un passaggio parlamentare
anche per i Lep. C’è chi vede in questo una volontà di rallentamento del
processo riformatore.
Io sto alle parole dei loro leader. E da veneta,
considerando che FdI ha preso il 32% in Veneto, gran parte di loro è per
l’autonomia. Non c’è alcun pregiudizio da parte nostra. Ben venga il passaggio
alle Camere, ne guadagnerà la democrazia. Per i Lep erano stati individuati i
dpcm perché sono stati previsti anche per i Lea. Tra l’altro si poteva
impugnarli davanti al Tar. Mentre con i decreti legislativi si deve sollevare
eccezione di costituzionalità.
A che punto siete con il convoglio parlamentare
dell’autonomia?
In Prima commissione, al Senato, stiamo votando
gli emendamenti e si proseguirà in settembre. Sarà un percorso abbastanza
spedito perché la maggioranza è compatta e perché l’approvazione del disegno
Calderoli è stata collegata alla legge di bilancio e dunque non subirà la
sospensione per la sessione di bilancio. In autunno mi aspetto il voto
favorevole.
Poi toccherà alla Camera.
Lì il percorso potrebbe essere più lento perché
molto dipenderà agli intenti ostruzionistici dell’opposizione, dal numero degli
ordini del giorno. Il regolamento lo consente. La questione di fondo è che
l’autonomia così come sarà votata non potrà spaventare nessuno. La stessa
opposizione al di là di un clamore di facciata, ne è consapevole. Quando parlo
con i colleghi me lo dicono. È bagarre parlamentare. Per carità, ci sta, è la
democrazia bellezza, il confronto aspro è legittimo, ma non ci sarà alcun spacca
Italia. Fidatevi.
Zaia ha ripetuto che l’autonomia passa entro il
2024 o sarà il fallimento del centrodestra.
Il programma va attuato con lealtà. Per noi
l’autonomia è fondamentale. Anche il presidenzialismo è nell’accordo di
programma, ma una riforma costituzionale prevede maggioranze qualificate e il
probabile referendum. La Lega è leale su tutto, il patto di legislatura reggerà.
Autonomia differenziata e Lep, Fratelli
d'Italia contro la Lega. ANTONIO TROISE su Il Quotidiano del Sud il 4 Agosto
2023
LA RIFORMA Calderoli sull’autonomia differenziata
continua a scivolare sui Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, vale a
dire la quantità e la qualità dei servizi che devono essere assicurati a tutti i
cittadini indipendentemente dalla loro residenza. Nella versione originale della
legge era previsto che fosse direttamente il governo, d’intesa con le Regioni,
ad emanare un Dpcm, dopo aver incassato la delega da parte del Parlamento.
Invece, due emendamenti firmati, tra gli altri, dal presidente di Fdi della
Commissione Affari Costituzionali della Camera, Alberto Baldoni, hanno di fatto
riscritto l’articolo 3 del testo licenziato dal Calderoli. E, in particolare,
per quanto riguarda la determinazione dei Lep, impegnano il governo ad adottare,
entro “24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi”. Insomma, salta la norma sui Dpcm, fortemente voluta dal ministro
leghista anche perchè considerata “la strada più rapida”.
Ma non basta. Perchè sempre ieri i deputati hanno
deciso di far slittare a settembre l’esame degli emendamenti, allungando di
fatto i tempi della discussione parlamentare. Calderoli, ha incassato il doppio
colpo senza fare drammi: “Troviamo uno strumento condiviso perché si definiscano
in due o tre anni al massimo. Però non possiamo aspettare altri 20 anni per
definire i Lep. Questa non è una gara sui cento metri ma una maratona”. Ma
l’iter, delineato ieri dall’emendamento dei Fratelli d’Italia sui Lep, potrebbe
rallentare fortemente l’operatività della riforma sull’autonomia differenziata.
Anche perchè la definizione dei Lep, spiega
Massimo Bordignon, uno dei massimi esperti in materia di federalismo, è
pregiudiziale al trasferimento di alcune delle competenze dalla Stato Centrale
alle Regioni. E, del resto, proprio sulla definizione dei livelli ministri delle
prestazioni, si è consumato nei mesi scorsi un duro scontro all’interno del
Comitato dei 61 esperti nominati da Calderoli, con l’addio all’organismo
presieduto da Sabino Cassese, di quattro big: gli ex presidenti della Corte
Costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, l’ex presidente del Consiglio di
Stato Alessandro Pajno e l’ex ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini.
Del resto, dallo stesso Comitato, era arrivato un allarme sui tempi giudicati
troppo stretti per la definizione dei servizi minimi da assicurare a tutte le
Regioni.
Per non parlare, poi, del problema delle coperture
finanziarie legate alle scelte da effettuare. In ogni caso, con l’emendamento
presentato ieri i decreti legislativi per l’adozione del Lep avranno un percorso
piuttosto articolato nel difficile cammino verso l’autonomia differenziata:
“Sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri
competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Gli
schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere
per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni
parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai
principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e motivazione”.
Insomma, una doccia fredda sulle aspettative della
Lega. Del resto la partita sui Lep è quella più delicata, soprattutto perchè una
scelta sbagliata potrebbe ulteriormente aumentare il divario fra il Nord e il
Sud del Paese. Per capire perchè sono importanti è sufficiente leggere alcuni
dei documenti circolati all’interno della commissione di esperti. Uno dei punti,
ad esempio, è quello di stabilire un nesso fra i diritti che deve garantire lo
Stato, ad esempio l’assegno minimo per le pensioni, e quelli che finirebbero
nelle mani delle regioni, come ad esempio il numero degli alunni per classe. Dal
momento che la cassa dalla quale prelevare le risorse è la stessa, bisogna
evitare che per finanziare i “Lep ragionali”, si possano sacrificare altri
diritti altrettanto essenziali e garantiti dalla Costituzione.
Ma c’è di più. Se si stabilisce che, sempre per
fare un esempio, il livello minimo per gli asili è quello di avere 26 alunni per
classe, si fotografa l’esistente e non c’è quindi nessun aggravio da parte dello
Stato. Ma potrebbero esserci le Regioni che, proprio grazie all’autonomia
differenziata, potrebbero decidere di ridurre il numero per aula, aumentando
docenti e personale scolastico. Questo finirebbe per aumentare le differenze fra
le Regioni più ricche e quelle più povere.
SMENTITA LA FAVOLA NERA DEL SUD IMMOBILE.
RAPPORTO SVIMEZ/NEL BIENNIO 2021/2022 RISPETTO AL 2020 LA CRESCITA DEL SUD È
SUPERIORE A QUELLA DEL CENTRO-NORD E NEL 2023 TIENE IL PASSO. ROBERTO
NAPOLETANO su Il Quotidiano del Sud il 18 Luglio 2023.
Questi numeri di verità che solo noi raccontavamo
e tutti negavano riguardano anche l’occupazione. La recessione temuta dalla
stessa Svimez è stata sostituita da una ripresa sostenuta che può migliorare
ancora grazie a Zes unica, decontribuzione e Repower Eu. Le donne e gli uomini
del Sud devono svegliarsi dal sogno negativo per avere coscienza di questa
realtà nuova. Non esiste più la favola che non ha capacità di crescita, ma
siccome non è arrivato lo zio d’America allora tutti ripetono la leggenda di
prima perché il Sud è obbligato nell’immaginario collettivo ad andare male. La
cultura da diffondere è quella che dimostra con i fatti che ha rotto
l’incantesimo, fa e farà di più. Quindi, basta lamentazioni, e andiamo avanti.
Abbiamo posto al primo punto della carta di Napoli
un’affermazione impegnativa: cambiare la narrazione del Sud. Che non vuol dire,
sia chiaro, inventare una narrazione, ma documentare quella realtà che è già
cambiata e nessuno vuole vedere per cambiare ancora di più e velocemente il
contesto economico e sociale. La carta di Napoli è il frutto dei lavori del
festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato da questo giornale in
collaborazione con Parlamento e Commissione europei, che ha chiamato a raccolta
nella sala dei baroni al Maschio Angioino le voci più autorevoli dell’economia,
della politica e delle istituzioni europee e multilaterali.
Un lavoro certosino passato al vaglio
dell’advisory board guidato da Patrizio Bianchi, che è stato presentato nella
sala Spadolini a Roma alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro
Sangiuliano, e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che si propone di
offrire in modo documentale un racconto controcorrente della situazione attuale
del Mezzogiorno partendo dal capitale umano e sviluppandosi in una serie di
allegati tecnici su energia, portualità, industria, economia del mare. Sono
testi e documenti analitici che riteniamo possano contribuire in termini di
principi e di proposte operative alla programmazione generale di lungo termine e
alla stesura dei documenti di economia e finanza e delle note di aggiornamento
del governo per cogliere al meglio le opportunità offerte dal nuovo quadro
geopolitico globale.
Ci battiamo in assoluta solitudine da almeno un
paio di anni per raccontare il miracolo nascosto dell’Italia di Draghi di cui il
Mezzogiorno è il protagonista assoluto senza rendersene conto e segnalare a
tutti che storia e geografia combattono senza risparmiarsi perché il Sud
italiano diventi il nuovo Nord europeo garantendo con il grande hub energetico e
manifatturiero del Mezzogiorno l’unica nuova crescita aggiuntiva possibile per
l’intera Europa. Spesso guardati con sospetto e attraversati da quello spirito
di rassegnato piagnisteo che tanto male ha fatto e fa al Mezzogiorno abbiamo
insistito in modo ostinato perché la verità venisse a galla e la coscienza
collettiva cominciasse a prenderne atto.
Questa lunga premessa, mi perdonerete, è stata
necessaria per esprimere la mia soddisfazione nel vedere un rapporto della
Svimez che finalmente non ripete più che il divario si allarga o annuncia nuova
recessione, ma prende finalmente atto della nuova realtà. I fatti, quelli certi
e documentati, ci dicono che nel biennio 2021-2022 l’economia del Mezzogiorno è
cresciuta del 10,7% ponendosi oltre due punti sopra la perdita del 2020 (-8,5%)
e che nello stesso periodo la crescita del Centro-Nord è stata dell’11% ma si
confronta con una perdita maggiore del 2020 (-9,1%) e quindi si colloca con una
crescita sotto i due punti percentuali.
Questo dicono i dati della Svimez. Per farla
breve, il secondo miracolo economico italiano dopo quello del Dopoguerra
certifica che l’Italia è cresciuta più della media europea e delle grandi
economie europee, ma che per la prima volta dopo decadi nel biennio preso in
esame il recupero del Sud è stato superiore a quello del Centro-Nord mostrando
una reattività e una capacità di riorganizzazione superiori. Ovviamente dentro
un quadro strutturale di marcata distanza che persiste tra le due aree del
Paese. Anche i dati della occupazione segnano un contributo superiore del Sud
rispetto al Nord con una crescita sostenuta di nuovi contratti che permette di
collocarsi nella media del 2022 nettamente al di sopra della media del 2019.
Perfino il dato di crescita del Pil per il 2023
previsto dalla Svimez, quello che secondo il rapporto dell’anno scorso della
stessa Svimez rischiava di riportare il Sud in recessione e allargare di nuovo
il divario, parla di un +1,1% con un Sud che fa +0,9 e un Centro-Nord che fa un
+1,2% mostrando già di fatto la capacità del Mezzogiorno di tenere il passo del
resto del Paese, ma avendo l’avvertenza di non perdere la consapevolezza che la
piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza consentirà al
Mezzogiorno di mettere in essere un flusso di investimenti pubblici e privati
superiori a quelli del Centro Nord in modo da garantire il proseguimento
dell’andamento del biennio 2021/2022 segnato da un passo di crescita e di
occupazioni più sostenuto.
Questa è la pura realtà già accertata, che noi
raccontavamo e tutti negavano, ma vi avvisiamo sin da ora che questa pura realtà
non ha nulla a che vedere con quella che si manifesterà negli anni a venire
presumibilmente infinitamente migliore in termini di crescita e di nuova
occupazione. Perché le scelte della Zes unica per il Mezzogiorno, la
decontribuzione strutturale non più legata a rinnovi semestrali che annullano
l’effetto di attrazione di investimenti esteri, il lavoro di riprogrammazione e
di ridefinizione più stringente sui temi energetici e manifatturieri, cambiano
le cose. Sono tutte azioni dovute alla regia italiana e europea del ministro
Fitto che modificano il quadro per l’oggi e per il domani.
Ovviamente anche qui bisogna vigilare
sull’attuazione e sulle singole modalità di esecuzione, ma la portata storica di
queste decisioni e dei risultati che ne scaturiranno richiedono gioco di
squadra. Sul piano politico, tra maggioranza e opposizione, sul piano tecnico, a
tutti i livelli centrali e territoriali, e sul piano delle relazioni sociali,
coinvolgendo il mondo della produzione e tutti i sindacati. Questo è il senso
profondo della sfida delle sfide del Paese.
È successo, o perlomeno sta succedendo, qualcosa
di veramente straordinario. È cambiata quella favola dei bambini che ripeti
tutte le sere e che è uguale da sempre. Ecco, quella favola lì, per quanto
riguarda il Mezzogiorno, non esiste più o almeno sta di molto cambiando. La
favola di prima raccontava sempre la stessa storia che era più o meno così: il
Mezzogiorno non va, il Mezzogiorno non ha capacità di crescita, il Mezzogiorno
fa fatica; e siccome non sai a cosa legare questa crescita nuova perché non è
arrivato lo zio d’America, perché hai sempre detto che il Sud non ha classe
dirigente, perché la rivoluzione non è avvenuta, allora tutti continuavano a
ripetere la leggenda di prima perché il Sud era obbligato nell’immaginario
collettivo ad andare male. E anche se emergeva qualche segnale controcorrente,
c’era subito pronto quello che si affrettava a profetizzare che “al Sud presto
sarebbero tornati ad essere quelli di prima”.
No, non era così, non è andata così e non andrà
più così. Bisogna crederci. Soprattutto le donne e gli uomini del Sud, giovani e
meno giovani, devono tutti svegliarsi dal sogno negativo per avere coscienza di
questa realtà nuova. La cultura di prima che qualcosa arriva se ci si lamenta, a
volte a ragione a volte a torto, o che il piagnisteo è comunque indispensabile,
ebbene questa cultura va bandita per sempre.
Diciamo che va demolita per prendere atto che sta
andando meglio del previsto e che tutti bisogna impegnarsi sempre di più perché
vada sempre meglio. La sola cultura che dobbiamo tutti diffondere e incrementare
è quella che appartiene a un pezzo rilevante della realtà. È la cultura che
dimostra con i fatti e può dire a voce alta “siamo capaci di fare, abbiamo rotto
l’incantesimo, abbiamo fatto e faremo sempre di più”. Quindi, basta
lamentazioni, e andiamo avanti. Ricordiamoci tutti che il Sud non è più
periferia ma centro. A guidare il grande gioco ora siamo noi, non più gli altri.
Mettiamocelo bene nella testa e agiamo di conseguenza.
La qualità dell'informazione è un bene assoluto,
che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del Sud è il prodotto
di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con il massimo di
passione e di competenza possibili.
Abbiamo un bene prezioso che difendiamo ogni
giorno e che ogni giorno voi potete verificare. Questo bene prezioso si chiama
libertà. Abbiamo una bandiera che non intendiamo ammainare. Questa bandiera è
quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti calpestati ma conosce
e adempie ai suoi doveri.
Contiamo su di voi per preservare questa voce
libera che vuole essere la bandiera del Mezzogiorno. Che è la bandiera
dell’Italia riunita.
Autonomia differenziata, un modello che
funziona esiste già. Ma Roberto Calderoli lo cancella. Una commissione del
Mef ha elaborato un sistema per assegnare le risorse direttamente ai comuni per
la gestione dei nidi. Si potrebbe replicare anche per gli altri Lep, i livelli
essenziali di prestazioni. Ma il nuovo Governo ha messo in panchina Alberto
Zanardi, l’economista che lo ha elaborato. Gloria Riva su L'Espresso il 7 Luglio
2023
Autonomia, il modello esiste già. Ma Calderoli lo
ignora. Dopo le dimissioni dei quattro big - Giuliano Amato, Franco Bassanini,
Franco Gallo e Alessandro Pajno – dal comitato per l'autonomia differenziata, il
ministro leghista Roberto Calderoli ha affermato che si andrà avanti ugualmente.
Anche senza di loro. In attesa che i 58 membri rimasti nel Comitato riescano a
definire ciò che in trent'anni nessuno è riuscito a definire (e finanziare,
soprattutto), ovvero i Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni sociali, che
sono previsti dalla Costituzione per garantire diritti civili e sociali in tutto
il territorio nazionale, è interessante sapere che l'unico economista italiano
che finora è riuscito a offrire un simile diritto agli italiani, ovvero un
lep, Alberto Zanardi, professore Ordinario di Scienze delle Finanze
all'Università di Bologna, che era a capo della Commissione Fabbisogni Standard,
non è stato in alcun modo coinvolto nella suddetto comitato per l'autonomia
differenziata. Strano ma vero.
Ma andiamo con ordine.
Nella lettera che Amato, Bassanini, Gallo e Pajno
hanno inviato a Sabino Cassese, presidente del Comitato, i dimissionari
sostengono che nella definizione dei lep, così come li vorrebbero Cassese e
Calderoli, restano irrisolti alcuni problemi di fondo, fra cui la stima
economica di massima e le coperture a disposizione. La verità è che calcolare
l'ammontare complessivo dei Lep è quasi impossibile – come ha detto l'Ufficio
Parlamentare di Bilancio in audizione a giugno - e la cifra potrebbe essere
stratosferica. Ecco perché l'obiettivo di Calderoli è ridurre i lep alla spesa
storica regionale e limitarne la definizione alle materie che Lombardia e Veneto
vogliono trattenere per sé, ovvero cristallizzare il problema del divario
economico e sociale fra regioni.
Soluzioni alternative per evitare che, ad esempio,
al Sud la speranza di vita sia un anno inferiore al sud? E che le mamme possano
lavorare a Milano ma non a Catania perché non ci sono servizi scolastici
adeguati? Ci sono già. O meglio, un esempio c'è già.
Nella legge di bilancio 2022, quindi ai tempi del
governo di Mario Draghi, è stato creato e finanziato un apposito fondo per
garantire la gestione degli asili nido a tutti i comuni per raggiungere la
soglia minima del 33 per cento di posti nido in tutti i comuni: ecco un
obiettivo Lep stabilito dal Parlamento. La cifra stanziata è pari a 1,1 miliardi
di euro da distribuire a 500mila comuni entro il 2026 e sarà rifinanziato con
ulteriori risorse anche a seguire.
Ma come è stata calcolata questa cifra e come è
possibile garantire ai bambini di tutti i comuni l'accesso a queste risorse?
Semplicemente tagliando fuori le Regioni, ovvero il contrario di quanto ha
intenzione di fare il ministro Calderoli, che con la riforma dell'Autonomia
Differenziata intende dare più peso ai presidenti delle Regioni.
L'assegnazione delle risorse per la gestione dei
nidi – ovvero pagare le educatrici, le bollette, i pasti per i bimbi (mentre per
la realizzazione di nuove strutture, in teoria dovrebbe pensarci il Pnrr) – è
frutto di un lavoro certosino realizzato dalla Commissione Tecnica per i
Fabbisogno Standard che calcola, per ciascun comune d'Italia, il numero di
bambini con meno di tre anni in relazione ai posti nidi oggi disponibili e alla
necessità economica del municipio per raggiungere la soglia minima del 33 per
cento quando i nidi saranno costruiti.
Per capirci, se un comune ha le risorse per
finanziare il Lep – cioè l'obiettivo di almeno un terzo di posti nido a carico
del pubblico – non riceve nulla, ed è stato anche istituito un monitoraggio di
verifica della spesa, per evitare che quel denaro venga speso per fare
altro. Insomma, un sistema efficace, un modello di autonomia differenziata che
da più risorse ai comuni che ne hanno davvero bisogno, anziché concentrare
risorse sulle Regioni che poi rischiano di non sapere correttamente distribuire
le risorse. Quel modello è frutto del lavoro dell'ex capo della Commissione
Tecnica, il professore Alberto Zanardi, un docente che non ha mai manifestato
orientamenti politici, ma con un'enorme competenza rispetto alla questione dei
Lep. E forse è proprio per questo che, al cambio di governo, il professore è
stato messo in panchina. Prima spostato al Ufficio Parlamentare di Bilancio come
membro del consiglio, poi relegato nel comitato scientifico dello stesso.
E chi ha preso il suo posto nella Commissione
Fabbisogni Standard? Elena D'Orlando, giurista, professoressa di diritto
regionale e soprattutto componente della Commissione creata da Luca Zaia per
l'Autonomia del Veneto. D'Orlando è sicuramente una docente con grande
esperienza di diritto, ma non certo un'economista e, soprattutto, ha le idee
molto chiare rispetto all'autonomia differenziata “stile Zaia”, al punto che
nell'audizione Affari Costituzionali del Senato D'Orlando ha fortemente
sostenuto “Lo stato regionale come processo di integrazione”.
Nella stessa commissione è stato nominato anche
Andrea Giovanardi, tributarista vicentino, autore del saggio “Autonomia,
differenziazioni, responsabilità”, componente della delegazione trattante per
l'autonomia della regione Veneto e vicino a Zaia. Anche in questo caso non si
tratta di un economista ma di un esperto di diritto, per altro con una chiara
connotazione politica. E chi elabora per conto della Commissione Fabbisogni
Standard i dati utili alla realizzazione dei modelli di distribuzione dei
finanziamenti ai comuni? La Sose, una società per azioni partecipata dal
ministero dell'Economia e la Banca d'Italia. Anche qui, il nuovo governo ha
portato un cambio al vertice: è stato nominato Marco Stradiotto, esponente del
partito democratico veneto e sostenitore dell'autonomia differenziata.
Ovviamente, sono tutti esponenti che siedono anche nel Clep, il comitato per
l'autonomia differenziata, insieme ad altri esponenti filo leghista, da Mario
Bertolossi, costituzionalista dell'università di Padova, a Ludovico Mazzarolli e
Luca Mezzetti, anche loro espressione di Luca Zaia.
Dunque, con l'uscita di Alberto Zanardi nella
commissione Fabbisogni Standard, l'unico ente con una minima esperienza di Lep,
le nuove nomine filo leghista e la formazione a trazione veneta del Clep (oggi
ancora di più con l'addio dei quattro big, a cui si aggiungono l'uscita di
Luciano Violante e Anna Finocchiaro) è più probabile che il documento che il
Clep presenterà alle Camere rispecchierà il volere della Lega Veneta, ovvero
limitare la definizione dei Lep a quelle materie che Lombardia e Veneto
intendono tenere per sé, rinviando (per sempre) la definizione di tutti i
livelli essenziali.
«Questa autonomia differenziata piace solo alle
regioni del Nord: così lo stato cattivo tassa e loro spendono».
«Disporrebbero di amplissime competenze e risorse, ma non avrebbero alcuna
responsabilità del prelievo di fronte ai propri cittadini». Parla Gianfranco
Viesti. Gloria Riva su L'Espresso il 7 Luglio 2023
Gianfranco Viesti, docente di Scienze Politiche
all'Università di Bari, nel 2019 ha pubblicato per Laterza il volume “Verso la
Secessione dei Ricchi” e a settembre sarà nuovamente in libreria con il libro
“Contro la Secessione dei Ricchi”, come giudica le dimissioni di Giuliano Amato,
Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajno, dal comitato per l'Autonomia
Differenziata?
«Penso che all'interno della commissione si sia
creato uno scontro e i quattro giuristi si siano trovati in minoranza. La loro
intenzione era quella di procedere alla valutazione di tutti i lep e non
piegarli alle esigenze di Veneto e Lombardia. Ma più in generale ritengo che
l'intero Clep sia un errore perché esautora il Parlamento dal compito (anzi,
dall'obbligo), stabilito dalla Costituzione, di definire i Lep. Ma credo che il
fatto più grave sia un altro».
Ovvero?
«Veneto e Lombardia cercano di ottenere condizioni
finanziarie di favore paragonabili a quelle di cui godono le autonomie speciali.
Propongono di disegnare regole e metodi ad hoc, ignorando anche l’impegno del
Pnrr con la Commissione Europea in base al quale tutto il sistema di
finanziamento di regioni ed enti locali deve essere messo definitivamente a
regime per il 2026. Secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, “l’applicazione
della Costituzione nella parte concernente l’attribuzione a Regioni diverse da
quelle a statuto speciale di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia sembra venire anticipata rispetto alla attribuzione a tutte le Regioni
di una piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa”».
A cosa mirano esattamente le regioni secondo lei?
«Come nel caso delle regioni a statuto speciale,
puntano a ottenere dallo Stato centrale una percentuale garantita di gettito dei
tributi statali. Questo creerebbe una situazione molto singolare, e assai
comoda: le regioni disporrebbero di amplissime competenze e risorse, ma non
avrebbero alcuna responsabilità del prelievo di fronte ai propri cittadini. Lo
Stato, cattivo, tassa; la regione, buona, spende. Ecco perché l'Autonomia
Differenziata trova grande sostegno da parte dei governatori».
In quale percentuale?
«Essa sarebbe definita in un primo momento in base
a una trattativa diretta fra Stato e regione e poi da parte di una Commissione
paritetica Stato-regione. È importante ricordare che la composizione di queste
commissioni verrebbe definita dal governo e dalla regione interessata. La
Commissione avrebbe il potere di rivedere annualmente le proprie decisioni. Se
la dinamica nel tempo del gettito fiscale è superiore nelle regioni che hanno
ottenuto la maggiore autonomia rispetto alla media nazionale – come è
storicamente avvenuto per decenni nelle aree a statuto speciale del Nord e come
è avvenuto nel XXI secolo per le tre regioni –, esse vedranno costantemente
crescere le risorse disponibili grazie all’aliquota percentuale di
compartecipazione».
Chi può bloccarla?
«Ci stanno provando i ministri di Fratelli
d’Italia a rallentare l’iter della riforma, che è uno dei motivi di maggiore
attrito tra la premier Meloni e Matteo Salvini. A breve non è scontato anche
l’arrivo di un commissario per il Clep, che potrebbe depotenziarlo».
Sinistra, amnesie storiche: quando il Partito
comunista invocava l'Autonomia. Francesco Carella su Il Riformista il 27
giugno 2023
Tra le tante costanti della vita politica del
nostro Paese ve n’è una che affonda le radici addirittura nell’epoca
preunitaria. Infatti, la riflessione sui rapporti fra lo Stato centrale e il
sistema delle autonomie locali è al centro del dibattito fin dal 1851, quando
Carlo Cattaneo scrisse che «il federalismo è l’unica via della libertà». Il
teorico degli “Stati Uniti d’Italia” ha influito non poco sulla formazione della
nostra classe politica dall’Unità ai giorni nostri. In tal senso, si può dire
che vi è un lungo filo che parte da Luigi Carlo Farini, esponente di spicco
della Destra storica, e raggiunge Roberto Calderoli, padre del Disegno di legge
sull’autonomia differenziata.
Il ministro Farini nell’agosto 1860, dopo avere
ricevuto l’imprimatur di Cavour, propose di conciliare «l’autorità centrale
dello Stato con le necessità dei comuni, delle province e dei centri più vasti».
Se, però, per il progetto Farini e subito dopo con quello del suo successore
all’Interno Marco Minghetti gli ostacoli che ne impedirono la realizzazione
avevano un fondamento storico rilevante (la fragilità di uno Stato giovane e la
spinta disgregatrice lanciata nel Mezzogiorno dal brigantaggio) per ciò che
riguarda la riforma del ministro Calderoli le ragioni sembrano meno nobili e più
legate a un approccio demagogico da parte di una sinistra che ha dimenticato la
sua stessa storia. Vale la pena di ricordare a Elly Schlein che la questione
dell’autonomia era già al centro dell’attenzione di Palmiro Togliatti ed è
sempre stata presente nel dibattito politico interno al Partito comunista. Del
resto, già nel lontano 6 novembre 1975 in un’intervista a “La Stampa” il
presidente della regione Emilia Romagna Guido Fanti individuava nella «forma
decentrata dello Stato l’unica possibilità per il Paese di uscire dalla crisi
che stava attraversando».
Egli propose di lavorare attorno a un «progetto di
aggregazione tra le cinque regioni della Valle Padana che avrebbero dovuto avere
un ruolo fondamentale in una politica di programmazione regionale e
nazionale». Un altro leader di primo piano del Pci, Renato Zangheri, nel corso
di un dibattito parlamentare sulle riforme istituzionali nel maggio 1988,
afferma che «il Pci auspica un energico decentramento legislativo con una reale
rivitalizzazione degli organismi locali per mezzo di una concreta autonomia
finanziaria e impositiva». Lo spartito non muta con il Pds. Il 12 dicembre 1994,
in assemblea, il segretario Massimo D’Alema presenta «il federalismo come
l’unico strumento in grado di realizzare una nuova unità del Paese». A rileggere
le polemiche delle ultime settimane vengono in mente le parole del
meridionalista Guido Dorso: «Occorre augurarsi che non ci siano più cervelli che
concepiscano l’unità nazionale, sacra ed inviolabile per tutti gli italiani,
come mezzo per continuare con lo sgoverno attuale». Quei cervelli sono ancora in
mezzo a noi pronti a fare danni.
Antonio Giangrande: Quelli che…o tutti o
nessuno e poi vogliono la secessione!
Lo sproloquio del saggista e sociologo storico
Antonio Giangrande. Da far riflettere…
2 e 3 giugno: Si festeggiano il giorno della
Repubblica ed il giorno della libera circolazione tra regioni.
Il tutto sotto diktat della Padania.
I Padani hanno voluto l’Unità d’Italia per
depauperare l’Italia meridionale.
I Padani comunisti hanno voluto la Repubblica per
continuare a saccheggiare l’Italia Meridionale.
I Padani con le sedi legali delle loro aziende nei
paradisi fiscali vogliono continuare a dettar legge con la scusa della
secessione.
L’Italia divisa in due.
L’autonomia che piace alla Lega rischia di far
saltare l’Italia (e il governo). La riforma di Roberto Calderoli, se portata
avanti, metterà fine all’unità del Paese. Ma è una bomba molto rischiosa per
l’esecutivo Meloni. Virman Cusenza su L'Espresso il 30 Maggio 2023
Una certezza c’è: dei due forni avviati da Giorgia
Meloni per le riforme uno già brucia ed è quasi incandescente. È quello
dell’autonomia differenziata cara alla Lega che spinge per una rapida
approvazione, minacciando di sabotare la maggioranza.
L’altro, il tavolo istituzionale per l’elezione
diretta del premier o del capo dello Stato, è ancora al caro amico. I nodi sono
venuti al pettine della premier prima del previsto. L’alleato Matteo Salvini,
incalzato dalla curva Nord dei governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, vorrebbe
un drappo da poter sventolare al popolo di Pontida, addirittura per settembre
(motivo per cui il raduno celtico è slittato). O quantomeno entro l’anno, come
sbotta il ministro Roberto Calderoli che sa come il vero traguardo siano le
Europee 2024. Ma per Meloni ottenere entro quella data un risultato sul fronte
del premierato o simili è impossibile, tanto a colpi di maggioranza in
Parlamento quanto con una commissione bicamerale. I due forni non possono
proprio andare di pari passo.
Si arriva così al nodo cruciale: la legislatura è
appesa alle sorti dell’autonomia, ma soprattutto a quest’ultima è appesa l’unità
del Paese. Con la riforma di marca leghista si va a cambiare di fatto la forma
dello Stato, trasformandolo in federale, con legge ordinaria e senza nemmeno
applicare i passaggi obbligati per riscrivere la Costituzione. L’obiezione di
Calderoli è che si è già votato in Veneto e in Lombardia, sei anni fa con un
referendum… Così le altre Regioni vedrebbero decollare il Grande Nord, che,
gestendo ben 23 materie oggi di competenza dello Stato, diventerebbe ancora più
ricco trattenendo il «residuo fiscale» (cioè larga parte del gettito garantito
dai residenti).
Obiezione lumbard: con la definizione dei Lep
(Livelli essenziali di prestazione che assicurino pari condizioni ai cittadini
da Nord a Sud) questo rischio non c’è. Ma la Corte dei Conti mette in guardia:
la spesa pubblica farebbe un balzo, perché lo Stato sarebbe costretto a
intervenire per evitare sperequazioni tra aree floride e depresse. E chi
pagherebbe il salasso, visto che le tre Regioni più ricche, nel frattempo, si
sarebbero tirate fuori?
Un partito romano-centrico come Fratelli d’Italia,
con l’elettorato più filo-unitario, potrebbe stare a guardare? La risposta
finora è stata di questo tenore: l’autonomia andrà avanti solo con il
rafforzamento delle istituzioni centrali. In realtà, vista la tempistica,
rischiamo che si cambi il telaio dell’auto prima ancora di sapere quale motore
si monterà. In più c’è la questione Roma.
Come dimostra il dossier Calderoli, le 500
competenze che verrebbero trasferite alle Regioni che ne facciano richiesta
(vera anarchia regionale) svuoterebbero la Capitale. Non è un problema di
poltrone e privilegi ministeriali. Semmai di garanzie: solo con un monitoraggio
centrale, ti accerti che il Paese vada tutto nella stessa direzione e con uguali
diritti per i cittadini di ogni latitudine. Che fine ha fatto il disegno di
legge costituzionale che rafforza i poteri di Roma, garantendo, più che la
dignità, l’operatività di uno Stato che abbia una sola e non cento teste?
Altrimenti non resta che il celebre sarcasmo del pittore Mino Maccari: «O Roma o
Orte!».
Con questo numero termino la rubrica per un nuovo
progetto professionale. Un caloroso grazie ai lettori, alla direzione e alla
redazione de L’Espresso.
Battaglia federale. Ivano Tolettini su
L'Identità il 24 Maggio 2023
È il chiodo fisso di Luca Zaia e non poteva certo
non ripeterlo durante le prime audizioni al Senato sull’autonomia differenziata.
Che preferirebbe fosse chiamata federalismo. Prendendo come riferimento uno
stato autenticamente federale come la Germania, con l’obiettivo di una vera
unità e maggiore omogeneità tra aree dell’Italia: tra un Nord ricco e un Sud che
arranca. “Si continua a ripetere che ci sono aree del Paese a due velocità –
afferma esordendo in commissione Affari costituzionale – e non è colpa
dell’autonomia perché ancora non è stata applicata. Trovo immorale che oggi ci
siano zone d’Italia dove i cittadini devono fare le valige per potersi curare o
devono vivere senza servizi”. Ecco che per il governatore del Veneto l’autonomia
è una sfida comune, perché è “la vera rivoluzione che può dare risposte ai
cittadini, soprattutto ai giovani di cui si parla sempre poco”. Egli pone in
relazione la “fuga dei cervelli” con la scelta come “destinazioni i paesi
squisitamente federali, segnati dalla modernità, dal senso di responsabilità e
da minori distanze tra potere decisionale e cittadino”. Egli ribadisce che è un
progetto studiato, sostenuto e su cui il Veneto si è impegnato avendo come unico
faro la Costituzione. Zaia cita anche l’ex presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano e l’attuale Sergio Mattarella, che era alla Corte Costituzionale
quando il Veneto la consultò per avere il via libero al referendum consultivo
che portò alle urne il 57% dei veneti, 2,3 milioni di ogni colore politico: il
98% rispose affermativamente, dopo la sentenza della Consulta contro
l’impugnazione dell’allora governo Renzi.
POLEMICHE E ANALISI
Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla bozza di
lavoro per i parlamentari uscita dall’Ufficio tecnico del Senato assai critica
con il disegno di legge voluto dal ministro competente Roberto Calderoli,
quest’ultimo è stato presente per tutta la durata delle audizioni. “Sono
soddisfatto per le analisi che ho sentito ed ho ascoltato con grande rispetto
tutti i punti di vista – osserva – Chi conosce la materia e ne approfondisce i
contenuti nel merito, non può negare il valore e l’importanza di questa riforma
per il Paese. Si tratta di una sfida di responsabilità e trasparenza
nell’interesse dei cittadini”. L’obiettivo del responsabile del dicastero per
gli Affari regionali e le Autonomie nel governo Meloni, è di garantire un’Italia
“efficiente e senza più sperequazioni come accade adesso”. Il ministro era
contento dopo la prima giornata conclusasi nel pomeriggio perché da più parti
“sono arrivate testimonianze positive, per i molteplici spunti di riflessione,
anche se non sono mancate obiezioni che sono parse sostanzialmente ideologiche e
non corroborate da solidi contenuti”. Dall’entourage del ministro si afferma che
da più fonti è arrivato un “pieno e convinto sostegno alla riforma da parte
delle istituzioni pubbliche”
CRITICHE
Il capogruppo Pd in commissione Andrea Giorgis,
dopo l’audizione del governatore veneto Luca Zaia sottolinea che “perfino dalle
sue parole si può trarre l’invito a una maggiore cautela nell’ipotizzare, come
fa il disegno di legge Calderoli, ulteriori forme di differenziazione e
autonomia in base all’art.116 costituzione”. Il
ragionamento “può sembrare provocatorio, ma se, come ha riconosciuto lo stesso
Zaia, vi sono oggi significative differenze nell`attuazione del Servizio
Sanitario – continua Giorgis – che si traducono in disuguaglianze tra i
cittadini nell’accesso alle cure, obbligando molti a fare le valige per potersi
curare, forse, prima di approvare il disegno di legge Calderoli e aumentare le
disuguaglianze ed i costi anche in altre materie, sarebbe opportuno capire come
riorganizzare un efficiente e universale servizio sanitario pubblico”. Secondo
il Pd nel Veneto, come rivendica Zaia, “le strutture ospedaliere pubbliche sono
in grado di erogare servizi di qualità e di soddisfare quasi l’intera domanda e
la cardiochirurgia non è stata appaltata ad alcun operatore privato”. Il
problema per l’esponente del Pd è che siano possibili anche situazioni diverse e
che il Servizio sanitario “si sia progressivamente impoverito ed affidato ad
operatori privati”.
GIMBE E PERICOLI
“Tenendo conto della grave crisi di sostenibilità
del Servizio sanitario, delle inaccettabili diseguaglianze regionali e
dell’impatto delle maggiori autonomie, la Fondazione Gimbe propone di rimuovere
la tutela della salute dalle materie su cui le Regioni possono richiedere il
trasferimento delle funzioni da parte dello Stato, perché la loro attuazione
finirà per assestare il colpo di grazia alla sanità pubblica”, attacca il
presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, durante l’audizione sulle
proposte di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata. “I dati –
prosegue – confermano che nonostante la definizione dei Livelli essenziali di
assistenza risalgano al 2001, il loro monitoraggio e l’utilizzo da parte dello
Stato di strumenti quali i piani di rientro e i commissariamenti, persistono
inaccettabili diseguaglianze tra i 21 sistemi sanitari regionali, in particolare
un gap strutturale Nord-Sud”.
LEP
Tuttavia, nel corso dell’audizione iniziata alle
11 e conclusasi nel tardo pomeriggio, durante la quale gli esperti si
alternavano con una relazione di 10 minuti, rispondendo poi alle domande dei
senatori, anche da studiosi ed esperti di orientamento opposto sono arrivate
conferme della bontà del ddl Calderoli. Il docente di diritto costituzionale
Alfonso Celotto sottolinea con “favore la mappatura dei Lep, che finalmente è in
corso dopo oltre 20 anni, quale modo per attuare pienamente e seriamente il
terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione”. Infine, Andrea Del Monaco,
anche lui guardando da posizioni critiche al regionalismo disegnato da Calderoli
“ammette che non esiste all’interno del testo legislativo sull’autonomia alcun
riferimento alla possibilità di trattenimento del gettito fiscale da parte dei
territori”, tale da aumentare le differenze Nord-Sud.
La trappola. I tecnici del
Senato bocciano l’autonomia differenziata di Calderoli e Salvini. Linkiesta
il 17 Maggio 2023
Il documento firmato
dall’Ufficio bilancio di Palazzo Madama e pubblicato su Linkedin mette in
guardia dal pericolo disuguaglianze e indebolimento dei servizi fondamentali.
Poi la retromarcia dopo la telefonata tra il ministro per gli Affari regionali e
La Russa. Oggi il Pd chiederà conto
C’è il rischio di un aumento
delle disuguaglianze e di indebolimento dei servizi fondamentali nelle regioni
meno ricche, dietro il progetto di Autonomia differenziata targato Lega. Solo
che stavolta a bocciare il disegno di legge del ministro Roberto Calderoli, con
una analisi tecnica super partes, è il Servizio Bilancio del Senato. Ieri
pomeriggio questo documento, titolato “Il costo dell’Autonomia differenziata”, è
deflagrato nella giornata politica con un post su Linkedin dal profilo di
Palazzo Madama.
Il documento esamina le
criticità del ddl Calderoli, avanza dubbi sugli effetti dal punto di vista
finanziario e pone interrogativi sul ridimensionamento del bilancio statale, a
vantaggio di quello di alcune Regioni. Col rischio di non riuscire a conservare
i cosiddetti Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in tutto il Paese.
Repubblica racconta di una
telefonata burrascosa tra Calderoli e il presidente del Senato Ignazio La Russa,
al quale l’Ufficio fa capo. Il ministro chiede il ritiro del dossier, la
cancellazione, la smentita. A quel punto che del documento si perdono le tracce.
Il testo sparisce dal web. Nel frattempo, il leader della Lega Matteo Salvini si
sarebbe anche messo in contatto con la premier Giorgia Meloni volata in Islanda
per il Consiglio d’Europa. Meloni è spiazzata, dice di non saperne nulla e che
si informerà.
Il testo elaborato dai tecnici
di Palazzo Madama nel frattempo accende le opposizioni. Intanto Palazzo Madama
interviene con una nota in cui si spiega che quel dossier «non è verificato», è
stato sì pubblicato sui social ufficiali, ma «per errore». Così dice, almeno,
una prima correzione. Ma passa un’ora e mezza e, di fronte alle reazioni che
ormai dilagano, ecco la seconda smentita che corregge la prima: lo studio non è
rimosso.
Qualcuno osserva, tra l’altro,
che in calce a quel post argomentato su Linkedin figura il like di uno stimato
tecnico interno: si tratta del professore Renato Loiero, già capo ufficio del
Servizio Bilancio dello Stato, oggi consigliere economico della presidente
Meloni.
Oggi il Pd chiederà conto del
documento alla maggioranza e al governo in conferenza dei capigruppo e poi in
aula. Se i tecnici del Parlamento, alti funzionari con decenni di esperienza
alle spalle, sono stati trascinati in una disputa politica tutta interna alla
maggioranza, allora c’è qualcosa di più serio e più grave di un «errore».
I sospetti leghisti si muovono
intorno a Fratelli d’Italia. Siamo alla vigilia delle audizioni sulla riforma,
che partiranno dalla prossima settimana in commissione Affari costituzionali,
presieduta da Alberto Balboni, meloniano che proprio pochi giorni fa aveva già
criticato l’uscita di Calderoli sul “governatorato”, ovvero la via leghista
all’elezione diretta del capo del governo tanto cara a Fratelli d’Italia e alla
premier. «Ma da quando Calderoli ha scambiato le deleghe con Elisabetta
Casellati? Spetta a lei non a lui istruire la proposta, che comunque è nelle
mani del presidente del Consiglio », aveva attaccato. Nella stessa intervista,
Calderoli diceva che se la riforma dell’autonomia si blocca lui si ritirerà
dalla politica.
Autonomia differenziata, un film già visto con
il Sud unica vittima. «Ucci ucci, sento odor di cristianucci», diceva
Perrault nella favola di Pollicino. «Ucci ucci, sento odor di imbrogliucci» si
potrebbe dire parlando dell’autonomia differenziata. LINO PATRUNO su La Gazzetta
del Mezzogiorno il 19 Maggio 2023
«Ucci ucci, sento odor di cristianucci», diceva
Perrault nella favola di Pollicino. «Ucci ucci, sento odor di imbrogliucci» si
potrebbe dire parlando dell’autonomia differenziata.
Perché bisogna capire bene questa storia della
bocciatura del progetto Calderoli da parte dell’Ufficio Bilancio del Senato.
Tanto per cominciare, e con tutto il rispetto, non è che bisognasse aspettare il
Senato. Certo è importante che sia un organo dello Stato a confermare i conti
che un qualsiasi ragioniere aveva potuto fare. Se tu dai alle tre Regioni
candidate ciò che loro serve per fare ciò che ora fa lo Stato, e consenti loro
anche di trattenersi proprie tasse, che succede? Succede che lo Stato rischia di
non avere i mezzi per assicurare i servizi nelle Regioni «non differenziate». Si
dissangua con le tre e gli resta poco per le altre.
Bene, bravo, bis. Però scusate, ma già ora cosa
succede? Con la spesa storica che da decenni privilegia il Centro Nord, lo Stato
non ha soldi sufficienti per provvedere agli altri. Insomma al Sud. Per ciascun
cittadino del quale la spesa pubblica è fra i 3 e i 4 mila euro in meno
all’anno. Diversamente italiani. Cosicché il Sud ha servizi e infrastrutture
tutti al di sotto dell’eguaglianza prevista dalla Costituzione. Il destino di
una persona è segnato dal luogo in cui nasce. Con l’autonomia differenziata
questa sperequazione sarebbe addirittura fissata per legge: ai sensi della legge
tal dei tali, tu meridionale devi essere trattato peggio degli altri.
Dice: non è così. Perché proprio grazie alla legge
sull’autonomia, si calcoleranno quei bisogni del Sud mai calcolati. Champagne e
cotillons, se non fosse già stato premesso che comunque ci deve essere una
«invarianza di bilancio». Cioè si calcolerà che la spesa per quei bisogni è
insufficiente, ma non si potrà spendere un euro in più per adeguarla. Al
confronto il gioco delle tre carte è al livello di una tombolata. Però
l’apposita commissione è comunque al lavoro: stabilirà ciò che non potrà essere
rispettato. Fatte le somme, Kafka era un dilettante.
Il problema è che nel silenzio sospetto sceso fino
a ieri l’altro sul tutto, il sospetto è che si stessero facendo cose di
nascosto: prima cosa che si dice ai bambini di non fare. Esempio, contrattare
roba del seguente tipo. Se tu Regione differenziata non ce la fai a fare ciò che
faceva lo Stato con gli stessi soldi, faccelo sapere: non aumentare le tue
tasse, perché per te lo Stato avrebbe il solito occhio di riguardo. Presentaci
una lista a parte delle spese in eccesso, e noi sotto sotto ti rimborsiamo.
Risultato: ancora meno a disposizione delle
Regioni non differenziate. E attingendo addirittura anche dalle loro tasse di
«poveri». Il Sud che assisterebbe il Nord non solo per farlo stare meglio come
oggi. Ma anche se, nel caso, questo Nord dovesse avere una spesa in eccesso,
chessò, per regalare un Rolex a tutti i suoi cittadini.
Il fatto è che non è cabaret. Ora l’Ufficio
Bilancio del Senato dice che l’autonomia differenziata di Calderoli mette a
rischio il Sud. Lo mette a rischio non solo di non vedersi parificato al resto
del Paese con i Lep (Livelli essenziali di prestazione), anzi con i Lup (Livelli
uniformi di prestazione).
Lo mette a rischio non solo di non vedersi
riconosciuto un diritto finora negato ma senza possibilità di rimediare (e
parliamo di parità per sanità, scuola, asili nido, trasporti, assistenza agli
anziani e ai disabili: cioè vita di ogni giorno). Ma con le famose «intese»
private fra Regioni e il medesimo Calderoli, mette a rischio il Sud di farlo
state peggio del peggio, battendo ogni record di regresso invece di progresso.
Ora sul dossier fatto uscire dal Senato dal quale
non doveva uscire, si incrociano le accuse su chi è stato. Una faida di governo
per far capire agli alleati della Lega di fermarsi qui senza però dirglielo, ci
dovesse essere una crisi di governo. Oppure, nel Paese (indegno) di Machiavelli,
una faida nella stessa Lega per far capire a Calderoli di smetterla con questa
ossessione differenzial-autonomista che non lo fa dormire la notte (e per la
quale ha già detto che, se non ci riuscirà, lascerà la politica). Lui accusa i
burocrati romani di non voler perdere le poltrone a favore delle Regioni.
È una dietrologia nella quale l’Italia è campione
del mondo. Non ha bisogno di farsi troppe ipotesi solo il Sud: come la si mette
e mette, è la vittima di tutto. Un film tanto già visto da essere un sequel, si
dice. Usato premium.
Il disegno di Calderoli e quel vecchio sogno
del ricco Settentrione. Gli specialisti che verificano la tenuta economica
di tutti i provvedimenti all'esame del Senato hanno rilevato forti criticità sul
testo di legge all'esame del Parlamento. ONOFRIO INTRONA su La Gazzetta del
Mezzogiorno il 19 Maggio 2023
I tecnici del Senato bocciano la riforma
Calderoli: «un testo spacca-Italia»: l'autonomia differenziata aggraverà le
disparità tra le Regioni. Ovviamente sottoscriviamo le valutazioni, ma non sono
nostre: si leggono nel report pubblicato sul portale ufficiale di Palazzo
Madama, che ha scosso le certezze padano-venete. Uno schiaffo al progetto «alla
larga dal Sud», tanto da fare ventilare addirittura una rottura dell'accordo di
governo da parte della Lega, se non dovesse passare un caposaldo del patto
politico nazionale su cui si regge la maggioranza di centrodestra.
Gli specialisti che verificano la tenuta economica
di tutti i provvedimenti all'esame del Senato hanno rilevato forti criticità sul
testo di legge all'esame del Parlamento. Innanzitutto, rischia di rendere ancora
più ricche le Regioni già ricche, di ridimensionare il bilancio dello Stato 1e
di impedire ai territori più indietro di garantire servizi essenziali ai
cittadini, come scuola e sanità.
Nel dossier tecnico si legge che dal trasferimento
alle Regioni (col relativo personale e le risorse finanziarie) di funzioni ora
svolte dallo Stato, competenze e materie aggiuntive, deriverebbero una forte
crescita del bilancio regionale e un ridimensionamento di quello statale, che
non potrebbe assicurare i livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni non
differenziate. Oltre alla salute dei cittadini e all'istruzione, sarebbero a
rischio nel Mezzogiorno i servizi sociali, i trasporti, i rapporti culturali e
così via. Le più colpite? I tecnici non hanno dubbi: le autonomie più povere,
quelle con bassi tributi erariali nel proprio territorio, avrebbero «difficoltà
a finanziare le funzioni aggiuntive». Inoltre, il trasferimento delle nuove
funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane da parte delle
Regioni differenziate «potrebbe far venir meno il conseguimento di economie di
scala, dovuto alla presenza dei costi fissi indivisibili legati all'erogazione
dei servizi la cui incidenza aumenta al diminuire della popolazione».
Il giudizio tecnico tanto severo sta dando ragione
a quanto andiamo sostenendo fin dal 2018 nella nostra battaglia contro
l'autonomia differenziata e prima ancora contro la folle accelerazione nordista
verso il federalismo, impressa sotto l'ultimo premierato Berlusconi nel 2011 e
stoppata dalla caduta del Cavaliere, sostituito dal Governo Monti.
Da oltre un decennio sostengo sui quotidiani del
Mezzogiorno le ragioni del Meridione, insistendo sull'esigenza di interventi
infrastrutturali non rinviabili, primi tra tutti una rete ferroviaria moderna,
efficiente, rapida: la Puglia non è un binario morto (lo rivendica
meritevolmente la campagna d'opinione della Gazzetta del Mezzogiorno) e
l'interportualitá adriatico-ionico-tirrenica, da valorizzare per trasformare il
Mezzogiorno d'Italia in una grande piattaforma avanzata e attrezzata dell'Europa
nel Mediterraneo, ponte strategico per lo sviluppo di rapporti sociali, politici
ed economici con i Paesi dell'Africa e del Medio Oriente. Senza trascurare, come
si è fatto colpevolmente finora, il diritto dei meridionali a un welfare
dignitoso, a collegamenti moderni di ogni rete, anche digitale, alla stessa
attenzione ricevuta dal Nord negli ultimi anni e a vedere riconosciuto come una
priorità il riequilibro con il Centro Nord.
Oggi più che mai, contro la nuova campagna
secessionista del Nord mascherata da autonomia differenziata, il Mezzogiorno
deve pretendere risposte ai problemi che non ci consentono ancora di essere
pienamente Europa. Le grandi infrastrutture sarebbero in grado di dare risposte
efficaci in termini occupazionali e di spingere il Paese verso la crescita.
Anche e soprattutto di aiutare il Sud a superare i ritardi: far correre
finalmente il Sud alla stessa velocità delle regioni settentrionali e
centrocontinentali sarebbe un beneficio anche per l'Italia e l'Unione Europea.
Al contrario, l'autonomia di Calderoli non punta a
crescere insieme, è una riforma malata, funzionale solo agli istinti separatisti
della Lega, è una fuga in avanti del Settentrione ricco per liberarsi del
Mezzogiorno, il vecchio sogno di Pontida e dintorni.
Servirà questa «fuga di notizie» a scuotere il
Mezzogiorno? A prendere atto che da anni si sta tentando, a suo danno, di
costruire un progetto egoista, ingiusto e incostituzionale? Questo, anche per la
cecità, la complicità, la pigrizia e la colpevole sottovalutazione della sua
classe politica, dalle amministrazioni e dalla stessa società civile. È tempio
che la classe dirigente del Paese, tutto il Sud, il mondo della ricerca
(Università e Politecnici) le Regioni meridionali e i sindaci, a cominciare da
quelli delle grandi Città, devono sventare qualsiasi disegno autonomista. Il
regionalismo differenziato, oltre a danneggiare il Mezzogiorno e a minare
l'unità del Paese, viola l'uguaglianza tra i cittadini sancita dalla
Costituzione repubblicana. Se non sarà così, a centosessantadue anni
dall’unificazione il Governo Meloni sarà responsabile della tristissima disunità
d’Italia.
Scontro al veleno sull'autonomia, Viesti:
«Riforma ridicola, quel documento dice solo la verità». L’economista: a
Palazzo Madama anche la nostra proposta costituzionale. LEONARDO PETROCELLI su
La Gazzetta del Mezzogiorno il 18 Maggio 2023.
Professor Gianfranco Viesti, economista - in
questi giorni in libreria con il nuovo volume «Riuscirà il Pnrr a rilanciare
l’Italia?» (Donzelli 2023) - ha letto il documento della «discordia» prodotto
dal Servizio di Bilancio del Senato sull’autonomia? Che idea si è fatto?
«È un testo molto corretto che, oltretutto, non
dice nulla di sovversivo. La Camera e il Senato hanno uffici tecnici
straordinari che producono, per tutti, documenti impeccabili».
Anche questo lo è?
«Certamente».
E allora entriamo nel merito: è vero, come
riportato, che l’autonomia rischia di ingrossare i bilanci parlamentari e
assottigliare quello nazionale?
«Se tu spogli il bilancio nazionale di parte del
gettito fiscale che arriva da regioni molto grandi come Lombardia o Emilia
arrivano molti meno soldi. Non c’è dubbio. Sa qual è il problema?».
Prego.
«Che quei soldi servono a fare due cose. Far
fronte al bilancio dello Stato, naturalmente. Ma anche a provvedere ai servizi
pubblici in quelle Regioni che non hanno l’autonomia differenziata e che dunque
non dispongono di risorse ulteriori. Ecco, se ti entrano meno soldi, come fai?».
Ci sarebbero i Lep...
«Guardi, su questo punto bisogna esser chiari. E
spiace perché nel cosiddetto Comitato per i Lep ci sono anche personalità
autorevoli ma si tratta di una iniziativa almeno discutibile».
Discutibile perché?
«Innanzitutto, i Lep devono essere fissati dal
Parlamento e non da qualche commissione di studio. E poi, se vuoi farli
seriamente, bisogna preventivare un aumento di spesa cospicuo nel tempo. Se
tutto va bene si potranno raggiungere tra 10-15 anni. Ripeto, spiace per chi si
è prestato ma, evidentemente, il fascino del potere è sempre forte».
Altro punto: l’autonomia impedirebbe lo
svilupparsi di «economie di scala». Che significa?
«Le economie di scala sono politiche uniche per il
Paese. E ci sono competenze che è molto meglio esercitare a livello nazionale».
Un esempio concreto?
«Se ne potrebbero fare tanti. Ma in questi giorni
di disastri dovuti al maltempo ricordo che anche la Protezione civile è
un’economia di scala con mezzi nazionali e con una centrale operativa unica.
Solo che il Veneto vuole farsi la propria. Facile immaginare le conseguenze».
Alla fine sembrano obiezioni circostanziate. Ma il
ministro Calderoli parla di «criticità non oggettive, ipotetiche».
«È un punto di vista politico ma solitamente chi
difende l’autonomia quando il gioco si fa tecnico butta la palla in calcio
d’angolo».
Chi ha fatto uscire quel documento secondo lei?
«Non saprei proprio ma posso dirle che in passato,
al tempo del Conte I ad esempio, ne uscirono anche di più duri. Il punto è che
parliamo di una proposta ridicola. Il termine è questo: ridicola. E resto
convinto che quando nel 2017 il Veneto formulò la lista di richieste non ci
credevano neanche loro».
A sinistra è passata l’infatuazione per
l’autonomia?
«Bella domanda. Al Sud vedo una buona
mobilitazione ma la nuova segretaria del Pd non l’ho ancora sentita esprimersi
su questo tema: va benissimo dire no al ddl Calderoli ma quello norma solo il
processo. Il problema è il contenuto, sono le richieste delle regioni fra cui
l’Emilia-Romagna. E da qui non si scappa. In compenso c’è una buona notizia».
Quale?
«Si è chiusa la raccolta di firme per la nostra
proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare. Siamo arrivati quasi a
100mila. In sintesi, noi chiediamo che le Regioni debbano motivare le loro
richieste e che alla fine del processo la parola sia data ai cittadini. Inoltre,
vogliamo che allo Stato resti la competenza esclusiva su educazione, energia e
grandi infrastrutture e, infine, che sia attivabile una clausola di supremazia
dello Stato per ragioni di interesse nazionale».
Ora che succede?
«La proposta sarà incardinata nei lavori del
Senato, se ne dovrà discutere. E, si badi, è una proposta di rango
costituzionale mentre il ddl Calderoli è una legge ordinaria che può essere
scavalcata da un’altra, ad esempio da quella che ratifica l’intesa con una
Regione. Quindi non serve modificare la Calderoli per avere più garanzie».
Al Senato partiranno ora anche le audizioni con i
governatori del Sud. L’autonomia esce allo scoperto?
«Finora è stato tutto molto opaco. Circolano
documenti del ministero di Calderoli con gli elenchi delle funzioni svolte dallo
Stato che potrebbero passare alle Regioni: sono circa 500. Di rimando, ci sono
repliche forti dei ministeri della Salute e dell’Ambiente. Ma è tutto un
carteggio di mail lontano dagli occhi dei cittadini mentre dovremmo discutere di
una sessione parlamentare di tutto interesse per il Paese. Se leggessero quei
documenti si spaventerebbero non solo a Bari, ma anche a Milano».
Col decreto Calderoli gli
italiani dicono addio al Servizio sanitario nazionale. L’autonomia
differenziata, non solo aumenterà i divari fra la qualità del servizio offerto
fra Nord e Sud, ma farà crescere anche la mobilità sanitaria, cioè i viaggi dei
meridionali per curarsi rischiando di mandare in tilt le strutture del
settentrione. Gloria Riva su L’Espresso il 5 aprile 2023.
In Toscana c'è una sola azienda
sanitaria territoriale. In Veneto ce ne sono nove. In Lombardia le aziende
sanitarie si chiamano Asst, altrove si chiamano Ats, al sud si chiamano aziende
provinciali. In Friuli Venezia Giulia ci sono le aziende uniche, al cui interno
vengono coordinati ospedali, università e strutture territoriali. Poi il Veneto
ha avviato la formazione complementare degli Oss, gli assistenti socio
assistenziali, mentre in Campania è stato istituito lo psicologo di base, mentre
in Lombardia non c'è. E si potrebbe andare avanti all'infinito, nel tentativo di
dimostrare che, limitatamente alla Sanità, l'autonomia differenziata esiste già,
eccome. E gli effetti del federalismo sanitario, che esiste dal 1992 e prevede
che siano le Regioni a gestire la sanità, sono sotto gli occhi di tutti: basta
leggere gli ultimi dati dell'Agenas, l'agenzia che fa capo al ministero della
Salute e monitora l'attività delle singole regioni, a proposito dei Lea, cioè i
Livelli essenziali di assistenza.
Dunque, i Lea sono le
prestazioni e i servizi minimi – in termini di prevenzione, assistenza
distrettuale e ospedaliera -, che il Servizio sanitario nazionale è obbligato a
fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o con una quota di ticket. Sono le
Regioni che devono organizzarsi in modo tale da garantire un servizio adeguato a
tutti, in modo tale che, da Palermo a Milano, il Ssn sia universale e le cure
uguali per tutti. Questo, almeno, sarebbe l'obiettivo, perché nei fatti
Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte e Lombardia riescono a soddisfare
almeno l'87 per cento dei livelli minimi di assistenza, le regioni del centro
Italia, più Liguria e Trento li raggiungono ma non pienamente, e invece sono
profondamente arretrate le regioni del Sud.
Detto altrimenti, la Sanità
italiana è diseguale. E la novità è che, con l'introduzione del Decreto legge
Calderoli sull'autonomia differenziata, la situazione peggiorerà ulteriormente
perché le Regioni potranno chiedere ancora più autonomia in ambito sanitario,
specialmente rispetto al compenso previsto per il personale infermieristico e
medico. Ma andiamo con ordine.
Con l’approvazione da parte del
Consiglio dei ministri del Ddl Calderoli sull'autonomia differenziata è iniziato
il percorso che dovrebbe portare le Regioni a chiedere e ottenere maggiore
indipendenza legislativa nella gestione di 23 materie che, oggi, sono di
competenza dello Stato. Dentro c'è di tutto, dalla scuola all'energia,
professioni e alimentazione, porti e casse di risparmio, sostegno
all'innovazione e finanza pubblica, fino alla tutela della salute.
Dai sindacati alle sigle di
categoria dei medici, tutti hanno espresso un parere negativo rispetto
all'estensione dell'autonomia a un tema delicato come quello sanitario.
Addirittura lo stesso ministero della Salute ha dichiarato che sarebbe meglio
mantenere in capi al ministero stesso un ruolo di indirizzo.
Mentre la Fondazione Gimbe, un
ente indipendente che si occupa di analisi sulla sostenibilità economica del
Servizio Sanitario Nazionale, ha realizzato un intero dossier sulla questione,
arrivando a descrivere uno scenario da incubo (per la qualità di vita dei
cittadini delle regioni più svantaggiate) qualora l'autonomia differenziata
fosse confermata anche per la sanità: «Il mancato raggiungimenti dei Lea in
molte regioni, nonostante decenni di tentativi di riequilibrio, conferma quanto
la disuguaglianza sanitaria sia un fenomeno già attuale», commenta Nino
Cartabellotta, presidente di Gimbe, che continua: «Di conseguenza, l’attuazione
delle maggiori autonomie richieste dalle Regioni con le migliori performance
sanitarie è amplificherà le diseguaglianze di un Ssn, oggi universalistico ed
equo solo sulla carta. I princìpi fondanti del Ssn si sono già dissolti senza
alcun ricorso all’autonomia differenziata e il regionalismo differenziato finirà
per legittimare normativamente e in maniera irreversibile il divario tra Nord e
Sud, violando il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel
diritto alla tutela della salute».
Per Cartabellotta l'unica
soluzione possibile è eliminare la materia sanitaria dall'elenco di competenze
al centro del processo di autonomia.
Il cuore del problema è capire
infatti come sarà possibile finanziare le regioni economicamente meno floride se
il Nord tratterrà per sé il denaro raccolto dalle proprie tasse. Per capirci,
come colmeranno il gap oggi esistente Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio,
Molise, Puglia e Sicilia senza gli stanziamenti provenienti dalle regioni più
ricche? E poi, già oggi la spesa sanitaria pubblica si attesta attorno ai 2.147
euro pro-capite, ma la distribuzione fra Regioni è già piuttosto diversificata:
si va dai 2.186 euro per i veneti ai duemila euro per i campani e siciliani. E
con l'autonomia questa diversificazione andrà ulteriormente aumentando.
Il punto più dolente del ddl
Calderoli riguarda la possibilità, per ciascuna regione, di remunerare il
personale in autonomia. Oggi tutte le Regioni hanno difficoltà a reclutare
medici e infermieri, e se Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna aumenteranno il
salario dei propri camici bianchi da 60 a 100 euro l'ora, è chiaro che ci sarà
una vera e propria migrazione di massa dei sanitari dalle aree più depresse a
quelle più ricche, cosa che per altro già avviene, ma è calmierata dal fatto che
i salari dei medici sono più o meno gli stessi in tutta Italia.
A ruota, si intensificherà il
fenomeno della mobilità sanitaria, con un pellegrinaggio ancora più massiccio
dei cittadini del sud in cerca di cure adeguate al nord. Finanziariamente sarà
un disastro, perché le regioni più carenti dal punto di vista dei servizi,
pagano alle regioni in cui i pazienti scelgono di curarsi una compensazione
finanziaria: secondo i calcoli della Corte dei Conti, 13 regioni, quasi tutte al
Sud, hanno accumulato un debito di 14 miliardi nei confronti delle regioni del
Nord (dove i meridionali scelgono di curarsi).
Ma sarà altrettanto disastroso
dal punto di vista della sostenibilità materiale delle strutture sanitarie del
Nord Italia, che a stento riescono a rispondere alle richieste di assistenza dei
propri cittadini e, con l'autonomia differenziata, rischiano di doversi fare
carico dell'assistenza sanitaria dei pazienti di tutta Italia. Proprio così,
l'autonomia differenziata potrebbe incatenare ancora di più le regioni del Sud
alla dipendenza sanitaria degli ospedali del Nord.
L’autonomia è pure musicale:
il Veneto avrà il suo inno. Al Bano replica: «E noi canteremo Felicità».
Proposta approvata dalla Lega Veneta, Fdi si astiene. Contrario il Pd. Il Sud
risponde: parlano Al Bano e Pino Aprile. AL BANO CARRISI su La Gazzetta del
Mezzogiorno il 30 Marzo 2023
Ha ottenuto l’ok delle
Commissioni, e tra poco giungerà nell’aula del Consiglio regionale, la proposta
di legge che intende dotare il Veneto di un «inno regionale» da intonare nelle
cerimonie pubbliche, da scegliere tra «motivi esistenti» o di nuova ideazione.
Il testo è stato licenziato
dalla sesta commissione consiliare Cultura; a favore hanno votato i consiglieri
della Lega-Liga Veneta, contrari i membri di opposizione Pd e Veneto che
vogliamo; l’alleata di maggioranza Fratelli d’Italia si è però astenuta.
A firmare il testo è il
capogruppo della Liga veneta, Giuseppe Pan, assieme al presidente
dell’intergruppo leghista Alberto Villanova, e da altri consiglieri del
Carroccio. Il Veneto seguirebbe l’esempio di altre regioni, come Sicilia,
Sardegna e Marche, che si sono già dotate di un proprio inno riconosciuto a
livello locale e istituzionale. Anche la Lombardia ha commissionato a Mogol e
Lavezzi la scrittura di un inno regionale.
Secondo il progetto di legge,
sarebbe la Giunta regionale a individuare testo e musica, e stabilire in quali
ricorrenze e cerimonie debba essere eseguito, e le modalità di esecuzione, nel
rispetto del cerimoniale di Stato per l’inno nazionale della Repubblica. È stato
tuttavia raccomandato ieri che per la scelta dell’inno venga istituita una
commissione apposita.
«L’idea di dotare il Veneto di
un inno - ha detto in commissione il consigliere leghista Marzio Favero -
rappresenta un contributo all’affermazione di una idea universalistica di
società e di Stato, da condividere e da sostenere, anche con un modesto sostegno
economico». Di tutt’altro avviso la consigliera Pd Vanessa Camani, che sarà
correlatrice di minoranza, la quale ha annunciato emendamenti da parte delle
opposizioni, in considerazione - ha spiegato - della «valenza politica e
ideologica» del provvedimento e degli «ampi margini di discrezionalità» lasciati
alla Giunta regionale.
La replica di Al Bano: Noi
pugliesi baciati dal sole canteremo la hit «Felicità»
Vogliono un inno tutto loro?
Allora lo facciamo pure noi, mettendo al centro di ogni manifestazione una delle
cose più belle che abbiamo in Puglia: dove da sempre viviamo “Nel sole”. E ogni
volta che quel “sole tornerà”, noi saremo pronti a cantarlo.
Oppure, a proposito di “inni”
conosciuti (e richiesti) in tutto il mondo si potrebbe pensare a “Felicità”. Non
me ne vogliano i veneti, ma credo che si sposi alla perfezione con la nostra
Puglia, visto che chi viene qui torna a casa sempre con un carico di...
felicità, dal momento che la nostra regione non è solo capace di offrire “un
bicchiere di vino con un panino”, ma anche tante altre belle cose offerte ai
turisti che scelgono la Puglia per le loro vacanze o anche per investire in una
terra sempre ospitale, sotto tutti i punti di vista: compreso quello
dell'accoglienza.
Al di là di tutto, devo dire
che non mi piace questa proposta che arriva dal Veneto. Per avere un inno
unitario è stato sparso tanto sangue e – piaccia o no – pensare di cambiarlo mi
sembra decisamente assurdo. Ho avuto il piacere l'onore di cantare l'Inno degli
Italiani in ogni parte del mondo e mi sono sempre sentito molto orgoglioso della
mia nazione e anche di questo motivetto che ancora riesce a commuovere quando
viene eseguito nelle manifestazioni ufficiali o anche negli stadi.
Chissà che non lo si possa
cantare anche a Verona, dove festeggerò con tanti colleghi e amici quattro volte
i miei vent’anni, il prossimo mese di maggio, in un’arena dove ci saranno
italiani provenienti da ogni regione d’Italia e sicuramente anche dall’amato
Veneto.
Anche per questo vorrei che
orgogliosi - di fronte all’inno degli italiani - lo fossimo tutti, compresi i
promotori di questo paventato inno regionale del cosiddetto “Popolo Veneto”, che
mi auguro non rinuncerà mai al canto che da sempre unisce tutto il “Popolo
Italiano”. Se poi è intenzione degli amici veneti “solo” aggiungere qualcosa di
autoctono all'inno nazionale, allora la proposta potrebbe anche essere compresa
e – di conseguenza – potremmo (e dovremmo) fare la stessa cosa, ammesso che poi
non ci prenda una “Nostalgia canaglia” per “l'Italia s'è desta...” di mameliana
memoria. Ma se qualcuno pensa di sostituire con un canto qualsiasi un inno che
trasuda della nostra storia, allora non ci sto, come sicuramente non ci starà la
maggioranza degli italiani.
“L'Italia chiamò”. E noi
risponderemo sempre "Si".
Un capro espiatorio chiamato
Sud. FRANCESCO SAVERIO COPPOLA, Coordinatore A.I.M Alleanza Istituti
Meridionalisti, su Il Quotidiano del Sud il 02 Aprile 2023
FAVOLE o Realtà? Il dilemma
dello sviluppo del Mezzogiorno. Si può ripensare il Mezzogiorno? Senza essere
migranti, né briganti? Si può ripensare al suo sviluppo, ad una nuova
integrazione del Paese, nel contesto europeo e mediterraneo, rispetto a una
linea di orizzonte, sempre più vicina, dove ci attende una spaccatura sociale ed
economica sotto il vessillo dell’autonomia differenziata voluta dalle regioni
del Nord Italia?
Pietro Massimo Busetta, nel suo
ultimo libro “La rana e lo scorpione” edito da Rubbettino con la prefazione di
Massimo Villone e la postfazione di Gaetano Savatteri, prendendo spunto da una
antica favola prova a ricostruire la catena delle responsabilità del mancato
sviluppo mostrando come egoismi territoriali o fallaci e opportunistiche teorie
dello sviluppo, avallate dalla politica e dalle Istituzioni, hanno aumentato le
diseguaglianze del Paese, dove il Sud è il capro espiatorio, come direbbe Daniel
Pennac. Di favole ne abbiamo sentite parecchie, le hanno raccontato le forze
politiche di destra, di sinistra e di centro ma anche le Istituzioni hanno
contribuito o con la loro inerzia o con il loro silenzio. Adesso abbiamo la
favola dei Lep (livelli essenziali di prestazione) e non, come dice giustamente
Busetta, Lup (Livelli uniformi di prestazione), senza rinunciare ai soldi
sottratti dal 2009 al Sud con il meccanismo perverso della spesa storica.
Si vuole trovare un metodo che
pareggi i diritti essenziali pur restando invariate le grandi differenze
economiche e sociali. Un grande paradosso statistico. In ogni caso non sono
chiare le fonti di copertura, salvo a non inventarsi i Lep progressivi o a rate.
Un messaggio chiaro e forte nell’apertura del nuovo saggio di Pietro Massimo
Busetta dedicato al Mezzogiorno tra passato, presente e futuro. Un appello, che
richiama ad una forte azione e alla mobilitazione civile e democratica, ma anche
a una presa di coscienza e consapevolezza della classe politica del Nord e del
Paese e dei cittadini del Nord, per evitare che il Paese si spacchi e aumentino
le diseguaglianze e le diseconomie. Un Sud senza rappresentanza politica che a
fronte di doveri paritari richiede anche rispetto di diritti paritari.
Sì, si può ripensare allo
sviluppo. Purché ci liberiamo di una serie di infingimenti, pregiudizi e che
vengano riconosciute responsabilità e irresponsabilità della classe dominante,
delle Istituzioni e anche di una certa cultura economica. Busetta apre con un
appello ai liberi e forti, citando due personaggi, due meridionalisti doc, che
hanno auspicato una rivoluzione sociale ed economica del Sud Don Sturzo e Guido
Dorso, due azionisti diversi per cultura, fede e tradizione, che hanno capito in
anticipo che sola una concreta azione della gente del Sud, l’avvento di una
classe dirigente, che sostituisca o pervada quella dominante, poteva trasformare
il Mezzogiorno da tema culturale o di annotazione in alcune agende politiche ad
azione per uno sviluppo sociale ed economico reale.
Il libro oscilla fra un
“J’accuse” e “Allons Enfants” con la citazione nelle pagine iniziali
dell’Apocalisse 3: 15- 19 “Guai ai tiepidi, li vomiterò”. Una sollecitazione
chiara a reagire e a prendere coscienza per molti di uno sviluppo volutamente
negato. Il passato, presente e futuro sono tre grandi ripartizione che il libro
ci propone come viaggio temporale, tre parti connesse fra di loro, generative e
propositive di una visione dello sviluppo in gran parte mancato, ma ancora
all’orizzonte. Il saggio è l’ultimo di una trilogia di libri dello stesso Autore
che ha come protagonista il Mezzogiorno. Tre libri che disegnano nel legame che
li collega, non solo una passione indomita dell’Autore verso la propria terra,
ma anche la saggezza di una persona, che da tempo ha deciso di lasciare la
turris eburnea e di cimentarsi nello sviluppo concreto non solo del Sud , ma
dell’intero Paese.
Nella pagine rimbalza
attraverso le diverse analisi qualitative e quantitative la questione
meridionale, questione nazionale di un Paese che ha perso da tempo una visione
di sviluppo integrato e sinergico. Si sono alterati i rapporti di forza fra i
vari territori e alla cooperazione si è sostituita una competizione
territoriale, che ha penalizzato, oltre che il Sud, anche i territori meno
sviluppati. L’Italia è cresciuta in maniera diseguale, pur in presenza di un
ceto politico che ha governato il Paese di estrazione meridionale. Difatti il
Sud e Nord geografico sono diventati nel tempo due contesti sociali ed economici
diversi con disparità di diritti di cittadinanza (sanità, scuola e università,
lavoro). La riforma del titolo V della Costituzione e il federalismo fiscale
hanno aggravato il gap con il drenaggio di significative risorse spettanti al
Sud, dirottate a Nord, con l’uso distorto del meccanismo della spesa storica. La
questione meridionale, come emerge dal libro, contrariamente a preconcetti e
fake news sul Sud, nella sua formulazione resta una risposta strategica per lo
sviluppo del Paese e non solo di una sua parte. Un forte appello alla
mobilitazione civile e democratica per evitare che il Paese si spacchi.
Sicuramente per cambiare il
futuro occorre individuare i fallimenti istituzionali e culturali che hanno
riguardato il Sud, il libro con l’originale metafora dantesca dei gironi
infernali prova a classificare le responsabilità o irresponsabilità di Enti e
persone, non tanto per giudicare o ricercare colpe storiche, quanto per dare una
chiave di lettura a persone e istituzioni per agire diversamente per il futuro,
evitando gli errori e le disattenzioni del passato nella logica del rimpallo
delle responsabilità o dell’assenza decisionale o della denuncia mancata. Senza
sconti per nessuno e senza peli sulla lingua si chiamano in causa i tanti che a
voce si dichiarano a favore del Mezzogiorno. Tra passato, presente e futuro si
mette in evidenza come l’approccio verso le problematiche del Mezzogiorno sia
stato sempre “leggero” per non dire superficiale basato o sul mito fasullo delle
eccellenze, che pur esistendo, non fanno sistema o con un approccio
microeconomico affidato ai regionalismi, che non hanno saputo esprimere neanche
nell’utilizzo efficace ed efficiente della spesa dei fondi comunitari progetti
importanti di sviluppo economico. Aver trascurato o voluto trascurare che
l’approccio doveva essere macroeconomico, guidata da una visione strategica
centrale, trattandosi il Mezzogiorno di una area vasta confrontabile con alcune
nazioni europee ha segnato il destino di venti milioni di persone, dei loro
diritti di pari cittadinanza e soprattutto del loro diritto al lavoro. Sotto la
lente il Governo Draghi e le ultime elezioni, parlando di quello che viene
definito lo scippo del Recovery Plan, non dimenticando il fallimento della Lega,
della “rivoluzione” dei Cinque stelle e il fenomeno “Reddito di cittadinanza”.
Lo scippo del PNRR, non tenendo
conto dei parametri adottati dall’Europa che privilegiano le variabili
economiche negative del Sud, è stata l’ennesima dimostrazione di una visione
errata dello sviluppo del Sud. Uno sguardo ampio alla prospettiva del
Mediterraneo, alla valorizzazione dei sei pilastri logistici del Sud (Augusta,
Brindisi, Cagliari, Napoli, Salerno, Taranto) e alle Zes collegate, che
esprimono un potenziale ancora troppo basso di sviluppo. Nel libro si esprime
una forte critica a una pubblicistica nazionale mirata a far sentire i
meridionali inferiori o evidenziare come tipici del Sud, fenomeni ben diffusi su
tutto il territorio nazionale, come il lavoro nero o l’evasione fiscale. La
strategia di comunicazione del Sud resta carente, per mancanza di network
strutturati, anche la Rai che dovrebbe garantire diritti di pari comunicazione
su tutto il territorio nazionale, non svolge un ruolo decisivo. Il libro si
chiude con l’appello ai liberi e forti per evitare e scongiurare, scelte
secessioniste o divisive, come l’ipotesi Cecoslovacchia, o l’ipotesi Jugoslavia,
o peggio l’ipotesi Catalogna.
La Rana e lo scorpione, una
chiamata alle armi per i meridionalisti. MASSIMO VILLONE su Il Quotidiano
del Sud il 3 marzo 2023.
Questo non è un libro nato per
una rilassante lettura sotto l’ombrellone in riva al mare. È una chiamata alle
armi per una nuova classe dirigente che si impegni in una battaglia
meridionalista. Per cogliere l’occasione – forse l’ultima – di rendere l’unità
della Repubblica voluta dalla Costituzione del 1948 una realtà, e non un
miraggio che sfuma in un orizzonte sempre più lontano.
La riflessione dell’Autore
assume i dati, certificati da fonti molteplici, di un divario tra Nord e Sud che
ha radici nella storia e che ha visto in anni recenti le diseguaglianze
accrescersi di molto. La novità della lettura offerta non è tanto nelle cifre
del divario – già in larga parte note – quanto nella considerazione della
dimensione della realtà meridionale. L’Autore osserva che il Sud, se fosse
separato dal resto dell’Italia, sarebbe per popolazione il sesto paese in
Europa. Ben dodici paesi europei sono più piccoli della sola Campania, e nove
della Sicilia. Una dimensione territoriale che con ogni evidenza non regge
soltanto analisi quantitative. che peraltro l’Autore svolge – ma si presenta
anche come dato eminentemente politico.
È proprio la dimensione
territoriale e il suo rilievo politico che spiegano, come sottolinea l’Autore,
il conferimento all’Italia delle risorse europee in misura superiore a quella
riconosciuta a qualsiasi altro paese. E che – riferite ai tre parametri di
popolazione, tasso di disoccupazione e reddito pro-capite – andrebbero ben oltre
il 40% che formalmente viene riconosciuto al Mezzogiorno secondo un mantra
governativo tante volte ribadito, e per la verità mai davvero e pienamente
dimostrato. Al contrario, si sono moltiplicati i dubbi, anche fortemente
argomentati, sulla reale distribuzione territoriale dei fondi in questione.
Come e perché è accaduto e
tuttora accade che le risorse pubbliche in vario modo disponibili fossero
assegnate in prevalenza al Nord, senza alcuna considerazione di un obiettivo che
pure dovrebbe essere da tutti condiviso e che è persino prescritto dalla
Costituzione, come l’unità del paese? Paradossalmente, lo vediamo oggi assegnato
come priorità dall’Europa. Perché la politica italiana è così restia ad
assumerlo?
Sono in campo due letture
contrapposte del ritardo del Sud e del divario strutturale rispetto al Nord, che
segnano ad un tempo il pensiero economico e quello istituzionale. Per una il
divario è dovuto non a una insufficiente dotazione di risorse pubbliche, ma alla
incapacità delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni meridionali di
spendere per inefficienza, clientelismo, o persino inquinamenti malavitosi.
Riversare maggiori risorse in una siffatta realtà può solo bruciarle,
togliendole alla parte di paese – la locomotiva del nord – che ne può davvero
trarre frutto, rimanendo competitiva con i paesi europei più forti e sul piano
globale. Attaccare il divario Nord-Sud allora non è un bene per il paese, ma
reca danno. Bisogna invece lasciare il Sud al suo destino, al più garantendone
un minimo livello di sopravvivenza.
L’altra lettura dice ovviamente
il contrario: la comparativa inefficienza delle strutture pubbliche meridionali
è dovuta alla insufficiente dotazione di risorse pubbliche, che rende
impossibile un funzionamento adeguato rispetto alle esigenze. Ridurre il divario
Nord-Sud attivando una seconda locomotiva nel Mezzogiorno è la sola politica che
possa portare l’Italia tutta a un più alto livello di competitività. Questo
nell’interesse non solo del Mezzogiorno ma dell’intero paese, diversamente
condannato a un inevitabile declino.
L’Autore sceglie nettamente la
seconda lettura, che ha un preciso riscontro nella realtà. Chi studia il
Mezzogiorno non da oggi sa che l’attenzione per la locomotiva del Nord ha
condotto il Paese alla stagnazione. Nel rapporto Svimez 2021 una tabella
comparativa certifica che nella classifica territoriale europea le nostre
presunte eccellenze – ad esempio, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte,
Toscana, Liguria – sono negli ultimi venti anni in caduta libera e perdono
decine di posizioni rispetto all’inizio del secolo. È esattamente l’esito della
politica italiana di investimento sulla locomotiva del Nord. Se si vuole far
crescere il Paese a ritmi paragonabili a quelli dei partner europei più forti
bisogna rivitalizzare il Mezzogiorno. Un secondo motore oggi reso ancor più
necessario dalle conseguenze geo-politiche della guerra in Ucraina, e dal nuovo
centralismo che potenzialmente assume una presenza europea in chiave
euro-mediterranea.
È uno scenario cui l’Autore
presta una giusta attenzione. Ma come realizzarlo? È cruciale un cambio di
classe dirigente, al Sud come al Nord. L’Autore sottolinea la bulimia
economico-sociale della classe dirigente del Nord, volta a fagocitare la maggior
quota possibile di risorse pubbliche senza alcuna attenzione per il divario
Nord-Sud e i diritti dimidiati in tanta parte del Paese. Ma sottolinea al tempo
stesso la subalterna connivente complicità della classe dirigente meridionale,
estrattiva e attenta a difendere clientele e familismi, senza tenere in alcun
conto l’interesse dei territori da essa rappresentati.
Una riflessione su questo punto
va fatta sul Movimento 5 Stelle, cui l’Autore guarda essenzialmente come una
occasione perduta. Indubbiamente ha ragione quando vede nel risultato elettorale
del 2018 aprirsi uno scenario possibile di profondo cambiamento per il
Mezzogiorno. Avrebbe potuto essere l’avvio del formarsi di una nuova classe
dirigente per il Sud, volta a sostituire quella estrattiva, subalterna e
connivente con il Nord, incapace di andare oltre la pratica della gestione
clientelare e familistica del potere. L’occasione quindi per il Mezzogiorno di
conquistare una pari dignità sul palcoscenico della politica nazionale. Ma la
promessa non è stata mantenuta, “per una carenza di preparazione e di capitale
umano adeguato oltre che per una deriva populista che ha prevalso nelle loro
fila” (pag.21).
Una considerazione
sostanzialmente da condividere. Anche un osservatore benevolmente attento
all’ascesa e alla progressiva crescita dei consensi del Movimento nei turni
elettorali del 2013 e 2018 ne vede i limiti. Soprattutto con il voto del 4 marzo
2018 il Movimento ha la possibilità di diventare soggetto egemone nella politica
italiana e struttura portante nell’architettura istituzionale. Con quel voto,
però il Movimento segna il suo punto più alto, e inizia la caduta. Ha dato quel
che poteva dare, e l’evoluzione successiva avrebbe richiesto un cambiamento
profondo. Il movimento del “vaffa” doveva tramutarsi in soggetto di governo
capace di parlare al Paese tutto, e non solo a questo o quel nucleo di protesta
militante. Una impresa certo difficile, ma non impossibile. Sarebbe stato, però,
a tal fine necessario un vero gruppo dirigente e una solida struttura, capaci di
elaborare un progetto organico e di tradurlo in azione politica e di governo.
La mancanza di queste
condizioni ha segnato la storia del Movimento5S nella legislatura che ora si
chiude, e ne ha conclusivamente prodotto l’implosione. La stessa mancanza ha
fatto sì che il Movimento non si sia mai mostrato consapevole di poter essere
protagonista di un nuovo meridionalismo, imperniato sul dato indiscutibile di
avere una cassaforte elettorale nel Mezzogiorno, e di disporre delle possibilità
offerte dai poteri di governo. Inconsapevolezza provata dal fatto che tre
esecutivi di diverso colore – Conte I, Conte II e Draghi – hanno assunto come
priorità il tema dell’autonomia differenziata portandolo alla soglia del
Consiglio di ministri senza che M5S avviasse mai una seria riflessione volta a
saggiarne la compatibilità reale con l’unità della Repubblica e specificamente
con gli interessi del Mezzogiorno. La necessità che il Sud richiedesse sul punto
valutazioni attente e tutela non è mai veramente entrata nella riflessione
politica del Movimento. Al più, si rilevano sporadiche esternazioni di questo o
quell’esponente, e nulla di più. Pur essendo questione di ben maggiore portata
rispetto a bandiere che il Movimento ha deciso di volta in volta di piantare.
Nel voto del 25 settembre 2022
il Movimento non ritornerà ai fasti del 2018. Le prospettive sono buie, dopo le
carenze di azione politica nella legislatura, la scissione guidata da Di Maio,
la mancata fiducia al Governo Draghi sotto la regia del capo politico Conte. Con
la legge elettorale vigente e complice il taglio degli eletti fortemente voluto
proprio da M5S, il Movimento ha visto ridotto il proprio consenso elettorale a
poco meno del 20%, portando in Parlamento una sparuta pattuglia di poche decine
e rimanendo sostanzialmente marginale o del tutto ininfluente nella politica
nazionale. Quel che qui conta è che viene meno la prospettiva di un protagonismo
del Movimento utile a una nuova stagione meridionalista.
Dove volgersi allora? L’assunto
dell’Autore è che ci sia una maggioranza silenziosa, sia al Sud che al Nord,
disponibile per un radicale cambiamento delle politiche seguite finora. Una
maggioranza resa silenziosa dalla mancanza di una offerta politica adeguata. Si
cita come supporto l’Unione europea, di cui si assume l’interesse a valorizzare
il ruolo dell’Italia in una prospettiva euromediterranea, in specie dopo
l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ma è cruciale un cambiamento
radicale della classe dirigente del Sud.
Come? L’Autore individua un
punto debole nel fatto che le forze di rinnovamento meridionali, che pure
possono contare su una élite intellettuale, non hanno un seguito elettorale, e
non sono state in grado di produrre un fenomeno politico come quello della Lega
Nord. Mancano della struttura organizzativa necessaria per tradurre l’analisi in
consenso. L’assunto del libro è che l’appello “ai liberi e forti” possa superare
tale mancanza.
Una scommessa non facile.
Nemmeno è facile la parte che riguarda la classe dirigente del Nord. È
significativo che con ben quattro governi di diverso colore – Gentiloni,
gialloverde, giallorosso, e infine Draghi – sia stata costante la spinta per
avviare il processo attuativo dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
sull’autonomia differenziata. Il fatto che sin dall’inizio la spinta sia venuta
non solo da regioni a trazione leghista, come Veneto e Lombardia, ma da una
storica roccaforte della sinistra, come l’Emilia-Romagna, contribuisce a
spiegare in ampia misura come anche in soggetti politici che dovrebbero essere
attenti all’eguaglianza e ai diritti il divario Nord-Sud non trovi l’attenzione
che meriterebbe. Lo stesso vale per il sindacato. Forse il termine connivenza va
oltre il segno. Ma se non di connivenza, di sicuro è giusto parlare di
tolleranza e ambiguità. Mentre è significativo che subito dopo la caduta del
governo Draghi la pressione verso l’autonomia sia immediatamente ripresa, e
che è stata oggetto di campagna elettorale. Lo dice in chiaro Zaia, presidente
del Veneto, che promette battaglia già all’apertura dei lavori del
nuovo Parlamento.
Conclusivamente la chiave di
lettura fondamentale del libro si può forse individuare in un assunto: che le
classi dirigenti del Nord e del Sud devono cercare un interesse che le accomuni.
Un interesse che può essere volto allo stare insieme, per ridare al Paese unito
la grandezza e la centralità che ha in parte perduto, oppure al separarsi, per
dare a ciascuna delle due parti la libertà di perseguire i propri obiettivi in
una condizione di parità nella competizione europea e globale, in specie senza
alcuna indebita subalternità del Mezzogiorno.
Se non si raggiunge una
sinergia positiva “a qualcuno potrebbe venire in mente che un collegamento
diretto con l’Unione potrebbe essere vantaggioso per un Sud, che potrebbe
trattare le condizioni, di volta in volta, direttamente, sia con gli organismi
europei che con quelli internazionali” (pag 26). Le parole dell’Autore ci
riportano a uno scenario di separazione consensuale come quella del 1993 in
Cecoslovacchia, a seguito di un voto nel Parlamento ancora formalmente unitario:
il “divorzio di velluto”.
Sono potenziali sviluppi che
non si prevengono con un richiamo puramente formale alla Repubblica “una e
indivisibile” di cui all’art. 5 della Costituzione. In una prospettiva di medio
o lungo periodo si mostra insostenibile – comunque, e al di là di qualsiasi
formula – la continuazione di una politica che vede il Sud stretto in una
marginalità crescente, e destinato a una desertificazione economica e sociale.
Uno scenario non solo incostituzionale, ma soprattutto politicamente ed
eticamente inaccettabile.
La vulgata nordista dice che
il Sud non sa spendere così spera di intascare i fondi per il Mezzogiorno.
PIETRO MASSIMO BUSETTA su Il Quotidiano del Sud il 24 Febbraio 2023
Per De Luca vi è un progetto
nazionale volto a far credere che il Sud non sa spendere per redistribuire al
Nord i fondi del Mezzogiorno
“La Campania dovrebbe ricevere
fondi per lo sviluppo e la coesione per 5,6 miliardi di euro. Ma sono bloccati e
nessuno dice niente, perché siamo un Paese nel quale tutti vogliono essere amici
di tutti e quando ci sono problemi in genere si gira la testa dall’altra parte.
Molte cerimonie, ma poca sostanza…».
Pesante l’attacco che il
Governatore della Campania Vincenzo De Luca, Regione che rappresenta il 10%
degli italiani, seconda dopo Lombardia e a pari popolazione del Lazio, sferra al
Governo nazionale.
La tesi che sostiene il
Governatore della Campania è di una gravità inaudita. Secondo De Luca vi è un
progetto nazionale che mira a far passare la vulgata che il Sud non riesce a
spendere le risorse, inventando una serie di blocchi che portano a questo
risultato, per poi redistribuire tali risorse, accedendo come a un bancomat
della Nazione, a tutto il Paese, facendo rientrare nella distribuzione anche le
Regioni settentrionali.
«UN PROGETTO PER SPOSTARE I
FONDI DEL MEZZOGIORNO AL NORD»
Tale comportamento porta al
risultato di una spesa pro capite inferiore, malgrado le grandi risorse che
dovrebbero arrivare con i fondi strutturali. E l’accusa è circostanziata con i
passaggi che vengono evitati per impedire che le risorse vengano messe a terra,
con l’obiettivo, dichiara il Governatore, di spostare tali risorse verso il
Nord: «È un pericolo grave vedere risucchiati i soldi del Sud dal Nord.”
Ovviamente a tale comportamento
si suggerisce che sottende una regia di alcuni ministeri, in particolare quello
dell’economia con a capo Giancarlo Giorgetti, ma evidentemente anche quello del
Mezzogiorno con a capo Raffaele Fitto, che operano per impedire la destinazione
delle risorse o, con peccati di omissione, stanno inermi a guardare malgrado non
si compiono tutti gli atti necessari perché le risorse arrivino sul territorio.
FONDI DEL MEZZOGIORNO AL NORD,
L’ATTACCO: «IL GOVERNO NON CONVOCA IL CIPESS»
La dichiarazione é esplicita
“C’è un capitolo sui Fondi di sviluppo e coesione, destinati per l’80 per cento
al Mezzogiorno. Parliamo di 67 miliardi di euro, con un riparto definito da sei
mesi, ma il Governo non convoca il Cipess (il Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) per fare concretamente
l’investimento con 5 miliardi e 600 milioni di euro che spettano alla Campania».
Probabilmente non è completamente vero che vi sia una regia occulta, per non far
arrivare i soldi al Mezzogiorno, del Ministero dell’Economia, ma non è
incredibile che si ritardino delle procedure e conseguentemente delle
assegnazioni e che quindi la spesa, per problemi di bilancio nazionale, per
rispettare per esempio il rapporto debito Pil.
“IL SUD NON SA SPENDERE” MA
SPESSO NON VIENE MESSO IN CONDIZIONE DI SPENDERE
I solerti funzionari del
Ministero dell’Economia, che conoscono bene l’esigenza di presentare i conti in
ordine, come buoni padri di famiglia, potrebbero ritardare, laddove possibile,
alcune spese in maniera da consentire di avere i conti in ordine.
Ovviamente la vulgata poi
diventa quella che il Sud non sa spendere le risorse, mentre viene messo in
condizione di non poterlo fare, come peraltro viene ribadito da molti
amministratori locali, compresi molti sindaci, che dicono che i meccanismi della
normativa dei bilanci sono tali per cui l’assegnazione delle risorse spesso è
teorica.
E allora il problema non è più
l’assegnazione, che potrebbe anche essere fatta correttamente, quanto i
meccanismi da correggere per far si che le risorse non arrivino sui territori
con i ritardi soliti. Adesso con il PNRR e con le scadenze catenaccio che, nel
caso non vengano rispettate, portano alla perdita delle risorse il problema
diventa ancor più cogente.
Non si può contemporaneamente
pensare di eliminare il reddito di cittadinanza per i cittadini cosiddetti
occupabili, cioè quelli che sarebbero in condizione di lavorare, ma che non
hanno una domanda di lavoro sul territorio e poi non far arrivare le risorse che
l’Europa ha assegnato, per l’esistenza di un Sud cenerentola d’Europa, ai
territori pertinenza, per salvare i conti dello Stato italiano.
Perché ovviamente la mancanza
di risorse destinabili ai territori porta poi come conseguenza la presenza di
diritti di cittadinanza diversi rispetto a quelli di cui usufruiscono i
cittadini di serie A del Nord. Così come ritardano le opere pubbliche
indispensabili, perché si possa finalmente avere quella infrastrutturazione
complessiva che consenta la attrazione reale di investimenti dall’esterno
dell’area.
NON SI PUÒ DIRE A PAROLE CHE IL
SUD E CENTRALE E NEI FATTI DIMOSTRARE IL CONTRARIO
Insomma non si può
contemporaneamente affermare che il Sud è centrale rispetto alle politiche a
parole e poi nei fatti avere un comportamento vizioso che porta a conseguenze
nefaste per tutto il Paese. Perché se é giusto che il buon padre di famiglia
risparmi e rimandi ad anni successivi le spese non indispensabili diventa
intollerabile invece che per risparmiare non ripari la casa per cui entra
l’acqua delle piogge, oppure non mandi i figli a scuola, o non faccia curare la
moglie.
Ed è quello che sta facendo lo
Stato italiano, perché le risorse che non vengono indirizzate o sbloccate
significano servizi indispensabili ed investimenti importanti che non vengono
attuati. É necessario che Il Ministro Raffaele Fitto, responsabile della
governance delle risorse destinate al Mezzogiorno, intervenga per evitare che vi
siano anche troppi annunci di risorse che vengono assegnate alle aree del Sud e
pochi reali trasferimenti.
SE NON È VERO CHE I FONDI DEL
MEZZOGIORNO VANNO AL NORD SERVONO PRECISAZIONI PUNTUALI
E se invece le accuse lanciate
da Vincenzo De luca non fossero vere allora sono necessarie precisazioni
puntuali, perché se non è tollerabile che le risorse non arrivino non lo è
altrettanto se gli annunci di mancata attenzione siano soltanto polemica
elettorale politica. “Dovremo ora fare una battaglia unitaria al Mezzogiorno, al
di là delle bandiere di partito, perché ci giochiamo il futuro delle prossime
generazioni» è una chiamata alla responsabilità del Governatore alle tante forze
politiche, spesso formate da classe dominante estrattiva per la quale il bene
comune non è un obiettivo, mentre lo è molto di più la possibilità di poter
gestire anche poche risorse ma per i propri clientes.
È chiaro che non troverà
accoglienza visto che i partiti nazionali e i rappresentanti di essi
preferiscono l’adesione all’indirizzo politico del partito piuttosto che la
difesa dei territori, anche perché la dissociazione da esso potrebbe portare a
perdere la possibilità di essere rieletti. Ma forse una riflessione di una forza
politica meridionale che si intesti alcune battaglie diventa indispensabile.
NORD CONTRO SUD LA RIVOLTA
DEI SINDACI. Ivano Tolettini su L’Identità il 25 Febbraio 2023
Doppia rivolta. Per adesso a
parole. La battaglia entra nel vivo e dalle aule parlamentari si trasferisce
sempre di più nel Paese. Non è soltanto un derby dialettico Sud-Nord tra sindaci
che la pensano in maniera diametralmente opposta sull’autonomia differenziata.
Se il governatore veneto Luca Zaia la definisce con enfasi la “madre di tutte le
battaglie”, da Verona nella partita politica, per ora dal sapore molto
ideologico, entra a gamba tesa anche il sindacato che con il segretario generale
della Cgil, Maurizio Landini, chiama alla mobilitazione “tutto il Paese a difesa
dei diritti fondamentali della Costituzione”. Così se l’altro giorno 57 sindaci
su 80 della provincia di Catanzaro, con in testa Nicola Fiorita del
centrosinistra, hanno firmato il documento “Per la Repubblica una e
indivisibile” consegnato al prefetto, in cui si contesta il disegno regionalista
di Roberto Calderoli con l’appoggio del presidente dell’Anci nazionale, Antonio
Decaro, primo cittadino di Bari; ai quali hanno fatto da controcanto numerosi
colleghi veneti con in testa il sindaco leghista Mario Conte di Treviso,
presidente dell’Anci regionale, secondo il quale “tanti sindaci meridionali
voglio rimanere nella loro confort zone”, il serrato dibattito sta
surriscaldando il confronto a più livelli. L’altro ieri, come sottolineava
L’Identità, la Fondazione Gimbe monitorando i “Livelli essenziali di assistenza”
per certificare la qualità dei vari servizi offerti ai cittadini nella Penisola,
ha sottolineato che con l’autonomia la sanità peggiorerebbe. Una conclusione che
ha fatto storcere il naso a molti propugnatori dell’autonomia, secondo i quali
una volta stabiliti i “Livelli essenziali delle prestazioni”, cui faranno da
contrappeso i fabbisogni e i costi standard, la scelta autonomista non sarà un
obbligo per quelle regioni che non volessero andare a braccetto con
l’autonomismo.
MINISTRI E RESIDUO
“Non condivido l’analisi di
chi teme che la mia proposta sull’autonomia determinerebbe un’Italia a due
velocità. E sapete perché? – afferma il ministro per gli Affari regionali,
Roberto Calderoli – Chi lo sostiene dovrebbe aprire gli occhi: l’Italia non a 2
ma 5 o 6 velocità c’è già oggi. Noi vogliano adeguare la velocità di tutti a una
che non sia quella di oggi, ma sia un’alta velocità migliorando i servizi per i
cittadini in uno sforzo corale che non lasci indietro nessuno”. Il ministro lo
spiega ai cronisti all’ arrivo a Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale
del Piemonte, dove ha partecipato a una riunione della Commissione Autonomia. Ai
timori manifestati dall’Anci col sindaco barese Decaro, Calderoli replica:
“Fermo restando l’autonomia dell’Associazione dei Comuni, non credo che la
posizione espressa da alcuni sindaci che ideologicamente sono contrari
all’autonomia rappresenti la maggioranza dei sindaci in Italia: giovedì, in
occasione della Conferenza unificata, ce la rappresenteranno”. Calderoli ha la
convinzione che “anche i sindaci, oltre alle Regioni, hanno solo da trarre
benefici dall’autonomia”. Il ministro ribadisce che oggi non c’è equità con il
sistema centralista. “Con l’autonomia differenziata siamo certi che con la
responsabilità degli amministratori e delle competenze che vengono lasciate sui
territori si possa ottenere maggiore efficienza, trasparenza e risparmio”. Ad
esempio ieri è emerso che il Piemonte ha un residuo fiscale di 11 miliardi di
euro. Per Calderoli “ nel rispetto di un’Italia che vogliamo forte e unità
abbracciando il criterio, voluto in modo intelligente del premier Meloni, di un
fondo per evitare sperequazioni tra aree del Paese”. Da Palermo risponde a
Calderoli l’ex ministro degli Affari regionali, l’azzurro Enrico La Loggia: “Da
un primo conteggio pare che per l’integrazione dei servizi essenziali su tutto
il territorio nazionale siamo ben oltre i 140 miliardi. Li ha disponibili
Calderoli per poter fare questa riforma? Se non li ha, credo che sarà un grande
problema attuare l’autonomia differenziata “.
SINDACATO E BUGIA
Chi non la digerisce proprio
perché teme la spaccatura dell’Italia è Maurizio Landini. Dietro la riforma
dell’autonomia differenziata “c’è una politica e una logica accentratrice, c’è
una bugia di fondo che è quella di pensare che tante piccole patrie regionali
sono in grado di fare i conti con i processi generali”. Una denuncia che il
segretario generale della Cgil, Landini, brandisce nell’intervento al congresso
nazionale dei pensionati della sua confederazione a Verona. È il motivo perché a
fronte di quella che bolla come una “bugia”, il tema dell’autonomia
differenziata sarà al centro del congresso della confederazione. “La difesa dei
diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione – analizza – deve diventare
mobilitazione di tutto il Paese e delle organizzazioni sindacali in modo largo
ed esteso”.
SINDACI
Al coordinatore veneto di FdI,
Luca De Carlo, sindaco di Calalzo (Belluno), che dice convinto di “non capire
perché alcuni colleghi meridionali alzino barricate pregiudiziali su un progetto
che garantirà migliori servizi ai cittadini”, fa eco il primo cittadino di
Catanzaro, Fiorita, per il quale “è un progetto dichiaratamente a favore di una
parte del Paese, e per questo è inaccettabile, tanto più perché la parte
svantaggiata del Paese siamo noi: la Calabria e tutto il Meridione”. È la doppia
rivolta.
Countdown Autonomia.
Domenico Pecile su L’Identità il 24 Gennaio 2023
Il più sicuro, il più ottimista
è il vice premier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.
“Entro i prossimi giorni, non i prossimi mesi – giura – arriva in Consiglio dei
ministri il primo passo sull’Autonomia. Ed entro fine inverno sarà cosa fatta.
Ma non perché è una richiesta della Lega, ma perché serve all’Italia”.
Salvini – che ha rilasciato le
dichiarazioni sabato, a Cremona, in occasione di un incontro con gli industriali
e le associazioni di categoria – aveva anche affermato che “valorizzare le
Regioni e i territori, dargli più potere significa sprecare di meno, perdere
meno tempo e competere. C’è nel programma del centrodestra, come la riforma del
presidenzialismo. Non è che se va vanti l’autonomia è un favore che la Meloni fa
a Salvini o se va avanti il presidenzialismo è un favore che Salvini fa alla
Meloni.
Abbiamo un’idea di Italia
federale e presidenziale: moderna, veloce, efficace, responsabile, quindi
procediamo spediti”. Salvini detta quindi l’agenda sui tempi (“il tempo è
denaro, quindi prima arriva l’autonomia meglio è per tutta Italia”) di
approvazione del provvedimento. Il leader del Carroccio spera di riuscire a
ingraziarsi nuovamente i ceti produttivi del Nord e soprattutto quello che sta
per andare al voto, nel mentre il resto della coalizione fa di necessità virtù.
E non pone scadenze.
Il Capitano pare essere l’unico
ad avere innestato la quarta, a scalpitare. Pochi giorni fa il presidente della
Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, commentando gli otto punti presentati dalla
Conferenza delle Regioni al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie,
Roberto Calderoli e fatti propri da quest’ultimo prima di essere rinviati alla
Conferenza delle Regioni, aveva affermato che “Mi pare evidente che stiamo
andando in una direzione di collaborazione istituzionale e proprio per questo è
importante in tale senso.
Per questo mi auguro che la
condivisione, scevra da interessi partitici, possa andare avanti senza intoppi”.
Per il realista Fedriga il vero obiettivo della riforma deve essere quello di
evitare lo strappo Stato-Regioni. E non a caso la presidente dei senatori di
Forza Italia, Licia Ronzulli, pur confermando che “il presidenzialismo è da
sempre nel programma di Forza Italia” perché “è un intervento necessario che va
di pari passo a quello dell’Autonomia differenziata”, ha poi aggiunto che
“abbiamo sempre detto che serve un’Autonomia differenziata che non spacchi il
Paese in due e non crei cittadini di serie A e di serie B”. Dunque: “Dobbiamo
garantire a tutti gli stessi servizi e gli stessi diritti, da Nord a Sud, anche
attraverso l’attenta riscrittura dei Lep.
Certamente il Parlamento avrà
la possibilità di dire la sua”. Entusiasta il governatore del Veneto, Luca Zaia.
Il quale sostiene che il Governo sta rispettando gli impegni presi. “L’Autonomia
– ha sottolineato – parte dal Veneto e non solo da quel 22 ottobre 2p017, ma da
molto prima. Vedo che un Governo che è lì da quasi 100 giorni è un Governo che
ha portato nella manovra finanziaria un articolo che obbliga alla definizione
dei Lep. Adesso c’è la legge di attuazione a palazzo Chigi. Si dice che entrerà
in Cdm e questo è assolutamente positivo, visto che è il percorso che deve fare
questa legge”.
Infine, Zaia pare replicare a
distanza ai timori della Ronzulli e in parte anche a quelli di Fedriga quando
dichiara che “l’Autonomia non è la secessione dei ricchi, non è una messa in
discussione internazionale, e chi lo afferma non legge le carte, non rispetta la
Costituzione, ma soprattutto si dimentica che Paesi che sono p0ercepiti come
grandi Nazioni – penso agli Stati uniti ma anche alla Germania – sono Paesi
federali”. Dunque, anche Zaia ritiene assolutamente positivo che il ddl
sull’Autonomia approdi quanto prima in Cdm. “In Veneto – è la sua chiosa – non
c’è un Comune in dissesto. In Calabria – e non me ne vogliano i calabresi – uno
ogni due. E non per colpa dell’Autonomia”.
Su fronte delle opposizioni
arriva un sì al progetto di decentramento, ma viene bocciato il come e il cosa.
“Sono assolutamente a favore del decentramento, dei poteri, delle funzioni e
delle risorse. Ma oggi – sono le parole del candidato governatore in Lombardia,
Pierfrancesco Majorino – siamo di fronte a una proposta che va in un’altra
direzione, che ripropone una dimensione burocratico-accentratrice sulle spalle
della Regione e non credo che questa sia la soluzione”. Insomma “si
all’autonomia ma non così”. Majorino e con lui anche il Pd si dice certo che la
proposta di Autonomia differenziata sarà affossata dal Governo “a causa delle
divisioni della Destra” su questo tema. E il tema soprattutto per Fratelli
d’Italia Il tema è quello di garantire che lo Stato si tenga strette alcune
competenze, mantenendone l’esclusività, come il fisco, la Difesa, il ministero
degli Esteri, la Sanità perlomeno nei livelli essenziali, l’assistenza e la
scuola. Il dibattito si preannuncia tutt’altro che facile per la maggioranza di
Governo. E non a caso su questo argomento non c’è stata ancora una presa di
posizione articolata da parte del premier Meloni.
Anche se il governatore uscente
della Lombardia, Fontana, ha ricordato che la Meloni ha più volte ribadito che
si tratta di una riforma indispensabile. Dura anche la posizione del Terzo polo:
Mara Carfagna teme infatti che la Riforma Calderoli consegni “ai nostri figli
un’Italia estremamente divisa. Un’eventualità, questa, che come Terzo polo
ostacoleremo in ogni modo
LA TRAPPOLA DELL’AUTONOMIA
PER LA MELONI. ROBERTO NAPOLETANO su Il Quotidiano del Sud il 21 Gennaio
2023
Questo progetto Calderoli è
costitutivamente divisivo. Opera contro l’interesse nazionale perché fa male al
Sud come al Nord. Siamo alla miopia della doppia velocità italiana che riproduce
i vizi della doppia velocità della vecchia Europa. Questa autonomia va contro
l’indirizzo strategico della nuova Europa che fa debito comune per risolvere il
grande irrisolto squilibrio territoriale europeo. Che è quello italiano. Ci
danno i soldi degli altri per andare nella direzione opposta. La verità è che
ballano decine di miliardi ogni anno tra cittadini del Nord e del Sud, tra aree
metropolitane e interne, come è stato certificato dalla commissione di indagine
parlamentare nata dalle nostre inchieste giornalistiche. Procedere senza sanare
in modo effettivo le distorsioni rompe la coesione sociale e fa cadere il
governo
Questo progetto Calderoli è
costitutivamente divisivo. Opera contro l’interesse nazionale perché fa male al
Sud come al Nord. Siamo alla miopia della doppia velocità italiana che riproduce
i vizi della doppia velocità della vecchia Europa. Questa autonomia va contro
l’indirizzo strategico della nuova Europa che fa debito comune per risolvere il
grande irrisolto squilibrio territoriale europeo. Che è quello italiano. Ci
danno i soldi degli altri per andare nella direzione opposta. La verità è che
ballano decine di miliardi ogni anno tra cittadini del Nord e del Sud, tra aree
metropolitane e interne, come è stato certificato dalla commissione di indagine
parlamentare nata dalle nostre inchieste giornalistiche. Procedere senza sanare
in modo effettivo le distorsioni rompe la coesione sociale e fa cadere il
governo
L’unica vera trappola politica
che può fare cadere in un burrone il governo Meloni è in casa e si chiama
autonomia differenziata. Chi ha a cuore le ragioni di stabilità dell’Italia e le
sorti del primo governo conservatore italiano con ambizioni riformiste non si
deve mai stancare di ripeterlo a Giorgia Meloni. Si possono usare le armi della
diplomazia e della tattica giocando sui vincoli istituzionali reali e gli
obblighi di passaggio in Parlamento dove si esercita la sovranità su temi
costituenti come questo. Si può essere anche più tranchant rispondendo a muso
duro se ci si accorge che il batticuore elettorale non permette di domare i
vecchi leoni leghisti nelle loro scorribande in una battaglia sbagliata nata
male e proseguita malissimo.
Quello che è assolutamente
cruciale per la sopravvivenza di questo governo e la tutela dell’interesse
generale è bloccare il cammino dell’autonomia differenziata in questa versione
della bozza Calderoli che riproduce i vizi costitutivi della legge del
federalismo fiscale del 2009 firmata dallo stesso ministro e, di fatto, porta ad
aggravare ulteriormente la diseguaglianza nei diritti di cittadinanza tra un
territorio e l’altro, tra regioni più avanzate e regioni più arretrate, tra aree
metropolitane e aree interne.
Perché non si misura
preventivamente con l’operazione verità condotta da questo giornale sulle
distorsioni inique della spesa pubblica per sanità, scuola e trasporto pubblico
locale. Si è giocato sulla spesa storica per cui il ricco è diventato sempre più
ricco e il povero sempre più povero, ma il problema si declama a parole senza
entrare nei numeri. Ballano decine di miliardi ogni anno come abbiamo denunciato
dal primo numero di uscita di questo giornale ormai più di tre anni fa e come è
stato certificato in sede di commissione di indagine parlamentare nata dalla
denuncia del Quotidiano del Sud-l’ALTRAVOCE dell’Italia dalle massime autorità
nazionali di spesa pubblica territoriale e dal ministro per gli Affari regionali
dell’epoca, Francesco Boccia.
Questo progetto Calderoli è
costitutivamente divisivo e opera congiuntamente sia contro l’interesse
nazionale perché fa male al Sud come al Nord riducendo complessivamente
competitività e capacità decisionale sia contro l’indirizzo strategico della
nuova Europa che punta alla riunificazione delle due Italie e si è decisa a fare
debito pubblico comune per risolvere il grande irrisolto squilibrio territoriale
europeo. Che è proprio quello italiano. Chiede, insomma, di andare nella
direzione opposta a quella prospettata e sicuramente la scelta dell’autonomia
differenziata si farebbe sentire con ricadute finanziarie per l’intero Paese che
non ci possiamo permettere.
Proprio per queste ragioni di
fondo oltre che per evidentissimi motivi etici dobbiamo augurarci che i tempi di
gestazione siano esattamente come devono essere di lunga durata e che vengano
fatti tutti i passaggi parlamentari che sono assolutamente sovrani. Per capire
quanto è incandescente la materia, basta leggere il rapporto shock della Corte
dei Conti sui servizi sanitari regionali 2012/2021 di cui ha dato conto ieri
dalle colonne di questo giornale da par suo Vincenzo Damiani.
In tale arco di tempo le
Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Abruzzo hanno speso per la
mobilità passiva, i cosiddetti “viaggi della speranza”, oltre 10,8 miliardi di
euro. Tutti soldi che sono finiti nelle casse del Nord, principalmente Lombardia
(6,1 miliardi) ed Emilia Romagna (3,3 miliardi), ma ci hanno guadagnato anche
Toscana (1,3 miliardi) e Veneto (1,1 miliardi).
Questo dato da brivido misura
in modo algebrico l’abisso di diseguaglianza a cui ha condotto il perverso
meccanismo del federalismo fiscale all’italiana che ha portato il sistema
sanitario a spaccarsi in due tra chi ha sempre di più e chi ha sempre di meno.
Arrivando ad allargare il solco delle disparità territoriali di anno in anno con
un 40% della popolazione italiana che non gode nei suoi luoghi di residenza e di
lavoro degli stessi livelli di prestazione dell’altro 60% generando un flusso di
risorse all’incontrario. Chi è più indietro finanzia la crescita di chi sta più
avanti andando a sostenere con i viaggi della speranza gli ospedali lombardi,
emiliani, veneti, toscani.
Questo flusso di circa 11
miliardi, sì avete capito bene, si va ad aggiungere all’iniqua distribuzione di
risorse pro capite in sede di riparto del fondo sanitario nazionale che grazie
proprio alla legge Calderoli del 2009 premia le regioni del Nord che vantano una
maggiore spesa storica. Tutto questo è possibile perché esattamente come si
propone con la bozza di oggi anche allora si disse “dobbiamo fare i livelli
essenziali di prestazione” sanando la storica diseguaglianza di base, ma nel
frattempo e, cioè, in attesa di definirli e attuarli, si volle ostinatamente
procedere al riparto secondo quello che era successo l’anno prima in un quadro
fintamente federalista che fa venire meno le compensazioni a livello nazionale.
Siamo fuori da ogni ambito costituzionale che, a nostro avviso, dovrebbe
spingere verso una centralizzazione del servizio sanitario liberandolo dalle
distorsioni finanziarie territoriali e dai vassallaggi regionali puntando
viceversa a recuperare criteri di equità e di selezione meritocratica.
Anche perché il doppio
squilibrio da decine e decine di miliardi l’anno che nessun bilancio pubblico
italiano può sanare se non si utilizza prima a questo scopo almeno una parte
rilevante delle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e di resilienza
(Pnrr) non si coniuga nemmeno più con la tiritera delle solite cattive prove
degli amministratori regionali meridionali. Che non sono ovviamente esenti da
errori e devono essere anche duramente criticati quando sbagliano, ma che sempre
secondo lo stesso rapporto shock della Corte dei Conti sono anche quelli che
negli ultimi dieci anni hanno migliorato di più i loro conti e la qualità
dell’assistenza riducendo da 2,1 a 0,7 miliardi i loro disavanzi.
Siamo davanti a un
miglioramento del 59% del disavanzo del 2020 sul 2019 delle Regioni meridionali
contro quello del 34% delle Regioni non sottoposte a piano di rientro e del 19%
delle autonomie speciali del Nord. Si è proceduto, dunque, più velocemente sulla
strada del risanamento finanziario al Sud che non al Nord. Bisogna rendersi
conto che passa anche dal fare i conti seriamente con l’operazione verità su
sanità, scuola e trasporto pubblico che abbatte le diseconomie strutturali, la
sfida strategica del Mezzogiorno d’Italia come hub energetico dell’intera Europa
e luogo privilegiato di attrazione di investimenti internazionali. Per effetto
della ri-globalizzazione derivante dalla guerra mondiale delle materie prime e
dall’accorciamento delle catene della logistica. Non si può uscire dalla miopia
della doppia velocità europea se non si esce prima dalla miopia della doppia
velocità italiana.
Altro che autonomia! La
fantasia differenziata fa vincere il Sud. Il Sud conquista il pubblico
televisivo grazie alle fiction in auge: Le indagini di Lolita Lobosco, La vita
bugiarda degli adulti e The Bad Guy. Oscar Iarussi su La Gazzetta del
Mezzogiorno il 14 Gennaio 2023
Fantasia differenziata alla
carica in quest’avvio del 2023. Mentre il Nord insegue l’autonomia cara al
ministro leghista Calderoli (e non solo a lui), il Sud conquista il pubblico
televisivo grazie alle fiction in auge: Le indagini di Lolita Lobosco, La vita
bugiarda degli adulti e The Bad Guy. È la conferma di una tendenza in atto da
tempo. Da Montalbano ai Bastardi di Pizzofalcone, da Gomorra a Imma Tataranni,
dal Commissario Ricciardi all’Amica geniale, non v’è produzione di successo che
non vibri di umori e luoghi meridionali. Il fenomeno si nutre della provenienza,
della lingua letteraria e dei temi degli autori che scalano le classifiche in
libreria, vincono i premi e spesso ispirano le fiction o i film: Camilleri,
Ferrante, De Giovanni, Genisi, Venezia, Saviano, Carofiglio, Savatteri, De
Cataldo, Carrisi, Lagioia, Auci, Desiati etc.
Insomma, lo stesso Sud
redarguito o bollato come querulo se batte cassa e reclama diritti economici e
sociali, piace a tutti quando sboccia nel recinto della fantasia: mare, sole,
intrighi, crimini e, sometimes, un accenno di riscatto. Fanno testo gli oltre
sei milioni di spettatori per l’esordio della seconda serie di Le indagini di
Lolita Lobosco, regia di Luca Miniero dalle storie di Gabriella Genisi, con
Luisa Ranieri in una Bari che più splendente non potrebbe (domani sera un nuovo
episodio su Raiuno). In testa alla classifica delle serie su Netflix c’è La vita
bugiarda degli adulti, dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, con la regia di
Edoardo De Angelis e la produzione della Fandango di Domenico Procacci. E su
Amazon Prime Video continuano a essere gettonate le prime sei puntate di The Bad
Guy, regia dei materani Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana: un’incursione
grottesca e paradossale nell’immaginario mafioso, di cui ha scritto un gran bene
Attilio Bolzoni, fra i massimi esperti delle cose di Cosa nostra.
Bari, Napoli, la Sicilia... Non
è un Sud indistinto né tutto coincide nelle capitali dell’immaginario
televisivo. Non parliamo della verosimiglianza delle location che molti
criticano sui social, dimenticando che il cinema non ha l’obbligo del realismo
toponomastico. Sugli schermi una strada può finire nella piazza di un’altra
città e il mare sorprenderti dopo un tornante della Murgia materana, come
nell’ultimo film della saga 007, No Time To Die.
È interessante, piuttosto,
buttare l’occhio alla geografia sentimentale, al paesaggio culturale e talora
antropologico, al sostrato politico delle fiction. Così, The Bad Guy appassiona
per l’estro di mescolare stili e stereotipi intorno alle vicende di un eroico
magistrato che diventa suo malgrado un «uomo d’onore» alla macchia (Luigi Lo
Cascio). La Sicilia - da Palermo al Trapanese - è «decostruita» e ricomposta in
un mosaico di colori sgargianti e situazioni talmente assurde da apparire
plausibili: il leggendario ponte sullo Stretto di Messina esiste, ma crolla!
Invece la Bari vecchia di
Lolita è manierata e amabile come un rosè (il vero colore della serie, non
giallo né tanto meno noir). Il racconto edulcora le contraddizioni nel folklore
pugliese, ma non sfugge ai temi sociali sullo sfondo degli episodi delittuosi, a
cominciare dall’ecologia. Luisa Ranieri è una vestale mediterranea formato
famiglia: la sua ostinazione a rimanere single, solo da poco vinta, è una specie
di fedeltà edipica al padre scomparso, in un contesto peraltro tutto
matriarcale. Di scena c’è il genius loci della baresità sempre controversa,
levantina e accogliente, pragmatica fino all’eccesso. Un’identità oggi incerta
fra tradizione e visione, sottesa al rischio di restare ostaggio del perenne
elogio delle orecchiette, con fattura o senza: un problema del capoluogo, che
sarebbe ingiusto addossare al vicequestore Lobosco (non la fattura, no, diciamo
l’ipoteca dell’orecchietta sul futuro).
Napoli, infine. La vita
bugiarda degli adulti le restituisce una centralità nell’immaginario che,
nonostante i film di Sorrentino e Martone, un po’ s’era persa dopo i fasti
vesuviani anni Settanta-Novanta fra arte, letteratura e cinema. La Partenope
della Ferrante - anche sceneggiatrice con De Angelis, Laura Paolucci e Francesco
Piccolo - è doppia per definizione: quartieri alti e bassi, mito e storia, feste
dell’Unità e suggestioni felliniane. Il canto della sirena accompagna il viaggio
iniziatico verso l’età adulta della giovane protagonista Giovanna (Giordana
Marengo), che coincide con la «discesa agli inferi» dal Vomero al degrado del
Pianto, cioè di Poggioreale, dove vive la reietta zia Vittoria (Valeria Golino).
Il precoce mal di vivere della
ragazza si esplica in uno scenario che non è più il «Mezzogiorno di fuoco» di
tanti luoghi comuni, bensì un terreno accidentato e affascinante di frontiere
dietro l’angolo, di scelte tanto cruciali quanto occasionali scandite dalla
musica del caos orchestrata da Enzo Avitabile, con brani di Almamegretta,
Peppino di Capri, 99 Posse, Rosa Balistreri, Edoardo Bennato, Raiz... La vita
bugiarda degli adulti dà corpo alla post-modernità inquieta e cosmopolita del
Sud, risalente ormai alla fine del ‘900, altro che l’arcaismo cui noi stessi a
volte ci condanniamo. La finzione certe volte è un esercizio di realtà.
«L’Autonomia? Vogliono
puntare tutto sul Nord». Il giurista Villone: è un investimento sulle
disuguaglianze. Leonardo Petrocelli su La Gazzetta del Mezzogiorno il 02
Febbraio 2023
«Balcanizzazione dell’Italia,
smantellamento dello Stato centrale, destrutturazione del Paese». Non usa mezze
parole Massimo Villone - napoletano classe 1944, costituzionalista e già
presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato al tempo
dell’Ulivo di Romano Prodi - nel bocciare il disegno di legge Calderoli
sull’autonomia differenziata. Una scomunica netta che si accompagna a una
proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, di cui Villone è il
principale animatore, per rivedere il riparto delle competenze Stato-regioni e
ribadire la centralità dell’«interesse nazionale».
Professor Villone oggi il ddl
Calderoli approda in Consiglio dei ministri: che tipo di giornata sarà per il
Sud e il Paese?
«Una giornata non priva di
rischi perché non è chiaro quale sarà il dopo. Ma resta un fatto».
Quale?
«Il ddl Calderoli è una scatola
vuota. Non c’è nessuna indicazione: che tipo di autonomia, per quali regioni,
con quali limiti. Nulla. Sappiamo che non è previsto finanziamento per i Livelli
essenziali delle prestazioni (Lep) e che il Parlamento è marginalizzato. Anzi,
chiuso in uno scantinato. Per il resto, è un procedimento a valle del quale non
si sa cosa verrà fuori».
E allora cosa dobbiamo
aspettarci?
«Partiamo da ciò che abbiamo
ascoltato finora. Giorgia Meloni è stata molto cauta e, anzi, ha mandato un
messaggio chiarissimo sull’eguaglianza dei diritti nel Paese. Anche la
Confindustria ha espresso la propria contrarietà rilevando come ci siano
materie, infrastrutture in testa, su cui non si può prescindere dal ruolo
cardine dello Stato. Mi sembrano prese di posizione di un certo interesse».
La presidenza del Consiglio è
cauta, Confindustria nutre dubbi, i sindacati non ne parliamo. Ma allora chi
vuole l’autonomia? Davvero l’Italia è ostaggio di un partito, la Lega, all’8%?
«L’autonomia non dipende
certamente da qualche leghista di passaggio. È chiaro che a muovere i fili è una
visione precisa che cammina sulle gambe di molti e già da tempo».
E cioè?
«Il Paese deve accelerare per
essere competitivo in Europa e nel mondo. Ma non è possibile che l’Italia intera
acceleri quindi conviene concentrare le risorse nell’unica parte che, credono
loro, può accelerare davvero: il Nord. È un pensiero espresso da autorevoli
economisti ed è politicamente trasversale. Magari in tanti lo reputano perfino
sgradevole, una sorta di male necessario. Ma per trent’anni si è fatto così:
andare avanti investendo sulle disuguaglianze».
Questo spiega il posizionamento
favorevole di alcuni pezzi del Pd?
«Questo spiega perché nei
pre-accordi del 2018 due regioni leghiste, Veneto e Lombardia, e una roccaforte
della sinistra, l’Emilia Romagna, si trovarono sullo stesso fronte. L’Emilia, ad
esempio, è legata a doppio filo all’industria automobilista tedesca. Guarda
all’Europa, appunto».
Ma è un progetto che ha un
qualche senso?
«È una tesi sbagliata,
totalmente. Le nostre presunte eccellenze, dalla Lombardia al Veneto alla
Liguria, perdono regolarmente decine di posizioni nelle classifiche europee. La
locomotiva non tiene il passo continentale».
Dunque?
«Dunque alla tesi della
locomotiva andrebbe opposta quella delle due locomotive: bisogna far ripartire
il sistema produttivo meridionale. L’Italia si salva usando due motori, non uno
solo e pure malmesso».
Replica alla Luca Zaia: anche
il Sud potrebbe ottenere grandi vantaggi dall’autonomia se solo giocasse bene la
sua partita.
«Sarebbe un’idea condivisibile
se solo ci fossero condizioni eguali di partenza. E invece questo Paese è già
tremendamente diviso: Nord e Sud, aree metropolitane e aree interne. Ci sono
divari ovunque. Come fa il Mezzogiorno a sfruttare l’occasione con un Pil che è
la metà di quello del Nord? La posizione di Zaia è un imbroglio, un pacco».
E tuttavia, se passiamo alla
sfera delle competenze infrastrutturali, a tanti governatori del Sud potrebbe
far gola mettere le mani su porti, ferrovie, autostrade. Si rischia un
«collaborazionismo» per gola?
«Il pericolo c’è. Dalla
balcanizzazione del Paese, dalla sua destrutturazione, il ceto politico
regionale, a ogni latitudine, qualcosa comunque guadagnerebbe. Un vantaggio solo
illusorio al prezzo dello smantellamento dello Stato».
Ma tutto questo non tradisce lo
spirito del Pnrr?
«Non c’è dubbio. L’Italia ha
avuto molte risorse proprio per riequilibrare il divario territoriale e far
crescere il sistema Paese partendo dalle sue aree più svantaggiate. Qui si va
nella direzione opposta».
Esempio concreto: un territorio
contrario, disponendo di nuove e specifiche competenze, potrebbe bloccare un
progetto del Pnrr?
«Un’opera di interesse
nazionale stoppata dalla frammentazione delle competenze? Possibilissimo. Una
sciagura non impossibile».
Ma tutto questo non è
anticostituzionale?
«Vede, l’Italia è una e
indivisibile. D’accordo. Ma c’è il problema delle competenze così come
immaginate dalla riforma del Titolo V del 2001. Molte di esse sono già in regime
di concorrenza fra Stato e regioni. Il punto è quello. Si parte già da una certa
base».
Fu un errore quella riforma?
«Fu una pessima riforma. Come
si disse all’epoca, un modo per fare shopping nel mercato delle competenze. Un
puro elenco di desiderata. Purtroppo a farla fu il centrosinistra. Ma il clima
era quello degli anni Novanta nei quali la spinta secessionista della Lega aveva
spostato l’asse della politica italiana. Prova ne sia che la riforma cancellò il
riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno e delle Isole, presente nel testo del
1948. Di certo non un dettaglio».
Autonomia differenziata,
Emiliano: «Indigna questa accelerazione per favorire la Lega». «Temo che la
fretta sia dettata dalla volontà di non far fare brutta figura alla Lega nelle
elezioni in Lombardia e questo è vergognoso, ci indigna profondamente».
Redazione online su La Gazzetta del Mezzogiorno il 02 Febbraio 2023
«L'autonomia differenziata del
ministro Calderoli? È come se avessimo un equipaggio con 20 vogatori e, per far
migliorare quelli meno efficienti, dessimo i remi più lunghi e potenti a quelli
più forti. La teoria non sta insieme: noi avevamo chiesto di dare a tutti dei
remi più lunghi, facendo però allenare ogni vogatore per arrivare ai livelli
migliori. Questi sono i Lep, i livelli essenziali nelle prestazioni, non basta
scriverli. Bisogna investire 60/70 miliardi in personale e infrastrutture, per
consentire al sud di arrivare ai livelli del nord. È un processo lungo, a cui
non siamo contrari, abbiamo accettato di discuterne. Siamo invece contrari
all’idea di fare questa riforma rapidamente. In questo senso, temo che la fretta
sia dettata dalla volontà di non far fare brutta figura alla Lega nelle elezioni
in Lombardia e questo è vergognoso, ci indigna profondamente». Lo ha affermato
il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ospite della trasmissione
"Timeline" su Sky Tg24.
"Noi potremo accettare che ci
sia una superdotazione di alcune regioni che lo chiedono e di altre che non lo
chiedono solo quando le regioni saranno messe tutte sullo stesso livello di
partenza, con un riequilibrio preliminare che, nella migliore delle ipotesi,
costerebbe tra i 50 e i 60 miliardi. Se il Governo dice che non c'è una lira,
non si può parlare di autonomia. Noi saremmo d’accordo con lo Stato se
prevedesse un progetto decennale volto a riequilibrare nord e sud, con diritti
uguali per tutti. Una volta equiparate, nulla vieterà di dare più potere alle
regioni che lo richiederanno. Oggi però parliamo di intese uniche tra regioni e
governo per dare solo ad alcune di esse più poteri. Un’impresa con più sedi,
avrebbe in alcune regioni come interlocutore la Regione, in altri lo Stato:
sarebbe una follia"
Il ddl spacca la politica.
Autonomia differenziata, sì in Cdm alla riforma-bandiera della Lega: Meloni cede
all’alleato, rivolta dei governatori del Sud. Redazione su Il Riformista il
2 Febbraio 2023.
Un voto unanime seguito da un
applauso. Così il Consiglio dei ministri tenuto questa sera ha approvato il ddl
sull’Autonomia differenziata, provvedimento bandiera della Lega messo a punto
dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.
Calderoli che trionfante si è
presentato nella conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando che con la
riforma si avrà “un’Italia ad alta velocità” mentre il centralismo, fino ad
oggi, ha creato solo sperequazioni: “L’esistenza di cittadini di Serie A e B è
una realtà, in cui la sperequazione non riguarda solo le differenze tra Nord e
Sud, ma anche tra diversi territori: un problema che va risolto e che non può
essere attribuito all’ Autonomia differenziata, ma è frutto di una gestione
centralista”.
Parole che con forte difficoltà
la premier Meloni avrà dovuto digerire, visto che all’autonomismo regionale la
destra sociale ex missina ha sempre contrapposto il centralismo ‘sovranista’.
Il testo approvato in CdM
prevede che su molte materie, alcune a dir poco delicate, la Regioni possano
chiedere l’autonomia: si va dall’istruzione alla sanità, dall’ambiente
all’energia. Testo votato all’unanimità che però non risolve una criticità,
ovvero i livelli essenziali di prestazione che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale, i Lep. Livelli che andrebbero stabiliti prima delle
richieste di autonomia differenziata delle Regioni, ma il ddl Calderoli prevede
che entro un anno dall’entrata in vigore della legge sull’Autonomia
saranno stabiliti con un Decreto del presidente del Consiglio, i Dpcm diventati
‘pratica comune’ durante la pandemia Covid per il governo Conte.
Disegno di legge votato in
Consiglio dei ministri che verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata
Stato-Regioni-Città entro un mese per poi passare nelle Commissioni di Camera e
Senato e quindi ritornare a Palazzo Chigi. Tempi lunghi insomma, come
sottolineato su Twitter dal leader di Azione Carlo Calenda: “L’approvazione del
ddl Autonomia in Cdm è l’ennesima presa in giro elettorale di una politica che
fa propaganda sull’assetto istituzionale dello Stato. Questa roba arriva in
Parlamento fra 6 mesi. Ma lo approvano di corsa e male la settimana prima delle
elezioni regionali“.
Ma proprio dagli enti locali
arrivano le critiche più feroci, in particolare dagli amministratori del
Mezzogiorno di stampo Pd. Per Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna
e candidato alla segreteria Dem, “la bozza Calderoli sull’autonomia
differenziata approvata in Consiglio dei ministri è irricevibile e noi
siamo pronti alla mobilitazione perché non è stata condivisa con la Conferenza
delle Regioni, cosa clamorosa e incredibile, e perché è un’autonomia
differenziata che non tiene conto delle nostre proposte e va nella direzione di
spaccare il Paese’’.
“L’ ipotesi di autonomia
proposta è inaccettabile, è una proposta propagandistica che spacca l’Italia”, è
il commento invece del presidente della Campania Vincenzo De Luca, mentre per il
collega della Puglia Michele Emiliano il governo starebbe accelerando
sull’attuazione dell’autonomia “solo per non far fare brutta figura alla Lega”
alle prossime elezioni regionali in Lombardia.
Critiche arrivano anche dai 5
Stelle. Per Giuseppe Conte “la patriota Meloni paga a Salvini la tassa per
tenerlo in maggioranza, svende l’unità d’Italia per qualche punto percentuale in
più alle regionali. Dobbiamo contrastare questo progetto di autonomia
soprattutto sulla scuola e sulla sanità”.
Attenzione ai passi da fare:
oggi lo Stato può decidere la condanna a morte del Sud. Tre regioni del
Centro Nord stanno facendo di tutto per uscire dall’Italia restandoci. Con una
autonomia tanto spinta non solo da equivalere a una secessione. Lino Patruno su
La Gazzetta del Mezzogiorno il 02 Febbraio 2023
Nel poker si chiama rilancio.
Scusate, ma se fosse il Sud a rilanciare? Tre regioni del Centro Nord stanno
facendo di tutto per uscire dall’Italia restandoci. Con una autonomia tanto
spinta non solo da equivalere a una secessione. Ma da arricchirsi tanto da
impoverire il resto del Paese. Allora il Sud potrebbe dire: arrivederci e
grazie, siamo noi ad andarcene. Separiamoci visto che volete farlo voi.
Ma almeno noi conserviamo ciò
che volete toglierci prima che ce lo togliate. Così, 162 anni dopo una unità a
vantaggio degli uni e a danno degli altri, finirebbe la finzione di un Paese in
cui alcuni sono trattati da italiani e altri da diversamente italiani. E in cui
si vuole farlo addirittura per legge. Un nuovo Risorgimento a condizioni ancora
peggiori di quello già discutibile del 1861.
Dice la presidente Meloni: «Qui
o si fa l’Italia o si muore». Roba già ascoltata. Ma quale Italia, presidente? E
chi sarebbe a morire? Con la nuova Italia che il governo ha avviato non solo non
si eliminerebbe il divario che avvilisce il Sud, già il più ampio e duraturo
d’Europa. Ma questo divario sarebbe cristallizzato per sempre, così è e così
sarà, anzi peggio. E non in nome del popolo italiano. Ma in nome del popolo di
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna che già stanno meglio degli altri grazie a una
spesa pubblica dello Stato che le ha sempre favorite e continua a favorirle.
E dopo starebbero ancora
meglio, visto che la squilibrata spesa storica a loro favore non si toccherà,
anzi. Mentre qualsiasi miglioramento per il Sud dovrà avvenire senza aggravio di
spesa. Per opera dello spirito santo.
Un Sud che fosse costretto ad
andarsene per proprio conto sarebbe la settima potenza manifatturiera d’Europa,
prima di Paesi come Olanda, Portogallo, Slovacchia. E la prima potenza
agroalimentare. Sarebbe tutt’altro che un deserto industriale, anzi sarebbe un
Sud che produce e innova.
Potrebbe non continuare ad
arricchire gli altri con ogni studente o ogni malato che emigra. Potrebbe uscire
da una trappola del ritardato sviluppo per cui chi fugge dal divario è il primo
ad ampliarlo. Potrebbe beneficiare di un Recovery Fund concesso soprattutto a
suo favore e ora distribuito invece a suo sfavore. Potrebbe destinare a sé una
tassazione che ora, per dirne solo una, finanzia l’alta velocità ferroviaria
solo al Nord escludendolo.
È tutta una provocazione,
ovvio. Ma quale provocazione di fronte a quella di chi vuole arrogarsi tutte le
funzioni attualmente dello Stato senza un euro in meno? Anzi possibilmente
trattenendo le proprie tasse, quindi avendo servizi ancora migliori con annessa
bella qualità della vita. Mentre per il Sud, che già ha servizi peggiori per
grazia della sperequazione dello Stato, e annessa peggiore qualità della vita,
ogni possibile miglioramento dovrebbe avvenire a costo zero. Roba da scherzi a
parte.
Fine della metafora. I mai
calcolati bisogni essenziali del Sud, i famosi Lep, Livelli essenziali di
prestazione (ma in effetti Lup, Livelli uniformi di prestazione) con
l’ineffabile disegno di legge Calderoli si dovrebbero calcolare in un anno non
essendo stati calcolati in ventidue. E invece andrebbe avanti come fatto
compiuto la sopradetta spesa storica per Lombardia, Veneto, Emilia Romagna.
Risultato: i più ricchi lo resterebbero per grazia della legge, i meno ricchi lo
resterebbero per disgrazia della legge. Nonostante ritocchi contrabbandati per
chissà quali miglioramenti, l’autonomia differenziata verrebbe concessa con
accordi privati fra le Regioni interessate e lo Stato rappresentato da chi? Dal
medesimo Calderoli, la cui imparzialità sarebbe più sicura delle attuali difese
di Milan e Juventus. Parlamento esautorato, al massimo parere consultivo e
approvazione a scatola chiusa. Non possibile un referendum per rimediare al
malfatto. E Stato (alias Calderoli) che non potrebbe intervenire se una delle
regioni interessate facesse tanti sfracelli da gridare vendetta al cielo.
Così oggi in consiglio dei
ministri potrebbe passare non un progetto di miglioramento dell’Italia. Ma la
trasformazione dell’Italia in un’altra cosa. Un altro Paese ancora più diviso
con frontiere fra i suoi territori. Ancora più ingiusto. Ancora più
ingovernabile. In cui figli e figliastri lo sarebbero per sempre. E in cui il
Sud sarebbe condannato alla morte lenta mentre la presidente assicura che tutti
saranno trattati allo stesso modo. Oggi può essere l’inizio della fine. Allora,
chi sarebbe il separatista?
AUTONOMIA, DISSENSI ANCHE
DAL NORD: «È INGIUSTA E NON CONVIENE A NESSUNO». La voce di Innocenzo
Cipolletta si aggiunge a quella di tanti sindaci, governatori,
costituzionalisti, giornalisti che chiedono al capo dello Stato di intervenire
contro quella che reputano una “secessione nascosta”. PIETRO MASSIMO BUSETTA su
Il Quotidiano del Sud il 02 Febbraio 2023
Sempre più voci si alzano
contro l’ipotesi di autonomia differenziata che il “bulldog” Roberto Calderoli
sta portando avanti, malgrado i tanti segnali di dissenso che arrivano anche
dalla sua maggioranza e da un Paese che dà più parti ritiene un errore storico
quello che vorrebbe attuare.
E una nuova voce si è aggiunta
alle tante già levatesi negli ultimi mesi, che vanno da illustri
costituzionalisti, giornalisti attenti alle problematiche del Sud, sindaci che
si riuniscono in associazioni e che chiedono l’incontro al capo dello Stato
perché intervenga contro un’ipotesi che ritengono essere una secessione
nascosta, presidenti di Regioni di destra e di sinistra, organizzazioni
datoriali e sindacali. La voce che si è aggiunta è quella di Innocenzo
Cipolletta, ex direttore del Centro studi di Confindustria e membro dei cda di
tante società, oltreché opinionista molto ascoltato.
L’ERRORE ALL’ORIGINE
Bene, anche Cipolletta, in
un’intervista di ieri, oltre che in un fondo di un quotidiano nazionale, si
pronuncia pesantemente contro, affermando che il progetto è sbagliato e che non
conviene nemmeno alle regioni settentrionali perché è un errore, oltreché
anticostituzionale aggiungerei io, l’idea di lasciare le entrate fiscali nei
territori «perché non è corretto attribuire alle Regioni le tasse di cittadini e
imprese residenti in una Regione, che hanno maturato il reddito anche in altre
Regioni».
L’affermazione più pesante è
però la risposta che dà al giornalista che chiede se il testo sia da migliorare,
se sia scritto male oppure se sia proprio sbagliata l’idea di fondo. La risposta
di Cipolletta è che l’idea è sbagliata, poiché le Regioni che si sentono ricche
e che vogliono trattenere i tributi riferibili ai propri residenti non hanno
chiaro che un’azienda che ha sede in Lombardia ma è attiva in tutto il Paese,
non può e non deve lasciare le tasse nel proprio territorio, visto che lo
produce in un’area più ampia. E lo stesso principio vale per un avvocato che ha
cause in tutto il Paese, per cui l’idea è che il meccanismo è errato
concettualmente.
Sono parole che pesano
tantissimo e che si aggiungono a quelle di coloro che affermano che in realtà
pensare che via sia un residuo fiscale – perché questo è il vero motivo della
secessione dei ricchi, quello di trattenere le risorse provenienti dalla propria
tassazione nel territorio – è sbagliato perché in Costituzione si fa
riferimento non alle Regioni, ma agli individui, i quali hanno uguali diritti in
qualunque parte del Paese essi nascano.
Ma dimostra che è anche
economicamente sbagliata, perché in realtà moltissime aziende che pagano le
tasse in una parte del Paese fanno affari anche in altre parti, per cui il
contributo al loro reddito, e quindi alle imposte che pagano, è distribuito in
tutto il Paese.
SPESA STORICA TORNA L’INCUBO
Il tema è quello del
contribuente percosso. Infatti i soggetti passivi del tributo vengono definiti
anche“ ”contribuenti di diritto”, per distinguerli dai cosiddetti “contribuenti
di fatto” o incisi. Vale a dire da coloro sui quali l’onere finanziario, in cui
si traduce la prestazione impositiva, viene ad essere riversato dal soggetto
tenuto per legge a effettuarla e che quindi sono gravati in via definitiva da
detto onere.
Spesso, infatti, non esiste
coincidenza tra il soggetto chiamato dalla legge a pagare il tributo (soggetto
percosso) e colui che ne subisce effettivamente l’onere (soggetto inciso, o
contribuente di fatto).
Ritornando alla normativa,
qualcuno sostiene che in realtà non bisogna aver paura della sua approvazione
perché, essendo essa palesemente incostituzionale, vi sarà sempre la possibilità
che il Parlamento la blocchi o che un referendum successivo la abroghi.
Senza voler entrare troppo nel
merito di questioni giuridiche, non si può non sottolineare come in realtà il
Parlamento sia totalmente escluso dal progetto e possa soltanto, a conclusione
degli accordi, votare sì o no. Senza poter apportare modifiche: il che rende
particolarmente pericoloso il percorso che si sta avviando.
Quindi non sottovaluterei il
passo in avanti che anche una promozione generica del progetto di Calderoli
possa rappresentare.
Fa parte della strategia tipica
del personaggio che con determinazione, utile se ci fosse come obiettivo il bene
del Paese, sta portando avanti con una forza e una cocciutaggine necessaria e
opportuna per obiettivi più saggi.
Purtroppo credo che la stessa
presidente del Consiglio abbia ben poco da fare rispetto a una slavina che si è
messa in moto e che rischia di diventare una valanga distruttiva per
l’ordinamento del nostro Paese, come affermano ormai giuristi ed economisti, di
provenienza le più diverse.
L’aspetto riguardante alcune
parti della Costituzione che verrebbero non più attuate, come per esempio i
diversi diritti di cittadinanza che conseguirebbero all’attuazione del progetto
voluto dalla Lega, potrebbero essere sollevate, anche se la moral suasion che il
capo dello Stato ha cercato di proporre non pare finora aver sortito alcun
effetto.
E la stessa dichiarazione di
principio della presidente Meloni viene contraddetta da un progetto che in
realtà ha come obiettivo quello di statuire e regolarizzare la spesa storica
come corretta.
DANNI IRREVERSIBILI
Si è ormai in un cul-de-sac che
non pare abbia vie di fuga, e anche se l’unica forza a volere tale normativa,
nemmeno unanimemente considerato che forse lo stesso Salvini ha una visione più
nazionale del proprio partito, finirà con il contribuire a un ulteriore passo
verso lo spezzettamento del Paese in tanti piccoli staterelli.
Il danno potrebbe essere
irreversibile, così come lo è stato quello della modifica del titolo quinto che
stiamo pagando pesantemente.
La stessa proposta di Massimo
Villone, che mira ad arginare i disegni di autonomia differenziata attraverso
una modifica costituzionale, diventerebbe più complicata. Il Coordinamento per
la Democrazia costituzionale, presieduto da Massimo Villone, di concerto con le
organizzazione sindacali della scuola (Flc-Cgil, Cisl e Uil Scuola, Snals
Confsal e Gilda) ha infatti avviato una raccolta firme per la proposta di legge
costituzionale di iniziativa popolare che modificherebbe direttamente il terzo
comma degli articoli 116 e 117 della Carta.
La proposta esclude la
possibilità che una legge quadro generica nasconda intese tra Stato e singole
Regioni e introduca una clausola di supremazia della legge statale, scremando di
molto le materie concorrenti. Ma cosa accadrebbe se già venisse approvato “la
norma Calderoli spaccaitalia”?
Autonomia differenziata in
Cdm, uno scalpo dato alla Lega. GIUSEPPE ALBERTO FALCI su Il Quotidiano del
Sud l’1 Febbraio 2023
GIOVEDI sarà il giorno del
disegno di legge sull’autonomia differenziata. Il testo approderà in consiglio
dei ministri, come richiesto dalla Lega, prima delle regionali in Lombardia. E
così, esulta Luca Zaia, «si tratterà di una giornata storica». Il pre-consiglio
dei ministri ha dato il via libera a un testo che nelle prossime 24 ore dovrà
essere esaminato dai tecnici di palazzo Chigi e di altri ministeri. «È stato
apportato qualche ritocco, non sostanziale», filtra da Palazzo Chigi. Restano
ancora aperti due nodi: i Livelli essenziali delle prestazioni e il fondo di
perequazione. «Non avete detto nulla», scherzano in Transatlantico deputati di
maggioranza e di opposizione.
Quanto ai Lep, nel testo si
legge, «sono determinati con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei
ministri». Cui segue: «Il presidente del Consiglio dei ministri, valutato il
contenuto dell’intesa della Conferenza unificata e del parere delle Camere o,
comunque, una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per
l’espressione del parere di queste ultime, adotta il decreto, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri».
In sostanza, i Lep non saranno
definiti in questa fase ma successivamente con i Dpcm. Ed è qui che nascono le
tensioni dentro e fuori la maggioranza. Il testo non scioglie il nodo della
definizione e del finanziamento su tutto il territorio nazionale. E oltretutto
non coinvolge il Parlamento, come avrebbe voluto un pezzo di maggioranza e
l’opposizione. Tutto questo fa bofonchiare i governatori del sud in quota Forza
Italia che per tutto il giorno restano in silenzio. Anche se a sera Roberto
Occhiuto, presidente della Calabria, utilizza toni distensivi e parla «di
positivo passo in avanti». E ancora, sempre Occhiuto: «Molto bene che dal
provvedimento siano stati cancellati i riferimenti all’ingiusto criterio della
spesa storica. Come ho affermato in più occasioni, nessun pregiudizio
sull’autonomia differenziata, che è una possibilità offerta dalla Costituzione
alle Regioni. Ma si garantiscano prima gli obblighi che la nostra Carta
fondamentale pone in capo allo Stato in ordine alla definizione dei fabbisogni
standard, ai diritti sociali e civili garantiti con uniformità su tutto il tutto
il territorio nazionale, e alla perequazione».
Qualche ora prima la linea di
Forza Italia era stata dettata dal leader Silvio Berlusconi: «Le Regioni avranno
più risorse e più poteri con l’autonomia, per gestire i servizi essenziali per i
cittadini, a partire naturalmente dalla sanità». L’impressione è che il
Cavaliere voglia spegnere il fuoco amico dei parlamentari e dei governatori del
Sud più critici, in vista dell’appuntamento elettorale in Lombardia. «Non
possiamo dare l’impressione di essere una coalizione divisa e soprattutto di non
rispondere alle richieste del Nord» sussurra un deputato azzurro eletto proprio
in Lombardia.
Eppure più di un rumore di
fondo arriva dalla galassia berlusconiana. Mario Occhiuto, senatore azzurro e
fratello del presidente della Regione Calabria, usa questi toni con l’Adnkronos:
«La bozza lascia irrisolte questioni essenziali demandandole a momenti
successivi alla concreta applicazione. Quindi sembra più un programma di intenti
che rischia di dividere l’Italia se tutte le regioni non partiranno dallo stesso
livello». Sempre dalle parti di Forza Italia, interviene la deputata napoletana
Annarita Patriarca: «Rimandare a un secondo momento la risoluzione di questioni
strategiche, solo accennate nel Ddl approdato oggi in pre-Cdm, come l’analisi
dei Lep, non è certamente una decisione che può rendere più facile il percorso
dell’Autonomia. È inutile forzare i tempi e accelerare. Meglio studiare e
risolvere i problemi prima».
Tutto risolto? Non si direbbe.
Anche perché fonti di governo depotenziano il passaggio in pre-consiglio: «È
solo uno scalpo dato alla Lega per le regionali ma non se ne farà nulla». Anche
perché il ddl dovrà passare in Parlamento, e in quel consesso Fi e FdI
proveranno ridimensionare i desiderata leghista. D’altro canto, restano scolpite
le parole di 24 ore prima di Giorgia Meloni all’evento organizzato da Poste:
«Noi vogliamo unire l’Italia e non ci rassegniamo all’idea che ci siano
territori e servizi di serie A e B».
Ragionamento che non a caso
viene ripetuto dalla deputata e sottosegretaria azzurra Matilde Siracusano:
«L’obiettivo è quello espresso dal Governo di non creare cittadini di serie A e
serie B e trovare un equilibrio per non innescare discriminazioni verso il
Mezzogiorno. Ritengo che si troveranno le condizioni per raggiungere questi
traguardi, come indicato dal presidente del Consiglio Meloni». Ecco perché la
strada dell’autonomia a firma Calderoli è ancora in salita…
L'OPERAZIONE VERITÀ CHE
SERVE ALL'ITALIA. L'AUTONOMIA CHE NON ROMPE IL PAESE DEVE VINCOLARE MAGGIORANZA
E OPPOSIZIONE A DARE AL SUD L'80% DI TUTTE LE RISORSE EUROPEE DISPONIBILI
L'editoriale di Roberto
Napoletano, autonomia differenziata su Il Quotidiano del Sud il 02 Febbraio 2023
Sul piano istituzionale si
vedono i segni del lavoro prezioso di Mattarella e della azione riequilibratice
di Giorgia Meloni. La coerenza di Calderoli sarà misurata dalla attuazione del
modello Fitto. Che significa: 1) via le marchette di Regioni del Sud e del Nord,
lo scandalo dei progetti sponda dei fondi di coesione e sviluppo, e concentriamo
tutto nella ricostruzione dei diritti di cittadinanza violati a partire da
scuola, ospedali e trasporti; 2) utilizziamo le risorse di Pnrr e Repower Eu per
fare mega piano di rinnovabili e infrastrutture energetiche, ferroviarie,
digitali nel nostro Sud attraverso una struttura tecnica tipo Cassa di Pescatore
capace di spendere e una rimodulazione degli interventi che ponga al centro
dell’agenda mediterranea e europea il Sud. Che deve accettare di essere sotto
esame per l’efficacia della sua azione.
Nessuno si permetta nemmeno
lontanamente di pensare di potere fare una qualsivoglia riforma di autonomia
differenziata senza un voto a maggioranza qualificata del Parlamento. Perché
quando si incide sulla sostanza dei principi costituzionali non basta ribadire
quelli di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia, aprendo a un
processo di semplificazione e sburocratizzazione del decentramento
amministrativo.
Non basta per la semplice
ragione che siamo dal 2009, altra legge Calderoli, dentro un meccanismo perverso
di federalismo fiscale all’italiana che di anno in anno acuisce i divari tra un
territorio e l’altro negando i diritti di cittadinanza di almeno venti milioni
di persone rispetto agli altri quaranta su temi vitali come la sanità, la scuola
e i trasporti. Non basta neppure mettere nero su bianco all’articolo 1 di un
disegno di legge che speriamo sia solo la cornice di un quadro che non verrà mai
dipinto se non si vincolerà ogni nuovo meccanismo di autonomia alla
determinazione dei livelli essenziali di prestazione che riguardano i diritti
civili e sociali di tutti i cittadini italiani e che proprio per questa ragione
devono essere garantiti ovunque dalle Alpi a Pantelleria.
Bisogna prima fare i conti con
l’operazione verità su uno Stato che fa figli e figliastri e si nasconde dietro
il grimaldello di un pasticcio di ventidue anni fa della Sinistra e di un
federalismo fiscale della Destra del 2009 che hanno consentito negli ultimi
dieci anni di fare finanziare le Regioni più ricche da quelle più povere per 14
miliardi attraverso i viaggi della speranza della sanità dopo avere deciso in
modo strutturale che le Regioni più ricche dovessero ricevere per ogni loro
cittadino molto di più di quello che ricevono le Regioni più povere avendo
adottato come criterio unico di erogazione dei trasferimenti pubblici quello
della spesa storica.
Uno scandalo che rappresenta la
peggiore delle vergogne italiane perché addirittura sugli ospedali e le cure
mediche come sull’istruzione e sui trasporti si decide a tavolino che se nasco a
Reggio Calabria sono un cittadino di serie C e se nasco a Reggio Emilia sono un
cittadino di serie A. Siamo oltre ogni decenza e pensare di legittimare in modo
strutturale con qualche nuovo marchingegno la miope perversità di questo
meccanismo è semplicemente aberrante. Per questo il testo è stato più volte
corretto e riscritto e ora possiamo dire che si sente il peso della posizione
fermissima più volte ribadita dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.
Questo giornale pubblica ogni
giorno in prima pagina le sue parole pronunciate a Bergamo nel novembre del
2022: punti fermi sono la garanzia dei diritti dei cittadini, che al Nord come
nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree
interne, devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali.
Siamo altrettanto consapevoli
che la stessa premier, Giorgia Meloni, ha fatto sentire con forza la sua voce
dicendo chiaro e tondo che non possono esistere cittadini di serie A e cittadini
di serie B. D’altro canto la storia politica interna e di conservatorismo
europeo della nuova Destra italiana di cui la prima presidente del Consiglio
donna della Repubblica è espressione parla questo linguaggio, non quello della
frammentazione.
Così come è evidente che solo
questo bagaglio di idee e di valori può avere costretto il ministro Calderoli a
mettere per iscritto all’articolo 1 del suo schema di disegno di legge che “tali
livelli (quelli essenziali di prestazioni detti Lep ndr) indicano la soglia
costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere
effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura
fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti
finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un’equa ed
efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari
territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e
sociali”.
Il punto dirimente, però, è un
altro. Questa solenne affermazione di principi nella situazione data può essere
utile perché si faccia finalmente l’operazione verità sulle diseguaglianze
territoriali frutto di un federalismo malato che ha minato per oltre dieci anni
la competitività e le ragioni di sviluppo solidale dell’Italia e che affonda
addirittura in una sperequazione che finanzia i ricchi con i soldi dei poveri.
Non può consentire, però, di fabbricare le decine di miliardi che servono per
sanare in modo effettivo queste diseguaglianze come auspica la legge.
Il rischio atomico è che si
riproduca il modello del 2009 per cui si comincia a delegare e distribuire
ulteriormente a favore dei più ricchi in attesa di trovare le risorse pubbliche
introvabili a favore dei più poveri per sanare le miopi disparità di partenza
con il loro carico odioso di inciviltà. Siamo certi che Mattarella, Meloni e
Fitto sapranno fare muro, le parole in conferenza stampa di Calderoli e
Casellati sono state inequivoche, ma il Parlamento dovrà dire la sua con il peso
della sua sovranità e i tempi di gestazione di un eventuale riassetto delle
funzioni dello Stato così rilevanti sono obbligatoriamente quelli di una
legislatura.
Bisogna utilizzare i fondi
europei per ridurre le distanze di partenza facendo spesa effettiva e attuando
trasferimenti certi con criteri differenti. Bisogna chiarire in modo assoluto
che su scuola e sanità non sono ammissibili corsie differenziate. Bisogna avere
contezza che sui temi strategici dell’energia e delle grandi reti la
frammentazione dei poteri coincide con la frammentazione decisionale che ha
bloccato il Paese negli ultimi vent’anni facendone sempre il fanalino di coda
europeo tranne che durante la stagione del governo di unità nazionale guidato da
Mario Draghi. Parliamoci chiaro.
Questo schema di legge non ha
niente a che vedere con la prima bozza Calderoli. Perché non ci si limita a
chiedere un parere al Parlamento, ma un atto di indirizzo e, soprattutto, il
testo finale approvato dal Consiglio dei ministri dovrà essere sottoposto a un
voto a maggioranza assoluta del Parlamento. Il lavoro di ricucitura con i
principi invalicabili sanciti dalla nostra Costituzione è stato fatto anche se
andrà sempre vigilato con attenzione. Chiariamoci bene, però.
La coerenza politica di quello
che è stato affermato dal ministro Calderoli passa per la capacità politica di
attuare fino in fondo il modello Fitto. Che significa essenzialmente fare due
cose. 1) Togliamo le marchette alle Regioni del Sud e del Nord e chiudiamo lo
scandalo dei progetti sponda dei fondi di coesione e sviluppo per concentrarli
nella ricostruzione dei diritti di cittadinanza violati a partire da asili nido,
scuola, ospedali e assistenza agli anziani 2) Utilizziamo le risorse del Piano
nazionale di ripresa e di resilienza per fare le infrastrutture energetiche,
ferroviarie, digitali nel nostro Mezzogiorno che è stato colpevolmente
abbandonato sperimentando modalità di spesa effettiva che passano attraverso una
centralizzazione efficace della capacità di spesa e una priorità altrettanto
strategica nell’agenda del Paese.
Per essere chiari tra una
rimodulazione e l’altra del Pnrr e l’utilizzo delle risorse di Repower Eu l’80%
delle risorse europee deve essere destinato al Sud e serve una nuova Cassa come
fu ai tempi di Pescatore che fa le cose nei tempi prestabiliti e liquida tutte
le clientele regionali e ministeriali. Questa paradossalmente è la vera
autonomia che serve al Paese.
LA BOLLA DELL'AUTONOMIA E IL
SUD DA VENDERE AL MONDO. L'ITALIA CORRE PIÙ DELLE GRANDI ECONOMIE E HA I
NUMERI PER GIOCARE LA CARTA MEZZOGIORNO SUL TAVOLO DELLA CRESCITA EUROPEA.
ROBERTO NAPOLETANO su Il Quotidiano del Sud il 31 gennaio 2023
Al posto di perdere tempo in
progetti di miope frammentazione dei poteri decisionali e di giochini sulla
cassa che allargano i divari e annullano gli effetti del super boom italiano, si
metta su una squadra all’altezza per vendere il prodotto Sud nel mondo e
richiamare in casa le risorse umane che abbiamo formato e pagato noi regalandole
a chi affida loro la guida dei centri finanziari e industriali globali. Non
perdiamo tempo con l’autonomia di Calderoli che di bozza in bozza, una più
surreale dell’altra, si auto elimina e attuiamo un progetto Paese Sud -Nord del
mondo che riunisca maggioranza e opposizioni individuando figure e strumenti che
sopravvivano al cambio delle maggioranze politiche perché è interesse di tutti
preservarli. Questa è la stabilità che serve al Paese per avere capacità
realizzativa.
Non ne possiamo più di questo
balletto mediatico sull’autonomia differenziata. Qualcosa che semplicemente non
esiste perché c’è un ministro che risponde al nome di Roberto Calderoli che
sforna bozze a ripetizione che ignorano sistematicamente gli ineludibili
passaggi parlamentari a maggioranza qualificata perché si incide su elementi di
sostanza della Costituzione che non sono sostituibili con un parere delle Camere
espresso in sessanta giorni. Non ne possiamo più di un’ostinazione
presumibilmente elettorale, forse neppure condivisa in toto da Salvini, che non
fa altro che rendere sempre più palese agli occhi di tutti le decine di miliardi
di trasferimenti pubblici che indebitamente ricevono le Regioni più ricche a
scapito di quelle più povere su scuola, sanità, trasporto pubblico locale. Per
cui più scrivi che senza la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni
(Lep) non ci può essere attribuzione alle Regioni delle nuove funzioni delegate,
più rendi evidente la iniqua anomalia della spesa pubblica italiana. Che è
frutto del federalismo malato voluto proprio da Calderoli con la legge del 2009.
Più fai questa operazione
verità e più imponi sul piano costituzionale che nulla possa essere delegato sul
territorio se prima le nuove determinazioni dei livelli essenziali di
prestazione non si traducono in erogazioni effettive. Visto che il Capo dello
Stato, Sergio Mattarella, ha chiarito da tempo che non possono esistere
disparità tra cittadini del Nord e del Sud come tra chi abita nelle metropoli e
chi nelle aree interne. Visto che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,
lodando il Piano Polis delle Poste che offre servizi integrati ai Comuni
italiani sotto i 15 mila abitanti, è stata addirittura tranchant: non possono
esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Abbiate pazienza, ma di
che cosa stiamo parlando? Stiamo giocando a scassare il bilancio pubblico della
Repubblica italiana o abbiamo voglia di presentare il conto alle Regioni e alle
metropoli del centro nord indebitamente super foraggiate da almeno un decennio?
O forse, più terra terra, vogliamo fare giocare Calderoli e non so chi altro,
magari Fontana e Zaia, per continuare a prendere in giro un po’ di elettori
lombardi per le regionali e quelli veneti per le europee?
Si rendono almeno conto che
stanno facendo correre a entrambi il rischio serissimo di vedersi svuotare i
portafogli dei trasferimenti pubblici con i quali fabbricano parte di quei
residui fiscali di cui si riempiono a sproposito la bocca? Siamo seri, per
favore! Occupiamoci piuttosto di un Paese che continua a correre mettendo a
segno una crescita del 3,9% nel 2022 superiore a quella di Cina, Stati Uniti e
delle grandi economie europee dopo lo storico +6,7% del 2021. Occupiamoci
piuttosto di un Mezzogiorno ricollocato al centro della politica di sviluppo
europeo per un ruolo strategico di hub di energia e manifattura delle due
sponde, ma anche come centro di attrazione di capitali internazionali. Questo è
il futuro produttivo di cui il dibattito della pubblica opinione si deve
occupare non in una logica di Sud che parla al Sud o di Mediterraneo che parla
al Mediterraneo, ma di un’Europa che ha bisogno della sua porta di ingresso sul
mare Nostrum e che si candida con il Mezzogiorno italiano a diventare la
capitale manifatturiera del Mediterraneo per potere continuare a fare crescita
aggiuntiva e occupazione di qualità.
Occupiamoci piuttosto di
inchiodare i vertici di Ice, Sace e Fincantieri alle loro responsabilità e di
organizzare una squadra autorevole che venda il Mezzogiorno nel mondo
liberandolo da uomini e donne che sanno fabbricare solo carte, porre vincoli e
che nel momento del bisogno si rivelano sprovvisti di un disegno industriale
all’altezza della sfida. Bisogna fare capire agli investitori globali che dopo
un’eternità l’Italia torna ad avere un governo politico di legislatura e ci sono
qui quelle condizioni necessarie di stabilità per promuovere finalmente il ruolo
e l’immagine dell’Italia. Serve una rivoluzione nel modo di fare rete dei nostri
ambasciatori alcuni dei quali sono specialisti in pranzi e cene, ma devono
ancora acquisire il metodo francese che mette gli affari prima di tutto e tutti.
Bisogna fare conoscere al mondo
il grado di specializzazione tecnologica che già oggi ha il Mezzogiorno
italiano. Bisogna raccontare al mondo che gli investimenti energetici in nuovi
rigassificatori e, ancora di più, nelle fonti rinnovabili oltre che nelle reti
di trasporto ferroviario e digitale finanziati con i fondi europei possono tutti
insieme rendere ancora più attrattiva questa destinazione territoriale per gli
investimenti globali. Ma come è possibile che se vai alla Borsa di Londra trovi
squadre di uomini di finanza campani, calabresi e pugliesi e noi come Paese non
riusciamo a rendere attrattivi i nostri territori per questo capitale umano che
abbiamo costruito e pagato noi? Possibile che occupino molte tra le posizioni
più rilevanti nei centri finanziari e industriali del mondo e noi non riusciamo
mai a richiamarli in casa mettendo in rete le eccellenze universitarie e
professionali e facendo esplodere il valore aggiunto del nostro software, del
packaging, dei nuovi materiali, ma anche dell’intelligenza artificiale e
dell’aerospazio?
Smettiamola di perdere tempo
con il giochino dell’isolatissimo Calderoli e concentriamoci sulle cose serie.
Aiutiamo il governo Meloni a liberarsi dal fuoco amico dei suoi alleati e
stimoliamo la parte migliore delle opposizioni a investire su un progetto Paese
che ha superato l’esame dei mercati e dell’Europa e che ora ha solo bisogno di
ritrovare in casa capacità realizzativa. Quella che ci manca da almeno venti
anni e che o recuperiamo ora con una stabilità politica di legislatura o non
recupereremo più.
Autonomia: quali competenze
potrebbero passare alle singole Regioni e cosa sono i Lep? Marco Cremonesi
su Il Corriere della Sera il 2 Febbraio 2023
Ecco i punti fondamentali del
disegno di legge presentato dal ministro Calderoli e approvato all’unanimità dal
Consiglio dei ministri
Che cosa è l’autonomia
differenziata?
È la possibilità per ciascuna
Regione di chiedere allo Stato nuove funzioni insieme alla risorse «umane,
strumentali e finanziarie» per svolgere adeguatamente tali compiti. Il disegno
di legge approvato ieri in Consiglio dei ministri definisce «i principi generali
per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e
condizioni particolari di Autonomia» nonché le «modalità procedurali di
approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione». È insomma, anche, una
sorta di programma di quanto accadrà nei prossimi mesi. Secondo il ministro
Roberto Calderoli l’iter richiederà circa un anno.
Si tratta di una riforma
costituzionale?
No. Proprio perché il ddl
approvato ieri dà attuazione a quanto previsto dalla riforma costituzionale del
2001 (titolo V), le Autonomie avranno un percorso parlamentare e istituzionale
normale, anche se piuttosto articolato: non sono comunque previste doppie
approvazioni distanziate nel tempo come nel caso delle riforme costituzionali.
Che cosa contiene il disegno di
legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri?
Ieri è stata data all’unanimità
l’approvazione preliminare dei 10 articoli del disegno di legge di attuazione
delle Autonomie. I passaggi attraverso cui le Autonomie entreranno nell’assetto
dello Stato. Il prossimo passaggio è il parere della Conferenza unificata, che
dovrebbe avvenire entro due o tre settimane. A quel punto il Consiglio dei
ministri potrà approvare definitivamente il quadro della riforma che poi
affronterà l’esame delle Camere.
Quali sono le competenze che
potrebbero passare alle Regioni?
Ciascuna Regione può chiedere
le competenze che ritiene di poter svolgere tra le 23 materie indicate nella
riforma del titolo V del 2001. Si tratta di un lungo elenco di materie anche se,
al momento, soltanto il Veneto ha chiesto tutte le materie possibili secondo
Costituzione.
Che cosa sono i Lep che
accendono la discussione politica?
I Livelli essenziali di
prestazione sono, materia per materia, i livelli minimi dei servizi erogati
dallo Stato. Una delle discussioni cruciali a venire, sarà appunto su come
definirli e, in caso di necessità, come finanziarli. Non è un passaggio
eludibile: secondo il ddl, la richiesta di Autonomia «è consentita
subordinatamente» alla definizione dei Lep. Per comprendere che cosa siano i
Lep, spesso vengono paragonati ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), già
definiti nel 2001 e poi nel 2017. E cioè le prestazioni e i servizi sanitari,
con il loro corrispettivo economico, che lo Stato è tenuto ad assicurare a tutti
i cittadini. In questo senso in questa settimana si è sentito chiamare i Lea «i
Lep della sanità». La definizione dei Lep sarà utile anche a definire i
cosiddetti «costi standard» dei diversi servizi.
Che cosa è la «cabina di
regia»?
I Lep saranno determinati da
una commissione paritetica tra Stato e Regioni. A supporto di quest’organo, il
ministro Roberto Calderoli nelle prossime settimane costituirà una «cabina di
regia» a cui daranno il loro contributo numerosi esperti di chiara fama,
ciascuno per l’argomento di competenza.
In quale modo si esprimerà il
Parlamento riguardo all’iter della riforma?
Le Camere dovranno esprimersi
in due distinti momenti. Una prima volta sulla legge di attuazione una volta che
abbia ricevuto il definitivo via libera del Consiglio dei ministri. In un
secondo momento, le Camere saranno chiamate a esprimersi sull’intesa preliminare
che sarà raggiunta tra lo Stato e ciascuna Regione. Ogni intesa, infatti,
porterà in calce due firme: quella del premier e quella del presidente della
Regione. A quel punto, appunto, l’accordo tornerà in Parlamento.
Quali sono le materie su cui si
è già accesa la polemica?
Certamente l’istruzione, al
punto che molti sostengono che non sia detto che la materia sarà mai
effettivamente devoluta. Assai discussa anche la competenza sull’energia e le
sue reti. Fermo restando che «da ciascuna intesa non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica» è già molto accesa la
discussione sul fondo di perequazione che si renderà necessario per la
«promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale
e della rimozione degli squilibri economici e sociali».
Autonomia, Zaia: «Sarà
un'equa distribuzione del benessere. Al Sud dovrebbero festeggiare». Martina
Zambon su Il Corriere della Sera il 2 Febbraio 2023
Il governatore del
Veneto: «Giornata storica ma resta un punto di partenza. Sindaci e Regioni del
Sud contrari? Chi esce dalla confort zone fatica sempre»
Il binomio d’acciaio
«autonomia-Zaia» è dato per acquisito ma alla notizia, attesa, del primo
passaggio formale in Consiglio dei ministri del disegno di legge d’attuazione
per l’autonomia, il presidente del Veneto Luca Zaia centellina il giubilo e
veste i panni del maratoneta.
Presidente, primo traguardo
tagliato?
«Immagino ci sarà un passaggio
in Conferenza unificata. Ciò detto, questa resta una giornata storica ma non è
assolutamente un punto d’arrivo. Piuttosto un punto di partenza verso una
rivoluzione. Questo paese ha deciso di cambiare pelle e scrivere nuova pagina di
storia con una riforma che sarà la più importante dal 1948 a oggi, varrà ben più
della modifica al Titolo V della Costituzione perché cambia il paradigma del
sistema Paese».
Il passo avanti arriva con un
governo a trazione FdI, probabilmente il partito più centralista mentre la Lega
non ci era riuscita durante il governo giallo-verde…
«Partiamo col dire che Salvini
da segretario federale si è speso politicamente ed è altrettanto vero che il
ministro Calderoli ha seguito in modo certosino la concretizzazione del
progetto. Ma voglio ringraziare il governo nel suo complesso che in cento giorni
ha fatto più di altri 5 governi nel recente passato».
Le polemiche non fanno che
montare, però. Sono contrari sindaci e governatori del Sud, la Cgil ha già
annunciato una mobilitazione e il clima è incandescente come non mai…
«Ritengo che il dibattito in
corso sia ragionevole. Chi si sente chiamato fuori dalla propria comfort zone fa
fatica. Invece non è giustificabile la polemica da chi ha ruoli istituzionali e
molto spesso, senza aver letto le carte, dipinge questa scelta come una
tragedia. Lo devo ripetere per la centomilionesima volta? Questa non è la
secessione dei ricchi e tanto meno è un’operazione occulta per distruggere parte
del Paese. Le Regioni, fra loro, da Nord a Sud, sono gemelli siamesi. Voglio
essere ancor più chiaro: trovo riprovevole e non giustificabile sentir dire che
è una forma di secessione per spaccare l’Italia perché è come accusare il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, garante della Costituzione, di
avallare operazioni secessioniste».
Autonomia Regioni, Zaia:
«Inizia percorso verso federalismo, è occasione per crescere tutti insieme»
La penserebbe allo stesso modo
se fosse un governatore del Sud?
«Se fossi un governatore del
Sud oggi sarei in festa perché, a processo ultimato, passerà un principio: più
Stato dove serve e meno Stato dove non serve. L’autonomia al Sud darà voce alla
foresta che cresce e che non ha mai voce, un pezzo di Paese che ha voglia di
modernità e crescita. Non possiamo pensare che l’alternativa sia il centralismo
che ha vergognosamente fallito dando vita a un paese a due velocità,
deresponsabilizzando, creando debito e disoccupazione e che, ed è forse
l’aspetto più grave, non ha pensato ai giovani».
Il criterio inserito da
Calderoli per procedere con le intese sono i Lep, i livelli essenziali di
prestazione su alcune delle 23 materie, ma non sembra sia bastato a placare il
Sud…
«I Lep sono una questione etica
e morale. È vergognoso che in questo Paese non si siano fatti e che, forse,
finiranno con il non essere applicati».
Nella legge di attuazione pare
di capire si possa procedere con l’iter delle intese su materie che non avranno
i Lep, è così?
«La scelta spetterà alla Cabina
di regia, ai tecnici. Verranno valutate le materie, mi si passi il neologismo,
“leppizzabili”. Penso a una delega come quella sulle banche di credito
cooperativo, lì che Lep vogliamo applicare? Ma, sia chiaro, non sarò certo io a
oppormi alla “leppizzazione”, anzi. Da cinque anni a questa parte i Lep sono
diventati un mantra per non procedere con l’autonomia. Il governo li ha messi
già in legge di bilancio, si proceda».
Prima dei Lep, prima delle
Intese Stato-Regione, il ddl Calderoli dovrà essere licenziato dal Parlamento.
La maggioranza avrà la forza per farlo passare? «Voglio augurarmi che ci sarà un
consenso trasversale perché spero che dopo tante polemiche qualcuno leggerà le
carte. A chi continua a essere contrario dico che sarebbe più coerente aver
chiesto direttamente la modifica della Costituzione. Non votare il ddl
significherebbe essere fuori dal mondo perché, lo ripeto, l’autonomia è in
Costituzione. Il parlamento ha una sua sacralità ed è giusto che sia coinvolto,
è il luogo della discussione, ma spero si entrerà nel merito e non ci si
limiterà alle dichiarazioni “per partito preso».
Stefano Bonaccini pensa a una
mobilitazione contro «questa» autonomia, l’ha sentito di recente?
«No, francamente. Ora lui è in
campagna elettorale per la segreteria del Pd, in altre faccende affaccendato».
Come vive queste giornate? «Sono talmente assuefatto al tema che lo vivo in modo
sereno».
Calderoli ostenta una cravatta
con le tartarughe, lei ha qualche portafortuna? «Conservo il decreto di
indizione del referendum nella mia scrivania, è iniziato tutto da lì». Il Veneto
rivendica la primogenitura sull’autonomia... «Nel 2014 abbiamo fatto una legge
referendaria che, dopo essere stata impugnata dal governo Renzi, viene approvata
dalla Corte costituzionale a luglio 2015. Nel 2017 indiciamo il referendum e, a
quel punto, si affianca la Lombardia, poi anche l’Emilia Romagna ma senza
referendum. Aggiungo che il concetto di gradualità nel conferimento delle
materie l’ho chiesto io ai tempi delle pre intese col governo Gentiloni a inizio
2018. L’autonomia parte dal Veneto no?».
Ci dà una definizione nuova di
autonomia?
«I detrattori preferiscono
un’equa distribuzione del malessere. Chi è a favore dell’autonomia è per un’equa
divisione del benessere».
Paese di figli e figliastri
ma si può essere diversamente italiani? Solo l’accenno a una sia pur
remotissima idea di parificazione ha dato ali alla fretta di Calderoli & Soci:
bisogna fare prima che qualcuno metta in discussione la spesa storica. Lino
Patruno su La Gazzetta del Mezzogiorno il 03 Febbraio 2023
Ciò che sorprende su questa
storiaccia dell’autonomia differenziata è la fretta. Con Calderoli in
concorrenza con Marcell Jacobs. Dice: si vota fra qualche giorno per le
regionali in Lombardia e bisogna portare uno scalpo. Poi al governo ci siamo noi
del centrodestra e dobbiamo approfittarne (ma non è che il centrosinistra si
opponga, anzi). Poi il contrabbandato grido di dolore di regioni privilegiate
che vogliono vivere sempre meglio dei non privilegiati. Ci sta più o meno tutto.
Ma la fretta ha un filo conduttore che in quanto a egoismo e indifferenza alle
sorti di un Paese unito è da Guinness dei primati.
Come si sa, Lombardia, Veneto
ed Emilia Romagna vogliono farsi Stato ai danni dello Stato. Vogliono cioè
sottrargli tutte, ma diciamo tutte, le funzioni: dalla scuola alla sanità, dai
trasporti alle infrastrutture, dall’ambiente all’energia. Sostengono di essere
più capaci, sia pure senza un solo argomento a favore. Dateci le funzioni e
passateci i soldi che spendete, così facciamo noi. In verità appare e scompare
pure un Bingo da sogno: ci teniamo anche i nove decimi delle nostre tasse.
Perché? Perché abbiamo il diritto di essere trattati meglio del resto degli
italiani. Ma così togliete agli altri. Abbiamo il diritto della ricchezza manco
ci fosse ancora Re Sole. Restando nello stesso Paese, mica andandosene.
Ma torniamo ai soldi. E qui
spunta la polpetta avvelenata (per gli altri, non per loro).
Per le tre regioni interessate
(ma anche per le restanti del Centro Nord) c’è la spesa storica. Spesa che da
sempre (appunto storica) è superiore a quella per il Sud. Non lo dice qualche
neoborbonico. Lo dicono fonti neutrali (e documenti ufficiali) come i Conti
pubblici territoriali, emanazione del ministero dell’economia.
Lo dice l’Ufficio parlamentare
per il bilancio. Lo dice la Banca d’Italia. Si calcola 3671 euro in più all’anno
per ogni cittadino centrosettentrionale rispetto a uno meridionale. Se qualcuno
si chiede perché, la risposta è da freddura: perché si è sempre fatto così. E
perché si è sempre fatto così? Perché ci sono italiani e diversamente italiani,
cosa vi devo rispondere.
Il problema è che da un po’ di
tempo i meridionali se ne sono accorti. E cominciano (cominciano) a protestare:
questo avviene perché non sono stati mai calcolati i nostri bisogni, dicasi
fabbisogni. Così i servizi che lo Stato ci garantisce sono tutti (ma proprio
tutti) sotto il minimo previsto dalla Costituzione, la quale osa dire che non ci
deve essere differenza di trattamento a seconda del luogo di nascita. Bisogna
allora calcolare i Lep, Livelli essenziali di prestazione. Anzi i Lup, Livelli
uniformi di prestazione.
Solo l’accenno a una sia pur
remotissima idea di parificazione ha dato ali alla fretta di Calderoli & Soci:
bisogna fare prima che qualcuno metta in discussione la spesa storica. Perché,
con l’autonomia differenziata, questa spesa oltre che storica diventa
cristallizzata come acqua al gelo. Diventa per sempre.
In verità nel Paese dei figli e
dei figliastri non è che per i privilegiati ci fosse tutto questo pericolo. I
Lep si dovevano calcolare almeno da 14 anni, da quel 2009 in cui lo stesso
Calderoli lo ammise con la legge di perfezionamento del federalismo fiscale che
porta (udite udite) il suo nome.
Si doveva fare anche la
perequazione infrastrutturale, quella che fa andare fra Milano e Torino in
un’ora e da Napoli e Bari in cinque. Mai fatto nulla. Fino alla beffa (sempre
«made in Calderoli») di dire che i Lep si faranno ora in un anno. Ma senza
contrastare l’autonomia differenziata, che parte a prescindere, dovessimo fare
scherzi. E fatti questi Lep, per migliori servizi e migliore qualità della vita
al Sud non si deve spendere un euro in più (mentre costerebbero 100 miliardi,
tanto il furto finora). Roba impossibile anche con tutti gli algoritmi del mondo
e l’intelligenza artificiale pure. Ma così è anche se non vi pare. Nel nome
della giustizia, sia chiaro.
La fretta dei già più ricchi
grazie allo Stato ha un altro padre putativo. Queste regioni che vorrebbero
spadroneggiare in Italia perdono di continuo colpi in Europa. Tutte le
classifiche le vedono retrocedere rispetto alle più forti del continente.
Inevitabile in una economia in cui non puoi crescere più di tanto senza far
crescere gli altri (vedi la Germania con l’Est e l’Ovest). Allora occorre
prendere sempre di più benché tutti gli studi dimostrino che una maggiore
crescita del Sud (dandogliene ovviamente i mezzi) andrebbe anche a vantaggio del
Nord.
Insomma, il futuro di
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna è più nel Sud che nell’autonomia
differenziata. Lo ripete da tempo la stessa Europa. Però noi abbiamo Calderoli
(ma è un santuario, presidente Meloni?) più Fontana, Zaia, Bonaccini. Notare la
differenza.
Autonomia differenziata,
parla Sales: «Vogliono trascinarci in un nuovo feudalesimo». Lo storico: «Il
Sud non può reggere la riforma. Il ministro? Un pifferaio». Leonardo Petrocelli
su La Gazzetta del Mezzogiorno il 03 Febbraio 2023
«Ci vogliono trascinare in un
nuovo feudalesimo. Questa è la realtà: il Sud non può reggere l’autonomia
differenziata». Isaia Sales, salernitano classe 1950, docente di Storia delle
mafie e già sottosegretario al Tesoro, traccia una linea netta tra il prima e il
dopo. Dopo la riforma Calderoli, infatti, ci aspetterebbe soltanto il trionfo
delle disuguaglianze territoriali. «Evidentemente gli ultimi, drammatici anni
non hanno insegnato nulla», commenta sconsolato.
Professor Sales, qual è la
posta in gioco?
«Con l’autonomia differenziata
si costituzionalizza la “disuguaglianza di luogo”. A seconda di dove vivi hai
maggiori o minori possibilità di usufruire di ciò che ti spetterebbe come
cittadino di una nazione. È un assurdo».
Cosa la preoccupa di più?
«Il tema più delicato è quello
dell’Istruzione che dovrebbe essere esclusa dall’elenco delle competenze
trasferibili. E poi c’è la Sanità: dovremmo tornare indietro, altro che
autonomia differenziata».
La lezione della pandemia è
stata dimenticata?
«Guardi se un marziano
arrivasse ora sulla terra penserebbe che l’autonomia sia un premio per le
eccezionali prestazioni delle regioni durante la pandemia. E invece sono state
un disastro. Le regioni, a differenza dei Comuni, più efficienti ma più poveri,
hanno dato pessima prova di sé, fallendo la prima vera sfida storica. E noi cosa
facciamo? Le premiamo?».
Eppure per molti anni il
regionalismo aveva funzionato...
«In linea di principio non c’è
contrapposizione fra autonomia e nazione ma solo a patto che si tuteli
l’interesse nazionale e, soprattutto, che siano delegate solo quelle competenze
che, effettivamente, possono essere meglio gestite con il decentramento. Dal
1970 al 2000 questo meccanismo ha funzionato».
Poi cosa è successo?
«Dopo il tramonto dei grandi
partiti nazionali, la politica si è territorializzata. Ha fatto irruzione, con
la Lega, quello che io chiamo “etnoregionalismo” o “egoregionalismo”. Cioè
l’egoismo del veniamo prima noi».
D’accordo, ma anche il Partito
democratico, a cominciare dal probabile futuro segretario Bonaccini, è in prima
linea per l’autonomia. Come se lo spiega?
«Il Pd non è più abituato a
identificare se stesso con la lotta alle disuguaglianze. E dunque è stato
incapace di leggere, in questa riforma, la prepotenza delle disuguaglianze
territoriali che si affermano».
Gioca anche un ruolo l’emergere
dei leader regionali?
«Indubbiamente. Bonaccini, De
Luca, Emiliano: sono tutti satrapi. Il partito è ormai un cda di cui i leader
territoriali detengono le quote. E le fanno pesare. Ma lei immagina Togliatti,
Berlinguer o Moro sedotti dagli egoismi territoriali? Quelli erano leader della
nazione».
E Fratelli d’Italia, invece? In
fondo l’autonomia è estranea anche alla cultura della destra nazionale.
«Lì c’è un altro assurdo. Il
centrodestra cerca di tenere insieme il patriottismo con le piccole patrie. Ma
sono incompatibili. Così come lo sono il presidenzialismo, cioè il rafforzamento
di una autorità centrale, e l’autonomia, ovvero il rafforzamento di una podestà
territoriale. Ho solo una speranza».
Quale?
«Che quello di FdI sia, in
realtà, solo un atteggiamento tattico. Fanno passare l’autonomia in Cdm e poi la
congelano. Ma temo che la Lega non si farà fregare».
Lei è esperto di storia della
mafia. Il decentramento di competenze e risorse agevola le mire della
criminalità organizzata o le complica?
«La mafia è scimmia delle
istituzioni, assume la forma necessaria in quel momento. Non abbiamo una
controprova, ma certamente il livello regionale è molto aggredibile. Penso
soprattutto alla sanità che oggi è una delle maggiori attrazioni per la
criminalità, sia dal punto di vista della corruzione che da quello del crimine».
Professore, il Sud può reggere
il colpo dell’autonomia?
«No, non può. Può sopportare
una economia differenziata, ma non una differenziazione dei servizi. D’accordo
sviluppare meno Pil, ma vedere l’80% dei bambini malati gravi prendere la via
del Nord per curarsi è drammatico. Aumentare ancora di più questo divario
sarebbe terribile».
Conosce la riposta: saranno i
Lep, cioè i Livelli essenziali delle prestazioni, che il governo si impegna a
calcolare, a garantire servizi omogenei.
«Il ministro Calderoli è un
pifferaio che ci ha scambiati per dei minorati mentali. Anche se stabilisci i
Lep devi prevedere i finanziamenti che, però, non ci sono. Dunque è inutile
calcolare di quanti ospedali, di quanti tram, di quante ferrovie ha bisogno la
Puglia se poi mancano le risorse per realizzarli. Andrebbe spiegato ai
governatori del Sud».
Non l’hanno capito?
«Emiliano e De Luca l’hanno
capito ma, per giustificare l’appoggio a Bonaccini, fingono di no. Si nascondono
dietro la definizione dei Lep. In fondo, l’autonomia porta più poteri nelle loro
mani. Ma in un Sud completamente devastato. Quello che ci aspetta dietro
l’angolo è un feudalesimo regionale»
Autonomia differenziata,
Capone: «così il governo dichiara guerra al Sud». Le reazioni. Il commento
della presidente del Consiglio Puglia Capone e le parole della Cgil Puglia:
aumenta diseguaglianze nei territori. Redazione online su La Gazzetta del
Mezzogiorno il 03 Febbraio 2023
L’autonomia è una
«dichiarazione di guerra al Sud»: lo sostiene la presidente del Consiglio
regionale pugliese, Loredana Capone. «Il disegno di legge del ministro Roberto
Calderoli - scrive su Facebook - è stato approvato ieri in Consiglio dei
Ministri. Adesso chi ha più soldi e più servizi potrà averne ancora di più e
chi, invece, ne ha di meno è destinato a restare ancora più indietro». «I
livelli essenziali delle prestazioni - aggiunge - saranno definiti da una cabina
di regia attraverso un Dpcm, il Parlamento, totalmente escluso da ogni confronto
e discussione, non potrà fare altro che ratificare, ovvero, prenderne atto, e
questo si aggiunge l’invarianza di spesa perché la riforma, che pure mette come
condizione base l’individuazione dei Lep, non prevede nessuna spesa pubblica
aggiuntiva per lo Stato». «Saranno le Regioni, infatti, a dover fare fronte alle
nuove spese utilizzando il proprio gettito fiscale. In sostanza - sottolinea -
la ripartizione delle risorse non avverrà su base nazionale a seconda delle
necessità collettive dei territori ma sarà affidata alla contrattazione diretta
con le singole regioni». Secondo Capone «una pagina politica tra le più brutte
che il nostro Paese abbia mai conosciuto, realizzata dal governo in tutta fretta
prima di un confronto approfondito con la Conferenza Stato Regioni e con le
forze economiche e sociali, e soprattutto prima di individuare e impegnare le
risorse necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, e si
parla, per iniziare, di oltre 60 miliardi». Per la presidente si tratta di una
«dichiarazione di guerra al Sud».
«Fermiamo l’autonomia
differenziata». E' quanto dichiara in una nota la Cgil Puglia che «chiama alla
mobilitazione lavoratori, cittadini, istituzioni e forze sociali e culturali».
«L'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sull'autonomia
differenziata - riferisce il sindacato - rappresenta un fatto politicamente
grave nella direzione di aumentare le disuguaglianze sociali e territoriali nel
Paese anziché provare a contrastarle che, come abbiamo denunciato sin da subito,
rischia di colpire pesantemente i servizi pubblici delle regioni del
Mezzogiorno, dalla sanità ai trasporti all’istruzione in quella che
efficacemente è stata definita 'secessione' dei ricchi». «Non è questo ciò di
cui la Puglia, il Sud e l’Italia hanno bisogno in questo momento. Servirebbero -
sottolineano dal sindacato - invece politiche industriali, investimenti su
infrastrutture sociali e materiali che garantiscano pari diritti su tutto il
territorio, buona occupazione». Per questo la Cgil Puglia propone «a lavoratori,
cittadini, istituzioni, a tutte le forze sociali, politiche e culturali della
Puglia di condividere e sostenere il nostro percorso di mobilitazione. Dobbiamo
far sentire la nostra voce».
LE REAZIONI IN ITALIA
È ancora muro contro muro
sull'autonomia differenziata, con il centrodestra che parla di riforma storica e
il Pd che definisce il testo «spacca Italia».
Lo scontro, però, non è solo
tra maggioranza e opposizione: all’indomani del varo del disegno di legge si
apre una crepa anche dentro il governo, in particolare sulla sanità, tra il
ministro Orazio Schillaci e il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.
Il primo, tecnico di area FdI,
lancia un monito chiedendo che le Regioni siano in qualche modo «guidate dal
Ministero della Salute» che, a suo dire, deve avere «non solo un potere di
indirizzo e distribuzione dei fondi ma deve anche sostenere un meccanismo
virtuoso insieme alle Regioni per capire chi lavora meglio e aiutare chi è in
difficolta o non riesce a lavorare così bene». Di tono assai diverso
l’intervento di Salvini: «Se in alcune Regioni il livello di assistenza
sanitaria è scadente, non è per l’autonomia, che non c'è, è per l’incapacità di
alcuni governatori, penso a De Luca ed Emiliano, che - attacca - chiacchierano e
per anni non hanno fatto nulla».
Al di là del tema specifico,
l’appello dal sapore “centralista” di Schillaci, in qualche modo, rappresenta
bene lo sforzo che sta facendo Fratelli d’Italia per garantire il proprio
elettorato meridionale sul fatto che questa riforma, fortemente voluta dalla
Lega, non aumenterà in alcun modo i divari esistenti tra Nord e Sud. In tal
senso si inseriscono le parole rassicuranti del ministro Francesco Lollobrigida,
molto vicino alla premier Giorgia Meloni: «Il nostro partito - spiega - nasce
dalla coesione nazionale, un partito radicato e forte al sud. Potrebbe mai
approvare un testo di legge che produce quell'effetto? Sarebbe un pò un
suicidio».
Ma a parte i dissapori interni
al centrodestra, la polemica tra maggioranza e tutte le opposizioni resta
fortissima, uno scontro reso ancora più violento dal clima pre-elettorale, a una
settimana dal voto in Lombardia e nel Lazio. Piero Fassino lo denuncia in modo
esplicito: «Il governo - attacca l’ex leader dei Ds - vuole imporre un
centralismo regionale spezzettato, disorganico che crea disuguaglianze e divide
il Paese. Uno specchietto per le allodole per raccattare qualche voto per le
elezioni regionali». Secondo il dem, Francesco Boccia, «il governo si è piegato
alla peggior Lega. Quella di Fontana e Calderoli non è l’autonomia prevista
dalla Costituzione ma quella deteriore contro l’uguaglianza, la scuola pubblica
e la sanità pubblica; per loro autonomia coincide con privatizzazione dei
servizi».
Anche il governatore della
Puglia, Michele Emiliano lega questo testo all’esito del voto, in particolare
quello lombardo: "Se la Lega va sotto il risultato di Fratelli d’Italia in
Lombardia - afferma - cambiano gli assetti interni al Governo in maniera ancora
più negativa per la Lega e FI. Temo e spero che dopo le regionali in Lombardia
questo discorso sull'autonomia possa estinguersi».
Netta la bocciatura da parte
dei Cinque Stelle: l’ex ministro Stefano Patuanelli definisce il ddl «un’altra
porcata di Calderoli». Anche il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni
attacca frontalmente il partito di Salvini, osservando che «con l’approvazione
dello “Spacca Italia”, il partito della Meloni ha ceduto alle scempiaggini della
Lega, che finalmente potrà impugnare la bandierina dell’autonomia delle
Regioni». Severo infine Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, secondo
cui «alla Meloni piace regalare giocattoli ai suoi ministri. Li lascia giocare,
li fa girare a vuoto e li fa ripartire sempre dal via»
Autonomia, è scontro Ma il
Sud ha un’altra idea “Dateci la Macroregione”. Giovanni Vasso su L’Identità
il 4 Febbraio 2023
Come ampiamente prevedibile, il
via libera da parte del consiglio dei ministri all’autonomia differenziata by
Calderoli ha scatenato un fuoco di fila da parte dei governatori delle Regioni
del Sud. Vincenzo De Luca, dalla Campania, e Michele Emiliano, dalla Puglia,
guidano il fronte agguerritissimo del “no” alla proposta leghista di autonomia.
Spalleggiati, in ciò, da Stefano Bonaccini, in veste (più che di governatore
dell’Emilia Romagna) di aspirante segretario del Partito democratico. Le voci
della protesta, o della proposta, che si alzano da Sud, però, non stanno tutte
nelle stanze delle Regioni. C’è chi, come Sabino Morano, presidente
dell’associazione Primavera Meridionale, le vorrebbe addirittura rottamare e a
L’Identità spiega: “Il regionalismo ha fallito, se davvero si vuole riformare il
Paese, bisognerebbe restituire forza e competenze alle Province e,
contestualmente, affidarsi alle macroregioni per una pianificazione armonica e
veramente efficace”.
Secondo Morano: “Le polemiche
da parte del centrosinistra, che ha voluto e fatto la riforma del titolo V, sono
stucchevoli, è un gioco delle parti. Bonaccini, De Luca ed Emiliano erano
d’accordo con l’autonomia, ora per ragioni politiche la attaccano perché l’ha
proposta Calderoli. Contestualmente, non è un mistero che la Lega faccia
affidamento sul ddl per ragioni di consenso elettorale. La verità è che pur di
superare l’attuale regionalismo, va bene anche questa riforma un po’
pasticciata”. La soluzione sarebbe altrove: “Servirebbe, nel nostro caso,
pensare a una macroregione del Sud continentale. Non ha senso continuare a
tenere in piedi Regioni slegate tra loro, sarebbe utile invece immaginare un
organismo che, agendo su un contesto più ampio di territori legati dagli stessi
interessi, sia capace di armonizzare una pianificazione per le grandi
infrastrutture che servono per cogliere le sfide del tempo e avviare una
programmazione. E che riesca a farlo con una regia unica, che dialoghi magari
con un’Agenzia del Mediterraneo, per rafforzare il ruolo del Mezzogiorno in
un’area sempre più strategica per il futuro. Inoltre, occorrerebbe rafforzare il
ruolo delle Province, con compiti di gestione di prossimità e di sussidiarietà,
specialmente sui territori e nelle cosiddette aree interne”.
Ma le Regioni, per il momento,
resistono. Ieri Vincenzo De Luca, nel consueto “angelus” via Facebook del
venerdì coi cittadini della Campania, ha scomunicato definitivamente Calderoli e
la sua proposta di autonomia differenziata. “E’ una grande truffa e un grande
pericolo perché non affronta la sostanza dei problemi che riguardano il divario
tra Nord e Sud”, ha tuonato il governatore sceriffo, che ha aggiunto: “Il primo
divario è quello della spesa pubblica allargata: al Nord per ogni cittadino
arrivano 17mila euro l’anno, al Sud 13mila euro l’anno, in Campania 12mila euro
l’anno pro capite. Sono i dati del sistema dei conti territoriali che sono una
struttura interna all’agenzia della Coesione, quindi sono numeri ufficiali. La
prima cosa da decidere è come si fa a recuperare questo divario. Su questo il
Governo non dice nulla”. De Luca, poi, torna a battere sul tema dell’unità
nazionale: “Una valanga di retorica e poi ci ritroviamo con l’avvio della
distruzione della nazione nella sua unità, perché hanno approvato una ipotesi di
legge sull’autonomia differenziata che spacca l’Italia sui grandi servizi di
civiltà, sanità e scuola pubblica. Questo è il quadro”.
Parole durissime sono arrivate,
all’indirizzo del ministro Calderoli, da parte del governatore pugliese Michele
Emiliano. “Un errore grave del governo, che si è imbarcato su questa storia
dell’autonomia differenziata, ed è un’occasione imperdibile per diminuire
ulteriormente il prestigio di questo Governo che in questi primi 100 giorni
certo non ha brillato per capacità di rappresentare gli interessi degli
italiani”. Dunque, parlando in collegamento video al congresso regionale della
Cgil campana tenutosi ieri a Napoli, ha chiamato le piazze: “Bisogna essere
preoccupati e bisogna mobilitarsi. Io spero che dopo le elezioni in Lombardia
questa storia possa estinguersi, ma d’altra parte non vorrei che si
incastrassero da soli per eterogenesi dei fini, perché la tenuta generale di
questo governo non è elevata”.Un appello che è stato immediatamente colto dalla
Cgil campana che, con il segretario regionale Nicola Ricci, tira le orecchie
proprio a De Luca: “Ci sarebbe piaciuto sentire la voce di De Luca sul giusto
cambio di direzione dopo l’incontro con Calderoli nel quale fu prefigurato un
accordo su 7 materie tra le 23 previste e che, pochi giorni dopo, ha smascherato
il vero pensiero di Calderoli e della Lega che, fin dalla sua fondazione, ha
puntato sull’autonomia del Nord. Ora è importante una mobilitazione”.
Non è solo propaganda:
l’autonomia può davvero «dissolvere» il paese. Perché «ennesimo atto
propagandistico»? Perché fin qui su un tema delicatissimo qual è la forma di
Stato, è stata gettata una quantità di fumo insopportabile negli occhi degli
elettori. Gaetano Quagliariello su La Gazzetta del Mezzogiorno il 04 Febbraio
2023
L’approvazione del disegno di
legge sull’autonomia differenziata va considerata, assieme, l’ennesimo atto
propagandistico in materia di rapporti tra Stato e Regioni e un evento che
potrebbe avere rilevanti conseguenze politiche.
Perché «ennesimo atto
propagandistico»? Perché fin qui su un tema delicatissimo qual è la forma di
Stato, è stata gettata una quantità di fumo insopportabile negli occhi degli
elettori. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. E la pietra non può
certamente essere scagliata dalla sinistra. Gran parte dei problemi che anche
oggi si stanno originando derivano, infatti, dalla sciagurata riforma del Titolo
V, approvata dal centro-sinistra nel 2001 negli ultimi giorni della legislatura,
nel tentativo disperato di catturare voti leghisti e sovvertire così il
risultato delle imminenti elezioni.
Quella riforma, per
l’essenziale, riduceva i poteri dello Stato concedendo alle Regioni competenze
legislative concorrenti in moltissime materie, senza prevedere un modo per
dirimere gli inevitabili conflitti. Ne è scaturito un contenzioso sfibrante e
senza fine che ha impegnato e ancora impegna la Corte Costituzionale a porvi
rimedio. Prevedeva inoltre «ulteriori forme di autonomia» riguardanti ben 23
materie - la più parte di competenza concorrente e alcune di competenza
esclusiva dello Stato - attribuibili alle Regioni che ne avessero fatto
richiesta attraverso una semplice legge statale, concepita d’intesa con le
Regioni interessate e approvata a maggioranza assoluta.
La legge voluta dal ministro
Calderoli utilizza, dunque, la scia di quella infelice riforma costituzionale
che a suo tempo, giustamente, il centro-destra avversò. Perché si sostiene che
si tratti di un ennesimo atto propagandistico? Perché la legge approvata è una
«legge quadro» della quale, però, non c’è bisogno. Il Titolo V darebbe, infatti,
la possibilità di saltare il passaggio per stabilire direttamente le intese. Non
a caso, a suo tempo, il governo Gentiloni avrebbe voluto percorrere proprio
questa strada, senza per fortuna riuscirci.
Si può ritenere, a questo
punto, che queste critiche nascano da una considerazione arcignamente
centralista dei rapporti tra Stato e autonomie, ispirata da un pregiudizio
meridionalista. Non è così. Si è ben consapevoli della lezione di uomini come
Sturzo e Salvemini che capirono per tempo come il centralismo non avrebbe
giovato al Mezzogiorno e alla soluzione della sua atavica questione. Il fatto è
che al rafforzamento delle autonomie non giova l’eccessivo indebolimento dello
Stato. In un assetto efficace, esso dovrebbe esser messo nelle condizioni di
svolgere il ruolo che è del direttore d’orchestra, al fine di armonizzare
politiche non uniformi all’interno di un sistema unico e coerente. Ma perché ciò
sia possibile, almeno quattro nodi fondamentali non possono proprio essere
elusi:
1) La previsione di una
«clausola di supremazia» che consenta allo Stato di prevalere di fronte a crisi
e situazioni emergenziali. Questa clausola, non casualmente, è prevista persino
negli stati ad assetto federale come gli Stati Uniti e la Germania.
2) Una sede di raccordo tra
Stato e Regioni, più forte e più legittimata dell’attuale Conferenza.
3) La revisione dell’elenco
delle 23 materie «devolvibili», alla luce dei cambiamenti epocali nel frattempo
intervenuti. Nell’elenco del 2001 sono tra l’altro presenti le «grandi reti di
trasporto e di navigazione», «l’ordinamento delle comunicazioni» e addirittura
la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Per queste
materie l’attualità si sta incaricando di dimostrare la difficoltà di agire
persino in contesti nazionali. Non è questione d’ideologia ma di buon senso:
pensare di attribuire competenze esclusive alle Regioni sarebbe un atto di
sovversivismo anti-statale.
4) La Costituzione, infine,
prevede espressamente fondi perequativi al fine di garantire su tutto il
territorio nazionale gli stessi livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali (i famosi Lep). Bisognerà dunque spiegare all’Italia
più disagiata, in termini non equivoci, quanti soldi saranno in ciò impegnati,
se ci saranno e da dove proverranno.
Su tutto ciò il testo approvato
è invece reticente. Esso apre però, non senza qualche ambiguità, alla
possibilità di un effettivo esame parlamentare. Che ciò avvenga sarebbe
nell’interesse di tutti. Anche di chi guida l’attuale governo. Se l’approvazione
di un provvedimento ancora immaturo è stato un atto di solidarietà nei confronti
di un alleato in difficoltà, esposto a un deludente risultato elettorale e alla
ventilata scissione «nordista» del suo partito, la circostanza può essere
politicamente compresa. Ma se invece quel testo chiude la partita, va
considerato una perdita secca: innanzitutto per il premier.
Antonio Polito, in un
editoriale di qualche giorno fa, ha evidenziato come l’azione di governo di
Giorgia Meloni starebbe provando a differenziarsi da quella dei leader dello
stesso schieramento che l’hanno preceduta, proprio per il tentativo di
restaurare l’autorità dello Stato. Non ha nascosto né la difficoltà né le
insidie dell’intento. Oggi queste ci appaiono ancora più chiare: dalla
«restaurazione» alla «dissoluzione» il passo può essere breve.
Autonomia, Laterza: «Il vero
problema? Il Sud che non si mobilita». L’editore: «Mi aspettavo una forte presa
di posizione dell’opinione pubblica». Leonardo Petrocelli su La Gazzetta del
Mezzogiorno il 04 Febbraio 2023
«Il vero problema siamo noi».
Dove quel «noi» sta per opinione pubblica meridionale. E il «problema» è
l’annoiata indolenza con cui, a queste latitudini, si accoglie il galoppare
dell’autonomia differenziata. I cui effetti, potenzialmente devastanti ,non sono
stati colti nella loro interezza. È una constatazione amara quella che l’editore
Alessandro Laterza, già vice presidente di Confindustria per il Mezzogiorno e le
Politiche regionali, affida alla «Gazzetta» dopo il via libera del Consiglio dei
ministri al ddl Calderoli.
Laterza, che sta succedendo?
«Tutta la vicenda
dell’autonomia differenziata è accompagnata da una certa, generale debolezza.
Non solo nella dinamica maggioranza-opposizione ma anche a livello
territoriale».
La politica meridionale non
imbraccia il fucile?
«Emiliano e De Luca non mi
sembrano estranei a tentazioni “ducali”, per così dire, nonostante le roboanti
dichiarazioni delle ultime ore. In fondo, il ragionamento è umano: meglio essere
re di una piccola patria che conte in una patria più grande. Ma il punto non è
quello».
E qual è?
«L’informazione meridionale, ma
anche l’accademia, si sono mobilitate cercando di stimolare il dibattito. Il
problema è che non mi pare di intravedere un grande fermento nell’opinione
pubblica, soprattutto a Sud. Le battaglie, poi, si possono vincere o perdere, ma
è un argomento su cui mi sarei aspettato non dico una sollevazione ma almeno una
presa di posizione molto forte. Così non è».
L’autonomia non è solo una
faccenda leghista. Raccoglie consensi trasversali: e se fosse proprio la
politica a far da «tappo»?
«Lo escludo. La trasversalità è
un dato di fatto, certo, ma non punterei il dito contro quel partito o quella
persona. Ormai la politica è debole, sono tutti partiti di sopravvivenza. Il
vero problema siamo noi».
E quindi qual è la ragione di
questo sostanziale disinteresse?
«L’autonomia, nella sua
sostanza, è tema iper-tecnico e per questo non di facile compresione. E poi c’è
la convinzione diffusa che tutto si risolverà in una bolla di sapone. In fondo,
si tratta di un argomento “appeso” lì da vent’anni».
E non potrebbe, anche stavolta,
sfumare tutto come al solito?
«Non si può dire perché
l’evoluzione della situazione ha dei contorni non chiari. Di certo, la
motivazione principale di questa precipitosa fuga in avanti è elettorale».
Il voto in Lombardia?
«Sì, è una faccenda tutta
interna al centrodestra. Meloni ha promesso a Salvini di dargli una sponda per
le regionali in Lombardia dove il problema, per loro, non è solo vincere. Ma
vincere con un alto margine. La segreteria di Salvini è debole e, soprattutto,
pressata da Luca Zaia, il vero uomo forte del Carroccio».
Anche il Pd ha il suo ruolo in
questa vicenda. Bonaccini è in prima linea.
«Il Pd è dentro questa storia,
non c’è alcun dubbio. Non ci dimentichiamo certo la riforma del Titolo V del
2001. Una mossa maturata nella convinzione, sbagliatissima, di poter gestire
l’elettorato leghista. Però, più del Pd, un vero e proprio universo misterioso,
mi sorprende Fratelli d’Italia che, nella sua retorica, ha sempre difeso i
valori di unità nazionale. Vedremo, molto dipenderà dal voto lombardo».
Nel merito della riforma,
invece, cosa la preoccupa di più?
«La rottura del sistema
nazionale nel suo insieme che potrebbe esplodere e disfarsi in venti ducati,
rispetto ai quali si tratterebbe poi di capire il ruolo, il peso e le fonti di
approvvigionamento dello Stato centrale. I sistemi federali nascono come tali,
non sorgono da un processo di decomposizione».
Il Sud che fine rischia di
fare?
«Il tema è l’incremento
potenziale dei divari: noi siamo già, rispetto al Nord, in una posizione di
disparità per spesa corrente e investimenti pro capite. Così, rischiamo davvero
di assistere a un peggioramento ulteriore».
Due nodi: Istruzione e Beni
culturali, entrambi inseriti nell’elenco delle 23 competenze «trasferibili».
Cosa può succedere?
«In entrambi i casi c’è un
gioco degli equivoci. Abbiamo già in vigenza un sistema di autonomia scolastica
che non mi pare impedisca di portare avanti delle parziali modifiche. Mi sfugge
quale sia il vantaggio di perdere un ordine di grandezza nazionale, in termini
di istruzione di base, in favore di una ventina di sistemi scolastici minori».
E i Beni culturali?
«Anche qui una larga componente
di decentramento esiste già. Ogni regione fa la sua attività di promozione.
Dovremmo piuttosto interrogarci su come proiettare una grande immagine del
sistema-Italia nel suo complesso. Davvero mi sfugge il senso di una simile
iniziativa».
Autonomia differenziata,
Irpef alle regioni: ecco chi ci guadagna. Valentina Iorio su Il Corriere
della Sera il 3 Febbraio 2023.
Autonomia, come saranno
stabilite le risorse
Il disegno di legge
sull’Autonomia differenziata è stato approvato giovedì 2 febbraio in Consiglio
dei ministri. Nel testo si dice che «le risorse umane, strumentali e finanziarie
per l’esercizio delle funzioni sono determinate da una commissione paritetica
Stato-Regione. Il finanziamento avviene attraverso compartecipazioni al gettito
di uno o più tributi o entrate erariali regionali», ma non si specifica come si
tradurrà in concreto la compartecipazione. Il parametro della «spesa storica»
per quantificare le risorse da dare alle Regioni è saltato, si prevede invece
che siano le singole intese a stabilire quante risorse dovranno essere
trasferite dallo Stato alle Regioni una volta individuati i livelli essenziali
delle prestazioni (Lep), tenendo conto dei costi e dei «fabbisogni standard».
Una percentuale di Irpef alle
Regioni
L’ipotesi è che la
compartecipazione al gettito di una o più entrate si traduca in una percentuale
di Irpef che andrà alle Regioni, tenendo conto anche del fatto che il principale
tributo proprio delle Regioni, l’Irap, in questi anni è stata progressivamente
smantellata e, secondo quanto annunciato da alcuni esponenti del governo, pare
destinata ad essere cancellata definitivamente dalla prossima riforma fiscale.
Ipotizzando che venga stabilita una percentuale di compartecipazione Irpef
uguale per tutte le Regioni, «Lombardia e Veneto, che hanno chiesto maggior
autonomia su tutte le 23 materie citate nell’articolo 117 del Titolo V della
Costituzione, e in generale le Regioni del Nord, che negli ultimi dieci anni
hanno avuto una dinamica del reddito migliore di quelle del Sud e storicamente
hanno una base imponibile più elevata, sarebbero avvantaggiate», spiega Massimo
Bordignon, professore ordinario di Scienza delle finanze e vice presidente
esecutivo dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica.
Inoltre nelle pre-intese del 2019 Veneto e Lombardia avevano ottenuto che si
stabilisse che le risorse derivanti dalle compartecipazioni non possono generare
un gettito inferiore alla spesa media dello stato per le funzioni delegate su
tutto il territorio nazionale. Vale a dire che se negli anni il gettito
dell’Irpef dovesse aumentare le risorse extra rimangono alla Regione, se invece
le cose dovessero andare male ci penserebbe lo Stato a mettere la differenza.
Meccanismi di controllo
«Il dibattito attuale è molto
concentrato su quante risorse avranno le Regioni, ma non sul come, ovvero sulla
forma che questi meccanismi di finanziamento dovrebbero assumere. - sottolinea
Bordignon - Il rischio è che le competenze di spesa delle Regioni aumentino,
senza che si introducano contemporaneamente meccanismi o regole che le
incentivino a controllarne la dinamica, con risultati potenzialmente devastanti
per le finanze pubbliche». Un altro tema su cui bisognerebbe interrogarsi, dice
Bordignon, è «se ha senso al giorno d’oggi, tenuto conto degli interessi
nazionali, attribuire alle Regioni tutte le materie previste dall’articolo 117,
che potenzialmente vanno dall’energia alle banche regionali».
Autonomia e flat tax
Sul fronte delle imposte
l’altra questione è che si ragiona sul garantire maggiori risorse alle Regioni
attraverso l’Irpef, ma «negli ultimi anni - sottolinea il vice presidente
esecutivo dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica - la
base imponibile dell’Irpef è stata continuamente erosa, attualmente l’85 per
cento circa della base imponibile è composta dai redditi dei lavoratori
dipendenti e dei pensionati. La flat tax fino a 85 mila euro, introdotta dalla
legge di Bilancio 2023, aggraverà la situazione sottraendo la maggior parte dei
professionisti e dei lavoratori autonomi dal pagamento dell’Irpef e anche dal
pagamento dell’addizionale regionale».
Altro che autonomia
differenziata: il governo manda le regioni del Nord in rosso. La Lega
festeggia perché il ddl è stato approvato in consiglio dei Ministri. Ma nel
frattempo le zone che più hanno subito i contraccolpi del Covid rischiano di
chiudere i conti in negativo, compromettendo la possibilità di avanzare
qualsiasi istanza di indipendenza. Gloria Riva su L’Espresso il 3 Febbraio 2023.
Il ministro Roberto Calderoli è
soddisfatto: giovedì il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge
sull'autonomia differenziata, che in teoria dovrebbe diventare legge entro la
fine dell'anno. Soddisfatto lo è anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, e
con lui brinda il presidente uscente della Lombardia, Attilio Fontana, che fra
una settimana potrà presentarsi alle elezioni regionali con lo scalpo di “Roma
ladrona” e il bottino dell'autonomia differenziata, sperando che questo basti
per portare la Lega almeno in doppia cifra: «Finalmente, l'abbiamo portata a
casa», par di sentirlo. Tenere al Nord i soldi del Nord è l'obiettivo della
vecchia Lega secessionista, che stavolta – verrebbe da dire - a furia di mirare
lontano non si è resa conto (o finge di non rendersi conto) del gigantesco
sgambetto che i palazzi romani stanno facendo proprio alle regioni del Nord sul
fronte economico.
Che c’entra la contabilità
ordinaria con l’autonomia differenziata? C’entra eccome, perché se le Regioni
del Nord non avranno i bilanci in ordine, difficilmente potranno presentare una
richiesta di autonomia differenziata. Ma andiamo con ordine.
È di un paio di settimane fa la
richiesta di un incontro urgente da parte delle Regioni - Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto in testa – per trovare una soluzione ai giganteschi
sforamenti di bilancio che soprattutto le regioni del Nord hanno fatto fra il
2020 e il 2022 per far fronte all'emergenza pandemica, accollandosi i costi di
vaccini, assunzioni straordinarie, dispositivi medici e tutto quello che è
servito per contenere la diffusione del Covid 19: «Questa situazione determinerà
conseguenze catastrofiche per il servizio sanitario pubblico che ha invece
urgenza di rivedere i modelli organizzativi per rafforzare e sviluppare
l'assistenza territoriale», scrivono le regioni al ministro dell'Economia, il
leghista Giancarlo Giorgetti, e al ministro della Salute Orazio Schillaci. Da
parte del governo nessuna risposta, ma nel frattempo le Regioni devono chiudere
i bilanci. Per ora dall'amministrazione centrale – a trazione per un terzo
leghista, ricordiamolo – arrivano solo spiccioli e, per esempio, alla Regione
Emilia Romagna i 207 milioni del governo per coprire gli extra costi del covid
non basteranno: «Il bilancio 2022 è stato chiuso in pareggio solo perché abbiamo
messo risorse nostre per il terzo anno consecutivo, o comunque risorse
straordinarie sbloccate negli ultimi giorni dell'anno», fa sapere l'assessore
alla Sanità dell'Emilia Romagna Raffaele Donini, che spiega come per la loro
regione i costi Covid non rimborsati per l'Emilia Romagna superano i 400 milioni
di euro, mentre le spese energetiche vanno oltre i 200 milioni. A livello
nazionale l'accollo regionale del post Covid è di oltre due miliardi di euro che
rischiano di mandare in piano di rientro (cioè in rosso) - e quindi di dover
tagliare la spesa - molte regioni. Insomma, se i governatori non riescono
neppure a portare a casa i quattrini che hanno dovuto spendere per far fronte
alla pandemia, figuriamoci come andrà a finire la partita dell'autonomia
differenziata, che implica bilanci regionali in ordine.
Così, mentre Calderoli
festeggia perché sulla carta ha portato a casa la promessa dell'autonomia
differenziata, sulla testa dei cittadini del Nord – nell'assoluto disinteresse
dei ministri - si sta concretamente per abbattere la scure dei tagli alla
sanità, come se la situazione degli ospedali non fosse già abbastanza
compromessa.
Altro che soldi al Nord,
l'intera riforma dell'Autonomia Differenziata rischia di tradursi nell'ennesima
batosta (fiscale) per i già tartassati cittadini e imprenditori.
Entrando nel dettaglio del
disegno di legge presentato al Consiglio dei ministri da Calderoli, il testo
lascia aperte ancora molte questioni cruciali, su tutte il palese tentativo di
scavalcare il ruolo del Parlamento, interpellato solo per un parere non
vincolate in una materia che dovrebbe stravolgere l'Italia. «Definire quella di
ieri una giornata storica, perché secondo molti esponenti della Lega sono
convinti di aver concluso il processo che porta all'autonomia differenziata, è
oggettivamente esagerato», commenta Paolo Balduzzi, economista dell'Università
Cattolica di Milano, che nel 2018 è stato consulente tecnico per la Presidenza
del Consiglio al tavolo di trattativa con le Regioni per la stesura delle intese
di autonomia differenziata con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Che
aggiunge: «Del resto sono altrettanto esagerati i commenti di alcuni esponenti
dell'opposizione che giudicano “eversiva” l'operazione in atto. Le criticità ci
sono: ma sembra che i toni sopra le righe servano soprattutto a condizionare
l'imminente campagna elettorale per le regionali».
Entrando nel merito dei 10
articoli, al primo punto si pone la priorità della determinazione dei Lep, i
livelli essenziali delle prestazioni: senza di quelli, non ci sarà alcun
autonomia differenziata. Se si pensa che i cittadini italiani attendono la
determinazione dei Lep da oltre vent'anni, è facile intuire che il percorso
dell'autonomia sarà più lungo del previsto. «Lo spirito della riforma dovrebbe
essere quello di innescare una competizione virtuosa tra le regioni, in grado di
fare di più e meglio dello stato centrale. Tuttavia, il pericolo è quello di
moltiplicare le burocrazie e i centri decisionali, di ingolfare le istituzioni
(e il paese) con regole troppo diverse da regione a regione, nonché di
alimentare un ulteriore sovrapposizione delle competenze tra stato e regione»,
avverte Balduzzi, che fa notare come l'intero asse decisione si muova tra
l'istanza di autonomia da parte di ciascuna singola Regione, le prerogative del
presidente del Consiglio, le disposizioni del Consiglio dei Ministri, i pareri
(non vincolanti) della Conferenza unificata, e la totale impossibilità per il
Parlamento di modificare la norma, che va approvata in toto o respinta, senza
poter proporre alcuna modifica. «Infine vale la pena ricordare che al momento
non esiste nemmeno un criterio oggettivo o tecnico per stabilire se una regione
sia o meno in grado di fare meglio dello stato negli ambiti di competenza che
saranno trasferiti. Come criterio minimo, bisognerebbe almeno richiedere alle
regioni che i conti siano in ordine», chiude Balduzzi. Dunque, un criterio
minimo per l'accesso all'autonomia differenziata dovrebbero essere i conti in
ordine. E già, peccato che i conti delle Regioni del Nord, gravati dagli extra
costi del Covid, siano parecchio in sofferenza. E allora addio autonomia
differenziata.
Estratto dell’articolo
da blitzquotidiano.it il 3 Febbraio 2023.
Il testo del disegno di legge
sulla Autonomia differenziata appena licenziato dal Governo ha cominciato il suo
iter parlamentare […] le opposizioni, compatte, ne denunciano il profilo
disgregante sul piano dell’unità nazionale e potenzialmente eversivo (è la
parola usata anche dalla Fondazione Gimbe), quando prefigura standard diversi
nell’offerta di diritti e servizi.
[…] Come la mettiamo in ambito
sanitario? Sembra lapalissiano, dati i livelli di sviluppo, ma a sud
l’aspettativa di vita è di gran lunga inferiore agli standard del nord.
“Un neonato di Firenze ha
un’aspettativa di vita di quasi quattro anni in più rispetto a uno di
Caltanissetta. Mentre un bambino nato nel 2021 in provincia di Bolzano ha una
speranza di vivere in buona salute per 67,2 anni, contro i 54,2 di uno nato in
Calabria”. Una constatazione non smentibile quella offerta dal presidente
dell’Ordine nazionale dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli. […]
“Tutte le persone sono uguali
davanti alla Repubblica – spiega Anelli – come recita l’articolo 3 della
Costituzione. E anche per la salute vale lo stesso: ad ogni persona presente sul
territorio nazionale, lo Stato garantisce il diritto alla salute. Ma il testo
che è stato presentato sull’autonomia differenziata, che esalta ovviamente il
ruolo delle Regioni, rischia di non essere un testo che aiuta a colmare le
differenze che, purtroppo, esistono sul territorio nazionale, le disuguaglianze
in tema di salute”. […]
La critica della Fondazione
Gimbe è ancora più netta. Un “colpo di grazia al Servizio sanitario nazionale e
la legittimazione normativa delle diseguaglianze nella tutela della salute”, ha
dichiarato il presidente Nino Cartabellotta, presentando il report ‘Il
regionalismo differenziato in Sanità’, chiede al governo di “espungere la sanità
dalle richieste di autonomia differenziata”.
Altre istanze, rileva
Cartabellotta, “risultano francamente ‘eversive’. Una maggiore autonomia in
materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi darebbe il via a
sistemi assicurativo-mutualistici regionali sganciati dalla, seppur frammentata,
normativa nazionale”.
Autonomia differenziata,
qual è il percorso? Le tappe dopo il via libera del governo. Lorenzo Salvia
su Il Corriere della Sera il 3 Febbraio 2023.
Un anno di tempo per concludere
l’iter: ogni singola regione che chiede più poteri dovrà stringere un’intesa con
il governo. Il nodo dei Livelli essenziali di prestazione
Secondo il governo, il sistema
dell’autonomia differenziata dovrebbe essere operativo tra circa un anno. È una
previsione ragionevole?
In linea di principio sì,
secondo Ernesto Bettinelli, professore emerito di Diritto costituzionale
all’Università di Pavia, che oggi nello stesso ateneo insegna Storia
costituzionale. Quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei
ministri non è un disegno di legge costituzionale, che avrebbe tempi di
approvazione più lunghi, con la doppia lettura e la possibilità del referendum.
Anche se adesso, dopo il via libera di due giorni fa, serve il parere della
Conferenza unificata e poi un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri. È vero
che ormai in Parlamento arrivano soprattutto decreti legge, che hanno una corsia
preferenziale vista la necessità di essere convertiti entro 60 giorni. Ma i
tempi ci sono. Specie considerando l’ampio margine che, in questo momento, la
maggioranza ha in Parlamento.
Saranno necessarie intese con
le singole regioni che sceglieranno di ampliare le loro competenze. Questo può
essere un ostacolo che rallenta il processo?
È la strada giusta da seguire,
in base all’articolo 116 della Costituzione. La Regione presenta una richiesta,
si raggiunge un’intesa con il governo e infine serve un voto del Parlamento. Una
procedura da ripetere per ogni Regione che deciderà di avere più autonomia.
Quantificando la parte dell’imposizione nazionale che le singole regioni devono
trattenere pro quota per far fronte alle competenze aggiuntive. Un processo
complesso ma fattibile. E comunque ineludibile.
Prima però andranno definiti i
Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, per fissare una base minima di
servizi in tutto il Paese, materia per materia. Anche questo passaggio è
compatibile con l’obiettivo di concludere il processo nel giro di un anno?
Se ne occuperà una commissione
paritetica fra Stato e Regioni, con il supporto di una cabina di regia, composta
da esperti nelle varie materie. Il processo è complesso, anche perché si dovrà
comunque tenere conto di un Paese con marcate e storiche differenze in tanti
settori. Ma mettere sulla carta i livelli essenziali delle prestazioni è
comunque un’operazioni possibile. Quello che appare molto più complesso, semmai,
è il successivo rispetto dei Lep.
Perché sarebbe difficile il
successivo rispetto dei Lep?
Ci sono regioni che non
avrebbero nemmeno bisogno dei Lep, perché il loro il livello dei servizi è alto.
E altre che rischierebbero di partire e restare al di sotto della soglia minima.
Senza risorse aggiuntive è difficile che le Regioni in difficoltà recuperino
terreno.
Il testo parla di invarianza di
spesa. Vuol dire che le risorse aggiuntive non ci saranno?
Non è detto. Quelle sono le
risorse totali, la torta nel suo complesso. Il punto vero è come saranno
tagliate e distribuite le fette. In linea di principio una redistribuzione delle
risorse ci può essere anche con l’invarianza di spesa. Quando la Germania
affrontò il problema della riunificazione si pose lo stesso problema e decise di
trasferire ingenti risorse da Ovest verso Est.
Cos'è l'autonomia
differenziata approvata dal governo Meloni e cosa prevede Redazione
idealista.it il 3 Febbraio 2023.
Il Cdm di Meloni ha approvato
il testo del ddl sull'autonomia differenziata a punto dal ministro degli Affari
Regionali Roberto Calderoli. Ma vediamo qual è il significato, che
cos'è l'autonomia differenziata, cosa prevede e soprattutto quali saranno le
conseguenze per la gestione delle regioni di materie importanti come la scuola o
la sanità. Diverse le reazioni dopo l'approvazione, da quella positiva del
presidente del Veneto, Zaia, alle critiche di Bonaccini e De Luca, che
sottoliano i contro più che i pro.
L'Autonomia
differenziata consentirà alle regioni a statuto ordinario di chiedere allo Stato
la possibilità di legiferare su materie non di potestà esclusiva dello Stato, si
tratta appunto di materie delicate come la sanità, l'istruzione, la tutela
dell'ambiente o la produzione dell'energia. Ad essere escluse saranno le regioni
a statuto speciale, ovvero Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige e Valle d'Aosta.
Autonomia differenziata, il
testo del ddl Calderoli
Il procedimento di
approvazione delle intese tra Stato e regioni e la loro durata
Le materie e gli ambiti in cui
si possono siglare le intese tra Stato e regioni
I livelli essenziali delle
prestazioni (LEP)
Le risorse e le garanzie su
coesione e perequazione tra le regioni
Le parole di Meloni
sull'autonomia differenziata
La risposta delle regioni, dal
Veneto alla Campania di De Luca
Autonomia differenziata, il
testo del ddl Calderoli
Ill testo del ddl Calderoli che
contiene l'autonomia differenziata testo provvede alla definizione dei “principi
generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di
approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.
Il procedimento di
approvazione delle intese tra Stato e regioni e la loro durata
In merito al procedimento di
approvazione delle “intese”, si stabilisce che la richiesta deve essere
deliberata dalla regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo,
acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro
dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il
negoziato con la Regione interessata. Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e
regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei
ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro
trenta giorni.
Trascorso tale termine viene
comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi
parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi
regolamenti, entro sessanta giorni. Il Presidente del Consiglio o il Ministro
predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un
ulteriore negoziato. Lo schema è trasmesso alla regione interessata per
l’approvazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da
parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione
tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge
di approvazione da presentare alle Camere.
L’intesa è immediatamente
sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della
Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa è allegata, è
richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Nelle intese sarà specificata
anche la durata delle stesse, che comunque non potrà superare i dieci anni.
L’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e può
prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne
la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla
scadenza del termine, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo
diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima
della scadenza.
Le materie e gli ambiti in cui
si possono siglare le intese tra Stato e regioni
Le materie sulle quali potranno
essere raggiunte le intese tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario per
l’attribuzione, alle regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia sono elencate all’articolo 117 della Costituzione. Si tratta
prevalentemente delle materie relative alla legislazione concorrente.
I livelli essenziali delle
prestazioni (LEP)
Il provvedimento stabilisce che
l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita
subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023. Il
finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sarà
attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell’articolo 17 della legge
di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Qualora dalla determinazione
dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si
potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai
provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Qualora, successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano
modificati i LEP con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori,
la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla
revisione delle relative risorse. Il Governo o la regione potranno, anche
congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei
livelli essenziali delle prestazioni.
Il trasferimento delle funzioni
non riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie,
potrà essere effettuato fin dalla data di entrata in vigore delle intese, nei
limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
Le risorse e le garanzie su
coesione e perequazione tra le regioni
Il disegno di legge stabilisce
che l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di
conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che
procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni
regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi
all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica
e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.
Il finanziamento delle funzioni
attribuite avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi
erariali a livello regionale, con modalità definite dall’intesa. Le funzioni
trasferite alla regione potranno essere da questa attribuite a comuni, province
e città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e
finanziarie. Le intese, in ogni caso, non potranno pregiudicare l’entità delle
risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.
Inoltre, sarà garantita
l’invarianza finanziaria del fondo perequativo e delle altre iniziative previste
dall’articolo 119 della Costituzione per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Allo
scopo di rafforzare tali iniziative e di garantire un utilizzo più razionale,
efficace ed efficiente delle risorse ad esse destinate, il disegno di legge
prevede l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di
finanziamento statale di conto capitale, la semplificazione e l’uniformazione
delle procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di
rendicontazione. Saranno garantiti gli specifici vincoli di destinazione e la
programmazione già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme.
Le parole di Meloni
sull'autonomia differenziata
Dopo l'approvazione nel CDM del
ddl sull'autonomia differenziata, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha
diffuso una dichiarazione a mezzo stampa. "Con il disegno di legge quadro
sull'autonomia - ha detto- puntiamo a costruire un' Italia più unita, più forte
e più coesa.
Il Governo avvia un percorso
per superare i divari che oggi esistono tra i territori e garantire a tutti i
cittadini, e in ogni parte d'Italia, gli stessi diritti e lo stesso livello di
servizi. La fissazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, in questi anni
mai determinati, è una garanzia di coesione e unità. Un provvedimento che
declina il principio di sussidiarietà e dà alle Regioni che lo chiederanno una
duplice opportunità: gestire direttamente materie e risorse e dare ai cittadini
servizi più efficienti e meno costosi.
La risposta delle regioni, dal
Veneto alla Campania di De Luca
Le regioni vanno in ordine
sparso dopo l'approvazione del ddl sull'autonomia differenziata. Il
presidente della regione Veneto, Luca Zaia, parla di "una giornata storica. Oggi
diamo corso alla volontà dei Padri Costituenti che scrissero la Carta
Costituzionale in vigore dal'48".
Diverso il parere
del presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano
Bonaccini, che parla di una riforma "irricevibile". Dello stesso avviso anche il
presidente della Campania, Vincenzo De Luca, "Non si sfugge alla sensazione che
questo rilancio dell'autonomia differenziata i modo così affrettato e
ideologizzato risponda a esigenze politiche di partito e a scadenze elettorali a
breve"
Autonomia differenziata, una
scommessa rischiosa e perdente. Il disegno scommette, sul piano
macroeconomico, sull’accelerazione dell’Italia a doppia velocità ma vi sono
ottime ragioni per ritenere il piano governativo fallimentare. Guglielmo Forges
Davanzati su la Gazzetta del Mezzogiorno il 05 Febbraio 2023.
L’approvazione, in Consiglio
dei ministri, con applausi, del progetto di autonomia differenziata costituisce
il primo passaggio di un ridisegno istituzionale della ripartizione dei poteri
sul territorio che vedrà la fine fra due anni, se non ci saranno intoppi. Il
processo è iniziato con il negoziato con il Governo Gentiloni da parte di
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nell’ottobre 2017, con referendum consultivi,
in quelle Regioni, risultati vittoriosi. Dopo la bozza Calderoli, lo scorso 3
febbraio si è approvato un documento che rinvia all’attuazione del regionalismo
differenziato, con la clausola di salvaguardia allargata (le singole intese non
dovranno comportare costi addizionali per lo Stato). Si tratta di un disegno che
scommette, sul piano macroeconomico, sull’accelerazione dell’Italia a doppia
velocità, che però ben difficilmente potrà realizzarsi. Vi sono ottime ragioni,
cioè, per ritenere il disegno governativo fallimentare. Vediamo perché.
1) Il trasferimento di poteri
alle Regioni dovrebbe comportare, nelle intenzioni dei promotori, maggiori
risorse in loco e, per conseguenza, maggiore produzione nei territori ora già
più ricchi, con la previsione - nella nuova bozza del febbraio 2023 - della
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e di un fondo
perequativo per il Mezzogiorno. Per la decisione del 3 febbraio scorso, i LEP
saranno definiti attraverso un DPCM da una commissione tecnica con la Legge di
Bilancio 2023, non dal Parlamento. I DPCM sono atti amministrativi impugnabili
al TAR e non davanti alla Corte costituzionale. Il dispositivo individuato dal
Governo si fonda sulla convinzione stando alla quale le regioni ora più ricche
potranno ancor più agganciare le loro economie al traino tedesco. Già ora - è
vero - un segmento importante del Pil del Nord è generato in regime di
subfornitura, attraverso, cioè, produzioni intermedie (si pensi alla
componentistica auto). Questa scommessa è estremamente rischiosa dal momento che
rompe il patto implicito che ha tenuto in vita il Paese - non a caso, «Gazzetta»
ha fatto riferimento al pericolo di fine dell’Unità nazionale - cioè di un Nord
produttore e un Sud consumatore, dal momento che aggancia il Nord alla Germania
assumendo che quest’ultima cresca senza attraversare cicli recessivi e, infine,
dal momento che ignora la circostanza che la crescita economica del Nord Italia
presuppone anche un certo controllo sulle politiche fiscali, che, ovviamente, le
regioni del Nord non avrebbero rispetto ai Paesi - sovrani - del centro d’Europa
con i quali intrattengono maggiori transazioni commerciali. Dunque, l’autonomia,
nel medio-lungo termine, potrebbe non convenire neanche ai suoi promotori,
troppo miopi e troppo sedotti dalla retorica politica per accorgersene ora.
2) Il Sud è ancora, anche se
meno rispetto al passato, un importante mercato di sbocco per le produzioni del
Nord. Infatti, sono ancora elevati i valori dei moltiplicatori fiscali
interregionali cumulati, ovvero dei coefficienti che stimano di quanto aumenta
il Pil nazionale a seguito di un aumento di 1 euro al Sud. Resta vero che se lo
Stato italiano versa trasferimenti nel Mezzogiorno, i consumi che si attivano
producono un aumento più che proporzionale della ricchezza generata in Italia.
Potrebbe essere sufficiente questo dato per sconsigliare processi di
regionalizzazione. Vi è da aggiungere che la previsione dei LEP difficilmente
troverà piena attuazione. Innanzitutto, infatti, va chiarito che i LEP non sono
puro fatto tecnico, come implicitamente suggerito dal Ministro Calderoli (che,
ingannevolmente, ne demanda la quantificazione a una cabina di regia svincolata
dal dibattito parlamentare), bensì sono un prodotto squisitamente politico:
infatti, la loro quantificazione - che attiene, lo si ricordi, a servizi
considerati essenziali da distribuire in modo uguale e uniforme sul territorio
nazionale nella sua interezza - richiede finanziamenti e questi ultimi, essendo
impossibili scostamenti di bilancio in questa fase storica, rinviano a scelte
politiche sulle cosiddette «coperture».
Secondo alcune stime
approssimative e preliminari, riferite dal Governatore Emiliano alla stampa,
occorrono almeno 50-60 miliardi di euro per finanziare livelli di prestazioni
oggi uniformi sul territorio nazionale, a partire da sanità e scuola. Sembra un
calcolo approssimato per difetto, ma sarebbe opportuno un piano di riferimento
comune formale per alimentare un dibattito realmente costruttivo, nello spirito
del «conoscere per deliberare».
La questione è estremamente
seria nella Sanità in particolare, come messo in evidenza nel recentissimo
Report dell’Osservatorio GIMBE («Il regionalismo differenziato in sanità»,
1/2023). Si parte dal dato per il quale i LEA esistenti - livelli essenziali di
assistenza - sono rispettati quasi al 100% nelle regioni del Nord (e in Toscana)
e per una percentuale bassissima nelle Regioni del Sud. Si aggiunge che, su
fonte Corte dei conti, la mobilità sanitaria interregionale configura vere e
proprie fughe dal Sud estremamente costose, sia in termini diretti (i costi
della mobilità), sia in termini indiretti (perdita di ore lavorate). Si
considera che il regionalismo differenziato comporterà maggiori assunzioni di
personale nelle strutture sanitarie del Nord e, per conseguenza, un
approfondimento delle distanze. I costi sono altissimi per le famiglie italiane
residenti nel Mezzogiorno ma, purtroppo, a quanto pare, il loro livello di
consapevolezza degli scenari imminenti è particolarmente basso.
I sindaci del Sud a Napoli
per dire no all'«Autonomia differenziata». Chiediamo che tutti i referenti
delle Anci e delle Leghe delle autonomie locali del Mezzogiorno si raccordino
per far sentire il loro dissenso nei confronti di una riforma che potrà solo
peggiorare le diseguaglianze che condannano da decenni il nostro Sud. Redazione
online su la Gazzetta del Mezzogiorno il 05 Febbraio 2023.
I sindaci del Sud uniti per
dire no all'Autonomia. «L'Associazione dei Sindaci del Sud Italia Assi- Recovery
Sud, invita tutti i primi cittadini, i parlamentari, i presidenti di Regione e i
consiglieri regionali il 17 marzo, in occasione del 162esimo anniversario
dell'Unità d'Italia, a Napoli per una grande manifestazione di protesta contro
l'autonomia differenziata - scrivono in una nota - nel frattempo aderiamo a
tutte le iniziative contro la riforma che si stanno svolgendo in Italia, a
partire dalla manifestazione promossa dalla Cgil sabato a Bari o alle altre
iniziative che si stanno organizzando nell'Agrigentino e in altre città del
Meridione». «Chiediamo che tutti i referenti delle Anci e delle Leghe delle
autonomie locali del Mezzogiorno si raccordino per far sentire il loro dissenso
nei confronti di una riforma che potrà solo peggiorare le diseguaglianze che
condannano da decenni il nostro Sud, e riteniamo che sia il superamento di
questi divari, e non l'autonomia differenziata, la vera priorità che il governo
debba affrontare in questo momento. Rivolgiamo questo appello anche a tutte le
associazioni, agli studenti universitari e delle scuole superiori e alle forze
politiche che sposano il nostro punto di vista. E invitiamo tutti a sostenere la
petizione organizzata dall'associazione giovanile "Facciamoci sentire" di Santo
Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento», concludono.
Sallusti e l'autonomia:
trionfo leghista e affare per il Sud. Alessandro Sallusti su Libero
Quotidiano il 03 febbraio 2023
Il Consiglio dei ministri ha
approvato il primo passo – di un percorso che non sarà breve – della riforma che
dovrebbe portare a una maggiore autonomia delle Regioni rispetto allo Stato
centrale. Il merito principale, indubbiamente, è di Matteo Salvini e della Lega
che da anni – meglio dire da sempre – inseguono questo progetto con maggiore
convinzione e determinazione dei suoi alleati. L’argomento non è tra quelli di
semplice comprensione per la gente comune, in pratica l’autonomia differenziata
– questo è il cuore della legge – permetterà a ogni Regione di sfruttare al
meglio le proprie potenzialità e ampliare i suoi poteri su settori, per esempio
la scuola, oggi di stretta competenza dello Stato.
L’Italia, a differenza di
quanto sostengono le opposizioni, resta e resterà una, indivisibile e solidale
al suo interno. E non è vero che la possibilità delle Regioni di correre a
differenti velocità in alcuni campi porterà ad aumentare il divario tra Nord e
Sud. Semmai è l’inverso: a velocità costante per tutti chi oggi è dietro non
avrà mai alcuna possibilità di accorciare le distanza, e viceversa con i limiti
di velocità imposti oggi chi è davanti si trova impossibilitato a crescere
ulteriormente.
Si prende atto insomma che, per
fare un esempio, la Basilicata e la Lombardia non sono la stessa cosa, hanno
ovviamente necessità diverse e diverse priorità, si muovono su differenti
contesti economici e sociali e con la riforma ognuno potrà spingere là dove
riterrà di poter avere maggiori benefici. L’approvazione di questa riforma
dimostra poi un’altra cosa e mi riferisco alla felice intuizione di Matteo
Salvini a fare uscire la sua Lega dai recinti del Nord, cosa che come 7 noto ha
provocato di recente qualche mal di pancia nella vecchia base di stretta fede
bossiana da sempre scettica a mettere il naso fuori dalla Padania. Perché se si
vuole davvero incidere sulle scelte politiche che più ti stanno a cuore, tipo
appunto l’autonomia regionale, non basta il consenso poco o tanto che sia di una
sola parte sia pure importante del paese. Nell’Italia “una e indivisibile” le
questioni si decidono non nelle piazze, non con gli slogan bensì stando nel
parlamento nazionale e nel governo centrale con un peso e una autorevolezza
adeguati.
Il sì del Cdm. Autonomia
differenziata, la destra parla di nazione e sovranismo ma poi fa a pezzi
l’Italia. Aldo Torchiaro su Il Riformista il 3 Febbraio 2023
Dal sovranismo della Nazione
all’autonomismo regionale spinto. E pazienza se sono l’esatto opposto.
Nell’ottovolante del centrodestra si deve concedere qualcosa a ciascuno pur di
avere il sostegno di tutti alla grande riforma che Giorgia Meloni ha in
cantiere. Il Ddl Autonomia differenziata che ieri il Consiglio dei Ministri ha
approvato all’unanimità e con un grande applauso finale arriva giusto in tempo
per le elezioni regionali lombarde.
La misura di bandiera
della Lega scontenta il Centrosud e apre ad incognite di ogni tipo per i
passaggi istituzionali ora necessari, ma poco importa. È un vessillo, e come
tale va agitato, a partire dalle piazze elettorali. Il testo approvato ieri
dal Cdm prevede che su molte materie, tra cui alcune delicatissime e
strategiche, le Regioni possano chiedere l’autonomia. Tra queste: istruzione,
sanità, produzione di energia e tutela dell’ambiente. La criticità irrisolta
del disegno di legge sull’autonomia riguarda i livelli essenziali di prestazione
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (Lep), che secondo
la Costituzione riguardano “i diritti civili e sociali” dei cittadini.
La loro entità andrebbe
stabilita prima delle richieste di autonomia differenziata, così da sapere la
quantità di risorse da erogare a ciascuna regione richiedente. E infatti la
proposta di Calderoli dice che entro un anno dall’entrata in vigore della legge
devono essere decisi i Lep con un Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm).
Vulnus su cui il legislatore dovrà intervenire: si tratta infatti, malgrado la
fanfara della maggioranza, solo di un primo testo. L’iter di approvazione
dell’intesa prevede che sia la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, entro
un mese, a dare un responso. Che andrà poi elaborato dai due rami del
Parlamento, con le rispettive commissioni di Camera e Senato. Quindi il testo
dovrà tornare a Palazzo Chigi, che avrà ulteriori trenta giorni per lavorarci
su. Una road map di cui non tengono conto le dichiarazioni trionfalistiche
del centrodestra. La premier ci mette il cappello per prima: “Coerenti con il
mandato dei cittadini”.
La scuola secondo Valditara,
stipendi differenziati su base regionale: il ministro rispolvera le “gabbie
salariali”
Per il leghista Centinaio “È
una svolta storica, il primo atto dell’Italia federale”. Stessa esultanza
per Luca Zaia: “Un successo realizzato in soli cento giorni di governo”. Piano:
di realizzato c’è ancora poco. Lo fa notare Carlo Calenda: “Questa roba arriva
in parlamento fra 6 mesi. Ma lo approvano di corsa e male la settimana prima
delle elezioni regionali”. Dal Pd è una levata di scudi. “Si convochi subito la
conferenza Stato-Regioni”, esorta Elly Schlein. “Italia della Meloni aumenta il
divario tra Nord e Sud”, tira le somme il responsabile autonomie del Pd, Piero
De Luca. “In un Paese dove i diritti non sono ancora per tutti, l’Autonomia
differenziata servirà solo ad aumentare le disuguaglianze”, sintetizza Paola De
Micheli. La capogruppo al Senato del M5S se la prende con l’accordo di
maggioranza del Presidenzialismo in cambio dell’Autonomia differenziata: “Adesso
Salvini sarà contento e non metterà ostacoli sulla strada del presidenzialismo.
È questo il senso delle istituzioni di Giorgia Meloni: scambia le riforme per
una partita a figurine”.
Versa acqua sul fuoco il
governatore ligure Giovanni Toti: “Già oggi i Lep che questo Paese offre ai suoi
cittadini non sono gli stessi, se no facciamo una finzione dicendo che in alcune
zone del Nord e del Sud i cittadini hanno uguali diritti sociali. Non
prendiamoci in giro”. Ma come interverrebbe nel riequilibrare le distanze
l’Autonomia differenziata? Economisti, tecnici ed esperti sono scettici. Il
direttore dello Svimez, Luca Bianchi, ha avversato pubblicamente la riforma. La
Voce.info ha raccontato le contrarietà di alcuni tra i più autorevoli
economisti. E anche all’interno della maggioranza sembrerebbero nascondersi
delle crepe. Forza Italia è tiepida. La sottosegretaria ai Rapporti con il
Parlamento non nega una certa dialettica, quando dice che questo testo è frutto
di emendamenti di FI che lo hanno reindirizzato. “Nella nuova bozza della
riforma Calderoli sono presenti tanti nostri contributi”.
Aldo Torchiaro. Ph.D. in
Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di
attualità e politica con interviste e inchieste.
Tanto parlare di Patria. E
adesso? Qui si disfà l’Italia o si muore. Parafrasando la celebre frase di
Giuseppe Garibaldi, ecco l’amara sintesi del Consiglio dei Ministri di ieri.
Oscar Iarussi su La Gazzetta del Mezzogiorno il 03 Febbraio 2023
Qui si disfà l’Italia o si
muore. Parafrasando la celebre frase di Giuseppe Garibaldi, ecco l’amara sintesi
del Consiglio dei Ministri di ieri. In preda a una fretta degna di altre cause,
il Governo ha approvato il disegno di legge sull’«autonomia differenziata» del
ministro per gli Affari regionali, il leghista Roberto Calderoli. Approvazione,
riferisce l’Ansa, avvenuta tra gli applausi. Tornano insomma le stagioni
della devolution cara a Umberto Bossi, oltre vent’anni dopo la discussa riforma
del Titolo V della Costituzione (2001) e a tre anni dall’inizio della pandemia
che ha dimostrato quanto invece sia necessaria una salda guida unitaria. Va in
porto la possibilità che alle regioni a statuto ordinario vengano attribuite, in
via esclusiva, competenze su un ampio spettro di materie. L’economista barese
Gianfranco Viesti ne ha elencate ventitré: da scuola e università a sanità e
trasporti, da ambiente ed energia a lavoro e immigrazione...
Esulta la Lega di Salvini, che
non ha mai dismesso la vocazione padana delle origini, e con essa gioiscono le
regioni che più hanno spinto per l’autonomia: Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna. Presto potrebbero altresì trattenere i singoli gettiti fiscali da
spendere in loco, sui rispettivi territori. Chi è ricco, diventerà più ricco.
Chi è povero, diventerà più povero. Di fatto il disegno di legge Calderoli dà il
la a una musica ribalda: la frammentazione di un Paese in cui lo storico divario
Nord-Sud non è mai stato colmato, anzi, negli ultimi decenni si è allargato. A
proposito del presunto meccanismo di garanzia offerto, solo sulla carta, dai Lep
(i livelli essenziali di prestazione), ha detto bene ieri il presidente pugliese
Michele Emiliano: «I Lep non basta scriverli. Bisogna investire 60-70 miliardi
di euro in personale e infrastrutture, per consentire al Sud di arrivare ai
livelli del Nord».
La fretta, dicevamo. Secondo
taluni sarebbe stata dettata dal bisogno della Lega di sventolare un vessillo in
vista delle elezioni in Lombardia del 12 e 13 febbraio, recuperando consensi
nell’ambito della coalizione di centrodestra data per favorita. Tanto plausibile
quanto assurdo, non credete? Ma sono corresponsabili i partiti di opposizione,
il Pd in primis, troppo preso dallo psicodramma congressuale per valutare il
pericolo incombente. Mentre la «grande stampa» del Nord e la Tv semplicemente
parlano poco o nulla di autonomia differenziata, preferendo il ciacolaio sul
caso Soumahoro o attualmente sull’allarme-anarchici (pare di esser tornati a
fine ‘800).
Il trasferimento dei poteri è
già un vulnus per l’idea stessa d’Italia. È un’offesa concreta e simbolica al
futuro di una nazione europea che aspira, o dovrebbe aspirare, ad allargare gli
orizzonti piuttosto che a restringerli in localismi fobici. Già, la Lega nei
suoi esordi si giovò del legittimo sdegno per Tangentopoli («Roma ladrona»), ma
anche del panico del Nord di non farcela ad entrare nel mercato comune europeo,
come scrisse Piero Bassetti (L’Italia si è rotta? Un federalismo per l’Europa,
Laterza 1996). Non capiamo invece l’avallo di Forza Italia e di Fratelli
d’Italia, gli altri due partiti oggi al Governo, e in particolare non capiamo la
premier Giorgia Meloni. Figlia di una cultura politica comunitarista, esponente
della destra sociale e «patriottica» da sempre centralista (lo ha ricordato
Adriana Poli Bortone su queste colonne), Meloni ha rinverdito nel dibattito
pubblico il termine «nazione». L’«idea di nazione» è cruciale, diremmo con il
titolo di un classico dello storico Federico Chabod che guardava all’equilibrio
tra i caratteri profondi del paese e l’anelito europeo.
Non è un dogma, l’Italia. Caso
mai è riconoscersi in una luce, in un patto mai urlato eppur stretto da uomini e
donne, tra monti e mari; tra Cavour e Garibaldi, se volete. E ora? Tanto parlare
di patria per poi minarla alle radici?
Ma la riforma può essere uno
schiaffo benefico per la borghesia sudista. L’autonomia differenziata è una
provocazione che potrebbe arginare questa politica culturale di elemosinare dal
governo centrale aiuti e sostegni
Umberto Sulpasso, Senior Fellow
Center for Digital Future Annenberg School of Communication University of
Southern California, Los Angeles United States, su La Gazzetta del Mezzogiorno
il 06 Febbraio 2023
Non ci sono dubbi che frutto
della conquista delle Due Sicilie e annessi della casa Savoia è stato quello di
trasformare il Sud in terra di raccolta di mano d’opera a basso costo – a volte
bassissimo - per alimentare lo sviluppo industriale del Nord. Terra di conquista
e non di unità nazionale, il serbatoio meridionale di mano d’opera a costi
bassissimi andava mantenuto in uno stato di sottosviluppo per produrre Fiat
competitive con i mercati nazionali e internazionali. E così fu. Il meccanismo
voluto del sottosviluppo meridionale si ampliò a macchia d’olio sulle
istituzioni civili, tribunali, amministrazioni locali, scuole, ospedali,
università, squadre di calcio, giornali sostenuto da un sistema di elargizioni
elemosiniere della struttura centrale che ha provocato un danno culturale anche
peggiore di quelli materiali: il sud ha inventato il meccanismo del piangersi
addosso. Meccanismo che si riproduce purtroppo grazie alla cd middle class
culturale, eccellente ma non produttiva.
Negli Usa la middle class è
stata il risultato di una crescita di redditi di lavoratori di basso profilo
diventati ricchi che volevano diventarlo sempre più. Come? Continuando a
inventare e produrre. Nel sud la middle class professionale – avvocati, medici,
docenti universitari – non si è mai legata alla imprenditoria locale che
direttamente o indirettamente nata da elargizioni di spesa pubblica. I buoni
imprenditori ci sono anche da noi. Gente in grado di innovare, creare attività.
Ma nessuno di essi riesce a diventare grande imprenditore perché sommersi
dall’atmosfera generale del piangersi addosso: male supremo del sud, autentico
virus che infetta tutta la società meridionale e che oggi riceve uno schiaffo a
mio avviso benefico dalla Autonomia differenziata. Personalmente nulla può
distinguermi maggiormente da un punto di vista culturale, di etica di governo,
ma anche delle straordinarie miopie antiquate economiche, dalla Lega che
aggredisce l’Europa. Ovvero ipotizza una codificazione sciocca di una Italia
strutturalmente spaccata in due. Ma ciò debitamente premesso sono personalmente
contento che sia passata l’idea dell’autonomia differenziata perché è una
provocazione che potrebbe arginare questa politica culturale di elemosinare dal
governo centrale aiuti e sostegni. L’Europa si deve trasformare in una
federazione di Stati, se vuole sopravvivere alle sfide Usa-Cina in cui la Russia
rischia di essere balcanizzata come successe alla Jugoslavia. E l’Italia deve
trasformarsi in una federazione di regioni, come di fatto è la Germania, se
vuole avere un ruolo vero nell’immenso territorio che sono il retroterra del suo
vero sviluppo: Mediterraneo e Africa. Invece di piangersi addosso bisogna
accettare la sfida della autonomia differenziata che è l’unica che può porre un
argine alla mortale emigrazione delle menti giovanili. Ci sono due esempi che mi
fanno pensare che questo sarebbe possibile. Ambedue vengono dalla Campania. Il
governatore di quella regione è da tempo il personaggio di maggiore qualità
operativa e culturale del partito degli ex (ex Pci, ex Pds, e forse ora ex Pd).
Immortalato settimanalmente dal genio socio culturale comico di Crozza che, come
avviene per Feltri, Zaia, Renzi etc interpetra i personaggi meglio degli
originali, dietro la vis comica è evidente che De Luca possiede una forza
costruttiva che purtroppo manca ai leader Pd. De Luca non si piange addosso.
Critica, condanna, difende il Sud, ma sempre proponendo iniziative, e
realizzandole. Ignoro le dinamiche politiche interne bizantine del Pd, ma De
Luca sarebbe stato un eccellente segretario Pd. Il migliore possibile. Certo
meglio di una Schlein che prova ogni potenziale risvolto mediale per affermarsi,
ma non da garanzie di niente, anche se ha fatto campagna elettorale per Obama,
cosa di cui tutto sottolineato non vale la pena evidenziare. E mentre Emiliano
non ha voluto cimentarsi, chissà perché, mi auguro che Bonaccini, voglia fare di
De Luca un pilastro della sua segreteria.
Poi c’è Aurelio De Laurentis.
Col Napoli si avvia a vincere uno scudetto sintomatico del non piangersi
addosso. Bilanci positivi, giocatori strapagati lasciati andare via, allenatore
ideale per gestire un parco di bravi giocatori, ma non stelle (Spalletti a
differenza di Ancelotti con le star non va mai d’accordo. Lui voleva insegnare a
Totti come si gioca al calcio…): il Napoli che vince senza Maradona è un ottimo
esempio del sud che non si piange addosso. Il virus di una eccellente middle
class culturale meridionale che non riesce a sostenere l’imprenditorialità che
esiste, brava, ottima, e non la fa decollare: perché si piange addosso.
Apprezzo di questo governo
l’autonomia differenziata. Spero sia quel ceffone che risveglia istinti
culturali costruttivi. Perché après ca, le deluge. Se la nostra cultura
meridionale non la smette di piangersi addosso, il sud invecchierà perdendo
tutte le migliori forze giovanili che andranno a rendere più ricche le autonomie
del nord.
“Altro che autonomia è il
federalismo fiscale la vera svolta per il Paese”. Edoardo Sirignano su
L’Identità il 6 Febbraio 2023
“Non comprendo la polemica dei
presidenti delle Regioni del Sud. L’Autonomia si farà solo quando verranno
definiti i livelli essenziali delle prestazioni, su cui non ci potranno essere
differenze”. A dirlo il noto costituzionalista Giovanni Guzzetta.
Cosa ne pensa dell’ultima
riforma voluta dal ministro Calderoli?
È un’iniziativa che riprende
tentativi già compiuti nel passato per l’attuazione di un articolo della
Costituzione approvato ventidue anni fa. Mi sembra, quindi, un qualcosa di
doveroso.
I governatori del Sud, intanto,
sono pronti a scendere in piazza contro un provvedimento, che a loro parere,
penalizzerebbe il Mezzogiorno…
Francamente non capisco la loro
polemica. Il progetto, che è stato approvato, prevede una condizione che
dovrebbe tranquillizzare tutti e cioè che l’autonomia si farà solo nel momento
in cui verranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni, che dovranno
essere assicurati su tutto il territorio nazionale, sia per quanto concerne la
competenza dello Stato che delle Regioni.
La verità è forse che tanta
agitazione è dovuta al fatto che stiamo parlando di chi a causa dell’improvvisa
crisi e perché no anche di scelte sbagliate si ritrova le casse vuote…
Il problema c’è sia quando si
tende ad accentrare che decentrare. È una difficoltà generale, che si pone
qualunque sia il margine di autonomia. Tutto ciò, quindi, non c’entra nulla col
dibattito in corso negli ultimi giorni.
Su quali aspetti del testo
occorrerebbe lavorare?
Sicuramente sull’attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione che prevede il federalismo fiscale, che è
un’altra norma, completamente inattuata. Stiamo parlando di un’iniziativa che
deve essere a tre teste: la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni, il compimento del federalismo fiscale e l’autonomia differenziata.
Quest’ultima è prevista dalla Costituzione e le Regioni hanno il diritto di
chiederla. Lo Stato, poi, deve valutare politicamente, con una deliberazione del
Parlamento, se e quanto concedere.
Quale la sua idea, invece,
rispetto al presidenzialismo tanto voluto da Giorgia Meloni?
Ritengo che non esistono
ragioni che consentano di difendere l’esistente e quindi è necessario andare
verso una riforma che dia maggiore efficienza alla macchina di governo. Penso
che il presidenzialismo sia il modello che più si adatti all’Italia per svariate
ragioni. La prima è che è stato adottato in Paese come la Francia, che aveva
esattamente gli stessi nostri problemi e li ha risolti sessanta anni fa. Questo
modello, poi, consente di coniugare una stabilità del ruolo di colui che deve
garantire il buon funzionamento del sistema, cioè il Presidente della
Repubblica, conservando la logica del sistema parlamentare. Le alternative, dal
punto di vista della praticabilità, mi sembrano molto più complicate.
Su tali temi dovrebbe esserci
una maggiore collaborazione tra maggioranza e opposizioni? Magari si può
riprendere lo strumento della Bicamerale?
La storia di quaranta anni di
fallimenti ci insegna che non basta la collaborazione. Ci vorrebbe altro.
Sostengo da tempo che debba esserci un referendum che permetta ai cittadini di
scegliere il modello che preferiscono, spingendo così le forze politiche ad
arrivare a un risultato. Il problema non è la sinergia, che in passato c’è
stata, ma il fatto che malgrado la collaborazione le riforme falliscono. È
indispensabile un vincolo esterno rappresentato da una spinta popolare, proprio
come accaduto in Italia in occasione del referendum tra monarchia e repubblica.
Altro argomento dibattuto negli
ultimi giorni è il ritorno degli anarchici. Rappresentano davvero una minaccia?
Non ho elementi per fare una
valutazione di questo tipo. Occorre basarsi su informazioni e attività di
accertamento che sono deputate alle forze di polizia, alla magistratura, al
ministero dell’Interno.
Ha, però, una sua particolare
idea sulla vicenda?
Su questo 41 bis si deve e si
può discutere, pur tenendo presente che stiamo parlando di un qualcosa che
esiste da ventuno anni. Alzarsi all’improvviso e scoprire che ci sono degli
ostacoli, mi sembra un atteggiamento sbagliato. La Corte Costituzionale
sull’argomento si è pronunciata più volte. Ha eliminato delle norme che erano
illegittime nell’organizzazione. Detto ciò, il legislatore ha esteso aree di
applicazione della misura. Va fatta, pertanto, una riflessione politica, ma non
una ideologica.
La sinistra, in particolare,
spesso ha cambiato parere sull’argomento…
Diverse sono le anime belle che
oggi scoprono di avere una posizione. Stiamo parlando di questioni che
dovrebbero andare oltre i colori politici.
Considerando la sua ampia
conoscenza del Parlamento, Donzelli nel suo intervento sugli anarchici ha alzato
troppo il tono?
Dal punto di vista
costituzionale, è tutto lecito. Ricordo una sentenza della Corte che si è dovuta
occupare del fatto che c’erano state delle aggressioni fisiche tra parlamentari.
In quell’occasione, fu detto che queste non rientrano nell’immunità di cui
godono deputati e senatori. Ci sono stati, quindi, sicuramente episodi più
gravi. Dopodiché non voglio sminuire la delicatezza di quanto accaduto. Ritengo
che faccia parte di una dinamica politica molto deleteria da una parte e
dall’altra. Tutti i nostri rappresentanti, senza esclusione, dovrebbero avere un
sussulto di responsabilità e non speculare in maniera opportunistica.
LUCA RICOLFI: “Gli
amministratori locali sono i più ostili alla riforma”. Edoardo Sirignano su
L’Identità il 7 Febbraio 2023.
“Gli amministratori locali,
anche quando governano bene, sono una delle forze più ostili alla
razionalizzazione della Pa”. A dirlo il sociologo e politologo Luca Ricolfi.
Il Sacco del Nord, Federalismo
addio. Cosa è cambiato in Italia da quando ha scritto quel testo?
Impossibile dare una riposta
rigorosa. Il sacco del Nord, che è una radiografia degli squilibri territoriali,
è stato scritto nel 2009, e ha richiesto un anno di lavoro a tempo pieno a me a
alle mie collaboratrici. Per aggiornare la radiografia, ci vorrebbe un altro
anno di lavoro, che peraltro fotograferebbe la situazione del 2020, stante la
lentezza con cui escono i dati necessari. Quindi le rispondo lo stesso, ma
avverto che nessuno ha i dati e gli strumenti per dare una risposta
circostanziata. Bene, data la lentezza con cui si modificano gli squilibri
territoriali, la cosa più probabile è che poco sia cambiato. Probabilmente, se
potessimo aggiornare Il sacco del Nord, ritroveremmo squilibri simili.
E cioè?
Che il Nord stacca ogni anno un
assegno di 50 miliardi (che nel frattempo saranno alquanto lievitati, causa
inflazione) a favore delle regioni del Sud, ma anche di alcune regioni
inefficienti del Centro e del Nord. E che quell’assegno, oltre a coprire
l’eccesso di spesa pubblica corrente del Sud (che è solo di 12 miliardi), copre
le inefficienze nella erogazione dei servizi (20 miliardi) e il mancato gettito
fiscale (18 miliardi), dovuto all’abnorme tasso di evasione della maggior parte
delle regioni meridionali. La vera differenza rispetto al 2010, quando uscì il
mio libro, è che mentre allora si poteva temere che la Lega avrebbe tradito il
progetto federalista (un dubbio che espressi allora, perché gli indizi c’erano
tutti), ora è evidente che alla Lega quel progetto non interessa più. Molti
l’hanno dimenticato, ma secondo le promesse di allora, oggettivate nella legge
42 del 2009, il federalismo avrebbe dovuto decollare entro 5, massimo 10 anni.
Qualcuno lo ha visto? Del resto è stato il Parlamento stesso, nel 2019, a
certificare che quella legge è rimasta largamente inattuata, nonostante i
partiti che l’avevano proposta siano stati quasi sempre al governo.
Ha sempre la stessa idea
sull’Autonomia?
Sì e no. Penso, come pensavo
allora, che – in teoria – il federalismo fiscale sarebbe un’ottima via per far
ripartire la crescita, che in Italia è ferma da quasi 30 anni. Ma, a differenza
di allora, penso che ormai sia troppo tardi e che i politici non abbiano la
minima intenzione di attuare quel progetto. Il che si vede anche dalla domanda
che lei mi ha posto: come mai mi parla di autonomia, dopo trent’anni di discorsi
sul federalismo fiscale? La ragione è semplice: il ceto politico attuale del
federalismo fiscale se ne infischia, perché comporterebbe un costoso
(elettoralmente) richiamo alla responsabilità dei territori, e preferisce
assecondare la spinta del ceto politico locale ad espandere la propria sfera di
intervento. E, di conseguenza, le proprie possibilità di acquistare consenso con
la spesa pubblica e l’aumento dei propri poteri regolativi e autorizzativi. Un
progetto politico che, giustamente, viene portato avanti in nome dell’autonomia,
senza alcun riferimento al federalismo fiscale.
La riforma proposta dal
ministro Calderoli può funzionare?
Certo. Dal momento che non
stabilisce nulla, nessuno può affermare che non funzionerà.
Condivide le proteste dei
governatori del Sud?
Le capisco, più che
condividerle. È possibile che, nell’attuazione dell’Autonomia, i territori che
più dissipano risorse e meno contribuiscano al gettito fiscale, possano essere
costretti a subire qualche ridimensionamento. Ma secondo me lo scenario più
verosimile è quello di un ulteriore aumento della spesa pubblica in tutti i
territori, compresi quelli che dovrebbero ridurla.
Sono legate probabilmente al
fatto che ci sono Regioni che in questo particolare momento hanno maggiori
difficoltà economiche rispetto ad altre?
No, sono legate alla
consapevolezza che – con l’Autonomia – il paradigma vittimario con cui il
Mezzogiorno ha finora negoziato il proprio rapporto con lo Stato centrale
potrebbe subire un’incrinatura, perché la gestione della riscossione e dei
servizi pubblici del Sud è indifendibile. E, prima o poi, quel paradigma
potrebbe dover competere con il paradigma responsabilista di Dambisa Moyo, la
coraggiosa scrittrice zambiana che – giusto nel 2009, anno in cui in Italia
veniva approvata la legge 42 sul federalismo fiscale – pubblicava Dead Aid, il
suo libro più f moso (La carità che uccide. Come gli aiuti dell’Occidente stanno
devastando il Terzo mondo). Una delle lezioni di quel libro è che gli aiuti ai
territori sviluppati, se prolungati, privi di controllo e meccanismi di mercato,
possono favorire la nascita di una classe politica inefficiente e priva di senso
di responsabilità, con il risultato di bloccare lo sviluppo anziché promuoverlo.
Si è parlato anche di
macroregioni. Potrebbe essere la strada da seguire?
È la vecchia e saggia idea
della Fondazione Agnelli, ma il ceto politico locale si opporrà con tutte le sue
forze: macroregioni significa anche riduzione dei poteri dell’immensa rete di
vassalli, valvassori e valvassini che si spartiscono il potere locale.
Contrariamente a quanto sembra credere Bonaccini (e con lui tanti altri
governatori e sindaci) gli amministratori locali – anche quando governano bene –
sono una delle forze più ostili alla razionalizzazione e semplificazione della
Pubblica Amministrazione.
Altro tema il
presidenzialismo. L’Italia è matura?
La maturità degli italiani è
fuori discussione. È il ceto politico che non è maturo per varare una riforma
delle regole del gioco senza mettere in primo piano gli interessi egoistici
delle forze politiche coinvolte.
Cambiando argomento, oggi
tornano gli anarchici. Cosa sta succedendo nel Paese?
Sta succedendo che, come
sempre, un piccolo problema gestibile (un terrorista che fa lo sciopero della
fame) è stato trasformato in un grande problema ingestibile per la miopia delle
forze politiche. E qui mi riferisco sia al duo Delmastro-Donzelli, sia al
quartetto Orlando-Serracchiani-Verini-Lai.
Considerando la crisi attuale,
c’è più di qualcuno che è scettico verso una linea troppo atlantista.
Dobbiamo temere qualcosa?
Certo! Dobbiamo temere la terza
guerra mondiale, che la classe politica occidentale sta rendendo ogni giorno più
probabile. E questo non perché mandiamo armi all’Ucraina, ma perché – come ha
spiegato nei giorni scorsi il generale Fabio Mini – non abbiamo alcuna ipotesi
seria su come far terminare questa guerra. Non esiste un end state, un obiettivo
finale che si cerca di raggiungere. Dire che l’unica soluzione è la resa della
Russia, con il ritiro integrale dall’Ucraina, significa preferire il rischio di
una guerra nucleare piuttosto che accettare un compromesso sui territori
occupati. E il fatto che l’opinione pubblica sia poco preoccupata per la guerra
è pericolosissimo, perché favorisce e alimenta l’irresponsabilità dei
governanti. Zelensky a Sanremo è il simbolo perfetto di tutto ciò: l’orchestra
europea continua a suonare mentre il Titanic affonda.
Due studenti su tre al Sud
hanno competenze inadeguate per affrontare il mondo del lavoro o lo studio
universitario! Si tratta di un’emergenza enorme, che dovrebbe vedere l’intera
Nazione impegnata. Paolo Saggese su La Gazzetta del Mezzogiorno il 7
Febbraio 2023.
Sono sinceramente preoccupato,
e il nuovo anno non si apre nel migliore dei modi. La Scuola italiana, in
particolare quella del Sud, sta vivendo in questo torno d’anni una crisi di
identità e di risultati, che scoraggiano anche i migliori docenti e dirigenti
scolastici, quelli più motivati e attivamente impegnati. Il quadro che
forniscono le prove standardizzate Invalsi e internazionali propongono un Paese
spaccato in due, con alcune aree, soprattutto del Nord est, che sono alla pari
con le migliori realtà scolastiche europee, e con altre aree, in particolare del
Mezzogiorno, che presentano risultati in linea con la Grecia e la Turchia.
Un libro, che andrebbe letto,
al proposito, con opportuna attenzione, è quello firmato da Andrea Gavosto,
Direttore della Fondazione Agnelli (“La scuola bloccata”, Editori Laterza,
Roma-Bari, 2022), che fornisce un quadro abbastanza desolante.
Scrive, tra l’altro: “Le
rilevazioni dell’Invalsi del 2021 mostrano che circa il 70% dei maturandi in
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia non va oltre il livello 2, quello minimo
per comprendere un testo, svolgere un ragionamento logico, capire alcuni
elementi di lingua inglese. Anche prima del Covid-19, la percentuale nelle
regioni meridionali era del 60%. È un dato che lascia sgomenti: il nostro
sistema scolastico può essere in grado di fornire un titolo (il 99% di chi
sostiene la maturità la supera), ma dietro quel titolo vi è, per due studenti
meridionali su tre, un vuoto in termini di competenze” (p. 25).
Due studenti su tre al Sud
hanno competenze inadeguate per affrontare il mondo del lavoro o lo studio
universitario! Si tratta di un’emergenza enorme, che dovrebbe vedere l’intera
Nazione impegnata in un’azione a favore della Scuola, da cui dipende il futuro
dell’Italia. La stessa annosa “questione meridionale” non può essere risolta se
non si risolve il “problema Scuola”. Infatti, dove c’è “povertà economica”, ci
sarà “povertà educativa”; quest’ultima alimenta la prima (la “povertà
economica”), la prima alimenta l’altra.
Ce lo hanno insegnato, vari
decenni fa, Carlo Levi, Manlio Rossi-Doria, Rocco Scotellaro, Anna Lorenzetto,
Umberto Zanotti-Bianco, Gaetano Salvemini.
Mi hanno da sempre indotto a
riflettere queste parole scritte nel 1946 dell’autore del “Cristo”: “Che
l’analfabetismo sia legato alla miseria è un fatto di ovvia osservazione. Se si
potesse fare una carta della sua diffusione credo che essa coinciderebbe, fino
ai più minuti particolari, con quella della povertà, della sterilità della
terra, della mancanza di industrie, delle cattive condizioni sanitarie, della
malaria, dell’insufficienza delle comunicazioni e delle opere pubbliche”.
Mutate le circostanze, è ancora
vero.
Mentre la nostra Scuola è in
crisi, si discute di altro, di autonomia differenziata, ad esempio, di ridurre
il numero di dirigenti scolastici, di DSGA, di amministrativi e collaboratori
scolastici. E in seguito di docenti. E invece si dovrebbe garantire ad un
giovane del Sud pari destino di un giovane appartenente a regioni più
“fortunate”. Perché, come scrive ancora Andrea Gavosto, “essere penalizzati in
termini di studio e, successivamente, di lavoro per il solo fatto di essere nati
nel Mezzogiorno - e nessuno sceglie dove nascere - rappresenta un’ingiustizia
che il sistema scolastico non è mai riuscito a correggere” (pp. 22-23).
Dunque, invece di discutere di
tagli alla scuola, si dovrebbe parlare di maggiori finanziamenti, per aumentare
il tempo scuola, per arricchire l’offerta formativa, per remunerare più
dignitosamente il Personale tutto, per fornire edifici scolastici belli, sicuri,
confortevoli, moderni.
Umberto Zanotti-Bianco
ricordava come in Svizzera gli edifici più belli siano quelli del Comune e della
Scuola. Secondo questa semplice regola, giudicava la forza e l’equità di ogni
democrazia degna di questo nome.
"L'autonomia differenziata?
La decisero i costituenti". Il costituzionalista: "Per avere un'Italia
uniforme non si sarebbero dovute introdurre le Regioni". Francesco Curridori
l’8 Febbraio 2023 su Il Giornale.
«I costituenti scelsero di
introdurre le Regioni, accanto a Comuni e Province, perché ritenevano che
occorresse combattere centralismo e uniformità ed assicurare alle collettività
locali un notevole grado di autogoverno, avvicinando il potere pubblico ai
cittadini». Il costituzionalista Sabino Cassese ricorda così le motivazioni che
portarono alla nascita delle Regioni, a cui il ddl Calderoli vuole attribuire
nuovi poteri.
L'autonomia differenziata
spacca l'Italia?
«Se si voleva un'Italia
disciplinata uniformemente, non bisognava introdurre l'istituto regionale. I
costituenti hanno, inoltre, introdotto l'autonomia differenziata perché vi sono
cinque Regioni che hanno un'autonomia speciale. Più di metà della popolazione
del Centro - Sud vive oggi in Sicilia in Sardegna, due Regioni ad autonomia
differenziata».
Eppure Sardegna e Sicilia non
sembrano aver sfruttato al meglio le proprie potenzialità. Con il ddl Calderoli
sarà diverso per le Regioni del Sud?
«Vi sono Regioni diverse e
diversi modi di governare. Gli studi fatti finora, specialmente quelli di Robert
Putnam, uno studioso americano, mostrano che le Regioni d'Italia dove vi era più
forte tradizione di gestione comunale le Regioni hanno operato meglio, mentre
nei territori dove la tradizione di governo locale era più debole e maggiore il
centralismo, le Regioni hanno operato peggio».
Il ddl Calderoli può ridurre il
divario tra Nord e Sud?
«Il testo originario, quello
del 1948, della Costituzione prevedeva, all'articolo 119, che, per provvedere a
scopi determinati e per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna
per legge a singole Regioni contributi speciali. L'articolo 119, modificato nel
2001, prevede che per promuovere la coesione e rimuovere gli squilibri economici
e sociali lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati comuni, province, città metropolitane e Regioni. La parola
Mezzogiorno nel 2001 scomparve dalla Costituzione, ma è rimasto il principio che
lo Stato interviene per le zone meno sviluppate».
Non si rischia uno
sbilanciamento di poteri tra Stato centrale ed enti locali?
«Un adeguato bilanciamento dei
poteri tra Stato e periferia può essere assicurato soltanto distinguendo i
compiti che hanno dimensioni locali e i compiti che, invece, possono avere solo
una dimensione o statale o sovrastatale. Quando si parla di autonomia
differenziata si pensa alla differenziazione su tutte le 23 materie che sono
indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ma
tra queste vi sono anche i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il
commercio con l'estero e le grandi reti di trasporto e di navigazione, che
sarebbe utile lasciare come sono ora - alla legislazione concorrente, cioè la
legislazione nella quale lo Stato stabilisce principi fondamentali e le Regioni
provvedono con legge, invece di aumentare il grado di autonomia conferito alle
Regioni».
I critici del ddl Calderoli
sostengono sia sbagliato affidare alle Regioni materie come l'energia. Lei cosa
ne pensa?
«In settori dove le strutture
pubbliche sono ordinati a rete, come la sanità, la scuola e in futuro anche
l'energia, con lo sviluppo dell'energia eolica e di quella solare, l'ordinamento
può essere deconcentrato, purché al centro della rete vi siano strutture capaci
di stabilire gli standard, di verificarne l'attuazione e il rispetto e di
intervenire in via sostitutiva, quando gli standard non vengono rispettati».
Autonomia differenziata e
presidenzialismo devono andare di pari passo?
«Possono, in teoria, andare di
pari passo. Ma hanno passaggi diversi e quindi tempi diversi. L'autonomia
differenziata non richiede modifiche costituzionali, perché è disposta dalla
Costituzione. Si tratta di dare attuazione ad essa con una procedura complessa
che è disciplinata dalla proposta avanzata dal governo Meloni. Il
presidenzialismo ha bisogno di una modifica costituzionale e, prima ancora, di
una determinazione delle modalità di attuazione, perché con la parola
presidenzialismo si intendono molte formule organizzative diverse, sia una delle
numerose forme di presidenzialismo in senso stretto, sia il cosiddetto
semipresidenzialismo, sia una forma di premierato, a sua volta di tipo molto
diverso, perché altro è il premierato del tipo del cancelliere tedesco, che non
passa per un'elezione diretta, altro è un premierato che eventualmente comporti
una elezione diretta del capo dell'esecutivo».
L’altra faccia della secessione «dei ricchi». Marco
Demarco su Il Corriere della Sera l’8 Febbraio 2023.
Prendersela con la Lega facendo salva la
Costituzione suona almeno malizioso, e sembra spuntare un’altra secessione non
meno rischiosa
E se per scansare la cosiddetta secessione delle
Regioni ricche finissimo per ritrovarci faccia a faccia con un’altra secessione
non meno rischiosa della prima? Insomma, allarma il progetto per l’autonomia
potenziata voluta da Salvini, Zaia e Calderoli, ma si fa poco caso a ciò che
dell’Italia politico-istituzionale si sta già separando, se non dalla realtà,
dal senso comune. Il titolo V, le Regioni, i governatori: sono già altra cosa
rispetto a qualche tempo fa. La critica all’autonomia, ad esempio, è per molti
versi una critica legittima ai tempi e ai modi scelti per attuare la riforma. Ma
l’autonomia è prevista dalla Costituzione, al Titolo V, appunto, e prendersela
con la Lega facendo salva la Costituzione suona almeno malizioso. Si arriva, di
conseguenza, a parlare di disposizioni vincolanti sì, ma fino a un certo punto.
La Costituzione? Dipende, si dice. Ma se dipende
oggi per me, può dipendere anche domani per te, in un crescendo di relativismo
interpretativo per nulla rassicurante. Ad un certo punto, poi, sotto il fuoco
polemico sono finiti i presidenti regionali. Anzi, soprattutto loro, senza
distinzioni, come se fossero tutti dei piccoli Cesari, spesso confondendo la
funzione con la persona, e facendo dell’eccezione la regola, vedi De Luca che
ormai fa anche il sindacalista e infatti litiga con la Cgil. Infine, è venuto il
turno delle stesse Regioni: non per come potrebbero ricollocarsi nella gerarchia
dello Stato una volta «armate» di nuove competenze, ma in assoluto, per il solo
fatto di esistere, sebbene anche queste previste dai costituenti per evitare un
centralismo totalizzante e un municipalismo nebulizzato, modello Ischia, sei
Comuni per una sola isola. E così, dopo un colpo alla Costituzione, un altro
alla rappresentanza dei territori e un altro ancora al pluralismo delle
autonomie, che un tempo era un valore e ora è invece diventato un ingombro, ecco
il paradosso: si urla al lupo che verrà, non al cinghiale che è già sotto casa.
«L’autonomia? Si rischia la secessione»: il
punto di Pino Aprile. «L’abbiamo già fermata una volta e di certo lo faremo
ancora». Leonardo Petrocelli su La Gazzetta del Mezzogiorno l’08 Febbraio 2023
Sono passati 13 anni dall’uscita del suo Terroni,
libro spartiacque nel dibattito meridionalista. Ora, il giornalista e saggista
Pino Aprile, presidente del Movimento 24 agosto, è tornato sugli scaffali con
una nuova edizione del volume, edita da Libreria Pienogiorno, e con un tempismo
invidiabile. Cioè nel bel mezzo di un nuovo scontro sull’autonomia
differenziata. Il primo si era consumato cinque anni fa, tra il 2018 e il 2019.
«Allora abbiamo vinto - ricorda Aprile - e vinceremo anche questa volta. Ma sarà
più difficile.
Aprile, perché sarà più difficile fermare
l’autonomia?
«Perché questa volta sono andati avanti. Mi
riferisco ai passi politici e tecnici e, in particolare, al via libera in
Consiglio dei ministri».
Come andò nel 2018?
«Tutto iniziò con un patto scellerato firmato dal
Governo Gentiloni con Regione Veneto e poi esteso a Lombardia ed Emilia Romagna.
Non solo non lo resero pubblico ma Gentiloni lo firmò il 28 febbraio a
pochissimi giorni, direi a poche ore, dalle Politiche del 4 marzo. Una questione
così delicata la lasci al Governo in arrivo».
Poi il documento è venuto fuori....
«Sì, per merito di un attivista di quello che
sarebbe diventato il nostro Movimento per l’Equità territoriale. Girai subito le
carte al professor Gianfranco Viesti, non potevamo credere a ciò che leggevamo:
prima l’autonomia, poi forse i Lep. E le risorse da trasferire correlate al
gettito fiscale: più soldi per le regioni più ricche».
A quel punto?
«Iniziò una crociata che culminò nell’appello
contro la secessione dei ricchi, firmato da oltre 60mila persone. Una
sollevazione. Ricordo di aver trascorso mesi a distribuire numeri, dati,
cartelline a deputati e senatori. Una decina di 5 Stelle si convinsero: “Questa
porcheria non la votiamo”. E così saltò il Consiglio dei ministri che avrebbe
dovuto dare il via libera all’autonomia».
Questa volta il Cdm c’è stato. Ma la proposta
Calderoli, ammetterà, non è quella del 2018.
«Stanno provando in tutti modi a rigirare la
faccenda per farcela digerire. Certo tra la prima e l’ultima bozza c’è una
distanza che sembra abissale...».
.... sta arrivando un «ma»...
«... ma la sostanza è rimasta la stessa: vogliono
l’autonomia prima che tutto il Paese sia messo in pari. Cioè abbia lo stesso
livello di prestazioni essenziali».
I famosi Lep che si vogliono determinare ma per i
quali non sono previste risorse. Il problema è sempre quello?
«Non solo quello. A parte che vogliono definire in
sei mesi ciò che non si è riusciti a individuare in vent’anni, l’ex ministro
Francesco Boccia stimò i Lep per Sanità, Trasporti e Istruzioni tra gli 80 e i
100 miliardi. Dove sono? Chi ce li ha? L’ultima Manovra è costata 35 miliardi di
cui 21 sacrificati per il problema energia. Ne sono rimasti “liberi” 14. Non mi
pare siano sufficienti a risolvere il problema. Davvero vogliono prenderci in
giro?».
Ma, alla fine, qual è la posta in palio?
«Se l’autonomia va in porto l’Italia si spacca. È
la secessione».
Addirittura?
«Guardi, la situazione è molto seria. Le
disuguaglianze sono tra i temi economici più frequentati in questi anni. Si
misurano con il coefficiente di Gini, compreso fra 1 e 100. È storicamente
provato che quando il grado delle disuguaglianze supera il livello 40, le
disuguaglianze stesse vengono abbattute con la violenza. Scorre il sangue. Ecco,
lei sa qual è, in tutto il mondo, il Paese più vicino al livello 40?».
No, ma tiro a indovinare: l’Italia.
«Esatto. Siamo sull’orlo del baratro e questi
vogliono aumentare ancora il carico? Per fortuna il quadro non è così roseo
nemmeno per loro».
A cosa si riferisce?
«A quello che io chiamo “Pun”, il Partito unico
del Nord. Sull’autonomia non è più così compatto. Confindustria ha apertamente
preso posizione contro. Una cosa inimmaginabile fino a sei mesi fa. Anche uno
dei campioni del Partito unico, cioè il governatore emiliano Stefano Bonaccini,
sta facendo retromarcia. Non so quanto sia reale questo cambio di rotta ma ha
capito che se vuole fare il segretario del Pd deve dismettere quella bandiera».
Resta la Lega, irriducibile.
«Ed è naturale che sia così. Ormai per loro è
l’ultima battaglia. Se la perdono vanno sotto il 4%».
C’è da dire che, su questo tema, molti governatori
del Sud hanno tenuto una posizione ambigua, sbandando parecchio. Prima sì, poi
no, poi forse. Perché?
«Perché per loro significa comunque più potere. È
un meccanismo coloniale: la colonia, in questo caso il Sud, si impoverisce, ma
le sue classi dirigenti, intermediarie col potere centrale, si rafforzano. Le
nuove competenze fanno gola. E poi c’è qualcuno davvero convinto, in buona fede,
di poter gestire alcuni settori meglio di Roma».
Mettiamo il termometro al Sud. La febbre
anti-autonomia onestamente non è molto alta...
«Diciamolo chiaramente: se chiedi a cento persone
cosa sia l’autonomia ti risponderanno in tre».
Un disastro, quindi.
«Non proprio. Fino a qualche anno fa quel numero
sarebbe stato zero. E comunque anche se la vicenda è ostica, di certo al Sud si
è diffusa in questi anni una nuova coscienza».
Cosa è cambiato in questi anni?
«Abbiamo ottenuto dei risultati enormi di cui
spesso non ci rendiamo conto. Terroni fu un cerino ma la paglia era lì. Quello
che ha fatto la differenza è stato il cambio di passo del meridionalismo. Da
raffinata dottrina comunicata da grandissimi autori, come Salvemini o Nitti, ad
una élite selezionata di pochi interessati, è diventata un sentire di popolo. Il
nuovo meridionalismo, infatti, parla alla gente della strada. E il Mezzogiorno è
tornato centrale».
Un esempio concreto?
«Qualunque politico deve passare da qui per
vincere qualcosa. Altrimenti non sfonda. Le elezioni si decidono al Sud. È stato
così per il Pd di Renzi, per il M5S e ora per Fratelli d’Italia. Per esistere
devi mettere una sciarpa meridionalista. Diversamente, Bonaccini insisterebbe
con l’autonomia. Certo, è meglio di ciò che vorremmo ma è una base di partenza».
Una «base» che intende usare nella battaglia
contro l’autonomia?
«Dobbiamo osteggiarla ovunque, dalle piazze ai
social, chiedendo conto delle loro scelte ai nostri rappresentanti che hanno
deciso di appoggiarla. Quando tornano a casa per il weekend chiedete loro: mi
spieghi perché ti schieri con i nemici del Sud contro di noi? Sarà dura, ma
vinceremo anche questa volta».
BABELE ITALIA Giovanni
Vasso su L’Identità il 10 Febbraio 2023
“L’Italia dell’autonomia? Sarà
una Babele”. Così il giurista Gaetano Azzariti, professore ordinario di Diritto
Costituzionale all’Università La Sapienza di Roma che analizza, a L’Identità, la
riforma fortemente voluta dal governo.
Professore, perché ha definito
il progetto dell’autonomia differenziata “spacca-Costituzione”?
La proposta dell’autonomia
differenziata viene presentata come attuazione della Carta: del terzo comma
dell’articolo 116. C’è però attuazione e attuazione. La mia impressione è che,
ove la riforma fosse realizzata nei termini che si stanno delineando, si
imporrebbe un modello di autonomia diverso da quello definito dai principi
supremi nel nostro ordinamento costituzionale negli articoli 2, 3 e 5. Questi
principi imporrebbero un regionalismo di tipo “solidale”, mentre il modello che
si sta delineando è di tipo “competitivo”. Perciò dico che spacca la
Costituzione.
Alle Regioni si vogliono
affidare le chiavi del Paese. Ma quale è lo stato di salute del regionalismo
oggi?
Siamo ad un finale di partita.
Il regionalismo non ha mai avuto vita tranquilla in Italia, neppure quello
solidale s’è mai realizzato. Dopo la riforma del titolo quinto, nel 2001, sono
aumentate le incertezze. Tant’è che tutti oggi vorrebbero cambiare, sebbene in
direzioni spesso opposte. Se si scorre la giurisprudenza costituzionale, ci si
rende conto della fatica che ha fatto il nostro giudice delle leggi per
ridefinire un qualche equilibrio che nel testo non c’era. La mia impressione
però è che con il ddl Calderoli e con le norme inserite nella legge di bilancio
per la determinazione dei Lep, non si raggiunge un traguardo stabile, ma si
aumenta la confusione.
In che senso?
Credo che un legislatore
consapevole, imparando dalla storia irrequieta che abbiamo alle spalle, dovrebbe
tornare a ridiscutere a fondo il modello di regionalismo che si vuole attuare,
sforzandosi di tornare ai principi scritti, ma non realizzati, della
Costituzione. Dovrebbe, ad esempio, non tanto limitarsi a preoccuparsi di
distribuire materie e competenze alle regioni più fortunate dal punto di vista
delle risorse e delle possibilità di sviluppo, in base alle richieste di
quest’ultime, quanto assicurare una differenziazione e articolazione delle
funzioni in grado di assicurare l’unità ed indivisibilità della repubblica,
nonché il rispetto dei principi di eguaglianza nei diritti entro tutto il
territorio nazionale. In fondo è questo che pretende l’articolo 5 quando scrive
che è necessario promuove le autonomie.
Eppure ci sono i Lep…
Si è predisposto un meccanismo
di definizione dei Lep forzato, e non privo di ipocrisia. Le forzature sono
quelle che assegnano ad una cabina di regia e a un comitato di tecnici la loro
determinazione, che verrà poi formalizzate da un dpcm, escludendo ogni più
meditata discussione parlamentare. L’ipocrisia è dettata dal fatto che si
dovrebbe ben sapere che non basta “determinare” i Lep perché i sottostanti
diritti economici e sociali possano ritenersi garantititi. Per assicurare
l’effettività della tutela è essenziale anche impegnare le risorse economiche
necessarie e sufficienti. Non si può ritenere di aver conseguito il risultato
limitandosi a porre un’asticella sotto la quale non si può andare, occorre
preoccuparsi anche delle necessarie variazioni di bilancio e redistribuzione
delle risorse. Invece nella legge di bilancio si legge che i Lep saranno
determinati senza prevedere ulteriori costi. Così non si può fare.
Quali tempi prevede per questa
riforma?
Si sta accelerando moltissimo,
andando anche oltre i limiti di velocità consentiti in un ordinato ordinamento
democratico. Sia la legge di bilancio (per quanto riguarda i Lep) sia il disegno
di legge Calderoli (per quanto riguarda la definizione delle intese con le
singole regioni) stabiliscono delle procedure assolutamente accelerate. Impone a
tutti soggetti interessati il compimento di atti di verifica e controllo (mai di
contrattazione e di discussione reale) entro spazi di tempo strettissimi, tra i
trenta e i sessanta giorni. Così al Parlamento, che già non conta nulla, non gli
si dà neanche il tempo di meditare e discutere. Si va avanti come Caterpillar.
A proposito di parlamento…
Il dibattito sulla necessità di
assegnare un ruolo al parlamento nella definizione delle intese è il più
discusso, da sempre. Ha persino investito la maggioranza, trovando voci in Fi e
Fdi. L’obiettivo dovrebbe essere quello di permettere al parlamento di
modificare ed emendare, il testo dell’intesa in via di definizione. Insomma,
fare un gioco a tre: Regione interessata, governo e parlamento. Cosa è stato
concesso nell’ultima versione del ddl Calderoli? Ebbene, se prima ci si limitava
a chiedere un parere alla commissione, entro 30 giorni, adesso si concedono 60
giorni e si afferma che potrà essere l’assemblea, e non la sola commissione, a
dare un indirizzo, non vincolante. Ma dal punto di vista sostanziale non cambia
nulla. In realtà si vuole continuare a far sì che la partita sia rigorosamente a
due tra Regioni e governo. Decide comunque l’esecutivo. Il parlamento non ha
potere di emendare, solo di verifica e di ratifica.
Come sarà l’Italia che verrà?
Sarà una Babele. Ogni Regione
parlerà la sua lingua, incomprensibile agli altri. E noi sappiamo che la
mancanza di comprensione è sempre alle origini di conflitti e lacerazioni. Mi
permetto un suggerimento: chi vuole attuare il terzo comma dell’articolo 116 non
in chiave conflittuale, dovrebbe partire dall’attuazione del 119 secondo cui è
necessario individuare fondi perequativi a favore delle Regioni meno sviluppate.
Solo una volta ristabilito un principio di uguaglianza si potrà procedere.
Altrimenti, le disuguaglianze si accentueranno.
La fotografia della Svimez.
Le due scuole in Italia, al Sud meno ore e bimbi in sovrappeso per assenza
palestre: “Autonomia aumenterà divario”. Redazione su Il Dubbio il 10
febbraio 2023.
Un paese, due scuole. Le storie
di Carla e Fabio, due bambini di 10 anni che frequentano la quinta elementare
rispettivamente a Firenze e a Napoli. Se la bimba toscana, secondo i dati
raccolti dalla Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno, ha avuto garantita dallo Stato ben 1.226 ore di formazione,
l’alunno partenopeo non ha avuto a disposizione la stessa offerta educativa
perché nel Sud Italia in generale mancano infrastrutture a tempio pieno.
Secondo la Svimez, infatti, un
bambino di Napoli, o che vive nel Mezzogiorno, frequenta la scuola primaria per
una media annua di 200 ore in meno rispetto al suo coetaneo che cresce nel
centro-nord che coincide di fatto con un anno di scuola persa per il bambino del
sud durante il suo percorso alle elementari. È questa una prima fotografia
emersa oggi, in una video illustrazione presentata a Napoli, in occasione
dell’incontro “Un paese due scuole”, promosso da Svimez e L’Altra Napoli onlus,
presso La casa di Vetro di Forcella, in cui ci si è confrontati sui divari di
cittadinanza, tra istituzioni, esperti della scuola, della cultura e del terzo
settore.
Un solo Paese, due scuole
diverse per quanto riguarda l’offerta educativa. Come evidenzia l’ultimo
Rapporto Svimez, i servizi socio-educativi per l’infanzia sono caratterizzati
dall’estrema frammentarietà dell’offerta e da profondi divari territoriali nella
dotazione di strutture e nella spesa pubblica corrente delle Amministrazioni
locali. Secondo i dati Svimez, nel Mezzogiorno, circa 650mila alunni delle
scuole primarie statali (79% del totale) non beneficiano di alcun servizio
mensa. In Campania se ne contano 200mila (87%), in Sicilia 184 mila (88%), in
Puglia 100 mila (65%), in Calabria 60 mila (80%). Nel Centro-Nord, gli studenti
senza mensa sono 700mila in totale, il 46% del totale.
Per effetto delle carenze
infrastrutturali, solo il 18% degli alunni del Mezzogiorno accede al tempo pieno
a scuola, rispetto al 48% del Centro-Nord. La Basilicata (48%) è l’unica regione
del Sud con valori prossimi a quelli del Nord. Bassi i valori di Umbria (28%)
e Marche (30%), molto bassi quelli di Molise (8%) e Sicilia (10%). Gli allievi
della scuola primaria nel Mezzogiorno frequentano mediamente 4 ore di scuola in
meno a settimana rispetto a quelli del Centro-Nord. La differenza tra le ultime
due regioni (Molise e Sicilia) e le prime due (Lazio e Toscana) è, su base
annua, di circa 200 ore.
UN ALUNNO SU TRE E’ SENZA
PALESTRA – Circa 550 mila allievi delle scuole primarie del Mezzogiorno (66% del
totale) non frequentano inoltre scuole dotate di una palestra. Solo la Puglia
presenta una buona dotazione di palestre, mentre registrano un netto ritardo la
Campania (170 mila allievi privi del servizio, 73% del totale), la Sicilia (170
mila, 81%), la Calabria (65 mila, 83%). Nel Centro-Nord, gli allievi della
primaria senza palestra, invece, raggiungono il 54%. Analogamente, il 57% degli
alunni meridionali della scuola secondaria di secondo grado non ha accesso a una
palestra; la stessa percentuale che si registra nella scuola secondaria di primo
grado.
BAMBINI IN SOVRAPPESO AL SUD
– Questi divari nelle infrastrutture scolastiche frenano anche la diffusione
della pratica fisica e sportiva, con conseguenze negative per la salute, la
spesa pubblica e lo stile di vita della popolazione, con particolare riferimento
ai minori. Nel meridione quasi un minore su tre nella fascia tra i 6 e i 17
anni, infatti, è in sovrappeso, rispetto ad un ragazzo su cinque nel Centro
Nord. Nel Centro Nord il 42% della popolazione adulta pratica sport regolarmente
e il 26,8% saltuariamente. Nel Mezzogiorno invece le percentuali si invertono:
la maggioranza pratica sport saltuariamente (33,2%) mentre la minoranza lo
pratica abitualmente (27,2%). Il divario si riflette sulla percentuale di
sedentari, con particolare riferimento per i minori: 15% nel Centro Nord e 22%
nel Centro Sud. Ma ancor più allarmante è il dato sulle aspettative di vita: nel
Mezzogiorno sono inferiori di tre anni rispetto a quelle degli adulti
centro-settentrionali.
MENO INVESTIMENTI PUBBLICI AL
SUD – La Svimez ha analizzato la dinamica dell’intensità dell’intervento
pubblico nell’istruzione – dalla scuola all’università – sulla base dei dati
di spesa pubblica di fonte Conti Pubblici Territoriali. Dallo studio risulta un
progressivo disinvestimento dalla filiera dell’istruzione che ha interessato
soprattutto le regioni del Sud. Tra il 2008 e il 2020, la spesa complessiva in
termini reali si è ridotta del 19,5% al Sud, oltre 8 punti percentuali in più
del Centro-Nord. Ancora più marcato il differenziale a svantaggio del Sud nel
calo della spesa per investimenti, calati di quasi un terzo contro “solo” il 23%
nel resto del Paese.
Per l’ultimo anno per il quale
sono disponibili i dati risulta un differenziale di spesa pubblica pro capite
nell’intero comparto Istruzione, comprensivo dell’istruzione terziaria,
favorevole al Mezzogiorno di circa 90 euro, ma il dato non fornisce una
fotografia reale dell’effettivo impegno pubblico per l’istruzione. Più
significativo è il rapporto tra spesa e studenti, dal quale risulta uno scarto
sfavorevole al Sud, dove la spesa per studente è di circa 100 euro annui
inferiore rispetto al resto del Paese (5.080 euro per studente contro 5.185). Lo
scarto aumenta se si considera il solo comparto della scuola, con una spesa per
studente di 6.025 euro al Sud contro un valore di 6.395 nel Centro-Nord. Lo
scarto è ancora più significativo se si guarda alla sola spesa per investimenti:
34,6 contro 51 euro per studente.
LA MIGRAZIONE DEGLI ALUNNI
– L’indebolimento dell’azione pubblica nella filiera dell’istruzione incrocia un
trend demografico avverso, un fenomeno che causa la riduzione degli studenti. I
due fattori rischiano di autoalimentarsi in un circolo vizioso nazionale, ma
particolarmente intenso al Sud. La debolezza dell’offerta scolastica e, più in
generale, la limitata qualità dei servizi pubblici alimenta il processo di
denatalità e i flussi di migrazione giovanile che, a loro volta, comprimono il
numero di alunni, con il conseguente adeguamento al ribasso dell’“offerta” di
istruzione. Tra il 2015 e il 2020 il numero di studenti del Mezzogiorno (dalla
materna alle superiori) si è ridotto di quasi 250.000 unità (-75.000 nel
Centro-Nord).
PNRR PER COLMARE GAP O CON
AUTONOMIA AUMENTA – Secondo il Direttore della Svimez Luca Bianchi, “per
contrastare queste dinamiche occorre invertire il trend di spesa e rafforzare le
finalità di coesione delle politiche pubbliche nazionali in tema di istruzione.
Il PNRR è l’occasione per colmare i divari infrastrutturali, tuttavia
l’allocazione delle risorse deve essere resa più coerente con l’analisi dei
fabbisogni di investimento, superando i vincoli di capacità ammnistrativa. La
priorità oggi è rafforzare il sistema di istruzione soprattutto nelle aree più
marginali, sia del Sud che del Nord. Garantendo asili nido, tempo pieno,
palestre, rafforzando l’offerta formativa dove più alto è il rischio di
abbandono. Il quadro che emerge dai dati, e che rischia di rafforzarsi ancor più
se passano le proposte di ’autonomia, è quello di adattare l’intensità
dell’azione pubblica alla ricchezza dei territori, con maggiori investimenti e
stipendi nelle aree che se li possono permettere, pregiudicando proprio la
funzione principale della scuola che è quella di “fare uguaglianza””.
Per il vicepresidente della
Onlus L’Altra Napoli Antonio Lucidi, intervenuto nel corso della tavola rotonda
a Forcella: “Si parla di ‘due scuole’ perché il sistema scolastico nel Sud,
rispetto al resto d’Italia, è carente sotto il profilo delle strutture, della
capacità di attrarre i giovani, perché ha maglie larghe e troppo spesso non
riesce a contrastarne l’abbandono degli studi, ed ancora perché la scuola non
riesce a trovare sbocchi, una volta terminati i percorsi, nel mercato del
lavoro.”
“C’è la necessità –
dichiara Clementina Cordero di Montezemolo, psicoterapeuta infantile e
presidente dell’associazione Yolk – di creare e ricreare un patto condiviso tra
la scuola e le famiglie, motivo per cui la scuola dovrebbe assumere un ruolo
fondamentale nell’educazione alla vita. L’idea di tenere aperte le scuole nel
pomeriggio con una collaborazione pubblico – privato, non solo ha una valenza
sociale perché rappresenta un alleggerimento per le famiglie ma anche
individuale, di crescita per il singolo, di sviluppo del sé, soprattutto nelle
ragazze e ragazzi delle scuole medie”.
Divario secolare. I licei
del sud sono la fucina della fuga di cervelli verso il nord (e l’estero).
Gianni Balduzzi su L’Inkiesta il 16 Febbraio 2023.
Nel Mezzogiorno acquisire un
buon diploma, e poi una laurea, è un asset migliore di una competenza specifica
che non riesce a trovare applicazione pratica immediata. Il passo successivo,
però, è spostarsi nelle regioni in grado di valorizzare quelle conoscenze a
livello lavorativo
Che scuola faranno i ragazzi
che oggi frequentano le medie? Se in altri Paesi in realtà la scelta di un
indirizzo avviene solo successivamente, quando si è più grandi, in Italia già a
tredici anni di fatto si deve decidere quale potrà essere la propria carriera di
studi e poi lavorativa.
Certo, non vi è nulla di
assoluto, diplomarsi all’Ipsia non preclude l’iscrizione a qualsiasi facoltà
dell’università, ma è pur vero che la gran parte degli studenti dei nostri
atenei vengono soprattutto dai licei e, di conseguenza, da lì viene la maggior
parte di coloro che avranno i salari maggiori. Checché ne dicano coloro che
ancora pensano che convenga non laurearsi per guadagnare bene e subito.
Per questo è significativo
osservare come cambia l’orientamento dei ragazzi e delle loro famiglie e, visti
i grandi gap tra le diverse aree del Paese in tutti i campi, anche dove cambia.
Decisamente più delle metà
degli alunni di terza media, il 57,1 per cento, farà il liceo. Vi è un aumento
del 0,5 per cento rispetto all’anno scorso. È la conferma di un trend di lungo
periodo. Nell’anno scolastico 2020/21 a sceglierlo era stato il 56,3 per cento,
nel 2019/20 il 55,4 per cento, e prima ancora, nel 2016/17 il 53,1 per cento.
I numeri, però, variano molto
in base alla regione. Il Lazio si conferma quella in cui vi sono e vi saranno
più liceali, quasi sette studenti delle superiori su dieci. Seguono Molise,
Abruzzo, Campania, Sicilia. In sostanza, al Sud solo la Puglia si piazza sotto
la media nazionale.
Al contrario, la Liguria è
l’unica regione settentrionale in cui questa media viene superata. Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna rimangono le tre in cui il liceo viene scelto meno.
Nelle ultime due, anzi, lo fa meno della metà delle famiglie.
Qui sono di più quelle che
prediligono gli istituti tecnici e professionali. Anche se proprio questi ultimi
sono tra quelli che hanno subito il maggior calo di “consenso” nel corso degli
anni, ancora più dei tecnici.
Dati Miur
Di primo acchito viene
spontaneo commentare questi numeri con le diverse vocazioni economiche delle
aree del Paese. La regione in cui lo Stato, l’Amministrazione Pubblica, ha
maggior peso, il Lazio, vede la più grande incidenza di liceali, mentre laddove
l’industria, grande e piccola, è forte, al Nord, vi è una maggiore tendenza ad
acquisire competenze tecniche.
Ma non può passare inosservato
come questo gap si stia ulteriormente allargando. Se facciamo un confronto con
le scelte effettuate prima del Covid, quelle per l’anno scolastico 2020/21, si
può notare come nel Mezzogiorno, dove già vi era la più grande concentrazione di
iscrizioni al liceo, queste salgano ancora di più, per esempio in Sicilia (+3,2
per cento), Campania (+2,3 per cento), Molise (+5,1 per cento).
Vanno in controtendenza
scendendo rispettivamente del 0,6 per cento e del 0,1 per cento dove l’incidenza
era già minore, in Veneto e Lombardia.
Sempre nel Veneto, oltre che in
Emilia Romagna, sale di poco la preferenza per i professionali, che invece
scende in modo ben visibile in Campania, in Sicilia e in tutto il Sud, con la
Liguria, dato paradigmatico, che in questo si comporta come una regione del
Mezzogiorno. Un ulteriore segno della deindustrializzazione di Genova e
dintorni?
Dati Miur
Insomma, la correlazione è
chiara. A fare parzialmente eccezione è proprio il Lazio, dove d’altronde il
gradimento per i licei era già ai massimi livelli.
Dati Miur
Ma quali licei? Una delle
novità di questi ultimi anni è il relativo declino del classico a favore degli
scientifici – includendo nel conto quello a indirizzo sportivo e quello delle
scienze applicate – e del liceo linguistico e delle scienze umane.
In particolare questi ultimi
vedono un deciso aumento, che è ancora una volta più pronunciato proprio nelle
regioni del Sud.
Dati Miur
È probabile che molte famiglie
che non avrebbero scelto in altri tempi un liceo per i propri figli oggi si
direzionino verso indirizzi relativamente nuovi, ritenendoli più accessibili.
Detto questo, rimane sempre un
grande divario tra quanti scelgono il classico, il liceo per eccellenza, al
Centro-Sud e al Nord. In Sicilia sono più del triplo che in Emilia Romagna, il
9,6 per cento contro il 3,1 per cento.
Dati Miur
Che implicazioni ha tutto
questo? Nel Mezzogiorno di fronte a un divario economico che non accenna a
ridursi, e che anzi continua ad aumentare, è sempre più chiaro che è meglio
acquisire un buon diploma e poi magari una laurea, un asset che poi si potrà
spendere in vario modo, che una competenza specifica che non riesce a trovare
applicazione pratica immediata.
Del resto gli ultimi anni hanno
mostrato che è solo l’istruzione universitaria, indispensabile nei servizi
avanzati e nell’industria ad alto contenuto tecnologico, a poter garantire i
salari maggiori e qualche possibilità di sfuggire alla precarietà, in
particolare per i giovani.
E proprio laddove tali settori
sono di fatto assenti si assiste a un incremento di coloro che intraprendono gli
studi che più predispongono a lavorare in essi.
Cosa produce questa apparente
contraddizione? L’emigrazione. Sia quella verso l’estero che quella interna. La
percentuale di laureati tra i venticinque e i trentaquattro anni che si
trasferiscono in altri Paesi è passata dal 2012 al 2021 dal 28,5 per cento al
45,7 per cento.
E all’interno dell’Italia,
invece, si produce un massiccio afflusso a favore di quelle aree in cui i
settori trainanti sono presenti, ma spesso soffrono la mancanza di manodopera
altamente istruita. Lombardia ed Emilia Romagna insieme hanno avuto dal 2012 in
poi un saldo positivo in entrata di circa ottantamila giovani 25-34enni con
istruzione universitaria, mentre Puglia e Sicilia ne hanno avuto uno negativo di
più di trentamila unità e la Campania uno maggiore di quarantamila.
Dati Miur
In questo senso tali movimenti
migratori sono perfettamente comprensibili. Non sono questi a dover
scandalizzare, sono un semplice sintomo, così come probabilmente sono un sintomo
le scelte delle famiglie sulle scuole da fare frequentare ai figli.
Si tratta di una conseguenza
della situazione strutturale dell’economia, del gap secolare che divide Nord e
Mezzogiorno.
Finché questo non sarà chiuso,
nelle regioni meridionali sarà anzi un fattore di riequilibrio necessario, quasi
salvifico, potremmo dire, puntare su competenze più elevate e consentire loro di
essere spese altrove.
Scuola, studiare al Sud
significa perdere un anno di formazione rispetto al Nord. Chiara Sgreccia su
La Repubblica il 10 Febbraio 2023.
L’istruzione in Italia è sempre
più diseguale. E i divari nelle infrastrutture pesano anche sulla salute degli
studenti. «E l’autonomia differenziata aggrava il quadro», denuncia Svimez
Carla e Fabio sono due bambini
della stessa età. Hanno 10 anni e frequentano la quinta elementare. Carla vive a
Firenze e pranza a scuola, per questo segue una dieta bilanciata come l’85 per
cento dei bambini in Toscana che hanno accesso al servizio di mensa. Il
pomeriggio, più volte a settimana, si ferma per giocare a basket, altre per fare
i compiti. In un anno Carla, grazie al tempo pieno, svolge 1.226 ore di
formazione.
Fabio invece vive a Napoli.
Dove l’80 per cento dei bambini non ha il servizio mensa. Così per pranzo torna
a casa oppure mangia cibo già pronto, preconfezionato. Fabio ha un rischio
doppio di essere obeso o in sovrappeso rispetto a Carla anche perché non può
fermarsi a scuola per fare attività fisica dopo le lezioni, visto che l’83 per
cento degli istituti in Campania non ha una palestra. Fabio in un anno ha
garantite dallo Stato mille ore di formazione. Circa 200 in meno rispetto a
Carla che alla fine del percorso di istruzione elementare è come se avesse
frequentato un anno intero in più.
«Si chiama furto di
formazione». A spiegarlo è Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria
nel Mezzogiorno, impegnata sul tema del divario tra nord e sud, nell’istruzione
e nelle infrastrutture scolastiche. Secondo l’ultimo rapporto, infatti, nella
scuola primaria la percentuale di alunni che frequenta il tempo pieno nelle
regioni meridionali è del 18 per cento. Mentre la media del resto del paese
supera il 48 per cento. Così nel Mezzogiorno circa 650 mila alunni delle scuole
primarie non beneficiano del servizio di mensa, 550 mila non hanno una palestra.
Questi divari nelle infrastrutture hanno conseguenze negative anche sullo stile
di vita e sulla salute della popolazione: al sud quasi un minore su tre, tra i 6
e i 17 anni, è in sovrappeso. Nel Centro-nord la media è di uno su cinque. Più
grave ancora la differenza sull’aspettativa di vita: al sud è inferiore di tre
anni rispetto a chi vive nelle regioni centro settentrionali del Paese.
Dallo studio di Svimez emerge
anche il progressivo disinvestimento che caratterizza da anni il settore
dell’istruzione in Italia soprattutto al sud: tra il 2008 e il 2020, la spesa
complessiva in termini reali si è ridotta del 19,5 per cento. Oltre 8 punti
percentuali in più del Centro-nord. Per il Direttore di Svimez, Luca Bianchi:
«Il quadro che emerge dai dati, e che rischia di rafforzarsi ancor più se
passano le proposte d’autonomia, è quello di adattare l’intensità dell’azione
pubblica alla ricchezza dei territori, con maggiori investimenti e stipendi
nelle aree che se li possono permettere, pregiudicando proprio la funzione
principale della scuola che è quella di fare uguaglianza».
«Ai bambini del Sud rubato
un anno di scuola». Storia di Paolo Ferrario su Avvenire il 10 febbraio
2023.
I divari territoriali si
misurano anche confrontando il girovita degli studenti: al Sud sono di più
quelli in sovrappeso, rispetto al Nord, perché nelle scuole mancano le palestre
e non ci sono altri spazi dove effettuare attività sportiva. E questa è soltanto
una delle tante carenze che gravano sul sistema scolastico del Mezzogiorno,
puntigliosamente ricordate dal rapporto “Un Paese, due scuole”, presentato dalla
Svimez a Napoli. Secondo i dati dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno, mediamente un alunno della primaria del Sud usufruisce di 200
ore di lezione in meno rispetto ad un coetaneo del Centro-Nord, essenzialmente
per la mancanza del tempo pieno. «Di fatto si tratta di un anno di scuola
persa», si legge nel rapporto.
La mensa, un servizio fantasma
Per far sì che una scuola possa
offrire il tempo pieno alle famiglie, è necessario sia dotata del servizio
mensa. Un optional per la gran parte degli istituti del Sud. Secondo i dati
Svimez, nel Mezzogiorno, circa 650mila alunni delle scuole primarie statali (79%
del totale) non beneficiano di alcun servizio mensa. In Campania se ne contano
200mila (87%), in Sicilia 184mila (88%), in Puglia 100mila (65%), in Calabria
60mila (80%). Nel Centro-Nord, gli studenti senza mensa sono 700mila, il 46% del
totale, mentre la media nazionale è del 57,94% di bambini senza mensa.
Il tempo pieno? Un miraggio
A causa di queste «carenze
infrastrutturali», solo il 18% degli alunni del Mezzogiorno accede al tempo
pieno a scuola, rispetto al 48% del Centro-Nord. La Basilicata (48%) è l’unica
regione del Sud con valori prossimi a quelli del Nord. Bassi i valori di Umbria
(28%) e Marche (30%), molto bassi quelli di Molise (8%) e Sicilia (10%). E
ancora. Gli allievi della scuola primaria nel Mezzogiorno frequentano mediamente
4 ore di scuola in meno a settimana rispetto a quelli del Centro-Nord. La
differenza tra le ultime due regioni (Molise e Sicilia) e le prime due (Lazio e
Toscana) è, appunto, di circa 200 ore all'anno.
Video correlato: Il miracolo
dei due bambini estratti vivi dopo 17 ore dalle macerie a Idlib (Corriere Tv)
Meno palestre, più bimbi obesi
Anche sul versante
dell'educazione motoria, il Sud è messo male. Sono circa 550mila (il 66% del
totale) gli alunni delle primarie del Mezzogiorno che frequentano scuole non
dotate di palestra. L'unica eccezione è la Puglia. Per il resto, la Svimez
registra un netto ritardo in Campania (170mila allievi privi del servizio, 73%
del totale), in Sicilia (170mila, 81%), in Calabria (65mila, 83%). Nel
Centro-Nord, gli allievi della primaria senza palestra, invece, raggiungono il
54%. Analogamente, il 57% degli alunni meridionali della scuola secondaria di
secondo grado non ha accesso a una palestra; la stessa percentuale che si
registra nella scuola secondaria di primo grado. Questa lacuna ha un'influenza
diretta sullo stile di vita dei bambini: nel Meridione quasi un minore su tre
nella fascia tra i 6 e i 17 anni, è in sovrappeso, rispetto ad un ragazzo su
cinque nel Centro Nord.
Crollati gli investimenti in
istruzione
Un altro indicatore che aggrava
ulteriormente il divario Nord-Sud è quello relativo alla spesa per investimenti
nell'istruzione. Nel periodo che va dal 2008 al 2020, mentre in Italia questo
capitolo di spesa ha perso, in media, il 14,3% (circa 8 miliardi di euro in
meno), al Centro-Nord il taglio è stato dell'11,2% (circa 3,7 miliardi di euro),
mentre al Sud del 19,5% (oltre 4 miliardi di euro). «Più significativo è il
rapporto tra spesa e studenti - osserva lo Svimez - dal quale risulta uno scarto
sfavorevole al Sud, dove la spesa per studente è di circa 100 euro annui
inferiore rispetto al resto del Paese (5.080 euro per studente contro 5.185). Lo
scarto aumenta se si considera il solo comparto della scuola, con una spesa per
studente di 6.025 euro al Sud contro un valore di 6.395 nel Centro-Nord. Lo
scarto è ancora più significativo se si guarda alla sola spesa per investimenti:
34,6 contro 51 euro per studente».
In cinque anni persa la
popolazione di Venezia
Complice anche il calo
demografico, tutte queste carenze infrastrutturali e di servizi, hanno portato a
un progressivo spopolamento delle scuole del Mezzogiorno. Secondo il rapporto
della Svimez, tra il 2015 e il 2020 il numero di studenti dalla materna alle
superiori) si è ridotto di quasi 250mila unità (-75mila nel Centro-Nord). È come
se il sistema scolastico del Sud avesse perso, in appena cinque anni, una
popolazione studentesca pari agli abitanti di Venezia.
«Pnrr, occasione di rilancio»
«Per contrastare queste
dinamiche - spiega il direttore della Svimez, Luca Bianchi - occorre invertire
il trend di spesa e rafforzare le finalità di coesione delle politiche pubbliche
nazionali in tema di istruzione. Il Pnrr è l’occasione per colmare i divari
infrastrutturali, garantendo asili nido, tempo pieno, palestre, rafforzando
l’offerta formativa dove più alto è il rischio di abbandono».
«L’Autonomia avanza, ma il
Sud continua a non fare squadra»: la parola al giornalista Marco Esposito.
«Le regioni meridionali dovrebbero costituire un organismo comune». Leonardo
Petrocelli su La Gazzetta del Mezzogiorno il 10 Febbraio 2023
Un Nord non più così compatto
ma abituato a far squadra meglio di un Sud che, d’altra parte, vede crescere la
propria consapevolezza. Marco Esposito, giornalista e saggista, autore del
fortunato volume Zero al Sud (Rubbettino), mette il termometro al dibattito
scatenato dal via libera in Cdm al ddl sull’autonomia differenziata. Proprio la
riforma targata Calderoli sarà oggetto oggi, all’Università di Bari (Aula Magna,
ore 15), di una tavola rotonda, moderata dal direttore della «Gazzetta», Oscar
Iarussi, che vedrà Esposito tra i relatori insieme agli economisti Gianfranco
Viesti e Nicola Daniele Coniglio, all’editore Alessandro Laterza, al deputato 5
Stelle Gianmauro dell’Olio e al sindaco di Acquaviva Davide Carlucci.
Marco Esposito, cominciamo
dalla fine e dunque dallo spunto offerto dalla tavola rotonda di oggi. Quale
livello di consapevolezza c’è al Sud sul tema dell’autonomia?
«Un livello sempre crescente.
D’altronde, questo tema è caldo dal 2017, cioè da quando si sono tenuti i
referendum per avviare il percorso in Veneto e Lombardia».
Poi però la cosa è scivolata
sotto traccia...
«I primi accordi, con il
Governo Gentiloni, e le successive trattative, durante il Conte I, hanno avuto
luogo in modo non pubblico. L’obiettivo era tenere il Mezzogiorno all’oscuro di
tutto».
Anche perché, diciamocelo, il
Sud non aveva dato prova di particolare belligeranza come racconta nel suo «Zero
al Sud». O no?
«La precedente attuazione del
federalismo fiscale era avvenuta con una grande disattenzione del Sud con regole
nate distorte e finite peggio»...
IN 10 ANNI LA
DESERTIFICAZIONE DEL SUD: VIA OLTRE 500MILA RESIDENTI. Si emigra
maggiormente da Campania, Sicilia e Puglia. Lombardia ed Emilia Romagna le
regioni di approdo. Per studio e lavoro il Regno Unito al top delle scelte dei
giovani. GIAMBATTISTA PEPI su Il Quotidiano del Sud il 10 Febbraio 2023
Il dato non è nuovo ma si
aggrava: il Mezzogiorno continua a perdere popolazione a vantaggio del
Centro-Nord. Nel decennio 2012 – 2021 ha perso 525mila residenti accrescendo
l’impoverimento strutturale sia per lo spopolamento, sia per il depauperamento
di risorse umane qualificate.
Si parte di più da Campania
(30%), Sicilia (23%) e Puglia (18%). Tassi sopra il 6% in Basilicata e Molise. I
principali flussi sono diretti verso Lombardia (28%) e in particolare
l’Emilia-Romagna. Visto da Sud il Rapporto dell’Istat sulle migrazioni interne e
internazionali (relativo al 2021 e aggiornato ai primi 10 mesi del 2022)
conferma, se ancora ce ne fosse stato bisogno, il divario della popolazione
residente tra il Mezzogiorno e le altre macro aree del Paese. Del resto è
l’Istituto nazionale di statistica stesso nell’incipit del Rapporto a confermare
la ripresa nel 2021 della mobilità interna (un milione 423mila trasferimenti, +
6,7% rispetto al 2020, che era stato l’anno in cui era esplosa la pandemia
Covid-19).
Nei 10 anni 2012-2021 sono
stati circa 1,13 milioni i movimenti in uscita dal Sud e dalle Isole verso il
Centro-Nord e a circa 613mila quelli sulla rotta inversa. Il bilancio tra uscite
ed entrate si è tradotto, come detto, in una perdita netta di 525mila residenti
per il Mezzogiorno. Nel 2021 la ripresa della mobilità interna ha interessato
anche gli spostamenti lungo questa direttrice. Ammontano a circa 112mila i
trasferimenti dai comuni meridionali verso quelli settentrionali, in lieve
aumento (+3%) rispetto al 2020, ma in deciso calo (-17%) rispetto al periodo
pre-pandemico.
La regione del Mezzogiorno da
cui si parte di più è la Campania (30% delle cancellazioni dal Mezzogiorno),
seguita da Sicilia (23%) e Puglia (18%). In termini relativi, rispetto alla
popolazione residente, il tasso di emigratorietà più elevato si ha in Calabria
(circa otto residenti per 1.000). Tassi sopra il 6‰ si registrano per Basilicata
e Molise. La regione verso cui si dirigono prevalentemente questi flussi è, in
termini assoluti, la Lombardia (28%) ma, in termini relativi, l’Emilia-Romagna è
quella che li attrae di più (quattro trasferimenti dal Mezzogiorno per 1.000
residenti).
La provincia del Mezzogiorno da
cui si registrano più partenze verso il Centro-nord è Napoli in termini assoluti
(17mila partenze), mentre Crotone ha il tasso di emigratorietà più elevato: 11
residenti su 1.000 che si spostano al Centro-nord. Viceversa, la provincia
centro settentrionale che riceve più emigrati dal meridione è Milano (14mila
arrivi), ma, in termini relativi, l’area metropolitana di Bologna è più
attrattiva (6‰).
Ci confortano fino ad un certo
punto gli altri dati salienti dell’Istat: l’aumento delle immigrazioni (oltre
318mila; +28,6%) la diminuzione delle emigrazioni (poco più di 158mila; -1% sul
2020) soprattutto dei cittadini italiani (94mila; -22%).
IN RIPRESA LA MOBILITÀ DEI
COMUNI
Nel 2021 il volume dei
trasferimenti di residenza interni al Paese, pari a 1 milione 423mila (+6,7%
rispetto al 2020), è quasi in linea con il dato del 2019 quando si registrava
circa 1 milione 485mila movimenti tra Comuni. L’aumento della mobilità
residenziale si riflette sia tra i movimenti all’interno delle regioni (+7,4%)
sia tra regioni diverse (+4,6%).
IL CENTRO-NORD “RECUPERA”
GIOVANI LAUREATI DAL SUD
Con riferimento alle regioni
d’origine, le perdite di popolazione dovute allo scambio con l’estero possono
essere compensate dai trasferimenti di residenza tra le ripartizioni del Paese.
Il movimento di giovani risorse che si spostano dal Mezzogiorno verso il Centro
e il Nord riesce, talvolta, a invertire il bilancio negativo trasformandolo in
guadagno di popolazione.
È quello che accade al Nord
Italia dove, durante il decennio, a fronte di perdite complessive di giovani
residenti causate dai movimenti con l’estero, si osserva un saldo migratorio
positivo dovuto agli scambi di popolazione in maggioranza proveniente dal
Mezzogiorno.
Negli ultimi dieci anni,
infatti, gli espatri di giovani laureati sono sempre stati quantitativamente
superiori ai rimpatri e hanno prodotto, per ciascuna ripartizione, un saldo
migratorio con l’estero negativo
La perdita complessiva di
giovani risorse del Nord a favore dell’estero ammonta a circa 39mila unità,
quella del Centro è di circa 13mila mentre quella del Mezzogiorno è di circa
28mila unità in tutto il periodo considerato. A fronte di queste significative
perdite, il Nord e il Centro riescono a compensare in buona parte le uscite
verso l’estero grazie ai movimenti migratori provenienti dal Mezzogiorno. Il
Nord guadagna oltre 116mila giovani risorse provenienti dal Sud e dalle Isole,
il Centro quasi 13mila. I saldi migratori interni evidenziano la perdita o il
guadagno di popolazione dovuti ai trasferimenti di residenza da una regione
all’altra. In termini relativi i saldi migratori per 1.000 residenti più elevati
si hanno in Emilia-Romagna (+3‰) e nella provincia autonoma di Trento (+2,3‰),
quelli più bassi in Basilicata (-4,7‰), Calabria (-4,3‰), e Molise (-3,7‰). In
generale, le regioni del Centro-Nord mostrano saldi netti positivi (in media,
+1,3‰); viceversa, quelle del Mezzogiorno riscontrano tutte perdite nette di
popolazione (-2,5‰).
PIÙ RIMPATRI DAI PRINCIPALI
PAESI EUROPEI
Con riferimento alla componente
italiana proveniente dall’estero, nel 2021 i rimpatri dei cittadini italiani
sono stati 75mila (+34% rispetto al 2020 e +10% rispetto al periodo
pre-pandemico).
I rimpatri provengono in larga
parte da paesi che sono stati in passato mete di emigrazione. Con in testa Regno
Unito e Germania (che, insieme, originano complessivamente il 27% dei flussi di
immigrazione), il 7% dei flussi di rientro proviene dalla Svizzera, il 5% dalla
Francia, il 4% dalla Spagna. Per quanto riguarda le provenienze oltre oceano, il
5% dei rimpatri arriva dagli Stati Uniti, il 4% dall’Argentina e dal Brasile.
I PAESI DOVE VANNO GLI ITALIANI
L’Europa continua a essere la
principale area di destinazione delle emigrazioni dei cittadini italiani (83%
degli espatri) ma è anche l’area che ha risentito maggiormente del calo degli
espatri nel 2021 (-22% rispetto al 2020). Rallentano, ma restano numerose, le
partenze degli italiani verso il Regno Unito (23mila, 24% del totale degli
espatri), così come quelle verso la Germania (14mila, 15%), la Francia (11mila,
12%), la Svizzera (9mila, 9%) e la Spagna (6mila, 6%). Tra i paesi extra
europei, le mete preferite sono gli Stati Uniti (4mila, 4%) e l’Australia
(2mila, 2%).
La qualità dell'informazione è
un bene assoluto, che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del
Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con
il massimo di passione e di competenza possibili.
Populismo differenziato.
L’autonomia di Calderoli moltiplica i danni della riforma ulivista del Titolo V
del 2001. Alessandra Senatore su L’Inkiesta il 7 Febbraio 2023.
Se passasse il disegno di legge
proposto dal ministro leghista, il Parlamento sarebbe estromesso dal processo
che deve definire quale sia il livello essenziale delle prestazioni per tutti i
cittadini italiani su temi cruciali come scuola e sanità
Dopo i governi pentaguidati,
che nella scorsa legislatura hanno nuovamente relegato le politiche per il
mezzogiorno all’assistenzialismo improduttivo e alla dipendenza socio-economica,
e dopo un breve, fortunato e illuminato momento in cui sembrava che, con il
governo Draghi e l’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fosse
finalmente iniziata una stagione di politiche in grado di affrontare in modo
strutturale il divario territoriale tra le regioni del nostro paese, il Sud
torna ad essere esposto al rischio di un’ulteriore marginalizzazione. Rischio
molto concreto, se si desse davvero attuazione alla cosiddetta autonomia
differenziata, come prospettata nella proposta del ministro Roberto Calderoli
approvata dal Consiglio dei ministri.
Sono passati più di vent’anni
dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che – è il caso di ricordarlo –
originariamente provò a tener conto della pluralità e delle differenze esistenti
nel tessuto sociale, culturale, politico ed economico del nostro Paese e portò
quindi l’Assemblea costituente a concludere che la Repubblica italiana dovesse
garantire l’equilibrio tra il principio di unità dello Stato e quello del
decentramento dei poteri costituzionali.
Passarono vent’anni prima che
nel 1968 venisse approvata la legge che disciplinava l’elezione dei consigli
nelle regioni a statuto ordinario. Un ritardo importante, legato a
considerazioni di opportunità più politica, che istituzionale, nell’Italia in
cui l’appartenenza atlantica, nel pieno della Guerra Fredda, rendeva impossibile
l’attribuzione di veri poteri politico-legislativi a organi elettivi
egemonizzati in diverse regioni dal Partito Comunista Italiano.
Ma dal 1970, quando le regioni
videro finalmente luce, alla riforma del Titolo V di anni ne passarono altri
trenta, senza che il regionalismo italiano desse segni di particolare efficienza
e capacità di interpretare i bisogni territoriali, se non in una logica
localistica, rivendicativa, vittimistica e protestataria.
La riforma del 2001, approvata
dalla sinistra, non fu il tentativo di razionalizzare il regionalismo italiano,
ma di arginare la crescita della destra condizionata dall’ipoteca leghista, in
cui il cosiddetto federalismo era semplicemente la versione istituzionalmente
non eversiva della vecchia e mai rinnegata istanza secessionista.
Con questo stesso spirito oggi
la Lega spinge a usare l’autonomia differenziata voluta dalla sinistra, come in
precedenza provò a usare la cosiddetta devolution, cioè la riforma
costituzionale approvata dalla maggioranza berlusconiana nel 2006 e poi bocciata
nel referendum confermativo.
Anziché procedere inerzialmente
sulla strada tracciata nella riforma del 2001, oggi bisognerebbe aprire una
riflessione onestamente revisionistica sui suoi esiti.
Durante il Covid è emerso in
modo evidente quanto possa essere inefficiente un sistema di competenze
concorrenti per prendere decisioni coordinate e coerenti su questioni che
toccano profondamente la vita delle persone, soprattutto in settori cruciali
quali la sanità pubblica e l’istruzione. Ci sono inoltre materie, come il
turismo, i trasporti, le opere infrastrutturali e la produzione di energia, in
cui una regia centralizzata che definisca regole comuni, ragionando con una
visione di sistema e non per singole parti, è strategicamente più efficace ed
efficiente. Ne è prova il fatto che l’ambiguità nella potestà legislativa –
presente in molte materie di legislazione concorrente – ha di fatto, in questi
anni, determinato un pesante rallentamento nelle decisioni operative, sempre più
soggette a lunghe discussioni in Conferenza Stato Regioni e all’arbitrato della
Corte Costituzionale.
Anche sul piano finanziario,
pur non potendo affermare che la riforma sia stata l’unica causa di questo
fenomeno, a partire dall’inizio degli anni 2000 si è verificato un aumento della
spesa pubblica locale, in particolare in ambito sanitario: le regioni hanno
speso più di quanto avessero a disposizione, soprattutto al Sud, a fronte di un
abbassamento drammatico del livello di servizio.
Però, anche al netto delle
valutazioni di merito sugli esiti di quella riforma, resta comunque chiaro che
l’assetto definito nelle linee essenziali dall’articolo 119 della Costituzione,
come modificato nel 2001, configurava un modello volto a perseguire finalità di
carattere solidaristico, che nulla hanno a che fare con le derive disgregative
innescate dalle attuali forze di maggioranza, con il solo alibi della
definizione di LEP, però interamente assegnati alla discrezionalità
dell’esecutivo.
Il Parlamento, sulla base della
proposta Calderoli, sarebbe estromesso dal processo che deve definire quale sia
il livello essenziale delle prestazioni per tutti i cittadini italiani su temi
cruciali come scuola e sanità.
È evidente che l’istanza
federalista, a cui si accompagna la richiesta di maggior potere legislativo,
oggi (come ieri) esprime l’antagonismo tra regioni nella ripartizione delle
risorse fiscali, e non rappresenta una reale risposta alla richiesta di
adeguamento delle scelte pubbliche alle peculiarità di ciascun territorio. Per
altro non è nemmeno realistico credere che una maggiore autonomia legislativa
possa di per sé essere garanzia di buona amministrazione delle risorse: in
talune materie è esattamente il contrario.
L’Italia alle prese con la
gestione del Pnrr e con la necessità di avere processi decisionali tempestivi ed
efficienti non ha bisogno di più leggi e di ulteriori conflitti di competenza.
L’autonomia amministrativa è sufficiente per ottenere tutto quello che è
necessario per adeguare le norme alle specificità delle realtà territoriali.
Peraltro, in un momento di difficoltà economica e sociale come quello che il
Paese sta attraversando per un complesso di ragioni nazionali e internazionali,
non possiamo permetterci di innescare processi sperequativi che acuirebbero
ulteriormente le disuguaglianze sociali di alcuni territori.
È innegabile che il
conferimento alle regioni di materie cruciali per la vita delle persone ha
creato palesi disuguaglianze tra i cittadini delle regioni meridionali e quelli
delle regioni del centro nord, creando l’humus su cui naturalmente germoglia e
dilaga la propaganda populista. L’attuazione distorta del federalismo fiscale,
fino ad oggi in assenza dei LEP, e il venir meno di un controllo centrale per
garantire l’economicità della spesa e standard delle prestazioni omogenei, hanno
consentito che l’inefficienza gestionale e i relativi disavanzi di sistema,
spesso derivanti da logiche di governo basate su criteri tutt’altro che
aziendalistici,si traducesse nell’incapacità di alcune regioni di offrire quei
servizi essenziali che pure dovrebbero essere garantiti in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale, come sancito dal dettato costituzionale.
In particolar modo, in ambito
sanitario il venir meno della funzione di riequilibrio svolta dal SSN in seguito
al conferimento alle regioni di un’autorità legislativa che ha legittimato
scelte operative spesso molto differenti, ha generato disuguaglianze importanti
ed ingiuste. È un dato indiscutibile che prestazioni fondamentali come quelle
riguardanti le cure primarie, l’assistenza neonatale, la gestione delle urgenze
e, non meno importante, la prevenzione, siano quantitativamente e
qualitativamente presenti in misura drammaticamente diversa tra una regionee
l’altra. È emblematico che alla fine degli anni ’90 l’aspettativa di vita nelle
regioni del sud fosse maggiore che in quelle del nord, mentre oggi la situazione
appare praticamente ribaltata.
Il rapporto
Osservasalutehttps://osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2021
dell’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che
approfondisce il tema delle disuguaglianze sociali nella salute in Italia,
evidenzia un divario tra regioni del nord e regioni del sud, dove il tasso di
decessi per cancro e altre malattie croniche – su cui impattano un’efficace
prevenzione e la capacità di agire in urgenza – è maggiore alla media nazionale.
I dati presentati dall’Osservatorio nel 2021 testimoniano il sostanziale
fallimento delle politiche sanitarie: “troppe e troppo marcate le differenze
regionali e sociali rispetto all’aspettativa di vita e alle condizioni di
salute”.
In generale poi la questione
dell’autonomia va anche letta in modo più laterale: se è vero che l’attuazione
incompiuta e distorta del federalismo fiscale ha fatto sì che per anni i
territori con scarsa capacità fiscale venissero deprivati di parte delle risorse
necessarie a garantire molti dei servizi correlati ai diritti sociali e civili
propri di tutti i cittadini italiani, aggravando quindi il divario territoriale,
buona parte della responsabilità di tutto questo è ascrivibile alla classe
politica meridionale, poco attenta e presente ai tavoli di discussione e
decisione sulle scelte attuative.
Si tratta di quella stessa
classe politica che oggi rivendica la giusta perequazione delle risorse, senza
però assumere mai un impegno di piena responsabilità sui risultati nell’utilizzo
delle risorse richieste. È esattamente qui il nodo cruciale di un discorso
realistico e corretto sull’autonomia differenziata, perché il problema del
divario territoriale non si risolve con la sola redistribuzione delle risorse in
funzione dei fabbisogni standard e con l’introduzione dei LEP in luogo della
spesa storica.
La perequazione non è solo
questione di risorse disponibili, ma è anche e soprattutto una questione di
capacità di governo nella gestione delle risorse.
La gestione di risorse
importanti, come quelle destinate alla Sanità, ha solo accresciuto il potere e
la discrezionalità della classe politica locale, cosa che – in molti casi, e
prevalentemente nel sud Italia – ha finito per alimentarele ataviche logiche
clientelari e le inefficienze croniche della Pubblica Amministrazione. Se a
questo aggiungiamo il proliferare del populismo che si nutre proprio delle
disuguaglianze sociali, con il suo reflusso assistenzialistico, sembra
verosimilmente impossibile immaginare quel controllo democratico da parte dei
cittadini, che era uno dei presupposti essenziali affinché la riforma cosiddetta
federalista potesse avere un impatto positivo sulla capacità di governo degli
amministratori locali.
Nell’analizzare le possibili
evoluzioni dell’assetto istituzionale dello Stato, non si può prescindere dalla
realtà del nostro sistema politico e non tener conto dei sui vizi storici.
L’autonomia è stata e sarà disfunzionale in contesti in cui il potere si
sostanzia nell’occupazione, da parte della politica, di ruoli decisionali
decisivi per la gestione delle risorse, al solo fine di consolidare e perpetrare
ulteriormente quel potere.
Tutto questo produce un vero e
proprio corto circuito sistemico, perché il mal governo di alcuni territori,
aggravato appunto dal maggior potere conferito dall’autonomia, chiaramente
alimenta la narrazione delle regioni “virtuose”, che pertanto rivendicano una
sempre maggiore autonomia.
Pensare che si possano
contrastare le inefficienze dovute alla cattiva gestione delle risorse al sud
perseguendo una maggiore autonomia, che di fatto sottrae risorse ai suoi
cittadini, non solo è ideologicamente sbagliato ma è politicamente ed
economicamente fallimentare. L’autonomia differenziata sarebbe semplicemente un
“di più” dei difetti e dei danni prodotti fino ad oggi dal federalismo
all’italiana.
«Decentrare rende più
efficienti? Un falso mito, vi spiego perché». L’economista Coniglio:
politici locali meno qualificati e legati a logiche di consenso. Leonardo
Petrocelli su la Gazzetta del Mezzogiorno il 05 Febbraio 2023.
Ci sono i talebani
dell’autonomia differenziata al seguito del ministro Roberto Calderoli. Poi, sul
fronte opposto, le sparute forze della società civile (soprattutto meridionale)
che si oppongono al progetto. E infine, nel mezzo, una terza compagine, quella
che nei prossimi mesi farà probabilmente la differenza: «Sono coloro che non
ostacolano né supportano attivamente la battaglia, ma spesso dichiarano che
l’autonomia differenziata avrà un effetto positivo sulle politiche». È a loro
che si rivolge Nicola Daniele Coniglio, ordinario di Politica economica
all’Università di Bari, proprio per smentire il falso mito che a un maggior
decentramento corrisponda una maggio efficienza nella spesa e nell’erogazione
dei servizi.
Professor Coniglio, da dove
partiamo?
«Proprio da questa posizione
che aleggia nel dibattito. Ho sentito il ministro Raffaele Fitto dichiarare che
l’autonomia consentirà di rispondere meglio alle istanze dei cittadini senza
togliere nulla ad altri».
E non è così?
«Da tempo gli economisti si
interrogano sul rapporto tra decentramento ed efficienza. Studiosi come Donahue,
Putnam e Tiebout hanno messo in evidenza i tre principali “doni”, cioè vantaggi,
che deriverebbero da una maggiore autonomia concessa a livelli di governo
sub-nazionale».
Andiamo in ordine: il primo
dono quale sarebbe?
«Una maggior vicinanza ai
cittadini consentirebbe di disegnare politiche migliori, più adatte alla realtà
di cui si parla».
Questo, in effetti, sembra
piuttosto logico...
«Lo sarebbe se il livello
qualitativo delle classi dirigenti locali fosse identico o superiore a quelle
nazionali. Non è così. È il contrario: i livelli più “bassi” sono in media meno
qualificati e più scadenti. Ma c’è dell’altro».
Prego.
«Un serie di politiche, come
Sanità e Trasporti, perdono di efficacia se “spacchettate”. Il Covid, per dirne
una, ha dimostrato senza ombra di dubbio che la scala ottimale per le politiche
sanitarie è quella nazionale. La risposta regionale è stata tutt’altro che
vicina alle esigenze dei cittadini».
Passiamo avanti: il secondo
vantaggio del decentramento quale sarebbe?
«Una maggiore spinta
all’innovazione delle politiche. Una diversità di approcci a problemi comuni
porta, nel medio periodo, a trovare e diffondere soluzioni collettive migliori».
Anche questo è un falso mito?
«Tralasciando l’idea secondo
cui le innovazioni migliori le farebbero le regioni e non lo Stato centrale, non
è chiaro quale sia il canale di trasmissione delle “politiche migliori” da
un’area del Paese all’altra».
Cioè se un territorio individua
una buona pratica non è detto che anche gli altri la adottino?
«Esatto. Anzi, è più probabile
che non la adottino e che tutto si risolva nell’avere servizi migliori dove hai
istituzioni migliori. Al contrario, è l’approccio centralistico a garantire la
diffusione. Oggi il Paese che innova più al mondo, dalle monete digitali al
welfare, è la Cina e lì il potere del governo centrale è fortissimo».
Terzo e ultimo «dono».
«Una maggiore responsabilità
della classe politica locale che deriverebbe proprio dai maggiori poteri
ottenuti. Questo è l’assioma meno certo fra i tre».
Perché?
«Perché maggiori poteri e
maggiori responsabilità dei politici locali potrebbero tradursi facilmente in
una spesa pubblica assai distorta dal consolidamento del consenso. Soprattutto
in tempi di forte astensione si tende a canalizzare gli sforzi sulle minoranze
che possono garantire, o comunque aiutare, la rielezione».
Alla fine, professore, qual è
la morale?
«È quella contenuta in un
emblematico studio di Andrés Rodriguez-Pose e Roberto Ezculla del 2011 che
analizza la relazione tra decentramento e crescita economica in 21 Paesi ricchi,
tra cui il nostro, e mette in luce l’effetto negativo sulla crescita. Processi
come l’autonomia differenziata sembrano produrre più danni che vantaggi».
E dal punto di vista fiscale?
«Altro studio di Rodriguez-Pose
e altra dimostrazione empirica: a una maggiore autonomia politica non segue una
adeguata autonomia fiscale. Il cosiddetto “mandato non finanziato”».
Ricorda un po’ la questione dei
Lep per i quali non ci sono, al momento, risorse.
«Il nodo è quello. Un semplice
elenco dei Lep non serve. Il problema sono le risorse per finanziarli. Ed è il
motivo per cui non sono stati messi nero su bianco finora».
E il risultato quale sarà?
«Che alle regioni più povere
non saranno associate adeguate risorse mentre è più probabile che, nel caso di
Lombardia e Veneto, a un mandato più ampio corrisponderanno risorse maggiori. Di
fatto, saranno in pochi a guadagnarci e per chi resta fuori l’effetto non è
neutrale».
Dunque dovrebbe essere
nell’interesse dei governatori del Sud alzare le barricate.
«Vedremo. Di certo, ad un
governatore populista, diciamo così, anche con i Lep sulla carta e poche
risorse, il barattolo di marmellata fa gola comunque. E il barattolo sono le
nuove competenze che potrebbero arrivare».
L’autonomia è la ricetta
sbagliata per curare la sanità malata del Sud. VINCENZO DAMIANI su Il
Quotidiano del Sud il 03 Febbraio 2023.
L’ATTUAZIONE dell’autonomia
darà il colpo di grazia alla sanità del Mezzogiorno, già in forte ritardo
rispetto al resto del Paese come dimostra già la valutazione dei Livelli
essenziali di assistenza. A fornire la “prova” è un report della fondazione
Gimbe elaborato per rilevare i possibili effetti della riforma Calderoli:
dall’aumento della mobilità passiva per il Mezzogiorno alla ulteriore fuga dei
medici dagli ospedali del Sud, attratti da stipendi maggiori al Nord. Andiamo
con ordine. I livelli essenziali di assistenza (Lea) sono le prestazioni e i
servizi che il Sistema sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i
cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di compartecipazione
(ticket).
Ogni anno il ministero della
Salute esamina l’adempimento delle Regioni nell’erogazione dei Lea, attraverso
la valutazione di 34 indicatori suddivisi tra attività di prevenzione collettiva
e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Gimbe ha
calcolato i punteggi ottenuti da ciascuna Regione in 10 anni, dal 2010 al 2019,
il massimo raggiungibile è di 2.250 punti. Ai primi posti ci sono solo regioni
del Nord: “Le tre Regioni – si legge nel report – che hanno avanzato la
richiesta di maggiori autonomie, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, si trovano
tutte nel primo quartile (adempimento cumulativo 86%). In secondo luogo, nei
primi due quartili (adempimento cumulativo 76,6%) non si posiziona nessuna
Regione del Sud e solo due del Centro (Umbria, Marche). Infine, tutte le Regioni
del Centro-Sud (eccetto la Basilicata) rimangono da 12-16 anni in Piano di
rientro (giallo) e Calabria e Molise sono ancora commissariate (rosso)”. Senza,
quindi, la garanzia di fondi per riequilibrare la situazione i sistemi sanitari
regionali del Mezzogiorno sono destinati ad affondare.
Capitolo mobilità sanitaria:
l’analisi della conferma la forte capacità attrattiva delle Regioni del Nord,
cui corrisponde quella estremamente limitata delle Regioni del Centro-Sud, visto
che nel decennio 2010-2019, tredici Regioni, quasi tutte del Centro Sud, hanno
accumulato un saldo negativo pari a 14 miliardi. E tra i primi quattro posti per
saldo positivo si trovano sempre le tre Regioni che hanno richiesto le maggiori
autonomie: Lombardia (+6,18 miliardi), Emilia-Romagna (+3,35 miliardi), Toscana
(+1,34 miliardi), Veneto (+1,14 miliardi). Al contrario, le cinque Regioni con
saldi negativi superiori a un miliardo sono tutte al Centro-Sud: Campania (-2,94
miliardi), Calabria (-2,71 miliardi), Lazio (-2,19 miliardi), Sicilia (-2
miliardi) e Puglia (-1,84 miliardi).
“La richiesta di maggiori
autonomie – commenta Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe –
viene proprio dalle Regioni che fanno registrare le migliori performance
nazionali in sanità”. Infatti, dalla “fotografia” sugli adempimenti al
mantenimento dei Lea relative al decennio 2010-2019 emerge che le tre Regioni
che hanno richiesto maggiori autonomie si collocano nei primi 5 posti della
classifica, rispettivamente Emilia Romagna (1a), Veneto (3a) e Lombardia (5a),
mentre nelle prime 10 posizioni non c’è nessuna Regione del Sud. Da qui
l’allarme del presidente di Gimbe: “Il testo che al momento blinda l’autonomia
differenziata come un affaire tra Governo e Regioni esautorando il Parlamento –
commenta Cartabellotta – non prevede risorse per finanziare i livelli essenziali
delle prestazioni (Lep) e consente il trasferimento delle autonomie alle Regioni
prima senza recuperare i divari tra le varie aree del Paese”.
Quindi, “l’attuazione delle
maggiori autonomie darà il colpo di grazia al Servizio sanitario nazionale,
aumenterà le diseguaglianze regionali e legittimerà normativamente il divario
tra Nord e Sud, violando il principio costituzionale di uguaglianza dei
cittadini nel diritto alla tutela della salute”. Il report Gimbe, ripercorre la
“cronistoria” del regionalismo differenziato, analizza le criticità della bozza
del DdL, valuta il potenziale impatto sul Ssn delle autonomie richieste da
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, “fotografa” l’entità delle diseguaglianze
regionali sull’adempimento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e della
mobilità sanitaria. Secondo la fondazione, alcune “istanze risultano francamente
“eversive””. Una maggiore autonomia in materia di istituzione e gestione di
fondi sanitari integrativi darebbe il via a sistemi assicurativo-mutualistici
regionali sganciati dalla, seppur frammentata, normativa nazionale. Inoltre, la
richiesta del Veneto di contrattazione integrativa regionale per i dipendenti,
oltre all’autonomia in materia di gestione del personale e di regolamentazione
dell’attività libero-professionale, rischia di concretizzare una concorrenza tra
Regioni con “migrazione” di personale dal Sud al Nord, ponendo una pietra
tombale sulla contrattazione collettiva nazionale e sul ruolo dei sindacati.
Per Gimbe, “alcune forme di
autonomia rischiano di sovvertire gli strumenti di governance del Ssn aumentando
le diseguaglianze nell’offerta dei servizi: sistema tariffario, di rimborso, di
remunerazione e di compartecipazione, sistema di governance delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario regionale, determinazione del numero di borse
di studio per specialisti e medici di famiglia”. “Questi dati – continua
Cartabellotta – confermano che nonostante la definizione dei Lea dal 2001, il
loro monitoraggio annuale e l’utilizzo da parte dello Stato di strumenti quali
Piani di rientro e commissariamenti, persistono inaccettabili diseguaglianze tra
i 21 sistemi sanitari regionali, in particolare un gap strutturale Nord-Sud che
compromette l’equità di accesso ai servizi e alimenta un’imponente mobilità
sanitaria in direzione Sud-Nord”.
Di conseguenza, l’attuazione di
maggiori autonomie in sanità, richieste proprio dalle Regioni con le migliori
performance sanitarie e maggior capacità di attrazione, non potrà che
amplificare le inaccettabili diseguaglianze registrate con la semplice
competenza regionale concorrente in tema di tutela della salute.
La qualità dell'informazione è
un bene assoluto, che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del
Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con
il massimo di passione e di competenza possibili.
PAGO I DEBITI, MA DEVO
FALLIRE! IL CONTO DEI DIVARI STRUTTURALI E DI UN MECCANISMO FINANZIARIO PERVERSO
CHE PAGANO 170 COMUNI DUE TERZI DEI QUALI TRA CALABRIA, CAMPANIA E SICILIA.
ROBERTO NAPOLETANO su Il Quotidiano del Sud il 05 Febbraio 2023.
Sono state rimesse in
discussione anticipazioni di liquidità su debiti pregressi anche per gli enti
locali in dissesto costringendoli a ripianare in dieci anni ciò che si era
concordato di restituire separatamente in trent’anni e che si sta regolarmente
restituendo. Tutto di un colpo bisogna onorare debiti commerciali fatti da altri
e ritenuti anche il frutto di un’emergenza nazionale strutturale che ha
riguardato enti locali, asl e altre amministrazioni come se il Comune non fosse
più in dissesto. Questo ulteriore vincolo va rimosso subito restituendo tutto
alla liquidazione. Vale per Benevento come per Cosenza. Per Catania come per
Afragola. Siamo sempre al Sud comunque. Anche per questo serve l’operazione
verità sui divari e sui trasferimenti di spesa pubblica.
Per capire come è davvero
differenziata la situazione in questo Paese è esemplare la storia del fondo
anticipazione di liquidità, il cosiddetto Fal, che può fare saltare per aria 170
Comuni italiani di cui oltre due terzi sono nel Mezzogiorno. Per la precisione
in Calabria, Campania, Sicilia. Si passa da Benevento a Cosenza.
Da Catania a Casoria e Afragola
nel napoletano. Riguarda debiti accumulati da precedenti gestioni delle attuali
amministrazioni comunali che gli enti locali si sono impegnati a saldare nelle
modalità concordate attraverso il meccanismo di un Fondo escogitato dal
ministero dell’Economia e finanze (Mef) e attuato dalla Cassa depositi e
prestiti (Cdp) esattamente come stanno facendo. Si era deciso di tenere queste
anticipazioni distinte dal debito pubblico proprio per evitare che incidessero
sui coefficienti di bilancio contribuendo a fare avvitare la spirale della crisi
in atto e ritardando i pagamenti stessi.
Di fatto tenendoli dentro non
si sarebbe favorito l’assolvimento degli impegni contratti, ma si sarebbero
piuttosto moltiplicate le difficoltà contabili per quegli stessi Comuni che
hanno adottato e stanno attuando dolorosissimi piani di rientro. Quindi sarebbe
stato ancora più difficile pagare la rata alla liquidazione.
Tutto bene, dunque? No, si è
deciso viceversa che la rata dello speciale fondo anticipazione di liquidità
(Fal) debba essere iscritta a bilancio imponendo nei conti una restrizione della
spesa di pari importo. Nessuno mette in discussione questo impegno e tanto meno
decide di non onorare la restituzione della rata concordata, ma il nuovo
meccanismo finanziario escogitato con l’iscrizione a bilancio modifica i
coefficienti complessivi, annulla le ragioni costitutive del Fal e moltiplica i
casi di ulteriori crisi successive. Nessuno di questi Comuni ha messo in dubbio
la restituzione della rata e onora i suoi impegni.
Perfino la Corte costituzionale
è intervenuta sul tema sostenendo ovviamente i diritti dei creditori, ma
stabilendo in modo chiarissimo che il legislatore deve tenere conto della
sostenibilità e della composizione degli interessi in gioco. Per la verità la
Consulta è andata oltre invitando esplicitamente a tenere conto delle condizioni
di debolezza strutturale in cui si trovano alcuni Comuni praticamente tutti
collocati nel Mezzogiorno. Quello che l’operazione verità della famigerata
autonomia differenziata dovrebbe almeno aiutare a disvelare perché se lo Stato è
davvero uno, ma le entrate cambiano a secondo delle attività del contesto
territoriale e dei trasferimenti pubblici diseguali, è evidente che si producono
questo genere di guasti.
Perché il federalismo fiscale
all’italiana ha vincolato i flussi pubblici alla spesa storica dando sempre di
più ai ricchi e sempre di meno ai poveri nascondendosi dietro una riforma del
titolo quinto della Costituzione mai portata a termine.
Tutto ciò ha ulteriormente
acuito i divari penalizzando i bilanci dei Comuni più in difficoltà. Molti dei
quali sono quelli oggi in dissesto di cui stiamo parlando. La verità è che dopo
una serie infinita di interventi legislativi e di legittimità costituzionale in
senso opposto, i Comuni sono stati obbligati dal 2019 a considerare le
anticipazioni ricevute come un disavanzo di bilancio da ripianare in dieci anni
anziché nei trenta previsti di ammortamento e questo ulteriore vincolo coinvolge
con il nuovo provvedimento gli enti locali in dissesto.
Tutto di un colpo bisogna
onorare debiti commerciali pregressi inevasi ritenuti anche il frutto di
un’emergenza nazionale che ha riguardato enti locali, asl e altre
amministrazioni come se il Comune non fosse più in dissesto. Si era fatto un
piano di ammortamento trentennale che consentiva una forma di pagamento diversa
dalla rata del prestito e, attraverso un meccanismo finanziario che coinvolge
Cassa depositi e prestiti (Cdp), tutti questi debiti da pagare si erano fatti
confluire in un fondo che sterilizzava la spesa impedendo utilizzi impropri.
Parallelamente si consentiva al Comune in dissesto, proprio grazie alla
separatezza dei conti, di continuare ad attuare il piano di risanamento. Qualche
Comune o Regione che hanno fatto i furbi non restituendo quello che dovevano
restituire sono stati subito messi in mora.
Ora con la nuova normativa si è
di fatto aggiunto un onere ulteriore anche per i Comuni in dissesto facendo
mettere in bilancio ogni anno una certa quota di ripiano che fino a novembre
2022 era esclusa. Questo è il punto. Facciamola breve. Per Comuni in dissesto
che devono ridurre le spese sotto l’essenziale e contemporaneamente aumentare al
massimo le entrate l’unico modo che hanno per andare avanti è quello che si
decida con urgenza di rimettere la gestione di questo pacchetto di debiti
storici all’organismo di liquidazione e a un funzionario liquidatore che divide
i conti separando tutto ciò che è successo prima di una certa data da quello che
è avvenuto dopo fino a oggi.
Serve un emendamento al
milleproroghe che diventi immediatamente esecutivo. Questo emendamento deve
restituire il pacchetto di debiti al fondo in cui era stato collocato e al suo
gestore individuato dall’organo di liquidazione. Se non si blocca subito questo
nuovo perverso meccanismo finanziario il numero dei Comuni destinati a saltare
toccherà quota 250 e poi continuerà a crescere ancora. Ovviamente a pagare
saranno sempre le comunità del Mezzogiorno che sono state penalizzate certo
soprattutto in passato da amministrazioni incapaci e clientelari, ma che hanno
comunque sempre dovuto fare i conti con trasferimenti pubblici da
amministrazioni di serie B rispetto a amministrazioni ritenute
ingiustificatamente di serie A.
Quello che poi proprio non si
capisce è perché a pagare il conto dovrebbero essere gli amministratori che non
hanno alcuna responsabilità dei debiti pregressi e stanno mettendo a posto i
bilanci. Altro mistero di un’Italia costitutivamente diseguale che ha davvero
bisogno di un’operazione verità che ovviamente tutti rimetteranno in discussione
Battaglie leghiste.
Calderoli prova a convincere gli alleati sulla necessità dell’autonomia
differenziata. su L’Inkiesta il 17 Gennaio 2023.
Il ministro per gli Affari
regionali spiega che servirà per lo più un anno per fare le cose per bene, con
una Cabina di regia che vedrà coinvolto «il gotha del costituzionalismo e
dell’economia italiana, perché andranno definiti quali sono i diritti sociali e
civili dei cittadini: voglio vedere, quando si saprà chi parteciperà ai lavori,
chi avrà ancora dubbi»
Roberto Calderoli, ministro per
gli Affari Regionali e le autonomie, vuole convincere tutti che l’autonomia
differenziata «non è la bandiera elettorale della Lega, ma quello che serve a
questo Paese». Con tutte le garanzie che ci saranno, spiega in un’intervista
al Corriere. Servirà per lo più un anno per fare le cose per bene, con una
Cabina di regia che vedrà coinvolto «il gotha del costituzionalismo e
dell’economia italiana, perché andranno definiti quali sono i diritti sociali e
civili dei cittadini: voglio vedere, quando si saprà chi parteciperà ai lavori,
chi avrà ancora dubbi».
Dubbi che in verità affiorano
anche nella maggioranza. Calderoli dice di averne parlato con Berlusconi «e mi
ha assicurato che non c’è nessun ripensamento ma che la riforma va fatta bene, e
a lui come a Tajani dico che ci sono due canali da seguire». Ovvero: «La cabina
di regia, che in un anno dovrà definire i Lep (livelli essenziali di
prestazioni, ndr)» e «la legge di attuazione la deciderà il Parlamento, non il
governo. Salvini ha parlato di riforma nel 2023 perché ci vuole più o meno un
anno per portare a compimento una legge ordinaria come questa».
Calderoli racconta che non è
vero che la Lega che vuole fare in fretta per vincere le Regionali. «Ho
presentato il mio testo il 29 dicembre all’esame degli uffici necessario perché
approdi in Consiglio dei ministri, ora tutti insieme faremo un cronoprogramma,
poi andrà in Cdm. Quale sarebbe la forzatura? Sulla polemica che il Sud sarebbe
svantaggiato, mi si dica un solo punto del mio testo da cui si evince che si
danneggiamo le regioni meno ricche, una riga, un comma. Si parla solo per
parlare! È il sistema attuale che ha permesso una sperequazione netta, anche per
questo bisogna cambiare».
In ogni caso Forza Italia
chiede un fondo perequativo. «Sul fondo di perequazione ho lavorato con il
ministro Fitto per tradurre in norma il comma 3 e 5 dell’articolo 119 della
Costituzione che lo prevede, perché possa essere utilizzato anche da chi non
chiede l’autonomia differenziata», assicura Calderoli. «Lo immaginiamo
implementato da tutte le risorse europee sulla coesione non utilizzate e altri
capitoli per renderlo omogeneo e utilizzabile più facilmente, proprio per
superare disparità tra Nord e Sud».
Anzi, dice il ministro, «vorrei
fare una mappatura su come vengono spesi i soldi che lo Stato trasferisce agli
enti locali e alle Regioni, perché i cittadini lo sappiano. Forse è questo che
spaventa tanti…».
Il presidente
dell’Emilia-Romagna Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd e favorevole
all’Autonomia, vede tre punti critici: fare il Lep appunto, superare la «spesa
storica» e togliere dal testo le parole «residui fiscali», o si rischia che ogni
Regione si tenga le proprie tasse, una sorta di «secessione». Calderoli
risponde: «Sui Lep io ho fatto mettere l’obbligo di definirli prima del
trasferimento delle funzioni, nella legge di Stabilità. E appunto se ne occuperà
una qualificatissima cabina di regia. Sulla spesa storica, a differenza di
quello che aveva chiesto Bonaccini concedendo 6 anni prima di stabilire i costi
standard, io voglio farlo in un anno. E il residuo fiscale non esiste nel mio
testo».
"Ora basta, sono
solo calunnie". L'ira di Calderoli. "Mi si attribuisce un'inventata volontà
di spaccare il Paese, è calunnia". Il ministro per gli affari regionali e le
autonomie smentisce alcune critiche al ddl autonomia differenziata. Marco Leardi
il 3 Gennaio 2023 su Il Giornale.
"Adesso basta con gli
attacchi che sfociano in offese e anche di peggio". A essere descritto come uno
"spacca-Italia" Roberto Calderoli non ci sta. Mentre la proposta di legge
sull'autonomia differenziata continua ad animare il dibattito, il Ministro per
gli Affari Regionali e le Autonomie è intervenuto in prima persona per sgombrare
il campo da alcune interpretazioni erronee attribuite alla sua azione.
L'esponente del Carroccio, in particolare, ha voluto respingere alcune
ricostruzioni giornalistiche nelle quali si parlava di un suo presunto strappo
con gli enti territoriali.
Autonomia differenziata, lo
sfogo di Calderoli
"Sono stato paziente per
settimane ma adesso si è passato il limite", è sbottato il ministro,
prendendosela in particolare con alcune espressioni di stampa quali appunto
"spacca Italia" (riferito al ddl sull'autonomia differenziata) e "lo strappo di
Calderoli". "Io da ministro ho giurato sulla Costituzione, che sancisce l'unità
nazionale, per cui scrivere che voglio spaccare l'Italia significa darmi dello
spergiuro. Questa è diffamazione, forse addirittura calunnia, perché mi si
attribuisce un'inventata volontà di spaccare il Paese", ha lamentato l'ex
vicepresidente del Senato, che nei giorni si era confrontato anche con i veti
dei sindacati Cisl e Uil proprio sull'autonia differenziata.
"Altro che spacca Italia, sto
girando tutte le Regioni"
"Ricordo poi che io sono il
Ministro per le Regioni, di tutte le Regioni italiane, non di alcune sì e altre
no e proprio per questo sto girando l'Italia in lungo e in largo per incontrare
di persona tutti i governatori regionali. Altro che spacca Italia…", ha
sottolineato ancora Calderoli, stizzito dalla narrazione attribuita al suo
provvedimento. "Ora basta, i giornalisti hanno un codice deontologico da
rispettare, c’è un limite alla cronaca che non può trascendere in offesa o
in bugia".
"Non intendo querelare nessuno
per ora, non sono il tipo che querela, ma se mi capiterà di leggere ancora frasi
offensive e calunniose nei confronti del mio lavoro da ministro, frasi come
queste sullo spacca-Italia, allora sarò costretto a procedere alle vie legali",
ha inoltre avvertito il ministro, che già nelle scorse settimane era intervenuto
per smentire categoricamente alcune indiscrezioni di stampa sul presunto
"ritorno" del residuo fiscale. Ora, la nuova infastidita precisazione. "Totale e
sacrosanta libertà di critica dei giornalisti, ci mancherebbe, ma non di
inventare qualcosa che non esiste e di diffamare, chiaro?", ha concluso
Calderoli in una nota.
CALDEROLI, BASTA
PROVOCAZIONI! ROBERTO NAPOLETANO su Il Quotidiano del Sud il 02 Gennaio
2023
Siamo alla volontà recidiva
della incostituzionale certificazione della spesa storica, che è il bottino
regalato ai ricchi a spese dei poveri, attraverso il federalismo all’italiana
attuato più di dieci anni fa con le medesime modalità che vengono oggi
riproposte dallo stesso Calderoli. Non può essere questa bozza neppure la base
di ragionamento sull’autonoma differenziata perché va contro i principi fondanti
della Repubblica di coesione e solidarietà. Peraltro si muove in controtendenza
rispetto a quella centralizzazione decisionale a livello nazionale che è
necessaria perché il Paese torni a riconoscere le sue priorità, perché i diritti
di tutti i cittadini siano tutelati, perché fare gli investimenti, aprire i
cantieri e attuare gli impegni di spesa assunti con l’Europa non sia più mera
esposizione di annunci. Il ministro Calderoli deve vergognarsi di questa nuova
bozza che ricalca principi e spirito della prima da lui già arrotolata e che ha
come solo obiettivo di allargare i margini di azione per consentire alle Regioni
più ricche di trattenere la compartecipazione al gettito di uno o più tributi
erariali maturato nel territorio regionale
Avevamo chiesto più di un mese
fa di mettere sotto tutela istituzionale il ministro per gli Affari regionali e
le Autonomie, Roberto Calderoli, perché aveva fatto circolare una bozza di
disegno di legge per l’autonomia differenziata che minava le fondamenta della
Costituzione della Repubblica italiana. Sanciva la violazione a vita dei diritti
di cittadinanza di almeno venti milioni di persone. Riduceva il Parlamento al
ruolo di passacarte per di più con un mandato a termine di trenta giorni per
esprimere un parere privo di alcun valore vincolante. Di fatto quella bozza
riduceva una riforma di rilievo costituzionale, che determinerebbe la
frammentazione istituzionale fino alla nullità decisionale dell’intero Paese
oltre a abolire ogni minimo vincolo costituzionale di coesione e solidarietà, a
poco più di uno scambio di segrete intese tra lui e i suoi danti causa che sono
i capi leghisti delle Regioni del Nord.
Siamo davanti all’efferatezza
di concepire sul piano legislativo qualcosa che assomigli molto da vicino a veri
e propri rogiti notarili tra soggetti privati fatti con i soldi pubblici che
sono di tutti i cittadini italiani. L’obiettivo manifesto era solo il bottino da
portare a casa con la fretta di chi concepisce un disegno politico che deve
essere mantenuto all’oscuro di tutti. Questo bottino consisteva nella
stabilizzazione eterna dell’indebito privilegio di cui godono le Regioni ricche
nei trasferimenti pubblici pro capite per i loro cittadini nei settori vitali
della sanità, della scuola, e del trasporto pubblico locale, attraverso il
trucco della spesa storica inventato più di dieci anni fa proprio dallo stesso
ministro in una legge sul federalismo fiscale all’italiana che è un caso unico
al mondo e fa ballare ingiustificatamente ogni anno decine di miliardi da un
territorio all’altro.
Un obbrobrio che non si era mai
visto per la gravità del disegno arbitrario concepito e la sfacciataggine con
cui si era avuto l’ardire di metterlo per iscritto addirittura in una proposta
di legge. Per tutte queste oggettive ragioni avevamo chiesto di mettere con
urgenza Calderoli sotto tutela istituzionale per l’abnormità di una serie di
comportamenti che costituiscono nei fatti il tradimento della Repubblica
italiana nell’esercizio del mandato ministeriale. Si era fatta sentire subito la
Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiedendo di incanalare la discussione
dentro la logica e i tempi di un eventuale riassetto istituzionale con il
bilanciamento dei poteri conseguenti a eventuali scelte di presidenzialismo o di
semi presidenzialismo che richiedono in modo vincolante precise e qualificate
maggioranze parlamentari. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha fatto molto
di più e, davanti a tutti i sindaci italiani, alla conferenza di Bergamo di fine
novembre dell’anno scorso, ha detto chiaro e tondo che “Punti fermi sono la
garanzia dei diritti dei cittadini, che al Nord come nel Mezzogiorno, nelle
città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter
vivere la piena validità dei principi costituzionali”.
Questa frase, da quel giorno, è
sempre sulla prima pagina del Quotidiano del Sud-l’ALTRAVOCE dell’Italia. Per
noi rappresenta una bandiera identitaria. Ricordiamo a tutti che la denuncia di
anni del nostro giornale ha determinato una commissione di indagine parlamentare
che ha consacrato nella sede più autorevole l’operazione verità con il suo
carico di sperequazioni intollerabili e che oggi nessuno può più mettere in
dubbio quei numeri. Tanto meno un ministro della Repubblica.
Fatto sta che dopo interventi
così netti da parte della massima carica dello Stato italiano e del Presidente
del Consiglio, il ministro Calderoli si era affrettato a definire in sostanza
carta straccia quella bozza di autonomia differenziata di cui in qualche modo
disconosceva la paternità. Non era così. Perché all’articolo 3 della nuova bozza
dello stesso ministro è scritto che “i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale (di seguito, LEP) sono determinati con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio”. I cosiddetti LEP sono la base ineludibile del
principio di uguaglianza dei diritti civili e sociali evocati di tutti i
cittadini italiani e di cui Mattarella peraltro ha di nuovo parlato con la
consueta chiarezza nel messaggio di fine anno. Ora, scrivere che sono
“determinati” con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
non vuol dire affatto mettere nero su bianco che sono attuati e che diventano,
cioè, erogazioni effettive ai singoli cittadini che sono oggi fortemente
penalizzati dal trucco della spesa storica inventata dallo stesso ministro più
di dieci anni fa. Viceversa, nello stesso schema di disegno di legge
all’articolo quattro comma tre punto a è scritto testualmente che “le risorse
necessarie per le funzioni relative a ciascuna materia o ambito di materia sono
determinate in base al criterio della spesa destinata a carattere permanente,
fissa e ricorrente, a legislazione vigente, sostenuta dallo Stato nella Regione
per l’erogazione dei servizi pubblici corrispondenti”. Qui, cioè, ancorché
smaccatamente ingiuste, le erogazioni sono effettive.
Siamo sempre lì, siamo fermi
alla recidiva volontà della incostituzionale certificazione della spesa storica,
che è il bottino regalato ai ricchi a spese dei poveri con il federalismo
all’italiana concepito e attuato più di dieci anni fa proprio con le medesime
modalità che vengono oggi riproposte. Non può essere questa neppure la base di
qualsiasi ragionamento sull’autonoma differenziata che, peraltro, a nostro
avviso, va in netta controtendenza rispetto a quella centralizzazione
decisionale a livello nazionale che è assolutamente indispensabile perché il
Paese torni a riconoscere le sue priorità, perché i diritti di tutti i cittadini
siano finalmente tutelati, perché fare gli investimenti pubblici, aprire i
cantieri e attuare gli impegni di spesa assunti con l’Europa non sia più mera
esposizione di annunci. Il ministro Calderoli deve vergognarsi di questa nuova
bozza che ricalca principi e spirito della prima da lui già giocoforza
arrotolata e che ha come solo obiettivo di allargare i margini di azione per
consentire alle Regioni più ricche di trattenere la compartecipazione al gettito
di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale.
Uno scandalo assoluto che
rivela un progetto politico che si muove in direzione opposta a quella coesione
e a quella solidarietà invocate dal Capo dello Stato per preservare l’importante
crescita italiana conseguita con il suo carico di fiducia dalla comunità
economica, sociale e civile del Paese. Si fermi Calderoli o lo si metta comunque
nelle condizioni di non nuocere più. Deve almeno capire che è finito il tempo
delle provocazioni e che, rispetto al suo primo nefasto blitz fiscale di più di
dieci anni fa, ora tutti sanno come stanno le cose e nessuno gli permetterà più
di ripetere i vecchi trucchi. Il cammino che deve percorrere è a ritroso, non
quello di andare avanti sulla strada sbagliata di prima. Non intravediamo più in
questi suoi comportamenti neppure una briciola di quell’esperienza normativa,
politica e istituzionale che pure abbiamo sempre ritenuto di riconoscergli. Con
l’unità della Repubblica non può essere consentito a nessuno di scherzare. Tanto
meno lo può fare un ministro in carica della stessa Repubblica. Almeno questo
dovrebbe ricordarselo.
Cure mediche solo per i più
ricchi: è questa la ricetta dell’autonomia di Roberto Calderoli. L’autonomia
differenziata avrebbe per la Sanità conseguenze deleterie. La regola dei costi
standard avvantaggerebbe le regioni con reddito più alto e danneggerebbe quelle
più povere. Ivan Cavicchi su L’Espresso il 19 Dicembre 2022.
Per sostenere progetti politici
tanto terrificanti come il regionalismo differenziato bisogna avere prima di
tutto quello che mia madre chiamava “l’animo cattivo” e essere individui
indifferenti e insensibili alle sofferenze e alle tribolazioni degli altri.
Nel caso del regionalismo
differenziato se alla cattiveria e all’egoismo regionale aggiungiamo
l’ignoranza, la malafede e la disonestà intellettuale, si ottiene davvero il
peggio dell’umanità fino a rasentare l’orrore.
Vorrei richiamare due orrori
del regionalismo differenziato dei quali non si parla mai: la possibilità di
finanziare la sanità definendo dei costi standard e la possibilità di ridurre le
complessità delle tutele sanitarie a prestazioni. Cioè i Lep.
I costi standard nascono dalla
contabilità industriale e si basano sulla possibilità di analizzare con
precisione tutti i costi che partecipano al processo produttivo e i vari
scostamenti tra i costi teorici e i costi reali. Se per chi fabbrica bulloni
questo è del tutto possibile, in sanità no. Nel senso che solo una minima parte
dei costi delle attività sanitarie si potrebbero standardizzare. La maggior
parte dei costi sanitari degli ospedali, dei distretti, dei vari servizi
territoriali, dei dipartimenti di salute mentale ecc., non sono standardizzabili
perché la cura, a fronte della complessità clinica del malato, non è
standardizzabile.
Ciò nonostante i patiti dei
costi standard soprattutto Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, quando girava la
storiella delle siringhe che costavano di più al Sud e di meno al Nord, in
occasione del riparto del fondo sanitario 2013 imposero a tutte le altre regioni
il criterio dei costi standard. Il risultato fu un flop clamoroso tanto da
indurre le regioni a ritornare ai vecchi criteri della spesa storica pro-capite.
Da una parte non si riusciva a misurare i costi effettivi per la gran parte
della sanità e dall’altra i costi che si era calcolati erano tutti sballati e
approssimativi.
Nonostante i costi standard in
medicina siano praticamente immorali, il regionalismo differenziato nella bozza
Calderoli li propone come base di finanziamento della futura sanità.
Quanto ai Lep la bozza
Calderoli di fatto propone in base all’art 117 di passare dai Lea ai Lep. La
legge (L.502) che nel 1992 ha istituito i Lea parla di «livelli di attività di
servizi e di prestazioni». I Lep, invece, sono solo “prestazioni” intendendo per
prestazione un singolo e specifico atto clinico-assistenziale, di natura
diagnostica e/o terapeutica. I Lea in sanità sino a ora sono stati definiti come
macro aggregati di attività servizi e prestazioni e suddivisi in tre grandi
gruppi (salute pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera). In
pratica nella proposta di regionalismo differenziato con i Lep l’intenzione
sembra essere quella di ridurre il concetto di tutela facendo coincidere il
bisogno di cura con la prestazione tecnica tout court. Cioè con il minimo del
minimo.
L’idea folle per chi non
conosce le complessità della clinica è probabilmente costruire costi standard
quantificando i costi di ogni singola prestazione. Esattamente come si usa nei
prontuari delle assicurazioni. Cataloghi di “articoli” da vendere definiti da un
prezzo.
È ovvio che i Lep in sanità
alla fine funzioneranno come minimo consentito, ma solo per le regioni povere.
Cioè le regioni ricche non sono obbligate a rispettare i Lep. Se esse avranno le
risorse necessarie i loro Lep potrebbero essere ben maggiori di quelli del Sud.
Altrimenti non si spiegherebbe perché Calderoli nella sua bozza parla di
“perequazione infrastrutturale”.
Si supponga di aver un cancro e
che la sua cura preveda un costo standard al quale i servizi dovranno attenersi.
Si supponga anche che per curare il cancro siano prestabilite delle prestazioni
standard. Si supponga che il caso di cancro abbia un costo reale superiore allo
standard e che le prestazioni predefinite per la sua cura non siano sufficienti.
Le scelte possibili non sono
molte: o si interrompono le cure o i costi eccedenti si mettono a carico del
malato o si autorizzano le aziende a coprire i costi eccedenti mettendoli in
bilancio.
In questi casi l’onorevole
Calderoli, sapendo che in ragione dei costi standard e dei Lep il cancro in
Veneto è una cosa e in Calabria è un’altra cosa, che suggerisce di fare?
Autonomia differenziata,
delirio Calderoli: fa tutto solo e scavalca i governatori. CLAUDIO MARINCOLA
su Il Quotidiano del Sud il 30 dicembre 2022.
Il ministro Calderoli ha fretta
e sull’autonomia differenziata va come un treno, fa praticamente tutto solo
scavalcando anche i governatori
Ha fretta il ministro
Calderoli. E va avanti come un treno, a costo di deragliare. Anziché trasmettere
il testo del suo disegno di legge alla Conferenza Stato-Regioni, come pure
avrebbe richiesto il percorso istituzionale, lo ha trasmesso per le vie brevi
direttamente a Palazzo Chigi. Procedura che salta a pie’ pari il parere dei
presidenti delle Regioni. Un dettaglio che proprio dettaglio non è. E la dice
lunga sul metodo che il titolare degli Affari regionali intende seguire per
raggiungere l’obiettivo dell’autonomia differenziata.
AUTONOMIA DIFFERENZIATA,
CALDEROLI PIANTA UNA BANDIERINA SUL NULLA
Non è una semplice questione di
bon ton istituzionale. Quel testo, riveduto e corretto, era stato già bocciato e
rispedito al mittente per il lungo elenco di omissioni e incongruenze che
conteneva. Una miscela esplosiva in grado di creare squilibri in ambiti
strategici come istruzione, trasporti e ambiente, pur di dare sovranità alle
regioni più ricche. Un testo in aperto contrasto con la Costituzione, dal
momento che non si prevedeva sin dall’inizio il criterio di calcolo dei Lep per
l’assegnazione delle risorse.
«La fase dei lavori per
l’autonomia differenziata può finalmente entrare nel vivo – esulta il padre del
Porcellum – Il testo del disegno di legge è stato ufficialmente trasmesso alla
presidenza del Consiglio», si legge in una nota del ministro leghista.
Una bandierina piantata sul
nulla, poco più di uno spot elettorale (in Lombardia si vota a febbraio) visto
che finora non c’è stato alcun accordo tra i governatori e il governo, tantomeno
sulle materie da devolvere e sui criteri da seguire. A partire dalle
compartecipazioni al gettito, altro tema caldissimo.
«Gli impegni presi fin
dall’inizio dal governo – sottolinea ancora Calderoli- sono stati pienamente
rispettati, ora non resta che procedere su questo doppio binario per regalare al
Paese e ai cittadini una forma di Stato più efficiente e che permetta a tutte le
Regioni di rendere al meglio».
CALDEROLI PUNTA ALLA ROAD MAP
SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Il ministro del Carroccio, un
medico chirurgo che ha lasciato molti anni fa il bisturi per la politica, ha già
in testa la sua road map. L’iter parlamentare del disegno di legge inizierà solo
dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri. Il testo, sostiene il ministro,
recepisce i contenuti del documento approvato all’unanimità dalla Conferenza
delle Regioni. La cabina di regia, prevista dall’articolo 143 della legge di
Bilancio, dovrà predisporre i Dpcm per definire i livelli essenziali delle
prestazioni, costi e i fabbisogni standard. Una volta definito il tutto, sarà la
volta delle varie intese con le singole Regioni, quindi gli accordi passeranno
all’approvazione delle Camere.
Nel testo varato da Calderoli
non c’è traccia di perequazione. I trasferimenti statali, in una prima fase e
per un periodo non definito, avverranno solo sulla base della spesa storica, che
penalizza le regioni del Mezzogiorno. E nella manovra non sono state previste
risorse per la determinazione del Lep di cui si parla da almeno 21 anni.
BOCCIA: «IL MINISTRO SA COS’È
LA DEMOCRAZIA?»
Aver scavalcato la Conferenza
Stato-Regioni significa per Francesco Boccia, senatore e responsabile enti
locali del Pd, voler evitare il confronto. «Il ministro sa che in Italia esiste
la democrazia e che le riforme riguardanti gli assetti istituzionali, per prassi
ed educazione politica, seguono iter di confronto preventivo con gli altri
livelli istituzionali?», si chiede Boccia, che nel Conte II occupava la poltrona
di Calderoli.
«Non ci risulta – aggiunge –
che il disegno di legge sia mai approdato in Conferenza Stato-Regioni o in
Conferenza unificata, così come era avvenuto nel 2020, per un confronto tra i
diversi livelli istituzionali, così come non ci risulta che in Conferenza delle
Regioni, dove ci sono tutte le sensibilità politiche e le differenti visioni tra
nord e sud, sia mai stata discussa la nuova proposta del governo».
A seguire una raffica di
domande: «La destra al governo ritiene di affrontare con questa arroganza le
riforme che incidono sugli assetti del Paese senza alcun confronto preventivo?
Il presidente della Conferenza delle Regioni era informato o è stato ignorato
come tutti gli altri presidenti di Regione? Questa è anche la posizione della
presidente Meloni?».
ELLY SCHLEIN: «GRAVE
SCORRETTEZZA»
In ballo c’è il destino delle
aree più deboli del Paese, Sud e zone interne. Un solco profondo le separa dalle
tre3 Regioni più sviluppate che hanno già fatto richiesta di autonomia
differenziata con richieste che richiederebbero costi aggiuntivi rispetto alla
spesa statale attuale.
Attilio Fontana, presidente
della Regione Lombardia, non più tardi di mercoledì scorso, al raduno leghista
di Alzano Lombardo, nella Bergamasca, è tornato a spingere perché il progetto
autonomista si concluda entro il 2023. Idem Luca Zaia, governatore veneto, che
si è compiaciuto per l’impulso dato dal suo collega Calderoli al ddl.
Scettico, invece, il presidente
campano Vincenzo De Luca (Pd), per il quale la previsione temporale del ministro
è decisamente troppo ottimista. Da segnalare, infine, la dura presa di posizione
della deputata Elly Schlein, candidata alle primarie Pd, che parla di «grave
scorrettezza istituzionale».
Chi è la più bella del
reame…La narrazione fraudolenta. La favola della rana e dello scorpione è un
racconto tradizionale che verte sull'immutabilità degli istinti degli individui.
Da
Trama
Uno scorpione chiede ad
una rana di lasciarlo salire sulla sua schiena e di trasportarlo sull'altra
sponda di un fiume. In un primo momento la rana rifiuta, temendo di essere punta
durante il tragitto. L'aracnide argomenta però in modo convincente
sull'infondatezza di tale timore: se la pungesse, infatti, anche lui cadrebbe
nel fiume e, non sapendo nuotare, morirebbe insieme a lei. La rana, allora,
accetta e permette allo scorpione di salirle sulla schiena, ma, a metà strada,
lui la punge condannando entrambi alla morte. Quando la rana chiede allo
scorpione il perché del suo gesto folle, questi risponde: "Non posso farci
nulla, è la mia natura!".
Uno scorpione chiede ad una
rana di lasciarlo salire sulla schiena per trasportarlo sull'altra sponda di un
fiume. La rana rifiuta, temendo di essere punta durante il tragitto ma
l'aracnide argomenta in modo convincente sull'infondatezza di tale timore: se la
pungesse, infatti, cadrebbe nel fiume e non sapendo nuotare, morirebbe. La rana
accetta e permette allo scorpione di salirle sulla schiena. A metà strada, lo
scorpione la punge condannando così entrambi alla morte. Quando la rana spirando
chiede allo scorpione il perché del suo gesto folle, questi risponde mentre
affoga: "È la mia natura!".
Origine
L'origine e l'autore non sono
noti. La storia è spesso attribuita a Esopo, tuttavia nelle sue favole appaiono
solo delle variazioni. Uno studio pubblicato nel 2011 indica una connessione tra
la genesi della fiaba e la tradizione del Pañcatantra, una raccolta di favole di
animali risalenti all'India del III secolo a.C.
Autonomia differenziata, ma
la Lombardia non è più la locomotiva dell’Italia. Dopo decenni di retorica
sulla regione più virtuosa del Paese. Guglielmo Forges Davanzati su La Gazzetta
del Mezzogiorno il 25 Gennaio 2023.
La Lombardia non è più una
locomotiva potente per l’economia italiana. Dopo decenni di retorica sulla
regione più virtuosa del Paese, alcuni dati recentemente prodotti dalla Cgil
(gennaio 2023), per opera di Roberto Romano, destituiscono di fondamenta questo
luogo comune che è tuttavia fondamentale per dare credito e legittimità
scientifica e politica al progetto di autonomia differenziata del Governo e del
Ministro Calderoli, in particolare. Si tratta di una questione cruciale anche
per le prossime elezioni regionali in quella Regione.
In un articolo pubblicato nella
rivista «Sbilanciamoci», dal titolo «La meridionalizzazione della Lombardia in
Europa», il ricercatore mette in evidenza alcune evidenze empiriche schiaccianti
che destituiscono di fondamenta la visione dell’eccellenza lombarda. La fonte
informativa è il sistema dei conti pubblici territoriali. La Lombardia ha una
popolazione di poco meno di 10 milioni di abitanti, con individui in età
lavorativa (15-64) di oltre 6 milioni: è più grande di alcuni Paesi europei (per
esempio, la Danimarca). Soprattutto a partire dalla crisi del 2007-2008, il
tasso di crescita lombardo comincia a divergere da quello tedesco. In più, la
migliore performance di quella Regione rispetto al resto del Paese diventa
irrisoria.
La minore crescita del PIL
della Lombardia rispetto alla crescita della Germania, tra il 2008 e il 2020, è
in media annua pari a meno di 1,5 punti percentuali, e meno 0,5 punti
percentuali rispetto alla Francia. Sebbene la Lombardia abbia fatto meglio
dell’Italia, questo valore è decisamente contenuto e pari al solo 0,5% del Pil.
Il rapporto investimenti/PIL si riduce notevolmente, passando dal 22% del 2007
al 17,5% del 2019. Sebbene la dinamica del valore aggiunto della Lombardia (non
il valore assoluto) fosse in linea con le maggiori economie europee tra il 2000
e il 2008, a partire dal 2009 si registra un importante rallentamento, maturando
un ritardo pari a 10 punti rispetto a Germania e Francia nel 2021. Il risultato
è coerente con la dotazione tecnica e tecnologica della struttura economica
lombarda, che a loro volta condizionano la domanda di lavoro e la distribuzione
del reddito da lavoro dipendente.
Uno degli effetti della
dinamica del valore aggiunto, sebbene non sia l’unico, è il peso specifico del
reddito del lavoro dipendente sul PIL. Il reddito da lavoro dipendente
(aggregato) regionale è pari al 40% del PIL nel 2019, contro una media tedesca
del 53% e del 51% francese.
C’è da sottolineare che la
Lombardia ha sempre avuto un trattamento di favore dai Governi nazionali, in
termini di dotazione di risorse. Da ultimo, le è stata riconosciuta una
numerosità di Dipartimenti universitari di «eccellenza» di gran lunga superiori
a quelli del resto d’Italia. Va anche riconosciuto che è stata governata
sufficientemente bene e che, dagli anni Novanta, dopo Tangentopoli e l’inchiesta
Mani Pulite, non ha conosciuto inchieste e scandali di rilevanza nazionale: ciò
a dire che si è candidata a rappresentare la capitale economica del Paese, a
fronte di quella amministrativa romana.
Ma questi vantaggi, ai quali va
aggiunto oggettivamente quello geografico e di localizzazione (prossimo a uno
dei più grandi poli industriali al mondo e uno dei massimi mercati di sbocco per
numerosità di consumatori potenziali), non si sono sedimentati evidentemente in
modo tale da evitare che essa ritenga di poter svolgere il suo ruolo solo –
mediante il regionalismo – sottraendo risorse alle regioni deboli economicamente
del Paese.
Come è stato messo in evidenza
in un importante libro recente – «L’impresa italiana» di Franco Amatori, edito a
fine 2022 da Treccani – la Lombardia è lo specchio del declino economico
italiano, che si manifesta nell’evidenza, ormai acclarata, del fallimento del
nostro modo di fare impresa (il fallimento sostanziale dell’esperienza dei
distretti industriali e l’eccessiva numerosità di imprese troppo piccole per
stare nella dinamica della globalizzazione) e nei continui processi di
acquisizione dall’estero. Con eccezione di Ferrero e Luxottica, le sole due
imprese globali che abbiamo, le altri grandi aziende italiane sono finite in
mani straniere, a partire da Fiat collocata presso la holding olandese
Stellantis, o Pirelli diventata cinese o Italcementi passata ai tedeschi.
La reazione guidata dalla
rivendicazione autonomista appare, in tal senso, fuori fuoco: la ripresa
dell’economia italiana passa per iniziative che recuperino i nostri vantaggi
competitivi, nella misura dell’ancora possibile, nei settori che abbiamo
trascurato, a partire dalle nuove tecnologie. La Lombardia può tornare a essere
locomotiva solo a condizione di limitare il ruolo di subfornitore del capitale
tedesco (anche perché non ha voce politica in quel Paese), ovvero di Sud del
Nord, e di scommettere sul mercato interno nel Mezzogiorno.
Meridionalizzazione della
Lombardia in Europa. Roberto Romano su Sbilanciamoci.info il 16 Gennaio
2023 Di fronte al progetto Calderoli di autonomia differenziata e alle prossime
elezioni passa la narrazione di una Lombardia scintillante locomotiva d’Italia.
Ma è un’immagine in parte appannata a partire dal 2009.
Invece di parlare di spesa
pubblica si dovrebbe discutere di politiche industriali, investimenti, del gap
con l’Europa.
Autonomia differenziata
C’è tanta politica politicante
nella narrazione della cosiddetta Autonomia differenziata che, la Regione
Lombardia e quelle ricche (rispetto a chi e che cosa?) utilizzano per distorcere
la grave situazione economica del Paese e, peggio ancora, che immaginano di
essere “le più belle del reame”. Riflettendo sul database “Sistema Conti
Pubblici Territoriali” e combinando la spesa pubblica aggregata con la
popolazione e il valore del PIL territoriale, registriamo, invece, che la spesa
pubblica pro capite per istruzione, formazione e sanità, per esempio di Calabria
e Lombardia, è ben distribuita a livello territoriale, diversamente dal reddito
pro capite di mercato. Un esito che riflette le diverse strutture economiche.
Questo reddito non è legato alla spesa pubblica, piuttosto alla dimensione
storica e polarizzata dell’economia nazionale. Guardando all’economia reale del
Nord, non alla spesa pubblica, è facile osservare che sia migliore di quella del
Sud, ma la narrazione di un sistema economico forte ed europeo è quanto di più
falso si possa immaginare: la Lombardia è arretrata rispetto all’Europa; un
arretramento lungo 20 anni che nessuno analizza, preferendo litigare sulle
risorse pubbliche disponibili che, alla fine, sono quelle meglio distribuite.
La cosiddetta Autonomia di
Calderoli è una azione che rimuove la politica economica, cioè i problemi legati
al reddito da lavoro, agli investimenti privati, alla ricerca e sviluppo e alla
povertà prima delle tasse. L’assenza di consapevolezza del ritardo economico
costringe tutti i candidati alle elezioni regionali di febbraio 2023 a discutere
di tasse e federalismo, piuttosto che dell’impoverimento delle Regioni ricche
nel consesso europeo. L’Autonomia differenziata è diventata una novella, ma
questa novella elude la politica economia e l’industria. La Lombardia è la
strega cattiva che domandava: specchio delle mie brame, chi è la più bella del
reame? Come nella favola, lo specchio ha ragione.
Fotografia della Lombardia
La Regione Lombardia con poco
meno di 10 milioni di abitanti e una popolazione potenzialmente in età
lavorativa (15-64 anni) di oltre 6 milioni, ripartita equamente tra uomini e
donne, è più grande di alcuni Paesi europei come la Danimarca (6 milioni di
abitanti) o l’Irlanda (5 milioni di abitanti), ed è poco più piccola della
Finlandia (7 milioni di abitanti) e del Belgio (11 milioni di abitanti). La
Lombardia, quindi, è un territorio equiparabile a Paesi che concorrono al
funzionamento del governo europeo.
La costante e ingiustificata
narrazione dell’eccellenza lombarda, lunga ormai 30 e passa anni, ha nascosto
come e quanto fosse difficile per l’economia e la società lombarda diventare una
economia europea, attrezzata per affrontare le sfide che l’Europa considera
fondamentali.
PIL
L’osservazione della dinamica
nel tempo del PIL restituisce l’immagine di una Regione che, progressivamente,
perde terreno rispetto ai principali partner europei. Il fenomeno si acuisce a
partire dalla crisi dei subprime e dei debiti sovrani, rispettivamente 2009 e
2011, consolidandosi negli anni successivi. La minore crescita del PIL della
Lombardia rispetto alla crescita della Germania, tra il 2008 e il 2020, è in
media annua pari a meno di 1,5 punti percentuali, e meno 0,5 punti percentuali
rispetto alla Francia. Sebbene la Lombardia abbia fatto meglio dell’Italia,
questo “meglio” è abbastanza contenuto: 0,5% di PIL. Questa minore e sistematica
crescita della Lombardia non è, ovviamente, attribuibile al solo governo della
Regione, responsabile di solo una frazione delle risorse finanziarie pubbliche
spese che interessano il territorio lombardo. È piuttosto attribuibile alla
mancata discussione sulla reale struttura economico-sociale che la caratterizza,
portando ad un indebolimento e al rallentamento delle azioni necessarie per
correggerne i punti critici.
Investimenti
La letteratura economica
assegna agli investimenti un ruolo fondamentale alla crescita economica.
Infatti, gli investimenti delle imprese sono direttamente proporzionali alle
aspettative di crescita e di profitto delle stesse “imprese”. La dinamica e
l’incidenza sul PIL degli investimenti restituiscono due informazioni
(economiche) importanti: 1) da un lato, le aspettative (speranze) di crescita
del PIL del capitale e degli imprenditori; 2) da un altro lato, la quantità di
capitale necessario per il sistema economico e industriale in particolare per
rigenerare la propria struttura economica e tecnologica. In generale possiamo
affermare che (1) tanto più gli investimenti sono realizzati per soddisfare la
domanda emergente, tanto più l’impatto sul PIL sarà positivo; (2) tanto più gli
investimenti sono knowledge-oriented, tanto più alto sarà il loro valore
aggiunto; (3) tanto più il rapporto investimenti-PIL sarà elevato, tanto più la
struttura economica è dinamica e capace di creare tanto lavoro quanto se ne
perde, con il vantaggio (strutturale) di occupare persone che hanno maggiori
qualità formative.
Italia e Lombardia registrano
un livello di incertezza (minori investimenti) che merita una riflessione
puntuale. Non solo la dinamica degli investimenti è contenuta (le curve per
Italia e Lombardia sono quasi piatte), ma il rapporto investimenti-PIL
restituisce un fenomeno più complesso. Questo rapporto si riduce notevolmente,
passando dal 22% del 2007 al 17,5% del 2019 in Lombardia. Se gli investimenti
restituiscono la fiducia delle imprese rispetto al futuro, se il rapporto con il
Pil cattura il livello dell’investimento necessario per riprodurre il capitale,
allora pare evidente che la struttura economica lombarda (e nazionale) sembra
intrappolata in una sorta di tunnel arduo da attraversare. Infatti lo scarso
livello degli investimenti rispetto al PIL è associabile ad un contenuto livello
di specializzazione delle imprese ed è correlabile alla debole dinamica degli
stessi investimenti. Più semplicemente, il capitale necessario per il buon
funzionamento del sistema economico diverge dalla media europea, che nel tempo
si è orientato verso settori a maggiore contenuto tecnologico, coerentemente con
l’evoluzione quali-quantitativa della domanda.
Produttività e valore aggiunto
La minore intensità tecnologica
degli investimenti e la contenuta, ma coerente, propensione agli investimenti,
così come la dinamica del PIL, vincola il valore aggiunto per addetto. Sebbene
la dinamica del valore aggiunto della Lombardia (non il valore assoluto) fosse
in linea con le maggiori economie europee tra il 2000 e il 2008, a partire dal
2009 si registra un importante rallentamento, maturando un ritardo pari a 10
punti rispetto a Germania e Francia nel 2021. Il risultato è coerente con la
dotazione tecnica e tecnologica della struttura economica lombarda, che a loro
volta condizionano la domanda di lavoro e la distribuzione del reddito da lavoro
dipendente.
La dinamica del valore aggiunto
richiama la così detta produttività del lavoro. La domanda a cui sarebbe
necessario rispondere potrebbe essere la seguente: data la dotazione tecnica,
sarebbe possibile aumentare la produttività del lavoro e, quindi, il reddito da
lavoro dipendente?
Reddito da lavoro
Uno degli effetti della
dinamica del valore aggiunto, sebbene non sia l’unico, è il peso specifico del
reddito del lavoro dipendente sul PIL. Il reddito da lavoro dipendente
(aggregato) regionale è pari al 40% del PIL nel 2019, contro una media tedesca
del 53% e del 51% francese. Questa distribuzione del reddito richiama il ruolo e
il peso sociale di lavoro e capitale, nell’accezione data da Tarantelli, e
dell’azione pubblica come agente economico preposto alla intermediazione tra
capitale e lavoro, così come alla politica economica che dovrebbe guidare le
grandi transizioni economiche.
Questa dimensione della
politica economica (regionale) è tanto più importante se consideriamo che le
misure legate al mercato del lavoro sono, sostanzialmente, attribuite alle
Regioni e agli enti locali. La formazione e le altre misure adottate dalla
Regione per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, senza una
adeguata politica economica e industriale, riproducono l’esistente e non possono
governare la trasformazione della struttura economica.
Conclusioni
Le considerazioni riportate
nelle precedenti sezioni portano a sfatare la retorica della Lombardia come
“motore trainante d’Italia”. Una narrazione che si è spesso basata su slogan,
quasi mai su dati o fatti verificati, e che rimane ancorata ad un passato ormai
troppo lontano (storicamente poteva anche avere un senso definire la Lombardia
come la locomotiva del Paese). L’immagine che abbiamo delineato tramite le
analisi è quella di una regione che nel contesto italiano ha ancora margine per
brillare e guidare il Paese (reddito medio pro-capite nettamente più elevato,
crescita degli investimenti e della produzione sistematicamente migliore della
media nazionale), ma che al suo interno è piuttosto instabile (crescita della
produzione e degli investimenti molto contenute e un mercato del lavoro con un
peso basso sulla ricchezza generale).
Il grido d’allarme dei
sindaci del Sud: “Con l’autonomia si spacca il Paese”. Giovanni Vasso su
L’Identità il 20 Marzo 2023
Venti di guerra da Sud. I
sindaci sono scesi in campo per dire un no arciconvinto all’autonomia
differenziata. E lo fanno proprio mentre il leader della Lega Matteo Salvini fa
appello alla neosegretaria del Pd, Elly Schlein, per garantire al ddl voluto dal
ministro Roberto Calderoli un passaggio ampio e condiviso in parlamento. Più che
una possibilità, una pia illusione.
Venerdì a Napoli, le fasce
tricolori del Sud, riunitesi attorno alle organizzazioni dell’Anci e di Ali, si
sono ritrovate professare la loro opposizione al progetto. “Non è una questione
di destra o di sinistra perché io ero contrario quando il governo Gentiloni
firmava l’intesa con tre regioni”, ha spiegato il presidente dell’Anci e sindaco
di Bari Antonio Decaro, che ha ricordato ai “colleghi” di partito le
responsabilità della sinistra che “tutto parte da lì”, cioè dalla riforma
Bassanini, quella che ha interessato il Titolo V della Costituzione. Per Decaro:
“I Comuni in questi anni hanno dato di più a chi aveva più bisogno, semmai
togliendo a chi aveva meno bisogno. E le Regioni non lo l’hanno fatto. Se non lo
hanno fatto sino adesso lo vedo difficile per il futuro”. Le differenze, per il
numero uno dell’Anci, non solo soltanto tra Nord e Sud “ma anche tra aree
costiere e quelle interne, tra città e piccoli comuni della montagna, perché nel
nostro Paese ci sono tante differenze dal punto di vista economico e sociale”. E
si tratta di divari, che rischiano di essere ampliati dalla riforma voluta da
Calderoli e della Lega.
Il padrone di casa, il sindaco
di Napoli Gaetano Manfredi, aveva ribadito che l’approccio che sottostà alla
riforma dell’autonomia è, secondo lui, obsoleto. “La sfida è l’Europa e il
Mediterraneo – ha affermato Manfredi – parlare di autonomie regionali, di
frammentazione delle competenze sull’energia, sull’industria o sui porti può
essere un danno mortale per il nostro Paese. Noi lo continueremo a dirlo al
Governo e i parlamentari dovranno agire in questa direzione”.
Allo scetticismo dei sindaci
meridionali ha risposto il ministro del Sud Raffaele Fitto. Che proprio da
Napoli, ma dal palco del festivale euromediterraneo dell’economia, ha spiegato:
“Sull’autonomia c’è una discussione paradossale. Si dice che si rischia di
rompere il Paese, come se il Paese fosse unito e se il Sud fino a oggi avesse
avuto delle risposte adeguate”. E dunque: “L’ autonomia si attua in base a
quanto previsto dalla nostra Costituzione. Il testo al suo interno ha dei
passaggi molto chiari che escludono rischi e pericoli che vengono paventati. Il
primo è quello collegato al fatto che, laddove non dovesse esserci un accordo
sulla definizione dei Lep e costi standard, non ci sarà in alcun modo il ritorno
alla spesa storica, il secondo è che l’articolo 9 della legge richiama in modo
molto chiaro i commi terzo e quinto dell’articolo 119, quindi la possibilità per
le aree più svantaggiate di avere degli interventi di riequilibrio finalizzati a
una maggiore coesione”. Per il ministro: “Questi sono i fatti. Chiaramente non
leggendo il provvedimento e immaginando una contrapposizione fatta più sulla
propaganda ci può stare che parliamo di altro, ma io sto ai fatti e mi piace
parlare sulle questioni vere”.
Proprio dallo stesso palco, a
Fitto ha replicato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca:
“Siamo preoccupati per la gestione dei fondi Fsc. Sono in totale dissenso. Si
può immaginare di tenerli bloccati da nove mesi. Si sta rilanciando di nuovo il
luogo comune del Sud che non ha capacità di spesa, ma i primi che non hanno
capacità di spesa sono i Ministeri. La certificazione di spesa del ministero
dello Sviluppo è del 33%, non hanno certificato neanche la banda larga, il
ministero della Salute non ha certificato le spese Covid, il ministero delle
Infrastrutture non ha certificato la spesa per i lavori della Linea 1 della
metropolitana di Napoli. L’incapacità di spesa è in primo luogo centrale”. E
infine: “Stiamo facendo miracoli per quella che è la Pubblica amministrazione
italiana ridotta in ginocchio. Abbiamo fatto un concorso per 10mila assunti, in
questo momento se ne stanno scappando dal Sud diplomati e laureati, è un
disastro. E abbiamo la Pa con l’età media di 56 anni, quale digitalizzazione
vogliamo fare?”.
Infine, il presidente campano
De Luca mette il dito sulla piaga del Pnrr, non senza ribadire qualche stoccata
al predecessore di Fitto, l’ex ministro per il Sud Mara Carfagna: “Doveva essere
una grande occasione. Si è detto con il Governo precedente che era un grande
successo il 40% dei fondi al Sud, ma è una stupidaggine. Quelle risorse le
abbiamo avute dall’Europa per affrontare i grandi divari, strutturale,
occupazionale e di genere. Se il tema del Sud è un’emergenza concentri nel Sud
non il 40%, l’equivalente della popolazione del Sud, ma l’80%. Questa era la
scelta che avremmo dovuto fare”.
«L’AUTONOMIA APRE LA STRADA
AL GRANDE NORD». La riforma oltre che allargare il gap territoriale e
mettere a rischio la competitività, secondo il presidente di Svimez, Giannola,
porta a una «riorganizzazione istituzionale all’italiana», svuotando la
sovranità dello Stato. LIA ROMAGNO su Il Quotidiano del Sud il 21 marzo 2023.
La spaccatura del Paese, con un
ulteriore allargamento della distanza tra il Nord e il Sud, rischi per la
competitività economica del Paese: sono gli scenari più evidenti cui conduce il
percorso verso l’autonomia differenziata incardinato con l’approvazione, il 15
marzo in Consiglio dei ministri, del testo definitivo del disegno di legge
delega Calderoli.
Ma accanto a questi se ne apre
un altro – che li ingloba ed esacerba – che porta «ad una riorganizzazione
all’italiana» del sistema istituzionale, con un «Grande Nord autonomo» e uno
Stato centrale praticamente «fantasma».
E’ il quadro evocato dal
presidente della Svimez, Adriano Giannola, nel corso dell’incontro sul tema
“Politiche pubbliche e geografia istituzionale – Autonomia differenziata”,
organizzato dall’associazione in collaborazione con il Cnel, cui hanno preso
parte Luca Bianchi, direttore generale di Svimez, Massimo Villone, professore
emerito di Diritto costituzionale della “Federico II” di Napoli, Giuseppe Roma,
segretario generale dell’Associazione per le Città Italiane Rur (Rete Urbana
delle Rappresentanze), Alessandro Bianchi, consigliere di Svimez, Giordana
Pallone, consigliera Cnel e coordinatrice area Stato Sociale e diritti Cgil,
Enzo Bianco, presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci, e Vito Grassi,
presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di
Coesione Territoriale e vicepresidente di Confindustria.
Giannola ha posto l’attenzione
su quello che considera un processo irreversibile, «non emendabile dal
Parlamento», che di fatto ne resta ai margini. Si tratta, ha sottolineato, di
«una legge rafforzata»: «La reversibilità potrebbe esserci con una nuova intesa
tra Stato e Regione, ma è difficile che una Regione rinunci all’autonomia», ha
spiegato Villone, evidenziando la possibilità «di un effetto domino che
metterebbe a rischio l’unità del Paese, mentre il divario tra Sud e Nord
inevitabilmente si allargherebbe».
Giannola ha poi indicato i
rischi che derivano «dall’astuzia di Calderoli» nel congegnare il meccanismo a
due tempi su cui si regge il provvedimento, sul quale ha sollevato dubbi in
termini di costituzionalità, oltre alla dubbia costituzionalità di un’autonomia
differenziata che di fatto arriva a federalismo incompiuto. Il primo tempo, ha
sostenuto, consente all’autonomia di «procedere come un treno», arrivando in
“stazione” entro un anno. Il secondo invece è legato alla definizione dei Lep,
per cui le materie che li prevedono – sanità, istruzione e mobilità pubblica –
non possono essere oggetto delle pre-intese, e quindi finché non si sarà
provveduto in tal senso e sia stato costruito «l’armamentario finanziario
necessario» non potranno essere trasferite.
Ma le altre sì, «con le
risorse, il personale e le salmerie che stanno dietro queste funzioni, e con il
riferimento alla spesa storica, che è quello che interessa alle Regioni». «La
polpa economica, che interessa davvero le Regioni, è la rete delle
infrastrutture che è ciò che abilita una Regione a farsi Stato: la gestione di
aeroporti, porti, autostrade, protezione civile. Questo è l’obiettivo vero, il
resto è demandato a futura memoria, o ai Dpcm di un premier che si prenderà la
responsabilità di definire entro un anno quello che non è stato definito in 20
anni, cioè i Lep».
Le rassicurazioni date da
Calderoli al presidente di Confindustria, che aveva evidenziato come il sistema
imprenditoriale non avrebbe retto di fronte alla necessità di confrontarsi con
tante burocrazie diverse, secondo Giannola, poggiavano sull’articolo 117, comma
8, della Costituzione, cioè sulla possibilità per le Regioni di trovare intese
per costituire organismi comuni: «È il passaggio immediatamente successivo per
chi razionalmente vuole l’autonomia. Nei fatti il ministro ha detto a Bonomi,
non ti preoccupare, tempo un anno le Regioni, senza aver fatto la secessione,
attraverso le intese faranno un “grande Nord” che diventa autonomo, e intanto
tramite le intese con il governo centrale hanno già ricevuto la sovranità sulle
infrastrutture. La polpa è tutta in questo nuovo grande assembramento che mette
le Regioni alla pari dello Stato». «E’ un mistero come in un simile contesto si
possa pensare al presidenzialismo, tanto più che – ha detto Giannola – quello
che resta è uno Stato fantasma, che governa sui sette colli di Roma, mentre la
sovranità vera è altrove».
C’è poi il nuovo scenario
geopolitico ed economico da tener presente e che fa emergere le contraddizioni
di questo processo: è venuto meno il modello mitteleuropeo con cui le Regioni,
ha sostenuto Giannola, «hanno condizionato il Sud» anziché puntare «sul
rafforzamento del Mediterraneo». Anche l’Europa, «dopo 20 anni ha scoperto che
il Mediterraneo è importante, che il porto di Gioia Tauro e Augusta sono la
nuova Rotterdam da qui a 20 anni, perché è con l’Africa e il Medio Oriente che
sono i marcati e la demografia del futuro l’Europa deve fare i conti». «Bisogna
portare il dibattito in Parlamento perché questi temi possano arrivare
all’attenzione dell’opzione pubblica e far emergere le diverse sensibilità nella
coalizione», ha avvertito Villone.
Luca Bianchi ha posto in
evidenza i rischi che arrivano da quella che ha definito «un’attribuzione delle
competenze a la carte», slegata dalla “virtù” dimostrata in quell’ambito su cui
si richiede la competenza: «Potremmo arrivare al paradosso che una Regione
commissariata come la Calabria potrà chiedere l’autonomia sulla sanità. Avremo
tante ragioni a statuto speciale, ognuna speciale a modo suo. Altro punto
importante – ha aggiunto – è il meccanismo di finanziamento: si stabilisce la
spesa su base della spesa storica e si stabilisce su quel valore finanziario a
quanto corrisponde il gettito Iva di quella regione. Si tratta di un federalismo
senza responsabilità. Che riduce i Lep a un’esigenza burocratica, senza peraltro
prevederne il finanziamento, spacca il Paese e cristallizza il divario Nord-Sud
quando l’Europa ha messo in campo con il Next Generation Eu un modello
cooperativo fondato sul principio che la crescita del Continente si ottiene solo
riducendo i divari».
Per Giuseppe Roma «il rischio
che stiamo correndo è enorme: perché il problema non è solo una doverosa difesa
del Mezzogiorno, ma la difesa del Paese. La frammentazione burocratica rende il
sistema centrale meno efficiente, l’Italia diventerà più debole, non governerà i
processi economici e ci sarà una frammentazione che renderà meno efficienti i
settori pubblici». E questo, ha sottolineato, di fronte a una geografia
economica che è cambiata, «l’asse portante è diventato Bologna-Milano, il
sistema veneto della piccola impresa non sta reggendo alla dimensione
competitiva, e comunque la forza produttiva, anche nelle regioni più ricche, si
concentra in pochi territori». «Quindi – ha puntualizzato Roma – il nostro
sistema istituzionale deve andare dietro a questa concentrazione o avere una
qualche funzione di riequilibrio?».
Vito Grassi ha posto la
questione soprattutto su un piano di competitività globale, con la Cina e usa
Europa hanno messo sul piatto cifre stratosferiche sulla sfida dell’industria,
mentre l’Europa fa fatica a trovare un strategia unitaria. «L’Italia da sola non
riesce a competere – figuriamoci un singolo territorio – ha bisogno di
un’Europa sempre più compatta che condivida politiche non solo nelle condizioni
di emergenza di emergenza, ma di scelte strategiche condivise sulle produzioni
da preservare, sull’energia, sulle produzioni che ci svincola dipendenza di
altre grandi potenze».
Grassi ha quindi indicato i
paletti che l’associazione degli industriali ha posto di fronte un percorso che
si ritiene legittimo in quanto previsto dalla Costituzione: «Non deve
compromettere l’unità nazionale, e qui si passa per l’individuazione delle
materie: quelle individuate 20 anni fa richiedono una revisione, bisogna
escludere, ad esempio, le politiche commerciali dell’Unione, le grandi reti
energetiche e di comunicazione, non possono essere declinate da campanilismi
regionali ma asservite a strategie e scelte comuni, e condivise con il mercato
unico europeo».
C’è poi il tema della finanza
pubblica: «La riforma non deve comportare risvolti negativi» su questo fronte:
«Il passaggio al criterio del costo storico a fabbisogni ottimali calcolati per
benchmark implica lo stanziamento di risorse ingenti per consentire alle Regioni
meno avanzate di affrontare con successo la sfida per l’ottimizzazione. Ma
veramente pensiamo di farlo a invarianza dei saldi di finanza pubblica? Si può
affrontare con la sola logica delle quote di compartecipazione a tributi
nazionali che possono variare di anno in anno nella legge di Bilancio? Il fondo
di perequazione non può essere asservito al gettito fiscale: se l’obiettivo è
quello di ridurre i divari – e questo è l’input che l’Italia ha ricevuto
dall’Europa e finanziamento ricevuto con il Pnrr lo sottolinea -, non possiamo
legare all’annualità fiscale la scelta e intervenire o meno».



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: